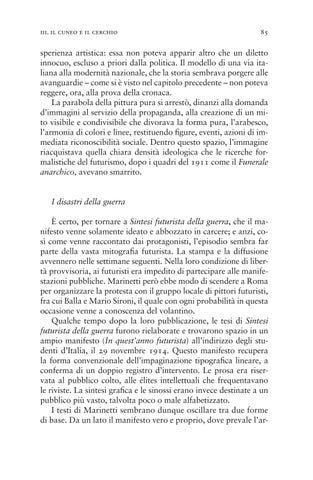iii. il cuneo e il cerchio
85
sperienza artistica: essa non poteva apparir altro che un diletto innocuo, escluso a priori dalla politica. Il modello di una via italiana alla modernità nazionale, che la storia sembrava porgere alle avanguardie – come si è visto nel capitolo precedente – non poteva reggere, ora, alla prova della cronaca. La parabola della pittura pura si arrestò, dinanzi alla domanda d’immagini al servizio della propaganda, alla creazione di un mito visibile e condivisibile che divorava la forma pura, l’arabesco, l’armonia di colori e linee, restituendo figure, eventi, azioni di immediata riconoscibilità sociale. Dentro questo spazio, l’immagine riacquistava quella chiara densità ideologica che le ricerche formalistiche del futurismo, dopo i quadri del 1911 come il Funerale anarchico, avevano smarrito. I disastri della guerra È certo, per tornare a Sintesi futurista della guerra, che il manifesto venne solamente ideato e abbozzato in carcere; e anzi, così come venne raccontato dai protagonisti, l’episodio sembra far parte della vasta mitografia futurista. La stampa e la diffusione avvennero nelle settimane seguenti. Nella loro condizione di libertà provvisoria, ai futuristi era impedito di partecipare alle manifestazioni pubbliche. Marinetti però ebbe modo di scendere a Roma per organizzare la protesta con il gruppo locale di pittori futuristi, fra cui Balla e Mario Sironi, il quale con ogni probabilità in questa occasione venne a conoscenza del volantino. Qualche tempo dopo la loro pubblicazione, le tesi di Sintesi futurista della guerra furono rielaborate e trovarono spazio in un ampio manifesto (In quest’anno futurista) all’indirizzo degli studenti d’Italia, il 29 novembre 1914. Questo manifesto recupera la forma convenzionale dell’impaginazione tipografica lineare, a conferma di un doppio registro d’intervento. Le prosa era riservata al pubblico colto, alle élites intellettuali che frequentavano le riviste. La sintesi grafica e le sinossi erano invece destinate a un pubblico più vasto, talvolta poco o male alfabetizzato. I testi di Marinetti sembrano dunque oscillare tra due forme di base. Da un lato il manifesto vero e proprio, dove prevale l’ar-