
7 minute read
Gli italiani sani
stagione dei «Valori Plastici», fino ad acquisire una «potenza ingenita e feconda» e, quel che a Carrà stava più a cuore, una solidità d’intenti che porta l’«alta figura morale» del pittore a scavalcare ogni possibile gusto retrospettivo o accademico. (Carrà parlò proprio di una «procella pseudo-tradizionalistica» cui è doveroso opporsi)12. Siamo nel 1925. L’anno successivo cadde la prima partecipazione alla mostra del Novecento Italiano. Solo tre opere, accuratamente ripartite tra figura (l’Autoritratto con cappello 1924), paesaggio (Vitali 108) e natura morta. Un Arlecchino ad acquerello venne destinato a «Solaria» per una fugace apparizione, e quindi nel volume di Raimondi Dialogo, dello stesso anno.
Quando Morandi giunse a uno dei momenti più alti, densi e conseguenti della sua pittura, negli anni 1927-28, era pienamente nell’orbita del «Selvaggio». Qui si compì la maturità stilistica di Morandi e, nello stesso tempo, presero forma i caratteri della sua fortuna critica. «Il Selvaggio» e «L’Italiano», Soffici Maccari e Longanesi furono i protagonisti di questa fase.
Advertisement
Gli italiani sani
Nel giugno 1926 Morandi venne reclutato a fianco degli «italiani sani» richiamati da Longanesi sull’«Italiano» e fra gli artisti e poeti incaricati della riedificazione artistica del regime: insieme a Soffici, Rosai, Maccari, Oppo, Bartoli13 .
Per almeno un quinquennio, la figura di Morandi fu pienamente organica alle posizioni del «Selvaggio» di Maccari. Non voglio con questo ratificare le conclusioni eccessive che ne sono state tratte14, strumentalizzando la partecipazione a una rivista che, in realtà, fu assai meno ossessionata dalla politica di quanto non sembri. Vi sono però almeno due punti utili per confermare una piena affinità con l’estetica strapaesana. E sono, per primo, la
12 C. Carrà, Giorgio Morandi, «L’Ambrosiano», 25 giugno 1925, ora in Id., Tutti gli scritti, cit., pp. 489-491. 13 L. Cavallo, «A Prato per vedere i Corot», corrispondenza Morandi-Soffici per un’antologica di Morandi, Milano, Galleria d’Arte Farsetti, 1989, p. 20. 14 Cfr. E. Braun, Speaking Volumes: Giorgio Morandi’s Still Lifes and the Cultural Politics of Strapaese, «Modernism/Modernity», II, 1995, n. 3, pp. 89-116.
densità di presenze: quattordici fra disegni e incisioni nel triennio 1926-28 sul «Selvaggio», e poi certo a diminuire, ma per un totale non disprezzabile di ventotto acqueforti fino al gennaio 1940. Il culmine dell’attività grafica di Morandi corrispose agli anni di più intensa collaborazione con il «Selvaggio». Non è esistito alcuno spazio più rappresentativo del lavoro di Morandi almeno fino alla metà degli anni Trenta.
Inoltre – e questo è il secondo punto – va considerato che una lettura contenutistica, fosse anche limitata alle fruste categorie strapaesane, era a quella data l’unica percorribile a fronte di una pittura che, a lungo, si rese indisponibile a indagini formalistiche o a scandagli storicistici, in ragione della sofisticata elaborazione delle proprie fonti visive. Il denso filtro dello stile, insomma, rimaneva una forma di opacità e forse, anche, di autodifesa. L’opera di Morandi si poneva volutamente al di fuori della storia e della retorica di un’arte nazionale. Rimaneva la cronaca, e quella caparbia e meschina del «Selvaggio» fu l’unica possibile.
Come si è visto in precedenza, Soffici cercava ossessivamente un artista: il tipo d’artista italiano, classico, equilibrato, in grado di confortare i modelli della tradizione figurativa con un’espressività sorvegliata e non epigonica, abile a ricusare tanto le lusinghe della più superficiale «modernità» quanto di sposare una misura definitiva, moderna ma non retorica; capace di un affondo nella tradizione delle forme. Lo trovò in Morandi, ed esortò il pittore a fornire d’incisioni e disegni il foglio di Maccari.
A partire dal settembre 1926 «Il Selvaggio» informò con puntualità sull’opera incisa di Morandi. Il bolognese fu proclamato da «Strapaese» vincitore del premio di pittura per il 1928, senza aver mai pubblicato un dipinto, ma solo grafica: un aspetto che condizionò alquanto la sua ricezione15 .
I primi fogli d’incisioni (il Paesaggio bolognese del 1921 e il Paesaggio con la ciminiera, fig. 8.2) furono pubblicati in un formato ridotto. La scelta editoriale vincolava queste opere a un valore essenzialmente illustrativo. Un caso singolare è la pubblicazione, nel maggio 1927, di un foglio morandiano di sette anni
15 F. Fergonzi, Giorgio Morandi, in Dizionario del fascismo, a cura di V. De Grazia e S. Luzzatto, Torino, Einaudi, 2003, ad vocem.
Figura 8.2 Giorgio Morandi, Paesaggio con la ciminiera, 1926, «Il Selvaggio», 1 ottobre 1926.
prima, unico indizio della precedente maniera metafisica, e prima riproduzione in assoluto di un suo disegno16 .
Ma la presenza di Morandi si comprende ancor meglio in una valutazione complessiva della rivista, nell’orchestrazione di testi e immagini. Si prenda come esempio il numero del settembre 1926. Troviamo fogli di Ensor, Rosai, Maccari, Soffici e la minuscola acquaforte Natura morta con pane e limone. Sotto quest’immagine, venne impaginata una satira di Salvator Rosa «contro Giorgio Morandi»: un testo si faceva leggere come l’assoluzione alla presunzione dei pittori di dipingere solo nature morte e oggetti meschini.
L’autoritratto morandiano a matita che Maccari pubblicò il 15 marzo 1927 è un foglio di carta che venne piegato in quattro per renderne agevole la spedizione (se ne indovinano le pieghe anche nella riproduzione fotografica). Impaginato in prima pagina, al
16 Pasquali, Tavoni, Morandi. Disegni, cit., n. 1920/7.
centro, su due colonne, per l’intera larghezza ebbe in calce il titolo di un brano di Soffici, Semplicismi. Il disegno (che è una variante degli autoritratti a olio del 1924) offriva un tipo di artista giovane, la camicia ben chiusa, senza il gilet che aveva indossato durante le sedute per gli oli, ma con una giacca. Lo sguardo è diritto verso lo spettatore, la bocca appena socchiusa, le mani non stringono pennelli e si capisce perché: questo è un autoritratto a disegno, e a nulla servono gli attrezzi del pittore; ma per chiarire il ruolo, il mestiere che è in effigie, compare la tavolozza. Una gran curva nell’angolo basso a sinistra del foglio, ed ecco un oggetto a memoria (nelle varianti a olio la tavolozza è rettangolare), che qualifica il pittore nel suo offrirsi ingenuo, immediato, gli occhi spalancati a corrugare la fronte con effetto di meraviglia. Morandi ritrovò il suo disegno scontornato dall’ennesimo feroce monito di Soffici, contro il deforme spirito gotico contrapposto a quello, sobrio ed equilibrato, delle civiltà latine17. È fra il profluvio delle pagine di Maccari e Soffici reiterate di moniti a italianità e antimodernismo, e di un’iconografia al loro traino, che il lettore del «Selvaggio» giungeva alle acqueforti morandiane. Incontrarle sulle colonne della rivista non era come coglierle nella delibazione puramente formale del foglio scontornato.
Ed ecco qualche altro esempio. La figura femminile assopita (Vitali 29) si trovò vis-à-vis con un legno di Leonetto Tintori a segni bruschi e rapidi e, accanto, la recensione di Soffici al volume apologetico di Carlo Delcroix Un uomo e un popolo. Il nitido Ritratto femminile 1928 (Vitali 49) fu accompagnato da Fedeltà di Piero Bargellini, prosa d’antimodernismo reazionario, fitto di richiami austeri alla consapevolezza del vivere cristiano. Una campagna con cascine covoni e prati declivi, disegno morandiano del 1926 che Arcangeli menzionò come un «ristagno» di una stagione debole, fu presentato a fianco di una spigolatrice di Giuseppe Gorni che sembrava essere la naturale abitante di quel paesaggio.
Episodio dirimente fu la pubblicazione, nell’aprile del 1928, del Paesaggio (Casa a Grizzana), fig. 8.3. Per la prima volta, l’acquaforte fu presentata in un formato ampio, che dava ancora più enfasi alla monumentalità del soggetto. Questa tavola divenne
17 A. Soffici, Semplicismi, «Il Selvaggio», 15 marzo 1927, p. 1.

Figura 8.3 Giorgio Morandi, Paesaggio (Casa a Grizzana), 1927, «Il Selvaggio», 15 aprile 1928.
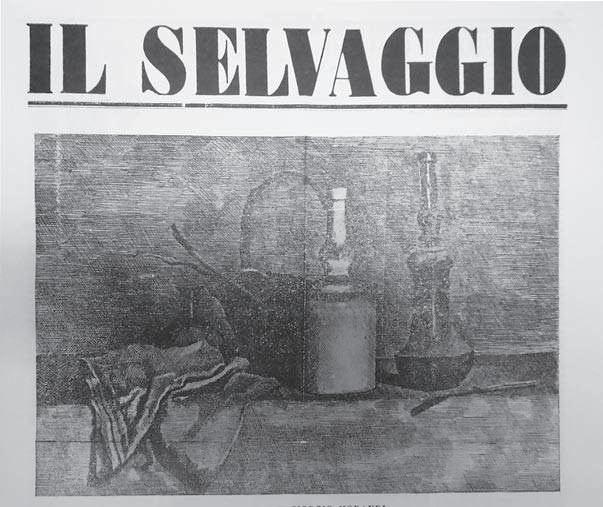
Figura 8.4 Giorgio Morandi, Natura morta con panneggio a sinistra, 1927, «Il Selvaggio», agosto 1928.
l’archetipo di una serie d’opere testimoniate sul «Selvaggio» dalle varianti di Soffici e di Tintori, che ripresero il tema della dimora isolata in un paesaggio severo e spoglio, in formato verticale.
La monumentale Natura morta con panneggio a sinistra guadagnò la prima pagina del «Selvaggio» nell’agosto 1928 (fig. 8.4). Solo a partire da questa data, la grafica di Morandi iniziò a ottenere un’autonomia e uno spazio propri, e dunque una ricezione meno vincolata alla linea ideologica della rivista. Senza andar troppo oltre gli anni Venti, è infine opportuno segnalare un paio di disegni proposti nell’estate del 192918. Sono due paesaggi: il primo con punto di vista dall’alto, quasi a volo d’uccello, assai sgranato, con edificio rurale nel piano intermedio e vege-
18 Pasquali, Tavoni, Morandi. Disegni, cit., nn. 1926/5, 1926/6.




