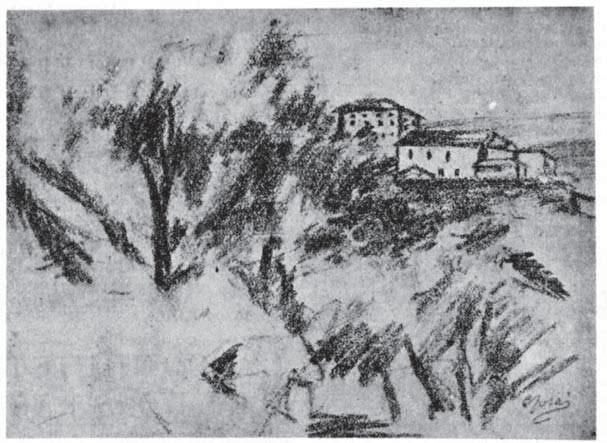
16 minute read
Homo rusticus
niva una prassi attualizzata nella coscienza del mestiere. La virtuosa mescolanza delle risorse del «paratesto» – per riprendere il concetto estensivo di Genette – innescava un registro parodistico che prendeva la forma dell’iperbole, dell’allusione compiaciuta, della dilettazione artificiosa e della satira. Quella per la regia di Maccari fu la tentazione di una commedia umana, non poco contrastata dal temperamento di Soffici, che nel frattempo, riavvicinatosi a Papini, stava invece vivendo un profondo dramma interiore.
Homo rusticus
Advertisement
Segno concreto della continuità del lavoro di Soffici, «Il Selvaggio» ospitò l’ultimo articolo della serie Roma-Napoli-Pompei, resoconto del viaggio di Soffici con il pittore Armando Spadini, pubblicato inizialmente su «Galleria».
Ancora una volta, il confronto con l’arte antica suggeriva un paragone con la situazione attuale. L’arte cristiana e bizantina, pur nelle sue scorrettezze di disegno e di colore, di sproporzione delle forme, e nonostante lo smarrimento della tecnica classica, emanava per Soffici una forza di comunione, «un senso di verginità primaverile, con qualcosa di popolaresco e di appassionato». In questa voluta assenza di perfezione si poteva così ravvisare «l’elemento doloroso, tragico del cristianesimo, quello che apre ed approfondisce l’anima umana, nello stesso tempo che vi ripone i germi dell’amore e della carità fraterni, i germi dell’Humanitas». Soffici cercava, ora, di riformulare il proprio canone estetico alla luce di un ritrovato senso di religiosità.
Secondo lo sperimentato modello di critica che diveniva determinazione di poetica, egli notava così che i volumi e le masse si rassodavano nella «chiarificazione aerea», nella «casta attenuazione del colorito», nella «drammatizzazione del colore», confermando, ancora una volta, quell’ampio paradigma di continuità – già storicizzato, da parte sua, nel Longhi delle lezioni romane del 191422 – che correva da Masaccio a Piero, Tiziano, Tintoretto
22 R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura italiana (1914), Milano, Rizzoli, 1994; Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana, «L’Arte», XVII, 1914, pp. 198-222. L’impatto della monografia di Longhi su Piero della Francesca
e poi s’irradiava in Rembrandt, Goya, Delacroix, Cézanne: «Così, se di barbarie si deve parlare, barbara dovrebbe essere tutta la modernità, barbari noi stessi». A confronto di quella greca e pagana, la bellezza moderna, cioè cristiana, vinceva sull’equilibrata serenità dell’arte classica per un elemento sostanziale: la «terribile profondità dell’anima che ha vissuto il dramma del dolore e del sacrificio, ed è umana ed atrocemente religiosa».
Da risorsa squisitamente formale, la gaucherie di Cézanne diveniva, insomma, un’attestazione di fede. Rimuovendo il mito della classicità pagana, e riavvicinandosi così agli orientamenti confessionali di Papini, Soffici sposava il dramma della modernità cattolica, della «realtà nostra, di occidentali, di cattolici e d’italiani». Parole che erano chiuse da un disegno a matita di Rosai raffigurante la fiorentina Piazza del Carmine (fig. 7.5): un’immagine desolata e silenziosa che sembrava testimoniare la natura, popolana ma tormentata, del suo autore23 .
Testi e immagini del «Selvaggio» s’intrecciavano così in una pluralità di referenze; la disputa culturale si alimentava col riscatto della tradizione, resa attuale nei suoi essenziali valori di modernità: «E se vi sembra oscura questa qualifica di selvaggi, sappiate che per noi essa esprime quanto vi è di più schiettamente italiano, di antico, di caratteristico, di paesano, in perpetua incompatibilità con quanto è liberalesco, democratico, americano, dozzinale, macchinale, “turistico”, enfatico e retorico»24. Tutt’intorno a queste pagine comparivano, come dimostrazioni imperiture, i paesaggi rurali e i volti contadini ritratti da Rosai, Maccari, Lega. «Arte o trucco: ecco il nostro dilemma», affermò Rosai: la difesa delle «piccole cose» attraverso il recupero dell’Ottocento più intimista, della tradizione macchiaiola impressionista (da Fattori, oggetto d’una cruciale monografia sofficiana nel 1921, a Lega, Signorini, fino a Corot, Millet, Cézanne) contrapposto al colto
(Roma, Valori Plastici, 1927) è ampiamente acquisito dalla storiografia: si rinvia pertanto ai saggi di F. Fergonzi e G. Agosti nel catalogo della mostra Piero della Francesca e il Novecento, cit. 23 A. Soffici, Roma-Napoli-Pompei, «Il Selvaggio», 31 maggio 1926, p. 1; Rosai si fa vivo con alcune becerate, ibid., 15 giugno 1926; A. Lega, Ottone Rosai pittore fiorentino, ibid., 15 febbraio 1927. 24 M. Maccari, Idee selvagge e parole a muso duro, «Il Selvaggio», 15 luglio 1926, p. 1.
e sorvegliato classicismo del gruppo toscano del «Novecento» che si stava richiamando, esplicitamente, allo «stile di intelligente modernità» promosso a Milano25. La rivalutazione mercantile dell’Ottocento più deteriore, la facilità della materia pittorica, il modernismo come cifra, apparivano nel loro insieme come insidiose scorciatoie, che conducevano infine a un mero tecnicismo e alla disumanizzazione dell’immagine26 .
Ecco dunque spiegata la centralità riconosciuta al disegno: la «sincerità» (termine che ha una ricorrenza quasi ossessiva) di un rapporto immediato con le cose e la necessità di riconoscimento del reale implicava un linguaggio autonomo, che permettesse la trasmissione emotiva al di fuori del cifrario preconcetto. Le immagini andavano condotte dalla sensibilità dell’autore alla percezione condivisibile senza il filtro di stili e linguaggi predeterminati. Se c’era un modo per annullare tutta la didattica modernista di Soffici, il suo insistere intorno al 1913 sulla trasparenza del «geroglifico espressivo» e dell’arabesco pittorico, era questo27 .
Né appunto né abbozzo, il disegno venne qualificato come genere proprio e compiuto: una tecnica che determinava uno stile; un testo specifico, offerto nell’esemplarità di temi e soggetti (come si è visto, paesaggi, nature morte, figure) sottratti a ogni altra determinazione, al punto da lasciare alla didascalia la sola menzione della tecnica e dell’autore («Disegno di Ottone Rosai», «Incisione di Giorgio Morandi»). La semplicità, e non la povertà, venne accreditata come la più grande audacia dell’epoca. Il disegno fu celebrato come arte capace di rendere il massimo delle impressioni e delle intenzioni con il minimo dei mezzi sensibili (fig. 7.6). Fu rigettato l’uso eccessivo e sensuale della materia pittorica: essa appariva come il frutto d’una destrezza inventiva, destinata a sci-
25 R. Franchi, I toscani del Novecento, «L’Illustrazione toscana», IV, 1926, n. 4, p. 29; Id. Mostre fiorentine, «La Fiera Letteraria», 1 aprile 1928, p. 4; per l’intera polemica di questo gruppo (che si identificava nelle posizioni di «Solaria») e «Il Selvaggio», v. G. Uzzani, Artisti e letterati fra il Novecento toscano e Solaria, «Bollettino d’Arte», LXXI, n. 39-40, settembre-dicembre 1986, pp. 65-102. 26 O. Rosai, Canagliate fiorentine, «Il Selvaggio», 15 luglio 1926, p. 3, e 1 ottobre 1926, p. 2. 27 Cfr. P. Fossati, Paragrafi per il disegno fra le due guerre, in Disegno italiano fra le due guerre, catalogo della mostra (Modena, Galleria Civica, 1983), Modena, Panini, pp. 11-59.
Figura 7.6 Ottone Rosai, Disegno, «Il Selvaggio», 15-30 luglio 1926.
volare inesorabilmente in un traboccante manierismo. La visione poetica del mondo riposava, invece, su mezzi tali da rimuovere ogni forma estrinseca e inessenziale. Questi mezzi erano per Soffici l’affresco, il mosaico, la tempera; il disegno era il loro naturale esercizio primo. Si trattava di tecniche antiche, che permettevano di fissare in modo evidente e duraturo concetti e sentimenti dell’autore, e lasciare affiorare in pieno lo spirito che, per essi, si manifestava nell’opera. Ogni residuo di materialità andava occultato come realtà grezza e reso inosservabile28 .
Tratteggiati gli intenti della nuova rivista e delimitati gli schieramenti, nell’ottobre del 1926 si avviò la «Mostra permanente del disegno italiano», nello sforzo di rivalutare un’arte fino a quel punto negletta, «troppo aristocratica, troppo sdegnosa e aborrente dal chiasso reclamistico». Ma quali sono i temi addotti, nella pagina di presentazione? Un ragazzetto, due lattanti, un vecchio dal naso rincagnato, una donna paziente, un paesaggio primitivo;
28 A. Soffici, Periplo dell’arte, «Il Selvaggio», 15 dicembre 1927, p. 1.

Figura 7.7 Ardengo Soffici, Carrà sur le motif, «Il Selvaggio», 1 ottobre 1926.
uno schizzo di Soffici che sorprende Carrà en plein air e una lunga didascalia esplicativa (fig. 7.7). Al sublime recupero del classico e alle seduzioni dell’immagine moderna si opponeva l’eternità del popolo e delle sue leggi. La pittura e il disegno di figura dovevano assecondare questi valori, senza adoperarsi a un recupero figurativo che mantenesse il sapore, tra l’archeologico e l’estetizzante, del corpo nudo, così come stava riemergendo dalle tante estetiche neoclassiche o neorinascimentali promosse dalle Biennali veneziane e romane. «Ritorna il nudo; e con il nudo la bellezza: gli dei ritornano, tenendosi per la mano», aveva notato la Sarfatti in una distesa pagina; «ci preme la decadenza del bel nudo umano, come prima espressione estetica delle stirpi millenarie, prima estrinsecazione artistica della gioia di vivere», constatò Bragaglia, preoccupato dal panorama di fanciulle dai seni avvizziti e di uomini filiformi che masticavano hashish29. Sulla
29 M. Sarfatti, Segni colori luci, Bologna, Zanichelli, 1925, p. 44; A. G. Bragaglia, Scultura vivente, Milano, L’Eroica, 1928, p. 243.
ruvida carta stampata da Maccari mai vi fu traccia del maschio vigore dei nudi corpi atletici; solo la fisionomia spietata e familiare, il contrassegno genuino, la garanzia dei valori incarnati.
Soffici s’incaricò ancora un volta di chiarire la questione: Tornare al segno fu l’articolo di apertura di un fascicolo successivo (Maccari, perché s’intendesse, vi impaginò anche una sua incisione con una madre che pulisce il bambino). L’arte veniva intesa come baluardo contro la dissoluzione della morale e dei valori, come moto di ripristino delle virtù italiane. «È ormai troppo tempo — scrisse infatti Soffici — che al rigore fascista, alla austerità, alla religiosità, alla fattività, all’eroismo […] vanno parallele sotto veste di principi estetici, di poesia e d’arte le aberrazioni più contrastanti con tali virtù». Vi era dunque la necessità di attuare «un ristabilimento totale di certi valori, che sono poi valori italiani, cioè intimamente connaturati all’essenza del popolo italiano, ma per troppo tempo e troppo bestialmente barattati con valori falsi ed opposti, indicabili con vari termini come: europei, protestanti, rivoluzionari nel senso anarchico, idealistici alla tedesca, e simili»; diversamente, sarebbe stata solo la caduta inevitabile verso il «nullismo internazionale», fase estrema della degenerazione romantica, antitaliana per eccellenza. E che contrastava apertamente, per l’arbitrio creativo e l’anarchia sovversiva, con la misura d’ordine, di cultura e di gusto della tradizione italiana. La necessità, ossessivamente ripetuta, era quella di rendere attuali i valori eterni della storia contro la «sbracata originalità»: la consapevolezza della memoria contro il rispecchiamento meschino e superficiale sulla grandezza del passato.
In questi termini si inquadrò anche una polemica lettera rivolta da Maccari a Marinetti, partecipe al dibattito di «Critica fascista» con una presuntuosa equazione tra arte italiana, futurismo e fascismo30. Certo, dietro a questa linea intransigente del primo «Selvaggio» artistico vi erano motivazioni contingenti e ineludibili: cosa altro potevano scrivere, gli artisti, una volta interpellati nelle inchieste ufficiali? Essi risposero come non altrimenti potevano fare dei tesserati di partito sulla rivista di Bottai:
30 Sull’inchiesta del 1926-1927 dedicata alla cultura fascista, v. C. Bordoni, Fascismo e politica culturale: arte, letteratura e ideologia in Critica fascista, Bologna, Brechtiana, 1981.
rilasciare delle rassicuranti dichiarazioni di fedeltà, e poi tornare a lavorare come prima. Così, dichiarandolo «assolutamente incompatibile con il regime fascista», Maccari denunciò il futurismo come artificioso prolungamento ricco di «internazionalismo, manierato, convenzionale, democratizzato, adatto al bolscevismo»: lontano da un effettivo contributo alla restaurazione dei valori secolari e al raggiungimento di quella che invocò, scrivendola tutta in corsivo, come «modernità nostra, italiana»31. E per farlo comprendere, Maccari e Soffici riempirono la pagina di quello stesso numero del «Selvaggio» con acqueforti di Morandi (la Natura morta con il cestino di pane, Vitali 14) e Carrà (la Testa di ragazzo 1924) e poi Rosai, Lega, Soffici. Tutti autori che avevano a loro particolare modo attraversato il futurismo e che si ritrovavano ora, per impiegare le parole con cui Lega presentò Carrà, «sui piani immutabili della verità in cerca della struttura e dell’intimità poetica delle cose». Parole che sembrano, e forse erano davvero, suggerite da Soffici.
L’accurata mescolanza di testo e immagini fu uno stratagemma ripreso qualche tempo dopo, allorché Maccari scrisse una lettera aperta a Marinetti dove, pur rispettando il movente politico futurista, non si taceva la netta divergenza verso la sua componente «anticlericale e antirurale».32 Argomenti che sembravano trarre conforto dal paesaggio di Rosai e dall’asciutta natura morta con pani tazza e bottiglie tracciata a matita da Morandi nel 1920 (fig. 7.8).
E ancora sulla figura di un pittore futurista che si era lamentato di essere stato messo sul piano del «luteranesimo» e del «protestantesimo» si aprirono i Semplicismi con cui Soffici recuperò il titolo di una rubrichetta ai suoi bei tempi stilata con Carrà su «Lacerba». Soffici confermò l’esistenza di una vera e propria estetica di derivazione protestante, ravvisando in essa un principio di libero esame, che non ammetteva per l’arte «altre norme all’infuori di quelle che intuitivamente stabilisce, col fatto stesso della propria espressione, il cosiddetto genio individuale dell’artista». Donde lo «sfrenato individualismo creativo e ne-
31 «Il Selvaggio», 15 gennaio 1927, p. 2. 32 M. Maccari, Lettera aperta a Filippo Tommaso Marinetti, «Il Selvaggio», 31 maggio 1927, p. 38.
gazione implicita di ogni tradizione, di ogni regola di giudizio, come di qualsiasi funzione sociale dell’arte, nel senso che questa possa avere una qualche funzione connettiva fra gli uomini di una medesima comunità». La pagina di Soffici paventava l’oscurità e l’incomprensione della libera creazione individuale: l’autonomia della fantasia conduceva per forza all’astrattismo e all’arbitrio delle forme invece che alla rappresentazione poetica del mondo reale33 .
Assai presto, si arrivò alla contrapposizione tra uno spirito «gotico», caratterizzato da spontaneità, indisciplina, libertà – una sensualità dionisiaca che sfociava nell’orrido, nel deforme e nel mostruoso – e uno spirito «latino», mediterraneo, greco-romano: retto da ordine, misura, equilibrio, sobrietà, squisitezza virile. La contrapposizione grafica che abbiamo incontrato in Sintesi della guerra mondiale (cfr. cap. 3) si sostanziava con argomenti attuali: «esigenze italiane» opposte ai «tentativi aberranti di operatori bastardi», così volle concludere Soffici. Tali argomenti, rilanciati nella cultura italiana a partire dalla coeva diffusione delle tesi di Spengler, sembravano confermare quello «sciovinismo romanogermanico» denunciato da Trubeckoj già nel 1920. La contrapposizione tra esprit e geist, che nondimeno ebbe definitiva confutazione da parte di Croce, facilitava la preoccupante schematicità delle opposizioni34 .
Mentre questi «semplicismi» si avviavano a prendere la forma di estenuanti variazioni intorno a un’ossessiva idea di italianità, Soffici tollerò, anzi sembrò per certi versi incoraggiare, la revisione delle sue stesse scoperte. Carrà liquidò così l’opera di Henri Rousseau: la sua purezza e ingenuità primitiva appariva ora, all’epoca del «Selvaggio», come frutto di un’invenzione intellettuale da parte dei fumistes millantatori dell’avanguardia parigina. E pazienza se era stato proprio attraverso costoro che Soffici e Carrà stesso lo avevano conosciuto, ammirato e imitato. Carrà dichiarò la chiusura del caso Henri Rousseau decretando-
33 A. Soffici, Semplicismi, «Il Selvaggio», 30 gennaio 1927, p. 1. A partire da questo fascicolo la rivista adottò la numerazione progressiva per annata. 34 A. Soffici, Semplicismi, «Il Selvaggio», 15 marzo 1927, p. 16 e cfr. V. BeonioBrocchieri, Spengler. La dottrina politica del pangermanesimo postbellico, Milano, Athena, 1928; N. Trubeckoj, L’Europa e l’umanità (1920), Torino, Einaudi, 1982, p. 13; B. Croce, recensione a E. Wechssler, Esprit und Geist, «La Critica», XXV, 1927, pp. 389-392.
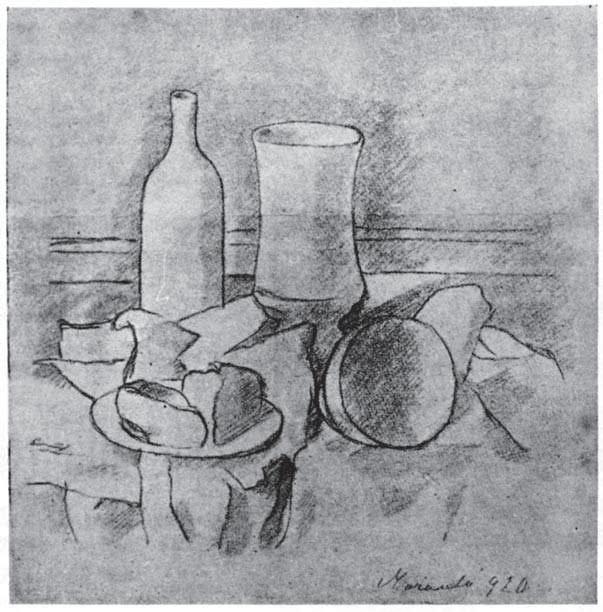
Figura 7.8 Giorgio Morandi, Disegno, 1920, «Il Selvaggio», 31 maggio 1927.
ne l’inattualità e invocando la subordinazione al vero immutabile principio italiano35 .
Un successivo intervento di Carrà contro De Chirico dimostrò quanto la loro distanza, dopo la breve intesa del periodo metafisico, si andasse incrementando per analoghi motivi ideologici. De Chirico aveva infatti rilasciato alla rivista parigina «Comoedia»
35 C. Carrà, Revisioni critiche: Henri Rousseau, «Il Selvaggio», 15 febbraio 1927, p. 11. Sulla «invenzione» di Rousseau da parte del clan Apollinaire, cfr. R. Shattuck, Gli anni del banchetto. Le origini dell’avanguardia in Francia (1885-1918), Bologna, Il Mulino, 1990,
un’intervista impietosa verso lo stato della pittura italiana, che giudicava completamente aliena a tutti i movimenti d’arte moderna («ni marchands, ni galeries») e dichiarandola in blocco pressoché nulla, salvando solo Modigliani e lui stesso («mais nous sommes presque Français», aggiunse). Nella sua replica, sentenziando che le basi naturali dell’arte europea stavano nello spirito italiano, Carrà tratteggiò in De Chirico una figura di pittore ricco di servilismo e piaggeria allo straniero, plagiario degli antichi maestri, critico incapace e pittore principiante. E fece seguire un ritratto altrettanto ostile di Savinio, sospetto ebreo [sic], internazionalista degenere e illetterato raté («Considera l’arte come se nulla avesse a che fare con la morale e con la vita politica»)36 . Segno dei tempi: Carrà aveva infatti in precedenza ammesso la difficoltà a imporre la pittura italiana in mancanza di un mercato d’arte moderna, con un’insofferenza non dissimile dai toni usati da De Chirico («da noi non esiste un mercato d’arte moderna e il mercato straniero ci è completamente chiuso»)37 . Bastarono però pochi anni per osservare una netta inversione di giudizio e la condanna del mercato artistico parigino, reo di sostenere l’artificiosa École de Paris (Sandro Volta la osservò alla Biennale di Venezia del 1928 come un’accolita di fuoriusciti che avevano snaturato il «divino spirito della più nobile tradizione francese»)38. Ancora nel 1931, parlando della pittura di Massimo Campigli, Carrà sostenne che l’accusa di «stilolatria» e di citazionismo era giustificata da una «legge di necessità», secondo la quale non si poteva trascendere il fatto contingente e negare il carattere umano e fenomenico: altrimenti era solo
36 M. De Chirico, peintre, prédit et souhaite le triomphe du modernisme, «Comoedia», 12 dicembre 1927, in Id., Il meccanismo del pensiero, cit., pp. 281-282; C. Carrà, L’italianismo artistico e i suoi denigratori, «Il Selvaggio», 30 dicembre 1927, p. 95 (una ulteriore menzione in B.M. Bacci, L’Ottocento italiano e la «Scuola di Parigi» alla XVI Biennale veneziana, «Solaria», III, 7-8, luglio-agosto 1928, p. 38). Non mi sembra inutile ricordare che l’intera partecipazione del Carrà articolista sul «Selvaggio» venne rimossa dall’autore stesso (in tutti i volumi del secondo dopoguerra, autobiografia compresa), dai suoi esegeti, e dall’antologia dei suoi testi inopinatamente intitolata Tutti gli scritti. 37 C. Carrà, Della nuova coscienza artistica, «Il Convegno», 30 ottobre 1925, in Id., Tutti gli scritti, cit., p. 259; Id., Del Surrealismo, «L’Ambrosiano», 26 novembre 1930, ibid., p. 270. 38 S. Volta, Scuola di Parigi, «Il Selvaggio», 30 aprile 1928, p. 29.
l’estetismo decadente del fallace intellettualismo picassiano39 .
Quello stesso anno avvenne però la riammissione di De Chirico: accolto da Carrà come pittore moderno, «da non confondersi con gli anarcoidi dell’avanguardismo internazionale», e accolto ancor prima sul «Selvaggio» con un bel disegno40. Dopo aver realizzato la Hall des Gladiators nella residenza parigina di Léonce Rosenberg, episodio che aveva segnato nel 1929 il culmine della stagione dell’«Effort Moderne», la galleria istituzione primaria del modernismo parigino, De Chirico aveva in effetti ripreso a esporre in Italia. Ma non fu questo il principale motivo dell’inversione di giudizio che condusse alla riabilitazione di De Chirico. Negli stessi mesi in cui il commercio di Rosenberg si avviava al fallimento, a causa del crack finanziario del 1929, le decorazioni della sua dimora erano state oggetto di un articolo di Waldemar George (autore di cui Soffici tradurrà l’influente Profitti e perdite dell’arte contemporanea) che vi riscontrò riferimenti stilistici ai sarcofagi romani del tardo impero41. Lo stesso George alla Biennale del 1930 aveva presentato gli «Appels d’Italie», gruppo franco-italiano di artisti «umanisti e classici» i quali, nel segno di un nuovo «ordine politico e sociale», promulgavano una «revisione totale dei valori dello spirito» a dimostrazione dello spostamento del centro di gravità dell’arte contemporanea, che ritrovava ora la sua fede a Roma e nell’Italia «una visione del mondo e della vita»42. Fu la consonanza di questi toni con quelli della radicale italianità artistica a consentire, ora, il riscatto italiano di De Chirico.
È certo vero che, dietro queste polemiche si celava un timore ben più vasto. Sollecitati da una parte dalle esigenze ideologiche
39 C. Carrà, Massimo Campigli, «L’Ambrosiano», 20 maggio 1931, ora in Id., Tutti gli scritti, cit., pp. 517-518. 40 C. Carrà, Giorgio De Chirico, «L’Ambrosiano», 6 maggio 1931, in Id.,Tutti gli scritti, cit., p. 514. 41 W. George, Profitti e perdite dell’arte contemporanea, Firenze, Vallecchi, 1933. M. Affron, Waldemar George: A Parisian Art Critic on Modernism and Fascism, in Fascist Visions. Art and Ideology in France and Italy, a cura di M. Affron, M. Antliff, Princeton, Princeton University Press, 1997, pp. 171-204, 186. 42 W. George, Appels du Bas-Empire: Giorgio De Chirico, «Formes», 1930, n. 1, p. 13; il disegno di De Chirico venne pubblicato su «Il Selvaggio» in data 28 febbraio 1931; W. George, Appels d’Italie, in XVII Esposizione Internazionale d’Arte, Venezia, Ferrari, 1930, pp. 92-94 e cfr. W. George, Profitti e perdite dell’arte contemporanea, Firenze, Vallecchi, 1933.




