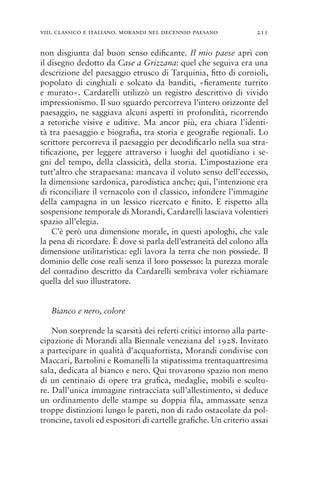viii. classico e italiano. morandi nel decennio paesano
211
non disgiunta dal buon senso edificante. Il mio paese aprì con il disegno dedotto da Case a Grizzana: quel che seguiva era una descrizione del paesaggio etrusco di Tarquinia, fitto di cornioli, popolato di cinghiali e solcato da banditi, «fieramente turrito e murato». Cardarelli utilizzò un registro descrittivo di vivido impressionismo. Il suo sguardo percorreva l’intero orizzonte del paesaggio, ne saggiava alcuni aspetti in profondità, ricorrendo a retoriche visive e uditive. Ma ancor più, era chiara l’identità tra paesaggio e biografia, tra storia e geografie regionali. Lo scrittore percorreva il paesaggio per decodificarlo nella sua stratificazione, per leggere attraverso i luoghi del quotidiano i segni del tempo, della classicità, della storia. L’impostazione era tutt’altro che strapaesana: mancava il voluto senso dell’eccesso, la dimensione sardonica, parodistica anche; qui, l’intenzione era di riconciliare il vernacolo con il classico, infondere l’immagine della campagna in un lessico ricercato e finito. E rispetto alla sospensione temporale di Morandi, Cardarelli lasciava volentieri spazio all’elegia. C’è però una dimensione morale, in questi apologhi, che vale la pena di ricordare. È dove si parla dell’estraneità del colono alla dimensione utilitaristica: egli lavora la terra che non possiede. Il dominio delle cose reali senza il loro possesso: la purezza morale del contadino descritto da Cardarelli sembrava voler richiamare quella del suo illustratore. Bianco e nero, colore Non sorprende la scarsità dei referti critici intorno alla partecipazione di Morandi alla Biennale veneziana del 1928. Invitato a partecipare in qualità d’acquafortista, Morandi condivise con Maccari, Bartolini e Romanelli la stipatissima trentaquattresima sala, dedicata al bianco e nero. Qui trovarono spazio non meno di un centinaio di opere tra grafica, medaglie, mobili e sculture. Dall’unica immagine rintracciata sull’allestimento, si deduce un ordinamento delle stampe su doppia fila, ammassate senza troppe distinzioni lungo le pareti, non di rado ostacolate da poltroncine, tavoli ed espositori di cartelle grafiche. Un criterio assai