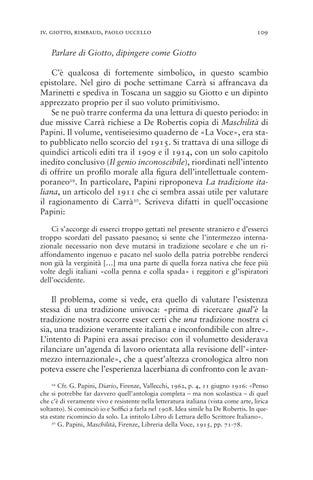iv. giotto, rimbaud, paolo uccello
109
Parlare di Giotto, dipingere come Giotto C’è qualcosa di fortemente simbolico, in questo scambio epistolare. Nel giro di poche settimane Carrà si affrancava da Marinetti e spediva in Toscana un saggio su Giotto e un dipinto apprezzato proprio per il suo voluto primitivismo. Se ne può trarre conferma da una lettura di questo periodo: in due missive Carrà richiese a De Robertis copia di Maschilità di Papini. Il volume, ventiseiesimo quaderno de «La Voce», era stato pubblicato nello scorcio del 1915. Si trattava di una silloge di quindici articoli editi tra il 1909 e il 1914, con un solo capitolo inedito conclusivo (Il genio inconoscibile), riordinati nell’intento di offrire un profilo morale alla figura dell’intellettuale contemporaneo29. In particolare, Papini riproponeva La tradizione italiana, un articolo del 1911 che ci sembra assai utile per valutare il ragionamento di Carrà30. Scriveva difatti in quell’occasione Papini: Ci s’accorge di esserci troppo gettati nel presente straniero e d’esserci troppo scordati del passato paesano; si sente che l’intermezzo internazionale necessario non deve mutarsi in tradizione secolare e che un riaffondamento ingenuo e pacato nel suolo della patria potrebbe renderci non già la verginità […] ma una parte di quella forza nativa che fece più volte degli italiani «colla penna e colla spada» i reggitori e gl’ispiratori dell’occidente.
Il problema, come si vede, era quello di valutare l’esistenza stessa di una tradizione univoca: «prima di ricercare qual’è la tradizione nostra occorre esser certi che una tradizione nostra ci sia, una tradizione veramente italiana e inconfondibile con altre». L’intento di Papini era assai preciso: con il volumetto desiderava rilanciare un’agenda di lavoro orientata alla revisione dell’«intermezzo internazionale», che a quest’altezza cronologica altro non poteva essere che l’esperienza lacerbiana di confronto con le avan29 Cfr. G. Papini, Diario, Firenze, Vallecchi, 1962, p. 4, 11 giugno 1916: «Penso che si potrebbe far davvero quell’antologia completa – ma non scolastica – di quel che c’è di veramente vivo e resistente nella letteratura italiana (vista come arte, lirica soltanto). Si cominciò io e Soffici a farla nel 1908. Idea simile ha De Robertis. In questa estate ricomincio da solo. La intitolo Libro di Lettura dello Scrittore Italiano». 30 G. Papini, Maschilità, Firenze, Libreria della Voce, 1915, pp. 71-78.