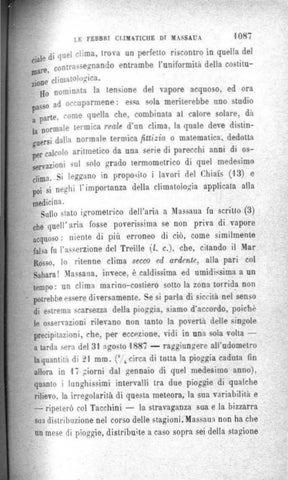!.F. FEBBRI CI.I MATICHE DI H.\SSAUA
108i
'ala di quel dima, tro"Va un perfetto riscontro in quella del et re contra,segnando entrambe l'uniformità della costituJIIS ' . ne climatolu:.!ica. ~IO Elo nominata la ten,ione del vapore acquoso, ed ora passo ad o ·cuparmene: e·~ sola meriterebbe uno studio parte. l'ome quella che. combinala al calore solare. dit 8 la normale termica reale d'un clima. la quale deTe distio~uers i dalla normale termica fi.tti:ia o matematica. dedotta per calcolo aritmetico da una serie di parecchi anni di osservaziont ~ul solo ~rado termometrico di quel medesimo clim:~. Si leggano io propo.;ito i lavori del Chiais (13) e poi si neghi l'importanza della climatologia applicata alla medicina. Sullo stato igrometrico del l'aria a Massaua fu scritto (3) che quell'aria fosse poverissima se non priva di vapore acquoso: niente di più erroneo di ciò, come similmente falsa fn l'a~:'crziooe del Treille (l. c.), che, citando il !\1ar Rosso, lo ritenne clima secco ed ardmtl', alla pari col ~al1ara ! 'lassaua, invece, e caldissima ed umidi:;sima a un tempo : un eli m:~ marino-costiero solto la zona torrida non potrebbe es;;ere diversamente. e si parla di siccila nel senso di e~trema :;carsezza della pio!!~ia, siamo d'accordo. poichè lt> o·senazioni rile,·ano non tanto la po>erl:\ delle iogole precipitazioni, che. per eccPzione, vidi in una sola l'Oita a tarda .;era del 31 :~go~to l 87 - ra~giunJ!ere all'odometro la quanlltil di ~l mm. {' , circa di tolta la pioggia caduta fin allora in 1i ;:iorni dal gennaio di quel medesimo anno). quanto i lnoghissìmi intervalli tra due pioggia di qualche rilievo, la irregolarità di questa meteora, la sua variabilità e -ripeterò col Tacchini - la stravaganza sua e la bizzarra StHI òistrihm:ione nel corso delle stagioni. Massaua non ha che un mese di pioggia, distribuite a caso sopra sei della stagione