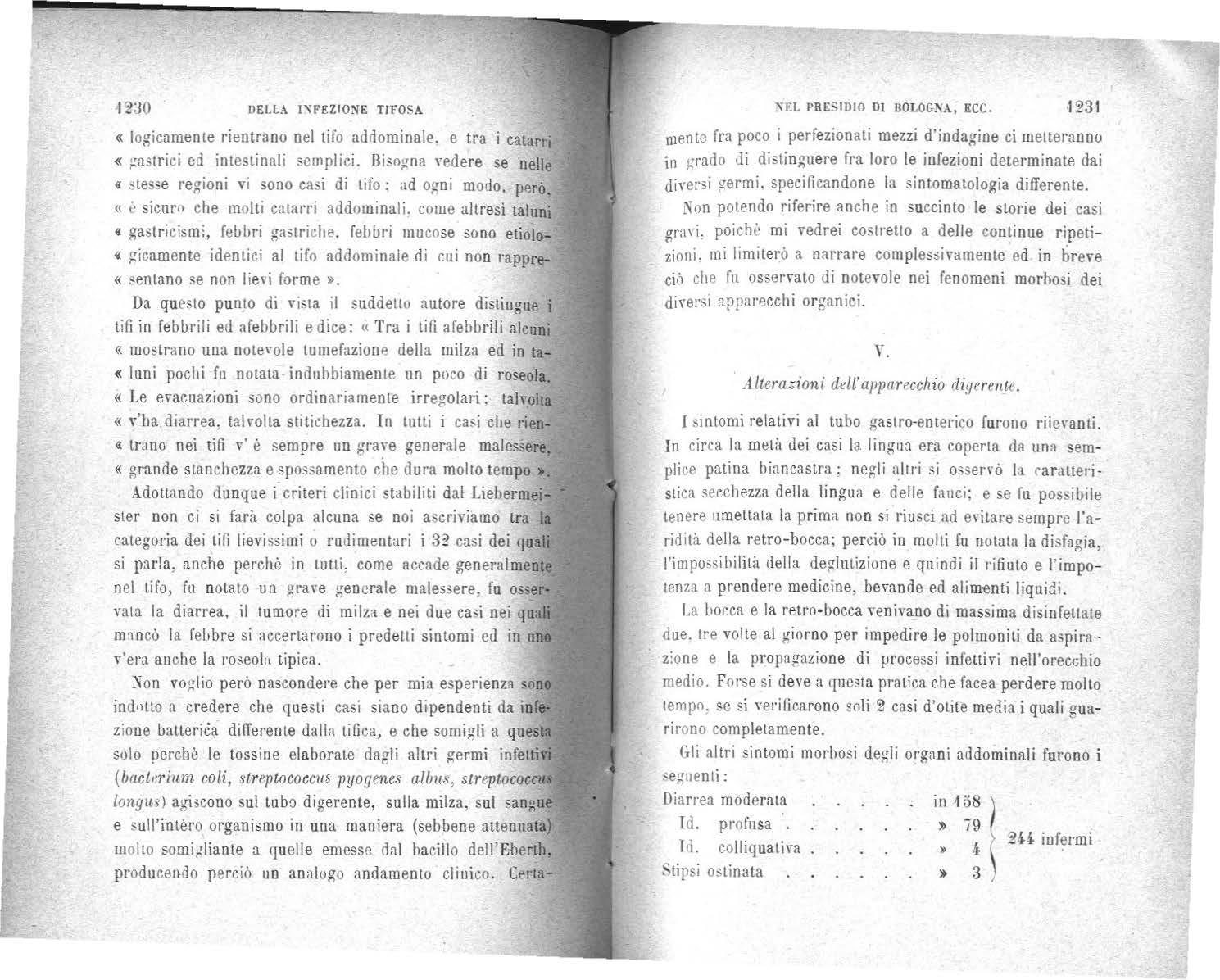
6 minute read
t no DELLA
Tn"OSA
« logicamente rientrano nel tifo addominale. e tra i catarr i
Advertisement
« ed intestinali semplici. >edere se nelle
« :;tesse 1·egioni vi sono casi di tifo : ad ogni modo, però.
<< è sicuro che molti catarri addominali, come altresì taluni c gastricismi, febbri gastri che. febbri mucose sono etiologicamente identici al tifi) addominale di cui non rapp re-
« sentano se non lievi forme ».
Da questo punto di >ista il suddeuo autore distingue i tifi in febbrili ed afebbrili e dice : << Tra i tifi afehbrili alcuni
« mostrano una note\·ole tumefazione della milza ed in ta-
« !uni pochi fu notata · indubbiamente un poco di roseola.
« Le evacuazioni sono ordinariamente irregolari; talYolta
« v'ha dia1Tea, talvolta stitichezza. In tutti i casi ehe rien-
« lrano nei tifi v' è sempre on generale malessere, l'ion voglio però nascondere che per mia esperienza indotto a credere che cruesti casi siano dipendenti da infezione batleriè!). differente dalla tifica, e che somigli a qu solo perchè le tossine elaborate dagli altri germi infettivi (bacl••1·ium coli, streptoco ccus ]>yogenes albus, streptococcus longns) agiscono sul tubo digerente, sulla milza, sul sangue ,_,_.;-..:• e sull'intèro organismo in una maniera (sebbene attenuata) molto somigliante a quelle emesse dal baciHo deii'E-berth, producendo perciò un analogo andamento clinico . Certa-
« grande stanchezza e spossamento che dura molto tem po » .
Adottando dunque i criteri clinici stabiliti Lieber meister non ci si farà colpa alcuna se no i ascriviamo tra la categoria dei tifi lievissimi o rudimentari i 3? casi dei <t uali si parla, anche perchè in tutti, come accade generalme nte nel tifo, fu notato un g-rave generale malessere, fu osser· vata la dian·ea, il tumore di milza e nei due ca ·i nei quali mnncò la fehbre si accertarono i predetti sintomi ed in une "'em anche la roseoh tipica.
XEL PRESIDIO DI BOLOG:XA; ECC. 1231 mente fra poco i perfezionati mezzi d'indagine ci metteranno in grado di distinguere fra loro le infezioni determinate dai diversi germi, speciftcnndone la sintomatologia differente. Non potendo riferire anche in succinto le storie dei casi gr:n·i, mi vedrei costretto a delle continue ripetizioni, mi limiterò a narrare complessivamente ed in breve ciò che fu osser·vato di notevole nei fenomeni morbosi dei diversi apparf3cchi organici .
Y.
Altera.=ioni ddl' apparl'cchio di!Jeren_te.
I sintomi relativi al tubo gastro-ente rico fur·ono riieranti. In circa la metà dei casi la. lingua er.a coperta da una semplice patina hiancastra; negli si osserrò la raratteristica secchezza della lingua e delle fanci; e se fu possibile tenere umettata la prima non si riuscì ad e'iLare l'aridità della retro - bocca; perciò in molti fu notata la disfagia, l'impo:;sihilitit della deglutizione e quindi il rifiuto e l'impotenza a prendere medicine, bevande ed alimenti liquidi.
La bocca e la retro-bocca venivano di massima disinfettate due. tre volte al giorno per impedire le polmoniti da aspiraz:one e la di processi infettivi nell'orecchio medio. Forse si deve a questa pratica che facea perdere molto tempo. se si Yerilìcarono soli 2 casi d'otite media i quali guarirono completamente.
Gli altri sintomi morbosi degii organi addominali furono i Diarrea moderata I
Enterorragia » 6
Perdita involontaria delle fecce . . & 78
Peritonite . )) 7
Le fecce ebhero ge..,eralmente il carattere di quelle tifìr he· ' erano di colore pisello e col r·iposo si dividevano io due strati. Una di :;creta quantità di muco si osservò negli escrementi di 30 ammalati.
L'eoterroragia non determinò mai direttamente la morte : ma nell'ulteriore decorso del tifo morirono ::l òegli am malati che ne aveano sofferto; 2 per peritonite da porforazione (Ciccolini , Teodori) ed uno per grave infezione Plelizza) .
11 meleorismo ed il gorgolio nella fossa ileo-cecale osser-vati in tutti gli ammalati in cui la malattia decorse ÌQ più di due settimane.
La peritooite si manifestò in 7 infermi; in 4 i si n to mi rooo violenti : il vomito, il singhiozzo, il polso piccol o 11 quentissimo si presentarono in breve tempo e la mo rte per lo più in 24 ore. Negli altri questa fatale COIIDP ilC:lZ'I<>ne si sviluppò con minore acuzie, ebbe un decorso di due o giorni e poi segni il decesso. primi 4 casi, all'auto fu riscontrata la perforazione dell'intestino , negli al tri 3 vece il peritoneo era intatto e tappezzava il fondo delle cere (Y. § dei morti).
La differenza nella intensità dei sintomi potrebbe leggermente f:lre distinguere una peritonite da perforazione, da una peritonite dipendente da semplice propagazion e del pro· cesso settico attra,·erso la sierosa intatta.
Il vomito s'ebbe in 12 infer·mi, non contando quelli di peritonite.
Stato della mil.:a - Il collega Altobelli , tenente medico del 50° fanteria, circa due mesi or sono, intrattenne l'adunanza sul tnmore precoce di milza, e l'indicava quale sin- soldato Ci cr.olini, del 49° fanteria , il quale non avea mai sofferto d'infezione malarica, la milza era ingrandita 20 giorni prima della manifestazione del grave tifo, che lo condusse nlla tomba in pochi giorni. altri casi l'ingorgo splenico verso la fine della prima settimana come viene indicato da i clinici più rinomati (Niemeyer, Iaccoud, Sch midt).
NEL PRESIDIO DI BOLOGNA, ECC 1233 tomo importante nei primordii d'infezione tifo sa, massime per i medici militari, i quali , tr·ovandosi a prestare servizio presso i corpi , possono avere così oltre la febbr e, 1111 criterio sic uro di dial!nosi. Io MD voglio ripetere qrwnto l'egregio coll ega ebbe a dire : solo aggiunp:o che l'ingorgo splenico precoce venne osservato in 54- ammalati i quali er-ano appena all'i nizio della malattia. Yi furono anche dei soldati in cui si rilevò il tumore di milza prima che si manifestasse la febbre . Tra questi ve ne fu uno classico: il maggiore medico cavaliere notò nel suo attende nte (wldato Chiari Antonio) un cospi cuo tum ore di milza: egli osservò ripetutamente 11 soldato e solo dopo 8 giorni venne in campo la febbre ed un tifo imponente.
La puntura dell a milza Tu eseguita due volte nei soldati J.ongo Antonio del 23° e Rutulo Tommaso del 49° fa nteria. Essa fu fatta solo quando si fu certi dello stato disper·ato degli infermi. Col ·sangue estrauo in vita dal primo , ·ehberc. colonie dei bac illi dell'Eberth e dopo la morte il maggiore cav. Pabis le ottenne ancora dalla coltura del succo ' plenico . Invece , dal sangue aspirato dalla milza del Rutulo, il dott. A. Bruschettini, assieme alle colonie del bacillo del tifo , _vide nascere quelle dello streptococco lungo setticemico.
Questo fatto non è isolato ed il Vincent su f 6 autopsie lo
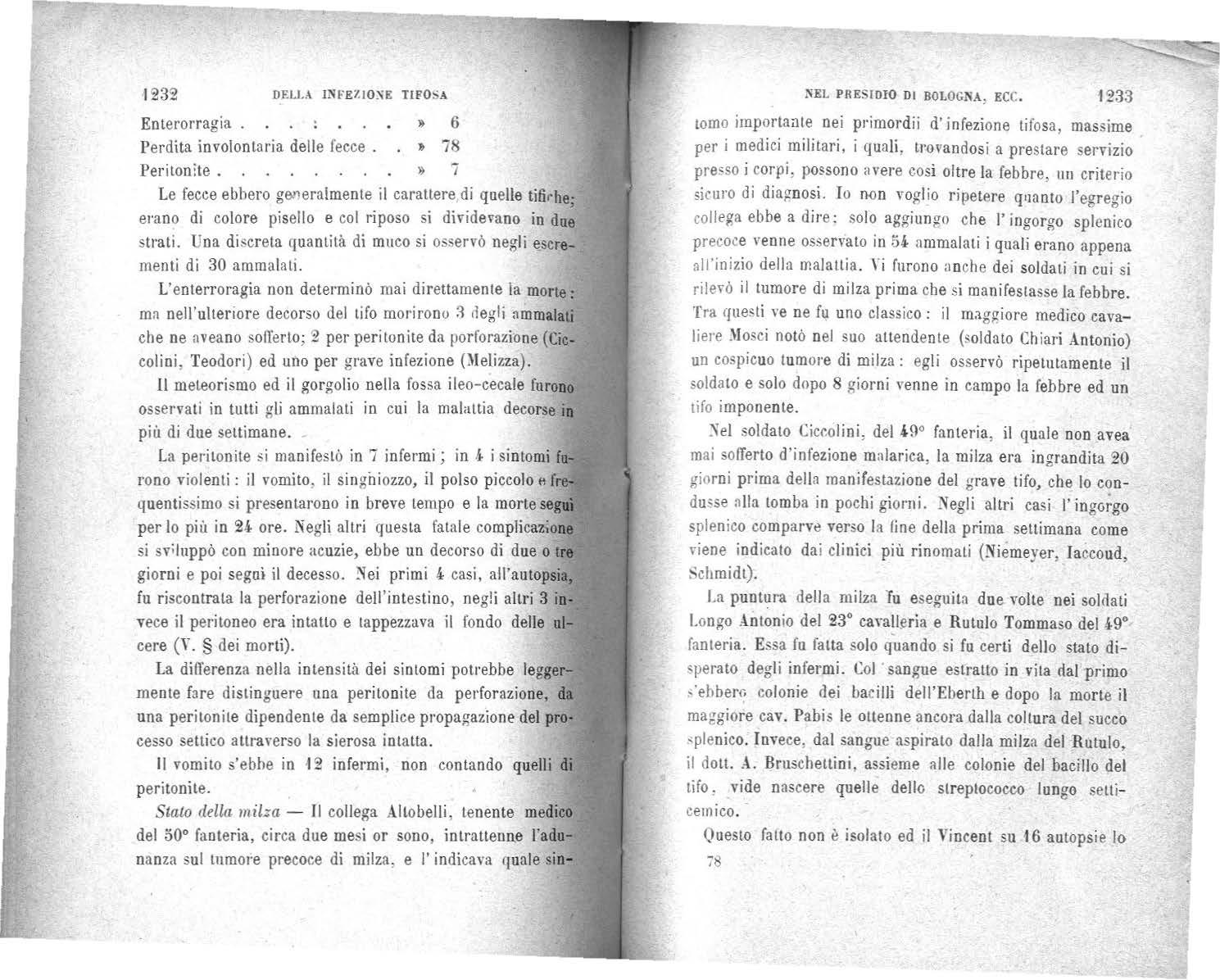
1234- DELLA INFEZIONE TIFOSA
rmvenne iS volte nelle colture fatte col succo delle glandul e mesenteriche. del fegato e della milza ('1).
In alcuni ammalati J' splenico persistè ancora a convalescenza inoltrata. Yl.
Lesioni dell'apparecchio respiratorio ..
Senza tenere conto del lie ve catarro bronchiale che suole accompagnare il tifo, e che. si verificò in quasi tutti i casi importanti, le complicanze più rilevanti degli organi respiratori furono : la bronchite diffusa in 29 casi la bronco-pnenmonite in 9 id. la pleul'ite in 3 id. l a bronco-pneumonite, oltre a minacciare direttamen te i nostri ammalati, ebbe per carattere una risoluzione lenta e ritardata: ciò non deve fare maraviglia ove si consideri che non è sempre nua pneumonite da aspirazione, ma spesso una localizzazione del bacillo deli'ELerlh {2) . In 4 infern:ti che morirono per grave infezione la bronco-pneumonite fo la complicanza degli ultimi giorni .
Nel corso del tifo, il soldato Liverani Luigi del 3° artiglieria. colto da pleurite, mori in brevissi mo tempo (V.§ dei morti); gli altri due casi si notarono durante la convalescenza nei soldati Cainmi e Cipres::o e t utti e due furono inviati in licenza con residui suscettibili di guarigione.
{f ) Società medica ospedali di Par igi, tornata del f3 novembre. vedi Riforma medica del !3 dicembre f891.
(!} Deutscht \Vochenschri(t, 1887.
Alterazioni dell'apparecchio ci?·colatorio
Interessanti furono i fenomeni dell'apparecchio cardiaco' 'ascolare ed io andrei troppo per le lunghe se volessi rire ciò che si notò in ogni ammalato; dirò solo che in 60 infermi st osservò l'indebolimento dei toni e la presenza di so fii : in uno il soffio sostituiva il 1o tono alla punta; in 50 il dicrotismo spiccato; in molti la frequenza del polso non era in rapporto con l'altezza della temperatura essendo questa relativamente moderata e le pulsazioni insolitamente frequenti. Alcuni (fra i quali il Fontana, allievo ufficiale del •15° artigli eria, Tiber i e Ferrari del 4.9°) con la febbre di poco superiore ai 38° aveano fino a 120 battute al minuto: dippiit il Fer rari presentò tale freque nza del polso ancora durante la conval escenza e sol:.l.mente quando fu ristabilito il cuore riprese le pulsazioni normali.
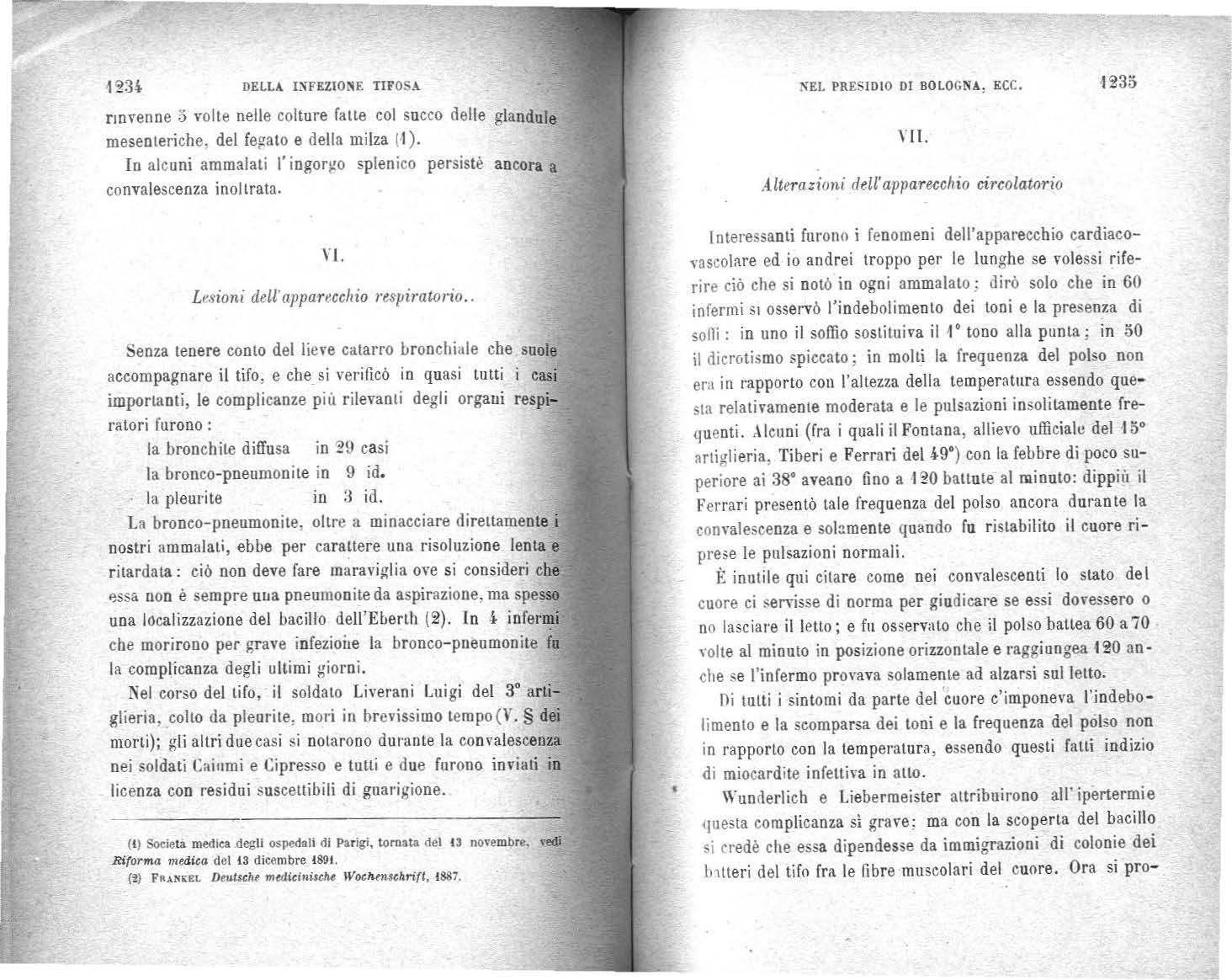
È inutile qui cita re come nei convalesce nti lo stato del cuore ci serrisse di oorma per giudicare se essi dovessero o no lascia re il letto ; e fn osservato che il polso battea 60 a 70 ,·olte al minuto in posizione orizzontale e raggiungea 120 anche se l'infer mo provava solamente ad alzarsi sul letto.
Di tutti i sintomi da parte del 'éuore c'imponeva l'indebo· limento e la scomparsa dei toni e la frequenza del polso non in rapporto con la temperatura, essendo questi falli indizio di miocardite in fettiYa in atto .
Wunderlich e Liebermeister attribuirono all'ipertermia questa complicanza sl. grave; ma con la scoperta del si credè che essa dipendesse da immigrazioni di colome del lntteri del tifo fra le fibre muscolari del cuore. Ora si pro-










