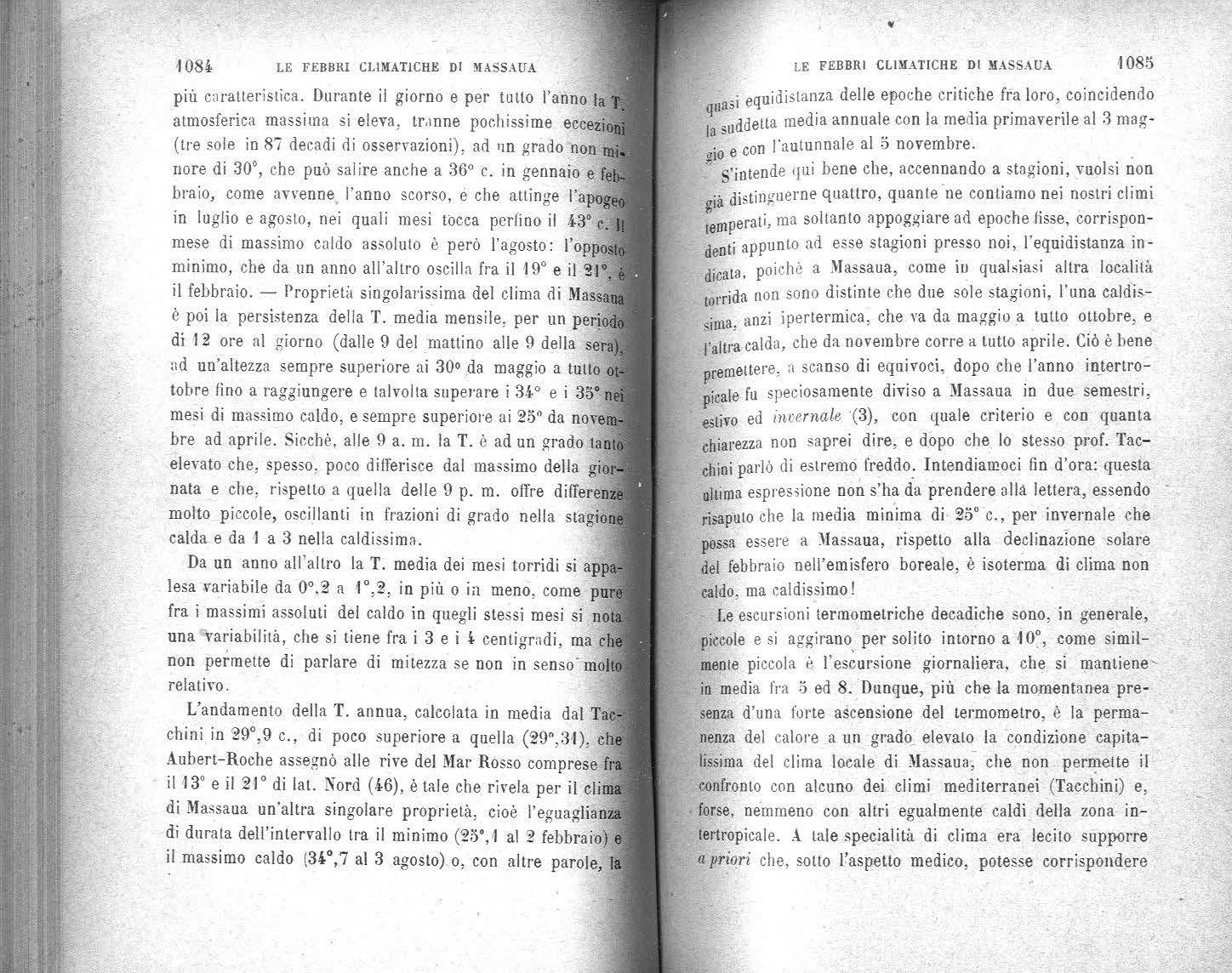
12 minute read
LE FEBBRI CLIMATICHE DI MASSAUA
più cnraLLeristica . Durante il giorno e per tutto l'a·nno la atmosferica massima si eleva , tr.mne pochissime (tre sole in 87 decadi òi osservazioni), ad llfi grado non nore di 30°, che può salire anche a 36° c. in gennaio e braio, come aV\'enne, l'anno scorso, e che attinge l' in luglio e agosto, nei quali mesi tocca perfino il 43° c. mese di massimo caldo assoluto è però l'agosto: l' minimo, che da un anno all'altro oscilla fra il 19° e il ' il febbraio. - Proprietà singolarissima del clima di è poi la persist.enza della T. mensile, per un di 1:2 or·e nl gior·no (dalle 9 del mattino alle 9 della ad un 'altez za sempre superiore ai 30o da maggio a tullo tobre fino a raggiungere e talvolta superare i 34° e i 35o. mesi di massimo caldo, e sempre superiore ai 25° da bre ad aprile. Sicchè, alle 9 a. m. la T. è ad un grado elevato che, spesso, poco differisce dal massimo della nata e che, rispetto a quella delle 9 p. m. oJl're diiT molto pi ccole , osci.ilanli in frazioni di grado nella s calda e da 1 a 3 nella caldissima·.
Da un anno all'ailro la T. media dei mesi torridi si lesa variabile da 0°,2 a · 1°,2, in più o in meno, come fra i massimi assoluti dei caldo io quegli stessi mesi si no una variabilità, che si tiene fra i 3 e i 4 centigradi, ma non permette di parlare di mitezza se non in senso · relativo.
Advertisement
L'andamento della T. annua, calcolata in media dal chini in 29°,9 c., di poco superiore a quella (290,3'1), c Aubert- Roche assegnò alle rive del Mal' Rosso comprese il ,l3" e il 21° di lat. Nord (46), è tale che rivela per il cii di l\fassaua un'altra proprietà. cioè l'eauaalia ; {") di durala dell'intervallo tra il minimo (25.,1 al 2 febbraio) il caldo (3 4°, 7 al 3 agosto) o, con altre
Le Febbri Climatiche Di Massaua 1085
,asi equidistanza delle epoche critiche fra loro, coincidendo suddetta media annuale con la media primaverile al 3 ma g. e con l'autunnale al 5 novembre.
n S'intende !JUi bene che, accennando a stagioni, vuolsi non ià distinguerne quattro, quante ·ne contiamo nei nostri climi ma soltanto appoggiare ad epoche fisse, corrispondenti appunto ad esse stagioni presso noi, l'equidistanza indicata, a Massaua, co me iu qualsiasi altra località tòrrida non sono distinte che due sole stagioni, l'una caldiS-sima, anzi ipertermica , che va da maggio .a tutto ottobre, e l'altl'a calda, che d:t novembre corre a tutto aprile. Ciò è bene pcemellere, a scanso di equivoci, dopo che l'anno in_tertt·opicale fu speciosamente diviso a .in due semestri, estivo ed iniJernale '(3), con cruale crtteno e con quanta chiarezza non saprei dire, e dopo che lo prof. Tacchini parlò di estremo freddo: Intendiamoci fin d'ora: questa ultima espressione non s'ha da prendere :lllà lettera, essendo risaputo che la media min'ima di 25" c., per invernale possa essere a )1assaua, rispetto alla declinazione solare del febbraio nell'emisfero boreale, è isoterma di clima non caldo, ma
Le escursioni termometriche decadiche sono, in generalé, piccole e si aggirano per solito intorno a 1 come similmen te piccola è l' giornaliera, che si mantiene ' in media fra 5 ed 8. ·Dunque, più che la momentanea presenza d'una forte ascens·ione del termometro, è la permanenza del calore a un grado elevalo la condizione capitaljssima del clima loeale di )fassaua ; che non il confronto con alcuno dei climi mediterranei (Tacchini) e, forse, ne.mmeno con altri egualmente caldi della zona intertropicale. A. tale specialità di clima era lecito sùpporre a priori che, sotto faspetto medico, potesse corrispondere una particolare a1.ione sugli atti nutriti\'i e funzio nali ganici e quindi sugli stati morbosi che derivano. mancano i dati per discorrere della temperatnra suolo, ma ritengo per fermo che esso si co nservi caldo, durante la notte, a un grado molto prossimo a dell'aria. l'irradiazione essendo impedita dalla forza del vapore acquoso. Quanto al mare, è noto che le a dell'Eritreo superano in grado termometrico tutte le salse del mondo, dando alla superfi cie, tra Aden e un minimo di 18>,8 in gennaio ed un massimo settem.hre : eccezionalmente si sono misurate marine supe riori alla tempet·atura del sangue umano. il capitano di vascello cav. Grillo, fece rilevare alcuni mesi consecutivi la T. dell'acqua di mare a d profondità e distanze dalla costa, allo scopo precipuo di rificare se un notevole abbassa!flento di T. negli strati i riori avrebbe permes.;o di adoperare con vantaggio l' fresca ad una certa profondità, per ottenere un'azione gorilica più potente da rendere possibile l'impiego di tipi di macchine da ghiaccio, fondate sul principio della densazione dei Yapori d'etere e d'ammoniaca.
Il risullato di tali affidate al tenente di signor F. Verde, fu:
) 0 che in gennaio e febbraio la temperatura del oscilla fra i 26° e i 27• alla superficie, variando di pochi cigradi in meno a piccola profondità e segnando in un gt·ado di meno a 4Q metri al di sotto del suo livello;
2•. che, a da marzo, con l'incalzare del nell'aria, la T. del mare si eleva di pari passo fino a giungere, nei mesi del massimo caldo, un grado che a a 1O m. di profondità si mantiene prossimo ai 33".
Sicchè, l'andamento diurno della T. atmosferica, cosi
. le di quel cl ima, trova un pel'feuo riscontro in quella_ del eta contra=-segnando entrambe l'uniformità della costttumare, . . e climatologtca . z100 ' . d
IIo nominata la tenstOne del vapore acquoso, e ora ad occuparmene: sola meriterebbe uno stu dio passo 1 d' i dalla normale Lermtca fittl:;ta o matemattca. dedotta . · d. n teolo aritmetico da una serie di parecch 1 aom 1 osper ca . . d · ·oni ·ul solo arado termometnco dt quel me estmo servazt " · " . . .. . "-i leaaano in propo,ito i lavon del Chtals (13) e chma .. v nr> • • · · ne(Yhi l'importanza della climatologia apphcata alla pOI SI e medici na. .
•e ('ome quella che, combinata al calore so are, a a par• . . d. . male termica reale d'un chma. la quale de'\'e ISttnja nor... . ...
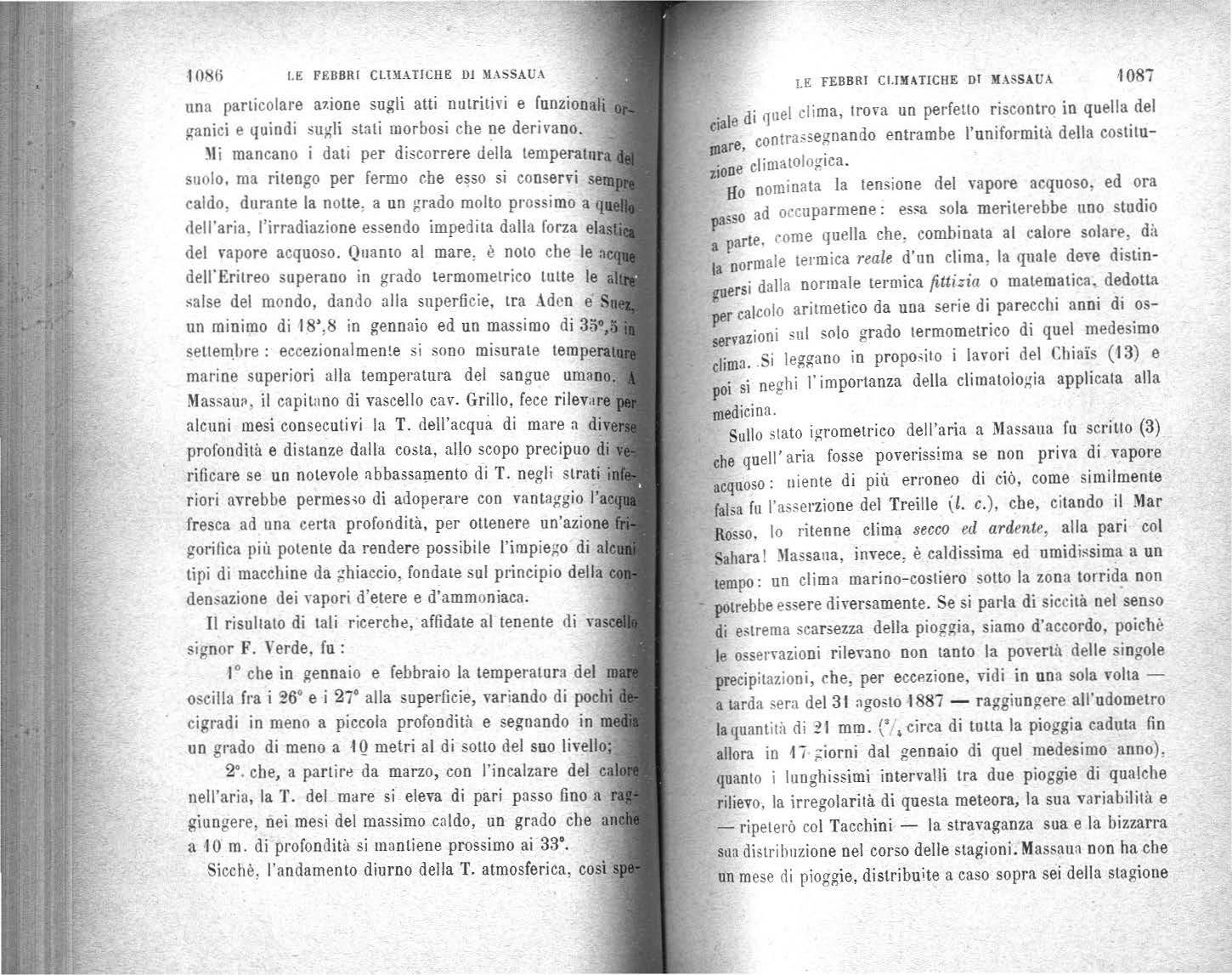
Sullo stato igrometrico dell'aria a fu scr1llo (3) che quell'aria fosse poverissima se non priva _vapore acquoso: niente di più di ciò, stmtl_mente falsa fu l'as:>erzione del Treille c.), che, cttando ti Mar Rosso, lo ri tenne climl} secco ed ardente, alla pari col Sahara t Massana, invece, è caldissima ed umid issim_a a un tempo: un cli ma marino- costiero sotto la zona torrida non potrebbe essere diversamente. Se si parla di siccità nel di e5trema scarsezza della pioggia, siamo d'accordo, po1chè le osser\'azioni rile"ano non tanto la poverLà delle si ngole precipitazioni, che, per vidi in una sola voltaa tarda sera del 3 f agosto 1887 - raggiungere all'odo metro laqu antilit mm. {'/ l circa di tutta la pioggia caduta fin allora io 17 ;iorni dal gennaio di quel medesimo anno), quanto i lunghissimi intervalli tra due pioggie di qualche rilievo; la irregolarità di questa meteora, la sua variabilità e
- ripeterò col Tacchini - la stravaganza sua e la bizzarra slla distribuzione nel corso delle stagioni. Massaua non ha che un mes e di pioggie, distribuite a caso sopra sei della stagione calda, con un totale d'acqua raccolla di Il O mm. media annua, che in altri paesi intertropicali rap la quantità giornaliera 6 perfino or,u•ia : ond'è lecito ur.olJIIr'N che l'acqua meteorica è cosi povero e tra3curabile fen da non meritare davvero d'essere tenuta io conto, nè dare a quel semestre il pomposo e ridicolo nome di stao . p10VOS"t, nè per invo!:arne l'azione nella produzione infermità, nè tanto meno per fondare su di essa agricole o industriali. Perchè a }lassaua non piova sarebbe da aspettarsi per la sua giacitura sotto il còe il sole fa da un tropico non avrei spazio a di qui nè importerebbe poi molto : il lettore avido di sapere domf:ndarlo all'immortale libro del Maury (43), il .vuu111.ur. della meteorologia marina. Quel che importa stabilire questo , che per dire se un clima sia secco o umido, non più il criterio di Quetelet e De Candolle, che ricorsero al n mer·o dei giorni di pic)ggia, nè all'altro di Matteucci e ;:\1 che, stimarono doversi wltanto tener conto dell' dità l'eia tiva ossia del grado di . saturazione dell'aria per vapore acquoso, ma importa valutare la tensiorio di ques per legge fisica che l'acqua tende ad evaporarsi diretta della tempera tura. È la temione del vapore quoso, non la frnione di saturazione delln spazio, il fa meteorologico più importante , anzi fondamentale, dell'i tluenza che il clima caldo esercita sui processi vitali, normal e patologici : è questa tensione, che le acc urate ricerche dott. Borius ( 6) posero in evidenza nei suoi rapporti la frazione di saturazione, la causa d'ogni azione clima tica Massaua, fra l'estremo della siccità raffigurato nel Sahara. il più grande braciere del globo , la emersione dal · , modilicò la climatologia subalpina {67), e l'altro della piovositù, quale si riscontra in generale nelle regioni intertrop i-
LE FEBB RI CLIMATICHE Dl ){ASSAUA ·l 089 cali ed in particolare a Cherrapongi; in In dia, dove la annua la favolosa cifra di 15 metri ( Lombard, /. c.) , è da collocur.-i molto. ma molto più dappresso al primo anzicbè al secondo estremo . Una C<"ra stagione di pioggie, come si ha in Abissinia, manca a }lassaua, ad Assab e su tutta la costa meridionale del }far Rosso, e questo fia 8Uff9el ch'ogni 110mo sgwmi; ma è un fatto certo che per la sua umidità torrida Massaua è a qualsiasi altra colonia fra le più note. ad esempio ad una delle francesi, il Senegal, la Guiana, la Cocincina, }Jaiotta ecc., come ognuno può con vinconfrontando le tabelle del dott. Panara e del prof. Tacchmi con tfuelle del dott. Dutroulau ('19).
Si tenga presente il fatto principalissimo, che emerge dagli specchielli pubblicati, sei anni fa, dal secondo degli autori or citati , cioè che per quanto più elevata sia la frazione di saturazione nel. semestre caldo, la differenza che la tensione del vapore acquoso presenta col semestre torrido è pochissimo rileYabile . Siffatto enunziato ricevette luce meridiana dal confronto. che mi piacque istituire fra la tensione del vapore acquoso del mese di febbraio e quella dell'aaosto l'> ' i due mesi estremi ed opposti del caldo, per il quinquennio 1887-91: ebbene , la differenza oscilla, da un anno all'altro, fra un minimo millimetro e un di -i-,5 mm.; t:osi ad esempio, nell'87 la media mensile della tensione del vapore fu di 18, l mm. in febbraio e di 19,'1 in agosto, e nel 1891 fu di 19,0 e 23,5 mm. Questa costanza equabile di tensione, opposta agli sbalzi fi.n di 16,9 mm. io uno stesso mese e di 31 ,G nel cor;;o d'lm anno rilevati dal Borio:; per il Senegai (8), sito sullo stesso parallelo di :\lassaua, rende il clima di questa unico al mondo, fra quelli finora sLudiati . Lo stesso autore ha dimostrato, con l'esame comparativo delle tabelle di patologia e meteorolog.ia, che l'evoluzione delle malattie
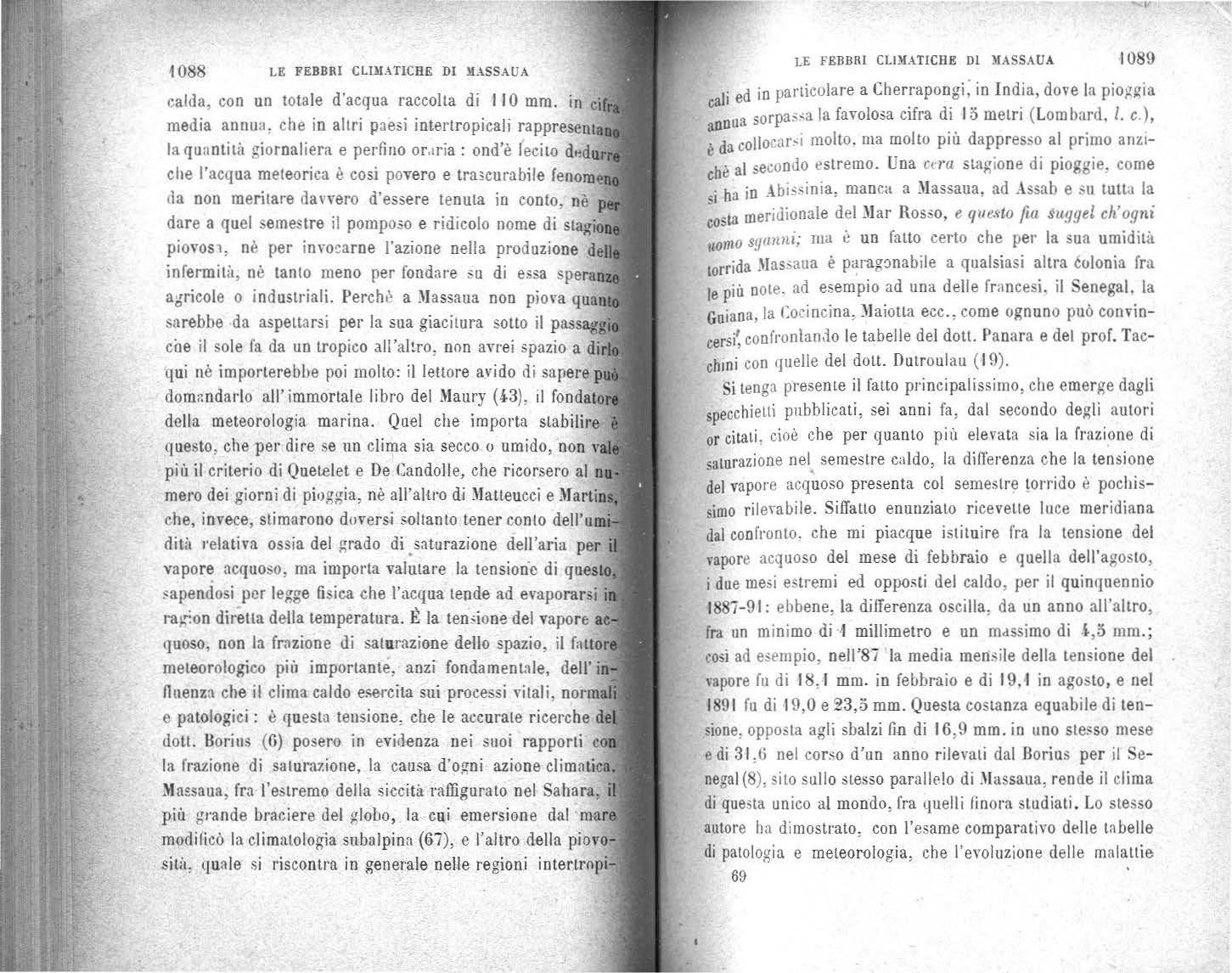
1090 LE FEBBRI CLIMATICHE DI MASSAUA
endemo- epidemiche, più che all'umidità. relativa, è intimamente legata alla T. ed alla tensione del vapore acq compiendosi con la regolarità d'un fenomeno astronomico. dunque, su questa forza elastica del vapore atmosferico che io, d'accordo .col Treille, insisto per richiamare tutla l' zione: essa è rappresentata a Massaua dalla cifra annua di 20,2 mm., mentre la frazione di satura1.ione espressa da analoga cifra di 68 centesimi. Le variazioni orarie della tensione del vapore sono debolissime, ma dono manifestamente ad un lieve aumento ,del gra<\o umi dità nel valore delle 9 p. m.- Non mi è possibile · logare in pochi periodi ciò che ho svolto in molte nella monografia originale: ho accennato alle cose princi ma aggiungerò ancora che si deve a questa medesima sione, che è compresa nella somma della colonna ba (71)8 mm. in mP-dia annua), se la pressione dell'aria secca Massaua è abbassata al di sotto di 738 mm.: donde l'in ficienza della tensione deli 'ossigeno, resa ancor più signi cante dal calore, e quindi la riduzione dell'ematosi, la primaria dell'anèmia tropicale, si potrebbe anche eh Jl'are anemia termica o, meglio ancora, anossiemia, dirò appresso.
Per ciò che riguarda la nebulosità, rimando alle relazioni del Tacchini, dalle quali i venti a Massaua sono irregolari nella direzione, i nella forza e presentano piuttosto il carattere di venti come si arguisce dal fatto rhe ii periodo più ventoso giornata a Massaua è compreso, in ogni stagione, tra giorno e le 3 pom. : e guai se non fosse così!
Se l'aria stagnasse co là sempre immc•bile, la vita compromessa: se noi vediamo , invece, che vi si vive men peggio, vuoi dire che il movimento dell'aria,
Le Climatiche Di Massaua 1091
'llOD molto efficace, quanto ad Assab, a sottrarre calorico al a mot•vo della sua alta qualità igrometrica, costituisce nondimeno un sufficiente beneficio per gl'indigeni e per gli .europei, che possono risentirne salutat:e vantaggio, non già perfrigerazione morbosa: insomma, è il difetto del!'evapora.zione attiva dell'acqua esalata dai polmoni e segregata dalla pell e, per l'ostacolo che incontra nella tensione del vapore .acquosc., e non l'eccesso, quel che rende l'organismo suscet:tibile alle febbri sotto quel cielo. Infatt i, è noto che .ad Assab si brucia, si suda a rivoli, si stilla acqua da t&tli i pori e d'estate co me d'inverno -e dàlli con l'inverno! - di .come di notte, in un verso o nell'altro, si è sferzati dai mon.soni costanti e potenti di sud-est, che sono alisei deviati e ·.che agitano quella baia da renderne talvolta difficile o impossibtle il traffico, si è rinfrescati dagli altri monsoni di nord-est, che trovano la pelle in profusa traspirazione o si .è deliziati dalle brezze notturne, ca rezzevoli come il sibilus aurae tmtàs della Scrittura. Si cammina ad Assah sopra un suolo, avvampato come lastra di forno, ma si vive alla grand'aria e si respira abbastanza fresco, « così clte vera« mente strana è l'impressione delle gambe che bruciano « per .le potenti irradiazioni del suolo , mentre aleggia sul -« viso una brezza che dà perfino un'impressione di freddo » ·(3J). Assnb, prima che ìe nostre truppe si elevassero sugli altip iani abissini, costituiva il Sanatorium pei convnlescenti di allora, non giiL per _la sua ascinttezza assoluta, come credette il d,ott. Nerazzini nelle sue Osservazioni mediche sulla haia di Assab (Giorn. di medicina milita1·e, •1884), ma per la stia minore umidità, relativ&mente a Massaun, io quanto -che anche quello è clima marino-costiero, e perciò sul quale la potenza termica del sole è parimenti considere._ vole, ma la forte e costante ventilazione, spazzandone in
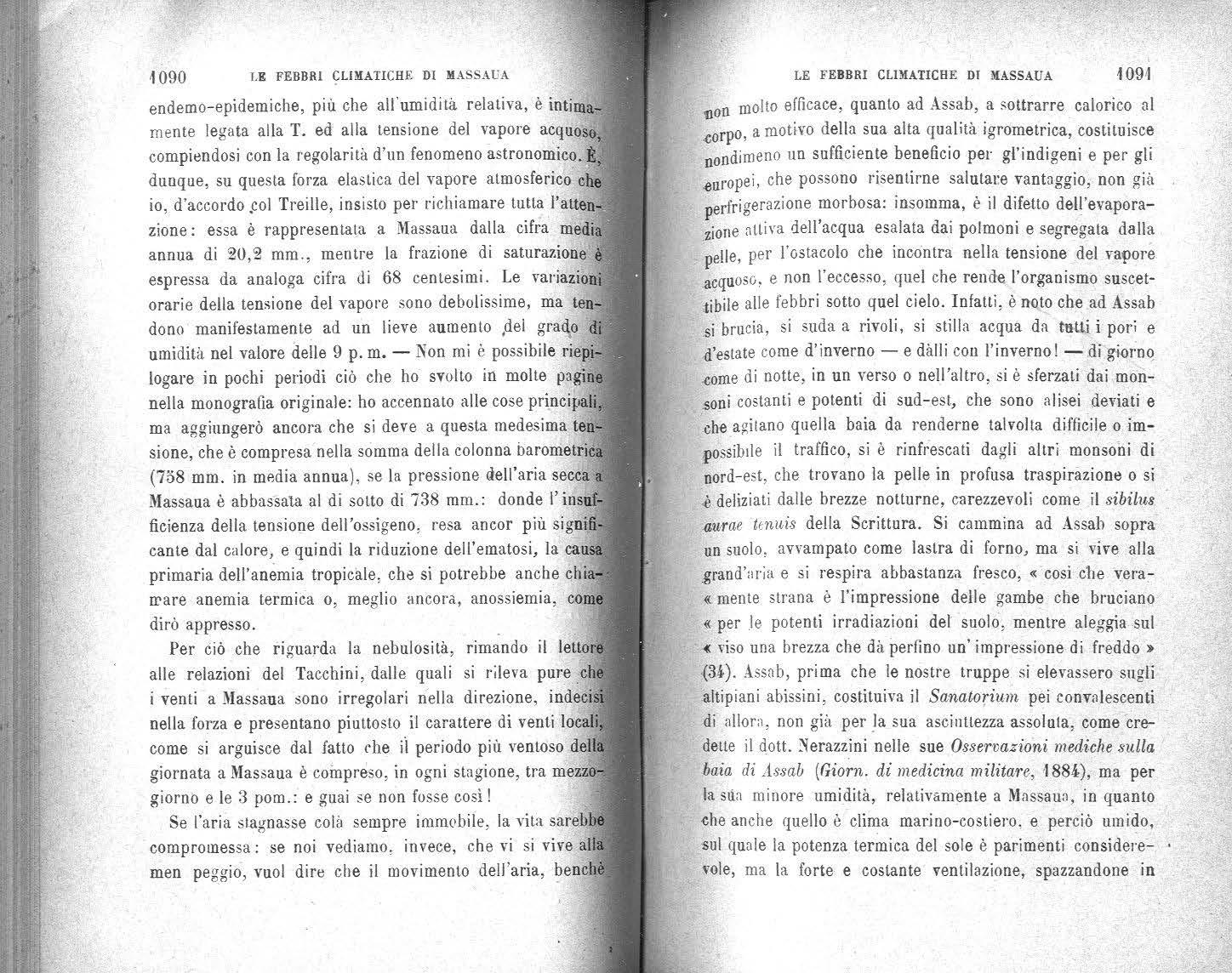
LE F.I!.BBRI CLIMATICHE DI MASSAUA modo più attivo il vapore acquoso atmosferico e qui ndi vorendo l'evaporazione del sudore, assicura l'equilibrio mogeno org:mi co e determina una sal ubrit à di gran lu
Ben chè lo studio comparato in medica sempre a co ncl us ion i prati ch e, come dice il bard (l. c. ) . nondimeno mette conto di confrontare S. del enegal con )l assaua, giacenti a un dipresso sullo s parallelo. La ristrettezza dello spazio, però, mi vieta iii trare nei particolari, ma, se al lellore prendesse vagh ezza conoscerli. potrebbe leggere i brillanti lavori del dott. Bori ripètutamente citati, o l'articolo del Roch arJ sul clima e conv incersi che, pur esistendo al Senegal , più - che Assab, tutte le maggiori condizioni perfriaeranti da • n mentare il verso del nostr-o Divin ·Poeta che la è dannata li1 «a sofferir tormenti, caldi e geli» , non vi si mala di raffreddori se non in proporzioni minime.

Per concludere. il clima di è ad isoterma di 30• ad isobara di 758 mm., con tensione di vap ore acquoso mm . 20,2 (med ia annuale), che abbassa la pressione l'aria secca a q1eno di 738 mm., e con una frazio ne di razione, per il va pore acquoso, espressa in 68 cen (media annuale). Yi si debbono riconoscere due stagi oni, 5tiu te da una gradazione di caldo, la cui media minima è
C., e non da una decisa, r egolare ed abbondante sità, nè tànto meno da oscillazioni negative, significa dello stato igrometrico assoluto , che si ver ifica no sotto !'azio ne del vento di nord -est, quando assume , mesi· tor ridi. il carattere di bufera termica (kamsin) :• t• clima dove la siccità è la regola e la pioggia l'eccezione, evaporazione prevalendo sulla precipitazione nel rapporto 24 ad ·l , e dove la tensione equabile del vapore acq uoso
LE FBBBRl CllliATICHE DI MASSAUA 1093
sicura la regolarità delle oscillazioni barometriche (ore tropicali di Humboldt) e si oppone ai bruschi ca mbiamenti di tem peratura dopo il tramonto . Yi si risco ntrano singolari proprietà termich e, la permanenza cioè del forte calore medio men sile per i? ore del giorno iu tu tto l'anno , ad un grado sempre elerato, non minore di 25° C. , e l'equidistanza semestrale dei massimo e minimo caldo e del medio a nnuale nelle epoche critiche, avendosi oscillazioni termiche negati\'e poco note,·oli. " assaua, insomma, ha un clima ipertermico, umido e co;;ta nte.










