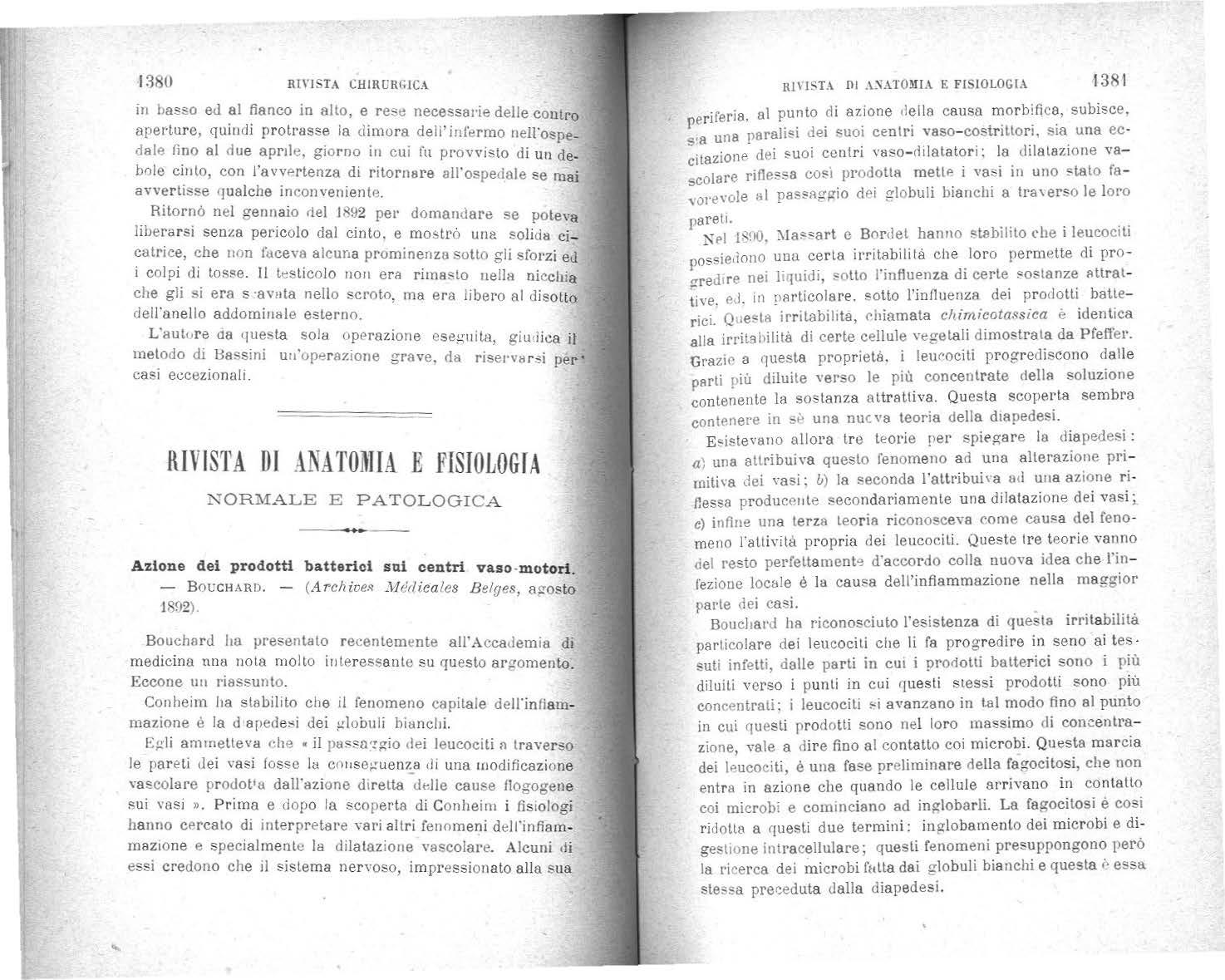
30 minute read
RIVISTA DI E FISIOLOGIA
Normale E Patologic A
Azione dei prodotti batterici sui centri vaso -motori.
Advertisement
- Bot:CHARD .ì1drli ca les Belges, a f!'O s to 18!)2).
Bouchar d ha pt·esentato recentemente all'Accademia di medicina nna nola molto interessante su q uesto argomento . Ecco ne un t·iassunlo.
Conhei m ha stabilito che il fen omeno capitale dell 'in fi a mmazione è la dei globuli bianchi
Egli a mmetteva ehe • il pass n·rgio de i leucociti 11 traverso le pareti ùei vasi fosse ltl cc) trse;w enza di una wodi fi cazi one vascolare pr odot1a dall'azione dr retta delle cause flogogene sui vasi » . P rima e dopo la scoperta di Conheim i fisiologi h anno c Prca to di inter pr e tal'e vari altri fe no meryi dt:ll'i nfìam - mazr one e sp eci almente la dil ataz ione vascolal'e. Alcuni di essi credono che il sistema nervoso, impressionato alla s ua
Rl
VISTA DJ .\:\AT OMIA E FISIOLO GIA
eri feria, al punto d i azione de lla causa morb ifica, subisce, una paralisi dei suoi centri vaso- cosir illo r i, sia una eccitazione de i suoi centri vaso- dilatatori; la d ilatazi one vascolare piflessa cosi prodotta melle i vasi in uno :::talo favor-evole al dei globuli bianchi a tra,erso le loro pareti.
Nt>l 18fl0. :.\l a!>sart e B0rdet h a nno !>labilito l'he i leucocili pos siedono uuu certa it•rìlabili tà c h e loro permette di pronred ire nei lif)uidi, sotto l'influen za di certe !>Ostanze AllrateJ . in sotto l'influenza dei p r odotti batter ici. Que!>LA irr ilabilita, rhiam a ta chimicotassica è identica alla irrita hilità di certe cellul e vegetali d imostra ta da Pfetl'et·. Grazie a (]Uesta proprietà . i leurociti progrediscono dalle pArli più diluile verso le più conce ntrate de lla soluzione contenente la sostanza attr attiva. Qu esta scoperta sembra contenere in st> una nuc. va teoria de lla. dtapedesi. Esistevano allo ra tre teorie rer spiE>gare la diapedesi : a) una attribui ,•a. questo fenomen o a d una alterazione primith·a dei \·asi: ù) la seconda l'altribuh·a ad una azione riflessa p roducente secondariamente una di latazi one dei vasi;.
c) infine un a terza teo ri a ri conosceYa rome causa del fenomen o l'altivita propria dei leucociti. Queste Ire t eori e vanno del resto d'a ccordo colla. nuova idea che l'infezione é la causa dell'infiammazione nella maggior pat·te dei casi.
Bouclrat·d ha riconosciuto l'esistenza di questa irrita bilità particolare dei leucociti che li fa p r o g redire in seno ai tes · suti infetti, dalle parti in cu i i proòotti batterici sono i più diluili verso i punti in cui questi stessi prodotti sono più concentrati; i leucocili avanzano in la l modo fino al punto in cui questi p rod otti sono nel lo ro massimo di concentrazione vale a dire fino al contatto coi microbi. Questa marcia ' dei leucociti, é u na fase preliminare della fago ci tosi, che no n entra in azione che quando le cell ule arrivano i n contatto coi microb! e cominciano ad inglobarli. La fagoci tosi é cosi rid otta a questi due termini: in p:lobamento dei microbi e digestione intra cellulare ; questi fenomeni presuppongono però la ricerca dei microbi futta dai globuli bianchi e questa i> essa stessa preceduta dall a d iapedesi.
Si avrebb ero cosi nell'infiammazione , e, in un mod<J più generale, nella lotta dell'organismo contr o l'infezione locale tre atli che si succedono e si completano:
1• la diapedesi, scoperta da Conheirn;
2• la ricerca dei balterii falla dai leucociti, dimostrata da :\fassart e Bordet; a• la fagocitosi, messa in luce da Metchnikoff.
Massart e Bordet ritengono che le due prime fasi del fenomeno ne costituiscano una sola; ch e l'attrazione pro lotta su i leucociti dai prodotti batter·ici basta a provocare la loro migrazione a le pareti dei vasi. Ma Bouchard non co ndivide tale opinione per· il fallo che il plasma sanguigno che costituisce l'edema inHammatorio passa coi le ucociti anzi prima di essi c talvolta senza di essi; e Lutta,·ia non ammette che il plasma possieda una irritabilità analo.,.a & fJuella che si riconosce ai Ieucociti. "'
Bouchard !w riconosci ... to inoltre che uno dei prodotti batterici, per la sua azione gener ale sull'economia, rende impossibile l'allo ca pitale detrmfiammazione, vale a dire la diapedesi. Charrin e Gamaleia hanno completato la dimostrazione stabi.lenclo che questo prodollo speciale si oppo ne egualmente all'uscita del plas ma ed alla dilatazion e infiamma toria. Quc:::sta azione ._ dovuta al potere paralizzan te che questa sostanza, chiamata da Boucha r d anectasina. esercita sui centri vaso- dilatatori.
L 'anectasina im pedisce la diupedesi locale con la s ua a zione generale, qualunque sia il processo col •JU81P. si tenta di provocare quesl:i rliapedesi. Ec;sa paralizza i centri ''a'>odilatatori, i!ppedendo così la congestione e l'edema infiammatoria; BoucharJ crede che si è pa r iment i colla sua 8Zione paralizzan te sui centri dila tatori che questa si oppone alla Jiapedesi. Egli è riuscito ad impedrre questa coll'iniezione intra- venosa o sotlo-cutanea di anectasioa e cio, sia introducendo questa sostanza in un punto lontano dal in cui risiedevano le a ttrattive secr ete dai micr obi, sia iotroducendola nel mezzo infetto.
Una proprietà importante di questa anectasina si è che essa si oppone. non solo all'uscita del plasma e dei leucociti,
Dl E FISIOLOGIA 1383
anche a quella dei globuli rossi. ai quali non è stata rima •1·uta alcuna propr ietà chimicotassica. I ofalti, essa arconosc . , . t le er1 wrrayie. Bouchard ha r1scootralo quest az10ne res a . . . · d. a·a sull'uomo in cinque casi tl'em.otltSI m tre 1 emorra.,t . t. 1ale 1 'auectasina non Interviene net processt mfiam- tnle!' tt . . . matorii cile come moderatore o agente d1 arresto. Sotto questo punto di vista, essa puo essere collocata tra agenti antiftogistici.
Vi un"altt·a !'Ostanza che Bouchard ha scoperta la cui azi one l'eccitamento dei centri vaso - di· el tatori: sostanza provoca , nella regione d·oude PN'a . . . de J'infìamnaazione, una congestione riflessa p!U energtca, ce . . ... una essudazion e più abbondante ed una dtapedest mten;<A; le sue proprieta !'ono quindi per'fdtamenle rnverse di queilrl ò elranectasina. In certi come i reni, i moni e la retina, la sua azione vaso-dtlatalrrce può manifestarsi senza alcuna provo cazione locale. Questa sostanza antagonista dell'anectasina è stata chiamata da Bouchard eccasina: essa Y..rme nella tul>ercolina di Koch. Questa conoscenza di prodotti batterici che hanno per effetto, gli uni di · diminuire il passaggi o dei glohuli b ia nchi ed anche deg-li altri elemen ti del sangue al punto òi prevenit'4' le emo r ragie; gli altri, di provocare una abbondante mi g 1 azione d t IPucociti e l'essudazione del plasma, è di una grande importanza per il medko pr·atico : e un che promette 1->er l'avvenire a pp ii .azioni terapeul!rhe nurnero:::e
- L 'etiologia del canoro . - çThe Lancet, maggio 'll-\92).
Piu di 40 anni fa, quando Virchow annuncio la sua storira do tlr'ina, che tan to nei lì come nei pale cellule producono la proprill vita, aùombr·ò anche il p;incipio che quantunque ogni cellula nasra da una cellula, la prvgenie l'assomigli ai proprii generatori solo quando la ripr·<>duzioue avvenga in un ambiente ecl in condizioni cirCO!'<Crilte entro limiti ben <lefìu iti, \! noi ora sappiatno bene che cambiando le condizioni di nutrizione, le 'ie di e:>cr·ezione, e la nRtura e quantità di Stimolo e d'irrita zione, posalterare il carattere delle cellule prodolle da certi tessuti.
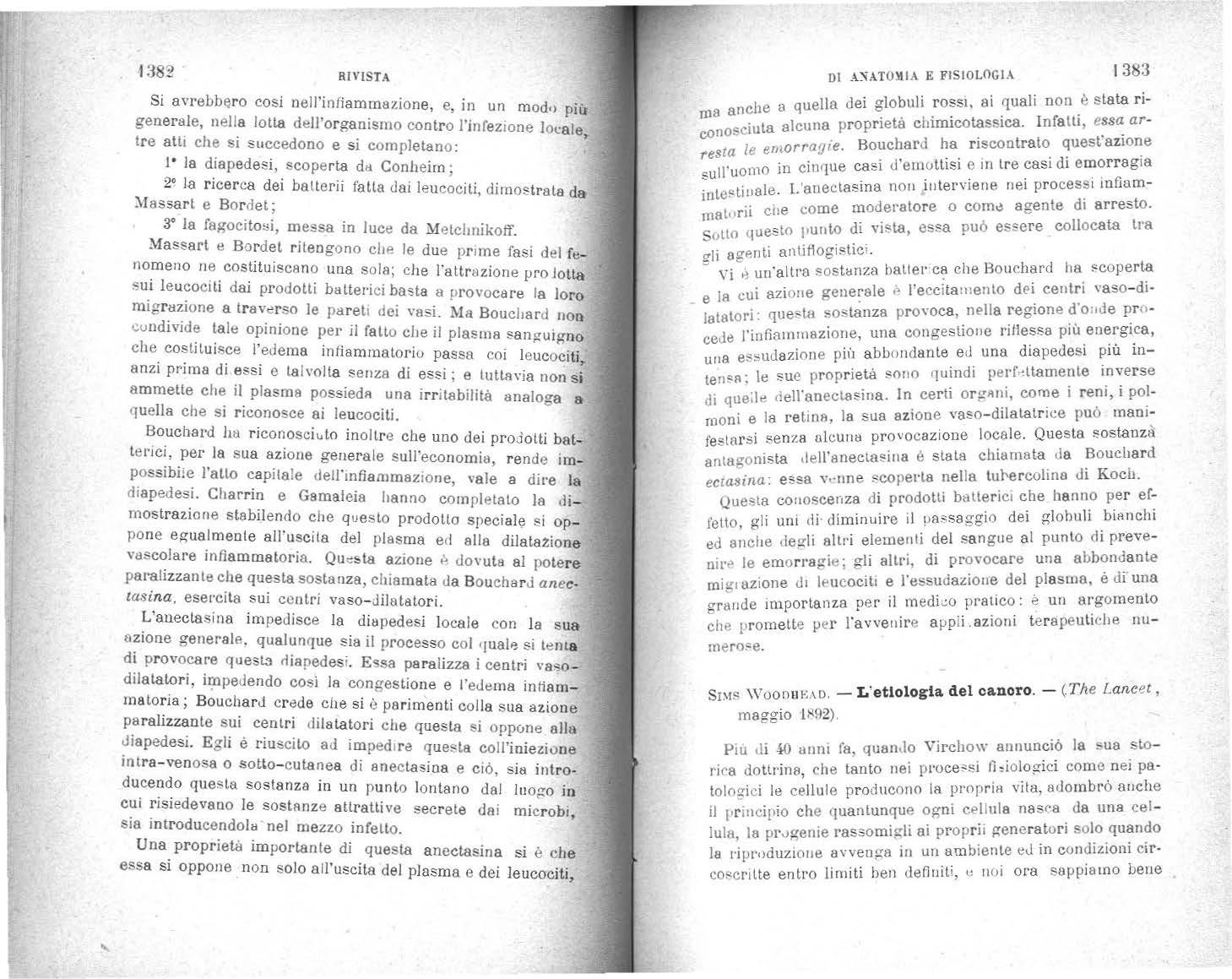
Tutte le superficie t-pitclial' sono coverte da uno o più strati di cellule, la forma delle quali varia secondo In lor·o funzione, ma qualunque cellula epiteliale si esamini, ed in qualunr1ue condizione, si trover·à che ove rna,Q"g-io r e è il loro potere vegetativo, meno completamente si sviluppa la loro attivita funzionale. Nell'embl"ione iufalti, nel quale lo sviluppo e raccrescimento proeec:le rapidamente, le cellule esercitano poche o ne:>suna funzirme, essendo tutte depul8te alla riproduzione, mentre •nvecP- le c-ellule del connettive sono molto attive benchè poco s,·iluppate, c-omP. si osser,·a nel tl\ssuto mucoso che è il precursore del tessuto areolare sottocutaneo .
È dur·ante questo periodo che si a vvera tutta l'i11voluzione dell'epitelio nel la vita fetale, elle si compie !"impalcatura d'una glandola formata molto tempo pr·irna che siR chiamAta a compiere la sua funzione. Durante questo periodo di s,·iluppo dell'embrionu nell'utero. e delle mammelle nella puberrà, non ran-isiamo alcun gr·uppo stabile di tessuti. possiamo appena immaginare che per un di:::turbo nutriti,·o do' uto ad un'irritazione locale, possa sorgere un tumore. Perchè i tumoz·i sono più comuni ne!Ja vita fPtale e nella prima eta che nelretà avanzata? P e rch ù i tumori dell'età adulta, adenomi, cisti g-landolarì, iìbt•omi , cis tonon hanno tend enza a d •venir mostrano nn accrescimento nei due ordini di tessuti, e diventano più sarcomatqsi o più glandolari secondo l'età alla quale si souo sviluppati? Perchà g-li epiteliomi s'incontrano di regola nella ta1•da eta, od almeno alla finp deireta Non potrebbe darsi che le ir·ritazioni e srli stimoli fosse ro capa ci di dar origine a diverse forme di tumori secondo le diverse epoche della vita, e che la differenza essenziale consistesse nella dive r sa condiz ione di nutrizione e di sviluppo dei tessuti? Noi sappiamo che gli epiteliomi della pelle e delle mucose, la funzione delle quali non è mai altamente specializzata,
DI A:\ATOlfJ,'. E FISIOLOGIA
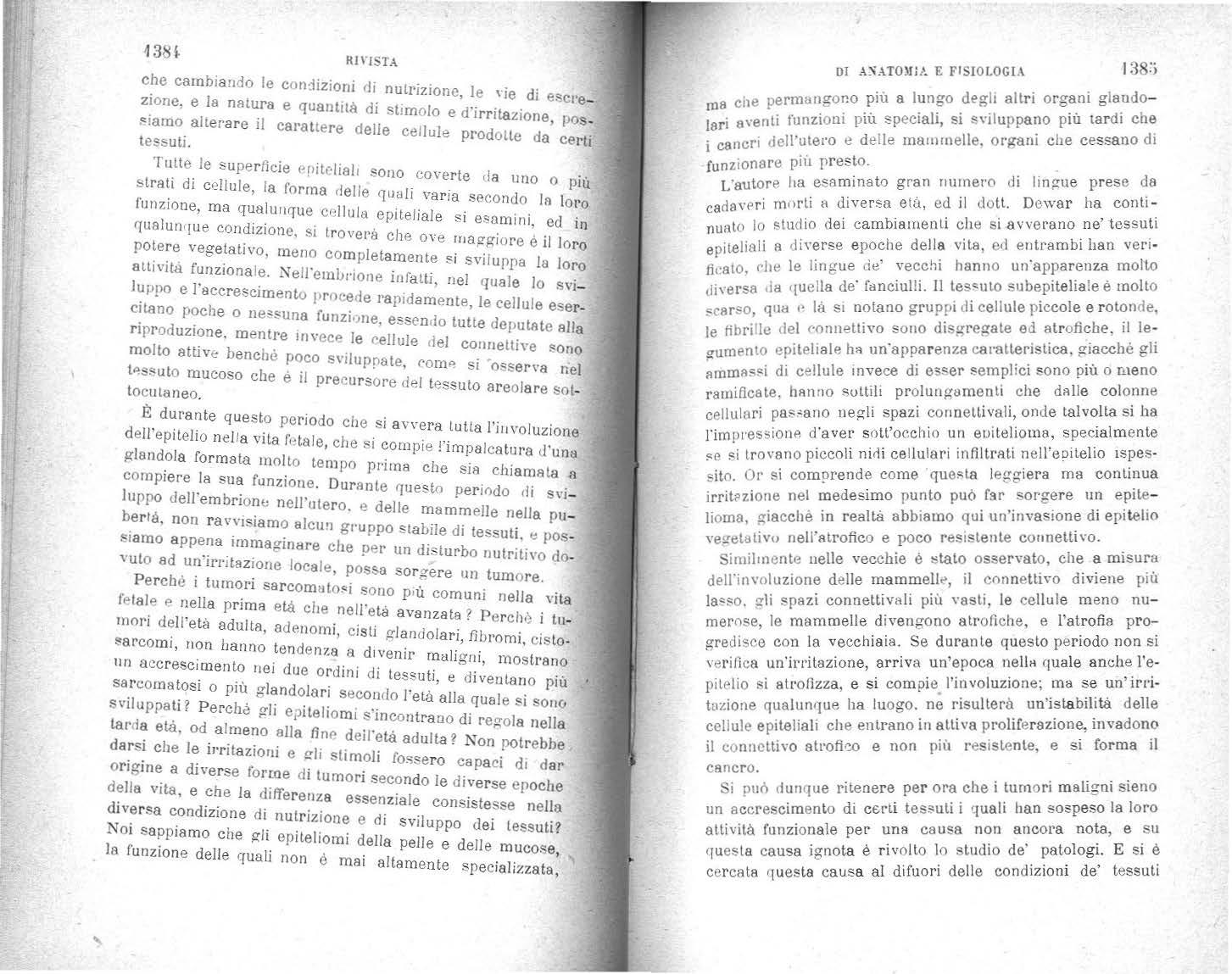
0 "0 pt·u · a lunao desrh altri organi glando- permang e " d" h rna. ch.e . più speciali, si s'·iluppano pm tar ' c lari ll'uter·o e delle mammelle. orp:ani che cessano dr · cancrr ue 1 . are più presto. d ha esaminato gran nurnet·o di lingue prese .a L autorE> . . t' ed il dott. Dewar ha conti· molrt1 A drversa e a, , . cadavnr r lei cambiamenti che si avverano ne tcssutt nuato lo stm IO < l e della vita ed enteambi han veril. 1· a JtYer.:e epoc 1 ' Il epite la r , ' h. hanno un·apparenza mo o he le lin!!ue ae vecc. .J • • Il fkato, r v • f . Il. Il les"utO subepitehale e mo o •tuella de ancJU L d dr versa ota . . t .,.ruppi di cellule p iccole e roton e, q ua ,, la se no ano o 1 1 "carso, . d. "' "'ale ed atrofiche . 1 e- l fibrille del connettivo sono rs,.,re,.. . . ". hè <>'li e •t r !P. hll un·apparenza ca ..atler•strca, ,...racc e :f'c:/,:1: invece di esser semplici sono più o meno v l T rolun<>'ùmenti che dR!Ie colonne ramifìcate, hAnno su t•. l P . ,.., oetlivali onde tal volta si ha cellulari euitelioma, specia lmente rimpres siOil P. d a ve,: s _,. e l!ulari infl!tt·ati nell'eo ilelio tspes- . l ovano p1cco 1 lllnl c ·
!"C "'' r . ta le..,...,.iera ma contrnua O • si comorende come que>'> "'" stto. I to può far soraere un eplte. . · e nel medes1mo pun "' . . . . . lta abbiamo qui un'invasione di ep•leho roma trtacche m rea . 1 ' :' , e oco resistente connettivo. ,·e!?elatrvo nel! atrofico P . t che a misura Ile vecchie è :;tato osser'a o, . Simiilnenle ne Il .l con ne ttivo diviene più delle . .... ·a'sti le cellule meno nur zt connettrvll 1 pm ' ' lasso, g ;el':ammelle divengono atrofiche, e l'at.r ofìa cc hiaia Se durante questo perwdo non SI gred•sce co.n ·. a un'epoca nellH quale a nche l'everifìca un'rrl'ltazwo e, arrlv . l . . ma s e un' irl'ilì si compie l'1n vo uzwne, pitelio sr atro 1zza, e . lterà un'is ta bilità delle . l nue ha luogo. ne rlsu toziOne qua ltiva prolifer azione, invadono cellule epiteliali che entrano tn le t e -i forma il fi on pm r es1s n e, :::; il connclt1vo all·o e n cancro. h i tumori mali"'ni sieno Si può dunque ritenere. per .c han sospe:o la loro un accrescimento di cerlt tes,.u t l q on ancora nota e su . . f · aie pee una causa n ' alttvità unz10n d. de' patolo"'i E si è . ta è r ivolto lo stu 10 o • . questa causa 1gno · . ,. d 11 condizioni de' tessutr cercata (]uesta caus a al di fuo r J e e e si. è tr o"ato che i turnor•i malia-ni di un ti . ha le non SI possono produrre . l . . po eplle- In essut1 sani q t che se !"irritazione . . . e ,ano, e SI e rttenuto per un tumori semplici dura luppa l"elernento c!: u eta del e si svitazione dell'epitelio ch e in va i e . / ;'potere Ùl rap1Ja vege. la ca usa eccitatrice della atdiCil. M a qual'é dun que P el 1 e e cancro? suo sv1 uopo c . .. . .. · un 1rr1!a;done CO f e Thi erschn che il conneltivo otrr·e all'' . . e della vulnerabilità una certa e ta e ·ott delle cellule epiteliali ad rlimostrò che 'i ir r·ilative. Quando si d l . ano rn tturre una proliferaz· e connetL1vo si ce . . r •one durre una i capaci di proche comun· , fì. erl '"'na, ma ,lOn SI tr ovar<Jno l sapro tJ. D« lungo temp . mente certi oara '"it' . . o SOli noti zoolol!ical poco mob•l• di struttu r a .. omogenea r·icover, 1 · da u d ' PIU o meno ' • na ura cut' 1 1 cellulA eDHeliar l •cu a, c le alter ano le v • •, c re vanno sotto il no d ' .d tro vano nel fegato de' co .,.,. d . I cocct u, che si fo rmano d..,' nod l' _,.. nr., •, Ovc trrJtando l dotti biliari · u 1 ut psor osperm i i qual · · D ' cisti conten ... nti p r oiezioni Pll )ilfiC , . l St co_n orman o covrono d 'epile!io pro!'' t l orm l r.be ra ptJamente SI e le cui cellule .. cor·pi pr·otoplasmati <:i che ' . . sono r tptene di descritti coc"idii 01'""'rl· r•spvnd ono perfetta mente ai · c-"' 1:>m1 Stmili si trova 10 Il epiteliali delrintestino de' t l ne e cell ule dell' uomo e nel opr, ca:·u, gatlt, conigli, ed anche , percorrere la letterat l . cruesti parassiti si r est . . ur·a e e di , a rnerA\'Jcr!Jatt' l li . . solo aJ 1 · < e a somwlranza non . occ llO nudo, lf'la ancho istol ,.. e · ' dt psorospe r mi e le pro·' . . o.....camente, fra r noduli u UZ!Ont ca nce r•t "'ne dun.,ue neglr animali inferioori d·e · mi cr • • pa rassttJ ciel tessuto epiteliale Il l croroanrsmr gono un a continua pro liferazion: quale e sostend . · · , c ompiendo tutte le IZtonr dell'irritazione . concausa del cancro. contmua che esser
Di qui la scoperta annunzi ata da Ru;.s el de' cor·pi a fucs ina ,
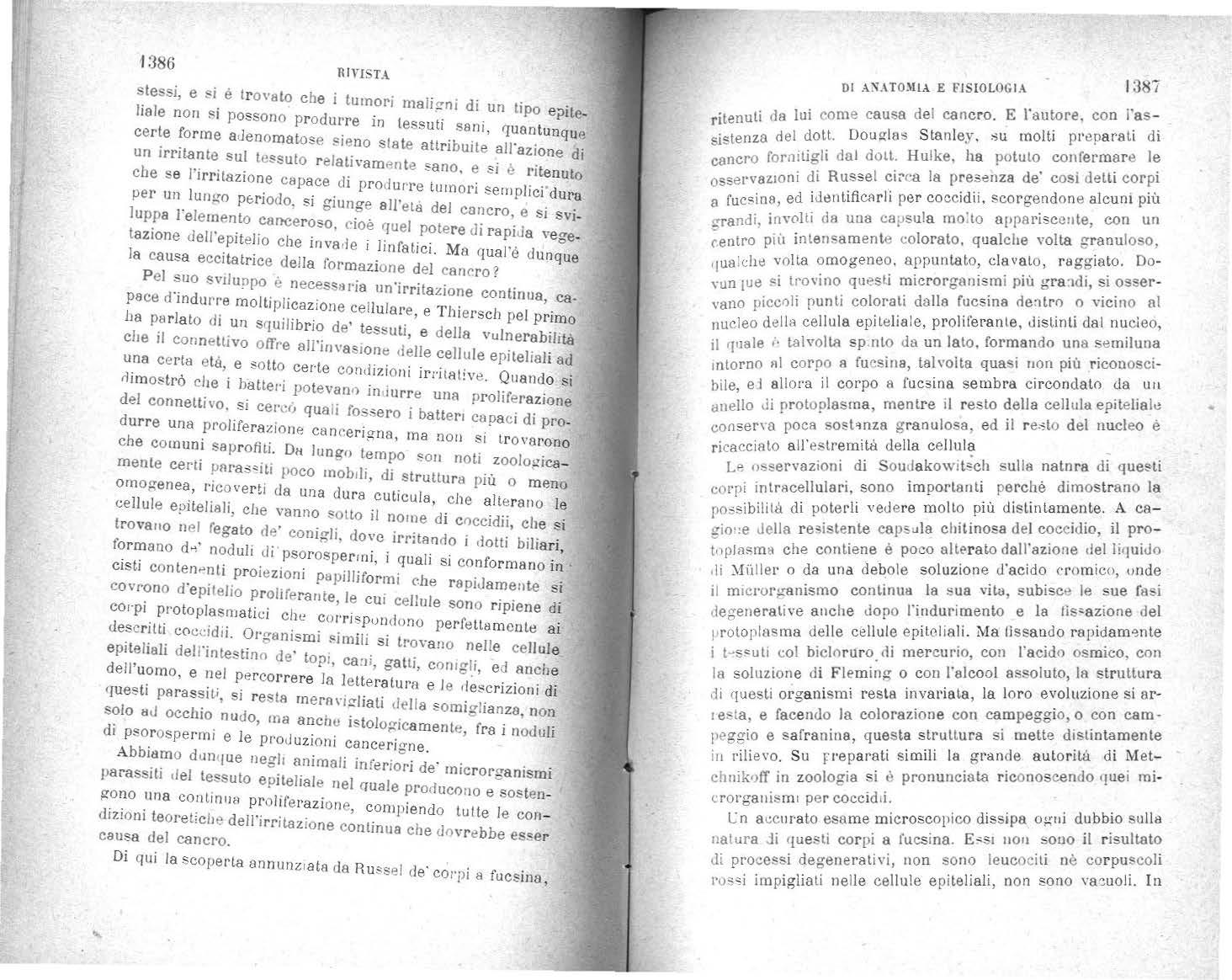
Dl E FlS IO LOGIA 1387
ritenuti da lui come causa del cancro. E l'autore, con l'assistenza del dott. Dougla!S Sta.nley , su molti pt•epa rati di cancro fornitigli dal dott. Hulke, ha potu to conlermare le osse1•valJOni di Russe! ci;-c·a la presen za de· cosi detti corpi a fucsina, ed identificArli per coccid ii, scorgendone alcuni più zrandi, involli da una ca psula mo:to ap pa l'isceute, con un più intensamente colorato, qualche volta granuloso, volta omogeneo, appuntato, eia valo, ra ggiato. Do· yun rue tr·ovino questi microrganismi più gra:1di, si osservano picc0li punti colorali dalla fucsina cie:1tro o vicino al nucleo della cellula e pi te liale, proliferante, d istinti da l nucìeo, il quale i· talvolta sp .nto da un lato, formando una semiluna mtorno tll corpo a fucsiua, talvolta quasi uon più .riconoscibile, ej allol'a il corpo a fu csina s embra ci rcon da to da Utt anello di pr otoplasm a, mentre il r esto della cellula con ser,·a poca sost'lnza g ranulosa, ed il r e:->lo d el nucleo è ricacciato all'estremita della c ellula osservazioni di Soudakowit5ch sulla natnra di questi corpi intracell ulari, sono importanti pe rchè dimos trano la possibil ilu di pote rli ved e re mollo più d istintamente. A cagio·:e Jella resistente cap:;u la chitinosa del coccidio, il protoplasma che contiene é poco alteralo dall'azione del liquido di o da una d ebole soluzione d'acido c r o mico, onde il mici'OI'J.!anismo continua la sua vita, le sue fasi degenerative anche dopo f'indurimento e la fìs"azione d el dell e cellule epii.C\Iiali. Ma fissando r ap idam<>.n te i col bicloruro. eli mercut•io, con l'acido os mico, con la soluzione d i Fleming o c on l'alcool assoluto, la struttura di questi o r g anismi resta invariata , la lo ro evoluzione si arr esia, e face ndo la colorazione con campeggio, o con ca m· peggio e safranina, questa strullu ra si mette distintam ente iu rilie,·o. S u p ·eparati si mili la gt·ande auto r it.à di Metchnik,>ff in zoologia si è pronunciat.a riconoscendo que i mic.:rot·ganil:)m • per coccidd.
C n a(;cur·ato esa me microscopico dissipa ogni du bbio sulla natura Ji c1ue;:. ti corpi a fucsina. E"SI non souo il r isultato di processi degenerativi, non sono leucocit i nè co rpuscol i l'ossi impiglia ti nelle cellule epiteli ali , non sono In
111\'ISTA alcune caosule si scorrre Uil · e 'O J • si \'edono piccoli psorospermi rot- ;. < • in alfre · . Ollul o semlluna · · casl ess• sembrano libe f r •, m alcun i rJ ra le cellul 't l' · dopo la rottura della capsula m· rl : t>pt •alJ, sfuggiti dezza, d"l diametro ·' a re, dJ varia ...ran - ua uno a tre o tl ,...del sangue. qua ro Col·puscoli r ossi
Esaminand o una sezione d'un can " . mente crescente elle t ero rapida. con en"'a quest' . . .
IIfet•azione dell'epitel' . . o. ' corpi, st vtde la pro- 10 p1u spiccata capsulati SOJIO più numerosi. Ne,.l i i corpi incellule conten,.ono ([Uest · . . .,. ptu grandi molte
. "' • Itllcroro-am"m· . e ristretti coperti da un :;oJ "' •, neglt spazi lunm ogni tr e o quattro celi l o ordme dJ cellule u e se ne vede u h un corpo incapsulato, mentr>e n l . _na c e contien e questi spazi un solo dr' . e le seziOni trasve r sali d i . ' (jUeStl CO rpi r'e · ganismi sieno la \'era ai al prova che questi micror -
Peto :siamo ancora lontani d Il • mp•e tutte le cavità .
· :::sa <e cancro Pere! è ·
Pss1 10 cond: · . · · l !':J !t•ovan o .zlon• soltanto . l . .
\'ita ? Si potrei ùirA dt' lo . . llt cerh per iodi della - ro c1o che H th· cillo tubercolare che l b' . uc mso n dice del ba-
' Jan JSO"'no d1 un t alla nutrizione del t:> e rreno appropriato psorosperma 1 1 resistono all'attacco de' . . . , c l_e e cellule epiteliali sane ptu 0 · · la fun ziona lità e la vifàl;ta d Il "' "' . arassJLI, e che quando · e ecellul e èi fi · ta · . . possono trovare un nido "'UI . 11 Cla . t cocc1d1 vi prodotti del loro proto l yual_e sv!lupparsi, l"ner\'al'e i sping-endole alla sg•re !':UI!e cellul e epiteliali per· mezzo d'unfl al _loro !';Viluppo, indi fo r ma embrionale nell l • rlcondurla alla lo t'O . ' a qua e l att1vr1a ve"' t r rug•one inversa dell'alt' t. f "'e a t\'8 cresce in · l VJ èl unzion l l{etativa la spiog 1 a ·' . . d a e, e questa attività veu Jll\a ere "''• "Pa .. 1. , . netti ,·o D'ali . "' ZII ln.alr ct ed il (:on. ra parle questi "tes<:i d . devono esercitare un e,...ett . , pro o tll del metabolismo 11 ' o 1rr1tante s 1 · c•ontatto delle celi 1 . . ··u connetti vo è a . u e proltft::ra ntt. e pr odu r\·i 'l . suto dt Kranulazione, ed ali . . . nuo' o testana dal suo norm a le Il. connettn·o ,.!<i a llondelle proliferanti cellule SJ r>resta ali mva sìone
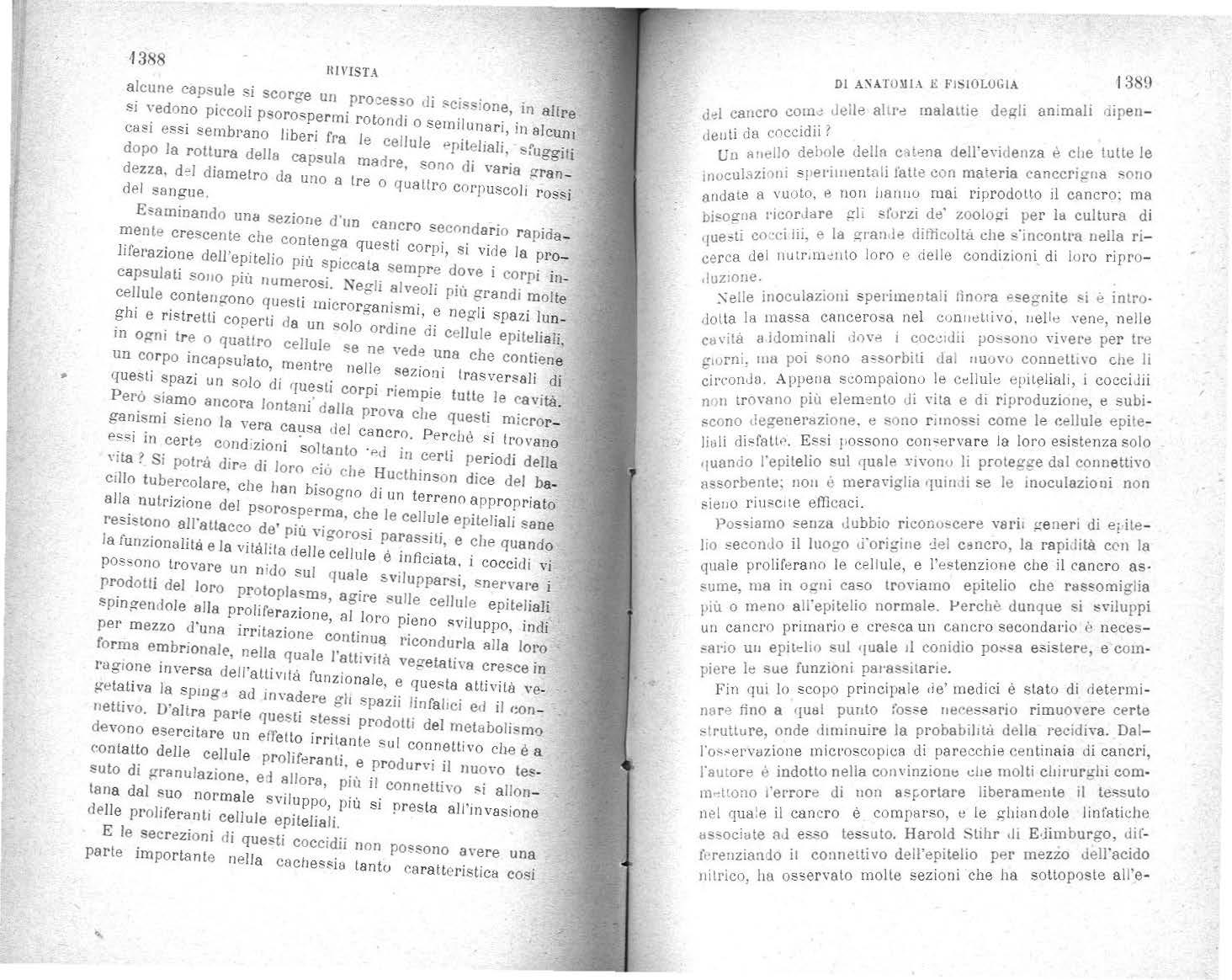
E le secrezioni rl i questi coccidii parte im portante nella cachessi a non possono aYere una tanto r.a ra ttcristica cosi dd cancro <!0111-.: delle altt'd mala ttie degli animali tlipendeo ti da coccidii ? uo debole della caldna dell' eyiden za è che tutte le s pet·i•uentali fatte con ma teria canccri gn a s 0no andate a vuoto. e non !Ja11no mai riprodotto il cancro; ma bi;;ogoa •·icorJare !!li sforzi de' zoolop-i per la cultu r a di que;;ti co ·ci fii , e la g-ran le difficoltà che s 'incont t·a nella ricerca dei loro e delle condizioni di loro riproluzJOue . ,:\e lle inoculazioni s pe1·imeotaii lì n oJ'a Ps egnite f'i è introdotta la massa cancerosa nel Yene, nelle c 6 ,·ìta a iùorninali dova i coc.;rùii po:;;sono per tre g:10 rn i, ma poi sono a:::sorbiti dal nuo\'o connelll\'O che li cir('onJa. Appena s.;om paiono le Cellule e piteliali, i cocciJii D'Hl tro\'ano più e lemento d i \' ila e d i ripr·oduzione, e subif'cono degene1·azione , e r imossi come le c ell ule epiledisfatl<' . E!< si possono con..,erva re la loro esistenza solo quando l'epitelio sul quale •;ivon o li protegge dal co nnettivo non è mera\·iglia •1 uìndi se le inoculazioni non :::ieno riu:<c11e efficaci .
P ossiamo senza Ju bbio ricon o$Ce re vari1 g e neri di e! ·ilelio !:'econJo il luogo ù 'origine Cclllcro, la rapidi tà ccn la quale prolifera no le cellule, e l'estenzione che il cancr o as· :::urne, ma in ogni caso troviamo epitelio cbe piu o mt>n o a ll' epitelio normale. 1->erchè dunque si un cancro p r imario e cres ca un cancr·o seconda r io è neces::ario u11 epitdi o sul quale il conidio po;;sa esistere, e co mpiere le sue funzioni pa1·assitari e.
Fin qui lo s copo principale 1ie' med ici è stato di determifino a •1ual punto fos:::e 11e ressario rimuoYe re certe :-lrutture, onde diminuire la ptobabi!Jtà della rec 1diva. Da lro,.,.el'V<:JZione mic•·oscopica d i parecch ie centinaia di cancri, l'auto r e è indotto nella con \' inzione .;Ire m o lti chii'Urghi commdtono t'eero r è di non asr-ortare liberame nte il te!>suto n e l q ua !e il cancro è compa rso, e le giJiundole lìnt'atiche aJ es.:::o tessuto Ha1·old Stihr di Edimburgo, dit'ù·reHziando il connetti vo dell'epitelio per mezzo Jell'acido nitrico, ha osservato molte s ezi oni che ha sottoposte a ll'e -
·1390 Rl\1STA 01 AX.HOliiA E FISIOLOGIA same de!rautore, ed entrambi si son convinti che nel rimuovere un cancro, la sola anc ora di salvezza sta nell' _ sportare ad e;,so tutta In massa glan.iolare, e la pnrte adracente al tessuto p-hiandolare, di se facendo delle SPZioni con i marg-ini della parte aspo rtata, e tr·allandole con al cool mctilico eù acido nitrico f\ poi con acqua, vedaao an co ra colonne opache o frammenti, si possa drre che )"a;.:portaz ione non è stata sufficiente. E questo esame dev'essere fatto specialmente nelle vicinanze dello sterno dopo l'aspostozione della mammella, perché ivi frequentemente r estano fram•nenti di f!"landola.
Rivista Dellemala Ttieve Nereeedella Pelle
Sulla ptirlaai rubra (Hebra) e suoi rapporti con la. tubercolosi: - J JAO.\SHO.N. - (A.rc!t. fi.i r Derm. und Suph e Centralb . .fur clie med ie . Wissensch. 30, 1892). '
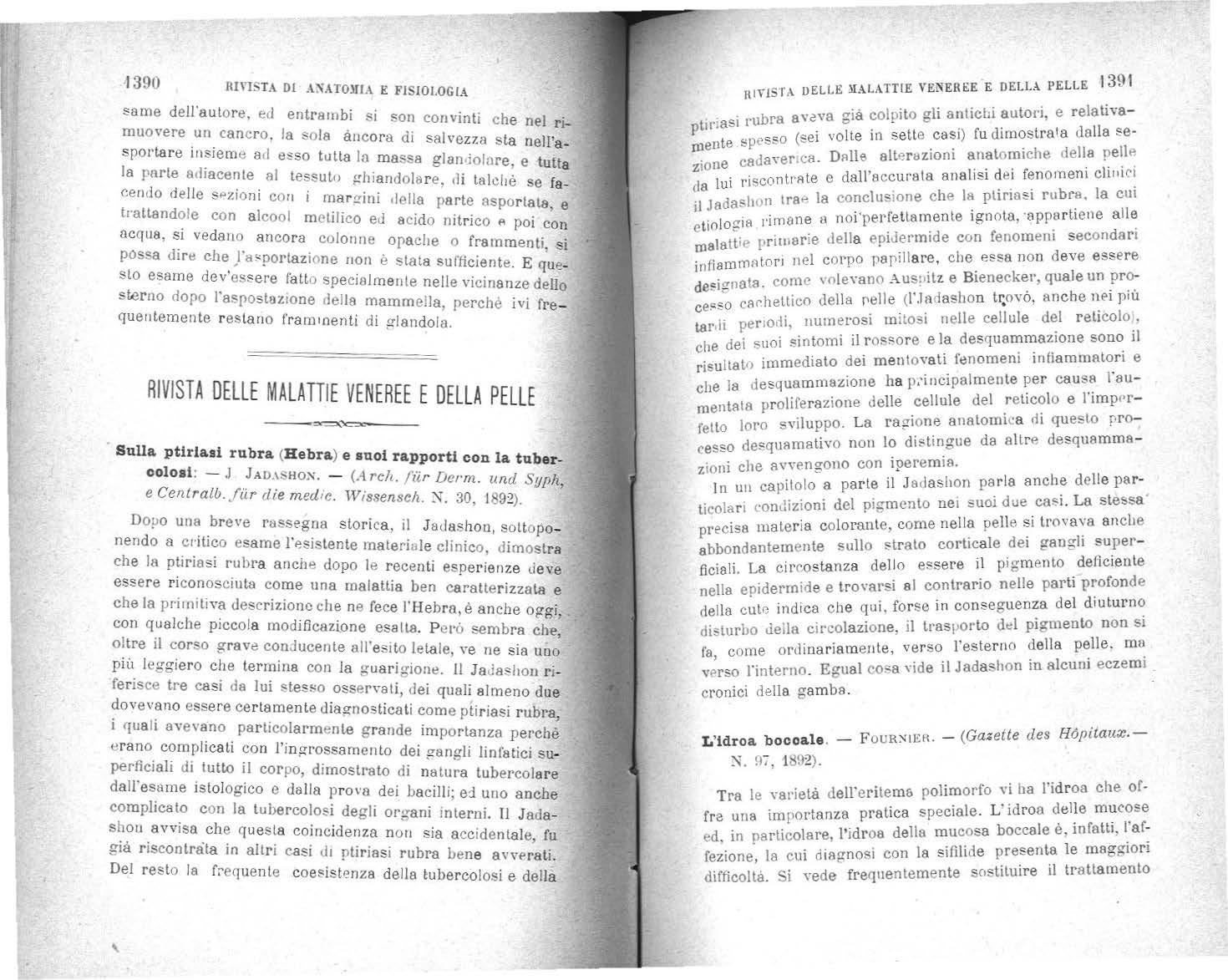
Dopo .breve ra sse gna storica, il J aùashon, sottoponendo a c rrtrco esame l'P-sislente materiole clinico, dimos tra che la ptiriasi rubra anche dopo le recenti esperienze Je ve essere ricon osciuta come una malattia ben caratterizzala e che la primiti va descrizione che ne fece l'Hebra è anche o<><>i ' t"' n ' con qualche piccola modificazione esalta. P et'ò sembra che oltre il corso grave conducente ali"esito letale, ve ne sia un; più leggiero che termina con la guarigione. Il JaJashon riferisce tre casi da lui stesso osservati, dei quali almeno du e essere cer tamente diagnosticati come ptiriasi rubt'a, t quah ave,·ano particolarmente grande importanza perché e rano complica ti con dei rzangli linfatici superficiali di tutto il corpo, dimosti·ato di natura tubercola r e dall'es.ame istologico e dalla prova dei bacilli; e::i uno anche complrcato c on la tubercolosi degli organi interni. 11 Jadashon avvisa che questa coincidenza non sia accidentale fu .. . . ' g1a rtscootrata in altri casi dr ptiriasi rubra bene a''Yerati .
Del resto la f:·equente coesistenza della tubercolosi e della
RIYISrA DELI.E .liALATTIE VENEREE E DELLA PELLE 1391
· ·ubra avè''a aia colpito gli antichi aulol'i, e relativap tu·tasr r o t Spe "'"'o ("'ei volte in sette casi) fu dimostrata dalla seroen e . cadaYer:ca . DAlle alLP.razioni anato miche della pelle zrone · 1· · · da lui risconlt'Ate e dall'accur·ala analrs1 c . d tra<' la conclusione che lA pllrtasi rubra, la cut 11Ja a-- 1 . 1 (T,·., rimane a noi'perfettamente tgnota, ·appa r ttene al e ctro o," . . · d · malattie priu.ar:e dell a eptdennrde con fenomem secon arr infìamm fl tori nel corpo papillare, che essa non deve essere d c:·anata. come ' 'oleYa no Aus:•ilz e Bienecket·, quale un procArheltico della relle (l'.ladashon t r.ovò, anche nei piu ce!<- . tar•li per tod i, numerosi mi tosi nelle cellule reltcolo .' (te dei s uo i !"in tomi il r osso re e la desquammazrone sono rl immediato dei mento,•ati fenomeni infiammatori e he la desquammazione h a p:incipalmeule per causa l'auproliferazione delle cellule del e l'impPrfetto loro sviluppo. La ana.tomh:a dr questo processo desqusmativo non lo distingue da allre desquammazioni che avYengono con iperemia.
In un capitolo a parte il J adaslt on parla anche delle particolari condizioni del pigmento nei suoi due casi. La ste!:>sa · precisa materia colorante, come pelle trova:a anche abbondantemente sullo strato corltcale der gangh superficiali. La cirrostanza del lo essere il pigmento deficiente nella epidermide e tro,·arsi al contrario nelle parti profonde della cute indica che qui, forse in conseguenza del disturbo della circolazione, il l!'aspor·to del pigmento non SI fa come ordinariamente, verso l'esterno della pelle, nnterno. Egual co::;a ,·ide il Jadashon in alcuni eczem r c ronici della gamba
L ' ldro a. bocoa.le - F ouR:-IIEK - des HtJpitau:c.::\. 97, 18H2) .
Tra le Yat'ietà d ell'eritema polimorfo Yi ha ridroa che offra una im po rtanza pratica speciale . L' idron ed, in pa rticolare, l' idroa della mucosa boccale è, m fatti, l. fezione, la cui diagnosi con la sifilide presenta le magg10r1 difficoltà. Si Yede frequen temente sostituire il trattamento cosi semplice dell 'idroa boccale con un a cura me1·curiale assolutamente noci va. l erpete u·•deo si può n otare un aspetto cerch ialo una ser· d' h' . ' •e
L'idroa considera to in genPrule puo osservars i, non so lo m_ucose, sul!a pelle. Quesl\·sautema cu tan eo fol'ma 1111 eruz iOne e r 1temalo- Yescicolare limitata ad alcune d'd ' d.1 . . , e 1 1 pre 1èzto ne. Essa occupa, per esempio, la r egione do rsale del con alcune diramazioni " er:::o :e dita e l'antlbraccJO, la CJrconf<:lreuza del ginocch io, del gomito, del collo del piede. con un mas!'imo da pa r te delres tensio l C l · ne. oco a1 s::ono r egionali, non gen ... r-al izzati. L'eruzione for ma d a i'è sola, tutta la malattia. Lo :;>lato febb r ile deU· inizio é molto leggiero. quando non manca completamente.
Da l punto eli dsta della sua cos::tiluzione l' id r oa è d . . . ' ap- prlma formato da un er1tema comprew:iente dischi di tutte 1 . r e c 1 un rosso intenso vinoso e tal vol ta livido. Dopo ve ntiqua tt r o. o trentase1 o1·e co m paion o vescich e tte al ce ntro clel d1"CO e r1tc matoso, esse in vade r·e la totalità del d 1sco. I nvece di una Yescichetta centrale si può Ol'<serva re di due a tre piccole vescicoìe irregolari.
• r piu_ palliJi centr·o, p iù oscu 1·i alla periferia e. Circondati da un aureolo vPscicolosa. T alvol ta anche la marcia può essere serpiginMs . L'er-uzioue non si fa d'un
"'01 ma qualunque sia la sua forma Grunh al pe•·iodo di regre;:;si one, g li elementi erite mato- Yescicolari si ricoprono, pe r disseccazione, di una piccola c rosta. La scompar:;a del r ossore, il disseccamento, sono talvolta così rapiJi, che si è potuto descri,·er e una fol'm 11 !lborliva riell' id r oa. A fianco d i quella for·ma a bortivA venn ero segna late molle altre . Le due piu im pot·tanti sono quella. con bolle talor'H eno rm i, quella i n cui lc1 vescicolazione è così minimil, che fa d'uopo, in q ual che modo, indovinarJa.
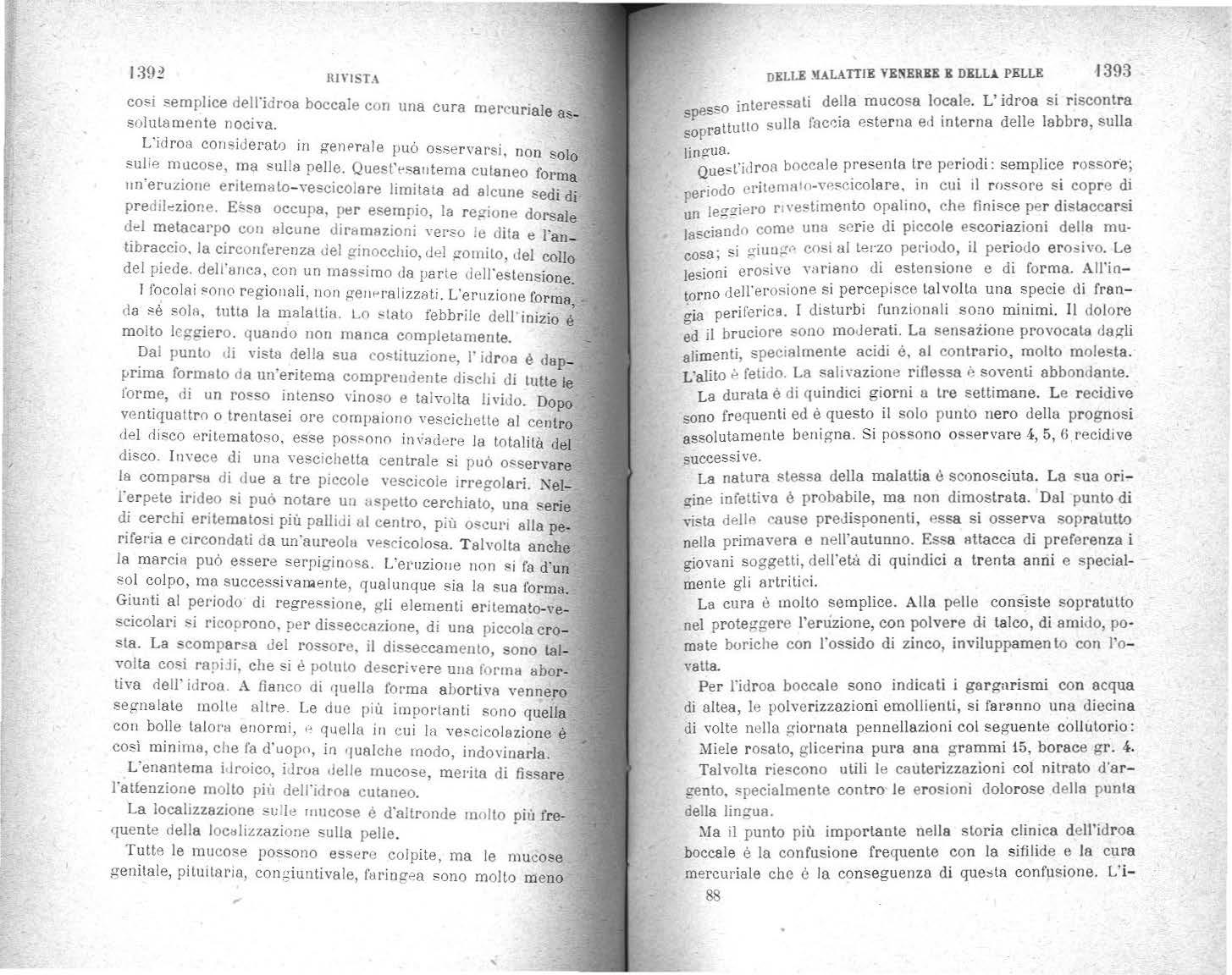
L'enantema i.Jroico, idroa delle mucose, meri ta di fissa re l'alfenzione molto più dell'idroa cutaneo.
La localizzazione sulle 1uucose é d'altronde molto più freq uente della sulla pelle .
Tutte le mu cose possono esse r e colpite, ma le mucose genitale, pituitaria, congi untiva le, :::ono molto m eno
DELLE ).(ALATIIB YBNBRBB B DRLU. PBLLB 1393
.,0 interessati della mucos a locale . L ' idroa si ri scontra spesa ttutto sulla este rn a ed interna delle labbra, s ulla sopr Jino-ua.
Que;:t'iJ r oa boccale presenta tre periodi: semplice r osso re; eriodo eritenmio-vPscicolare, in cu i il r ossore si copr e di leg!,!it>ro r1 ,•esttmento opali no, rh e finisce per distaccarsi lasciando come una serie d i piccole escoriaz ioni della mucosa; si cosi al terzo per·ioùo, il periodo ero:aivo Le lesioni erosive v<! riano di estensione c di forma. All 'intorno dell'er·o!'\ion e s i percepisce talvolta una specie di franperiferi c a. I disturbi funzionali sono minimi. Il dolore il bruciore sono moJerati. La sensaiione provocata dagli alimen ti, spectalmente acidi è, al contrario, molto molesta. L'alito t> fetido. La sali,·azion e r iflessa è soventi abb ondante.
La durala è di q uindici giorni a tre setti mane. L e r ecidive sono frequenti ed è questo il solo punto nero della pr ognosi assolu tamente b e nigna. Si posso no osserva re 4, 5, H.r ecidive successi ve.
La natura della malattia è scono sciuta. La sua o riiofetti,·a è p ro babi le, ma non dimost ral-a. Dal punto di ,·ista deliA cause pr ed isponenti, Pssa si osserva sopralutto nella primavera e nell'autunno. Essa attacca di preferenza i giovani soggetti, detl'ew di quindici a trenta anni e s pecialmente gli artritici.
La cura il IOOltO s emplice. Alla pe lle consiste sopratuttonel proteggere l'eruzione, con polvere c:li talco, di amido, pomate boriche con l'ossido di zinco, inviluppamen Lo con l'ovatta.
Per l'idroa boccale sono indicati i gargarismi con acqua di altea, le polvc rizzazioni emoll ienti, si faranno una diecina di volte n ella g iornata pennellazioni col seguente collutorio: il punto più importante nella storia clinica dc ll'id r oa boccale è la confusio ne frequente con la sifilide e la cura mercuriale che è la conseguenza di que:;ta confus ione. L' i88 droa boccale è infatli la lesione sifiloide per eccellenza. Rammenta, con tulli i su oi caratteri, colla sua forma, col suo c olot·e rosso opalino, colla sua base cedevole, le placche mucose. La somi:rlianza è tale che h• diagnosi talvolta riesce impossibile. casi però in cui la diagnost diffe renziale è possibile, si può ten er c •>n to itc·i sl:!guPntt sintomi. L' idr oa, almeno nell' inizt<', nei primi giorni, è più r ()sso, più &culo, piu dolente deliA placca mucosa La sua colorazione è talv olta di carmini o. È anche più confluente; talvolta fa tutto il gi r i) delle labbra (i!lroa orbicolare). La SUA forma e più irregolare. Vi è un altro segno patognomonico, ma, sfortu netamente, è impossibile di con s tatarlo; la persistenza, de parte dell e lesioni erosive, di lesioni rimaste ancora nel periodo '"esc.icol nre.
:Miele r osato, g li ce rina pura ana g rammi 15, borace g r. 4.
Talvolta riescono utili le cauterizzazioni col nitrato d'a rgento, specialmente contro le e rosi oni dolorose della punta della lingua.
In realla, i cat·atteri obietliYi della lesione basteranno raramente a lla diagnosi. Praticamente, si è s oprattutto r icercando, per una parte, nei punti di predilezione sovra delti le eruzioni di idroa cutaneo che accompagrwno so venti l'idl·oa mucosa, per altra parte, gli <"Jllri segni sifìlitici , che sarà possibile pro nu11cia r si forma recidi, anle, la nozione manife,tflzioni !'UcccssiYe può anche riescire utiln.
Ma per quanto completo, per quanto accurato siA l'e s Ame, la diagnosi re!'terà talvolta dubbia. In questo caso, è regola J.H'atica Gtssoluta l'astenersi :-:empre dalla cura mercu r iale, che non !JOtrebb.; che nuocere alla lesione boccale dell' idro&. Anche quando !>i trnttnsse di si filid e, è meglio lasciare gere, sen za distur·barle, le lesioni tìno al momento in cui la diagnosi diventa certa.
Incubazione della sUllide.- - Journal d e medecine et de chiruryte, luglio 189-2).
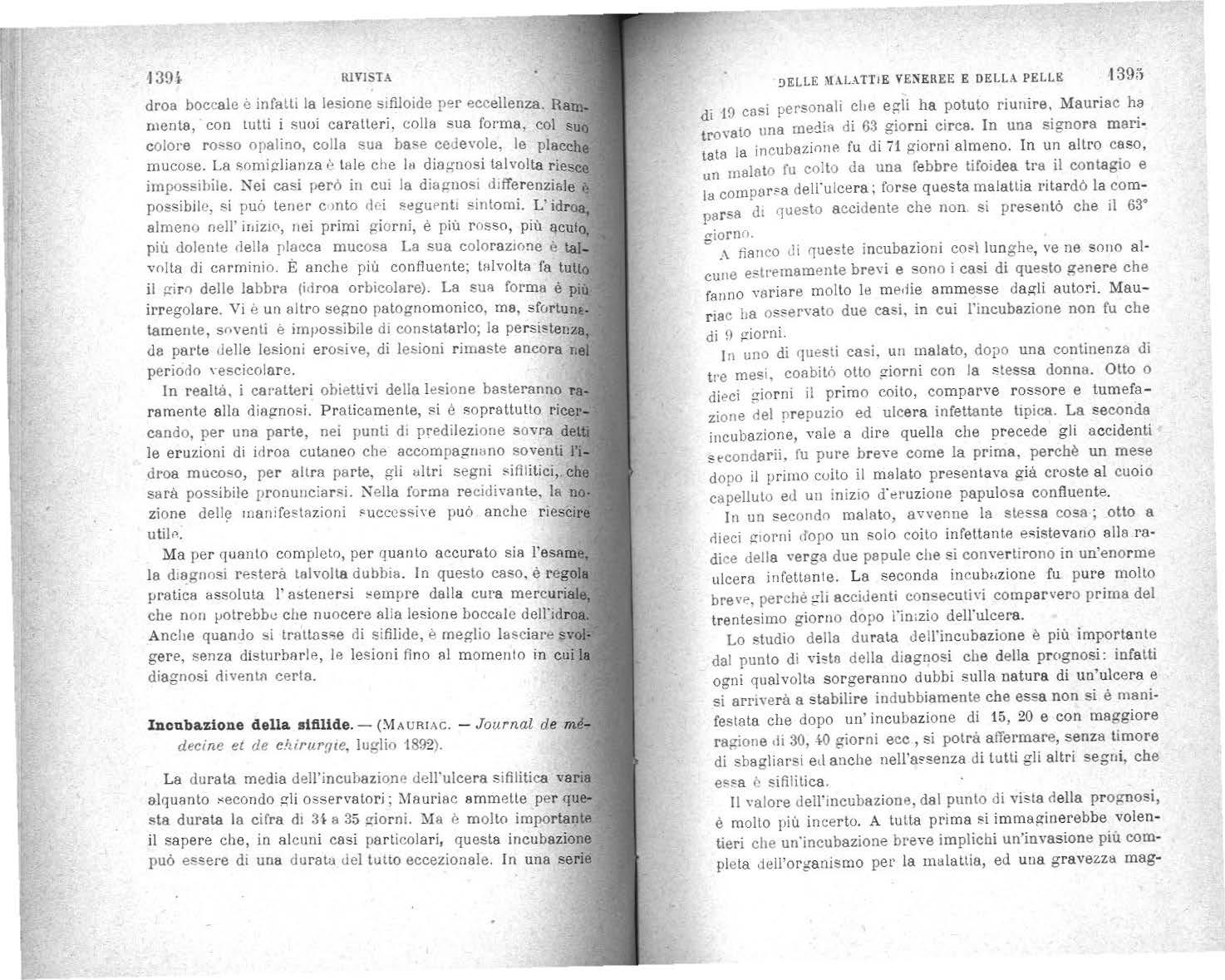
La du rata media dell'incubazionP. dell'ulcera sifilitica varia a.lquanto ><econdo gli osservatori; Mauriac ammelle per q uesta durata In cifra dr a 35 Ma è mollo importan tE! il sapere che, in alcuni casi particolari, questa incuba zione può essere di una dellulto eccezionale. In una s erie di 1o casi personali :he e?li ? .otuto riunire,_ Mauriac tro,·ato una dr 63 gtorm crrca. In una s1gnora mari· tata la incubazioni'\ fu di 71 almeno. In un altro un malato fu colto da una febbre tifoidea tra il contagiO e la dell'ulcera; forse questa malallia la _co m: parsa dt questo accidente che non. si presento che 1! 63 (Tiorno.
" A fianco d i queste incubazioni co<'ì lunghe, ve ne sono alcune e::tr·emamente brevi e sono i casi di questo gènere che fanno "ariare molto le medie ammesse dagli auto!'i. Mauriac ha osser,·ato due casi, in cui l'incubazione non fu che di !) çriorni.
I n uno di questi casi, un malato, dopo una continenza di tr·e mesi. coAbitò otlo con la stessa donna. Otto o di eci giorni il primo coito, comparve rossore e tumefazione del J1 re puzio ed ulcera infettante tipica. La seconda incubazione, vale a dirs quella che precede gli a c cidenti stcondarii, ru pure breve come la prima, perchè un mese dopo il primo coito il malato presentava già croste al cuoio capelluto eù un ini zio d'eruzione papulosa confluente.
In un seco ndo malato, aYvenoe la stessa cosa; otto a dieci dopo un solo coito infettante esistevano alla radi ce della verga due papule che si convertirono in un'enorme ulcer a infettante. L a seconda incubl,zione fu pure molto breve, perchè gli acciJenti consecuti,·i comparvero prima del trentesimo giorno dopo ì'in;zio dell'ulcera.
Lo studio della durata Jell'incubazione è più important e dal punto di vi::; la della diagnosi che della prognosi: infatti ogni qualvolta sorgeranno dubbi sulla natura di un' ulcera e si arrh·erà a stabilire indubbiamente che essa non si è manife stata che dopo un'incubaz ione di 15, 20 e con maggiore ragione tli 30, 4-0 giorni e cc , si potrà affermare, senza timore di sbagliarsi ed anche di tutti gli altri segn i, che essa è sifìlitica.
11 valore dell'incubaz ion e, dal punto di vista clella prognosi, è mollo più ince rto. A tutta prima si immaginerebb e volentieri che un'incubazione breve implichi un'invasione piu completa dell'organismo per la malattia, eù uua g ra vezza mag-
1396 RIVISTA giore di questa. Al contrario un'incubazione lunga sembre.t•ebbe indicare una attività minore dell'agente morboso. L'o sservazione parrebbe dimostrare che vi sia qualche cosa di vero in questa opinione e nella storia stessa della sifilide sj. troverebbero argomenti in favore di questo modo di vedere ,. che è abbastanza per la patologia generale delle malattie Yirulenti ed infeltive. Si dice infatti che altre volte l'incubazione della sifìliùe era m eno lungo che oggi. Ora non èda meller·si in dubbio che nei secoli 15°, t6• e 1;•, gli accidenti imme•1iati fossero mollo più gravi che presentemente .
Tuttavia, si osserva no tanti fatti clinici in opposizione con questa idea, si sono vedute cosi spesso sifilidi gravi succede r e a d ulcer e la cui mcubazione era stata mollo lunga, cheè impossibile di stabilire a questo riguardo alcuna legge a ssoluta invariabile. · l casi esaminati e rano così di visi:
L'albuminuria nelle malattie veneree . - L. B. GtRAU(). médecin-major di t a cla sse. - (rlrchioes de médecine et de pha r macie militaires).
L'albuminuria nell e malattie veneree é stata dall'autore studiata in 1M casi e le analisi sono state eseguite ogni giorno.
Blenorragia acuta
Orchite semplice.
Orchite doppi a cronica
L'albumina è stata trova ta 2 volte nella blenorragia acuta ,. t v o lta nell'orchite semplice, 9 volte nell'orchite doppia, 4 volte nell'uretrite cronica.
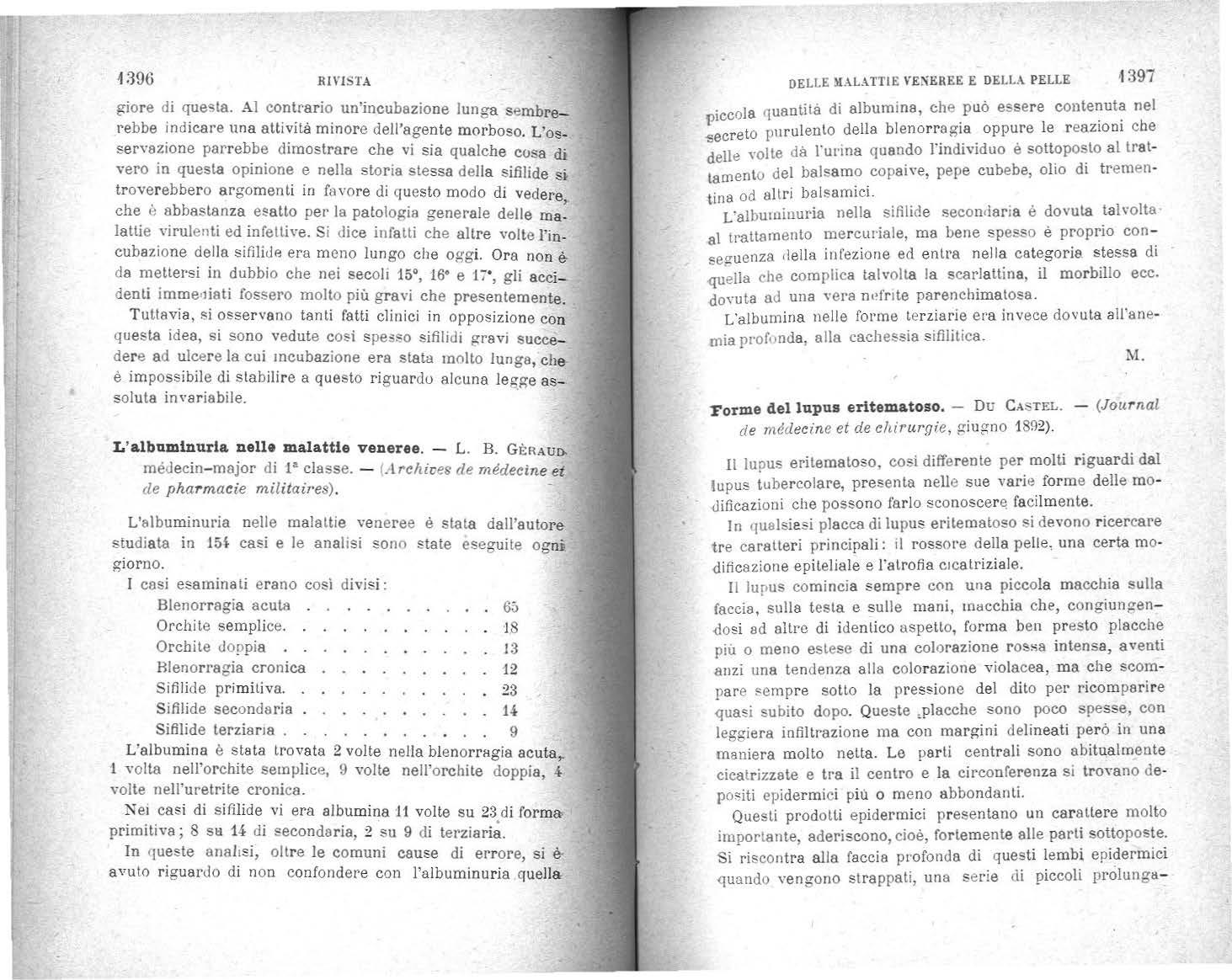
Nei casi di sifilide vi era album ina 11 volte su 23 di for ma primitiva; 8 Sii 14 di secondaria, 2 su 9 di
In queste oltre le comuni cause di errore, si èavuto riguardo di non confondere con l'albuminu r ia quella,
DELLE MALATTIE VENEREE E DELLA. PELLE 1397
. ol a nuantila di albumina, che può essere contenuta nel f)ICC , · · h ecreto pnrulento della blenorragia oppure le r eaz10m c e
Ile Yolle dà l"Ut·ina quando l'individuo è sottoposto al tratdel balsamo copaive, pepe cubebe, olio di trementina od allri balsamici .
L'albu!l1inuria nell a sifilide secondaria è dovuta talvolta · al trattamento mercuriale, ma bene spesso è proprio consecruenza della infezione ed entra nella categoria stessa di che complica tah•olta la scarlattina, il morbillo ecc. doYuta ad una ·vera nt>fr1te parenchimatosa .
L'albumina nelle forme terziarie eca invece dovuta all'an emia pl'ofu nda, alla cachessia s ifilitica .
Torme dellupus eritematoso . - Du CAS TEL. - (Journat de médecine et de chirurgie, 18!)2).
II lupus eritematoso, cosi differente per molti riguardi dal lupus tubercolare, presenta nell e sue varie fo r me delle mo·<lificazioni che possono farlo sconoscerE\ facil mente .
In qualsiesi placca di lupus eritematoso si de von o ricercare tre caratteri principali: il rossore della pelle. una cer ta m o<lificazione epiteliale e l'atrofia CICatriziale.
11 lunus cominci a sempre cCln una piccola macchia sulla faccia,· sulla testa e sulle mani, mttccbia che, <lo si ad allr·e di identico aspetto, forma ben presto placche più o meno estese di una colorazione r osHa intensa, aventi anzi una tendenza alla color a z ione violacea, ma che scompare !<emp re sotto la pressione del dito pet· ricompari r e quasi subito d opo. Queste ,placche sono poco spesse, con leggiera infiltrazione ma con margini delinea ti per ò in una maniera molto netta. Le parli centrali sono abitualmente cicatrizzate e tr·a il centro e la cit•conferenza si lro..-ano d epo,::iti epidermic i più o meno abbondanti.
Quesli prodotti epidermici p r esentano un carattere molto importante, aderiscono, cioè, fortemente alle parli sottoposte. Si riscontra alla faccia pt'ofonda di questi lembi epidermici q uando vengono strappati, una serie d i piccoli prolung!l - menti in rorma di radici approiontleotisi in direzion e verticale e la pelle cosi scoperta presenta una quanti tà di piccoli orifici beanti: questi sono gli orifici delle ghiandole nelle quali era immersa la massa epidermica. Quanto alla cicatrice centrale, essa è so·;enti molto !rtegolare nella sua forma e varia collo sviluppo ùelle lesioni.
Il lupus eritematoso presenta d'altronde forme molto di. stinte le une dalle allrP. e che dipendono sopr·atulto dall'intensità del rossore e datra:::pe tto delle concretioni che sono secrete alla sua superficie. Si descrive dapprima una forma . eritema tosa pura o vascolare, nella quale predomina il rossore eJ anche la vascolariuazione della pelle che è sempre mollo pronunciata; Yi hanno in questo caso pochi s;,ime p r oduzioni epidermiche e queste possono anche mancl\re qua s i completamente. Queste sono forme attiYe, con estensione molto rapida, con recidh·e frequenti, ma abbastanza superficiali come lesione; esse ·possono guarite senza lasciare cicatrici. A queste forme appartengono varietà che somigliano mollo all'acne r·osacea e la cui diagnosi può esser e molto difficile.
Una seconda for ma ha rice vuto il nome di lupm: acneico od anche di erpete cretaceo, a cagione delle e!'prezze biancastre che ricoprono la pelle, le quali sono prodotte dalle concrezioni provenienti ùalle ghiandole sebacee. Questa crosta finisce pef' cadere ed é sostituita allora da una
Questa forma si oss erva sopl'attutto sulla facci a e sulle orecchie. Questa può essere semplicemente grassa e la lesione rassomil!'liare molto all'eczema. Altre volte, essa é assolu tamentP. psoriasiforme. D'altra pa rte, queste dive r se varietà di aspetto possonv riscontrarsi nello stesso malato e da questo polimorfismo può anche risultare un aspetto che ramme!lta quello dell'erittlma polimorfo propriamente detto. Tuttavia, revoluzione molto lenta della malattia è un segno distintivo sufficiente per non cadere in tale errore.
Fra le form e di difficile diagnosi de vesi citare anche il lupus asfittico che sopraggiunge in soggetti giovani e predisposti ai geloni. Esso interessa soprattutto le guancia, il naso, le orecchie, le dita e presenta soventi la f0rma e rite-
Delle Malattie E Della Pelle 1399
ra
L'evoluzione sola della lesione permette in ato"a pu · · d t l' 111 i- casi di distinguerla, perché per!'Jsle e eroolt . . poca in cui i sono scomparsi. lnollre, tale ID un e . . s ' c:o contemporaneamente il lupus sopra regwm siste spese te Questo Jupus d'altronde è ancora caratter,z- on . . . . 1 0 d 11 ·ua tend enza asfittica, che puo determ1nare u cezato a a "' · · f . · n"renose. Infine· devestlenerconto m questa orma raziOni ga ,... ' · · 1 • è . " di un elemento diagnostiCO 1mportante, c 1e cto d• Jupu- · · · o pro . ttorno alla placca un'infillraz10ne piU o meoestsle a · ·· anto d d ura e che é di una prognost tanto ptu grave qu fon a e · iù è pronuuciata. . . . . _
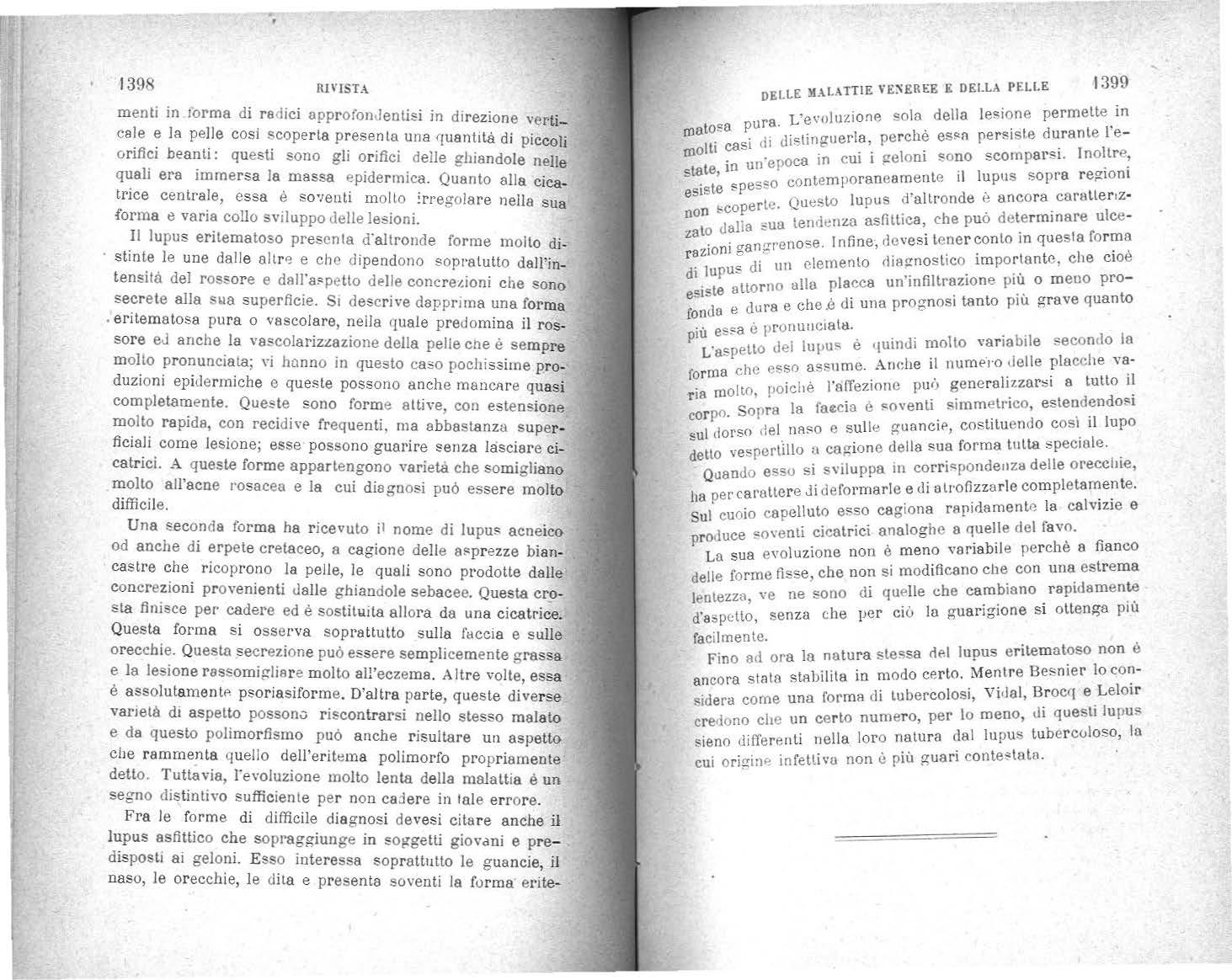
P L'aspetto del lupuo; è 4umùt varrabtle ::-econdo ,la h , e!';so assume. An<:he ti numel'o Jelle placche 'a- forma c <, · · ·1 lto JlOiché l'affezione può generahzzarl;• a tutto J r ra mo , . d d · Sopra la faecia è !':O\'enti simmetrtco, esten en O!'l corpo. . . d . 'l l po o;ul dorso del nA!'O c sulle guancre, costJtuen o cos•. t u dello vesperÙI!o u cagione della forma tutta .
Qtiando esso si sviluppa m corrto;pondenza delle 01 ecclne, l . car·attere ji defor marl e e di alt·ofizzarle completamente. la per l l . . e sul cuoio capelluto esso cagiona rapidamente a ca vtzJe produce !'oventi cicatrici analoghe a q.uel.le del favo. , La sua evoluzione non è meno vanabtle perchè a fianco delle forme fisse, che non si modificano con estrema lentezza ve ne sono di quelle che cambtano senza che per cio la guarigione si ottenga pru facilmente.
Fino ad ora la natura stessa òP.l lupus eritematoso non è ancora stata stabilita in modo certo. Mentre Besnier lo sidera come una forma di tubercolosi, Vida l, Brocf{ e .Lelotr credo no che un certo numero, per lo meno, di queslt lupus !:'ieno differe nti nella loro natura dal Jupus tubercoloso, la cui infettiva non è più guarì ·










