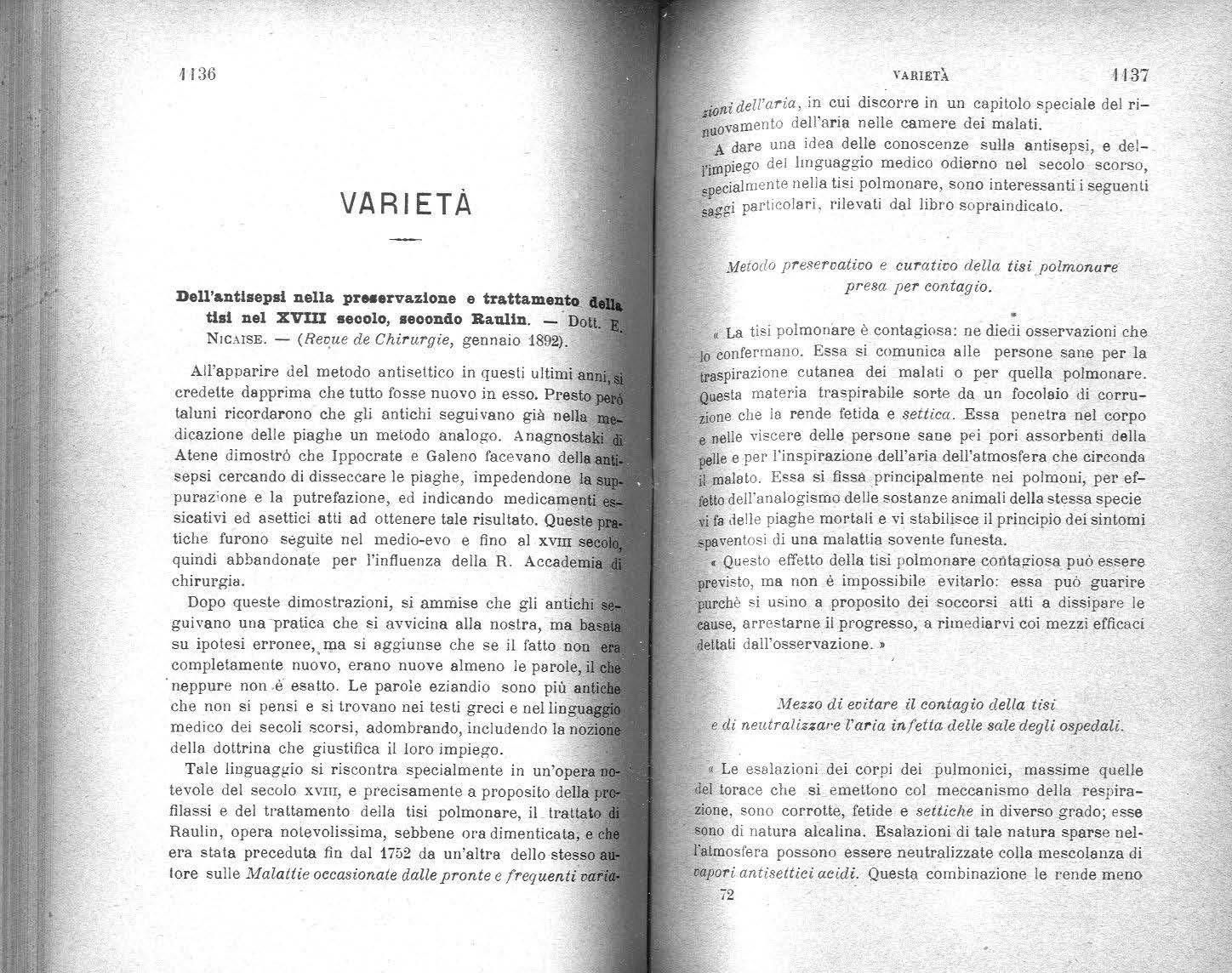
61 minute read
VARIETÀ
Dell'anttsepsl n e ll a pre.ervazlone e trat t ament4t tlsl nel XVIII secolo, secondo Raulln.· Dott. NJCAISE. - (Re-o_ue de Chirurgie, gennaio 1892).
All'apparire del metodo antisettico in questi ultimi credette dapprima che tutto fosse nuovo in esso. Presto taluni ricordar ono che gJj antichi seguivano già nella dicazione delle piaghe un metodo analogo. A Atene dimostrò che Ippocrate e Galeno facevano della sepsi cercando di disseccare le piaghe, impedendone la purazione e la putrefazione, ed indicando medicamenti sicativi ed asettici atti ad ottenere tale risulta to. Queste tiche furono nel medio- evo e fino al quindi abbandonate per l'influenza della R. chirurgia.
Advertisement
Dopo queste dimostrazioni, si ammise che gli antichi guivano una -pratica che si avvicina alla nostra, m a su ipotesi erronee, , ma si aggiunse che se il fatto non completamente nuovo, erano nuove almeno le parole, il ·neppure non è· esatto . Le paroìe eziandio sono più che non si pensi e si trovano nei testi greci e nel li medico dei secoli scorsi, adombra ndo, includendo la n della dottrina che giustifica il loro impiego.
""
Meio do p rese-roatioo e curatioo della tisi polmonare presa per contagio.
« La tisi polmonare è contagiosa: ne dieài osservazioni che 10 confermano. Essa si comunica alle persone san.e per la traspirazione cutanea dei malati o per quella polmonare. Questa materia traspirabile sorte da un focola io di corru-zione che la rende fetida e settica. Essa penetra nel corpo e nelle viscere delle persone sane pei pori assorbenti de lla pelle e per l'inspi razione dell'aria dell'atmosfera che circonda il malato. Essa si fissà _principalmente nei polmoni, per effetto delranalogismo deUe sostanze animali della stessa specie vi fa .ielle piaghe mortali e vi stabilisce il principio dei sintomi spaven tosi di una malattia sovente funesta.
• Questo effetto della tisi polmonare può essere previsto, ma non è impossibile evitarlo: essa può guarire purchè si usino a proposito dei soccorsi atti a dissipare le cause, arrestarne il pi'ogresso, a rim ediarvi coi mezzi efficaci dettali dall'osservazione »
Mezzo di eoitare il contagio della tisi e di neutraliz.;at·e l'aria infetta delle sale degli ospedali.
72
.
Var1e
capaci di fare nei polmoni delle impress1oni settiche. ali a cidi si , ·errelali che sono atti a produrre '"' , C' dfelto, ma i vegetali sono da preferirsi, come quello l'aceto i cui vapori si elevano nell'aria. •
E spiega il modo di impiegarlo facendolo evapora re su laminu ar r oventata , non in quantità ecces:::iva, per non vocare tosse, irr itazione, emot·ra7ie, e continua:
• Si spand e ancora più utilmente nPll'atmosfera della mera dei dell'acqua comune acidulata co n vitriolo. Si può anche con questo mezzo e con lavblure neutralf::zare l'aria infetta delle sale d egli delle cucine, e dei luoghi che da nno esalazioni """"'·""''" ri pete l'operazione in proporzione della ab bondanza delle terie che si devono neutralizzare. »
A proposito del tr·attamento Jelle ulceri del polmone discute il valot•e dei vapori medicamentosi.
« Si ebbe e si ha ancora qualche fiducia pe1' la gua della tisi nei vapori di medicamenti pro pri a dete rgere ceri dei polmoni ed a cicatri::zarle. Si inspirano questi pori a misura che esalano dai vasi in cui !'\i prepa rano; penetrano così nella trachea - arteria confusi coll'aria. si dono nei b r onchi, nelle loro vcscicole e si insinuano sostam:a di questo visce r e attraverso i pori assorben a tale effetto il latte caldo, la decozione di piante rili ve, detersi ve e vulnerarie , la te r ebentina, i ed antisettici. Siccome questi "apori penetrano d nello sostanza polmonare, essi l'imbevono, la disseccano, o fanno in questo viscere degli effetli vari condo le loro proprietà. Questo mezzo di guarire la lisi monar e é quasi sempN infedele, e vi sono poc:1i per questa via. »
Riconosce la necessit.ù degli antisettici interni durante dei precedE> n ti, c seri ve:
• Sh.:come arl l'ec::pirazione dei pulmonici si dal loro pello delle csRiazioni putride e settiche, ficil e neutralizzarle totalmente ed all'istante colla zione dell'aceto, o coll'aspersione dell'acqua acidulata di vitriolo. Hgli è essenziale allora di ricorrere a degli tisetlici prt:si inte rnam ente, per secondare l'effetto dei oapori e dellE> esal azioni_ onde g arantire la massa del sanfiu .; dalle esalazJO:li putride che si inspirano allorchè si entra nella atmosfera dei maiali .• c Dacché un pulmonico è riconosciuto tale, gli si mar ca il letto, le lenzuola, la linge ria da tavola, la posata e lutto ciò che è di ser,·izio abituale òi lui, e, fuori di lui, nessun altro se ne sen·e. Dacché egli è morto si smobilia la sua camera, si raschiano le mura ed i tramezzi e si imbiancano a nuo,·o. si lavano i soffitti ed i pavimenti, e non si adoperano più il suo letto ed i suoi pannilini; spesso si abbruciano o si ven i ono dopo aver li ripetutamente Se la camera aveva tappezzet·ie si espongono all'aria libera per nn anno ìntiero. l n genere non si usa ciò che ha servito ad un pulmonico , qualunque precauzione siasi impiegata, che colla più grand e ripugnanza. •
E qui fa l'enumerazione dei rimedi consigliati. Come s i vede i proces"i usati da Raulin sono quelli impiegati ai giorni nostri: egii vuoi far respirare un'aria impregnata di agenti antisettici, ::-ia m•'diante l'evaporazione, come da noi lo si fa col sia mediante la poloeriuazione, come si consigliò soluzioni di bijoduro di mercurio. Essi differiscono dà quelli cl1e usiamo noi, ma l'intenzione è la stessa.
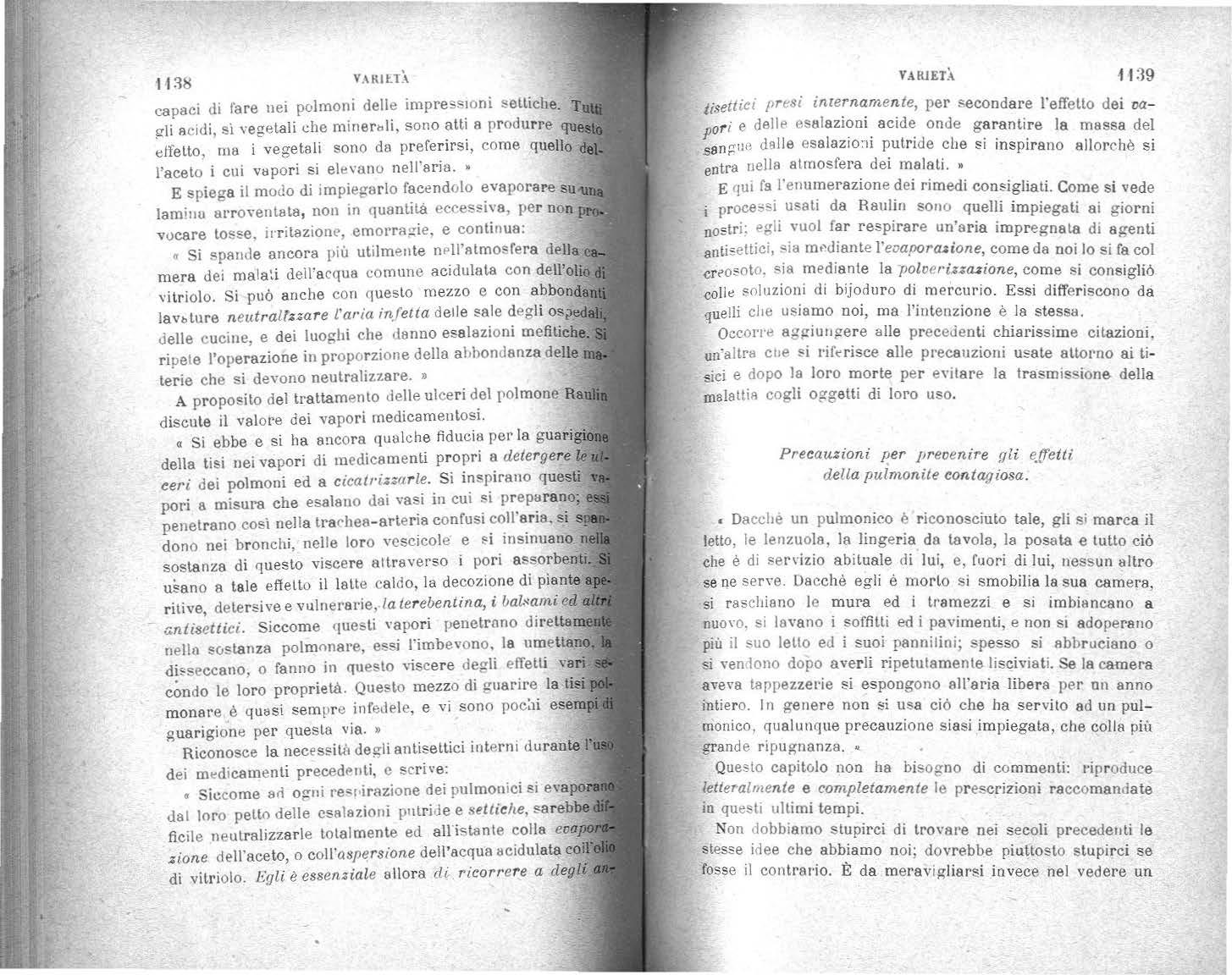
Occor1·t> alle precedenti chiadssime citazioni, un'a ltra cue si t·ifaisce alle p1·ecauzioni usate allot•no ai Lisici e dopo la loro morte per e"itare la trasmis ione. della malattia cogli oggetti di lol'o uso.
Precauzioni per prevenire gli e.ffetti della pulmonite contagiosa.
Questo capitolo non ha bisogno di commenti: rip r oduce letteralmente e completamente le pr escrizioni raccomandate io questi ultimi tempi.
Non dobbiamo stupirei di trovare nei secoli precedeuti le stesse iòee che abbiamo noi; dovrebbe stupirei se foss e il contrar·io. È da meravigliarsi invece nel vedere un
YARfETÀ 1141 simile libro e tali dati caduti nel più assoluto oblio. storia delle scienze spesso verità e scoperte importanti paiouo affatto. sostituite da errori; pùi la è di 1 scoperta e sostituisce l'errore.
Pare che gli uomini lavorino ciascuno in un aùgolo conto proprio, ricomincian io lavori già fatti, o che il sta pure compiendo, per modo che una gran parte del vor·o intellettuale nuovo va perso in ripetizioni.
Non si potrebbe far in modo che una scoperta imuu1rr,. un'opera considerevole non andasse perduta pei Non bavvi mezzo di rilevare e centralizzare .tutti i lavori dotti in guisa che ciascuno possa conoscerli?
Furonv fatti, in medicina, lodevoli tentativi in medieus; in Germania i Cannstatt's be r iehte, ed i vari Centralblatter; in Francia la Reou e sciences méclicales, ecc.
L'organizzazione d'un·opera così vasta è difficile: non corre ril evare tutti i lavori, di cui. moltissimi sono senza !ore o copie o ripetizioni: occo rre fare una scella.
Ogni paese liovrebbe rare un indice dei propri lavori vi !':ì meglio gli uomini e !·ambiente, il che é una f!'UiJa: in seguito tutti questi indici nazionali venit· centralizzali, ed allora ne risulterebbe una 'JU&si che renderebbe servizi inapprezzabili studiosi del mondo intier·o.
Sper·iamo che presto si· realizzi qualche cosa analo:za questa proposta.
Denti uti1lotali. - I l dott. Zuamenski professore li di odonloiatria all' Universita imperiale di Russia nel IV gresso P u•ogoff comunicò un suo metodo felicemente di fissazione mecc11nica di denti di porcellana, gomma stira e di metallo negli alveoli.
L'A. dice che egli pratica delle aper·ture che attra da parte a parte o anche delle incisioni alla radice dei artifìciali, ed che un tessuto granu!Pso che dal midollo dell'osso viene a svilup.pMsi e a penetrare dette aperture, che poscìa ossificandosi ferma dente nell'alveolo con una solidità sorprendente:
Aug uriamo per i progressi della protesi dentari&. che il felice successo da buona esperienza confermato dia al metodo di Zuamenski tanta presa, quanta egli ne ha data nelle sue affermazioni ai denti impiantati col suo nuovo sistema.
Congressi
qatn to Congresso di interna de! 1892 In B oma.
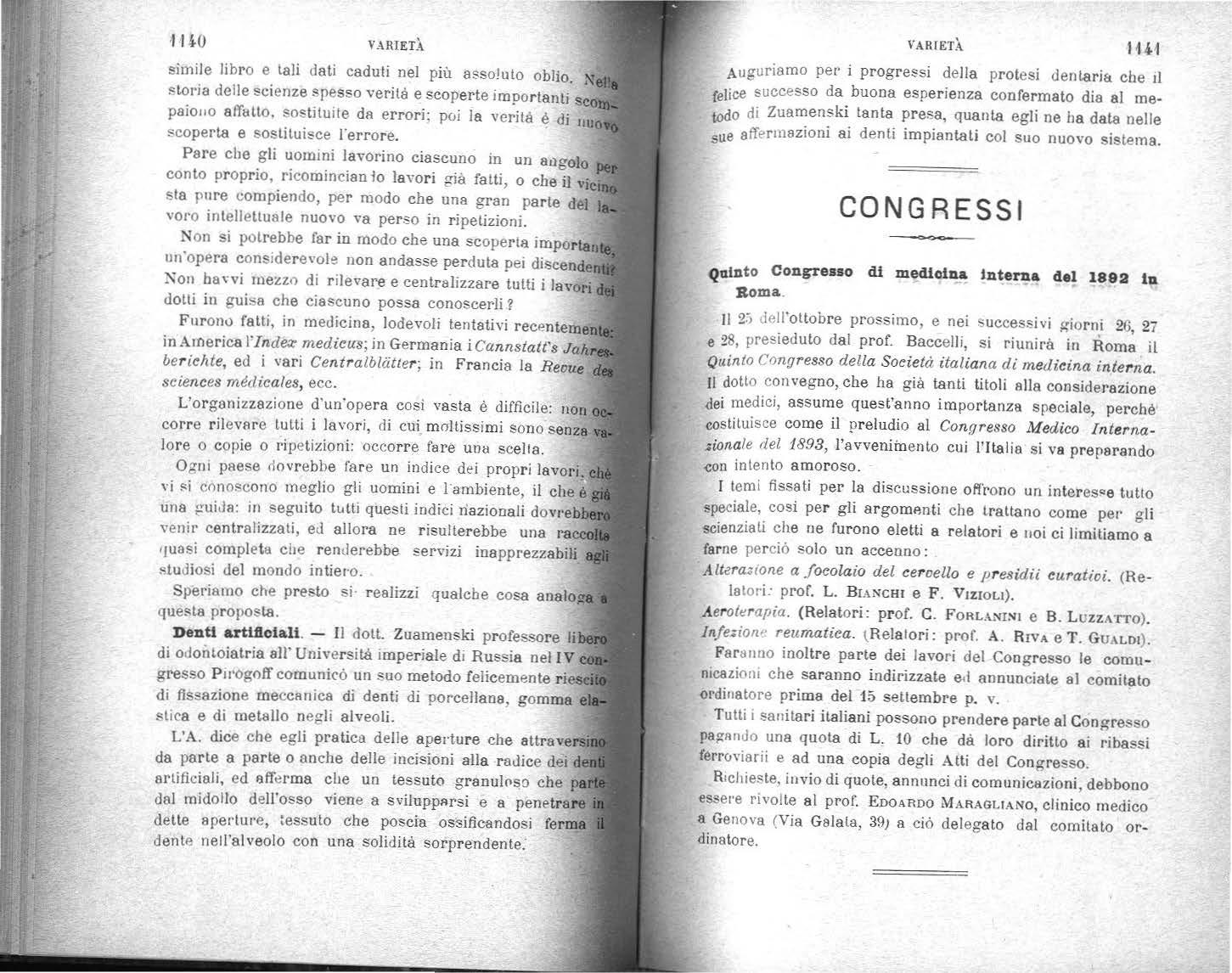
Il 2-i dell'ottobre prossimo, e nei successivi giorni 26, 27 e 28, presieduto dal prof. Baccelli, si riunirà in Roma il Quinto Congresso della Società italiana di medicina inte r ri,a. Il dotto convegno, che ha già tanti titoli alla considerazione <lei medici, assume quest'anno importanza speciale, perché costituisce come il pr eludio al Congresso ìtledico Interna;ionale del 1893, l'avvenimento cui l' Ita lia si va preparando intento amoroso.
I temi fissati per la discussione offrono un interesc:e tutto speciale, così per gli argomMti che trattano come per• ,.l i scienziati che ne furono eletti a relatori e uoi ci limiliamo 0 a farne per ciò solo un accenno:
Alterazione a focolaio del ceroello e p r esidii euratioi. (Rela tori: prof. L. BI.-1.!\CHI e F . VJzroLr).
A eroterapia. ( Relatori: p r of. C. FoRLANI!'ll e B. LuzzATTO). Jnfe.;iorw reumatica. t Relatori: prof. A. RIVA e T. GUALOI) .
Faranno inoltre parte dei lavori del Congresso le comun•cazioni che saranno indirizzate eli annunciate al comitato Ol'dinatore prima del 15 seUembre p. v.
Tutti i sanitari italiani possono prendere parte al Congresso una quota di L, 10 che dà loro diritto ai ribassi férroviarii e ad una copia degli Atti del Congresso.
R1chieste, invio di quote, annunci di debbono esser·e rivolte al prof. EDOARDO MARAGLtANO, clinico medico a Genova (Via Galata, 39) a ciò delegato dal comitato ordinatore.
Concorsi

V oonferenza internazi onale della Croce
- Concorso reale a premi.
Nella s ed uta inaugurale della V conferenza della Croce Rossa, che fu tenuta in Roma il 21 scorso a pervenne alla pr eside nza un Reale dispaccio datato dal 15 pl'ile, così redatto :
« Le LL. MM. il Re e la Regina d' Halia, volendo a
• la loro alta considerazione e simpatia per la V
« ferenza delle Società della Croce Ro
« che si riunirà in Roma, hanno stabilito un concorso
• premio su d' un soggetto che possa essere utile ull'
« generosa che costituisce lo scopo di questa
« istituzione.
• mi Augusti Sovrani , convinti che per rendel'e
• cul'e apprestate ai feriti, bisogna siano sovralutto più
« possibile pronte, hanno determinato che il soggetto
• concor so sia esclusivamente il perrezionamento dèi c nec essa ri per isgo mbrare immèdiatamente il ter re no c battaglia togliendone i fe r iti, trasportaadoli ai posti di
• socco r>so, indi alle sezion i a vanzate di med irazione e
• na lmente a gli ospedali e luoghi di provvisorio ricovero.
« In tale intento i Sovràni mettono a disposi zione
• presidenza della con fe r enza la somma di dieci mila
« italiane pe r stabilirne due premi, e delle menzioni
« voli costituite di medaglie di argento alla augusta
• delle LL. MM ., provvedute dal Ministero della Casa reale.
• Il concorso dovrl') essere internazionale, si terrà in resterà. aperto fino alla fin e di giugno 1893; le LL. MM.
: alla conferenza la cura di determinare le condi -
' zioni tiel programma e di slabilirne i dettagli. c Gli Augusti S ovrani sperano che il buono risultato di c concorso varr à ad aumentare il mer·ito òegll studi
• dei -1uali la confer enzA si occuperà, ai quali essi te rranno
• dietro col più vivo interesse, come a conquista gloriosa di c umana civiltà e fra ternità.
• Colla ecc.
« delle LL. MM
« Pe l Ministro: U. RATTA7.Zr »
• Al CONTE DELLA
• Senator·e del Regno » .
Alla comunicazione immediata, falla dal presiden t e, di tale Reale messaggio l'assemblea con ripetuti unonimi applaus i manifestava la sua viva e pr ofonda riconoscenza per l'atto grazioso e gen eroso delle LL. MM., e, portalone l'ogge tto in discussione nella seduta rlel successivo giorno 22, l' assemblea accetta va la proposta di deferire ad una special e commissione, della quale lasciava la nomina 11llo ste sso presidente, lo stuòio della imrortantissima ed opportunissimo questione dalla Regale letter a sollevata; da ndo incarico ad commissione di r ifer irgliene e di presental'le un progetto di programma.
In una suc.cessiva seduta (24 apri le), la cnnferenza appro· va,·a la t'dazioM dell a commissione e lo di pr ogramma che fissava le essenziali massime del concorso, defet•endo a l Consiglio direttivo del comitato cendella Cr oce Rossa italiana la nom ina del gi ur i inleruazionale per el5aminare, giudicare e classificare gli oggetti inviati ed a ccettali per il concorso, e per la definitiva asse:;tnazione dei premi. Il comitato cent•·ale della Croce Rossa italiana fu inoltre incaricaLo di prendere e pubblicare in te mpo tutte le disposizioni relative al concorso e d alla esposizione degli oggetti presentati.
In adempimento dell'onorifico delicato mandato, il presidente della Associazione italiana della Croce Ro ssa, ottem-
CONCORSI perendo al disposto dell'ultimo comma deliA r elazione accennata sul concorso, convocò il direttivo e propose la formazione d'una apposita com missione di 7 bri, la quale, approvata dal Consiglio ne-lla seduta del t) gio 1 9:?, assunse !"incarico di redigere lo schema del gramma : questo fu poi nella seduta del Consiglio delli 20 luglio 1892 definitivament.e concretat() stabilito come in appresso.
CROCE ROSSA ITALIANA..
Programma pel ooncono a premi atabWto dalle LL. il Be e la Regina d 'Italia .
A - Oggetto del concorso.
1) Il concorso deve esclusivamente avere per oggetto mezzi tutti che possono essere adatti ad ottenere, •a<"m"''" affrettare il sollevamento dei feriti ed il loro rapido, e comodo sgombero dal terreno della pugna, comin dalla linea del fuoco fino al primo ospedale da ('ampo ai luoghi dai quali l'ulteriore trasporto dei feriti coi mezzi di trasporto ordinari, · già noti e adottati .
2) Il concorso é esteso a tutti i mezzi materiali, di r e tti indiretti che possono contribuire a1 1o scopo, e quindi ai per togliere i feriti dal campo, avuto anche riguardo difficili condizioni dei terreni nelle guerre di montagna, portare i feriti là o ve possono impiegarsi le ordinar·ie o ciali barelle d ai porta-feriti; ai mezzi di trasporto dal ai luoghi di primo soccorso e quindi alle barelle da feriti, ridotte s icure, leggierè e rispondenti ai più lunghi sporti oggidì ri chiesti dall'aumentata distanza di essi stante la sommamente accresciuta effica0ia delle armi, nendo un risparmio di tempo e più delle forze dei sicché possano così attendere a lungo al loro ufficio piendo più numerosi viaggi;
Corsi
Ile vetture pel trasporto dei feriti agli ospedali da campo, 8 nderle Jecrcriere capaci di maggior numero di infermi er re "'o • p · acri alte a passare per terrent e strade d1ffiC1It; e v18,.,::- • . i mezzi d'illu minazione del terreno della battaglia, atti Ji faro direttivo e come mezzo illuminante, per a se . . . l . h l oare la \·ia 81 porta - ferttJ, ad agevo are le r1cerc e su seg ffi h . . . l" . campo, e per e_ an c e 1 pm ICI . . ed efficaci mezzt d• nsch1aramento, portatili ed mdJvtbCI d · r •t· duali per gli inca ricati dèlla rtcerca et .erJ 1 .
B - Premi.
3) 11 peemio complessivo è di 10 mila lire italiane, divisibil e in due premi, ai migliori e più utili oggetti proposti, oltre ad un certo numero di medaglie d'argento colla effigie degli augusti donatori. . _
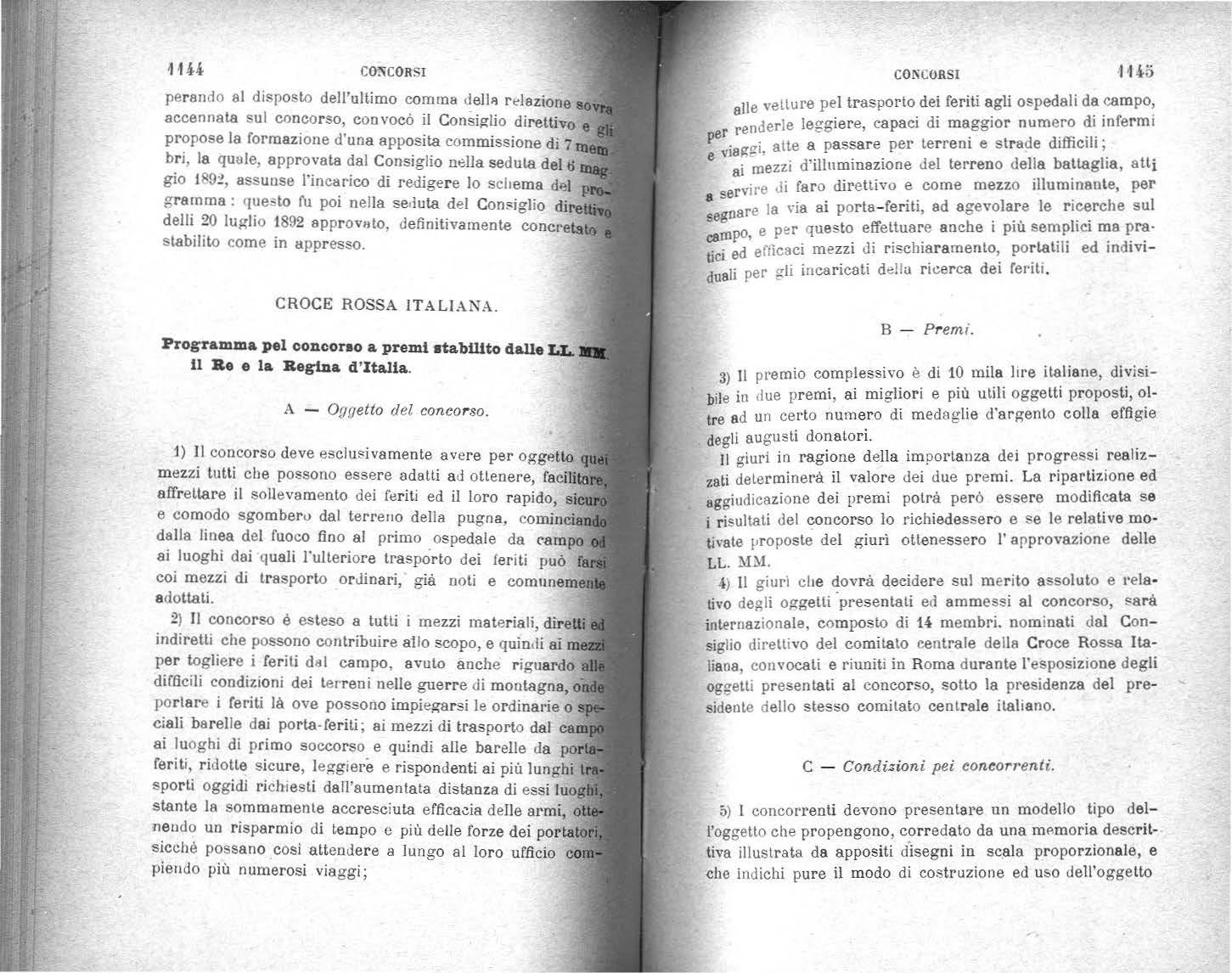
11 giuri in ragione della importanza dei progress1 realizzati determinerà il valore dei due premi. La ripartizione ed aggiudicazione dei premi potrà però essere modificata s e i risultati del concorso lo richiedessero e se le relative motivate proposte del giurì ottenessero l' a pprovazione delle LL. M.M.
4) II o-iuri che dovrà decidere sul m erito assoluto e t•ela · o . livo degli oggetti presentati ed ammessi al concorso, !>ara internazionale, composto di 14 membri. nominati dal Consiglio direllivo del comitato centrale della Croce Ross a Italiana, convocati e riuniti in Roma durante l'esposizione degli oggetti presentati al concorso, sotto la presidenza del presidente dello stesso comitato cen trale italiano.
C - Condizioni pei concorrenti.
5) I concorrenti devono presentare un modello tipo dell'oggetto che propengono, c9 rredato da una rnP.moria descrittiva illustrata da appositi disegni in scala proporzionale, e che indichi pu re il modo di costruzione ed uso dell'oggetto
Concorsi 1147
il suo co s to, ec c., onde il giuri possa meglio apprezz mtrm s ec e e pratiche qualita ed i pregi tutti. Le uH
1nno.ù do vranno essere redatte in italiano o in francese accompaguate d'una traduzione nell'una o nell'altra' d. due lingue.
6 ) I m od e!li saranno di grandezza naturale; potranno c he essere m proporzioni ridotte ma semprechè la scal sia infe riore del q ua1·to. a i ) I d isegui non a ccompagnati da modelli sono escl 11 s i con cor.so: po tranno essere dal giuri esaminati eù a zati, però co nsiderandoli ad ogni modo assolutamente co ncorso.
8) I n omaggio fld LW generoso pensiero che trovò . . ) s1mpat1ca eco e che fu applaudito dalla conferenza, ch e " nulla di ci ò che può valere in soccorso dei feriti e ad « leviarne le sofferenze deve tenersi segreto ,, si sta che tutti i Gover ni e le Societa stesse di soccor so Croce Rossa où altre , potranno, e ne è a nzi loro fa [t0 moroso invito, inviat·e alla esposizione di R oma modelli oggetti del genere od affini a quelli ammessi pel come di qualsia"Si altro oggetto il quale segni un n"""""'··nei mezzi di soccorso, ecc. Saranno con pr emurosa citudine accolti, e con ogni cura messi in opportuna ma essi pure saranno, lutti e sempre, senza eccezione sibile, considerati però come oggetti fuori concorso.
O - Norme amministratioe.
9) l modelli degli oggetti presentati pel concorso e le morie descrittive e i disegni illustrativi saranno indi al comitato centrale della Croce Rossa ital•ana gliene consegna in tempo perché tutti gli ogge[ti gli possano essere pervenuti e si procedere al loro col mento pella mostra prima del 30 giugno 1893, termine di as.soluto rigore.
10) Ogni con corr ente dov r à a ncora con lette r a data, diretta al pr·esidente di esso comita to centrale, l n mese prima dell'invio, ed indica rgli così :carlo a meno u ' 1 atura de ll 'oggetto ed approssimativamente il p es o e le la n . diutansion l. . . .
) sarà lecito all'espositorè m essa lettera d1 preve nt1vo Jl . R io dell'in vio desi crnare un rappresentante 10 orna, anounz ' o rso na pr i\·ata, agenzia, uftìc1o d1 sped1z1one, ecc. d1. sua pe · per la co n-=ea-na dell'oggetto nel locale clal comtla to fìdUCI8 - 0 l 1.. -=!a bilito per assrstere alla scassatura , ecc ., e se d el cen ra "' . . . dirigerne la montatura. Dopo c1o deve cessa r e tuttavra, caso, , . . . . . . r essi dele g ati, come per gh ogn1 mge · pe el col locamento decrli 0"'"'ettr e nell ordmarnento della renza n . o oo t ch e resta interamente !lftìdatù alle pe1·sone mcarl- mos ra. cale da l comitato centrale. . . . . t21 Per c iò megl;o ottenPre e salvaguardare n.et. hmrt1 del ibile i diritti di tutti i concorrenti esposrzrooe, esso poss · · la t•e ' t to c:arà anzi nel locale della esposlZlone e per • COlUI a · . lati va corrispondenza, rapprese ntato da. una appos rta . ·one or··dinatrice della mostra nom10ata dal ·consrgho wm ' . . di rdtivo del romitato centrale italiano, tre dell'apertura dell'esposizione ed alla quale commrss10ne gh esponenti potl'auno dirige r si personalmente o pee lettera, per tutti gli ;. chiarimenti, reclami, ecc. che credessero dover chiedet·e o p1·e;;enlare. . .
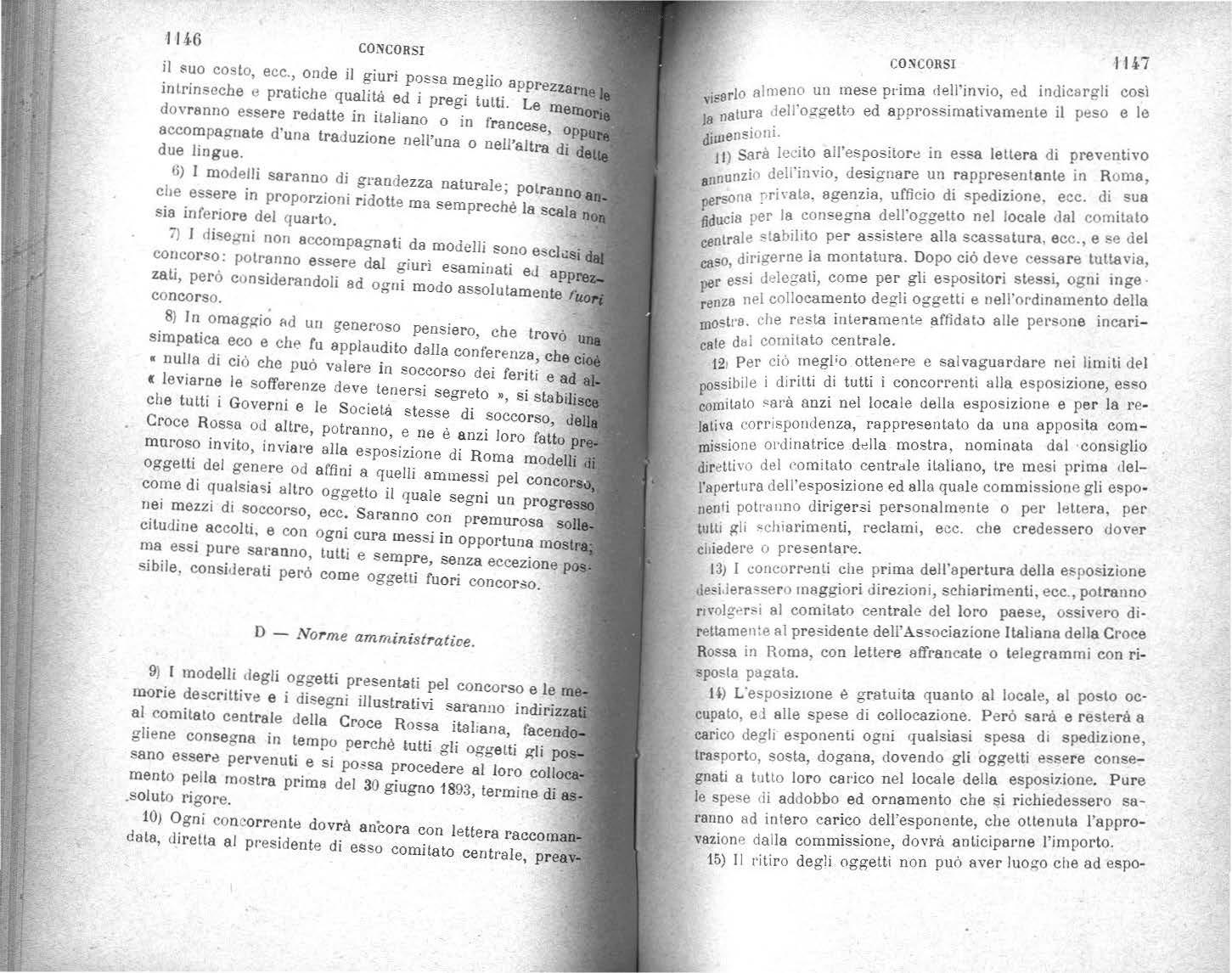
13) I concorrènli che prima dell'apertura della es pos1zrone desi .l era'5se ro mtJggiori direzioni, schiarimenti, ecc , potranno r1volgt> rs i al comitato centrale del loro paese, ossivero di· rettame nte a l presidente dell'Associazione Italiana della Croce Rossa in Ro ma, con lettere affrancate o telegrammi con risposta pagata.
Ji) L'esposizione e gratuita quanto al locale, al posto oc· cupato, e J alle spese di collocazione. Però sa1·à e a carico degli esponenti ogni qualsiasi spesa d1 sped1zrone, trasporto, sosta, dogana, dovendo gli oggetti esser e consegnati a tutto loro carico nel locale della esposi1.ione. Pure le spese d i addobbo e d orna mento che si richiedessero saranno ad intero carico dell'esponente, che ottenuta l'approvazione dalla com missione, dovrà anticipa1·ne l'importo.
15) Il eitiro degli oggetti non può aver luogo che ad espo-
CO:'ìCORSI
sizione ultima ta e chiusa. Deve essere fatto e com te rmine di gio rn i 30 dalla chi usura Dopo tale epoca oggetto non esportato diventerà di diritto e re •A .. d l s..,rtt e comitato centrale italiano che potr à d•spo r ne.
16) Le spese di ri mballaggio, esportazione e sono . tutte ed interamente a carico degli espositori. Il dovra fallo dall'espositore o da pe rsona .indi l UI come dt su a tld ucia. cata
1i) Non saranno ammes si reclami pel' depe r imenr deg li_ oggetti e:>posti, non Imputabili a colpa della commissio nalr1ce. ne E - A.pertura e chiusura della esposizione.
181 L'.esposizione sarà compiutamente or di nata , causa di forza m aggior e. ed inauo-urAta il 1- t ed . . · o o agos o aperta qwndt al pubblico dal 16 a gosto a tutto il 15 tembre.
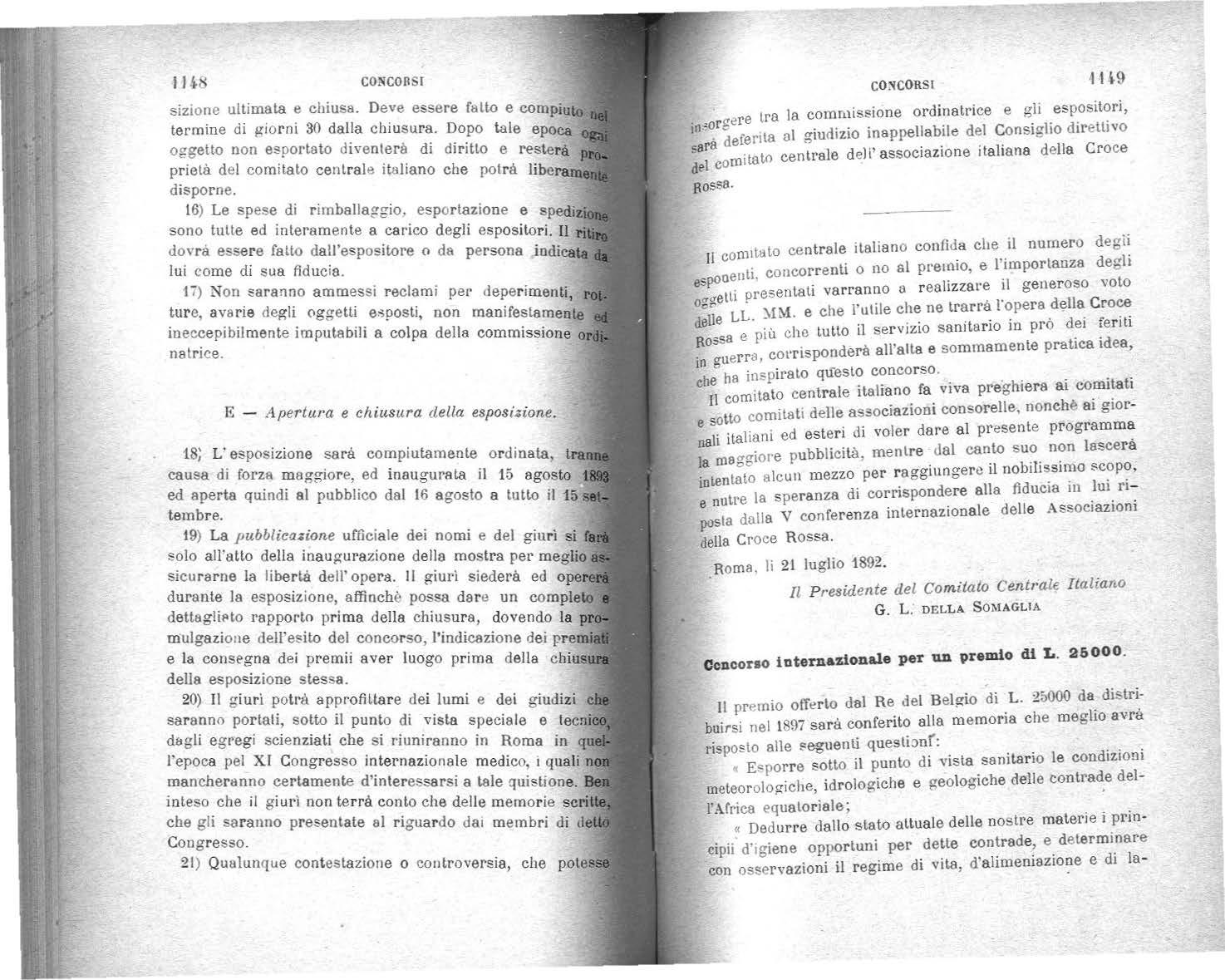
19) La pubblica.:ione ufficiale dei nomi e del .,.· . . c: l [}' 0 1Url S I o a atto della Inaugurazione della mos tra per mealio s1curarne la li bertà dell'opera. 11 giurì siederà ed 0 la esposizione, affinché possa dare un com pleto dettagh.t>to rapporto pri ma della chiusur a dovendo la m ulgaziOue dell'esito del concorso, dei e la cons(>gna dei premii aver luogo prima della della esposizione stessa.
20) Il giurì potl'à ap profittare dei lumi e dei ,.,.iudizi solto il punto di vista speciale"' e d&gh e greg' scienziati che si riuniranno in Rom . l'e l XI a m poca pe Congresso inte rnazionale medico, i quali certamente d'interessarsi a tale quistion e mteso. che il g iurl non te r rà conto che delle m e mo r ie . che gh sa r a nno pr esentate al riguardo dal memb ri di Co ng re sso.
2 1) Qu alunque con t estazione o controversia, che tra la commission e ordinatrice e gli espositori, defertla al giurlizio inappellabile del Consiglio direttivo del comitato centrale dell'associazione italia na della Croce (lQSSa. -- - - -
11 comttato centrale itali an o confida che il numero degli espOnenti, concorrenti o no al p1·emio, e l'importanza degli O""'etti presentati varranno a. realizza1·e il generoso voto ;ue LL. e che l'utile che ne trarrà l'opera della Croce Rossa e più che tutto il serv izio sanita rio in prò dei feriti in guerN , cot·risponder à a ll'atta e sommamente pratica idea, che ha inspirato qùeslo concorso .
Il comitato ce ntrale italiano fa viva preghiera ai comitati e sotto comita ti delle associazioni consorelle, nonchè ai giornali italiani ed esteri di voler dare al presente programma la ma ggior·e pubblicità, mentre · dal canto s uo non lascerà inleotato alc un mezzo per raggiungerò il nobilissimo scopo, e nutre la speranza di corrisponde re alla fiducia in lui riposta dalla V conferenza in te rnazionale delle Associazioni della Croce Rossa.
Roma, li 21 luglio 1892.
Il Presidente del Co m itato Cent,·ale Italiano G. L .' DELLA SOMAGLIA
Ccncorso in t ernazionale per un premio eU L . 26000 .
Il premio offerto dal R e del di L . 25000 da distribui rsi nel 1897 sarà conferito alla m e moria che megl io avrà 1•isposto alle 11=eguenti questi:>nr:
« Ec:porr e sotto il punto di vista sanitario le condizioni meteorologiche, idrologiche e geologiche delle contrade delrArrica equatoriale; .
'' Dedur re dallo stato attuale delle nostre materie i principii d' igien e opportuni per dette contrade, e determ inare con osservazioni il r egime di vita, d'alimeniazione e di la-
1'150 CONCOHS!
,-oro, come il miglior ;:istema di vestimenta e per meglio la salute e la forLa;
(C Desct•ivet•e la .sinlomatologia, retiologia e la y v •Vl'VIC.II delle malattie che si osservano nell'Africa equatoriale, dicando la cura sotto il rapporto protìlaltico e Le memorie saranno inviate a Bruxelles, al ministro l'Interno e della pubblica istr·uzione avanti il 1• gennaio 1
Notizie
L 'associazione del oa.va llnl it a.lfani tare Ordine dl Malta. p er il ser vizio sa.nltarl o gue rra. . - rlllustrazione militare italiana).
L'Ordine Sovr<'!no Militare di Malt<'l, comprende nei Stati d'Europa vari gran priorati ed associazioni che f<'l centro nel gran magistero residente a. Roma, alla cui sta S. A. il principe gran maestro Ceschi a Santa C -eletto a questa suprema dignita il 14 febbraio oltre la creazione di Ùn trenÒ ferroviario, esso tiene pronto l'arredamento per sei treni capaci di trasportare 600 feriti ed ospedali da campo agli stabilimenti sanitari di rise r va l'interno della monarchia Come in Italia anche nell'
· Fedele alle secolari sue tradizioni l'Ordine di Malta, di possedere parecchi ospedali, dove l'umanita teova aiuti ' e conforti, rivolse le maggiori sue cure al tuzione di mezzi di soccorso ai feriti ed ammalati in raccogliendo per primo i voti che nell'aQno 1863 si rono a Ginevra dalla conferenza internazionale per l oizzazione della Croce Rossa.
In Italia l'Ordine di Malta ba approntato 1'arredamento di 3 treni-ospedale, ed un ospedale capace di olLre 100 letti, e pr·Òmuove continuamente l'aum di questi mezzi di soccorso.
Unghet•ia, l'Ordine_ di di un . e o:anitarro mcar1cato dt d1stmpegnare r rJspetttvJ tJVO servigi.
1 cava!ieri di Malta austro - ungheresi ebbero a prestare se"'nalali soccorsi nei combattimenti seguiti per l'occupazi;ne della Bosnia e dell'Erzegovina e nella guerra serbo- l/uniforme adottato pel personale direttivo e sanitario dell'associazione è di uoa forma particolare e che non rrova molti riSCOI)tri nelle uniformi d'altri corpi ed associazioni. Consiste, in una giubba di velluto turchino ad un petto di 6 bo ttoni di metallo ossidato portanti l'impronta della croce di Malia in rilie,·o; pantaloni larghissimi, alla zuava, della stessa stolTa e colore ed entranti negli sti,•ali. Berretto da ufficiale di marina in panno turchinonero e spada di tul modello assai caratteristico con impugnatura a croce in Utetallo ossidato e croce di Malta in rilievo. J commendatori e cavalieri dell'ordine- dire ttori e v direttori di treni o baracche ospedali- si distinguono dal personale sanitario (medici o farmacisti) per la croce dell'ordine,llendente dal collo (pei commendatori anche la croce ottagona sopra la tasca a sinistra) e pei speroni d'oro ed inoltre per : non aver alcun distintivo di grado ne al berretto ne alle maniche.

Nella Slesia e Vestfalia i cavalieri di Malta prestarono efficaci servigi nella guel'l'a franco-tedesca del 1870. Oltre / di troval'si coi loro vasli mezzi di soccorso sui campi di di Saarbrucken, GravE>lotte, Amiens, Querrieux, Bajaurne, St: Quentin e .Metz, essi eressero per primi dei lazzar·etti da campo in prossimità ai luoghi di combattimento . Le colonne dei cavalieri seguite da molli carri di ambulanza trasportar-ono dai lazzeretti agli ospedali interni oltre 10,000 uomini.
In Spagna ed in Fl'ancia, dove soltanto di recente si organizzarono delle associazioni dei cavalieri di .Malta, si studia pura alla c1·eazione di corrispondenti mezzi di soccorso nè minol'e è lo spirito dei cavalieri britannici.
L'Ordine di Malta è quindi un importante fattore nel campo dell'&ssistenza dei feriti, come in quello della filantropia e beneficenza, ed a buon diritto esso conser·va in Europa quell'alta considerazione che i gloriosi fasti del passato gli hanno giustamen te attr1buita.
Questi distintivi son(l invece riser1•ati al personale sanitario e di segreteria, si portano sul berretto e maniche nella seguente misura:
Ispettore medico Vice-ispettore medico Medico capo distintivi da !.colonnello da maggiore da capitano Medico assistente da tenente Farmacista e se)'(retario
Detti distintivi sono in argento. n personale tecnico - medici e - porta inoltre il caduceo in sulla controspallina.
U cappotto e turchino scuro e a due petti. Il vestiario d'es tate e in eolo•· bronzo chiaro, coi pantaloni lunghi, le scarpe di cuoio naturale e la perla del berretto bianca. .
Il basso personale veste invece cpme quello della Croce Rossa italiana, in panno color marengo, ma le filettature sono scarlatte anziché crelllÌII berretto conserva la rorma di <1nello di marina. l graùi 1fon vanno rnrier maggiore e sono cosi di>tinti : IJJftllO lllofeh•
Infermiere e cuoco ! Jlletli rossi, lana t gallone rosso, lana Sorvegliante di cl. ! Rletti rossi, lana i gallone e l lìletto rosso, Sorvegliante di t• cl. 3 filetti rossi, lana t gallone e :! filetti rossi, Capo sorvegliante di i" cl. 3 filetti rossi, seta t gallone 2 filetti, C:\po sorvegliante di t• cl. 4 llletU rossi, seta i gallone e 3 filetti, Il capo sorvegliante non porta controspalline. Distintivo generale per tutti snl colletto· e sui berretti la croce ottagooa l'ordine. bianca su tondo scarlatto.
Kedioi milltarl all'estere.- Leggiamo con Messaggero eg i;iano del 16 agosto. Col· piroscafo italiano Arabia giunsero ieri, da Napoli, ove risiedon o, il dottor W. Kruse, capo del lorid del pro f. Dhorn, ed il dottor A. mediéo della R. J.Vlarina italiana.
Essi si fe rmeranno in Alessandria pochi mesi per negli ospedali della città alcune malatiie d'infezione al di vista delle cause che le producono. Intendono così nuare dell e ricerche di palotogia esotica, alle quali hanno dedicalo altrove la loro operosità.
Il Diret.t.ore
Dott. STEFANO R EGI colon nello medico ispettore . ll Collaboratore perla R.• Marina Il R""'-'·""•·LU'....,.
D .r TEODORICO ROSATI
.fledico di t • elcuu
NuTtNJ FEDERICO, Gerente .
Febbri Cluiati Che Di Massaua
Se la climato log ia delle regioni tropicali - dice il dottor .J ousset nel suo eccellente lavoro (26) - rassomigliasse alla estate dtli nostri paesi meridionali, basterebbe esaminare il meccani,mo funzio nale degli organi al momento dei forti calori, esagerandl) al massimo i falli osse1·vati, per por gere una idea approssimativa dell a fisiologia degli uomini abitanti più o meno press o nll'equatore. Senonchè, la formola climatologica d'nn cli ma ipe-rtermico come ,fa ssau a non autorizza ad agire l'anno intertropicale esse ndo be n !ungi d:1 l ri produrre colà una sola delle nostre esta ti: s'i ngannerebbe, quindi. a partito chi credesse in buona fede di poter desum ere da cosiffatto confronto il concetto fisiologico della vita d'un eur,>peo sotto il cielo del )[ar Rosso.
Quando dalle regioni temperate o fredde l'europeo si traalle torride, il suo organismo - disse il Lévy (33)nasce ad una nuova vit11. Vitruvio, però, il grande architetto dell'ant ichitil romana, s'era hen appos to al vero , prima di ì3
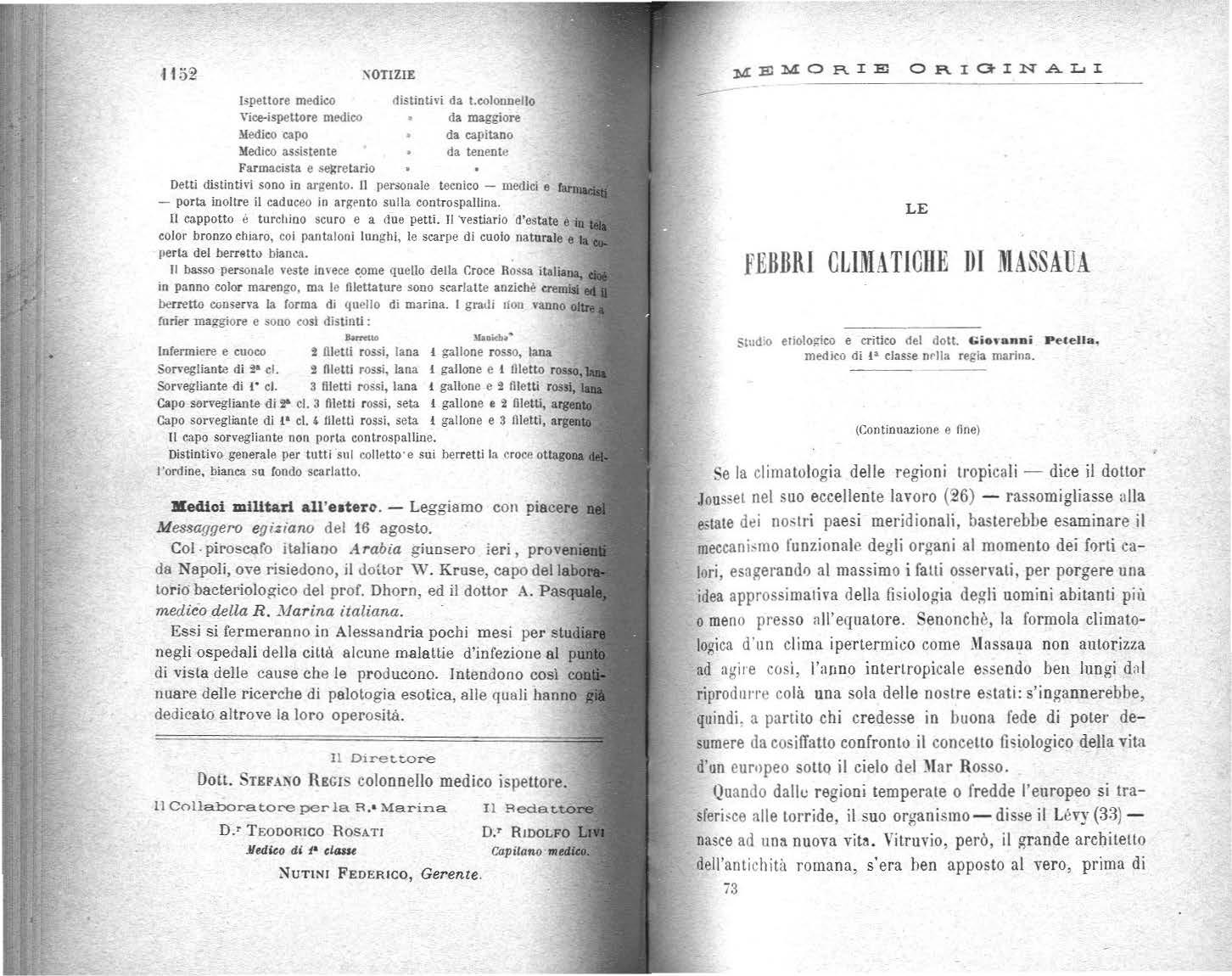
11iH fEBBRI. CLIMATICHE DI MAS:-o .\UA tutti, quando scrisse: quae a frir;idi.s regionilms cor-pora thwmiur in calidas, non pos.vunt durar·e sed <HJ,!)'u,lrm1 E difatti, la questione dell'acclimata mento e dell'accl ima zione - come accennai innanzi - si è risoluta in q senso, che nessuna immigrazione europea 0 iu grado di servarsi a lungo sotlo i tropici. se non a condizione che ogni tanto rimutata con elementi nuoY i. \'irchow, 0\·erbeck de (48 ) concordarouo pienamente conclusione che, senza incrociamenti con le razze ind· non si può vivere a lungo in quei climi e che, anche i ciandosi, il sangue europeo scompare interamente alla generazione. A tale risultato pervenne pure il dott. Orgeas suo pregevole studio antropologico ed economico· fatto
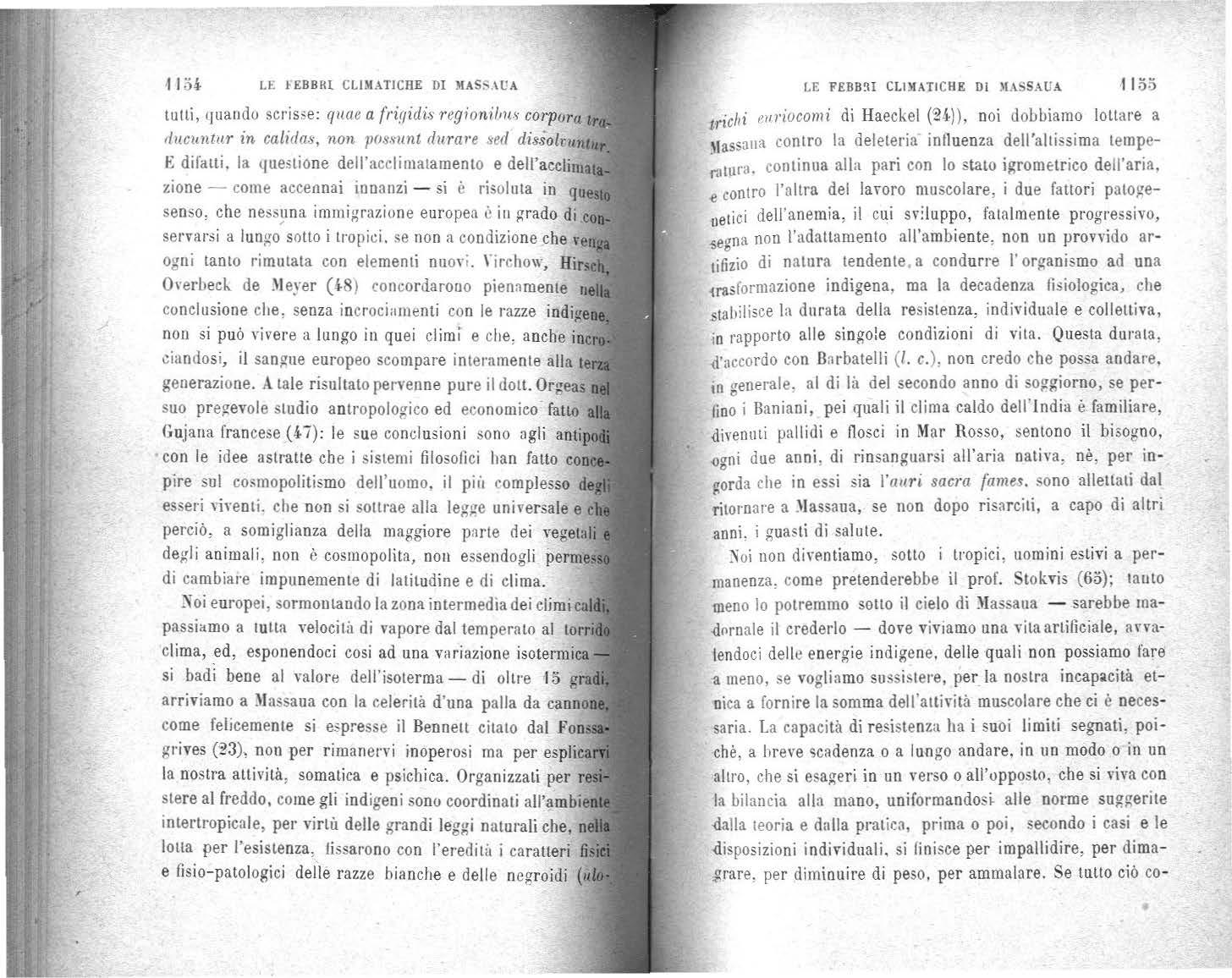
Gujana francese (4 7) : le sue co nclusioni sono agli an · con le idee astratte che i sistemi filosofici han fatto c pire sul cosmopolitismo dell ' uomo, il più comples so esseri ,·h ·enti. che non si sollrae alla legge universal e e perciò, a somiglianza della maggiore parte dei degli animali , non è cosmopolita, non essendogli di cambiare impunemente di latitudine e di clima .
Xoi europei, sormontando la zona intermedia dei climi passiamo a tul.la velocità di vapore dal temperato al clima, ed, esponendoci cosi ad una variazione isotermica si badi bene al valore dell'isoterma- di oltre ·15 arri viamo a )Jassaua con la celerità d'una palla da .......uv''"' come felicemente si espresse il Benoett citato dal Fo gri ves non per riman ervi inoperosi ma per la nostra attività, somatica e psichica . Organizzati per stere al freddo, co me gli indigeni sono coordinati all'a mbi intertropicale, per virtù delle grandi leggi naturali che, lotta per l'esistenza, fissarono con l'ereditit i caratteri e fisio -patologici delle razze bianch e e delle negroidi
LE FEBB!II CLllfATtCHE Dl )IASSAUA f
155 trichi euriocomi di Haeckel (24-)), noi dobbiamo lottare a contro la deleteria infl uenza dell'altissima tempeflltura. continua alla pari con lo stato igrometrico dell'aria, e contro l'altra del lar'Ofo muscolare, i due fattori patogenetic i dell 'anemia, il cui sv!luppo, fatalmente progressivo, non l'adattamento all'ambiente, non un provvido artifizio di natura tendente a condurre l'organismo ad una -trasformazio ne indigena, ma la decadenza fì$iologica, che .stahilisce la durata della resistenza, individuale e collettiva, in rapporto alle si ngole condizioni di vita. Questa durata, -d'accordo con Barbatelli ( l. c.), non credo che possa andare, in generale, al di là del secondo anno di sosrgiorno, se perfino i Baniani, pei quali il clima caldo dell'India è familiare, divenuti pallidi e llosci in Mar Rosso, sentono il bisogno, {)gni due anni. di rinsanguarsi all'aria nativa, nè, per in«ord a che in essi sia l'auri sacra fames, sono allettati dal l'l ri tornar'e a se non dopo risar citi, a capo di altri anni, i gua5ti di salute. non diventiamo, sotto i tropici, uomini estivi a permanenza, come pretenderebbe il prof. Stokvis (65); tauto men o lo potremmo sotto il cielo di )lassaua - sarebbe rna-dl\roale il creder'! o - dove viviamo una vita artificiale, a vvatendoci delle energie indigene, delle quali non possiamo fare -a meno, se vogliamo sussistere, per_la nostra incapacità etnica a fornire la somma dell 'a ttività muscolare che ci è necessaria. La capacità di resistenza ha i suoi limiti segnati, poichè, a hreve <;cadenza o a lungo andare, in un modo o in un altro, che si esageri in un verso o all'opposto, che si viYa con la bilancia alla mano, alle norme suggerite '<!alla teori a e dalla pratica, prima poi, secondo i casi e le disposizioni individuali, si finisce per impallidire, per dima,grare, per diminuire di peso, per ammalare. Se tutto ciò co -
CLIMATICHE DI MASSAUA
stituisca una modificazione tìsiologica, giudichi il lettore suo buon senno: come sarebbe puerile, per il dott. Org:eas c.), il pensare che lo della pelle del negro il nostro ci e lo sia un effetto del l'adattam ento al cli ma peralo, quasi una prova della variabilità dell'uomo per le tate condizioni mesologiche, così sarebbe per me non puerile il credere che tutte le modificazioni fisiologic he, quali si va incontro a 1\lassaua, non conducano, invece, variazioni d'ordine patologico, in quanto che tullo ciò esprime disag io, sofferenza , deperimento , entra nel d della patologia, mass ime quando dalla sal ute alla ma il passo è breve: e tal e è il caso per )J assaua. Partendo , col dott. Orgeas , dal princ!pio indiscutibile la differenza dei caratteri fisici fra il negro ed il .hianco è posta nelle condizio ni di adattamento al clima rispettivo e dalla divers ità dei loro alti derivano le va · patologiche, noi crediamo che il negro possegga tulle le dizioni capaci di disperdere il massimo del calore attraverso Jr, propria pelle e di ma ntenere equilibrata la mogenesi organica, in grazia di tal une parti col arità fisiologiche, ch e sono: a) la ma j?gio1·e volatilità del direi quasi eterea· , e, per conseguenza, ·la sua proprietà r efrigerante, che è incontestabile, dovttta ad acidi grassi latili e fors'an che a prin cipi tultor<l ignoti, che oe scono l'odore stt i generis : b) lo svil uppo più del sistema vasale cutaneo e sudori paro e c) il debole svil u del sistema sebaceo e pilifero, che sono particolarità certe, indirizzate entrambe ad assicurare all'orga nismo radi azione massima del calore animale : infine d) l'emiss più co nsiderevole di questo per la stessa irradiazione, il pigmento cutaneo: questa è condizione probabile,· sulla legge fisica del p·otere emissivo maggi ore che le
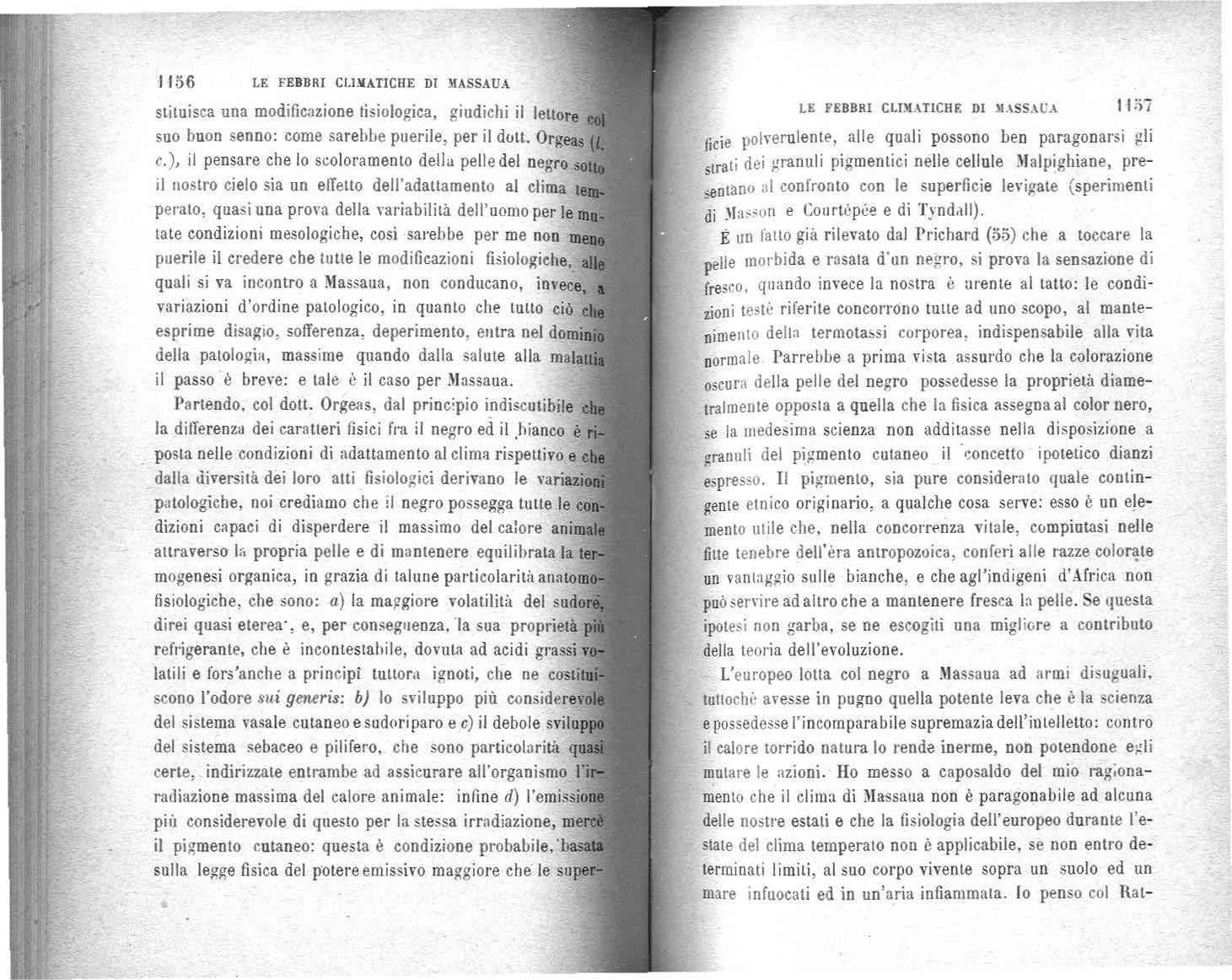
LE FEBBRI CLnlATIC HF. DI liASS.U:A Il i)7
[Jcie polverulente, alle qu ali possono ben paragonarsi gl i strati dei granuli pigmentici nelle cellule !U alpighiane, pre560tan o al confronto co n le superfi cie levigate (speri menti di e Courtépée e di Tynd,lll).
E un ratto già rilevato dal Pr·ichard {55) che a toccare la pelle morbida e rasata d'un negro, si prova la sensazione di fres co, qua ndo invece la nostra è urente al tatto: le condizion i te:>tè riferite concorrono tutte ad uno scopo, al mantenime nt o della termota:,si corporea, indispensabile alla vita normale Parrebbe a prima vista assurdo che la colorazione oscura della pelle del negro possedesse la proprietà diametra lmente opposta a quella che la fisica assegna al color nero, se la medesima scien?.a non addita sse nella di sposizione a urannli del pigmento cutaneo il ·.-;oncetto ipotetico dia nz i "' espresso. Il pigmento, sia pure considerato quale co ntingente etn ico originario, a qualche cosa serve: esso è un elemento utile che, nella concorrenza vitale, co mpiutasi nelle fitt e tenebre dell'èra antropozoica , conferì alle razze colorl!te un sulle bianche, e che agl'indigeni d'Afri ca non puòserri re ad allro che a mantenere fresca In pelle. Se questa non garba, se ne escogiti una migliore a contributo della teo ria dell'evoluzione.
L'europeo lotta col negro a ad armi disuguali, tu ttochi· avesse in pugno quella pote nte leva che è la sc ienza e pos sedesse l'incomparabile supremazia dell'intelletto: co ntro il calore tor rido natura lo renda inerme, non potendon e e}!li mutare le azio ni. Ho messo a caposaldo del mio rag;o namento che il clima di non è paragonabile ad alcuna delle nostre estati e che la fisiologia dell'europeo duran te l'estate del cl ima tempera to non è appli cabile, se non entro deter minati limiti, al suo corpo vivente sopra un suolo ed un mare infuocati ed in un'aria infiam mata . fo penso col R.al- tra), il dotto e zelante medico della )Jarina Britannica. con le sue pazienti ricerche, (56) e (57), miziò la osser vazioni metodicamente scientifiche, penso che la 6 logia comparata delle razze umane, abitanti le regioni del gl?bo, debba precedere lo studio della patologia di q medes1me razze, senza di che non è possibile disti nguere apprezzare al loro giusto valore i fatti morbosi, che sono .. ' PIU spesso, esagerazione dei fenomeni fisiologici mescolati a fenomeni patologi.ci . Le razze sono figlie dei cl lo disse il gran padre lppocrate, cui bisogna far di anche oggi: non è figlio del secco ed ardente Sa l'uomo magro, focoso ed infaticabile, che lo abita da immemorabile? il figlio del caldo-umido Sudan non è infingardo quanto un Dànkalo della costa Eritrea? e 1 ri cano del nord non è forse debitore della sua proverbiale tivitit all'esigua umidità del clima nativo? Pu rtroppo, la siologi'l delle razze è da farsi quasi per intero, come può convin cersi le)Zgendo il Topinard (70bis), ma è merito medici della marina francese, emul i del Rattray, se oggi passo avanti si è fatto sulla via da lui tracciata. Non si no .sce, è vero, il chimismo intimo, organico, delle razze picali, proverbialmente note per la loro frugalità e temente vegetariane, come la chimica fisiologica dell' smo europeo ha molti problemi ad incognite ancora da solvere, ma, da 30 anni a questa parte, tutte le piu i tanti funzioni organiche furono sottoposte ad accurate che sperimentali, che il Jousset raccolse, insieme con le proprie, in un corpo di libro (l . c.) che fu onor:to di p
Io mi son dato la briga di leggere tutto ciò che m'è sott'occhio su questo interes3antissimo argomento della patologia comparata e, dopo un accurato esame analitico tutte le modificazioni nutritive e funzionali che il clim a
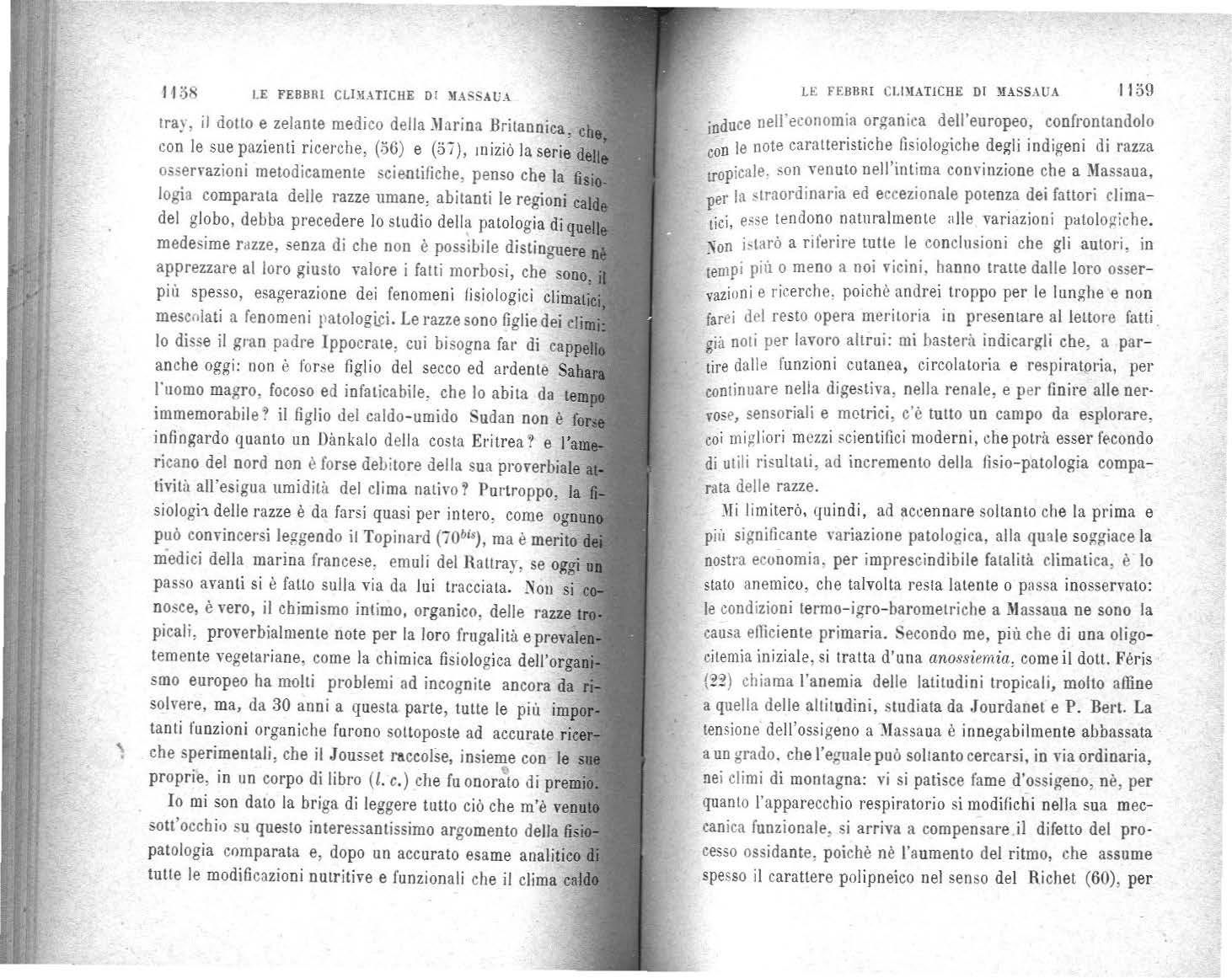
LE FEBBRI CLDIATlCHE Ol :lfASSA UA 11 59 induce nelreconomia organica dell'europeo, confrontandolo con le note caratteristiche fisiologiche degli indigeni di razza tropicale , son venuto nell'intima convinzione che a 1\fassaua, per In straordinar·ia ed eccezionale potenza dei fattori climatici, es:;e tendono naturalmente alle variazioni ,\on i;:-tarò a riferire tutte le co nclu sioni che gli autori, in tempi più o meno a noi ricini. hanno tratte dalle loro osservazioni e ricerche , poiché andrei troppo per le lunghe e non farei di'l resto opera meritoria io preseDLare al lettore fatti già noti per lavoro altrui: mi basterà indicargli che, a partire dalle funzioni cutanea, circolatoria e respiratoria, per· continuare nella digestiva, nella renate, e per finire alle nervose, sensoriali e motrici, c'è tulto un campo da esplorare, coi migliori mezzi scienti fici moderni, che potrà esser fecondo di utili risultati, ad incremento della fisio-patologia comparata delle razze.
)[i limiterò, quin di, ad accennare soltanto che la prima e più significante variazione patologica, alla qu'lle soggiace la nostr-a economia, per imprescindibile fatalità. climatica, è lo stato anemico, che talvolta resta latente o passa ino sservato : le condizioni termo-igro- barometriche a .M assaua ne sono la causa efficiente primaria. Secondo me, più che di una oligocitemia iniziale, si tratta d'una anossiemia, come il dott. Féris {2.2) chia ma l'anemia delle latitudini tropicali, molto affine a quella delle altitudini, studiata da J ourdanet e P. Bert. La tensione dell'ossigeno a .\fassaua è innegabilmente abbassata a un grado, che l'eguale può soltanto cercarsi, in via ordinaria, ne i climi di montagna: vi si patisce fame d'oss igeno, nè, per quanto l'apparecchio respiratorio si modifichi nella sua meccanica funzionale, si arriva a compensare il difetto del processo ossidante, poichè nè l'aumento del ritmo, che assume spesso il carattere polipoeico nel senso del Richet (60), per
·160 u: FEBBRI CLIMATICHE DI MASSAUA
l'insufficienza dell'evaporazione polmonare, nè la ampiezza della spirometria valgono a far variare la tensione del gas vivificante, che per di piit si presema alveoli in condizioni termiche tali, da impedire come strarono !Uathieu e Urbain, l'energia della sua fissazio ne globuli sanguigni . La crasi sanguigna deve, dunque, per sità subire, a conlatw dell'atmosfera intertropicale, una riazione qoalitativa per effello della sola azione cli matica.
Jl dott. Maurel, che fece ricerche ematologidle alla lupa, dimostrò appunto (4 '1) che in soldati giovani e i quali averano soggiornato in quella colonia da 6 a 3? senza mai ammalarsi, le ematie si numeravano in normale e perfino ad una media superiore a quella am in Europa, ma avevano perduto, al contrario, il 20 •jo loro emoglobina. È onesto. però, il dire che il dott. in ricerche posteriori (40) negò questa diminuzione binica, onde allo Stokvis non parve vero di negare, a sua (l. c., pag. 197), l'esistenza della anemia termica essendosi prefisso di incoraggiare la dominazione sulle razze indigene dei paesi caldi. A Massaua, però, sol gl'individui si sottopongano all'esame clinico, si rende essi palese l'impoverimento del sangue, che non si rivelò dott. Pasquale come vera ipoglohulia, per il fatto ch e il porto fra la parte liquida e la corpuscolare era alterato da lasciare piutlosto ammeuere un aumento numerico, tivo, degli emociti : sarebbe quindi più saggio consi g1io, espr·esso in voto dal dott. Rho (6 ·1, pag. 1454),• di a d'ora innanzi del cromocitometro del Bizzozero per uno ematimetrico comparato fra gl'individui colà dimoranti. rebbe anche importantissimo verificare se l'ispessimento plasma sanguinisJ osservato dal dott. Pasquale, sia un costante o soltanto occasionale, essendo generalmente
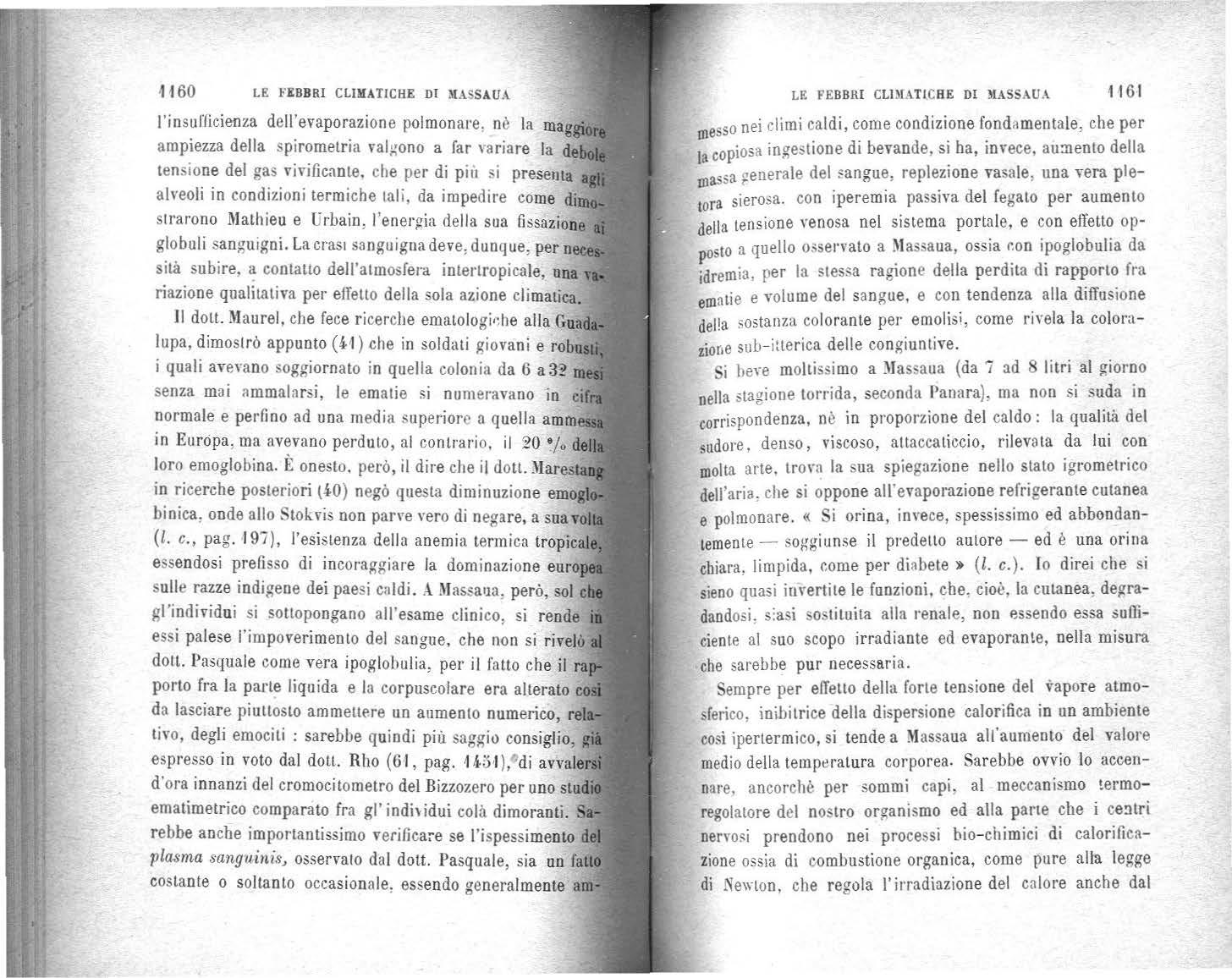
LE FEBBRI CLHIATlCBE DI )IASSAUA ·11 6·1
messo nei climi caldi, come condizione fond amentale, che per la copiosa ingestione di bevande, si ha , im·ece, au:nento della a··a oen erale del ::angue. replezione vasale , una -vera pie- m . tora sierosa. con iperemia passiva del fegato per aumento della tensione venosa nel sistema portale, e con effetto opposto a quello osservato a Massaua, ossia r.on ipoglobulia da idremia, per la stessa ragion e della perdita di rapporto fra ematie e volume del sangue, e con tendenza alla diffusione del!a sostanza colorante per emolisi, come rivela la colorazione sub - itterica delle congiuntive.
Si here molti ssimo a )Jas·aua {da 7 ad 8 litri al giorno nella stagione torrida, seconda Panara), ma non si suda in corrispondenza, nè in proporzione del caldo: la qualità del sudore, denso, viscoso, attaccaticcio, rilevata da lui con molta arte, trora la sua spiegazione nello stato igrometrico dell'ari a, che si oppon e all'evaporazione refrigerante cutanea e polmonare. « Si ori na, imrece, spessissimo ed abbondantemen te - soggiunse il predetto autore - ed è una orina chiara, limpida, come per di11 bete )o) (l . c.). lo direi che si sieno quasi inrertite le funzioni, che, cioè, la cut.anea, degradandosi. s :asi sostituita alla renale, non essendo essa sufficiente al suo scopo irrad iante ed evaporante, nella misura che sarebbe pur necessaria.
Sempre per effetto della forte tensione del vapore atmosferico, inihitrice della dispersione calorifica in un ambiente così iperlermico, si tende a )lassaua all'aumento del valore medio della temperatura corporea. Sarebbe ovvio lo accennare , ancorchè per sommi capi, al meccanismo tel·moregol atore del nostro organismo ed alla parte che i ce!llri prendono nei processi bio-chimici di calorificazion e ossia di combustione or·ganica, come pure alla legge di Newton, che regola l'irradiazione del calore anche dal
H62 LE FEBBRI CLIM.\TIC HE DI MASSAUA
cor po umano, ed ai calcoli quantitativi dei fisici e dei chi· miei per determinare le calorie di produzione e di dis persione in determinati ambienti e sotto certe condizion i di riposo e di attività. A me basta rilevare che, co me durante l'estate de i nostri climi la T. del co rpo si mantiene più elevata di O•;l a 0°,2 C, secondo il Beaun is ( 4- ), così tutti gli ossèrvato1·i ammettono un 'ipertermia normale, sotto la zooa intertropicale, negli europei ed anche un po' negli stesa indigeni. Per gli eu ropei Davy co nstatò un aumen to di o• a 1o Fahr: .Brown-Séquard lo segnalò di o• ,9 C: Ratt ray mise in media t •, 1 C in più, Guéguen soltanto 0,3. diede per media 37°,5 (42 ); ma Jousset (l . c.), ch e a uuLmnl:= termometri di precis ione, trovò che la media oscilla fra minimo di 37°,6 e nn massimo di 38°,2, beninteso che nessun caso con tali temperature gl'individui avve rti malessere febbr ile . A il dottor Barba telli ( l. pag. l 125 ) verifi cò pure che la temperatura del co rpo una elevazione di o•,6 a 00,7 e cionondimen o l'o rgan seguita a funzionare normalmente , massime nell' , ·,,-..,..,,n., di gestivo, che è, in generale, il più suscettibil e alle zioni patologiche, co me dirò appresso. Io medf!si mo ricordo d'aver mai avuto nè riscontrato in altri una ratura sott'ascellare inferiore ai 37° ,5, dall'aprile a sette mbre : rammento pure che, sot to l'azion e del vento infernale, C') per la violenza con la quale infuria e calore secco che trasporta dal deserto della i\" uhia, si .,v,...... ..
!.E FEBBRI CLUIATICHE UJ YA.:;SAt.: \ t
atur e corporee. prossime ai 38 ed anche superiori, te rnper ,che per ciò si avesse febbre, ma soltanto un male:>sere senza . . . l'ardore interno ed esterno che marlon a\""a. I l magg101 e cav . l\tanescalchi raccolse in uno. .(ined ito) mperature di uomini sani , durante 1l kamsm, nlevando le te , 1 \
- ·oldato robust issimo perfin o la misura del 38•,8. G 1 t ID un . h · 11 un ambiente relate è l'aria acom et oce,cmeva sn1 c e 1 • • )lassaua nel periodo in cui sollia quel vento, tollera .11 . ldo co me in parecchie terme roma no - irlandesi, dove esica 0 stanze calde "a 90° C ma secche (calid arinm ), molto ston . u • l'l Non di nord -est, come per errore ru stampato a pag. 109!, ma di ovest Il a Massaua questo vent-O, cosi detto dalla parola araba kamsi", vuoi di re cinquanta, per il soffiare che ra , in Egitto, giorni pri ma ed tr·ettanti dopo il solstizio d'estate. Stando alla lettera, non meriterebbe nome a Massaua, dove ha una durata molto minore, ma gli indigeni oon tanto per il sottile in fatto di etimologia!
·· a lun()'o che in ambiente caldo e um1do (o81 : da CIÒ s1 p!U o • . capisce perchè un'e;;tate intera, passata dal fr e11le nel Sahara roarocchi no, possa ri spettare l'integrità della sal ute , mentre pochi giorni in clima opposto bastano a .
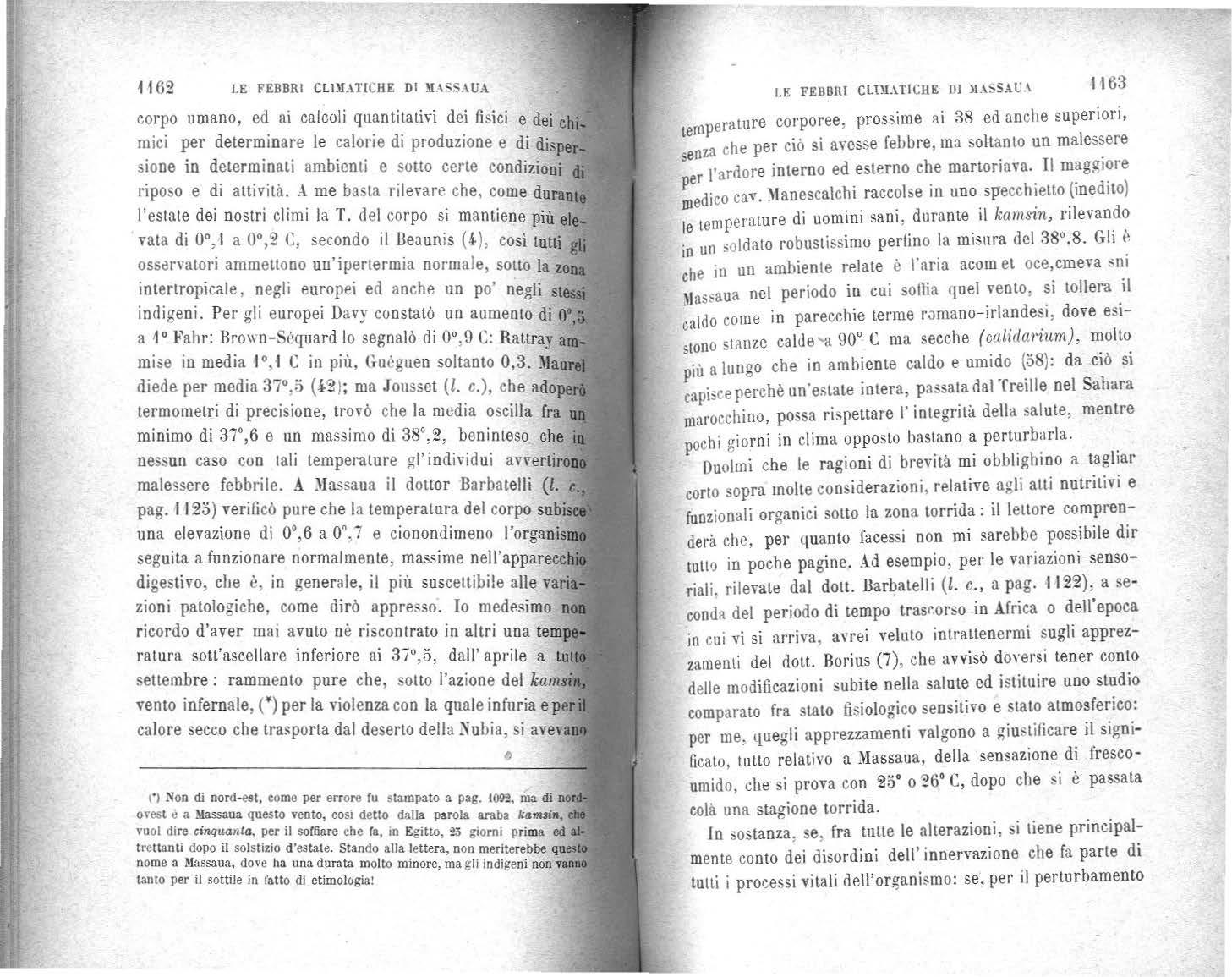
Ouolm i che le ragioni di brevità mi obbllgh1no a tagliar corto sopra molte co ns iderazion i, relative agli atti nutritivi e funz ionali organici sotto la zona torrida: il lettore co mprenderà che , per quanto facessi non mi sarebbe possibile dir tollo in poche pagine . Ad esempio , per le variazioni sensori ali. rilevate dal dott. Barbatelli (l. c. , a pag. 1122}, a seconda del periodo di tempo trasr.orso in Africa o dell'epoca io cui vi si arriva, avrei veluto intratl.e nermi sugli apprezzamenti del dott. Borius (7) , che avvisò doYersi te ner con to delle mod ificazioni subite nella salute ed istituire uno studio comparato fra stato fisiologico sensitivo e stato atmosferico: per me, q uegli apprezzamenti valgono a il significato, tutto relativo a )fassaua, della sensazione di frescoumido, che si prova con 25° o 26° C, dopo che si è passata colà una stagio ne torrida.
In sostanza, se , fra tutte le alterazioni, si tiene principalmente co nto dei disordini dell' innervazione ch e fa parte di tu tti i processi vitali dell'organi&mo: se, per il perturbamento
1164 LE FEBBlll CLlllATICHK DI lL\SSAliA
delle funzioni, massime della digestiva e respiratoria t pensa che il ricambio materiale soggiace nece::sariamente deviazioni dalla normale, in un clima, dove !l eccentrico dei liquidi organici verso la pelle e la copia be,ande ingeste illanguidiscono il potere dei succhi enterici , e dove l'atlinilit che possiede mentalmente per !"ossigeno è diminuita per le climatiche : se per poco si suppone che la reazione acida tessuti più importanti (nen'oso e muscolare). quelli che Massaua sono più esposti alla prova di resistenza. d'intensità, mentre il grado di alcalinità del sang ue invariato o diminuisca per lo stato anemico e quindi la rente di diffusione, basata sulla differenza di reazjo ne, sangue ed elementi anatomici sia resa men attiva da riparare il consumo dei tessuti al grado necessario ( 1): inollre, si riflette che i sistemi di compensazione tìsiol pei quali l'economia animale trova la via di espellere le stanze D()Cive che continuamente la inquinano, a un momento si rendono insunìcienti a ristabilire l'armonia funzioni: se, iofine, mettendo a calcolo tutte le anzidette costanze, si considera che, per la tendenza all' iperter·mia, calore organico è in una specie di equilibrio instabile che più lieve causa n il più piccolo errore basta a turbare, e considera altr-esi che il centro ne!'voso regolatore della genesi nell'europeo è adattato ad una specie di ginnasti per cui sopporta bene le variazioni atmosferiche eroprie nostri climi, meglio che non sia in grado di reggere a lo alle condizioni ter·mo- igrometriche eccessive di Massaua, pare che si possa ragionevolmente cooelndere che tutto verge, ad esporre l'organismo europeo ad un cime nto , essendo suprema la lotta impegnata contro gli menti climatici ma disuguali i nostri mezzi di difesa, e che
LE FEBBRI CLIMATICHE DI MASSAUA H65 bbre, quando non si prenda per gli occhi, come e comune Ie edenza sollo i tropici pel' l'intensità della luce solare, è la cr . b .. d . Il' 0 ,...·1a manifestazione de1 pertur amentt 10 ott1 ne orga- ptu '•nismo da quel clima eccezionale . li L mio la\""oro sull 'i nsolazione e colpo di calore (l. c.) mi ropo' i, due anni fa, di interpretare la patogenesi di questa morbosa in una maniera diversa dalla più universalmente accetta, e pervenni alla concl usione che il concetto più adeguato ne fo sse la tossicemia autogeoetica o creatinemia di terzo grado, come la chiamni . Soggiungo ora che a siffatla denominazi one intesi dare un significato comprensivo e provvisorio, salvo a formarne altra equivalente: della quale creazione filologica ognuno è a sua volta libero, purchè in un qual siasi derivato sia compreso, il concetto generico dell'autointos:-icazione.
Le {eb/Jri climatiche di sarebbero da ,;ioni. Jpot.esi dl'lllt possibile loro eroluzwne tn m(mirr ti foche.
:\ po..:o più di un anno di distanza dalla pubblicazione di ,1uello ebbi il piacere di veder condiv iso il mio modo di pensare dal prof. Albertoni (di Bologna) e dal Sil'a (di Pavia), i quali nelle loro bri.llanti e dolle relazioni sul tem a delle autointossicazioni, lette al IV Congresso della Società di medicina interna (39), parlando del colpo di calore o di sole lo attribuirono ad un vero intossicamento per imperfetto ed incompleto ricambio materiale nei tessuti organici: anzi, il primo di essi ebbe, non ha guarì, la bontà di
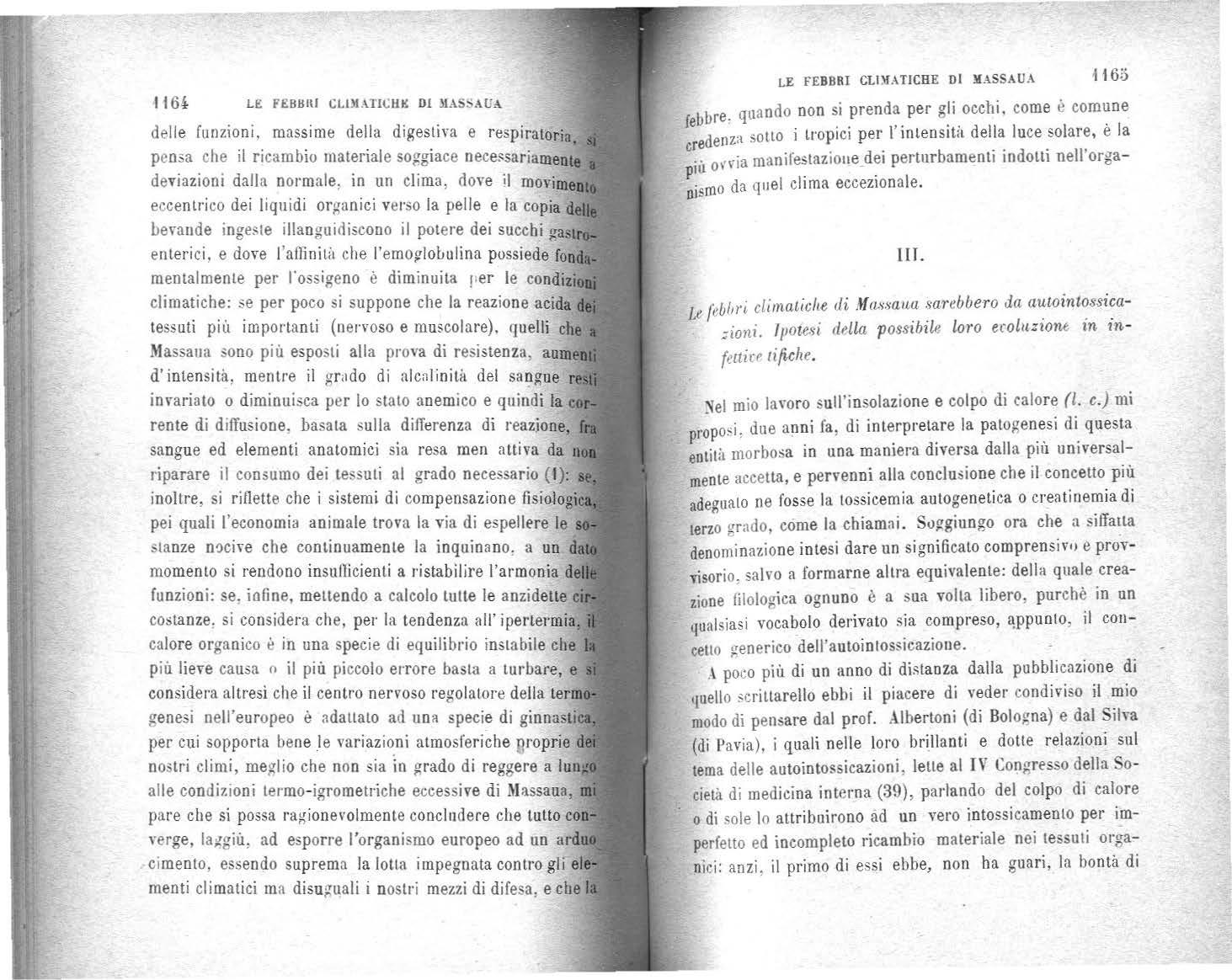
1166 LE FEBBRI Cl.IMATICHE DI YASSAUA
signifìcarmi che di quel concello da me espresso aveva nuto conto in un articolo sul tema favorito, che ha già la luce per le stampe nel Trattato italiano di patologia e rapia medica, (YoL l. P. T., pag. 4-0), in corso di zione per merito della solerte Casa editrice dott. F. )fi e particolarme nte grato rilevare anche le parole prof. Baccelli, presidente ùi (ruel indirizzate a -cordare che in Africa i medici militari vanno comp iendo sulle febbri anticamente dette gastriche, alle qual i il s'era pur riferito nella sua letlura, e che non sono da fondersi con le febbri tifoidi. heocbè di queste abbiano sembiaoze. Sono febbri con disturbt gastro-enterici pre da attribuirsi allo strapazzo od a qualsiasi lavoro prolu .anche leggiero. che sotto quel cli ma è micidiale, feb bri ereatinemia, come il colonnello medico dott. )fontanari · fin dal 1875, Yariabili nella gradazione d'intensità, come -cennai di poi {l. c.). Il dott. Fayrer (2 l ) le chiamerebbe

I ndia febbri enteriche climatiche, per distin guerle dalle teriche
L'idea che la febbre effimera a Massana fosse da auto i tossicazione fu già con molto ac ume concepila dal dott. nel suo primo lavoro (6 1, pag. l i- l i>), veneodogli fors e geri<a dal medesi mo dott. Fayrer, che, parla ndo della bricola od effimera in In dia, espresse l'identico cv (l. c. , pag . 'l 55) .
Per l'effimera, dunque, siamo in piena .dotlrlna del! sicazione autogenetica, come vi siamo per il -colpo di di calore: perchè allora non potremmo esservi anche {}Uelle altre piressie, che, non essendo a prin cipio tificbe divenendo tali in seguito, stanno precisamente in mezzo ìl grado più leggiero e l'altro estre mo per gravezza de lla bre termica, quando si è dimostrato che il calore è
61 recipuo di morbosità a :\las saua? Se il mio valente collega dopo aver accen nato ai lavori del nostro Selmi sulle ptomaine e indicato nelle leucomaine del Gautier la causa efficiente delle febbri più comuni in )Jar Rosso, avesse se· guito la 'i a piana e diritta. e non si fosse, invece, cacciato nel labirinto delle infezioni mi crobiche, ci saremmo incontrati al certo e non auemmo tar·dato ad intenderei pienamente.
I.E FEBBRI CLIMATICHI<: DI MASS.\l'.\ 11
Se un ùuhbio ancora mi restava nell'animo che le febbri climatiche di :\l assaua fossero da autointo;;sicazioni, dopo lo studio da me fatto di quel clima e la lettura delle relazion i sopra citate, esso è oggi interameme dissipato. I l nostro or- ù un laboratorio di veleni: indipendentemente dai l) microbi i nostri tessuti, aggregati di cellule vive, elaboran o sosta nze alcaloidee tossiche, a somiglianza delle cellule i ed a spe::e delle materie prc1teiche. Questa produzione di principt V"elenosi è normale ed incessante. ma se per insufficienza degli apparecchi depurato r i sono ritenuti nel sangue o !ie, pur essendo eliminati per le vie ol'dinarie, la quantità loro è eccessiva in ragione della stessa prod u· zione, diventano ipso facto pir·ogeni.
A )la ssaua noi troviamo due condizioni capitalissime perchè l' intossicazione autogenetica sia all'ordine del giorno, mi si passi il l'uaa è nel clima e si riferisce ai suoi molteplici elementi, r ilevan tissimi, l'altra è nell'organ ismo e ri siede nella compagi ne dei tessuti e nell'apparecchio dige- · slivo: vi troviamo, cioè, la sorgente delle an ormali decomposiziolli degli albu minoidi nel parenchi ma e nei sucthi dei tessuti per effetto del diminuito trasporlo di ossigeno sotto l'azi one diretta del calore umido, e la sor gente dell'anor male decomposizione degli alimenti, della loro putrefazione nel tubo !{astro-enterico, sotto l'infl uenza indiretta della mede- sima causa. Sono condizioni innegabili e così evid enti uisognerebbe vivere in altro pianeta per non Quanta parte possa avere la luce solare intensa sul ....... materiale non saprei precisare: credo, però, di poter in sio che il benefizio igienico di essa nello sterilizzare i germi togeni si volge in malenzio verso il nostro organismo qu1nto che per l'eccessiva sua forza eccitante sul cellulare concorre ad accrescere la scomposizione delle stanze organiche ( Il ), ed aggrava l'autointossicazione, Crederei di far un torto alla sapienza del lettore, se entrassi ora nel discorso dei progressi che ha fatto la chi biologica, indispensabile presidio della bacteriologia: progressi giornalieri, nei quali il nome italiano non resta altri secondo. L'idea dei vaccini chimici, che informa la dell'immllnitn preservatrice per rirenzione di sos tanze sibili è la più accreditala. Si sa che, quando il gocitismo vien meno, è lo stato batterici da, 1nsito alla posizione chimica degli umori normali, che modera ed la pullulazione degli agenti p:llogeni organizzati, che li e soppri me le loro secrezi oni tossiche (9). Chimica e chimica, ecco la lìnale d'ogni processo, de01ro e fuori corpo umano: bastano minime differenze nella N\fnn.,... degli ambienti vivi ed inerti, liquidi o solidi, per iu tluire sviluppo, sulla morfologìa e sulle funzioni delle cell ule, esse isolate come i micr·obi o raggruppate come i co me gli istobi (meta6ti e metazoi) di Haeckel. meraviglia, quindi, se nella dottrina delle intossicazioni si faccia oggi largo posto ai prodollì propri dell'organismo e se, accanto all'avvelenamento Lossìne microbiche, nelle malattie infettive si ponga no le tossine autoctone, endorganiche, sviluppa_tesi per complesse. Lo stato tifoso è notoriamente sintomatico dì
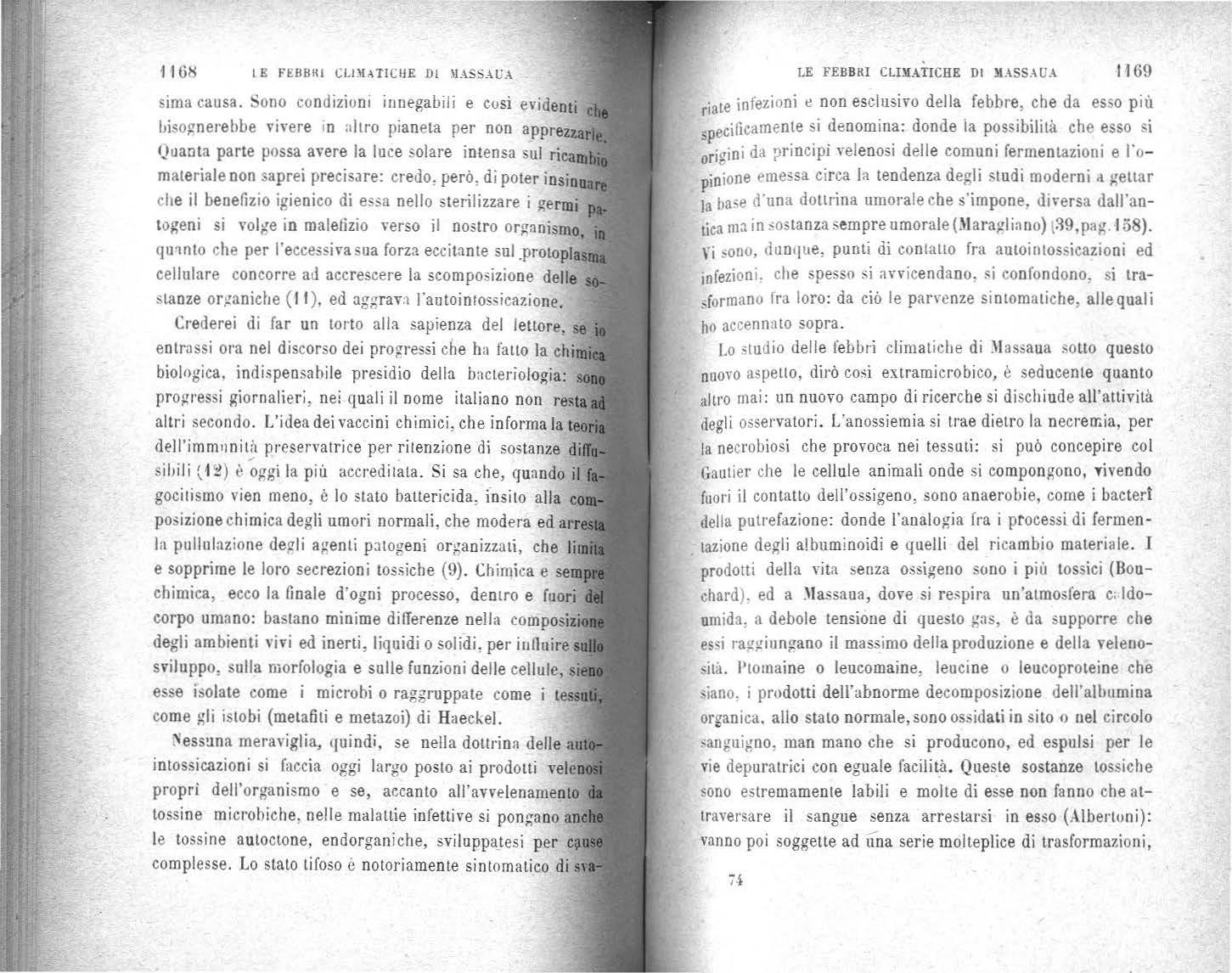
LE FEBBRI CLIMATICHE DI MASSAUA t 169
riate infezioni e non esclusivo della febbre, che da esso p1u specilìcamente sì denomina: donde la possibilità che esso si origini da principi Yelenosi delle comuni fermentazioni e l"opin ione emessa circa la tendenza degli st udi moderni a gettar la base d'una dottri na umorale che s'impone, diversa dall'antica ma in :<ostanza sempre umorale t39,pag . l58). \' i dunque, punti di contauo fra autointossicazi oni ed infezioni. che spesso si avvicendano, :;i confondono, si trasformano fra loro : da ciò le pan·cnze sintomatiche, alle qual i ho ac ce nnato sopra.
Lo studio delle febbri climatiche di .\lassaua so tto questo nuovo aspello, dirò così extramìcrobico, è seducente quanto altro mai: un nuovo campo di ricerche si dischiude a ll 'attività degli osservatori . L'anossiemia si trae dietro la necrerr.ia, per la necrobiosi ch e provoca nei tessuti: si può concepire co l Gautier ch e le cell ule animali onde si compongono, Yiv endo fuori il contatto dell'ossigeno , sono anaerobi e, come i bactert della putrefazione : donde l'analogia fra i processi di fermentazione degli a!bum!noidì e quelli del ricambio materiale . I prodotti della Yita senza ossigeno sono i più tossici (Bouchard), ed a dove si un'atmosfera c; !doum ida, a debole tensione di questo gas, è da supporre ch e essi il massimo della produzione e della veleoo·ita. Ptoma ine o leucomaine, leucine o leucoproteine che i prodotti dell'abnorme decomposizione dell'albumina organica. allo stato normale, sono ossidati in si to o nel circolo man mano che si producono, ed espulsi per le vie depuratrici con egual e facilit.à. Queste sostanze tossiche sono estremamente ·lahìlì e molte di esse non fanno che attraversare il sangue senza arrestarsi in es so (Aib ertoni): vanno poi soggette ad una serie molteplice di trasformazioni,
H/O LE FEBBRI CLJliATICHE DI MASSAUA massi me negli stati intermedi, e, secondo il Kobert ' prese ntano caratteri netti e decisi per dagli Crtloidi vegetali . Gli splendidi lavori del Brieger·, ai quali corsero quelli del Selmi, hanno non solo condollo a care ch im icamente le ptomaine fra loro, ma a r ivelarne straordinaria mutabil ita dt compos izio ne.
}la a .\t a.ssaua, oltre che dalle sostanze nlcaloidee, intossicazione deriva dalle azotate e dai numerosi ch e dànno la reazione agli elementi anatomici. L'azìone ralizzaote, che, insieme co l forte ca lore, esse eserci tano centri nervosi e sul cuore, conduce allo squilibrio degli parecchi compensatori. Come se non bastassero i tossici del con sumo, nuovo materiale venefico è versato circolo sa nguigno con quelli dell'i ntroito, il tubo rico essendo il più soggetto a perturbamenti delle su e Qu es to grande fabbricatore di veleni,. sorgente unica di ntossicazione per alcuni aut or·i, contribuisce indubbr'ame:nla ad aggravare le condizioni morL•ose alle qa ali te nde l nismo europeo. La febbre climatica si accompagna · cabilmente a dist urbi gastro-enterici , spesso grav i ma sempre proporzionati all'altezza della temper·atura : alla ventrale, os tinata nello stato sano ed anche a pri ncipio febbre, talvolta subentra il sintomo opposto , la diarrea, cui tal'altra si esplica la cri si sa lutare e che perdura convalescenza. Io ravviso in questi fenomeni, som indicati , un legame etiologico con l'intossicazione u wLvv:•vu••
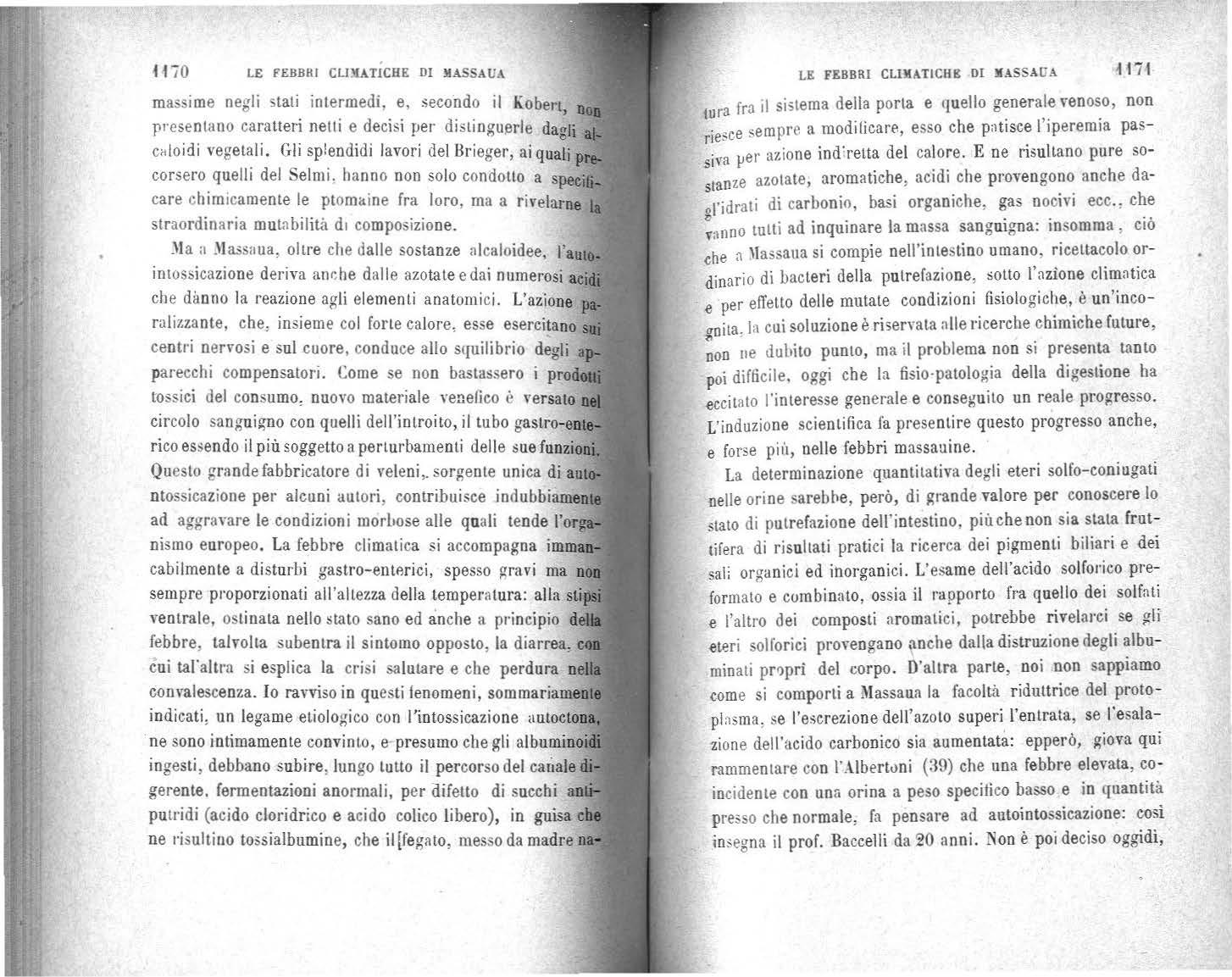
·ne sono intimamente convinto, e· presumo che gli albu ingesti, debbano subire, lungo tutto il percorso del ca riale gerente. fermentazioni anormali, pe r difetto di succhi putridi (acido cloridrico e acido colico libero), in guisa ne risultino tossi albumine, che il [fegato, messo da madre
LE FEBBRI CLIMATICO& 0[ llASSAUA H 7 i
ra fra il sistema della porta e quello genera le venoso, non tu . ,. .
' Ce sempre a modi!ìcare, e sso ch e patrsce lrperem1a pas- · siva }Jer azio ne ind :retta del calore. E ne risullano pure sostan ze azota te, aromatiche, acidi che provengono anche daol'idrati di carbonio, basi organiche, gas nocivi ecc., che tutti ad inquinare la massa sanguigna: insomma , ciò che a si compie nell'intestino umano , ricettaco lo ordinario di bac teri della putrefazione, sotto l' nzìone climatica e per effetto delle mutate co ndizioni fisiolo giche, è un' incola cui soluzione è riservata alle ricerche chimiche future , non ne dubi to punto, ma il problema non si presenta tanto poi difficile, oggi che la fisio-patologia della digestione ha eccitato l'i nteresse gene rale e conseguito un reale progr esso. L'induzione scientifica fa presentire questo progresso anche, e forse pit't, nelle febb ri massau ine.
La determi nazion e quantitativa degli eteri solfo-coniugati nelle orine sarebhe, però, di grande valore per conosce re lo stato di putrefazion e dell'intestino , più c he non si a stata fruttifera di risultati pratici la ricerca dei pigmenti biliari e dei sali orga nici ed inorga ni ci. L'esame dell 'acido solforico preformato e combinato, ossia il rapporto fra quello dei solfnti e l'altro dei composti nromati ci, potrebbe rivel arci se g-li eteri solforici provengano anche dalla distruzione degli albuminati pr opri del corpo. D'altra parte, noi non sappiamo come si comporti a Massaua la facolta riduttrice del protoplasma , se dell'azo to superi l'entrata, se l'esalazion e dell'àc ido carbonico sia aumentata: epperò, giova qui rammentare con l' .\ lbertùni (39) che una fe bbre elevata, coincidente co n una orina a peso specifico basso e in quantità presso che normale; fa pensare ad autointossicazione: così 1nsegna il prof. Baccelli da 20 anni. Non è poi deciso oggidi,
FBBBRI CLDI.HfCBE DI MASSA
in modo se l'aumento dell'eliminazione dell costituisca parte integrante del processo febbrile e se proporzionata all'altezza della temper·atura: gli speri dei prof. Wood e .\Iarshall (di Pennsylvania) tender·eb a provare l'opposto {73). Secondo \foursO<! (U.), l'urea rebbe notevolmente diminuita nelle regioni calde, allo sano
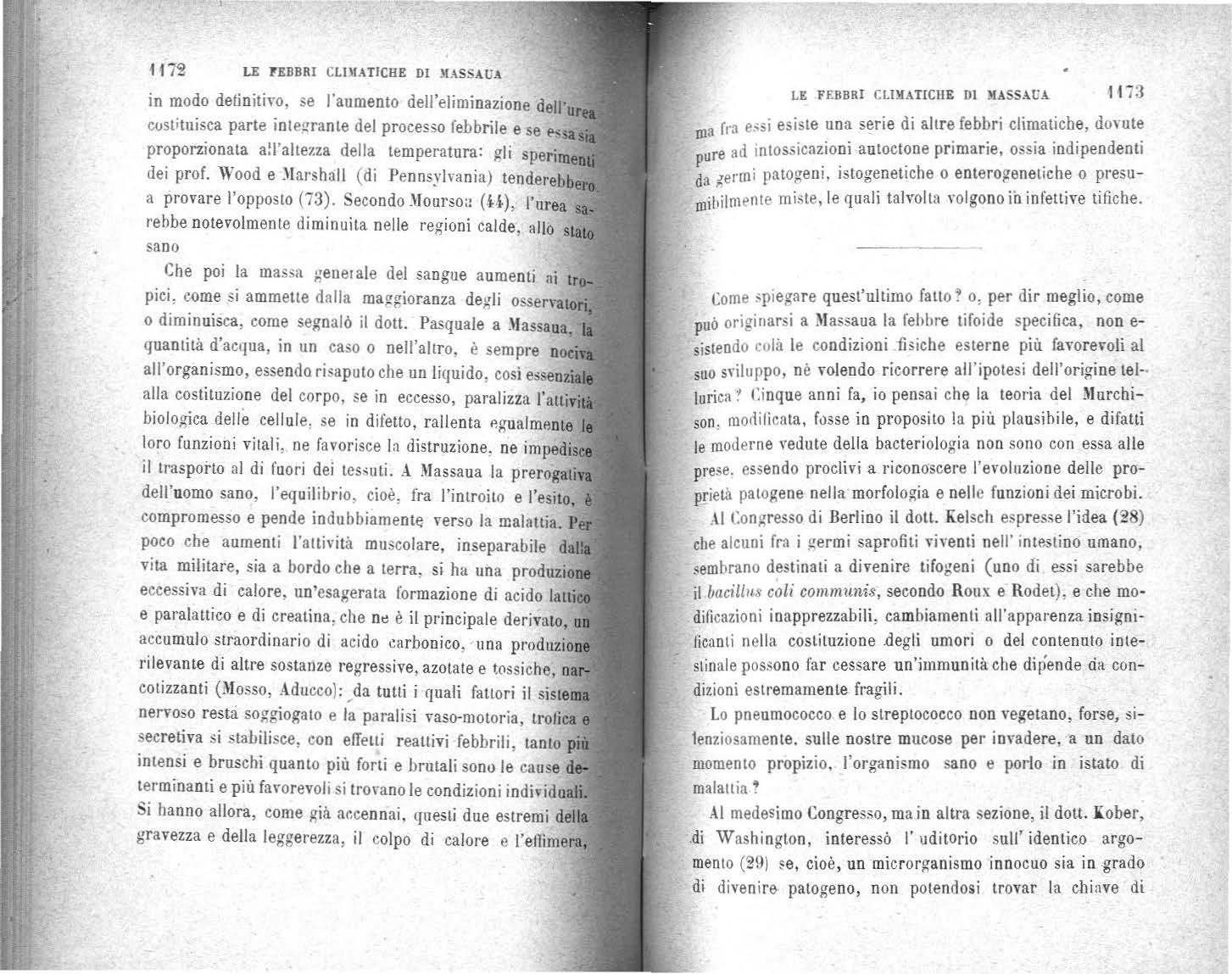
Che poi la mas.>a gener aie del sangue aumenti ai pici, come si ammette dalla maggioranza degli oss o diminuisca, come segnalò il dott. Pasquale a .\f assa ua quantità d'acqua, in un caso o nell'altro, è sempre n ' all'organismo, essendo risaputo che un liquido, così alla costituzione del corpo, se in eccesso, paralizza l' biologica delle cellule , se in difetto, rallenta egualmente loro funzioni vitali, ne favorisce In distruzione, ne imped' il trasporto al di fuori dei tessuti. A Massaua la dell' uomo sano, l'equilibrio, cioè, fra l'introito e l'esito, co mpromesso e pende indubbiamente verso la malallia. poco che aumenti l'atti,•ità muscolare, inseparabile vita militare, sia a bordo che a terra, si ha una produz eccessiva di calore, un'esagerata formazione di acido e paralattico e di creatina, che è il principale derivato, accumulo straordinario di acido una produz i rilevante di altre sostanze regressive, azotate e tossiche, cotizzanti (l'fo sso, Aducco) : }a tutti i quali fattori il <:.1<:-I'Am nervoso resta soggiogato e la paralisi vaso-ruotoria, trolica secretiva si stabilisce, co n effetti reattivi febbrili, tanto intensi e bruschi quanto più forti e brutali sono le cause terminanti e più favorevoli si tro\·ano le condizioni individ uali. Si hanno allora, come già accennai, questi due estremi della gravezza e della leggerezza, il colpo di calore e l'etlimera,
LE FEBBRI CLnlATICIIE Dl MASSA ti A 4 i 73
!lla esiste una di altre febbri climatiche, do,·ute pure ad autoct?ne primarie, indipendenti da patoge nr, Jstogenet1che o o presumiste, le quali talvolta Yolgono in infettive ti fiche.
Come quest'ultimo fatto? o, per dir meglio, come può originarsi a l\lassaua la fehhre tifoide spec ifica, non esistendo colà le co ndizioni :fi;;iche esterne più al suo sviluppo, nè volendo ricorrere all'ipotesi dell'origine tel-· Jurica ? Cinque anni fa, io pensai che la teoria del son, modificata, fòsse in proposito la più plausibil e, e difatti Je mod erne \' edute della bacteriologia non sono con essa alle prese. essendo proclivi a riconoscere l'evoluzione delle proprietà patogene nella morfologia e nelle funz ioni dei microbi.
Al di Berlino il dott. Kelsch espresse l'idea (28) che alcuni fra i germi saprofhi viventi nell'intestino umano, sembrano destinati a divenire tifogeni (uno di essi sarebbe il bacillus coli communis, secondo Roux e·Rodet), e che modificazioni inapprezzabili, cambiamenti all'apparenza insignìficanli nella costituzio ne .degli umori o del contenuto intestinale possono far cessare un'immunità. che dipende àa condizioni estremamente fragili.
Lo pneumococco e lo streptococco non vegetano, forse, silenz iosamente. sulle nostre mucose per· invadere, a un dato momento propizio, l'organismo sano e porlo in istato di malattia!
Al medesimo Congresso, ma in altra sezione, il dott. l(ober, .di Wash ington, interessò l' uditorio sull' identico argomento (29) cioè, un microrganismo innocuo sia in .grado di divenir& patogeno, non potendosi trovar la chiave di
CI.LILI.TICHE DI :liASSAUA
molte oscurità nell'etiologia della febbre tifoide in certe dizioni della vita militare. In appoggio della sua te:;i e suoi casi, altrimenti inesplicabili, citò le osservazioni del chemin, che attribuì appunto ad autoinfezione, a seguito di fatiche eccessive e di brusche variazioni atmosferiche, l' epidemia di febbre tifoide che, nel ·1885, si sviluppò fra le truppe accampate presso )Jarsiglia, colpendo 1560 soldati.
L'anno scorso, al YII Congresso internazionale d'igiene demografia, tenuto a Londra, il dott. Davie:;, Britannico. in una interessantissima lettura sul tema febbre tifo ide in campagna, concluse: ·t • che. a mal della dottrina generalmente sostenuta circa il contagio fico della febbre tifoide, è tuttavia molto diffusa, fra i militari inglesi , france s i ed americani,. la fondala che la malattia possa originarsi spontaneamente: 2° che, al bacilltt$ typhi abdominalis, ve ne sonò altri, s connessi con esso, tanto da non poterli distinguere in caso- bacilli ordinariamente saprofitici - che hanno un etiùlogico con la febbre tifoide: 3o che la teoria pitogenica dell'autoinfezione si fa avanti e concorda con la teoria riologica su!l'origine delle malattie, ammettendo la possibilità dell'evoluzione delle proprietà patogene per mezzo di sue• cessive generazioni microbiche.
L'idea che infor·ma questa dotLrina evoluzionista di cilli innocui in bacilli eberthiformi tifogeni, per qua nto i matura, è degna di considerazione, checchè Chante Perdrix e Vidal abbiano detto in contrario, il Dubief a dipoi infir mato l'assoluto positivismo delle loro obbiezion i Ii dott. Lucatello (39, pag. 346) ne fece oggetto d'una bre comunicazione all'ultimo Congresso di Roma, nota ndo nell'epidemia di Genova il bacillo di Escherich primegg iò al reperlo hacteriologico in quantità straordinariamente el evata.
LE FEBBRI CLL\IATICHE DI llASSAUA 11 i5
Più convincenti sono per me le conclusioni recentissime, ubblicate per le stampe dal dott. Vallet in una pregevole (7 1) '\ e indirizzate a sLabilire, sulla base di criteri critici, di ricerche batteriologjcbe e di studi sperimentali, l'unità specifica del bacillo di Eberth e del bacillo di Escherich, la loro rassomiglianza e variabilità morfologica e quindi la possiòilità che l'uno sia scambiato per l'alt!'O, l'identità dei loro effetti patogeni, il diverso loro modo di comportarsi nel cryntenuto delle fosse escrementizie per ciò che ri)!uardn specialmente la virulenza loro, infine il potere _che il ba.cilllt$ co l'i communis, ospite abituale del nostro mtest mo, acquista in certe circostanze . Si tratta , in somma, di sosti-. tuire alla teoria classica, spesso insufficiente , un'altra teoria più plausibile e seducente, quella dell'evo luzione delle propnetà patogene di un bacillo ordinariamente innocuo. È in certo modo richiamata in onore la teoria del Murchison , non come sv;Juppo spontaneo, de novo, dell'agente infettivo per fermentnzione delle materie fecali, ma come evoluzione autoctona della sua virulenza, indipendentemente da un anteriore.
Epperò, qualunque sia il germe saprofìta che nell'intestino uman o evolva in tifop;eno, e comunque esso si chiami, sia oppor no tifo- simile (typhtt$iihnlir.h di Hneppe), io arrischio pensare che a Massaua, dove il chimismo gastro-enterico e generale organico subisce modificazioni significanti, anche il bacillo di Eberth e Gaffky, annidato insidiosamente nell e recondite oscurità del tubo intestinale e vivente allo stato virtuale, possa, a un dato momento e in date condi-
("} Ne ho avuto conoscenza ed ho potuto leggerla, dopo che il presente lavoro si trOYava già in tipografia per la eomposizione, in tampo utile, parò. per citarla in aggiunta ed appoggio alla tesi che
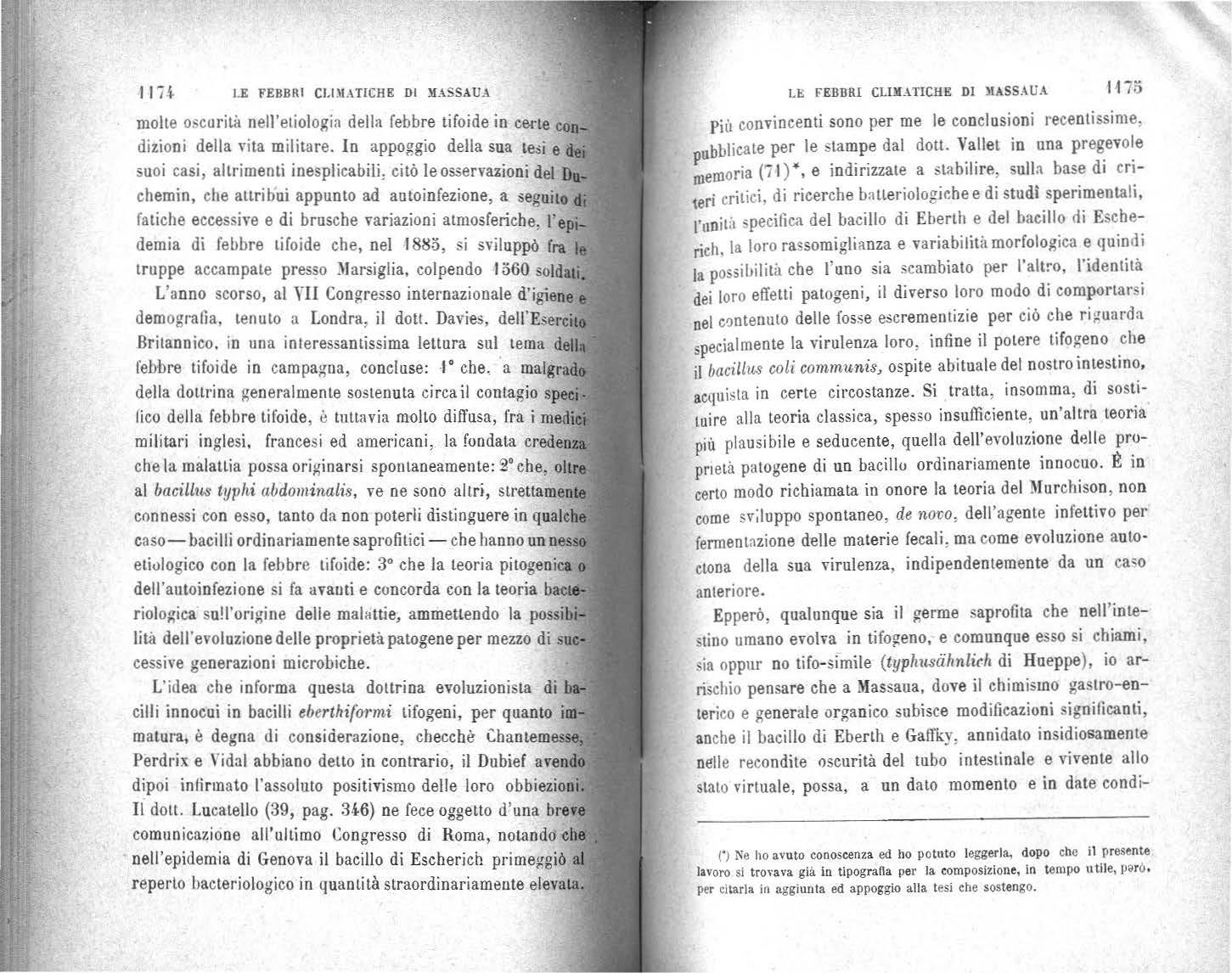
H/6 LE FEBBRI CLIMATICHE DI lfASSAUA
zioni di recettività individuale e di concorrenza vitale, gredire l'organismo e sostituire la febbre da infezione propria (tifotossica}alla fehhre da autointossicazione p · iniziale, pregressa o in atto, la quale predisporrebbe ad aprire la porta al germe specifico e così ne r-es, ..,,.,.n..A , trasformata ed aggravata. Questa è l'ipotesi che a me s più in armonia coi fatti osservati e con le più recenti dute della scienza.
Conclusione.
Lo studio del clima di )lassaua, messo in rapporto co n fisio-patologia e eo n la bio-chimica, mi ha a mulare l'etiQlogia delle febbri ivi predominanti, nel seguente :
1o Gli elementi climat ici dell'atmosfera massauina. preferenza i termo-igrometrici, per l'intensità e con tin dell a loro azione sull'organismo europeo rappresentano cause febbrigene remote.
2° Le variazioni patologiche, che per essi ne der· al medesimo organismo, p1·incipalmente nella termotassi, sistema nervoso e nel ricambio materiale, sono le cause sime delle piressie , dal colpo di calore o febbre termica eccellenza, alle effimere ed alle climatiche propriamente
3° Tutte queste febbri sarebbero da autointossica zi primarie.
4° Esse preparano il terreno al germoglio degli organizzati e, tendendo per loro natura al tifismo, pred gono all'infezione specifica, per evoluzione autogenetica germi viventi nell'intestino, e si aggravano in tal caso di autointossicazioni secondari;.
LE F&BBRI CLIMATICHE DI MASSAUA 1177
Essendo pervenuto a questa conclusione, dopo aver preso le mosse dal clima di Massaua, mi si consenta da ultimo ritornare su di esso, per esprimere il voto che il Governo dell'Eritrea mandi ad effetto le proposte che il prof. Tacchini fece, fin dal 1890, per il miglioramento del servizio in quella nostra colonia: ciò ch e si è fatto finora e troppo poco.
(l) ALBERTONl e STEFANI. - Manuale di fisiologia umana, Milano, eJ. Vallardi, 1886.
(2) ASSMA:'\'N. - Ueber die Beziehungen zwischen Krankheiten und meteorologìschen Vorgiingen. (Verhandlungen d. x internat. m ed. Congresses , Bd. V, X VI Abth. (Medicinische Geographie und Klimatologie), Berlin , Veri. v. Htr· schwald, 1891.
(3) BARBATELLI. - Mia permanenza p, Massaua dal giugno 1887 al maggio 1888. Brevi osservazioni climatologiche e cliniche. (Giornale medico del R. esercito e della R. Marina , N. 10, ottobre, 1888).

(4) BEAU:-Its. - Nouveaux éléments de ph!fsiologie humaine, Paris, 1881.
(5) BtRt.NGErt- FÈRAUD. - De la jlèo re dite bilieuse injlammatoir e aux Antilles, Paris, 1878. Traité des maladies de.s Européens a la J1artinique, P a ris 1881.
(6j Boaws. - Recherches sur le climat du S é négal, Paris 1875.
(/) BoRtuS. - Topographie médicale du Sénégal, (Archives de Médecine navale, Paris, O. Doin. éd., 1881 - 82.
(8) B01mrs. - Les maladies du Sénégal, Paris, Bailliére éd., 1882.
478 LR FEBBRI CLIM.HICHE DI
(9) BoucHARO. - Théorie de l'infection, ( Verhandl. d. int. med. Cong., Bd. I , Allgem. T heil, Berl in, 1891.
(10) BuRoT. - De la ,tléore dite bilieuse inflammatoire à Guyane, Paris, 1880.
(11) CANALIS. - L'igien e e gli studi bacteriologici. sione al corso d'igiene dell'ann o scolas tico 11390·91 nella Univer sità di Genova. (Rioista d'igiene e sanità anno II, 1891, Roma, tipografia delle Mantellate).
(12) CANTù . - Le teor ie dell'immu nità. Rassegna criti ca (La medica, magl<iO 1890).
(13) CHIAIS . - Le climat de Menton pendant la h i oernale, (Verhand. d. X int. med. Co ng., Bd. v, x Abth., Berlin , 1891.
(H) CoG:sETTJ. - Appunti di geografia medica sul ài Mas saua. (Giorn med. del R. Ese r cito e della R. N. 7, luglio, 1887).
(15) C oRRE - Traité des /lèores bilieuses et typh ique8 pays chauds, Par is, O. Doin, éditeur, 1883 .
(16) C oRRE. - Traité clin i que des maladies des chauds, Paris, O. D oin, éditeu r, 1887.
(1-7) De CoNCILII S. - Cont ,.ibuto allo · studio d elle climatiche di J1assaua (Gio rna le medico del R. esercito della R . marina, N. 2, febbraio 1889).
(18) D E LT EIL. - Considé rations su r le c limat et la brité de la Réunion (A rch . de méd. naoale, 1881).
(19) D UTROULAU. - Traité des maladies des dans les pays chauds, Pari s 1880.
(20) EsCLANGON. - Rapport médical sur Obok méd. naoale, 1889).
(2i) FAYRER. - T h c c limate and feo ers of India, ....v u •IJ'a,; J. and A . Churchill, 1882.
(22) F E:RIS. - Étude su r les climafs équato r i a ua: (A de m éd. naoale, 1879). .
(23) FONSSAGRI VES. - Tr aité d'hygièn e na oale, Paris, Baillière, 1877.
(24) H AECKE L. - Natùrliche SchOpjungs-Geschichte, V Aufi., Be rlin, i 889.
LE FEBBRl CLIMAT ICHE Ol MASSAUA · 109
(251 H•RSCH. - Ilandbuch der pathologie, Il Aufl , I Thell, Veri. v F. Enke,, i881: m(27) KELSCH et KIENER. - Tra ité des maladies des pays cllauds (région p r ét r opicale), Paris, Ba illière, éd iteu r , 1889. t28). KELSCH -De la}ièvre tgphoide dans certaines conditions rle la vie militai r e ( Verhandl . d. X int. med. Coitg r ., BJ. V, XVI Abth ., Berlin, 1891) . i30 LAVf:RA N. - T rllitédesjièo r esp{Llust res, P aris, O. Doin, eàiteur, 1884.
(Z6) - l'acclt mat ement et de l accltata tion, O. Dom, é<hteur, 1884.
(29) - A contribution to the etiology oj l!Jphoi d (eoer, ( Verhandl. d. X. i nte r nai. med. Cong r., Bd. V, X V ·Abth. (H ygieine), Be rlin, 1891 ).

(30) KocH.- Ueber bakte rio logische F orschu ng (Verhandl. d. x. int. med Congr.,· Bd. I , Allgem. Theil, Berlin, 189 1,.
(321 LAYET. - Étude d'hggiè n e i ntertropicale ( Arch. de méd. navale, 1877).
(33) LF:YY.- Traité d'hygiè n e publique et prioée, Paris 1881. LICATA - Assc:b e i Dandchili, Milano, editori Tre\·es. 1890. .
Traitédeclimalologiemédicale, Paris, 1880.
(3G). MACCAGNO. - Cenni ed appun t i di patologia massauense (Gior nale medico del R. esercit o e della R marina, 9, settembre, i887).
(37)MAGGELSEN. - Uebe r die d er Krankheiten
11on de r Witteru ng, (Uebersetzt von W Berger ), L eipzig, 1890.
(38) - Programme de séméiotique et d'étiologie pou r l'étud P. des maladies e:xoliques et p r incipalem ent des pa ys chauds, Paris, 1880. •
(3!J) e LucATELLO. - La oo r i dei congress i di med icina inte rna !IV Congresso ten u to a R oma nell'ottobre 1891), Milano, editore V allardi, 1892.
(40) :\IARESTANG. - Hématimétrie normale de l'Eu ropéen auz pays ehauds (A r eh. de méd. naoale, 1889).
(.U) :MAUREL. - Hématimétrie no r male et pathologique des pays chauds, (A rch. de méd. naoale, 1884)
(42) MAUREL. - De l'influence d u clim rd et de la race su r
LE FEBBRI Cl.l'IA TIC HE IH liASSAUA la température de l' ho mm e !Bu lle tin de la Soeié t é d' A n polo[Jie, Paris, 1884).
(43) MAURY. - Geograjla fisica del ma r e, trad. dall'ingl.
(41) MouRsou. - No te su r les va r iations de l'urée éli· minée pa r les rei ns ,çuioant /es climats tempéres ou ehauda, (Il rch. de méd. navale, 1881).
(i;)) - 11 Trea tise on the confi n ued /eoera o.f Great Britain, II ed , London, 1873.
(46) Souoeau dictionnaire de médecine et de chi ru r9ie pratiques, Art. Climat (Roc!Jard), vol. VII l , Pat•is.
(n) ORGF:AS. - L'l p atho logie des races et problème de la co lonisation, Paris, O. Doin, éditeur, 1886.
(i-8) OvERBECK de MEYER. - Ue be r den Einftus$ des pisch en Kl im as auf Eingewanderte aus hohe re n uber d as Ver halten derselben dt3fL in den Tr open h errschenden Krankll ei ten gegenilber, und uber dù: M ogliehkeit àe ,. Acclimatisation oo n Eu ro paern und No r d - A merikanern i n den Tropen (l'erha n dl. d. X. internat . med. Co n gr., Bd. V, XVI
(49) PAN ARA . - L'ospedale da eampo in Mas saua e le ce nde sanitar i e del corpo di spedj;ione dal .febbraio al settembre 1885 (Giornale medieo del R. esercito della R. ma· rina, N. 4 e 5, april e e maggio 1886).
(50) PASQUA LE. - Nota preoe nlioa sulle febb r i di Massau.a, (Giornale medico del R. esercito e dell a R . marina, N. 5 e 6, maggio-giugno, 1889).
(51) P ASQUALE. - Sul tifo a Jlfassaua. Studio clinico ed osservazioni batteriologiche (Gio r nale m edico del R. eseréito e della R. ma rin a, N. 7, luglio, 1891).
(52) PASQU ALE. - Rieerch e batte r iologiehe su l cole ra tJ Ma ss aua e eons ider azio n i igien iehe (lbid., N. 8, agosto, 1891).
(53) P ASQUA LE. - Studio e tiolog ico e clin ico delle malattie febb rili più comuni a Mass aua (lbid., 11 e 12, n ovembre e dicembre, 1891 )
(54) P ETELLA. - In'solazione e colpo di calo r e (G iornale merlico del R. esercito e della R. marin.a, N. 6 e 8, giugno e agosto, 1890).
(551 PRtCHARO - His lo i r e nature /le d e l'ho m me, Paris, 18\ 3.
(56l RATTR.>.Y . - [njluence du régime, du clim a t et des ooyages la santé des d éduite des oa r ia · tions de leur pctds. T ra t!. de l"au ;lai;; (Ar ch de méd. na· vale, 186H). .
(57) RATTBAY. - On s-o me of the m ore tmportant physiological clta n ges induced in the human economy b!J ehange of climate ( Procee din.[}s o.f the R oy a l Society, 1871). Voltato anche in fr ancese negli A r ch. de méd . navale, 1872.
(>8) - L'aria . (Patologia e terapia medica speciale d i Ll·ad. ital., vol. I, parte I, Sez. 2•)
59) - Ueport on the Egyptian p r ooi nces o.f the Sud.an , R ed Sea anrl Equato r , compiled in the I ntelli genge Branch Quartermasler-G eneral's D epa rte m ent, H o r se Guards, \Yar Offìce, Lon do n, 188i.
(60) R1cBET. - La chaleur animale, Paris, 1889. - E:x:pér ienc es su r la polypnée thermique ( Verhandl. d . X. infe rnat. m ed. Cong r. , Bd. II , II Ablh.- (Physiologie uncl physiologisehe Chemie), Berlin, 1891.
(61J RHo. - allo s tudio delle piressie ptu co mv.ni a Massaua (Giorn ale ·medico del R. ese rc iio e della R. marina, 12, dicembre. 1886).
(62) RHo. - Dell e febbri p redo min an ti a M assaua (Rioista clinica -- A r eh ioio italiano di clin. iea me dic a, Puntata III. 1891). v. Nota a piè della pa g . 300.
,6:3J SErTz. - Le malattie da r affreddo r e ( Pa tologia e te· rapia mediea speciale di Zienissen, trad. it.al. vol. Xl 1J, parte 1)
(6t) SQUtR E. - The typho -mala r ial feoer (The Lancet, jan 188i). _, r65) STOK\'JS. - Ueber r;e r gle ichende R assenpathologie und die Widersta n ds(i.ihigkeit d es Europà er s in den T ropen. (Verhan.dl. d X int e rnat. med Cvngr., B d. I. l\llgem. Theil, Berlin, 1891). .
(66) S roPPA :-ol. - Co rs o di geologia, vol. l , M1lano, 1871, parte II, cap . Il.
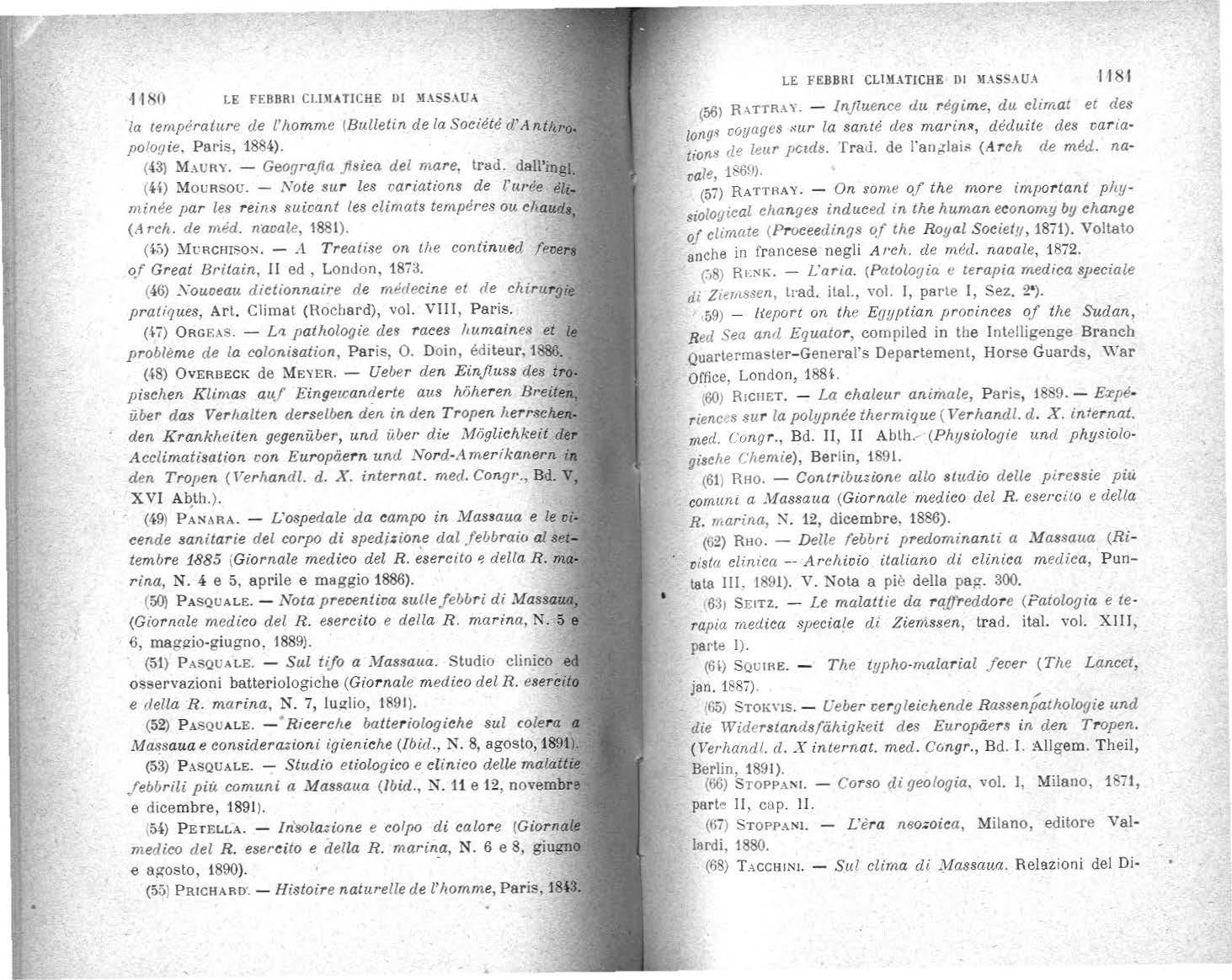
(67) STOPPA NI. - L'èra neo.;oica, Mi lano, editore Vallardi, 1880.
(68) T.-\CCHINI - Sul clima di Massaua. Relaz ioni del Di·
1182 LE FEBB RI CLI)lATICHE Dl MASSAUA r ettore dell'Ufficio centrale di meteorologia a nistro della guerr a (Annali della meteorolooia parte I, 1886).
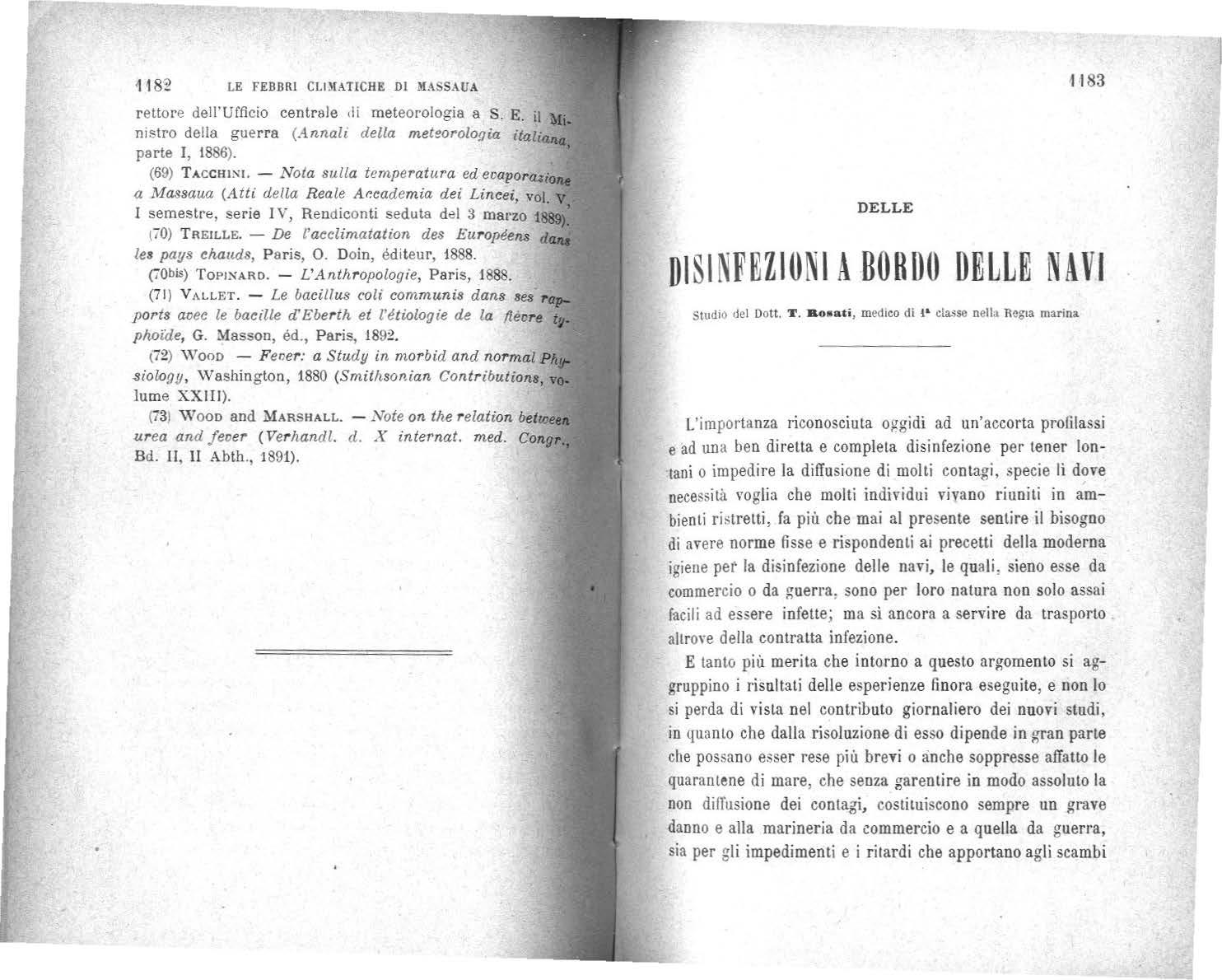
(69) T Ac CRI='I. - Nota sulla temperatura ed evapo a Massaua (Atti della Reale d ei Lineei, vo l. I semestre, se rie I V, Rendicon ti seduta del 3 marzo
(70) TR EILLE. - De l'a eelimatation des Eu r opéens !e s pags chauds, P a r is, O. Doin, éditeu r , 1888.
(.'Obis) ToPJNARO. - L'Anth ropologie , Paris, 1888.
(71 ) V ALLET - Le baci ll u s coli communis dan s ses ports aoec le baeille d'Ebe r th et l'é tiologie de la M ore phoi"de, G. Masson, é d., Paris, 189 2.
(72) "\Vooo - F ene r: a Study in morbid and no r m a l .s iologu, Washingtoo, 1880 (Smit hsonian Contributions, lume XXIII).
(73) W o oo and M ARSH ALL. - Note on the r ela tion urea and feo er (Verhan dl . d. X internat. med. Bd. Il, Il Abth. , 1891).
Dell E
Di Sinfe Zio Ni Abordo Delle Navi
L' importanza riconosciuta oggidì ad un 'accorta profilassi e ad una ben diretta e completa disinfezione per tener lontani o impedire la diffusione di molti contagi, speci e li dove necess ità voglia che molti individui vivano riuniti in ambienti ristretti , fa più che mai al presente sentire il bisogno di avere norme fisse e rispondenti ai precetti della moderna igien e pel' la disi nfezione delle navi, le quali , sieno esse da commercio o da guena, sono per loro natura no n solo assai facili ad essere infette; ma sì ancora a servi re da trasporto , allrove della contratta infezione.
E tanto più merita che intorno a questo argomento si aggruppino i risultati delle esperienze fi nora eseguite, e non lo si perda di vista nel contributo giornaliero dei nuovi studi, in quanto che dalla risoluzione di esso dipende in gran parte che pos sano esser rese più brevi o anche soppresse affatto le quarantene di mare, che senza garentire in modo assoluto la non diffusio ne dei contagi, costitui scono sempre un grave danno e alla marineria da commercio e a quella da guerra, sia per gl i impedimenti e i ritardi che apportano agli scambi
1184 OEI.I.E A BORDO DELLE commerciali, sia per l'inazione alla quale rid ucono i nav armati ('1).
D'altro canto gli i mportanti studii sperimentali degli u tem pi avendo diradato dal campo delle malatti e infettive, meno per gran parte di esse, la nehbia fitta dei falsi SU JlDOisb":: e delle argomentazio ni empi riche, si impone oggi ma mente il dovere di non trascurare a bordo dell e navì a dei preceLLi consigliati dall'esperienza, dovendosi ad essa ad u n serio fondamento scientifico rattuazione di quei vedim enti che sono eitenuti meglio alli ad ottenere una fetta disinfezione.
Ond'è che se nza perdere di vista le speciali co nd · nelle quali è forza si svolga la vita collettiva a bordo di naviglio. spec ie se da guerra, avendo pur troppo le e le previsio ui di qnesla imposto che aria, luce e spa zio tutti ceduti al cann one e all e macchine e l'uomo asse rva essi , e senza allo ntanarci dall'avere la dovuta con delle odierne costruzioni navali, cerche remo di esporre fra le pratiche di . disi nfez ione che sono da preferirsi navi, e il modo più co nveniente di eseguirl e in relazione svariate conti ngenze di necessità e di urgenza ed alla natura degli ambienti.
Certo che disi nfettare una nave non è dis infettar e un ficio o un quartiere, sia per la impossibili tà che spesso oppone di vuotarla affatto delle persone, sia per la di non potersi in ogni caso e per tutti gli ambie nti indifferentemen te di quei mezzi ri c(lnosciuti i atti vi sono i mezzi disin fetta nti ai quali fin da tempi non vicini si è ricorsi per combattere i contagi, ed anche oggi, nonosta nte dalla maggior parte degli scienziati ed esperim entato ri si accordi fiducia solta nto a pochi di q uesti agenti, non si può di re es ista un 'assoluta uni for mit à di cl'iterii nel dare la prefer enza all'uno piuttos to che all 'altro . lovero, mentr·e in Germania non si crede , diremmo , che ·olo al potere del subl imato e dell' acido fe nico, in Francia ed in Russia si lodano le virtù di altre sostanze come ad esempio le gassose, ed in Italia si pencola fra l'una opinione e l'altra.
DELLE DlSI:'iFEZIO:-ìJ BORDO DELU "A \'I 11 85' efficaci. donde la necessità. di sapersi avva lere di ciascuno di essi in rappol'IO alla natu ra del male la cui difl'u:;ion e si intenda combattere, ed a quella delle condizio ni di luogo, di persone e di co:;e su cui essi mezzi debbano agi re. Perciò, e perchè presso di noi non esiste un vero e propri o regolame nto per le disinfezioni su lle navi. nonosta nte non facci ano difeUo :>cru po lose prescrizioni e premure da parte delle civili e militnri , nel raccoglie re ed esporre nel pre.sen te lavoro quanto vi ha di più accertato dai rece nti studi sulla attirità ed efficacia dei migliori disinfetlanti, per l'appli cazi one <ii essi non sapremo di molto staccarci dalle norme prescritte nel regolamento germanico, il qual e ollre che informato ai ri sultati delle ult ime esperienze, è senza du bbio :<pecialmente pregevole per le minuziose e precise disp osizion i ( l ).
Quali che si possano essere i vari giudizii intorno al pote re bacteric ida dei diversi agenti, per le di sinfez ioni delle i{)
(t) Di ratto nella conferenza sanitaria internazionale tenutasi a Venezia gennaio di q uesto anno, fu stabilito di accorJare il passaggio io n naran•prima di cinque giorni a quelle navi che avendo a bordo un medico e parecchio di dlsinrezione potessero pratica.rla secondo le norme ( P1·oLocollcs et procè& verbeaux àe la con(erence san itaire internationiJÙ Veni st, 1892) .
(l) Oi questo regolamento feee l'anno scorso minuta relazion e il dott. Onimus della marina rrancese negli Archives de m èàicine navale. et co loniale (N. 8).











