
55 minute read
RIVISTA
potranno far riconoscere un tumore situato ne ll'unione dell'S iliaca e del retto.
La palpazione rettale indicherà la presenza di un cancro, se la lesione risiede più in basso.
Advertisement
Nella forma ulcerata i souo più caratteristici.
Dapprima, si rirerisce spesso !"emorragia alle emorroidi. Si commette questo erro r e nei malati uffetti da cancro rettale. È quindi necessario essere prevenuti. E tanto più facile ingannarsi inquantochè il canc t·o è soven ti causa di emorroi di che , salvo forse una certa esagerazione dei fenomeni dolorosi, sono in tutto simili alle emorroidi ordinarie .
si confonderanno di piu le emor·t•agie rettali del cancro con quelle della dissenteria o della tabe nell'inizio .
La ragade anale può anèhe essere una causa d'errore. Quando infatti l'ulcerazione si estende fino alrano e gli spasmi do lorosi, pt·ovocati da essa, sono violenti, si può credere ad uno spasmo vet·o dello sfintere. Ma nella ragaJe, non siriscontra nè restringimento del retto. né sintomi di occlusione intestinale. Questa occlusione, nei malati che hanno un'u lcerazione, è il più spesso Acutissima, e provoca un vivo dolore. Essa é dovuta agli spasmi dell'intestino causati dall'ulcerazione, la quale può risiedere in diversi luoghi. Se essa non occupa che la superficie del cancro, ti dolore è fisso e localizzato. ì\la accade qualche volla che il soggiot·no troppo prolu ngato delle materie nell'intestino cagioni l'inOammazione della mucosa e poco dopo l'ulcerazione .
Si è allora in di varie ulcerazioni; il dolore cha era localizzato nel caso precedente si generalizza e si irra· dia In una porzione dell'addome. Gli spasmi dell"intestiuo sono pi.i frequenti e più dolorosi; l'emorragia. è anche più lo presenza di questi sintomi non si deve tr ascurare la palpazione rett.al c, perché si è in di ritto di temere un cancr o. È una reg:ola assoluta che pet·metterà di evitare eno ri so· venti rinct·escevoli. Ed auche quando nu lla si sara ri levato colla palpazione, non si concluderà con la non esistenza di un cancro, il quale può risiedere ad un'altezza inaccessibile al dito.
É ancora utile praticare in questi casi la palpazione e la percussione della parete addominale nella fossa iliaca che unite allu palpazione relt ale, possono fa<:-1litare molto la diagnosi.
Il cancro ulcerato del retto, oltre l'emorragia, è ancora accompagnato ùa scolo di mucosità e di siero- sanauinolento
" Raramente è stato osser, ato l'ingorgo ganglionare nelle forme ad andamento latente del cancro del retto .
Ma quando il chit•urgo ha constatato l'esistenza di un lu· mot·e o di un' ulcerazione, deve ancora cl"iff"erenziarl a dall"ulcerazione tuber colosa e dal sifìloma ano-rettale. tubercolosa, i margini sono pigmentati, Yiolacei, scollati, soveuli ricc hi in g ra nu!azioni lubercolose. La base é cedevole, molle, po<!O indurata. Il malato può es· sere affetto Ja tubercolosi polmonare. . .
;>;el sifiloma ano-retta le, l'uno presenta induraziom, plea forma ondulata, tal volla conditomi . Il dtto esp_lorator e t·iscontra nell'intestino una porzione du ra, fibrosa, mestensibile, cilindrica, con scanalature sporgenti e al di sopra una porzione molte, ulcerata, segregante un _pus. Cettdo, c aratte· ri stico. Il malato ,.resenta altri segn1 dt Sifilide.
Nel cancro, il chirurgo terrà conto dell'età del m_alalo e la palpazi one fll rà s entire una massa fungosa sanguinante, ineguale, bitorzoluta, irregolare, con base mdurita e diffusa.
Infine, se il cancro si è esteso alla pat•ete anteriore del r etto , esso può p-ropagarsi alla vescica. . , fecali e gas sfuggono all ora per 11 canale uretra. Questa novella complicazione richiamerà l'attenziOne e permetter à di riconoscere la presenza di ull
L'evolu zione lenta e senza esercitare alcuna aziOne sulla salute generale è uno dei p-randi caratteri del cancr o de corso latente del r etto. I malati sono da mollo tempo tn preda alla loro affezione senza che nulla possa supporre.
Generalm ente i rivelatori della malattia s1 presen- tano in un IUOLiD in,.idioso. E q uando il chi t•urgo può rare la sua diap-nosi, i mortali non tardano a compa rire.
Esf'i sono quelli dell'occlusione intestinale c r onica nelle forme non ulcerate o quelli dell'occlu sio ne intestinale a cutissi ma, se esiste una o piu ulcerazioui.
Nelle os ser,·azioni citate, i ma la ti non hanno ma i presentato la tinta !!iallo -pallida, così ri cercata altre YOlle . Essi non hanno presenta to che ra1·amenle una gen er•alizzazione, sia a l fe!!ato, sia a i g an gli linfAtici.
Essi soccombono quindi meno per la loro lesione cancerosa che per l'occlusion e cr•ns ecut1va a l neopla sma._
P1•ol>a b1lm en te. in pr esenza de ll'ulcerazione intestinale so,·enti considere,·ole . a,·v1ene una auto-inlossica1. =one più g rand e che nello strozzamento sempl ice e capace di determinare la mor te . Il caso del professore RenilUt, che ha pubblicato un'osservazione di sitìlo ma rettale ulcerato, in seguito al quale sopraggiunsero g ra vi sintomi di auto-intossicazione, v e rrebbe in a ppoggio a questa ipote si.
La di queste forme di cancrc• è poiche a ll'infuo ri si devono se mp r e temere le complicazioni che mettono in peri colo la vit a del malato.
La c ura chiru r gica in presenza d i un cancro d el retto e sopra ttutto ùi que i cancr i con eYoluz ione latente in cui i pri mi sintom• sono que lli dell'occlus ione inteslillale croni cu acutissima, consisterà nel praticare quasi sempr e un ano ilia co. I ma lati possono , per qualche tempo, .t.l'arre beneficio da questa o pe razione, sopr!ltlutto fino a che no n si pro,lurrà ulce r azione, sia rlel ca ncro, sia della mucosa intestin ule. L l:l cura medi ca consisterà nel cal ma re i dolori, nel facili tare le e vacuazioui e nel sostenere le forze del malato.
Della. creazione dl un' uretra contro naturanelpro•tatl ol.
- SALYA T OR Bo1\AN - (Journat de médecine et de c!tirurgie, 1892).
Il dotto r Bonan ha descritto un'ope razione c he il professore P oncet ha immaginato e p ra ticato varie volte pr ol:otatici e che può rende r e grandi se1·vigi.
Chi Rurgica 1597
s otto il nome di <'istostomia sopra-pubica, P once t designa un 'operazione che ha per iscopo, in certi mala ti, eli imp iantare un'uretra contro natura nella r egione ip•Jf!a.5lr•ca; as·cura io tal modo lo scolo continuo dell'orin a per una bocca l 888 ve«cicale pa•·ago nabile ad un ano contro Mtura. F u ne l che il P oncel. ha praticato tale operazione per la prima volta, dopo d'allora l'ha fatta 33 volte. Quasi nello stesso : senza av er conoscenza del proced imento .11 dotto r "Mac Guire . american o, concepiva un' operaz1one simile ed - è giunto n conclusioni identiche.
Le indic a zioni della cistotomia sopra- pubìca posso no esse re riferite a tre ordini di fatti .
In primo luogo, soavi i o di tli fficoltà dE'l catet'erismo per causa meccamca, deformazwne del d'origine prostatica ecc. In secondo luogo, per e vitare accidenti infettivi che aiun,.ere dopo false strade e quando catete r1 sm' frequenti, d ol orosi , mal sopportati, devono t>gualmente far temere acciden ti settici. . . .
Infine per lottare c on tro i fenomeni òi orlna ria g ià esistenti, e che, n t>lle manovre ri petute 111 c 1asru n gio rn o di -cateterismo, n on posson o che aumen_ta re P er P oncel l'operazione e an che necessaria ' luand o le difficoltà del cateterismo sembrano esigere l'uso della s onda in sito , la quale, nei pros tati: i, è un parte Jei fenomeni infell1v1 81 quali es,-a da cos1 o rigine. . .
Lo stesso dicasi quando alle difficoltà del rateler1smo aJ a ggiungersi la sua frequenza, esem p!o 1.. 'tabililà vescicale esi?e oLto o d1ec1 cateten.m1 nelle _4 1rr1 r · n 1 o re ed anch e piu. Esi s ton o a tlora fenom eni ' 1 c1s 1 c c 1e non a uarisco no che coll'a pertura della ves cica alle contr oind icaz ioni, esse sono quasi nulle; esse dipendono solianto dal cattivo stato del malato, dal suo indebolimento es tremo e da lle les1ont a da pa r te dei re ni. Anche nei casi più gra il c1stotom1a ' mane nncOI'("\ J'ullima risorsa . Essa costitUISCe d e l resto rl ., . . 'l t un'ope razion e gravezza : nell e 35 osservaz10111 Cl a e, la morte uon fu mar né dalla peritonile né d Il'' fìlt · · ' a m- raziOne urmos11, e. praticata sotto !"anestesia, essa è di breve durata P. non espon e allo shock traumatico eh é molto da temersi nei vecchi. e non differ·isce molto dal taglio ipogastrico e fìnt,ce colla sutura della vescica alla JJarete addornin 1 L ·d·t· d l . . a e. a ra p1 l a e l operazioue é una buona condizion e 0 p 0 c ed l . d' . ncet r _ e c 1e m tect o dodici minuti essa debba essere te _ mmata. r

Le c_ure consistono dapprima unicamente nelle d1 proprietà nPcessarie per impedire l'irritazione delle pat·h che sono costante mente tmb1·attate dall'orina per•ch · i pri mi gior·ni, durante le prime l a poco a poco per il meato ip ogastrico. Non 11 benessere del ma lato è considerevole, il suo mig lioramento immediato è enorme, ed è urgente il non dinulla il ri pos? salutare che tien dietro alle prove d t. cateter1smo e a1 dolo t't della ritenzione della cistite. Poa poco a poco le cose !'i modificano, l'orina che dapprtma era evacuata a mano a mano che Ri produceva è trattenuta di _più in più pe r lun go tempo nella vescica . Per la sua. sttuaztone tra i margini interni dei due retti anteriori gh formano un'ansa contrattile, per la sua Juno-hezza dt tre centimetri in media, talvolta più per la st7a obliq_mta dt basso in alto, in!lrle per la sua ristrettezza cica triztale, t! condotto nuovo può r<>ndere lo stesso servizio dell'uretra no rmale.
Nei casi favorevoli, l'orina e traUPnuLa per più ore (4-5 ore). Pre\·enulo dal bisogno d'orinare, l'operato può vuotare sua vescica, sia spontarieamente, sia meglio ancora meuna .sonda introtlo lta nel meato ipogastrico. Nei casi 111 CUI p_ers1ste. incontinenza non si do vrà dimenticare che questa. ha un' importanza secondaria, poiché si trat_ta Il p1u spesso per il prostalico di una <Juestione. di vita o eh morte.
. vi st può rimediare con apparecch i otturatori ti cut uso è anche necessario per evitare l'atresia troppo grande ed anche la chiusu ra Jell'orifìcio. Vi he. una ecce-
CHIRURGICA '1599 zionr, ed é il ca so in c ui rurinazione si ristabilisce per }'uretra normale: in questo caso si deve favorire I'obliterazi onc del canale artificiale. }fa ciò è un fatto talmente raro da non potervisi contare.
Nella grande maggioranza dei casi , l'orifizio é conservato e ,;.t malAti, ill cui situazione era assolutamente di!'perata, ristabilirsi in salute e ripren de re la loro vita quasi normale-, abituandosi ad una infermità, la quale non è molto pii.t pP. nosa della necessita di ripetere frequentementè il cateterismo.
L'artrotomia nelle lussazlonl antlohe trreduclblll . -
PBRDRL\T.- (Jou r nal de Médecine et de Chirurgie, giuano 189t) .

La antisettica permette di rimediare ora ad infermità per l'addietro incurabili che le lussazioni irriducibili lasciano <:Osi spesso dopo di esse. Si tratta di praticare op•'razioni molto ùelicate, ma di cui qualsiasi chirurgo deve conoseerne ·Ie indicazioni Il dottor Perdrial ha studiato quesla questione in modo co mpleto' ed ha dimostralo con numero!'e osservazioni gli eccellenti risultati che si possono in tal modo ottenere. Il dottor Ricard, per esempio, in malati ridotti ad una impotenza completa io conseguenza di una lussazione antica dell'anca , ha potuto con pieno successo ricostituire colla sgorbia, col raschiatoio e col mazzuolo la cavità articolar·e e reintegrare in questa nuova cavità cotiloidea, !'<ia la femorale stessa, se esc:a non è troppo deformala, sia solamente il collo, se si è stati obbligati a resecat·ne la. testa, per·ché la sua reintegrazione era di"entat a impossibile, ciò t'be è il caso t:>iù frequente.
"tessa guisa, Lucas-Championniére, per una lussazione antica della rolula in fuo r i, aprì ampiamente l'articolazione in dentro, scavò sul condilo interno una fossa in forma di gola di puleggia per fissarvi la rolula, richiuse io seguito la sua ferila che guai'Ì in dodici giorni. L'operazione fu coronata da un pieno successo.
l:HlRUllGICA 1601
Tu tte le ar <ico!lnioni lussate e;;sere assoggettate a d operazioni dello stesso
Si può di re che le contro-indicazioni all e oper azio ni cruente sono poco numerose; tutt'al piu si potrebber o menzionare la pres en za di una enar·trosi o di un a an cb ilo::<i che permettono al mem bro una libe rtà sufficiente per il libero eserciz io della professione del malato; le alterazioni lrofiche pervenute ad un m olto pronun cia to; l'eta avanza ta dei m a lati. quantunquP sieno ::<tati riferiti dei successi sopra vecchi di 58 Anni; i d ifetti patologici a nti chi .
È però nece >"sario non dimenticare che a fianco dei <".a si nei qua li si produce unn nuova a rticolazione che permet te la ri produzione de lla maggior pa rte d- i movimenti pr ecedenti, ve ne sono molti in cui il :nalato rimane piu o meno infermo: l'arto infe riore in cu i una buon a en Artrosi potrebbe rende re molti servizi, è quello in cui s i pr oduce il meno faci lmentE', sia per assen za comple ta di neofot·mazione fib r osa a ttorno alla tes ta fem orale spostata., sia per difetto d'azion e o atrofia dei mus coli peri- articol3ri .
Ne lle lussa zìoni dell'anca s i ri sco n tra il piu spesso un'attitudine viziosa che equivale, p y•ess·a poco, all'impoten za dell'arto ed a Ila s oppressi one ti el la s ua fun z ion e.
Infine si deve tener conto del falLo che i tentativi di ridu zione l'>ulle Jussazioni anliclJe, anch e coi mezzi di dolcezza, non sono sempre innocenti. P e r diat ha citato a questo prou n'osservazione del dottor Po ncet., nella 'luale manov re fsll1' con dolcezza per la du rala di quindici a venti mi11uti per ridurre una lus sazione dell'anca data nte da 111 gio 1•ni , de terminar·ouo occidenti pronta mente mortali. Fatti di questo genere costituiscono quindi argomen ti importanti in favo r e dell'artrotomi a in si mil e caf\o.
Epite liomi svlluppatl sui nèi . - RENOCL. - (Journal de .\tlédecin e et de C'hir ur{Jie, 8!.;'0Sto 1892).
S i che le cicatrici clelle scottat ure e di a ltr·i sono so venti la s ede di sv iluppo di tu m ori maligni; pare ch e un'alterazione anatomica accidentule abbia potuto servire di punto di origine alla neoplasia. Lo ste;;so si ''erifica pei nèi, vascolari , sieno pigmentati. Il dottor Renoul, metter.do a pr·olìllo le collezioui molto numer·ose òel laboratorio d'anatomia patoiogica di ha fatto uno studio mollo completo di questa co mplicazione, più fr equente di quanto siritiene, stud io che di m ostra che il il quale si sviluppa in queste cond izioni, pr esenta alcune particolarità cliniche. òe la str·uttura Ò('i nf>r dimostra che 111 ec:si la mentazione è molto esagerata, che l'a lte razioue del de rm a e delle sue ghianclole da luogo a prodoLLi anormal i : si com. pren le <J uindi facilmente elle essi possono tr aslo r mat·;.i age in tumori, dr cui essi sono già come un abbozzo.
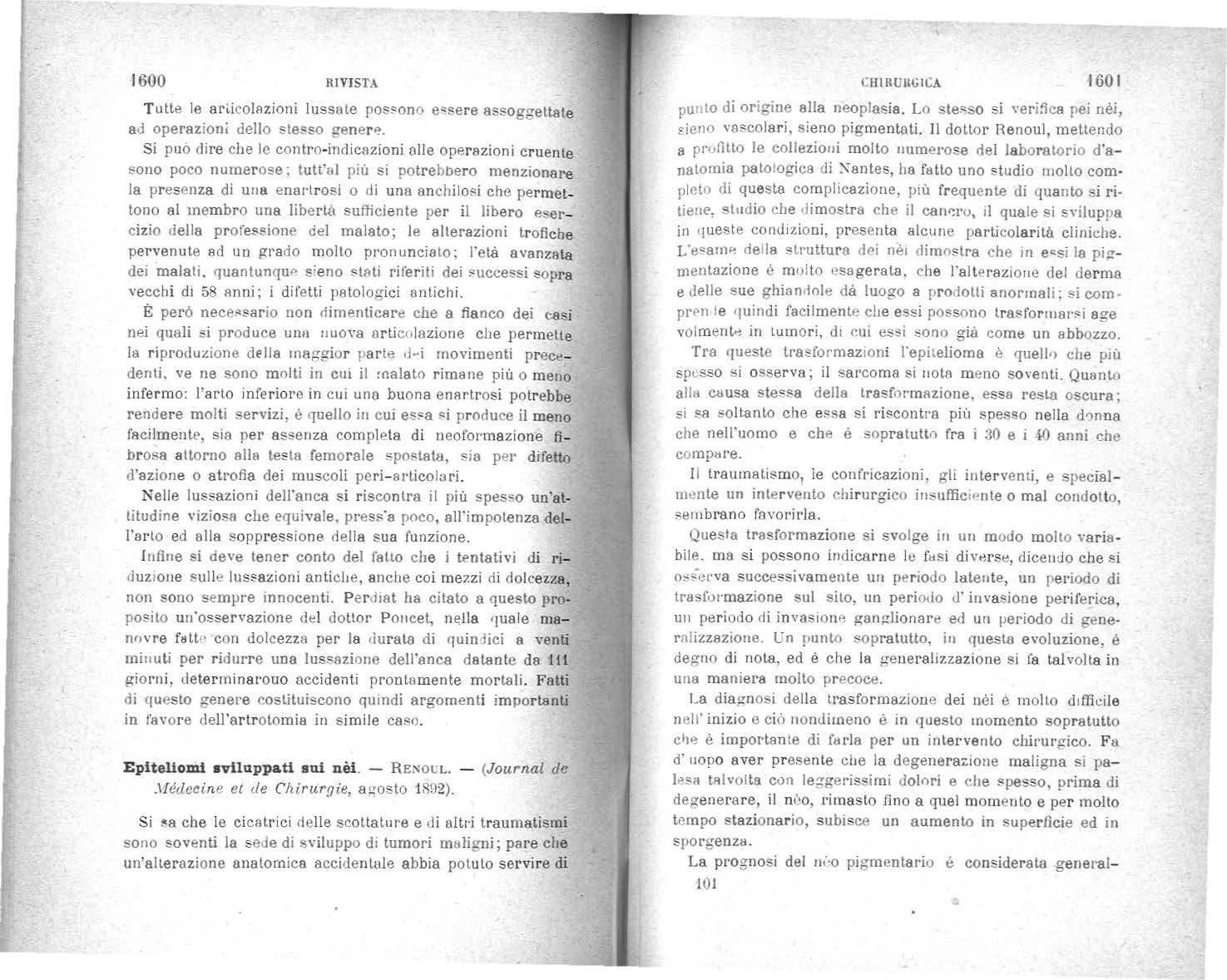
Tra queste tr·asfor·mazioni l'epitelioma è quell'' che più sp t.:sso s i o sserva; il sa r coma si uota m e no s o venti. Quanto alla C11usa stessa della trasfor·mazìone, ess a resta oscura; si sa ;;;ol tanto che essa s i riscontra più spesso nella d0n n a che nell'uomo e che è sopratutto fra i :30 e i 40 anni che comp11re.
Il traumatismo! le confricaz ioni, gli interventi, e specialmente un inter vento ch irurgico insuffici«>nte o mal condotto, ;.embrano favot'irla.
Questa trasformazione si svolge in un m odo molto variabile. ma si possono indicarne le dicertdo che si successivamente un pe r iodo lateute, un periodo di trasfol'maz ione sul sito, un peri odo d'inva sione periferica, un period o di invasione ganglionare ed un periodo di genernlizzazione. Cn punto soprat utto, iu questa e voluzione, é degno di nota, ed è che la generalizzazione si fa talvolta in una maniera molto precoce
La diaf,!'nosi della trasformazione dei nèi è molto drffieile nell' in izio e ciò nondi meno è in questo mom ento sopr atutto cfle è importante di fat' la per un intervento chiruy·g ico. F a d' uop o aver prese nte che la d egenera:.:ione maligna si palesa talvolta con le;ge:·issimi dolori e che spesso, prima di degenera re, il n <\o, rimasto fin o a quel m o m euto e per molto tempo stazionario, s ubisce un aumen to in super ficie ed in s po t·genza.
La peog nosi del ui·o pigmentar·io è considerata general - mente come essenzialmente Tutta via, se uegli indiv!dui curan ti della loro persona e che praticano tutte le cut•e di proprietà necessarie, i nèi non hanno, per così di r e, tendenza a degenerare, nella r.lasse operaia. e più l'lpecialmente nei coltivatori, i tumori epiteliali in generale, i tumori sviluppati sopra i néi in partieola r e, presentano insomma una di cu i devesi tener conto. Ma d<:ll punto di vista della degenerazione il néo presenta un prono>'tico molto più R enoul h!:l dimostrato che questa trasfo1'mazione unA volta etlettualasi. il deco rso •ii questo epitelioma è molLo più rapido che quello dell'epitelioma sopraggiunto nelle cond•zioni ordinarie che uon venne ancora alcuna guarigione radicale dopo l'estirpazione di un epitelioma sviluppato sopra un néo. A cagione della melignita di questi tumori carcinomatosi, Yi ha quindi tutto I' inter'esse ad esportarli il più presto ed il più la r gamente possibile.
La cura del Mosetig- li!Ioorhof nel tumori ma.llgnl tnoperablll. - D ott. CcKO=-<L - (Bollettino delle scienze mediche di Boloyna, fase . 1892).

Primo ad applicare i colori d'amlina alla cura dci tumo ri fu il Il suo metodo di cura co nsiste nell'iniettaee nella massa del tumore in direzione coo, ·ergente dal tessuto sano al tessuto neoformato una sot u.aione di violetto di ml'iile ull' l o al 2 o•;••, da 2 a 6 c. c. per volta in modo da colorare f'uccessi vam ente tutta la mas sa del tumore.
Esso ritiene che tale trattamento a rresti l'attività prolife· r atiYa dei tumori attaccandone gli elementi mot'fologici e più specialmen te i nuclt:i, stank l'affinità che questi dimostrano nelle prepa1·azioni per il violetto di metile co me in gener e pei colori basic i di 11nilina.
A questo p r imo fatto !'eguirebbe poi o il ramm olli mento , con successiva eliminazione o la degene r azione g rassa co n successivo assorbimento degli e lementi morfologici così de-
CHJRURGICA 160a aenerati od anche entrambe queste due metamor fosi re" gressive.
L'autore però, fond andosi !:-Opra alcune sue osser vazioni sperimentali, ritiene non giustificato il concetto di MosetigMoorhof e non efficacs il suo metodo, poiché, per quanto si voglia e si possa insistere, non si riuscirà mai a raggiu ntutti gli elementi morfologict del tumot·e e quindi gli elementi rimasti intatti, per quanto pochi, saranno s empre in grado, per la loro enor me attività prolifel'ativa, di filr ri· pl'endere al tumore il suo fatale accresci m ento. R itiene quin , i ch e questa cura può bensì determinare una diminuz ione di \'Oiume di un neoplasma, roa che però tale effetto è puramente non perdurando che per quel lasso di tempo in cui la cura Yien praticAta. G.
Contributo alla chirurgia. dello stoma.oo. - Prof. ANDR EA. CECCH•.RELLi. - (Rivista Veneta di scienze mediche, sette mbre 1892).
L'autore <· d'aYVi so che mentre la piloroplastica è a pplicabile a tutti i restringimenti dell'esofago purché non dipendenti da epiteliome, la dioulsione invece trova le s ue -indicazioni più ri strette . Infatti, a prescindere dalla fa cile recidiva, essa non è applicabile se esiste un'ulcera o una cica trice faci!mente lacerabile, poichè potrebbe r o avvenire dei guai non illdifferenti specialmente >"e durante l'atto o perati'vo non avverte l'accidente incorso. La pi:oroplastica ha poi anche il pregio d i por r e sott'occh io l'alterazione morbosa q uale essa è, e quindi si può adottare la proposta del Berna..Yz di raschial'e o anche escidere una piccola porzione di stllmaco pe1• asportare rruella parte ove esiste il pr ocesso patologico. Di più, quando nessuno di questi atti ope rativi fosse possibile, e alia pilorectomia che si può sempr e ricorrere. Queste opiuioui dell'auto r P. sono convalidate da numerosi? <>sserYazioni cliniche che egli riferisce, e conclude facendo il pronostico che la terapill delle malaUie dello ><to rnaco in massima parte fra pochi aoni apparterra al chirurgo.
HERBART BuRRELL - n tra.tta.mento delle fra.tture composte con i metodi moclernt . - ( The Boston Jfeaécu.l and Sur!JiCal Journal, settembre 1802).
In pochi anni la cura ùelle fratture compost(> l1a fallo gt•audi progress1, e 8ubilo mutamenti, per l'accurata esplorazion e, la delei'Sione e rantisepsi delle ferite, ed il riconoscimento del pri ncipio fìsiolo .!!ico che t'ichiede un completo r iposo dell'o!':so fratturato. Ne' 20 anni che deco rsero dal f84-1 Al 1861, nPl Gu r · s Hospital fu,•vi una mortalità per fratture del 28 per %; di Pennsyh•ania dal 1839 al 1851 la mortalita ascese al 44- pel' o;.; nell'ospedale di New York durante lo stesso periodo vi ru una mot•tttlità del p. 100. o neii'Obuchow Hospil al Report di St. Petersburg la mortalità ascende al 68 p. 100, mentt·e secondo la statistica di Denni>', su 681 casi di fratture compo:::te, non vi è stato che un caso di m ot•lc per sepsi
L'autore considera le fratture sotto quattro punti di vista:
1• La classe dei casi 'ne· quali si è salvatà una gamba ulile. e quella de' casi che han t•icbiesJo l'amputazione.
L'amputazione primaria cii una fratlul'a composta nel ·Boslon City Ho!>pital è es tr em amen te ral'a, mentt·e pochi anni addietro era comu11e . Come reg0la, l'autore stabilisce che l'età avanzata è un'indicazione per l'amputazione; che si deve tener calcolo delle condi zi oni fisiche del fratturalo in riguardo alla gotta ed all'alcoolismo. che bisogna badare all'ambiente nel quale !"inferm o vive, ed Alle cure che può ri cevere dopo la ricomposizione do.>lla fl'allura; che bisogna por me nte alla facilità di ric.:>mporre e curare una frattura con mezzi antisettici. ed alle condizioni delle part i molli, arterie, vene e net·vi.
L'esteso schiacciamenlo parti molli in un giovane rich iede di necessita l'ampulttzioue, ma la richiede bensi la oblilerazione do::' vasi principali; bisogna però non lasciat·si ingannare dall'eccessiv o ::ronfiore delle parli, che spesso oscura la pulsazione, specialmente nell e tibiali anteriore e posteriore. Xel vecchio invece, l'e::tesa contusione, la dist ru-
Chirurgica 1605
'lione di molle quantità d'osso, indica l'amputazione, auche qutJndo i grossi vasi sono_ integri: _
2" I particolari pe r la n co mpos1Z10ne dt una frattura com po ::-ta. L'accul'ala e_ la antisepsi sono di prima necessità. Quando v1 &.a una s emphce puntura elle prodotta da frammento fuo ruscito, od una nella mclfatta dall'osso stesso, esista una reale protru: sio ne di ft•a mmen ti. considerevole distruzione dellA rnolli e c ontaminazione per sudicìume, o quando la les1_one ;-ia così gra'"e da far pensare all'amputazione, una la va nd a di sublimato in all'i p. 2000, 11 n estesia pe1'chè lo toletta possa esser completa, e prevnl la ,·anda prima con sapone, indi con etere, assicureranno rantisepsi della piaga.
Se v'è un a "empli c.: puntura della pelle si sutura, se ,., é pt'tJ trusione di frammenti si dilata la ferita, si m ette allo sco. pel'lo la cavità interna ed ogni saccoccia che possa prodolla, si l'i muovono tutte le s cheggie "taccale, lasciano quelle cbe sono grandi e d aderenti al peri nst io, si recidono tutti i tessuti non più vitali, si le ossa in opp.ortuna e si sutura la fel'tta ::oenza alcun drenaacrio. In di si fascia l'a1·to cnn garza nella ;;ol uzione di 0 ;ubliroato all't su 2000," e se v'è difficoltà nel mantenere la posizione delle os<::a fratturale, si taglia il tendine d'Achille nelle fralture della gamba, indi si ad?pera per ultimo in volgimen to un circolare d i _emp1astro di Parigi. Se si suppone che anche mal g rado CIÒ 1 . · · · are la stocc:-.a anteriOre menti possono scomporsi, s1 puo us "'" . di Smith, o dei cuscinetti inferio1·i con stecche lateral1.

3• Il mane.-.(Tio di una fratturi\ composta. Dopo due selli · oe l l mane è bene 1·imuovere l'appat·ecchio, perché talvo ta, ma"l'ado tutte le p1•ecauzioni, si ll'ova nella fel'ita una raccolta d1
11 us senza che vi s ia statA elevazione di e si trova una devi"zione nella direzione è uopo correggere in tempo. Naturalmenre, d• temperatura consigha la rimozione dell'app arecchiO lll. lunq ue periodo della cura dopo 1 primi tre o g1orn1; cosa deve esegui.rsi nel caso di dolore 1nsorgente nell'arto leso, e spesso il dolore è alle,·iato dalla semplice incisione dell'apparecchio i n senso longitudinale, alla qual cosa si rimedia poi con altre str·iscie aggiunte o con fibbie. Il r innovamento dell'apparecchio dev'essere fatto a nche se nell'inferm o insorge una polmonite, il delirium zr emen s, l'uremia. od altra c<•m pl icanza , altrimenti c' è da vedere una deviazion e consid erevole della frattura alla fine della cura.
4• Prognosi. Il ritorno dell'ar·to al proprio uso è l'oggetto principale della cura, al qnaltl bisogna mirare Anche quando insorga suppurazione, gonfiore, necrosi . Le de,•iazioni laterali od ante ro - posleriori sono le deformità piu comuni nell'adulto, rare nell'infa nzia; il pericolo della, sepsi no n é grave, è possibile il tetano e l'embolismo .
In conclusione, ogni frattura composta dellR g amba, braccio ed avambraccio scr upolosamente detersa e •l immobilizza la con bendaggio cir·colar•e, ed asettico, il quale dev'esser·e rimosso al 1:l• giorno, onde nire i deviamenti dell'arto. Quantunque eccezionalmente possa seguirne gonfiore, suppura zi one, nec r osi o deformi tà, la r iunione per prim a intenzione, e la conser ,·azi one dell'arto dev'esser. la regola che il chirurgo deve seguir•e.
HERBERT \V. P AGE. - Lesione violenta. del ora.nlo seguita. da emiplegia e dilatazione della pupilla. - ( The Lancet, a gosto 1892)

Un uomo di 25 anni, a lle 5 pomer idi ane del 2 m ar?O, fu trasportato all'ospedale, mezz'o r a dopo esser da un le gno, i cava.lli del q uale eran o a g ra n corÒ'a. lin gonfiore ed un'escoriazione sul sopracciglio dest r o e l'uscita di poco sangue dal naso, un'altra f1'altur a o ferita, indica,·ano la sede della lesione, essendo il fer ito incosciente, ma nQn al punto che scuoten dolo egli non avverti sse un'impressione, e la fisonomia non mostrasse dolo r e se gli si stra ppavano i ca- · pelli. Non par la va, e pa reva che potesse muovere il braccio sinistro, ma non il dest r o .
Non v'era paralisi facciale nè i neguaglianza nelle pupille, ed a così breve t empo dalla caduta, era imposs ibile il dire
CHtRURGICA 1607
se quello sta to fosse attribuibile alla sola co mmozione od a !JU alche lesione endocra nica. Alle 11 di sera la r espirazione si manteneva ancora a 18 al minuto, il polso a 70 come dopo l'accaduto, ma si era mtlnifestata l'emiplegia » destra, nella !accia, nel braccio e nella gamba, la pupilla destra era dilatata ed immobile.
Con una paralisi a vvenuta nell' istesso lato della lesione e!"tema del cranio, e ra che la Je-.ione cer ebr al e doveva r iconoscer !"i nell'emisrero opposto, e si pensò a d una lacerazione o contusione per contraccolpo, o ad un'emor r·agia della pol pa cerebrale opposta al pun to della contusion e Crt)nica, q uin di ness una o pe r·azione chirurgica av rebbe potuto rimedi are alla paralis i, neppure una trapa nazionc eseguita a !"inislra. perchè l'èmorra zi a doveva Pssere centrnle, mancnndo ogni segno d' ir·ritazione meningea.
casi di emorra gi a dell'artP-ria media, la dilata zione della pupilla nell' is tesso lato è un sin tomo di llran valo r·<>. su l quRie H utchin;::on ha richiamato pe l primo l'atten zione de' prAtici, ed esprime la pt'essione d'un ;::angui gno che si fo r ma l'ra la durA ma Ire e l' O"'M Alla ba s e del crRnio, e che comprime di r ettamente il 3• paio di ner·vi. I n questo caso e.r a inverosimile un'es tes a emorra!5ia dalla bAse del c ra nio, per·chè mancavano i segni ddl'an· uullata funz ione cerebral E', la perd ita a ssoluta della coscienza, il coma profondo, ii pols'l la r do e la r espirazione stertorosa e ra più probabile una piccola emorragiA della base, probabiliss ima una lesione dtt·etta del nervo pe r frattura dello ,.;fenoide dall'avanti in dietro attraversante il processo clinoideo, e ciò couvinse rautor·e del l' inutilità dellQ. trapanazione in corrispondenr.a delrcrr·teria meningea media.
Le fr attu r e della base del cranio s ono ordinariamente trasversali, m a possono deco rre r e 1l a ll'avanti all'indietro, da un Jato o dall'allrn deìla fossa occipilale, sec ondo il modo di agire dalla vi olenza esterna. Comunque avvenga, lu. fra ttura non .ha altr À importanza ch e quella della lesione cer ebrale . Ed iu questo caso, r emiplegia e la dilatazione dell a pupilla che e r ono l'ell'etlo della lesione cerebrale. rimasero all' islesso g rado Dno all' indomani, allorché, sia per
1608 RIVISTA l' in!:orgo polmonare, sia per la commozione del miùollo allungalo, la r espirazione divenne difficile, e la mor·te avvenne dopo .H ore dall'accaduto.
Se in un caso simile un chi rur!{O ave;::se voluto al!a trapanAzione, non avr·cbbe ce rtamt!nle saputo dove appìicare il trapano, e l'autore, riprova ndo ogni operAzione che non tJbbiH U11' indicazione prima di addiv<'ni r e airapertura del cadavere, a r gom enta dai >:intomi e dallt! considerationi suespres>: e che vi stata coatusione immediAtamente Hl disotto dellA lt>sione cr·anicfl, contusi(m e e fors'anche lacerazione per contracçolpo nell'emisfer·o sh, conside revole emorragia della super·tìcie e delle vicinanze della contusio ne per contraccolpo, ma più pr·obabilmente una diffusa emorraf!ia intercerebraie occupante lo vicinanze del c•1rpn striato e la gran zona motrice del Iato !"inistro; qua lche piccola emorragia della base del r rani o, non dall'arteria meniogea media, che possa aver leso il terzo paio de' nerv 1 tna piu pPobabll!òente una lesione diretta del neno da una frattur·a dall'a van ti all'indietro della base Jel cranio in vicinllnza del processo clinoideo ' li reperto della necroscopia dal dottor Clarke fu il
Abras ione frontale destra, con ecchimosi della corrispo ndente aponevt'osi cranica, nessuna frattura sulla ca lvarie, ùur·a madre fortemente aderente all'osso; suJ!a pflrlf; po:;<ter·iort> dP-' lobi piccola quantita di sangue effuso al di<;nlto dell'Aracnoide; nella fossa aoterior·e. media e posteriore Ialo dest ro del cranio molti picco li e nella fossa posteriore considerevole quantita di san:w e liqu.do. Rimoss& la du r a madre, si scovri una fessu ra ch e partiva dalle vicinanze dell'e!> terno pr•ocesso angolare dell'osso frontale destro, che incrociava il paYimento o rbilario destre, il forarne ottico e rorlo anter·iore della fessura sfenoidale destra. e distaccava il pt'ocesso clinoideo anteriore. L'oc ulo-motore com une destro laceratosi nel rimuovere la dura madre, n on lasciava scorgere la sua vera condizione ; il ner vo ottico era illeso. Nel lobo fr·ontale d'ambo ali emio sferi, ma specialmente del Jeslro, numerose aree emorra -
CHIRURGICA 160!)
giche, s··nza cvntu!"ione di cont:·a co lpo ne· lobi occipilali . mezzo detla capsula interna sinistra un focolaio emorragtco dell<'l d'una fava, nessuna effusione sanguigna dei Yentricoli. operazione d ' EstHinder. - Dott. REM Y. - (Reoue de Chi- . rurgie, N. 8. 1892) .
II numero ·ielle o>::>ervatio ni pub!Jiicale su questo soggetto non é sì che riesca inutile aggrungervenealtre uuove, massime a,·endo avuto questo tentativo un risultato inco -
Dopo la discussione al Congrt!sso di chirurgia nel '1888, disparvero ùalla lette ratura e pare tale operazi one sia stata a!"sRi meno fre,,uente.
L'autore riferisce con certa larghezza e precisione di particolari la sua osservazione. relativa ad un giovine di 25 anni, robusto, sano, che si ammala di bronco - polmonite, sul fine del 18 9, seguìla ùa pleurite essuJativa a sinistra. Si pratica una prima toracentesi il 4 il liquido si rtfopma, purulenlo. e fino al :ii marzo si ripetono 7 toracentesi con lavature c!isinfellanti: si introduce il sirone del e si fanno prima con acqua alcoolizzata al terzo. poi colla soluzione di clor uro di zinco al centesimo; vantaggio progressi,·o, fìn chè, tollo in maggio il tubo a permanenza, troppo p resto. Iu raecolta si rilorma, il polmone é di nuovo schiacciato, i dolori r icompaiono, il cuore di nuovo respinto, la di!'lrrea, la prostrazione aumentano. Si decide l'itllc rvento ehi!'urgico e si eseguisce l'oper azione dell'ero piema che dà esito a 4 litri di pus e che é da rapido miglioramento '"'enerale e locale fino a ridursi ai primi di luglio la cavita " a contenere non piu di 200 grammi di liquido. Giunta a questo punto l' si rese stazionaria per ci r ca altri sei mesi. A 1lora un tentativo per togliere il tubo falli, l'icomparvero fc:>nom en i di ritenzione di pus e dovette rimettersi il tubo e riprendere le Ja,•ature, findt è nell'aprile successivo, dopo 16 mesi di malattia la supput•azione si l"ifece abbondante, ricomparvc la diat·rea, con I'{Ualche accesso febbrile,
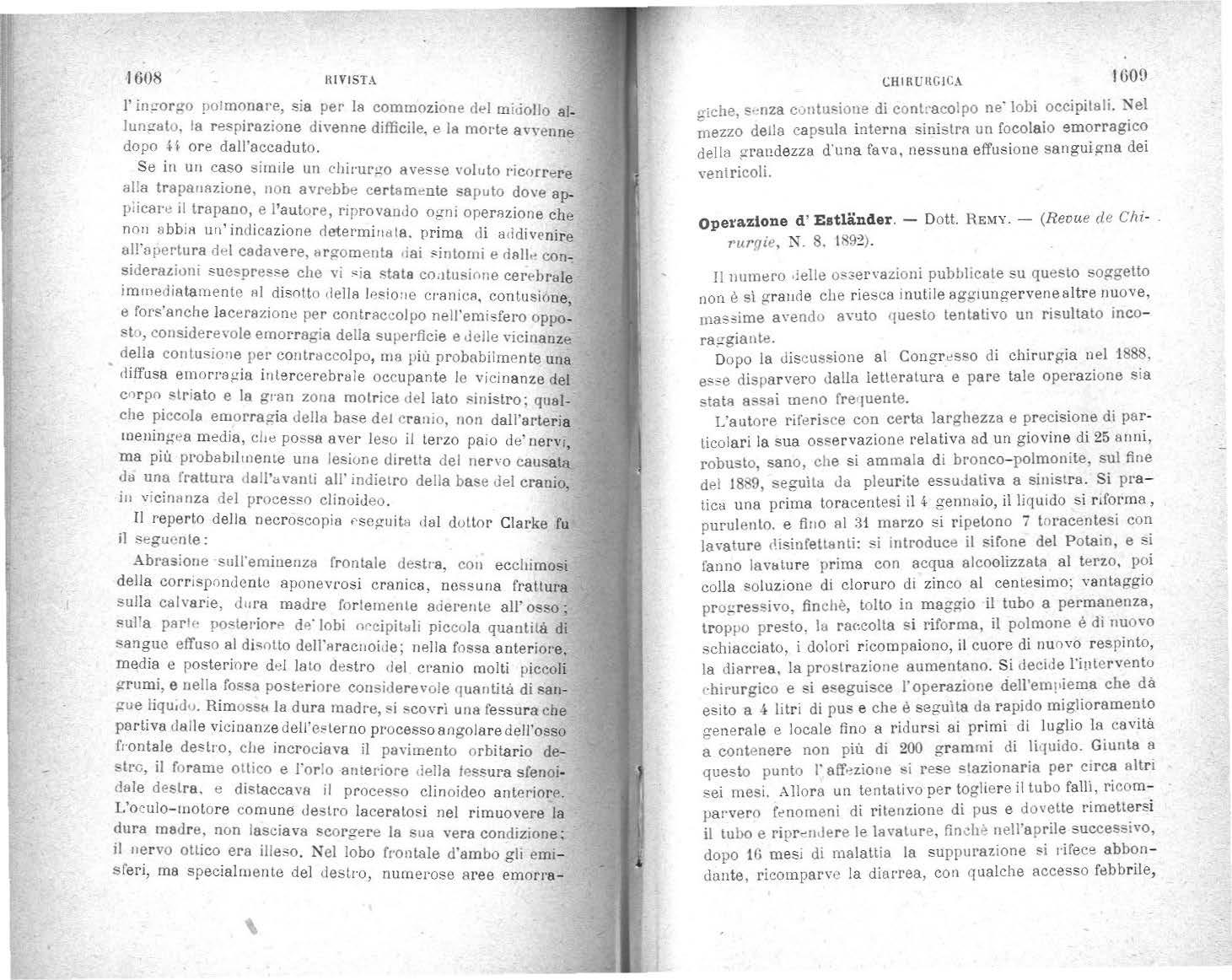
. alterazione dello !'lato g-enerale tanto da far ritenere che non sarebbe mai guari to senza l'opera zione di Estlander.
L'operazione viene eseguita C'ol proposito di con s ervare il più possibile i nervi e Yasi intercostali co11 incisioni parallele alle coste approfìttando dello scorrimento della pelle sulle parti profonde per raggiungere parecchie di esse colla stessa incisione: vengono resecnti col primo taglio d! 12 centimetri che segue il ì 0 spazio inter ostal e, 9 centimetri della ottaoa cost.a. 1 l centimetri della se ttima e 7 centimetri della sesta: poi con un secondo taglio sul i-• spazio intercostale, pure di 12 centimetri di lunghezza sono resecati 4 centimetri della quinta costa, e 3 centimetri della quarta .
La cavità !'t sente allora molto ri stret ta, colla superficie i11terna rivestita di incrostazioni fine non lamellari: la pleura misura i centimetro di spessore.
Si at>portauo col cucchiaio, colrunghia o collo sfregamento di tamponi di garza asettica i depositi calcari e lo strato fungo so della siel'osa, con molta p r ecauzione sull a facci a Lavatura accurata colla soluzione di subli mato a l mille!<irn n. racool a 00 e i'acido borico : emorragia molto scArsa. emostasi accut'ota.
La fer'ita esterna è anfrattuosa pei fasci del gran denta to che furono divisi, ma fu l'isparmilito il nervo che vi si dirama arrestan do il taglio anteriormente; si é pure cer li dell'integrità dei muc;coli, dei vasi e dci nervi intercostali. Si chiude l'aper'tura superiore dt>lla pleura attraverso al perio.,tio della cost J per non infettare la muscolare esterna che s i lascia aperta: nella infer·iore si lasciò beante l'ap erturà della pleura, centimetri, e quella della pelle, 12 ceulimetri: quattro grossi tubi da d renaggio salgono il più possibile in vari e direzioni: mt>dicatura antisettica al salol o e garza imbevuta di su blim11to, mantenuta umida da uno strnto di tnffettlt gommato.
Al 5• gio rno agitazione e febbre crescente e pus abbondante raccolto nella pleura: la piaga superiore riunita per prirna inLPnzione; la febbre. cessato, ritorna dopo due gior ni, ed alla F>econda medicazione si trovano 150 grommi di pus nella ca\•ità: abbondanti lavature e medicazione quotid iana .
Chirurgica 1611
A favorire il delle pareti toracich e si guisce la compressione col cerotto diachylon, che non e toller'ala. Allora si tenta la compressione cou molla ovatta e la fascia d' Esmarch e questa volta con pieno succe sso, cessano i dol(>ri, rinasce l'appetito ed in i2 giorni di compressione e 2i- dopo l'operazione, la cicatrice è chit:sa. Il miglioramento continua anche dopo: per quAlche settimana persistono dolori nella regione delle false coste vicine alroperazione, dovuti alla mobilità delle coste resecate, ma la loro consolidazione si produce approssirnath·amente nel tempo abituale del com:olidamento delle fra1ture e 50 giorni dopo l'operazione è scomparsa ogni sofferenza, r individuo è ingrassato ed un mese dopo si f« opera re di un'ernia inguinale !'inistra, <!he guaric::ce pe r prima intenzione.
Circa un anno dopo la traccia dell'operazione di non è s egnata che da tlue cicatrici lineari cutanee. La l'espirazione è normale: vi ha una diminuzione ò'àmpiezztt del torace dal lato opet'alo, ma non \'i ha devi azione della colonna vertebrale. La salute generale é perfetta e il pa7.iente IIIVOI'a nP.l suo mestier e di commesS>o negoziante.
Sulla iniezione sottooutanea. del sangu e e un nuovo metodo di tras tasiobe . i ntravenosa . -V. (Allgem. Wiene,.. medie. Zeitung, N. 2:3, 1892.)
Importa per la trasfusione del sangue anda re in traccia di un metodo che elimini ojl'ni pericolo. o, in altre parole, nel quale sia più che è possibile evitata la separazione della sostan za fibrino plastica e del fermento fibrinogeno, l'entrata dell'aria nelle vene ed una lesione meccanica delle cellule del !;angue, e che inoltre sia semplice e facile ad applicarsi. Come tale, ho, dice il dott. Ziemssen, da alcuni anni raccomandata la iniezione sottoculanea del sangue . ed il mio pr()Cesso, dopo che ho potuto fare di meno della defi.b rinazione del sangu·e, può anche oggi raccomanda rsi come il più semplice per la pratica. S'evita la defibrinAzione aspi.r rando direttamente dalla vena nella siringa il sangue per mezzo di un ago tubulare e iniet.tandolo subi to nel te!'suto
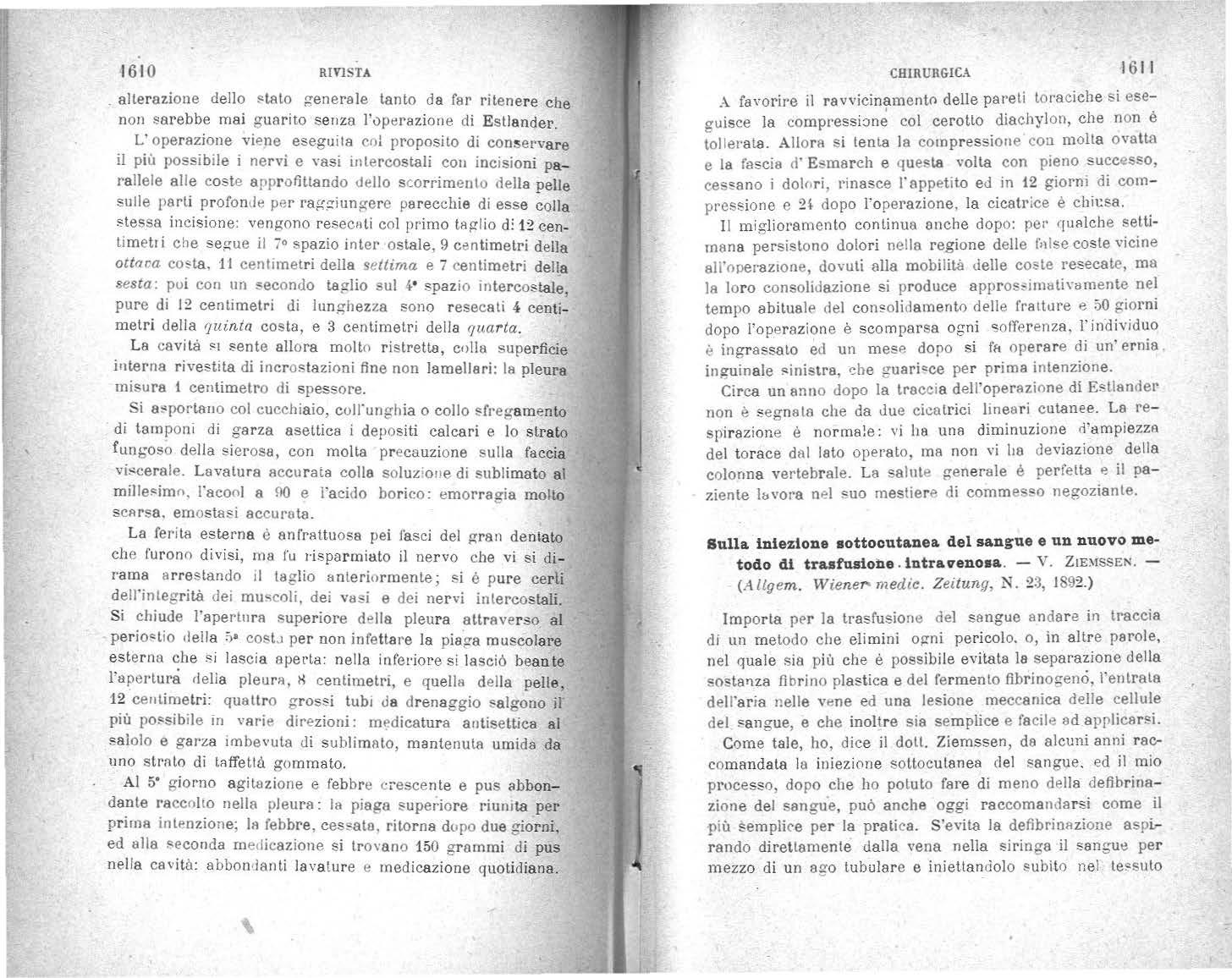
Chirurgica
cellulare sottocutaneo. Durante la in iezione, ed anche pJ> r un quarto d'ora dopo, ìl sangue iniettato è schiacciato e disteso cor1 un f< ·rte ma ssaggio e così è imped ita la formazione di ll'ombi. Con questo pr ocesso pos:;ono introdu r re in una seJut.li g r andi quantita eli senza cho:: nel te :;sulo co11nettivo p resso il luogo della iniezione rimanga alcuna traccia di coagulo :::aoguigno, in ''irtù del ma;.saggio. A vendo pr ovato (juesto metodo su malati votati a certa morte. mi sono molle volle persuaso col r i$conlro anatomico dopo morte, <:h e il te, suto cellulare é e di sangue, ma che non esiste alcun coagulo, nè si sente dopo la iniezioue alcuna ' infili razione. l punti della iniez ione son0 molto dolo r osi per la tensione del tessuto cellul are, ma non si ha né infi ammazione nè febbre. Su quelli è neces sat'iA ne>i primi fdorni la vescica di ghiaccio. Per· mostr a r e quan!e g randi quanlita dr sangue si possono in q uesta guisa iniettare, di r ò che in una donna ho iniettato 367 eme. di sangue e in un'alt r a 446, senza che si manifestasse nè febb r e, né emoglobinemia, nè emoglobi nuria.
La quantità di e moglobina si dopo la iniezione e nei primi giorni, corrispondentemente alla enl!là dell a traaumentata del 10 e 15 "/, . ma gio r ni suecessi\'i diminuisce -ordina ri amente no n po<:o, cosicchè dobbiamo credere o che uu gran numero di corpuscoli sono nel fegato o che l'art·ivo di sangue estraneo a bbie provocato ·un rorte d i lirruido dai tessuti al sangue, onde la conse€<uenza di un a re la tiva diminuzione della emoglobina.
l n quanto alla tecnica, occorrono due assistenti, uno per trarre il sangue dalla vena e l'altro pel massaggio. Questo processo non ha alcun pericolo e d'altra parte possiede il gran vantaggio ch e si può r ipeter·e ind efinitamente . D'ordinario faccio la in iezione ne lle cosce, per ogni si ringa in luogo diverso; così può seozfl impedimento fare it massaggi o nel luogo della precedente iniezi on e. Il dor·"o sarebbe molto adattato per la grande estensione del suo tessuto connettivo, ma dopo che n'è stata fatta una volta la iniezione, i malati vi si dispongono difficilmente lllH:l secon la, poichè pel dolo r e che succede alla pelle male stare coricali e sono impedili di dot·mire. . .
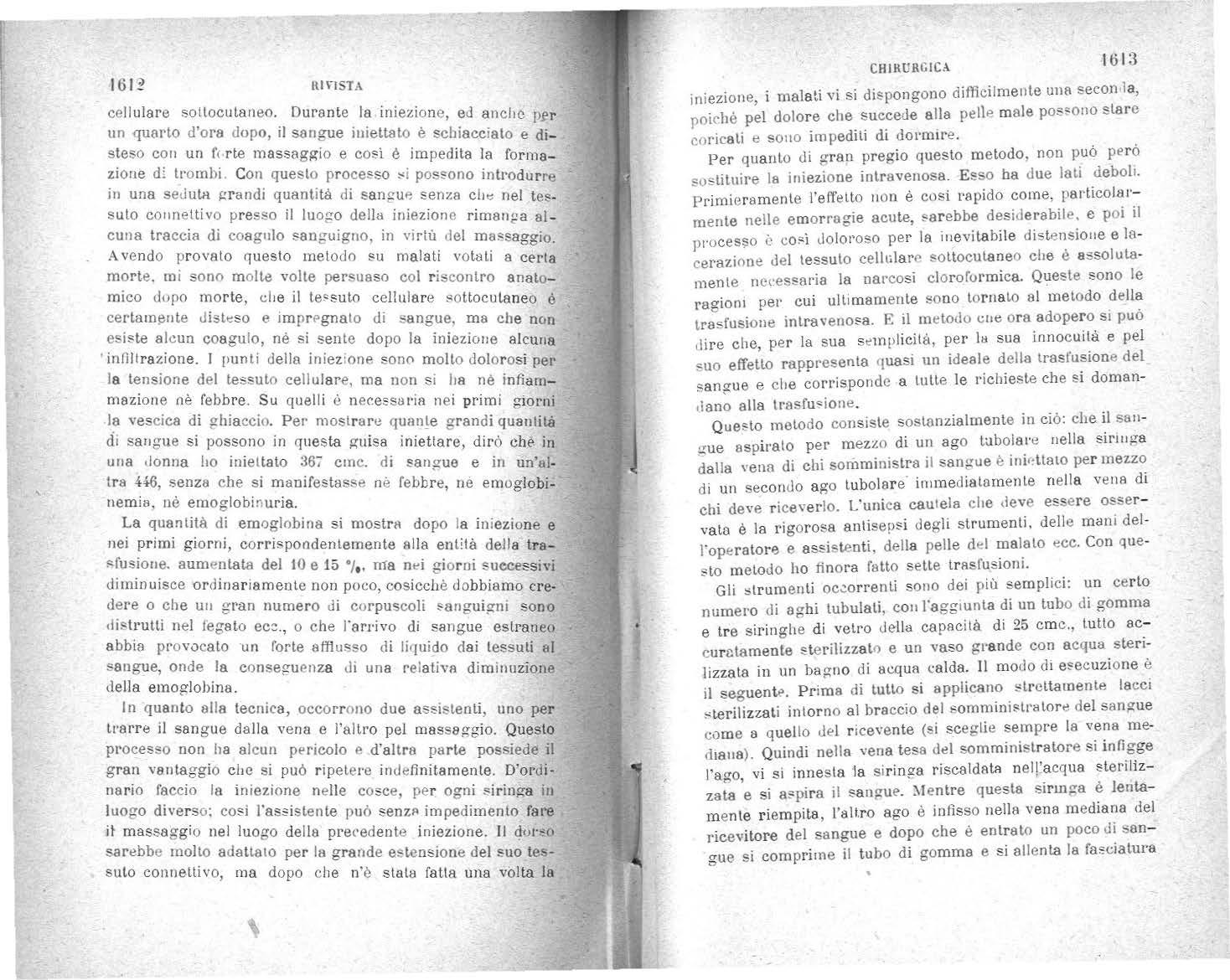
Per quan to d i gran preg io questo metodo , non puo pero sostituil'e la iniezi one intravenosa . Esso ha due lati deboll. l'effetto non è cosi rapido come, partico la t·mente nelle emorragie acute, desiJerebile, e poi il è co;::.ì Jolo r·oso per la inevitabile e lacet>azi one Jel tessuto celh;lare sottocutaneo che è assolutamente ncces!i'ar·ia la nar·cosi cloroform ica. Queste sono le ragionr pet· cui ultimamente sono to rnalo a l metodo trasfusione intraveno:::a E il metodo ora adoper o st puo <li re che, per la sua s emplicila, per 111 sua innocuità e pel suo effetto rappresenta r1uasi un ideale della trasfusione del s anf'!ue e che corrisponde a tutte le richieste che s i domandano alla
Que!i'to metodo consiste s ostanzialmente in ciò: che aspi1·ato per mezzo di un ago tubolar·t.! nella strlll €<a dalla vena di chi somministra il sangue è per d i un secondo ago tubolare· immediatamente nell a vena d1 chi deve r iceverlo . L'un ica caulela che deve esse r e osservata è la rigorosa antisep:;i degli strumenti, delle mani dell'operatore e assistenti, della pelle del ecc. Con que!i'tO m etodo ho finora fatto sette trasfusJOnr.
Gli ::;trum enti so no dei pitì semplici: u n certo numet'O di aghi tubulati, c o n raggiUnta di un tubo di gomma e tr e siringhe di vetro Jella capaci tà di 25 e m e., lutto curclamente sterilizzato e un vas o gr·aode con acqua s terrlizzata in un bagno di acq ua calda. Il modo di e:;ecuzi one è il seguentt>. Prima di tul\.o si appl icano lacct !'terilizzati intorno al braccio del s omm io io:Lt•atorè del co me a qu e llo del r ice\'ente (si sceglie la medtana) . Quindi nella "ena tesa del sommrmstratore SI 101ìgge l'ago, vi si inne s ta 1a si ringa riscaldata !i'terilizzata e si aspi r a il s a ngue.>. :\fentre questa s mn ga è lentam e nte rie mpita , l'altro ago è infisso nella vena mediana del ric evitore del sangue e dopo che è en trato un poco Ji sangue s i comp ri me il tubo d i gomma e si allenta la fasdatu ra
RIVISTA
del braccio. Frattant9 è innestata la siringa piena e lentamente iniettato ìi sangue. In questo tempo è riempita una seconda sirinlo{a dal braccio ùtll somministratore del sangue, e, dopo ,-uotata la prima siringa, è continuata con la seconda la iniezione f: una terza siringa, perché così la siringa pr ima YUOlata pu6 essere Ja,·ata con acqua ste rilizzata allo scopo di toglier e ogni residuo di sangue. Così si ha sempre nello stess o tempo una siringa riempita , una vuo ta ta nella vena e la terza lavata ron acqua ste rili zzata Il giro è così tranquillo e ra !Jido che, tolto il c aso che !"afflusso del nella veoa del r icevente soffra q ua lche di s turbo, un'8 trasfusione Jel sanp-ue di circa 250 eme. non richiede più di 15 minuti. Un poco di esercizio è uecessario tanto da parte dell'operatore quanto degli assisten ti. Ma questo processo è cosi semplice che già fin dai primi tenta tivi tuUo corre r eg-ola rmente. In particolare la introdu zione dell'ago (senza preceden te incisione della pelle) è piu facile di quello che a pr iori si potrebbe supporre. Nelle vene Yuote e strette deg-li an em!ci di alto grado si ha vera mente un poco di difficoltà, m a é ben raro che la puntura fallis ca. L'a go si deve infiggere più" che è possibil e orizzontalmente alla superficie cutanea ossia corrispondentemente della Yena e cosi con un legg ie r o movim en to di va e vieni nel cana le venoso ci si pu6 a ssicurare c he le punta non incagliala nella interna superficie della pa: . r e te. Quando nei primi sperimenti non facevo uso de lla p iccola aggiunta del tubo di g-omma, ma innestavo la cannula di r etlamE>nte nella siringa, accadde più volle che !"ago pungessP la parete venosa dalrin tern o e cosi s i formass e un trombo perivascol are. Questo inciden te era senza importanza poiché lo stravaso era subito eliminato col massaggio ma et•a necessario di allontanare la cannula e infigger·la in un'altra vena.
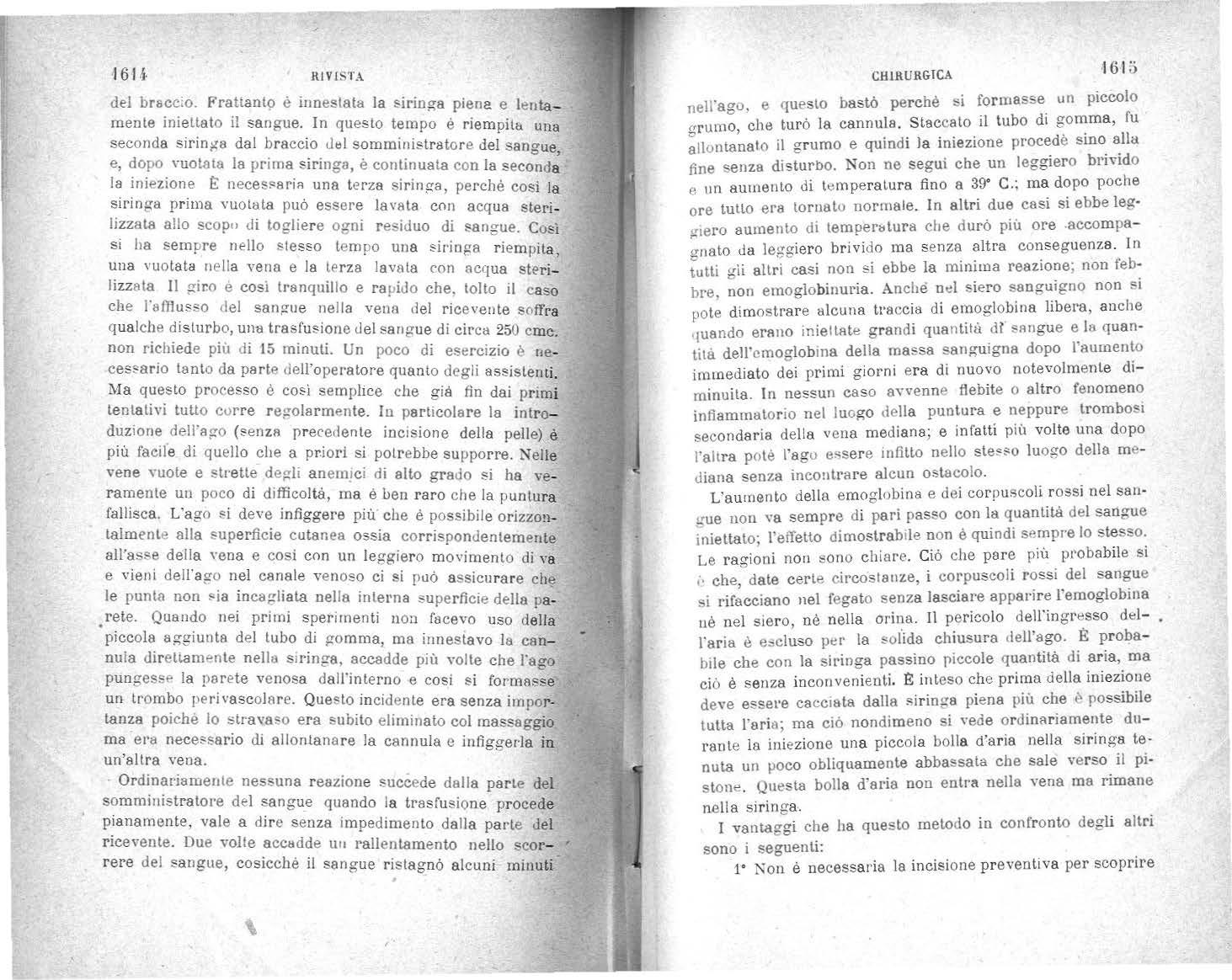
· Ordinariarneute nessuna r eazione succede dalla parte del sornministratoJ•e del sangue quando la tt•asfusione procede pienamente, vale a di r e senza impedimento dalla parte del rice,·ente. Due volle a ccadde uu rallentamento nello scorrere del sa ngue, cosicché il sangue ristagno alcuni minuti
Chjrurgica
nell"ago, e questo bas tò perchè si fo r masse_ un piccolo ,.rumo che turo la cannula. Staccato il tubo dt gomma, fu il crr umo e quindi la iniezione procedè sino alla a c "d fine senza disturbO. Non ne segui che un leggier o briv1 o e un aumento di fino a 39• C. ; ma dopo poche ore tutto era toruato normale. I n altri due casi si ebbe leg· )!iero aumento di tempet·11tura che du rò più ore accompagnato Ja leggiero brivido ma In tutti gìi a ltri casi non si ebbe la mwuna reaziOne; non bre, non emoglobinuria. Anchè nd sier o sanguigno non st pote dimostrare alc una traccia di emoglobina libera, anche quando erano iniellate grandi quantità dr sangue e la qua ntita dell'cmocrlobma della massa sanguigna dopo l'aumento 1:> d" im wediato dei primi giorni era di nuovo notevolmente Iminuita. I n nessun caso a..-venne flebite o altr o fenome no infiammatorio nel luogo della puntura e neppure trombosi secondaria della vena mediana; e infatti più volte una dopo l'altra potè l'ago essere infìUo nello stesso luogo della m ediana s enza inco!ltra re alcun ostacolo .
L'au mento della emoglobina e dei corpuscoli r ossi nel sant!Ue 0011 va sempre di pari passo con la quantità del sangue :-'niettato· l'effetto dimostrabtle non è quindi lo ste sso. l Le ragioni non sono chi are . Ci6 che pare più probabile SI i· che, dale certe circoslan ze, i corpuscoli rossi del s a ngue si rifacciano nel fegato senza lasciare appat·ir e l'emoglobina uè nel siero, né nella Il pericolo del l'in gresso delraria è e;:;cluso pel' la ch iusu ra dell'ago. È pr obabile che con la siringa passino piccole quantità di aria, ma ciò è senza inconven ie nti. È inteso che prima della iniezion e deve esset·e cacciata dalla siri nga piena più che è possibile tutta l'aria; ma ciò nondimeno si Yed e ordin!\r iamente durante la iniezione un a piccola bolla nella si rin g a te· nuta un poco obliquamente abbassata che sale ve rso il pistone . Questa bolla d'a1·ia non entra nella vena ma rimane nella siringa.
I vantaggi che ha questo metodo in confr onto degli al tri sono i seguenti :
1" Non è necessat'ia la incisione pr eventiva pe r scoprire
RlriSTA
la vena, né la narcosi. Anche le donne, alle quali finora quasi e<'clusivamente fu fatta la tra<'fusione, sopportano Ja puntura st<nza lo.mento, mentre spesso ri fiutano il piu piccolo taglio So:} n()n <'i usa il cloroformio.
2• È evitata la incisione della vena così il pericolo dell'entrata dell"aria.
3• Non occorre In dctìbrinazione e cosi è cansato il pericolo della separazione di gran oli quantita di fib rinogeno.
4° La trasfusione nel corso normale uon ha per conseguenza alcuna reazione e può !'ssere ripetuta seconào il bisogno senza che i· mtllàLi vi facciano opposizione.
CHARLES Evt:-;G, capitano chirurgo a"sistente dell'O. S. A.
- La c ura d e lle ferite in relazione al germi d 'lnfefezlone . - (The Bo.ston Jtfeclical an.d Sttrgical Jou.rnal, ott. 18!J2) riconosciamo per inl't!zione di una ferita !"introduzio ne in ess a di microt·ganismi specifici p1·oùucenti la s u ppurazione, quindi P*''' ben comprenderne la cura dobbiamo determinare quali sieno questi mict·organismi, ùove si tl•o ,·ino e come pen etrino nelle ferite. parlando, i germi piogeni sono lo statìlococco piogene albo ed aureo, lo streptococco piogene, e lo stafilococco a lbo dell' epidet·mide di ':Velch. una fo1·ma modifkata di quello d i Rosenbach . senza tener èouto delle sostan7.e piogenich e di natura chimica, e delle sterilizzate di div ersi mic:organismi, che indipendentemente da questi mict·obi possono produrre la suppu r azione, e senza calcolare terza specie di stafìlococcbi piogeni, il citrino. il cereo albo ed il cereo flavo di Passet, il flavescen te di Babes, il micrococco tenue di Rosenbacb, il piocianeo di Gessard ed il piocianeo (beta) di Ernst.
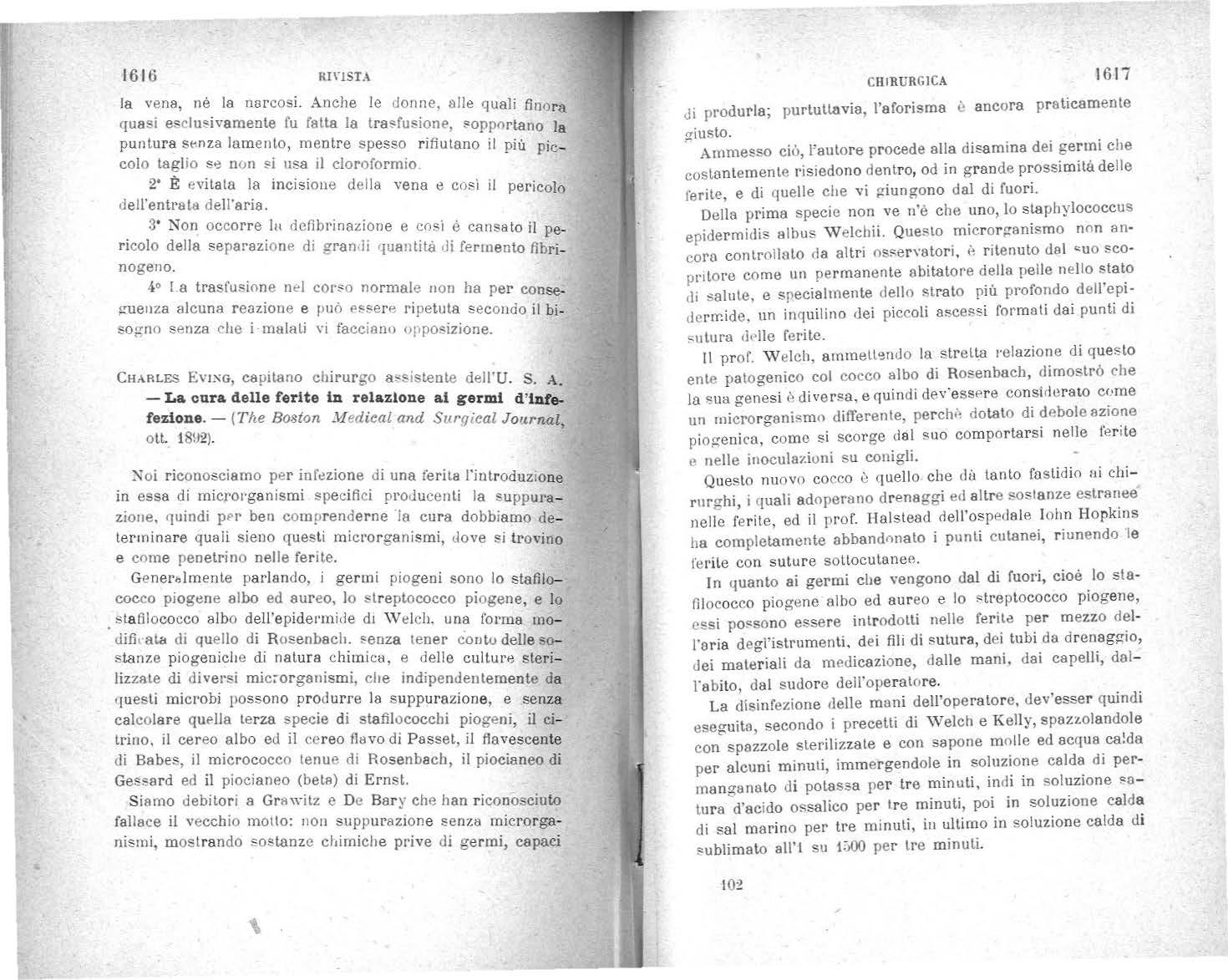
Siamo debitori a Grawitz e De Ba.r y che han ri conosciu to fallace il vecchio mollo: non su ppurazione senza micror ganismi, m ostrando sostanze cl.imiche prive di germi, capaci
Chirurgica 1617
Ji produrla; purlutt.avia, l'aforisma è ancora p r aticamente (J'iusto . ,.., Ammesso ciò, fautore procede alla disamina dei germi che costantemente risiedono dentr o, od in grande prossimita delle ferile, e di quelle che vi ::riungo no dal di fuori.
Della prima specie non ve n'è che uno, lo staph)'lococcus epiderm idis albus W elchii. Questo .micr or:ranism o non ancorn controllalo da altri os::.e n ·ator1, r1tenuto dal "-UO scopt·ito1·e come un perman en te abitatore pelle nello di salute, e specialmente dello strato pm profondo del! dcrrr. ide . un inquilino dei piccoli ascessi formati dat punt1 dJ. sutura dl'lle ferite.
11 prof. W elch, la di ente patogenico col cocco albo di Rosenbach, dtmostro che la genesi<' ùiversa, e quindi dev·essPre considerato un microrganismo differente, perc hi• dotalo d1 piogenica, c ome si scorge dal suo comportarsi nelle fer 1te e nelle inoculazioni su conigli .
Questo nuovo cocco è quello che dù tanto fa stidio ai chirurghi, i quali adoperano drenaggi ecl a ltr e sostanze nelle ferite, ed il prof. IIalsteacl dell'ospedale l oh n Hopkms ha completamente abbandonato i punti cutanei, r iunendo le ferile con suture sollocuLanee.
In quanto ai aermi che vengono dal di fuori, cioe lo sta. mococco piogene albo ed aureo e lo ,.lreptococco ptogene, essi po!'sono essere introdotti nelle ferit<l per m ezzo l'a ria decrl'istrumenti, d e i fili di sutura, dei tubi da drenag::r1o, dei da mE-dicazione, dalle mani, dai capelli, dall'abito, dal sudore dell'operatore. , . .
La dlsinfe:lione delle mani dell'operatore, dev esser qwndt esecruita secondo i p recetti di Welch e Kelly, spauolandole ' d 'd con spazzole sterilizzate e con sapone molle e acqua .ca. a per alcuni minuti, immergendole. in cal d1 pertntlnganato di potassa per tre mmull, md1 m !'Otu ra ossalico per tre minuti, poi in soluziOne di sal marino per tre minuti, in ultimo in soluzione calda d t sublima to all'l su iWO per tre minu ti.
11 campo d'opei'azione può esser reso asettico spazzolandolo con spazzola, acqua calda e sapone, laYandolo con tr ementina, indi con etere, indi con soluzione di al1'1 l>U 1;){)0, indi ponendovi sopi'a delle compresse bagnate nella stessa soluzione C:i sublimalo, fasciandole con bende onde tene1·le in l'ilo per qualche tempo.
Dopo roperazione, l'ideale d'una medicazione è la chiusura della ferita con seta sterilizzata, cd il sigillamento e rmetico che prevenga l'introduzione dei ge1·mi dal di fuori, me1·cè una soluzione di polvere di iodoformio in collodion se la lesione rigua 1·da i tegnmen Li, o. mercé una soluzione di iodoformio nell'etere se i tegumenti sono stati distrutti. La soluzione applicata con un pennellino dopo che la ferita sia ben dete!'Sa ed asciutta, procurando ai proteggere non l>Olo la linea della ferila, ma anche le parli a diacenti ad un pollice di distanza .
Dopo una settimana si può rinnova r e la vernice di c ollodion iodoformico mediante etere. e si possono toglier e ì punti. Se mal g ra do ciò lo stafìlococco dell'epider mide av r à pr odotto la suppurazione dei punti· di sutu r a, come potrà rilevarsi dal rossore, dal dolore e dall'elevazione di temperatura, bis ognerà tosto rimuovere i punti, e facilitare lo sgorgo del pus
- Un' insolita ferita d ' arma d a f uoco. -
(The Boston .\1erlical and Sur[Jical Journal, ott. 1892).
Un giovanello robusto e vigoroso di 16 anni. andando a caccia, ave,·a ad un rialzo di terreno il suo fucile, e mentre saliva sull'erta, un suo compagno saltò s enz'avve ier·sene sul fucile, che, a \'endo i cani montati, esplose.
Il proie llile d'una canna carica a palli,ni del N. 6 entrò in massa al disoLlO del g ran trocantcre dest r o, traversando l'arto in tutta h:1 l;U8 spe::<Sezza, Seoza offendere organism i importanti La carica dell'altra canna, del 4, entrò a l disotto della luherosita ischiatica C:el medesimo lato, ed e ssendo il paziente in posizione quasi eretta , penetr ò pr obapel gran forarne ischiatico ne lla cavita a ddominale .

1 CHIE\URCICA 16 '19
Oooo un immediato colla s so, i!· ferito si riebbe, l'emorra"'ia. non fu considerevole pe rchè i grossi ,·asi della pelvi furono colpiti, ma trasportato il ferito a casa, si notò perdita d'orina sanguinolenta, costipazione intestinale, peratura 3s•, polso 120. Si medicarono le ferite, si str a r ono gli oppiati, e l'infermo migliorò nei tre g1orm se · n-uenti. La temperatura ridivenne normalE>, il polso scese a i lassaliYi salini procuràre>no copiose eYacuazioni, l'orina di qu a ntità no1·rnale conteneva poco sangue, l'appetito mis:-lioraYa, la ferita d'ent-rata, benchè vasta. dava poco dolore, la linaua era un poco irnpatinata, il sensorio era libero. L'arlùome era leggiermente timpanitico senza molta dislen · :::ione, ma a sinistra della linea mediana, e. metà fra l'ombel ico ed il pube. si notava un'a r ea sospetta, grande come l)leta della palma di una mano, tesa, lucida, leggermente arrossita. più calda delle regioni circostanti, dolente alla pres· sione, dovuta e vide n temen te ad un proce:;so flogistico dello strat.o profondo della pare te addominale, e presumibilmente involgente un' area limitata di peritoneo. .
La carica, trave r s a ta la pelvi, lacerato il retto e la vesciCa, si e ra innicchiata 'nell e pareti addominali. Il numero dei piccoli proiettili aveva evidentemente leso il viscere, ed un'operazione qualsiasi subito è.opo l'accaduto non a·vrebbe dato speranza di buon esito.
Pure, il corso di questi tre giorni non auebbe fatto pensare a condizioni casi serie. perchè non s'era visto sangue nelle feci l'infermo non a veva an·ertilo dolo r e al retto, non v'eran o ;tali sintomi di perilonite generale, l'ematuria era presto cessata, .senza lenesmo e senza di Ciò non o:::tante, la zona ·infiammatoria delle pareti anter iori dell'addome dimostrava razione del proiettile, e fors'anche quella d'un'infiltrazione o rinosa, e d'un' infezione della ferita per materiali trasportati d.al rello, .
Si provvide per una medicazione della ferita con creohna calda si ordinò una dieta stimolante, si pensò a tenere aperto l'alv; e si rimandò a tempo opportuno l'apertur a dell'ascesso· Ma dl li a poco il giovine tto di venne inqu ieto, il polso fece tArdo, si manifestò sete inestingu ibile, la s1
1620 RI VISTA a 39•, il ventre si gonfiò e divenne dolente, la macchia oscura delraddome dh·enne livida, poi il polso divenne rapido fino. a 140 e debole, cominciò il delirio, ed in due giorni l'infermo morì.
L'autore dopo la morte passò una lunga sonda dal foro d'ent rala, e giunse a sentire i pallini sotto la parete addom inale, ma l'autopsia non fu permessa.
Delle settioemte consecutive all'ottte media .de Chiru roie, N. 8, 1892).
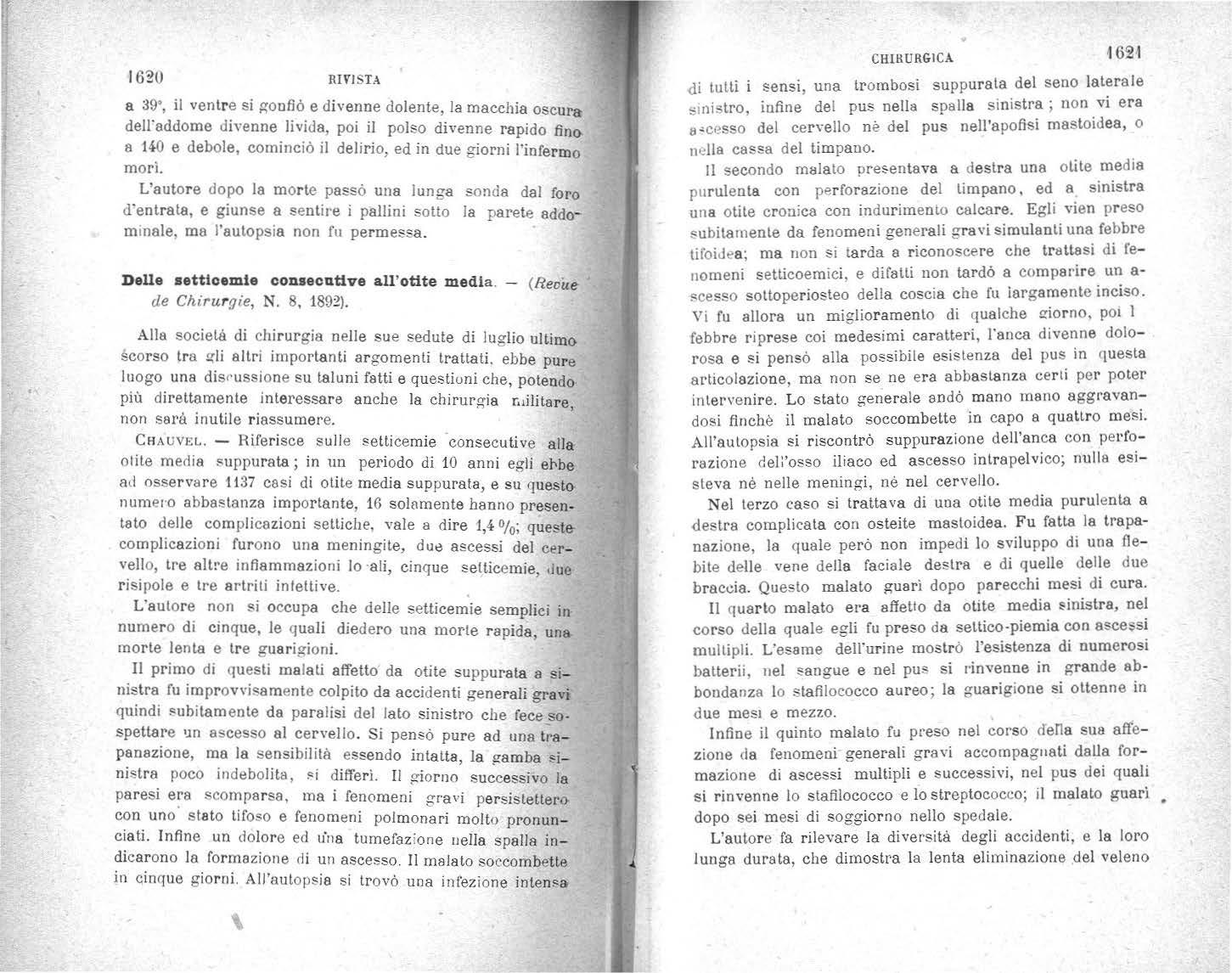
Alla societa di chi rurgia nelle sue sedute di luglio ultimo. scorso tra !:\"li altri importanti argomenti trattati. ebbe pure luogo una disl'ussione su tal uni fatti e questioni che, potendo più direttamente interessare anche la chiruro-ia r.dlitare ,., ' non sara inutile ri assumete.
CHA OVEt.. - Riferisce sulle setticemie ·consecutive alla olite media l'Uppurata; in un periodo di 10 anni egli et-be ad osservare 1137 casi di otite media sup purata, e su questo numer-o abbastanza importante, 16 sol11mente hanno presentato delle complicazioni settiche, vale a dire 1,4 %; questecomplicazioni furono una meningite, ascessi del ce rvello, tre infiammazioni lo ·ali, cinque seltice mie, J ue risipole e tre artriti infettive.
L'autore non si occupa che delle setticemie semplici in numero di cinque, le quali diedero una morte rapida, una morte lenta e tre guarigioni.
Il primo di questi malati affetto da otite suppurata a sinistra fu colpito da accidenti generali gravi quindi subitamente da paralisi del lato sinistro che fece so· spettare •1n ascesso al cervello . Si pensò pure ad una trapanazione, ma la sensibilità essendo intatta, la sinistra poco indebolita, differì. Il successivo la paresi scompa r sa, ma i fenomeni gravi persistettero con uno stato tifo so e fenomeni pol m onari molto pronunciati. Infine un dolore ed u na tumefaz ione uella spalla indicarono la formazione di un ascesso. I l malato soccombette in cinque giorni. All'autopsia s i trovò una infezion e
Chirurgica
<li tulli i sensi, una trombosi suppurata del seno laterale san i:;tro, infine del pus nella spalla sinistra; non vi era a del cene!lo n è del pus nell'apofisi mastoidea, o nella cassa del timpano.
Il secondo malato presentava a destra una olite media purulenta con per forazione del timpano, ed a sinistra un a otile cronica con indurimenlo calcare. Egli vien pr eso subitamente da fenomeni generali gravi simulanti una febbre tifoidea ; ma non si tarda a riconosce re che traltasi di fenomeni setticoemici, e difatti non tardò a comparire un a!'Cesso sottoperiosteo della coscia che fu largamente inciso. Vi fu allora un miglioramento di qualche giorno, po1 l febbre riprese coi medesimi caratteri, l'anca divenne dolorosa e si pensò alla possibile esistenza del pus in questa articolazione, ma non se ne era abbastanza certi per poter interYenire. Lo stato generale andò man o mano agg,·avandosi finchè il malato soccombette in capo a quattr o mesi. All'autopsia si riscontrò suppurazione dell'anca con pel·forazione del:'osso il iaco ed ascesso intrapelvico; nulla esisteva né nelle meningi, nè nel cervello.
Nel terzo caso si trattava di uoa otite media purulenta a destra complicata con osteite mastoidea. Fu fatta la trapanazione, la quale però non impedi lo sviluppo di una flebile delle vene della faciale destra e di quelle delle due bracda. Questo malato guarì dopo parecchi mesi di cur a.
Il qua rto malato era affello da otite media sinistra, nel corso della quale egli fu preso da seltico·piemia con ascessi multipli. L'esame dell'u r ine mostrò l'esistenza di numerosi batterii, nel sangue e nel pus si 1·invenne in grande abbondanza lo staftlococco aureo; la guarigione si ottenne in due mes1 e mezzo.
Infine il quinto malato fu preso nel corso <fena sua affezione da fenomeni generali gravi accompagnati dalla formazione di ascessi multipli e successivi, nel pus dei quali si ri nvenne lo stafilococco e lo streptococco; il malato guarì • dopo sei mesi di soggiorno nello spedale.
L'autore fa rilevare la diversità degli accidenti, e la lor o lunga durala, che dimostra la lenta eliminazione .del veleno settico. Qu esti fatti comba ttono la teoria di F ochiér sugli ascessi fissat or i nelle setticemie.
HEcLUs riferisce il caso di un malato ch e, affe tto gia da otite media, fu preso da accidenti qu a lifi cati siccome febbre tifoidea a normale. Durante questa pretesa febb r e tifoidea ' l'otite si riacutizzò, e si pr esentò una serie di ascessi periarticolari che aperti diedero esi to ad un pus di aspetto oleoso; il malato guarì dopo di ave r a tt raversato un pe. ri odo assai grave.
REYNIER , asse risce ch e bisogna ben disti n g uere le complicazioni settiche locali dagli a ccid e nti s ellicemici gene rali. Spesso si attribuisce ad una olite la setticemiache e siste,·a prima, e di cui rotite non è che una manifestazione locale; è co sì che nel corso del grippa si "idero comparir·e dell e otiti medie purulente . Egli pensa ch e la trapanazione mastoidea debba farsi alla più leggera minaccia, anche se non vi fo ss e ancora pus in quella apofisi, permettendo tale operazione la facile lavatura della cas sa del tim pano, ed avendo osservato che i malati così operati guarivan o meglio degli altri e l'udito r itornava più presto.
QuÉNU pensa pure che soveole l'otite med ia è dipendente da uno stato infettivo preesistente; ma non diYide ropinione di Reynier sull'utilità de lla trapaoazione p reventiva. Questa non deve essere praticata che dietr o indicazioni locali manifestate.
CAUYEL ammette la possibilità di oti ti medie insor.te sotto l'influenza di una ma ques to non era certo il caso ne i cinqu e maiali che moti,·arono le sue osservazion i.
Trazione d.ella lingu a noi casi di morte apparente per asfis sia . - Processo LABOR DE.- Accade mia di medicina belga, 22 nove mbre 1892.
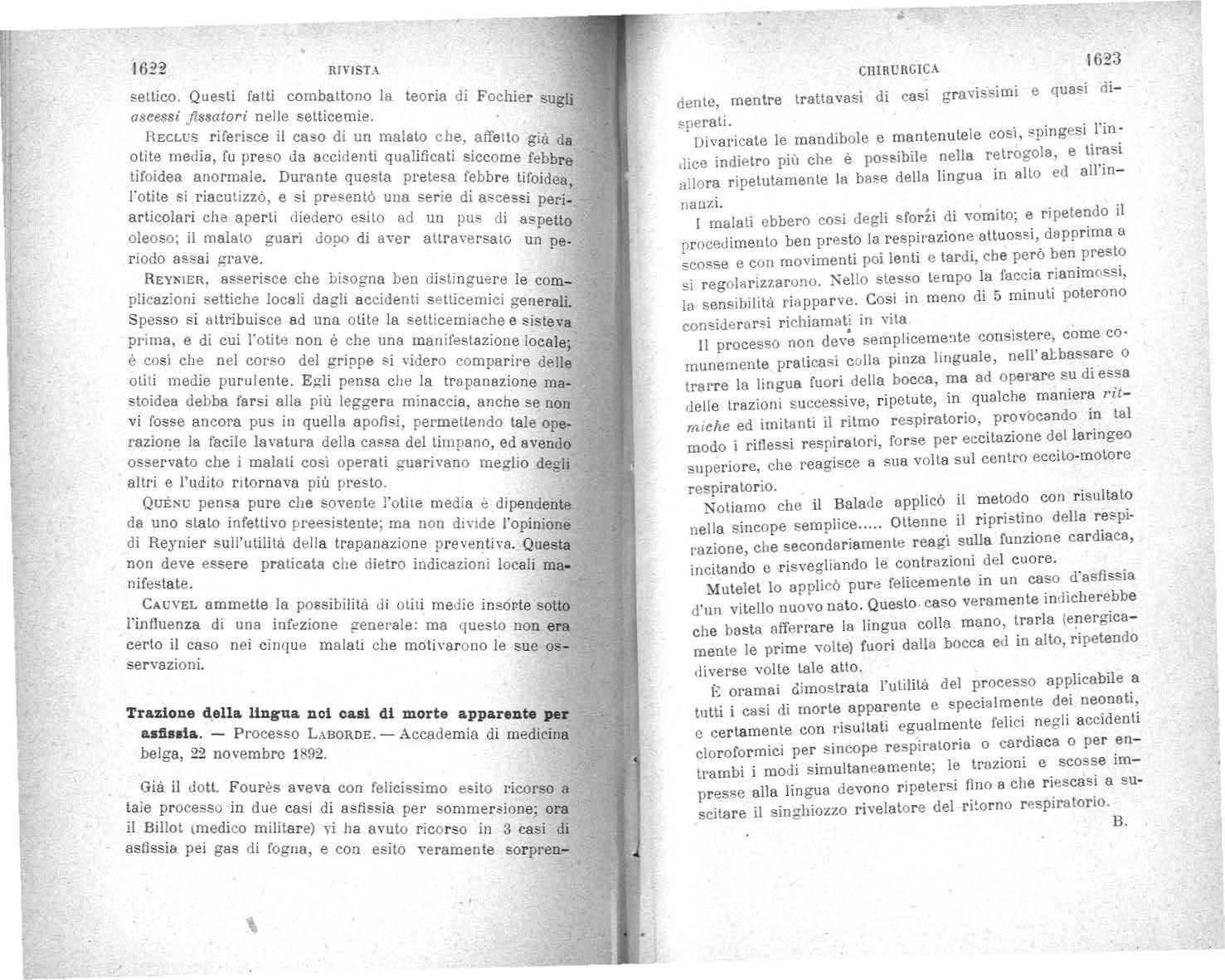
Già il dott. Fourès aveva con felicis simo esito ricorso a tale processo in due casi di asfissia per ora il Billo t tmedico militare) yi ha avuto rico rso in 3 casi di asfissia pei gas di f'ogna, e con esito veramente sorpren• dente, mentre trattavasi di casi gravissimi e quasi di"perali . . . r·
Di vat•icate le mandibole e mantenutele così , !;pingesl. dice indietr o più che è possibile nella retrogola, e allora ri pelutamen te la base della lin g ua in allo ed ali mnanzi. d 'l
1 malati ebbero cosi degli sforzi di Yomito; e r ipeten o r procedimento ben presto la attuoss i,. dapprima a scosse e con movimenti poi lenb c tard1, che pero ben pres t?
"i r e " oiQ r izzarono . Nello stesso tempo la faccia rianimosst, riapparve. Cosi in meno di 5 minuti poterono richiamati in vita .
11 processo non se mpliceme:1te consistere, come co· munemenle pralieasi c olla pinza linguale, nell' o trat·re la lingua fu ori della bocca, ma ad operare d1 dell e trazioni s uccessive, r ipetùte, in qualche, mtche ed imitanti il ritmo r espi ratorio, provocando tal modo i riflessi res pi ratori, fo rse per eccitazione superiore, che reagisce a sua volla sul centro e cctto-moLore r espiratorio . . Notiamo che il Balaùe applicò il metodo con nella s inco pe s emplice ..... Ottenne il della raziooe che secondariamen te reagì sulla funz10ne cardiaca, incitando e risvegliando le contra zioni del cuore. . _ .
Mutelet lo applicò pura felicemente in un caso .d asfbsra d'nn vitello nuovo nato. Questo . caso ve ramente che basta afferrare la lingua colla mano, mente le prime volte) fuori dalla bocca ed m alto, rr petendo diverse volte tale atto. _ . .
È oramai dimostrala l'utilità. del proces so .a tutti i casi di morte apparente c specia lmente 0 certamente con l'isullati e gu a lmente felici .negh accldenll cloroformici per s in cope respiratoria o o per .entrambi i modi s imultaneamente; le traz10m e. Impresse alla lingua devono ripete rsi fino a che a s uscita re il singhiozzo rivelator e del r esptrator tO . B.
C ur a. dell e ulcert della gamba . - BuTT E. - (Jou rnal d e Médecine et de Chirurgie, luglio, 1892).

Il do tt. BulLe seg nala il segu ente procedimento che egli ha adoper ato con buoni r isultati:
1• Nettare la piaga matti na e sera con un a soluzione di sublimato caldo al 1/ , per 1000 o di coaltar sa ponato al •; , 5; spargere dopo ciascuna lavatura di polver e di e di iodol mescolati a parti eguali: inviluppare d'ovatta asettica e mantenere il tutto con una benda. Dopo 3 o 4 giorn i di questo trattamento i dolori, molto intollerabili, si a ttenuano e scompaion o a :1che. Si va riano all ora i topici.
2• Dopo una accuJ'ala e com pl eta, toccar e l'ulcera e le parti vi cin e con un pennello immer;;o in una mescola nza di glicerina creosotata al ' /10, as per gere di polvere di aristol e d1 talco mescolati a parli uguali, ovatta e benda.
Questa medicatura è fatta mattina per otto giorni.
3° Negli otto gio rni consecutivi la m ed icalura si fa soltanto ogni due giorni e si adope r a una m escola nza a par ti eguali di creosoto e glicerina.
4• Soslituiru quindi alla glicerina creosotala una mescolanza a parti e gua li di lintnr a di iodo e di :Spar ger e dP.Ila medesima polve re.
S otto l'influenza di questo tr attamento, l'ulct•r a di minuisce a poco a po co e si a r riva a non più fare la medicatura che ogni 3, 4 ed anche 5 gio r ni .
Gen e ralme nte, dopo un mese e m ezzo a due mes i, la c icatrizza zio ue è completa. Si raccomandano allora le doccie fredde sulla gamba ogni mattina .e il porto di una calza da varici di tessu to per quan to più è possibile elastico.
Durante la cura il malato deve cammina r e il meno poss ibile e mantenere la gamba distesa qua ndo s ta seduto; ma non devesi impedire la marcia in un modo assolu to.
In H malllti cosi 'curati, alcuni dci q ual i e rano affetti da ulceri estese mollo dolorose, che datavano da più a nni, si la guarigione in due mesi in media.
RI VIST A DI ANATOliiA E FISIOLOGIA
Normale E Pato L Ogica
Ricerche biologiche sopTa. alcuni bacteriDott. GALEOTTI. - (Lo sperimentale, 30 g1ugno 18!12).
L'auto re crede che la biologia dei microrganismi in quanto riguarda la pr oduzione coloranti, sia sta ta finora poco studiata, ed egh SI è perc1 ò proposto di ri ;:oh·ere i seguenti quesiti :
1o Ricercare se la produzione delle sostanze coloranti nei batteri è collel!ata o no ind is s olub ilm ente con la vita di questi esse ri; . .
2• variando le condizioni di vita di al cum bacteri, vedere quali di queste condizioni sia no capaci di alterarne la proprietà cromogena; . .
3• Data una con dizione sfavo r evole per la produ ziOn e d1 pigmenti in un determinato ved.ere se e quando qnesto microrganismo é capace d1 la sua proprietà cromogena pur seguitando a pers1stere la iste1>sa condizio ne.
1 mtcrobi che a dope r ò nelle sue ricerche sono stati i seguenti: m. prodigiosus, b. violace.us, m . au ranti ac us, b. pyoeyaoeus, b. rosso delle acque, sarctna rossa, b. fluoresc...us, b. lactis erytrogenes. . .
Le esper ien ze fatte por terebber o Hlle seguenti concl us10ru c ome risp0!;,\8 ai quesiti formulati più sopra:
1· La proprietà l'lei bacteri crom?gen i produrre sostanze color anti, non ò c ollega[Jl indts solubtlm ente. la · vita di questi bacteri; cioè tali microrgamsm1. guitare a ar.cbc senza pr odurre i loro caratler!SLICI pig menti ;
2• Le con di zioni di vita che ne alte ra no la proprietà cromogena sono generalmente quelle che hanno un'insfavorevole sopra i bacteri stessi, in tutte b loro funz rom;
3• Da ta una condizione sfavorevole per la pr:)duzione delle sostanze di un determin ato cromogeno, puo que:;to, in un period 0 di tempo più 0 meno l ungo, riacq ui stare la pr'oprietà di prod urre sosta nze coloranti adatla odosi a q uella condizione sfavorevole.
. L'au tore dichiara inoltre di esse rsi r ivolto il seguen te quesrto : qual' è il signi ficato fisiologico di queste sostanze coloranti prodotte dai bacterii c r omogeni ?
Le ipotesi con cui si potre bbe rispondervi sono queste: a) le so stanze coloranti sono il risultato di un processo dJ _degen e r azione per cattive cond iz ioni di vita o per vecchiezza dei microrganismi; b) oppure si tratta di un a vera secrezione, cioè le so- · stanze col oran ti ven gono elaborate dalle cellule bacteriche con un determinato scopo fisiologico. e) oppure si trana di un fenomeno di eserez i one e in questo cas? le sostanze colo!'anti rappresentano i prodotti del rrcamb10 materiale dei microrganismi. co loni e delle cult ure aerobie il capocchiato non si pr esen ta p iù come tale ma sotto fo rma di un cocco o di un corto bastoncino c he può vegetare anche a fo rm.a di bacillo e talora, anche per strisciamento in agar- agai', il bacillo caratteristico a capocchia; questo stadio di vegeta zione è ab ba stanza raro nelle culture all' aria m a si tro va; mentre l'ordina r ia è la coccacea o bacillare c orta.
Sulla. morfologla del ba.elllo del tetano. - D. BELFANTI.(Gio rna le dell a R Aeeademia di medicina di Torino, fascicolo 7°, 1892).

Il bacillo del tetano è un anaerobio facoltativo, ma date cer te co ndi zion i, coltivandolo io determi naLi modi, si può re nder lo anaerobio assoluto .
Questa anaerobicità s i può conferire sia coltivandolo nel v uoto, nell'H, nel gas ammoni aco, e !ascian dolo molto tempo in que ste cond izioni, trasportandolo allora io mezzi os :oigenati non vi C!'esce più.
.
L'ultima di queste tr e ipotesi è secondo l'autore la più pr obabile, e con essa si a ccordano perfettamente i risultati otte nuti dalle sue esperienze. Nè contro vi il fatto della delle sostanze coloranti pur· segui tando i microrganrsmi a v ivere. Poiché, date alcune condizion(sfavorevoli é naturale che il ricambio materiale vena-a alterato e cosl . o ' pure. SI i prod<) tti di esso nelle loro proe chimiche in modo da non mostrarsi più con J carattei'J d1 sostanze co loranti . Di analoghi fatti s e ne posrrscontrare molti non solo nella biologia de i microrganrsmJ, ma anche nella biologia degli esse ri super iori.
L'autore é q uindi convinto che le sostanze coloranti ehe caratte rizzano i bacteri cromogeoi, non s iano altro ehe i prodo tti del ricambio mate riale d i ques ti G.
Il baci llo del tetano può essere colli vato all'aria per s t risciamento su aga r o in qualunque m e zzo o rdinario dove vi sia presenza di ossigeno, e vi cresce più rigogliosamente che non· lo stesso coltivllto in H, anzi se si fanno colture per punture in gelatina a d agar- , rado s i sviluppa nel pr-ofondo, mentre vegeta tutto alla superficie.
I due mo di di cultura o iu ossigeno, od io gas H o nel vuoto, son o generalmente dive rse . In quesç ullimo modo si trovano gene ralmente le colonie e le forme bacillari capocchiate o non, descritti dagli a_utori, mentre in quelle in os· sigeno le forme morfologi che sono diverse.
Stu diando questa forma per una lunga di tempo si osservano dei pe riodi vegeta ti vi dagli Ol'dinari, e che non sono nè possono essere forme involutive, ma sono invece vere forme di vegetazione del microrganismo Queste forme sarebbero la coccacea, la bacillare; da questa si passerebbe poi alle filamentose con filamenti l un ghissimi circonvoluti, òicotomizzati con dicotomizzazio ne vere e non false. In fi lamenti poi si fo rmere bbe!'o le s pore ; ed a ogni spora resterebbe attaccata una parte del protoplasma che costituirebbe il r esiduo ct· e costituendo così un bacillo c'aesso un'appendice dale talora é retti!" pocchtalo. Questa parl mea come u b e causfibrata costituendo n aclllo Yero. Tal'alt
D Il come una coda ra è a a sovraesposla l . : . tetano ha molli punti di rtsulta che il bacillo del dm·e 0 · ' mtg tanz tl col (7 ra st colloca anche l' t penere 8ireptot -r·
Tutte queste fo d' ac !Jnomic es. l b . rme tverse hann . rLcare la tossina del tetano. ? pero la pt·oprieta di f6bla classica forma del tetano ' toss ma che negli animali dà ture aerobie che anaerobie ' tanto che proYenga dalle col-
Volendo l' - · . . . autore m quec:to la v . .
SJZtone della morfologia -del hmttarsi soltanto all'tspomLche e _fisioloJ!iche della sua o e a!le proprie ta chila proprtelà fluidificante del b S.! limita A di re che as-solutamente le<>ata al pot acl o che per molli autori è cosa distinta tossico, e:;? li la ritiene invece tere tossico. potendost' " , potere pepsico non è il po 1 · .. vere un b ·11ge alma e che pure fabbri.: . act o che non fluidifica la ceversa _si può a vere una ; e viquesto stavi prod . . a tluuilflcante senza eh d ' u z woe dl Q e per ua.e ad alcuni bac'Jl' d l uesto potere é ind' . 1 1 e tetano lVIvirus tetanico ' e non ha a che ra · •· re col

DI ANATOlllt. E FlSIOLOGlA
Riassumendo, i principali fatti ri;:contrali sarebbero:
1• che il potere di assorbimento della mucosa nasale corrispondente ·alla regione vestibolare deve con sid erarsi come nullo;
2' che invece il resto della mucosa nasale mostrò costantemente di essere dotalo di potere assorbente;
3" che questo potere di assorbimento varia secondo le sostanze: cosi mentre il ioduro di potassio è già riscontrabile nelle urine dopo 10' dal momento d'applicazione, il salicilato di s odio non lo sarebbe prima di 20', e così dicasi del santonalo di sodio, ecc. ;
4• che questo potere d'assorbimento varia secondo gli individui e le variazioni oscillerebbero entro limiti assai più ampii che non si osservino nell'assorbimento per la mucosa d ello stomaco ; ;>o che il potere di assorbimento della mucosa nasale ed il potere assorbimen to della mucosa dello stomaco non
'i è diretta correlazione;
Dl al cune ricerche l t n orno al p t della mucosa nasale o ere dl assorbime nto della R. Accademia d.. -D M. TREVES. :-( G io -rnale t me lCl na , N. 7, 1802).
L autore ha intrapreso alcu . sorbimento della m ne ricerche sul potere d' . ucosa nasale 1 asrlsulta sia stato _argomento che finora non
A oggetto d1 s tuù· . questo scopo h · IO parl!colar e . . a tnlrodotlo n 1, . . · reccht Indi vidui de<71 . d . e e ca VIta nasali cii t . o l a atti tamp · d' pa- enenh sostanze le qnal· om ' cotone idrofilo con s·bil · '• assorbite - l e rtscontrare nelle u . , sarebbe poi stato po"col · h rme e con · - ogtc e o con riceJ·che chi :n· l esperienze fisio·tossidi atropina, idrocloralo me bleu di metiline toduro di porassio, san tonato ddl salicilato di sodio' l SOdiO. '
6° che infine il potere di assorbimento della mucosa namerita di es sere considera lo come assai grande. Fin q ui le ricercne. Ora l'autore si propone, p r oseguendo le medesime, di cercare se, dalo questo forte potere ass orbente della mucosa nasale non abbia a d es;;ere questa per av"entura una delle vie di penelrazione nell'organismo c osi di certi veleni come del fosforo, mercuriO, piombo, ecc., che di germi infettivi quali sarebbero quelli della pneumonite, meningite, tubercolosi. malaria e molle altre affezioni di cui malgrado le più minuzi"se indagini, non si riesci finora a trovare quale ne sia slala l a porta d'entrata . A questo già accennammo alcuni fatti clinici quale ad esempio la fr equenza con cui la nevrosi fosforica, il lup1.1S, colpiscono in modo p rimitiv o la r egione nasale; vale inoltre a confor· tare in tale presupposto anche la considerazione che la mucosa nasale pur essendo esposta quasi· come quella delle vie digerenti al pericolo di assorbir-e dei materiali nocivi pr ovenienti dall'esterno, non solo non è provveduta di alcuno di quei mezzi di difesa di cui quest'ultima può invece disporre (succhi digestivi, peristalsi, funzione epatica) ma si
RI\'I'TA 0[ A"'ATO)flA E FISIOLOGIA trova anzi nelle <:ondizioni perchè i bacterii per l ,delle vibrisse che li soffermano e delle l come in camere di cultura. possano, assor btlt, effettuare Il loro entro all'organismo.
G.
Rivista Delle Malattie Veneree Edella Pelle
D e lla cosi detta malattia del Raynaud (oan l grena s mme· tr:tca.) di origine sifilhlca.- A. ELSE<"f<ERG. - (A rch Dermat und Syph. e Centralb .fii.r die med. w· sensch., 32, 1892). tS
In una giovane donna si riscont r arono su ambedue le al e alla superficie dorsale di ambedue le mam, m corn spondenza della te.,ta delle o-.,a t d l . - ' me acarpee el e maccllle di color violetto "Curo E · t . . ' 1 · s1s mollre foco al :Snl!renosi e ulcerazioni ai diti indici alle ooamb alle (l!ta dei. piedi: un macuioso, tronco e estremi ta; diarrea in frenabile febbre· Nessuna alterazione al cuore e ai aros"i \,asi· N · t.· · 11 o . r umerose ci ca Cl a e gambe. e alcune intume<::cenze delle ossa del cra_niO tesl!monian za della pregressa sifilide.
:\on alcuna cura specifica e il malato mo.rì. Alla. sezJOne si nodi gommosi nel fegato; i piccoli rami. della arteria dorsale del piede (che solo polé esse re e sammato) erano aleromatosi; nel tessuto sotto le ulce:e. caogrenose, le piccole arterie, segoatamenle la lor o avveollzla erano molto inspessite e infillrate da poche piccole cel!ule r otonde .che qua e là fra la intima e la media erano .a g,ruppate p1ccolmoduli.le cellule epiteliali o,·e gonfie, ove _mollo ristret to. L'Eisenberg consider a le alteraz!Om del vas1 di natura sifilitica.
RIHSTA DELLE MALATTIE VEl'iEREE E OELI..\ PELLE 163·1
Sulla. cura. della sifilide con le iniezioni di subUmato al 5 per 100.- V•l. L UKAStEwtcz - (Wie1 .. kUn. Wochens. e Ct!nlralò . Ju r die medie. Wissensch .. N. 40, 1892).

Le iniezioni. già provate dal Lassar e Oestreicher, delle forti soluzioni di sublimato furono usate in 100 malati con leggieri, gl'avi fenom eni sifìlitici precoci e tardivi. Era iniettata o:rni settimana ne1 muscoli glutei una siringa di una soluzione al 5 p. 100 di sublimato (sublimato, cloi·ur o di sodio ana 0.5, acqua distillata 10). Il risultato fu sempre mollo pronto e ordinariamente era manifesto !>ubito dopo la prima iniezione. Lo stato generale m igliorò prestissimo, ed i fenomeni sifilitici rapidamente si dileguarono anèhe in casi che prim a avevano ostinatamente t'esistito ad altri metodi curati\'i. S perimenti di confr onto con l'olio cinereo al 30 p. 100 e con l' ioduro di mercurio circa la loro influenza sulla in,·oluzione delle glandole inguinaJi e della sclerosi furono decisamente faYorevoli alle iniezioni di sublimato. Il dolore p r odotto dalle iniezioni fu in gene rale lievissimo; solo eccezionalmente si fece una leggiera infiltrazione, n f> furono mai os"'erYate la stomstite od altri dispiacevoli effetti seconda ri. I n 11 malati si potè notare un mediocre aumento di temperatura dopo la prima iniezione. Le indagini sul sangue mostrarono fenomeni (aumento del peso specifico nei primi giorni, aumento dei corpuscoli rossi del sangue), <;he sembravano indicare un prim itivo spessimento e consecutivo assottigliamento del sangue.
Quanto al numero delle iniezioni, esse variarono eecondo i d1vei'Si casi fra 4 e 12; però, avuto riguardo all a rapida del sublimalo, è da consigliare di non fa rne meno di sei od. otto per una cura . L'autore raccomanda questo metodo, che ha i vantaggi aelle soluzioni risolubili di sublima.lo senza il lor o pericolo degli effelti cumulativi.










