
28 minute read
RIVISTA A1EDICA
Dell 'aobllla gastrloa . - MAx TI:>:HORJS. - (Medical 11 giugno 1892).
L'achilia gastr:ica (mancanza di succo gastrico da sucoo) è il sintoma principale di quella forma morbosa scritta finora sotto il nome di << atrofia dello stomaco », Nello studio di ques ta malattia, al contrario di ciò che gue comunemente, l'anatomia patologica é servita di all'osservazion e clinica, chè il riscontro di atrofia nelle dole osser vate nelle autopsie ha indotto allo studio cl della speciale alterazione, e si è giunti a riscontrare i clinici corrispondenti. L'A. tace dei pa rticolari di questa sione rinviando il lettore ad una speciale memoria del intit.ulata" Zur Kenntniss der sogenannten M agenat roph ie nella quale è descritta questa forma clinica in tutti dettagli con speciale accuratezza.
Advertisement
La forma clinica dei casi di.atrofia dello stomaco p ri ma da Feuwick e poi da Osler (1), Nothnagel (2) e d corrisponde esattamente a quella dell'anemia perniciosa. nonostante i citati autori dai risultati delle autopsie dano che la lesione dello stomaco (atrofia della mucosa) la causa dell'anèmia, pure, per quanto possibile, ciò non stato ancora dimostrato. Di fatto non esiste prova che tì della mucosa gastrica si riscontri in tutti i casi eli atro a . h · · t · d' .ft · . perniciosa , ne c e sempre 1 sm om1 1 ques"" corrtnenua . . h . . b 't . . dano con la lesiOne gastrtca, c e puo ene rt eners1 m casi l'atrofia dello stomaco essere cagionata dalle SI 8 . . t't' d Il' condizioni di depauperame nto nutrJttvo, euetto e anemta pernici osa.
EwAld e Le\·oy più tardi hanno dato un'esatta r elazione icroscopica de ll'atrofia dello stomaco, ed il primo dice di :Ver riscontrato spesso tali condizioni in individui morti pel' cancro 0 per cachessia senile.
In tu tti i casi non solo la mucosa era affetta, ma anch e lire parti dello stomaco, e il Meyer dice « in questa affe: ione la muscolare dello è in tale grado la contrattilità dell'organo è seriamente 1rnpegnata e perc1ò resta notevolmente disturbata o anche abolita la facolta dell'assorbimento. Le tre funzioni quindi dello stomaco restano abolite per la scompa rsa del parenchima, e come per altri orgt>ni, continua il .Meyer, io uon so perch é non s i possa a questa lesione dello stomaco dare il nome di tisi » E l'ha chiamata « anadenia dello stomaco • per le condJzJom cbe questa tisi crea, della scomparsa cioè del parenchima secretore con tutte le conseguenze.
Quanto alla sintomatologia il Meyer raggruppa tutti i segni clinici in un quadro simile a quello dell'anemia permciosa progressiva con la sola diffe rehza che dominano 1uelli dell'apparato digerente. La dvrata de lla varia da qual che mese a due o tre anni, nel qual caso è la digestione intestina le che compensa il difetto della gastrica. funzione peraltro sempre vicariante e che in r elazione al potere limitati) dell'mte;:tino tenue, non può ritene r si sufficiente per mantenere la nutrizione di simili infermi per un tempo relativamente luogo. .
Ritenendo adunque nella maggiore dei casi menzionati nella letteratura che la malattia è di natura che tutte le funzioni dello stomaco disturbate in guisa da produrre gradualmen te la morte, il nome di gastrica è ad essa convenevolmente dato .
In moltis,;imi casi, non controllali con l'autopsia, l' a trofia dello stomaco' e stata congetturata dai sintomi clinici o glio dall'analisi chimica del contenuto gastrico; e il zach, uno degli og;:ervatori più. accurati di questa l nota che in di questa malattia spesso mancare i sintomi subicttivi nonostante che le condi chimiche dello stoma co siano distu rbate in grado ele
L'A. ebbe l'opportunità di ossE-rvare quattro casi ben nunziati della cosidetta atrofia dello stomaco, uno dei ha potuto seguire per ben quattro anni, e perciò si autorizzato ad esporre il risultato delle sue osservazio ni.
Egli anzitutto contrasta le denominazioni di atrofi a strica, at r ofia della mucosa dello stomaco, tisi gast rica anadenia dello stomaco, perch è sono solamente fonda te segni clinici e non sulle condizioni a natomo -patolog-iche, quali del resto non sono ancora con sicu rezza ben
Pertanto, egli riferendosi a lla mancanza del succo "'"""'""" crede che sia meglio appropriato alla lesione il « achilia gastrica ».
I sintomi principali osservati dall'A. in lutti i casi da riportati consistevano in costipazione intestinaìe, vomi ti, di capo , inappetenza, senso di pienezza gastr ica e era allo stomaco; in tutti pallore della pelle e delle mucose però g rave dimagramento. Nel contenuto gastrico, a sto rligiuao, consistente esso in un liquido torbido, scarso e reazione alcalina, si riscontrò all'esame microscopico che cellula epiteliale in disfaci mento.

L'esame de l c ontenuto dopo un'ora o un' ora mezza dall'aver fatto ingertre ai pazienti la colazione Ewald, diede presso a poco in tutti i seguenti risultati : giera reazione acida, pet' la presenza di acido lattico cloridrico, assenza di peptone e propeplon e, assenza o di pepsina, non cattivo odore, nè segno di decompoiSIZitone; Dai segni clinici e dal risultato dell'esame la gnosi di achilia gast rica era per l'A non discutibile.
P er il trattamento l'A. consiglia di somministrare agli · fe rmi il cibo assai minutamente triturato, . perchè lo sto,mftco; no n essendo più capace di dissolvere l'a lbumina non è ad allaccare gli in volucri dei granuli amilacei:
MEOICA ·1097
me assai utili i rimedii tonici dello . stomaco come il la: ,.gio e la di:etta. L'acido clorid:ico in 1 cast gli rmsCl va ntaggwso, nè la pancreatma r1spose raccomandazioni che ne fanno Reichmnnn, Ewald Boas. cura però bisogna a vere nella dieta, l' unica, seodo L\.. che se ben regolata possa dare vantaggi positivi, egli s perimentato in tre dei casi studìati esser dipeso da sola la c e ssazione del vomito.
In tutti i r-asi òi mancanza di succo gastrico la digestione si compie principalmente per l'intestino tenue; non si può dire esclush·amente, perché la tra5formazione dell'amido in zucchero, fino a che i granuli di am ido sono liberi, principia dalla bocca e si continua e si compie, specialmente in questi casi , nello stomaco; ma l'albumin a non può essere digerita che nell'intesti no tenue. Se il cibo é dunque ridotto in piccolissime pat'licelle, la funzwne vicariante del tenue si compie assai ptù facil mente e l'organismo pu ò alimentarsi senza graYi disturbi, di guisa che se dallo· stomaco passa il contenuto nel tenue a tempo regolare, e se quest'uHimo non è incapace di sostene re il maggior lavorio di funzione, si determina uno stato di compenso e l'orga nismo ritorna nel suo naturale e necessario equilibrio, tanto che i pazienti possono vi \·ere molti anni senza disturbo veruno.
Dal punto di vista anatomo-patologico non si può nell'achilia gastrica ritenere con cer tezza una com pleta atrofia della mucosa dello stomaco, ciò non essendo finora pr ova to. Così non si può nulla r ecisamente affermare per l'etiologia , per la quale ha un certo valore la supposizione che gli intensi catarri cronici dello stomaco cagionino atrofia della mucosa e quindi l'chillia. Per tal ragione Jawarski e Boas a questa forma di catarro gastrico che è accompagnata da grande diminuzione di acido cloridrico e che pr ocede fo rmazione di muco, come la for ma atrofica, hanno dato il nome di « catarro cronico atroftnante ,. _
Beatrlnglmento dell'artena. polm ona.r e e malattie nlte del cuore.- CoMbY.- (P ro gres médical, 28 gio 1892).
Le malattie congenite del cuore spesso sono compa con una >'Opravvivenza più o meno . lunga, purché però div1duo rimanga in riposo, ché al menomo sforio esse rivelano con palpitazioni, cianosi, accessi di soffocazione, 1 restringimenti dell'arteria polmonare assai sono acquisiti. - Il cuore dei bambini ammala di frequente e ciò in ispecie per le malattie infettive vanno soggetti, ma in questo caso le lesioni si · nel cuore sinistro quasi costantemente, mentre le congenite colpiscono sempre il cuor destro, quantunque entrambe sia identico il substrato anatomico, cioè la cardite, la miocardite, la endoarterite. - Inoltre se le latlie acquisite, per la integrità costante del sistema rioso che compensa l'alterazione del cuor·e, senza zione, possono l'imanere a lungo inavvertite, le invece sono mal tollerate e si rivelano assai
Se la flogosi colpisce un cuore incompleto, ne e devia in vario modo lo sviluppo a seconda dell'epoca vita del fo::to, producendovi delle cattive conformazioni, possi bili quindi dopo la nascita, ossia dopo il suo sviluppo. - Il setto interventricolare si forma dal basso ratto e si completa nella 7• settimana della vita in l'arteria polmonare e raorta sono gia formate pri ma
7• settimana: quindi perché il loro sviluppo sia arrestato necessario che una malattia precocissima colpisca il nelle prime settiman e della .gestazione. Al contrario il interventricolare comincia a formarsi alrs· settimana foro del Botallo non si chiude che a lla nasèita o poco donde la sua persistenza relativamente più frequente. Le malattie congenite del cuore clinicamente si ,.,·,1""".,. a tre:
1• Cattiva co.nformazione dell'aorta e degli orifizi colo-ventricolari destro e sinistro per lesione valvolare d'altro genere.
llEDlCA 1099
2• ca ttiva conformazione e in ispecie r estringimen to dell'arteria polmon are.. . . .
3' Cattiva conformazrone e spec1almente persrstenza del forallle del Botallo e della inter ventricolare.
Mentre il primo gruppo di lesion i clinicamente non differis ce punto dall e congeneri acqu isite, gli altri due esigono una tra ttazione speciale.
Il restringimento dell'arteria polmonare è la lesrone più importante e do mina le altre. - Il forarne del Botallo, la comunicazione interventricolare possono esistere da soli, ma in questo caso sono reperti piuttosto anatomici che clinici : difatti non vi si osserva cianosi, la mescolanza del sangue veno5o coll'arteri oso, perc:hé essa non da questa dipende, ma dalla imperfetta ossigenazione del sangue venoso causata dall'ostacolo che il restringimento dell'arteria polmonare reca alla piccola circolazione. - Il ventricolo destro s'ipertrofizza per vincere questo ma, poiché il restringimento avvenne prima della chiusura del setto interventricolare o interauricolare, non si dilata: da ciò e evidente come da tale lesione primordiale tutte le altre · dipendano. E cioè: 1° la ipertrofia senza dilatazione del ventricolo destro: 2• la comuniçazione fra i d ue cuori per il setto in tei·ventricolare o per il forv del Botallo a seco nda dell'epoca in cui a vvenne la lesione primitiva: :l•, be nehè più raramente. la persi:::tenza del canale arterioso di comunicazione fra l'aorta e l'a . polmonare il restri ngimento di questa sia giunto fino alla otlite razione.
Le lesioni dei !>etti sono accessorie e spesso latenti. - Il reslringimento della polmonare si man ifesta invece precocemen te con la cianosi più o meno intensa e con un arresto di sviluppo cne imprime ai mala ti l'aspelLo di bambmi : han.no il vo lto violaceo, le labbra bluastre, gli occhi a fior di testa, le estremità fredde ed umidicce, le dita l"igonfiale a clava: al minimo sforzo hanno accessi di soffocazione e la cianosi aumen ta: all'ascoltazione si odono i battili tumultuosi, frequ enti, irregolari, ma i soffi non sono costanti e possono anche mancare: allorchè sopravvivono restano piccoli, senza peli, la pubertà l'itar·da ed . a 20 anni ne 10. La prognosi è tristissima: i più muoiono nelle e nei primi anni di vita, pochi raggmngono l età adulta: tubercolosi polmonare infine li predilige e ne uccide buon numero.
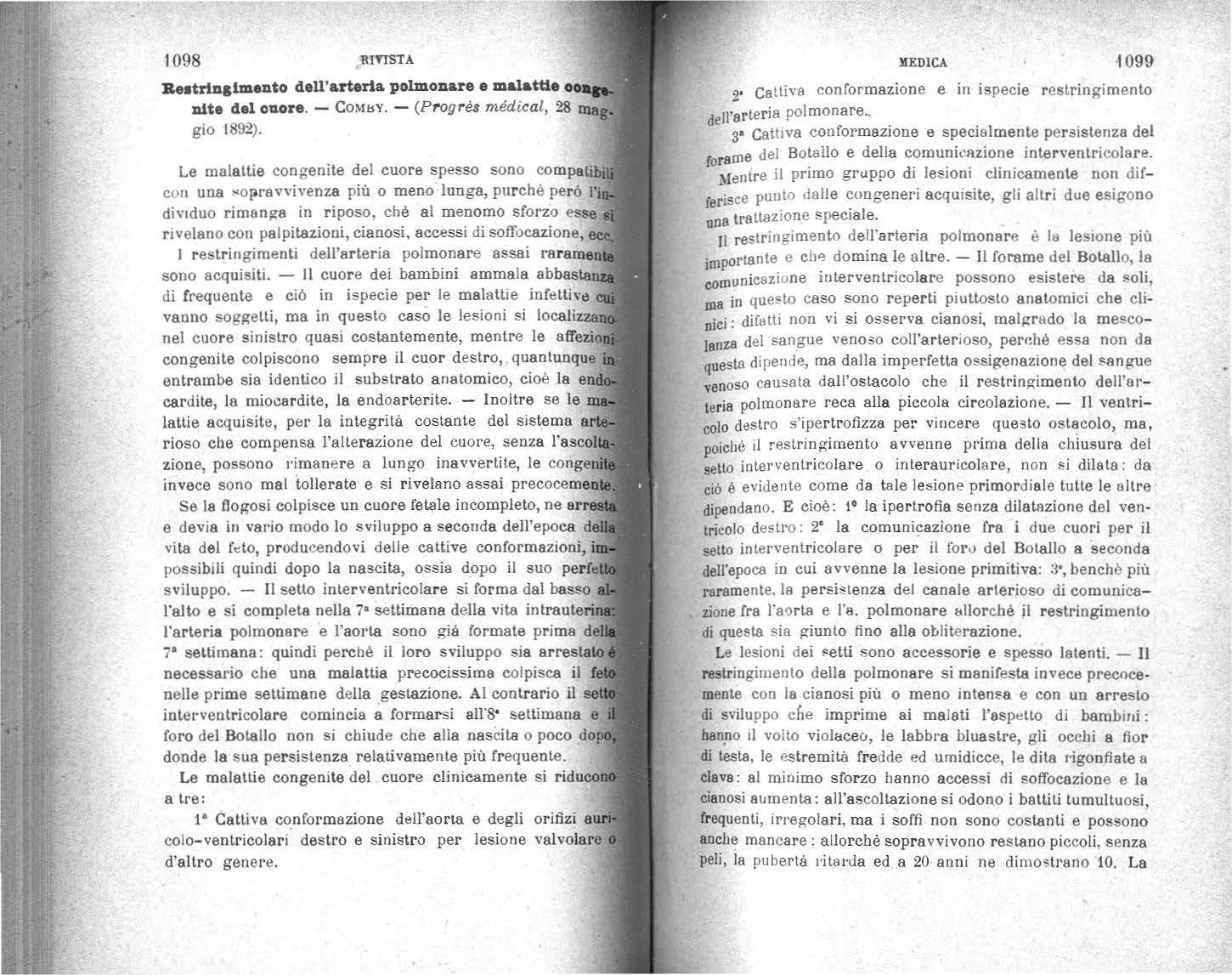
O"'i!idi viene generalme nte ammesso che le malattie del cuor e siano il reliqualo di una · te rina anzichè il fallo terat.olop;ico di un sempl 1c e arresto sviluppo.- Una caduta, un patema d'animo, il della madre possono gen erare la malattia del feto, ma questa é affatto indipendente da t)gni affeziono ma.te:na.
11 restringimento dell'arteria polmonare, benche m senz& paragone più raro , ptJò avveni re anche la . scita ossia essAre acquisito. Se ne conoscono poch1 cas1 slinl;' dai congeniti anatomicamente per la chiusura del rame del Botallo, clinicamente per la mancanza della Del resto anche questi malati hanno prese ntato una disposizione alla tubercolosi.
Per spiegare il della cianosi si sono due teori e principali . Gintl'ac l'attribuisce alla mescolanza s angue arterioso col ven osn attraverso le dei ma ciò viene cootradelt.o dai casi numerOSI d1 del forarne del Botallo senza cianosi: Lanis, Fallol riferiscono invece alla deficente ossigenazione del la cianosi diCatti si osserva non solo nelle malattie che ostacolano l'arrivo del sangue nei polmoni, o il ·suo to r no al cuore, ma anche negli stati asfittici di origine monare, tossica, infettiva, nell'asistolia ecc. secondo il F allot in 74 •t . dei casi di cianosi o malatt ia si riscontra il tipo anat.omo - patologico seguente: i• dell'arteria polmonare; 2' comunicazione in tricolare; 3• deviazione a des tra dell'origine dell' 4• iper trofia quasi sempre concentrica del ventricolo persistenza del fo r o del Botallo è accessoria e senza !ore. TuLte le varie lesioni dipendono dal restringimento l'arteria polmonare.
La cianosi manca sempre nei restringimenti acqui siti, per eccezione nei congeniti. - Nei rrimi, verificatisi dopo svilu ppo completo del cuore, il ventricolo dest ro s'i
lfEDICA HO!
fìzza concentrtJnJo ogni suo sforzo nel vincere l' ostacolo tro . l . . . d bb' ]la circolaz wne po monare e c on CIO previene senza u w cianoiòi . -Nei secondi la ipertrofia del . venlricolo destro on produce altrettanto ef'!'etto utile perchè il sangue attra · il fo r o de l Botallo sfugge nel cuore sinistro. (Restano però i casi di manca nza, della cianosi ne1 conge n1t1).
G. C.
La Dlorte repentina nelra. para.ltsl generale. - H. GuERt:->. - (Journal de Méd ecine et de Chirurgie, maggio 189 2'.
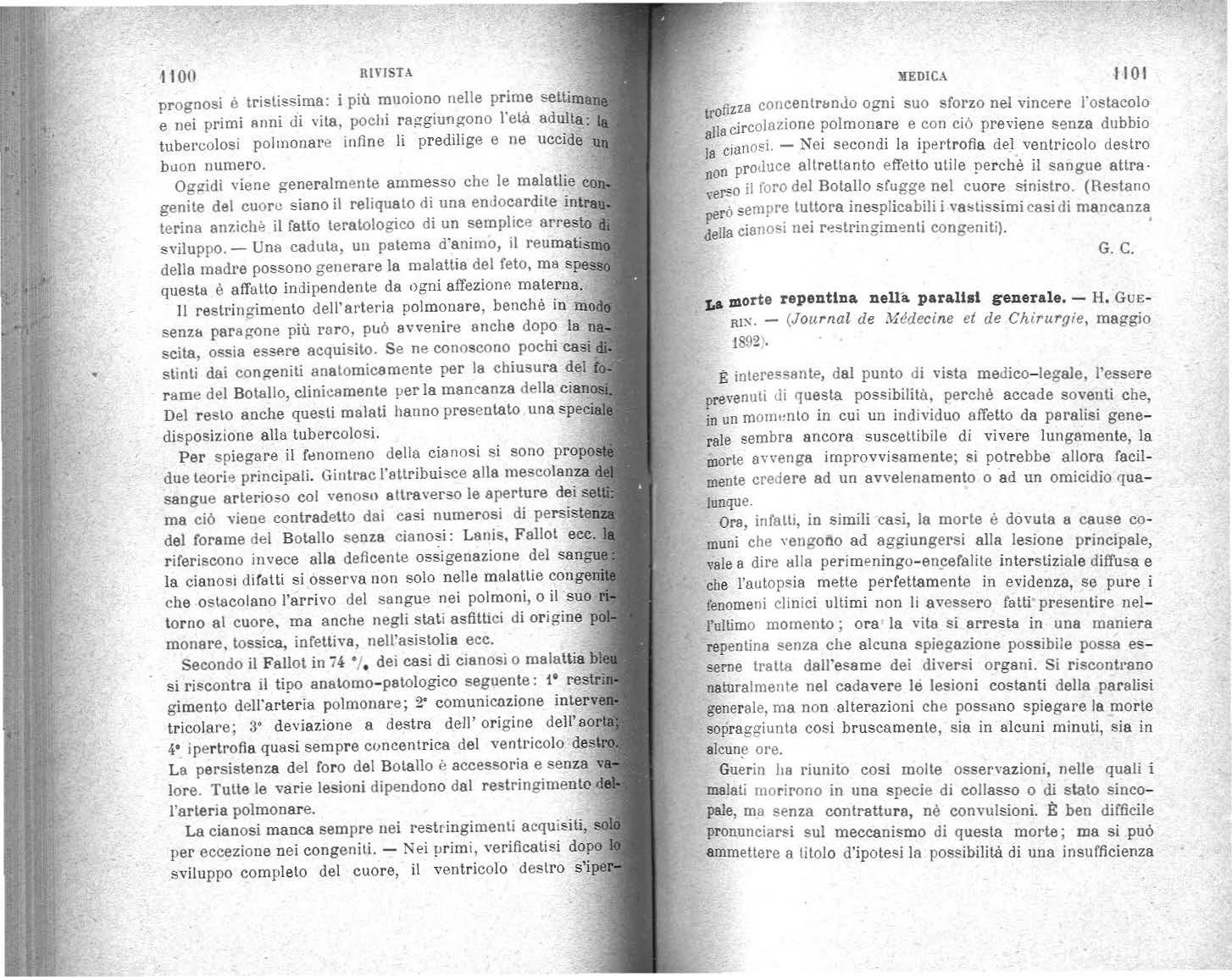
E interessa nte, dal punto di vista medico- legale, l'essere prevenu ti di questa possibilità, perché accade sovenli che, in un mo mtmlo in cui un individuo affetto da paralisi generale sembra ancora suscettibile di vivere lungamente, la morte avvenga improvvisamente; si potr ebbe allora facilmente cred ere ad un avYelenamento o a d un omicidio qualunque.
ora, infa tll, in simili casi, la morte è dòvula a cause comuni che "en gono ad aggiungersi alla lesione principale, vale a dire lilla perimeningo-encefalite i nterstiziale diffusa e che l'autopsia mette perfettamente in evidenza, se pure i fenomeni clin ici ultimi non li avesser o fatti presentire nell'ultimo mom ento; ora la vita si arresta in una maniera repenti na senza che alcuna spiegazione possibile possa esserne tratta dall'esame dei diversi organi. Si riscontl·ano natural me nte nel cadavere le lesioni costanti della paralisi generale, ma non .alterazioni ch e possono spiegare la morte sopraggiunta cosi bruscamente, sia in alcuni minuti, si a in ore.
Gueri n ha riunito cosi molte osservazioni, nelle quali i malati mo r ir ono in una specie di collasso o di slato sincopale, ma senza contrattu ra, nè convulsioni. È ben difficile pronunciarsi sul mecca nismo di questa morte; ma si può a mmettere a titolo d'ipotesi la possibilità di una insufficienza
)fltDICA 1103 della funz ione orin aria, pr oducente uno stato uremico ehe, io certi casi, si esplich erebbe cogh acciden ti e la morte n modo d'inizio non è meno variabile : ora è lento e <iuale, consocialo in certi casi a dolori vivi; ora è s ubi apopleltiforme, soprattutto nelle paralisi a forma Qu est'ultima forma è soventi grave e le sono essere allora quelle di un attacco ordinario. Ma vi casi in cui la complicazione è soltanto passeggiera e la :Stitu tio ad iniegrum avviene rapidamente.
Le par&llsl della febbre tifoidea . - R JOBLA:-!C.de M éde.:ine et de Chi r urgie, 7 maggio i 892) .
Le paralii>i della febb r e tifoidea, come del resto tutte paralisi delle malattie acute, sono su3cetti bili di assumere forme più diver se. Dalla semplice placca di m onoplegia la più limitata, tino alla para plegia ed alla completa dei quattro arti, la sclerosi a placche e tassia locomotrice progressiva; dai fenomeni paretici seggieri fino ai più persistenti ed ai più gravi, lesioni d -o localizzate, tutto è stato riscontrato.
Solto qualsiasi forma essa si presenti, la può parire in tutti i periodi, invasione, stato, valescenza. Murchison ha anzi notato che la compi poteva solo dopo <iopo la guarigio ne, e che per certi l!pl (mlehtl sistenoaliclll patereccio di Mo rvan ecc.) lo sviluppo è an co ra più <livo. Nella parte ilei casi però q uesti accid -osservano verso il periodo di decrescimento o nella lescenza.
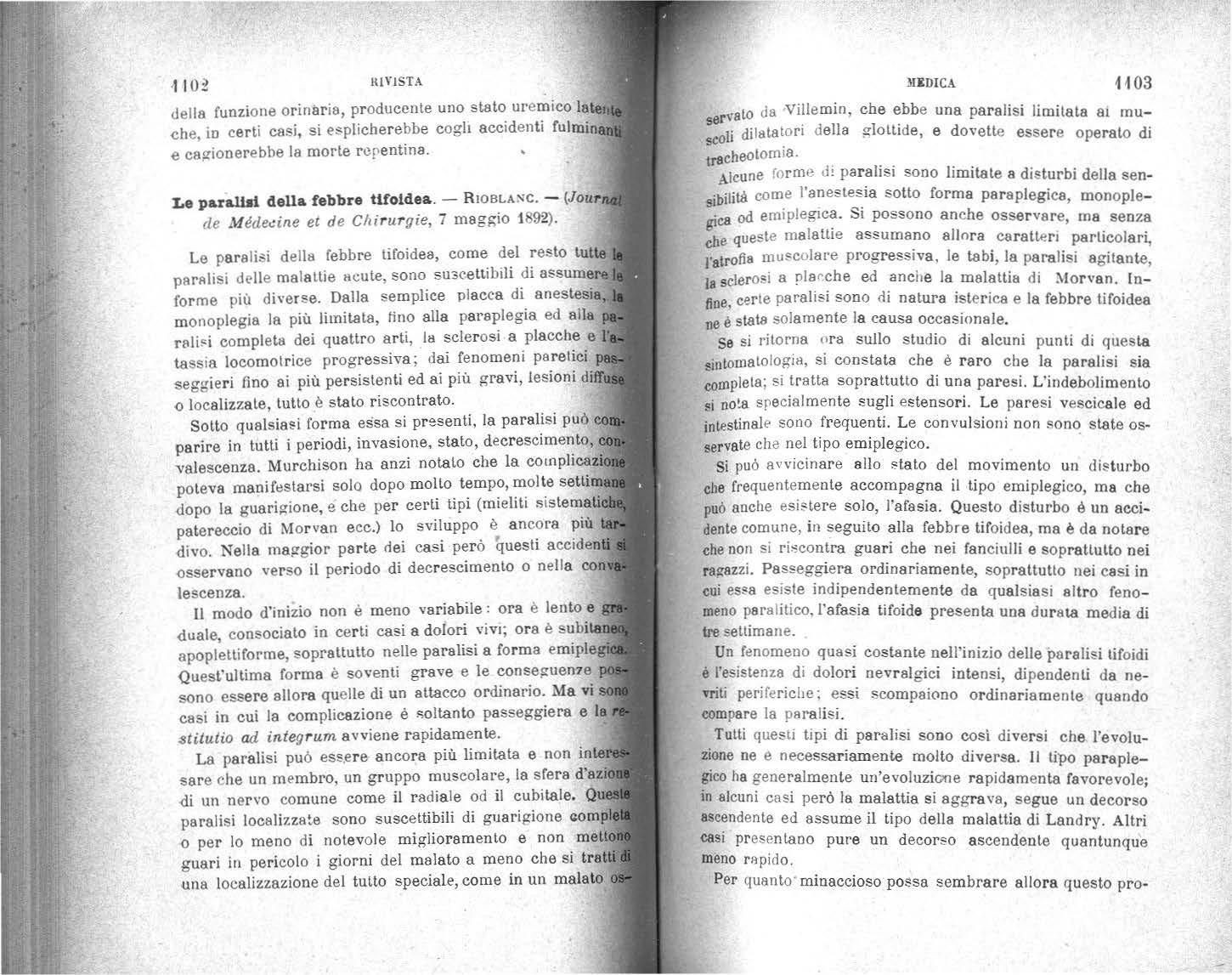
La paralisi può ess.ere ancora più limitata e non in sare che un membro, un gruppo muscolare, la sfera <li un nervo comune come il radiale od il cubitale. paralisi sono suscettibìli di guarigione o per lo meno di notevole miglioramento e non guarì in perico lo i giorni del malato a meno che si un a localizzaz ione del tutto speciale, come in un mala to rvato da Ville min, che ebbe una paralisi limitata ai mu::oli dilatato ri de lla glottide, e dovette essere operato di tracheotom ia. se si ritorna o ra sullo studio di alcuni punti di questa sintomatologia, si constata che è raro che la paralisi s ia completa; si t ratta soprattutto di una paresi. L'indebolimento si specialmente sugli estensori. Le paresi vescicale ed intestinalE> sono frequenti. Le convulsioni non sono state osservate che nel tipo emiplegico. ·
Alcune d! paralis i sono limitate a disturbi della senibilità co me l'anestesia sotto forma paraplegica, monople- s . gica od ::SI possono anche osservare, ma senza che queste malatlle assumano allora cara tteri l'atrofia mu$colare progressiva , le tabi, la paralisi agitante, la sclerosi a ed anche la m alattia di :\1orvan. Infine, certe paralisi son o di natura isterica e la febbre tifoidea ne è stata solamente la causa occasiona le.
Si può a,·vicinare allo del movimento un d is turbo che frequ ente me nte accompagna il tipo emiplegico, ma che può anche esistere solo, l'afasia. Questo di s turbo é un accidente comune, in seguito alla febbre tifoidea, ma è da notare che no n si rb;contra guarì che nei fan ciull i e soprattutto nei Passeggiera ordinariamente, soprattutto nei casi in cui esiste indipendentemente da q ualsia si altro fenomeno pa ra litico, l'afasia tifoide presenta una du r a ta media di tre settimane.
Un fenomeno qua si costante nell'inizio delle paralisi tifoidi è l'esistenza di dolo ri nev r algici intensi, dipendenti da nevriti peri fe riche; essi scompaiono ordinariamente quando compare la paralisi.
Tutti questi tipi di paralisi sono così diversi che l'evoluzione ne e necessariamente molto diversa. Il tipo para plegico ha generalmente un'evoluzione rapidam enta favor evole; in alcuni casi però la malattia si aggrava , segue un de corso ascendente ed assume il tipo della malattia di Lan dry. Altri casi presentano pure un decorso ascendente quantunque meno r apido.
Per quanto ·minaccioso possa sembrare allora questo pro-
Medica 1105
nostico, non lo si deve pe r ò ritenere disperato, perché aver in tal moòo progredito fino a far ritener e la morte mineote, il più !>pesso la malattia decresce lutto ad un t:: sopraggiunge la guarigione.
Nel t ipo emiplegico, le lesioni sono generalmente più sisLenti e ciò è soprattutto Yero per i casi io cui l'· apoplettico. In fine le paralisi localizzate cedono al trattume nlo, quantunque in ce r ti casi la paralisi e per sistano.
La maggi or parte di dive r se paralisi sono nevr iti perifer iche. Devesi fare eccezion e principalmente le paralisi emiplegiche, le di cui forme gravi sono dovute ad una emorragia sotto-aracnoidea, sia ad un embolismo viano, m entr e che le forme benigne possono essere derate come disturbi vaso-motori riflessi.
Come trattamento si ricorrerà al solfato di c hinino ed l'elettricità; l'idroterapia ed il massaggio unitamente acque min erali ed ai tonici completeranno la cura.
Etiologia della tabe dorsale . - F . RAméclical, 11 giugno 1892) .
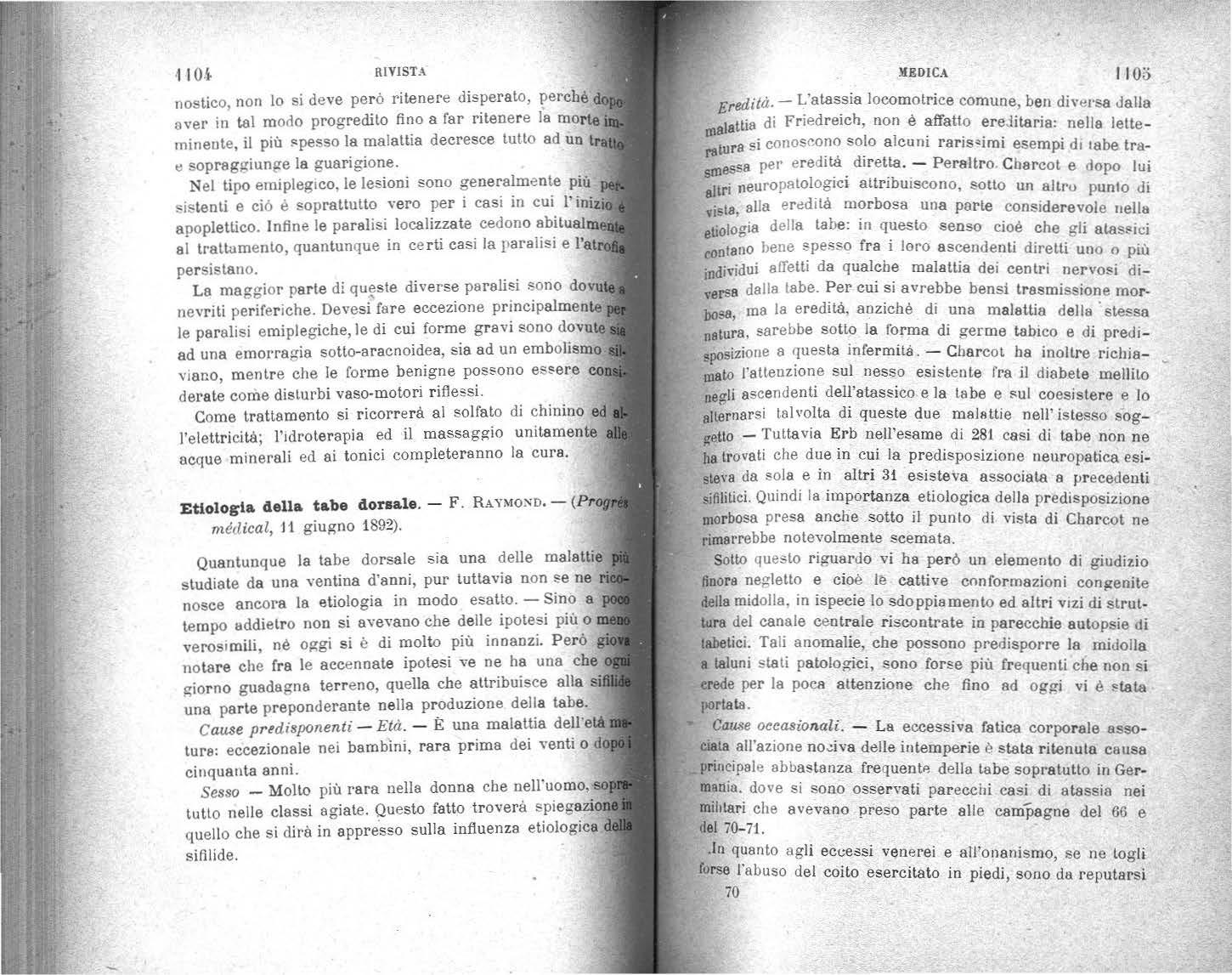
Quantunque la ta be do rsale studiate da una ventina d'anni, pur tuttavia non se ne nosce ancora la etiologia in modo esatto. - Sino a tempo addietro non si avevano che delle ipotesi piu o verosimili, nè oggi si è di molto più innanzi. Però nota re che fra le acce nnate ipotesi ve ne ba una che giorno guadagna terreno, quella che attribuisce alla una parte pre ponderante nella produzione della tabe.
Cause predisponenti - Età. - È una malattia dell'etA tura: eccezionale nei bambini, rara prima dei venti o cinquanta anni. .
Sesso - Molto più rara nella donna che nell ·uomo, lutto nelle classi agiate. Questo fatto troverà quello che s i dirà in appre.sso sulla influenza etiologica sifilide.
Ered ità.- L'atassia loeomotrice comune, ben divet·sa dalla alatlia di Friedreich, non é affatto ere.iitaria: nella letteJll tura si conoscono solo a lcuni esempi d11abe t r a:assa per eredità di r etta . - Pe raltro Charcot e dopo lui sliri neuro patologici attribuiscono, sotto un altro punto di :isla, alla eredità morbosa una parte considerevole nella etiologia della tabe: in questo senso cioè che gli conta no bene $pesso fra i lero ascendenti diretti uno 0 più individui affetti da q ualche malattia dei centr i nervosi diversa dalla tabe. Per cui si avrebbe bensì trasmissione morbosa, ma la eredità, anziché di una malattia de lla· stessa natura , sarebbe sotto la form a di germe tabico e di predisposizione a questa infermità. - Charcot ha inoltre richiartl&to l'attenzione sul nesso esistente fra il diabete mellilo negli asce ndenti dell'atassico e la labe e sul coesistere e lo alternarsi tal volla di queste que malattie nell' istesso sog- Tuttavia Erb nell'esame di 281 casi di tabe non ne ha trovati che due in cui la predisposizione neuropatica esisleYa da sola e in altri 3i esisteva associata a precedenti silìlilici. Quindi la importanza etiologica della predisposizione morbosa presa anche .sotto il punto di vista di Charcot ne rimarrebbe notevolmente scemata.
Sotto questo riguardo vi ha per ò un eleme nto di giudizio finora negletto e cioè lè cattive conformazioni della midolla, in ispecie lo sdoppiamen lo ed altri vizi di struttura del canale centrale riscontrate io parecch ie autopsie di tabeLici. Tali anomalie, che possono pre disporre la midolla a taluni stati patologici , sono forse più frequenti che non si crede per la poca attenzione che fino ad oggi vi è s tata r>artate.
Cause oceasio nali. - La eccessiva fatica corporale associata all'azione nodva delle intemper ie è stata ritenuta causa pr incipa le abbastan za frequent P. della tabe sopralutlo in Germania. dove si sono osservati parecchi ca s i di atassia nei militari che avevano preso parte all e can(pagne del 66 e rlel 70-71 .
.In quanto agli ec(.;e.ssi venerei e all'onanismo, se ne togli ror:se !"abuso del coito esercitato in piedi, sono da reputarsi
l!EDlCA H07
piultosw effeUo che causa della malattia per la grande citazione genetica cui gli infermi sono in preda nei primi periodi.
Traumatismi. - Esistono alcuni casi moslraLi nei quali la tabe si sviluppò sotto l'influenza siva di un qualche lraumati smo. P erò essi sono ben cosa di fronte alla frequenza relativamente notevole di sta malattia.
Sifilide. - Da non molli anni la sifilide ha 8S!'=Or bila, cosi dire, l'attenzione di quanti si sono occupati della dell'atassia . Benchè la questione non possa ritenersi definitivamente risoluta e le opinioni siano state e tuttavia in parte discordi, nondimeno le presunzioni in della origine sifilitica della tabe dorsale vera vanno r almente acquistando ogni giorno terreno e crescono di peso e di verosimiglianza. _
Fin dal principio si è voluto risol vere' l a questi one statistica: ne uscirono i risultati i più conlradittori. osservatori troyarono antecedenti sifilitici nel 100 p. 100 propri atassici, altri il 20, il 15 ed anche meno .
Tale discrepanza non da altro poteva sorgere se non preconcetti che inspirava no ciascun osservatore. Gli sari della origine sifilitica della tabe , severissimi nell' mettere una infezione celtica a ntecètlente nei loro di atassia, trovarono delle proporzioni deboli: i invece erano forse troppo corrivi nel riconoscere come filitiche persone appena sospette. Nondimeno l'esame m· dei la vori pubblicati su lale questione e delle rice r che guite sui campi di osservazione più svariati fa nascere il vincimento che quanto più diligentemente venner o gli antecedenti dei malati di tabe, tanto più spesso, quasi sempre si P-bbe ad accerla1·e in essi una infezione sifllitica.
Stephan, olanq_ese, dice f:he i fatti dimostrano lo rapporto fra ta be e sifil ide : non si può drre che gli i da sifilide non corrAno rischio di contrarre la Labe, ma sta predilige in modo speciale chi fu già affetto da lue.
Mino1·, I'Usso, rife risce il fallo s&guente. È risaputo za ebraica offre un numero considerevtlle di malattie del nervoso: d'altra parte la sifilide è rarissima negli stS . d . f d . Il ebrei che paes1 vtvo.no senza erst .co o polazione come t n Russ1a: ora neglt ebx-et appunto in la è più. ra:a che .nei Inoltre su 8 ebre1 tabetiCI ne trovo 7 mdubbtamente sifihtici. eoostatò pu re i sifil iliche in 8 donne atassiche con risultati uali a quelli ottenuti da Erb nelle sue ricerche. io Germania la dottrina della o rigine sifilitica fraente (iella tabe acquista ogni giorno proseliti. edicono che alla sifilide deve essere attribuita ttna parte prepooderante, quantunque non esclusiva, nella etiolo"ia dell'atassia locomotrice. Strumpell, autore di lavori a:atomo- patologici importantissimi sulla tabe, ha trovato in questi malati il 61 p. 100 di sifilitici, pr oporzione che si eleva al 90 p. 100 se si tien conto dei casi dubbi. .
Ancor esso ha cons tatato la maggio r frequenza della tabe nelle donne del popolo: nelle agiate l'ha veduta sempre p ra. ceduta òa antecedenti di lue: una fanciulla a 13 anni atassica era affetta da sifilide ereditaria . .- su 400 casi raccolli in 25 anni Fournier h'l tro vato il 91 P.· 1(10 di ?.ntecedenti sifilitici certi.
S i ban:to infine le st:1 Listiche di Fournier e di Erb che portano un contributo gran iis<>imo, se non decisivo, a lla soluzione della question e.
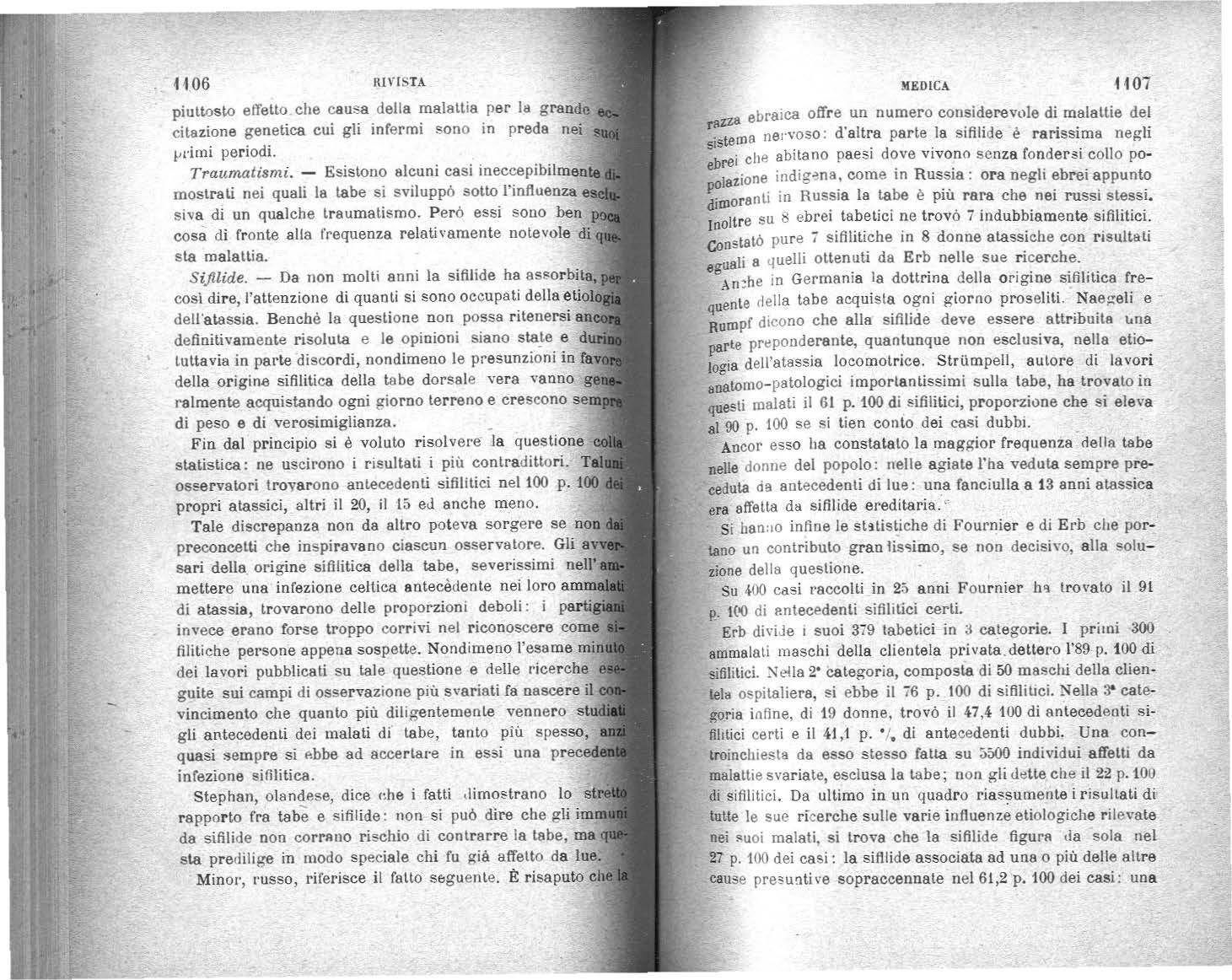
Erb di,·iJe i suoi 379 tabetici in 3 categorie. I pritoi 300 ammalali maschi della clientela privata . dettero 1'89 p. 100 di si61itici. 2• categoria, composta di 50 maschi della clientela ospitaliera, si ebbe il 76 p. 100 di sifilitici. categoria infine, di 19 donne, trovò il 47,4 100 di antecedenti sitì!Jtici certi e il 41,1 p. ·; di antecedenti dubbi. Una controinchiesta da esso fatta su 5500 individui affeLti da malattie svaria te, esclusa la labe; non gli dette che il 22 p.100 di sifilitici. Da ultimo in un quadr o i risullati di tutte le sue ricerche sulle varie influenze etiologiche ril evate nei l"UOi malati, si trova che la sifilide figuri\ tla sola nel 27 p. 100 dei casi : la sifilide associata ad una o più delle altre cause presu!lti ve sopraccennate nel6 1,2 p. 100 dei casi: un a o più di queste ultime cause, escl usa la sililide, solo nell'l p. 100 dei casi.
Gli avvers ari della dottrina della origine sifi lilka della invocano specialmente due or J ini d'argomenti: 1• la im tenza della medicazione specifica; 2• la localizzazione e qualità delle lesioni spinali in malattia.
È pur troppo vero che la c ura iodomercuriale r iesce sempre inefficacP. nei tabetici, per quan to vi siano delle cezioni: ma ciò non basta a il valore etiologico lue. Per qoolli che considerano la tabe do rsa le svi lu in un sifllitico quale cons eguenn diretta della sifilide, le sioni spinali della labe non sono lesioni sifìlitiche nel volS!are della parola. l overo le lesioni sifìliliche pro · dette dd centri ner vosi sono lesioni di superficie per lo al principio: partono dalle meningi, in teressano i yasi, il più spesso si in un'e poca assai alla infezione, si sviluppano e possono scomparire ra m e nte, sono curabili; e tuttociò dimostra che esse sono prod ott o diretto dell a immigraz ione e della moltipl dei batteri patogeni delle sifi lide. All'i ncontr o le lesioni nali della tabe comirH,iano nello spessore dei fasci (posteriur•i) della midolla, talvolta rispettano i vasi e -li inlert!ssano solo e in m odo secondario, si svolgono eslremn lentezza, sono essenzialmente incurabili e nei getti sililitici si sogliano iungo tempo dopo infòzione. Ciò dipenderebbe da che queste lesioni non · CAusate direttamente dai b11tteri della sifilid e, ma da da tossine chP. impegna no lentamente gli organi del e che nei centr i nervosi manifestano un'azione elettiva c erti s istemi anatomici, come del r e sto si osser va aQche altri veleni che penetrano a ccidentalmente nell' o umano, p. e . la ergotina.
Questa spiegazione, ragionatissima se si tien conto dei recenti lavori dei ba tte r iologi, ris ponde anche a l at·gomento contrario tratto dalla localizzazione e dalla q lilà delle lesioni spinali della tabe dorsale. Dal momento gli organi del sifiliti co sono impregnati di un virus (to la cui azione deleteria si svolge lentamente e si liEDICA 1109 con alterazioni sclerotiche e proliferazioni connettivali diffuse negli organi più svariati e note per la loro resistenza alla cur·a ioclo-mercuria le, se si a mmette che l'azione deleteria di flUesLo vir us rie1 centr1 nervosi si spiega isolata- , men te su talu11i sistemi anatomici, nulla impedisce che le Je$iooi spinalr della tabe siano considerate q ual i un prodotto diretto clelia Sifilide a llorquando la mala ttia nervosa s 'inizia dvpo una infezion e si filitica.
Riassumendo: la tabe dorsa le è una malattia dell 'età matura, sen!'ibilmente più fr equen te nell'uomo che nella donna.
La predisposizione nevropatica congen ita influisce certamente nel suo sviluppo, ma la eredità diretta del tutto eccezional e.
Le le e ccessive fatiche corporali, tal um ecress1 venerei, un traumatismo grave so no stati tal · volta, appa•·enternonte almeno, la causa occa sionale della mala ttia.
Il numero però di tutti questi c asi è ben piccolo di fronte a quello in cui la tabe dors ale si è sviluppata individui sifìHtici senza che apparentemente vi sia intervenuta véruna altra causa occasiona le. Oggidi è ben dimostrata che la grande maggio ranza dei tabetici sono stati antecetiente mente sifilitici.
Non é provato, ma è estremamente verosimile che la siiìlide ha una parte o indiretta nello sviluppo de lla tabe allorché questa malattia s i manifesta in un sitìlitico. per ò necessa r ia una pregressa sifilide perc hé si sv!Iupp1 la labe dorsale: lo dimostrano i rari casi di sifilide · da sogge tti atassici, quantunque anche in ques.ti si dovreb be tene r conto della possibilità di una riinfezione sitìlitica.
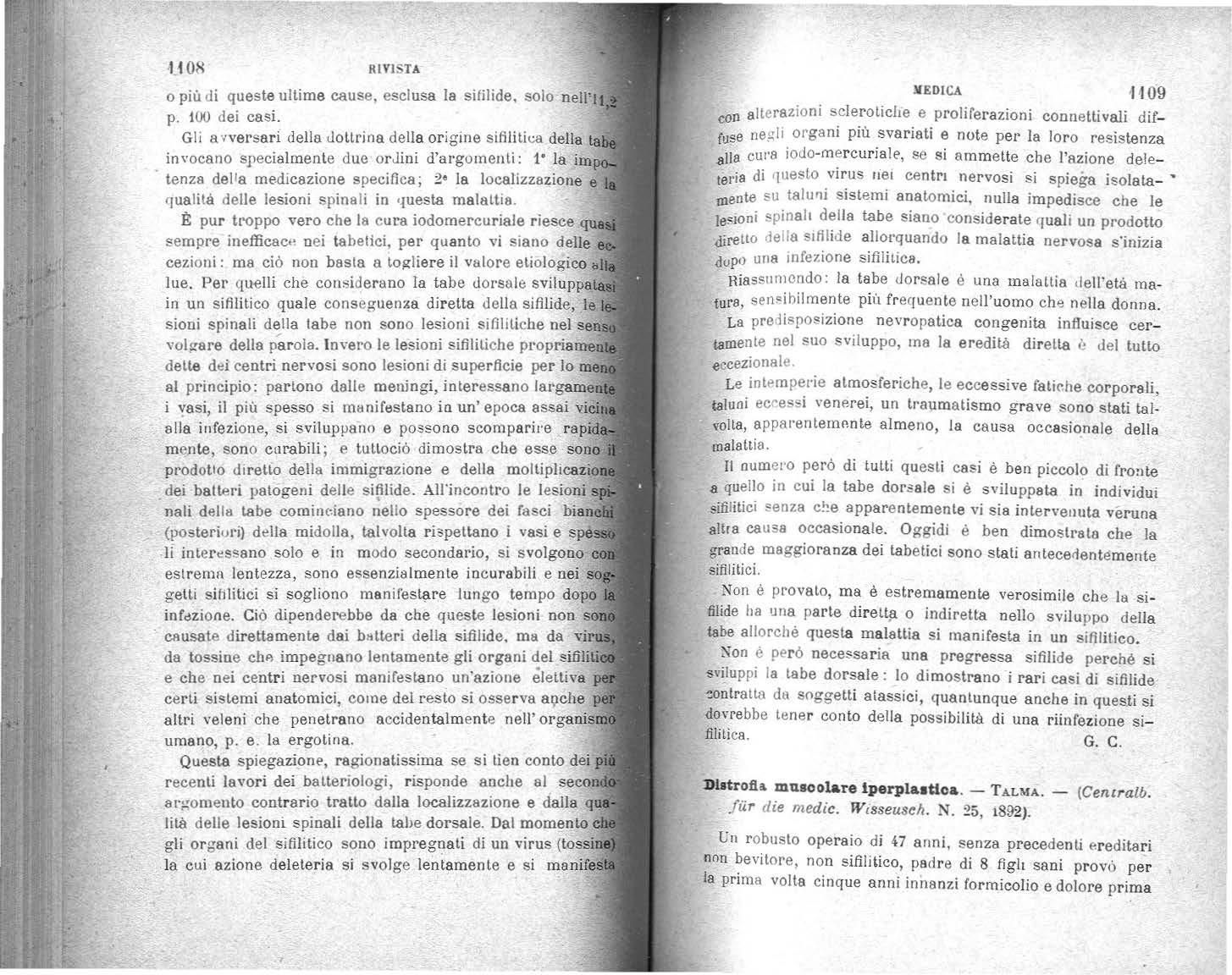
G. C.
Un robusto operaio di 47 anni , senza precede nti e reditari non non sitìli tico, padre di 8 tìgh sani provò la pr1ma volta ci nque anni inn a nzi formi colio e dolore prima nel braccio e nella gamba sinistra, poi anche a destra, persistono ancora. Poche sellimane dopo: diminuzione forze, spossamento, inabilità al lavoro; la separazione • l'urina, la funzione intestinale, l'appetito rimasero
Due anni appresso esisteva uno straordinario sviluppo tutti i muscoli delle estremità la cui forza come quella muscoli del tronco era notevolmente indebolita Nel sinistro diminuzione òel senso del tatto, il senso della peratura debole; un poco diminuita la sensibilità aolOr'Iftf! diminuita quella per la corrente fa r adica. Nelle altre milA e nella faccia le anomalie sono più lievi ma d Questi disturbi rimasero circa tre anni allo stesso riflessi esistevano dappertulutto.
L'esame microscopico di pezzelti asportati dal muscolo pite:e dal nervocut.aneo medio mostrò nel nervo numerose senza guaina midoìlare, e in altre era questa molto sottile. muscolo non fu osservato in alcun luogo sv iluppo ziale di tessuto connettivo o di grasso, il sarcolemma 'cava dappertutto, non si scorgevano limiti distinti dei primitivi; questi erano allontanati fra di loro e negli valli eranvi numer osi nuclei.
Il tessuto muscolare aveva in gran parte perduto striature trasversali ed era sostituito da fibre long· molLi fasci primitivi mostrava/lo indistinta striatura sale, ove questa non esisteva, erano le fibrille forte incurvate. Tra i fasci !>rimitivi si trovavano molte con motti nuclei allungati circondati da alcune Queste lacune avevano diverse grandezze. Nel luogo vecchi fasci primitivi con sarcolemma ne erano compars i dei giovani. Dove solo pochi fasci primitivi mali striati sono rimasti, lo sviluppo della forza é
Rivista Delle Malattie Veneree Edella Pelle
Secondo l'A. in tutti i casi in cui non vi sia estesa e manifesta fluttuazione, si otterrebbe un presto e sorpr endente vantaggio con Io ìn.iettare io due punti del bubone un mezzo " rammo di una soluzione all'uno per cento di benzoato di o mercurio con l'aggiunta di una soluzione a l '1. "lo di cloruro di sodio. Con questo metodo l'A. avrebbe otten uto subito una diminuzione del tumot·e, e talora una certa fluttuazione ebe però non tardò a scomparire, residuand one un iofillrato indolente e appena sensìbile. Solo raramente si sarebbe verificata la fuoriuscita di poco pus nel fare l'iniezione, cosa che non complicò nè ritardò la guarigione.
Superfluo il dire che durante la cura l'infermo deve esser tenuto uel più stretto riposo. R.
Le prtnolpall varietà dell' erpete. - FouRNIER. - {Ga.;ette de s 64, 1892).
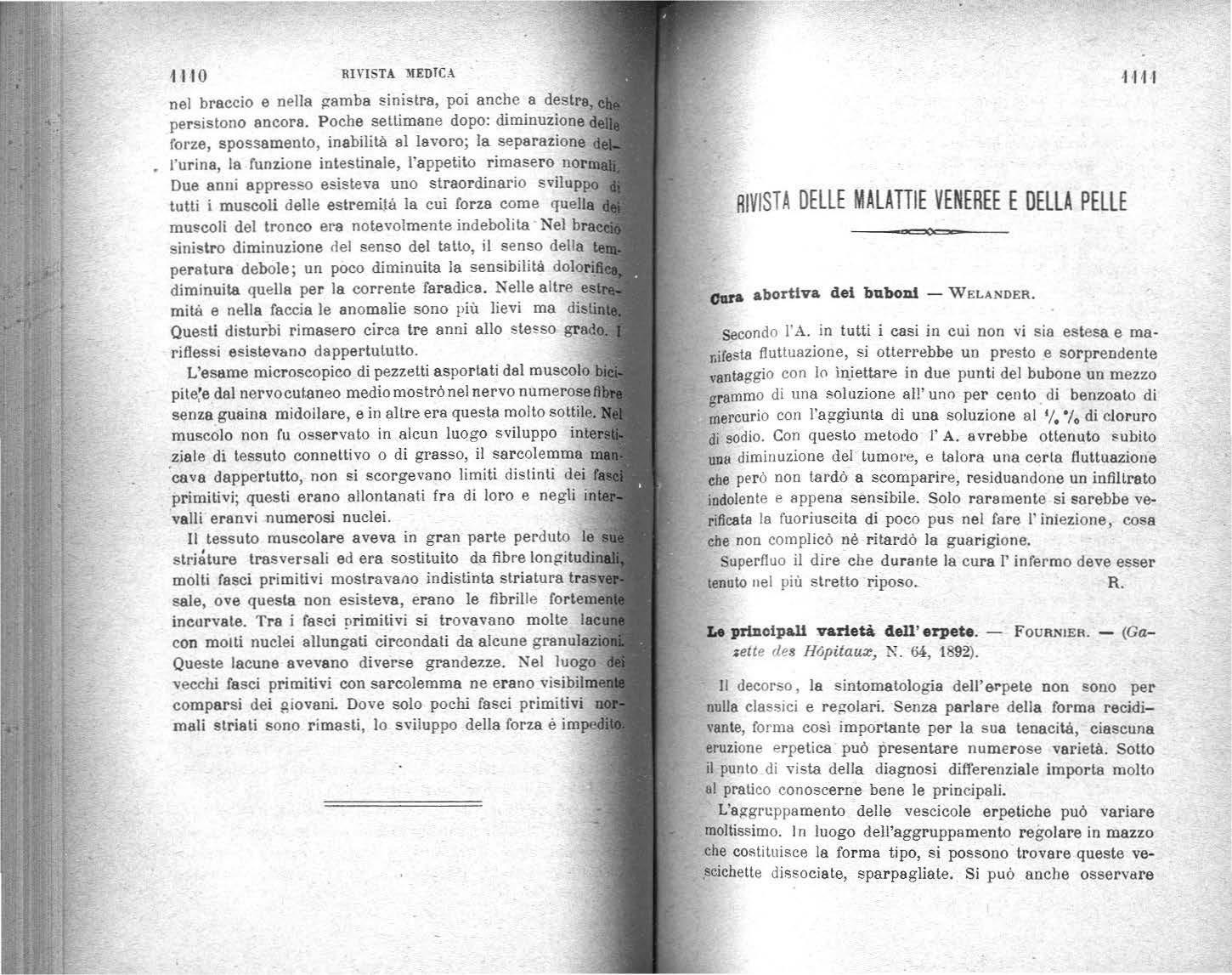
Il decorso, la sintoma tologia dell'er pete non sono per nulla classici e re:;:rolari. Senza parlare della forma recidivanta, forma così importante per la sua tenacita, ciascuna eruzione erpetica può presentare numer ose varietà. Sotto il punto di vista della diagnosi differenziale importa molto al pratico conoscerne bene le principali.
L'aggruppamento delle vescicole e r petiche può variare moltissimo. In luogo dell'aggruppamento regolare in mazzo che costituisce la fo r ma tipo, si possono trovare queste ve.scichette dissociale, sparpagliate. Si può anche osservare un mazzo di "escichette circondate chette devianti. In luogo di essere vescicolosa, talvolta tlittenoide e bollosa. Le variazioni di forma e di profondità sono ancora più grandi e più im tanti. Invece di conservare le dimensioni e la for ma di grano di miglio, l'eruzione «>rpetica può prendere quelle una lenticchia, di una moneta di cinquanta cent«>si mi, di nocciolo di albicocca. Queste eruzioni estese sono uel solco balano- prepuziale; le loro dimensioni, un alla loro forma allungata, faimo si che a. prima vista ben !ungi dar pensare all'erpete.
Dal punto dt vista della profondita, in costituire una semplice intaccatura a fior di pell e o di cosa, può approfondirsi. Ora la per dita di sostanza è ''ala, cupoliforme, ora essa presenta come tagliata stampo.
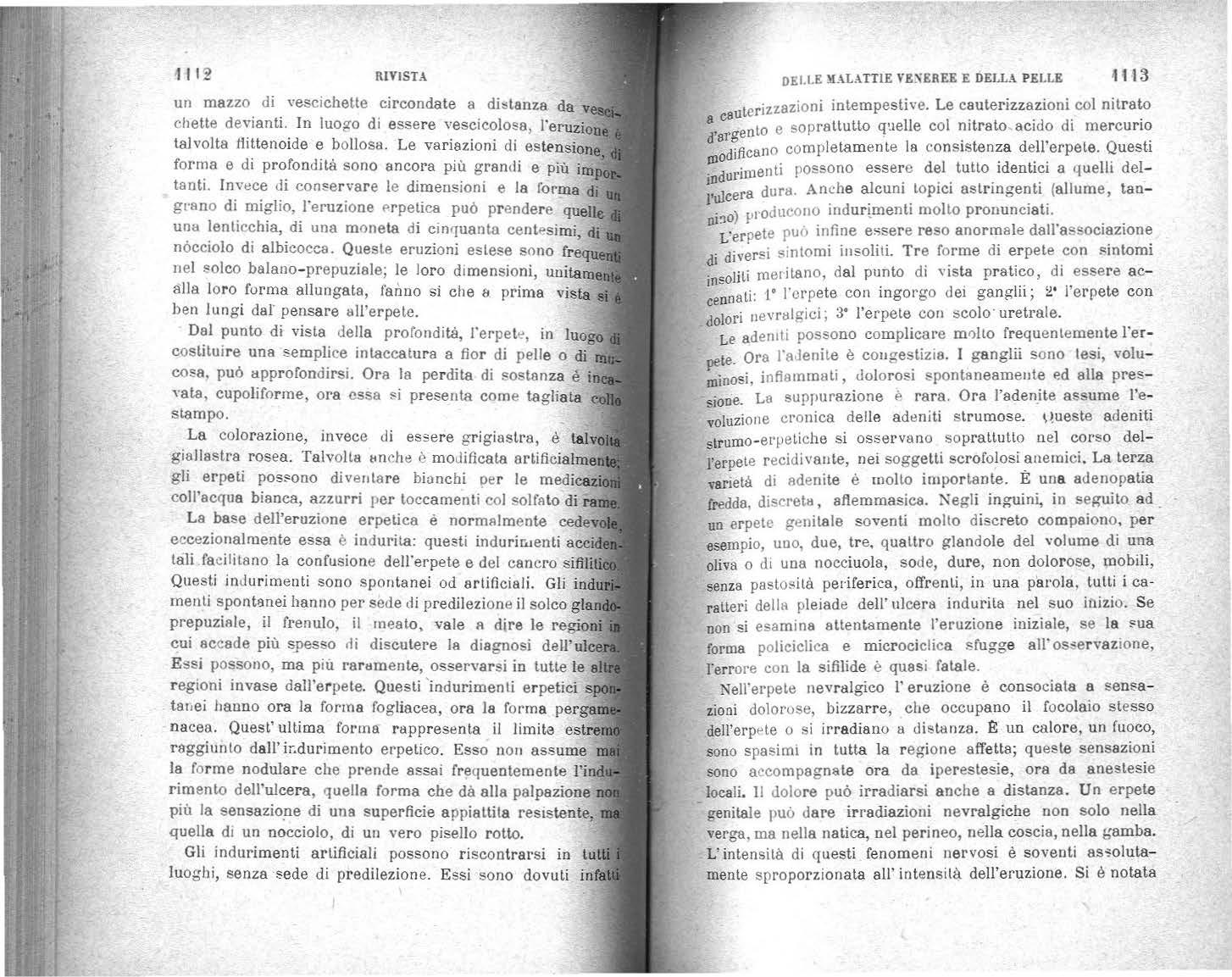
La color azione, invece di essere grigiastra, è giallastra rosea. Talvolta è modificata arti gli erpeti diventare bianchi per le mou1oo.oauo coll'acqua bianca, azzurri per toccamenti col solfato di La base dell'eruzione erpetica è normalmente eccezionalmente essa è indurita: questi indurirHenti tali facilitano la confusione dell'erpete e del cancro sifil Questi inJu r imenti sono spon tanei od artificiali. Gli menti spontanei hanno per sede di predilezione il solco prepuziale, il frenulo, il rneato, vale A dire le regioni cui accade più s_pesso eli discutere la diagnosi deU' E ssi possono, ma piti osservarsi in tutte le regioni invase dall'e r pete Questi ' indurimenti e r petici tar,ei hanno ora la forma fogliacea, ora la form a nacea. Quest'ultima forma rappresenta il limite r&ggiunto dall' ir.durimento erpetico. Esso nou assu me la forme nodulare che pl'ende assai frequentemente l'i rim ento dell'ulcera , quella forma che dà alla palpazione più la sensazio_ne di una superficie a ppiattita resistente, quella dr un nocciolo, di un vero pisello rotto.
Gli indurimenti artificiali possono riscontrarsi in luoghi, senza sede di predilezione. Essi sono dovuti uterizzazioni intempestive. Le cauterizzazioni col nitrato 8 es eolo e soprattutto qDelle col nitrato acido di mercurio d'arg · 1 · d Il' t Q t' dificano completam ente a cons 1stenza e erpe e. ues 1 possono essere del tutto identici a quelli del1?u]cera dura. Anche alcuni topici astringenti (allume, tanl . o) producono indur!menti molto pronunciati. può infine essere reso anormale dall'associazione di diversi sintomi insoliti. Tre forme di erpete con sintomi . soliti mer itano, dal punto di ' ' ista pr atico, di essera ac:noati: t• rorpete con ingorgo dei ganglii; 2' l'erpete con dolori nevralgici; 3• l'erpete con scolo· uretrale.
Le ademti possono complicare m0lto frequentemente l'erpete. Ora è I ganglii sono tesi, voluJllinosi, inflarnmatr, dolorosi spontaneameute P.d alla pressiooe. La suppurazione f> rara. Ora l'aden.ite assume l'evoluzione c1·onica delle adeniti strumose. adeniti strumo- eqJeliche si osservano soprattutto nel cor·so dell'erpete recidivaute, nei soggetti scrofolosi La varietà di adenite è 1Dollo importante. E un a adenopatia fredda , afiemmasica. Negli in seguito ad . uo erpete ge nitale soventi molto discreto compaiono, per eseJllpio, uno, due, tre, quattro glandole del volume di una oliva o di una nocciuola, sode, dure, non dolorose, mobili, senza per·iferica, offrenti, in una par·ola, Lutti i cara ueri della pleiade dell'ulcera indurita nel suo ioizio. S e non si esamina attentamente l'eruzione iniziale, se l a !i'ua forma policiclica e microciclica sfugge all' OS$ervaz ione, l'errore con la sifilide è quasi fatale .
Nell'erpete nevralgico I' eruzione è consociata a sensazion i dolorose, bizzarre, che occupano il focolaio stesso dell'erpete o si irradiano a distanza. B un calore, un fuoco, sono spasimi in tutta la r egione affetta; queste sensazioni sono accompagnale ora da iperestesie, ora da anestesie locali. Il ùolore può irradiarsi an che a distanza. Un erpete genitale può da re irradiazioni nevralgiche non solo nella verga , ma nella natica, nel peri neo, nella coscia, nella gamba. L'intensità di questi fenomeni ner vosi è so venti menle sproporzionata all'intensità dell'eruzione. Si è notata la comparsa di dolori atroci con una sola vescichett& petica. Essi sono soprattutto la proprietà degli recidivanti, s ia delle mucose, sia della pelle e degli erpeti genitali. Ora accompagnano ora seguono da cino l'eruzione erpe tica, ora la precedono. Ciascuna diva d'erpete può essere annunziata da una burrasca vosa premoniloria. Agli organi genitali, i dolori sono consociati soventi da un eretismo locale molto eccitamenti venerei , erezioni penose e prolungate, notturne, voglie d'o rinare frequenti e dolor ose.
L'erpete con scolo uretrale è poco conosciuto, sia abbastanza frequente. Alcuni giorni dopo la di un erpete del prepuzio, del glande, si n ota uno scolo tenuto, quasi sempre, per uno scolo blenorragico.
Quattro caratteri differenziali impediscono di co m questo errore di diagnosi: 1° lo scolo è, e rimane considerevole, poco intenso; appena produce nelle 24 sei a dieci macchie sulla biancheria; 2° lo scolo è quasi acquoso, grigiastro; le macchie che esso forma un centro giallastro, un aspetto molto & quello macchie spermatiche; 3o lo scolo é quasi indolente; 4" risce spontaneamente in otto o quindici giorni, tre setti al più.
Divaricando il mesto, si osservano talvolta una o più cole erosio ni giallas tre separate o collegate. La p di queste erosioni può spiegare lo scolo uretrale, ma nulla si può scoprire né a l mesto, nè nell' uretra nata coll' endoscopio; è quindi necessario, in simile amme tte re un' uretrite erpetica essenziale, analoga alle vralgie e rpetiche . Le eruzioni erpetiche in del m.-alo sono sempre consocinte, e questo è un fatto portante da ritenere, ad un indurimento mollo netto che facilmente credere ad un' ulcera dura. ·
Questi erpeti con scolo urE>trale permettono, secondo di spiegare alcuni fatti straordinari della pratica ci pretes e blenorragie spontanee sòpraggiunte s enza sessuale o col rapporto con una donna riconos ciuta E"si presentano infine la particolarità terapeulica
DELLE
Malattie Veneree E Della Pelle
entre guariscono spontaneamente e rapidamente, tutti i Ill ttaroenli, i ba lsamici e soprattutto le iniezioni, li esacer6 li aggravano. Solamente le tisane diluen ti ed alcaline a 0 100trensive e possono essere utili.
111
41 1Ul' &nnosa lsohialgla IIUUltloa - Osservazione del do tt. G. VAIRO. - ( Prog1'esso medico, N. 7 8 del1892).

L'au tore rife risce un caso clinico di ischialgia ribelle ad ogni tra ttamento curativo, e guariLo poi con una cura anlisitìlitica. L'infezione sifilitica era stata contraUa molti anni addietro, ma in seguito ad opportuna cura ri petuta per più anni non era mai più comparsa alcuna mamfes tazione sifiJiLica e l'individuo prese moglie ed ebbe prole robusta. Da questo caso di riproduzione tardiva della sifllirie l'autot•e lrae le se}!u enti conclusioni pratiche:
1• Il microbio della sif.lide (se non è quello di Lustgarten, sarà un' altrol potrà essere sporigeno e la spot•a potrà restare tale per moltissimi anni nell'organismo senza passare con lo sperma fecondante.
2" Fuori uscito dalla spora il germe patogen o non ha antagonismo, né chimico né dinamico, per l'ematozoario di Laveran ma anzi ad esso si associa (come avvenne nel caso clinico in parola nel quale durante la lunga cura comparve anche un' iufezione malarica) come suole anc he fare col bacillo della tubercolosi e con quello dell'erisipt>la.










