














Chiusure annunciate, in corso, temporanee, definitive. Pause di riflessione che vanno al di là di una semplice sospensione transitoria del lavoro.
La ristorazione tutta sembra accusare i sintomi di una seria crisi esistenziale, ma in realtà si commenta e si pontifica sul web solo intorno a 4 o 5 ristoranti che fanno notizia, e sempre arrivando alle conclusioni più nefaste: il fine dining è in crisi, è finito, è da rimodulare.
Ma se è vero che una rondine non fa primavera, non sono le sole difficoltà di Redzepi, Niederkofler o La Mantia a determinare l’autunno di questo settore.
Certo, le foglie cadono, nell’Ho.re.ca. come in ogni altro comparto produttivo, eppure, invece di fare sempre i soliti discorsi circoscritti alla sola solita cerchia, occorrerebbe chiedersi perché, oggi, anche qualche “ricco” piange, perché, per la prima volta nella storia della ristorazione italiana, il saldo dei ristoranti che aprono è in passivo.
Di fatto, andrebbe detto che si è continuato ad aprire senza sosta e senza senso, con permessi di somministrazione dei cibi ormai estesa quasi anche ai bagni pubblici: come si poteva non pensare che la saturazione sarebbe arrivata?
Se nel 2022 hanno chiuso quasi 27.000 attività, se i fallimenti segnano un +2,7%, la colpa non può essere solo di pandemia, guerra, crisi occupazionale.
Il fatto incontrovertibile è che non c’è più trippa per tutti i gatti e che la domanda, anche se in realtà molto consistente, risulta inferiore all’offerta, ormai palesemente eccessiva.
Non ho avvertito da parte delle forze politiche che si occupano di questo settore la consapevolezza di ciò che sta succedendo, infatti la panacea per il malessere diffuso è il solito pannicello caldo, la pioggerellina sottile di aiutini in forma assistenziale, senza visioni sul futuro, senza una progettualità strutturale.
Fortunatamente però questo è un comparto in grado di autorigenerarsi e rafforzarsi proprio grazie al fisiologico scomparire di ciò che non serve, non funziona, è con ogni evidenza superfluo: anche se attorniato dalle ceneri dei locali che sono spariti, chi ad oggi si è salvato può risorgere e questo può essere il momento giusto per farlo.
Come? Leggete le analisi e le previsioni 2023 a pagina 20 del nostro giornale...
Chi ha letto il titolo dell’articolo, già sta immaginando di trovare la ricetta magica dell’elisir di lunga vita, ma, purtroppo, rimarrà deluso, anche se è vero: vivere 100 anni si può! E questo grazie al cibo. Non esiste però una ricetta o un alimento; esiste una strategia a lungo termine, che va seguita a lungo termine e come regola di vita: solo così l’effetto benefico del cibo si può far sentire.
Dovete considerare che l’invecchiamento è un processo fisiologico (invecchiare NON è una malattia) e dinamico, nel senso che non solo è progressivo, ma può essere rallentato e anche bloccato per un certo periodo di tempo.

Non posso addentrarmi in discorsi troppo impegnativi, ma dovete pensare che ci sono 4 importanti pilastri da tenere in considerazione quando parliamo di longevità:
1. la genetica;
2. l’ambiente;
3. il cibo;
4. i farmaci.
Liquido in modo molto approssimativo ambiente e farmaci, perché qualcuno potrebbe parlare di questi aspetti in modo più appropriato, e vi parlo invece di genetica e cibo. Cosa c’entra la genetica con la longevità? C’entra eccome. Sono stati identificati oltre 100 geni collegati alla longevità direttamente, ma se consideriamo poi tutti i geni che ci predispongono a malattie croniche tipo tumore, diabete, malattie cardiovascolari, allora possiamo dire che i geni collegati direttamente o indirettamente alla longevità sono migliaia .
Per capire quanto sia importante la genetica, vi faccio solo 2 esempi e poi vi cito uno studio scientifico.
Il primo esempio riguarda Winston Churchill: la vita di questo illustre statista è stata costellata di tutto quello che una persona non dovrebbe fare. Churchill fumava come un turco, beveva alcolici in modo esagerato ed era obeso; eppure, è vissuto 91 anni! Pensate che una volta, di fronte al Re d’Arabia, disse: “La mia religione mi impone come rito asso-
lutamente sacro il fumare sigari e il bere alcolici prima, dopo e se è il caso durante tutti i pasti e nell’intervallo tra un pasto e l’altro”
Ora è evidente che o tutti gli studi osservazionali fatti per decenni su centinaia di migliaia di casi (che dicono che fumo, alcol e sovrappeso sono nemici della longevità) sono tutti falsi oppure ci troviamo di fronte ad un rarissimo caso di combinazione genetica assolutamente resistente a diversi fattori ambientali che, per la maggior parte dei casi, sono dannosissimi.
Il secondo esempio è il contrario del precedente:
Georges Ohsawa , l’inventore della dieta macrobiotica . Persona incredibilmente misurata, con un’alimentazione ineccepibile, che però è morto a 73 anni! Anche in questo caso, se avessimo modo di studiare il genoma di questo illustre personaggio, probabilmente scopriremmo una rara situazione in cui la predominanza di geni contrari alla longevità era altissima.
Conoscere il proprio genoma è importante perché, innanzitutto, si riesce a capire in quale fascia di rischio cadiamo per ciascun disturbo o patologia. Ovviamente, proprio in virtù di quanto scopriamo, possiamo mettere in atto alcune misure che possono rivelarsi decisamente un salva-vita personale, perché il DNA, in qualche modo, si può hackerare, cioè, conoscendo nel dettaglio i geni buoni e i geni cattivi, possiamo usare determinati cibi o sostanze che ci permettono di potenziare i geni buoni e silenziare i geni cattivi.
Questo, ai tempi del Sig. Ohsawa, non si sapeva e, sebbene egli avesse vissuto in modo morigerato e corretto, mangiando bene e senza eccessi, non è comunque riuscito ad allungare la sua vita. È solo in questi ultimi anni che le frontiere prima della nutrigenomica e poi dell’epigenetica ci hanno aperto delle prospettive interessantissime.
A tal proposito vi parlo appunto di uno studio interessantissimo, proprio legato alla longevità e alla possibilità di hackerare il DNA.
Uno dei geni più interessanti e direttamente legati alla longevità è il SIRT1 . Questo gene interviene a livello di decine e decine di reazioni biochimiche aumentando il metabolismo, diminuendo l’infiammazione, limitando la neurodegenerazione e chi più ne ha più ne metta. Ebbene è stato fatto un interessante studio sui topi (Mitchell SJ, Martin-Montalvo A, Mercken EM, et al. The SIRT1 activator SRT1720 extends lifespan and
improves health of mice fed a standard diet. Cell Rep. 2014;6(5):836-843. doi:10.1016/ j.celrep. 2014.01.031) in cui è stato evidenziato come attivare specificatamente il gene SIRT1 allunghi in modo considerevole la vita dei topi. Sono stati creati 4 gruppi di topi:
• SD = nutriti con una dieta standard
• SD + SRT1720 = nutriti con una dieta standard e un attivatore di SIRT1
• HFD = nutriti con una dieta ricca di grassi
• HFD + SRT1720 = nutriti con una dieta ricca di grassi e un attivatore di SIRT1.
Ebbene, se avete la pazienza di interpretare il grafico vedrete che il 50% dei topi (linea tratteggiata orizzontale) nutriti con HFD (linea viola) erano già morti dopo 90 settimane (considerate che la vita media di un topo è 140 settimane). Il 50% dei topi nutriti con HFD con aggiunta di attivatore di SIRT1 (linea arancione) era morta dopo 120 settimane, con una sopravvivenza media maggiore di 30 settimane (che, per un topo, è un’eternità). Se poi, invece di mangiare male, i topi mangiano “normale”, con una dieta standard la sopravvivenza aumenta ancora e, con aggiunta di attivatore di SIRT1, aumenta ancora di più!
Il cibo è fondamentale quindi sia come supporto diretto alla longevità, sia per hackerare il DNA, attivando geni fondamentali per vivere più a lungo. Spero quindi di avervi convinto ad aspettare il prossimo articolo dove parlerò di tutti i cibi che ci allungano la vita. Alla prossima!

Il progresso e la scienza, si sa, fanno passi da gigante. Cambiamenti epocali sono dovuti alla conoscenza, all’esperienza e alla continua ricerca. Oggi possiamo affermare che, con analisi dettagliate, chi soffre di intolleranze ha aspettative incoraggianti per migliorare la propria qualità della vita. Molte persone soffrono, spesso per anni, di disturbi come cefalee o stanchezza cronica senza capire che la causa può essere un particolare cibo o bevanda non perfettamente assimilabili dall’organismo. Un’intolleranza alimentare può essere infatti la causa di numerosi problemi e anche responsabile, per esempio, di vertigini, insonnia, nervosismo e depressione. Trovare un equilibrio tra gusto e benessere sembra sia arduo ma lo è solo in apparenza.
Anche in ambito finanziario possiamo trovare delle intolleranze e questo ci porta a fare un parallelismo. È importantissimo prendersi cura del proprio organismo ma è altrettanto importante prendersi cura della salute del proprio portafoglio . Proprio così: è importante se non fondamentale capire quali siano le scelte più appropriate in termini finanziari per ciascuno di noi. Generalizzare è impossibile, come nella medicina. In entrambi i casi ci sono delle prassi da seguire, ma ognuno di noi è diverso e pertanto è importante un “dieta” mirata. La possiamo fare da soli?
Certamente sì, infatti i primi medici siamo noi stessi, ma con competenze diverse rispetto ai dottori. Un articolo recentemente diffuso parlava di un
semplice test informatico, tecnologicamente avanzato, dove vengono raccolte informazioni quali abitudini alimentari, profilo metabolico, stress, reazioni alimentari e altri disturbi, fondamentali per poter arrivare a una diagnosi nella quale riconoscersi e trovare una serie di risposte per stare meglio. L’esito viene successivamente elaborato e lo step successivo è la preparazione del programma alimentare personalizzato dal quale non verranno esclusi gli alimenti a cui si è intolleranti: questi saranno sapientemente calibrati e introdotti per gradi in modo da poter continuare ad assumere ogni tipo di cibo in modo più corretto ed equilibrato.
La novità che balza agli occhi è proprio questa: non ci sono cibi da eliminare o diete drastiche. Si tratta di modulare varietà e quantità di cibo alle esigenze di ogni singolo individuo per far sì che una regolamentazione alimentare diventi un percorso educativo. Analogamente, per la salute finanziaria è importantissimo valutare prima la persona e il suo contesto: così facendo è possibile individuare quelle che definiamo intolleranze finanziarie. Si procede ad una anamnesi dettagliata di tutte quelle che sono le caratteristiche che generano risorse finanziarie da un lato e dall’altro quelle che sottraggono risorse. In che modo? Attraverso una pianificazione finanziaria si individuano esigenze (che possono mutare nel tempo) come per esempio il mutuo, l’università dei figli, la macchina, la cucina nuova, o anche un passaggio
tra generazioni, come nel caso di un ristorante di famiglia che passa di padre in figlio.
Il passo successivo è quello di individuare gli strumenti finanziari adeguati in termini di oscillazioni monetarie e di tempo. Se mi aspetto che mio figlio debba andare all’università fra 15 anni, allora devo individuare un asset che abbia quella durata e che sia coerente con le mie aspettative di gestione.
Ma ciò è più facile a dirsi che a farsi sia in termini di analisi, sia in termini pratici. Capita tuttavia che non ci accorgiamo di come spendiamo i nostri soldi. In termini pratici non sappiamo quale tipo di asset usare, vista la vastità degli strumenti finanziari che ci sono e che continueranno ad emergere nel tempo grazie al progresso tecnologico. In ultimo, ma non meno importante, sono da considerare la disciplina e l’educazione finanziaria . Come per la dieta e l’alimentazione, è necessario informarsi e mantenere un comportamento adeguato con le decisioni prese e mantenerle per tutta la durata del proprio obiettivo o progetto. Se passiamo dall’alimentazione al campo enologico vale lo stesso discorso: la visione del vino che potrà diventare partendo da una vite, significa saperci lavorare senza cogliere immediatamente i frutti. Esattamente come fissare un obiettivo finanziario e vederlo realizzare a distanza di anni. Ne consegue che in tutti i settori vale un vecchio saggio secondo il quale “il giorno stesso che pianti un seme non è lo stesso in cui mangi il frutto. Sii paziente, sii umile.”
a cura di antoniEtta MazzEo tEcnico Ed EsPErto dEgLi oLi d’oLiva vErgini Ed ExtravErgini

sottolineando quelli più sfumati e attutendo quelli più marcati. Nella creazione di un piatto, di una preparazione, si cercano diversi contrasti, per esempio caldo/ freddo, amaro/dolce, ect.; a compendio di questi elementi c’è l’Olio Extravergine d’Oliva, l’ingrediente basilare che chiude il cerchio al gusto.
Ma quali sono le caratteristiche organolettiche degli oli e gli abbinamenti con i diversi cibi? Gli oli extravergini di oliva si classificano, dal punto di vista organolettico in:
• Fruttati Leggeri
• Fruttati Medi
• Fruttati Intensi
Si tratta di differenze che incidono sul risultato finale di un cibo, sia che si utilizzi l’olio a crudo che in cottura, alla ricerca dell’armonia.
Fruttato leggero: oli leggeri, dal sottile e delicato profumo: ideali per pesci bolliti, insalate dal gusto delicato, maionese, verdure all’agro.
L’Olio Extravergine d’Oliva è l’indiscusso protagonista di tutte le prelibate preparazioni della Dieta mediterranea. Il suo valore si esalta se utilizzato a crudo o in cottura, inserito nelle ricette non solo salate, ma anche in quelle dei dolci; è perfetto, contrariamente a quanto si possa pensare, per le fritture, visto il suo alto punto di fumo.

L’Olio Extravergine d’Oliva non è un semplice grasso da cottura o un condimento, ma è un vero, imprescindibile e differenziante ingrediente, capace di reggere un ruolo da protagonista nel piatto.
La sua funzione è quella di amalgamare i vari ingredienti e fare da equilibratore naturale tra i vari sapori,
Fruttato medio: oli fragranti e freschi, su minestre di verdura, pesci grigliati al forno, carni al pomodoro, frittura e soffritti di carni bianche, creme di legumi, verdure lesse.
Fruttato intenso: aromi pronunciati e forti note amare e piccanti. L’olio è indicato per piatti dal gusto deciso, ideali per zuppe di cereali, carni rosse alla griglia, minestre di ceci.
Ecco alcune ricette della cucina tradizionale italiana che vedono l’Olio Extravergine d’Oliva protagonista fondamentale.

Olio Extravergine d’Oliva consigliato:
Blend composto dalle varietà Moraiolo , Leccino e Frantoio
Fruttato verde medio con sentore di pomodoro ed erbe aromatiche, dal gusto mediamente amaro e media piccantezza, per arricchire armonizzare, ed esaltare tutti gli ingredienti.
La ricetta ha origini molto antiche, risale a tempi precedenti l’arrivo del pomodoro dalle Americhe.
Sembra che fosse un mangiare tipicamente contadino, preparato dalle donne di casa con il pane avanzato.
PER 4 PORZIONI
g. 500 di pomodori maturi sodi • g. 400 di pane toscano raffermo • 1 cipolla rossa • 1 cetriolo • 15 foglie di basilico • aceto di vino bianco • olio extravergine d’oliva • acqua • sale e pepe q.b.
Tagliare il pane in fette spesse circa cm. 1, adagiarle su una larga pirofila e bagnarle con g. 250 di acqua, premere leggermente con le mani per farle inzuppare, quindi lasciarle riposare per 40-45 minuti.
Mondare la cipolla, tagliarla a fettine sottili e raccoglierle in una ciotola con g. 70 di acqua e g. 70 di aceto di vino; lasciare a mollo per 15-20 minuti, mescolando spesso.
Sgocciolare. Spuntare e sbucciare il cetriolo, tagliarlo a metà per il lungo, affettare tutto in modo molto sottile. Tagliare i pomodori a dadini, sbriciolare il pane ammollato in una grande ciotola e, se è molto bagnato, strizzarlo leggermente. Unirvi le cipolle sgocciolate precedentemente, mescolare i cubetti di pomodoro, le fettine di cetriolo e il basilico spezzettato a mano. Far riposare la panzanella ottenuta in frigorifero per circa 1 ora, poi condirla con 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, g. 15 di aceto, un pizzico di pepe e uno di sale: ricordarsi che il pane toscano è insipido, quindi aggiustate di sale dopo l’assaggio.
Se la si prepara il giorno prima, evitare di condirla per non rovinare la consistenza delle verdure.

La caprese è una ricetta facile da preparare; il segreto del suo successo è quello di utilizzare ingredienti di qualità.
Olio Extravergine d’Oliva consigliato:
REGIONE CAMPANIA » Blend o monocultivar delle varietà Ogliarola , Rotondella , Frantoio o Leccino . Fruttato verde medio, sentori di fruttato di oliva e con fini e piacevoli note di erbe aromatiche.
Lievi note di amaro e piccante, in chiusura note speziate e mandorla verde.
Link alla ricetta: www.cuocicuoci.com/ricette/insalata-caprese
La fettunta è la classica bruschetta toscana di pane casereccio, aglio, Olio Extra Vergine di oliva e sale.
Olio Extravergine d’Oliva consigliato:
REGIONE TOSCANA » Blend o monocultivar della varietà Moraiolo , dal fruttato verde medio con sentori “pomodorosi” e vegetali, sarà un’ arricchimento gusto olfattivo. Amaro e piccante equilibrato.

“Pesto” letteralmente significa schiacciato, spiaccicato. Parliamo quindi dell’uso antico del mortaio. Il basilico, lavorato in modo sapiente con l’Olio Extravergine d’Oliva, grazie alla sua tenerezza ed eccellente resa ne è protagonista.
Olio Extravergine d’Oliva consigliato:
REGIONE LIGURIA » Monovarietale da varietà Taggiasca . Fruttato verde leggero, note erbacee e fruttate, erbe officinali, foglia di pomodoro e frutta bianca. Finale leggermente piccante, dona freschezza e una piacevole persistenza.

Link alla ricetta: www.cuocicuoci.com/ricette/pesto-alla-genovese
Cazzimperio, zalimperio, cacimperio... Il pinzimonio è uno dei modi più classici per servire le verdure crude, tagliate a bastoncini, a strisce o a pezzetti.
Olio Extravergine d’Oliva consigliato:
REGIONE LAZIO » Blend o monocultivar delle varietà Canino , Leccino e Frantoio . Fruttato verde medio, profumo fragrante di erba appena tagliata, sapore deciso, note aromatiche di carciofo, equilibrato retrogusto di amaro e piccante.
Link alla ricetta: www.cuocicuoci.com/ricette/pinzimonio-di-verdure-aforma-di-trenino-per-i-bambini-che-bella-idea
La ricetta originale è della Dogale Confraternita del Baccalà Mantecato.
Olio Extravergine d’Oliva consigliato:

REGIONE VENETO » Blend o monocultivar delle varietà Grignano , Favarol , Leccino e Casaliva . Fruttato verde leggero dai sentori di frutta secca fresca, note amare e piccantezza leggere.
Link alla ricetta: www.cuocicuoci.com/ricette/baccala-alla-vicentina
Un recente sondaggio effettuato da GEA Group – azienda tedesca del settore food and beverage - dimostra che numerosi chef di tutto il mondo sono interessati a introdurre sempre più alternative vegetali alla carne animale e derivati nei menù dei loro ristoranti.
L’intervista ha visto partecipare ben 1000 chef provenienti da 11 paesi, tra cui Brasile, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Germania, India, Israele, Paesi Bassi, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti. Oltre il 90% degli chef ha notato un crescente interesse alle alternative vegan da parte dei propri clienti, un 40% ha rimarcato che questo è un trend in costante aumento. Il 92% degli chef conosce i vari tipi di proteine alternative alla carne, e il 63% ne fa già largo uso nelle proprie cucine; solo il 2% asserisce di non averne mai sentito parlare.
Nel report si analizza anche la carne coltivata che, sebbene non sia vegan, rappresenta sicuramente un enorme passo avanti verso la liberazione animale e la diminuzione dell’impatto ambientale da allevamenti intensivi. Attualmente la carne coltivata è in commercio solo a Singapore, ma un buon 80% degli chef conferma di avere familiarità con questi prodotti e il 41% sostiene di essere molto informato su sviluppo e tecniche di produzione della carne coltivata.

L’elevato livello di consapevolezza sull’ utilizzo di proteine alternative da parte di molti chef è motivato dal proprio interesse professionale: molti vogliono essere ben informati sugli sviluppi alimentari e stare al passo con questa tendenza in crescita. Dal sondaggio emerge a chiare linee che questo interesse è generato anche dalla crescente domanda dei clienti che chiedono sempre più alternative al cibo convenzionale
Esattamente come dimostra il sondaggio di Blue Horizon/Boston Consulting Group del 2022 che ha rivelato che su oltre 3.700 consumatori in tutto il mondo, più della metà di loro sono consumatori occasionali di proteine alternative, il 35% consumatori frequenti e circa il 13% consumatori “esclusivi o quasi esclusivi”. Il sondaggio europeo del Good Food Institute condotto nel 2022 mostra che più della metà dei consumatori in Spagna e Italia mangia già carne a base vegetale su base mensile, con il 65% degli spagnoli, il 55% degli italiani, il 57% dei tedeschi e un terzo dei consumatori in Francia, indicando la loro disponibilità ad acquistare carne coltivata quando sarà disponibile sul mercato. Un altro studio recente dimostra che l’80% dei consumatori britannici e statunitensi è disposto a mangiare carne coltivata.
Il 75% degli chef intervistati considera il cibo in generale un fattore molto importante per la salute umana, mentre il 62% considera il cibo un fattore molto importante per la salute ambientale . Inoltre, quasi la metà degli chef (48%) ritiene che le nuove alternative alimentari possano avere un grande impatto sul miglioramento della salute umana o ambientale. Si delinea quindi il ruolo chiave degli chef e i ristoranti, consapevoli della propria responsabilità professionale e personale nell’assumere un ruolo di leadership in tal senso. Difatti, lo studio rivela che il 33% sta riducendo significativamente la quantità di carne che consuma per motivi di salute o
ambientali . Circa il 15% è completamente vegetariano o vegano. Quasi tutti (96%) affermano che il loro ristorante sta adottando misure per ridurre il proprio impatto ambientale, con il 44% che lavora attivamente su questo fronte. La maggior parte degli chef (53%) ritiene di svolgere un ruolo fondamentale nelle scelte alimentari dei propri ospiti, ancor più dei social media, della pubblicità, degli amici e della famiglia, degli influencer o dei critici gastronomici.
Gli chef di tutto il mondo credono che la tendenza verso proteine alternative sarà in continuo aumento . Quasi il 95% prevede che i loro ospiti richiederanno più proteine vegetali nel prossimo decennio; la metà degli chef si aspetta un fortissimo aumento proprio in questo periodo.
Il 23% degli chef intervistati ritiene che i nuovi alimenti costituiranno più del 50% di tutto il cibo entro il 2040. Un ulteriore 43% è convinto che entro il 2040 i nuovi prodotti e ingredienti alimentari costituiranno da un quarto alla metà di tutto il cibo a nostra disposizione. Una prospettiva straordinaria , che mostra come molti degli chef intervistati - la maggior parte dei quali ha meno di 40 anni - considerano le proteine alternative una parte significativa e sempre più essenziale dei loro lavori futuri.
In conclusione il sondaggio GEA mette in luce che i professionisti del settore alimentare di tutto il mondo sono ampiamente aperti e positivi nei confronti delle proteine alternative . Alcuni hanno ovviamente i loro dubbi, ma i dati del sondaggio indicano che solo il 10% circa degli chef può essere classificato come scettico. Il restante 90% è più o meno equamente diviso in due categorie: gli ambasciatori aperti e positivi all’aumento delle proteine alternative, che stanno già utilizzando i nuovi alimenti e sono fiduciosi del loro potenziale futuro; e quelli cauto adottanti, che sono generalmente positivi, ma ancora si esprimono con riserva in termini di utilizzo e prospettive. Questi ultimi ritengono che molti dei nuovi prodotti alimentari non abbiano ancora raggiunto il livello di qualità da ristorante.
Questo atteggiamento non sorprende, soprattutto perché i tre quarti degli intervistati lavorano appunto nei ristoranti più costosi. Ciò è comunque coerente con i risultati del sondaggio sui consumatori, sebbene in generale siano molto aperti e positivi riguardo alle proteine alternative e ai loro benefici, ma si aspettano ulteriori miglioramenti sulla qualità. Si conferma dunque la posizione della maggior parte
degli chef (70%) che vede il miglioramento della qualità come la chiave per aumentare in futuro il consumo dei nuovi alimenti. Al contempo, un terzo degli chef ritiene che le proteine alternative di oggi abbiano già raggiunto una qualità sufficiente in termini di gusto, consistenza e prezzo per sostituire in larga misura gli alimenti prodotti in modo convenzionale.
Questi dati sono significativi e testimoniano gli enormi passi avanti compiuti nel migliorare la qualità delle proteine alternative negli ultimi anni.
Il livello generale di interesse tra gli chef nell’utilizzo di proteine alternative rafforza un numero crescente di dati che ci dicono che la maggior parte degli chef di tutto il mondo sicuramente non sta aspettando, ma ha già iniziato a passare a nuovi alimenti .
AMA IL CIBO VEGANO
Il famoso chef Gordon Ramsay ha aperto la nuova sede della sua catena Hell’s Kitchen a Washington, DC.
Il ristorante offre piatti a base di carne, ma i piatti vegetariani e vegani assumono un ruolo più importante con un menù dedicato a vegetariani e vegani . Il 60% del menù del ristorante è privo di carne, con piatti come capesante di tofu scottate in padella con radice di sedano e mele Granny Smith in salamoia; risotto vegano con zucca butternut; Wellington di barbabietola; insalata di quinoa; lenticchie Beluga con verdure saltate e insalata di finocchi a scaglie; insalata di barbabietole dorate con yogurt vegano, kumquat, granola al pistacchio e vinaigrette al balsamico bianco Ricordiamo le esternazioni di qualche anno fa da parte di Gordon Ramsay, poco positive nei confronti dei vegani (aveva dichiarato di essere allergico ai vegani).
Nel corso degli ultimi anni Gordon ha introdotto qualche piatto vegetale nei suoi ristoranti, come una pizza a base vegetale in uno dei suoi ristoranti londinesi nel 2018, mentre l’anno successivo ha aggiunto l’ Impossible Burger al menù dei ristoranti di Singapore e Chicago.
In un episodio del 2022 di US Masterchef, Ramsay ha rivelato:
“È un segreto così grande che ho quasi paura di dirlo alla televisione nazionale. Dopo tutti questi anni, posso finalmente ammettere che amo davvero il cibo vegano.
Mi ci sono voluti 20 anni per arrivare a questo punto. Grazie ai bambini , ho capito che va bene essere vegani... A VOLTE!”
Gordon RamsayLo sviluppo di nuove tecnologie alimentari e la dimensione globale dei mercati fecero sì che già dagli anni ’90 il legislatore europeo dovesse intervenire per regolarizzare la procedura di autorizzazione o di notifica per gli alimenti considerati nuovi .
Questo per adempiere ad uno degli obiettivi principali alla base della normativa alimentare sui nuovi alimenti, ossia la libera circolazione di alimenti sicuri e sani, aspetto fondamentale del mercato interno in grado di contribuire in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini nonché ai loro interessi sociali ed economici. Questo bilanciamento di interessi tra salute del consumatore e valutazioni economiche sarà di certo il focus dei prossimi dibattimenti europei sulla carne coltivata

Ad oggi la carne sintetica è già stata approvata in varie parti del mondo tra le quali Singapore e di recente negli Stati Uniti . In Europa , gli alimenti nuovi costituiti, isolati o prodotti da colture cellulari o colture di tessuti derivati da animali, piante, microrganismi, funghi o alghe rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento UE sui nuovi alimenti, quindi anche la carne coltivata richiede un’autorizzazione prima dell’immissione in commercio e l’approvazione da parte dell’ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).
La carne coltivata, sintetica, artificiale o in vitro, è un prodotto ottenuto raccogliendo cellule muscolari animali che vengono poi coltivate in laboratorio e alimentate con proteine per stimolare la crescita dei tessuti. Nell’ultimo decennio tanti sono stati gli studi indipendenti europei, condotti per esplorare il potenziale della carne coltivata per ridurre gli impatti ambientali della produzione zootecnica in Europa, concludendo che se tutta la carne prodotta nell’UE fosse sintetica al posto della attuale convenzionale, le emissioni di gas a effetto serra , l’uso del suolo e dell’acqua sarebbero ridotti di due ordini di grandezza rispetto alle attuali pratiche di produzione di carne.
Lo sviluppo di nuove alternative alla carne è sostenuto come un importante percorso verso la realizzazione del programma europeo Food 2030 della Commissione, per fornire un sistema alimentare ecologico e sostenibile per un’Europa sana, come una
tecnologia chiave che potrebbe aiutare a conseguire una riduzione sostanziale delle emissio ni dirette di gas serra dalla produzione alimentare.
La stessa EFSA ha confermato che l’introduzione di carne sintetica non è pura fantasia, ma possibile realtà e allo stato attuale sono almeno una ventina le startup che lavorano in quest’area in vari paesi europei, pertanto ci si aspetta a breve la presentazione di domande di registrazione alla Commissione europea per l’immissione in commercio da parte di produttori di cibi sintetici, facendo leva sui benefici ambientali che comporterebbe questa nuova tecnologia.


Ma al di là delle motivazioni ecologiche, c’è chi invece sottolinea che la produzione di carne sintetica rafforzi il dominio sui sistemi alimentari da parte delle multinazionali agro alimentari, di diete standardizzate a base di alimenti trasformati e delle filiere in dustriali che danneggiano
le persone e il pianeta.
Si sottolinea appunto che il mercato delle proteine alternative , tra le quali la carne coltivata, è caratterizzato da aziende che hanno creato i cosiddetti monopoli delle
proteine e questo potrebbe peggiorare i problemi già esistenti nel mercato alimentare industriale.
In Italia Coldiretti e Ministero dell’agricoltura proseguono la campagna per impedire la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico considerandolo una minaccia per l’agricoltura, la salute dei consumatori, la biodiversità del pianeta ed in generale per la nostra civiltà e stile di vita.
Alla luce di tutto ciò l’auspicio è che nel momento in cui le istituzioni europee riceveranno i primi dossier di analisi di questi nuovi alimenti, siano in grado di orientare la propria decisione verso sistemi alimentari democratici, sostenibili ed equilibrati.
“Napoli inventò le zeppole, tutta Italia se ne leccò le dita”, scrive Giovanni Bideri nel suo libro “Passeggiata per Napoli e contorni”.
E come dargli torto, visto che le zeppole napoletane sono il dolce più apprezzato, realizzato e consumato in tutta Italia il giorno della festa del papà, ovvero il 19 Marzo. Un dolce talmente celebrato che il filologo Emmanuele Rocco avrebbe voluto addirittura un monumento cittadino con un’epigrafe che riportasse la citazione di Bideri, proprio a sottolineare quanto le zeppole fossero uno dei tanti tesori che l’Italia aveva ereditato da Napoli.

Come per tutti i dolci che hanno fatto la storia della pasticceria anche la nascita delle zeppole è avvolta da diverse leggende e si fa ricondurre la loro creazione ad antichissime tradizioni.
Pare, difatti, che le origini di questa leccornia siano da ricercare nel 500 a.C., quando a Roma si celebravano le Liberalia , ovvero le feste organizzate dai romani per omaggiare Bacco e Sileno, le divinità dispensatrici del vino e del grano. Durante queste feste, che si celebravano nel giorno del 17 marzo, si bevevano fiumi di vino e si gustavano profumate frittelle di frumento, fritte in abbondante strutto bollente.
Secondo altre fonti pare che le origini delle zeppole siano da ricercare nei riti di purificazione agraria che si tenevano nei paesi del Sud il giorno del 19 marzo: per festeggiare la fine dell’inverno e l’entrata della primavera si accendevano dei falò e si festeggiava mangiando delle frittelle dalla forma di serpentello arrotolato su se stesso (da qui la forma caratteristica di ciambella e probabilmente il nome zeppola, facendolo derivare dal termine “serpula”, ovvero serpente) e ricoperte di miele.
Una leggenda cristiana, invece, fa risalire la nascita delle zeppole alla fuga della sacra famiglia in Egitto. Secondo tale leggenda, difatti, pare che San Giuseppe per mantenere Maria e Gesù dovette affiancare al mestiere di falegname anche quello di friggitore ambulante, vendendo frittelle dolci per strada.
Da qui sembrerebbero nati il collegamento della zeppola con la festa in onore del santo e la tradizione degli zeppolari di strada a Napoli, che fino ai tempi del primo Pintauro erano soliti imbastire piccoli banchetti davanti alle loro botteghe, dove friggevano e servivano le zeppole ai passanti, direttamente in strada.
A conferma di ciò Goethe , in visita a Napoli verso la fine del 1700, scriveva: “Oggi era anche la festa di S. Giuseppe, patrono di tutti i frittaroli cioè venditori di pasta fritta... Sulle soglie delle case grandi padelle erano poste sui focolari improvvisati. Un garzone lavorava la pasta, un altro la manipolava e ne faceva ciambelle che gettava nell’olio bollente, un terzo, vicino alla padella, ritraeva con un piccolo spiedo, le ciambelle che man mano erano cotte e, con un
altro spiedo, le passava a un quarto garzone che le offriva ai passanti...”.
Ma la storia della zeppola di San Giuseppe ha inizio ufficialmente nel 1837, quando il gastronomo napoletano Ippolito Cavalcanti , Duca di Buonvicino, inserì in un suo trattato di cucina la prima ricetta ufficiale in lingua napoletana, anche se pare che la prima ricetta delle attuali zeppole napoletane sia opera del famoso Pintauro , già leggendario “ideatore” della sfogliatella napoletana.

Rivisitando le antiche frittelle romane e prendendo spunto dai consigli del Cavalcanti il bravo Pintauro creò le attuali zeppole arricchendo l’impasto di uova, strutto e aromi, procedendo poi con la caratteristica doppia frittura (dapprima nell’olio e poi nello strutto) e farcendola con una ricca e gustosa crema pasticcera sormontata da una succosa amarena.
In tempi moderni, vuoi per l’attenzione alla linea o per la ricerca di una cucina più salutare e leggera, nei banchi di pasticceria, così come nei vari blog di cucina e nei libri di ricette, troviamo, al fianco delle classiche zeppole fritte, le più leggere zeppole al forno. Ma come afferma un decano della pasticceria artigianale napoletana, Mario Scaturchio , “la vera zeppola di San Giuseppe è solo fritta!”.
E non solo! Secondo il famoso pasticciere napoletano le zeppole devono essere fritte esclusivamente nello strutto.
Vediamo, dunque, come preparare le tradizionali zeppole di San Giuseppe fritte, secondo la ricetta generosamente condivisa dal Maestro Scaturchio.
g. 380 di farina 00 (povera di proteine) • g. 150 di strutto o burro • ml. 500 di acqua • g. 500 di uova • g. 10 di sale
La pasta choux utilizzata per la zeppola fritta prevede un bilanciamento dei grassi decisamente diverso rispetto alla tradizionale pasta choux: si diminuisce la materia grassa perché nella pasta cotta per immersione in un altro grasso la struttura del pastello tenderebbe a rompersi. Quindi, rispetto alla classica pasta choux si diminuisce la % di burro/strutto e uova.
Portare ad ebollizione l’acqua con lo strutto e il sale. Togliere dal fuoco quando lo strutto sarà completamente sciolto e versare in un solo colpo la farina precedentemente setacciata e mescolare finché avrete ottenuto un composto omogeneo, quindi riportare su fiamma bassa e far asciugare la pasta mescolando continuamente finché si formerà una palla che si staccherà dalle pareti del pentolino.
Trasferire l’impasto nella ciotola di una planetaria e con la frusta a foglia (gancio K) far scendere di temperatura mescolando la pasta a media velocità. Aggiungere un po’ per volta le uova precedentemente sbattute, procedendo con le aggiunte solo quando la prima parte si sarà completamente amalgamata all’impasto, che dovrà risultare liscio ma sostenuto (tipo una crema pasticcera densa), per poter utilizzare la sac a poche. Preparare dei riquadri di carta forno. Riempire
con l’impasto una sac a poche munita di beccuccio a stella e dressare su ognuno dei quadrati di carta forno le zeppole in forma di ciambella piuttosto piccola poiché in cottura aumenteranno di volume.
Veniamo ora alla frittura delle zeppole, tassativamente con lo strutto.
Metodo Scaturchio (Storica pasticceria di Napoli) Scaturchio consiglia una doppia frittura con due temperature diverse: la prima a 120 °C, una temperatura piuttosto bassa che serve a far gonfiare perfettamente le zeppole; e la seconda a 170 °C, che è la cottura vera e propria. In questo modo si ottengono zeppole friabili, leggere e per niente unte. Quindi, predisporre le due padelle con lo strutto e tenere d’occhio la temperatura con un termometro: calare le zeppole (con tutto il quadratino di carta forno, che alzerete non appena si sarà staccato dalla pasta) nella prima padella (120 °C) e friggerle rigirandole continuamente finché saranno gonfie e si coloreranno di un bel biondo e si sarà stabilizzata la forma definitiva (circa 3 minuti), quindi passarle subito nella seconda padella (170 °C) e ultimare la cottura, quindi scolare su carta assorbente.
Un’altra modalità per cuocere bene le zeppole fritte è quella della doppia cottura: preriscaldare il forno a 220 °C; abbassare poi la temperatura a 180 °C e infornare le zeppole per circa 20 minuti, dopodiché passare a friggerle in olio di mais o girasole a 170 °C.
LA PASTA CHOUX
g. 500 di acqua • g. 520 di burro • g. 10 di sale • g. 450 di farina • g. 800 di uova
Il procedimento è lo stesso utilizzato per la pasta choux della zeppola fritta.
Cottura in forno
Preriscaldare il forno a 220 °C, abbassare la temperatura a 175 °C e cuocere per 40 minuti, di cui i primi 20’ con umidità e i restanti 20’ senza umidità.
CREMA PASTICCERA
lt. 1 di latte intero • ml. 200 di panna al 35% m.g. • g. 150 di zucchero semolato 1 bacca di vaniglia • g. 40 di amido di mais • g. 30 di amido di riso • g. 400 di tuorlo d’uovo
Incidere la bacca di vaniglia e asportarne i semini, che andranno aggiunti ai tuorli, allo zucchero e agli amidi creando una pastella. Riscaldare il latte, la panna e la bacca di vaniglia incisa e lasciare in infusione 10 minuti. Togliere la bacca di vaniglia, aggiungere un po’ di liquidi alla pastella di tuorli per fluidificarla, versarla nei liquidi e portare a bollore. Trasferire in una teglia e abbattere immediatamente.
Spolverare le zeppole con lo zucchero a velo, con una sac a poche munita di bocchetta a stella farcire prima internamente e ultimare con un ricciolo di crema in superficie, dove si andranno ad apporre 3 amarene sciroppate ben sgocciolate.

Gestione professionale dei tuoi profili social (Facebook, Instagram, Pinterest...) attraverso la definizione della migliore strategia, la redazione di un piano editoriale su misura, la creazione di campagne di advertisting per raggiungere i tuoi obiettivi.

Gestione dei profili Google Maps e TripAdvisor della tua attività, attraverso l’aggiornamento costante delle informazioni, delle foto e degli orari e la risposta alle recensioni dei clienti.
Realizzazione professionale di still life di piatti e ricette, foto di ambienti, ritratti e creazioni studiate per valorizzare i singoli prodotti. Ripresa e montaggio di video brevi per i social (reel) e video promozionali per ogni tipo di piattaforma.


Scrittura professionale di testi pubblicitari destinati ai social, al web, alla radio, alla televisione e alla carta stampata, per comunicare il tuo brand con successo.


Ufficio stampa rivolto ai media locali e nazionali, progettato e realizzato per promuovere presso i mezzi di comunicazione (agenzie di stampa, carta stampata, radio, tv, web) il brand, il concept e l’immagine della tua azienda.
Il “Maître dei Maître” Luigi Carnacina sosteneva con profonda convinzione che “fintanto che gli uomini continueranno a coltivare i valori che alimentano il vigore civile, la nobile ambizione di affinare gli istinti, la gioia di ospitare e di intrattenersi con i propri simili, il gusto genuino della buona tavola non decadrà mai”.
La parola Maître, che nella traduzione letterale in italiano significa “maestro ”, ha insite nel ruolo professionale a cui si riferisce le qualità di Grandezza, Serietà, Disciplina, Educazione, ma soprattutto... Esperienza.
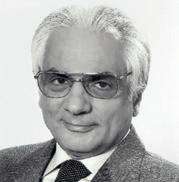
Nostro Signore, il Maestro per antonomasia, insegnava ai suoi discepoli come amare la vita rispettandone il valore, così il Maître d’Hotel insegna ai propri dipendenti come amare il proprio mestiere, come considerare il cliente e come “amarlo” rispettando regole deontologiche fondamentali.
Il Maître d’Hotel è riconosciuto dalle Istituzioni dello Stato come dirigente d’albergo e di ristorante, avendo la responsabilità dell’andamento aziendale
Collabora con il Direttore e con lo Chef di cucina alla stesura del menù del giorno e dei menù per banchetti in generale, stabilendo contestualmente anche i turni di servizio del personale e curando i rapporti con i Capi servizio.
Riceve i clienti, assegna i posti agli ospiti, prendendo successivamente le varie ordinazioni e cercando di soddisfare ogni desiderio del Cliente.
Deve inoltre distinguersi nell’aspetto e nei modi: il proprio maggiore pregio è infatti quello di possedere carisma , in tal modo assumendo anche il delicato compito di diventare quasi un buon psicologo nella gestione del personale, allo scopo di consentire ad ognuno non solo di essere soddisfatto del proprio lavoro, ma soprattutto di indirizzare tutte le risorse umane allo svolgimento quotidiano di un servizio il più professionale possibile. Ne consegue che, come uomo e come tecnico, il Maître dovrebbe meritare grande e attenta considerazione da parte del pubblico, poiché reca un preciso contributo al
servizio: tedoforo del vino, consulente alimentare, amabile dispensatore di informazioni sui prodotti e sul territorio, egli mette le proprie competenze a disposizione di quelle fondamentali manifestazioni di cortesia e civiltà che si realizzano attorno alla tavola, nell’ambito appunto di una attività organizzata ed efficiente.
La ristorazione dovrebbe infatti mantenere o recuperare, anche in questi tempi di rarefatta educazione e sensibilità, il proprio scopo primario che è quello di “donare ristoro ”, ossia essere il rilassante, ricreativo, a volte festoso punto di riferimento indispensabile per chi è lontano da casa per lavoro o turismo, o per chi vuole semplicemente ritagliarsi un momento speciale tutto per sé. A ben poco varrebbe infatti utilizzare locali elegantemente arredati, attrezzature e impianti tecnologicamente avanzati, cibi buoni e coscientemente preparati, se mancasse l’accoglienza del Maître e dei suoi collaboratori, l’ordinata e dignitosa esecuzione dei servizi, il giusto suggerimento nella scelta delle vivande e dei vini, il sorriso e la parola gentile e, perché no, il saper presentare il conto con grazia nel momento del congedo dal locale.
Il Maître è così protagonista nella funzione di “ospitare ” con senso di dignitoso altruismo e premura, di gentilezza e di efficienza, doti senza le quali il turismo diverrebbe solo una caotica transumanza di gente, generalmente insoddisfatta e disordinata, come si evince ormai dai troppi, incompetenti e spesso maleducati commenti sul web. Il nostro “maggiordomo ” svolge dunque un compito assai arduo e impegnativo, oggi più che mai.
Oltre alla fatica fisica e alla tensione nervosa di chi è a contatto con il pubblico e cerca di arrivare a tempo de -
bito a soddisfare le infinite necessità, il Maître d’Hotel ha oggi infatti l’ingrato compito di far fronte a individui pretenziosi, oltremodo irritabili, maleducati o irriconoscenti, così come anche a persone abuliche, eternamente indecise, problematiche per reali, ma troppo spesso fittizie intolleranze alimentari.
Il “ Maestro di casa ” ebbe già nel passato una collocazione cardine nell’arte dell’ospitalità. Era presente in tutte le dimore nobili e dell’alta borghesia, con la piena responsabilità dell’intero menage di casa.
Da lui dipendevano la governante personale dei padroni, i cuochi, i camerieri, gli uomini di fatica.
Organizzava i ricevimenti, sia mondani che privati, suggerendone tutti i particolari che potessero garantirne il sicuro successo. La sua formazione avveniva sotto la diretta guida di maestri già affermati, passando al loro servizio da una casa all’altra.
Il termine Maître divenne di uso comune in Italia con la modernizzazione dell’attività alberghiera per opera dello svizzero Cesare Ritz (1860-1918). Lui stesso, da ragazzo di campagna, aveva cominciato come garzone, per poi incamminarsi nel settore della ristorazione come aiuto cameriere.
La sua progressiva sfolgorante carriera lo portò a dirigere il Savoy di Londra, dove impose l’installazione dell’acqua corrente in tutte le camere, i bagni e le luci soffuse in ambienti destinati ai momenti di relax, la musica di un’arpa o di un pianoforte negli spazi comuni. Per le sue innovazioni, sovrani e principi dell’epoca lo definirono il Napoleone degli Albergatori.
Ritz a capo della ristorazione volle Auguste Escoffier, allora quarantatreenne e già cuoco famoso. Volle anche il Maître, assunto per dirigere i servizi della ristorazione, delle sale e dei saloni dove, nel corso di alcune feste, addirittura il canto di Enrico Caruso allietava gli illustri ospiti. Cesare Ritz creò uno stile, sia nell’immagine architettonica che nel servizio.
Oggi non c’è albergo di buona categoria, ristorante di provato decoro, che non abbia un Maître nella sua perfetta divisa: lo smoking ha sostituito in tempi moderni il frac, ugualmente elegante. Così abbigliato, può avere
una sorta di rivalsa professionale rispetto allo chef, esibendo la propria preparazione enogastronomica: può riservare al cliente la sorpresa di preparare un proprio piatto flambè, da ammannire sull’apposito carrello portato accanto al tavolo.
Per quanto egli abbia saputo istruire i suoi dipendenti, egli è sempre preoccupato che il proprio pensiero, il proprio stile , la propria premura e gentilezza vengano travisate e non arrivino a destinazione nel modo dovuto.
Dunque risulta evidente che oggi la sua sia la figura ideale di insegnante Tecnico-Pratico: la sua importanza in una scuola alberghiera è talmente fondamentale che è impossibile parlare di scuola alberghiera, nel suo contesto più ampio e tecnico, se priva di questo docente. La presenza del Maître costituisce l’asse portante della struttura scolastica stessa.
Sia ben chiaro, nessuno pensa, con questa affermazione, di sottovalutare i delicati compiti dei docenti delle altre discipline, anzi solo da un equilibrato rapporto di valori fra le varie categorie di docenti, la scuola professionale in generale e quella alberghiera in particolare, acquisterà vigore nella sua funzione di istruzione professionale vera e propria.
Possiamo tuttavia affermare con tutta tranquillità che, senza il concorso del Maître, nell’aula non può esistere autentica formazione professionale alberghiera.
Ma quale tipo di Maître possiede le caratteristiche più specifiche per salire in cattedra e ricoprire il ruolo di insegnante Tecnico-Pratico?
Quello proveniente dal mondo del lavoro, magari senza titolo di studio, oppure quello nutrito di nozionismo teorico senza aver mai effettuato reale pratica?
L’optimum sarebbe avere un Maître formato teoricamente, ma con una lunga esperienza pratica, ma per quanto riguarda la scuola professionale alberghiera in Italia, ribadisco la necessità della presenza di un Maître altamente “collaudato” da una notevole esperienza, non escludendo tuttavia l’inserimento per gradi di giovani particolarmente vocati alla professione, così da rinnovare l’apparato professionale italiano, ma sulle solide basi di un mestiere che orgogliosamente affonda le sue radici in un passato e un presente importanti.
Finalmente, ci sono buone notizie. Infatti, non solo ci siamo lasciati alle spalle i tre anni più difficili di sempre nel campo della Ristorazione, ma abbiamo anche tutti la consapevolezza che... Possiamo, vogliamo e DOBBIAMO voltare pagina.
Io non solo sono convinto che il 2023 sia l’anno PERFETTO per tornare a crescere, ma ho anche dei dati che supportano questa tesi.
Infatti con il nostro Osservatorio Ristorazione abbiamo individuato e selezionato tre dati che vogliamo condividere e che faranno tornare il sorriso a molti operatori del settore.
Il primo dato riguarda la spesa alimentare fuori casa degli italiani. Che, letto in altri termini, è quanto gli italiani hanno speso al ristorante, al bar e in pizzeria e in generale nelle attività di ristorazione.
Questo dato ci dice chiaramente che gli italiani vogliono spendere al ristorante, stanno spendendo sempre di più e continueranno a farlo. Non lo dimostrano a parole, ma con i fatti, mettendo mano al portafogli. La spesa alimentare fuori casa ha fatto un +11% dal 2020 al 2021 (mentre il PIL italiano cresceva solo del 7%).
Potrebbe sembrare un dato “timido”. Lo è. Ma la verità è che è MOLTO migliore di quanto potrebbe sembrare. Per ulteriori tre ragioni:

1. Da Gennaio ad Aprile del 2021 erano ancora in atto forti restrizioni dovute al contenimento della pandemia che hanno impedito agli italiani di spendere quanto avrebbero dovuto;
2. In questo dato non sono contemplate le spese al ristorante dei turisti;
3. Manca... il “sommerso”.
FATTO STORICO:
Valori espressi in unità. Dati Movimprese, elaborazione Osservatorio Ristorazione by RISTORATORETOP.
Il secondo dato riguarda il numero di attività di ristorazione sul territorio italiano, che per la prima volta nella storia... Stanno diminuendo velocemente di numero! E di parecchio...
Il dato in sé non è importante, ciò che è importante è che è senza precedenti e che è sintomo di un sistema che non solo scricchiola, ma sta iniziando a collassare. E questo significa che per la prima volta da sempre la torta si sta ingrossando e ci sono meno commensali a tavola per spartirsela. E questo non era mai successo prima. Mai mai mai. Negli anni precedenti il numero di ristoranti sul territorio italiano è sempre andato aumentando. E cresceva ad una velocità folle, senza controllo. La ristorazione sembrava il paese dei balocchi e tutti volevano investirci. E tutti ci investivano! Significava che anche per i più bravi, c’era meno, perché il mercato era affollatissimo di concorrenti. Da domani invece ci sarà di più per tutti, perché ci sarà MENO concorrenza (ma sarà più agguerrita, questo è fuori di dubbio!). La selezione naturale che tanti invocavano è qua, tra noi. Domani ci saranno:
• Meno concorrenti
• Ma più strutturati, forti e agguerriti
Le nostre conclusioni sono lapalissiane: c’è di più per pochi, meno per tutti. E ci sarà MOLTO di più per i pochi che rimarranno in piedi tra pochi anni.
Il terzo dato riguarda il clima di sfiducia che regna nel nostro settore. Il grafico riportato sopra rappresenta il numero di imprenditori che decidono di investire nel nostro settore, aprendo un locale: la linea di tendenza è in picchiata da diversi anni. In poche parole, non solo il numero di ristoranti sta diminuendo in termini assoluti, ma sono sempre meno gli imprenditori che decidono di investire nel nostro settore in virtù del clima di sfiducia che aleggia. Nel settore sono anni che si parla di “licenze bloccate” e della necessità di “fare pulizia”. Ecco, è successo, e senza interventi governativi. Il mercato si sta aggiustando e “pulendo” da sé. Ecco, quelli che ti abbiamo appena mostrato sono tre dei motivi per i quali pensiamo che il 2023 sarà un anno davvero incredibile, in positivo. E tu, se stai leggendo queste righe e hai ancora un ristorante, una pizzeria o un bar... Sei in piedi tra le rovine. Il 2023 può essere anche il TUO anno dei record. Non hai davvero più scuse.
SUL DELTA DEL PO

Foto di Michela Balboni e Veneto secrets
“Sono rimasto stupito dall’intensità e dalla definizione del ripieno dei Raviolotti Polenta e Montasio DOP, ma anche della qualità della pasta all’uovo, particolarmente adatta a piatti gourmet”. Esordisce così Cristian Mometti - chef executive del ristorante In Marinetta , raffinata sosta gourmet sul Delta del Po - nel descriverci il suo rapporto con la pasta Divine Creazioni ® di Surgital. Lui cuoco di provata professionalità, padre della vasocottura, con molteplici esperienze in prestigiose strutture del veneto e dell’Emilia Romagna, si è calato completamente nella filosofia lagunare della straordinaria area polesana in cui lavora, esaltando nei suoi piatti i prodotti del grande fiume che incontra il mare: le vongole veraci, la ormai famosa ostrica rosa di Scardovari, il sapido riso carnaroli bio del Delta ma anche gli ortaggi, meravigliosi in ogni stagione, coltivati nelle antiche sabbie marine. È questo territorio, con tutte le sue valenze irripetibili, a entrare nei piatti di Mometti: anche nei test realizzati per Surgital ha utilizzato le materie prime che sceglie abitualmente per il ristorante, abbinandole a questi prodotti, usando la sua professionalità per dare valore aggiunto e costruire nuove suggestioni su paste “Divine”.

Abbracciato dalle acque blu, dove il primo ramo del Delta del Po incontra il mare di Rosolina, In Marinetta è uno degli ittiturismi più incantevoli del Veneto dove cucina gourmet e un intramontabile stile “à la marinière” regalano un’esperienza davvero indimenticabile.



Immerso in una delle lagune più spettacolari del Delta del Po, tra stormi di fenicotteri rosa, valli di pesca e specchi d’acqua, il locale è una storia d’amore con un territorio magnifico, quello MAB UNESCO ricco di eccellenze tutte da scoprire. Il freschissimo pescato locale include pesci di mare e di laguna, alghe e piante erbacee che crescono rigogliose sui terreni salmastri e fertili.
In MarinettaVia Po di Levante, 2a 45010 Rosolina (RO) Tel. 345 0318387
www.inmarinetta.it
In Marinetta
g. 250 di Strichetti
all’uovo Divine
Creazioni®
g. 300 di cefalo
g. 300 di branzino
8 canocchie
8 mazzancolle
8 scampi
16 fasolari
g. 500 di vongole
2 calamari cacciaroli
medi
2 scalogni
1 cipolla bianca
2 spicchio d’aglio
Polesano dop
¼ finocchio
½ arancia
1 foglia d’alloro
2 pomodori S. Marzano
maturi
1 gambo di sedano pepe bianco in grani q.b.
sale fino q.b.
olio evo del Garda q.b.
prezzemolo q.b.
1 peperoncino
Mettere a spurgare per 8 ore le vongole e i fasolari in acqua non fredda con il 30% di sale sciolto; nel frattempo, pulire, squamare e sfilettare i pesci e metterli a spurgare in acqua salata al 30% per 2 ore.
Rosolare in forno a 250 °C per 5 minuti le teste e le lische ben pulite; brasare con olio evo e acqua una mirepoix di cipolla, 1 spicchio d’aglio in camicia, i gambi del prezzemolo e ½ gambo di sedano; inserire quindi le teste e le lische, aggiungere del ghiaccio a coprire, quindi unire l’arancia affettata, l’alloro, il finocchio a cubetti, 1 pomodoro tagliato a metà e 5 grani di pepe bianco; portare a bollore e cuocere per 15 minuti a fuoco molto basso; filtrare fine e abbattere in positivo.

Pulire gli scampi e le mazzancolle dai carapaci e dal budello mettendo da parte la polpa e utilizzando gli scarti per preparare una leggera bisque; rosolare quindi in pochissimo olio evo i carapaci e le teste fino a biscottarli, aggiungere lo scalogno, l’aglio, il peperoncino, un po’ di prezzemolo tritato, del ghiaccio e portare a bollore; cuocere 10 minuti a fuoco basso; a cottura ultimata filtrarla fine e abbatterla.
Aprire i fasolari e togliere la polpa tenendola da parte con la loro acqua. Rosolare in una casseruola l’aglio e il prezzemolo tritato, aggiungere le vongole e acqua a coprire per farle aprire; sgusciarle e abbatterle nel liquido di cottura filtrato.
Mescolare i liquidi tenendo conto della salinità dell’acqua delle vongole, e regolare di sapore; nel frattempo scottare in padella a fuoco alto i filetti di pesce senza pelle, i crostacei, i calamari e cuocere per 2 minuti gli Strichetti nel brodo.
Posizionare gli Strichetti e il pesce sul piatto quindi servirli con il brodetto e un filo d’olio evo.
CON BLU DI CAPRA, ZAFFERANO, VERZA E PASTA DI SALAME
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
g. 400 di Mammoli di patata viola Vitelotte Divine Creazioni®

g. 300 di verza
1 carota piccola
1 cipolla
g. 50 di olio evo
1 spicchio d’aglio
4 foglie di salvia

1 rametto di rosmarino
1 rametto di timo
g. 100 di blu di capra
g 200 di panna 35% ridotta di 1/3
pistilli zafferano q.b.
g. 150 di pasta di salame
g. 50 di burro di montagna
Far appassire nell’olio la cipolla e la carota tritati, aggiungere la verza, salare e portare a cottura in una casseruola con coperchio a fiamma bassa.

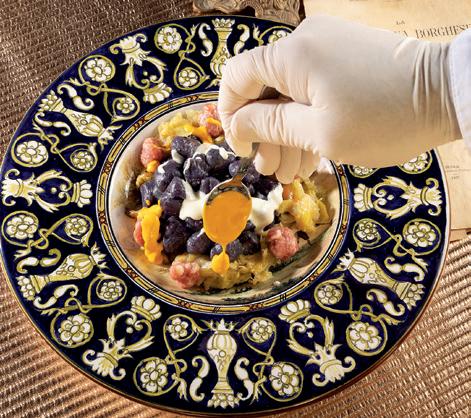

Dividere la panna e il blu di capra in due sacchetti da sottovuoto e in uno di questi aggiungere alcuni pistilli di zafferano; chiuderli al massimo del vuoto e cuocerli nel roner per 1 ora a 65 °C; frullare le due salse a crema liscia e conservare a bagno maria.
IMPIATTAMENTO
Cuocere i Mammoli in acqua bollente salata e, a cottura ultimata, ripassarli nel burro con il mazzetto di erbe aromatiche, adagiarli sulla verza stufata, decorarli con le due salse di formaggio e le polpettine di pasta di salame.
Foto di Davide Piras
12 nidi di Garbugli®
taglierini a sfoglia ruvida Divine
Creazioni®
12 canocchie
kg. 1 di cime di rapa
2 filetti di alice
1 peperoncino
olio evo q.b.
1 limone bio del Garda
2 spicchi d’aglio bianco
Polesano dop
1 scalogno sale q.b.
pepe nero di Timut q.b.
Lavare le canocchie e abbatterle in negativo ben stese. Selezionare i fiori più belli e le foglie più piccole delle cime di rapa; sbianchirli in acqua bollente, raffreddarli in acqua e ghiaccio, lasciarli sgocciolare e tenere da parte; ripetere la stessa operazione con il resto delle cime di rapa. Rosolare con l’olio metà di quest’ultime rape con lo scalogno tritato, l’aglio, mezzo peperoncino e l’acciuga; frullare a crema liscia e regolare di gusto. Con l’altra metà di rape ricavare una clorofilla con l’estrattore e tenerla da parte.

Prendere tutte le canocchie ed estrarne la polpa ancora congelata; con i carapaci e le teste, preparare un brodo dalla cottura veloce e filtrarlo all’etamine.
Marinare 4 canocchie con olio, sale, pepe, succo e buccia di limone per il tempo di cottura della pasta.
Cuocere i Garbugli® direttamente in padella con il brodo di canocchie, a metà cottura aggiungere le canocchie rimaste, la clorofilla e la crema di cime di rapa. A cottura ultimata aggiungere un po’ di succo e buccia di limone, una macinata di pepe, un filo d’olio evo; rotolare i garbugli e decorare con le cimette e le foglie selezionate, il peperoncino e le canocchie marinate.

Per la pasta
20 Raviolotti con polenta e Montasio DOP Divine
Creazioni®
g. 50 di burro di malga
Per la salsa Teriyaki
g. 30 di salsa di soia non salata
g. 200 di gin Caleri
g. 100 di mirin
g. 50 di aceto balsamico di Modena IGP
g. 60 di zucchero
Per l’anguilla
1 anguilla da g. 600/800
g. 100 di gin Caleri dealcolato
Per il porro
2 porri di media
grossezza
1 scalogno olio evo q.b.
1 patata farinosa bollita sale e pepe q.b.
Per la salsa Teriyaki: portare a ebollizione tutti gli ingredienti e far restringere.
Per l’anguilla: sfilettare l’anguilla e farla ripulire in acqua e ghiaccio per 3 ore, farla sgrassare in forno a 250 °C a secco per 2 minuti e raffreddarla in abbattitore; mettere in sottovuoto con il gin e un po’ di salsa Teriyaki e far cuocere per 15 minuti a 100 °C.
Per il porro: bucherellare un porro e cuocerlo nel bbq; con quello rimasto preparare una crema: far appassire olio e scalogno, aggiungere la parte bianca del porro tagliata finemente e, a cottura ultimata, aggiungere la parte verde sbianchita e la patata bollita sbucciata. Frullare a crema liscia, regolare di gusto e passare allo chinoise.
Passare al bbq l’anguilla mentre i Raviolotti si cuociono in acqua bollente salata; levarli dalla cottura con una ramina dopo 2 minuti e finirli in padella con il burro e l’acqua di cottura. Posizionare sul fondo del piatto il porro al bbq, poi i Raviolotti e sopra a tutto l’anguilla con le salse.
Foto di Davide PirasCorreva il lontano 1925 quando Nunziadêina , vezzeggiativo di Annunciata Balestri (1882-1966), rilevava una rivendita di generi alimentari, a Cittanova, lungo la via Emilia, appena fuori Modena. Arrivava da Vignola, vedova, con quattro figli da mantenere e con tanto bisogno di lavorare.
Già all’epoca erano numerosi i viaggiatori e i birocciai che transitavano su quella strada che taglia in due la Pianura Padana, e presto Nunziadêina intuì che se al banco del negozio avesse affiancato alcuni tavoli, lì avrebbe potuto servire, ai molti che entravano affamati, quei piatti di tradizione che così bene sapeva cucinare. La decisione fu presa, e il successo arrise subito a Nunziadêina.
Passata la guerra, negli anni della ricostruzione e del boom, la sua insegna divenne uno dei luoghi simbolo della cucina modenese, sinonimo di grandi tavolate della domenica, di leggendarie tagliatelle al prosciutto, di minuscoli tortellini del dito mignolo, di giganteschi
tortelloni dalla sontuosa farcia di ricotta ed erbette, di succulente cotolette alla petroniana, di monumentali carrelli dei bolliti.
Attraverso le generazioni – la figlia Olga prima, i nipoti poi – il ristorante ha consolidato la sua fama e continuato, per ben settantasette anni, ad accogliere, con immutata atmosfera, passanti e habitué (fra i quali anche tanti personaggi famosi, tra cui il maestro Pavarotti, che tanto amava questo luogo) sino a che, nel 2002, la famiglia prese la decisione di chiudere.

Grande fu lo sconforto dei modenesi (che di lì a poco avrebbero visto chiudere un’altra istituzione della loro città: Fini). Ma grande fu la gioia quando, nel 2013, la quarta e la quinta generazione – Rina Mattioli , con la figlia Elisa e il genero Luca Stramaccioni , decisero di riaprire Nunziadêina, non più a Modena, ma nella vicina Nonantola, a pochi metri dalla celebre abbazia, negli storici spazi in passato adibiti a ostello per i pellegrini, e che poi divennero il ristorante Santa Maria fuori le Mura.

I piatti della Nunziadêina, nel modenese di Gianluca Montinaro
Si respira l’aria dell’elegante trattoria di paese in questa Nunziadêina “in versione 2.0”. I mobili d’antiquariato contadino. Le tovaglie candide e ben stirate. I bicchieri giusti. Il grande camino, ove vengono anche cotte le carni e le verdure... e su tutto i piatti che Rita trae dal ricettario della bisnonna, da sempre gelosamente custodito e trasmesso di generazione in generazione.

Mera archeologia gastronomica? No, perché con sensibilità
Rita e i suoi validi aiutanti, i giovani Fabio Brinati e Alessan -
Per preparare la pasta occorrono mezzo chilo di farina e quattro uova.
La farina e le uova vanno lavorate in modo che la consistenza dell’impasto sia soda. Tirare la sfoglia con il mattarello, ricavarne tante strisce sottili, quindi lasciarle asciugare. E la pasta è pronta. Per il sugo occorre scegliere un prosciutto di Parma non troppo stagionato, di 24 mesi, che abbia un sapore dolce e non sia eccessivamente magro. In una casseruola creare un fondo di cipolla e olio extravergine d’oliva. Aggiungere il prosciutto con un po’ di passata di pomodoro. Fare sobbollire pianissimo e pochissimo.

dra Kelly (questa ultima nata e cresciuta a San Francisco ma da anni ormai innamorata di questo scampolo d’Italia), apportano quei giusti mutamenti che rendono contemporanei i piatti di Nunziadêina, secondo una vincente linea di “tradizione attualizzata”.
L’uso dei condimenti e del sale, per esempio, è più parco e calibrato secondo le esigenze nutrizionali contemporanee.
Le cotture sono espresse.
E l’attenzione alla materia prima è massima. Su questo aspetto la cucina può poi contare sull’aiuto determinante di Luca, cannarese di origine e nonantolano di adozione, appassionato ricercatore, di stagione in stagione, dei migliori ingredienti e prodotti tanto locali quanto di origine foresta. Ricerca che raggiunge l’apice nel caso dell’aceto balsamico tradizionale, spillato dalle batterie di famiglia.
Questo “oro nero” arricchisce numerosi piatti: lo sformatino di zucca con pancetta croccante, i tortelloni di zucca, o ancora, passando ai dolci, il gelato alla crema mantecato al
Al termine, si può aggiungere una noce di burro per ammorbidire. Una volta cotte le taglioline, condirle con il sugo, ed eventualmente una spolverata di parmigiano reggiano. Il piatto è pronto.
Prendere del fegato di maiale freschissimo. Tagliarlo della dimensione di piccoli fagotti, quindi salare e pepare. Avvolgerli nella rete di maiale precedentemente ammollata senza lasciare parti del fegato scoperte.
Procedere alla cottura su brace viva a calore medio per circa 5 minuti avendo la cura di adagiare i fegatini su foglie di alloro. A rosolatura ultimata, servire i fegatini caldi accompagnati da cipolla di Cannara precedentemente stufata a fuoco lento.
Salare e pepare a piacere e guarnire, se piace, con aceto balsamico tradizionale di Modena DOP extravecchio.
momento, in quello che è universalmente uno degli abbinamenti più riusciti per questo nettare degli dei.
Ma la proposta non si ferma qui. Il palato dell’ospite può godere anche di uno gnocco fritto aereo e soffice come pochi, accompagnato dai ‘giusti’ salumi così come delle paste all’uovo, fra le quali la celebre tagliolina stretta, tirate alla perfezione e condite, per esempio, con ragù d’anatra e tartufo nero, con porcini o con ragù di prosciutto, approntato secondo la ricetta della fondatrice.

Tutti carnivori sono i secondi: i fegatini con alloro, pepe e cipolla di Cannara (un vero tuffo nel passato!); la faraona laccata in “camicia di pancetta” e l’immancabile cotoletta “della nonna Annunciata” , una versione della cotoletta alla petroniana ripassata con prosciutto di Parma e parmigiano reggiano.
Spetta sempre a Luca, smessi i panni del selezionatore, il compito di dirigere la sala: con travolgente passione si muove di tavolo in tavolo, raccontando i piatti, narrando degli ingredienti, consigliando i vini... Quest’ultimi giungono da una selezione che, seppur non amplissima, annovera un discreto numero di etichette, non solo italiane, con una ovvia prevalenza di rossi.
Ristorante La Nunziadêina Via Vittorio Veneto, 95 41015 Nonantola (MO) Tel. 059 541112
www.ristorantelanunziadeina.com
 Rina Mattioli, nipote di Nunziadêina, con il carrello dei suoi dolci.
Rina Mattioli, nipote di Nunziadêina, con il carrello dei suoi dolci.
Immagina di fargli festeggiare una Pasqua alternativa, con gli amici del cuore, in un locale che ha sempre solleticato la sua fantasia: il tuo. Le battute con i suoi amici, le loro risate… tutto intorno a lui sembra trasmettere allegria e voglia di stare insieme. Quasi contemporaneamente si fermano, si scambiano uno sguardo che ti fa capire che hanno scelto il locale giusto per stare bene. Il piatto che gustano è un’esplosione di sapore.
Sysco, la nostra migliore selezione di carni
100% USA grain fed.
Per i piatti che fanno sentire bene.

Andiamo un po’ indietro nel tempo, non di molto. Novembre 2021 nasceva Periferia Iodata , una rete di uomini legati profondamente al loro territorio, a quella Fiumicino, spesso vista come periferia romana, che nel mare (e non solo nell’aeroporto) ha la sua grande ricchezza. Una città satellite della capitale, che come tutte le periferie offre interessanti subculture, visioni differenti, tradizioni che arrivano dal basso o da angoli estremi, visioni e prodotti che trovano espressione nelle forme sperimentali. A tutti gli effetti la periferia è laboratorio e Periferia lodata lo è al 100%. Anche e soprattutto in cucina.
Lo statuto dell’associazione è molto chiaro e punta tutto sulla valorizzazione di un patrimonio storico, artistico, culturale e gastronomico immenso, lavorando sulla salvaguardia dell’ambiente che li rende unici, attraverso le proprie professionalità e investendo nella crescita della formazione. In questo modo il termine periferia si trasforma in un confine fluido che va oltre la geografia del territorio.
Periferia Iodata si sta, infatti, rivelando nel tempo una realtà sinergica capace di creare unità, una rete di persone e di intenti che mette insieme le diverse forme d’espressione senza diventare l’ennesima vetrina di sé stessi, ma con lo scopo univoco di riportare l’attenzione verso il locale, far crescere il tessuto sociale, culturale e produttivo del territorio - Fiumicino e la costa laziale - e portarlo ad essere uno dei valore aggiunti di Roma, spesso concentrata a guardare il suo ombelico, tralasciando la bellezza periferica.
Sono 15 attualmente gli chef e i produttori protagonisti di Periferia Iodata, tutti impegnati nella loro missione di salvaguardia e conservazione della cultura e del territorio stesso; promotori di sostenibilità, cucinano per sensibilizzare al rispetto del mare e dei suoi frutti.
Questi professionisti della gastronomia sono riusciti a mettere insieme visioni e stili differenti, guidati da un unico obiettivo che il Presidente Gianfranco Pascucci , di Pascucci al Porticciolo, stella Michelin sintetizza così: “Vogliamo lavorare sul territorio, unire le forze e fare laboratorio. Cucinare è la cosa che ci riesce meglio. Questo facciamo per Fiumicino”

E poi aggiunge: “Periferia Iodata nasce con l’intento primario di voler raccontare e promuovere un territorio, di valorizzare i prodotti della nostra terra, del nostro mare e dei nostri artigiani. Un progetto dal tratto inclusivo che intende accogliere tutti coloro che lavorano con standard di qualità alta, a prescindere dalla tipologia di ristorazione del singolo” .
E infatti Periferia Iodata in un anno di vita è cresciuta in tutte le direzioni e non solo numericamente.
Al suo interno la ristorazione è una delle forme “attive”, la forza di propulsione che ha dato il via a tutto, ma non esiste l’esclusività dei fornelli.
Da novembre 2022 sempre più produttori si sono legati a Periferia Iodata: ci sono i pizzaioli come Luca Pezzetta di Clementina e Sancho che hanno fatto
Gianfranco Pascucci
Socio fondatore
Ristorante Pascucci al Porticciolo
Lele Usai
Socio fondatore
Ristorante Il Tino e 4112
Marco Claroni
Socio fondatore
Ristorante l’Orologio di Fiumicino
Benny Gili
Socio fondatore
Ristorante La Baia di Fregene
PER FIUMICINO
Luca Pezzetta
Ristorante Clementina
Alessandro Capponi
Ristorante Host
Alessandro Pietrini
Ristorante La Marina
Franco Di Lelio
Pizzeria Sancho
Arcangelo Patrizi
Pasticceria Patrizi
PER FREGENE
Andrea Salce
Ristorante Il Riviera
Fabio Di Vilio
Ristorante La Scialuppa da Salvatore
Marco Fiorucci
Ristorante
Gina al Porto Romano
Marco Fedeli
Ristorante Angoletto
Dario Araneo
Ristorante Barman
Hepp
Maria Cristina Sebastiani
Ristorante Rosario
del loro prodotto un portabandiera della città di Fiumicino; c’è il pasticcere Arcangelo Patrizi con i suoi lievitati richiesti da ogni dove o il barman Dario Araneo che nei suoi cocktail ci mette addirittura il mare; c’è Ammano , azienda familiare a conduzione biologica che produce –come si intuisce dal nome - tutto a mano, formaggi e latticini e salumi da allevamenti propri.
Tutti nomi, quelli citati, di chef o professionisti di settore premiati e riconosciuti, che all’interno del gruppo non cercano una conferma di successo, ma lavorano senza etichetta alcuna in nome del territorio e della sua crescita. Nessuna star, tutti protagonisti di questo nuovo distretto gastronomico.
“La coesione attiva è una delle cose più belle che Periferia Iodata ha saputo produrre - ci racconta Fabrizio Monaco , giornalista associato tra gli ideatori del progetto che preferisce stare, però, dietro le quinte.
Oggi sono 15 gli associati e ognuno, sia singolarmente che in team, con il suo ruolo, la specificità professionale porta avanti progetti e attività su cui Periferia Iodata si sta concentrando. Progetti per noi importanti, che spaziano dalla formazione con l’ Istituto Alberghiero Paolo Baffi sia gastronomica sui prodotti tipici locali che dell’accoglienza per trasformare Fiumicino in una meta turistica di livello, ai progetti di sostenibilità ambientale o di riconoscimento delle denominazioni comunali. L’attenzione al territorio e ai suoi prodotti e luoghi sono ovviamente il comune denominatore”.
Un capitale umano associativo che si dichiara aperto e inclusivo a nuovi ingressi, ma assolutamente irremovibile sui valori che ne determinano l’appartenenza.
Sul sito ufficiale Periferia Iodata si definisce e si autonomina come “custode della tradizione, per accompagnarla nel futuro, custodi non gelosi di una bellezza che trova la sua strada ovunque” . Da qui la missione di far conoscere l’identità culinaria e territoriale di Fiumicino, rispettarla e farla arrivare con gusto in tutto il mondo grazie agli eventi, ai progetti differenti, all’azione del singolo. E il viaggio parte proprio da casa loro.
1 arzilla di circa kg. 1 • g. 500 di broccoli • g. 150 di spaghetti • 1 gambo di sedano •
1 cipolla • 1 spicchio d’aglio • prezzemolo q.b. •
4 pomodori • 1 carota • 3 acciughe • 1 bicchiere di vino bianco • olio evo q.b. • sale e pepe q.b.
In una pentola capiente, insieme alla razza lasciata intera e pulita dalle interiora, mettere una costa di sedano, il prezzemolo, la carota, l’aglio e il sale. Cuocere per circa 30 minuti. Scolare l’arzilla, pulirla dalla lisca e dalla cartilagine e tenerla da parte.
In una padella soffriggere la cipolla tritata con le acciughe; unire le cime dei broccoli lavate e, dopo averle fatte insaporire alcuni minuti, versare qualche mestolo di cottura del brodo di pesce. Quando le cime del broccolo saranno leggermente appassite sfumare con il vino bianco.

A questo punto aggiungere i pomodori tagliati e aggiustare di sale e pepe. Unire il brodo di pesce e ultimare la cottura. Calare gli spaghetti spezzati nella minestra e, quando mancano 3 minuti alla fine della cottura, aggiungere l’arzilla pulita. Servire caldo.
La regola interna, sottoscritta e rispettata da tutti, è la scelta e l’utilizzo costante del prodotto locale nelle loro creazioni.
Fiumicino con la sua Asta del Pesce rifornisce tutti quelli di Periferia Iodata che nei loro personali menù, come negli eventi collettivi, puntano a far conoscere a chi siede a tavola quella varietà di pesci di minor fama, ma di alta qualità.
Sarà, dunque, facile trovare a menù sgombro e alici, gallinella, palamita, lampuga, alalunga, ombrine e rombi, telline e lupini, che se usati in cucina in alternativa ai soliti pesci aiutano anche alla sopravvivenza dell’ecosistema marino.
Al prodotto, diventa fondamentale l’aggiunta della grande cultura marinara e di conservazione, prerogativa di questi chef, che si divertono a giocare con affumicature, frollature per ammorbidire e ingentilire le carni dei pesci più grandi, marinature raffinate, utilizzo di spezie e alghe che conferiscono aroma e sapidità ai piatti. Un percorso di alto livello dove il pesce, povero e locale, diventa principe e dove anche la pizza può acquisire nuova identità.
Lo abbiamo testato in una recente cena per festeggiare il primo anno di Periferia Iodata , durante la quale abbiamo potuto degustare assaggi di stagionati di mare come il prosciutto di pesce spada o la bresaola di tonno che ridisegnano il concetto di Antipasto all’italiana; arrosticini di lampuga, frollata 5 giorni, marinati e cotti alla brace; crostone di pane cafone arricchito di crema di zucca locale e ‘nduja di alalunga - due preparazioni articolate sorprendenti al palato per la loro semplicità.
Non manca poi la pizza a base di polveri di mare o alghe come la “marinalghe” o quella al padellino che diventa un’ottima base per il crudo di lampuga . E per chiudere in bellezza una porchetta di pesce spada , un tripudio di sapore che non teme rivalità con la porchetta originale.
Insomma da questo sintetico elenco è già possibile individuare prodotti e piatti da considerare veri manifesti della filosofia d i Periferia Iodata . Ma, quando si parla di valorizzazione di territorio, bisogna anche rimarcare il concetto che territorio non è solo mare: c’è un’ampia campagna
capace di regalare prodotti unici, che bisogna far conoscere anche al di fuori di questa periferia. Un esempio fra tutti il Pinolo di Fregene e le Mandorle di Maccarese , (produzione, questa, iniziata a fine estate 2022) due semi di grande qualità che si ritrovano nei piatti di molti chef del gruppo e nei dolci e panettoni di Patrizi. Lo stesso vale per la creazione delle carte dei vini, che strizzano l’occhio ai produttori dell’hinterland, delle birre artigianali o degli oli.
Divertente e interessante è anche l’abbinamento che si cerca di promuovere culturalmente con i cocktail, non semplici, né banali, bensì ricercati e studiati per un matrimonio perfetto con le sapidità, le affumicature, le consistenze dei vari prodotti, nati anche dal confronto e dalla commistione diretta tra barman e chef. Un esempio lo Spritz Iodato ideato da Dario Araneo con al suo interno una marmellata di gamberi, preparazione segreta scaturita dalla collaborazione con Fabio Di Vilio de La Scialuppa Da Salvatore.
Trovare, segnalare, selezionare e promuovere: questo il percorso in tappe che viene effettuato ogni giorno all’interno di Periferia Iodata, che intende diffondere un vero e proprio marchio di qualità , a garanzia del prodotto stesso. “L’intento è quello di sposare una linea di prodotti, magari in futuro crearne una, e trasformarli in un menù o in un piatto identitario e condiviso, manifesto tangibile dell’associazione e della sua missione” sottolinea Benny Gili, altro chef fondatore.
Il primo passo in questa direzione è stato il riconoscimento di otto nuove De.C.O ., Denominazioni Comunali di Origine, del litorale romano. Così, dopo il riconoscimento della Tellina di Passoscuro e del Cannolicchio , di qualche anno fa, la commissione (composta da ristoratori, esperti del territorio ed esponenti del commercio) ha esaminato le domande presentate e ha approvato l’iscrizione al registro del Risotto alla pescatora , della Minestra broccoli e arzilla , degli Spaghetti con le telline , della Pizza alla marinara con alici fresche (preparata secondo la ricetta della Pizzeria Sancho), della Birra agricola , del Pinolo di Fregene (sotto richiesta dell’azienda a lavorazione artigianale Pinus Pinea), della Caciotta Pa -
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
kg. 1,5 di telline • 1 spicchio d’aglio • peperoncino g. 400 di spaghetti • prezzemolo • olio evo
Far spurgare le telline per alcune ore, se non si ha a disposizione acqua di mare, metterle in una soluzione di acqua e sale in proporzione di 330-335 grammi per litro.
Cambiare l’acqua all’occorrenza. Stirare leggermente l’aglio in una padella piuttosto grande con peperoncino a piacimento. Aggiungere le telline e mezzo bicchiere d’acqua; far cuocere a fiamma sostenuta e coprire. Come si saranno aperte le telline, trarle su e tenerle in caldo.
Cuocere la pasta molto al dente in acqua leggermente salata e ripassarla nel brodo delle telline a fiamma viva. Aggiustare di sale, aggiungere del prezzemolo tritato finemente, un giro d’olio e le telline, impiattare aggiungendo una spolverata di prezzemolo.

Luca Pezzetta è tra gli ambasciatori del suo territorio attraverso lievitati di ogni genere, dalla pizza al padellino, alla contemporanea, fino alla pizza romana stesa al mattarello, di cui è maestro indiscusso. Impasti e cucina con Luca Pezzetta trovano un equilibrio importante: c’è fantasia, ma soprattutto ci sono tanta artigianalità, ricerca e tecnica.
“È stato Gianfranco Pascucci a propormi di entrare a far parte di Periferia Iodata: avevo appena aperto Clementina a Fiumicino. Il progetto e le iniziative dell’associazione rispecchiavano i miei ideali e, quindi, ho aderito subito. Clementina ha una sua identità, fortemente legata al territorio e Periferia Iodata promuove e valorizza il territorio: ecco perché viaggiano di pari passo. Quasi tutte le pizze di Clementina sono dedicate alla filosofia di Periferia Iodata, lavoriamo quotidianamente con l’Asta del Pesce di Fiumicino e con le barche, acquistando solo pesce locale, con cui produco anche i miei salumi di mare artigianali” .
IMPASTO
Impasto realizzato con lievito madre vivo e farina italiana: miscela ideata da Luca Pezzetta, macinata a pietra dal Mulino Angelica (Modica, RG).
TOPPING
Trippa, pancetta di maiale, crudo di mazzancolle, pecorino romano Dop, sedano arricciato e pomodoro migliarese.
PROCEDIMENTO
Sbianchire la trippa, rosolarla con sedano e carota, sfumare con una punta di vino bianco. Aggiungere acqua e stracuocerla, aggiungere anche un po’ di pomodoro. Eliminare una parte della trippa per friggerla.
Nel frattempo, condire la base della pizza con il pomodoro, la pancia di maiale fresca (lasciata leggermente stagionare in frigo con sale e pepe e tagliata finemente) e la trippa: infornare la pizza. In uscita, completare con mazzancolle, pecorino romano Dop, trippa fritta e sedano arricciato.

Perché un cocktail bar dovrebbe far parte di Periferia Iodata? Ce lo racconta direttamente Dario Araneo , bartender di professione con il suo Da.Heppi che ha deciso di sposare qualche mese fa la causa di Periferia Iodata come unica realtà beverage all’interno del gruppo.
“Collaboro con Gianfranco Pascucci da diversi anni e “giocare” con il pairing meno consueto tra cocktail e cucina è qualcosa che ci lega e ci diverte. A mio avviso questo gioco di abbinamenti ha trovato una naturale conseguenza come attività di valorizzazione dei prodotti di territorio all’interno dell’associazione e per ovvi motivi. Il primo è che siamo una realtà di Fiumicino e ci siamo riconosciuti subito negli intenti e negli obiettivi di creare qualcosa di unico per
dare maggior valore al nostro territorio; il secondo è che ci siamo trovati, io e la mia socia Helena, catapultati in un ambiente e in un gruppo super stimolante, lavorando a fianco dei big della ristorazione che sono riusciti a creare un gruppo unito, in cui si può fare molto e anche divertirsi.
Prova ne sono i diversi eventi realizzati - tra cui l’ultimo per l’anniversario di Periferia Iodata - dove abbiamo potuto creare per i piatti ideati dagli chef una serie di cocktail ad hoc. Niente di casuale e improvvisato, ma tutto studiato in dettaglio come lo Spritz Iodato con marmellata di gamberi . E ci pare che sia un’ottima leva anche di crescita e di formazione per il pubblico”.
Anche la mixology è dunque protagonista di questo progetto e lo fa vei -

lidoro (dall’azienda Salvucci di Palidoro) e pure della Sagra della Tellina di Passoscuro .
“Un lavoro di rilancio territoriale che le istituzioni hanno svolto in stretta collaborazione con Periferia Iodata – ci racconta sempre Fabrizio Monaco - sono gli chef dell’associazione che hanno codificato le ricette dei piatti inseriti nel registro De.C.O.”.
Ma la periferia deve essere anche sostenibile e l’approccio che hanno voluto fin dall’inizio i fondatori è stato proprio quello del rispetto concreto del territorio. Non c’è sostenibilità senza rispetto. E senza tutela del mare e dell’ambiente sarebbe anche inutile parlare di qualità ed eccellenze in ambito gastronomico. Netta e tagliente, senza troppi giri di parole, la visione degli chef. La tutela dell’ambiente si pone come tema centrale negli obiettivi di Periferia Iodata e tanti sono i progetti in essere e quelli a cui si sta studiando. Tra i nuovi goal portati avanti dal gruppo c’è quello dell’ eliminazione della plastica che arriva con le barche, come ci racconta Lele Usai , vicepresidente di Periferia Iodata: “Tutti i pescherecci che ritornano dalla pesca portano con sé tanta plastica che viene tirata su con le reti, obiettivo è che venga raccolta e riciclata in modo corretto, senza rischio che torni di nuovo in mare. Grazie al Comune di Fiumicino è più di un anno che abbiamo attivato un meccanismo di
colando gli stessi valori e prodotti in combo con la cucina: basta pensare a una serie di prodotti come le alghe e le erbe spontanee. Esempio fra tutti il cocktail l’Americano di Duna , forse da prendere come simbolo di Periferia Iodata.
Classico americano a base di bitter e vermouth che danno la parte amaricante. Ma con la particolarità di una soda aromatizzata con un mix di “erbe di dune”, che Araneo raccoglie tra le dune di Fiumicino e Maccarese. Si tratta di un mix di salvia, rosmarino, mirto, finocchietto selvatico e finocchio di mare che vengono messe in infusione e poi carbonate in un sifone, andando così ad arricchire la soda che nel cocktail crea una stratificazione di sapori interessanti.
smaltimento di questi rifiuti. Così come abbiamo sollevato il tema dei rifiuti trasportati dal Tevere, problema da affrontare e risolvere una volta per tutte e stiamo puntando e facendo ricerca per far abbandonare il polistirolo con cui il pesce viene trasportato in favore di contenitori in plastica durevole . Un’iniziativa nella quale vogliamo coinvolgere l’Asta del Pesce e le cooperative della pesca locale. Avere un pescato di Fiumicino senza più polistirolo, anche a bordo delle imbarcazioni, sarebbe un grande segnale di attenzione verso la sostenibilità ambientale, il mare e la sua biodiversità. Sono tutte piccole cose, ma che in realtà impattano notevolmente sul nostro ecosistema e sulla vita di tutti” .
Alla luce di tutto questo la periferia diventata così qualcosa che nutre le città, ha ripreso il suo territorio e ne trae spunti proattivi, perché è proprio nelle periferie che nascono e crescono le identità riconoscibili.
Periferia Iodata crea nuovi spazi, sempre più in espansione e interconnessi tra loro, generando una nuova geografia gastronomica, dove il cibo non è l’unico obiettivo, e innescando un’economia virtuosa, in nome di una crescita collettiva senza alcuna forma di sterile concorrenza.
Periferia Iodata A.P.S. www.periferiaiodata.it
LE DORATELLE

A Borgo Tressanti in Capitanata, nel cuore di quella Puglia, da sempre rinomato Granaio d’Italia, si estendono ettari di natura incontaminata dove pratichiamo l’Agricoltura Biofilica. Nei nostri campi si recupera una storia nobile di antiche tradizioni rurali.
Concept e foto: Sergio Supino Testi : Sonia Leo
Sfiziose delizie pugliesi di forma sferica, fatte a mano, leggere, fragranti, dal cuore soffice. Ottenute da una lenta lavorazione e fermentazione dell’impasto, con le Doratelle si percepisce e si assapora l’intenso gusto del nostro grano.
La leggenda narra che una donna, incantata dal suono delle zampogne, cominciò a seguire la musica in giro per la città, mentre il suo impasto continuava a lievitare. Al suo ritorno lo trovò gonfio, cresciuto e soffice, così decise di friggerlo in piccoli pezzi nell’olio. Il risultato fu sorprendente, vennero fuori delle pettole buonissime che riscossero un grande successo. Oggi come allora, seguendo l’antica ricetta dei nostri nonni che arricchirono l’impasto di altri segreti ingredienti, prepariamo sempre a mano le Doratelle.

Le Doratelle mantengono viva l’usanza delle nostre origini e, come spesso accade con i piatti più semplici, ad ogni assaggio sprigionano tutto il gusto della tradizione risvegliando i ricordi.
Nel cuore della Puglia, terra ricca di bellezze naturali, masserie, storia e tradizioni, noi di Spirito Contadino produciamo grano e verdure dell’orto a campo aperto dal carattere unico e autentico come il territorio in cui nascono. Coltiviamo questo antico cereale nei nostri

campi, nella pianura del Tavoliere, territorio particolarmente vocato all’agricoltura grazie al microclima che lo distingue: mite e temperato. Con la farina ottenuta dalla coltivazione naturale lavorata col sentimento e i segreti dei nostri nonni, prepariamo ancora a mano un leggero e fragrante impasto che dà vita alle nostre speciali Doratelle che, mangiate calde, esprimono nel profumo e nel loro sapore tutta la bontà del contrasto tra la consistenza soffice e la croccantezza dell’involucro esterno.

Le Doratelle oggi sono un simbolo della gastronomia d’Apulia: arricchite di ingredienti sfiziosi queste golose frittelle sono una vera istituzione delle feste pugliesi e delle regioni limitrofe. Grazie al sapore delicato, sono versatili e possono accompagnare un aperitivo, abbinate a creme salate, con le nostre verdure, formaggi e salumi. Interessante è l’interpretazione in chiave dolce: possono diventare sfiziose creazioni di piccola pasticceria. Il vantaggio per gli Chef è di avere un concentrato di bontà e tradizione da offrire ai propri ospiti in svariate forme gastronomiche. Richiedile al tuo distributore!



ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL SETTORE FOOD

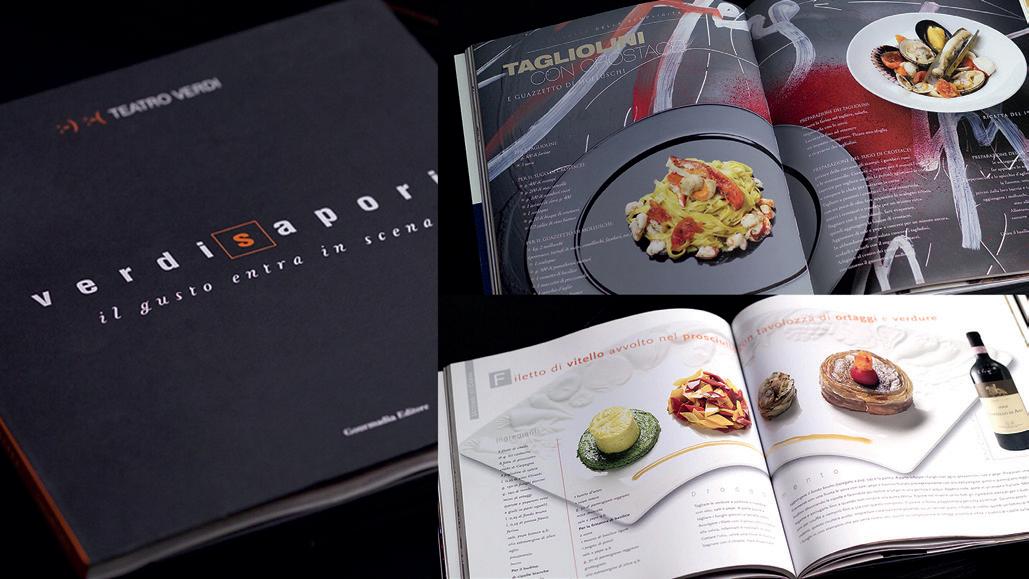
LIBRI E BROCHURE SULLA TUA ATTIVITÀ A PREZZO CONCORRENZIALE
L’elevata specializzazione ci consente di realizzare in toto (foto, grafica e stampa) pubblicazioni di alta qualità per il consolidamento della tua immagine
Still-life e immagini di grande suggestione con la supervisione di esperti food-stylist


La quasi quarantennale esperienza nel settore ci permette di fornire un servizio di estrema precisione con redemption certa
Un team in grado di risolvere qualsiasi problema di gestione dei Social, di Google Maps e di Tripadvisor, un lavoro mirato che in poco tempo produce grandi risultati

Organizzazione totale di manifestazioni per aziende, privati, enti pubblici, in Italia e all’estero
info e preventivi gratuiti
Tel. +39 0547 23821
www.lamadia.com - lamadia@lamadia.com


Sull’arco alpino nord-orientale, nella vallata di Sappada tra le case della Borgata Hoffe, il ristorante Laite si presenta chiuso a settentrione dalla piccola cappella intitolata a San Giovanni Bosco, avvolto in un paesaggio arioso, fatto di prati e boschi fitti di larici e abeti che sfumano nei mughi e nella vegetazione rada sulle quote più alte, fino ad arrivare alle rocce dolomitiche.

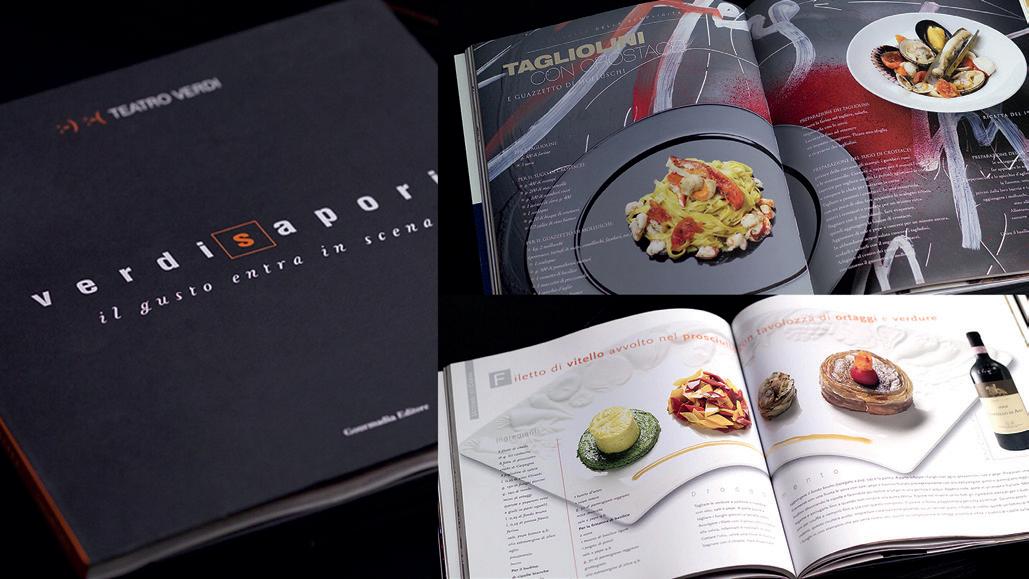
Si tratta di una tipica casa sappadina quasi interamente in legno, costruita secondo il sistema blockbau caratteristico dell’Europa centro-settentrionale, in base al quale le travi vengono sovrapposte e incastrate orizzontalmente per formare le pareti.
Al suo interno sono presenti due Stube - di cui una risalente al primo ottocento, l’altra addirittura a due secoli prima - nel classico rivestimento in legno e con eleganti soffitti a cassettoni. Vi si respira attenzione, cura dei particolari e un calore emanato non solo dal kòchouvn, l’imponente stufa in muratura che occupa una parte notevole dell’ambiente, ma soprattutto dall’accoglienza delle due padrone di casa, Fabrizia Elena Brovedani , impegnate in cucina l’una, in cantina e sala l’altra.


 di Paola Calvano
Foto di Ennio Calice
e Riccardo Di Luca
di Paola Calvano
Foto di Ennio Calice
e Riccardo Di Luca
Ristorante Laite
Borgata Hoffe, 10 33012 Sappada (UD)

Tel. 0435 469070
www.ristorantelaite.com
Le due si raccontano e si confrontano in questa intervista, sedute intorno a una tavola concepita affinché “gli ospiti possano sedersi comodamente per godersi un’esperienza gastronomica in assoluto agio.”
In entrambe è percepibile la necessità di condividere e di rendere partecipi i propri ospiti di quel sogno che prima era anche di Roberto [Brovedani], perché lui in realtà non è mai andato via, ma continua a vivere nei loro occhi che si illuminano nel ricordo.
Fabrizia ama profondamente un territorio che è imprescindibile e del quale lei dice: “È tutto, lo vivo sempre. Questo territorio, per me, è come l’aria”.
Ma è anche la sua principale fonte di ispirazione a cui attinge a piene mani per rendere concreta la sua idea di “cucina di montagna”, fatta delle erbe, dei fiori, dei profumi che la circondano e a cui si è accostata con grande rispetto e riconoscenza, in un percorso intimo e creativo in continuo divenire.
Ma come nasce un nuovo piatto o la variazione di uno già presente in menù?
Non esistono schemi fissi per la creazione di un nuo -
vo piatto, dipende un po’ dall’impulso, dal periodo; mi collego molte volte a un ricordo d’infanzia, oppure a un assaggio accidentale, da cui partono poi le sperimentazioni. Mi piace molto giocare su gusti opposti, dosando le giuste quantità di un determinato ingrediente in relazione a quanto sia persistente o forte, calibrandone l’apporto a seconda dell’effetto che voglio ottenere. Ogni ingrediente è oggetto di studio.
C’è una base tecnica, sicuramente, ma poi quello che fa la differenza è l’istinto maturato con l’osservazione, l’assaggio e la sperimentazione. Sono quelli che io amo definire metodi arcaici
Cosa significa studiare l’ingrediente?
Vuol dire informarsi sui periodi di raccolta, di crescita, sulle caratteristiche del luogo in cui cresce: è tutto questo che determina quella che chiamo la forza di un determinato ingrediente.
Sta facendo riferimento allo studio delle erbe spontanee? Non a caso “laite” significa “prato al sole”...
Sì, ma anche ai pesci di acqua dolce, a un formaggio o a un latte come quello di capra, che a me piace molto, che non è detto che abbia un gusto forte, intenso, come si pensa, perché dipende ad esempio dall’alimentazione, dalla tenuta e dalla pulizia della stalla. Questo per dire che ogni prodotto è il frutto di un insieme di attenzioni nei confronti dell’animale o della pianta, affinché presenti o meno determinate caratteristiche: si pensi ad esempio al diverso sapore del latte delle vacche d’alpeggio nei vari periodi dell’anno.
Mi ha colpito molto l’utilizzo del cirmolo come ingrediente, soprattutto in abbinamento al cervo. Come nasce il suo utilizzo?
Avevo conosciuto un intagliatore del legno che era venuto a cena qui e si era portato addosso questo profumo, che non ho potuto non avvertire, perché apre il cuore. Così ho iniziato a informarmi. Ho trovato degli oli utilizzati soprattutto per profumare l’ambiente delle Spa, nei quali vengono utilizzati soprattutto la resina e i rami; a me interessava quell’aroma di cirmolo ma proveniente solo dal legno, escludendo la resina.
Così, con un’amica che si occupa di distillazioni, ho provato a distillare il legno di cirmolo che è particolarmente morbido e dolce, evitando però di utilizzare il legno tagliato con la motosega perché ne annulla l’odore. L’olio di cirmolo conferisce alla carne, e non solo, particolare dolcezza, perché non c’è resina. È un legno che esce dagli schemi. Io lavoro con altri legni come le pigne, il larice, l’abete rosso, il ginepro, ma lui è a sé...
Io dico sempre che bisogna guardare le cose che ci circondano e farlo con occhi curiosi e sempre nuovi , non bisogna snobbarle e lasciarle andare, ma dare loro la giusta attenzione, perché è sempre importante confrontarsi su materie prime o tecniche che non c’entrano con la nostra storia.
Lei dichiara di aver segnato la propria svolta stilistica dopo l’incontro con alcuni ristoranti famosi che non manca mai di citare.
Ha rubato qualcosa dalle cucine dei suoi locali preferiti, come il Roma di Cosetti a Tolmezzo, o il Dolada di Pieve d’Alpago?
Gianni [Cosetti] per noi [si riferisce a Roberto] è stato un faro: eravamo ragazzi ed è stato illuminante avere questo rapporto di stima e amicizia con lui, che era
Per la pasta
g. 420 circa di patate medie pasta gialla
• 2 tuorli • sale • olio • g. 200 di farina 00
Per la farcitura
g. 200 di formaggio spalmabile •
g. 50 di mascarpone • g. 150 di mocetta di camoscio • g. 60 di burro • g. 40 di parmigiano reggiano • 1 cucchiaio di semi di papavero
Bollire le patate in acqua leggermente salata in una pentola capace, scolarle e passarle a setaccio; una volta raffreddate impastarle con i tuorli, il sale e la farina, velocemente. Preparare la farcia: tritate la mocetta con il tritacarne e amalgamare accuratamente con i due formaggi. Stendere a mattarello l’impasto fino a ottenere una sfoglia sottile, fare attenzione a tenere ben infarinata la superficie del piano di lavoro in modo tale da evitare che si attacchi la pasta di patate.

Ritagliare dei dischi con l’apposito tagliapasta di circa 5 cm. Farcire ciascun dischetto con un po’ di impasto al camoscio; richiudere a mezza luna, sigillando il bordo dei ravioli con le punte di una forchetta incidendo leggermente.
Tuffare in acqua bollente leggermente salata; quando verranno a galla scolarli, disporli sui piatti condendo con un po’ di parmigiano grattugiato, semi di papavero e burro fuso ben caldo.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
g. 200 di merluzzo dissalato • 1 finocchio piccolo • g. 20 di crème fraîche • yogurt liofilizzato • pepe bianco selvatico • olio extra vergine di olive taggiasche • g. 100 di latte • 2 cucchiai di latte in polvere • mezzo albume • g. 2 di sale • ml. 100 di aceto di siero di latte • g. 15 di zucchero • g. 100 di latte scremato • burro • g. 50 di stravecchio Piave • 1 cipolla piccola • 1 carota piccola • ½ costa di sedano • ml. 300 di acqua
PREPARAZIONE
Tenere 1 cucchiaio scarso di aceto di siero di latte per condire il finocchio e, con il rimanente, ottenere una riduzione del 60% aggiustando con un po’ di zucchero e sale. Scaldare g. 100 di latte scremato a 80 °C per 5 minuti e lasciare intiepidire. Aggiungere lo zucchero, il sale e montare in planetaria fino a creare una meringa ben ferma; ricavare delle piccole meringhe, porle sopra una placca e asciugarle in forno a 90/100 °C per 2 ore.

Preparare un brodo con le verdure e la parte di scarto del finocchio, cuocere per 40 minuti, infine aggiungere il formaggio e le croste del Piave e lasciare in infusione per 8 minuti, dopodiché filtrare e tenere in caldo, aggiustando eventualmente di sale. Versare in una ciotola l’albume con il latte in polvere, mescolare adeguatamente. Ungere con un po’ di burro una padella antiaderente e formare con un pennello di silicone delle cialde di cm. 8 x 3, lasciando che si asciughino 2 minuti circa su ambo i lati. Versare il latte intero in una casseruola, portarlo a 85/90 °C e lasciarlo riposare un paio di minuti. Sollevare con molta cura la pelle ottenuta e porla ad asciugare in un luogo caldo. Pulire il pesce dalla pelle ed eventuali spine, tagliare a cubetti e condire con olio e pepe.
Disporre la tartare di merluzzo al centro del piatto, adagiare un po’ di finocchio tagliato finemente e condito con olio, aceto di siero e sale; aggiungere la pelle di latte, la cialda, la crème fraîche, lo yogurt, la riduzione di aceto e la meringa. Servire anche del brodo caldo in una piccola ciotola.
tornato da Roma e aveva scommesso la sua carriera a Tolmezzo, con tanto lavoro legato al territorio, il che per l’epoca era un concetto un po’ all’avanguardia.
Anche al Dolada, malgrado l’esperienza sia stata piccolissima perché eravamo sempre aperti e non c’era la possibilità di fare stage prolungati, Enzo [De Pra] è stato splendido: è uno dei pochi con la passione dentro.
Aveva questo dono dell’insegnare, ma non ti dava la ricetta, però c’erano in lui, fortissime, la cura e l’amore per la

materia prima da trasmettere.
Un’altra bella esperienza, sempre brevissima, ma assolutamente utile, è stata da Vissani, perché ha la capacità di unire ingredienti e ispirazioni diverse. Lui è come un contenitore dove si può inserire veramente di tutto perché da ogni cosa sa creare sempre nuove suggestioni.
A differenza mia che utilizzo ingredienti differenti, ma faccio in modo che ogni elemento che compare nel piatto sia avvertito in maniera distinta, lui, invece, sa utilizzare ingredienti di ogni tipo per ottenere un gusto sorprendente che in natura quasi non esiste. Lui punta sulla sintesi, non sulla scomposizione e differenziazione degli elementi.
Qual è il piatto che la rappresenta di più e quale quello che è rimasto nel corso di questi anni?
Tutti i piatti sono miei e quello che mi contraddistingue è la capacità di farli riconoscere come miei.
È bello poi sentirsi dire dai clienti: potrei avere gli occhi chiusi e, ricordando un tuo piatto, avere comunque la percezione di essere qui. Ho lavorato molto per costruire la mia identità, ciò che mi distingue e che mi fa restare nella memoria dei miei ospiti.
La stella Michelin è arrivata per caso o era un obiettivo raggiungerla?
No, è arrivata inaspettata, per nulla programmata, eravamo ragazzini quando è successo.
 Laite
Laite
C’è in programma la seconda stella?
No, cerchiamo di lavorare con impegno come sempre, valorizzando la casa e l’atmosfera, per il nostro piacere e per quello dei nostri ospiti, senza forzature.
Passando, invece, alla cantina, Elena, ho letto che la vostra vanta più di 2.000 etichette. Come avviene la scelta e l’assortimento?
La maggior parte del lavoro è stato fatto da mio padre nel corso degli anni, soprattutto sui vini cosiddetti “importanti”.
Quello che stiamo facendo adesso è un discorso relativo all’abbinamento, per esaltare i piatti creati da Fabrizia; diciamo che l’acquisto al momento è finalizzato a questo, poi, è chiaro che, se ci sono dei vini che, secondo me o Ovidio, che si occupa soprattutto della cantina, si prestano all’invecchiamento, li lasciamo in cantina.
Il discorso del vino è un po’ cambiato, perché prima si vendeva la bottiglia, oggi, invece, con questi percorsi gustativi, la gente si fa accompagnare, perché sennò si rischia di rovinare il piatto e il vino.
Qualcuno ha parlato di vostri “abbinamenti provocatori e azzeccati”. Quale può essere un abbinamento provocatorio?
I gusti sono un po’ più delicati rispetto a quelli di una volta. Molti nostri piatti, anche di selvaggina, si abbinano bene ai bianchi, che sono molto duttili, cioè ce la fanno a sostenere questi percorsi.
E se inizialmente le nostre proposte hanno lasciato perplesso qualche commensale, una volta provate, sono state apprezzate anche nell’azzardo.
Ogni stagione cambiamo le cantine che per la maggior parte conosciamo personalmente: sappiamo come lavorano e ci fidiamo. Noi cerchiamo di valorizzare le uve autoctone e in genere quelle italiane.
E mentre per alcuni piatti il vino è solo di accompagnamento perché cerca di non sovrastare il cibo, in altri casi, come nel nostro menù più lungo, il vino diventa un ingrediente che contribuisce a creare quell’equilibrio che Fabrizia ricerca, per esempio dando più sapidità o abbassando l’acidità, modificando così la percezione che si avrebbe se il vino non ci fosse.
Lei prima di tornare al Laite ha fatto una serie di esperienza diverse in varie realtà anche famose. Mi incuriosiva quella a La Torre del Saracino a Vico Equense, di Gennaro Esposito.
Sì, è stata l’ultima esperienza: fantastica! Avevo il desiderio di andare al Sud, per la ricchezza della materia prima, il clima.
Se assaggi un limone lì, ti domandi cosa hai mangiato fino a ora, perché nulla di quello che noi chiamavano limone ha quel sapore e quel profumo. Lo stesso dicasi per il pomodoro o altri prodotti.
Cosa si è portata a casa di quell’esperienza?
Soprattutto l’ospitalità del Sud, poi l’ordine e la pulizia: tutto deve essere perfetto, preciso.
E poi, il cuore del Sud! È chiaro, quello che va bene nelle varie strutture che ho frequentato, non è detto vada qui, ma ciò perché l’Italia è varia ed è giusto che sia così.
Non ha mai pensato che il suo futuro avrebbe potuto non essere qui?
Avevo in programma di viaggiare ancora e fare altre esperienze, ma poi gli avvenimenti mi hanno portata a fermarmi.
Ha pensato a un Laite2?
La nostra forza è la famiglia: chi viene qui sa che troverà lei e troverà me e a noi fa piacere. Aprire un nuovo locale significherebbe farlo gestire a terzi e non sarebbe il Laite, sarebbe altro.
Mise en place essenziale ed elegante. Ho dovuto lottare molto con mio padre perché fosse così. Prima la tavola era sì bella, ma molto addobbata, c’erano le candele, i sottopiatti...io, invece, volevo l’essenzialità in modo che l’ospite si possa concentrare sul piatto. E, secondo me, l’ordine, la mancanza di distrazioni favorisce il relax, che a tavola è fondamentale; un aiuto ce lo dà anche musica.
Tra le proposte degli aperitivi mi ha incuriosita l’Idrolato di fieno, quale ingrediente dell’HAI. Sì, anche questo è fatto per rimanere nel territorio, ha un buonissimo odore di fieno e, offerto in una location come la nostra, all’inizio del pasto, fa comprendere agli ospiti dove si trovano, anche per dare un’alternativa al vino.
g. 280 di controfiletto di cervo olio extravergine
Per la marinata
g. 400 di sale grosso • g. 300 di zucchero di canna • 4/5 bacche di ginepro • 6/7 grani di pepe bianco e nero • 1 foglia di alloro • 1/2 buccia di arancia grattugiata
Per il muschio
g. 40 di tuorlo
• g. 80 di albume •
Pulire la carne di cervo da eventuali filamenti, riporla in una ciotola abbastanza capace da contenere anche la marinata composta da sale, zucchero di canna, i grani di pepe e il ginepro schiacciati, la buccia di arancia e l’alloro sbriciolato, amalgamati accuratamente. Coprire bene la carne e riporre in frigorifero per 3 o 4 ore.
• g. 20 di zucchero
g. 40 di nocciole tostate
• g. 3 di tè verde • 2 gocce di olio essenziale di muschio di quercia
Per le foglie di radici
1 piccola patata a pasta gialla
• 1 patata viola • 1 patata dolce
arancione • 1 rapa rossa
• 1/2
sedano rapa • olio extravergine • sale
Per la vellutata di radici di prezzemolo
g. 100 di radici di prezzemolo
extravergine
• sale
bacche di crespino
• nocciole tostate
• olio
• acqua q.b.
•
• olio di nocciole
• saurnschotte
•
Preparare la vellutata di radici di prezzemolo: dopo averle pelate e lavate, tagliarle a rondelle e cuocerle in una pentola con un filo d’olio, un po’ di sale e coperte con acqua; quando risulteranno morbide, frullarle ottenendo una crema vellutata; se necessario aggiustare di sale e tenere da parte. Preparare il muschio: tostare le nocciole, frullarle con tutto il resto degli ingredienti per un minuto o poco più; passare al setaccio, versare in un sifone, caricare di gas e versare distribuendo un po’ di composto in 2 o 3 bicchieri di plastica monouso; cuocere per un minuto in microonde alla massima potenza. Lasciare raffreddare leggermente, poi estrarre il biscotto al vapore dai bicchieri.
paratamente; ricavare la forma di piccole foglie aiutandosi con un coltellino; adagiarle su fogli di silpat e spennellarle leggermente di olio extravergine e un pizzico di sale. Ricoprire con un altro foglio di silpat e infornare per 30 minuti a 130 °C circa: devono diventare leggermente dorate e croccanti. Staccarle delicatamente e tenerle da parte.
Trascorso il tempo stabilito, togliere la carne dalla marinata, risciacquare brevemente e tamponare con carta assorbente. Tagliare 4 o 5 fettine sottili per ciascun commensale, porle un po’ distanziate su un foglio di pellicola trasparente, bagnarle con un filo d’olio, ricoprirle con un altro foglio di pellicola e batterle energicamente con un batticarne fino ad appiattire lo spessore del cervo.
funghi chiodini sottolio
• qualche foglia di crescione
Preparare le foglie di radici: sbucciare, lavare e affettare sottilmente tutti gli ingredienti se -
Disporle sui piatti, distribuire le foglie di radici, i pezzetti di muschio, formare delle piccole quenelle di saurnschotte, le bacche di crespino, un filo d’olio di nocciole, qualche nocciola tostata, qualche fungo sottolio, la vellutata di radici di prezzemolo qua e là, qualche fogliolina di crescione e servire.

I sapori di tre regioni si fondono con armonia nella cucina di Romano e Iside , titolari del ristorante La Parolina , unica stella Michelin nella Tuscia fin dal 2009, arroccato su una piccola collina del borgo di Trevinano nel comune di Acquapendente.
Il bellissimo scorcio panoramico che si gode quassù parla molto di Toscana, con l’Amiata in posizione dominante, eppure siamo nel Lazio e, allungando una mano, possiamo virtualmente toccare l’Umbria. Location baciata da questo incrocio geografico, dispone di una scelta infinita di prodotti.
Iside e Romano, lui di Forlì, lei di Roma, hanno sempre saputo gestire con creativa professionalità questa ricchezza gastronomica, vero grande valore aggiunto nella loro cucina. Dai funghi dell’Amiata ai tartufi delle Crete senesi, dai pesci del lago di Bolsena a quelli del vicino Tirreno, dalle nocciole dei monti Cimini fino ai salumi di Cinta, molte sono le tipicità che concorrono a definire una precisa identificazione di questa cucina. Provenienti entrambi da significative esperienze professionali, maturate a fianco di grandi nomi della cucina italiana, come Gianfranco Bolognesi della Frasca di Castrocaro Terme, Gianni d’Amato con il suo Rigoletto e poi l’Albereta di Marchesi, per Romano,

“La cucina è nutrimento e perciò fermento. La tavola andrebbe sempre vissuta come un inno alla vita”.
La Parolina
Via Giacomo Leopardi, 1
Trevinano (VT)
Tel. 0763 717130
www.laparolina.it
4 finocchi grandi
8 arance
g. 200 di aceto di arance
g. 200 di olive nere in salamoia
g. 200 di camomilla
anice
chiodi di garofano
pepe in grani
g. 20 di zucchero
sale e pepe q.b.
Preparare un infuso con 2 litri di acqua, la camomilla e le spezie, far bollire, aggiungere i finocchi tagliati in 4 parti e cuocere fino a far ridurre il liquido.

Intanto mettere sul fuoco il succo delle arance con l’aceto, lo zucchero, il sale e il pepe.
Denocciolare le olive ed essiccarle, quindi tritarle grossolanamente.
Asciugare i finocchi, rosolarli e glassarli con la salsa di arance, quindi terminare con la polvere di olive.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
1 zucca mantovana
1 cipolla dorata
g. 30 di zucchero
cucchiai di aceto di vino q.b.
uvetta
pinoli tostati
olio d’oliva
aceto balsamico
sale e pepe
Tagliare la zucca a metà e privarla dei semi. Mettere metà zucca coperta in forno a 180 °C, una volta cotta svuotarla, passarla in un tegame dove si sarà messo a scaldare olio e scalogno, aggiustare di sale e pepe quindi frullare.
In un altro tegame porre la cipolla e lo zucchero a caramellare; versarvi la restante zucca tagliata a brunoise e far cuocere per 10 minuti dopo aver sfumato con l’aceto, quindi aggiungere l’uvetta. Disporre in uno stampo prima la caponata, poi la crema di zucca spolverata di zucchero a velo e caramellare con una fiamma.
Terminare il piatto con un’emulsione di olio, aceto balsamico e pinoli.


INGREDIENTI
Per la pasta
kg. 1 di farina
g. 850 di tuorli acqua q.b.
Per il ripieno
g. 200 di carne maiale di Cinta senese
g. 200 di prosciutto di Cinta senese
g. 200 di mortadella
g. 200 di parmigiano reggiano noce moscata q.b. sale e pepe
Per le perle di brodo di cipolla dorata e spezie
g. 100 di brodo affumicato
g. 10 di colla di pesce brodo di alloro
Per il ripieno: cuocere la carne di maiale in padella, quindi tritarla insieme alla mortadella e al prosciutto, aggiungere il parmigiano, la noce moscata e aggiustare di sale e pepe.

Per la pasta: impastare tutti gli ingredienti, tirare la sfoglia e confezionare i cappelletti.
Per le perle di brodo: aggiungere la colla di pesce precedentemente ammollata al brodo insaporito con verdure affumicate, versare il composto in uno stampo e mettere in frigorifero a tirare. Per l’estratto di alloro: mettere in infusione 5 foglie di alloro in ml. 300 di fondo.
Cuocere i cappelletti in abbondante acqua salata e servirli in brodo caldo insieme alle perle di brodo affumicato e all’estratto di alloro.
INGREDIENTI
g. 700 di baccalà • 1 testa di aglio rosso di Proceno • 1 testa di aglio nero • g. 50 di latte di soia • olio di semi di girasole q.b. • g. 100 di pane • peperoncino in polvere • paprika • rosmarino • olio evo • sale e pepe
Per la polpa di pomodoro aglio • olio evo • uvetta • pinoli • sale
Per la pastella g. 100 di farina • g. 100 di amido di mais • g. 100 di amido di patate • g. 8 di baking powder • acqua q.b.
Per la salsa verde olio evo • prezzemolo • capperi • sale e pepe
PROCEDIMENTO
Frullare la mollica di pane (oppure sostituirla con del panko) e spadellarla con olio, peperoncino e paprika fino a renderla croccante. Mettere 2 pezzi di baccalà sottovuoto con olio evo, rosmarino e uno spicchio d’aglio quindi cuocerli nel forno a vapore per circa 7 minuti a 64 °C. Intanto marinare un terzo pezzo di baccalà con olio evo ed erbe. Preparare un’emulsione con il latte di soia e l’aglio nero setacciato e ridotto in purea e aggiungendo a filo l’olio, poi mettere in una sacca da pasticceria. Preparare la salsa di pomodoro facendo imbiondire l’aglio che poi verrà tolto, quindi aggiungere la polpa di pomodoro e alla fine uvetta e pinoli tostati. Preparare la salsa verde tritando prezzemolo e capperi, aggiungendo l’olio e aggiustando di sale e pepe. Preparare la pastella, immergervi uno dei due pezzi di baccalà cotti e friggere in olio ben caldo.

Comporre il piatto con un trancio di baccalà cotto al vapore e cosparso di pane alla paprika accompagnato dalla maionese di aglio nero. A parte porre il baccalà dorato appoggiato sulla salsa di pomodoro e infine il baccalà marinato in accompagnamento alla salsa verde.

Per la torta di mele
g. 250 di farina
g. 180 di uova
g. 150 di zucchero
g. 12 di lievito
Per il gelato di rosmarino
g. 300 di panna
g. 200 di latte
g. 90 di tuorli
g. 125 di zucchero
mentre nel curriculum di Iside ci sono Agata e Romeo di Roma, Le Colline Ciociare ad Acuto, la Pergola di Heinz Beck e poi l’approdo anche per lei alla Frasca dove incontra Romano e dove inizia la loro bellissima storia di coppia.
Con la forza dei loro sentimenti e del comune lavoro decidono di dare avvio ad un nuovo progetto di vita e di rilevare un ristorante già esistente sulle tranquille colline di Acquapendente: lo ristrutturano e gli conferiscono una nuova identità, aderente a ciò che vogliono trasmettere ai propri ospiti.
g. 125 di latte
g. 75 di olio evo
g. 300 di mele
1 ramoscello di rosmarino PROCEDIMENTO
Per la torta di mele: tagliare le mele a fette e condirle con g. 50 di zucchero e il rosmarino tritato. Intanto miscelare le uova con lo zucchero restante, aggiungere il latte, l’olio e da ultima la farina setacciata insieme al lievito.
Aggiungere le mele e cuocere in forno a 165 °C.
Per il gelato al rosmarino: mettere il rosmarino in infusione in latte e panna per 6 ore, quindi procedere come per fare una crema inglese e mantecare.
IMPIATTAMENTO
Comporre il piatto con una fetta di torta di mele precedentemente passata nel caramello, e il gelato di crema al rosmarino; decorare con lamponi freschi.
“La Stella Michelin arriva a riconoscere ufficialmente la validità del nostro percorso nel 2008, insieme ad un’altra bellissima stella, la nostra prima figlia. - raccontano sorridendo Iside e Romano - Un traguardo professionale bellissimo e un po’ inaspettato, a soli tre anni dal nostro esordio da chef titolari, un riconoscimento, affiancato a quello dei nostri clienti, che ha contribuito a dare soddisfazione e conforto al nostro impegno, confermandoci di essere sulla strada giusta nella nostra convinta ricerca del bello e del buono”. Dopo 7 anni, acquistato un terreno di fronte al primo locale, progettano da zero quello che dovrà diventare il ristorante da sempre desiderato, l’attuale sede definitiva; ed ecco qua: una cucina grande e funzionale, spazi interni ed esterni, con spettacolare vista panoramica.
Arredi sobri sono il dovuto omaggio al quadro naturale che si disegna, sconfinato, oltre le vetrate che danno sul versante dell’Amiata.
Un limitato numero di coperti, circa 30, disposti in spazi generosi, permettono un servizio snello e curato, mentre all’esterno due diverse zone
entrano in funzione nella buona stagione, anche se i coperti rimangono più o meno gli stessi. A disposizione degli ospiti due camere, dotate di ogni comfort, fanno diventare suggestiva locanda l’intero complesso, a cui si affianca un’altra struttura ricettiva, distaccata da questa, situata nella riserva del Monte Rufeno. Romano e Iside si destreggiano in un percorso caratterizzato da una profonda conoscenza del multiforme territorio e delle sue tradizioni col grande impegno di dare loro nuove vesti, lavorando quindi su varianti, consistenze, trame e con i virtuosismi gastronomici di chi ha testa e mestiere.
Interscambiabili grazie ai 22 anni di lavoro fatto insieme, si compensano l’una con l’altro.
“La creazione dei piatti rappresenta sempre un bellissimo confronto tra noi - racconta Iside – che ci porta a soluzioni condivise e a volte sofferte: entrambi sempre molto critici, cerchiamo il tratto che unisce i nostri punti di vista, consapevoli del valore di ciò che andiamo a proporre”.
Il risultato della loro esperienza e affiatamento si ritrova in un menù intrigante, che si adatta molto alle stagioni, con i sapori e i colori più adatti, un menù dotato di personalità, creativo, ricco di sapore, piacevole e divertente. Per noi il piatto signature, quello che lo distingue nettamente da proposte che potremmo trovare altrove, è stato il “brodo progressivo” dei cappelletti: un affascinante gioco di rimandi, cucchiaiata dopo cucchiaiata, dal delicato al sapido, dall’intenso

della carne, all’aromatico dell’alloro, in una incantevole reale progressione gustativa. Iside rapporta la genesi di questo piatto alla famosa scultura “Apollo e Dafne” per la quale il Bernini si ispirò alle “Metamorfosi” di Ovidio: “Questo piatto ha una doppia chiave di lettura; - spiega la chef - da un lato si evidenzia la mutazione dal tradizionale all’innovativo, dall’altro, in parallelo, tale processo di trasformazione viene rappresentato metaforicamente da Apollo che insegue Diana che, una volta raggiunta, si trasforma in alloro: dalla fase sensualmente carnale dell’inseguimento, si passa alla sublimazione dell’atto, compiuta mediante la progressiva trasformazione della dea in pianta. Ed è questo ciò che succede nella nostra preparazione”.
In sala, il servizio, affidato a giovani figure, è molto curato, ricco di piacevoli dettagli, e racconta il cibo interpretando con proprietà la passione e il grande lavoro che Romano e Iside stanno portando avanti da anni a livello di qualità agroalimentare. Notevole anche la parte enologica, a iniziare dalla ricerca di produzioni meritevoli, ancorché meno note, fino alla loro presentazione in carta, incredibilmente dettagliata, a cui fa seguito la spiegazione al tavolo della scelta delle etichette suggerite e del risultato che si riscontra nell’abbinamento dei vini con i rispettivi piatti. L’interazione tra cucina e sala qui è ammirevole pratica quotidiana. Ne consegue che la sosta alla Parolina è ricca di emozioni che parlano di territorio e raccontano storie profumate di buono.
di Sandro Romano
Foto di Giorgio Baroni e Aldo Ricci

Il breve tratto di costa pugliese che va dalla località di Savelletri a quella di Torre Canne, alcuni anni fa non offriva nulla a livello di servizi, ma “solo” un mare bello e incontaminato.
Lì - consuetudine in atto sin dagli anni 60/70 - in alcune case di pescatori si vendono ancora ricci di mare aperti su improvvisati vassoi ricavati dai sottovasi delle piante e serviti ai pugliesi in occasione delle loro prime uscite primaverili fuori porta.
Quei due borghi del litorale brindisino erano, in un tempo neanche tanto remoto, espressione di un turismo popolare fatto di case e villette in affitto, qualche ristorantino di pesce, alcuni bar e pizzerie: gustare ricci – come si usa dire nel dialetto locale - ‘ngànne a màre (vicino al mare), è dunque da sempre un piacere irrinunciabile. Poi, la svolta. Alla fine degli anni ‘90 si cominciano a comprendere le potenzialità di quel territorio e si investe sulla ristrutturazione di antiche masserie e casali, oltre che sulla realizzazione di lidi attrezzati con ogni tipo di servizio.
In questo contesto di crescita si inserisce anche Borgo Egnazia , resort di lusso costruito sullo stile delle antiche masserie pugliesi, inaugurato nel 2010 dalla famiglia Melpignano che ne è proprietaria. Numerosi, sin dall’apertura, i premi ricevuti da questa splendida struttura, ma importantissimo è stato, nel 2016, il riconoscimento di “Best hotel of the year” del network internazionale Luxury Travel, a cui ha fatto seguito, nel 2019, la stella Michelin al ristorante “Due Camini” .

Borgo Egnazia è, in realtà, un vero e proprio borgo, non nato da una ristrutturazione, ma costruito su un’area a breve distanza dal mare grazie al progetto dell’architetto, scenografo e designer fasanese Pino Brescia che ha puntato sul tufo, elemento naturale utilizzato in di ogni masseria di Puglia, per ricreare, appunto, una sorta di villaggio nel quale è presente ogni cosa si possa desiderare per una vacanza all’insegna del benessere e del relax. Tre i bar e sette i ristoranti, questi ultimi curati, dal 2016, dall’executive chef Domenico Schingaro , detto Domingo, che coordina le varie brigate formate complessivamente da 87 elementi, quasi tutti pugliesi. Il ristorante principale è il “Due Camini”, dotato di una cucina di oltre 350 mq., una raffinata sala con bianchissime volte a crociera, pavimento in pietra e colonne in tufo a cui si appoggiano antiche scale per la raccolta delle olive, oggetti antichi e di design, lampadari con lampadine a luce calda ben visibili tra le trame del legno grezzo utilizzato e, elemento centrale, due camini in pietra a creare un’atmosfera di grande suggestione.
Schingaro nasce nel 1980 nel quartiere più povero di Bari, il San Paolo o C.E.P. (Centro Edilizia Popolare). Suo padre Onofrio era pescatore e vendeva il pesce ‘Ndèrre a la lanze , una sorta di mercato dove i baresi si recano a fare colazione a base di frutti di mare, allievi e polpi, tutto rigorosamente crudo come da antica tradizione, e consumato direttamente sul posto. Domenico sin da piccolo impara a conoscere il mare e i suoi prodotti fino a voler ripercorrere le orme paterne:
farebbe volentieri il pescatore di professione ma è proprio suo padre, non volendo per lui una vita così dura fatta di sacrifici, a convincerlo a desistere.
Si iscrive così all’istituto alberghiero “Perotti” di Bari e lì ha la fortuna di avere tra i suoi docenti di cucina una vera istituzione della cucina pugliese, lo chef Mino Maggi , che è stato per Domingo un ispiratore, un vero maestro che lo ha aiutato a formarsi. In quel periodo collabora con altri professionisti di alto livello, in particolare con Antonio De Rosa e Corrado De Virgilio, facendosi le ossa prima di cominciare a fare esperienze in giro per il mondo, in particolare a Londra e a Bangkok.
Torna a Bari nel 2003 e lavora allo Sheraton Nikolaus Hotel con Raffaele De Giuseppe, poi importantissimi sono i dieci anni ad Alessandria, dove, nel 2014, incrocia lo chef Andrea Ribaldone. Quest’ultimo, dopo una breve stagione a Borgo Egnazia, propone Schingaroche nel frattempo era stato per sei mesi chef resident a Identità Expo - ad Aldo Melpignano , ritenendolo figura ideale per dirigere la complessa struttura ristorativa del prestigioso resort pugliese.
Nasce così quella che lo stesso “Domingo” definisce una sfida, in quanto effettivamente Melpignano si affida ad un cuoco di buona esperienza, ma che non aveva mai guidato un’organizzazione tanto complessa. Schingaro, non senza timore per il difficile compito che gli viene affidato, si mette in gioco. Dal 2016, quindi, si rimbocca le maniche e trasforma in un’organizzazione
pressoché perfetta il meccanismo operativo delle cucine dei vari ristoranti di Borgo Egnazia. Il resto è storia recente: nel 2019 arriva la meritata stella per il “Due Camini” che entra, così, nel gotha dei migliori ristoranti italiani, senza tuttavia adagiarsi sugli allori ma iniziando un percorso di crescita continuo.
Oltre all’elegante cucina di territorio, va rimarcata l’organizzazione della sala che riserva grande attenzione al cliente, ma con misurata discrezione.
Chi coordina tutte le attività di sala dei vari ristoranti è Giuseppe Cupertino , wine experience manager in Borgo Egnazia sin dall’apertura, e altra sfida vinta di Aldo Melpignano. Cupertino, all’epoca giovane maître di belle speranze, è ormai una delle punte di diamante nel panorama nazionale del servizio di sala.


L’attuale offerta ristorativa del Due Camini è composta da tre menù degustazione, denominati Foglie, Selva e Apulia , ispirati a tre diversi fili conduttori.
Foglie è composto da piatti esclusivamente vegetariani, un percorso tra i sapori e la biodiversità della terra pugliese, mentre Selva si sposta nei boschi, e si compone di piatti a base di cacciagione, bacche, radici ed erbe. Apulia è, invece, legato alla memoria dello chef e ai suoi ricordi d’infanzia, rivisitando la tradizione in chiave contemporanea. Solo a pranzo è possibile gustare i piatti del menù A Mano Libera , 5 portate che Schingaro realizza in base alla stagionalità e alla disponibilità delle materie prime.
Ovviamente la cantina del “Due Camini” è di assoluta eccellenza e conta oltre 1200 referenze selezionate personalmente da Giuseppe Cupertino, di cui circa la metà a rappresentare la Puglia e il resto suddiviso tra Italia, Francia e resto del Mondo, con rarità davvero memorabili e di grande pregio.

Abbiamo assaggiato piatti del menù Selva iniziando da uno snack di pasta di tarallo con capocollo di Martina Franca , un peperoncino ripieno di olive e uva , un babà di frisella con spuma di olio extravergine e bagnato con acqua di pomodoro, oltre ad un boccone a base di zucca e vermouth. In tavola ottima e semplice focaccia, e pane che arriva appena sfornato: non paninetti, bensì un bel pezzo di pane casereccio che Grazia , il maître che si occupa della cena, dopo aver inforcato dei candidi guanti, spezza direttamente al tavolo, ripetendo l’antico gesto conviviale delle famiglie contadine.
Insieme ad una fetta di manteca - il tradizionale formaggio pugliese nato anticamente come metodo di conservazione del burro - questa gestualità rappresenta un momento davvero speciale nel rito del servizio, peraltro curato anche da un dinamico staff di giovani capaci e molto attenti, formato anche da Nicole , Giusy , Tommaso ed Eleonora , quest’ultima preziosa nella scelta dei vini in abbinamento. Alcuni piatti vengono completati al tavolo, per suscitare curiosità e interesse da parte dell’ospite, in
INGREDIENTI
porcini • ciliegie fermentate • spuma di bufala • polvere di porcini • olio al fico
Per i porcini: mondare i porcini eliminando la base più terrosa, dopodiché spazzolare con un pennello morbido per togliere le parti di terra sulla superficie del fungo. Passare con un panno umido per terminare la pulizia grossolana. Con l’aiuto di un pelapatate pulire il gambo, e, se necessario, con un coltello regolarizzare la testa del fungo.
Per le ciliegie fermentate: lavare bene le ciliegie, e, per evitare di avere problemi in fermentazione, eliminare le ciliegie con difetti. Mettere le ciliegie all’interno di un recipiente di vetro con una soluzione di salamoia al 4% e tappare. Lasciare a temperatura controllata (18/20 °C) per almeno 40 giorni.
Per la spuma di bufala: tagliare a pezzi una burrata di bufala da g. 200 e riporla in un recipiente alto. Mettere a ridurre g. 200 di panna, con della scorza di lime in infusione (all’incirca 3 pezzi). Una volta ridotta la panna della metà, quindi aggiungere g. 100 di panna ridotta; ancora a caldo filtrare e unire con la burrata. Far riposare all’incirca per 10 minuti, poi frullare il tutto molto bene. Filtrare ancora una volta e mettere nel sifone con due cariche. Per l’olio di fico: estrarre l’olio di fico dalle foglie mettendo nella planetaria g. 125 di foglie e g. 250 di olio di semi di girasole, impostare la temperatura a 85 °C e frullare a velocità 6 per 10 minuti. Filtrare l’olio con un panno e raffreddarlo velocemente per preservare il colore.

Far scaldare bene una padella in ferro, aggiungere una nocetta di burro e le erbe (tipo salvia, rosmarino, verbena) e scottare bene i porcini fino a doratura, infine sfumare con del vino bianco Verdeca e salare. Servire circa 8 pezzi di porcino e 3 di ciliegie fermentate, con polvere di porcino, spuma di bufala e olio al fico.
batata • salsa di cime di rapa • cimette saltate • alici • aglio nero • laccage di alici

Per la batata: tagliare la batata a metà, condire con sale, olio e aglio intero a spicchi, chiudere in una stagnola e far cuocere sul barbecue senza fiamma viva per circa 20 minuti. Una volta cotta la batata, togliere la pelle cercando di tenerla intera, e farne una dadolata. Per le chips di pelle di batata: seccare la pelle di batata con la forma di un semi cilindro, e poi friggere a 160 °C.
Per la salsa di cima di rapa: pulire le rape e tenere da parte le cime piccole staccandole dalle parti più grossolane; fare un fondo di olio, aglio e acciuga con la padella molto calda, saltare le rape, sfumare con del vino rosso e aggiungere del ghiaccio. Raffreddare infine in placca con l’aiuto dell’azoto liquido e poi usare l’abbattitore. Una volta fredde, estrarre il liquido e legarlo a 0,2 di Xantana ogni g. 100 di liquido. Per le cimette saltate: saltare le cimette con olio ben caldo, mettere del ghiaccio e coprire per un minuto circa.
Per la laccage di alici: realizzare un fondo con alici grigliate, scalogno, salsa di soia, aceto, acqua e ghiaccio e passarlo allo chinois.
Disporre nel piatto la dadolata di batata dolce, condire con il laccage di alici, aggiungere le cimette saltate, l’aglio nero a fettine, le alici in conserva a losanghe, la salsa di rape di lato, e coprire con la chips.

ragù di colombaccio • ravioli di giardiniera • tartare di petto affumicata • tulsi in polvere (basilico sacro)
RAGÙ DI COLOMBACCIO
g. 180 di colombaccio • g. 30 di carota • g. 30 di cipolla rossa • g. 30 di porcini • g. 30 di pancetta (salume) • vino rosso • alloro • chiodi di garofano • 1 spicchio d’aglio • 1 bacca di ginepro
Tostare il colombaccio in padella, una volta dorato aggiungere i porcini, la cipolla, la carota e la pancetta. Continuare a cuocere, aggiungere alloro e bacche e sfumare col vino. Coprire con l’acqua e lasciare ridurre. Una volta ben cotto, togliere l’aglio e le bacche quindi passare prima la carne all’estrattore e poi tutti i vegetali. Far ridurre e se necessario legare con 0,2 di Xantana per g. 100 di estratto.
RAVIOLI GIARDINIERA
Per la pasta all’uovo
g. 700 di farina 00 • g. 300 di semola • g. 750 di tuorlo pastorizzato
Per il ripieno
g. 200 di giardiniera in conserva ben asciutta
g. 100 di patata lessa schiacciata
TARTARE DI PETTO
Una volta staccati i petti dai colombacci, passarli sul barbecue molto velocemente per sigillarli e dare una parte affumicata. Raffreddare subito, e tagliare a cubetti senza battere.
un’atmosfera di piacevole interazione che rende il tutto più divertente e meno formale. A seguire tre antipasti molto particolari: porcini, ciliegia e bufala , un bel contrasto tra l’acidità della stracciatella di bufala, la ciliegia trattata in salamoia, i porcini semplicemente spadellati e il condimento a base di olio aromatizzato con foglie di fico in infusione; poi lumache, tuorlo marinato e lattuga arrosto, un ragù di lumache monacelle, tuorlo d’uovo marinato con un miso di lenticchie, salsa di lattuga arrosto e la lattuga di mare fritta a dare un delicatissimo sentore salmastro al piatto. Nella batata, cime di rapa e acciughe, la patata dolce a cubetti con le acciughe, l’aglio fermentato, un laccage di acciughe e alcune cimette di rapa sbollentate, l’attenzione viene catturata dall’energico rimbalzo di sapori netti e decisi.
Tra i primi il raviolo di giardiniera e colombaccio, che gioca tra il sapido e l’aromatico e la castagna, nocciola, rafano e tartufo bianco, con brodo di bucce di castagne e terra di funghi. Sempre sul tema della cacciagione è lepre, topinambur e fico d’India , in cui la carne cotta in padella con il burro, ben si lega con il topinambur e la salsa di fico d’India, in un abbinamento simbiotico. Il predessert zucca, barbabietola e latticello insieme ad un the fermentato all’acino pugliese, pianta spontanea tipica della Murgia, apre al dessert macchia mediterranea, olivo, carrubo, liquirizia e tabacco, ingredienti che il pastry chef Tiziano Mita lavora singolarmente con l’effetto dolce non dolce.

Altro importante anello nella catena organizzativa del ristorante, questo abile pasticciere evidenzia doti di grande creatività e tecnica per dessert innovativi e mai banali. La chiusura è affidata alla piccola pasticceria che viene servita su un vassoio a forma di ramo le cui foglie contengono i preziosi bocconcini, accompagnati da un liquore di arancia amara.
I vini serviti in abbinamento da Eleonora sono stati il Chakra Verde di Giovanni Aiello, il Friulano di Bastianich, lo spagnolo Sospechoso e il Dolcetto d’Alba di Bosset. Inusuale il menù stampato su una carta grezza che contiene al suo interno dei semi, divertente cadeau da portare a casa e che, per rinnovare il ricordo di una bella cena, può essere piantato in un vaso per vedere spuntare dei colorati fiorellini di campo. Anche questo è un modo per evocare lo stretto contatto con l’ambiente e con la natura che Borgo Egnazia vuole trasmettere, in un riuscito connubio tra comfort, eleganza e il sapore antico della ruralità.
lumache del tipo “monacelle” • tuorlo marinato • brodo di lattuga • fondo di pollo • lattuga di mare fritta
Per le lumache: sciacquare bene le lumache dalla terra, poi metterle a cuocere in acqua, vino bianco, alloro e aglio per circa 2 ore. Dopodiché pulirle dal guscio e dall’intestino e conservare.
Per il tuorlo marinato: mettere a marinare i tuorli per circa un’ora, poi scolarli dalla marinata e passarli al setaccio. Far riposare almeno un’ora in frigo prima dell’utilizzo.
Per il brodo di lattuga: lavare bene la lattuga, condirla con abbondante sale e olio, grigliarla sul barbecue fino ad ottenere una bella doratura. Mettere sottovuoto con il doppio del peso in acqua (es. g. 100 di lattuga grigliata, g. 200 di acqua).
Per il fondo di pollo: tostare bene kg. 5 di ali di pollo in una casseruola, una volta dorate, aggiungere g. 500 di scalogni (sporchi) e far stufare per bene. Una volta ottenuta la giusta cottura aggiungere acqua e ghiaccio a copertura. A metà cottura aggiungere circa g. 80 di salsa shoyu di ceci e frumento.
Una volta ben ridotta, coprire con pellicola e far raffreddare per poi filtrare dalle ossa e dalle impurità. Far riposare una notte in frigo, il giorno dopo sgrassare e ridurre.
Per le lumache: in una padella calda aggiungere l’olio e tostare le lumache, una volta fatta la crosticina, sfumare con del Porto bianco, evaporato il Porto aggiungere rosmarino e salvia, dopodiché aggiungere burro e del brodo, fino a una glassatura delle lumache.
 di Carla Latini
di Carla Latini
Anni fa almeno una volta, ogni estate, andavo a trovare Marzia a La Costarella , a Numana. Apriva solo d’estate accanto a quella che era la falegnameria del fratello. Marzia ‘scendeva’ da Milano e cucinava con la grazia di una dea in un luogo che era la sua casa, a metà di un vicolo suggestivo da percorrere, in salita, a passi ampi e sostenuti.
Casette basse e colorate affittate ai vacanzieri, balconcini fioriti, ballatoi e bambini festosi, la porta sempre aperta ad accogliere, pochissimi tavoli e il profumo della sua cucina.

In questo luogo le cui pareti proteggono ricordi gastronomici indelebili adesso c’è Casa Rapisarda : fatale che quando un’energia positiva chiama, possa attirare l’inquilino giusto come una calamita.
Anche oggi la porta è sempre aperta e, nel vicolo, ‘la gente’ fa la fila e aspetta il suo turno per prendere posto e dare sfogo gaudente alla propria prenotazione.
Alessandro accoglie, sorride, saluta e lascia gli ospiti ai suoi collaboratori che li seguono con discrezione chiedendo, dopo ogni portata, se sono stati bene. Non se il cibo era buono, ma se sono stati bene.
Per Alessandro il suo territorio, il Monte Conero, Baia di Portonovo, in termini gastronomici, storici e descrittivi, equivale ai suoi mitici moscioli selvatici . Che con lui assumono un aspetto mutevole: diventano liquidi e salmastri per essere risucchiati in un unico sorso lasciando sul tavolo un luminoso guscio di cozza in vetro nero che vorresti, ammettilo cliente, portare a casa. Ma diventano anche ripieni con la tartare di fassona, pomodoro, limonella e basilico, dove la delicatezza della carne ben si accompagna con la sapidità del mosciolo e il profumo pungente della limonella.
Nella cucina di Rapisarda gli ortaggi e le verdure di stagione trovano una casa sicura e un modo di essere raccontate che le fa arrossire di compiacimento. Perché non è facile glorificare il tanto bistrattato cetriolo, far diventare regina la comune carota, rendere

omaggio ai cespugli selvaggi del Parco del Conero in un burro che vorresti non finisse mai e usare l’erba Luigia, o Limonella, o erba Cedrina con la leggerezza sensuale del ‘vedo non vedo’.
Durante la mia cena sono seduta accanto ad una mia carissima amica che abitualmente non mangia pesce, soprattutto crudo. Ho avvertito lo Chef che mi ha detto: “Ho capito, ci penso io.”
La capacità professionale di un cuoco si vede anche in questo. Arrivano in tavola piatti apparentemente uguali ma per la mia amica costruiti in base alle sue esigenze.
È come un lento svezzamento e alla fine del viaggio gastronomico abbiamo ‘svalicato’ insieme falsi miti e barriere costruite in anni di diffidenza. “Fidati di me” mi ha detto Alessandro. Fiducia molto ben risposta.

I menù di Rapisarda sono 3 (li trovate ben delineati su www.ristorantecasarapisarda.it) e potete scegliere in base al vostro stato d’animo del giorno.
Se siete in vena moderata andate sul ‘Classico’, se invece la vostra vena propende verso i crudi, ‘Purezza’ fa al caso vostro. Se avete voglia di sfidare i confini del palato, allora affidatevi a ‘Esagerare ma con equilibrio’. Un’azione che piace molto al nostro Chef, tanto che con questa massima decora la parete in fondo alla sala più grande.

Per la crema di cozze selvatiche kg. 2 di cozze selvatiche di Portonovo (presidio Slow Food)
Lavare le cozze e togliere la barbetta. Aprirle gentilmente a fuoco lento togliendola man mano che si aprono. Riempire il bicchiere del Bimby con la polpa di cozze e la loro acqua filtrata. Frullare alla massima velocità per 5 minuti a freddo. Conservare la crema ottenuta in un pentolino.
Per il burro acido (g. 350) g. 10 di cipolla bianca • g. 500 di vino bianco (Verdicchio) • g. 500 di burro d‘alpeggio) • g. 2 di pepe rosa
Far ridurre di tre quarti il vino, la cipolla tagliata a julienne e il pepe rosa; aggiungere il burro e frullare il tutto al Bimby. Montare con una frusta in un bagnomaria ghiacciato e conservare in fresco.
Per l’acqua di pomodoro kg. 5 di pomodori rossi
Passare i pomodori al Bimby alla massima velocità, a freddo. Colare il succo su una super bag o su un telo bianco per estrarre l’acqua.
Per la crema al nero di seppia
kg. 1 di patate gialle • g. 20 di nero di seppia
Cuocere le patate già pelate a vapore e frullarle nel Bimby aggiungendo acqua per conferire una consistenza vellutata.
Aggiungere il nero di seppia fino a raggiungere una colorazione nera intensa.
Per la crema di canocchie
kg. 2 di canocchie vive • g. 1 di sale • g. 2 di succo di limone Passare le canocchie al tritacarne. Passare l’impasto ottenuto attraverso uno chinois a maglie medie e poi in uno a maglie molto fini. Aggiustare di sale e acidità e mantenere in caldo.
Per la salsa di clorofilla g. 200 di bietola • g. 200 di prezzemolo • g. 200 di rucola • sale • g. 250 di ghiaccio • g. 100 di acqua panna • Xantana q.b. Sbianchire le erbe precedentemente lavate e sfogliate in acqua bollente. Raffreddare in acqua e ghiaccio e strizzare bene. Passare al Bimby le erbe cotte con ghiaccio e acqua e un pizzico di Xantana per ottenere una crema stabile.
Per la polvere di Sansho g. 5 di pepe Sansho japponese Polverizzare il pepe Sansho in un trita spezie.
Per la polvere di semi di Angelica g. 5 di semi di Angelica Polverizzare i semi di Angelica in un trita spezie.
Per il riso g. 200 di riso biodinamico • g. 150 di acqua di pomodoro • g. 200 di acqua panna • g. 20 di burro acido • g. 15 di parmigiano 36 mesi • g. 100 di olio evo (tenera ascolana) • succo di limone • sale
Mettere il riso in una pentola di rame e far partire la cottura senza tostarlo. Utilizzare acqua di pomodoro e acqua panna in parti uguali (a seconda dell’acidità del pomodoro). L’acqua di pomodoro potrà essere leggermente scaldata ma non fatta bollire troppo. A cottura ultimata ci sarà la mantecatura. Si aggiunge il burro acido, succo di limone, olio extra vergine di oliva e poco parmigiano. Si regola di sale e acidità.
Per la presentazione
g. 20 di polvere di pepe Sansho
g. 20 di polvere di semi di Angelica
g. 100 di crema di clorofilla legata g. 100 di crema di cozza

g. 100 di crema di canocchia

g. 100 di crema di nero di seppia erbe e fiori del momento
Mettere nella fondina un pizzico molto piccolo di pepe Sansho e uno altrettanto piccolo di polvere di semi di Angelica. Aggiungere la quantità di riso necessaria per la degustazione (50 grammi).
Dressare con le 4 salse partendo dalla crema di clorofilla, poi la cozza, la canocchia e il nero di seppia per ultimo. Terminare con le erbe e i fiori.
Cerco di percepire l’ambiente intorno dentro e fuori. Stasera ha piovuto e fa quasi un po’ freddo. Mi sento in un locale a San Sebastian quando ci portano Moscow Mule di gamberi dove grida vittoria un croccante cetriolo. Mi sento a Caiazzo, a casa di Franco Pepe, quando sbircio dalla finestra sul vicolo le persone, diligentemente, in fila.
Rapisarda tiene d’occhio con velocità cucina e sala. La sua brigata va spedita e la sala non perde un colpo muovendosi agilmente in un luogo molto piccolo.
Ed ecco in una tazza da consommé bianca e slanciata i cappelletti in brodo: sfoglia sottile verde di clorofilla di basilico, ripieno di parmigiana di melanzane. Il tutto tiepido, quasi freddo, da gustare con il cucchiaio.
Il risotto alla marinara , il piatto che vinse la selezione italiana del premio internazionale S. Pellegrino
Young Chef 2016, è, come si vede nella foto in alto a sinistra, ipnotico. Concentriche linee armoniose che non hanno un inizio né una fine. Rapisarda considera questa ricetta un punto di arrivo e anche di partenza.
Una dimostrazione di capacità di utilizzare tecniche professionali consolidate per raggiungere quello che, secondo lui, deve esprimere la ‘marinarità’ assoluta.
Il vostro cucchiaio inseguirà il sapore appena percepito ma non lo ritroverà subito, perché le linee guida nascondono ingredienti diversi, stratificati, paralleli. Io ricercavo il riccio di mare.
E l’ho trovato ben 3 volte.
Seguono pre dessert, dessert e piccola pasticceria. Si va in Sicilia, si riscopre il lychees e un cappero su panna cotta alle mandorle, indimenticabile.
E poi, fuori, c’è Numana che fa parte del Parco del Conero, bella in ogni stagione.
Ristorante Casa Rapisarda
Via IV Novembre, 35
60026 Numana (AN)


Tel. 071 9696138
www.ristorantecasarapisarda.it
Per il mosciolo ripieno
g. 500 di moscioli selvatici di Portonovo (Presidio Slow Food) • g. 200 di polpa di manzo piemontese razza
Fassona • succo di limone q.b. • sale e pepe q.b.
Per la coulis di pomodoro
g. 250 di pomodorini datterini maturi • 1 spicchio d’aglio • g. 50 di finocchio marino (Paccasasso) in conserva • olio evo q.b. • sale e pepe q.b. • origano secco q.b.
Per il mosciolo ripieno
Iniziare la preparazione aprendo i moscioli a vapore, privarli dello stoppino e conservare i gusci interi. Passare poi alla carne, tagliandola a cubetti molto piccoli (come per una tartare).
Tagliare la polpa dei moscioli in maniera grossolana e inserirla in una bowl assieme alla carne a cubetti. Condire successivamente il tutto con olio, sale, pepe e succo di limone. In seguito, regolare di sapore il composto ottenuto e farcire i gusci dei moscioli.
Per la coulis di pomodoro
Frullare i pomodorini e passarli al setaccio per eliminare bucce e semi al fine di ottenere una coulis da condire con olio, sale, pepe e origano secco. Successivamente, mettere uno spicchio d’aglio in infusione per due ore con lo scopo di far insaporire il tutto.

Legare i moscioli con lo spago realizzando una specie di fiocco. Impiattare il tutto mettendo sul fondo del piatto la coulis di pomodorini datterini, adagiare il mosciolo legato e terminare il lavoro arricchendo con del finocchio marino in conserva.
A PAESTUM
Casa Coloni a Paestum è il ristorante di Tenuta Duca Marigliano , il boutique hotel nato dal recupero di una residenza nobiliare di caccia del XIX secolo, a pochi passi dal sito archeologico dell’antica Poseidonia: un’oasi di bellezza e silenzio, circondata da prati e giardini, alberi di agrumi, querce centenarie ed essenze mediterranee. La struttura è oggi un piccolo albergo di charme di 19 camere e suite, distribuite tra la casa padronale e l’abitazione un tempo riservata ai coloni impegnati nei lavori agricoli. In una parte di questo edificio c’è anche il ristorante che, oltre ai 25 coperti della sala interna, dispone di un ampio patio con ulteriori 30 coperti, allestito durante la bella stagione. Pergolati e giardini, un’ area benessere intima e riservata, con sauna, bagno turco e mini pool Jacuzzi nascosta tra gli agrumi, completano la Tenuta.

La posizione, di fronte alla Porta Aurea - una delle quattro porte di accesso all’antica città greca di Poseidonia - fa di Tenuta Duca Marigliano un indirizzo privilegiato per conoscere ed esplorare il territorio e l’area archeologica con i maestosi templi di Hera, Nettuno ed Atena, Patrimonio Unesco dal 1998.
I lavori di ristrutturazione hanno preservato e valorizzato l’architettura storica della dimora padronale: gli intonaci rossi, i portali in pietra chiara, gli archi e le volte, lo stemma gentilizio dove si legge la data di fondazione, 1882. Linee essenziali, materiali contemporanei ed elementi di design connotano gli spazi interni che conservano i soffitti alti e le volte a botte: il fascino del luogo storico emerge qua e là in qualche frammento di pietra e di muro portato volutamente a nudo.


Guidato dallo chef Luigi Coppola , originario di Capaccio-Paestum, classe 1984, Casa Coloni è un laboratorio permanente di cucina mediterranea: tra memoria e innovazione, lo chef conduce una costante ricerca sugli ingredienti, sulle ricette della tradizione cilentana e sulle tecniche di preparazione, a cominciare dal pane. Questo, cotto nel forno a legna e realizzato con farina di ghiande, secondo un’antica usanza contadina, è il prezioso benvenuto dello chef: arriva in tavola avvolto nella sua carta, con un filo di spago, ancora caldo e profumato di buono. Un segno semplice, inequivocabile, che racconta in pochi gesti la cultura locale e l’approccio dello chef.


“L’impasto nasce da un blend di farine di tipo 2 a cui aggiungo un 30% di farina di ghiande fatta da me direttamente con le ghiande raccolte dal nostro piccolo querceto”, racconta lo chef. Il burro – rigorosamente da latte di bufala - che accompagna il pane è fatto come lo smen marocchino: fermentato, salato e aromatizzato.
 Foto di Aurora Scotto di Minico
Foto di Aurora Scotto di Minico
Casa
Foto di Aurora Scotto di Minico
Foto di Aurora Scotto di Minico
Casa
lt. 1 di brodo vegetale
g. 300 di riso Carnaroli
g. 100 di burro allo
scalogno
kg. 2 di zucca invecchiata
g. 100 gamberi sgusciati
2 arance
1 limone
semi di zucca
mandorle pelate sale e olio evo q.b.
La cucina è una questione di chimica. Lo sa bene Luigi Coppola che utilizza tecniche di ossidazione controllata per creare interessanti giochi di sapori e consistenze: una fonte di calore costante e prolungata nel tempo, va a modificare l’aspetto visivo, gustativo e olfattivo del prodotto iniziale mantenendone però inalterate le qualità e le proprietà nutritive. “L’ossidazione controllata degli alimenti permette di avere un approccio diverso nei confronti delle materie prime e della stagionalità. In estate lavoro frutta e verdura all’apice della maturazione – albicocche, finocchi, pomodori, fragole, ciliegie - con lo scopo di riproporle anche a distanza di mesi in una veste del tutto diversa” afferma lo chef. “La lavorazione di ogni alimento richiede tempi molto lunghi – dai 10 ai 90 giorni – ma il risultato finale regala un gusto del tutto nuovo e inaspettato. Un prodotto pensato per essere conservato e gustato ben oltre il proprio naturale ciclo di vita”.
Per ossidare gli ingredienti dei suoi piatti lo chef di Casa Coloni utilizza un forno speciale che cuoce gli alimenti in maniera uniforme ad una temperatura costante mai inferiore a 60 °C.
La frutta e la verdura fresca vengono prima raccolte e lavate, poi chiuse ermeticamente in appositi contenitori sottovuoto ed infine sistemate in forno. L’assenza di ossigeno innesca subito il processo di ossidazione.
Tagliare grossolanamente la zucca e chiuderla in sottovuoto; cuocere in forno a 60 °C per 60 giorni.
Sbucciare gli agrumi, bollirne per 3 volte la buccia; nel frattempo ricavarne il succo e ridurlo della metà. Unire il succo alle bucce e frullarli. Tostare le mandorle e frullarle finché non diventano cremose.
Cuocere il risotto nel metodo classico e mantecarlo con il burro allo scalogno. Impiattarlo come da foto.
Col passare dei giorni, in alcuni casi di mesi, il colore degli alimenti diventa sempre più scuro, tendente al nero, mentre le profumazioni cambiano acquisendo note nuove e intense: le albicocche ad esempio presentano uno spiccato sapore di caramello, il finocchio un fresco retrogusto di liquirizia mentre il pomodoro note calde di tabacco.
Consultando il menù di Casa Coloni è possibile imbattersi ad esempio nella tartare di manzo in cui le radici ossidate di sedano, sedano rapa e finocchi sono cotte a basse temperature per 60 giorni; il sugo alla pizzaiola lasciato ossidare per ben 90 giorni diventa invece una sfoglia impalpabile che aggiunge al piatto una nota dal gusto deciso.
E per chi ama i sapori freschi c’è anche il risotto agli scampi rifinito con polvere di agrumi ossidati: “Limo -

RAVIOLI
Per la pasta all’uovo
g. 250 di farina
g. 150 di tuorli
Per il ripieno
g. 300 di polpa di pollo
g. 100 di polpa magra di maiale
g. 100 di polpa di manzo
sedano, carota, cipolla q.b. sale e olio evo


Rosolare sedano, carota e cipolla ed aggiungere le carni, far cuocere a fuoco basso per qualche ora. Una volta cotta la carne, tritarla finemente e tenerla da parte.
BRODO ALLA CACCIATORA
g. 300 di funghi misti
g. 50 di cipolla
1 spicchio d’aglio
g. 50 di salsa di soia
g. 20 di radice di zenzero
g. 20 di citronella
g. 10 di concentrato di pomodoro
Unire tutti gli ingredienti e far bollire per 90 minuti.
IMPIATTAMENTO
Data la forma voluta ai ravioli, cuocerli in acqua salata e metterli in un piatto fondo con solo un filo d’olio. Servirli con il brodo alla cacciatora direttamente al tavolo, aiutandosi con una teiera.
MAIALINO
kg. 1 di pancia di maiale
g. 10 di sale
g. 10 di zucchero
aglio, sedano, carote e cipolle q.b.
Marinare la carne con sale, zucchero e aromi per 12 ore. Chiudere in un sacchetto da cottura e cuocere a bassa temperatura per 9 ore.
SALSA DI PRUGNE
g. 300 di prugne
g. 10 di zucchero
g. 50 di aceto di mele
g. 20 di olio evo
Caramellare lo zucchero e sfumare con l’aceto, aggiungere le prugne, cuocere per 10 minuti, frullare e aggiungere l’olio. Aggiustare di sale.
FAKE ’NDUJA
g. 200 di macinato magro di maiale
g. 50 di grasso macinato di maiale
g. 50 di peperone dolce secco
g. 9 di sale
finocchietto q.b
Unire tutti gli ingredienti, chiudere in un budello e stagionare per almeno 30 giorni.
IMPIATTAMENTO
Rosolare in padella la pancetta di maiale. Sulla base del piatto disporre un cucchiaio di salsa di prugne. Completare il piatto con delle sfere di finta ’nduja e del fondo bruno di carne.
ne, lime e pompelmo vengono prima sbollentati in acqua salata al 20%, poi posti in forno per 10 giorni” racconta Luigi Coppola. “Una volta ossidati, gli agrumi vengono frullati fino a diventare una polvere sottile e aromatica che sposa bene il sapore del pesce fresco.”
kg. 1 di oca disossata
g. 100 di fondo bruno di volatili
g. 200 di carne magra di maiale
g. 100 di lardo stagionato
g. 200 di foie gras
g. 50 di tartufo nero
dl. 2 di Borgogna
sale q.b.
zucchero q.b.
mazzetto aromatico q.b.
scalogni q.b.
Marinare le carni con sale, zucchero, Borgogna e mazzetto aromatico per circa 12 ore; asciugarle e cuocerle in una casseruola ricoperte di olio. Trasferire la casseruola in forno alla temperatura di 130 °C per circa 2 ore e mezza.
Tagliare le carni grossolanamente, metterle in una terrina e pressare per circa una notte.
Tagliarle a fette e rosolarle in padella.
Servire con abbondante tartufo, pezzi di foie gras e fondo bruno.

I piatti di Casa Coloni sono un felice incontro di gusto ed estetica del piatto: celebrano con rigore e sobria eleganza lo straordinario giacimento gastronomico e le tradizioni secolari di questo lembo di terra che è ricco di storia e biodiversità, porta di accesso al Parco Nazionale del Cilento e culla della Dieta mediterranea. Il carciofo IGP di Paestum viene proposto nel piatto Tonno, carciofo e il suo fermento, una ricetta che recupera tutte le parti del carciofo: una parte viene cotta in argilla con erbe aromatiche e l’involucro viene poi rotto al tavolo; il gambo viene arrostito e da altre parti, generalmente scartate, viene ricavato un liquore che accompagna la degustazione del piatto. Oltre al menù a la carte, i percorsi proposti dallo chef Coppola sono tre: “Cis Alentum” di terra, “Da Paestum a... Paestum” di mare, e il percorso vegetariano “Le Foglie della Terra”.
Tra le proposte del menù primaverile, negli antipasti troviamo il Cannolo di patate tartara, gelato ai capperi e il Baccalà asparagi e arancia; tra i primi il Risotto borragine, limone nero, popcorn di scampi; tra i secondi l’ Oca come la royale di lepre, il Miso di mais e cavolfiore arrosto e la Nizzarda d’astice; dolce non dolce l’ Erborinato, cipolla, pompelmo
Il racconto dei piatti è affidato al maître Michele Mascolo che governa con competenza la sala insieme al giovane sommelier Danilo Manzo che guida gli ospiti nel pairing più adatto. La carta dei vini, in costante aggiornamento, annovera ad oggi poco più di 100 etichette, con un occhio di riguardo ai vini del Cilento e della Campania più in generale. Le bottiglie riposano nell’antico forno in pietra che un tempo serviva la Tenuta, anch’esso recuperato e oggi adibito a cantina e piccola sala degustazione.
Casa Coloni - Tenuta Duca Marigliano
Via Tavernelle, 86 - 84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel. +39 0828 721297
www.tenutaducamarigliano.it
PASTA FROLLA
g. 300 di farina debole
g. 175 di burro
g. 50 di zucchero a velo
g. 20 di glucosio
Impastare la pasta frolla e ricavarne delle tartellette. Cuocerle in forno a 170 °C per 12 minuti.
MADELEINE
2 uova intere
1 tuorlo
g. 70 di zucchero
g. 60 di farina
g. 2 di baking powder
g. 75 di burro
g. 2 di sale
Unire tutti gli ingredienti a parte il burro. Verrà unito successivamente dopo averlo reso nocciola. Lasciare l’impasto per una notte in frigo. Colare negli stampi e cuocere a 180 °C per 6/8 minuti.
CREMA AL BURRO
g. 250 di latte
g. 75 di zucchero
g. 30 di amido di mais
g. 75 di tuorli
g. 150 di burro
g. 75 di panna
vaniglia q.b.
Unire tutti gli ingredienti a parte il burro e portarli ad ebollizione. Aggiungere in seguito il burro morbido.
Raffreddare e mettere in una tasca da pasticceria.
GELATINA AL VERMUT
g. 150 di sciroppo TPT
g. 150 di Vermut bianco
g. 4 di agar agar
Portare ad ebollizione lo sciroppo con l’agar agar. Togliere dal
fuoco ed aggiungere il Vermut bianco. Colare in uno stampo e far rapprendere.
GELATO ALLA VANIGLIA
g. 300 di latte
g. 80 di panna
g. 10 di destrosio
g. 10 di zucchero invertito
g. 70 di saccarosio
g. 3 di neutro per gelati
1 bacca di vaniglia
Mettere tutti gli ingredienti in un mantecatore da gelato.
IMPIATTAMENTO
Farcire la tartelletta alternando la crema alla madeleine e completare in ultimo con cubetti di gelatina al Vermut.
Servire al centro di un piattino da portata e completare con gelato alla vaniglia e confettini colorati.



D’altronde, se volevamo vedere l’aurora boreale non avevamo alternative: ci rimaneva poco più di un mese per farlo, perché da marzo le ore di sole non sarebbero state più solo tre e il fenomeno avrebbe iniziato a svanire, salvo aspettare nuovamente settembre e rinviare il viaggio.
74 TravelFood

Così, a metà gennaio ci siamo imbarcati a Bologna e, dopo lo scalo a Francoforte, siamo arrivati a Evenes , da dove ci siamo spostati verso le isole Vesterålen sopra il Circolo Polare Artico, quindi, oltre latitudine 66° 33’ N.
Lungo il tragitto, a Risøyhamn, ad accoglierci un paesaggio da fiaba: un’esplosione di luce verde in un cielo di stelle e la neve, tanta tutta intorno, a rendere ancora più magica e surreale la scena, così da non sentire che la temperatura era scesa a -16°.

 Il cielo illuminato di verde a Risøyhamn.
Il cielo illuminato di verde a Risøyhamn.
Il secondo giorno abbiamo camminato in mezzo alle casette rosse sparse nella cittadina di Andenes avvolta in una ovattata, romantica e perenne aurora, grazie a un sole appena sopra l’orizzonte e che da lì non si sarebbe mosso, in grado però di tingere di rosa il ghiaccio e il mare.

Non sapevamo, però, che lo scenario che si sarebbe aperto, dopo la visita al centro “Whale2sea”, sarebbe stato completamente diverso: abbiamo preso il largo in un Mare del Nord con le onde nero pece, mosse da un vento così forte che ci costringeva a urlare per farci sentire e, mentre l’aria gelida e pulita ci penetrava nei polmoni, eravamo sospesi in attesa di uno spetta -

colo unico: ecco le balene nuotare, sbuffare, saltare, avvicinarsi incuriosite e poi scappare via.
Dopo un paio di ore su quel pezzo di ghiaccio a motore, stremati dal freddo, il faro rosso ci ha accolto nuovamente in porto.
Il terzo giorno è stato di trasferimento verso le Lofoten e di immersione nella cultura Sami; abbiamo dormito a Nappstreaumen in un “rorbu”, cioè una tipica casa di pescatori sulle palafitte di legno.
Dal quarto giorno la Natura si è manifestata in tutta la sua forza: le bufere di neve, il vento forte, le nubi basse e il ghiaccio non ci hanno più lasciati e, nonostante tutto, abbiamo continuato il nostro itinerario toccan -

do le località più famose delle Lofoten: Henningsvaer , la Venezia delle Lofoten, Eggum , Nusfjord , Reine , Svolvaer , Hammnot .


Seguendo la strada E10, a pochi km da Reine abbiamo trovato Hamnøy , uno dei più antichi villaggi dell’intero arcipelago, dove il rosso delle tipiche casette è stata l’unica variazione cromatica che ha risvegliato i nostri occhi, assuefatti al grigio costante.
Calato il sole, abbiamo ricevuto in regalo una incredibile notte, con filamenti verdi di una rara bellezza, che erano proprio lì per noi a indicarci la strada.

A Eggum la nostra anima era tutt’uno con il mare, il vento e le montagne innevate lungo la costa.
E così, senza neanche rendercene conto, ci siamo ritrovati seduti nuovamente in aereo, scettici - data la quantità di neve in pista - sulla possibilità di decollare e, invece, anche in quel caso i Norvegesi ci hanno insegnato che: “Non esiste il brutto tempo, ma solo un abbigliamento inadeguato!”
Si è concluso un viaggio che ci ha riconnesso con la natura e con noi stessi: la neve, la pioggia, ma anche le balene e per tre notti questa luce magica che ha danzato sui nostri nasi all’insù facendoci diventare parte di paesaggi unici e indimenticabili.
E se la felicità oggi fosse un’immagine, sarebbe quella di una casetta rossa isolata, in riva a un fiordo.
Il sole alle isole Vesterålen.
vino, bon vivant,

Facendo un breve excursus storico, il termine Chianti fu rinvenuto per la prima volta in una pergamena risalente al 790. Già nel basso Medioevo, sulla scia degli insegnamenti dei monaci, famiglie i cui nomi sarebbero rimasti celebri a lungo, come i Ricasoli e gli Antinori, dettero inizio alla propria produzione vinicola.
Da bevanda di lusso, appannaggio delle sole tavole nobili, il vino divenne presto una bevanda di consumo popolare. Sappiamo da documenti medievali che nel 1398 il Chianti era un vino bianco, noto per freschezza e vivacità. Nel 1400 fu ormai evidente la sua notorietà e di conseguenza si impose la necessità di tutelarlo proteggendone il nome e la qualità.
Nel 1716 il Granduca di Toscana Cosimo III decise di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti e stabilire sanzioni per il traffico clandestino e la contraffazione. Facendo un bel salto in avanti nella storia, nel 1924 nasce il Consorzio per la difesa del vino tipico del Chianti e della sua marca di origine. Il simbolo scelto per la sua rappresentazione è il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti. Nel 1932, per differenziare il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato nel 1716, viene aggiunto il suffisso “Classico”.
Il Chianti Classico ottiene la DOCG nel 1984.
Il Chianti Classico può essere prodotto con uve Sangiovese al 100%, oppure con una base minima di Sangiovese pari all’80%, per il restante vitigni esclusivamente a bacca nera: autoctoni come Colorino e Canaiolo nero o internazionali come Merlot e Cabernet Sauvignon.
Esistono tre tipologie di Chianti Classico , le quali
si differenziano tra loro per caratteristiche chimiche e organolettiche:
• Il Chianti Classico Annata deve essere invecchiato per almeno 11 mesi prima di uscire in commercio, e con una gradazione alcolica di almeno 12 gradi. Ha le caratteristiche di essere un vino di facile beva e con una struttura moderata, predisposto per un consumo immediato.
• Il Chianti Classico Riserva viene sottoposto ad almeno due anni di invecchiamento, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia prima di uscire sul mercato. Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia. Deve avere un titolo alcolometrico minimo di almeno 12.5%.
• Il Chianti Classico Gran Selezione : la denominazione Gran Selezione è stata introdotta nel gennaio 2013 nel disciplinare del Chianti Classico a seguito della decisione comune degli stessi produttori. È la prima volta che nella legislazione vitivinicola italiana viene introdotta una nuova tipologia di vino posta al vertice della piramide qualitativa. È prodotto da uve Sangiovese di esclusiva pertinenza aziendale, coltivate nei vigneti più vocati e con regole più stringenti. Oltre a prevedere caratteristiche chimiche ed organolettiche idonee a vini di elevata qualità, la Gran Selezione può essere introdotta in commercio solo dopo almeno 30 mesi di invecchiamento e un periodo di affinamento in bottiglia minimo di 3 mesi. Essa ha il merito di esaltare i diversi caratteri e le particolarità di un vasto territorio, che include 9 comuni in zone climaticamente e pedologicamente differenti.
La vera anteprima quest’anno è l’annata 2021 nel
a cura di alessandro rossi esperto di
fondatore del premio “dire fare sognare”
Chianti Classico. Al primo assaggio non un’annata di quelle da ricordare, ma che mostra una buona freschezza sia al naso che al palato. In questa fase i vini hanno poco corpo, ma credo che l’evoluzione li porterà a grandissimi miglioramenti.
Chianti Classico sicuramente più floreali e speziati che fruttati, il palato al momento un po’ rigido, ma un po’ di bottiglia non gli farà male: parliamo sempre di un’annata calda e secca.
La 2020 ha un passo differente, un sangiovese sicuramente più identitario. Un’annata che oggi, dopo un anno di bottiglia in più, ha trovato una sua espressività. Vini più eleganti, freschi, profumati che in precedenti millesimi. Credo che questa annata rispecchi un ottimo risultato anche sotto il profilo agronomico.
L’annata 2019 assaggiata alla Chianti Classico Collection 2023 dimostra – oggi ancora di più – quanto importante essa sia.

Millesimo già grande anche durante le anteprime dell’epoca, conferma oggi quanto di buono si sia detto. Un’annata in vigna caratterizzata da un’estate calda ma senza particolari picchi, dove le piogge primaverili hanno regalato una buona riserva idrica. Il settembre è stato asciutto e ventilato, insomma tutto lasciava intendere ogni bene.
Bicchieri alla mano, il tratto che più impressiona è la tensione; vino con poco alcol, sul bicchiere brillante, fresco e dall’ottimo corredo aromatico. Frutta e spezie in grande equilibrio.
Passeggiando per le vie di Torino, i palazzi storici e i tanti portici non cessano mai di ricordare all’ospite l’eredità del passato e i respiri del presente.
Un giro in centro, quattro passi nel quadrilatero romano bastano spesso a creare un giardino di emozioni tali da restare paralizzati da impulsi e desideri che talvolta si oppongono tra loro. L’ambiente è colmo di stimoli e dopo una giornata di lavoro è un piacere sedersi al tavolino di un caffè e godersi l’atmosfera..
È questa la cornice ideale per apprezzare le rotondità di un vero Vermouth di Torino .
Un tempo era la prassi, era l’ora del vermouth, poi la celebre bevanda, famosa in tutto il mondo, ha vissuto un periodo accompagnato dall’oblio, come una grande squadra di calcio che per alcuni anni si spegne e non riempie più la sua bacheca di trofei. Ma le vittorie dei grandi tendono a tornare a vivere, ed ecco anche il Vermouth, da qualche anno, sta riprendendo le sue performance occupando i vertici di classifica che gli competono. E pensare che alle sue spalle ci sono secoli di storia, per non parlare della conoscenza legata ai vini aromatici degli antichi romani già al tempo di Marco Gavio Apicio. Ne abbiamo una testimonianza scritta nel “De Re Conquinaria” in cui si trova traccia di un vino all’assenzio . L’assenzio, ingrediente principe del Vermouth. È la parola germanica “wermuota”, con la quale si identificava la pianta dell’assenzio e poi ripresa da altre lingue nord europee, a dare l’abbrivio al nome che oggi tutti conosciamo.
La storia del Vermouth di Torino è molto lunga, a partire dal lontano 1786 quando Antonio Benedetto Carpano ne mise a punto la formula.
Un vino aromatico, speziato, che si produce grazie all’uti -
lizzo di svariate botaniche: artemisia su tutte. Dal grande apprezzamento dei Savoia, che contribuirono a sviluppare in città una vera e propria aristocrazia di Vermuttieri, alle prime esportazioni in sud America e negli Stati Uniti. Dalla nascita di tante distillerie alle molteplici etichette propagandistiche: cartelloni, disegni, slogan che un tempo erano il magico mondo della “réclame”. Nomi come Martini, Cinzano, Gancia, Riccadonna, Cora. Dal Risorgimento italiano, con personaggi come Camillo Benso conte di Cavour, che amava berne un bicchierino prima dei pasti come stimolatore dell’appetito, fino al proibizionismo americano. E arriviamo ai giorni nostri, che hanno riacceso i riflettori sulla storica bevanda, e ai tanti produttori che lavorano per questo elisir del tempo ed icona Sabauda.
Del Vermouth di Torino ho scritto sul web e sulla carta stampata, ne ho parlato alla radio e alla televisione e di recente ne ho incontrato uno che ancora non conoscevo. Si chiama MU ed è il figlio dell’intraprendenza di un giovane nutrizionista, Andrea Balestrini
Andrea era seduto al tavolo di un noto locale di Alba mentre si gustava, guarda il destino, un Vermouth. In quel momento gli balenò nella testa il pensiero di provare a fare un Vermouth dal gusto personale. Quante volte nella vita capita che ci vengano delle idee, magari nei momenti più stravaganti della giornata, ma quasi sempre ci ridiamo sopra e passiamo oltre. Andrea ci ha creduto subito. E allora vino, la prima prova con del Moscato, erbe e spezie. Un esperimento; e se le cose si fossero fermate li,
avrebbe avuto dei regali per amici e parenti durante le feste natalizie. Ma l’esperimento non si fermò: anzi!
Andrea decise dunque di continuare a lavorarci e nel frattempo di trovare altre persone che credessero nel progetto. Entrano in scena Fabrizio Stecca , enologo, Paolo Masoero, appassionato e conoscitore di vini e la psicologa Emilia Masoero.
MU è un Vermouth rosso ottenuto dall’infusione di vini pregiati esclusivamente piemontesi, bianchi e rossi, con una miscela composta da 29 erbe e spezie accuratamente selezionate.

Realizzato seguendo la ricetta originale di Andrea Balestrini e frutto di un meticoloso e appassionato lavoro di ricerca e miscelazione , al fine di ottenere un armonioso equilibrio delle botaniche, ha un colore ambrato con riflessi aranciati; al naso presenta un profumo intenso e complesso, con note di cannella, arancio amaro e genziana.
Al palato risulta corposo, presenta un ingresso elegante e floreale, in cui le note del caramello si mescolano con quelle della cannella e della vaniglia. In uscita prevale invece la componente amara, data da sentori di china, rabarbaro e artemisia , che conferisce un retrogusto amaricante e persistente, piacevole e mai stucchevole.
I vini utilizzati sono per il 10% Barbera d’Asti e il 90% Cortese
E il nome MU? Nei libri storici del passato il nostro quartetto di passionari si è spesso imbattuto un due termini: Vermutte e Vermuttino. Un tempo era tipico sentire dire alla persone: “ci beviamo un Vermuttino al posto del caffè?”.
Quella sillaba MU sempre presente è stata lo stimolo per il nome finale. L’elegante etichetta è stampata su carta vegetale, mentre la dicitura Vermouth Rosso Superiore ci rammenta che stiamo parlando di un vino speziato che supera i 17 gradi. MU è ottimale come aperitivo, da gustare liscio con una fetta d’arancia o con una spruzzatina di scorza di limone; ideale in miscelazione per la preparazione di cocktail come il Negroni e l’Americano. Il suo caratteristico retrogusto amaricante lo rende di pregio a fine pasto, abbinato ad un fine cioccolato fondente o a una torta di nocciole del Piemonte.
CONTATTI:
Romano Lambri - Presidente Cell. 393.9815078
Mauro Marelli - Console della Stampa Cell. 392.3591439

www.cegourmet.eu - info@cegourmet.eu
La Madia srl
Sede legale e operativa: Via Pacchioni, 365 - 47521 Cesena (FC)


Tel. 0547 23821 - Fax 0547 25809
Internet: www.lamadia.com - E-mail: lamadia@lamadia.com
Direttore responsabile: Elsa Mazzolini
Direttore: Elsa Mazzolini
Caporedattore: Maria Chiara Zucchi
Impaginazione: Barbara Volpe
Stampa: Tipografia Luce - Osimo (AN)
Web e Social: Giorgia Zucchi
Sofia Sarpieri
Silvia Bianco, Lorenzo Braschi, Paola Calvano, Teresa Cremona, Gianni Di Lorenzo, Mario Federzoni, Giusy Ferraina, Lorenzo Ferrari, Luigi Filippi, Giulia Gavagnin, Lucy Gordan, Giuseppe Lo Russo, Antonietta Mazzeo, Alessandra Meldolesi, Claudio Mollo, Gianluca Montinaro, Gianluca Ricci, Alessandro Rossi, Fabrizio Salce, Roger Sesto, Flavia Tomaello, Primo Vercilli.
Fotografi: Claudio Mollo, Pasquale Spinelli
Illustratori: Valentino Menghi
PUBB LIC ITÀ
marketing@lamadia.com
Abbonamento Annuale Italia € 35,00 (6 numeri)
Abbonamento Annuale verso i Paesi CEE € 80,00 (6 numeri)
Abbonamento Annuale verso i Paesi extra CEE € 120,00 (6 numeri) Acquistabili solo sul sito www.lamadia.com
SERVIZIO ARRETRATI PER NON ABBONATI
1 copia + spese di spedizione 12 euro STAMPA
e La Madia Travelfood TM sono marchi registrati di proprietà

Questa nuova padella vanta un perfetto e universale accoppiamento induttivo con i fornelli a induzione, garantendo il funzionamento anche alla massima potenza. Ciò si traduce in una generazione del calore più rapida e uniforme rispetto alle esistenti tipologie di fondi per induzione.
Rivestimento antiaderente Shark Skin® Shark Skin® non-stick coating Alluminio Aluminium Acciaio Stainless steel


























