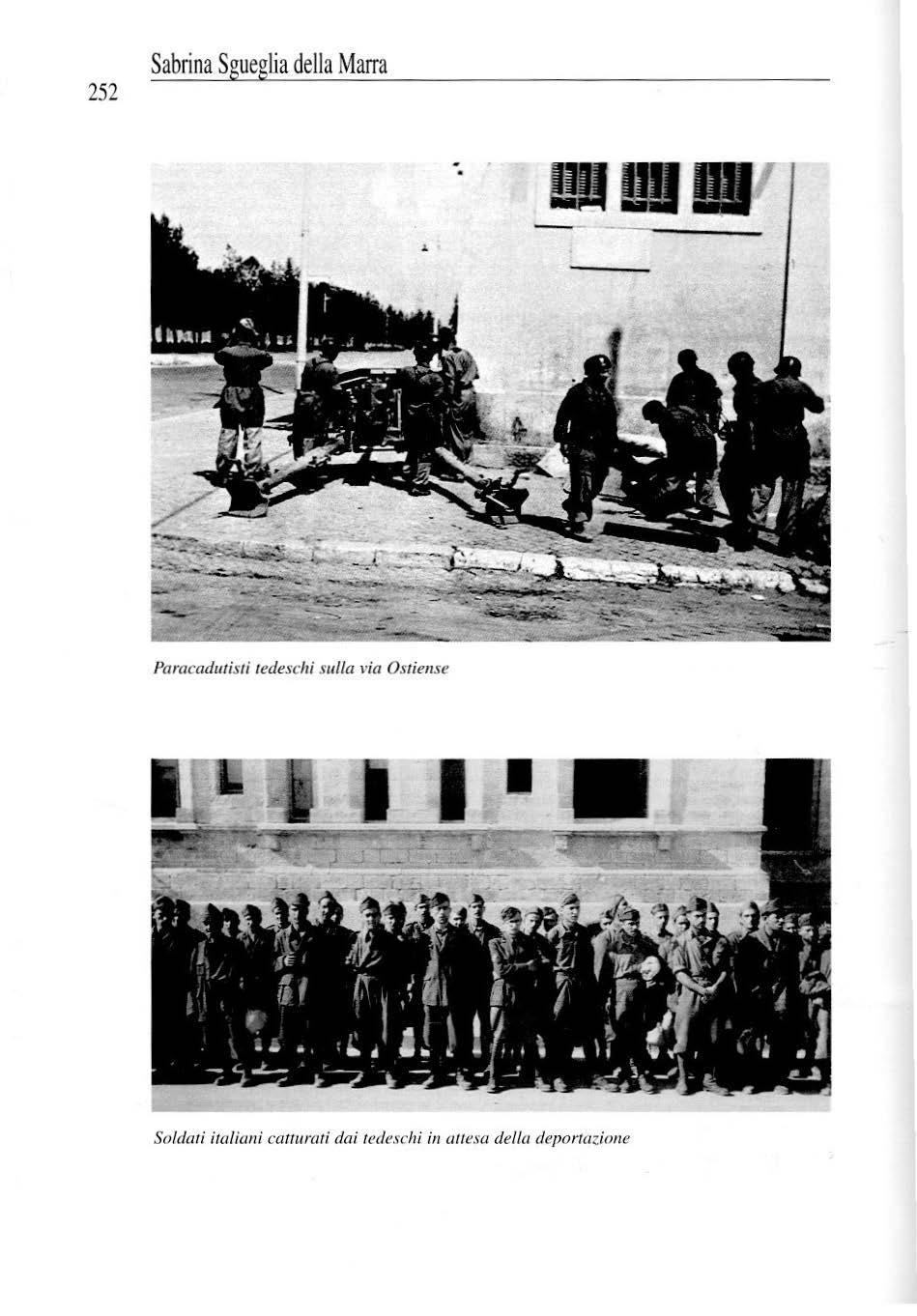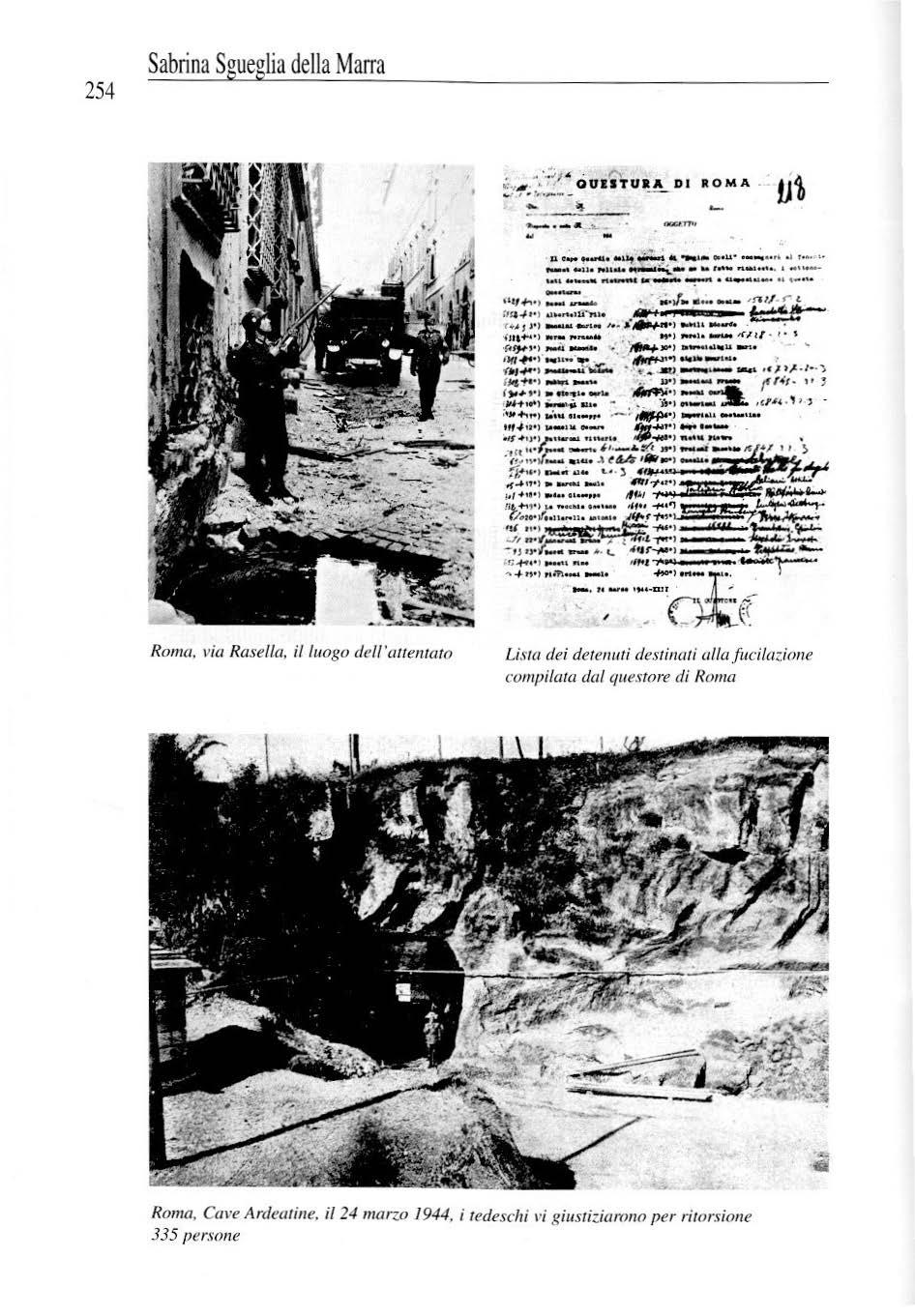settembre I 943, giorno della proclamazione ufficiale della Repubblica Sociale Italiana, Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, co lonne ll o dell ' Esercito , s i sottrasse al gi urame nto di fedeltà al regime di Salò e ri conobbe come unico governo legittimo quell o trasferitosi al Sud I n seguito alla resa , Montezemo lo non abbandonò la cap ita l e , pa r tec ip ò alla di fesa di Rom a e presiedette all'Ufficio Affari civil i nell ' ambito del Comando della città aperta. Det ermina to a combattere strenuamente per affra n ca r e il paese dall ' occ up a z i o ne s t ranie ra e d al fascismo repubblicano, realizzò un ' organizzazione mi litare clandestina che si co ll egò con Brindisi , col Comando S upr emo e con gl i Alleati, di c u i si accreditò come principale int er locutor e e referente della Re siste nza rom ana. 11 colonnello comprese rapidamente la necessità di unire tutte le forze e le ri so rse di sponi bili per offrire a l movimento patriottico qualche pos sibilità di riuscita e si fece promotore di una solida cooperazione tra il Fronte Militare Cland es tino ed il Comitato di Li b eraz i one Nazionale che a nda sse a l di l à di ogni prec l usione ideologica e accantonasse qualunque pregiudiziale politica, confidando nel pocere di coesi one eserci tato dall'obiettivo comune della libertà e del riscatto de ll ' Italia. Non ostan te le co ncezioni s trategic he differissero profondamente nelle modalità tattiche ed operative, nella diutumitas della lotta q uo t i diana du ra nt e i nove interminabili me s i di occ up az ione ge r manica , s i delineò una co ll aborazione assidua e fruttuosa tra militari e partigiani ricca di speranza, di affiato umano e di solidarietà.
TI FMC R inquadrò numerose bande annate che operarono all'interno del territorio urbano e nelle regioni attigue svolgendo attività e compiti svariati volti a contrastare il nemico , a sostenere lo sforzo bellico delle Nazioni Uni te e a preservare l'incolum ità della popolazione. Il Servizio I nformazioni , in particolare, ass urse ad un significativo gra d o di sviluppo. Di fondame nt a l e impo rt anza fu l ' apporto e l a collaborazi on e con le orga n izza z ion i clandes tine aJl es tite dalla Marina , dall 'Aeronautica, dai Regi Carabinieri e dalla G uardia di Finanza.

La v ic enda d e l F MCR , i c ui principali protagonist i trovarono la morte nell' ecc id io delle Fosse Ardeatine , è uno dei più fulgidi esempi del contribu to che l'Esercito Italiano ha dato alla Resistenza.
In copertina:
Giuseppe Cordero lanza di Montezemolo
D 23
STATO MAG GIORE DELL' ESERCITO UFFICIO S TOR1CO
SABRINA SGUEGLIA DELLA MARRA
MONTEZEMOLO

EIL FRONTE MILITARE CLANDESTINO
Roma 2008
Presentazione
I1 colonnello Giu se ppe Cordero Lanza di Montezemolo, dopo aver d.iretto l' Ufficio Affari C ivil i n e l Comando della "città aperta", il 23 settembre 1943 , giorno dell'insediamen t o formale del regime n eofascis ta a Salò, riconobbe come unico gove rn o leg itt imo quello del Sud e diede imm ediatamente avv io aJla formazione di u n centro operativo clandestino che s i collegò co n B rindis i , col Comando Supre mo e con gli All eati. Eg l i comprese che il movimento di Re sistenza avrebbe avuto q ualche probabilità di s uccesso solta nto se fosse riuscito ad a m algamarne le vari e co m ponen ti, a convogliare i singoli sforzi verso u n obiettivo comune e definito. Monteze m olo promosse, a tal p roposito, la cost itu zio ne di u n comitato permanente, emanazione della Giu nta militare del CLN. L'investitu ra ufficiale del Coma ndo S up re mo, t uttav ia, non fu s uffic ie nte ad eli minare d e l tutto attriti e d incomprensioni tra militari e partigiani: i primi obbedivano agli ordini che gi ungevano da Brindi s i , i partit i seguivano le direttive del CLN. Di fferivano anche nelle modal ità operative della g u erriglia. Montezemolo , fino a l giorno del suo arresto, rima se in contatto col Coma ndo S up remo . A partire dal 2 ottobre 1943, fino al 5 giugno 1944 , fu att ivo u n ponte radio co l governo del Sud attrav e rso due ap parati alternativamente in funzione in l uoghi div ersi d ella città. Nacq ue così il Centro X e tutto il personale e materiale di collegamento venne sottoposto agli o r din i de l tenen te co lonne llo Musco. I messaggi c he Montezemolo , q u otidianamente, fino al giorno del suo arres t o , fece pe rve njre al Comando S upremo, rip o rtavano in maniera precisa e tempestiva notizie s ulla cons iste nza delle for ze nemiche, su llo sc hieramento e i movimenti dei re parti , su ll'ubicazione di magazzini e depositi dì muruzioni, s ull e attività operative del nerruco. I dispacci toccavano altresì tutt i i prob lemi connessi alla lotta di liberazione: oltre a questioni d'ordine militare, i l colonnello si preoccu pava cos t an tem e nt e d el morale e del sostentamento dei patrioti e di tutta la popo lazione. Con una delle pri me comunicazioni , il l O ottobre, il Comando S upremo nominò M o ntezemolo suo di retto rappresenta nte in Ro ma e lo investì ciel compito cli orga ni zzare e dirigere la lotta di li be razione . Fu l' atto d i nasc it a del Fronte Militare C la ndestino di Roma che, nei s uoi nove mesi dì attività, riuscì ad orgaruzzare miglia ia di patrioti nella capitale e n elle regioni vic in e
li FMCR disponeva d i una capillare rete d ' informatorì presenti nelle varie regioni ciel territorio occupato. Tra i numerosi gruppi facen ti capo a l S IM ,
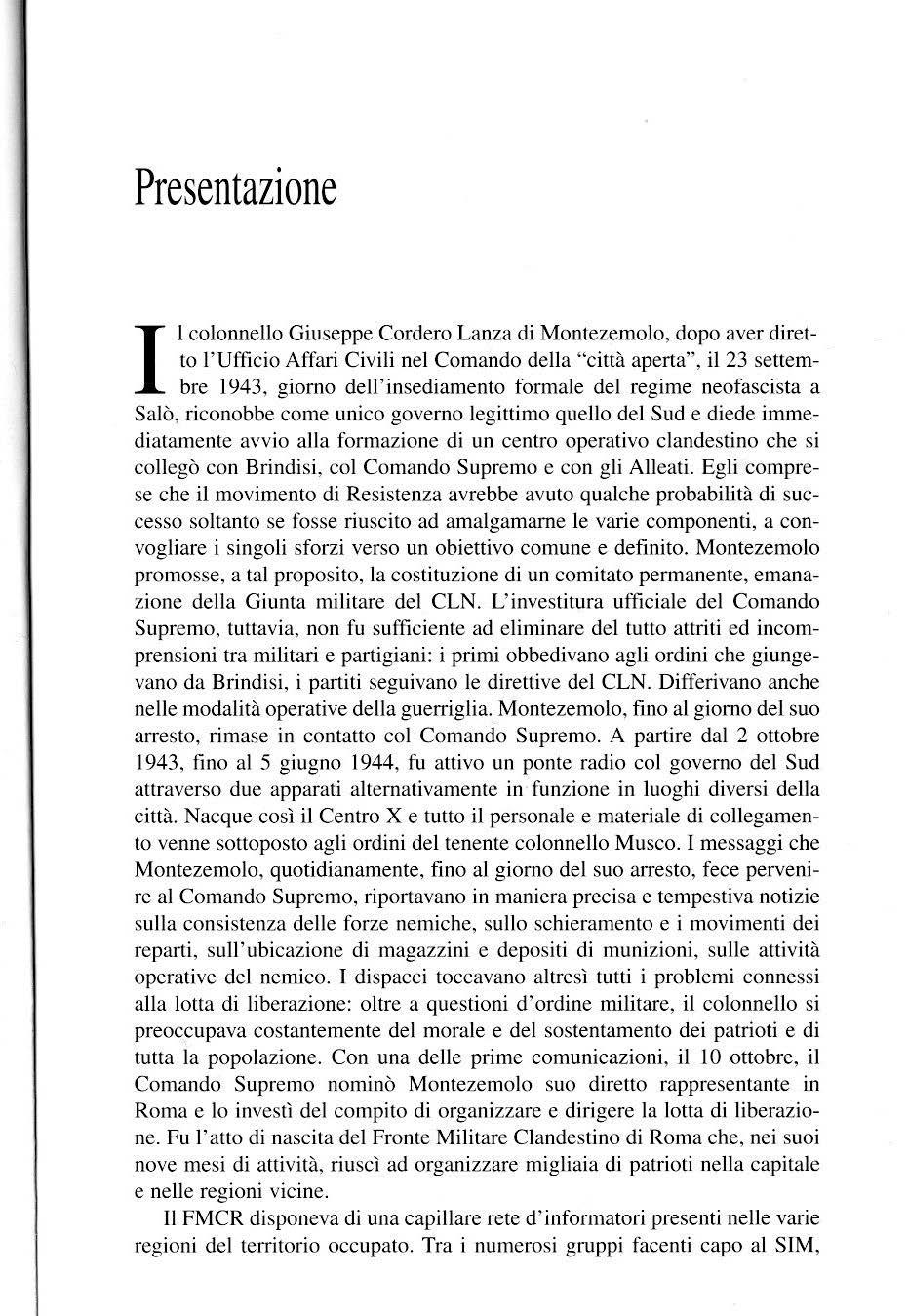 Sabrina Sgueglia della Marra
Sabrina Sgueglia della Marra
c he s i s e rvì dell ' Uffic io di Coll egam en to per agev o larne la cost itu z io ne e il fun z ion a me nto , il " Grup po Montezemolo " ri s ultò i l p iù effic iente e completo . Venn e in ol tre cos tituita un a speciale Se z ione Sta mpa ci e l FM C R adibita a ll a fabb r ic azi on e in ser ie e alla distri buzione di tesse re ann o nari e, docume nti p erso nali per s fu gg ire a ll e persec uz ioni nazifasciste , e alla stampa cland est ina di un bollett ino in fo rmati vo. i l co s iddetto " Bolle ttino Giallo".
Accanto a ll ' attiv it à info rm at iva , M o nte ze mo lo si a dope rò per riunire in un fr o nte uni co le tante formazio ni militari cl an d est in e costitu itesi s pont a neame nte dop o l 'a rmi s ti zio. Le bande de l Lazio e cie li ' Abruzzo ve n ner o affidate da M ontezemo lo a l co lon ne llo D e Mich e li s, gi à capo di Stato Magg iore de l Corp o d ' Armata di Rom a, e al ca pi tano Jannotta. De Mi c he li s e J an notta le inqu adra rono ne i raggrup pame nti: " M o nte S oratte", " Castel l i e L az io Sud", " Gran Sasso", " M onte Amiata". Le az ioni previs te pe r le bande d e ll' Ita li a centrale mir avan o a creare disordini ne ll e retro vie tedesc he sabota ndo i collegamen ti , ostaco land o l' affluenza dei ri forn im e nti , rall e nt a nd o lo spostam e nto de ll e ri se r ve. Le b and e interne e rano destinat e a ri un ire e lementi fe deli a lla cau sa nazional e in coraggia nd o li moralment e, soste ne nd ol i mater ialm ente, a ddestra ndo li pe r il g io rn o in c ui sarebbe sta to p os s ibile en trare apertamente in azion e al fianco d e ll e for ze lib e rat rici , ma a nc he per reagire a lle v io le nze perpet ra te in città da i tede sc hi. Tra le principal i band e intern e: la " F il ippi ", la " Fulvi", la " Pilotta", la " Gran a tieri di Sa rd egna", !' I. V.E. Ta lvo lta il FMCR in c ontrò r es i s te nze in a lcun e form az io ni che, per non rinunciare alla propria au to no mi a, no n a cco nse nt irono a fonders i co n esso, co me la " Berto ne", la " Sori ce" e la " Dodi " Alla fine d e l 1943 , l 'o rga ni zzaz ione de ll e ba nd e usc iva da ll a fase preparato ria e prese ntava un'in telaiat ura ben d efinita. Il IO dice mbre M o nteze mo lo scri ss e " le dirett ive per l 'o rgani zzazione de ll a g ue rri g lia". L'attiv it à d el FMCR d i minuì sen s ibilmente in seg uit o a ll 'a rresto d e i s uoi pri ncipa li es po ne nti ne i giorni dell o s barco di An zi o. Montezem olo ve nn e catturato e co nd o tto a via Ta sso in s ie me ad uno dei s uo i più val idi co ll aboratori, il ten ente D e Gren et. Fu rinc hiu so per c inquant otto giorn i ed ucciso alle Fosse Ard eat in e.

All 'a ut rice di qu es to volum e rivolgo un se nti to ringraziamento pe r l ' inte nso e sc rupolo so la voro di ri c e rca svo lto, sopra ttutto all ' inte rno de ll ' Arc hivio St o r ic o dello S.M.E. , e per a ver co ntrib uito co n la su a opera ad illumi nare gli avv e nime nti d i un peri odo assa i d e licato e diffi c il e pe r la s to ria ita li a na .
Colonnello Antonin o Zarcone
e e e e 'a a e · 4
Prefazione
In que s ti ultimi a nni s i è mo lto parl ato - o riparlato - del contribu to dei mili tar i alla R es istenza italiana: contr ibuto mai del tutto ignorato, ma ce rto largam en te sottoval utato da larga parte della sto riografia "resistenziale", in quanto ascritto alle categorie (imp l icitamente negative) dell'attesismo e del contin ui s mo monarchico. A questa rivalutazione hanno contribuito sia alcuni lavori st oriografici (cito ad esempio Soldati di Carlo Vallauri o l ' ul ti ma ed iz ione di Una nazione allo sbando di E lena Aga Rossi), s ia l'operazione di rila ncio dei valori nazi on al i e patriott ici promo ssa, fra i1 1999 e il 2006, dalla presidenza Ciampi . Affermare, in polemica con la tesi della " morte d ell a patria" consumatasi dopo 1' 8 sette mbre 1943, l'esistenza di un filo di contin uit à, a nche istituzio n ale, nella storia nazionale dal Risorgimento alla Re siste nza e alla Rep u bblica non poteva lo gicam ente non comportar e u n gi udiz io più benevolo (o no n preg iu diz ialmente negativo) su coloro, m ilitar i in pri mo luogo, che questa cont in uità avevano fis icamente e si mbolicamente incarnato, s ia pure sotto bandiera monarchica e badogliana. Stando le cose in questi termini , mi risultava sorpren d en te l'assenza di uno st udio ampio e specifico sull'o rgan izzazione che prima e più di ogni altra s i era fatta carico d i quella continuità, fin dai giorni cao tici del dopo -arm istizio - il Fronte mi litare clandes tin o di Roma - e sop rattutto sul su o capo , il colonnello Montezemo lo: figura di cu i peraltro era diffici le disco nosce re le eccezionali ca pac it à o rga ni zza tive, la dedizione alla causa e la dime ns ione aute nticamente eroica, te stimonia ta daJl ' opera ass idu a d i pochi diffici l issimi mesi e in ultimo dalla duri ss ima dete nzion e, sto icamente affrontata, nelle mani dei tedeschi e d alla morte alle Fosse Ardeati ne.
E' q uesto il motivo che, quando, dive rs i a nni fa, l 'a utrice di questo libro si è prese nta ta da me per la sce lta della s ua tesi di laurea, manifestando il suo in teresse per il tema d ell a R es istenza a R oma, mi ha s pinto a proporle u n lavoro su Montezemo lo e il Fronte mil itare. Lo confesso, con qualche perplessità, visto che l'argomento , per il tag li o tematico e per le font i da ut ilizzare, non sembrava a prima vista il più adatto pe r una ragazza di poco pi ù di ven t 'an ni evi d ent emente digiu n a di cose mili tari. E ' accaduto invece (accade pi ù spesso di quanto non si pe nsi) che la ragazza si s ia gettata n el lavoro con un ent usiasmo s uperiore a ogni as pettativa e si sia s ubito immedesimata ne l tema e fa mi lia ri zzata con le fonti. Dopo la lau rea brillanteme nt e co nseguita, attrave rso successiv i passaggi , limature e rielaborazioni, la te s i è diventata un
 Sabrina Sgueglia della Marra
Sabrina Sgueglia della Marra
lib ro: un libro che g li es perti dell ' Ufficio storico dello Stato maggio re esercito hanno ev id ente mente apprezzato, se hanno accettato di ospitarlo tra le loro pubblicazioni.
Ho parlato dell'entusias mo con cui Sabrina Sgueglia della Marra ha affrontato il suo lavoro e della sua immedesimazione col te ma e co l personaggio. Qualche traccia di questa partecipazione emotiva si può cogliere anche in questo libro . E a volte l 'a utrice tende a smussare ( mai ad ignorare però) l'asprezza dei contrasti e delle contraddi zio ni che a ll ora s i manifestarono nel corso della lotta contro gl i occ upanti tedeschi, c h e erano poi, soprattutto per i militari, gli alleati del giorno prima (e già ques ta è una contraddizio ne di non poco conto). Mi riferi sco alle indubbie divergenze tattiche e strategiche tra resistenza militare e resisten za politica (che non avrebbero comunque impedito una sostanziale collaboraz ion e) e alle s tesse fratture c h e si produssero, tra la fine del ' 43 e l'inizio del '44, all'interno del Comitato di lib erazione romano e nazionale (e che si sarebbero approfondite in seguito all ' attentato di via Rasella). Ma penso a nche alle pol emic he storiografiche degli anni s uccess ivi che qui, salvo casi s pecifici, risultano un po' attutite. Non si pensi tu ttav ia c h e questo sia un lavoro acritico o agiografico. Si fonda al contrario su una ri cerca ampia e approfondita, condotta soprattutto negli archivi militari, ma poggiata anche su una sis temat ica consultazione della letteratura r ece nte e meno recente. Una ricerca che ha consentito all'aut rice non solo di rico st ruire nel dettaglio un percorso sinora noto solo nelle sue linee generali, ma anche di fornire una mappa esauriente de ll a re te organizzativa facente capo al FCMR, delle s ue molteplici diramazioni , delle sue diverse fo rm e di azione , d e i suoi rapporti sia con le autorità monarchiche e con ciò che restava dei corpi militari e delle forze di polizia (Carabinieri , Guardia di Finanza, Polizia dell'Africa ital ia na), sia co n le componenti politiche della Resi s ten za romana (importante i l rapporto con Bonomi, ma anche qu e llo con Amendola , peraltro già te stimoniato nei s uoi libri autobiografic i dall'es ponente comunista) . La mappa dà conto in effetti di una attività ampia, in te nsa e non priva di effic acia, se non altro in rapporto alle condizioni difficil iss ime in cui s i svo lgeva. Facciamo pure u n po' di tara s ul valore di documenti prodotti dag li stessi protagonisti, comprensibilmente d esiderosi di valoriz zare il proprio contributo a ll a lotta di liberazione. Ma anche dati di fonte diversa - le tes timo nianze di altr i res iste nti, delle a utor ità alleate , degli s te ssi tedeschi - concordano nel riconoscere al Fron te e al suo capo un ruolo no n trasc urab il e, in qualche tratto preponderante, nell'attività di contrasto agli occupanti svolta a Roma e nel Lazio fra l' 8 se ttembre 1943 e il 4 giugno 1944: in particolare ne i primi mes i, fino al fallimento d e llo s barco alleato ad Anzio e alla cattura di Montezemolo

6
Fu quello - tra la fine d i ge nnaio e l ' in iz io di febbraio - uno dei momenti piì:t difficili di tutta la storia de ll a Resiste nza, e non s olo di quella romana . Trovatosi isola to e s bil anciato, come og ni avan guard ia lasciata allo scoperto da u n improvv iso r ipi egamento, il Fronte mil itare fu decapita to e privato della s ua gu ida caris m atica, pagando un prezzo elevatissimo in terrrùni di uom ini e di reti organizzative. Co n tin uò ugualmente a svolgere un'attivit à , soprattutto d i informaz ione e di collegamento co l Su d , ed ebbe u n q ualche ru olo nelle comp licate manovre di preparazione de l passagg io di co nseg ne ag li alleati n el moment o dell a li berazione della Ca pita le. Ma non s i ri prese mai - come l' int era Resistenza romana - dal do ppio colpo su bito pri ma co n il fallimento dell'operazione Shingle, poi con l ' ecc idio delle Fosse Ardeat ine. Anche di ques ta fase il lavoro d i Sab r ina Sguegl ia della Marr a fornisce una puntuale ricostruzione , co lman do così una ri leva nte lac una in forma ti va. Pe r fi ni re, u na considerazio ne ge nera le , p ure s u ggerita d all a lettura di questo li bro. L a vicen d a del Fronte mi l itare, e in p artico lare q ue lla di Montezemolo, c i mos tra con in discutibi le eviden za q ua n to fosse sa ld o il legame degl i uffic ial i ita l iani con l'istituzio ne mona rc hi ca, sia pur in d ebo l it a e screditata da ve nt'an ni di collaborazione subalterna con la dittatura mussoliniana; e quanto fo r te fosse il ri ch iamo a un a continuità patriottica che il fascismo aveva stravolto, p iegato ai suo i fini, ma non interrotto. Ci si p u ò chiedere allora che cosa sarebbe accaduto non solo nel caso che il re, la corte, il governo e i vertici d elle Forze armate avessero ten uto u n compo rtamento diverso nella crisi del dopo - 8 settembre (e su quest o p u nt o si è a lungo riflett uto e d is cusso), ma a nche nell ' ipotesi c he , a d isas tro co ns um ato, l'opera di Montezemo lo e de i suo i collab o ratori fosse s tata megl io s upportata e valor izza ta (o se un personaggio co me M o ntezemo lo fosse ri usc ito a sfuggire alla cattura) . Probabi l me nte q uesto no n sarebbe bastato a dete r minar e un'egemonia della com po nente "nazio nale" e moderata sull'intero fronte resistenziale (a ll a mani era, p er inten der ci, di qua n to accad de, in tutt'altre condizioni , con De Gau ll e io Francia): non è d a es cl udere, però, che sare bbero sensibilme nte mutati g l i equilibri po litic i e mi litari della Res istenza, e no n s o lo nel ce ntro-Sud , con qualche significativa ripercuss io ne s ull a stessa partit a istituz ionale da giocarsi a gu erra finita. Ma q ui e ntria mo nel cam po de ll e ipotesi co ntrofattua l i, di cu i non è il caso di abusare . Acco ntent iamoc i di p rende re atto d i un quadro del movimento r es is tenzia le e della sua dial ettica interna più co m plesso di q uello che siamo abituati a osserva r e . E di ringraziare l'autrice di questo li bro p er averc i aiu t ato a ricostruirlo
 Giovanni Sabbatucci
Giovanni Sabbatucci
Mon
tezemolo e il Fronte Militare Clandestino
7
Introduzione
1. / "qua ran tac inqu e giorn i" e l 'armistizio
Il 24 marzo 1944, tra le trecen totrentaci nque vittime dell'eccidio de lle Fosse Ardeatine vi fu il colo n nello d i stato maggiore Giuseppe Cordero Lanza d i M o nteze molo, cap o del Fron t e Mi l itare Clan d estino ·di Roma, un'organizzazio ne d i r esistenza che ebbe un ruo lo d etermi nante nei nove mesi di occupaz ione ted esca della capitale
L'a rmi s tizio sorp rese il co lonnello M ontezemolo mentre era al coma nd o, da c irca tre sett imane, clell'XI Raggruppamento gen io del Co rpo d'A rm ata mo tocorazzato, impegnato nella costituzio ne di un re parto operativo c he av rebbe dovuto rinsaldare i l d isposit ivo di d ifesa d ella capitale . Dopo 1'8 settembre, malgrado il collasso morale cie l paese e de l le fo rze a rm ate, egli non ebbe es itazioni : non tentò d i varcare le lin ee per trovare riparo al Sud, ma sce lse di restare a Roma e di porsi a l serv izio de ll a causa n azionale. Monteze mo lo si mi se immediatame nte a l lavoro face ndo app ello a tutte le s ue risorse pe r coad una re in u n ' unica compag in e tutti quei n uclei militari for matis i spontaneamente in seg ui to all o s b a n damen to dell'esercit o , decisi a non de p o r re le armi e ad opporsi ai ted eschi e ai fasc isti rep u bblicani. fL FMC R in quad rò e coo rdinò l'attività di una fitta rete d i bande che opera rono nel campo ass istenz i ale, informativo e del sabotaggio , al fi ne d i abbattere qu a nto p iù rapidamente possibile il d ominio t edesco , affra ncare la pop olaz ione dall ' oppre ssi one s traniera e conse nt ire al re e a l gove rbo legitti mo di far r it orno nella capitale.
Il 3 settem bre 194 3 l'Ital ia s i a rrese agl i A ll eati: fu la pri m a app licazione d e l pr incipio di resa incon di zio nata fo rm ulato da Roosevel t e Chu rchill nella confe re nza d i Casabl anca de l 12-1 6 gennaio 1943, poi arprovato d a St al in 1
L a capi tolazio ne ebbe con siderevol i riflessi sulla nascente Resis te nza: se d a un lato scoraggiò gli an ti fascisti e antinazisti moderati che speravano in un a pace cl i compromess o, dall'alt ro leg ittimò la radicalizzazio ne de ll a lo tta 2
2 Claudio Pavone , Ge og rafia e slrultura della Resisl enw eu,vpea , in Franco De Felice (a cura di) , Amifasc ismi e Resis ten ze , La Nuova Italia Scientifica , Roma , 1997 , p.373.
 1 Elena Aga Rossi. Una na zione allo sbando. L 'armistizio italiano del settembre 1943, 11 Mu lino , Bo logna, 1993, p.29.
Sabrina Sgueglia della Marra
1 Elena Aga Rossi. Una na zione allo sbando. L 'armistizio italiano del settembre 1943, 11 Mu lino , Bo logna, 1993, p.29.
Sabrina Sgueglia della Marra
L'obiettivo deJJa vittoria totale s ul nazi s mo e s ul fascismo avrebbe dovuto rin s aldare l'alleanza ma fu su bito evidente come il concetto di resa se nza condizioni fosse diversame nte intes o d a ognuno dei tre leader3 Profondi d issensi sorsero anche in merito al trattamen to da riservare all a popolazione italiana: al co ntrario del presidente ame ri cano, ChurchiJJ ri teneva essenziale conclude re una pace p unitiva atta ad impedire la rinasc ita di u no stato militarmente forte per un congruo numero d i a nni 4 •
L' armist iz io venne firma to in un uli veto nella zona di Cassi bile, in provincia di Siracu sa, sotto una tenda militare ove s'i nc ontrarono il genera le di briga ta Giuseppe Castellano , rappresentante de l governo e del Comando Suprem o italiano, Dwigh t E isen hower col s uo capo di s tato maggiore , genera le Walte r Bede l l Smith, e il gene rale inglese Haro ld R upert Alexander, comandante s upr e mo del Mediterran eo. L a ri unione eb be b revissima durata. I sovietici eran o assenti, delegarono gli ang loamericani; il governo francese non era stato messo a l co rre nte delle tratta tive 5 Badoglio inviò un telegramma al Ftihrer e agli ambasc iatori italiani a To kio, Bucarest, Sofia, Zagabria e B rat is lava per comunicar e l ' armi stizio ai rispett ivi gove rni , spiegando che, mal g rado l'Italia non avesse abba ndo nato le ostilità anch e do po la caduta d el fascismo, ormai ogn i dife sa era cro ll ata, l ' invasione e ra in atto e non poteva esse re in alcu n modo arrestata Pe r tanto , i1 governo non avrebbe pot uto assumersi la respo nsab ilità di gravare oltremodo su un paese in gi nocch io , distrutto e sconvolto.
Non s i può esigere da un popolo - concluse il capo del gove rno - di co ntinuare a combattere quando qual s iasi legittima speranza non dico di vittoria, ma financo d i difesa, s i è esauri ta. L' Ital ia , ad evi tare la s ua totale rovina, è pertanto obbligata a rivo lgere al nem ico una richjes ta di arm istizio 6 li 10 luglio , gio rn o de llo sbarco allea to in Sicilia, s in da ll ' ini zi o delle operazioni era appar so chiaro che gli italiani, ormai priv i di riso rse morali e materiali , non avrebbero reagito energ icamente all'invasio ne del territorio na zio nale. II morale dell'ese rcito era ormai fiaccato dal sussegu irsi dei rovesci : in G recia, in A frica, in Ru ssia, e la popo lazio ne manifestava a p ertame nte l'avversione alla dittatura e alla gu erra 7
3 Elena Aga Rossi, o p. cit., pp 32-33.
4 Elena Aga Ro ss i, L'Italia nella sconfilla. Politica interna e situa zione interna z ionale durante la seconda g ue rra mondiale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napo l i, I 985 , p.83

5 Ivan Palermo, Storia di un armistizio, Mondadori , Mi lan o 1967, p 11; Filippo Stefani, 8 set · tembre 1943. Gli armistizi de/l'Italia , Marzorat i , Settimo Milane se, 1991 , p.52.
6 En zo Fedeli , 1940-1945 L'Italia e il s uo ese rc ito, Fiori ni , Torin o , 1946. pp.61 -62.
7 Guido Gigli , La seconda g uerra mondiale, Laterza, Bari, 1964, p.436.
10
Dopo la caduta del regime fascista, i partiti an ti fasc ist i aveva no prospettato a Baclogl io l ' urgenza d i promuovere un' in tesa fra i comandanti militari e i rapp resen tan ti d el Fronte naziona le perché cooperasse ro in prev is ione de ll a lotta antitedesca. A loro parere, solo l'att iva pa rtec ipazio ne d eJle nostre forze arm ate a l grande moto popolare antinazista ne avre bbe potu to r iscattare l 'o nor e . La miope politica d el gove rn o dei "q uarantacinque giorni ", tuttavia , malgrad o i re iterati a pp eJli all 'esercito dei promotori de ll a Resiste nza, res e va no og ni ten tativo in q ue sto se nso 8
Nel l ugl io 1943 l ' organ i zzazio ne comunista era l'unica a disporre , in alcu ne città, di u n discreto grado di sv iluppo: l ' impreparazione d e lle formazio ni poli t iche , pertanto, fece sì che il crollo del fascismo avvenisse ad ope ra de l sovra no, deJle alte sfere de ll e fo rze a rm ate e d ell a gran d e borghesia, ne l comune auspicio di mantenere pressoché intat ta la stru ttura po rtante dello s tato autoritario e di presentare tutta l 'operaz io ne de l 25 lug li o come "una sorta d i passaggio di po teri indolore ed asettico"'>, senza dirimere il pressante probl e ma del l' abb ando no delle osti lità 10 : l'iniz ia ti va monarchica non avre bbe tardato a mo strare i s uoi li mi ti nei "q u aran tacinque giorni" e, soprattutt o, nell'infau sto epilogo di se ttembre 11 •
Il nuovo governo , dunque, ancorché deci so a liquid a r e una s ituazione irrimediabilmente com promessa, era altr etta nto r isolu to ne ll ' impedire che alla fine d el fasc is m o seguisse il rovesciamento del l'assetto soc iale cos tituito 12 : le c irc o lari d el ministero de ll a Gu erra e de l capo di Stato Maggiore t estimoniano l 'es igenza di garantire la so lidit à e la ten uta delle forze armate per un impi ego prevalentemente interno , di tute la dell'ordin e pubblico. Sembra che la rigidi tà e il rigore impos ti avess e ro contribui to a d iffon dere, seg na tamente ne ll a truppa e tra g li ufficia l i suba lterni , una certa ri lutta nza ad eseg uire g li ordini più seve ri 13 •
8 Roberto Battag li a , Storia della Resistenza italiana 8 seuem.bre 1943 -25 aprile 1945, Einaud i, Tori no, 1964, pp.96 -97; Giorgio Bocca, Storia dell' Italia partigiana, Mondadori, Mi lano, 2002, p.6.
9 AA.VV., L'Italia dei quarantacinque giorni. Studio e documenti , Ist ituto nazionale per la s toria de l movimento di li berazione, Milano , 1969, p .39.
10 Paolo M onelli, Roma 1943, Mo ndador i, Milano , 1979, p.78 ; Ros ario Bentivegna, Achtung Banditen!, Murs ia , Milano , 1983, p.19
11 Giorgio Amendola , Le 11 e re a Milano, Ed ito ri Riu n iti , Roma, I 973 , p. 167
12 Riccardo Bauer, Resistenza italiana: le origini nell'am(fa sc ismo, i g ruppi so c iali, la formazione fino al 1943, in Fascismo e antifascismo. Lez ioni e testimon ianze, Feltrinelli, M ilano , 1962 , p.444.
13 AA.V V. , l'Italia dei quarantacinque g iorni. Studio e documenti, cit , pp.63 , 37

Montezemolo
Fronte Militare Clandestino
e il
Il
Sabrina Sgueglia della Marra
Lì beratosi di Mussolini, Vittorio Emanuele lll , con la designa zione del M a re sciallo d ' Italia Badoglio alla guìda del governo e il conferimento dei pi en i poteri mil itari , aveva indiv id uato nell'esercito il principale strumento politico e l 'ìstituzione cu i affidare l 'ard ua responsab i lità di co nd u rre il paese fuorì dal conflitto 14 • Già il 4 luglio, Umberto di Savoia, in un abboccamento col M a r escìa llo d'Italia, si era d ìc hì arato disponibile a sostenere un movimento diretto dall'elemento militare teso ad affrancare il nostro paese d al fasc i smo e d al conflitto 15 , segno c he vent'anni cli regìme non erano riusciti a mìnare la fiducia della monar chìa nell ' esercito. La notte tra ìl 25 e il 26 luglio venne a ltresì prospettata la cos tìtu zione di un gove rn o mìlitare cui avrebb ero dovuto partecipare var i generalì propo s ti eia Ambrosìo, tra cui Carbonì per il Min ìstero della Propaganda, Castellano per quello deglì Esteri e Amoroso , l'unìco alto ufficiale r ealme n te in cluso ne l gabinetto, per le Comunicaz ioni 16
Badoglio ricevette d al sovrano un p romemoria 17 in cui s ì ribadiva il carattere m ìlitare del govern o, come afferma to nel proclama del 26 luglio, e la necessità d i procrastinare le questioni p olitìche. Non sar ebbe stata co nsent ita ai partiti alcu n a attività organizzata e al fine dì ìmp edirne la ricostituzione , le prefetture furono inc a ri cate di eserc itare una stretta sorveg l ianza sugli organ i di stamp a e s u ognì movimento di pensìero 18 • L' atteso rivolgimento, dunque, non si compì, rim ase "a mezza strada" 19 , dì s velando la carente preparazìone tecnico-profe ss ìonale e l'ìnadeguatezza del governo. Le poche mì sure di carattere liberale furono l ' abolizione del Gran Consiglio e d el Tribunale Specìale e Io s cioglimento del Par ti to nazionale fascista, della Gioventù italiana del Littorio e della Camera deì Fasc i e d elle Corpo razioni. Solo al la fine dell'ottobre 1943 Badoglio , intend e ndo dare "una prima tangibile prova del suo programma di ripristìnare la libertà d e l Paese", autori zzò la pubblk:azione dei giornali editi daì pa rtìt i : abolì ogni forma di cen-
14 Carlo Vali auri, Soldati, UTET, Torino , 2003, p. IO; AA. VV. , l'Italia dei quarantacinque g iorni. Studio e documemi, Istituto nazio nale per la s toria del mov im ento di liberazione, Mi lano, I 969 , p .63; Giovarnù De Lu na, Badoglio. Un militare al potere, Bompiani , Milano , 1974, p.234.
15 Gianfran co Bianchi , 25 luglio cmllo di 11n regime, Mursia, Mi lan o , 1963, p.417.
16 Ivi, p.712.

17 Secondo quanto affermato da Badoglio, il prom e moria venne custodito nella cassaforte del VirrùnaJe e ven ne in seguito sottratto dai fascist i; cfr. Pietro Badoglio, L'Italia nella s,econda guerra mondiale, Mondadori , Milano, 1946, p.89.
18 Archi vio Ce ntrale dello Stato (da qui A.C. S. ), Presidenza del Consiglio dei Ministri , I 9401943, fasc.l/4-1 , n.21367, sottofasc.4-2
19 Giaime Pintor, I 4 5 g iorni, in Giampiero Carocci , La Res itenza ilCllian.a, Garzan t i; Milano, 1963 , p.30.
12
sura ad eccezione di quella preventiva ese rcitata dall a regie prefetture 20 . Ancora una volta, come ha sottolineato Piscitelli , il riconosc im e nto d elle libertà fondamenta li e il libero sv iluppo democratico del paese vennero sacrificati sull'altare della conservazio ne e della tu tela dell 'ordine pubblico21, rit en uti indi spe nsabili anche per il con seguimento di un a minima credibilità internaziona le .
L'OVRA, l a polizia politi c a di Mu sso l i ni , non fu so ppre ssa: continuò le sue funzioni di sorveg lianza per impedire eventuali com plott i o rivolgimenti politici 22 e, il 26 lu g l io, una disposizio n e del ministero della Guerra richiamò alle armi gl i ex gerarchi fascisti e gli ex s quadri s ti. Il 22 ottobre, tuttavia, come si legge nel comunicato del Capo di Stato Maggiore Ge nerale Ambrosio , se ne pre scrisse l ' imm ediato congedo al fine di ev itare "la presenza, n on necessaria, ne lle FF.AA. d i elementi poco desiderab i li, offren d o conte mp oraneamente alle autorità di P.S. la possibil it à di prendere in esame la posizione dei singo l i, in relazione alla loro passata attività politica"23 . Con un r egio decre to del 26 lu g lio, altresì, ven n e disposto l'inquadrame n to nell e forze annate d ella Mil izia Vo lo ntar ia p e r la Sicurezza Naziona le ( MV SN), il cui coman do, tenuto sino ad a ll ora dal genera le Ga lb iati, fu assegnato al ge nerale Armellini. Il provve di mento, b enché volto a neutralizzare la M iliz ia pr ivandola di ogni au tonomia, si rivelò foriero di ulteriore d isordine e confus ione nei reparti militar i che, con notevole ritardo, a partire dal 4 novembre , ve nnero sciolti e trasformati in unità dell'esercito24. Soltanto all a m età del mese, in vece, un comunicat o stampa e radio del Coman do Supremo ann unc iò il reintegro in serv izio perma nente col grado e l'anz ia ni tà maturata al momen to del congedo di t utti gli uffi-
20 Archivio de ll'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'E sercito, (d a qui. A .U.S.S.M.E.),
N.1 -11 , Diari s10rici za Guerra mondiale , b. 3054 , allega to n.180, "Pubb li caòoni periodiche d i partiti po l itici" , Ufficio Stampa e Propaganda del Governo al prefetto di Bari, Brindis i, Foggia, Lecce, Matera, Taranto e , per cono scenza, al Comando Supremo, al Superesercito, al Comando VII Armata , a l Comando X Co rpo d'Armata, a l Comando LI C.A , al Comando CC.RR. It alia Meridionale, 28 - 10- 1943.
21 Enzo Pi sci teli i, Storia della R esisten za romana, La terza , Bari , I 965, p 2 I.
22 Enzo Piscitelli, op.cii p.25
23 A.U.S.S.M.E ., N. / -/ / , Diari storici 2 ° Guerra mondiale, b.3052, allegato n.774 , "Ex gerarchi fascisti ed ex sq uadri sti ", Comando Supremo, Ufficio affari var i, il Capo di Stato Maggiore G enera le Amb rosio alla Presi den za de l Con siglio dei Ministri, 22- 10 - 1943.
2 4 Enzo Pisc i te li i, op . cit. , pp. I 9-20; Paolo Monell i, op . cii. , pp .1 54, I 59. Con lo sciogli mento dei reparti , si co stituì il 345° Reggimento di fanteria "Saba ud a"; il 359° fanteria " Calab ria"; il 340° Reggimento di fant.eria "Bari" e i Raggruppamenti di corpo d'annata ter ritoria le XL, XVI e XX, A.U.S.S.M.E , N.l - 11 , Diari storici zn Gu e rra mondiale , b.3054, allegato n. 122, " Scioglimento di repart i M Y.S.N. e lo ro t rasformazione in unità del R. Ese rcito"

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
13
Sabrina Sgueglia della Marra
cial i ebrei in s .p .e. sollevati dai prop r i in ca r ichi per effetto delle leggi razziali del 1938 25 .
A cap o della sua seg reter ia particolare B adoglio design ò il co lo nnello Montezemolo 26 Ne l pomeriggio del 25 lu glio, avendo sta bil ito di trasferire la sede d el governo al Vi minale, gli affidò u n comp it o assai delicato che palesa la fiducia di cui godeva presso il capo de l gove rn o: lo inv iò a Palazzo Venezia e g li o rdinò di sottrarre i documenti più im portanti dall'uffic io d i Mu ssoli ni . Nei cassetti il colo n ne llo tro vò un'ingen te so mm a di denaro e, t ra gl i incartamenti, un dettagl iato sc hedario, un vero e prop ri o casellario, in cui figuravano addirittura i membri della Casa reale. Montezemolo si rivelò u n prezioso collaborato r e, in un periodo di grave caos e te ns ione , e assolse tutte le incombenze affidategl i q uotid ianame nte co n precisione e tem pestività 27
Tuttavia, il nuovo incar ico , seppur svolto con serietà e dedizio ne, non rie ntrava ne ll e s ue aspirazioni . Egli era e si senti va un soldato, era assol utamente dis inte r essato all e questioni politiche e des id e roso so ltanto di partecipare attivamente all e operazioni belliche. In quelle settiman e il generale Carboni era im pegnato ne ll a ri orga nizzazione e nel potenziamento de ll ' effic ienza bellica del Co rpo cl ' Armata Motocorazzato (CAM) cu i era a ca po. Aveva s ollecitato l'anivo di due nuove divisioni al fine di completare il di s positivo di m anovra e si era messo perso nalm e nte in cerca di ufficiali idonei da assegnare allo stato magg io re del CAM, anco ra s provvisto deg li organi fondamenta li 28
Ricevuta la necessaria a utorizzazione da Badogl io, il 16 agosto Carboni nominò Montezemolo comandante de ll ' XI Raggruppamento genio del Corpo cl' Annata motocorazzato29 : fi nalmente, dopo reiterate richieste , il colonnello otte nn e di prestare servizi o in un reparto combatte nte e, in sua sos tituz ion e, fu nominato segretario particolare del capo del gove rn o il vice prefetto Mario Micati30
25 A.U.S.S.M.E., N 1- 11, Diari storici 2a Guerra mondiale, b.3055, allegato n.495, "Ufficiali di razza e braica", Comunicato s tampa e radio de l 13-1 1-1 943 il cui testo è in viato al Commi ssariato informaz ioni .
26 A.C.S. , Presidenza d el Consiglio dei Ministri, /940-1943 , fasc.1. 1. 5. n.21463, souofasc.l. Il colon nello fu nominato il 30 luglio, con decorren za dal 25 luglio, "segretario partkolare del Capo del Governo Primo Min istro Segretario di Stato con l'indennità giornaliera di l ire 17,50 ridotta del 12 per cento ai te rmini del R.D.L. 20 novembre 1930 n . 1491 "
2 7 Cfr. A.C.S ., Segrete ria Particolare del Duce, Carteggio O rdinario, 1922-1943, Badoglio, b.2518.
28 Giacomo Carboni , Memorie segre te. 1935- 1948. '' Più che il dovere", Parenti , Firenze, 1955 , pp 249 -250.
29 Sta to di servizio del colonnello di S.M. G i useppe Cordcro Lanza d i Montezemolo, Ministero della Guerra , Regio Esercito Italiano , Direzione Ge ne rale personale ufficiali , Divis ione matrico la e libretti person ali , Sez ione I"
30 A C.S., Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1940- 1943, fasc.1.1.5. , n .21463, sottofasc.3.

14
L'es perienza maturata nei numerosi inc arichi di r es p onsabilità r ico pe r ti, la par tecipazjo ne com e es p erto de ll o Sta to M agg iore ai vari incontr i al ver tice ital o-ted esch i, a l B ren n ero, a Berl in o, a Kl esheim e a Feltr e il 19 lug lio 1943 , no n g li consentivan o soverc hi e illu sio ni circa la tenu ta dell'i ntero appara to mi litar e le cui poten z ia lità , p ressoc hé nulle, rendevan o orma i inesora bilmente segnat o l ' esito della g ue rrn. Malgrado ta le co nsa pevo lezza, Montezemo lo s i adoperò alacremente, fi n o all ' 8 settembre , pe r cos tituire una vera u ni tà com b atte n te amalgama ndo ed ad destrando il pe rso nale scarsamen te pre parato che e bbe a d is pos izio ne31 , nella spera nza d i p red is p orre u na valida massa di manovra da i mpiegare n ell a difesa de ll a ca pi ta le Sebbene Carbo n i nutri ss e pe r plessità suJJa sce lta operata a favore d i M o ntezemolo, si dove tte ricred e r e e, ne ll e sue me mor ie, affer mò c h e "si rive lò subito un collaboratore di grande capacità tecnica e di una intrapren denza mo lto spreg iu dicata" 32 . Sembra che il co lon nello d esid erasse lasciare la segreteria particolare cli Badogli o no n solo pe rché a ns ioso d i assumer e u n incarico operativo, ma a n che p erché no n cond ivideva la pol itica de l gove rn o , sopratt utto pe r q ua nto attene va a lla con du zione delle trattativ e d 'arrrustizio 33 che pa les arono la s uperfic ial ità, l ' im p reviden za e la mode s tia della classe d irigente i ta liana .
Me nt re la gu erra e la forma le a ll eanza prosegu ivano al fine di non co mprom ettere ulteriormente i rap porti col Reich , le trattative con g li ang loa mericani furono condotte " pe r vi e moltep li ci e vag he" 34 S in dal 194 2, qu a ndo già s i profi lava l'inesora bi le débacle, da a m bie nti legati alla monarc hi a erano state promosse un a serie di iniziative per sagg iare gli umori alleat i in merito ad un ' ipote tica pace separata co n l'Ita l ia. Tali tentativi riguardarono esclusiva mente la G ran Bretag n a nell'illusio ne c h e con una mo narc hi a sare bbe stat o più agevo le trova re un terreno d' int esa. Mu sso lini, di cont ro, sosten ne fino a ll ' ulti mo la necess ità d i g iu ngere ad un' i nt esa unilatera le con l' Unione Sovietica con l' ob ie ttivo s tra teg ico di conce ntrare t utte le fo rze dell ' Asse nel Medite rraneo; prospettiva, questa, c h e non ve nn e mai p resa in considerazione da Hitle r35 .
Second o la te s ti monia nza d el fig l io s eco ndoge nito, Andrea , il governo e il Comando Su premo sce ls ero Mo nteze m olo p e r a ffidarg li un a mi ss io ne
31 Oreste Bovio, Sa ce rdoti di Marte, Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio storico, p.340.

32 G iacomo Car boni, o p. cit . , p.250 .
33 Ange lo Antonio Fumarola Essi non sono morti. Le ,nedaglie d ' Oro della g uerra di liberaz ion e, Magi-Spinetti , Roma , 1945 , p.92.
34 Giame Pintor, / 45 g iorni, in Giampiero Carocci, op. cit , p 26.
35 Ele na Aga Ross i, Una na zione allo sba ndo, cit. , pp 37, 39
Mon tezemolo e il Fro nte Militare Cland estino
15
Sabrina Sgueglia della Marra
diplomatica, che venne poi an nulla ta, da compiersi presso gli inglesi in assoluta segretezza ed assumendo la falsa identità di colonnel lo della Sanità. Sebbene si trattasse di un incarico oltremodo delicato e rischioso, egli accettò3 6
L'armi stizio tra l' Ital ia e g li Alleati ha costituito una netta cesura ne lla storia del nostro paese. La resa pose fine ad una g uerra le cui sorti erano irrevocabilmente segnate; fu una deci s ione irrefragabile, senza alternati ve, o gni sfo rzo ulteriore non avrebbe portato che danni ulteriori 37 • Tuttavia, malgrado il ge nera le sollievo per l'agognata fine delle ostilità, d ete rminò un profo ndo disorientamento nella popolazione e rappresentò , per le nost re forze armate, una cocente umilia z ion e. Tra le numerose tes timo nia nze, quella di Gabrio
Lombardi risulta particolarmente efficace per comprendere lo sta to d'animo chi aveva combattuto per tre lu nghi ann i:

Tristi giorni, quelli dell'armistizio; per ogni italiano , soprattutto per ogni soldato italiano. La gioia di vedere finalmente ripudiata un ' all ean za e una guerra c he erano state imposte dal dittatore, ve niva amaramente offuscata. Ancora una volta gli angloamericani avevano dimostrato profonda incompren s ione della s ituaz ione italiana; attraverso l 'imposizione di un armistizio duriss im o avevano pregiudicato irrimediabilmente la possibi lità di una partecipazione decisiva delle forze annate italiane all a gueffa contro la Gennania. Le trattative e rano state condotte male da parte italiana; ma erano state peggio impostate da parte angloamericana Ora l ' Italia e ra devastata dalla guerra. Le in ermi popolazioni di gran parte della peni sola esposte alle feroc i rappres aglie tedesc he38.
Claudio Pavone, ne l suo saggio dedicato alla "moralità della Resiste nza", ha usato l'ica stica esp ressio ne "sfascio" per de scrivere 1'8 settemb re
3 7 A U .S S.M.E. , N. I - I/, Diari s tori ci 211 Guerra mondiale, b.2997/A, c art.3 , 'Tre relazioni del generale Roa tta", f.16 , "D ipl omaz ia militare nei quarantacinque g iorni-Cro naca di un armi stizio clandestino". Cfr Ivan Palermo , S1oria di un armistiz io, Mondadori, Milano , 1967 ; El ena Aga Rossi , Un a nazione allo shando. L' armis tizio italiano d e l s ettembre 1943, Il Mulino , Bologna , 1993: Guido Gigli, La seconda guerra mondiale , Laterz a , Bari , 1964; Pietro Badog l io , L 'Italia nella sec onda g uerra mondiale Mondadori , Mi lano , 1946; Francesco Rossi , Come arrivammo all'armis tizio, Garzanti, Milano , 1946; Mario Torsiello. Settembre /94 3, Ci s alpino , Milano , 1963; Filippo Stefani , 8 seu embre 1943. Gli armisti zi d e ll'Italia, Marzorati, Se ttimo Mi lanese , 1991 ; Lu tz Klinkhammer, L'o cc upa zion e tede s ca in flalia , Bollati Boringhieri , Torino, I 993; Enzo Fedeli, 1940- 1945. L 'Italia e il suo es e rcito. Fio rini ,.Torino, I946; Giacomo Za nu ss i, Guerra e catas1rofe d ' Italia , Cas a e ditrice libraria Corso , Roma , 1945; Ruggero Zangrandi , 1943: 25 luglio -8 settembre, Fel t rinelli, Milano , 1964.
38 Gabrio Lomba rdi , Mont e zemulo e il Fronte militare clandestino di Roma (o ttobre 1943ge nnaio 1944), Quaderni del mu seo s torico della liberazio ne d i Roma, Roma 1972, p.14.
16
3 6 Testim o ni anza rila scia ta all ' autri ce.
e la diffusa sensazione del crollo, l'eclissi delle strutture militari e c iv ili, l a rottura de l monopolio statale della vio l.e nza . T utto venne r ime sso in discussio ne : valori, m iti, fede l tà . Se , come ha affer mato Hobbe s, il fine dell'ob bedienza ne i co n fronti dello Stato è la p ro tez i one, il ve n ir m eno delle ist ituzioni poté esse r e viss u to con un senso di smarrimento o co m e un 'occasione d i l iber tà . Nel v uoto ist i tuziona le, g l i obblighi ve r so lo Stato no n costituiro no p iù un sicuro pun t o di r ifer imento per i comportamen ti indi v id u a l i. T u ttavia, a l pos to dell'ipotizz a b ile bellum omnium contra omnes , s i de l i neò, in un primo mome n to, quella fraternizzazion e tra c i v il i e militari che non era riuscita nei q uarantacinque giorni . Q uando le tru ppe ger m aniche in iz i arono a confe r ire alla loro vio l e nza un a più compi u ta for m a li zzazione e, immed ia tamente do p o , venne creata la Rep u bb li ca Soc ia l e a Sa l ò, quando cioè quel vuoto venn e in q ua lche m odo colmato, la sce lt a resistenz i ale s i r ivelò sempre più d u ra e d ramma ti ca3 9 Vi fu , in fatti , ch i, gi udi can d o la cap i to l azio n e una s celta u miliante e d isono revo le, ravvisò ne l furore tede s co un ' ' fon d ame n to inoppugnabile" : Musso li ni, p u r ammetten do c h e "i tedeschi non erano s tati se m pre sensibili, forse nemmeno sempre le ali" nei co n fronti dell ' Ita l ia fascista , condannò recisa m ente l'armisti z io , un a "coltellat a pro di to r ia" , un ' in famia per tutt i gli italian i che , da allora, sarebb ero s tati dec las s at i come i nd ivid ui e come pop o lo p er "la bassa fe llonia, i l turpe tradi m ento" che la R epubblica Soc iale avreb be "lavato co l sa ngue"4 0
L 'a n nuncio della resa ven ne dato alle 18:30 del1'8 settembre attraverso la radio di A lgeri da un disco c h e riproduceva la voce de l generale Eisen hower, e dal cap o del governo italian o via radio alle 19 :42 . l n quelle stesse o re, m entre cominc iarono le operazio n i a ll eate di sba rco a Salerno, si riu nì fretto losamente il consiglio de ll a coro na che s tabi lì l'i m mediato allontanamento da Roma del re , del governo e d e l Coma ndo Su p remo4 1 •
L'abba ndono de ll a capitale fu motivato da ll a necess ità di assicurare l ' indipendenza , q uantome no formale , de ll o Stato: avreb be imped i to un'event uale catt ura d e l re, un ica fonte d i legitt i mità del gove rn o italia no, che sareb be stato altrimenti cos tretto dai tedeschi a sconfessa re la resa e a rico ndur re in
3 9
storico su/La
Res istenza, Bollati Boringhier i, Torino, I 994, pp.3 - 19 .

40 Renaio Perrone Capano , La Resistenza in R oma Macch iarol i, Napoli, 1963, pp 159, 2 57, 294.
4 1 A.U S S.M. E , N. l - 1 / , Diari storici 2" Guerra mondiale, b.2997/A , cart.3 , "Tre re lazion.i d e l ge nera le Roatta" , f.16, " D ip lomazia mi li ta re nei quarantacinque giorni - Cronaca di un armisti zio clandestino" Partec iparo no al con s ig lio della Corona: Badog li o, Soric e, Acquarone , Gua riglia , Ambrosia, Carboni, Sandalli , De Cou1ten , De Stefanis, Marches i
Mon tezemolo e il Fronte Militare Clandestino
Claudio Pavone , Una guerra civile Sag gio
moralità n ella
17
Sabr in a Sgueglia della Marra
guerra il no stro paese42 Secondo Badoglio, tale risoluzione, sebbene recasse in sé " qualche cosa di repu ls ivo", appariva "logica" ed "indi sc utibil e" e avrebbe trovato pi e na giustificazione nei fatti d 'Ungh eri a43 Non sare bbe s tata , dunqu e, una decisione atta esclusivamente alla tutela della loro incolumità personale: malgrado g li aspetti " in decorosi" che la caratterizzarono , si trattò d i una mi sura estrema dettata dalla ragion di Stato, di conseguenza non ce nsu rab ile44
In realtà, la fuga di Pe scara, che tanto smarrimen to creò nella popolazione, sa ncì il definitivo di stacco tra monarchia e popolo, una s eparazione che non s i s arebbe più colmata e di cu i il sovrano non fu in grado di ponderare gli effetti poiché non poteva preved ere c he que l popolo avrebbe espresso una propria autonoma volontà45
La so la direttiva cui poterono far riferimento le nostre fo rze ar mate fu I' ultim a frase del com unicato an odino che Badoglio lesse dichiarando la resa: dovevano cessare le ostilità con tro le forze angloamericane, ma bis ognava reagire "ad eve ntuali attacchi di altra provenienza" . Roatta ha so ttolinea to c he il proclama, b e nc hé corredato della disposi zio ne di opporsi a q ualsiasi
42 Agostino degli Espinosa, li Regno del Sud. 10 settemhre 1943 -5 giugno /944 , Editori Riuniti , Roma, 1973, pp. 5-6.
43 Pi etro Badogl io , op. cit. pag. 115-116. L'a mmira gl io Horthy, in seguito alla proclamazione dell'arm istizio , fu arrestato dai tedesch i e costretto a sconfossare la resa.
4 4 Domenico Bartoli , L'Italia si arrende , Ed itori ale Nuova , Mi lano, 1983, p.112. L' autore stigmat izza l'espressione "fuga di Pescara", o meglio , "di Ortona" , asseverandone l'assoluta necessità. Sottolinea tuttavia che si sarebbe dovuta compiere in modo più dignitoso, partendo in ae reo da uno degli aeroport i in mano agli italiani, o p er mare da Civitavecchia, ov'erano dirette due navi da g ue rra , e "senza portarsi un codazzo di ufficiali"(p.112). Storici come Iva n Palermo , Ruggero Zangrandi e Piero Pieri , hanno sostenuto che la deci s ione di a bbandonare la capitale non non rapp resen tò l'ex trema ra tio dell ' ultim 'o ra, ben sì la realizzazione di un progetto studia to si n dall'agos to. Piero Pieri , altresì, ha aggiunt o che, avendo pagato l'alto pre zzo polit ico della resa incondizionata , I.e autorità italiane s i erano ass icurate il riconoscimento alleato come leg iuimi detentori del potere che, per tanto, era loro primario obiettivo sa lvaguard are in ogni modo. La con tiunuità is tituzionale coincideva dunque col mantenimento del lo ro con trollo sullo s tato. Cfr: Ivan Palermo, op. cit. , p 274; Ruggero Zangrand i , /94 3: 25 luglio -8 settembre, Feltr inelli , Milano, 1964, pp.385391; Piero Pieri , Pietro Badoglio , UTET, Torino, 1974 , pp.819-820 Ne ll a re lazione del generale di Corpo d ' Armata Carboni, s i legge che il proclama del capo del governo sarebbe stato motivato dalla sua " preconcetta volontà di allontanarsi dal territorio occupa to" senza trovare "i ntoppi " in co nflitti armati "sorti prematuramente" s ull' itin erario da percorrere per raggiungere il porto d ' imbarco. Badoglio, pertanto, s i sa rebbe preoccupato e~c lus iva men te di predisporre la fuga "con tutte le migliori gara nz ie di celerità e di s icurezza" (A.U .S.S .M. E. , N.1-11, Diari stori ci 2" Guerra mondiale , b.3000/A , "Giacomo Carbo ni , ge n era le di Corpo d'Armata-La verità sulla difesa di Roma").
45 Roberto Battag lia , op.cir., p.92

18
vio lenza, non avrebbe potuto che avere " effetti pernicios i e d issolventi sul mora le delle truppe" in quanto subordinava l'az ione italiana a q uella tedesca. I soldati attendevano la fine della gue r ra s in dal 26 luglio: non si poteva preten dere che fossero propensi ad impugnare immediatamente le armi cont ro l'alleato di ieri di cui, peraltro, avevano potuto ben constatare il vasto potenziale offensivo. A su o pa rere, molti elementi che diedero seg ni di incertezza e rim àsero passivi in que i momenti drammatici, "se ave ssero avuto la sensazio ne d iretta od indiretta di un fo r te ed immediato intervento degli alleati", avrebbero reagito diversame nte , opponendo una r isol uta resistenza46
S econdo Lutz Klinkhammer, la passività de l Coman d o Supremo è da ascrivere alle perpless ità circa la compattezza e la ten uta delle truppe italiane, nonché a l ti mo re che si sviluppassero disord in i47 Le for ze tedesche in Italia, all'an nu ncio dell 'armistizio, ammontava no a diciassette divis ioni e due brigate, oltre a quattro divisioni seg nalate in arrivo alla frontiera o ri e ntale e se ttentrionale
T utto c iò che accadde dall'8 sette mbre in poi fu l' a tto fina le d i un 'ag gress ione già in atto a partire dalla caduta d i Mus sol ini, volta a garantire alla Germa n ia il domin io incontrastat o dell'Italia settentrionale . Su richiesta di Hitler, infa tti, il 27 luglio 1943, era no state p redisposte le operazioni d el piano Alarich, s uddiviso in q uattro fas i: Eiche, per la l iberaz ione d i Mussolini; Student per l' occupazione di Roma e la r estaurazione del Governo fascista; A chse, pe r impadronirsi della flo tta in caso di armistizio separato; Schwar z, in fine, per esautorare i comandi ital iani , ne utrali zz are l' ese rc ito e porre sotto controllo i punti cruciali de l terri torio italiano48 . A confer ma dei propos iti di vendetta de l Re ich , in o ltre, il 7 settembre, l'ambasciatore von Mackensen ve nne sostitu ito dall 'ex gau le ite r della Boemia e min istro plenipot enziario del R eic h von Rahn, uno degli artefici del p utsch d i Vienna e dell'as sass in io di Dolfuss, che no n aveva alcun legame con l'I ta lia e con gli it alia ni49 .
46 A.U.S.S.M.E., N.1-JJ , Diari s 1ori ci za Guerra mondiale, b 2999 , doc .42, " Memoria s ulla priorità dell'aggress ion e germanica, compilata da l generale Roana" Tale int erpretazione è confermata anche dal sottocapo di stato magg iore Francesco Ros si , (cfr. Francesco Ross i , op ci i. , pp.272-275 ) Filippo Stefani ha messo in evidenza come gli sc rupoli di coscienza dei so ld ati itali an i furono talmente profondi da indurli , in nume ro si casi, a tentare di raggiungere intese locali coi comandan t i tedesc hi che, al contrario , non s i peritarono d i attua re quanto prima l'aggressione predi s posta in ogni dettag lio (Fi lippo Stefani, op cii., p.75).
47 Lutz Kli nkhammer, L'o cc upa zione 1edesca in Italia, Bollati Boringhieri , Torino, 1993 , p.33.
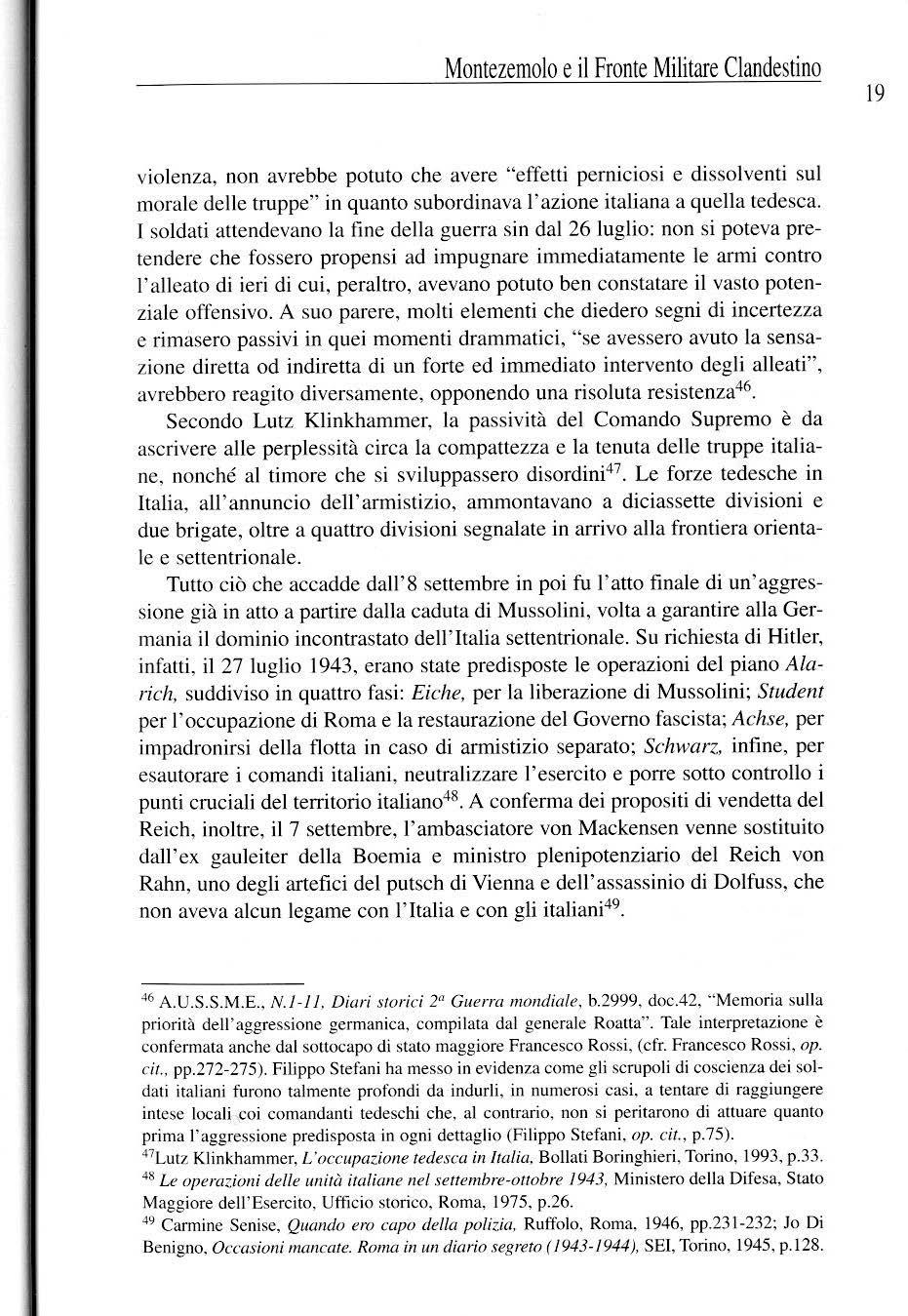
48 Le operazioni delle unilà i1aliane nel settembre -onobre 1943, M ini stero della Difesa, Stato Maggiore dell 'Esercito , Uffic io storico, Roma, 1975, p.26.
4 9 Carmine Senise, Quando erv capo della polizia, Ruffolo , Roma, 1946, pp .23 1-232; Jo Di Benigno, Occasioni mancate. Ronw in un diario segreto ( /943 - /944), SEI, Torino , 1945, p .1 28.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
19
Sabrina Sgueglia della Marra
L' occupazione era avvenuta progressivamente mediante " in caps ulamenti" dei reparti italiani. Sebbene apparisse del t utto evidente la natura offe nsiva di tal i provvedimenti, non più volti al conten ime nto degli sbarc hi alleati e alla difesa della peni so la, bensì al consolidamento delle posizioni germaniche nelle regioni se tte ntrionali , le autorità ita li ane, po ste di fronte alla politica del "fatto compiuto", non contrastarono apertamente tali ini ziative, avallando, così, le previsioni d ell'ex alleato c he aveva preconizzato una resistenza " trascurabile"50. Come ha sottolineato Dollmann, il nostro esercito, d ' altro nde, ad eccez ione degli alpini, era giudicato sulla base delle sconfitte di Lissa e Caporetto e co nsiderato, pertanto, di terzo o quarto ordine51 . L'8 settembre, gli unici settor i in cui lo sc hi eram e nto delle forze italiane risultava conforme agl i ordini emanati erano l'Alto Adige, la Sardegna e la Corsica. r raggruppamenti predispost i ne lle altre regio ni erano in fase di riordinamento; numerose unità si trovava no in v iaggio, frazionate su numerosi treni e impossibilitate a prendere qualunque iniziativa
Inoltre , svariati comandi inferiori, specie di carattere territoriale, non aveva no ancora provved uto all'applicaz ione delle misure previs te dalla Memoria
N.44 poiché gi u nse agli en ti più lo ntani soltanto il 7 settembre. La Mem oria
N.44 costituiva un'integrazione dell'ordine llJC.T. e, be nché confermasse il pericolo d i un 'offensiva tedesca atta a ristab ilire il regime fascista sottraendo alle autorità ita liane le leve d e l co mando militare e c ivile, ribadiva che le nost re truppe avrebbero dovuto reag ire solo se provocate e prescriveva contromisure da adottare esclusivamente in caso di attacco. Entrambe le direttive non contenevano alcun accenno alla conclusione di un armistizio 52 Tale omissione, determinata dall 'estremo riserbo che avvolse i negoziati come dispo st o dal Governo e dal Comando Supremo, contribuì sens ibi lm ente aJ disorientamento dell'esercito ed impedì una concentrazione di forze in grado di sostenere l'urto germanico.
È lecito pensare che la Memoria N.44 si sarebbe potuta diramare molti giorni prima. Bisogna tuttavia considerare i necessari aggiornamenti apportati al documento su lla base delle noti zie che, quotidianamente, pervenivano rigu ardo gli inte ndimenti degli Alleati 53 Solo il 4 sette mbre fu diramata ai tre Stati Maggiori la Memoria N.l , un ampliamento della M emoria N.44. A differen-
so lvi , p.32.
51 Euge n Dollmann, Roma na zista, Longan es i , Milano , 1949, p.134.
52 A.U. S .S.M.E., N.1 - 11, Diari storici 2a Guerra mondiale, b.3000/A, "Me mo ria de l generale Roana" doc .44 , "O rdini emanati dallo S tato Maggiore del Regio Esercito ci rca il contegno da tenere di fronte ad una evenn1ale aggressione ger manica"
53 Ministero del la Difesa, Stato Maggiore dell'Eserci to, Uffic io storico, op.cii., pp.42 -46.

20
za d elle direttive precede nti , in essa s i faceva esplicit a menzione di un a poss ibil e aggressione teut on ica motivata da ragioni politiche o daJJa "co nclu s ione da part e nostra di armistizio a loro in sapu ta" 54 Infin e, ne lla Memoria aggiuntiva N.45, ven iv a dato l' o rdin e di prendere accordi con i Comandi della Reg ia Marina e della Regia Aeronautica in v ista di azioni co m uni 55

L'esercito , d un q ue, si t rovò assolutame nte i mp repara to a respingere l'assalto delle trupp e ger maniche , a ni mate, pera lt ro, dalla co nvi nzione che la loro sal vezza dip e n desse unicame nte da un attacco drastico e ri solutivo pe r neutral izz are l'avversario a n tici p ando il concorso de ll e forze angloamericane.
Il generale sbandamento seguito a li ' 8 settem bre fu il prodotto dell' inco ngrua preparazione spiri tual e e nù Htare dell 'esercito e del l'intera popo lazio ne al m utame nto cli fro nte e alla prosecuzione d e ll a g uerra. Tale inadeg uatezza è d a asc ri vere, in primis, ~ùl'eccessiva preoccupazione del Comando Supremo d i ce lare la resa. Se gli Alleati , tuttavia , avessero rispettato gl i acco r di relativi a ll a dichi arazio ne d ' armistizio, i predis pos ti raggruppame nti sarebbero stati com plet at i e , din anz i a mass icci sbarchi angloamericani nel La z io , le di v is ioni tede sc he schiera te più a Sud avrebbero do vu to ripiegar e accorren do in que ll a zo na . Le forze si tua te in Calabria e d in Puglia , infatti, si concentrarono a Sale rn o per tentare di con t enere l 'i nvasione n e mi ca A riprova di ciò , Roat ta ha ri corda to le parol e pronunciate da Keitel a Ta r visio: "u n balzo nemico nella z ona di Roma av r eb be tagl iato fuor i le truppe germanic he dislocate più a s ud " 56.
"L' esercito regolare - ha sc ritto Giorg io Bocca - muo re per dissanguame nto e pe r abbandono : sc hi acc ia t o da un a g u erra piì:1 grande di lui ma a n che lasciato a sé, ne ll e ore de ll 'agonia, dal re e dal Comando Supremo" c he, pur di non far trapelare nu ll a delle trattative , emanò a ll e grandi unità ordin i " ambigui come i s uo i s ilenzi '' 57 • Il generale Trabucchi ha scort o nell 'accusa di tradim e nto ri vo lta ai nostri solda ti il pi ù lacera nte torme nto che furono costretti a vivere : a causa de ll' assolu ta segretezza, della mancan za di una qualsivoglia propaganda ps ico lo gica a loro s osteg no , essi no n seppero c h e
54 A.U S.S.M. E. , N. I - I I, Diari sto rici 2" Guerra mondiale, b.2997/A, f 5 , ricompilazione a memoria de lla Mernoria il.i a cura del generale Ross i .
5 5 A U S S M.E , N. I - J1, Diari stori ci 2" Guerra mo ndiale , b. 2999 , "Memoria del ge neral e Ro atta". doc.45 , " Noti z ie de l generale Roatt.a in data 16-8 - 1944 su: Ordine n 111 C. T. ; Memoria 44; Mem o ric1 agg iunti va 45"
56 A U.S :S.l'vtÈ., N.J -11 , Diari storici 2° Guerra mondiale , b .2999, doc.42, "Memoria sulla priorit à dell'aggres sione germanica. comp ilata dal ge ne rale Roana "
57 Giorgio Bo cca , op cit., p 5.
Montezemolo e il Fro nte Mi]jtare Clandestino
21
Sabrina Sgueglia dell a Marra
cosa contrapporv i e tal i carenze, o ltre a q uelle materia l i, ge nerarono u n se n so d i sfi d uc ia e d'i m poten za che, inesora bi lmente, portò al collasso de ll ' orga nis m o mi lit are 58 .
Nella c ri si di coma ndo, tuttavia, "mentre l'esercito ital iano s i d isso lveva in mi ll e e mille rivoli di uo mini dispe ra ti, umi liat i , atterriti, sgo me nt i" 59 , alcuni nucl e i militari, scio lt is i i repart i d'appartenenza, non co nsegnaro no le armi ma dec ise ro di rivolgerle co ntro i tedesc hi : fu rono molto pi ù numerosi di quanto s i sia sol iti pensar e e la loro fu u na sce lta assai gravosa e carica di s igni fi ca to m ora le poiché op erata ind ivid ualmente co n p rofonda consapevolezza. No n s i trattò d el l ' esec uzione d i un ordine, ma di u na vo lontaria op posizione all'a ll eato di poco tempo p ri m a .
I comand an ti ed i so ld ati pronti a res iste re organizzaro no tutte le fo r ze di sponibi li al fine di costitui re unità com b atten ti e trupp e ausi l iarie per coop erare a ll o sforzo be ll ico delle Nazio n i Un ite; per partecipa re a ll e azioni de ll a R esis te n za ital ia n a con le formaz ion i pa rtigiane attrave rso la raccolta di info rmazio ni s ug l i app restamenti dife ns iv i tedeschi , sulla dis locazione e s ugl i spostame nti delle divis io n i nemich e; p er sv ilup pare un a capi ll are opera d i controspionaggio, sabotagg io e antisa bo tagg io; per p rovvedere ai bisog ni primari de ll a p o polazione e p reserva rl a dalla feroc ia nazista; per ass ic urare , infine , il ma nte nim e nto dell'ordine pub blico ne ll e citt à e nelle retrovie 60 .
Testimo nfa n za del contri bu to, spesso sotto valu tato, d ato a lla R esiste nza, so no le con siderevo li pe r d ite su bite d all e nostre forze ar mate che si ad operarono fino all 'es t re mo sac ri fi cio p er la ca usa nazionale: so lo a R oma, nell'ecc id io de ll e Fosse Ard eatine, furono uccis i sessantasette mi litari, di cui tre ntotto era no ufficiali. In rea ltà, si può verosimi lm e nte stimare che fossero assa i più n um e r osi se si co ns id era c he molte vitti me, identi fica te co me civi li , appar teneva no alle class i d i leva e ai r ichi amati a ll e armi.
In seg ui to alla cad u ta d el fascismo, le as pettative ol tremodo o ttimistiche nutrite soprattutto d alla G ra n Bretagna s ulla ca pacità di r eazio ne dell' eser cito ita l iano nel ricacciare i tedesc hi a l d i l à de ll e Alpi, fu ro no dis a ttese . Agli A ll eati, d unqu e, co me uni ca soluzion e p ossi bi le, no n ri mase c h e l 'i m pegnat iva risa lita d ella p enisola, le cui modalità op erative si d etermin aro n o pro-
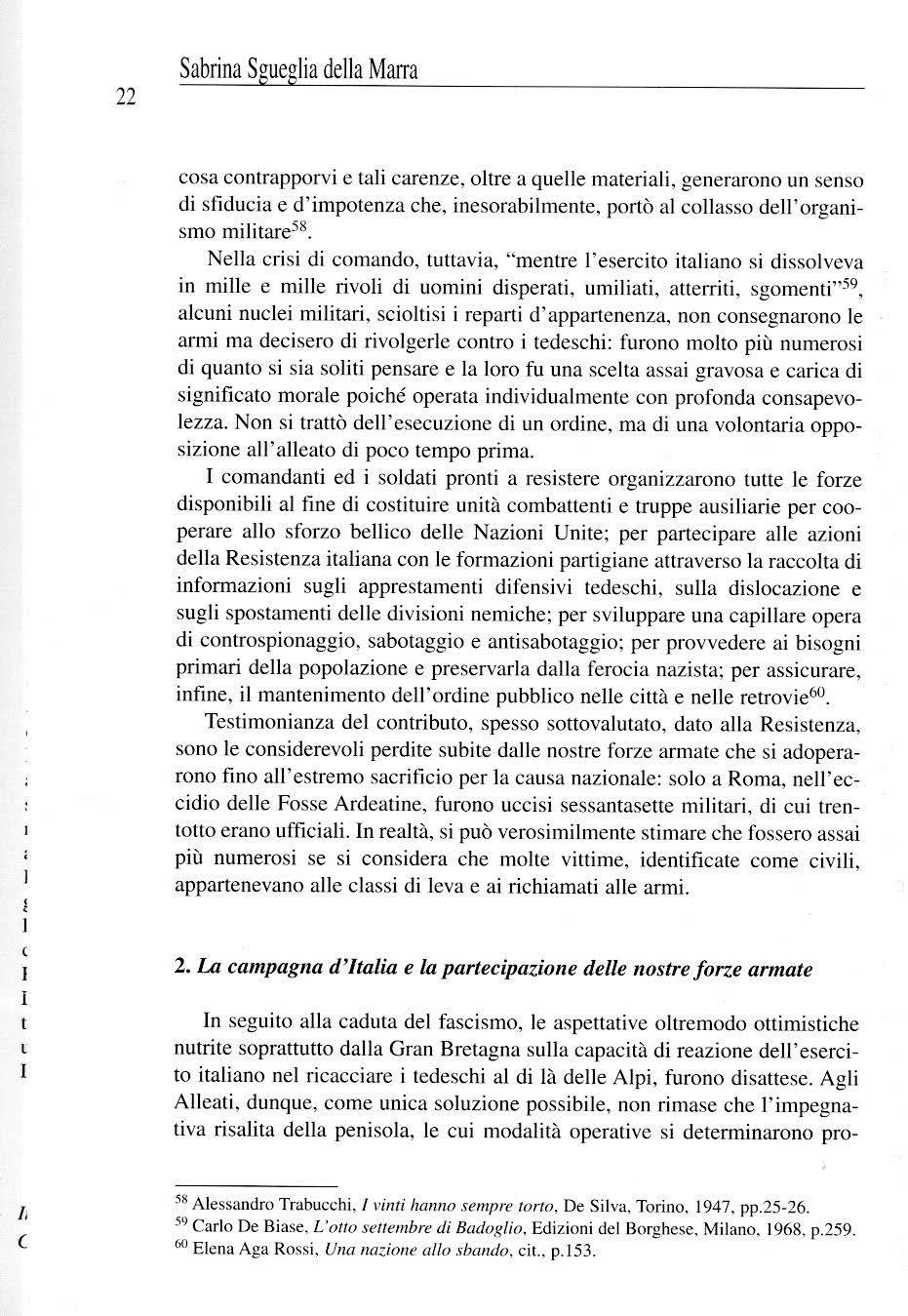
58 Alessandro Trab ucchi , I vinti hanno sempre torto, De S ilva, Torino, 1947, pp.25 -26.
59 Car lo De Biase, L'otto se l/ embre di Badoglio , Ediz ion i de l Bo rghese, Milano , 1968 , p.259.
60 Elen a Aga Ro ssi , Una naz ione allo sbando , cit. , p. 153.
22
2. La campagna d ' Italia e la partecipaz ione delle n ostre forze arma te
gressivamente, attraverso compromess i e non fac ili mediazioni fra l'approcc io p uramente milita re d i Eisenhowe r e Roosevelt e la s tra tegia po l it ica di Churchi ll 6 1 I preparativi dell'Overlord p regi udicaro n o in maniera significativa la condotta de lle op e razioni: la campagna d' Itali a, cominciata con lo sbarco in Sicilia, p roseguì a rile nto e con svil u p pi altalenant i. Non fu elaborat o un piano definito poiché, ai fi ni dell'impostazion e bellica alleata, r isultava di primaria importa nza tatti ca la dispo ni bilità di aeroporti n e l meridione, non la rapida occupazione d i tutto il n ostro teITitorio
Gli angloamericani m iravano, infatti, ad impegnare in Italia il magg ior numero poss ibi le di divisioni germankhe sto rna ndole dall' Uni o ne Sovi etica, ove l 'offe nsiva ru ssa stava riguad agnando il teITitorio pe rduto, e dal fron te che si sarebbe aperto in Francia. Le Nazion i Uni te considerarono il ribal tamento di fronte una mera que s tione militare, non ne afferraro no il valore moral e né le imp li cazio ni spiritua li , e non compresero la drammatica crisi d i coscienza che portò le nostre forze a r mat e, fino ad allora impeg nate sul fronte opposto, a riprender e la lotta contro l'ex alleato malgrado l'assenza di direttive62 .
Gli Alleati impedirono, di conseguenza, la formazione di eserciti clandesti ni come q ue ll i so rti in Ju goslav ia e in Grecia, co n l'evide nte ob iettivo di affidar e alle nos tre forze arma te un ruolo accessorio e s ub o rdinato . Le diverse fina l ità della campagna d ' I talia e le co nt rastanti impostazioni , seg natamente per quanto atteneva al concorso d i unità regolari e fo rze partigiane italiane, determinarono p rofonde incom prensioni , con grave preg iudi z io della nascente R esistenza63 , c u i gli a ngloamericani non riconobbero mai una reale autono mi a, diffidando di un movime nto la cui matrice politica era per Io più di si ni stra.
D a parte italiana, di contro, si riteneva , e si cercò reiteratamente di dimostrare nei vari abbocca m enti, come il drammatico s usseguirsi deg li eventi avesse capovo lto la nostra posizione.
Ro atta , il 20 settembre, inviò a t utti i coma nda nti una circo la r e in cui r ibadiva che la vile aggressione tedesca aveva trasfo rm ato la Germania da paese a ll eato a feroce nemico e , al co ntempo, d ichiarava "virtualmente superate" le clausole contenute nell'armist izio : le truppe ita liane, affiancandos i a q ue lle angloame ri cane, ne erano div en ute alleate . Le ambigui tà e gli eq ui voci che sorse ro tra le au t orità italia ne e quelle d elle Nazio n i Unite , derivarono proprio dalla diversa in te rp retazione de ll ' offensiva tedesca, de ll a no stra di sponi -
61 Elena Aga Ro ssi, Cltalia nella s confilla, cit., p.90; Guido G igl i, op ci t , p.455 .

62 Giorgio Rochat, Una rela zione ufficiale sui militari n ella Resisten za romana, estratto da Il movimento di libera z ion e in Italia, n.96 , fasc.3, lugl io- settembre I 969 .
63 Carlo Vallauri, op. cit., pp 253 -254, 359-360.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
23
Sab rina Sgueglia della Marra
bi lità a comb attere e d ello status inte rn azionale dell' It a lia, c he g li angloamerican i cont inuaro no a ritenere un paese avver sario 64
L a Ge r mania, il 25 luglio, era d i fatto di ven uta nostra nemica, ma G ran Bretag na e Sta ti U ni ti non ci consideraro no automaticamen te un loro po te nziale a ll eato e le con di zio ni di resa, be nc hé costi tu issero il n aturale ep ilogo della sco nfi tta militare, r is ultarono di una d urezza eccessiva. Se, in d ubbiamente, anc h e le posizioni it aliane risentirono, com'è ovv io , di un a ce rta unilateralità, esse pogg iavano tu ttavia su basi oggettive, no n erano affatto velle itarismi p ri v i d i fondamento reale. Nel memoran d u m di Q uebec, in fatti, ma lgrado l ' ass istenza atti va delle nos t re forze a rmate non venisse contemplata, si s tabilì c he le clauso le p rev iste dall'armis tizio sarebbero st ate mitigate in base al co ntr ibuto dato dal governo e d al popolo italiano alle Naz ioni U nite fi no al termi ne d elle osti lità, riceven d o, ne ll a lotta cont ro l' occupaz ione tedes ca, tutto l 'aiu to possibi le 65 Le apparen ti apert ure a ngloameric a ne, d unque, suffragate da num erose dichiarazioni favorevol i alla cooperazio ne bellica, ind ussero i l governo a provvedere rapidame nte alla ricos tit uzio n e degli orga ni d irettivi, Mini stero de ll a Gue rra e Stato Maggiore , e a l ri ord i namento de ll 'o rganizzazione territoria le in Pu glia, Sar degna e Ca labria, c reando la ex novo in Sicilia e Campania, ov' e ra scompa rsa de l t ut to . Come ha affermato il Maresciallo d' Italia Messe, l'esercito e ra r idotto a " un tro nc one staccato d a un co r po prima comp leto" ch e, col sostegno d e ll e Nazio ni Un ite , " occorreva rio rga ni zzare per ren derlo a sua vo lta capa c e di v ita a utonoma" 66 Il pr imo band o del Coman do Supre m o, che dava veste giuridi ca a ll e disposizio ni conten ute nella c irco lare "Riscossa" del 2 0 se ttem bre, fu d iramato i l 1O ottobre. R oatta, illustra ndo la de li cata situazione, prescrisse ai coma nda nti di mantene re ad ogni costo la più ferrea d iscipli na, di ffo nden do la convinzione c h e l'apparat o mi itare fosse ancora in piedi, che sap esse far eseguire gli ordini e che fosse dotato di una salda gerarc hia. Sotto lineò, altresì , l'i mportanza d e ll 'opera di rec u pero, nell'Italia me r id ionale , dell'eno r me massa d i militari sbanda ti , u fficiali e gregari . La co ll a b o razione, p rovando che l'armi stiz io e ra sta to ric hi esto per u na s ituazione oggettiva, no n per vig liacch e ria, av r eb be ri s cattato l 'o no re dell' Ita li a che, da paese vi nto, sareb -
64 A.U.S.S.M.E. , 13 , 233/1, S ta to Ma gg iore dell 'Esercito, n. 1260, R elaz ione sulla sirua z ion e delle Forze Armate, in Giu seppe Comi, li Prùrw Raggruppam ento motoriu,ato, Sta to Maggiore dell'Ese rcito , Ufficio s torico , Roma , 1986, pp .8 - 11.
65 A U S.S.M.E N. I - I I Diari storici 2" Gu erra mondiale, b.3056 , allegato n 798, "Partecipazion e militare ital ia na alle operaz ion i" Comando S u premo, Ufficio Operazioni, il capo di Stato Maggiore General e Ambrosio, a l Mi n istero degl i Affari Es teri, 2 1- 11 - 1943.
66 A.U.S.S . M. E ., 13 , 233/1, Stato Maggiore dell 'Ese rcito , n. 1260 , R elazione sulla situaz ione delle Forze Annate, in Giuseppe Conti, op. c it , p.7 .

24
be divenuta paese cobelligerante67 Analogamente , Ambrosio, in seg uit o all'incontro di Malta del 29 settembre, auspicando un 'a tte nu azione dei termin i di resa , d iramò ai capi d i Stato Maggiore dell' E ser c it o, della Marina e dell'Aeronau tica, le di rettive pe r "l'approntamento de ll e G randi Unità": Eise nhower avrebbe se lezionato le di visio ni mig li or i tra i corpi d ' elite, armati ed eq uip agg iati co n mezzi propri 68 .
Tu t tavia, le a utorità ital ia ne dovettero constatare ben pres t o c he, a fronte di un a maggiore di s p onibili tà americana , quantomeno es pressa a parole , l'atteggia me nt o di Alexander a pp a ri va improntato al più rigido o struzionismo. L a Gran Bretagna, in fatti, no n avrebbe potu to toll erare che g li ital iani , concorrend o a llo sfor zo bellico , acquis isse ro meriti che, al tavolo delle trattativ e di pace, avrebbero potu to pesare a sca pi to d elle proprie as piraz ion i69 . Gli ing les i, con la cap itolazione, la firma della resa e, in segu ito , con l'acqui s izione de llo statu s di cob e llig erante da pa rte d ell ' Italia, furo n o costretti a ri nun c ia re alle mire che avevano sulla Sici l ia e a des istere dal progetto di infierire s ul nostro paese fin o a schiacc iarlo completa me nte .
Il 30 settem bre venne inv iato a l generale Srni th , Capo di Stato Maggiore d i Eisen hower, u n promemoria i talia no in cui s i proponeva l'impiego a breve s cadenza di un raggruppamento motorizzato già in cost itu zione e s i illu strava la possibi lit à di approntare dieci d iv is ioni a co n diz io ne che gli Alleati avessero agevolato i l tras p orto di trupp e ne ll a pe ni so la dalla Sardegna e dalla Co rs ica. Ancora una vo lta, t ut tavi a ignorando le legittime aspiraz ioni italiane e sottova lu ta ndo, pera ltro, qu a nto fosse doloro so veder com b attere truppe fra ncesi e polacche se nza l ' interven to dei nostri soldati, alle benevoli enunciazion i d i p rincipio n o n corrispos e alc u n provvedime nto concreto
70
Gli Alleat i appar ivano o ri entati piuttosto all ' impiego delle nostre u ni tà aus ilia ri e : non s i peritarono, infatti , di d re na re risorse e di sottrarre manova-
67 A .U .S.S .M .E., N./ - 11 , Diari sto rici 2" Guerra mondiale , b.3052, a ll egato n.496, " B ando
· n. I de l Com ando Supremo", Stato Maggiore Reg io Ese rcito, Ufficio Personale e Segreteria, ai Co mandanti d ' Armata e di Corpo d ' Armata , a i Sigg. Generali Comandant i di Divisione , Brigata, Presidio ecc., ai Sigg. Proc urato ri Militari del Re Impe ratore, ai Sigg. Sostituti Procuratori Mii. De l Re Imperatore.
68 A U .S.S.M E., N. l - 1/, Diari storici 2a Guerra m ondiale , b.305 l , allegato n.21, "Appro ntamento G.U. per le pross ime operazioni". Comando Supre mo-Uffic io Operaz ioni , 11 capo di St ato Maggiore Generale A mbrosio al l' Ecc i l capo di S.M. R Esercito , all' Ecc il capo d i S .M . R. Marina , all'Ecc. il capo di S.M .R. Aeronautica , l - 10-1943.
69 Sa lv ato re Lo i , I rappor1i.fra Alleati e Italiani nella colle/li geranza, Stato Maggiore dell'Esercito , Ufficio storico , Roma , l 986, pp.22, 44-45.
70 A. U S S M.E., N. 1-11, Diari storici 2" Gu e rra mondiale, b.3056 , allegato n.798, " Partec ipaz ion e milit are italiana a lle operazion i" Co mand o Supremo, Ufficio Operazio ni, il capo di St ato Maggio re Generale Ambro sio, al Mini stero degli Affa ri Es teri , 21 -11-1 94 3.

Montezemolo e il Fron te Militare Clandestino
25
Sabrina Sgueglia dell a Marra
lanza a qualsiasi organismo, a nche a cos to di compro m etterne l 'effici enza e , come ha amaramente chiosato il generale Berardi, manca ndo del "senso della previsione", "trattavano g li uomini come chicchi di grano", sottoponendoli a "continue e deprimenti mort ificazioni". Gli i ngle si, in part ico lare, sembravan o perseguire l' unico intento di sfrutta r e l'esercit o italia no ese rcitandovi un controllo umiliante71
Al fine di soddisfare le pressanti richieste del Comando alleato e, seg natament e , di Eisen hower che giudicava inderogabi le la regolarizzazione d ello status in ternazionale dell'Ita lia , il governo Badogl io, non senza perplessità e temporeggiamenti, il 13 ottobre I 943 notificò la dichiarazione cl i guerra alla Germani a e, lo stesso giorno, ne diede l'annuncio ufficiale.
La not iz ia attesa è giunta - commentò neHe sue memorie Carlo Trabucco - la dichiarazione di guerra alla Germania è un fatto compiuto. Attesa e anc he temuta , perch é i tedesc hi ora premeranno di più la mano sugli invasi. Ma non v'è riscatto senza sacrific io e se si devono riscattare gli errori polit ici e militari degli ultimi an n i bisogna pas sare interamente sull'altra riva e mutare radicalmente direzion e 72
Con il medesimo proponimento , per ottenere una maggiore credibi l ità e s ment ire le accuse cli un 'eccess iva cautela ne l r imuovere g l i ufficial i compromessi col fascismo, si procedette all'epurazione de i capi militari maggionnente invis i agl i angloamerica ni: l' 11 novembre 1943, Roatta fu so llevato dalla carica di capo di Stato Maggiore; il nuovo titolare, Paolo Berardi , fu desig nato il 18 novembre. Inoltre, liberato da lla prigionia ad opera degli Alleati, i l generale Messe fu nominato Maresciallo d'Italia e, il 20 novembre, su proposta di Badoglio, divenne Capo di Stat o Maggiore Generale in sostituzion e di Ambrosia.

Tali misure , tuttavia, non bastarono a dissipare le profonde rise r ve sulla ten uta e sulla solidità ideo log ica dei mi litari italiani: ancora ad ottobre, il generale Taylor della Miss ione alleata di Br in disi, comunicò c he era previsto l'ingresso in linea di una sola u n ità, il Primo R aggruppamento Motorizzato7 3 ,
7 1 Paolo Be rard i , M emo rie di un capo di stato maggiore dell'esercito ( /943 -1945) , O.D .C . U.. 1954, pp.74 -75 , 123.
72 Carlo Trabucco , La prigionia di Roma. Diario dei 268 g iorni de/l ' occupazione tedesca , Boria, Torino , 1954. p 75.
73 A.U.S .S.M . E ., N.l - lJ, Diari s torici 2" Guerra mondiale, b.3056 , allegato n.798, " Panecipazione militare italiana alle operazioni" , Comando Supremo, Ufficio Operazio ni , il capo di Stato Maggiore GeneraleAmbrosio , al Mini s tero degli Affari Esteri , 21 - 11 - 1943 Per la storia de l Primo Raggruppamento Motorizzato cfr Giu se ppe Conti, Il Primo Ragg ruppamento Motoriz zato. Stato Maggiore dell'Ese rcito , Ufficio Storico, Roma , 1986.
26
dalla c ui prestazio ne in combattimento sa r ebb e dipesa la partecipazione d i a ltre divisioni ital iane 74 .
" L' azion e - h a scritto Bera rdi - fu veramente un esa me d ato d agli Alleati al va lore ita l ia no" 75 che dimostrò " la ferrea volo ntà dei soldati ital ian i di liberare la patria dal giogo naz ista fi no alla vittoria, com b attendo su d i u n terreno as pro e impervio" 76 •
Le Naz ioni Unite ap prezzaro no i n modo s ignificativo i risulta ti conseguiti da l Pri m o Raggruppamento Motorizzato 77 ne ll a battaglia di Monte L u ngo, un su ccesso per nulla scontato c ui si affidarono le speranze italia ne di addive n ire, fi nalmente , ad un'effettiva co bell igeranza.
Nonostante le po tenzialità di most rate e i reiterati tentat iv i d i se nsibilizzare g li angloamericani sull'affidabi li tà e la combattività delle nostre truppe , per lu ngo tempo, invero, fino alla primavera del 1944, il R aggruppamen t o , che dal 17 ap rile ass unse la d enomi naz ione d i Corpo I taliano d i Liberazione, sareb be rimasto l 'u nica unità combattente al loro fianco .
7 4 A.U.S S M.E., N.1 - 1 I, Diari storici 2" Guerra mondiale b.3053 , a llegato n. 1 110, " Impiego truppe ital iane", Stato Maggiore Reg io Ese rcito , Ufficio del capo di Staio Maggiore generale Roatta , a s ua Ecce llen za il capo di S.M Generale, 29 - 10-1943.
75 Paolo Berard i, op. cii., p.80 .

i 6 Agost ino degli Espinosa, op. cit., pp 253 -254
77 Per la storia del Primo Raggruppamen to Motorizzato cfr Giuseppe Conti, op cit.
Montezernolo e il Fron te Militare Clandestino
27

L'INIZIO DELLA RESISTENZA ROMANA E LA NASCITA DEL FRONTE MILITARE
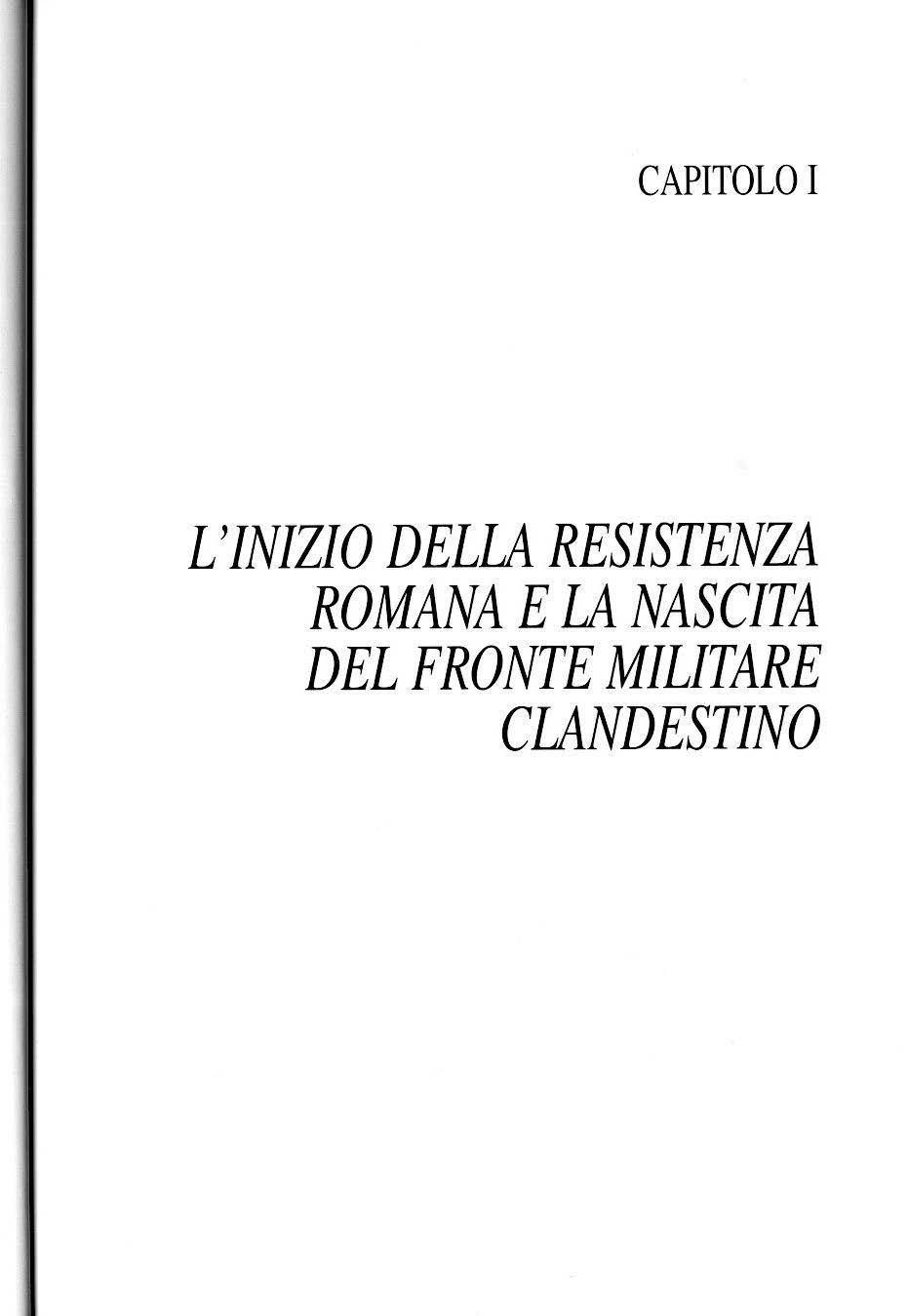
CAPITOLO I
CLANDESTINO

Vittor io Emanu ele III , il governo e il Coman d o Su pre mo, abban d onata Roma ancor prima di averne te nta to la difesa, s i trasferiro no in quello ch e divenne i l "Regno del Sud ", costituito dalle quattro prov in ce p ug li esi di Bari, Brindi s i, Lecce e Tara nto, non occupat e né dai tedeschi né dagli ang lo america ni e sottoposte all 'auto rità esclusiva della Corona7 8
Di fronte alla priorità di pro teggere e trarre in sa lvo il r e, dunq ue , la capitale ve nne sacrifica ta se bb e ne, come asserì un o de i fuggiaschi , Roatta, paventan do si un colpo di mano tedesco volto a sca lzare i l governo Badogl io imponendo ne u no fascista, fosse ro stat i a ppron tati piani di dife sa per la zo na di Rom a in cui l'emergenza ch e s i può definire "ge rmanica" era p reva lsa su que lla "angloamericana" 79 .
L'eccessiva apprensione per le sorti della ca pitale, come rilevò il generale Ross i s ti gmat izzando la strategia adottata , andò a detrimento de ll a necessità dì sa lvagua rdare il resto del territ orio e g li scacchi eri oltre front iera80

I n assenza di un coordinamento a livello s upe rio re, tra le inc ertezze delle autorit à civi l i e mil itari, la difesa di Roma, co me ha chiosato Enzo Cat aldi , " finì co n l 'essere solt an to l ' azio ne generosa d i coloro, dei pochi, che, lasciati a llo sbarag lio, vollero essi solo per loro determin az io ne e per loro virtù combattere quella che res ta davvero nella sto ria d'Italia la loro battaglia, nel più alto senso dell'o no re, nel più genuino amore d i Patria'' 81 .
78 Il " Regno del Sud" non rientrava nel territorio sogge tt o a ll 'a utorità dell ' AMG OT, l' All ied Mi litary G overnmen t Oc c upied Te rritory Il 19 sette mbre gli Angloamerica n i stab iliron o che le quattro province rim anessero sotto l' ammin istrazione d el governo Badoglio che tutt av ia non fu mai pienamente sovrano poi ché so ttopo sto ali' ACC , l' Allied Co ntrol Co mmission; cfr. Giorgio Gia nnin i, Lotta per la libertà Resistenza a Roma 1943 - /944 , Edizioni Assoc iate, Roma , 2000 , p.41
7 9 A .U.S.S.M.E., N. I .J 1, Diari swrici 2a Gu e rra mondiale. b.2997/A, cart.3 , " Tre relazio ni del generale Roatta", f IO, "Memo ria s ull a di fesa di Roma" .
8°Fra ncesco Ro ssi, op. cit , p.16 8.
81 Enzo Cataldi, ÙI difesa di Roma, in La difesa di Roma e i Granatieri di Sardegna nel set· rembre 1943, a cura de ll o S tato Maggiore dell'E sercito, Ufficio storico, Roma , 1993, p.23 I.
1. La difesa di Roma e il Comando della città aperta
Sabrina Sgueglia della Marra
Ambrosio e B adoglio, aus pi ca nd o di addiven ire ad una s o lu zion e dip lomatica c he potesse ri s parmiare Roma d a lle nefaste co nseguenze di un a ba ttagl ia e nt ro le s ue m u ra. affi daro no "se mplicem e nte" la difesa della capitale a ll a pub bl ica dichiarazio ne de l s uo status di città a perta82 li governo de l Sud aveva notifi cato fin dal 31 lu g lio , tramite la Sa nta Sede, la determin azio ne di proclamare Rom a città aperta- com ' era s ta to fatto per Atene e s' int endeva fare per Il Cairo - ed attese a lu ngo di ricevere comunicazioni in merito al r iconosc imento ufficial e de ll o sta to di imm uni tà. Il Vat icano av e va da tempo avviato una serrata attiv ità dipl o m atica tesa a preservare l'Urbe da bo mbardamenti e devas tazioni , inten sificando i propri sforz i qu a ndo, conc luse le operaz ioni be lliche in Afii ca, l'attacco a lla peni sola se mbrava ormai in ev itabile. n 17 maggio 1943 furono lan c iati s u Ro ma manifestini c he min acc iavano la " coventrizzaz ione" dell ' Italia se non avesse accettato la capi tolazione.
Nei "qu aran tac inqu e g iorni", g li Stati Unit i s i dichiararono in linea di principi o favorevoli, m a si rimi se ro , di fat to , al gi udizio di Londra.
La Gran Bretagna di ffidava del go ve rno italia no e nutriva un forte sen timento di rivalsa nei confro nti de l no s tro paese. R ivendi cava, pertanto, una piena li be rtà d 'azio ne , ta nto più c he i b o mbard amenti e rano con si derati un ir repugnabile s trumento di pressio ne pe r cos trin ge re il ne mi co a deporre le armi . Sin dal 1941, Churc hill aveva affermato dinanzi ai Comuni ch e, pe r g iungere a d u na rapida co nclu s ione d e l co nflitto , se le es igenz e bellich e lo avessero ri c hi esto , Roma sarebbe s tata colp ita se n za esitazioni.
l1 5 agosto, le is tanze i1.a)jane vennero respinte dallo Stato M aggiore de ll e forze arm ate alleate . La g iu s tific az ione add otta fu c he l'opinione pubblica inglese ed europea non avr e bbero approva to un trattame nto di fa vore nei ri guard i de l1' [ta li a fascista. Badoglio, du nqu e, a l fine di pres e rvare quanto più po ssibi le il territorio urban o bombardato per la prima vol ta il 19 luglio e, nu ovamente, il 12 agosto , du e gi orn i dopo, il 14, procedette u nilat e ra lmente alla fonna le proc lamaz ion e cl i Rom a c ittà ape rta83 Ta le pro vvedime nt o palesò imm ed iatamente la s ua inefficac ia: come reg istrò il mini s tro d eg li Este ri Guari g li a ne ll e sue memorie, si assiste tte prop ri o in quelle settimane, all ' in quietante di scesa della cosidde tta "quinta co lonna" germanica c he il ca po de lJ a polizia Senise, verso la fine dell'ago to 1943, c on un ap pos ito cens im ento, stimò ammontare a c irca se imi -
K2 A.U .S.S. M. E.. N. I - I I , Diari storiri 2° Guerra m ondiale. b.3000/A, " Gi aco mo Carbo ni, ge neral e d i Co rp o d 'A rmata -La verità s ulla difesa di Rom a (8-10 se ttembre 1943)" .
83 Alberto Ben zoni -E li sa Ben10ni. Attentato e rappresaglia. li PCI e via Rase/la, Ma rsilio, Venezia 1999, pp .27-30; Gi org io G iannin i, Lotta per la libertà. Resis tenza a Roma / 9431944, Edi z io ni A ssoc iate, Rom a. 2000. p. 17; Albe rto Gi ova nn e tti , R oma città ape rt a. A ncora. Milano. 1962. pp 10- 11.

32
la te deschi s ta bili tisi nella cap it~ùe gradu alme nte e "se nza dare ne ll 'occhio".
Alla richiesta d i sp ieg az io ni in me ri to a ll a prog ressiva calata teuto nica, l ' ambasciata ger ma ni ca ri s pose con una nota uffici a le in c u i s i p retendeva l 'assol uta rego lar ità della ci rco lazione d i soldati tedeschi in uniforme per le strade ro mane in qu a n to trattavas i di ri servisti dell e tru ppe precede ntemen te d islocate in Ita1ia e c he allo ra e ran o stati equipaggiati a nuo vo 84
Le prime m is ure atte aJla d ifesa della capitale fu rono predi sposte d a ll o Stato M aggio r e il 15 agos to, a l convegn o di Casal ecc hi o . L e div is ioni " R e" e " Lup i di Tosca na", ri ti rat e ris p ettivamente d a ll a Cor s ica e d a ll a Francia, a ncorché destina te a ll a P ug li a, sa reb bero d ov ute affl uire con la massimace lerità consen tit a nella zona di R o ma 85 per so stit uire le divis ion i " P iave" ed "Ariete" ;86 analogamen te, il X VIII R egg im e nto bersaglieri fu s torna to d alla Sardegna e diretto ve rso ]a c ittà e t erna.
I movim e n ti fe rrov iari, tuttavia, in iz iati con notevo le ri tard o, conse ntirono so lo a pochi e le menti d i ragg iu ngere R o m a per 1'8 settembre87 I provved ime nti s t abi liti furo no notificat i a ll a G e rm ania add ucen d o c o me giu stificazio ne l'im poss ibi l ità, pe r le due division i d i fan teria e il reggimento , d i proseg uire ver so su d se non con un ri tmo le n tissimo e con grave pregiud izio d egli in dispe nsabi li trasporti d e i ri fornimen ti . I: Oberbefehlshaber Sudwest
(O B S, Comando Su premo d e l Sud), pave nta ndo u no sbarco a ll eato su ll e coste d el L az io, d iede il proprio assenso e si offrì d i fo rn ire il car bura nte necessa rio a ll a marcia d ella "Piave" .
Lo Stato Magg iore affidò la p ro t ez ione de ll a c ittà a l Coma ndo del Corpo d'Armata di Roma. L a d ifesa es terna fissa fu asseg nata a l Comando del XVII ° Corp o d 'Armat a che s i sa reb be dovu to dis locare a Ve ll etri, e alle divisio ni "Gra na ti e ri ", " Pi ace nza", " Re" e " Lu pi di Tosca n a", no nché ad un gruppo tattico d e ll a "Sassa ri " e, s ulle posiz ioni avanzate, ali "'Ariete" e alla division e au tot ras po rta bi le " P iacen za"; a ll a di fesa m obile avreb be provvedu to il Comando de l Corp o d'A rm ata motocorazzato c on la d ivisione motor izzata '' Piave" e le d iv is ioni corazzate "Ariete" e "Ce ntau ro "
Attraverso ta le d ispositivo che, se le interruzioni fe rroviar ie lo avessero consent ito , sareb be stat o completa to presumibilme nte ne ll a notte del 12 settem bre,
84 Raffaele Guarigl ia , Ricordi 1922 - 1946, Edizioni Scient ifiche lrn lia ne, Napol i, 1950, pp.652 -653
85 Mi ni stero della Difes a, Stato Maggiore dell'Ese rcito, Uffic io storico. Le opera z ioni d elle unità italian e n el s etr embre -ottobre 1943, Ro m a, l 975, pp.8 1-82 .

86 A . U.S.S.M.E . , N.1 - 11 , Diari s tori ci 2" Guerra mondiale , b.2997/A, f.3 . "Tre relazioni del generale Roatta", sottof. 1O, "Memoria s ulla Dife sa di Roma " .
87 Ministero della Di fesa, Stato Maggiore dell' Esercito, Ufficio storico, op. cit , pp 8 1- 82
Mon tezemolo e il Fronte Militare Clandestino
33
Sabrina Sgueg lia della Marra
la cap ital e avrebbe potuto co ntare su un a "massa di man ovra", p rima ines is te nt e, da impiegare co ntro le forze germanich e e al fianco di quelle angloamericane in arrivo88 . In realtà , co me ha ev idenziato Mari o Torsiell o, l ' impostazio ne delle operaz io ni, che non av e va s ubito rilevanti modifich e né gli opportu ni agg iornamenti , p rospettava u no schieramento di truppe sos tanzialmente anal ogo a que ll o c he era s ta to elaborato in una s itu azione del tutto di versa e in previsione di un a ltro ne mico89 L'o rganizzaz io ne log is ti ca, di co nseguenza, non era adatta a fro ntegg ia re i tedeschi poiché concepita in fun z ion e antii ngl e se, co n depos iti settoriali a porcata dell e truppe cos ti e r e e de positi inte rni per i re parti mobi li des tinati a ri nforza rl e in cas o di attacco a ll eato90. Elemento negat ivo co mun e a tutte le di v is ioni pre po s te a ll a difesa, peralt ro, e ra l a defic ienza di m un izio nam ento co ntrocarro in confro nt o a d un ne mko che s ui mezzi co razzati e s ulla m ob ilità ba sav a la propria pote nza. S e, mal gra do ciò, lo s pirit o delle truppe s i mantenne alto, graz ie a lle tradizioni. a l co nflitt o mo ndi a l e o norevo l me nte co mbattuto , a lla coes io ne e a ll ' inquadrame nto91, è tuttavia in negabi le che, all ' intern o d e i rep arti it aliani a lligna sse la radicata co nvinzione dell ' invincibilità germa ni ca92 : nei tre anni di gue rra, in fatti , l 'es a ltazi one della sc hia ccian te s u periorità tecnica de ll ' alleato aveva prodotto la se nsaz ione dc li ' impo ss ibilità d i affrontare i ted esc hi con qu a lc he sp e r a nza di successo93 .
Obiettivo precipu o de l piano mil itare, imperni a to s ull a dislocaz ione di divi s io ni a sso lutamente inadeguate alla g rave in com benza, a presidio di tutte le vie d'access o alla c ittà , era la tute la delle mass ime is titu zi oni. In realtà, come ha a ffe r mato Ca ta ldi , i cos iddetti "ca pi sald i" che cos titui vano la cintura di s icurezza, altro non erano se non s barramenti stradali , p ri vi de i necessar i reticolati di protez ione e so lo in parte c ircond a ti da zone min ate. A compromettere u lteriormen te la so lidità e l ' efficacia de lla lin ea difens iva e retta, furono la p os izione geog rafica di Rom a, i num eros i aggl o merati urbani che la c irco ndav a no e l ' assenza di profondit à nel settore me ridionale a causa de ll a p rossimità della costa tirrenica94 . l tede sch i, ancorché per s uas i che prima o poi sa rebbe so pra ggiu nta la
88 A .U .S.S.M.E., N.1 -1 i. Diari 2" Guerra numdinle. b.2997/A. f.3, ' "Tre relazioni d e l gene rale Roa tla", sotto f. IO, " Me mo ria sull a difesa di Roma"
89 Mario TorsieJlo. op. cii p. I 67.
90 Francesco Rossi, op. cit pp.183-184.
91 Mario Torsi e li o, op. cir p. 157, 161.

92 Ferru cc io Parri. Dalla Res is1enw alla Repubhlica, a lla Cos 1it11 zio11e. in Fascismo e antifascismo. Le::.i<mi e 1es1i111011ia11:e Feltrinelli , Milan o, 1962. p.612.
93 Francesco Ro~ si, op. cii pp 272-273.
94 Enzo Cata ldi. np c ii. , pp. 96, 107-108, 2 15.
34
defezione italiana, nella notte tra 1' 8 e il 9 settembre apparvero sorpresi e disorientati : l'ambasciata germanica bruciò i suoi archivi, al personale venne ord in ato di pa1ti re e s i predi spose il success ivo a ll ontanamento dei civili Veros imi l me nte, fu presa in con s iderazione l'eventualità di dover abbandonare la c ittà. Le autorità teutonic he erano in atte sa di uno sbarco alleato e, se questo fosse avvenuto ne i pre ss i della capitale, le truppe german iche avrebb ero pres umibilment e seg uito le dire ttive s upe ri or i di defl u ire verso il n ord 95 Numeros e testimoni a n ze ha nno accreditato ta le ipote si : Enzo Forcella, ad esempio , ha affermato che a villa Wo lkon s ky , dopo u na rap ida cons ul taz ione, si conv en ne che l 'unica s olu zion e fosse la fuga. Otte nuto il nulla osta di Berlino , vennero selezionati i documenti da portare via e quell i da d istruggere perché non ne fosse propa lato il contenuto. Il no s tro governo mise a dispos izio ne un treno speciale ch e sarebbe partito dalla st a zio ne Termini alle tre de l mattino. Solo Kappler, contravvenendo ag li ordi ni ricevuti di ripiegare in Germania, si trasferì a l q uartier generale di Kesselring96. Il fe ld maresciallo, nelle sue memorie, ha raccontato c he il 9 set te mb re fu info rma to da un ufficia le d i div is ione ital ia no, "un vecchio fascista", c h e le nostre truppe non avreb bero opposto alcuna resistenza e c h e erano pronte ad iniziare le trattative di re s a97 Se dapprima, du nque, Ke ss elring aveva disposto l' immediato ritiro verso Sud , me ntre altr i comandi d ist accati s i muovev a no fre ttolosamente di propri a iniziativa ver so Nord, le scars e possib il ità difen si ve delle forz e italiane, acclarate da i p ri mi rappo rti consegnatigl i, lo deci sero a ma ntenere le posizioni acquisite ne l1a capitale 98 .
Lo sconcerto e la concitazione dell ' OBS, dunque, duraro n o assai poco : giunta la not izia dell 'avvenuto sbarco a Salerno, Kesselr ing dedusse che, qua s i certamente, non ne sare bbe seg uito un altro s ul litorale laziale e che, in assenza d i un piano italo-alleato per un'azione com une nella regione , Roma sarebbe stata abbando nata a se stessa99 . Il feldmaresciallo non emanò di sposizio n i sc ritte sotto l 'as petto tattico, ma si li mitò a colloqui per so na li coi comandanti che avrebb e ro dov uto appl icarJe 100 : le division i tedesc he, c he poteva no contar e su dodic im i la uo min i pro n ti a d ag ire da s e ttimane d a ll e basi attorno alla capitale , acquartierati a Nettu no, Lad is poli, s ui Coll i Alba n i e s ui Castelli Roma ni, e in posizioni strategiche per controllare le vi e Cass ia e
9 5 Enzo Pisci te lli, op cii. , pp .46-47.

96 Enzo Forcella, La resislenza in conven lo , Einaudi, Torino, 1999, pp 8 -9.
97 Albert Kesse rlin g , M emorie di guerra, Garza nti , Milano, 1954, p 203
98 Pao lo Monelli. op cit pp 268-269
9 9 A U S S M .E., N. I - I I Dia ri 2° Guerra mondiale, b 2997/A, f.3, "T re relazioni del generale Roaua··, sottof.10 , " Me moria su l la difesa di Rom a" .
100 M ario To rsie llo , op.cii., p.181.
Montezemolo e il Fronte Mi litare Clandestino
35
Sabrina Sgueglia della Marra
Nomentana, non si concentrarono su ll a co s ta ma poterono proceder e liberamente all'offensiva contro la città eterna 101 •
Il generaJe Rossi , di contro, richiaman do alla memo ri a la tenacia d imostrata da Kesse lr in g nell'oppo rsi con tutte le fo rze all'abban d ono della Li bia, tene ndo testa a Rommel, ha categoricamente escluso che l'a lto ufficiale tedesco potess e aver preso in considerazione i l ripiegamento. A suo parere, infatti , i l feld maresciallo concepì l' idea milita r mente ineccepibi le d i stornare le truppe dalla città al li torale avviandole a fronteggiare lo sbar co che, log icamente, prevedeva si sa rebbe verificato nei dintorn i di Roma, ma non p ens ò affatto d i ri tirars i a Nord 102

Sepp ur nell 'impossibi lità di valuta re co n esattezza la concentrazione d elle forze tedesch e nella cap itale, lo Stato Maggiore ita lia no , come ris ul ta da ll' ordine impartito al Corpo d'Armata Motocor azzato i l 9 s ettembre alle o re 5: 15, esc luse "una lunga resistenza delle truppe di s locate attorno alla capita le" poiché av reb be espos t o la città e la cittadinanza a "gravi e sterili perd ite". TI comando del Corpo d'Armata Mo tocorazzato, pertanto, av rebbe dovuto r ipiegare rap idamente ve rso Tivoli seg uito, con la mas s ima cele rità, dalle d ivis ioni "Ariete" e "Piave", orientandos i a p roseguire verso est. Sarebbero rimas ti nella capi tale per provvedere al mantenimento dell'ordi ne p ubb li co i soli reparti dei carabinieri e della Pubblica Sicurezza prese nti 103
Secondo la minuziosa ricost ruz ione del generale Carbon i , Roatta , assegnatogli i l co m ando, gli as s icurò che s i sarebbero ri vis ti a T ivo li in s ieme ad Ambrosio e che av rebbe trovato gli ord in i successiv i presso la case r ma dei CC. RR . Hl4_ Carbon i, pur essen d o rimasto l 'u ni co alto ufficiale responsabile d e lla difesa di Ro m a, mentre in c ittà divam pavano i co m ba ttimenti, fu per molte ore irreperibile 105
'°1 A . U.S.S.M . E., N. l-1 / , Diari 2°Guerra mondiale , b.2997/A , f.3, " Tre rela zioni del generale Roatta", sottof.10, "Memoria s ulla d ifesa di Roma"
102 Francesco Ross i, op cit Garzan t i, Milano, 1946, pp 240-241.
103 A.U.S.S.M .E., N. / - 1 /, Diari 2acue rra rnondiale , b.2999 , doc.51 , "Ordine dello S.M.R.E. al Corpo d 'A rmata Motocorazzato in data 9 settembre 1943-ore 5 , 15 -firmato Gen. De Stefani s", Stato Magg iore Regio Ese rcito al Comando d e l Corpo d 'Annata Moiocorazzato e, per conoscenza, al Comando Corpo d ' Armata di Roma , 9-9 - 1943
104 A U.S.S M.E , N.l-11, Diari storici 2"Cuerra mondiale , b.3000/A , " Gia como Carboni, generale di Corpo d ' Armata -La verità s ulla difes a di Roma (8- I O senembre 1943)".
105 Il generale Carboni ha moti vato in una dettag li ata relazione le rag ion i d ella s ua pres unta irreperibil ità al fine di co nfutare le accu se mosseg li: l 'a lto ufficial e ha asse rito che non trovò traccia né d eg li ordini né dell'Alto Comando e che, malgrado le s ue in sistenze, Roatta affermò che Roma s i trovava in trappola e che pertanto s i sare bbe do vuta ev itare un a res istenza inutile; cfr A. U .S.S.M . E ., N. l-J I , Diari storic i 2a Gu e rra mondiale, b.3000/A , "Giacomo Carboni , generale di Corpo d'Armata - La ve rità sulla difesa di Roma (8-10 settembre 1943)"
36
La part e nza d i Roana, dunq ue, impresse una forte acce lerazione al processo involutivo c h e stava travolgendo il s istema di coman do 106 , u no sfaldamento inarrestabi le prodotto dall a comp leta latitanza d e i poteri ist ituzio na li.
Come ha ammesso i l generale, infatti, ne l viaggio di trasferi me nto a Brindisi, ove il corteo giunse nel pomeriggio del l O settembre, n on fu possi bi le comunicare coi Comandi d ipend enti né averne no ti zie 107 Lo Stato Maggiore , dunque, allo nta nandosi da lla capitale , non so lo derogò alla propria funz ione di rettiva e di coordinamento ma, poiché non era stata predisposta una sede d'emergenza , non ebbe neanche l'accort ezza di portarsi in località ove si potessero tras mettere ord in i alle u n ità perife ri c he .
Alle ore 10 de l 9 sette m bre, il M a r esciallo d' Ital ia Enrico Caviglia , affiancato dal min istro della Guerra, genera le An to ni o Sorice, assunse provvisoriamente le fu nzion i di governo e des ignò il generale Vittorio Sog no capo di Stato Maggiore d ell'E se rcito ad in terim
Il co n cor so de ll e fo r ze alleate all a di fesa de ll a cap ita le s i sarebbe dov u to concretare ne ll ' operazione Giarzt 2, attraverso l'impiego d i u na div isio ne aviotrasportata americana , 1'82a "Airbone", che sarebbe s barcata i n tre aeroporti nell'arco di quattro notti , una volta comp letata l ' operazio n e Avalanche, lo s barco nel golfo di Salerno.
L' 8 settembre , tuttavia , la divi si one aviotrasportata ricevette il contrordine per il lancio s u ll a ci ttà 108 .
Seco ndo la test imonianza del generale Carboni, la sera del 7 settembre il ge ne rale Tay lor, v icecoma nda nte de ll '82a "Ai rbone", arr ivò a Roma ass ie me al colo nnello Gard iner per com unicare che, in vi sta dell'annunc io de ll' a1mistizio e dello sbarco alleato a Salerno, la sua d iv isione paracadut is ti sarebbe stata messa a d isposizio ne del Comandante del Co rpo Motoco razzato se q uesto avesse garantito la difesa dei ti-e aeroporti in mano tedesca Ambrosie si trovava al lora a Torino e Rossi non si sentì autorizzato a prendere iniziative in sua assenza.
I due u fficiali americani furono così ricevuti da Carboni. Questi, constatata la lo ro scarsa conoscenza cieli.a si tuazione in cui versavano le nostre forze armate, ne inferì che i l generale Castellano, d urante le trattative , non avesse provveduto ad e ru d irli adeguatamente in merito. Spettò, dunque, a Carboni, informarli del!' asso luta impreparaz ione dell'eserc ito italiano a soste nere l 'ass alto tedesco e, dopo aver illumi nato il ge nerale americrn10 s ui vantaggi che, anche per le Nazio-
106 Carlo Vallauri, op. cit. , pp.67 -69.

107 A. U .S .S . M .E. , N.1-11 . Diari sto rici 2a Gu e rra mondiale. b.3000/A, doc. 44, "Ordini emanati dallo Stato Maggiore R. Ese rcito circa il contegno da tene re di fronte ad una eventuale aggressione germanica", " Memoria Generale Roatta " .
108 Mario Tors iello. op.cit pp.97-99.
Montezemolo
e il Fronte Militare Clandestino
37
Sabrina Sgueglia della Marra
n i Uni te, sarebbero d e r ivati dal la proroga della p roclamazione di. re s a , confidando ch e Taylo r avrebbe inte rced uto in nostro favore presso E isenhower, lo accompagnò a ll a vill a di Badog lio. Dopo un breve, dramm at ico c o ll oq uio , il capo del governo inv iò un teleg ram ma al Comando alleato in c ui , ri bad e ndo la fenna intenzione di co nco rrere a ll o sfo rzo bellic o, o biett ò l' in at tuabili tà dell ' aviosbarco e richiese di procrasti nare il comunicato ufficiale a l 12 settembre pe r conse nt ire un p iù agevo le svo lg ime nt o de Ue o pe razioni 109 •
Roatta ha ind ividuato nell' o rdine ame r icano re la ti vo a ll a di v is ion e paracadutis t i, di c ui r icevette una co pia trad otta il 6 settembre , l' unico dato conc reto d e ll ' a z io ne all eata co n ne ssa alle tratta ti ve d i resa c he sia mai pe r ven uto a ll o Stato Maggi o re e, vero s imilmente, al C o m a ndo Supre mo ' 10 • L'o perazione non po té esse re e ffet tu a ta poich é gl i Alleati pretesero c he i l no st ro e serc ito , cui n o n concessero i l te m po minim o occo rre nte pe r com pl etare il d is pos itivo di difesa, assumesse l'iniziativa contro le forze germaniche, bl occ ando i l fu oco an ti ae reo e sferr a ndo un 'o ffe n siva volta alla l ibera z ione e al pre s idi o de i tre campi d ' aviazione oc c upa ti 111 •
D a parte ita li ana , in ve ro , non s i giud icava imp oss ibi le pro te gge re la di visio ne " Airbone" front egg iando la seconda e la terza divisione tede sca, ma s i ecc e piva c he, pe r a sso lve re t a le co m ple sso com pito, sar ebbe sta to neces sario a tte nd e r e l 'arrivo di r inforzi. D ispo ne nd o d e l C orpo d'Armata M o tocorazzato, ido neo a ll a man ov ra , s i sa rebbe potuto con tenere l ' a ttacco te de sco e garantire un co ncre to s ostegno a ll ' o p eraz ione Giant 2 . li Comando angloame ri ca no , tuttav ia , progettò l ' invio d e ll "'Airbon e" com e se l ' Ital ia avesse godu to de ll a pi ù a m pia l ibertà d ' azio ne, se nza ponderare in modo co ngru o l 'e ntità d elle forze ne m iche. Seco ndo Tors iello , tu tto ciò in durrebbe a s u pporre che il co ncorso delle forz e a lleate fosse stato offerto co n la co ns apevolezza c he non sarebbe st a to po ss ibi le accettarlo' 12 Ta le interpretazio ne è condivi s a a nche da Batta g lia che, a lla luce di un 'a pp ro fo nd ita a na lisi d e ll a situazio ne d i Roma, ha sos te nuto l ' irrea lizz ab ilità de ll e co ndizi oni tecnico-milit ari fo rm ulate ed im pos te dagl i an g loamer icani 11 3
1® A.U.S.S.M.E .. N./ - 1/ , Diari storici 2° Guerra mondiale, b.3000/A, ··Giacomo Carboni. ge nerale di Corpo d 'Armata-La ve ri tà s u ll a di fesa di Roma (8 -10 settembre 1943) La vers io ne d i C arbo ni è co nfermata da Ivan Palerm o il qua le affer ma che il co lloqui o tra C arboni e Tay lor cui assistette il so lo Gardin er. ven ne trascrino esclusivamente da Carboni (cfr. I van Palermo. op. cit pp . 198-199). Pi etro Badoglio, op. cit , pp . 103- 104.
110 A.U.S.S.M .E., N. / - //, Diari storic i 2° Gu erra m ondiale, b.2997/A , ca rt.3 , "Tre re lazio ni del ge nera le R oa na" . f. IO . M emoria s ulla difesa di Rom a".
11 1 Gilbert Alan Shepperd. Lo campagna d' Italia, Garzanti. Milano. 1970. pp.135-136.
112 Mario Tors iello , op cit pp.99-11 8.
113 Ro be rto Battagl ia, op. cit. , p .88 , n I.

38
Con le es igue fo rze di s ponib ili , infatti , assicurarsi il dominio di tutti g l i aeroporti sarebbe stato im pensabi le: il capo di Stato Maggiore dell ' aeronautica calcolò che per eseguire tutti i provvedimenti postulati sarebbero stat i necessari sette giorni, ovvero dal 5 al 12 set tembre 114 .
Roberto Ciumi, al contrario, ha opinato che i generali italiani decisero d i arrendersi e di ricusare il progetto di un 'azio ne co nce1tata con gli Alleati poiché atterriti dal confronto con l 'ese rci to ne m ico di cui , tuttavia, s ovrastimavano le poten zialità offensive sottoval utando, co nseguentemente , le proprie 115 .
Il generale Rossi , pur non sminuendo il con tributo che 1'82a "Airbone" avrebbe potuto arrecare alla difesa della capitale, ha forteme nt e ridi men s ionato le riperc ussio ni del s uo mancato afflusso: l'aviosbarco non s i sarebbe dovuto effett uare la sera dell ' 8 settem bre in quanto le condiz ioni tecniche r ichieste no n erano state soddisfatte. Il contesto operativo e lo gistico no n era favo revo le e gl i acco rdi non erano s tati adeguatamente definiti. L e probabilità di s uccesso della Giant 2 risultavano pressoché nulle e, se la div is ione fosse stata catturata o distrutta , l'Italia sarebbe s t ata accusata di tradimento1 16 . Anche secondo il gene rale Zan uss i, il des tino di Roma appariva irrimediabilmente compromesso. Tuttavia, egli ha voluto sottolineare c h e, se effettivamente, l'esercito italiano, nelle con di zio ni in cui fu posto tra 1'8 e il 9 settembre, sarebbe andato incontro ad u n 'ennesima disfatta, avrebbe potuto e dovuto batters i ugua lm ente . Zanu ss i, pur non rinnegan do il fondamento oggettivo della remiss ività e dell ' arren devolezza delle gerarchie militari, ne ha deplorato 1' incapacità di rendersi conto c he, "anche s enza s peran za di success o, occorreva combauere"' 17 , come fecero coraggiosamente numeros i ufficiali e solda ti c he contin uarono a compiere il proprio dovere nonostan te la totale vacanza del potere militare dello Stato Maggio re e del comando della difesa di Roma.
Militari , squadre di operai , civi li organizzati dai dirige nti dei vari partiti di sinis tra come Baldazzi e Lussu pe r gli azionisti , Longo e Trom badori per i comunisti , Pertini e Li zza dri per i soc ialisti , si scontrarono eroicamente con le preponderanti forze tedesche 118
Tra i molteplici episodi che portarono alla d iss oluzione dell'esercit o , De Felice ha a ttribuito alla vicenda romana una posizione d i ri lievo, una s ingo-
114 F rance sco Rossi , op. cit .. p .2 I 9 . 244.
115 Rob erto Ciumi , L'Italia di Badoglio , Ri zzo li , Mi lano , 1993 , pp.39 -4 0.
116Franc esco Ros si , op. cii. , pp.240 , 247-248.
117 Gi acomo Zanussi, Guerra e cawstrofe d'Italia, Casa editric e li brar ia Corso, Roma , 1945 , pp .236-239.
118 Enzo Pi sc it elli , op c ii p.60.

Montezemolo e il Fro nte Militare Clandestino
39
Sabrina Sgueglia della Marra
lari tà ascrivi bil e no n allo squi lib ri o de ll e forze c h e si fron teggiaro no, bensì al fatto che, d u rante la difesa della capitale e nella fase s uccessiva del Comand o della c ittà aperta, "eb bero parte no n solo militari sfiduciati , politicanti senza principi, preoccupati solo della prop ria sorte , ma a nc he figure di tutto rispetto e fedeli monarchici" c h e, invece di eclissarsi e di porsi al riparo, non si sottrassero alle proprie resp o n sab ilit à e s i a d operarono per ges tire la si tuazio ne ne l modo ch e rite nnero più opportuno, s alvaguardando come meglio poterono la popo lazio ne e , per quanto possibile, "q uella c he a loro sembr ava dover esse re l'immagine di un esercito che tra i s uoi valori a n noverava ancora in qua lc h e mi s ura a nche quello d ell'onore" ' 19
Non s i trattò d i un'unica battaglia se nza soluzio ne di continuità: g l i attacchi tedeschi , sfe rrati a pi ù rip r ese , venn ero d apprima co ntenuti nel perimetro dife ns ivo pre di s posto attorno alla città, poi dilagarono all ' interno e si concentrar ono in varie zone della capi tale i20 , come alla M agliana, al l 'EU R , alla Cecchignola, lun go la via Ostiense.
I Granatieri di Sar degna, co n l'apporto dei La nci e ri di Mont ebe llo , furono di sloca ti a presidio del setto re meridio n a le della città ove, la sera dell '8 settem bre, dal caposa ld o n.5 che s b arrava la v ia O stiense, fu esp loso il p ri mo colpo d 'a rma da fuoco della zona su d . Ess i si opposero s trenuamente alla seconda divi s ione germanica di pa racadutisti e subiro n o ingenti pe rdite . N uclei di c ivi l i accorsero pe r s upportare i so ld ati nel t en t ativo di bloccare la strada ai tedesc hi diretti a Porta San P aolo, o ve s i era attestato il fronte res istenziale. Gli ultimi scontri si registrarono a Porta San G iovann i e alla stazio ne Termini 121 •
Paolo Mone ll i ha descritto i combatti me nti mettendo in luce la ge nerosità ed i l coragg io di co loro che si ba tterono pe r difend ere la capit ale:
Chi era s tato la matt ina fuori porta San P ao lo aveva potuto sperare ancora nel miracolo, che Roma av rebbe tenuto lontano il nuovo ed antico nemico. Nei pre ssi della basilica si respirava un'a ri a d i quarantotto , di repub bl ica romana, bo rghesi am1ati e an i mo si, operai, artisti , studen ti, m.ischiat i a so ldati di gran cuore 122
B attagl ia ha posto l'acce nt o sull' immediata e spontanea fusione prodottas i fra esercito e popolo , "raggiunt a di slancio d opo che tutta la con dotta del
119 Renzo De Felice, Mussolini l'alleato. La guerra civile /943-1945, Einaudi , Torino, 1998, pp.85 -8 6.
120 Carlo Vallauri , op. cit., p .69 .
12 1 Enzo Pi scitclli, op cit., pp.58 -6 1; Enzo Cataldi , op. cii , pp.100- I OI , 129-1 32.
122 Paolo Monelli , op . cii., p. 181.

40
governo Badoglio e il modo stesso in cui fu trattato l'armistizio aveva mirato a mantenerli sciss i e divisi" 123 .
Mentre crollava il potere che aveva condotto il paese alla rov in a, alc un i lu ngimiranti uomini politici compresero, come ha affermato Ame ndola, c he la difesa della capitale avrebbe segnato so lo l'iniz io di una lunga lotta c he popolo ed esercito, " u niti s u una piattaforma patriottica per l'indipendenza e la libert à", avrebbero dovuto intraprendere assieme 124
Il Comitato delle oppos iz ion i antifasciste , nell a riu n ione del 9 Settembre, sotto la preside nza di l vanoe B o nomi, assunse la denominazione, suggerita da Ruini e poi adottata nel resto d ' Italia, di "Comitato d i L iberazione Nazionale" , mass im o organo della Res iste nza romana al fianco della Giunta Militare Centrale. Lun gi dal rappresentare una mera formalità, tal e mutamento sanzionò la rivendicazione del CLN di avocare a sé, di coordinare e di dirigere il mov im ento di liberazione nazionale 125 Lo componevano Mauro Scoccimarro, Giorgio Amendola e Giovanni Roveda per il Par tito Comunista, Alcide De Gasperi, Giovanni Gronchi e Giuseppe Spataro per la Democrazia Cristiana, Pietro Nenni, Giuseppe Romita e Sandro Pertini per il Partito Socìalista di Unità proletaria , Ugo La Malfa e Sergio Fenoaltea per il Partito d'azione, Alessandro Casati e Leone Catta n i pe r il Partito Lib era le , M ario Cevolotto, Meuccio Ruini e Giovanni Persico per il Partito Democratico del L avoro.
La Giunta Militare Ce ntrale fu costituita da Sergio Fenoaltea e Riccardo Bauer del Partito d'Azione , Giorgio Am e ndola e Celeste Negarville del Partito Comunista, Giuse ppe Spataro ed Ercole Chiri della Democrazia Cristiana, Mario Cevolotto della Democrazia del Lavoro , Sandro Pertini ed Eugenio Colorni del Partito Socialista, Manlio Bros io del Partito Liberale. Tali organi tuttavia, non ebbero sempre la stessa composizione poiché alcuni membri vennero aJTestat i, mentre altri , identificati, furono costretti a nascondersi e, a far perdere le loro tracce o ricevettero incarichi diversi da i partiti c he rappresentava no.
Il CLN, nell 'unico numero del giornale Il lavoro · italiano, a s uggello del carattere democratico della Resistenza, rivolse un appe ll o a l popolo italiano perché s i mobilitas se e pa,tecipasse attivamente alla lotta 126 : come ha ch iosato Battagl ia, dunque, " la volontà moral e, l'impuiso etico dell'antifascismo" precedette l'individuazione e la defi~izione di un preciso programma politico 127 •
123 Roberto Battaglia, La R esistenw italiana: lo sviluppo dell'intervento armato fino all'insurrezione, in Fa sc ismo e antifascismo le zioni e testimonianze, ciL, p.479

124 G iorgio Amendo la, op cit pp. 161 - 162
125 Roberto Battaglia, op cit p.94.
126 Giorgio Amendola, op. cii , p. 163.
127 Jvi. p.94 .
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
41
Sabrina Sgu egl ia della Marra
La R es is te nza armata ebbe ini zio a Roma , l' unica grande città ove, in segui to alla p roclam azio ne d e ll 'armi stiz io , s i bauerono insieme reparti dell'esercito e g ruppi di c ivili che, s en za es itazio ne , co nsapevol i della s overchi a nte fo rza teut onica, in gaggiarono un a ba ttag li a di spera ta il cui profondo s ig ni ficato id ea le no n fu m enoma me nte infic iato d a l co nseguimento di un un ico ri sulta to strategico, ovve ro im ped ire un ulte riore afflusso di rinforzi ted esc hi nel g olfo di Sa le rno ove g li All ea ti erano impe g nat i ne ll e operazioni di sbarco 128
Assai toccan te è la tes timonianza d e l te nen te co lonnello Savini , c apo di Stato Magg iore della " Piave", da cu i affiora la coce nte am a r ezza di chi impug nò le armi e dovette s ub ire la disfa tta a ca us a dell' in e t titudine e d e lle co ntraddizioni d eg li alti co mandi mi litari:
Tu tto ciò e ra s tato voluto, ripet o , vo l uto. se non per tradjm e nto, certa m ente per pa nic o dai capi , poic hé le divi s io ni vo leva no , ane lava no il co mbattim e nt o contro i tedeschi Lo hann o dimos trato tu ttj i re parti che ha nn o potuto comb atte re. Non ci hann o fa tt o co m battere, l'ese rc i to , e co n esso il paese, sono c roll ati 129 •
Le trattative tra le autorità ital ia ne e tede sch e iniziaro no i l 9 settembre e s i co nclu se ro i1 g iorn o success ivo a ll e 16, quan d o i I te n e nte c olonn e llo G iacco ne e il ge nerale West ph al firm arono la resa 130
Giaccon e g iunse a F rascati al tramonto, assi e me all'inte rprete , il te nente To r in i. Con dotti in u na mod esta an ticamera che d ava s ull a ce n trale o pe rati va, ve nn ero lasciat i so li in a ttesa di Ke sselring.
Con trari ame nte alle no rme previs te dal reg ola ment o per i negoz ia to ri ne mi c i, ne ss uno si occupò di loro . L'u ffic ial e ita l iano, come rife rì ne ll e s ue m e m o rie , a ppuntò la propri a a n e nzi one s ul se r v iz io int e rn o d e l coma ndo , no n pienam e nte effic ie nte; l ' atmosfera e ra te sa e su tutto a leggiava l' in certe zza e il nervos i s m o pe r il timore di possibili sbarchi al lea ti di c ui non s i potevano prevedere né i luog h i né l 'entit à.
I ton i p e re ntori d e l co lloquio non lascia rono adi to a dubbi in meri to al car a tte re al ea to rio e m e ramente formale d e l ricon osci m ento , per R oma, dell o sta tu s di città a perta Fu a pi ù rip rese rim arca to il p resunto t ra dim en to italiano e la nec ess ità, al fin e di rip a rare quan to meno in parte al la proditoria defe-
128 Enzo Pis c ite lli , op. cit p 147, 62.
129 A .C.S . . Mini ste ro della R ea l Casa. Ufficio del Primo aiutante di campo Seri e Speciale b.81. f.30.
130 Viva Tedesco. li co11trib11t0 di Roma e provin cia nella lo tta di libe ra z ione, Ammi nis trazion e provin c ial e di Rom a. SAIPE M , Roma, 1964, p . 184.

42
zione, che tutti i mi l itar i ital iani fossero " in vi tati" a p restare se rviz io p resso i tedeschi.
Q ualora le co ndi zio n i d ettate no n fossero state piename nte esaud ite, i l capo di s tato maggiore, generale Wes tpha l, p rospettò u na du ri ss ima r ito rs ione: min acciò di far sa ltare in a ria tu tti gl i ac qu edotti cli R oma, sui q uali erano già sta te p red isposte le interru zi on i , e cli bo m ba r dar e senza riguardi l'int era c ittà
G iacco ne s i fece la to re ci e li' ul timat um germanico presso il min is tro della Gue rra Sori ce c h e, tuttavia, opinan do di non potersi assumere la grave re sp o nsabi l ità d i d eci d e r e , pr egò il s uo capo d i Gabinetto, co lonnello Bonelli, di accompagnare il te nente dal mare sciallo Cavigl ia . Qu esti s i trovava a co ll oquio co n B o nomi e C asa ti ma sos pese immediatamente I' a bboccamento e li ricevette senza farli attendere . Gi u nsero a nche Calv i di Bergo lo e il colo nne ll o Mo ntezemolo, inv ia ti da Sorice c he des ide rava ave re q ua nto prima ragg uagli.

Cav ig lia, cons ul ta tosi con gl i as tan ti , come c hi osò Gi acco ne, "ebb e i l fegato di dire s ì, se nza mezz i termin i". Av reb be d irama to, pe rta nto, l'ordin e esecutivo, non a ppena fosse pervenu ta l 'auto ri zzaz ione d e l s ovrano, c ui trasmise un a p posito telegra m ma aus pi cando che, in assen za d el capo del governo, gl i fosse ro co ncess i in via tra ns itoria i p oteri militari e civi li.
Gi acco ne, Ca l vi e M ontez e molo agg iornarono s ugli ultimi svil upp i il m inistro de ll a G uerra e il gen era le Carbon i che, in mancanza di concre te al ternative, conve nne ro s u ll ' in elu tta bil ità della cap itolaz ione, l' u nica via pe rco rrib i le.
G iaccone , ne ll 'am pia e d ettagliata cro naca redatta, b ia s i mò il con teg no ten uto, in q u elle ore conci t a t e, d al coman dan te d el C AM , in c ui ra vv isò un' incoerc ibile q ua nto ri provevole ri lu ttanza ad assumere respo nsabi lità c he gl i co mpetevano . L ' uffic ia le, in fatt i , seco nd o tal e tes ti mo ni anza, si ti rò indi etro affe rm a nd o espl ic ita mente c h e l a firma di que l do cu m ento av r e bbe macc hi ato i n maniera ind eleb ile l'avve nire po litico d i chiunq u e l'avesse a pposta 131 •
Ca r bo ni, di con tro, so stenne che, invitat o da Sorice a pron un ciar s i su c hi avesse ri te nu to o pp ortun o in caricar e di sottoscrive re l'armis t izio , eg li fe ce il nome d i Cal vi d i Bergolo , perso nalità be ne accetta ai ted eschi. Po ic hé, invero , ciò avre bb e im plicato il di retto coi nvo lgi mento de ll a monarchia nella ca pit olaz ion e , ì1 co m an d a nt e d e l CAM suggerì la desig nazione ciel tenente
Mon tez emolo e il Fronte Mil itare Clandestino
43
13 1 Leandro Giaccone, Ho fi rma to la resa di Roma, Cava ll ott i, Mi lan o , 197 3 , pp.156 , 16 3166.
Sabrina Sgueg!ja dell a Marra
colonn e ll o Giacc on e c he, a s uo parere, se ne mostrò " felice" Ca rboni , altresì, non s i pe ritò di a gg iun gere c he Calvi, Cav ig li a, Sorice, Cadorna , G iaccone e molti a ltri ufficiali di c ui no n pre c i sò l' identi tà. avev an o ca ldeggiato la rapid a co nclu s io ne d e lle trattati ve d i re sa animat i unicamente d a l de s iderio d i s alvag uarda r e la propria pers o na 132
Il ge nerale Caviglia , nel di ario di qu e i g iorni infau s ti, evocò un ' icasti ca rapprese n taz ion e de ll ' I ta lia e d e ll a s ua ca pita le c om e ·'un a n ave in a lto m a re s enza timoniere", c ui eg li se ppe imprim e re la giu s ta rotta ver so "un port o d i circostan za a bba stanza s ic uro ", ove la ormegg iò conseg nan d o la nelle man i del gen e r a le cont e Ca l vi di B e rg o lo.
II to tal e c edim e n to del pres idio di Roma r e nd eva ind iffe ribil e il c ons eguim e nto di un pacifico m odu s vi ve ndi con l ' o cc upa nt e . Il g enero d e l re, dunq ue, accett ò di assolv e re la gravosa in comb e nza 133 e d assuns e i I Comand o de ll a citt à apert a : " no n s i t ra tta va - co m e puntu a li zz ò Gia ccone - di s e d e r s i s u un a poltro na; m a so pra una cas s a di dinamit e per rit a rdarne lo s copp io i I più a lun go possibil e, ne ll 'i ntere s s e di Roma e dei suo i a b i tanti " 134
A qu es ta s orta di con to a ll a ro vesc ia co rri s po se, s ul front e ne mi co. il c auto a pproccio t a tti c o pe r c ui optaron o i tede schi. le c ui lin ee direttri c i s i a ttagl iarono grad ualmen t e a ll a s trategia a ll eata.
Ne lla notte de l 9 se ttembre, pav e ntando uno s barco an g loa meri c an o s ulla c o s t a laziale, Ke sselrin g co ndu sse i neg ozi a t i co n re l a ti va la rgh ezza e accon se ntì alla c es s az ione d e ll e ostilità e ntro le ore 7 della m a ttina success iva . Ne l con tempo , t uttav ia , pred ispo s e un n uovo a ttacco, " i l più fort e e d o rgani co tra que lli a ttuati ", seco ndo la tes timonian za di Roatt a da s ferr ar e una vo lt a c hi ar it a la s ituaz io ne . Quand o, a ll ' a lb a de l 10 , appres e che s ul litoral e romano non s i p rofilava alcun pe ricolo , il fe ldm are s ciallo, " no n avendo a lcu n int e re sse ad a c c e ttare co nd izioni qualsiasi ", di e de ini z io all'offe n s iva a vva le ndo si an c he della p a rt e c ip a z ion e di fasc is ti , e lan c iò il s uo u ltim a tum. L 'e lemento d e terminan te fu , ev id e ntement e, il pre s unt o sba rco al leato 135, c ome atte s ta to , inol tre , dalla relazione del t e ne nte co lonne ll o Cano, in format o da M o ntezemol o s ui parti co la ri dell e trattativ e in c o r s o. Eg li r i fe rì c he d a parte ital iana ve nn e ro s o ll eva t e obi ez ioni e c r e at e difficolt à proprio a llo scopo di posticipare la capitol az ione i l più po ss ibil e .
132 Gi aco mo Carbo ni , op. c i1., pp 342-3 44.
133 Enri co Cav iglfa , Dia rio (aprile 1925-marzo 1945 ), Gherard o Ca s ini , Ro ma , 1952, p .44 8 .
134 Leandro Giaccon e, op . ci1., p. 16 8.
135 A .U.S S M.E N. 1 -1 I Dia ri s10ri ci 2° Gu e rra 111011 d iale, b.2997/A f. 3. "Tre re laz ion i de l ge nerale Roa n a .., sott of. IO, " Me moria s ulla dife sa d i Roma...

44
qu a ntomeno di cinqu e g iorni , p e r consent ire ag li inglesi di raggiungere Rom a e conservare in tatte, n el frattempo, le nostre forze 136
Il feld maresc ia ll o, allorché venne m eno la minaccia di un approdo n e mico s ul litorale laziale, inas p rì i ter mini di resa e poté lib eramente inv iare la III Panze r grenadiere a Salerno sin dal pom e ri gg io de l 10 se ttem bre.
L' armi s ti zio local e tra il Comando tedesc o e i r eparti allora prepo s ti alla difesa d i R oma impose a ll e t ruppe italia ne di c essare le o s tilità in un ra gg io di cin qu a n ta c hi lometri e di depo rre le armi per divi s ion e, mentre quelle ge rmaniche avre bbero procedut o allo sgombero d e lla città. Fu s tabilita l' is tituz ione di un comando it a lian o con un rappresen tante di Kesselrin g che avre bbe atteso alla tutela della pu bbli ca sic urezza mantene nd o a i propri ordini tutte le forze di polizia ed una div is ion e senz a artiglieria.
L e armi e i materiali dell'eserc ito sarebbero s tati co nsegnati all e autorità tedesche che, a ll'in terno d e l territorio urbano, avrebbero pres idiato l 'ambas ciata, la cent rale telefonica e la sede deU'Eiar. Si di c hiarò, infine, che tale comando non s i sareb be opposto al passaggio dei militari ita lia ni che l o avessero vo lu to, co me com ba ttenti se avessero g iurato fe del tà al F ti hrer, o come lavoratori, al serv iz io della Germania 137
La s era d e ll o stesso giorno, vennero firmati g li accordi di d ettag lio pe r l' esec uzion e d ell' armi s ti zi o dal colo nne ll o Trettner e, per la parte i taliana, dal colo nn ello Montezemolo. E g li attrav e rs ò la lin ea di combattimento s ulla v ia Tu sco lan a sventolando una rudimen t al e ban diera bianca per ragg iun gere il co mand o d i Kesse lrin g t ra Frasc a t i e Grottaferra ta ed ottenere il ri conoscim e nto di Roma città aper ta, sa l vandola così d a lla distruzio nel 3 8 L a scelta di affi darg li l' onero so inca ri co fu indubb iame nte m oti vata dalla provata fedeltà a lla mo narch ia e dalle s in golari capacità in telle tt uali e diplo ma tiche d el colonnello, no nché dalla pers o nale conoscenza delle autorità germaniche in virtù dei molteplici convegni militari c ui aveva presenziato.
Giacc o ne non si m erav igliò affatto della s ua pi e na ed imm ed iata d is p o nibi lit à : "era di gra n lung a il m ig lio re eleme nto di tutto il Co r po d ' Armata
136 A.C .S. , Mini stero d ella Real Casa, Uffi c io del Prim o aiutante di campo, Serie Speciale , b.81, f. 38.

137 A .U.S.S.M.E. , N.1 -11, Diari s toric i 2" Guerra mondiale, b.3055, a ll ega to n.657, " Re lazione del Ten. Co l. di S .M. Lea ndro G iacco ne sugli avvenime nti nella zona di Rom a d al giorno 8 al 25 settembre 1943, pe r quanto è a s ua diretta co nosce nza e memoria " ; A C.S , Presid enza d el Cons iglio d e i Ministri /940 -1943 , fa se. 1.1.2 ., n.22 89 7 , "Ordinan za n .l "
138 Anna Baldinotti , Il Fmnte Militare Clandestino di Monte zemolo, estratto d a Roma alla macchia Personagg i e vicende d ella Resisten za , a c ura di Mario Avagliano . Atti del Conveg no di studi o " L a Resi stenza rom ana e il partigiano Teve re", organizzalo d all'Associazione Nazionale Miri a m Novitch , Roma , 19 dicembre 1996, p.6 1.
Montezemolo e il Fronte Militare Cl an de stino
45
Sabrina Sgueglia della Marra
M otocorazza to - co mm e nt ò - no n so lo d a l punto di v is ta pro fess ion a le, ma a nc h e m o rale: non era uo mo da tirarsi in d ietro ne ll e s i tuaz io n i più deli ca te e ne i mom e nti pi ù c ritic i" 139 .
Al fin e di c on solidare l'ec cezio nal e s ta tu s giuridico di Roma, ve nne fi ssata la p ianta internaz iona le della città . F u pre v ista una s udd iv isione in due zone co nce ntri c he: qu e lla e nlro la lin e a rossa, c he co mprend eva l' abit a to, la c it tà a perta, e q uella co mpresa tra la lin ea rossa e qu e ll a verde, la zona cli s icurez za. Le truppe italian e sare bbe ro rima s te entro la linea ro ss a , qu e lle ted esc he avrebbe ro d ov uto rip iegare imm e di a tamente di a lm en o du e c hil o metri di e t ro la lin ea ve rde. P e r contro ll are o g ni movimento sa rebbero s tati istitui ti po s ti di blocco mi s t i in vari punti della c ittà, ad ecc ezio ne del P o nte de ll a Mag li an a c he, per es igenze d i riforn im ento , sarebbe s tato occ upato o lo ei a fo rze ge r ma nich e .
Il Coma ndo d e lla ci ttà a perta di Rom a, a ll a c ui g uid a c iv il e e milit a re fu pos to i l ge neral e Cal v i di Be rg ol o, già c oman da nte de ll a di vis io ne C e nt a uro e ge ne ro di Vitto rio Em a nu e le m, fu ripartito in du e uffici: l ' ufficio affa ri c ivi li , a ssegnato a l co lonnello Mon t eze mo lo , e l ' uffici o affari militari e c ollegam e n to co i tedes c hi , a l ten e nte c o lonn e llo Gi acc on e . Il C o ma ndo a vr e bbe a v uto all e s ue dipe nden ze tre battag lio n i s ottratti a ll a "Piave" , c h e sarebbe ro a ffluiti a Roma d a ll a vi a Tiburtin a 140, e le fo rze di polizi a e di pubblica sic ur ezz a, affidate a ll a direzi o ne a l c oo rdinamento de l c omandante ge nerale de lla P ol izia dc li ' Afri c a Ital ia na Maraffa 141 • Ques ti , sec ondo la puntual e r e lazione d i Gi acco ne, a cce ttò l'in carico so lo d o po il pe rso na le int e r vento di Cal v i e a co ndi zi o ne di esse rne soll e vato a utomat ic amente a llorq ua ndo i l c oma nda nte d e ll a c ittà aperta fosse s ta to s os ti t uito 142 Gli e ffe tti v i d e ll e for ze di p o li zia a di s po s iz io ne de l C o mando erano : di eci mila de l Corpo Age nti di Pub bl ica Si c ure z za ; otto mil a Carabinieri; tre mi la d e lla Gu a rdia di Finanz a; mi ll e du ece nto de l C o rpo PAI. 143
139 Leandro Giaccone. op. cit., pp.169- 170.
140 A.C.S , M inistero della R eal Casa, Ufficio del Prim o aiuta nt e di campo Serie Specia le, b.8 1 f.8. a ll egato n. 2.
141 A. C.S M in istero della R eal Casa. Ufficio del P rimo aiwame di campo. Serie Spec iale, b.82 , f.44. Il Corpo P.A .1 era s ta to istitui to co n Reg io decre to legge de l 14 d ice mbre 193 6 ' 'pe r as s ic urare la difesa dell e ist in12io11i e del te rr itorio d e ll'Afri ca iia li ana e pe r sal vag uardare la sa n ità fi s ica e morale de ll a popo laz ione d i detto territo rio ' ' . Da l 2 5 lu g li o I 943 il Corpo venne inquadrato in tre batt aglio ni e d islocato i n Ab ru zzo. Il 2 6 lu g lio. s u o rd ine de l capo d el governo Badoglio il ge neral e Maraffa tra s ferì tal e c onti nge nte a Rom a pon e ndolo a d ispo siz io ne de l Min iste ro d ella Gu er ra per la p rotez ione di opere e serv izi d i pubbli ca utili tà.

1 2 A U.S.S. M E N./-1 /, Diari 2° Guerra mo11diale, b.3055, a ll egato n 657 " Re lazio ne de l Tc n. Co l. di S.M . Lea ndro G iacc o ne s ug li avv e nime nt i nella zon a di Ro ma dal g iorno 8 .il 2 5 sette mb re J 94 3, per quanto è a s ua dire tta c on osce nza e me moria".
14J A. C.S. , Ministe rv della Real Casa, Ufficio del Primo aiutante di campo, Serie Speciale, b.82. f.44.
46
L e intese ragg iun te, t uttavia, furono ben presto disat tese : le forze -tedesc he, tra I' 11 e il 12 settembre, attaccarono alc uni eleme nti delle divi s ioni italiane ment re s i recavano nelle zone designate tra Rom a e Ti vol i per la co n seg na delle armi; prorogarono il ripiega me nto dei reparti paracadutisti che avevano com ba ttuto nella capitale; s ' impossessa rono di alcu ne caserme 144 • S'instaurò di fatto , u n vero e proprio regime d ' occupazione: come chiosò il generale B e ncivenga al processo Ka ppler, la struttura politico-militare d e ll a città aperta non fu c he una mera finzio ne gi uridi ca 145 No n venne mai ri s p et tata d a i tedeschi , né vi si atten nero i fascisti r e pubblicani, che insediarono, acca nto a i numerosi co ma ndi ed u ffici mil itari germanici, quelli della Rep ub blica Sociale, co l m inistero d ella Gu e rra , retto dal marescia ll o Graziani , e lo Stat o M agg iore, presieduto dal generale G am bara.
Le dichiarazion i pubbl ic he d e ll e a utorità germaniche, t uttavia, millantando una realtà co mpl etame nte di versa, infi erivano beffarde s ulla popo lazio ne romana : i l general e Stahel , ad esempio , come riportato dal Corriere della Sera del 7 otto bre 19 43, asserì ch e Roma no n era occupata perché era "u na c itt à amica d e i ted eschi" in cui la vita s i svo lgeva normalmente e "se nza limitazion i di sorta" ; " la sorveglianza germanica" , infatti, mirava esclusivame nte alla pace interna e alla sicu rezza della ca pi ta le, c ui sar ebb e s tato garanti to il costante r ifornime nto dei gene ri d i p rima nece ssi tà 146
La sera dell ' 11 sette mbre, s ui muri d i R oma ve nne a ffisso u n ed itto d el fe ld marescia ll o Kesselring che riportava le regole fondamentali c ui atteners i per tutta la dura ta d e l p redo min io tedesco:
Il Comandante in Capo Tedesco de l Sud
O rd in an za
I. li terri torio dell ' Ital ia a m e sottoposto è chiamato territorio di gue rr a. In esso sono valide le L eggi Tedesc he di guerra .
2 . Tutti i de l itt i commess i contro le Forze Armate Tedesc he saranno giud icat i seco ndo il d iritto Tedesco di guerra.
3. Ogni sciopero è pro ibito e sarà giu d icato secondo i Tri bunali di g ue rra .
4 G li organ izzato ri di sc iope ri , i sabotator i e i franchi tiratori saran no g iud icati e fucila ti pe r giud i zi o so mmario.
144 A U S S M E., N. I - I 1, Diari 2" Guerra mondiale , b.3055 , allegato n .657, "Re lazione de l Ten Col. di S.M. Leandro Giaccone sug]j avveniment.i nella zo na di Roma da l giorno 8 al 25 sette mbre 1943, per quanto è a sua diretta conoscenza e me moria"
145 Aless andro Portelli, L'ordin e è già sta ro eseg uito R oma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Don zelli, Roma 1999, p. 403 , estratto da ll a tes ti mon ia nza de l genera le Bencivenga al p roce sso Kappler udienza del 28 6 1948.
146 Carlo Trabucco , op. cit., pp.69-70

Montezemolo e
Fronte Militare Clandestino
il
47
Sabrina Sg ueglia de lla Marra
5 S o no deciso a man te nere la calm a e la di sc ip lin a e a sos te ne re le Au t o ri tà italian e com pe tenti con t utti i mezzi. per assicurare a ll a popolazione il nutrimento.
6 . Gli opera i ital ia ni , i qu a li si m e tto no vo lo nt a ri ame nte a d is pos iz io ne de i se rviz i tedesch i. saran no t ratta ti e pagati secon do le tariffe Tedesche.
7. I Min i s teri amministrntivi e le Autorità Giu di z ia rie continuano a lavorare.
8. Sa ra nno s ubito ri mess i in fu nzi o ne il se r v iz io fe rro vi ario , le co mu n icaz io ni e le pos te.
9. È proibita fino a nuovo ordine la corrispondenza p rivata. Le conversazi oni telefon ic he, che dovrann o essere limitate a l minimo, saran no severa mente s orveg lia re.
I O. Le Auto ri tà e le organ izzazioni c ivili i taliane so no verso di me re s ponsab il i per il fu nz io name nto d e ll 'ordine pubblico. E sse compi ranno il loro dovere solamen te se i mp e dirann o og ni a u o d i sabotagg io e l a res is te nza pass iva contro le m is ure Te d esc he e se collaboreranno i n m od o esemp lare co n g li Uffici Tedeschi 147 •
Il gio rn o segue nte, in un a s uccess iva o rd in a nza, Kesselring si rivo l se a l Comandante de ll a P iazza di R oma 148 affi nc hé di sciplinas e l'affl uss o e la p e rm an en za ne ll a capitale di tutti gli ufficia li dei di sciolti co ma ndi su periori ita l ia ni e d e l Co rpo M oto ri zz a to. Avre bbe do v u to co muni ca re i l nume ro degli uffic ia li e ntro il 13 settem b re , indican do ne i nomi, i gra di , i rep arti d 'appartenenza e le r ispe ttive abitazioni 149 • li Coman do dell a c it tà aper ta, c o me s i inferì c hiara m e nt e d a ll e prim e disposizi oni e messe, fu nse da copertu ra a ll e soverchie ri e tedesc he: l'es istenza di un formale pote re itali a no pe rmi se , di fat to, a ll 'occ u pa nte, di otte nere qu a nto vol eva e di d ispo rre de ll a pi ù a mpi a lib e rt à d 'a z io ne senz a ass um e rn e la res po n sabi lità 150 .
L' 11 se ttem bre, il Co ma ndo della c ittà aperta d iede com un icazi one a l Presi di o di Rom a, all e fo rze di P ol iz ia , al T r ibunal e mili tare e a ll a po po laz io ne d e ll e avve n ute negoziazio ni e degl i ordini co nseg ue nti 151 •
147 Ma nifesto originale espos10 al Mu seo storico della Liberazio ne a Ro ma.
148 Da a ll ora in poi no n s i fece più menzione del Co mando dell a Pia zza ma sempre del Coma ndo d e ll a c itl à aperta .
149 A.U.S.S.M.E N.1 -1 I. Diari storici 2" Guerra mondiale. b.2997/A. f.4 Dife sa di Roma ·. allegalo n .4, ··umcialj dei disciohi comandi supe riori italiani e del di scio lto Corpo Motorizza to Carboni", li Com andante Supremo de l S ud Kesselrin g a l Co mandante la Pi aiw it ali ana di Roma, 12-9- 1943 .
150 Viva Tedesco. op. cit p.184.
151 A.C.S . . Ministero della Real Casa, Ufficio del primo C1i11ta11te di ca mpo. S erie Speciale, b.83, f.74/6 8

48
La cittad in a n za, come p resc ri t to dalla pri m a ordin anza d iramata, avreb be dov uto atte nder e alle · norma li occ u pazioni "co nservando perfetto o rdine, ca lm a ed o b bedi e nza alle d ispos izio ni delle au t o ri tà mil itari "; i trasg resso r i sa re bbero stati tradott i al T rib una le di Gue r ra che avrebbe sedu to i n perm ane nza.
A t utti i mi lita ri , d i qua lu nq u e gra do, c he si fossero trova ti a R oma, fu in gi unto di -presen tarsi e ntro ·ventiquattro o re a ll a caserma più v ic in a con l ' arma me nto indiv id uale e l 'equipaggia me nto in dotazio ne 152 Nel l 'o rdinanza success iva, si in t imò l' im m ediata co nsegna delle armi ai commissariati d i p olizia riona li: c hiu nque avesse cont ravvenu t o sareb be s tato fuc i lato p er gi udi zio so m mario 153
Il Comando ital iano, pur nei l imi ti imposti d all ' occu pante, ten tò di ovviare ai grav i problemi c h e, in di retta men te, coinvolgevano la vita della nazio ne . Po ic hé la si tuazione non pe rm etteva ai ministri in ca ri ca il no rmale svo lg ime nto de H' attività p olitica, pe r garan tire con tinui t~t e funziona lità al i' o rdinari a am ministraz ione deg l i ·o rgani - centrali , ve nne nomina to un commissario per ogni .dicastero c he, con adeg uate co m petenze spec ifi c he , fu incaricato d i esercitar e, nell'am bit o del.l e leggi.in vigo re, tutte le fun z io ni tec ni c he, ammini s trative, disciplinari de i m ini str i 154 • D 'intesa co l Coman d a nte tedesco della pi azza d i R oma ge neral e Stahel 155 , fu s tabi li to c h e, per mantener e l ' o rdine pubb lic o , nessuna m a n ifestazio ne pol itica, cli qualsiasi ge nere, sareb be stat a conse nt ita ~ . 56
Le a utorità germaniche trovarnno ne l colonnello Mo ntezemo lo, "il più efficie nte nemico dei tedesc h i" 157 , un'assol uta osti lità ed un tenace ostruz ioni smo. Al fi ne di prov vede re q ua n tomeno alle pr im arie esigenze della cittad in a n za, come l 'a nnona e gli app rovvigionam ent i , la mattina de ll ' .1 1 settem-
152 A.C.S., Pres idenza del Consiglio dei Ministri 1940-1943 , fase. 1.1.2 , n.22897, "O rdinanza n. r·.
153 A:C.S , Mini s tero della Real Casa, Ufficio del prinw aiutante di campo, Serie Spe c iale, b 83, f.74/68; A C.S , Presidenza del Consig lio dei Ministri 1940- 1943 , fase. 1.1.2 , n 22897 , " Ordinanza n 2".
154 A.C.S. , Presidenza del Consiglio dei Ministri 1940-/943, fase . 1.1 .2., n .22897 , " Ordinanza n:3"
l5 5 Ne l genna io 1944 fu sostitu ito dal generale Mael tze r.
156 A.C.S. , Ministero della R eal Casa, Ufficio del primo aiutante di campo. Seri e Speciale, b.83, f 74/68; A.U.S.S.M E , N.1 - 11. Diari storici 2° Gu e rra mondiale, b 3055, allegato n 657 , "Re l azione de l Ten. Co l. di S M. Leandro Giaccone sugli avv e nimenti nella zona d i Roma da l g iorno 8 al 25 settembre 1943, per quanto è a sua diret ta conosce nza e memoria " .
157 Fulv ia Ripa di Meana , Roma Clan.destina, Vincenzo Ramella Editore, Torino 1946, p.34.

Mon tezemolo e il Fronte Militare Clandestino
49
Sabrin aSgueg lia della Marra
bre, Ca lvi ed i l co lon ne ll o presero conta tto co l senato re M otta, G overna to re di R o ma, pe r rip ris tin are l ' in tera organ izzazione d e i mercati gene r al i e r ion ali, e r iavv iare i se r vizi dei p ubb l ic i tras p orti 158 •
A r ipro va dell 'ost i na t a r es i stenz a a ll e p repo ten ze g er man ic he . C a l v i e M o nt ezemo lo il 18 sett embre opposero u n ne tto r ifiuto a ll a r ichies t a d i Kessc lrin g di se im il a os t ag g i da a vv ia re a i l av or i pe r l 'ese rcit o te d esco. li fe ldmaresc i a ll o, traendo p r e tes t o da un pres u nto a ttacco ita l ia n o all 'os pe d a le aero n a u t ico di R o ma , a tto n on con fo r me a ll e conve nz i o n i i n tern az iona li , n o t ifi cò al Coma nd o d e ll a c ittà ape rt a che, per rappresag l ia, sa r ebbero di ve nu t i pri gion ie ri di g uerra g e r ma ni c i m ill e it a l.ia n i a b il i a ll e arm i pe r og ni so ldato tedesco ucc iso. Calvi a ffid ò ad una commiss ione d ' i n ch iesta l'accert a m e nto dei fa tt i e, ne l messaggio d i ris posta a Kess e lri ng, e cce pì c h e, pur de pl o ran do p e r so na lm ente l' acca d uto, dalle i ndag i n i espe r it e era emerso c h e l' uccis ione si e r a verificata al d i fu o r i dell ' os p e d ale, q u an do a nc o ra i n fu r iava n o i co m bat t iment i e, dunque, pri m a c h e le part i avve r sarie fossero venute a co nosce nza de ll e inte se ragg i u n te
P e rt an t o, nessun a p p u n t o potev a ven i r mosso alle nostre fo r ze a r mate c h e aveva no ag it o ne l r is pe tto de l d ir it to be ll ico e de l di ri tto de ll e ge n t i. All 'o s t ina t a i nsiste n za ge rm a n ica, il Coma n do, co n futa n do p u n tu alme nt e e con leg i tt i me a rgomen tazioni l a fonda tezza d ella ri torsio ne, rib a tt é ch e, se i I fe ldmaresci a llo n o n avesse des i s t i to dai s uoi p r oposi t i sconsidera t i , av r e bb e dov uto p ro vvede r e da sé a ll a ca tt ura de i sei mil a os t aggi pre tes i. L e a ut orit à ita l ia ne, p e r a ltro , co l sero l 'occas ion e pe r so ll ec itare il r i lasc io dei n ostri prigio n ieri che, a diffe r e n za d i que ll i te d esc h i e contravve nen d o ag li acc o rdi stab i l iti , no n era no a n co ra s ta t i li be r ati 159 D i nanzi a ta le r i sol ut o a tt eggiamento , i tede s chi fu ro no cos tretti a de s is te re.
Del tut to vani , d i co ntro , s i rive larono g li sforz i di Monteze molo per im ped ire c h e, il 20 settemb re, le SS si a p pro pi ass e ro de ll e rise r ve a ur ee de ll a B a n ca d ' Ita lia, cen todici otto tonne lla te d'oro 160
La reaz ione d i R oma, risvegl ia tas i I' 11 se tte m bre "come ci ttà occu pa-
158 A.U.S .S.M.E., N. I -Il, Diari sto rici 2° Guerra mondiale, b.3055, a ll egato n.657 , ' Relazione del Ten . Col. di S.M. Leandro Gia cco ne ~ugli avvenimenti nella zona di Roma dal giorno 8 al 25 seuembre 1943, per qua nto è a sua d iretta conoscenza e me moria" .
1.59 A.C S Ministero della Real Casa. Ufficio del Primo aiutC111te di campo, Serie Speciale, b.81. f.8 allegato n.2.
160 Viva Tedesco, op. cit., p.1 88

50
ta " 161 , fu ene rgica e risoluta : s i c reò spontaneame nte " u n'un i tà resiste nz iale da l bas so" 162 che offrì so lid arietà e protez ione a c hi unque avesse voluto op porsi a l comune nemico, malgrado la spietata repressione pol iziesca e le precarie co ndizioni d i vita.
La Re s iste nza romana è un fe no m e n o complesso , ricco di sfumature, da val utare s ingolarme nte per le circosta nze peculiari in c ui nacque e s i svolse e per il ruolo c h e l ' Ur be aveva ri vestito durante il ventennio Giorgio Cap uto l'ha de fini ta " un 'espressio ne co m plessa di forze e di m ome nti politici d iffere nti , ri sultato di una battag li a combattuta nel corso di lunghi anni , crogi uolo di convincimenti ideologici determinati e di se ntimenti patrio ttic i non a ncora maturi " 163 •
A R oma, come al Nord, la re s isten za dovette ovviare a que ll o c h e B attag l ia ha descr itto come " il punto morto dell ' attesismo". Tutt avia, a differenza di quanto accadde nell'Ita li a settentrionale , la capita l e fu più espos ta a ll a f ur ia teuton ica: chi scelse di b attersi si trovò imm ed iatamente in prima lin ea, non so lo per l a pre ss ione della poliz i a nazifascista , ma anche per l a sua presenza capilla r e nella realtà po i itica e ne l tess uto socia le della città 164
Polemizzan do co l gruppo dirigente d i Milano , Giorgio Amendola ha contestato la validità della tradizionale accusa di attes ismo r ivo lta alla Resistenza romana , sostanz iata a suo parere, d i preconce tti , di valutazioni approssimative e di una rigida schema ticità incapace di cogliere, nella sua natura composita, una realtà, come quella de ll a c ittà eterna, innervata delle p iù svariate implicazion i po li t ico -militari: il prec ipuo co mpito di Roma c he, in quanto capi tale d'Italia, doveva realizzare una vera unità nazionale; la pre senza del Vatica no, che dava ass istenza ai membri d el CLN; il proble ma po li t ico del governo che s i sarebbe costituito a liberaz io ne avvenuta, di cu i il C LN vo leva essere espressio ne; i rapporti tra CLN e monarchia; le condiz io ni di vita, le tradizion i po litiche, gli orientamenti de ll a cittadinanza. Roma non era una città indus tri a le e, in assenza di u n proletariato con sistente ed o rgan izzato, non esistevano i presupposti per una lotta partigia na che muovesse dagli scioperi de ll a classe operaia, come accadeva al Nord . La città cost itu iva la principale base d i rifornimento dei tedesch i e la popolazione, stremata dalla fame, nelJ'impossibilità di provvedere alle p iù e leme ntari necessi tà , v iveva delle sue esigue scorte e non poteva far al tro che ricor-
161 Giorgio Amendo la , op. cit., p.17 l.
162 Roberto Battag l ia , op. cit. , p .240.

163 Giorgio Caputo , Problemi e documenti della Res istenza romana , Libreria l'Europa letteraria, Roma , 1966, p.13.
164 Rob erto Battaglia , op. cir , pp 231 , 238 -239.
Montezemolo e il Fro nte Mili tare Clandestino
51
Sabrina Sg ueg lia della Marra
re re al me rcato nero, diffusosi per me zzo di u na fin a rete di p iccoli produttori e co mme rc ianti provenienti dalle zo ne agri cole limitrofe 165 Nella primavera del 1944, in molti qu a11ieri co me Tras tevere, Garbate ll a, P rati e Tri onfa le, si ve r ificarono i pri mi ass alti a i fo rni c h e, mal g rado la durn repress ion e, si protra sse ro fino a magg io. La carica rivol u zionaria d e lla Resis tenza romana ne doveva ris ulta re in esorab ilm e nte affi evolita.
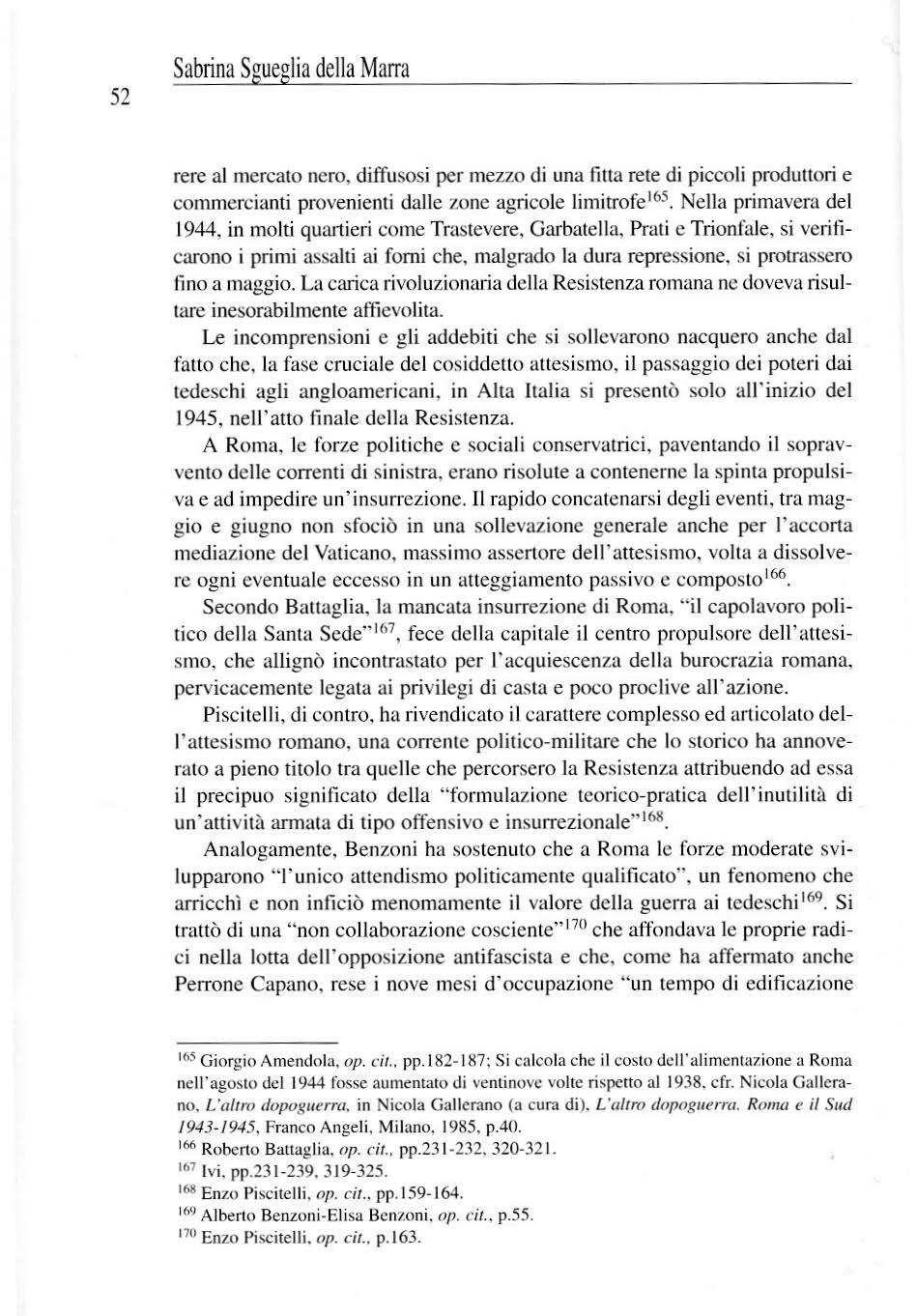
Le in co mpre ns ioni e g li ad d e biti ch e s i so ll eva ron o nacqu e ro anch e dal fatto c h e, la fa se cruciale del co s iddetto a ttesis mo , il pa ss aggio de i pote ri dai te d esc hi agli a n g loam er ica ni , in Alta It al ia si pre se ntò so lo a ll ' inizio del 1945 , nell ' atto finale d e lla Re s is tenza.
A Roma, le forze politiche e sociali co nse r vatrici , pave nta n do il sopravve nto d e ll e co rrenti di s ini stra , era no ri sol u te a co ntenerne la s pinta propu ls iva e ad impedire u n 'in s urrezione. Il rapido co n c a tenars i d eg li event i, tra magg io e g iu g no n o n sfoci ò in u n a s o lle vazio n e ge neral e a nche pe r l 'acco rta media zio ne del Vatican o, mass im o as se rtore d e ll ' a ttesismo, volta a disso l vere ogni e ven tu ale ecces so in un atteggia mento p ass ivo e c ompo s to 166
Secondo Battag lia, la man cata insu rrez ion e di Roma , "i l capolavoro po l itico dell a Santa Sede" 167 , fece della capi tale il ce ntro propulsore dell 'a tt es is mo, c h e a lli gnò incon trasta to pe r l'acquiescen z a dell a burocr az ia roma n a, pe rvica ce mente lega ta a i privil egi d i ca sta e poco pro clive a li ' azione.
Pi sc it e ll i , di co ntro , h a rivend ica to il ca ratt ere co mpl esso ed a rticolato dell 'attes is mo rom a n o, un a co rre n te p olitico- milita re c h e lo s to ri co ha anno vera to a pi e no tito lo tra qu e ll e ch e percor se ro la Res ist e n za attribu e ndo ad essa il precipu o s ign ifi ca to d e lla "fo rmulaz ione teo rico-pr a tica d e ll'inu ti lit à di u n ' atti v it à armat a di t i p o offensivo e in su rrezionale " 168 .
An a lo g amente, Benzon i ha s ostenu to che a Roma le forze moderate sv ilupparo n o " l'uni co atte ndi smo politicame nte q u a lificato", un fe n o me n o c h e arricchì e non infi ciò m e nomam e nte i l va lore de lla guerra ai te deschi 169 Si trattò cli una " n o n collaborazion e cosciente" 170 c he affondava le proprie radici n e ll a lotta d e ll ' oppos iz ione a ntifasci s ta e c he, co m e ha afferma to anc h e Perron e Capan o, rese i nove m es i d 'occ upa z ion e " un tempo di ed ifica z ione
165 Giorg io Amendol a, op ci t pp 182- 187 ; S i c:,lcola c he il cos to de ll ' alim entazione a Roma ne ll 'agosto del l 944 fosse aumentato di ve ntin ove vo lte rispetto al I 938 cfr. Nicola Gallerano. L'altro dopoguerra, in icola Gallcrano (a cura di) L'altro dopoguerra. Roma e il Sud 1943 - 1945, Fran co Ange li , Milano , 1985, p .40.
166 Roberlo Battag lia , op. cir pp.23 1-232 . 320-321.
167 l vi, pp.231 -239. 319-325.
168 Enzo Pisc ite ll i, op cit. , pp 159 -1 64.
169 Albe rto Benzoni -E li sa Be nzoni , op. ci i. , p . 55.
170 Enzo Pi sci telli. op. cii., p. 163.
52
morale" in c ui la cittadinanza diede prova di "umana solida ri età, di civica generosi tà, di p atriottica unione con tro il nemico" 171
"Resistere è del romano -h a scritto Jo Di Be ni gno - egli è maestro in que s to , resiste sempre, a tutt i" , provocando v iepi ù il di so rientamento dei tedeschi che reagiva no con ordina nze in timida tori e ed oppressiv em. La resis tenza costituì prima di tutto, un 'ostilità etica e spiritu ale che, d eclina ta in forme, espress ioni ed int ensi tà diverse , a R oma non ma nc ò di concretizzarsi in veri attacchi e non dev'essere consi derata esclusivo appannaggio deg li uom in i in uniforme inquadra ti nelle formazio ni del FMCR , o dei partigiani che militava no nelle avan guardi e armate d e i partiti. Le carce ri roma ne, infatti, pullulavano di oppositori che, con la pubbl icazione di un gio rn ale clandestin o , la costituzione di un movime nto loca le, il lancio di volan tini a ntifascisti o con p roteste e denunce scritte sui muri co nt ro le efferatezze e la p r epotenza dell 'o ccupante, te st imoniarono l'unanime ri volta mora le agl i arbitri e alle cmdeltà nazifasci ste 173 Partigiano era anche chi proteggeva e dava as i lo agl i ebre i e ai perseguitati politici , chi cambiava le segnalazioni stradali , e c hi , se mpliceme nte, portava avanti con tenac ia u n ostruzionismo p assivo 174
Un'az io ne di sab otagg io assai diffusa, ti pica d ella resis tenza romana, fu lo spa rgimento di chio di a tre o quattro punte s ull e principali v ie di tran s it o . A fornire quest'arma assai efficace di c ui s i avvalsero copiosamente i pa r tigiani di ogni co lo re, fu i1 fabbro Enrico Ferola che adibì alla fabb ri caz io ne dei chiodi lo scantin ato de ll a s ua bottega nel qu artiere Trastevere. Il 19 marzo 1944, fu scoperto e imprigio nato nella pen sione Jaccarino; incluso nella lista del q uesto re Caru so, fu trucidato alle Fosse Ardeatin e 175 Partigiane erano a ltresì quelle "dame elette", così d efinite dal colonnello S a lvat i, capo della banda " Bi lli", come la marchesa Fu lvia Ripa di Meana, la marc hesa Ange li ca M o rozzo della Rocca, la contessa Guerra, c he offrirono ospitalità nelle propri e case, fondi p er sos tenere i patrioti, e collaborarono attivamente metten d o a rischio la propria incolumità, reca pi tando armi, docume nti compromettenti e comun icazio ni importanti 176 •
17 1 Renato Pe rrone Capano , op cit., p 377.
172 Jo Di Benign o, op cir , p .1 88 .
173 E nzo Piscite ll i, op. cir., p.122-123.
174 G iuseppe Intersimo ne , Cattolici nella R esist enza ,vmana, Edizioni Ci nque Lune , Roma, 1976, p.11.

175 Lorenzo D ' Agost ini-Rob erto Forti , Il sole è sorto a Roma. Setrembre 1943 , AN PI , Roma, 1965 , p.145.
176 A.U.S.S.M.E., N.1 -/ 0, Diari storici 2(J Gu erra mondiale, b.3022 , f 3, "Attività svolta dal ten.col. S.M Salvati Giu seppe. quale coma ndante del gruppo bande Billi e della ri serva a dispos izione del comando Fronte C landes tino in Roma", Comando gnippo bande "Billi" , 18-6- 1944.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
53
Sabrina Sgueglia della Marra
Proprio in v ir t ù della genero sa res is tenza c he i romani o pp o. ero a ll 'occupan te, i capi, s ia milit a ri che d i partito, furo no decim a t i d alla belluina fe ro c ia germanica. Venn e a ma nca re , co s ì , la condizione fo nd amentale perc hé la città s i so ll evasse 177 Force ll a, pur ri c ono sce nd o l ' impegno d ipl omati co della Chiesa teso ad impedir e lo scop pio di un ' insurrezione eg emonizza ta da i co mu ni s ti al m ome nto de l passaggio dei po te r i, ha conve nuto co n Pi s c itelli s ull'in a ttuabilità della soJleva z ion e ge neral e. La cittadinanza, g iunta a l 4 g iu g no stre m a ta da lla fam e e dalle vessaz i o ni subite, era priva di una gui da certa , di una lin ea direttrice impo s t a da ll' alto in grado d i veico lare le re s idu e energ ie in un estre m o sfo r zo comune. La popo la zione, p e rtanto , s i dimo s trò comprensib ilment e o rientat a a d assec ondare più l 'a tte ndi s mo del Va ti ca no c he l ' inte r ve nti s m o della re s isten z a armata. C onfutan do l'e s pressione " in surrez ion e mancat a", Forc e ll a h a r it e n uto più appropriato parla r e di " in s urrezio ne no n acce ll a ta " d a tutte le forze i n campo , p e r s uase c he ne manca sse ro i req ui s iti fo ndamentali 178
Silverio Corvi sie ri ha illustrato in maniera esa us tiv a le ra gio ni per cu i R o ma fu l' uni ca gra nde c ittà itali a na ove la lib e ra zio ne no n s i co mpì altravers o lo sc oppio di un m oto pop o lare. E g li h a op in ato co me il g iudi zi o di Ba ttaglia possa ri s u ltare eccessiva me n te u nil aterale qualora no n s i indi v iduino le '·condi z io ni oggettive e le respon sa bili tà sogge ttive " c he permi sero alla Santa Sed e e all e forze polit ich e moderate di sco ng iu rare po ss ibili es iti r ivoluz io na r i. I partiti dell a s ini stra a ntifa sc is t a dove ttero rinun c iare all ' insurrez ione in primi s a causa dell e divi s io ni inte rne al CLN che, seco ndo Co rvi s ie ri , non cos tituì ma i un reale ce ntro direttiv o, co n grave preg iudi z io dell 'o rga ni zzaz ion e de ll a lo tt a . L a sv o lta di Sal e rno accentuò ulterio rm en te il dissidio tra comunisti e s ocia list i
Togli a tti , coeren te m e nt e con la po liti ca d'u nit à nazio nale , di s pose c he il suo partito no n pre ndes se iniz iative isolate poich é tutte le ene rg ie e le ri sorse disponib.ili sare bbero s tate convogliate nell ' in s urre z io ne so lo se qu esta fosse s t a ta appro va ta da tutte le formaz ioni operanti ne ll a ca p ital e. La co mbattività de ll ' avan g uard ia armata del PCI , inolt re, era fortemente scema ta a ca us a dell o sc ioglimen to dei Gap 179 , impos to da r agioni di prudenza in seg uito alla d e lazione di Gu g li elmo Blas i , un gappi s ta arre s talo ne ll 'a prile del 1944 c he tradì i co mpagni e si pose al se r viz io d e ll a banda Koch 180 •
177 Enzo Pi sc itelli . op. cit. , p .359.

178 Enzo Forcella, op. c i,. , pp .19 1, 195.
179 Due Gap furono arres tati al compl e to .
180 Si lv erio Corv is ie ri. " Bandiera rossa" nella Res is 1em:.a rom ana , Samo nà e Save lli, Ro ma. 1968 pp.1 57- 160.
54
U n ' opinione d e l t utto discord e, infin e, è qu ella di Giorgio Bocca, che h a bollato quella romana come un a resistenza " passiva" di cui la capitale non avrebbe dovuto acco nte ntar s i . Roma gener ò e propagandò " un co mpatto, massiccio attes is mo, co n fuoch i sparsi cli lotta armata" e, durante i nove mesi, l' osti li tà all'occ upan te si espresse " ne ll e omiss ion i, nei rifi u ti , nelle elusioni, più che ne ll e azioni". Pu r riconoscendo i l caratte re eccez io nale d e lla solidari età collettiva sv iluppata si a sos teg no d egli antifas c isti, Bocca ha giudicato d e ludente la prova data da R oma ne lla lotta a rma ta: l ' onore della c ittà, a s uo avvi so , fu ri sc attato sol o grazie all ' attività d e i G a p 181
Nel va lu tar e i li m iti della re s istenza romana, credo sia o pportun o co nsiderare de bita m ente l'influ e nza che s u di essa, lu ngo tutto il suo percorso , ese rc itò la s trategia adottata da gli Alleati, propen s i a co nsentire e, dunque , a sos te nere singole ed isolate iniziative mili tari, ma fe rmamente risoluti a stroncare un ' eventu a le ri volta ge nerale
Ritengo che la prospettiva da c ui Gia como Novent a ha analizzato l'esse nza più ripos t a d e ll a R esis ten za italiana possa a iu tar e a co mpr e nd ere come, al di là degli es iti co ncre t i, a presc indere d a chi impu gnò le a rmi e da chi i nvece s i limitò a dare as ilo ai partigiani, la lotta di lib e razione ab b ia avuto il valore profondo di una "s peranza universale" che, a Roma , si caratterizzò per il profondo afflato umanitario e per l'an s ia d i un ra d icale rin novam en to s oc iale . Tutt a la naz io ne ne fu coinvolta, desiderosa non so lo di abbattere il fasc is mo e il n az is mo, ma di sco nfi ggere q uell ' indifferenz a popolare e que lla d ecade nza delle classi politiche succe du tes i d a Giolitti in poi, che avevano perme sso s im ili aberrazio ni 182 L ' attivismo e l 'attesismo perseguirono il com un e ob iettivo di creare il vuoto a tto rno ai nazifascisti 183 : le energie d ella Re sis tenz a, malgrado le differenti ide olog ie e le conce z ioni s trategic he contrapposte , furono complementari, tesero a sommarsi, non ad el id ersi vice nd evolme nte , al contrario d i quanto era acc ad uto ne l Ri so rgimento a ca usa d ell' i nsa nab ile fratt ura tra "modera t i" e " democratici" 184 .
Benché la r esistenza a rm ata a bbi a cos ti t uito la summa di elate virtù co me la de te r minazi o ne , il coraggio, l'ardim e nto , Pietro Scoppola ha suggerito di esaminare " la contro vers a questione dell'attendismo" su ll a ba se dell' un a nim e co n co r so d eg li ital iani alla terribile lotta contro l'occupan-
181 Gi orgio Bocca, op cit., pp. 149, 282, 284.
182 Giacomo Noventa, Tre parole sulla R e sistenza. Vallecch i, Firenze, 1973, p .82.
183 Giuseppe l ntersimone , op. cit., p.89.
1s4 Roberto B attaglia, La Resistenza italiana: lo sviluppo dell ' inte rvento annata.fino all'insurrezione, in Fascismo e antifa scismo. Le zioni e testimonianze cit. , pp.491 -492 .

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
55
Sabrina Sgueglia della Marr a
te , all a luc e del "co i n volgimento totale e p rofo nd o della popo la z ion e n e l s uo in s iem e", "dello spe sso r e e del sig nificato mora l e di una re s i s ten z a diffu s a che fu event o coral e di tutta l a nazion e" 185 . ln It alia , i nfatti s i realizzò ciò che pe r altri pae s i , come la Grec ia o la Ju gos la v ia , rap prese ntò un a m era as tra z ione teo r ica , un anelito cui tendere che co ll id eva c on la realtà: l 'in tesa tra co muni s ti e non comu ni sti, un'a lle an za fa ti cosa mente r ice r ca ta, ragg iun ta e mantenuta n e ll a diu tu mi t as d e lla lotta, un a co n c reta co llabora zio n e ch e si attuò n e i Comitati di Liberazion e, n e l Comand o Volontari d e ll a Lib e rtà 186 e, a R o m a, g razie a ll 'o p era d el FMC R.
11 multiforme svi l uppo della R es istenza è d a ascrive re alle diverse matric i da c ui tra sse o ri gi ne e a lle molte plici is pirazioni che la animarono. Claudio Pavo ne h a tra ttato am p iamente le finalità c h e m o sse ro le va rie formazion i combattenti di sting u endo tra g uerra pa tri o tti ca, gue rra civ il e e g ue rra di classe. Ali' int e rno dei gruppi ar ma ti e n e lla co sc ie n za de i s in go li , co n fl uirono e tal volt a s i sovra pp osero qu es te tre m o ti vazio ni id eali . La gu e rra d e ll e band e non fu solo un fatto militare, né i Comi ta ti di lib eraz ione posso n o co ns id erar s i escl us ivam e nte un fatto p ol itico 187
R o ma , n e i no ve mesi d'occ up az ion e, vis se "u n a vi cend a ad a lt a int e ns ità g iuridi ca, po li tica , mi li t a r e, religios a" 188 , "u n doloro so calva r io " 189 in c u i pre se r o corpo va r ie fo r me d i R es i s t e n za. Vi fu q u ella popo lare dell e borgat e , prepo liti ca , espr es sa d a una nutr ita sc hi e ra di a band e c om e que ll a di Centocelle, del Quadraro , de l T iburtino , in cu i la lotta co nt ro i tede sc hi s i co lorava di as pira z io ni soc i a li e s pe sso s i configurava come un a m era battag l ia per la so pra vv ivenza . 190 V i fu quella politi ca del M ov im e nt.o Comuni s ta d ' Itali a , di or ientamento a n archico-tro z ki s ta, co no sc iuto col nome di " Band iera R ossa", da l g i orna l e pubbli ca to , che , s otto l'egida de ll e p i ù radica li parol e d'or din e dem oc rati c h e, se ppe convogli are l ' imp etuoso f erme nt o popolare in più m at ur e m an ife s t a z io ni d i a ntifa sc is m o. Fond ato da ll 'avvoc ato calabrese R affae le D e Lu ca, ana rc h ico in giove nt ù , po i p ass ato al PS 1, il m ovi m e n to , estinto s i a ll ' ind oman i della libera z ione , e ra cos tituit o pri n c i p al m e nte da intellettu a li , operai e d art ig i ani , e ra cco ls e co nsen s i sopratt utto nelle borgate . Com e
185 Pi e tro Scoppola, 25 aprile. Libera::.ion e. Einaudi. Torino. 1995. pp.49. 52.
186 Elena Aga Rossi, Cltalia nella sco11ji11a, c it.. p.203.

187 Cfr. C laudi o Pavone, op c it.
188 Ful via Rip a di Meann. op. cit p. 7.
189 Luciano Morpurgo. Caccia a/l"uomo. Dalmat ia, Roma. 1946, p.147
190 Gi o rg io Boc ca, op. ci t. , pp 28 5-286
56
ha os se rvato Silverio Corvisieri, era un'organizzazione di comunisti diss id enti che rav v i savano ne lla resistenza la prima fase della rivoluzione soc iali sta 19 1 e il cui precipuo obiettivo , dunque , era quello d i affrancare l 'Ita lia da lla dominazione straniera e poi d a quella borghese 192 Contrari alla co llab orazione col CLN, e dunque avversi alla politica d'unità naziona le , dissentivano su ll'impo s ta z ione che il PCl aveva conferito alla lotta antifascista e n e condannavano il burocratismo e il mon o liti s mo nei rapporti int e rn i 193 L'attività di sabotaggio e g li attentati co mpiuti dagli uomini di " Bandiera Ro ssa" furono pagati a prezzo di cospicue perdite: centotrentasette arrestati e d e portati e centottantas ei caduti 194 Tra ques ti, il capitano Aladino Govoni , appartenente al I Reggim ento Granatieri di Sardegna, e il cap itano dell'Aeronautica Nicola Ugo Stame, truc idati nell ' eccidio delle Fosse Ardeatine.
La Resiste nza dei partiti si sviluppò attraverso la cospirazio ne e gli atti teIToristici. I comunisti, già in poss esso di u n ramificato e consistente apparato clandestino , formarono i Gap, gruppi di azione patrio ttica , denominati Gramsci, Pi s acane, Garibaldi e Sozzi. Ad e ss i s i d evono le più impo1ta nti azioni di guerriglia e di sabotaggio contro gli invasori, sferrati col dichiarato intento di non desistere fino alla totale evac uazione d e lla capitale, all'insurre zione nazionale per la cacciata dei tedeschi, all'abbattimento del fas cismo e alla conquista della libertà.
Mentre l'antifascista politico era perseguitato per la s ua posizione ideologica e per l ' attività svolta in tale veste, il militare , di qualunque gra do ma s oprattutto, l' ufficiale, era oggetto di una caccia feroce, compendiando nella sua p ersona l'oppositore politico, il nemico militare e iJ traditore che aveva osato rivo lgere le armi contro il vecchio alleato.
Ciò su cui ha pretestuosamente insistito Kesselring nelle s ue memorie, è che la guerra part ig iana , "per il modo con cui venne iniziata e condotta", non fosse conforme al diritto int ernazio nale. La lotta cli l iberazione e " i brutali ass assi nii " cui diede luo go, a suo parere, avevano infranto l'ormai co ns o lidata " fratellan z a d'armi" 195 I parti g iani , contravvenendo a tutti i principi di correttezza cui avrebbe dovuto informarsi ogni operazione militare, pro vocarono "u n forte senso cli inqui e tudine": " nelle zone infestate
19 1 Sil verio Corvi s ieri, op. c ii. , pp.9 -1 O, 16, 50.
192 Viva Tedesco , op.cit., p.258.

193 Sil ve ri o Co rvi s ieri, op. c it pp .8- 10.
194 Alfonso Bartolini-Alfredo Terron e , I militari n ella guerra partigiana in Italia. / 94 3-194 5 , Ufficio s torico dello Stato Maggiore de ll' Esercito , Roma I 998 , p. 25.
195 Alb ert Kes selring , op c it., p. 251
Monteze
molo e il Fronte Militare Clandestino
57
Sabrina
Sgueglia
della Marra
d a ll e bande" , i sol d a ti tedesc hi furono cos t retti a s upp orre c he "ogni borghese di amb o i sess i fosse ca p ace di un assassin io a trad i me n to , e che da og ni casa pot essero partire colpi di arma da fuo co mortali " . La situazio ne r is ult ava inso s te ni bile pe r il feldma resciallo proprio i n virtù de ll 'appogg i o d iretto de ll a p opolazione che espo neva i s uo i mil it ar i ad una con t inua imp oderabile minacci a A cau sa del "co mportamento b rutale e ta lvo lta barba ro de ll e bande" , Kesse lring dovet te o rdi nare a ll a tru ppa l ' uso ill imita t o delle arm i p o iché la lotta , "se non si voleva add ir itt ura c omp iere un s ui cid io", esigeva u na tra sfo rma z io ne mentale: doveva esse re po s ta s ullo stesso piano de ll a guerr a a l fr o n te 196
2 . Il co lonnello Giuseppe Cordero Lanza di Mont ezemolo
Giusepp e Cordero Lanza di Montezemolo nacque a R oma il 26 magg io 1901 da u na famig l ia d i ant ica tradiz ione militare originar ia di Mo ndovì. Com e ha c hi osa to Giu sep pe C a tanzaro , il s uo fu "u n sacerd ozio mi lit are" in cui l ' ero ismo, la devo z ione alla Pa tria e al dovere, s'ide n tificarono con la profe ss ione di solclato 197
Term in ati g li s tudi medi su p eriori , ne l g iugn o 1918 , a di ciassett e anni si arr uolò volontar io nel Hl R egg imento Alpini , B attaglione P inerolo.
D appri ma fu asseg nat o a lla sede d e l centro di M ob ilit az i o ne poi , ad agos to, al le trupp e mobi lit ate in zona di gue rra del I Reggim e nto Alpini' 98 . R icevette be n presto il battesimo del fuo co e combatté sui monti Le ss ini e su ll ' A lti ssimo 199
Nel dice mbre dello stesso anno , fu ammesso a l V corso spec iale pe r ufficiali di comp lemen t o del G e nio e di milizia te rritoria le , presso l ' Accademia Militar e di Torin o. Prom oss o sottote ne nt e di c ompl eme nto ed assegnato a l I R eggi me n t o Genio con a usil iarietà a p arti r e dal 27 ap ril e 200 , si cl assificò p ri m o s u centosessa n tacinque pa r tecipanti al corso e il 2 novem-
196 Ivi. p.255-256. 260-261.
197 Giuseppe Maria Catanzaro, Mo111 eze molo L 'uomo e l 'impresa cla ndes tina . Edi torial e Romana. Roma 194 5 , p. 12.
198 Stato di servi~,io del colonnello di Stato Maggiore Giuseppe Cordero Lanza di Montezem olo. Ministero della Guerra, Regio Eserc i10 Italiano, Direzione generale personale uffi ciali . Divi s ione m atri co la e li bre tli perso nali , Sc2.io ne I''

199 Rambaldo Galdieri. Bolfettino delrls 1i11110 storico e di cultura dell'Arma del G enio. fascicoli 18-19-20-2 l. dicembre 1943-gi ugno 1945. Tipografia reg ionale, Roma, 1945. p.19.
200 Stato di servizio del colonnello di Stato Maggiore Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo cit.
58
bre 1919, di nanz i alla ba ndi era del I Reggimento Genio a Pavia, prestò quel giuramento c he avrebbe ottemperato fi no all'est remo sacrificio20 1 Rimase a Pavia per un breve periodo ; ne l giugno 1919 , fu tra s ferito alla 100a compagn ia zappatori mobilitata e, nel novembre, al V R eggimento Genio di Torino 202
Non potendo accedere al servizio attivo permanente, Monte ze molo s i co ngedò e riprese gli studi al Reg io Politecnico di Torino interrotti due anni prima. Il 29 luglio 1923, a soli ventid ue ann i, s i laureò col massimo dei voti in In gegneria C ivile e fu immed iata mente assunto da un 'i mportante impresa di costruzione di Genova203 .
Si sposò a Torino i l 22 agosto 1923 con Amalia Dematteis, da cui e bb e c inq ue figli: Manfred i, Andrea, Lydia , Ysolda e Adriana. Nel dicembre 1924, fedele alla s ua vocazione militare , partecipò con successo al concorso bandito d al governo per la nomina a tenente in serviz io attivo permanente del Genio, riservato ai laureati in in gegneria r edu ci dalla g uerra
In s eguito, al comando Genio di Torino , fu de s tinato all ' Ufficio fort ific azi oni e, nel dicembre del 1926, al Reggimento Ferrovieri 204
In q ueg li anni, Montezemolo si concentrò s ull 'attività sc ien ti fica e pubblicò tre st udi di notevole valore dottrinale relativi allo svuotame nto, per ragioni mil itari, dei gran d i laghi artificiali , alle costruzioni ipers tatiche mediante costruzioni s u modelli e al calco lo d e ll e impalcate dei ponti militari su sostegni galleggianti.
Dalla soppressa Direzio ne Ge nio Militare di Torino, fu trasferito all ' Ufficio fortificazioni del Corpo d'Armata. Concluso l'apprend istato presso il Reggimento Ferrovieri, divenne comandante di plotone e, success ivamen te, capo Stazione Militare di Aosta. Promosso capitano nel ge nnaio 1928, entrò alla Scuola cli Applica z ione di Artiglieria e Genio come insegnante aggiunto di scie nza delle costruzioni. Freque ntò dal l. 930 al 193 3 la Scuola di Guerra, classificandosi primo su settantuno ufficiali allievi; i suo i superiori lo definirono "eccezionale" per doti fis ic h e, intellettuali e morali.
Il 27 novembre 1934 , Montezemolo venne assegnato come I capitano al comando del Corpo d'Armata di Torino e, malgrado l ' oneroso incarico , no n trascurò l'att ività sc ie ntifica, ma vi si dedicò alacremente approfondendo le
201 Rambaldo Galdieri, op. cit., p.19.

202 Stato di servizio del colonnello di Stato Maggio re Giu seppe Cordero Lanza di Montezemolo. cit.
203 Rambal do Galdieri, op. cit., pp.19 -20.
204 Stato di Serv iz io del co lonn ello di Stato Maggiore Giu se ppe Co rdero Lanza di Montezemolo , c it.
Montezemolo
Clandestino
e il Fron te Mi litare
59
Sabrina Sgueglia della Marra
competenze tecniche acqu1s1te, come ri s ulta da un suo e laborato sulla "costruzione di travate contin ue a cerniera con materiale Kohn " che venne pubblicato sulla rivista d'Artiglieria e di G enio 205 Com e ha o s se rv a to Ore ste Bovio, egli riuscì a co nserva re intatta la tradizio ne d e ll 'esercito piemontese "che riuniva ne ll 'ufficia le del genio il coman d an te di truppe e il co s truttore di infrastrutture militari" 206 .
Durante la campagna d'Etiopia, fu c hiamato a Roma all'Uffic io Servizi del Corpo di Stato Maggiore, ove rima se fino a l maggio I 936.
Nominato magg iore a scelta il 16 marzo 19 36 , gli fu attribuito il com an do di un battaglione del I Reggimento Genio fino al 22 gennaio del1'ann o s ucce ss ivo , q ua ndo, a Napoli, partì p er l'Eritrea come membro di un a co mmi ssione d i collaudo delle ro t abili Massaua - Asmara e NefasitDecame rè207 .
Dopo circa u n m ese , imbarca tosi a Massaua, giun se a Napoli il 22 febbraio. Nel settem bre 1937 fu inviato in Spag na quale capo di Stato Maggiore della Bri gata Frecce Ne re. In ta le peri odo, ottenne la prom oz ione a tenente co lonne ll o per merito di guerra e una c roce di guerra al vaJor militare con le seguenti motivazioni:
Capo di S. M. di un comando di brigata mista durante un ciclo opera ti vo parti colarment e import ante e difficile. si è distinto per e empio e valo ri pers ona li , a l comando di reparti, per s piccate doti organizzative, dando così un valido contributo ai success i de ll a bri ga ta stessa - 9 marzo-19 apr il e 1938.
Capo di S. M. di un comando di brigata mi s ta, incari ca to di portars i p resso un coma ndant e di reggimento impegnato sulle lin ee avanzate per dirigere il contrattacco delle s ue truppe, a ss olveva completamente il compito a s segnatogli, malgrado avesse avuto ri petutamente colpita la sua vettura dal fuoco di fucileria e di mitragliatrici nemiche, cooperando arditamente alla vittoriosa riuscita dell'azione - La Molati Ila, 9 marzo I 938 208
Ne l giugno 1938, Montezemolo venne nominato insegnante aggi u nto di logi st ica all'Istituto S uperiore di Guerra, ove , a nc ora una vo lta, ricevett e enco mi e ri co noscimenti dai suo i superio ri che ne elogiarono il ragguardevole apporto d idattico.
205 Rambaldo Ga ldieri. op. cii .. pp.20-21 .
206 Ores te Bov io . op. c ii ., p.337 .
207 G iuseppe Maria Catanzaro op. cii pp.81 - 85: Ores te Bovio, op. cii p.338; Stato di se rvizio del colonnello di S.M Giu seppe C o rclero Lanza di Montezcmolo, cit.
208 Stato di serv izio del colonnello di S.M. Giu !teppe Co rdero La1ua di Monteze molo, cit.; Giu seppe Maria Catanazaro, op. ci i., p.85.

60
Alla vig ili a dell' e ntrata in g u e rra , il 4 giugno 1940, fu trasferit o al Comando Supre m o, dapp rim a in qua lità di ca po della sezione eserc ito, poi di capo dello scacchiere afr ica no , e d infin e di capo dell'Uffic io Op erazioni. I ca pi di Stato Maggi o re Generale che s i succedettero, B adog li o, Cavallero, A mbrosio , nono stan te le pressanti ri ch ies te di M o nt ezemo lo di e ss ere assegna to ad unità combatten ti , non vo ll ero privarsi della s u a preparaz ion e, della s ua operosità e della sua sp iccata intelJige nza, ne l diffic il e compito di ottenere il m ass imo rend im e nto dagli assai defic itari mezzi a di spos izio n e per il co ntlitto209 • Ali' ini z io de ll e ostilità, benché avesse co noscenza di retta d elle car enze e delle scarse pos s ibi lit à de ll'apparato mi litare italian o, sc ri sse: "In Italia nessu no se ne pe rs uade, ma c 'è la g ue rra ... Il mio elementare dovere è q ue ll o di dedicare ogni mia energia, pur nel piccolo quadro delle mie attribuzioni , al bisogna vinc e r e ... " 210
Monteze molo sep pe guadagnars i la stima e la fiduc ia di tutti i s uoi su periori: il generale Cavig)ja, ad esempio, lo definì nelle sue memorie, "un simpa tico e valoro so ufficiale , d i idee ape rte, ma assai preciso" 211
Dura nt e la s ua permanen za al Comando Supremo, eg l i compì sedic i m i ssioni in Africa sette ntrionale che gli val s ero una me d ag l ia d i bron zo a l valo r militare poiché, a Tob ruk, dopo un improvv i so attacco nemico, seppe disporre efficacem e nte i repart i r ipiega nti a difesa delle proprie posi z ioni , ristabilendo in ta l modo una s itua zi one c h e sembrava ormai irrec u perab ile. Ne l gennaio I942, fu insign ito di una med agli a d'argento e , il l 9 marzo 1942, della Croce di Ferro ted esca di secon d a classe . Il d iario redatto d a l generale Cavallero negli ann i 1940-1943 , quand ' era capo d i Stato Maggiore, de sc rive la so l e rte e preziosa attività svol ta da M on teze molo nello scacchiere africano, attes tando l'alti ss im a considerazione cui era ten uto, l'a ss oluta fiducia in lu i ripo sta e le s ue capacità pro fessionali.
Complessi e delicati , infatti, furono gli in caric hi che d ovette assolvere. Cavallero usò inviarlo a colloquio con Rommel e s i avvalse r egolarmente de lla s ua consulenza nella compilazione d e ll e direttive da im partire ai coman di ita l iani per le operaz ioni in Libi a fino alla st re tta di El Alamein. li generale s i affidò, altresì , a ll a s ua opera di medi azio ne : eg li funse d a raccord o tra i coman danti dell ' Africa sette ntrion ale e tra ques ti e i I capo di Stato M aggiore.

Montezemolo e il Fronte Militare Cl andestino
2m Rambaldo Galdieri , op. cit., p.23; Oreste Bovio, op. cit. , pp.339-340.
210 Gabrio Lombardi, op. cit., p.16.
61
2 11 Enrico Cavi g li a, o p. cit., p. 223.
Sabrina Sgu eg lia della Marra
Bastico, a d esempio, ri corse sovent e a Montezem olo p er riferire a Cava llero su lJe di fficili re lazio ni col Comando tedesco e pe r metterlo in guardia su ll e crescen ti pretese dell'alleato che, come annotò, contava di farla da pad rone asso luto . Montc ze mol o , dun que, ebbe modo di affinare l ' inn a ta capaci tà di medi a to re c he tan to g li sarebbe ser vita in futuro , prod i gandos i ne l te nt ativo di co nc iliare le p os izioni co ntr as tan ti c he ta lvolta emergevano su ll e mo da lità opera tiv e co me accadde, ad e se mpi o, quand o B as ti co e Gambara ebbero opinio ni dive rgent i riguardo la fus ione dei due coma ndi esisten ti in Trip olita ni a, o pe r diri m ere i di ss idi che animarono, sem pre più spes so, i rapporti co i tedeschi.
Allorch é sor se un g rave di sse nso t ra i coma ndi di Rommel e Ga mb ara, Cavallero adottò la risol uzio ne prospena ta da Mo nte zemol o, ovvero non sollevare il ge nerale italian o dall'incarico ricop e r to in quanto si trattava di un co nflitto tra organ i mili tar i, non tra pe rso ne, e un provvedimento del genere no n sar ebbe s tato i nterpreta to eia parte tedes ca co me u na m is ura vo lta a d in asp rire , non a distendere , i rapporti tra i due p aes i212 .
Promosso colonne ll o il I magg io 1942, gli fu conferita la c roce di cav aliere de ll ' Ord in e Milita re di Savoia con tal e motivazione :
Uffic ial e di S . M. di eccezionale capac it lt, in tre anni d i la vo ro presso l'Ufficio Operazioni , caposezione dell'e se rcito prima, capo scacchiere Africa poi, ed infine capo dell'Ufficio Operaz ioni. ed in nu merose mi ssio n i presso le truppe operanti oltre mare, ha re so segnalati se rvigi e validamente co ntribuit o ag l i s tudi per la condotta delle o perazioni delle tre forze armate, nei vari scacchieri della no stra gue rra - G iugno l 940 - Gen na io I943 2 13

3. Le prim e fa si di vita d el Fronte Militare Clandestino
Su ll a Re s istenza militare che s i d ispiegò nell' Ital ia centrale e che ebbe a R oma il suo cen tro nevralg ico è stato se ri no dec isame nte poco. La fonte di dati più ri cca e d oc ume nta ta è i l libro sc ritto a cald o , ne l 1945, dal colonn e llo Ezio De Mi chelis, cui fece capo una complessa e ramifica ta a tti vi tà clandcs tina214 .
212 Ugo Cavallero. Comando Supremo Diario /940-194 3 del Capo di S M.G Cappelli, Bol og na, 1948 pp 162 -3. 173 , 199-200, 214. 24 1-3. 247 - 8 252, 281 -4.
213 Stato di servizio del co lonn ello di S.M. Giu se ppe Cordcro Lan1.a di Montezemolo, cit.
214 De Micheli s rie ntrato nella cap itale dopo un'in c ursione in Piemo nte ove aveva spera to di trovare ancora effic iente la IV Armata. iniziò ad o rgani zza re un primo nucleo di Res istenza che si estese in breve nella pro vinc ia e in alcune regioni dell' Italia Centrale. impegnando un gruppo di uffi c ia li di notevole valo re.
62
In generale, l ' approfondimento storico continua ad esse re carente per quant o concerne la partecipazione dei militari alla lotta pe r la liberazione. Non s i nega che il movimento p art igia no debba molto al l' eserc it o, ma si tende per lo più a cons id erare tale fondamentale co ntributo u n fenomeno spontaneo, affi d ato all'i n iziativa di elementi s parsi , di grado poco eleva to e se nza alc un collegame nto col Coma n do Supremo.

L'attività svolta da Montezemolo, affia ncata da quella d el colon nell o D e Michelis, sta a d im ostrare, invece, che, pur trovandosi in cond iz ioni di q uasi totale im potenza p er la punitiva politica a n gloamericana, il Coma ndo Supremo non solo incoraggiò costan te me nt e i mi litari rimasti nelle zo ne occupate ad entrare nella clandestinità e a partecipare attivame nte alla lotta par tigiana, ma si prodigò con ogni mezzo a s ua di s p os izione per coordinare e sostenere il movime nto cli Resiste nza.
Il 23 settembre 1943, g io rn o de ll 'i n sediamento formale del regime neofasc ista cli Salò, in seguito al proclama di Mu sso lini che il 16 aveva dichiarato i mil itari italiani sciolt i da l g iuramento di fedeltà alla monarchia , il generale Stahel annunc iò un a propria vis ita al co nte Cal vi Con autoblin d e e mitragliatrici, i tedesc hi bloccaro no tutte le uscite del mini s tero degli Internj - dal quale pre levaro no gl i e le nchi degli ebrei residen t i in Italia, conserva ti presso la Direzione G e neral e d ella D emografia e R azza - e il ministero della Guerra215 . Stahel comunicò a Calvi c h e , ne ll' arco di pochi minuti sarebbe stata proclama ta la R epubblica Sociale I ta li ana e c he si esigeva la s ua fattiva collaborazion e . Otten ne però risposta nega ti va: Calv i si dichiarò fedele a l re e a l giuramento pr esta togli , perta nto, in vio lazione d e ll e conve nz ioni stab il ite, fu arrestato Venne così a cessare ogni , sia pur lontana , parvenza di legittima autorità militare in Roma ed ogn i p oss ibi lità d i adoperarsi in forme legali per la causa nazionale. M en tre Stahel si recò dal co lo n ne ll o Chie li, anch ' egli al comando della città aperta, per rivolgergl i la s tessa domanda, in un drammatico colloquio , Calvi e Montezemolo si accom iataro n o . Il genero del sov rano , a cui era sta to concesso di porta re con sé un u fficiale, invitò il co lo n ne llo a seguirlo ma questi replicò che sarebbe rimasto a Roma, avrebbe cercato di metters i in salvo e di rendersi uti le a ll a cittadinanza. Ca lv i, pertanto, lo pregò di ri fe rire a Vittorio Ema nu ele che lo aveva servito fed elmente fino all'ultimo e che, nonostante l ' ini ziale diffidenza, aveva trova to in Montezemo lo il più fedele amico e collaboratore.
Qu esti non ebbe es itazioni: decise di non attraversare le lin ee per trovare rifugio al Sud, ma d i rimane re per combattere e "si avviò all'impresa grandi o-
Montezemo
lo e il Fron te Militare Clandestino
21
63
5 Anna Baldinotti , op ci t. , p. 64.
Sabrina Sgueglia della Marra
sa con i ' aria mod es ta dell ' uomo qualunque" 21 6 Congedatosi dopo un affettuoso sal uto , ri entrò nel suo ufficio , si vestì in borghese, nascose la di visa in una valig ia, e mi se in tasca la pistola e alcuni documenti. Passò dava nti ad alcune sentine ll e tedesche c he , ev identem e nte , non lo riconobbe ro malgrado l 'avessero v isto poco prima in div isa, e abbandonò il minis tero attraverso il sotterraneo.
Ma ria R oss elli , mog li e del gene rale Ma ri o Capita ni , capo d i stato ma ggior e del Corpo d'A rm ata di R oma, ha racco n tato c he qu el giorno , co n suo marito , s' imbatté in Montezem o lo e, ignari d i ciò che s tava accadendo, ri sc hiaron o di farlo ca ttura re: il co lonn el lo passò ve locemente accanto a loro e rispose frettolosamente , cosa in solita, a l saluto che il collega, ad alta voce e chia mandolo per nom e, g li ri volse. Il generale avrebbe scoperto solo in seg ui to c he eg li s t ava tentando di s fuggire ai tedeschi e comprese il pe ri co lo cui, in volontaria men te, l 'aveva esposto2 17
Calvi d i Bergolo fu fallo salire insiem e al capo della Poli z ia dell ' Africa Italiana , ge nerale Maraffa, su un treno dire tto in Germani a, ma riuscì a fuggire e a trovare riparo in Piemonte. Su bentrarono al Co ma ndo de ll a ci ttà ape rta, formalmente ri co nosciuto anche dal neon ato governo n azionale fascis ta , il generale Chieli, ape rtam e nte ted escofi lo, e il genera le Chirie le iso n. Quest'ultimo ha affe rmato che, malgrado le difficoltà cui an dò incontro e la ferrea oppos izione d i Mussolini a qual un qu e priv il eg io per la capita le, cercò d i attenersi a ll a lin ea politica dei s uoi pred ecessori vol ta a co rroborare le p re roga t ive del co mando , co nt ravvenend o, così, alle direttive di Graz iani c he gli im po nevano d i limi tare le proprie funzion i all'ambito militare. Ma ntenne stretti rapporti con la Santa Sede, in particolare col cardinal Maglion e, ed entrò in co ntatto co n l'Office of Strateg ie Serv ices e co l CLN da cu i ricevette l'auto ri zzazione a prestare giur amento alla Re pubb lica Sociale, sacrificio che s i rendeva nece ssa rio in vista dell'obi e tti vo da consegui re. Allo stesso modo, Chirie le iso n im prontò ad un'apparen te cordia li tà le relazioni col co mando ger ma n ico e vi ri u cì, in partico lare, col generale M ae ltzer, seb be ne, co l passar e de l tempo, gli incontri s i diradarono per la crescente diffidenza nei suoi confronti: nel maggio 1944, gli furono rivo lte accuse di sa bot agg io da Maeltzer e Kappler. I buo n i rap porti inizi a li ve nn ero sfruttati soprattutto dal te nente Borin, ufficiale interpre te e di collegamento col Comando germanico, che ebbe modo di entrare in possesso d i preziose informazion i s tra tegic he as sa i ut i li a ll a V Armata2 18
216 Ful v ia Ripa di Meana. op. cit., p.45 .
217 Mario Capitani, LCI d(fesCI di Roma. C,vnis toria dal 25 luglio al 29 serrembre 1943, Mucchi. Modena. 1973, pp. 114-115.
218 A.C.S , Ministero d ella Real Casa. Ufficio del Primo aiuwnte di campo, Serie speciale, b 81. f.7. "Re laz ion e ge nerale C hirielci so ri' '
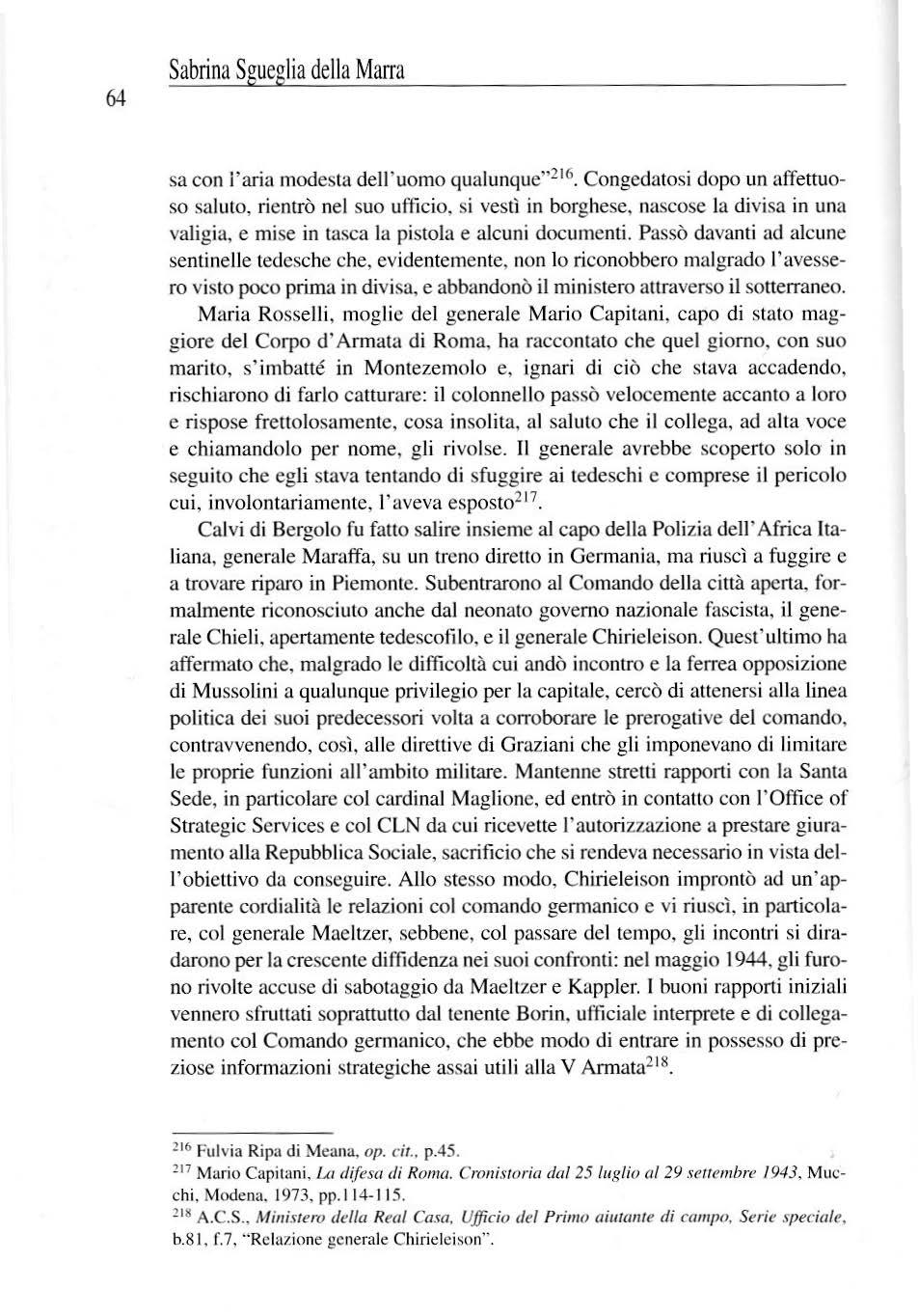
64
Il generale della PAI Umberto Presti si assunse la responsa bi lità di s ubentrare a Maraffa, ponendo come condizione l'assolu ta apoliticità della polizia che avrebbe dovuto occuparsi escl us ivam en t e del ma nt enimento de ll' o rdin e pubbl ico e de lla tu tela de ll e per sone e dei ben i219 Gli in te rv e nti volti a lenire le s offerenze del la cittadinanz a ed i te nt ativ i di impedire che Roma venisse coinvolta nelle op erazioni belliche , tuttavia , pe r la magg io r pa rte, no n riusciro no nell'inte nto.
Il 25 sette mbre, Kesselring fece trasmettere per radio e pubblicare sui g iornali l'avviso ai sabotatori in cui g li occu panti ammonivano la popolazione che chi s i fosse fatto is truire dagli inglesi e dai seguac i di Badoglio e chi avesse danneggiato g l i interessi dei tedeschi in Italia, avre bbe su bito tutta la durezza delle leggi militari germaniche. Tale sorte sarebbe toccata non so lo ai "malfattori", ma anche aJle loro famiglie 220 Ana logame nte, i l 29 settembre, l'ordinanza "per la difesa delle armate tede sche" in timò che chi unque aves se osato "distu r bare la quiete e l'ordine del paese o sollevare movimenti comun isti e a narchic i contro la sicu rezza del popolo italia no", considerato nemico della s ua patria, sa rebbe incorso nelle pene previ s te dalle se veri ss ime leggi del tribunale mili tare22 1
Il regime d'occupazio ne dipanò , dunque, si n d a ll e prime setti ma ne, quella struttura tentacolare e per vas iva che av re bb e conc ulc ato per nove lu nghi mesi, i diritti, le aspiraz io ni e la d ign ità della cittad in a nz a . M on tezemolo, dopo ave r profuso ogn i e nergia a l consolidamento de l Comando della città aperta, scampato miracolosamente alla cattura, riconobb e come unico governo legittimo quello del Sud e realizzò un centro operativo clandestino c h e si collegò co l Governo di Brindisi, col Comando Supremo e co l Comando alleato.
La sua fede di soldato, l 'a ttaccamento alla pa tr ia e l'avve rs ione ai tedeschi, non gl i avrebbe r o m a i co nse nti to di assiste re d a ine rm e spettato re al generale sba nd a mento dell'e se rc ito e del paese . Si dedicò all'organ izzazio ne della lotta facendo appello a tutt e l e s ue ri sorse : l' esper ie nza acqu i s i ta n egli a nn i d i se r viz io , l'ampia preparazione tecn i ca e la perfetta conoscenza d ei tedeschi , che sapeva capaci di qualunque sopruso. Montezemolo intuì che il movim e nto di R esiste nza avrebbe avuto qualche proba bilità di successo so ltanto se fosse riu sci to ad a ma lgamare le varie compo ne nti, ad indirizzare i singo li s forzi verso un obiettivo co mu -
220 Renato Pe rron e Capano , op. cit., p.159.
22 1 lvi, op. ci i ., pp.450 -454.

Mon tezemolo e il Fronte Militare Clandestino
2 19 A.C.S , Ministero della R eal Casa, Ufficio del Primo aiutante di campo , Serie .speciale, b.82, f.44.
65
Sabrina Sgueglia della Marra
ne e definito. Fed e le al m otto della s ua fami g li a, honn e ur et fide lit é, ancorché n o n avvezzo alla cos pirazion e a r mata, eg li cominciò a lavora r e alacremente per in quadrare e fondere, in un uni co dispo s itivo militare di resi s te n za , gl i uffici ali e i so ldati sbandati ch e, per sottra r s i alla cattura, si erano rifu g iati ne ll e località i ntorno a R oma. q u ell i che erano r i usciti a na sco nder s i in città presso le proprie famiglie o in sedi dello Stato Vaticano , e qu elli c he avevano già cos t itui to , spon taneam e nt e, dei repart i armati di diverse dimens i oni e potenzialità , alcuni se n za una particolare ideologia, a ltri già sensibili ad un determinato orie nt amento pol i tico. Ai gruppi cland est ini, presci ndendo dall e pec uli ari co nnota z ioni acquisite, il colonnello impose un unico indis pen sa bile requ is ito , ovvero, che fossero determi nati a " r iman e re fedeli, ad ogni costo, all'ltalia" 222 Eg l i, infatti, s i n dai giorni del Comando della città a p erta, individuò chiaramente il percorso da intraprendere:

Bisogna ricominc iare ogni cosa daccapo , far vedere aJ tede sco di c he cosa sia ca pace il popolo italiano tutto unito conlro di lui. Dobbiamo crea re un fronte di re s istenza. lavorare clandestinamente nonos tante l a nostra occupazione. L' attesa non dovrebbe essere lunga, del res to. Dal Sud abbiamo avuto co munica zione che lo s barco , c he doveva aver luogo poc he ore dopo la dich iar azione dell 'armist izio. può ora attendersi tra il 28 settembre e i primi di ouobre. Se co sì avverrà. il nostro com pito sa rà facile. In caso contrario , la prova s i presenta dura , ma bisogna affro ntarla e l'affrontcremo223
La sua integrità e il s uo rigore non amme ttevano eccezioni: a chi gli chiedeva in dulgenza nei co nfronti d i coloro c h e si d iceva no cos tre tti ad aderire alla repubblic a fasci s ta per necess ità materiale di vi ta, rep li cava: "Non esiste, seco ndo me. ne ss una rag ione plaus ibi le perché un ufficiale tradi sca il suo g iu rame nto, nemme no la fame" 224 Non co ntav a la sorte dei singo li , bensì che il lavoro com un e contin uasse e de sse i suoi frutti.
Il ca po del FMCR s i fece c rescere i baffi e cambiò subito le propri e generalità: s u l suo passaporto comparve il nome di Giacomo Ca teratto, ingeg nere , pseu donim o col qu ale era s tato inviato in Spagna nel 1936. I n seguito, per magg iore prudenza, fu c ostretto ad ass umere u na nuova identità e di ve nne l'avvocato Giuseppe Martini.
222 Es tratto da l discorso com memorativ o del generale Umberto Borla agl i studenti della Scuola Media Statale di Roma intitolata a Monteze molo. il 22.3. 1969. in "Tradizion e militare"
maggio 1969.
223 Fulvia Rip a di Meana. op. cir.. p.42.
224 lvi. p. 80.
66
Dopo ripetuti tentativi, finalm en te, il 5 ottobre, riu scì ad incontra r e il ministro d ella Guerra Sorice tramite l 'avvocato Dona to Tommasi, ne l cu i s tudio , sempre aperto, furono accolti tutti i più attivi cla ndestini. Montezemolo poté dunque riprendere i contatti col suo min is tro e dare l'abbrivio ad un'abituale e cos tante co ll aborazione225 A cementare l ' in tesa pro filatasi furono l'anelito alla libertà dell ' Italia dal giogo stran iero e la comune volontà di riscattare l ' autorevolezza, la credibilità e l'onore, così gravemente appa nn ati, dell'esercito che, sebbe ne sostan zialment e afascista, aveva s ubito fortemente l'influ e nza del potere statale per ragioni di p res tigio e avanzamenti professionali.
L'attività s volta da Sorice a sosteg no della compagine militare ed il serio impeg no profu so nella lotta antitedesca e antifascista a fianco del FMCR 226 ne fecero uno d ei principali colla boratori d i M o ntezemo lo.
Non appe na divenuto ministro, infatti, riso lu to a por re una netta cesura col passato r egime e ad imprimere nu ova vita l ità alle forze armate, nel luglio del 1943, sancì il ripristino del regolamento di d isci plina che impo neva agli uomin i in divisa l'asso lu ta aste nsio ne dall 'a ttività politica dopo le pregiudiz ievoli commistioni del periodo fascista 227 Coi medesimi inte ndiment i , nell' agosto, Sorice diramò un'apposi t a circolare incentrata s ulla mentalità degli ufficia li, di cui condannò, non senza apprensio ne, la " rilassat ezza s pirituale", pernic ioso fenomeno da arg in are con ogni me zzo per restituire all'esercito, ist it uzio ne ancora "fonda mentalmente sa na, vit ale, operante", il pre s ti gio di c ui aveva sempre goduto. Gli ufficiali, pe r primi, s i sarebbero dovuti cons id erare al di sopra di ogni altro cittadino per "il tremendo onore loro con ferito di g uid are altr i uomini , con le armi in pug n o, «ov u nq ue venga dal Sovrano ordinato» (pag.1 reg. Disc. Mil.) " 228 •
Jo Di Benigno, moglie del generale Olmi e co llaboratrice del ministro, ha raccontato che il co lo n nello a partire da ottobre, fino all'arresto , si recò due o tre volte alla settimana a rapporto. I giorni prestabi li t i erano il lun edì e il venerdì , tal volta il mercoledì. Arrivava sem pre per primo, con un po' d'ant ic ipo , e , infor mato d ettagl iatamente il s uo s uperiore, riceveva i struz ion i Le li nee direttrici cui Sorice presc risse di atte nersi scrupo lo samente, basate s ul
225 Jo Di Benigno, op. cii., p.177 .
226 A .U.S .S.M. E .. 1-3, b.148, f.2. "Ba nd e armate della Democrazia Cristiana", A utorità Militare Italiana in Roma (1.M .A.R.), Ufficio Stralc io, al Reparto Fronte Clande stino di Resistenza - Ufficio Pers onale 2• Sez.ne, 21-8 - I 944.
227 Giuseppe Co nti , La c risi morale del '43: le forze armate e la d(fesa del territorio na zio· nate, in Storia contemporanea", n.6 , dicembre i 993, p. I I 36.
228 A C.S Pres iden za del Consiilio dei M inislri 1940-1943, fasc. 1/2 -2 , n 22442 ·'Circolare del Mini s tro della Guena in merito a l ca ratt.cre e alla mentalità degli uffi c iali "

Montezemolo e il Fron te Mi litare Clandest ino
67.
Sabrina Sgueglia della Marra
r iconosc imento d e ll'autorità legittima del governo del S ud, vennero verbalizzate l' 8 otto bre:
Ad esso ricominc i a l 'epoca dei governi a rotazione e quindi più che mai l'esercito deve stare fuori dalla politica e non legarsi, per ness una ragione, ad alcuno d e i capi de i parti ti. Per no i, Bonomi, O rl ando, Sforza, C roce, so no t utte ri s pe tta bili ss im e perso ne che tengono al bene del pae se, ma i l lega rs i con uno o qualcuno di essi è ne ttamente contrario allo sp irito del regolame nto di disciplina militare Ricord i amoci che fin dall'agosto è sta ta da me emanata una disp os iz ione severi ss ima che vieta agl i ufficiali in serv izio attivo di iscrive rsi a parti ti politici. Sotto il fascismo ci siamo difesi come ness un ' a ltra amministrazione, epp ure già incominc iano ad accusarc i di aver s ub i ta nel 1934 l' i mpos izione della tesse ra. Evitiamo adesso i l ripetersi di un errore che, nell 'a ttual e gioco politico, sarebbe ancora più grave. 11 nostro lavoro dev e attenersi a queste d irettive : guerra al tedesco, mantene re l'ordine p ubb l ico, non fa re politica li governo legale è quello nominato da l re in base all ' armistizio . L a no stra coll aboraz ione ai partiti deve essere data con assoluta sincerità ma con altretta nta indipendenza, mettendo a disposizione tutte le nostre conoscenze tecnic he ed organ izzative e, a questo fine, tu , Monte ze molo , devi esse re J' osservatore militare ne l comitato di liberazione, ma non ti lascia r trascinare a simpatizzare né co i monarc h ici , né coi repubblicani, né con altri 229

Sorice , inoltre, ind ividu ò nelJa Guardia d i Fina n za e nei Carab in ieri le due istit uz ioni fon d amentali sulla c ui sal d ezza la monarch ia avrebbe potuto co ntar e : "sono queste e queste sole - disse - le forze sulle q ua li l'autoritù costituita potrà fare affidamento all'a tt o della liberazio ne". Rig uardo alla creazione di bande, asseverò l'opportun ità d i organizzarle in "gruppi di sabotaggio, di di stu r bo, d i inform az ione". Non servivano "g rossi nuclei di ge nte , armata s ì e no con un modesto fucile" po ic h é, al contrari o, avrebbero favo ri to gli interessi personali di c h i se ne fosse impossessato. lJ mi nistro della Guerra concluse l'esposizione del s uo programma ca ldegg ia n do m oderazione e avve dutezza , e suggere ndo a Monteze molo di fars i promotore d i u n comportamento aderente alla realtà, avendo cura di non d isgustare nessu no e can al izzando ogni risorsa ver so gli obiettiv i indicati 230
Come riportato dalla relazione co nsuntiva sull'attivi t à della Del egazio ne del Comando Supremo in Roma e de i comand i C iv ili e Militari della città d i R oma, ne l periodo 22 settembre 1943 - 5 giugno 1944, M onteze rn olo incontrò, nel pomeriggio del 23 settembre, in un viale di Vi lla Borghese, ne i pressi d i piazzale F lam inio , il co lo n nello Giovan n i Pacinotti e il maggiore d'arti-
230
68
229 Jo Di Beni g no, op. cit pp.177 - 179
Ivi, 178- 179.
glier ia delle batte ri e a cavallo Mario Argenton 231 S i co noscevano da anni e non fu necessari o intendersi sull'attegg iamento da adottare : pro ced ettero immediatame nte all'esame delle modal ità esecutive e, come p rim o passo , co nvennero d i mettersi in contatto co l Comando Supremo .
Lo S ta to Maggiore, abb an d ona ndo la capitale, aveva provveduto a nascondere in un posto sicu r o un a de ll e due stazioni rad io clan destine tramite cui aveva condotto le trattative d'armistiz io con g li Alleati. Pertanto, il 13 sette mbre , fu inviato in miss ione a Ro ma il maresciallo radiotelegra fi sta Baldanza col compi to di rintracciare l 'apparecchio ed attivare un collegamento col governo del Sud. Pochi giorni d opo, a rrivò a Brindisi il tenente Zoppi che, con un a rad io cl a ndestina della Regia Aeronautica, tentò di comunicare con la cap it a le, ma il contatto stabi lito s i ri ve lò p recario e del tu tto inadeg uato232 M o ntez emolo, nel Comando de lla c ittà aperta, aveva avuto modo di conoscere d ue uffic iali della R egia Aeronautica, il te ne nte colo nnello M usco ed il maggio re Santini, in possesso di un app arecc hio rad io Secondo la tes ti moni anza di Pa c in o tti , a ca usa d i diffico ltà tecniche, non fu p oss ibi le p redisporre rapidame nte un regolare co ll egamento. Il capi tano Francesco Vassall i, dunq ue, partì eia Brindis i con un nu ovo cifrario e, g iunto a Roma , affia ncò la missione B aldanza e, a pa1t ire dal 2 ottobre 194 3 fino a l 5 gi u g no 1944, se nza interruzioni, fu istitu ito u n po nte radio co l governo d e l S ud attraver so due apparati alternativamente in fu nz ione in luog h i diversi della città: d a piazza
Mignanelli233 a via M o n tezebio, a via Gianturco, piazza Galeno, a v ia Savoia, piazza San Pietro , v ia Flaminia, pi azza San Giovanni , via Veneto, p er sfugg ire alla radiolocalizzazione te desca 234
Nacque, così il Centro X e il lavoro di tu tto il personale di collegament o fu congeg nato, pianificato e diretto dal te nente co lon nell o Musco. F ra gli operator i gi un ti da l s ud, bi sog na annoverare d ue fig ure di p a r iticolare rilievo: il te nen te cie li ' 8 I O R eggimento fanteria Maurizio Gi glio, " C ervo", posto al
231 A.U .S.S.M.E., /- 3 , Carteggio versato dallo Stato Mag!{iore Difesa, b.187, f.5, " Relaz ione co nsuntiva sulla attività s uccessivame nte svo lta dalla Delegazione de l Comando Supremo in Roma, dai Comandi Civ i li e Militari della c ittà d i Roma , nel periodo 22 settembre 1943 -5 g iugno 1944 ; periodo 22 settem bre -5 gennaio 1944 (de legaz ione del Comando Supremo), in sos titu z i<me del Colonnello Montezemolo (cadu to), il Colonnello g ià vic e capo dell'ufficio di collegamento del Comando Supremo G. Pacinotti, allo Stato Magg iore Gene ra le, Uffic io Patrioti , 23 sette mbre 1944
232 A.U.S S .M .E., L 9 , Rac c 021, fase. 4/2, Stato Maggiore Regio Es ercito , Ufficio Informazioni, "L'Ufficio I nella Guerra di Libera z ione " , Roma, 31 gennaio 1946.
m A poche decine di met ri da piazza Mignanell i. all a Sa li ta San S ebas tianello, s i tro vava l'abitazione di Dollmann .
234 Alfonso Banolini-Alfredo Terrone, op. cit., p. 22; Jo Di Ben igno, op. cit . , p.255.

Montezemolo
e il Fronte Militare Clandestino
69
Sabrina Sgueglia della Marra
servi z io dell ' OSS d a l co m ando della V Arma ta, e l 'age nte dei se r viz i seg re ti a meri cani e capo de ll a mi ss ione a Roma , Pe ter Tompkin s.
Gi g lio riceveva da Napo li le di sposiz ioni dell'OSS: g li fu ord in ato di avviarsi in macc hin a fin sotto gli sbarramenti d ifensivi tede sc hi , nei pre ss i d e ll 'altip ian o del M a t ese e qui , in compagnia d e l te nente Me ni cant i, auraver sò le li nee rec a nd o con sé i q uarz i e d il cifrario di u na radio tra s mitt ente235. La figura di Gi g lio è tra le p iù sign i ficative de ll a res iste nza ro mana. Fu arrestato il 17 m arzo 1944 dag li sc herani de l ques to re Caruso e di Koc h m e ntre , in siem e all ' atte nde nte S co llu , era imp eg nato ne l tenta ti vo di prelevare un a pparecc hi o rad io co ll oca to s ul galleg giante del Dopolavoro d e l mini stero de ll e F inanze. AU·iniz io del mese, il telegrafista B onoco re , rivelatosi poi un traditore, e r a stato indi vid uato da un a spia fascista , co no sc iuta co l nome di Walter Di Franco , c he lo fece ca tturare il 16 marzo. Gi g lio , pertan to , d iede su bito ord in e ai s uoi co ll abora to ri di mettere al sicuro i documenti e, sebbene si trat tasse un 'operaz ione o ltremodo ri sc hi osa , vo ll e occ up ar i personalmente della rim oz ione e de l trasferim e nto in al tro luogo delle due radi otras mitte nti temendo c he Bonocore potesse sv elarne l' ubicazione , proc ura ndos i, peraltro, un grave capo d 'acc usa 236 .
Per i pri mi me s i, rim asero in funzione du e stazion i c he s i dividevano i l lavoro s ulla stessa lun ghezza d ' onda, success ivamente n e r estò att iva un a sol a. Con una delle pr ime comunicazioni , il 10 otto br e, il Com a ndo Supremo nominò M o ntezemo lo s uo di re ll o rap presentante in R oma e lo inves tì. de l r a tto comp ito di impo s tare e dirigere l a lotta d i liberazio ne : " Comunicate se Mont e es t in s itu a zio ne ass um ere compito direttivo et o rga nizzat ivo" 237 .
Fu l 'a tto di nasc ita ufficia le del Fronte Militare C landes tin o di Ro m a c h e. nei s uoi nove me si di a ttiv ità , riu scì a d orga ni zza re dodicimi l a patri ot i in arm i nella cap ita le e dic iasse ttemil a nelle ba nde esterne. Dall ' e s ige nza d e lla mo narchia di garant irs i a R oma u na rappresentanza qu as i ufficiale, ne ll ' inte nto di pre pararsi la strada per il rito rn o , derivò la s t retta connessio ne t ra la resis tenza mili tare e le vicend e del gove rn o del Sud 238
Il co lo nnello , co n fer mand o, così, di vole r assume re la r esponsa bilità cu i era s ta to chia m ato, ne llo s te sso g io rn o in c ui ricevette da l govern o del Su d la
235 Ang e lo Antonio Fumarola. op. cii. , p. 146.

236 A.C.S Mi11is1ero della Real Casa, Ufficio del Primo ai111a111e di campo del re, Serie specia le b.81, f. I 8. m Gabri o Lombardi. op. cir., p .1 7.
238 A.U .S.S. M.E /- J. b. 148 , f.2 " Situazione dell e forze milit ari in Ro m a e ne ll'I ta lia CentroMe r id ionale Relazioni con le autorità angloamericane··. Autorità Militare Italiana in R oma. I.M.A R al Comando Supremo. 26-6-1944.
70
fo rm a le in vestit ura, in viò un telegram m a a Brin disi prec isa ndo il numero e la dis locazio ne delle d iv ision i germaniche allora presenti in It a li a e, pochi giorni dopo , fu in grado di forn ire importan ti ragguagli c irca la neonata Rep u bbl ica Sociale in via di cost ituzione a Salò:
1 tedesc hi intendono anzic hé nuc lei asportare i nt.eri min is teri da Roma et tutti organi pu bbl ici et pri vati a lt unica difficol tà mezzi trasporto alt ri nnovate in ter ruzion i ferrovia ri e nord R o ma239.
P eter Tompki ns, agente dell'Office of Strategie Serv ices, arrivato a Sa le rno nel settembre I943, p ur giu d ica ndo e ncomiabile l'opera coraggiosa di M o ntezemo lo , ne l suo libro di memorie ha liq uidato la p ol itica del capo d el FMC R come il riflesso ped isseq uo e acquiescente d i q u ella di B adogl io, or ien tata, perciò, contro le forze d e mocrati c he e antifasc iste ital iane non me no d i quanto lo fosse contro i nazifasc is ti.

Seco ndo l'interpretazione riduttiva e ta lo ra speciosa d i Tompkins, il solo fine per seg ui to da q uelle che egl i ha bo ll ato come "le fo rze fedel i a Badoglio e al re", fu la p rese rvazio ne della monarc hi a sab auda co n ogni mezzo dis p onibile, una difesa a ni mata non dagli a lti idea li artata m ente millantat i , bensì da mere val u taz io ni o p portunistiche ed economiche. Pe r coloro c he appartenevano alle c lass i magg ior me nte abbie n ti o agli alt i comand i dell'esercito , p iù o meno compromessi da ve nt 'anni di fascismo, il sovrano, m ira ndo alla co n servazione, di cui ra pp rese ntava il bal uardo estre m o, cost it ui va l' u ni ca v ia di salvezza nell'assetto p olitico ed eco nomico de l dopoguerra .
L' age nte americano, d u nque, ravvisò nella poli tica e n e ll ' atti vità svolta da l colo nnello, cui riconobbe tu ttav ia i l m erito di essere " un so ldato veramen te in trepido " , il so lo o biettivo d i garant ire la co ntin uità istituzionale tutelan d o g li interessi de ll a corona che s o la avreb be pot uto sal vaguardare l ' ordine sociale ed impedire la rivoluzion e 240
U n par ere a nalogo è q uello espresso da B occa che ha co nsiderato il FMCR un'app en di ce del governo del Sud , un instrumentum regni privo di qua l unque autononùa Pur riconos cendo l'eroismo di M onteze m olo e " un a s ua in toccabi le virtù personale", lo storico lo ha desc ritto come u n "uo mo del re" dalle o bbedienze riso rg ime nt ali c he s i es pose a rischi gravissinù nel tentativo di protegge re il dispos itivo m ili tare da l ui fo ndato e di assicurar e la permane nza della monarchia 24 1 .
Mon tezemolo e il Fro nte Mi litare Clandes tino
239 Gabrio Lombardi, op. cit. , p.24.
7 1
240 Pete r Tompkins, Una spia a Roma , Ga rzanti, Mi lano 1972, pp. 21, 67 24 1 Giorgio Bocca, op. cit., p 284
Sabrina Sgueglia della Marra
La dip e nd e nz a d a Brindis i e i condi z io namenti c he ne co ns eguiro no ha co nve nuto Pi e tro S ecc hi a, limi ta ro no sens ibilme nte le po te nz ia li tà d e l Fronte cla nde s tin o c he , a s uo parere, fu crea to a l solo sco po di co nferire a l movim e nto re s is te nziale un caratte re marca ta ment e, s e non es clu s iv a me nte , "govern a tivo ' ' in opp os iz io ne a l C L N e a ll a g uerri g li a p o p o la re . C iò. a parere d e llo stori co marxi s ta, e merg e re bbe so prattutt o d a ll ' indiri zzo impresso dal co lon ne ll o alla guerra per band e che e g li , peraltro, ha a s critto ad un a sc arsa co mp re n s ion e del co nt es to rea le: Mon tezemol o av re bbe do vut o a mb ire ad o tte ne re il co mpleto co nt rollo d e ll a lott a armata in og ni reg io ne d e ll a pe ni s ola so ttraendola , così , a lle influ e nz e dei partiti politi c i24 2
C o rv is ie ri , infin e, ha a ffe rm a to c h e l ' impo st az io ne ta tti ca a d o tt ata d al FMCR, ch e eg li pure ha d efinit o a ttendi s ti c a , de ri vò d a un a p reci sa lin ea politic a c o nserva trice s c e vr a tuttavia , di fin a l ità oppor tun istich e 243 .
In re altà l 'o pera di Monteze mo lo , la c ui gran dez za m o r a le fu in di scu tibil e, s' is pirò a l più alto sen so patrio e a ll ' integerrima fed e lt à a l s uo g iuramento La s ua missi o ne, port a ta avanti co n abn e gaz ion e fi n o all' es tremo s a c rifi c io e a pre z zo di s offere n ze in e na rrabili. no n a vr eb be po tuto trarre impul so d a mesc hini ca lco li uti lit a ri s ti c i. Se i m ilitari avessero a ffro ntat o
" c o n dignit à e a te s ta a lt a" i s a c rifici ri c hiesti d all a dram matic h e c irco s tanze , eg li assic urò ch e s i s areb be i mpeg na to a ri ve ndi c are pe r lo ro u n deg no " p os to mo ra le" nell a v ita futu ra de l p ae e, un ri co nos cim e nt o e ti co pe r l 'a lt o se r vizio pres tato , p e r la fed e lt à al d ov e re, no n ga ra nz ie po litic h e od economi c he244 . Monteze m o lo , in o ltre , no n e r a un so ldato qua lunqu e : aveva c om b a ttu to a l fi a nco dei tedesc hi , c o noscev a pe r so nalm e nt e num eros i ufficial i di stanza a Rom a e, d unqu e, poteva es sere fac il me nte ind ivid uato, ricono sci uto e c a tturato Se è in dubitabile ch e il F M C R fu es press ion e d e ll ' e s ig en z a di u na co ntinuit à is t itu z io na le , e c h e, pe rt a nt o, si a p p untaro no s u d i e sso le a m bi z io ni , le mire, e gl i int e rss i di chi tendeva a ll a c onserva z io n e , è a lt re tt a nto evi d e nt e co me ta l i pre ro g ati ve no n possa no es a urire l a co mp le ssa e be n pi ù s ig ni fica ti va v ice nda c u i esso d ie de o ri g in e, un 'es pe ri enza mate riata d i a fflato um a no, di so l id arie tà, di coragg io e di a lti id e a li . S i deve c o ns id e rare c he il FMC R nacq ue in un period o in cui l 'an d a m e nt o dell a g ue rra e l ' avve ni re de ll ' It ali a no n eran o a ffa tt o sc onta ti. Il m ov i me nto di re s is te nza dire llo dal co lonnell o s i sviluppò in un momento dominato dal-
242 Pie tro Secc hi a -Filippo Frass ati. S toria de lla R es i ste n za . u , g ue rra d i lib era zion e in Ita lia
1943- / 945. Edi to ri Riu ni ti. Ro ma, 1965, pp .344-3 48 .
243 Sil ve rio Corv isie ri , // re Togliatti e il Gobbo. 1944: la prima rramtl el'ersil'a Od radek.
Roma. 1998, p.59.
244 Ful v ia Rip a di Meana , op. c it., p. 80.

72
l' in ce rtezza e dalla so praffazione , in un a città, come Roma , ove la con tempo ran ea presenza del CLN e del Va ti ca no contribuì a rend e r e oltr em odo problematico i l quad ro politi co, un intricato viluppo di interessi , di p ote ri e di a spiraz ioni contrastanti di ffic ile da dipanare, in cu i il FMC R dovette ins erirsi funge ndo s ov e nte eia med ia tore . La coesistenza di organi tedeschi e re p u bblicani, a lt resì , d e termin ò un a moltiplicazione is tituzionale che, tipi ca dei r e gimi autoritari, fu foriera di co nfu s ione e d in ce rt ezza de l diritto , producendo interferenze e sovrap posizi oni , co m e attestano i b a ndi germanici e fascisti i c ui con tenu ti erano per lo più iden ti ci .
Ad a p pesantire ulte ri ormente l'atm osfera satu ra di violenza s i aggi u nse la p rol ife razione . di reparti polizieschi e parapolizieschl, alc u ni dei quali, capeggiati da p e rso na gg i se nza sc ru poli assurti a ruoli di coman d o, agivano p ressoché au tonomamente, come la sq ua dra di Pietro Koch.
Questi, ne l ge nna io 1944, costitu ì un dipartimento d e lla p oliz ia repubblicana posto al serv izio dei tedeschi che o però pri ncipalmente a Roma, nel1 ' orbi ta de l min istro dell' Interno della R ep u b bl ica Social e Buffarini Guidi e del tenente Kappler e, in segui to alla liberazione della capitale, s i trasferì a Milan o La s qu adra, tristemente nota per le sue efferatezze, ebbe du ri sco ntri con la " M uti" e con la "X Mas", i cui uomini , nel settembre d e l 1944, riusciro no a cattu ra re Koch 245 .
Vi erano po i la Guardia nazionale repubblicana , la Pubblica Sicurezza, la Guardia di Finan za , la Polizi a p rovincia le, la Legio ne Italia delle SS , la P olizia di Stato, c h e co mprendev a anch e l'OVRA, la p ol izia segreta, la Poliz ia d ell'Africa Ita li ana e la Mi li z ia fasc ista. D a l I fe b braio 1944, inoltre , fu nominato questore di Rom a Pietro Caruso , fascista della p ri ma ora ed ufficiale della MVSN che , con la sua poli zia regolare, co m' era negli intendimenti d el Comando tedesco, concorse attivamente alla repress io ne del movimento pa rtigiano246 .
4. I principali esponenti del Fronte Militare Clandestino
Al pri mo nucleo raccoltos i attorno a Montezemol o, ri co nosciuto spontaneamente all'unanimit à come capo, a d eriro no il colonnello Pacinotti , incaricato d i inq uad rare le bande interne d i Roma , il tene nte colon ne ll o M usco, il tene n te colon ne ll o Ercolani , il maggiore S an tini, il capitano B o do di Albare -

Montezemolo
Clandestino
e il Fronte Militare
24 5 Re nzo De Fe li ce, op. cit., p.12 3 246 D ' Agos tini -Fo rt i, op. cit. , p.72 73
Sabrina Sgueglia della Marra
to, il tene nte Ribecchi , il pittore Multedo , che di ve nne segretario di Montezemo lo e de i capi c he si avvicen daro no al co mand o dell 'organizzazio ne e, s ubito dopo , i tenenti colonne ll i Sal vat i e B or ia, il capita no dei cara bin ier i Aversa , il cap itano B attis ti e i te nenti Basev i, che d iresse il serv iz io s tampa e propaganda, e Bontempi. " Con g iu rati principi a nti - co me ha sc ritto P ac inotti, so tto lin eando la diffico ltà. per i militari, di abbracciar e una menta lità ed una disci plin a cosp irati va cui non erano adu si - ci me ttemmo pe r la s tra da a ri cerca r cono sce nti che la pe ns asse ro co m e noi, s iste ma ma ledettam e nte imprude nte e che, peraltro, a nc he dopo il l ungo tiroc inio fatto ne ll a lotta clan des tina, riconosco essere s tat o l'uni co poss ibi le per cominciare" 247 . Al fine di este ndere il più poss ibil e la ret e degli affi liati, si ricorse anc he al recl utamento de i mil itari feri ti durante la difesa di Roma e ricoverati negli ospedali.
Gli u ffici ali e i s o ld at i, a n corché fede li al gi uramento e a l governo de l Sud, r iconosciuto co m e unico leg ittimo , era no vo lontari come i parti giani gravitan ti all'i nt erno delle formazioni po litiche, determinati a com batte re s tren uamente p e r non tradire se s tessi ed i propr i ideali. Sotto l 'a utorità de l Co ma ndo Supre mo e ne l pieno ri s pell o della disci plina, ne ll 'a mbito del F MCR, fu consent ito d a re direttive anche ad ufficiali di grado s uperio re Come ha testimoniato la fig li a del colon ne llo , Ad rian a. contava i l rispello e l 'a u torità di ch i impartiva gl i ordi ni , no n la sca la gerarchica Mo ntezemo lo d ec ise di present a rs i n o n co me comandante ma , se mp licemente , come capo d e ll'Ufficio C o ll ega me nto del Coman do Su pre mo, me n tre Pacinotti ass u nse la cari ca di v ic e capo
Il co lon nell o s i occupò, con la so llec itudin e nei confronti deg li affilia ti c he co ntrad di stinse l ' in tero suo operato, dell a so rte che sarebb e toccata ai patrioti ca tturati , a llora cons id erati dai tedeschi dei fuori legg e . Ri c hie se, pe rtanto , al governo de l Sud l 'a utor izzaz ione a dotare i membri del FMCR di un disti nti vo c he li preservasse, per quanto possibile, da gravi riperc uss io ni ed info nd es se loro la sensa z ion e di appart enere ad un ese rc it o r ego l a re :
Sarebbe utile proclama re band e al i quote esercit o operante rim aste iso late alt di stintivo dop pio nastro tricolore bavero giubba a lt se approva to d irlo e rid i rlo per radio e t depositarlo Gin evra alt non sal verà fucilazione ma sarà uti le per morale248 .
247 A.U.S . S .M.E. , 1-3. b.187. f.S, '·Relazione con s untiva sulla anività successivamente ~volta dalla De legazione del Comando Supremo in Roma, dai Comandi Civi li e Miliiari della c ittà di Roma. ne l periodo 22 se tte mbre I 943 -5 giugno I944; periodo 22 seuem bre-5 gennaio 1944 (de legaz ione del Comando Supremo) in sostitu zione d el Colon ne ll o Mon tezemolo (caduto ), il Colorrnello già vice ca po dell'ufficio d i collegamento d e l Comando Su premo G Pacinotti , a ll o Stato Magg io re Genera le. Ufficio Patriot i, 23 settembre I 944.
248 Gabri o Lomba rdi. op. cit p.33.

74
Si n da settembre, si unirono al dispositivo clandestino e contrib uirono allo s viluppo e all'estensio ne dell'attività cosp irativa, i general i della ri s erva Ae ronautica R ob e rto Lordi, cug in o di Achill.e Lordi , del Partito d ' Azione , e Sabato Marte!Ji Castaldi .
Essi en trarono a far parte ci el C e ntro X raccolsero una banda fort e e num erosa che s i riuniva a casa Lordi , in un appartamento di via Dalmazia o nella ville tta dello sc ult ore Cesare Civelli in v ia Flaminia, ne l cui giardino fu aJJes tito un depos ito di armi e m unizioni per i partigiani. Per comunicare col comando della V Armata, Martelli Castaldi si serviva di una radiotrasm ittente montata s u una piccola automobile . Utilizzando un c ifrario, riu s cì a fo rnire ag li Alleati importan ti inform azio ni militari: segnalò le installazioni nemiche e le zone adatte all'atterragg io e al lancio dei rifornim en ti tra la via Tiburtina e la Casilina, e individuò le s trade obbligate per la ritirata tedesca. M a rtelli Castaldi, ne i messaggi cifrati di Radio L ondra, ebbe un nome in codice, "Tevere", probabilmente in riferimento alla s ua pas sio ne per il canottaggio. Con Lordi, promo sse la costituzione de lla banda di Tivoli, in Sabina, che prese sotto la sua protezione un gruppo di prigioni e ri ing les i fuggiti dai campi di concentrame nto e sovvenzionò reparti armati operanti nelle zone di monte Gennaro, dei monti Prenestini, di Pal est rin a e Alatri. I due generali posero la loro competenza tecnica al completo servizio della causa nazionale e riuscirono ad a ttrezzare un campo di fortuna per aerei nei dintorni di Roma , tra Guidonia e Lungh ezz a. Fecero app ello a tutt e le loro co nosce nze e poterono così avvalersi della preziosa ass is tenza di fratel Paolo Prudenzi e frate! Venceslao Viti Mariani del collegio San Giuseppe De Merode, che provvidero cos ta nt eme nte alla distribuzione di viveri e benzina ai patrioti e misero a disposizione i magazzini dell'istituto Pio IX per i l deposito di ma teriali utili alla lotta cland est ina.
Martelli Castaldi e Lordi , inoltre , dal 1939 erano rispettivamente il dire ttore tecnico-ammini s trativ o ed il vicedirettore del polverificio Stacchini, in via M e rulana. Il I O settembre, gli stabilimenti furono chiusi. I macchinari vennero smontati e nascosti in luoghi sicuri e una buona parte delle materie prime, esplosivi, polv eri , deto natori, micce , fu sotterrata o mura ta pe r evitare che finissero in mano nazista. Dop o pochi g iorni, infatti , il polverificio fu occupato da reparti tedeschi di paracadutisti che depredarono tutto ciò che era rima s to nei depositi. A metà ottobre, il Comando tedesco obbligò Stacchini a riaprire gli sta bil imenti e questi incaricò il generale Rodrig uez e l'ispettore amministrativo Chieffi cli chied e re istruzioni a Montezemolo.
Il co lonnelJo diede parere favorevo le poiché un ' eventual e opposizione avrebbe potuto ri torcersi contro le maestranze; raccomandò , tuttavia , di lavorare quanto meno possibile. Martelli Castaldi d iede ordine agli operai di ca ri-

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
75
Sabrin a Sg ueg! ja della Marra
ca re le bom be de Lina te ai nazisti per metà con po lvere da sparo. e per metà co n te rra. in modo da renderle in u ti lizzab ili; ino ltr e, sep p e ac c a tt iva rs i le si mpatie di a lcuni uffi ci a li te d esc h i e, ins tau ra n do co n essi rap po r ti rego la ri improntat i alla massima co rdialità , ri u scì a carpire ri leva nt i noti z ie e a procu rarsi sa lvaco nd o tti e permess i di c irco laz io ne che poi ve nivan o ra ls ifi ca ti e d istribui ti a mili ta r i e civi li249 .
B e n presto , il FMCR s tabilì contatti col m in istro de ll a Gu e n·a Sorice, col general e Sogno e co l comandan te de lla Leg io ne Te rritoria le di Roma, tene nte co lonnello d e i C C. RR Frignani. Al vice comandan te de ll a di visione di Cavall eria Corazzata "Arie te", ge nerale Fen ulli, che aveva ricong iunto una nutrita sc hi er a di e lementi sbandati appartenenti a var ie unità d isc iol tesi a Roma, fu assegnato l ' incarico di organizzare le bande in te rne , sin o ad aJJora d i competenza del colo nn e ll o Pac ino tti, e di se lezionar e e raccogli ere i membri delle fo rmaz io ni estern e c he si andavan o progress ivamente presentando250 ; il generale Cad o rna, ex co mandante della div isio ne "A riete", se bbe ne non cond ividesse l'i mpostazione purame nte mil itare c he Montezc moJo voll e impri me re a l FM CR. accolse tuttavia di buon grado l'invito a cooperare. Notoriamente a ntifasc ista, il ge nerale, si n da lla prì mavcrn del 1943, a veva insta urat o legami co i pa rtiti antifasc is ti c he avrebbe ro costi tu ito il C L N. Attraverso l' in ter cess ione del sostitut o proc uratore de l re a Ferrara, avvoca to Colagran de, aveva conosc iuto il repu bblicano Cino M acrel(j e il comun ista Co nce tto M a rch esi. Ca dorna poté così da re l'abbrivio a q uell'i nte sa profi c ua e dwc1tura col Partito Comun ista che pose le pre messe della s ua s uccessiva des ignazio ne al comando de l C orpo Volo ntari dell a Li bertà.
Il p rimo incon tro co n M onteze mo lo avve n ne l ' 8 ottob re 1943. 11 generale , co nfid an do nella possi bil ità d i affran ca re in te mpi bre vi la ca pitale dal p re d omini o n azifascis t a, ecc epì c he , a ll a lu c e del d is cre dit o ge tta to s ull 'ese rc it o d alle dolorose v icende seguite alla r esa, sarebbe sta to q uanto mai uto p is t ico, se non darmoso , conferi re un cara tt e re e min e nte me nte milita re a l disp o s itivo cl a ndes tino . Ne cal degg iò, dun qu e , il g ra d ua le in se ri ment o nell'organi zzazio ne pol itica , p rosp e ttan do u na soluzio ne di co m prome sso che, a s uo avv is o, av rebbe rin vigorito l' az io ne antifasc ista accresce ndone la popolar ità, acc redita ndone il valore e gli o bi ellivi agli occhi del l 'op inio ne p ubb lica, e p rom uovendo la " ri scossa" de ll e forze annate deci se a non abbandonare le a rmi , attrave rso u n o rga ni co riordin a me nto25 1 No nos ta nte s i1'fa tti in te n-
249 Mar io Avag liano. Il Partig ian o Te vere. Il gene rale Sabt1 to Mart e lli Castaldi da/Le vie dell 'a r ia alle Fosse Ardeatine, Avagliano Edito re. Cava dei Tirreni 1996, pp. 50-56.
250 Alfon so Bartolini -Alfredo Te rrone , op. cit , p. IO.
251 Viva Te des co, op. ci t., pp. 297 -298; Raffael e Cadorna, La riscossa, Bi ettj. M il ano, 1976, pp.57 -58

76
d imen ti collidessero co n quelli del co lo nn ello , i due ufficiali ebbero un confronto costruttivo. Ne l novemb re 1943, infatti , Cadorna, allo scopo di intraprendere una sistematica azione di guerriglia contro gli occupanti, c hi ese di spos izioni al Comando Supremo attraverso Montezemolo. Rapida giu nse la ri s posta:
Approvas i pienamente azione Cadorna tendente orga niz zare g ue rriglia et sabotaggio comunica z ioni alt teneteci però informati per evitare eventua l i interfe renze con direttive date da noi a gruppi bande territorio con le q uali s tiam o pre ndendo collegamento alt riveste partico lare importanza preparazione sq uadre dec ise per i mpedire ult.imo momento distruzione opere essenziali vita c iv ile con particolare riguardo ba ci ni id roelettrici c he precise re mo altro telegramma alt252
"Dalle riunioni romantiche ma poco pratiche, co m binate ali ' imbrunire agli angoli delle s trade , preferibilmente nelle zone di piazza Fiume e di Porta Pia" come ha riferito Pacinotti, il comitato di rettivo del FMCR, "il piccolo s tato maggiore" formato da Montezemolo, Pacinotti, M usco, Bodo di Albareto , Santini , Multedo, Bontempi e Basev i, passò ad incontri sem pre più regolar i, tre volte a se ttimana, e in luoghi chiusi, per elud e r e la vigilanza nemica , come il loc ale via d ei Villini messo a disposizione dal generale Simoni , lo studio del pittore Giordano Bruno Ferrari, in via Margutta, o la casa dell'avvocato Bonte mpi ai Parioli 253 Tale rifugio non venne mai scoperto sebb e n e, con ritmo incessante e più celere, si stesse svilu pp ando l'a pparato poliziesco fascista e delle SS. Assai generosa fu l ' assistenza di molti romani volenterosi che prestarono la propria casa ag li affiliati del FMCR perché vi tenessero le quotidiane riuni o n i, e di num eros iss ime donne c h e s'impegnarono coraggiosamente per mantenere i contatti fra i patrioti ed assicurare collegamenti.
Dopo una frettolosa prese ntazione all'incontro di Feltre, nella notte di ca podanno I 943, Montezemolo conobbe il diplomatico Filippo De Grenet, tenente di co mpl emen to di cavalleria, a casa de ll 'ambasciatore Viola di Campalto. ln breve tem po , strin se con lui un a profonda amicizia ed un fervido rapporto di co ll a bo razione che sarebbe stato prematuramente interrotto dal loro
252 Gabrio Lombardi, op. cii., p.32.
253 A.U .S.S.M.E, /-3 , b.187 , f .5 , " Re laz ion e consuntiva s ulla attiv ità successivamente svolta dalla Delegazione del C oma ndo Supremo in Roma, dai Comandi Civili e Militari della città di Roma, nel periodo 22 se ttembre 1943-5 giugno 1944; periodo 22 set tembre -5 gennaio 1944 (del egaz ione d el Comando Supre mo) , in sos titu z ione del Colonnello Monte ze molo (caduto), il Colonnello g ià vice capo de ll 'u fficio d i collegamento del Comando Supremo G. Pacinotti , allo Stato Maggiore Generale , Ufficio Patriot i, 23 settembre 1944

Montezemolo e il Fronte Mil itare Clandestino
77
Sabrina Sgueglia della Marra
arre s to. Dc Gren et, a lJ' indo ma ni d e ll'arrrù s tizio. non ave va avuto alcun tente nnamento e si era posto s ubito in netto con trast o co n g li occ up a nti : tra il 9 e il I O settem bre, i fi tti cartegg i d epos itati a l min istero d eg li E ste ri furono in buona part e di s tru ni o nascos t i ne i so tterrane i di palazzo Lance ll otti affi nché non c a dessero in mano tedesca . In segui to alla p roc la ma zio ne d e ll a R e pu bb lica Soc ia le, pe r sottrars i a i bandi di Grazi ani, il te ne nte di compleme nto i e ra r ifugiato nei press i di Pa lia no. Qui , in breve tempo , a ll estì u n centro di raccolta in fo rmazio ni per i patri oti c he mjse imm e diatam e nte a di sposizione di Montezemolo . Durante i venticinq ue giorm c he li videro fianco al fi anco nella lo tt a ai tede sch i, De Gre net si ado pe rò per ricercar e fondi e procurare con ta tti utili . Curò , ad ese mpio , il coll ega ment o tra il FMCR e il centro della De mocraz ia I taliana , c ui faceva capo la banda " B ianchi" . Mont eze mol o gli affidò altresì il co mpito d i tra spo rta re mess ag g i da e pe r la stazio ne ra d io poi c hé, essendo muti la to , riteneva non sare bbe mai s tato s oggetto a retate. De G re net offrì il pro prio apparta men to per le riuni o ni degli esp o nenti d i maggior s pi c co dell 'o rgani zzaz ion e : la s ua abi tazi o ne ven ne ab itu a lmen te frequentata dal genera le Fe nulli , dal ge nerale Armell ini e dal pittore Multedo25~.
TI figlio prim ogen ito de l colonnello, Manfred i, giu nse nell a ca pital e da Pe rugia i l 18 novem bre 1943 pe r rivedere suo p ad re e coa diuvar lo nelle s ue svariate ini z iati ve. n capo del FMC R abitava allora in via Mart e lli , in casa Giulia no , in s iem e al gen e rale Ac c ame . Ri so lsero di in cont ra r s i tu tti i giorn i verso le 14:30 co s icché Manfred i potesse ricevere e d e seg uire gli o rdini c on ass iduità. Attrave rso il com mi ssa ri o d i po liz ia Musco, s i p rocu rò dei do cumenti fal s i a nome di M anfredi Conti. da Capracotta, s fo ll ato a Rom a e d appartene nte alla classe I927, pe r ev itare la c hi ama ta al le armi con la cl asse di leva 1924.
Il colonn e llo , seco nd o la testimo nian za del fig l io , benc hé av ess e l ' abit udin e di parlare p oc hls s imo del proprio lavo ro , a propo s ito dei d ue frate lli Mu sco, g li confidò di prova re s in c era s tim a per il commi s sario : lo con s iderava un prezioso in formato re poic hé aveva messo la s ua carica di funzi onario de lla Pu bb lica Sic ure z za a l s ervi z io della lo tta, procurando docume nti fa Js i ai p a tr io ti e ad o pe ran d os i pe r la scarceraz ione di q ue lli arresta ti. M a nfredi no n h a escl uso c he s i occ upa sse an c he de ll a racco lta d i fondi. Di contro, il ca po de l FMCR , p ur riconoscen do i l valid o apporto dat o d e l te nen te co lo nnello Mu s co aJle trasm iss ioni de l gov e rn o del Sud , lo defin ì " u n gran fanfarone molto leggero" .
254 A.U.S .S. M.E , f .J b. 148, f.2 , ·'Tene nr e De Gren e t Filipp o. Propo sta d i ri compensa'·, Uffic io S tralc io. al Mini s tero della G uerra. ga bi netto , 8 -8 - 1944 ; Angelo Antonio F umarol a. op. cit pp.108 - 109: Ruggero Zangrandi. op cit pp .503-504.

78
Il co lon nell o P aci nott i e il te nente co lon ne ll o Ercolani erano gli ufficiali più fidati, gli unici a conoscere l 'a bit azione di M o nt ezemo lo. Ma nfre di fu ospitat o dal senat ore Mo tta, a mi co di famig lia, e, in ves tito d el co mp ito di funge re da collega me nto, fu ass u nto co me imp iegato d e l suo gabinetto ri servato in Campidog l io. D a a ll ora, tenne il padre costantemente informato circa l' organizzazio ne d e i serv izi e deg l i e n ti civi li che Mott a s t ava appron tando in prev isio ne del pe ri odo d'e mergenza tra la ri tirata d ei tedesc hi e l ' ingresso a R oma deg li ang loamerica ni255 .
Il p rog ressivo a um en to degl i affil ia ti pose all'ordine del giorno il prob lema del finanziamento 11 sosteg no d i cui pot eron o giovarsi i partigiani ris ul tò sempr e largamente inferiore alle più elementari necessi tà d i v ita e d u nq ue alle es igenze de ll e band e e delle strutt ure di c ui si co mponeva il d ispos itivo clan dest ino . Dapprima, si sperò in un cong ru o aiu to da pa rte di Brindisi, m a ben presto fu chiaro c he s i sareb be dovuto provvede re au to nomame nte256

Della raccolta d i fondi, mansione oltre mod o de l icata che esigeva tatto, prudenza e d iscrezione si occ u pò Mo nteze molo. Poiché i l de naro afflui va sen za contin ui tà, egl i de li berò che chiu nq ue fosse stato in grado di sostentarsi co n mezzi prop ri avrebb e dov uto rin u nc ia r e ad ogni sussidio Per procurare sovven zioni che co nsen ti ssero al FMC R la prosecuz io ne dell a lotta, il colonnello r ico rse a sis te mi dive rs i. Sp esso ri lasc iava sem pl ic i ricevu te a sua firma, sulla fid uc ia, ad ist ituti bancari ed imprese. A volte gli ve nn ero accredi tate ingenti so mm e di d e n aro e, cont e m poraneamente, il governo italia no provv id e a versare la somma, in co nta nti, ad altra sed e del med esimo gru ppo in d ustria le nell'Ital ia l iberata. I n alcu ni casi Mon t ezemolo si impegnò personalmen te alla resti tuzione in valu ta es tera a li beraz ione avve nu ta. Il reperimen t o de ll e risorse finanziarie costi tuì l 'attività più rischiosa: seco ndo la test imon ianza d i Pac in ott i, il colo n nello Du ca, che se ne occupò do po il 25 genn a io, ve nne ar restato prop1io d ura nte lo svolgimento di tale perico losa incom benza257
25 5 A.U.S.S M.E. , / 3 , b. 146, f.7, " Re lazione di Manfredi Montezemolo".
256 A.U.S.S.M .E., l-3, b.148, f .2, " Si tuazione delle forze m ilitari in Roma e ne ll ' Ital ia Cemrol'vleridio na le. Re lazio ni con le autorità angloamericane", Autori tà Mil itare Ita liana in Roma, I. M.A.R., al Comando Supremo, 26 -6 - 1.944.
2 57 A.U.S.S.M.E., / -3 , b. 187, f.5, "Relazione consuntiva sulla attività succes siva mente s volta dalla Delegazione del Comando S upremo in Roma, dai Comand i Civil i e Militari della citt.à di Roma. ne l periodo 22 settembre 1943-5 gi ugno I944; periodo 22 settembre-5 gennaio 1944 (de legazio ne del Comando Supremo), in sos tituzione del Colonnello Montezemo lo (caduto) , il Colonne llo g ià vice capo de ll 'ufficio di collegamento del Comando Supremo G Pacinotti. allo Stato Magg iore Generale, Ufficio Patriot i, 23 settembre I 944
Mon tezemolo e il Fro nte Militare Clandes tino
79

STRUTTURA E ATTIVITÀ DEL FRONTE MILITARE CLANDESTINO
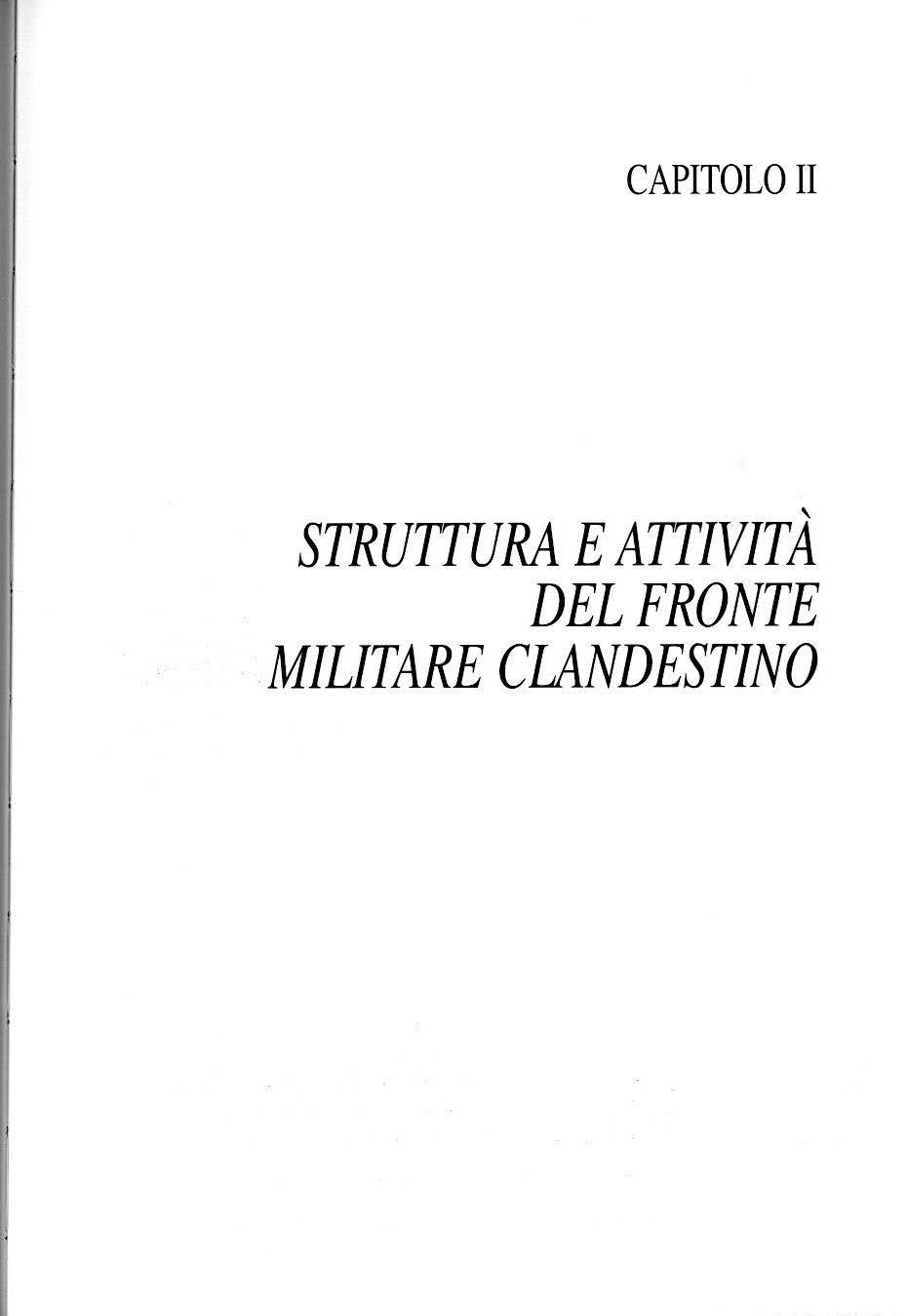
CAPITOLO II

1. L'attività informativa
II personale del Servizio Info rm azioni Mi l itari, la cui attività, dalla caduta del fascismo, era diretta da un commissario straordinario , il generale di Co rpo d'Armata Carboni, in seguito alla firma dell 'armist izio , rimase, per la maggior parte, fedele al gi uram ento prestato dandosi alla macchia , attraversan do le l inee, o inserendosi nelle formazioni partigiane che progress ivamente si andarono raccogliendo. Una parte, seb bene inferiore , aderì alla R e pubblic a Soc iale e cooperò alla creazio ne del Serviz io Info rm ativo di D ifesa, i l SID .

Tra le più stringent i esigenze che si pro spettarono a l Co m ando Supr emo, s'i mpose quella di ripr istinar e il Se rv iz io In formazio ni Militari riorgani zzando e rimettendo in funzio ne ciò che rim a neva delle ce ntrali p eriferiche esistenti nell ' Italia Li.berata, coordin ando il lavoro con le forze armate dislocate nel territorio occupato e intrapre ndendo u na lo tta se rrata contro agenti nemici e fia ncheggiatori dei nazifasci sti .
Si cost it uì , du nque, il primo nu cleo dell ' Ufficio Informazioni e Collegamento o Uffic io l , par te integrante d el Reparto Operazioni che, malgrado la penu ria di mezzi e la conseguente dipende nza dal sostegno alleato, ri uscì ad offrire un val ido supporto logi s tico alla collaborazione miUtare ital iana assiste ndo le forze armate regolari e, in maniera a ncor più incis iva, potenziando la fitta intelaiatura che so rreggeva l'intero moviment o res is te nz iale Dopo una preliminare fase orientat iva, il capo di S tato Magg io re Ge nera le diramò precise direttive s ulle compete nze, le mansioni e g li obiettivi del serv i zio inform ativo del Coma nd o Supremo e deg l i Stati Maggiori delle tr e armi, appuntando una parti colar e atte nzione alle di sposizion i che attenevano al coordinamento deg li organi informativi e all'allestimento e alla distri bu zione dei cifrari
Atti vato il co ll egamento con Brindi si, come si ap pr e nde dalla relazione sull ' Ufficio I , il capo del Fronte mi litare organ izzò un se rvizio informazioni politico-militare straordina ri amente effic iente258 .
25& A U.S.S.M E., L 9 , Racc. 021 , fase. 4/2 , Stato Maggiore Regio Eserc ito, Ufficio In formazioni , L ' U.ffiicio I ne lla guerra di Libera z ione, Roma , 3 1 genna io 1946
Sabrina Sg uegl ia della Marra
Ne ll a ca pital e, s ubi to dopo la resa, si era delineato un precoce serv izio militare inform a tivo ad opera di volo ntar i c he, age nd o di pro p ri a in iziativa, avevano ra dun ato dei gru ppi non co ll egati tra loro e a ll a ricerca di un ce ntro operativo uffici a lmente a utorizzato e d in po ssesso d i m ezzi cli trasmi ss io n e col Sud. Allorché i nuc lei maggiormen te a tti vi e addes tra t i e bbero no ti z ia del1'es istenza d el FMCR , diretto dal rappre se ntante de l Coman do Su pre mo a Roma, presero co nta tto co n M ontezemolo , co nfluirono nel dispositivo da lui fo ndato e s i pose ro ,ù s uo i ord ini.
Co me s i app re nd e d a lla re laz io ne a l C o m a nd o Su premo sull'att iv ità Ce nt ro I n forma ti vo R oma, c he prese no me di " Cen tro R ", a d esso venne asseg n ato il com pit o d i in q uadrare un a fitt a r ete di in for ma tori interni ed es te rni a ll a c ittà.
I primi do veva no raccog liere notiz ie di ca rattere mil ita re, come le ma novre dell e truppe nemic he, gli a pprestame n ti difens ivi, l'ubicaz ione dei depos iti , e di caratte re polit ico, come i mo v im enti de ll a pol iz ia na z ifasc is ta o le iniz ia ti ve dei pa rtiti , ed infin e riferire su ll 'u mo re, le es ige nze e l 'attegg iame nto della popolazio ne. Gl i es te rn i, in vece, no n asso lvevano co mpit i pres tabi liti ma o pe rava no co n fo rmem e nte a ll e ri c hi es te c h e, a sec onda de lle necess it à, ri cevevano di vol ta in volta. Fu rono inca r ic a ti di im plementare un se rv izio cli cont ro s pi onaggio, di co ntroll are l 'azio ne d eg li informatori , di aggio rn are u no sche dario per le pers one sos pette e d i com pil are ed inv iar e quo tidianamente al Centro X il messagg io da tra smet tere a Badog lio c he conte neva tutte le no tiz ie st ra teg ic he pi ù u rgent i e ril eva nti pe r il governo del Sud e, dal vaglio d i tale di s paccio, ven iva rica vato un notiziario ri a ss untivo riprod o tto in un limit ato numero di copi e.
In seguito, pe r volontà del generale Armelli nì , furono cost ituiti ed entrarono im medi a ta mente in azione, i ce ntri "A", dell'Aero nautica , cd "M", della M a rina, c he facevan o pervenire al Centro R le informazion i raccolte affinché fossero esaminate ed eve ntu almente inclu sio ne nel messagg io rad io e ne l notizia rio.

Il C e ntro R e ra forma to da oltre d uecen tottanta e leme nti ripart iti ne i segue nti g ruppi:
- il g rupp o Centra le, as seg nato a i tene nti colonne l lo B oncinelli e D e Lorenzo, che diri geva ra tti v ità dei gruppi d ipen den t i e che provvedeva all 'e labo raz ion e delle no tizie in base a lle qua li erano redatt i i com unicat i giornal ie ri ;
- il g rupp o Margarit o ndo , ag li ord irù d e l colonnello Peppino, che o pe rava a ttra verso num eros i affili a ti in Italia cen trale e saltuaria m ente in q ue ll a sette ntrionale;
- il grupp o Lo Faso, che p rovvedeva a l repe ri me nto e al vaglio delle seg na lazi on i affluite t ramite nuclei adde tti a l co nt rollo d e i mo v imenti
84
stradale e ferrov iari o e alla ricerca, nel Lazio , in Abruzzo e nelle retrovie nemiche, di indica zio ni utili dal punto di v is ta be ll ico;
- il gruppo C.S. , c h e, in virtù delle investigazioni co ndo tte quotidianamente, attendeva alla compilazione e all'agg iornamen to di uno schedario delle perso ne accertate o sospette di collaborare co i tedesc hi o coi fascisti e provvedeva ad avvertire te mpestivamente t utti co loro per cui si temeva l' arresto per motivi politici.

Ogni giorno , i gruppi dovevano s tilare un bo ll ett ino informativo la cui redazione era controllata e coo rdinat a direttame nte dal capo del FMCR.
Il complicato e meticoloso serviz io informativo venne svolto con puntualità e precisione se mp re maggiori ed i l volume e l' inte resse delle indicazion i fornite al Sud risultarono fondamentali, come più vo .lte so ttolineato a me zzo radio d al Comando alleato che, a testimonianza dei no tevo li tr ag uardi ragg iunti attraverso un duro e logorante lavoro eseguito a prezzo di rischi grav iss imi , s i rivolse s ovente al Centro R per ottene re ragguagli utili alle operazioni belliche. Pa rticolarme nte profic ue si rivelarono le segna lazioni relative al traffico fe rroviario e s tradal e, agli apprestamenti difensivi, all ' ubicazione dei campi minati e all'attività degli aeroporti nell e reg io ni dell'Italia centrale. Dei duecentottantaquattro e lemen t i c he compos e ro il servizio informativo, cinque furono fucilati , quattro condannati a morte e sfugg iti miracolosamente all'esecuz io ne, cinque a rre stat i e tratte nu ti in p rigio ne fino alla liberazione di Roma. D o po il 4 g iugno , il capo del Centro Informat ivo di Roma Boncinelli , nella re lazione sc rit ta di suo pugno sull ' attività svo lta durante l'occupazione naz ista, pe r "valorizzare la memoria dei caduti e la fatica dei collaboratori" , affermò :
Tutt i conosc eva no a q uale ri sc hio mortale si esponevano co n la lo ro opera e tutti, per il raggiungimento dello scopo comune, han no dato , se nza es itaz ione e con e ntusiasmo quanto era nelle loro possib il ità. Solo un alto senso di patriott ismo ha assist ito e sorretto co loro che, per lunghi me si, nelle condizion i più disagiate , con indomabile fede, hanno svol to , incuranti de l pericolo g io rnali e ro d i una morte preceduta da atroci torture e animati dall 'esempio degli ero ic i cadu ti, un compito così difficile e rischioso, perseverando anche quando , specie negli ultimi tempi, il cerchio vieppiù s i stringev a. La loro opera diuturna, infaticabile, e spesso oscura era animata dal solo ambitissimo scopo di serv i re la Patria come il momento consentiva"259
Montezemolo e il Fron te Militare Clandestino
85
259 A.U.S.S.M .E.. N.1-10, Diari storici 2° Gue rra mondiale, b.3022, f.5, Centro ln fo m1 ativo Rom a a l Coma ndo Supremo, "Re lazione sull'att iv ità svolta dal C en tro R", 5-6 - 1944.
Sab rina Sguegli a della Marra
I messagg i che Monteze m olo, q uot idi a namente, fi no al giorno de l s uo a rres to , fece pe r ve nire a l C oma ndo Su premo, co s ti tui scono una fon te essenziale per la storia de l FMC R poiché toccarono le molte plic i q uestioni d'ordine milita r e e le p ro bl ema tich e inerenti a ll a lo tt a cont ro i naz ifascis ti. Siglati da u na " M " , riportavano in man iera esauriente e te m pes t iva le notizie s u ll a consis te n w d ell e fo r ze ne mic he, s ull o sch ie ra me nt o e s ulle m a nov re de i repar ti , s ul l' ubi caz ione d i magazzini e de po s it i di muni zio ni , e s u ogni attività belli ca de l ne mi co 260 . I telegrammi, r icev ut i e sp ed iti, co m pres i que ll i success iv i a ll' arresto de l co lo nn ell o ne l ge n naio 1944 , sono circa u n centinaio e la da ta c he indica no è q ue ll a d i ar rivo e di in vio da Brindis i .
Tutti i di s pacci s on o s tati racco lti d al gi uri s ta Ga bri o Lo mbard i, uffic iale d'a rt ig l ie ri a c h e , do po aver pre s o parte alla d ifesa d i Ro ma , attraversò le linee d i co mb a tt ime nto e da ll 'o ttobre, di ve nn e capo d e ll a seg re te ri a de ll 'U fli c io In fo rmaz io ni d el Co mando S upremo. Ogni g iorno egli ebbe tra le mani le com unicazioni scam bi ate per mezzo de l ponte radi o261 Le au torità ital ia ne al sud , du nq ue , f urono messe s istematicame nte al corre nte di c iò che accadeva ne ll ' Italia occupata e , provvede ndo alla rego lare tras missione de ll e in formazio ni r ic ev ute a l C oma ndo a ng lo a me ric a n o, con se nt iro no all e fo rze de lla R e s istenza romana di co nt ribui re in modo signi fi cativo a l s uccesso de ll a ca mpagna d ' It a lia. La re te inform a ti va riu scì an c he a val ic are le Al p i e a dar e ragguag li s ull e arm i per la guerra ch imica c he la German ia stava co ngegnando:
Da fonte s icura a lt offic ine F.G. Farben località L udw igshafen fabbricano gas larga scala ah te deschi attribui scono grande importanza at sostanza g rassa a s sorbe nte gra ndi qu antità gas c he vie ne mess a in lib e rtà le ntamen te a lt ci ttà co lp ita rimarrebbe co sì del tulio i nabitab il e per più s ettiman e alt bonifica tulli tetti muri terre no len t issima 262
Bri ndi s i, pertan to, be neficiò largame nte de ll a feco nda attività de l F MC R, co me prova no le fr eq ue nti le a ttes t az ion i d i sti m a e di rico nosc i mento :
Co mu n ica te ad M c he Co ma ndo S upre mo appre zza s ua o pe ra me rit or ia et patriottica et g l i i nv ia vivissimo e logio a lt263
A p arti re d al 13 ott ob re, il co lo nn e ll o domand ò p iù volte al r e q ual i p revi -
260 Giorgio Giannini. op. cii.. pp. 89-97.
26 1 Lo studio di Lombardi, pro nt o per la stampa nel nove mbre 1945 , fu pubb licato so lo ne l 1972.
262 Gabrio Lombardi , op. cii p. 26.
26 -' lvi, p. 26.

86
s ioni potessero farsi s ul s uo ritorno ma, all'eccessivo ottimismo delle prime ris poste pervenute, seguì l'amara delusione di chi a Roma era in attesa e viveva nella speranza. Il 18 ottobre Montezemolo, dimostrando realmente di avere a cuore i l morale dei "fedeli", nel di s paccio inviato al Sud ev idenziò come il mancato ritorno di Vittorio Emanuele e l'ass e nza di sbarchi alleati sul litorale laziale av essero avuto gravi ripercus s ioni sulla situazione politica e militare. In particolare, ne risentivano la popolaz ion e e le bande armate bisognose di un concreto sostegno. Egli, dunque , consig liò caldamente di accelerare i tempi paventando la perdita della capit ale . Allorché il governo del Sud lo interpellò sull'opportunità di entrare in co ntatto con generali passati ai fascisti, egl i non s i peritò di dissentire recisame nte poiché ciò avrebbe contraddetto il valore morale della causa patriottica in nome della qual e i patr ioti inquadrati nei reparti armati me ttevano a rischio la propria vita per liberare il paese dall ' oppressione. li colonnello, dunque, si prodigò per mantenere alto lo spirito degli affiliati e , ri s oluto a neutralizzare i tentativi nemici di demotivarli o di ridurne la combattività, provvide a sconfessare tutte le false notiz ie propalate ad rute come le voci sul presunto pagam e nto dell'armistizio da parte del re , di B adogl io e di Ambrosio264 , e quelle gi unte da Londra circa procedimenti per crimin i dì guerra contro lo stesso Ambrosio, Roatta ed altri ufficiali italiani 265 .
Priorità assol uta del capo del FMCR fu proteggere con ogni mezzo la cittadinanza e garantirne, per quanto po ssibile, l'incolumità Egli, infatti, spese notevoli energie per far sì che la popolazione potesse contru·e s u un adeguato sostentamento: nei me ssaggi inviati al Sud, deplorò reiteratamente le difficoltà e l ' irregolarità con cui a Roma giungeva il vettovagl iamento e, non se nza esprimere il suo vivo rammarico, esortò il governo ad intervenire con urgenza per assicurare rifornimenti proporzionati alle esigenze di un milione e mezzo di abitanti.
La capitale, attanagliata dalla fame , fu altresì sottoposta ai rovinosi bombardamenti aerei alleati. Il primo, prec ede nte alla caduta del fascismo , il 19 luglio 1943 s i abbatté s ui quartieri San Lorenzo e Tuscolano ; nell ' ottobre, fu colpita la periferia romana e, tra il 12 e il 14 febbraio 1944, i quartieri Salario , Tiburtino, Esq uilin o, Ostiense, Portu ense, Monteverde e Trionfale266 Assertore convinto dell'inutilità dei bombardamenti ai fini della strategia bellica delle Nazio ni Unite, a fronte degli effetti devastanti che producevano su lla
264 In seguito alla re sa nell'Italia occupata la propaganda nazi -fasc is ta aveva diffuso la tendenziosa notizia dell ' avvenuto pagamento d e ll'annistitio in s terline da parte de ll e autorità italiane .
265 Gabrio Lombardi, op. cit , p. 24
266 Roma rima se a lungo priva della seg nala z ion e d ' allarme. I po sti di avvi stamento e s egnalazione periferica , la cosid detta cintura, furono me ss i fuori uso dalle autorità tedesche che, pre sumibilmente , ne usufru iva per proprio conto.

Montezemolo
Militare Clandestino
e il Fronte
87
Sabrina Sg ueglia de ll a Marra
po polaz ion e, offre nd o pre te sti ed a rgo mentazioni su rre tt iz ie all a propaga nda fascista, Montezemolo so ll eci tò a p iù ripre se il Co mando Su premo ad inte rcede re presso g li a ng loame ri ca ni pe rc hé sospe nd es sero la gue rra ae rea Si pre m urò, in oltre, di in di ca re forme d i ostruz ioni s mo e di sabotaggio da appl ica re ne ll e fab briche, ne ll e i nd u stri e e ne ll e officine pe r ra ll entarn e la prod u zion e cos icc hé , manten e ndo le fu nz io nanti con un'att ività rid otta al mini mo , si sareb be sco ngi ura to il t rasferi me nto in G e r mania di in te re maes tranze:

indu striali italiani lottano contro s fruttament o tedesco ridurre minimo produzione pur conservando maes tran ze alt tale fi n e uti l i g li allarm i aerei non necessa ri bombardamenti industri e qualora mantenute interruzioni ferroviarie va li c hi frontiera alt distruzione d'a ltrond e dann osa pro ducendo con gedo pe rsonale et suo a rruo lamento G e rmania per neces si tà econonùche alt qualora seg na lati precis i obie t tivi perseguiti da g ue rra economi ca - ad ese mpi o cuscinetti sfe re- potrebbesi ri ch ie de re i nd us trial i sa botaggio tota le p rod uz ione relativa p ure circoscrivendo danni alt 267 •
Monteze mo lo a più r ip rese ca ldegg iò l ' ingresso in li nea de ll e truppe italia ne, ce rt o che la cooperazio ne co n le ba nde arm ate av re bbe r ite m pra to e moti vato a nco r d i pi ù i pa trioti in esse mi lita nti:
Interve nto trup pe itali ane in lin ea sare bbe necessario per trattenere dalla chiamata all e armi di Graziani et pe r dare all e bande impres s ione concorrere gue rra ita l iana et per trattenere indu s triali da co ll aborazione con tedesc hi alt per togliere in s ostanza impress io ne gu erra continui tra ted esc hi e angloameri cani s oltanto aJt268.
Il capo de l F M C R, al fine di r ealizzare gli inte ndimenti de l Comando Su p remo, organi zzò sin da ottobre n umero se mi ss ioni per sta bilire co ll egam en ti co n le altr e r eg io ni . So lo nel peri odo in iz iale, se n e calco la no ventisette; fu ro no cos titui te da pe rso na le esclusiva men te ita li ano e pe r lo più appa rte ne nte all e fo rze arm ate U na fitta in te laiatu r a d ' in forma tori s i ramificò innervando progress ivam e nte il te rrit o rio occupa to -L azi o, Ma rche , Emi l ia, Toscana, L igu ri a , Ven ez ia G iu lia , L o mb ard ia, Pi emonte e Vene to - e promuove ndo la fon daz ione di nu ov e cen t rali 269
267 Gabrio Lombard i. op. c it.. p 25.
268 l vi. pp. 24-25.
269 A.U.S.S M.E., L 9, Racc.02 1, fase 4/2 , Stato Maggiore dell 'Ese rc ito. Uflicio In formazio ni L'Ufficio Informazioni nella guerra di Liberaz ione. R oma, 3 1 gen naio 1946.
88
N um eros i furono i reparti per la c ui c reazio ne ed attivazione il Servizio Informazioni Militari si servì dell ' Ufficio di Collegame nto. Quello predis posto dal capo de l FMC R s i ri velò il più attivo, efficiente e com pl eto. Il cosiddetto " Gruppo Mo nrezemolo" nacque il 24 se ttembre 1943 a Ponte Milvio , in una riun ione tra M ontezemolo e g li ufficia li di Stato M aggiore Giorgio Ercolani e Vincenzo Fornaro.
Si convenne c h e l 'articolata struttura avrebbe gravitato attorno alla centrale di Roma e da qui, attraverso le sedi dis locate nelle altre regioni, s i sarebbe irradiata nel t erri to ri o occ upato a co mparti m enti stagn i, al fine di pre se rvare l' in columità d egli affi l iati impede ndo che la scope rta di u n reparto, even tuali arresti o perquisizioni locali, comportassero lo sma nt ellam en to dell 'intero appa ra to . M algrado l'es iguità dei fo ndi a disposiz io ne, i l 20 n ovemb re 1943 erano o perative le centrali di Varese , Bologna, Bo lzano , Venez ia , Treviso e Milano , cui s i aggiu nsero success ivamente q uelle di Verce lli , P avia, Ale ssan d ria, Cass ano d'Adda e Cremona.
Il ce ntro di M ilano permise al Gru ppo di entrare i n contatto co n l'organizzazione F e rré-Gas parotto -Pug lies i de ll a cui cooperazione si avval se sopratt utto per l'in di viduaz ione e l ' assiste nza dei prigionier i a ll eat i. In seguito alla catt ura di Pugliesi e Ga spa rotto , mem bri del P artito d ' Azion e, il 15 d icembre 1943 s i ad divenne alla completa fusione de l di spositivo da loro coordinato co l Gruppo Montezemolo.
È p ossi bile tr acciare so lo u na s int esi delle pri nc ip al i informazion i racco lte nei quindici rapporti com pilati d al Gruppo ed inviati regolarme nte a M o ntezemolo ed Ercolani dal 25 settembre 1943 al 10 ma r zo 1944: le cop ie autentiche, infatti , furono distrutte durante u na perquisizione delle SS in uno dei ce ntri de ll a capitale . L e prin ci pali seg nal azioni forni te a l Comando Supremo ital ia no ed a lleato rig uardarono g li sc h ieramen ti delle truppe t edesc he al fronte sud, n ell ' Ital ia sett e ntrionale e a ll a fr ontiera francese, le fortificazio ni apprestate sul l it orale adriatico, lig ure e tirrenico , la s itu azio ne logis ti ca nemica e la dislocazione dei serv izi.

A Verona , da in d iscrezioni ca rpi te nell'ambien t e delle SS, si app rese c h e il colonnello sarebbe stato ben pre st o catturato a Ro ma Riccard o Del Giudice, uno degli agenti del Gruppo , si m ise subito in viagg io verso la ca pi ta le per mettere al corrente il cap o del F MC R dell'incombe nte pe ri colo. Egl i , tuttav ia, sepp ur rico nosce nte per l ' interessamento e per la solerzia con c ui era st ato avv isa to, afferm ò d i non pote r abbando na re il lavoro, a nche solo per poco tempo .
C o n l'arresto di M o ntezemolo, il 25 ge nn aio, il Gruppo entrò in u na fase di pro fonda crisi moral e cui s i aggi un se l'ogget tiva impossibilità di fa r procede re il lavoro poiché venne a man care l ' unico sos tenitore finanziario . Al
Montezemolo
Clandestino
e il Fron te Militare
89
Sa brina Sgueglia della Marra
fine d i lim itar e i l diso ri e ntame nto e le cons eg uen ti discras ie c he la g ra ve pe rd ita av re bbe certa me nte prod ono s ug li altri centri inform a t ivi, s i risolse di tacere i l più a lu ngo p oss ibil e l'accad uto . Il colonnello Du c a, s ub en trato a l co lon ne llo , te n tò di rian nodare le fi l a dell ' orga ni zza z i on e ripris tin ando i collegam e nti tra i vari dispo s itivi a fferenti al S JM pe r riavviarn e l'attivi tà. I suo i s forzi, tutta via, ve n ner o in terrotti bru scamente dalla cattura.
La stessa so pravvive nza de l Gruppo r isul tò se riamente comprom ess a e le forze raccol te e inquadrate a prezzo d i nu meros i sacrific i ri sc h iarono d i essere d is perse . L'o rga ni zzazione, tuttav ia, g iova ndos i d e l pres t ig io d.i cui il g ru ppo Gas parotto- Fe rré godeva presso il C o mitato di L iberaz ione A lta Ital ia, dopo brevi tra ttative e co n la med i azione del segretario e del coordin ato re de ll ' organo po litico, fu asso rbita dal serviz io info rmazioni de l Com ando G e ne rale Corpo Volontari dell a Li be rtà e passò alle djp e ndeze d i " Ma urizio ", Ferrucci o Parri 270
2. Il Ce ntro Stampa e Ass is ten za
Nel sett e mbre 1943 , i l dotto r Basev i e l 'avvocato B on tem pi r icev ettero da Mo nte z e mo lo l ' inc ar ico di costi tuire una s pec iale Sezione Stampa del FMCR a dibit a a ll a produ zio ne in se rie e a ll a di st r ibuzione d i tessere annona ri e e di d oc um e nt i p e rs o nal i per s fug g ire a ll e per secuz ioni na z ifasc is te. Dapprim a s i avva lse ro d e ll a co mpli cità di alc un i patri oti addetti ag l i uffi ci del Gove rn atorato ma, be n p res to , ri s olsero di al les tire una vera e propria fab bri ca cl a ndest ina .
Lavorarono a pieno ritmo , alle loro di rette d ip ende nze, la tip ografia Mine rvini in via de l G overno Vecchio , l a ti po gra fi a Aurora in vicolo della Pasta e la t ipografia Martella de l Go ve rnato rato.
Tu tti col o ro ch e erano ri cercat i s i rivol sero a l Ce ntro e s i g iovaro no dell a s ua assis tenza: partigianj ita li a ni di og ni partito, a presc ind e re dalle opi ni on i po liti c he pe rso na li , mi li tari , ebre i e, su vas t iss im a sc ala, prig ionieri alleati. Nei nove mes i di occ up az ion e ven ne ro di s tribu ite c irca nov e mila ca rte d ' identità fa Jse rec anti pe r lo p iù int es taz ioni e timbri d ei comu ni d e ll ' It alia liberata, a ll o sco po di intralciare ogni ev entu a le accertam e nto. Tale es pedi e nte, oltre a no n des tare sos pe tti poic hé R o ma e ra pien a di sin istrati e sfo ll a ti d e l s ud , 27 1 ri sult ò
270 Vin ce nzo Fornar o. Il Servi zio Inf ormazioni nella /orta cla 11de sti11 a. Gruppo M o ntezem olo . Editori ale Domus. Rozzano (Mi) 1946. pp. 6. 10. 17-24, 47.
271 A.U.S.S.M.E.. N. l-10, Diari sto rici 2" Gu erra mondiale. b.3022, f.7. Fro nte Clandestino di Res is te n za a l Comando Sup rem o "Centro SLampa e Ass iste nza - Rel az ione s ull'att ività vo lta··.

90
titolo di merito per i falsi profughi c h e, es ibendo timbri di province campane o calabresi, potevano d ich iarare di aver abbandonato il comune di provenienza per sottrarsi all'occ upazione angloamericana272 Furono stam pa te ben cinquantamila carte an nonari e per il pane ed oltre mill e documenti di vario genere : in occasio ne del censimento si rilasciarono più di ottom ila ric evute di denunce mai effett uate e, pe r el ud ere u no dei tanti ordini di presen tazione, ven nero consegnate al capitano dei carab in ieri Aversa diecim i la ricevute del distre tto militar e273 .
Il Centro X realizzò , altresì, un 'efficiente agenzia gio rnali s tica clandest ina, il cosiddetto Bollettino Giallo , dal co lore della carta con cui era impa ginato. Ideato da Basevi, il not iziario cic lost ila to forniva info rmazioni di carattere politico e militare proven ienti sia dai fronti di g uerra che dall'Italia liberata e racco lte da veri e propri reporters. Il bollettino era stampato quotidianamente in cinquanta copie c he , ad ore prefissate, venivano consegnate ai patrioti ag li angoli delle strade, nelle chiese, nei teatri e nei c in e ma. Addette alla distribuzione furono soprattutto le donne, co nsiderate idonee all'incarico poiché meno soggette alle perquis izioni della polizia nazista e repubblicana274. L'agenzia g iorna li stic a clan destina lavorò ind efessa mente sino alla liberaz ion e .
Il 20 gennaio 1944 Basevi , B ontempi e l'intero personale della tipografia Minervini , ven nero arrestati dalla polizia fascista repubblica na. Ancorché min acciati e sottoposti ad esten ua nti interrogatori, non rivelarono alcun dettaglio dell ' organizzazione cland es tina e, grazie a ll e preca uzioni adottate, riuscirono ad eludere le indagin i: la fabbricaz ione d ell e carte d' id entità false, dei manifestini e de ll e carte an no narie , reato puni to con la massima pena, non risultò a car ico del Fronte militare e tutti g li imputati furono prosc.iolti e rilasciat i dopo quaranta gio rni di carcere.

Ali' ini zio del 1944, il generale Armellini , succeduto a Montezemolo, assegnò al Centro Stampa il comp it o di sostenere le famiglie dei caduti per la causa na zionale, dei prigionieri politici e degli ufficiali alla macchia . Nonostante l ' es iguità dei fondi c ui si poté attingere, tutte le richieste pervenu te furono esaudite. Seco ndo le direttive im partite si corrisposero duem ila l ire agli ufficial i inferiori, tremila lire ai capita ni e da qu attro a cinquemila
272 Armando Troisio. Rom a so uo il te rrore na zifa sc ista 8 seu embre 1943 - 4 g iugno 1944, Francesco Mondini, Roma, 1944, p. l 97.
273 A. U .S.S M E. , N.l - 10, Diari stori ci 2" Gu e rra mondiale, b.3022 , f.7 , Fronte C landes tino d i Res istenza al Comando Supremo, " C e ntro Stampa e Ass i ste nza -Relazione s ull ' attività svolta".
274 Il bo ll e ttino giallo e ra di s tribuito da un gruppo di giovan i donne: la redattr ice Lily Marx , Laura Polli , Clara Cannarsa, Silvia Pintor, Maria Muratori , Nicoletta Coppin i ed El e na Ros s i.
Montezemolo e il Fronte Mili tare Clandestino
91
Sabrina Sgueglia della Marra
lire ag li ufficiali sup e riori. C e ntinai a di famigli e romane be neficiaron o d e ll ' ass isten za de l Centro ch e, impavid a mente, fece appe llo a tutte le s ue risorse pe r la scarcerazione de i det e nuti e per metter li in con tatto tra loro e coi propri ca ri e c he, c on l'esace rba rs i della repress ione poliziesc a, d o vett e assolvere a fun z ioni s traordi nari e di co llega ment o 275

3. Le bande interne ed esterne
Accanto ali ' a tti vità informativa , Monteze molo s i a dop e r ò per far convergere in un fron te uni c o e coeso le formazioni militari c land es tin e cos tituites i spon taneamente dop o l'arm is ti z io , nel ge neral e di so rientament o delle g iornat e di se tte mbre. Con la d iss olu z ion e dell 'esercito, infatti , era no so rti num ero s i drappelli di uffi c iali e di so ld ati mossi dall a co mun e avver s ione ai ted es chi. Alcu ni el e menti confluirono nelle avanguardie a rmate c he i parti ti stavano appre s tand o, m ol ti in vece , decisero di u nir i in repart i scev ri di c on notazi o ni po lit iche per res istere a g li invas ori.
L ' Ufficio d i C o llegame n to s i att ivò pe r seg nal are ai g ruppi armati la prese n za di un dispo s itiv o militare c lan d es tino dirett amente so ttopo sto agl i o rdi ni de l C omand o Supre mo e p er eso rt arli , dunqu e, a lla fu sio ne e alla coopera z ion e c on ess o , illustrandon e il di s eg no, i proponimenti e l ' attiv ità ad a mpi o rag g io ch e s'in te nd eva implem e ntare . Gra z ie all ' indi sc usso pres ti g io d e l s uo co mit a t o direttivo , il FMCR pot é e span ders i ra pidam e nte e di ve nire , in breve te mp o, l ' orga no d i direz ione , di raccordo e di coordiname nto di un a folta sc hiera di b a nd e urb a ne ed ext r a urba ne i c ui co mpiti , nell 'a mbi to d e lla g uerra di libe r a z ion e , furono moltepl ici: s o ttra ev an o uomin i a i ba ndi ted esc hi e fasc is ti , a lime nt ava n o ne l la p opolazione lo s p irito di r e s istenza e di rea z ione a ll'oppressione nazifa s cista , svo lge vano un a si ste ma ti ca opera di sa botagg io, predis p onevano , in a tte sa de ll 'a rrivo a lleato , la r ivolta armata in o g ni r eg ion e d'Italia e l a prot ez ion e d eg li imp ia nti indu s tri a li e d e lle lin e e di c omuni cazione
275 A.U .S.S. M.E ., N. I-1 0, Diari storici 2• Guerra m ondia le . b. 3022, f .7. Front e Cl andestin o di Resistenla al Comando Supremo, "Centro Stampa e Assistenza- Re lazio ne sull'a ttiv ità svolta "
276 A.U.S.S.M E 1-3 b.187, f.5. "Relazione consuntiva su lla attività success iva mente wolta dall a Del egal ione d e l Co mand o Supre mo in Roma. dai Co mandi C ivili e Milit ari d e lla c ittà di Ro ma , ne l periodo 22 se ttembre 194 3-5 gi ug no 1944; periodo 22 se ttembre-5 ge nnaio 1944 (delegaz io ne del Co ma ndo Supre mo} , in sos tit uz ione del Co lonn e llo Mo nte zemo lo (c ad uto). il Colo nn e ll o già vice capo dell'uffi c io di co ll egamento del Comando Supremo G. Pacinotti. all o Stato Maggiore Genera le, Uffic io Patri oti. 23 sette mb re 1944.
92
276
Il colonnello, dunq ue, prefiggendos i un allargamento de l FMCR, sulla cui compagine in fieri mi rava ad innestare progress ivamente il maggior numero possibi le di formaz ioni, ravv isò l'u rge nza d i provvede re a ll e loro esige nze con un adegu ato sostegno finanziario atto ad ottimizzarne le p otenzialità operativ e e, al con t e m po, a prese rvarne la compattezza ne utralizzando le eve ntual i s pinte ce ntrifugh e. li 27 ottobre, p ertanto, ric hi ese al Comando Su premo l ' a u torizzazion e a spendere c irca un milio ne al gio rn o . Affermativa fu la risposta c he, du e g io rni dopo, g iu nse da Brindis i277
Il dispositivo militare clandestino, infatti, nato dal nu lla , mos se i primi passi in co ndi zioni oltre modo aleatorie e disagiate . L' armamento, quanti tativame nte e qua litativame nte in sufficiente, s i limi tava alla dotazio ne dei reparti dat is i alla macchia , a quello p rocacciato con azio ni successive o fornito da privati. Anche gli al tr i mezzi scarseggiavano: le modestissime possibil ità iniz ia li si esauriro no ra pidam ente e i s uss idi economici offerti dalla popolazione non poteva no coprire in toto le crescen ti es igenze dell e b ande. Il co lonnello P acinot ti ha opinato che, in quei primi mesi, se fossero stati dispon ibili i fondi necessari , si sare bbe potuto fare molto di più per promuovere , nell'Italia occupata, organizzazio ni patriottiche emine ntemente militar i. Tuttavia, care nti di tutto e privi del supporto d el governo d e l Sud, i mi lit ari delle regioni sette ntrionali dovettero ap poggiarsi ai partiti ed operare in posiz io ni s ubalterne , in ficiando ulter iormente il prestigio dell 'esercito.

Il FM C R so r se e si svi lu ppò in un ambiente q uant o mai sfavo revole all'attività cos pi rativa , non solo pe r la longa manus della polizia tede sc a e fascista, ma a nche per la fo rm a m entis dei compo nenti, non avvezzi alla lotta cland estina, e per l'incoerc ibi le pettegolezzo dei salotti roma ni.
Con la fusione di n um erose bande , g ià tra ottobre e n ovem br e, la strutt ura portante dell'organizzazione ass unse contorn i più razio na l i, coerenti e definiti. M ontezemolo si collegò con le formaz io ni del Pi emo nte e della Liguria, P ac in otti con que ll e de ll a R omagna.
I repa rt i operanti nel Lazio e nell'Abruzzo, agl i o rd ini dello st esso P acinotti e di Fenulli, acquisiro no , in pochi mes i, una ragguard evo le consis tenza278 .
277 Gabrio Lombard i , op. cit., p. 32.
278 A .U .S.S.M.E. , / . J, b. I 87, f.5, " Rel az ione con sun tiva s ull a attività s uccessivamente svolta dalla Delegazione del Comando Supremo in Roma, dai Comandi Civil i e Militari della città di Roma , nel per iodo 22 se ttembre 1943-5 giugno 1944; periodo 22 sette mbre- 5 genna io 1944 (delegaz ion e del Comando Supremo) , in sostitu zi one de l Colonnello Montezemolo (caduto), il Co lonnello già vice ca po dell'ufficio d i collegame ntO del Comando Supremo G. Pacinotti , allo Stato Maggiore Generale , Ufticio Pat r ioti , 23 sene mbre 1944.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
93
Sabrina Sgueglia della Marra
Mal gra do i notevoli risulta ti con eg uiti , il Comando a ll ea to , fino al ge nnaio 1944, non comprese i proponimenti, la ratio int erna , l'ispirazion e e le fina l ità della R es istenza italiana , ne sottovalu tò le poss ibilità di sv iluppo e, di cons eguenza, non stimò opportuno né conven ien te sostene rla ne lla lotta ai tedeschi. Le bande mi litari in quad r ate nel FMCR e J"int ero movimento di liberazione, infatti, pe r lu ngo tempo non furono a d eguatame nte assi sti ti e su pportati. Gli angloamerican i , nei primi me s i della campag na d ' Ital ia , escl ude ndo c he alla guerra partigiana p o tessero affidar s i altri co mpiti all ' infuori del sabotaggio , aveva no stu diato e predisp os to un tipo di rifornimento adatto u nicame nte a ta le scopo e consis te nte in es plosivo ed armi au toma ti c he a brev e g ittata.

Solo nella primavera del 1944 , va lu tate le pro porzion i del mov imento , l a cui fo r za politico-militare costi tu iva o rm ai una ri so rsa d ' innegabile val o re , si pe rsuase ro dell a nece ss ità di poten z iare le fo rma zioni arma te a l fine di co nse ntirne un efficace impiego nelle operazioni be ll iche e di equipaggiarl e ed is truirle per condu rre vere e proprie az ioni di guerriglia. I patriot i, tutt avia . co me constatò amara men te il capo di Stato Mag g io re Berardi , ve nnero trattat i seg ue ndo u na pra ssi pretta ment e ingle se, made in England: era no sfr uttati " fin c hé es s i fossero nelle retrov ie de l ne mi co", di sa rm ati e imm e diatam e nte riman d ati nell e loro case co n u n atte sta to di buona co ndotta, un a vo lta g iunti al di qu a delle linee279
Il Servizio Informaz ioni dello Stat o Maggiore G ene rale sotto po se al Comando alleato alcuni st udi orientativi sull'attività clandestina it a lian a illustrando in detta g lio le probl ematiche più importanti ad essa connesse. Venne reda tt o una rappo rto co n indi caz ioni a ppross imativ e sui ma te riali occorrenti a ll e band e armate e s ui me zz i aerei nece ss ari per effettuare gl i aviorifomimen ti. Il secondo stud io, in cen trato s ull e poss ib ilità tecniche di av iosbarchi ed aviolanci s ui laghi italiani. pro s pe ttò u na puntu a le di s amina de ll e caratteri stiche fisiche degli s pecchi d'acq ua e dell'ambi e nte geo - topogra fico circ os ta nte , la cui conclus ione era che l 'ammaraggio. pur e sse ndo un ' a lt ernativa praticabile in alcu ni cas i, non e ra con s igliabile per le particolari con di zio ni di l uce che esigeva, per la nece ss ità di predi s po rre i relativi segnal i, a sc apito ovvia men te della segre te zza e dunque della sicu rezza , per la c omples sità de lle operazioni di ric ez ione e di sba rco de l persona le e del mat e riale e, infine, per le diffi co ltà p rese nt ate dal s uccessivo dec o llo dell'aereo.
TI te rzo st udio, realizza to ne l m agg io 1944, pa ssò in rassegna le modalità attravers o cui le form az io ni mili tari italian e, se raffo rzate e do tate di un ido-
94
279
p . 131.
Paolo Berardi, op. cit.,
neo equipaggiamento, avrebbero potuto co nco r rere a ll e manovre alleate. In par ticolare, s i rimarcò la ril evanza strategica d e ll e azioni di di sturb o che i raggruppamenti delle Marche-Umbria, d el Lazio e della Toscana, avrebbero povuto effett ua re n e lle retrovie tedesche.
In seguito alle p ressioni dell'Ufficio Informazio ni del Coma ndo S upremo, la N.l Spe cial Force , l ' orga ni s mo ing les e che si occupava d e lla lotta d i re sistenza, chiarì, attraverso u n u fficiale di collegamento, la posizione degli Alleat i in merito all'impiego delle bande patriottiche: la N. l Special Force, sprovv is ta di un apparato logistico adat to a sostenere la g uerriglia nel territorio italiano e priva dei mezzi occor re nti per allestir lo , non aveva interesse né avrebbe tratto alcun vantaggio dall'armamento di un esercito clandestino.
L' appoggio alle formazioni armate, dunque , sarebb e s tato circoscritto e limitato a qualche aviorifornimen to di materiale , mentre, dalle band e già operative, sarebbero stati selezio n ati gruppi di ci rca cinquanta uomini , tecnicame nte preparati, da destinare a l sa botaggio delle retroguardie nemiche, per dann egg iarne soprattutto le vie di com u nicazione. L'attrezzatura necessaria sare bbe stat a fornita escl us ivamente ai n ucl ei scel ti.

Lo Stato Maggiore Ge ne rale, risol uto a non tollerare ulte ri ormente che le ampie potenzialità d e ll a Resiste nza it aliana fossero sv ilit e e ridotte a meri att i d i d istu rbo, perseverò nell' in coraggiare le attività dei repar ti armati procura ndo ad essi a nche la dotazione mi lit are atta a sfe rra re vere e proprie az io ni di gue rri glia , avva lend osi talvo lta dell'appor to dell ' americana G2 che s'in teressava di tutti i prob lemi relativ i all ' Ital ia occu pa ta . Inn umerevo li furono le difficoltà incontrat e, in particolare pe r la diffide nza e le perpless ità nutrite nei confronti d egli ita li ani, considerati pur sempre popolo vinto. Gli Alleati , d ' altronde, erano per s uasi che le operazioni milit ari s ul n ostro territorio si sare bbero conclus e in breve tempo e non re putavano ragionevole foraggiare u n movime nto clandestino che, presumibilmente , non av rebbe contribuit o a ll 'es it o della campagna d'Ita li a .
Mentre a R oma, pur tra in nega bili ostaco li, prende va corpo il FMCR, la N.J Special Force e la G2 no n furo n o in grado di sovven ire neanche alle esige nze primarie, ovvero ali' appres t a mento di un ' organizza z ione logistica per provvedere ai riforn im enti: campi di aviaz io ne, velivo li per i tras po r ti, armamenti , munizioni280 .
Solo ne ll'in verno tra il 1943 e il 1944, le Nazioni Unite, dato l 'evo lversi acc id entato delle operaz ioni be lli che, com in ciaron o a prend e re in considera-
280 L ' a zione dello Staio Ma gg iore Gen era le pe r lo sviluppo de l Movùnent o di Libera zione, Mini ste ro della D ifes a, Uffi c io Storico dello Stato Maggio re d e ll ' Esercito. Rom a 1975, pp. 20 -22 , 67-71 , 137- 143.
Montezemolo e il Fron te Militare Clandest in o
95
zione l ' opportunità di im pi egare, co nform e mente alJe proprie finalità , le forze del movimento di resi s tenza italiano. Sulla base delle d iretti ve e m anate a febbraio dal Coma ndo Superiore alleato n el Mediterraneo, nelle regioni meridionali s i predis pose l'attrezzatura atta a con senti re l'affl usso dei rifornimenti attraverso aviola nci , ovvero: campi d i aviazione e di ri cez ione, aerei e piloti special izzati in tali mansioni , segnali da terra. colJega me nti radio e maga zz ini. Ad aprile, grazie a ll ' int enso lavoro svolto, l'appara to logist ico delle basi ae ree di s poneva di novantuno campi di ricezione in cui, nonosta nte le co ndi z io ni atmosferic he particolarmente avverse in quel periodo, furono effe ttuati , entro la fine del mese , sessa nt atr é avio ri fornirnenti per un to tale di novantanove tonnellate di materiale. Gli aviolanci app arvero immed iatam ente il s is tem a più vantaggioso poic hé permettevano di effettuare i rifornimenti con tempes tività e rapidità, e raggiungendo le band e partigiane ne ll'area preci sa in cui operavano. I primi aviolanci partirono da basi aeree del1 ' Africa settentrionale e, s uccessivamente , da Brindisi; furono ut ili zzate pe r i l tra s por to di mater iali le bas i di B a ri e Foggia, per i l perso nale quella di Rosig nano. Tali o perazioni aume nt aro no progre ss ivam ente per le cresce nti esige nze d elle formaz io ni armate.
I riforn iment i v ia ma re, d i contro, prese ntavano impedimenti tali da sco nsigliarne il ricorso. L e difficoltà derivavano dalla s tretta so rveglianza del lit orale , cos te ll ato, pe raltro , di campi minati. I noltre, tali manovre potevano essere eseguite rigoro sa mente d'inverno , sfruttando l 'os curità, e per spostamenti assai ridotti. Mal g rado le controindicazioni , si us ufruì delJe basi navali di Te rmoli, Nizza, Brindisi e B astia, in Corsica, con mezzi esclusivamente italiani 28 1.

Mon tez e molo , in qua l ità di del ega to del Comando Supremo, funse da a nello di co ngiunzio ne tra i l governo del Sud e le organizzazioni cl andestine che, sp ontan eame nte , si raccolsero nelle a ltre reg ioni d'Ita lia. Una delle prime so rse a Torino ov e il genera le Tra bucchi , a ll ' indomani dell'8 settembre, coad un ò un gr u ppo di ufficial i che operò sopratt utt o come centro informazioni e ricercò la cooperaz ione del CLN piem o nte se. li CLN nominò , pertant o, un Com itato militare che tentò su bito di m e ttersi in contatto con Brindisi. Fu inviato a Roma il maggiore C reonti c he, facendo appe ll o alle s ue vaste co no sce nze ne .Ila ca pital e, riu scì a rintracciare Montezemolo e a far t ras mettere, s uo tramite, al gove rn o il primo rapporto su ll ' attività de lla resis ten za armata piemontese 282 .
281 L'a :.ione dello Sta/O Ma gg iore Generale p er lu n •iluppo del M ovimento di Libera:.ione. cit., pp.100-112.
2 82 A lessandro Trabucchi. op. c it. , pp 47-57.
96
Sabrina Sgu egl ia della Marra
li Comando Supremo, col fermo proposito d i conferire al movimento di li berazione un assetto un jtario, funzionale , prettamente militare, ordinò all' Ufficio di Collegamento d i attende re all a creazione di organizzazio ni regio na li c he , una volta messe in contatto con esso , sarebbero pas sate alle s ue dirette dipende nze. Montezemo lo diramò con prot enzza o alacri tà le disposizioni relative e, in breve tempo , si isti tuirono nove co m andi regionali: in Piemonte e L iguria , L ombardia, Ven eto e ba sso T r entino , Emj]ja, Romagna , Toscana, Marche ed Umb r ia, L azio e Abruzzo , zona di Roma. Furono retti da u n comandante m ilita re soven t e appoggia to, per quanto concerne gli elementi civi li inseriti nelle bande, dai comita ti loca li dei partiti. Il colon nell o prescrisse ad ogni comando di imprimere alle formazion i u n indirizzo organico, d i assegnare e delimi tar e le zone di com pete nza , d i avv iare rapporti diretti e rego la ri co l Comando S upremo e di collaborare coi partiti a n tifascis ti 283
A partire dall'ottobre 1943, si lanciaro no numerose missioni di collegame nto tr a l 'Italia occupata ed il territorio liberato. Furono costit uite da militari dell 'esercito, dell'aero nautica e della marina , offertis i vo lontari e s ottopos ti ad una rigorosa e specifica preparazio ne in app osite scuo le aperte all ' uopo nelle regioni meridionali. Fino a ll 'aprile 1944, i l personale im piegato fu esclusivamen te italia no e, a seco nda d ella zona d'ap parten enza e degli incarichi da ass o l vere, dovette frequenta re vari co rs i: paracadutisti , canottaggio , ricezion e aviolanci , radiote legrafis ti e sabotaggio.
L e mi ss ioni dovevano esple tare svari ati co m piti: prendere contatto con le b and e armate , seg nalarne forza, equ ipaggiamento e attività al Comando Supremo , potenziarn e l'apparato , coo rd inarne il lavoro, istruirle e addestrarle a l sabotaggio e all ' utiliz zo di tutti i mezzi occorrenti alle operazioni. La missione speciale "Man", in v iata n elle Marche , area di primario interesse s trategico pe r i combattime nti che avevano l uogo n el settore adriatico , conseguì risultati significativi. In questa regione, infatti , il movimento clandestino, anco r ché delineatosi pre cocemente, era rrunato da dissens i loca li che lo avevano framme n tato in slegate ed anodine iniziative a utonome. Nel gennaio 1944 , i due ufficiali prescelti della "Man" ris uciro no a ricompor re le diverge nze sorte tra gli esponenti dei p rin c ip ali gruppi politici e a promuov e r e così una solida coo peraz ione tra le bande, armonizzando ne e concord an d one l'azione verso un unico obiettivo.
28 3 A .U .S.S.M.E., 1-3, b. J87, f.5, " Relazione consuntiva sulla att ività s uccess ivamente svo lta dalla Delega zione del Comando Supremo in Ro ma, dai Com and i Civili e Militari della città di Roma, nel periodo 22 settembre 1943-5 gi ugno 1944; pe riod o 22 settembre-5 gen nai o 1944 (delegazio ne de l Comando Supremo ). in sostit uzione del Colonnello Montezemo lo (caduto), il Co lonn ello già vice capo dell'uffic io di collegamento del Comando Supremo G. Pacinotti, allo S tato Mag giore G e nerale, Ufficio Patriot i, 23 settembre 1944.

Montezemolo e il Fronte Mi litare Cl andestino
97
Sabrina Sgueg lia de ll a Marra
Imp o rtanza fo ndame nta le e bb e ro, a1tresì , le m 1ss 1oni c o mpiu t e d a g li is tru tto ri d i s abo ta ggio . G li e s plos ivi e le armi d is tribu it i dagli Allea ti e r a no, infa tt i, d i fabbrica z io ne ing le s e o a meri can a, pe rtanto, poco co no sc iute d a i patri oti ita l iani c he in c o nt raro n o no n poch e d iffi c o ltà ne ll 'ad o p e ra rl e . D ' intesa c on la N. I Sp ec ial Force, ve nn e ro orga n iz zate co m pl e ss iva me nt e quara ntaqu a ttro mi ss ioni co s tituite d a un mass imo d i s ei is tru t to ri il c ui re cl u tame nto fu severa men t e se le z io na to. I nv ia te in te rr ito ri o oc c u pa lo pre s s o i ragg ru ppa m enti a r m a ti , add es trarono i patri ot i a ll ' u so d e ll e armi e de gl i e s pl os ivi p e rc hé potesse ro otte ne rne il ma ss imo il re ndim ento 284
I p ri m i d i nove mbre , le fo rm a z io ni cos t it uite s i a l di fu o r i de l te rri to r io urb ano , d ata l a co ns is te nza acq ui s ita, esigeva no in de ro g a bilm e nte di tro va re una coe re nte s is te mazio ne in un u n ic o o rga ni s mo. Ne l L azio e seg nata me nte ne ll a ca pit a le , s i e ra reg is tra to u n no te vole affl uss o d i mil ita r i c he de s id e ravan o un irsi a l le fo rze a ll e a te . Le ba n de del L az io e ci e li ' A bru zz o , riversa tes i a R o ma in cerca di o rdini e d i fo ndi , ven nero affidate d a p pri m a al ge ne rale Fe nu l li ma , in seguito, aume ntato co ns ide re vo lmente il num e ro deg l i effett ivi , s i res e ind is pe ns ab i le d es ig na r e un ca po c he ne reg o lasse l 'a tti v ità e a d divenire a lla c reaz io ne di un c om a ndo .
Il 18 nov e m b re 28 5 , M o ntez e mo lo inco nt rò s ul L u ngoteve re de ll e Nav i il co lo n ne ll o D e Mi c he lis , g ià C a p o d i S ta to M a g gi ore d e l C o r po d ' Arm a ta di
Rom a 286 Q ues t i , ri en tr a to nella ca p ita l e d o po a ve r te nta to in vano di c ong iun gers i ai repa rti d is lo ca ti ne ll a z o na tra C u ne o e B o ves, aveva racc o lt o c irc a tre nta uffi c ia li e du e cen to m ilitar i di tru p pa app a rt e nt i a l s uo coman d o e al l a d ivis io ne " S ass a ri " 287
Il ca po del FM C R lo in c a ri cò di ra du nare u n nu cl e o a rm a t o a ll ' in te rn o d e l territorio ur bano cui fu d ato nom e cli P il otta , e g li pro po se di ass u me re i l c o m a nd o delle fo rm az ioni de l L az io e dc li' A bru z zo . D o po du e o tre gi o rni , De M ic he lis acce ttò l'on e ros o im peg no e com u nicò la s ua d eci s ion e a l co lo n-
284 L' a-:, ione dello S ta to Magg iu re Gen e ra le p er lo svilup po de l Movim en to di l ihe ra zion e. c ii. , pp. 71 -75 88 -89 95.

265 Secondo la test imonianza de l colo nn e ll o De Mi c he lis l 'incont ro avven ne il 23 novembre. cfr. Coma ndo Ragg ruppam e nt i Ba nd e part ig iane Ita l ia ce ntral e. A 11i vità delle ha 11de. Se 11e111h re 1943 -luilio 1944. Istituto Po li g rafi co de ll o Stato. Ro ma , 194 5. p 7
286 A. U .S.S. M E 1-3 b 187 f.5. Re laz io ne con su nti va s ull a atti vit à su ccessiva me nt e vo lta da ll a Delegaz ione de l Comando S upremo in Roma. dai Co man di C ivi li e M ilit a ri della ci n à di Ro ma, ne l pe riodo 22 se tt e mbre 1943 - 5 g iugno I 944; per iod o 22 settem bre-5 ge n na io 1944 (deleg az io ne de l Co ma nd o S upre mo), in sos tit uzio ne d e l Co lo nn e ll o M on tezc molo (ca dul o), • il Co lo nne ll o g ià vice capo de ll"uftìc io di co ll egamento de l Co mando S upremo G. Pac in o tt i allo Sta to Maggiore Gene rale. Ufficio Patrio ti, 23 se tt e mbre 1944.
287 Co mando R agg rup pamenti Bande parti g ia ne Ita lia ce ntra le, o p. ci i , p 5.
98
nello , il quale , a sua volta, diede ordine a Fenull i di p assare la conseg na de lle bande es terne.
De Michelis, coadiuvato dal suo capo di S ta to Maggiore, cap ita no Ja nnotta, fece eseg uire inda g ini approfond ite per in dividuare i mill antatori di credito ed avviò un 'accura ta di sa m in a de ll e bande al fine d i accertarne le reali di me ns ioni, s p esso go nfiate dai capi d ei var i nuclei pe r ragioni di pr es ti g io pers ona le o pe r accaparrarsi ma gg iori sovvenz io ni288 . Le incong ruenti s tim e fornitegli , infatti , no n erano s tate controllate a dovere: risultavano ve nti bande nel Basso L azio, con 4150 uomini , otto nell'Alto La zio, con 5600 uomini e 4 nell ' Abruzzo composte addiritt ura da 15600 effettivi. Giudicand o oltre mod o approssimativ i i da t i perven uti, il ge nerale ordin ò ai coma ndant i d i R agg rupp amen to di a ppurare, attrave rso appositi is p ettori , la forza rea le, l'equip aggiamento e l ' arm a m en to di ciasc un reparto. Dalle ver ifiche effettuate emerse c he appena un decimo dei patrioti dichiarati fosse b e n ad des t ra to e pronto a ll'azio ne 289 .
A ll ' in terno di c iasc una zona , fu is tit ui to un serv iz io in formazioni. Il coma nda nte del I R aggruppamento, Jan narone , fu incaricato d i predis p orne uno s pec ifi co per la capitale che sarebb e stato adibito per lo più alla segnalazione d e lle ordi nanz e emanate dalle a utorità naz iste e fasciste repubblicane , dei rast rel la me nt i, dei nomi dei delatori e delle spie. A capo della rete in format iv a di Roma fu pos to il magg iore Ayroldi affiancato dal sottote ne nte Patri zi.
Gra z ie al ri assetto dell' int ero di spo s itivo milit are este rno promos so da De Mi c h eli s, fu possibile definire co mpiu tamente le modalità op e rativ e ed i s ussidi necessari all e bande c he poterono cos ì coordinare le proprie az io ni con qu elle dell e avang ua rdi e armate de i part iti, gettan d o le basi di un a collaboraz ione che s i sarebbe r ivelata frutt u osa e d uratura290
288 A.U S S M.E. , [ -3 b I 87. f.5 , " Re lazione cons unti va s ulla attività s uccess ivam en te svolta dalla Delegaz ione de l Coma ndo Supremo in Roma , dai Comandi C iv ili e Militari della città di Roma , nel pe riodo 22 se u embre 1943-5 g iugno 1944; pe riodo 22 seuembre -5 ge nn aio 1944 (delegazio ne del Comando Supremo), in sostituz ion e d el Colonne ll o Mo ntezemolo (caduto) il Colo nn e ll o già vice capo dell ' ufficio d i collegamento del Coma ndo Supremo G . Pacinoni , all o Stato Maggiore Gen eral e, Uffic io Pat ri ot i , 23 sette mbre 1944.
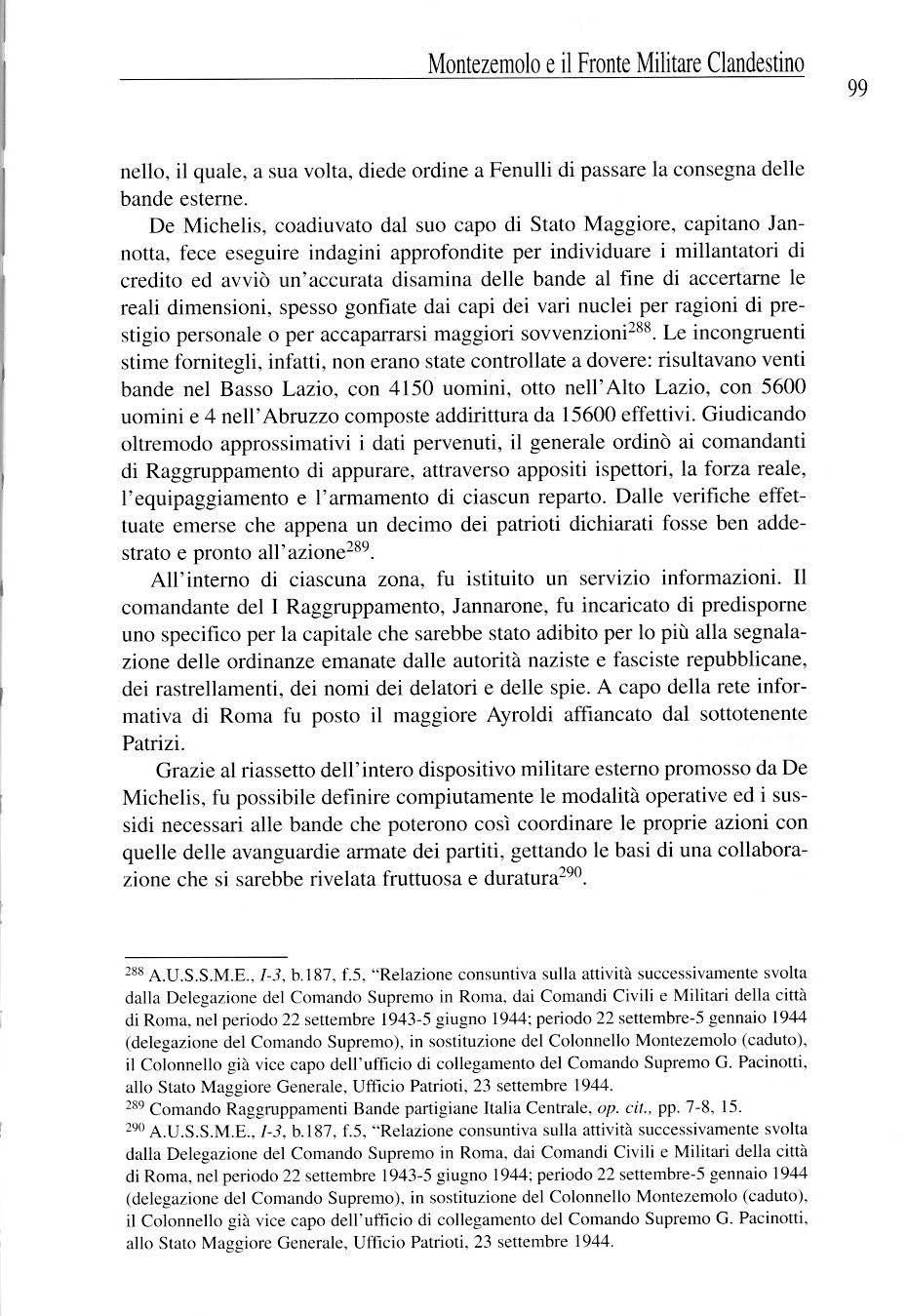
289 Comando Raggruppa me nti Bande partigian e Italia Cent ral e, op. cit ., pp . 7- 8. 15 .
290 A. U.S.S.M.E. , J-3, b.187, f.5, " Relazio ne consunt iva s ulla attiv ità s uccess ivame nte svolta dalla Del egazione del Comando Supremo in Rom a , dai Comandi Civili e Mi li tari della città di Roma, ne l periodo 22 s ettembre 1943 -5 g iugno 1944; periodo 22 settembre -5 gennaio J944 (delegazio ne de l Comando S upremo), in sos titu zione de l Colo nnell o Monte ze molo (caduto) , i l Colo nn e llo già vice capo de ll'ufficio di collegame nto del Co mand o Supremo G Pac in ott i , allo Stato Maggiore G e nerale, Ufficio Patriot i , 23 sette mb re 1944.
Montezem olo e il Fronte Militare Clandestino
99
Sabrina Sgueglia della Marra
L e bande esterne furono inquadrate nei seguenti raggruppamenti :
' 'Monte Soratte", al comando del tenente co lonn e llo Bernabò;
- "Castelli e Lazio-Sud", agli ordini del maggiore Iannarone;
" Gran Sasso", con a capo il maggiore Rocch i;
- "Mon te Amiata" , retto dal tenente colonnello Croci 29 1 Jannotta ve nne nominato capo di stato maggiore del Comando Raggruppamenti.
La Pi lotta fu collocata alle dirette dipendenze del Comando ed investita di un articolato programma operativo che si componeva di svariati compiti, come il rifornimento di uomini, armi e munizioni a Roma e in tutte le aree assegnate alle altre bande, L'ass istenz a morale ag li affiliati, la propaganda, le ricogni zio ni e le mi ss ioni di s occorso. Il gruppo, costituito il I ottobre 1943, da una base in iziale di trenta militari tra ufficiali , sottufficiali e truppa , raggiunse una forza di ben duecento effettivi 292 .
Le direttive generali impartite alle formazioni este rne dal Comando Supremo riguardavano l'az ione d i sa botaggio ("sa botare quanto il tede sco uti lizza, salvare quanto egl i in te nderebbe distruggere" ), la tutela dell'ordin e pubb lico sopratt utt o nei grandi centri, l ' organizz a z ion e d e l servizio informaz ioni e la raccolta dei fondi anche tramite "sollecitazioni di versamento da parte dei privati e dei partiti"29 3 Le bande dell'Italia centrale furono impiegate prevalentemente in operazioni volte a de stab il izzare le retroguardie nemic h e ostacolandone i movimen ti e le comunicazioni e bloccando I' afflusso dei rifornimenti.
Fra le azioni d i sa botaggio ri sul tarono particolarmente efficaci i d e ragliamenti d e i treni e le interruzion i ferro viarie che , oltre a provocare numero se p erd it e, causarono gravi difficoltà ai trasporti e agli approvvigiona m ent i tedesch i294
I reparti vennero addestrati all'uso dell e mine e dell e micce, agli assalti di automezzi iso lati , all'occupazione dei passi e dei punti di preminente inte -
29 1 Comando Raggruppamenti Bande partigiane Italia Centrale, op. cit., p. 9.
292 A. U .S.S M.E. , N.1 -10, Diari stori ci 2a Gu erra mondiale, b .3022, f .20, " Re i.az ione s ull ' attività della Banda Pilotta", Comando Ra gg ruppam ento Bande esterne Ita li a centrale
293 A.U. S.S.M.E. , 1- 3, b. I 87 f.5 , "Re la zione consuntiva s ull a anività s uccess ivamente svolta dalla Del egazione del Comando Supremo in Rom a , dai Coman di Civi lj e Militari della città di Rom a, nel periodo 22 settembre 1943 -5 giugno 1944; periodo 22 settemb re-5 gennaio 1944 (delegaz ione del Co mando Supremo) , in sost itu zio ne del Colonnello Montezemolo (caduto) , il Colonnello già vice capo dell'ufficio di collegamento del Co mando Supremo G. Pac in oll i, allo Stato M aggiore Generale , Ufficio Patrioti , 23 settemb re J 944
294 A.C.S .. Minist e ro della Real Casa, Ufficio de l primo aiutante di camp o, Serie speciale, b.8 4, f.2.

100
resse tattic o e, in s p ecie, alle azioni s im ulta nee sui due versanti del I' Appennino, per arrestare il passaggio de ll e riserve da un versante aJJ'altro 295
Per congegnare in mod o razionale ed unifor me il fu nzion amen to e la strutt ura de ll 'o rga ni zzaz ione , in alcune riu n io ni te nutesi a casa del capitano Jannotta, i l territorio del L azio, Abruzzo , Umbria, Toscana e Marche fu ripa rtito in tre Rag gruppa menti:
- f Ra ggruppamen to, assegnato al maggiore Miche le Jannarone , c h e agiva ne lla zona a s ud di R o ma compresa fra il Tevere, il litorale, la linea del fron te fino a l confine fra Lazio e Abruzzo;
- II Raggruppamento, ag li o r dini del te nen te co lonnello dei bersaglier i S iro Bernabò, affiancato d a l dott. Lui g i Sartori, capita no di co mpleme nto, che co nt ro ll ava la zona a no rd di Roma, fra il Tevere, la costa, ed i confini con Abruzzo , U m bria e To sca na;
- IlT R agg rupp a m e nto , guidato dal magg iore Lui g i R occhi, che operava per lo pi ù in A bru zzo e in U mbria.
O gni Raggruppamento, a sua volta, fu s uddiv iso in zo ne e sottozone corrispondenti alle sedi d e ll e formazio ni ; le a re e di p ert in e nza furono rigidamente circosc ritte per evitare interferenze o sovrapposizioni. Tutte le bande, rafforzate dall'introd uzio ne di u ffic ial i e di militari di provata affidabili tà ed espe ri enza, av rebbe ro dovuto atti vare rapidamente i co llega m enti con le altre.
A ciascun r eparto venne attr ibu ito un nome co nve nzio nale o un'indicaz ion e num e rica; tutti i grad u a ti assu nsero uno pseudonimo e fu ro no in ca ri cati di individuare , t ra i sottopo sti, un degno sosti tuto ca pa ce di portare avanti la loro o pera qu alora fossero s tati arrestati o avessero dovuto rinunciare a ll a lotta pe r malattia . Essi gi urarono su l lo ro o no re che, in caso di cattura, avrebb ero sempre negato l' affiliaz ion e al FMC R 296
Le injziative e le attivi tà delle b ande d e l L azio e de ll ' Abruzzo, strettamente connesse, dal punto di vista o p erati vo, informativo e fi nan ziario, a q uelle delle for maz ioni interne al territorio u r bano, non furon o collocate alle immediate d ip en d enze del Comando Supremo ma rimasero sotto il controllo dell ' organizzazione clandestina roma na . Di co ntro, i reparti opera nti nelle Marche agli ordini del colo nn ello P etrone furono so ggetti diretta mente all ' a utorità del Comando S upremo.
Il generale Tamassia effettuò un giro di ri cog ni zio ne in Veneto nel tentati vo di prendere contatto coi ca pi s egnalati attivi e di saggiarne le inte nz ioni. Dall e ri sposte ricevu te , tutt avia, affiorò un ' in o pin ata freddez z a nei confro nti d ella lotta patriottica, una sca rsa moti vaz io ne a combattere c he strid eva con

Montezemolo e il Fro nte Militare Clandestino
29 5 Comando Raggruppament i Bande partigiane Ita lia Centrale, op. cit , p 2 1. 296 Ivi, pp. 12- 15 101
Sa brina Sgueglia dell a Marr a
l 'atmo s fera carica di tens ione aleggiante nelle r egioni centrali. Ta mass ia si prodi gò part icolarmente nella ricerca del generale Nasci pe r pos pett arg li la direz ione di un vasto organismo militare di resis te nza la c ui a rea operativa s i sareb be espansa be n al di là de i co n fi n i ve ne ti. L a pro posta non poté essere accolt a in quanto Nasci e ra ma lato. II ten e nte co lon nello C r oc i , che aveva cos ti t uito un nucl eo a rm ato a Fo ll on ica, su ord in e d e l F M C R estese la prop ri a azio ne nel Senese e ne ll ' Am iat ino. Altre ri cog ni zioni ebbero luogo nella Ve r s il ia e ne ll a L ucches ia . Le missio n i esp lorative, du nqu e, no n sor tirono g li es iti sp erati ma ottennero riscontri posit ivi ne ll 'ambito dei p artiti .
L' U ffic io di C ollegame nto mo ni torò, senza soluzio ne d i co nti nuità , le condizioni i n cu i versavano le bande e rivolse ripe tuti a p pelli agli Alleati c hie den d o co n in sistenza aviolanci di armi, equipaggiament o mi li tare, munizion i e viveri297
I fondi necessari al sovvenzionamento delle formaz io n i e ra no fo rn iti dal FMCR ed amminis trat i da u na commissione com posta dai coma nda nti d i Ragg ru pp a mento e d a Jan notta c he , ce rca ndo d i co nt e mpera re le es igenze de i repar ti, s i occu pava de ll a di str ibu zione dei s uss idi . Le riso rse d is po ni bi l i, t uttavia, furo n o sem pre es igu e.
De M ichel is, p ertan to, nell'i mpossibi lità di s up pl ire a lle sp ese pe r i l funzionamento sem pre più com pl esso e all e cresce nti necessità de ll 'a p parato mili tar e d a l ui dir etto , dec ise di ricorrere, com e extr e m a ratio, a pr es t iti d a privati c he Jannotta riuscì ad ottenere agevolm e nte per co nto de l Comando Supremo. La di tta d i costruzion i Ma nfredi si dimostrò assai munifica298
P er coor di nare le attività de l dis posi tivo cla n des tino es terno occorrevan o , solo a Roma, d ai di eci ai q uindici collo qui segreti al g iorno c h e, nel tenta tivo d i sc hi va re la so rveg li anza nazis ta, avven iva no ne i luog hi p iù di spara ti.
De M ic h el is valutò conc r etame nte l 'op portun ità di trasfe rire l a sede de l suo coman do al di fuo ri d e ll a ci ttà per ragioni di sicu rezza, ma lo d issuase la necess ità d i tene rs i in costa nte com u nicazione co i vert ici de l FMC R e, tramite esso, col CLN, e d i serv i1·si delle tras miss ioni radio per mantenere un regolare co ll egamen to col go verno del S ud299
29 7 A.U.S.S.M.E. , 1-3, b.I87 , f.5, " Relatione consuntiva sulla a tti v ità s uccess ivamente svo lta da ll a De legazione de l Coma ndo Sup re mo in Roma , da i Comand i Civili e Mi l itari della città di Roma, nel peri odo 22 se ttembre 1943 - 5 giugno 1944; periodo 22 se ttembre-5 gennaio 1944 ( del e gazione de l Comando Sup remo), in sos t i tuzione del Co lonn e llo Montezc m o lo (caduto), il Co lonnello già vice capo dell ' ufficio di collegamen t o de l , Comando Supremo G. Pacinotti, allo Stato Maggiore Generale, Ufficio Patrioti, 23 settembre 1944.
298 Comando Raggruppament i Ba n de pa rt igia ne Italia centra le, op. cit., p. I 9
299 fv i, pp. I O. 12.

102
li Comando Raggrupp a me nti B an de parti gia ne dell ' I tal ia ce ntral e eb be frequenti contatti co n gappist i ed espone nti dei va ri partiti a ntifasci s ti. TI so tto tene nte Patrizi fun se da a ne llo di raccord o tra i re parti militari e il M ovimen to Comuni s ta d ' I tal ia, in part icolare con le fo rm azio n i organ izzate dal giorna li s ta E z io Malate s ta, in cui , dopo 1' 8 sette mbre erano co nflu it i numero s i uffici ali sbandati an s ios i di battersi ch e ag ivano prin c ipalment e ne lla pa rt e se ttentri o na l e di R oma e nel Lazio. P atrizi collab orò con Cino Macrelli, Franco Fran c hini e G iorgio Bracc ialarg he, mem bri dell' esecu ti vo del PRJ, con Sa nnuc c io Be ne lli e Le o Solari d e l Partit o Socia li s ta; il capitano J annotta, stabili inoltre un proficuo rapp o rt o . finalizzat o so prattutt o a llo scam bio di in formazio ni di carattere militare, co l Pa rt ito Comun is ta300.
Montez e mo lo , pertanto, decise c he, d' intesa co l CLN , si sarebbe effettuato un esperim e nto d i a z ione s imultan e a pe r le bande estern e del La z io e del1 ' Abr uzzo nell a notte tra i l 6 e 7 di cem bre.
Malgrad o il poco tempo a dispos iz io ne, i ri s ultat i furono apprezza bilj: g li atti di sabotaggio provocaron o la distruzion e di alcun e linee te lefo ni c he tedesc he, la rottura di deviatori ferroviari e il ri ba lta mento di un a utotreno s ulla via Cass ia.
La pressio ne p o lizie sca, d inanzi a q ues ti attacc h i, si fece ancor più a sfi ss ia nte 30 1: le a utocolo nne di munizi on i e di carbu ranti furono dotate di sco rta a rm a ta e, nell e retrovie e s ulle rotabili di magg ior s corrim e nto , furon o istitui te pattugli e di perlu straz ione. Tal i co ntromi s ure, tuttavi a, non imped iro no la progettaz ione ed il com pimento di nuove e più vas te ope razioni.
Particolarme nte dinami c he e ric che di ini z iativa s i ri velaro no le ban de coad unate s i ne ll ' area dei C a s te lli R om ani, ov e a ll ig na va una radi ca ta tradizione anarc hi ca, soc ia li st a e repubbli ca na. Lev i Cavagl ione ha sottolineato come i co ntad ini , so p rattutto di G e n za no, fosse ro fam osi in tutta la regio ne " pe r il loro coragg io e p e r la tenacia de l loro antifasc ismo" 302
Graz ie ag li st retti legami con R oma, la re s iste nz a dei Caste lli romani ne divenne una s orta d i appe ndice e poté svil upp ars i co n una re lativa i mmediatezza in ambient i politi came nte favorevoli alla lo tta, a tti va e pass iva, con tro na z is ti e fas c is ti 303 . Alla s ponta ne it ~ t e a lla tem pes tività c he caratteri zza ro no le o ri gini de l mov imento partigiano na to a s ud de lla capiLa le, fecero da co ntra ltare g l i esiti in cert i d i q uello so rto a no rd, a scri vibi l i segnatamente al sovra pporsi di prospetti ve e finalità differe nti , ta lora contrappos te 304
300 l vi. pp. I 6 - 17: Si lveri o Co rv i~icri, Bandiera rossa nella Resisren::,a romana. ci t.. p.49.
30 1 Co mand o Ragg ruppam e nti Bande parti giane Ita li a ce ntral e, op cii pp. 24-2 5
302 P in o Lev i Cavag li one , G u er rigli a nei Caste lli rom an i. E inaudi , Rom a, 1945, p.1 7.
303 A l fonso Bartolini -Alfredo Terro ne. op. c ii p.52; Viva Tedesco, op. cii. , p.307.
10-I Vi va Tedesco. op. cir p.31 O

Montezemolo e iJ Fronte Militare Clandes tino
103
Sabrina Sgueglia della Marra
I gruppi partigiani c he s i formaro no a part ire dall 'a rmi stiz io fecero capo ad un comando mil i tare alle dipendenz e del capitano Ruggiero Ques ti mobilitò tutte le forze disponibili nella zona d i Ariccia e ne afiìdò a l tene nte Castiglio ne l'i nq uadramento e la pianificazione militare. Le band e erano per la maggior parte legate al Fronte militare o ad organ izzaz ioni c h e ad esso afferivano, e coo rdinate da u ffic ial i o sottufficiali305 In esse conflu irono elementi di fede politica diversa che co ntribuirono ad accrescere la riotto s ità di a lc une squad re ne i confronti d el Comando pe r quanto atteneva aJle modalità operative, gi udicando più consenta nea alla lotta parti gia na u n 'az ion e a utonoma basata su ll a liber a iniz iativa dei capi.
L a vivacità e l'afflato rivoluzionario c he domjnavano il panorama res is te nz iale dei Castelli romani si evi d enziò, al tresì, nello svil uppo di una corrente favorevole a trasfer ire l ' attività di resiste nza nelle zone co llin ose e boscose di ffic ilmente accessibili, allo scopo di gettare le basi d i una guerr iglia di tipo jugoslavo.
Le forme di lotta che misero più a dura prova i tedeschi, furono le azio n i di sabotaggio, come g li attacchi dinamjtardi s ulle li nee ferroviarie, l'interruz ione delle vie di comunicazione attraverso il taglio dei fili t elefonici, lo spargimento dei c hi odi a tre o q uat tro p unte lu ngo le principali arterie, Appia , Tu sco lana , Casilina, Ardeatina Le bande furono sove nte impegnate in sa ng uin osi scontri. a fuoco che p rovocarono perdite in genti.
L'intens i ficazio n e d ella lotta registratasi, in part icolare, tra dicembre e gennaio fu possibile grazie al contributo d i un gruppo di ex p rigio n ieri russi, combatte nti accani ti e valorosi, che indussero i t edeschi a localizzare il centro nevra lg ico del l' attiv ità pa rtig iana ne ll a zo na ov'erano appostati. Venne p erta nto effettua to un rastrellamento in grande stile con l'accerchiamento d i tutta l' area, ma i ru ss i contrattaccarono efficacemente e ripiegarono nella zona boscosa attorno al lago di Nemi, nascondendosi in u n ce ntro di raccolta a pp ro ntato dai partigiani d i Genzano 306
L'attività resistenziale della zona dei Castelli romani a ppare a ncor più sig ni ficativa se s i cons id erano le precarie condizioni di vi ta d el mondo rurale . A lle ataviche carenze strutt urali s i aggiunsero , in fatt i, i disast rosi effetti della guerra che d etermi narono il grave depauperamento della terra. Si lavorava a s tent o e l' economia agr ico la era ormai ridotta a ll a m e ra s ussiste nza; le attiv ità commerciali erano press oché ines istenti, il mercato nero fioriva e si moltiplicavano le requis iz ioni tedesc he 307 .
3o5 Alfons o Bartolini-Alfredo Terrone, op. cii., pp 52-53.
306 Pino Lev i Cavaglio ne, op. cir. , pp.43-44 , 106 , 108.
307 Viva Tedesco , Vita di guerra, Res isten za, dopoguerra in provin cia di R oma, in Nico la Gallerano (a cura di) , op. c it. , p 225.

104
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
Le fo rm az ioni interne alla capitale , a diffe re nza di que ll e este rn e, non era no des tin ate a ll a lotta quotidiana ma , sop ratt ut to, ad inanimare i patrioti in co raggiando li a rimanere fedel i al g iuramento , sos te nen doli moralmente e materialm e nte, e addes trand oli per il g iorn o in cui sarebbe stato possi b il e entr are in az ione a l fianco dell e forze al le ate e per oppors i alle viol e nze e a ll e devastazion i che i tedeschi av rebbero te ntato di co mpiere in città.
La compos izione dell e bande in terne ri spondeva pe r fettamente ai com piti ad es se assegnati: num eros i erano infatti g l i ufficiali di g rad o elevato, no n più giovani , di provata esperienza, mentre la minoran za attiva era costitui ta dagli o rganizzat ori, dai capi banda, dai capi g ru p po , e dagli in formatori , p a rticola rm e nte espo s ti alle rappresaglie della pol i zia tedesc a e fa sc is ta come attes tato dalle alti ss ime p e rce ntuali degli arrestat i e dei caduti 308 . L a magg ior parte delle azioni di sa botaggio avve nute ne l centro a bitato furon o effettuate con tro a u to mezz i: d urante i nove m esi ne vennero distrutti circa trecen toventi 309 .

Una formazio ne particolare fu la banda "Pilotta", d i cui si è già detto , agli o rdini del co lonn e llo De Michelis , c he assun se lo pseudonimo di " Bianc hi " , e del suo capo di Stato Maggiore, cap ita no Jannotta, per copertura. " Jannini "
Alcune bande c itta din e del FMCR furono costituite in gran parte da carabinieri. U n vas t o raggru ppamento di militi dell'Arma con fluì ne lla banda " Filippo", formata s i a Tra s te vere su iniziativa del ten e nte Rebecc h i. c he va ntava, tra le s ue fi le , il capitano Fabri zio Vassall i310; nella banda " M a nfredi", creata dal colo nn e llo Citern i in conformità de ll e direttive ri cevute da Monteze molo , che entrò in contatto co l ca p itano Blundo e il m aggiore De Caro lis dei CC.RR. 311 ; infin e, ne lla banda " Valentini ", inquadrata nella " M a nfred i" , fo rmata da cara bini e ri in servizio pre ss o il ministero degli Affari Esteri che, dopo l ' annuncio della re sa, decisi a res istere, avevan o distrutto e d occ ultato documenti e mat eria li che no n dovevano cadere in man o tedesca.
:io~ A.U.S .S. M.E .. l- 3. b. 187, f.5 , .. Re lazion e cons untiva s ulla attività s uccessivamente svo lta dalla Delegaz ione del Co mando Supremo in Roma. dai Co mandi Civili e Militari della c it là di R oma. ne l periodo 22 s ettembre 1943-5 giugno 1944: periodo 22 scttembre-5 ge nnaio 1944 (delegazion e del Comando Supremo). in sos tituzio ne d e l Co lonnell o Monteze m o lo (caduto), il Colonnell o già vice c apo d e ll'ufii c io di col legamento de l Comand o Supremo G. Pacinotti , allo Stato M aggiore Generale. Ufficio Patri o ti. 23 se tt emb re 1944
J09 A.C S Ministero della Real casa. Uffi c io del prim o aiutante di ca mpo de l re Serie s p eciale, b.84. f. 2. ,io A.U.S .S. M.E N J- 10, Diari storici 2" Guerra mondiale b.3022. f.17 , " Re la z ione s ulla cos titu zione s ulrorgani zzazione e s ull'azione della B anda Filippo
3 1 1 A U.S .S .M.E., N. l - 11. Diari sto rici 2" Gu e rra mondiale. b.302 2. f. I9. ' Re laz ione B anda Manfredi a l Mini s tero de lla Guerra , 18-6- 1944.
105
Sabrina Sgueglia della Marra
1 sottufficiali al comando d e l tenente di complemento Valentini dapprima progettaro no di attraversare le linee per raggiungere il Sud e pors i a di spos izione del governo ma, in seguito all'incontro col barone Enzo Selvaggi 3 12 , c he aveva pianificato una spedi z ione s ull 'altopiano del Mate se per s upportare le forze già operative, decisero di attendere le s ue is truzioni. Selvaggi, e ntrato in contatto col FMCR, funse da elemento di raccordo con la banda. Il nuc leo armato si rimise dunque agl i ordin i di Montezemolo e, poiché si componeva per lo più di militi de ll'Arma , fu impiegato in servizi di scorta e vigilanza per la salvaguardia degli esponen ti di maggior sp icco dell'organizzazione romana. Assai efficiente ri su ltò , inoltre, il servizio di propaganda compiuto, prevalentemente , attraverso il ritiro e la di stri bu zio ne de l giornale Italia Nuova grazie alla ininterrotta sorveglianza dei locali ove l'opuscolo veniva stampato 313
La banda "Fu lv i" fu raccolta dal tenente Mosco ni che, dopo lo sbarco di Salerno , giudicando imminente l 'arrivo degli Alleati , si adoperò per costituire una formazio n e in grado di sa botare il contrattacco tedesco e di preservare le opere di pubbl ica utilità. In s ieme ai general i della Regia Aeronautica Lord i e Marteljj Cas taldi , suddiviso il raggruppam en to in r e parti , Mosconi definì un piano d'azione che prevedeva l'occupazione dei mini steri , il presidio degli impianti di gas, luce ed acqua pe r impedirne la distruzione , e il mantenimento dell 'ordin e pubblico in tutto il centro urbano. Ai fi ni della riusc ita dei compiti da espletare, fu considerata di fondamentale importanza la ricerca di un collegamento con gli angloamericani.
Mosconi, Lordi e Martelli Castaldi , all ' ini z io di ottobre, entraro no in rappo rti con l'ita lo-brasiliano Gambareri, sedicente rapprese ntante della V Armata che, pertanto, si dichiarò dispos to ad intercedere presso il Comando alleato per un aviolancio di armi in luogo prescelto dal comandante della banda. Mosconi e Lordi si recaron o dunque alla tenuta del duca Gra z iali a Passo dell'Orsa, tra Pantano e Finocchio, distante circa ven ti chilometri da Roma, per s incerarsi dell ' idoneità dell 'area.
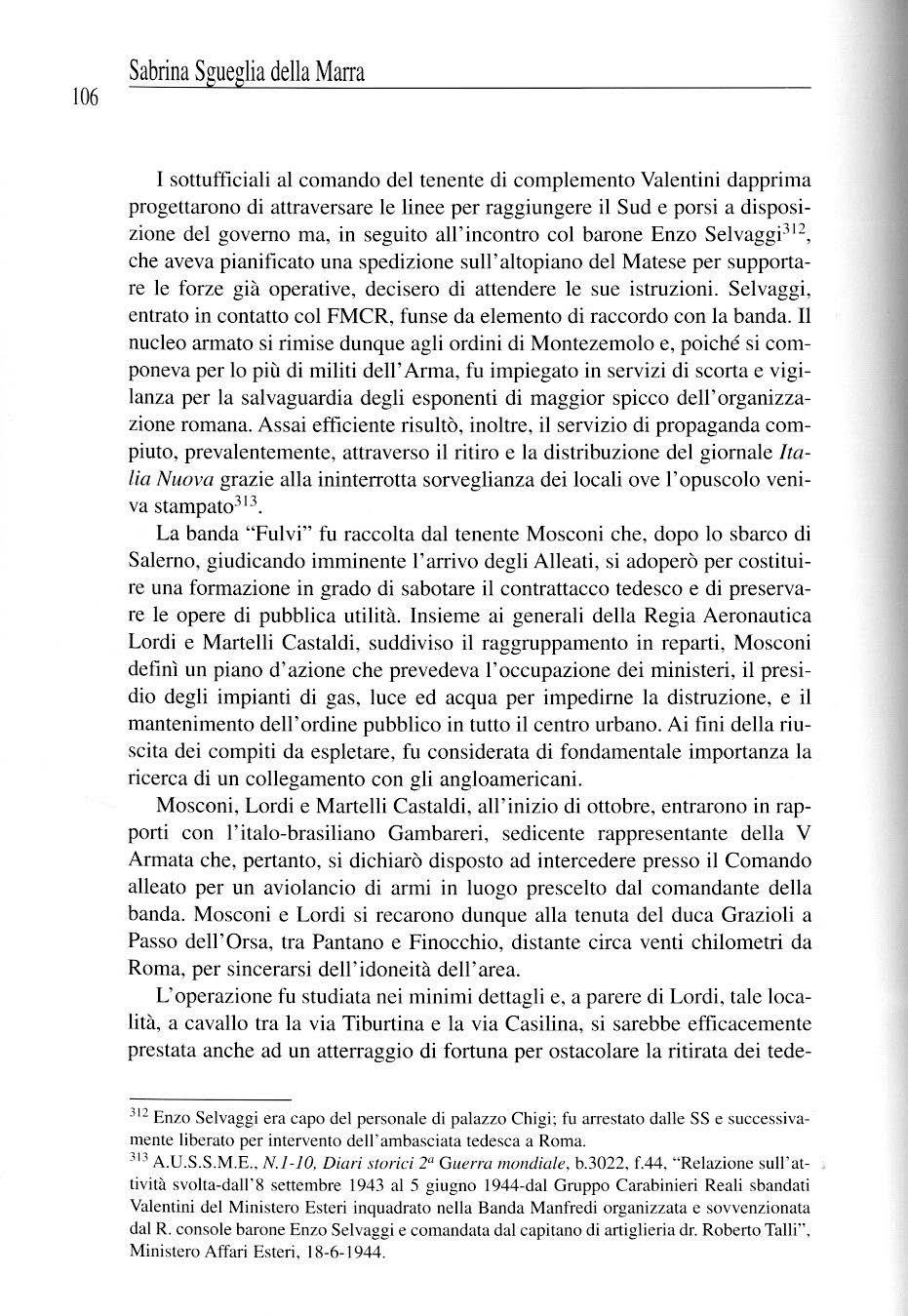
L' operazione fu st udiata nei minimi d ettag li e, a parere di Lordi, tale locajjtà, a cavallo tra la v ia Tiburtina e la via Casilina , si sarebbe efficacemente prestata anche ad un atterraggio di fortuna per ostacolare la ritirata dei tede-
3 12 En zo Selvaggi era capo del personale di palazzo Chigi; fu arrestato dalle SS e success ivamente lib erato per interve nto dell'ambasciaLa tedesca a Ro ma.
31:l A.U.S.S.M.E. , N.1 -10, Diari st orici 2a Guerra mondiale , b.3022, f.4 4 , " Relaz ione sull'atti vità svolta-dall'8 settemb re 1943 al 5 giugno 1944-dal Grnppo Carabinieri Reali s bandati Valentini del Mini stero Esteri inquadrato nella Banda Manfredi organizzata e sovvenziona ta dal R. console barone Enzo Selvaggi e comandata dal capitano di artiglieria dr. Roberto Talli", Ministero Affari Este ri , 18-6 -1944 .
106
Montezemolo e il Fronte Militare Clandes tino
sc hi. li ge nerale p regò Gambareri d ' inform a rn e g l i angloamericani e, a l contem po, fu approntata la s quadra c he avre bbe provveduto a raccogliere le a rmi lanciate e s i sta bil irono i lo ca li ove sa rebbero state depositat e . Purtr o ppo i co ntatti di G a mbareri co n la V Annata si rivelarono occas ionali ed il piano, se bb e ne s tudi ato n ei ei e ttagli , no n po té essere att uato.
A ll a fine di ottobre, L ordi incontrò Mo ntezemo lo c he, in q ua li tà di rappresentante ufficiale d e l governo , invitò il g ruppo a conflu ire ne l FMC R. Mo sco ni , ch e con di v id eva l 'a politicità ed il patriottismo profes s ati d a l co lonnello, non eb be es itazioni e pose a ll e dip en d e n ze de l di s positi vo militare da lui fon dato c irca mill eci nqu ece n to uomi ni. In seguito a ll a ten tata e limin az ione cieli ' Arma, M on t ezemolo ordinò che, tramite il mare sc iallo Tozzi, fi d ato coll aboratore e viceco mandant e di Mo sco ni , ve ni ss ero affil iati all a ba nd a c inqu ecento carab ini er i in sos ti t uzi one d eg li e leme nti non ri t enuti affidabi l i per se ri e tà ed onestà. Il nucl eo armato si a vva lse della prez iosa co llab oraz ion e di d on Giuse p pe Morosini, g ià cappella no m ilitare, c he ne divenn e ass isten te sp iritual e " portando la sua parol a di conforto a coloro che p iù tri steme n te e più e ro icam en te lotta va no con tro i tedesc hi ne ll e boscagl ie vicino Rom a" . Don Moro s ini s'adope rò a lac remen te p e r procurare armi e vet tovagl iame n ti e, so p rattutto, per raccogl ie re in fo rm azio ni. I so ttot e nenti S ucchi e Costan z i lo coadiuvarono i n questa attiv ità

c he, pu r p res e n ta nd o ris chi e leva ti ssi mi , co nseg uì ri s ultati in s perati: mante ne nd o costa nt i rappo rti con un ca p itano aus triaco ad d etto a li ' uffi cio operazioni del co m a nd o tedesco , si riu scì a tra smettere al Sud l' org anigramma dello sc hie ramen to nem ico dife ns ivo s ul fronte di Cassi no e d altri importanti dettagl i s u l la lin ea Gu stav.
D e nun ciato da u n d e la to re, D a n te Bru na , che in compe ns o ricevette 70.000 lire , D o n Morosi ni fu arresta to d a ll a Gestapo ne l qu a rtiere Pr ati, in v ia Po mpeo Magno, nel ge n naio 1944 e fuci la to il 3 apri le a Forte B ravetta da un plotone d e lla PAI 314 .
Formata dal ca pi tano paracad uti s ta Co stanzo, la b and a "Va le n ti" dapp rima s i affian cò all'orga ni zza z ione patri otti ca de i CC. RR. , in s eguit o, nel marzo 1944, con fluì ne l fr o nt e c la nd estino. Costanzo, il 13 se ttembre , riu nì un primo nu cleo di ufficial i e so ttuffi c ia li ne ll a B ase Paracad uti s ti a Co r so d ' Italia. Suo obiettivo e ra la cos tituzion e di un ' unità pa triotti ca di res is tenza c he potesse a ss is tere g l i s b andati e dissuaderl i dal passare a ll e forze nazifascis te; s abotare il nemico du rante l'occupazione e, ne ll a delicata fase d 'e-
.M. E. , N.1 - 10. Diari storici 2" Gu erra mondiale, b. 3022, f.25, ··Re lazion e s ull'attiv ità svo lta da l sottoscr i11 0 e dai suoi gregari". Co mando Militare del Fron te C lan desti no di Resi s tenza. il Comandante la banda Fu lvio Mosconi. 25 -6-1944
3 14
107
A.U.S.S
Sabrina Sgueglia dell a Marra
m e rge nza tra la ritirata dei tedesch i e l ' in gr esso degli Alleat i, impedire ritors ion i e preservar e la popolazione e la città dal furo re germa ni co. A tale formazione era co llegato u n gruppo di paracadutisti c h e si cos tituì nella zona di Tarquin ia al comando del te nente colonn ello Sa lta lamacchia e del cap it ano Turrini. Un a ltro nuc leo di pa t ri oti si racco lse ad opera del te nente Mon tefusco a Poli, presso T ivo li.

La banda "Val e n ti" svo lse, co n grande compet enza tec ni ca, un'intensa opera di sabotaggio contro le l in ee di comu ni cazione e i mezzi di traspor to tedeschi. II gruppo di Tarquinia , cost retto a un duro scon tro a fuoco con r e pa rti nazifascisti, subì perdite consistenti. Turrini venne arrestato ed i l capita no Gozer fu catturato insieme a i suo i mentre s tava predisponendo un attentato co ntro un treno della l in ea Roma-Napoli: il personale del suo nuc leo, tuttav ia, no n abbandonò i Caste lli R o m ani ma, riso lu to a persistere nella lo tta in t rap resa, si pose alle di pende nze de ll a sez ione del Par tito comunista operante nella zona. La banda e bbe un rap ido svilu pp o nei q uartieri Garbat e lla , Tes taccio, Os tiense ed App io , ove si ad di ven ne ad un' intesa immed iata con le forze comuniste. Tra aprile e maggio , il ritmo dell'attivi tà scemò sensibilme nte : ve nn ero studia ti e predispost i colp i di mano , come queJlo approntato per l' inc ursio ne ne l carcere di via Tasso, ma no n giunsero mai gli ordini operativi. In q uei mesi, infatti, cominciò q uel la che il capitano Costanzo definì "la persec uzione" che , co n g l i arresti messi a seg no, falcidiò il raggruppamento 315
La banda "Napoli", comandata dal tenente colo nnello Barbara, nacque dal gruppo " P eppino" nella compagine d el FMCR . Proclamata la resa , il tenente co lonnello, d opo ave r tentato in vano di oltrepassare le lin ee, s i unì ad alcuni ufficiali ansiosi di co m batte re l'occupante. A metà sette m b re, il generale Cadorna lo esortò a proseguire nell ' opera di raccolta d e i militari fedeli alla ca usa nazionale e ad atte nde re i s ucce ss ivi sv il uppi. Barbara si avva lse dell'ass id ua collaborazione del tenente colon nello carrista Stella e del capita no di cava ll e ri a Cassano , già s uo ufficiale nei Lancieri di Firenze. Alla m età di ottob re, era no riu sciti a radunare circa c in quanta uomini ripartiti in d ue nuclei. Allorché non fu più possibile ricever e or dini da Cadorna, Barbara, deciso ad inq uad rare il raggruppamento in un ' or gan izzazione apo l itica e d i carattere eminentemente militare , nei primi giorn i d i dicembre , ebbe un abboccamento co l tenente colo nn ello Sa lvati in cui fu s tabilito l'inserimento della "Na poli " nel gruppo ban de " Billi "
3 1.5 A.U .S .S.M.E. , N.1 -1 0, Diari storici 2a Gu erra mondiale, b.3022, f.4, " Re lazio ne s ull 'att ivi tà svol ta daUa Banda Valenti (arditi -paracadutisti) nel periodo dall' 8 settembre I 943 al 4 giugno 1944 ".
108
Nel m agg io 1944, fu assegnato a Sa lva ti il co m a n do di un gruppo di re parti clan d estin i de lla ri se r va che , col nuc leo " Pep pin o", potenz iato d a ll 'afflusso di nuo v i elementi s in o a raggi un gere i l cosp ic u o n um ero di mill e trecento effe ttivi , s i tra sfor mò n e lla banda " N a poli " . Tale for maz ione fu s uddiv isa in squadre in mod o ta le che i compo n e n ti di og n una ris ie d essero n e lla pro p ria zona op erativa. La s tre tta soffocante d e lla p ol iz ia n azi fascis ta i m pose l ' introduz ione d i e leme n ti fid ati n e lla PA I. co rp o ove s i ri u scì a g u adag nare un co s picuo n um ero di gregari a lla ca usa p atriottica, nel b attag li o n e a us ili ari d e lla Pu bb li ca Sicurezza, in cui venn e ro immess i circa ce nto agenti , e ad dirittura n e ll e SS.
Il commissario G uida, ex ufficia le di cava ll eria, s i rese a ssai util e a ll a ba nd a atrraverso la tempestiva segna la zio n e di ogni immine n te p ericolo e d i l ri fo rnim en to di armi e m uni z io ni p oi dep ositate nell e sedi de ll e s quadre e, in parte, n e i so tterrane i de U' Alta re d e ll a Pa tri a. li serv izio info rm azio ni s i co nce ntrò in part icolare s ull e forti ficaz ioni ge rm an ich e lung o la costa tirrenica e su l pian o di evacuaz ione della c ittà in previ s ione d e ll ' arrivo degli ang loamerica ni.
L'a tti vi tà di sab otaggio, poic h é la band a o pera va a ll'in terno d e l territorio u rbano, fu assai co ntenuta per n o n s u sc it are vio lente reazioni d a pa rte delle au to rità ger mani c h e 3 16 .
Il colonnello Sal vati eresse u n'articolata o rganizzazio n e. il gruppo bande " Bi ll i" . R ecato s i a Rom a verso la m età cli se tte mb re, in contrò num erosi ufficial i dello Stato Maggi o re ri so luti a non rispo nd ere ai b a ndi di p rese nt az ione ema nati da i fasci s ti e dai tedeschi . Il com pl esso di sposi ti vo, c h e s in dai primi di otto bre s i pose so tto la dire zione del FM C R per mezzo del ma gg io re Fornaro, si com p ose di c irca ci n quem ila e leme nti civil i e mi li tari afferenti a svariate ten d enze p o litich e e d inqu a drati in form azio n i a rmate d islo cate nel braccianese , nei Ca ste lli e n e ll a zona di Ta rquin ia. J nu c lei a tti v i ne l centro ab itato operaro no preva len te mente n e i quartieri Te s ta cc io , Quadraro e M onte M ario. L' attiv ità informat i va , in izialm e n te circosc ritta alla capitale ed affidata a grad ua t i non ad usi alla raccolta di n o tizi e, acquisì nel te mpo vaste p ropo rzion i. Le ri cog ni zio ni , infatti , si estesero s in o a ll 'Appennino tosco-emiliano e alla Li g u ria apportando , così , al F ro nte cl a nd est in o u n regolare afflusso di segnal azio ni rela ti ve a lfa di slocaz ion e e all 'identilì caz ion e d e lle gra ndi unità germaniche, agl i app restamenti di fe ns ivi cost ieri, ai dep os iti d i munizioni e ai
316 A .U.S.S.M .E., N. l-11, Diari s toric i 2" Guerra mondia le. b.3022, f.5 , ··Relazio ne s ulla cos titu zio ne e s ull 'a tli v it.à svo lta da l Gruppo Pep pino (Ten.Col. S.M . G iuseppe Ba rb ara)- trasforma to, poi. in Banda Napol i- in seno alrorganizzazione militare del Fronte Clandestino di Res isten za ·· . 25-6- 1944.

Montezem olo e il Fronte Militare Cland est ino
109
Sabrina Sgueglia della Marra
m ov imen t i fe rrov iari. Verso la metà d i d ice mbre, il tenente colo n ne ll o B arbara mise a disposiz ione di Salvati il nu cleo d i ufficiali che aveva riuni to .
L a ban d a "Fabbri", agli ordini d e l magg iore Stegagnin i, s i racco lse nella caserma Lama nn ora Co mposta i n principio da c in que ufficiali ed un piccolo nucleo di bersag li e r i a ncora attiv i o congedati do po 1'8 settembre, alla fine di dicembre, con la progressiva affi l iaz ione di patri o ti s ottr att is i ai band i rep ub blicani, i mil itari abba ndo narono il serv izio presso l'u ffi cio s tralcio de ll a cas erma e, ass unta la de nomi nazione di banda " Fabbri ", entrarono a fa r par te de l grupp o " Billi ".

Il gruppo "Billi" sta bi lì co ntatt i anc h e co n l'Aeronautica e la M a rin a , con age nti de ll a Guardia di Fi nanza, de ll a PA I e d ella P S, c h e fo rni rono in genti quantitativ i di anni e m uniz io ni, e co i pa rtiti di s ini stra de l C L N. All a ma ncanza di un d efin it o programma, Sa lvat i ce rcò di sopperire facendos i promot ore d i ''un' in tensa opera morale" volta ad "elevare lo s pirito m il itar e degl i o rganizzati" e a mantene re sald o "l'amor di Patria". Il 10 magg io, Sa lva ti ricevette ordine di cede re il comand o e di assume re q ue ll o della riserva, allora costituita d alle ba nde " Vale nti " , "Napoli", "F ulvi", " G uer ra" , il c ui es iguo a1mamento copriva solta nto il c in q uan ta p er cen to della forza. Il gru p po " B illi " , d unque , p assò agli ordin i di Bar bara.
T ra i cadu ti, Salvati ha vo l uto mette re in risalto la m o r te e ro ica del magg iore d'a rtiglieria Ebat che, d opo ave r affronta to coragg iosa m e nt e le dis uma ne to r ture in flittegli d uran te la p rig ionia, a ppresa la sua con d a nna a mo rte, espresse la ferma volontà di seguire fi no a ll 'ul ti mo, ins ieme ai suo i co m pagn i , l'esemp io de l colon ne llo Montezemolo 317
La banda "U mbe rto" s i formò su iniz iativa del te nente colo n nello B o ri a . Ne ll a seconda decade d i settem bre, egl i s i a d o però pe r raccogliere attorno a sé un gru ppo di u fficiali in s .p .e. e d i compleme nt o da ti s i alla macchia Ad ottobre, r icevette precise dirett ive da l co lonnello Mo ntezem olo per la costituzio ne di una banda che si sarebbe d ov uta occupare dell'assiste nza a i mjlitari e del ser viz io in formazion i .
Tale nu cl eo clan des tin o fu il prodotto de ll 'a malgama d i un gruppo di circa tre nta mi l itari sardi sfugg iti all'arr uola men to n e i ba ttaglioni repu bbl ican i, ma scio lti si ben pres t o a ca usa di o gge tti ve di fficoltà e malin tes i che ne minarono la c om pattezza; di un repart o di accademist i, c ui venne affidato il servizio di co ll egame nto; della squadra "Mariani", che, al su o inte rn o , annoverava
3 17 A.U.S.S .M.E . , N. /-IO, Diari storici 2a Gu erra nwndiale . b.3022, f.3, "Attiv ità svolta dal ten.co l. S .M . Salvati Gi useppe , q uale comandante de l gruppo bande B illi e della rise rva a d ispos itione de l Comando Fron te Ca landestino in Roma", Comando Gruppo Bande Bi ll i, 186 - 1944.
110
u na cosp ic ua p rese nz a di ard iti da im p iegare in e ven t uali co lpi di mano ; in fine , di un reparto de lla PA I che. modem a m e nl e arma to, avre bbe cos t it uito una po te nte riserva a disposiz ione de l Coma ndante mi litare di Ro ma pe r il mantenim e nt o de ll 'o rdi ne p ub blico se le d iretti ve s u per io ri no n avesse ro ri c hi es to la conce ntrazione di tutte le forze de l corpo a ll a Farn esin a. U n notevo le s u ppo rto fu dato a lla ba nda da pe rso na le civil e e fe m m in ile a ttraverso ri fornim e n li d i v iv er i, a ll oggi , ca rte an non arie , d oc ume nt i fa ls i, p e r mess i di sogg io m o 318 _
La ba nda Ne ri , assemb lata dal tene nt e colonnello R ossi . era in real tà la " brigata G offre do M ameli", il c ui nom e ri e vo cava una de ll e e ro ic he fi gure de l nostro R isorgim ento col ch iaro intento d i riaffennarne g li i deal i patrio tti c i e d is pirare ad essi la lotta co ntro l' inva so re. R oss i, coad iuvato da l v iceco mand a nte A d ucc i, vo lle dotare gl i a ffilia ti d i una so li da stru ttu ra di ri fe r ime nto , organica e fun z ionale. I nuclei opera ti vi in essa inquadrati fu ro no ad ib iti prin c ipalme nte a ll a pro paganda e all 'attiv ità info rm ativa che resero vani ru tti gli appe lli la nc ia ti dalle au tor ità ge rm a n ic he. 1 ted esc hi , seco ndo la tes tim on ianza de l capo della ba nda. sgo me nti e turba ti dall' irriduc ibil e r itros ia d imostrata da ll a po po lazio ne, confessaro no a pi ù ri prese di avve rtire attorno a loro un v uoto, co me ma i e ra a c cad uto in ness u na ci ttà, poic hé g li o rd ini e le min acce bra ndite no n o rt ivano alc un e ffetto. A ge nn aio, il rag g rup pam e nto ve nne inq uad rato ne l FMCR e, a magg io, il ge ne rale Tamass ia, confid a ndo nelle s ue al te potenz ia lit à ope rative, ri chiese a ll a banda " Neri" tre battagl io ni da assegn a re a i se ttori in cui fu suddivisa la capi tale, ed uno d a attri bu ire a ll a ri se rva3 19 De s tina ta al la ri s erva fu altresì la ba nda "Accili", agli ord in i de l co lonne llo A zzaro. C o mp os to pe r lo pi ù da uf fic ial i e so ttuffi cia li sca m pa ti all a ca ttu ra , ta le ragg ru ppame nto s i occupò p revale nt e me nt e de ll'assi s tenz a sp iritua le e ma te ri ale dei mi lita ri sbandati , medi a nte la di s tribuzio ne di vive r i , su ss idi e d oc um en t i di ide ntità fals i. La for maz ion e fu rip ar t ita in d odic i g rupp i tra cui q ue ll o costituito a R oma dal te ne nte colo nne llo Sav ini il 26 sclte mbre , due gio rn i dopo il di sarmo dell a d ivisio ne " P iave" . I n se gu ito ad a lcu ni brev i co lloqui con Pac inotti e Fen ull i, il nuc leo ent rò a fa r p arte d el FMCR. La b anda "Acc il i" accreb be progre ss iva me nte i propri effe tti vi co n l'affl usso di sol dati fu gg iti dai ca m pi d i co ncen t rame n to e dai treni di deportazion e ma , a lla fin e di ott obr e, le strin ge nt i d iffic ol tà ec onomiche ind ussero

3 18 A .U.S.S. M.E. , N. l - 1 /, Diari storici 2° Guerra mondiale , b.30 22 . f.2 . " Re lazio ne s ull ·attivi tà della Banda Umberto". il co ma ndante della Banda Umberto Ten.Co l. S.M. U mberto Boria, giugno 1944.
3 19 A .U.S.S.M .E ., N. / - /I.Diari s torici 2" Guerra mondiale. b.30 22. f. 18. '" Relalio ne sull"at1i v it à svo lt a da ll a B ri ga ta Go ffredo Mame li '', 15-6 - 1944.
Mo ntezem olo e il Fron te Militare Clandest ino
111
Sabri naSgueglia della Marra
molti mi l it i ad abbando nare la lotta ed altr i a passare alle dipendenze de i partiti politici.
Con lo s barco di Anzio, i l gruppo dive nne l'XI e poi il XII gruppo "Azzaro " . Nella prima deca de di m agg io, malg rado l'opera svo lta tra nu merose diffico ltà, la ba nda "Accili" fu definitivamen te s memb rata : due nuclei furono assegna ti a l I e al II distretto di R o m a, e d un gruppo, a l co ma ndo del magg iore D e A lfaro, fu destinat o a d uno d e i settori in cui a febbraio fu suddiv isa la c ittà con u n im piego eminentemente operativo320 .
Come la "Accil i", la ba nda "Bart olucci", agli o r dini del tenente colonnello Commento, si occ u pò in particolare della d istribuz ione ai patriot i di sovvenzioni, ca rte a nnona ri e, docume nti di r ico noscimento e di lavoro . S i formò nella prima deca d e di ottob re allorché i maggiori Basile e Magr i, tramite la marchesa Ben zoni ed il cap itano B odo, entrarono in contatto con Montezem olo e ricevettero l ' incari co di raccog li e re uffi cia li e sottuffic iali di provata fede32 1.
II FM C R po té avvalersi del fo n dame n tale appo rt o d ell'organizzazione a n t i sabotagg io predisposta d al generale d i b r iga ta Co r te ll essa . Q uesti , do p o 1'8 sette m bre , d' intesa con la d ire z io ne genera le de l Gen io pres so il m inistero de ll a G uerra , s up erando notevo l i i m ped i m ent i, s ' im possessò del carteggio amm i nis tra t ivo in esso c u s t od ito ed istitu ì un uffic io stralcio della Sicil i a p repos to a ll a l iq u idaz io ne dei lavori ordinari e di d i fesa compiuti nell'isola per il terr i tor io d el XII Corpo d'Armata s i no al mome n to dell'invasione. Q u i si raccolse ro rapi damen te t utti gl i ufficiali sottoposti a l generale reduci d alla Sicil ia e, be nc hé la sca rs a dispon i bilità finanziaria non consen ti sse che esigue erogazio ni , l'uffic io dive nn e vi a via un ce n tro d'assiste nza morale e materia l e . Mon tezemolo, venu to a conoscenza d i tale attiv ità , volle incon t rare Cor tellessa e i pr imi d i di cemb r e 1943 lo invitò a col labora re co l Fronte m i litare per riordi nare le file del Ge ni o apportando il necessa ri o co ntribu to tecnico e pe r ottenere sovve nzioni attraverso i suoi rappo r t i amm in istra tivi col Ministero della G uerra e con svariate ind ustr ie.
I l co lonnello g li affidò inoltre l'antisabotaggio dei princip ali impi anti d i p ubbl ica uti lità in dispensa bi li a ll a v ita della capi tale. L'en ergia elettrica, allora, proven iva essenzialmente d a Terni; a R oma v i era no soltanto due centrali

320 A.U S.S M. E , N 1- 10, Diari storici 2• Gu e rra mondiale , b.3022, f 12, " Relazione sull'att ività s volta dalla Banda Accil i dal 4 aprile 1944 allo sciogli mento de lle organizzaz ioni ", a l Comando del P residio Militare di Roma, 15-6-1 944.
321 A.U S S.M. E ., N. 1-10, Dia ri s toric i 2" Gu e rra m ondiale , b.3022 , f. 14 , "Relazione s ull'atti vità svolta" , Banda Bariol ucci, 6-6-1944.
112
te rmic he nel quartiere San Pao lo che e ro gavano c irca il venti per cento del fabbisogno de ll a c ittadinan za. Per m es i C o rtcllessa, ass ieme a l co l onnello De Mi c he li s, a l ca pitano Jannotta e all ' ingeg ner Ri ccio ne, s tud iò un art ico lato pi ano d ' azio ne volto ad impe dire even t ual i devastaz ioni nem iche ne l cen t ro abitato e d a assegna re a ll e bande int e rne ed es te rn e co l concorso cli un gruppo di operai e di gregari agli o rdini de l ten e nt e De Cola che, appo s itamente istrnili , av reb bero di s inn escato le cariche es plos i ve e ne utralizzato i sabotatori prepo s ti a ll 'accens ion e di esse. La sca rs ità dei mezzi a d is posiz io ne ed una probabil e delazione a ll a polizia germa ni ca p regi udicò il s ucce sso de ll ' inj zia tiva.
L' antisabo tagg io delle centrali termk he di San Pao lo e de ll o s tabilimento di produzione del ga s ad e sse annesso, in segu ito ad u n accurato sopra ll uogo e ffe tt uato d a Co rte ll ess a e da l prof. Ippol ito, diede invece g li es iti spera ti. In previsio ne d i un ' interru z ione degli acq uedo tti " P ao lo" e "Ve rgine", s i esamin ò la p oss ibilit à di a ttin gere a i po zzi medi a nt e motopompe per l'e s trazione dell'acqu a c he sa rebbe sta ta s uccess ivamente dis tribu ita a lla popolazion e trami te au tobotti de l Governa torato di R oma. Furono al tresì e labora ti progetti a tti a lla sa lvaguardia d ell e v ie di co mun icazio ne telefoniche d ell e ce ntra li più im p ortanti per la ci ttà e per gli Alleati , com e qu ella dello Sta to al Vimina le, la centrale urbana Teti , la centrale militare e la cen trale de l Gove rn atorato. Quest 'u lti ma, per inte rcess ion e d el prof. Ipp ol ito , mi se a di sposizio ne d e l FMCR una line a te lefo ni ca di cu i le autorità ge rmaniche ignoravan o l'esiste nza e c he, pe rt anto, rappresentò un a re te di collegamen to uti le per far fronte all e es ige nz e di ordi ne pu b bl ico .

L' ant isabotagg io delle stazio ni radio di R o ma minate d a gu asta to ri tedeschi , ve nne esamin ato app rofo ndi tame nt e d a ll 'i ngeg ne r Bl asucc i che riuscì , coi s uoi dipe ndenti , ad a p rire le polver iere e a sost iruire le ca ri che e s p losive co n altre rese inoffe ns ive per elud ere i controll i. Tuttav ia , un'i spezio ne ted esca vani fi cò l' operazione: so lo un attacco fulmineo co n l'i nte rvento di paracadutis ti all ea ti avre bbe potuto co ndurla a te rmine e. per evitare co mbattimenti dall e co nseg ue nze in calco labili , il di seg no venne abbandonato.
L 'o rganiz zazione creata da Cort e lles sa sv olse anche u n ' intensa attività in forma ti va il c ui ca mpo di r acco lt a s i es te nd eva a no rd fino al paraJlelo di Tern i, a sud fino alla zona operaz ioni.
A partire dal mese di feb braio il Fron te milit a re in caricò il reparto di approntare a z ioni cli s a bo taggio. Il genera le s i mise alac r em e nte a ll ' opera e, valutati i punti di m agg iore inte nsità de l traffi co a utomob ili stico ted esco, stabilì di colpire le principali a rterie s ituate a nord de ll a capitale . De Cola prese ntò un p roge tto pe r l'interruzion e di c in que pon t i s ull ' im portan te a nello s tradale tangente a ll a Tern i- Ri eti-L' Aqui la , da att uarsi co l co nco r so del
Monte ze molo e il Fro nte Mil itare Clandestino
I 13
Sa bri na Sgueglia dell a Marra
Co m a ndo bande es t erne, tramite Jann otta , no nché il tras po r to delle s quadre e d eg li esp losivi su un autoca1TO forni to dalla G uard ia di F in a nza.
C o n la cattura di Cortellessa a IJ a fine di maggio, tuttavia, il di spos itivo clandestino, p riva to della s ua dire zio ne, fu costretto a ridurre le bellicos e ve lle ità della prima fase ad azio ni limitate e di più basso profilo che provocarono l'interruzion e d elle vie di comunicazione co l t aglio dei cavi telefonic i e d il danneggiamento di a utocarri tedeschi assaltat i di s orpresa.

Ri s ultati assai s ignifica tivi furono conseg uiti in un 'a ttività di sabotaggio " p ass ivo" co nd otta da Cortell essa co n grande abilità e compe tenza tecnica. Egli riu scì a p roc urare ai patriot i un g r an num ero di cer ti fi cat i del servizio de l lavoro e fece stampare un'ingente quantità d i tessere del l' organizzazio ne Tod t intestandole a di tte conosc iu te che aveva no sed e fuo r i Rom a .
Le evas ioni dal serv izio ob blig atorio d e l lavoro, la re nitenza alla leva, la mancata ottemperanza a i ba ndi da parte degli ufficiali e so ttufficia li avevano comportato, infatti , re tate sempre più freq uen ti. L a polizia esigeva, p er non procedere ai fermi, che le carte d i id en ti tà fossero accompagna te da un ce rt ificato in c ui s i attestava un a r ego la re pos izio ne militare o lavorativa . Vennero q uindi rec uperati gli s tampati dei documenti mi li tari tramite s ottufficiali del comando provincia le e si ripr odu ss e il timbro che vi era appos to .
Su ri c hie s ta di Sorice, il ragg rup pamento si occupò d e ll a costruzione di stazio ni radio grazie alle capac ità e alla preparazio ne acquisit e d a l te nente Fa nt ò Nascosti in una va li gia, gli apparecch i fu ro no trasportati attraverso la città e depositat i in local i extraterritoriali.
Cortellessa, ino lt re, al fine di provveder e a ll a po polaz ione nell'event ual ità di azioni militari a ll ' interno del territorio urba no , avv iò l ' approntamento di un presidio sanitario . La ricerca e la raccolta del materiale occ01Te nte avvennero gradualmen te e con grand e c ircos p ezione. L ' iniziati va, lunga e d onerosa, si svolse preva le ntemente attraverso acqui s ti fra zio nati in pi cco le q uantit à per non des tare sos petti nelle autori tà tedesch e e ragg iu nse i risultati sperati: ven nero alles tite trenta cassette di pront o s occorso chirurgico ed un centro trasfusio nale.
ln tal modo , fu po ssi bil e insta urare un collegamento ed una feconda coop erazione co n un'an aloga s truttura che faceva capo a l Vicariato ed il cui pri ncipale soste nito re era il segreta1io gene ra le dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Amm alati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI), Rampolla.
Infi ne, ad ap rile , il Fronte in caricò Cortell essa d i e laborare, d'intesa coi CC.RR., un col po di mano a v ia Tasso per scarcerare i prigionieri poli tici c h e vi erano rinchiu s i. I maggiori ostaco li all'i mpresa cons istevano nell a necessità d i agire se nza s pargimento di sangue a l fine di evitare crudeli ritorsion i come qu e ll a sfe rrata p er i fatti d i via Rasella. L'operazione avrebbe richiesto l' inte r-
11 4
ve nto de ll 'av iaz ion e all eata pe r simul are un a ttacco no rtu rn o co n lan c io di razzi e bo mbe in ce ndiari e d irette in parti co la re ve rso il g iardi no de ll ' ed ifi c io ch e, di s trugge nd o le ma cc h in e iv i parch eggia te , av re bb e ge ttato ne l panico le SS. Una s qu a dra di g uas ta to ri , al co nte m po . av rebbe abba ttuto un o de i muri perimetrali del palazzo apre nd o u na brec c ia in gra do di c o ns e nt ire il pa ssagg io di u n g ruppo di arditi c he , un a vo lta in tro dotto s i a11 ' inte rn o . avrebbe dovut o liberare rapidam e nte i de te nuti. L' incurs ione , de finita in de ttag li o al general e Odon e in un 'a mpia re lazione , no n ri ceve tte ma i un ordine e sec utivo.
Il 27 magg io , il ca po d e ll 'o rgani zzazion e ve nn e arre s ta lo da ll a po l iz ia germanica e tradott o a via Ta ss o. Durante il c olloq ui o con Kappler, Corteilessa a ppre se c he l'uffìciale d e lle SS e ra a c o noscen za del proget tato a ttacco a ll a prigion e e ne de d uss e c he. con ogni pro ba bilità . v i fo sse s ta ta una delaz ion e. Il gen e rale fin se di ac c etta re la propo s ta di co ll abora re co n le au to rit à germ ani c he e. in c a mbi o , do po a ve r fi ss ato un a ppunt a ment o per il po meri gg io seg uent e, ve nne ri las ci a to R im ase na sco s to fino a l 5 gi ug no322
Una fo rm azio ne ch e s i di s tin s e per il corag g io e la ded izio ne dei s uo i so ldati fu qu e ll a c rea ta d a i " Gra nati e ri d i Sardeg na", ag li ordin i d e l c o lo nnell o Carig na ni e de l suo braccio d es tro , il c apitano Guerra.
M o nteze m o lo ord in ò a C a ri g nani , tramit e il Prof. Margottini , di riunire le di s pe r se fo rze de ire se r c ito d isc iolto dopo gli avve nim e nti di se ttemb re , e di raccog l iere tutti g li e le menti appar te ne nti al la Divi s ione Gra natieri di Sardeg na C arign a ni riu scì a contattare alc uni uffi c ia li d e l 11 R e gg iment o Gran atieri , c he egli aveva c omandato s in o ad allora, e no min ò vi ce capo b a nda il capit a no Gu e rra.
In s ie me , com inc ia ro no a rec lutare g ruppi d i p atri o t i a ppart e ne nti per lo pi ù alla loro divi s ione , vag liandon e attitud ini ed affidab ilità sulla base della comune es pe rie nza be llic a e fa vore ndon e lo s pirito di corpo affin c hé, di rifl esso , s i diffonde s se a nc he tr a i milita ri da1J e a ltre armi. Cari gnani avv iò un di alogo press oché quotidiano c ol cap o del F ro nte a l fin e di stabilire le moda l ità operati ve più c on se ntan ee al grup po e di assegn ar e agli a ffil iati i d ivers i c omp iti
A nov e mb re, s i ravvi sò l ' e s ige nz a di co nferire alla banda un ' artico la z ione più definita: i primi nucl e i fur o no inquadrat i pre s c ri vendo ad og ni cap o nucleo des ig nato, di r adun ar e a tto rn o a s é g li uffic ial i e i mil itari in c ui a vesse nutrito a ss o luta fiduc ia ed a s segn a ndo agli uomini di grado infe ri o re il compi to di cooptare ne lla for m az ione e le me nti val idi e s ic u ri
Pe r molto te mpo , i c api nu c leo no n s i con o bbero tra loro e d i loro so ttoposti no n e bbero rapporti che c o i propri s uper iori. Si reali zzò u na struttura a ri gi -

Montezemolo
Fronte Militare Cl andestino
e il
322 A. U.S .S.M .E N. J-1 0. Diari s to ric i 2" Gu e rra m o 11d iale, b. 30 22, f.2, " Re lazion e s ull ' attivi tà w o lta dal gene rale d i brigata Rodo lfo Co rte ll essa dall ' 8 se ttem bre 1943 al 5 g iugno" 115
Sabrina Sgueglia della Marra
d a compartimentazione al fine d i prese r vare l' in tegri tà del dispos it ivo clandes tino : in tal modo, la scoperta e l 'eventuale falcidia d i un grup po da parte della po lizia naz ifascis ta, non avrebbero comportat o l ' automatico s m ante ll a m ento degl i altri, anc he se gli arres ta t i fossero stat i sottoposti a to rtura . Con l' int ens ificars i de ll e attività ne l campo operativo e i nformativo , tuttavia, le es ige nze della cooperaz io ne, de ll a ri cerca di a rmj, a utovett ure e mezzi di sostentam ento, imposero ai r epar ti d i sta bi lire rego lari contatti tra loro.
Nel gennaio I 944, si co ngiu nse alla fo rm az ione dei Gra natieri di Sard eg na un gruppo misto di cavalleiia e di fanteria forte di circa centocinquanta uomini al comando de l tenente co lonne ll o A iro ld i di R obbiate, s u bentrato a l maggiore Lusena ucciso da ll e SS .

S i costituì un nucleo di cinquanta corrazz ier i be n arma ti ed equipaggiati agli o rd in i del capitano Piscicelli e, n e ll a caserm a ove s i d islocò, prosp iciente a l min is tero d ella Guerra, fu convocat o il cen tro d i racco lta de ll 'intera ba nda . Un in gresso s egre to ricavato da un appartamento di via le R eg in a Elena con se ntì ai mil i tari d i accedere all'edificio senza esser e visti e, co mpiuta l'ad un ata, di ag ire d i so rp resa. Q ui ve nnero murate armi e gra nd i qu a nt ità di viveri, nascosti così bene da sfuggire alle perquis izi oni tedesche.
I cap i ed i gregari d e l dis positivo clandest ino , in cessantemente ricercati dalle SS , furono braccati con pa r tico la r e acca ni me nto dal t enente Koch. Q uesti co n siderava un pun t o d ' o nore r iuscire a d ipa na re la t rama cospirat iva del l a fo r maz ione ed imprigionarne g l i u fficiali po iché aveva fatto pa r te de i Gra na t ie r i mili tando proprio nel II R eggi m ento . L a sua perman enza su l fr o n te occide ntal e e b be breviss i ma durata: in sol i due me s i, infatti, gl i furono com mi nat i c i rca ce nto gio rn i di arresti, un rim provero solenne e la definit i va es p ul s io ne da l corpo. Mosso , dunque, da ra n co r e e desiderio di rivalsa, con grande spiegame nto di forze, nella notte d e l .20 a prile I 944, mise a seg no l' arresto di t re cap i n uc leo, i tene nti Barosini e Sabetta, il capita no Meoli , e di un gregario, il tenente Pu ddu. A n ulla valsero le accurat issime perquisizio n i dom ic il iar i , i tentativi d i cor ru zione ed i b rutal i in te rrogatori nel covo di via Pr i nc ipe Amedeo : l'abil ità e l a fe rmezza de i d etenu t i fu ta le da costringere Koch a rilascia rli la mattina seguente quas i scusandosi pe r il trattame n to loro riservato malgrado l a co noscenza personale.
B arosini lo raggirò così sapi e nteme nte d a ricevere a d diritt ura un invito a co lazio ne alla pe ns ione Jaccarino . O ttenuta la necessari a autorizzazione dal capitano G ue rra, il tenente vi si recò a l solo scop o di carpi re prez iose informaz io ni che tras mi se immediatamente al FMC R 323 .
116
323 A. U.S S M. E , N.l - 10,
Diari s rorici 2" Guerra mondiale , b.3022 , f.6
li primo problema che s i p o s e a ll 'o rdin e del giorno fu la necess ità di p rovved ere all e es igenze finanz iarie della banda. D app rim a, si ri corse a fondi provenient i dal di sc iol t o II R egg ime n to Gra natieri e ad e la rg iz ioni di pr ivati, s ucce ss ivamente a s ovv e nzioni del FMCR . Fulvia Ripa di M ea na ha raccontato che ogn i dieci gi orni veniv a no ve rsate a ll a ba nd a cen tomil a lire , s uo t ramite. La marchesa era in continuo co ntatt o con Carignani, cu i tra s mette va ordini e direttive di Mo nlezemolo 324 . A m a rzo, la banda Granatieri di Sard eg na raggi u nse un effetti vo di be n 764 uomini 325
Nei g iorni convulsi della difesa di Rom a , i l cap itan o Batti sti cre ò u n raggru ppament o che, col nome di " O rga ni zzazione Commi ss ariati ", OC, volle fo nda re "i n memoria d ei cadut i" , " tra il do lore d e i feriti d i un repa rto del IV Reggime nt o carristi" L'es pon e n te de m ocri s ti ano A m erigo M ei offrì a B attis ti il comando dell'avanguardia a nn ata d el su o pa rti to, ma i l capi ta no, p ur ausp icando la diuturna coope razio ne di tutt e le fo r ze parti g ian e, rifiutò la p roposta e, rivoltosi a l colo n ne ll o, si unì a l FMCR.

Divisa in tre se ttori e coll oca t a alle dirett e dipe ndenze d i Paci n otti , l ' OC sv olse prin c ipa lm e n te co mpiti i n forma ti v i e di co llegamen t o 326 L 'elabora z ione dei piani operativi si a ppuntò s ull' i n te rven to del gruppo dura n te il periodo di tran siz io ne d ei po teri. I nuclei mili tari , po s ti a pre s idio d e i co m mis s ariati di Pubbli ca Si c ure zza, a v r ebbero do v uto co nc orr e re a ll a tutela dell'ordi ne pub bli co nei dspettivi r ion i, occ up are gli e di fici d ' intere sse ge nerale e s o s ten e re gli altri re p ar t i nelle azio ni più im pegnat ive e r isc hi ose .
Presso c iascun c ommi ss ariato , si c o s tituì un g ruppo form a to in med ia da t re nta e lementi in carica ti di sorveg liare la lea le esec uzi one d e ll e di s pos iz ion i e manate dal Comando mil i tare. L ' importanza d e ll a OC con s is tett e propri o nella su a base rionale c he ne favorì la cap ill a re pe netra z io ne tra i funzion a ri e gli agen ti , alla m acchia o in se rvizio. sia ne l campo della pro paganda e d e ll 'ass is tenza , che in q uello in forma ti vo 327
324 Fulvia Ri pa di M e:ma. op. r it p 78.
m A.U.S.S.M E N. I - IO, D iari storici 2° Guerra mondiale. b .3022. f.6.
326 A. U.S .S.M .E , N./ /0 , D iari storiri 2" Gu erra m ondiale , b.302 2, f.24 , ··Re lazi one s utrmtività svolta dall"Organizzazio ne C ommissaria ti" ' Fronte Clande s tin o della Re s is te nza Organi zzaz ione C o mmissa riati (OC) . al C oman do del Pres idi o Militare di Ro m a, al Co ma ndo Mi l itare della ci ttà di Roma . g iugno 1944.
m A. U.S. S.M.E .. / -3 b.187, f.5 . ··Re laz ion e co ns unti va su lla attivi tà s ucces sivame nte svolta dall a D elegazione del Co mand o Supremo in Roma , dai Comandi C ivi li e Mili tari de l la città di Roma. ne l periodo 22 sett e mbre 1943 -5 giugno 1944; periodo 22 se uembre -5 gennaio 1944 (delega z ione ci e l Comando Supremo). in sos tituzion e ciel C o lon nell o Montelemo lo (cadut o), il Col o nnello g ià vice ca po d e ll ' ufficio di co ll eg amento del Co mando Supre mo G Pacinoui , a llo Srato Magg iore Ge ne ral e, Ufficio Patri oti. 23 scuemb re 1944.
Montezemo lo e il Fronte Militare Cl andestino
117
Sabrina Sgueg li a della Marra
Una banda interna di sta m po prettamente monarchko fu l' IVE , dal mot to " Italia Vitto r io Em a nu ele", so r ta anc h 'essa nel settem bre 19 4 3 d urante la difesa de ll a capitale. Il prof Vince nzo Mall eo riunì a ttorn o a sé un nucl e o di mi lita ri s ba ndati d ell'V III Regg im ento Genio appar tenen ti alla caserma " Uliv e lli " e provvide a l lo ro sostentamento. Atti nge ndo al guardaroba d e i s uoi famigliari, Malleo ri cavò ab it i c ivili e ca l za ture da di stribuire ai p at ri ot i e recuperò , d e po s itand og li nell a s ua ab itaz ion e, una g rande quanti tà di fucili , muni z ioni e bombe a mano d i cui li equ ip agg iò . Malleo affi dò l'o r gan izzazi o ne ed il co mando delle ba nd e arma te in v ia di formazione al ge nerale R overo. Qu esti s i mi se s ub ito in con tat to col re , attraverso i l mi nis tro della Gu e rra Sorice, col capo d el FMC R, col generale Armellini e col generale Benc ive nga, c ui inviò q uo ti di ana m e nte re so conti dettagliati s ulle att iv ità svolte e ric eve nd o, al contem po , tramite i l C en tro X , g li o rdini d a eseguire .
Attravers o il cap ita no G e niola e d il tenente Fi lippi, si in stau rò un vantaggioso e d ur evo le rap porto di co ll a borazione tra le forze de l generale Ro vero e la Band a Caru s o.
L e dimen sion i d el ragg ru ppamento, dapprim a fl uttuanti , au m entaro no notevol m en te in seg u ito al tentativo di el im in azione dei carabi ni e ri da parte dei ted eschi : il 7 ottobre 1943 , s i r egistrò un loro con s iderevole afflu sso ne ll e fi le d ell ' IVE , graz ie anche a l pres t ig io di cui go d eva Mall eo presso l ' Arma, esse n do ne un noto es timatore e sosten itore . Da ta la folta s chiera di p at r ioti raccolti si sot to l'insegna dell ' IVE , l ' area d ' impiego fu progressivame nte estesa d a i quartieri Trionfale, Flam inio e M o nt e Mario a quelli pe riferici. A ciascuna zon a , ve nn ero assegnate ma ns ioni be n definite d e lla c ui ese cu z ione eb bero piena responsa bil ità gli ufficiali ed i capi banda .
P roblema spinoso, d i difficile sol uzi one poich é com une alla ma gg ior parte delle fo rm azioni, fu qu e ll o d e l finanz iamen to. Nell'apri le de l 1944, per la prima vol ta , l' IVE otte nne una sovvenzio ne d i 150.000 li re e, a mag g io, una s econda d i 100.000 dal Centro X.

Il servi zio informativo fu affi da to a ve nticinque unità d e ll'Arma e della Pubbl ica Sicurezza impeg nati prin cipalmente a comp iere sopralluoghi fuori
Ro ma per individuare ed in dicare con prec is io ne agli All eati le zone s u cui effett uare i bom bardamenti aerei . M ail eo creò, inoltre, u na s quadra c o mpos ta da nove carabini e ri e sedic i age nti di Pu bb li ca Sicurezza co l co mpito di raccogliere not iz ie d i carattere mi litare e po liti co. Ess i dovevano riferire ogni g io rn o sug l i s po sta menti delle tru pp e tede s che o sulle ma nov re della direz ione del partito fasc is ta rep ubblica no ove , peraltro , d ispon eva no di u na rete di info r matori che agiva anc he ali' in te rno d e i vari ministeri
I I 8
U n'az io ne d eg na di nota svol ta dall' IV E fu il salvatagg io della s ta z ione radiote legrafica in caverna c he il coma nd o operativo della M a rina aveva installato in località Santa R osa, un 'appa recc hi atura scie ntific a di notevo le importan za, si tu ata nella zona di competenza de ll e ban d e M o nte Mari o - L a Storta. La centrale, p res idi a ta dai tedeschi , fu minata con dodic i casse di dinam it e co ll egate ad un ci rcu it o elettric o ad oro lo geri a. M a lleo affid ò il del ica to com pito di disattivare le mine a l brigadiere dei CC. R R. Lui gi Farru ggi o. Dopo qu attro mes i di feb bril e e meticoloso l avoro, i patri oti dell ' l VE riuscirono nell ' im pre a e sa lvarono la centraJe 3 28
li FMCR, ta l.vo lta, si d ovette scontrare con le ubbie e le res istenze di a lc une bande c he, per la naturale ri luttanza dei capi a rin unc iare a ll a prop ri a au tonomia, vo llero mantenere una fi sio no mia a se sta nte. I n questi cas i, l'Ufficio di Collegame nto, ne ll ' interesse d ell a causa naz ion a le , te ntò di in stau rare e conserva re nel tempo rapport i di collaboraz ione c he, in alc uni cas i, portarono ad un a fu s ione di fatto.
L'organizza z io ne Berto ne, ad esempio, ag li ordini del maresc ial lo d 'Ital ia B as tico , co ns egnò all e bande es terne ap pa rtenenti a l Fronte i poc hissimi elementi di c ui di spo neva fuori R o ma e all'interno de lla città, godendo di una rea le au to nomia limitata mente alla raccolta e all'ammini s trazion e dei fondi.
La banda "Sorice" , dal nome del ministro della Guerra in carica, ma lgrado il generale ne aves se promosso l'inquadr a ment o nel F MC R, visse appogg ia ndo si to talm e nte alle forz e politiche m on arc hi c h e 329
Uno dei membri più atti vi di es sa fu R affae le Rid olfi c he , r icercato pe r propaga nda antitedesc a e antifasci s ta , fu costretto ad abba ndo na re la propria abitazione e a disperde re la famig li a. Eg li trovò ospitalità presso il colonne llo De Ange li s, della Guardia di Fin anza, in u na vecc hia casa di campagna a Pri ma Por ta, lo calità di co ns iderevole ri levanza strateg ica per le vie ch e l 'at-

328 A.U.S.S.M.E N.J -10 Diari storici 2° Guerra 111011diale. b.3022. f.31. ·Re lazione ci rca l'attività svo lta dall"l.Y.E fra 1" 8 seurnbre 1943 al 6 giugno 1944. Comi t ato clandestino di re s iste nza, I.V.E Unic io Stra lcio , al Mini s tero della Guerra , Gabi ne u o-Uffic io ba nd e in te rne. 4-9-1944: Un'altra versio ne è data da Roberto Ciumi: il capi tan o delle Armi Navali Giusep pe La Marca rubò un inn esco per stu diare co me disinnescarlo. Il serge nte cleurici sta Egisto Bianchi penetrò di nott e nei so tterranei della stazione radiotele g rafica e. co l capitano, svuotò rutti g li inne ~chi la sciandone gli in vo lu c ri ormai di satti vat i; cfr. Roberto Ciumi. L'Italia di Badoglio, Ri zzo li , Mil a no, 1993 . pp.402-403.
329 A.U.S.S.M.E., 1-3 b.187. f.5. "Relazione consuntiva su ll a attività s ucce ss ivamente s volta dalla Dele gazio ne de l Comando Supremo in Roma. dai Comandi Ci vi li e Militari della città di Roma, nel period o 22 se ttembre 1943 - 5 giug no 1944: period o 22 se u e mbrc-5 ge nnai o 1944 (de legazi one del Comando Supremo). in sos tituzione del Colonnello Montezemolo (caduto), il Co lo nn ello già vice capo delr uffi c io di collega mento del Comando Supremo G. Pac inotti. allo Sta to Maggiore Generale. Uflìcio Patri o ti. 23 settembre 1944
Montezem olo e il Fronte Militare Clandestin o
119
Sabrina Sgueglia della Marra
trav ersavano e pe r la presenza di un vasto de pos ito di munizioni. Pertanto , vi installarono un "cent ro d 'osservazione" adi bito al controllo dell' inte nso traffico nemico e fornirono as ilo e protezione ai milita ri sbandati e ai p ri g ion ieri a ll eati della zona 330 .
L a banda " Dodi" faceva capo a l ge nerale di cavalleria della riserva Pietro Dodi c he , abbandonato da sed ici an n i il serv izio att ivo , sebbene l' età avesse potuto d is pen sarlo da attività così rischiose, s i dedicò alacremente a lla lot ta clandestina. Organiz zò il raggruppamento che da lui prese il nome, e ne adibì a sed e ce ntrale gli uffici di una s ocietà di imp o rtazio ne ed esportazione di equ ini. li legame e la cooperazione col Fronte ven nero affida ti qu asi escl usivamente al rapporto di pe rso nale amicizia es is tente tra Dod i ed i1 generale Fenulli. Montezemolo assegnò a tale versatile fo rm azione l'incarico di coordin are ed ass istere i CC .RR. e la massa degli ufficiali ap parte nenti alle forze armate che, opportunamente d ivisi in gruppi per condurre al meg lio le operazio ni da effett uare, apportaro no alla causa patriottic a un cont ributo sig nifica tiv o in ogni ambito. Braccato dalla poli z ia tedesca , il generale, in seg uito a ll a seg na lazio ne di un ignoto d e latore alle SS , fu arrestato e rinchiuso n e l carcere di v ia Tasso per diciannov e giorni, finc hé , il 4 giugno , venne barbara mente trucida to a La Storta. Il maggiore Pianella, g ià capo di stato maggiore di Dodi e s uo più attivo collaboratore, g li s ubentrò a l comando della banda che, nell'aprile 1944 , fu definitivamente inglobata nel FMCR 331
Alcune formazioni , a nc orch é ufficialmente ri conosc iu te da Sorice e da Montezemolo , non d e rogarono alla propria ind ipen den za neanch e quan d o si procedette al loro effe ttivo i nq uadramento all'interno del Fronte militare. Le b a nde afferenti al gruppo d eno minato "Mo nte Sacro-S .Ag nese" si co stit uirono su iniziativa del generale di divisione dei carab in ieri Luigi Sabatini e del ge nerale d'artiglieria Vann e tti. Essi s i conobb ero il 13 settembre nella cam era mortuaria dell'os peda le del Littorio ove s i erano recati per ren d ere omaggio alle salme dei ri s pe ttivi figli, Camillo e Francesco, deceduti coraggiosamente nei combattimenti co ntro i tedeschi. I general i giuraro no c he avrebbero p roseguito l'opera d i redenzio ne d ella patria cominciata dai due giovani e,
330 A.U.S.S.M.E ., N-1 - /0 , Diari 2a Guerra mondiale, b. 3022, f.32, " Re laz ione sulla costi tuzio ne e funzionamento de ll"organi uaz io ne militare cla nde stina, so rta in Roma nel settembre I943 . e i s uoi s uccessiv i sv i luppi, fino alla liberazione d ella capi t a le' ·, Banda Soric e:
33 1 A.U.S .S. M.E. , 1- 3, b.187, f .5. " Relaz ione consunt iva sulla attività successivamente s volta dalla Del egazio ne del Comando Supremo in Roma , dai Coma nd i Civ ili e Militari della città di Roma, nel periodo 22 settembre 1943-5 giugno 1944; per iodo 22 sette mbre-5 genn aio 1944 (delegaz ion e del Comando Supremo), in sos titu zione del Colonnello Montezemo lo (caduto), il Colonnello già vice capo dell'ufficio di colleg amento del Coma nd o Sup remo G Pacinotti, a llo Stato Maggiore Genera le , Ufficio Patrioti , 23 settembre 1944

120
pertanto , s i adoperarono pe r raccogl ie re nu c lei di ufficiali e so ttuffici al i per lo più apparten e nti a li ' Arma, fermam e nt e de termina ti a res is tere. A fine settembre , entra ti in contatto col ge neral e di Corpo d ' Arma ta Dall ' Ora, posero il reparto milita re amalgamato a ll e sue dip e ndenze. Attraverso il d uca Caracciolo, influente es ponente comuni s ta, sta bilirono inoltre un a sol ida intes a col partito de ll ' es trema s inistra , menomam e nt e inficiata dalle divergenti pro s pettiv e s ul futu ro dell'istituto monarchi co .
L' attività che più co ntraddi stinse il raggrupp a me nto fu l' introduzi o ne di e leme nti fidati ne ll e case rm e, nei servizi del lavoro , nella Pubbli ca Sicurezza , nell'organi zzazione To dt, nei comandi ted eschi e ne l partito fa s cista repubblicano 332

Nei giorni s ucces s ivi a ll'armi s tizio , iJ m archese G a rofal o della Rocca raccolse num erosi soldati ed ufficiali d e l S.I.M. e dei CC.RR. che, dispersi e senza ri sorse, erano tuttavia pronti a bat ters i per la sa lvez za del paese. Il marchese, dunqu e , li cooptò all'interno d e ll a banda di Monte Sacro, nella banda di Monte Sempreviso , nella banda di Badia di S. Salvatore e nell a banda del1'Urbe. I gruppi. benché a utonomi , coope raron o as s iduamente col Fronte militare e furono imp eg nati in ri schio se azio ni di gu errigl ia e di s abotaggio. Parti colarmente utili furo no le seg nal az ioni degli obiettivi s trateg ic i verso cui indiri zza re gli attacch i p rogettat i. Ad ese mpio, su richiesta di Montezemolo , i nu clei fo r nirono a l FMCR indicazio ni re lative al viadotto in muratura press o Pome z ia , ad un po nte di ferro su ll ' Ama se no pres so Pri verno, alla RomaFormia e al!a linea Ancona-Rim ini 333
L' organizza z ione " Rosi", dal nome di copertura del maggiore Pian e lla, s i sviluppò in comp leta autonomia fino al 4 aprile, allorché il generale Odo ne ne di s po se l'inquadramento nel Fronte clandestino.
Co nsiderando immin e nte l 'arrivo degli Al leati, il maggiore rag giun se la capitale e. per so tt rars i alla ca ttura , si rifu g iò a Ru scio insieme ad altri ufficia li In seguito all'occ up azione della località da parte delle truppe germaniche, i militari , dopo un sa nguinoso scontro a fuoco. dati si alla m acc hia e privi di ri so rse , fecero ritorno a Rom a. ove s i posero agli ordini de l generale Docli. Pian e lla , grazie a B oria e a Salvati, inco ntrò Montezemolo e lo eru dì in merito alla consistenza e alle poten zia lità del reparto cos titui to che, in breve tempo, aveva assunto vaste proporzioni.
Nel di cembre. a causa delle pressanti ri cerche dell e SS, Dodi fu co stretto a cedere la g ui da del dispositivo clandestino da lui diretto a Pian e lla , la cui
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
332 A.U.S .S . M.E. , N./ /0 Diari storici 2" Gu erra 111011diale. b.3022. f.45. :m A.U.S.S.M E N.1 -1 0, Diari storici 2" Gu erra mondial e. b.3022 , f.36. 121
Sabrina Sgueglia della Marra
desig naz ione fu ufficialmente sanzionata dal capo del FM C R. Suddivisa in nuclei riona li , l' o rgan izzaz ione " Rosi " svolse un' in fa ti ca bile opera di reclutamento, equ ipa ggiam en to ed assistenza dei militari. E ssi p oterono regolarmente attin ge re ad una s pec iale sez ione preposta alla raccolta di materia le come automezzi , bici clette, carburante, armi ed esp lo siv i , e di sporre di un ufficio composto d a un a tip ografia e da una fab bri ca d i tim bri, ad ibi to alla stampa di documenti falsi.
Il servi z io informazioni si occu pò per lo pi ù d el controllo de i m ovimenti s tradali e ferroviari , della co llo cazio n e dei comand i e delle fortificazioni costie re . Assai efficace si rive lò l'attività di controsp ionaggio diretta dal maggiore Sa lomo ne, impeg nata nell'indiv id uazio ne e nell 'eventuale elimin azione degl i age nti nemici 334
Un nucleo di circa cinquanta militari tra ufficial i, so tt ufficiali e so ldati , ri uniti d al capitano d 'a rtiglieria Talli, appena costit ui to, fu inquadrato nell'organi zzaz ion e " Rosi". La complessa attività de ll a for m azio ne, de nominata banda " Bianchi", volta al sabotaggio, alla propagan da patr iottica attr avers o la stampa e la diffusione d i op uscoli, giornali e manifest in i, all'assiste nza d egli sban da ti, allo sp ionaggio e a i pedinamenti, si estese anche a ll a p rovinc ia, s in o a comprender e Bracciano, Ca pr aro la e Palidoro. Già dalla fin e di settem b re , animatore e finanziatore del raggrupp ame nto fu il barone S elv aggi, di noti se ntim e nti antiteclesc hi e an ti fasc is ti, in contatto da tempo con Montezemolo In seg uito allo sciog li me nto dell' Arma, Selvaggi ord inò ai suo i sottopost i di raccogliere circa d uemi la carab ini e ri c he , introdotti ne lla banda, furono s uddivis i da Ta lli in vari nucle i .
Funzioni prec ip ue dell 'o rganizzaz ione furo n o, ino l tre , il s ervizio di vigila nza ed il collegamen to tra g li e s pon enti civili e mi litar i de l FMCR e tra la ba nd a "Bianchi " e la banda "Caruso" .

Ne l maggio del 1944, l'organizzazione R osi fu assorbita dal Fronte c la ndesti no ed i carabirùeri confluirono nella banda "Manfredi " 335
Alla " Rosi" afferiva anche la banda "C hi od i", comanda ta dal maggio re Bochicchio . Costituitasi ne l novembre 1943, amp li ò rap idame nte il suo organico fi no a raggi u ngere quattrocento effe tt iv i che, ripartiti i n sei gru pp i rionali furono addestrati ed armat i p er co mpi ere az ion i di forza. L a formazione si occu p ò del serv iz io informativo e della so rveglianza di e l ementi sospetti, ma l 'attiv ità in cui s i s pecializzò ed ecce lse furono gli
334 A.U.S.S . M. E ., N.1 - 10, Diari storici 2° Guerra mondiale, b.3022, f.30, "Relazio ne s ull'att ività svo lta dall'organizzazione Rosi' '.
335 A.U.S.S.M .E. , N.1 - 10, Diari storic i 2" Guerra mondiale , b.3022, f. I 5, "Relazione sull ' att iv ità svo lta dalla Banda Bia nchi".
122
a tti d i pi cco lo sa bot agg io co me lo s p arg im ento s ull e s trad e di c hi o di a ppo s iti per la fo ratur a d e ll e gom me o l ' incendi o degl i automezzi in c us t o diti 336 .
U n'o rg ani zzaz ion e con ca ratte ri stich e peculiari, non a ss imilabil e ai nuclei militari e s amina ti s ino ra, s i raccolse a ll ' int e rn o del Vaticano ad o pera d e l cardin a le irl a ndese O ' Flah e rty, di Padre Borgia e del d o lt. M oo re , pa r e nte de l maresc ia ll o Montgomery, comandante dell e forze armate britanniche d e l Medit e rran eo, che e bbero frequenti cont atti col CLN e con vari esponenti d i spicco dell a resist e nza di Rom a e del Lazio. L a formazione s i dedi cò al sos teg no spiritu a le e materia le dei pri gioni eri allea ti fugg iti dai ca m pi di co nce ntram en to e poté be n e ficiare del s upporto di un a folta moltitudine di ufficia li in glesi e ame ri cani c he parlavano corre nte me nte l'ital ia no ed erano d o tati di docum enti fal s i per poter c irco lare ne lla capita le 337 .
Alla fi ne del 1943 , te rmin a t a la fase prel imin are , il FMC R aveva acq uis ito un 'inte lai a tura ben defin ita . Il 1O dic em bre Mont eze molo , per consol id a re e poten z iare l ' orga ni zzaz io ne delle band e , r edasse la circolar e N.333/0P., le ·' di rettive p e r l ' organizzazione e la condotta de lla g uerrig li a" che, scri tt e a macc hin a in varie c opi e , trasmise ai com andanti militari reg io na li s p ec ifi cando che erano r iservate alla loro p ersona e a quel la dei loro più s tretti co llab ora tori . La nota si compo neva di se tte facciate dattilo sc ritt e s t il ate co n n otevo le acu me tattico e con la m eticolosità dell ' uffic iale di S tato M ag gior e, com e so tt o lineat o da Lombardi c he po té pren derne v is ion e.
Compl e tata la stesura del documento, il colo nn e ll o es itò, dapp ri ma , s ulla firma da ap po rre. In seguit o, confo rmem e nte all ' inves titura d e l Com a ndo
Suprem o, firmò: " il capo di S tato Maggiore G enera le: M esse" e decise di co ntrofirmare in quant o autore dell e direttiv e: "per co pia co nfo rme, il co lonne ll o s. S.M. Montezemo lo " 338
Le di sposizioni conte nute e rano t utte improntate al m ass imo ri s petto per la vita de ll a popolazione. d a p ro teggere sem p re e co n og ni m ezzo. 11 capo del FM C R ebbe costantemente a c uo re la sa lvaguard ia della c ittadin anza, sfi nita e provala. o ltre c he dal regi me d' occupazione, d a ll a grave s itua z ione alim e nta re per le difficoltà d egli approvvigionamenti e la crescen te infl azione. Il co lon nello propugnò che. in Italia, te rreno e popol azion e si pres tava-
336 A . U.S.S.M .E .. N. I IO. Diari storici 2" Gu e rra mondiale b. 30 22. f. I6. " R e lazione s ulratti vi tà d e ll a Banda C hiodi dcli" o rga ni zz a zione cla nd es tina Rosi··, 18-6 - 1944.
337 Loren zo D ' Agos tini -R obe rt o Forti. op. cir., p.203 ; Teresa Umb ica . Il prigioniero. Episodi d e lla forra clandestina in Roma. Tipografia G. Bardi R oma, 1946, p 12. Gabrio Lombard i op. cit. , p.35.

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
123
Sa brin a Sgueglia della Marra
no ben poco, per le loro intri nseche ca ratte r istiche , a ll a g uerrig l ia Tuttav ia, al fine d i ademp iere a ll 'i mpegno ass un to dal governo di port are a termine la lotta ai tedeschi e di liberare la peniso la d all ' oppressione st raniera, era necessario svi lu p pa re tale forma d i guerra in tutto i l territor io occupato e con ogni energ ia.
Mo ntezemolo, ne lla c ircolare, s ottolineò l ' impr escindib ile contributo de ll e formazioni pol itiche a ll a causa nazionale. R iconobbe ai pa rtiti antifasc isti il merito di aver promos s o cospicue ed importanti iniziative sebbene no n s i peritò di o sservar e che, nella maggi or parte dei casi, fossero sembrate rivolte al co nseguimento de i propr i fi ni in t erni.
Nonosta nte tali riserve, eg li p resc ri ss e a i coma ndanti militari reg iona li d i considerare i parti ti i loro mig liori alleati e d i collaborare con essi all ' insegna de l r e ciproco rispetto, senza mai abbracc ia re alcuna fede, né di destra né d i sinistra, e metten do a disposizione le prop ri e co mpetenze tecnich e . L'autonomia che ogn i gru p po po li t ico ambiva a mantenere inalterata, tuttavia, era d' impedimento a que ll ' orga n izz azione un itaria c h e, il Comand o Supr emo e l 'Ufficio di Collegamento, comunicando a mezzo radio co n tutt i i comandanti dipendenti, te ntavano di realizzare s u basi mil i tari. Il ca po del FMCR r itenne , pertanto , indisp e nsabi le dare un impulso organi co alla guerra ai ted eschi, coo rdinando le operaz ioni co ndotte nelle region i occ upa te con quelle c h e aveva no luogo nel territorio orma i l iberato e valorizzando , ne l no me dell'Ital ia, q ua nto fatto ne l campo d e lla g uerriglia "senza smin uirlo con colore di parte" Solo impri mendo alla lotta clandestina un marcato carattere ita li ano essa avre bbe costituito meri t o della naz ione dinanzi ai paesi cobelligeranti. Nei rapporti co i par ti ti , Monte ze molo auspicava il deli nearsi di un'a ll eanza in cui , gradua lm e nt e, s i impo nessero il pr estig io e la ca pacità del comanda nte militare che, d inanzi a ll e divergenze e alle reciproc he gelos ie a leggianti tra le formazioni partig iane, av rebbe affermato la sua s up re mazia per l'autorevolezza c he gli derivava da ll a sempl ice fedeltà al giuramento e dall'assol uta neutral i tà politica.
La battaglia contro i fascisti rep ubb lican i , que s t ione interna assai de l icata e dalle moltepl ici con ness ioni interne, i n base a ll e direttive sare bbe rien trata ne ll a sfera cli compete nza dei partiti che, tuttav ia, si sarebbero sempre potu ti giovare dell'appoggio de i militari per quan to atteneva a ll a s icurez za, come ad esempio la difesa dall e sp ie, e nei casi in cui le operazio ni da portare a termine fossero state vere e proprie azio ni di guerra contro i tedesc hi 339 .
339 l 'azione dello Stato Maggiore Genera le per lo svilupp o del Movimento di liberazione, c it. , pp. 149- 154; Comando Raggruppamenti Bande partigiane Ita l ia centrale. op. cii pp.195- 196.

124
Nello s tesso pe riodo , anch e il CLN , in u n co muni cato d e l 2 9 di cembre 19 4 3, suggellò la c oll aboraz ion e tecni ca ed il c oordinamen to co n le bande ed i nucle i militari a ll e dipendenze d e llo Sta to M ag gi o re defin e ndo la fondam e ntale3-l-O
Le forma z io ni mi litari dovevano e s sere c ons id e rate a li quote de ll e fo rze a rmate it a li a n e rimas te iso lat e in te rritori o occ up a to e p o ic hé, a ca usa d e ll e obiettive difficoltà incontrate , n o n tutti av e vano potuto con se rvare la propria uni fo rm e s i ad o ttò, p e r il pe rso nal e in abiti c iv il i , un distinti vo d e po sitat o dal g o verno r e gio a Gi n evra, co stituito d a doppi o nastro tricolore aJ b avero d e lla g iubba. Gl i uffi c ia li e d i g regari operanti ne i nucl e i armali , compresi c o loro ch e alla d a ta del1 ' 8 se tt e mbre non facev an o p arte de ll ' e ser c it o, erano , pertant o, da rit e ners i combatten ti regol a ri in servizi o rnmta re pre ss o le var ie z on e d ' o pe razi o n e Gli uomini in di v is a ch e no n s i fo ssero in se rit i a ll ' interno delle va ri e formazioni , sare bbero s tati giud ic a ti " prigionie ri di gue rra del te d es co" e la lo ro po s iz ione sare bbe s tata esam in at a s in go la 1me nte a lib e raz ione avv e nuta.
M o nt eze mol o, nel doc um e nto , presc r isse d i gara ntire il m ass imo appoggio a i mil itari ingle s i o ameri ca ni ex prigionj e ri di g u e rra , acc ogli e ndoli n e lle
b a nde o ag evolandone il trasfe ri mento vers o il territorio g ià affrancato dal -
!' oc cup az io ne o ne ut ra le Gli a g enti d e i se rvi z i in form az io ni a p p arte n e n ti a g U s tati co belli g eranti , inoltre , dovevano e sse re cons id erali alleati e s i s are bb e perci ò co op era to c o n essi in pi e n a lealtà.
Preoccupato d i confe rire al movim e nto di resis te nza italiano una connotaz io n e m arc atam e nte naz io nal e, il cap o del FMCR rac com andò di te nere presente, in ogni momento , " la n ecess ità di sa lvag uardare la dignità italian a" e di ag ire, pertanto, "agi i ordini , m a non a l so ld o dell 'a lle ato , riman e ndo s e mpre all e dipend e nze d e l Com a ndo Supremo itali a no " . Eg li d e di c ò u n a m pio ca pito lo dell a nota all ' organi zz az io n e e a ll ' attività dell e b a nde , sottolin e ando l ' imp o rta nza d i imprimere a ll a gu e rr igli a un a direz ione milit a re unitari a

Le bande p ote va n o ess e re rite nut e ta li solo in b a se alla c omprovata seri e tà , all a fo rz a, all' a rmam e nt o, all a di s locaz ion e, al le co ndizi o ni di v it a e all e p o ss i b ilità ope rat iv e . Si sa re bbe dunqu e provv e duto a d un lo ro pot e nz iam e nto acco rpan d o le fo rma z io ni conti g ue ed o ttimi z zand o ne co o rdinamento e ce ntrali zzaz io ne.
Ad o g ni nu c le o sare bbe s pe ttata una zon a d'opc razioni ben d e lim ita ta e d eg li obi e tti v i s p ec ifi c i a cui vo lge re le p ro prie a tti v it à Le vari e ini z ia ti ve sa rebbero s tate atte nt ame nt e va lut ate e determinate in bas e alla s ituazion e, ai m ezz i di po nibili e all e p oss ibili rappres a g li e n e m ic h e .
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
340
2
I 34. 125
Ga b riella Fa nello Marc ucci, franoe Bonomi dal fascismo alla R ep11/Jhlica, Pi e ro Lacaita Edit ore, Ma nduria.
005 , pp.133 -
Sabrina Sgueg lia della Marra
L a N.333/0 P. d el FMC R, in o ltre , intes e p rom uovere in t u tto il t erritor io occupato u na "azione g e nerale coord inata " d irett a contro le co m unicaz io ni utili zz ate da i tedeschi, co l da n neggiame nto de ll e ferrov ie, l' i n terruzi one d i ponti, l'a s portaz io ne de ll e rotaie e, su ll e s trade rotab i li, provocando frane, frap p one ndo intralc i di ogni gene r e come i chiodi per buca re le go m me . Se le ope raz ioni di sabo taggio fosse ro state p ia ni fica te in modo conc e r tato ed organico , si sare b bero ottenut i buoni ri s ulta ti p ur d i spo nendo d i pochi u omi n i e mezzi .
Il fi nanziam ento, in fatt i, costit uì il maggior ostacolo allo sv iluppo de ll e ba nde, po ic h é il Comando Supremo non fu in grado , fino a l s uo rientro a R oma , di inv ia re i fondi nece ss ari ai coma ndi region ali. Mon tezemo lo, per ovviare ali' in so s te ni bile s i tuaz ione econo m ica , riso ls e d i p rovvedere al sos tentam e nto e all e esigenze della lotta attin ge ndo ai fo ndi de ll e ammin istrazioni dell 'esercito, de ll a ma rin a e dell 'ae rona ut ica, ai p arti ti e a ver samenti otten uti da p rivati, indu s tria l i e comm e rc ia nti: sin dal p rincipio , " la nece ss ità d i me ndicare" , scris se, fu "il peso m agg io re" dato ai coman d anti , i qual i avre bbero do vuto affron tarl o per i propri uomini , ricorren do a nche ad amic izie e conosce nze pe rso nali. Bisog na tenere pres e nte altresì , che la co llaboraz io ne coi partiti non si rive lò m ol to proficua dal punto di vista fi na nz iario in qua nto essi ten d evano ad uti lizzare le proprie risorse quasi esclusivamente per i fini po l iti ci prefissati 34 1
Come d imostrarono gli atte ntati or diti a Roma, le fo rm az io ni po litich e a nt ifasci s te di s ini s tra sostenevan o la necess ità di muove re g ue rra aperta al nemico a n che a li ' int erno d e l te rritorio urbano . Per compren dere a ppieno la ratio delle d irettive ed ave re, così , la mi s ura di qua nto la strategia c he in formò l'az ione de l FMC R fosse diffe r e nt e nelle mod a lità operative, è interessante leggere u n paragrafo es tratto dal cap it olo ri servato a ll e ba n de :
Nell e g randi città la gravità delle conseg uenti po ss ibi l i rapp resaglie impedisce di condurre mol to atti vamente la guerriglia : vi ass ume p re m inente importan za la propaganda atta a mantenere nelle popolaz ioni spirito ost ile ed os tr uz io nist ico verso il tedesco, propaga nda che è comp i to essenzia le de i partiti , e l 'orga nizzazion e della tutela dell ' ord i ne pubb l ico, compi to militare sia in prev is ion e del momen-to de lla liberazione, s ia per l'eventua li tà che un collasso german ico i nd uca l'occupante ad abbandona re impro vv is amente il territorio ital ia no 342

34 1 L 'az ione dello S tato Maggiore Gen e rale per lo sv iluppo del Mo vim ento di liberazion e, c i r. , pp 149 -154 ; Comando Raggruppam ent i Band e pani g ia ne Itali a centrale, op cii , pp. I 96-198.
342 L 'az ione dello Stato Ma ggiore Gen eral e p er lo sv iluppo del M ovim ento di libe razione, c it. , p.152; Com a nd o Ragg ruppamenti Band e partigiane Ita lia ce ntrale , op. c it p 197
126
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
Per quan to att e neva alle i nd us tri e, il capo del FMCR in gi u nse di non colla b o ra re coi te d esc hi , di . abo tare la produ z ione che interessava il ne mi co ridu ce nd o la al minimo e, al te mp o stesso, di man ten e re al lavoro il magg ior numero di opera i e tutelare g li interess i eco no mici it a li a ni.
Negl i ultimi d ue parag rafi vennero d a ti ragguagl i s u l problema dei collegamenti a nnunciando c he pres to il C o ma ndo S upremo si sa rebbe messo in co ntatto con tutti i coma ndanti regio nal i a mezzo radio, e si indi caro no le informazioni mili tari di magg io r interesse c he ogni banda avrebbe dovuto raccog li ere e trasmettere tempes ti vame nte dalla periferi a a l ce ntro, come le notizie inere nt i alla condotta della g uerra aerea o a ll a di s locazion e d e ll e uni tà tedesche .
L a N.333/0P. s i co nclu se co n l' in v ito ri vo lto da M o ntezem o lo ai comandant i ad applic are quan to presc ritto attagli and o c iascuna direttiva all a situazione pec uliare de ll a propri a regio ne 343
Il colo nnell o fece perve nire al C omando Supremo, per conoscenza, la si ntes i del documento. Nel di s paccio in viato a l S ud , fu aggi unto un esplicito rife ri mento ad u n a ltro prob le ma di d i ffi cile ri so lu z ion e, ovve ro, il cosiddetto doppio g ioc o. Durante il periodo in cui presiedette l'Uffi c io di Coll egame nto , Montezemolo no n co ncesse a lcuna a uto r izzazione a p restar gi uramento al go verno re pubbli ca no. Seco ndo Ja te s ti m o ni a nza di Pacinotti, come attestato da un a re laz ione c he l ' u fficiale redasse apposita men te pe r di ri me re la q uestione nell 'agos to 1944, va lu tate tutt e le eventual i con seg uenze col ca po d e l FMCR , ess i co nve nne ro che il p ermess o di v io la r e i l g iu ram e nto pres tat o potesse esse re concesso so lt a nt o dal re o da un a pe r sona espressamente delegata dal sovra no: s i trattava, pe rtan to, di un a co mpetenza c he eso rbitava da i poteri di rapprese ntanza co nferiti a Mont eze molo dal Comando Supremo.
Il dop pi o g ioco, in realtà, co me sc ri sse Pacin otti , "serviva mo lto be ne a t utelare g l i interess i dei s in go li, no n certo q ue lli dell a ca usa na z ionale" 344 Il co lonn e ll o, pera ltro , mal grado le pressanti ri c hies te ava nzate d a pe rso nalità che avevano a derito al regime di S alò e pre te ndevano una so rt a di legitt im azi one del pro prio o perato 345 , co me riferito d a l s uo segreta rio Mi c hele M u lte -
343 L 'azione dello Stato Maggi ore Gen e rale per lo sviluppo del M ovim ento di libe ra zion e. c iL p.154: Comando Ra ggruppa menti Bande part ig iane It alia cen tra le, op. cit., pp. 197 - I98.

J4-I A.U.S.S.M.E., 1- 3 b.188. f.2: A.U.S.S.M. E /-J. b.187. f.5 Ufficiali autorizzati a prestare g iuram e nt o a ll o pse udo gove rno rep ubb licano". A ut orit à Militare Italiana in Roma, J.M A.R il colonnello già capo di Staio M agg iore del Fro nt e Militare Cl a nd est ino G. Pac inotti. al M inisLero della Guerra. Gabinetto. 25 -8-1944.
:us A.U.S .S. M.E., I 3. b.146 f.7, "Azione di comando del Fronte C landest in o. genna io-giu gno 1944 '', re laz ion e de l ca pitano di frega ta Re nato Montezc mo.lo .
127
Sabrina Sgueglia della Marra
do, escluse categoricamente il ricorso a simili mezzi non solo poiché considerava nulli i vantaggi derivanti da eventuali "doppi giochi", ma anche per l'esp li cito ordine pervenuto dal Sud , di non avallare tali iniz iati ve, contrarie allo spi rito e al rigore dell'organizzazione militare346
L'attegg iamento assunto dall'Uffic io di Collegamento, come attestato dalle direttive, fu quello di esser e attenti testimoni senza ergersi a giudici. S i deliberò cli accettare pre s tazioni di q ue sto tipo da parte dì ufficial i che avessero giurato fedeltà alla Repubblica Sociale o che comunque avessero avuto rapporti di collaboraz ione coi na z ifas c isti, ammonendo, tuttavia, chiaramente, che ciò non avrebbe implicato una futura assoluzione. Si sarebbe tenu to conto soltanto delle benemerenze acquisite che avrebbero influito s ul giudiz io pronunciato, a tempo debito , dalle autorità competenti . Il generale Faldella, il cui contributo al l'attività del fronte clandestino fu pressoché nullo nel campo informativo e assai modesto in que ll o ass istenzial e, incalzò invano Montezemolo perché gli accordasse l 'a utorizzazio ne a prestare giuramento alla Repubblica Sociale e, infine, la ottenne dal generale Cadorna. L'alto ufficiale si considerò investito del potere necessario dal CLN poiché no n riconosceva l'auto rit à de l Comando Supremo e, pur mantenendo rapporti col FMCR, non ne e ntrò mai a far parte 347
Il Comando Supremo, a dicembre, ordinò all ' Ufficio di Collegamento cli saggia re le intenzioni del generale Gambara, capo di stato maggiore dell'esercito della RSI, in merito ad una possibile collaborazione Montezemolo e Pacin o tti eccepirono, tuttavia, che l'inserimento di una personalità così ambigua all'interno del fronte clandestino ne avrebbe fortemente intaccato la credibilità ed il pre stigio ag li occh i de i patrioti . L'integra zione di Gambara , infatti, sarebbe sta ta in terpreta ta co me la sanzione ufficiale del " tradimento degli opportunisti" e di coloro che non avevano una fede autentica e s pecchiata nella causa nazionale. La dispo siz ione, peranto, d ecadde.
Nel periodo successivo all'arresto di Montezemolo , Armellini consentì una so la autorizzazione al "doppio gioco" al generale Crimi e agli a ltri componenti dell 'organizzazione clandestina della Guardia di Finanza, informandone tempes ti vamente il Comando Supremo e s peci ficando le relative motivazioni.
Il generale Bencivenga, altresì, ricorse a tale esped iente in casi limitati ed unicamente nell'ambi to dei funzionari civ ili .
346 Archivio di Stato di Roma, (da qui A.S.R.) , Sede succursale, Cone d'Appello di Roma. Conc d 'Ass ise, sez istruttoria , fase. 836, foglio 34
347 Secondo la testimon ianza di Jo Di Benigno non fu Cadorna bensì Sorice ad autorizzare il generale Fa ld ella, cfr. Jo Di Benign o, op. cii., p.302.

128
Dalla relazi one di Pacinotti, inoltre, ri s ul ta che alcuni capi banda, in mod o arbitrar io ed in d eroga a d isposiz ioni a loro assai no te , o rd ina ro no ai propri so ttoposti di pre s tare serv iz io pre sso i fasc isti. Alcuni ufficiali, ne ll a sc heda personale, di c hi ararono d i aver giurato fedeltà allo pse udo governo repu b blicano sotto l'egida dei propr i s upe ri ori.
Ne l lugl io 1944, pertanto, lo Sta to Maggiore Generale stabilì che le co mmissioni preposte al gi udizio de i patr io ti emettessero parere favorevo le solo nei confron ti di co loro che avessero dimostrato incon trovert ibil mente di essere stati autorizzati a l doppio gioco dal CLN o dai centri mili ta ri direttam en te dip e ndenti dal Comando Supremo348.
Secondo quanto ri po rtato dalla relazione de l ca pitano di fregata Mo ntezemolo sull'attività d e l FMCR , a parere de l colonnello, le persona li tà aderenti alla rep ubblica che asserivano di essersi sacrificate p er il bene della Naz ion e, in realtà , come unic o "sacrificio", av re bbero d ovuto perdere grad o ed i mpiego a liberazio ne avve n ut a: no n sa r ebbero stati tol lerati compromess i349 .
Il generale Trab ucchi ha attribu it o alla N.333/0 P. un'im portanza fondame nt ale, m ette nd o ne in ri sa l to il va lore di svo lta, di netta cesura n e l movimento clandest ino poiché , attraverso tale documen to, il Comando Su p re m o ap provò ufficialmen te la r esistenza a rm a ta contro i naz i fascisti giudicando p ositivament e la cooperazio ne con tutte le forze dis p onibili . II foglio, come ha messo in luc e Trabucchi , costituì " una spi nta per gli incerti, per i pavidi , per tutt i coloro che cercavano di giustificare il loro atten di s mo con l'affermazio n e c he essi ignorava no se l'attività - alla q ua le contribuivano anche elementi es tre mi come i comu ni sti - era o n o accetta al governo lega le e legittimo" 350
348 A.U .S .S . M.E. , l -3, b. 187, f.5 , "Ufficiali autorizzati a pres tare giuramen to allo pseudo governo repu bbl ica no ", Autorità Mi l ita re Italiana in Roma. l.M. A. R. , il co lonnello gi à ca po di Stato Magg iore del Fronte Militare Clandes tino G Pacinotti , al Mini s tero della Guerra , Gabinetto, 25-8 - 1944; A. U S.S.M.E. , I -3 , b.187, f 5, " Re laz io ne consuntiva s ulla attività succes sivamen te svo lta dalla Delegazione de l Coma ndo Supremo in Roma dai Comandi Civili e Mil itari della città di Roma , nel perio do 22 settembre I 943 -5 g i ugno 1944; periodo 22 settemb re-5 gen naio 1944 (delegazione del Comando Supremo), in sos tituzione de l Colonnello Mont ezemolo (ca dut o), il Colonnello gi à v ic e capo dell 'ufficio di collegamento del C omando Supre mo G. Pacinotti , a llo Stato Maggiore Generale, Ufficio Patriot i, 23 settembre 1944; A.U.S.S.M .E., l -3, b. 148, f.3, "Dich iaraz ioni di aut o r izzazione a prestare gi urame nto allo pseudo eserc ito repubbli cano", Ufficio Stralcio, a l Comando Pres idio Militare di Roma e. per conoscenza al Mini stero della Guerra , Gabinetto, 15 -7 - 1944.
349 A.U S.S.M.E , 1-3, b 146, f 7, ''Az ion e d i co man do de l Fronte M ilitare Clandestino gennaio- g iu gno 1944", relaz ione del cap it ano di fregata Renato Montezemolo.
350 Ales sandro Trabucc hi , op. ci t., pp.67-68

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
129
Sabrina Sgueglia della Marra
Battagl ia, di contro, ha propugnato un 'i nterpretaz ione diam etralmen te opposta : a s uo pare re, le dire ttiv e cos tituiro no l ' em bl ema de l tentat ivo operato dal govern o regio di ri ac qu isire il co n trollo dell' Ital ia occupa ta. Lo stori co ha ravvisato nella not a u na sorta di sa nzione ufficiale dell ' attesismo corrob o rata da ll a total e s fidu cia nell e pote nz ia lità de ll ' organi zzaz ion e mili ta re che, a suo parere, a legg iava sin dalla premessa del docum en to. Se Battaglia ha co nvenuto sull'analis i de l territorio italiano, rilevandone una co nform azio ne non favo revo le alla gue rri g lia per la mancanza di g ra ndi fo reste e per le zo ne m on tuo se so lcate da vie di com un icaz ioni e di va ll a te agevolmente accessibi li, la circo lare, tuttavia , e ra cadut a nell 'er ro re di va lutar e anche il po polo " in termini tecni ci t rad i zio na li" Ne aveva così ig no rato le r is orse so ttov al utand o ne la forza di es prim ere ''una propri a vo lont à com batt iva" che costitui va " un'arte milita r e a udace e originale ri spe tto a que lla ormai in vecc h iata delle accademie mi litar i". A ll a concezione defini ta "s tatica" della s trategia di lotta pro spe ttata d alle d ire ttive , che facev a ri fe rim e nto ai so l i d ati oggettiv i co me la debo lezza dell e bande o la sca rsità deg li armamenti con chia r i in tenti polit ici, Battagl ia h a co ntrapposto la resistenza dell a part e più avanza ta de ll 'anti fasc i smo che c so,tava aJl ' in surrez ion c nazionale come " opera quotidiana" 351
Ana logamen te, Pietro Secch ia ha d esunto d a lla lettura dell a ci rcol a re c h e Mont ezemo lo, in rea lt à, non co nfidasse n ell 'az ion e de ll e ava nguardi e armate de i part it i a ntifa scis ti temendo ne gl i eccess ivi i nt e r essi d i parte e paven tando ini zia ti ve is pir a te p e r lo più d a o b ie ttivi pol it ic i e non da finalit à naz io n ali. Lo s t or ico, pur no n co ntestando l 'es i s ten za di settari s mi e di ve rge nze i n seno a ll e for mazioni pa rti g iane , ha opinato che essi non min aro no la co mp a ttezza né l' efficac ia de ll a lo tta , ben sì la a rri cc hir o no i m pr ime ndo ad essa un impulso ideologico. Ad ind e b o lire e a togli ere vi go re all a g uerra per b and e comp ro mettendo n e, così , ine lutt a b ilme nt e gli es i ti furon o. secondo Secc hia , le pr eve nzi on i e i d u bb i d e l colo nn e ll o s ull e p ossib il ità di sv iluppo de ll a guerrig li a , uno scetticismo cu i eg li h a ascritto la rid uz io ne d e ll'att iv it à re s is te nzial e ad iso la te az io ni d i di st urbo e sabo t aggio, un a g ue rra " di c io tt o l i" e " d i rot aie" c h e relegò la fu n zione d e lle for ze armate a l m an tenim e nto de ll 'o rdi ne pubbli co. L a c irco lare, a nco rché redatta s ulla base di valide a r gome nt azio ni t ec ni co- mil itari , nell'e sec u z io ne pratica, risultò quindi improntata a d una con troprod uce n te moderaz io ne. Dal p unto di vis ta politico inoltre , Secc hia ha ra vvisa to ne ll e di retti ve, ne fosse consapevo le o no il co lon nello, " un senso con se r va to re
351 Roberto Battaglia. Lll Resis1e11;;p i1a/ia11a: lo sviluppo dell'i111en1e1110 armatn f,110 al/"i11.rnrre::.io11e. in Fascismo e amifascismo. Le:.ioni e resri111011ia11::.e. cit., pp.481-484.

130
s in troppo scoper to" determinato dalla cont r apposizione tra i contenuti c lass i sti della "g uerra di popolo" e quella condotta dalle forze politiche del governo del Sud.
Lo storico, tuttavia, riconoscendo il leale impegno di Montezemolo, ha sottolineato che, esse ndo un valoroso e coraggioso ufficiale, fu il primo a disattendere l e direttive che egli stesso aveva elaborato352
Piscitelli ha escluso che la nota perseguiss e fini politici: il FMCR aveva rappre sentato la resid ua fo r za dell ' esercito che, con un ' inde fessa opera di solid arietà , difesa, collegamento ed informazione, cercò di ri s cattare i l proprio onore35 3 Vallauri, infine, ha g iudica to il testo delle direttive eccessivamente te o rico rispetto alle s itu azio ni di fatto , obiettando che bu o na parte delle formaz ioni partigiane già operanti con l'apporto di milita ri , avevano assunto un colore politico. La N.333/0P, a suo avviso , costituì un progetto militare molto circostan ziato che si riferiva a c ircostanze in via di superamento e il cui valore giuridico internazionale era limitato alle bande composte e guidate da appartenenti alle forze armate 354 .

Risulta, in vero, che le dirett ive per la condotta della guerriglia , favorirono s en s ibilmente l'attività ciel FMCR, le cui bande, sul finire del 1943 , si andarono vieppiù ingrossando. Gli sviluppi del movimento partig ia no nell'Italia centrale e settentrionale , infatti, posero all'ordine ciel giorno l'e sigenza di pro muo vere all'interno d el Fronte una più marcata centralizzazione. Si delibe rò che il coordinamento delle numero se formazioni sar ebbe sta to assicurato dalla designazione di un capo c ui il g rado rivestito av r ebb e conferito di gn ità e autorevolezza nei contatt i personali con esponenti militari e dei partiti. Nominato dal governo del Sud, il comandante unico avr eb be agito alle sue immedi ate dipendenze.
La sce lta , dopo un'attenta val utazione delle personalità militari di s picco presenti nella capi tale e disposte ad assolvere incarichi direttivi nell ' ambito delJa lotta di lib erazio ne, ricadde dapprima sul generale Armellini ed in seguito sul generale Bencivenga. Ciò produsse un benefico effetto sull'attività delle varie organizzazioni militari che percepirono di non co mbattere più isolatamente ma di esser e, a l contrario, sostenute e dirette dalle a utori tà legittime dello Stato italiano.
Monte zemolo, in linea con tal i provvedimenti , esaminò l'opportunità di unificare l 'az ione d e i primi gruppi antisabotaggio e, all ' inizio di gennaio, ne incaricò in un primo momento il colonnello De Pet ra e, s uccessivamente , il
Montezemolo e il Fronte Mil itare Clandestino
3 52 Pietro Secc hi a- F ilippo Frassat i , op cit., pp.349 -353 .
353 Enzo Piscite lli , op. cit., p.200 .
131
354 Carlo Vallauri , op . cit.. p. 306.
Sabrina Sgueg li adell a Marra
genera le de l Ge ni o Cortellessa, cui affidò il comp ito di soprintendere e d i concertare tutt e le opera z ioni avvalendo s i d ella co ll a borazio ne di Girotti , C aratti, Od o ne e Ta m assia
Alla fi ne di d icem bre, l ' Ufficio di Co ll ega m e nto aveva organizzato c irca diecimi la uo mini a R oma, oltre ci n quemi la nel L az io e ne ll ' Ab ru zzo e trem il a ne lla Toscana m e r idio nal e Il Fro nte patr iottico ass un se la s ua definitiva co nfi guraz io ne e, come at testa to da ll a re lazione cons u n t iva st il ata da Pacinott i, risultò co sì compo s to:
- lo Stat o Magg io re co m p re ndeva i l tenen te Basevi per la s tampa, le in formazio ni e la pro du z ione di documenti falsi , il te ne nt e Erco lan i per le inform a z ioni, il tenen te colo n ne ll o de ll 'aeronau ti ca Musco pe r i collegam e nti , e n tramb i co l diretto int eressa m ento e l a supervisione di M o n teze m o lo, che si occupava dei rappor ti coi pa rt it i e de l re pe r i m ento d e i fondi la cu i d istrib u zio ne ve n ne affidata fino a novembre al co lonn e ll o B odo e in seguito a l colo n nello Pacinotti;
- l 'org anizzazio ne de ll a R egia M ar ina, face n te capo al l' a mmira gl io Ferreri e al s uo capo di Sta to Maggiore comandante Cornei;

- l ' orga ni zzaz ione de ll a R egia Aero nautica guidata dal ge neral e di divis io ne Cappa;
- i l coma ndo dell e formazio n i mi litari della città di Roma , affi dato al generale Fenu lli e s ucc e ss ivame nt e a l co lon ne llo Paci notti e al s uo ca po d i s tato m agg iore te ne nt e co lo nnell o S imone lli ;
- i l co m an d o delle formaz ion i mi litar i del Laz io -Abruzzo , agl i o rdini d e l co lonne ll o D e Michel is e del ca pit ano Ja n notta;
- il coma ndo d e ll e formazio ni mil ita ri de lla Toscan a m e ridion a le, a tt ribui to a l tenente colo n nell o Croci.
132
I RAPPORTI CON LE ALTRE COMPONENTI DELLA RESISTENZA ROMANA

III
CAPITOLO

1. I rapp or ti coi partiti del Com itato di L iberazion e Naz io nale

II co mpi to più arduo che la R es istenza d ovette affron tare fu ricomporre s u l terre no d ella lo tta pa tr i ott ica le moltep lici com p o nen ti c he in essa co n fl uirono. Il problema de ll 'amalgama tra soldati e par tigiani, profilatosi sin d a l settem bre, rapprese ntò un a q uestione oltrem od o spinosa e complessa dalla c ui risol uzione, come in tuì immed iata m ente M o ntezemolo, dipendevano le sort i dell 'int ero mov ime nto di l iberazione. I mi lit ari, in nome dell'apo l iti cità professata, des ideros i d i co mba tte re per J'ltalia senza "colore cl i parte", rifugg ivano da ll ' in quadra m e n to in formazioni p ol itiche .
TI colonne ll o, come h a rilevat o Enzo Fo rce ll a , non esitò a p ors i in netto di saccordo con g li al tri generali ed ufficiali a p par te nen ti al FMC R e co n lo stesso A rm ell i ni, in virt ù de l s uo profo ndo e ind efe tti bile convincimento c h e solo un a stretta unità d 'intent i e d 'azione tra cosid detti "bad ogliani" e a ntifasc i st i potesse offrire co ncre te poss ibi li tà di successo alla lotta clan des tin a 355 .
I partiti, a lo ro vo lta, era no tradi z ion almente in do tti a diffi d are d ei mil itari e ad agi re in piena a uto nomia ma , tra le loro file, si an noverarono uomini che, come F erruccio Parri, co ntrastarono ri solutamente la po l iticizzazione delle bande pa rti g ia ne poic h é per suas i della necessità di con ferire alJe forze della Res istenza anna ta , "s tru m ento d ella r iscossa", un cara tte re nazio na le e non di parti to 356 .
M o nteze m o lo s i prodi gò con tenacia e ass iduità per a bb attere i tim ori e le ba rr iere ideo logiche s u c ui si arroccavan o mi lit ari e partigian i : la sua opera d i mediazio ne mirò a con te mperarne esigenze e proponimenti, a sm ussare le asp eri tà di un'ost inata avve rs io ne reciproca i cui presu ppos ti po l itic i s i sare bbero dovu ti stemperare ne ll 'op posizi one co ll ett iva ad un nem ico ben p iù pe ri coloso e temi bile. Il su peramen t o d eg li an tagonism i e dei contrasti era all ora im pos to da q uell' id entità d egli o bi ettivi s uperiori in cui il capo de l FMC R in d iv id uò la reductio ad unum c h e ra pp resentò la c hi ave di volt a d ella Resistenza roma na, ovvero la collaboraz ione tra mondi o sti li e d is tan ti in un a sfida comune co ntro la fa me, i rast re ll a me nti , g li arresti e le d ecimaz ion i.
355 Enzo Forcella, op. cii., p.181.
356 Ferrucc io Parri , op. c it ., p. 214.
Sabrina Sgueglia della Marra
M on teze molo, il 25 nov e mbre, poté com un icare a l Co mand o Su p re mo:
Pa rtiti vanno riconosce nd o necessità rim e tt e re at mil itari o rgani zzazione con dotta bande e t immettere bande militari parte attiva bande partiti a lt da raggiungere quindi in ogni reg ion e capo militare appoggiato da locale comitato di partiti alt parti to azione te nde i mporre cap i m ilitari acqu i si ti a t p roprie idee ma reazione comune et gelo s ie altri partiti portano ad ouima sol uzion e ri cercare militari c he nella se mplice fedeltà pro prio gi urame nto no n facc iano politica a lt comunque sce lta cap i vincolata pochi disponibili id one i est mo lto delicata a lt ritengo poco potrà fare gu erriglia in Ital ia co munqu e quel poco debba esse re fatto nome co mand o sup remo itali a no al t opportuno q uindi capi mil ita ri sia no nominati aut con fermati comando s upremo al t anche per affer maz ione italiana di fronte iniziative " inte lli gence" di cui ho ri fe ri to alt Roma comitat o nazionale partiti non ha vol ut o gene rale ma preferito me quale collegamento rappresentante Coman do Supremo 357 .••
Tre g iorni dopo , il messaggio di ri s posta giu nto da Brind isi ri badì a l colo nn e llo ch e, ne ll a desi gnazi one de i cap i di ciascu n nu cl eo, av rebbe dovut o tener c ont o non del g rado re lativ o a lla scal a gerarchi ca, ben sì del prestigio acqu isito dai vari u ffic iaJi 358.
L' in vest itura uffi c ial e del Co ma ndo Suprem o non bas tò ad appianare co mp letamente di sse ns i ed incompren s ioni tra militari e fo rmazioni po li tic he. T primi si a tten evano a ll e d irettive prescritte da Brindis i, i partiti alle d isposizioni del CLN; g li uo mini in uniforme , fede li al g iuramento, asp irava no a ll a co nservazione della monarchia, i partigiani ad un rad icale mutamento istituzionale.

Di ametralm en te o pposte e rano , a ltresì, le co ncezion i re lativ e a ll ' impostazio ne e alle modalità operative dell a gue r riglia: i soci alisti e , ancor d i più , i co muni s ti , ad esem pi o, inten d eva no condurre un a vera e propri a g uerra rivolu zio naria con l'attivo concor so della c ittadinanz a.
D i co ntro , la s trat eg ia praticata al l'interno de lla capitale da ll ' Uffi c io di Co ll ega mento , si proponeva di evitare le rap presag li e ne mi c he e, d u nqu e, proibiva la lo tta armata ne l territori o urbano, ad eccezione delle az ioni be ll ic he offensive richieste dal Co mando a ngloa me ri ca no. Le bande avre bbero dov u to atten dere alla prop r ia o rganizzazio ne, all ' armamen to e al l' eq uipaggia men to, in v ista dell ' insurrez ion e ge ne ra le ch e s i sa reb be comp iu ta so lta nto a llo rché la s ituaz ione si fosse prospettata favorev ole.
L a cond otta mi li tare del FMC R informava la s ua azione g uarda ndo alla fase c ruciale della libe razio ne de lla capi ta le , eve nt o dai più considera to im min ente e che al Sud si atte nd eva no n se nz a a ppren s io ne: occorreva, per-
136
357 Gabri o Lom ba rdi , op cit., p 34. 358 l vi. p.35
ciò, predisporre le for m az ion i militari per sos tene re l'ingresso a ll ea to co ntro eventu ali resis ten ze dei tede schi in ritirata, e per assicurare 1' ordinata e regolare tra ns iz io ne dei p oteri . Monteze molo e i suo i collaboratori ap pli caro no tali dirett ive co n duttilità e lun gi miran za .
Come ha affermato Bocca, se ppure in un'a ccezio ne negativa, il FMCR e r a per il ri s petto di Roma 359 .
I p artit i d e l CLN ader iron o a tale imp ostaz ion e determinando, a fron te di una vigorosa e proficua attività resis ten ziale nel campo logistico ed informativo, la co nseg uen te limita zione dell ' am bito o perativo, seb bene ris ultino degne di nota alcu ne importanti azioni svolt e nella p eriferia e nelle vicine campagne, ta lo ra in collaborazione con le bande esterne.
L a capitale doveva configurars i come un cen tro n evra lg ico di irradi azion e de ll a propa ga nda patriottica , un a base info rma ti va ed organizzativa di prim'ordine, non un campo di battag lia. L'a ppo gg io d el Vaticano al FMCR dip ese proprio d all'ap pli caz ion e di tali principi.
Contemporaneamente alle bande c he confl uiron o n e l FMCR , si cos tituiro no i di s po si ti v i milit a ri d e i part iti antifascisti. Le avanguardie armate sorsero e si svilu pp arono sop ra ttutto grazie al senso di continu ità c he la pre senza del mjnis tro della Guerra So rice e di un così prestigioso rappresentante dello Stato Maggiore del! ' esercito al suo fianco , po terono garantire con la loro assid ua e coraggiosa attività t ra i partigiani.
A Roma , sotto l'eg ida della presidenza di Pietro Nenni, prese corpo l 'ap. parato militare de l Partito Social ista Ital iano di U nità Pro letaria3 60 , il cui comando generale, ass u n to da Sandro Pe tt ini, affidò i l controllo e la di fesa del q ua rtiere Pra ti a Carlo Andreoni, d i Tras tevere ad Alberto Vecchi ett i, del ce ntro storico ad Edoardo Perna, d e l qu a r tiere T rio nfale a Mario Fioretti, di Forte Aurelio e Forte Bra vetta a Giulia no Vassalli, d e l Flaminio ad Eugenio Colo rn i e, infine, di San Lorenzo a Tull io Vecchietti.
La De mocrazia Cristiana si mobilitò s uc cessiva me nte ad opera dell'avvocato Ercole Chiri che conse r vò il coma ndo militare fino al gio rn o del suo arres to , il I marzo 1944. L' 11 gen nai o Pacino tti, s u o rdine di Monteze molo, inc o nt rò, attraverso il genera le Rodr ig uez, Chiri ed un o dei s uoi più val idi collaboratori , il capitano Sartori, con c ui ven nero raggiunte in t ese a nalog he a quelle stab il ite con g li altri partiti del CLN 361 .
35 9 G iorgio Bo cca , op. ci t ., p . 149 .
360 Il Partito s oc ial ista italiano di un it à proletaria era nato il 22. agosto I 943 da ll a fus ione del Par tito soc ia li sta italiano , del Movimen to d i un ità pro letari a e dell'Unione proletari a ital iana .

Pi e tro Ne nni fu de signato segretario men tre Sandro Pe rti ni e Carlo Andreoni vicesegre tari.
36 1 A.U S S M. E, 1-3 , b.1 4 8, cart 2, " Bande Armate della Democ ra z ia Crist iana ", Au tori t à Mi litare Italiana in Roma, l.M.A.R., U fficio Stralcio al Reparto Fronte C land es tino di Resiste nz a, Ufficio Pe rsona le , 2a S ezione , 21-8 - 1944.
Montezemolo e il Fron te.Militare Clandestino
137
Sabrina Sguegli a dell a Marra
Il tene nte Giu se ppe lnters im one, coman dante di una co mpa g ni a di antiparaca du t is ti presso i l campo d'aviazione di Grazzani se. datos i alla macch ia dopo l'a rmi stiz io , s i affi a ncò a ll 'organi zzaz ione clandestina de l partito democris t iano c ui fu co nferita un a s trntni ra giu ri s di zio na le c he rip art ì il territorio di Roma i n o tto zone: la prima compre nd eva i qu a rtieri Prati , T ri onfale , C ava ll egge ri ; la seco nda Tra s teve re e M o nteverd e; la te rza il Fl aminio e i Pario li; la quarta si es te ndeva per tutto i l cenLro della c itt à; la qui nta i quartieri M o nte Sacro, Nomentano, Ital ia, San Lorenzo, Tor Pi g na tta ra; la s esta co mpr e nd eva l' Esqui lin o, l' Appi o, il C e lio e il Pre nes tino ; la s e tt ima racch iud eva i q uarti er i lim itro fi di Testacc io , Sa n Pao lo, Garbatella, Aventino e San Saba ; l ' ultima zona, l ' ottava s i trovava in perife ri a: Quadraro. Torres pa cca ta , Borgata Angelica e C en toce lle.

Sotto la g uida de l ge ne rale R odriguez furono not evo lemente accres ciu te le potenzia lit à operative de i g ru pp i armati il cu i o b ie tti vo principale era impedire ai tedesc hi, d ura nte la ri t irata ve rso nord , di di st ruggere q uan to era esse nzia le pe r la pop o lazione. Una de ll e b ande p iù effi c ie nt i dell a De mocrazia Cristia n a fu comandata da l colo nnello A lbe rtini , ideatore di una sp ecial e pi s tola atta a perfo rare i bidoni di benzina che venn e util izza ta di ffusamente e co n s uccesso362
Il P artito Com u ni sta d is pose per pri m o il s uo disp os it ivo d i g ue rra e l'apparato c la nd es tino c he al les tì fu tra i più a tti vi e compl ess i.
Ne ll a pr ima fase, t ra sette mb re e novembre 1943 , i co m u ni s ti lavo rarono prevalentemente al la se lezi one , a trinquadram ento e alla prepa raz ione m ilitare dei nuclei armati in previ s io ne della g ue rriglia e d e ll 'a rrivo deg li Alleati , se nza tuttavia tra scu r are "l' a z ione immediata co ntro i tedesc h i e i fasc is ti , contro l e cose e contro gli uomini", c he a nz i, seco ndo le dirett ive del partito, cos ti t ui va il fine prec ipuo de ll e formazio n i m il itari di Roma e d e ll a camp agna circostante e s i d oveva attuare "co n tutti i mezzi e con tutte le fo rme " 363.
Rom a fu s uddiv isa in otto zone asseg nate og nuna ad un respon sabi le po litico . L e zone, a loro vo lta , si com posero di un numero varia bil e di settori.
A lla fine di sette mbre , ciasc u n resp o nsabi le p olitic o fu affiancato d a un res po nsabil e mi litare. Gli e le me nti p iù energ ici vennero inquadrati in particolari fo rm azio ni d 'assalto, i Grup pi d 'azione pa tri o tti ca. I Gap central i fu rono organi zzat i da Antone llo T rombadori, il cui nom e fitti zio fu " Giacomo", c he rim ase a l comando fino a l s uo arresto ne l fe bbraio 1944, e, per u n breve pe riodo , g l i s ubentrò A l fio M archini. Furono predisposte du e r eti p rincipali :
362 A l fo nso Bar tol ini - Alfrcdo Te rrone. op. cit. pp 29-33.
' 63 Archivio del Parti!O Com uni sta ( da qui A. P.C. ). Direzi o ne 1940- 1945, 7 - 2-20. ··Roma. I dicembre 1943. Relazione sulla situ azione dell'organiz1.azione militare di Roma··.
138
una diretta da Carlo Salinari , "Spartaco ", l 'al tra da Franco Calamandrei, "Cola" . La prima era costituita dai Gap "Gramsci" - al cui vertice fu collocato Mario Fiorentini, il cui nome di battaglia fu "Giovanni" - e "Pisacane", guidato da Rosario Bentivegna, detto " Pao lo". Il di spositivo posto agli ordini di Calamandrei era composto dai due Gap, "Sozzi" e "Garibaldi".
Ogni gruppo era formato da tre- se i combattenti che, per esservi ammessi, dovevano possedere dei precisi requi s iti: una certa pre s tanza fisica ma sopratt utto una sosta nziale fer mezza morale ed ideologica.

Dovevano esser e uomini fida ti , capac i di r es iste re alle pressioni e alle torture naziste, liberi da precedenti legami politici.
Bentivegna ha riferito che, quando fu inquadrato nei Gap assieme ai suo i compag ni , gli fu impartito l'ordine di recidere ogni legame con qual siasi altro gruppo o reparto della Re s istenza a cui fo sse stato collegato sino ad allora e, ove possibile, con gli stessi familiari. Furono imposizioni e sacrifici assa i gravosi, ma tutti i componenti eseguirono quanto prescritto dal rigido regolamento e adottarono uno pseudonimo in cui quasi si disperdeva la propria identità.
L'isolamento era completo e la vita cospirativa, cui era necessa rio attenersi scrupolosa men te, era sca ndita con preci s ion e ed assai c urata ne i d ettagli: i gappisti venivano impiegati so ltanto nelle azioni di sabotaggio e di combattimento, non potevano in alcun modo prender parte alla vita politica del partito o avere contatti al di fuori de l g ruppo. G li fu interdetta qua ls iasi forma di partecipazione alle azioni di massa.
La cosiddetta "Santa Barbara" dei Gap, ove ve ni vano preparati e depositati gli ordigni esp lo sivi poi di str ibuiti ai partigiani , eb be sede in via Giulia e fu apprestata da Giorgio Labò, s tudente di architettura e tenente del Genio minatori che, dichiarata la resa, dopo aver combattuto nella zona di Poggio Mirteto, mi se al serv izio del movimento clandestino l'e spe rien za tecnica acquisita sotto le armi. Per quanto concerne la compos izion e soc ial e dei Gap, si componevano in gran parte parte di giovani intellettuali e, in misura minore, di op era i364
Il d ispositivo di g uerra eretto dal Partito d'Azione fu realizzato d a Cencio Baldazzi, Mario Chi erici e Pilo Albertelli. In segui to all'armistizio, venne creato a Roma un comitato militare clandestino presieduto da due civili, Giovanni Ricci e Tomma so Carini, e da due militari, il tenente pilota Furi o Lauri e Ferdinando Lucchini. A novembre , il co lonnello Emilio Silvestri ne assunse il comando e addestrò i reparti armati alla guerriglia365
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
364 Rosario Bentivegna, op. cit . , pp. 19-33. 365 Alfonso Bartolini-Alfredo Terrone, op. cit. , pp. 33 -34. 139
Sabrina Sg uegli a della Marra
Montezemo lo. fin dall'inizio di otto bre, ricercò costan teme nte la cooperazione del C L N. Dapprima i nco ntrò, ass ieme a Pacinoui, Lu ssu ed alc uni esp o ne nti del Partito Comunist a al fine d i sagg iarn e la di s p onibi lit à a co ll aborare e di concretare i primi accordi vo lt i ad ostacolare la ritirata ted esca e a mantenere l'ordi ne pubb lico in c ittà.
li capo d el FMCR promosse la cos t it uz ione di u n com it ato perm anente, e man azione della Giunta militare de l CLN , ove qu es t'ultimo sarebbe s tato rap presentato da Brosio e da B auer e il Coma ndo Suprem o da Monte ze molo, c he cercò di porsi co me ele men to di equi l ibrio e di con ci liazione delle co ntrapposte tendenze. Tale o rg ano s anzionò ufficialmente l ' int esa raggiunta e avrebbe contribuito a consol idarla ne l te mpo consentendo l'assiduo co nfro nto tra i principali attori della resis ten za r oma na.
Se da parte azionista e so cialista tra pelò una malce lata oppo s iz io ne al co llegamento con l ' organ izzaz ione militare clandestina, assolu ta mente propenso ad esso si ri ve lò i l Pa rtito Comuni sta , i l più co nsiste nte ed agguerrit o tra quelli impegnati ne l movimento di lib erazio ne. Il capo del FM C R considerava in fa tt i tale for m azio ne politica la sola su c ui poter fare s icuro assegnamento per le capac ità, la dedizione e la coscenziosità di cui aveva sapu to dar prova. Il primo co lloqui o tra Amendo la e Mo nt ezemo lo, cui seg uirono fr eque nti abboccamenti, s uggellò la mutu a volo ntà di co ngiunge re le pr op ri e for ze per co ntrastare il nemico comu ne Il generale Fen ulli , in co ntatto co n le bande comun is te della provincia, fu incaricato di incontrare e prendere accordi con Po mpi li o Molinari. membro del co mando region ale delle Brigate Garib ald i.
Carlo Anclreoni , che in seguito a ll 'arresto di Pe rti ni rimase l'unico v iceseg re t ar io del Partito Socialista in sie me a Ne nni , s i arroccò su posizioni in transigent i ed ost ili ad ogni tipo di apertura. Varie testi m onianze hanno acc reditato l ' ip otes i che eg li non so lo s i fosse profes s ato apertamente co ntrario alla co ll aborazione col FM C R , m a c he avesse pro p os t o lo studio di azioni volte ad e li mi narne i prin c ip ali espone nti. li ve ro n emico ei a abba tte re, a suo avvi so, erano i mo na rchici c he, erge ndo s i a tutori dell'o r d in e, a l momen t o della ritirata tedesca , av r eb b e r o im pedit o un a so ll evaz ione generale tesa ad affermare l 'ege monia della classe operaia. L 'espo ne nte social is ta ch e, allontanantos i da l PSTUP nel novembre 1943 , fondò i l Movimento P art igiano , identificò nella rottura dell ' unità del CLN e nell'alleanza con le forze esterne acl esso, i principali obiettiv i politici cui te n dere. Il provocato rio attegg iam e n to di Andreo ni portò a ll e ultime conseg ue nze la tesi pro'p ugnata da B ass o a Milano , seco n do la q ua le la c!asse operaia si s are bbe dovut a as ten ere dalla guerra p arti giana per entrare .in azione in una fut ura lotta social ista.
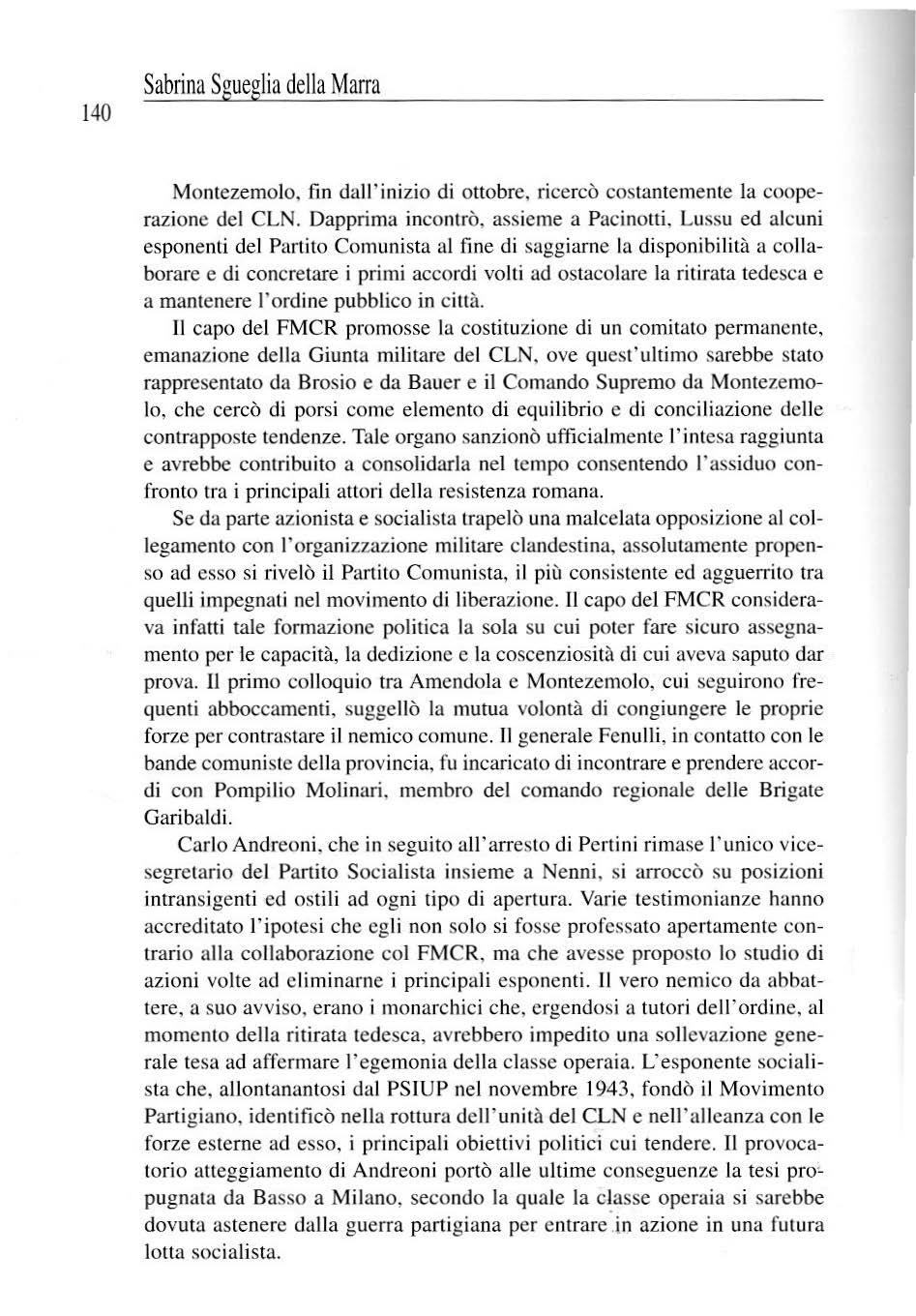
140
Nen ni, p ur dissenten d o tot al mente da An dreo ni s u lla lin ea antiu nitaria c ui vo leva impro ntare la politica del part ito , te meva com unq ue che un collegamento col FMC R potesse favori re la des ignazio ne di un generale alla testa della lotta p a r tig ia na.
Il C L N co nservò se mp re un a ce rta d iffide nza nei confronti dei mHita ri non in seriti n ell e formazio ni de i partiti rappresentati in e ss o e so lo il p restigio p ersonale di Mon t eze molo e la li nea di condotta rigida me nt e apo lit ica i mposta da ll 'U fficio d i Co llega me n to, valsero a dissipare , alme no in parte, sospetti e perpless ità . Nei confronti dei gruppi m o na rchic i e d e i partiti no n aderenti a J C LN , i l fronte m ilitar e adottò un a n alogo a ttegg iamento imperniato sulla lotta co mu ne ai tedeschi e ai fascisti ed ispirato dall'asso luta neutralità. Per com prendere app ieno il potere di coes ione c he ese rcitò la cau sa naz io nale baste rebbe ricordare il tren o che a Vell etri venne fatto saltare in a ri a da azion is ti, gappi sti e membri di B an d iera R ossa co n esp losivi forn iti da l fro nte clandestino.
Secondo la testimonianz a di Amendo la, tu ttavia, l'os tilità che cont in uò ad a legg ia r e in alcuni setto ri politici d el C L N, in d usse a ritenere l' a rresto de l colonnello u na manovra vol ta a rec ide re d efin itivamente la collaborazio ne tra forze po l itiche di sinistra e ba nde mi l itari 366 .
L' esponente comu ni sta, al con trario, sta bilì rapport i u mani e d i fid ucia con Mo ntezemo lo e s i adoperò alacrement e per conso lid are la coop erazione delineatasi, gi ud ica ndo la indispensabi le ai fi ni de ll a g uerra p art ig ia na 367 NeJJe orga nizzazio ni p a r tig iane, infa tti, agirono mo lti militari ed ex militari come, ad esempio, i l gapp i sta Giorgio L a bò , c he proven iva dall'arma del Gen io, A ladi no G ovoni, del I Reggimento "Granatieri di Sard egna", c he m il itò in B andiera Rossa e il capita no del!' Ae ro nautica Nico la Ugo Stame368
Soldati e ufficiali dell ' eserc ito, ormai sfasciatos i - hanno scritto Paolo Robo ni e Giovanni Germanetto - i nvece di segu i re l'ese mpio de ll a qua s i totalità dei general i che si arresero ai tedeschi o passarono a ll a «Repubblica soc iale» , si unirono ai patrioti per sfid a re con lo ro la fame , i rast re ll amenti, l'arresto, le torture e la morte, per condurre la lotta contro un nemico ancora fo rte e reso be s tia lme nte cru dele dalla visione de ll ' im m inente catastrofe369

366 G iorg io Amendola , op cit. , p. 274.
367 lvi, pp.229-230; S i lve rio Corvisieri, Il re, To g liatti e il Gobbo 1944: la prima trama eve rsiva, cit., p.23; Viva Tedesco, Il con tributo di Roma e pro vincia nella loua di liberazione, cit. , p.261.
368 Anna Baldino t.ti, op cit , p. 65.
369 Paolo Robotti, Giovan n i Germanetto, Trem 'anni di lolle dei comunisti italiani. /921 - 1951 , Edizioni di cu ltura so cia le, Roma, 1952, p. 211 .
Montezemo lo e il Fronte Militare Clandest in o
141
Sabrina Sgueglia della Marra
Come ha messo in e viden za Por te lli , infatt i, il FMCR s i con fig urò più c ome " un mo vimento di co lon ne ll i , te ne nti e ca pit ani , c he di gener a li"; queti ult imi ne c os t itui va no una m in oran za e d ac c e ttaron o di bu o n g rado di esse re au s ili a ri di M o nte zemoto 370 .
Parti giani e mili ta ri s i sca m biaron o vicend e volmente informazioni , consig li, anni , co mpre se le g ranate u sate nell 'a tte ntato di v ia R ase ll a del 23 marzo . Gra zie ai reg o lari c ont a tti s ta biliti s i, fu po ss ibil e pianifi ca re a z ioni c omuni da a ffidare all e bande ch e o peravan o all ' e stern o del territori o urban o
Giorgio Ame nd o la ha raccontato che l ' a z ione di g u e rra pi ù s ig nificativa dei G a p fu effettu a ta l a notte d e l 20 di ce mbre 194 3 co ntro i tre ni militari in tran s ito s ull a lin e a Rom a- Cass in o e , co ntemp o r anea me n te, s u qu e lla Roma - Fo rmia. Il s u c cesso del s a bota g gio , eseg u it o materi alm e nte da co muni s ti e d azioni s ti , fu garant ito non s o lo d a l ri forn im e nto di e splosiv i e d e to nat o ri , ma so prattutt o dall 'effi c ie n te s e r v iz io i n fo r ma t ivo d e l FMC R. Il co lonn e ll o fu in grad o di fornire prec i se indica z io n i s ulr ora in cu i era pr ev is to il p a ss aggio d ei treni e ra gg uagli es se nz iali a ll a r iusci t a d e ll'impresa che con s entirono di s f e rrar e un att acc o sim ult a neo s u e n tramb e le linee 371
D ' inte sa c on Montcze mo lo , De Miche li s ass eg n ò i l de lica to in carico all a banda "Cas te lli romani " affia ncat a da lle sq uadr e di M arino e d Alb a no . I co nvogli ed i loc omotori furono co mpletam e nt e d is trutti , la li ne a fe r ro viaria rimas e int e rrotta pe r una una se tti m a na e , tr a mo rt i e fe riti , i tedesc hi persero c irca q uattrocen to solda ti. L' a z io ne, per ragio ni di pru de nza, fu a vvolta d a l rigido s eg re to cospirat ivo : il CLN no n ne di e de no ti zia s ull a s ta mpa clan d es tin a e le a utorità ge rmanich e, p e r s uase c he i parti giani ita l iani no n fos sero c apaci di co mpiere a tt e nt a ti co sì effi caci e sc rupolo s i ne ll'ese cu z io ne, furono in d otte a rite nerne re s po nsabili i paracadutisti ingle si 372
Amend o la e Monteze molo s i diede ro appu ntame nto, attraver s o Giulia na Be nzoni , ne i locali d e ll ' Asso c ia z io ne per il M ezzog io rno. Fu un co llo q ui o s incero : " Non av rei m ai credu to c he io , mo narc hi co e , lo c on fesso . an ti com uni sta s fe g atat o - ammise il col o nn e llo - mi sarei incon trato con un es p onente com uni s ta pe r o rgani z zare in s ie me un 'az io ne di q ues to genere" . A ques te parole A m e ndo l a r e pli c ò co n a ltre ttanta sc hiettezza: "Anch ' io no n a vrei mai pen sato , un tem po , ad una s imi le possibilità. Ma dall ' inizio d e lla g uerr a a b biamo riv o lto il no s tro appello a nche a voi monarchici. No n ci a vete volu -
370 A lessandro Porte ll i, op. cii. , p .1 69
37 1 Giorgi o Am e ndola , op. c i i , p.228.
372 Comando Ragg ruppa menti Band e p anigia ne It a lia ce nt rale , op. cii ., p. 27; Pino Levi Cavaglio ne op. cir pp .95- 98: Pie t ro Secchia- F ili ppo F rass ati. op c ii., p p397 -399.

142
to asco ltare in tempo. A ll ora s i amo qua a fare quello che è il nostro dov ere, lotta re insieme contro il tedesco e i traditori fasc is ti" 373
Il dialogo co s tante , la mutua assist enza, la s intonia prodottasi fra l'e sponente comunista e il capo del FMCR assunse un significat o d' in dubbio valore umano , ideale e politico.
Uomini che proveni va no da mond i e tradizioni dista nti decisero di acca ntonare momentaneamente qua ls ias i p regiudiziale poiché in d iv idu arono nella Patria e nella lib ertà quegli idea l i s upe riori a cui isp irars i che pote rono pi ù di ogni altra con s id erazione di parte. Le pos izioni pol iti c h e contrastanti, infatti , non impedirono ad Amendola di ri co noscere l'impegno ed apprezzare il valore del co lon n ello c h e , come egli ha sottol in eato, pur potendo indi care i recapiti ed i luogh i di incontro freq uentati dai com unisti, malgrado le atroc i torture, non parlò ma " tenne alto il suo onore di solda to " 374 La poli t ica antifascista un itaria che se ppero elaborare giorno per giorno, ancorché attr aversata da settari s nù e nùre egemon iche, rapp rese nta una delle più alte co nquiste della lott a cli libera z ione .
Come ha scritto Giaco mo Nove nta, la Resistenza è una fase della storia del nostro paese in cui "uonùn i di diversa formazione c ultu ra le e di partiti politici diver s i si so no tro vati insieme" . Non si trattò solo di " un uccidere e un morire" , ma di "un rivolgers i alle pe rsone un attimo prima sconosciute o nenùche" , di " una fede nell'ig noto" : fu un'espe ri enza in cui " la disperaz ione d i sé , di tutto ciò che in solit udine o con i propri famil ia ri o con i propri compagni di parte si era ragionato e voluto, sembrava coincidere con l a speranza di tutti in tutti gl i altri". In q uesto senso Nove nta ha definito la Res istenza virtù morale e pol itica375
Il co lonnello no n s i occ upò esclusivamente di qu estioni mi lit ari . Al fine di corroborare ulteriorm e nt e il fro nte comune di resistenza , si fece mediatore met icoloso e pazie nt e tra il CLN, espression e d ella nuova Italia, deciso , perta nto , ad avoca re a s é il potere dopo la ritirata tedesca , e il governo Badogl io I min istri, a ncora formalmente in ca ri ca, p er la magg ior parte, erano rimast i a Roma e v ivevano nascosti. Il ca po de l FMCR ebbe sem pre a cuore i l problema di ottene re dalle fo rm azioni politiche il ricono scime nto di u n capo militare l a cui a utorità fosse rispettata anche da ll e bande partigiane.
Ancora nella prima me tà di novembre , tale questione si presentava aperta e in a ttesa di ri so luzione. Tuttavia, Mon tezemolo poté comun icare al Sud che i partiti, pur ricusand o perentoriamente la prospettiva di un capo nùlitare alla 373 Giorgio Amendola , op. cit , p 228 3 74 lvi, pp.228-229 375 Giacomo Noventa, op. c ir .. pp.81.
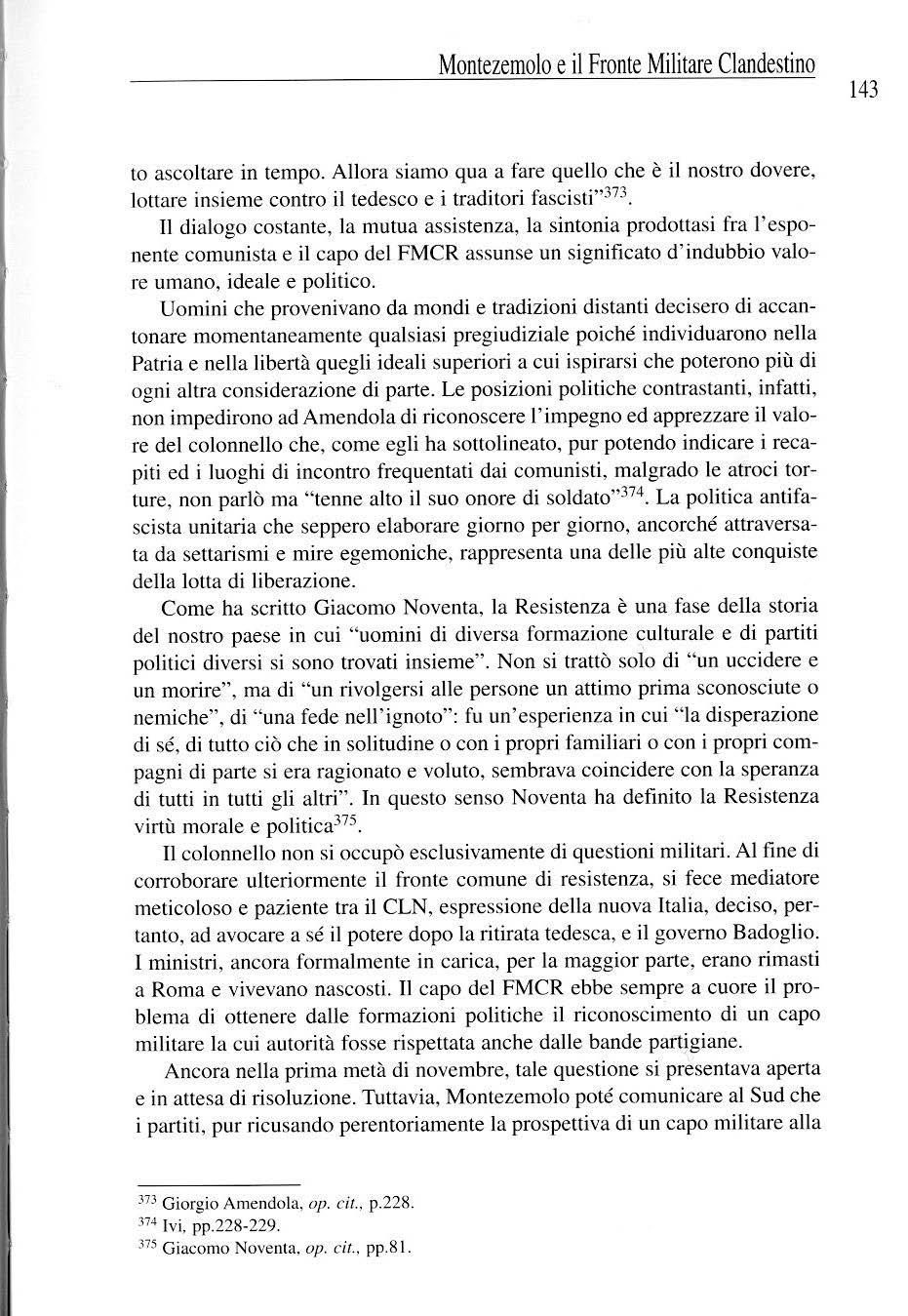
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
143
Sabrina Sgueglia della Marra
tes ta delle loro formaz ion i, si s tavano orientando a d "accettare segr eteria mili tare coo rd inat rice " 376 , come reg is trò nel relativo di s paccio radio .
P oc hi giorni dopo, a testi monian z a dell'au to revolezza e della fiduc ia o rm a i acquisita anche nell'ambiente politico, egl i info rmò il governo regio deg li ultimi risul tati conseguit i in q uesta direz ione:
R oma conùtato nazionale partiti non ha vo luto genera le ma me quale collegamento ra pprese ntant e comando s upremo alt377
Il presid e nte d e l CLN, B o nomi, persuaso c h e fosse necessario unificare le fo r ze dei pa1titi con quelle di pro venienza militare, nel dicembre 1943 annotò su l dia ri o regolarme nte aggiornato durante i no ve mes i di occ upaz ione, c he suo grande desiderio sareb be stato am mettere il colonnello " come settimo membro in parità di co ndi zioni" del Comitato pe r la g uerra di ba nd e . Egli avrebb e cost ituito un legam e regolare e costante tra le bande pa rt ig ia ne e quelle mi litari , favorendo il coo rdinam ento delle operazioni c he avrebbero guadagnato in ra pidi tà ed efficienza. Non solo ragioni pratiche di rafforzamento e d i potenziamento de lla lotta gli consigliavano tale risoluzione , ma anche una sca rsa fiduc ia ne ll e possib il ità delle avanguardie armate predisposte dalle formazioni po litic he : " in sosta nza - scrisse - le fo r ze mi litari . .. sono più num erose e agguerrite d e ll e bande dei cosiddett i pa rtit i" 37 8 •
Come h a ri levato Gabrio Lo m bardi, i partiti a ntifasc isti, nelle pr im e se ttimane di resistenza , c ircosc rissero i l cam po visuale a ll ' Ital ia centro-sette ntrionale e non ebbero una p ercezione globale della s itu azio ne in cui ver sava il paese Non consideraro no adeguatamente che, se le reg ioni a nord eran o soggette all'occ upazio ne tedesca, nel territo rio liberato, i l cont ro ll o a ngloame ri cano res tringe va sen sibilme nt e i marg ini di manovra politica. Terre no di sco ntro fra il FMCR ed il Comi tato di liberaz ione, in fatti, fu il complesso e spinoso probl ema del tra sfe rim e nto dei poteri dopo il collasso germanico e la conseguente evacuazione di R oma. Gli Alleati, il governo ita lia no e l' o rgani zzaz ione cl andestin a, determinati a garantire l'ord in ato e regolare ins edi ame nto dell e autor ità angloamericane, g iudic avano indispen sa bile a tal fine evitare perturb a m e nti della pubblica si curezza nel peri od o d'emergenza.
Il Comando de ll e Nazioni Unite ing iun se la s o s pe nsio ne d i qu a lsias i attività politica ne ll e ore comprese fra il ritiro d e ll e truppe te utoniche e l ' in-
376 Gabrio Lom bardi , op. ci i., p.44.
37 7 Ivi , p.44.
378 lvanoe Bonomi, Diario di un anno. 2 giugno /943 - 10 giugno 1944, Garzant i, Mi lano, 1947, p .1 38.

144
gresso in città di qu e lle alleate. Badoglio , ricevute tali d isposizioni , volle che ad informarne i partiti fosse il rappre sentate più st imato e fidato di cui il governo regio disponeva nella capitale, M o nt ezemo lo.
Questi, a partire dal 10 ottobre, richiamò a più riprese l'attenzione di Brindisi su ll 'opportu ni tà di addivenire in te mpi rapidi al conferimento dei poteri militari ad un'autorità, come ad esempio il generale Sogno, in grado di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico nel delicato frangente della transizione.
Il colonnello richiese ad Ambrosio l ' autori zz azione ad investire formalmente, a nome del capo di Stato Maggiore Generale, la personalità che avesse ritenuto più idonea alla gestione della grave incombenza. La questione atte neva all'a mbito sq ui sitamente politico e rientrava nelle competenze del governo che, dopo averla esaminata nelle s ue possibili implicazioni, il 13 otto bre , delegò ufficialmente a Montezemolo la designazione d.i un ge nera le.
Il compito di condurre e coordinare le attività militari aJ momento del trapasso s arebbe spettato di diritto al ministro della Guerra, cui facevano capo tutte le opera z ioni in virtù della carica formalmente ricoperta . Pertanto, interpellato da Badoglio in merito all'opportunità che Sorice raggiungesse il governo al Sud, il capo del FMCR es presse parere contrario: la s ua presenza a Roma avrebbe assicurato il regolare passaggio dei poteri "senza speciali investiture" e il pacifico in sediamento delle autorità alleate, consentendo altresì di fronteggiare eventuali dissidenze o colpi di mano. Il programma che Montezemolo presentò al governo, contemplava anche la situazione degli altri mini s tri:
Rim ettere loro po s to ministri qui pre se nti commissari dei ministri che sono con vo i et tutte le altre autorità legali n on ammettendo di sc us sioni su di esse in attesa si proceda ai rinnov i che il sovrano deciderà alt coordine rebbe varie autorità ministero guerra cui fa capo ordine pubblico et che concederebbe in nom e governo ma ss ima libertà ch e eccezionale situazione militare può con379 sentire ...
Egli confidava che tali provvedimenti, atti aJla preservazione de lla pubblica sicurezza e al ripri sti no del normale funzionamento degli organismi statali , avrebbero trovato il consenso deJla popolazione. A contrastare i "poch i faziosi" , che ammantavano le proprie "a mbizioni personali " del nome della patria e della libertà, avrebbero provveduto le forze organizzate dal FMCR e

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
p. 46. 145
379 Gabrio Lomba rd i, op.
cit.,
Sabrina Sgueglia della Marra
i due reggimenti di fante ria autocarrati di cui il colonnello richie se 1·immedi ato inv io 380 .
Per a ttuare il progetto , tuttav ia, s arebbe s ta to neces sa rio il ricono sc imento , da parte d e l Comando aJleato, della p iena giuris dizione del go ve rno regio sulla c ittà aperta e , attraverso e ss o , del min is tro della G ue rra So ri ce, una so luzione che. ovviamente, non poteva essere ben accolta dai partiti .
Motta , in q uan to gove rnat ore d i Ro m a 38 1 , secondo i l pi a no pre se ntato , avreb be dovuto assicurare l 'effic ienza dei serviz i , un compito onero so il cui prospettato co nferimento va lse come attestazio ne d e l patriottismo e della costanza dimo s trati co ll abora ndo co l FMCR.
Ne i d is pacc i diretti a l Sud , Motta esp re sse u na netta op posiz ione all ' ipotes i Sorice, de s critto come un perso naggio ambiguo e dalle dubb ie fin a lità, la c ui figura , invisa ai più , destava sospetti e diffiden za . Ca ld eggiò, di contro, la desig nazione d i u n comandante gra dito all 'o rg anizzazion e mi li tare e al CLN a llo s copo di evitare c he si acui sse ul teriorm e nte il forte dissen so s u sc itato dalla paventata inve stitura del min istro. n governatore esortò più volte Badog lio a favorire la di stens ione e s i premu r ò di fornire al gove rn o d e l S ud " le esa tte info rm azioni" in b ase a c ui il sov rano e il Comand o Sup re mo avrebbero potut o o perare un a scelta più ocula ta che tenesse conto della necess aria approvazione dei par ti ti. Auspicando , dunqu e, la nomina di una pe rso na lità a utorevole capace di a rm o nizzare e disciplinare g li sforz i c omuni , suggerì il ge ne ral e B e nc ivenga, add ucendo c he i l m ovi m e nto di res is tenza ne avre bbe notevo lmente benefici a to per il passato antifasc ista del ge nerale ed il prestig io di cui godeva nell 'ambie nte pol itico.
Perp lessità s ull'in ves titu r a d e l mini s tro d e lla Guerra, a lla luce del s uo passa to , degli incaric hi assunti dura n te il ve nte nni o fa scista e della s ua fama di reazionari o , s orse ro ben presto anche in Montez emo lo. li 29 dicembre, infatti, comun icò a Brindi s i c he l'op z ione Sorice non s i mo s trava appropr iata in qu a nto non era u n " puro mi litare" e d a va nzò, pe r la p ri ma volta, l' ipotesi Armellini.
Come r ic hi esto da B adogl io, i I co lonnello passò in rasseg na gli a ltri generali rim ast i ne lla capita le per valutarne l ' idoneità aJl ' incarico. TI ca po del fr o nte avvert iva particolarme nte tale re s p o n sa bilità poiché considerava esse nziale o tt e nere dai partiti il riconoscimento di u n capo mil it are c he po tesse e stend ere la propria autorità anche s ulle bande politiche. L a ri cerca, tutt a-
380 lv i, p. 46.
)ij l Ric cardo Mo tta. prefetto a riposo e sena to re , uomo d i fiducia di Badoglio, era stato des ig nato governatore di Rom a il 22 agosto 1943 in sostiru zione del dimbsionario prin ci pe Gian Giacomo Bo rghe~e.

146
via, non diede i ri sulta t i sperati: non conosceva ancora bene Bencivenga e non era in grado, di es prim e re un giud izio al riguardo; nonos tante reit era ti ten ta t ivi, non r iu s cì a rintracciare Sogno e non poté c o sì saggiarne le intenzioni; Caracciolo, seco ndo le notizie r icevute, era sta to arrestato; Ago, infine , fu costretto a rifiutare l ' incarico per mot ivi di salute.
Il governo regio, pertanto, inca lzato da p iù pa1t i, ruppe gli indugi e sospese le inconcludenti trattative in corso da settima ne: il 4 genna io ri so lse di affidare i l Comando militare e civile di Roma e del suo te rritorio, al generale Quir ino Armellini. Q uesti avrebbe diretto e coordinato ogni attività nel periodo d'emergenza e i poteri conferit igli sarebbero stati limitati a l periodo di tempo compreso fra l'e vacuazio ne delle t ruppe tedesche e l'ing resso di que ll e a ll eate. Il controllo mi litare non avrebbe avuto nulla a che fare con la polit ica382
La scelta di Armellini, t uttav ia, non ri s ultò immune da riserve e cr itiche, come ha confermato il generale stesso in una relazione re datta nel l 'agosto del 1944, in cu i s i legge come Montez emolo si fosse s e ntito in serio imbara zzo quando, dopo aver proposto la designazion e d i Sorice prima e di Armellini poi , si avvide di quanto tali personal ità fossero mal tollerate da i part iti 383 In seg ui to alla caduta de l fascismo, infatti, i l generale aveva assunto il comando de l la Mi lizia. Da più parti, tuttavia , gli fu riconosciuto il merito di averla sc iolta prima di essere promosso generale d i Corpo d 'A nnata e nominato pre s idente del Consiglio Super iore delle Forze Armate. I noltre, sin dal 4 novembre 1943 , Armellini aveva preso con tatti col capo del FMCR per essere messo a parte dell ' attivit à s vo lta sino ad allora 384 • Nel messaggio tra smesso da Brin disi in merito a ll a s ua d es ignazione, si dispose, inoltre, che Montez e mo lo sarebbe r imasto capo di stato maggiore di Armellin i. Questi si sarebbe dovuto avvale r e della collaborazion e di Bencivenga, il q uale, due me s i dopo , il 22 marzo 1944, avrebbe ricev uto ufficialmente da l governo de l Sud e dal Comando S u premo i poteri d i Co mandante civi le e m ilitare di Roma.
Ribad e ndo l'apoliticità del FMC R , il di s paccio ammonì a ncora una volta c he le Nazioni Unit e av eva no vietato l'esercizio cli qualsiasi attività po l it ica. Le disposizioni del governo vennero comu n icate ad Armellini in un incontro appo si tame nte organizzato a casa del maggior Cottafavi ed appe na insedia-
382 Gabrio Lombardi , op . cii., pp. 41-51.

383 A.U.S S M E. , /- 3, b.148, f l , "O pera to del gen. S orice in periodo di occupazione nazifascista", Stato Maggiore Gene ral e, Ufficio Patri o ti , al Ministero della Guerra, I Re parto Fronte Clande stin o, 1-9- 1944.
384 A .U.S.S .M.E., 1- 3, b. 148 , f. I, ·'Operato del gen. So ri ce in periodo di occ upa zione nazifasc ista", Stato Maggiore Gen erale. Ufficio Patrioti, al Ministero della Gu erra , I Repa rto Fronte Clandes tino , I -9 - 1944.
Montezemolo
Clandestino
e il Fronte Militare
147
Sa brin aSgueg li a dell a Marra
tos i, t ras mi se il segue nte d is paccio al S ud : " Ri cev uto ogg i di eci vos t ra com un icazio ne ass um o co m an d o".
Negl i s tess i g iorn i, ve n ne no mfo ato u n nuovo governa to re di Roma e M o tta, costretto a sospe nde re le s ue fu nzio ni , si d ic hi a r ò pro nt o, in og ni mo me nto , ad as su m ere nuo vam e nte I' inc a ri co 385
Badogl io, in un a nota s uccess iva, prec isò c he g li All eati, e ntrati a Ro m a, ·'considera ta zona operaz ioni", ne avreb bero avocato i mmediatamente iJ contro ll o assol uto. Tem e ndo c he l'espress ion e "zo na op eraz io ni " p otesse esse re t rav isata , in part icol a r mo do da i pa rt iti , e s usc ita re così eq u ivoci e po le mi c he, il ca po de l governo ritenne op po r tuno da re de luc idaz ion i in me ri to. Inv itò, d u nque, il colo nnello. a spiegare c he, co n ta le definizio ne s' in te ndeva esclusiva me nte affer ma re la pre min e nza d e ll e es igenze mil ita ri fin o alla com pl e ta evac uazio ne de ll e for ze germ a ni c h e e no n ad o mb ra re la po ss ibil ità che, all'in terno della cap ita le o ne ll e i mmediate vicinanze, si verificassero operazioni di guerra ver e e pro pri e386.
Ne l s uo d ia rio , Bo no mi d es c ri sse ta l i svi lupp i no n se n za es prim ere le proprie pe r pless ità:
Co n l 'a n no n uovo è cominciata un'al t ra preocc upazione. C hi governe rà a R o m a ne ll ' inte rvall o fra l' u s cit a d e i tede sc hi e l ' i ngresso d e ll e fo rze a ll eat e?
Il Comita to di Li be razione ha semp re ri tenu to che fosse co m p it o suo ass um ere co i s uoi partigiani il comando della città e d ella reg i one , ma il governo i talian o, i ns ta ll ato nel Mezzogiorno , è di co n t rario avv iso. Esso, sapendo di avere fo rze milit a r i c l and es t i ne i n Ro m a, i n te nde pre nd e re in ma n o qu es te fo rze p er do m inare la c itt à fi n dalle p ri missime ore della s ua l iberaz ion e li gove rn o Badog li o. c he aveva la sc iato in R oma. a ta l fine. il colonne ll o Mont eze mo l o , ha deciso di m etlere tali forze sotto il comando del gen e ra le di Corpo d' Arm a l a Q u ir i no A r m e llin i. Og g i so no s ta to in v it a l o d al co l o nn e llo M o nt eze mo lo - col qua le so no g ià i n rap porto da o ttobre - e da l genera le A r me llini ad un segreto convegno in casa fidata. I due me ss i de l governo Badoglio mi comunicano un fonogramma c he, per il s uo sti le. sembra un ordine militare a cu i si d eve obbed i re se nza disc ute re Il fo no gra mm a co mi nc ia co l d i ffi da re i se i parti t i de l Com it a to di Li beraz io ne di astenersi da ogni a tti v i tà po li tica appe na s ia avvenuto l ' ingresso degli ang loame rica n i in Roma e ciò pe r ord ine tassativo del Comando in capo a ll eato Faccio s u bito nota re ai due messi, che so no perso ne assa i ragio nevo li , l ' inop po rtunità d i co muni ca re ta le tes to a i capi d e i sei pa rti t i. S i susci terebbe su bi to un'op pos i z io ne c h e non si potreb be pi ù s up erare. Dico anche al genera le Armellini che la s ua sce lta susciterà diffidenze nei parti t i di si nistra. Egli, che fu incaricato da B adoglio di assumere ne i famosi
185 Gabrio Lombardi, op. cii pp. 51 -52.
386 Ivi p.57.

148
quarantaci nque g iorn i, il coman d o d elle camicie nere , dovette fare allora un proclama elogiat i vo de ll a Mili z ia. In sosta nza, il proclama era il canto de l cigno della Mi li zia che moriva . Ma s iam o in un ' ora in cui i sospett i s ono v igili e quel proc l ama - de tt ato da opport un i tà momentanee dì cu i i o mi rendo con to - sarà un ostacolo da su p era re . Ai due m ilit ari fac cio un a p roposta che prego d i trasmettere a Badoglio Al momento dell a liberazio ne d i Roma si nomini ca po della M uni c ip alità il gen era le B encivenga , persona che p uò essere de sig nata an c he dal Comitato di Liberaz i o ne e certamente il ge n era le B encivenga potrà collabora re col generale Armellini, che av rà il coma nd o m i litare della piazza 38 7
Il 18 gennaio Bonomi convocò il CLN e decise di riferire le d ispos izio ni del gove rn o reg io in un testo , co me a nnotò, "mol to ... d olc i ficato" 388 , allo sco po d i non comprom ettere l'intesa. La trasformazione del m essaggio originale r isulta p e rspicua: nella vers io ne artatamente ed ulcorata, le in dic azioni con t en ute furono ascritte all a so la vo lo ntà alleat a, non a qu ella d el gove rn o L a proposta des ignazione a capo della Municipalità del generale Bencivenga, persona li tà in po ssesso d ell e necessarie c redenz iali in quanto a ntifascis ta c he aveva pagato di person a, venne approva ta col consenso di tutt i i partiti membri del Comitato di Liberazione il 25 marzo.
Tutt avia, qu a ndo s i pa ssò alla di s cu ss ione su i rapporti che sareb bero intercor si tra l'au tori tà civ il e e quella militare, ovvero Armellin i, i ton i si fe cero acces i ed i contras ti, apparentemente sopi ti, si rivelarono inco nciliabi l i. Dovette ro trascorrere ore pri ma d i pote r deliberare un ordine del giorno in cui si evi tò di affermare che il Comune avrebb e collaborato con l'autorit à militare it aliana e si ricorse ad un a formu la meno impegnativa pe r sco ngiurare l' eve nt ualità di ulteriori scont ri : il Comune, dunqu e, av r eb be "coordinato la propria az io ne'' 389 col generale Arm elli ni.
Nel testo si leggeva c he il CLN, dopo aver suscitato e orga ni zz ato le fo rze popolari per combattere l 'invasore e il suo a ll ea to fascista , avreb be voluto c h e Roma , a l mo me nto d ell'evacuaz ione de ll e truppe nemiche, es primesse, attraverso i propri uomini , la volon tà di riscossa naz io nale . A tal fine , il Comi tato sta bi lì c he il municipio della città sarebbe sta to re tto d a rappresentanti d e i part ili con a capo un uom o di pro vata fede an ti fasc ista che, per quanto atteneva alla salvag ua rdia de ll 'ordine pubb lico e alla riatti vazione dei serviz i ess e nzial i , avrebbe provveduto al coordinamento delle forze militari con t utte le forze popolari impegnate nella ba ttagl ia con tro i t edesc hi.
38 & lvi , pp .1 41-142
389 I vi, p.142 .

Montezemolo e il Fro nte Militare Clandestino
387 Ivanoe B onomi , op. cit ., pp. 140- 141.
149
Sabrina Sgueglja della Marra
Armellini, t uttavia, secon do le p revision i d i Bon om i, non av rebbe mai accettato u na sol uzione che lo avesse posto in su bordine ri s petto al Comune.
La questione di Roma , in realtà, per il capo del C LN cost itu iva s olo appare nteme nte un nodo inestricabile da dipanare con urge nza in vista della ritirata tedesca . A suo giudizio, infatti, gli angloamer icani, dopo aver fatto il loro ingresso nella capitale, si sarebbero curati ben poco deg li equilibri e dei bilanciame nti delineatisi fra le autorità italiane. Non avrebbe avuto alcuna importanza il predominio del Comu ne, emanazione del CLN, o di Arme llini, de sig nato dal governo regio e rappresentante del potere militare.
Bonomi , temendo una s it uazio ne assai più sco nfortante che av rebbe van ificato l'impegno profu so da coloro che si contendevano il controllo di Roma a liberazione avve nu ta, non es itò a preconi zzare che gl i A ll eati avrebbero fatto " il lo ro comodo da padro ni ", come scrisse nel suo di a rio , e avre bbero imp osto perentoriame nte la " propri a legge" 390
Il conferimento dei poteri civili e militari a B encivenga, tuttavia , non fu completame nte scevro di contrasti. Bonomj ha riferito che fu necessaria un'accorta opera di mediazio ne pe r dirimere malintesi ed abbattere leprevenzioni sulla legittimità del C L N che il comandante ricusò a lungo di ricono s cere, giudicandolo u n organo no n rappresentativo dell'antifascismo nella sua interezza391 . Dopo un fitto sca mbi o di messaggi, l ' intesa poté essere d efinitivamente ragg iunta allorc h é, in seg uito all'incidente occorsogl i cadendo per le scale e fratturandosi il femo r e, Bencivenga trovò riparo al La tera no e qui ebbe u n abboccamento chiarificatore con Bonomi392
Il prob lema principale, dalla cui risoluzio ne dipese la tenuta del fronte patr iottico, fu risol vere in una sorta di transito ri o s in cretis mo resistenziale le dicotomiche posizioni circa il futuro assetto is tituzionale: alla fede ltà monarchica professa ta dai militari che ambivano alla conservazio ne, infatti, si contrapponevano le mire dei partiti che aspiravano ad un radicale mutamento dell ' ordine cos t ituito. Le del iberaz ioni del CLN furono ufficiali zza te dal congresso di Bari del 28-29 gen na io 1944, ove i novanta d elegati accorsi, si pronunciarono a favore dell'abdicazione d el re , di un governo espressio ne di t utt e le formazioni pol it ic he antifasciste e della co nvocaz ione di u n 'assemblea costitue nte .
Su tali qu estio ni , evidenteme nte, il co nflitt o appa r ve inconci li abile. L' atteggiamento sovente a mbiguo di B adog li o, inoltre, contribuì ad alimentare la riluttanza dei partiti c he presagivan o oscure m acchin az io ni del governo regio
390 lvan oe Bonomi , op cit., p.142.
391 lvi, p.187-188
392 Ruggero Zangrandi, op. cil., p.812.

15 0
volte a ridurli all ' im potenza nel pe r iodo d'emergenza pe r poi respingerli ai margini della vit a politica al termi ne delle ostilità. Tali sos p etti condizio narono notevo lm en te l'appro ccio delle formazioni politiche nei confro nti del1' agente american o Tompkins che, d u ran te l'occupazione, funse da elemento di raccord o fra i vari gruppi clandestin i. I suoi re iterat i tentativi di sta bili re un con tatto col C L N, infatti, vennero frustrati dalla scarsa prope nsio ne delle Sinistre a co ll aborare, nel conv in c im ento che s i trattas se di una manovra tesa a scavalcarle n el rapporto d iretto co l Comando alleato393 .
Mo ntezemo lo, che Enzo Forcella ha definito "l' esponente più combattivo dei badog l iani e il più ben di sposto verso ìl C L N"394, profuse te mpo ed e nergie in un a tenace opera di conciliaz ione.
Bonomi ha rico rdat o n elle sue memo r ie che il suo pri mo incontro col ca po dell'organizzazio ne mi lita re romana avven ne i l pomeriggio d el 19 ottobre 1943 nell 'abitazio ne di Monsignor P iet ro Barberi ove s i era ri fugiato Casati .
Montezemolo giu nse al co nvegno accompagnato da Cadorna e, in qu ali tà di rap presentante del Coman d o Supremo, invitò l ' espo nente liberale a partec ipare al governo Badoglio prec is ando di aver bisogno al più pres to di una ri s po sta. Bonomi replicò che si sar ebb e costa nteme nte attenut o alle determinazioni dell 'organo che presiedeva, il CLN e che, pertanto, non avre bbe accetta to. Aggiunse altresì di co nsiderare impresc in di bi le la fo rm azione di un ministero co m posto da so li uomini pol itic i a nti fasc i sti, opi na ndo come la lotta armata non dove ss e impli care l ' a utomatico pa ssagg io dei poteri alle a uto1ità mi litari. Argo me ntò tale asserzio ne face n do riferi mento all'esperie nza della prima guerra mondiale: i l gove rn o era stato gu id ato da politici, ovvero Salandra, Boselli ed Orlando e ciò non aveva impedito ai grandi capi militari come Cadorna e D iaz, d i mante nere salda nelle proprie mani la su prema direzione della guerra
Il preside nd e de l CLN, tuttav i a, era profondamente convi nt o che in quel dra mm atico momento, per favorire l'unità d egl i ita lia n i occo rresse accanto na re ogni divergenza e r inviare a tem pi m eno convu l s i il confro nto s u i tem i p iù scotta nti. E g l i giudicava condizione impresc i ndibile al provv isor io superamen to d e ll e con troversie, il solen ne imp eg no a consu lta re il pa ese s ulla for ma istituziona le una volta conclusesi le ostilità, in base a quanto espressamente gara nt ito da ll a comune dichiarazio ne inglese, americana e russa .
Nel progra m ma prospettato d a Badoglio tale imp egno non fu ben chiar i to: si accennò ad un futuro mi n istero ma non alla forma d e llo Stato .
393 Enzo Forcella, op. cit., pp. 181- 182.
394 Ivi, p.183.

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
151
Sabrina Sgueglia della Marra
Bonomi ass ic urò che avrebbe s p eso la sua i nfl u enza per s tron care s u l nascere nocive s pec ul azio ni po l i t ic h e ma pretese che no n venissero ava nzate ip o te s i c ir ca gl i eve nt ua l i mem bri del gabinetto prospe tt ato a l fine di non creare d issi di 395 .
I se i parti ti riu niti nel CLN pur dimostra nd os i favorevo li a coop erare con le altre fo rze di r es istenza per la caccia ta dei tedeschi e l 'abbattimento del redivi vo reg i me fascista, esclusero rec isame nte la possibi lità di una loro p artecip azione al mi ni ste ro Badoglio. Obiettivo dichiarato de l CLN era so stitu irsi a quello c h e veniva d efini to lo " pseu d o-governo del Sud" , ed agire come governo d i fatto, con le funzioni di organo dire ttore ed organizzatore di tutto i l movimento d ì liberazione na z ional e Le posizion i di Badog li o, dunq ue, divennero a nco r più intran s igenti, inas prendo notevolmente i toni del confro nto: egl i ribadì la sua ferma in te nz ione di g uida re il paese s ino a ll a com pl eta liberazio ne di Roma, nel rispetto del vo le re d el r e, per poi rass eg nare le dimiss io ni e ritirarsi a vita priva ta . Vo ll e pu ntua liz zar e, inoltre, di non aver mai richiesto l'a pprovazio ne d el s uo op erato e di assumersi in toto la responsa bili tà delle proprie scelte . Sarebbe spettato alla monarchia, al mo mento app ropriato, il compito di costit uire di un gabinetto di soli uomini poli tici.
11 capo del FMCR, in virtù della co mp leta fiducia acq ui sita pr esso il re ed il Comando Supremo, eccepì che u na nota dai s iffatti contenuti avrebbe avu to il solo effetto di esas perare la s ituazion e . Ravvisando, cli conseg ue nza, l 'opportunità di non co nseg nare il m essagg io a Bono mi, rese nota tale d ecis io ne a Brindi s i, motivandola con la complessità e l'incertezza che dominavano la v it a po liti c a romana. Le propo s te suggerite d al preside nte del C LN , in fatt i, furono in terpre ta te come un ambiguo com promesso fra d estra e s ini stra e p e rciò accolte co n m o lta freddezza.
La coesio ne de ll e formaz io ni po litich e di ed e ev id en ti seg ni d i cedimento, lasciando così s paz io ad ulteriori negoziazioni : le destre, come osservò Montezemolo , si erano avvicinate ai socia li sti ed il Partito d ' Azio ne, isolato d agli a ltri g ruppi , rim a neva att ivo ma se mbra va un partito d i " generali senza solda ti" . Nel dispaccio trasmesso al Sud, il colonnello invitò il re e Badogl io a g iud icare di person a quanto s tava accadendo, a uspica nd o ne il rientro a Ro ma . L'affe rmazione r elativa al Partito d 'Azione si sareb be rive lata quanto mai fondata a riprova dell 'acume politico di M onteze molo s ulla reale rappresen tatività di a lcune formazioni ade re nti al CLN allora molto attive, che non sare bbero so pravv issu te alla prova e lettorale del d opog ue rr a396 •
395 lvano e Bonomi , op c it , pp. 124 - 125
396 Gabrio Lombardi, op cit., pp. 4 3- 44.

152
2. I rapporti coi Carabinieri
I giorni d ella difesa di Roma rappresentano una parentesi infausta per la s toria dei Carabinieri. In seg uit o alla defezione dei capi e aJla confusione genera le che ne conseguì , tra 1'8 e il 12 settembre, il comando dell'Arma di Roma si disgregò e , malgrado singoli episodi di resis tenza, attraversò un breve periodo di disorientamento.
Ne l corso del mese di settembre, tuttavia, ad opera soprattutto di ufficia li di grado infer iore, emerse un movimento di ferma opposizione all'occupante che il Comando germanico e il maresciallo Graziani tentarono di stroncare s ul nascere397
li 1° ottobre , la Repubblica sociale designò Comandante dell'Arma dei Carabinieri il generale Archimede Mischi. Sei giorni dopo, il 7 ottobre, traendo pretesto da una millantata inefficienza morale e materiale del corpo 398 , i tedeschi penetra rono nella sede del Comando generale e in tutte le caserme di Roma al fine di prelevarne i militi e trasferirli al Nord399.
L' ordine del disarmo e del conseguente internamento fu impartito dal maresciallo Grazian i direttamente al generale d ei CC.RR. Mi s chi, alla presenza di Pavolini e di Buffarini Guid i400
Come si apprende dalla r e la z ione del generale di brigata Caruso, il Comandante dell ' Arma "supinamen te obbedì, consuma ndo nella notte del 7 ottobre, la supre ma ignominia" Tuttavia, alcuni ufficiali inferiori appartenenti ai comandi te rritoriali riuscirono ad allertare i militari dislocati nelle caserme e a farli così allontanare prima che gl i edifici ve nissero circondati · dalle truppe germa n iche. La provvida ini ziativa consentì ai tedeschi di catturare solo un terzo della forza allora pre se nte nella cap itale , meno di tremila uomini. Circa seimila carabin ieri riuscirono sfuggire alla cattura disperdendo s i nella città o nelle campagne circostanti 40 t Assai pre z io so fu anche l'io -
J9 7 A.U.S,S .M.E., N.1 -10, Diari 2" Guerra mondiale , b.3022 , f.27, "Relazione sull'attività svolta dall 'orga ni zzazione dei CC.RR. (Ba nda Ca ru so) del Front.e C land est ino di Resistenza dalla s ua cost itu zione all'8 giugno 1944", Fron te Clandestino di Resistenza dei CC.RR. in Ro ma (Banda Caruso), I6-6- I 944.
398 A.C.S ., Ministero della Real Casa Ufficio del Primo a iutant e di campo, Serie sp eciale , b.82, f.44.

399 Renato Perrone Capano , op c ii ., p.298.
4 00 A.C.S ., Ministero della R eal Casa, Ufficio del Primo aiutante di campo, Serie speciale , b.82 , f.44
40 1 A . U.S.S . M.E., N.J-10, Diari 2" Gu erra mondial e, b.3022, f.27 , " Relazione s ull'attivit à svo lta dall ' orga1ùzzaz ione dei CC.RR. (Ba nda Caru so) del Fron te Clandestino di Res isten za dalla sua costituzione all '8 g iugno 1944", Fron te Clandestino di Res istenza dei CC.R R. in Roma (Banda Caruso) , 16-6- 1944.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
153
Sabrin a Sgueglia della Marra
terv e nto del generale Presti: il capo della Poli zia, infatti, pavent ando l'imminente colpo di mano tedesco teso a lasciare la popolazio ne romana alla mercè delle SS, ri levò le st azioni ed i pos ti d i blocco tenuti dai carabinier i e le assegnò, malgrado l'esig ua fo rza di sponi bil e, alla PAI , che provvide ad avve rtire tempestivamente i repa rti dei CC.RR. d ell'incom bente pericolo402
In seguito alJa catt ur a d i mo lti dei suoi militi , l'Arma , ancorché travolta e sove rchiata dalla ferocia na z ista, riuscì a trovare nel prop ri o s e nso di disciplina e nell ' incitamento di n um eros i ufficial i ri masti fede li al dovere e alla divisa, la forza di ricostitu irs i in forma zioni c la nde s tine pro nte a res istere403 .
I carabinieri desiderosi di combattere si po larizzarono gradatamente attorno ad alcun i uffic iali che coadunaro no le fo rze disperse dando ad esse ass is tenza moral e e materiale. Compito prec ipu o c h e l'Arma se ntì di do ver asso l vere ad ogni costo, nonost ant e l'affannosa cacc ia all'uomo di cui erano oggetto i suoi membri, era as s icurare la co ntinuità na zio nale , qualunque fosse stat o il futuro assetto politico-is tituzional e
Il 28 novembre , Montezemo lo, in no m e del governo legittimo dell ' Ita li a, assegnò il comando de l Fronte clandestino dell'Arma al generale Caruso404 che, pur essendo in congedo, " ri s pose con entu s iasmo all'appello della patria" e si mise s pon tan eam e nte a capo di questo vas to movimento, "sfida ndo serename nte i gravi rischi e perico l i che comportava" 405 Suo capo di Stato Maggiore fu designato il maggiore Ugo De Caro li s.
I nu cle i pr eesis tenti formatis i attorno ai capita ni Aversa e Blundo furono pertanto in quadrati in un ' u nica organizzazio n e s uddivisa in due raggruppamenti: un raggruppamento t erri to ri ale che faceva capo a l tenente colonnello Frignani , costit uito per lo più da carabini e ri sbandati appartenenti alle stazioni delJa capitale, e u n raggruppamen to mobile agli ordini del te nente colonnello Bers anetti 406 .
L'inquadramento d ei Carabinieri nel FMCR fu uno dei proble mi più complessi fra quelli cui si dovette far fronte , soprattu tto in quanto il ge nera le Mi s ch i, posto da Mussolini alle dirette dipendenze di Wolff, fu incaricato di
4 oz A C.S. , Ministe ro della Real Casa, Ufficio del Primo aiutante di campo, Serie sp eciale , b.82 , f .44.
403 A.U.S S.M E. , 1- 3, b 149, f.2
404 A . U.S .S .M. E. , N. l - 10, Diari 2" Guerra mondiale , b. 3022, f .27, " Re la zi one sull'attività svo lta dall 'o rga nizzazione de i CC.RR. (Banda Caru so ) d e l Front.e Clandes tino di Resiste nza d alla sua costituzione all ' 8 giugno 1944" , Fron te C la nd est ino d i Re s istenza dei CC.RR. in . Roma (Banda Caruso ), 16-6- 1944.
4o5 A.U .S .S .M.E., 1-3 , b.149 , f.2.
406 Filippo Caruso , L'Arma dei Carabinieri in Roma durante l'occupazione tedes ca . 8 se ttembre 194 3 -4 giugno 1944 , Istituto Poli grafico de llo Stato, Roma, I 949, p.16 .

154
cos tituire reparti eia imp iegare ne lla lotta antip artigian a . Perta nto, dopo la tentata eliminazione deJJ' Anna, a R oma molti u ffic ial i tradiro n o, co n vari espedie nti , i propri uomi ni datis i alla m acc hi a e a ppli cand o g li o rdin i ricevuti d alle autorità na z is te , ce rcaro no di o s taco la rn e con ogni mezzo la fuga per consegnarli ai tedeschi. Ci ò con tri buì alla diffusione di u na profon da di ffidenza de i militi nei confronti dei p ropri superio ri la cui credibi lità, peraltro, era sta ta forteme nte minata d a i tristi avven imenti della di fesa di R oma. Altra di ffico lt à d a s uperare fu l'esigua d ispon ibi lità di fondi c h e non p ermise a li ' Uffi c io di Collegam e nto d i soste ne re a d egu atame nte i carabinieri durant e i nove mesi d ' occupazio ne .
I militi del co rpo, per la magg io r parte, non avevano fa miglia a R o ma e si trovava no nell 'impossi bili tà d i trovare una collocazione nell'ambito dell a vita c ivile . Molti accettarono Je sovvenzioni conces se dai partiti impegnat i ne lla Res iste nza che poterono così a nn overare, tra Je loro fi le , numero si carab inieò407
Inoltre, co me ha affermato Pi sc itelli , dopo lo sgome nto e Jo sco n fo rto d iffusosi ne ll a cittadinanza per l'improvvisa e r epentina scompa rsa d e lla di v isa dell'Arma dall e v ie e d alle piazze romane , i carabinie ri potero no b eneficiare di queJl '"aJon e d i rispetto e di s im pat ia c he fac ilitò la loro partecipaz io ne alla lotta" 408 La so lidari età della popol azio n e romana costitu ì , per usare le parole di P erro ne Capa no, "una delle prime e più va lid e smen tite co ntro ogn i pretesa rappresen tanza d e ll a vo lon tà na z ionale da parte de l fascismo" 409
Il 2 ge nnaio 1944, eludendo Ja rig id a s orveglianza della poli zia germa nica, M o ntezemo lo e Pa c in otti incont rarono B ersanetti , Av ersa e Blundo in casa del commendator Cottafavi . Stud iarono minuziosamente le po ss ibilità ope ra tive d elJ'ap parato r es is tenzi a le e retto dai carabinieri, a ttesero al potenziamento e ali ' inqu a dra me nto dei re par ti, aggiorna ro no i pro getti re la tivi a l pre s idio di determinati o bi ettivi e s tab ilirono Je modalità di preallarm e, alJarme e radu na ta per entr are in azione. Il capi tano Av e rsa fu inc arìca to del rit iro e dell'a mm inistrazione dei fond i. Furo no mante nu te le fo rm azioni in nuclei s uddivi s i in s quadre poi ché le ridotte dim e n sioni d e ll e uni tà di base appariva no le più conve nienti pe r l'esecuz ione de ll e direttive emanate, ovvero la d ife s a dalla polizia ne mi ca, la tras mi ssio ne degli ordin i, la raccolta delle
40 7 A U S.S.M E , / -3 , b.187, f.5, " Re laz ion e cons untiva s ull a att ività success ivamente svo lta dalla Delegazione d el Comando Supremo in Ro m a , dai Co mandi Civili e Mi.li tari della citt.à d i R oma , nel pe ri odo 22 sette mbre 1943 -5 g iu g no 1944; periodo 22 sett.emb re -5 gennaio 1944 (delegaz ione del Comando Supremo), in sostituzione del Colonnello Monteze molo (caduto), il Colonn e llo già vice capo dell 'ufficio di collegamento del Comando Supremo G . Pac in ott i, allo Stato Maggiore Generale , Ufficio Pa trioti , 23 se u embre 1944.
40 8 Enzo Pi sc itelli, op cii., p. I 84.
40 9 Re nato Perro ne Capano op cii., p .297.

Montezemolo e il Fronte Militare Clande sti no
155
Sabri naSgueglia della Marra
not iz ie , l'intercettazione postale, l ' indiv id uazione degli obiett ivi da presidiare, la di stri bu z ione dei sussidi.
Al fine di predisporre al megl io le varie attività del dispositivo costituito e, special mente, i l servizio informazioni, si conferì al fronte d e l! ' Arma un carattere giu ri s di z ionale. Roma fu suddivisa in sei zo ne operative assegna te rispettivamente ad ogni nucleo del raggruppamento territoriale:
- la prima , S. Lorenzo in L ucina, venne affidata al nucleo facente cap o a l tenente Basignani ;
- la seconda comprendeva i l Viminal e e fu attribuita al nucleo guidato dal maresciallo D i Iorio;
-la terza si estendeva n ell ' area di piazza B ologna e venne pre sidiata dal nucleo del te nente Boldoni;
- la q uarta, viale Mazzini , venne difesa dal nucleo del tenen te Fi lip pi;
- la quinta inclu d eva il quartiere di Trastevere e fu posta sotto il controllo e la protezione del nucleo del te ne nte Filippi;
- la ses ta zona, l'Ostiense, fu asseg nata al nucleo del tenente Pas saro. Il raggruppamento mobi le, di contro, non ebbe carattere g iurisdizionale ma par tec ip ò attivamente alla raccolta delle info rm azioni operando a li ' in te rno e all'esterno della città410
Si tentò inoltre d i este ndere il movimento resistenziale anche ai reparti dell ' Arma dell'It alia centro -settentrionale ma l ' ini ziativa s i dove tte scontra re con la prese nza massicc ia, in quelle regio ni , dell e autorità rep ubbl icane Tra dicembre e marzo vennero inviati degli emissari in Piemonte, Tosca n a e Liguria per sagg ia r e il terreno ed e ntrm·e in contatto coi comandi locali qualora se ne fosse p resentat a l' opportunità. L e missioni, malgrado gli sforzi, non sortirono gli es iti sperati 4 11
Allorché ne ll 'aprile del 1944 il FMCR s uddivi se la capita le in tre settori operativi, i repart i dell'Arma adibiti all ' occupazi o ne e al pres idio degl i ob iettivi prefissa ti fu ro no tras ferit i a ll e d ipendenze dei comandanti di setto re e, in seguito, del generale Carauj , po sto a capo del g ru ppo settori. Tu tt e le fo rm azio ni dei carabinieri , in previsione della ri tirata tedesca, ebbe ro ordine di p rese rvare a qual siasi costo la legalità, di provved ere al recupero degli annamenti abbandonati, di agevolare l'ingresso delle truppe alleate e di salvaguardare l'inco lumità della popolazio ne im pedendo rappresaglie e sacchegg i412 .
Le azio ni di sabotaggio , se dall'armisitizio al 7 ottobre si limitarono al boicottaggio delle ord inanze tedesche, con la confluenza nel FMCR, s'intens ifica-
4 1°Filippo Caruso , op cit. , pp.21 -22.

4 11 lvi, pp.54-55 .
4 12 lvi, pp.63 -64.
156
rono ed amp liarono sensibilmente i propri ambiti operativi, mira ndo in particolare a colpire le linee ferroviarie e stradali attraversate da ll e trup pe occupanti e ad interrompere le comunicazio ni tranciando i cavi telefonic i ed elettrici.
I numerosi arresti messi a segno dalle SS alla fine cli gennaio 1944, imposero tuttavia anche alle forze clandestine dei carab in ieri un forte ridimensio namento dell a lotta che, sino alla alla li berazione, fu c ircoscr itta per lo più ad azioni di antisabotagg io attraverso il presidio di edifici pubblici, case rme, ministe ri , uffic i e stabilimenti, al fine di preservarli da eve ntu ali devastazioni e razzie.
Un'att ività svolta d al corpo che si rivelò assai valida, benché delicati ssima , fu la sottrazione dagli uffici addett i alla ce nsura, di lettere co m promette nti e di denunce ano ni me sporte contro patrio ti 4 13 . I Carabinieri de l fr onte dell'A rma , infatti, ricorre ndo a m piamente al sist ema della corruz ione e , quando falliva, alla fals i ficazione, ri usc iro no ad introdurre u na pa rte del loro per sonal e, accuratame nte selezio n ata, presso il Comando de lla città aperta, la Que st ura, i Commissariati di Pubbl ica Sicure zza, la Federazio ne fascis t a d el1'Urbe , il Governatorato, l ' Annona, l'Ufficio anagrafe, l ' Eiar e, persino, in alcuni Comandi tedesc hi e in l uoghi che e ra not o pu ll ulassero d i spie4 14 •
A tutti i capi- nuc leo fu altr esì ordinato d i far ric e rcare dai loro dipe nde nti i prigionieri degl i eserc iti alleati e di da r loro ass istenza per protegg e r l i dalle polizie nemic h e 41 5 .
Concors e alacremen te alla lotta co ntro i na zifas cisti il "Battaglione CC.RR. H azo n", così denominat o in ricordo del comandante Azolino H azon , caduto d urante il bombardamento d i R oma de l l 9 luglio 194 3 . D opo il 7 ottobre, il b ri gad ie r e Noto ed il vicebrigadiere Carbone si prodigarono per rinc uorare e da re sostegno morale a i compagn i che, "na useat i dall'indegno comportamento di alcuni dei lo ro uffic iali", avevano vist o crollar e in poche ore le pi ù radicate idealità de ll a loro vita di soldati. Al nucleo in iziale, for te di d uecentosedici uomini, si agg iunsero progressivamente numero si ufficiali , s ottufficiali e soldati de i carabin ie r i e delle altre armi. Nel febbraio 1944, il R eparto poteva conta re su settecen toquarantotto mi li ta ri c he, su ddivisi in s q uad r e mobili, svo lsero pr in c ipalmente attività informativa e di sabo taggio ai danni delle fo rze a r mate tedesche. S u bit o dopo la liberazione della capital e, all'atto dello sc ioglimento del battag li one , in ma ncanza di riconoscimenti sostanziali,
413 Fi lippo Caruso, op. ciT , pp 28-32
4 14 A . U.S.S.M.E., N.J-10, Diari storici 2" Gu erra mondiale , b.3022, f .27, "Re la z io ne sull ' attività s volta dall 'o rganizzazione dei CC.RR . (Banda Ca ru so) del Fronte Clandes t ino di Res istenza da lla sua costituzione all'8 gi ugno L944", Fronte Clandesti no d i Resistenza dei
C C .RR. in Ro ma (Banda Caru so), 16-6 - 1944.
4 15 Filippo Caruso, op. c it p .32

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
157
Sabrina Sgueglia della Marra
ogni membro ric evette u n tesserino c he attestava l ' appartenenza alla for mazione m ilitare, in rico rdo dell'opera prestata al servizio della patria.
Noto e Car bo n e, animator i e fondatori del R eparto, furono arrestati e barbaramente torturati e, i l 4 giugno, ve nnero liberati 416 .
In tutte le s ue articolazioni, dun que, il co mplesso disposit ivo resistenziale dei carabinieri, c ui i capi vollero co nfe rire caratte re di assoluta apolitic ità, rappresentò pe r il FMCR un vero e proprio centro di mo bilitazione sul qua le il colo n nello poté fare affidamento sopratt utto per qu a nto atteneva a ll a tutela dell'ordine pu bblico, poiché riteneva il corpo una delle forze che m aggiormente avrebbero potuto contribuire al mante nimento della pace sociale .
Secondo la test im o ni anza del gen erale Ar mell in i, i partiti politic i guardarono inizialmente con sospetto e malcelata apprensione a tale collaboraz ione417. M ontezemo lo, tuttavia, riu scì a di ss ipare rap id ament e ogni ti more sulle finalità del rapporto instauratosi tra le due organ izzazioni mil itari dimostrand o coi fatti di non avere preferenze né preg iu diz i e di mirare so lamente al coinvolgi mento, nella lotta, di chiunque vi avesse vo lu to partec ip are.
Pe r Caruso , Montezemolo rappres e ntò il fulcro d e ll 'intero movimento per la lotta ai ted eschi : "egli - ha sot tolineato il generale - alla rara per iz ia profess io nale univa u n 'ani ma nobi li ss ima, una su pe r io r e intelligenza, u n tratto cortesissi mo, non disgiunto da una fe rm ezza di carattere c he isp irava fiducia illi mi tata in tutti coloro che l'avvicinava no"418 .
Caruso ven ne arres t ato il 24 maggio 1944 mentre era in te nto a prendere accordi co l generale Caratti. Trad otto a Regina Coeli, fu poi trasferito a l carcere di via Tasso e con d an nato all'esecuzio ne capitale. TI mattino del 4 giugno r iuscì miraco losamente a salvarsi . De Carolis, a l contra ri o, non poté sfuggire alla brutalità tedesca e fu inclu so tra le vittime del massacro delle Fosse Ardeat ine , ins ieme ai te nent i colonnelli Fri gna ni e Talamo, al capitano Aversa, ai te nenti Ro d riguez Pereira e F o nt ana, ai brigadieri Manca e Sergi, ai carabinieri Foti e R onzini, a pp a rtenen ti alla legion e territo ri ale di R oma.
3. I rapporti con la Guardia di Finanza
L a Guardia di Finanza, con una forza complessiva che al momento del1' arm istizio non s uperava le 23 .000 unità419 , durante l ' occupazione visse
4 16 A U.S.S.M E ., N.1 -1 0, Diari s toric i 2° Guerra mondiale , b.3022 , f.34.
4 17 I vi , p.32 -33.
4 18 Filippo Caruso, op. cii., p 45.
4 19 Giuliano Oliva, La Guardia d i Finanza nella Resistenza e per la Libera zione, Comando Generale della Guardia d i Finanza, Roma, 1985 , p.97.

158
una vice nda a lquanto s in go lare se co nfro nta ta con quella d e ll e altre fo r ze di pol i zi a Il Corp o, per lo più di tend e nza antitedes ca ed antifasci s ta, malgrado la conti nua minacc ia di sciogl imento , riuscì a sopravviver e , a m a n tenere pressoché intatta la propria organi zzaz ione e a dispo rre di notevole a uto no mia. Le ragioni di questa partic ola re s itua zione so no asc rivib ili alla co nnota z ione emi ne nte mente tecnica che 1e Fiamme gialle si s for zar o no di co nferire alla loro att ività, a ll e faglie poli ti co-amministrative d ella Rep ubbl ic a Sociale e, sop rattutto , alla recisa opposizione di Maeltzer all a prospe ttiva di un trasferimento di r epa rti al no rd . Il generale, infatti, per dispe nsare le truppe tedesche da un eccessivo impiego ne l controllo dell 'area urbana , riteneva indispensabil e il concorso dei finan z ieri a l mantenime nto dell'ordine pubblico. 420
L' 8 se tte mbre, malgrado l'assenza di ordin i precis i , c irca tremila mi liti rimasero a Roma e moltep lici furono gli episodi di re s istenza all ' aggressione germanica. In seguito aB' in sta urazione della città ape rta, il comando delle forze di po lizi a venne assegnato al te nen te generale Riccardo Maraffa, d ella PAI , e passò a fa r parte di esse anche la Gu a rdia di Fin a nza 421 .
Le Fiamme gialle potevano contare a Roma s u una fo r za di 120 uffici ali , 600 sott u fficia l i, 1752 uomini di truppa con un perfetto a rmam ento indiv id uale, di 22 fuc ili mitragliatori , 9 mortai d 'assalto, 200 casse di bomb e a mano e di un a mpio autoparco Co nt i nuarono a presi diare g l i enti istituziona li co me il Ministero d e lle Fin a nze, il Po ligra fico , la Zecca. Furono costit uiti corp i di guardia negli sc ali ferrovia ri Tu sco lano, Tiburtino, Ost iense , Casilino e Prenes tino ed in altri edifici pubblici di notevole rilevanza. Si approntarono diec i compagnie, ciascuna compos ta da se ttanta uorninj , ad ibite all a preservaz io ne d e ll a pubb l ica si curez za e tenute semp re pron te ad intervenire contro i tedeschi per gara ntire la ma ssi ma tempestiv ità allorq ua ndo si fos s e reso n ecessario il loro impiego. In seguito alle d i mi ss ioni del genera le Aymon in o che, dopo il 23 sette mbre aveva chiesto ed ottenuto di essere conge dato, il governo repubblic ano de s ignò il generale di divisione Poli comandante del Corpo422
Il ge n erale Filippo Cri mi , non in se r v iz io perc hé in missione a Roma p e r l 'esame d 'ammiss ione alla Regia accademia, prese co ntatto col FMCR e col CLN. Ne l me s e di ottobre , radunato un folto grup po di finanzi eri,
420 Pierpaolo Meccariello , La Guardia di Finanza nella Seconda Guerra mondiale. 19401945, Mu seo storico della Guardia di F in anza, Rom a , 1992, pp.42 5 , 436-437 .

42 1 A. U .S.S.M .E., N. / - /0 , Diari storici 2" Guerra mondiale, b.3022 , f.28, ;<Contribu to al Pro nte Clandes tino della Resi s tenza della Banda Fiamme G ialle".
422 Fili ppo Crimi , Lu ce di Fiamme gialle Le Fiamme gialle durante il /errore n azifascis 1a a R oma, Ist ituto Po li grafico dello Stato, Roma , 1945 , pp.2-3 .
Montezemolo
Clandestino
e il Fronte Militare
159
Sabrin a Sgueglia della Marra
assunse la d ìrezìone dell'organizzazione clandest ina de ll a Guardìa dì Finanza ìnquadrando tu tti i r e parti e i nuclei di pe nden t ì
M onteze m olo e B auer incon t rarono Crimi a casa del capì ta no Argenziano e il co lon nello fu entusiasta n e l co nstatare c he anche i finanzìerì era no ansìosi di con fl uire nel fronte patriottico come già ì carabinì eri . M olti mil iti, allo scopo di sottrarsi ai bandi e ag li ordinì ge rm a n ic i , si di e d ero a ll a macchia me ntre quelli rimasti a pre s tare serv ìzio ne ll a capitale, per la maggior parte, n on si piegarono supinamente alla dominaz ione nazifascista ma si adoperarono con ogni mezzo pe r difendere la c ittadinanza d alle vessazioni e dagli arbitr i dell 'occupante423 •
Ne ll e nume rose riunioni c h e si susseguirono, furono defi nite le m oda lità operati ve d a adottare in str etto coord in ament o con apparato cla ndes tìn o del-
1' Arma: la Guardia di Finan za s i sare b be tenut a pronta ad attaccare i tedesc hi non appena ricev u to l'ordin e relativo dal capo del Fronte e , po ic hé s i pave ntava il disarmo e l ' internamento del Corpo, come avvenuto nell'ottob re prece d ente a ì carabinieri, si stabilì che i finanzieri sposa tì s i nasco ndessero in città con armi e mu ni zio ni , in attesa de l seg na le d i adunata, gli altri si sa re bbero asserragliati s ul M o nt e S .Angelo e s ul M o nt e S.Gen naro , nella zona Ti burtina, nei pres si della case rm a XXI aprile e ai posti d i blocco istituiti dal comando tedesco per osse rvar e i movimenti di uomini e materiali. Tal i presidi, al c ui comando sar e bb ero stati collocati so ttufficiali di provata fiducia , av reb bero atteso a ll e operazioni di afflusso e d eflusso d ei patrioti agevo landone gli spos ta m e ntì. Le Fiamme gialle distribuirono pertanto una carta t o pografica ov'erano indicati tutti i posti cli blocco esiste n ti attorno a Roma, comp resi quelli tenuti dalla PS e dalla PAI424
L e bande interne ed es t erne del FMCR e , soprattu tto i l R aggruppamento " Gran Sasso", potero no contare s u un regolare cospicuo rifornimento di viveri e generi di prima necessi tà , d i a rmi e di munizìoni , effett u ato tramite autocarri d ella G uardi a di Finanza che, al contempo, fo rn iva coper tura e protezio ne ag li ese rce n ti c he, anima ti da senti m enti pa triottic i, d avano il loro contrìbu to425
42 3 A.U. S .S.M E., N.J - 10, Diari 2n Gu erra mondiale , b 3022, f.28 , "Con tributo al Fronte Cla ndestin o della Resistenza della Banda Fiamme Gialle" ; Filippo Crimi, op cit , p.3.

424 Filippo C rimi , op. ci t., p. 3 ; Giu liano Oli va, op. cit ., p.l 18.
425 A.U.S.S.M.E. , J-3, b. 187, f .5 , " Relazione consuntiva sulla attività s uccess ivamente svolta dalla Delega zione de l Comando Supremo in Roma, dai Comandi Civili e Militari de ll a c illà di Roma, ne l pe riodo 22 settembre 1943-5 giugno I 944; pe riodo 22 se ttembre -5 gennaio 1944 (delegazione del Coma ndo Supremo), in sost itu z ione del Co lon nello Monte ze molo (caduto), il Colonnello g ià vice capo de ll'ufficio di co llegam ento del Comando S upre mo G. Pacinotti , allo Stato Maggiore Gene rale , Uffic io Pat ri oti, 23 seuembre I 944
160
Tu tto il materiale raccolto ne ll e città e nelle campagne vicine ven iva depositato nella caserma XX I apri le e da qui traspo rta to d i notte in locali prestabi liti , come una r imessa nei press i di piazza Bolog na o le tipografie del dott . Bon te mpi, pe r poi essere consegnate alle ban d e42 6
Un gru ppo di finanzieri, ad esempio, riuscì a recu p erare tutte le armi a bba ndo nate in segu ito al ra st re ll amento de l 7 ottobre nella case rm a dei carabini eri d ello Scalo San Lorenzo e provvide a dis tribuir le ai partigiani427 • Spesso i n orma li co m pi ti dì polizia che spettavano al Corpo non veniva no assolti. Nella compi laz ione dei rapporti giornalieri, le pattug lie des tina te all'osservan z a del coprifuoco r eg is travano qu asi esclusivamente le manovre ed i movimenti nemici n el territorio u rbano, indicando le notizie di maggio r intere sse strateg ico e segnala nd o le infrazioni co mm esse da tedeschi e gerarchi del partito fascista repubblica no . I posti di blocco retti dai finanzieri, contravve nendo agli ordini uffic iali, si attene van o alle istruzioni riservat e trasmesse d a l comandante dell ' organizzazione cland estina a nche q ua n do collidevano palesemente co n essi, ricusandos i d' intralc iare l' afflusso di viveri nella ca pi ta le . Fin o al 4 gi ugno , le perquisizioni per so nali e domiciliari e i rastrellamenti di mi litari di s ertori assegna te aJl e Fiamme g ialle non vennero eseguite o di edero e sito negativo428
On erosa ed assa i profi c ua risultò anche l'attività di sabotagg io economico e quella svo lta nel ca m po assis ten ziale. Roma fu una delle città italiane in c ui si soffrì maggio rm en te la fame. Si t rattava per lo più di un probl e ma di t rasporti: se, fino al gen naio 1944, i viveri gi un gevano ancora attraverso le fe rrovie, in seguito allo sbarco di Anzio e a ll' inten sificarsi deg li attacchi ae rei, si ricorse agli autocarri. L o stesso Co mando del Servi z io di Sicure zza germa ni co, ne l febbraio , d efi nì catastrofica la s ituazione alimentare di Roma429
Con l'ap p ross im arsi del fron t e, il razio na me nto del pane s ubì u n ' ulteriore riduzione e la c itta d in a nza fu quasi completamente p ri vata del b as il a r e alimento. Si prosp ettò, dunq ue, l'inde roga bile urgenza d i fa b bricare carte a nn onarie false, una compli ca ta e rischio sa o pe razione di cui s i occuparono il capo dell ' Ufficio Stampa del Centro X , Basevi, e il capitano Argenziano. Il prog etto d i un co lpo di mano alle cart ie r e d i Fab ri a no dovette essere immediatamente accantona to poiché la str etta so r veg lianz a tedesca avrebbe lasciato
41 6 Filip po Crimi, op cit., p.4.

427 Giu liano Oliva, op. c ii , p. 11 6.
428 A . U.S.S .M.E., N.1-10, Diari storici 2" Gu e rra mondiale, b.3022 , f.28, "Contr ibuto al
F ronte Clandesti110 della Resistenza della Banda F iamme G ialle"
429 Lutz Klinkh a mm er, op. cit., pp.190 - 193
Mo ntezemolo e il Fronte Militare Clandestino
161
Sabrina Sgueglia della Marra
all ' impre sa ben poche possibilità di s uccesso Pertanto, con la complicità dei finanzieri che presi diavano il Poligrafico dello Stato , in via Ve rdi , vennero sottratti numerosi pacchi di carta fili granata ivi depos itata, c he se rvì a s tampare centinaia di migliaia d i carte annonarie . A metà dicembre , una nott e, verso le due, un autofurgone in servizio s i fermò davanti ad un ingresso secondario del vasto edificio. Basevi e d al tri quattro uomin i varcarono la porta la sc iata aperta da Argenziano , mentre i finan z ieri di guardia fingevano di non accorge rs i dello s trano movimento e controllavano le operazioni pronti a dare avviso di eventuali pericoli. L'autofurgone , caricato di pesanti pacchi di carta filigranata, al posto d e i quali venn e ro lascia ti pacchi identici ma p ie ni di cartacci a, si allo ntanò velocemente ed andò a depositare al s icuro il prezioso bottino L a tipografia De Sanctis s tampò rapidamente le tesse re e ben presto, mezzo mi li one di carte annonarie per il pane ed altri generi alimentari di pri ma necess ità, perfettamente riprodotte , entrarono in circolazione a Roma e in provinc ia grazie al traspo110 e alla capillare distribuzione cui provvidero gli uomini delle Fiamme gialle coordinati dal capitano Argenziano.

Tedeschi e fascisti notar ono b en presto le irregolarità che presentava il se rvizio dei razionamenti. Denunciarono più vo lte , anc he alla radio, il grave "attentato all' e conomia dello stato" , minacciando di morte i re sponsabili ed allettando con laute ricomp ense chiunque avesse agevolato 1e indagini , ma ogn i tentativo di venire a capo delle anomali e ris contrate s i rivelò inefficace43 0
L'organi zzazio ne clandestina della Guar dia di Finan z a creò anche un servizio informativo a ss ai e fficiente la cui struttura era imperniata su un "sistema a cellule" volto a neutrali zzare il nem ico eludendone la sorveglianza Tal e d e licata attività venne svolta sia nel campo militare che in quello politico e fu effettuata attraver so ricognitori isolati c he si spingevano fino alle prime linee di combattimento43 1 , con se ntendo agli ufficiali e ai sottufficial i di segnalare tempestivamente al Comando de lla Leg io ne Allievi noti zie rela tive aUe op e razioni nemiche , come il passaggio di autocolonne , trupp e, carri armati . Ogni giorno l e informazioni venivano raccol te dal capitano· Argen-
430 Enzo Pi sci telli , op ci t., pp 3 15-3 16; Carlo Trabu cco , op. c it , pp. 157- I 58; Arm a ndo Trois io , op. c ii . , pp . 192- 195.
43 1 A.U.S.S.M E , 1-3, b. 187, f.5 , " Relaz ione con s unti va sulla atti vi tà s uccess ivamente svo lta dalla D elegaz ione del Comando Supremo in Roma , dai Comandi C ivi li e Militari della c ittà di Roma , ne l periodo 22 settembre l 943-5 giug no 1944 : per iod o 22 sette mbre-5 ge nnaio 1944 (de legaz ione de l C omando Sup re mo), in sostituzion e del Colonn e ll o Monteze molo (c adutq), il C o lonnell o g ià vice capo dell ' ufficio di collegamento del Comando Supremo G. Paci notti , allo Stato Ma ggiore Gen e rale , U fficio Patrioti, 23 settembre 1944; A .U.S.S .M.E. , N. / - 10 , Diari st ori ci 2° Gu e rra mo ndiale, b.3022, f.28, · ' Contributo al Fronte Clandest ino di Resist e riza d e lla Band a Fiamm e Giall e"; Filippo Crim i, op.cii p.3.
162
ziano e messe a d is posiz ione del FM C R432 che provvedeva a tras metterle al Co mando alleato per indi care all'aviazio ne ang loamerican a gli ob iettivi tattic i da abbattere. Il servizio infonn at ivo venne perfezio na to in due riun io ni a casa d i Cottafavi alle quali partec ip aro no Mon teze molo , De Mich eli s, Fe nulli , Pacinotti, De Santis e Aver sa 433 .
Allorc hé Poli fu collocato in con gedo, le au t orità repu b bl icane des igna rono C ri mi comandante generale de l Co rpo ne ll 'amb ito della città a p erta. E gli accettò il nuovo incari co dopo aver consultato e pre so gli ordini r elativi dall'Ufficio di Collegame nto, es pressosi favorevolmente confid and o nelle ampie prospettive di lotta che, con un ruolo così ri leva nte ricope rto dalle Fiamme gialle, si sarebbero offert e al movimento resis tenziaie434
L'organizzazio ne clandes t ina della Guardia d i Finanza s i andò così d elineando:

- u n nucleo operante con le ba nde esterne dell'Italia centrale dipendenti dal colonnello De Mi c h elis, al comando del t enente Patriz i;
- il I O cen tro raccolta notizie co man dato dal tenente colonnello Li o nti, c he faceva capo al tenente co lon nello Simonetti t ramite il capitano Furbini;
- il 2 ° ce ntro raccolta noti z ie ag li o rdini del maggiore Tani;
-u n cent ro rifornimento armi e muni zioni, viveri, equip agg iamento, materiale sanitario, retto dal tenente Pa rl ante e dipendente dal co lonnello De Micheli s;
-un centro di con trospionaggio co m andato dal tenente De Laurentis, dipendente dal co lonnello Pacinotti e da Bauer a ttraverso il capitano Argenziano;
- un centro tras porti e co ll egamenti con le bande esterne guidat o dal tenente M el zani;
- un centro di osservazio ne eco no mi co e in dustriale presso il Comando tedesco;
- un n ucleo di collegamento con le a lt re Forze di Po liz ia: la PAJ , tra mite il te ne nt e Festa e la PS tramite i l com mi ssa ri o Midolo.
432 Giuliano Oliva , op ci t., p 118.
433 Fil ippo Crimi , op.cit. , p.3 .
434 A.U .S.S.M.E. , 1- 3, b. 187 , f.5 , " Relaz ione consun ti va s ulla allività success iva me nte svolta da lla Delegazione del Comando Supremo in Rom a, da i Comandi Civili e Militari della città di Roma , nel periodo 22 senembre ·1943.5 g iu gno 1944; periodo 22 s ettembre- 5 ge n na io 1944 (delegazione del Co mando Supremo), in sos titu zione del Colonnello Montezemolo (cadut.0) , i l Colo nn e ll o già vice capo deJl' u fficio di collegamento del Comando Supremo G. Pacinotti , allo Stato Maggiore Generale, Uffic io Patrioti, 23 settemb re 1944; A.U.S .S .M.E., N.1-10, Diari 2a Gu e rra mondiale , b.3022, f 28 , ·'Contributo al Fronte Clandestino della Res istenza della Banda Fia mme Gialle".
Mo ntezemo lo e il Fron te Militare Cland est ino
163
Sabri na Sgueglia della Marra
E lemento di collegame nt o col FMCR fu il capitano Marinelli, i ns iem e aJ capita no Furbini ; col CLN, principalmente col Partit o d'A zio ne, il tenente Maconì o e il tene nte De Lauren ti is 435 .
Secondo quanto ha affermato ìl co lonnello Pacinotti , tuttavia, ìl FMCR entrò ìn co ntatto a n c he con la PS attraverso il genera le Fantoni , e con la PAI, tramite il co lo nne llo Toscano, ma senza addivenire ad una reale cooperazìone436.
La PAI rifornì di armi , munizioni , au tomezzi , materiale rad io e viver ì alcuni esp o nenti del C L N e del Cen tro X e dette assistenza e ri covero a tuttì co loro che e ra no soggetti aì bandì Graziani Malgrado g li ordìni pere ntori del Ministero d eglì Interni , fermo fu il rifiuto dì partecipare alle retate e a ll e pa ttuglie mi ste a d ibite all'arresto dei renitenti alla leva e al lavoro obbliga to rio ; quanto a ll e esec uzioni capitali, sembra c he la PAI , nell' i mpossibilità di sottrarsi a i turni imposti dalle autorità fasc iste che comprendevano anche la Fi nanza e la Pubblica Sicurezza, fu obbligata a prendervi parte ma ìn non più di tre occasioni 437 .
A riprova della fid ucia riposta anche d agli a nglo america n i neg l i uomin i delle Fiamme g ìalle, nel gen naio 1944, il tenen te Pollock della Po li zia alleata presso il qua1ti er generale della V Armata a Caserta, ordinò al Co mando S u periore della Guardia di Finanza l'approntame nt o di un battagl io ne speciale dì novecen tottanta militari del corpo da ìrnpìegare nel serv izio d i pu b blica s icurezza a R o ma. Pollock precisò che la forza da predispo rre, inquadrata in quattro compagnie, si sare bbe dovuta costit uire a Ruti gliano, ìn provincia dì Bari , e avrebbe dovuto dislocarsi a Napolì per attendere al controllo e alla so rv egl ia nza delle operaz ion i d'imbarco d e i viveri dìrettì alla capitale; a ll a scorta delle imbarca z ion i destinate a tale trasporto ; alla v igi lanza a Roma deì depos iti di generi al im e ntari , soprattutto dì grano; all'accer tamento della di stri buz ione dei viverì alla popolazion e; al presidio dì ba nche, istitu ti di c r edito e , col
435 A.U.S.S.M E ., N / - 10, Diari storici 2" Gu erra mondiale, b.3022, f.28, "Contributo al Fronte Clande stino della Resistenza della Banda Fia mm e Gialle " ; Giuliano Oliva, op. cit , pp . 118- 119 .
436 A.U.S S M E., J-3 , b.187 , f.5, " R elaz ione consun t iva su ll a attiv it à s uccessivamente svo lta dalla D elegaz ione del Comando Supremo in Roma , dai Comandi Civili e Mi l itari della città di Rom a, nel periodo 22 se ttembre 1943-5 g iu gno 1944: periodo 22 se ttembre5 gen nai o 1944 (de legazione del Comando Supremo) , in sos tituzione del Colonnello Montezemo lo (cadu t o), il Colon nell o già vice c apo dell ' ufficio di collega me nto dy l Co mando Supremo G. Pacinotti, allo Stato Maggiore Generale , Ufficio Patrioti, 23 settembre 1944
437 A.C.S., Ministero della Real Casa, Ufficio del Primo aiutante di camp o, Serie s pe c iale , b.82, f.44

164
concorso della polizia alleata , della Zecca; al controllo dei mercati per la repress io ne della vend ita clandestina a prezzi magg iorati 438
Ben du ecen tos essa ntas ei furono gli ufficiali , i sottuffic ia li e i fi na nzieri che vennero riconosciuti partigiani o patrioti. In virtù del loro ge ne ro so contributo alla Resistenza romana, il generale Crimi, il capitano Argenziano e il te ne nte Spaccamonti furono p romossi al grado superiore per merito di g uerra439
Copiose furono le testimoni anze che riconobbero l'apporto d elle Fiamme gialle alla causa patriottica. Ass ai s ignificativa è la lettera che Riccardo Bauer inviò al ge nera le Oliva in occasione della cerimo ni a tenutasi a Milano il 25 apri le 1982 per celebrare la partecipazione de lla Guardia di Finan za alla Resistenza e alla lib erazio ne del capoluogo lombardo:

Arroccata la Guardia di Finanza, nella sede XXI Aprile, resis te tte impavida agli ordin i, agli inviti e alle minacce del Comando tede sco , decisa a difendersi con le anni quando da qu esto fosse tentato un atto di forza. E non tardò a prendere contatto co l comando clande s ti no so rto in città in vista di un'azi o ne liberatrice che non poteva mancare.
Vi ss i personalmente qu el contatto pel tramite di un giovani ss im o te nente, Augusto De L aurentis. Ch e cosa significasse a Roma quel forte nucleo armato e risoluto a non fars i sove rchiare a ne ss un costo dalla Wehermacht an co ra al potere nella città, è supe rfluo dire. Tanto che il comando tedesco mai dimise l' idea di una vio lenta sorpresa sopraffattrice di quel centro che poteva da un momento all ' al tro, quando le operazio ni militari generali lo impones sero, operare in mo do de terminante contro la guarnig ione nemica. E quando si seppe, ne l maggio 1944, che il comando tedesco e ra in proc into di tentare l 'assalto alla XXI April e, assediata ma ferma nel proposito di difend e rsi si no all'ultima cartuccia e a non ced ere le armi, mi occupai di mobilitare le nostre forze clandestine pe rché all e spalle dei tedeschi , tendenti alla distruzione di quel fortilizio, s i muov esse un non me no deci so attacco popolare che li piegasse co stringendoli a des is tere dall'intento440
4. I rapporti con la Marina e l'Aeronautica
Le vicend e della Marina e dell'Aeronautica non co nsen ti vano previsioni circa il comportamento che avreb bero tenuto dopo 1'8 sette mb re .
A.U.S.S.M.E. , N. l - 1/ , Diari sto rici 2" Guerra mondiale, b.306 1, allegato n.645 , " Predis pos izione di un battaglion e spec iale per il servizio di poli z ia in Roma", Mini ste ro delle Finanze , Comando Superiore della R.Guardia di Finanza al Comando Supre mo , 19- 1-1 944.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
438
165
4 39 Alfonso Bartolin i-A lfredo Terron e, op. ci t., p. 46. 44 0 Giuliano Oliva, op. c ir., p.379-381.
Sabrina Sgueglia della Marra
L a M a rin a risultava sic uramente pi ù a utonoma e m eno compromessa co l fascismo: in segu ito all'annuncio d ell'armi stizio, rispondendo all'ap pe ll o all'ubbidienza e alla fedeltà lanciato dal mini st ro De Courten, tutte le uni tà in condizioni di m uove rs i441 , conformemente alle clauso le previste e alle disposizioni del governo, pr esero il m are al comando dell ' ammi rag li o B e rgamin i e, raggiu nti i po1ti presid iat i dag li angloamericani, iniziarono imm ediatame nte a co llaborare con ess i. Le altre navi , per imped ire che cadessero in mano nemi ca, ven n ero affondate n ella quasi totalità.
Appartengono a ll a Ma ri na i pri mi caduti italiani vitt im e di u na sp ietata azio ne b e llica te d esca : i milleduecento marinai imba rcati sulla nave ammiragl ia " R oma" 442 rappresentano emblematicamente l'apporto c h e questa forza a rm ata tr ibu tò al movimento di resistenza .
F urono messe a disposizione delle Nazion i Uni te tutt i i porti, gli arsenali, le officine e le opere di difesa cos tiera e co ntraerea . Tuttavia, l 'asso luta d ipe ndenza dagli Alleat i stabili ta da lle clausole d'ar mistizio, come ad esemp io la proibizio ne agli eq uip agg i ita lia ni d i scendere a tetTa nei porti del Nord Afr ica francese frappose gravos i ostacoli all a libe rtà d'azione della nostra Ma ri na443 .
L'Ae ro na utica, p oiché conseguì il suo massimo svilu ppo negli a nn i compresi tra le d ue gue rre mondia li , costi tuiva senza dubbio l'arma maggiormente all in eata col passato reg i me, ma il legame co l fascismo, a ncorché ri nsaldato da ev id enti interess i corporat ivi, nulla poté contro il richiamo patriottico.
A metà settem bre del 1943, era ancora in piedi l'organ izzaz io ne territoriale della Pug lia e della Sardeg na mentre era co mp letamente scomparsa in Sicilia, Calabria e Campania. I problemi che si posero all'ordine del giorno per concorrere attivamente alla g uerra di liberazio ne furono la ricostit uzio ne deg li organi d irett ivi, il rio rdiname nto dei reparti, l'approntamento e il recupero degli appar ecchi dan negg iati 444
44 1 Dalla relazione del capo di Stato Maggiore generale Messe al capo del Governo del 24 aprile 1944 (A.U .S .S.M.E., N.1 - 11. Diari storici 2° Gu e rra mondia le , b.3070 , allegato n.738) , risulta la seguente con s iste nza delle unità nava li : c inque corazzate, nove in croc iatori; undici cacciatorpediniere; quaranta torpedini e re e corve u e ; trentase ue sommerg ibili ; trenta M.A.S. e motosi luranti; naviglio ausiliario e minore .
442 Renato Pen-one Capano, op. cit., p.88 .

443 A.U.S.S .M. E. , N. l-11 , Diari storici 2" Guerra mondiale, b.3070 , allegato n.73 8, "Re lazio ne", Comando Supremo, Ufficio Operazioni, il capo di Stato Maggiore Ge ne ra le Mes se al capo del Governo, del 24-4 -1 944.
4 44 A.U.S.S M.E., N.1 -11, Diari s loric i 2° Guerra mondiale , b 3070, allegato n.738 , "Re lazione" , Co ma ndo Sup remo , Ufficio Ope raz ioni , il capo d i Stato Magg iore Generale Mes se al ca po del Governo, de l 24-4 - 1944. L' Aeronautica disponeva a metà settembre di centoquindici velivoli del Raggruppamento Caccia e A ssalto; novanta per bombardamento e trasport i ; c inquama del Raggruppamento Idro.
166
F in dal g iorno successivo alla p ro cl amazione della resa , in tere sq uad re di vel ivoli ri maste isolate, elu dend o la so rveglianza tedes c a, co min c ia ro no ad affl uire al Sud d alle reg io ni de ll ' I talia occ upata.
Negl i u lti mi mes i de l 1943, fu p red is p osto il rec u pero d i tutto i l ma te ri ale aero nau ti co ri mas to in Africa set ten trion ale , nelle isole , nelle zo ne liberate del co ntine nte e di etro le linee d i combatti mento . I rotta mi e i re sti degli aere i fuori u so, i ma cc h inari e le materie p rime, che s i ten tava di sottrarre il più po ss ibi le all e co ntin ue r equisizioni a ll ea te , veni vano poi inv ia ti , per mezzo di n av i ed ae rei appos iti, alle Squad r e d i Rip arazion i Aero mob il i e Mot ori (SRA M ) No nos tante le in genti perdite s u bite, q uesta pi cco la organi zz azione, rimette ndo in effic ienza gli app arecchi fu ori uso, co n se ntì all'aviazion e d i d ar e un ragguard evo le contr i bu to ai rep arti op erat ivi 445 .
Il Capo di S tato Maggiore Ge nerale M ess e ha ev id enziato l ' un ic ità d i ta le ini ziativa nel campo aerona utico , resa a ncor più significa tiva alla lu ce d ella tota le ass e nza, in Itali a, di fa b bri c h e di pro du zione446
O ltre a d are il proprio a pporto al la ca mpagna d' Italia, la Mari n a e l' Ae ronau tica cost itu irono spontaneamente d ue or gan izzazio ni clandestine di Res is te nza che trovar o no nel FM C R sos tegn o eco nomico , armi, doc umenti fals i , nonc h é la p oss ibi lità di com unicare, suo tram ite , co l Coma ndo Supremo e il
C L N447 _
Nella re laz io ne r edatta dal generale Mattini , s i legge c h e su bi to d opo l' occupaz io ne d i R oma, il fe ldmares ciallo Kesselring e l' a mmi raglio M ee ndse nBohlken aveva no rec la mato la collabora zione de lla Reg ia Marin a, ai loro occ h i p iù co lpevo le d i tra d imento ri s petto alle al tre fo r ze armate ita lian e per ave r consegnat o la fl otta ag li ing les i .

L' ammirag lio Ferreri, a d im ostrazio ne della perspicua tendenza antitedes ca e della p iena fed el tà al gov e rno d el S ud, op pose un cat egori co ri fi u to e p untual izzò c he la M arina si sar eb be li mi tata a svo lgere il servizio in terno dei por ti , a seg nalare l' u bicazione e l'install az ione de ll e lin ee di telecom unica -
445 A.C .S . , Mi n is te ro d ella R ea l Casa, Uffi cio del Primo aiutante di cam po, Serie speciale, b.84 , f.2.
446 A. U .S.S.M E. , N.J-11, Diari s torici 2" Guerra. mondia.le , b. 3070 , allegato n.738, " Relaz ione", Comando Supre mo, Ufficio Op erazioni, il capo di Stato Maggiore G e neral e Messe al capo de l Governo , de l 24-4 -1 944.
-14 7 A.U S.S.M E , / -J, b.187 , f.5 , ;< Re lazion e consuntiva s ulla attività su cce ss ivamente svo lta dal la De legazio ne del Comando Sup remo in Roma , dai Comandi Ci vili e Mi li tari della citlà d i Roma, ne l periodo 22 se ttembre 1943 -5 gi ugno 1944; periodo 22 settembre- 5 gennaio 1944 (delegaz ione de l Comando S u premo), in sos tituzione de l Co lonnello Montezemolo (caduto), il Co lonnello già v ice capo dell' uffi c io d i collegamento del Comando Supre mo G. Pacinotti, all o S tato Magg iore Generale , Uffi c io Patrio ti , 23 settembre I 944.
Mon tezemolo e il Fro nte Militare Clandestino
167
Sabrina Sgueglia della Marra
zion e e a c u rare l'assistenza ai mili t ari e alle famiglie dei caduti, dei dispersi e dei pr igio ni e ri. Tali proposte furo no accettate da p arte germanica e , nel contem po , venne o r dinat o al ministero della Marina, attraverso il Comando de ll a città ape rta, d i sciogliere lo Stato Maggiore e di ridurre il numero di t utti gl i a ltri u ffic i per a d eguarl i ai nuov i compiti fortemente ridimensionati 44 8 .
Sin dal mese di ottobre, il F MC R en trò in contatto col cap itano di fregata Co m e l e, grazie alla sua intercessio ne, con l ' ammiraglio Paro na Il comando d ell'orga ni zz az ione clandes tina della Regia Marina che, come quella del -
1' A eronautica , assu nse u na fisionomia be n definita nel mese di novem bre, fu ass u nt o dall'ammiraglio di di visione Ferreri , co n c ui vennero pres i accordi per un'az ione u ni taria nel campo della propaganda e d e ll 'assis te nz a449 .
Il ca pitan o d i fregata Re na to Montezemo lo 450 , fratello d e l colonnello , illustrand o in una lunga r e lazione l'attività resi stenzia le del Fronte clandesti no , ha osservato come Ferreri non godesse di grande prestigio fra i patrioti po iché era sta to Commi ssario della Marina nel Comando della città aperta fi no al 30 settembr e, ovvero per una settimana dopo la nascita della R ep ubblica Socia le. Date le regolari consegne del Commissari a to all'ammi rag li o re pubblicano Falango la , Ferreri era ri masto tre mesi in licenza riscuo te n do assegn i d alle a utorità fasciste pe r l'intero periodo. In segu ito si d iede alla macchia e se, nominalment e, l 'organ izzazione fece capo a l ui , ad occu parsi di tutto fu , in realtà, il capita no di fregata Cornei.
Ques ti procedette alac;remente alla costituz ione di piccoli nu clei operativi di resistenza r ecl utando uffic iali del grado ma ss im o di capitan i di corvetta, pe r l' accred itata opinione secondo cui si potesse fare maggiore affidamento su di essi. Durante l'occupaz ione naz ista , il mini stero della Marina rimase pr esid iato d a cinquantad ue carabinieri a l co mando del capitano Parmegiani , il qua le, benché prestasse s ervizio per la Repu bblica Sociale, mantenn e conta tt i con Cornei, cui d iede costa nte me nte utili raggu agli.

448 A.U.S.S.M.E , N.1 -11 , Diari storic i 2° Gu e rra mondiale , b.3055 , allegato n.688 , ' Rela
z ione del Generale A N. Ca rlo Matteini "
449 A. U .S.S.M.E., 1-3 , b 187, f.5 , "Relazio ne consuntiva sulla attiv ità s uccess ivamente svo lta dalla Del egaz ione del Co mand o Supremo in Roma , dai Comandi C ivili e M iliLari della città d i Roma , ne l periodo 22 settembre 1943-5 g iu gno 1944; periodo 22 se tte mbre -5 gennaio 1944 (de legaz ione del Comando Supremo), in sos titu zione del Colonnello Montezemolo (caduto) , il Colonnello già v ice capo dell 'u ffi c io di collega me nto del Co mando Supremo G. Pacinotti, allo Stato Maggiore Ge nerale, Ufficio Patrioti, 23 se ttembre 1944. .
450 Renato Monteze molo , giunto a Roma il 2 3 gen naio , s i mi se immediatamente in contat to col fratello . Ri chiese il suo aiuto per attra versare il fronte ma il capo del F.M.C.R. s tabilì cbe rimaness e ne lla capi tale e lo presentò al gen e ral e Arm e llini . Questi lo nominò uffi c iale d i co llegamento co l comando c landestino della Marina.
168
-
Il Servizio i nfo rm azioni agì in maniera quasi in dip enden te men t e. F aceva capo all'ammira gl io M augeri che aveva abba ndonato il minis tero s in dal 10 settembre, ricusando di gi urare fedeltà al fasc ismo di Salò, ed era perciò rice rcato dai rep ubbli cani. L' att ività inform ativa, s olerte e fruttuosa nei primi mesi , r alle ntò se n sibi lm e nte a partire d a gen nai o a ll orché la pe r vasiva presenza della polizia impose a M augeri maggiori cau te le45 1
Per qu an to ri guarda l 'o rga nizzazione res istenzia le della Regia Aeronautica, i primi co nta tti ven nero p res i attraverso il tene nte colonnello M usco. In seg uito, all' in izio di novembre, M o ntezemolo incontrò il generale Umberto Cappa e, co ns tatata ne la dispo nibil ità a cooperar e, raggiun s ero intese analog he a quelle stabilite con la Marina452
Nei success ivi colloqui , d efi niro no gradatame nte le modalità operative e, fra i d ue ufficia l i, s i delineò una co mpleta identità di vedute. Cappa inq uadrò in un un ico grande disposit iv o pa trio ttico tutte le forze des id ero se d i conco rrere attivamen te alla lotta co ntro l'occ up ante e c o s tituì il F r o nte Clan d est ino di Res iste nza d ella Reg ia Aeronautica, cui im presse un ma rcato orientame n to a n t itedesco e a nti fascis ta ed un carattere puramente militare. Le diretti ve del comando furono a ltresì infor ma te alla più rigida o sservanza d e l principio di scipl inare che imp oneva al sol d ato una conoscenza approfondita ed un i nteresse costante pe r i fenomeni polit ic i ma, al co n tempo, l'astens i one tot a le da ogni forma att iva di partecipa zi one. A tal fine, nei nove mesi d 'occ upa z ione , venne s tampato il pe riodico a tiratu ra limi tata Osse rv azione politico diplomatica c h e, oltre a contenere articoli s u lle operaz ion i e su ll e problematiche p i ù urgenti che atte nevano alla stra teg ia be lli ca, conce d eva ampio spaz io a chiarimenti, interpre tazio ni e riflessio ni su no ti z ie di altro ge ne re riguardanti fatti accad uti ne l la settimana.
Il Fronte fu suddiviso in g ru p pi e i capi, il c ui ve ro nome era noto a pochi ss imi, adottarono pseudonimi c he id entificavano l'intera banda e c h e, per rag io ni di prude nza, venivano spesso cambiati. Gli obiettivi delle formaz ioni erano ad un te mpo difen s ivi ed offe nsivi, prevedeva no un 'in tensa attività di sabotaggio ed u n accu rato servizio informazioni per la racco lta e la

45 1 A U .S S .M.E., /-3 , b. 146 , f 7 , "Azione di co mand o. de l Fron te Clandes tino , gennaio -giug no 1944", relaz ion e del capi tano di fregata Renato Mon tezemolo. ·
452 A. U .S.S .M.E. , l -3, b. I 87, f.5, " Rel az io ne co nsu ntiva su lla auività s uccessivamente svo lta d alla Delegaz ione del Comando Supremo in - Ro ma, dai Co inandi Civ i li e Militari delJa città cli Roma , nel peri odo 22 settembre 1943 -5 giugno 1944: periodo 22 settem bre-5 ge nnaio 1944 (delegazione del Coma ndo Supremo ), in sos titu zione del Colo nn ello Mon tezemolo (ca d uto), i l Colo nn e llo g ià v ice ca po de ll ' ufficio di collegamen to de l Comando Supremo G. Pacinotti, allo Stato Maggiore Generale, Ufficio Patri oti, 23 settembre 1944.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandes tin o
169
Sabrina Sgueglia della Marra
trasmissione di segnal azio ni e d a ti s ignificativi , affidato a personale specializzato in rilievi di carattere nùlitare.
L'a ttività informativa , ma lgrado la scars ità di mezz i e ri so rse, la pe nuria di carburante e la diffi coltà di o ttenere lasciapassare dalle autorità germani che, s i dipan ò in mod o fitto e ram ifi ca to in un terri torio assai es teso: ne l Perugino, nel Vite rbese , ne l Grosseta no, intorno a C ivitavecch ia , nel Reatino, in Ciociaria e in Abruzzo. Il collegamento tra i nucl ei c he controllavano t ale vasta regione e la central e aerona u ti ca ven ne effett uato da staffette mentre la r ete tentacolare dell e pol izie ge rmani c he e rep u bblicane fu pos ta sotto stretto con trollo in col laboraz ione co n espo ne nti d el Parti t o comun ista e della Guardia di F i nanza. Una sez ione s pec ia le del se r v izio in formaz ioni , infi ne, fu adib ita ad azioni di sabotagg io e co lp i di ma no co ntro i ted eschi, a ll a ricerca di campi per avio lanci e aviosbarchi e a lla riproduzione fotocartografica, in part ico lare per la zona co m presa tra i l para ll elo di Cassino e qu ello di Orvieto 453
L ' Aeronauti ca, du ra nte i nove mesi di occ upaz ione, conservò un "Ce ntro" in via Po, ove t utti gli u ffic i co nt inuarono a funzi o nare rego larmen te. Quant unq ue non appaia verosi mil e l'ip otes i c he le au torità rep ubblicane non ne fos sero a cono sce nza, i l ce ntro non ve nn e ma i perquisito: Rena to M ontezemo lo ha ipoti zzato che potesse essere to ll era to454
I ge nerali Lordi e Martelli Casta ld i, direttori del po l verificio Stacchini , fo rn iva no dinamite , mine , detonatori ed arm i a i partigian i di Roma, del Lazio e dell 'A bru zzo. Di con t ro , ordinarono ai propri operai d i sabo tare la prod uz ione desti nata ai tedesc hi carica ndo le bombe per metà con po lvere da sparo e per il resto co n terra, in m od o da rend e rl e inuti lizzabili. II gru ppo Lord iMarte lli Cas ta ldi provv ide costantemente, sec ond o le prop ri e possi bi lità, al sostentamento, a ll ' armamento e alla direzione di bande armate che operavano ne ll e zon e dei mon ti Pre nest ini , Pale strina, A latri e d e i Caste lli romani , attraverso i l co muni sta Mario Colacc hi , e d i bande interne come la ban da M osconi, del quartiere Monte Mario.
U na delle loro p ri me azio ni co lpì proprio il ministero d e ll ' Ae ro nau tica: riu sc irono a so ttrarre n umerose mitrag liatri ci ed una cassetta di esp los iv i che distribuirono ai partigiani 455 Ad essa seg uirono numerose operazioni nottur-
453 A.U.S.S M.E. , N.1 -10, Diari storici 2" Guerra mondiale, b.3022. f.29. " Relazione s ull'atti vità e organizza z ione del Fro nte C landes tino di Res isten za de ll a R. Aero nauti ca dura nte l 'occupazio ne tede sca a Roma".
454 A.U S.S.M.E 1-3 b.146. f.7. '"A zio ne di comando del Fronte Clandest ino, gennaio-giugno 1944'', re lazio ne de l capitano di fregata Re nato Montezemo lo.
455 Mario Ava gliano. op. cit pp.4 1, 54 -55.

170
ne vo lt e a l trafugamento di armi e viveri al c ui successo contr ibuì il maresc iallo dei carabinieri Tozzi che, se bbene fosse rimasto in serv izio come comandante di stazione ciel ministero, condiv id eva in toto gli ideali patriottici e coadiuvò come meglio poté i genera li456 .
Monte zemolo assegnò alla ban da Castelli romani una delicata e pericolosa azione di guerrig lia: ordinò la distruzione del viadotto cli Ariccia per bloccare l' invio di t ruppe tedesche e di rifornimenti nelle regioni merid iona li . G li esp los ivi occorren ti vennero procurati dai generali Lordi e Martelli
Casta ldi 457
Su ini ziativa del generale Cappa, un g ru ppo di ufficiali fu inviato in missione a Firenze e a Mi la n o allo scopo di gettare le basi per costituire, anche nell' lta lia settent rional e, un Fronte clandes tino dell'Aeronautica a nalogo a quello operante a Roma. Tuttavi a, la grave disorganizzazione e l 'incessante pressione esercitata dalla po li zia nazifascista sul personale mi li tare c he n on aderì alla Repubblica Sociale rese vano o g ni tentat ivo458
456 A.U.S.S .M. E. , N.1-10, Diari storici 2° Guerra mondiale, b.3022 , f.25 , " Re lazione s ull 'attività svolta dal sottosc ritto e dai suoi gregari", Comando M ili tare del Fronte Clandestino di Resistenza, Banda Mosconi, 25 -6 - 1944.
457 Tale atto di sabotaggio è stata rappresentata nel film "Un giorno da leon i" del regista Nanni Loy e ne costituisce l' episo d io princi pa le Nella trasposizio ne cinematografica compaiono numerose figure sig nificativ e del la Re sistenza nel Lazio come , ad esempio, l'ingegnere, in cui è facile riconoscere l'ingegne r Cateratto, identità di copert u ra assunta da l capo del F.M.C.R I " leoni " sono un gruppo di uomini che, inseguiti dai tedeschi , decidono di unirsi ad una banda partigiana intenta a preparare un'azione di guerriglia, cfr. Anna Baldin otti , op. cit., p. 67.
458 A . U .S .S.M.E., N.1-10 , Diari storici 2" Guerra mondiale, b.3022, f.29, " Relazione sull ' atti vità e organ izzazio ne del Fronte Clandestino di Res istenza della R.Aeronautica durante I' occupazione tedesca a Roma" .

Montezemolo
e il Fronte Militare Clandestino
171

DALLO SBARCO DI ANZIO ALLA LIBERAZIONE DI ROMA

CAPITOLO IV

1. Lo sbarco alleato e la decapitazione del Fronte Militare Calendestino
Agennaio Roma era stremata dalla fame p e r le dìffico ltà dì t raspo r to degli appro vvigio nam en ti. Proliferava il mercato nero, scarsegg ìavano i medicinali neg li ospedali e, b enché i serv izi pubbli cì fossero ìn fun zion e , l e comunicazioni telefonich e eran o sottoposte a seve ra cens ura. La cìttadìnanza, completamente asservi ta all'occupante, e ra nella m orsa delle SS che dìsponevano dì una for za assai consistente di quas i cinqu emi la uomìni all'interno della città459
In pross imìtà dell o s ba rco alleato ad Anzìo , le comunicazioni tra Roma e Brin di si s'infitt ìrono. li capo de l FMCR ìmpre sse un rinnovato impul so all ' attività informativa in partìcol are nel campo ta ttico:
7 gennaio - Rommel venuto Rom a dicesi predi sporre ripiegamento al t effettivam ente numerosi element i serv i zi mossi verso nord alt n ess una assegnazione ad industrie do po qu ella per du e mes i fatta primi nove mbre alt affretta to tra sferimento ul timi e lem en ti ministeri

J. 3 gennaio - ln corso uscita da Roma entro qui ndi c i ge nnaio co mandi et reparti te desc hi po l iz ia esclusa seg uito pare ri c hi es ta Vati can o s u minacc i a in glese bo mbardare R oma se presenti reparti tedesc hi alt talu ni coma ndi p erò anziché pe riferia vanno Firenze al t.
15 gennaio - Autorità germaniche hanno invitato c ivili cittadini germanici lasc iare Roma entro quindici genna io alt ministero in accordo con germanici p rescrive tutti uffi c ia li effettivi anc he malati devono lasc iare Roma en tro ve ntitre alt Grazia ni et Gambara con loro uffici partono entro quindi c i per nord alt460
I mes s agg ì che, a ll'ìnì z io del 1944, gìungevano quotidi anam en te al governo regio documen tand o gl i s vìluppi della s ìtuazione po litico -militare
459 A. U.S.S.M. E , N. I - I/ , Diari storici 2" Guerra mondiale, b.3062 , a ll egato n.939 , " Situazione di Ro ma " , Com an do Supremo, Uffi cio In fo rmaz ioni , al Comando Supremo-Uffic io Informazioni , al Mi niste ro della G uerra, allo S tato Maggio re R. Ese rci to - Ufficio Operaz io ni , 27-1-1944.
460 Gabr io Lom b ardi , op c it. , pp. 52 - 53.
Sabrina Sgueglia della Marra
ro ma na , te st imoniano non solo il fe rvore e la solerzia del FMCR ma a nche il grado di efficienza, l a compl ess ità e l 'articol azione dell'intera s truttura operante nel ca mpo info rmativo.

A riprova dei ragguardevoli ri s ul tat i co nseg uiti in ogni se ttore, l ' Uffici o I si accreditò come massimo o rgano della resi stenza ro m a na agli occhi degl i All e ati che, in vista d ello sbarco sul litorale lazia le , ne richi esero il fattivo concorso da realizzars i attraverso la c r eazion e di un " di staccamento avanzato " di med ia con s isten za , che av rebbe affiancato l'organ izzazio ne angloameri cana nel pro g ress ivo avv icinamento alla capitale46 1 •
La so rveg lian za e l 'accanimento dei tedesc hi re ndevan o i mo v im enti sempre più pericolosi L'aria , come co nsta tò amaramente Mon teze m olo , s i faceva "se mpre più irrespi rabi le" .
Il 18 gen na io, d a Brindisi arri vò un messaggio in cui si sollec itava no co n urgenza ragguag li circa le co nt ro mi su re a d ottate dai tedesc hi nell e zone a nord e a su d del Tevere, aree considerate a ri schio d i invas io ni nemiche, ed indicazioni r e l ative alla dislocazione dell a III divisione Panze r grenadiere e al s uo prevedib ile impiego, alle unità tede sc h e s tan z ia te a Frasca ti e a ll 'even tuale pre s enza di cannoni a lunga gittata ne i pressi Centoce ll e . La r is po sta di Monte ze molo g iun se, no n ostante le difficoltà, rapida e d esa us t iva.
Nonostante fos se braccato d alla po li zia nazifas cista, il co lonne llo conti nu ò a p re occuparsi costante m en te dell' in columità d e i suoi affili a ti , in te nsificò la propria attività e si espose, co me di c onsueto, in prim a p e rsona , pers uaso che il momento es ige sse il ma s s imo sforzo . Fu un a tt o di estremo coraggio, di gen eros ità, privo di qual sivo glia velleitarismo: pro fon damen t e reali s ta, il capo del F MCR era consa p evo le d e i pericoli cui andava inco n tro462
Il 29 dic em bre, infatti , confidò ai s uoi familiari che non avrebbe re sis t ito p iù di un mese e, in qu e llo che s i sar ebb e rivelato l ' u ltimo in co ntro con la moglie, il 19 gen naio 1944, asserì che o rm a i gli r es tava n o n più di una settimana di re spi ro: se gl i Alleat i no n fossero ar ri vati in breve tem po, sarebbe stato sicuramente a rres tato46 3
All ' indomani della lib e razione , Pac inotti dep lorò esplicitamente le capz iose argomentaz ioni con cui, da più part i, s i volle p ro pa la re un 'i mm ag in e
46 1 A U.S.S M E , L 9 , Racc. 02 1, fase. 4/2 , Stato Maggio re Regio Eserc ito, Uffic io In formazio ni , l'Ufficio I 11ella guerra di libera zio11e, Roma, 31 gennaio I946.
46 2 G iu seppe Mari a Catanza ro , op. cit , p. 36.
463 Gab ri o Lombardi , op cit., p. 63.
176
di Montezemolo non corrisponde nte al vero, attr ibu endo la sua scelta resiste nzia le ed il suo operato a temerarietà, scarsa avved u tezza e sprezzo del perico lo.
La speciosità d i t ali a d debiti, la cui inco nsiste nza venne ava ll ata d a tutti i suo i collaboratori, è testimoniata dall 'i m peg no e dalle energie c he il co lo nnello profuse ne lla creaz io ne e nello sv i luppo del FMC R , co nsc io dell'alto prezzo d a pagar e . Egl i avrebbe potuto m etters i in s alvo o quantomeno rallentare la propria att iv ità ma, al contrario, volle rimanere a Roma r isoluto a no n s ottrarsi a qu e llo c h e avvertiva come il suo prec ipuo dovere. Animato dall' unico desiderio sincero ed in coercibi le di servire la patria, s i p ro d igò per co nsen tire a l paese di risollevarsi e di tornare libe ro cancellando i l disdoro della resa in condiziona ta e dell'occupazione 464
Gli ang lo a m e r ica ni , ne ll e prime se ttim a ne di ge nn aio, mi se ro a punto l ' operazione Shingle, nome convenzionale dato allo s barco di Anzio. Onde ev itare l'afflu sso delle trup pe nem iche s u l lito rale l azia le, la V Arma ta s ferrò un a serie d i attacchi pr e li minari co n l'obi e ttivo di superare i fiumi Garigliano e R a pi do. G li scontri furono oltre mod o cruenti po ic h é le truppe tedesc he e ra no decise ad im ped ir e lo sfondame nto de ll a lin ea Gustav c he , facendo perno s u Cass in o, costit ui va lo s barramento più arretra to del loro sistema difens iv o .
L' offensiva vera e p ropri a fu lanciata il 22 gennaio e le c ircosta nze oltremodo favo revoli che si dipanarono sotto gli occhi deg li A ll eati fecero presag ire un trio n fo immediat o:
. .. Ci so no g iunte le prime noti zie dello sbarco - anno tò Harold Macmillan, consig li ere politi co del governo ing le se per l ' Italia presso il coma ndante supremo del Med it erraneo e poi presidente della Commis sion e a ll eata - pare che t utt o sia an dato beniss imo. Pe r non so quale miracolo lo sba rco è stato una so rpresa totale e come abbiano fatto i tedeschi a no n sco rgere i grand i convog li che per tutto ieri so no a ndati avv icinandosi alla riva ( hanno cominciato a muoversi alle quattro d i vene rdì ), pu r proc edendo alla ve loc it à di poc hi nodi, non me lo so s piega re465
4M A. U.S.S.M . E. , l-3, b. 187, f.5, "Relazione cons untiva sulla attività succes sivamente svol ta dalla Del egaz io ne de l Comando Supremo in Roma , dai Comandi Civili e Militari della c itt à di Roma , nel periodo 22 settembre 1943-5 giugno 1944; pe riodo 22 settembre-5 gennaio l 944 (delegazione del Comando S up remo), in sostituz ione del Colonnello Montezem olo (caduto), il Colonnello già v ice capo dell'ufficio di collegamento del Comando Supremo G . Pacinotti , allo St ato Magg iore Genera le, Ufficio Patrioti , 23 settembre 1944 .
465 Harold Macmillan, Dia ri di gu e rra. /943 - 1945, Bologna, Il Mulino , 1987, p.512.

Montezemolo
Militare Clandestino
e il Fron te
177
Sabrina Sgueglia della Marra
Secondo la testimonianza del ge nerale Westphal, capo di Stato Maggiore di Kesse lring, al mom e nt o dello s b arco a s ud di Roma, i ted eschi disponevano in quel settore delle batteri e costie re permanenti e di so l i d ue battaglioni. No nostante lo sb ar co, il fe ldm aresciallo rimase fermo nella dec is ion e di resistere agli attacchi alleati a Cass in o, co me at testat o da un o rd ine di Hitl e r in te rcettato dagl i in g les i il 24 gennaio:
La linea Gustav deve essere tenuta ad ogni costo in co ns iderazione dell e conseguenze polit iche c he p uò avere una difesa vittoriosa. li Fuhrer confida che ci si batterà con la massima tenacia per ogni palmo di te rre no466.
Le con tro misure tedesche , dun qu e, divennero efficaci e pote rono contrastare i te ntat ivi di avanza ta ne mi ca solta nto dopo ventiqu attro ore.
La strada per la cap it al e, d unqu e, sarebbe s ta ta agevolmente pe rco rr ibi le: "ness uno - amm ise l'alto ufficiale - avrebbe pot uto arre s tare un' audace avanguardia ch e s i fosse s pinta risolutamente verso l a Città Eterna"467.
Al berto Tarch ia ni , u n espo nente del Partito d 'azione, come si legge nel s u o diario, ipotizzò persi no che i tedesc hi , costrett i ad abbandonare i Colli Albani , no n s i sa r eb bero diretti alle po rte d i Roma per no n scontrarsi con la temuta "resis tenza in extremis" . A s uo avv iso, le fo rze teu toni che si sa r e bb ero at testate su lin ee organizza te a Nord , pro babi lmente La Spezia- Rim in i, e " d ' un colpo" sareb be caduto l'int e ro fro nte Garigliano-Pescara468.
Churchill, appre so l' esito positivo de ll e fas i iniziali de ll 'o perazione Shingle, impartì istruzioni al ge nerale Alexander d i sp in gers i risolutamente in avanti se nza attardars i a rafforzare le teste d i sbarco . I calcoli logistici, tuttavia, si rivelaron o eccessiva mente prudenti e, malgrado la su p erio rità dei mezzi a di s posi zio ne , "il gatto selv atico" ch e il primo mjnis tro britannico aveva spera to di lancia re s ull a spiaggia romana , s i fermò sulla riva come " u na balena arenata"469
Le prime s pi egazio ni in me rito all'inopinata de bacle vennero forni te dal generale Wilson che addebitò alle cattive co ndiz ioni a tm osferiche il mancato a pport o d eci sivo dell'aviazione , impos sibili tata ad interven ire etlicace-
466 Win s ton Churchill , La S econda Gu erra Mondial e. Parte V-Voi. Il, Mondadori , Milan o 1953, pp.188-189.

46 7 l vi , pp. I 85 - 188
468 Alberto Tarchiani , Il mio diario di Anzio, Mondadori , Mila no , 1947, p. 87.
469 W inston Ch urchill , op. cit , p. 195.
178
mente p er ev it are in utili perd ite, e all'in ten s a p ress ion e d e l ne mico su ll a prima div is ione britannica, che fu costretta a cede re terreno470
Nel s uo libro s u lla campag n a d ' It al i a, William Jackson, inv ero, ha op inato c h e Clark e Lu cas s i conce nt rarono q ua si esc lu s ivamente s ull' impiego d e i mezzi atti a respingere i contrattacchi n e mi ci pe r ricacciarli i n mare, sottova l uta ndo le poten z ialità delle forze aeree che , c on un ma ss iccio bo mb ar d ame nto delle vie rotabili e ferroviarie verso Anzio , avrebbero potuto b loccare o quantomeno ra ll e ntare l 'afflusso delle truppe tedesc he471.
li ri s ultato fu, a d ogn i modo , che le truppe angloamericane non riuscirono a raggi un ge re i Colli Al ban i, la cui occu pazione col blocco d e ll a via Casilina, a rte ri a principale d e l fronte tirre nico fino a Cassi no, cos ti tui va il primo obiettivo st ra te g ico d e lI' operazione472
Il sottoseg r etario di Stato Orl a ndo sottopose al generale Messe un a lu nga relazione su lle o pera z ioni di sbarco al fine di valutare quali sareb be ro state le ripercussioni de l fallimento a ll eato su ll 'auspicata pa rtec ipazio ne italian a alle o p e razioni belliche.
Nella puntu ale disamina de ll'ina tteso insuccesso con seg ui to ad Anzio, O rlan d o pre se spunto d alle esternaz io ni di un a trasmi ssio ne di Ra dio L o ndra andata in o nd a il 7 fe bb raio, in c ui la disfatta fu adde bitata non solo a palesi e rrori strategici ma anche alla scarsa audacia e alla caren te determinazione con c ui erano stati condotti i co mba tt im e nti dei pri mi gio rn i . Le du e direttive o perative, quella della testa di ponte verso no rd-est e q u e ll a del tratto occidentale verso nord-ovest, risultavano strettamente connesse. Orlando ne infe rì , pertanto, che le t rup pe di s barco, raggi unta una co n grua con sis tenza , avreb be ro d ov uto osare di più e marciare risolutamente alla vo lta dei colli laz iali ove le for z e tedesc he era no alquanto esigue. In tal modo , tutta 1 ' ala destra dello sc hi e rame n to germanico su l fronte del Garigliano , co lta alle s palle, sarebbe s tata co s tret ta a ripi egare, li berando così ag li angloamericani la strada per R oma. Con un at tacco pod eroso contro le li nee avver s arie, essi sa re bb e ro s tati in grad o di aprire una breccia e penetrare in profondità lu ngo la via della capitale . Ciò avreb be costituito u na seria minaccia pe r i reparti germ anici che s i stava no raccogliendo da ogni parte d ' Ital ia per sferra re la controffensiva.
47 o Winston Chu rc hill , op. cir , pp. I 95 - 196.
4 7 1 William Godfrey Foth erg ill Jack so n, La battaglia d ' Italia , Ba ld in i e Cas to ldi , Mi lano, 1970, p.231.
4 72 Enzo Pi sc ite lli, op. cir , p.266.

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
.
179
Sabri na Sg uegl ia della Marra
Il s o ttoseg reta ri o di Stato, i nfine, co ns iderando gli as p etti emine ntemente tec n ici d ello s macco s ub ito su l G arigliano, ri levò pesan t i lacu ne nel l ' imp iego d ell 'artiglieri a a ll eata, specialità di cu i l'eserc ito ital iano, nel te rritorio libe rat o , poteva vanta re un 'ampia disponibi li tà e quadri di prim'ordi ne473
Pe r Ch u rc hill, q uella della b attagl ia di An zio, fu " u na stor ia d i gra ndi occas ion i perdu te e di sp eranze i nfrante, di u n bri ll ante in iz io da parte nos tra e d i un altre tt a nto brillante recupe ro da par te del ne mi co, di ges t a valorose compiute d a e ntram be le parti" 474 All o s tesso modo, Kesselring, ne ll e sue memorie, avrebb e d efinit o lo sb arco a lleato "un'occasio ne un ica di conquistare R oma"475
Alla pop olaz ione ro ma n a, delusa e sfid ucia ta per la con d ott a inefficace de ll e operazioni, "q uell 'orizzonte brul ican te di promesse"476 , co me Io definì Ta r chiani, po r tò so lo l' infittirsi dei bo mba rd amen t i attorno all a ci ttà, maggiori difficoltà neg li app rovvigionamen ti e l'a ma r a consapevolezza che la l ib eraz ione fosse a ncora lo nta na .
Il Comando germa ni co fece affigge re sui muri de ll a città u n ap pello urgente a t utti coloro che no n avesse ro avuto una rego l are occu p azione affi nché si presentassero al serviz io de l lavoro per ri cever e " la voro e pa ne nella giusta misura" : l'interruzion e dell'afflu sso d ei r ifo rnim e nti aveva notevo lment e pegg iora to la situ a zione a li me ntar e e , per sco ngi urare il pericolo d ell a fame, ci si d oveva ad operare con tutte le e nergie p er i l sos te ntamen to de ll e proprie famiglie, altri m e nt i "la di soccu p az ione volon t aria e in volo ntaria" in ques to caso sare bbe sta ta co nsiderata "un d el itto"477
Il 22 gennaio, un'ora p ri ma dello sbarco, g li Alleati si era no mess i i n contatto radio con Montezemo lo . G li ordi n arono di te nersi pro nto ad in te r ve nire con tutte le forze cla n destin e d a l ui in qu adrate a sostegno d elle tr up pe ang lo a m e ri ca ne approda te ad Anzio e c h e si sarebb ero mosse in d irezion e della capitale :
22 gennaio - Pe r M alt urgentissimo a lt Coma ndo Allea to ch iede c he bande Roma en trino in az ione 478 •
4 73 A .U .S.S.M.E. , N.1 - 11, Diari storici 2" Guerra mondiale, b.3063, a ll egato n .280, "Partecipazione italiana a lla g uerra", Ministero della Guerra , Gabinetto, a S.E. il Mare sciallo d'Ita lia G iovanni Messe capo d i S tato Magg iore Gene ra le , 8-2 - 1944.
4 74 Winston Churchill, op cii., p. 201.
475 A lbert Kesse lring, op cit. , p. 233.
476 Albe rt o Ta rchiani, op cil , p. 88.

4 7 7 Enzo Pisc itelli , / bandi tedeschi e fascisti, in " Qua derni della Resistenza laz iale" , n.4, Roma, 1977 , pp . 172-173.
4 7 8 Ga b rio Lombard i, op. cit. , p.58.
180
Nello stesso giorno, Bonomi an not ò il tan to atteso evento ne l s uo diar io :
U na not iz ia giunta attraverso le s tazion i estere ci elettrizza . G li ang l oamericani son o sbarca ti fel iceme nte nei pressi di Nettuno e di Anzio a 55 c hilometr i da Roma. L a nostra liberazi one si avvic ina! 479
Ar mellini ravv isò l 'oppor tu nit à che il governo d e l S ud so ll eci tasse g li angloa m er i cani a trasmettere comunicati rad i o racco m and and o alla popolazione romana d ì man t enere "ord i ne discip li na et obbe d ienza" 480 , m a soltanto ne i confron t i d e lle autor i tà legalme nte costituite . ll gio rn o seguente , il 23 ge nn aio, a rri vò a li ' Ufficio d i collegamen to un lu ngo dispac cio i n viato d a Brindis i i n cu i erano compe nd iate le dispos izio n i d e l Comando a ll ea to .
Per Roma e per tutti gli ita l iani era giu nta l'o r a di lottare strenu amen te con ogni mezzo e con tu tte le fo rze: bi sognava ri fiutarsi di lavora re per i tedeschj e sabo tare il nemi co bloccan d ogl i la ritira ta, d istruggendo le v ie di co mu nicaz ione e colpendolo ov unqu e possibile.
Le ban de e le avanguard ie armate dei partiti avre b be ro dovu t o convogl iare energie e r isorse nella battaglia, conce ntran d osi s ul comune o biettivo e r invia ndo qua lunque preg iu diz iale politica.
Bad oglio affi d ò al generale A rm e ll ini i l com pito di provvedere al manteni me n to dell ' ordine pu bblico, a uspicando potesse giovarsi d ella co ll a borazione del genera le Benc ivenga; al sena t ore Motta assegnò la respo nsa bi lità di assic urare il fu nzionamento d e i serv izi pu bblici e di garantir ne la pi ena efficienza anc he n el periodo d ì tem po compreso fra il ri tiro delle tru pp e tedesche e l'ing resso in citt à di quell e ang loamerica ne481
Montezemolo , p reco ni zzan d o u na rap ida avanzata deg li A ll ea ti , pers uaso c he so lo u na stretta co ll aborazione arm ata av re bbe consen t ito i l loro in g resso nella capitale, s ì m ise subito alr.o pera per mob il ita re l'intero d ispos itivo del FMCR.
Ricevuto il mes saggio del colon nello, all'alba d el 23 , i l ca pit a no Aversa convocò tutti i capin ucleo pe r ri epilogare i co mpiti assegnati a ciasc un reparto , c he av re b be d ov uto occu pare gli ob iettiv i prefissati e ntro diec i ore da allora4 82
4 79 I vanoe Bo nomi, op. cii , p.1 43.
480 Gab rio Lombardi; op. cii. ; p.7 1.

481 A. U S S.M.E., N.1 li. Diari s torici 2° Gue rra mondiale, b.306 1, allegato n.726, "Notizie da Roma" , Comando Supremo. Uffic io Operazioni , a S.E. il capo de l governo , 22 - 1-1944 .
48 2 Filippo Caruso. op c ii. , p 34.
Mon tezemolo e il Fro nte Militare Clandestino
18 1
Sabrina Sgueglia della Marra
Force lla ha affermato che Montezemolo, in que i mo me nti di forte ince rte zza e concitaz io ne genera le, non riuscì ad in contrare né ad aver contatt i co n alcun dirigen te politico. Secondo I.o storico, risu ltere bbe un solo colloqu io con Ame ndo la e con la spia in glese To m pkins che si ri solse in u n null a di fatto a ca usa d ell' atteggiamen to s u ssiegoso e non coJlaborativo di q uest'ult imo e della ritrosia del dirigen te comunista c h e dichiarò la piena a u tonomi a del CLN e l'asso l uta libertà d i p re ndere dec isioni sulla base delle proprie deliberazio ni483
Pu r confermando tale a b boccame nto, Amendola , in realt à, ha racco nt ato che il co lo nnello, come sta bilito , riu scì a fa rgli pervenire, tramite un me ssaggio, le d isposizioni ricev ute dal Comando allea to484
Il 24 gen na io Armellini comu nicò a B r indi s i che le b ande del Lazio e del1' Abruzzo erano entrate in azione dal mattino del 22 e che queJl e disloca te nelle altre r egion i sarebbero in tervenute non a ppe na raggi unte dall 'ordi ne inviato. Tutti i reparti armati av re bbero coordinato le attiv it à da espletare con l' andamento delle operazioni di guerra aJleate485
L 'anelato successo d ella Shingle, tuttavia , avrebbe tarda to ancora a lun go e, ne ll'i mmediato, la co nseguenza pi ù nefasta della generale ag itaz ione prodottasi ri s ultò l' in asprimen to della g ià intensa press ione po li ziesca c he , con rinnovato accanimento , si concentrò s ugl i esponenti di maggior spicco del FMC R la cui organizzaz io ne centrale venne decapitata.
Roma, ancorché partec ipe delJ'atmosfera di trepida nte attesa, seb be ne lo s tesso Maeltz er ritenesse che alla c ittà sarebbe bastato "solo un tocco pe r far intervenire la popolazio ne in favore degli Alleati" 486 , no n s i so ll evò. L'op inione degli occ upan ti, esp r essa da DolJmann , fu che la ca pital e non insorse per c h é "i romani n o n volevano né i tedeschi, né g li americani " 487
Il 17 gennaio vennero arrestat i L ordi e M ar telli Castaldi, il 22 il genera le S im o ni , il 23 D e C a ro lis, Aversa e Frignani . Qu est i ultimi , in s ie me al cap itano Vigneri , erano affannosamente ri cercati poiché avevano arrestato Mu ss olini il 25 lugl io. F r ignani , inolt re, e ra ritenuto i l m andante d el l'uc cisione di Ettore Mu ti , ex seg re tario de l Pn f, avvenuta i l 24 agosto 1943 a Fregene.
Marte lli Castaldi escogitò subi to uno st ratage mm a per inviare sue no tizie alla fa m iglia, sfugge ndo alla pur strettissima sorveglia nza delle SS:
4 8 3 Enzo Forcella, op. cit , p. 182.
484 Giorgio A mendola, op cit., p.269.
4 85 Gabrio Lombardi, op. cit., pp. 58 -59.
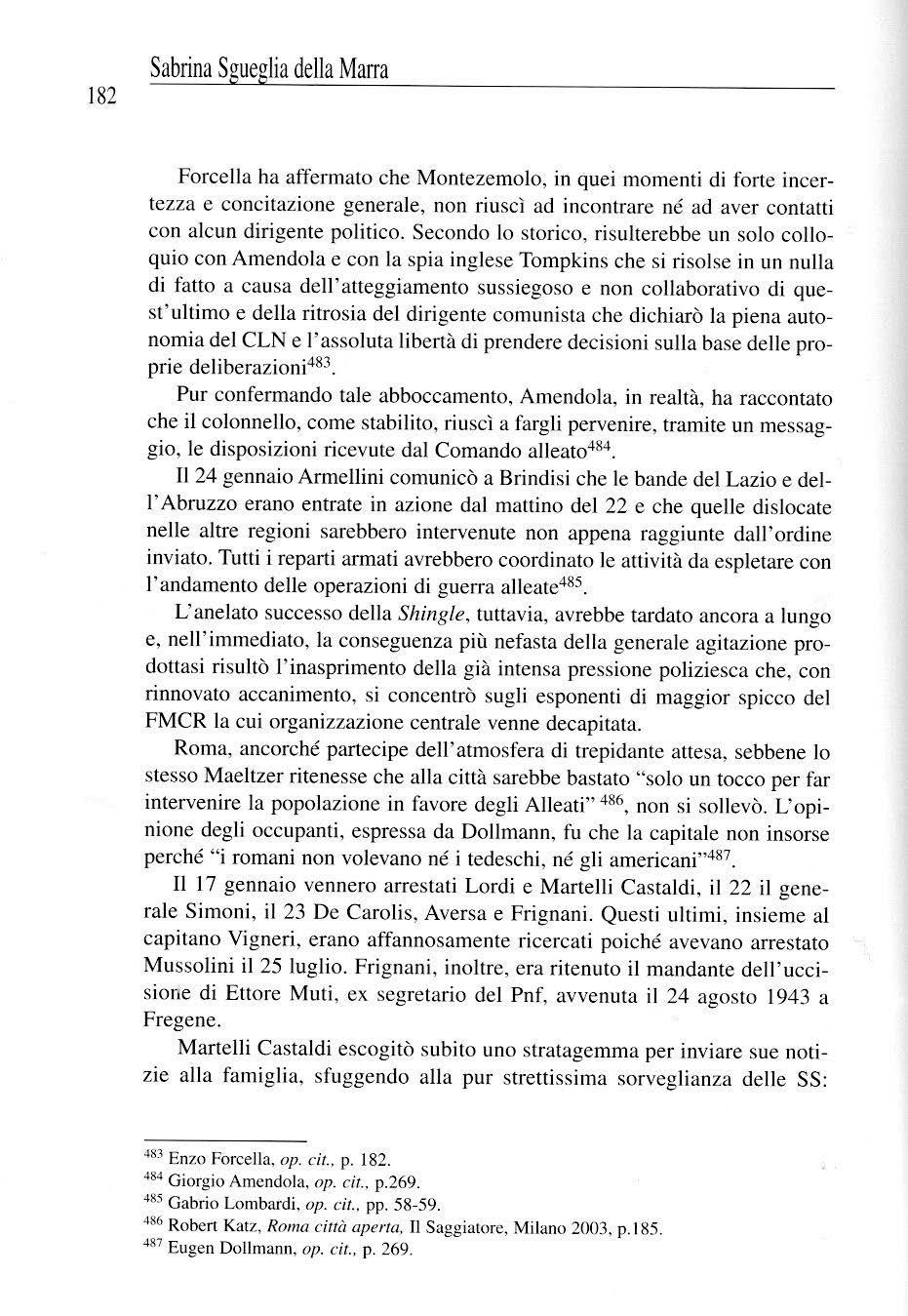
486 Robe rt Katz , Roma città aperta. Il Saggiatore, Milano 2003 , p. 185.
487 Eugen Dollrnann , op. cii., p. 269
182
an notava i s uoi brevi messaggi co n un pe nnin o e del succo di li mone s ul fondo di un a gavetta. Sua mog li e li decifrava attraverso il fumo di un a cande la e, d opo averl i trascritti , li nascondeva. Ess i costituirono una so rta di dia ri o d ella prigionia in cui trovarono a mpio s p azio le desc r izioni delle belluine to rtu re cu i venivano sottoposti i dete nu ti e delle lun gh e gio rn ate trasco r se nel ca rcere in at tesa di quella lib erazio ne che per i più si sa re bb e rivelata una mera illusion e 488 Il genera le Si m oni venne imm ediat amen te interrogato da Kappler c h e s perava di estorcerg l i informazioni su Montezemolo. F u orribi lmente sev iz iato , gli bruciarono ad dirittura le piante d ei piedi, ma egli non co n fessò e, a test im o ni anza d ella sua te na cia, non scalfita dall'età, di sse ai su oi aguzzi ni : " Mi rincresce di non essere stato più g iovane perché avrei vol ut o fa re ancora di p iù" 489 Fu arrestata a nc h e la moglie di Frig na ni , Lina, e fu co s tretta ad assistere alle torture cui fu sott opos t o il m a r ito:
Lo trovai ap poggiato al muro - disse - col viso sanguinante per i pugni e le frus tate ricevute; 8 o IO uomi ni erano ancora intorno a lui e ognuno sfogava su d i l ui il suo istinto b estiaJe: chi aveva in mano un grosso pallone che gli batteva s ull o sto mac o e s ul ventre; chi g li conficcava lungh issimi spilJi nelle carn i e sotto le unghie Egli non emetteva un gemito; io ebbi la forza d i reggermi in pi ed i e di guardarlo profondame nte negli occhi; egli comprese c he se mi fosse toccata la stessa sorte, mi sarei comportata come lui: morire, ma tacere! 490
La loro cattura, insie me a quella di Montezemolo che avvenne pochi g iorni d opo, segnò l a fine della fase più attiva ed operosa d el FMCR e paralizzò i dirig en ti dei par tit i c he, a loro volta, dovettero s ubire le consegue nze de ll a feroce cacc i a all ' uomo.
Il 31 ge nn a io le SS organ.izzarono un ras tre ll amento in v ia Nazio nale e nelle zone adiace nti che portò all'ar resto di circa d uem il a civili. Il p rim o febbraio, in via Giulia , i gap subirono due do lorose perdite: fu rono presi Giorgio Labò , c h e venne fuc il a to poco tempo dopo a Forte Bravetta, e Gianfranco Mattei che, rin chiuso nel carcere di via Tasso, s i to lse la vita impiccandosi con le sue bretelle il 19 febbraio . Anche il Partito d'Az io ne fu d uram ente colpito: la banda Koch , avvalendosi de lla fo lta s chiera d i delatori assolda ti , addive nne ali' arresto di venti tré es p on enti az ionist i e di que st i, ve ntuno furon o trucidati alle Fosse Ardea tin e.
488 Mario Avagliano, op. cir., p. 14.

489 A lessandro Portelli, op. cit , p. 178.
490 Filippo Caruso, op. c it., p.26.
Mon te zemolo e
Militare Clandestino
il Fronte
183
Sabrin a Sgueglia della Marra
Il generale Mae ltzer, ch ia mato da tedesc hi e roman i "i l re di Ro m a" , in u n ricevimento ten utosi all' h ote l Excels ior a fi ne gennaio, d ic hi arò ai gio rn al is t i che la fine della Res i stenza era ormai vic in a491 . Dopo l'iniz iale disorie n tamento , in fatt i, l'insuccesso dello s barco alleato e la falcid i a delle SS che, in esorabile, ridus se ali' impotenza numerosi patrioti imprigiona ndo Ii a via Tasso, i tedeschi giudicaro no di aver saldamente rec uperato il domi nio della cap itale e, a riprova di c iò, prorogaro no il coprifuoco all e 18. A tale disposizione, tuttavia, non corris pose u n allenta m e nto della press ione poliziesca che lanciò un duro ammonime nto alla popo lazione giustiziando d iec i uomini acc usati di aver preparato atti d i sabotaggio co ntro le forze armate tedesche e ai danni dell ' ord in e pubblico, col chiaro inte nto d i diffida r e la cittadinanza d al compiere azio ni del genere492 . n 4 fe bbraio, come attestato da un d ispaccio inv iato da Armellin i al Sud, le autorità germaniche ritenevano che il perico lo fosse ormai del tutto scampato. 493
L'intensifica rs i dell ' attività cospirat iva co m port ò una magg iore corrività ne l l'applica z io ne delle consuete mis ure di sicu rezza, rendendo la ret e clandest in a assai vulnerabile. Com'è evide nziato dalla testimon ia n za di Giuliano Vassa ll i, membro delle b rigate Ma tteotti ed espon en t e social ista de l CLN, si com mi se ro imperdonab il i imprudenze e l'abbandono delle usuali preca uzionj avvan taggiò spie e delat ori le cui v ittime principali furono gli uomini d el FMCR, a cominciare dal loro comandante494
Gli arresti, infatti, de starono s ospetti fra i resistenti no n solo perch é furo no nu merosi, ma soprattutto perché colpirono espo nenti di spicco del movimento r esis tenzial e: '' Mi risulta che alla sede centrale dell ' OSS, c'è un traditore co llegato via radio co l nemico", scrisse un detenuto su u na parete delle prigioni di via Tasso, nella cella in cui fu r inchi uso anche il ge nerale Marte lli Castaldi, aggi unge ndo più in basso l'eloque nte monito: " Attenti al conig li o"495
Montezemolo, ne i giorni conv uls i della Shingle , organizzò numerose riunioni pe r tra smette re le direttive che riceveva da Br indi s i. A tal i incon -
49 1 Mario Avagliano , op c it. , p .63.
4 9 2 En zo Piscitelli, op. cir. , p.267.
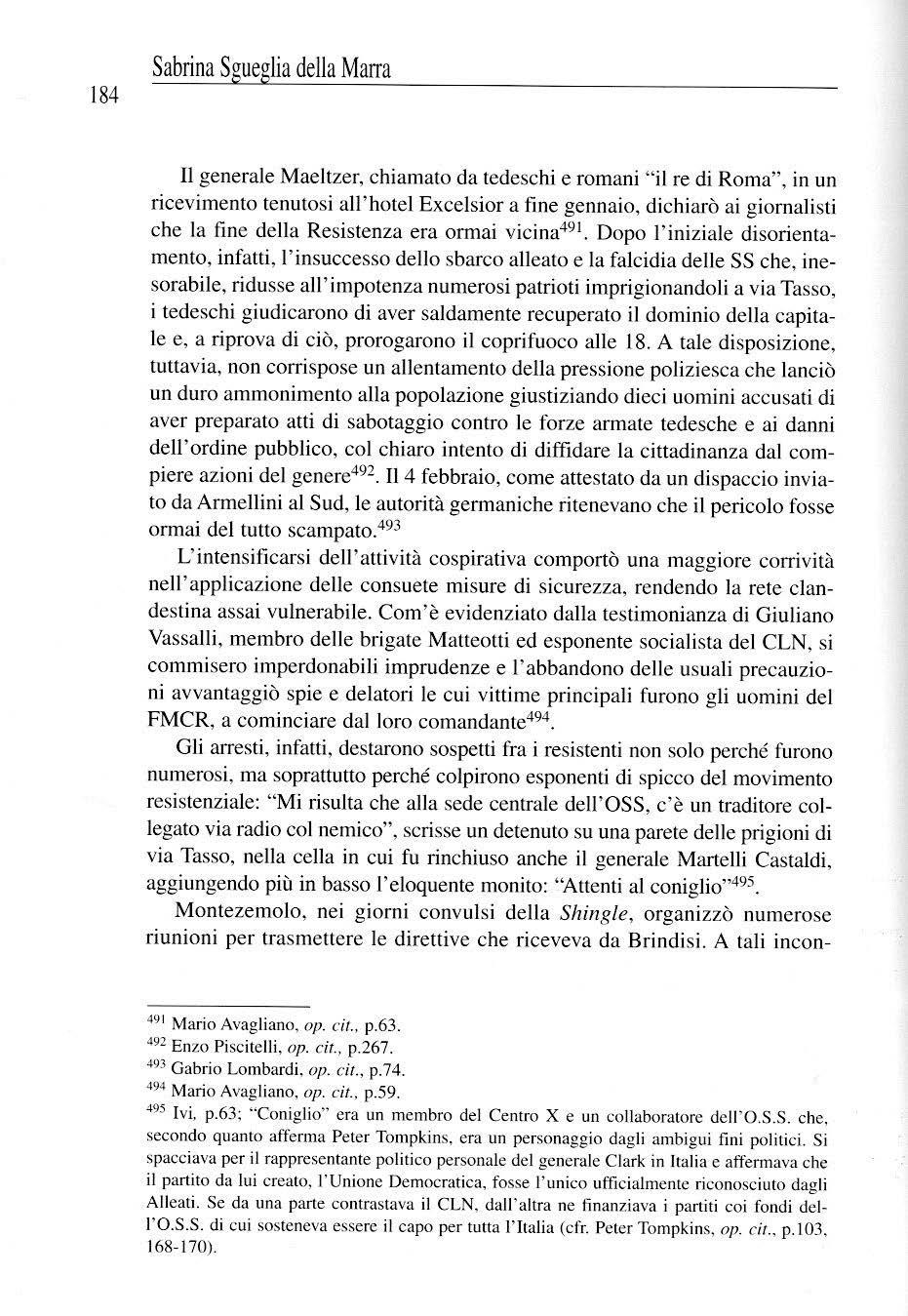
493 Gabrio Lombardi , op. cir., p.74 .
494 Mario Avag liano, op. cit., p 59.
49 5 Ivi, p.63 ; "Coniglio" era un m e mbro del Centro X e un collaboratore dell'O.S.S . che, secondo quanto afferma Peter Tompkin s, era un perso naggio dagli ambigui fini politici. Si s pacciava per i l rappresentan te politico pers ona le del generale Clark i n Italia e affermava che il partito da lui creato , l ' Unione Democratica, foss e l'unico ufficialm ente riconosc iuto dagli All ea ti Se da una parte contrastava il CLN, dall'altra ne finanziava i partiti coi fondi del1'0.S.S di cui sos teneva e ss ere i l capo per tutta l'Italia (cfr. Peter Tomp kins , op cir., p 103, 168- 170).
184
tri, veros im ilmente, riuscirono a partecipare infiltrati che carpirono informazioni deci sive per chi gli dava la cacc ia . L a mobilitazione ge nera le delle bande pro spettata dal colo nn el lo, se ppur volta ad agevolare l 'avan zata a ng loamericana e, d un q ue, ad accelerare i tempi della l iberazione, s' imbatté in for ti ed inopinate resi s tenze. Alla luce di tali d isse ns i , Am endo la ha d e dotto che l ' arresto del colon ne ll o fu favorito d a q uell e fo r ze decise ad impedire in ex trem is un intervento popo lare e ad incrin are la co llaborazione ormai compiutamente de l ineatasi tra i partiti del CLN e il FMCR496 Montezemolo era da tempo sorvegliat o e la polizia, dopo m esi di affannose ricerch e, era ormai s ull e s ue tracce . Nel l 'ult imo colloquio con la moglie , egli si di sse certo che, una volta preso, sa r ebbe stato sic uramente fuci lato . fn un o de i loro fugaci incontri, le aveva c hi esto perdono per ave rla tra sc inata, insieme ai loro cinque figli, in quell'impresa di cui , evi d entemente, present iva i l drammatico e pil ogo 497
Il 25 gennaio 1944, Mo nte zemo lo , sorpreso con De Grenet, ve nne arres tato dall e SS e condotto al carcere di v ia Tasso, sede dell' Einsatzkommande der SJPO und des SD der Stadt Rom (Comando di S icurezza e di Polizia di Roma)498 •
Il capo del FM C R aveva trascorso la notte tra i l 23 e il 24, le sue ultime ore di libert à, a pa lazzo R ospigliosi.
Il giorno s eguente, verso le nove e trenta della mattina, si era recato ad un co nv eg no in piazza Mignanelli , ove, secon do la testimonianza di R enato Montezemolo, si premurò di emanare ulteriori direttive per le bande dell'Italia settentriona le e per gara nt irn e i collegamenti anche quando il fro nte s i fosse s po sta to a nord della capi tale. Sulla base delle notizie perv e nu te e riferi te prontam e nte ad A rm ell in i, sos tenne la necessità di eseg uire azioni di g uerriglia e di sabotagg io. Propose altresì i nomi di d ue generali cui assegnare il comando dei settori e diede di s posizioni per ottenere notizie di alcuni dete nu ti in via Ta sso, in pa rticolare di Frignani. Per R oma tu tto era pronto. Era stata raggiunta l'int esa coi partiti, i ri s ul tat i co nseguiti potevano considerars i provvisoriam e n te soddisfacenti. Gli obiettivi di ciascuna banda
496 Giorgio Amendola , op. cir , p.274 .
497 Gabrio Lombardi, op. cit., p.63.
4 9 8 Il servizio d i po Jj z ja e d' in formazione germanico e ra cost itu ito da tre principali divi sioni: la Ordn ungspo li ze i, c he vest iva l' uniforme, cui erano assegnate normali funzioni di poli zia quali la tutela de ll a legge e il mantenimento dell ' ordine pubblico; la SicherheitspoJize i, la polizia di sicurezza , in uniforme o in borghese a seconda dell ' impi ego, s uddivisa in poli z ia crimina le e poli zia s tatale segreta o Ge stapo; infine , il Sicherheitsdients des Re ichsfuhers Schutz Staffe) o SD, il Servizio di sic urez za ed informazioni del pa rtito na zista. fo rmato dall'elite del panito.

Montezemolo
e il Fronte Militare Clandestino
185
Sabrina Sgueglia della Marra
erano sta ti co ncordati e definiti: si discusse pertanto b reve mente su dettag li relativ i a ll e modalità operative499 •
Secondo Catanzaro, Monteze mo lo riten eva che proprio que l g iorn o, il 25, gli All eat i si sareb bero spinti tin o a Roma. Ta le ottimistica previsione fu corroborata da un di sp accio radio pervenuto a l C e ntro X ed int erpretato come se gli angloamer icani avessero programmato un altro s barco ad Ostia. Il co lonne ll o ne evinse c h e l'obiettivo fosse Roma e, calco la ndo le forze a d isposizione di Kesselring, r iten ne assai probabile che l'operazione avesse buon esito. Fece, pertanto, diffon d ere a rtata mente la fa lsa notizia c h e la V Armat a ameri cana del genera le C la r k si accingesse a s barcare nei pressi di Ci vitavecchia, a S. M a rin e lla. Il coma ndo tedesco di Monte Soratte fu in dotto , così, a spostare truppe in quella direzione500.
Alle 13 d el 25 gen naio si tenne un a ri un io ne tra Arm e llini, M ulted o e Montezemo lo a casa di D e Grenet, in v ia Tacc hin i. Verso le 15 uscirono per primi d al portone del p a lazzo Multed o e Armellini seg uit i, a poca di stanza, da Montezemolo e De Gr e net. Avvicinati dalle cinque SS appos t ate all'usc ita, fu rono co stretti a fe r marsi e a mostrare i documenti 501 . Kap pl e r, no nost an te la falsa ide ntità assunta dal colonnello , che fece un so lo te ntativo d i nasco ndere le proprie generalità, lo ricono bbe immediatame nte502 ma domandò lo stesso a De Gre net da quanto tempo non lo vedesse, ed egl i rispose che da al m eno due mesi no n aveva no contatt i.
I nazisti confidaro n o che q uesti im p ortanti arres ti avre bbero finalmente sc iol to e portato alla luc e la complessa trama dell'organizzazio ne ma , ben presto, d ovettero rendersi co nt o dell ' imposs ibili tà di estorcere anche la più in s ignificante confess ione al capo del FMCR.
Un reduce di v ia Tas s o fornì alla mog li e Ju ccia un parti co lareggiato r es oconto "dell'inferno de ll a via malfamata" :
(Mon tezemolo) fu condotto in cella la notte del 25 gennaio ad ora tarda. Lo vidi arrivare ne llo stesso piano ove era l a mia cella, sangu ina nte in vo l to , co n qualche grumo di sa ngu e alla bocca, la mascella leggermente spostar.a a sin istra, un occhio t umefatto. M algrado le eviden ti soffe renze camminava alto nella persona, la testa fieramente sollevata, P ortava i l cappotto col bav ero al zato. Fu aperta la po rta de ll a ce ll a I- a , vi fu s pinto dentro e vi fu rinchi uso.
Il suo portamento nobile e austero non si era mod ifi cato. Visse comple tamen te segregato, co l viso sconvolto dall e percos se
499 A U S.S .M .E., 1-3, b.146 , f.7 , "Azione di comando del Fronte Clandestino gennaio-gi ugnp 1944", relazione del capitano di fregata Renato Montezemolo. soo Giuseppe Maria Catanzaro, op. c it., pp.143 - 144. 50 1 lv i, p. 131.
502 Renato Perrone Capano, op. ci t , p.274

186
TI colonnello non s'i lludeva sulla sorte che lo attendeva Ci incitava ad aver fede ne i destin i della Patria , ma parlava della morte con familiarità, con una ca l ma e un a serenità sconcertanti. Non ebbe ro alcun riguardo per lui , nemmeno quando, a seg uito delle percosse s ubite e della frattura della masc e lla , gli sco pp iò un a vio len ta mastoi dite
. . .In tan to orrore , Montezemolo ha sempre conse r vato la sua dignitosa calma. Non l 'abbiamo mai sen tito lamentarsi, non aveva mai bisogno di niente , non chiedeva mai nulla. Questa fermezza d i carattere in cuteva r i spetto e soggezione a t u tti , anche ai p i antoni più cattivi, anche agli sg herr i più inferociti delle SS naziste In un a lurida cella, ma l andato in s alute, egli era se mpre di esem pio a noi. Era il Maestro, il Comandante503
Un a ltro deten uto raccontò che il capo del Fronte m il itare " pur tra gli sghe rri tedeschi", malgrado "gli abit i e il viso sconvolt i dalle percosse, aveva conser va t o lo sg u ardo fer mo e sicuro" 504 . Mo ntezemolo , durante l a pe rqu isizione effettuat a a via Tas so sub i to dopo l a cattura , fu trovato i n possesso d e l proc l ama prepara to pe r la cittadi nanza nell ' eventualità dell'occupazione di Roma da pa rt e d egli A lleati , considerata proba bile fino a l 25 gennaio. Interroga to in me r ito a l docume n to , affermò di ave rlo redatto a l solo s copo di ass ic u rare la rego lare e pacifica trans izio n e d e l potere 505 Egli, auspicando di essere sottoposto a processo, fin dai prim i interrogatori, si preocc up ò di im b astire una linea difensiva che va l esse a r isolvere la s ua situaz ione nell'ambito poliziesco ma so prattutto nella spera nza che il caso venisse d eferito a l la pretesa lega lità del tri bunale degli u fficiali d e ll a Wehrmacht , anche per la cono s cenza p erso nal e del cap ita no Schutz506
In un bi g lietto che fece pe rvenire dalla p ri gio ni a, dando istruzioni per la sua liberazione, consigliò di rivolg e rs i al colonnello Calzavara che aveva mantenuto rapporti amichevoli coi tedeschi. Tuttav ia, questi rispose d i no n potersi occupare della que stio ne 507 Come ha raccontato il figlio Manfredi, fu interessato alla vicenda l 'avvocato Bruno Cassinelli 508 ; si diceva fosse u na spia tedesca e, probab ilm ente, p er ottenere un trattamento di favore in seg uito , s i diede mo lto da fare per te ntare di liberare il colo nnello509.
5o3 Ange lo Anwni o Fumarola, op. cit , pp.95 -96
504 Gabrio Lombardi , op. c ii., p.64

5o5 Giuseppe Maria Catanzaro, op cii. , pp. 168 - 169.
506 Ivi , pp. 170 - 171.
507 A.U.S.S.M.E ., l -3, b.146 , f.7, relazione di Manfredi Montezemolo.
508 Il nome di Bnrno Cas si nelli compare nell 'ele nco dei collaborazionisti che Radio Bari, sulla base di notizie giunte da Roma , divulgò nel maggio del 1944.
509 A.U.S.S.M.E. , l-3 , b.146 , f.7, relazione di Manfred i Montezemolo.
Montezemolo
Militare Clandestino
e il Fro nte
187
Sabrina Sgueglia della Marra
Bonomi, annotando l'acc aduto nel suo diario, affermò con rammarico di aver appreso la notizia dell'arresto di Montezemo lo 5 10 , mentre Am1ellini, il 30 gennaio, ne informò Brindisi con un dispaccio radio:
Venticinque M at uscita appuntamento cui partecipavo alt ignorasi se pe r delazione aut piano predisposto da tempo alt M attua lm ente Regina Coeli non escluso sia stato seviziato per indurlo confessare5 11
Come attestato da questo messaggio, in un primo momento si pensò che il capo del FMCR fosse stato portato a Reg ina Coeli e non a via Tasso. Armellini, preoccupato per le conseg uenz e politiche e militar i che sarebb ero derivate dalla grave perdita, propose di effettuare uno scam bio tra un importante prigioniero tedesco e Montezemolo , la c ui guida, come i mesi successivi avrebbero confermato , risultava indispensabile all ' organizzazione512
Kappler considerò l' arresto del colonnello un successo pe rso nale , conosceva l'i mportanza d ella preda su cui aveva messo le mani e ricorse ad ogni mezzo per indurlo a parlare, senza ottenere alcuna confessione. Secondo il s uo racconto, il colonnello ammise di esse rsi dedicato alla lotta contro i tedesc hi , ma non fece mai il nome dei suo i collaboratori nono stante la bru talità delle tortu r e che dovette subire 513 . Il capo de lle SS, come avrebbe affermato nella sua d epos izione al processo del 1948, sapeva bene che il colonnello e ra stato inc aricato da Badoglio di rimanere a Roma per la lotta clandestina quale capo di stato maggiore del generale Calvi di Bergolo.
Egli - disse - aveva il compito di tenere i contaui con gli ufficiali rimasti fede li al re e a Badoglio. All'uopo si costituì un segreta riato militare presieduto da Montezemolo, di cui faceva parte anche il generale Fenulli. L'organizzazione di Montezemolo era già pronta per effett uare una rivolta aperta a Roma: l'armamento era stato approntato ed ogn i uomo aveva avu to assegnato il s uo compito514
5 10 Jvanoe Bonomi, op. cit. , p 144.

5 11 Gabrio Lombardi, op. cit , p.74.
5 12 A.U.S .S.M . E. , N.1 -11 , Diari 2ò Guerra 1non.diale, b.3062, allegato n . J051, "Notizie da Roma", Comando S upremo, Ufficio Operazioni , al la Segreteria Particolare di S.E. il capo del governo, 30- 1-1944; A.U.S.S .M. E , N.1 -11 , Diari 2a Guerra mondiale , b.3062 , allegato n.1052 , "Notizie da Roma'', Comando Supremo, Uffic io Operazioni , alla Segreteria Particolare di S E. il capo del governo, 30- 1- I 944.
5 13 Robert Katz ha accennato ad un rapporto in fondato archiviato da un u fficiale dell ' O.S.S. in cui si affe rm ava che probabilmente Monte zemolo, cedendo alle t orture , avesse provocato l'arresto d i Cervo e Bonocore. Tale ipotes i ovviamente fu smentita ed ebbe poco credito, poiché a Roma tu tti sapevano che, malgrado le sev izie , il colonnello non fornì la benché minima in formazione ai tedeschi; cfr. Robert Katz, Roma città aperta, cit., pp .235 -236.
514 Il Messaggero, 4 giugno 1948, in Mario Avagl iano, op. ci i ., p.52.
188
Montezemo lo , subito, senza acc usare nessuno, dichiarò quello che aveva fatto e quello che aveva in animo cli fare. "Voglio p recisare - agg iu nse Kapp le r - che mai da parte nostra era stato riconosciuto il merito d i un so ld ato come al colonnello Mon teze molo" "Devo dire - chiosò l'ufficia le - che ero commosso del suo modo di agire. Anc he Schultz era commosso con me" . T rascinato co ntinuamente dalla cella in cui venne rinchiu so, pr iva di ill umi nazio ne e co n le finestre murate, una vo lta adibita a cucina, il capo del FMCR fu sottopos to ad un trattame nto disumano: ve nne colp it o più volte con lo spacca masce ll e e i l pugno d ' acciaio , battu to ripe tutamente con fruste e caten e . Un prigioniero del secondo piano ha riferito che , mal grado ciò, eg li co nservò sempre la sua dignitosa c alma:
Non l'abbiamo mai sent i to lamentars i, non ha mai bu ssa to alla porta, non aveva mai bisog no di niente, non chiedeva mai nulla . Que sta fermezza di carattere incuteva rispetto e soggez ione a tutti, anche ai piantoni più catt ivi , a nche ai marescialli delle SS pit1 inferociti 515
Il dottor Cardente che, convoca to da Kappler, s i occ u pò come meglio poté de i d etenuti nel carcere tedesco a partire dal febbraio 1944 , ebbe modo di incontrare varie volte Montezemolo, la cui "alta e simpat ica perso na", nonos tante le pess im e condizioni di sal ute, colpiva "pe r la forza del carattere che emanava d a quel volto energico e ne l co n tempo signori le" 516

A null a valsero gli este nuanti interrogatori e le bruta li sevizie dei carcerieri di via Tasso: egli rest ò fede le al suo impegno d'onore e , avendo a cuore cos tantem en te la sorte dei s uo i collaboratori, tra le not izie più import anti che riuscì a far trapelare dalla prigione, avvertì suo fratello Renato che i tedeschi in sistevano con ogni mezzo per esto rcergli in formazioni circa il prof. Bianc hi, ps eu donimo del colonnello De Miche li s, e il dott. Gian nini, iden tità di copert ura assu nta dal ca pitano Jannotta517
D u rante i cinq uantotto giorni di prigion ia, riuscì più volte a comu ni car e fatti con s ua cugina, la marchesa Fulvia Ripa di M eana, cui affidò i suo i desideri e le sue speranze: "Se tutto andasse male - scrisse in uno dei m essagg i fatt i recapitare alla famiglia - Juccia sa ppia che non sapevo di amarla tanto: rimp iango solo lei ed i figli Confido in Dio. Però occorre aiutarsi Io non posso che res istere e durare. Lo farò per quanto umana mente poss ibi le. Insi -
517 A.U.S.S.M.E., l-3, b.146, f.7 , "Azione di comando del Fronte Clandestino , ge nnaio- gi ugno 1944", relazione de l capir.ano di fregata Re nato Montezemolo.
Montezemo lo e il Fronte Militare Clandesti no
5 15 Gabrio Lombardi , op. cit. , p 65. 51 6 Re la zione del dott. Rodosindo Cardente , A.N.F.I.M. , p.8.
189
Sabrina Sgueglia della Marra
stete per la sol uzione totale. 11 Vaticano chieda l ' internamento. Se vuole può ottenerlo e risolvere tutto" 51 8 •
Secondo la testimonianza dj Catanzaro, il colonnello, sentend o v ic ina la fin e, scris se il suo testamento su tre fogli di ca1t a velina che ri us cì a rimed iare in cell a e lo fece pervenire alla fam iglia arrotolato nel thermos di Frig nani 51 9 •

Tra lo sgo mento generale per la sorte di Mo ntezemo lo , prese sempre più corpo l ' ipotesi ili una delazione ai s uoi danni, suffragata anche dal fatto c he Multedo e Armellini , usciti poco prima dal portone del palazzo e di stanti circa venti me tri, furono ignorati dalle SS . Il figlio Manfredi, in una relazione in cui ha documentato il periodo della s ua collabo razione col FMCR, ha avanzato dei sospetti s ull'arres to de l padre, precisando tuttavia , di non disporre di prove certe, bensì di rifl essio n i nate da singo lari coincidenze. Manfredi ha riferito un episodio appreso da Motta secondo c ui il colo nn ell o Musco , in un gio rn o imprecisato, era stato s everamen te rimproverato da Mon tezemolo perché, contravvene ndo agli ordini ri cevut i, non aveva inviato un telegramma al Sud. Natura lm ente, ciò insinuò il du bbio nel senatore e in Manfredi c he no n si fosse trattato di un cas o isolato ma ch e il capo del FMCR avesse d ep lo rato il co nteg no del suo affiliato in altre occasioni. Motta d ichiarò altresì che Musco, verosimilmente per i richiami fre que nti d i cui fu oggetto, intraprese un ' accanita camp ag na diffamatoria contr o il suo s uperiore .
All ' inizio di marzo, il senator e fu arrestato dalla polizia fasc ista e tras portato prima alla pensio ne Jaccarino, p oi a San Gregorio , infin e a Castelfranco Emilia. Il commissario M u sco, malgrado la s ua fami l iarità col questore Caruso e col vicecapo della po li zia Cerreti se, per altre personalità, era stato in grado di avvertirle dell'imminente cattu ra, per Montezemolo e Motta non si attivò né s i mise a disposiz ion e per te ntarne la liberazio ne .
Tale atteggiame n to destò perp lessità in Manfredi che, success ivame n te , ricostruì l'accaduto in s ie me a l figlio de l senatore e al comm. Ballarini, che aveva collabo r ato co n s uo padre fu ngendo da tramite con vari capi di partito. Da tale co nfr onto , emerse che, il giorno d e l suo arresto, M ontezemolo si era recato di mattina ad una riunione a casa Ballarini con Armellini, i l commissario Musco ed a ltr i esponenti dell'organi zz azione . Verso le undici, s i recarono da Motta e M usco si co n ge dò frettolosamente. Alle tredici, Monte ze mo lo ed A r m e llin i erano a casa De Grenet per un altro abboccame nto e si fermarono per il pranzo. Verso le quindici, come si è detto, appena usciti di casa, Montez e mo lo e D e Grenet furono catturati. Quel g io rn o, o il giorno prima, il colonnello sottosc r isse un finanziame.n-
190
5 18 Ful via Ripa di Meana. op. cit. , p 11.
5 19 Giuseppe Maria Catanzaro, op. cit , p. l 71.
Montezemolo e il Fronte Mjlitare Clan desti no to di parec c hi m ilioni. De Grenet si sarebbe d ov uto occ up a re della parte am ministrativa.

Ana logame nte, il senatore Motta fu arrestato me ntre era in trattative per un s uss id io di circa sessa nta mili o ni c he venne fi rmato il giorno seguente da l colonnello Mu sco. Questi, co n la designazione di Bencivenga a Comandante c ivile e mili tare di Roma, raggi un se u na posizione di notevole potere e prestigio.
Manfred i h a evidenziato la singolare coinciden za che, per ben due volte, proprio nel gio rn o in cui ven nero sta bi liti de i finanz iamenti, ne furono arrestati i responsa bili , ovvero coloro che avre bb ero dire tto e controllato la des tina z ione e l'im piego di ta li fondi. Ha aggiunto , infine, c he M otta e Montezemolo s i e ra n o pi ù volte irritati per le assi lla nti richieste di d enaro avanzate dal colo nnello Musco520 .
I l cap itano d i fregata Renato Montezemolo, durante l' att iv ità tendente a l iberar e i l frate llo , ebbe modo di avvicinare Elena Hoh n che, nei mesi precede nti, era sta t a aman te d el tene nt e colonn e llo F ri gnani. Su di essa s i c o nce ntraro no i maggiori sos petti riguardo a ll 'a rresto dei numerosi espone nti di s picco de l FMCR.
Come attestato da l rapporto di d e nun cia della don na , acc usata di aver favorito l 'arres to di Frignan i , nel cors o d ella loro freq ue nt az ione e lla era riuscita a guadagnarsi in teramente la fiducia del colon nello , tan to da diventare uno s trum en to attivo d ell 'org anizzaz ione clan de stina. Po té q uindi assistere soven te ai collo qui che si tenevano tra Fri g nani, Av e rsa, Caruso, ed apprende re così info rm azio n i sull'attività del mov im e nto, sui pi a ni in proci nto di essere realizzati e s ull 'ubicazio ne dei dep os iti d i armi. O gni giorno veniva a conoscenza di nuo vi importa nti par ticolari s ul Fronte militare ed i suoi membr i. Non a caso, l ' arresto di De Carolis, Aversa e Frignani avve nn e a casa de l marito di Elena Ho h n521
Il FMCR si adope rò co n te na cia ne ll a speranza di sa l var e il co lon ne llo d alla prigionia, non lasciò nulla d ' in te nta to. Re nato M o nt eze molo, che tanto si prodigò per la v ita de l frate ll o, ha raccontato che dapprima si p ens ò di raccoglie re u n quantita ti vo d'oro del valo re di circa d ue milioni per ottenerne il rilascio Tale tentativo di corruzione, in acco rdo co l generale O done, fu affidato a l tene nte colonnello dell ' aviazio ne repubblicana Lo ffranco, s ed icente a mi co personale di Ke sse lring 522
52 0 A.U.S S.M E., /-3, b 146, f.7, Relazione di Manfredi Mon tezemolo. 52 1 A S .R , Sede succursale , Corte d 'App ello di Roma, Corte d'A ss ise, sez istruuoria, fas c .1 4 18, foglio 19. 522 A.U.S.S M.E , l- 3 , b.146 , f.7, "Azione di co mando del Fronte C lande st ino , gennaio -gi ug no I 944", relazione del cap ita no di freg ata Re nato Monte zemo lo. 191
Sabrina Sgueglia della Marra
Secondo la testimonianza di Manfredi, quando fu arrestato Ercolani , otto giorni prima del padre, Montezemolo lo aveva incaricato di occuparsi della sua scarcerazione seguendo tale s trada. Ri s ulta va, infatti, che dietro forti ricompense in denaro, Loffranco avesse fatto liberare numero si pr ig io nieri dei tedeschi 523 Gli fu dunque corrisposto il cospicuo a ntici po di trecentomila lire ed egli garantì un intervento celere e risolutivo. Alle in sistenze dei vertici del Fronte che premevano per avere notizie, L offranco replicava con una se rie di assicurazioni e promesse che, ricche di particolari, in un primo momento sembrarono provare una reale so ll ec itudine ma, ben presto, s i accla rò la s ua malafede e s i scoprì che erano solo menzog ne 524 . Renato Montezemolo s i rivolse allora al capo del s ervizio informazioni tede sco a Roma , il maggiore von Grisheim , con cu i ebbe u n lungo colloquio . Qu es ti esaminò attentame nte il caso sottopostogli ma il dissid io interno tra esercito e Ges t apo e gli oggettivi conflitti di competenza che avrebbe implicato il s uo interessamento, resero inattuabili le ipotesi prese in con s iderazione 525 .

A tali sfo rzi si affia ncò parallelamente il tentativo di far trasferire i l colonnello in una clinica al fine di alleviarne le sofferen ze causate dalla brutale r eclusione. I famil ia ri si affidarono alla mediazione dell'a mabasciata tedesca presso la Santa Sede ma, a nche stavolta, malgrado le critiche condizioni di sa lute per le torture sub ite, le pre ss ioni esercitate ri sultarono vane 526
Com e h a raccontato il figlio Andrea , fortunatamente, ali' inizio di marzo, il temporan eo trasferimento al quarto piano, arrecò a Monteze m olo un leggero sollievo: gli fu concessa una sedi a a s draio ove riposare e, poiché da n sarebbe stato impos s ibile evadere, le por te furo no !asciate aperte, consente ndo all' aria di ci r colare più agevolmente. In quei giorni , egli eb be occasione di conoscere Milaide Ri ccio, moglie di un ufficiale di marina , che, sapendo di es se re pross ima alla scarceraz ione , si premurò di domandare al colonnello se avesse bisogno di qualcosa. Egli, prudentemente, si ri s e rvò del tempo per pensare. P ersuasosi delle since re intenz io n i della donna, la pregò di portare i su oi salut i alla moglie e di avvisare alc un i esponenti dell 'organ izzazione di agire con avved utezza e circospezione perché i tede schi erano sulle loro tracce.
La marchesa Fulvia Ripa di Meana s i adoperò con ogni mezzo per tentare la liberazione del cug in o . Intraprese una battaglia quotidiana incuran te dei
523 A.U.S.S.M.E., /-3 , b.146 , f.7, Relazione di Manfred i Montezemolo.
5 24 A S R. , Sede su ccurs ale , Corte d'Appello di R oma, Corte d'Ass ise, sez istruttoria, fasc.836, allegati n.1 36-I 37.
5 2 5 A.U S S M .E., /-3 , b 148, f.4 , " Re la z ion e del cap itan o di fregata Montezemolo ", al Comando S upremo- Ufficio Personale Affari Vari, 16-7-1944.
526 A.S.R., Sede s uc cursale, Corte d' Appello di Roma, Cort e d ' Assise, sez istru ttoria, fasc. 836, allegato n.137.
192
rischi cui s i esponeva e degli inviti alla p ru denza che prove n iva no non s olo dai fami li ari, ma dalle stesse autorità germa ni ch e527 La coraggiosa don na si moss e nell'am bie nte de ll'aris to cr azi a romana , face ndo appello a tutte le sue co noscenze e, tramite il principe Francesco Ru spo li, otten ne u n colloquio con Dollmann. Fu ricevuta dal capo delle SS il 3 marzo e, dall'incontro , em erse la profon d a stima ed il rispetto di cui il colonnello god eva p resso 1e au torità tedesc he, come uomo e come soldato .
Mo ntezemo lo, t uttav ia, era ormai co nsiderato il più acerrimo avversario dei tedesc hi co me , peraltro, egl i stesso no n si peritò di ammettere d uran te i feroc i interrogatori, di c hi ara ndo di aver lavorato contro di ess i con t utte le sue forze e dovu nque gl i fosse ri uscito possibile 528
La costante presenza della marchesa a via Tasso irri tò Kappler, tanto che uno dei s uoi uffic iali la ammonì di non present arsi ancora e di desistere dai s uo i proposit i p er non incorrere a sua volta in u n arrest o529
A p ar ere d i D oll m an , per Kesselring e il s uo s ta to magg io re, era risultato assai penos o accettare che i più valenti ufficiali italiani di carriera, con cui s i era combattuto s ino al l' 8 settembre, s i ad operasse ro in ogn i modo p e r sa botare il loro sforzo beHico e provocare la sco nfitt a dell 'ex all eato tradito. Le prove a c arico di Montezemolo erano dun q ue gravissi m e, pertanto, Dollman asserì di non pote r intercedere presso Kap pler in s uo favo re. In oltre, sp iegò alla marc h esa Rip a di Meana che una ri chi esta del genere es orbitava dalle s ue attribuzioni: egli non aveva la possibilità m ateria le di dare ordini o consig li are il tene nte colonnello ne ll 'a mbito d elle sue specifiche compete nze, ovve ro, la neu tral i zzazione dell' intero movimento di resiste nza, secondo l ' ordine di Ke sse lrin g530.
Esortata dal cug in o attraverso un messaggio che 1e fece fortuitamente recapitare, la march esa Ripa di Mea na cercò di otte nere udienza pres so Pio Xli. Gra zie a ll ' interessament o della pri nc ipessa Colonna, poté incontrare Mo ns ignor Nasalli Rocca , Maestro di Camera de l pontefice e cappellano presso Reg ina Coe li , c he , il 19 ma rzo, la int rod usse nello stu dio d el Santo Padre. La marchesa , ri so l uta ad otte ne re la sc arceraz ion e o , quantom en o I' estradiz io ne di Mon te zemo lo, portò con sé un promemoria per illus trar e al meg li o le ragioni che rendevano q uanto m a i necessario fare pressione sui ted esc hi affinché ri lasc iassero il ca p o del FMCR. Con la sua liberazio ne,
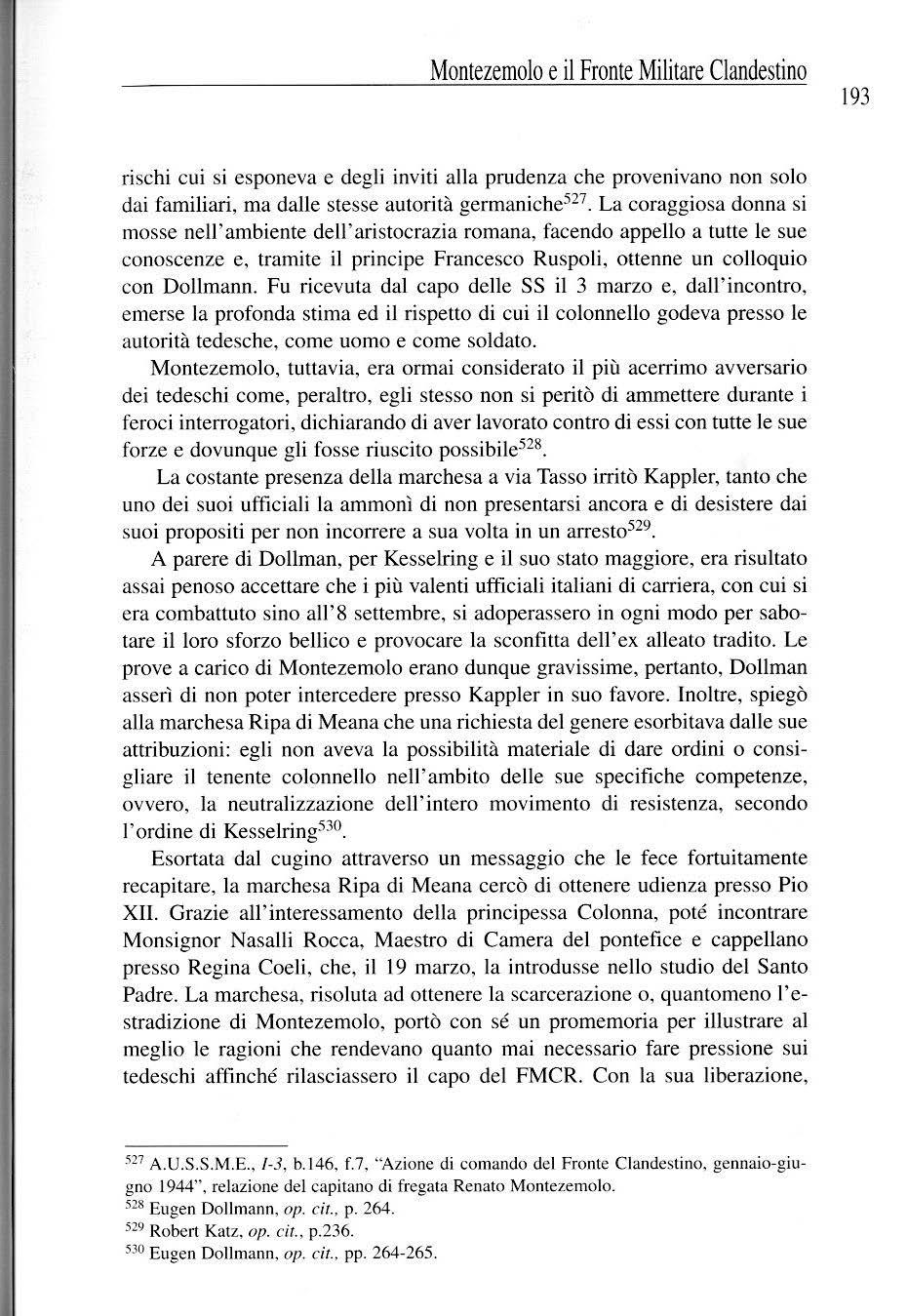
527 A.U.S.S.M.E., /- 3, b. 146, f.7, "Azione di co mando del Fronte Clande stin o, ge nnaio- giugno 1944" , re lazione de l capitano di fregata Renato Montezemolo.
528 Eugen Dollmann , op. cit., p 264
529 Robe rt Katz, op. cit., p.236
530 Eugen Dollmann, op cit. , pp. 264 -265
Montezemolo e il Fro nte Militare Clandestino
193
Sabrina Sgueglia della Marra
in fa tti , non solo si sareb be sa lvata la vita ad u n uo mo so ttopos to a terribili torture e che altrimenti avrebbe av uto la sor te seg nata, ben sì ne avreb be conside revol mente giovato la sicu r ezza e la pace soc iale della città. Facendo abilmente leva su lle preoccupazioni di papa Pacell i, Fulvia Ri pa di Meana sotto lineò il costan t e impegno del colonnello per la salvaguardia della popolazione e ramme ntò co me egli avesse in più occas io ni ri s parmiato la ca pit ale dai bombardamenti in discriminat i , s egnalando t e mpe stivamente e con p recisione agl i Alleati, d i cui era divenuto il principale referente, gl i obiett ivi da co lpire. Nel periodo d'emergenza tra la ritirata tedesca e l'ingresso degli a ngloamericani, pertanto, i l cap o del FMCR avrebbe potuto garantire il regolare passaggio dei poter i ed il mantenimento de ll' o rdine pubblico preservando la cittad in anza da ulteriori patimenti e d evas tazioni.
Il po ntefice ascoltò co n attenz io n e; s i fece lasciare il memoran d um e pro mi se che avrebbe fatto tutto ciò che era in suo po t e re. D apprima incaricò Mo ns ig no r Montini di occuparsi del caso ma, pochi giorni dopo , a causa d e ll e difficoltà presentatesi, la delicata questione fu sottopos t a al cardinale Maglione. Venne così red atto, seppur in ritardo, un nuovo promemoria e furono inviat i appelli all ' ambasciata t ed esca presso la Santa Sede. A vanificare ogni sforzo sop ragg iun se tuttavia la notiz ia che il capo del FMCR risultava tra le vitt im e dell'eccidio del 24 marzo Ogni p asso verso le a u torità germanic he ven ne sospeso 53 1
Anche il ge nerale Armellini, seco ndo la testi monianza di Renato Montezemo lo, diede il s uo contribu to per ottene re la scarcerazione de l co lon ne llo peroran do ne la ca usa presso le auto ri tà diplomatiche ing lesi della Santa Sede e l' Intell igence Serv ice.

Si st udiò, inoltre, la possibilità di far rico noscere il FMCR come u n moviment o volto esclusivame nte alla t utela della pubblica s ic urezza a l fine di accreditarne la piena legitt imità agl i occhi dei tedeschi. Se ne occupò il duca Fabri z io Catalano Gon zaga di Cirella ma, anche stavolta, senza risul tati.
Contemporaneamente a tali te n tativ i, si n dal giorno s uccessivo all'arresto, Renato Mont ezemo lo p ropose a l generale Odon e di sferrare un co lp o di mano co ntro il carcere nazista. F u necessa r io molto tempo per anal i zzare il prog etto, individuare la precisa ubicazione d el colonnello all'interno dell'edificio, effe tt uare soprall uo gh i nelle immediate vici nanze di via Tasso e d efini r e l'ardita i nc ursio ne nei minimi particolari. Odone mise a disposi zione d e l piano la b anda costi t uita dal capitano p aracad utis t a Costanzo c he si sarebbe avvalsa d e ll a collaborazione d el capitano carris ta Batt i sti .
194
53 1 Robert Katz , op. cii pp 236 -239.
L' impresa , tuttav ia, s i p rea nnunciava irta di in sidie e priva di reali speranze d i su ccesso, perta nto, non ri ceve tte mai il v ia libera. L'o rganizzazione, p ur non entra ndo mai in funzio ne, restò pronta ad agire anche dopo il massacro d e ll e Fosse Ardeatine, fino al 20 apri le 1944.
li capita no di fregata Montez e molo e il genera le Odon e ha nn o alt resì evidenziato la sollecitud in e ed il ta ng ibi le interessamento del Part ito Com un jsta ne i confronti d e l capo d e l FMCR , pe r la cui salvezza fu p rogetta to u n assalto armato al carcere di via Tass o 532 An che tale disegno non si tradu sse in realtà per le es igue po ssibi lità di ri usc ita , m a il su o sig nifi cato , al di là della mancata attuazione , risiede nella so l ida ri e tà umana di cui fu alta esp r ess ion e e nell'afllato ideale dell ' alleanza ad esso sottesa.

Il tene n t e De Grenet, malgrado il breve period o che lo v i de a l fia n co di Montezemolo nella lotta contro i te desc h i, si rivelò uno d e i suo i più ferv idi collaborator i: ne condiv ise la cattura, la pr ig ion ia e l ' est remo sac rifi c io . Come ri corda to da Pa c in o tt i , nei gio rni i n c ui fu rinchi us o a via Tasso, De Grenet mantenne un con teg no "fermo e nobile " 533 e, nonostante il se l vaggio tratta mento s erbatogli , rifiutò di forn ir e la be nc hé minima ind icazio ne s u ll'attività s volta d al co l onnello e s u ll'apparato mili ta re che presiedeva.
I du e d etenu ti riu sc iron o ta lora ad in contrars i d u rante il pe ri odo di comune recl us io ne: una volta, il te nente, pe rce pe ndo il tormento de l s uo cap o, il cui volto tradiva il profondo rincresc im e nto di chi avverte i l p es o d ella responsab i lità, lo rassicurò affermando che, malgra do le sofferenze patite, q ual unqu e cosa fosse successa, non avrebbe mai rimpianto la notte dell'ultimo dell'anno in cui si erano conosciu t i534
In s egui to all'arre sto di Montezemolo , Armellini chiamò a s o s titu irlo il generale Od o ne , che g li s ubentrò in u n mome nto q ua nt o mai critico pe r i l FMCR. Secondo la testi m o nianza d i Renato M o nt eze molo , egl i no n possedev a una conoscenza approfondita dell'organ izzazione mi litare e d ella trama cospirativa che da essa s i irradi ava: il co mp ito di r iann od arne le fila e di riprist inarne le regolari att ività si pr ese ntò assa i oneroso . Il ge nerale, t uttav ia, dopo l ' iniz ia le disorienta m e nto, si mi se all'opera con coraggio ri schian do in prima p e r so na sull'ese mpio del su o pr edecessor e. Curò in pa r ticol are il set-
532 A S. R. , Sede succursale, Corre d'Appello di Roma, Corre d ' Assise. sez istruttoria, fasc.836 , allegato n .137; A.U S S.M.E., 1-3, b. 148 , f.4 , " Re laz ione del ca pitano di fregata Montezemolo", al Comando Supremo -Uffic io Persona le Affar i Vari , 16-7 - 1944
533 A U.S S.M.E , 1- 3, b.148 , f.2, "Tenente De Gre net Fi lippo. Propos ta di ricompensa " , Uffic io Stralc io , a l Mini stero de lla Gue rra, Gabine tto , 4 -8 -1 944 .
534 A .U.S.S .M .E ., / -3, b. 148, f.2 , "Tenente De Gre net Filippo. Propo st a di ricompensa", Ufficio Stralcio, a l Ministero della Guerra, Gab inetto , 4-8-1944.
Montezemolo
Clandestino
e il Fronte Mil itare
195
Sabrina Sgueglia della Marra
tore ass i s tenziale e, per rein tegrare , quantomeno nel numero, le perdi te inflitte dai rastre llamenti tedeschi, s elezionò nuov i ele menti d a impiegare in q uesta nuova fase 535
2. L'eccidio delle Fosse Ardeatine
li 23 marzo 1944, anniversario della fondazione dei Fasci di combattim ento, fu organizzata u na vasta az ione partigiana nella ca pi tale . Inizialmente la Giunta mi litare aveva previsto un d uplice attacco: al carcere di via Tass o e al corteo ch e, seco ndo i l programma del vicesegretario d e l partito fascista repubbl ic ano, Pizzirani, pubblicato sul M essagge ro, s i sarebbe co nclu so in via Veneto dopo l 'ad unata ali' Adriano .
L'az ione di via Tass o, t uttavia , risultò troppo risc hiosa se non preceduta da un'adeguata preparazione e l a parata fascista venne an nulla t a in una ri unione a villa Wolkon s ky in detta dal console Mohlau se n. Le celebrazion i , dunque, sare bbero s tate trasferite al minis tero delle Corporazioni. Il d iploma tico tedesco av rebb e successivamente so ttolinea to l'inopportunità di una s iffatta manifestazione che, a Roma, una città ridotta allo s trem o dalla fame che additava a l fascismo la res po nsabilità dei propri patime nti, sare bbe apparso un atto offensivo e pro voca torio, s e non u na vera e propri a is tigazione alla rivo lta.
Appresa la noti z ia dell'avvenu ta revoca del corteo, la Giunta militare ri so lse di pro cras tinare le due az io ni progettate, ed in loro sostituz ione, a pprovò un attacco terro ristico di vaste d ime ns ioni da sferrare contro le ce lebrazioni fasciste del 23 marzo , un' op era zion e di gue rri glia in via Rase lla c he , finalmen te, avrebbe co ron ato il programma in dicato, sin dall'ottobre, dai Gap , p er imp orre realmente lo status di città aperta. li fine p reci puo era scuotere la capit ale dal profondo e dimostrare perentorimente c he fascisti e tedeschi non erano padroni di Roma e no n potevano, pertanto, sfilare i mpun emente per la città: la Wehrmacht non era inv ic ibil e e l 'os tili tà della p opolazione si sarebbe espressa in tutta la s ua potenza536
Il gap pi sta Mari o Fiore ntini, dai primi di feb braio, s i a ppo s tò ogni giorno a ll'ango lo della via per osservare i movime nti dell 'o bi ettiv o c he s'in ten-
53 5 A U.S.S.M.E. , 1-3, b.146 , f.7, "Azione di comando del Fronte C la nd esLino , ge nn aio-giugno 1944", re lazio ne de l capitano di fregata Ren ato Mootezemolo . ·
536 Ales sandro Porte lli , op cii. , pp 152 - 153 , 188 ; Roben Katz, Mort e a Roma. Editori Riuniti , Rom a , 1994, pp .2 5- 28; Roben Katz, Rom.a città aperta, c it., pp.246-247 ; Rosari o Ben tivegna, op cit , pp.152 -1 55.
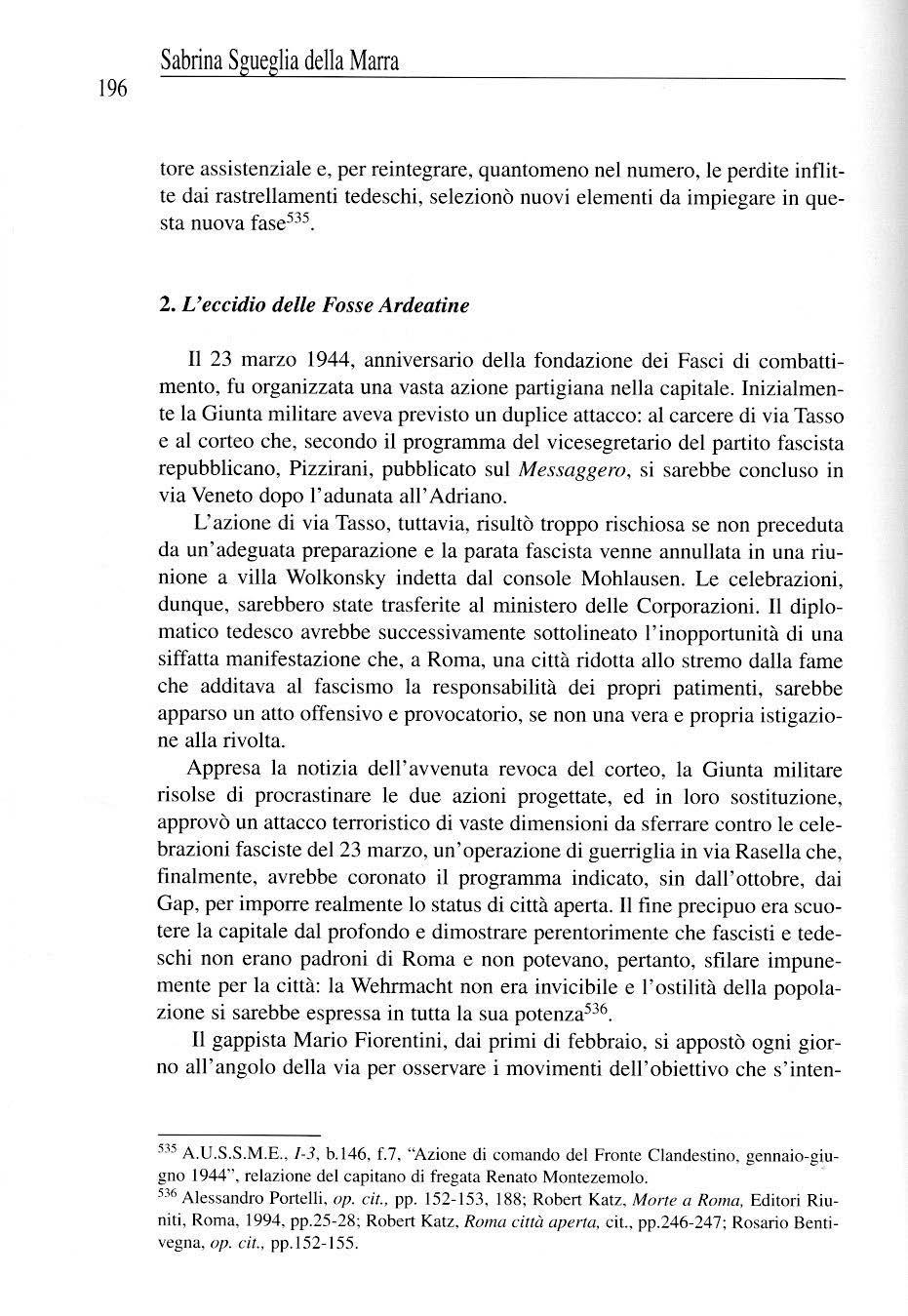
196
deva colpire, ov vero, l' Xl comp agn ia del III battaglione Bozen, in servizio d ' ordine pubb li co a Roma. Il 22 marzo 1944 Ca rl a Cappo ni ri tirò l 'esplos ivo pres so il FMCR537 • La mattina seguente, Rosari o Bent ivegna a ttraversò Roma a piedi, travestito da netturbino, s pin gendo fin o a v ia Rasella un carrett o che co nteneva dodi ci chi li di t rito lo ed a ltri se i chi li di esp losivo con pe zzi di ferr o sfus i coperti da immondizia. Era molto pesante, aveva u n doppio bid o ne quadrangolare e l'intero q uan titativo di tritolo fu co llo cato in quello posteriore 538
L'esp los ione ucci se s ul co lpo p iù di venti t edesc hi e ne inv estì altri trenta , di cui molti rimasero fe riti mortalmen te Vi furono anche due vittime civili, un uomo di quarantotto an n i e un ragazzo di tredici ; i partigiani riuscirono a fu ggire illesi.
In pochi minuti, la no ti zia si di ff use in t utta la ca pi t ale e s i recarono immediatamente sul luogo d e ll 'a tten tato il que s tore Carus 0-; ..che abbandonò la cerimonia fascis t a, e il ge nerale M aeltzer. Nella concitaz ion e ge nerale , comi nciarono i rastrellame nti: tutt i coloro c h e s i tro vavano in via R ase ll a e ne ll e st rade attigue vennero all ine a ti davan ti ai cance ll i di pa la zzo Barbe r ini in piedi e con le mani s ulla te sta , le do nn e e i bam b i ni se parati dagli uomi ni 539
"Q ua ndo a rri vai solo, s ul pos to - raccontò Dollmann - lo s p et tacolo e ra raccapricc ia n te: mi p e rm etto di dire che nel gi udic are la reazio ne ted esca non bi s ogna perdere di vista l 'im p ressio ne des t ata da una strage co sì tremenda"540. Kappler, so praggiu nto poco dopo , ordinò ai suo i uomini di prendere i l comando: le SS irru ppero ne ll e case e ne ll e botteghe trascinando fuori chi unque vi trovassero.
Il co lo nn ello Bee litz comunicò s ubi to l ' ac cad u to all'Ob e rkommando de r Wehrmacht, il quartier genera le del Fuhre r: ve r so le 16,30 Hit le r e ra a conoscenza dei fatti d i Roma541 La s ua reazione alla no tiz ia, seco nd o qu a nto riportato d al genera le vo n B uttler, fu i ncontenibile: i n preda all'ira e a llo sdegno, ini z iò a s trep itare g rid a nd o che avrebbe fatto sa ltare in a r ia un int e ro quartiere de ll a c ittà co n tu tti quelli c he lo ab itav ano e che , pe r riparare l 'on ta su b ita, s i s arebbero dovuti fucilare italiani in una prop o rzio ne assai alta: eia trenta a ci nquanta it a l iani per og ni po li z iotto tedesco ucciso.
53 7 Al essan dro Porte ll i op. c it. , p.1 89; Rosari o Bentivegna, op ci r., p. 157
538 Alessandro Porte ll i. op. cii., p.1 90 ; Ro sari o Be nti vegna, op cir., p.158
539 Robert Katz. Roma ci ttà aperla,op . ci t.. pp. 260-262.
540 Eugen Do llm ann, op cit., p. 241.
541 Robert Katz, Morie a Roma , op . ci t. , p.77.

Montezemolo
e il Fronte Militare Clandestino
197
Sabrina Sgueglia della Marra
H imml er, al microfono , pronuncìò contro Roma minacce che D oll mann de finì nero ni a ne 542
La rappresaglia , dunque, doveva e ss ere ese mplare, tanto da far " t rema re il mondo " . Maelt zer tentò inuti lmente di contatta re Kesse lrin g, ir raggiungibile poiché impegnato s ul fro nte di Anzio ad ispezionare le truppe d ella IV Armata d i Macke nsen. P reso atto della supe ri orità dell'artiglieria e d ell ' aviazio ne nemiche e riconoscendo , di co nsegue nza , l'impossibilità, per i propri so ld ati, di sostenerne gl i attacchi, il fe ldmaresciallo ri so lse di rinviare la prevista controffen siva e di far ritorno al suo quartier genera le. Qui, informa to del1' avvenu ta esplosione e delle contromis ure pretese da Berlino543 , convenne anch'egli sulla necessità di com piere " una grande azio ne intimidatoria" 544 che il F uhrer, sebb e ne ancora fu rent e e mo lto eccitato per l ' accad uto, si p ers uas e fosse di competenza del Comando tedesco in I tal ia 545
Kapp le r stabi lì di affidare l'esec uzio ne della rappre sagl ia ai s uperstiti dell'XI compagnia. Convocò, dunque, He lm ut Dobbrick, comandante del III battaglione Bozen, e gli in gi un se di p redispo rre in temp i brev i la rito rs ione. L'ufficiale, tu ttavia, oppose un netto rifi uto a dd ucendo come motivazio ne il mancato addestramento dei s uoi uomini all'uso delle armi, l' età avanzata e i l poco te mpo a d isposizione per provvedervi adeguatamente Non furono, dunque , i soldati a so ttrarsi a ll 'ord in e ricevu to: si trattò d ell ' autonoma decisione di un s uperiore la cui insu b o r dinazione, peralt ro, noti fi cata a l generale Wolf con una denu ncia ufficiale avanzat a da Kappler, non fu soggetta ad alcu n p rocedimento forma le 546
Spettò a l coman da nte della Gestapo e ai s uoi dipendenti l'onere di vendicare i cad uti di via R ase lla.
Kes se lring, Kappler, Mae ltzer e von Mackensen fissarono i l limite massimo a dieci ita liani pe r ciascun mil ite tedesco, rapporto d iv enuto tassativo a ll orché la sera, verso le otto , giunse l'ordin e d i Hi tler che ne diede san zione u fficiale. Le vitt im e sarebbero s tate sce lte tra p e r sone già tratte in arres to pe r azion i co ntro le leggi ge rm a niche, condannate o passibili di pena di morte , ovvero " To deskand id aten" o " Todes w urti g " , meritevoli di morire.
Alle 23, l ' ultima disposizione pervenuta dalla G e rm ania pose un termine di ventiq uattro ore all'esp letamen t o d ell'inte ra operaz ione.
L a leg ittimità d e ll a rappre sagl ia non fu mai in d ubbio né vi furono con -
542 Eugen Dollmann, op. cit , pp. 246, 252.
543 Robert Katz, Roma città aperta , op. cit., p.265-266
544 Albert Kes selring, op. cit., p. 355.
545 Alessandro Portelli, op. cit. , p.205
546 Robert Katz , Mort e a Roma, cit.., p. 115 ; Ales sandro Portelli, op. cit , p 201 -202

198
front i s ulla necessità di compierla. Oggetto delle frenetiche discu ss ioni che si tennero in quelle ore furono la sua entità e le modalità d'attuazione : il numero delle vittime , in fatti, non scaturì da un a ferrea legge di guerra bensì da trattative, mediazioni e ripensamenti 547 .
Pe r Battaglia, l'attentato di via Rasella cost it uì il s uggello della lunga progress io ne di atti terrori s tici condotti dai Gap romani ali' interno della capitale . Ad essi, tuttavia, s ino ad allora non erano mai seguite rappressaglie di tali propo rzio ni ma inasprimenti , talora transitori, delle misure di sicurezza 548 .
L' attacco partigiano del 23 marzo rappresentò un a realtà in quietante con cui le autorità teutoniche, sgome nte, dovettero misurarsi per la prima volta , un avvenimento dirompente e inopinato che aveva palesato la vulnerabilità del Reich: in nessuna città occupata dell ' Europa occidentale la Germania aveva su bito un simile affronto549 .
La sanguinaria ritorsione, dunque, non può ascriversi alla reazione precipitosa ed impulsiva di un esercito in preda al pan ico , bensì ad un articolato e ben ponderato processo deci sionale da cui scaturi un 'o perazione militare predispos ta nei minimi dettagli, finalizzata aJla pubblica re staurazione del potere ferito550
Kappler s i mise s ubito all ' opera. Cominciò la comp ilazione notturna delle liste ma, come riferì Erich Priebke, dall'esame degl i a rchivi non ri su ltò un numero s ufficiente di persone per raggiungere la cifra st abilita. Ricorse, dunque , al fidato questore di Roma Caruso che accettò di consegnare cinquanta uomini a condiz ion e di ottenere l 'a utorizzazion e del suo su periore, il ministro degli Interni Buffarini Guidi, e a Pietro Koch 551 L'el enco del questore Caruso comprese alcuni tra g li esponenti di maggior sp icco della Re sistenza romana , tra cui molti appartenenti al Partito d 'azio ne, come Pilo Albertelli e num erosi militanti di Bandi e ra rossa . Nella li sta di Kappler comparve, fra i primi, il nome di Montezemolo, incluso fra le 335 vittime su insistenza dell'ufficiale tedesco che, secondo Fumarola, intese co sì pu nire il "tradimento" d el colonnello. Eppure , poiché la sua morte era già stata decretata , il capo delle SS " non avrebbe potuto rendere a Montezemolo un tributo morale di più alto s ig nificato . Ha permesso al fondatore del Fronte Militare Cla nde stino di morire tra i suoi fig li , tra i s uo i compagni , in una com unione sovru man a di sacrificio e di passione"552
547 Al ess andro Portelli, op. cit , pp. 205 -206.
548 Roberto Battaglia, op. cii. , p.261.
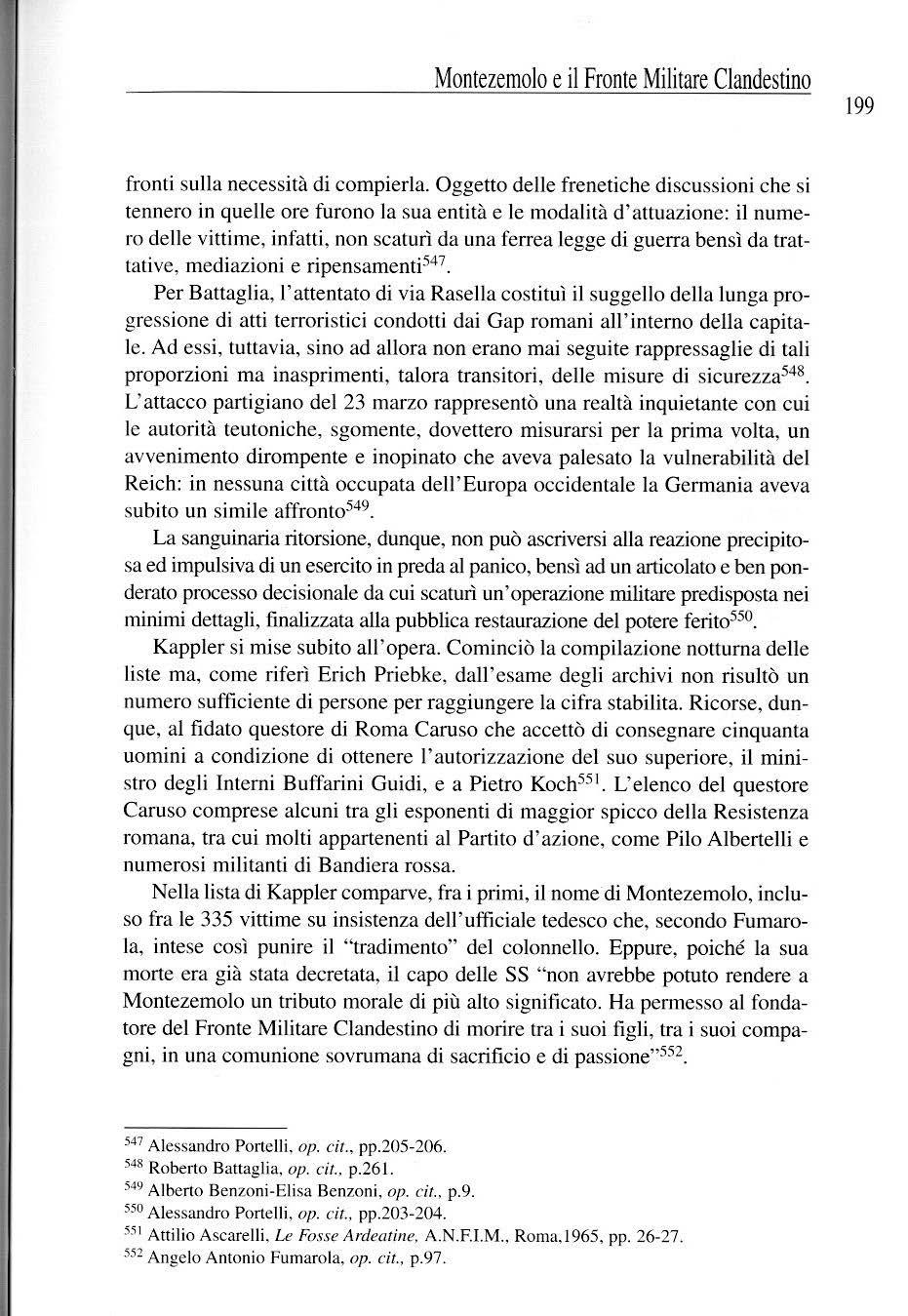
54 9 Alberto Benzoni-Elisa Benzoni, op . cii ., p.9.
550 Alessandro Port e lli , op. cit., pp.203-204.
55 1 Attilio Ascarelli, Le Fosse Ardeal in e, A .N. F.1.M., Roma , I 965, pp. 26 -27.
552 Angelo Antonio Fumarola, op. cit., p.97.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
199
Sabrina Sgueglia della Marra
Appare alqua nto singolare c he le autorità germaniche, perfettamente a conoscenza de ll' att ivi tà clandestina svo lta dal colonnello, non decisero di sottopor lo ad un proc esso nominativo per disfarsene quanto prima co n una condann a all'esecuzione capitale . TI ca po del FM C R sebbene, fi n dal primo inteIToga torio, fu chiaro che non av rebbe mai parlato, venne trattenuto a via Tasso per cinquantotto gio rni e fu po i trucida to alle Fosse Ardeatine. Perché s i optò per I' incl us ione d i u n personaggio così ingombrante in u n'an onima rappresag li a?
Come ha osservato Gabrio Lombardi propugnando una sp iegaz ione per null a p eregrina, i tedeschi era no persuasi c h e l ' eliminazione di Mo nteze molo avrebb e fo r temente im pr ess ion a t o l'opinione p ubb li ca romana e, pa ventando reaz ioni avventate e in co nt rollabi li da parte de ll a cittadinanza e del!' o rganizzazio ne c landestina da l ui d iretta, pr eferiron o tem poreggia re e non assumersi la r es pon s abilità di decide re dell e sue sort i. La rito rs ion e d el 24 marzo apparve l ' occasione propi zia per s barazzars i di quello che Kappl e r e l ' intero Com an do german ico g iudicava no il nemico più pericoloso 553
R uggero Zangran di h a scritto che il colonnello ven ne "catturato in circostan ze misteriose", sotto gli occhi di altri "c lan d estini" che riuscirono a sfuggire alle SS, nei giorn i dello sbarco. La liberazione di Roma si c r edeva immine nte e co n Monte zem olo, altri ufficiali inv is i ag li occupanti ma a nche deposi tari di molti segreti - sulla catt ura di Mus so lin i, s ulla mo r te di Mu t i e sulla battaglia pe r la difesa di Roma - caddero nella r e te della Gestapo.
Alla luce di t a li co ns ide razioni , lo storico ha adom brat o i l s o spetto che le autorità italia ne fossero in teressate ancor più di quelle tedesc h e a ridurre al s ile nzio Montezemolo, uomo cui egl i ha attribuito un "temperamento irrequieto". L'al t o ufficiale, in virtù della s ua carriera militare e del ruo lo di p ri mo piano :assunt o nelle vicende cruc iali seguite a l cro ll o del regime, e ra veros imil mente a con oscenza di verità scomode c he s i temeva potessero essere propalate. La su a eli mina z ione, pertanto, fu "l' unico modo per tappargli definitivamente la bocca" 554
Al contrario, secondo la testi mo nianza d e lla figlia del colonne llo , Adriana , da pi ù parti s i confid ava ch e le autorità germaniche non l' avreb bero ucciso ma che s e ne sare bbero serv iti p er il ma nte nimento d ell 'o rdine pubblico duran te la ri tirata.
Furono poi aggi unt i all'elenco altri trentasette memb ri delle forze armate ita lian e, per lo più membri del fronte militare, come i genera li Simoni , Martelli Castaldi e Fenulli, il ma ggiore CC.RR. De Carolis, il capitano Frignani e Aversa. A via Tasso era no rin c hiu si anche d ue sacerdoti: don Giuseppe Mor.o-

200
55 3 Gab rio Lombardi, op cii., p. 66.
554 Rugg e ro Zangrandi, op. cit , p 680.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
s in i, cappellano del FMCR, acc usa to di traffico d 'armi e spionaggio a favore deg li Alleati , arrestato ins ieme al part igiano Marcello Bucchi su delazio ne di un infiltra to, e d on Pietro Pappagallo, cappellan o delle s uore d e l co nvento d e l Bambin Ge s ù, c ui era s ta to intentato un processo pe r "attività comuniste" in seg uito al tradimen to d i una donna rivoltasi a lui fingendosi in difficoltà. Il capo della Gestapo incluse nella lista il più an zi ano, don Pappagallo555
Alle otto di ma ttina l'elenco era pronto; Koch died e il suo s olerte contr ibuto con l ' in se rimento nell e liste di trenta nomi tra cui q ue llo del s uo " prigioniero s pecial e", il te nente Maurizio Giglio , agente dell'OSS
Caruso assicurò che per le t redic i avrebbe fatto perven ire a Ka pp ler l ' elenco delle cinquanta p e r so ne . Come luogo deputa to all ' eccidio, furono sce lte le cosiddette "cave di sabbia" . Situate tra le Catacombe di San Callisto e di Sant a Domitilla, furono scavate ali' ini z io de l se colo per trarne la pozzolana usata come materiale da co stru zio ne, ma allora erano ormai esaurite ed in s tato di abba ndono 556
li .n umero degli uomini a di sposizione di Kappler e ra di mol to in feriore a qu e llo dei " Todeska ndid aten". L'ufficiale, dunqu e, pe r eco no mizzare. al meglio te mpo e munizioni, calcolò i minuti necessari ad ogni s in gola fucilazione, ne quan ti fi cò le a rmi occorrenti ed o rg anizzò piccole sq uad re c he s i sarebbero alte rnate. Di s po se che ciascuna SS s parasse un s olo co lp o alla m inima di stanza; mirando a l ce r velletto per provocare una morte istan tan ea, si sarebbe evitato che i proiettili a nd assero a vuoto. 557
I primi dete nuti , stipati in c amionette adib ite al trasporto della carne appena macellata, lasc iaro no via Tasso intorno alle quattordi c i. Tra questi vi erano d o n Pietro Pappagallo, il generale Simoni e il co lo nne llo Montezemolo.
Accen nerò so ltanto ad un colonnello che stava davant i a m e - scri sse Jo seph R aider, on g iova ne austriaco arruo la to nell 'esercito tedesco - un certo Montezemolo , da l volto già gonfio per le percosse e i col p i ricevuti, con un 'e norme borsa sotto l' occh io destro , il cui as pet to sta nco ma tuttavia marzia le ed e roico, non poteva nasco nd e re le pa ssa te so fferenze Tutti aveva no i capelli irti e molt i erano incanutiti nel frangente per le perdute speranze, assal it i dal terrore o co lti da improvv isa pazz ia I n mezzo al fras tu o no udii es cl amare co n voce mesta e s upp lichevole: «Padre , benediteci!». In qu e l momento accadde qualche cosa di sov rum ano: deve avere operat o la man o di Dio perché don Pietro riuscì a lib erarsi da i suoi vin co li e pronunciò una preghie ra , im pmte nd o a tutti la s ua paterna bened i zio ne558
555 Robert Ka tz, Roma ci11à aperta, op. ci t.. , p. 276.
556 Attilio Ascare lli , op. cit.. p . 30.

557 R obert Kat z, Morte a R oma, c it. , p.117.
558 Luciano Morpurgo , op. c it , p 295.
201
Sabri na Sgueglia della Marra
Kappl e r in seg u ito di c hi arò c he M on tezemo lo , Si mo ni , F ri gnani, Lordi e Marte ll i Casta ld i , morirono da gran soldati 559
Martelli Castal di lasciò la s ua estrema testimonianza sca lfita sulla parete grezza dell a sua cella: "Quando iJ tu o corpo non sarà p iù, il tuo s piri to sarà ancora più viv o ne l ri cordo d i c hi r esta. Fa' che possa essere se mpre d 'ese mpio! "560 .
A meno di ve ntiq ua ttro ore da ll 'attenta to, la brutale ri torsione era comp iuta. T utto si svolse nell a mass im a seg re tezza, onde ev itare p roteste o vere e pro prie sollevazioni da parte della cittadi nanza. Le autori tà german iche tentaro no di ce lare il più a lu ngo pos s ib ile lo sce mp io delle Fosse Ardeatine sop rattutto perché te mevan o d i forn ire ag li organi della R es istenza ro mana l 'occas io ne per sferrare rapida me nte un nuovo artacco561 : al fine d i occultare i corpi delle vi ttime , co ncl us a la spietata carneficina, i soldati tedesch i del gen io minaro no le catacom be per fame crollare le vo lte ed impedire l'accesso all e gall erie.
Nei di ar i s toric i del Comando Su pre mo italiano, s i legge che le vittime de ll a furia tedesca, mas sacrate con le ma n i legate e prive di co nforto s piritu ale, furo no così accomun ate , ne ll a sorte avversa, ai martiri di San Calli sto 562 Verso le ven titré , l ' Alto comando tede sc o rilasc iò il bo ll enino che venn e diffu so dall 'age nzia Stefa ni:
Nel pomeriggio del 23 marzo 1944 , elementi cr i minal i hann o esegu i to un attentato con lancio di bombe contro una colonna ted esca di po l i zia in tran si to in via Rasella I n seg ui to a q uesta i m bosca ta , tren tad ue uomini de l la pol iz ia te desca so no stati ucc is i e pa recch i feriti. La vile imboscata fu eseguita da comunistibadogliani. Sono ancora i n ano le indagini per chiarire fino a che punto questo criminoso fatto è da attri bu irs i a inc itamento angloamericano.
Il Coma ndo tedesco è deciso a s tro ncare l 'a t tiv ità di questi banditi sce ll erat i. Ne ss uno dovrà sabotare impunem e nte la cooperazione italo-tedesca nuovamen te affermata Il Comando tedesco, perciò, ha ordinato che per ogni tedesco ammazzato dieci co munisti-b adog liani sarann o fu ci la ti . Q ues t 'ordine è già sta to eseguito563
L ' Osservato re R omano ri portò il co m unica to col primo co mmen to p ubbl ico su ll 'accad uto. I n ess o s i lesse c he vi e rano s ta te " trentad ue vitti me da una part e" e " trecentoven ti p erso ne sacrifica te per i col pevo li s fu ggiti all 'ar-
559 Ma r io Avaglia no, op. cii., p.84

560 Serina s ul muro di una ce lla del carce re di via Tasso. ora Museo storico della Liberazione.
561 Rosario Ben t ivegn a, op. c ii , p. 168 .
562 A.U.S.S.M.E., N 1- 11 , Diari storici 2" Guerra mondiale. b.3070, allegato n 873. " Barbarie tedesca", Comando Supremo. Ufficio Operazioni, al Mini s te ro degli Esteri , Ufficio Stampa. 28-4-1944 .
563 Ma nifesto espos to a l Mu seo sto ri co de ll a L iberaz io ne.
202
res to dall ' altra". Il Vaticano g iu dicò "colpevol i" per la strage delle Fosse A rdeatine, non i tedeschi, bensì i partigiani d i via Ra sella che avevano provocato il sacrificio di trecento v ittime innocenti 564 . Come se non bastasse, be nché la notizia d ell'ecc idi o si fosse propagata per tutta la città, le autorità ge rmaniche continuarono a rifi ut a r s i di rive la r e l'identità delle vittime e il luogo ove si era compiuta la carnefic in a . A circa d u e settima ne dalla rappresaglia, la Gestapo provvide ad inviare alle famig lie un lapidario avv iso in tedesco in cui compariva il nome del p rigioniero e s i chiedeva di andare a ritirarne gli effetti persona li in via Tasso 155 per l'avvenuto decesso di c ui , tuttavia , no n erano s pecificate le circostanze, ma solo la data: i l 24 marzo
li C LN apprese dell 'ecc idio il 31 marzo, come appuntò Bonomi nel suo diario esprimendo dolore e sconcerto per " l 'atroc ità tedesca senza precedenti" 565 .
TI dis paccio in cui fu data conferma d el massacro, invece, giu n se a Brindisi solo il 21 aprile 566 Ult eriori dettagli sulla barbarie german ica ven nero notificati nei giorni successiv i.
A ll orché 1' Alto Comando germanico di c hiarò pubb li ca mente di aver esegu ito l a ritorsio ne per l'attentato partigiano di via RaselJa, Ke sselring indirizzò a ll e sue truppe un comun icato in cui affermò la sua determinazione a ridun-e aU' impotenza le forze della resistenza: s i dovevano ne utralizzare "g U infami banditi" in ogni parte d'Italia , sorvegUando strettamente la popolazione civ il e, denunciando con te mpe s tività le "riunioni sediziose", agendo "con severità e senza rimors i" . Il fe ldm aresciallo esortò i suoi uomini a considerare tutti gli italiani spie o sabotatori che sfruttavano " la natura fiduc iosa del so ldato tede sco per danneggiarlo" e fece ammenda per aver sottoval utato la pe ricolo sità del movimento patriottico e della popolazione. D a aUora in poi, ovunque vi fossero s tate "zone infestate dai partigiani", tutti i civi li , di entrambi i sessi, sarebbero s tati trattati come "fanatici assassini". Pur ammettendo che anche i tedeschi, in qualche caso, aveva no compi uto delle "irregolarità ", Kesselring opinò c he, tuttavia , no n avevano mai commesso le efferatezze di una simile "marmaglia". Tale accolita di "criminali" " derubava, uccideva e saccheggiava" e con le azioni d i sabotaggio, contravve niva to talmente a lle regole della lotta militare pura costituendo un serio pericolo per i p iani di ripiegamento germanici
567
La pressione poli zies ca fu notevo l me nte accentuata e s i diede applicaz ione alla direttiva hitleriana , già in vigore dal 1942 sul fronte orientale, volta a
564 Alessandro Portelli, op. cit., pp. 4-5 ; Robert Katz , Roma città aperta, c it. , p 297
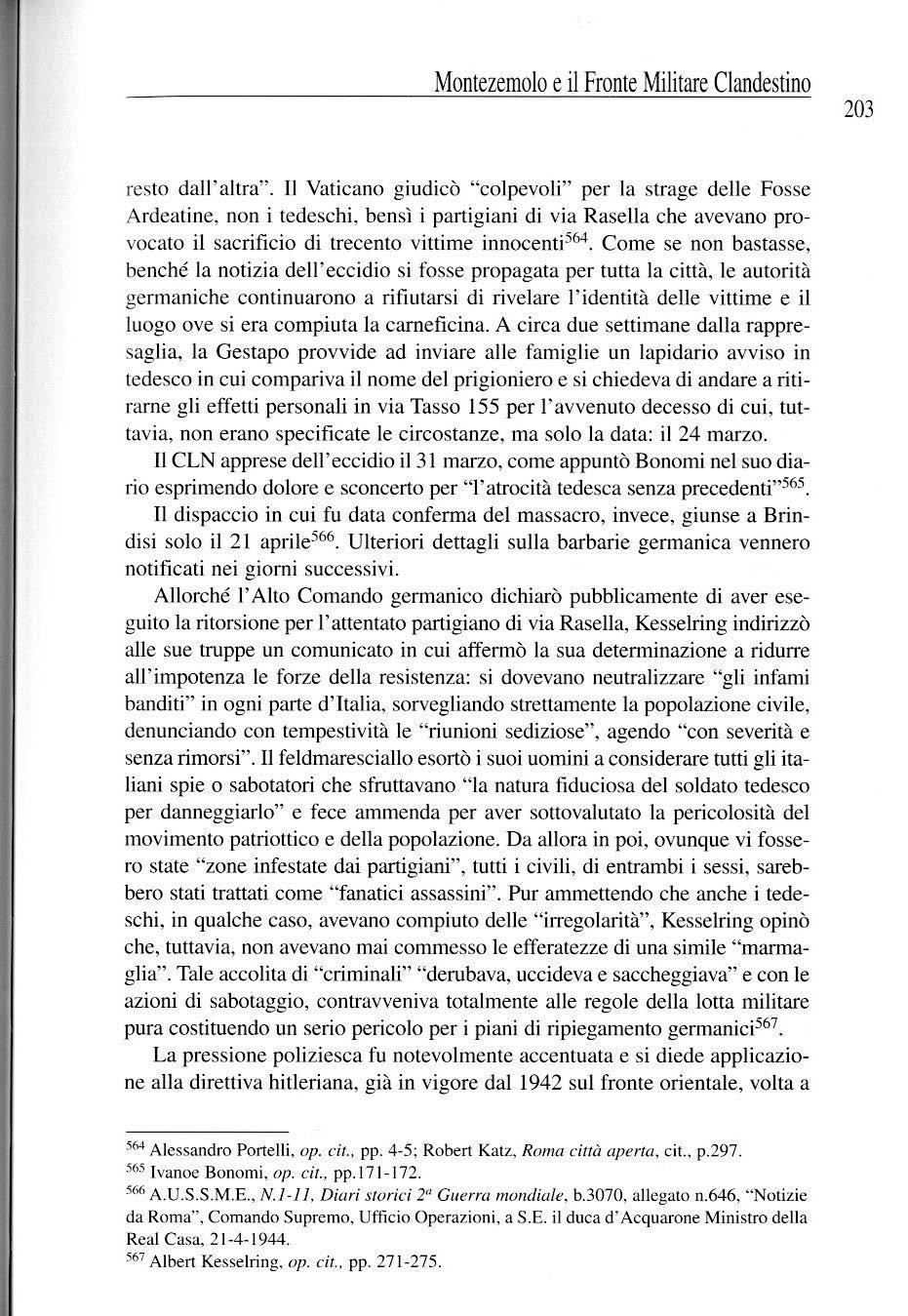
565 I vanoe Bonomi, op. cit., pp. 17 1-1 72.
566 A.U .S.S.M.E. , N.1 -11 . Diari storic i 2" Guerra mondiale, b.3070 , allegato n.646 , "Not izi e da Roma", Comando Supremo, Ufficio Opera z ioni, a S.E. il duca d ' Acquarone Ministro della Re al Casa, 21 -4 - I 944.
567 Alben Kess elring, op cit., pp. 27 1-275.
Montezemolo e il Fronte Mi litare Clandestino
203
Sabrin a Sgueglia della Marra
stronca re la guerrigl ia con ogni mezzo, se nza risparmi are , all ' uopo, le donne i ba m bini. Qualora un comandan te avesse ecced uto nell'esecuz ione delle contromis ure adottate, non sare bbe in co rso in alcu n p rovvedimento di sc iplinare: un e rrore in questo senso sare bbe s tato tollerato, l ' in adempi e nza agli ordini asso lu tamente no568
Il 25 ma rzo, altresì, fu decre tata la "tem poranea" rid u zione da ce ntocinq uanta a cento g rammi della razione di pa ne. L a speciosa gi ust ificazio n e uffic iale addo tta fu l'a umento de ll a popolazione p rodotto dal contin uo afflusso d i sfollati c he aveva costretto le au tori tà germaniche a predispo rre u n n uovo e pi ù raziona le piano di distri buz ione alimenta re pe r ragg iu ngere la "normalizzazione del settore agricolo" 569 .
Pe r dimostrare al l 'occupante che la Res istenza romana, no nos t a nte la grave fe ri ta arrecatag l i, era ancora in grado di colp ire, i Gap centr al i rivendicarono p u bblica m e n te la respo nsab il ità dell'attentato di via R ase ll a, precisa ndo n e la nat ura di ve ro e proprio atto di guerra e, i l 30 marzo, repl icand o a l comun icato del Co ma ndo t edesco definito "bugia rdo e in timi d ato ri o" , su L'Unità am moniro n o c he " le az io ni di guerriglia partig ia na e pa triott ica" non sareb be r o cessate fino a ll a completa l iberazione . Occor reva rip r e ndere l' iniziati va in fligge ndo i n rapida succession e , altri colpi in g rande sti le : si p e nsò, dunq ue, ad un nuovo atte ntato terroristico contro il b raccio germanico d el carcere di Regina Coe li . A ca usa delle acc r esciute mi sure d i sicu r ezza, tuttavia, si ri te nne opportuno op ta re per un b ersaglio mobi le in dividuato nel convogl io tedesco c h e quotidi anamen t e, a mezzogiorno , andava a d are i l cambio ai soldati d i gua rdia, all'altezza d i largo Disso ni. Poco p ri m a delle dod ic i , q uando Lgappisti già schierati da un quarto d 'ora si appre s tava no a lanc iare l'offe nsiva, s opragg iunse trafe lata una staffetta con l ' ordine perentorio di s ospe nd ere l'operazione e di fa r r itorno alla base . L a Giunta mi lit are ce ntrale aveva ricevu to press io ni da alcuni settori del C L N che, venuti a co n oscenza de lla st rage dell e Fo ss e Ardeatine, d ecisero d i an nullare qualu nq ue azione 570 .
Le fo rm azioni po l iti che affere nti al CLN affidaro no a L'Unità d el 13 aprile 1944 una p rotesta che, s c ritta ali' ini zio del mese da l p reside nte Bonomi ma dat ata 28 ma rzo, deplorò "i l de litto senza nome " di c ui l'occ upante s i era reso reo massacran d o d elle vitt im e innocent i. La ri torsione era g iudicata del tutto illeg ittima in qu an t o sferrata co nt ro un atto d i g uerra di p atrioti ital ia ni. [ cadu ti erano uo min i de l tutto estra nei all'attacco di via Rasella, "uomini non
568 Robert Katz, Roma città aperta, cit. , pp. 308-309.

569 Enzo Pisc itelli, / bandi tedesch i e fascisti , cit., p. I 93
570 Rosario Bentivegna, op. cit., pp 170- 172; Robert Katz, Roma città aperta, cit., pp 298 -299
204
di altro colpevoli che di amar e la patria", uccisi "senza forma alcuna di processo, senza assistenza religiosa né conforto di familiari: non giustiziati ma assassinati" . Gli italiani e le italian e, pertanto, erano eso1tati a cooperare per "la liberazione della patria dall'invasione nazista" e per "la ricostruzione di un'Italia degna dei suo i fi g li caduti" .
Il proclama si concluse preannunciando l'insurrezione della città che, "inorridi ta per questa strage senza esempio", si sarebbe sollevata in nome dell'umanità per vendicare le vittime dello scemp io , "l'estrema r eazione della belva ferita che si sente vicina a cadere" 571

Nel suo diario , Bonomi raccontò di aver appreso dell'uccisione di Montezemolo alle Fosse Ardeatine soltanto il 2 aprile da monsignor Ferrero di Cavallerleone dopo .la consueta mes sa domenicale. Commentò la penosa notizia ricordando i loro frequenti inc o ntri , in luoghi semp re diversi, assieme al generale Armellini e a Carlo Scialoja, e la proficua collaborazione che da tali colloqui aveva preso le mosse.
Elogiò il va lore d el colonnello, tratteggiandone la figura eroica: egl i aveva assunto "il comando delle segrete forze militari antifasc iste" e con "azione coraggiosa e sagace", le aveva raccolte, organizzate e inq uadrate . "En trato nella schiera dei nuovi martiri della lib ertà italia na - sc ri sse i l presidente del CLN - il suo nome, custodito nei nostri cuori, sarà inscritto nelle pagine del nostro seco ndo Risorgimento nazionale" 572 •
Le parole u sate dal Capo di Stato Maggiore Generale nel caldeggiarne il co nferimen to della medaglia d'.oro al valor militare , illustrano significativamente la profonda amm iraz io ne che destò nell' eserc it o l'opera generosa del capo del FMCR:
Sire,
nelle drammatiche vicende che seguirono la conclus ione dell'armistizio tra l'Italia e le Nazioni Unite, molti furono i generosi che, animati da un profondo cul to per la Patria e da un e levatissimo senso del dovere, affrontarono nelle stesse retrovie tede sche, i pericoli e l e in sidie di una lotta oscura ed eroica, tene nd o desta in mezzo al popolo tradito ed oppresso dall'infido alleato di ieri, la fiaccola della fede nella rina scita della Patria.
Fra questi valorosi ed indomiti patrioti emerge in modo partico l ariss imo e s ' impone all'ammirazione di tutti l 'eroica figura del colonnello del genio in s .p.e . Cordero Lanza nobile dei Marchesi di Montezemolo. Soldato di preclare doti di mente, di cuore e di carattere, combattente va loro so in più guerre, ufficiale di S.M. di elevatissime capacità, trascinatore ed educatore, nel corso di una rapida
Montezemolo
Fronte Militare Clandestino
e il
57 1 L
I
I
572
Bonomi , op . cil.,
172-1 73 -1 74. 205
' Unità.
3 aprile
944. in Robert Katz, Roma città aperta, cit. , p.512.
Ivanoe
pp.
Sabrina Sgueglia della Marra
e brillantissima carriera eg li ha reso servizi preziosi alle FF.AA. ed alla Nazione, dimo stra ndo , da ultimo , quale capo ufficio operazioni del Comando Supremo, negli anni dal 1940 al 1943, una l evatura veramente eccezionale.

Il colonnello Cordero di Montezemolo comandava, all'atto dell'armistizio , il ge nio del corpo d ' armata corazzato. Jn una s itua z ione di estrema d e licate zza, tra difficoltà di ogni genere , partecipava volontari amente ed attivamente a ll e vicende dei gio rn i success ivi all'arm istizio. Dopo l 'occupazione tedesca di Roma , rima neva volontariamente nella Capitale ed affrontava con altri animosi il pericoloso e diffic il e compito di organizzare la resistenza armata co ntro l ' invasore. Costituitosi il comando della "Città aperta di R o ma " ne reggeva per alcuni giorni l'utlìcio affari civili. Entrato in segu ito a contatto con elementi i nviati a Roma dal Comando Supremo italiano per stabilire un pr i mo collegamento tra l'I tal ia Liberata e la zona occupata dei tedeschi , non esitava a farsi "informatore", perfettamente consc io delle difficoltà e dei pericoli in s iti in tale dec isione.
Col prest ig io di una personal ità d ' eccezione, di una dirittura morale integerrima, d i un carattere adamantino e di un ' intellig e nz a spiccatissima, riusciva a stringere attorno a sé tutta una completa organizzazione di informazioni: le noti z ie , vagliate accuratamente attraverso la s ua esperi e nza e la s ua sens ibilità, giungevano quotid ia namente nell ' Ita lia liberata- brevi e prec ise -permettendo d i avere , i mmediata, la sensazione degli avvenimenti politici e militari. Accanto all ' attiv ità informativa, il colonnello Co rdero d i Montezemolo s i fece, fino dai primi giorn i, animatore di patrioti , gettando con opera assidua le basi dell 'o rganizzazione regionale delle " bande" .
Così dall'ottobre, per quattro mes i, instancabile.
Se mpre pagando di persona, sempre risch iando, pur di sapere, vedere ed atùmare. Di giorno in g iorno le autorità italia ne ed alleate stup ivano ammirate, raccogliendo i frutt i del suo duro lavoro , constatando, attraverso g li avvenimenti, la prec isione e la tempestività delle sue informazioni, la fondatezza delle s ue previsioni.
li 25 gennaio e .a. il colonnello Cordero di Montezemolo veniva arrestato a Roma. Nulla lasciaro no d'intentato le a utorità tedesche e fasciste per strappargli una co nfe ssione. A nulla valse l a lunga attesa in carcere, la tortura feroce, il rico rdo della sposa e dei figli ancora in tenera età. Ancora una vo lta il colonnello Cordero di Mon tezemolo confermò, serenamente, la sua stoica forza d ' animo e la sua tempra di uomo veramente eccezionale .
Il giorno 24 marzo e a questo eroico ufficiale veniva barbaram e nte trucidato , con altri ostaggi , nei pressi delle catacombe di San Callisto, durante una esecuzione somm aria di rappresaglia tedesca .
La sua opera di ufficiale e di patriota suscita in quanti lo conobbe ro e ne seg uirono l 'attività un senso di profonda ammirazione e di commossa riconoscenza, così come il s u o nome res te rà per sempre l egato a questo nuovo, sanguinoso e tormentato Risorgimento della Patria.
Ravv iso nel comportamento del colonnello Cordero di Montezemo lo gli estremi per la concessione della massima ricompensa aJ Y.M. e sottopongo pertanto alla
206
Augusta firma della Mae stà Vostra la determi nazione di co ncess ione della med aglia d'oro al Y.M. "su l campo" "alla memoria"57 3
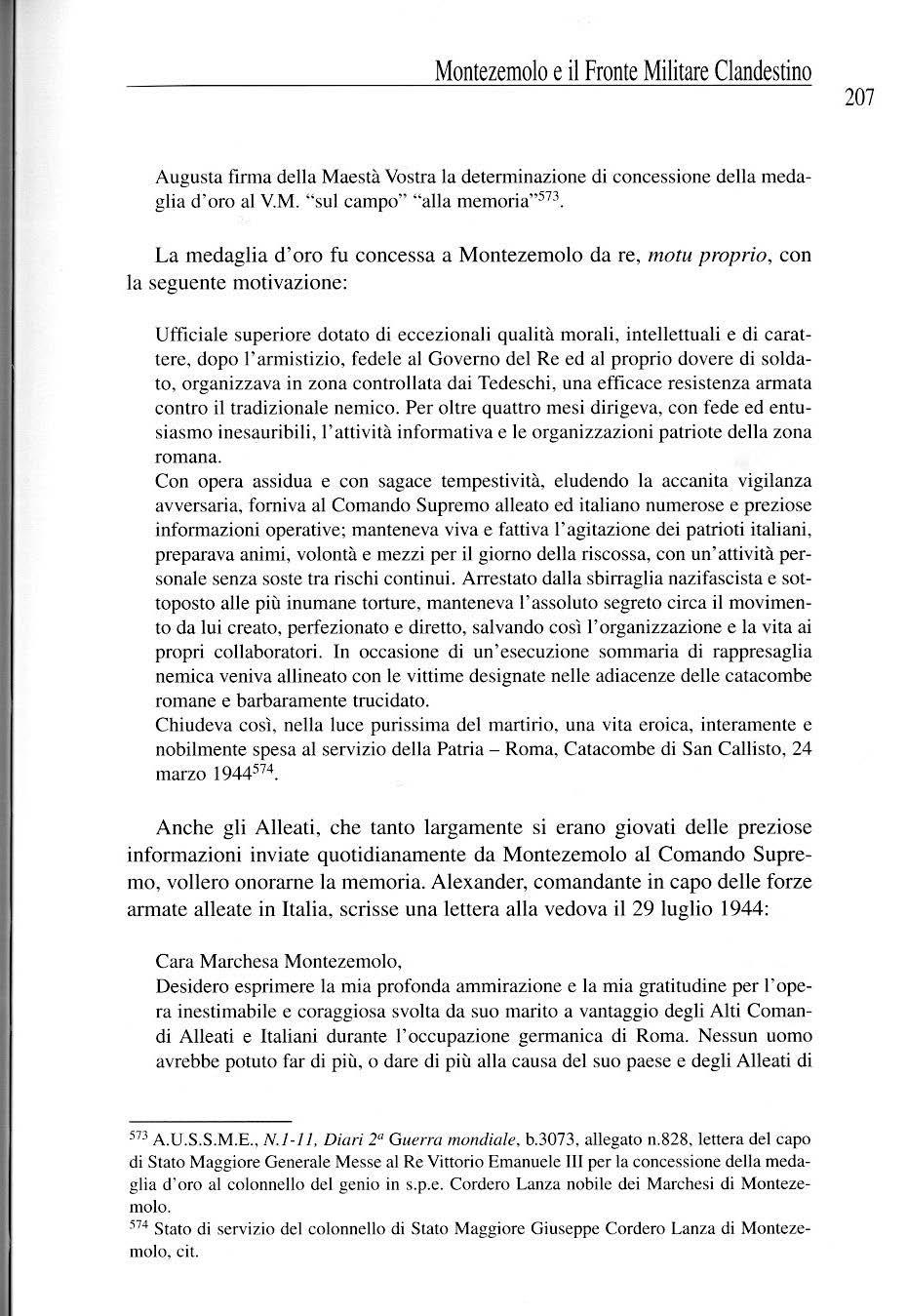
La medag lia d ' oro fu concessa a M o n teze molo da re, motu proprio, co n la seg uente mot ivaz ione:
Ufficiale s uperiore dotato di eccezion a li qualità morali, intellettuali e d i caratte re, dopo l'a rmi s ti z io, fedele al Gov e rn o d e l R e e d al proprio dov e re di sol dato , organizzava in zo n a contro llat a dai Te deschi, una efficace resistenza armata contro il tradizionale nemico. Per o lt re quattro mes i dirig eva, con fede ed entus iasmo in esaurib i l i, l'attivi tà informativa e le o rganizzaz io ni patri o te della zon a romana
C on opera assi du a e con sagace tempest iv ità, e lu de ndo la accani ta vigi lanza avve rsaria, fo rni va a l Comando S upre mo alleato ed i tal iano num erose e pre z iose informazio ni operative; man ten eva viva e fattiva l'agitazione dei patriot i ital iani, preparava animi, volontà e mezzi per il giorno della riscossa, co n un'attività pe rsonale senza soste tra ri sc hi continu i. Arres tato dalla sbi rrag li a nazifasc ista e so ttoposto alle più i numane to1 i ure, manteneva l'assoluto segreto circa il movimento da l ui creato, perfezionato e d iretto, salva ndo così l' organizzazione e la v ita ai propri co ll aborator i. ln occas io ne d i un 'esecuzione som maria di rappresaglia nemica veniva all i neato con le v ittim e des ig n ate nell e ad iacenze delle catacombe romane e barbaramente trn cidato.
Chiudeva così, nella l uce puri ss ima del marti,io , un a v ita e roica, in te ramen te e nob ilmente spesa al servizio de ll a Patria -R oma, Catacombe di San Callisto, 24 marzo 1944574 •
A nch e gli Alleati, che tanto largam e nte si era no giovati d elle preziose informaz ioni inviate quo tid ian a m e nte da Montezemolo a l Coma ndo Supremo, vollero o norarn e la me mo ri a Al exan der, comandant e in capo delle forze armate alleate in Ita l ia, sc ri sse una lettera alla vedova il 29 luglio 1944:
Cara Ma rchesa Montezemolo, Desidero esprimere la mia profo nd a ammirazio ne e la mia gratit udine per l'o pera in es timabi le e coraggiosa svo lta da suo marito a vantaggio degli Alti Comandi Allea ti e I taliani dur ante l'o ccupazione germani ca di R oma . Ness un uomo av rebbe po tu to fa r di p iù , o dare di p iù alla causa del suo pa ese e degli Alleati di
5 73 A.U .S. S.M.E. , N. 1- 1 / , D iari 2° Gu erra mondiale , b.3073, allegato n.828, lettera del capo di Stato Magg iore Generale Messe al Re Vittor io Ema nu e le lll per la concessione della medag lia d 'o ro al co lonnello del ge nio in s .p.e . Cord ero Lanza n obile dei Marchesi d i Mon tezemo lo .
574 Stato di serviz io d el co lon nello di SLato Magg iore Gi use ppe Co rdero Lanza di Montezemolo, ci t.
Montezemolo
e il Fronte Militare Clandestino
207
Sabrina Sgueglia della Marra
quanto eg li fece : ed è ragione di rimpian to per me che egli non abbia potuto vedere gli s plend idi ri sultati della s ua inalterabile lealtà e sacr ificio pe rso nale . Con lui l'Ita lia ha perduto un grande patriota e g li A ll eatj u n vero amico
La prego di accettare, i n sua vece, questa assicurazione dell'altis sima st ima in cui egl i e la sua opera sono tenuti e l 'es pressione della mia sincera si mpatia per la sua grave p erdita personale
S in ceramente s uo
H.R. Alexander Generale Comandante in Capo575
Il "cavalie re dell'um iltà v irile" , come lo ha defi n ito Fuma rola, espresse ne l suo testamento i l desiderio che i fami li a ri no n in dossasse ro le gramag lie, poiché rite neva che " la morte sul cam p o non deve essere ragione di tri stezza, ma di orgoglio"; raccomand ò, pertanto, d i non dar lu ogo ad alcuna m anifestaz io ne di dolore576
3. Il FMCR dopo Montezemolo
Con l'arresto di Montezemolo e di mo lti dei principali espone nti del FMCR, l 'attività dell'o rganizzazio ne ed i l suo ruo lo nell'ambito de l mov imento di R es ist e nza si ridim e nsionò notevolmente. A partire da llo s barco di Anz io , i Comandi alleati avevan o cominc iato a s u pporta re in mani era più assidua e conc reta l'attività delle formazion i armate, confidand o ne lle loro potenzia lità a sosteg no delJe operazioni bellic he , ma la conco mitante d eca pitazio ne dei ve r tici militari comprom ise in esorabi l me nte l ' inizia ti va , in ogni amb ito, d el dispositivo clandestino.
Tra la fi ne cli gennaio e d il mese d i febbraio, dunque, si impose l'urgenza di avviare una vas ta opera di ri ordina m ento che, ott imi zzando le riso rse disponibil i e te ntando di rimediare alle perdite s ubite, conferisse al FMCR u n assetto q uant o più razion ale, so li do ed e ffi cient e ed accrescesse le capac ità operative, di co nt rollo ed offensive delle s trutture e dei nuclei a rm ati di cui s i componeva. 11 territorio di Roma f u pertanto su d diviso in t re settori : il I settore fu posto agli ordin i del genera le Tamas sia; il Il settore, attribuit o dapprima al ge nerale Caratti, dal 19 aprile , in s eguito al suo trasferimento al Coma ndo de l gr u ppo settori, venne affida to al co lonne ll o D e l Bello; i1 III se ttore , infine, fu assegna to a l generale Girotti

208
57 5 Lettera espost a al Mu seo storico della Liberazione di Roma.
576 Angelo An tonio Fumaro la , op. cit., p.19.
Le prospettive apertesi con l'operazione Shingle , malgrado lo s tentato avv io, impressero alla strateg ia resistenziale del fronte un ind irizzo più marcatame nte volto alla salvaguardia della pace soc ial e ne l te muto periodo d 'emergenza, ovvero l'interva llo di tempo compreso tra l 'evacuazione tedesca e l'ingresso degli Alleati nella capitale. Si procedette, dunque, ad un aggiornamento de lle attività e d ei meccanismi che r ego lavano il dispositivo militare.
Il criterio informatore delle nuove priorità impo ste al FMCR dallo sbarco angloamericano e dall'attesa della liberaz ion e, fu la tute la della pubblica s ic urezza, col preciso obiettivo di assicurare immediatezza ed efficacia alle operazioni vo lte al mantenimento clelJ'ordìne, di garantire il corretto funzionamento dei serv iz i e di preservare la popolazione e la città da rappresaglie e distruzioni.
Il generale Odone, verso la metà di gennaio 1944 , contattò Tamassia per in vitarlo ad ass umere un incarico direttivo nell ' ambito dell'imminente riordinamento del fronte clandestino e glì chiese consiglio su un a ltro uffici ale c ui affidare una tale responsabilità. Egli accettò di buon grado e propose il generale Girotti , allora ricoverato all ' ospedale militare del Celio, che dopo essere stato consultato, s i mis e immediatamente a disposizione. Tama ssia cominciò a ri cercare ufficiali per gettare le basi del I settore, inizialm ente denominato zona, il cui fun z ionamento effettivo , t uttavi a, si poté avv iare s olo verso la met à d e l mese success ivo.

NelJa riunione indetta dal generale Armellini il 15 febbraio, infatti, furono definite le zone di giurisdizione e le forze di cui disponeva ciascun settore . Tamassia poté dunque procedere ali ' organizzazione effettiva del I settore che, per ragioni dì s icurezza, venne caratterizzato da una rigida compartimentazione. Fu predispo s to un comando, co s tituito dal suo capo di Stato Maggiore tenente colonnello Croci e da quattro ufficiali di co llega m en to , e tre co mandi di sottosetto re , posti rispettivamente agli ordini del maggiore Padovano, d el colo n nello Mess ina e del colonnello Campagna.
I sottosettorì A, B e C, si strutt urarono come comandi di reggimento composti da tre ba ttag lion i ciascu no. Ogni sottosettore avrebbe do vuto approntare un servizio dì vettovagliamento ed uno sanitario, appoggian do si anche ai pres idi assistenzia li ov'erano inseriti affiliati del Fronte, come quelli della città aperta, della Croce R ossa o glì is ti t uti rel igio si.
li I settore poté con tare su un battaglione della riserva dei CC.RR. alle dipenden ze del maggiore Scirocca composto da tre compagnie, e su un reparto della Guardia di Finanza la c ui forza complessiva, dislocata a prote zione di obiettivi particolarmente se nsibili, am mo ntava a centosettanta uomini. I partiti comunista, repu bblicano e soc ialista raccols ero ed affia ncarono al I settore alcune fo rmazio ni disarmate che, secondo il programma stabil ito ,
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
209
Sabrina Sgueglia della Marra
all'arrivo degli angloamericani , av rebbero dovuto conce ntrarsi ne l quartiere Trionfal e. Tali nuclei ricevevano le di retti ve del settore attrave rso un loro uffic iale di co llegame nto co l comando centrale e ricono sceva no ap pi eno l'autorità milita re con c ui s i propo neva no di coo perare fed e lm e nte fino alla liberaz ione per il mantenimento dell 'o rdine pubblico.
Afferirono altre sì a l di s pos itivo realizza to dal generale Tamass ia du e nuclei di CC.RR. che operarono nei quartieri Prati e a Trastevere all e dipenden ze, ri s pe tt ivamente, del bri gadiere Vuoto e del tene nte Filippi. Tali reparti svolsero un'inten sa attività informativa di carattere pol itico, militare e civile seg na la ndo con te mpestività le notizie p iù rilevanti che venivano raccolte in periodiche relazi o ni . In seg uito, si affiliarono all' o rganizzaz ion e mi l itare la banda " Filippo", agli ordini del tenente Rebecchi, e la banda " Neri" .
L' o rd ine di opera z ione, malgrado l 'esiguità degli uomini a di s posizione e l 'i n s ufficiente armamento, venne diramat o ai comandi dipend e nti verso la metà di a pri le.
Gli obiettivi Ja c ui protezion e ri s ultava di primari a importanza furono la Città del Vaticano, i l palazzo di G iu stizia, Castel Sant' Ange lo , le caserme, le s tazioni , g li scali ferroviari ed altri punti della città cons id erati a ri sc hio. L a caserma di Castro Pre torio fu assegnata ad un gruppo di cento paracadutisti , mentre, pe r il carcere di Regin a Coeli, si raccomandò la massima accortezza a l fine di consentire il regolare svolg imento delle operaz ioni di rilascio dei detenu ti .
Inoltre , grazie al te nente colonnello Croci, Tamassia riuscì a cos tituire un gruppo di ardi ti , denominato banda "Strappo" , formato per lo più eia s tudenti univers itari armati di fucili mitragliatori , mo sc hetti e pistola, c he vennero impiegati in azioni p articolarm e nte audac i e pericol ose, com e la difesa de l Comando o la distribuzione deg li ordini dal ce ntro agli organi p er iferici.
Il 11 se ttore, la cui giurisdiz ione si estendeva ne ll a parte se ttentrional e della città s ulla riva s inistra del Tevere, fu assegnato da Odon e al generale Caratti. A tale di spos iti vo s i unirono la banda della Pilotta, a liquote della Guardia di Finanza e due nuc lei di CC.RR. della te nenza di Piazza San Lorenz o in Lucina e di Piazza Bologna al coma ndo ri s pe ttivament e del tenente Bas igna ni e del ten e n te Soldoni.
Anch e il II settore s tabilì contatt i con elementi di partiti politi c i e con essi ve nnero co ncretate intese al fine di add ivenire ad un impiego coordinato delle forze dip en denti.
Il 19 a prile, il co lonnello D el B ello s ubentrò a l general e Caratti , e d agg iun se a l comando del I settore, allora costit uit o dal tenent e colon nello Fabbri e dal ten ente Ferrito, i l maggiore d 'artiglieri a Grazzini, co n cui già aveva milita to nell 'o rganizzaz ione " Ro si". II colonnello s i occupò in parti-

210
cola re del potenziamento dei co ll egament i e dei mezzi di comunicazione necess ari alla trasmissio ne degli o rdini e d e l segnale di a dun ata che, nel periodo di emergenza, si sar e bbero rivelati indispensabili alla riu scita del piano o p erat iv o577
Il comando del III settore fu assunto il I febbraio dal genera le Girotti che scelse, come suo capo di Stato Maggiore, il colonnello Bogliaccino Il territorio che faceva capo al generale , al margine meridio nale della città, compre ndeva alcuni tra i rioni più malfamati che, se i tedeschi, all'arrivo degli ang lo americani , avessero deciso di combattere per tentare io e xtremi s di mantenere la capitale, sarebbero stati coinvo l ti per primi neg li sco ntri. La forza destin ata a presidiare g li obiettivi s trategic i as segnati al III settore era cos ti tuit a da nuclei di Carabinieri , Guardia di Fin a nz a e agent i di PS , p er un to tale di più di mille elementi.
A maggio fur ono inquadrate in tale o rg a ni zzazio ne la banda " Bartolucci", che disponeva di circa ottanta unità , p er lo pi ù ufficiali, e la banda "Alfieri", nata dalla banda "Accili", con cinquecento effettivi tra ufficia li di cavalleria e car ri s ti. Quando il 29 magg io, Girotti fu arrestato dall e SS, il comando del setto r e venne asseg nato al colonnello Bogliaccino578 .
li problema d ell'assistenz a fu sempre considerato di estrema rilevanza: gli affiliati non p ercepiva no alcun reddito proprio ed erano costretti a sostenere spese ingenti per provvedere al vitto e all'allog gio, ricorrendo soven te alla borsa nera poiché sprovvis ti di regolari documenti personali. Po chi fo r t unati trovarono fraterna ospitalità presso amici e parenti, a volte trovarono ricovero a nch e in cas e appartenenti ad estranei che con s ideravano proprio dovere di buoni italiani aiutare in ogni modo i patrioti. Talora, a causa dei ritardi ne lla distribuzione dei sussidi, la situaz ione diven n e grav iss ima , quasi insostenibile ma , dal mese di aprile, fortu na tamente, si registrò una maggiore regolarità.

Il 19 aprile 1944 fu istituito il Comando gruppo settori del FMCR col compito di potenziare e completare, in conformità alle direttive del Comando Supremo, il piano operativo dei t re settori e d i avviare e perfezionare il coordinamento con l 'o rg a ni zzaz ione ant isabotaggio del generale Cortellessa.
I collegamenti presentavano numero se difficoltà : s i basavano s u appuntamenti che spesso, per ragioni di prudenza, variavano nei tempi e nei luogh i. Le riunioni si tenevano p e r lo più in locali chiusi messi a disposizione da priva ti ma, a causa dei pedinamenti, erano ormai ridotte al minimo; le
577 A.U.S.S.M.E. , N. /-IO, Diari storici 2" Guerra mondiale, b .3022, f. IO , " Relazio ne su lJ'attività svolta dal Comando 2 ° Settore dalla metà di gennaio al 19 ap ril e e.a.".
578 A.U.S.S.M.E., N. /-10, Diari storici 2" Guerra mondiale, b.3022, LI l, "Relazione attiv ità del 3 ° Settore del Fronte Clandestino Miljtare".
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
211
Sabrina Sgueglia della Marra
conversa zio ni telefo ni c he era no stre ttam e nt e so rveg liate e g li ord ini scri tti , recapitati personalmen te, apparvero b e n pre sto una so luzione a stento percorribi le pe r il pe ri colo di a rrest i e perqui siz ioni da par te delle SS.

Le di s posizioni da te da Montezemolo allo scopo di ass icurare l'ordine pubblico ed im pedire a tti di sabo tag gio d u rante "l'inte rregno " sub irono modi fi c he e aggiornamenti a cau sa delle in compren s ioni e deg l i attriti che, dopo la su a cattura , era no so rti nei rapp orti coi parti ti del C LN. Le trattative co n le formaz ion i politiche , in ques ta fase, furono co nd otte princ ipalm e nt e dal ge nerale Caratti e dall 'es pon en te libe rale B rosio.
Il ser vizio sa ni tario fu a ll estit o dal maggio re med ico de ll a Marina Pa lmisa no . E gl i ce nsì tutti g li e nti ospedalieri , sa nitari e di p ronto soccorso p rese nti all 'in tern o della ca pita le e. s incer atos i de ll e co ndiz ioni e de l grado di efficienza d i ci ascun pre s id io , ne ripri s tinò il pieno fu nz ionamento.
Gli obiettiv i asseg nat i ai s e t tori furono p a ssa ti in rassegna e suddiv is i tra le va ri e forz e di c ui es s i s i co mpo nevano. l coma nd a n ti di so ttosetto re ne esamin arono accura tamente le mo dalità di occupaz ione s tudiando so luz ioni a tt e a ga ra ntirn e la s im ulta nei t~ t e la massima rapidità. Alcun i nucl ei di riser va furo no l as ciat i a dispos izione de i setto ri per far fronte a qual s iasi e mergenza.
Tutte le operaz ioni s i sarebbero dovute esp letare nel pi ù com pleto ri go re al fi ne di rassicu rare la c ittadinanza e di guadagnars i la fiduc i a delle tru ppe an g loamericane. Non sa rebb e ro stati toll e rati , in ness un caso, att i di indiscipl in a o di violenza i nd ividuali . G li o rdini sarebbero stati resi noti so lo al mo me nt o op portun o e q ualunqu e in di sc rez io ne al ri gu a r do av r eb be ass unto s igni fi cato di tradi mento 579 .
Il FM C R, tuttavia , a seguito di ta le rio rga nizzazio ne, il 27 e il 29 m agg io , fu travolto da una nuova o ndata di arre s ti c he . anche s tavolta, colpirono persona lit à di rili evo. Si a prì , così, un nuovo pe ri odo cl i crisi caratterizzato da un a sensibile flessione dell ' attività clandestina580 . Vennero catt urati c inque generali, fra cui Odon e, Caratti e Caruso: q uest' ultimo s ubì feroci s evi zie ma non rive lò alcuna informazione su ll 'apparato c lande s tino dell 'Arma . In o ltre , po ic hé si trova va in p ossesso di alcuni d oc um enti co mpromettenti c he avre bbero potuto fornire preziose indi cazio ni a lle SS , ebbe la prontezza d i in goiarli per non far li ca dere nelle ma ni s bagliate .
579 A.U.S.S.M.E .. N. I - IO. Diari sro rici 2" Guerra mondiale , b.3022 , f.8. " Relaz ione s u li' attività svolta dal Coma ndo G ruppo Settori de ll 'o rga nizza z ione militar e cla nd es t ina in Roma riferita al periodo 19 apri lc-29 maggio e.a.".
580A .U.S.S M.E. , N./ -10 Diari s to rici 2" Guerra mondiale, b. 3022, f.9 , ·'R elatione sulro rganizzazìone e il funzio name nto del I Settore di Roma (fro nte C landes tin o dì Res is tenza) nel peri odo febbraio- 7-6-944 ' '.
212
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
Nel me se di apri le com in c iò la pianificazione e l'addestramento della prima vera campag na in Italia dopo i deludenti risu lt ati de ll'inv erno : l'operazione Diadem, il cui obiettivo era lo sfondame n to della lin ea Gustav, apprestamento difensivo che si presupponeva i tedesc hi avrebbero difeso s trenuamente581 e, dunqu e, la neutrali zz azione delle truppe germaniche prima di raggiungere la capitale.
La Diadem ebbe inizio l ' 11 maggio. La penetrazione della V Armata fu impetuosa e incontenibile: travo l se la Wehermacht nella valle del Liri e, superati i fiumi Garigliano e R apido, il 16 costrinse Kesselring ad ord in are alla X Armata l'immediato abba ndono di Cassino.
Lo sfondamento della linea Gustav, tuttavia, segnò l'inizio del redde rationem tra Clark e Alexa nd er. li generale Harding, al fine di realizzare gli intendimenti di Alexander, ovvero i mpedire che la X Annata di von Vi etinghoff in ritirata si cong iu ngesse alla XIV Armata di Mackensen, si fece promotore dell'operaz ione Buffalo in base alla quale, le truppe impegnate ad Anzio si sarebbero dovute spostare ad es t , oltre i Colli Albani, per sbarrare il passo ai tedesch i all'altezza di Valmontone. In tal modo , la X Armata sarebbe stata strito lata dalle forze aJleate di Cass in o c he l'insegui va no , e quelle di Anzio che la bloccavano. Clark, tuttavia, non gi udicò attuabile il piano propugnato dagli in glesi e ne fece presenti i p unti deboli: p rimo fra tutti, la poss ibilità che i tedeschi percorre sse ro altre st rade per la ritirata.
Secondo alcuni storici , Clark rit e neva che l'op eraz ione Buffàlo fosse finalizzata a permettere aU'VIII Armata di fare per prima il suo ingresso nella capita le 582 • Bidwell e Graham hanno asseverato che il comandante della V Armata, la cui car ri era e ra stata seriamente compromessa dal ri stagno dell 'operazione Shingle, sospettasse un complotto britannico volto a d efra udarlo de l merito della v ittoria nella battaglia di Salerno. Pertanto, considerava d' importanza fondamentale la conquista della Città Eterna poiché ad essa riteneva fossero affidate le sorti della s ua carriera: l'arrivo a Roma sarebbe avvenuto due giorni prima dello sbarco in Normandia e questo, a s uo parere, lo avrebbe reso intoccabile 583 S ull e strategie belliche, pertanto, come dimostrato dalla ris olute zza con c ui Clark volle puntare s u Roma ed a ssegnare alla sua armata q uesto ambito traguard o, gravarono ancora una volta consideraz ioni meramente politiche.
Malgrado la situazione volgesse in favore degli angloamericani, tutto faceva presuppore che la città eterna sa rebbe s tata te atro di scontri, quanto-
 58 1 Dominick Graham-She lford Bidwell, La battaglia d'Italia, Rizzoli , Mi lano, I 989, p.252.
582 Robert Katz , Roma c ittà ape11a, c it., p.323-327 .
58 1 Dominick Graham-She lford Bidwell, La battaglia d'Italia, Rizzoli , Mi lano, I 989, p.252.
582 Robert Katz , Roma c ittà ape11a, c it., p.323-327 .
213
583 Dominick Graham-Shel ford Bidwell, op. cit , pp.268 -269
Sabrina SguegLia della Marra
me no in periferia e la Sa nta Sede attivò og ni cana le di negoz iazione per sco ngiurare l'im min e nt e pe ri colo. La Segre ter ia di Stato in terpellò gli ambasc iatori di Germania e Spagna per ottene re rassic urazi o ni in merito a ll e m a nov re b elliche: il primo affermò che, dal pu n to di v is ta em in entemente mi l itare, i tede sc hi avrebbero po t uto collocare a Roma la lin ea di re s is tenza all'avanzata alleata; il sec ondo si dichi a rò pers uaso che Kesselring non av re bbe abbandonato la c ittà se no n dopo averne tentato un' est rema d ifesa. Se ciò s i fo sse verifica to, ine vita bilme nte alcuni quartieri sarebbero s tati di s trutti.
li t im ore cli u n ' indi scri min ata devas taz io ne , tut tavia, si di ssolse ben pres to, allo rché avvenne que ll o che Giovannetti ha de finito "un meravigl ioso si ncro n ismo" tra l ' ingresso delle truppe alleate e la ritirata di quelle germaniche. Lo storico, pur ave ndo ampia me nte doc umen tato l'effic iac ia dell'attiv it à diplomatica vaticana durante la guerra e l'occupazione. ha escluso rec isame nte c he tale fe l ice evenienza possa asc r iversi o in q u alche modo 1icondursi ad un accorcio preciso: mal grado le apparenze , non fu possibi le co ncl ud ere alcu na treg ua ufficiale 584

Q uan to alla posizione delle Nazioni Un ite circa il r icono sc imento della città aperta in prossimità della l iberazione, Macmillan ha rifer ito che, ne lla riunione politica del quartier generale alleato tenutasi il 16 maggio, egl i r iu scì a far p r evalere l ' op ini one i ng lese seco ndo cu i s i sa rebbe rivelata oltremodo controp roduce nte 1' a ttribuzion e cli tale stat us pr ivilegiato alla capitale, non perché si vo le sse attaccarla. be nsì per poterne di s porre liberam ente una volta con q u is t a t a . Di eci giorni dopo, esam in ata la proced ura da seg uir e nella presa di Roma, per vo lere di A lex ande r s i giudicò co n s ig liabil e che l' operazio ne non assume ss e altri s ignificati ma si svo lgesse co me un se mpl ice eve nto mi l itare e se nza alcuna e n trata ufficiale. I noltre , poic hé la battag l ia in corso mirava al com pleto a nnientam en to d e ll 'es e rci to teutoni co , og ni manifesta zione trio n fal istica doveva esse re rin viata all'occupazione dell 'o biettivo.
li gene rale J oh n son, della V Annata ame rican a, avrebbe ass unto le funzion i di governatore per co nto di Clark e sa rebbe s tato affiancato d alla Special Force e da ufficial i dell ' AMGOT 585
A lexan der, i l 27 maggio, in un me ssagg io rivolto ai patrioti italiani op era nti nella zona compresa tra Firenze e Roma, li esortò a sabotare con ogni mezzo le linee di com unicazio ne usate dai tedeschi per il trasp orto de i rifornimenti alle truppe germaniche e a segnalare qual s ias i movimento delle divi-
214
58-1 Alberto Giovan netti, op. cir., pp.1 7-19. 585 Harold Macmillan, up. cii., p 604, 6 I 3.
s ioni ne mich e586 I n un co ll oqu io te nu tos i il 3 g iu gno, il co mandant e in capo de ll e forze alleate ass icu r ò a Messe c he ali' ingresso nella cap itale avrebbero partec ip ato reparti ital ia ni scelt i appartenenti al CIL pe r i quali avrebbe disposto per tempo il trasporto587

Il primo giugno cadde Velletri e si aprì la strada per Ro m a . Tre g io rn i dopo, la penetrazione delle truppe della V Armata nelle posizio ni difens ive tedesch e a sud, travolse le linee nemiche. O gni r es istenza sulla via Casi lin a cess ò e l'VIII Armata, operan t e in quel se ttore , s ' im possessò d i Co ll efe rro ed Anagni, costringen do i tedeschi a ritirarsi disordinatame nte verso nord ovest588 e, il 5 gi ugno, procede ndo l 'avanzata, riuscì a liberare numeros i centri fra c ui Pales trin a, Fi uggi, Palian o, Grottaferrata e Marino.
Un comu nicato spec iale del Quartier Generale alleato annunciò i risultat i conseg ui ti e l'avv e nuta occupazio ne di Roma da parte de lla V Armata, nella notte tra il 4 e il 5 gi u gn o: "elementi avan zanti avevano a t traversato la città e s i trovavano in vari punti al di là d el Tevere"589 .
Il bollettino germanico comunicò nelle stesse ore il progress ivo avv icinamento della li nea del fro nte alla cap itale e che, perta nto, il Fiihre r aveva ordin ato il ritiro delle truppe su pos izioni a nord -o vest della città al fine di salvag ua rd a re l ' integ ri tà del più antico centro culturale . La battag li a sarebbe com unque pro segui ta finché l'avanza ta nem ica non fosse s tata spezzata e fino alla v ittoria, " in stretta collaborazione con l 'It al ia fascista'' 590 .
Il cong iungimento delle truppe della V Armata con la testa di ponte di Anzio provocò, invero , la fretto losa partenza del Maresc iallo Graziani . Il mattino d el 4 giugno , l' ufficiale di collegamento germanico presso il Coma ndo della città aper ta abban donò i l suo uffic io dopo averne bruc i ato tutti i documenti. Maeltzer co mun icò c he i poteri mil ita ri ve ni vano tr as mess i al generale Chirieleis o n59 1 .
586 A .U.S .S. M. E., N./-1 /, Diari sto rici 2" Guerra mondiale, b. 3 07 3, allegato n.942, "Bolle ltino german ico", 28 -5- I 944 .
587 A .U.S.S.M .E. , N.1 - 11, Diari sto ric i 2° Guerra mondiale, b.3074 , allegato n.100 , "Co lloquio avvenuto il giorno 3 giugno 1944 ore 14 lra: generale Alexander-ge neral e Mac Farlanemaresciallo Messe-Ammira glio De Courten -genera le Infante" .
588 A . U.S.S.M.E. , N. l -1 /, Diari s torici 2a Gue rra mondiale , b.3074, a ll egato n.63, " Comun icato all eato", 4 -6- I944
589 A.U.S.S.M.E. , N.1 - 11 , Diari storici 2° Guerra mondiale , b 3074, allegato n 101, "Com unicato a ll eato" , 5-6 -1 944.
590 A U.S.S.M.E , N.1 -11 , Diari storici 2" G uerra mondiale, b.3074, allegato n.102 , "Bollett ino germanico", 5 -6- 1944.
59 1 A.C.S., Mini stero della Real Casa, Ufficio del Primo aiutante di ca mpo del re, Serie spec iale , b 81 , f.30, " Re laz ione Bon za n i".
Montezemolo e il Fron te Militare Clandestino
215
Sabrina Sguegl ia della Marra
Tamass ia si recò a rapporto dal C oma ndante militare e civ il e di Roma Benciven ga che, d opo opportun i raggua g li s ug li ultimi s vi lu ppi , g li comunicò le nuove diretti ve e gli affidò il compito di riun ire nelle pro prie man i la fin a trama de ll 'a pp arato mili tare clandes tin o .
L' impresa presentò moltepli c i ostacoli deriva nti da ll a rigid a co mpartimentazione cui era i mpro nta to il s iste ma di lavoro. A c iò s i aggiun se la latitanza di co loro c he. ave nd o ag ito al fianco dei generali ca d uti pri g ionieri , sareb bero sta ti i più indicati pe r riannod are le fila del movimento ed eventua lmente sostituirli ne lle loro fun z ioni , m a res taron o na scos ti a lun go pe r rag ioni di s ic ure zza.

Il p ri mo gi u gno , il ruo lo di prim o p iano ass unto d a T ama ss ia , che era d i fatto su b e ntrato aJ ge nerale Caratti , otten ne sanzion e u fficiale: raggi unto da Pac ino tti , g li ve nn e co municata la desi g naz ione a nuovo Com a nd a nte de l gru ppo se ttori e la no mina a s uo ca po di s tato maggio re del te ne nte co lonnello Si mo ne tti .
Be n c ive ng a avocò direttament e a sé i com piti attribuiti al gen e ra le Odo ne e s uo capo di Stato M agg iore di ve nne P acinotti ; fu ro no a ltresì ap provati i provvedimenti r el ativi ag li aJtri in caric hi propos ti da Ta massi a , ovvero l 'assegnaz ione del I sett ore al col o nn e llo M essi na , già co m a ndante del sotto setto re B , e del IU settore a l colonnello Boglia cc ino , in sost ituzione de l generale Girotti.
Il ge nera le Corte ll essa, infin e, riu scì a sfuggire aJ la prigio ni a poc he ore dopo l'arres to e, pur rima nendo prudentemente nascosto, fu in grado di conserv are sa ld a mente la d irez ion e d e lle attivi tà di s ua compete nza , in partico lare di q uella a nti sa botagg io .
li Com ando ge ne ral e e il Co m a ndo gruppo se ttori avreb bero dovuto insediars i appena poss ibil e in Cam pidog li o .
All ' arrivo degli All ea ti , per tan to , il Comando Mil ita re ital ian o provvisorio in Roma e ra cost it uito dai ge nera li Benci ve nga , Ta m ass ia e Od one, Girotti , Caratti e Corte ll essa, e dai co lonn e ll i Pac inotti , De Pe tro, Balzani e Sa mpò 592
Tamass ia co nv ocò i tre comandanti di settore p er esa minare la s ituaz ione e g li ordini o perativi c he app arivano maggiormente conse ntanei ad essa. L a riu nion e, ind e tta per saba to 3 giug no, ven ne rinviata a l g iorno success ivo m a i l ge neral e, imposs ibil itato a ra ggiu ngere la s tazione Ter mini, luogo stab il ito per l'in co ntro , si fece sos tituire dal capo di s ta t o magg iore per i l l setto re, C roci , c he assicurò un collegam e nt o d iretto co l colo nnello Mess ina, co m a ndante inte rin al e del I se ttore.
216
592 A.U.S.S.M.E I-3. b. 188. f .2.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
Poco dopo le 20, quando ebbe la certezza che pattuglie di avanguardia americane ave s sero fatto il loro ingresso nella capitale, Tamassia, scampato al fuoco dei carri leggeri tedeschi e americani in via Cavour, primo tra gli ufficiali, s i trasferì in CampidogUo.
Da qui, died e ordine a i CC.RR. di ve stire l ' uniforme e di attuare il p i ano loro assegnato. I Regi Carabinieri entrarono in città alle ore 7 del 5 giugno e, accolti con grande entusiasmo da parte della cittadinanza, adottarono celermente la forma z ione di Legione territoriale di Roma prestabilita, ovvero, un comando cli legione , due comandi di gruppo, quattro comandi di compagnia territoriali, due compagnie riserve e dieci nuclei u fficiali con a capo i ri s pettivi ufficiali.
Il tenente colonnello Patrignani, comandante del raggruppamento territoriale, nell ' imminenza del ripi egamento germanico, valutò la pos s ibilità di effettuare un colpo di mano a yia Tasso per lib erare i detenuti, tra i qmùi vi era il capo dell'organiz zazione clandestina cieli' Arma. Furono presi in esame alcuni progetti ma gli eventi presero il sopravvento. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, infatti, ebbe inizio il disordinato deflusso delle truppe teutoniche dai Colli Albani attraverso la via Appia.
Verso le ore 9 del 4 , tuttavia , si apprese la notizia dell'evasione di un gruppo di prigionieri e, fra questi, di Geniola e di Caruso 59 3 . Questi, s chivata la s orveglianza tedesca, riu scì in breve tempo a raggiungere Bencivenga per ricevere ordini in merito all'attua zione dei piani elaborati di concerto col FMCR: come prescritto , le direttive furono es eg ui te all e ore 21 del 4 giugno col sincronico afflu s so dei miclei verso gli obiettiv i da presidiare e i pattugliamenti al fianco delle bande partigiane, mentre le retroguardie avversarie occupavano ancora alcuni settori della città. L'azione rapida ed energica dei CC.RR. impedì al nemico in ritirata di compiere atti di sabotaggio, incendi e distruzioni e , nonostante il delicato momento, contribuì notevolmente alla pre servazione dell ' ordine evitando ulteriori spargimenti di sangue.
I carabinieri procedettero altresì alla perquisizione di numerosi edifici, fra c ui le sedi di vari partiti, che portarono al recupero di ingenti quantità di armi e ricondussero alla legalità quanti, arrogandosi il diritto di sostituirsi a.Ile autorità legittime e avocando a sé poteri che solo ad ess e sp e ttavano, nei nove mesi d'occupazione aveva no compiuto fermi , arresti e sequestri. Per integrare la forza occorrente all'adempimento di tal i onerosi compiti, fu necessario riammettere in servizio 1200 carabinieri già appartenenti alle bande dei patriot i594

59:1 Fi li ppo Caru so, op. c it., pp 79 -80 594 A.U.S.S.M.E. , 1-3 , b 149, f.2. 217
Sabrina Sgueglia della Marra
Grazie alla prova data nel movimento di res iste nza, il Comando d ei CC.RR. , giu nto da Napoli al fianco degl i Alleati, otten ne l ' inserimen to della banda " Caruso", riconosciuta come for m azione di so lida fede patriottica e an tifascista, nel servizio regolare dell' istit uto dell' Arma595
Anche l'organizzazione clandestina della Guardia di Finanza entrò prontamente in azione e, in conformità degli ordini ricevuti dal FMCR, effett uò le operazioni previ s te: numeros i reparti armati circondarono le caserme al fine di proteggerle eia eve ntuali attacchi; gli ufficiali della Legione Territoriale occuparono il Commissariato di Porta Maggiore e qui un gruppo di militari ag li ordini del tenente Stella, in collaborazione coi patrioti attivi nella zo na , provvide ad ass icurare iJ servizio d 'ordine pubblico. Al contempo, una pattuglia di Fiamme gialle respinse un colpo di mano tentato in extremis, a più ripre se, dalle ultime retroguardie germaniche contro la caserma di viale XX1 aprile , per impadronirs i degli automezzi in essa c usto diti che avrebbero consentito di accelerare la fuga. Duran te il breve ma intenso combattimento, persero la vita due partigiani e i1 finanziere Sciuto, mentre il capitano Altamura rimase ferito.

La Guardia d i Finan za impedì la distruzione di impo1tanti edifici pubblic i, fra cui l'Istitu to Poligrafico dello Stato, ove un piccolo gruppo di soli cinqu e elementi, riuscì a respingere l ' incurs ione di un ben più copioso n ucl eo di guastatori tedeschi 596 .
L' Organi zzazio ne Comm issariati , all'arrivo delle truppe a ngloamericane, dislocò le proprie forze a presid io della Qu es tura Centrale e dei vari commissariati. Passata alle dipend enze della polizia alleata , l'OC costituì l'ufficio militare presso la Regia Questura, pos to agli ordini d el maggiore Battersbey, vice capo della Pubblica Sicurezza. All ' ufficio furono attribuite diverse competenze che concernevano la sorveglianza dei co mmi ssariati di PS, di cui doveva controllare l'efficienza e l'atti v ità svolta, o attenevano ad un ambito più spiccatamente politico, come la raccolta di tutte le informazioni significative circa la situazione interna della capitale, non solo dal punto di vista militare , a partire dal l 'insediamento del Comando della città aperta fino alla liberazio ne. Fu avviata, infine , l 'epurazione dei funzionari compromessisi con la dominazione nazifascista che, debitamente denunciati, vennero tratt i in arresto 597
595 A.U.S.S.M.E., N.1-10, Diari storici 2" Guerra mondiale , b .3022, f .27 , "Relazione s ull'attività svo lta dall 'orga ni zzazione dei CC.RR ( Banda Caruso) del Fronte Clandestino di Res is ten za dalla s ua co stituzion e all'8 gi ug no 1944" , Fronte Clandestino di Resistenza dei CC.RR. in Roma (Banda Carus o), 16-6-1944.
59 6 A.U.S.S M.E., /V. I -IO, Diari storici 2° Guerra mondiale, b.3022 , f.28, " Contributo al Fronte Clandestino della Resiste nza della Banda Fiamme Gialle"
59 7 A.U .S.S.M E. , 1- 3, b 187, f.5 , "Promemoria", il capitano in s p. e Luigi Battist i, 15-7- I 944
218
Come attestato da lla relazione stilata pochi giorni dopo la l iberaz ione, Ta m ass ia, giu nto in Ca mp idog li o alle o re 2 1, in viò al tenente colonnello Croc i , tramite un fu nzionario del Gove rn atora to , le nuove direttive c h e, nella sostanza, confermavan o que ll e im partite in pr eced enza.
Poco dopo, u na comun icaz ione te lefonica del capo di gab in etto di B encivenga ann unciò al ge nera le c he, d a q ue l mome nto in po i, avreb be dovu t o a d empiere le funzio ni di co m an d ant e del p resid io d i R o m a poiché, la mattina success iva alle o re 6,30, i l Coma ndante mi litare e civ il e de ll a capitale av rebbe ass un to u fficialmente i poteri in C ampidog l io
Tamassia, pert anto , volle s in cerarsi c he i settori avessero g ià ri cev uto l'ordine di agire: Simonetti e Croc i g li assicuraro no c he le operazio n i p restabil ite erano già in co rso. Nella notte , il generale d iede dispos izio n i al q uestore Morazz ini perché venisse rimosso i l maggior numero di man i festi fascisti e n az isti c he tapp ezzavano i muri d ella città598 •
Chirieleiso n , la matt in a del 4 g iu gno, ri cevette un d ispaccio d ell' O SS in cu i P eter Tomp kin s lo s o ll ecitò a pors i agli ord ini di Bencivenga e a fa r rifer im e n to al genera le pe r tu tte le questioni in e r e nti alla ges ti one del Coma ndo d ella città ape r ta, p rega ndolo di dare t u tto il sosteg no e l'assistenza possi bile .
Analoga m ente, il gen era le Prest i app rese da u n messaggio le nu ove d isposizio ni d e l generale A lexander: al fi ne di p reserva re le ope re di pubblica utili tà della capitale, le forze di p olizia sareb bero passate a ll e dip en d enze di Chirieleison, responsa bi le verso il co m a n do d ell' O SS d e ll a salvag uardia di tutti gli edifici d a atti di sa bot agg io, dell'arres t o e de ll ' in te rn amento d e i mi litari s ba ndati d e ll e fo rze armate tedesche e rep ubblicane. In fine, si sa r e b be dov uto con tene re l'esodo d egli element i civ ili
599
To mp kins , tuttavia, ha affermato d i non essere affatto a co nosce nza, in quel momento , d e ll a presenza a R oma di "altre autorità affaccendate a emanare o rd ini" . L a spia inglese h a riferito di aver consegnat o a Chirie leiso n e a Presti una direttiva scritta in fo rm a uffic iale s u cart a intestata "Ufficio de i Servizi Strategici d eg li Stati Un it i", in cui era s tab il ito che i ge neral i assumessero i l controllo d ell'ordine p ubbl ico im p iegando tutte le fo rze dispon ibili600.
598 A.U S.S M E , N./ - /0, Diari storici 2° Gu erra mondiale, b 3022, f.9, " Re lazione sull'organizzaz ione e i l funzionamento del I Setto re di Ro ma ( Fronte Clandestino di Resi stenza) nel periodo febbraio -? gi ugno 1944 ".

599 A. U.S.S.M E., N. I-I I , Diari storici 2a Guerra m ondiale, b.2 121, f.3, Office of Strategie Servic es, Headquarte rs Fifth Army, Rome Area, to Generai C hirie le ison , Comandan te della Città Aperta di Roma, 4 -6 - 1944
600 Peter Tomp kin s, op cit. , p.37 1.
Mon tezemolo e il Fronte Militare Clandesti no
219
Sabrina Sgueglia della Marra
C o ntra vvene nd o a lle direttive alle a te , la se ra de ll o s tes so giorno Tam ass ia comunicò al coma nd a n te de ll a ci ttà ape rt a c he da a llo ra av rebb e dov u to riten e rs i d eca du t o dalla c arica ricoperta, ma s i d ove tte sco ntrar e co n la r isoluta opp os izion e di Chirielei s o n. 11 ge nerale repli cò pere ntoriament e che q ua lun qu e dec is io ne sa rebb e s tata presa l ' indoman i , una vo l t a avven uto l ' i nsediame nto ufficial e di B e nciven g a. I l mat tin o de l 5 g iugn o, infatti , s i recò in Campidogl i o recando co n sé gli o rdi ni a m er ica ni m a Paci no tti, secondo la te s timoni anza d e llo s tess o Chirie le ison e de l s uo ca po di stato mag gio r e, n on gli p e rmi se di confer ir e co n B enc ive n ga: dop o due ore di a tt esa , gli rib ad ì ch e le di s posiz io ni all ea te non avevano più valore e ch e il gen e rale av re bbe dovuto mettere il Comando della citt à aperta in stralci o 601 .
Chirielei so n no n poté c he r imette r si ag l i ordin i ri cev uti ma affidò le s ue ,obiez ion i ad una mi nu ziosa e c ir costa n ziata re laz ione in c ui doc um entò l 'a tti v it à del Com an do della città ap e rta es primendo il s uo "convinto" ramm a rico p er il trattamento , a s uo pare r e i n gius tifi cato, r i se rvato a ll a sua per sona e ai s uo i so ttop osti. So tt o lin eò, in particolare, che , pochi g iorn i p rim a de lla liberaz ione, il tenente colon ne llo Mu sco e il ge ne ral e Van nett i, a no me di B e nc ive nga , g li ave va n o ord i nato di rim a nere al propr io po s t o insiem e a B o nzani.
Chiri e le is on s i d isse per s uas o c he il s uo p as s ato di so ldato e la fiduci a in lui n utrita d a i s uperio ri e d a i co ll eg hi , "a vrebb ero dovuto div e rs am e nte c ons igli are" e , pe rtanto , aus pi cò ch e attraverso u n 'es auri e nte inc hie s ta , fo sse ricon osc iut a l'azion e svo lta in s ie me a i s uoi co llabora tori , " un blocco di volont à e di e nergia , inspirato a d alto se nso d ' italianjtà e pa triotti s mo" 602
A ncor più amaro fu lo s fo go de l te nent e co lonnello Bo nzani che, a ddirittura , parago nò la s ituazione crea tas i allo sfasc io seguito a ll a pro c lamaz ione d e J1' a rmi s ti zio:
Si ripetev a no i fatti de11' 8 se tte mbre 1943 , so ltant o c he p urtro p po que s ta volta e rano gl i ita liani a co mp ierli e proprio verso qu e ll ' organi zzazione e qu e i colleghi ch e c on le bene vo i i dispo s izioni , co n l ' ostruzioni s mo ai voleri germani ci e rep u bbli cani, con ai uti materia l i, avevano reso poss i bile il sorge re e il fio rire in R oma dell ' Organi zzazi o ne c lan des tina i n ge nere; e che , in partico lare, avevano dato a g ra n part e degli u ffi c iali a ll a macc h ia , co n gravi ri schi pers ona l i. una copertura ch e aveva facili ta to lo svolgimento de i comp iti che c ia sc uno si era prefisso. L'o ra
601 A. C.S , Mini s tero de lla Real Casa, Ufficio del Primo aiu tant e di campo del re, Se rie sp ecia le. b 8 1. f. 30 ' Rela z ione Bonza ni"
602 A.C .S Mini stero della Real Casa, Ufficio del Prim o ai111a111e di ca mpo del re, S erie sp ec iale, b.8 1, f.7 , Relazio ne genera le Chiric le is on ".

220
solenne che si attrave rsava impon eva che s i ev itassero dissidi e lotte intestine spec ie verso Comandi e d en ti da noi ritenuti legalmente in sediati603
Il generale Bencivenga volle intervenire personalmente nella controv ersia redigendo una relazione in c ui , dopo un'excursus dell ' opera svolta da Chirielei s on , testimoniò l'impegno e il coraggio con cui aveva adempiuto alle proprie fu nz ioni malgrado l'ambigua situazione della capitale , soggetta " all'ibrido connubio d el potere di fatto dell ' occupazione militare tedesca dei rappresentanti della repubblica di Salò". Da ciò era scaturito "un intreccio di rapporti, una fonte di contrasti, un complesso di esigenze di ordine materiale e morale che richi edeva tatto, accorgimento, abnegazione e coraggio non comune" in qu ei comandanti e fun zio nari che , to llerati dalle autorità germaniche, si erano prefissi, come Chirieleison, di concorrere attivamente , con tutti i mezzi e le possibilità di cui erano in grado, all ' opera patriottica alle forze della resistenza.
Il 23 marzo, il Comando d ella città aperta era passato clandestinamente agli ordini d el Comandante civile e militare di Roma ma ciò non interruppe l'attività del generale che con tinuò a collaborare sabotando gli ordini tedeschi, sos tene ndo le bande patriottiche e proteggendo le perso ne più esposte al pericolo.
Bencivenga osservò, infine, che Chirieleison avrebbe potuto sottrarsi alla delicata incombenza di presiede re e gestire il Comando, dandosi alla macchia, nascondendosi a Roma o nei dintorni, o entrando a far parte di uno dei gruppi clandestini di resistenza, cosa che gli sarebbe valsa una medaglia d' argento604
Un'al tra contesa che sollevò accese polemiche vide contrapposti Pacinotti e Renato Montezemolo. Come s i apprende dal particolareggiato resoconto vergato dal capitano di fregata sui concitati avvenimenti del 4-5 giugno, egli, informato della scarceraz ione di Odone, tentò invano di mettersi in contatto col generale che, nel frattempo, aveva riparato in Laterano con Benc ive nga. Provò dunque a rintracciare Pacinotti ma questi risultò irrepe ri bile per molte ore.
La ritirata tede sca era cominciata, le comunicaz ioni telefoniche erano interrotte , i mezzi di trasporto sospes i: l'incalzare degli eventi, pertanto, lo d ec ise all'azione. Ancorché in assenza di direttive superiori, l ' ufficiale della Marina istituì un comando provvisorio con sede al collegio San Giuse ppe per
603 A.C.S., Ministero della Real Casa . Ufjìcio del Primo aiutante di campo d el re, Seri e speciale, b.81 , f.30, '' Rela zion e Bonzani".
604 A.U.S.S.M.E. , N. l-1 /, Diari sto rici za Guerra mondiale, b.2121 , f .6, 'Testimon ianza res a dall'on. Sen. Gen. Roberto Bencivenga" .

Montezemolo
Fronte Militare Clandestino
e il
221
Sabrina Sgueglia dell a Marra
da re ap pli caz ion e agli ordini ema na ti ne i mes i precedenti. Tra g l i u ffi ciali de l comando, s i annove ravano il maggiore Pi anell a, i ca pi tani S ircana, B atti s t i, C a ndi lo e Dalitala.
Mon teze m olo riferì, i no ltre , di esse rs i ri vo lto alla moglie di Pac i no ll i affinc hé , appe na avess e avu to modo di incontrarl o, so ll ecitasse i l co lo nne ll o a raggi u ng e r lo quanto prima. S eco ndo ta le rico s truz ione, il capitano di fregata, a lle 2 1,3 0 s i occupò della diramazio ne d e ll e direttive contenute ne l pia no d i occu paz ione d eg l.i obi ettiv i a ll e fo rze c la ndestine delle tre Ar mi e alle band e dei parti ti Poco dopo , e bben e no n s ia preci sa to come gli ven ne r ecapitata , ri ceve t te l'au tor izzaz ione d i Pacinotti a dar e !.'a b br iv io a ll e operazioni Al l 'a lba d e l 5 gi ugno, non ave ndo ricevu to indicazio n i dai su oi s up eri o r i, M o ntez emolo t rasferì il coman do provv isorio da lui cos titu ito in Campid ogl io, ove t rovò Pacinotti e Tamassia605
La testimonianza di Pa c inotti confutò, quasi int e ramente , taJ i di c hiarazioni gi ud icandole mendac i e s urre tt iz ie . Egli stigmatizzò il tenta tivo del capit ano d i me tte rs i in contatto con O d o n e poiché il capo di Sta to M agg iore in carica e ra lo s tesso Pacino tt i e contestò l' u rge nza d i c r e are un a l tro co m ando in q uan to g ià es is teva q ue llo leg ittimo di Bencivenga. In caso co nt ra rio , no n sa re bbe s petta to a Mon tezemo lo ado ttare una s imile riso luz ione poiché esorbitava dall e co m pe tenze di u n semplice ufficial e di co ll egamento. Il capi tano d i freg ata, pe r ta nto , s i sare bbe d ov uto li mi ta re ad a tten de re g li ord ini es ec uti v i e a tras metterl i alla Regia Mar in a. La r iunion e de l co ll eg io S a n G iu seppe, ino lt re, seco ndo Pacinotti, fu indetta da P ia ne ll a e in virtù di una dispo s iz ione ar bitrariame nte impartit a da O d one . I nfin e. s m e n tì l'incontro con la moglie e sco nfessò la " pre tesa" atl ivit à d e l co mando p rovv is orio: in realt à, s i era svol to tutto co me prestab ilito e le ope razio ni furono eseguite se nza la nec essità d i apportarv i modifich e o aggi o rname n ti di sorta. Pacinotti soste nne di esse re ri uscito a mantenere cos tanti co ntatti c ol Comandant e Bencive nga e co l ge ne rale Ta ma ss ia. L'occ u pazio ne del Ca m pido gl io , a d is pet to di quanto asse rito d al c apitano di frega t a, fu e ffettuata regolarmente 606 .

Benc ivenga, co me s i legge in un bre ve comme nto pos t o a ma rg in e d i q uest a re l az io ne, ne confe rmò tutti i punti , s al vo es c l ud e re categoricamen-
605 A.U .S .S.M. E 1-3. b.148 f.4. "Relazione del cap itan o di fregata Renaio Montezemolo", al Co mando Su pre mo -U ffic io P erso nale Al'fari Va ri 16 -7 - 19 44; A U.S .S. M. E., 1-'.l b.1 48 , f.4, "Espos to de l c ap itan o di fre ga ta Renato Montezemolo'', a ll o S tato M agg iore Gene ral e- Ufficio Patrioti. al Mini ste ro della Ma rin a-Gabinetto , 22- 12- 1944.
606 A.U.S.S.M.E., 1-3. b. 148. f.4. Mini s tero della Gue rra , Ufficio S tral e io -I.M.A . R .. il colonne llo Pac in o ll i s ulla relaz ione de l capitano di fregata Renato Monte zemo lo al Re parto Fronte c landestino di resi stenza (M ini stero d ella Guerra). 15-9- 1944.
222
te c h e O do ne s i fosse permesso di i m partire disposizioni c h e non gli compet eva no
Il general e condannò severamente l 'arbitraria iniziativa d i Renato Montezemolo ravvisandone l 'asso luta i Ueggitimità dimo strata in modo inoppugnabi le dalla completa e puntuale attuazione dei piani prefissa ti. Solleci tò dunqu e, il ministro della Marina a richiamare ufficialmente il capitano a d u na maggio re o nestà esortando lo a ri trattare le "false e basse in s inuaz ioni " con tenut e ne l rapporto redatto che lo rend eva no "indeg no de l nome c he po rtava"607 • Nel gen naio del 1945 , tutt avia, il Comandante c ivile e mi litare di R oma prese visio ne dell'e sp osto608 che, co rredato di prove e documenti per s uffragare la propria versione dei fatti, Montezem olo fece pe rvenire allo Stato Maggiore G enerale e a l Ministero della M a rin a, e rico n siderò la sua p osiz ione in merito. L e affermaz io n i de l capitano di fregata, a suo modo di ve dere, non scaturirono da un inte nto di ffamatorio a i danni di Pa ci notti ma mirarono verosimilmen te, più che a screditare la condotta d e l co lonne llo , a provare la buona fed e sottesa ali ' azione de l comando "provvis orio". Sebbene Montezemolo , col s uo "strafare", avesse fatto , seppur " in co ns ciamente" , il gioco "di osc uri armeggi" tenden ti a so ttrarre a B e ncive nga il co ntrollo della s it uazione, esponendo così ad un serio pericolo I' intesa fa ticosame nte raggi unt a tra FM C R e CLN, q uesti, su lla base degli acce1t a men ti effettuati , ritenne opport uno atte nu a r e il suo d uro g i udizio " limita ndo l' addebito a defici e n za di qu ell'autocontrollo c he è doveros o nella r elaz ioni ufficiali, specie q u a nd o d a ta le deficien za può derivare danno alla reputazio ne di colleg hi od u rta rn e la susce ttibi lità" 609
L'occu p azio ne a n gloameri cana si svolse senz a particolari disord ini , in un'atmosfera d i calma s ingo lare che non rese necessario , pertanto, alc u n intervento mi litare da parte dei settori, i cui reparti armati potero no raggi ungere, pacificamente ed en t ro i limiti di tem po previs ti , t utti g li obiettiv i territorial i assegn ati.

Si presentò un solo in co nv e ni e nte determinatosi pe r la temporanea sovra pposi zio ne dei nuclei ag li o rd ini del ge neral e Cerica, Comandante s u periore d ell'Arma, la cui adunata fu indetta nella caserma d i piazza S. L o r e nz o
607 A.U S.S.M.E., 1-3, b.148 , f.4, Mini stero della Guerra , Ufficio Stralc io- 1.M .A.R. , il generale Benciven ga sulla relazione del capitano di frega ta Ren ato Mo ntezemo lo al Reparto Fronte clandestino di resistenza (Ministero della Guerra), 15 -9- 1944.
608 A.U.S.S .M. E. , 1- 3, b .1 48 , f.4 , "Esposto de l capitano di fregata Ren ato Montezemolo" , allo Stato Maggiore Generale-Uffic io Patr ioti, al Mini s tero della Marina -G abinetto, 22-12-1944.
609 A .U .S.S.M.E. , I -3 , b. 148 , f.4, Comando Civ ile e Militare della città di Roma e s uo territorio s ituat o in zona di guerra - Ufficio s tralcio , al Maresciallo d'Italia capo d i Stato Maggiore Genera le Giovanni Messe , "R isposta al foglio n .8089 in data I 9 genn aio 1945 ", 23-1- I 945.
Montezemolo e il Fro nte Militare Clandestino
223
Sabrina Sgueglia della Marra
in Lucin a, con quella della Legione dei CC.RR. operante con la V Arma ta coma ndata dal tenente colonnello Perinetti che, in un primo momento, non riconobbe alle for ze dell 'organ izzaz ione militare clandestina l'autorità di operare 610
Ne l rapporto che il federale di Roma Luigi Pas qualu cci inviò a Mussolini nel luglio del 1944 per dare ragguagli circ a la partenza dei fascisti repubblicani, si leg ge che fino al mattino del 3 giugno il generale Maeltzer escl use a più riprese l' e ven t ualità dell'abbandono della capitale e non consentì l 'evac uazione con automezzi delle famiglie di colo ro che risultavano iscritti al Fascio romano. Secondo il federale , le autorità germaniche s i ripropon evan o di evitare eccess i e di sordini in seno alla popolazione e di non intasare le vie di accesso alla città. Gli organi del partito fascista repubblicano cercarono di mantenere la calma tra gli aderenti tenendoli, al contempo, pronti a mobilitars i per ogni eve ntualità. Furono predispo sti clandestiname nte i mezzi necessari per un'improvvisa partenza degli ele m en ti più compromessi col regime di Salò e si diede ordine di provvedere alla distruzione di archivi , schedari e documenti contabili.

La mattina del 3, apparve ormai chiaramente che Roma era perduta. Non riu scendo ad avere contatti con le autorità germaniche, pervicac e mente ostinate a mantenere il più stre tto riserbo circa l'evacuazione malgrado fossero le sole ad avere la facoltà di dare diretti ve in merito alla ritirata, Pasqualucci si recò dall'Alto Commissario Zerbino. Qu es ti , dopo un colloquio con i tedeschi, diede appuntamento al federale nel pomeriggio per rendergli note le deci s ioni prese. Nella notte poté avere inizio lo sfo ll amen to . La Federazione, che in un primo momento si pen sò di spostare a Bracciano, venne trasferita a Viterbo. Il fede rale divisò di lasciar e a Roma un'organizzazione clandes tina composta da tre gruppi di dieci elementi ciascuno, atta precipuamente alla propaganda tra la cittadinanza e all'assistenza dei fascisti rimasti sul pos to6 11
Alle ore 3 ,30, giunse in Campidoglio il primo emissario della V Arm ata alleata, il tenente colonnello Pollok, capo della polizia americana. Fu ricevuto dal generale Tama ssia, dal generale Crimi, dal colonnello Pacinotti , dal questore Morazzini e da un portavoce del Governatorato. Pollok volle essere ragguagliato in maniera esaustiva sulla si tuaz ione politica, militare e civile della capitale , sullo stato della popolazione e su lla pre senza dell e forze tede-
6 10 A.U.S.S.M.E ., N. l - 10. Diari storici 2a Guerra mondiale, b.3022 , f.9 , "Relazione sull'organizzazione e il funzionamento del I Settore di Roma ( Fronte Cla nd est in o di Resi s tenza) nel periodo febbraio -7 g iugn o 1944".
6 1 1 A.C.S., RSJ, Segreteria Particolare del Duce, ca rteggio ordinario, b.65 , "Pasqualucci Luig i, già fede rale di Roma", ''1944 -udien za" .
224
sche event ualmente ri maste in ci ttà, ad esemp io in abitazio ni pr ivate o negli osped ali. Esaminò, in fi ne, i p rovve dim e nti previsti per il man tenimen to dell'ord in e pu bblico e richiese in dicaz ioni su i locali disponibil i p er la dislocaz io ne co m andi alleati.
Alle or e 5,30, arrivarono al t ri ufficia li della V Armata con uffic ia li de l S.I.M . e dello Stato Maggiore dell'eserc i to e, dopo un ' ora come aveva annunciato, il ge nera le Be ncivenga, segu ito da i generali Odone, Caratt i, Girotti e Caruso, lib eratisi d al carcere d i v ia Tasso la matt in a de l 4 g i ug no, pot é insed ia rs i in forma solen ne in Campidog l io 6 12
Dal mattino d el 5 g iu g no, ebbe inizio, quas i automa ti camente, la prog ress iva rid uzione de ll e fo r ze d e i sett ori. Comi nc iaro no i re part i de i Carabinie ri e i grup pi di r iserva, poi le ba nde c he, per i ritard i e le difficoltà cui eran o a nda te in co ntro, aveva no ragg i unto un a forza p ari a u n terzo di quella preve ntivata. L a Guard ia di F in anza, im pegnat a nei com pi ti pi ù svariati, p ri ncipal m en te per il mantenime nto de ll'ordin e pubblico, eliminò dapprima le riserve, per poi procedere allo s ciog li me nto dei nuclei p osti a pres idio d egli obiett ivi te rri toriali. L e formaz ion i dei p a rtiti , poiché la pu b bl ica s ic urezza fu sa ld amente garan tita, non furono impiega te Tamass ia, pertanto, propose lo st esso 5 giugno l'in tera s mobilitazione de i settori, completat a il 7 giugno. Vennero t uttavia lasc ia ti in carica per i d ue g iorni successivi, i coma ndi di se ttore, con funz ion i di co ntrollo e di i nformaz ione s u lla s ituaz ione politica e civile de ll a città. La relazio ne del ge neral e Tamass ia s ull ' attività svo lta fi n o a ll a l iberaz ione cli Roma, s i concluse con queste paro le:
Termino esprimendo tutta la mia rico noscenza ag li ufficia li d i ogni grado e di ogn i ca tegor ia, ai sottufficia li , ai m ilitari che per l ungh i mes i di a ttesa e di lotta han n o fedelmente ma ntenuto cont ro ogni perico l o, se mpre i ncombente , i l loro posto d i combattimento, fo rti della loro pa ss ione , del loro senti m ento di amor d i patria, de l loro s p irito d i d iscipli na , tetragoni anche ne i g iorni pi ù amari ad ogni co lp o d i for tu na; so rretti da u na fede nobilissima nei de s ti n i di qu esta nostra Italia613
Man man o che l' occu p azione s i estese ve rso Firenze, le formazio ni mi litari vennero in linea di diri tto sciolte e d isa rm ate, sebbene, per la magg io r
612 A.U.S S M.E. , N.1-10, Diari s toric i 2" Guerra mondiale, b. 3022, f.9, " Rela z ione s ull ' orga nizzazione e il funz ionamento del I Settore di Roma (Fronte C landestino di Res iste nza) nel periodo febbraio-7 g iugno 1944".
6 13 A.U .S.S.M.E., N.1-10, Diari storici zaGuerra mondiale, b.3022, f.9, " Relazione su ll'organinazio ne e il funzionamento del I Setto re di Roma (Fronte Clandestino di Resi ste nza) nel periodo febbraio- 7 gi ugno 1944".

Montezemolo e il Fronte Militare Clandes tino
225
Sabrina Sgueglia della Marra
parte, fossero ancora de s ide rose di co m batte re e di veder d eb itamente riconosciute la fedeltà e l 'a bn egaz ione di cui avevano da to prova.
Bencivenga ha affermato che , nei riguardi deg li appartenenti al FMCR, rite nn e op p ortuno adottare q uei provvedimenti di favore che i m ezz i a dispo s izione, se ppur scarsi, g l i consent irono. Gli affi liati dell ' orga ni zzaz i one mi l itare ottennero, pertanto, la corresponsione dell ' ind e nni tà di partigiano s ino a ll a seco nd a decade di giu g no e fu ass icurata l ' assiste nza ai reduci della prigionia e alle famiglie dei caduti e dei pr igionieri. Il Comandante mi l itare e c ivile di Roma, pe r suaso c h e si dovesse garan tire a tutti , patri ot i e attendisti, la possibil it à di fa[ fro nte a ll e pri marie nece ss it à di vita , dispose c he i milit a ri " fedeU ed attivi" sarebbero stat i giud ic a ti da c hi , " fed el me n te ed attiv amente", aveva v iss uto nove mesi di fatica, d i pericolo e di s pess o in soste nibili privazioni. L e Com mi ss io ni i nc a r icate di stab ilire la riammissione in servizio dei militari di carriera, pertanto, sarebbero s tate formate per lo più da ele menti de l FMCR e av re b bero fondato il loro giudizio s ul cont eg no ten uto nelle sa nguinose gio rn ate de ll a difesa cli R oma e ne i lungh i me s i dell ' oppressione nazifa sc ista. B enc ive nga s i prodigò per fa r otte ne re il g iu s to ri co noscime n to all 'i ntero per so na le militare che aveva operato nella ca p ita le 614

G li Alleati vo llero che i mi litari del presidio di R oma ap partenen ti ai Carabi ni e ri e a ll a Guardi a di F ina nza fossero p rogressivam e nte esaminat i da apposite commi ss ioni c he, se gi ud icat i id one i, li avreb bero imme ssi ne lle forz e regolar i. I patrioti c he aves se ro voluto arruolarsi nel! ' E se rcito , in vece, dappri ma sar e bbe ro stati raccolti in appos iti campi nei pres s i della capi t ale e , dopo un 'accurata valu tazione, sarebbero s tati avviati in zone a rretrate di riordinam e nto per esse re arma ti , equipaggiati e, infin e, asseg na ti a l Corpo Italiano di Li berazione615 •
La regol a ri zzaz ione de ll o s tatus de lle ba nd e pa trio ttiche stava mo lt o a cuore a l capo di Stato Maggiore d e ll'E se rci to. E gli prese contatti con molti co manda nti de ll e formazioni parti g ia ne che s timava ele menti d i pr im 'o rdine. Solo a Roma e in Ciocia ri a, M esse rep utava di p oter co ntare s u c irca cin quemila uo mini da impiegare imm ediatame nte co me comp lementi della V Armata o da in serire nel CIL. Il colonn e ll o P ids ley gli co nfe rmò p iù volt e l ' inte ndim en to di Alexander di ri solvere q ua nto prima la questione6 16
614 A.U.S.S .M .E 1-3, b. 148 , f.2, "S ituaz ione delle forze militari in Roma e nell' Ita lia Centromeridi onale. Relaz ioni con le Auto r ità ang loam ericane" Autorità M il itare Italiana in R oma, l.M.A.R .. 26-6-1944
61 5 A.U.S.S.M.E l -3, b.188. f.2.
6 16 A.U.S .S .M .E. . 1-3, b.18 8, f.2 .
226
M esse rite n eva si dovesse co nferire la qual ità di legittimi belligeranti a tutti i componenti le ba nde di patrioti e partigiani. Le norme d i di ri tto internazio nale relative ai "corpi a usiliari ", infatt i, non subordinavano il d irit to ad essere qualificati co m ba ttenti ad un riconoscimento d ella parte avversa, ben sì all'es is tenza di determinate condizioni, come la su bordinazione dei g regari ad un capo re sponsab il e dei suoi sottoposti, un di stint ivo ricono sci bil e, I' osservanza d e lle leggi di gu erra nelle operazioni militari e l'autorizzazione alla formaz ion e di unità armate da parte del governo.

Le bande dei patrioti risp o ndevano appieno a tal i r eq ui s iti , di conseguenza, il generale esortò il cap o del governo a non lasciare null a d'intentato dal punto di vista gi uridico per sa lvaguardare i di rit ti di quegli e ro ici patriot i617 Per quanto atteneva ai rapporti co n gli angloa m edcani, il capo d i Stato Maggiore Generale di c hiarò di aver avuto buon e re lazio ni coi coma ndi alleati , in par ticolare con la Commissione Alleata di controllo e col suo delegato , il colon nello Pidsley. Apprez zò vivame nt e i rallegram enti ed il plauso tributati ali' Ita li a che r is ult arono ancor più graditi po ich é, alla l uce dell'iniz iale atteggia m e nto osti le e diffidente , giunsero del tutto inaspettati. Il generale Mac Farl ane si congratulò per l'opera dei patr ioti e per l'ordin e e la di sc ipl in a risco ntrati nella capitale e ricono bbe l'autorità d e l ge nerale Bencivenga s u tutte le fo rze armate ital ia ne present i in Roma, comprese la Marina e l'Aeronautica, eccezion fat t a per quelle già inquadrate nelle formazioni della V Armata ame ri cana:
li capo d e lla Conuniss ione alleata di controllo d ' intesa col comandante americano del l 'area di Rom a hanno dat o, a titolo provv isorio , la loro approvazio ne a che il Genera le Bencivenga seguiti ad essere investito dell ' Autorità militare in Roma fino all'arrivo del Ministero della Guerra ne lla città ed alla presa d i possesso del1' Autorità da parte d i qu est'ult imo. Giustiz i a e co nsiderazione d ebbo no essere accordate al Gen. Bencivenga la c ui attività merita elogio L'assu n zio ne dei poteri d a parte del Ministero della G ue rra do vrà aver l uogo con ogn i rigu ardo e senza aggressività618
Il generale Odone, l'ammiraglio Ferreri e il genera le Cappa furono nomin ati Commissari mi li ta ri di Roma dspettivamente per la Guerra, la M arina e
6 17 A U S.S M.E ., 1-3, b. 149 , f.4, "Riconosc i mento della quali t à di legittim i belligeranti a i com pon ent i le bande di partigiani e patrioti", Stato Magg iore Generale, Uffic io Affari vari, a S E. il Pre sidente del Consiglio dei Ministri, 23 - 8- 1944.
6 18A .U.S.S.M.E. , 1-3, b 148, f.2, "S ituaz ion e delle forze mi litari in Roma e nell'Italia Ce ntromeridionale. Re la zioni con le Autorità ang loamericane", Autorità Militare Italiana in Ro ma, I.M A .R ., 26 -6- I 944, all egato n.2, "Disposizio ni transitorie co ncernenti le forze dell'Eserc ito italiano in Roma ", I 9-6- I 944.
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
227
Sabrina Sgueglia dell a Marra
I' Aeronautica6 19 La prese nza del l'Autorità militare italiana in Roma, IMAR , nuova de nominazione assegnata al FM C R , dal J 2 giugno a l I O l uglio l 944, ri sultò di in dubbi a utilità per il Governo e per il Comando Supremo ital iani c he pote rono d isporre ne ll a ca pital e d i una rapprese ntanza in grado di eseguire, sebbene con gravi difficol tà, g li ord ini e le diretti ve e manate.
L ca pital e e ra esa usta p e r la fa me e pe r la brutalit à su bita: la Commiss ione A ll ea ta di Controllo stimò che du r a nte l 'occu paz ione , i ted eschi avevano ucciso c irca ottocen to romani e che o lt re mill e avevano sub ito torture per o rd ine de l Comando ge rm a nico di sicu rezza. Tale rapporto non includeva, tu t tavia, gli omic idi , le violenze e le atroc ità commesse dalle s qu ad re dei fasc isti repubblicani e d a ll e SS ita li ane co n l' a utori zzaz ion e delle a utorità teuton iche620 . Epp ure, m algrado le dure prove c ui fu sottop os ta, la popo lazio ne romana s i ado però per co ncorrere a tti va mente a ll a libe razio ne : non in sorse, ma s i mob i litò per agevo lar e l'avanzata delle tru ppe a ngloame ri c ane, un valido contr ibuto alla lotta s p o nta neamente offerto e g ra ndeme nte ap prezza to da tutti i Comandi dell e Nazioni Unit e.
Tra gli episo di p iù sig ni ficativi degli ult imi giorni, ricordia mo c iò che avven ne i l 4 gi u g no , verso le ore 15,30, s ulla vi a Casilina: men tre infuriav a la battag l ia tra alc u ni rep art i alleati e truppe appartenenti a ll a retroguardi a ge rm anica, s'inserì ne i comba tt im en ti un g ru ppo di ve nti patrioti che attaccaro no ri so lut amen te le forze ne mi c he e ri uscirono a cattu rare sei tedesc h i cos tringen do g li altr i a ll a fuga O ltre mill e braccianti, a partire da l pomerigg io dello stesso giorno , prestarono volontariam en te la loro opera per coa diuvare gli Allea ti nel ripristin o dell a linea ferrovia ri a inte rrotta e in impo rtanti lavori s tradali. In fine , a Ponte G a ler ia, ne lle prime ore de l 5 giugno , oltre sessanta mano va l i d i quella borgata , presentat isi spo ntaneamente , aiutarono gli a ng loa mericani a riparare un po nt e sul F osso G ale ria che i tedeschi aveva no fatto sa ltare in ar ia pochi minu ti pri ma , pe r con se nti re alle formazioni a utocarrate un pili rapido inseg uimento del ne mico62 1

Il 5 giugno, un proclama de l CLN ri cordò il ge neroso contribu to di tutti co loro c he si e rano battu ti , afferma ndo che la liberaz ione di R o ma no n avrebbe av u to "il s uo pieno e g lo rioso s ignifica to " se non ave sse segnato " il risveg lio di tu tte le e nergie nazio na li per la guerra di liberazio ne".
619 A.U S.S.M.E l -3, b 146. f.7 , ··Azione di comando del Fronte C lande stino, gennaio- giugno 1944 ·, rela z ione de l cap itano d i fregata Renato Montezc molo 620 Le atrocità naz iste a Roma n e l rapporto de lla CommiJsione Alleata di Controllo. in Due italiani del '44. Edizioni Civita s Roma. 1955, p.61.
62 1 A.U.S.S M.E. , 1- 3 , b.149, f.2.
228
Conclusioni L'
8 dicembre 2003, nel discorso tenuto in occas ione della cel ebrazione del sessantesimo anniversario della battaglia di Monte Lun go, l'allora Preside nte della Repubblica Ciampi ha ricordato i l colonnello Montezemolo definendo lo " un eroe che merita di essere raccontato agli Italiani di oggi", "u na figura di ecceziona le va lore e intelligenza, l'a nimatore della guerra di l iberazio ne nei primi dieci difficilissimi mesi", " torturato e poi assassinato alle Fosse Ardeatine in sieme ai princ ip ali collaboratori che, con lui, avevano organizzato le azioni dietro le linee, sotto le direttive del governo legittimo". Il capo dello Stato ha altresì sottolineato l'aspetto più significativo della vicenda del FMCR: accantonando pregiudi zi e divergenze apparentemen te insuperabi li solo poco tempo pr ima, l'organizzazione militare "ricercò la solida ri età e la cooperazione di chi u nque avesse voluto dedicarsi alacremente alla nuo va e stringente priorità: abbattere i1 fascismo redivivo di Salò e affrancare l ' Ita l ia dall ' occupazione germa ni ca".
Il Fronte Militare Clandestino di Roma rappresenta uno de i capitoli fondamen tali della storia della Resistenza itabana, sebbene, ancor oggi, questa " armata del s ilenzio, ch e fece de l s ilenzio la propria arrna"622 , secondo l'icastica definizione che ne ha dato Anna Baldinotti, sia poco nota. Nato in seg uito all'armist izio e allo sbandamento dell ' esercito, nella fase più drammatica cui dovettero far fronte le nostre forze a1mate, il FMCR riunì quei nuclei militari che, dopo aver combattuto per tre anni, travolti dalla crisi di comando innescata da ll a resa e dal1'aggressione tedesca, decisero d i non deporre le a1m.i e di battersi per l'Ita lia.
Fu una consapevole scelta di coscienza, il cui profondo s ign ificato morale appare ancor più manifesto se s i co ns idera la formaz ione e la tradizione c ui afferivano, in part icolare, gli ufficiali di carriera. E ss i, ancorché adus i a ll 'obbedienza "sacrificando se necessario le simpatie ed i moti segreti deJJ'animo", come ha sottolineato il generale T ra bu cchi, in assenza di o rd in i da eseguire, "dovettero da soli decidere" 623 . I soldati ita li a n i determ in ati a rimanere fedeli al giurame nt o prestato, peraltro, otte nnero la formale autorizzaz io ne a misconoscere la rep ubblica sociale e gli e x alleati tedeschi, soltanto il 13 ottobre 1943, con la dichiarazio ne di guerra alla Germania , a fronte di un comunica -
622 Anna Baldinotti. op. cil., p.68.
623 Al essa ndro Trabucchi , op. cit , p.45
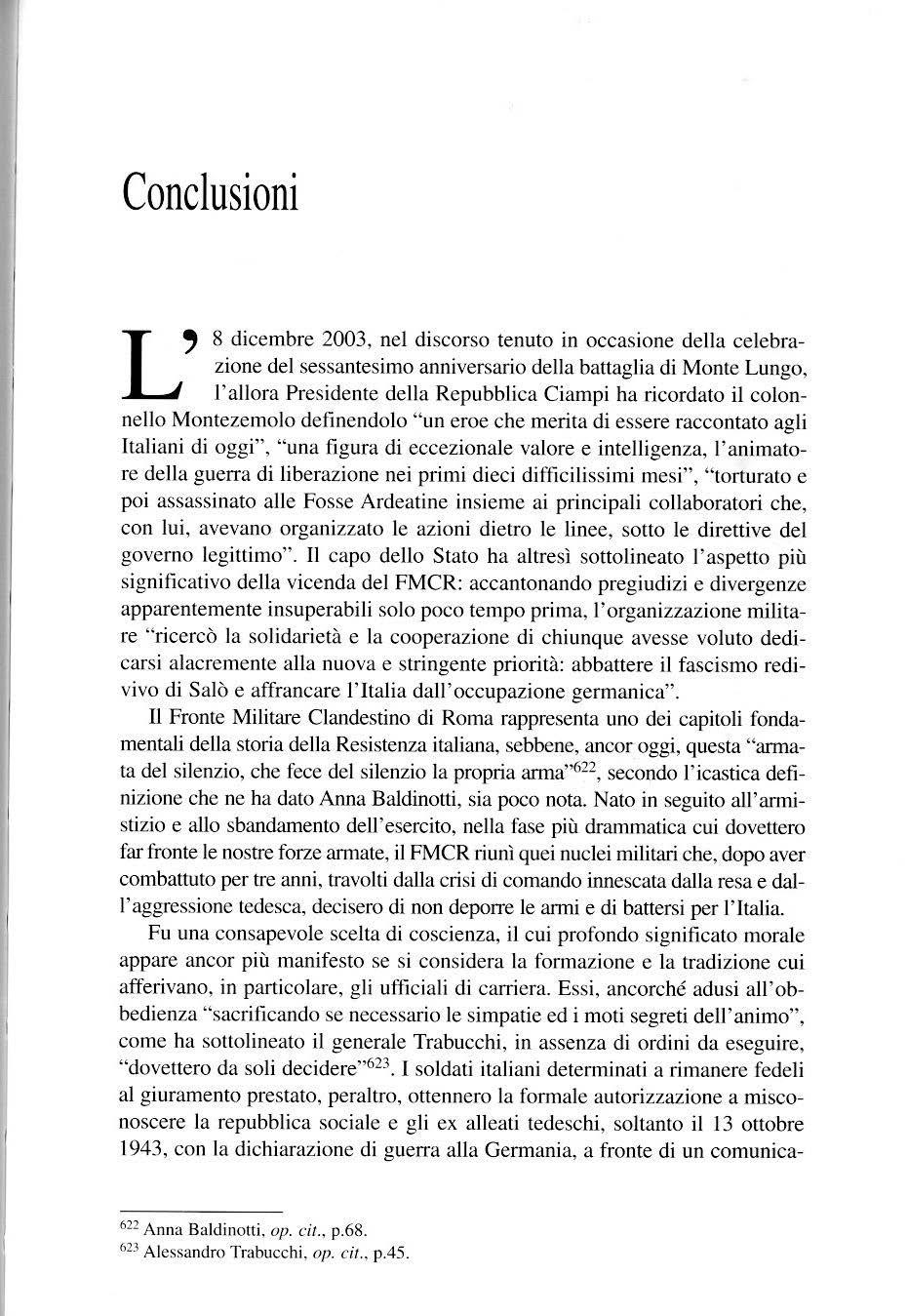
to trasmesso d a Mussolini circa un mese pri ma, in cui ven ivano d ichiarat i sciolti dal v in co lo e du n que liberi d i abbracciare il fascismo di Sa lò.

L e fo rm az io ni ant ifasc iste, nonostante la severa con d anna etic a e p olit ica della g uerra e la conseguente ri p rovazion e p er l'eser ci to c he l'aveva comba ttuta e in c ui ravvisavano il braccio armato de l regime, ri uscirono a su p erar e l 'avversione nutr ita sin o ad allora po ic hé ebbero a che fare con m i li tari che, come M ontezemo lo , si spese ro in ogni modo per tentare d i in staurare un rapporto di recip roca fi du c ia impronta to al di alogo e alla so lida r ie tà.
L a Res istenza roma na, pertanto, nonos t an te il variopinto pa norama po liti co in nervato di concezion i ideal i e di prospettive socia li affer e nti ad o pposte tradizioni , e giu di cat e pe r lu ngo temp o in concilia bi li, ha visto delinears i una profic ua colla boraz io ne tra mi l itari e pa r ti ti a nt ifasc isti che, nel p ieno rispetto d e lla p ropria sto ria e della p rop ria ide nt ità, riu sc irono a trovare un terre no d 'intesa su c ui gettar e le basi de ll a co mun e lotta d i l iberazion e. Ba nd e mil it ari ed avang ua r die armate dei part iti, du nq ue, face n do t esoro d e ll e r ispettive esp eri enze e poss ibilità, s i sos tenn ero vice nde volmente scambiandos i inform az ion i, cons igl i , co m petenza tecnica, armi.
C red o c he ad abb attere le diffi d enze e ad avvic inare so ld ati e p art ig ia ni politici abbi a sensi bi l me nte co ntr ibuito la r eciproca consapevo lezza di ave re co m e interlocu tori u om ini che, mal grado a pp arte nessero a mo ndi d istanti dal prop r io, avevano op erato una prec isa sce lta ind ividua le d i coscienza. I patrioti, a p resc in dere d agl i o ri entam e n t i e dalle ideo log ie, erano tu t ti vo lo n tari: essi s i riconoscevano in qu e s ta lo ro gravosa condiz ione co m une che co nferì c redi b il ità e pres ti gio a p erso ne co nsidera te nemiche fino a poco te m po p ri ma e legitt im ò gli uni agli occhi degl i altri. L e s tesse au t ori tà germaniche ebb ero netta p ercez ione de ll e m ol tepl ici fo rze che co nflui rono ne l movimento resis te nz iale ro m ano, le cui p rincipal i co mpone nti ven n e ro acco sta te nella definiz ione, inesa tta e spr egiativa, di "com u nist i bad og li an i" .
L a d ura ba ttaglia intra presa in s ieme d imos trò co m e la cau sa naziona le, il desiderio di r iscatto, l 'anel ito all a libertà, potesse ro avere la meg li o s ulle dive rge nt i posizion i po lit iche e c ultu rali: " ne ll a sven t ura - co me h a afferm ato Gi u liano Procacci -i l popo lo ita li a no comi nciava a ritrovare la s ua antica civ il tà" 624
L a coo peraz io ne c he si profi lò r is ulta a nco r più sig n ifi cat iva se si co nsidera il t ra tto pec u liar e d ella R es iste nza ita lia na , ovvero l' obi e ttivo di u n rinnovame nto istituz io nal e che rovesc iasse le strutt ure po liti c h e e s o cial i p reesistenti. Tal i fin alità, pe rseg ui te dai partit i , trovav a no s u posiz ioni diametralmen te opposte i mi li tari: il FMCR pro fessava l'asso lu ta apo li tic ità e rico no-
230 Sabri na Sguegl ia dell a Marra
624 Giu l iano Procacci , Storia degli italiani, voi. li , Laterza, Bari, I 998, p. 54 1.
sceva come unico governo legitti m o quello del Sud, in conformità co l g iuramento prestat o; per le formaz ioni ade re nti a l C L N, di contro, la partenza del re aveva in eso rabilmente segnato le sorti de ll a monar chia.
Il capo de l FMC R s i avvide pe rfettamen te della frattura prodottasi e, m algrado la sincera e in defettibi le defe re nza tribut ata aJJa monarc hi a, nei qu ot idian i dispacci t rasmessi a Brind isi, so ll ec itò più vol te Vittorio Emanuele e Bad og lio a far ritorno ne ll a capitale. Egli avvertiva come la loro assenza avesse disorientato il paese, perta nt o asseverò la necess ità di co lmar e quan to prim a il vuoto isti tuziona le al fine d i resti tuire fiducia aJJa popolazio ne g ià gravemente provata dalle vicende be ll iche. li co lon ne llo gi u nse persino a paventare la perd ita della cap ita le qualora il loro rientro fosse stato o l tremodo procrastinato.
L a fede ltà di Montezemolo, dunque, assoluta e inco rrutti bile, non p uò essere considerata una s upina accettazione e conseguente esecuz io ne d i tutte le d irettive a lui imprutite. Eg li s i trovava in pri ma l inea, viveva quotidianame nte il dramma dell'occupazione, pertanto, es presse sempre co n ri solutezza i suoi intendimenti, atte nu ò le posizioni eccessivamente rigide del governo e adattò tutti gli ordini provenienti dal S ud a ll a si tuazione concreta della città, a ll e esigenze de ll a cittadinanza e aUe reali prospett ive della lo tta , ce ns urando senza esitazione gli ordi ni che mal si attagliavano alJe contingenze.

A Roma, t utti sa peva no chi era Montezemo lo: il suo nome, co me ha scritto Fumarola, correva di bocca in bocca "avvolto da un alone di mistero" ed era si m bolo "di un'attività reale, co ncreta e prez iosa" 625 Egli d ive nne il principale punto ri ferime nto pe r tu tti coloro che des ideravano comba ttere e pe r chi cercava sostegno, materi ale e mora le . Il colonnello si ado per ò con ogni mezzo per es tendere quanto più poss ibi le la rete degli affiliat i poiché confidava p ienam ente ne ll e g randi potenzialità non so lo dei m ilitari, ma dell' intera popolazione romana, d i c ui conosceva a fondo gli umori , le opinioni e la mentalità
Nella cap ita le , infatti, i l fascismo no n cost it ui va ormai da tempo un a fo r za v itale: a ll a cad uta del regime , Roma era stata u na delle c.ittà in c ui l'en tu siasmo popolare era es pl oso co n maggiore in t ensi t à . I fasc isti , a riprova del loro isolamento, il 25 lug l io n on erano insort i. Ri comparvero solo dopo se ttimane, protetti dalle au t o ri tà germaniche, ma l'interdizio ne di R o ma alla Rep ubb lica sociale co nt in uò pe r l'inte ro periodo dell'occupaz ione e il du ce non poté più farvi ritorno626.
Il FMC R poté avvalersi d el pressoché una nim e co nsenso e de ll a compl icità de lla popo lazio ne romana che si sc h ier ò sin da l pr imo istante cont ro i
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
625
A nto n io Fumarola , op. cit ., p.89 . 626
Perrone Capano , op cit. , p. 125 , 287. 231
Angelo
Renato
Sabrina Sgueglia della Marra
n azifascis ti e, con un in te nso e ri sc hioso lavorio sotterraneo, su p portò tutto il m ovimen to d i resis te n za
Fo n damentale fu la funzione di interlocutore p olitico di Mo n tezemo lo: consapevole dell a n ecessi tà di convogliare e coo rdinare tu tte le energie in un 'u ni ca com p a g ine d i m u tua ass is te n za cont ro il nemico, ri so lu to ad unire in u n fronte compatto le forze di s pos t e a lottare, eg l i si assu n se il del ica to com pi to di mediare costantemente tra i l Com itato di L iber azio n e Naz ionale e il governo del Sud, mitiga n do le posiz ioni spess o m iopi ed in tran s ige n ti di Badogl io e te n ta nd o d i venire i ncon t ro, p er qua nto p oss ibi le, a ll e ric h ie ste e alle aspettative delle formaz io ni po liti c h e.

Proprio questa s u a lun gimira n za, la singolare attit u d i ne a comporre i diss id i addive n e n do ad in tese sino a d a ll ora im pe n sabi li, p er la capacità, che g li era consen tanea , di conc il iare la fede h à a l giurame n to con la luc ida va l utazion e delle es igenze de ll a lot t a e de ll e difficoltà c u i eg li quotidianamente dov eva far fronte, in d ucono a r iten e r e c h e l 'ana li s i di Tompkins non ab b ia comp reso i l ru o lo fon d amen ta le c h e i l F M C R r icop rì ne ll 'a mb ito della res is te n z a ro m a n a né l e rea li mo ti vaz ion i che sp i nsero il colonnello ed i s uoi affiliati a n on varcare le l in ee e ad in t rapre n dere un a lotta se r ra t a contro l 'occ u pa nt e .
L'agente de ll ' O SS, negand o og ni a u t o n o mi a a ll 'o rga nizz az ione mi lita re, ha asserito c h e la politica de l Fro nt e, riflettendo in modo ped issequo quell a di B adog l io, avesse come obiett ivo p recip u o la conservazione, la t u tela deg l i in te ress i po liti ci e d eco no mic i de ll e c lass i pi ù abbien ti e d egli alti co ma ndi delle fo rze arm ate compromess i da vent 'anni d i reg im e fascis ta. S ic u ra m ente il sovra n o vo ll e gara n tir si u na rapprese n tan za nella cap itale du r an te la sua a ss enza , ma gli obiettivi de l FMC R , il suo contribu to alla causa naz iona le , le m o lte pli c i fu n z ion i assolte n el perio d o d e ll 'occ u pazio n e, in p arti co la re fin o a llo s b a r co di Anz io, q u a n do a d ir iger lo era Mo nt ezemo lo, non consentono u na s i ffatta interp re taz ione oltremodo riduui va.
L a stre n ua bat tag lia q u otidiana ingaggiata co n tro i tedesc hi acc e ttand o d i assume re su cli sé ogni ri sc hi o, la costan te ri cerc a cl i esten d ere ed approfo ndire l a collaborazione, l'opera di s alvag u ardia e di sostegno della popo lazione , soprattu ll o per quanto concerneva il sos ten ta men to , se mpre p i ù diffico ltoso per il raz io n amento d e i gene ri a li me n ta ri e l 'avvic in ars i d e ll a linea del fron te , pales ano i n modo irrefragab ile l' assenza, n e ll 'a ttività d e l colo n ne ll o. di moventi o fin i al di fuori di qu e lli p atriottici. Egli rimase sempre a R oma ove gli abboccamenti che ogni giorno aveva co i suoi collaborat ori lo cos t ringevan o a co n tinui s p osta men t i co n l ' a lta pro b ab il it à di in co n tr are, pe r le strade de ll a capitale, qualche ufficiale tedesco che, ave n dolo conosc i uto in p rece denza , l ' avreb b e ide n ti fi ca to e im p rigio n ato.
232
In ol tre, per tentare di cogliere nella sua intima essenza la vicenda del FMCR, alla l uce della attività che seppe dis piegare, d ei risultati conseguiti e dell' influ e n za che esercitò nell'animo di coloro che Montezemolo c hiamava " fedeli ", si dovrebbe valutare attentamente il con te sto storico in cui n acq ue e s i svi lu ppò : le operaz ioni belliche non r egis travano ancora la netta prevalenza delle potenze alleate su lla Germania , la cui d isfatta, pertanto, non appariva certa. La guerra ri stagnava e ben presto fu ch iaro come il fronte itali ano rappresentasse p er gli angloame ri cani un obiettivo secon d ario.
M algrado le circostanze non consentissero pre vis ioni, in u n clima di violenza e di imperante prevari caz ione, Roma poté giovarsi dell'impegno e d el coraggio d i chi , come Montezemolo, rinunciò a lla possibi lità di mette rs i in salvo a l Sud, al contrario di buona parte dello Stato Maggiore e, pur avendo co n statato di persona la bruta lità de i tedesc hi , re stò nella capitale e diede la propria vita per affrancare la popolazione dal dominio germanico e restituire dignità alla divisa
Fulvia Ripa di M eana ha ci tato una frase del colo nn ello dalle cui sem pli ci parole s i infe risce lo spirito che animò quella c h e eg li avvertì come una miss io ne : le forze armate in quei mesi drammatic i erano chiamate ad affrontare dei sac rifici immensi ma, se li avessero superati "co n dignità e a testa alta", Monte zemol o assicurò che s i sare bbe adoperato per rivendi care quel posto morale che sarebbe spettato all'esercito nella fu tu ra vita civ ile del paese62 7 •
Ne ll a vasta lettera t ura su ll a Resistenza, che pure si è sca rsa mente occupata dell 'a pporto dell'e serc ito ed ha pre ssoché ignorato l' imp orta nza del FMCR, s o vente s' in contra no critiche rig uardo ali' impostazion e cosiddetta atte ndi sta della lotta im prontata al ri s p etto della citt à apert a, ma numerosiss imi s ono i testi m oni e i protagonisti che han no speso parole di profo nda ammirazione pe r Montezemolo come Amendo la, Ba ue r, Bonomi; L eo Valiani, ad ese mpio , lo d efi nì "u na g ran figura di genti l uomo e di patriota628 "; Pietro Secc hi a, p ur stigmatizzan d o reci samente l ' attività e l'organi zzaz ione del disposit ivo clandes t ino, ha d esc ritto il colonnello come " un u ffic iale coraggioso e ri so lut o a battersi veramente cont ro i tedeschi", sottolineando che av re bbe potuto sceg liere l'assai più facile e s ic ura strad a di attrave rsare le linee. Per dimostrare l'i nconsistenza di alcu ne sue po s izioni teoriche circa l'att uabilità della guerri g il ia nel territorio ita li ano, Secchia ha addirittura affermato che Montezemo lo s tesso contribuì a co n futar le a ttraverso "la pratica quotidiana di un attivismo in te nso e spericolato" 629 .

Montezernolo
e il Fron te Militare Clandestino
627
628
629
49
233
Fu lvia Ripa di Meana, op. cit., p .80.
Leo Va li an i , Tult e le strade conducono a Rmna. 11 Mulino, Bologna, 1995, p.120.
Pietro Secchia-Filippo Frassati , op. cit .. pp .395,
I.
Sabrina Sgueglia della Marra
Tra i mil itari, è u nanim e il rico noscimento delle qua lità professional i del cap o del FMCR, del va lo re di soldato e della sua opera generosa d i patriota che lo rese l'ele m en to vivificat ore d ella Resistenza; l' u nico ad usare paro le non lu singhie re nei s uoi co nfront i è stato il generale Ca rbo n i che lo ass unse come co mandant e del Genio del Corpo d ' Armata nel !' agosto d el 1943 L e ubbie del genera le s i ac uirono ul teriormente q uando venne a sa pe r e dell'esis tenza d ell 'orga nizzazione mili ta re da lui diretta e dei contatti s tabiliti col governo del Sud, cosa di cu i Montezemo lo non lo i nformò mai e che negò, a suo dire, ogniqual volta gli furo no chieste s pi egaz ion i al riguardo:
Nel s uo lavoro-h a scritto Carboni -l ' ufficiale agiva troppo scopertamente per non susc itare i sospetti di c hi, come me , ne seguiva da v icino l'opera e conosceva la s ituazio ne: o egl i e ra in accordo, ape110 o tacito, con i Ted esc hi , c he lo lasciavano fare, op pure egli commetteva degli imperdonabili errori, da ndo il modo ai ne mici di controllare, attraverso la sua attv i tà p ersonale, tutti g li svil uppi de ll ' organizzaz ione militare clandest ina e qu in di mettendoli in grado di neutralizzarla al momento opportuno. E infatti così fecero, arrestando il Mo ntezemolo all 'atto dello sbarco di Anz io Allo rché si sparse la notizia di q uesto arresto, non vi prestai fede. Solo la fuc ilazione alle Fosse Ardeatine mi to lse i dubbi 630
Epp ure, lo s tesso Car boni, che non si peritò di muovere al colo n nello l'infama nte addeb ito di tedescofil ia, d ovette riconoscerne la preparazione , le competenze tecniche , le ecceziona li capacità, il coragg io e , soprattutto, l'onestà di soldato 631
L a cooperazione tra il FMCR e le altre co mponenti d ella r es is tenza romana , il fe lice sinc retismo patriott ico, idea le e morale che s i del in eò a partire d all ' a rmi stiz io, credo rapp rese nti la p iù alta conquista del movimento di l iberazione svil uppatos i nella capitale. In alc une reg ioni it aliane, s imi li es pe rimenti fu rono so lo abbozzati o avviati ste ntatamente propri o per l ' incapacità di s u perare le rec ip roche diffidenze e d i in dividuare un modus operandi che contemperasse le differenti vi sio ni politiche e strategiche.
A Roma questo amb izioso progetto poté r eali zzarsi grazie a qu el "po nte d i solidarietà schiettamente italiana fra uomini dei vari partiti" 632 che Montezemolo edificò attraverso una tenace e infaticabile opera d i med iaz io ne volta a coniugare l 'a po li ticità dei militari , la fedeltà al g iurame nto e l 'impostazione conferita alla guerriglia, con le prerogative che le for mazioni politiche rivend icavano al CLN, le loro prospettive circa il fut uro assetto istitu zio nal e e la conduzione della lotta.
630 Giacomo Carbon i, op cit., pp 372-373.
63 1 Giacomo Carboni , op cit. , cfr. per es pp.249 -250, 343
632 Angelo Antonio Fumarola, op. cii., p.94.

234
Bibliografia
Aga Ross i, Elena, L'inganno re ciproco: l'armistiz io tra l'Italia e gli angloamericani del settembre 1943, Ministero per i Beni Culturali e Am biental i, Uffi cio Cen trale p er i Beni Archivistici, Roma , 1993.
Aga Ros si, El ena, Un a na zio ne allo sbando . L'armistizio italiano del settembre 1943, Il Mu l in o, Bolog na , 1993.
Aga Rossi, El ena, l'ltalia nella sconfitta Politica interna e situa zion e internaz ionale durante la seconda guerra mondiale, E diz ioni Scien ti fiche Italian e , Napol i , 1985
Arn e ndo la, G io rgio, L ettere a Mil ano, Editori Riuniti , Roma , 1973.
Ascarelli, Attil io, L e Fosse Ardeatine, A. N.F. I.M. , Roma , 1965.
AA .VV., Fasci smo e ant(fascismo. Lez ioni e testim onianze, Feltri nell i , Milano, 1962.
AA.VV., L 'ltalia dei quarantacinque g iorni. Studio e documenti, I s ti tu to nazionale per la storia del movime nto di libe razio ne, Milano , l 969 .

Avagl ia no, Mario, Il partigiano Tevere. Il generale Sabato Martelli Castaldi dalle vie dell'aria alle Fosse Ardeatine, Avagliano E ditore , Cava dei Tirre ni , 1996 .
Badog li o , Pietro , L'Italia nella seconda gue rra mondiale,Mondadori, Milano, 1946.
Baldi notti, A nna, li Fronte Militare Clandestino di Mont ezemolo, estratto da Roma alla macchia. Personaggi e vicende della Resisten za, a cura di M a rio Avagliano , Avag liano E ditore, Cava d ei Tirreni , 1997.
Bartoli, D ome n ic o , L ' It alia si arrende, E di toriale Nu ova, Milano , 1983.
Ba rtol in i, Alfonso-Terron e, Alfred o , / militari nella guerra partigiana in Ital ia 1943-1945, Uffic io storico d ello Stato Maggiore d ell ' Esercito , Roma, 1998 .
Battagl ia, Rob erto , Storia della Re sistenza italiana. 8 settembre 1943 -25
aprile 1945, Ein aud i, To rino , 1964.
Bentivegna , Rosario , A chtung banditen!, Murs ia , Milano , 1983 .
Benzoni , A lber to-Ben zoni , Elisa, Attentato e rappresaglia. Il PCI e via Ras e/la, Marsilio, Venezia , 1999.
Berarcli, Pa olo , M emo rie di un capo di stato maggiore dell'esercito ( 194 3/ 945), 0.D.C.U. , 1954.
Sabrin a Sgueglia della Marra
Bìanchi, Gianfranco, 25 luglio. Crollo di un regime, Mursia, Milano, 1963. Bidwell , Shelford-Graham, Dominick , La battaglia d' Italia, Rì zzol ì, Mi lano, 1989
Bocca, Gìorgio, Storia dell'Italia partigiana. Settembre 1943 -maggio /945, Mondadori, Milano, 2002
Bonomì , l vanoe, Diario di un anno 2 giugno 1943- /0 giugno 1944,Garzanti, Mi lano, 1947.
Boria, U mb erto, Tradi z ione militare, magg io 1969.
Bovio, Ores te, Sacerdoti di Marte, S tato Maggiore de ll'Ese rci to , Uffic io s torico, Roma , 1993.
Cadorna, Raffaele, La Riscossa, Biettì, Milano , 1976.
Capi tani, Mario, La difesa di Roma. Cronistoria dal 25 luglio al 29 settembre 1943, Mucchì, Modena, 1973.
Caputo, Giorgio, Problemi e documenti della Resistenza romana, Libreria l'Europa letterari a , Ro ma , 1966.
Carboni, Giacomo , Memori e segrete. 1935-1948. "Più che il dovere", Parentì, Fi renze , 1955.
Caroccì, Giampiero, La Resistenza italiana, Garzan ti, Milano, 1963 .
Caruso, Fi l ip po, L'Arma dei Carabinieri Reali in Roma durante l'occupaz ione tedesca. 8 settembre 1943-4 giugno 1944, Istituto Po li grafico dello Stato, Roma, 1949 .
Cataldi, Enzo, La difesa di Roma, in La dffesa di Roma e i Granatieri di Sardegna nel settembre 1943, a cura dello Stato Maggiore dell ' Eserc ito , Roma , 1993.
Cata nzaro, Giu s e ppe Maria, Monte z emolo. L'uomo e l'impresa clandestina, Edit oriale Roma na , Roma , 1945.
Cavallero , Ugo, Comando Supremo. Diario 1940-1943 del Cap o di S.M.G., Cappelli , Bo log na , 1948.
Cavìglia, Enrico, Diario (april e 1925-marzo/945), Gh erardo Casìnì, Roma , 1952.
Chu rch ìll , Win ston , La Seconda Guerra Mondiale, Mondadori , Mi lano, 1953.
Ci umi, Rob e110, L ' Italia di Badoglio, Ri zzo li , Milano, I 993.
Comando Ra ggruppamenti Band e partigiane Ita li a Cen trale , Attività delle bande. Settembre 1943- luglio 1944, Istituto Po lì grafico d ello Stato, Roma, 1945.
Conti, Giu seppe, Il Primo Raggruppamento motorizzato, Stato Maggiore dell' Esercito, Ufficio sto rico, Roma , 1986.
Contì , Giu seppe, La crisi morale del '43 : le forze armate e la difesa del territorio nazionale, in "Storia co ntemporanea", n.6, dicembre 1993 .

236
Co rvi s ieri, Silverio , Bandiera Rossa nella Resistenza romana, Samonà e Savelli, Roma , 1968 .
Corvisieri, Silverio, Il re, Togliatti e il Gobbo. 1944: la prima trama eversiva, Odradek, Roma , 1998.
Crimi , Filippo, L uce di Fiamme gialle. Le Fiamme gialle durante il terrore Nazifascista a Roma, Istituto Poli grafico d ello Stato, Roma , 1945.
D ' Agostini, Lore nz o-Forti, Roberto , Il sole è sorto a Roma. Settembre 1943, ANPI, Roma , 1965.
De Biase, Carlo, L'otto settembre di Badoglio, Edizioni del Borghese, Milano, 1968.
De Felice, Franco (a cura di), Antifascismi e Resistenze, La Nuova Ital ia Scientifica, Roma, 1997.
De Felice, Renzo, Mussolini l'alleato. La guerra civile 1943-1945, Ein a udi, Torino , 1998.
De L una, Giovanni , Badoglio. Un militare al potere, Bompiani, Mi lano , 1974.
DegU E spinosa, Agostino, Il R egno del Sud. 10 settembre 1943-5 giugno 1944, Editori Riuni ti, Roma , 1973.
Di Benigno, Jo , Occas ione mancate . Roma in un diario segreto (1943-1944) , Edi z ioni SEI, Torino , 1945 .
Dollmann , Eugen , Roma na zista, Longanesi, Milano, 1949.
Due italiani del 44, Edizioni Civitas, Roma, I 955.
Fanello Marcucci, Gabriella, lvanoe Bonomi dal fascismo alla Repubblica, Piero Lacaita Editore, Manduria, 2005.
Fedeli, Enzo, 1940-1945. L'ltalia e il suo esercito, Fiorini, Torino , 1946.
Forcella, En zo, La Resistenza in convento, Einaudi, Torino , 1999.
Forn aro, Vincenzo , Il Servi z io Informativo nella lotta clandestina. Gruppo
Monte zemolo, Editoriale Domus, Ro zzano (Mi), 1946.
Fum arola, Angelo Antonio, Essi non sono morti. Le medaglie d'Oro della guerra di libera zione, Magi-Spinetti, Roma , 1945.
Gallerano, Nicola (a cura di), L'altro dopoguerra. Roma e il Sud 1943-1945, Franco Angeli , Milano, 1985.
Giaccon e, L eandro, Ho.firmato la resa di Roma, Cavalloni, Milano , 1973
Gian nini, Giorgio, Lotta per la libertà. Resistenza a Roma 1943-1944, Edizio ni Associate, Roma , 2000.
Gigli, Guido , La seconda guerra mondiale, La te rza, Bari , 1964.
Giovannetti , Alberto, Roma città aperta, Ancora , Milano, 1962.
Guariglia, Raffae le, Ricordi 1922-1946, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli , 1950.

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
237
Sabrina Sgueglia della Marra
Jackson, William Godfrey Fo t hergill, La bauaglia d'Italia, Baldini e Casto ldi, Milano, 1970.
Katz , Robert, Morte a Roma, Editori Riun iti, Roma , 1994 .
Katz, Robert , Roma città aperta Settembre 1943-giugno 1944, Il Saggiatore, Milano, 2003.
Kesselring, Albert, Memorie di guerra, Garzanti, Milano , 1954.
Klinkhammer, Lutz, L 'occupa zione tedesca in Italia , Bo llat i Boringhieri, Torino, 1993.
Int ersimone, G iu seppe, Cattolici nella R esistenza romana, Ed. Cinque L une, Roma , 1976.
Levi Cavaglione, Pino , Guerriglia nei Castelli Roman i, La Nuova Italia, Firenz e, 197 l.
Loi, Salvatore, I rapporti fra Alleati e Italiani nella cobelligeranza, Stato Maggiore dell ' Eserc it o , Ufficio storico, Roma , 1986.
Lombardi, Gabrio, Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino di Roma, Ed izio ni d el Lavoro, Roma, 1947.
Macmilla n , Harold, Diari di guerra. 1943 -1945, Il Mulino, Bologna, 1987.
Meccariello, Pierpaolo, La Guardia di Finanza nella Seconda Guerra mondiale. 1940-/945, Mu seo storico della Guardia di Finanza, Roma, 1992
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell ' Esercito, Ufficio storico , L'azione dello Stato Maggiore Generale per lo sviluppo del Movimento di Liberazione, Roma, 1975.
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell ' Esercito, Ufficio storico, L e operazioni delle unità italiane nel settembre-ottobre 1943, Roma , 1975 .
Mini s tero dell'Aero nautica, L 'Aeronautica nella guerra di liberazione. Il fronte clandestino di Roma, Roma , 1946.
Monelli , Paolo, R oma 1943, Mond adori, Milano, 1979.
Morpurgo, Luciano, Ca c cia all'uomo, D almatia, Roma, 1946.
Noventa, Giacom o , Tre parole sulla Resistenza, Vallecc hi , Firenze, 1973.
Oliva, Giuliano, La Guardia di Finanza nella Resistenza e per la Libera z ione, Coma ndo Generale della Guardia di Finanza, Roma , 1985
Palermo, Ivan , Storia di un armistizio, Mondadori, Mi lano , I 967.

Parri , Ferrucc io, Lezioni sull ' antifascismo, La te rza, Bari, 1969.
Pavone, Claudio, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella R esistenza, Bollati Boringhi eri , To rino , 1994.
Perrone Capano, Renato, La R esistenza in Roma, Macchiaroli, Napoli, 1963.
Pieri, Piero , Pietro Badoglio, UTET, Torino, 1974.
Piscitelli, Enzo, Storia della Resistenza romana, Laterza , Bari , 1965.
238
Pi sc itelli, Enz o , 1 bandi tedeschi e fascisti , in " Qu ad e rni de ll a Res is tenza laziale", n.4 , 1977.
Portell i , Al essandro, L'ordi ne è già stato eseguito Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria , Don ze lli , Roma, 1999.
Procacci, G iuliano , Storia d egli italiani, Laterza, Bari , 1998.

Ripa d i Mea na, Fulvia, Roma Clandestina, Vi nce nzo Rame ll a, Torino, 1946 .
Robotti, Paolo-Gio vanni , Ge rma netto, Trent'anni di lotte dei comunisti italicmi. 1921 -195 1, Edizioni di cu ltura s ociale, Roma, 1952.
Rochat , Giorgio, Una relazione ufficiale sui militari nella R esistenza romana, dalla rivi sta Il movimento di lib eraz ione in I talia, n . 96, lu glio -settembre l 969.
Ro ss i , Fran cesco , Come arrivammo all'armistiz io, Ga rza nti, Milano, 1946 .
Secchia, Pietro- Frassa ti , Filippo , Storia della R esistenza . La guerra di libera zione in Italia. /9 43 -1945, Editori Riuniti, Roma, 1965.
Se ni se, Carmin e, Quand 'ero capo della polizia: 1940- 1943, Ru ffo lo, Roma , 1946.
Shepperd , Gilb ertAlan , La campagna d ' Italia . 1943-1945, Garza nti, Mila no, 1970 .
Stefani , Fi lip po, 8 settembre 1943. Gli armistizi d'Italia , Marzora ti, Settimo Milan ese, 1991.
nrchiani , A lb erto , Il mio dia rio di Anzio , Mondadori, Milano , 1947.
Tede sc o, Vi va, Il contribu to di Roma e pro v incia nella lotta di liberazione, Amministrazione provinciale di Ro ma , SA IPEM , Roma , 1964.
Tompkin s, P eter, Una spia a Roma, Garzanti , Milano , 1964.
Torsi elio, Mario , S ettembre 1943, Cisalpino , Mi lan o, I 963.
Trabuc chi, Alessandro,/ vin ti hanno semp re torto, De S il va, Torino, 1947 .
Trabucco, Carlo, la prigionia di Roma. Diario dei 268 giorni dell'occupaz ione tedesca, Boria, Torino , 1954.
Troi s io, Armando , R oma sotto il terrore nazifascista. 8 settembre 1943-4 g iugno 1944, Francesco Mondini , Roma, 1944.
U mbica, Teresa, Il prig ioni e rv. Episodi della lotta clandestina in Roma, Tipo grafi a G. Bardi, Rom a, 1946
Valiani, Leo , Tutte le strade conducono a Roma, Il M uli no, Bologna, 1995.
Vallauri , Carlo , Soldati. Le.forze armate ita liane dall'armistizio alla Liberazione, UTET, Torino, 2003.
Zangrandi , Ru gg ero , 1943: 25 lu g lio -8 s e ttembre, F eltrinelli, Milano , 1964 .
Zanu ss i, Giaco mo , Gu e rra e ca tastrofe d'Italia, Casa edit rice l ibra ria Cors o , Roma, I 945
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino
239

Ringraziamenti
Non potrei co n gedare q uesto volume senza esprimere la mia più profonda gratit udine al p rof. Giova nn i Sabbatucci e al prof. Giuseppe Conti.
Il prof. Sabbatucci m i ha incoraggiato ad intraprendere quest a ricerca e ne ha segui to con paziente premura tutte le fasi sin da ll e prime indagini arc hi vistiche. E ' grazie ai suo i insegnamenti, alla s ua part ec ip azio ne intellettuale, alle sue prez iose indicazioni ed al suo s osteg no affettivo se ho potuto ci m entarmi co n un progetto tanto complesso quanto appassionante
I l p rof. Giu seppe Co nti ha c reduto fermamente in questo lavoro e, con grande di s ponibilità , mi h a dato costantemente consigli, s uggerimenti , spunti e sollecitazioni sen za i quali q ues t o volume non avrebbe potuto vedere la luce .

Rivolgo un sentito ringraz iame nto al perso nale dell'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Ma ggior e de ll ' Eserci to e, in particolare, al capo dell'Ufficio Storico co lonnello A nto nin o Za rcone, al tenen te colo nnello Filippo Cappella no , a l tenente colonnello Salvatore Orland o e al te nente colo nnello Giancarl.o Mar zocchi.
So no vivamente grata aJla sig nora Adriana Cordero L anza di Montez emo lo Della C hi esa e al cardina le Andrea Cordero Lanza di Montezemolo che mi hanno fatto largame nte attingere alla loro memoria, aJla loro esperienza e ali' a r chiv io fotografico di famig lia.
Devo altresì ringraz ia re la prof. ssa Anna Mari a Isas ti a, il presidente del Museo storico de lla Lib eraz ion e prof. Anton io Pa ri sella, la dirett rice Elvira Sabbatini PaJlad ini , il cus tode Agostino Cardell i e la dott. ssa An na Baldinott i.
Desidero infine rivolgere con tutto il cuore un ringraziamento s pecial e ai miei genito ri e a mia so rell a Stefania per l'affetto, l'appogg io e la paz ienza c h e mi hanno dimos trato.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Sabrina Sgueglia della Marra

244
La famiglia Mont ezemolo nel 1941. Da sinistra a destra: Manfredi, Am alia Dematteis Mo ntezemolo, Andrea, Adriana, il co lonnello Monte zemolo, Ly dia e Yso/da

Montezemolo e il Fronte Mil itare Clandestino 245
3
Il colonnello Mon te zem olo nel /94
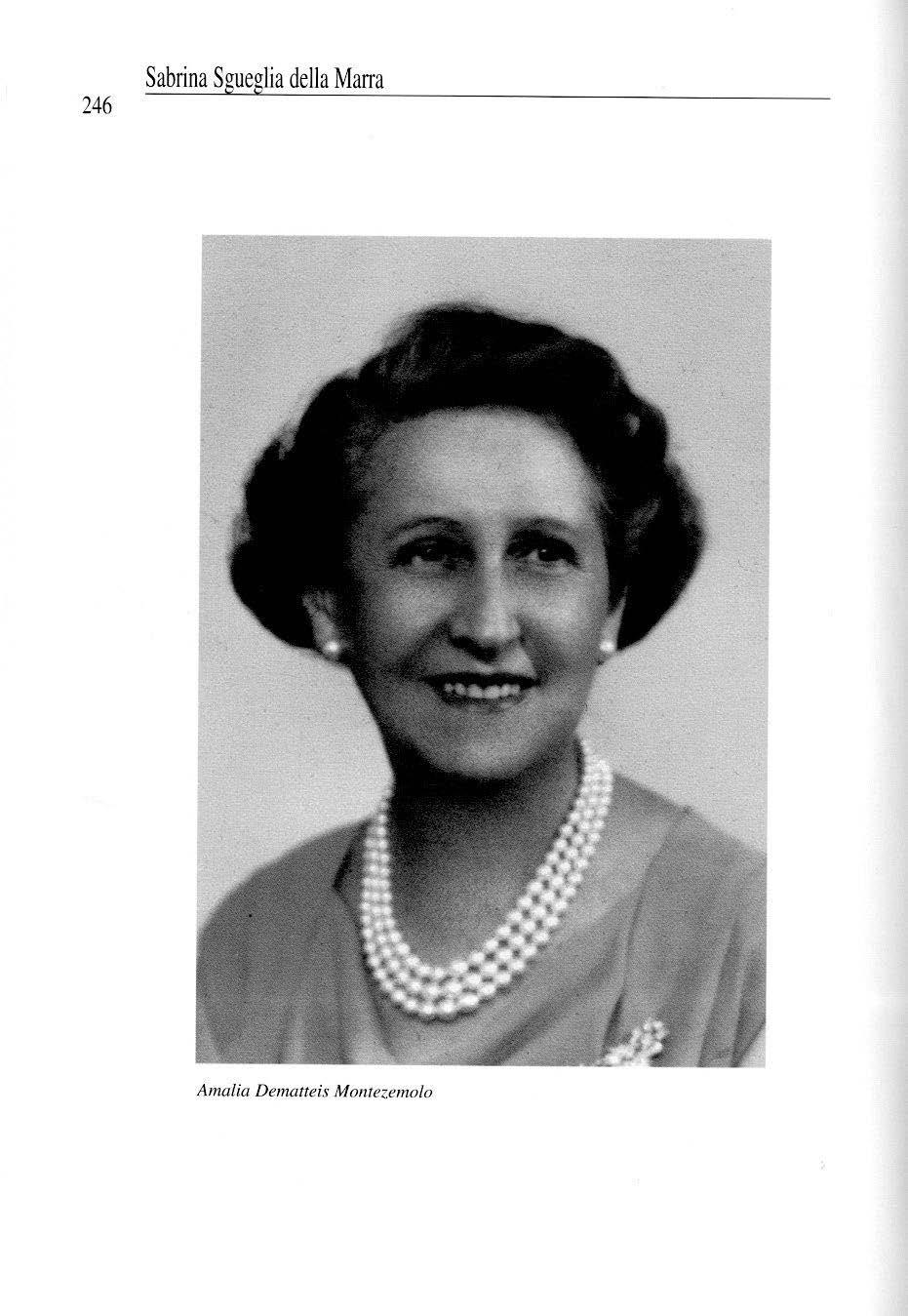
246
Sabrina Sgueglia della Marra
Am alia Dematteis Montez emolo

Montezemolo e il Fronte Militare Cla ndestino 247
Il
con la m oglie e i.figli nel 1943
Matrimonio d e l colonnello Mo111e zemolo con Amalia Dematteis, 23/8//923
colonnello
Sabrina Sgueglia della Marra
1i·e big liet ti inviati clandesti11a111e11te dal co lonn e llo Mont e:em o lo alla marc h esa Ripa di Meana durame la prigionia

248
•••• ••• • l& i111t.erro!,'qi o•r ml'! llr-. C•rcqi e11i qr ire olouni
Stralcio del ve rbale dell'interroga1orio di Kappler invialo alla m oglie del colonnello M ontezemolo dall'av1t Rin a ldo Tadd ei nel g iugno 1948

Der lBd!e h]shaber der Sichc/ bo ¼spolizo i u. de• S D n -lt.:ili en 1,;.~.Hoa
Giuseppe K onte z e mo 1 o iet am 24.}.1944 geetorben. E'f'tl. zurUekgelaseene peraijnliohe Gegenetbde k~nnen bei der Dienetetelle der Deutaohen Sioherheitapolizei in Tia
Taseo 155 abgeholt werden .
B iglietto in viato alla famiglia Montezem olo in cui le autorità tedesch e avvisano dell ' avvenuta mo rte de l colonn e llo il 24/3/1944
Montezemolo e il Fronte Militare Clandestin o -- =-=---- ==-----=:==:~=== - ===== - --= ·;;:==~-- - =--
-r--
.,
249
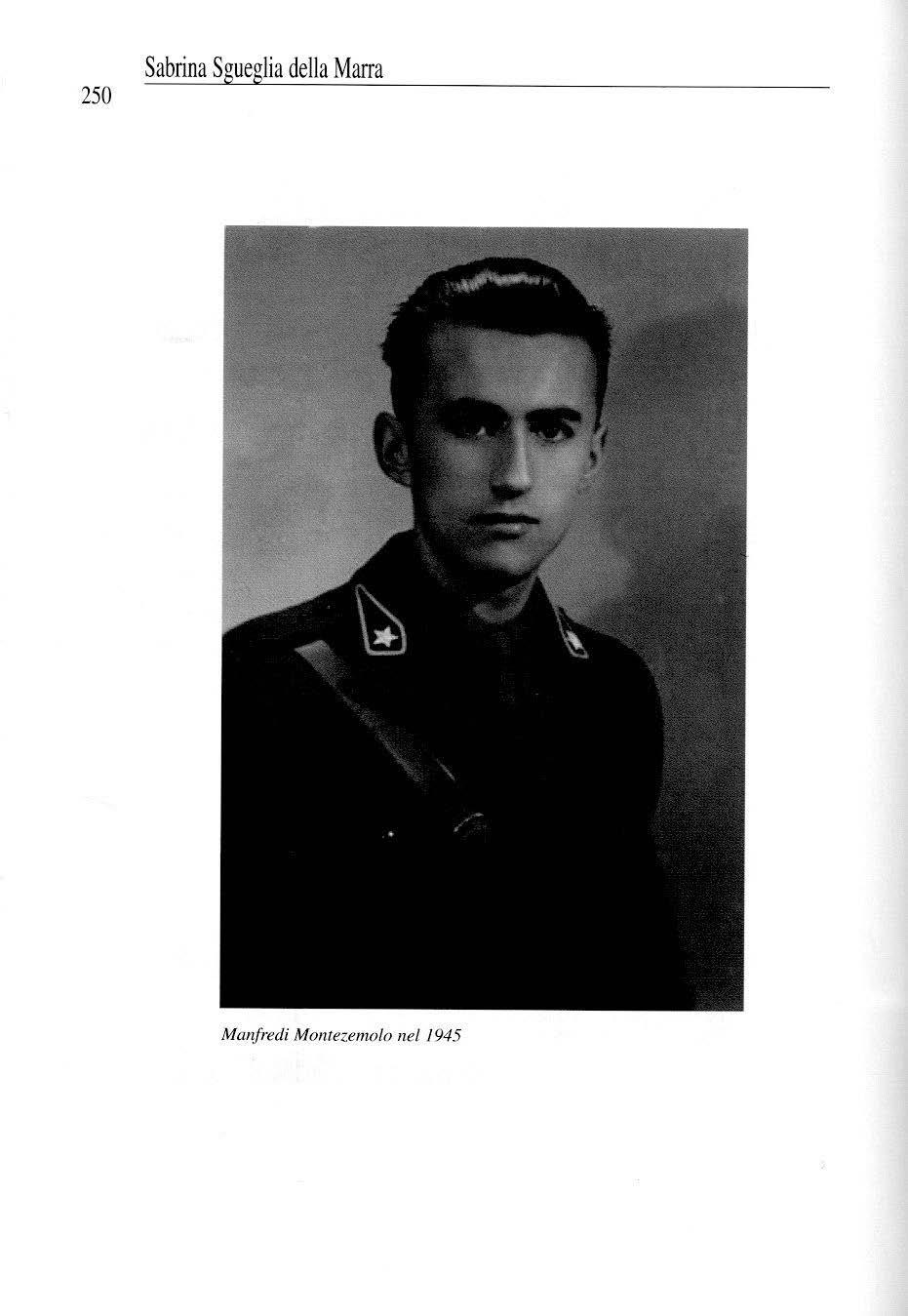
250
Sabrina Sgueglia della Marra
Manfredi Montezemolo nel 1945
Montezemo lo e il Fronte Militare Clandestino
 Rom.a, luglio /943, bombardam ento d el quartiere San. Lorenzo
Rom.a, luglio /943, bombardam ento d el quartiere San. Lorenzo
251
Roma, 9 s euembre /943, autoblinde italiane colpite dalle gran.ate tedesche sulla via Laurentin.a
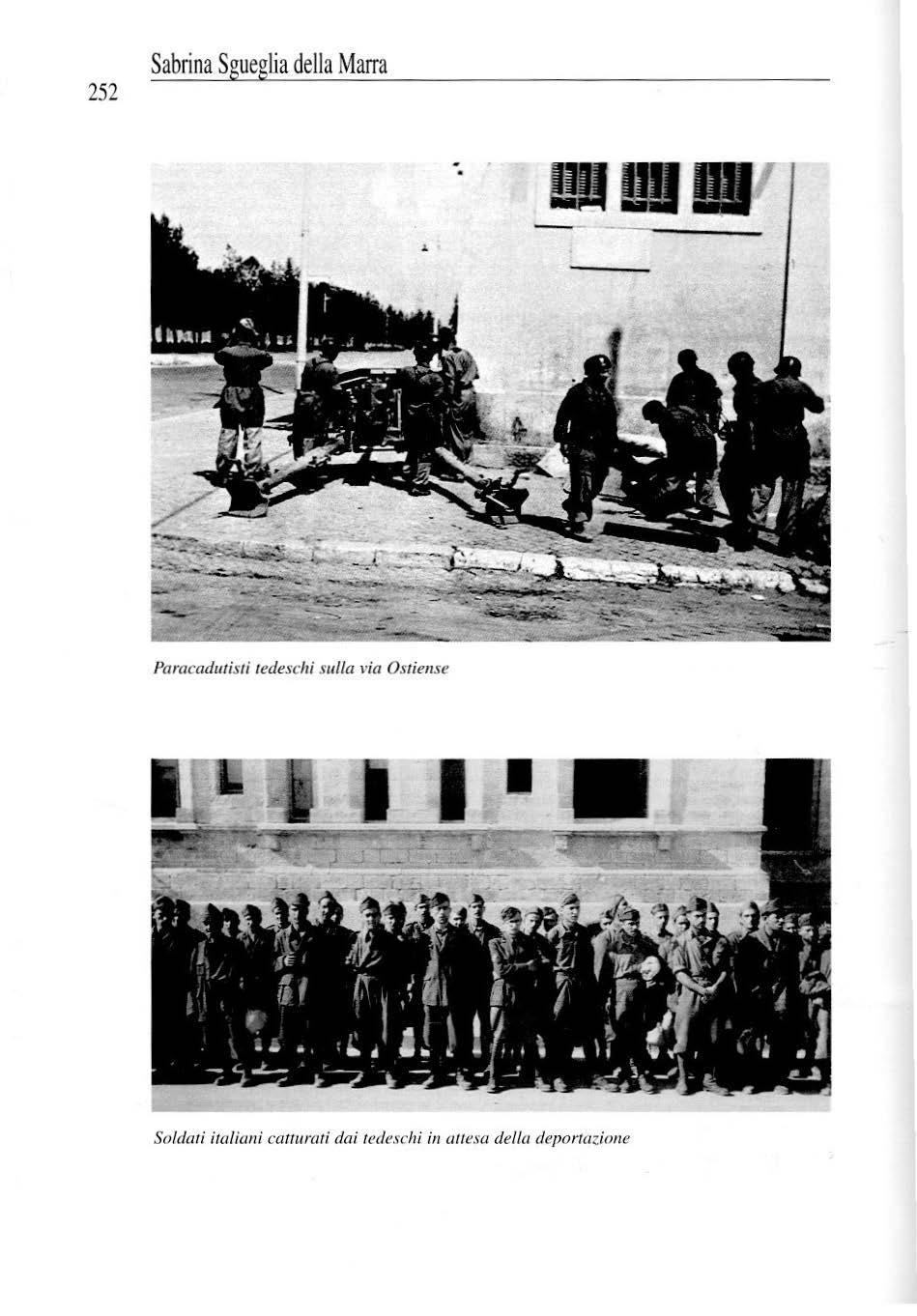
252
rina Sgu
della Marra
Sab
eg lia
. .
Paracadutisti tedeschi sulla via Ostiense
•••
Soldati italiani ca 1t ura 1i dai tedeschi in a/lesa d ella de p o rtm,io11 e

Montezemo lo e il Fronte Militare Clandestino
Roma, via Rase/la, soldati tedeschi subito dopo l'attentato
,., ,. 253
La rappresaglia na zifascista; rastrellam ento di civili fatti schierare lungo la cancellata di palazzo Barberini
Sabrina Sgueglia della Marra
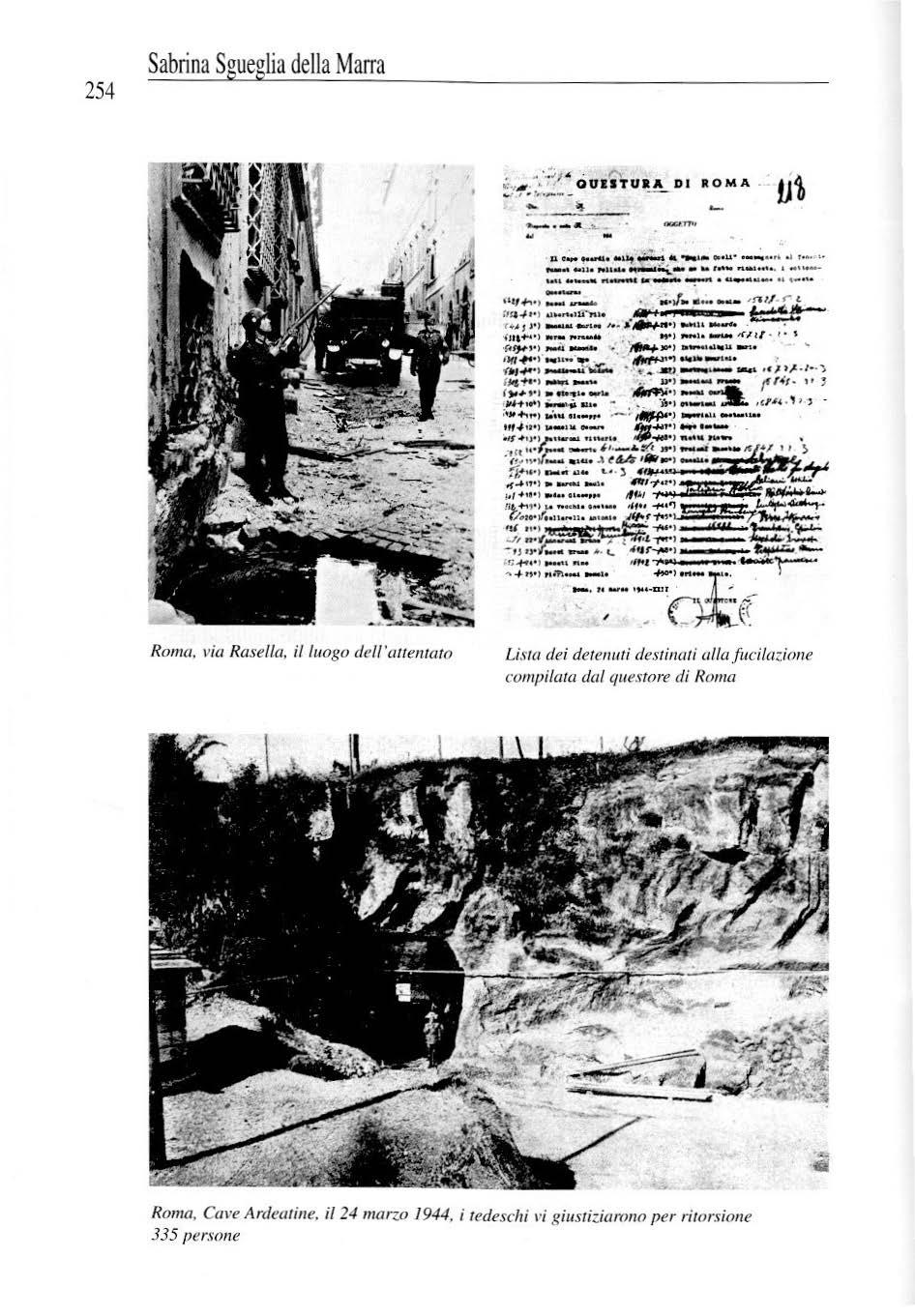
254
..·.."; , , ,.., ~~1'..;.,.:.. _ OUIITUa~Dl ltOMA...._. .-. .
Roma. via Rasella, il luogo del/'anemato
Lista dei de1e111 11i des1i11u1i a/lafucila::.ione co111pifc11a dal questore di Roma
335 persone
Roma, Cave Ardea1ine, il 24 marzo 1944, i tedeschi vi giusti::.iamno per ri1o rsio11e

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino 255
Le truppe alleate entrano a Roma
Roma, corteo con esponenti della Resisten za
Sabrina Sgueglia della Marra

256
Roma, giugno 1944, le truppe italiane ijìfa110 a Pia::::a Vene::ia
Folla es11fu1111r in Pia::;::.a San Pietro dopo la libera::ione di Ro11w

A11ge1, 11. 4 - aprile 1989 Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino • •• .. 4- • __ II Il Il Il I u\f11 1 \\ Il\ \ 1. 1 • I <:
lstitlllo Storico e di Cultura dell'Arma del Genio. /,,a vetrina
al Col. S.SM. Cordero Lon za di Monte-:;emolo 257
Roma.
dedicara

Fonti Archivistiche
Archivio dell ' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell ' Esercito:
Repertorio 1-3, bu ste : 146 ; 148 ; 149; 187; 188; 189.
Repertorio L-9, Stato Maggiore dell'Esercito , Ufficio Informa zioni
Repertorio N./-11, buste: 2121; 2997/A; 299 9; 3000/A; 3050; 3051; 3052; 3053; 3054; 3055; 3056; 3057;3058; 3059; 3060; 3061; 3062;3063; 3064; 3065;3066 ;3067;3068; 3069 ;3070 ;3071 ; 3072 ;3 07 3 ; 3074.
Repertorio N.1- I O, bu sta 3022.

Archivio Centrale dello Stato:
Mini s tero della Real Casa, Ufficio del Primo aiuta nte di campo del re, Serie Sp ec iale, bu ste: 80; 81; 82; 83; 84.
Archivio di Stato di Roma:
Sede s ucc ursale , Corte d'Appello di Rom a , Corte d ' Assise, sezione istru ttoria: fascicoli: 837 ; 836 ; 1418.


PRES ENTA ZION E PREFAZI O NE INTRODUZION E IN DICE Pag. » 3 5 I I "quaran t ac inque giorni" e l'armistizio...................... .. .... .. .. .. . » 9 2 La campagna d' Italia e la partecipazione delle nostre forze armate .. .. .. .. .... .. ........... .. .. .... .. ........ .. .. .. .. .. .... .. .. .. ...... » 22 I - L' INIZIO D ELL A RESIS T E NZ A ROMAN A E LA NA S C ITA D EL F RONTE MILITA R E CL ANDESTI N O I la difesa di R oma e il Comando della ciuà aperta » 31 2 li colonnello Giuseppe Cordero Lan za di Montezemolo » 58 3 le prime fasi di vita del Fronte Militare Clandestino.. )) 62 4 I principali esponenti del Fronte M ilita re Clandestino » 73 II - S TRUTT U RA E ATTIVITÀ DEL F RO NT E MILITARE CLA N DESTINO I L'attività informativa .. .... ...... .. ... .. .. ........ .. ........ .. .. .. .. .. .... .. ........... » 83 2 Il Centro Stampa e Assistenza ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . ...... ... .. ... .. .... » 90 3 Le bande interne ed esterne...................... .. ........ ..... ............. .. .. .. » 92 I II - I RAPPORTI CON LE A LTRE C OMPON ENTI D ELLA R E SIST EN ZA ROMA NA I / rapporti coi partiti del Comitato di liberazione Nazionale » 135 2 / rapporti co i Carabinieri » 153 3 / rapporti con la Guardia di Finanza........ » 158 4 l rapporti con la Marina e l'Aeronautica............ )> 165 IV -DAL LO SBARCO DI A N Z IO ALL A LIB E RAZION E DI ROMA I Lo sbarco alleato e la decapita zione del FMCR .................... .. ... )) 175 2 l'ec cidio delle Fosse Ardeatine .... .. ........ .... . .... .. .... .. ................. .. » 196 3 Il FMCR dopo Monte zemolo ... .. .. ......... . .. ... .. .. .. .. .... .. .. .. .......... .... » 208 CONC LUSIONI B IBLIO GRAFIA RINGRAZIAME NTI ARCHIVIO FOTOGRAFICO FONTI A RCHIV ISTICHE » 229 » 235 » 24 1 » 243 )) 259




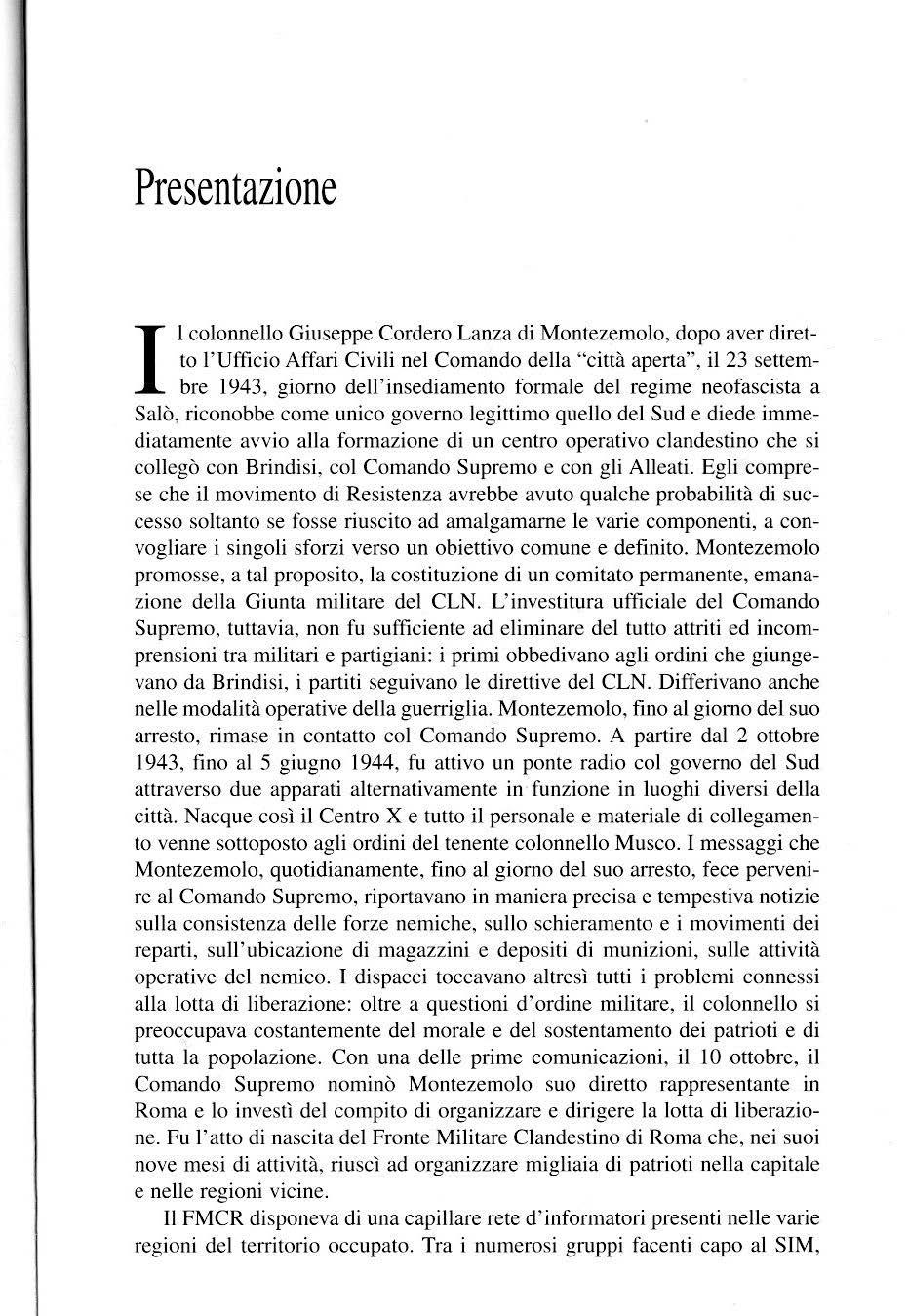 Sabrina Sgueglia della Marra
Sabrina Sgueglia della Marra

 Sabrina Sgueglia della Marra
Sabrina Sgueglia della Marra

 Giovanni Sabbatucci
Giovanni Sabbatucci
 1 Elena Aga Rossi. Una na zione allo sbando. L 'armistizio italiano del settembre 1943, 11 Mu lino , Bo logna, 1993, p.29.
Sabrina Sgueglia della Marra
1 Elena Aga Rossi. Una na zione allo sbando. L 'armistizio italiano del settembre 1943, 11 Mu lino , Bo logna, 1993, p.29.
Sabrina Sgueglia della Marra









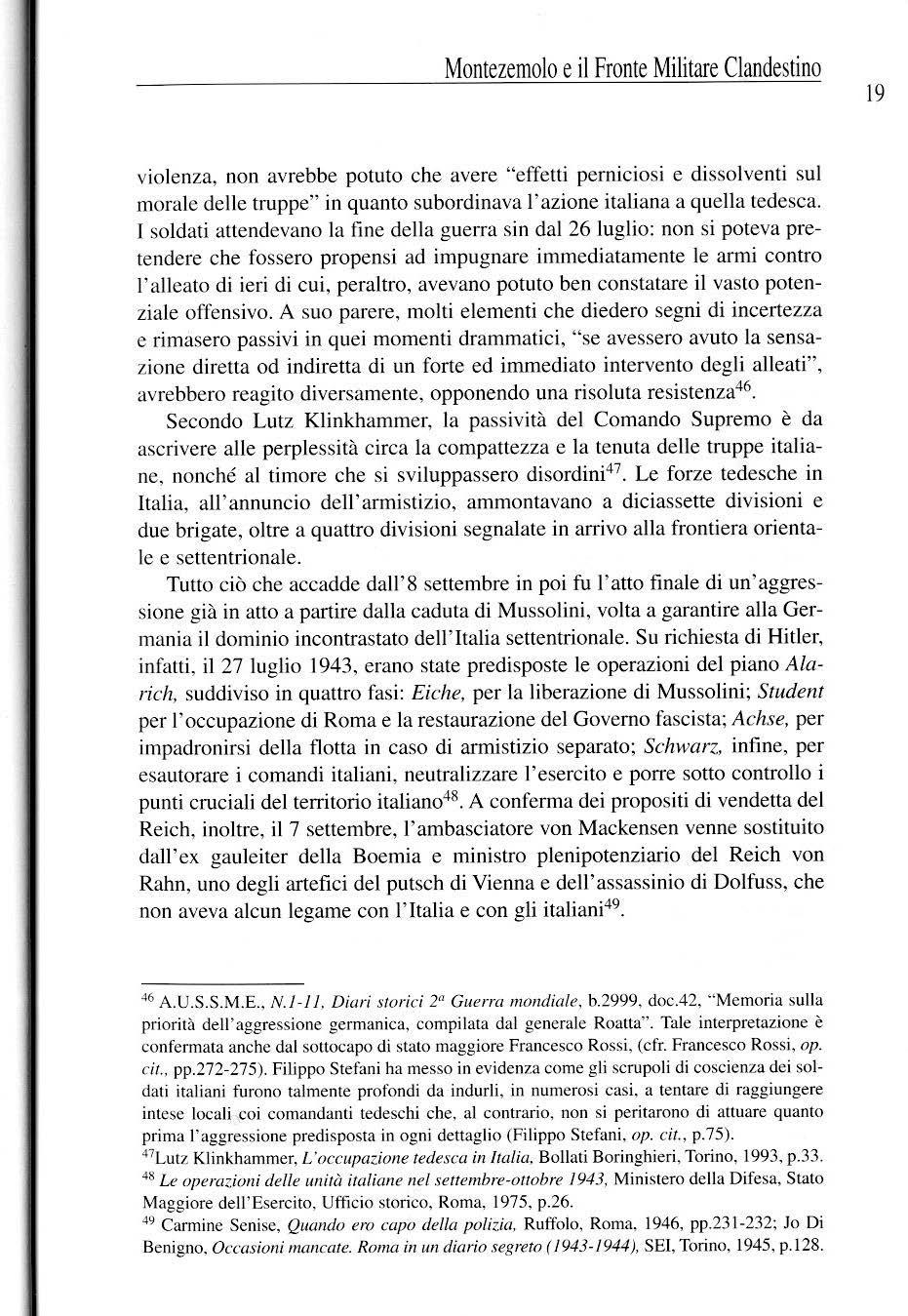


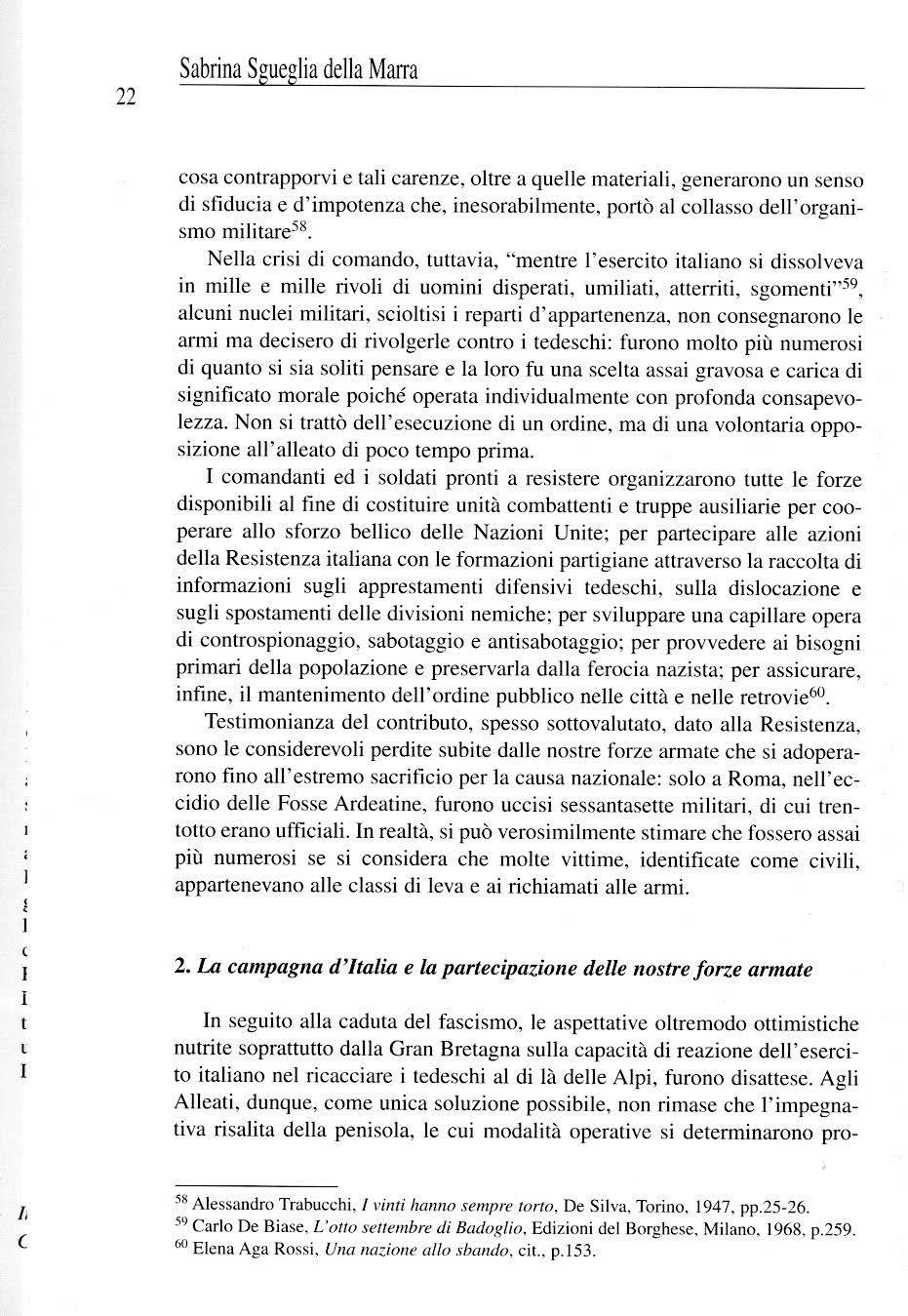






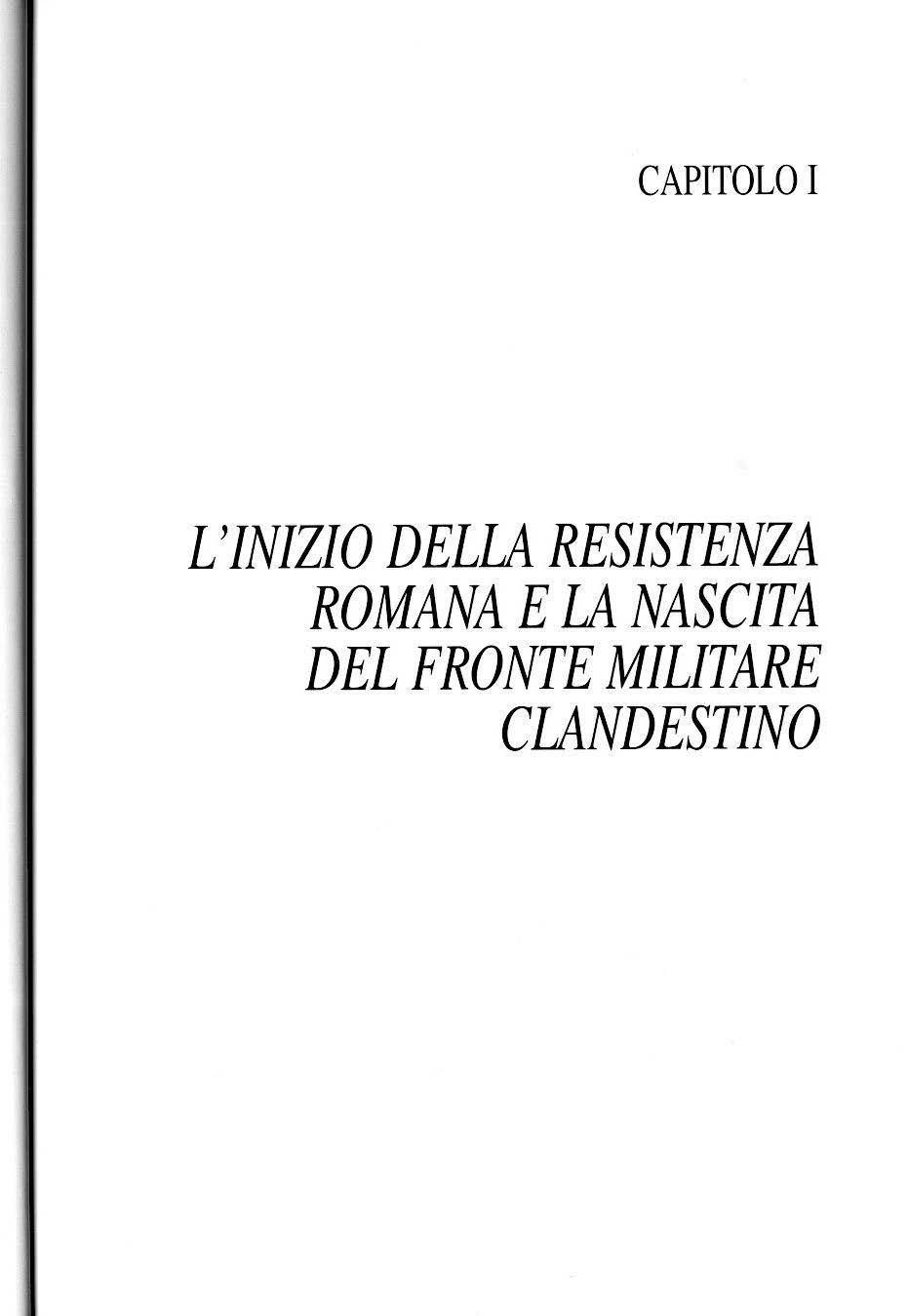






















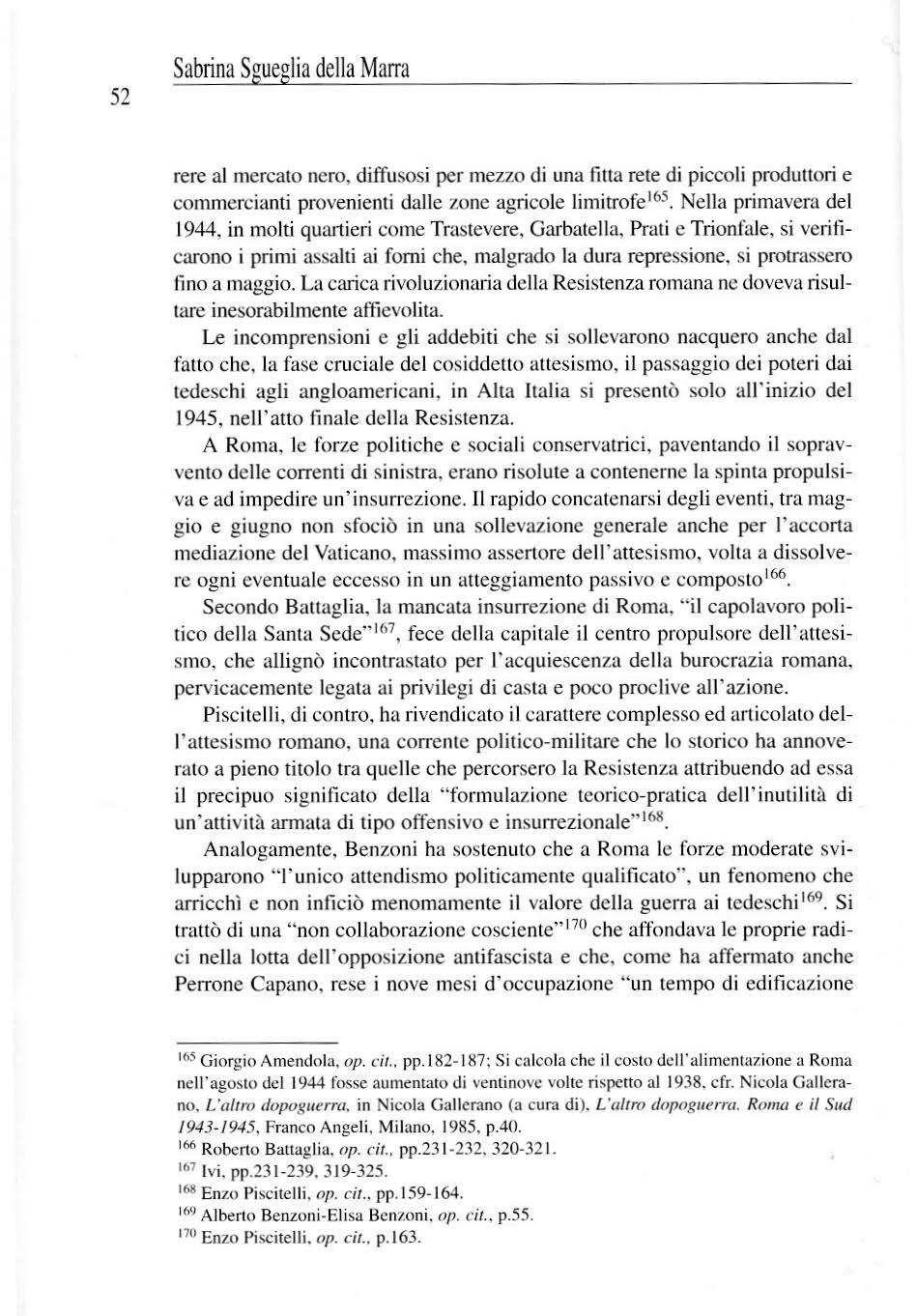











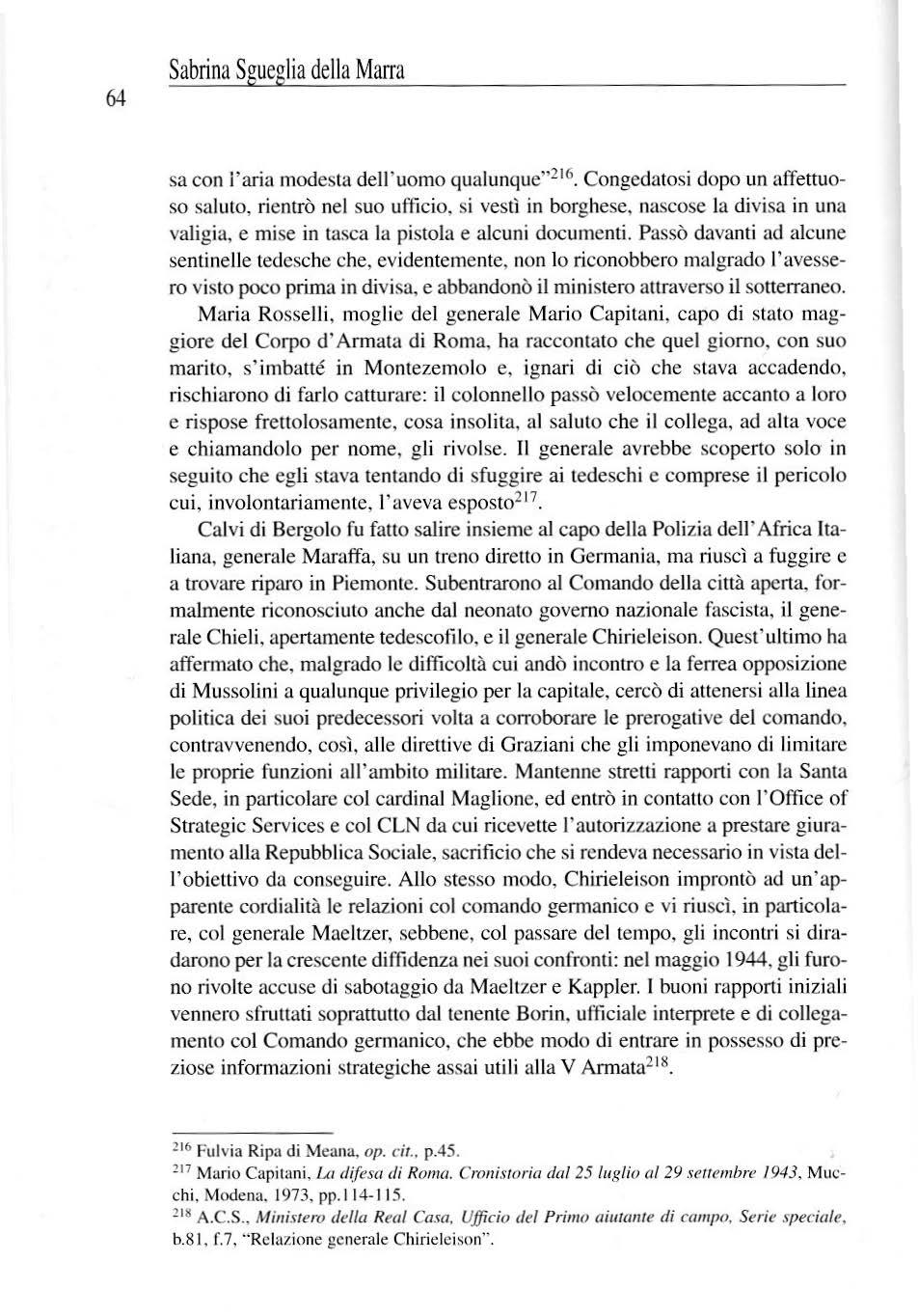
















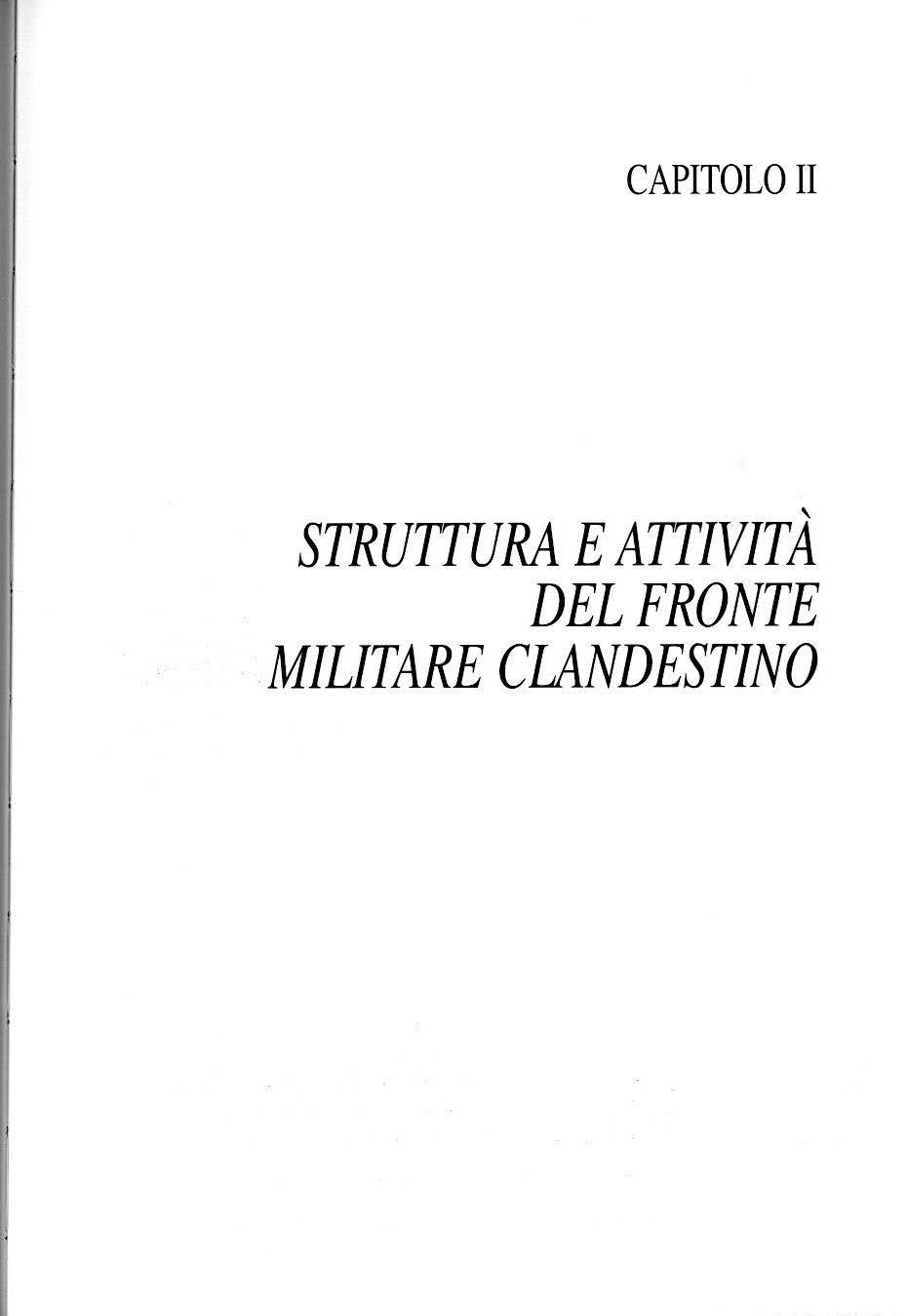

















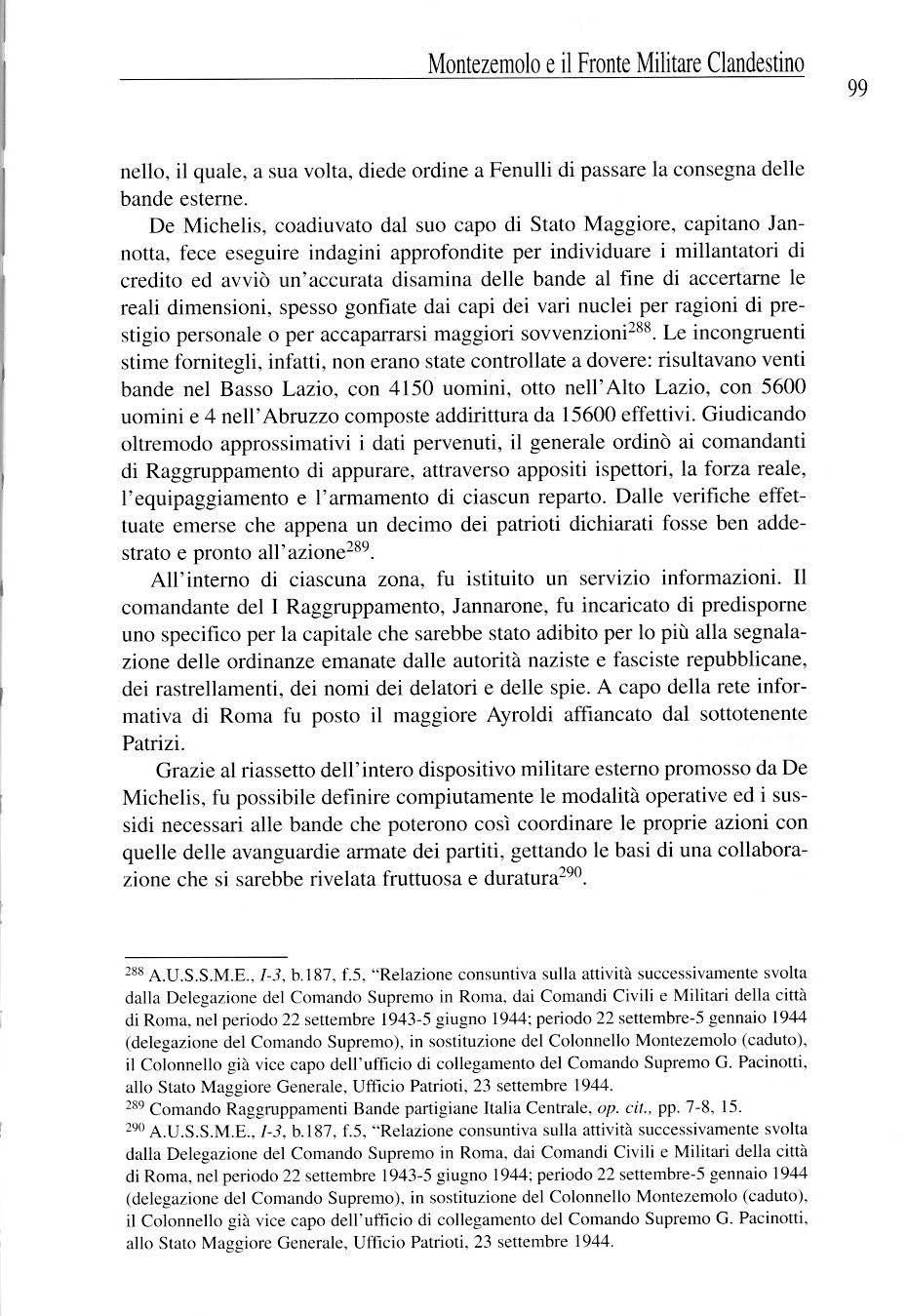






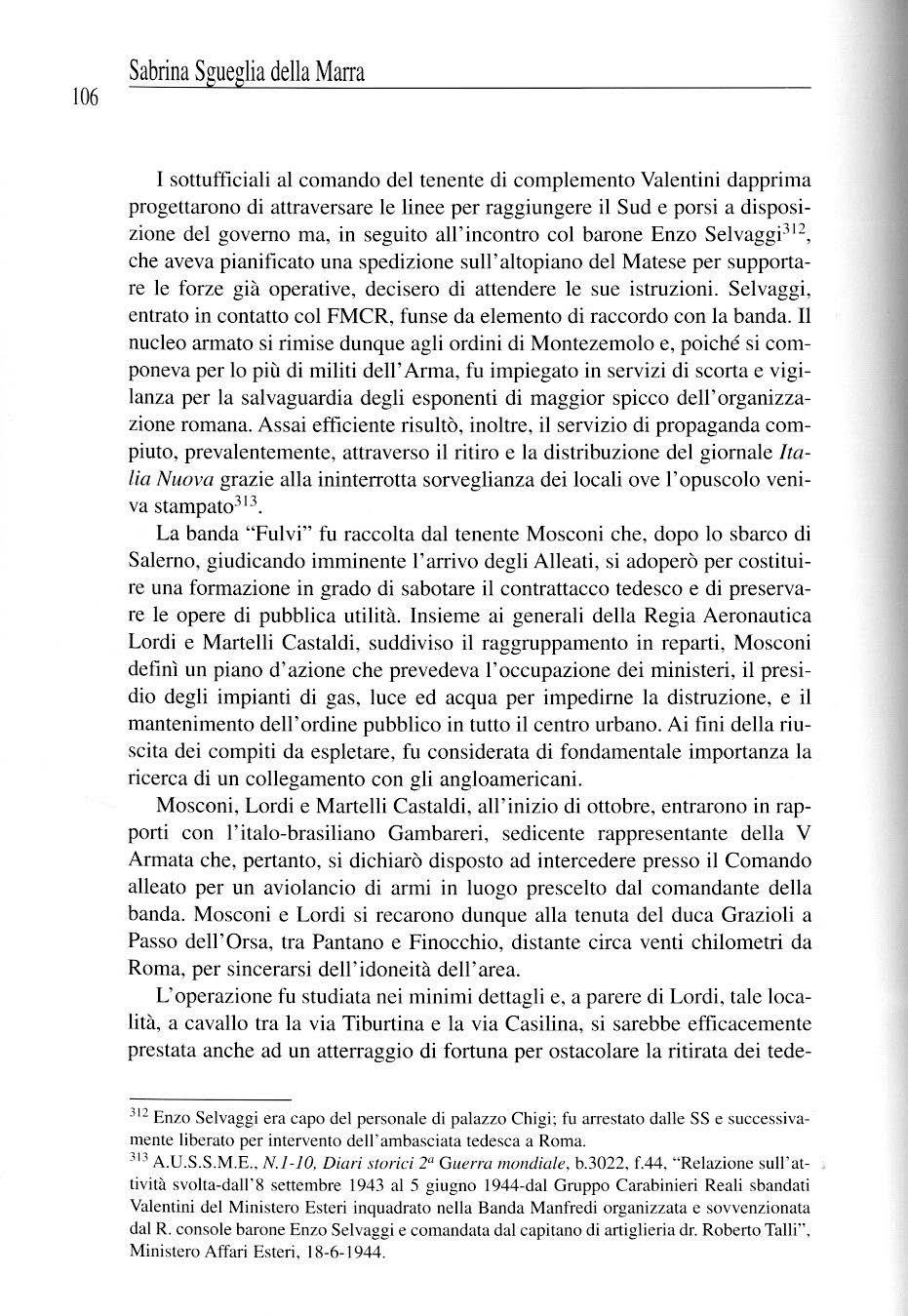

































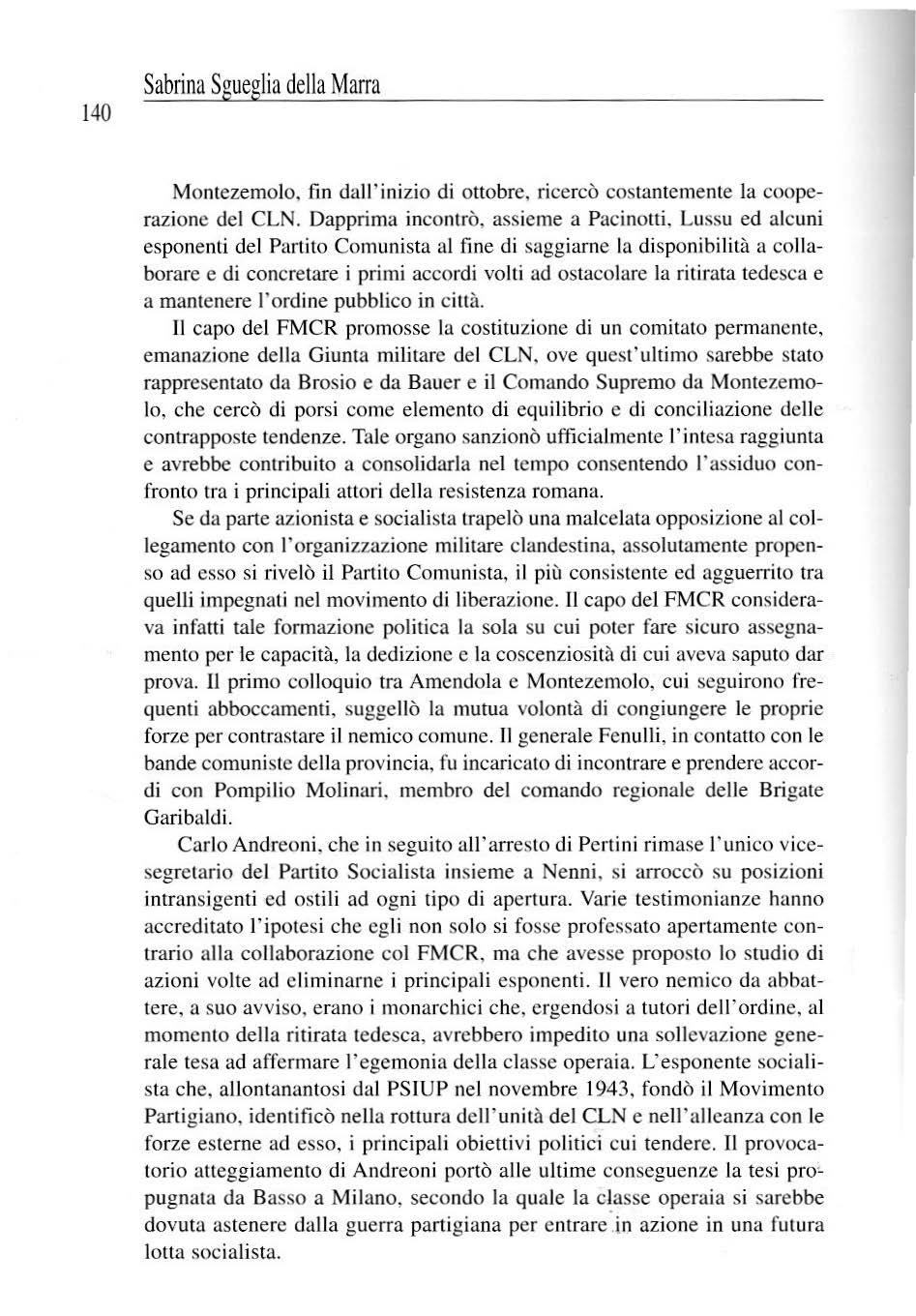


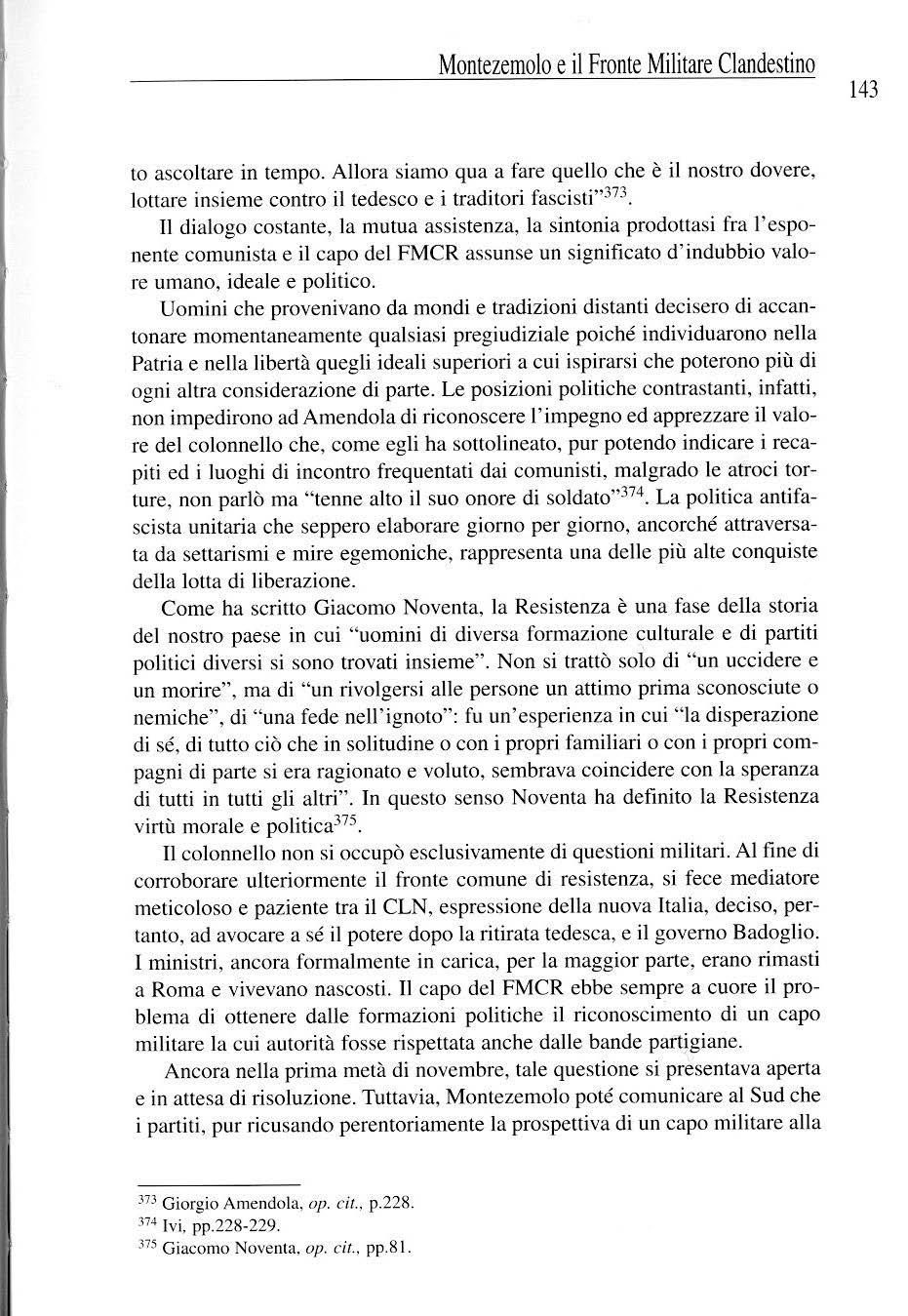






































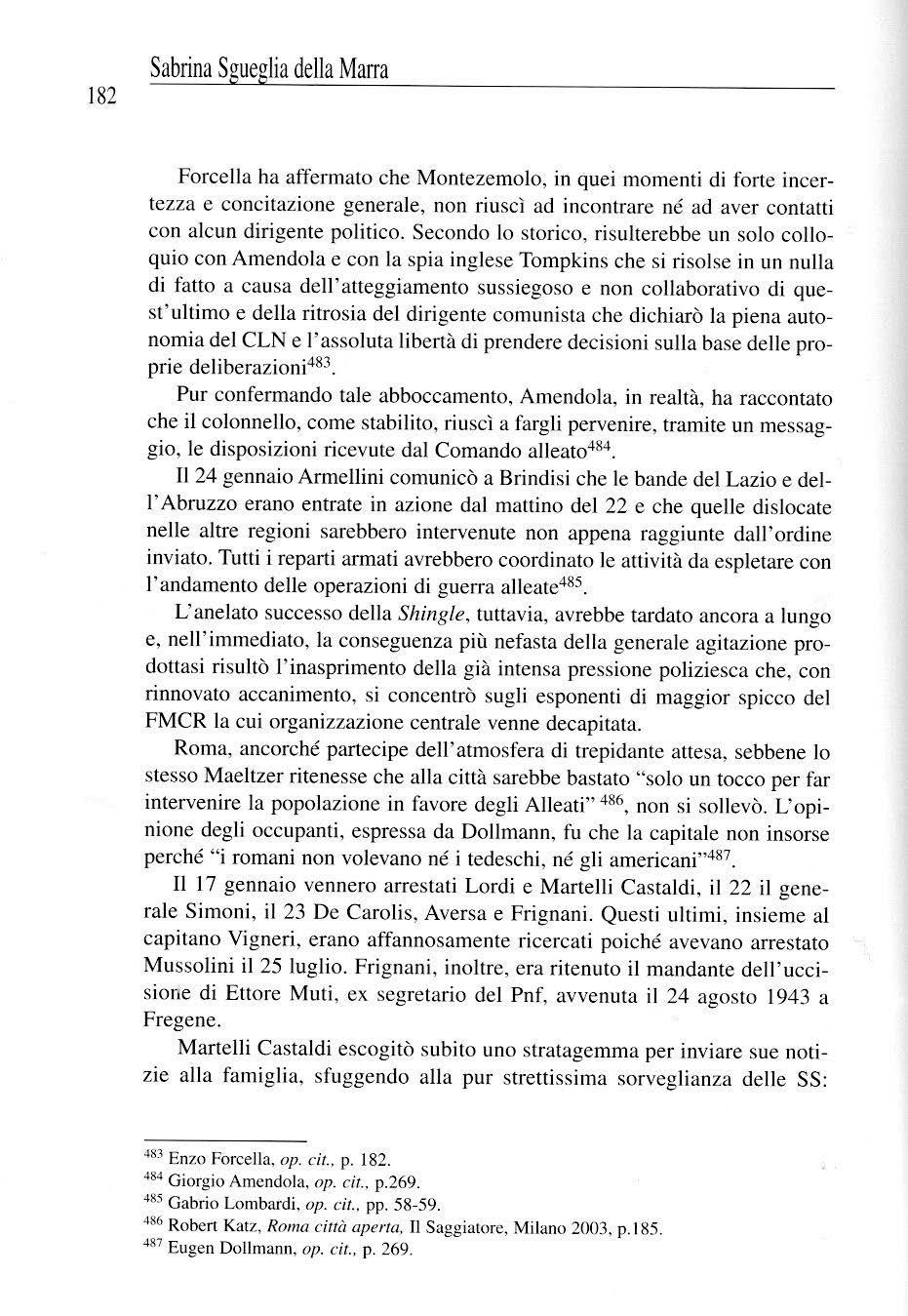

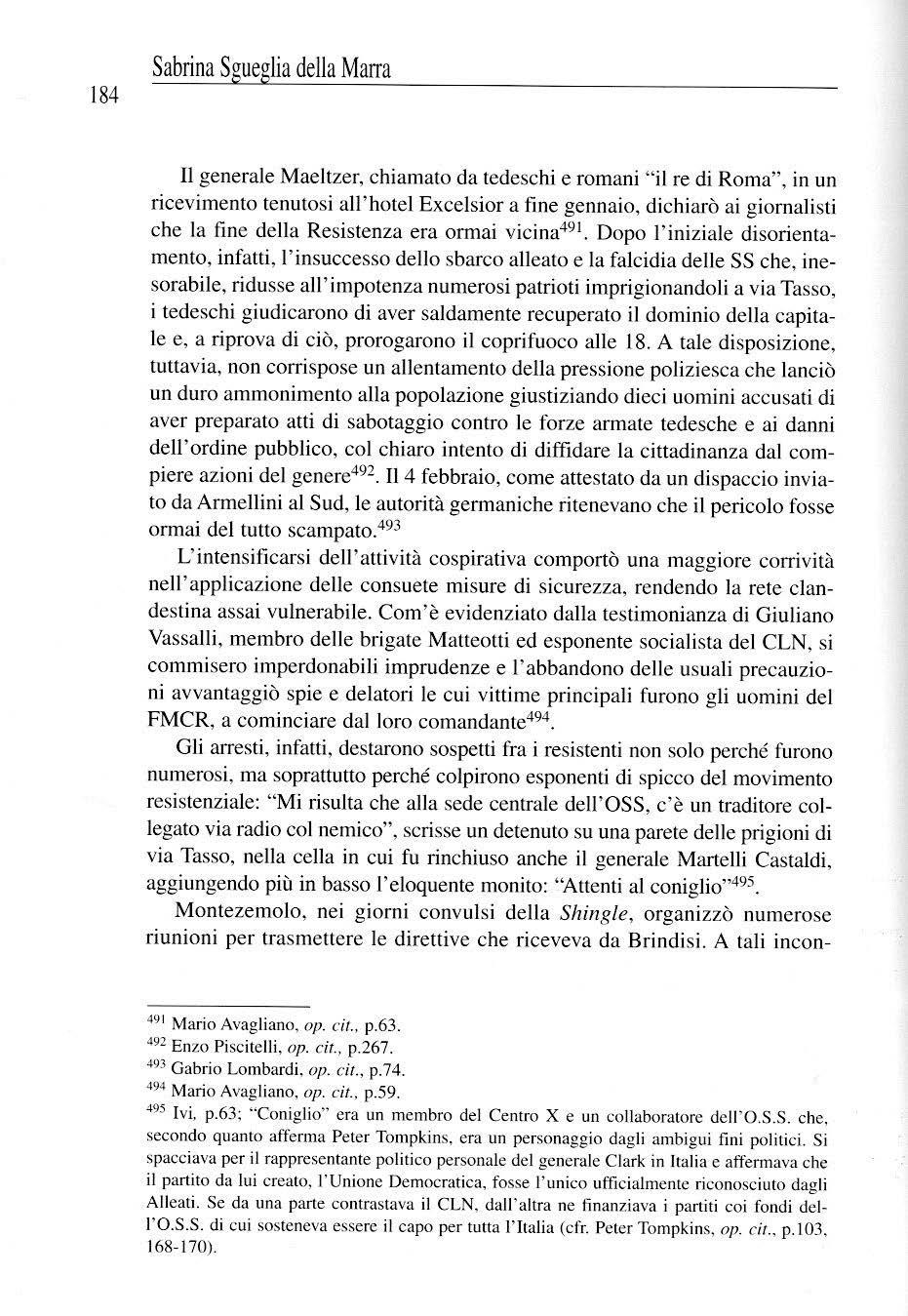








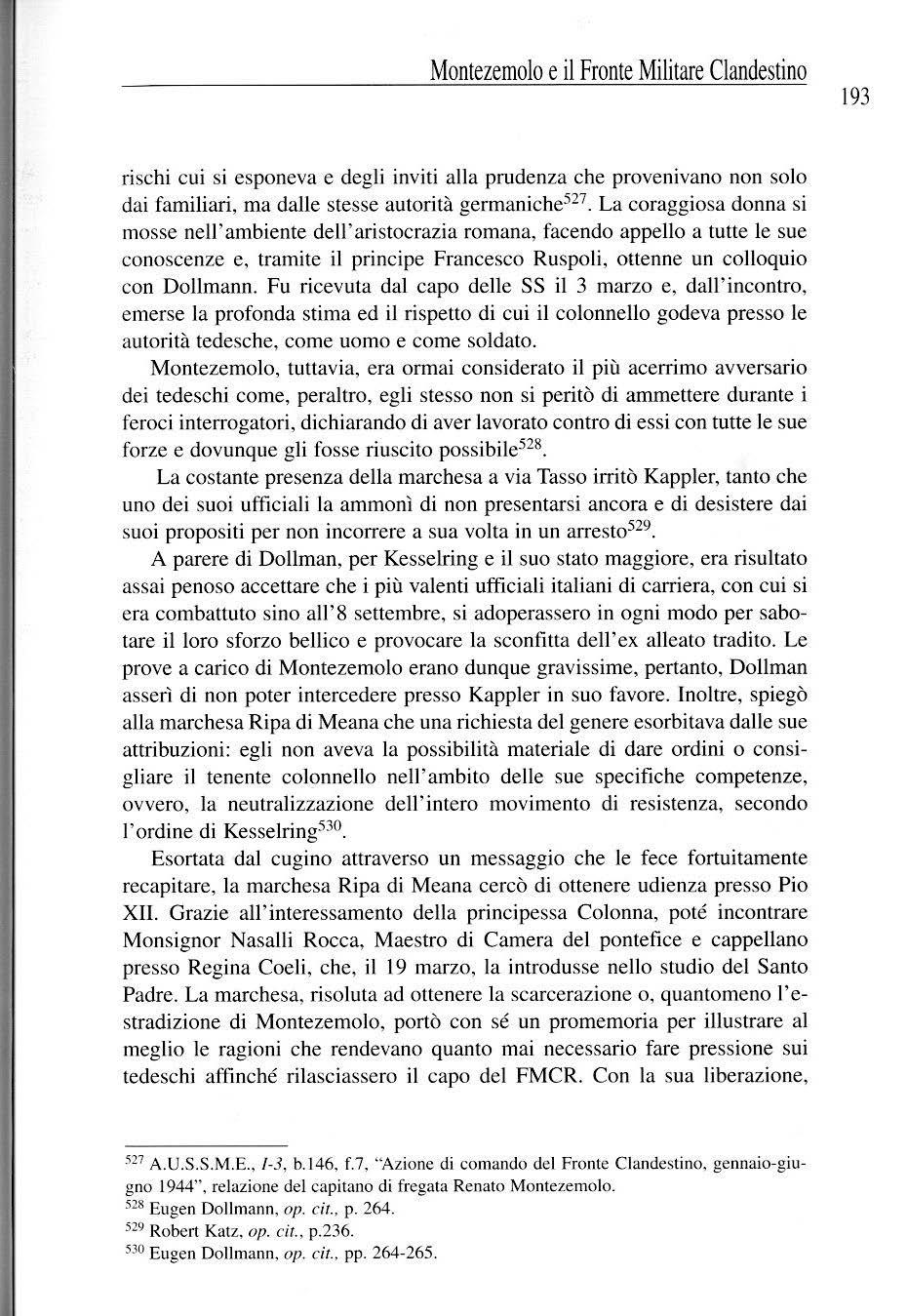


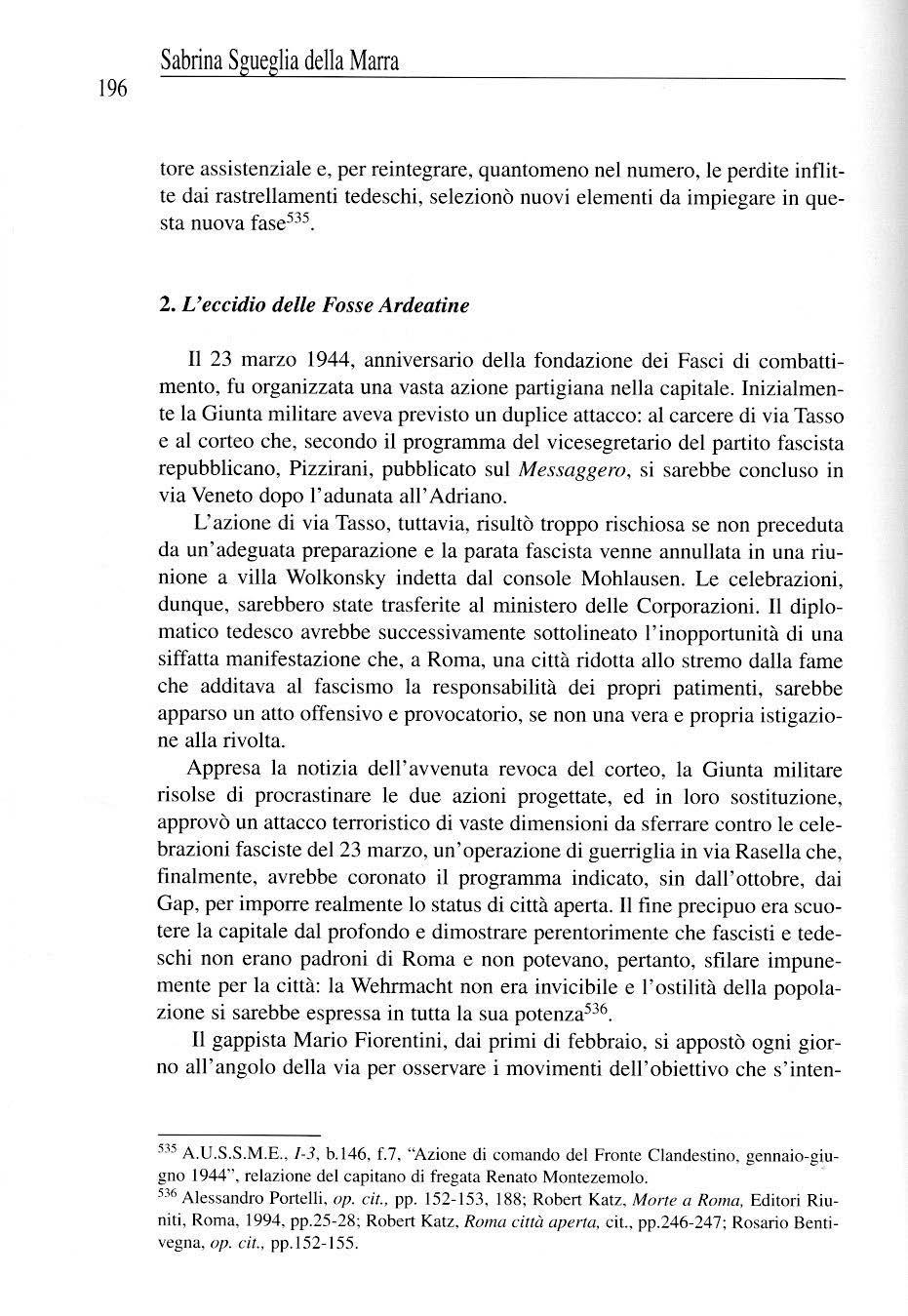


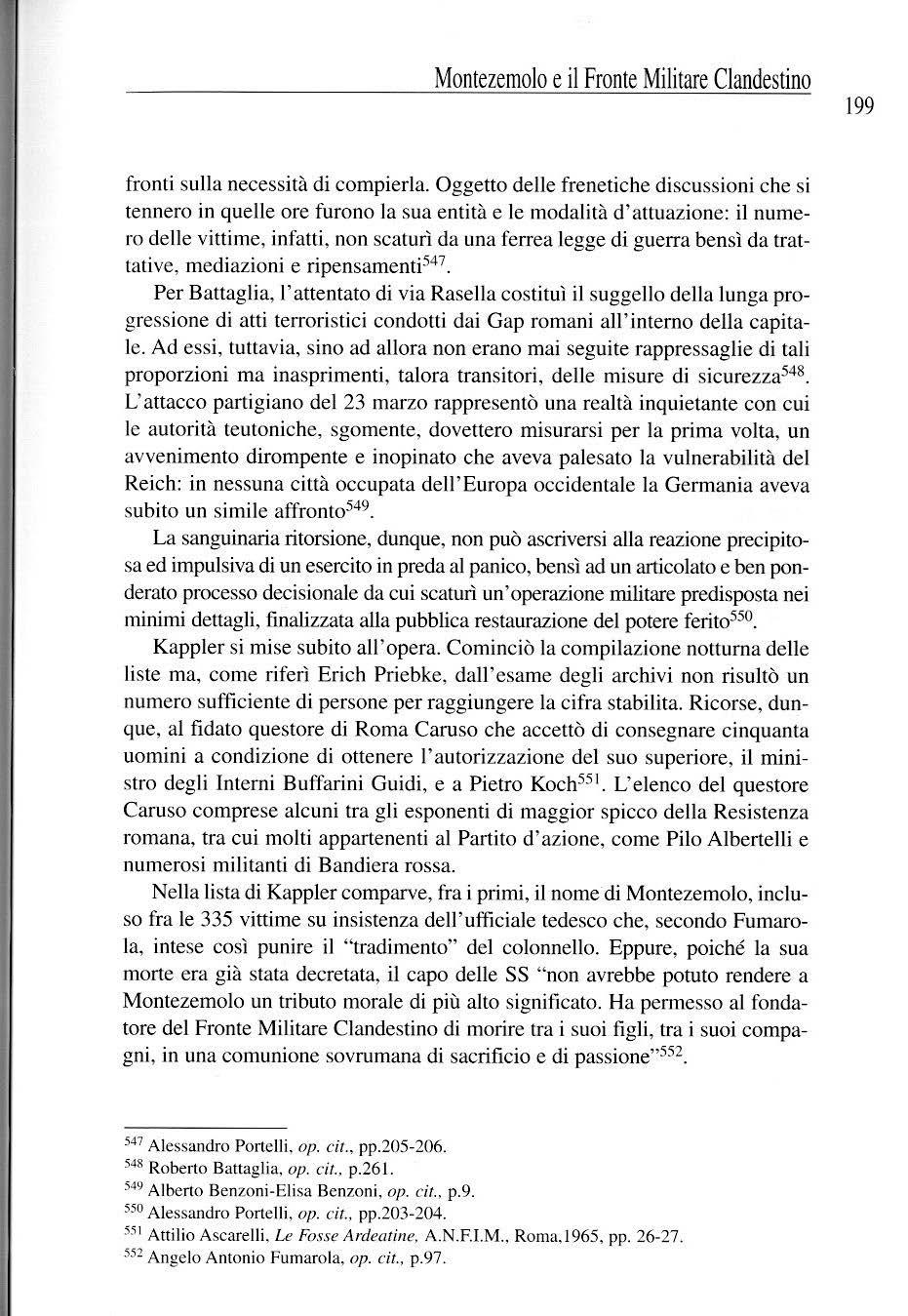



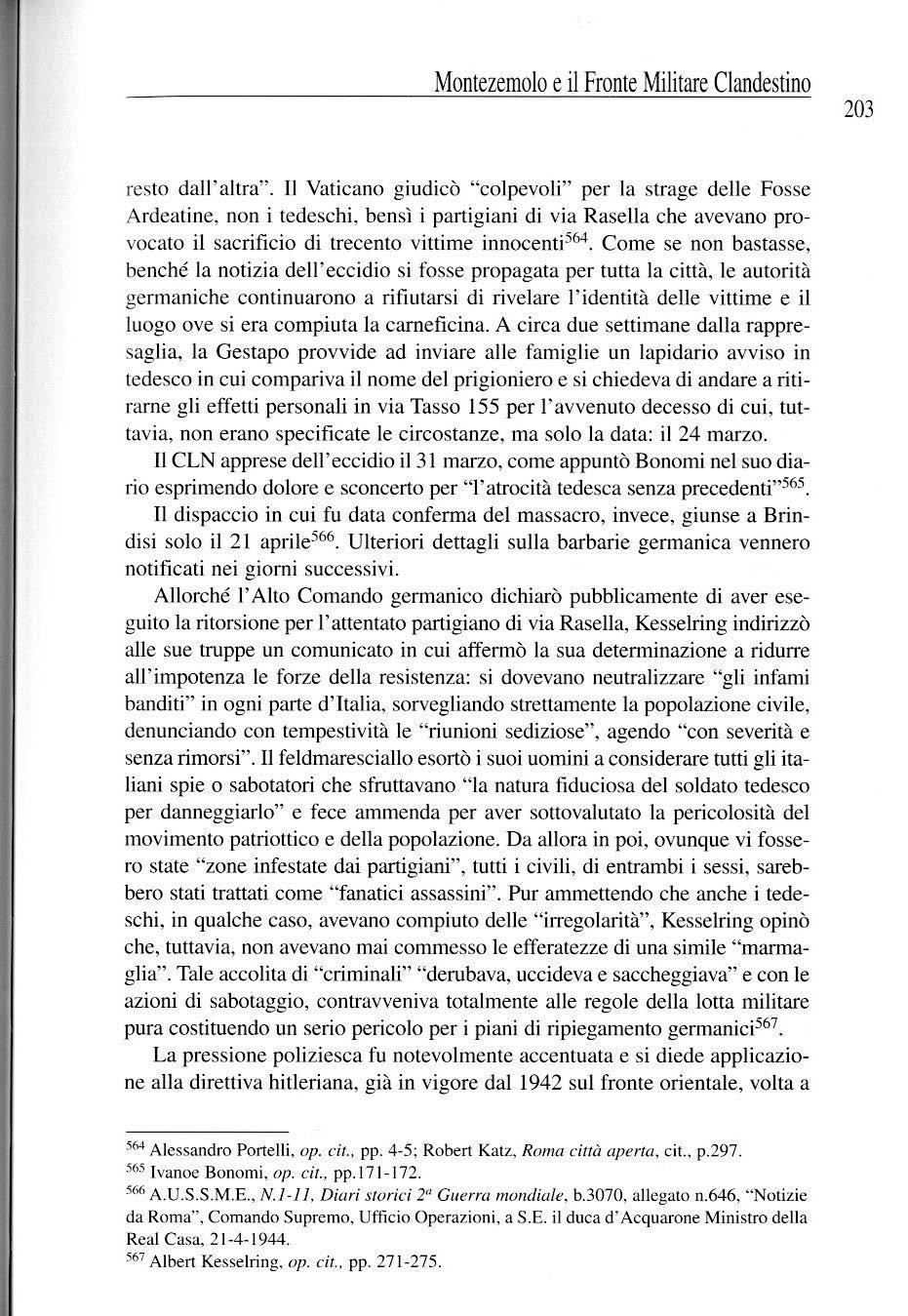



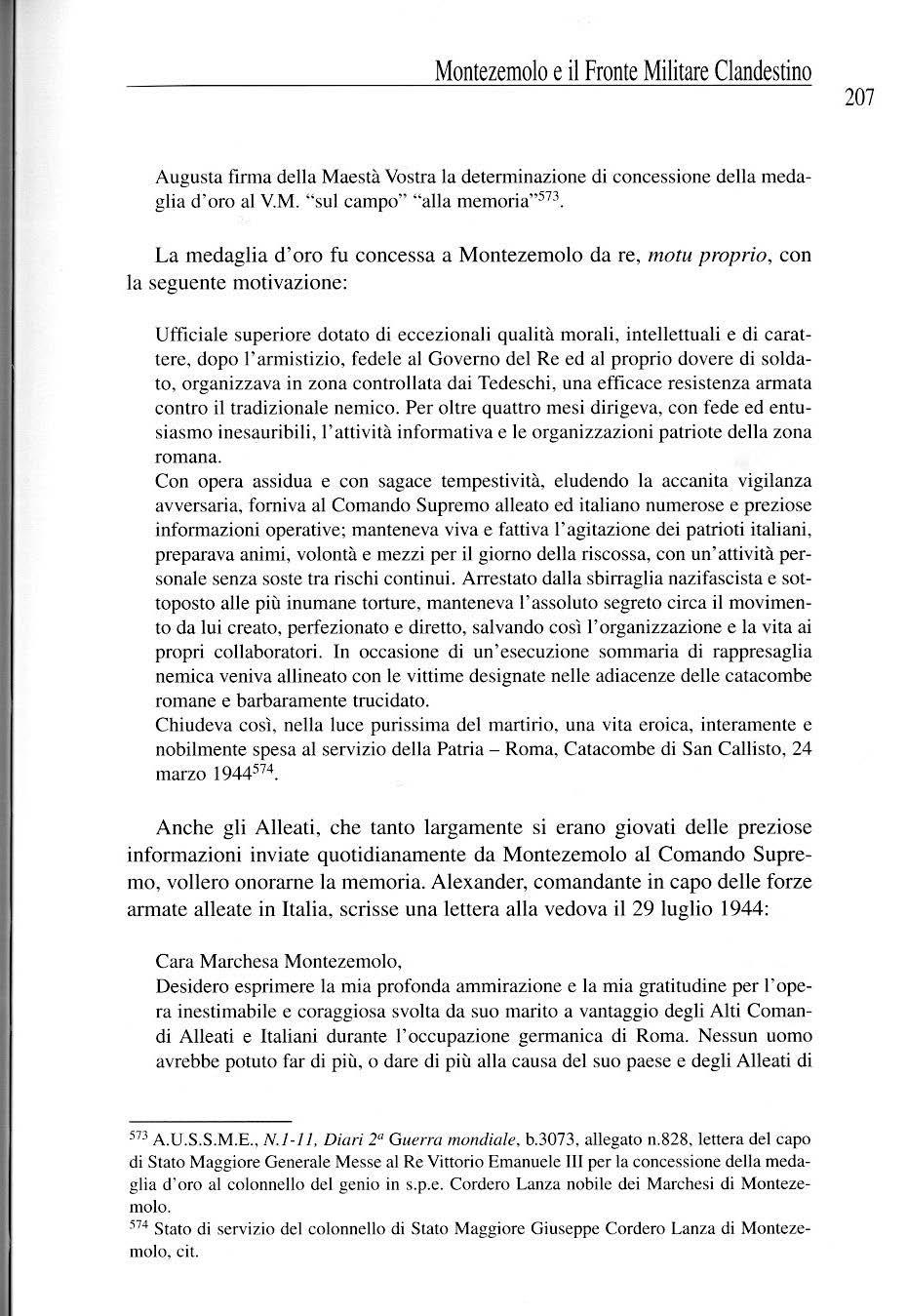





 58 1 Dominick Graham-She lford Bidwell, La battaglia d'Italia, Rizzoli , Mi lano, I 989, p.252.
582 Robert Katz , Roma c ittà ape11a, c it., p.323-327 .
58 1 Dominick Graham-She lford Bidwell, La battaglia d'Italia, Rizzoli , Mi lano, I 989, p.252.
582 Robert Katz , Roma c ittà ape11a, c it., p.323-327 .















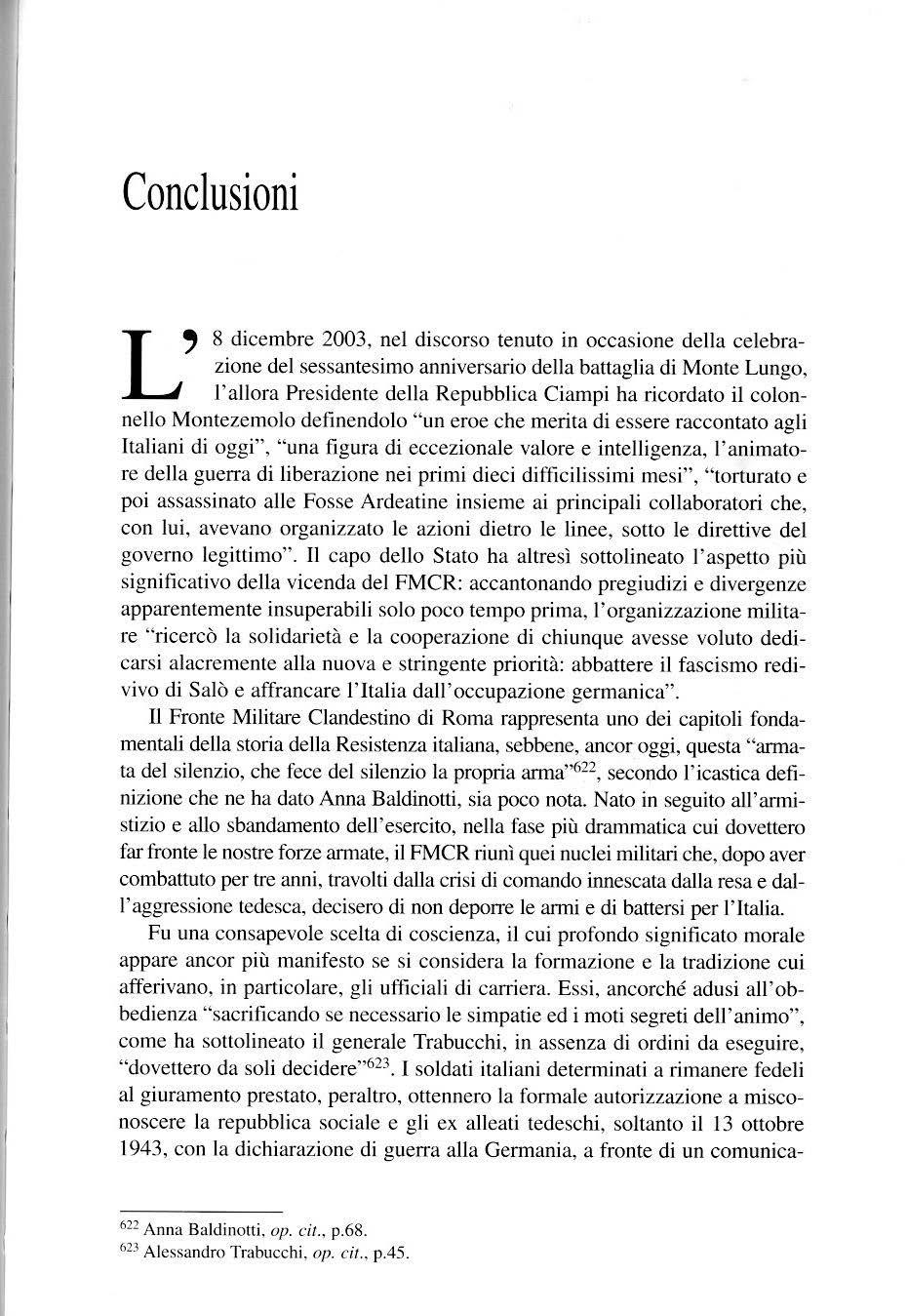
















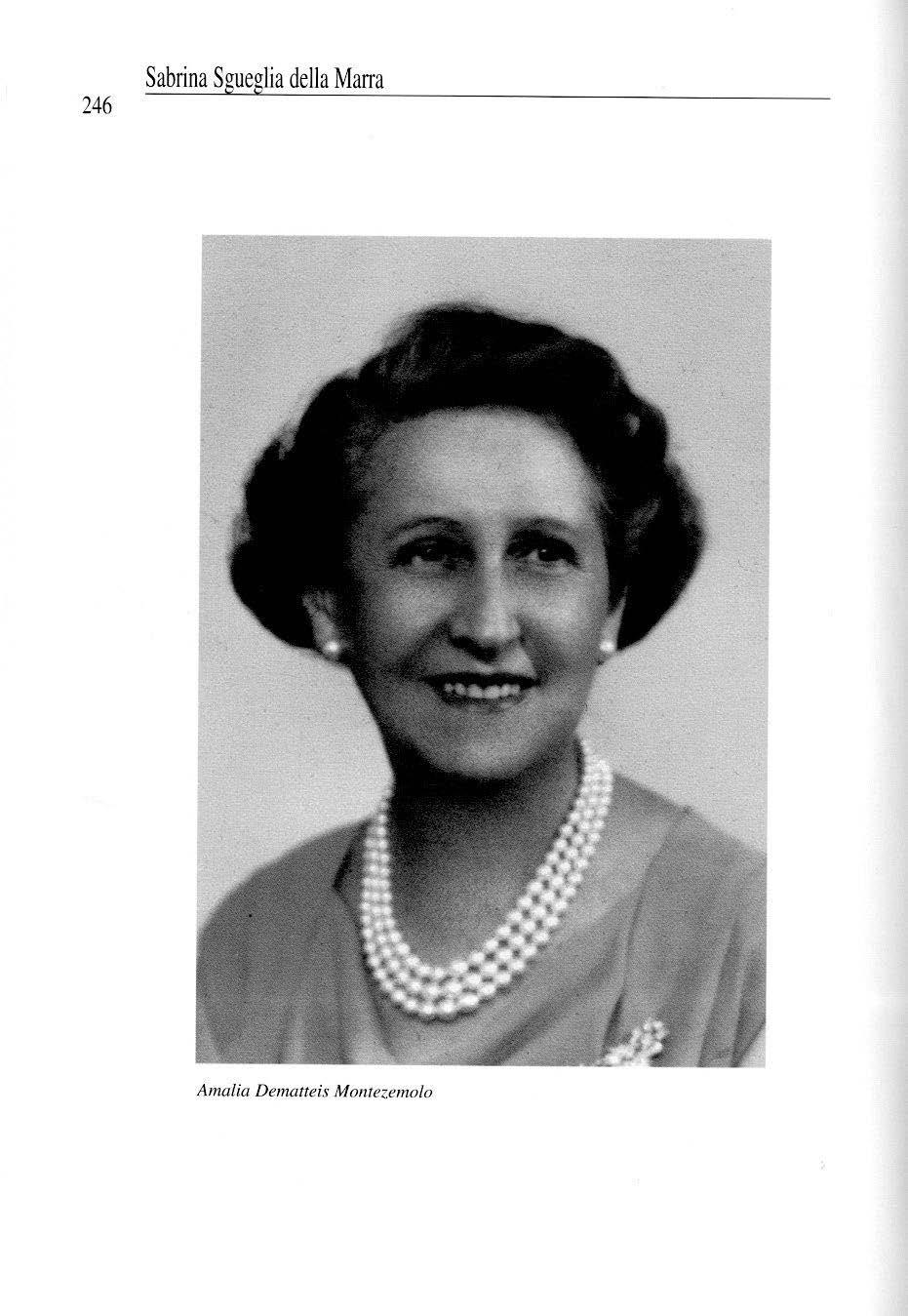



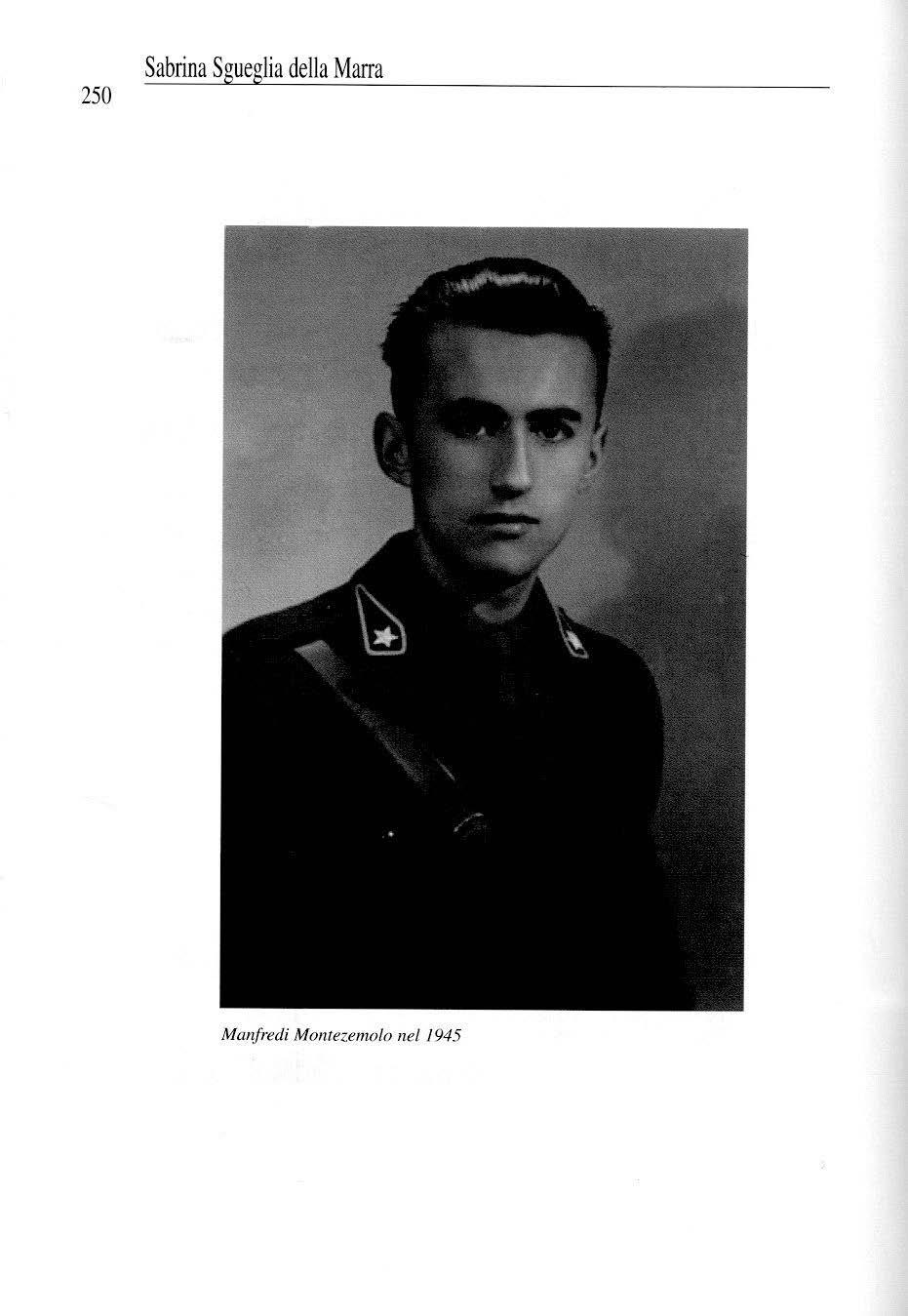
 Rom.a, luglio /943, bombardam ento d el quartiere San. Lorenzo
Rom.a, luglio /943, bombardam ento d el quartiere San. Lorenzo