









A ROMA TUTTE LE STRADE PORTANO IN TRATTORIA

GourmetFood
LA CUCINA DI MONTAGNA DI NORBERT NIEDERKOFLER


Un cuoco. Un mentore. Un visionario. di Gianluca Montinaro

50 68
COSA C’È DIETRO LA CHIUSURA DEL NOMA?
Il tema della sostenibilità nell’intervista dopo l’annuncio
di Flavia toMaello
L’ANTICA CORONA REALE DI GIAN PIERO VIVALDA
Una grande storia sabauda
58 73
di Gianluca Montinaro AZURMENDI
La cucina della sostenibilità rigenerativa
di alessandra Meldolesi
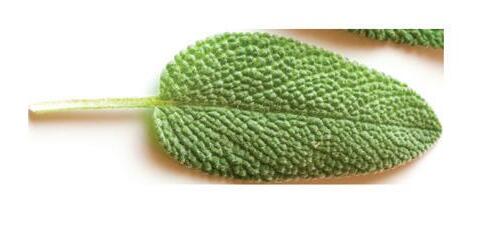
 Editoriale
di Elsa Mazzolini
Editoriale
di Elsa Mazzolini

Non mi sono appassionata all’annuncio su base planetaria della “non” chiusura del Noma: fin da subito ho pensato a un’abile operazione di marketing per camuffare da sensazionale notizia un normale e più conveniente cambio di rotta del format.
Perché diciamolo: se uno ha problemi di sostenibilità economica - come dichiarato - e quindi ogni mese aumenta i propri debiti, si mette subito ai ripari chiudendo il prima possibile e non dopo due anni. Sarebbe come sapere di avere una carie dolorosa, ma decidere di curarla due anni dopo.
Dunque il lasso di tempo che si è concesso, potrebbe servire a Redzepi non solo per rispettare impegni pregressi, ma anche per far cassa con quanti, temendo l’esclusione da quelle tavole mediatiche, si affretteranno a prenotare e a spendere.
Quindi per noi il motivo di interesse non sta nella notizia riportata da tutti i media del mondo, tant’è che nelle prossime pagine parliamo del Noma semplicemente raccontandone i fisiologici sviluppi, senza particolare enfasi narrativa.
Leggermente più pregnante, invece, il dibattito che si è acceso sull’effettiva sopravvivenza economica dei locali di alto livello, che comunque in Italia rappresentano lo 0,1% del totale dei ristoranti e lo 0,30% del fatturato annuo complessivo del settore.
Dunque, a livello numerico, di cosa stiamo parlando?
In soldoni, di poco; in termini di visibilità, invece, di tanto, perché si tratta di coloro che fanno notizia, tendenza, emulazione.
Pertanto più che parlare di crisi del modello ristorativo stellato, sarebbe bene parlare di crisi del modello Noma (o nordico) in particolare, e solo a latere della salute del nostro modello di haute cuisine, analizzandolo caso per caso perché, se c’è chi ha seri problemi economici (e chiude il prima possibile), c’è chi, anche se a fatica, cerca di far quadrare i bilanci.
A fronte di alcuni casi estremi, persino di suicidi dovuti a tracolli economici, alcune realtà, come l’indimenticabile Trigabolo, hanno chiuso ai primi venti di crisi, non certo dopo due anni.
In sintesi, siamo un po’ allergici alla comunicazione basata su sensazionalismi quotidiani spesso costruiti sul nulla: servono solo ad alimentare il fastidioso chiacchiericcio web di chi commenta e pontifica su tutto pur di ritagliarsi una sussidiaria visibilità personale all’ombra dei famosi.
Questo è il periodo in cui le persone si fanno maggiormente questa domanda: subito dopo le Feste Natalizie inizierà il tour de force per arrivare alla prova costume in gran forma; e quindi, ci si comincia a chiedere quale dieta seguire, se affidarsi a integratori o a semplice attività fisica e così via... non ambisco a risolvere in poche righe tutti i dubbi delle persone riguardo a quale sia il miglior tipo di dieta da seguire. Certamente possiamo partire da una verità incontrovertibile: le diete NON sono tutte uguali.
Per capire però alcune differenti sfumature tra un principio alimentare ed un altro, dobbiamo partire da una distinzione fondamentale: i tipi di dieta sono fondamentalmente 2 . Ebbene sì, non sono poi tantissimi... noi pensiamo che ogni dieta con un nome altisonante sia differente dall’altra, ma, alla fine, vi assicuro che le differenze sono poche, quasi nascoste... Il più delle volte, presentare una nuova dieta è come fare un gioco di illusionismo. Cosa fa l’illusionista nel suo show? Cattura l’attenzione delle persone verso un punto, mentre il trucco si svolge esattamente dalla parte opposta! Un esempio?
La dieta dell’ananas! Ci sono ancora persone convinte che, se hanno perso peso, lo hanno fatto grazie a questo frutto miracoloso, mentre la dieta proposta non è altro che una dieta iperproteica. E allora torniamo a noi. Come dicevo, ci sono 2 differenti metodi alimentari:
1. la dieta a controllo calorico;
2. la dieta di segnale.

Nella dieta a controllo calorico , quello che facciamo è stabilire un introito calorico massimo da somministrare alla persona e, così facendo, creiamo un bilancio energetico negativo (cioè facciamo in modo che la persona bruci di più energia di quella che ingerisce), in modo tale da andare ad intaccare le riserve energetiche di grasso e dimagrire. Le classiche diete in cui provate a fare un calcolo calorico di ciò che mangiate si basano su questo principio.
Dalla parte esattamente opposta di questo sistema alimentare c’è la cosiddetta dieta di segnale In questo tipo di approccio, si parte dal presupposto che le calorie non sono affatto tutte uguali, ma che il cibo, a prescindere dalle calorie che ha, rappresenta un segnale metabolico preciso per l’organismo. È questo messaggio metabolico che bisogna attivare, in modo tale da permettere al nostro corpo di controbilanciare alcuni fenomeni ormonali e infiammatori, indispensabili ai fini del dimagrimento.
a cura di Primo Vercilli medico dietologoIl prototipo più conosciuto della dieta di segnale (ma anche, in assoluto, il più estremo) è quello della dieta chetogenica. Questa è una dieta, in totale assenza di carboidrati , ma anche in totale assenza di quantità; quindi, in questo caso, non c’è minimamente un controllo calorico.
Se volete subito chiedermi quale dei due tipi funziona meglio, sappiate che funzionano entrambi. Il problema non sta tanto nel funzionare o meno, ma piuttosto nel valutare la fattibilità dei due metodi e di quanto questi possano, oltre al dimagrimento, apportare benefici a lungo termine.
In effetti, come in tutte le cose, gli estremi sono sempre quelli peggiori; è per questo che, nel tempo, sono poi sorti modelli alimentari che cercavano di modulare le calorie sfruttando però il cibo come segnale metabolico.
Perché, vedete, è ormai chiaro che 100 calorie di carne vi fanno dimagrire e 100 calorie di gelato, invece, no: eppure le calorie sono le stesse!
La differenza di risultato sta proprio nel fatto che carne e gelato, nel nostro corpo, danno poi segnali metabolici completamente opposti. Quello che fa il gelato (che invece la carne non fa) è aumentare immediatamente la glicemia; con l’aumento della glicemia abbiamo subito un incremento di insulina (che deve appunto occuparsi di riabbassare la glicemia). L’insulina svolge perfettamente il suo ruolo, ma per farlo, chiede all’organismo di concentrarsi solo su questo e dice a tutte le cellule: ”Abbiamo un’emergenza, dobbiamo abbassare la glicemia, quindi che nessuno di voi cellule si azzardi a bruciare grasso, perché dobbiamo bruciare l’eccesso di zucchero!”. Quindi 100 calorie di gelato dicono al nostro organismo “guarda che per le prossime 2 ore tu non devi dimagrire!”.
Capite bene quindi che il segnale che il cibo dà è molto importante , anche se noi spesso facciamo finta di nulla: quante volte ci è capitato di prendere un cioccolatino e dire “tanto cosa vuoi che sia!?”
Ma allora, come ci orientiamo?
Dieta a controllo calorico o dieta di segnale?
Direi che, come sempre, in medio stat virtus. Senza scomodare metodi estremi come la chetogenica, si possono ormai trovare sistemi che, da una parte, riescono a dare un segnale al nostro corpo senza privarci dei carboidrati e, dall’altra, riescono ad ottenere un controllo calorico senza dover pesare gli alimenti.
Un esempio importante di come si cerchi di trovare diete che coniughino il segnale con il controllo calorico lo troviamo nella Dieta Mediterranea , che non è propriamente quella che seguiamo noi tutti i giorni!
La Dieta Mediterranea, per essere considerata tale, ha bisogni di precisi apporti ed equilibri nutrizionali, affinché il segnale metabolico sia efficace; peccato che ancora sia troppo legate alle grammature dei cibi. Infatti, in questo momento, la Dieta Mediterranea è per il 75% controllo calorico e per il 25% segnale metabolico.
Ma ormai è solo questione di tempo: si stanno facendo avanti numerosi sistemi che, partendo dal modello mediterraneo, esasperando maggiormente il segnale metabolico, cominciano a staccarsi dall’obbligo del pesare tutti i cibi.
Questo è possibile anche grazie alle scoperte sul DNA, che ci aperto nuovi orizzonti (tramite la Nutrigenomica) nel campo delle diete di segnale. Una dieta che coniuga perfettamente controllo calorico e segnale, senza pesare il cibo è la dieta N.I.Ge.F. (Nutrizione Immuno Geno Funzionale) che sfrutta le conoscenze date dallo studio del DNA di ciascuno. Un altro modo di esasperare il segnale è quello di arricchire particolari diete con dei cibi (super food) dalle proprietà talmente peculiari che possono, inserite in un corretto contesto, portare messaggi metabolici importantissimi.
Un esempio è dato dalla Makai , la lenticchia d’acqua (non ancora in commercio in Italia) che si è dimostrata, all’interno di un piano alimentare di tipo mediterraneo, capace di ridurre in modo impressionante il grasso viscerale rispetto alla Dieta Mediterranea classica.
Come vi dicevo, le righe a mia disposizione sono tiranne... posso quindi chiudere con pochi consigli se volte approcciare ad una dieta:
• scegliete un professionista serio e con curriculum comprovato;
• non scegliete mai sistemi estremi;
• cercate un sistema che vi educhi a dare un segnale metabolico corretto all’organismo;
• cercato un metodo che, pur nell’indirizzarvi ad una misura, non vi obblighi a pesare tutti gli alimenti.
Detto questo: buona dieta a tutti!
In vetta alla classifica dei buoni propositi di inizio anno, spesso ci si ritrova a scrivere “fare più esercizio fisico”. Un po’ per smaltire quei chiletti accumulati durante le feste natalizie, un po’ perché mai come oggi sappiamo che l’esercizio fisico è un fattore fondamentale contro il decadimento psicofisico.

Per rimanere sani e attivi occorre pianificare diete vegane selezionando un carburante d’alta qualità. Pertanto, oltre a comprendere che occorre impostare un’alimentazione sana, bisogna capirne i principi.
La maggior parte dell’energia nella dieta dovrebbe essere fornita da carboidrati presenti nei cibi ricchi di amido come avena, patate, pasta, cereali, legumi e frutta. Farne rifornimento qualche ora prima dell’esercizio fisico, tanto quanto nel recupero del post-allenamento è importante.
Le opzioni ricche di carboidrati contenenti anche una quantità moderata di proteine sono l’ideale.
Ad esempio, pane di cereali antichi con hummus di ceci, por- ridge con latte di soia o mandorle e frutta, pasta con fagioli, ceci, lenticchie, o pasta fatta di farina di legumi. Cibi e bevande zuccherati possono essere utili prima dello sport soprattutto di endurance.
Il fabbisogno proteico standard è di 0,8-1 grammi per kg di peso corporeo al giorno, mentre il fabbisogno per lo sport può variare da 1,2-1,7 grammi sino a 2 grammi. I vegetali possono fornire tutti i mattoncini proteici essenziali, ovvero gli amminoacidi.
Le migliori fonti di proteine vegetali contengono buone quantità dell’aminoacido lisina, tra cui fagio -
 a cura di Silvia Bianco teStimonial di cucina vegana
a cura di Silvia Bianco teStimonial di cucina vegana
li, lenticchie, piselli, soia, arachidi, quinoa, anacardi, semi di chia, semi di lino macinati, semi di canapa e semi di zucca. Risulta quindi indiscutibile che in un pasto vegano si possano raggiungere i propri obiettivi proteici spaziando tra i cibi ricchi di proteine vegetali a disposizione.
Gli integratori in polvere proteici non sono essenziali in una persona atletica.
Il loro utilizzo è necessario se, con il proprio preparatore, si individua la necessità di seguire per un certo periodo un regime alimentare altamente proteico, che sarebbe difficile da raggiungere con il solo cibo, senza rischiare di sforare nel conteggio degli altri macronutrienti.
Questo vale sia per le diete vegane che per quelle onnivore ed è esclusiva di chi segue regimi altamente proteici dietro controllo specialistico. Ciò che rende unico il cibo vegetale è che può fornire fibre, vitamine e minerali, oltre che proteine.
Il Calcio è necessario per mantenere una struttura ossea forte e le diete iperproteiche sembrano aumentarne la perdita. Coloro che adottano una dieta basata su vegetali con un basso-normo livello proteico, possono avere un fabbisogno di calcio minore rispetto alla dose necessaria di chi segue diete ricche di proteine animali.
Raggiungere un soddisfacente livello di calcio attraverso una dieta vegetale è molto semplice: basta consumare verdure a foglia verde scuro come il cavolo, le cime di rapa e crucifere in generale, il tofu ottenuto con il solfato di calcio, fichi, mandorle, semi di sesamo ed altri cibi fortificati come yogurt o latte di soia, etc. (trovate un prezioso elenco delle quantità di calcio contenute nei vari cibi qui https://www.scienzavegetariana.it/conoscere/nutrienti/ calcio.html).
Mangiare cibi ricchi di ferro in associazione con una fonte di vitamina C ne ottimizza l’assorbimento. L’aggiunta di succo di limone nell’acqua o una spremuta di arancia ai pasti sono
utili se, dopo controllo medico, bisogna aumentarne i livelli, altrimenti non è prassi necessaria. Ci sono anche fattori limitanti l’assorbimento del ferro come i tannini, i fitati, l’eccessivo apporto di calcio, alcune fibre e i polifenoli del vino rosso. Basta quindi utilizzare il buon senso e seguire un’alimentazione equilibrata considerando che buone fonti proteiche vegetali tendono ad essere ricche di ferro, ma anche cavoli, uvetta e cereali per la colazione, fortificati.
Mezzo pompelmo e cereali conditi con uvetta e semi di lino macinati al momento, un curry di ceci e pepe, oppure tofu e broccoli saltati in padella sono ottimi pasti bilanciati con adeguati livelli di ferro.
Il nostro corpo è costituito da acqua per circa il 60% ed è quindi fondamentale assicurarsi una buona idratazione prima dell’esercizio fisico e durante tutto il giorno.
Se ci si allena per più di un’ora con notevole sudorazione, una bevanda o acqua contenente elettroliti ci aiuterà a mantenerci idratati, perché anche i muscoli necessitano di acqua!
Una dieta varia e bilanciata che includa molti alimenti minimamente trasformati ci dona equilibro.
Cibi amidacei e ricchi di fibre, cinque porzioni di frutta e verdura, fonti ricche di grassi omega-3, come noci o semi di lino macinati, ci aiutano nelle performance fisiche e mentali.
È essenziale integrare la vitamina B12 da un integratore e con l’aiuto di alimenti fortificati. Ci sono tanti altri integratori da considerare utili, ma in realtà non sempre sono necessari, poiché molti elementi sono a disposizione se si segue un’alimentazione equilibrata.

Il fabbisogno di selenio lo possiamo assumere con sole due noci del Brasile, lo iodio basta introdurlo utilizzando il sale iodato, etc...
L’integrazione di vitamina D è raccomandata ai vegani così come agli onnivori seguendo le linee guida e le indicazioni del proprio medico.
a cura di antonietta Mazzeo tecnico ed esperto degli oli d’oliva vergini ed extravergini

“...Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno dell’attenzione...”
(Franco Arminio da Cedi la Strada agli Alberi, Chiarelettere 2017)
Il progetto Olionostrum, “Biodiversità e Innovazione per un Olio Extravergine di Oliva di qualità” , nasce dalla volontà del Comune di Bucine di tutelare la biodiversità olivicola della Valdambra valorizzando l’intera filiera: dalla coltivazione alla raccolta, ai sistemi di frangitura fino alla conservazione del prodotto attraverso corsi di degustazione e di formazione con visite aziendali. Nato a febbraio 2019, il progetto, di cui il Comune di Bucine è il capofila del Gruppo Operativo, con il sostegno e la condivisione di alcune aziende del territorio, ha nel tempo sviluppato azioni mirate ad un concreto sviluppo del settore olivicolo della Valdambra finalizzate alla produzione di un eccellente olio di qualità, attraverso la definizione di un preciso disciplinare di produzione.
Olionostrum , come ricorda il nome, è frutto di un grande lavoro di squadra e ha costituito una scelta fondamentale per la sostenibilità dell’olivicoltura della Valdambra, attivando un processo virtuoso mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Tutelare e salvaguardare la straordinaria biodiversità olivicola della Valdambra anche attraverso la caratterizzazione genetica del patrimonio olivicolo ;
• Ottenere un Olio Extravergine di Oliva di elevata qualità utilizzando tecniche di estrazione innovative esaltando le caratteristiche degli olivi autoctoni di Bucine della Valdambra;
• Definire tecniche di produzione attraverso protocolli operativi e l’elaborazione di un disciplinare di produzione ;
• Formare olivicoltori e frantoiani specializzati in grado di assicurare la qualità, la sicurezza del prodotto e di controllare l’intera filiera produttiva;
• Mantenere il paesaggio olivicolo del territorio di Bucine della Valdambra.
Numerose le azioni attivate per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del progetto, in termini di divulgazione, partenariato, visite in azienda, caratterizzazione dei genomi autoctoni, definizione di protocolli operativi, formazione per la realizzazione di un frantoio prototipale .
Il rilevante finanziamento stanziato dalla Regione Toscana con i fondi PSR 2014-2020, al comune di Bucine, alle aziende agricole Bianconi Sara e Villa a Sesta, all’ Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Agraria e all’ANCI Toscana, ha consentito di realizzare un prototipo di frantoio dotato di una tecnologia di estrazione innovativa per accrescere la professionalità degli operatori, la qualità dell’olio e la redditività dell’olivicoltura in Valdambra.
La Valdambra è caratterizzata da uno straordinario patrimonio di biodiversità di olivi: nel territorio del Comune di Buci-
degli antichi patriarchi vegetali che prevede anche un itinerario di visita che si snoda fra campagna e castelli.
I fenotipi sono conservati e studiati nell’impianto di collezione di germoplasma realizzato dal Comune di Bucine in collaborazione con il CNR-IBE di Firenze e l’Azienda Agricola Villa a Sesta, per rilevarne i dati morfologici e bioagronomici necessari alla descrizione e all’iscrizione delle nuove cultivar autoctone della Valdambra ai repertori dell’olivo della Regione Toscana.
I dati agronomici di campo come la precocità di entrata in produzione, l’entità delle produzioni, la tendenza all’alternanza e la tolleranza agli stress biotici e abiotici vengono attentamente valutati nel corso degli anni.
I campioni in assaggio hanno confermato un cammino sulla strada della qualità certa.
ne i tecnici del CNR-IBE hanno individuato oltre 40 fenotipi , (varietà diverse tra loro anche geneticamente) esclusivi della Valdambra, tra cui l’ Olivone di Montebenichi , una pianta di olivo molto antica, probabilmente vecchia di oltre 300 anni , che ha superato indenne gelo, siccità e tutte le possibili avversità climatiche di una località collinare a 450 metri di altezza.
La pianta presenta caratteristiche morfologiche diverse rispetto alle più comuni varietà di olivo toscano e rappresenta anche l’unico esemplare di una varietà finora sconosciuta. Il comune di Bucine ha inserito l’Olivone nell’elenco degli “Alberi della Memoria” , progetto di protezione e promozione

Sono otto i temi di formazione specifica per gli olivicoltori, non solo della Valdambra, che con un linguaggio appropriato e l’uso di schemi e illustrazioni spiegano l’innovazione del processo dalla raccolta delle olive al frantoio, l’olio come cibo salutare per l’alimentazione, la sua composizione chimica, fino ad una serie di indicazioni pratiche da non trascurare mai per ottenere il miglior olio possibile.


Olionostrum è un marchio registrato dal Comune di Bucine. Attualmente in commercio non è possibile acquistare Olio Extravergine di Oliva con il marchio Olionostrum: le uniche bottiglie sono distribuite dal Comune di Bucine ad uso esclusivamente promozionale.

C ’ era una volta un re spodestato, lontan dal suo regno fu esiliato, in un palazzo dorato fu confinato a viver da nobile senza ducato. Il re si sentì così disperato che chiese un dolce per esser consolato. Lo chef di palazzo, suo amico fidato, un dolce un po’ secco gli portò trafelato. Ma son senza denti! - gridò il re stufato - inzuppalo un po’ che lo mangio ammollato. Di spezie e liquori il dolce fu bagnato e fu così che nacque il Babà prelibato.
No, non è una favola per bambini, ma sono i fatti storici (e un po’ di leggenda) che hanno portato alla nascita di uno dei dolci più popolari e goduriosi della pasticceria napoletana: il Babà. Se nell’immaginario collettivo il Babà è legato anima e cuore alla città di Napoli e ai napoletani viene attribuita in tutto il mondo la sua creazione, non è all’ombra del Vesuvio né per mano di un napoletano che questo dolce ha avuto i suoi natali.

Le sue origini, raccontate da Flavia Amabile nel suo libro “Si nu’ babbà”, sembrano siano attribuibili al re polacco Stanislao Lezsczinski, due volte detronizzato e mandato in esilio nel nord della Francia, precisamente nella cittadina di Luneville. Avendo parentele importanti (Stanislao era il suocero di Luigi XV di Francia, avendo questi sposato sua figlia Maria) ebbe come buona uscita il Ducato di Lorena (un ducato privato che non aveva peso politico).
Durante il suo esilio Re Stanislao si circondò di cuochi ed essendo molto goloso e appassionato di gastronomia, sperimentò egli stesso alcune ricette, tra cui quel-
 a cura di Marcella Orsi
Pasticciera Freelance
a cura di Marcella Orsi
Pasticciera Freelance
la del Babà, l’unica cosa della sua vita che lo avrebbe reso celebre.
Si narra che un giorno il re fosse particolarmente giù di morale e che chiedesse di poter mangiare un dolce per rallegrare i suoi umori.
I cuochi di palazzo gli portarono una fetta di kugelhopf, un dolce tradizionale austriaco molto in voga in Europa a quei tempi.
Il dolce, caratterizzato da un impasto poco “condito” di grasso, diventava piuttosto secco dopo pochissimi giorni. Il re, che aveva difficoltà di masticazione perché gli mancavano molti denti, andò su tutte le furie e chiese del vino per poter ammorbidire quel dolce e riuscire a mangiarlo.
Il vino che gli fu portato era il Madeira, e quell’aroma liquoroso, unito al sapore del dolce, ispirò particolarmente Stanislao, al punto che egli stesso si mise a sperimentare ricette e impasti per migliorarlo: la forma diventò a semicupola (per ricordare la cupola di Santa Sofia di Costantinopoli), le lievitazioni diventarono 3 e furono aggiunti uva passa, canditi e persino lo zafferano, che il re aveva conosciuto durante la sua prigionia ad Istanbul e la permanenza in Bessarabia, allora parte dell’Impero Ottomano.
Il dolce così creato fu chiamato da Stanislao Alì Babà , dedicandolo al protagonista de “Le mille e una notte”, tra le storie preferite da Stanislao che era anche un assiduo lettore, amante dell’arte e della cultura.
Questo incrocio di culture e di suggestioni portò Fabrizio Mangoni , autore de “La Fisiognomica del Cibo” e principale storico della pasticceria napoletana, a definire il Babà come “Dolce dei lumi”.
Ma siamo ancora molto lontani dal Babà napoletano e si dovrà passare per altre teste coronate e altri palazzi reali, prima di approdare alle falde del Vesuvio.
È l’inizio del Settecento quando la figlia di Stanislao, Maria Leszczynska, moglie del re di Francia Luigi XV, fa arrivare a Versailles il pasticcere polacco di suo padre, un certo Nicolas Stohrer (tra i più grandi pasticceri di tutti i tempi, inventore di alcuni dei dolci più celebri della pasticceria europea), a cui concederà la licenza per aprire la prima pasticceria privata in una città europea, al numero 52 di Rue Montorgue, dove Stohrer attuò i cambiamenti decisivi di quello che diventerà poi il moderno Babà e dove ancora oggi, allo stesso indirizzo, si possono gustare i suoi dolci.
In quegli anni alla corte francese impazzava la moda del rhum giamaicano e così Storher sostituì il Madeira col rhum, eliminò lo zafferano dall’impasto e cambiò la forma da cupola a fungo o cappello di cuoco, così come è conosciuta oggi e che caratterizza il tipico Babà napoletano.
Le modifiche ebbero un gran successo in una città alla moda e all’avanguardia come Parigi, ma pare che Stanislao non ne fu particolarmente entusiasta.
Qualche anno dopo, infatti, ne parlerà addirittura in una lettera indirizzata a Voltaire: “Ho diviso i giorni in ore e le ho riempite di emozioni, di cose degne di memoria, di cose fatte, ma anche di cose solo immaginate. Questo lasciamo di noi; anche l’Ali Babà. Non è cosa degna di un Re? Lasciamo questi pensieri ai cortigiani e agli intol-

Dosi per 1 Babà Savarin grande cm. 28 oppure 12 Babà monoporzione
Per la pasta Babà
g. 500 di farina 330 W
g. 40 di zucchero semolato
g. 200 di burro
g. 15 di lievito di birra fresco
g. 10 di sale fino
g. 550 di uova intere
Per la bagna al Rhum
g. 500 di acqua
g. 200 di zucchero semolato
g. 150 di Rhum a 70° volumi
g. 50 di miele d’acacia
scorza di 1 limone

scorza di 1 arancia
1 stecca di cannella
In una planetaria col gancio porre la farina, il lievito sbriciolato e metà delle uova e cominciare ad impastare. Appena cominceranno ad omogeneizzarsi gli ingredienti, aggiungere le restanti uova e continuare a lavorare a bassa velocità finché saranno inglobate.
Aggiungere, quindi, il burro morbido a tocchetti un po’ alla volta, il sale, lo zucchero e continuare ad impastare a media velocità finché l’impasto si incorderà.
Ungere uno stampo da Babà Savarin grande o 12 monoporzione, pirlare l’impasto e riempire gli stampi per circa 2/3 della loro capienza.

Mettere a lievitare a 28 °C per circa 90 minuti (dovranno raddoppiare il loro volume). Preriscaldare il forno a 220 °C; al momento di infornare abbassare la temperatura a 180-185 °C e cuocere il Babà Savarin per circa 25-30 minuti, i Babà monoporzione per circa 15 minuti. Una volta sfornati, lasciarli riposare (asciugare) per circa 12 ore.
Nel frattempo preparare la bagna portando a bollore acqua, miele e zucchero fino a quando quest’ultimo risulterà ben sciolto. Spegnere la fiamma, aggiungere le scorze degli agrumi e il Rhum e lasciar intiepidire.
Trascorse le 12 ore, portare la bagna a 60 °C e immergervi i Babà finché la bagna non farà più le bolle e i Babà saranno omogeneamente inzuppati. Trasferire su una griglia a scolare l’eccesso di bagna.
Lucidare i Babà con gelatina neutra o gelatina di albicocca e procedere alla decorazione con panna, crema, frutta o lasciarli al naturale.

leranti; a chi pensa di dedicare la vita alla carriera, a chi se l’accorcia al servizio di cose che credono di dominare e di cui sono solo le dileggiate e luccicanti vittime. A me invece ricorderà la luna turca della notte di Costantinopoli, mi porterà il sapore dell’amicizia col Re di Svezia, e i canditi riproporranno l’eleganza e la preziosità dei vostri ragionamenti [...] Lo scorso mese mi hanno presentato un Babà, così lo chiamano ora, talmente inzuppato di liquore che gli ho dato fuoco. Perde di leggerezza e di memoria”.
Arriviamo agli inizi dell’Ottocento e il Babà cambia ancora. Stavolta per mano di Anthelme Brillant-Savarin , uno dei più grandi gastronomi e autore della “Fisiologia del Gusto”, una vera e propria Bibbia della gastronomia di tutti i tempi. La versione di Brillant-Savarin elimina dall’impasto l’uvetta e aggiunge il burro che ne conferisce aromaticità e morbidezza, lo spennella con una gelatina di albicocche per preservarne l’umidità e soprattutto gli dà la forma di grande ciambella per poterlo farcire al centro con crema chantilly e frutta.

Questa nuova versione a forma di ciambella/torta, tuttora molto frequente sia nelle pasticcerie francesi che napoletane, prenderà il nome di Babà Savarin , o semplicemente Savarin (in onore del suo ideatore) e che si differenzierà dal classico Babà monoporzione a forma di fungo, che resterà semplice senza farcitura (almeno fino ai giorni nostri).
CI
IL DOLCE ICONA DELLA SUA CULTURA GASTRONOMICA?
Di mezzo ci sono sempre dei reali, ma in questo caso delle Regine. Il successore di Luigi XV era Luigi XVI, lo sfortunato re ghigliottinato durante la Rivoluzione francese, sposato con la famosa Regina Maria Antonietta, icona di moda e di stile, presa ad esempio da tutte le nobildonne e teste coronate d’Europa.
Maria Antonietta aveva una sorella, Maria Carolina d’Austria, che aveva sposato il Re di Napoli Ferdinando IV di Borbone. Tra le due regine sorelle maturò una sorta di rivalità, in realtà più sentita da Maria Carolina che da Maria Antonietta, coltivata nel tempo con la spedizione continua di emissari napoletani alla corte di Francia per scoprire le ultime tendenze in fatto di moda e gastronomia.
È di questo periodo, infatti, la tradizione dei monsù, i cuochi francesi che prestavano servizio nelle case aristocratiche dei nobili napoletani e che diedero il via a quel favoloso meticciato gastronomico fra la tradizione napoletana e la cucina francese, che si può riconoscere nella nascita di alcuni tra i più famosi piatti della cucina napoletana, come il gattò di patate (dal gateau francese), la pasta al gratin con l’uso della besciamella, gli sciù (dolci tipici di pasta choux di forma allungata simili agli eclair francesi), per finire col re della pasticceria napoletana, il Babà.
È a Napoli che il Babà consacra la sua forma a fungo, la bagna al rhum decisamente alcolica viene miscelata sapientemente dai cuochi napoletani con uno sciroppo aromatico di acqua, zucchero e scorze di agrumi, la gelatina di albicocche lascia il posto ad una gelatina neutra e diventa il precursore del concetto di street food, dato che verrà degustato dai nobili passeggiando per le vie della città.
Se il Babà moderno nasce a Parigi, dunque, è a Napoli che rinasce e che segna in maniera decisiva la storia di un dolce che deve la sua popolarità proprio alla tradizione partenopea, che ne fa talmente un figlio della sua cultura, da cambiarne persino il nome da Babà in Babbà , con due b, ma pronunciate morbide e con la inimitabile musicalità del dialetto napoletano, ad indicare la rotondità e l’armoniosità raggiunta nella sua versione definitiva e ufficiale. Versione attestata già nel 1836 nel primo manuale di cucina italiana scritto da Vincenzo Agnoletti per Maria Luigia di Parma, in cui il babbà appare come “dolce tipico napoletano”.
A Napoli, poi, il Babà ha visto infinite versioni, dalla bagna al limoncello, al liquore strega, all’impasto al cioccolato, al caffè, con crema pasticcera e amarene, con panna e frutta fresca, con chantilly e fragoline di bosco, in versione torta, versione mignon, a forma di Vesuvio (Scaturchio docet), versione da passeggio con la sua vaschettina che funge da bicchiere dal quale bere il rhum avanzato.
Insomma, possiamo affermare senza indugi che un dolce nato da un Re è diventato il Re della pasticceria napoletana prima, e italiana poi. Chissà se la versione napoletana del Babà sarebbe piaciuta al caro Stanislao... a me piace pensare che le note agrumate aggiunte dai napoletani avrebbero fatto breccia nel suo cuore ammaliato dai profumi e dai ricordi dell’esperienza turca.
Come gli italiani scoprono i propri ristoranti preferiti? È una domanda solo all’apparenza banale, in realtà molto importante, perché letta in un altro modo potrebbe essere interpretata così: “quali sono i canali di acquisizione clienti più efficaci per chi ha un ristorante, una pizzeria o un’osteria?”
Per scoprirlo prendiamo in prestito i dati gentilmente forniti da Plateform all’interno dell’ultima edizione del Rapporto Osservatorio Ristorazione, dal quale divulghiamo i dati che seguiranno. Ma prima, una breve nota metodologica per sottolineare quanti i dati siano attendibili e veritieri. I dati che seguono sono attendibili per due ragioni:

1. l campione analizzato è vastissimo. Le ricerche che seguono hanno come campione 564.031 sondaggi inviati e 103.848 risposte ricevute, coprono più di 1.000 installazioni in tutta l’area italiana, isole comprese.
2. Non sono stati effettuati sondaggi sulle intenzioni, ma sulle effettive azioni compiute. Infatti abbiamo domandato a più di 500 mila italiani «Come ci hai scoperto?» effettuando la domanda “post-stay”, quindi dopo che il cliente aveva lasciato il ristorante.
a cura di Lorenzo Ferrari direttore Marketing di ristoratoretop COME GLI ITALIANI SCOPRONO IL RISTORANTE 2021Queste risposte sono importantissime perché ci permettono di scoprire quali sono i canali di acquisizione clienti più efficaci quando si tratta di scoprire nuove attività ristorative.
Questi i risultati:
In un’Italia sempre più diffidente, cattiva e cinica (lo dice il CENSIS nel suo annuale rapporto) il passaparola si conferma il canale di scoperta principale di imprese ristorative. Non ci stupisce: la sua imparzialità è il segreto del suo successo e della sua longevità. Sono infatti 46,13 su 100 - quasi 1 su 2 - i clienti che hanno scoperto il ristorante grazie al passaparola di amici, colleghi e famigliari.
Erano 48,5 su 100 due anni prima, nel 2019.
oggi sono quasi 15 (14,85, +44%) i clienti che scoprono locali grazie al motore di ricerca più famoso al mondo e solo 11 (10,97, -16%) quelli che lo fanno grazie a Tripadvisor.
È la prima volta nella storia che avviene il sorpasso, ma non stupisce nessuno, era solo questione di tempo.
Google, Tripadvisor, Instagram e Facebook, se presi nella totalità, fanno scoprire nuovi ristoranti a 4 italiani su 10. Il 40,72% degli italiani, infatti, ha scoperto il locale grazie alle piattaforme online.
Erano 37,9 solamente due anni prima, a conferma del fatto che la pandemia ha accelerato l’approccio e la confidenza con i nuovi media.
Se si parla di portali di recensione, nel 2019 Tripadvisor faceva scoprire a 13,1 clienti su 100 il ristorante, contro i 10,3 che lo facevano grazie a Google.
Nel 2021 il risultato è invertito: Google sorpassa Tripadvisor:
I Social Media si confermano canali fondamentali quando si tratta di scoprire nuovi luoghi dove mangiare, bere e divertirsi, ma non «dominanti» come si potrebbe erroneamente pensare.
Seppur di pochissimi punti percentuali, Instagram risulta un mezzo più efficace per acquisire clienti rispetto a Facebook: sono 7,76 i clienti su 100 che hanno scoperto il locale grazie ad Instagram, contro i 7,14 che lo hanno fatto grazie a Facebook.
13 clienti su 100 scoprono il locale dove pranzare, cenare o fare un aperitivo grazie ad essa, «passandoci» davanti. Il risultato non cambia dal 2019. La location è ancora importantissima nel Processo di Scelta del proprio ristorante preferito.
1 CLIENTE SU 2 HA SCOPERTO IL RISTORANTE GRAZIE AL PASSAPAROLA 4 CLIENTI SU 10 SCOPRONO NUOVI RISTORANTI ONLINEQuante volte ci è capitato di andare al supermercato e di comprare prodotti biologici?
Ma siamo sicuri di sapere effettivamente in cosa consiste tale sistema produttivo?
Bisogna parlare infatti di sistema di produzione, specificatamente di metodo di produzione biologico, e non di prodotto biologico.
Non esiste infatti un marker che consenta di distinguere un pomodoro biologico da uno coltivato in maniera convenzionale ed è per questo che la disciplina di tale settore tratta del metodo di produzione e non del prodotto biologico . È quindi un sistema di processo e non di prodotto.
La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali, con norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali (considerando (1) Reg. (UE) 2018/848).
In effetti il numero di consumatori che fa uso di prodotti biologici è in forte crescita. Nel 2022 almeno l’89% delle famiglie italiane ha acquistato biologico , sei italiani su dieci consumano prodotti bio anche fuori casa e la crisi non sembra avere influenzato le scelte alimentari degli italiani. L’Italia è leader in Europea per superfici dedicate alla coltivazione biologica e per numero di operatori e la performance di export; rispetto al 2021 è cresciuto del 16%, con 3,4 miliardi di euro (fonte Nomisma).
Numeri quindi importanti che fanno comprendere che il consumatore è attento alle proprie scelte alimentari e che la produzione biologica è, nell’attualità, molto apprezzata.
La produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell’Unione, insieme alle indicazioni geografiche (DOP-IGP) e alle specialità tradizionali garantite (STG).
È opportuno evidenziare che non esiste una definizione giuridica di qualità, ragione per cui in dottrina ci si è interrogati se la produzione di determinati alimenti a DOP o IGP, per esempio, possa considerarsi effettivamente di qualità se si considera lo sfruttamento intensivo del suolo o l’inquinamento delle falde acquifere o, ancora, la produzione massiccia di deiezioni animali.
 a cura di avv. Lucio SaLzano SpeciaLiSta di diritto aLimentare e
a cura di avv. Lucio SaLzano SpeciaLiSta di diritto aLimentare e
Certamente la produzione biologica, rispetto a quelle a DOP e IGP, incontra limiti più stringenti rispetto all’utilizzo di determinate sostanze considerate inquinanti; tuttavia v’è da evidenziare un dato tecnico-giuridico noto e che pare che il legislatore voglia continuare ad ignorare.
Il sistema legislativo italiano, invero non solo in materia di produzione biologica, è caratterizzato dall’opinabile scelta di disciplinare attraverso una nutrita serie di fonti sub-legislative, decreti ministeriali o direttoriali che, di volta in volta, hanno dato attuazione a normative e raccomandazioni provenienti dalle istituzioni europee.
Nello specifico e per il caso che ci interessa, si fa riferimento al D.M. n. 15962/2013 e alla allegata tabella delle non conformità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori.
In sostanza, la tabella prevede ipotesi sanzionatorie da applicarsi agli operatori del settore biologico qualora violino i principi enunciati dal Regolamento (UE) n. 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
Diverse sono le problematiche che riguardano tale apparato sanzionatorio ma, per l’aspetto che qui interessa, è opportuno menzionare la lacunosità delle previsioni sanzionatorie della suddetta tabella.
In altre parole, non tutti i principi relativi alla produzione biologica, che sono espressi nel regolamento comunitario e che tutti gli operatori devono rispettare per potere commercializzare i propri prodotti con il marchio relativo alla certificazione biologica, vengono tutelati dal legislatore italiano. Questo in quanto non sono state previste le sanzioni.
Ciò comporta, per gli operatori assoggettati al sistema di controllo e per gli organismi di controllo, incertezza rispettivamente al precetto da rispettare ed alla relativa sanzione da applicarsi nel caso di violazione della normativa unionale.
Tale lacuna normativa italiana, se portata all’attenzione del consumatore, evidenzia fragilità di non poco conto del sistema di controlli relativi alla produzione biologica e potrebbe minare la fiducia del consumatore con conseguente perdite economiche rilevanti per le imprese nostrane.
Per una più precisa e completa disamina della questione si segnala che è in corso di pubblicazione l’elaborato dell’avvocato Lucio Salzano sul prossimo numero della Rivista di Diritto Agrario edita da Editoriale Scientifica .

Sovente mi capita, alla radio - che seguo più della TV - di ascoltare notizie o interpretazioni di fatti che non condivido, ma quasi sempre mi adeguo al principio che ognuno abbia il diritto di esprimere il proprio pensiero.
Questa volta però il mio spirito si ribella in maniera incontenibile al sentire che un professore universitario, tale Alberto Grandi , ha scritto un libro dal titolo “Denominazione d’origine inventata”, dove demolisce le caratteristiche identitarie della cucina e in parte dei nostri prodotti alimentari.
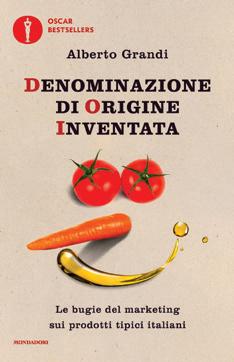
L’autore di questa pubblicazione così provocatoria avrà pensato di vendere un mucchio di libri proprio per lo “scandalo” provocato, io non voglio dargli la soddisfazione d’incassare impunemente i miei 18 euro e ho cercato informazioni per entrare nel merito delle sue affermazioni.
Il prof. Grandi sostiene la falsità di molte leggende riguardanti le nostre cucine regionali, nate dai prodotti del territorio, suggerendo che siano state le aziende produttrici a inventare uno storytelling che ha fatto presa sul pubblico, con ottimi risultati dal punto di vista commerciale ma, secondo lui, ingiustificato se si scava nella realtà dei fatti.
Voglio rimarcare che, anche ammettendo che in qualche caso questo possa essere parzialmente vero, nessuno storytelling
sarà mai sufficiente a creare un successo come quello della nostra cucina senza le adeguate qualità di base. Secondo Grandi la vera Cucina con la C maiuscola sarebbe quella francese, ma ci sono due fatti incontrovertibili che smentiscono questa affermazione. Parto dal secondo assunto che è, fatto innegabile, il grande successo della Cucina Italiana nel Mondo.
Grandi sostiene che, nel passato, in tutti i Paesi mediterranei si usassero dischi di pasta con qualcosa sopra e che quindi la leggenda della pizza italiana o napoletana non avrebbe alcun senso, ma allora a quale allucinazione globale si deve il fatto che ormai in tutto il mondo la pizza sia considerata italiana? Un amico, per motivi di lavoro con la moglie nella grande piazza di Berlino, trovò sul menù del ristorante prescelto anche la pizza, che fu ordinata per curiosità. Una volta gustata la pizza di buona qualità, chiesero al cameriere chi la facesse: forse un italiano? Fu così che scoprirono che le pizze arrivavano surgelate dall’Italia.
Chi abita, come il sottoscritto, in zone di frontiera, come mai può vedere ogni giorno arrivare a Ventimiglia o Sanremo frotte di francesi che si riforniscono di alimentari, salumi e formaggi in primis?
Perché sulla nostra costa non c’è più neppure un ristorante francese, mentre sulla bellissima Costa Azzurra c’è un gran numero di locali italiani?
di Mauro MarelliOra il primo punto, che sgretola dalle fondamenta la teoria del nostro autore. Ha infatti dimenticato, il nostro grande Grandi, il trascurabile episodio del matrimonio della nostra Caterina de’ Medici col Re di Francia Enrico II d’Orleans e successivamente il fatto che sia diventata madre di altri tre Re di Francia.
Trasferitasi alla Corte francese, Caterina non trovò di suo gusto la cucina della reggia e presto fece arrivare i suoi cuochi dall’Italia, toscani e siculi, introducendo in Francia prodotti e ricette di nostra provenienza; introdusse così oltralpe prodotti colà non in uso come cardo, scalogno, zucchine, sedano, funghi, fave e cipolle, oltre ai suoi prediletti carciofi cotti nel vino. Introdusse nella cucina francese anche la “salsa colla”, poi béchamelle, e altre ricette che hanno fatto grande la cucina francese quali macarons, omelette, crepes, bigné e zuppa di cipolle, per non parlare di tante specialità come i sorbetti di frutta, lo zabaione e altre specialità di cui i francesi s’impadronirono.
Sono bravi i francesi ad appropriarsi dei prodotti e delle ricette altrui vantandoli quindi come autoctoni; noi in questo siamo stati molto meno bravi, e comunque saremo sempre in ritardo rispetto ai nostri confinanti, sui quali stiamo comunque recuperando con la qualità.
Una piccola curiosità riguarda anche un elemento che fu sempre la nostra Caterina a introdurre sulle tavole di Versailles, ossia la forchetta: prima che lei la esportasse, i franchi si servivano delle tre dita principali della mano per assumere cibo.
Tanti possono essere gli esempi relativi ai nostri primati, sia autoctoni che mutuati da contaminazioni alloctone.
Un esempio su tutti è quello del Parmigiano: come mai si tenta di copiarlo e riprodurlo, tanto che troviamo nel mondo ampia offerta di falsi “Parmesan”?
Il Grandi sostiene che nel lontano Wisconsin esiste un formaggio molto simile a quello a suo tempo creato dai monaci emiliani.
Perché allora lo chiamerebbero Parmesan se non avessero bisogno di aggrapparsi a un riferimento italiano che fa da richiamo nel mondo?
Certo lo stoccafisso, arrivatoci dalle isole Lofoten per merito del navigatore veneziano Pietro Querini, è oggi piatto nazionale in Portogallo, oltre che specialità delle nostre cucine, in particolare campana, marchigiana, ligure e veneta, e allora? Dovremmo forse dare il merito alla Norvegia delle nostre ricette tipiche?
La ricca cucina sicula mostra evidenti influenze mediorientali, spagnole e addirittura normanne, frutto di storiche dominazioni: questi fattori ne hanno modificato usi ed abitudini anche a tavola, integrandosi con la cultura locale e diventandone caratteristiche identitarie.
Interessante, inoltre, la tesi per cui sarebbe assurdo attribuire alla Sicilia il merito di aver “inventato” il vino Marsala.
In effetti la sua storia è suggestiva: nella seconda metà del 18° secolo l’Inghilterra si trovò, per merito delle guerre napoleoniche, a corto dei vini portoghesi e spagnoli che là si consumavano, il Porto in particolare.
Per cercare rimedio il mercante John Woodhouse navigò verso la Sicilia e fu costretto da eventi temporaleschi ad attraccare al porto di Marsala; qui ebbe occasione di assaggiare un ottimo vino e ne approfittò per farne una grossa scorta, a cui aggiunse anche alcol per aver certezza della conservazione durante il viaggio.
Arrivato in Inghilterra il vino, grazie all’alcol e al periodo della navigazione, aveva assunto caratteristiche ancora migliori di quelle già apprezzate, da qui nacque la fama del Marsala, tanto che ancora esiste il Marsala Woodhouse, eppure le vigne sono quelle, siciliane, altrimenti perché non si fanno il Marsala in Inghilterra?
Perché svilire le virtù e cercar di immiserire la fama dei nostri prodotti?
I prodotti, direi mai, hanno una storia così lineare come pretenderebbe il Grandi; secondo la legge dei grandi numeri e certo anche per altre vicissitudini legate a migrazioni, guerre di conquista, sconvolgimenti sociali di vario genere, nel tempo accadono le cose più strane, le combinazioni più inverosimili; molti grandi prodotti, per non parlare di geniali invenzioni, hanno genesi spesso imprevedibili, ma non per questo si può metterne in discussione il radicamento storico che ne giustifica la denominazione d’origine.
In Italia, con venti regioni, abbiamo praticamente venti Cucine e una miriade di “sottocucine” territoriali o anche solo zonali che derivano dalle tradizioni e dalle caratteristiche del territorio: queste sono cose che si trascinano da secoli e che hanno contribuito alla creazione consolidata di un certo tipo di cultura enogastronomica nazionale.
Alberto Grandi vuole strapparci il tappeto da sotto i piedi, ma credo non ci trovi disponibili a disconoscere il valore storico del nostro patrimonio di prodotti, ricette, cucine territoriali, che dovremmo imparare a difendere da attacchi ingenerosi e ingiustificati.
c/o CarraraFiere
L’appuntamento che nel panorama delle mostre italiane è riconosciuto come uno dei più importanti momenti di incontro e confronto del settore

Giunto alla sua 43esima edizione, si presenterà forte dei numeri riacquistati dopo lo stop forzato della pandemia. Nei padiglioni di Carrara Fiere sono attesi infatti 400 espositori in rappresentanza di oltre 900 marchi commerciali; oltre alle migliaia di operatori del settore (tra ristoratori, operatori di bar e strutture ricettive di vario genere) in fiera anche per il ricco programma di contenuti.
Come sempre il cuore della manifestazione, anche segreto del suo ripetuto successo, è l’incontro qualificato e diretto fra domanda e offerta: uno scambio commerciale che crea importanti giri d’affari per gli operatori del centro e nord Italia.
A caratterizzare anche questa edizione dell’evento, grandi marchi del food&beverage italiano ed estero propongono non soltanto la semplice esposizione delle novità e dei prodotti di punta, ma anche presentazioni e momenti di approfondimento.

Dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria.



Un’intera area è dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti. Inoltre è esposto tutto ciò che riguarda le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria fino all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno.
Ormai da qualche anno hanno preso sempre più piede operatori del settore wine and beverage, che qui trovano i migliori prodotti per il lavoro dei mixologist e dei barman, rappresentati dalle principali associazioni di categoria, passando per tutto il settore emergente delle birre artigianali.
Presente un’ampia selezione poi di aziende vitivinicole, ma anche distillerie, rappresentate direttamente dai produttori.
In 42 anni Tirreno C.T. è stata il punto di partenza di centinaia di progetti, migliaia di incontri professionali; uno strumento che - lo dicono i tanti espositori che nel tempo continuano a dare fiducia alla manifestazione fieristica - ha saputo contribuire alla crescita dell’ospitalità italiana.
Un fiore all’occhiello per l’economia del nostro Paese.
Che apparecchiatura e mise en place facciano nettamente la differenza in fatto di stile e identità del locale, è un fatto assodato: ogni ristorante è esattamente lo specchio di come si presenta.
Ma arredi e strumentazioni specifiche servono anche a meglio espletare il servizio al tavolo, per meglio connotare i propri tratti distintivi davanti al cliente, dimostrandogli maggiore attenzione e cura.
Proprio questo tema è stato affrontato al San Domenico di Imola nel corso dell’evento “The Art Of Presentation” organizzato dalla Steelite in collaborazione con Rona , JRE Italia , FSG Italia che distribuisce questi prodotti sul territorio nazionale.

La cena di gran livello preparata dallo staff di Massimiliano Mascia aveva come obiettivo quello di creare un percorso enogastronomico, valorizzando l’esperienza con strumenti di forme, materiali e decori diversi.


Dai calici soffiati a bocca ai piatti in stoneware, al vetro riciclato, alla porcellana vetrificata, fino alla bone china luxury con decori e forme sviluppate apposta per il recentissimo rinnovamento del San Domenico - ora dotato di spettacolari cucine sostenibili che si sviluppano su 350 metri quadri, adiacenti una raffinata sala a vista con chef table per 6 persone - si è sviluppato un gioco fatto con la volontà di fare cultura sugli strumenti e sulla loro manifattura.
Da qui una carta creata per l’occasione contenente non solo l’elencazione dei piatti e dei vini abbinati pregevolmente da Francesco Cioria , ma anche quella dei materiali utilizzati.

In questa parte di Puglia, un tempo Granaio d’Italia, a Borgo Tressanti in Capitanata, si estende un piccolo gioiello: cento ettari di natura incontaminata dove si pratica l’Agricoltura Biofilica, si coltivano grano, olivi e ortaggi. Qui si possono scoprire luoghi segreti che affondano le radici molto lontano: stiamo parlando di Spirito Contadino che oggi caratterizza questo luogo a cui si è ridata splendida vita recuperando una storia nobile e contadina.
Concept e foto: Sergio Supino Testi : Sonia LeoLei è Damiana fondatrice dell’azienda, ritratta in questa foto con la sua più stretta collaboratrice Antonietta, entrambe sono testimoni di un paesaggio rimasto naturale che ha conservato la sua integrità così da mostrarsi oggi simile al passato, con usi e costumi che si tramandano di padre in figlio, nel solco di una memoria storica indelebile. Sin dagli albori con creatività e maestria hanno sviluppato il concetto di circolarità, una filiera corta, anzi cortissima, dove tutti i prodotti utilizzati provengono dai loro campi per

farli apprezzare alle cucine più esclusive. È la voglia di ritornare alle origini, ai sapori e agli odori della propria infanzia. È sul Tavoliere delle Puglie, tra le infinite distese dorate di grano, ondeggiano sia le spighe che i sogni di Damiana, che da sempre ha fatto della coltivazione dei grani antichi e dell’agricoltura una ragione di vita. È cresciuta con i racconti dei nonni, che per anni le hanno parlato di quei cereali trasmettendole un amore per la terra che piano piano l’ha trasformata in una contadina appassionata.
 Damiana, CUSTODE DI SAGGEZZA Antonietta, COLLABORATRICE
Damiana, CUSTODE DI SAGGEZZA Antonietta, COLLABORATRICE
Ai suoi sogni ha dato concretezza, così sin da ragazzina ha creduto di poter fondare la sua attività, la sua azienda, coinvolgendo prima suo marito Guido e poi successivamente i suoi figli, Antonio e Donato, custodi della terra. Inizialmente si è occupata personalmente di tutto, dalla semina al raccolto, assecondando la natura, lasciando che i frutti dell’orto maturassero alla luce del sole, senza forzature. La riscoperta e la valorizzazione dei cosiddetti grani antichi e del -
le verdure scomparse, l’importanza del recupero assume un grande valore per Spirito Contadino sia a livello culturale che storico, per far conoscere alle generazioni future le tradizioni fortemente legate all’identità del territorio e scoprire più da vicino sapori di cui per molto tempo si erano perse le tracce. Ciò che la ispira ancora oggi a proseguire nel suo amorevole lavoro, è portare ogni giorno, nella vita di ognuno di noi, benessere e gioia del mangiare sano.


La preparazione della crosta di farina di grano, fatta con l’antica ricetta della nonna, è affidata proprio alle sapienti mani di Damiana, una lavorazione che dà vita a impasti che donano croccantezza alle verdure dell’orto. Ad ogni verdura o ortaggio la sua ricetta e così un velo di crosta accoglie e avvolge all’interno la freschezza ed il colore naturale, senza perdere le proprietà organolettiche e l’aromaticità. Un perfetto equilibrio, riconoscibilità e leggerezza, dove il gusto si stratifica e poi esplode, come quando si assaggiano le “Pomodorelle” oppure la “Borragine” che può essere interpretata con abbinamenti fantasiosi e sorprendenti. Ingredienti umili, sinceri resi ancor più preziosi dal segreto della semplicità di un tempo.

Il meglio per te, il buono per tutti
La varietà di combinazioni che è possibile creare con le nostre verdure è pressochè infinita, il vantaggio per gli Chef è di avere un concentrato di salute e freschezza da offrire ai propri ospiti in svariate forme gastronomiche. Richiedi il catalogo



Custodi di storia, emblema di recupero ambientale e di rinascita sociale e culturale. La nuova vita di borghi spopolati, castelli diroccati, terreni confiscati alla mafia, all’insegna del turismo sostenibile.
Il paesaggio si rende protagonista di grandi storie ed è dalla storia che si può attingere per riscoprire la bellezza e l’identità di luoghi che, dopo essere stati abbandonati, sono diventati il simbolo di un riscatto , di una rinascita ambientale, economica, sociale e turistica. Spazi rurali in preda allo spopolamento, castelli a rischio crollo, terreni industrializzati sottratti dalle mafie alla natura, paesi distrutti dal terremoto, tornano a vivere grazie a lungimiranti azioni di riqualificazione e di rigenerazione, divenendo luoghi di speciale accoglienza turistica , ma anche posti in cui abitare.
A Castel del Giudice (IS), in Molise, lo spopolamento tipico delle zone interne dell’Appennino stava compromettendo il futuro del territorio. Finché il Comune, con il sindaco Lino Gentile , chiamando a raccolta abitanti, imprenditori, istituzioni, persone legate al paese, ha dato il via ad una strategia di sviluppo sostenibile partecipata , che ha riacceso la

 Foto di Emanuele Scocchera
Foto di Emanuele Scocchera
speranza, trasformando la marginalità in un laboratorio di rinascita delle aree interne.
Dapprima la scuola in disuso divenuta RSA, poi il recupero di terreni abbandonati per dar vita ai meleti biologici Melise, dove oggi nel Giardino delle Mele Antiche si coltivano frutti dimenticati, poi la rigenerazione urbana di parte del paese, ristrutturando stalle e fienili per dare origine all’ albergo diffuso Borgotufi , totalmente integrato nel paesaggio (oggi un bellissimo borgo nel borgo con 2 ristoranti, un centro benessere e 32 case indipendenti con tutti i servizi di un hotel di livello) e tanti altri progetti, soprattutto legati all’agricoltura sostenibile, che hanno restituito significato a Castel del Giudice.

Borgotufi è fulcro di turismo esperienziale: da qui si parte per fare tour nei meleti con degustazioni nel birrificio agricolo, passeggiate poetico-rurali con il poeta contadino del paese tra asini e capre, escursioni tra boschi e montagne, attività di apicoltura, rafting e vacanze slow.
INFO: tel. 0865 946820 - www.borgotufi.it
È un viaggio nella storia quello che si vive a Borgo Campello , relais di Campello Alto (frazione di Campello sul Clitunno PG), da un passo da Spoleto e da Assisi. Il terremoto del 1997 ha distrutto parte del paese, che Vincenzo e Daniela Naschi , lasciandosi alle spalle la loro precedente vita, hanno recuperato per creare una struttura ricettiva che rispetta e valorizza l’identità del luogo.

Il relais si trova dove oggi risorge l’imponente Castello che domina tutta la valle di Spoleto e che ha dato il nome all’intero abitato, essendo nella zona più antica: conserva intatta la sua struttura medievale, grazie a vari interventi di restauro, mostrandosi come tra i più caratteristici dell’Umbria.

 Foto di Francesca Bocchia
Foto di Francesca Bocchia
C’è, inoltre, il Convento dei Santi Giovanni e Pietro, ristrutturato dal 2011, con opere pittoriche importanti legate al periodo medievale e rinascimentale.

Il Relais Borgo Campello è stato ricavato da palazzi trecenteschi, case torri e fortificazioni di pietra. Gli ospiti dimorano dove un tempo vivevano i nobili del Castello o nelle celle dei monaci del Convento.

Per rilassarsi c’è una Private SPA ricavata tra antiche mura. Intorno, distese di uliveti candidati a diventare Patrimonio UNESCO con tutta la fascia che va da Assisi a Spoleto. Ma anche boschi ricchi di tartufi pregiati, da scoprire a seguito di esperti tartufai, per poi assaporare i piatti del ristorante Sapori nel Borgo.
INFO: Tel. +39 328 5986170 - www.borgocampello.com
Il riscatto di un intero territorio si legge nella meraviglia che provano coloro che giungono a Laghi Nabi , prima Oasi Naturale della Campania, sul Litorale Domizio (CE).
Qui, a Castel Volturno, c’erano 150 ettari di cave di sabbia abusive che avevano devastato la zona ed erano alla base di nuovi fenomeni di erosione e di degrado di larghe fasce di costiera.
Bonificando e liberando l’area dai rifiuti, ripiantando alberi e con un enorme lavoro di riqualificazione ambientale , è sorto un luogo protetto dove la natura regna sovrana, gli uccelli acquatici si lasciano scrutare, e gli abitanti e i turisti giungono per vivere esperienze a contatto con l’acqua (tantissime le attività che si possono fare, dalla canoa al kitesurf, ma anche bici, escursioni, birdwatching, yoga) e con il prezioso ambiente circostante.
I laghi sono lo scenario di un complesso turistico ecosostenibile, con le tende e lodge galleggianti del glamping (che unisce la libertà del campeggio ai servizi di un hotel di lusso), fatte di architetture removibili e in una completa immersione nel paesaggio, la struttura ricettiva alberghiera nel verde, la Nabi Water SPA con piscina termale a sfioro sul
 Foto Petrucci
Foto Petrucci
lago a 35°, il Nabi Restaurant con i suoi prelibati piatti mediterranei. Orgoglio per Gino Pellegrino , uno dei proprietari di Laghi Nabi, che hanno voluto con coraggio e passione restituire alla natura e dare nuova vita agli spazi del Litorale Domizio un tempo abbandonati e maltrattati dal malaffare.

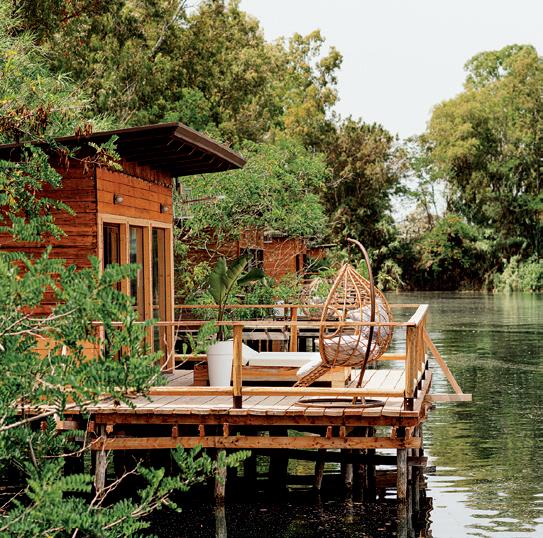
INFO: Tel. 0823 764044 - www.laghinabi.it


Prendersi cura del territorio è stata la chiave per la rinascita del Podere Millepioppi , a Salsomaggiore Terme (PR), nel cuore di Visit Emilia.
Questa vasta area agricola è stata confiscata alla mafia all’interno del Parco dello Stirone e del Piacenziano e da anni ospita campi di lavoro e di volontariato dell’associazione Libera, un centro di recupero per animali selvatici e di recente il MuMAB - Museo del Mare Antico e della Biodiversità con una sezione geopaleontologica allestita nell’edificio principale del podere e una sezione naturalistica ospitata nell’ex-stalla della casa colonica.
Visitando questo speciale museo, a poca distanza dalla splendida città termale, si scoprono i processi evolutivi che raccontano della Pianura Padana e dell’antico mare che qui sommergeva tutto. Ci sono fossili e reperti che contano ol -
tre 7 milioni di anni, canyon scavati dal torrente Stirone, coralli, conchiglie, denti di squalo, resti di balenottere. Questo territorio, da bene confiscato all’illegalità è luogo di storia e di turismo, al centro dei numerosi itinerari di Visit Emilia, la terra dello slow mix, per vivere esperienze autentiche tra natura, cultura ed enogastronomia.
INFO: www.visitemilia.com
nuovi progetti: si sta riqualificando anche il borgo adiacente il maniero, creando scuole-botteghe artigiane di alta formazione in quella che è stata inaugurata come Cascina Bassa , e un albergo diffuso che aprirà nel 2023. Si può ancora contribuire al restauro della vita del Castello e riscrivere la storia di un borgo recuperato e rifunzionalizzato: con la quota di 100 euro, si partecipa all’acquisto condiviso di Cascina Bassa e si vive una vacanza per 2 persone.
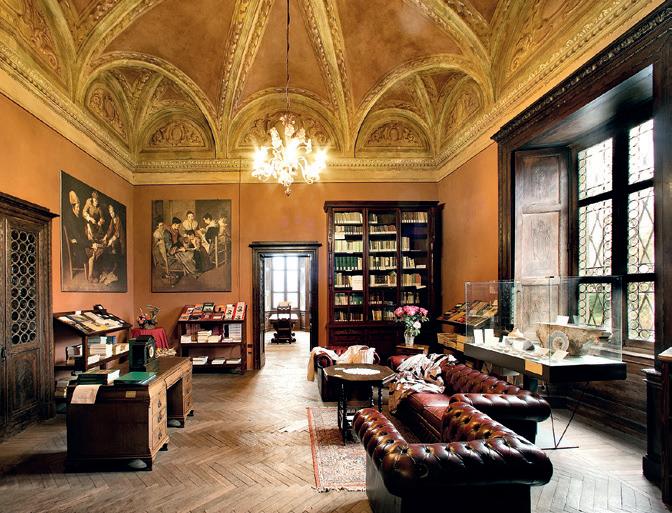

Dal 1965, quando è morto il Conte Salvadego, ultimo proprietario del Castello di Padernello , il maniero della Bassa Bresciana ha intrapreso il suo declino. Nel 2002, il crollo di parte delle cucine, fu il campanello d’allarme che richiamò la determinazione di un gruppo di abitanti e del sindaco di Borgo San Giacomo Giuseppe Lama di recuperare il castello e restituirlo alla comunità. Con Domenico Pedroni in prima linea - presidente della Fondazione Castello di Padernello - e la collaborazione di enti pubblici, associazioni, cittadini e fondazioni, una grande opera di crowdfunding ha vinto la sfida di restaurare il maniero e renderlo fulcro di sviluppo culturale, turistico ed economico. Oggi il Castello di Padernello è luogo di visite guidate nell’arte e nella storia, di eventi incentrati sullo sviluppo sostenibile, di mostre ed esposizioni, ma anche di

ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL SETTORE FOOD


LIBRI E BROCHURE SULLA TUA ATTIVITÀ A PREZZO CONCORRENZIALE
L’elevata specializzazione ci consente di realizzare in toto (foto, grafica e stampa) pubblicazioni di alta qualità per il consolidamento della tua immagine
Still-life e immagini di grande suggestione con la supervisione di esperti food-stylist


La quasi quarantennale esperienza nel settore ci permette di fornire un servizio di estrema precisione con redemption certa
Un team in grado di risolvere qualsiasi problema di gestione dei Social, di Google Maps e di Tripadvisor, un lavoro mirato che in poco tempo produce grandi risultati

Organizzazione totale di manifestazioni per aziende, privati, enti pubblici, in Italia e all’estero
info e preventivi gratuiti Tel. +39 0547 23821
www.lamadia.com - lamadia@lamadia.com



Se tutte le strade portano a Roma
è anche vero che nella città eterna tutte portano verso una delle tante trattorie
Si fa presto, però, a dire trattoria, visto che la definizione non è univoca. Aprendo il dizionario alla voce trattoria leggiamo “pubblico esercizio, prevalentemente di tipo popolare, tipicamente italiano, destinato alla vendita e consumazione dei pasti in loco.
Il nome deriva da trattore, “oste” dal latino, tractare, “trattare, preparare”. L’economicità dei prezzi praticati è una attrattiva di questi locali a cui fa riscontro una maggiore semplicità nel servizio e negli arredi”
Ma oggi le cose non stanno più così. Questa definizione non tiene ovviamente conto dell’evoluzione a cui la trattoria
è andata incontro negli ultimi anni: se prima era il regno dei piatti della mamma e della nonna, segnati sulla lavagna, oggi appartiene a nuovi cuochi visionari che hanno ri -
modellato in chiave contemporanea questi luoghi e la loro lunga storia. L’icona della tradizione culinaria cambia pelle, così come si trasforma il concetto di ristorazione a cui è legata. L’Italia abbraccia una cultura gastronomica ampia, che affonda le radici in un passato lontano e povero, fatto

di territorio e localismo. Una cultura che si declina in modo diverso in venti regioni che, sommate, riconsegnano un quadro variopinto di prodotti, sapori, ricette.
Portavoce di questa immensa tradizione, rappresentante del territorio e dei suoi prodotti, custode di ciò che c’era ieri e divulgatore dei piatti della memoria, è proprio il popolo degli osti con le loro trattorie.
Luoghi emblematici ed eclettici dove si gioca la partita della promozione del prodotti locali, della conservazione della tradizione e della costruzione di un futuro credibile per la cucina, fatto di nuove tecnologie e tecniche, di sostenibilità e chilometro zero (quello vero), di dialogo con i fornitori e di identità territoriale.
Le trattorie nel nostro immaginario condiviso altro non sono che luoghi della memoria casalinga, della cucina “come a casa”, dello stile informale e della convivialità più genuina.
E sono anche luoghi del ricordo di ciò che si era e che continuiamo a cercare come rifugio collettivo e intimo insieme. Allo stesso tempo sono luoghi che guardano oltre, potremmo definirli anche luoghi di commistione, dove passato e futuro si impastano letteralmente insieme per creare il moderno, l’attuale.
Futuro che troviamo, appunto, nell’utilizzo della nuova tecnologia, con le sue attrezzature (abbattitori, roner, sifoni, ecc.), ma anche in una più consapevole conoscenza delle materie prime, della loro provenienza, della filiera, della stagionalità.
E gli osti? Anche loro sono cambiati, oggi rivestono un ruolo più impegnativo che in passato: portano avanti le storie di famiglia e sperimentano il nuovo allo stesso tempo, cercano i prodotti giusti, diventano interlocutori e spesso amici dei piccoli artigiani e produttori.
Un ruolo sociale non da poco, che fa da collante tra le parti, un anello di congiunzione che riesce a mettere in contatto i vari attori, con la funzione di cantastorie o, come si direbbe oggigiorno, di storyteller.
Grazie a questa sua evoluzione la trattoria nel nuovo millennio è tornata ad essere riferimento per la ristorazione italiana. Eppure non si può generalizzare, considerando che, in breve tempo, le trattorie si sono moltiplicate e diversificate tra loro.
Si va dall’osteria moderna a quella tradizionale, passando anche per gli agriturismi con cucina casalinga, fino ai ristoranti della tradizione: in comune tutte queste forme di ospi -
talità hanno quella certa tendenza ad accogliere il cliente in modo informale e complice, per farlo stare bene offrendogli con semplicità uno spaccato del territorio senza inseguire le mode, ma magari creandole.
Roma da sempre è il regno del cibo popolare, quello della Sora Lella per intenderci: cucina verace, sostanziosa, abbondante nei condimenti.
Tutti i turisti sono alla ricerca di un posto tipico, magari quello dove si mangia la migliore carbonara o cacio e pepe; qualsiasi romano ha la propria trattoria di riferimento, e poi ci sono quelli che vogliono sperimentare, provare cose per loro insolite, o, perché no, coccolarsi ogni tanto con un bel primo opulento piatto a della tradizione.
Da nord a sud della città, senza tralasciare gli altri quadranti, ogni quartiere a Roma ha le sue trattorie tipiche, familiari, classiche, quelle che non cambiano e non vogliono cambiare, ma troviamo anche le trattorie nuove, belle da vivere, a tratti, esperienziali. Anche nella capitale da diversi anni si sente parlare di”trattoria moderna”.
Ma cos’è in realtà la cosiddetta trattoria moderna?
Si potrebbe pensare che il nome derivi da una questione di design e di arredamento minimal, che strizza l’occhio volutamente al vintage.
No, ciò che caratterizza la trattoria moderna è la decisione di scommettere su una cucina che guarda al territorio e alle sue materie prime e le usa per rifarsi alla tradizione o per ripensarla in modo inedito.
Una cucina che ha uno stretto legame anche con il vino, spesso biologico, naturale o ricercato.
E ve ne accorgerete dal racconto che tanti osti ci hanno fatto, ognuno dando una definizione diversa di trattoria moderna, ognuno regalandoci una visione personale del loro rapporto con la tradizione.
In questo numero abbiamo deciso, infatti, di raccontarvi alcune delle trattorie contemporanee romane in un ipotetico percorso: in qualsiasi angolo di Roma voi vi troviate, noi abbiamo individuato il posto dove farvi accomodare e anche il piatto iconico che dovreste assaggiare.
Partiamo da una delle zone più gettone della capitale, San Pietro – Musei Vaticani . A via Cipro troviamo Romanè , la nuova creatura di Stefano Callegari . Lui, celebre per impasti e pizze (suo il Trapizzino e diverse insegne di pizzerie in capitale) da un anno si cimenta nella versione “oste”.
INGREDIENTI
kg. 1 di cosce e sovracosce con tutta la pelle g. 150 di olio evo
1 mazzetto di rosmarino
2 spicchi d’aglio lt. 0,5 di vino bianco cl. 5 di aceto di vino bianco
g. 50 di pomodoro pelato g. 15 di sale pepe nero q.b.
Piatto simbolo e anche piatto del Buon Ricordo, di cui Romanè fa parte
“Romanè per me è soprattutto un ristorante della tradizione, anche se l’atmosfera è quella della trattoria: conviviale, rilassata, dove non devi fare l’esperienza, ma vieni per mangiare. È questo quello che il cliente si aspetta da noi, un luogo dove stare bene con piatti comprensibili”. Qui da Romanè è tutto abbondante e tutto ha un richiamo al passato. La tradizione è il primo ingrediente, si parte da quella romana per spaziare in altre regioni italiane, per un risultato finale sempre omogeneo e intrigante. Un esempio è il “murge inverse” che ribalta il classico macco di fave con cicoria trasformandolo in polpettine di fave su crema di cicoria o le “fettuccine al tortellino”, bollite nel brodo e condite con parmigiano, mortadella e prosciutto crudo, uno dei piatti più richiesti, dove c’è tutto il sapore del tortellino, ma senza il tortellino.
Come lo stesso Callegari ci dice: “La mia cucina è molto romana, la tradizione è alla base, ma altrettanto importante sono la modernità e l’innovazione nei piatti, che io cerco di conferire cambiando ruoli e forma agli elementi, ma sempre mantenendo un approccio concreto e di sostanza. Sono dell’avviso che si può trovare la contemporaneità anche nei piatti secolari. Nelle mie ricette nessun retro pensiero, ma piatti che aderiscono alla realtà, facilmente interpretabili e soprattutto godibili” .

Chi vuole trovare gli elementi della romanità, grandi materie prime, opulenza e fare un viaggio nel tempo tra i sapori di casa, trova in Romanè il posto giusto.
Inserire il pollo ben stretto con olio e rosmarino in un tegame o padella, coprire e far cuocere per circa 20 minuti a fuoco moderato. Dopo 20 minuti girare il pollo e far cuocere per altri 20 minuti. A questo punto il pollo sarà pronto. Frullare insieme l’aglio, il rosmarino, l’aceto, il vino e il pomodoro; usare il composto per deglassare il pollo.
Continuare la cottura per altri 10 minuti, aggiustare di sale e pepe e il gioco è fatto.

Raggiungiamo il quartiere Monteverde e puntiamo dritti verso L’Osteria di Monteverde . Già il nome ci dice quanto valore si dia al concetto di identità territoriale. “Noi ci definiamo un’osteria contemporanea;” dice Roberto Campitelli, che continua: “la nostra modernità passa per una declinazione attuale della tradizione, un modo per renderla più aderente al presente mediante l’utilizzo di nuove tecniche, scelta adeguata della materia prima e conoscenze sempre maggiori. Nessuno stravolgimento, ma una rivisitazione sensata cercando un modo per essere differenti, ma senza perdere la nostra peculiarità”.

Entrando da Osteria di Monteverde si viene accolti da un’atmosfera calda e piacevole, dove rilassarsi scegliendo in un menù non molto grande e che ha la capacità di cambiare anche giornalmente. Il suo punto di forza è proprio questo: offrire una cucina quotidiana (nel senso più ampio del termine) anche nel prezzo.
Dai fritti ai primi della tradizione romana, la scelta non manca ed è continua, a questi si aggiungono poi percorsi dello chef e piatti iconici della capitale, ma in una versione con libera interpretazione come il baccalà in panzanella , la lingua tostata con patate e acciughe , il tataki di cefalo, il tortellone alla picchiapò o il raviolo di broccolo e arzilla .

“Da quando abbiamo aperto, nel 2010, la nostra riconoscibilità è proprio il menù di poche portate che prende forma in base a ciò che ci offre il mercato rionale, dove vado a fare la spesa tutte le mattine.
Il nostro concept rimane sempre legato all’offerta di piatti riconoscibili e comprensibili. Ma ovviamente in cucina mi piace sperimentare, variare e quindi cerco di pro porre sempre qualcosa di nuovo. Da qualche anno punto molto sulla materia prima, specie quella povera e di territorio, per mantenere prezzi adeguati e un’aderenza maggiore alla tradizione.
Quinto quarto e pesce povero del litorale laziale sono i nostri plus, così come la carta dei vini che cambia spesso e che sposa il territorio laziale e i piccoli artigiani”.
INGREDIENTI PER 2 PERSONE
1 rognone di vitella privo del grasso esterno
1 spicchio d’aglio
g. 50 di burro
2 cucchiai olio evo
lt. 0,5 di acqua frizzantissima ghiacciata
vino bianco e aceto di vino rosso per sfumare
g. 30 di farina 00 poco prezzemolo tritato
Per la cipolla rossa
10 petali di cipolla rossa
lt. 0,3 di acqua
lt. 0,1 aceto di vino rosso
1 pizzico di sale grosso
Marinare il rognone intero nell’acqua frizzante per circa 15 minuti mantenendolo in frigo al fine di renderlo più sodo, lucido e pulito.
Lessare i petali di cipolla rossa nell’acqua bollente, salata con l’aggiunta dell’aceto, per 40 secondi circa; raffreddarla nel ghiaccio e acqua, scolarla, asciugarla e tenerla da parte.
Lessare le foglie e i gambi di prezzemolo nell’acqua bollente salata per 1 minuto circa, raffreddarle in acqua e ghiaccio ed asciugarle. Emulsionarle in un mixer con l’aggiunta delle acciughe, la senape, l’olio all’a-
Per la salsa verde
5 foglie di sedano
5 foglie di basilico
5 gambi di prezzemolo
2 filetti di acciuga sott’olio ben asciugate
1 cucchiaino di senape liscia
2 cucchiai di aceto di lamponi
3 cucchiai di olio all’aglio
Per la patata mantecata g. 200 di patata tagliata a mirepoix e ben sciacquata dall’amido g. 60 di olio evo di qualità sale e pepe macinato fresco q.b.
glio e l’aceto di lamponi. Si ottiene così una salsa verde densa e profumata che verrà usata in seguito.
Cuocere i dadini di patate in acqua bollente salata. Eliminare il liquido in eccesso e, quando ancora caldi, con l’aiuto di una frusta e una boule, montarli con l’olio di qualità. Aggiustare di sale e pepe macinato. Otterremo così un purè più leggero e salutare del classico, ma con un intenso sapore dato dai sentori dell’olio.
In una comoda padella sciogliere il burro con lo spicco d’aglio a fuoco dolce.
Tagliare il rognone a fette di cm. 1 circa, infarinarlo appena appena e cuocerlo un paio di minuti per lato nel burro aromatizzato all’aglio. Eliminare il grasso di cottura e sfumare con vino e aceto, continuare la cottura per 2 minuti ancora, se necessario aggiungendo un goccio di acqua calda. Mantecare con il prezzemolo tritato e la cipolla rossa.
Servire il rognone ben caldo accompagnandolo con la salsa verde e la patata mantecata.

Spostiamoci ancora e raggiungiamo il quartiere Ostiense , a due passi dalla Piramide Cestia, dal “Monte dei cocci”, dal gazometro e da alcuni dei più interessanti lavori della street-art romana contemporanea.
Qui troviamo la pluripremiata Trattoria Pennestri , segnalata in tutte le guide e fin da subito incarnazione perfetta della versione di “una trattoria odierna, perché molto legata alla realtà che è in continua evoluzione (come i nostri piatti e la nostra carta dei vini), ma anche al territorio e al nostro vicinato che ci ha accolto e di cui ci sentiamo parte”, sostengono i titolari.


In cucina c’è lo chef Tommaso Pennestri , in sala c’è l’ostessa Valeria Payero , che consiglia in maniera impeccabile cosa bere: entrambi hanno puntato sulla qualità della materia prima, costruendo relazioni di fiducia con i fornitori.
L’accoglienza offre la sensazione di sentirsi a casa in un ambiente discreto, grazie a un’innovazione senza stravolgimenti proprio perché si parla di una trattoria e perché allo stesso tempo si rompono degli schemi.
ASSOLUTAMENTE
Pici con cicoria
dizionale, e ciò che è innovativo, provando e sperimentando cotture e risultanti di sapore” . Grande valore aggiunto, la carta dei vini che predilige il territorio e i vini naturali, “in una ricerca oculata e a volte quasi ossessiva di piccole aziende in tutta la Penisola”, come sottolinea Valeria. Il racconto dei piatti al tavolo rende poi l’esperienza del cliente più ricca e consapevole.
Nel menù, i primi della tradizione romana sono intoccabili e restano fedeli alla tradizione, (si dice che i loro rigatoni all’amatriciana sono i migliori della capitale), per il resto tutti i piatti in termini di ingredienti e cotture sono soggetti a interpretazioni e varianti. Tante le materie prime del territorio, comprese quelle che hanno fatto la storia di Roma, quinto quarto su tutte per piatti come rigatoni con pajata e colatura o le animelle al vino bianco.

Regna anche sovrano il baccalà con uno dei loro antipasti must, crocchette di baccalà e patate, ma anche il baccalà mantecato con schiaccia di patate e, tra i primi, uno dei punti fermi sono anche gli gnocchetti acqua e farina, crema di scampi e stracciatella .
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
g. 500 di pici freschi • g. 100 di cicoria di campo lessata • g. 80 di olio evo • 1 spicchio d’aglio • peperoncino q.b. • mollica di pane condita • semi di finocchio
Prendere la cicoria pulita e sciacquarla ripetutamente; lessarla in abbondante acqua salata. Poi lasciarla raffreddare e strizzarla, dopodiché tritarla al coltello.
In un padellino a parte versare l’olio d’oliva, l’aglio schiacciato con tutta la buccia, il peperoncino e i semi di finocchio, far soffriggere, poi immediatamente dopo aggiungere la cicoria e far rosolare in padella finché l’olio non diventa verde clorofilla e fino a quando la cicoria è completamente ripassata, quasi fritta (come si serve nelle tipiche trattorie romane) e quasi bruciacchiata.
Nel frattempo prendere la mollica di pane precedentemente condita con olio, sale e semi di finocchio e ripassarla in padella in modo da renderla croccante. Far bollire i pici in abbondante acqua salata; una volta lessati scolarli e ripassarli in padella con la cicoria: quando i pici avranno assorbito tutto l’olio diventando verdi, aggiungere la mollica di pane. Servire e gustare.
Arriviamo a San Giovanni , un altro quartiere storico e di grande fascino di Roma, per andare a sederci da SantoPalato , uno degli esempi di successo della “nuova trattoria italiana”, con un ritorno al passato e la riproposizione di una cucina della familiarità e della tradizione.
In cucina troviamo Sarah Cicolini , una cuoca modernissima al comando e giovane imprenditrice dalle idee molto chiare da quando, nel 2017, ha messo su questo progetto.
Fin dall’inizio sono stati definiti senza troppi giri di parole “Trattoria Moderna” e, come lei stessa conferma: “Siamo una trattoria moderna al 100% e ritengo che questo sia sufficiente per dare un’idea a chi si approccia alla nostra filosofia. Modernizzare e/o interpretare sono le cose che facciamo più di frequente.

Sono azioni che vanno di pari passo con la conoscenza della tradizione tout court. È il nostro credo. Oggigiorno, nell’era del bombardamento mediatico, la cosa più importante è restituire la verità e l’autenticità, nel bere e nel mangiare. Questo è il nostro obiettivo e credo che sia anche una sorta di ‘manifesto’ di SantoPalato” .
La cucina di Sarah parte dal “basso”, pochi ingredienti e riconoscibili, grande materia prima, tanto studio delle tradizioni regionali, applicazione delle tecniche e anche un grande storytelling di ciò che fa.
E questi elementi, qui elencati, sono i capisaldi della sua espressione, dell’essenza di SantoPalato che dal primo giorno ad oggi non ha mai tradito l’identità, la credibilità e la riconoscibilità.
SantoPalato è celebre, inoltre, per l’utilizzo del quinto quarto, “croce e delizia di noi neo-osti” asserisce la nostra chef che lo usa in ogni forma e piatto. Fegato, fegatini, lingua, cuore, diaframma, c’è tutto, e sempre proposto in modo diverso, creativo, curioso.
Si parte dall’omaggio alla nonna, con la sua frittata con le rigaglie , la trippa alla romana , il prosciutto di cuore per poi provare la carbonara , che scala le classifiche capitoline, e il maritozzo di grano arso con la crema Chantilly, che diventa un obbligo a fine pasto.
Uno dei piatti che ha disegnato l’identità di questa trattoria
POLPETTE
kg. 1 di coda di vitellone
3 carote
4 cipolle
4 coste sedano
kg. 1 di pelati
ml. 800 di vino bianco
scorza di limone
1 cucchiaino di colatura di alici
sale e pepe
uova e pangrattato q.b.
olio per friggere
cacao amaro per guarnire
Marcare in padella la coda con sale e poco olio, arrostirla poi metterla in una teglia coperta con gli odori (cipolla, carota, sedano), vino bianco e pomodoro. Coprire e cuocere in forno a vapore a 110 °C, vapore 80% e ventola invertita, per 10 ore (tutta la notte).
Dopo la cottura, filtrare il fondo e farlo restringere in casseruola finché non diventa viscoso.
Spolpare la coda con le mani, sfilacciandola bene, aggiustare di sale e pepe, poca scorza di limone e la colatura di alici. Bagnare con il fondo ristretto e far raffreddare, in modo che esca un impasto modellabile.
A questo punto preparare le polpette, da passare prima in uovo e poi in pangrattato per due volte, infine friggerle in olio a 190 °C.

g. 500 di arachidi tostate g. 80 di foglie di levistico ml. 100 di olio di semi di arachidi 2 cucchiai di salsa di soia artigianale
Sciacquare le arachidi per 10 minuti e farle scolare, poi metterle nel Thermomix con l’olio di semi di arachidi e frullarle per ottenere una sorta di burro di arachidi. Aggiungere la salsa di soia e le foglie di levistico, frullando di nuovo alla massima potenza. Assaggiare per eventuali aggiustamenti di sale.
Sul fondo del piatto mettere un cucchiaio di salsa di arachidi e levistico, appoggiarvi sopra la polpetta e finire con una spolverata di cacao amaro.

sue parole - Sono un ortodosso, rispetto fedelmente le ricette tipiche di ogni regione o paese, quelle delle nonne, ricette che vado a ricercare, che studio e che spesso mi regalano nei miei viaggi, o che mi forniscono al ristorante gli stessi clienti con cui mi fermo a chiacchierare” .
Da Eufrosino la romanità è bandita per scelta, mentre si dà voce alla cucina di ogni parte d’Italia, disegnando dall’anti -
ASSOLUTAMENTE
DA PROVARE
CON MAIONESE AL LIMONE
Viaggiamo verso la periferia, che poi tanto periferia non è più. Siamo a Torpignattara e la nostra trattoria di elezione è Eufrosino , che prende il nome dal santo patrono dei cuochi. Entrando troviamo l’atmosfera e lo spirito delle trattorie, un po’ come quelle emiliane, tanti quadri alle pareti, tanto legno, lampade da biliardo che illuminano la sala. In cucina Paolo d’Ercole , un cuoco ultramoderno, che ha fatto della tradizione la sua missione. “La tradizione in trattoria per me è fondamentale, è la mia missione – queste le
pasto al dolce dei veri e propri viaggi del gusto. Mangiare in questa trattoria è come salire su una giostra, è un gioco per il palato, puro divertimento e scoperta.
Qui i menù cambiano mensilmente, in base alle stagioni e alle scoperte del nostro oste: “Non c’è una regione che mi colpisce in modo particolare più di un’altra, dipende dalla stagionalità dei prodotti; le ricette che propongo sono come una folgorazione: le incontro, mi ispirano, mi piacciono e le realizzo” .

Del Lazio ha conservato pochi piatti per lo più sconosciuti, come per esempio i grattaculi (le foglie della zucca e delle zucchine) con l’uovo strapazzato e il petto di vitello alla fornara .
Poi ci sono i piatti intoccabili, che stagionalmente rimangono fissi, come i mondelighi con salsa tartara , la chitarrina cacio, ova e pecora , le pappardelle con castagne, lardo e grappa . Lo stesso succede con i vini: è il sommelier Paolo Abballe che gioca con le etichette, le ricerca in ogni regione tentando di trovare cose nuove, ma senza seguire mai le mode.
Qui si fa tutto come una volta. Insomma tradizione senza compromessi, applicata quasi in modo scientifico. E forse la modernità di Eufrosino sta proprio in questo approccio, che ridà indietro concretezza, sapore, pochi fronzoli e un rapporto diretto con il commensale, che qui vive la tavola con curiosità.
“Potrebbe essere un eufemismo, - dice ridendo Paolo - da Eufrosino siamo così antichi che ci sentiamo moderni. Il punto cardine della nostra realtà è lo studio e la ricerca, quello classico (non sperimentale). Partendo da questo e dalla voglia di raccontare attraverso la cucina le storie familiari si può cominciare a parlare di modernità.
Un esempio? Posso dire che sono stato il primo a portare la carne d’asino a Torpignattara, nel primissimo menù, una vera sfida, ed è stato uno dei piatti più richiesti. La trovo una cosa molto attuale”.
CON MAIONESE AL LIMONE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
4 cosce e sovracosce di pollo (in pezzi)
Per la marinatura succo e scorze di 5 limoni
1 testa d’aglio
3 cucchiai di senape
1 bicchiere di vino bianco
3 rametti di
Per il pollo alla toscana
rosmarino
10 foglie di salvia
1 cucchiaio di pepe in grani
1 cucchiaio di bacche di ginepro
Per la frittura farina q.b.
3 uova olio per friggere
Per la maionese
1 uovo
g. 200 di olio di semi
2 pizzichi di sale
2 cucchiai di succo di limone
la punta di un cucchiaino di senape
Marinare le cosce e sovracosce di pollo con succo e scorza di limone, aglio, senape, vino bianco, rosmarino, salvia, pepe in grani e bacche di ginepro; coprirle e lasciarle in frigo per almeno 24 ore.
Trascorso il tempo necessario scolare e tamponare il pollo, passarlo nella farina e poi nelle uova sbattute. Portare l’olio di semi ad una temperatura di 160/170 °C ed immergere il pollo fino a doratura: ci vorranno almeno 20/25 minuti. Adagiare su carta assorbente, salare e pepare il pollo e servire con la maionese al limone appena preparata.

Per la maionese al limone
Nel bicchiere di un frullatore a immersione mettete l’uovo intero, il limone, l’olio, il sale e la senape. Iniziare a frullare senza muovere il pimer dal fondo del recipiente. Dopo circa 30 secondi proseguire sollevando e abbassando il minipimer finché la maionese sarà montata: ci vorranno circa 3 minuti.
Foto di Giulio Di MauroIl piatto che rappresenta la fase del cambiamento
Ultima tappa Centocelle , dove si respira un continuo fermento gastronomico. Tra i tanti posti che il quartiere offre, la nostra sosta obbligatoria è Menabò con la sua cucina da “trattoria Resistente”, come dicono i fratelli Camponeschi , con Daniele in sala e Paolo in cucina. Menabò appartiene senza dubbio a quel movimento della trattoria moderna contemporanea che cresce da vent’anni, un movimento che non impone codici o schemi, oppure definizione fisse, ma una variazione continua sul tema della tradizione per farla vivere sempre come cucina contemporanea.

Da Menabò si trova una cucina mediterranea, dove il Mediterraneo non è solo un riferimento geografico, non è solo una serie di prodotti rappresentativi da mettere in un piatto, ma diventa un’idea e una forma di narrazione storicosociale. Il Mediterraneo che i Camponeschi hanno deciso di tradurre nei loro piatti è un sistema di relazioni, di rotte, di incontri e di scambi, di fusioni di popoli. Si potrebbe parlare di contaminazione, ma è anche corretto parlare di integrazione, di inclusione.
“Il Mediterraneo è un qualcosa che abbraccia, che avvolge e mette in comunicazione: lo ha sempre fatto e continua a farlo.
E con la nostra cucina cerchiamo di indagare la complessità di questo sistema e delle sue radici.
Non prendiamo spunto dalla tradizione ma dalle tradizioni che si trovano a convivere nello stesso luogo.
La stessa Centocelle è fusione di diverse etnie e nazionalità, integrate da tempo, che prendono e danno alla nostra cucina. - ci spiega Paolo Camponeschi che continua: “In un piatto del nostro menù che si dice mediterraneo si trovano le materie prime classiche di Roma e d’Italia, ma si trovano anche i Balcani, la Spagna, o il Nord Africa che usano gli stessi ingredienti ma in altre forme.

A me piace mescolare il tutto per dare vita a qualcosa dove la tradizione è un punto di partenza: la nostra cucina mediterranea in poche parole è un atteggiamento mentale, una visione personale”.
Partiti dai fegatini di maiale nella rete che rimane un must del loro menù, i piatti che cambiano abbastanza di frequente sono oggi libera espressione, narrazione di questo concet-

Per la pasta fillo
g. 800 di farina 0
g. 400 di acqua tiepida
g. 40 di olio di semi
g. 2 di sale
Per il ripieno
g. 500 di polpa di agnello
g. 50 di concentrato di pomodoro
g. 100 di vino rosso
lt. 1 di brodo vegetale
g. 200 di patate
g. 200 di spinaci cotti
g. 200 di cipolla trito di erbe robuste q.b.
Per il latte affumicato
g. 500 di latte di pecora
g. 200 di ricotta stagionata affumicata al ginepro
g. 100 di pecorino
Per la finitura
1 uovo
semi papavero semi di sesamo
Menabò
Via delle Palme 44 D/E 00171 Roma
Tel. 06 8693 7299
menabovinoecucina.it
to di “spazio mediterraneo” che va dalla gricia di stagione alla pasta mista, ceci, cozze e rosmarino fino alla pita fatta in casa, spiedo di pollo, misticanza, maionese allo yogurt o al Börek del pastore passando anche per le interpretazioni dolci del Mediterraneo come la brioche sfogliata, agrumi, noci, cannella e coulis di uva fragola .
Menabò conserva dal primo giorno l’idea della trattoria, di un luogo dove vivere con informalità e convivialità il cibo, un posto dove condividere parole, risate e sapori. Un luogo dove consumare un pasto solido e sincero lontano dalla sperimentazione. Ed è quello che succede qui a via delle Palme: l’accoglienza e il servizio sono il fiore all’occhiello, qualcosa a cui il quartiere non era abitua.
Daniele ti racconta, ti aiuta a scegliere, ti fa sentire a tuo agio e poi ti lascia libero di goderti la serata. Il vino qui è al pari della cucina: contro chi dice che in trattoria non si può bere bene, Menabò punta sui vini alternativi, quelli artigianali, prodotti dall’inizio alla fine in modo diretto e attento.
Mescolare tutti gli ingredienti della pasta fillo, lavorare energicamente per attivare la maglia glutinica, per ottenere un impasto liscio e farlo riposare. Stendere sottilissimo con il matterello aiutandosi spolverando il bancone con dell’amido di mais. Rosolare in un tegame la carne di agnello con la cipolla, aggiungere il concentrato di pomodoro e farlo tostare leggermente, sfumare con il vino rosso e, quando è evaporato l’alcool, aggiungere il brodo. Cuocere lentamente come si farebbe per uno spezzatino. A cottura ultimata aggiungere le patate grattugiate, il trito di erbe e far ritirare il sugo. Aggiungere gli spinaci lessi e far raffreddare. Scaldare il latte, aggiungere la ricotta grattugiata e il pecorino. Frullare tutto con il mixer e setacciare. Stendere una striscia di ripieno sulla pasta fillo, spennellare la pasta con altro olio di semi, arrotolare facendo tre giri e formare delle chiocciole. Spennellare con uovo la superficie del börek, spolverarla con semi di sesamo e papavero, cuocere in forno a 170 °C per 15 minuti.
Mettere la salsa a specchio su un piatto fondo e posizionarci sopra il börek cotto in forno.
Ci sono tanti bravi cuochi. Ma, fra essi, pochi sono quelli capaci di ‘guardare’ oltre i fuochi della loro cucina e i tavoli della loro sala, presi come sono ad affinare i propri piatti e a governare la propria impresa economica. Eppure al di fuori del ristorante, che non è un microcosmo chiuso in sé, c’è tutto un universo.
Un insieme ipercomplesso che determina tanto i legami fra gli individui quanto i rapporti fra le persone e la natura circostante. Pensare che le scelte e le azioni che si compiono dentro un ristorante non abbiano conseguenze o ripercussioni è quindi sbagliato, perché tout se tien: un cuoco che compia una scelta eticamente ‘giusta’ ne riverbererà la sua

positività anche al di fuori. Al contrario, una azione eticamente ‘sbagliata’ ne rifletterà tutti gli esiti negativi.
Norbert Niederkofler , cuoco assai noto e che non ha bisogno di presentazioni, ha iniziato a riflettere sull’importanza del suo lavoro e delle sue scelte quando ha intrapreso il cammino che lo ha portato a elaborare la filosofia di cucina per la quale è divenuto celebre: Cook the Mountain . Venendo da una formazione ‘classica’ (scuola alberghiera e quindi tanti anni passati all’estero, in grandi alberghi e ristoranti blasonati, fra Stati Uniti, Svizzera, Austria e Ger-
di Gianluca Montinaro Foto di Alex Moling, Alex Filz, Daniel Töchterle, Luca Dal Gesso e Paolo Riolzimania: molto importante l’esperienza con il grande Eckart Witzigmann , lo chef che ha portato al massimo successo il Tantris prima e L’Aubergine poi a Monaco di Baviera) Niederkofler, tornato in Alto Adige all’inizio degli anni Novanta e assunta la responsabilità della ristorazione dell’hotel Rosa
Alpina (San Cassiano, Badia, Bz) e quindi del St. Hubertus , proponeva una cucina – in linea con lo stile di quei tempi – ove abbondavano ingredienti preziosi (come dimenticare la sua straordinaria variazione di foie gras?) e pesce (come
stesso, ho iniziato a far domande ai miei clienti per capire cosa poter offrire loro di migliore, e di unico».
La risposta, nel 2010, è arrivata, quasi ovvia, alzando gli occhi e guardandosi intorno: la montagna. L’apparente semplicità della soluzione, però, nascondeva insidie e complessità inaspettate, legate alla qualità e reperibilità dei prodotti alpini, alla loro ristretta stagionalità e, last but not least, ai gusti e alle richieste degli ospiti.
Ci sono voluti anni per portare a compimento il percorso
le triglie ripiene con pomodoro al forno, altro piatto che chi scrive ben ricorda), provenienti da tutte le parti del mondo. Eppure un tarlo rodeva la mente di Niederkofler.
L’amore per la sua terra, la sua passione per i viaggi alla scoperta delle usanze e delle tradizioni di luoghi anche lontani, lo portava a interrogarsi sempre più su cosa avrebbe dovuto essere la cucina, almeno la propria.
«Il St. Hubertus – ricorda Norbert – era conosciuto per avere una clientela internazionale abituata a trovare ovunque il meglio dell’haute cuisine.


Eppure mi sembrava assurdo che le persone dovessero venire in Alto Adige per assaggiare qualcosa che avrebbero potuto trovare anche a casa loro. Dopo aver interrogato me
verso un’alta cucina di montagna. Un percorso entusiasmante ed emozionante, ma non scevro di dubbi ed errori, che – anche grazie al sostegno della famiglia Pizzinini , proprietaria del Rosa Alpina – Niederkofler ha alla fine coronato con Cook the Mountain . Il suo nuovo approccio alla cucina era finalmente chiaro: territorialità delle materie prime, stagionalità, consapevolezza delle antiche tradizioni. Con un fine, neppure troppo recondito: nobilitare l’identità gastronomica dell’Alto Adige.
Ma, come parlare di cucina in un territorio così difficile come sono le valli alpine? Come dare una nuova interpretazione di una secolare tradizione di sussistenza senza snaturarne lo spirito?
g. 500 di brodo di gallina
g. 10 di grasso di gallina sciolto 20 bacche di crispino
Per la pasta all’uovo g. 125 di tuorli a pasta gialla 1 uovo intero a pasta gialla
g. 100 di farina di frumento
g. 150 di semola di grano duro rimacinata
Per la farcia al Formai de Mut
g. 62 di Formai de Mut o altro formaggio di monte
ml. 125 di panna a lunga conservazione
g. 3 di fecola di patate
Per la pasta all’uovo: impastare tutti gli ingredienti in una planetaria per 20 minuti circa, sfogliare la pasta e farla riposare avvolta in un canovaccio leggermente umido, riponendola in frigorifero per 2 ore circa.
Per la farcia al Formai De Mut: tagliare il formaggio a cubetti e scioglierlo con la panna in un thermomix a 70 °C per 9 minuti. Quando ne saranno passati 8, aggiungere la fecola disciolta in acqua e frullare ancora per 1 minuto. Versare quindi il composto in una ciotola e farlo raffreddare rapidamente.
Per i ravioli: tirare la pasta a sfoglia sottile, mettere il ripieno in un sacchetto da pasticceria e formare al centro della sfoglia una striscia per tutta la lunghezza, ripiegare la sfoglia su se stessa e schiacciare bene contro il ripieno per far uscire l’aria presente. “Pizzicare” la pasta lungo la striscia di ripieno a intervalli di cm. 2, quindi tagliarla nei punti di chiusura con l’ausilio di una rotella dentata, per ottenere la classica forma del “plin”. Cuocere i ravioli per 4 minuti circa e servirli con il brodo di gallina caldo, qualche goccia di grasso di gallina e le bacche di crispino.
Il passo successivo per Niederkofler è quindi stato ‘scoprire’ che si sarebbe potuto ‘cucinare la montagna’ solo a patto di conoscerne a menadito ciò che essa può offrire (in termini di ingredienti coltivati, allevati ma pure raccolti in natura), a patto di saperlo utilizzare («ho iniziato a valorizzare davvero il prodotto quando ho ridotto al minimo gli scarti. Dalle bucce di patate alla pelle del pesce fino all’acqua di cottura delle verdure, tutto può diventare un ingrediente di ricette gourmet »), a patto di saperlo conservare in modo adeguato, a patto di saper stimolare la miglior sinergia possibile, secondo un circolo virtuoso, fra il cuoco e i suoi fornitori.
Quest’ultimi sono anch’essi attori protagonisti: devono partecipare attivamente alla costruzione di questa identità gastronomica. Gli agricoltori e gli allevatori sono infatti «gli artigiani del territorio: sono la loro esperienza e la loro sapienza che ci permettono di avere materie prime pure e perfette. In ogni mio piatto – puntualizza Niederkofler –montagne, la fatica di chi ci la vora, la qualità dei loro prodotti, le tradi zioni tramanda te, la cura, la costanza e la leggerezza»

Tartare di coregone, brodo delle sue carcasse al vino Terlano, le sue scaglie croccanti, olio al levistico
Sicché al St. Hubertus, per esempio, è via via scomparso il pesce di mare, sostituito da quello d’acqua dolce: la tartare di coregone accompagnata da un brodo delle sue carcasse al vino Terlano che apre la serie degli antipasti è già di per sé un manifesto di Cook the Mountain.

RIDUZIONE DI RAPE ROSSE kg. 2 di rape rosse
Lavare e pelare le rape rosse, quindi tagliarle a pezzetti e centrifugarle. Versare il liquido in una pentola e lasciar ridurre a fuoco lento all’incirca dei 2/3.
GNOCCHI DI RAPE ROSSE g. 500 di patate bollite • g. 300 di farina di frumento • ml. 60 di riduzione di rape rosse • 1 tuorlo • sale
Lavare e cuocere le patate a 100 °C in forno a vapore per 50 minuti, pelarle e passarle con uno schiacciapatate. Raffreddarle e unire il resto degli ingredienti. Lavorare l’impasto fino a che risulterà omogeneo. Coprire e lasciar riposare un’ora in frigorifero.
Trascorso il tempo necessario, stendere l’impasto a matterello con uno spessore di circa mm. 4, ricavare dei dischetti del diametro di cm. 6 e inserire una mezza sfera di ripieno, chiudendo la pasta su se stessa, dando una forma quanto più simile ad una piccola rapa. Cuocere in acqua bollente per 4 minuti circa, scolare e glassare in una padella con la riduzione di rapa rossa.
Per il ripieno ml. 500 di panna • g. 150 di pasta di rafano • g. 6 di Agar agar
Mettere in infusione la pasta di rafa-

no nella panna e lasciar sobbol lire per 30 minuti, filtrare, ag giungere l’Agar agar e il sale, portare a bollore e togliere dal fuoco.
Quando il composto sarà freddo e ancora cremoso, inserirlo in un sacchetto da pasticceria e riempire delle mezze sfere in silicone; elimi nare il composto in eccesso e congelare.
kg. 1 di daikon • lt. 1 di panna fresca • lt. 1 di latte fresco • sale
Lavare e pelare la radice di daikon, tagliarla sottilmente e rosolarla con del burro in una casseruola, coprire con la panna ed il latte e cuocere fino a che il daikon risulterà morbido. A questo punto scolare e frullare in un thermomix fino a che la crema risulterà liscia, infine aggiustare di sapore.
PASTA XANTANA
g. 3 di polvere di Xantana • ml. 80 di acqua
Unire e frullare gli ingredienti fino a che si formerà un gel trasparente.
SUCCO DI RAPA
AROMATIZZATO
ml. 100 di riduzione di rape rosse • g. 20 di aceto di vino rosso • 2 rametti di timo • 1 spicchio d’aglio • g. 10 di acqua Xantanata
un pentolino (esclusa l’acqua Xanta nata), portare a bollore e togliere dal fuoco, lasciar insaporire 30 minuti circa. Filtrare e legare con la pasta Xantana.
TERRA DI BIRRA
g. 200 di pane “puccia” secco • ml. 50 di birra • g. 15 di carbone vegetale

Frullare tutti gli ingredienti per 5 minuti. Stendere sul silpat in silicone e lasciar asciugare in forno a 55 °C per 12 ore. Frullare e bagnare con la birra al momento dell’utilizzo.
Comporre il piatto iniziando con due schizzi di succo di rapa aromatizzato, inserire la terra di birra ed adagiare 5 pezzi di gnocco su di essa. Ultimare con la crema di daikon.
Nulla del pesce è sprecato: persino le sue squame, rese croccanti, si ritrovano nel piatto. E anche la golosissima anguilla porchettata al lardo (e laccata con soia e lenticchie, alla maniera del Sol Levante) è affiancata da un consommé affumicato preparato con la sua testa e la sua lisca.

È poi l’uso assai sapiente delle erbe e dei piccoli frutti selvatici di montagna a permettere alla cucina di lavorare su molteplici registri aromatici e gustativi, secondo una estetica minimale di impostazione scandinava, sopperendo a tutte quelle materie prime mediterranee il cui uso è stato in pratica bandito. Persino l’olio non è di oliva ma di vinaccioli, successivamente aromatizzato. Così, per esempio, i ditalini sono di farina di farro in essenza di selvaggina (succo di salmì estratto al torchio e legato con sangue di maiale) con ribes ghiacciato e acetosa. E il risotto con stracchino e bergna (carne di pecora marinata e stagionata, tipica delle prealpi biellesi) è profumato da un olio di vinaccioli all’aglio selvatico (orsino).

Attorno alla partitura centrale, Niederkofler costruisce poi alcune sapienti ‘variazioni’, ispirate a tecniche e suggestioni di Paesi lontani: i tortelli ripieni di coniglio con radice di cavolo rapa e olio aromatizzato al finocchietto selvatico, per esempio, mimano i ravioli cinesi. Mentre i nervetti di vitello con cavolfiore e cipollotti paiono una pietanza vietnamita.
Ma la filosofia Cook the Mountain – e Niederkofler ne ha preso piena coscienza solo in fieri – ha messo in moto un meccanismo complesso dal forte impatto socio-culturale. Si riflette, solo per dirne alcune, nello studio e nella messa in opera di pratiche di coltivazione e di allevamento sostenibile e biologico, nel rispetto dei tempi della natura e della biodiversità, nell’attenzione generalizzata a non sprecare o creare rifiuti, nella cura della terra vista come patrimonio e fonte di ispirazione da tramandare alle future generazioni. Un approccio, quindi, a tutto tondo, fondato sulla responsabilità verso «le risorse naturali che – ricorda Niederkofler – non sono infinite e che abbiamo il compito di preservare per chi verrà dopo di noi»

In una parola: sostenibilità, ecco il principio-guida. Che è diventato un libro in due tomi ( “Cook the mountain”. The na -
Strada Micurá de Rü, 20 39036 San Cassiano in Badia (BZ) Tel. 0471 849500 www.st-hubertus.it
ture around you, München, Südwest Verlag, 2020, 2 voll., 396 pp.; 160 pp., 98 euro) il quale, mostrando ciò che si è riuscito a fare in montagna, vuole anche invitare a «compiere scelte analoghe altrove. Cook the Mountain per noi è diventato uno stile di vita, e si può portare avanti solo in montagna. Ma i concetti che lo sorreggono si possono declinare su qualsiasi territorio che è around you».
In un certo senso se Cook the Mountain rappresenta un progetto ormai compiuto, Niederkofler guarda avanti perché il cuoco può essere, a tutti gli effetti, un educatore. E la cucina, per la forza universale del suo linguaggio, può «catalizzare nuovi processi culturali» tesi alla salvaguardia
Anguilla porchettata al lardo St. Hubertus - Hotel Rosa AlpinaBRODO DI FUNGHI
g. 500 di funghi misti • ml. 500 di acqua • ml. 250 di brodo di gallina • sale
Tagliare grossolanamente i funghi misti, sistemarli in una teglia, ricoprirli con i liquidi e chiudere con il coperchio. Infornare in forno a vapore preriscaldato a 80 °C per 2 ore. Filtrare e aggiustare di sale.
FUNGHI
1 porcino • g. 15 rispettivamente di: Clitocybe nuda (lepista nuda), Clitocybe gibba, Cantharellus lutescens (finferle), Cantharellus cibarius (gialletti), Lactarius salmonicolor, Craterellus cornucopioides (trombette dei morti), Ramaria (tipologia commestibile), Gomphus clavatus (neurofillo clavato), Sparassis crispa • g. 20 di olio di semi di vinacciolo • 1 spicchio d’aglio non sbucciato • 1 rametto di timo
Pulire i funghi e tagliarli a pezzi non troppo grandi, regolandosi in base alla forma del fungo stesso. Saltarli in una padella antiaderente con un filo di olio di semi di vinacciolo e gli aromi, aggiustando di sale.
OLIO AL FUNGO DELL’AGLIO
g. 100 di Marasmius scorodonius • ml. 600 di olio di semi di vinacciolo
Mettere in infusione il fungo Marasmius scorodonius nell’olio di semi di vinacciolo e porre per 10 giorni circa in frigorifero.
Quando l’olio avrà un odore di aglio misto a tartufo il prodotto sarà pronto. Pastorizzare in forno a vapore preriscaldato a 86 °C per 18 minuti e conservare.

ALTRI INGREDIENTI
g. 50 di semi di lino • g. 50 di semi di zucca • g. 10 di salsa di soia • 15 bacche di aglio orsino sotto sale • 20 fiori di erba cipollina in salamoia • g. 10 di olio al porro bruciato • g. 10 di rafano fresco • 1 cipollotto fresco
Tostare separatamente i semi di lino e quelli di zucca, aggiungere la salsa di soia e, una volta evaporata, togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. Grattugiare finemente il rafano.
IMPIATTAMENTO
Comporre il piatto con i funghi precedentemente saltati e versare il brodo bollente. Finire con i semi tostati, le bacche di aglio orsino e i fiori di erba cipollina, il rafano grattugiato, l’olio al porro bruciato e il cipollotto fresco tagliato a julienne. Aggiungere per ultimo qualche goccia di olio di fungo aglio.



 Risotto all’aglio orsino e bergna grattugiata
Tortelli ripieni di coniglio con radice di cavolo rapa e olio al finocchietto selvatico
Risotto all’aglio orsino e bergna grattugiata
Tortelli ripieni di coniglio con radice di cavolo rapa e olio al finocchietto selvatico
GELATO AI FIORI DI SAMBUCO
ml. 500 di latte fresco • g. 125 di fiori di sambuco secchi • ml. 210 di panna • g. 56 di glucosio • g. 102 di latte in polvere • ml. 38 di sciroppo sambuco

Infondere i fiori di sambuco secchi nel latte a 60 °C per 2 ore. Filtrare e ricavare ml. 425 di liquido, aggiungere la panna ed il glucosio, in seguito portare ad una temperatura di 50 °C, a questo punto aggiungere i restanti ingredienti e far raffreddare. Mantecare in una gelatiera. Formare delle quenelle e porle alla base del piatto, coprirle completamente con tutte le parti croccanti.
ARIA DI LATTE
ml. 500 ml latte fresco • 1 albume • g. 50 di zucchero
Miscelare tutti gli ingredienti e portare ad una temperatura di 82 °C, raffreddare e lasciar riposare il composto fino al giorno seguente. Scaldare il liquido e montarlo con un minipimer ad immersione per ottenere la schiuma, adagiare quest’ultima su un pezzo di carta forno e porre a disidratare ad una temperatura di 70 °C per circa 6 ore.
MERINGA
g. 200 di zucchero • g. 100 di albume
Unire gli ingredienti in una planetaria e lavorarli con una frusta fino ad ottenere una meringa. Stendere quest’ultima sottilmente e porla in essiccatore a 60 °C per 5 ore circa.

CHIPS DI LATTE
lt. 1 di latte • ml. 50 di panna • g. 30 di proteina del latte
Miscelare gli ingredienti e lasciar riposare l’impasto in cella frigorifera per una notte. Versare il composto in una placca e scaldarlo dolcemente fino a formare una pelle in superficie. Rimuovere la pellicina e porla in un disidratatore a 50 °C per 4 ore circa.

e alla promozione di modelli di sviluppo sostenibili. Così, da un lato, il cuoco altoatesino sta dando grande impulso agli appuntamenti organizzati da Care’s - The ethical Chef Days (questo il nome che ha dato al suo think tank, fondato nel 2016), in Alto Adige ma anche a Venezia e a Salina, col fine di diffondere il più possibile, in modo trasversale e non solo fra i suoi colleghi, il concetto del ‘prendersi cura’, anche attraverso la stesura di un chiaro manifesto programmatico: il Care’s Statement .
Dall’altro impegnandosi sempre più nell’attività formativa rivolta ai giovani. Non è una novità che Niederkofler sia considerato uno dei cuochi che più fanno scuola. Credendo nel valore dell’esempio personale come eredità da trasmettere ecco che, da molti anni a questa parte, il cuoco altoatesino ha cresciuto una vasta messe di giovani ai quali ha affidato responsabilità vie più grandi, secondo un principio di reciproco scambio: tanto la generazione precedente dà, ma anche tanto riceve in termini di entusiasmo e nuovi stimoli dalle nuove leve.
Sicché assai giovani sono le squadre che lo affiancano.
Il St. Hubertus si è giovato dalle capacità dei suoi executive chef: il bravo Michele Lazzarini prima e ora l’altrettanto bravo Mauro Siega . Come giovane è la squadra della sala, capitanata da Lukas Gerges (capace di gestire con estrema competenza una delle cantine più ricche e vaste d’Italia).
E il discorso non cambia sulle piste di Plan de Corones: sin dagli esordi, nel 2018, a guidare la cucina di Alpinn (un magnifico ristorante-rifugio in quota ove Cook the Mountain è declinato, in modo smagliante, alla portata di molti) è infatti un altro trentenne: Fabio Curreli



Ma la sfida educativa ora si fa più complessa, perché si sposta dalle cucina alle aule universitarie. Da poco Niederkofler ha infatti assunto un insegnamento presso l’ateneo di Bolzano. L’epigrafe del corso è assai chiara: Scienze enogastronomiche di montagna . L’obiettivo è quello di formare esperti capaci di elevare l’alimento a cultura, conferendogli una nuova identità e indagando i rapporti tra produzione, prodotto, territorio e consumo, secondo una innovativa visione multidisciplinare. Con un fine, che è un pensiero, che è un sogno: contribuire alla costruzione di un mondo migliore.
Solo pensieri e solo sogni? No, se si guarda al percorso intrapreso da Niederkofler. Perché il pen siero – scriveva già Platone – «non ha limiti». E perché – potrebbe aggiungerebbe Shakespe are – «tutti noi siamo fatti della stessa so stanza di cui sono fatti i sogni...»
Alpinn Plan de Corones 11 - 39031 Brunico (BZ) Tel. 0474.431072 - www.alpinn.it di Gianluca Montinaro
di Gianluca Montinaro
Era il 1815. Si scriveva la Storia, in quell’anno. Nella fastosa Vienna, il principe di Metternich guidava a conclusione quel congresso delle potenze vincitrici che avrebbe ridisegnato i confini dell’Europa dopo la bufera napoleonica.
Nella minuscola Cervere, a metà strada fra Fossano e Bra, lungo la ‘via del sale’ che collegava Torino al mare, Alessandro Vivalda apriva, in un imprecisato giorno di primavera, i battenti di una locanda di posta.
Il momento era propizio: si poteva sperare in una vita migliore. Si poteva sperare che, lungo quella strada che aveva visto per anni il transito delle truppe, con il loro passo cadenzato, lo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli e il cigolio degli affusti di cannone, prendessero nuovamente a passare i
carri di coloro che trasportavano vino e nocciole sulla costa, tornando carichi di sale, olio e acciughe. La Storia, e le storie. A volte, però, sono le seconde a perdurare alla prima. Così se dell’Europa di Metternich e della Santa Alleanza non è rimasta traccia alcuna, spazzata via dai moti risorgimentali, dai crolli delle monarchie e da due guerre mondiali, di quella locanda di posta, e di quella famiglia, la saga non solo continua ancora, ma fiorisce sempre più con rinnovata forza e vigore.
Sarà per il solido attaccamento alla propria terra. Sarà per il puntuale rispetto della propria tradizione. Sarà per la profonda consapevolezza di avere un proprio posto nel mondo. Saranno tutte queste cose, e molte altre ancora che sfumano nelle indefinite pulsioni dell’animo umano, se da allora,
da 213 anni, la famiglia Vivalda porta avanti la ‘sua’ storia, ancora lì, pronta ad accogliere gli ospiti nella loro locanda, ora divenuta uno dei ristoranti più blasonati e raffinati d’Italia: l’Antica Corona Reale .
Un luogo ‘proprio’, l’Antica Corona Reale: che è fulgido stemma della gastronomia piemontese. Che è massimo emblema di come una tradizione secolare possa, giorno dopo giorno, rinnovarsi rimanendo profondamente fedele a se stessa. Che è esempio da manuale di come una cucina possa attraversare il tempo senza infedeltà.
‘Classica’, ecco, si potrebbe dire. Ma non nell’errato modo con il quale si abusa di questo bell’aggettivo. Piuttosto nel vero significato del termine: ‘classico’ come elemento perenne e vitale in grado di incidere sul presente e segnare la via del futuro.
D’altronde, fra queste mura, tradizione tradite e tramandamenti traditi, la fanno da padrona, di generazione in generazione. E non potrebbe essere altrimenti perché qui le ricette «risalgono ai tempi dei nonni, che a loro volta le avevano imparate dai loro nonni», ricorda Gian Piero (classe 1968), Vivalda della settima generazione, con il suo sguardo mite, appena mimetizzato dai sottili occhiali, dietro il quale si celano tenacia, perseveranza e passione.
Una stirpe di cuochi, la sua: votata al lavoro con quella dedizione di piglio sabaudo che Gian Piero ha appreso dal padre, l’amato Renzo, scomparso da poco più di un anno. Una figura indimenticabile la sua, perché legata a quelle epopee
di Langa che hanno reso celebre questa terra: gesta di famiglie di vigna che, con lungimiranza, hanno portato i vini di queste colline all’attenzione del mondo. Facendo sì poi che il mondo arrivasse in Langa. Per vederne il paesaggio, respirarne l’atmosfera, gustarne la cucina.
Qui, negli ormai lontani anni Ottanta, oltre le due ‘colonne d’Ercole’ (a Costigliole d’Asti una, e a San Giacomo di Boves l’altra), appena due nomi, a Monforte e ad Albaretto, a spiccare sulle tante trattorie, perlopiù di buona qualità, che sorgevano su bricchi e declivi.
Ma Renzo la cucina l’aveva nel sangue. Ne aveva appreso rudimenti e segreti da suo padre Eugenio , palato fino. Aggiungendo di suo un amore viscerale per i prodotti della sua terra: il porro di Cervere (ora tutelato da un consorzio, nato nel 1996 anche grazie agli impulsi di Renzo), le rane, le lumache... materie prime straordinarie che Renzo valorizzava nei suoi piatti, mettendone in risalto quelle caratteristiche precipue che le rendono uniche.
Piano piano la fama di questa insegna (che all’epoca era stata nominata semplicemente «da Renzo») prese a travalicare i confini dello stretto circondario, divenendo sinonimo di piatti semplici, ma ben fatti.
Ma la svolta da osteria di paese a ristorante avviene grazie a Gian Piero . «Nonno Eugenio mi aveva trasmesso una grande passione: mi aveva fatto conoscere regole e piaceri della cucina. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera di Mondovì presi a fare le stagioni, al mare e in montagna, in

porcini scavati • polvere di camomilla • polvere di prezzemolo • polvere di funghi • sale Maldon q.b.
Per la salsa Duxelles g. 300 di gambi di porcini
• g. 30 di guanciale • g. 60 di panna • g. 50 di burro
• g. 50 di scalogno • 1 foglia alloro • g. 10 di pan grattato
Per il fondo di funghi
6 gambi di porcino • 1 costa di sedano • 1 carota •
1 cipolla • g. 150 di pomodori • g. 750 di Marsala • lt. 2,5 di acqua
Per il gambo dei funghi g. 200 di gambi di porcini
• g. 100 di petto di pollo • g. 40 di albume • g. 25 di panna • g. 3 di sale
Per la crema di Bra Duro
g. 200 di panna • g. 200 di latte • g. 100 di Bra Duro
• g. 10 di sedano • g. 10 di cipolla • g. 10 di carota • olio evo q.b.
Per il fondo di funghi: rosolare le verdure tagliate in mirepoix, bagnare con il Marsala e aggiungere l’acqua. Far cuocere per circa 4 ore, filtrare e ridurre (legare con kuzu 50 g./kg.).
Per la salsa Duxelles: tagliare in brunoise i gambi dei porcini, stufarli in casseruola con burro, alloro e scalogno tritato, unire il guanciale e far cuocere a fuoco basso, togliere l’alloro e unire la panna, far asciugare e unire il pan grattato.
Per il gambo dei funghi: pulire i gambi dei porcini, tagliarli a fette spesse, cuocerli in forno a vapore a 100 °C per 5 minuti, raffreddarli e asciugarli bene. Unire il pollo tagliato, l’albume, la panna e il sale e frullare per ottenere un composto liscio, stenderlo sulla pellicola, metterci dentro la duxelles di porcini, arrotolarlo e cuocere il forno a vapore a 100 °C per 10 minuti.
Per la crema di Bra Duro: tagliare le verdure in brunoise e farle stufare con poco olio, aggiungere panna e latte e portare a bollore, togliere dal fuoco e unire il Bra Duro grattugiato a microplane.
Scottare le cappelle dei funghi in burro chiarificato con aglio e rosmarino, mettere la crema di Bra Duro alla base del piatto, cospargere con le polveri di camomilla, prezzemolo e porcini, adagiare i funghi, glassare con il fondo e finire con sale Maldon.

Italia ma soprattutto all’estero. Fra l’una e altra rientravo a Cervere, a dare una mano. Poi, nel 1994, mio nonno mi spinse ad affiancare mio padre in cucina: per crescere decisi di intraprendere un percorso formativo che mi ha portato in Francia, a fare esperienze da Georges Blanc, Alain Ducasse, Alain Dutournier... Quando tornavo a Cervere pensavo a quei modelli. All’inizio fu difficile spiegare alla mia famiglia quello che avevo in mente e ottenerne l’approvazione».
La necessità di riempire la sala, il desiderio di non deludere i clienti abituali, la mancanza di uno staff adeguato spingono Gian Piero ad affrontare il percorso di cambiamento a piccoli passi: «io pensavo a piatti complessi, ma ai fornelli lavoravo con due o tre persone, quindi dovevo porre quelle idee nel cassetto, accantonandole per il futuro e sviluppando piano piano il mio progetto: assumere un dipendente in più, poi un altro e un altro ancora, poco a poco. Fino a oggi che l’Antica Corona Reale conta una quarantina di collaboratori. È stato un processo progressivo. Abbiamo anche fatto educazione del gusto: serve tempo, ma la clientela alla fine si seleziona da sola».
Giorno dopo giorno Gian Piero ripensa com -

pletamente l’approccio alla cucina, con un obiettivo: «migliorare ogni fase, ogni particolare: come sfilettare il pesce, come scegliere e come cucinare le verdure, come costruire le paste ripiene... sino a giungere al pane, ai grissini, ai lievitati. Occorre conoscere le caratteristiche di tutti gli ingredienti, quindi i prodotti che arrivano dai fornitori. Si sviluppa così un bagaglio di conoscenze e contatti, che ci si porta dietro, si arricchisce e ti arricchisce. Insomma, per azzerare l’errore sono necessari tanto lavoro e una ricerca continua sul prodotto e sulle tecniche: solo così si può raggiungere la perfezione. Ed è una sfida che, ancora adesso, affrontiamo tutti i giorni». Una cucina di terra e di acqua (sia dolce, sia salata) quella di Gian Piero il quale, se da un lato è stato capace, nei suoi piatti, di nobilitare come non mai gli ingredienti del territorio, facendoli conoscere a livello nazionale, dall’altro non ha mai rinnegato quelle ricette ( l’anguilla in carpione; i gobbi ai tre arrosti al tovagliolo; la trippa al cipollotto selvatico; la finanziera in doppia cottura , secondo la tecnica messa a punto da Renzo...) che da sempre sono patrimonio di questo luogo magico. Le ha solo ingentilite, donando loro un tocco di classe superiore che le rende memorabili.
scampi pomodori confit prescinsoa limone candito foglie di senape pimpinella melissa
Per la pasta bianca
kg. 3 di farina 00
kg. 1 di farina di semola
g. 1800 di tuorlo
g. 550 di uova intere
Per la pasta verde
g. 760 di farina 00
g. 260 di farina di semola
g. 350 di tuorlo
2 uova
clorofilla di spinaci
Per la bisque
g. 500 di carapace di scampi
g. 50 di cipolla
g. 50 di sedano
g. 50 di carote
g. 80 di vino bianco

g. 10 di concentrato di pomodoro
Per la pasta: mescolare le due farine poi aggiungere le uova unite al tuorlo in tre volte. Procedere allo stesso modo per la pasta colorata. Mettere sottovuoto e lasciar riposare per minimo 24 ore. Alternare la pasta bianca e quella verde in modo da creare una sfoglia unica e tagliare delle strisce di circa cm. 25 di lunghezza.
Per la bisque: stufare le verdure, unire i carapaci e farli tostare leggermente, bagnare con il vino, unire il concentrato e coprire con acqua e ghiaccio, far cuocere 40 minuti e filtrare, ridurre la salsa e montarla al burro.
Cuocere la pasta per 1 minuto, costruire la lasagnette su 4 strati, in ognuno mettere la prescinsoa, uno scampo al vapore cotto 2 minuti, un pomodoro confit, il limone candito e le erbe. L’ultimo strato deve essere sopra alla pasta, quindi completare con la bisque.

crostini di pane
g. 30 di Raschera
g. 110 di panna
1 uovo
g. 1 di sale
g. 2 di parmigiano
g. 10 di tartufo bianco
Tagliare il pane a cubetti di cm. 0,5 e farli asciugare in forno a 60 °C per 2 ore; tagliare il Raschera a cubetti di circa mezzo centimetro.
Nella cocotte mettere il pane, il Raschera, l’uovo intero facendo cura a non romperlo, il sale, coprire con la panna e finire con il parmigiano.
Cuocere la cocotte in forno a 200 °C e 43% di umidità, per 6/7 minuti. Finire con il tartufo bianco.

Classe superiore e alta scuola che trovano piena espressione in tre aspetti su tutto: l’attenta esaltazione dei profili aromatici e gustativi, senza confusioni, ridondanze, sovrapposizioni o inutili tecnicismi; il sapiente impiego e i millimetrici abbinamenti degli elementi vegetali, che spesso diventano co-protagonisti dei piatti (valido esempio possono essere tanto uno dei ‘vessilli’ dell’Antica Corona Reale, le lumache di Cherasco ai porri di Cervere, mele renette e radici , quanto il meraviglioso cuore fondente di cardo gobbo di Nizza Monferrato sulla sua tapenade all’acciuga, guanciale affumicato, Parmigiano croccante, zabaione salato al Rum e tartufo bianco); la perfezione delle cotture (da manuale, per esempio, quelle dello scamone di Fassona con salsa al tuorlo d’uovo sodo, fagiolini al sambuco e ciliege sott’aceto e del capretto di Roccaverano allo spiedo con purea di broccoli e rape violette).
In carta si rintracciano anche alcune raffinate inflessioni francesi. La scaloppa di fegato d’anatra, proposta su coulis di fichi neri al sambuco in agrodolce , è un piccolo capolavoro: insolitamente alta rapisce per i suoi contrasti di texture (croccantemorbido) e gusti (dolce-amaro).
Mentre le cappesante della Normandia in due consistenze ai funghi porcini e tartufo bianco colpiscono per sontuosità e finezza.
Negli anni, oltre alla cucina, anche il luogo è cambiato. Sin da principio Gian Piero ha voluto

riportato in auge il vecchio nome dell’insegna, «Antica Corona Reale», non solo per mero omaggio ai due secoli di storia di questo luogo, ma per onestà: qui si sarebbero gustati piatti con un cuore e un’anima: piatti capaci di emozionare.
E se si ammira ora l’Antica Corona Reale, con la sua bella articolazione delle sale (peraltro appena ristrutturate), il servizio dal perfetto incedere (sotto l’attenta regia di Davide Ostorero), l’estesa cantina, gli ampi spazi esterni, il crepuscolare pergolato, il curato giardino delle rose (progettato dal principe degli architetti paesaggisti: Paolo Pejrone), il magnifico orto, le perfette aiuole dei semplici, il laboratorio all’avanguardia (Atelier Reale) che si occupa della panificazione e della produzione di squisiti panettoni e colombe, si ha sì la netta impressione di trovarsi in una grande maison, ma con un cuore e un anima enormi.
Cuore e anima di una famiglia votata alla accoglienza da oltre due secoli. Cuore e anima di un cuoco coraggioso che ha fatto di una osteria di paese una tappa imperdibile nel firmamento della grande cucina italiana.
 Antica Corona Reale
Antica Corona Reale

Via Fossano, 13
12040 Cervere (CN)
Tel. 0172 474132
www.anticacoronareale.com

Uno dei temi più dibattuti nel “pensiero gastronomico”, ammesso che questo esista (noi, personalmente, non ne dubitiamo), è se un piatto d’autore possa assurgere a rango di opera d’arte. In un empito di modestia o forse di paura, supportato da raffazzonati concetti di pseudo-scienza, molti sono giunti a convergere sul punto che un grande piatto possa essere - al più - espressione di artigianato, ovvero di “alto artigianato”, con una impalpabile e indefinita tensione verso l’elevatezza dell’aggettivo.
Fatta salva una sparuta minoranza che non ci sta e, incurante delle critiche, ascrive al mondo dell’arte tout-court i piatti di Marchesi, Bottura, Mugaritz, i più si limitano a esultare quando un grande chef viene ospitato tra le mura di una grande struttura museale, come se quella dicitura, “museo”,
legittimasse l’ascesa del prodotto artigianale nell’empireo dell’espressione artistica.
È una polemica già superata: che il cibo possa essere considerato “arte” in senso stretto conta poco, quel che è certo, è che il cibo può avere la medesima potenza espressiva di un’installazione o di una scultura contemporanea, la medesima “potenza del divenire”.
Sono sempre i giovani a guardare oltre, a vedere con occhi diversi la realtà e a sfidare la sua (supposta) immutabilità.
Poi, quando ciò accade nella città affascinante, borghese, ma storicamente chiusa e un po’ provinciale del film “Signore e Signori” di Pietro Germi, e non a Berlino o a Londra, la faccenda si rende più intrigante.
Quella di TAD (Treviso Design District) e di Vite è una storia di incontri ambientata - giustappunto - a Treviso, città placida, benestante, autarchica.
TAD ha aperto nel 2018 grazie all’idea dell’imprenditore locale Diego Vanin , col patrocinio della famiglia Benetton. Si è progressivamente espansa fino all’apertura di 21 Gallery , un grande spazio espositivo con la collaborazione del gallerista Massimiliano Mucciaccia e il patrocinio – nientemeno - dell’architetto inglese David Chipperfield , lo stesso che ha disegnato il MUDEC di Milano che ospita il tristellato Enrico Bartolini.
E da qualche mese è arrivato anche Vite-Ristorante : 300 metri quadrati per 25 coperti distribuiti su tre piani, ognuno dedicato a un diverso brand o artista, con gran parte degli arredi disponibili per la vendita.
Diego Vanin aveva bisogno dell’ultimo anello della catena per completare il progetto: uno chef giovane, talentuoso, che con le sue idee sposasse il senso del “divenire continuo” dell’arte contemporanea. Uno in grado di stupire, di adattarsi al ritmo delle stagioni, di non lasciare il cliente indifferente o, peggio, cullato nella “comfort zone” di un territorio a volte un po’ autoreferenziale.

CON LATTE DI ANGELICA E CICORIA
PASTA FRESCA
g. 90 di acqua bollente • g. 200 di farina 00 • 1 pizzico di sale • 1 pizzico di acido citrico
Procedere come per una normale pasta senza uovo utilizzando l’acqua a 95 °C.
RIPIENO
g. 200 di succo di brovada • g. 10 di kudzu • 1 pizzico di sale
Ridurre del 50% il succo della brovada e legare con il kudzu come se fosse una polenta. Raffreddare e sbattere in planetaria per ottenere un composto da sac à poche.
LATTE DI ANGELICA
g. 50 di latte di cocco • g. 20 di radice di angelica • miso chiaro a gusto • g. 50 di panna vegetale
Scaldare il latte di cocco con la panna vegetale e infondere la radice di angelica. Filtrare, ridurre e portare a gusto con il miso.
BITTER DI CICORIA
g. 50 di succo di cicoria • g. 50 di Inca bitter neutro • Ultratex
Miscelare uguale quantità di succo di cicoria e bitter, lasciare macerare due giorni a temperatura ambiente. Portare a consistenza con Ultratex.
POLVERE DI MISO
g. 50 di miso
Stendere il miso sul Silpat ed essiccare a 75 °C, quindi polverizzare.
Stendere la pasta, coppare a 3 cm, farcire e chiudere a tortellino. Cuocere i tortellini in acqua non salata per 20 secondi e glassarli in un’ulteriore dose di acqua di brovada.

Disporre i ravioli sul piatto e nappare con il latte di angelica. Aggiungere alcune gocce di bitter di cicoria, la polvere di miso e gocce di olio di miso di soia e peperoncino.
Peregrinando, ha incontrato Simone Selva , classe ’97, studi classici alle spalle, spiccata attitudine all’ordine mentale, allievo di Lorenzo Cogo e di Francesco Brutto, in forza a Wisteria , Venezia città.
Segni particolari: la più giovane stella Michelin nell’edizione 2021 della “rossa”. E uno che a 23 anni si piglia il primo macaron, nel bailamme della pandemia, tra gli addetti lavori intenti ad accapigliarsi perché Tizio a 40 non l’ha ancora presa e quella maledetta seconda a Caio non l’hanno ancora appuntata sulla giacca, non può che essere un piccolo fenomeno. Selva non si aspettava una proposta così repentina, ha dovuto pensarci su. “Stavo bene a Venezia, ho dovuto prendermi un paio di giorni per riflettere, ma ho accettato la sfida”. Non vorremmo infrangere oscuri segni scaramantici da parte di Vanin&Co., ma è abbastanza chiaro – e legittimo - che la proprietà accarezzi il desiderio di riportare a Treviso la stella che è mancata con il trasferimento di Francesco Brutto a Venissa, nella dorata solitudine della laguna veneziana.
Secondo il parere del pubblico, che sta decretando il successo di Vite, non dovrebbe mancare molto anche se noi non diciamo nulla in segno di scaramanzia.
“Francesco Brutto è stata la mia influenza principale, con i suoi ingredienti spiazzanti, ma mai sovrabbondanti di numero. Lui era più deciso nei contrasti, io preferisco essere un po’ più rotondo. Mi piace lavorare con la maturazione degli ingredienti, le fermentazioni, le erbe spontanee, i profumi del bosco e gli imprescindibili ingredienti locali che non mancheranno mai dalla mia carta”.
Da Wisteria ha portato i due piatti più rappresentativi, quelli che gli hanno valso il riconoscimento Michelin, tra cui le geniali “pennette alla lambic” cucinate in infusione nella birra belga alla ciliegia e finite con ragù di anguilla e foglia di geranio, per un’espressione inedita del contrasto amaro/ dolce, e il piccione (di Laura Peri) con cannella, tabasco e olivello spinoso. Questi due piatti sono considerati “classici” e possono essere aggiunti al menù contemporaneo sempre in evoluzione, concepiti appositamente per Vite e non frutto di esperienze pregresse.

Gli altri piatti sono stati concepiti appositamente per Vite, all’insegna della sua filosofia, come i gamberi rossi in saor con animelle e foglie tenere di cipresso, in cui la fermentazione prende diretto spunto dalla tradizione litoranea veneta, o la stupefacente pecora trevigiana con sauternes e carciofi .
A questi si aggiungono, ad esempio, il tortello alla gallina, curry giallo, sedano rapa e aceto di caffè, e l’anguilla chiocciole e levistico rispettivamente dai menù stagionali di carne e pesce, entrambi a 70 euro.
Un pensiero ai vegetariani, su prenotazione a 60 euro e ai temerari: “L’avventura nel multiverso di Rick&Morty”, da 9 a 12 portate a 100 e 120 euro, con promessa di abbinamento vini scintillante.
SCAMPI IN SAOR
g. 150 di cipolla rossa di Tropea • g. 8 di olio di semi • g. 40 di aceto balsamico bianco • g. 40 di Vermouth bianco • g. 8 di zucchero • g. 4 di sale • 1 foglia di alloro • g. 40 di vino bianco • g. 1 di pepe bianco • g. 50 di brodo dashi • g. 30 di code di scampi • farina di semola q.b. • 5 pinoli tostati • 3 acini di uvetta ammollata
Procedere come un tradizionale saor appassendo la cipolla tagliata finissima con l’olio di semi, condire e asciugare sul fuoco. Sfumare con l’aceto bianco, il vermouth e il vino bianco; quindi aggiungere gli aromi, ridurre sul fuoco e portare a cottura con il brodo dashi. Terminare con uvetta e pinoli. Friggere in olio a 200 °C gli scampi infarinati per 20 secondi. Unire le due preparazioni e macerare in cella 5 giorni.
SUCCO DI CIPRESSO foglie giovani di cipresso • acqua • Xantana
Bagnare le foglie in acqua e passarle all’estrattore. Portare a consistenza con Xantana e mettere da parte.
g. 90 di animelle di cuore • ml. 500 di latte • ml. 500 di court bouillon
Lasciare riposare una notte le animelle nel latte. Sciacquarle, asciugarle e sobbollirle 35-45 minuti nel court bouillon. Raffreddare le animelle in acqua e ghiaccio e pulirle scrupolosamente eliminando pleura e vene. Maturare due giorni in cella.
GLASSA
1 noce moscata frantumata • g. 10 di glucosio • g. 50 di acqua di pomodoro • g. 50 di Garum di pomodoro • g. 50 di succo di datterini arrosto • g. 50 di brodo scuro di vitello • g. 5 di burro di cocco
Unire gli ingredienti sul fuoco fino a glassatura, emulsionare con burro di cocco.
IMPIATTAMENTO
Rosolare a fiamma viva le animelle con burro chiarificato, glassarle e comporre il piatto con gli scampi in saor, il succo di cipresso e guarnire con foglie di begonia e fiori di gelsomino.
Vite
Viale della Repubblica 3
31020 Lancenigo di Villorba (TV) Tel. 375 5644295
www.tadtreviso.com/vite
Il tema della sostenibilità nell’intervista dopo l’annuncio

Uno di pilastri della cucina danese si basa sui prodotti di prossimità o di stagione, il che è esattamente la tendenza in atto in tutto il mondo della ristorazione: kilometro zero e colture del territorio rappresentano ormai valori imprescindibili sia per la tutela dell’ambiente, che delle biodiversità locali.
In questo contesto, due sono gli ingredienti principe della cucina danese: il cavolo cappuccio e le patate, a cui si aggiungono anche la carne di maiale, il pesce e il pane di segale. Chi ha frequentato le tavole di Copenaghen ricorda sicuramente gli smørrebrød (panini aperti), ma anche il piatto nazionale, lo stegt flæsk , preparato con pezzi croccanti di maiale fritto, servito con patate bollite e salsa di prezzemolo. Un piatto che, insieme agli smørrebrød , ha alimentato decine di generazioni.
È a queste matrici identitarie, arricchite con tutto ciò che ha imparato nei suoi viaggi, Giappone in primis, che René Redzepi vuole tornare, dopo la clamorosa recente notizia di voler di nuovo chiudere il suo locale, ritenendolo inadatto al perseguimento del progetto di sostenibilità che da sempre sottende la sua ricerca.
L’intervista con René Redzepi inizia a poche ore dalla dichiarazione che ha fatto parlare tutto il mondo e che sta scuotendo le certezze dell’haute cuisine. Ma analizziamone la genesi... Il suo stile di cucina, caratterizzato da audacia, ricerca, rottura degli schemi abituali, si è consolidato proprio a partire dalle sue radici, affiancate da esperienze in diverse parti del mondo, accanto a stelle del firmamento gastronomico.

È il 2002 quando Claus Meyer gli offre la gestione della cucina del ristorante North Atlantic House , una taverna del XVIII secolo che si stava trasformando nel cuore pulsante della cultura danese. È stata questa la spinta propulsiva che lo ha portato, due anni più tardi, a inaugurare il proprio locale, il Noma , in un
antico magazzino ristrutturato affacciato sul mare, nella località di Christianshavn.
Qui, ad appena 40 anni, Redzepi avrebbe reinventato la cucina nazionale e conseguito il risultato di vedersi riconoscere le ambite tre stelle Michelin. Ma ciò non gli è bastato per mettersi tranquillo. “Ho sempre bisogno di mettermi in discussione e di cambiare”, ci spiega. E a riprova di questa sua forte necessità, non si è accontentato del successo, ma ha addirittura deciso di chiudere una prima volta il locale che faceva parte dei 27 ristoranti danesi che contavano, tra tutti, ben 38 stelle Michelin. Dunque, nel 2018 Redzepi, non più appagato dal solo fatto che tutto gli andasse bene, sentiva che, nonostante i riconoscimenti e le centinaia di gourmet che lo acclama -

vano e gli riempivano di prenotazioni il locale, doveva ricominciare da capo. Ha quindi ripreso a girare il mondo, si è lasciato contaminare dalle tendenze, sprofondare in nuovi gusti e investire da esperienze provenienti da tutti i punti del pianeta. Quando è tornato, giusto a pochi metri da quello che era stato il primo amore, ha seminato il Noma 2.0 in uno spazio ancora in costruzione, disegnato da Piet Oudolf , il paesaggista e creatore del parco di oltre due chilometri, l’ High Line , costruito sulla vecchia ferrovia sopraelevata a New York .
E subito, nel 2021, il nuovo ristorante si è ritrovato catapultato al primo posto nella lista dei The World’s 50 Best Restaurants della rivista Restaurant, dove ancora oggi si trova come The Best of the Best.

René, amante dei prodotti di prossimità, ha voluto aggiungere nella attuale versione del suo ristorante un proprio orto ecologico e mettere in piedi una cella di fermentazione, così da non disperdere neanche un po’ del proprio stile personale.
In questo modo è tornato a piantar bandiera sul concetto di stagionalità. Coerente, inarrestabile, con la propensione all’indagine naturalistica tipica degli artisti del Rinascimento, ad ogni suo passo è riuscito a trasmettere la tesi della necessità di rinascita ciclica come filosofia esistenziale nei suoi libri di ieri e di oggi: “Noma: nordisk mad” nel 2006 e “Noma: Time and Place in Nordic Cuisine” nel 2010.
Nel 2015 ha ideato il documentario “Noma My Perfect Storm” dove ha cercato di mostrare senza mezze tinte tutte le problematiche di un ristoratore che si fa carico di un progetto di tale portata.


In “A Work In Progress” (Lavoro in corso), la sua ultima opera, si autodefinisce come un ”percorso in evoluzione” e preannuncia una nuova inversione di rotta. Non si smentisce e il risultato è la dichiarazione della prossima, reiterata, chiusura.
“Sento di essermi nutrito di molte influenze – e le enumera -: “quella mussulmana, quella albanese, quella macedone... ma anche delle esperienze legate alla carestia del dopoguerra vissuta da mio padre.
Queste hanno avuto un impatto sulla mia cucina e anche sulle mie decisioni odierne.
Mio padre ha contribuito molto, con le sue origini slave, a imprimermi una visione cosmopolita e mutevole delle cose, mia madre danese ha aggiunto invece una sua visione più localistica.
Trovo tuttavia qualcosa in comune in entrambe le influenze che mi hanno trasmesso: il fatto di fare uso di ciò che c’è sul mercato o che viene dai raccolti, la volontà di mangiare tutto e di “reinventare” ciò che per molti è da buttare, di apprezzare le biodiversità, per quanto poche possano eventualmente essere, e diventare responsabile dell’acquisto di ciò che si mangerà come consapevole artefice e protagonista nella preparazione del cibo.
Non è però più possibile realizzare questo qui ed ora, perché vedo sempre di più tutti i limiti del fine dining, primo fra tutti la non sostenibilità economica, lavorativa e ambientale”.
In piena coscienza, con indubbio coraggio e con innegabile onestà, Redzepi ha deciso ancora una volta di rivoluzionare la sua vita e il suo destino per dare vita a nuovi progetti, uno dei quali è quello di reinterpretare il modo con cui procurarsi il cibo e di proporlo. “Foraging” è stato dunque il termine e la pratica quotidiana con cui Renè intende realizzare il suo nuovo corso.
“Si tratta di andare alla ricerca del cibo approfittando concretamente di tutto ciò che la natura ci offre” - ci spiega. “In questa ottica, il futuro Noma deve diventare semplicemente un mezzo per prendersi cura con coscienza del pianeta”. Per questa ragione le sale del locale riapriranno saltuariamente su progetto e altri locali, anche temporary, saranno sparsi nel mondo per diffondere, in modo accessibile, la filosofia della casa.
La sua prima stagione di lavoro è già prevista a Copenaghen, ma già si vocifera sull’apertura di un Noma in Giappone .
Sulla traiettoria del rinnovamento ha intanto appena lanciato Noma Projects , una linea di prodotti home made. Il primo esemplare è un garum di funghi che è la versione attuale di un suo piatto della memoria.
Non è esente dalle sue riflessioni il fatto che “ nei ristoranti si lavora molto e si guadagna poco. Il nostro margine si aggira infatti sul 3%. Le strade per modificare la tendenza in atto sono limitate: o triplichiamo i prezzi o cerchiamo un nuovo modello di business. La nostra linea di prodotti fatti in casa è dunque una prima risposta a questo. Cerchiamo di proporre alimenti che consentano al personale di lavorare un 25% in meno per guadagnare un 25% in più”.
Purtroppo quello che si prospetta è una chiusura definitiva del Noma 2.0, programmata per l’inverno del 2024.
“Per il 2025 il nostro ristorante sarà ormai diventato un laboratorio: una cucina per esperimenti pionieristici volti all’innovazione alimentare e allo sviluppo di nuovi sapori. Verranno tempi nuovi per i ristoranti: dobbiamo trasformare la gestione e le risorse umane. Reinventarsi sarà la parola della gastronomia di questo decennio ”.
 Anatra selvatica alla piastra, cervello d’anatra, brodo di funghi e summaco selvatico.
Anatra selvatica alla piastra, cervello d’anatra, brodo di funghi e summaco selvatico.
Verdi striati di blu, con prodotti full color; tenacemente abbarbicati alla loro identità, culinaria non meno che linguistica; operosi e benestanti ben oltre la media nazionale; vicini ma non troppo alla Francia, culla della gastronomia mondiale. Sono molte le ragioni per cui i Paesi Baschi rappresentano il cuore della cucina spagnola, il cui cervello alberga nella pazza Catalogna di Ferran Adriá.
Qui alla fine degli anni ’70 deflagrò il movimento della nuova cucina basca, una specie di ’68 gourmet che vedeva sulle barricate ragazzi arrabbiati come Juan Mari Arzak e Pedro Subijana, oggi padri e nonni canuti di giovanotti altrettanto arrembanti. Perché il miracolo basco continua ad accadere, con nomi quali Andoni Luis Aduriz, punta di diamante dell’avanguardia mondiale, e Eneko Atxa , quarantacinquenne chef di Azurmendi .
Nella sua Larrabetzu si arriva percorrendo un lungo tratto di strada: il ristorante è una scatola avveniristica depositata dagli alieni in mezzo alla natura, per quanto ben collegata alle arterie di comunicazione. Tutt’intorno un verde fitto di piogge abbondanti, che irrorano gli orti antistanti l’entrata, piantati a crucifere che saturano l’aria di zolfo. Grandi vetrate, spazi squadrati, una cucina sterminata: il modernismo è severo nella sua linearità, posta al servizio di quello che è il principio ispiratore della cucina: la sostenibilità. A guidare la costruzione ex nihilo dell’edificio è stata la matematica dell’efficienza energetica, che significa utilizzo di materiali riciclati, pannelli solari e centrale geotermica per l’autosufficienza energetica, riciclo dell’acqua piovana immagazzinata per le esigenze di cucina. Tanto che nel 2009

è arrivata la certificazione LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) , seguita nel 2014 e nel 2018 dal titolo di ristorante più sostenibile del mondo ai 50 Best e da una scontata stella verde, oltre le tre d’ordinanza. Ma in questa cittadella di vetro c’è posto perfino per una banca del germoplasma a tutela della biodiversità.
Di fatto Eneko Atxa è un fenomeno, il più giovane tristellato spagnolo di sempre (nel 2012 aveva 35 anni) nonché un paradigma di successo e di stile uscito quasi dal nulla. Se ama ripetere che suoi mentori in cucina sono state la mamma e la nonna, maestre di identità basca, il suo apprendistato dopo la scuola alberghiera ha poi continuato a svolgersi in zona, presso mostri sacri come Victor Arguinzoniz di Etxebarri e soprattutto Martin Berasategui, fuoriclasse a Lasarte.

Nessuno tuttavia avrebbe pronosticato i suoi clamorosi exploit nel momento in cui aprì nel 2005 Azurmendi, così battezzato dal soprannome della madre. Presentendo con intuito esemplare voglie e umori del mercato. La biografia resta nel piatto, dove Atxa non perde occasione di omaggiare il terroir, che spesso ispira le composizioni attraverso il repertorio tipico. Gli svolgimenti tuttavia sono indubbiamente contemporanei, per tecniche avanzate e presentazioni epurate, al limite del giapponismo, in simbiosi con la linearità dell’architettura.
Nella centralità delle salse e dei grandi fondi, nonché nella sapienza delle cotture, c’è posto poi per tanta Francia, quella che senza varcare i Pirenei ha assorbito da sua maestà Berasategui. Ed è un mix che seduce e avvince un pubblico assolutamente eterogeneo, tanto il signorotto appassionato di pil-pil e kokotxas quando il sofisticato globetrotter gourmet. Ars est celare avanguardiam, verrebbe quasi da dire, mentre le ostentazioni e gli spettacolarismi bulliani e post bulliani cedono felicemente il passo a un astuto comfort di nuovissimo conio.
Non che la tendenza sia ignota: sono tanti e altissimo locati gli chef che lavorano alla definizione ipertecnologica, da schermo di ultima generazione, e alla iperconcentrazione dei gusti inconfondibili della tradizione, volgendo per così dire il classico, moderato per definizione, in anticlassico secondo un mulinello intrigante. Non ultimo il nostro Andrea Aprea con la sua cucina italiana, centrata come il mirino di un cecchino. Qui, tuttavia, quello stile trova la sua massima consacrazione oltre che il suo apripista, con tutti i rischi annessi e connessi. Non è facile, infatti, lavorare su crinali così ripidi evitando la stucchevolezza e l’assuefazione del palato, che si stanca in fretta di melasse adesive come ragnatele e di umami che si tagliano con il coltello. Proprio quello, probabilmente, diventa allora il virtuosismo.
Ed è uno stile che stupisce, in fondo, da parte di uno chef giovanile che si presenta come un rocker, con i capelli corvini e perfino gli orecchini.
“La cucina è stato il mio modo per superare la timidezza”, confessa. “Noi baschi siamo così: forti fuori e teneri dentro. Come i miei piatti”. Contrappuntano languide delicatezze floreali e riduzioni esasperate, integrità dell’ingrediente, madido di succhi verginali, e intensità vertiginose. Mentre la sostenibilità entra in campo aiutando la decantazione del gusto grazie a ingredienti freschissimi e cotture puntuali. La sostenibilità, insomma, diventa gusto puro, quali tecniche favorite le basse temperature di vecchio e nuovo conio, lunghe come lo svolgimento di un racconto popolare. In tempi in cui la creatività arranca, non sono pochi gli chef che hanno cercato di guadagnare la ribalta attraverso varie forme di impegno e nobili concioni, mentre magari alzavano i prezzi accogliendo solo super ricchi, sbarcati da aerei privati seminanti CO2 . È forte il sospetto, insomma, che chi parla di sostenibilità lo faccia per moda e convenienza, ad uso di un pubblico zeppo di moralismo e conformismo.
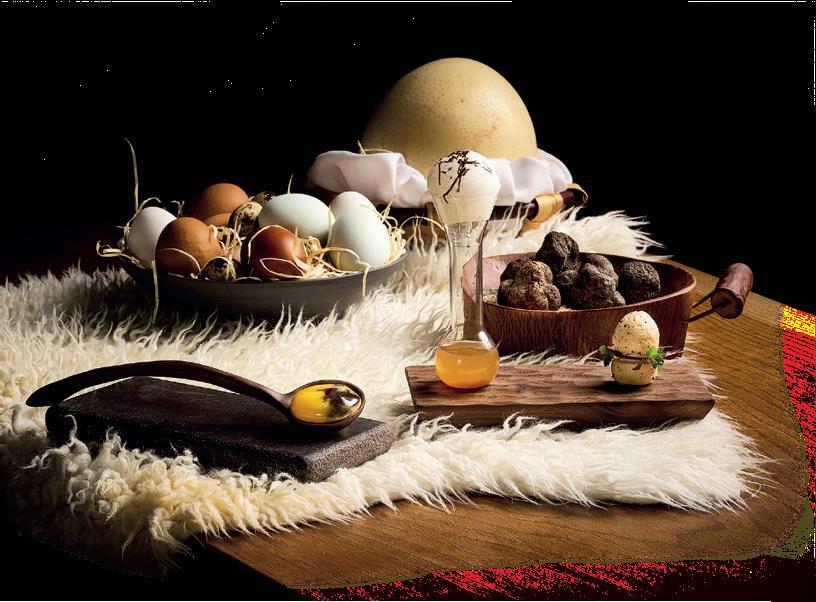
Eneko Atxa, tuttavia, fa indubbiamente sul serio, evitando al tempo stesso ogni riduzionismo. Non mira per esempio a produrre tutto in casa, quanto a mantenere viva la rete dei fornitori locali, a chilometro zero o poco più, assicurandosi che gli scarti tornino ai campi in forma di compost. Né esclude a priori la carne, che anzi nel suo ristorante gioca un ruolo di spicco, pur non essendo protagonista.
1 ostrica n. 0
Sbollentare l’ostrica in acqua bollente per un minuto, quindi raffreddarla in acqua ghiacciata. Aprirla con delicatezza, controllare che non ci siano schegge quindi tagliare le barbe e rimuovere il muscolo del piede. Pulirla con acqua fredda. Conservare le ostriche in gastronorm con buchi e ricoperte dalla pellicola.
TEMPURA (80 PAX)
g. 800 di acqua • g. 600 di farina di grano tenero • g. 400 di trisol • g. 12,7 di lievito • g. 8 di sale • g. 8 di zucchero
Sciogliere il lievito in una parte dell’acqua tiepida. Aggiungere il resto degli ingredienti e mescolare con una frusta fino a ottenere una massa omogenea. Passare attraverso un colino e conservare in frigorifero.
BRODO DI PROSCIUTTO
kg. 20 di osso di prosciutto oppure kg. 0,5 di ritagli di prosciutto
Pulire le ossa dagli scarti. Utilizzare i ritagli per il brodo nella proporzione indicata.
Mettere le ossa e gli scarti in una pentola e riempire d’acqua fino in cima. Portare a ebollizione e ridurre di oltre la metà a temperatura 6 su piastra a induzione per 2 giorni.
Far bollire delicatamente in modo che il brodo non diventi torbido. Mentre si sta riducendo, rimuovere tutte le impurità e il grasso che le ossa rilasciano. Filtrare e continuare a ridurre fino a ottenere il sapore desiderato. Il brodo deve risultare cristallino.
ZABAIONE DI PROSCIUTTO
g. 150 di brodo di prosciutto • 8 tuorli d’uovo
Mettere i tuorli nella planetaria e montarli a velocità 8. Nel frattempo scaldare il brodo di pro-
sciutto a 100 °C. Quando i tuorli saranno ben montati, aggiungere poco alla volta il brodo di prosciutto caldo.
Durante il servizio, lo zabaione continuerà a montare nella planetaria, quindi la velocità dovrà essere controllata in modo che mantenga la consistenza desiderata.
FRULLATO DI OLIVE
kg. 3,6 di olive ripiene di acciughe scolate • g. 10 di colorante alimentare verde
Passare le olive 2 volte nel frullatore. Passare l’impasto nel superbag. Aggiungere il colorante e frullare con il Bimby fino a eliminare i punti di colorazione. Mettere in frigo.
OLIO DI PROSCIUTTO
g. 400 di prosciutto • 1 pezzo di osso di prosciutto • g. 1200 di olio di semi di girasole
Mettete tutti gli ingredienti in una pentola e lasciare cuocere lentamente per 10 ore.
Passare attraverso un superbag e mantenere in freddo.
PROSCIUTTO IN POLVERE
g. 100 di prosciutto
Eliminare il grasso dal prosciutto e metterlo da parte per altre preparazioni. Affettare il prosciutto il più sottile possibile e metterlo su un piano riscaldato tra carta assorbente per una notte. Controllare che il prosciutto sia asciutto e friabile, in caso contrario metterlo di nuovo sul piano riscaldato finché non sarà completamente asciutto.
Una volta asciutto, ridurre il prosciutto in polvere dentro un macinino, azionandolo brevemente più volte per evitare che il grasso si sciolga. Conservare su
carta assorbente sul piano riscaldato.
EMULSIONE DI PROSCIUTTO
1 uovo • g. 15 di prosciutto in polvere • g. 1 di sale • g. 450 di olio di prosciutto
Aggiungere tutti gli ingredienti, tranne l’olio di prosciutto, nel Bimby e amalgamare bene. Aggiungere l’olio di prosciutto a filo, emulsionando il tutto. Continuare a emulsionare fino a ottenere una consistenza compatta. Aggiustare di sale e conservare in frigo dentro a una bottiglia.

TUILE DI OLIVA g. 600 di olive (senza liquido) • g. 7,5 di addensante • g. 0,7 di colorante alimentare verde
Mettere tutti gli ingredienti nel Bimby e mescolare fino a ottenere la consistenza desiderata.
Stendere su silpat e lasciare asciugare sul piano riscaldato fino a completa asciugatura.
Tagliare in pezzi di cm. 2,5 x 2,5.
ALTRI INGREDIENTI
fiori di campo (1 pax) • grasso di prosciutto • farina
Capovolgere il piatto, spennellare la base con un sottile strato di grasso di prosciutto e distribuirvi sopra la polvere di prosciutto esercitando una leggera
pressione. Posizionare 4 punti di emulsione di prosciutto facendo una croce, togliendo un po’ di polvere in modo che l’emulsione aderisca al piatto. Sui punti a sinistra, in alto e in basso mettere un fiore, uno per punto; in quello a destra adagiare la tuile di oliva. Al momento di servire, dare all’ostrica la forma di una sfera e passarla nella farina, togliere l’eccesso e passarla nella tempura, togliere l’eccesso quindi friggerla. Tagliare uno dei lati dell’ostrica in modo che possa essere visibile l’interno.
Mettere al centro del piatto un punto di emulsione di prosciutto, adagiarvi sopra l’ostrica con la parte aperta rivolta verso il cliente e aggiungervi sopra un cucchiaino di zabaione, quindi servire insieme al frullato di olive in vasetto.
BRODO DI MAIALE
30 musi di maiale • g. 750 di pancetta iberica • 3 cipolle • 3 pomodori • 3 carote • kg. 3 di ceci secchi
In una pentola disporre tutti gli ingredienti, tranne i ceci. Coprire con acqua e far ridurre di 4 dita, aggiungere i ceci. Filtrare e continuare a ridurre a fuoco basso. Sgrassare. Verso fine cottura passare il tutto attraverso un superbag e continuare a ridurre fino a ottenere la consistenza e il colore desiderati.
BRODO DI PROSCIUTTO
kg. 10 di ossa di prosciutto • g. 600 di ritagli di prosciutto • lt. 15 di acqua
Pulire le ossa del prosciutto rimuovendo tutta la carne. Mettere le ossa e i ritagli di prosciutto in una pentola; coprire con acqua. Mettere a ridurre su vetroceramica per due giorni eliminando costantemente la schiuma e il grasso.
È importante che il brodo bolla molto dolcemente in modo che non diventi torbido. Filtrare e lasciare ridurre a fuoco basso fino a ottenere il sapore desiderato.
GEL DI PROSCIUTTO
g. 500 di brodo di prosciutto • g. 6 di amido di mais
Aggiungere l’amido di mais al brodo di prosciutto caldo. Mescolare fino a ottenere un gel liscio.
TARTELETTA DI PASTA BRICK
pasta brick • 1 cucchiaio di burro • polvere di piselli
Sciogliere il burro, aggiungere la polvere di piselli. Stendere una sfoglia di pasta brick e spennellarla con il burro fuso. Incollarvi sopra un altro foglio di pasta brick. Pressare bene eliminando tutte le bolle che possono rimanere tra le sfoglie. Ricavare dalla pasta dei cerchi di 7 cm.
Mettere i cerchi di pasta sugli stampini per tartelletta capovolti e ricoprire con un altri stampi quindi cuocere in forno a 180 °C per 7 minuti. Sformare su carta assorbente. Controllare se le tartelletta sono dorate e croccanti, in caso contrario rimetterle nel forno per un altro minuto. Conservare su un piano riscaldato a 40 °C.
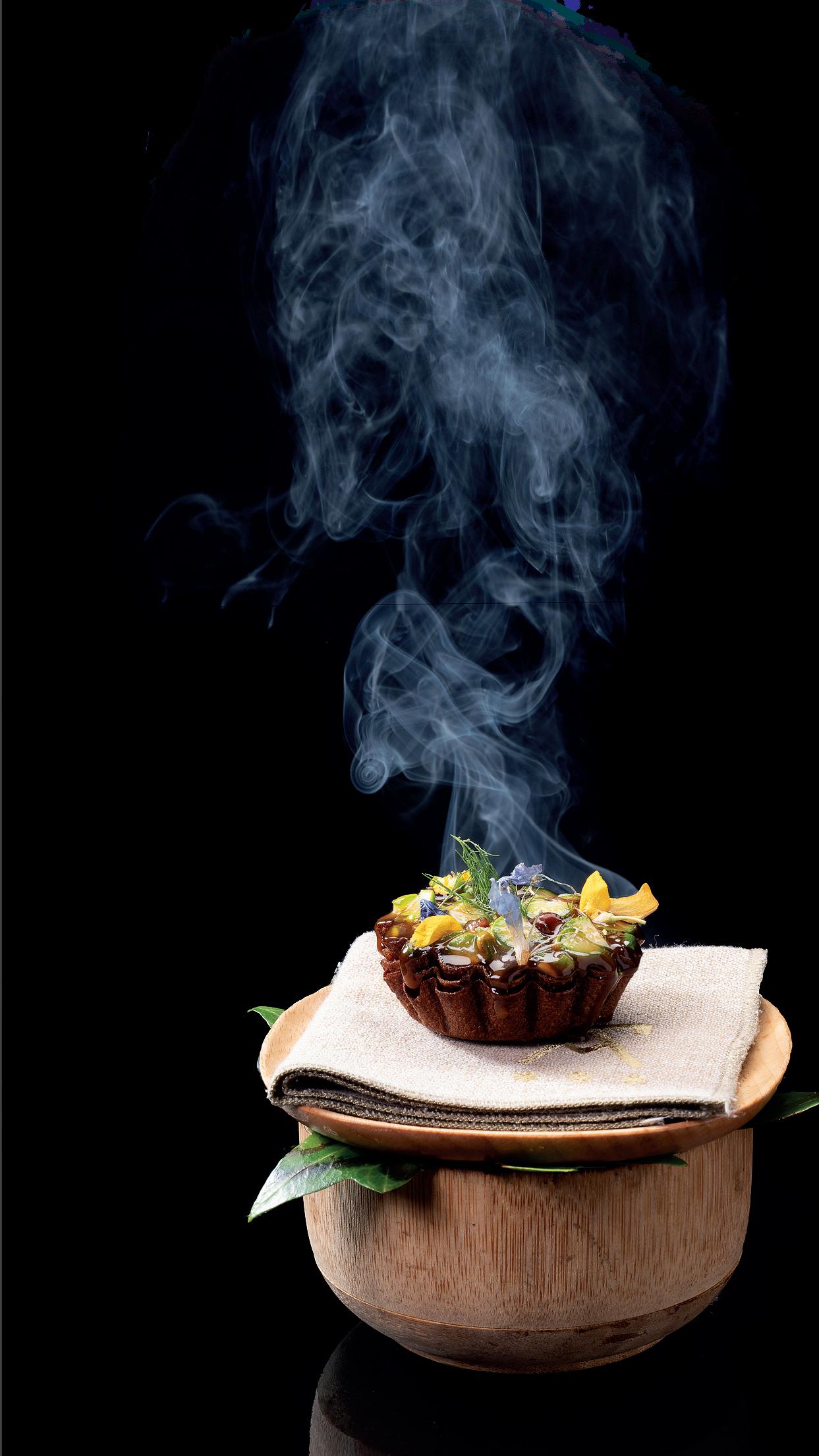
OLIO DI ERBA CIPOLLINA (70 PAX)
g. 170 di erba cipollina • g. 700 di olio di semi di girasole
Frullare l’olio con l’erba cipollina nel Bimby per 10 minuti a 40 ºC a velocità 8. Mettere un colino fine sopra un contenitore e filtrare l’olio per una notte. Il giorno successivo passare l’olio in un superbag e mettere da parte.
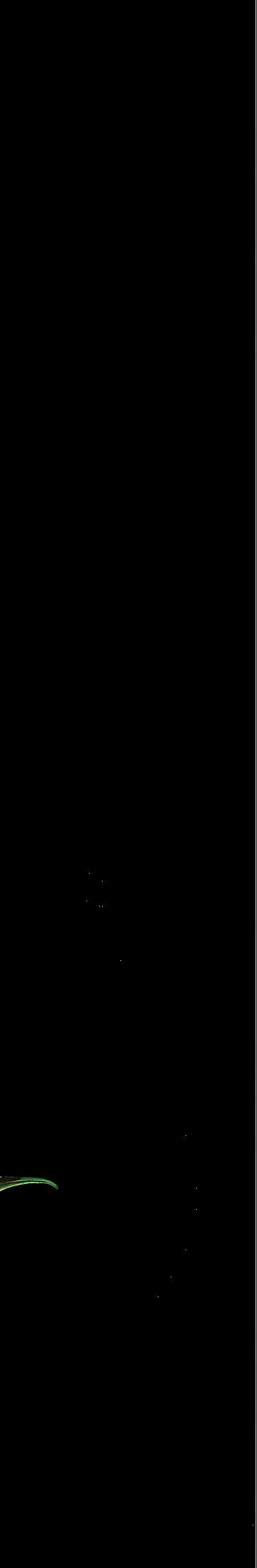
EMULSIONE DI CIPOLLA
2 uova • g. 872 di olio di erba cipollina • g. 4 di sale
Mettere le uova e il sale nel bicchiere del Bimby; frullare a velocità 3, aggiungendo gradualmente l’olio di erba cipollina fino a ottenere la consistenza dell’emulsione. Aggiungere un pizzico di sale.
ALTRI INGREDIENTI
18 piselli lacrima (1 pax) • fiore di ontano viola • erbe di prato essiccate • timo essiccato
Utilizzare come base due tartellette incollate con l’emulsione di erba cipollina per farle aderire una all’altra. Sopra la seconda tartelletta aggiungere altra emulsione di erba cipollina.
All’interno di una ciotola di legno mettere il brodo di maiale caldo. Accanto alla ciotola adagiare del timo essiccato che andrà bruciato con un cannello da cucina al momento di servire e coperto velocemente con un coperchio di legno in modo che il fumo non fuoriesca.
Al momento della passata, sbollentare i piselli in acqua bollente per 10 secondi. Scolare e mettere in un riduttore insieme al gel di prosciutto e all’olio di erba cipollina (controllare molto bene la cottura in modo che i piselli esplodano in bocca).
Aggiustare di sale se necessario.
Mettere i piselli a coprire la tartelletta. Disporre 3 fiori viola sopra i piselli, creando un triangolo alla base. Posizionare la tartelletta sul tovagliolo sopra al coperchio di legno come da foto.
“Una cucina sostenibile non è necessariamente vegetariana”, rivendica convinto. “Mi chiedo che cosa succederebbe ai piccoli allevatori, se si compisse questa svolta. Credo piuttosto nell’equilibrio: prima di rinunciare, bisogna riorientare”.
Ogni visita prende le mosse da una degustazione itinerante, durante la quale l’ospite pesca i primi assaggi in modo didattico da riproduzioni in scala dell’habitat circostante. È il cosiddetto “picnic di benvenuto”, seguito dal tavolo del tartufo in cucina e dalla nuova serra: un modo per ambientarsi nel microcosmo virtuoso e familiarizzare con le brigate, che contano 60 elementi e diversi italiani in posizioni chiave (su tutti il restaurant manager Matteo Manzini ).
Il menù degustazione Adarrak , intitolato alla montagna di San Sebastian, costa 260 euro, più 150 o 300 per il pairing base o deluxe, estratto da una carta dei vini internazionale. Fra i piatti firma arriva subito l’ uovo tartufato, ottenuto con una semplice siringa da un tuorlo d’uovo di fattoria completamente crudo: ne viene estratta la metà, rimpiazzata da acqua di tartufo caldissima. Per questo, dice lo chef, l’uovo è cucinato all’inverso, dall’interno verso l’esterno. A completarlo un goccio di serico grasso di prosciutto Joselito, per la crasi fra uovo al tartufo e uovo al bacon.
Il repertorio basco è protagonista nel “ Txipiron Pelayo”, rivisitazione di una tipicità della costa. Si tratta di calamari crudi affettati molto finemente, in modo da ottenere una testura stupendamente vischiosa, quasi di miele grazie alla fuoriuscita del collagene, serviti poi per via di paradosso a matassa su un letto di cipolla caramellata per quattro giorni. Un boccone memorabile nel suo minimalismo e nel contrasto fra potenza della cucina come forza di trasformazione e intensità dell’ingrediente al naturale.
Stessa centratura implacabile nella castagnola di maiale, sempre Joselito, cotta prima a bassa temperatura, poi finita sulle braci e accompagnata da una paletta di brodo di musetto concentrato; oppure nei fragranti piselli lagrima , icona della gastronomia basca, minuti e dolcissimi grazie alla raccolta precoce, prima che gli zuccheri si convertano in amido, che solleticano il palato rotolando come caviale verde. Vengono serviti con una ciotola di brodo di ceci dalla concentrazione proverbiale: di 50 litri
ne restano appena 4, senza bisogno di addensanti o gelificanti diversi dalle sostanze già presenti nella materia. Umami e minimalismo che sono puro Giappone. “Sembriamo popoli lontani, ma abbiamo tanto in comune”, commenta Atxa. “Un tavolo per noi non è un mobile, ma un luogo simbolico attorno al quale ci riuniamo per nascite, matrimoni, funerali e per qualsiasi altro rito. Poi il sentimento della natura. Noi baschi siamo molto cattolici, ma abbiamo radici pagane. Sentiamo la stagione, il clima, il mare. È un’arma potente per trasformare l’ingrediente”.
GRANITA AL MIELE (15 PAX)
g. 800 di acqua • g. 300 di miele della Dehesa • g. 0,8 di polvere 5 spezie
• fogli di gelatina q.b.
Scaldare l’acqua con il miele e la polvere di spezie a fuoco medio fino a raggiungere il bollore. Lasciare in infusione per 10 minuti coperto con la pellicola. Filtrare il composto in una superbag e unire i fogli di gelatina, sciogliere con l’aiuto di una frusta. Congelare.
ARIA DI MIELE (60 PAX)
g. 400 di acqua di miele . g. 8 di lecitina . g. 8 di sucro
Per l’acqua di miele: g. 2000 di acqua • g. 1000 di miele di Dehesa

Mettere l’acqua in una casseruola e scaldare per sciogliere il miele; tenere da parte. Una volta che l’acqua è tiepida, aggiungere la lecitina e il sucro e con l’aiuto di un frullatore e creare l’aria di miele.
LATTE DI PECORA (40 PAX)
g. 2000 di latte di pecora • g. 75 di foglie di basilico
Far bollire il latte e aggiungere le foglie di basilico; togliere dal fuoco, coprire con della pellicola e lasciare riposare per 5 minuti. Filtrare, passare attraverso un superbag e mettere da parte.
FINITURA E PRESENTAZIONE
fiori di rosmarino • mazzo di fiori • caglio
Mettere il latte infuso in una casseruola a 41 °C e tenere da parte. Adagiare il caglio in una ciotola e distribuirlo su tutta la superficie, aggiungere 45 grammi di latte infuso e farlo rapprendere in cella frigorifera prima di servire. La cagliata finirà di essere impiattata in sala. Mettere la granita di miele nella macchina kakigori e posizionarla su un carrello per poterla portare al tavolo insieme alla cagliata, l’aria di miele e il bouquet. Davanti al cliente grattugiare la granita sopra al latte cagliato dandogli un po’ di volume. Aggiungere in cima l’aria di miele formando una mezza sfera. Rifinire il piatto posizionando i fiori.
E il Giappone torna nella macchina da granita del dessert, la cagliata di erbe, miele e millefiori , rivisitazione di un dolce tipico basco chiamato gatzatua. Dove il latte di pecora viene infusionato di erbe e fiori della propria serra, più miele in cristalli ghiacciati, per salvaguardare gli aromi con una testura leggera e rinfrescante, aria di miele, rosmarino e fiori per colore e profumo. Mentre gira la ruota della sua granita, tuttavia, la mente di Eneko Atxa è già oltre. Per lui la sostenibilità non è un concetto al fermoimmagine, ma un ideale in divenire, che non smette di spostarsi più in là.
“Prendiamo la sostenibilità rigenerativa. Tutti sono concentrati a misurare l’impatto del cambiamento dell’industria automobilistica sul clima, proprio mentre gli esperti di Harvard stanno quantificando la forza rigenerativa di un albero o di una balena, che nella sua vita assorbe tantissime emissioni in mare. È la natura stessa che rigenera. Questo può rivestire un enorme significato per noi cuochi. Nella vita privata, poi, sono tenuto a insegnare alle mie figlie di 9 e 12 anni a pianificare i pasti e a fare la spesa, cosa e come comprare per evitare gli sprechi, come cucinare quotidianamente, prolungare la vita degli alimenti e riciclare gli scarti. È necessario costruire un circolo fra famiglie, settore primario, logistica, nutrizionisti e medici in questo senso. Se ci riusciamo, sarà l’avanguardia della sostenibilità, un esercizio continuo che a un certo punto diventerà superfluo”.


Da sempre collettore di culture di tutto il mondo, Vienna concede a ogni visitatore una sorta di giro per il mondo in un weekend.

Piuttosto esotica ma molto austriaca, decisamente bohémienne ma al contempo iper-moderna, ancorata al passato quanto proiettata verso il futuro: questa è Vienna “reloaded” e l’Hotel perfetto per immergersi in questo caleidoscopio di bellezza è, senza dubbio, l ’Hotel Beethoven . Allocato nel cuore del 6° distretto di Mariahilf/ Naschmarkt, super strategico, permette di visitare tutto ciò che di bello esiste semplicemente a piedi o con l’ausilio di qualche mezzo di trasporto.
L’Hotel Beethoven si trova a soli due passi dai luoghi della Secessione e del Modernismo e dai più importanti musei. Ex casa di tolleranza, è stata trasformata dalla sua proprietaria, Barbara Ludwig , in un hotel di design, dove ogni camera è racconta diversamente, dove ogni detta -

glio è specchio di un frammento di storia della città. Il centro storico con la Cattedrale di Santo Stefano è a pochi passi così come il “Naschmarkt”, il mercato delle ghiottonerie con oltre 120 bancarelle di frutta e verdura, spezie e curiosità da ogni parte del mondo, insieme a ristorantini gourmet. Questo mercato offre tantissime opzioni per una cena super-viennese con specialità autentiche e preparate a regola d’arte: la scelta è davvero vasta poiché Vienna è una delle pochissime città al mondo che ha dato il proprio nome a uno stile culinario a se stante: la cucina viennese. Attraversata dagli influssi dei paesi più diversi, Vienna è la patria di una cucina ricca di varianti, fantasiosa e sempre pronta a stupire con ricette nuove.
In 5 minuti a piedi si raggiunge il “MuseumsQuartier”, uno dei maggiori complessi espositivi al mondo. Attraversando la strada si arriva al “Kunsthistorisches Museum”, il museo
delle belle arti e al “Naturhistorisches Museum” il museo di Storia Naturale.
Mentre il celebre Theater an der Wien si trova proprio davanti all’Hotel Beethoven, e lo si può ammirare sorseggiando un caffè viennese dal mezzanino dell’hotel. Difficile non emozionarsi. Vienna, un tempo Capitale dell’impero asburgico, ha una ricchissima tradizione artistica.




Al Kunsthistorisches Museum, all’Albertina, al Museo Leopold e in altri grandi e prestigiosi musei si possono ammirare capolavori realizzati nel corso dei secoli.
Il Belvedere si prepara a festeggiare quest’anno una grandissima ricorrenza: il tricentenario della sua costruzione, a cui è dedicata per tutto l’anno la rassegna “Il Belvedere, da tre secoli luogo dell’arte”, allestita all’Orangerie, che racconta la sua storia, improntata al potere e alla partecipazione alle grandi feste di corte e ad eventi speciali della Storia.
Una mostra straordinaria, rinviata a causa della pandemia, si inaugura all’inizio di questo febbraio: “Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse...” . La mostra mette a confronto numerose opere, per un totale di circa 90 lavori di Klimt e di altri artisti.
All’Hotel Beethoven Wien la città stessa e la sua storia si respirano in ogni dettaglio. Ognuno dei 6 piani è declinato con un diverso tema legato alla tradizione e alla cultura viennese: i caffè letterari viennesi (primo piano), la Secessione (secondo piano), la musica e Ludwig van Beethoven (terzo piano), il teatro (quarto piano), personaggi celebri di Vienna (quinto piano), audaci donne viennesi di fine secolo (sesto piano). Oggetti e lampade di design, manifesti e wallpaper originali della Secessione, arredi curiosi e dettagli di stile provenienti da tutta l’Europa danno personalità agli ambienti e alle camere. La volontà della proprietaria, durante la ristrutturazione dell’hotel, è stata fin dall’inizio quella di imprimere a cia-


scuna camera una caratteristica di unicità, avendo sempre come priorità il comfort, il relax e la soddisfazione dei suoi ospiti, che provengono da tutto il mondo.
Le 47 camere assorbono al loro interno tutto il fascino elegante e un po’ ironico di Vienna. L’accoglienza è superlativa fin dal mattino con la ricchissima prima colazione tutta austriaca con prodotti selezionati da piccoli produttori servita nel mezzanino dell’hotel con vista esclusivissima sulla porta di Papageno del Theater an der Wien, dove Beethoven debuttò per la prima volta con il suo Fidelio.


Barbara, la proprietaria, conosce a menadito tutti gli indirizzi più trendy di Vienna e parla perfettamente l’italiano, suona il pianoforte per i suoi ospiti, e offre dritte e suggerimenti per rendere ogni soggiorno un momento unico.
Oggi all’Hotel Beethoven s’incontrano le persone più eterogenee: ci si sente accettati, benvenuti e coccolati dal primo istante, indipendentemente dall’età e dalla classe sociale.

Al Cocktail Bar Ludwig , (aperto dalle 6 del mattino all’1 di notte) ci si ritrova per un drink con gli amici o per un break d’atmosfera.
Cocktail meravigliosi, musica d’atmosfera, serate frizzanti e barman appassionati sono gli ingredienti di questo bar dal design unico firmato Gregor Eichinger, rinomato architetto viennese.



Tra scintille dorate, al grande tavolo comune si socializza, si chiacchiera in un epicureo rito collettivo ricco di fascino e allegria. I suoni della strada si mescolano alla musica proveniente dalle finestre delle sale da concerto, in una celebrazione quotidiana della vita cittadina.
 Cocktail Rock Me Amadeus
Cocktail Rock Me Amadeus
Vienna ha un nuovo museo per l’arte moderna e contemporanea: l’Albertina Modern (inaugurata nel 2020) nasce come estensione della storica Albertina. All’insegna dell’arte moderna, postmoderna e contemporanea, si dedica agli artisti internazionali del XX secolo, fino ad oggi.

Si trova a pochi minuti a piedi dall’Albertina stessa e dall’Hotel Beethoven.

È un luogo che presenta i grandi nomi del mondo dell’arte degli ultimi decenni come Egon Schiele (di cui si possono ammirare opere mai finora esposte e altri importanti artisti austriaci come Maria Lassnig e Valie Export, ma anche Friedensreich Hundertwasser e Gottfried Helnwein).
Vollpension in tedesco significa “pensione completa” ed è un caffè delle generazioni – un progetto sociale super innovativo e dal fortissimo impatto, sviluppato per combattere la povertà e la distanza sociale delle persone anziane. Infatti, impiega solo persone anziane che desiderano condividere momenti utili e piacevoli con persone di ogni fascia d’età, guadagnando al contempo qualche aggiunta alla pensione.
Le “nonne da forno” gestiscono il caffè in maniera singolare: ci si sente davvero come a casa della nonna, dove si è sempre i benvenuti.
È uno dei locali più cool e più accoglienti di Vienna e dista circa 5 minuti a piedi dall’hotel.

Da metà novembre 2023 al 6 gennaio 2024 Vienna si tinge di un fascino di profumi e colori tutto magico, che si accende una volta all’anno grazie ai tantissimi mercatini di Natale. I mercatini a Vienna hanno una tradizione importante.


Quasi tutti i “Bezirke” (distretti) hanno almeno un mercato di prodotti agricoli che si tiene da lunedì a sabato e che rispecchia la composizione etnica del quartiere. Uno dei più amati dai viennesi (a 10 minuti a piedi dall’hotel) si trova allo Spittelberg, un minuscolo quartiere (8° distretto) attaccato al Museumsquartier (quartiere dei musei).
Le romantiche viuzze acciottolate di questo quartiere Biedermeier fanno da cornice al mercato più amato dai viennesi. Uno dei più antichi invece è il mercatino di Natale di Freyung, che si trova proprio nel centro storico: già nel 1772 questa piazza ospitava un mercatino analogo.

Oggi si trovano oggetti artistici artigianali, decorazioni di vetro, presepi tradizionali e ceramiche e vi si respira un’atmosfera d’Europa d’altri tempi.
Ogni giorno, alle ore 16, risuona la festosa melodia dell’avvento. Poco più avanti c’è anche il mercatino di “Am Hof” dove si possono acquistare pregiate opere artistiche artigianali.
© Ente per il turismo di Vienna, Christian Stempera cura di alessandro rossi esperto di vino, bon vivant, fondatore del premio “dire fare sognare”
Il taglio bordolese è una delle espressioni più celebri dell’enologia internazionale e richiama subito alla mente vini di grande fascino e storia che ci riportano indietro nel tempo, nella regione francese del Medoc .
Il 18 Aprile del 1855, a Parigi, viene scritta la storia di questa area vinicola proprio durante l’Esposizione Universale dove viene presentata la classificazione ufficiale dei vini della Gironda, il punto culmine di una realtà di mercato già esistente da più di un secolo.
Infatti, il termine Bordeaux è diventato simbolo di unicità e di idea del vino nel mondo.
Perché a livello enologico parliamo di unione o mescolanza di vini di diversi vitigni vinificati separatamente per dare vita, successivamente, ad un unico vino.
Vitigni complementari con caratteristiche e attitudini opposte. Opposte complementarietà per dare regolarità: il merlot è famoso per gli aromi fruttati, la morbidezza e l’eleganza dei tannini; il cabernet sauvignon per la struttura, la bella tessitura tannica, l’acidità e un bouquet di grande finezza espressiva.
Il cabernet franc si distingue per freschezza, profilo austero ed elegante, infine il petit verdot per la sua profondità, per i tannini robusti e per le caratteristiche note speziate.

Ovviamente un vino di così grande successo ha trovato emuli in tutto il mondo e anche in Italia.
Nel nostro Paese è facile pensare a Bolgheri , oggi vera culla dei tagli bordolesi italiani, ma non mancano etichette prodotte anche in altre regioni sia al nord che al sud.
Pochi sanno, infatti, che i primi ad avere prodotto la prima espressione bordolese italiana non è stata l’oramai famosa costa Maremmana , bensì, negli anni 50, la zona di Ciampino, a pochi chilometri da Roma: parliamo del Fiorano Rosso , l’etichetta di punta della Tenuta Fiorano , vino che ha fatto la storia della viticoltura italiana.
Voluto dal principe Alberico, fu il risultato della consulenza dell’enologo Giuseppe Palieri prima, e in seguito anche di quella del noto Tancredi Biondi Santi .
Nel 1961 arriva poi Fojaneghe , nato 60 anni fa in Trentino grazie alla felice intuizione del Conte Federico Bossi Fedrigotti che ha tramandato la passione per la propria terra mediante vini che esprimono gli aromi e i profumi delle Dolomiti.
Ed eccoci arrivati nel 1968, la prima vera annata reperibile sul mercato della leggenda: il Sassicaia del Marchese Incisa della Rocchetta , il grande Premier Cru Bordolese made in Italy. Da lì in poi la storia del mito la conosciamo tutti.
Perciò non solo Lazio, Trentino, Toscana, ma anche altre regioni italiane hanno sperimentato i vitigni classici bordolesi
Con le radici nel passato, un mito che non passa di moda
e il loro affinamento in barrique fino ad arrivare, percorrendo fino in fondo il nostro stivale, in Calabria – terra ancora non ampiamente conosciuta nell’ambito vinicolo, ma che a breve avrà la sua rivalsa insieme ai suoi vitigni autoctoni come il Gaglioppo , Magliocco e Greco – dove troviamo un’azienda che ha prodotto e produce il primo Bordo-Calabrese, con uve provenienti da un’antica vigna di quasi 50 anni: si tratta della famiglia Pacelli della omonima Tenute Pacelli
L’alfiere degli Stati Uniti è la California: da sola produce circa il 90% dell’intera produzione americana e ha raggiunto un’elevata qualità oramai apprezzata in tutto il mondo. Nella Napa Valley – la zona vitivinicola più famosa della California – si è costruito un vero e proprio stile, lo stile Napa , simbolo di eleganza e potenza, dove l’eleganza stilistica enologica francese si unisce alla forza del frutto californiano.
Da qui nasce, con la vendemmia del 1979 a Oakville, l’ Opus One , icona di armonia ed equilibrio del vecchio e nuovo mondo. Per correttezza cronologica, va detto però che questo vino nacque nel 1970 al Mauna Kea Beach Hotel , sulla Big Island delle Hawaii, dove Robert Mondavi e il barone Philippe de Rothschild si incontrarono per la prima volta e iniziarono la loro collaborazione per fondere il vecchio e il nuovo mondo in un’unica grande opera.
Già dagli anni ’90 Opus One divenne vino cult in Napa Valley, negli Stati Uniti, ma anche in Asia ed in Europa, dove cominciarono a circolare le prime bottiglie.

Il nostro viaggio non può finire senza passare dal Cile , conosciuto anche con il nome di “Bordeaux del Sud”. Questo sta diventando uno dei più importanti paesi viticoli del mondo,
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Le regioni vinicole più famose si trovano nella parte centrale del Cile - Valle del Maipo, Valle del Rapel , Valle de Curicò, Valle del Maule - dove si producono vini di qualità che assomigliano a quelli prodotti nella zona francese di Bordeaux.
È il cuore pulsante, il punto d’inizio, l’alba, il preludio, l’origine, le fondamenta, lo start, l’incipit dove tutto ha avuto inizio. L’inizio della storia.
La leggenda del mito che affonda le radici in secoli passati, radici ancora ben salde e vive che continuano a pulsare e a generare nuovi miti, seppur diversi da quelli prodotti centinaia di anni fa.
Miti che reggono allo scorrere del tempo senza essere spazzati via come foglie dal primo soffio di vento chiamato moda.
Salve Vania, raccontaci la tua storia: come ti sei appassionata al mondo del vino in particolare a quello dello champagne?
Diciamo che tutto ebbe inizio quando, nel 1995, mi trasferii a Londra. Arrivai in quella città quasi astemia, o comunque completamente inconsapevole di quanta cultura e storia ci fosse dietro una bottiglia di vino. Fu grazie agli inglesi che intravvidi la profondità e lo spessore di questa meravigliosa cultura (lavoravo in un wine bar della City) e fu proprio a Londra che assaggiai i miei primi champagne e mi si aprì un mondo.
Così, una volta rientrata in Italia, decisi di iniziare il corso AIS per Sommelier, diplomandomi e conseguendo successivamente il titolo di Master Sommelier con la frequenza al Master ALMA-AIS di IV livello presso la Scuola Internazionale di Cucina a Colorno; infine, conseguii l’attestato di Degustatore Ufficiale AIS. Da allora non ho più smesso di studiare, approfondire.

La svolta però arriva nel 2014 con l’incontro con Albero Lupetti , esperto di champagne riconosciuto a livello mondiale, che mi chiede di collaborare con lui alla redazione della Guida Grandi Champagne (oggi alla 6a edizione) e di scrivere nel sito lamiachampagne.com .
Da allora non si contano più i viaggi Oltralpe, le visite ai produttori, gli assaggi; non mi sono più fermata.
Andiamo subito al dunque: è vero che stai inaugurando un tuo sito web dedicato al mondo delle bollicine? Come si chiamerà?
Da tempo desideravo aprire una pagina tutta mia in cui avere la possibilità di raccontare tutte le bottiglie che assaggio, siano queste francesi, italiane o inglesi. Assaggio praticamente ogni giorno, come si può ben vedere dal mio account Instagram (nonostante lì pubblichi solo un 30%) e, spesso, mi viene il desiderio di condividere con gli appassionati come me, ma anche con chi si sta approcciando da poco a questo meraviglioso mondo, quelle che sono le mie impressioni su quel determinato vino. Ma anche su quello che c’è dietro: una famiglia, una visione, un progetto, un territorio, una storia. So perfettamente che non è una novità, oggi i social sono saturi di gente che racconta e parla di vino (e champagne) ma, personalmente, sento di avere un’esperienza e profondità di analisi tali da essermi conquistata la fiducia dei tanti che mi scrivono ogni giorno chiedendomi consigli, impressioni. L’ho sempre fatto per passione, sui miei canali e su diverse testate giornalistiche; oggi vorrei invece che tutto questo avesse il mio nome. Il sito si chiama vaniavalentini.com
Quale scopo ha questo sito? Attribuisce punteggi come fanno tanti altri tuoi colleghi?
Pare che non parlerai solo ed esclusivamente di bollicine francesi, bensì provenienti da tutto il mondo; corretto? No, non “punteggerò” perché lo trovo capzioso e fuorviante; saranno troppi gli stili, i vitigni e le zone a confronto; difficile attribuire dei rates con queste condizioni e, in ogni caso, lo spirito non è quello. Voglio dare voce a delle bottiglie, raccontare chi le produce e dove, il perché le trovo interessanti. Ho deciso di aprire una pagina mia anche per questo; avrò la possibilità di aprirmi a più scenari oltre a quello della regione dello Champagne, che rimane tuttavia il mio riferimento assoluto. E scriverò, come sempre, solo di ciò che mi piace, di quei vini che posseggono una singolarità, un’identità, un loro fascino. Siano essi semplici lambrusco (che adoro, ma dopotutto sono emiliana), champagne o spumanti istriani.
Come è strutturato il tuo sito web? Troveremo solo degustazioni o ci dobbiamo aspettare anche novità che possano differenziarlo da tanti altri siti dedicati al mondo del vino?
Parto con le degustazioni e le monografie sui vari produttori. Dopodiché darò spazio agli approfondimenti dei vari territori, alle caratterizzazioni geologiche delle diverse aree, ai vitigni; si aggiungeranno poi le visite di gruppo in Champagne (ma anche in Italia, perché no), altra
richiesta che mi viene fatta da tantissimo tempo e che non ho mai avuto modo di sviluppare.
La didattica è il tuo forte, pensi che il futuro dei nuovi wine lover possa passare anche da un maggior affondo culturale/geologico come insegni nelle tue lezioni?

Assolutamente sì. Diciamo che l’idea del sito è partita proprio con l’intento di fare didattica. Mi viene chiesto da tempo di fare approfondimenti sulla Champagne e per me sarebbe la realizzazione di un sogno potere avere una mia piattaforma sulla quale proporre seminari dedicati. Tengo lezioni interamente legate a questa regione in diversi centri di formazione (Fondazione Mach, Intrecci, UNISG) e sempre di più mi rendo conto di quanto sia importante raccontare ai ragazzi, soprattutto a quelli giovani che si approcciano solo ora a questo mondo, la Champagne, la sua storia, il suo territorio... Credo che sia un grande contributo che i social, ancora, non riescono a dare. La Champagne è una materia molto più seria e complicata di quanto si creda e trovo si possa vivere questo vino con la solita spensieratezza e leggerezza (è nato per questo) ma con il plus di un vero coinvolgimento.
E questo avviene solo quando si prende consapevolezza di quanta storia, sacrifici, territori, stili
di vinificazione diversi ci sono dietro; solo allora se ne potranno cogliere davvero tutte le sfumature, la sua vera grandezza. Insomma, è come essere davanti a un grande dipinto e non conoscere il percorso dell’artista, il suo stato d’animo mentre lo dipingeva. Non ti rimane quasi nulla.
Come vedi il futuro dei Metodo Classico italiani?
Lo vedo molto sparkling! Stiamo crescendo tanto, finalmente abbiamo preso consapevolezza del nostro potenziale e delle nostre singolarità, dei nostri vitigni unici, dei nostri innumerevoli e differenti territori e, finalmente, abbiamo preso coraggio.
Oggi non cerchiamo più di emulare i francesi, di seguire un protocollo in modo sistematico, ma interpretiamo, sperimentiamo; stanno uscendo prodotti davvero interessantissimi, di personalità, piacevolezza e, cosa ancora più importante, sapore.
Quali sono le tue zone di produzione preferite?
Domanda difficile. Escludendo la Champagne, che trovo davvero incredibile e in grado di stupirmi ogni volta, in Italia le mie zone preferite sono quelle che ancora devo scoprire. Dico questo perché mi è capitato di sorprendermi, recentemente, con un metodo classico di Asprinio di Aversa, con uno da argilla rossa di terra piacentina, con un Durello della Lessinia e con una Spergola senza dosaggio e senza solfiti delle colline reggiane...
Il territorio italiano è davvero ancora tutto da conoscere e da esplorare, almeno per quanto mi riguarda; io non vedo l’ora di farlo.
Quando sarà online? Da questo febbraio.
In bocca al lupo allora, siamo curiosi di leggerti.
Conosciuta per pochi vitigni, l’Emilia Romagna enoica offre in realtà un’interessante biodiversità, dal potenziale ancora in gran parte inespresso. Dalla Bolognese Alionza, di remote origini, al profumatissimo e romagnolo Centesimino; dalle fortunose (ri)scoperte di Uva Longanesi e Famoso, al brio del “sabbioso” Fortana del Po. Senza tralasciare il tanto misterioso quanto imperioso modenese Malbo Gentile; lo “zergo” Negretto; il piacentino, versatile Ortrugo; la “scandianesissima” Spergola.
Anche dall’Emilia Romagna giungono buone nuove in merito al recupero di antichi vitigni alle soglie dell’estinzione. Una regione stereotipaticamente divisa tra Lambrusco (Emilia) e Sangiovese e Albana (Romagna), che invece mostra buone potenzialità in termini di biodiversità ampelografica. Va solo detto che se altri comprensori enoici del nord della Penisola hanno compiuto passi da gigante in materia, e che ormai molte cultivar sono state definitivamente recuperate dall’oblio e ora commercializzate, per quanto concerne

quest’area della Padania vi è la fondata impressione che vi siano ancora molte uve da studiare, rivalutare e rilanciare. Insomma, pare che qui si sia solo a metà dell’opera e che tante varietà non aspettino altro che di essere analizzate, testate e divulgate.
Anche qui, nella draconiana selezione che per ragioni di spazio siamo costretti a fare, abbiamo dato precedenza ai vitigni già ufficialmente riconosciuti, vinificati in purezza e regolarmente commercializzati.
Le descrizioni ampelografiche della bianca Alionza sono remote: la prima è quella del De Crescenzi (1303). Diffuso in provincia di Modena e Bologna, il Cavazza nel 1914 lo descrive come uno dei migliori vitigni a bacca bianca del Bo lognese; mentre poco prima, a fine ‘800, la si definiva “uva antichissima, poco produttiva, ottima da consumarsi fresca e per il suo vino molto alcolico, squisito e profumato”.
Giorgio Erioli , produttore emiliano di culto, è tra i protagonisti del rilancio di quest’uva. Dopo vari studi ampelografici “alla fine presi la decisione di recuperare due cultivar secondo me importanti per storia e diffusione: Alionza e Negretto.

La prima era quasi scomparsa a causa della sua bassa produttività, per il fenomeno dell’acinellatura e per via della sua buccia spessa a discapito del mosto”. Vitigno vigoroso, predilige impianti non troppo fitti a potatura lunga, suoli collinari, climi caldi, asciutti. “Nella nostra tenuta di 4 ha, a Valsamoggia (Bo), produciamo un’Alionza ferma e una metodo classico”. La ferma Emilia Igt Malvezza , frutto di basse rese (50 q/ha di uva), affina 30 mesi in acciaio sur lies; ha veste oro zecchino, sa di ginestra, mele al forno, tè; è morbida, elegante, fresca, equilibrata, con chiusura mandorlata e agrumata. Di buona longevità, raggiunge il suo apice dopo oltre un lustro.
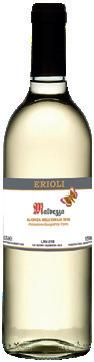
La storia di questo vitigno romagnolo, in dialetto Savignôn Rosso, comincia nel periodo postfillosserico; la sua diffusione si deve a Pietro Pianori di Faenza, detto Centesimino , che negli anni ‘50 avvia la propagazione di marze di vecchie vigne presenti nei suoi terreni.
Assodato trattarsi di una varietà autonoma, estranea all’Alicante spagnolo, solo nel 2003 viene ufficialmente riconosciuta. Oggi è coltivata da un piccolo gruppo di aziende consorziate sulle colline di Oriolo dei Fichi, vicino a Faenza (Ra). Tra queste, Poderi Morini
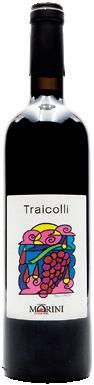
“Il Centesimino è incredibile, dagli aromi intensi e complesso. Quando sono venuto in possesso del podere Cà Donati, ai piedi della torre di guardia di Oriolo, ho avuto la curiosità di vinificarlo in purezza per verificarne il potenziale”, spiega Alessandro Morini
“I vini mi hanno dato ragione visto il loro successo: nel 2001 ho prodotto il Ravenna Igt Traicolli , affinato per 14 mesi in tonneau, e il Rubacuori da uve stramature, elevato 12 mesi in barrique. Luigi Veronelli ha apprezzato molto questi nettari, consigliandomi di produrne una versione in acciaio per esaltare i tratti varietali del vitigno; ed è così che è nato il Savignone. Infine, nel 2008, ho prodotto il Morosè, un metodo Charmat”.



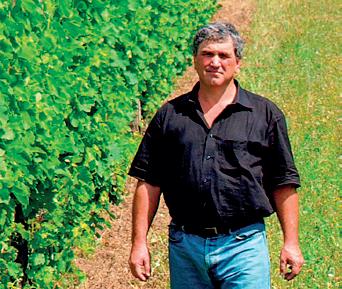
Iscritto nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite nel 2009, il Famoso risorge dal recupero di due vecchi filari dell’azienda Montalti di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena).
Nel 2000, a partire proprio da quei filari, si è iniziato a testarlo, con esiti subito interessanti. Le principali citazioni storiche di questa cultivar
sono del 1876-1879, dove si parla di un’uva Famoso tra quelle del Cesenate. Una storia, quella di questa cultivar, che si intreccia con quella della ravennate Rambella, suo probabile sinonimo.
Sia come sia, è chiaro trattarsi di una bacca di antiche tradizioni romagnole.
Si esalta sui più poveri terreni collinari, dove produce poco e il suo grappolo è più piccolo, spargolo e aromatico.
Ne scaturisce un vino giallo paglierino, con bouquet intenso, ricco di terpeni simili a quelli del Moscato, dai ricordi floreali dolci, note di frutta esotica, drupe mature ed essiccate, ma anche sensazioni fresche e balsamiche di agrumi, salvia ed erbe aromatiche; al sorso ha media acidità,
buona morbidezza e polpa, equilibrio e finezza.
Mauro Altini - titolare dell’azienda La Sabbiona di Faenza – è tra i principali interpreti di questa cultivar, producendo fra gli altri il paradigmatico Ravenna Igt Famoso Vip , e una versione spumante metodo Charmat Extra Dry, chiamata Divo.

La viticoltura del Delta del Po è unica: suoli sabbiosi, e quindi viti a piede franco; falde salmastre; limitate superfici vitabili distanti da altri aerali enoici. Longevità delle viti e selezioni massali, senza intraprendere quelle clonali, hanno fatto sì che il Fortana abbia mantenuto intatta nei secoli la propria matrice genetica.
Pertanto è rimasto da sempre una cultivar rossa tardiva, con moderato contenuto di zuccheri, maturazione difficoltosa e ottima acidità che permane durante la maturazione del frutto, caratteristica che l’esalta nelle versioni rifermentate in bottiglia.
Per questo, racconta il guru dei “Vini delle Sabbie” Mirco Mariotti , patron dell’omonima cantina con vigne a Lido di Pomposa, “nel 2006 provai a mettere sul mercato

il nostro ‘vino quotidiano’; ma da subito si presentarono difficoltà pratiche: il ‘metodo ancestrale’ porta a un vino fragile; per cui decisi di affidarmi alla classica rifermentazione con tirage del vino base secco addizionato di mosto congelato dalla vendemmia”.
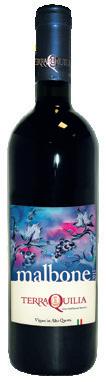




Negli anni, passione per Fortana e bollicine hanno indotto Mariotti a varare anche un metodo classico; inoltre, con il Consorzio Pescatori di Goro, ha messo a punto un protocollo di “affinamento dinamico” dello spumante sott’acqua, chiamato Symbiosis, crescono insieme.
Tra le etichette prodotte da Mariotti, forse la più varietale ed espressiva è la croccante Fortana dell’Emilia Igp frizzante Surliè!
MALBO GENTILE ; BUCCIA SPESSA E SCURA, GRAPPOLO SPARGOLO: QUESTI GLI ATOUT
Pur importante per la viticoltura modenese e reggiana, sulle origini di questa varietà non si sa quasi nulla mancando documentazioni; al di là di ipotesi fantasiose come quelle di una sua origine californiana, o di una sua – poi smentita – parentela con il Malbech.
Dal 1995 è iscritta al Registro Nazionale delle Varietà di Vite. Tra i suoi principali cultori, l’a -
zienda Terraquilia di Guiglia (Mo).
“Una delle cose a cui teniamo di più – chiosano Romano e Giorgia Mattioli , titolari della cantina - sono le tradizioni dei nostri luoghi, che includono anche la viticoltura. Perciò abbiamo voluto recuperare questa antica cultivar”.
Il Malbo Gentile ama terreni magri, trovando nella fascia pedecollinare appenninica il suo habitat d’elezione.
Non essendo auto impollinatore, necessita di essere vitato accanto ad altre varietà.
Sensibile alla peronospora per il suo ampio fogliame, ha grappolo piramidale-allungato e spargolo; tratto quest’ultimo che lo rende resistente al marciume; gli acini sono ricchi di antociani, pru -
inosi, un poco aromatici; avendo buccia spessa, ben si presta anche all’appassimento.
“Il nostro Emilia Igt Malbo Gentile Malbone fermenta sulle vinacce per 10 giorni e affina in vetro per almeno 12 mesi.
Ne deriva un vino violaceo, dai profumi intensi di more, mirtilli e pepe nero, con palato armonico, polposo, caldo, ricco di tannini e vivo di acidità”.

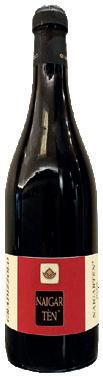


Antico vitigno a bacca rossa coltivato nel Bolognese e in Romagna, viene descritto già nel 1303 dal De Crescenzi, e citato poi in numerosi testi di ampelografia.

Impiegato in passato anche come uva da pasto, da alcuni anni è iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Vite e autorizzato su tutto il territorio regionale, sebbene insista soprattutto sulle aree collinari delle province di Bologna e Ravenna.
Cultivar robusta e di costante produttività, ha grappolo compatto, cilindrico-conico, con acini dalla buccia pruinosa e nero-violacea; la sua maturazione è medio-tardiva. Se ne ricava un vino rosso rubino intenso,
dagli intensi e vinosi profumi secondari, di buona texture tannica e con buona freschezza acida. Interessante l’interpretazione di questa bacca offerta dalla cantina Gradizzolo , di Antonio Ognibene , sita a Valsamoggia (Bo).
Il loro Emilia Igt Rosso Naigartèn , ottenuto da vigne trattate solo con zolfo e rame, è frutto di una lunga macerazione sulle bucce a seguito di una fermentazione spontanea;

l’affinamento si svolge per 12 mesi in botti grandi e per 6 mesi in bottiglia; molto adatto ad accompagnare i piatti tipici della cucina bolognese, ha buon successo anche sui mercati esteri, Stati Uniti e Giappone in primis.
Varietà bianca piacentina descritta per la prima volta solo a inizio ‘800, è solo nel 1927 che il Toni la nomina Ortrugo annoverandola tra “i principalissimi vitigni bianchi da vino della provincia di Piacenza”. Recuperata negli anni ’70 dall’azienda Mossi di Ziano Piacentino in Val Tidone, ha conosciuto un deciso allargamento della sua area di coltivazione a tutte e quattro le vallate provinciali: Nure, Trebbia, d’Arda e Tidone. Dal grappolo grande e compatto, con acini pruinosi e coriacei, matura non prima di fine settembre, prestandosi a essere vinificata ferma, frizzante e spumante; nel primo caso si ha un vino piuttosto strutturato, alcolico, asciutto, sa-

pido, fresco, lievemente aromatico; quando effervescente è più fragrante, snello, gradevolmente acidulo. Tra gli Ortrugo di Mossi, azienda oggi di Silvia Mandini e Marco Profumo , da citare l’identitario Ortrugo dei Colli Piacentini Doc Spumante Brut Contro Tempo .
Lo si ottiene con uno Charmat lungo, partendo da un vino-base frutto di un mosto fiore molto delicato data la pressatura ultra soffice delle uve che lo originano. Dopo la presa di spuma in autoclave il prodotto sosta 6 mesi sur lies; ne scaturisce un nettare dal bouquet morbido con ricordi di gelsomino e foglie di tè, con un sorso armonico e cremoso, fresco di acidità e ricco di sapidità.
Diffusa nel Reggiano, a lungo confusa con il Sauvignon, è solo nel 1811 che viene denominata Spergola; nel 1839 il Gallesio la pone tra le bacche rinomate del comprensorio di Scan diano, Sassuolo e Casalgrande. Dove ancora oggi tale vitigno trova la sua patria d’elezio ne, su circa 200 ettari. Il legame di questa varietà col proprio territorio è rivendicato dalla Compagnia della Spergola, unione di produttori di Scandiano e dintorni, il cui protocollo d’intesa proclama fra l’altro che “nel territorio di Scandiano è presente da tempo immemore nella collina e pedecollina scandianese il vitigno Spergola , autoctono e diffuso in pratica solo a Scandiano”.
Alla Compagnia appartiene Tenuta di Aljano di Jano di Scandiano, della famiglia Olivari .
“Produciamo più vini con la Spergola, ma quello che più ne esalta il varietale – sottolinea patron Stefano - è la versione metodo Charmat Colli di Scandiano e Canossa Doc Spumante Brut Brina d’Estate . Un Martinotti lungo foriero di una bollicina paglierino-brillante dai tenui riflessi verdolini e un brioso perlage; al naso è fragrante e fruttata, con ricordi di mela verde, pesca e agrumi.


In bocca è molto secca, di buona struttura e sapidità, a beneficio di freschezza e bevibilità, con un finale lungo e appena morbido”.

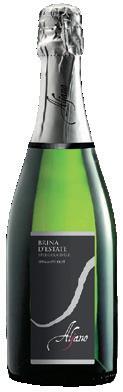

Il nome è un omaggio ad Aldo Longanesi, che ritrovò un vecchio ceppo di questa varietà nella campagna di Bagnocavallo (RA) intorno agli anni ‘20; negli anni ‘70 i suoi familiari impiantarono il primo vigneto in toto dedicato a questa cultivar, anche se – sottolinea Daniele Longanesi dell’omonima azienda di Bagnocavallo – “solo nel 1999, dopo un lungo iter, è stata iscritta al Registro Nazionale, e solo dal 2007 rientra nella Igt Ravenna”. Inizialmente confusa col Negretto, anche l’ Uva Longanesi ha genesi oscura, forse frutto di un’antica ibridazione spontanea. Il suo grappolo ha tratti morfologici piuttosto variabili, ma le bucce dei suoi acini spiccano per il colore blu notte.

Grazie all’impegno del Consorzio Il Bagnovacallo oggi questa bacca – localmente detta Bursôn - ha
ritrovato piena affermazione; la si vinifica in due declinazioni: Etichetta Nera, prodotta da uve passite (almeno il 50%), con affinamento in rovere; ed Etichetta Bianca, da uve fre sche sottoposte a macerazione carboni ca (almeno il 40%), vinificate in acciaio. Il longevo Ravenna Igt Rosso Bursôn Etichetta Nera di Daniele Longanesi è frutto di una parte di bacche (oltre il 50%) appassite per 20-40 giorni, provenienti dalla tenuta di Boncellino; la macerazione dura 10-15 giorni e l’affinamento è in tonneau per 12 mesi e in botti grandi per un altro anno, con maturazione finale in vetro di 6 mesi.


Scrivere sulla Val d’Orcia? E cosa mai potrei aggiungere che non sia già stato impresso sulla carta o sulle pagine elettroniche. Libri, recensioni, guide, opuscoli, locandine, siti internet, social post e chi più ne ha più ne metta. È una terra magica della quale persino l’Unesco nel 2004, stimolato da tanta bellezza si è accorto, al punto di riconoscerla come territorio rurale patrimonio dell’umanità.
Dovrei forse anche io decantare l’armonia delle verdi e tondeggianti colline, dei campi color terra di Siena amorevolmente coltivati, degli ulivi secolari e dell’olio di qualità.
Della Cinta Senese o della Chianina, o ancora del tartufo bianco delle Crete Senesi? Dovrei forse evidenziare la bellezza dei casali, dei luoghi di culto, dei castelli e delle testimonianze archeologiche?
Faccio un passo indietro di qualche anno. Quando fu inventata la radio tutti pensarono: che bellezza! Adesso saremo in contatto con il mondo intero. Poi arrivò la televisione: che meraviglia! Ora potremo vedere cosa succede nel mondo. Ma oggi, in quest’era di velocità e superficialità, di web e di social, sento il bisogno di approfondire, di andare oltre il confine delle cose già dette.
Ci sono luoghi che mi portano alle radici e che mi consentono di incontrare un campionario di esseri umani immenso che con il lavoro, la costanza e il proprio credo abbracciano la terra in cui vivono e la plasmano trasformandola con il sudore in sogni.
È la Val d’Orcia del vino, dei vigneti autoctoni e non, delle botti e delle cantine, delle donne e degli uomini. La Val d’Orcia dell’ospitalità, dei sorrisi, delle chiacchierate in armonia, di un piatto caldo e di un buon bicchiere di vino Sangiovese.

È la Val d’Orcia di Gabriella Giannetti (foto 1), dei suoi vini e del suo coinvolgente sorriso, che mentre ti fa assaggiare le sue produzioni enologiche ti prepara un piatto di pici fatti in casa conditi con il ragù. La Val d’Orcia della sobria eleganza di Roberto Terzuoli (foto 2) che, in parte tra le botti e in parte fuori della cantina, ti racconta del territorio e del vino, e ti ristora con un carosello di salumi locali.
C’è poi la Valle di Giulitta Zamperini (foto 3), Presidente del Consorzio di cui a breve vi parlerò. È lei, con papà Luca , mio coscritto, che racconta la sua vita di giovane donna produttrice di vino e rappresentante delle altre cantine consorziate. Tra un bicchiere e l’altro ti offre una corroborante ribollita e 2 metri di taglieri impreziositi dai sapori locali.
La Val d’Orcia di Donatella Cinelli Colobini (foto 4), colonna storica del vino territoriale che ama raccontare tra un sorso e l’altro la storia, ormai secolare, della sua famiglia: lo fa con grazia, con delicatezza, assaporando un crostino con il tartufo appena raccolto nella sua tartufaia. Racconta... affascinando l’ospite comodamente seduto in poltrona.
Ci sono poi i giovani come Emilio Caliani (foto 5) e Luca Mastrojanni (foto 6), produttori con alle spalle storia, tradizioni ed esperienze di famiglia nel mondo enologico.
Foto di Giuseppe ParisSono solo alcune delle 60 cantine che aderiscono al Consorzio Orcia DOC . Un giovane Consorzio nato nel 2000 con 153 ettari coltivati ed un potenziale che può raggiungere i 400 ettari. La produzione dell’ultima annata si è attestata a poco meno di 300 mila bottiglie.


E poi c’è lui, il protagonista: il Sangiovese. Ci sono dottori, idraulici, macchinisti, operai, insegnanti ma tutti indistintamente, se amano il buon vino, non possono che gioire alzando un calice di Sangiovese. Il disciplinare di produzione dell’ Orcia DOC prevede infatti la sua presenza per almeno il 60% per l’ Orcia e l’ Orcia Riserva . Arriva la 90% per l’ Orcia Sangiovese e l’ Orcia Sangiovese Riserva




Non manca il Rosato, minimo 60% di Sangiovese, e il bianco con una base del 50% di Trebbiano Toscano. Naturalmente il Vin Santo, non potrebbe essere diverso visto il lembo senese toscano territoriale di cui stiamo parlando. Per queste chicca di cantina ci aggiungo anche la Malvasia. Una menzione particolare per i vitigni autoctoni che compongono gli assemblaggi va al Foglia Tonda tipico toscano recuperato negli ultimi anni. Un giovane Consorzio con le idee chiare e un credo all’unisono: il Sangiovese. E in questa provincia conosciuta al mondo per la sua bellezza e per vini blasonati, forse è arrivato il momento per un altro grande dell’enologia italiana: l’ Orcia DOC.

E la radio e la televisione cosa c’entrano?
Poco o tanto, grandi mezzi di divulgazione che stanno lasciando il posto alle nuove tecnologie e ai nuovi linguaggi. Magari sarà così anche per il vino che si evolve e si propone con nuove espressioni e nuovi volti.
Ogni produttore che ho avuto il piacere di incontrare mi ha aperto le porte del suo lavoro con gioia e amicizia, mi ha illustrato i vini, le tecniche di produzione, gli affinamenti e mi ha ascoltato ogni qual volta io abbia rivolto domande importanti o banali. Mi hanno parlato delle loro Famiglie, della storia delle case se datate e come sono state realizzate se di recente edificazione. Le persone, prima del vino, e il vino come mezzo espressivo, artistico di tante persone. E poi, lasciatemelo dire, c’è la Valle di Agostino, chi è Agostino? Un lagotto di 2 anni che mi ha simpaticamente accompagnato tra i boschi di questa Valle alla ricerca del tartufo bianco delle Crete Senesi: ma lui non beve! Non so se lo terrò come amico.
La Madia srl
Sede legale e operativa:
Via Pacchioni, 365 - 47521 Cesena (FC) Tel. 0547 23821 - Fax 0547 25809



Internet: www.lamadia.com - E-mail: lamadia@lamadia.com
Direttore responsabile: Elsa Mazzolini
Direttore: Elsa Mazzolini
Caporedattore: Maria Chiara Zucchi
Impaginazione: Barbara Volpe
Stampa: Tipografia Luce - Osimo (AN)
Web e Social: Giorgia Zucchi
Sofia Sarpieri
Silvia Bianco, Lorenzo Braschi, Teresa Cremona, Gianni Di Lorenzo, Mario Federzoni, Giusy Ferraina, Lorenzo Ferrari, Luigi Filippi, Giulia Gavagnin, Lucy Gordan, Giuseppe Lo Russo, Antonietta Mazzeo, Alessandra Meldolesi, Claudio Mollo, Gianluca Montinaro, Gianluca Ricci, Alessandro Rossi, Fabrizio Salce, Roger Sesto, Flavia Tomaello, Primo Vercilli.
Fotografi: Claudio Mollo, Pasquale Spinelli
Illustratori: Valentino Menghi
PUBB LIC ITÀ
marketing@lamadia.com
Abbonamento Annuale Italia € 35,00 (6 numeri)
Abbonamento Annuale verso i Paesi CEE € 80,00 (6 numeri)
Abbonamento Annuale verso i Paesi extra CEE € 120,00 (6 numeri)
Acquistabili solo sul sito www.lamadia.com
CONTATTI:
Romano Lambri - Presidente Cell. 393.9815078
Mauro Marelli - Console della Stampa Cell. 392.3591439
www.cegourmet.eu - info@cegourmet.eu
e La Madia Travelfood TM sono marchi registrati di proprietà

Questa nuova padella vanta un perfetto e universale accoppiamento induttivo con i fornelli a induzione, garantendo il funzionamento anche alla massima potenza. Ciò si traduce in una generazione del calore più rapida e uniforme rispetto alle esistenti tipologie di fondi per induzione.
Attrezzature e forniture per: Alberghi, Ristoranti, Bar, Gelaterie, Pasticcerie, Panifici, Pizzerie, Arredamento Contract


