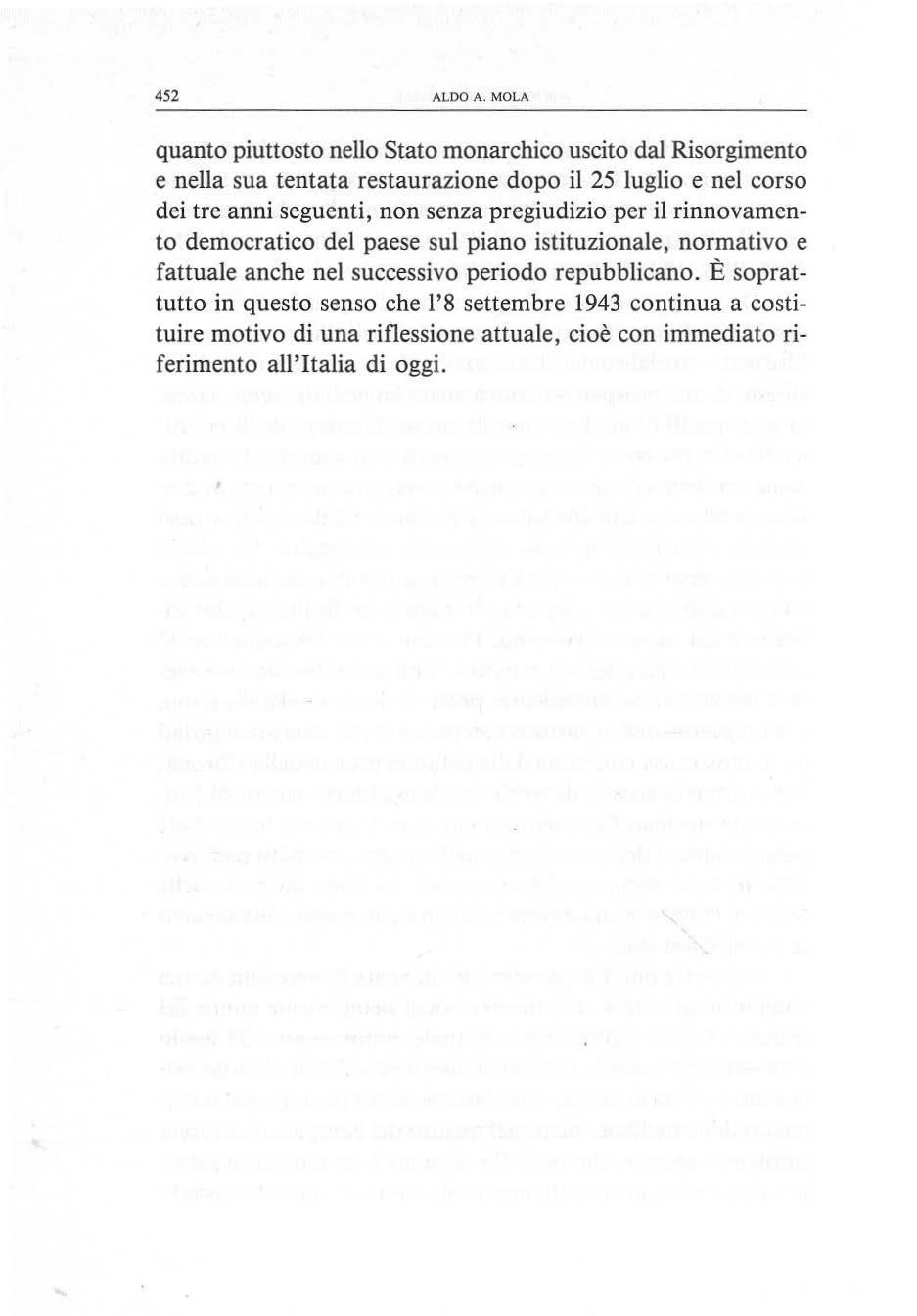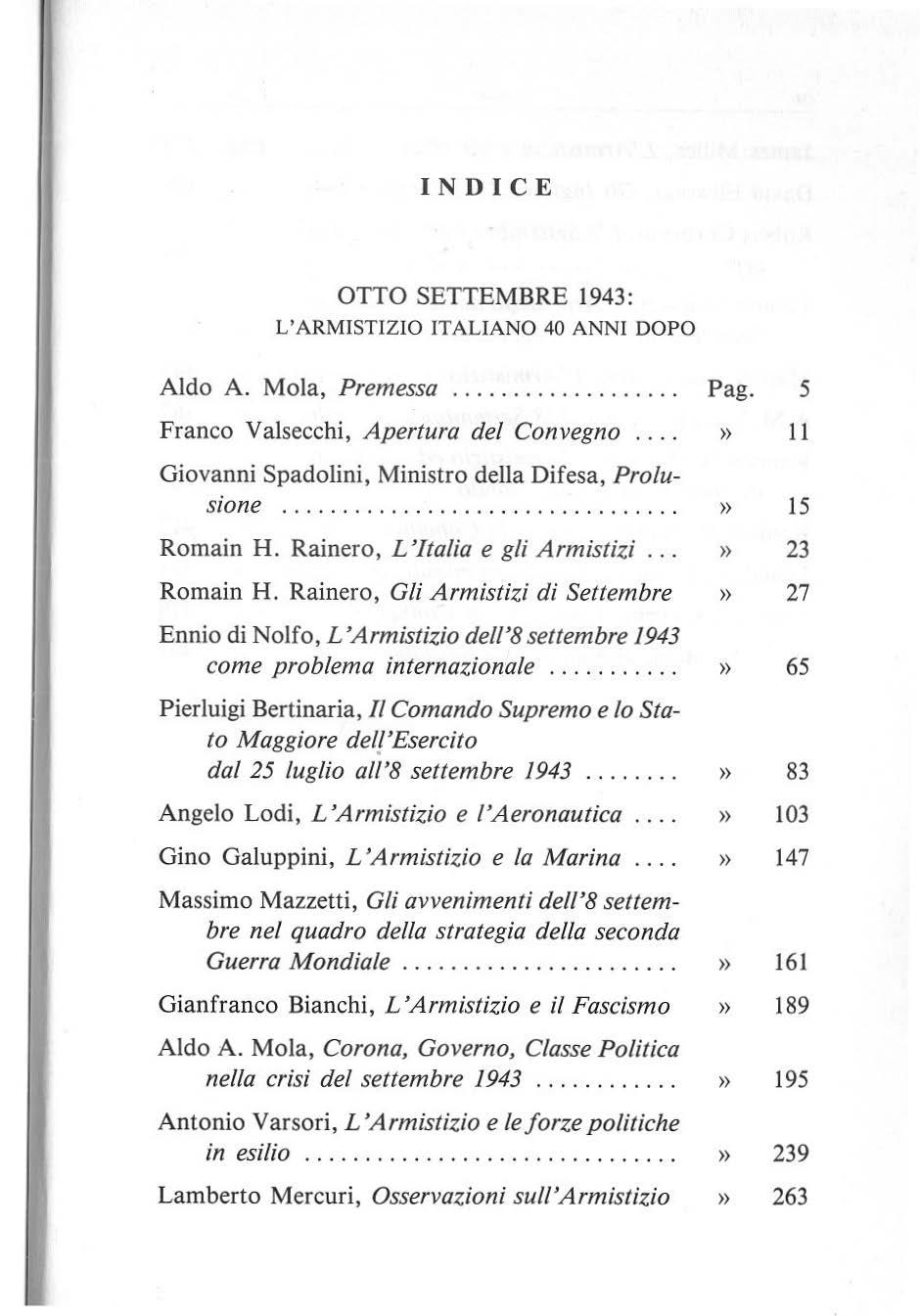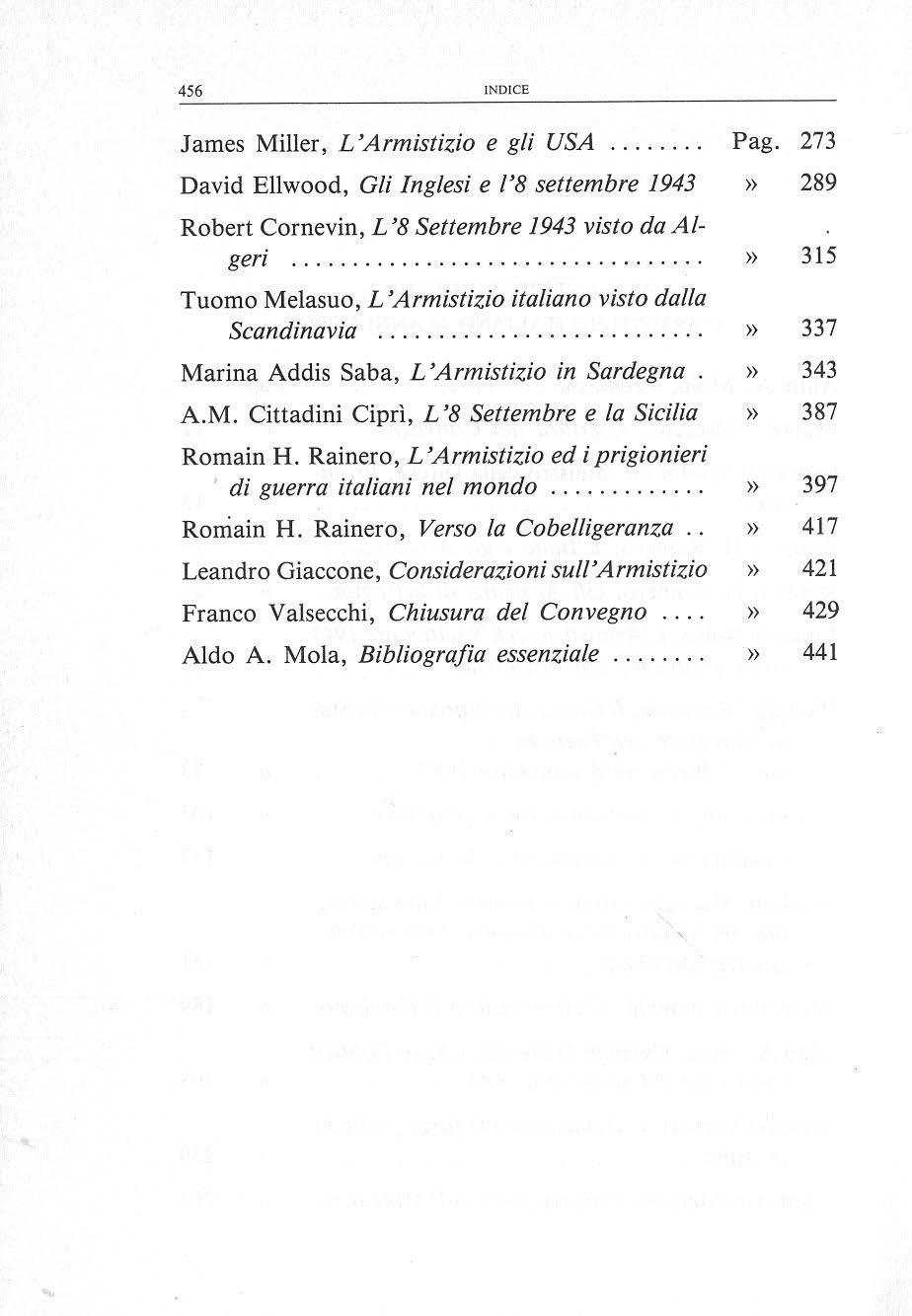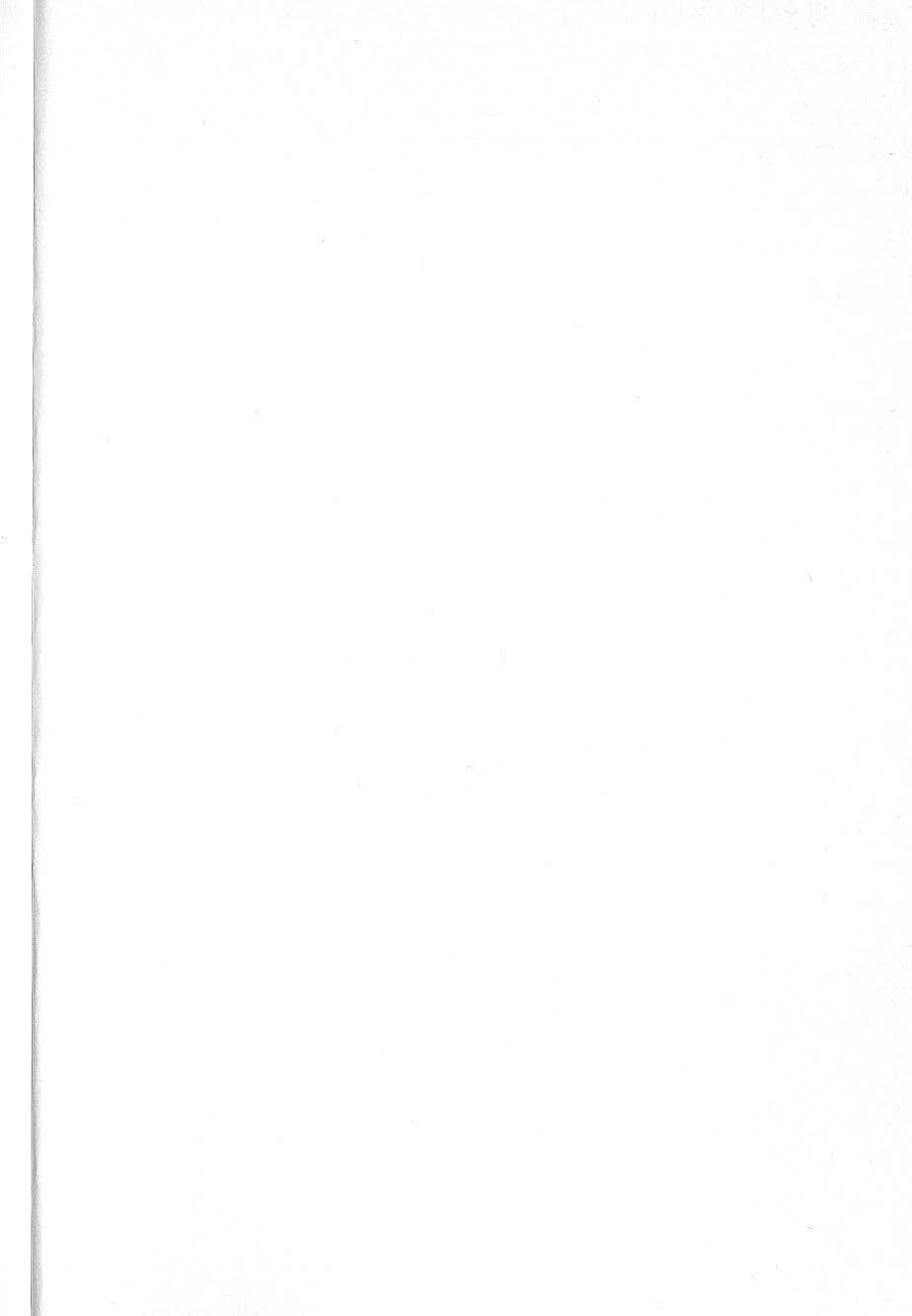MINISTERO DELLA DIFESA
COMITATO STORICO «FORZE ,ARMATE E GUERRA DI LIBERAZIONE»



COMITATO STORICO «FORZE ,ARMATE E GUERRA DI LIBERAZIONE»
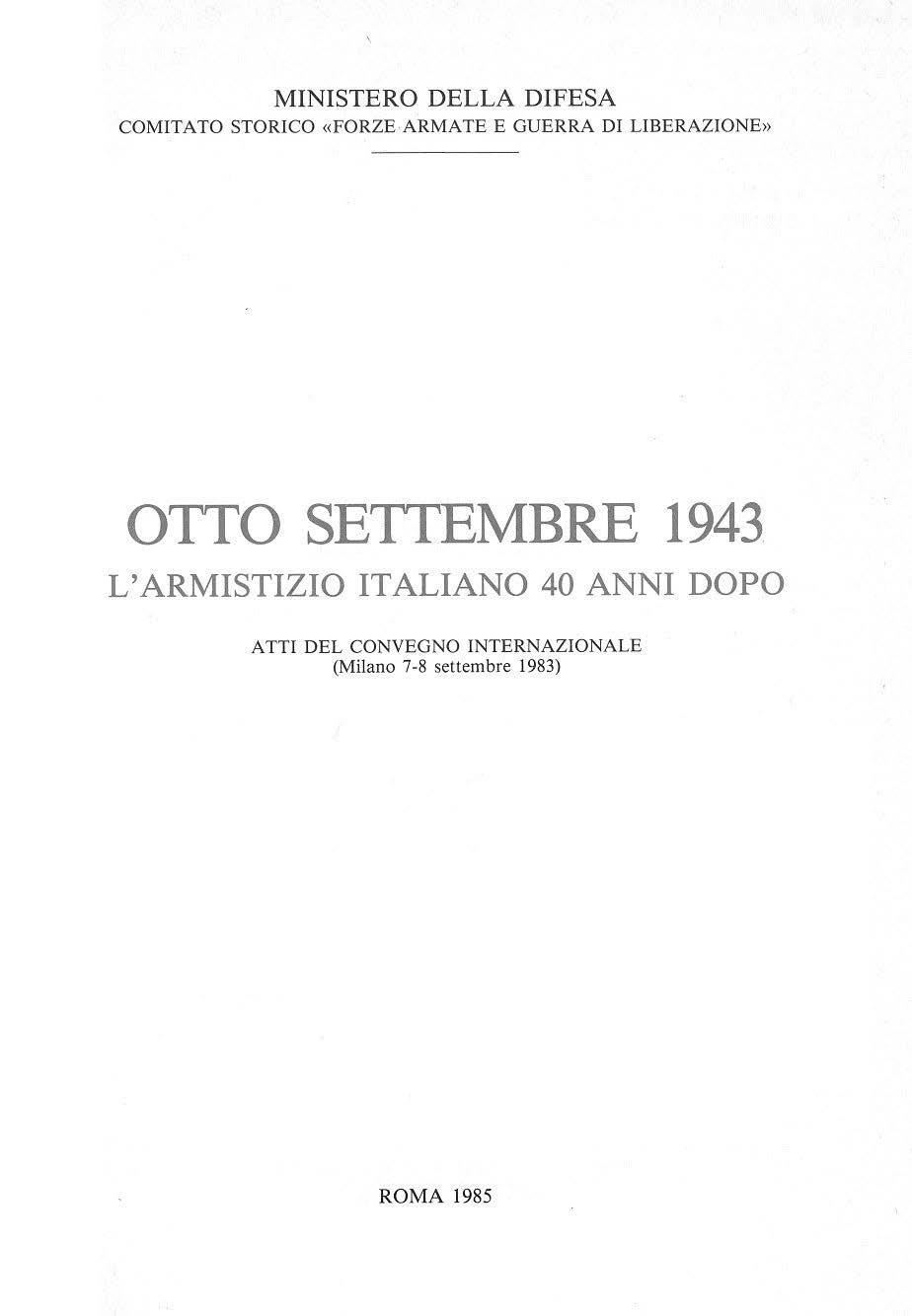
L'ARMISTIZIO ITALIANO 40 ANNI DOPO
ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE (Mi lano 7-8 settembre 1983)
ROMA
Tutti
© BY S ME UFFICIO STORI CO - Roma 1985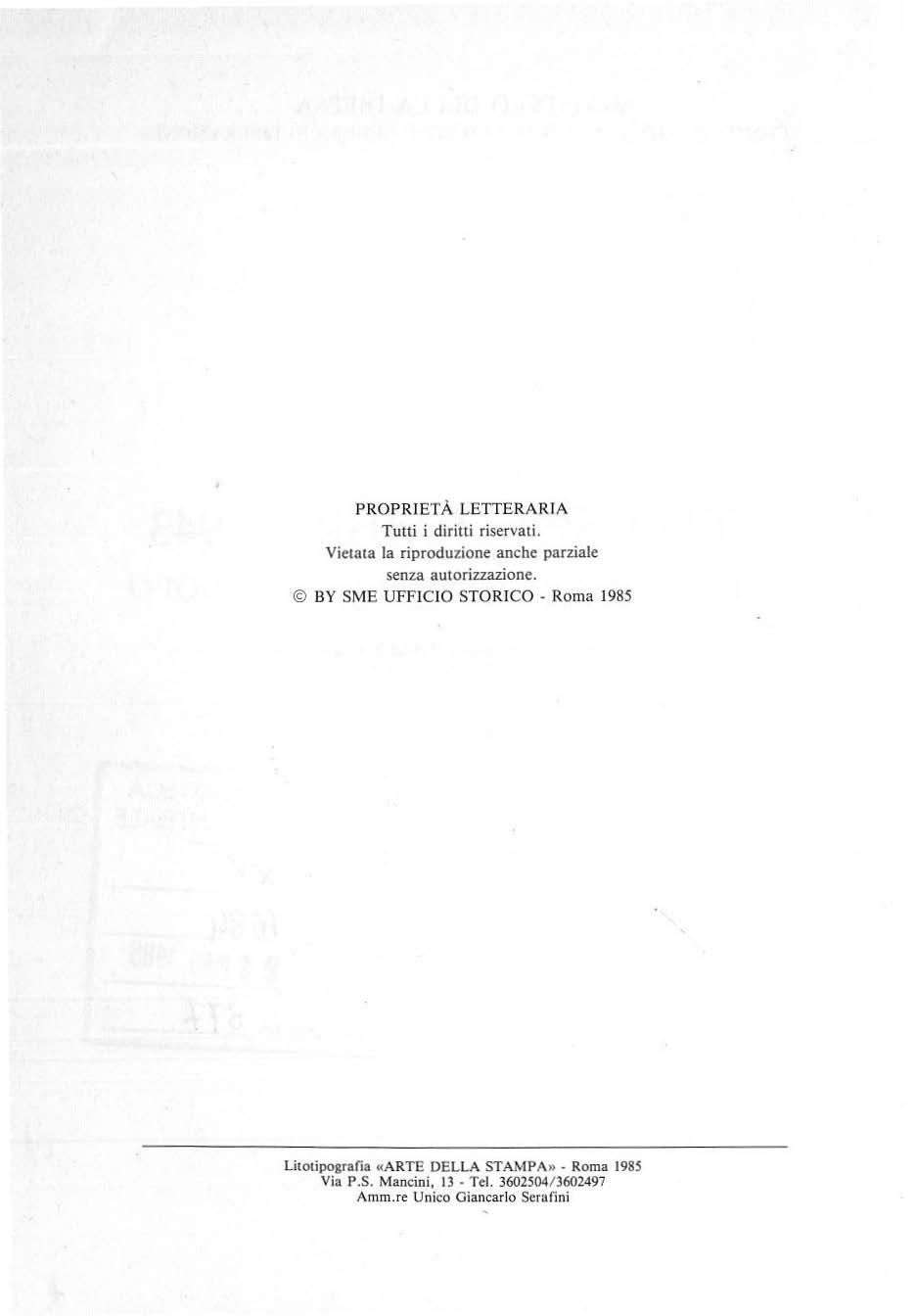


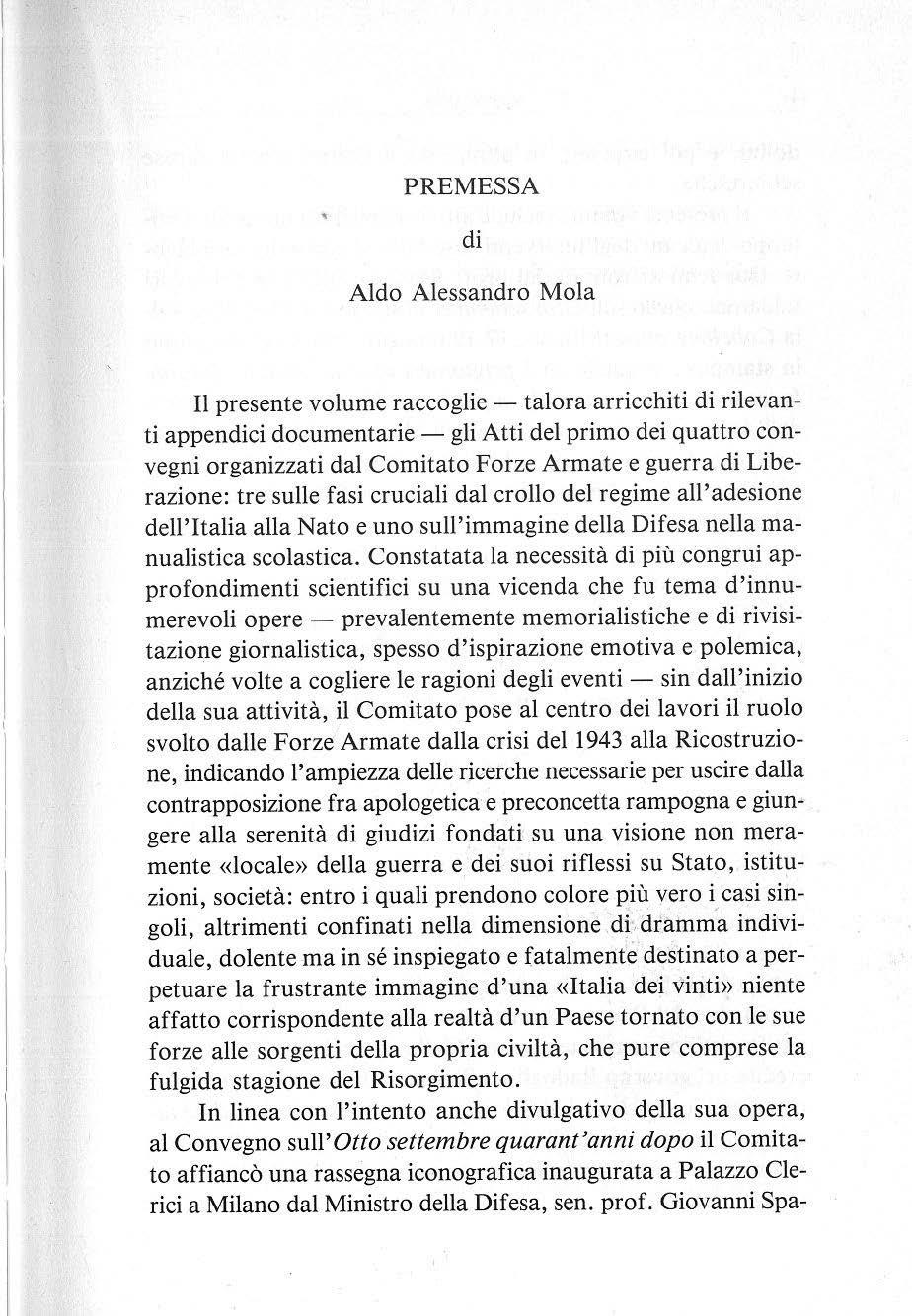
Il presente volume raccoglie - talora arricchiti di rilevanti appendici documentarie - gli Atti del primo dei quattro convegni organizzati dal Comitato Forze Armate e guerra di Liberazione: tre sulle fasi cruciali dal crollo del regime all'adesione dell'Italia alla Nato e uno sull'immagine della Difesa nella manualistica scolas tica. Constatata la necessità di più congrui approfondimenti scientifici su una vicenda che fu tema d'innumerevoli opere - prevalentemente memorialistiche e di rivisitazione giornalistica, spesso d'ispirazione emotiva e polemica, anziché volte a cogliere le ragioni degli eventi - sin dall'inizio della sua attività, il Comitato pose al centro dei lavori il ruolo svolto dalle Forze Armate dalla crisi del 1943 alla Ricostruzione, indicando l'ampiezza delle ricerche necessarie per uscire dalla contrapposizione fra apologetica e preconcetta rampogna e giungere alla serenità di giudizi fondati su una visione non meramente «locale» della guerra e dei suoi riflessi su Stato, istituzioni, società: entro i quali prendono colore più vero i casi singoli, altrimenti confinati nella dimensione .dLdramma individuale, dolente ma in sé inspiegato e fatalmente destinato a perpetuare la frustrante immagine d'una «Italia dei vinti» niente affatto corrispondente alla realtà d'un Paese tornato con l e sue forze alle sorgenti della propria civiltà, che pure comprese la fulgida stagione del Risorgimento.
In linea con l'intento anche divulgativo della sua opera, al Convegno sull'Otto settembre quarant'anni dopo il Comitato affiancò una rassegna iconografica inaugurata a Palazzo Clerici a Milano dal Ministro della Difesa, sen. prof. Giovanni Spa-
dolini, e poi circolata in altre città e visitata da numerose scolaresche.
Il presente volume includ e _ altresì contri buti maturati a sviluppo di alcuni degl'interventi suscitati nel corso dei suoi lavori. Due temi affro n tati dal prof. Rainero sulla fine dei lavori sa ldarono quello sull'Otto settembre al successivo Convegno sulla Cobelligeranza (Milano , 17-19 maggio 1984: i cui Atti sono in stampa) e a quello su I prigionieri militari italiani durante la sec onda guerra mondiale: aspetti e problemi storici, promosso dall'Amministrazione provinciale di Mantova (4-5 ottobre 1984: i cu i Atti furono or ora pubblicati nelle Edizioni Marzorati), e realizzato con l'egida del Comitato «FF .AA. e guerra di Liberazione».
Nell'offr ir e agli studiosi una circo scritta ma densa collana di documentati saggi sto rici sulle Forze Armate dalla sconfitta a lla Rico struz ione il Comitato assolve il compito affidatogli: contribuire a l superamento dei pregiudizi sulla stagione più diffici le dell'Italia contemporanea, promuovendo la riflessione storica su basi scie ntifich e e di sicura dignità intellettua le. Su ta le scorta, «Otto settembre» - crediamo - non potrà più suonare quale sinonimo di catastrofe, di fuga ignom ini osa, di rotta senza prospettiva alcuna, qua si più grave e irreparabile Caporetto . Dai lavori qui raccolti emerge infatti che, pur fra difficoltà gravissime e nella solitudine di responsabilità non potute spartire né ta ntom eno svelare, operò una classe di governo che lenta m ente pilot ò l'Italia verso meno angosciosi approdi e, più o ltr e, sulla soglia d'una r ip resa poi meglio consentita dalla sa ldatura fra la parte più lungimirante di quella diri genza e le forze più vive del Paese, organiz zate e rappresentat e nei comitati antifascisti: passaggio te mpestoso dalla «guerra del duce», greve eredità pel governo Badoglio, alla nuo va Italia, effett uat o con piena coscienza che «martello inglese est grosso et incudin e tedesca durissima» come il 14 agosto 1943 il Mini stero della Guerra scrisse al gen . Vittorio Ru ggero, comandante della difesa territoriale di Milano.
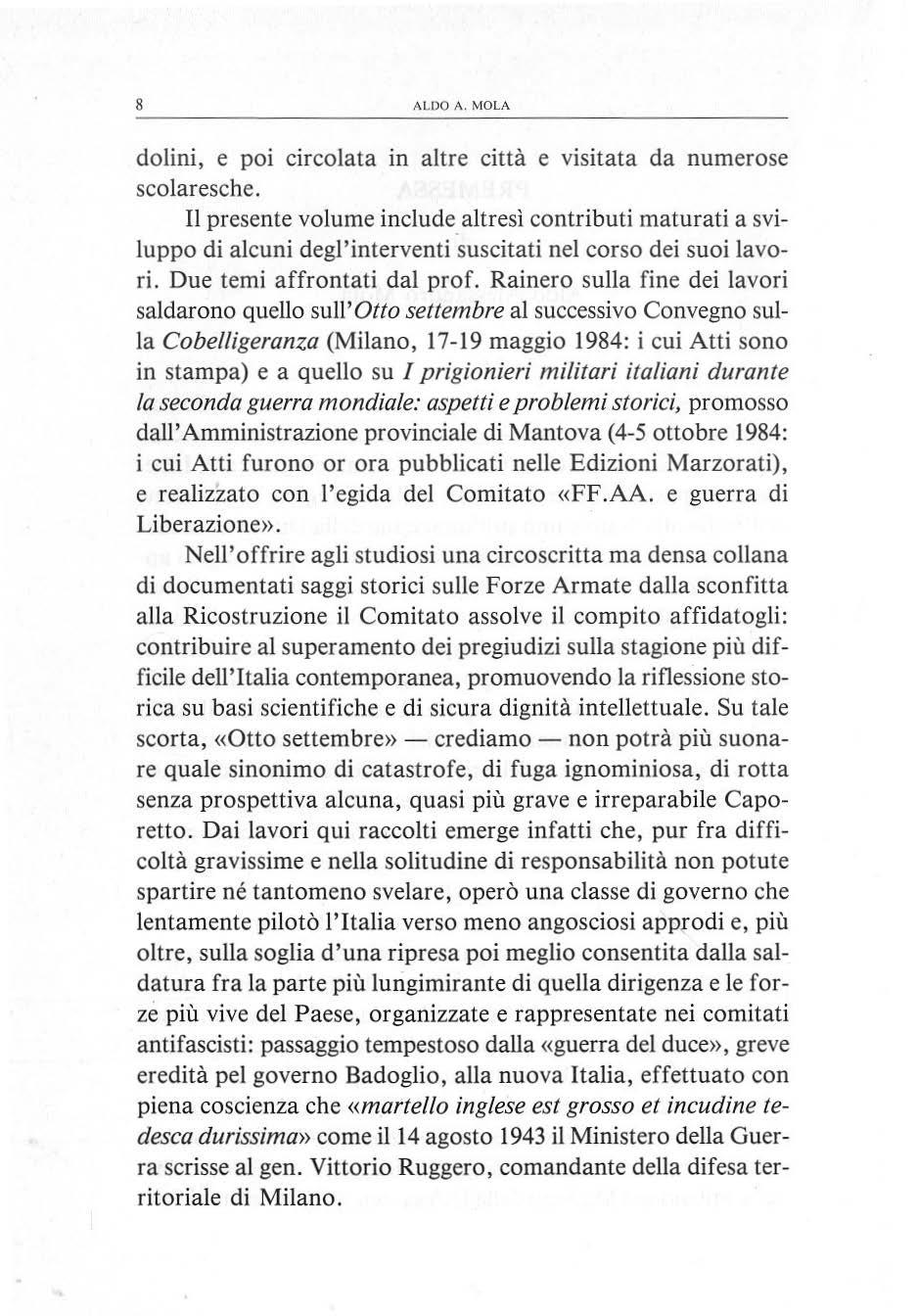
I curatori del volume esprimono il più vivo ringraziamento al Gen. Pierluigi Bertinaria, capo dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, nelle cui prestigiose edizioni esso compare, e per. la solerte ed esperta assistenza al magg. Saccarelli, al col. Alessandro Bianchini e al ten. col. Paolo Riccioni, che in diverse fasi ne propiziarono la realizzazione.
Nom inato dal M inistro della Difesa, il Comitato «F F .AA. e guerra di Liberazione»presieduto dal prof. Umberto Giovine e composto da l pro f Paolo U ngari , vice presidente, dai Cap i degli Uffi c i sto r ici dell'Esercito, della Mar in a e dell'Aeronautica (ge n P ierluigi Bertinari a, col. L uig i Casol ini, e dal C.A. Gino Galuppini (po i sosti tu iti dal C.U. Leonardo Panebianco e dal magg. Mario Cermelli) e dai pro ff. Elena Aga Rossi, Giuseppe Mammarella, Aldo A Mola, A lberto Monticone, Romain H Rainero - ebbe il compito di «approfondire gli aspetti storici e le componenti sociopolitiche che determinarono la ricostruzione delle Forze Armate e la loro partecipazione alla Liberazione nella campagna di guerra 1943 -/945 »)

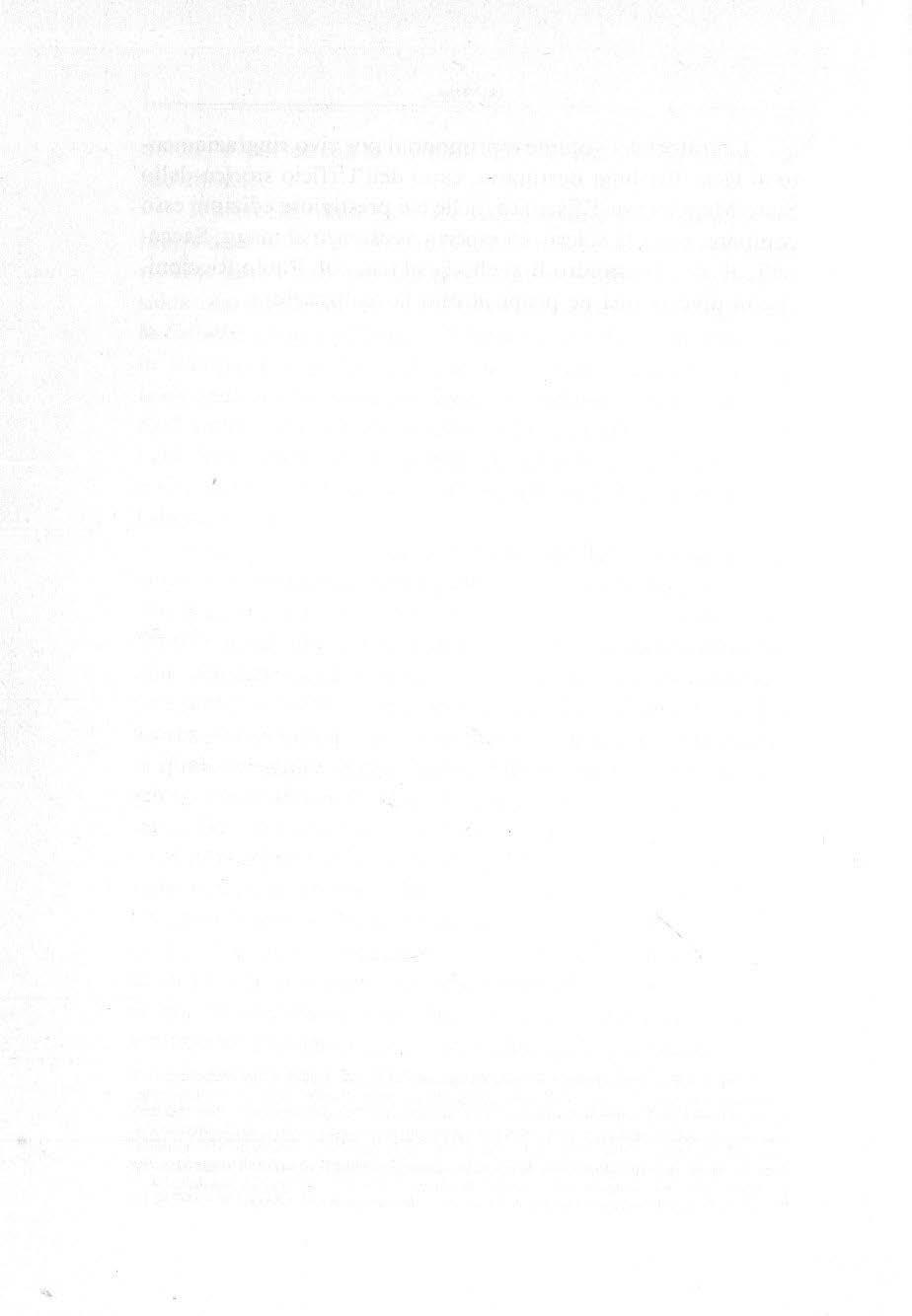
Franco Valsecchi

Adempio anzitutto al gradito dovere di porgere il nostro più grato benvenuto a quanti hanno voluto essere qui fra noi, in questo convegno ideato e promosso dal Ministero della Difesa; un convegno al quale l'I.S.P .I. è lieto .o orgoglioso di dare una sede, di fornire la incondizionata collaborazione, per la fonte dalla quale proviene l'invito, per l'interesse che presenta la trattazione, per il prestigio degli studiosi ai quali. è affidata. Interesse e prestigio, che trovano una eloquente testimonianza nell'affluenza del pubblico, di un pubblico d'eccezione, che raccoglie nelle sue file una rappresentanza qualificata e qualificante di militari e di diplomatici (vedo qui largamente presente il corpo conso lare milanese).
Una dettagliata elencazione ci porterebbe troppo lontano; e non ce la possiamo permettere. Mi limito a rivolgere un particolare sa luto al prefetto Vicari, e al presidente del Consiglio Regionale Sergio Malvezzi, ai quali tengo ad esprimere il nostro vivo compiacimento per la loro presenza. Una parola ancora, che rientra, d'altronde, nel protocollo, ma va ben al di là dei doveri protocollari d'ufficio: il nostro saluto, il più caldo, il più vivo saluto all'ambasciatore Enrico Aillaud, che fu, sino .a ieri, il presidente dell'I.S.P .I., e ci ha lasciato , trattenuto com'è dai suoi impegni romani. Tanto più siamo grati al Ministero degli Esteri di averci inviato a prova del suo interessamento per un Istituto come l'I.S.P.I., un suo eminente rappresentante, l'ambasciatore Fausto Bacchetti, con l'incarico di fiducia - fiduc iario, appunto, è il suo titolo ufficiale - di assistere, col consiglio e con l'opera, l'I.S.P .I. , nelle difficoltà in cui si trova, le incombenti difficoltà finanziarie.
Il nostro convegno, dicevamo,. è sotto gli auspici del Ministero della Difesa. Non si potevano desiderare auspici migliori, dato che a coprir la carica di ministro è uno storico: ed uno storico del formato di Giovanni Spadolini. Ritorneremo sull'argomento fra poco, quando si apriranno i lavori.

E fu il Comitato Storico istituito dal Ministro, «con il compito - cito il testo stesso dello Statuto - di approfondire gli aspetti storici e le componenti socio-politiche che determinarono la ricostituzione delle forze arma te e la loro partecipazione alla liberazione nella campagna di guerra 1943-45»; fu il suo presidente, Umberto Giovine, a dare l'avvio a questo nostro convegno, mentre Romain Rainero ne assunse la direzione scientifica, Romain Rainero un collega ed amico del quale ho sempre ammirato la non comune dote di saper conciliare, ad un tempo, lo spirito pacato e meditativo dello studioso di vocazione, e il più attivo e fattivo spirito di iniziativa, animato da una eccezionale carica vitale. * * *
Ed ora, adempiuto ai riti, ai debiti riti, di quella che si può qualificare «l'apertura formale» del nostro convegno - condotta con esemplare brevità, e sobrietà, bisogna riconoscerlo - preghiamo Giovanni Spadolini di voler procedere alla «apertura reale», l'inizio dei lavori, illustrando da par suo, il contenuto effettivo di questo nostro convegno, il carattere che riveste, gli intenti che si prefigge.
Una preghiera, che non si rivolge soltanto al Ministro, che si rivolge, non meno, allo storico, ad uno storico come Spadolini, che oc cupa un posto a sé nella storiografia italiana. Titolare di una cattedra fondamentale in una grande Università, e ad un tempo uomo politico al più alto livello, la storia, oggetto dei suoi studi, egli la sente, la vive con l'intensità di una esperienza di vita vissu t a.
Viene spontaneo il richiamo ad una grande tradizione, ai grandi Maestri dell'Ottocento, i Thiers, i Guizot, i Tocqueville. Il suo sguardo si rivolge, come il loro, ad un passato ancora vicino, che nel giudizio comune viene a collocarsi nella prospettiva politica del presente. Ma il suo sguardo, come il loro, mira a ben altri orizzonti: a collocare quel passato, che incombe sul presente, nella prospettiva della storia.
Ed è questa la via che si propone il nostro Convegno. Dedicato all'8 settembre 1943, nella sua quarantennale ricorrenza, - rivolto com'è all'esame di un evento come l'armistizio, che segna una fine ed un principio nella storia d'Italia, si propone di sottoporlo ad una indagine serrata, condotta, nella ricerca, nella critica, secondo le regole del più rigoroso metodo storico. Fare della storia, non della politica, della polemica o dell'apologia. Rinnovo al Ministro e al collega insigne l'espressione del nostro più vivo compiacimento e della nostra più viva riconoscenza per aver scelto l'I.S.P.I. come la sede più adatta per una manifestazione di così vasta portat a e di così alto significato.
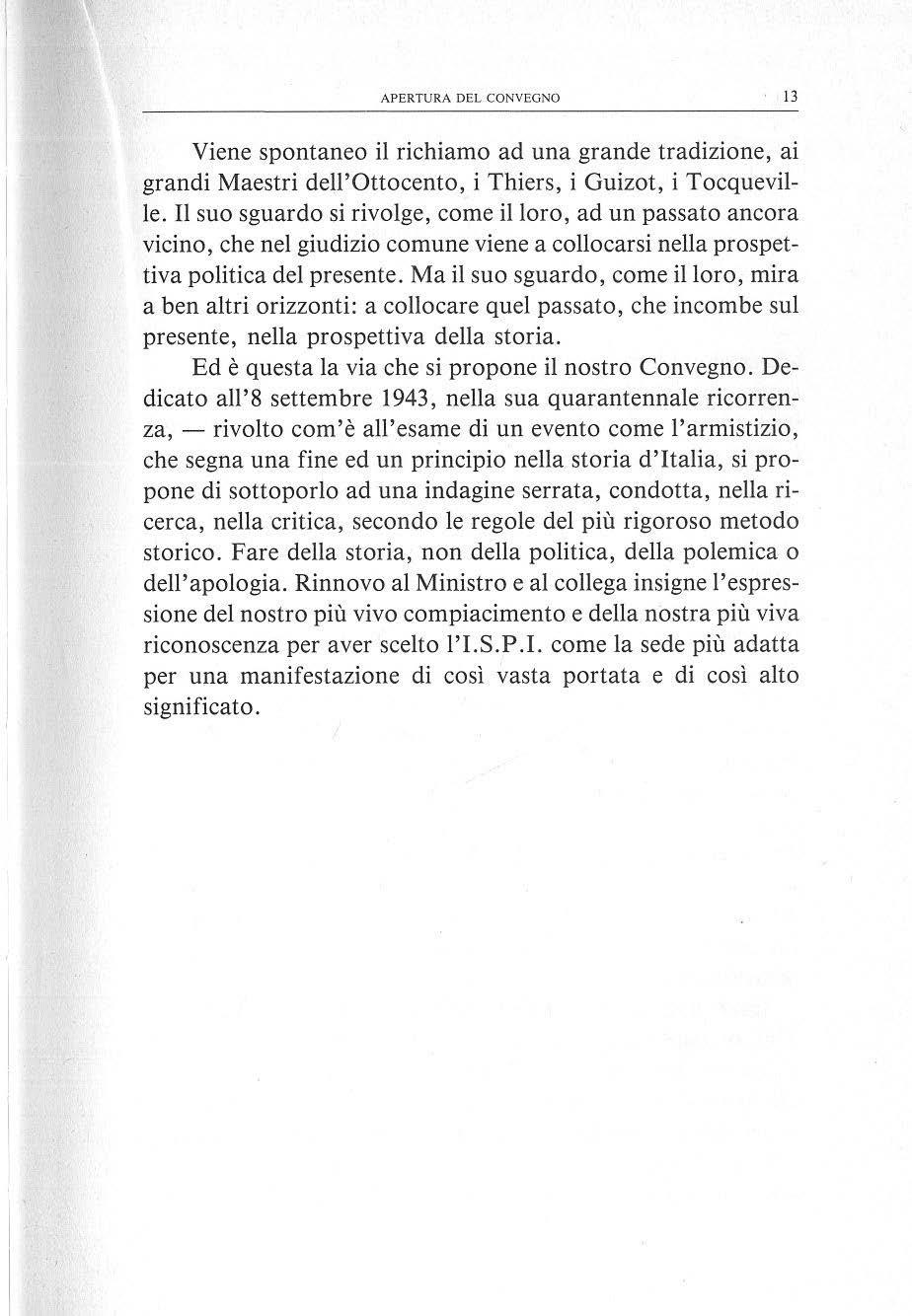
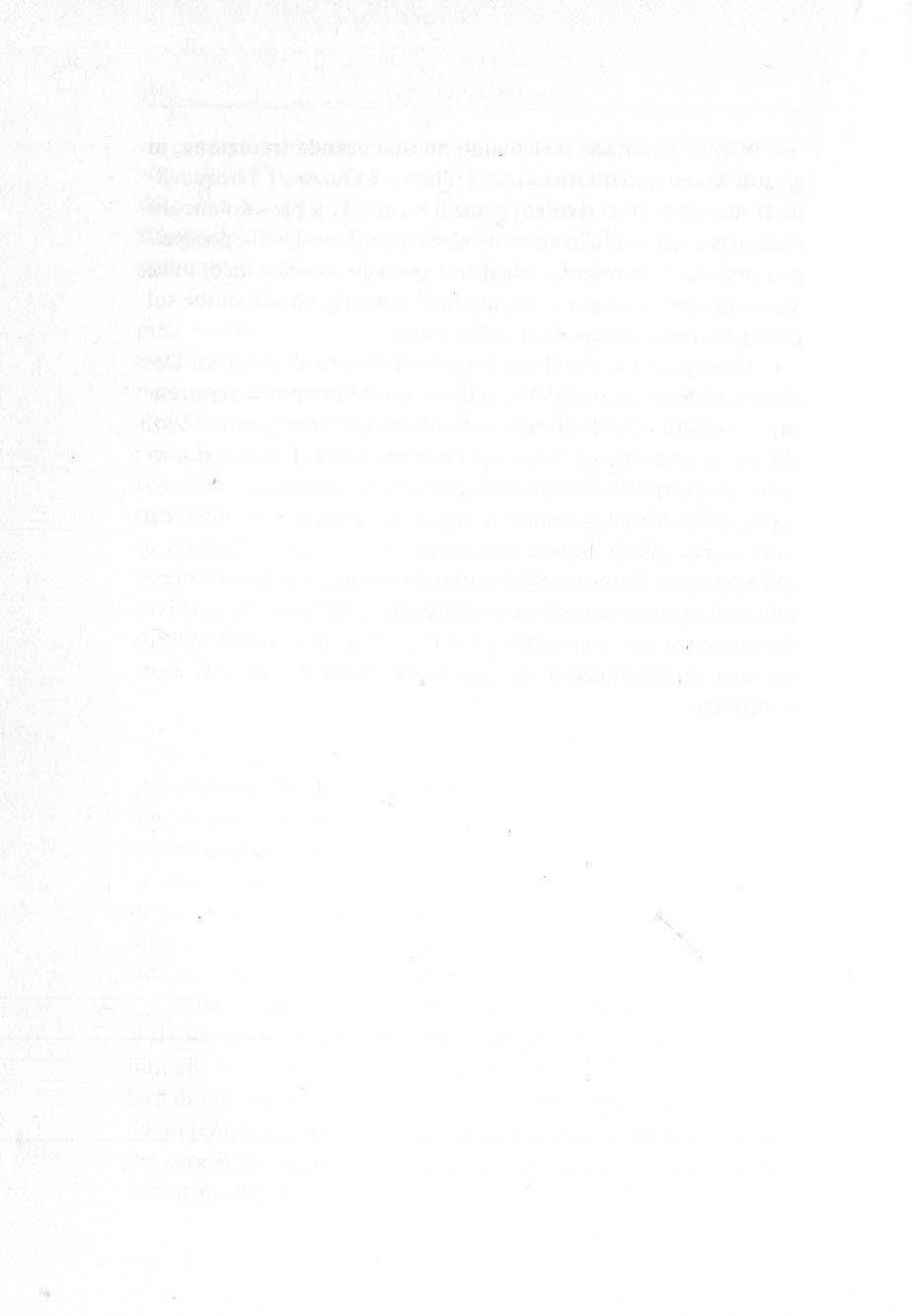
Quella sera dell'8 settembre di quaranta anni fa, dopo che alle 19.45 fu reso noto l'armistizio di Cassibile dando luogo a convulse alternative di coscienza, richiede ancora oggi a tutti noi di curvarci su quella vicenda con animo di pietas storica e con il senso intero di una tragedia italiana.
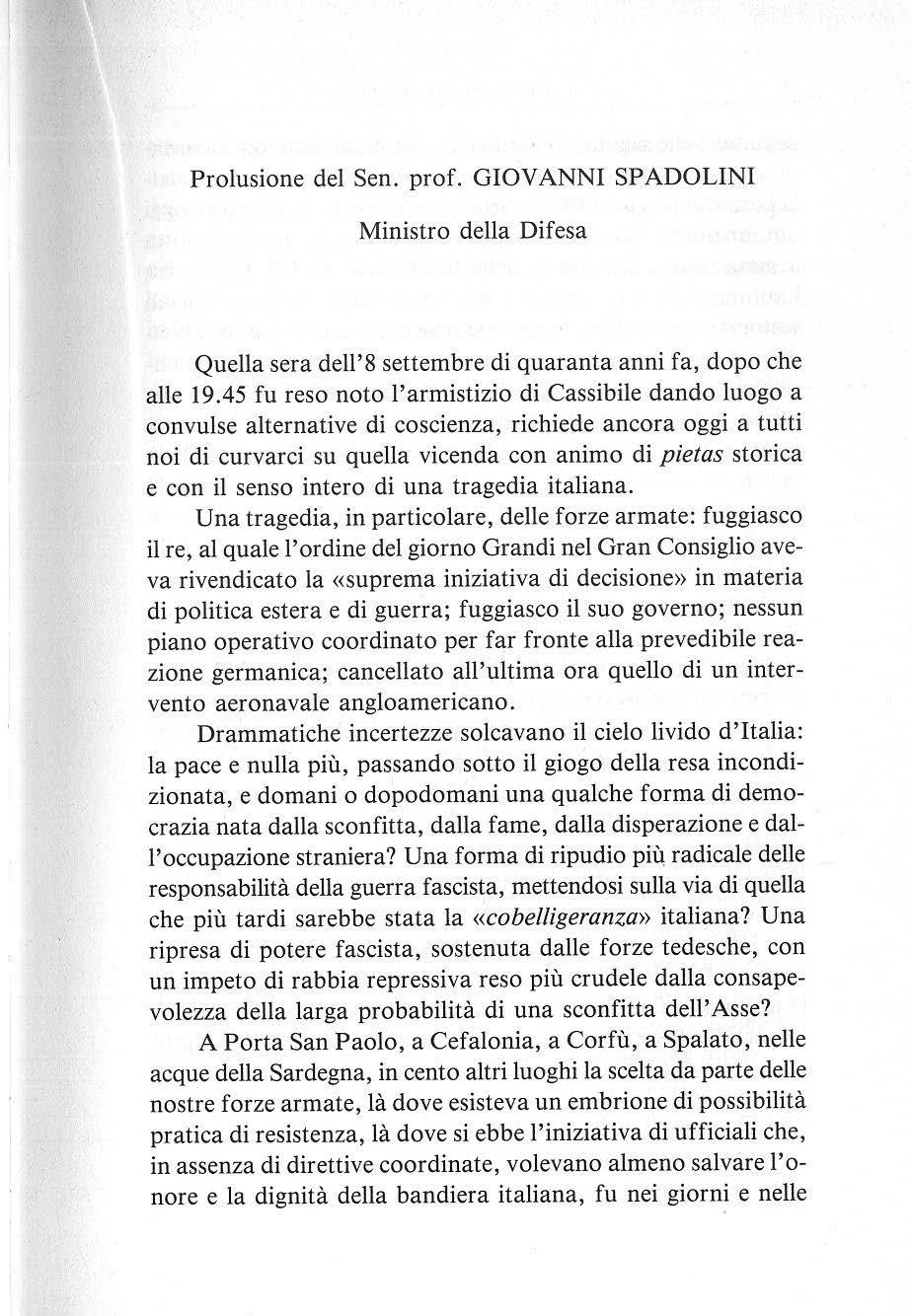
Una tragedia, in particolare, delle forze armate: fuggiasco il re, al quale l'ordine del giorno Grandi nel Gran Consiglio aveva rivendicato la «suprema iniziativa di decisione» in materia di politica estera e di guerra; fuggiasco il suo governo; nessun piano operativo coordinato per far fronte alla prevedibile reazione germanica; cancellato all'ultima ora quello di un in t ervento aeronavale angloamericano.
Drammatiche incertezze solcavano il cielo livido d'Italia: la pace e nulla più, passando sotto il giogo della resa incondizionata, e domani o dopodomani una qualche forma di democrazia nata dalla sconfitta, dalla fame, dalla disperazione e dal1' occupazione straniera? Una forma di ripudio pili; radicale delle responsabilità della guerra fascista, mettendosi sulla via di quella che più tardi sarebbe stata la «cobelligeranza» italiana? Una ripresa di potere fascista, sostenuta dalle forze tedesche, con un impeto di rabbia repressiva reso più crudele dalla consapevolezza della larga probabilità di una sconfitta dell'Asse?
A Porta San Paolo, a Cefalonia, a Corfù, a Spalato, nelle acque della Sardegna, in cento altri luoghi la scelta da parte delle nostre forze armate, là dove esisteva un embrione di possibilità pratica di resistenza, là dove si ebbe l'iniziativa di ufficiali che, in assenza di direttive coordinate, volevano almeno salvare l'onore e la dignità della bandiera italiana, fu nei giorni e nelle
settimane che seguirono, netta e corale. Essa verrà qui ricordata nei suoi aspetti particolari e memorabili. Ma al Ministro della Difesa di un governo democratico appartiene di ricordare oggi qui, anzitutto, che quella scelta si colloca agli inizi della lotta armata contro l'invasore, della Resi stenza. 87 .303 caduti, fra l'autunno '43 e la primavera '45, 365 medaglie d'oro a ufficiali sottoufficiali e soldati, altre medaglie d'oro che fregiano le bandiere di armi, corpi e reparti hanno una nuda, severa eloquenza che non patisce commentario di parole artificialmente commosse. Ed essi parlano ormai a noi anche attraverso le parole scolpite nella Costituzione della Repubblica, nelle quali il loro sacrificio senza esitazione e, in tanti, senza speranza, trova la forma di una volontà energica di vita nazionale futura.
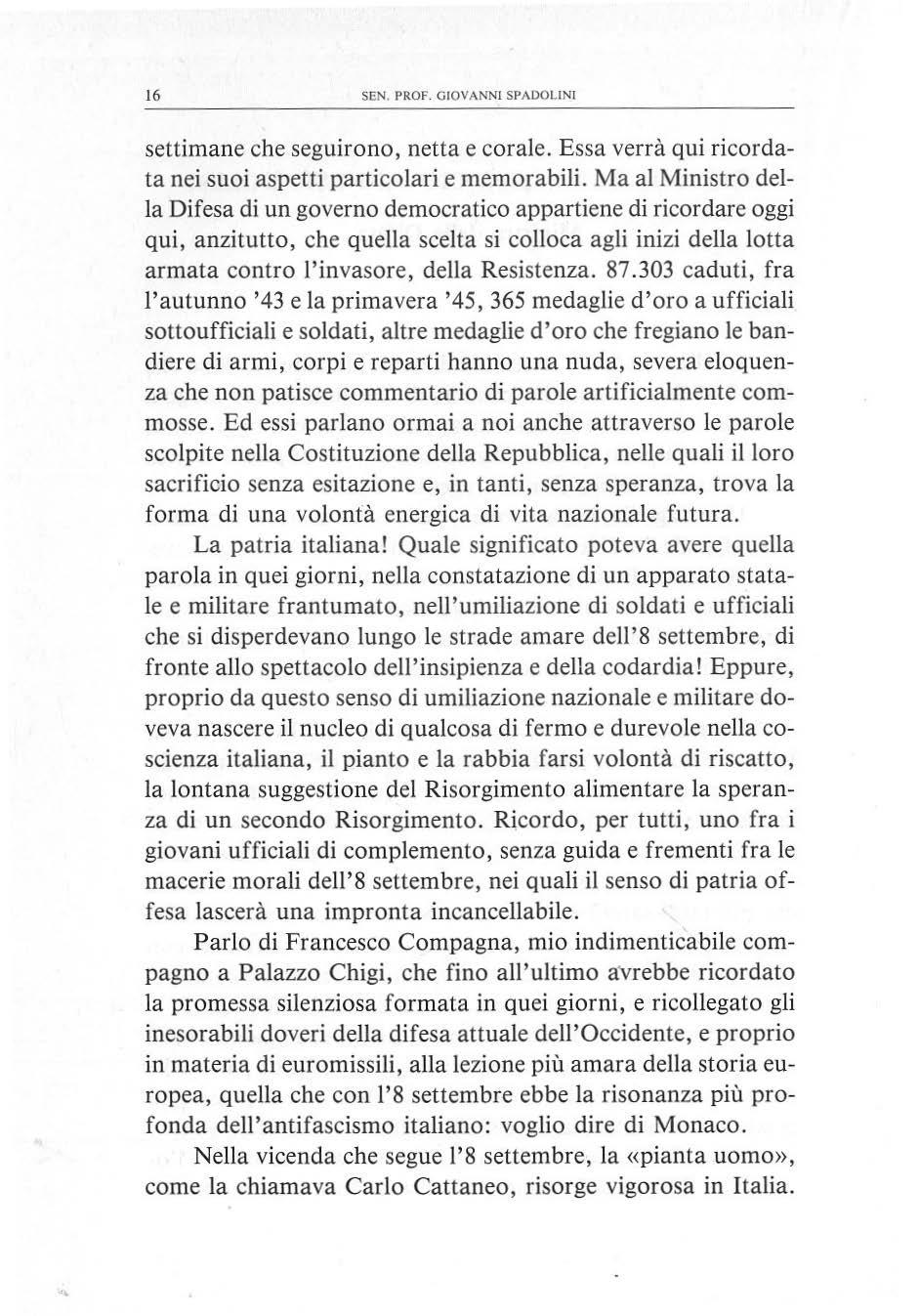
La patria italiana! Quale significato poteva avere quella parola in quei giorni, nella constatazione di un apparato statale e militare frantumato, nell'umiliazione di so ldati e ufficiali che si disperdevano lungo le strade amare dell'8 settembre, di fronte allo spettacolo dell'insipienza e della codardia! Eppure, proprio da ques to senso di umiliazione nazionale e militare doveva nascere il nucleo di qualcosa di fermo e durevole nella coscienza italiana, il pianto e la rabbia farsi volontà di riscatto, la lontana suggestione del Ri sorgimento alimentare la speranza di un secondo Risorgimento. Ricordo, per tutti, uno fra i giova ni ufficiali di complemento, senza guid a e frementi fra le macerie morali dell'8 settembre, nei qua li i l senso di patria offesa lascerà una i mp ronta incancellabile.
Parlo di Francesco Compagna, mio indimentic abile compagno a Palazzo Chigi, che fino all'ultimo avrebbe ricordato la promessa silenziosa formata in qu ei giorni, e ricollegato gli inesorabili d overi della difesa attual e dell'Occidente, e proprio in materia di euromissili, alla lezione più amara della storia europea, quella che con 1'8 settembre ebbe la risonanza più profonda dell ' antifascismo itali ano : voglio dire di Monaco. Nella vicenda che segue 1'8 se ttembre, la «pianta uomo», come la chiamava Carlo Cattaneo, risorge vigo rosa in Italia.
Nei soldati italiani di ogni grado (dovunque, ripeto, si ritrovasse un minimo di condizioni operative, entro e fuori i confini, e dei capi) scattò immediato l'impegno della riscossa. Un impegno ancor più meritorio perché prese corpo nel volgere di poche ore o giorni, e nel contesto di un giustificato sbandamento generale. Si reagì anche là dove non sussisteva ragionevole probabilità di successo, dove la certezza era nel senso dell'annientamento, o di crudeli rappresaglie.
Intere unità di dissolsero, è vero: ma in molti casi non perché mancasse lo spirito combattivo, ma per assenza di direttive ai comandi periferici unita a inferiorità schiacciante di armamenti, o per decisione di comandanti che preferirono con saggia umanità lasciar liberi, e serbare a future lotte, i loro uomini piuttosto che condannarli all'annientamento, ai plotoni di esecuzione, alla deportazione. Non pochi fra quei comandanti si offriranno poi con consapevolezza ai plotoni di esecuzione del nuovo nemico.
Esistono più ragioni, che il convegno verrà identificando e districando, per le quali i cammini della storiografia italiana e, ad esempio, francese sono stati nel dopoguerra così divergenti, e fra noi ha prevalso a lungo ùn senso come di oblio della sventura. Ma se la nostra letteratura storica non possiede un grande esame di coscienza come fu, ad esempio, L 'étrange défaite di Mare Bloch (e un'eco non placata ne ritorna nella sua Apologie de l'histoire), non si può assegnare come sola causa la inevitabilità della sconfitta finale della guerra fascista.
Quella convinzione di inevitabilità era un atto di fede combattente, più e prima che il risultato di un calcolo delle forze in gioco. Nel corso della guerra vi erano stati, invece, periodi nei quali la vittoria dell'Asse e l'avvento del Nuovo Ordine europeo (Neue europeische Ordnung») erano apparsi a più d'uno, anche dalla parte dell'antifascismo, inevitabili.
Nel 1943, senza dubbio, era già diverso. Eppure una lunga notte di quasi due anni attendeva ancora l'Italia perfino con lo spettro crudele della guerra civile che ci r iportava alla stagio ne pre-unitaria, ai seco li della decadenza e del servaggio .
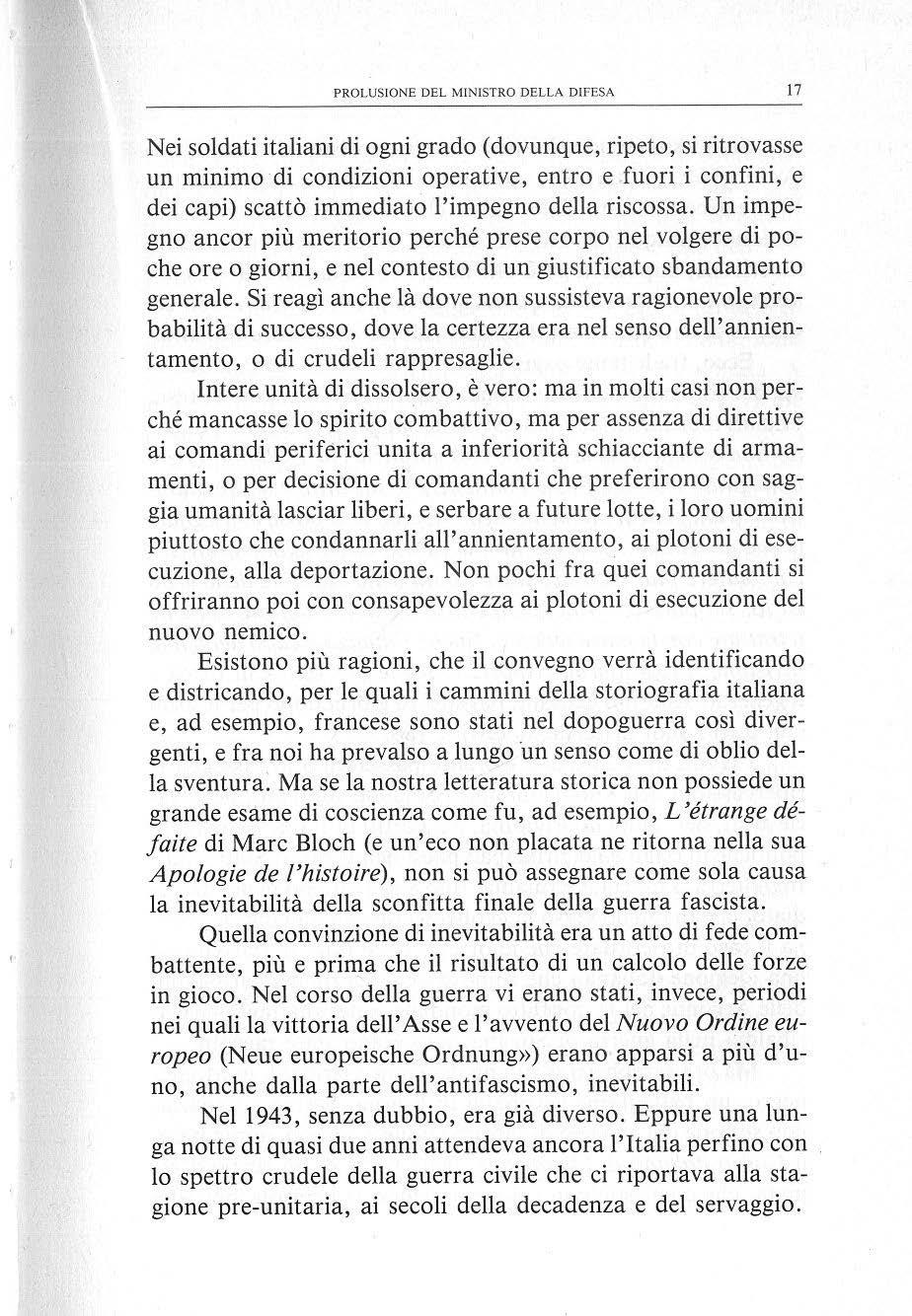
Su questo sfondo risalta il sempli ce eroismo di quanti, singoli e reparti militari, fino al livello di divisione, scelsero di obbedire al comunicato di armistizio che, mentre prevedeva la cessazion e ovunque di atti di ostilità contro le forze angloamericane, imponeva però alle nostre forze armate di «reagire ad a ventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza». Non cedere le armi : questo era l'ultimo ridotto dell'onore italiano.
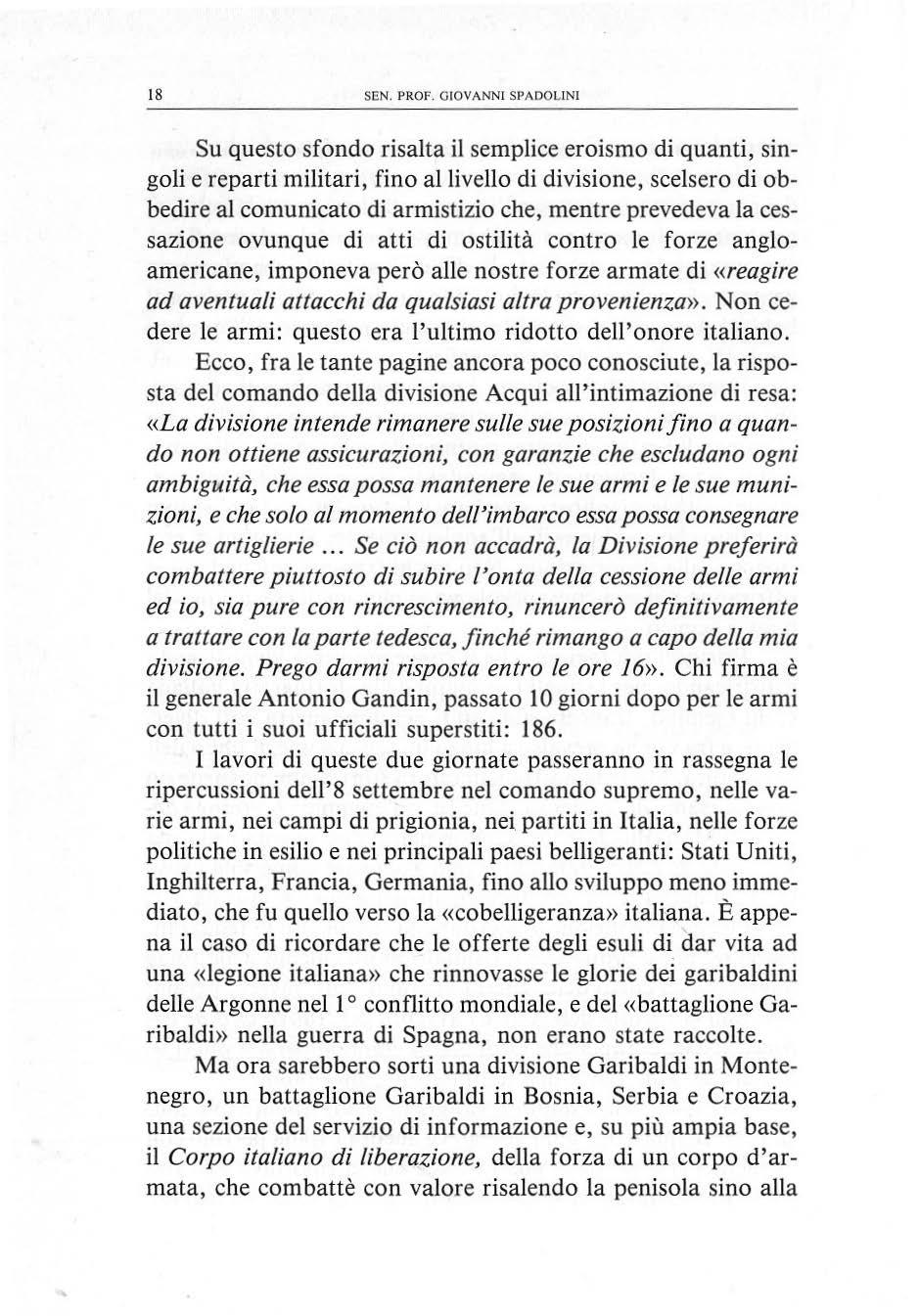
Ecco, fra le tant e pagine ancora poco conosciute, la risposta del comando d ella divisione Acqui all'intimazione di resa: «La divisione intende rimanere sulle sue posizio ni fino a quando non ottiene assicurazi oni, con garanzie che escludano ogni ambiguità, che essa possa mantenere le sue armi e le sue munizioni, e che solo al momento dell'imbarco essa possa consegnare le sue artiglierie .. . Se ciò non accadrà, la D ivisione preferirà combattere piuttosto di subire l'onta della cessione delle armi ed io, s ia pure con rincrescim ento, rinuncerò definitivamente a trattare con la parte tedesca, finché rimango a capo della mia divisione. Prego darmi risposta entro le ore 16». Chi firma è il generale Antonio Gandin , passato 1Ogi orni dopo per le armi co n tutti i suo i ufficiali superstiti: 186.
I lavori di queste due giornate passeranno in ra ss egna le riper cuss ioni dell'8 sette mbre n el comando s upremo, nelle varie armi, nei campi di prigionia, nei part iti in Italia, n elle for ze politiche in esilio e nei principali paes i belligeranti: S tat i Uni ti, Inghilterra, Francia, Germania, fino allo svil uppo meno immediato, che fu quello ve rs o la «cobelligeranza» italiana. È appena il caso di ricordare che le offerte d egli e s uli di dar vita ad una « legi one italiana» che rinnova sse le glori e dei garibald ini delle Argonne nel 1° conflitto mondiale, e del «battaglione Garibaldi » nella g uerra di Spag na, non er ano sta te raccolte. Ma ora sa rebbero so r ti una divi sione Garibaldi in Montenegro, un battaglione Garibaldi in Bosnia, Serbia e Croazia, una sezione del s ervizio di informazione e, s u più ampia base, il Corpo italiano di liberazione, della forza di un corpo d'armata , che combattè con valore risalendo la penisola s ino alla
linea Gotica, e nell'ultima fase i quattro «gruppi di combattimento» Cremona, Friuli, Folgore e Legnano, oltre a due già approntati, Mantova e Piceno, che avevano forza di divisioni, anche se la prudenza lessicale degli alleati impose una denominazione più riduttiva.
Queste, dall'angolo visuale che è e de ve essere proprio di un Ministro della Difesa della nuova democrazia italiana, sono alcun e non ignorabili origini della prima resistenza armata. A noi di non dimenticarlo, alla st oriografia di coglierne le vicine e lontane interrelazioni con la complessiva storia d'Italia.
Non dimenticare significa ricercare nella medi tazio ne del passato le sorgenti dell'energia costruttrice dell'avvenire. E chieder si, anche, in quale misura si sia stat i degni del sacrificio di uomini che non sono più. Quaranta anni formano una int era misura storica. Per gli anziani, che videro e vissero quegli avvenimenti, è un'ora di bilanci: e il co n su n t ivo delle speran ze è incerto, spesso amaro.
Per i giovani, che ancora non erano nati, vale nel bene e nel male il risultato del moto c he si svi luppò da quei giorni per approdare all'insurre zione d'aprile del 1945 e alla Repubblica. È questa la base sulla quale ess i sono chiamati ad agire, e questo anche l'o ggetto del giudi zio st ori co. Che non è giustificatore, né giustiziere ma ambisce a porci di fronte alla verità, attraver so l'accertamento di ciò che è realmente accaduto. E la verità è la sola premessa all 'azio n e consapevole, cioè efficace. Dobbiamo misurare in che cosa quel movimento di riscatto nazionale e di rinnovamento democratico è riuscito, e dov e è fallito. L ' Italia ha riscattato allora, combattendo, l'onore; ha riavuto l'indipendenza nazionale; ha ripreso il suo seggio nei grandi consess i democratici mondiali; ha fondato, per volontà di popolo, la Repubblica e ne ha disegnato le libere istituzioni. La sua Costituzione, come inse gnava Piero Calamandrei, è insieme un bollettino di vittoria sui resti della dit ta tura totalitaria sconfitta, e un programma di vita morale e di grandi riforme civili. Ci sono st ate insidie e minacce: ma la Repubblica ha re-
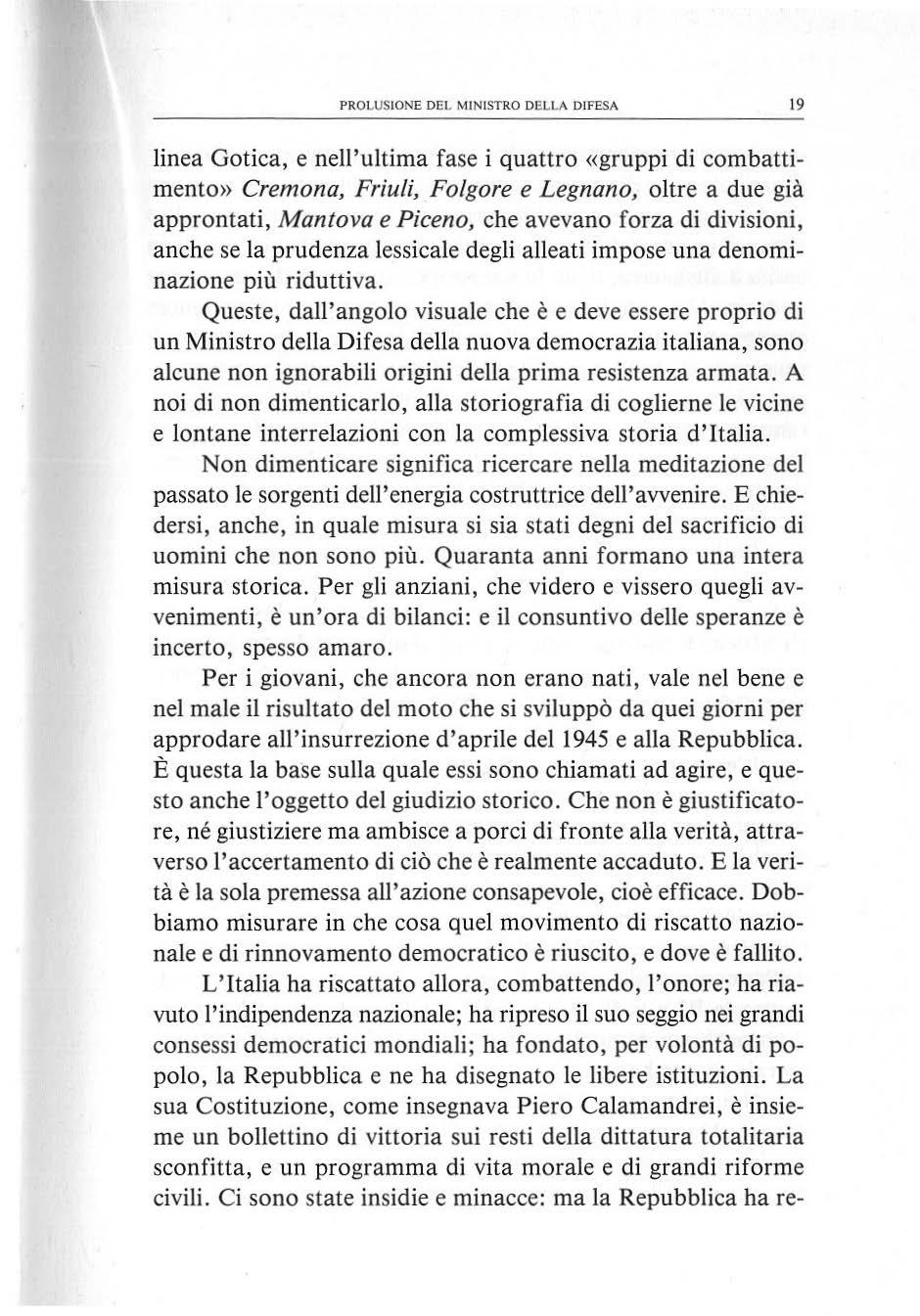
sistito, mentre prendevano via via forma le istituzioni costituzionali che ne delineano il volto concreto. Intanto, il paese ha attraversato, grazie a quell'inserimento fermo nel sistema delle alleanze occidentali che fu la scelta decisiva della generazione uscita dalla guerra, il più lungo periodo di pace della sua storia unitaria. Una condizione, questa, che ci appare tanto felice quanto scontata, mentre pure conflitti locali e bufere di guerra squassano il mondo; ma gli storici futuri sapranno apprezzarne le ripercussioni profonde sulla nostra vita collettiva, e ci diranno a quale prezzo è stata conquistata e mantenuta. Anche l'ora che attraversiamo, e le difficili responsabilità che affrontiamo, sono un capitolo della lotta per difendere le sempre attaccate garanzie della pace.
Indipendenza , Repubblica , pace: è molto , eppure non basta. Anche in questi giorni sentiamo dire e leggiamo che non è stata, non è la «Repubblica pura e dura» che sognavano i migliori della Resistenza. Non ovunque il senso del dovere è egualmente fermo, g li argini contro la corruttela invalicabili, l'efficienza degli apparati di Stato all'altezza della sfida di questo tempo.
L'organismo umano può lottare vittoriosamente contro le malattie: ma non è dubbio, se guardiamo a quest'ultimo giro di anni, che l'eversione terrorista e .quella dei centri di potere occulti, con le loro implicazioni interne e internazionali, fossero malattie mortali. La Repubblica, ancora una volta, ha vinto : ma la lotta per la sopravvivenza si colloca pur sempre sul terreno di una necessità assoluta e primordiale, diverso da quello dell'armoniosa edificazione di una città libera. Uno Stato in lotta contro la P2 e la P 38, secondo una formula semplificatrice, sì, ma efficace, è uno Stato che deve ancora fare appello ad una morale di combattimento.
Noi vediamo, perché lo viviamo, il dramma di questa condizio ne. Ma non scorgiamo contrasto fra questa morale di combattimento ed il grande slancio nazionale che è nec essario per porre mano alle riforme istitu zionali, e alle altre.
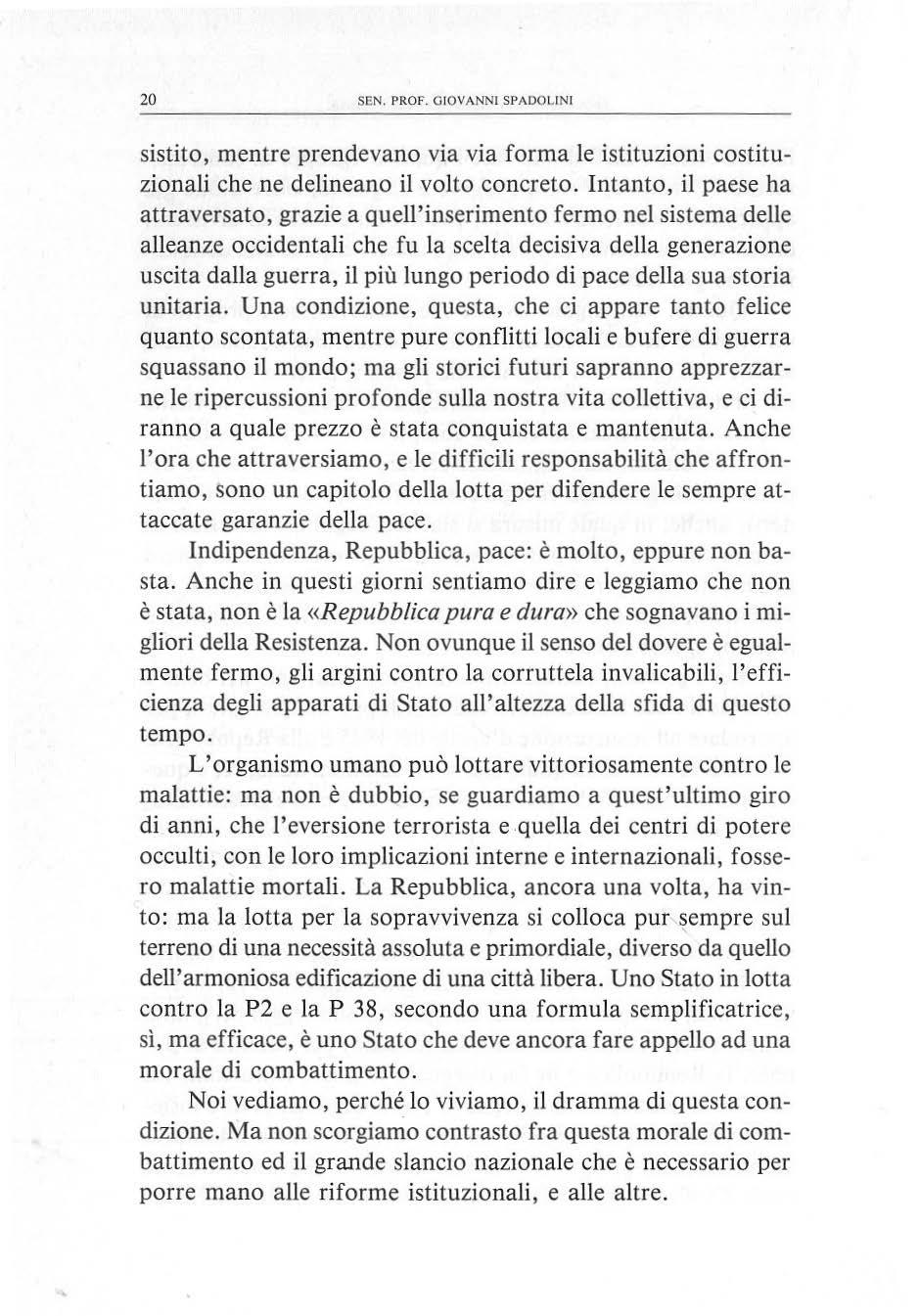
Al contrario, proprio coloro che, battendosi, cominciarono dopo 1'8 settembre a ricostruire il volto deturpato dell'Italia ed a restitu ire un fondamento morale alla sua indip endenza di nazione, non erano solamente, come si dice, i portatori di una speranza; essi sentivano di potere e voler portare nella risoluzione delle questioni della pace lo stesso ·spirito militante che li aveva sostenuti nella tragedia della guerra, e spinti a gettarsi senza riserve nella lotta armata. Un nuovo filone d'intransigenza doveva invadere, vivo e impetuoso, il sistema delle vecchie transigenze italiane, non diversamente da come avevano sentito gli uomini del Risorgimento.
Ebbene, non c'è dubbio che chi si volge con animo deluso verso quelle lontane speranze di una Repubblica «pura e dura» ha senza dubbio una sua ragione. Ma si deve anche subito aggiungere che se in questi anni la Repubblica è apparsa in pericolo, è anche stata più fortemente amata, se tanti uomini che la servivano (chiamati con sprezzo dall'eversione «servi dello Stato») hanno di nuovo dato per essa la vita.
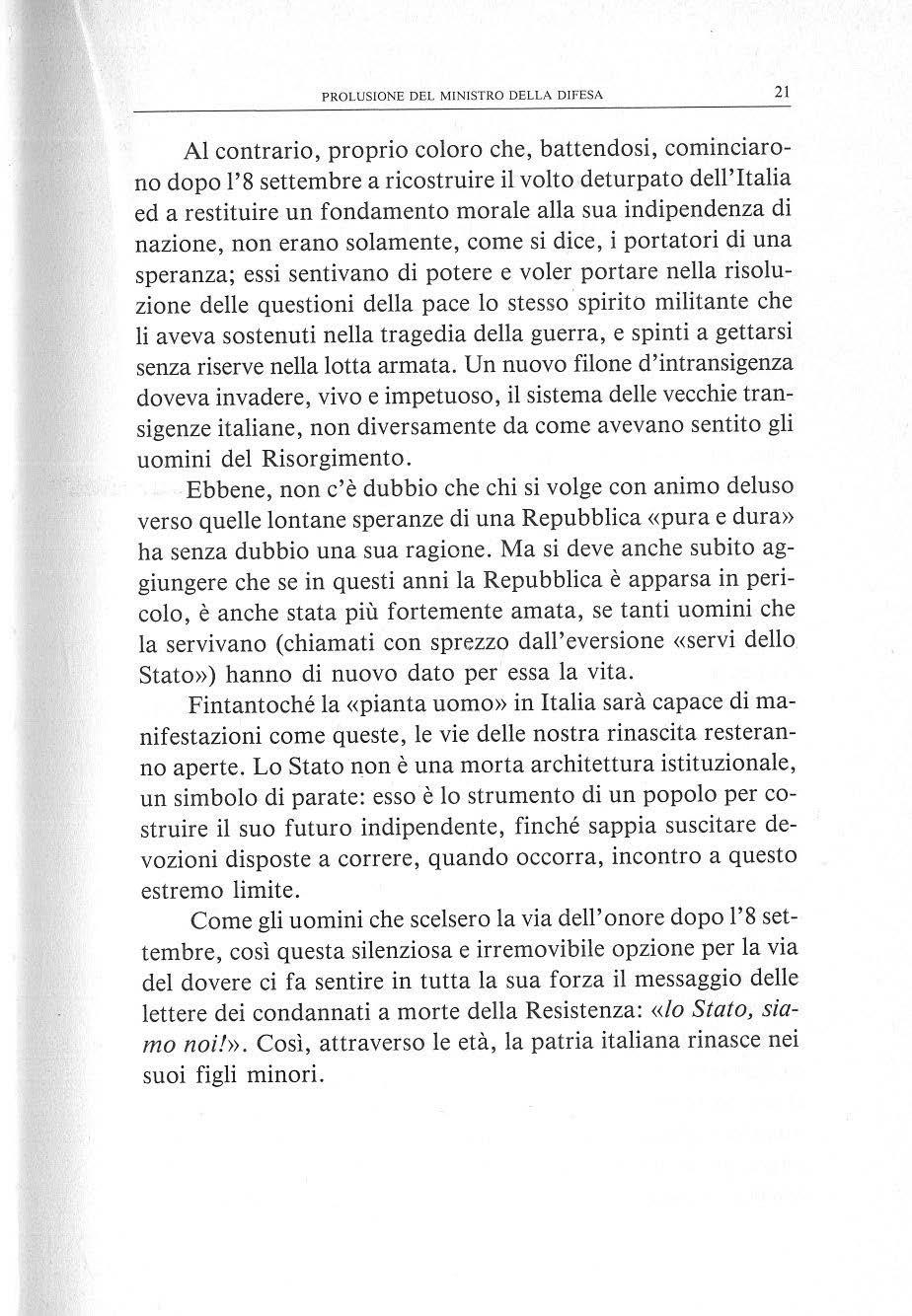
Fintantoché la «pianta uomo» in Italia sarà capace di manifestazioni come queste, le vie delle nostra rinascita resteranno aperte. Lo Stato non è una morta architettura istituzionale, un simbolo di parate: esso è lo strumento di un popolo per costruire il suo futuro indipendente, finché sappia suscitare devozioni disposte a correre, quando occorra, incontro a questo estremo limite.
Come gli uomini che scelsero la via dell'onore dopo 1'8 settembre, così questa silenziosa e irremovibile opzione per la via del dovere ci fa sentire in tutta la sua forza il messaggio delle lettere dei condannati a morte della Resistenza: «lo Stato, siamo noi!». Così, attraverso le età, la pa t ria italiana rinasce nei suoi figli minori.
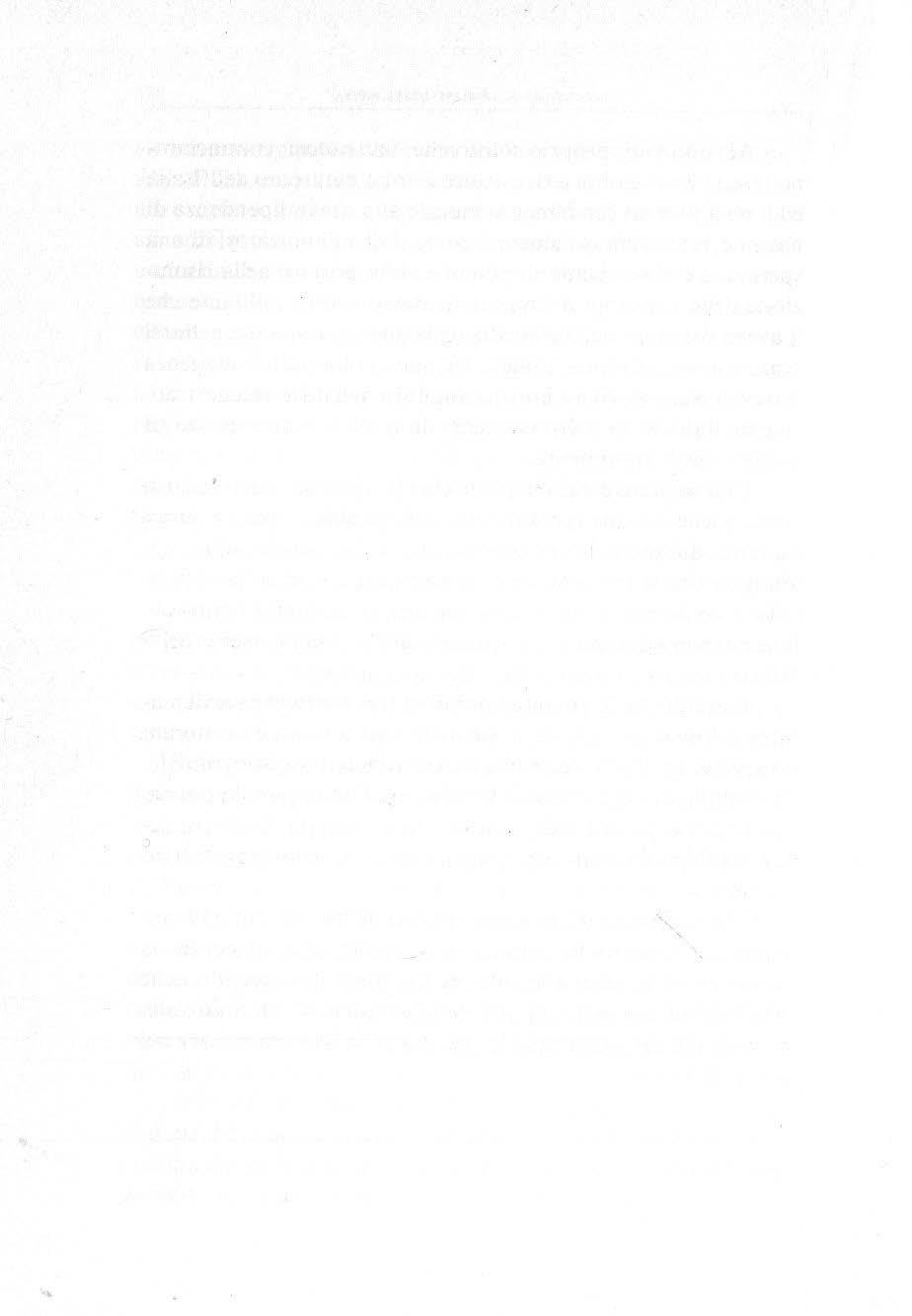
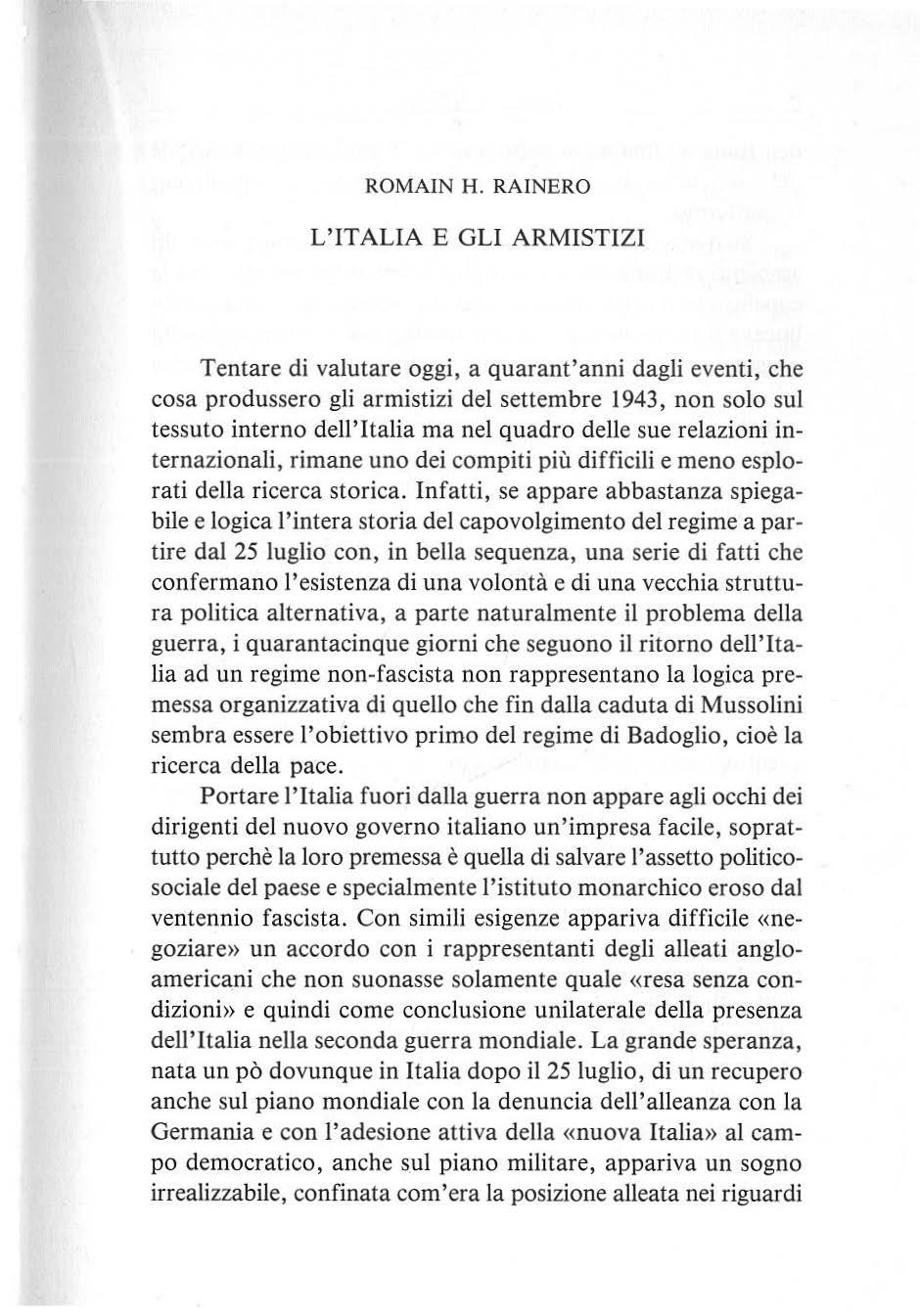
Tentare di valutare oggi, a quarant'anni dagli eventi, che cosa produssero gli armistizi del settembre 1943, non solo sul tessuto interno dell'Italia ma nel quadro delle sue relazioni internazionali, rimane uno dei compiti più difficili e meno esplorati della ricerca storica. Infatti, se appare abbastanza spiegabile e logica l'intera storia del capovolgimento del regime a partire dal 25 luglio con, in bella sequenza, una serie di fatti che confermano l'esistenza di una volontà e di una vecchia struttura politica alternativa, a parte naturalmente il problema della guerra, i quarantacinqu e giorni che seguono il ritorno dell'Italia ad un regime non-fascista non rappresentano la logica premessa organizzativa di quello che fin dalla caduta di Mussolini sembra essere l'obiettivo primo del regime di Badoglio, cioè la ricerca della pace.
Portare l'Italia fuori dalla gu erra non appare agli occhi dei dirigenti del nuovo governo italiano un'impresa facile, soprattutto perchè la loro premessa è quella di salvare l'assetto politicosociale del paese e specialmente l'istituto mon archico eroso dal ventennio fascista. Con simili esigenze appariva diffi cile «negoziare» un accordo con i rappresentanti degli alleati angloamericani che non suonasse solamente quale «resa se nza condizioni» e quindi come conclusione unilaterale della presenza dell'Italia nella seconda guerra mondiale. La grande speranza, nata un pò dovunque in Italia dopo il 25 luglio, di un recupero anche su l piano mondiale con la denuncia dell'alleanza con la Germania e con l'adesione attiva della «nuova Italia » al campo democratico, anche sul piano militare, appariva un sogno irrealizzabile, confinata com'era la posizione alleata nei riguardi
dell'Italia ad una mera debellatio che l'armistizio di Cass ibil e del 3 settembr e, il cosiddetto «ar mi stiz io br eve», puntualmente confermò.
Su queste premesse e non su quelle sperate e volute da mol ti ambienti in Italia, la giornata dell'8 settembre rappresenta la conclusione tragica dell'equivoco che, ancora una volta, sottolineava il ruolo ambiguo di una monarchia, che era sì riuscita a sganciarsi dal fascismo e dal suo duce, ma non era riuscita ad organizzare la seconda fase dell'operazione politica istituzionale del salvataggio dell'Italia, coordinando con istruzioni chiare e impegnative le attese che i militari, dislocati dalla Francia ai Balcani, dall'Italia del Nord alla capitale, attendevano, cioè nell'organizzazione di quella resistenza ai tedeschi, premessa necessaria all'agognata cobelligeranza che, per diffidenza e spesso anche per ignoranza, molte autorità alleate non vollero o non seppero assecondare.
Lo stesso messaggio del maresciallo Badoglio nella sua equivoca brevità non la evoca, e, se sancisce la fine dell ostilità con le forze anglo-americane, non fa cenno ai rapporti con le for ze germaniche, se non nella sibillina affermazione di reagire «ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza». Poco, troppo poco, per or dinar e in modo chiaro ciò che i contatti con i massimi esponenti alleati richiedevano, cioè lo sga nciamento e quindi l'attacco alle forze germaniche in tutti i settori.
Fatalmente lo sfascio e l'intero capitolo degli eroismi singoli e collettivi nella lotta contro i tedeschi non parevano trovare quella cornice politica ufficiale che avrebbero certo meritato. Le decisioni successive al messaggio di Roosevelt e Churchill a Badoglio del 1O settembre sulla lotta contro i tedeschi e il proclama di Badoglio, in fuga, di combattere contro le forze armate tedesche, non poterono certo riparare ai crolli ed alle tragedie che 1'8 settembre aveva provocato e continuava a provocare, disgiunto co m'era stato l'annuncio dell'armistizio da qual si asi coordinamento politico e strategi co a livello dei comandi militari.
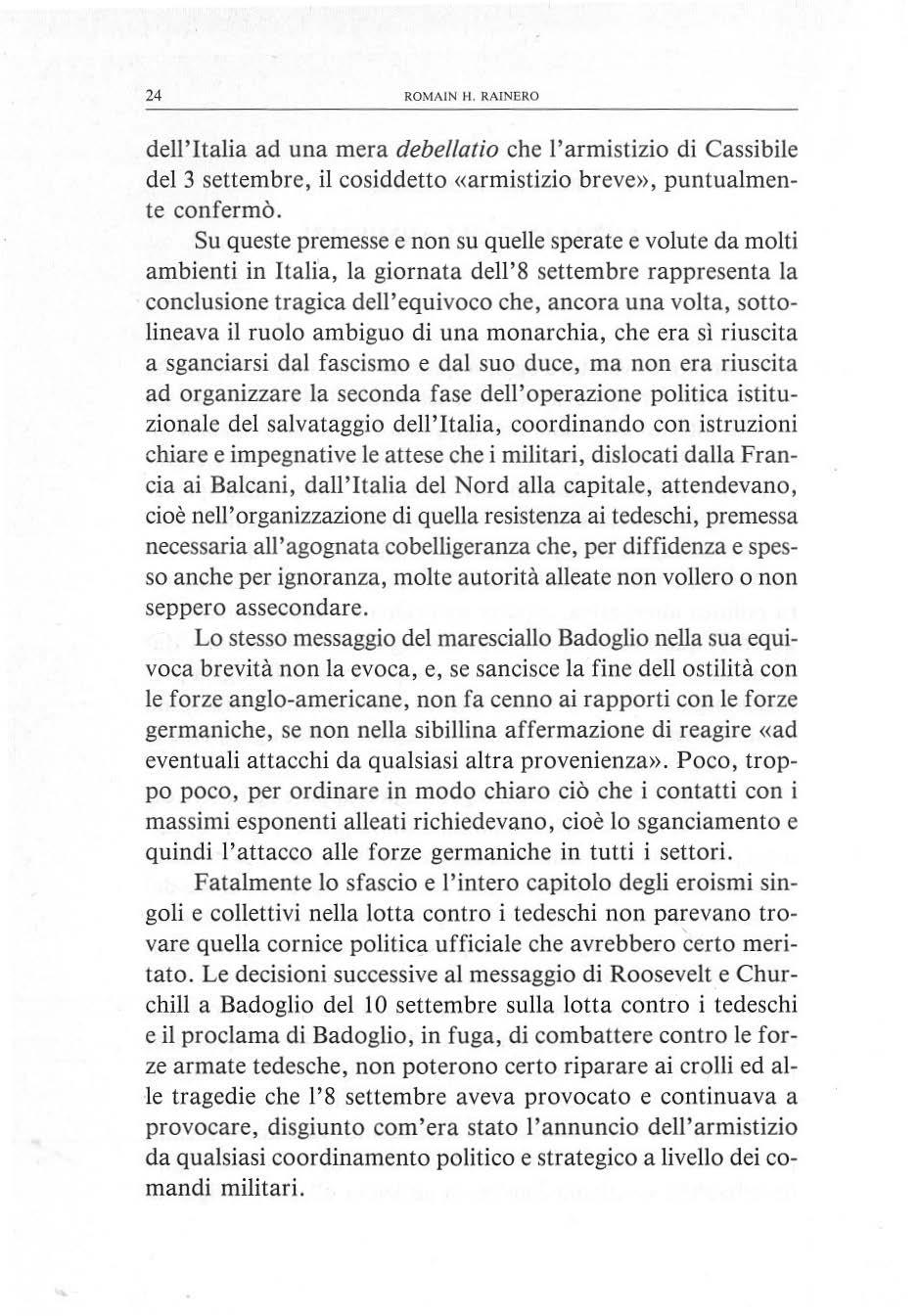
In un sim ile quadro il superamento della lettera dell'armistizio nella sua prima stesura si rivelò necessario e il nuovo testo, l' «armistizio lungo » di Malta del 29 settembre, rivela un netto riorientamento anche degli alleati: se l'armistizio di Cass ibile aveva sign ifica to solo la capitolazione, quello di Malta indicava la via della redenzione e della cobelligeranza, quindi l'avvenire di un'Italia che aveva toccato il punto più triste della sua stor ia e che ne aveva soffe rto le drammatiche conseguenze, e la tragica cecità di molte de lle sue massime autorità.
Sul piano esterno, quello internazionale, un'analoga situazione si presentava con un efficiente se rvizio del Ministero degli Esteri e con uno stuolo di ambasciatori di grande levatura ancora presenti in molte sedi, ma senza direttive lasciati tutti in balia al caso ed ai rimedi occasionali.
Rimaneva l'equivoco militare, che non fu certo risolto a tavo lino, nè a Malta, nè altrove; rimaneva la tragedia di un popolo, che si ritro vava so lo di fro nte al proprio dramma e che, senza strutture, ne inventerà alcune e che, quasi senza esercito, ne formerà uno nuovo e che inserirà con orgoglio e sacrificio la propria forza nella battaglia che per l'Italia non doveva certo concludersi con quel drammatico settembre. Un settembre che, a quarant'anni di distanza, tutti ancora ricordano.
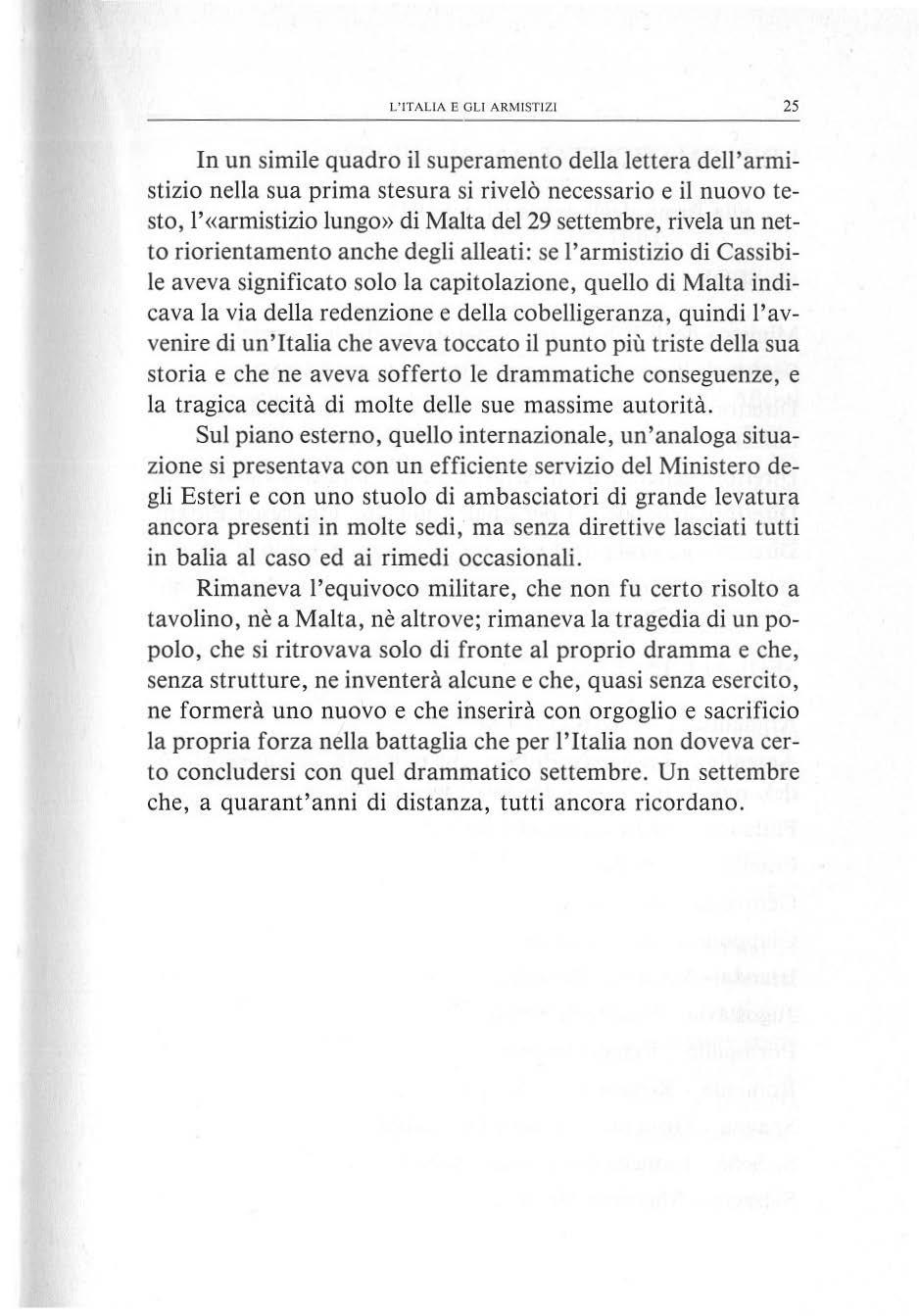
alla firma degli armistizi del 1943
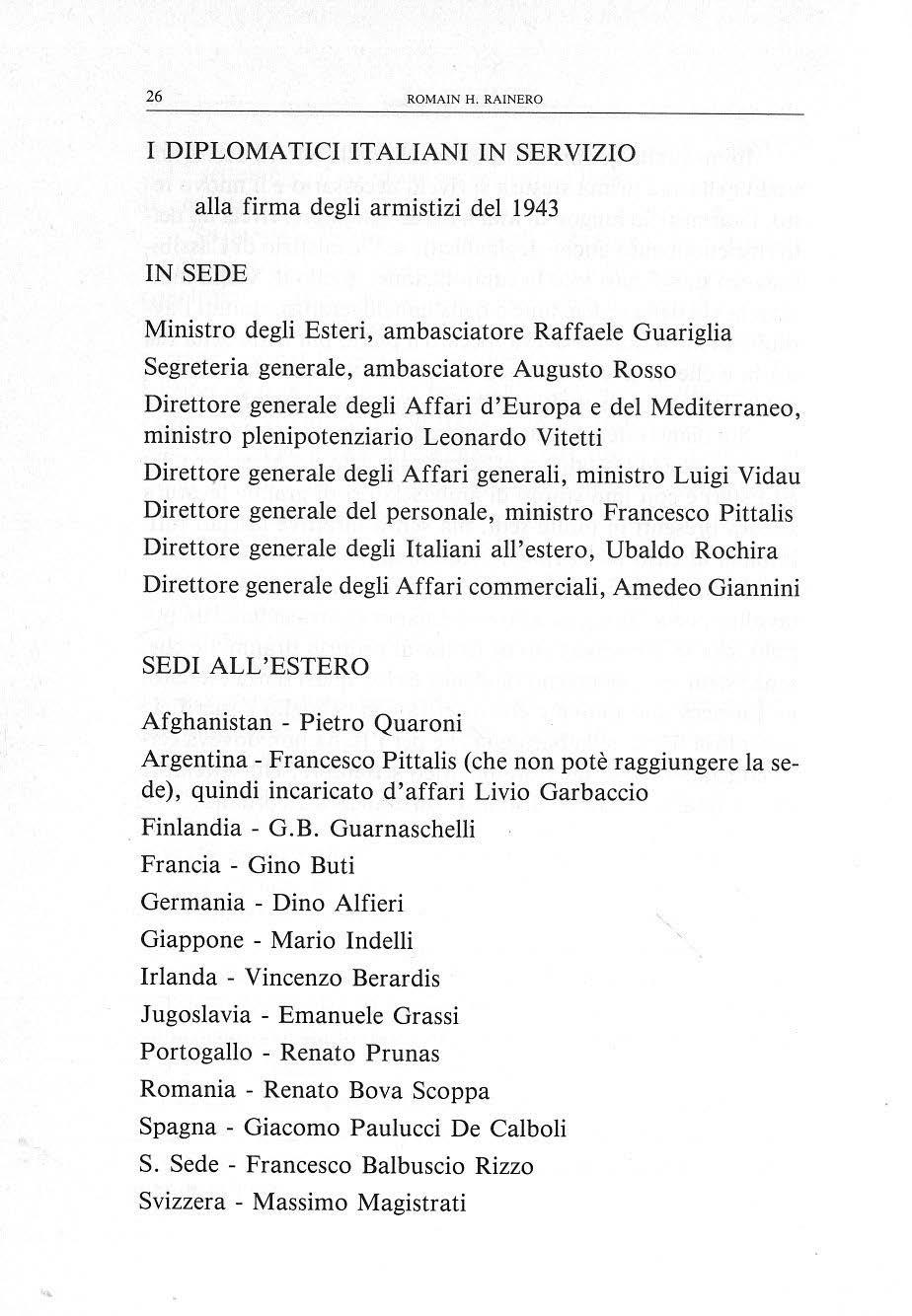
Ministro degli Esteri, ambasciatore Raffaele Guariglia
Segreteria generale, ambasciatore Augusto Rosso
Direttore generale degli Affari d'Europa e del Mediterraneo, ministro plenipotenziario Leonardo Vitetti
Direttore generale degli Affari generali, ministro Luigi Vidau
Direttore generale del personale, ministro Francesco Pittalis
Direttore generale degli Italiani all'estero, Ubaldo Rochira
Direttore generale degli Affari commerciali, Amedeo Giannini
Afghanistan - Pietro Quaroni
Argentina - Francesco Pittalis (che non potè raggiungere la sede), quindi incaricato d'affari Livio Garbaccio
Finlandia - G.B. Guarnaschelli
Francia - Gino Buti
Germania - Dino Alfieri
Giappone - Mario Indelli
Irlanda - Vincenzo Berardis
Jugoslavia - Emanuele Grassi
Portogallo - Renato Prunas
Romania - Renato Bova Scoppa
Spagna - Giacomo Paulucci De Calboli
S. Sede - Francesco Balbuscio Rizzo
Svizzera - Massimo Magistrati
L'osservazione non è nostra ma vale la pena di ricordarla quasi a sintetizzare in modo perfetto la posizione degli Alleati nei riguardi dell'Italia al momento della firma dei due armistizi: l'anelasticità del Comando alleato verso l'Italia «nuova» era tale che persino le iniziative più generose di cooperazione e quindi di cobelligeranza ebbero solo il destino di suscitare diffidenze e reazioni negative presso quel mondo miliare anglo-francoamericano, che da una parte continuava a vedere l'Italia una realtà fascista vinta e debellata e dall'altra pur appariva sedotto da un «certo» contributo degli italiani allo sforzo militare dell'ultima fase della guerra in Europa. Una applicazione così puntuale di quella che Roosevelt aveva annunciato fin dal 24 gennaio 1943 nella sua conferenza stampa dopo la conferenza di Casablanca, e cioè la «resa incondizionata» degli Stati del1' Asse, non poteva non produrre nel caso così anomalo dell'Italia guasti politici che certamente militavano alla fine contro il principio stesso della «liberazione» che da più parti, invece, e cioè dai politici, era stato enunciato anche e soprattutto per l'Italia.
Churchill tentò nelle sue dichiarazioni ai Comuni del 21 settembre, allorquando dalla fase teorica si era ormai passati per l 'Italia ad una fase pratica, di smussare gli angoli e di fare passare questa terminologia della «resa incondizionata» come di «direttive che seguivano l'atto di resa», quasi si trattasse non di un problema di fondo bensì di un problema di forma. In realtà la più tenace e dura espressione della resa incondizionata permea tutte le varie dichiarazioni alleate sia del breve come del lungo armistizio. La loro lettura suona di una durezza senza
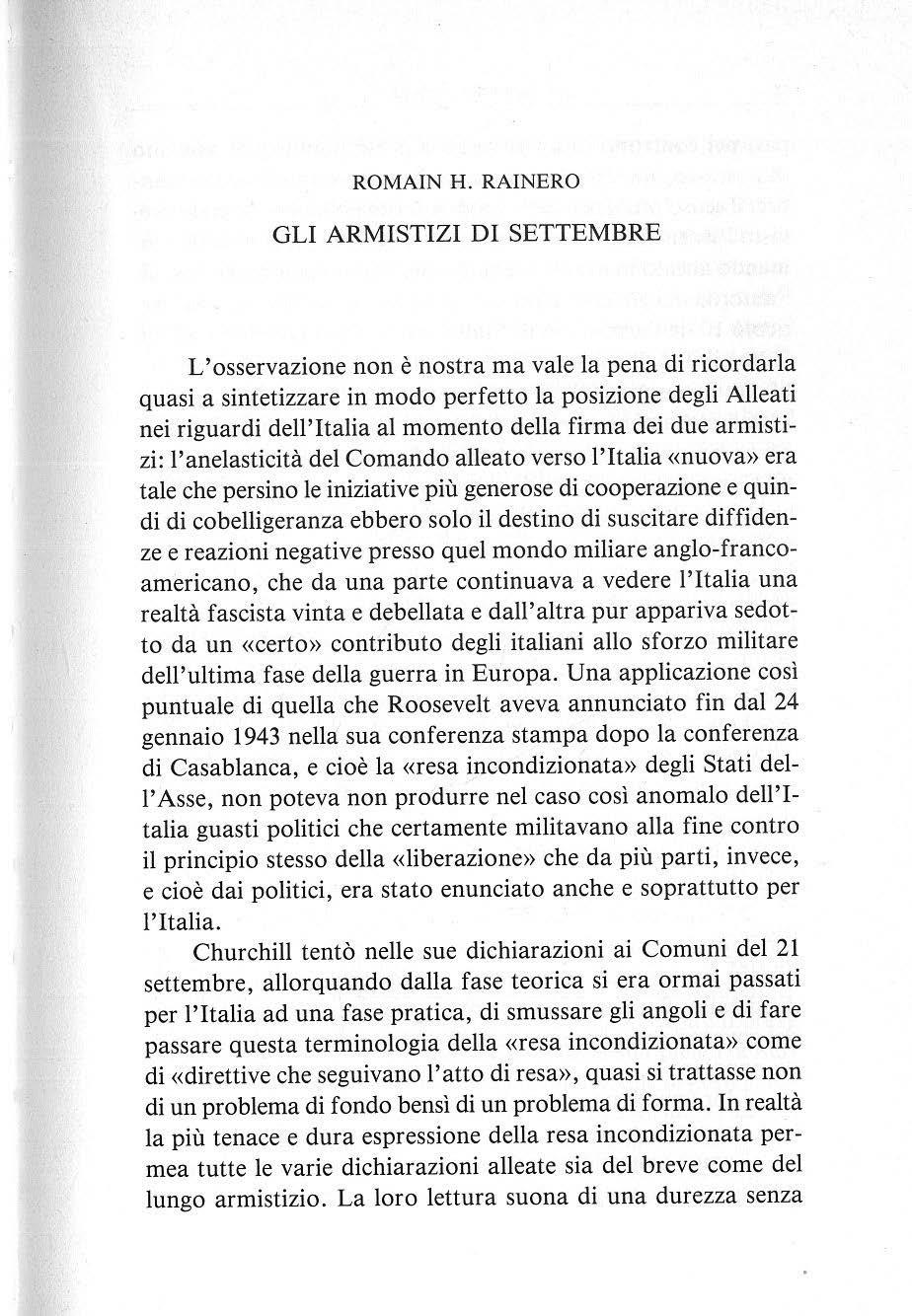
pari nei confronti di un governo e di un popolo che avevano dimostrato, fin dal 25 luglio e soprattutto dopo l'otto settembre, il senso profondo delle proprie scelte politiche. A vendo previsto l'istituzione di un governo alleato nelle parti in cui il Comando alleato lo avesse ritenuto opportuno si sottraeva così al1' autorità del governo ogni sovran ità globale effettiva; con l'articolo 10 dell'armistizio di Malta si negava al governo italiano la possibilità di conservare diretti rapport i diplomatici non solo con i paesi nemici e i paesi ancora da loro occupati - con i quali ovviamente dovevano essere rotti i rappo rti diplomatici e commerciali - ma anche con gli Stati neutrali. Alla istituenda Commissione alleata di co ntrollo veniva affidata infa tti l' esecuz ione della clausola che prevedeva il regolamento e la procedura per i metodi di comunicazione del governo italiano con i suoi rappresentanti in Stati neutrali e con i rappresentanti diplomatici neutrali in territorio italiano (art. 25 A e B). Durezza vers o l'Italia ma anche equivoca poli tica generale degli All eati, che doveva produrre frutti amari quali delusioni e co n trasti politici nell'ambito stesso delle forze antifascis te nel Regno del Sud, che stentavano a comprendere il doppio linguaggio delle potenze «vincitrici» che conti nuavan o a volersi tali e che ri fiutavano almeno in linea di principio quella pienezza di risorgimento politico nazionale italiano che un'oculata impostazione del concetto di cobelligeranza avrebbe dovuto obbligatoriamente comportare. Inevitabili quindi gli equivoci e le incertezze.
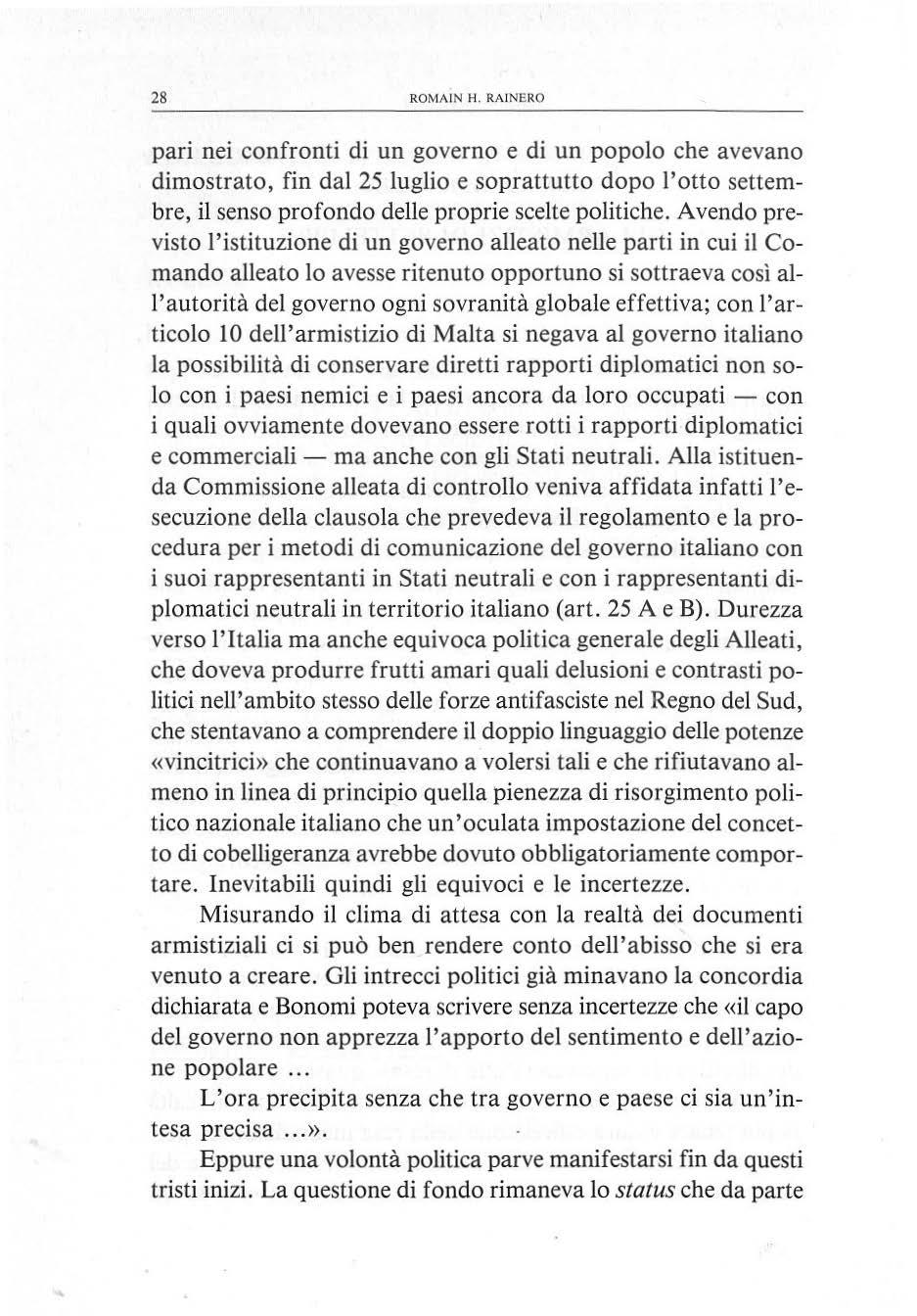
Misurando il clima di attesa con la realtà dei documenti armistiziali ci si può ben rendere conto dell'abisso che si era venuto a creare. Gli intrecci politici già minavano la concordia dichiarata e Bonomi poteva scr ivere senza incerte zze che «il capo del governo non apprezza l'apporto del sentimento e dell 'azione popolare ...
L'ora precipita se nza che tra gov e rno e pae se ci sia un'intesa preci sa ... ».
Eppure una volo ntà politica parve manifes tarsi fin da questi tristi inizi. La ques t ione di fondo riman eva lo status che da parte
italiana veniva richiesto e cha da parte alleata pareva soggetto a una serie di reticenze e di riserve. A Cassibile tale contrasto appare in piena luce allorquando da una parte, nel documento di Québec che era allegato all'armistizio, si affermava che «le condizioni di armistizio non contemplano l'assistenza attiva dell'Italia nel combattere i tedeschi>> e subito dopo si esigeva dall'Italia un impegno che contrastava profondamente con queste dichiarazioni: «Il governo italiano deve impegnarsi ... a ordinare alle sue forze e al suo popolo di collaborare ... con gli Alleati e di resistere ai tedeschi ... >> e nell'art. 2 dell'armistizio breve una formula equivoca e oscura: «L'Italia farà ogni sforzo per negare ai tedeschi tutto ciò che potrebbe essere adoperato contro le Nazioni Unite ... ». Da una parte disimpegno e dall'altra impegno: quale la via? Ciò che sembra sicuro è quanto scrisse Benedetto Croce proprio allora riguardo all'impegno: «Avevo o tt enuto senza pregare e serbando la maggiore dignità italiana che il comando americano consentisse la formazione di corpi volontari con la bandiera it aliana. Ma non so bene ancora se poi gli Alleati abbiano voluto far fallire quel tentativo ... o se il re e quelli che gli stanno attorno lo abbiano avversato presso il Comando alleato .... il fatto è che quel corpo in formazione è stato sciolto» (Quando l'Italia era tagliata in due).
E proprio a questo riguardo giova fare ciò che molti studiosi non paiono aver fatto e cioè rileggere quei processi verbali che accompagnarono la sottoscrizione dei due armistizi perchè essi rappresentano con i loro chiaroscuri la vicenda forse assai meglio dei due tanto studiati armistizi e del documento di Quèbec. Rimasti a lungo inediti, questi due processi verbali che riportiamo in allegato alla presente nota possono suscitare riflessioni interessanti ed utili specie per meglio capire il breve ma decisivo periodo che si concluderà, nella sua pienezza «armistiziale», il 13 ottobre 1943 con la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania e con la contemporanea dichiarazione di cobelligeranza riconosciuta dagli Alleati all'Italia. Anche se, evidentemente, non tutto si risolverà con questi documenti clamorosi .
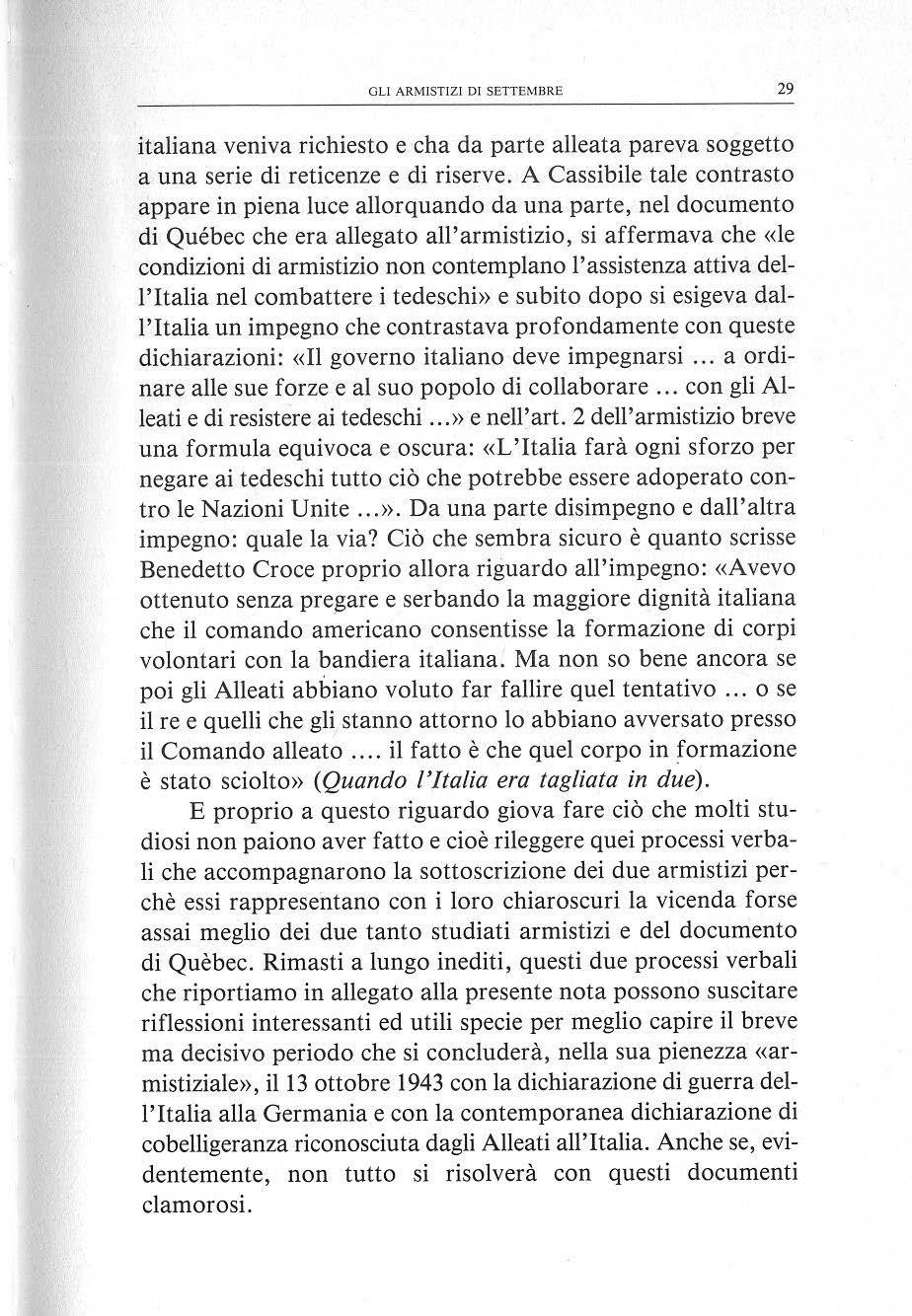
In genere peraltro si può dire che malgrado la loro gravità i problemi della cobelligeranza non furono affrontati nè sul piano militare nè su quello politico. Su quest'ultimo si può persino ritenere che l'acuta osservazione di Eden a proposito di Roosevelt e delle sue doti politiche potrebbe essere allargata a molti protagonisti di questo dialogo fra sor di tra l'Italia nuova e gli Alleati: «Roosevelt conosceva bene la storia e la geografia dell'Europa. Forse in questo era stato aiutato dal suo hobby di collezionare francobolli, ma le opinioni accademiche e nello stesso tempo fantasiose che egli si formava sulla base di quelle cognizion i erano allarmanti nella loro allegra inconsistenza ... Era come un giocoliere intento a lanciare in aria con perizia palle piene di dinamite senza rendersi conto di ciò che contenevano . . . >>.
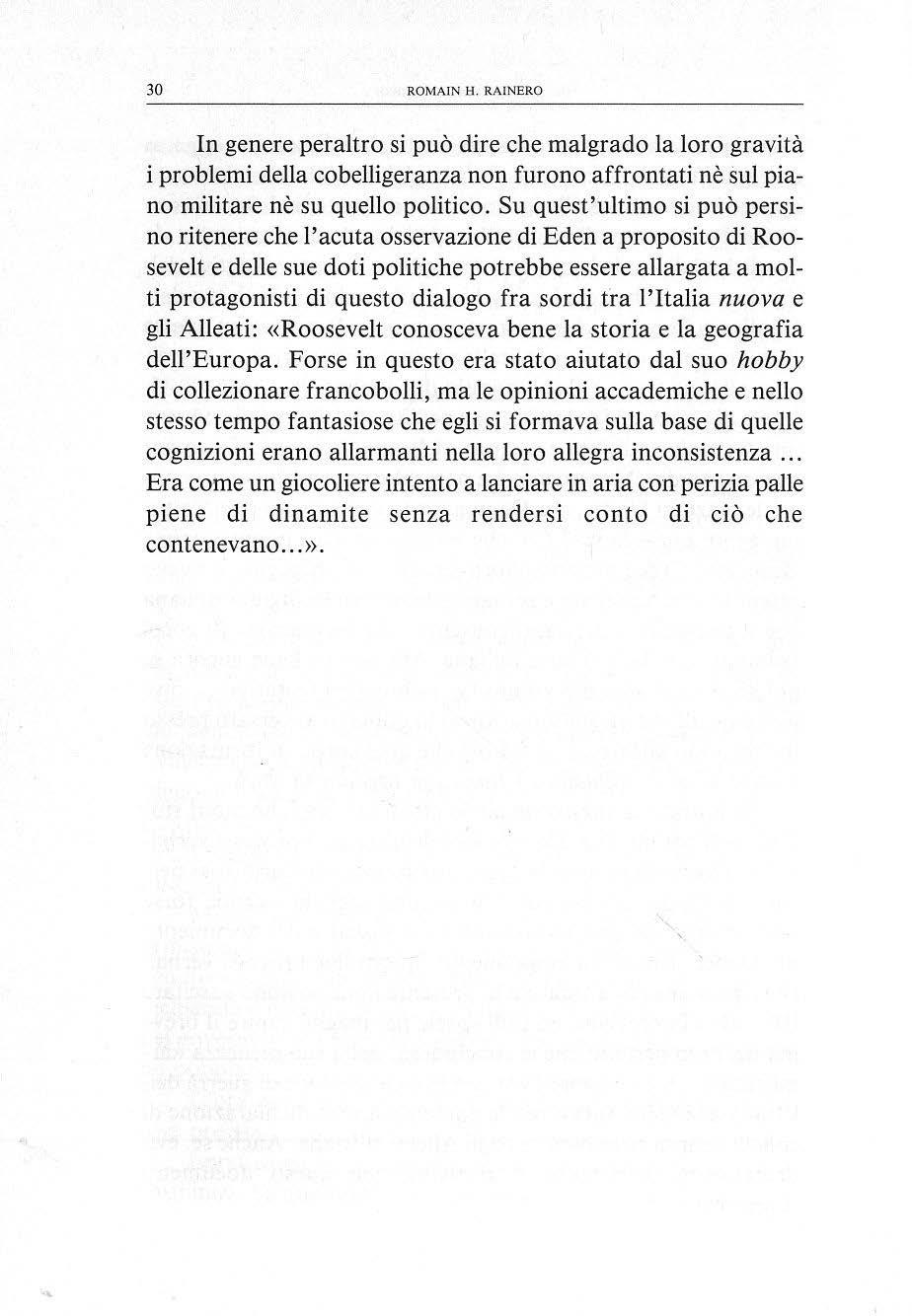
Le condizioni di armistizio non contemplano l'assistenza attiva dell'Italia nel combattere i tedeschi. La misura nella quale le condizioni saran no modificate in favore dell'Italia dipenderà dall'entità dell'apporto dato dal Governo e dal popolo italiano alle Nazioni Unite contro la Germania durante il resto della guerra. Le Nazioni Unite dichiarano tuttavia senza riserve che ovunque le forze italiane e gli italiani combatteranno i tedeschi, o distruggeranno proprietà tedesche, od ostacoleranno i movimenti tedeschi, essi riceveranno tutto l'aiuto possibile dalle forze delle Nazion i Unite. Nel frattempo, se informazioni sul nemico verranno fornite immediatamente e regolarmente, i bombardamenti degli Alleati verran no effettuati, nei limiti del possibi·1e, su obiettivi che influiranno su i movimenti e sulle operazioni delle forze tedesche.
La cessazione delle ostilità fra le Nazioni Unite e l'Italia entrerà in vigore a par t ire dalla data e dall'ora che verrà comunicata dal gen erale Eisenhower.
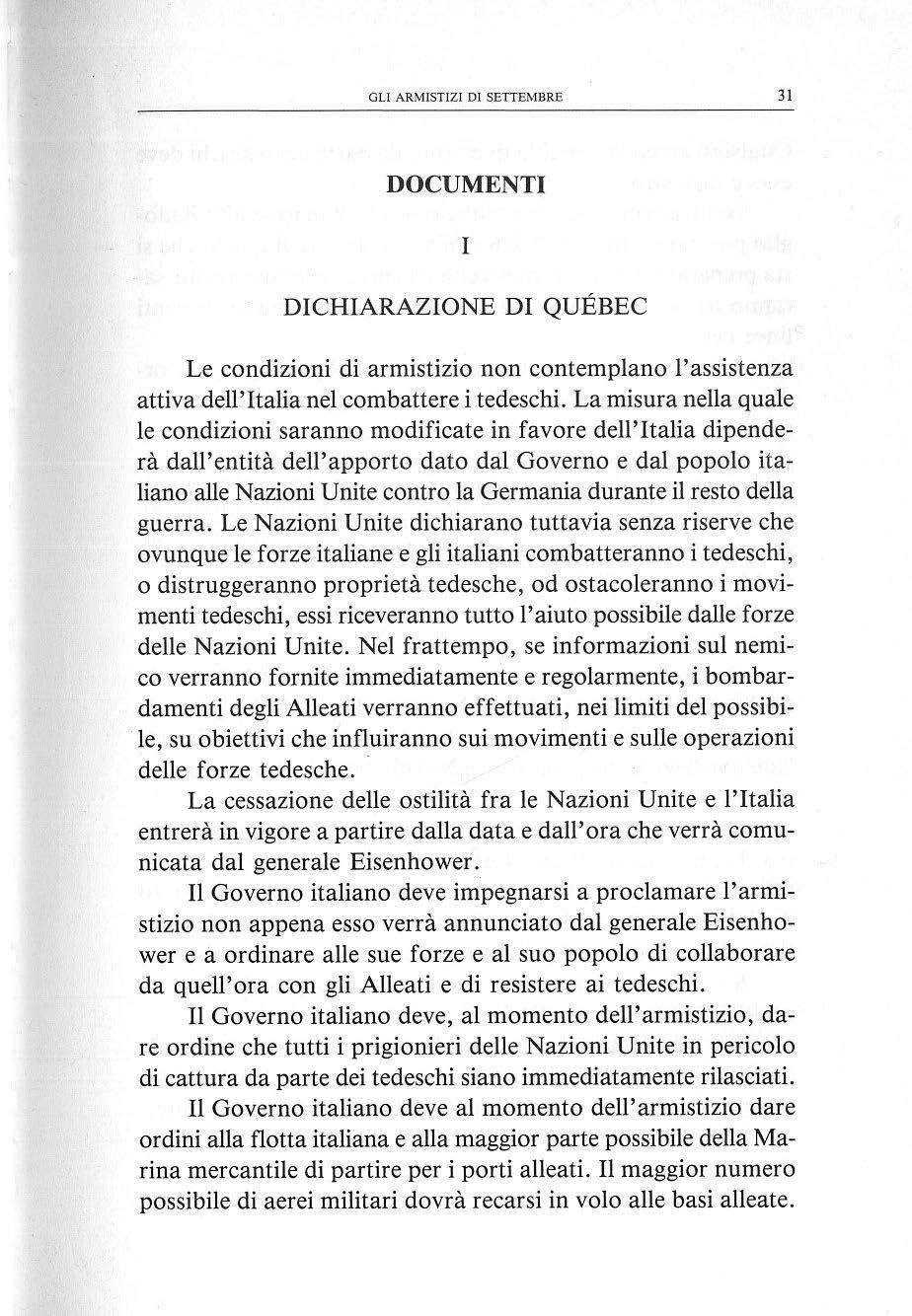
Il Governo italiano deve impegnarsi a proclamare l'armistizio non appena esso verrà annunciato dal generale Eisenhower e a ordinare alle sue forze e al suo popolo di collaborare da quell'ora con gli Alleati e di resistere ai tedeschi.
Il Governo italiano deve, al momento dell'armistizio, dare ordine che tutti i prigionieri delle Nazioni Unite in pericolo di cattura da parte dei tedeschi siano immediatamente rilasciati.
Il Governo italiano deve al momento dell'armistizio dare ordini alla flotta italiana e alla maggior parte possibile della Marina mercantile di partire per i porti alleati. Il maggior numero possibile di aerei militari dovrà recarsi in volo alle basi alleate.
Qualsiasi aereo in pericolo di cattura da parte dei tedeschi deve essere distrutto. '·
Nel frattempo vi sono molte cose che il maresciallo Badoglio può fare senza che i tedeschi si accorgano di quello che si sta preparando. La natura precisa e l'entità della sua azione saranno lasciate al suo giudizio, ma si suggeriscono le seguenti linee generali:
1 - resistenza generale passiva in tutto il paese, se quest'ordine può essere trasmesso alle autorità locali senza che i tedeschi lo sappiano;
2 - piccole azioni di sabotaggio in tutto il paese, specialmente delle comunicazioni e degli aeroporti usati dai tedeschi;
3 - salvaguardia dei prigionieri di guerra alleat i. Se la pressione tedesca per farli consegnare diventa t roppo forte, essi dovrebbero essere rilasciati;
4 - nessuna nave da guerra deve essere lasciata cadere in mano tedesca.
Disposizioni dovranno es sere date per assicurarsi che tutte queste navi possano salpare per i porti designati dal generale Eisenhower, non appena egli ne darà l'ordine. I sottomarini italiani non devono sospendere le missioni, dato che ciò rivelerebbe al nemico il nostro scopo comune;
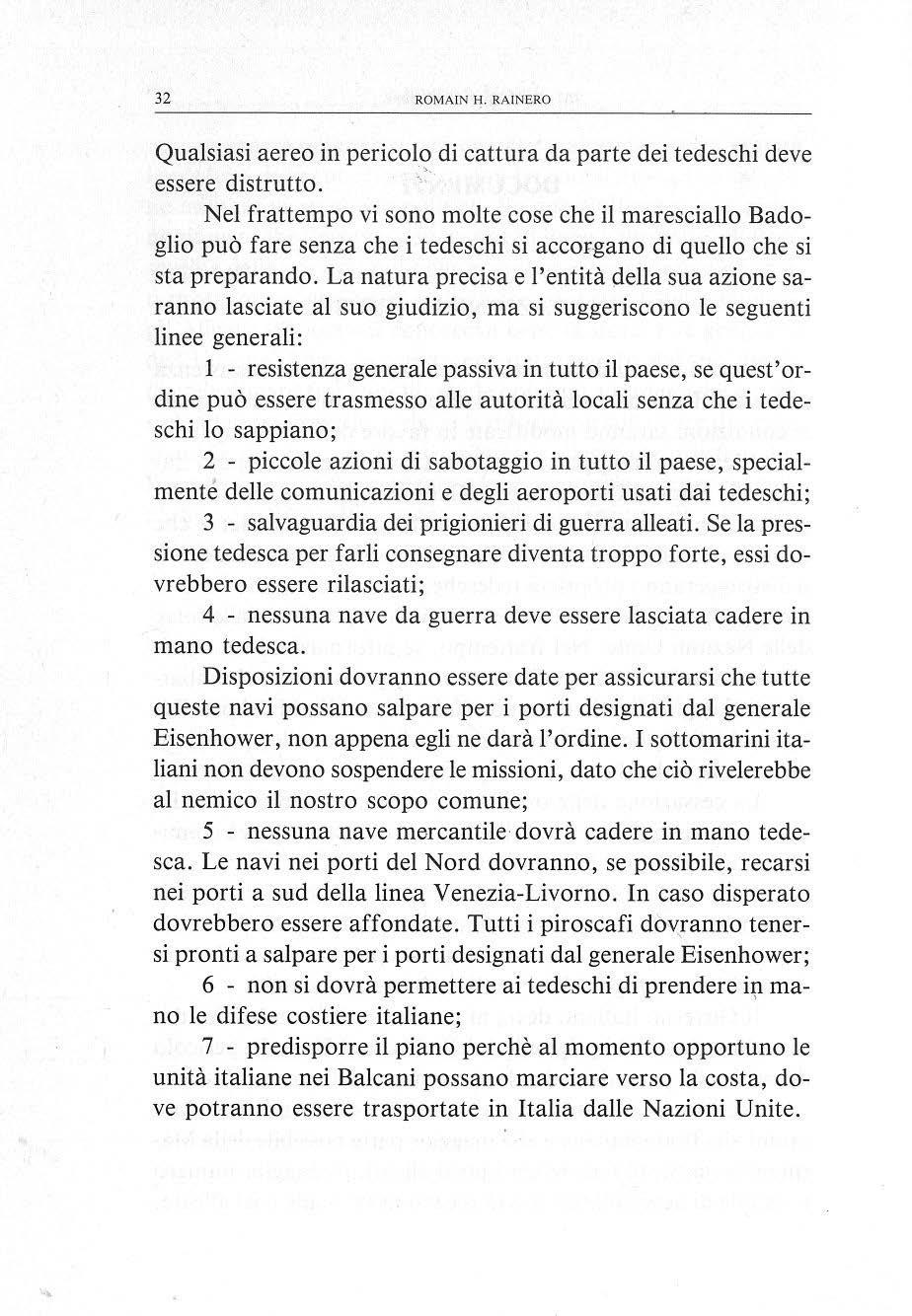
5 - nessuna nave mercantile ·dovrà cadere in mano tedesca. Le navi nei porti del Nord dovranno, se possibile, recarsi nei porti a sud della linea Venezia-Livorno. In caso disperato dovrebbero essere affondate. Tutti i piroscafi dovanno tenersi pronti a salpare per i porti designati dal generale Eisenhower;
6 - non si dovrà permettere ai tedeschi di prendere iµ mano le difese costiere italiane;
7 - predisporre il piano perchè al momento opportuno le unità italiane nei Balcani possano marciare verso la costa, dove potranno essere trasportate in Italia dalle Nazioni Unite .
L'ARMISTIZIO DI CASSIBILE (3 settembre 1943)
Sicilia, 3 settembre 1943
Le seguenti condizioni di armistizio sono presentate dal Generale Dwight D. Eisenhower Comandante in Capo delle Forze Alleate
il quale agisce per delega dei Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna e nell ' interesse delle Nazioni Unite, e sono accettate dal
Maresciallo Pietro Badoglio Capo del Governo italiano
1. - Cessazione immediata di ogni attività ostile da parte delle Forze Armate italiane.
2. - L'Italia farà ogni sforzo per negare ai tedeschi tutto ciò che potrebbe essere adoperato contro le Nazioni Unite.
3. - Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite dovranno essere consegnati immediatamente al Comandante in Capo alleato e nessuno di essi potrà ora o in qualsiasi momento essere trasferito in Germania.
4. - Trasferimento immediato della flotta italiana e degli aerei italiani in quelle località che saranno designate dal Comandante in Capo alleato, con i dettagli di disarmo che saranno fissati da lui.
5. - Il naviglio mercantile italiano potrà ess.ere requisito dal Comandante in Capo alleato per supplire alla necessità del suo programma militare navale.
6. - Resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, sia delle isole che del continente, agli Alleati, per essere usati come base di operazioni e per altri scopi a seconda delle decisioni degli Alleati .
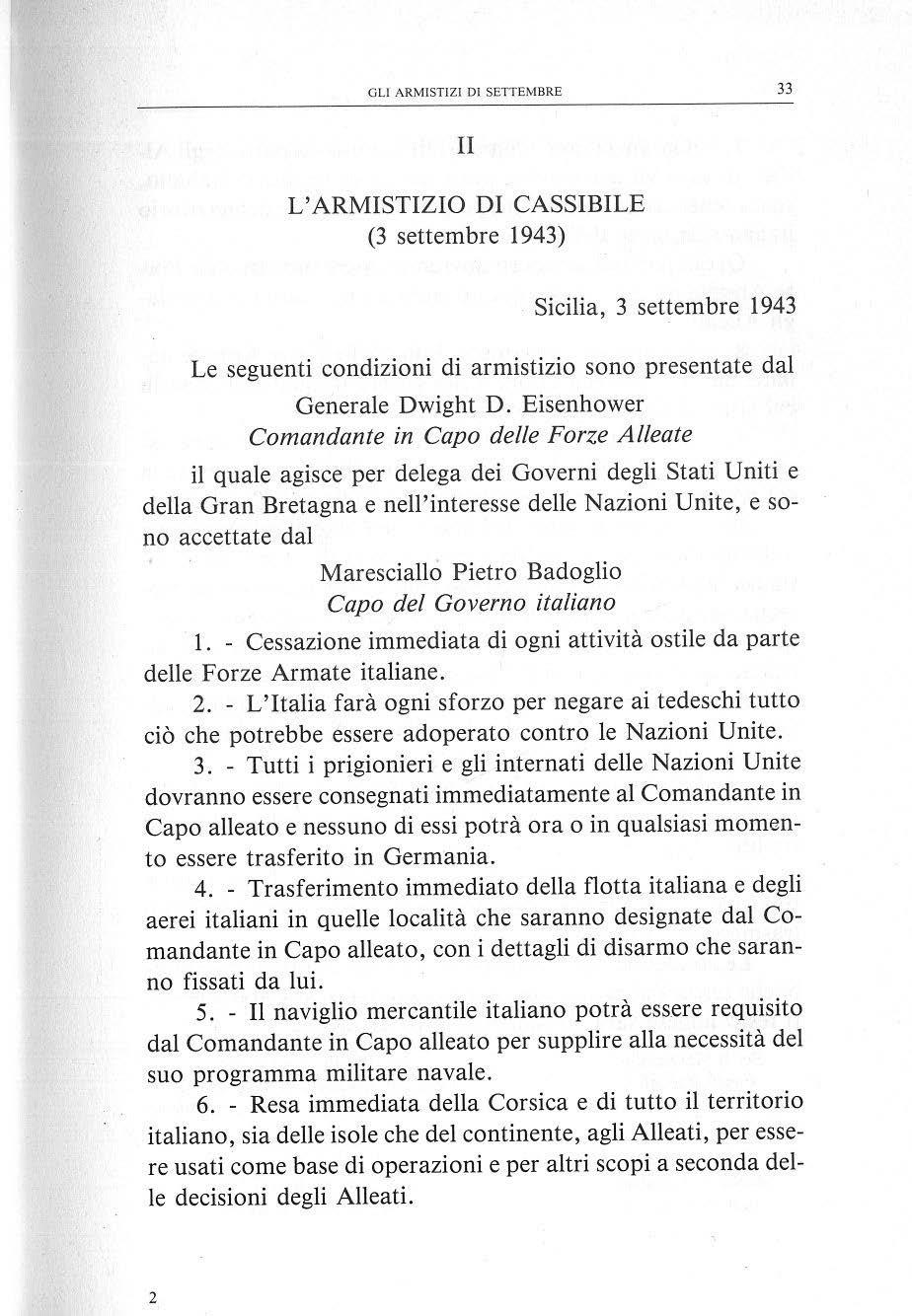
7. - Garanzia immediata del libero uso da parte degli Alleati di tutti gli aeroporti e porti navali in territorio italiano, senza tener conto dello sviluppo dell'evacuazione del territorio italiano da parte delle forze tedesche.
Questi porti ed aeroporti dovranno essere protetti dalle Forze Armate italiane finchè questo compito non sarà assunto dagli Alleati.
8. - Immediato richiamo in Italia delle Forze Armate italiane da ogni partecipazione nella guerra in qualsiasi zona in cui si trovino attualmente impegnate.
9. - Garanzia da parte del Governo italiano che se necessario iplpiegherà tutte le sue forze disponibili per assicurare la sollecita e precisa esecuzione di tutte le condizioni di armistizio.
10. - Il Comandante in Capo delle Forze alleate si riserva il diritto di prendere qualsiasi misura che egli ritenga necessaria per la protezione degli interessi delle Forze alleate per la prosecuzione della guerra, e il Governo italiano si impegna a prendere quelle misure amministrative o di altro carattere che potranno essere richieste dal Comandante in Capo, e in particolare il Comandante in Capo stabilirà un Governo militare alleato in quelle parti del territorio italiano ove egli lo riterrà necessario nell'interesse militare delle Nazioni alleate.
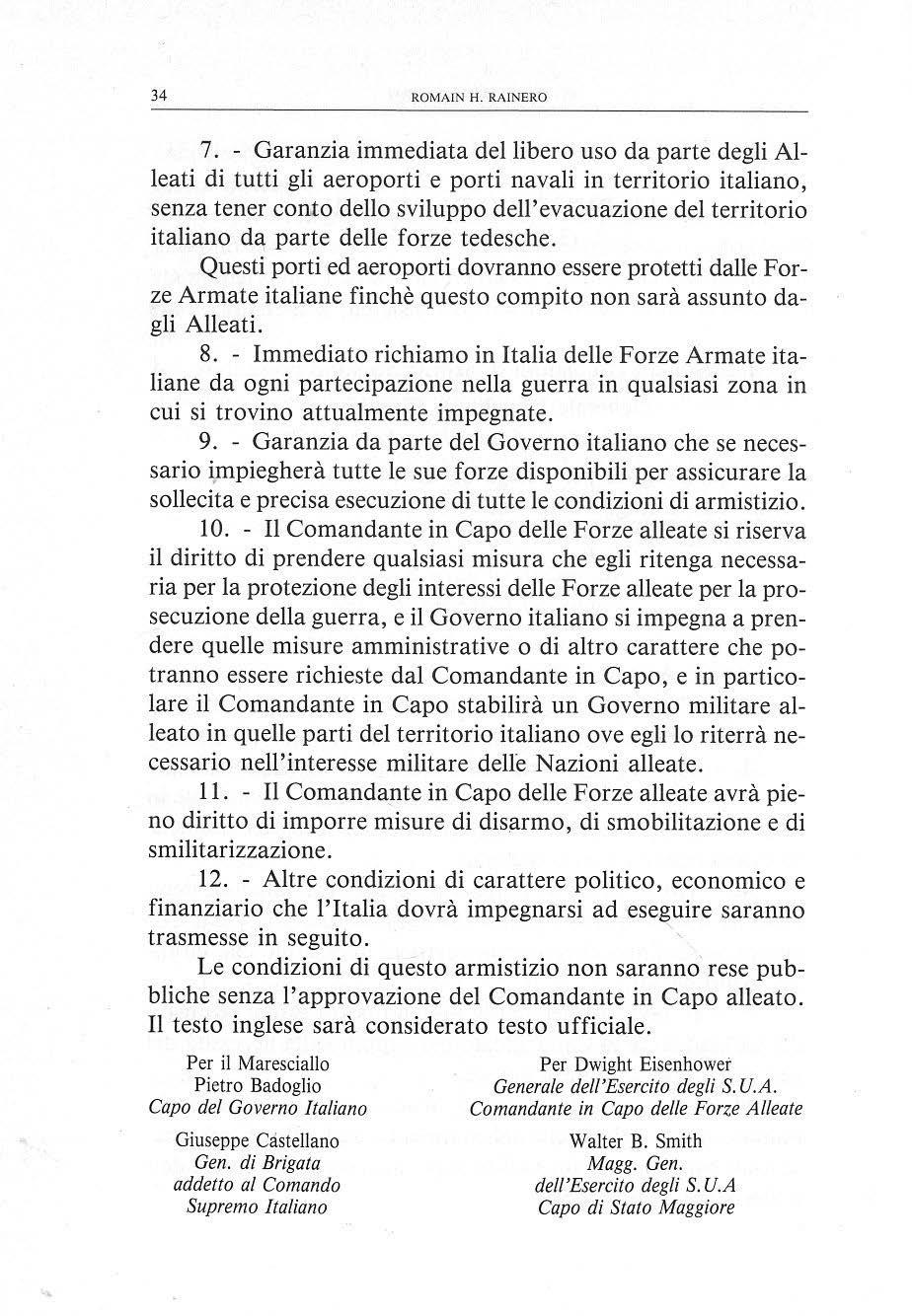
11. - Il Comandante in Capo delle Forze alleate avrà pieno diritto di imporre misure di dis~rmo, di smobilitazione e di smilitarizzazione.
12. - Altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario che l'Italia dovrà impegnarsi ad eseguire sara nno trasmesse in seguito.
Le condizioni di questo armistizio non saranno rese pubbliche senza l'approvazione del Comandante in Capo alleato. Il testo inglese sarà considerato testo ufficiale.
Per il Maresciallo
Pi etro Badoglio
Capo del Governo Italiano
Giuseppe Castellano
Gen. di Brigata addetto al Comando Supremo Italiano
Per Dwight Eisenhower
Generale dell'Esercito degli S. U.A. Comandante in Capo delle Forze Alleate
Walter B. Smith
Magg. Gen.
dell'Esercito degli S . U.A
Capo di Stato Maggiore
Presenti:
On . Haro ld Mcmillan - Ministro Residente britannico presso il Quartier Generale delle Forze Alleate
Robert Murphy - Rappresentante personale del Presidente degli Stati Uniti
Royer Dick - Commodoro della Reale Marina britannica - Capo di Stato Maggiore del Comandante in Capo del Mediterraneo
Lowell W . Rooks - Magg . Gen. dell'Esercito degli S. U.A . - Sottocapo di Stato Maggiore, G-3, presso il Quartier Generale delle F orze Alleate
Franco Montanari - Interprete ufficiale italiano
Brigadiere Kenneth Strong - Sottocapo di Stato Maggiore Generale, G-2 presso il Quartier Generale delle Forze Alleate
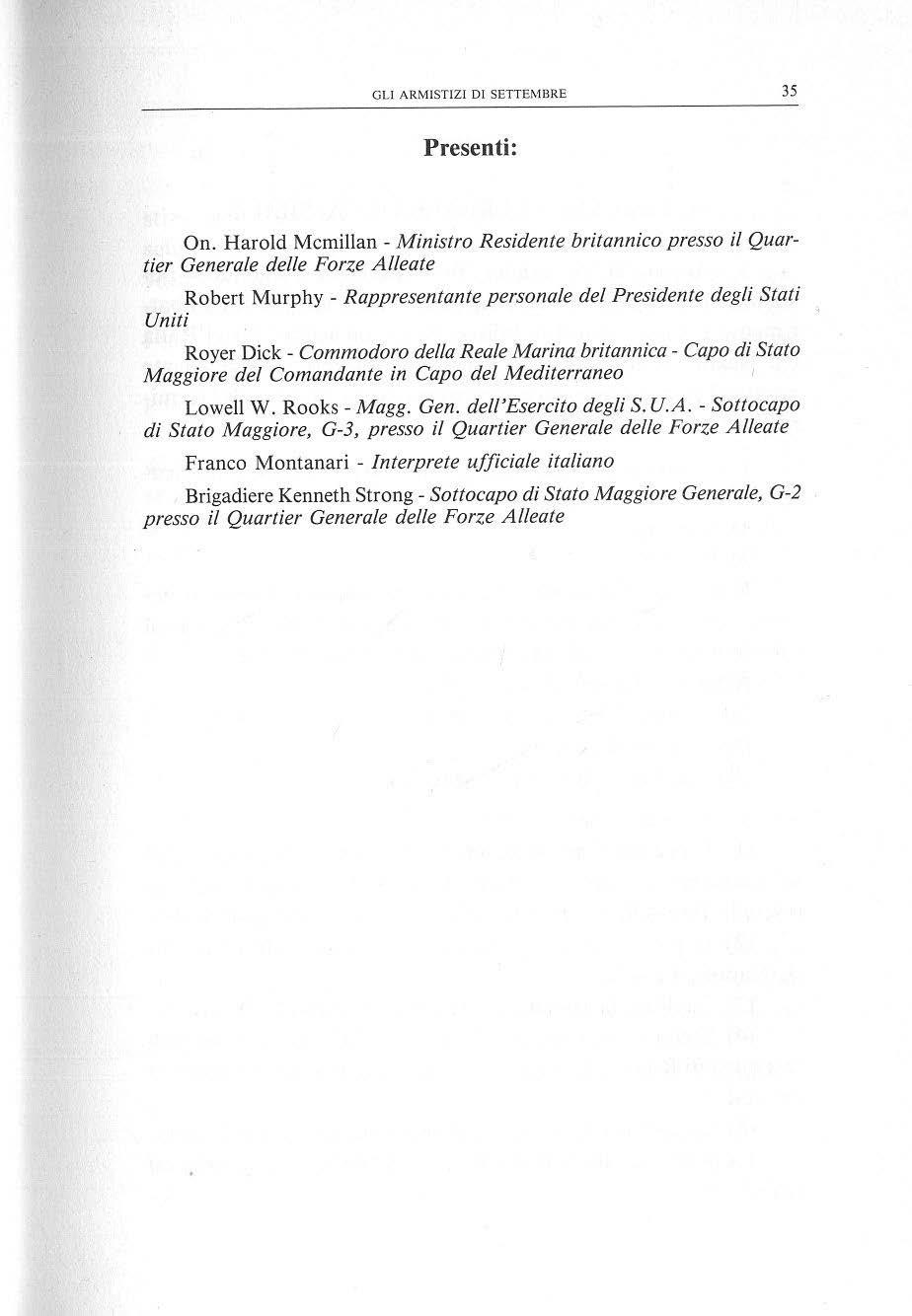
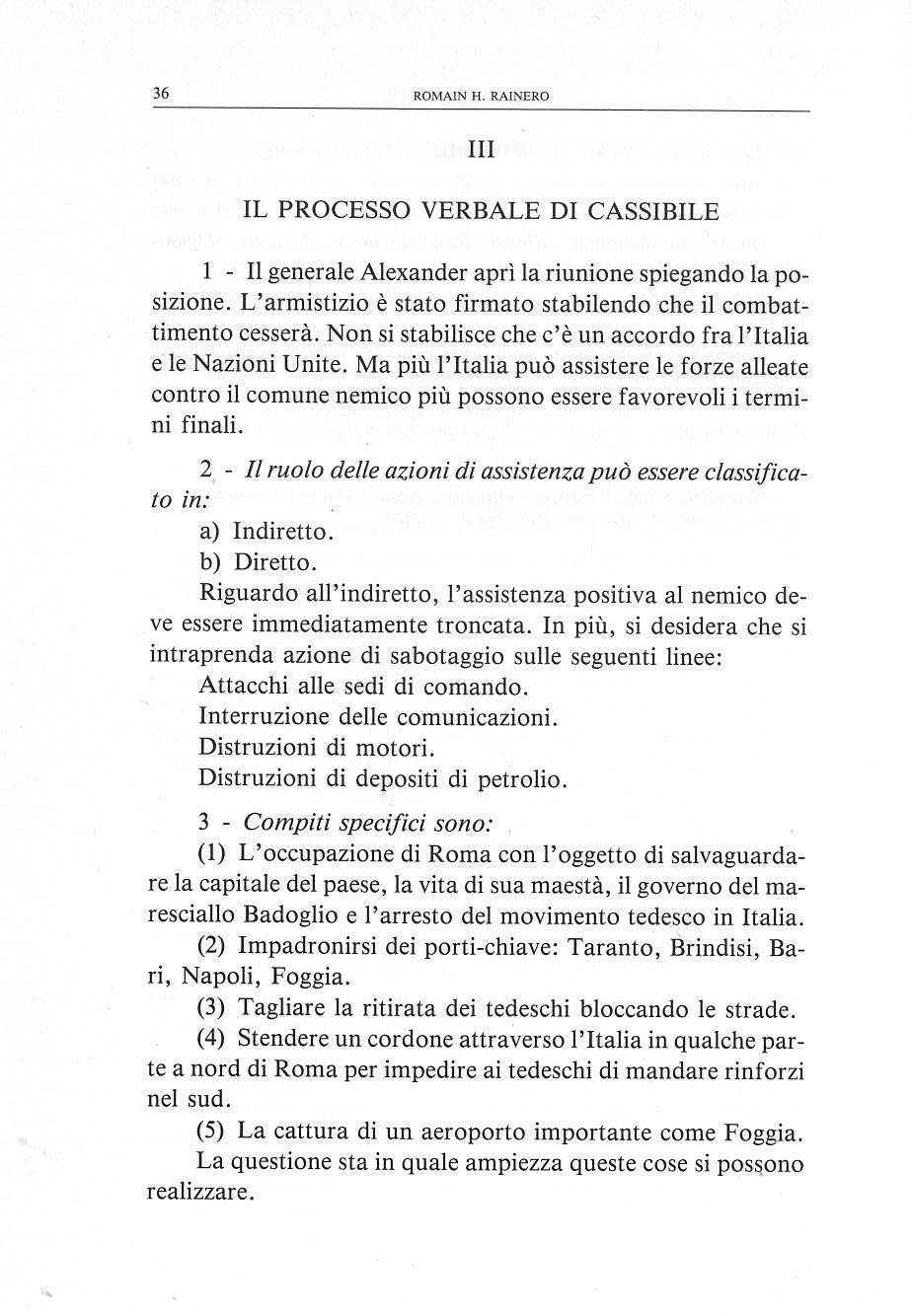
1 - Il generale Alexander aprì la riunione spiegando la posizione. L'armistizio è stato firmato stabilendo che il combattimento cesserà. Non si stabilisce che c'è un accordo fra l'Italia e le Nazioni Unite. Ma più l'Italia può assistere le forze alleate contro il comune nemico più possono essere favorevoli i termini finali.
2 - Il ruolo delle azioni di assistenza può essere classificato in:
a) Indiretto.
b) Diretto.
Riguardo all'indiretto, l'assistenza positiva al nemico deve essere immediatamente troncata. In più, si desidera che si intraprenda azione di sabotaggio su lle seguenti linee:
Attacchi alle sed i di comando.
Interruzione delle comunicazioni.
Distruzioni di motori.
Distruzioni di depositi di petrolio.
3 - Compiti specifici sono : .
(1) L'occupazione di Roma con l'oggetto di sa lvaguardare la capitale del paese, la vita di sua maes tà, il governo del maresciallo Badoglio e l'arresto del movimento tedesco in Italia.
(2) Impadronirsi dei porti-chiave: Taranto, Brindisi, Bari, Napoli, Foggia.
(3) Tagliare la ritirata dei tedeschi bloccando le strade .
(4) Stendere un cordone attraverso l'Italia in qualche parte a nord di Roma per impedire ai tedeschi di mandare rinforzi nel sud.
(5) La cattura di un aeroporto importante come Foggia. La questione sta in quale ampiezza queste cose si possono realizzare.
4 - L'armistizio. Può essere garantito?
Il generale Castellano disse che nel momento in cui l'armistizio verrà annunziato gli italiani saranno attaccati dai t edeschi e il loro compito deve essere quello di difendersi. Egli aveva chiesto al generale Smith se si poteva offrire una difesa coordinata ed era stato informato che gli it aliani debbono attaccare i tedeschi ovunque possono trovarsi. Riguardo all'armistizio, non c'è dubbio sulla nuova volontà del popolo italiano di eseguirlo. Il generale Alexander precisò che la cosa più importante era quella di paralizzare le ferrovie. Il generale Castellano di sse che non si potevano promulgare gli ord ini per ragioni di segretezza sino alla proclamazione quando il maresciallo Badoglio avrebbe pure proclamato che l ' Italia non doveva dare assistenza ai tedeschi. Essi non potevano passare immediatamente allo stato di guerra. Il generale Alexander suggerì che si potevano dare gli ordini attraverso i sindacati operai. Il generale Castellano concordò e disse che essendo il ministro dei Trasporti un generale si poteva dargli istruzioni di preparare gli ordini in antic ipo.
5 - Sabotaggio. Con quale ampiezza si potrà praticare?
Il generale Castellano disse che il popolo italiano odia i tedeschi ma non po t rebbe passare in un momento a uno stato di ost ilità attiva. Questa si dovrebbe sv ilup pare.
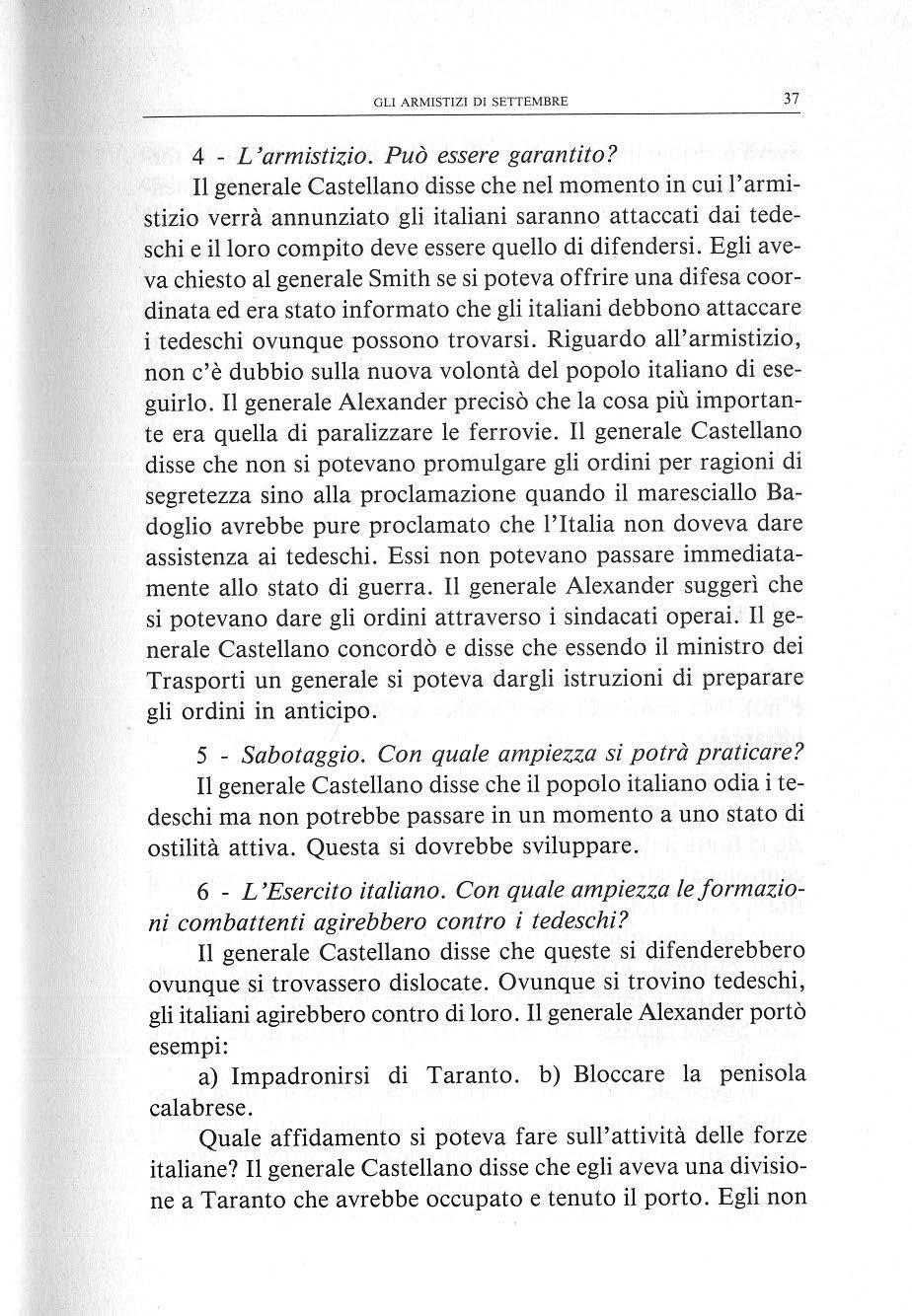
6 - L'Esercito italiano. Con quale ampiezza le formazioni combattenti agirebbero contro i tedeschi?
Il generale Castellano disse che qu(yste si difenderebbero ovunque si trovassero dislocate. Ovunque si trovino tedeschi, gli italiani agirebbero contro di loro. Il genera le Alexander portò
esempi:
a) Impadronirsi di Taranto.
b) Bloccare la penisola calabrese.
Quale affidamento si poteva fare sull'attività delle forze italiane? Il generale Castellano disse che egli aveva una divisione a Taranto che avrebbe occupato e tenuto il porto. Egli non
aveva divis ioni italiane a Napoli, dove le divisioni tedesche, tornate dalla Sicilia, erano state riequipaggiate quasi completamente. Il generale Alexander disse che le divisioni erano state battute due volte, in Tunisia e in Sicilia. Le divisioni a nord di Napoli potevano essere bloccate.
Il generale Castellano disse che la pianura di Napoli era troppo vasta per contenere un'intera sezione. Egli ripetè che gradirebbe coordinare piani integrati con gU Alleati. Il generale Alexander disse che quando gli italiani e gli Alleati si fossero conosciuti meglio rispettivamente si sarebbe potuto conseguire l'integrazione e ciò per il meglio. Nel frattempo gli italiani dovevano combattere per il loro paese. I contadini italiani armati combatterebbero bravamente con la guerriglia organizzata.
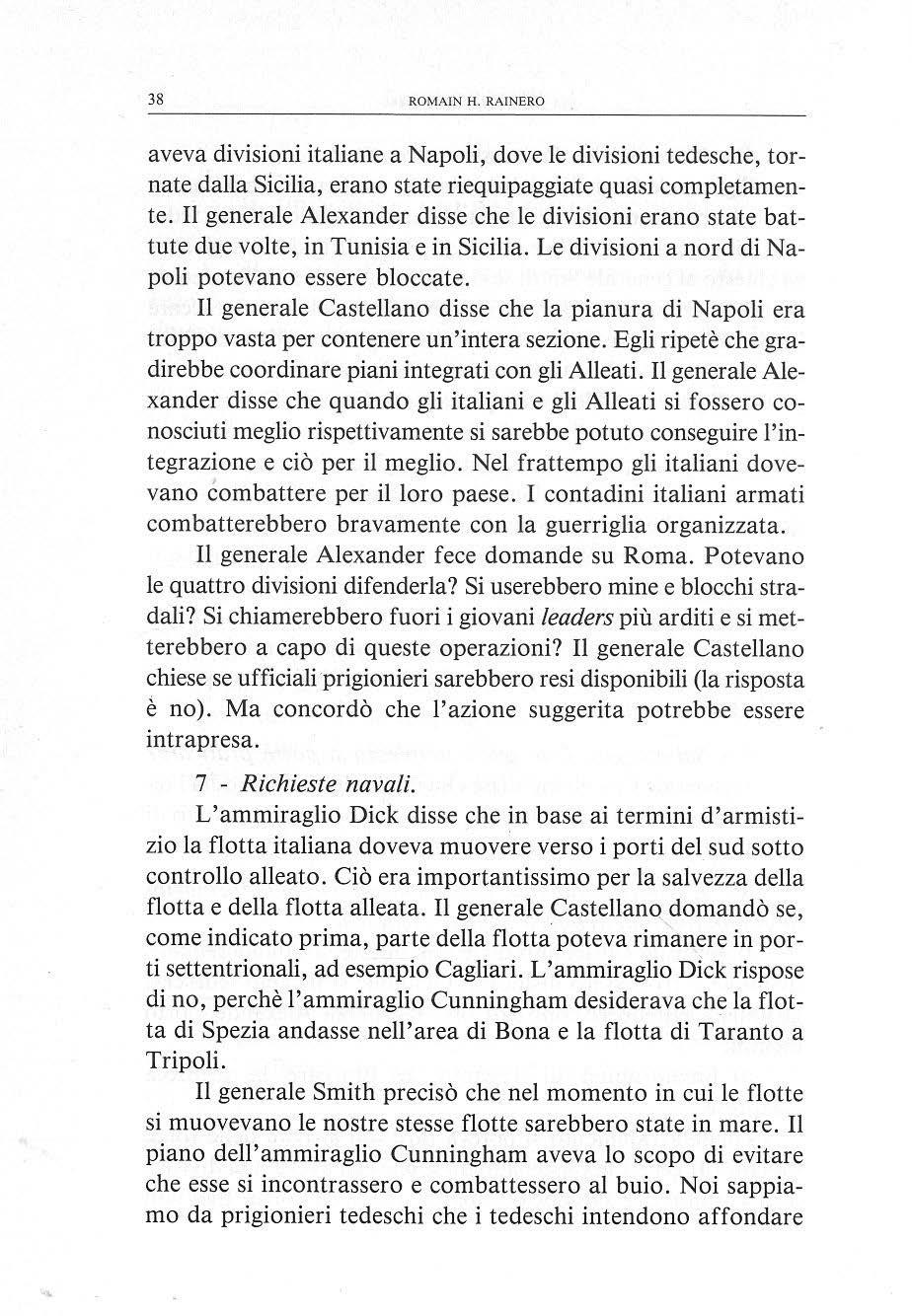
Il generale Alexander fece domande su Roma. Potevano le quattro divisioni difenderla? Si userebbero mine e blocchi stradali? Si chiamerebbero fuori i giovani leaders più arditi e si me tterebbero a capo di queste operazioni? Il generale Castellano chiese se ufficiali ·prigionieri sarebbero resi disponibili (la risposta è no). Ma concordò che l'azione suggerita potrebbe essere intrapresa.
7 - Richieste navali.
L'ammiraglio Dick disse che in base ai termini d'armistizio la flotta ita li ana doveva muovere verso i porti del sud sotto controllo a ll eato. Ciò era importantissimo per la salvezza della flotta e della flotta alleata. Il genera le Castellano domandò se, come ind icato prima, parte della flotta poteva rimanere in port i settentrionali, ad esempio Cagliari. L'ammirag li o Dick rispose di no, perchè l'ammiraglio Cunningham desiderava eh~ la flotta di Spezia andasse nell'area di Bona e la flotta di Taranto a Tripoli.
Il generale Smith prec isò che nel momento in cui le flotte si muovevano le nostre stesse flotte sarebbero state in mare. Il piano dell 'amm i raglio Cu n ningham aveva lo scopo di evitare che esse si i ncontrassero e combattessero al buio. Noi sappiamo da prigionieri ted eschi che i tedeschi in t endono affondare
con bombe e torpedini le navi italiane piuttosto di lasciare che cadano nella mani degli Alleati. L'ammiraglio Dick precisò che all'inizio si dovevano prendere precauzioni per assumere il controllo di queste potenti unità. Il generale Castellano ritenne che si sarebbe eseguita tale azione. Egli sperava che la forma sarebbe stata quanto possibile inoffensiva.
Il generale Smith disse che c'era così poco tempo che gli Alleati erano obbligati a seguire la procedura precisata. Vi sarebbe stato un processo di assestamento fino a che si potesse definire un'azione coordinata. Gli ufficiali ed i marinai italiani non sarebbero assoggetati ad alcuna indegnità. L'ammiraglio
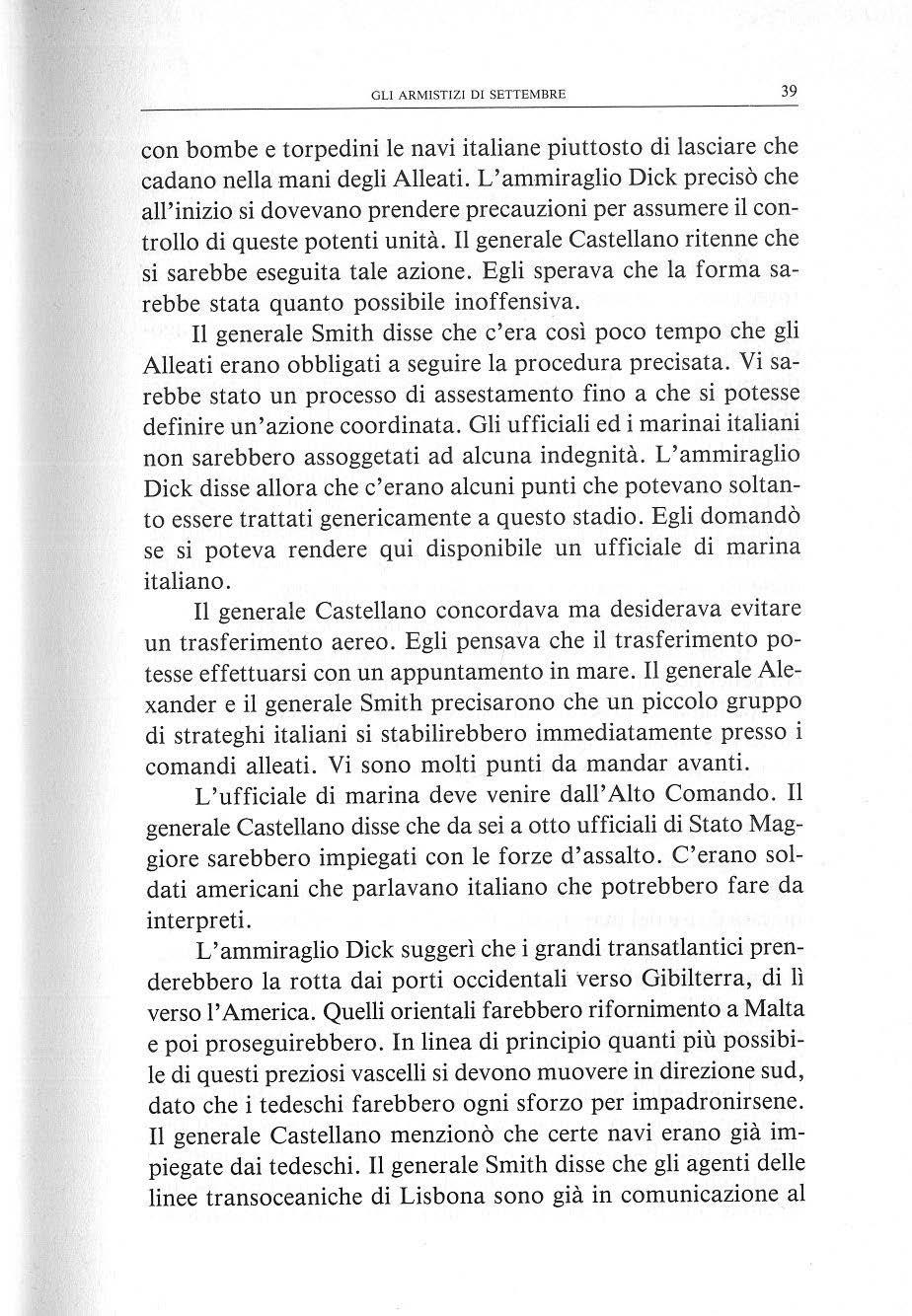
Dick disse allora che c'erano alcuni punti che potevano soltanto essere trattati genericamente a questo stadio. Egli domandò se si poteva rendere qui disponibile un ufficiale di marina italiano.
Il generale Castellano concordava ma desiderava evitare un trasferimento aereo. Egli pensava che il trasferimento potesse effettuarsi con un appuntamento in mare. Il generale Alexander e il generale Smith precisarono che un piccolo gruppo di strateghi italiani si stabilirebbero immediatamente presso i comandi alleati. Vi sono molti punti da mandar avanti.
L'ufficiale di marina deve venire dall'Alto Comando. Il generale Castellano disse che da sei a otto ufficiali di Stato Maggiore sarebbero impiegati con le forze d'assalto. C'erano soldati americani che parlavano italiano che potrebbero fare da interpreti.
L'ammiraglio Dick suggerì che i grandi transatlantici prenderebbero la rotta dai porti occidentali Verso Gibilterra, di lì verso l'America. Quelli orientali farebbero rifornimento a Malta e poi proseguirebbero. In linea di pr inci pio quanti più possibile di questi preziosi vascelli si devono muovere in direzione sud, dato che i tedeschi farebbero ogni sforzo per impadronirsene. Il generale Castellano menzionò che certe navi erano già impiegate dai tedeschi. Il generale Smith disse che gli agenti delle linee transoceaniche di Lisbona sono già in comunicazione al
riguardo. Il generale Castellano disse che certe navi potevano non avere abbastanza carburante per muoversi al sud. L'ammiraglio Dick disse che sarebbe pericoloso mandare petroliere.
8 - Richieste aeree.
Il generale Smith disse che a noi non abbisognava che le· forze aeree prendessero il volo. Esse sarebbero impiegate in Italia. Il generale Castellano disse che la benzina era scarsa. In agosto i tedeschi avevano fornito soltanto un quinto del quan t itativo preventivato. Egli pensava che ai bombardieri si poteva dare abbastanza carburante per raggiungere la Sicilia. Il generale Castellano disse che i combattenti italiani usavano benzina tedesca ma i bombardieri no. Il generale Castellano domandò se tutta la benzina disponibile si poteva concentrare nell'area di Roma. Il generale Timberlake sottolineò l'importanza degli aeroporti di Foggia come obiettivi militari. Il generale Castellano disse che non c'erano apprezzabili forze italiane.
9 - Formazioni italiane nei Balcani e nell'Egeo.
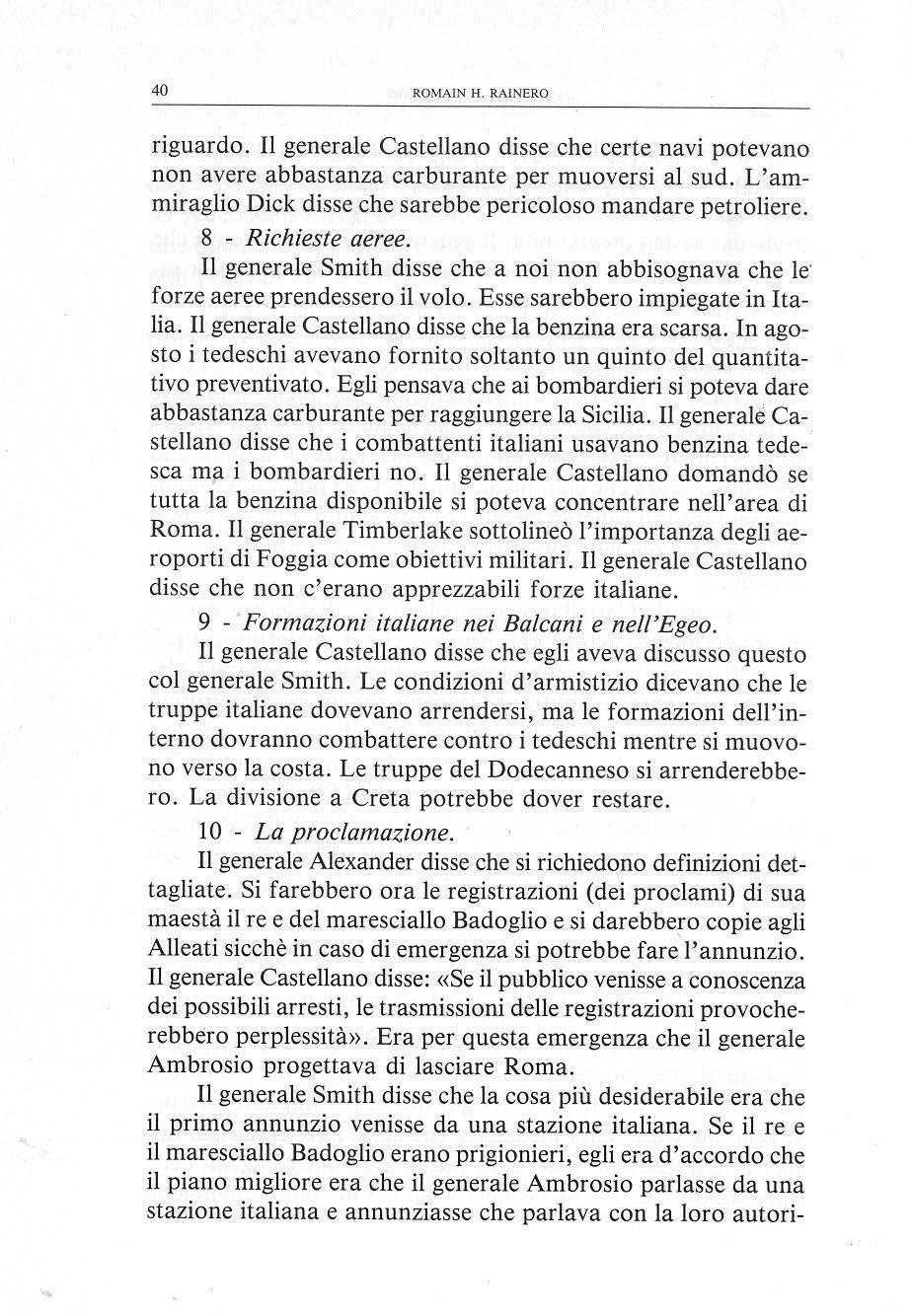
Il generale Castellano disse che egli aveva discusso questo col generale Smith. Le condizioni d'armistizio dicevano che le truppe italiane dovevano arrendersi, ma le formazioni dell'interno dovranno combattere contro i tedeschi mentre si muovono verso la costa. Le truppe del Dodecanneso si arrenderebbero. La divisione a Creta potrebbe dover restare.
1O - La proclamazione.
Il generale Alexander disse che si richiedono definizioni dettagliate. Si farebbero ora le reg istrazioni (dei proclami) di sua maestà il re e del maresciallo Badoglio e si darebbero copie agli ' Alleat i sicchè in caso di emergenza si potrebbe fare l'annunzio. Il generale Castellano disse: <<Se il pubblico venisse a conoscenza dei possibili arresti, le trasmissioni delle registrazioni provocherebbero perplessità». Era per questa emergenza che il generale Ambrosio progettava di lasciare Roma.
Il generale Smith disse che la cosa più desiderabile era che il primo annunzio venisse da una staz ione italiana. Se il re e il maresciallo Badoglio erano prigionieri, egli era d'accordo che il piano migliore era che il generale Ambrosio parlasse da una stazione italiana e annunziasse che parlava con la loro autori-
tà. Il generale Alexander disse che egli era ancora in favore a che si mandassero le registrazioni e che si fornissero le copie ai comandi alleati. Il generale Castellano menzionò che il re non trasmette bene e disse che il maresciallo Badoglio annunzierebbe la proclamazione. Egli domandò su quali linee direttiva questa si potrebbe fare. ·
Il generale Smith disse che questo poteva verificarsi per un annunzio ulteriore.
Il generale Smith spiegò come il generale Eisenhower avrebbe fatto la sua proclamazione. Il generale Castellano disse che la sequenza sarebbe:
(1) Proclamazione di cessazione delle ostilità.
(2) Una visita del ministro degli Esteri italiano alle autorità tedesche per notificarle.
Se i tedeschi offrivano di arrendersi, gli italiani cercherebbero un pretesto per attaccarli. Se, come probabile, essi rimanevano, gli italiani li avrebbero allora attaccati per quel motivo. Il generale Smith domandò se nel primo caso non si permetterebbe ai tedeschi di arrendersi. Il generale Alexander disse che no, non si doveva rimandare nessuna opportunità di uccidere i tedeschi.
L'ammiraglio Dick disse che la data era importante. A meno che fossero diramati i primi ordini di allarme, le navi dovevano essere in grado di prendere la rotta la notte della proclamazione. Egli disse che dettagli dell'annunzio di Eisenhower e della proclamazione devono essere coordinati in anticipo. Il generale Rooks spiegò le sue proposte per la data alle 18,30 ora di Roma in un giorno D specificato, immediatamente seguente all'annunzio del generale Eisenhower alle 18,15. La proclamazione sarebbe letta con ogni mezzo possibile. Il generale Castellano ripetè ciò che disse a Lisbona, che un preavviso di poche ore del giorno D era insu fficiente . Gli occorreva un preavviso di parecchi giorni.
Il generale Alexander disse che non poteva rischiare perdita di sicurezza.
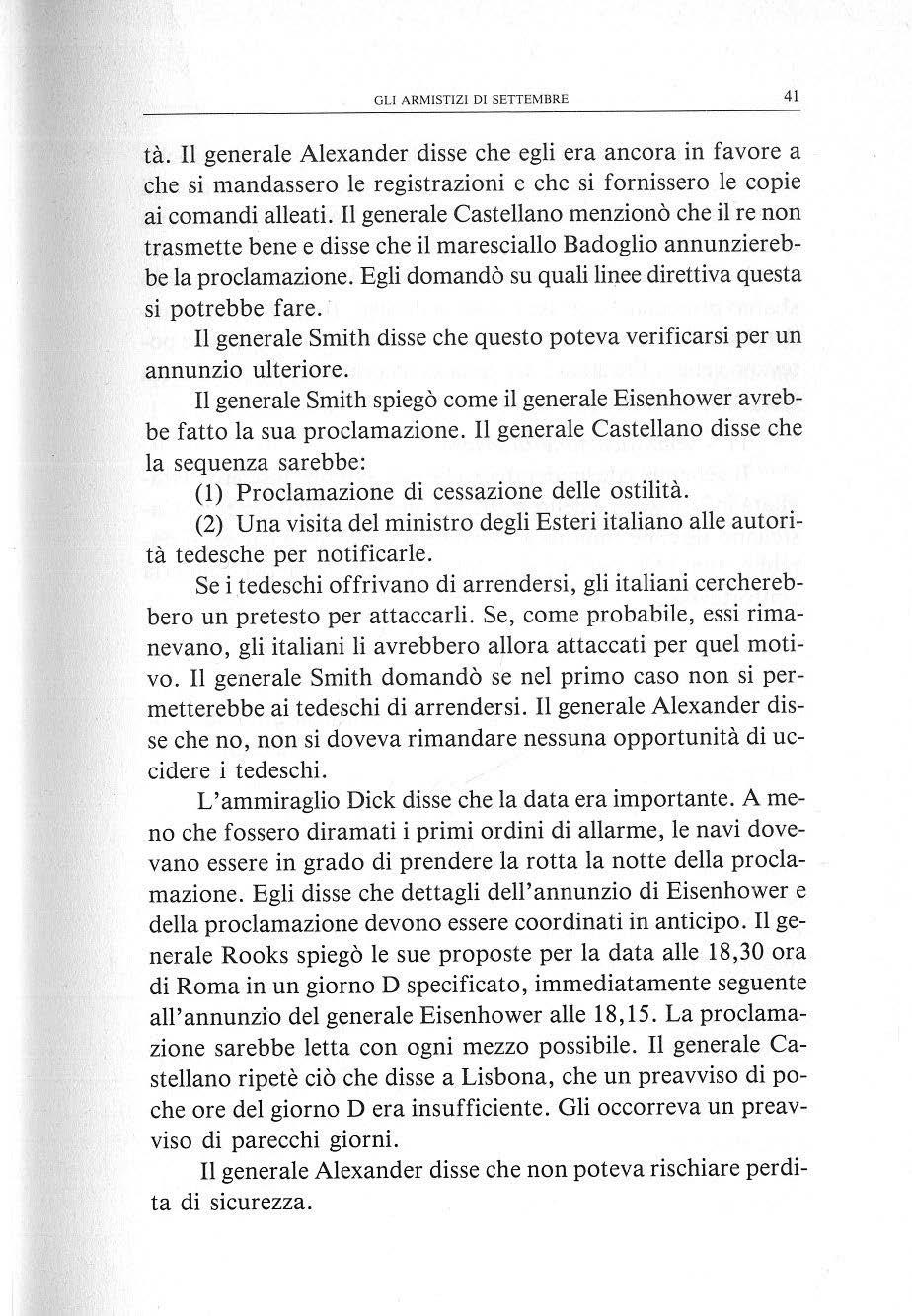
Era il minore di due mali che alcuni dettagli della proclamazione fossero incompleti. Egli poteva soltanto dire che gli Alleati avevano iniziato il loro armistizio oggi. C'era solo una questione di ore prima che seguisse lo sbarco principale. Il generale Castellano domandò se rimaneva il piano che un solo sbarco principale seguisse l'assalto di oggi. Il generale Alexander disse che non poteva saperlo. C'erano alcune mosse che potevano venire. Era stata fatta soltanto la prima mossa. Non c'era tempo da perdere.
11 - Pianificazione ulteriore.
Il generale Alexander disse che egli avrebbe lasciato dettagliata informazione dello staff. Si concordò che il generale Castellano sarebbe rimasto a Fairfield a Cassibile e che gli si darebbe una sede per lui e si farebbe ogni cosa per renderla confortevole.
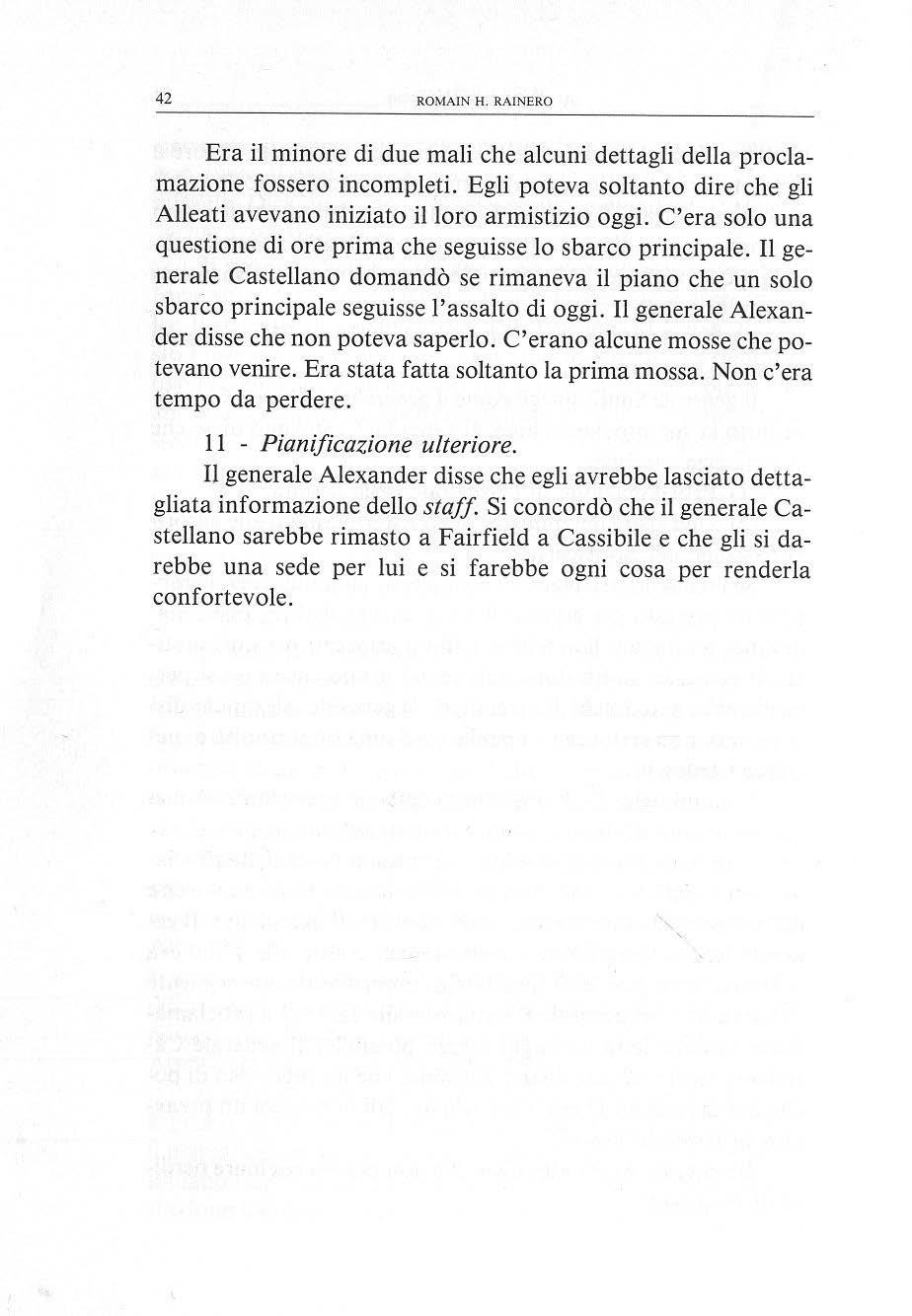
Poichè in seguito ad un armistizio in data 3 settembre 1943, fra i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna , agenti nell'interesse di tutte le Nazioni Unite da una parte, e il Governo italiano dall'altra, le ostilità sono state sospes e fra l'Italia e le Nazioni Unite in base ad alcune condi zi oni di carattere milita re; e poichè, oltre queste condizioni, era stabilito in detto armi st izio che il Go verno italiano si impegnava ad eseguire al tre condizioni di carattere politico, economico e finanziario da trasmet tere in seg uito;
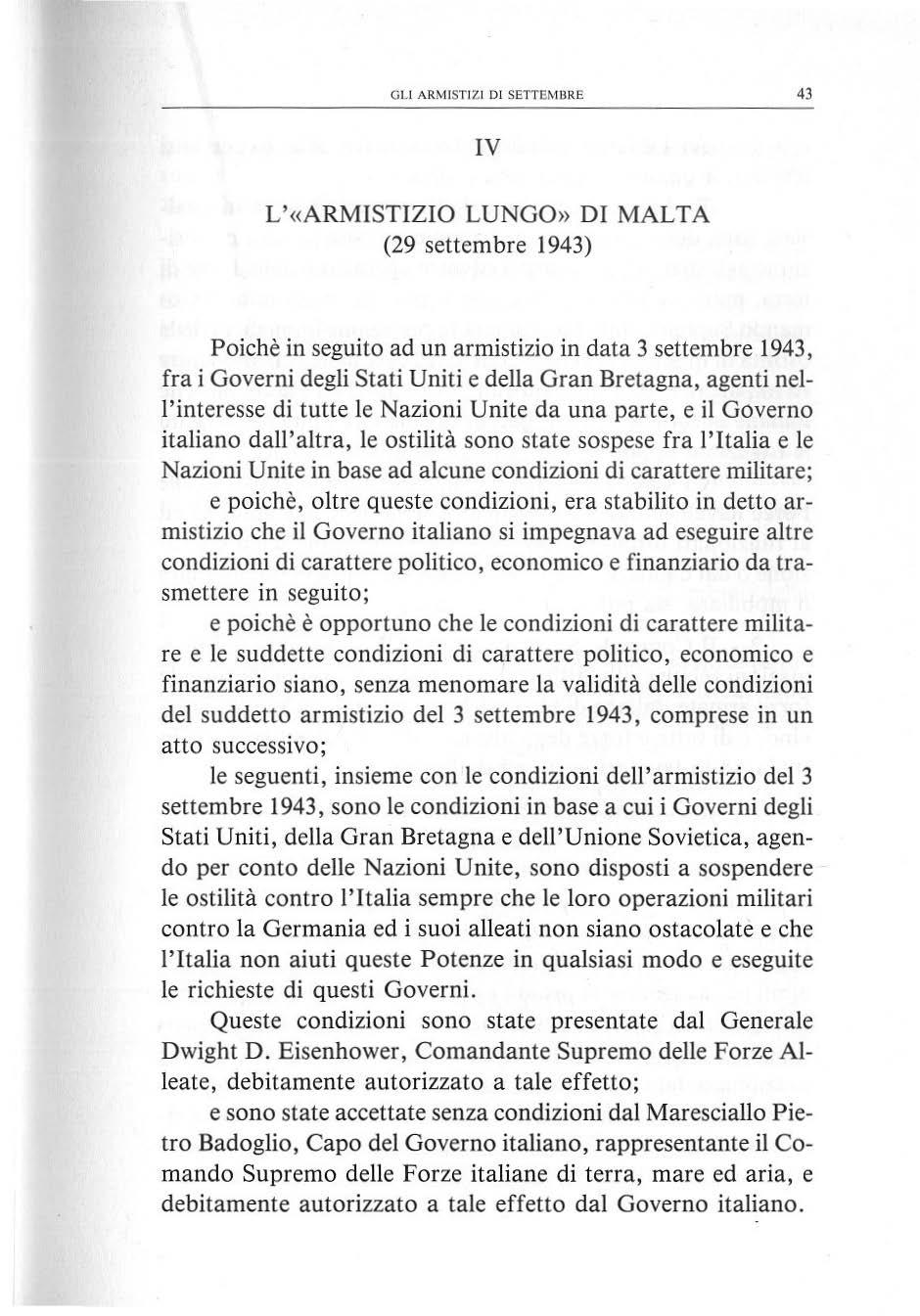
e poichè è oppor t uno che le condizioni di c ara tte re mili tare e le suddette condizioni di carattere politico, economico e finan ziario siano, senza menomare la validità delle co ndi zioni del sud detto armistizio del 3 settembre 1943, comprese in un atto successivo;
le seguenti, insieme con le condizioni dell'armi st izio del 3 settembre 1943, sono le condizioni in base a cui i Go verni degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, agendo per conto delle Nazio ni Unite, sono di sposti a sospendere le o st ilità contro l'Italia sempre che le loro operazio ni mili tari contro la Germania ed i suoi alleati non siano ostacolate e che l'Italia non aiuti que ste Poten ze in qualsia si modo e eseguite le richieste di que sti Governi.
Queste condizioni sono state presentate dal Generale
Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo delle Forze Alleat e, debitamente autorizzato a tale effetto;
e so no st ate a ccettate senza condizioni dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo ital iano, rappresentante il Comando Supremo dell e Forze italiane di terra, mar e ed aria, e debi ta mente autorizzato a tale effet t o dal Governo italiano.
1 - (A) Le Forze italiane di terra, mare, aria, ovunque si trovino, a questo scopo si arrendono.
(B) La partecipazione dell'Italia alla guerra in qualsiasi zona deve cessare immediatamente. Non vi sarà opposizione agli s barchi , movimenti ed altre operazioni delle forz e di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. In conformità il Comando Supremo italiano ordinerà la cessazione immediata delle ostilità di qualunque genere coi:itro le forze delle Nazioni Unite ed impartirà ordine alle autorità navali, militari e aeronautiche italiane in tutte le zone di guerra di emanare immediatamente le istruzioni opportune ai loro comandi subordinati.
(C) Inoltre il Comando Supremo italiano impartirà alle Forze navali, militari ed aeronautiche nonchè alle autorità ed ai funzionari ordini di desi st e re immediatamente dalla di struzione o dal danneggiamento di qual siasi proprietà immobiliare o mobiliare, sia pubblica che privata.
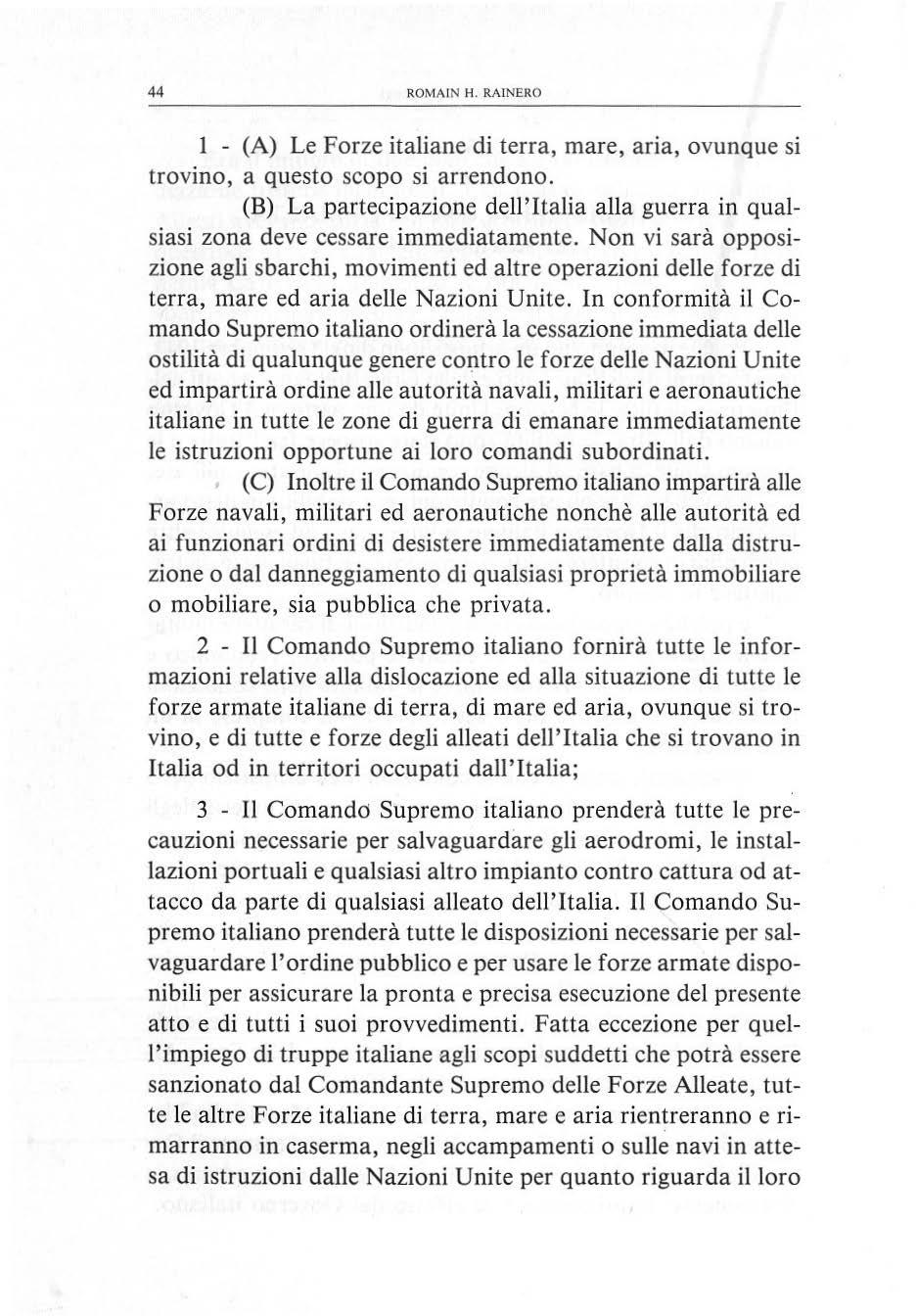
2 - Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative alla dislocazione ed alla situazione di tutt e le forze armate italiane di terra, di mare ed aria, ovunque si trovino, e di tutte e forze degli alleati dell'Italia che si trovano in Italia od in territori occupati dall'Italia;
3 - Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni portuali e qualsiasi altro impianto contro cattura od attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico e per usare le forze armate disponibili per assicurare la pronta e precisa esecuzione del presente atto e di tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione per quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti che potrà e ss ere sanzionato dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, tutte le altre Forze italiane di terra, mare e aria rientreranno e rimarranno in caserma, negli accampamenti o sulle navi in attesa di istruzioni dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il loro
futuro stato e definitiva destinazione. In via eccezionale, il personale navale si trasferirà in quelle caserme navali che le Nazioni Unite indicheranno.
4 - Le Forze italiane di terra, mare ed aria, entro il termine che verrà stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti i territori fuori dell'Italia che saranno notificati al Governo italiano delle Nazioni Unite e si trasferiranno in quelle zone che verranno indicate dalle Nazioni Unite.
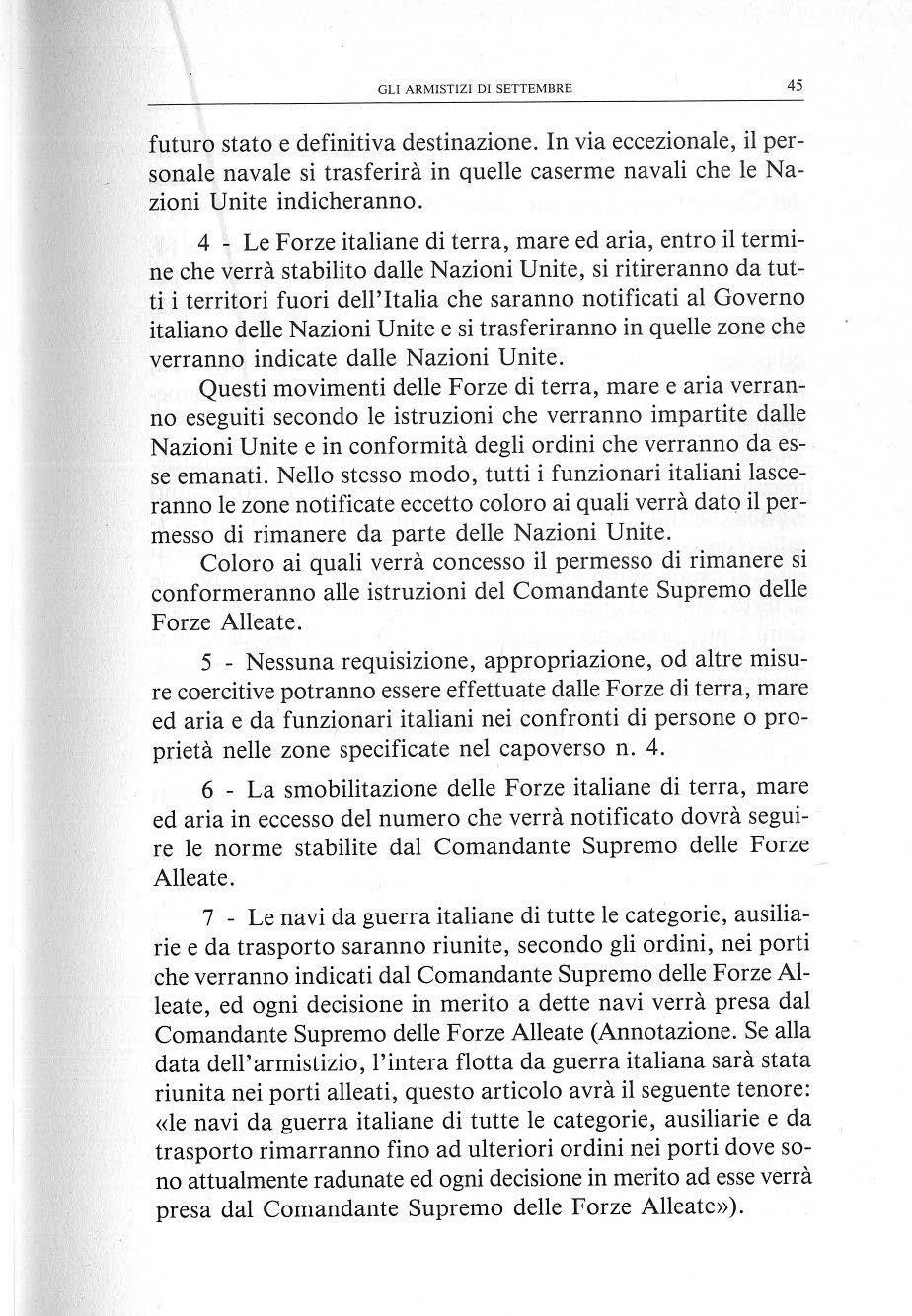
Questi movimenti delle Forze di terra, mare e aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite e in conformi t à degli ordini che verranno da esse emanati. Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone notificate eccetto coloro ai quali verrà datQ il permesso di rimanere da parte delle Nazioni Uni te.
Coloro ai quali verrà concesso il permesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate.
5 - Nessuna requisizione, appropriazione, od altre misure coercitive potranno essere effettuate dalle Forze di terra, mare ed aria e da funzionari italiani nei confronti di persone o proprietà nelle zone specificate nel capoverso n. 4.
6 - La smobilitazione delle Forze italiane di terra, mare ed aria in eccesso del numero che verrà notificato dovrà seguire le norme stabilite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.
7 - Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti che verranno indicati dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, ed ogni decisione in meri t o a dette navi verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate (Annotazione. Se alla data dell'armistizio, l'intera flotta da guerra italiana sarà stata riunita nei porti alleati, questo articolo avrà il seguente tenore:
«le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto rimarranno fino ad ulteriori ordini nei porti dove sono attualmente radunate ed ogni decisione in merito ad esse verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate»).
8 - Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non decolledranno dalla terra, dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del Comandante Supremo delle Forze Alleate.
9 - Senza pregiudizio a quanto disposto daglì articoli 14, 14 e 28 (A) e (D) che seguono, a tutte le navi mercantili, da pesca ed altre navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e i mezzi di trasporto interno di qualunque nazionalità in Italia od in territorio occupato dall'Italia od in acque italiane dovrà, in attesa di verifica della loro identità e posizione, essere impedito di partire.
10 - Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative ai mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti e difese, ai trasporti e mezzi di comunicazione costruiti dall'Italia o da suoi allea t i nel territorio italiano o nelle vicinanze di esso, ai campi di mine od altre ostruzioni ai movimenti per vie di terra, mare od aria e qualsiasi altra informazione che le Nazioni Unite potranno richiedere in relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza o al benessere delle Forze di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. Le forze e il materiale italiano verranno messi a disposizione delle Nazioni Unite, quando richiesto, per togliere le summenzionate ostruzioni.
11 - Il Governo italiano fornirà subito elenchi indicanti i quantitativi di tutto il materiale .da guerra con l'indicazione della località ove esso si trova. A meno che il Comandante Supremo delle Forze Alleate non decida di farne uso, il materiale da guerra verrà posto in magazzino sotto il controllo che egli potrà stabilire. La destinazione definitiva del materiàle da guerra verrà decisa dalle Nazioni Unite.
12 - Non dovrà aver luogo alcuna distruzione nè danneggiamento, nè, fatta eccezione per quanto verrà autorizzato o disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale da guerra, radio, radiolocalizzazione, o stazione meteorologica, impianti ferroviari, stradali e portuali od altre installazioni od in via generale di servizi pubblici e privati di proprietà di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la manutenzione necessaria e le ripazioni saranno a carico delle Autorità italiane.
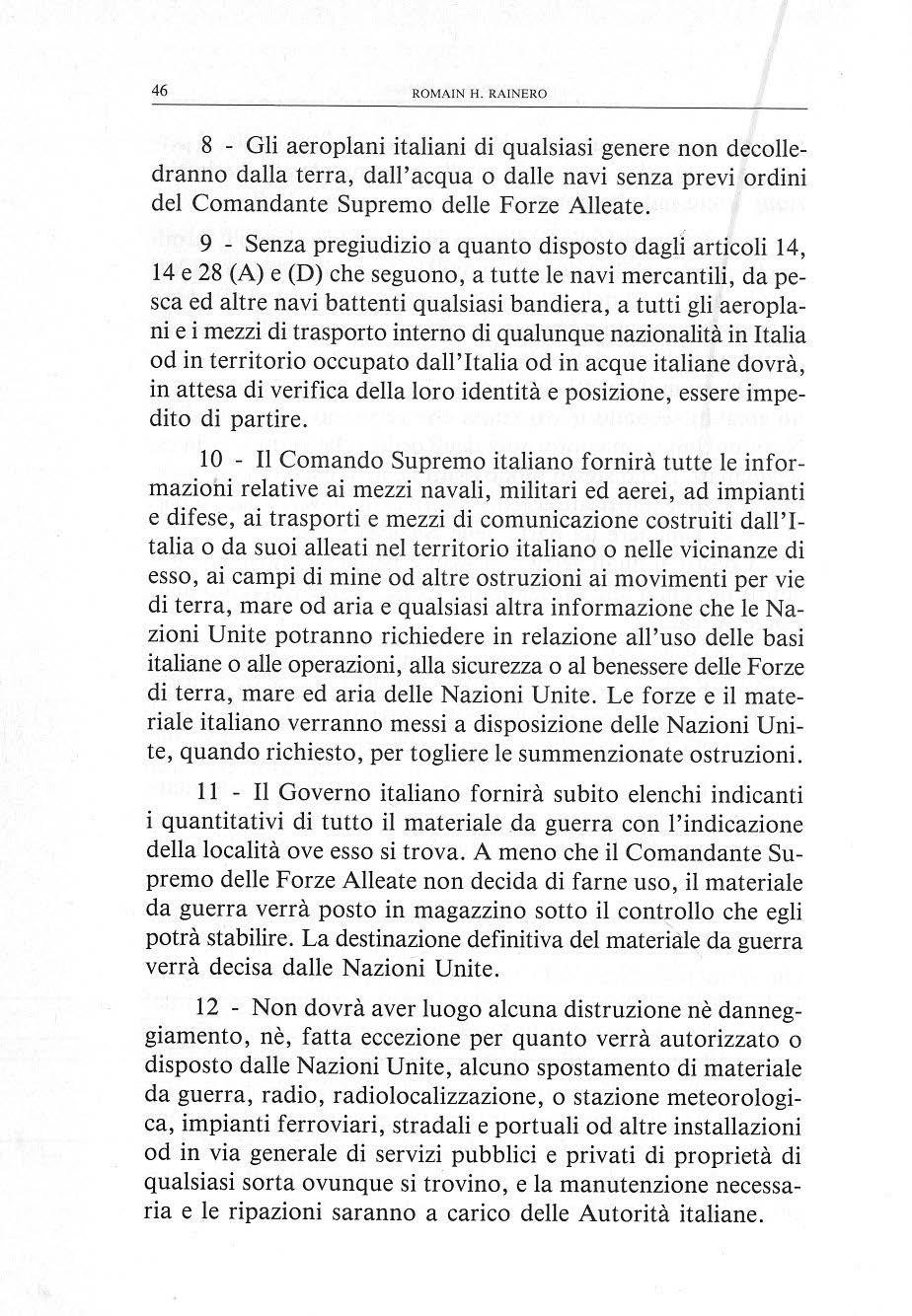
13 - La fabbricazione, produzione e costruzione del materiale da guerra, la sua importazione, esportazione e transito, è proibita, fatta eccezione a quanto verrà disposto dalle Nazioni Unite. Il Governo italiano si conformerà a quelle istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione e costruzione, e l'importazione, esportazione e transito di materiale da guerra.
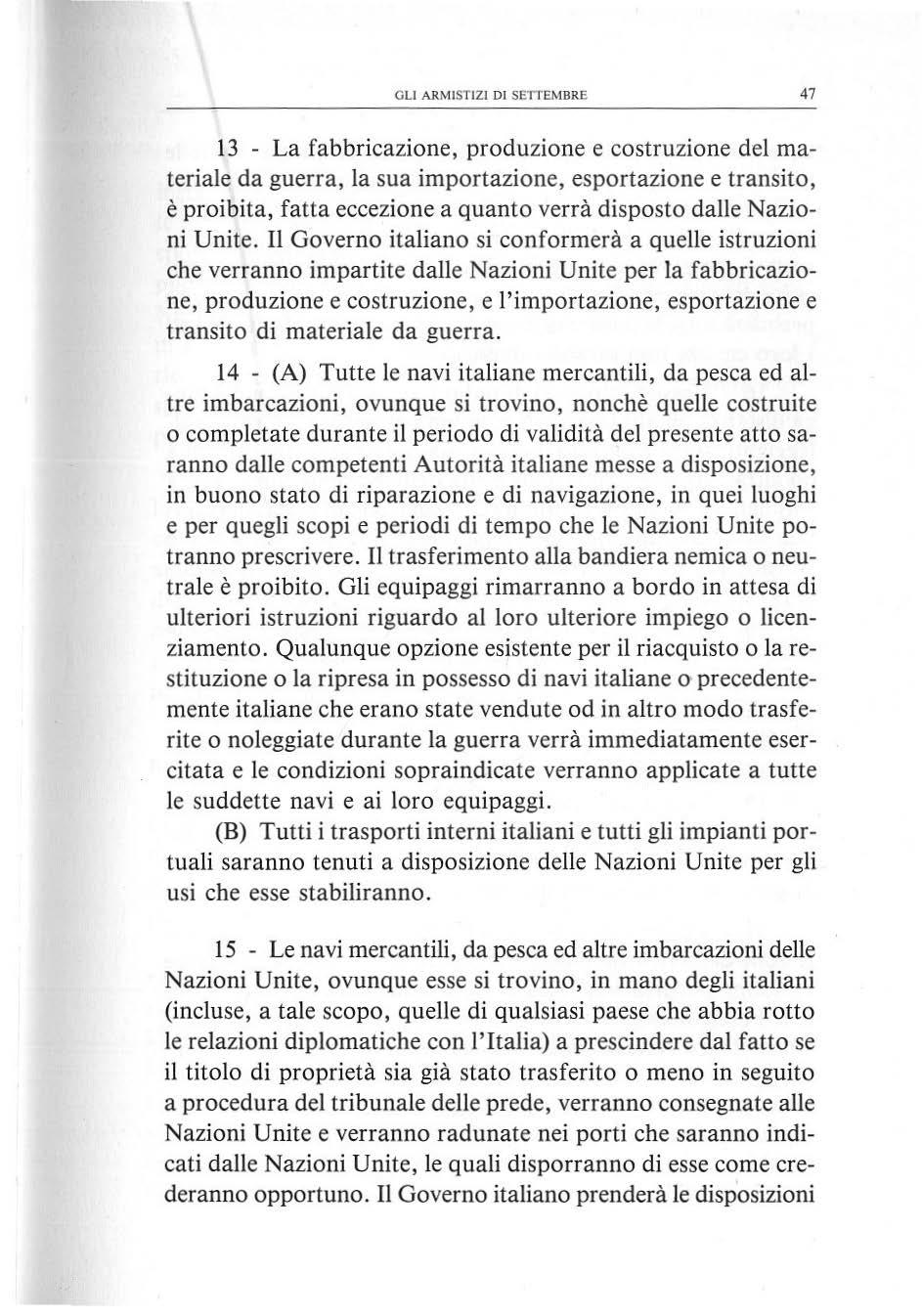
14 - (A) Tutte le navi italiane mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni, ovunque si trovino, nonchè quelle costruite o completate durante il periodo di validità del presente atto saranno dalle competenti Autorità italiane messe a dispo sizione, in buono stato di riparazione e di navigazione, in quei luoghi e per quegli scopi e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere . Il trasferimento alla bandiera nemica o neutrale è proibito. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulteriori istruzioni riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento. Qualunque opzione esistente per il riacquisto o la restituzione o la ripresa in possesso di navi italiane o, precedentemente italiane che erano state vendute od in altro modo trasferi te o noleggiate durante la guerra verrà immediatamente esercitata e le condizioni sopraindicate verranno applicate a tutte le suddette navi e ai loro equipaggi.
(B) Tutti i trasporti interni italiani e tutti gli impianti portuali saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gli usi che esse stabiliranno.
15 - Le navi mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni delle Nazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italiani (incluse, a tale sc opo , quelle di qualsiasi paese che abbia rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia) a prescindere dal fatto se il titolo di proprietà sia già stato trasferito o meno in seguito a procedura del trib un ale delle prede, verra nno consegnate alle Nazi oni Unite e verranno radunate nei porti che saranno indicati dalle Nazioni Unite, le quali disporranno di esse come crederanno opportuno. Il Governo italiano prenderà le disposizioni
necessarie per il trasferimento del titol o di proprietà . Tutte le navi mercantili, da pesca od altre imbarcazioni neutrali gestite o controllate dagli italiani saran no radunate in modo sim ile in attesa di accordi per la loro sorte definitiva. Qualunque necessaria riparazione alle sopra in dicate navi se richiesta sarà eseguita dal Go verno italiano a proprie spese. Il Governo italiano pre nder à tutte le misure neces sarie per assicurare che le navi ed i loro carichi non saranno danneggiati.
16 - Nessun impianto di radio o di comunicazione a lunga distanza od altri mezzi di intercomunicazione a terra o galleggianti, sotto controllo italiano, sia che appartenga all'Italia od altra Nazione non facente parte delle Nazioni Unite, potrà trasm et tere finchè disposizioni per il controllo di questi impianti non saranno impartite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le Autorità italiane si conformeranno alle dispo sizioni per il controllo e la censura della stampa e delle altre pubblicazioni, delle rappresen tazioni teatrali e cinemat ografiche, della radiodiffusione e di qualsiasi altro mezzo di intercomun icazione che potrà prescrivere il Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà a sua discrezione ri levare stazioni radio, cavi od altri mezzi di com uni cazione.
17 - Le n avi da guerra, aus ilia rie, di trasporto e mercantili e altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno il dirit to di usare lib eramente le acque territoriali itali a ne e di sorv ol are il territorio i taliano.
18 - Le forze dell e Nazioni Unite dovr ann o occupare certe zone del territorio italiano. I territor i o le zone in questione verranno notificate di volta in volta dalle Nazi on i Un ite, e tutte le For ze itali ane di terra, mare ed a ria , si r itireran no da quest i territori o zone in conformità a gli ordini emessi dal Comandante Supremo d elle Forze Alleate. Le di spos izion i di questo articolo non pr egiu di cano quelle dell'art. 4 so pradetto. Il Comandante Supremo italia no garan tirà agli Alleati l'uso e l'access o imm edia to agli aerodromi e ai po rti nava li in Italia sotto il suo controllo.
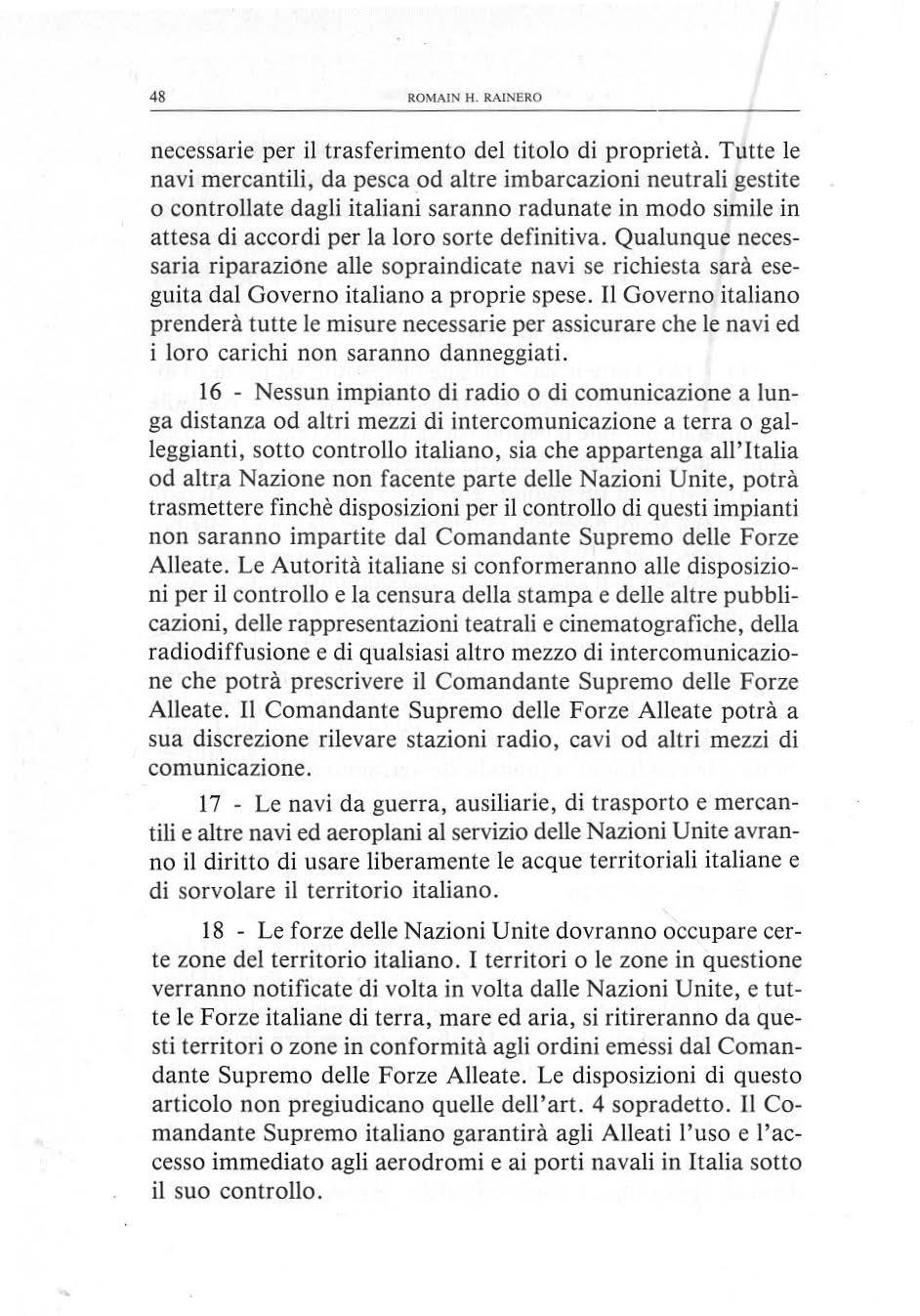
19 - Nei territori o zone cui si riferisce l'art. 18, tutte le installazioni navali, militari ed aeree, tutte le centrali elettriche, le raffinerie, i servizi pubblici, i porti, le installazioni per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi ed il materiale e quegli impianti e mezzi e altri depositi che potranno essere richiesti dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti Autorità italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo italiano metterà a disposizione quelle altre risorse o servizi locali che le Nazioni Unite potranno richiedere.
20 - Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle z one di cui all'a r.t. 18, per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in Capo Alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.
21 - In aggiunta ai diritti relativi ai territori italiani occupati descritti negli articoli dal numero 18 al 20,
(A) i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree ed i funzionari delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio nel territorio italiano non occupato o al di sopra di esso e verrà loro fornita ogni facilitazione e assistenza necessaria per eseguire le loro funzioni.
(B) Le Autorità italiane metteranno a disposizione, nel territorio italiano non occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti richieste dalle Nazioni Unite, compreso il libero transito per il loro materiale ed i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istruzioni emanate dal Comandante in Capo Alleato relative all'uso ed al controllo degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi e mezzi di trasporto terrestre, sistemi di comunicazione, centrali elettriche e servizi pubblici, raffinerie, mater ial i e altri rifornimenti di carburante e di elettricità ed i mezzi per pro-
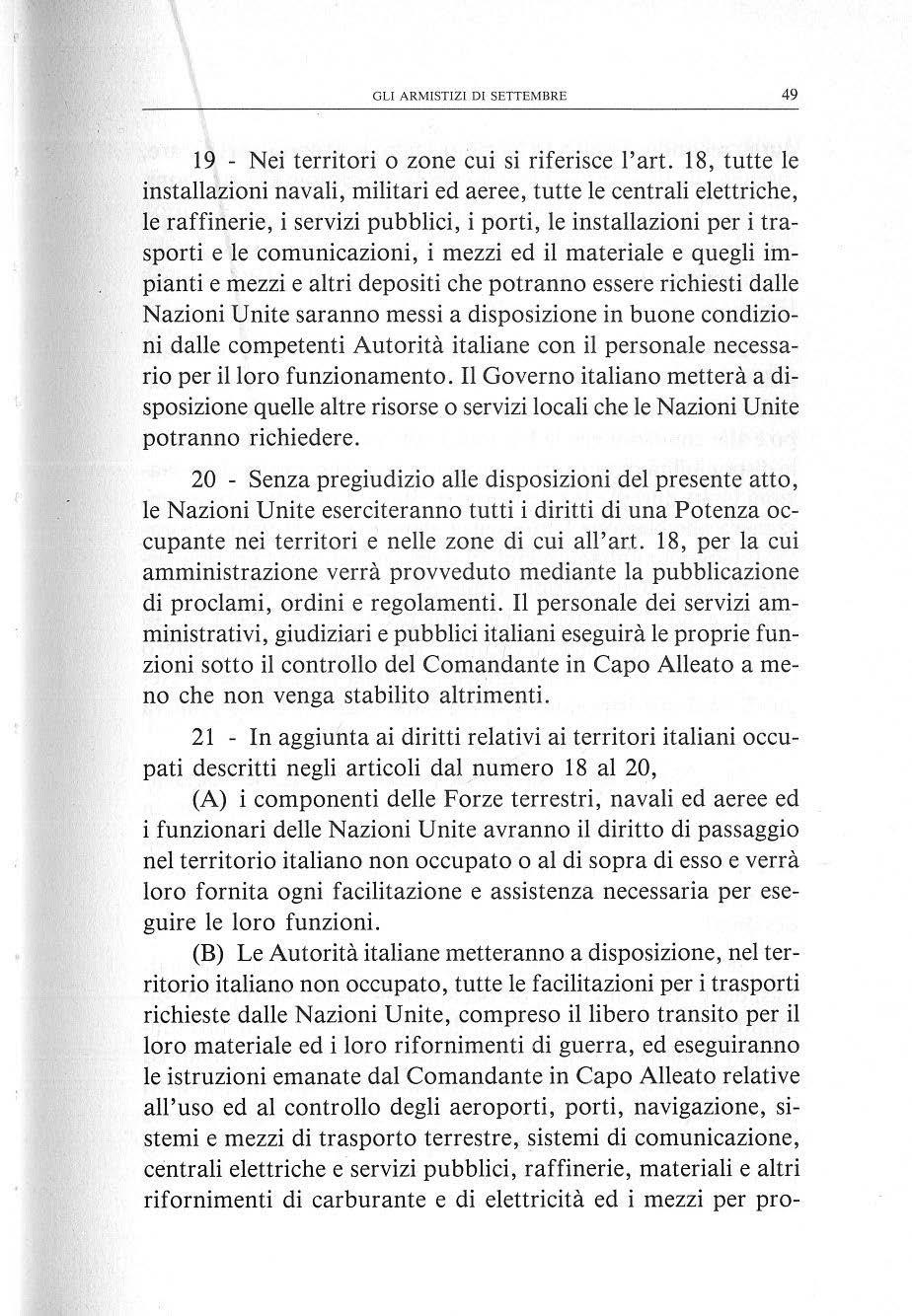
durli, secondo quanto le Nazioni Unite potranno specificare, insieme alle relative facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.
22 - Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite.
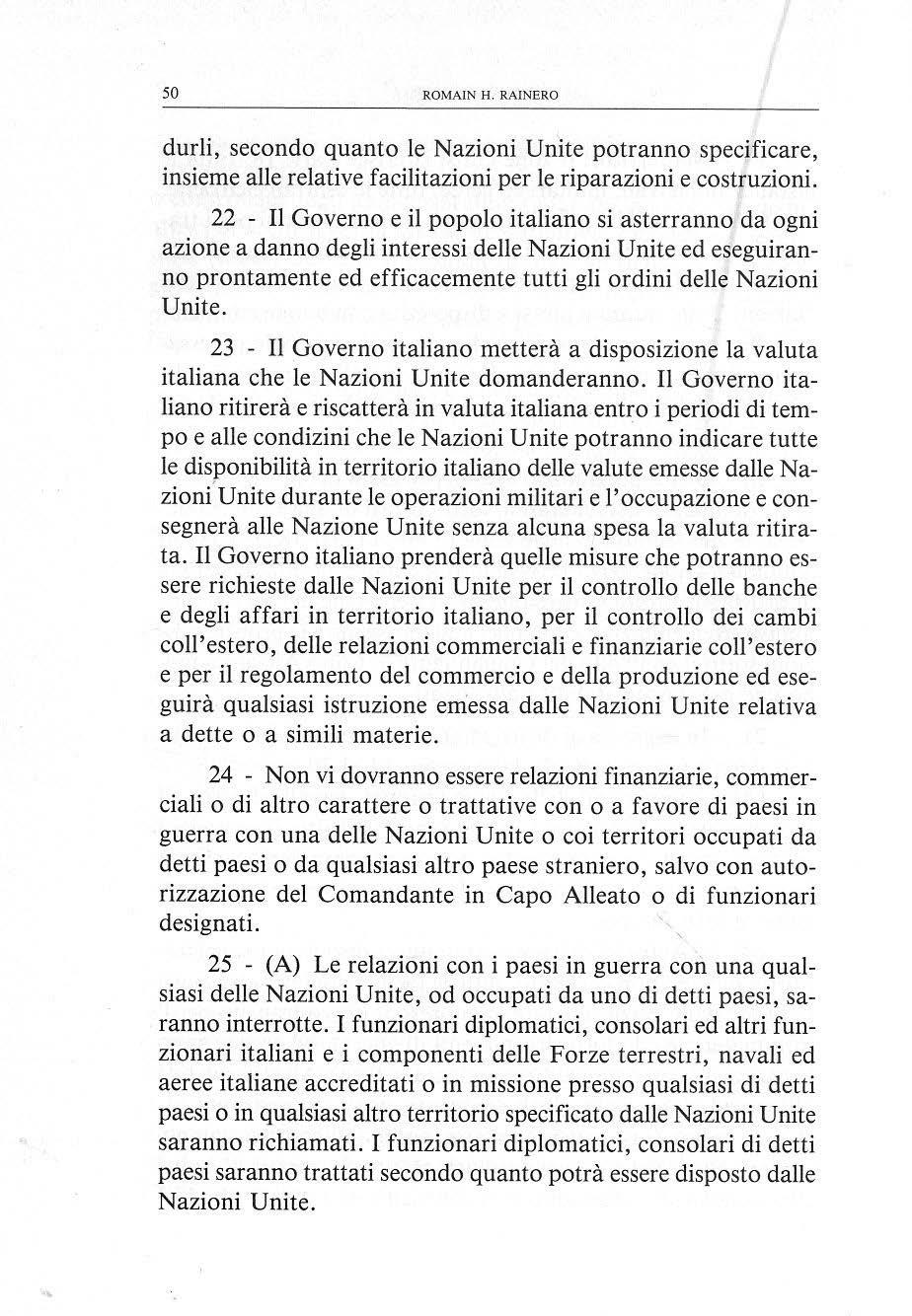
23 - Il Governo italiano metterà a disposizione la valuta italiana che le Nazioni Unite domanderanno. Il Governo italiano ritirerà e riscatterà in valuta italiana entro i periodi di tempo e alle condizini che le Nazioni Unite potranno indicare tutte le disponibilità in territorio italiano delle valute emesse dalle Nazioni' Unite durante le operazioni militari e l'occupazione e consegnerà alle Nazione Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata. Il Governo italiano prenderà quelle misure che potranno essere richieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano, per il controllo dei cambi coll'estero, delle relazioni commerciali e finanziarie coll'estero e per il regolamento del commercio e della produzione ed eseguirà qualsiasi istruzione emessa dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili materie.
24 - Non vi dovranno essere relazioni finanziarie, commerc iali o di altro carattere o trattative con o a favore di paesi in guerra con una delle Nazioni Unite o coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con autorizzazione del Comandante in Capo Alleato o di funzionari designati.
25 - (A) Le relazioni con i paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno interrotte. I funzionari diplomatici, consolari ed altri funzionari italiani e i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree italiane accreditati o in missione presso qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unite saranno richiamati. I funzionari diplomatici, consolari di detti paesi saranno trattati secondo quanto potrà essere disposto dalle Nazioni Unite.
(B) Le Naz ioni Unite si riservano il diritto di richiedere il ritiro dei funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occupato ed a prescrivere ed a stabilire i regolamenti relat ivi alla procedura circa i metodi di comunicazione fra il Governo italiano e i suoi rappresentant i nei Paesi neutrali e riguardo alle comunicazioni inviate da o destinate ai rappresentanti dei paesi neutrali in territorio italiano.
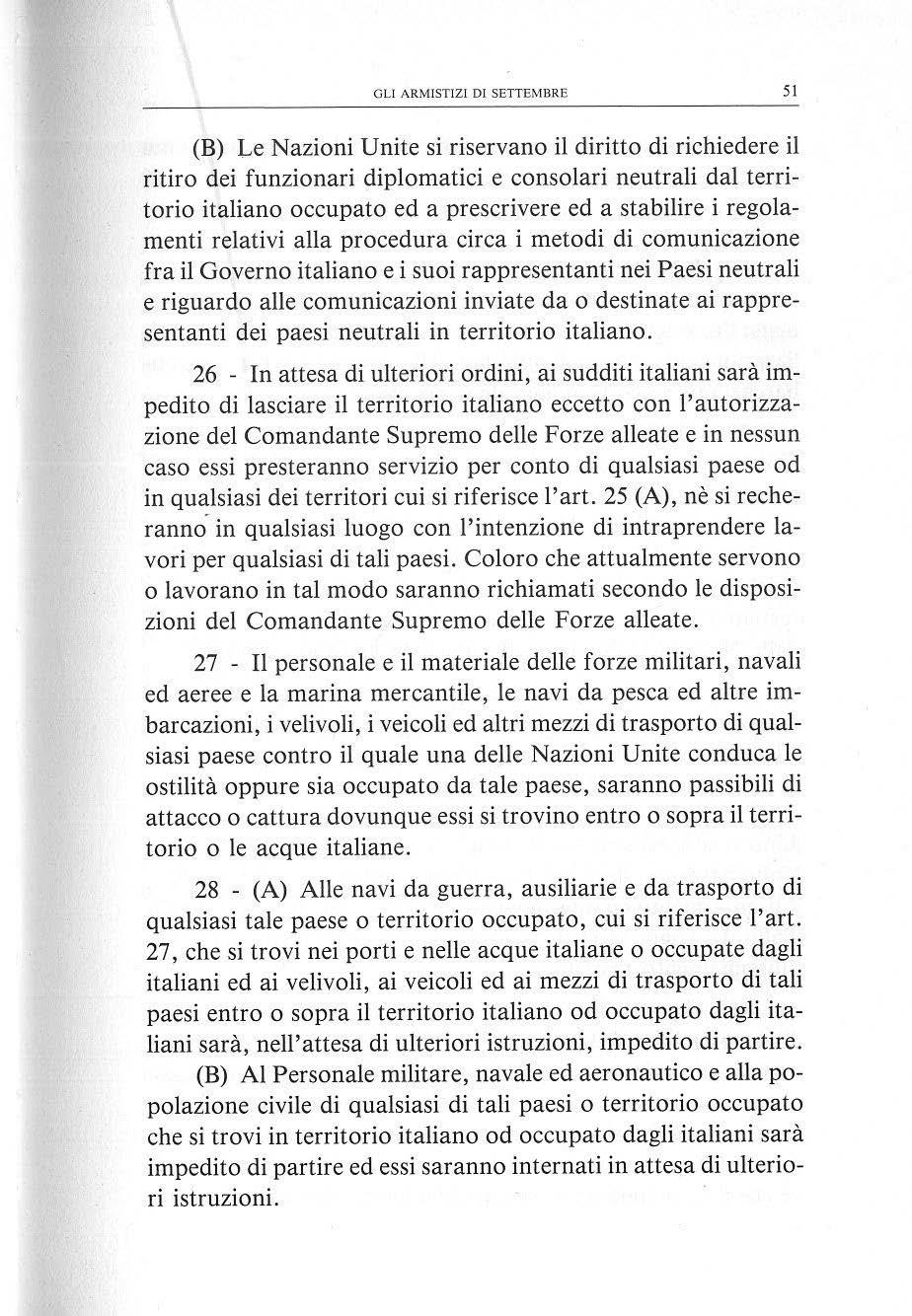
26 - In attesa di ulteriori ordini, ai sudditi italiani sarà impedito di lasciare il t erritorio italiano eccet to con l ' autori zzazione del Comandante Supremo delle Forze alleate e in nessun caso essi presteranno servizio per con t o di qual s iasi paese od in qualsiasi dei t erritori cui si riferisce l'art. 25 (A), nè si recheranno· in qualsiasi luogo con l'intenzione di intraprendere lavori per qualsiasi di tali paes i. Coloro che attualmente servono o lavorano in tal modo saranno richiamati secondo le disposizioni del Comandan t e Supremo delle Forze alleate.
27 - Il personale e il materiale delle forze militari, navali ed aeree e la marina mercantile, le navi da pesca ed altre imbarcazioni, i velivoli, i veicoli ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni Unite conduca le ostilità oppure sia occupato da tale paese, saranno passibili di attacco o cattura dovunque essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane.
28 - (A) Alle navi da guerra, ausiliarie e da trasporto di qualsiasi tale paese o territorio occupato, cui si riferisce l'art.
27, che si trovi nei porti e nelle acque italiane o occupate dagli italiani ed ai velivoli, ai veicoli ed ai mezzi di trasporto di tali paesi entro o sopra il territorio italiano od occupato dagli italiani sarà, nell'attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.
(B) Al Personale militare, navale ed aeronautico e alla popolazione civile di qualsiasi di tali paesi o territorio occupato che si trovi in territorio italiano od occupato dagli italiani sarà impedito di partire ed essi saranno internati in attesa di ulteriori istruzioni.
(C) Qualsiasi proprietà in territorio italiano appartenente a qualsiasi tale paese o territorio occupato o ai suoi nazionali sarà sequestrata e tenuta in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.
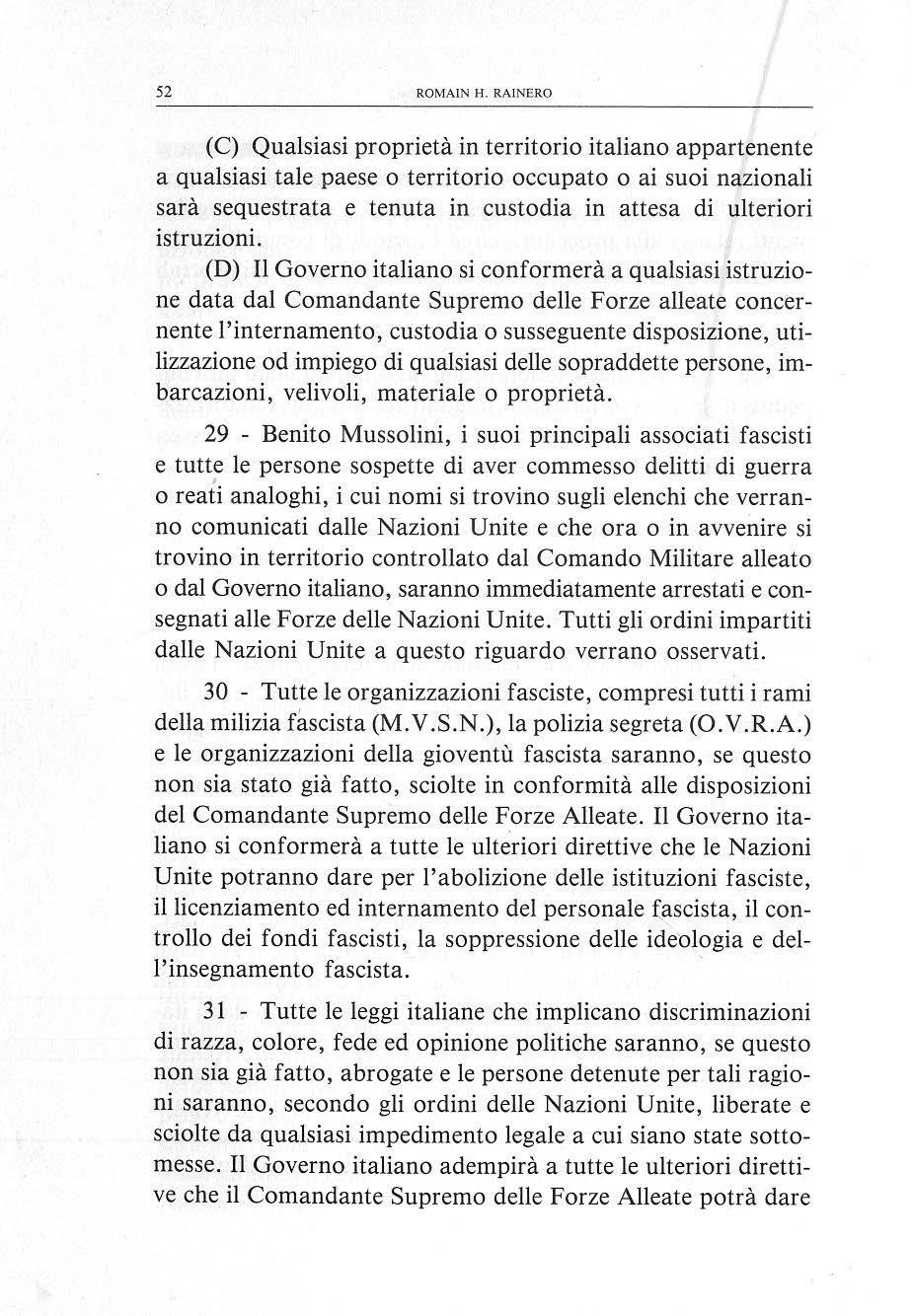
(D) Il Governo italiano si conformerà a qualsiasi istruzione data dal Comandante Supremo delle Forze alleate concernente l'internamento, custodia o susseguente disposizione, utilizzazione od impiego di qualsiasi delle sopraddette persone, imbarcazioni, velivoli, materiale o proprietà.
29 - Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando Militare alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verrano osservati.
30 - Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della milizia fascista (M.V.S.N.), la polizia segreta (0.V.R.A.) e le organizzazioni della gioventù fascista saranno, se questo non sia stato già fatto, sciolte in conformità alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione delle ideologia e del1'insegnamento fascista.
31 - Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede ed opinione politiche saranno, se questo non sia già fatto, abrogate e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà dare
per l'abrogazione della legislazione fascista e l'eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.
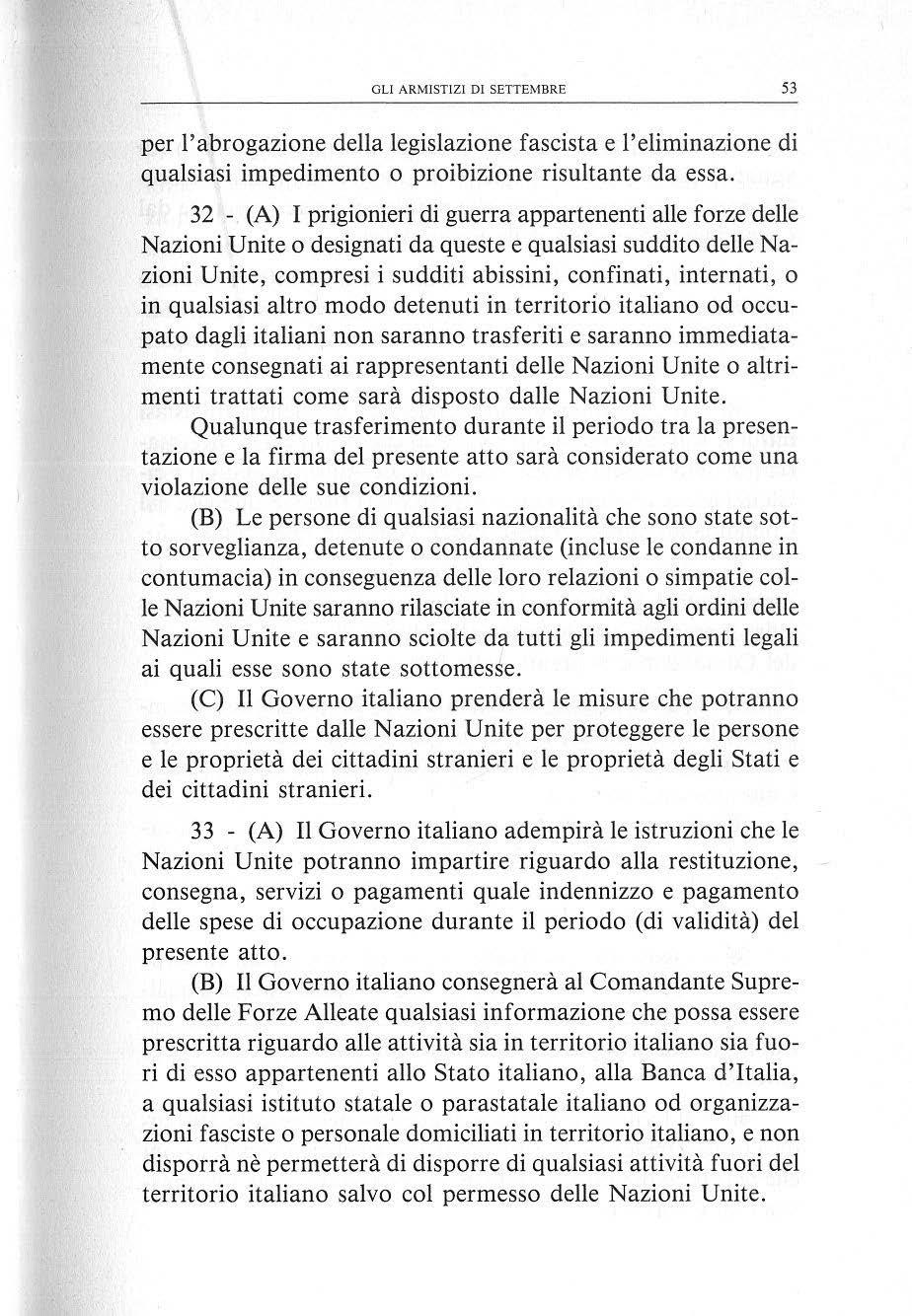
32 - (A) I prigionieri di guerra appartenenti alle forze delle Nazioni Unite o designati da queste e qualsiasi suddito delle Nazioni Unite, compresi i sudditi abissini, confinati, internati, o in qualsiasi altro modo detenuti in territorio italiano od occupato dagli italiani non saranno trasferiti e saranno immediatamente consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come sarà disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo tra la presentazione e la firma del presente atto sarà considerato come una violazione delle sue condizioni.
(B) Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia) in conseguenza delle loro relazioni o simpatie colle Nazioni Unite saranno rilasciate in conformità agli ordini delle Nazioni Unite e saranno sciolte da tutti gli impedimenti legali ai quali esse sono state sottomesse.
(C) Il Governo italiano prenderà le misure che potranno essere prescritte dalle Nazioni Unite per proteggere le persone e le proprietà dei cittadini stranieri e le proprietà degli Stati e dei cittadini stranieri.
33 - (A) Il Governo italiano adempirà le istruzioni che le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla restituzione, consegna, servizi o pagamenti quale indennizzo e pagamento delle spese di occupazione durante il periodo (di validità) del presente atto.
(B) Il Governo ita liano consegnerà al Comandante Supremo delle Forze Alleate qualsiasi informazione che possa essere prescritta riguardo alle attività sia in territorio italiano sia fuori di esso appartenenti allo Stato italiano, alla Banca d'Italia, a qualsiasi istituto statale o parastatale italiano od organizzazioni fasciste o personale domiciliati in territorio italiano, e non disporrà nè permetterà di disporre di qualsiasi attività fuori del territorio italiano salvo col permesso delle Nazioni Unite.
34 - Il Go vern o italiano eseguirà duran te di perio d o (di validit à) del presen t e atto qu elle mi sure di armame n to, smo bilita zione e smilitarizzazione che potranno esser e prescritte dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.
35 - Il Go ve rno itali a no forni rà t utte le informa zio ni e provv ed erà tutti i documenti occorrenti alle Na zioni U nite. Sarà proibito di st ru ggere o nascondere archivi, verbali, progetti o qual siasi altro documento od informazione.
36 - Il Gov erno italiano prend erà ed appliche rà qualsiasi misura , legislativa o di altro genere, che possa esser e necessaria per l'esecuzione del presente a tto. Le Autorità militar i e civili italia ne si conformeranno a qual sias i istru zio ne emanata dal Comandante Supremo delle Forze Alleate a tale scopo.
37 - Verr à nominata una Commi ssi one di Controllo che rappre se nterà le Nazi oni Unite, incaricata di regolar e e d eseguire il presente atto in base ag li ordini e alle direttive generali del Comandante Suprem o delle Forze Alleate.
38 - (A) Il termine «Nazioni Unite» nel presente atto comprende il Comandante Supre mo d elle Forze Alleate, la Commissione di Controllo e qualsiasi altra au torità che le Nazioni Unite poss ano nominare.
(B) Il termin e « Comandante Supremo d elle For ze Alleate» nel presente atto comprende la Commissione di Controllo e quegli altr i uffi cia li e rappresenta n ti che il Comandante Supremo delle For ze Alleate potrà nominare.
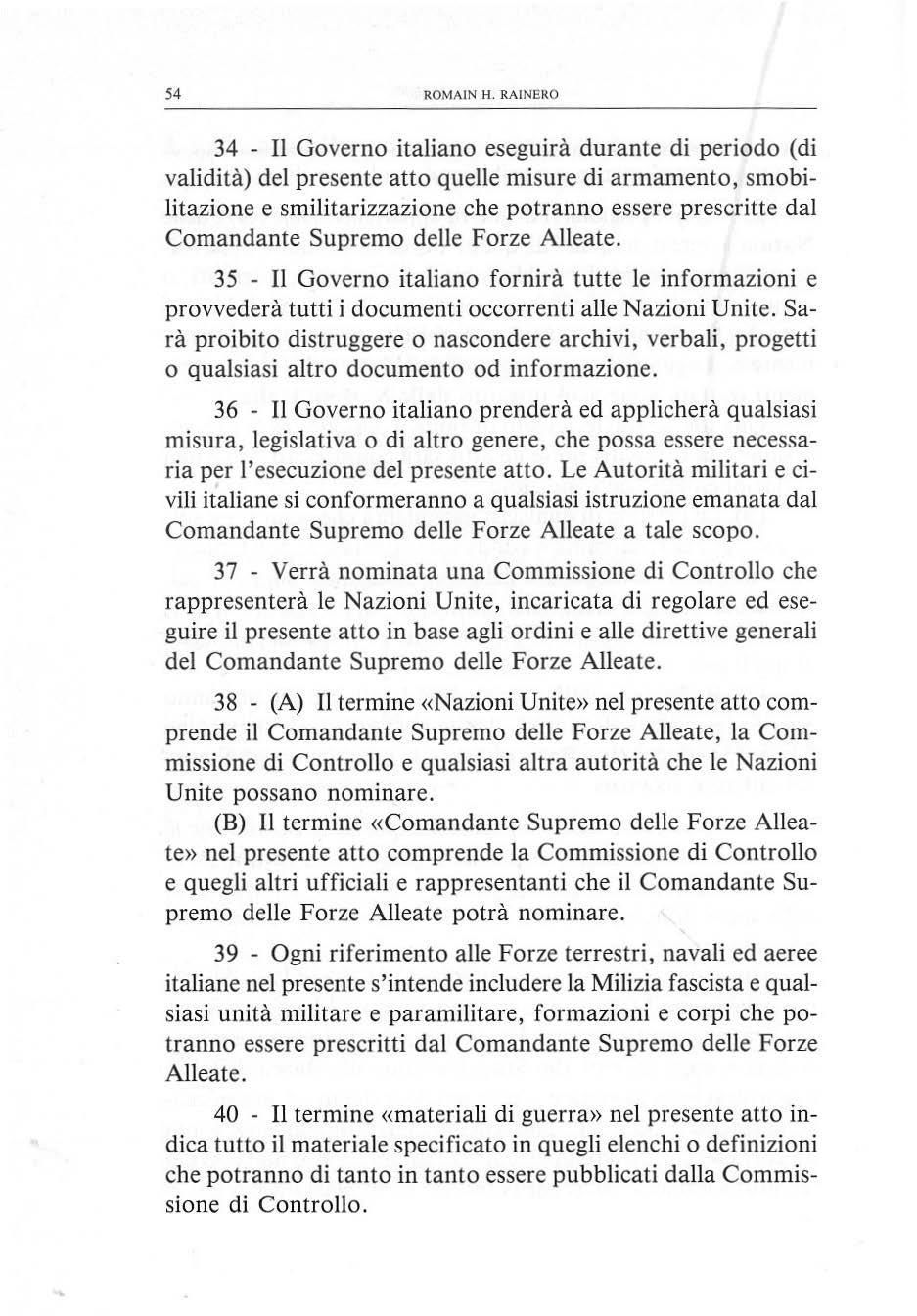
39 - Ogni ri feri men to a lle For ze terrestri, naval i ed aeree it aliane nel pres ente s' intend e includere la Mili zia fascista e qualsiasi unità militare e paramilitare, formazioni e corpi che potranno essere pr escritt i dal Comandante Supremo dell e Forze Alleate
40 - Il termine «materiali di guerra>> nel presente atto indica tutto il mat er ia le specificato in quegli elenc hi o de finizio ni c he potranno di tanto in ta n to essere pubb licati dalla Comm issione di Controllo.
41 - Il termine «territorio italiano» comprende tutte le colonie e possedimenti italiani e ai fini del presente atto (ma senza pregiudizio alla questione della sovranità) sarà considerato includere l'Albania. Resta tuttavia stabilito che, eccetto nei casi e nella misura prescritta dalle Nazioni Unite, i provvedimenti del presente atto non saranno applicati nè riguarderanno l'ammministrazione di qualsiasi colonia o possedimento italiano già occupato dalle Nazioni Unite, o diritti o poteri colà posseduto o esercitati da esse.
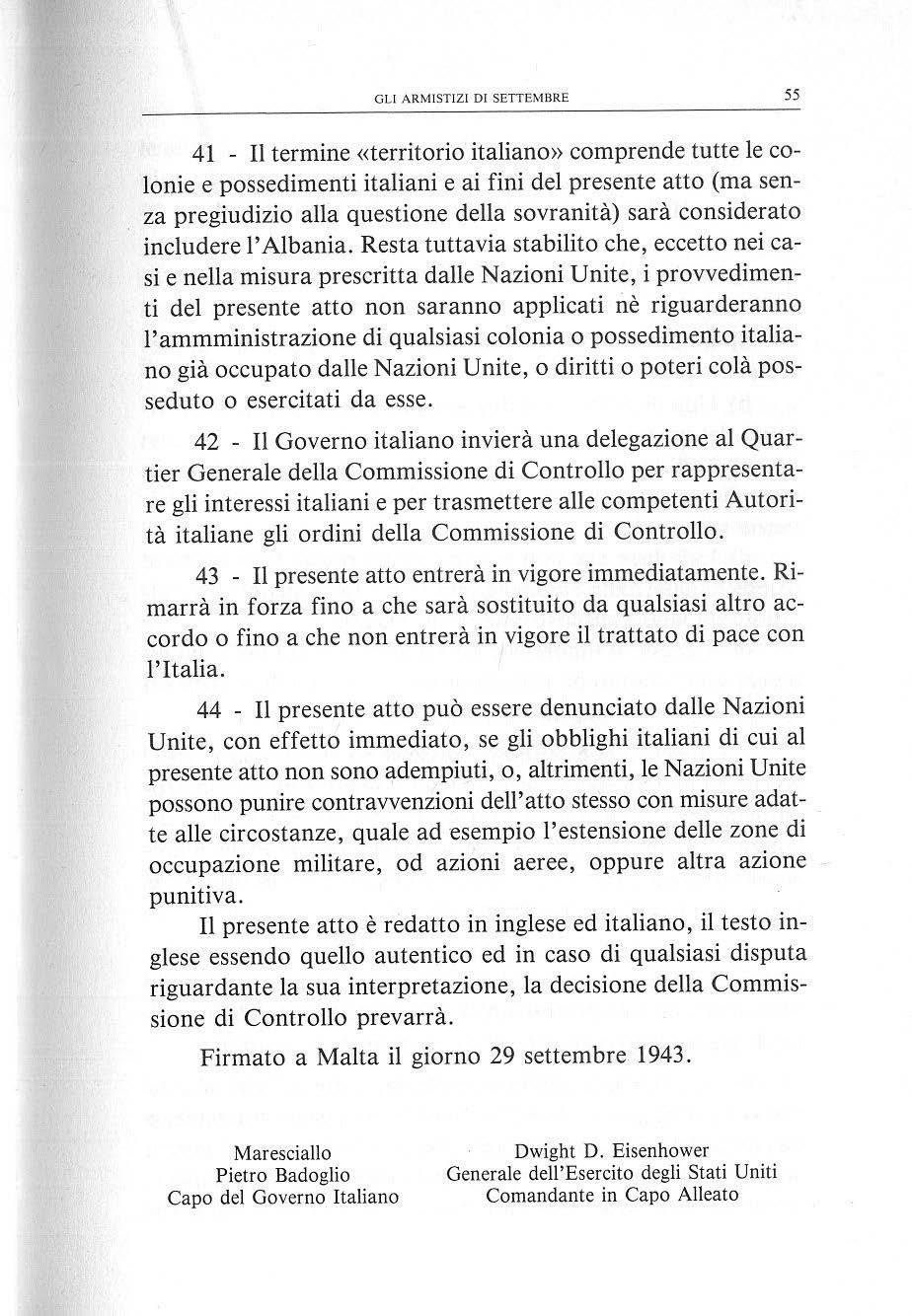
42 - Il Governo italiano invierà una delegazione al Quartier Generale della Commissione di Controllo per rappresentare gli interessi italiani e per trasmettere alle competenti Autorità italiane gli ordini della Commissione di Controllo.
43 - Il presente atto entrerà in vigore immediatamente. Rimarrà in forza fino a che sarà sostituito da qualsiasi altro accordo o fino a che non entrerà in vigore il trattato di pace con l'Italia.
44 - Il presente atto può essere denunciato dalle Nazioni Unite, con effetto immediato, se gli obblighi italiani di cui al presente atto non sono adempiuti , o, altrimenti , le Nazio ni Unite possono punire contravvenzioni dell'atto stesso con misure adatte alle circostanze, quale ad esempio l'estensione delle zone di occupazione militare, od azioni aeree, oppure altra azione punitiva.
Il presente atto è redatto in inglese ed italiano, il testo inglese essendo quello autentico ed in caso di qualsiasi disputa riguardant e la sua int erpretazione, la decisione della Commissione di Controllo prevarrà.
F irmato a Malta il giorno 29 settembre 1943.
Maresciallo
Pietro Badoglio
Capo d el Governo Itali ano
Dwight D. EisenhowerGenera le dell'Esercito degli Stati Uniti Comandante in Capo Alleato
Il maresciallo Badoglio aprì la conve r sazione con una dichiarazione su alcuni pun ti che diss e di avere in mente:
a) Il su o desiderio di veder formato un governo rappresentativo a base liberale.
b) Una dichiarazione di guerra cont ro la Germania al ritorno del governo a Roma.
c) Nell'intervallo, sottolineò, gli italiani erano de facto in sta to di guerra e combattenti contro i tedesc hi in Corsica, Dalmazia ecc.
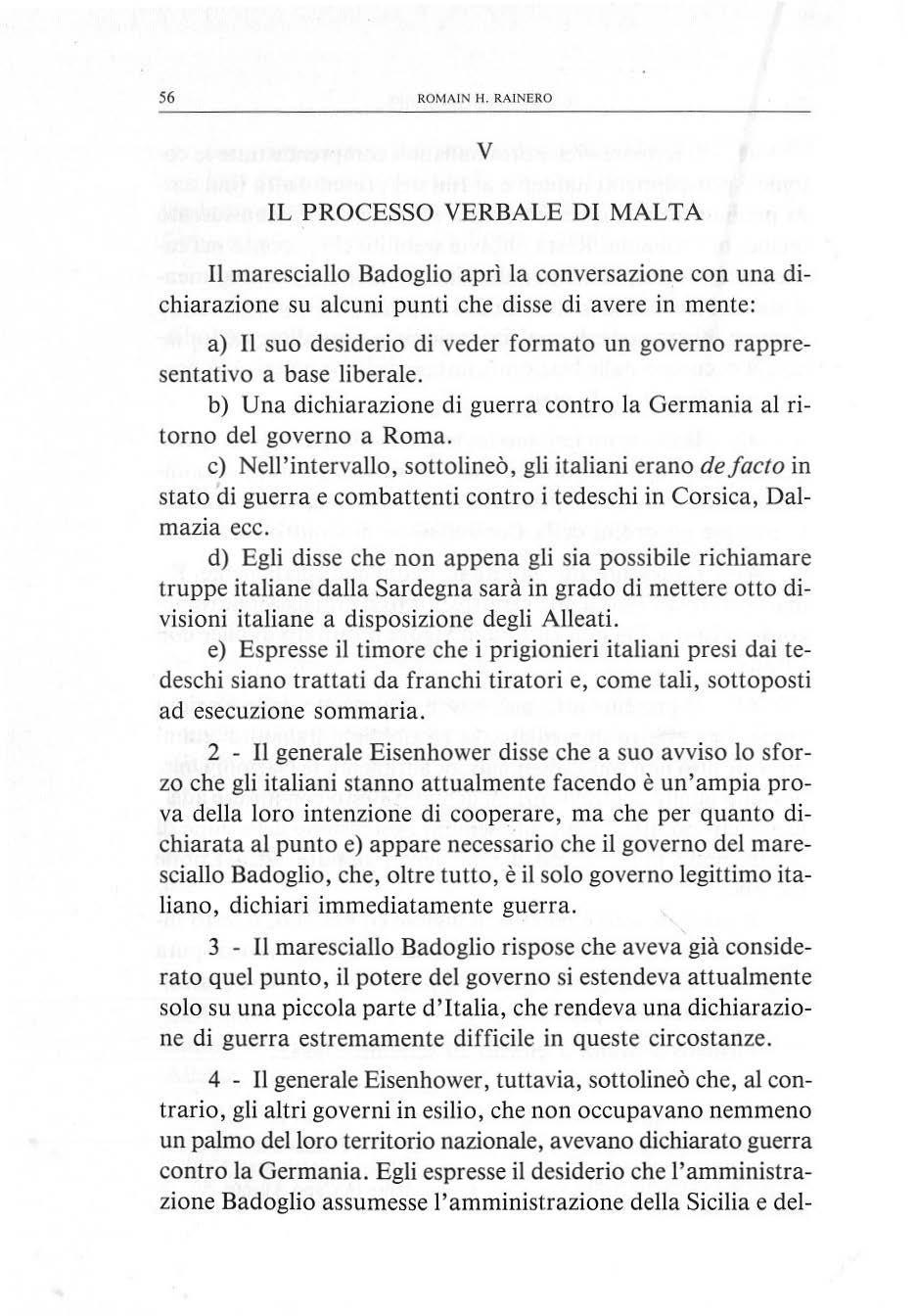
d) Egli disse che non appena gli sia pos sibile richiamare truppe italiane dalla Sardegna sarà in grado di mettere otto divisioni italiane a disposizione degli Alleati.
e) Espresse il timore che i prigionieri italiani presi dai tedeschi siano trattati da franchi tiratori e, come tali, sottopost i ad esecu zio ne sommaria.
2 - Il generale Eisenhower disse che a suo avviso lo sforzo che gli italiani stanno attualmente facendo è un'ampia prova della loro inten zione di cooperare, ma che per quanto dichiarata al punto e) appare necessario che il governo del maresciallo Badoglio, che, oltre t u tto, è il solo governo legittimo italiano, dichiari immediatamente guerra.
3 - Il mare sciallo Badog lio rispose che aveva già considerato qu el punto, il potere del governo s i estendeva attualmente solo su una piccola parte d'Italia, che rendeva una dichiarazione di guerra estremamente difficile in queste circostanze.
4 - Il generale Eisenhower, tuttavia, sottolineò che, al contrario, gli altri governi in esilio, che non occupavano nemmeno un palmo del loro te rritorio nazionale, avevano dichiarato guerra co ntro la Germania. Egli espresse il desiderio che l ' ammini strazi one Badoglio assumesse l'amministrazione della Sicilia e del-
le altre aree liberate, ma non gli era chiaro come si potesse venire ad una tale soluzione senza che si facesse una dichiarazione di guerra.
5 - Il maresciallo Badoglio promise di riferire questa questione al re il quale, disse, deve decidere in ogni caso. Per la legge italiana solo il re può dichiarare guerra. Badoglio disse perciò che si riservava la risposta sino a che potesse consultare · il re.
6 - Il generale Eisenhower dichiarò che tutto quanto il maresciallo Badoglio fa per condurre attivamente la guerra contro i tedeschi accrescerà molto per questo la stima delle Nazioni Unite verso il suo governo. Egli evidenziò che per tre anni l'Italia era stata nemica delle Nazioni Unite e che si era formata una psicologia di massa contraria ad accettare gli italiani nel campo alleato. Perciò, disse il generale Eisenhower, è dovere del maresciallo Badoglio fare oggi così al più presto possibile. Egli domandò se il maresciallo consiglierebbe il re in questo senso .
7 - Il maresciallo Badoglio rispose che comprendeva il punto di vista del generale Eisenhower e lo rappresenterebbe esattamente al re così come l'aveva espresso perchè il suo punto di vista corrispondeva a quello çlel generale Eisenhower.
8 - Il generale Eisenhower chiese se il maresciallo Badoglio si propone di cercare gli antifascisti e di invitarli a partecipare al governo.
9 - Il maresciallo Badoglio rispose che la scelta dei membri del governo sarà fatta dal re - egli stesso è soltanto un soldato, disse, e sa pochissimo di politica.
10 - Il generale Eisenhower espresse la sua simpatia come soldato ma disse che il governo italiano deve assumere un aspetto antifascista se combatte con gli Alleati.
11 - Nella lettera che gli darà, il generale Eisenhower lo dichiarerà, ma il fascismo è una delle cose che stiamo combattendo che noi riguardiamo con mortale durezza.
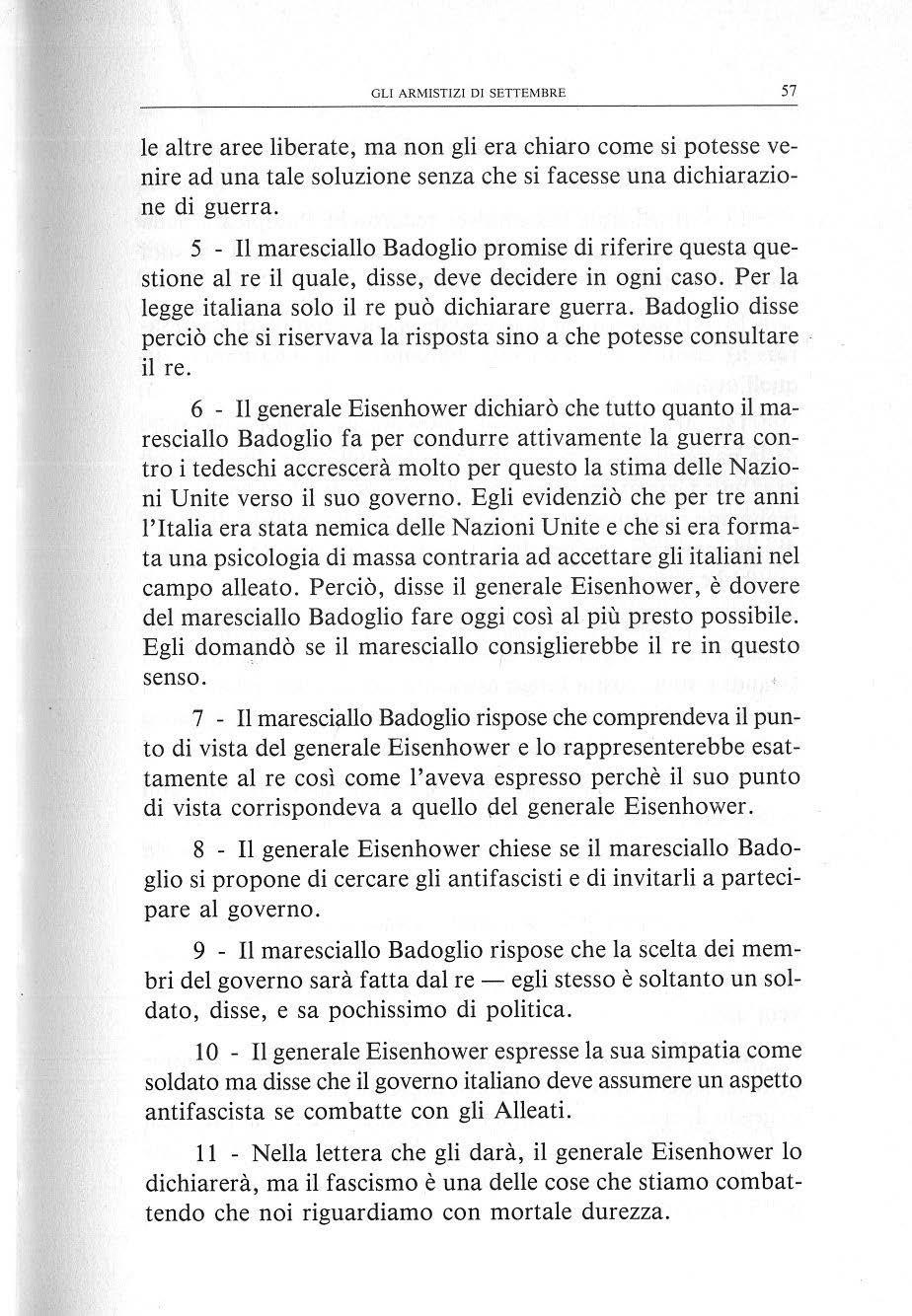
12 - Il maresciallo Badoglio indicò che comprendeva tutto ciò.
13 - Il generale Eisenhower reiterò che l'ampiezza della cooperazione con gli italiani che gli sarebbe permessa dai suoi governi dipenderà da questo punto.
14 - Il maresciallo Badoglio disse che il combattimento sarà: a) contro il fascismo; b) contro la Germania, in quell'ordine.
15 - Il maresciallo Badoglio lesse una lettera del re che chiede la partecipazione del conte Dino Grandi e che dichiara che in effetti Grandi fece l'attacco iniziale con t ro Mussolini ed è realmente responsabile della sua caduta. La presenza di Grandi nel governo rovinerebbe lo status del governo fascista repubblicano.
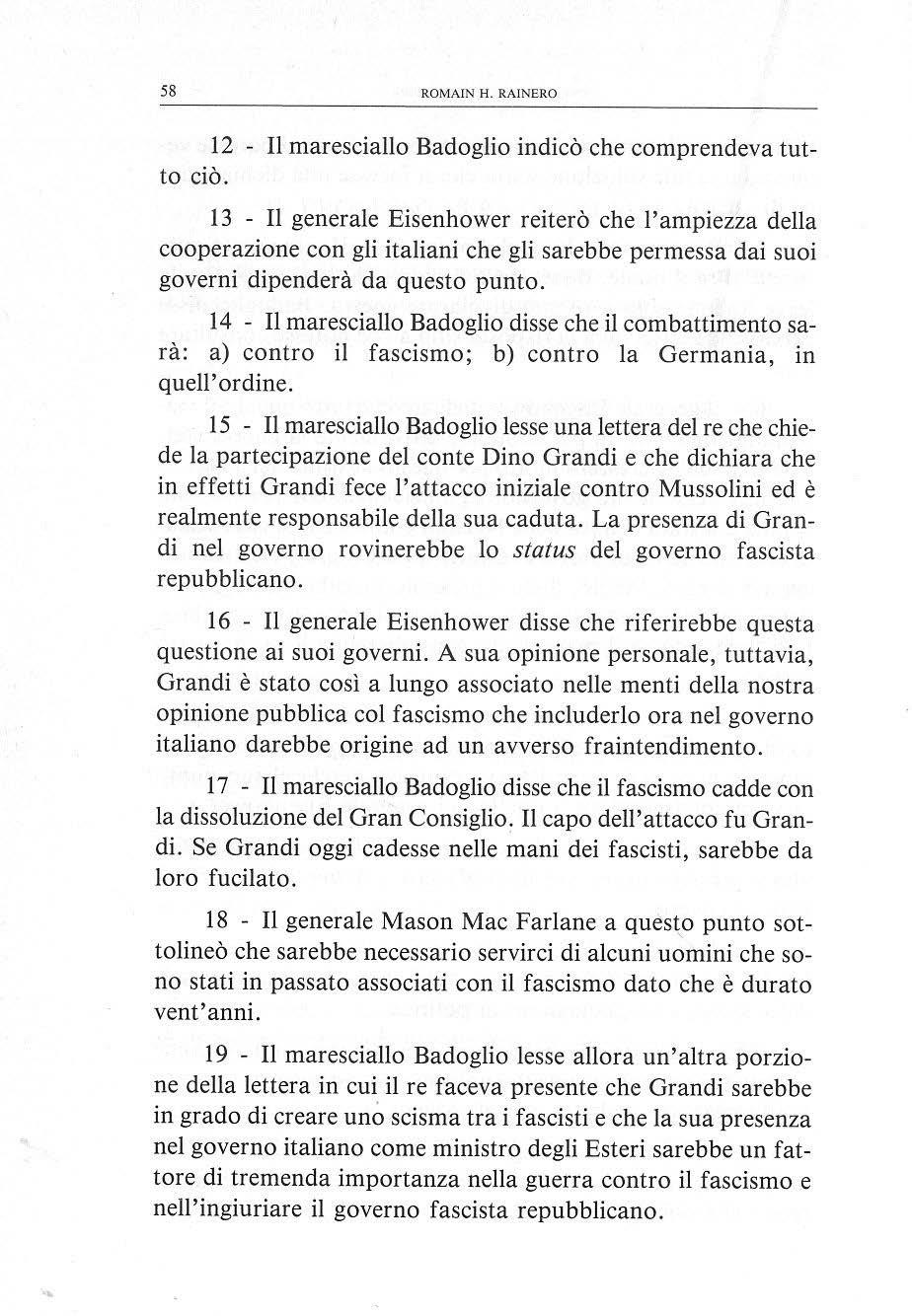
16 - Il generale Eisenhower disse che riferirebbe questa questione ai suoi governi. A sua opinione personale, tuttavia, Grandi è stato così a lungo associato nelle menti della nostra opinione pubblica col fascismo che includerlo ora nel governo italiano darebbe origine ad un avverso fraintendimento.
17 - Il maresciallo Badoglio disse che il fascismo cadde con la dissoluzione del Gran Consiglio. Il capo dell'attacco fu Grandi. Se Grandi oggi cadesse nelle mani dei fascisti, sarebbe da loro fucilato.
18 - Il generale Mason Mac Parlane a questo punto sottolineò che sarebbe necessario servirci di alcuni uomini che sono stati in passato associati con il fascismo dato che è durato vent'anni .
19 - Il maresciallo Badoglio lesse allora un'altra porzione della lettera in cui il re faceva presente che Grandi sarebbe in grado di creare uno scisma tra i fascisti e che la sua presenza nel governo italiano come ministro degli Esteri sarebbe un fattore di tremenda impo rtanza nella guerra contro il fascismo e nell'ingiuriare il governo fascista repubb li cano .
20 - Il generale Eisenhower ribattè che da soldato comprendeva tutto ciò, ma non poteva non vedere il fatto che l'opinione pubblica dei paesi alleati si era cristallizzata su questo soggetto e, come aveva detta prima, gli era necessario consultare i suoi governi su una mat eria di questa importanza.
21 - Il maresciallo Badoglio disse allora che il re si proponeva d'invitare i cap i dei diversi partiti - cioè i partiti politici - così come si sono ora costituiti in Italia, con speciale riferimento a quelli che hanno la maggiore influenza sul popolo. A suo giudizio il re ha oggi la miglior conoscenza di uomini validi in Italia. Il re vorrebbe nominare questi uomini, disse il maresciallo Badoglio, perchè mentre il maresciallo è competente a scegliere generali, non è in grado di sceglier e politici. Egli assicurò il generale Eisen hower che darebbe al governo un carattere liberale. Se scopre che un qualche ministro non segue la linea politica stabilita, si sentirà obbligat o a dimettersi.
22 - Il generale Eisenhower disse che riferirebbe la questione ai suoi governi. Il presidente e il primo ministro hanno preparato una lista di cose che sono necessarie per la collaborazione. Egli disse che sarebbe consigliabile che, se il re immetteva nuovi elementi nel suo governo, sottoponesse ufficiosamente a priori il loro nome tramite la missione del generale Mason Mac Parlane e che questa specie di cooperazione faciliterebbe le cose.
23 - Il generale Eisenhower spiegò poi che non desiderava interferire negli affari interni italiani, ma non poteva non tener conto dell'opinione pubblica alleata.
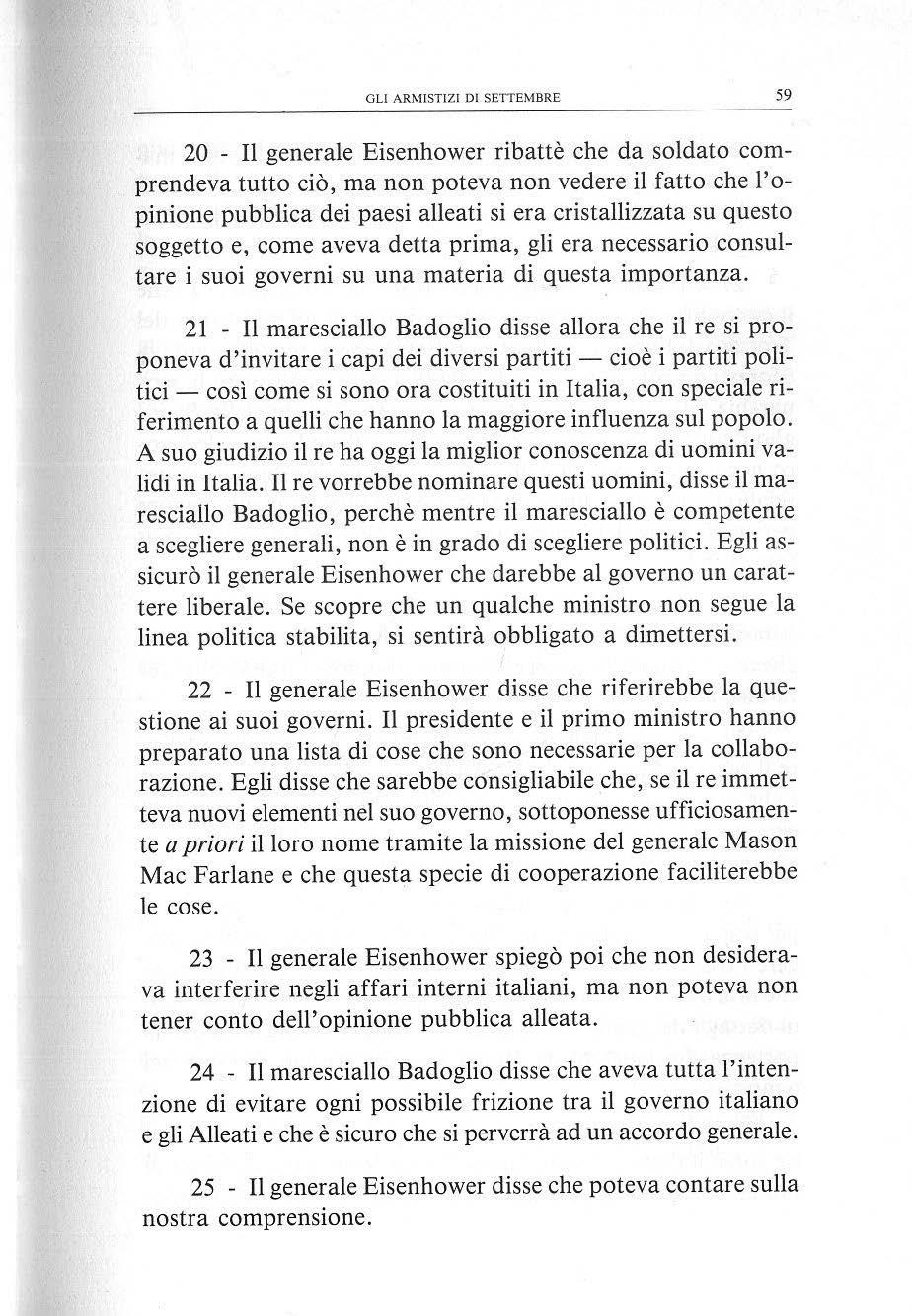
24 - Il maresciallo Badoglio disse che aveva tutta l'intenzione di evitare ogni possibile frizione tra il governo italiano e gli Alleati e che è sicuro che si perverrà ad un accordo generale.
25 - Il generale Eisenhower disse che poteva contare sulla nostra comprensione.
26 - A questo punto il generale Eisenho wer informò il maresciallo Badoglio del messaggio di Washington riguardante il desiderio americano che il conte Sforza visiti Brindisi nel prossi mo futuro .
27 - Il maresciallo Badoglio disse che egli conosceva bene il conte Sforza e ricordò di essere stato con lui alla firma del Trattato di Rapallo . Egli disse, tuttavia, che il re non guardava Sforza con simpatia a causa della dichiarazione co ntro la monarchia fatt a da Sforza qualche tempo fa. Il maresciallo Badoglio riconosceva, disse, che Sforza sta svolgendo un util e lavoro negli Stati Uniti ed egli l'apprezzava pienamente. Il maresciallo Badoglio dichiarò che farebbe un ult eriore tentativo per persuadere il re dell'opportunità di permettere a Sforza di visitare Brindisi.
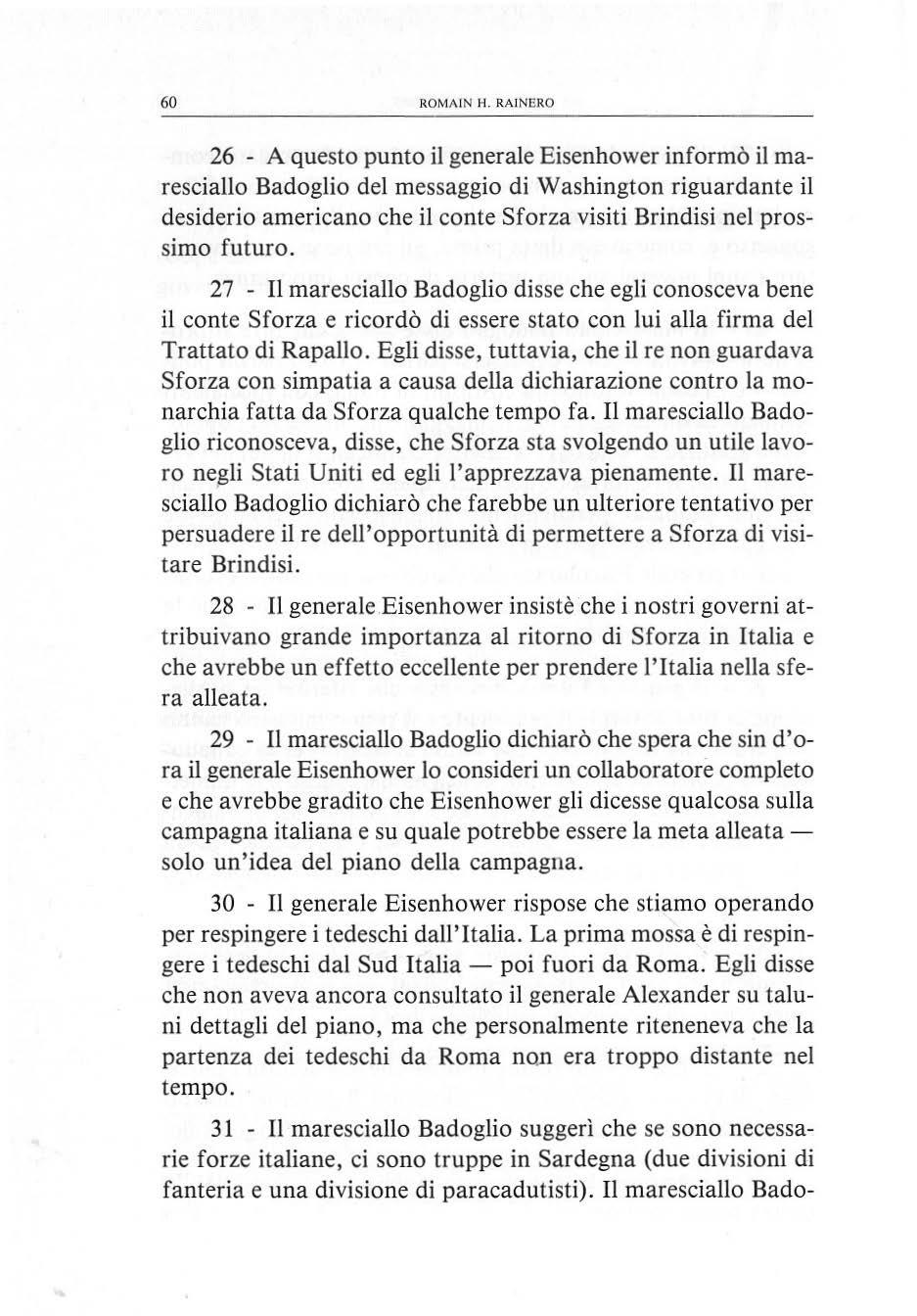
28 - Il generale Eisenhower insistè che i nostri governi attribuivano grande importanza al ritorno di Sforza in Italia e che avrebbe un effetto eccellente per prendere l'Italia nella sfera alleata.
29 - Il maresciallo Badoglio dichiarò che spera ch e sin d'ora il generale Eisenhower lo consider i un coll aboratore completo e che avrebbe gradito che Eisenhower gli dicesse qualcosa su lla campagna italiana e su quale potrebbe essere la meta alleatasolo un'idea del piano della campagna .
30 - Il generale Eisenhower ri spose che stia mo operando per re spingere i tedeschi dall'Italia. La prima mossa è di respingere i tedeschi dal Sud Italia - poi fuori da Roma. Egli disse che non aveva ancora consultato il generale Alexander su taluni dettagli del piano, ma che personalmente riteneneva che la partenza dei tedeschi da Roma n o.n era troppo distante nel tempo.
31 - Il maresciallo Badoglio suggerì che se sono n ecessarie forze italiane, ci sono truppe in Sardegna (due divisioni di fanteria e una divisione di paracadutisti) . Il maresciallo Bado-
glio spera che si permetta ad alcune truppe italiane di partecipare all'ingresso in Roma. Il generale Alexander disse che i piani completi della campagna d'Italia erano stati preparati ma che la partecipazione di truppe italiane dipendeva dalla dichiarazione di guerra italiana.
32 - Il generale Eisenhower aggiunse che se l'Italia dichiara guerra e coopera con gli Alleati, egli personalmente prometteva che un impegno per la partecipazione di truppe italiane sarebbe approvato per l'entrata in Roma.
33 - Il maresciallo Badoglio disse che comprendeva perfettamente che quando i piani militari sono fatti è difficile cambiarli. In merito al suo suggerimento su ll'en trata delle truppe italiane in Roma, egli ha in mente: a) l'effetto che avrebbe sul governo fascista repubblicano nel nord; b) ed egli è certo che i tedeschi faranno a Roma ciò che hanno fatto a Napoli, cioè ruberie, saccheggi e uc cisioni. Egli sotto linea che Roma non è soltanto la capitale d'Italia, ma che c'è un'obbligazione particolare per cui spetta al governo italiano difendere la Città del Vaticano. per quel motivo Badoglio chiedeva che partecipino truppe italiane. Queste verrebbero dalla Sardegna a Fiumicino e sarebbero in un giorno a Roma - la divisione paracadutis ti Nembo.
34 - Il generale Eisenh.ower di sse che ad ogni modo il generale Alexander considererebbe l'impiego della divisione paracadutisti. Egli disse che aveva udito un mondo di bene intorno a quella divisione. Non c'era difficoltà su questo punto.
35 - Il maresciallo Badoglio disse che la resistenza tedesca a Salerno è dovuta a Kesselring che si appoggia per re~istere lungo tutta la linea (la dorsale appenninica). A suo giudizio, egli disse, e voi dovete scusarmi, gli Alleati danno spesso l'impressione di aiutare i piani di Kesserlring. Egli aggiunse che la linea Spezia-Rimini ha un punto debole, presso Rimini.
Il maresciallo Badoglio parlò della sua conoscenza dell'Italia che giustificava la sua sicurezza nell'offrire suggerimenti
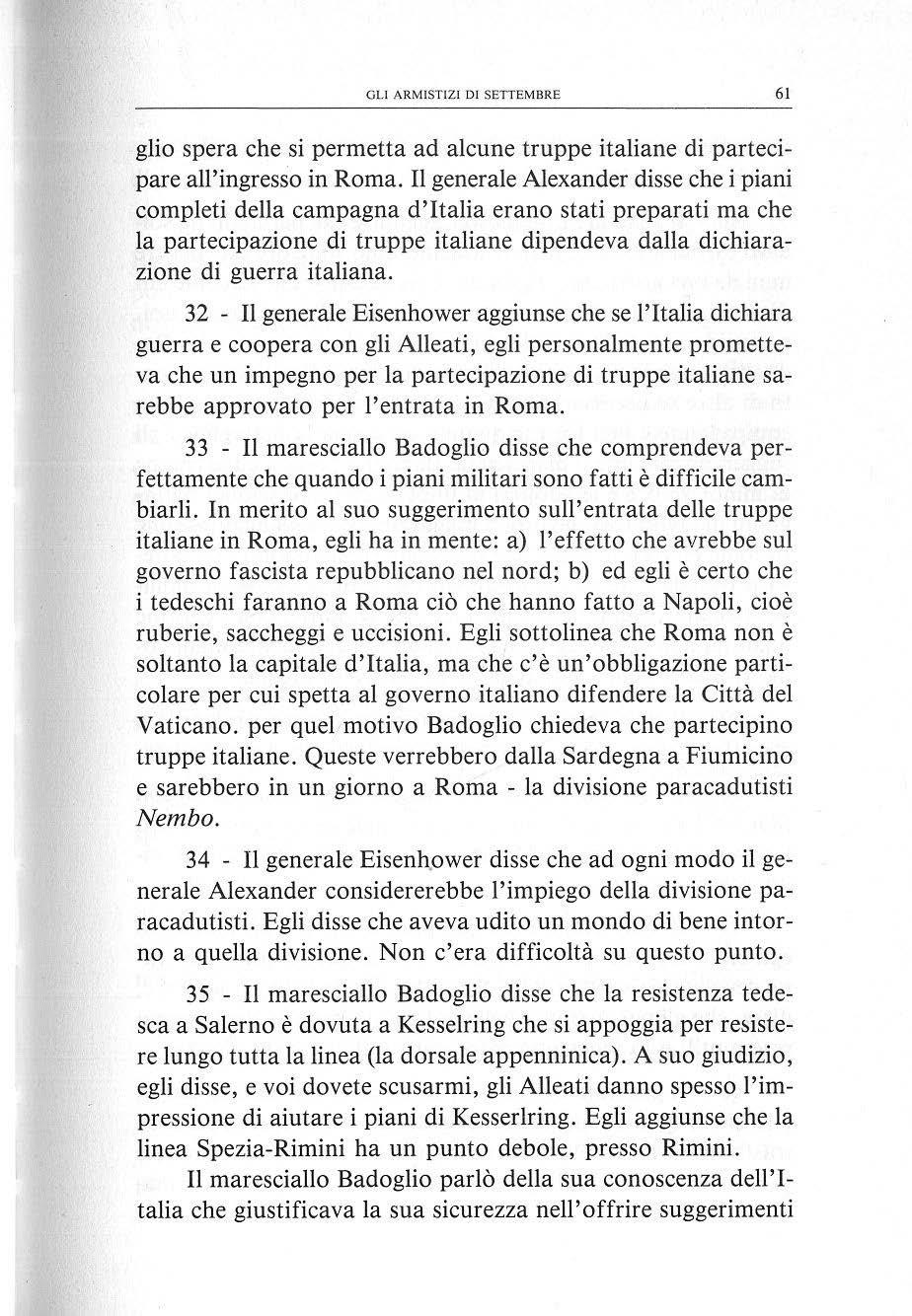
strategici e si scusò sorridendo del cara t terist ico amore dei vecchi di dar consiglio ai giovani.
36 - Il generale Eisenhower aggiunse che parlando da soldato è evidente che le truppe italiane sono state provate per tre anni da una guerra scoraggiante. Egli aggiunse che siccome andiamo su questa strada e le truppe italiane lavorano con noi, è considerato della più alta importanza che il maresciallo Badoglio scelga le divisioni migliori e concentri l'equipaggiamento di altre se neces sario cosicchè queste divisioni saranno ben equipaggiate e ben fornite quando comincia la battaglia. Egli suggerì ancora che il maresciallo Badoglio prenda altre truppe di minor valore e le adoperi in linee di comunicazione, battaglioni di lavoratori, lavoro ai magazzini ecc. Egli aggiunse che siccome gli eserciti delle Nazioni Unite si espandono non poteva provvedere all'equipaggiamento di tutte le divisioni italiane. Noi aiuteremmo, ovviamente, egli aggiunse, con l'enorme quantità dell'equipaggiamento italiano ora in nostre mani come risultato delle campagne di Tunisia e di Sicilia.
37 - Il maresciallo Badoglio rispose che era d'accordo e che eff~ttivamente sta già procedendo nell ' azione raccomandata.
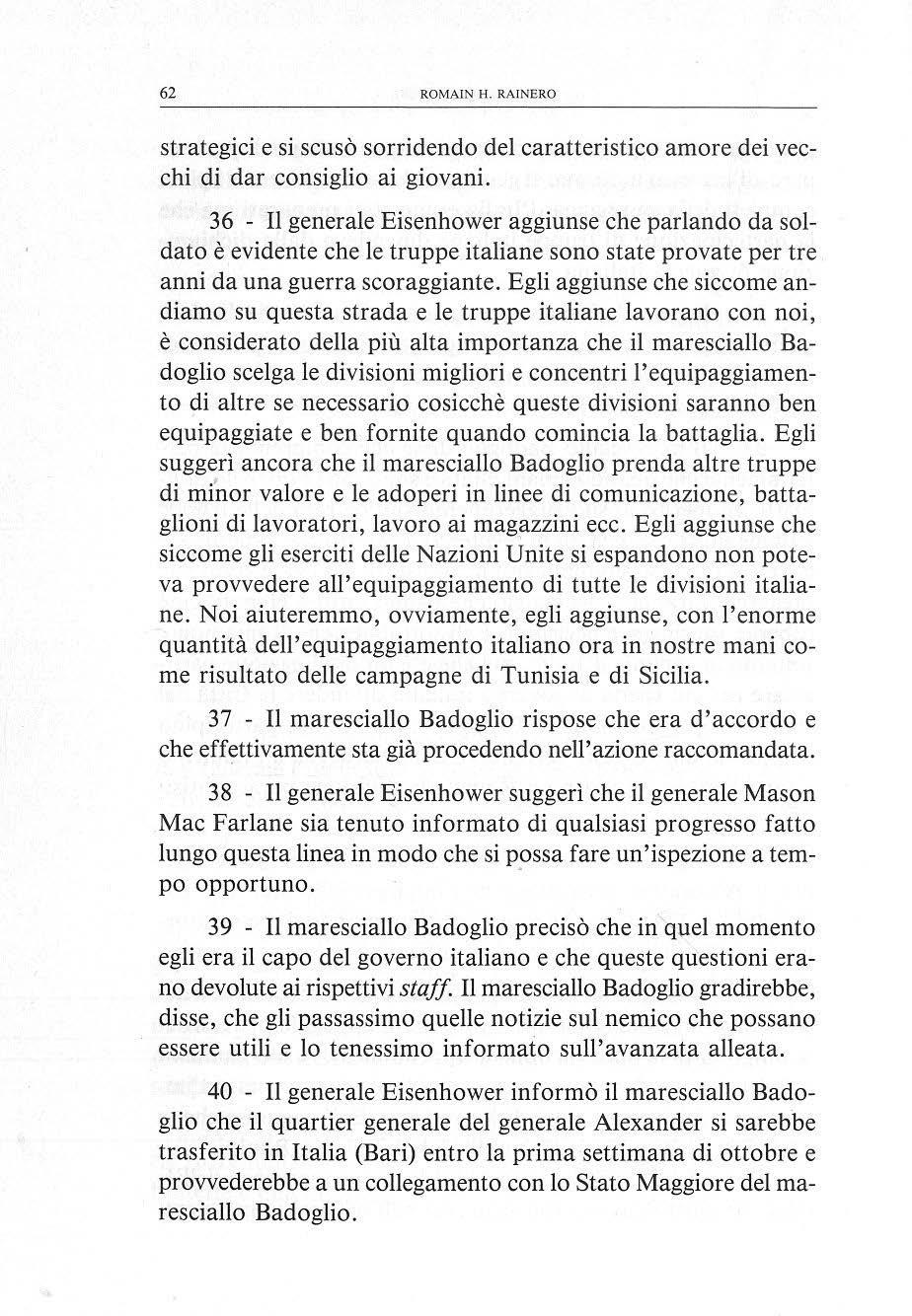
38 - Il generale Eisenhower suggerì che il generale Mason Mac Farlane sia tenuto informato di qualsiasi progresso fatto lungo questa linea in modo che si P!)SSa fare un'ispezione a tempo opportuno.
39 - Il maresciallo Badoglio precisò che in q:µel momento egli era il capo del governo italiano e che qu este questioni erano devolute ai rispettivi staff Il maresciallo Badoglio gradirebbe, disse, che gli passassimo quelle notizie sul nemico che possano essere utili e lo tenessimo informato sull'avanzata alleata.
40 - Il generale Eisenhower informò il maresciallo Badoglio che il quartier generale del generale Alexander si sarebbe trasfer ito in Italia (Bari) entro la prima settimana di ottobre e provvederebbe a un collegamento con lo Stato Maggiore del maresciallo Badoglio.
41 - Il' maresciallo Badoglio disse che sarebbe felicissimo di fornire al generale Alexander le installazioni necessarie.
42 - Il generale Alexander promise di fornire al maresciallo Badoglio le notizie che si potranno dare sul nemico e disse che potrebbe dargli i più ampi ragguagli sulla posizione delle unità nemiche ora in Italia.
43 - Il generale Eisenhower disse che darebbe una direttiva al suo staff perchè la sola pubblicità sull'incontro di oggi sia limitata alla discussione di dettagli sulle operazioni militari contro la Germania e che non si faccia alcun accenno alla firma di documenti. Il generale Eisenhower chiese al maresciallo Badoglio di adottare una identica procedura.
44 - Il maresciallo Badoglio si dichiarò d'accordo.
45 - Il generale Eisenhower aggiunse la richiesta che il maresciallo Badoglio cerchi di galvanizzare l'azione militare italiana contro la Germania e di accelerare per tutto quanto è in suo potere una dichiarazione di guerra contro la Germania.
46 - Il maresciallo Badoglio sottolineò che una delle difficoltà maggiori sta nel campo della propaganda. Egli può disporre soltanto di radio Bari.
47 - Il generale Eisenhower chiese al maresciallo Badoglio di presentargli una lista delle sue necessità a questo riguardo e disse che gli Alleati faranno del loro meglio per cooperare col maresciallo, adoprando gli esperti validi in quel settore.
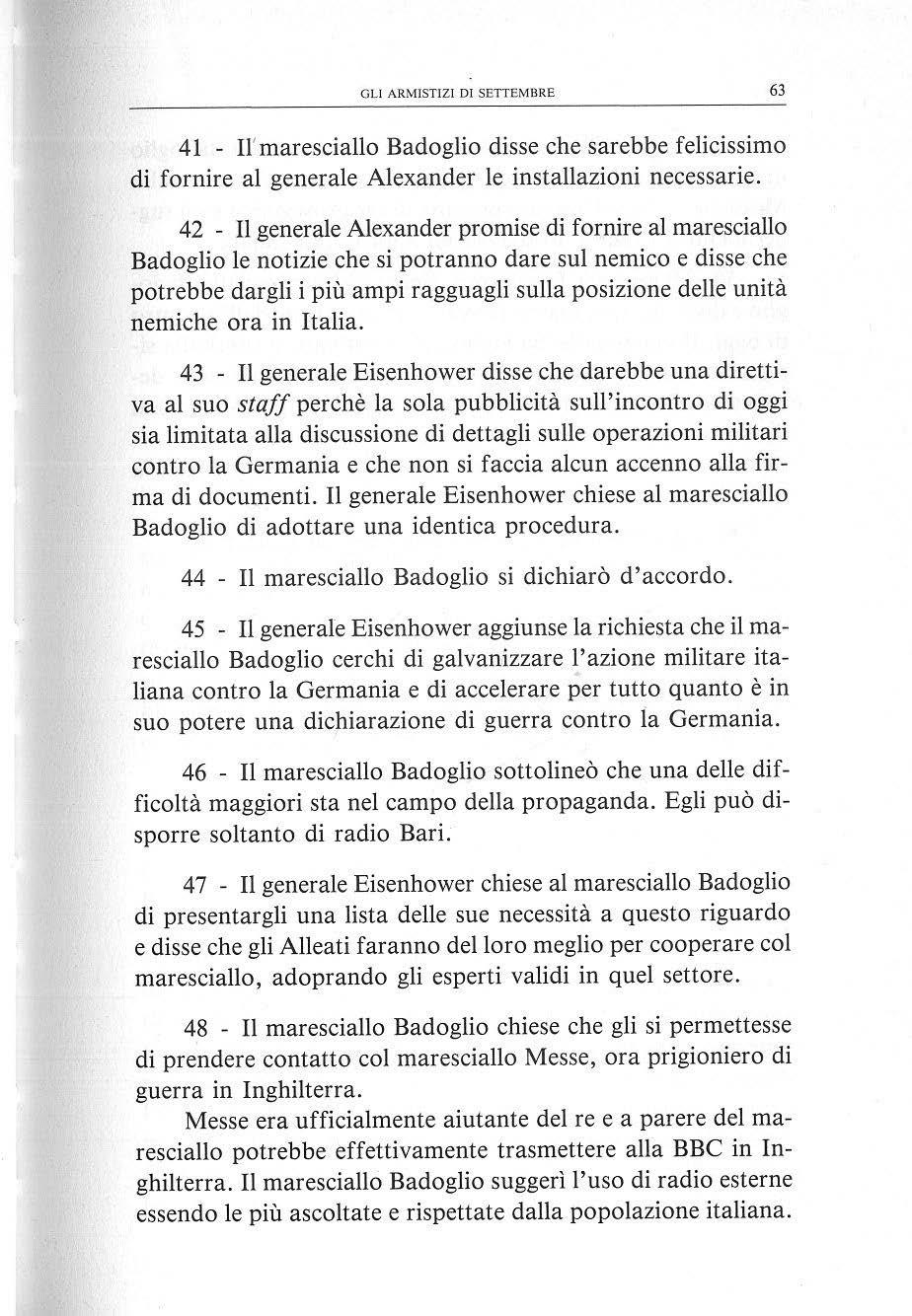
48 - Il maresciallo Badoglio chiese che gli si permettesse di prendere contatto col maresciallo Messe, ora prigioniero di guerra in Inghilterra.
Messe era ufficialmente aiutante del re e a parere del maresciallo potrebbe effettivamente trasmettere alla BBC in Inghilterra. Il maresciallo Badoglio suggerì l'uso di radio esterne essendo le più ascoltate e rispettate dalla popolazione italiana.
49 - Il generale Eisenhower disse al maresciallo Badoglio di mandare tutto il materiale che desiderava per il maresciallo Messe per la trasmissione e promise di far proseguire i suoi suggerimenti a Londra attraverso gli appropriati canali.
50 - Il generale Eisenhower ringraziò il maresciallo Badoglio e disse che sperava ne derivasse un gran bene dall'incontro di oggi. Il maresciallo Badoglio nel ricambiare si riferì alla situazione del 1918 quando gli italiani, disse, diedero il colpo decisivo ai tedeschi. Egli disse pure che a quel tempo c'erano con l'esercito italiano tre divisioni britanniche ed un reggimento americano, i quali tutti cooperarono st rettamente per la sconfitta della Germania.
51 - La riunione fu aggiornata verso le 12,15 p.m.
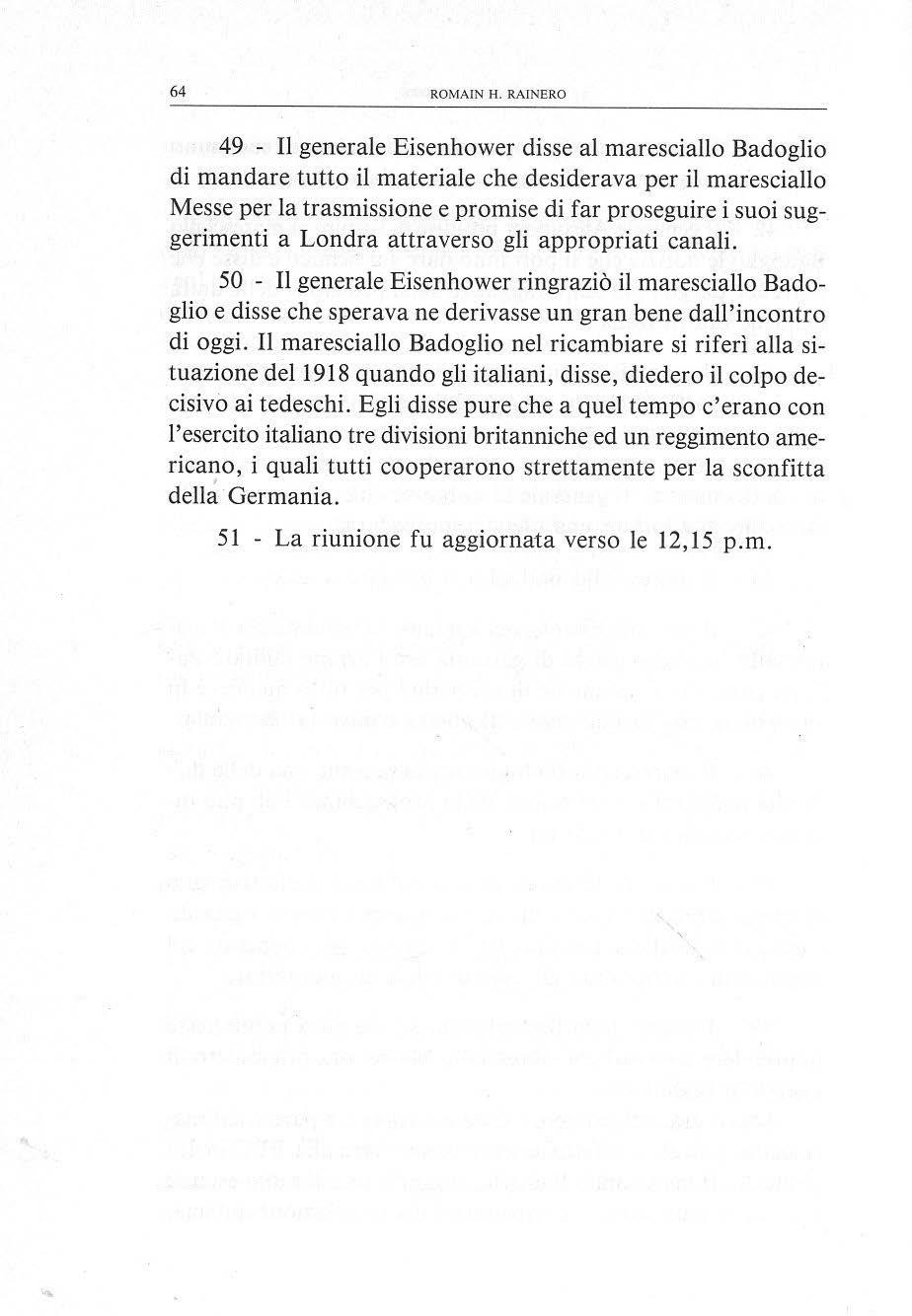
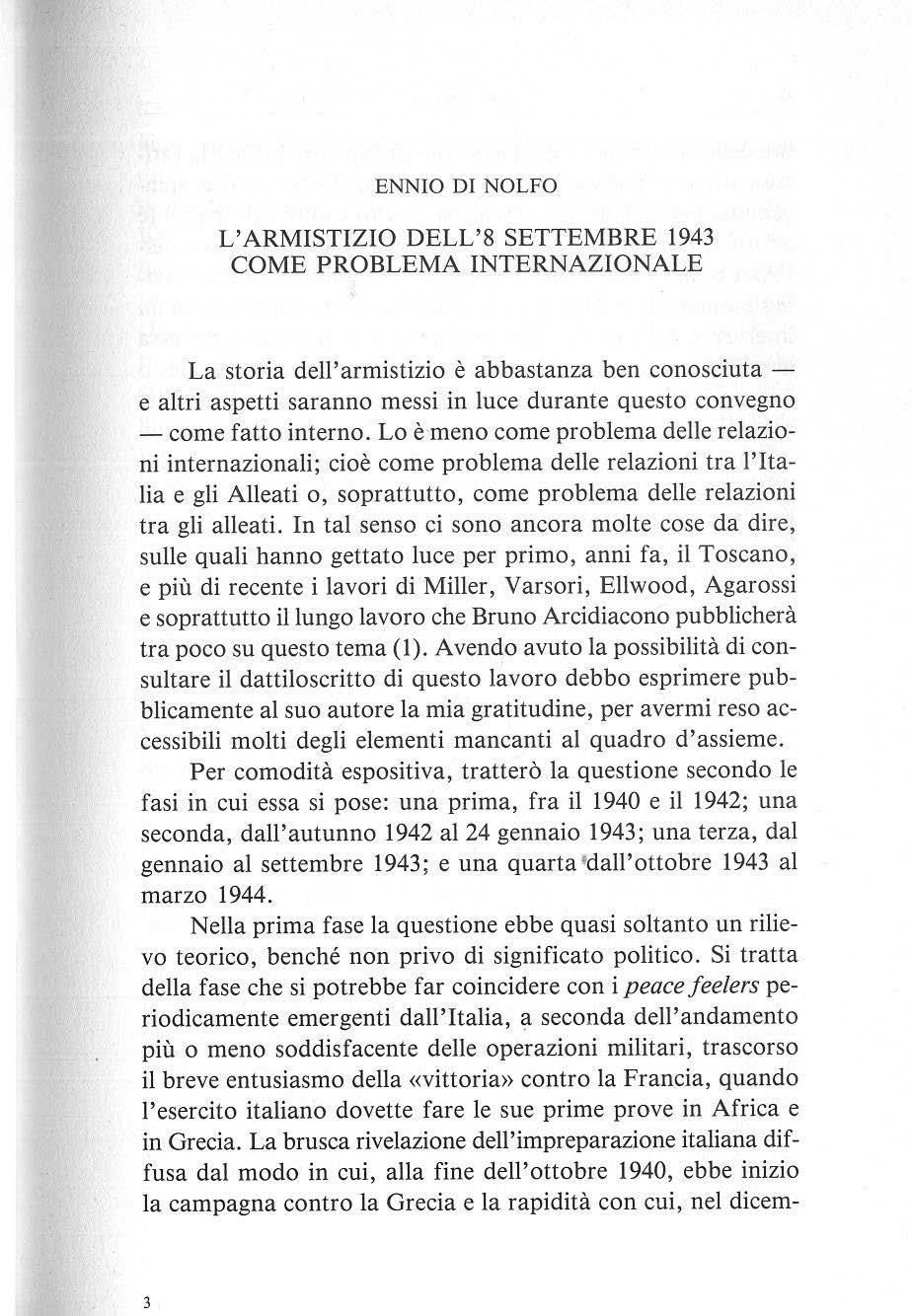
La storia dell'armistizio è abbastanza ben conosciutae altri aspetti saranno messi in luce durante questo convegno - come fatto interno. Lo è meno come problema delle relazioni internazionali; cioè come problema delle relazioni tra l'Italia e gli Alleati o, soprattutto, come problema delle relazioni tra gli alleati. In tal senso ci sono ancora molte cose da dire, su lle quali hanno gettato luce p er primo, anni fa, il Toscano, e più di recente i lavori di Miller, Varsori, Ellwood, Agarossi e soprattutto il lungo lavoro che Bruno Arcidiacono pubblicherà tra poco su questo tema (1). Avendo avuto la possibilità di consultare il dattiloscritto di questo lavoro debbo esprimere pubblicamente al suo autore la mia gratitudine, per avermi reso accessibili molti degli elementi mancanti al quadro d'assieme. Per comodità espositiva, tratterò la questione secondo le fasi in cui essa si pose: una prima, fra il 1940 e il 1942; una seco nda , dall'autunno 1942 al 24 gennaio 1943; una terza, dal gennaio al settembre 1943; e una quarta •dall'o tt obre 1943 al marzo 1944.
Nella prima fase la questione ebbe quasi soltanto un rilievo teorico, benché non privo di significato politico. Si tratta della fase che si potrebbe far coincidere con i peace feelers periodicamente emergenti dall'Italia, seconda dell'andamento più o meno soddisfacente delle operazioni militari, t rascorso il breve entusiasmo della «vittoria» contro la Francia, quando l'esercito italiano dovette fare le sue prime prove in Afr ica e in Grecia. La brus ca rivelazione dell'impreparazione italiana diffusa dal modo in cui, alla fine dell'ottobre 1940 , ebbe inizio la campagna contro la Grecia e la rapidità con cui, nel dicem-
bre dello stesso anno, gli inglesi riuscirono a rovesciare la faticosa offensiva italiana sulla costa settentrionale dell'Africa, spingendosi sino a Tobruch e Bengasi, fecero capire agli inglesi (e a tutte le forze in campo) che l'Italia era «l'anello debole» del1' Asse e che, a causa dell'impreparazione militare o della fragilità economica, o della pressione dell'opinione pubblica o di un intervento della monarchia, era opportuno prevedere che essa avrebbe cercato una pace anticipata. Chi ha studiato questo aspetto delle situazione italiana, cercando di capire il problema politico più' che di svelare gli episodi scandalistici relativi a strani mercat i progettati da millantatori scarsamente credibili, ha messo in luce portata e limite di questa ipotesi (2). Probabilmente nell'inverno 1940-41 gli inglesi pensarono, alquanì: o ottimisticamente, considerata la presa germanica sul continente e la dipendenza già ins t auratasi tra Hitler e Mussolini, che il ritiro dell'Italia dalla guerra fosse auspicabile e nego z iabile. Questo atteggiamento inglese, scrive il Varsori, «era più ipotetico che reale». Esso era influenzato dalla debolezza obiettiva dell'Italia, da un residuo di poli t ica di appeasement e dal calcolo dei vantaggi militari che una resa italiana avrebbe procurato. Tuttavia , raccomanda lo stesso autore, non si debbono ignorare due altri aspetti del problema: che la guerra non aveva ancora assunto il carattere di · scontro ideologico contro il nazifascismo, e che l'Inghilterra, essendo rimasta a combattere da sola, progettava senza tenere conto delle relazioni con i futuri alleati. Gli inglesi guardavano ai gruppi di , potere tradizionalisti in Italia - la monarchia e i militari, guidati da Badoglio - come agli interlocutori naturali di una fase di transizione.
Questa situazione mutò durante il 1941, quando il tema acquistò un più preciso profilo internazionale. Non era solo l'avversione suscitata in Inghilterra dalle vicende della guerranon ultima e sin troppo enfatizza t a, quella del bombardamento di Londra da parte dell'aviazione italiana - quanto il fatto che a ll a Gran Bretagna si associarono, caratterizzando ideologicamente la guerra, gli Stati Uniti, prima con la politica degli
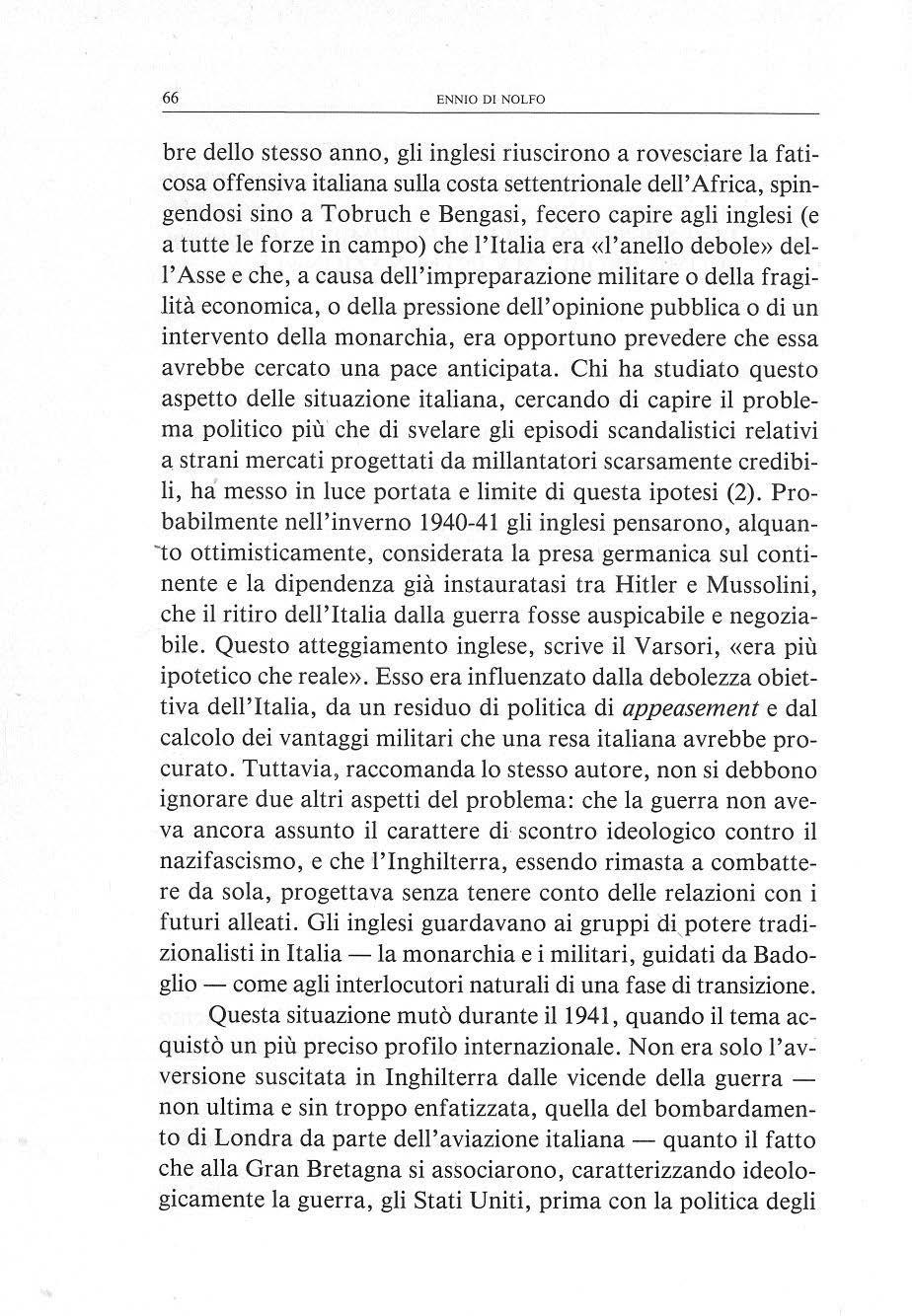
aiuti autorizzata dal Lend Lease Act del marzo 1941 e poi col diretto coinvolgimento nella guerra; e l'Unione Sovietica, dal momento dell'aggressione hitleriana. I nuovi alleati e la Gran Bretagna davano vita a una coalizione che, nel 1941 e nel 1942, ma forse anche dopo, definì solo a fatica i suoi obiettivi di guerra; perciò doveva anche sentirsi impreparata dinanzi all'ipotesi che uno degli avversari volesse una pace separata. L'Inghilterra non era più sola; essa non doveva più schivare la sconfitta con le risorse della diplomazia. Doveva invece pensare a una grande vittoria, con una grande coalizione, della quale facevano parte grandi potenze, difficili da mettere d'accordo; e potenze minori, sulla pelle delle quali in passato un compromesso sarebbe stato forse ipotizzabile, ma alle quali ora gli inglesi avevano fatto promesse che essi avrebbero dovuto mantenere, e che perciò rendevano anche impossibile parlare con gli italiani in termini di compomesso. Fino alla metà del 1942 questa situazione non doveva subire mutamenti sostanziali.
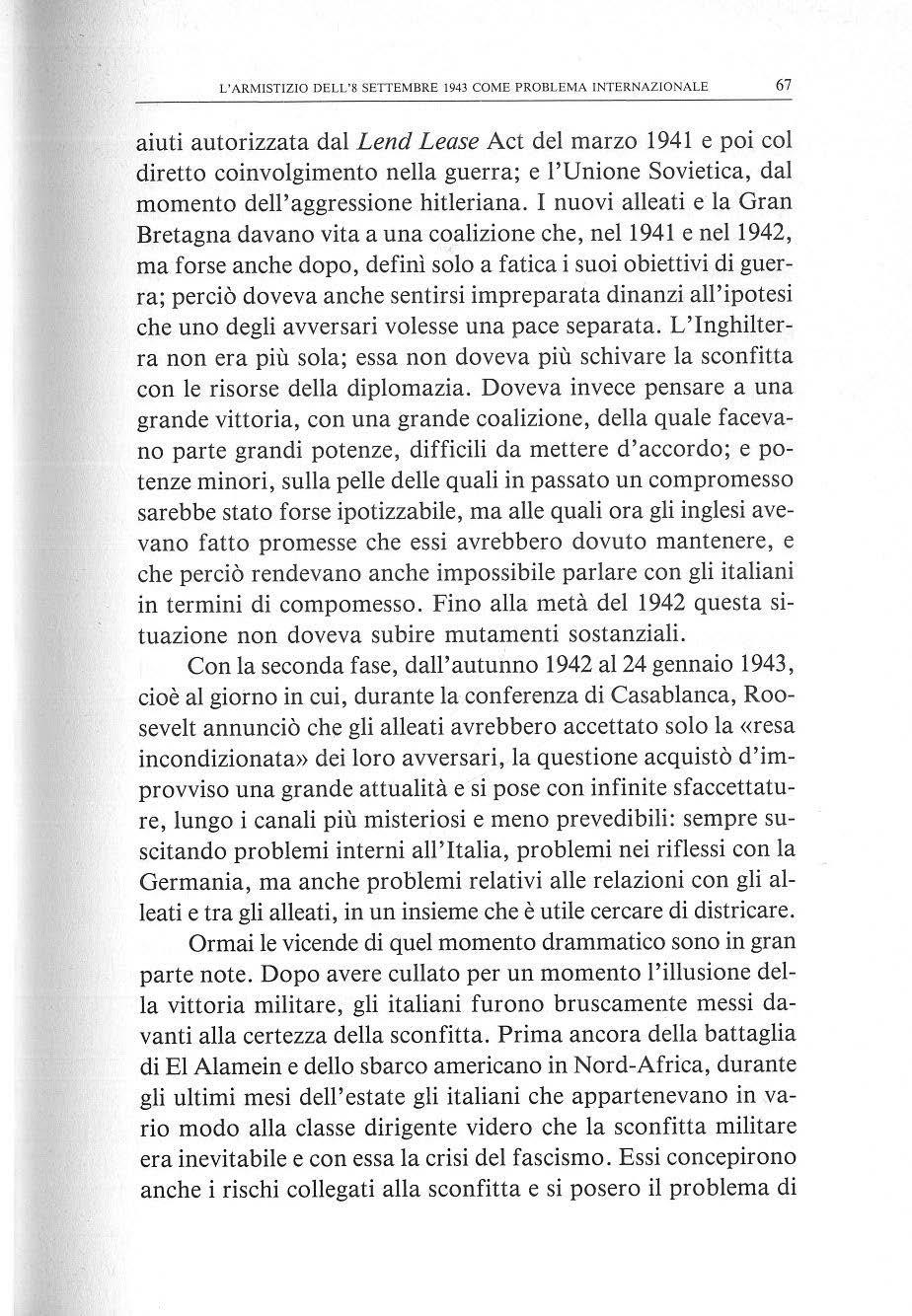
Con la seconda fase, dall'autunno 1942 al 24 gennaio 1943, cioè al giorno in cui, durante la conferenza di Casablanca, Roosevelt annunciò che gli alleati avrebbero accettato solo la «resa incondizionata» dei loro avversari, la questione acquistò d'improvviso una grande attualità e si pose con infinite sfaccettature, lungo i canali più misteriosi e meno prevedibili: sempre suscitando problemi interni all'Italia, problemi nei riflessi con la Germania, ma anche problemi relativi alle relazioni con gli alleati e tra gli alleati, in un insieme che è utile cercare di districare.
Or mai le vicende di quel momento drammatico sono in gran parte note. Dopo avere cullato per un momento l'illusione della vittoria militare, gli italiani furono bruscamente messi davanti alla certezza de ll a sconfitta . Prima ancora della battaglia di E l Al a mein e dello sbarco americano in Nord -Africa, durante gli ultimi mesi dell'estate gli italiani che appartenevano in vario modo alla classe dirigen t e videro che la sconfitta militare era inevitabile e con essa la crisi del fascismo. Essi concep irono anche i rischi collegati alla sconfitta e si posero il problema di
eluderli, o renderli meno gravi. Dovevano perciò tentare nuovamente, ma in condizioni del tutto diverse, di mettersi in contatto con gli alleati. La risposta che costoro avrebbero dato agli appelli italiani avrebbe dato indicazioni sul modo in cui essi concepivano il dopogu~rra, e vi collocavano l'Italia: non il modo retorico, affidato alle grandi dichiarazioni di principio, ma il modo pratico, della realtà politica. Ecco dunque la crisi italiana acquistare un significato che riguardava non solo il destino della penisola, ma coinvolgeva sin da allora il modo di essere delle future relazioni tra le potenze occidentali e l'Unione Sovietica.
Ciò avveniva sia per la natura degli appelli che da parte ital iana giungevano agli alleati, sia per lo stadio particolare che le relazioni delle potenze occidentali con l'U nione Sovietica avevano in quel momento raggiunto. Sul piano interno, l'immagine che si profilava dinanzi agli italiani che erano in grado di comprendere la situazione del paese, era quella di una sconfitta rovinosa, che avrebbe forse visto il fascismo trascinare nel suo crollo le stesse strutture fondamentali della società italiana. Era una sensazione che doveva diffondersi in profondo, suscitando allarme e paura. Perciò tutti (dai gerarchi dissidenti alle alte sfere militari, dagli esponenti della grande industri a a quelli della famiglia reale, e infine a quelli vicini alla Chiesa o interni a essa) videro la via d'uscita nel tentativo di operare una dissociazione, in qualche caso sfaccia tamente tardiva, rispetto . alla gerarchia fascista o, quanto meno, rispetto all'uomo Mussolini, sul quale si propendeva spontaneamente a concentrare l'intera responsabilità della scelta dell'Italia nel giugno 1940.
Questa operazione esigeva l'esistenza di due condizioni preliminari: la disponibilità dei destinatari a dar retta al messaggio loro inviato, e l'esistenza di un messaggio dai contenuti persuasivi per quei destinatari. La scelta dei destinatari non era oggetto di una possibile discussione. Dal momento che l'Italia stava per essere sconfitta dagli anglo-americani, questi sarebbero stati i protagonisti o i dominatori dell'immeditato futuro politico del-
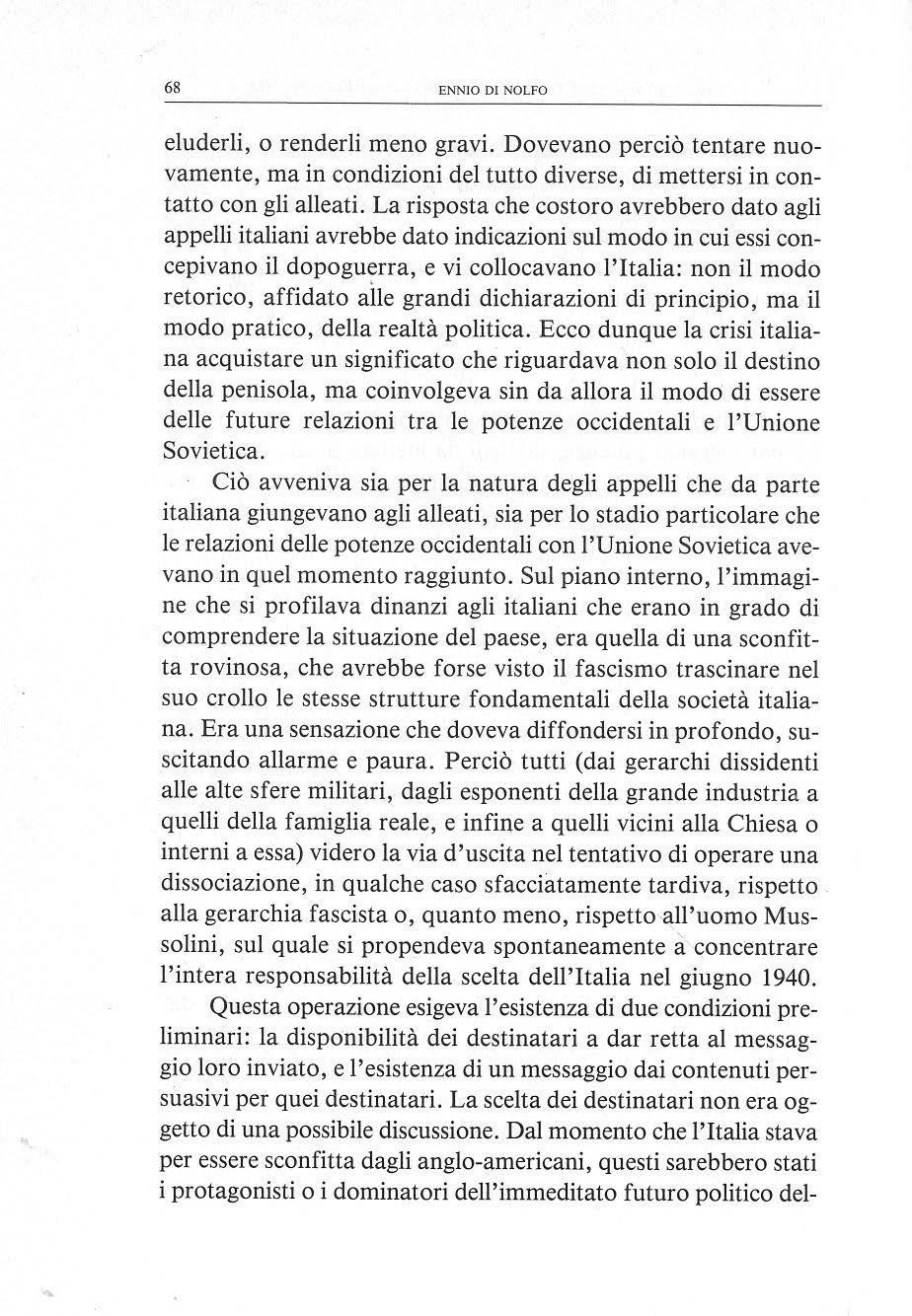
la penisola e con loro bisognava cercare l'intesa. Quanto al contenuto del messaggio da lanciare, esso derivava dalla stessa natura della diagnosi allarmistica. Se la sconfitta poteva provocare il collasso sociale dell'Italia, occorreva rendere sensibili gli alleati rispetto a questo rischio, persuaderli della necessità che l'ordine sociale fosse salvaguardato, che una destabilizzazione fosse evitata, poiché da questa avrebbero tratto vantaggio le forze della sinistra, trasformando la crisi del regime mussoliniano in una crisi della società italiana. Gli italiani che nut rivano queste preoccupazioni, lasciavano capire di essere pronti a sbarazzarsi presto di Mussolini e a fare una pace separata dalla Germania, purché l'operazione fosse condotta in modo tale da ev it are una sconfitta drammatica. In altre parole, il progetto collegava la precisa volontà di conservare il cont rollo della società italiana alla speranza che il recupero delle alleanze internazionali che il fascismo aveva spezzato servisse a dare quella forza che le classi dirigenti italiane da sole non possedevano più. E ra una proposta precisa di alleanze internazio n ali di classe (si direbbe usando certi slogan ricorrenti) in cambio dell ' offerta di mettere a disposizione degli alleati non t anto le restanti risorse militari italiane, quanto il territorio dell'Italia, con tutta l'importanza strategica che esso poteva avere nella prosecuzione della guerra contro la Germania.
La risposta che gli alleati avrebbero dato a questi appelli, che furono numerosi e sempre più angosciati (3), avrebbe rivelato il modo in cui essi concepivano il futuro dell ' Italia e perciò, indirettamente, il modo in cui essi concepivano le loro reciproche relazioni e quelle con l'Unione Sovietica. Tuttavia sarebbe difficile indicare con assoluta sicurezza il contenuto reale di tali risposte poiché anziché una reazione sola, se ne manifestarono due ordini: uno esterno e formale e un altro segreto e sos tanzi ale . Reciprocamente essi erano contraddittori, e rivelavano una certa incoerenza di fondo sia nel merito del problema italiano, sia nel metodo secondo il quale le potenze interessate av r ebbero dovuto trattarlo.
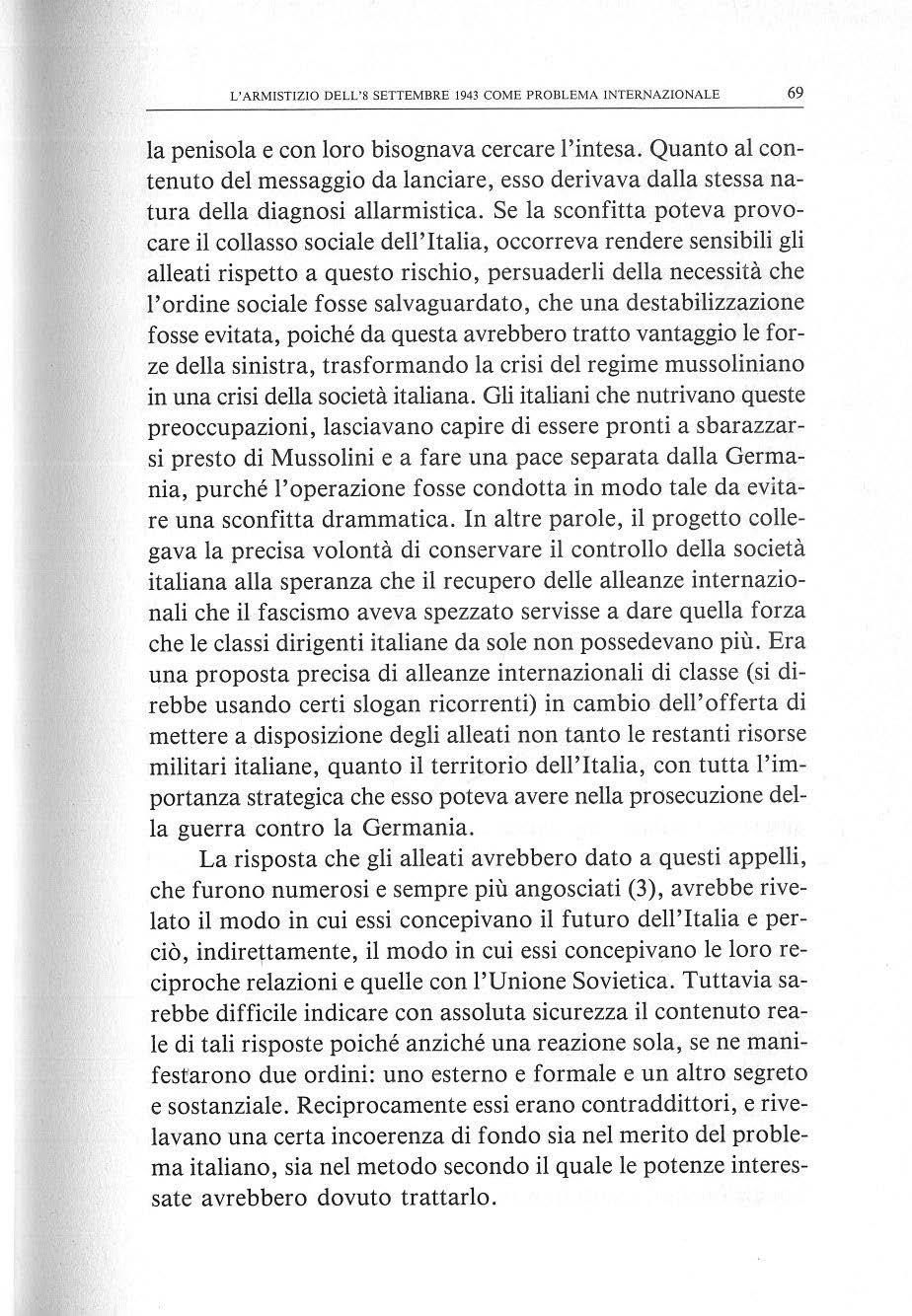
Sul piano esternamente percepibile si può dire che gli appelli ital iani furono respinti. Il 24 gennaio 1943, durante la conferenza di Casab lanca, il presidente americano annunciò la tesi della «resa incondizionata». Ciò implicava il rifiuto di trattare e per conseguenza l'indisponibilità degli alleati a prendere in considerazione ipotesi, come quelle segretamente provenienti dall'Italia, le quali invece erano basate sul presupposto che esistesse un mutuo interesse a negoziare. La formula della resa incondizionata contraddiceva l'idea di una pace separata e negoziata con l'Italia e implicava una politica di defascistizzazione radicale, cioè proprio quella politica che tante forze in Italia si preoccupavano di evitare, prevenendola. In realtà poi va detto che la formula della «resa incondizionata», come molti autori hanno rilevato, era più un ' astrazione politica o una petizione di principio, che una proposta di lavoro. Fatta eccezione per il caso della Germania , in cui il dissolversi dell'autorità politica del Terzo Reich produsse i risultati della «resa incondizionata», sia nel caso dell'Italia, come in quello del Giappone, due anni dopo, la resa sarebbe stata accompagnata da negoziati e condizioni che circoscrivevano l'assolutezza del proposito iniziale (4). Tuttavia lo slogan non era vuoto di contenuto diplomatico. Esso traeva ragione dalla situazione italiana ma aveva come destinatario il governo sovietico, e come scopo quello di provocare una diminuzione dei sospetti di Stalin verso gli alleati. Nel momento in cui, per fondate ragioni tecniche, Roosevelt non poteva tener fede alla pro- ' messa, fatta più vo lte , d i aprire un secondo fronte in Europa entro il 1942, esponendo i sovietici a ll a tentazione di fare loro una pace separata con la Germania (5) , diventava indispensabile fornire loro qualche garanzia che li rassicurasse che non sareb b ero rimasti so li a combattere contro i tedeschi, qualche garanz ia circa la determinaz ione degli alleati occidentali di combattere il nazismo sino alla sua sconfitta totale. Questa garanzia era c ontenuta - per l'appunto - nella formula «resa incondizionata», sost ituto provvisori o del secondo fronte in Eu-
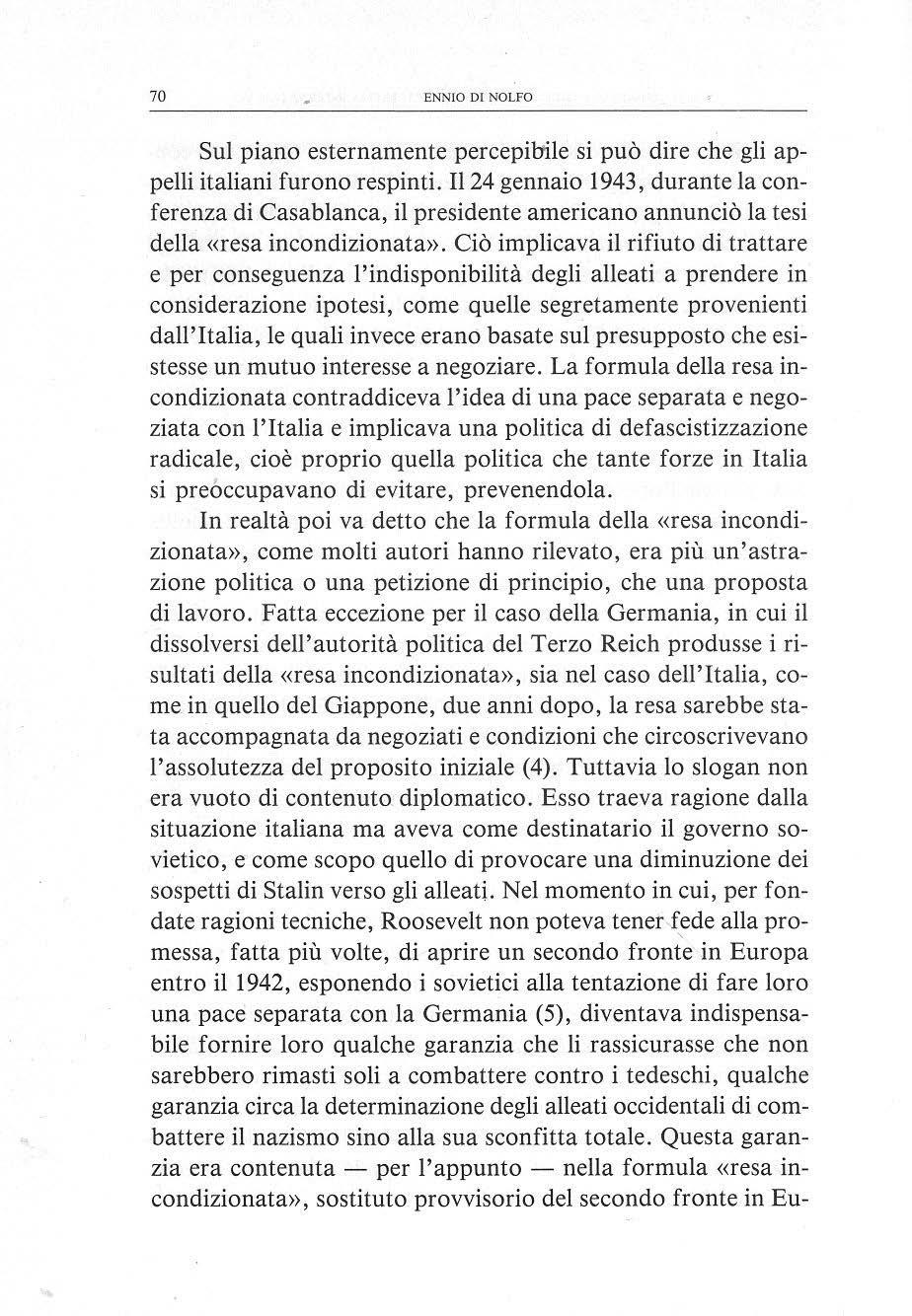
ropa e segnale inviato non tanto alle potenze dell'Asse (non comunque all'Italia) quanto all'Unione Sovietica. Dal punto di vista internazionale essa significava che gli allea t i occidentali non avrebbero agito da soli, non avrebbero assunto iniziative unilaterali. Era una posizione, dunqu e , che collegava il problema it aliano al progetto di una futura co ll aborazion e e convivenza t ra i vincitori. Invece, accogliere gli appelli italiani , imbevuti di anticomun ismo, e perciò di antisovieti smo, avrebbe avuto il significato oppos t o.
Tuttavia, se si passa dalle dichiarazioni pubbliche ai comportamenti effettivamente seguiti ~agli occiden t ali, l ' impress ione cambia. So tt o la sdegnosa dichiarazione di Roosevelt stava in realtà molto più variegata, intessuta a ncora di una tenace e costante attenzione verso gli ambienti it a liani disposti a di ssociarsi dal fascismo , senza esclusione di ne ssuna corrente politica o personalità (dai fascisti di sside nti, al re, ai mili t ar i). La t esi della «resa incondizionata» diventava perciò una sp ecie di coperchio sopra un ribollire frenetico di ipot esi alt ernative. Il problema era solo che tale ribollire non fosse visibile all' esterno. Né gli americani né gli inglesi si tiravano indietro di fronte alla possibilità di una pace separata: né prima né dopo il 24 gennaio 1943. Gli americani erano disposti a t rattare con il re persino dal giorno stesso in cui erano entrati in guerra contro l'Italia (6) e avevano continuato a essere disposti a farlo nel 1941 e nel 1942. Proprio nel gennaio 1943, mentre Roosevelt usava un certo linguaggio a Casablanca, il Post-War Foreign Policy
Preparation Committee del Dipartimento di Stato, discuteva in ogni suo aspetto la situazione italiana per raggiungere la conclusione che la sola soluzione possibile sarebbe stata quella di un governo di t r ansizione guidato dai militari, cioè dal maresciallo Badoglio , e il mantenimen t o di casa Savoia, salvo eventuale abdicazione del re (7). La resa incondizionata, si ammetteva dunque in seno al Dipartimento di Stato, doveva essere applicata solo all~ Germania e al Giappone. Cordell H ull scrisse
più tardi: «Il presidente Roosevelt e io ritenevamo ... che sa-

rebbe stato possibile far ritirare l'Italia dalla guerra prima della resa della Germania e del Giappone ... Sentivamo che il diritto dell'Italia sarebbe stato accelerato se noi avessimo adottato nei confronti degli italiani un atteggiamento diverso da quello che avevamo nei confronti di tedeschi e giapponesi» (8). Quanto agli inglesi, nonostante l'irrigidimento maturato con il tempo e sebbene Anthony Eden si distinguesse per una posizione personale tenacemente ostile all'Italia, sta il fatto che non appena dall'Italia giunsero, anziché le periodiche voci che riferivano di malumori o velleitarie intenzioni di questo o quel personaggio, precise indicazioni sulle intenzioni del maresciallo Badoglio e del maresciallo Caviglia, oppure quelle sulla disponibilità del nuovo duca d'Aosta a cercare la strada di un compromesso e di un armistizio (si badi bene: un armistizio e non una resa) lungi dal lasciarle cadere come irrilevanti o premature, come era stato fatto in passato, vennero prese nella più seria considerazione, nonostante l'impegno solenne enunciato a Casablanca. Fu solo alla fine di febbraio che Eden mise la parola fine a questa parte della vicenda (9). Ma questa pausa non significò anche l'interruzione del dibattito interno, poiché in seno al Foreign Office il dibattito proseguì ancora sino all'estate. Questa ambiguità e la mancanza di decisione che ne derivava, non erano solo il risultato della volo ntà di tenere i sovietici all'oscuro delle opzioni valutate dai due governi occidentali . Esse riflettevano anche l'esistenza di due prob lemi non risolti ma tali da non poter essere elusi: il problema çlel rapporto tra inglesi e americani rispetto all'Italia sconfitta e all'attuazione dell'armistizio; e il problema della partecipazione sovietica sia alla definizione sia all'attuazione dell'arm istizio stesso (o delle clausole di resa, se si vuole tener presente la differenza allora rilevata tra i due termini).
Il primo dei due problemi fu . posto, e risolto, almeno sul piano teorico, con sufficiente rapidità. Esso rifletteva le preoccupazioni di fondo che gli inglesi nutrivano verso l'Italia, perciò il desiderio di avere, nelle questioni italiane un peso pre-
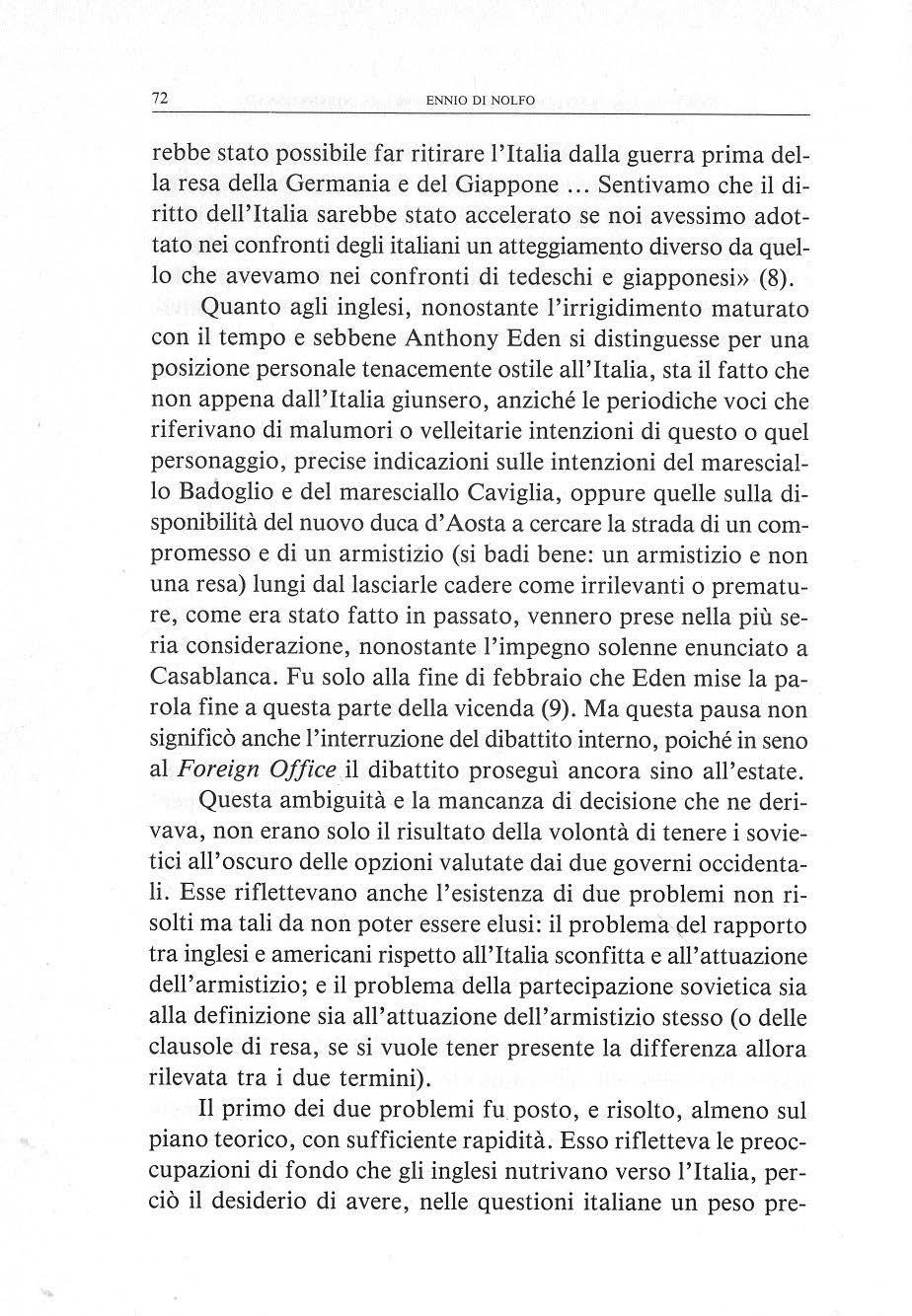
ponderante, così da avere la certezza che la «tenerezza» americana verso gli italiani (un sentimento spiegato da ragioni interne ben precise) lenisse il peso delle durezze che da parte britannica si volevano far sentire agli italiani.

La questione nacque di fatto quando, decisa l'operazione sbarco in Sicilia, gli stati maggiori alleati incominciarono a studiare i metodi di attuazione dell'occupazione militare (non si parlava ancora di armistizio o resa ma solo di occupazione militare). Iniziato in febbraio lo studio del problema, i vari organi inglesi pervennero, all'inizio di marzo, a definire la richiesta che la responsabilità dell'amministrazione non fosse divisa tra americani e inglesi in parti eguali ma in parti che tenessero conto dei maggiori interessi inglesi nel Mediterraneo e del maggior impegno britannico nelle operazioni belliche dello stesso scacchiere. Perciò si doveva riconoscere agli inglesi la posizione di «senior partner», cioè di primi e principali responsabili dell'amministrazione stessa, traducendosi poi la formula nell'assunzione delle maggiori cariche amministrative e del maggior numero delle stesse.
Si trattava, a ben guardare, di un'iniziativa ingenua. Il ruolo rispettivo delle due potenze che insieme operavano in Italia, non sarebbe stato determinato da intese di principio preliminari, ma dalla realtà esistente sul campo, cioè dalla maggiore o minore disponibilità di uomini adatti, dalla minore o maggiore capacità di elaborare soluzioni adeguate ai casi concreti. Il fatto che Churchill e il governo inglese si spingessero a enunciarle ufficialmente riflette le esitazioni e i sospetti esistenti anche all'interno dell'alleanza occidentale. Aspetti puntualmente riflessi nella risposta americana: un diniego secco e reciso, basato sull 'affermazione degli interessi americani verso la Sicilia e sull'attenzione con cui da parte della popolazione americana di origine sic iliana si guardava alla situazione che si stava delineando. Fu, questo, un serrato dibattito diplomatico, che proseguì sino alla vigilia dello sbarco in Sicilia, e fu concluso durante la conferenza TRIDENT, tenuta a Washington alla fine del mese di maggio (10).
La tesi britannica fu ridimensionata e l'unico risultato che gli inglesi ottennero fu l'istituzione, accanto al Comando supremo per il Mediterraneo, allora tenuto da Eisenhower, di una sezione politica, alla cui guida fu destinato Harold Macmillan, uomo così abile da dare agli inglesi qualsiasi garanzia di efficace controllo (11). E tuttav ia, proprio questa incertezza interna finiva per trasformarsi in un ostacolo rispetto alla disponibilità verso eventuali riprese delle iniziative di pace italiane. Si poteva sin dalla fase preliminare comprendere che la gestione e attuazione pratica dell ' armistizio sarebbero stati i motivi di molte difficoltà tra loro intrecciate. Le relazioni angloamericane sulla mutua divisione di responsabilità; i rapporti che, nell'ambito della formula della resa incondizionata, sarebbero stati tenuti con il governo monarchico e, dopo il 25 luglio, con il maresciallo Badoglio, e la mancata defini zione di criteri concordati con i sovietici, anzi la propensione delle due po t enze occidentali a agire autonomamente, salvo a chiedere poi la ratifica sovietica erano, nell'insieme aspetti che , se trattati isolatamente, potevano apparire marginali ma se considerati nell'insieme davano un quadro di dimensioni europee. In altre parole, rappresentavano un momento critico per l'avvio delle relazioni interalleate all'inizio del dopoguerra. È per questo che alcuni autori hanno poi parlato di preludio della guerra fredda o di precedente italiano.
L'aspetto più delicato - e con questo siamo in pieno nella terza delle fasi sopra accennate - era quello della partecipa' zione sovietica alla preparazione dell'armistizio e al controllo della sua esecuzione. È un tema che si pone ben avanti 1'8 settembre, ma che ebbe la sua verifica pratica solo dopo le conferenze di Mosca e Teheran, di ottobre e novembre-dicembre dello stesso 1943. Il problema fu posto, come fa giustamente osservare Arcidiacono, contemporaneamente alla polemica sulla «senior partnership», nel febbraio 1943, da Eisenhower, il quale indicò l'opportunità di intese relative alla Sicilia, ma rilevò anche che queste «avrebbero inevitabilmente costituito un prece-
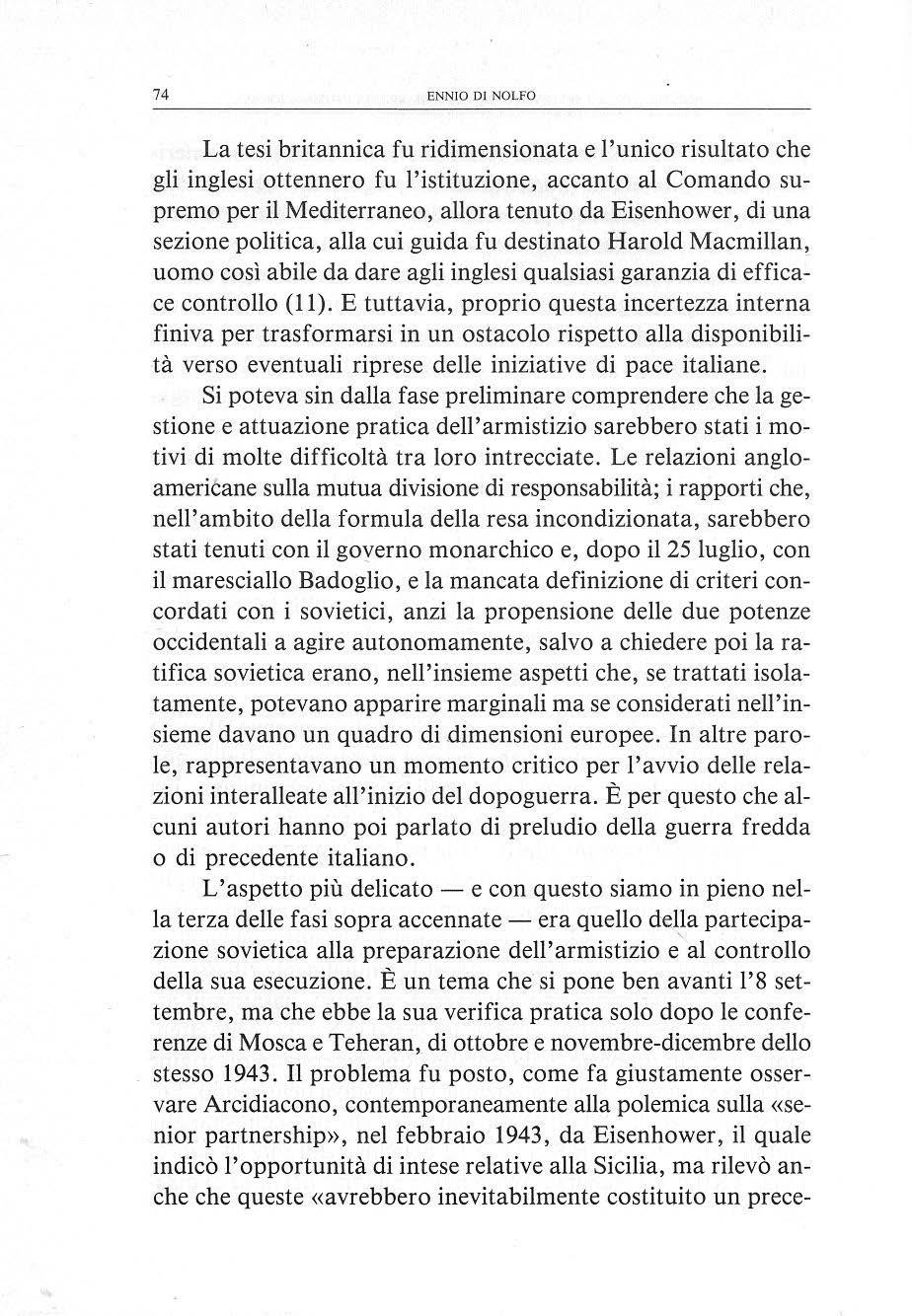
dente per l'amministrazione civile dell'Italia e della Germania» (12). La tesi che Eisenhower sosteneva era che le operazioni rientrassero esclusivamente sotto la responsabilità dei Combined Chiefs of Staff, mentre la preoccupazione inglese era quella di assicurare al governo britannico (proprio in considerazione degli interessi strategici inglesi in Italia) la possibilità di intervenire direttamente sul campo, senza dover seguire la lentissima trafila dei comandi mili tari. La presenza di Macmillan nella struttura alleata costituiva, da questo punto di vista, una sicura garanzia di controllo. Tuttavia questa appariva, agli occhi del Foreign Office, come una soluzione parziale del problema, che doveva anche essere considerato nella portata di occasione «per porre le fondamenta di una collaborazione tripartita capace di s opravvivere alla vittoria militare della coalizione». (13) Era questa, in particolare, l'opinione di un ufficio recentemente cos t ituito, il Dipartimento per l'Economia e la Ricostruzione, posto sotto la guida di Gladwyn Jebb. Sin dalla prima fase dei suoi lavori, questo nuovo dipartimento prese una direzione nettamente favorevole alla partecipazione sovietica alle maggiori decisioni relative a tutti i territori nemici, poiché in t al modo si sare bbe ottenuto il vantaggio di «impegnare i s ovi etici a consultare (gli alleati) rispetto a qualsiasi territorio nemico fosse catturato dalle forze russe». In cambio, essi avrebbero ottenuto l'impegno occidentale a consultarli «in relazione ai territori dell'Europa occidentale e dell'Africa settentrionale» (14). Su questa base, scrive Arcidiacono, «il Foreign Office avrebbe cost ituito un progetto generale, il cui obiettivo era facilmente percepibile: una soddisfacente transizione dalla cooperazione bellica alla collaborazione in tempo di pace, raggiunta, tale collaborazione, grazie all'adozione nei territori occupati, di una visio ne tripartita unitaria che, mentre concedeva a Mosca un droit de regard in Occidente, avrebbe evitato il rischio del monopolio sovietico nell'Europa orientale» (15).
Era, come si vede, una concezione basata sulla premessa della durevole intesa fra le grandi potenze, come garanzia per
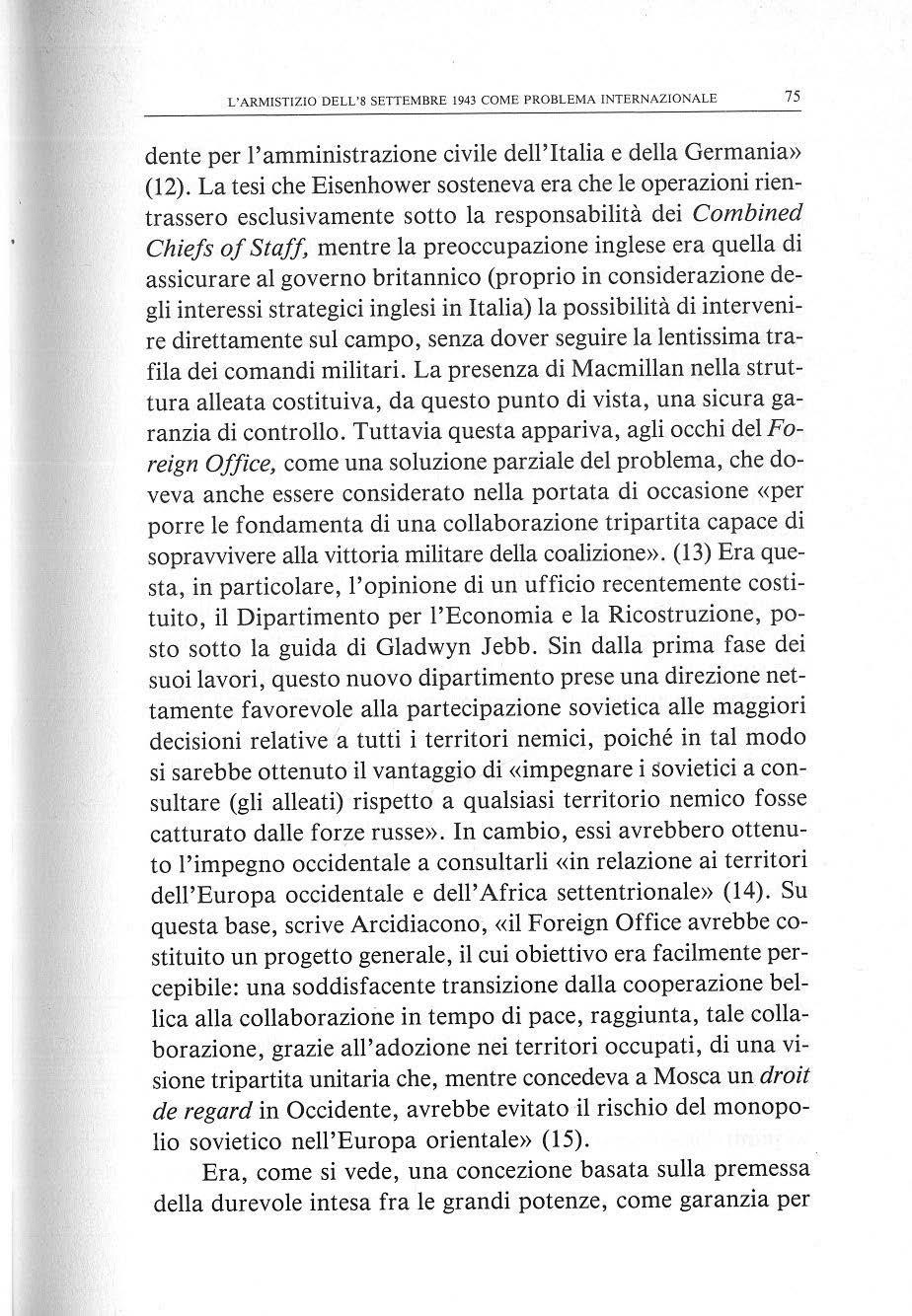
il mantenimento dell'ordine in Europa nel dopoguerra. E era anche una logica diametralmente opposta a quella che avrebbe poi condotto alla guerra fredda. Dentro questa visione si situavano nozioni come la resa incondizionata, la defascistizzazione, il rifiuto di rivalutare chi si era compromesso sino in fondo con la guerra. Infatti i sovietici avrebbero posto condizioni politiche parallele a quelle che avrebbero subito. Se la soviet izzazione doveva essere limitata, anche la rivalutazione delle forze che avevano sostenuto il fascismo in Italia e il nazismo in Germania avrebbe dovuto essere limitata. Perciò la visione illuministica di Jebb presupponeva un tipo di relazioni post-belliche che nella sostanza contrastava con i progetti strategici che lo stesso governo britannico nutriva nei confronti dell'Italia.
Ciò tuttavia non fu subito percepito. Lo stesso Eden fece mostra di condividere l'impostazione di Jebb, che aveva il merito di prevenire il rischio che una delle grandi potenze agisse alle spalle dell'altra (16). Perciò, dopo alcune settimane di elaborazione, si giunse alla redazione di un documento, che Eden sottopose il 25 maggio al War Cabinet, nel quale i principi enunciati da Jebb erano tradotti nella proposta che i diversi armistizi prossimi a stipularsi fossero affidati a una serie di commissioni interalleate, presiedute a rotazione dal rappresentante di una delle tre maggiori potenze. Una Commissione delle Nazioni Unite per l'Europa doveva assumere il compito ·di suprema autorità alleata sul continente, coordinando e dirigendo le atti' vità delle diverse commissioni e dei diversi comandi militari operanti nelle varie regioni occupate. Anche questa commissione doveva essere presieduta a turno, e diretta di fatto da un esecutivo a tre, con diritto di veto (17). Eden, che in quell'occasione caldeggiava l'accoglimento della proposta, usò principalmente l'argomento ricordato da Woodward, «che un accordo su questi punti fosse ·necessario, se si voleva evitare che l'Unione Sovietica firmasse un armistizio separato e organizzasse un sistema separato russo nell'Europa orientale» (18).
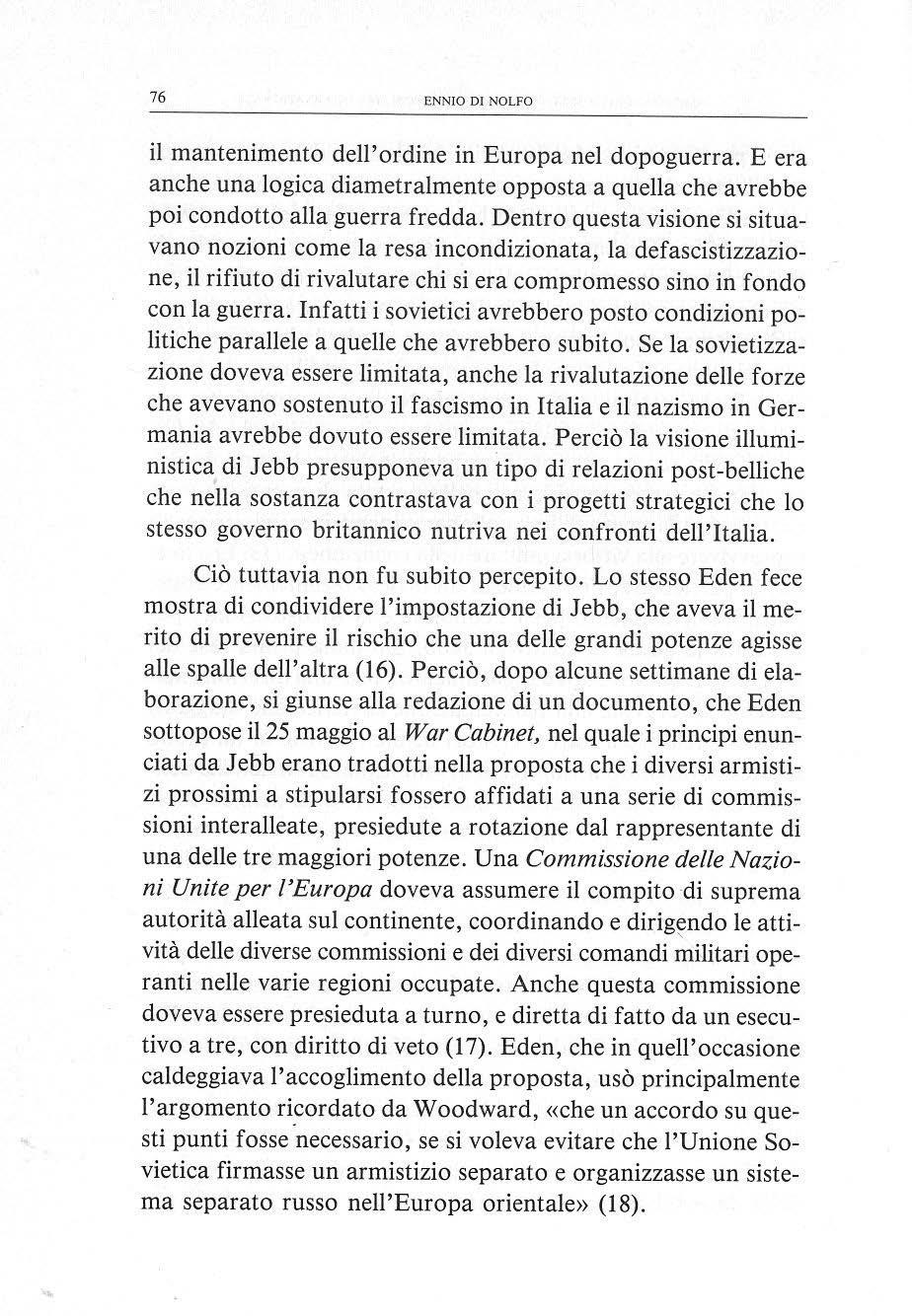
Le proposte di Eden vennero esaminate ancora per alcune settimane e alla fine di giugno il ministro degli esteri brit annico fu autorizzato dal suo governo a trasmetterne la sostanza ai governi sovietico e americano. Il che egli fece in un breve documento che dava al punto di vista britannico non più il carattere di elaborazione interna ma quello di proposta internazionale.
La proposta incontrò immediatamente seri ostacoli e, quasi senza che i sovietici ne fossero resi consapevoli, venne di fatto accantonata proprio durante le stesse settimane in cui, caduto Mussolini, il governo Badoglio compiva i primi maldestri passi verso la stipulazione dell'armistizio, ma per ciò stesso costringeva gli alleati a precipitare le loro decisioni me t odologiche . Tuttavia la svolta che accompagnò tale adeguamen t o e che rimase per un certo tempo inspiegata (19), risentì dell'accelerazione della vicenda politico-militare in modo che contribuisce a spiegare l'affiorare e l'affermarsi di tali ostacoli.
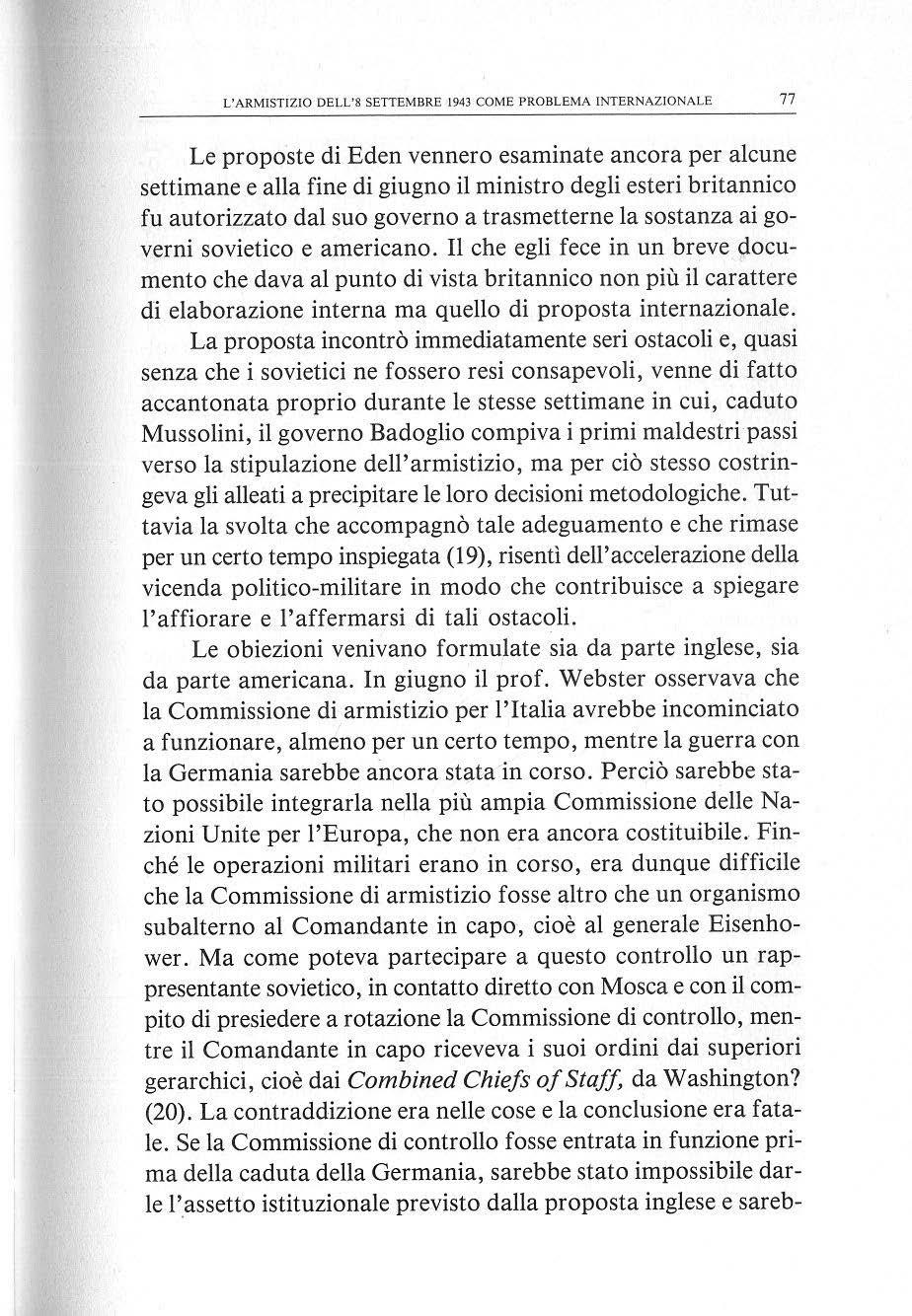
Le obiezioni venivano formulate sia da parte inglese, sia da parte americana. In giugno il prof. Webster osservava che la Commissione di armistizio per l'Italia avrebbe incominciato a funzionare , almeno per un certo tempo, mentre la guerra con la Germania sarebbe ancora stata in corso. Perciò sarebbe stato possibile integrarla nella più ampia Commissione delle Nazioni Unite per l ' Europa, che non era ancora costituibile .. Finché le operazioni militari erano in corso, era dunque difficile che la Commissione di armistizio fosse altro che un organismo subalterno al Comandante in capo, cioè al generale Eisenhower. Ma come poteva partecipare a questo controllo un rappresentante sovietico, in contatto diretto con Mosca e con il compito di pres iedere a rotaz ione la Commissione di controllo, mentre il Comandante in capo riceveva i suoi ordini dai superiori gerarchici, cioè dai Combined Chiefs of Staff, da Washington?
(20). La contraddizione era nelle cose e la conclusione era fatale. Se la Commissione di controllo fosse entrata in funzione prima della caduta della Germania, sarebbe stato impossibile darle l' assetto istituzionale previsto dalla proposta inglese e sareb -
be stato indispensabile porla sotto la s upervi s ione di Eisenhower. E ciò poteva portare al blocco di tutto il meccanismo pensato dagli inglesi, poiché la situazione andava a cozzare contro il fermo principio della dottrina militare americana, secondo cui durante il conflitto la piena supremazia sul teatro delle operazioni spettava al comandante militare. Ne seguiva che , finché in Italia fossero continuate le ostilità, non sare bbe stata tollerata la presenza di alcun altro «executive body», di qualsiasi natura esso fosse, capace di disporre di poteri propri, cioè sottratto al controllo militare. O ss erva ancora puntualmente Arc idiacono che que sta contraddizione metteva in evidenza il fatto che tutta la concezione ing lese era basata sul presupposto che all'armistizio tene sse dietro immediatamente la pace; perciò essa non contemplava la possibilità di altri due anni , o quasi, di guerra, nel corso dei quali i problemi militari avrebbero avuto la prevalenza (21). Sicché si può per paradosso affermare che l'armistizio ita liano divenne internazionalmente causa di di vis ione tra gli alleati poiché esso era venuto troppo presto r ispetto ai preparativi e agli stud i sulle possibile conseguenze e sul modo di provvedervi.
I primi a manife stare sul piano diplomatico le esigenze derivanti dall'affacciarsi della nuova situazione furono gli americani. Es si avevano una prima volta. affrontato l'argomento con Eden, durante una visita che questi fece a Washington nel marzo 1943, nel corso del quale Harry Hopkins «so tto lineò la necess ità di concordare un piano comune per il momento del croll o della Germania, per evitare che l'Europa fo sse sommersa dal caos e cadesse nelle mani dei com unist i, Italia comp res a» (22).
Questo scambio di ide e fu all'ori gine di un lungo stud io, ri chiesto da Roo sevelt, su tutti gli a s petti della s ituazione italiana (23), dal quale emergeva una diversa attenzione degli Stati Uniti verso il problema italiano e, se non ancora l'a ttua rsi di una politica autonoma, l'affiorare della volontà di far s ì c he la situazione non sfuggisse al controllo. E verosimilmente si può pensare che ques te analisi fossero anche all'origine del tipo di
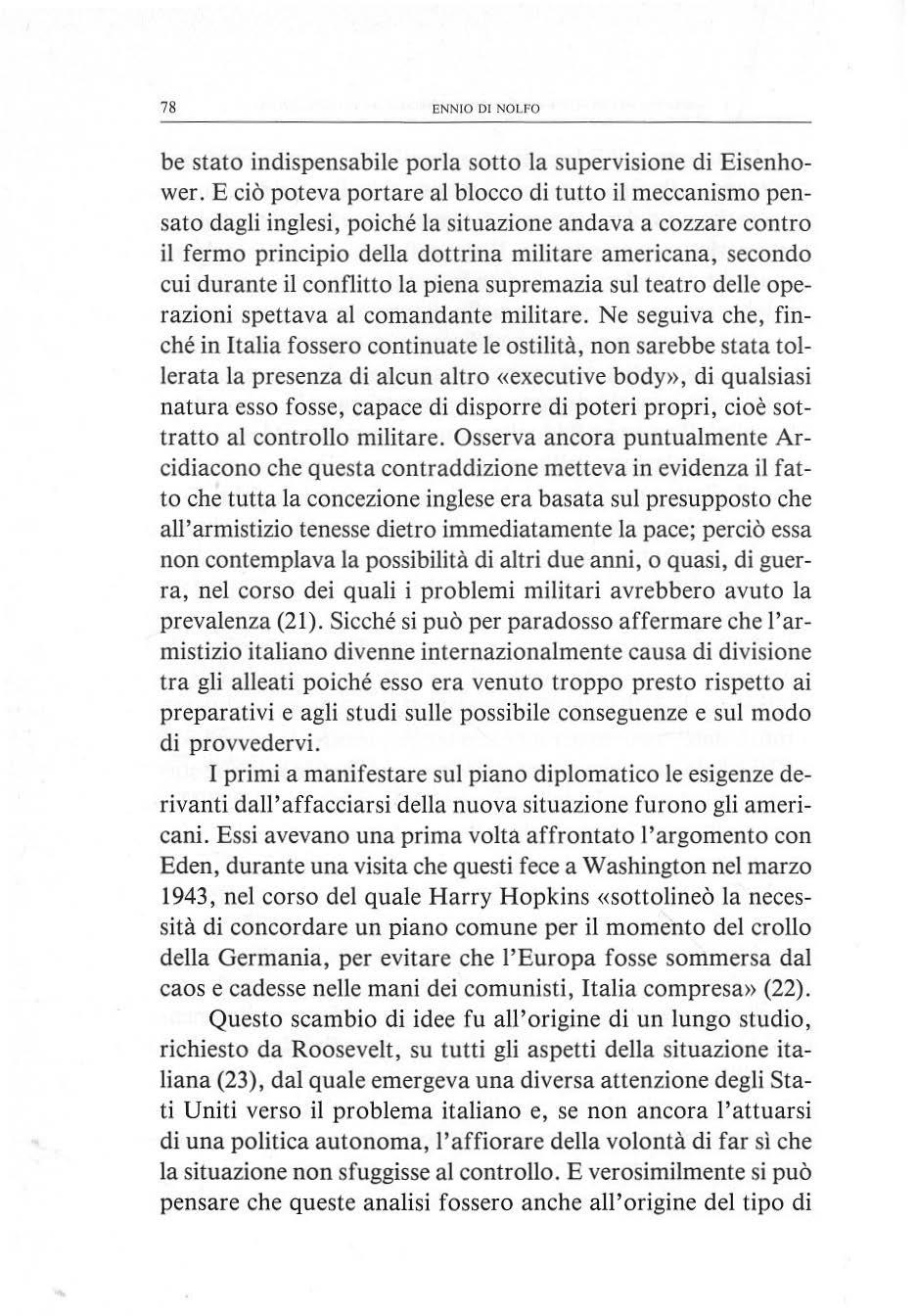
risposta che gli americani diedero poi al promemoria britannico, contenente le proposte di costituire il complesso meccanismo di controllo degli armis tizi europei. Il combinarsi dell'analisi politica e della dottrina militare confluì infatti, all'inizio di luglio, in una controproposta nella quale non si faceva alcune esplicita menzione degli organi di supervisione e si affermava che l'esecuzione dell'armistizio avrebbe dovuto interamente essere affidata al generale Eisenhower, sotto il controllo dei due governi alleati, per via gerarchica (24) . E da cià derivò che il governo sovietico ricevette solo scarse informazioni preliminari e dovette accettare di delegare gli alleati a rappresentarlo nel negoziato o, meglio, nella firma dell ' armistizio di Cassibile. Una fondata esigenza militare generava un problema politico dalla non lieve portata internazionale. Ciò emergerà sinteticamente nell'analisi della quarta fase della presente esposizione. Intanto va aggiunto che sia la dinamica rapida degli eventi in Italia, sia l'assenza dei sovietici, sia le propensioni reali degli inglesi e degli americani provocarono, all'interno della relazione Italia-alleati, la ricomparsa del tema che la resa incondizionata aveva sommerso. Infatti, subito dopo la stipulazione dell'armistizio, ponendosi il problema del rapporto con la monarchia italiana e con le forze militari che l'avevano appoggiata nell'allontanamento di Mussolini, risultò quasi spontaneo recuperarla, riconoscendone l'autorità legittima, ma congiuntamente sancendo una continuità istituzionale che salvava quegli equilibri di sostanza per i quali si erano nutri t i tanti timori nel 1942.
La quarta fase vide giungere alla conclusione il problema dei contenuti politici internazionali dell'armistizio italiano considerato come momento della creazione del sistema post-bellico di alleanze. La questione fu discussa infatti a Mosca, in una seduta della Conferenza dei ministri degli esteri. In quell'occasione Molotov assunse un atteggiamento non ben decifrabile e non ben decifrato. Infatti egli si riferì alle proposte inglesi sul controllo t ripartito, mostrando di considerarle ancora valide;
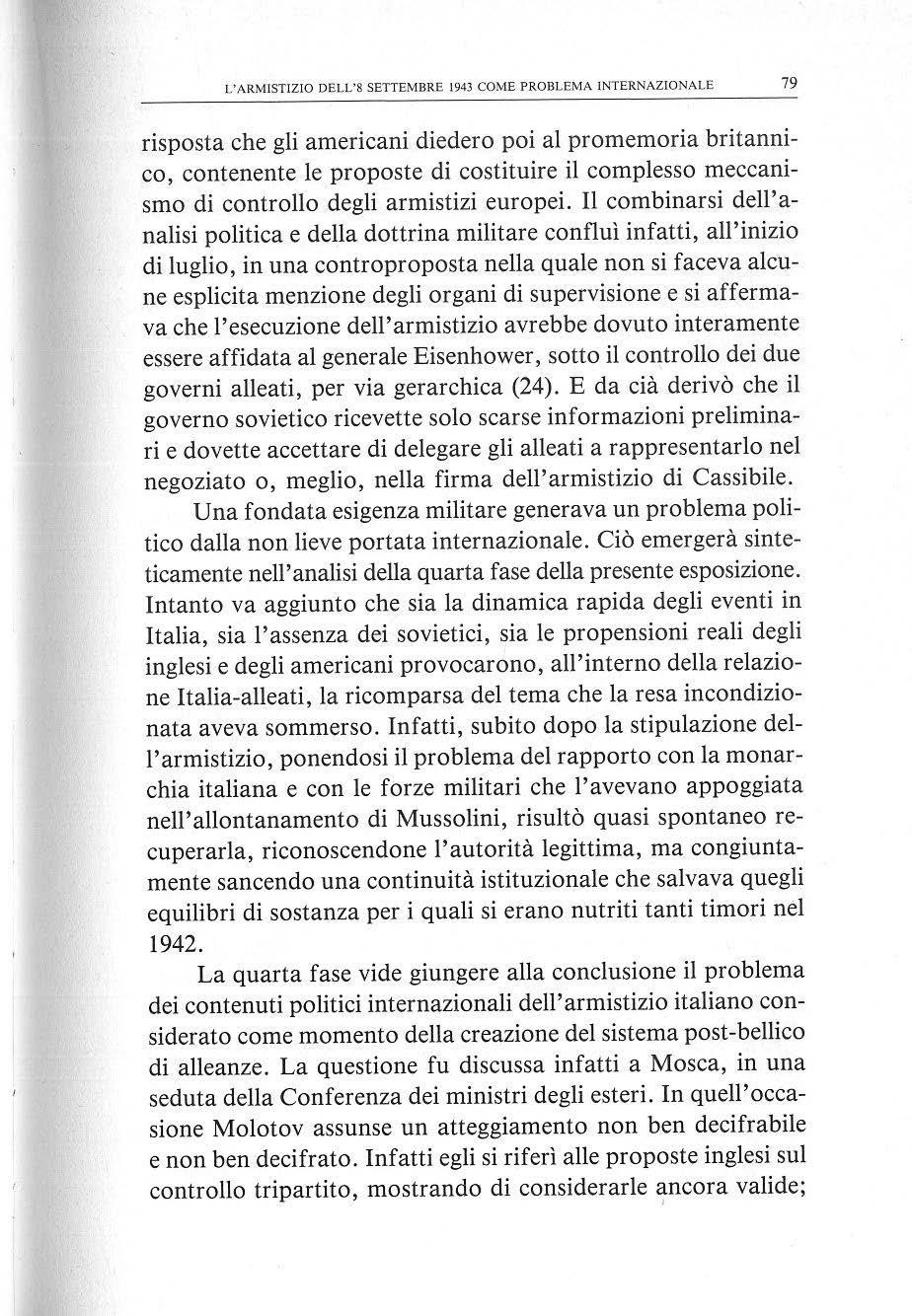
ascoltò da Eden e Hull spiegazioni più o meno contorte e reticenti su ll'in tenz ion e di far prevalere, al momento, le esigenze militari. Nel seguito della discussione, accettò che si costituissero tre Commissioni: la European Advisory Commission, che all'apparenza somigliava alla Commissione di coordinamento europeo suggerita dagli inglesi; un Advisory Council for Italy; e una Allied Contro! Commission p er l'Italia. I sovietici avrebbero preso parte alle prime due commissioni, che avevano soltanto poteri consultivi; non avrebbero avuto che una parte simbolica, come è ben noto, nella terza, che aveva poteri reali in Italia. Il punto non decifrato riguarda la misura in cui i sovietici furono volutamente fuorviati dagli alleati, quella in cui essi non cap irono la portata del compromesso raggiunto, e quella in cui fecero mostra di non aver capito, cioè fecero buon viso a cattiva sorte, riservandosi di restituire il colpo diplomatico nel modo e a l momento opportuno (25).
Propenderebbe per un'interpretazione avvalorante un relativo candore sovietico una risposta basata esclus ivamente sul riscontro della corrispondenza diplomatica tra sovietici, americani e inglesi, dopo la conferenza, e nella fase di costituzione della Advisory Commission for Italy: un n egoziato durante il quale i sovietici mostrarono di esser persuasi che la loro sarebbe stata una funzione di reale contenuto politico, così come il fatto che a guidare la delegazione nella Commissione fosse designato il viceministro degli esteri, Vishinski. Tuttavia, accanto a questa linea esterna, i sovietici, dopo la conferen za di Mosca, avviarono una linea int erna di intervento in Italia che, attraverso il rientro di Palmiro Togliatti, gli incontri di Vishinski con Renato Prunas, a ll 'inizio di gennaio del 1944, e la successiva, clamorosa svolta di Salerno, mostrò di portare a risultati assai più rilevanti di quelli che, con le loro restrizioni, gli alleati occidentali avevano voluto evitare. Era la linea che, mediante l'inatteso riconoscimento diplomatico sovietico del governo Badoglio e la proposta di collaborazione lanciata dal Partito comunista italiano, doveva portare i comunisti per la prima volta
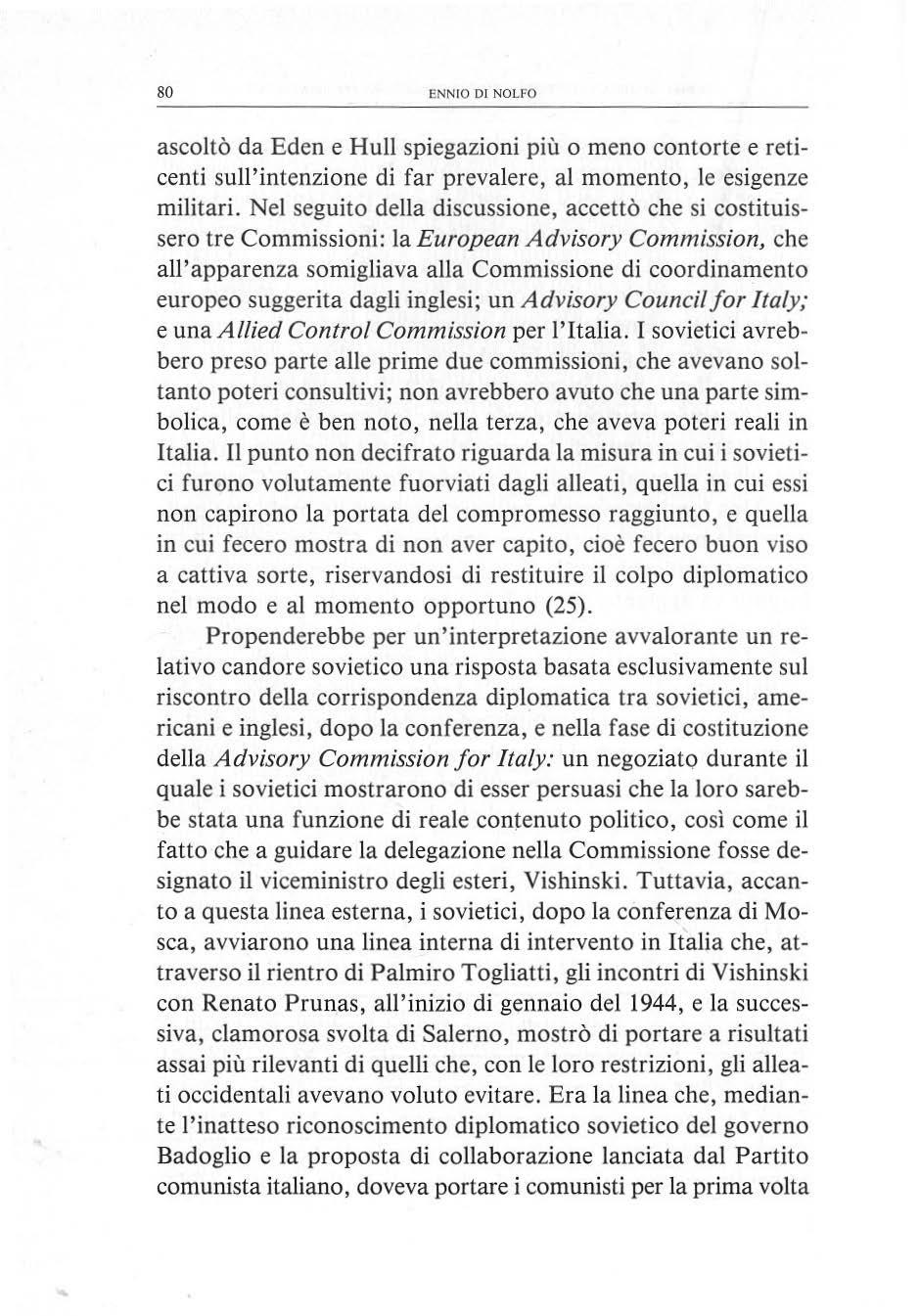
al potere in Italia. In tal modo i due aspetti che internazionalmente si era pensato di tutelare venivano aggirati: la vita sociale italiana era direttamente esposta all'attività di un forte partito comunista (del quale nessuno allora poteva valutare la disponibilità alla moderazione); e l'intervento sovietico nelle vicende italiane, impedito poiché avrebbe potuto turbare le retrovie di un esercito che combatteva, veniva attuato nella maniera più clamorosa e più carica di effetto che si potesse allora concepire (26).
(1) Cfr. infatti: M: TOSCANO, Dal 25 luglio all'B settembre (Nuove rivelazioni sugli armistizi fra l'Italia e le Nazioni Unite), Firenze 1966; D. ELLWOOD, L'alleato nemico, La politia dell'occupazione anglo-americana in Italia 1943- 1946, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 64-124; A. VARSORI, «Senior» o «Equa!» partner?, in «Rivista di studi politici internazionali», 1978, pp. 230 -60; A. VARSO RI, Italy, Britain and the Problem of a Separate Peace during the Second World War: 1940-43, in «The Journal of ltalian History», I, 1978, pp. 455 -91; E. AGAROSS1, La politica degli Alleati verso l'Italia nel 1943, in L'Italia fra tedeschi e alleati, a cura di R. De Felice, Bologna 1973, pp . 171 -219; B. ARCIDIACONO, L 'invasion de l'Italie dans /es relations interalliées . La Répétition générale: le Foreign Office et le problème du contro/e du territoire italien, 1943-1944, tesi di dottorato in corso di pubblicazione, presentata nel 1981 all'Jnstitut Universitaire de Hautes Etudes Internationales di Ginevra; B. ARCIDIACONO: The Dress Reharsal: The Foreign Office and the Contro! of Jtaly, 1943-1944 (espone alcune osservazioni portanti la dissertazione sopra citata); E. DI NOLFO, Montini e la Crisi italiana del '42, in «Il Veltro», 1978, pp . 247 -58;
(2) A. VARSORI, ltaly, Britain ecc. cit., pp . 455-67 e 488-90.
(3) Cfr.: M. TOSCANO, op. cit.; A. VAR SORI, op . ult. cit.; E. DI NOLF O, art. cit.
(4) Sugli aspetti generali della formula di resa incondizionata: A. ARMSTRONG, Unconditional Surrender, New Brunswick, 1961, R.G. O'CONNOR, Diplomacy for Victory. FDR and Unconditional Surrender, New York 1971; M. BALFOUR, Another Look at Unconditional Surrender, in «International Relation s» , 1970, pp. 719-36.
(5) Cfr.: R.M .W. KEMPNER, La pace separata di Stalin nel 1943, in «Rivista di st udi politici internazionali», 1951, pp. 85-88.
(6) Cfr. il doc pubblicato e commentato in: E. DI NOLFO, Dite al re Vittorio che l'America non vi abbandona, in « Il corriere della sera», 22 giugrto 1975, p. 11 .
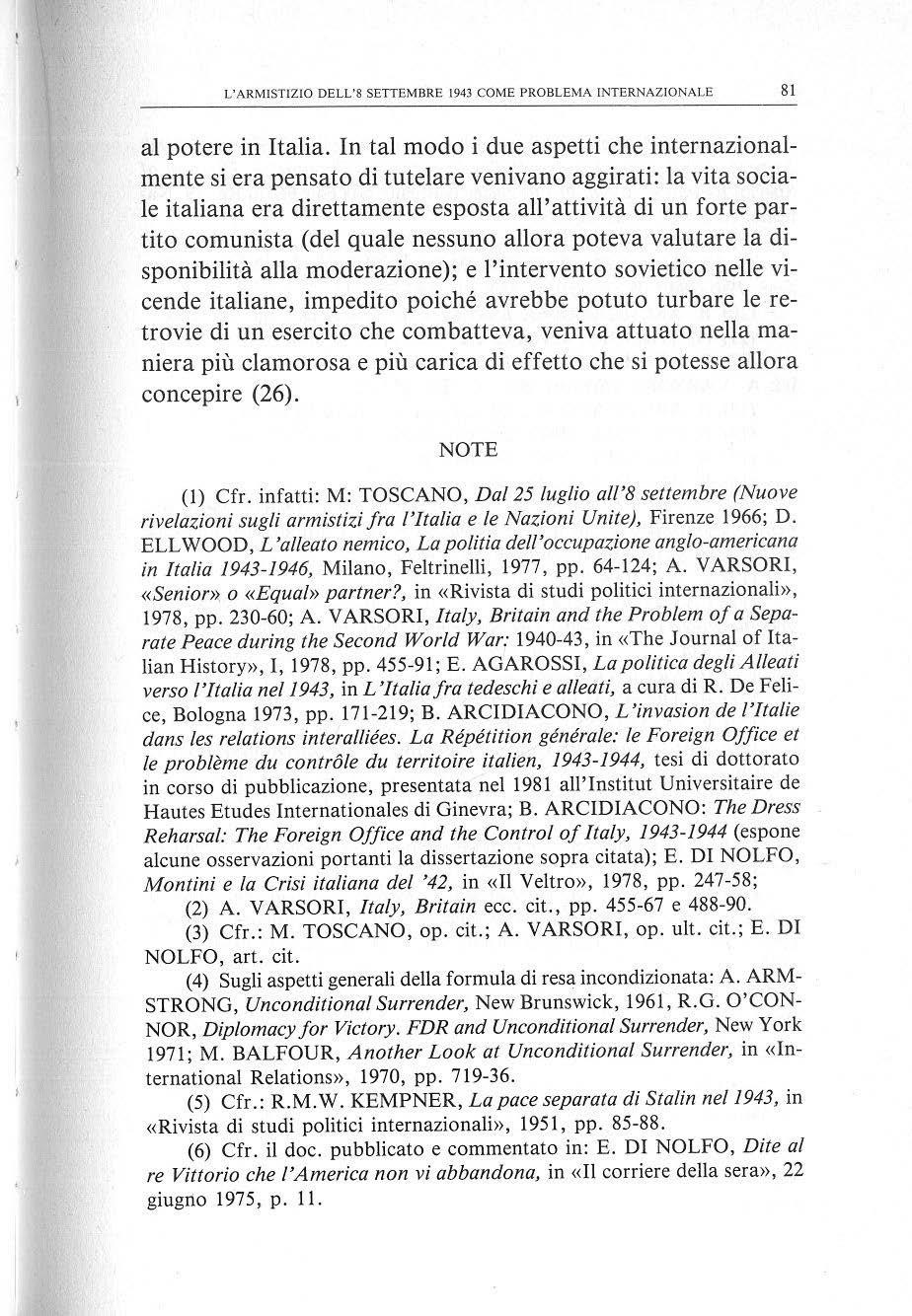
(7) Verbali di due riunioni rispettivamente tenute il 2 e il 9 gennaio 1943 da parte del Postwar Foreign Policy Preparation Committee, Division of Special Research, in Notter File rispettivamente box 64 e 66, in Rg . 59, National Archives, Washington.
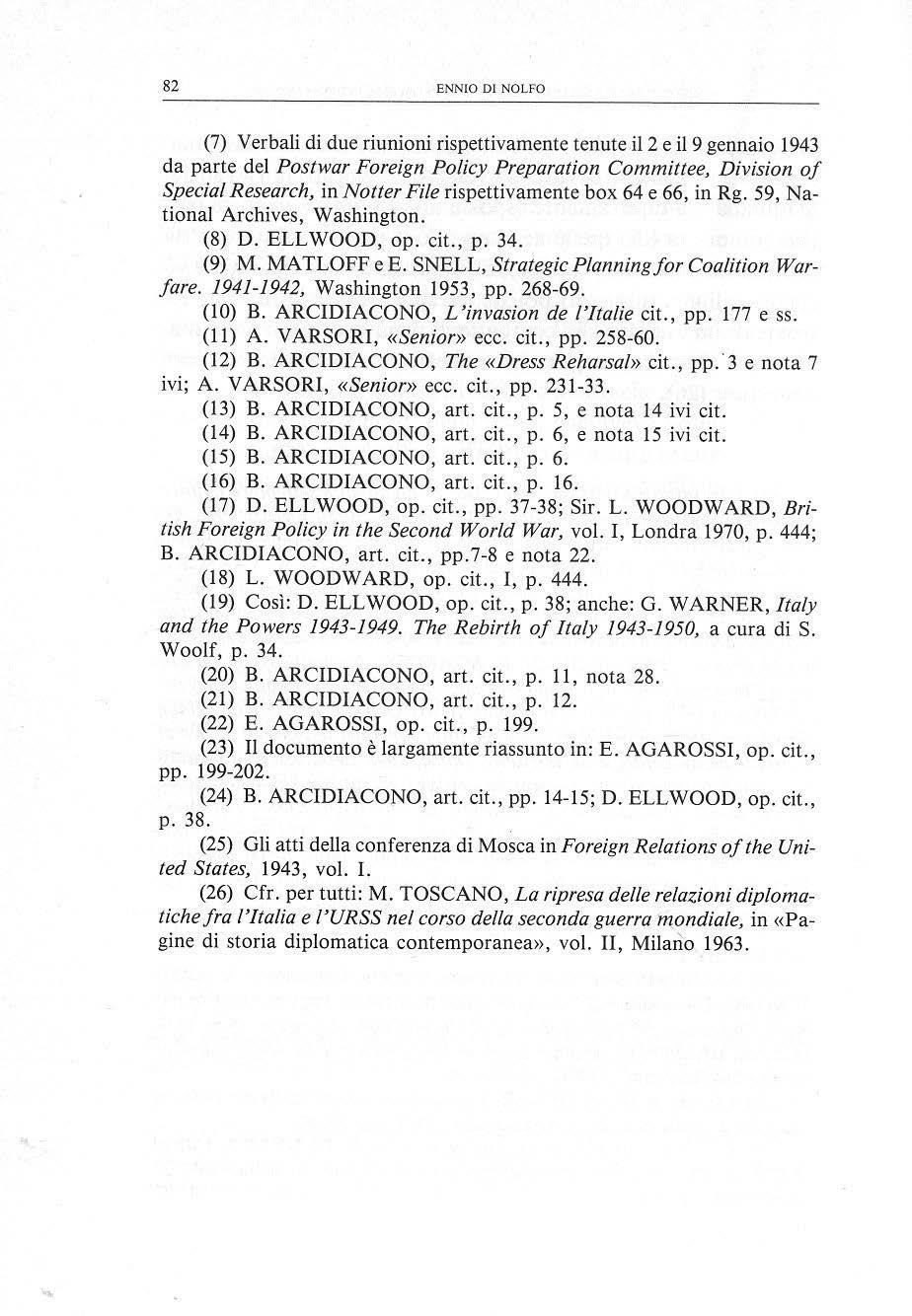
(8) D. ELLWOOD, op . cit., p . 34.
(9) M. MATLOFF eE. SNELL, Strategie Planningfor Coalition WarJare. 1941-1942, Washington 1953, pp . 268 -69.
(10) B. ARCIDIACONO, L'invasion de l'Jtalie cit., pp. 177 e ss.
(11) A. VARSORI, «Senior» ecc. cit., pp. 258-60 .
(12) B. ARCIDIACONO, The «Dress Reharsal» cit., pp. · 3 e nota 7 ivi; A. VARSORI, «Senior» ecc. cit., pp. 231-33 .
(13) B. ARCIDIACONO, art. cit., p. 5, e nota 14 ivi cit.
(14) B. ARCIDIACONO, art. cit., p. 6, e nota 15 ivi cit.
(15) B. ARCIDIACONO, art. cit., p. 6.
(16) B. ARCIDIACONO, art. cit., p. 16.
(17) D. ELLWOOD, op. cit., pp. 37-38; Sir. L. WOODWARD, British Foreign Policy in the Second World War, voi. I, Londra 1970, p . 444; B. ARCIDIACONO, art. cit., pp .7 -8 e nota 22.
(18) L. WOODWARD, op. cit., I, p. 444 .
(19) Così: D. ELLWOOD, op. cit., p. 38; anche: G. WARNER, ltaly and the Powers 1943- 1949. The Rebirth of ltaly 1943-1950, a cura di S. Woolf, p . 34 .
(20) B. ARCIDIACONO, art. cit., p 11, nota 28.
(21) B ARCIDIACONO, art. cit., p. 12.
(22) E. AGAROSSI, op . cit., p. 199 .
(23) Il documento è largamente riassunto in: E. AGAROSSI, op. c it., pp. 199-202 .
(24) B ARCIDIACONO, art. cit., pp 14-15; D. ELLWOOD, op. cit., p. 38.
(25) Gli atti della conferenza di Mosca in Foreign Relations of the Uniled States, 1943, vol. I.
(26) Cfr. per tutti: M. TOSCANO, La ripresa delle relazioni diplomatiche fra l'Italia e l'URSS nel corso della seconda guerra mondiale, in «Pagine di storia diplomatica contemporanea», vol. II, Milano 1963.
Dal 25 luglio all' 8 settembre 1943
1 - // 25 luglio 1943 ed i problemi del nuovo Governo Badoglio
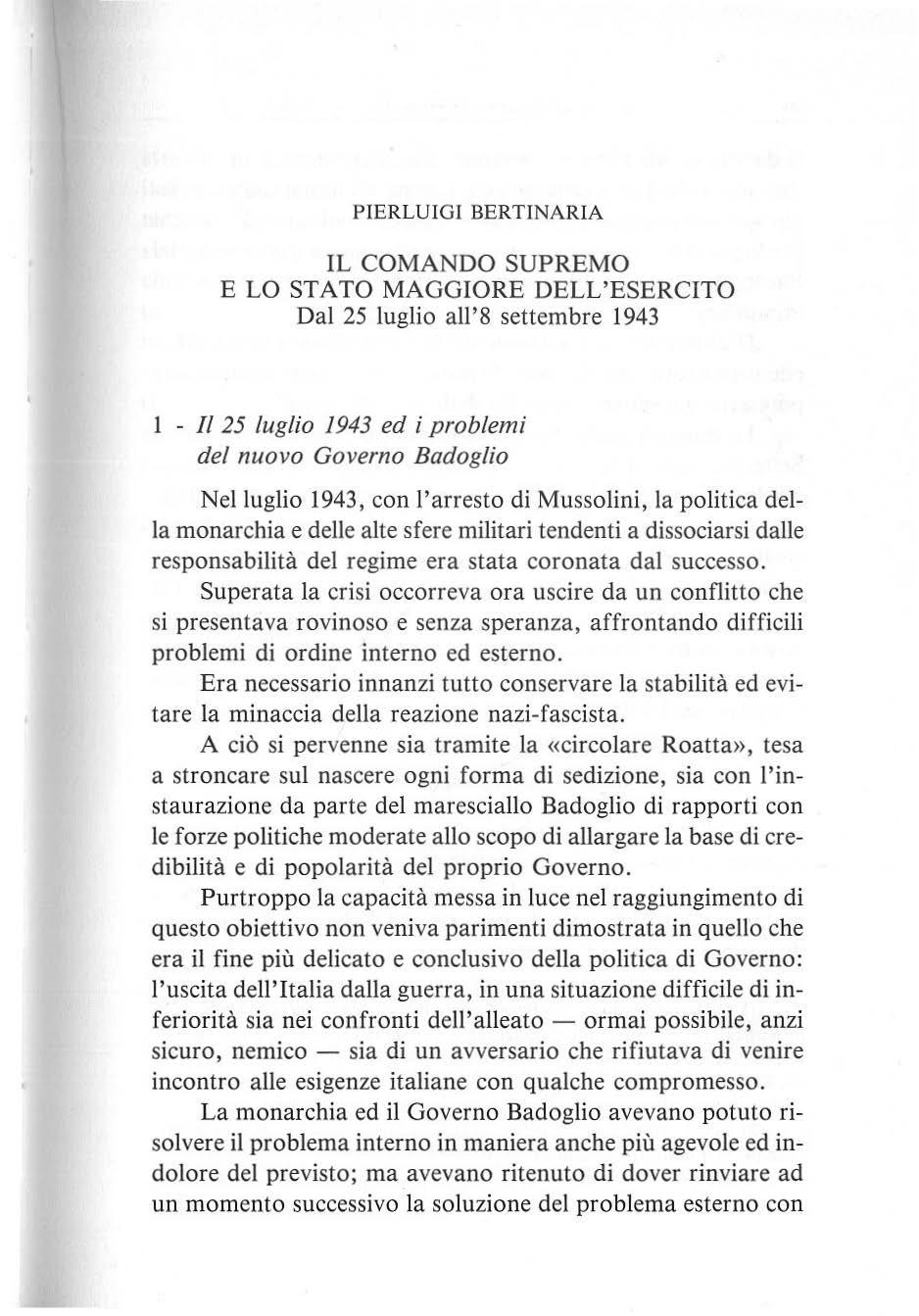
Nel lugl io 1943, con l'arresto di Mussolini, la politica della monarchia e delle alte sfere militari tendenti a dissociarsi dalle responsabi lità del regime era stata coronata dal successo.
Superata la crisi occorreva ora uscire da un conflitto che si presentava rovinoso e senza speranza, affrontando difficili problemi di ordine interno ed esterno.
Era necessario innanzi tutto conservare la stabilità ed evitare la minaccia della reazione nazi-fascista.
A ciò si pervenne sia tramite la «circolare Roatta», tesa a stroncare sul nascere ogni forma di sed izione, sia con l'instau razion e da parte del maresciallo Badoglio di rapporti con le forze politiche moderate allo scopo di allargare la base di credib ili tà e di popolarità del proprio Governo .
Pur tropp o la capacità messa in luce nel raggiungimento di questo obiettivo non veniva par imen ti dimostrata in quello che era il fine più delicato e conclusivo della politica di Governo: l'uscita dell'Italia dalla guerra, in una situazione difficile di inferio rità sia nei confronti dell'alleato - ormai possibile, anzi sicuro, nemico - sia di un avversario che rifiutava di venire incontro alle esigenze italiane con qualche compromesso.
La monarchia ed il Governo Badoglio avevano potu to riso lvere il problema interno in maniera anche più agevole ed indolore del previsto; ma avevano ritenuto di dover rinviare ad un momento successivo la sol u zione del problema esterno con
la decisione: «la guerra continua». Sarà però questa una affermazione ambigua e ingannevole poichè gli ital iani si attenderanno l'armistizio e la pace da un momento a ll'alt ro; i tedeschi predisporranno quanto necessario per assumere il controllo del Paese; gli alleati continueranno a premere per un resa ormai imm in ente.
D'altra parte la situazione del Governo Badoglio era difficile soprattutto perchè non disponeva delle forze militari che potessero garantire il rispetto delle sue decisioni.
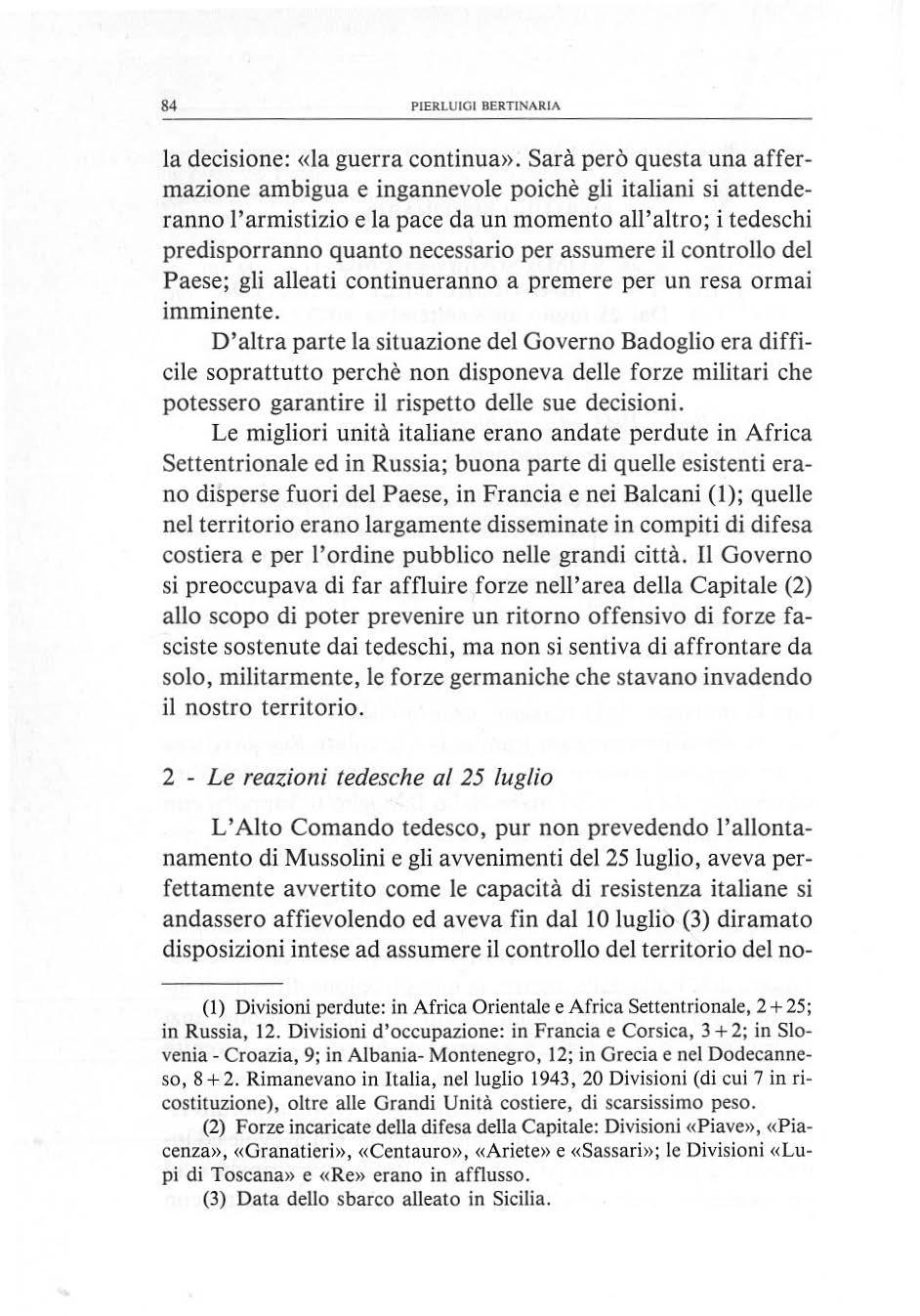
Le migliori unità italiane erano andate perdute in Africa
Settentrionale ed in Russia; buona parte di quelle esistenti erano disperse fuori del Paese, in Francia e nei Balcani (l); quelle nel territorio erano largamente disseminate in compi ti di difesa costiera e per l'ord in e pubblico nelle grandi città. Il Governo si preoccupava di far affl uire forze nell'area della Capitale (2) allo scopo di poter prevenire un ritorno offensivo di forze fasciste sostenut e dai tedesch i , ma non si sentiva di affrontare da solo, militarmente, le forze germaniche che stavano invadendo il nostro territorio.
L'Alto Comando tedesco, pur non prevedendo l'allontanamento di Mussolini e gli avvenimenti del 25 luglio, aveva perfettamente avvertito come le capacità di res i stenza italiane si andassero affievolendo e d aveva fin dal 10 luglio (3) di ramato disposizioni intese ad assumere il controllo del t erritorio del no-
(1) Divisioni perd ute: in Africa Orientale e Africa Settentrionale, 2 + 25; in Russia, 12. Divisioni d'occupazione: in Francia e Corsica, 3 + 2; in Slovenia - Croazia, 9; in Albania- Montenegro, 12; in Grecia e nel Dodecanneso, 8 + 2. Rimanevano in Ita lia, nel luglio 1943, 20 Div isioni (di cui 7 in ricos tituzione), oltre alle Grandi Unità costiere, di scarsissimo peso.
(2) Forze incaricate della difesa della Capitale: Divisioni « Pi ave», « Pi acenza», «G ranati er i», «Centauro», «Ariete» e «Sassa ri » ; le Divisioni «Lupi di T oscana» e «Re» erano in afflusso.
(3) Data dello sbarco all ea to in Sicilia.
stro Paese e delle nostre forze militari nel caso di un co llasso italiano. Sicchè, non appena al corrente degli avvenimen ti romani del 25 luglio e prima che Berlino accettasse, almeno in superficie, la decisione italiana di continuare la guerra al fianco della Germania, si verificarono, in Italia e fuori, numerosi incidentj che indicavano l'orientamen t o tedesco all'aggressione delle unità italiane.
Soprattutto, con la scusa di voler rafforzare la difesa contro sbarchi alleati e tutelare le vie di comunicazione, aveva inizio fin dal 26 luglio la penetrazione in Italia di Grandi Unità evidentemente tenute pronte per tale esigenza.
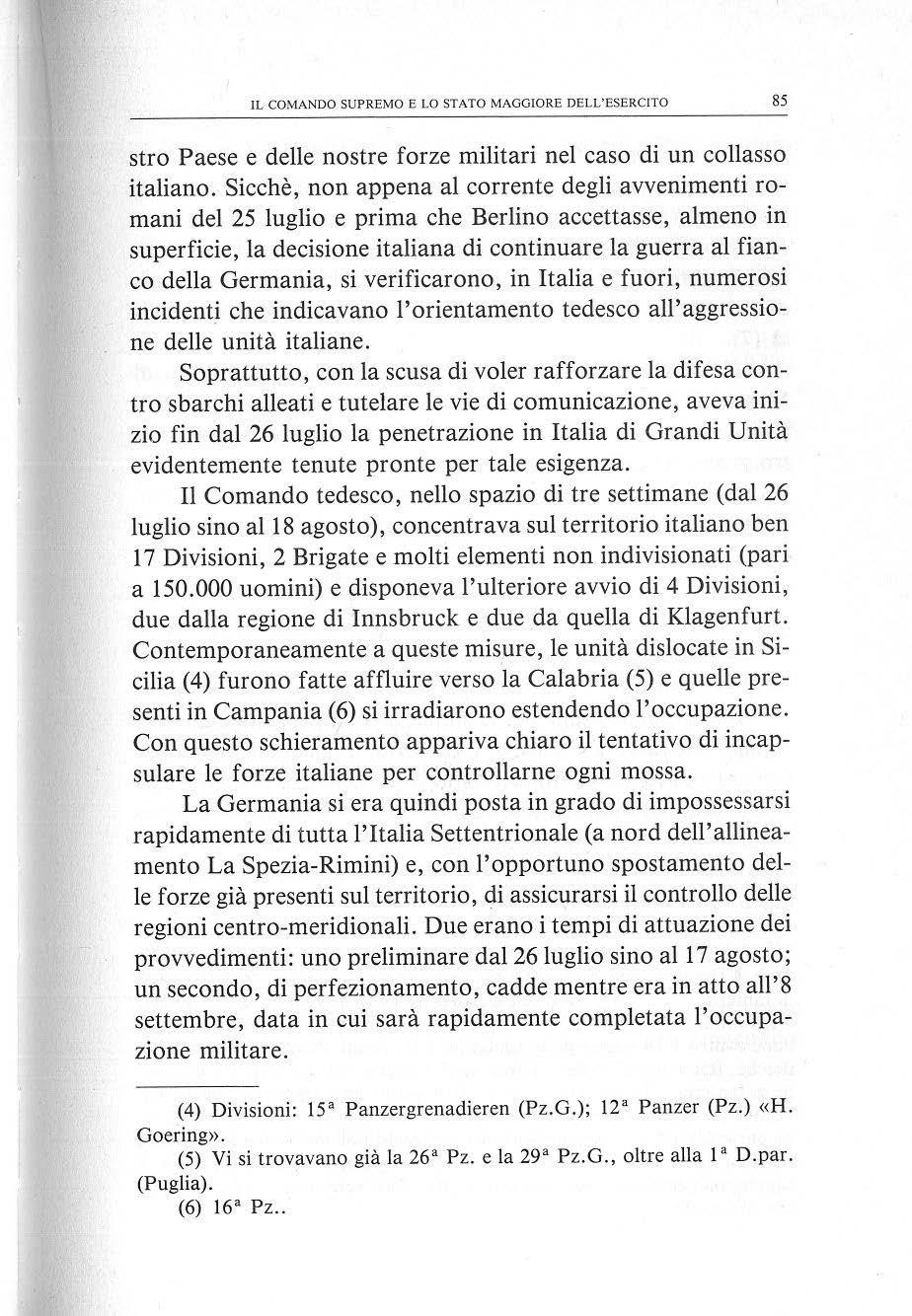
Il Comando tedesco, nello spazio di tre settimane (dal 26 luglio sino al 18 agosto), concentrava sul territorio italiano ben 17 Divisioni, 2 Brigate e molti elementi non indivisionati (pari a 150.000 uomini) e disponeva l'ulteriore avvio di 4 Divisioni, due dalla regione di Innsbruck e due da quella di Klagenfur t. Contemporaneament e a queste misure, le unità dislocate in Sicilia (4) furono fatte affluire verso la Calabria (5) e quelle presenti in Campania (6) si irradiarono estendendo l'occupazione. Con questo sch ieramento appariva chiaro il tentativo di incapsulare le fo rze italiane per controllarne ogni mossa.
La Germania si era quindi posta in grado di impossessarsi rapidamente di tutta l'Italia Settentrionale (a nord dell ' allineamento La Spezia-Rimini) e, con l'opportuno spostamento delle forze già presenti sul territorio, di assicurarsi il controllo delle regioni centro-meridionali. Due erano i t em pi di attuazione dei provvedimenti: uno preliminare dal 26 luglio sino al 17 agosto; un secondo, di perfezionamento, cadde mentre era in atto all'8 settembre , data in cui sarà rapidamente completata l'occupazione militare.
(4) Divisioni: 15a Panzergrenadieren (Pz.G.); 12a Pan ze r (Pz.) «H. Goering» .
(5) Vi si trovavano già la 26a Pz. e la 29 3 Pz.G., oltre alla I a O.p ar. (Puglia).
(6) 16 a Pz
Un raffronto fra le opposte forze presenti in Italia, effettuato non in rapporti numerici di Grandi Unità o di uomini, ma bensì in termini di coefficienti di potenza, fa notare una spiccata superiorità qualitativa e quantitativa germanica rappresentata da carri armati, semoventi, mezzi blindati, armi automatiche, controcarri ed artiglierie, riuniti in unità a elevata mobilità (7).
Nel contempo, ed entro quarantotto ore dalla caduta di Mussolini, il piano «Italia», definito in codice «Operazione Alarico», veniva predisposto nei particolari ed articolato in quattro grosse azioni:
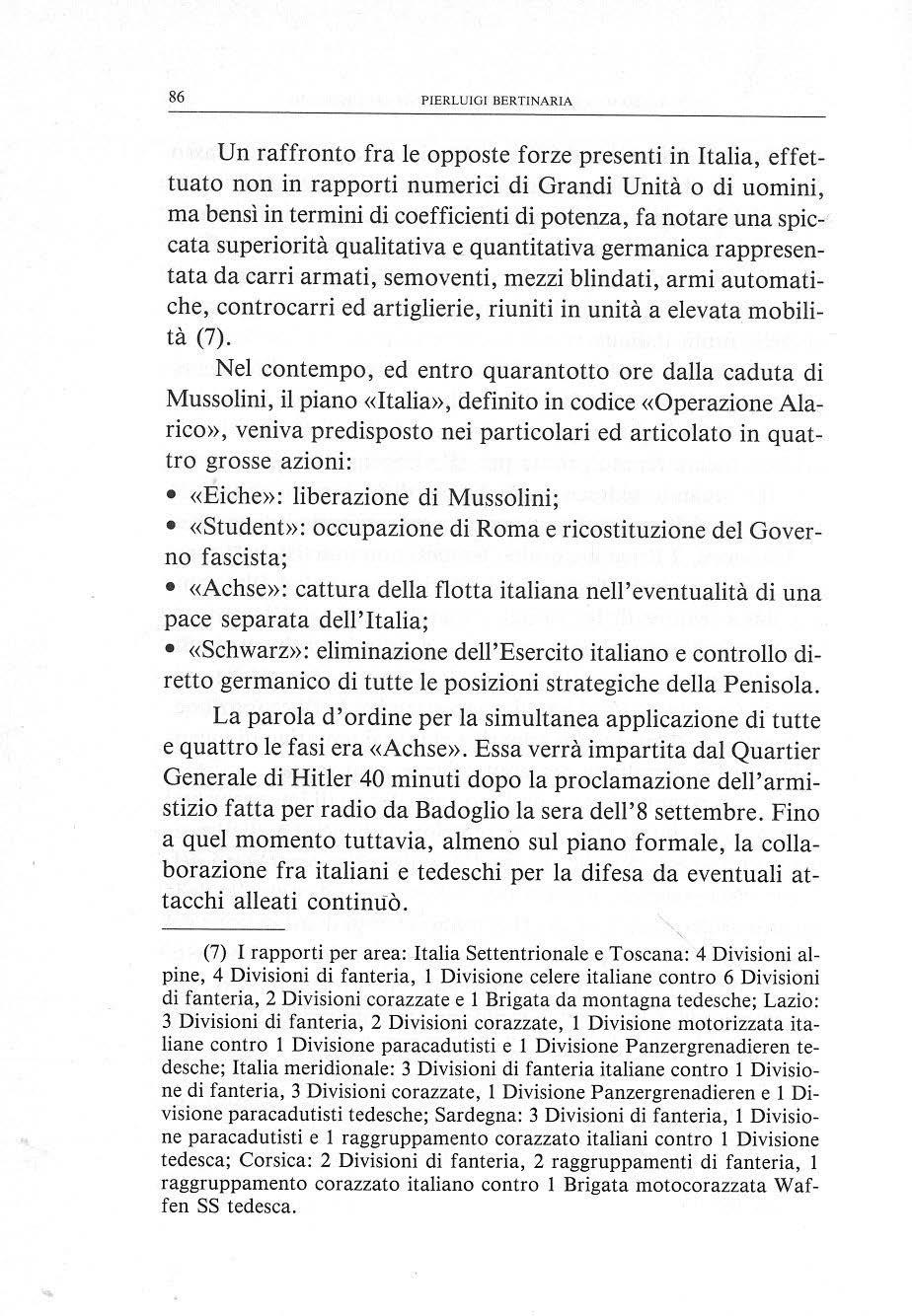
• «Eiche»: liberazione di Mussolini;
• «Student»: occupazione di Roma e ricostituzione del Governo fascista;
• «Achse»: cattura della flotta italiana nell'eventualità di una pace separata dell'Italia;
• «Schwarz»: eliminazione dell'Esercito italiano e controllo diretto germanico di tutte le posizioni strategiche della Penisola. La parola d'ordine per la simultanea applicazione di tutte e quattro le fasi era «Achse>>. Essa verrà impartita dal Quartier Generale di Hitler 40 minuti dopo la proclamazione dell'armistizio fatta per radio da Badoglio la sera dell'8 settembre. Fino a quel momento tuttavia, almeno sul piano formale, la collaborazione fra italian i e tedeschi per la difesa da eventuali attacchi alleati continùò.
(7) I rapporti per area: Italia Settentrionale e Toscana : 4 Divisioni alpine, 4 Divisioni di fanteria, 1 Divisione celere italiane contro 6 Divisioni di fanteria, 2 Divisioni corazzate e 1 Brigata da montagna tedesche; Lazio: 3 Divisioni di fanteria, 2 Divisioni corazzate, 1 Divisione motorizzata italiane contro 1 Divisione paracadutisti e 1 Divisione Panzergrenadieren tedesche; Italia meridionale: 3 Divisioni di fanteria italiane contro 1 Divisione di fanteria, 3 Division i corazzate, l Divisione Panzergrenadieren e 1 Divis ione paracadutisti tedesche; Sardegna : 3 Di visioni di fanteria, 1 Divisione paracadutisti e 1 raggruppam ento corazzato italiani contro 1 Divisione tedesca; Corsica: 2 Divisioni di fanteria, 2 raggruppamenti di fanteria, 1 raggruppamento corazzato italiano contro 1 Brigata motocorazzata Waffen SS tedesca.
Ai primi di settembre la situazione militare tedesca era dunque la seguente:
• Gruppo d'Armate «B» (feldmaresciallo Rommel) su 8 Divisioni dislocato a nord con il compito di assicurare il controllo dell'Ita lia Settentrionale (LXXXVII Corpo d'Armata in Piemonte e Liguria; LI Corpo d'Armata in Lombardia ed Emilia; XVI Corpo d'Armata nel Veneto e Venezia Giulia);
• Gruppo di Armate «C» (feldmaresciallo Kesselring) su 9 Divisioni nel resto della Penisola, articolato in:
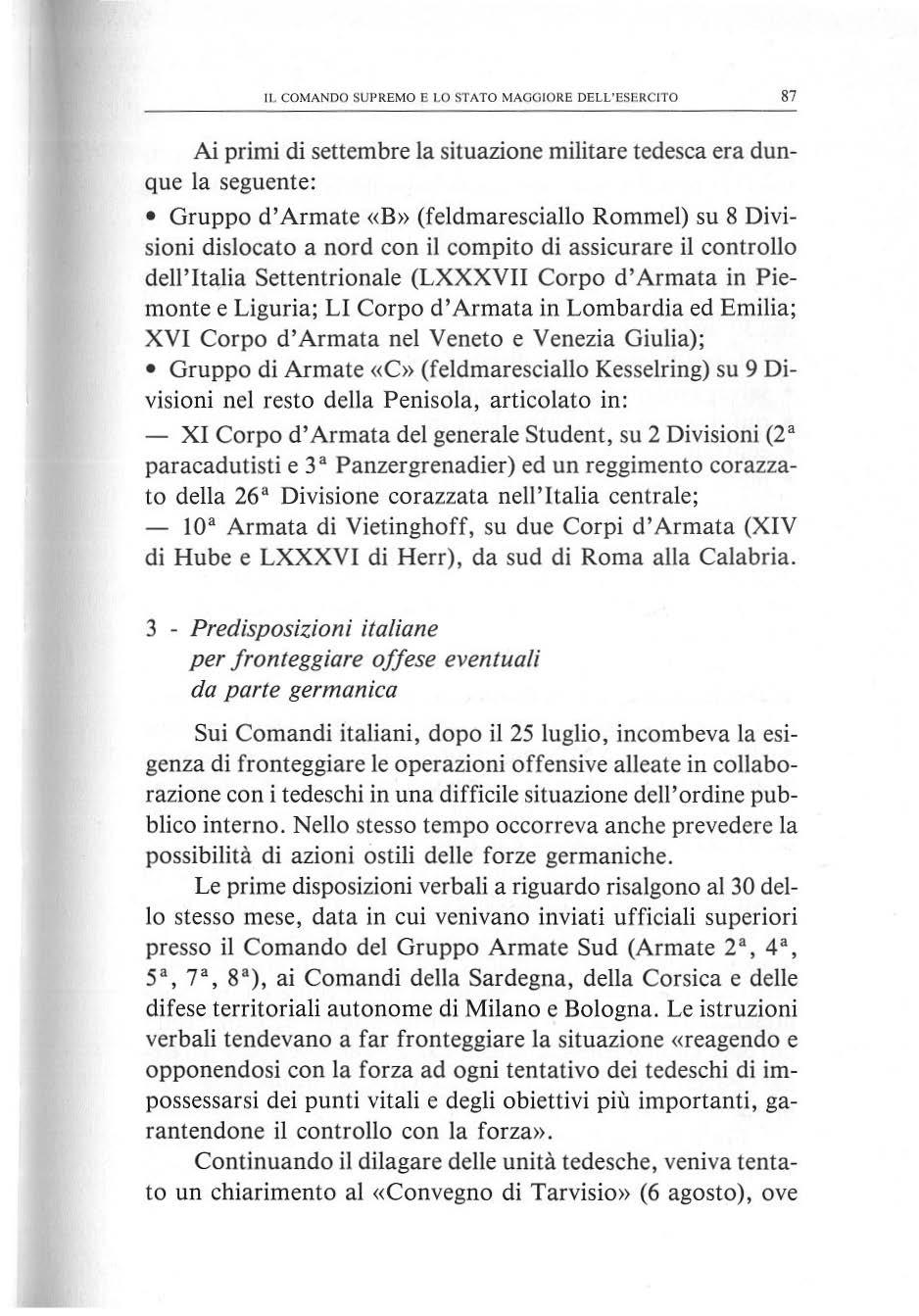
- XI Corpo d'Armata del generale Student, su 2 Div isioni (2 a paracadutisti e 3a Panzergrenadier) ed un reggimento corazzato della 26a Divisione corazzata nell'Italia centrale;
- 10a Armata di Vietinghoff, su due Corpi d'Armata (XIV di Hube e LXXXVI di Herr), da sud di Roma alla Calabria.
Sui Comandi italiani, dopo il 25 luglio, incombeva la esigenza di fronteggiare le operazioni offensive alleate in collaborazione con i tedeschi in una difficile situazione dell'ordine pubblico interno. Nello stesso tempo occorreva anche prevedere la possibilità di azioni ostili delle forze germaniche.
Le prime disposizioni verbali a riguardo risalgono al 30 dello stesso mese, data in cui venivano inviati ufficiali superiori presso il Comando del Gruppo Armate Sud (Armate 2 3 , 43, 5a, 7 3 , 8 3 ), ai Comandi della Sardegna, della Corsica e delle d ifese t erritori ali auton o me di M il a n o e Bologna. Le istruzioni verbali tendevano a far fronteggiare la situazione «reagendo e opponendosi con la forza ad ogni tentativo dei tedeschi di impossessarsi de i punti vitali e degli o b iettivi più importanti, garantendone il controllo con la forza».
Continuando il dilagare delle unità tedesche, veniva tentato u n chiarimento al «Convegno di Tarvisio» (6 agosto), ove
si giungeva alla determinazione che l'arrivo delle truppe germaniche s arebbe continuato, con l ' orientamento di permanere nel nord Italia.
Il 10 agosto lo Stato Maggiore del Regio E sercito, ri scontrando una sempre maggiore ingerenza tedesca, diramava l'ordine 111 C.T. confermando ed ampliando le dir ettive verbali de l 30 luglio.
L'ordine conteneva disposizioni per:
• salvaguardare i Comandi dalle sorprese;
• rinforzare la prote z ione degli impianti più importanti;
• controllare i movimenti delle truppe tedesche ;
• predis porre colpi di mano contro elementi vitali delle forz e occupanti.
In particola re, le azioni di for za do vev ano compiers i o su ordine del Centro o, in difetto di collegamenti , di iniziativa qualora gli atti o stili fo sse ro sta t i di na t ura colle ttiva (e non di violenza individuale).
Dopo il successivo «Convegno di Bologna » (15 ago sto) si capì chiaramente che la Germania , più che difendere la Penisola da sbarchi anglo-americani, intendeva attuare l'occupazione del Paese. Lo Stato Maggiore del Regio Esercito di sponeva quindi lo spostamento di numerose unità col criterio di salvaguardare almeno le areee più sens ibili e più minacciat e: l'Alto Adige , la zona di La Spezia e la Capitale.
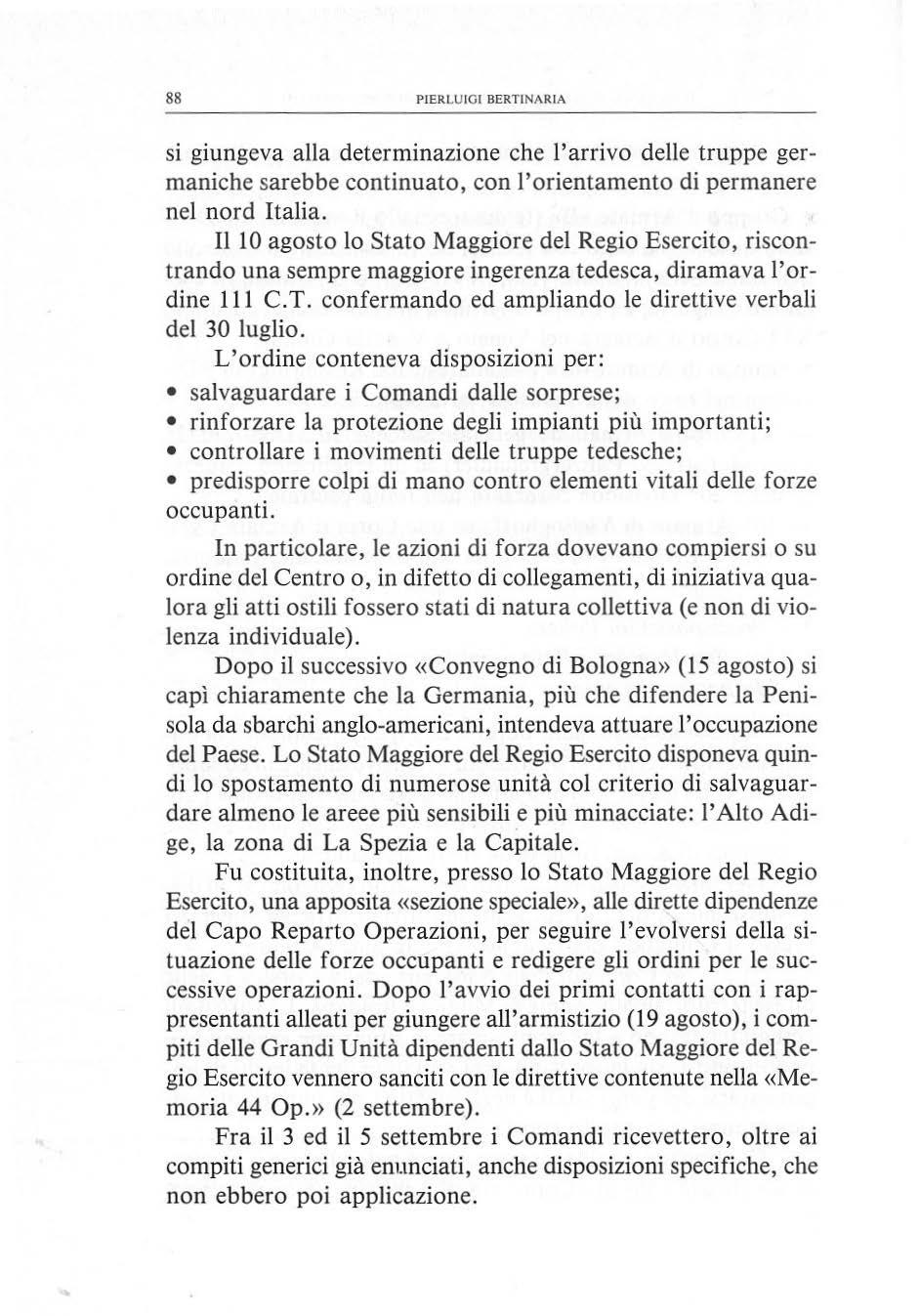
Fu costituita, inoltre, presso lo Stato Maggiore del Regio Esercito , una apposita «sezione speciale», alle dirette dip endenze del Capo Reparto Operazioni, per seguire l'evolversi della situazione delle forze occupanti e redigere gli ordini per le successive operazioni. Dopo l'avvio dei primi contatti con i rappresentanti alleati per giungere all'armistizio (19 agosto), i compiti delle Grandi Unità dipendenti dallo Stato Maggiore del Regio Esercito vennero sanciti con le direttive contenute nella «Memoria 44 Op. » (2 settembre).
Fra il 3 ed il 5 settembre i Comandi ricevettero, oltre ai compiti generici già enunciati, anche disposizioni s pecifiche , ch e non ebbero poi applicazione.
Il 6 settembre il Comando Supremo, in seguito alla firma dell'armistizio avvenuta il 3 settembre, emanava il promemoria n. 1 diretto ai Capi di Stato Maggiore delle tre Forze Armate ed il promemoria n. 2 per i Comandanti delle forze alle dirette dipendenze (che però non pervenne in tempo al Gruppo Armate E st ed al Comando Forze Armate Egeo). Infine, lo stesso giorno, lo Stato Maggiore del Regio Esercito diramò ai Comandi dipendenti la «Memoria 45 Op.» contenente norme complementari e chiarificatrici di quelle generali della «Memoria 44 Op.». In essa si prevedevano azioni in concorso con la marina e l'aeronautica con t ro l'organiz zazione militar e germanic a .
Tra il 3 ed il 7 settembre lo Stato Maggiore del Regio Esercito provvedeva inoltre ad emanare ulteriori direttive per la dif esa di Roma.
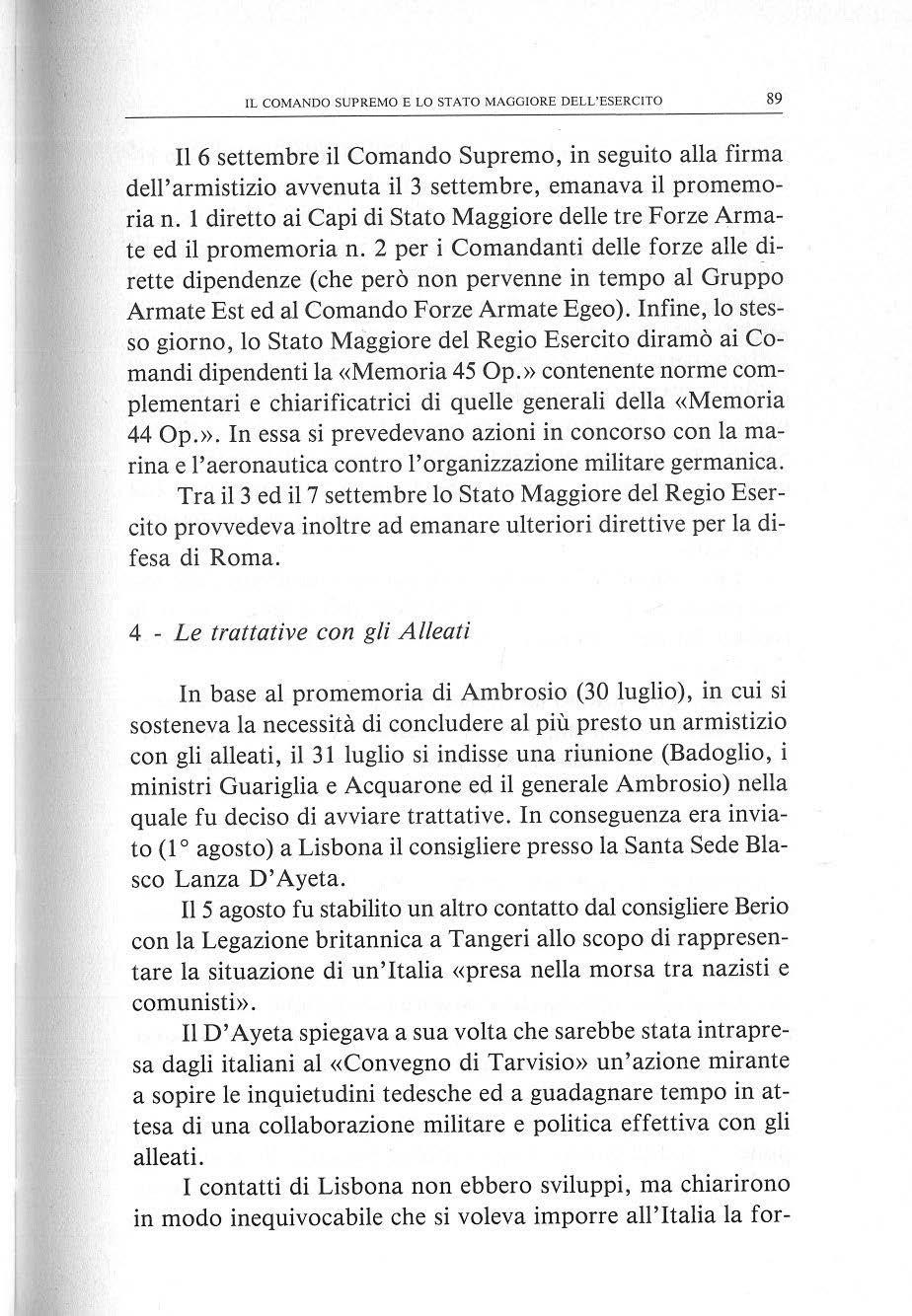
In base al promemoria di Ambro sio (30 luglio), in cui si sosteneva la necessità di concludere al più presto un armistizio con gli alleati, il 31 luglio si indisse una riunione (Badoglio, i ministri Guariglia e Acquarone ed il generale Ambrosio) nella quale fu deciso di avviare trattative. In conseguenza era inviato (1 ° agosto) a Lisbona il consigliere presso la Santa Sede Blasco Lanza D' Ayeta.
Il 5 agosto fu stabilito un altro contatto dal consigliere Berio con la Legazione britannica a Tangeri allo scopo di rappresentare la situazione di un'Italia «presa nella morsa tra nazisti e comunisti» .
Il D' Ayeta spiegava a sua volta che sarebbe stata intrapresa dagli italiani al «Convegno di Tarvisio» un'azione mirante a sopire le inquietudini tedesche ed a guadagnare tempo in attesa di una collaborazione militare e politica effettiva con gli alleati.
I contatti di Lisbona non ebbero sviluppi, ma chiarirono in modo inequ ivocabile che si voleva imporre all'Italia la for-
mula della «resa incodizionata». Tale intendimento veniva ribadito anche nei contatti avuti da Berio a Tangeri.
A seguito di questi colloqui, Badoglio, verso il 10 agosto, decideva di indagare sulle possibilità di un armistizio di carattere esclusivamente militare ed affidava l'incarico, su proposta di Ambrosio, al generale Castellano, cui venivano rilasciate direttive verbali.
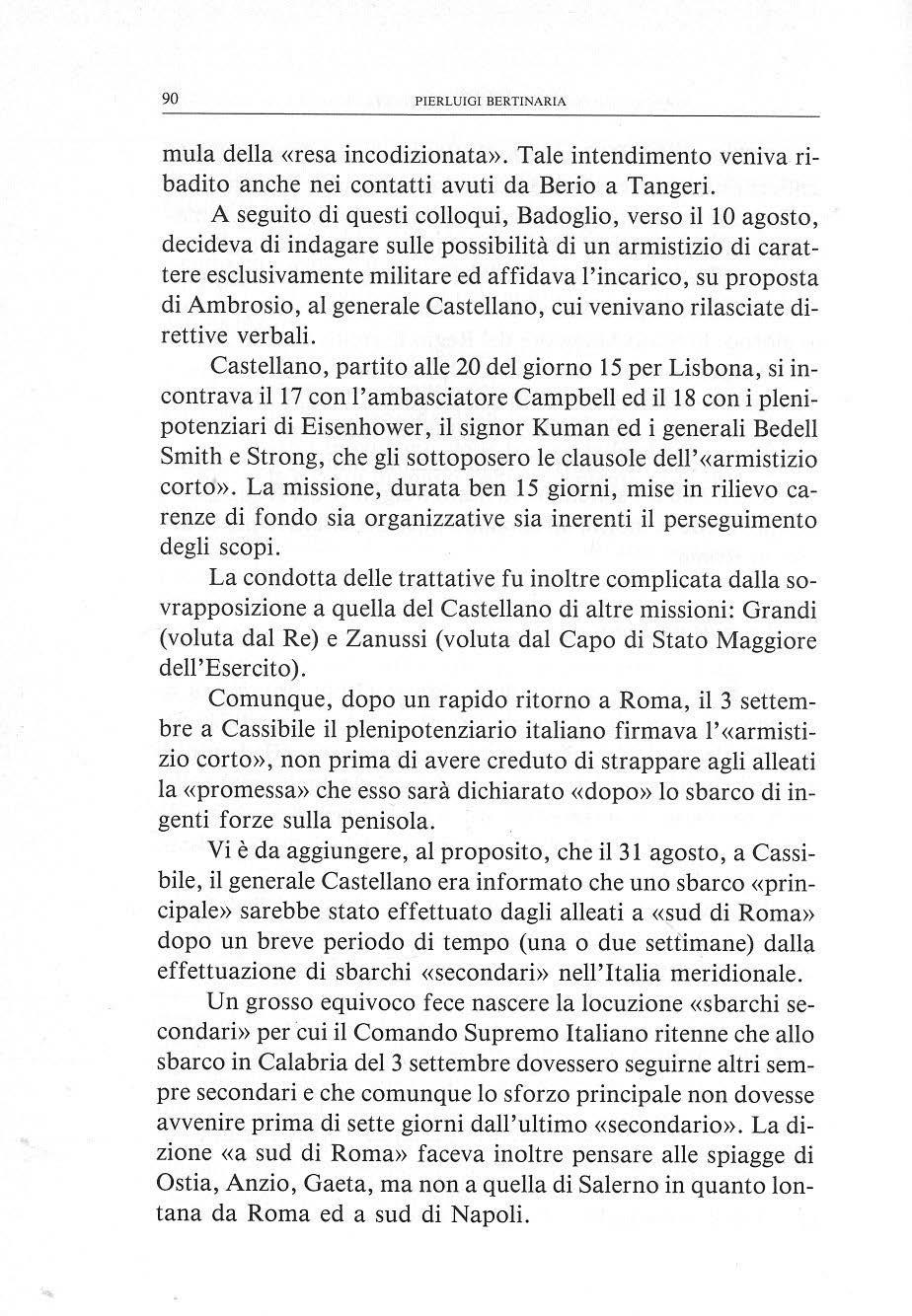
Castellano, partito alle 20 del giorno 15 per Lisbona, si incontrava il 17 con l'ambasciatore Campbell ed il 18 con i plenipotenziari di Eisenhower, il signor Kuman ed i generali Bedell Smith e Strong, che gli sottoposero le clausole dell' <<armistizio corto». La missione, durata ben 15 giorni, mise in rilievo carenze di fondo sia organizzative sia inerenti il perseguimento degli scopi.
La condotta delle trattative fu inoltre complicata dalla sovrapposizione a quella del Castellano di altre missioni: Grandi (voluta dal Re) e Zanussi (voluta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito).
Comunque, dopo un rapido ritorno a Roma, il 3 settembre a Cassibile il plenipotenziario it aliano firmava l' «armistizio corto», non prima di avere creduto di strappare agli alleati la «promessa» che esso sarà dichiarato <<dopo» lo sbarco di ingenti forze sulla penisola.
Vi è da aggiungere, al proposito, che il 31 agosto, a Cassibile, il generale Castellano era informato che uno sbarco «principale» sarebbe stato effettuato dagli alleati a «sud di Roma» dopo un breve periodo di tempo (una o due settimane) dalla effettuazione di sbarchi «secondari» ne ll 'Italia meridionale.
Un grosso equivoco fece nascere la locuzione «sbarchi secondari» per cui il Comando Supremo Italiano ritenne che allo sbarco in Calabria del 3 settembre dovessero seguirne altri sempre secondari e che comunque lo sforzo principale non dovesse avvenire prima di sette giorni dall ' ultimo «secondario». La dizione «a sud di Roma» faceva inoltre pensare alle spiagge di Ostia, Anzio, Gaeta, ma non a quella di Salerno in quanto lontana da Roma ed a sud di Napoli.
Le trattative per l'armistizio evidenziarono una carenza di strategia e di idee. Le scarse ed imprecise direttive date al generale Castellano indicano come - a distanza dal colpo di Stato - non fosse stata ancora definita una adeguata e fattibile linea da seguire per porre fine alla guerra. Non si teneva affatto conto delle richieste degli alleati e si evitava di parlare di resa senza condizioni o di armistizio ribadendo la richiesta di 'informazioni e di accordi militari.
Si aveva così la pretesa di condizionare una macchina da guerra complessa e multiforme come quella anglo-americana.
Tutti i tentativi per modificar.e l'atteggiamento all eato fallirono e l'accettazione delle condizioni fu decis a il 1° settembre con l'approvazione del Re, che in definitiva ved eva salvagua rdati tutti i suoi obiettivi di fondo.
Il Consiglio dei Ministri non fu m ai informato della vicenda.
Tuttavia, se i giudizi più iml)lediati furono tutti assai critici nei riguardi del vertice politico e militare italiano, con gravi ripercussioni di ordine politico, le valutazioni odierne tendono a mettere in luce le condizioni obiettive e le colpevolezze anche da parte anglo-americana.
Eisenhower ebbe a deplorare la mancanza di iniziativa e di flessibilità alleata nonchè i veri e propri inganni verso gli inviati italiani per un eccesso di sospettosità nei nostri confronti: ma è soprattutto oggi comprovato il malvolere britannico, specie del ministro Eden, che frappose ostacoli a qualsiasi contatto che potesse facilitare un passaggio dell'Italia a condizioni di cooperazione ed alleanza.
La diplomazia britannica intendeva eliminare definitivamente qualsiasi influenza o pericolo italiano nel Mediterraneo e nel Mar Rosso; voleva non soltanto quindi l'uscita dell'Italia dal conflitto ma intendeva soprattutto ostacolarne una ripresa di influenza politica, anche in relazione all'appoggio inglese alle

rivendicazioni austriache, jugoslave e greche. Mentre, in definitiva, la propaganda degli alleati tendeva a dissoci are il popolo italiano dal regime fascista proclamando quest'ultimo so ltanto colpevole di una politica dissennata, nella realtà essi perseguivano una politica che penalizzava l'intero Paese per la guerra portata all' Imp ero britannico.
Dopo la firma dell'armistizio il Governo e l'Alto Comando italiano non ritenevano di promuovere altri provvedimenti oltre a quelli delineati. Viene da alcune parti sostenuto che essi furono sorpresi da un anticipo dell'annuncio dell'armistizio all'8 settem bre anziché al 12, come in vece ritenuto a seguito dei suggerimenti del generale Castellano.
La tesi è sostenibile solo in parte; appare infatti chiaro che la limitazione delle attività è stata conseguente ad una voluta r icerca di una maggiore sicurezza dell'operazione attraverso una esasperata tut ela del segreto. Si temevano infatti le reazioni tedesche ad una eventuale conoscenza anticipata dell'avvenuta firm a di un armistizio; e per evitare fughe di notizie il Capo del Governo non ne fece menzione nemmeno ai ministri, mentre le maggiori autorità militari non diedero alcuna disposizione che potesse in qualche modo essere indicativa .
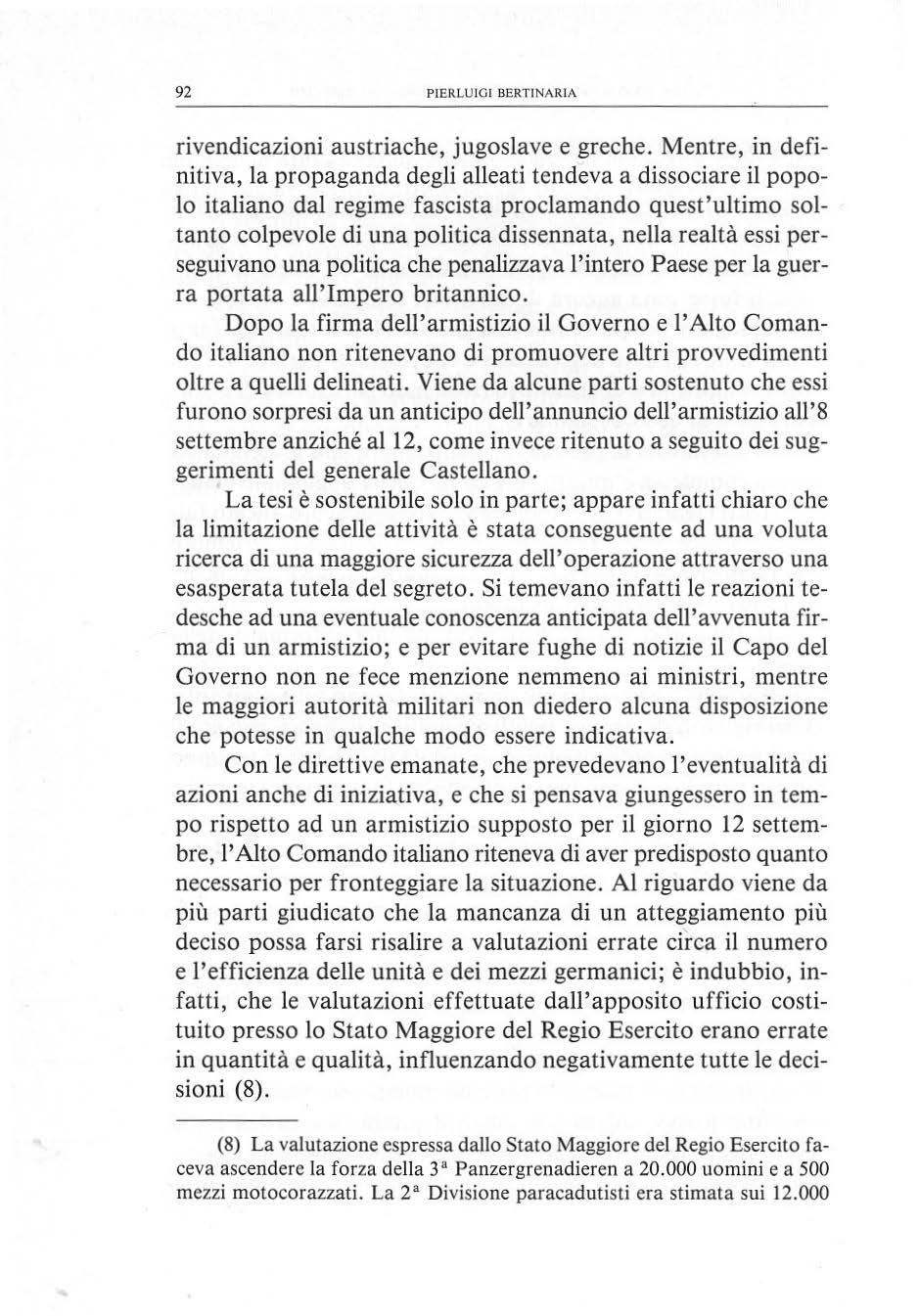
Con le direttive emanate, che prevedevano l'ev entualità di azioni anche di iniziativa, e che si pensava giungessero in tempo rispetto ad un arm isti zio supposto per il giorno 12 settembre, l'Alto Comando italiano riteneva di aver predisposto quanto ne cessario per fronteggiare la situazione. Al riguardo viene da più parti giudicato che la mancanza di un atteggiamento più deciso possa farsi risalire a valutazioni errate circa il num ero e l'efficienza delle unità e dei mezzi germanici; è indubbio, infatti, che le valutazioni effettuate dall'apposito u ffici o costituito presso lo Stato Maggiore del Regio Esercito erano errate in quantità e qualità, influenzando neg a tivamente tutte le decisioni (8).
(8) La valutazione espressa dallo Stato Maggiore del Regio Esercito faceva ascend ere la for za della 3a Panzergrenadieren a 20 . 000 uomini e a 500 mezzi motocorazzati. La 2 8 Di visione paracadutisti era stimata sui 12.000
Come si è detto, altro elemento condizionante fu la preoccupazione di mantenere il segreto, che superò i limiti di una giusta e oculata riservatezza; ciò si ripercosse sull'adozione e diramazione di opportune misure, creando ulteriore disorientamento e perplessità nei Comandi periferici.
In questa fase nessun ordine scritto fu diramato dai Comandi Centrali: per la reazione ai tedesch i e per la difesa di Roma furono sempre impartite direttive verbali. Solo nella prima settimana di agosto lo Stato Maggiore del Regio Esercito aveva diramato il foglio 111 CT.
Tranne questo ordine le altre disposizioni non raggiunsero, o raggiunsero con notevole ritardo, le unità cui erano indirizzate.
Il 22 e 26 agosto Ambrosio ordinò a Roatta di preparare direttive per i Comandi dipendenti al fine di assegnare loro compiti particolari in funzione antigermanica. Ma la «Memoria 44» divenne definitiva solo la notte del 2 settembre, quando Castellano aveva avuto già due incontri con gli alleati (Lisbona e Cassibile) e aveva già recapitato la bozza dell'armistizio. La procedura adottata per la diramazione della <<Memoria» ne prevedeva la distruzione dopo la lettura e dopo aver preso nota della parte di competenza.
Putroppo anche l'originale fu distrutto presso lo Stato Maggiore del Regio Esercito e non ne rimane che la ricostruzione redatta da parte del responsabile della compilazione (tenente colonnello Torsiello). Pur assegnando compiti di carattere offensivo contro i tedeschi, le disposizioni non compromettevano eventuali azioni antialleate, nè accennavano alla possibilità di un armistizio.
uomini. In effetti i dati attuali non concordano con le stime dello Stato Maggiore del Regio Esercito al quale è attribuita una valutazione errata in eccesso. I 60 carri della 3a Panzergrenadieren, gli unici nel Lazio, erano a protezione dell"Alto Comando tedesco del Sud a Frascati per cui alla 3a Panzergrenadieren è più facile attribuire i soli 37 cannoni semoventi d'assalto in organico La lunga battuta di arresto a tale Grande Unità provocata dall'«Ariete» dimostra l'attendibilità di questa ultima valutazione.
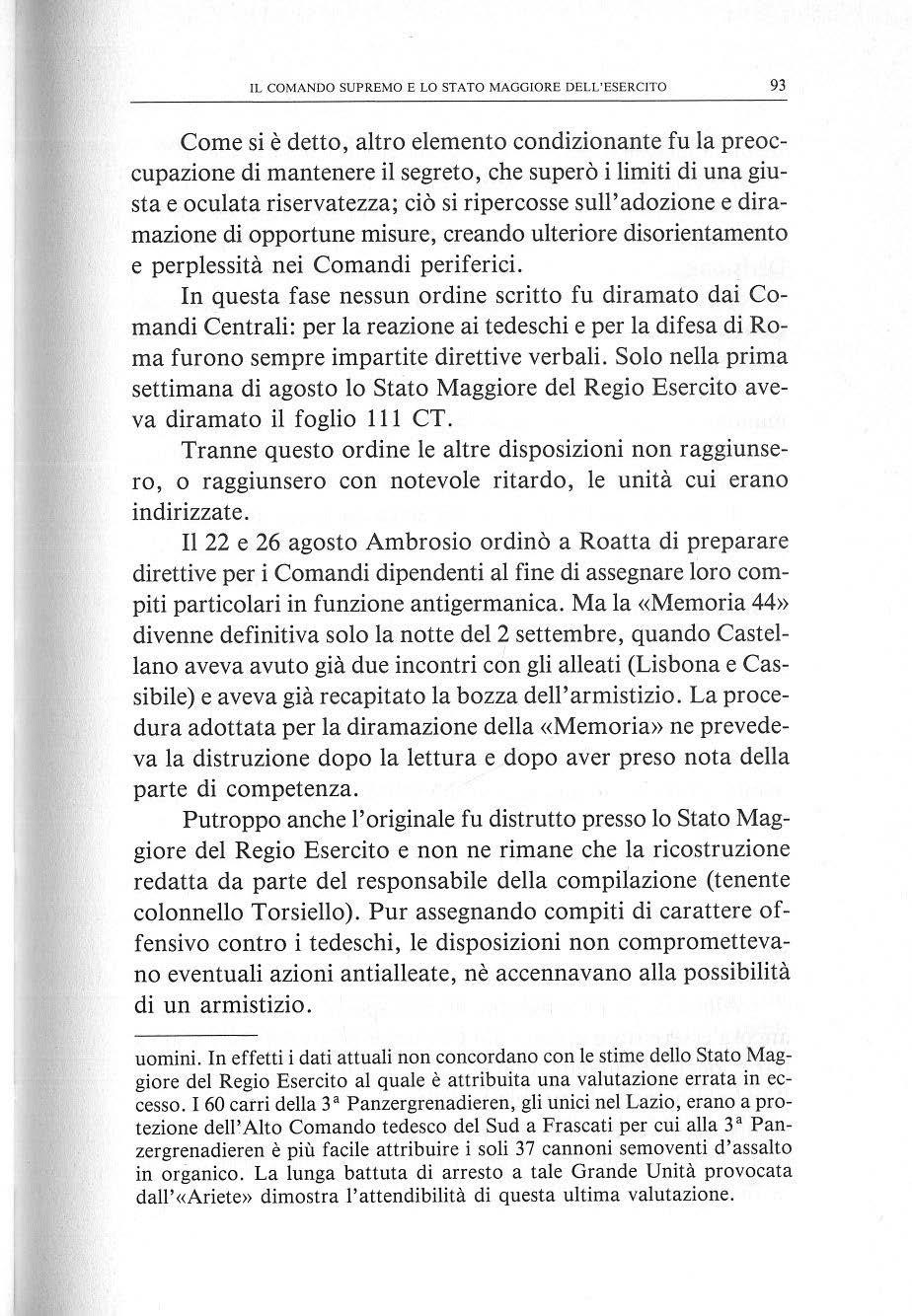
Si può aggiungere che non si teneva nel debito conto:
• l'effettiva consistenza delle forze;
• la necessità e la possibilità di raggruppare le unità;
• i compiti di carattere territoriale e di sicurezza affidati a molte Divisioni;
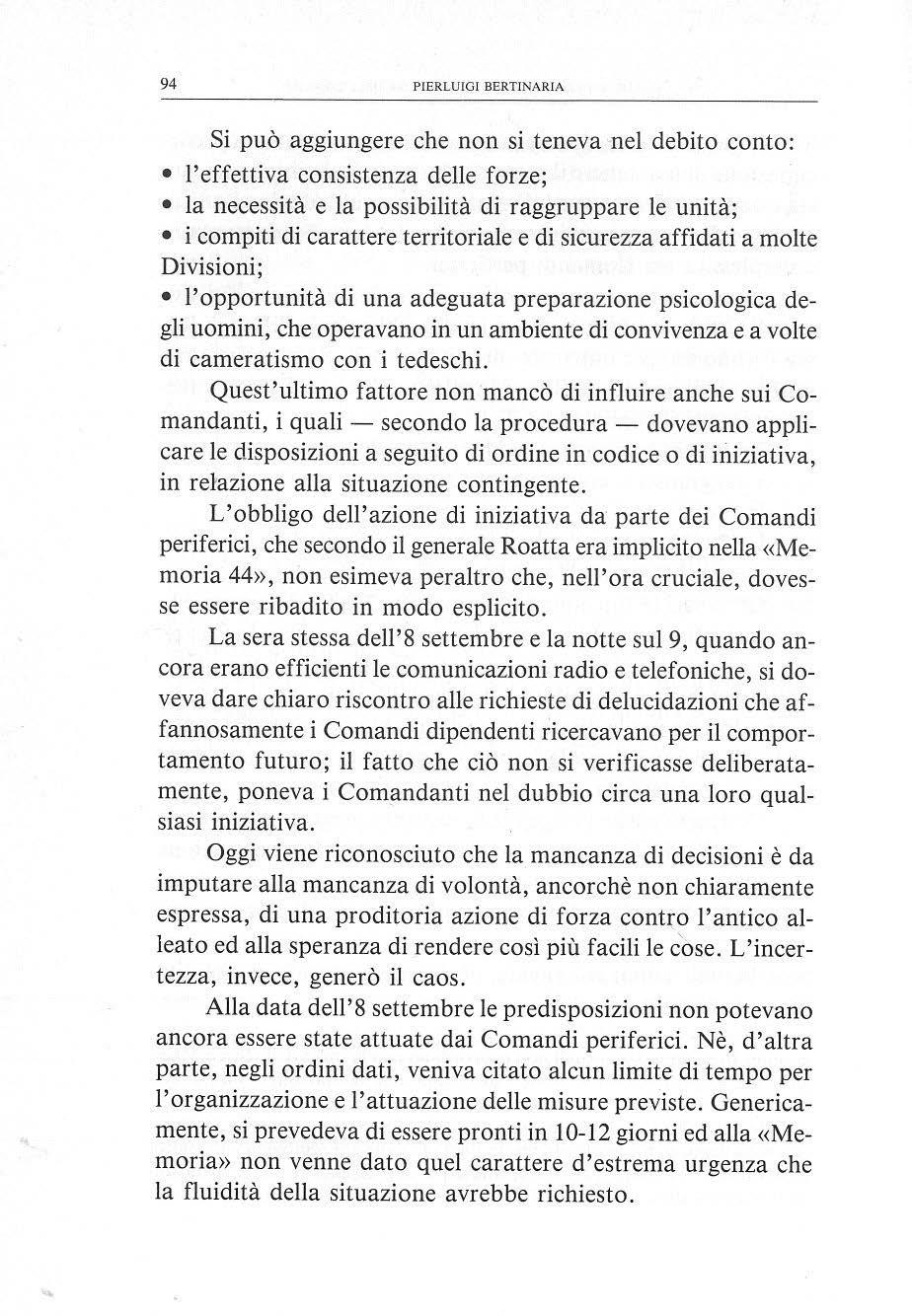
• l'opportunità di una adeguata preparazione psicologica degli uomini, che operavano in un ambiente di convivenza e a volte di cameratismo con i tedeschi.
Quest'ultimo fattore non mancò di influire anche sui Comandanti, i quali - secondo la procedura - dovevano applicare le disposizioni a seguito di ordine in codice o di iniziativa, in relazione alla situazione contingente.
L'obbligo dell'azione di iniziativa da parte dei Comandi periferici, che secondo il generale Roatta era implicito nella «Memoria 44>>, non esimeva peraltro che, nell'ora cruciale, dovesse essere ribadito in modo esplicito.
La sera stessa dell'8 settembre e la notte sul 9, quando ancora erano efficienti le comunicazioni radio e telefoniche, si doveva dare chiaro riscontro alle richieste di delucidazioni che affannosamente i Comandi dipendenti ricercavano per il comportamento futuro; il fatto che ciò non si verificasse deliberatamente, poneva i Comandanti nel dubbio circa una loro qualsiasi iniziativa.
Oggi viene riconosciuto che la mancanza di decisioni è da imputare alla mancanza di volontà, ancorchè non chiaramente espressa, di una proditoria azione di forza contro l'antico alleato ed alla speranza di rendere così più facili le cose. L ' incertezza, invece, generò il caos.
Alla data dell'8 settembre le predisposizioni non potevano ancora essere state attuate dai Comandi periferici. Nè, d'altra parte, negli ordini dati, veniva citato alcun limite di tempo per l'organizzazione e l'attuazione delle misure prev iste. Genericamente, si prevedeva di essere pronti in 10- 12 giorni ed alla «Memoria» non venne dato quel carattere d'estrema urgenza che la fluid ità della situazione avrebbe richiesto .
Motivo di indecisione sarà anche la portata del cambiamento di fronte, se trattarsi di armistizio con un avversario o di un cambio di alleanze.
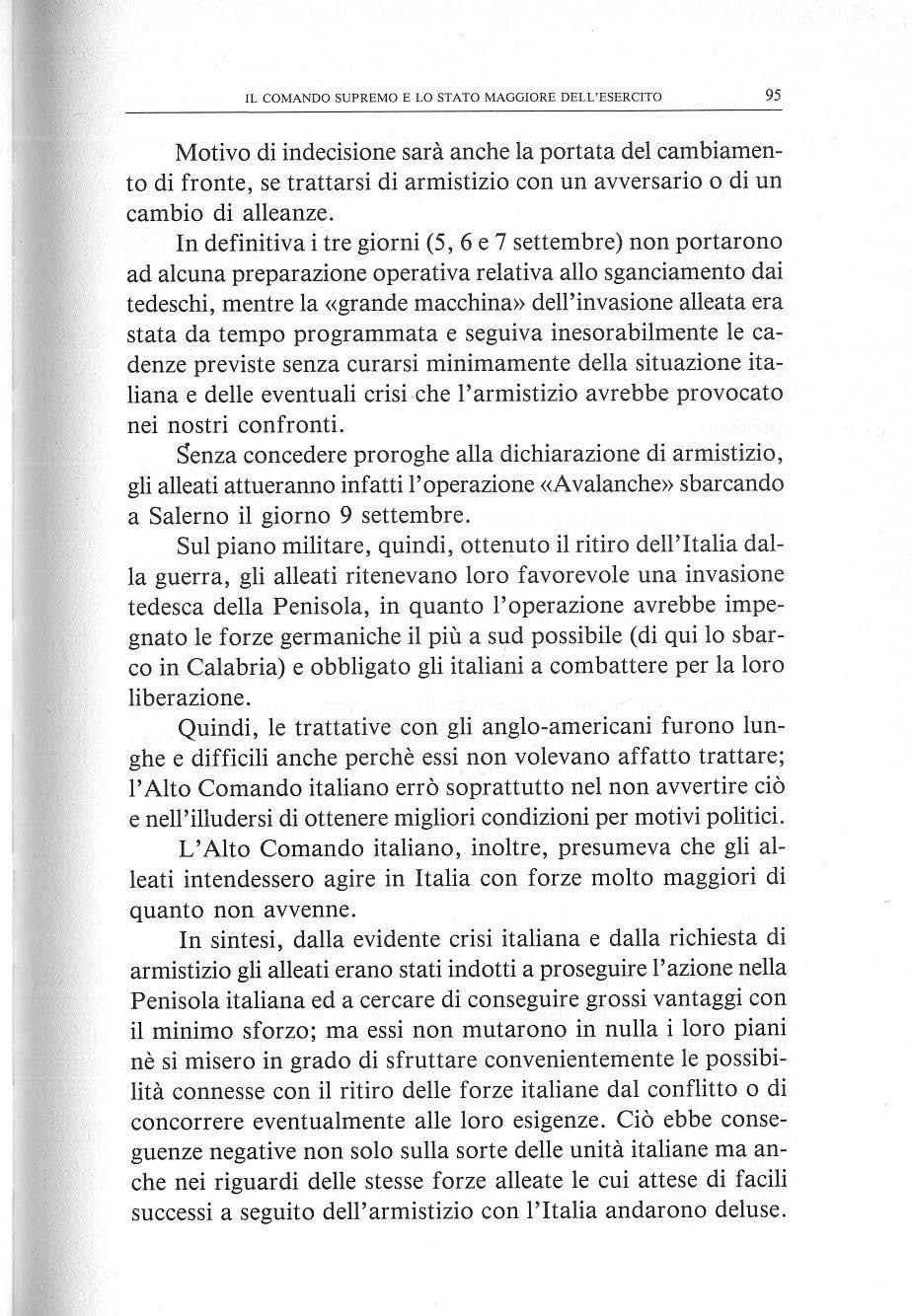
In definitiva i tre giorni (5, 6 e 7 settembre) non portarono ad alcuna preparazione operativa relativa allo sganciamento dai tedeschi, mentre la «grande macchina» dell'invasione alleata era stata da tempo programmata e seguiva inesorabilmente le cadenze previste senza curarsi minimamente della situazione italiana e delle eventuali crisi che l'armistizio avrebbe provocato nei nostri confronti.
Senza concedere proroghe alla dichiarazione di armistizio, gli alleati attueranno infatti l'operazione «Avalanche» sbarcando a Salerno il giorno 9 settembre.
Sul piano militare, quindi, ottenuto il ritiro dell'Italia dalla guerra, gli alleati ritenevano loro favorevole una invasio n e tedesca della Penisola, in quanto l'operazione avrebbe impegnato le forze germaniche il più a sud possibile (di qui lo sbarco in Calabria) e obbligato gli italiani a combattere per la loro liberazione.
Quindi, le trattative con gli anglo-americani furono lunghe e difficili anche perchè essi non volevano affatto trattare; l'Alto Comando italiano errò soprattutto nel non avvertire ciò e nell'illudersi di ottenere migliori condizioni per motivi politici.
L'Alto Comando italiano, inoltre, presumeva che gli alleati intendessero agire in Italia con forze molto maggiori di quanto non avvenne.
In sintesi, dalla evidente crisi italiana e dalla richiesta di armistizio gli alleati erano stati indotti a proseguire l'azione nella Penisola italiana ed a cercare di conseguire grossi vantaggi con il minimo sforzo; ma essi non mutarono in nulla i loro piani nè si misero in grado di sfruttare convenientemente le possibilità connesse con il ritiro delle forze italiane dal conflitto o di concorrere eventualmente alle loro esigenze. Ciò ebbe conseguenze negative non solo sulla sorte delle unità italiane ma anche nei riguardi delle stesse forze alleate le cui attese di facili successi a seguito dell'armistizio con l'Italia andarono deluse.
6 - Gli avvenimenti de/!'8 settembre: La crisi di comando a Roma
Nell'imminenza dell'annuncio alleato dell'armistizio e dello sbarco di Salerno, a seguito dei colloqui romani con il generale Taylor, Badoglio ed Ambrosio si rendevano inaspettatamente conto che l'armistizio si sarebbe verificato in condizioni molto peggiori di quanto preventivato: cioè in presenza di forze alleate di limitata entità operanti a sud di Roma e prima del previsto.
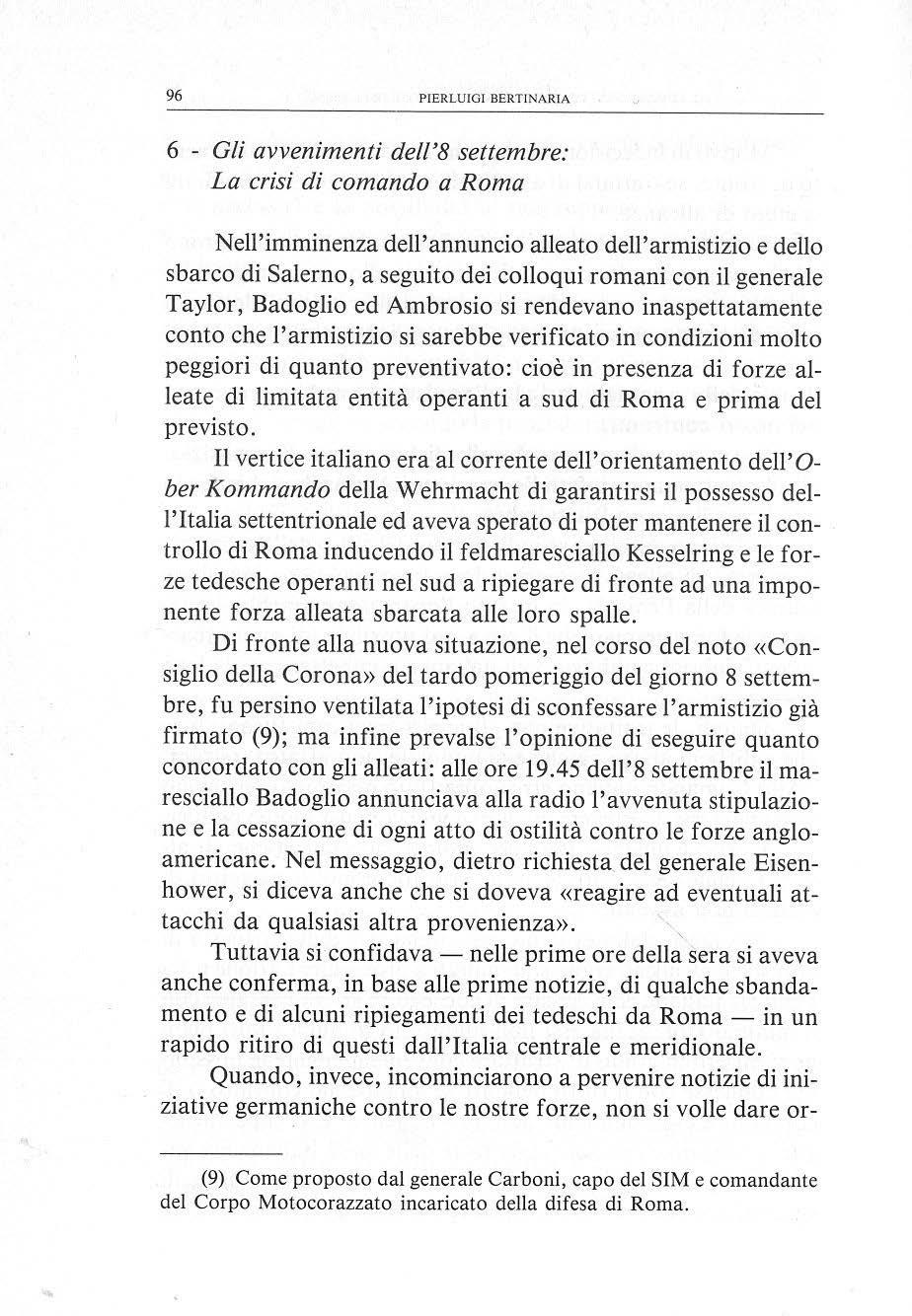
Il vertice italiano era al corrente dell'orientamento dell'Ober Kommando della Wehrmacht di garantirsi il possesso dell'Italia settentrionale ed aveva sperato di poter mantenere il controllo di Roma inducendo il feldmaresciallo Kesselring e le forze tedesche operanti nel sud a ripiegare di fronte ad una imponente forza alleata sbarcata alle loro spalle.
Di fronte alla nuova situazione, nel corso del noto «Consiglio della Corona» del tardo pomeriggio del giorno 8 settembre, fu persino ventilata l'ipotesi di sconfessare l'armistizio già firmato (9); ma infine prevalse l 'opinione di eseguire quanto concordato con gli alleati: alle ore 19.45 dell'8 settembre il maresciallo Badoglio annunciava alla radio l'avvenuta stipulazione e la cessazione di ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane. Nel messaggio, dietro richiesta del generale Eisenhower, si diceva anche che si doveva «reagire ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza». ,
Tuttavia si confidava - nelle prime ore della sera si aveva anche conferma, in base alle prime notizie, di qualche sbandamento e di alcuni ripiegamenti dei tedeschi da Roma - in un rapido ritiro di questi dall'Italia centrale e meridionale.
Quando, invece, incominciaro no a pervenire notizie di iniziative germaniche contro le nostre forze, non si volle d are or-
(9) Come proposto dal generale Carboni, capo del SIM e comandante del Corpo Motocorazzato ìncaricato della difesa di Roma .
dini di assumere l'iniziativa contro l'antico alleato, ritenendo con ciò di evitare accuse di tradimento e peggiori ripercussioni.
Per evitare questo, tutte le maggiori autorità si allontanarono da Roma; le reazioni furono lasciate all'iniziativa dei singoli, che ebbero a comportars i come meglio credettero opportuno per sè e per la propria unità in così difficili frangenti.
Le carenze nell'azione di comando, già gravissime subito dopo la proclamazione dell'armistizio, divennero assolute dopo la partenza dei Capi di Stato Maggiore da Roma.
Non si provvide a diramare l'ordine inequivocabile di attuazione della «Memoria operativa 44» e dei successivi «Promemoria n. 1 e n . 2 » .
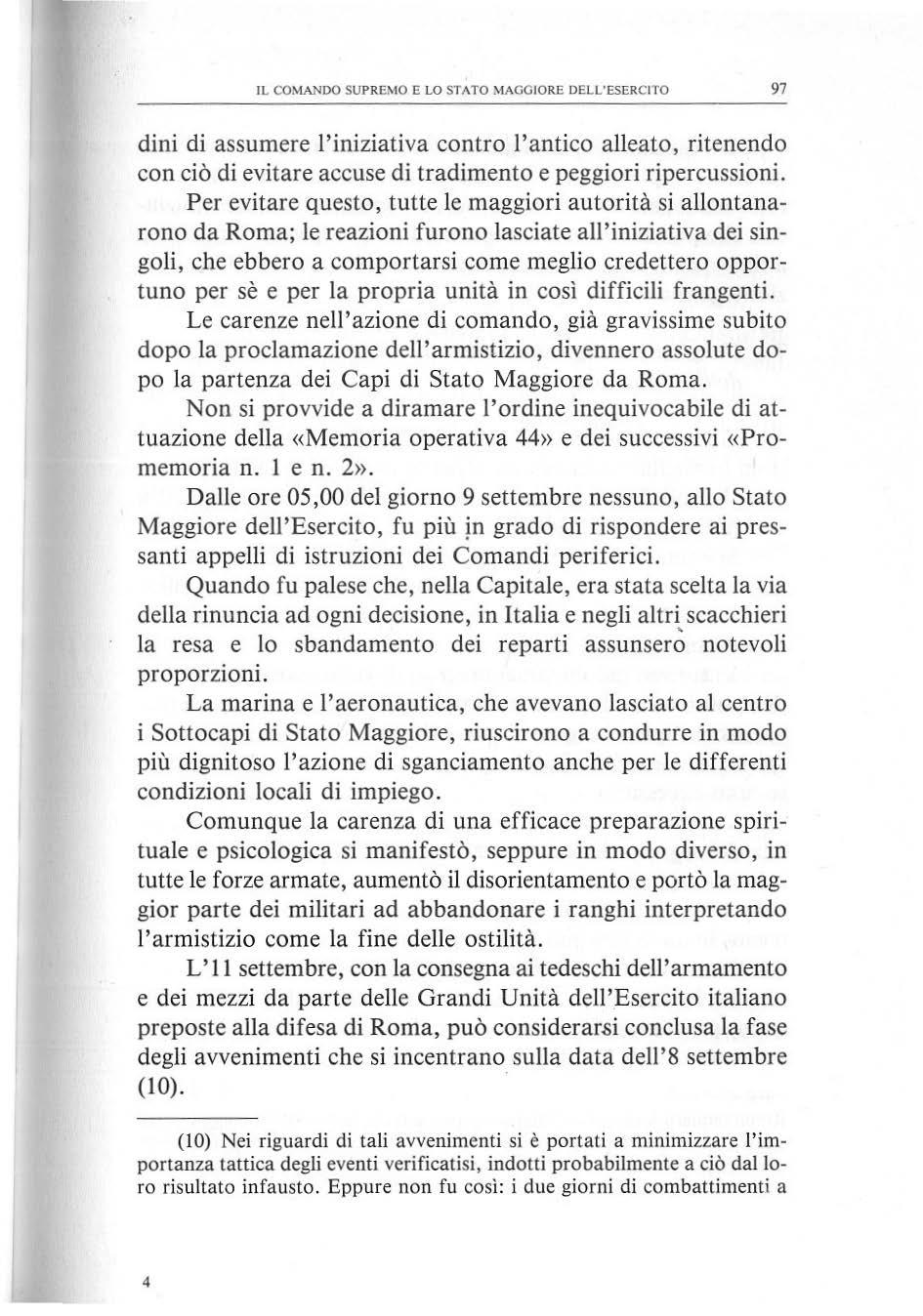
Dalle ore 05,00 del giorno 9 settem bre nessuno, allo Stato Maggiore dell'Esercito, fu più jn grado di rispondere ai pressant i appelli di istruzioni dei Comandi periferici.
Quando fu palese che, nella Capitale, era stata scelta la via della rinuncia ad ogni decisione, in Italia e negli altr~ scacchieri la resa e lo sbandamento dei reparti assunsero notevoli proporzioni .
La marina e l'aeronautica, che avevano lasciato al centro i Sottocapi di Stato Maggiore, riuscirono a condurre in modo più dignitoso l'azione di sganciamento anche per le differenti condizioni locali di impiego.
Comunque la carenza di una efficace preparazione spirituale e psicologica s i manifestò , se ppure in modo diverso, in tutte le forze armate, aumentò il disorientamento e portò la maggior parte dei militari ad abbandonare i ranghi interpretando l'armistizio come la fine delle ostilità.
L' 11 settembre, con la consegna ai tedeschi dell'armamento e dei mezzi da parte delle Grandi Uni t à dell'Esercito italiano preposte alla difesa di Roma, può considerarsi conclusa la fase degli avvenimenti che si incentrano sulla data dell'8 settembre (10).
(10) Nei riguardi di tali avvenimenti si è portati a minimizzare l'importanza tattica degli eventi verificatisi, indotti probabilment e a ciò dal loro risu ltato infausto . Eppure non fu così: i due giorni di combattimenti a
E a distanza di pochi giorni e di poche settimane ebbe luogo anche l'epilogo per le nostre unità stanziate fuori dal territorio nazionale dove non mancarono episodi di valore e iniziative che portarono alcuni reparti ad una lunga e cruenta lotta a fianco delle nazioni che intendevano affrancarsi dall'occupazio ne ger ma nica.
7 - Un giudizio sugli avvenimenti de/1'8 settembre
Gli avvenimenti dell'8 settembre 1943 , per le loro ripercussioni immediate e successive e per le immense tragedie provocate, hanno dato e danno luogo a gi udi zi critici pesanti ed a contrastanti polemiche.
Si è finito per ricercare più le colpe e le insufficienze di singoli piuttosto che le cause di fondo di avvenimenti così disas trosi, rapidi e diffusi in un organismo che aveva superato con onore tante prove.
Vi furono indubbiamente errori di valutazione sia del vertice politico sia di quello militare, i quali poi non seppero trovare, nel rapido volgere di gravi situazioni , n è l'energia nè lo s pirito di autocontrollo, di esempio e di sacrificio che sarebbero stati necessari.
La mancata azione di orientamento preventivo, per una tutela del segreto elevata fino all'assurdo, la poca chiarezza ed i ritardi degli ordini, soprattutto l'assenza dell'Alto Comando nelle ore successive all'arm i stizio erano destinate a provocare il caos in un organismo fondato su un ordinamento gerarchico e sulla esecuzione disciplinata degli ordini.
Le incertezze di ordine politico («non tradire l'alleato»), anche per le manifeste chiusure ed il malvolere di Washington, e soprattutto di Londr~, le cui promesse di distinzione fra fa-
Roma t e nnero lontano da Salerno - proprio nel momento di maggior crisi alleata - la 3 a Panzergrenadieren e la 2 a Par acadutisti il cu i intervento avrebbe potuto essere determinante, come è ammesso dallo stesso Kesselring (« Memorie di guerra » , Milano, 1954).
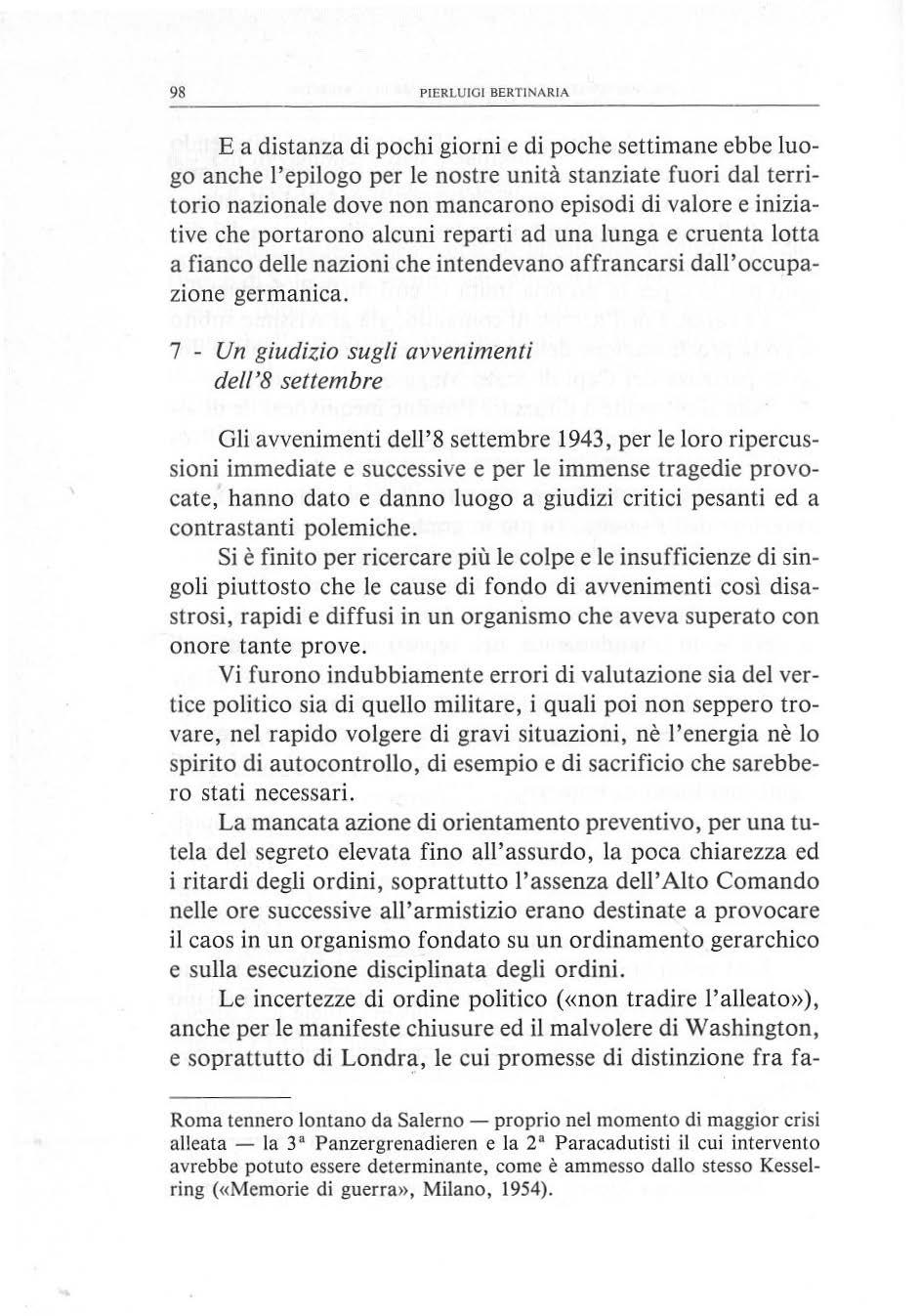
scismo e popolo italiano si rivelavano mendaci, divenivano paralizzanti, mentre la ricerca della riuscita dell'azione complessiva attraverso la tutela del segreto non sorprendeva affatto i tedeschi e risultava deleteria soltanto per le nostre unità.
Ma non si può ritenere che quanto avvenuto possa attribuirsi solo o soprattutto a deficienze di singoli individui.
Le cause vere di una situazione quale era venuta maturando, ed anche dell'andamento così generalizzato degli avvenimenti dell'8 settembre, sono individuabili -a mio avvisonelle deficienze quantitative e soprattutto qualitative dello strumento bellico italiano, orientato ad una guerra del passato, da condurre su teatri d'operazione diversi da quelli dove fu condotta, insufficientemente armato ed addestrato, che aveva curato -e male - più la quantità che la qualità, negli uomini e nei mezzi.
Da qui, la deficienza di Grandi Unità mobili corazzate, che impose l'afflusso di unità tedesche dapprima in Africa Settentrionale e poi in Sicilia, e che successivamente obbligò ad accettarne l'entrata anche in Italia dopo il 25 luglio; e per converso l'ampia disponibilità di unità di minore efficienza bellica che, per l'esigenza politica di bilanciare l'apporto alleato, furono inviate ad effettuare compiti di presidio o di presenza in Francia, nei Balcani, in Russia, in uno sforzo di onnipresenza che portò alla maggiore dispersione e lasciò l'Italia indifesa nel 1943.
Infatti 1'8 settembre, a causa delle deficienze di armamento e indubbiamente anche di orientamento, le nostre unità non dovevano reggere al confronto di quelle tedesche, perfettamente orientate, decise, bene armate; ciò quasi dovunque, eccetto per alcuni casi nei Balcani.
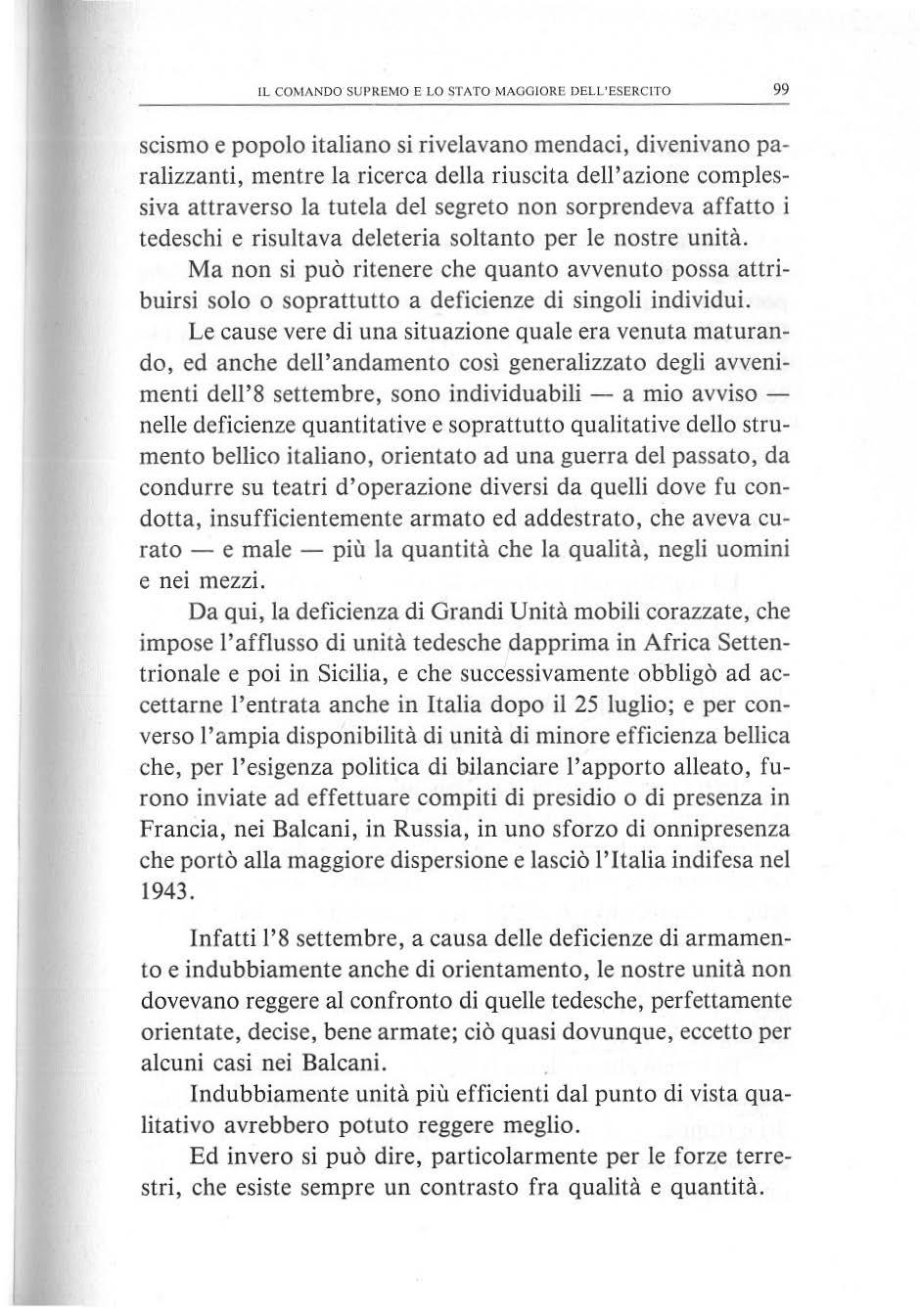
Indubbiamente unità più efficienti dal punto di vista qualitativo avrebbero potuto reggere meglio.
Ed invero si può dire, particolarmente per le forze terrestri, che esiste sempre un contrasto fra qualità e quantità.
Orbene, tale contrasto va sempre risolto a favore della qualità, così come a favore della assegnazione di maggiori risorse alle forze di manovra.
A limite, infatti, se ne dovranno ridurre i compiti e contrarre gli obiettivi ma esisterà certamente qualche obiettivo che potrà comunque essere conseguito attraverso la disponibilità di forze efficienti e manovriere, le quali saranno sempre in grado di controllare una sia pure minore estensione di territorio o di condurre almeno una efficace manovra in ri t irata.
In altre parole, la disponibilità di Grandi Unità mobili efficienti, avrebbe dato la possibilità di resi stere anche su parte del territorio nazionale o nei Balcani, di arroccare presso tali forze gli organi di Comando polit ico e militare, di pesare in qualche modo sulle decisioni altrui e sugli avvenimenti.
La consapevolezza di non disporre di uno strumento ad eguato e rispondente provocò negli Alti Comandi la cr isi di fiducia di poter affrontare la situazione con qualche prospettiva di successo; si tratta di crisi destinate a propagarsi rapidamente in strutture quali quelle militari e di maggiore gravità di qualsiasi insuccesso tattico o strategico.
In tre anni di guerra si era passati da sconfitta a sconfitta; la guerra in Africa Settentrionale 1ed in Sicilia aveva sottolineato l' inferiorità di mezzi di fronte alle Armate alleate ed alla loro aviazione; la convivenza ed il confronto con le unità tedesche avevano fatto toccare con mano, ad ogni momento, la nostra inferior ità in ogn i settore. '
D u rante il conflitto, anche se in condizioni difficili, le nostre Unità si erano comportate bene quando ben comandate ed impiegate in condizioni accettabili.
Di fronte alla evidente incertezza e alla fuga delle responsab il ità del!' A lto Comando dovevano emergere in tutt i , Quadri e truppa, quei motivi di sfiducia che erano già largamente diffusi; l'annuncio de ll 'ar m istizio fu inteso come la fine d i un impegno.
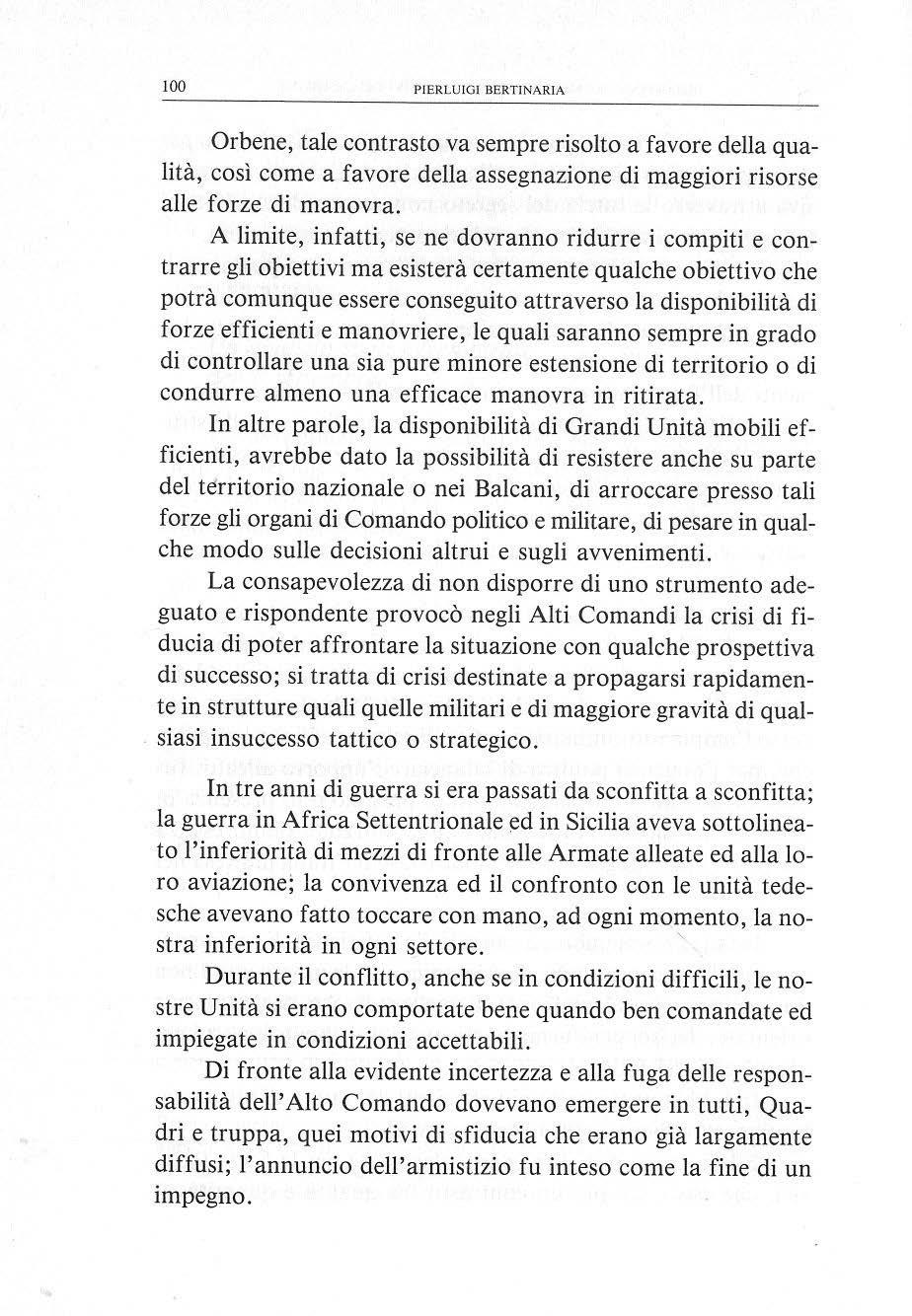
D'altra parte, il funzionamento gerarchico è basato su una corrente continua: ascendente di informazioni, discendente di ordini.
L'Alto Comando italiano non seppe trarre informazioni corrette nè fare valutazioni equilibrate sia sui tedeschi sia sugli alleati; esso si rifiutò di dare ordini perchè qualsiasi ordine poteva avere connotazioni politiche. In tale situazione ogni Comandante fu posto innanzi all'obbligo di prendere decisioni che il suo Comandante Supremo non aveva avuto il coraggio di adottare; e naturalmente ciò non poteva concludersi che con quella crisi generale che fu 1'8 settembre.
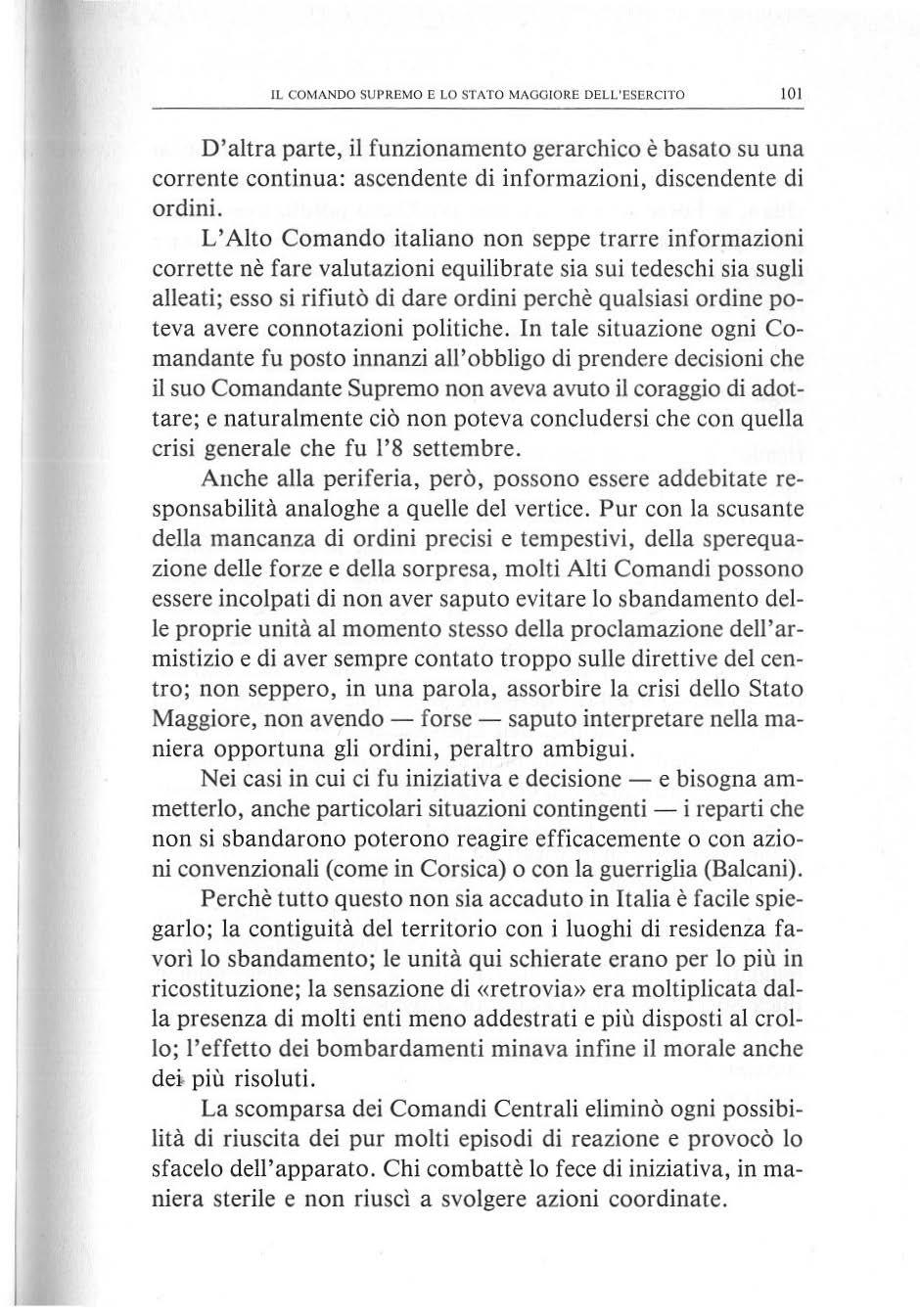
Anche alla peri feria, però, possono essere addebitate responsabilità analoghe a quelle del vertice. Pur con la sc usant e della mancanza di ordini precisi e tempest ivi, della sperequazione delle forze e della sorpresa, molti Alti Comandi possono essere incolpati di non aver saputo evitare lo sban damento delle proprie unità al momento stesso della proclamazione dell'armistizio e di aver sempre contato troppo sulle direttive del centro; non seppero, in una parola, assorbire la crisi dello Stato Maggiore, non avendo - forse - saputo interpretare nella maniera opportuna gli ordini, peraltro ambigui.
Nei casi in cui ci fu iniziativa e decisione - e bisogna ammetterlo, an che particolari situazio ni cont ing enti - i reparti che non si sbandarono poterono reagire efficacemente o con azioni convenzionali (come in Corsica) o con la guerriglia (Balcani).
Perchè tutto que st o non sia accaduto in I tal ia è facile sp iegarlo; la contiguità del territorio con i luoghi di residenza favorì lo sbandamento; le unità qui schierate era no per lo più in ricostituzione; la sensazione di «retrovia» era moltiplicata dalla presenza di molti enti meno addestrati e più dispo sti al crollo; l'effetto dei bomb ardament i minava infine il morale anche dei. più risoluti.
La scomparsa dei Comandi Centrali eliminò ogni possibilità di riuscita dei pur molti episodi di reazione e provocò lo sfacelo dell'apparato. Chi combattè lo fece di iniziativa, in maniera sterile e non riuscì a svo lgere azioni coordinate.
Se tutte le Grandi Unità, anzichè dissolversi su ordine, si fossero organizzate, come fuori d'Italia, per resistere «alla macchia», le Forze Armate italiane avrebbero potuto avere maggiore peso e sarebbe forse sparito il dualismo tra resistenza e guerra di liberazione, e le due avrebbero potuto essere considerate un unico avvenimento, politico e militare assieme.
II sacrificio - perchè i sacrifici sarebbero stati molti lo stesso - sarebbe stato considerato maggiormente e la concordia degli italiani si sarebbe accresciuta.
Se, come detto, la responsabilità della gestione della crisi ricade sull'autorità italiana, una concausa va anche attribuita· alle autorità politiche e militari anglo-americane.
Infatti, partendo da considerazioni politiche, esse rifiutarono dapprima ogni accordo che non fosse la resa incondizionata; poi, non comprendendo la situazione di quei giorni, accettarono la collaborazione contro i tedeschi a condizioni partico lari, tra cui anche quelle di non cambiare in nulla la loro pianificazione, sia pure rinunciando agli immensi vantagg i tattici, strategici e politici derivanti dalla collaborazione italiana e dal possesso di Roma, dell'Egeo e della Jugoslavia.
In un ambiente di completo sfacelo dell'organizzazione politica, amministrativa e militare italiana, il settembre 1943 si concludeva senza che la capitolazione. italiana fosse convenientemente sfruttata dagli Alleati sia nella Penisola sia nei Balcani.
Nella Penisola le speranze del Governo italiano di un rapido ritorno a Roma con l'aiuto alleato rimarranno deluse; i suoi poteri resteranno limitati a quattro sole province mentre nella maggior parte del Paese si affermerà il governo della Repubblica Sociale sostenuto dalle forze tedesche.
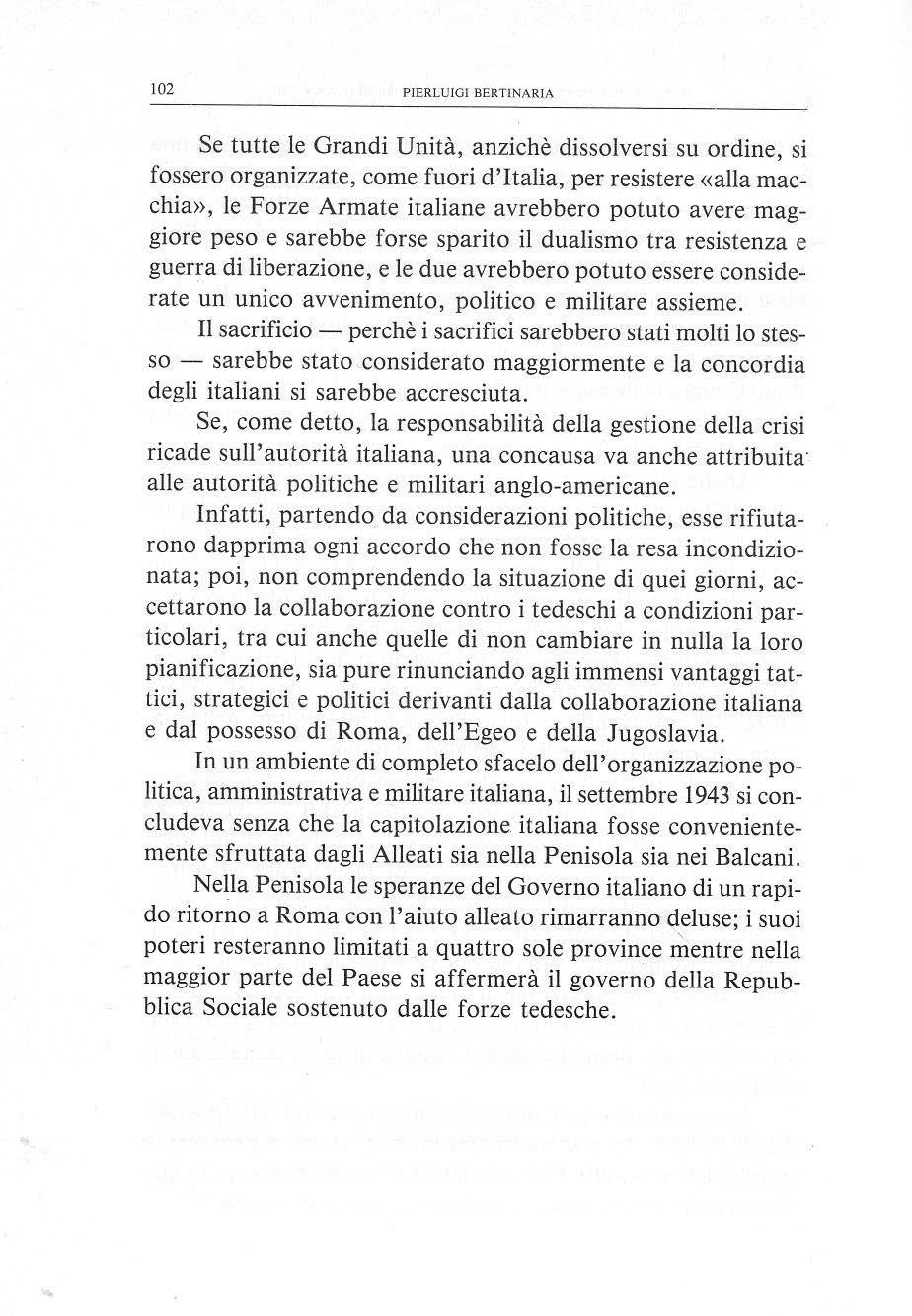
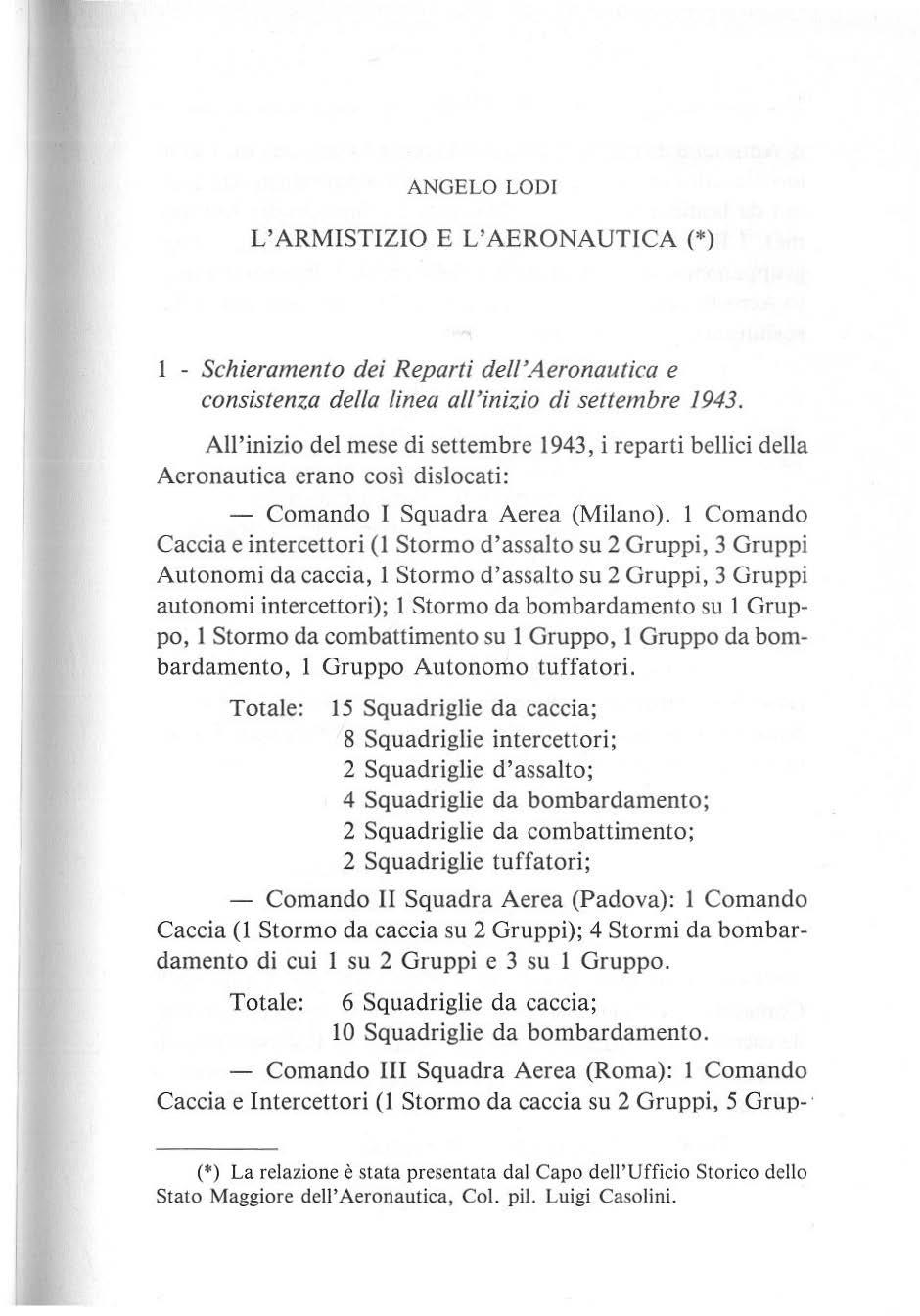
1 - Schieramento dei Reparti dell'Aeronautica e consistenza della linea all'inizio di settembre 1943.
All'inizio del mese di settembre 1943, i reparti bellici della Aeronautica erano così dislocati:
- Comando I Squadra Aerea (Milano). 1 Comando Caccia e in tercettori (1 Stormo d'assalto su 2 Gruppi, 3 Gruppi Autonomi da caccia, 1 Stormo d'assalto su 2 Gruppi, 3 Gruppi autonomi intercettori); 1 Stormo da bombardamento su 1 Gruppo, 1 Stormo da combattimento su 1 Gruppo, 1 Gruppo da bombardamento, 1 Gruppo Autonomo tuffatori .
Totale: 15 Squadriglie da caccia;
8 Squadriglie intercettori;
2 Squadriglie d'a ssal to;
4 Squadriglie da bombardamento;
2 Squadriglie da combattimento;
2 Squadriglie tuffatori;
Comando II Squadra Aerea (Padova): 1 Co mando
Caccia (1 Stormo da caccia su 2 Gruppi); 4 Stormi da bombardamento di cui 1 su 2 Gruppi e 3 su 1 Gruppo.
Totale: 6 Squadriglie da caccia;
10 Squadriglie da bombardamento.
Comando III Squadra Aerea (Roma): 1 Comando Caccia e In tercettori (I Stormo da caccia su 2 Gruppi, 5 Gru p-
-
(*) La relazione è stata presentata da l Capo dell' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Col. pii. Luigi Caso lini.
pi Autonomi da caccia, 1 Gruppo Autonomo intercettori, 1 Stormo d'assalto su 2 Gruppi); 1 Comando Bombardamento (1 Stormo da bombardamento su 2 Gruppi e 2 Squadriglie Autonome), 1 Raggruppamento Bombardamento (4 Gruppi), 1 Raggruppamento Bombardamento (4 Gruppi), 1 Raggruppamento Aerosiluranti (3 Gruppi Autonomi), 2 Gruppi Autonomi Aero siluran t i, 1 Sezione aerosiluranti.
Totale: 21 Squadriglie da caccia;
2 Squadriglie intercettori;
4 Squadriglie d'assalto;
1 Squadriglia aerofotografica;
12 Squadriglie da bombardamento;
1 Squadriglia da ricogni z ione strategi ca;
10 Squadrigli e aero siluranti;
1 Sezione aerosiluranti.
- Comando IV Squadra Aer ea (Bari): 1 Comando Caccia e In te rcettori (1 Stormo da caccia su 2 Gruppi, 2 Gruppi Autonomi da caccia, 1 Stormo tuffatori su 2 Gruppi); 1 Stormo da bombardamento su 1 Gruppo.
Totale: 12 Squadriglie da caccia;
4 Squadriglie tuffatori;
2 Squadriglie da bombardamento;
1 Sezione da bombardamento.
Comando Aeronautica della Sardegna ·(Cagliari): 1
Comando Caccia (1 Stormo da caccia su 1 Gruppo Autonomo da caccia, 1 Squadriglia da caccia); 1 Comando Bombardamento (1 Squadriglia da bombardamento, 1 Gruppo Autonomo tuffatori).
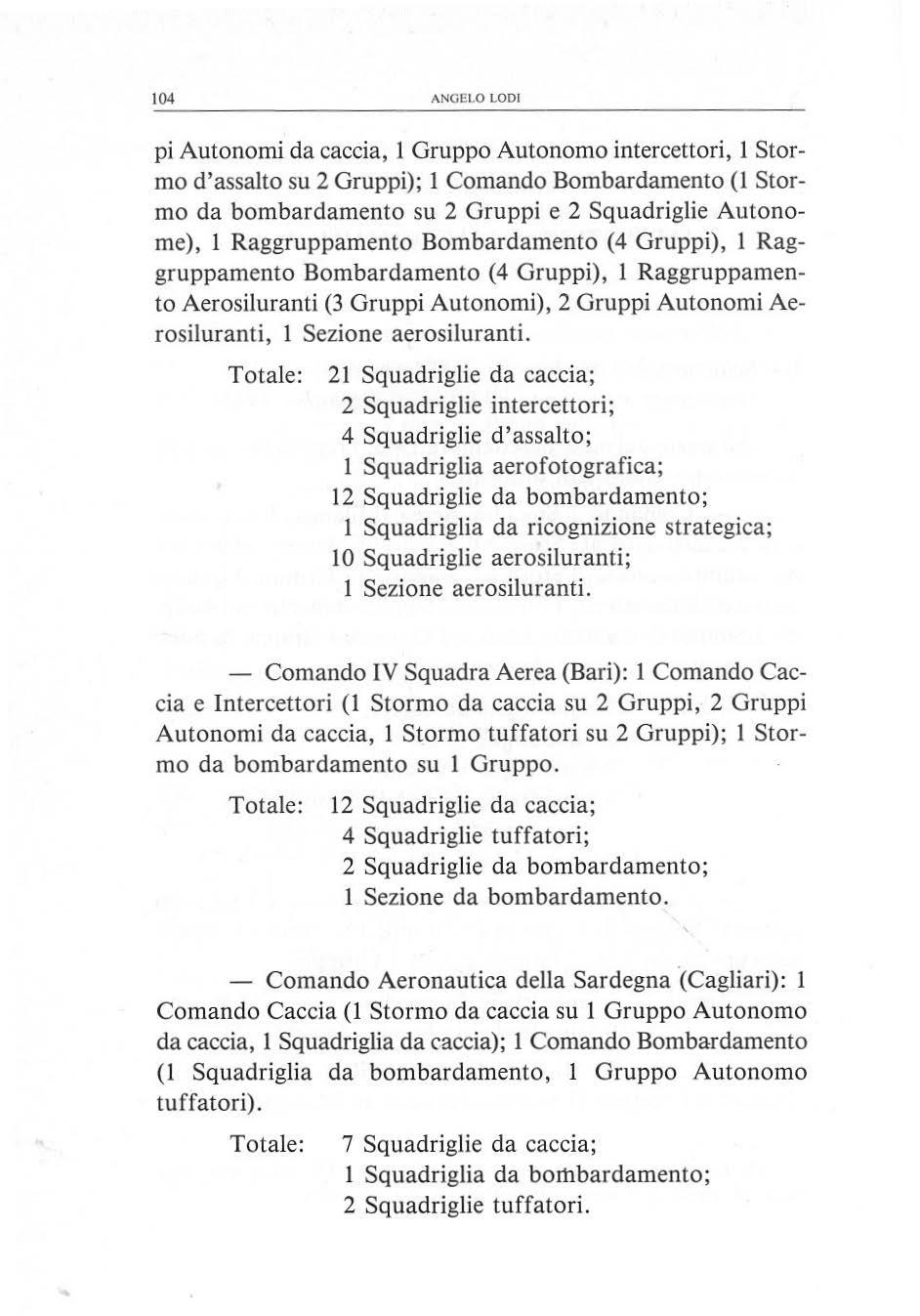
Totale: 7 Squadriglie da caccia;
1 Squadriglia da bombardamento;
2 Squadriglie tuffatori.
Comando Forze Aeree della Corsica (Ajaccio): 1 Sezione da caccia .
- Comando Aeronautica dell'Egeo (Rodi): 1 Gruppo Au t onomo da caccia, 1 Sezione intercettori, 1 Gruppo Autonomo da bombardamento.
Totale: 2 Squadriglie da caccia; 1 Sezione intercettori; 4 Squadriglie da bombardamento.
Comando Aeronautica dell'Albania (Tirana): 2 Squadriglie Autonome da Caccia, 1 Stormo da bombardamento su 2 Gruppi, 1 Gruppo da combattimento.
Totale: 2 Squadriglie da caccia; 4 Squadriglie da bombardament o; 2 Squadriglie da combattimen t o.
Comando Aeronautica della Grecia (Atene): 1 Squadriglia Autonoma da caccia, 1 Sezione Intercettori.
- Comando Aviazione della Slovenia-Dalmazia (Mostar): 1 Squadriglia Autonoma d'assalto, 2 Squadriglie Autonome da bombardamento.
- Comando Aviazione Ausiliaria per l'Esercito: un complesso di 12 Gruppi da ricognizione terrestre sparsi in Francia, Italia, Jugoslavia, Alban ia e Grecia.
Totale: 27 Squadriglie da ricognizione terrestre .
- Comand o Aviazione Aus ili a ri a per la Marina: Comandi Alto T irr eno, Alto Adriatico, Bass o T irreno, Jonio e Basso Adriatico, Sardegna, Grecia (complessivamen t e 20 Sq u adr iglie idrovolanti).
Totale generale: 66 Squadriglie da caccia e 1 Sezione; 8 Squadrigli e in t ercettori e 2 Sezio ni;
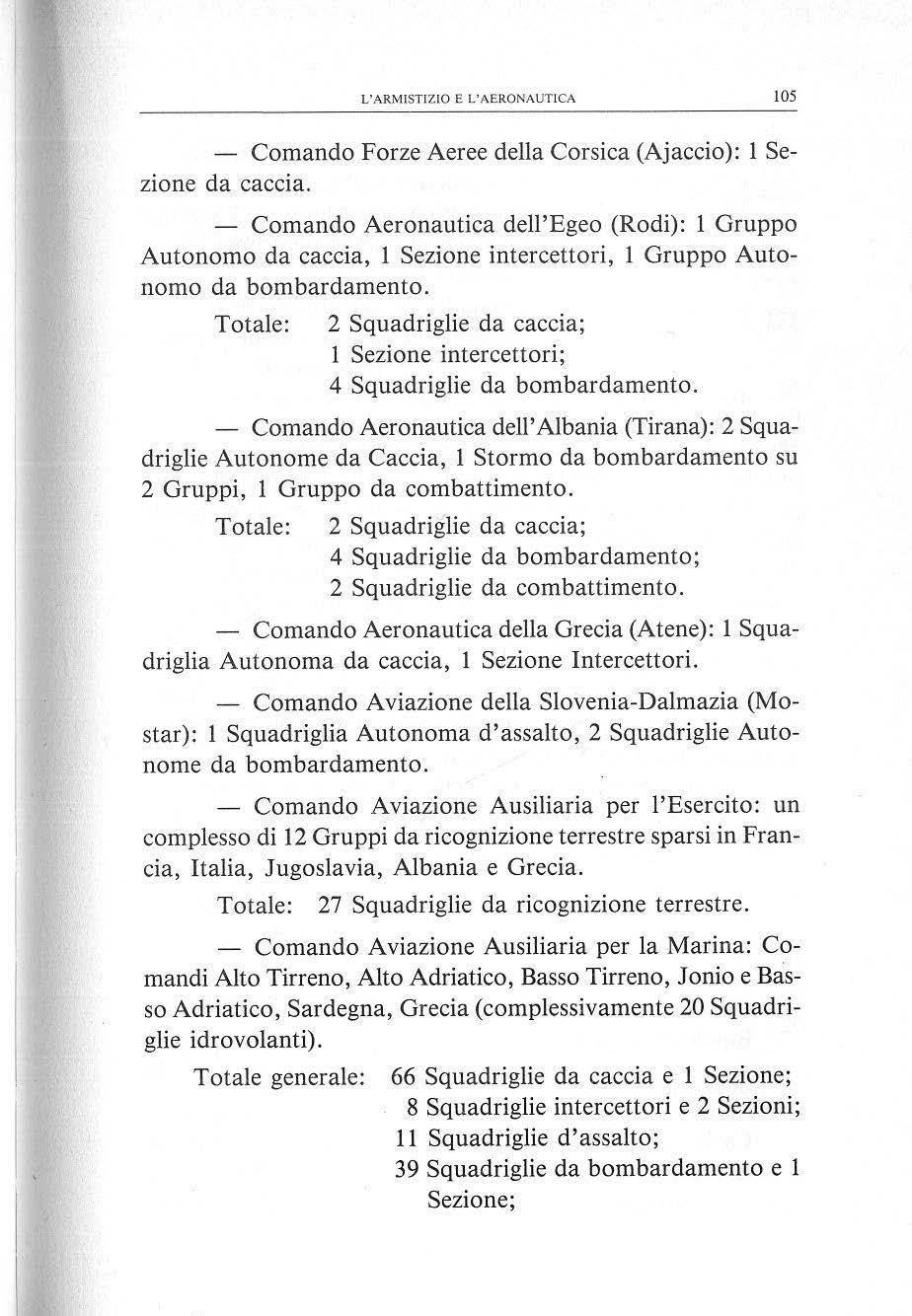
11 Squadrigli e d' assalto ;
39 Sq u adriglie da bombardamento e 1 Sezion e;
In complesso:
4 Squadriglie da combattimento;
8 Squadriglie tuffatori;
10 Squadriglie aerosil u ranti e 1 Sezione;
1 Squadriglia da r icognizione strategica;
1 Squadriglia aerofotografica;
27 Squadriglie da ricognizione terrestre;
20 S q uadrig lie idrovolanti.
195 Squad rigl ie e 5 Sezioni (1 ).
Il numero considere v o le di unità e di reparti aerei che risulta da questo schieramento non deve però trarre i n inganno. In realtà, le grandi unità aeree (Squadre , ecc.), malgrado la pesante struttura, assai spesso erano ben lontane dall'essere tali per il numero e l'efficienza dei rep ar ti dip e ndenti; Stormi e Gruppi avevano spesso il carattere di reparti «quadro»; infine, i minori reparti (Squadriglie) dovevano lamentare una forte scarsità di apparecchi in linea e, i n taluni cas i, la totale inefficienza di essi perchè antiquati, logora ti dal l u ngo uso e malridotti dagli sfavorevoli e venti della guerr a, s pecialme nte nei mesi immediat amente preceden t i l 'a r mist izio.
In particolare, alla vigilia d ell ' annunc io d e ll'armistizio , la situazione dei velivoli dell'Aerona utica i n carico ai repar ti e bellicamente efficienti era la s eguen te :
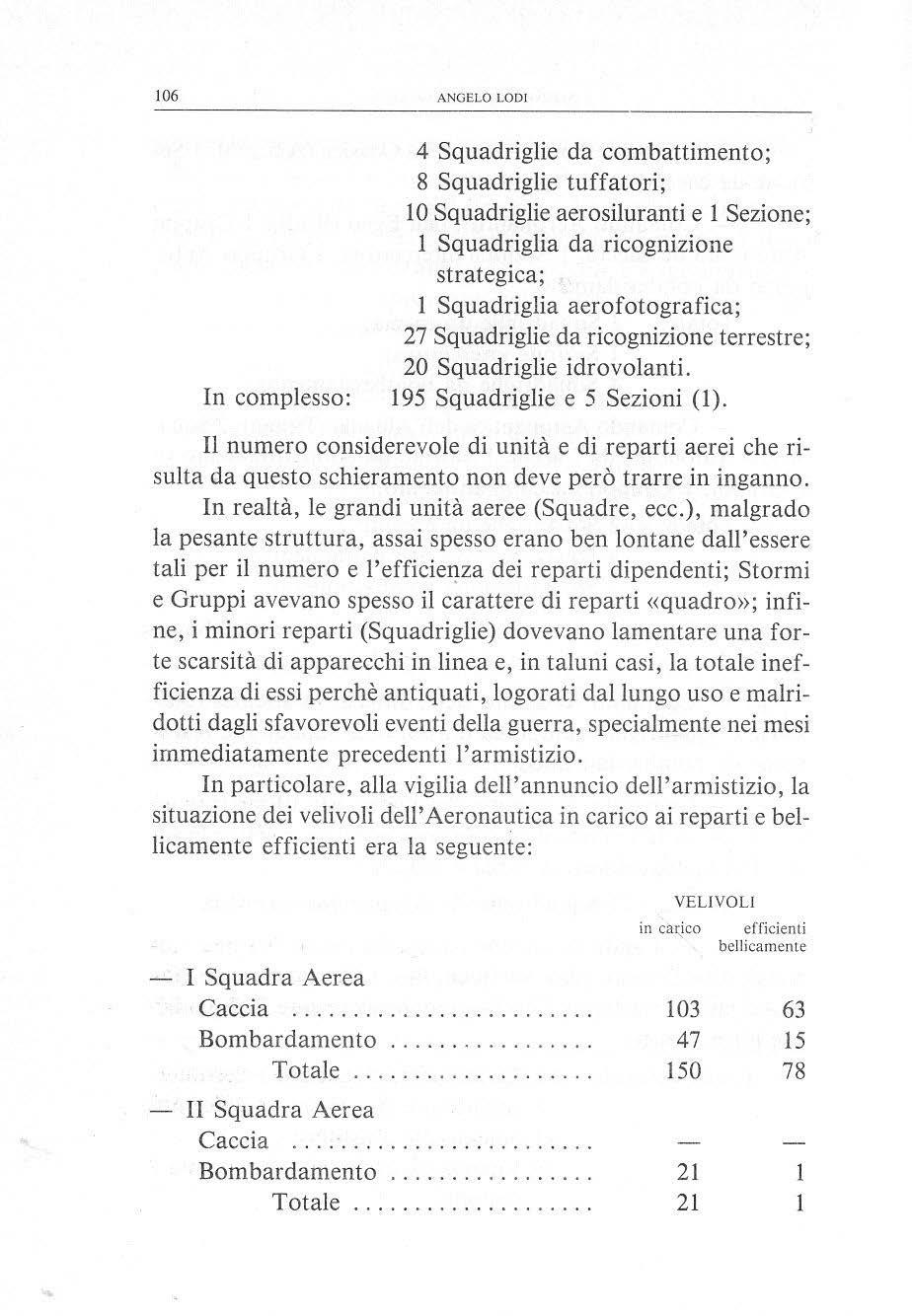
In totale: 420 (266 da caccia: 154 da bombardamento) velivoli bellicamente efficienti su 831 (555 da caccia, 276 da bombardamento) in carico all'armata aerea.
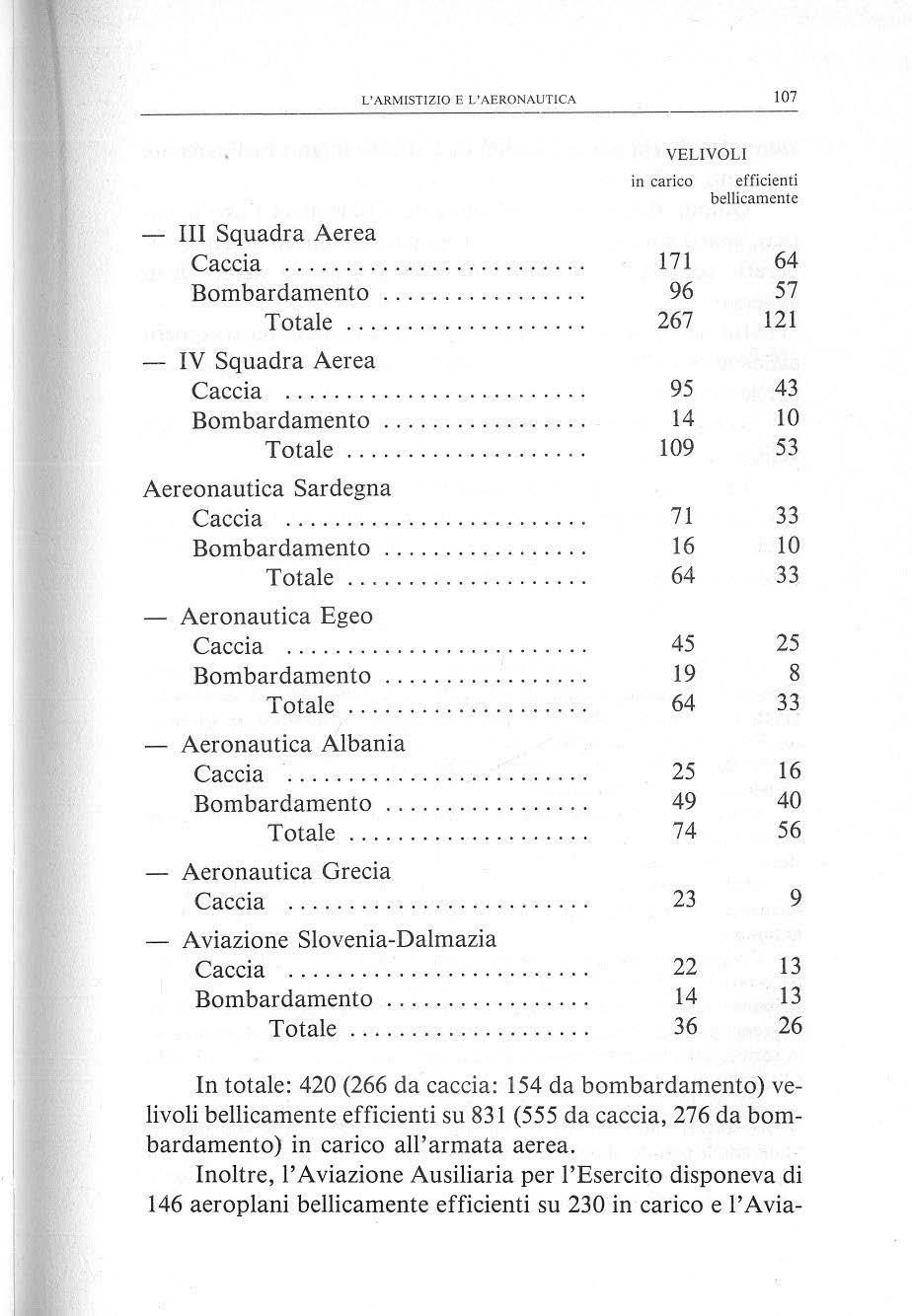
zione Ausiliaria per la Marina di 104 idrovolanti bellicamente efficienti su 204 in carico.
Quindi: 670 velivoli bellicamente efficienti su 1.265 in carico, sparsi sui vari fronti e in gran parte qualitativamente superati, soprattutto in confronto al potenziale aereo degli avversari.
Infine l'Aeronautica disponeva di 13 3 aerei da trasporto efficienti su 223 in carico ai reparti e di circa 600 apparecchi per le Scuole.
Totale generale (escludendo gli apparecchi da scuola): 1.488 velivoli in carico, dei quali 803 efficienti (1).
Per quel che riguarda il personale, alla vigilia dell'armistizio, la forze alle armi nell'Aeronautica comprendeva 12.013 ufficiali e 167.276 sottufficiali e militari di truppa (compresi 7.683 allievi) per un complesso di 179 .289 uomini (2).
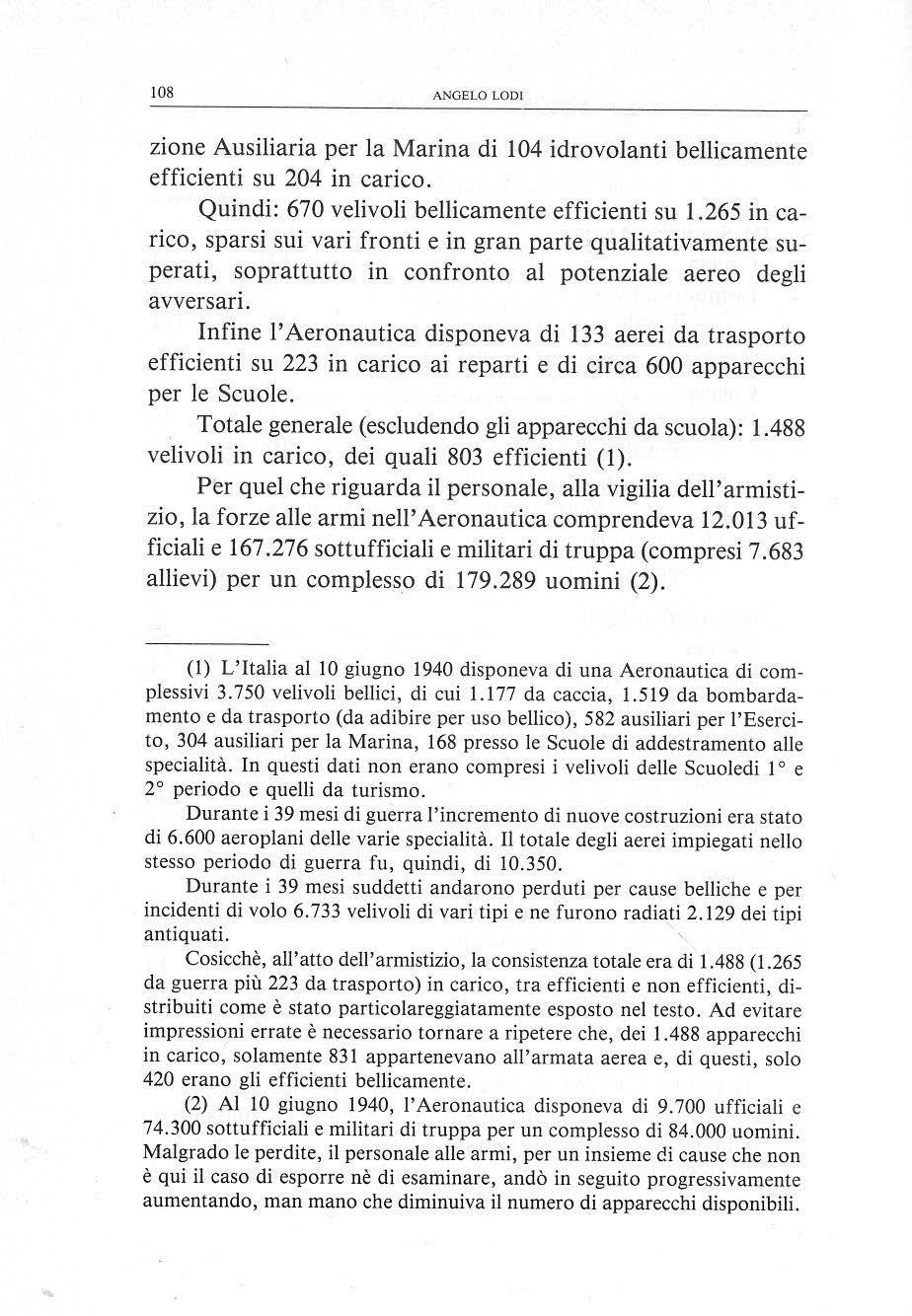
(1) L'Italia al IO giugno 1940 disponeva di una Aeronautica di complessivi 3.750 velivoli bellici, di cui 1.177 da caccia, 1.519 da bombardamento e da trasporto (da adibire per uso bellico), 582 ausiliari per l'Esercito, 304 ausiliari per la Marina, 168 presso le Scuole di addestramento alle specialità. In questi dati non erano compresi i velivoli delle Scuoledi I O e 2° periodo e quelli da turismo.
Durante i 39 mesi di guerra l'incremento di nuove costruzioni era s tato di 6.600 aeroplani delle varie specialità. Il totale degli aerei impiegati nello stess o periodo di guerra fu, quindi, di 10.350.
Durante i 39 mesi suddetti andarono perduti per cause belliche e per incidenti di volo 6. 733 vel ivoli di vari tip i e ne furono radiati 2. 129 dei tipi antiquati.
Cosicchè, all'atto dell 'armistizio, la consistenza totale era di 1.488 (1.265 da guerra più 223 da trasporto) in carico, tra efficienti e non efficienti, distribuiti come è stato particolareggiatamente esposto nel testo. Ad evitare impre ssioni errate è necessario tornare a ripetere che, dei 1.488 apparecchi in carico, solamente 831 appartenevano all'armata aerea e, di questi, so lo 420 erano gli efficienti bellicam ente.
(2) Al 10 giugno 1940, l'Aeronautica disponeva di 9.700 ufficiali e 74.300 sottufficiali e militari di truppa per un complesso di 84.000 uomini. Ma lgrado le perdite, il personale alle armi, per un insieme di cause che non è qui il caso di esporre nè di esam inar e, andò in seguito progressivamente aumentando, man mano che diminuiva il numero di apparecchi disponibili
In particolare, il personale navigante era costituito di 1.309 equipaggi per azioni belliche (trasporti esclusi), così suddivisi:
2 - Le disposizioni impartite dal Comando Supremo ed i provvedimenti presi dal Superaereo in conseguenza dell'armistizio.
Il 3 settembre 1943, il Ministro e Capo di S.M. dell'Aeronautica, Gen. Sandalli, fu chiamat o insieme ai capi responsabili delle altre Forze Armate, dal Maresciallo Badoglio, il quale comunicò che erano in corso trattative per l'armistizio. Il Capo del Governo aggiunse che la notizia doveva essere tenuta strettamente segreta e che, a suo avviso, la situazione non consentiva altra via di uscita possibile.
Il giorno 5, essendo stati recapitati al Comando Supremo alcuni documenti da parte degli Alleati, contenenti sommarie e frammentarie modalità per la pratica attuazione dell'armistizio, fu possibile entrare nel concreto.
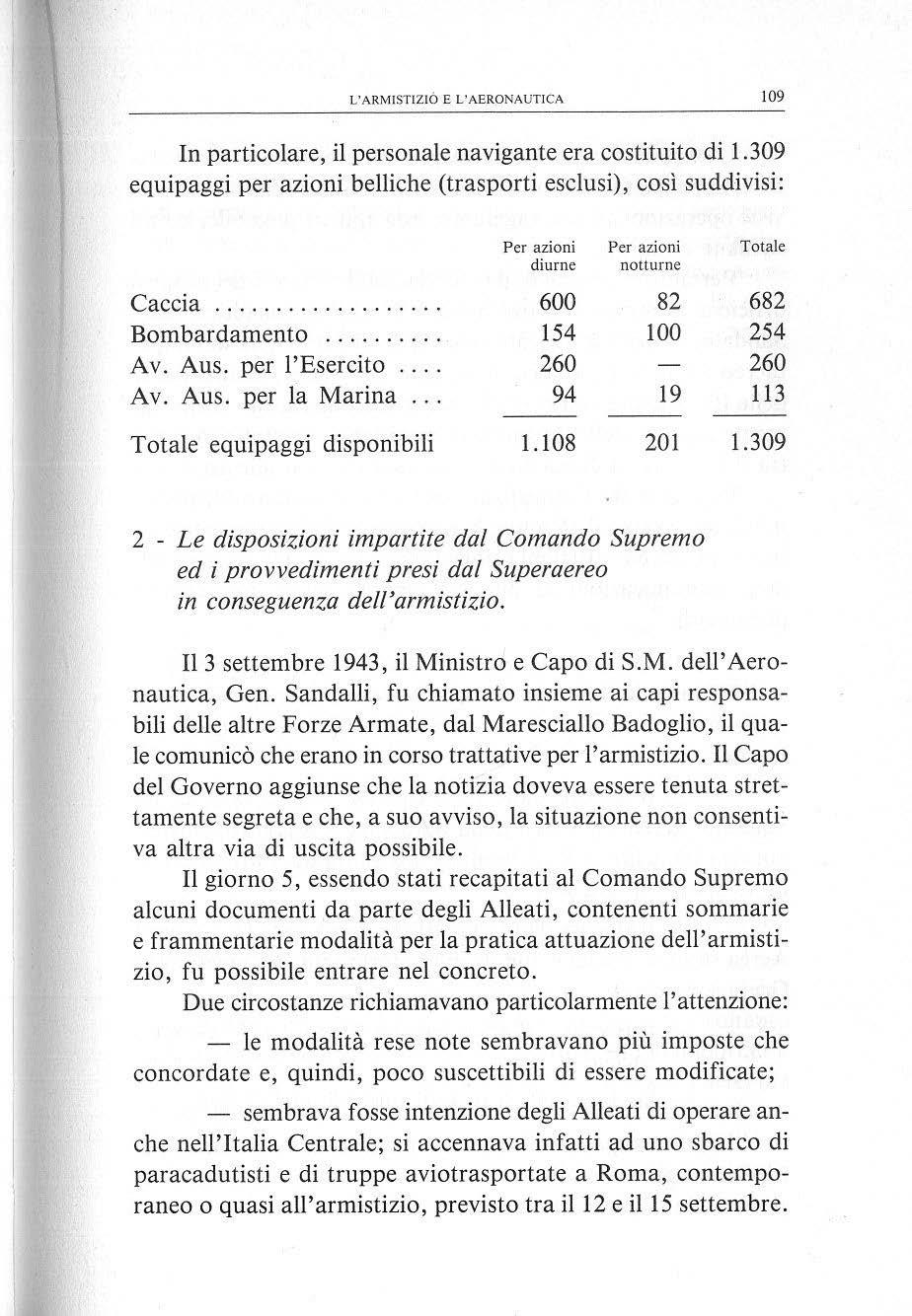
Due circostanze richiamavano particolarmente l ' attenzione:
- le modalità rese note sembravano più imposte che concordate e, quindi, poco suscettibili di essere modificate;
- sembrava fosse intenzione degli Alleati di operare anche nell'Italia Centrale; si accennava infatti ad uno sbarco di paracadutis t i e di truppe aviotrasportate a Roma, contemporaneo o quasi all'armistizio, previsto tra il 12 e il 15 settembre.
L'Aeronautica, avrebbe reagito ad eventuali offese tedesche; appoggiato l'azione dell'Esercito, intesa a sostenere lepreviste operazioni alleate; raggiunto, non appena possibile, le basi siciliane e tunisine.
Pertanto, il giorno 6, il Gen. Sandalli convocò nel proprio ufficio al Ministero il Sottocapo di S.M. dell'Aeronautica, Gen. Sandalli, che era distaccato nella sede di campagna del Superaereo a Gallicano (Palestrina), ed il Gen. Ilari, Comandante della III Squadra Aerea (Roma), per informarli, in via strettamente segreta, delle trattative di armistizio che erano in corso tra il Governo italiano ed il Comando in capo alleato.
Premesso che l'armistizio avrebbe avuto attuazione presumibilmente verso il 15 settembre e riservandosi di impartire ulteriori ordini ed istruzioni prima di quella data, il Capo di S.M. dette comunicazioni ai due Ufficiali Generali dei seguenti documenti:
a) Disposizioni da mettere in atto alla ricezione da parte del Comando Supremo dell'ordine convenzionale: «Attuare missione ordine pubblico memoria n. 1 Comando Supremo».
E cioè:
- trasferire dalle loro sedi del territorio della III Squadra Aerea sulle basi della Sardegna il Raggruppamento bombardamento, il Raggruppamento siluranti, tutti i velivoli da trasporto disponib il i;
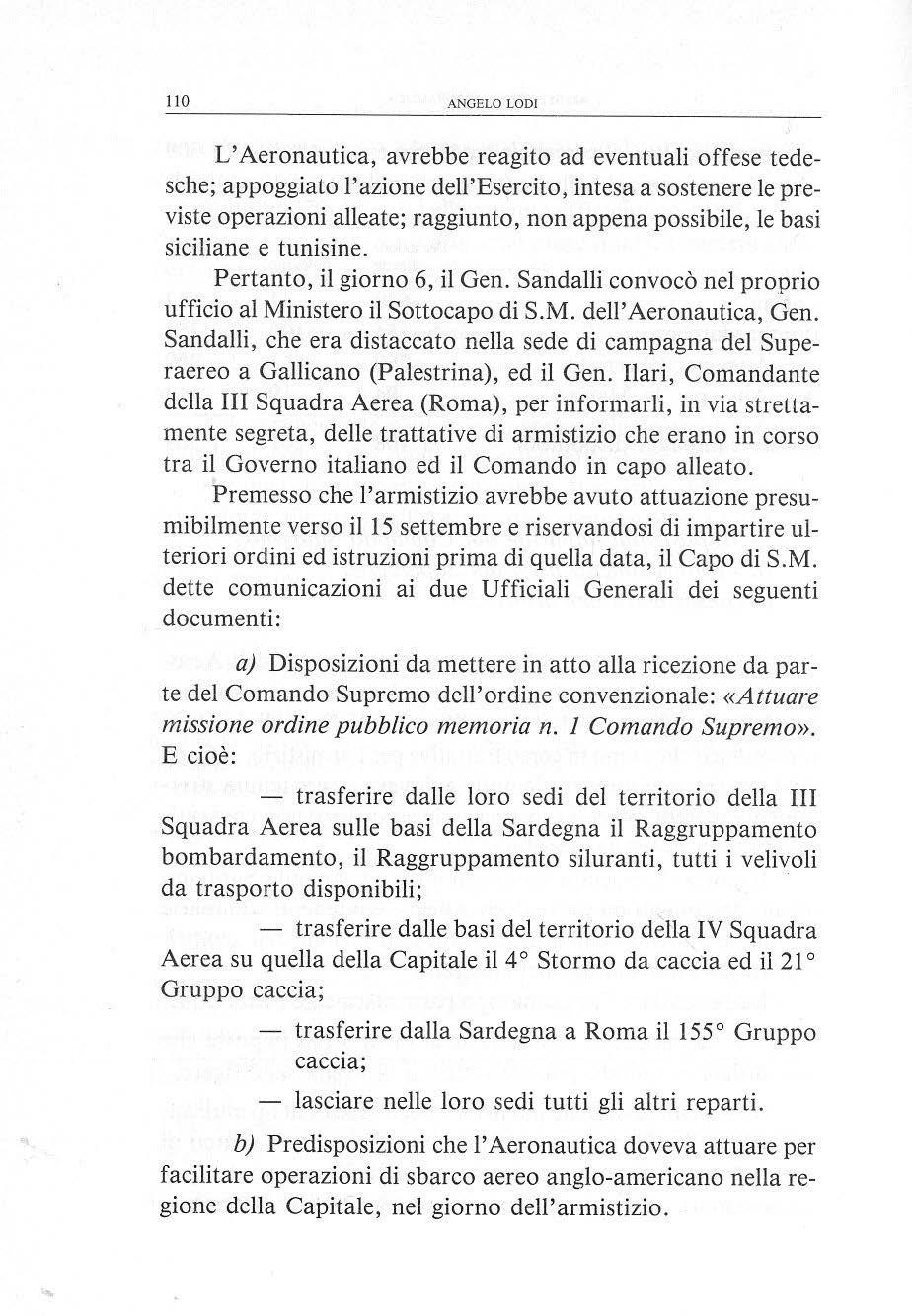
- trasferire dalle basi del territorio della IV Squadra Aerea su quella della Capitale il 4° Stormo da caccia ed il 21 ° Gruppo caccia;
trasferi re dalla Sardegna a Roma il 155° Gruppo cacc ia;
lasciare nelle loro sedi tutti gli altri reparti.
b) Predisposizioni che l'Aeronautica doveva attuare per facilitare operazioni di sbarco aereo anglo - americano nella regione de ll a Capitale, nel giorno dell'armistizio.
Tali predisposizioni, di cui era incaricato il Comandante della III Squadra, consistevano essenzialmente nel curare il concentramento di fotoelettriche e di autocarri su alcuni aeroporti della zona di Roma. Poichè si prevedeva di avere a disposizione oltre una settimana di tempo, venne particolarmente raccomandato di attuare gradatamente il concentramento dei suddetti mezzi, in modo da non suscitare sospetti nei Comandi tedeschi.
e) Alcune norme di massima relative alla consegna dei velivoli dell'Aeronautica sui campi Alleati, all'atto dell'Armistizio.
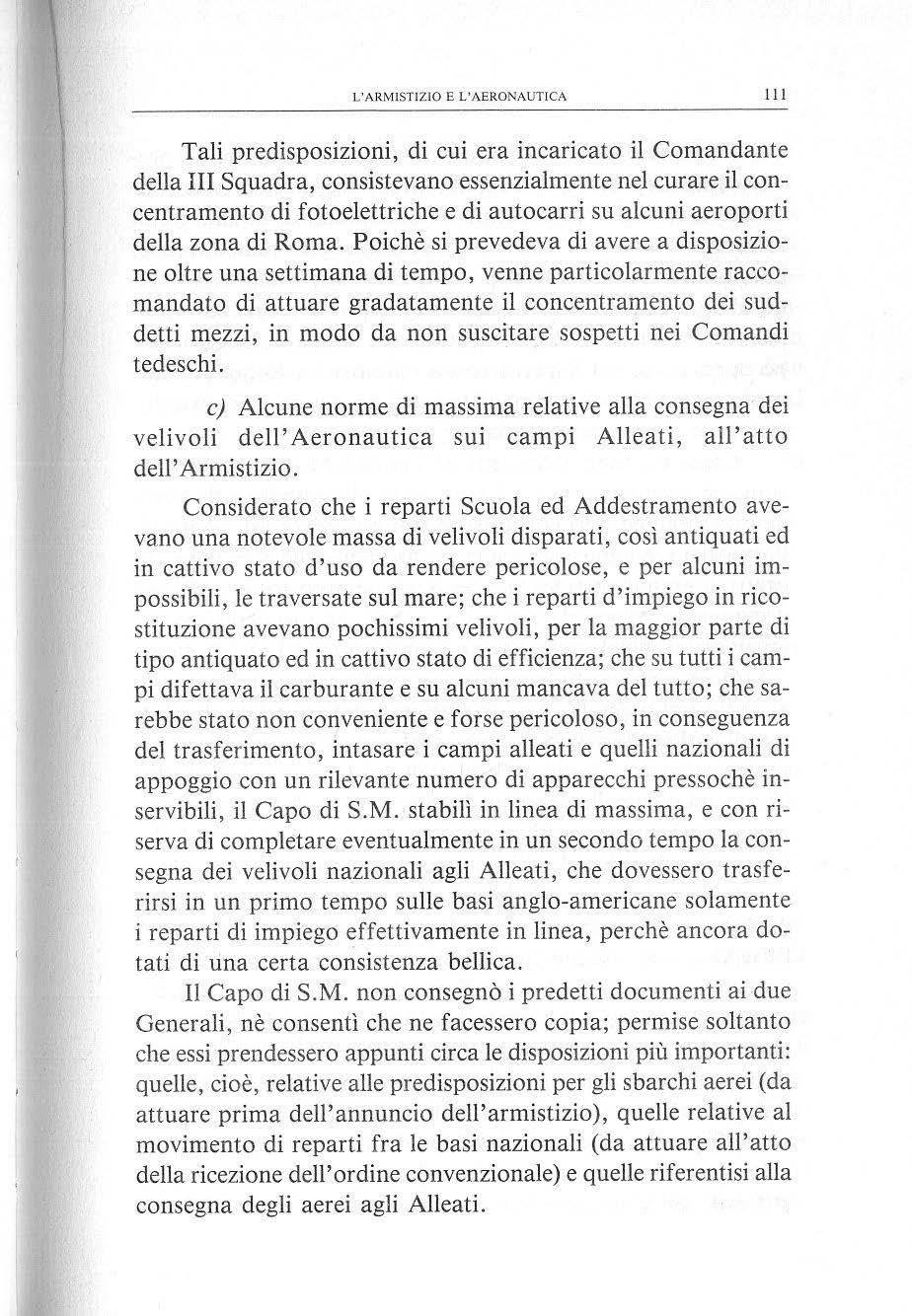
Considerato che i reparti Scuola ed Addestramento avevano una notevole massa di velivoli disparati, così antiquati ed in cattivo stato d'uso da rendere pericolose, e per alcuni impossibili, le traversate sul mare; che i reparti d'impiego in ricostituzione avevano pochissimi velivoli, per la maggior parte di tipo antiquato ed in cattivo stato di efficienza; che su tutti i campi difettava il carburante e su alcuni mancava del tutto; che sarebbe stato non conveniente e forse pericoloso, in conseguenza del trasferimento, intasare i campi alleati e quelli nazionali di appoggio con un rilevante numero di apparecchi pressochè inservibili, il Capo di S.M. stabilì in linea di massima, e con riserva di completare eventualmente in un secondo tempo la consegna dei velivoli nazionali agli Alleati, che dovessero trasferirsi in un primo tempo sulle basi anglo-americane solamente i reparti di impiego effettivamente in linea, perchè ancora dotati di una certa consistenza bellica.
Il Capo di S.M. non consegnò i predetti documenti ai due Generali, nè consentì che ne facessero copia; permise soltanto che essi prendessero appunti circa le disposizioni più importanti: quelle, cioè, relative alle predisposizioni per gli sbarchi aerei (da attuare prima dell'annuncio dell'armistizio), quelle relative al movimento di reparti fra le basi nazionali (da attuare all'atto della ricezione dell'ordine convenzionale) e quelle riferentisi alla consegna degli aerei agli Alleati.
Dopo aver tassativamente ordinato di non parlare del previsto armistizio con alcun collaboratore, aggiunse di aver convocato a Roma singolarmente i Comandanti di Squadra e di Aeronautica, per impartir loro di persona opportune direttive, in relazione agli avvenimenti che si andavano svolgendo. Infine, al Sottocapo di S.M. raccomandò di preoccuparsi per il momento soltanto di predisporre tutto per il rapido r itorno, al tempo opportuno, del Superaereo da Palestrina a Roma per sottrarlo a possibili colpi di mano tedeschi e per accentrare in un'unica sede gli organi essenziali di comando.
Come si è detto, il Ministro e Capo di S.M. successivamente convocò a rapporto tutti i Comandanti di Squadra e di Aeronautica. Egli conferì con ciascuno di essi senza far cenno all'armistizio, e lumeggiò così la situazione: i Tedeschi erano in istato di grande diffidenza e tensione, sempre più invadenti e decisamente avversi al nuovo Governo ed al nuovo indirizzo politico; era probabile un imminente conflitto con i Tedeschi stessi.
Ques te comunicazioni erano fatte allo scopo di conseguire alcuni primi risultati e cioè di mettere subito in istato di allarme gl i enti periferici; di far entrare il personale dipendente nel nuovo ordine di idee di un probabile conflitto con i Ted eschi; di concretare alcune predisposizioni relative alla infelice situazione contingente: molti campi completamente in mano tedesca, molti altri presidiati in comune da Italiani e Tedeschi. I noltre, il Gen. Sandalli dette ordine a ciascun Comandante di prendere particolareggiati accordi con i Comandi locali dell'Esercito, non essendo concepibile un'efficace azione locale se non coordinata con i Comandi stessi.
Si giunse così all'8 settembre. Verso le ore 17 ,3 0 di quel giorno, il Capo di Gabinetto dell'Aeronautica, Gen. Urbani, ricevette l'intercettazione di un comunicato radio di fonte alleata, relativo alla conclusion~ dell'armistizio. Chiestane subito conferma, la Segreteria del Capo del Governo smentì la notizia, qualificandola una manovra propagandistica, mentre un Ufficia le del Comando Supremo, ne ammise l'attend ibi lità.
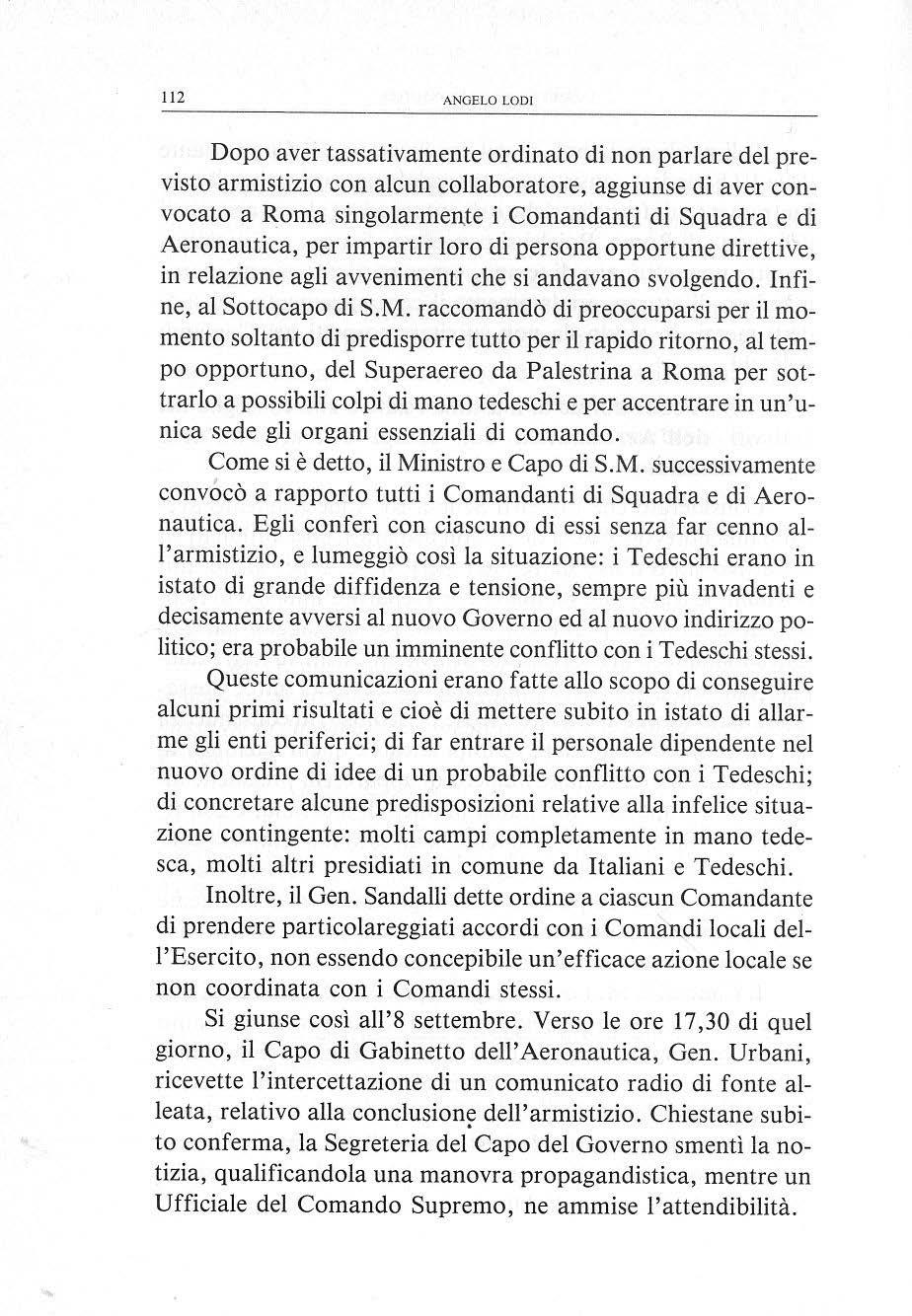
Il Sottocapo di S.M., che si trovava al Ministero per il giornaliero rapporto con il Capo di S.M., in assen za di questo ultimo -c he era stato chiamato dal Capo di S.M . Generale e non si sapeva dove fosse in quel momento - cercò di avere notizie inequivocabili, soprattutto allo scopo immediato di confermare o di annullare ordini già impartiti per azioni offensive, disposte dal Comando Supremo contro unità navali alleate nella zona di Salerno; ma soltanto alle 19, 15 riuscì ad aver e l'ordine di sospendere le azioni. I velivoli, già partiti, furono richiama t i per radio; molti rientrarono, mentre quattro, non av en do captato l 'o rdin e , eseguirono l'a zione , di cui p er l'oscurità non fu osservato l'esito.
Ritornato poco dopo al Ministero, il Capo di S.M. confermò l'avvenuta, anticipata ed inaspettata, con clusione dell'armistizio e ordinò al Sottocapo di S.M. di ritornare subito a Palestr ina e di preoccuparsi esclusivamente dell'immediato ritorno a Roma del Supe raereo; raccomandò di dare di sp osizioni per evitare iniziative avventate, suscettibili di portare ad incidenti con i Tedeschi; a ss icurò che avrebbe provveduto personalm ente a ciò, mettendosi in contatto telefonico con i Comandi di O. U. Aerea; si riservò, infine, di dare ulteriori di sp osizioni e direttive al Sott ocapo di S.M., quando que sti fosse rientrato a Roma, il mattino se guente .
Tornato immediatament e a Palestr ina, il Sottocapo di S.M. - che da Roma aveva già dato dispo sizi oni preliminari in proposito - accelerò le operazioni di trasferimento del Super aereo che, nel corso della notte, iniziò il movimento verso la sede del Ministero.
Alle ore 24 giunse al Superaereo a Palest rina il seg uente di s paccio del Comando Supre mo (prot. n. 16724), dirett o agli SS.MM. delle tre Forze Armate: «Il Governo italiano ha chiesto l'armistizio al Generale Eisenhower, Comandante in Capo delle Forze Armate Alleate. In base alle condiz ioni di armistizio, a partire dalle ore 10,45 di oggi 8 settembre dovrà cessare ogni nostro atto ostile verso le Forze Armate anglo-americane.

Le Forze Armate italiane dovranno però reagire con la massima decisione ad offese che provenissero da qualsiasi altra parte. Gen. Ambrosia» (3).
Questo dispaccio fu ritrasmesso integralmente a tutti i Comandi di G. U. ed il Sottocapo di S.M. ne dette comunicazione telefonica anche al Capo di S.M .. Ques ti informò il Gen. Santoro che la situazione gener ale non era preoccupante e che solo in alcune località si erano avuti incidenti non gravi, da attribuire più che altro ad iniziative individuali, e gli rinnovò la raccomandazione di consigliare ai Comand i dipendenti il massimo sangue freddo, per evitare atti os tili di no s tra ini ziativa.
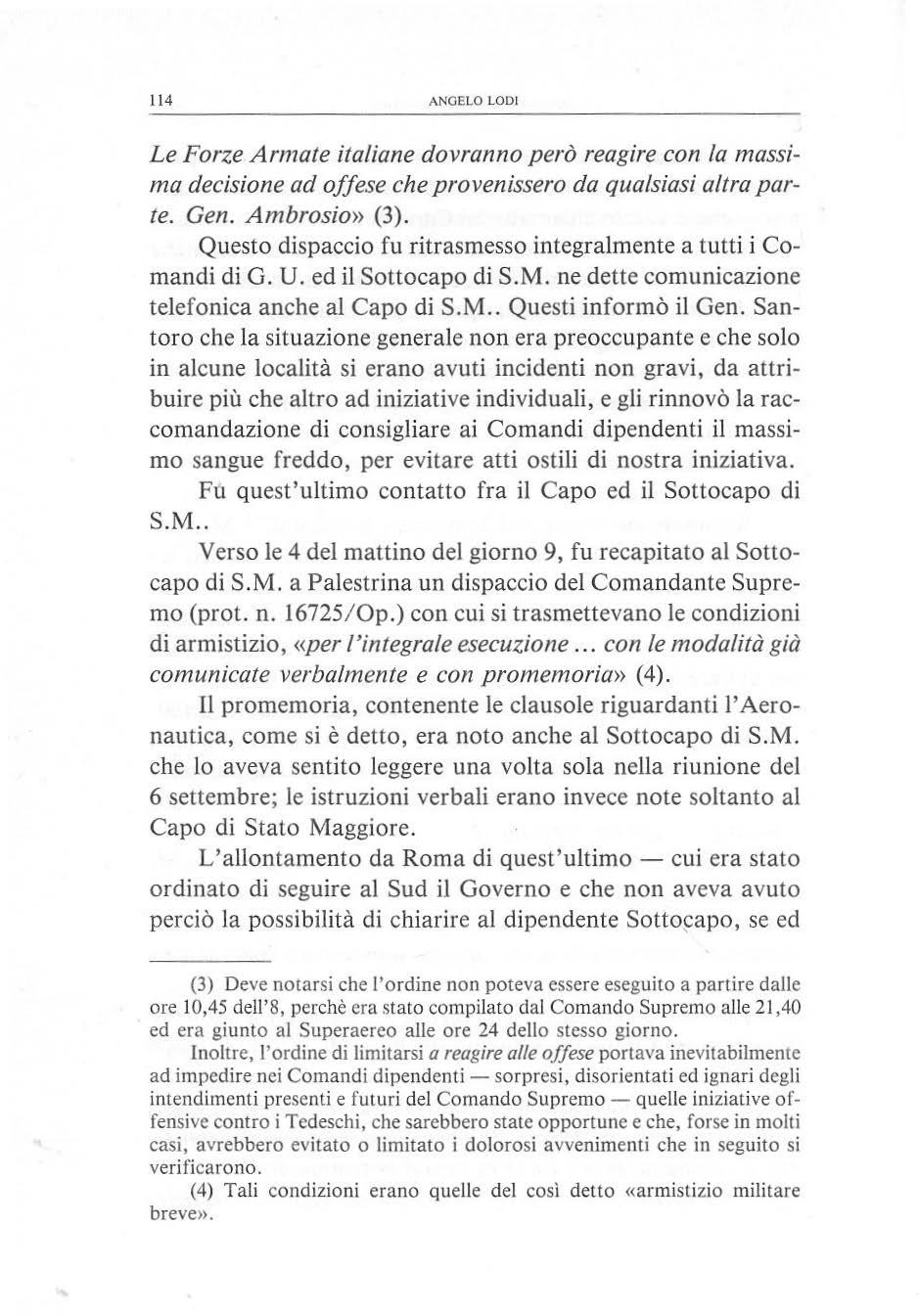
Fu quest'ultimo contatto fra il Capo ed il Sottocapo di S.M ..
Ve rso le 4 del mattino de l giorno 9, fu recapitato al Sottoca po di S.M. a Palestrina un dispaccio del Comandante Supremo (prot. n. 16725 / 0p.) con cui si tra s mettevano le condizioni di armistizio, «per l'integrale esecuzione ... con le modalità già comunicate verbalm ente e con promemoria» (4) .
Il promemoria, conten ente le clau sole ri g uardan t i l'Aeronautica, come si è detto, era noto anche al Sottocapo di S.M. che lo aveva sentito leggere una volta sola nella riunione del 6 se tt embre ; le is tru zio ni verbali erano in vece note so ltan t o al Capo di Stato Maggiore.
L ' allent a mento da Roma di que s t ' ultimo - cui era sta t o ordinato di se guire al Sud il Go verno e che non av ev a a v uto perciò la poss ibilità di chiarire al dip e ndente Sottocapo , se e d
(3) D eve notar si che l'o rdi ne no n p o teva esse re esegui to a pa rtire d alle o r e 10,45 dell' 8, perchè era stato comp ilato d a l Comand o Suprem o alle 21, 40 ed era gi un to al Superaereo alle ore 24 dell o stesso gio rn o Ino ltre, l ' ordine di limitar si a reagire alle offese p ortava inevi t abilmente ad im pe dire n ei C oman d i di pend ent i - sorpres i, di s ori e ntati e d ign ari d eg li in t endimenti pr ese n ti e fu turi del C omando S upremo - quelle ini z ia tive offens ive co nt ro i Ted eschi, ch e sa rebbero st at e opp or t u ne e ch e , forse in molti casi, avreb b ero ev itato o limitato i d o loros i avv enim e n ti ch e in seg uito s i veri fica rono.
(4) Tal i con dizioni e rano qu e lle d el cos ì eletto « armi s ti zi o mili tare breve».
in quale misura le istruzioni verbali modificassero il contenuto del promemoria - non contribuì certamente a facilitare il compito di chi, in seguito all'allontanamento del Capo di S :M., diventava il responsabile dell'esecuzione di quelle clausole, per quanto riguardava l'Aeronautica.
L'arrivo del dispaccio del Comando Supremo, dunque , lungi dall'apportare elementi chiarificatori, aumentò invece le cause di incertezza; soprattutto perchè, nelle allegate condizioni di armistizio, mentre l'art. 4 imponeva l'immediato trasferimento delle nostre unità aeree in zone sotto controllo alleato, con modalità di dettaglio che sarebbero state fissate dal Comando in capo alleato (modalità mai pervenute), l'art. 7 stabiliva che i campi di aviazione dovessero essere protetti dalle FF.AA. italiane fino all'assunzione di questo compito da parte degli Alleati e l'art. 9 obbligava il Governo italiano ad impiegare tutte le Forze Armate per assicurare l'adempimento di tutte le clausole dell'armistizio stesso.
Per ricevere chiarimenti in merito, il Sottocapo di S.M. cercò di conferire telefonicamente con il Capo di S.M . ; ma ciò fu impossibile, in quanto, in seguito all'ordine ricevuto, il Capo di S .M. si era già allontanato dal Ministero, per partire insieme ai membri del Governo.
Alle 6,30 dello stesso giorno 9, il Sottocapo di S.M. ric evette personalmente al telefono da un Ufficiale inferiore del Comando Supremo la seguente comunicazione (prot. n. 16733/0p.), indirizzata ai Capi di S.M. delle tre FF.AA.: «Informo che Governo e Comando Supremo lasciano Roma ore sei dirigendo su Pescara . Eccellenze Capi di S.M. delle tre Forze Armate devono seguire al più presto, lasciando loro rappresentanti in sito. Quale rappresentante del Comando Supremo resta in sito il Generale Palma. Gen. Ambrosio».
Poco dopo, mentre il Sottocapo di S .M. - avendo la quas i totalità del Superaereo lasciato Palestrina - stava per partire per Roma, pervenne il seguente ordine del Comando Supremo (prot. n. 52043/0p. ore 5,157: «Non appena condizioni luce
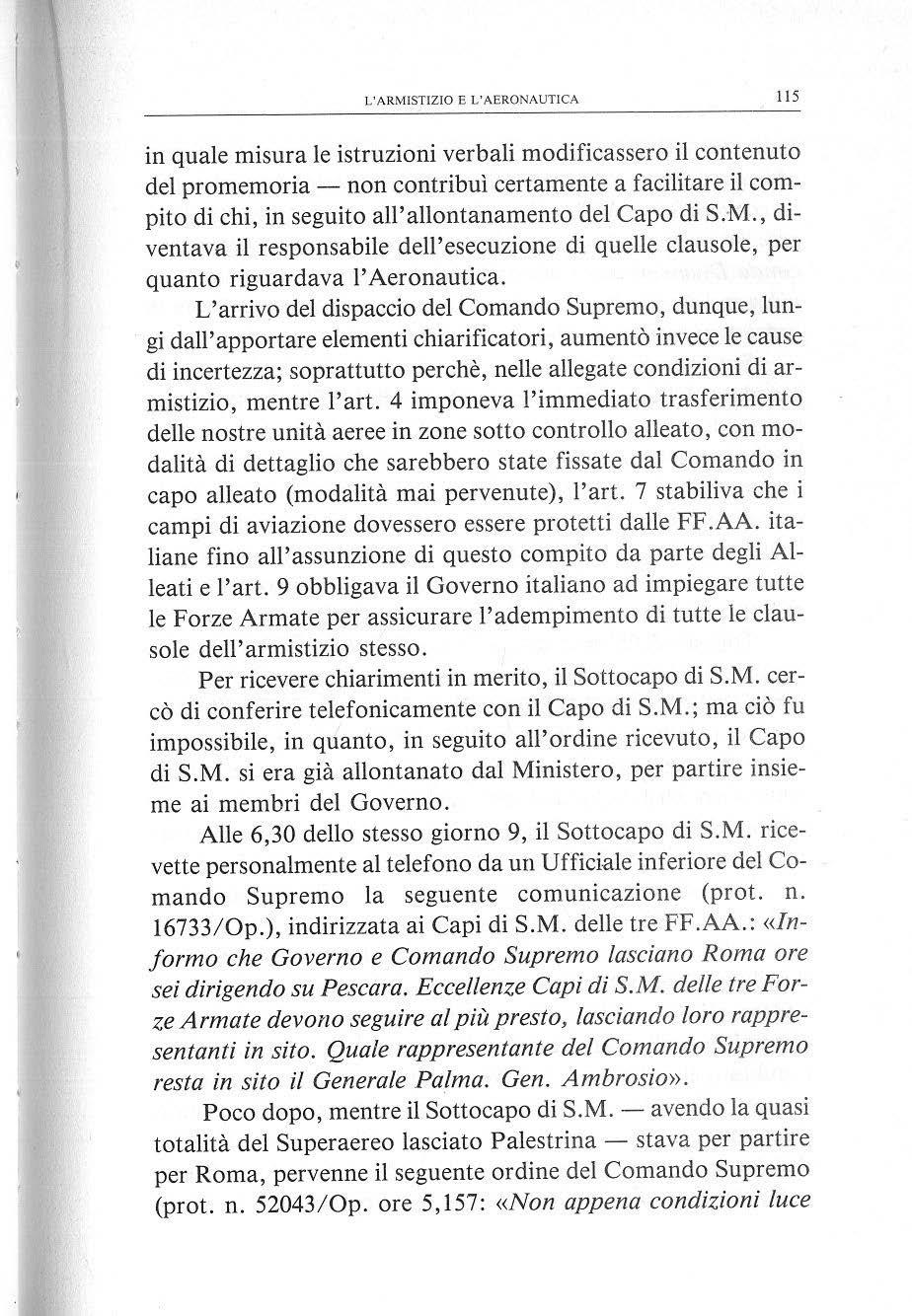
lo consentano dovranno essere battuti dall'aviazione seguenti obiettivi: colonna di circa 100 autoblinde dirette Roma su strada costiera Santa Marinella; colonne della terza Divisione «Panzer» ad ovest e ad est Lago Bracciano dirette sud; colonne seconda Divisione paracadutisti che premono su via Ostiense e più a sud dirette Roma; elementi corazzati da Formia Ga eta in movimento verso nord».
Fu disposta l'immediata ritrasmissione dell'ordine al Comandante III Squadra Aerea (prot. n. I B/ 13551). Tuttavia, per ragioni di prudenza; ad evitare che colonne italiane fossero scambiate per co lonne tedesche, si ritenne opportuno, prima che fosse data esecuzione all'azione offensiva, di far precedere questa da un'esplorazione con velivoli da caccia. Tali esp lora zi oni non rilevarono nulla, ve ro sim ilmente, a causa del tempo intercorso fra l'ora in cui le notizie - se pure esatte - erano pervenute al Comando Supremo e l'ora in cui le missioni furono eseguite.
Tornato definitivamente a Roma, il Sottocapo di S.M. ebbe conferma del già avvenuto improvviso allontanamento del Governo, del Capo di S.M . Generale e dei tre Capi di S.M .. Nel partire, il Ministro e Capo di S.M. dell'Aeronautica aveva lasciato disposizione che rimanessero a Roma il Capo di Gabinetto, Gen. Urbani, quale rappresentante del Ministro e re sp onsabile del Mini stero, e il Sottocapo di S.M. qual e rappresentante del Capo di S . M. e responsabile dello Stato Maggiore. Privo di istruzioni e di chiarimenti, oltre quelli già accennati, generici ed in gran parte superati dagli avvenirnenti in una situazione estremamente difficile e assai diversa da quella che il colloquio del giorno 6 con il Capo di S.M. aveva lasciato prevedere, all'oscuro di qualsiasi notizia concreta sulla situazione generale e sugli intendimenti delle supreme Autorità politiche e militari, il Sottocapo di S.M. cercò anzitutto di mettersi in contatto con il designato rappresentante a Roma del Comando Supremo, che riuscì introvabile; e poi, inutilmente , con lo S.M. dell'Esercito, con il Comando del Corpo d'Armata di Roma e con il Comando del Corpo d'Armata Corazzato. Unico Ca-
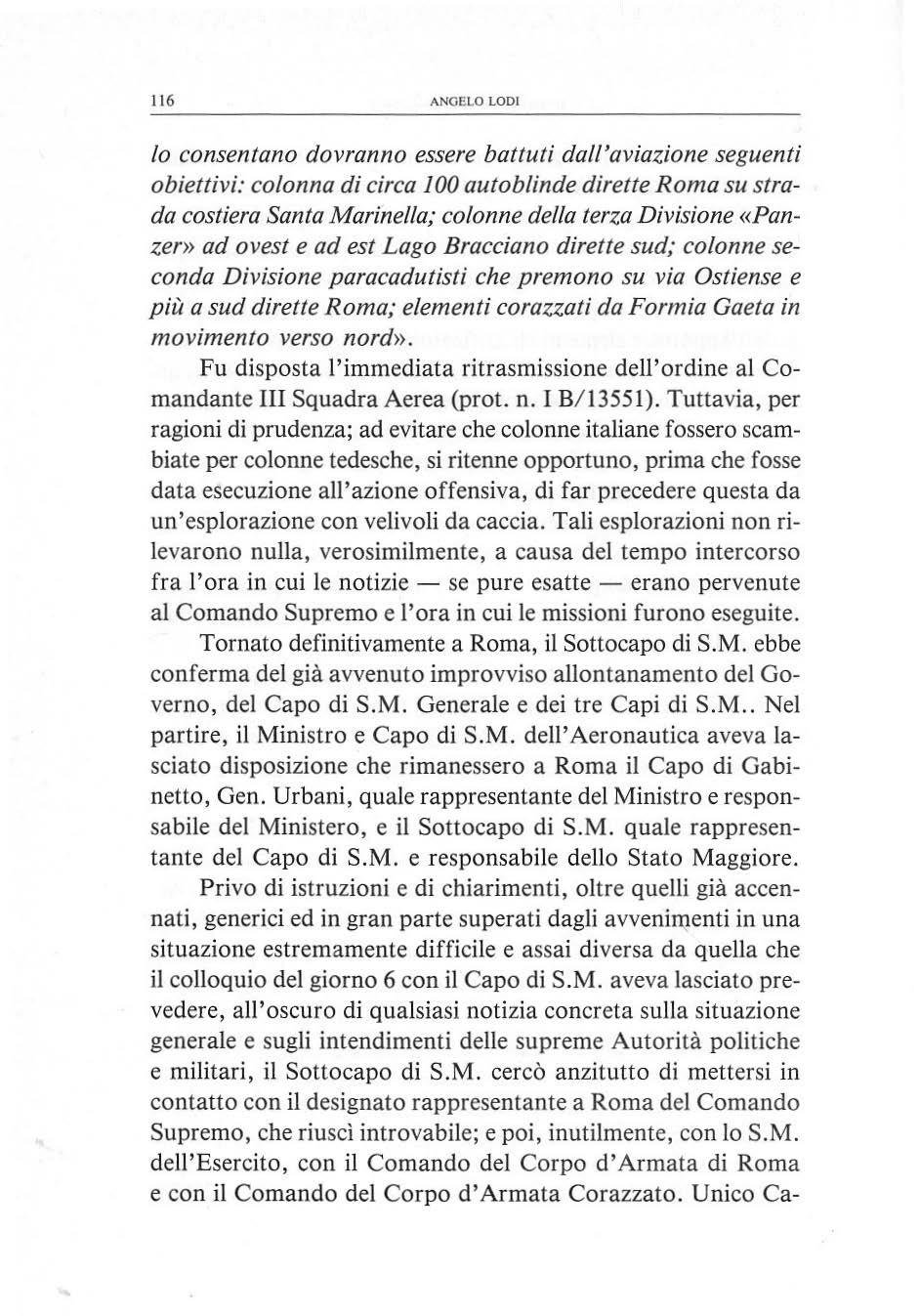
po militare presente al suo posto, il Sottocapo di S.M. della Marina, il quale però non potè fornire al Sottocapo di S.M. del1' Aeronautica alcun lume sulla situazione.
In mattinata il Supermarina chiese al Supreaereo con la massima urgenza una scorta caccia alla nave «Roma» che, in navigazione lungo le coste sarde, chiedeva protezione perchè attaccata da aerei tedeschi. L'ordine relativo fu impartito telefonicamente al Comando Aeronautica della Sardegna, ma naturalmente l'esecuzione di esso fu, e non poteva non essere, troppo tardiva.
Occorreva ed urgeva, intanto, che il Sottocapo di S.M. desse conveniente soluzione a tre ordini di problemi della massima importanza:
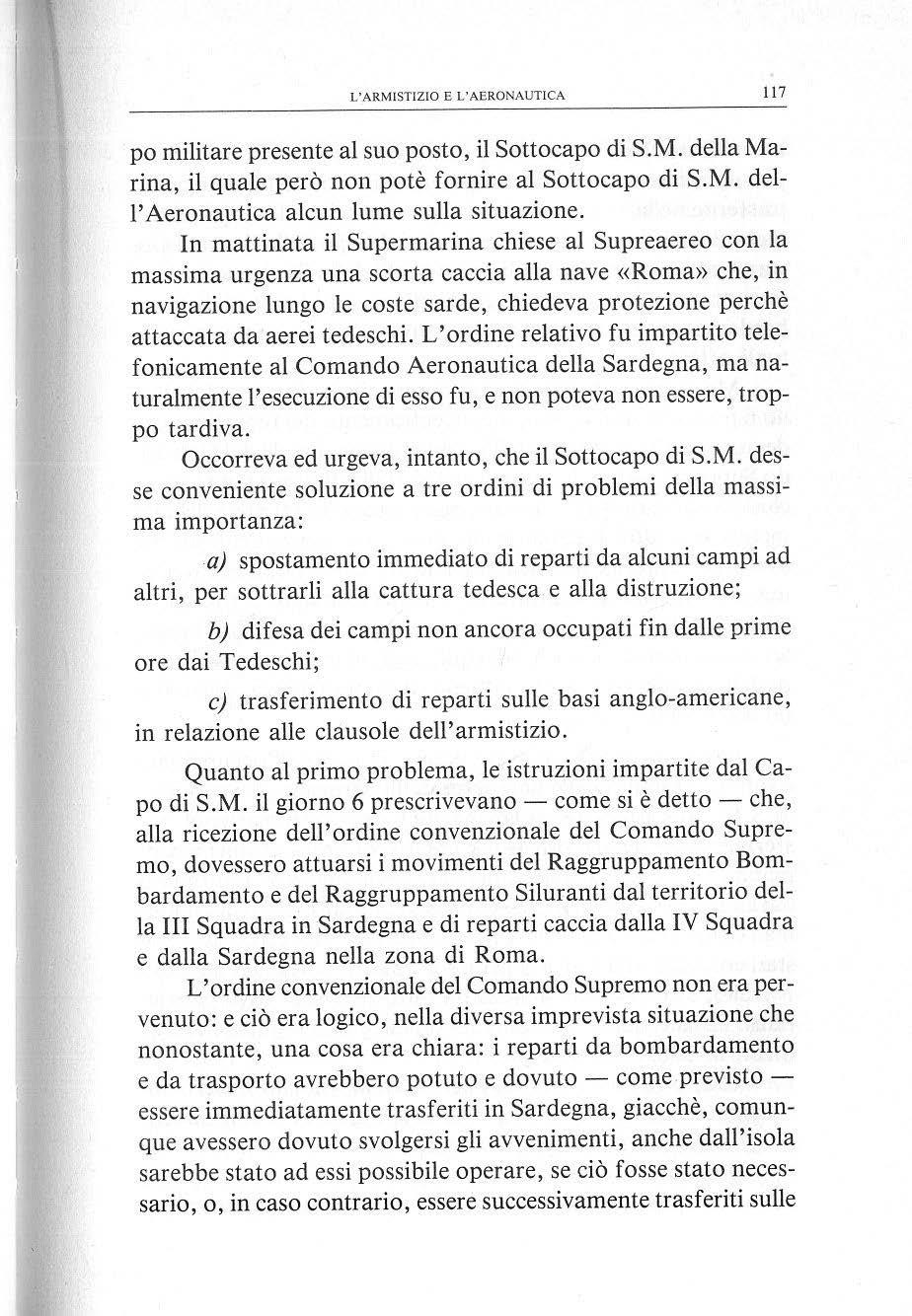
a) spostamento immediato di reparti da alcuni campi ad altri, per sottrarli alla cattura tedesca e alla distruzione;
b) difesa dei campi non ancora occupati fin dalle prime ore dai Tedeschi;
e) trasferimento di reparti sulle basi anglo-americane, in relazione alle clausole dell'armistizio.
Quanto al primo problema, le istruzioni impartite dal Capo di S.M . il giorno 6 prescrivevano - come si è detto - che, alla ricezione dell'ordine convenzionale del Comando Supremo, dovessero attuarsi i movimenti del Raggruppamento Bombardamento e del Raggruppamento Siluranti dal territorio della III Squadra in Sardegna e di reparti caccia dalla IV Squadra e dalla Sardegna nella zona di Roma.
L'ordine convenzionale del Comando Supremo non era pervenuto : e ciò era logico, nella diversa imprevista situazione che nonostante, una cosa era chiara: i reparti da bombardamento e da trasporto avrebbero potuto e dovuto - come previstoessere immediatamente trasferiti in Sardegna, giacchè, comunque avessero dovuto svolgersi gli avvenimenti, anche dall'isola sarebbe stato ad essi possibile opera re , se ciò fosse stato necessario, o, in caso contrario, essere successivamente trasferiti sulle
basi alleate. Nella situazione contingente appariva invece opportuno, in contrasto con le previsioni e con le direttive, non trasferite nella zona di Roma i reparti caccia della IV Squadra (nel cui territorio stavano spostandosi il Capo dello Stato, il Governo ed i p iù alti Capi militari) e quelli della Sardegna (nel cui te rritorio avrebbero dovuto concentrarsi tutti i reparti da bombardamento e da trasporto, che conveniva proteggere da eventuali offese aeree).
Ma al riguardo era da considerare che le direttive del giorno 6 prevedevano, è vero, il concentramento dei reparti in Sardegna, ma alla ricezione dell'ordine convenzionale del Comando Supremo, vale a dire prima che ai Tedeschi fosse no ta la conclusione dell'armistizio. Invece, nella situazione effettiva del momento, quando i Tedeschi erano già a conoscenza del fatto che avevano sorpreso e disorientato il nostro Governo, il nostro Comando Supremo e, soprattutto , i nostri Comandi periferici, la più elementare prudenza imponeva, prima di trasferirvi un notevole numero di velivoli e di equipaggi, di assicurarsi se i campi della Sardegna fossero o meno in mano tedesca, fossero o no a tterra bili.
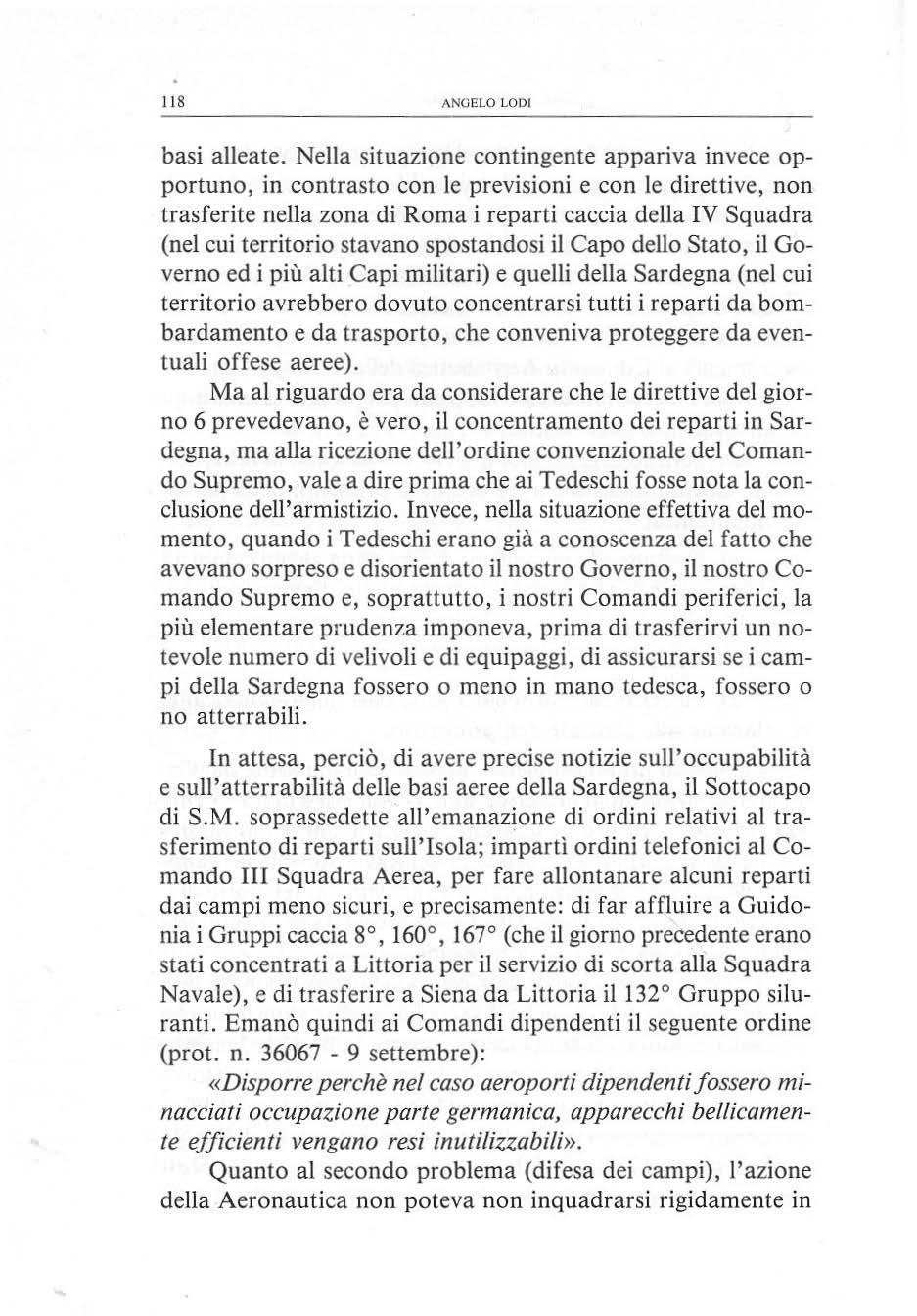
In attesa, perciò, di avere precise notizie sull'occupabilità e sull'atterrabilità delle basi aeree della Sardegna, il Sottocapo di S.M. soprassedette all'emanazione di ordini relat ivi a l trasfer im ento di reparti sull'Isola; impartì ordini te lefonici al Comando III Squadra Aerea, per fare allontanare alcuni reparti dai campi meno sicuri, e precisamente: di far affl uire a Guidonia i Gruppi caccia 8° , 160°, 167° (che il giorno precedente erano stati concentrati a Littoria per il serv izio di scorta alla Squadra Navale), e di trasferire a Siena da Littoria il 132° Gruppo siluranti. Emanò quindi ai Comandi dipendenti il seguente ordine (prot. n. 36067 - 9 settembre):
«Disporre perchè nel caso aeroporti dipendenti f assero minacciati occupazione parte germanica, apparecchi bellicamente efficienti vengano resi inuti lizzabili».
Quan to al secondo problema (difesa dei campi), l'azione della Aeronautica non pot eva non inquadrarsi rigidamente in
quella dell'Esercito, cui durante le ostilità era stata affidata la difesa interna ed esterna degli aeroporti: infatti, data la potenzialità difensiva dei nostri aeroporti - sui quali l'Aeronautica non disponeva di altre armi che di qualche mitragliera e.a. e dei pochi moschetti mod. 1891 per gli uomini di guardia - sarebbe stato assurdo pensare che essi potessero difendersi e resistere se, nel territorio circostante, le Unità dell'Esercito non avessero fatto altrettanto e non avessero concorso alla difesa esterna delle basi.
Era indispensabile perciò conoscere gli ordini, gli intendimenti, le possibilità e la situazione delle Unità dell'Esercito, per poter impar tire ordini precisi alle Unità aeree dipendenti: di qui i reiterati ed inutili tentativi di stabilire il contatto col Superesercito, con il rappresentante del Comando Supremo, con i Comandi delle O. U. terrestri della Capitale. Nell'impossibilità di evere elementi al riguardo, il Sottocapo raccomandò ai Comandanti, con i quali era in collegamento telefonico, di prendere contatti con i viciniori Comandi dell'Esercito e di armonizzare la propria condotta e quella dei Comandi dipendenti agli intendimenti, agli atteggiamenti ed alle possibilità dei reparti terrestri.
Quanto, infine, al terzo problema (trasferimento di reparti su basi alleate), a parte l'impossibilità di impartire ordini completi ed esatti a tutte le O. U. aeree (come si vedrà in seguito, co n alcune di queste non si comunicava più fin dalla notte sul 9: con altre le comunicazioni erano difficili e, presumibilmente, controllate dai Tedeschi), la situazione era del tutto diversa da quella prevista. Tanto è vero che il Comando Supremo, prima di allontanarsi da Roma , non solo non aveva emanato il noto ordine convenzionale, non solo non aveva dato alcun ordine di trasferimento di reparti, ma aveva invece disposto azioni offensive: si poteva pertanto presumere che altre azioni potessero essere ordinate dal Comando Supremo stesso, o disposte di iniziativa o su richiesta, per appoggiare eventuali azioni dell'Esercito, e per concorrere ad eventuali azioni di sbarco alleate, come previsto nell a nota memoria.

Ciò che essenzialmente sco n s igliava l'emanazione immediata dell'ordine di afflusso dei reparti sulle basi alleate, era la sopra accennata contraddizione fra le condizioni di armistizio e, di conseguenza, il sussistere del dilemma:
- trasferire su bito i reparti di impiego sulle basi alleate attenendosi così all'art. 4 delle condizioni di armistizio;
- o tenere sottomano i reparti, per coll abor are di iniziativa o su eventuali ordini superi ori con l'Esercito o con le truppe alleate in azione antitedesca, attenendosi all'art. 9 delle condizioni stesse?
A consigliare la prima decisione, oltre alla logica preoccupazione - e, in un certo senso, alla comoda soluzione - di mettere al più presto in salvo dai Tedeschi personale e materiale, es i teva un solo elemento: l'art. 4 delle condizioni di armistizio.
A consigliare e quasi ad imporr e la seconda deci sione, invece, oltre all'art. 9 delle stesse condizioni, suss ist evano, il 9 settembre ed i giorni successivi, non pochi altri elementi concreti:
a) anzitutto, l'ordine emanato alle 5 e 15 d el 9 settembre dal Comando Supremo, col dispaccio n. 52043, di effettuare azioni offensive contro i T edesc hi : altri ordini del genere potevano pervenire quel giorno stesso o i gio rni seguenti ed era, pertanto, prudente conservarsi la possibilità di dar e ad essi esecuzione;
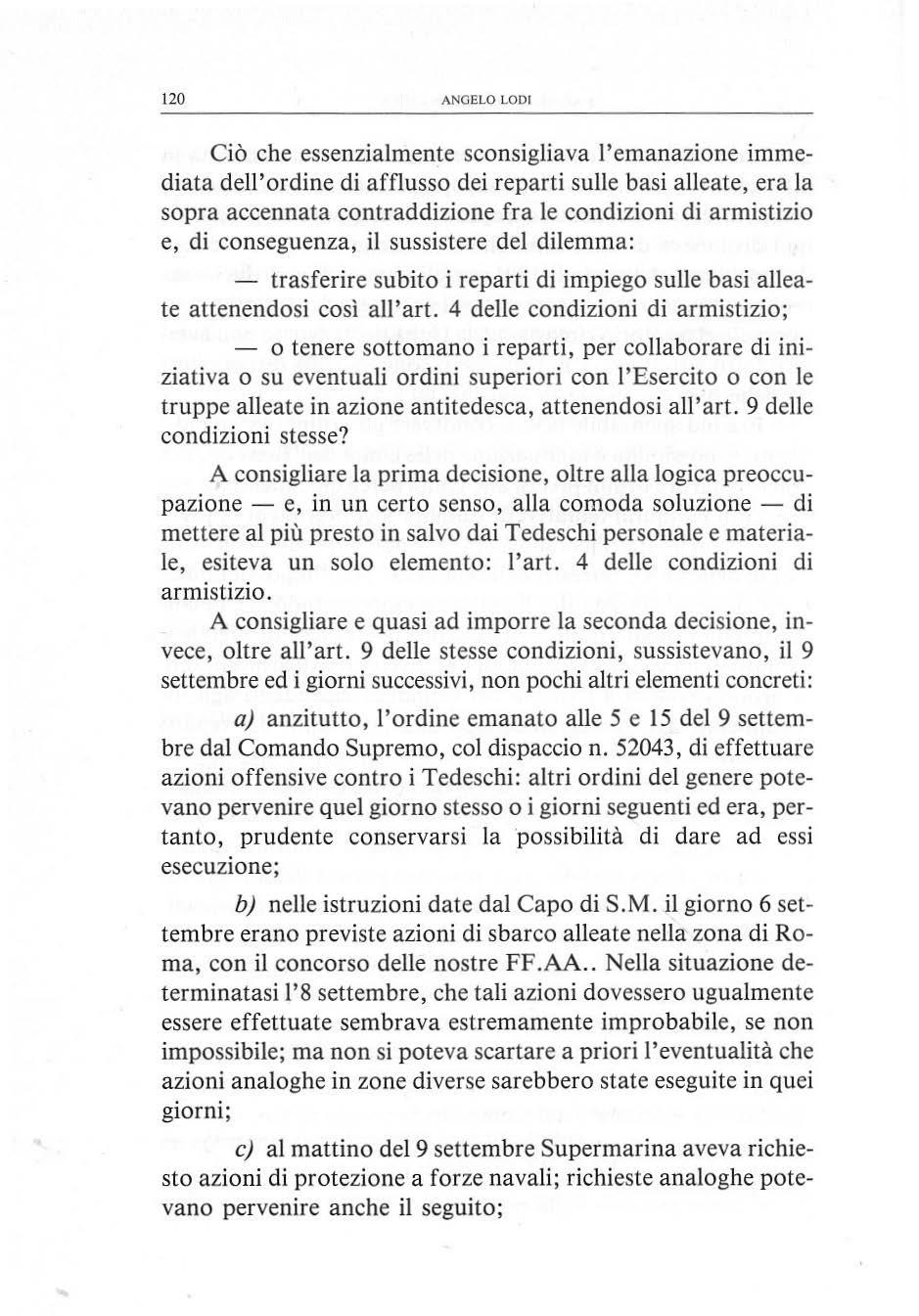
b) nelle istruzioni date dal Capo di S.M. il giorno 6 settembre erano previste azioni di sbarco alleate nella zona di Roma, con il conc orso delle nostre FF.AA .. Nella situazione determinatasi 1'8 settemb re, che tali azioni dov essero ugualmente essere effettuate sembrava estremamente improbabile, se non impossibile; ma non si poteva scartare a priori l'eventualità ch e azioni analoghe in zone diver se sarebbero state eseguite in quei g1orm;
e) al mattino del 9 settembre Supermarina aveva richiesto azioni di protezione a forze navali; richie ste analoghe potevano perven ire anche il seguito;
d) al mattino del 1O (come si vedrà fra poco) il Corpo di Armata Corazzato aveva chiesto esplorazioni aeree, per accer t are la effettuazione o meno di sbarchi, che si presumeva gli Alleati stessero effettuando fra Napoli e Gaeta: ciò evidentemente era un elemento che poteva indurre a dar consistenza alle supposizioni di cui alla lettera b);
e) la stessa mattina del 10 (come si vedrà) un Ufficiale dell'Aeronautica aveva chiesto al Sottocapo di S.M . , da parte del Capo di S.M., di esaminare la possibilità e la convenienza di trasferire uno Stormo da caccia da Brindisi a Roma. Il Capo di S.M. perciò, non solo non dava alcuna disposizione per il trasferimento dei reparti sulle basi alleate, nè chiedeva notizia se tale trasferimento fosse già avvenuto, ma intendeva invece trasferire a Roma uno Stormo già tranquillamente dislocato in zona sotto controllo alleato: ciò induceva logicamente a pensare che le Autorità Superiori prevedevano la necessità di impiego e d! intervento della Aeronautica nazionale.
In conclusione, la seconda soluzione appariva sotto ogni riguardo più prudente, se non addirittura necessaria; e quindi anche per iJ terzo problema il Sott ocapo decise di soprassedere alla emanazione di ogni ordine, in attesa del chiarirsi della situazione, nonchè di ordini ed istruzioni da parte del Comando Supremo e del Capo di S.M., appena questi avesse raggiunto la sede prescelta.
La situazione delle comunicazioni tra Roma ed i Comandi delle Grandi Unità aeree, al mattino del 9, era la seguente: Dalla I Squadra, interrotte le comunicazioni telefoniche fin dalla notte e non ricevendo risposta le comunicazioni radio, non si era riusciti ad avere alcuna notizia.

Dalla Provenza, un messaggio radio del Comando 4 a Armata in data 8 settembre aveva comunicato che tutti gli aeroporti erano stati occupati dai Tedeschi e che il personale era stato disarmato.
Dalla Corsica, nessuna notizia.
Con la Sardegna si comunicava, seppure con difficoltà, telefonicamente; i Tedeschi avevano distrutto alcuni campi e si stavano ritirando verso il nord dell'isola.
Con la II Squadra si era in collegamento telefonico. Il Comando di Squadra aveva comunicato che alcuni campi erano stati occupati dai Tedeschi, ma che la si tuazione generale non era preoccupante. Il Sottocapo di S.M. concordò con il Comandante della Squadra alcuni spostamenti di sicurezza dei reparti e trasmise alcune richieste di aiuto dell'Aviazione SloveniaDalmazia.
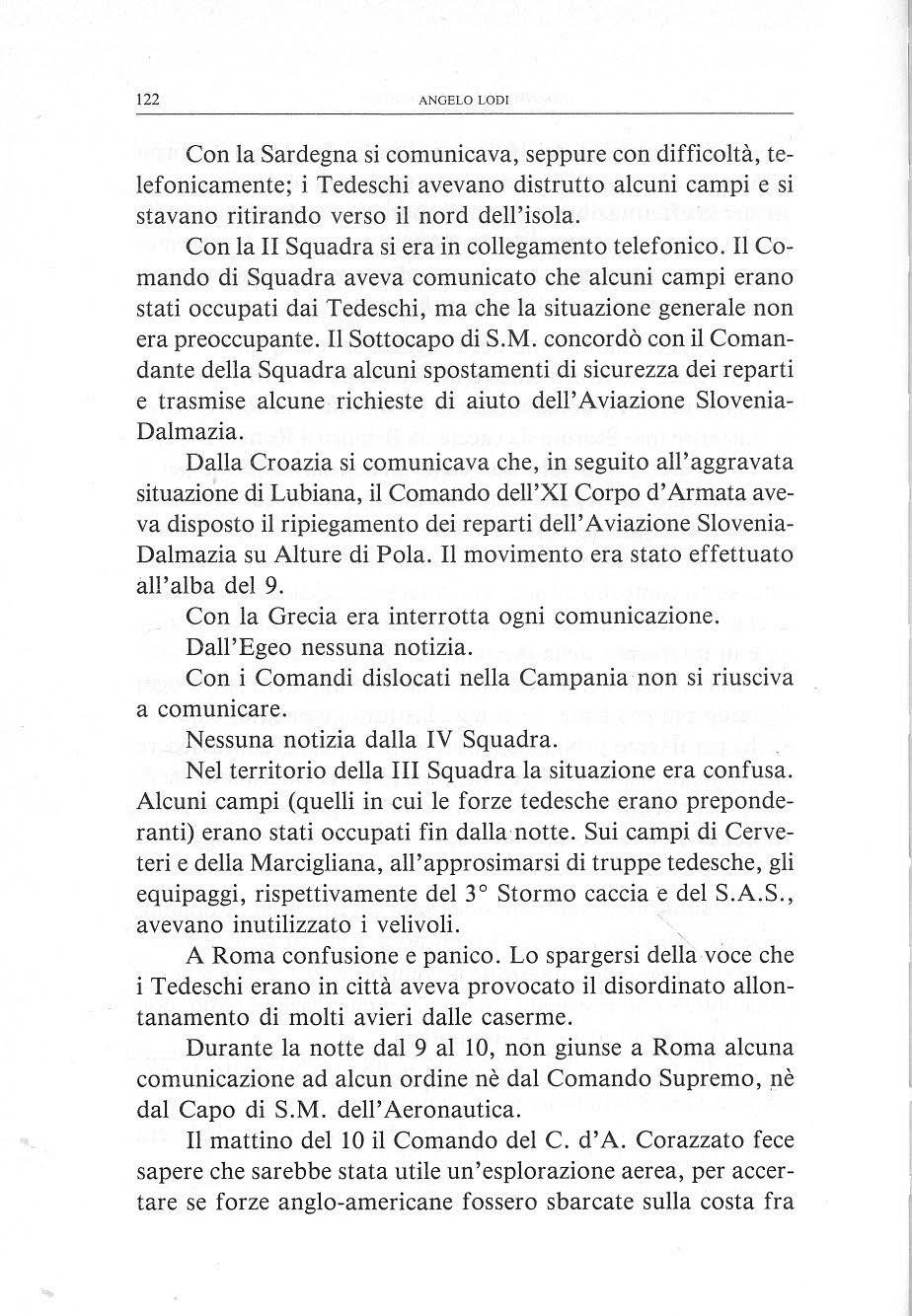
Dalla Croazia si comunicava che, in seguito all'aggravata situazione di Lubiana, il Comando dell'XI Corpo d'Armata aveva disposto il ripiegamento dei reparti dell'Aviazione SloveniaDalmazia su Alture di Pola. Il movimento era stato effettuato all'alba del 9.
Con la Grecia era interrotta ogni comunicazione.
Dall'Egeo nessuna notizia.
Con i Comandi dislocati nella Campania non si riusciva a comunicare.
Nessuna notizia dalla IV Squadra.
Nel territorio della III Squadra la si tua zione era confusa. Alcuni campi (quelli in cui le forze tedesche erano preponderanti) erano stati occupati fin dalla notte. Sui campi di Cerveteri e della Marcigliana, all'approsimarsi di truppe tedesche, gli equipaggi, rispettivamente del 3° Stormo caccia e del S.A.S., avevano inutilizzato i velivoli.
'
A Roma confusione e panico. Lo spargersi della voce che i Tedeschi erano in città aveva provocato il disordinato allontanament o di molti avieri dalle caserme.
Durante la notte dal 9 al 10, non giunse a Roma alcuna comunicazione ad alcun ordine nè dal Comando Supremo, nè dal Capo di S.M. dell'Aeronautica.
Il mattino del 10 il Comando del C. d' A. Corazzato fece sapere che sarebbe stata utile un'esplorazione aerea, per accertare se forze anglo-americane fossero sbarcate sulla costa fra
Napoli e Gaeta. L'esplorazione disposta dalla III Squadra nulla rilevò.
Poco dopo, un Ufficiale pilota, proveniente in volo da Brindisi, telefonò al Sottocapo di S.M. da Guidonia, per chiedere a nome del Capo di S.M. di esaminare la possibilità e la convenienza del trasferimento del 4 ° Stormo da caccia dalle Puglie su un campo della Capitale. Il Sottocapo di S.M. rispose che, data l'incertezza della situazione generale e degli aeroporti in particolare, non era opportuno prendere tale decisione, anche perchè si cominc iava a parlare di trattative con i Comandi tedeschi per il riconoscimento di Roma «Città Aperta».
Infatti, in un colloquio avuto nel pomeriggio col Maresciallo Caviglia, questi comunicò al Sottocapo di S.M. dell'Aeronautica che le trattative con i Tedeschi sembravano ormai concluse, nel sens o che essi sarebbero rimasti fuori di una «linea rossa» delimitante la Città Aperta. Poichè tutti gli aeroporti si trovavano fuori di tale linea, il Maresciallo invitò il Sottocapo di S.M. della Aeronautica a far inutilizzare, se ancora possibile, i velivoli eventualmente rimasti sugli aeroporti stessi (5).
Nelle prime ore de l pomeriggio dello stesso giorno 10, poichè la situazione in Sardegna appariva sufficientemente chiara, il Sottocapo di S.M. trasmise alla III Squadra il seguente ordine (prot. n. 36073 del 10 settembre): «Disporre perchè entro domattina il Raggruppamento Bombardamen t o si trasferisca all'aeroporto di Alghero ed il Raggruppamento Siluranti all'aeroporto di Milis».
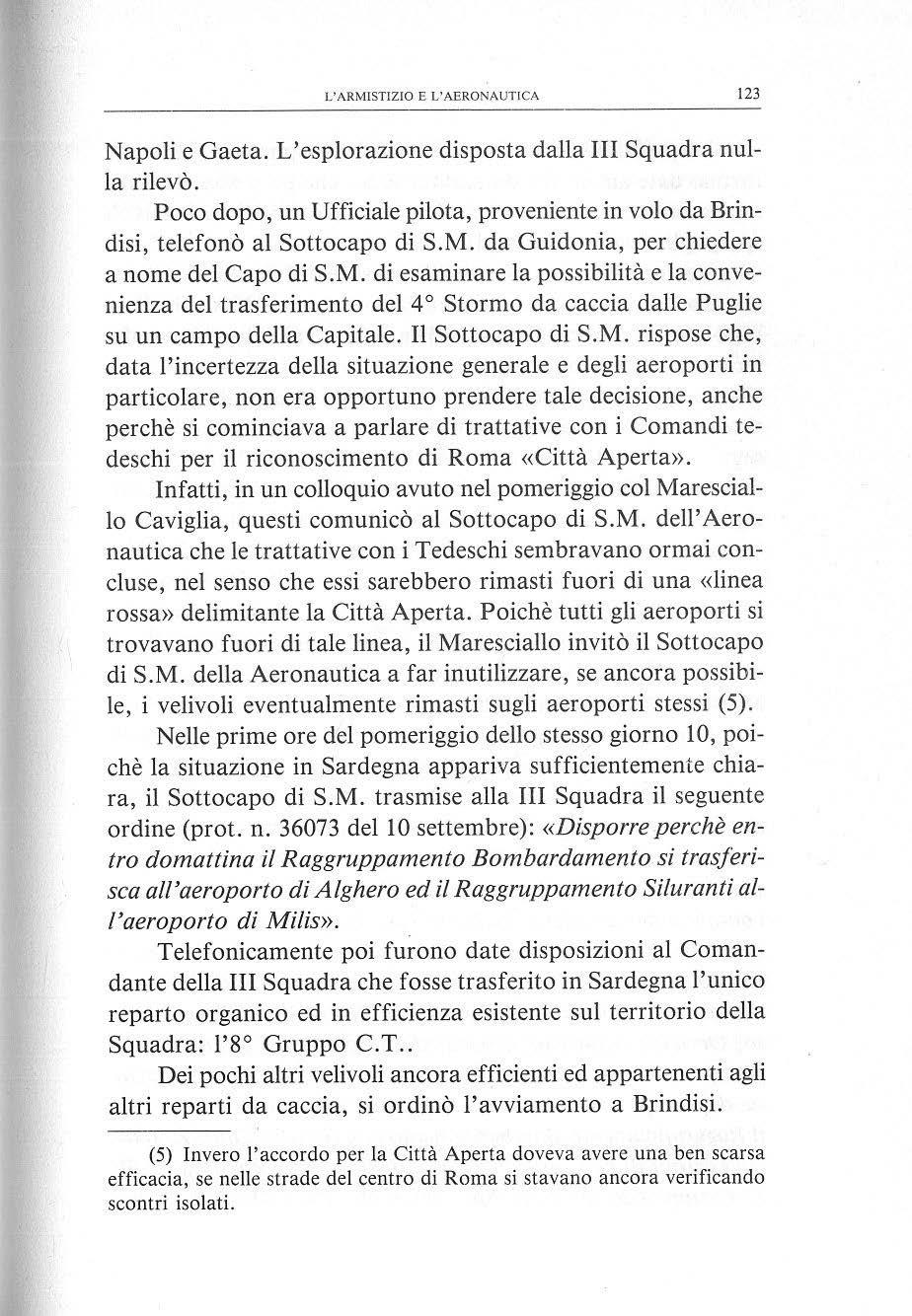
Telefo nicamente poi furono date disposizioni al Comandante della III Squadra che fosse trasferito in Sardegna l'unico reparto organico ed in efficienza esistente sul territorio della Squadra: 1'8° Gruppo C.T ..
Dei pochi altri velivoli ancora efficienti ed appartenenti agli altri reparti da cacc ia, si ordinò l'avviamento a Brindisi.
(5) Invero l'accordo per la Città Aperta doveva avere una ben scarsa efficacia, se nelle strade del centro di Roma si stavano ancora verificando scontr i isolati.
Disposizioni di inviare i velivoli da trasporto in Sardegna furono date anche al Comando S.A.S., che però non era molto al corrente della situazione dei suoi reparti e dei suoi velivoli sparpagliati sui vari campi.
Verso le 3 della notte dell' 11 giunse dal Comando Aeronautica della Sardegna la comunicazione (prot. 43000) che l'aeroporto di Milis era inutilizzabile in seguito alla distruzione del terreno di atterraggio e che l'aeroporto di Alghero era inefficiente. Si chiedeva pertanto che il Raggruppamento Siluranti si trasferisse a Decimomannu. Il Superaereo modificò in conseguenza gli ordini già impartiti alla III Squadra. Verso le 8 del mattino, dalla Sardegna si comunicò telefonicamente per consigliare di non inviare, come concordato, i velivoli da caccia a Venafiorita, perchè i campi del nord erano meno sicuri. Il Superaereo dette di sp osizioni in conseguenza alla III Squadra. Non furono impartiti ordini alle A viazioni per l'Esercito, per la Marina e a quelle Oltremare, che erano alle dipendenze di impiego, rispettivamen t e, dèi Comandi dell'Esercito, della Marina e dei Governi locali.
Nel pomeriggio di quel giorno, verso le ore 16, giunse finalmente una prima, assai laconica, comunicazione dèl Capo di S.M., da Brindisi; e precisamente il seguente dispaccio: Chiedo massimo numero notizie. Ministro Sandalli. Immediatamente da Roma si rispose con il seguente dispaccio (prot. n. 36075 - 11 set t embre): «Dalla I Squadra mancano completamente notizie. Nella II Squadra fino a ieri erano stati . ' occupati dai Tedeschi gli aeroporti di Ferrara, Ghedi, Reggio Emilia, Bologna, Osoppo; oggi mancano notizie. Nella III Squadra occupati i campi di Ciampino, Vigna di Valle, Pisa, Melato, Orvieto; in base ad accordi stabilito con il Comando della piazza di Roma, i Tedeschi stanno procedendo all'occupazione dei campi della Capitale. Riuscito a trasferire in Sardegna: il Raggruppamento Bombardamento con circa 28 Cant. Z. 1007, tre Gruppi di siluranti da Siena e Littoria con circa 25 S. 79, 8° Gruppo caccia con 24 Mc. 200, 6 Nlc. 202 e Mc. 205, nume-
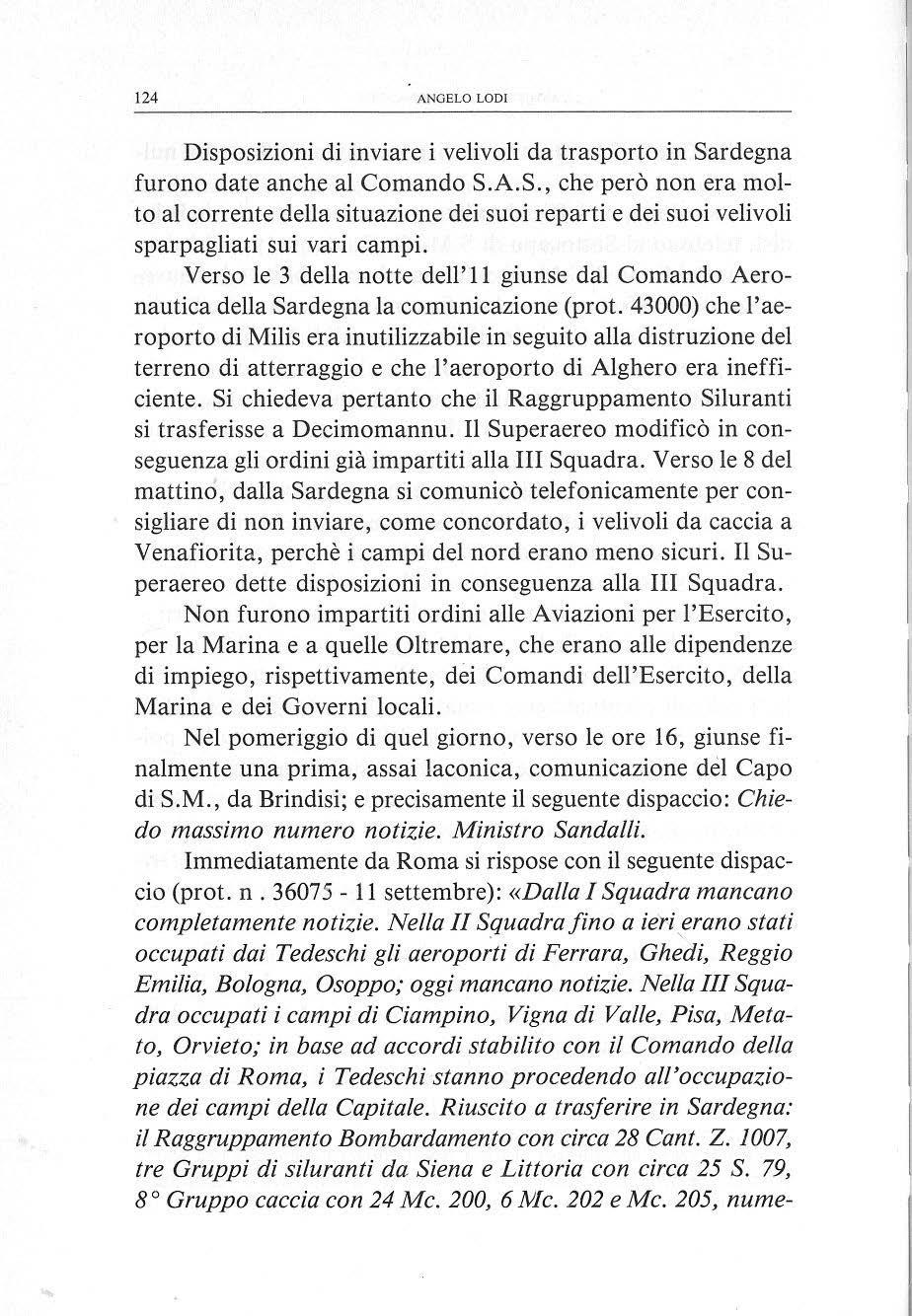
ro imprecisato velivoli da trasporto. Una dozzina di velivoli Re. 2001 del 160 ° e 167° Gruppo avuto ordine di raggiungere Brindisi. I velivoli siluranti di Pisa inutilizzati a causa della occupazione del campo all'atto della partenza. Analogamente i velivoli del 3 ° Stormo caccia inutilizzati dal personale, a causa del1'improvviso avvicinarsi di una colonna tedesca che circondava il campo. In Sardegna i Tedeschi, inutilizzati i campi di Villacidro e Milis, sembra si ritirino verso nord. Da Grecia, Corsica e Provenza mancano notizie. In Egeo i Tedeschi, contrariamente accordi con Comando locale, hanno occupato i campi di Maritza e Gadurra che si spera di rioccupare. In Albania in corso accordi fra Comando tedesco e il Gruppo Armate Est, di cui Aeronautica seguirà ordini e sorte. L'Aviazione SloveniaDalmazia ripiegata su II Squadra. A Roma situazione confusa a causa mancanza qualsiasi ordine e direttiva. Grave soprattutto la questione alimentare della truppa, in relazione numero uomini anche affluiti dai vari campi occupati. Mancanza di ordini e della conoscenza precisa situazione generale e accordi con Tedeschi ed aventualmente con Anglo-americani rende estremamente difficile mio compito. Prego, se possibile, inviare istruzioni e direttive. Gen. Santoro».
Al mattino del 12, poichè la situazione non lasciava prevedere probabili azioni dei reparti dell'Aeronautica e poichè non era giunta alcuna istruzione dal Comando Supremo e dal Capo di S.M. dell'Aeronautica, il Sottocapo inviò, tramite il Comando IV Squadra, il seguente telegramma (prot. n. 36093) al Capo di S.M.: «Pregasi comunicare se velivoli trasferiti in Sardegna è opportuno siano trasferiti, subito o quando situazione isola dovesse apparire pericolosa, su aeroporti della Tunisia . Caso affermativo pregherebbesi indicare se eventualmente esistono ulteriori accordi circa aeroporti di destinazione».
La sera dello stesso giorno, non avendo ricevuto risposta, nel dubbio che ogni comunicazione col Capo di S.M. fosse ormai impossibile e non ritenendo opportuno ritardare più oltre a dare attuazione alle clausole dell'armistizio , il Sottocapo di
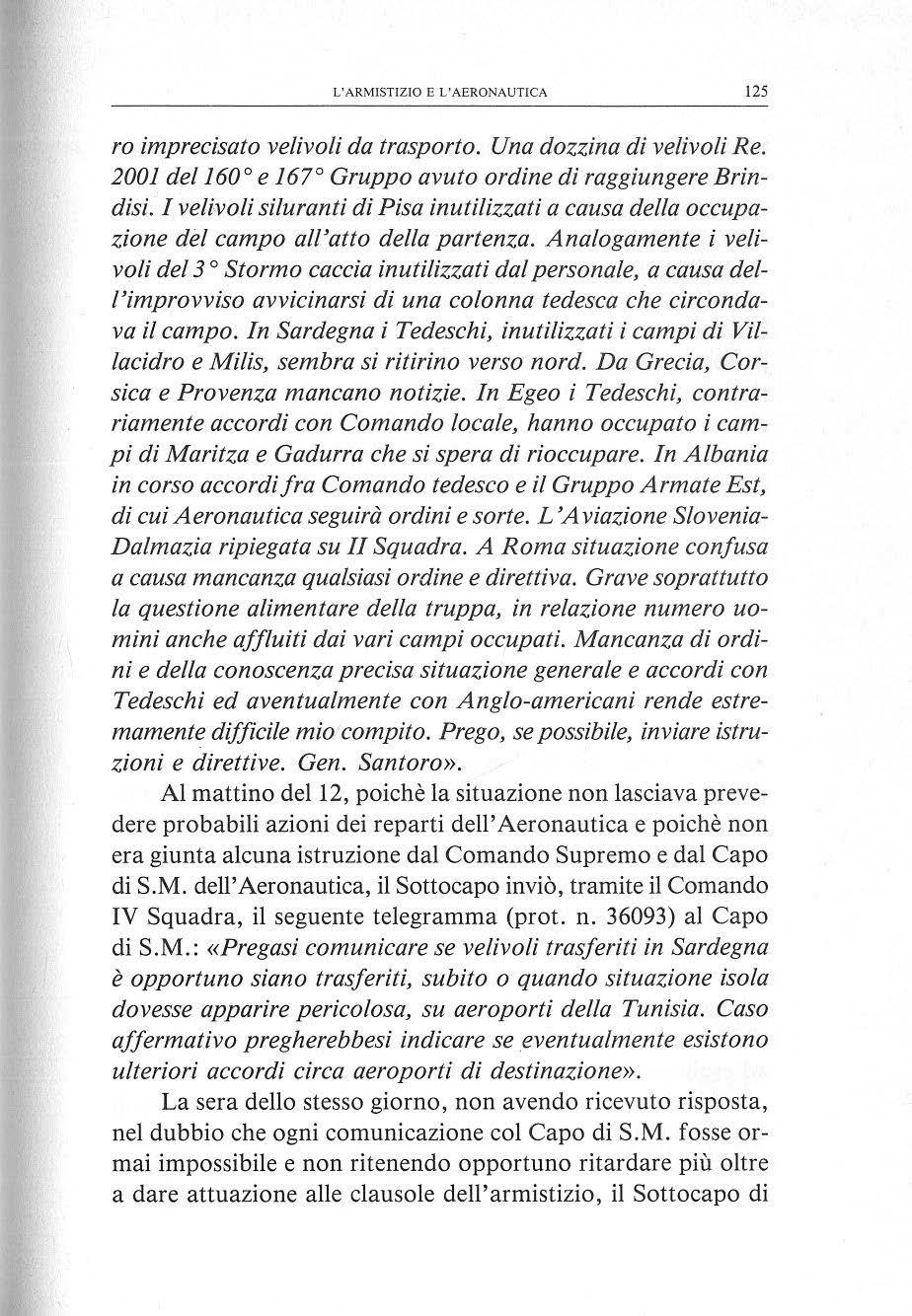
S.M. trasmise al Comando Aeronautica della Sardegna (unico Comando, oltre quello della IV Squadra, con cui si era in collegamento) l'ordine (prot. n. 36095) di trasferire al più presto sulle basi anglo-americane della Sicilia e della Tunisia tutti i velivoli di ogni tipo efficienti al volo esistenti sui campi dell'Isola. Analoghi ordini non furono impartiti al Comando IV Squadra Aerea, perchè non era nota la situazione determinata dalla presenza del Governo e dei Comandi superiori in quel territorio, nè erano note la situazione dell'avanzata alleata e le relazioni tra il Comando Supremo italiano ed i Comandi angloamericani; d'altra parte, il Capo di S.M., sul posto, sarebbe stato meglio in grado di dare ordini opportuni, in base a quelle situazioni e relazioni.
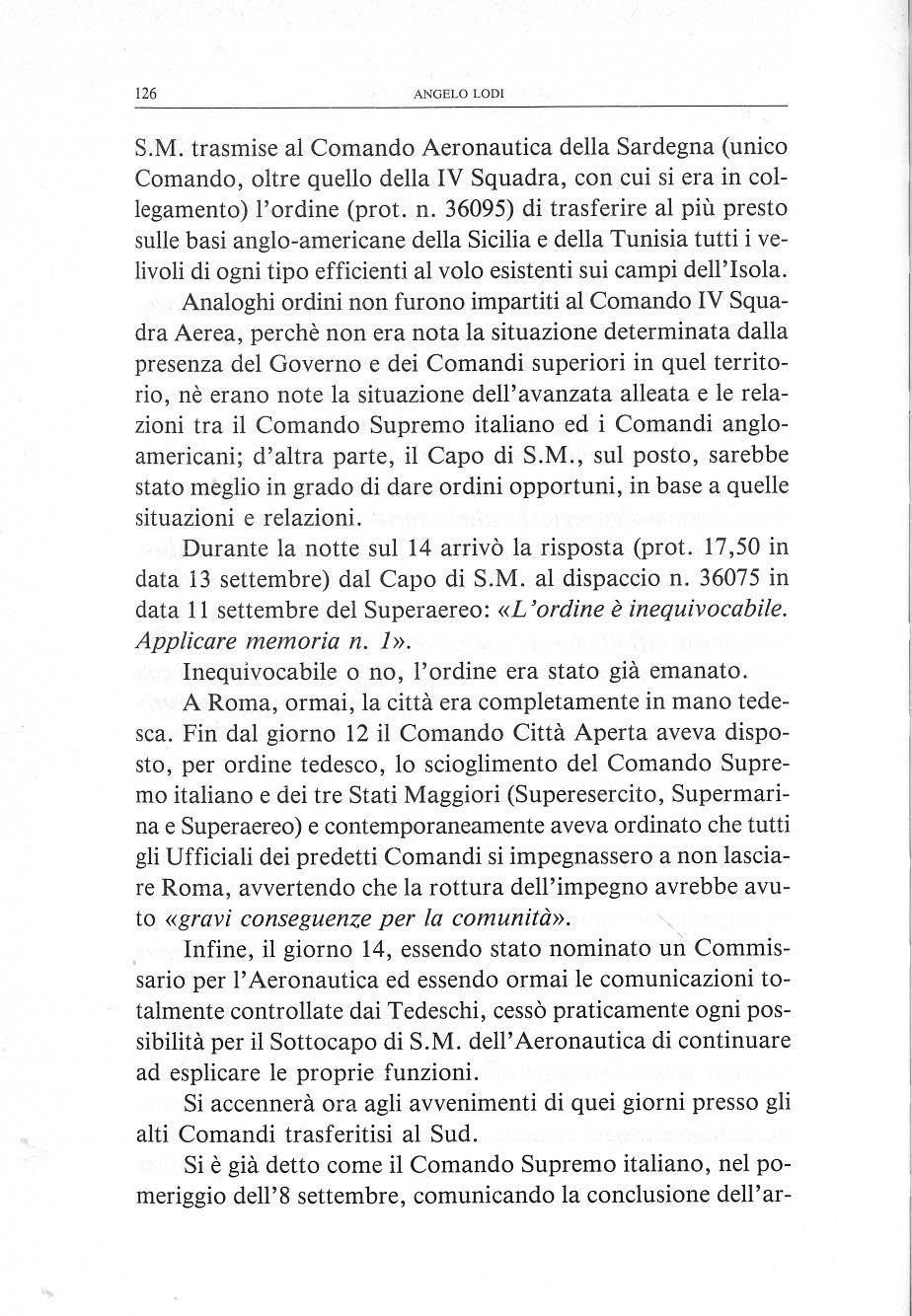
Durante la notte sul 14 arrivò la risposta (prot. 17,50 in data 13 settembre) dal Capo di S.M. al dispaccio n. 36075 in data 11 settembre del Superaereo: «L'ordine è inequivocabile. Applicare memoria n. I».
Inequivocabile o no, l'ordine era stato già emanato. A Roma, ormai, la città era completamente in mano tedesca. Fin dal giorno 12 il Comando Città Aperta aveva disposto, per ordine tedesco, lo scioglimento del Comando Supremo italiano e dei tre Stati Maggiori (Superesercito, Supermarina e Superaereo) e contemporaneamente aveva ordinato che tutti gli Ufficiali dei predetti Comandi si impegnassero a non lasciare Roma, avvertendo che la rottura dell'impegno avrebbe avuto «gravi conseguenze per la comunità».
Infine, il giorno 14, essendo stato nominato un Commissario per l'Aeronautica ed essendo ormai le comunicazioni totalmente controllate dai Tedeschi, cessò praticamente ogni possibilità per il Sottocapo di S.M. dell'Aeronautica di continuare ad esplicare le proprie funzioni.
Si accennerà ora agli avvenimenti di quei giorni presso gli alti Comandi trasferitisi al Sud.
Si è già detto come il Comando Supremo italiano, nel pomeriggio dell'8 settembre, comunicando la conclusione dell'ar-
mistizio, avesse ordinato che le Forze Armate italiane dovessero «reagire con la massima decisione ad offese che provenissero da qualsiasi altra parte».
. Una chiara precisazione del Capo di S.M. Generale ai tre Capi di S.M. dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, trasferitisi a Brindisi, avvenne solamente l' 11 settembre. Nel foglio n. 1015, oggetto «Impiego Forze Armate», era detto: «I Tedeschi hanno apertamente iniziato le ostilità contro di noi; di conseguenza sono da considerarsi nemici e le forze armate devono decisamente combatterli.
Le unità germaniche occupano in forze l'Italia settentrionale e centrale; un 'aliquota è tuttora in Italia meridionale e Sardegna.
Occorre pertanto raggruppare le forze a nostra disposizione allo scopo di:
- opporsi innanzi tutto ad eventuale ulteriore dilagazione delle forze avversarie;
- procedere quindi in cooperazione delle forze angloamericane all'azione offensiva per la liberazione di tutto il territorio nazionale.
Nella situazione in atto è di particolare importanza garantire l'attuale sede del Governo da eventuali improvvisi colpi di mano.
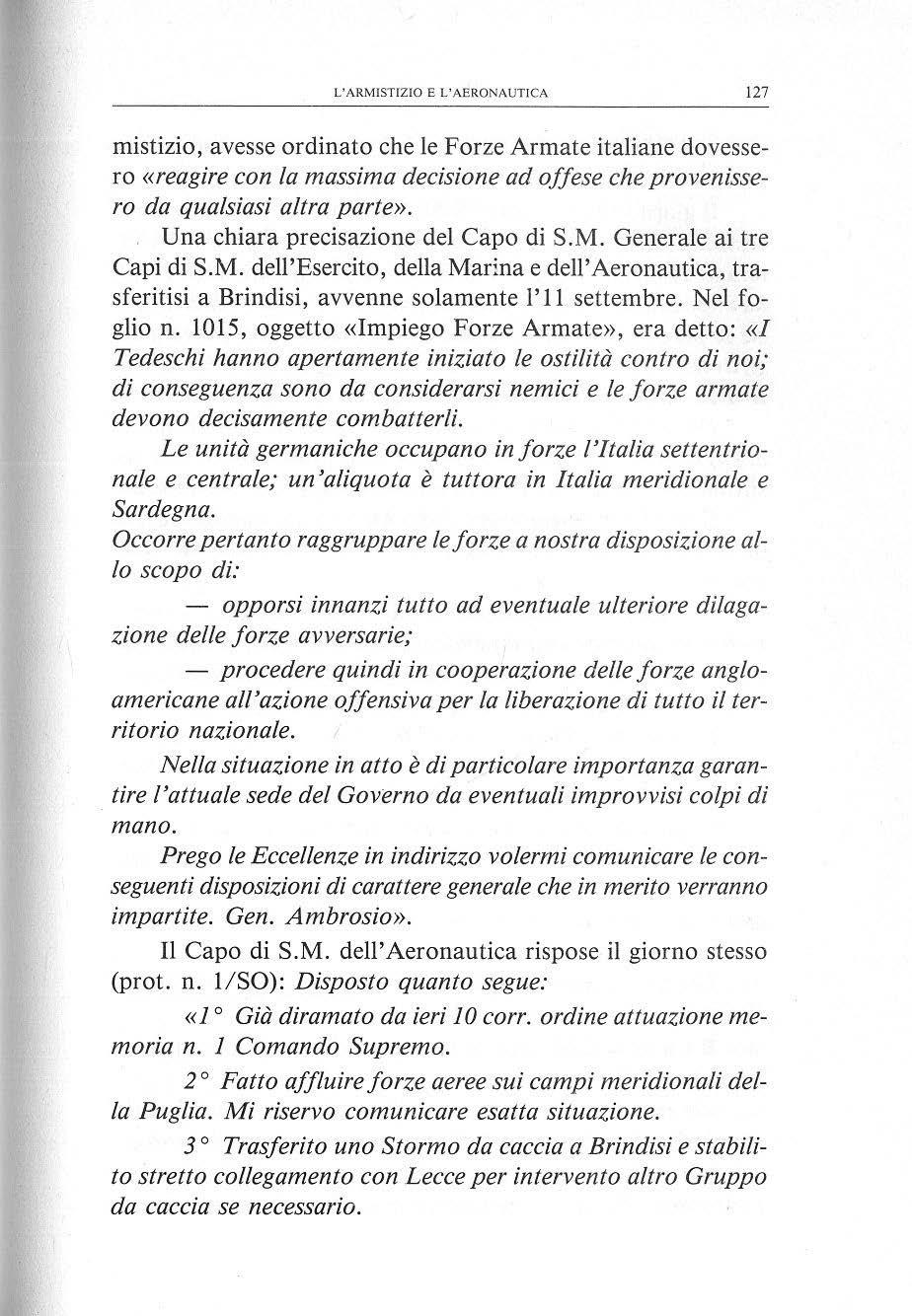
Prego le Eccellenze in indirizzo volermi comunicare le conseguenti disposizioni di carattere generale che in merito verranno impartite. Gen . Ambrosia».
Il Capo di S.M. dell'Aeronautica rispose il giorno stesso (prot. n. I/SO): Disposto quanto segue:
« J O Già diramato da ieri 1O corr. ordine attuazione memoria n. 1 Comando Supremo.
2 ° Fatto affluire forze aeree sui campi meridionali della Puglia . Mi riservo comunicare esatta situazione.
3 ° Trasferito uno Stormo da caccia a Brindisi e stabilito stretto collegamento con Lecce per intervento altro Gruppo da caccia se necessario.
4° In atto provvedimenti per deciso intervento contro Tedeschi in Puglia».
Il giorno 14, il Capo di S.M. Generale sentì ancora la necessità di orientare i tre Capi di S.M. sulla situazione. Nella lettera n. 1074/0p. di prot. era detto: «Il precipitare degli eventi ha impedito di orientare adeguatamente comandi e reparti, specie se periferici ed oltre frontiera, sulla reale grave portata degli avvenimenti che hanno determinato un sostanziale mutamento della nostra linea di condotta nel quadro della guerra in corso.
Da ciò un accentuato disorientamento che ha portato ad atteggiamenti non sempre conformi alla situazione ed alla posizione assunta difronte all'ex-alleato ed agli Anglo-americani.
Il proclama lanciato ieri 13 dal Maresciallo Badoglio al popolo italiano dovrebbe essere sufficiente ad eliminare ogni dubbio.
Comunque occorre siano impartite d'urgenza istruzioni a tutti i comandi ed enti dipendenti, atte a ribadire inequivocabilmente che un solo nemico oggi dobbiamo combattere, con ogni energia e con ogni mezzo: l'oppressore tedesco.
La resa di numerosi uomini o, peggio, di interi reparti a pochi carri od a piccoli elementi tedeschi deve cessare ed eventualmente essere repressa in modo esemplare.
Opportune istruzioni debbono essere impartite subito ai comandi e truppe coi quali è possibile fin d'ora il collegamento. Al più presto, escogitando a tale scopo ogni mezzo a disposizione, ai comandi e truppe dislocati nelle regioni occupate dal ' nemico.
Gradirò essere infarmato di quanto sarà attuato al riguardo».
Il Capo di S.M. dell'Aeronautica rispose il 15 settembre (prot. n. 57 /S0/ 4):
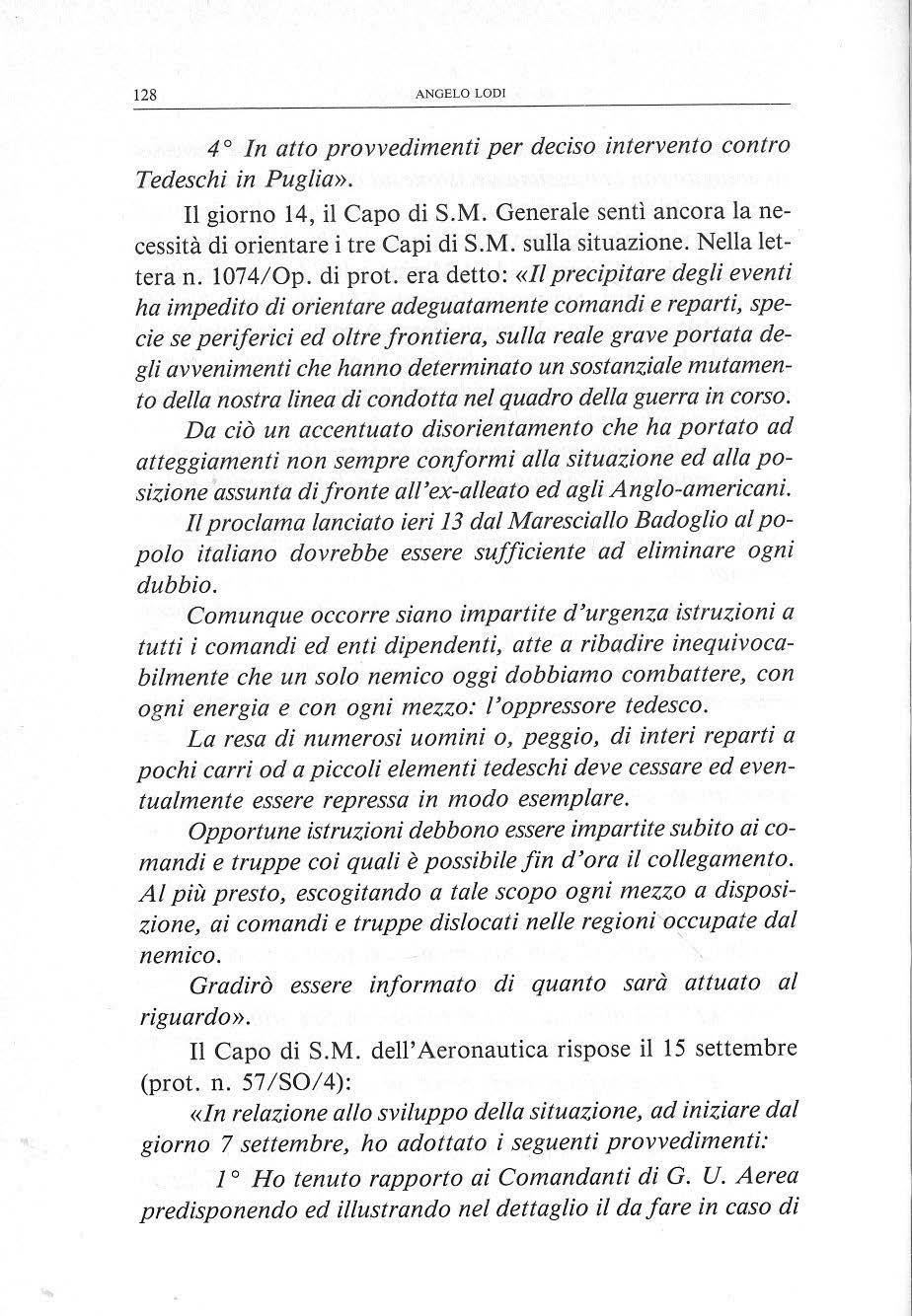
«In relazione allo sviluppo della situazione, ad iniziare dal giorno 7 settembre, ho adottato i seguenti provvedimenti:
1 ° Ho tenuto rapporto ai Comandanti di G. U. Aerea predisponendo ed illustrando nel dettaglio il da fare in caso di
attuazione della memoria n. 1. Ciò ha permesso di conseguire un primo orientamento sul possibile sviluppo della s ituazion e. Successivamente, e fin dove i collegamenti lo hanno permesso, ho emanato ordini relativi all'attuazione di alcune varianti a detta memoria imposte dallo svolgersi degli avvenimenti: soprattutto differente disloca z ione dei reparti da caccia e da bombardamento. Ciò mi ha consentito di recuperare reparti da caccia, che altrimenti sarebbero andati perduti nei campi presso Roma. Si era infatti, in origine, stabilito di accentrare tutta la caccia presso la Capitale .
2° Ho mantenuto il contatto r.t. ed emanato ordini allo Stato Maggiore (a Roma) ed ai Comandi dipe1J,dentifin quando e fin dove ho potuto. L'ordine esecutivo che ho emanato circa l'attuazione della memoria n. 1 deve aver chiarito l'indirizzo da seguire.
3
° Ho preso personalmente contatto coi singoli reparti trasferitisi sugli aeroporti delle Puglie illustrando a Comandanti e gregari la situazione e dando le direttive. Il morale in complesso è soddisfacente. L'inevitabile disorientamento iniziale sta per essere superato.
4° Ho recuperato tutti i velivoli che è stato possibile recuperare e che sono giunti nei vari aeroporti della Penisola e sto provvedendo all'inquadramento dei velivoli e dei relativi equipaggi giunti isolati in reparti organicamente e razionalmente distribuiti sugli aeroporti a disposizione. Gen. Sandalli».
Non si può non rilevare che le dispo sizioni degli alti Comandi, di cui si è dato notizia, mancarono di qu ella tempestività e di quella chiarezza, che era lecito attendersi in momenti tanto gravi.
Basti notare, fra l'altro, che il primo ordine esplicito di cons id erare come nemici i Tedeschi fu vergato dal Capo di S.M. Generale 1'11 settembre (foglio n. 105/0p. citato), quando, come è detto nel documento stesso, l'Italia settentrionale e centrale già era stata occupata in forze; e che, co munqu e, quest'ordine impartito ai t re Capi di S.M. a Brindisi, non poteva avere

efficacia sull'operato del Superaereo a Roma e dei vari Comandi periferici, ma solamente su quello dei Reparti del Sud (!orze a nostra disposizione).
Altre considerazioni sono forse superflue, giacchè possono agevolmente dedursi dall'esame e dal confronto delle date e dei fatti contenuti nei documenti citati nel testo.
D'altra parte, il comportamento dei reparti dell' Aeronautica nei giorni dell'armistizio (come è documentato nei due paragrafi seguenti), malgrado le circostanze avverse, in complesso fu degno di elogio e, nonostante la mancanza di ordini, di direttive e della conoscenza della situazione, l'azione e le iniziative del Superaereo a Roma furono opportune, se si considera quanto il Capo di S.M. dell'Aeronautica diceva in un promemoria per il Comando Supremo (n. 75/S0/4 del 17 settembre 1943). In questo si face v a osservare che nel giudicare gli a vveniment i, per quel che riguardava l'Aeronautica, bisognava t ener presente: «che la maggior parte dei campi era in mano tedesca; che, se fossero state eseguite alla lettera le istruzioni iniziali (tutta la caccia sui campi di Roma), non vi sarebbe ora più caccia; che i movimenti degli aerei verso la Sardegna e la Puglia sono stati tempestivamente eseguiti ed accortamente predisposti; che in sostanza si è salvato il salvabile, dando così, anche la R. Aeronautica, prova di disciplina, compattezza e iniziativa».
Le claus ole dell ' armistizio ponevano all'Aeronautica italiana due condizioni antitetiche, senza indicare modalità e misure per conciliarle: trasferire tutti gli aerei su basi alleate o occupa t e dagli Allea t i ; partecipare con le altre Forze Armate nazionali, rimanendo nelle proprie sedi, alla lotta contro i Tedeschi, allo scopo di favorire più o meno direttamente le operazioni alleate.
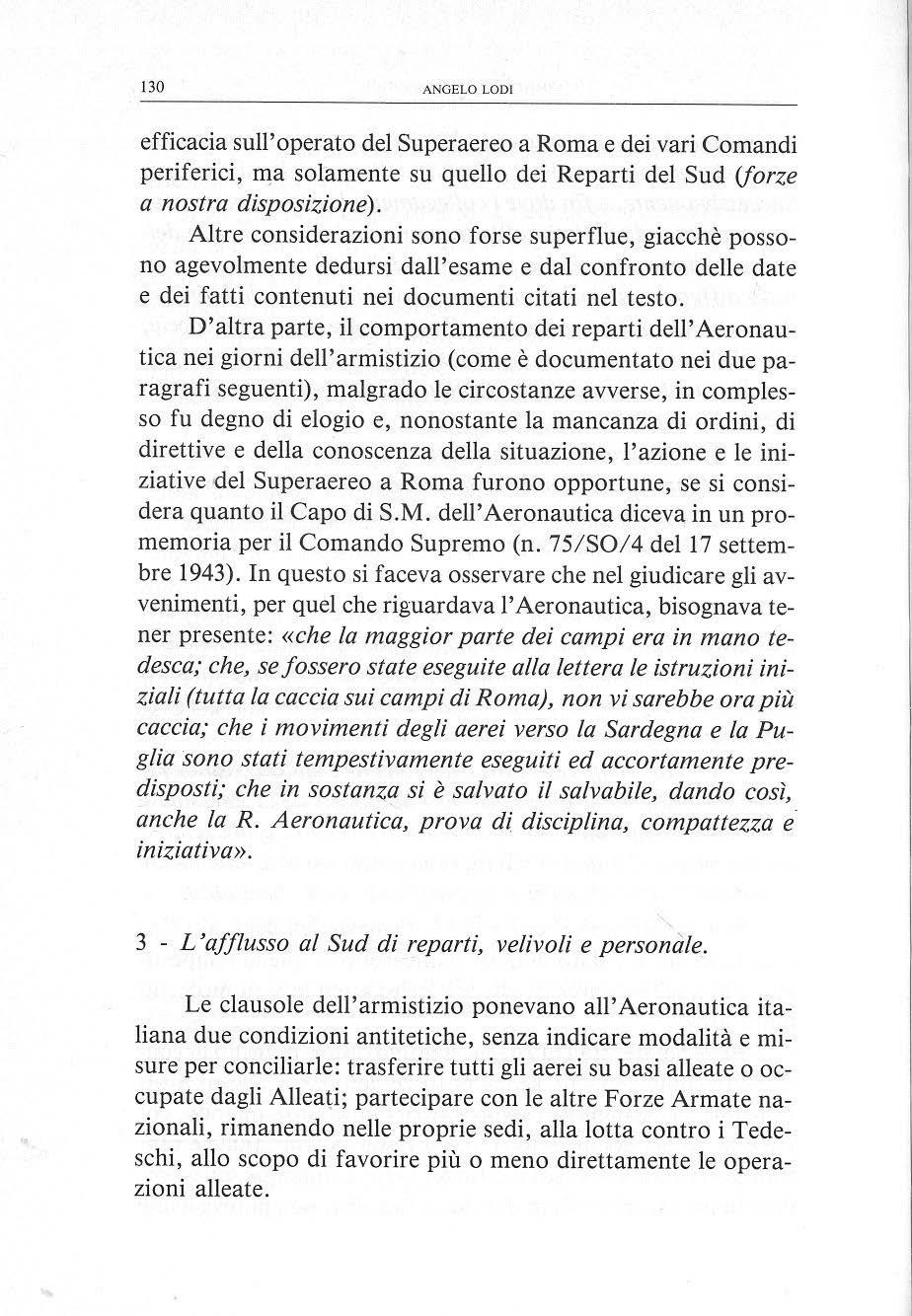
Le circostanze in cui fu denunciato l'armistizio; la deficienza o mancanza assoluta di precise disposizioni; la mancata conoscenza della situazione contingente da parte di quasi tutti i Comandanti delle Unità Aeree; la scarsità di carburante; la minaccia di invasione tedesca degli aeroporti indifesi da truppe a terra; la dislocazione di alcuni Reparti su basi lontane quali l'Egeo, la Grecia, l'Albania, la Slovenia-Dalmazia e, per gli aerei-scuola, la insufficiente autonomia di volo, resero particolarmente difficile e spesso impossibile l'esodo degli aerei italiani verso le basi alleate.
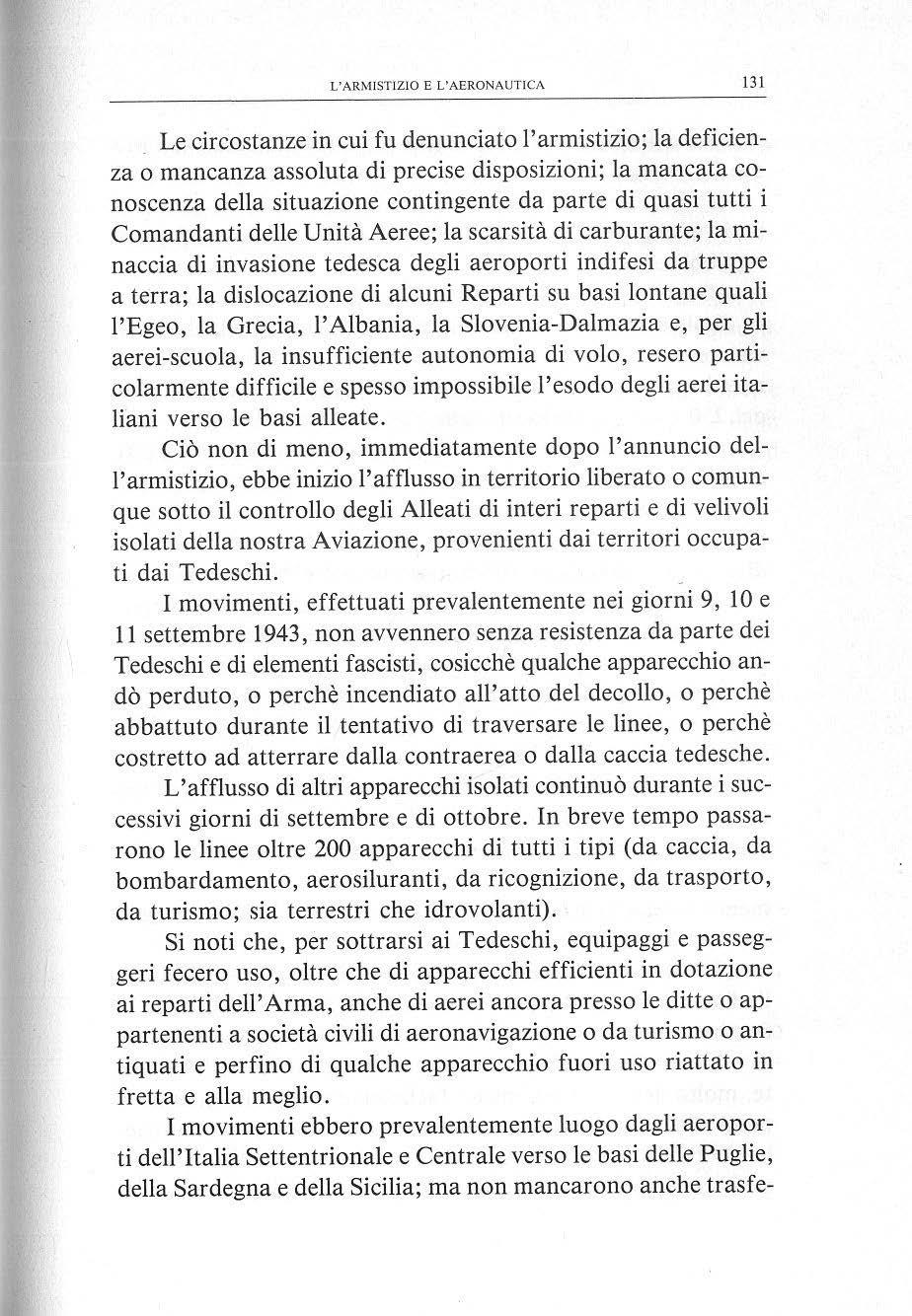
Ciò non di meno, immediatamente dopo l'annuncio dell'armistizio, ebbe inizio l'afflusso in territorio liberato o comunque sotto il controllo degli Alleati di interi reparti e di velivoli isolati della nostra Aviazione, provenienti dai territo r i occupati dai Tedeschi. -
I movimenti, effettuati prevalentemente nei giorni 9, 10 e 11 settembre 1943, non avvennero senza resistenza da parte dei Tedeschi e di elementi fascisti, cosicchè qualche apparecchio andò perduto, o perchè incendiato all'atto del decollo, o perchè abbattuto durante il tentativo di traversare le linee, o perchè costretto ad atterrare dalla contraerea o dalla caccia tedesche.
L'afflusso di altri apparecchi isolati continuò durante i successivi giorni di settembre e di ottobre. In breve tempo passarono le linee oltre 200 apparecchi di tutti i tipi (da caccia, da bombardamento , aerosiluranti , da ricognizione, da trasporto, da turismo; sia terrestri che idrovolanti).
Si noti che, per sottrarsi ai Tedeschi, equipaggi e passeggeri fecero uso, oltre che di apparecchi efficienti in dotazione ai reparti dell'Arma, anche di aerei ancora presso le ditte o appartenenti a società civili di aeronavigazione o da turismo o antiquati e perfino di qualche apparecchio fuori uso riattato in fretta e alla meglio.
I movimenti ebbero prevalentemente luogo dagli aeroporti dell'Italia Settentrionale e Centrale verso le basi delle Puglie, della Sardegna e della Sicilia; ma non mancarono anche trasfe-
rimenti dalla Balcania e dall'Egeo verso le basi alleate del Medio Oriente.
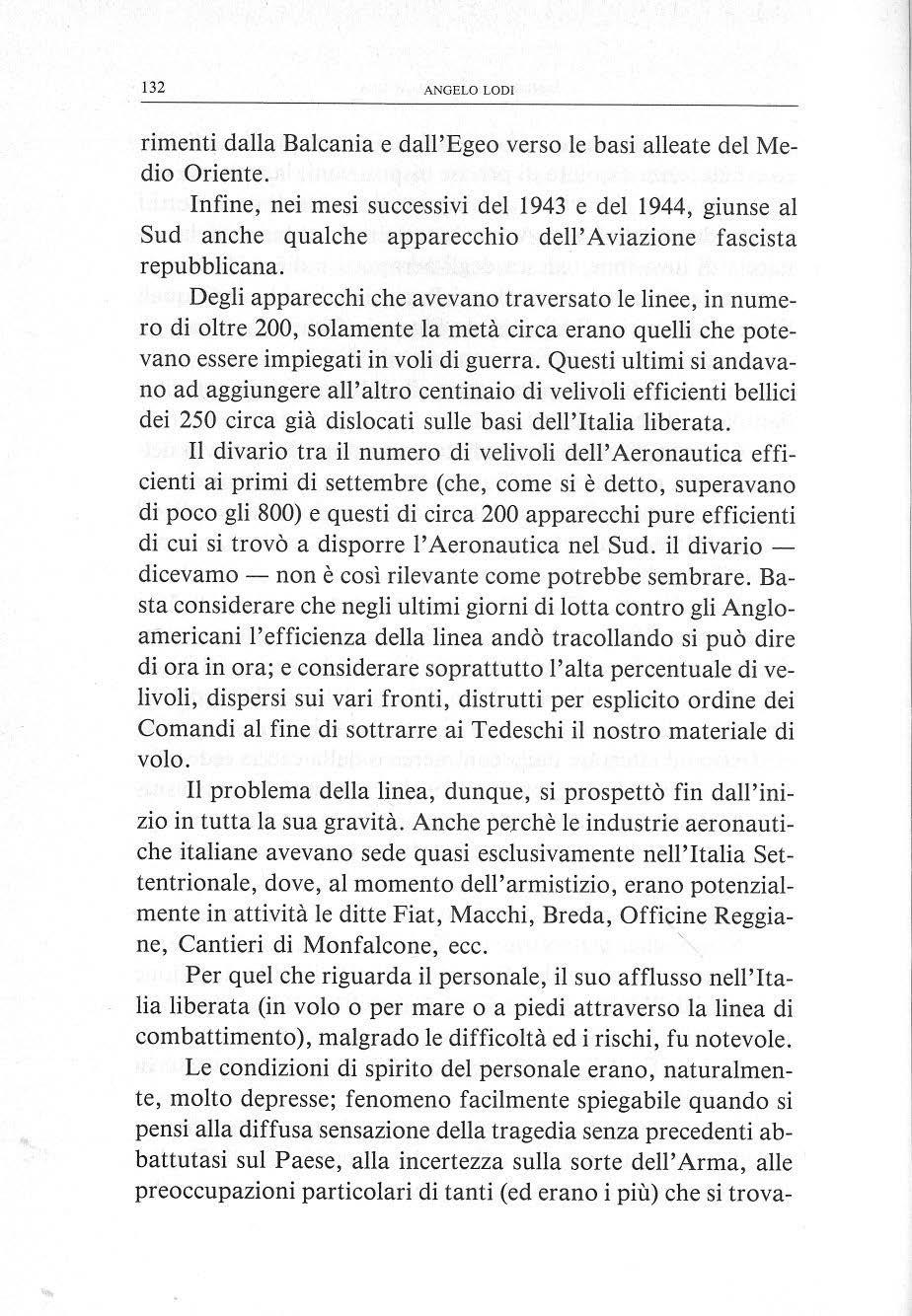
Infine , nei mesi success ivi del 1943 e del 1944, giunse al Sud anche qualche apparecchio dell'Aviazione fascista repubblicana.
Degli apparecchi che avevano traversato le linee, in numero di oltre 200, solamente la metà circa erano quelli che potevano essere impiegati in voli di guerra. Questi ultimi si andavano ad aggiungere all'altro centinaio di velivoli efficienti bellici dei 250 circa già dislocati su lle basi dell'Italia liberata.
Il divario tra il numero di velivoli dell'Aeronautica efficienti ai primi di settembre (che, come si è detto, superavano di poco gli 800) e questi di circa 200 apparecchi pure efficienti di cui si trovò a disporre l'Aeronautica nel Sud. il divariodicevamo - non è così rilevante come potrebbe sembrare. Basta considerare che negli ultimi giorni di lo tta contro gli Angloamericani l'efficienza della linea andò tracollando si può dire di ora in ora; e considerare sopratt utto l'alta percentuale di velivoli, dispersi sui vari fronti, distrutti per esplicito ordine dei Comandi al fine di sottrarre ai Tedeschi il nostro materiale di volo.
Il problema della linea, dunque, si prospettò fin dall'inizio in tutta la sua gravità. Anche perchè le industrie aeronautiche italiane avevano sede quasi esclusivamente nell'Italia Settentrionale, dove, al momento dell'armistizio, erano potenzialmente in attività le ditte Fiat, Macchi, Breda, Officine Reggiane, Cantieri di Monfalcone, ecc. '
Per quel che riguarda il personale, il suo afflusso nell'Italia liberata (in volo o per mare o a piedi attraverso la linea di combattimento), malgrado le difficoltà ed i rischi, fu notevole.
Le condizioni di spirito del personale erano, naturalmente, molto depresse; fenomeno facilmente spiegabile quando si pensi alla diffusa sensazione della tragedia senza precedenti abbattutasi sul Paese, alla incertezza sulla sorte dell'Arma, aUe preoccupazioni particolari di tanti (ed erano i più) che si trova-
rono tagliati dalle famiglie, spesso abbandonate improvvisamente senza alcuna difesa contro il minaccioso futuro; e quando si pensi, infine, alle precarie condizioni materiali, aggravate, nella quasi generalità dei casi, dalla perdita completa del corredo personale.
Tuttavia, malgrado i disorientamenti individuali, non vi furono esitazioni circa l 'atteggiamento da prendere nei riguardi della nuova guerra. Complessivamente, dal settembre 1943 all'aprile 1944, e cioè prima della liberazione della città di Roma da parte degli Alleati, circa 1.900 militari dell'Aeronautica si portarono al Sud e di questi circa 1.200 in volo.
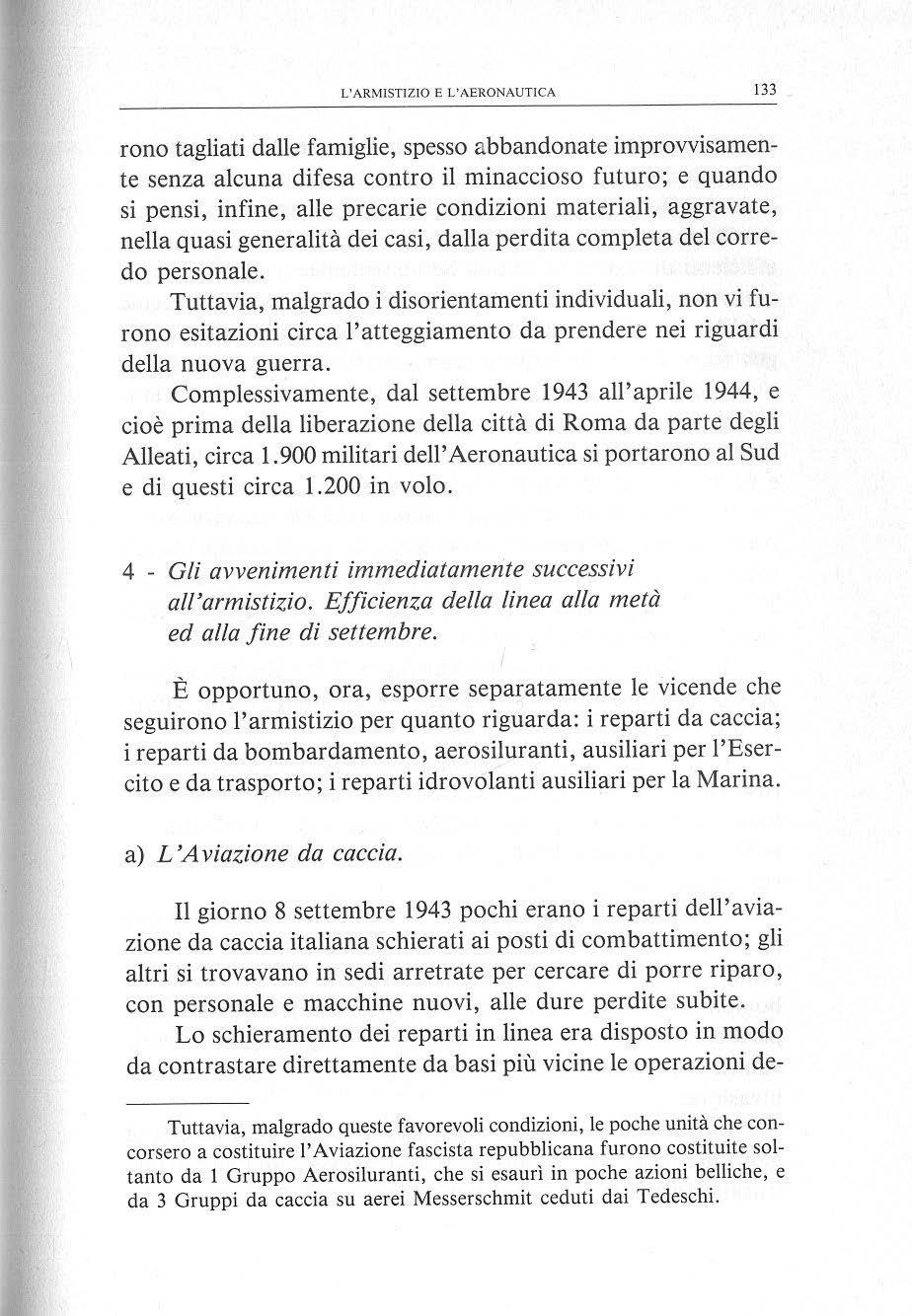
4 - Gli avvenimenti immediatamente successivi all'armistizio. Efficienza della linea alla metà ed alla fine di settembre.
È opportuno, ora, esporre separatamente le vicende che seguirono l 'armistizio per quanto riguarda: i reparti da caccia; i reparti da bombardamento, aerosiluranti, ausiliari per l'Esercito e da trasporto; i reparti idrovolanti ausiliari per la Marina.
a) L'Aviazione da caccia.
Il giorno 8 settembre 1943 pochi erano i reparti dell'aviazione da caccia italiana schierati ai posti di combattimento; gli altri si trovavano in sedi arretrate per cercare di porre riparo, con persona le e macchine nuovi, alle dure perdite subite.
Lo schieramento dei reparti in linea era disposto in modo da contrastare direttamente da basi più vicine le operazioni de-
Tuttavia, malgrado queste favorevoli condizioni, le poche unità che concorsero a costituire l 'Aviazione fascista repubblicana furono costituite soltanto da 1 Gruppo Aerosi luran t i, che si esaurì in poche azioni be ll iche, e da 3 Grupp i da caccia su aerei Messerschmit ceduti dai Tedeschi .
gli Anglo-americani. Infatti, eccettuate scarse aliquote a difesa di Roma e di Napoli, l'aviazione da caccia era prevalentemente dislocata nel territorio della IV Squadra Aerea nelle Puglie e del Comando Aeronautica della Sardegna. Pochissime le forze efficienti di stanza nell'Italia Settentrionale.
A sostenere l'urto delle poderose formazioni di parecchie miglia ia di velivoli delle Forze Aeree anglo-americane, le esigue forze da caccia italiane erano distribuite come segue.
I reparti d~ caccia e d'assalto della IV Squadra Aerea erano alle dipendenze di un Comando Caccia e Intercettori, con sede a Lecce (in seguito, si trasferì a Brindisi il 19 settembre e fu disciolto il 15 ottobre 1943).
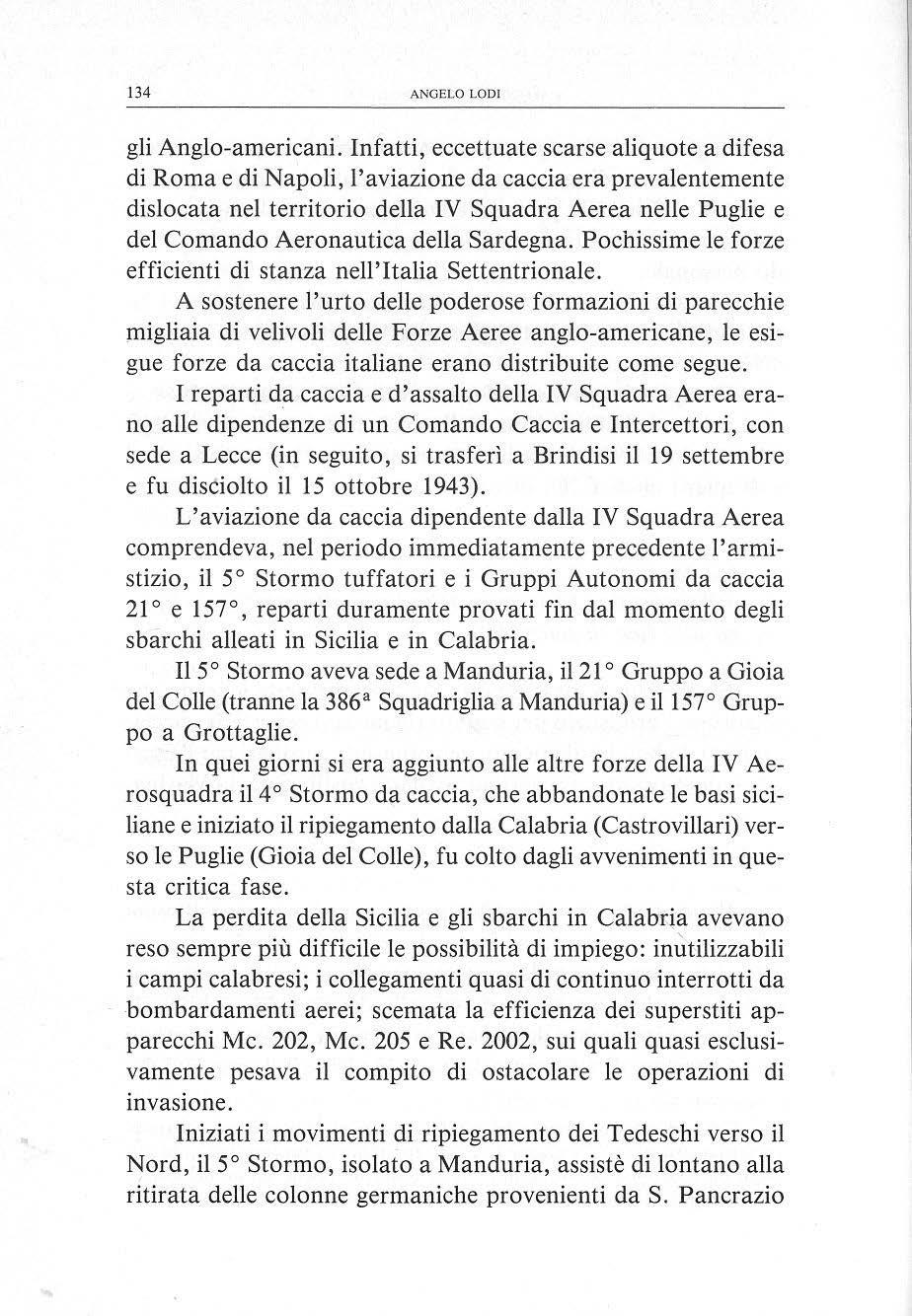
L'aviazione da caccia dipendente dalla IV Squadra Aerea comprendeva, nel periodo immediatamente precedente l'armistizio, il 5° Stormo tuffatori e i Gruppi Autonomi da caccia 21 ° e 157°, reparti duramente provati fin dal momento degli sbarchi alleati in Sicilia e in Calabria.
Il 5° Stormo aveva sede a Manduria, il 21 ° Gruppo a Gioia del Colle (tranne la 386 3 Squadriglia a Manduria) e il 157° Gruppo a Grottaglie.
In quei giorni si era aggiunto alle altre forze della IV Aerosquadra il 4 ° Stormo da caccia, che abbandonate le basi siciliane e iniziato il ripiegamento dalla Calabria (Castrovillari) verso le Puglie (Gioia del Colle), fu colto dagli avvenimenti in questa critica fase.
La perdita della Sicilia e gli sbarchi in Calabria avevano reso sempre più difficile le possibilità di impiego: inÙtilizzabili i campi calabresi; i collegamenti quasi di continuo interrotti da -bombardamenti aerei; scemata la efficienza dei superstiti apparecchi Mc. 202, Mc. 205 e Re. 2002, sui quali quasi esclusivamente pesava il compito di ostacolare le operazioni di invasione.
Iniziati i movimenti di ripiegamento dei Tedeschi verso il Nord, il 5° Stormo, isolato a Manduria, assistè di lon tano alla ritirata delle colonne germaniche provenienti da S. Pancrazio
e da Leverano, che azzardarono solo timidi tentativi di disturbo prontamente respinti.
Una situazione precaria si determinò per il 4 ° Stormo e il 31 ° Gruppo a Gioia del Colle, accerchiata dai paracadutisti tedeschi a protezione della Divisione H e rmann Goering in ritirata dalla Calabria. Con decisa prontezza si riuscì a risolvere la situazione: mentre tutti i velivoli dei due reparti s i sottr ae vano ai Tedeschi, trasferendosi in volo a Lecce e da Brindisi, l'autocolonna del 4 ° Stormo forzò no ttetempo il blo cco tede sco, giu ngendo a Brindisi e successivamente a Lecce. Il personale del 21 ° Gruppo invece, per mancanza di automezzi, fu costr etto a rimanere a Gioia del Colle fino alla liberazion e.
Pertanto, immediatamente dopo l'armistizio, s ugli aeroporti pugli es i la caccia s i ve nn e a tro vare così di slocata:
4 ° Stormo CT (Brindisi) s u M c. 205 e Mc. 202
9° Gruppo CT (Brindisi)
73 a Squadriglia CT
96a Squadriglia CT
97a Squadriglia CT
10° Gruppo CT (Lecce)
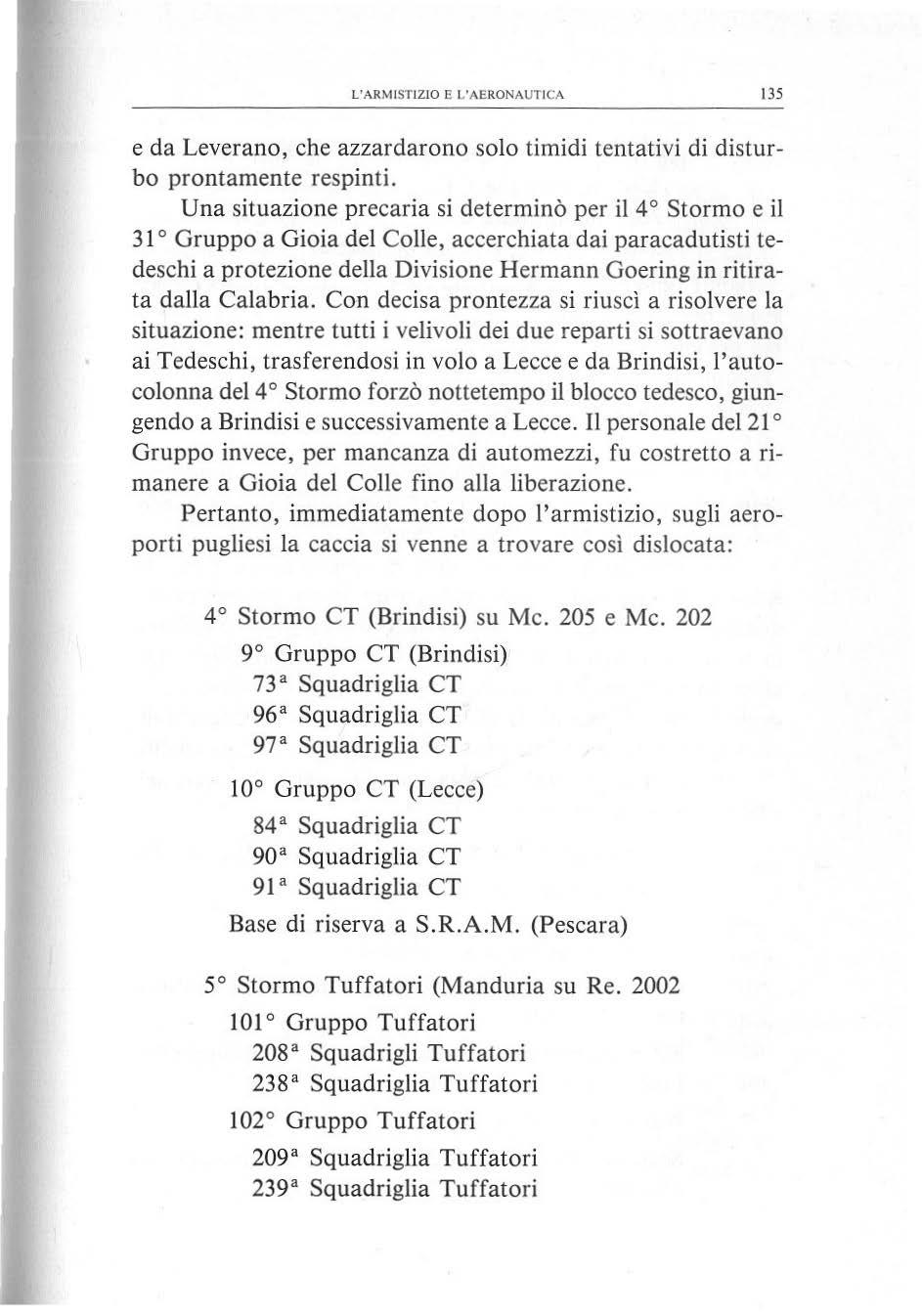
84 a Squadriglia CT
90a Squadriglia CT
91 a Squadriglia CT
Base di riserva a S.R.A.M. (Pescara)
5° Stormo Tuffatori (Manduria su Re. 2002
101 ° Gruppo Tuffatori
208a Squadrigli Tuffatori
23ga Squadriglia Tuffatori
102 ° Gruppo Tuffatori
209a Squadriglia Tuffatori
239a Squadriglia Tuffato ri
21 ° Gruppo Autonomo CT (Brindisi) su Mc. 202
356 a Squadriglia CT
361 a Sq uadriglia CT
386 a Squadriglia CT (Manduria)
157 ° Gruppo Autonomo CT (Grottaglie) su Mc . 200 Cr . 42
357 3 Sq u adriglia CT
371 a Squadriglia CT
384a Squadriglia CT
Tutt i questi reparti, in d efinitiva, disponevano di non più di un a cin quantina di apparec ch i efficienti bellica ment e, in prevalenza Mc. 202, Mc. 205 e Re. 2002.
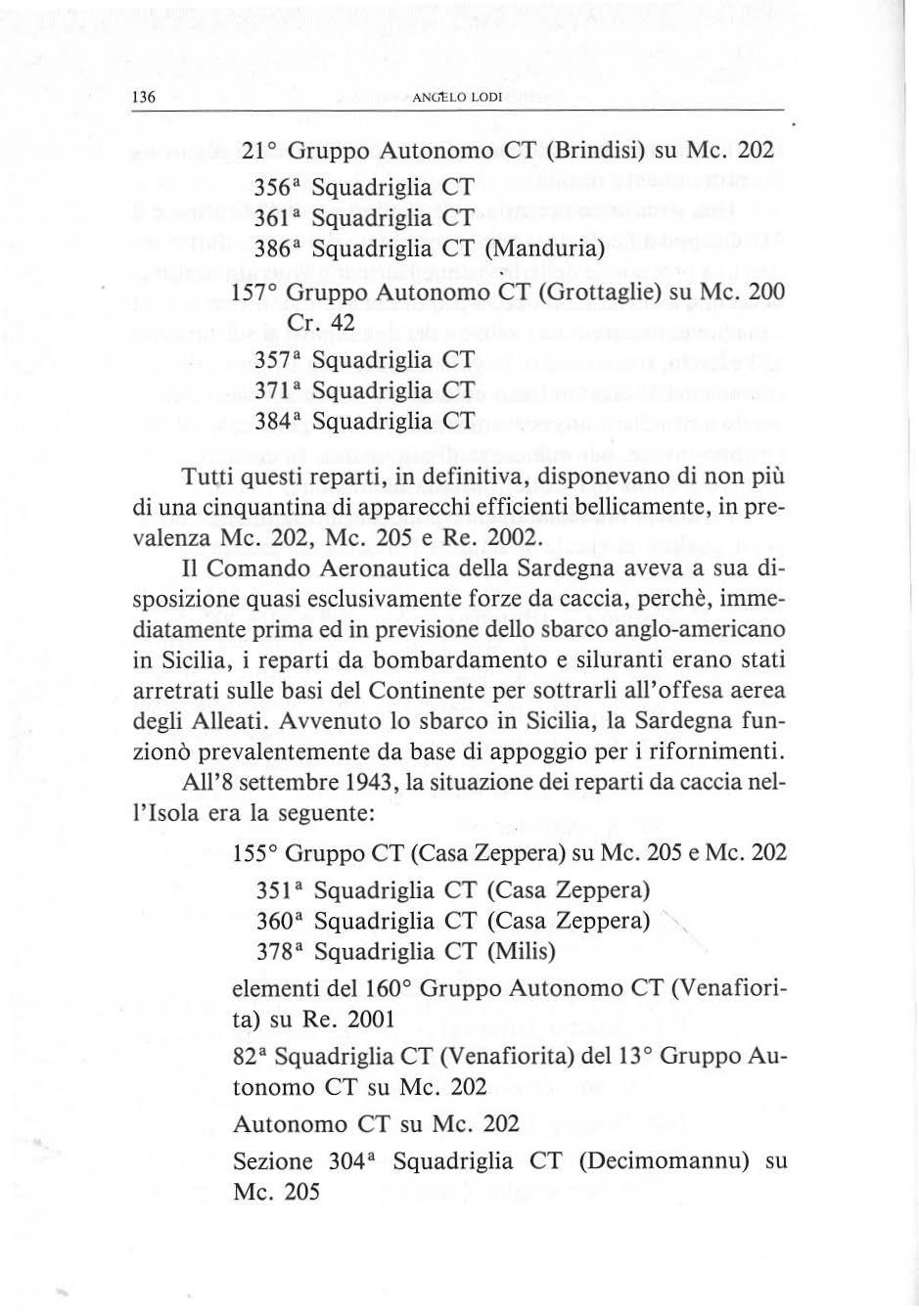
Il Coman do Aeronautica della Sardegna aveva a sua disp osizione quasi esclusivame n te forze da ca ccia, perchè, immediatamente pr ima ed in previsione dello s barco anglo-americano in Sicilia, i reparti da bombardamento e siluranti erano stati arretrati su ll e basi del Continente per s ottrarli all'offesa aerea degli Alleati. Avvenu to lo sbarco in Sicilia, la Sardeg na funzionò prev alen te mente da base di appoggio per i rifornimenti. All'8 settembre 1943, la situazio n e dei rep arti da caccia nell'Isola era la seg uente:
155 ° Gruppo CT (Casa Zepp era) su Mc. 205 e Mc. 202
351 a Squadriglia CT (Casa Zeppera)
360a Squadriglia CT (Casa Ze pp era)
378a Squad ri gl ia CT (Mili s)
elementi d el 160° G ruppo Autonomo CT (V ena fiori -
ta) su Re. 2001
82a Squadriglia CT (Venafior ita) del 13° Gruppo Au-
tonomo CT su Mc. 202
Autonomo CT su Mc. 202
Sezione 304 a Squadriglia CT (D ecim om annu ) su Mc . 205
Il più efficiente era il 155° Gruppo (dipendente dal 51 ° Stormo CT) con i reparti distribuiti fra Casa Zeppera e Milis. Respinti i tentativi di sopraffazione tedeschi, questo Gruppo riuscì a conservare personale e materiali, tanto da potere in seguito, ai primi dell'ottobre successivo, concentrarsi ad Elmas.
Il 160° Gruppo, in seguito ad ordine del Superaereo, si era trasferito a Littoria con la maggior parte dei suoi velivoli nei primi giorni di settembre, per l'impossibilità di essere impiegato a causa dell'epidemia malarica, che aveva colpito tutto il personale dislocato in Sardegna. Qualche elemento del Gruppo rimase in Sardegna perchè, ammalato di malaria, non era in condizioni di pilotare e fu poi assorbito dal 21 ° Gruppo; il personale a terra fu invece assorbito dal 155° Gruppo.
L'82a Squadriglia, dipendente dal 13° Gruppo Autonomo CT, non aveva alcun apparecchio efficiente. Il comando del Gruppo e le altre due Squadriglie dipendenti (77a e 78a) si trovavano ancora a Metato (Pisa).

Complessivamente, i reparti da caccia della Sardegna avevano a disposizione un limitato numero di velivoli efficienti bellicamente; e cioè una ventina fra Mc. 205, Mc. 202 e Re. 2001.
Agli apparecchi dei reparti da caccia nelle Puglie ed in Sardegna vennero ad aggiungersi quelli che si erano sottratti ai Tedeschi, trasferendosi in volo.
L'apporto fu costituito prevalentemente dall'8° Gruppo Autonomo CT, che si sottrasse al completo ai Tedeschi. Il giorno 8 settem bre 1943 , questo Gruppo, armato di Mc. 200, apparecchi di tipo superato, si trovava a Sarzana sotto la giurisdizione della I Squadra Aerea. Il giorno stesso si trasferì a Littoria col compito di effettuare scorta diretta agli aerosiluranti, che avrebbero dovuto attaccare la flotta alleati nel golfo0 di Salerno. Il 9 settembre, per ordine della III Squadra Aerea, si spostò a Guidonia per l'eventuale difesa della Capitale; quindi, nel pomeriggio del giorno stesso, dovette trasferirsi a Castiglione del Lago. Il giorno 11, in seguito ad ordine verbale della III Aerosquadra, raggiunse la Sardegna (Decimomannu). Succes-
sivamente, attraverso un susseguirsi di ordini dei nostri Comandi prima e di quelli alleati dopo, si trasferì in Sicilia, quindi in Tunisia per una decina di giorni, poi di nuovo in Sicilia ed infine raggiunse le Puglie (Lecce e successivamente Leverano) ~l principio di ottobre. Aveva iniziato i suoi trasferimenti con 22 apparecchi da caccia e 4 da trasporto; al termine delle sue peregrinazioni non contava che su 14 Mc. 200 in cattive condizioni di efficienza.
Oltre ai Mc. 200 dell'8° Gruppo, affluirono al Sud altri apparecchi da caccia Mc. 205 e Mc. 202, da Pescara e da Fo ligno, e Re. 2001, da Guidonia. I primi appartenevano agli Stormi 4° e 51 ° e si trovavano a Pescara ed a Foligno per riparazioni; i Re. 2001 appartenevano al 167° Gruppo Intercettori ed al 160° Gruppo CT, quest'ultimo trasferitos i in quei giorni, come si è detto, dalla Sardegna nel Continente. In particolare, gli apparecchi da caccia che si trovavano a Pescara furono ritirati dai piloti del 4° Stormo e del 21 ° Gruppo, partiti a tal e scop o da Brindisi a bordo di aerei da trasporto S. 82, tra il 10 e il 12 settembre.
Complessivamente gli apparecchi da caccia, che traversarono le linee e vennero ad aggiungersi alle rimanenti forze della R. Aeronautica, non arrivarono a cinquanta.
Quindi, dopo gli avvenimenti sùsseguenti all'armistizio, gli apparecchi da caccia in carico all'Aeronautica italiana comprendevano circa un centinaio di Mc. 205, Mc. 202, Mc. 200, Re. 2002 e Re. 2001, dei quali circa la metà efficienti.
I reparti da bombardamento (in qm>ta ed in picchiata, diurni e notturni), aerosiluranti e da trasporto, che all'atto dell'armistizio si trovavano al Sud, erano limitati di numero e di scarsa efficienza. Le incessanti e violen te incursioni aeree ang loamericane e la minaccia di sbarchi nelle isole italiane avevano

obbligato, già nei mesi precedenti, a spostare quei reparti su basi ·arretrate del Continente.
In definitiva, le forze da bombardamento erano quasi tutte riunite a Perugia, considerata base centrale dalla quale potevano spostarsi secondo le esigenze, e gli aerosiluranti erano dislocati a Pisa, Siena e Littoria.
All'8 settembre 1943, nel territorio della IV Squadra Aerea erano dislocati i seguenti reparti:
43° Stormo BT (Gioia del Colle) su S. 84
98° Gruppo BT
240a Squadriglia BT
241 a Squadriglia BT
Sezione 8° Stormo BT (Brindisi) su Cant. Z. 1007 bis Reparti da trasporto su S. 82.
Ben lungi dal possedere i mezzi assegnati dagli organici, questi reparti disponevano complessivamente di una decina di S. 84, qualche Cant. Z. 1007 bis e 14 S. 82 bellicamente efficienti.
A questi apparecchi debbono aggiungersi i 10 Ca. 314 efficienti della 103a Squadriglia da osservazione aerea di Bari (dipendente dal 69° Gruppo OA), unico reparto dell'Aviazione ausiliaria p er l'E serci to presente al Sud all'atto dell'armistizio.
Solo verso la fine di settembre il 98° Gruppo BT potè prendere in carico i superstiti Cant. Z. 1007 della Sezione 1° Stormo disciolta e gli S. 79 del 131 ° Gruppo Autonomo che da Siena si erano portati a Grottaglie, e si trasferì da Gioia del Colle a Manduria.
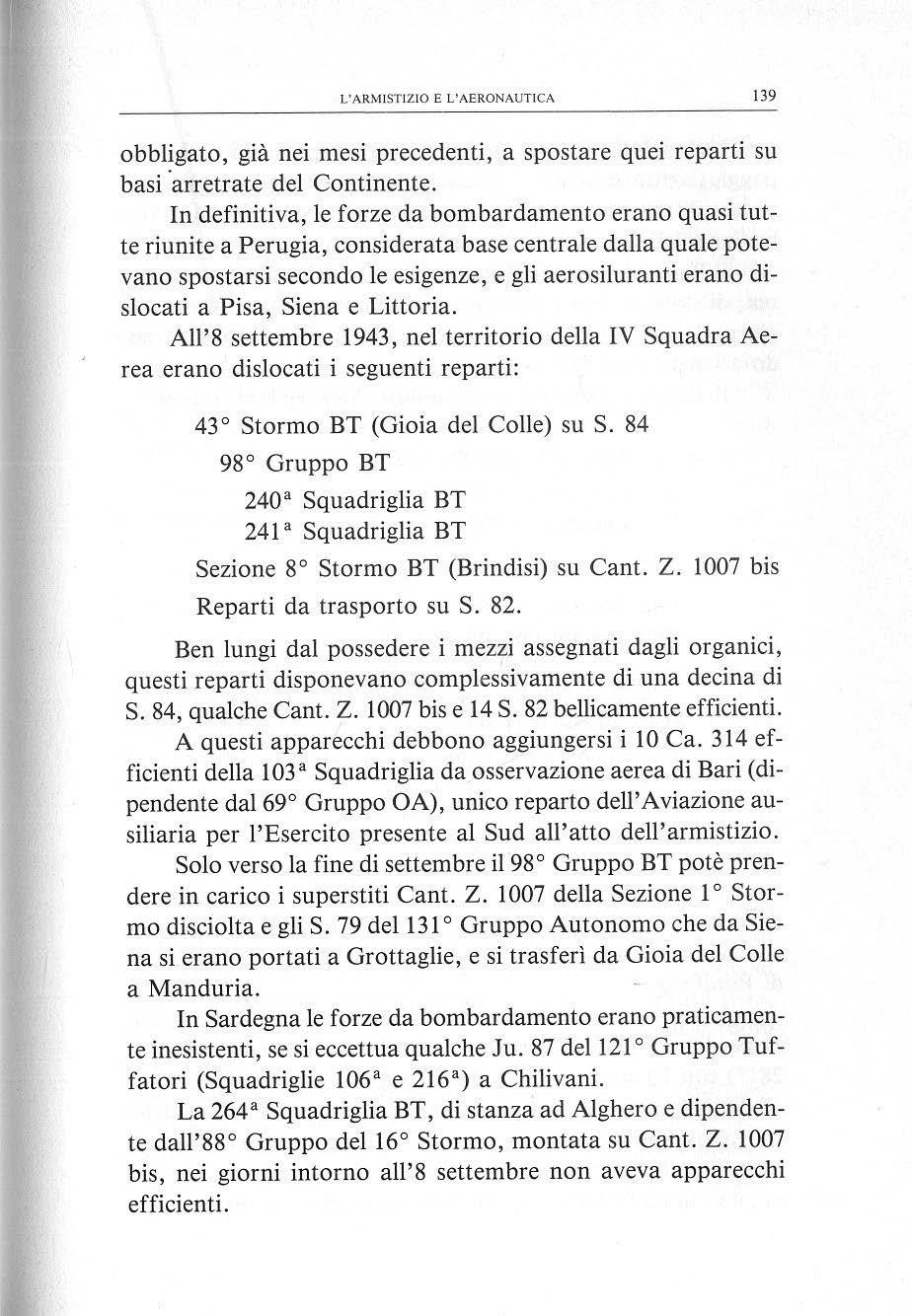
In Sardegna le forze da bombardamento erano praticamente inesistenti, se si eccettua qualche Ju. 87 del 121 ° Gruppo Tuffatori (Squadriglie 106a e 216a) a Chilivani.
La 264 a Squadriglia BT , di stanza ad Alghero e dipendente dall'88° Gruppo del 16° Stormo, montata su Cant. Z. 1007 bis, nei giorni intorno all'8 settembre non aveva apparecchi efficienti.
Notevole fu invece, per numero di apparecchi e di equipaggi, l'afflusso di interi reparti da bombardamento, aerosiluranti e da trasporto sulle basi sarde, pugliesi e siciliane, in obbedienza alle clausole dell'armistizio.

Il Raggruppamento Bombardamento della III Squadra Aerea , di stanza a Perugia, si trasferì al completo ad Alghero il giorno 11 settembre con 30 velivoli Cant. Z. 1007 e 4 S. 82 avendo a bordo oltre 200 uomini.
Il Raggruppamento era composto dei seguenti reparti:
28° Gruppo BT (dell'8° Stormo)
10a Squadriglia BT
19 a Squadriglia BT
86° Gruppo BT (del 35° Stormo)
190a Squadriglia BT
191 a Squadriglia BT
88° Gruppo BT (del 16° Stormo)
265 a Squadriglia BT
106° Gruppo BT (del 47° Stormo)
260a Squadriglia BT
261 a Squadriglia BT
Un apparecchio da trasporto S. 82 s'incendiò al momento del decollo e due bombardieri Cant. Z. furono abbaJtuti dalla contraerea tedesca durante il volo di .trasferimento all'altezza di Bonifacio.
Anche i movimenti degli aerosiluranti non avvennero senza perdite. Il 132° Gruppo Autonomo AS (Squadriglie 278a e 281 a) con 10 apparecchi S. 79 e 2 S. 82 si trasferì da Littoria ad Ampugnano (Siena) il giorno 10 settembre, per ordine della III Aeros quad ra. A pochissime ore di distanza, l'Aeroporto di Littoria cadde in mano tedesca. Durante la navigazione per Siena, il Gruppo fu fatto segno a violenta reazione contraerea na-
vale e terrestre. All'arrivo ricevette ordine di trasferirsi in Sardegna insieme ai reparti si1uranti già di stanza ad Ampugnano: il 41 ° Gruppo Autonomo.AS (Squadriglie 204a e 105a) ed il 104° Gruppo Autonomo AS (Squadriglie 252a e 253a).
Il mattino dell' 11, una prima formazione di S. 79 delle Squadriglie 204\ 205\ 252a e 278a partì per Milis in Sardegna. Intercettati sulla costa sarda da cacciatori tedeschi, due velivoli furono costretti a scendere in mare ed uno ad invertire la rotta; altri due apparecchi raggiunsero Decimomannu ed i rimanenti sette Milis: gli ultimi due, temendo che l'aeroporto di Milis fosse occupato dai Tedeschi, rientrarono a Siena.
La seconda formazione (Squadriglie 253a e 281 a) di 11 apparecchi giunse intatta a Decimomannu. Il giorno 13 settembre, i 13 S. 79 di Decimomannu ricevettero ordine dal Comando Aeronautica della Sardegna di trasferirsi a Castelvetrano in Sicilia e, per ordine del Comando Alleato, di qui ad Agrigento (giorno 14) ed a Korba in Tunisia (giorno 22). Quest'ultimo trasferimento fu effettuato dal 22 apparecchi, essendosi aggregati anche quelli che erano sfuggiti ai Tedeschi dall'Aeroporto di Foligno. Infine, il giorno 2 ottobre, 15 S. 79 del 132° Gruppo ancora efficienti poterono decollare dalla Tunisia alla volta di Lecce.
Si noti che il 132° Gruppo aveva riunito i superstiti apparecchi dei Gruppi 41 ° e 104 ° ed altri provenienti da Foligno e dalle Scuole di Fano e di Malpensa.
Anche vari apparecchi da trasporto (S. 82, S. 75, ecc.) del Gruppo Trasporti di Fano, del Reparto «P» di Centocelle e di altri reparti dipendenti dal Comando Servizi Aerei Speciali (S.A.S.) si trasferirono al Sud subito dopo 1'8 settembre 1943, trasportando un notevole numero di personale di vario ruolo e categoria.
Complessivamente, gli apparecchi da bombardamento, aerosiluranti e da trasporto (oltre a qualche apparecchio da ricognizione), trasferitisi al Sud, superarono il centinaio, compresi anche apparecchi di tipo antiquato e di scarsa o nessuna efficienza bellica.
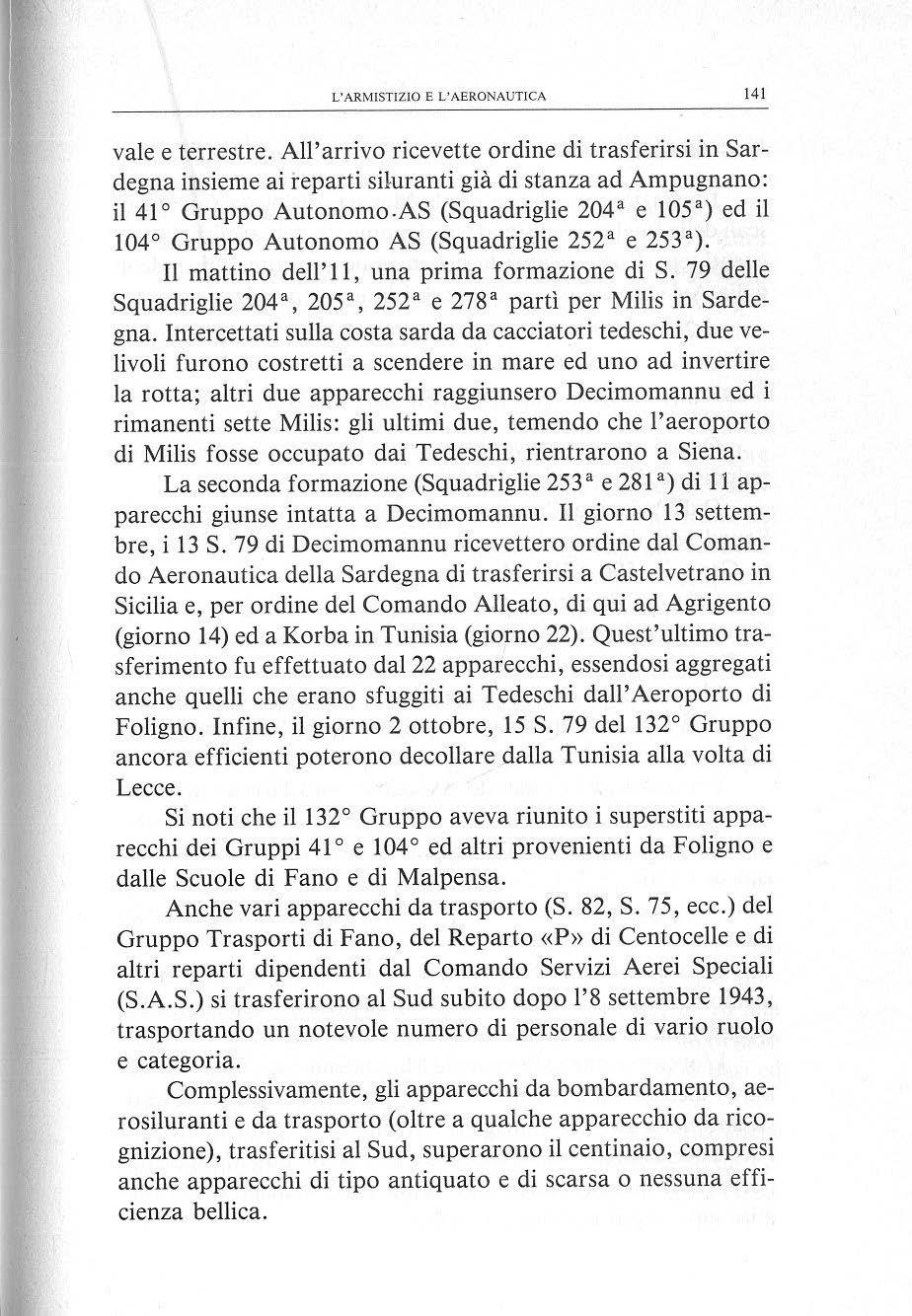
c) L 'Idroaviazione.
L'aviazione ausiliaria per la Marina, dislocata sugli idroscali delle Puglie, comprendeva al momento dell'armistizio i seguenti reparti idrovolanti da ricognizione marittima, dipendenti dalla Aviazione Jonio e Basso Adriatico con sede a Taranto:
288a Squadriglia RM (Taranto) dell'85° Gruppo RM su Cant. Z. 501
141 a Squadriglia RM (Brindisi) su Cant. Z. 501
Questi reparti avevano in carico complessivamente una quindicina di idrovolan t i efficienti.
Dall'Aviazione Sardegna per la Marina dipendevano le Squadriglie da ricognizione marittima 138\ 146a e 287a tutte su Cant. Z. 506 e Rs. 14.
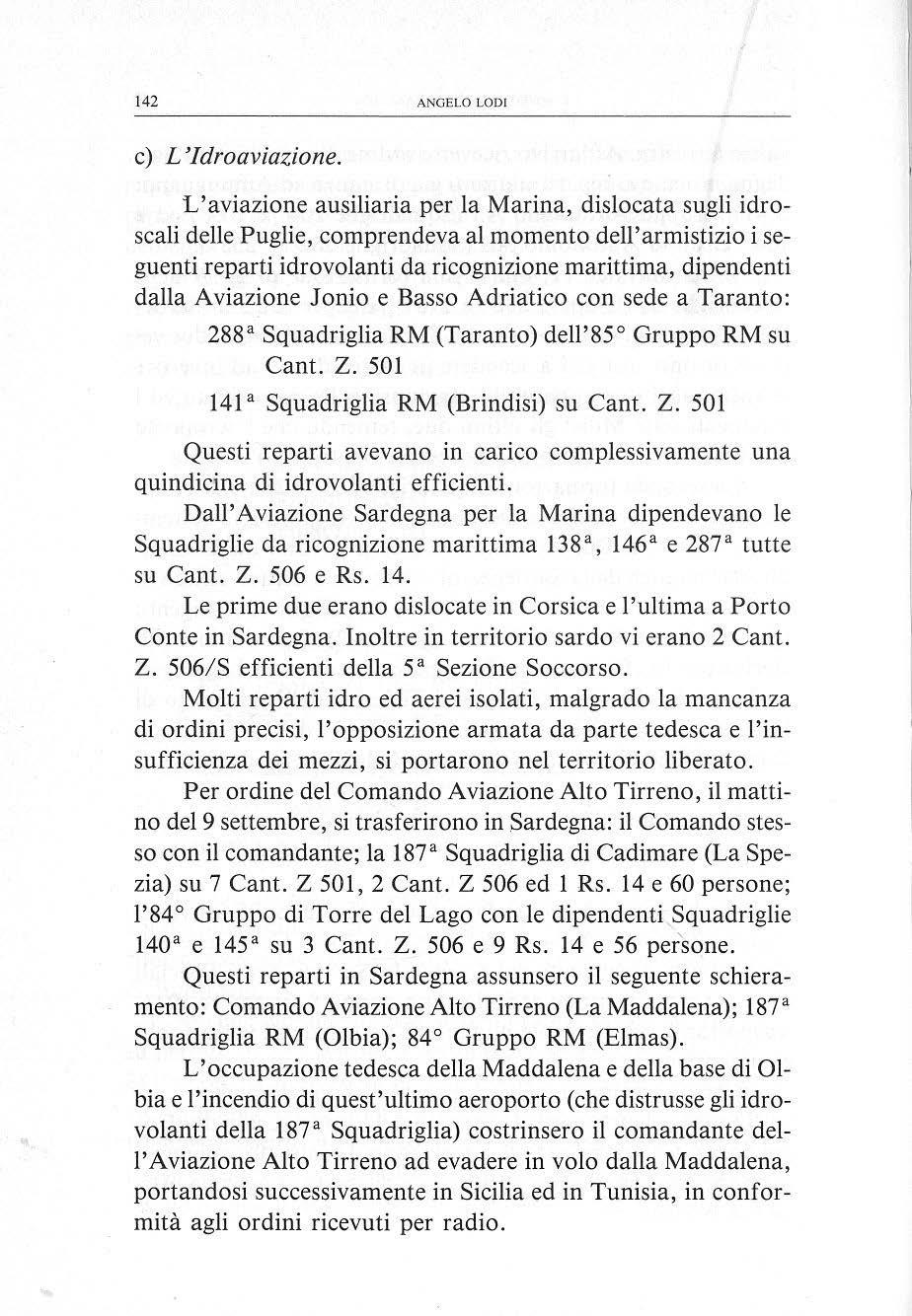
Le prime due erano dislocate in Corsica e l'ultima a Porto Conte in Sardegna. Inoltre in territorio sardo vi erano 2 Cant. Z. 506/S efficienti della 5a Sezione Soccorso.
Molti reparti idro ed aerei isolati, malgrado la mancanza di ordini precisi, l'opposizione armata da parte tedesca e l'insufficienza dei mezzi, si portarono nel territorio liberato.
Per ordine del Comando Aviazione Alto Tirreno, il mattino del 9 settembre, si trasferirono in Sardegna: il Comando stesso con il comandante; la 187 a Squadriglia di Cadi mare (La Spezia) su 7 Cant. Z 501, 2 Cant. Z 506 ed 1 Rs. 14 e 60 persone; 1'84° Gruppo di Torre del Lago con le dipendenti Squadriglie 140a e 145 a su 3 Cant. Z. 506 e 9 Rs. 14 e 56 persone.
Questi reparti in Sardegna assunsero il seguente schieramento: Comando Aviazione Alto Tirreno (La Maddalena); 187a Squadriglia RM (Olbia); 84 ° Gruppo RM (Elmas).
L'occupazione tedesca della Maddalena e della base di Olbia e l'incendio di quest'ultimo aeroporto (che distrusse gli idrovolanti della 187a Squadriglia) costrinsero il comandante dell'Aviazione Alto Tirreno ad evadere in volo dalla Maddalena, portandosi successivamente in Sicilia ed in Tunisia, in conformità agli ordini ricevuti per radio.
Sulla base di Elmas 1'84° Gruppo fu immediatamente sottoposto alla violenta reazione dei Tedeschi, che, durante alcune incursioni aeree (giorni 18 e 20 settembre), mitragl iarono gli apparecchi alla fonda indifesi, distruggendo 2 Rs. ~4 ed 1 Cant. Z. 506 e danneggiandone vari altri. Al personale del!' 84 ° Gruppo, dopo la prima metà di settembre, si aggregò parte del personale della 187 a Squadriglia.
La 171 a Squadriglia (Tolone), dipendente anch'essa dal Comando Aviazione Alto Tirreno, non potè ricevere l'ordine di trasferiment o , perchè era stata immobilizzata dalle forze tedesche dislocate sulla base di Tolone fin dalla sera de11'8 settembre.
Inoltre, al seguito degli idrovolanti del Comando A viazione Alto Tirreno, partirono 8 Ro. 43 ed 1 Ro. 44 agli ordini del Capo Servizio Aereo delle Forze Naval i, raggiungendo La Maddalena, destinazione prevista per la Flotta. Dopo l'occupazione tedesca della Maddalena evasero da que lla base, portandosi nelle Baleari. Due di essi furono abbattuti dalla contraerea tedesca dopo la partenza.
Quando, a i primi di novembre (come si dirà seguito), venne disciolta l'ldroavia Sardegna, 1'84° Gruppo accentrò gli idrovolanti s uper st iti delle sue Squadriglie e della 146 a Squadriglia RM già in Corsica (Aiaccio e Porto Vecchio).
L e Squadriglie da ricog ni zione marittima 149a e 183\ dipendenti dall'Aviazione Alto Adriatico, si portarono a Taranto al completo. La 149 3 Squadriglia vi si trasferì da Kumbor (Montenegro) co n 9 Cant. Z. 501 ed oltre 80 persone.
La 183a Squadriglia con 5 Cant. Z. 501 e 3 Cant. Z. 506 ed una settan t in a di uomini par tì da Di vulje in D almazia il giorno 8 settembre e, sfuggendo alle violente azioni aeree ed alla progr essiva occupazione dei Tedeschi, si portò a Lagosta (il giorno 10), ad An cona (1 ' 11), a S. Nicola Varano (il 12), a Bari ed infine a Taranto (il 13).
Si portarono a Taranto anche alcuni apparecchi isolati delle Squadriglie da ricognizione marittima 143 a (provenienti da Venezia), 184a (pro ve ni ente da Pol a), 144 3 (proveniente da Orbe-
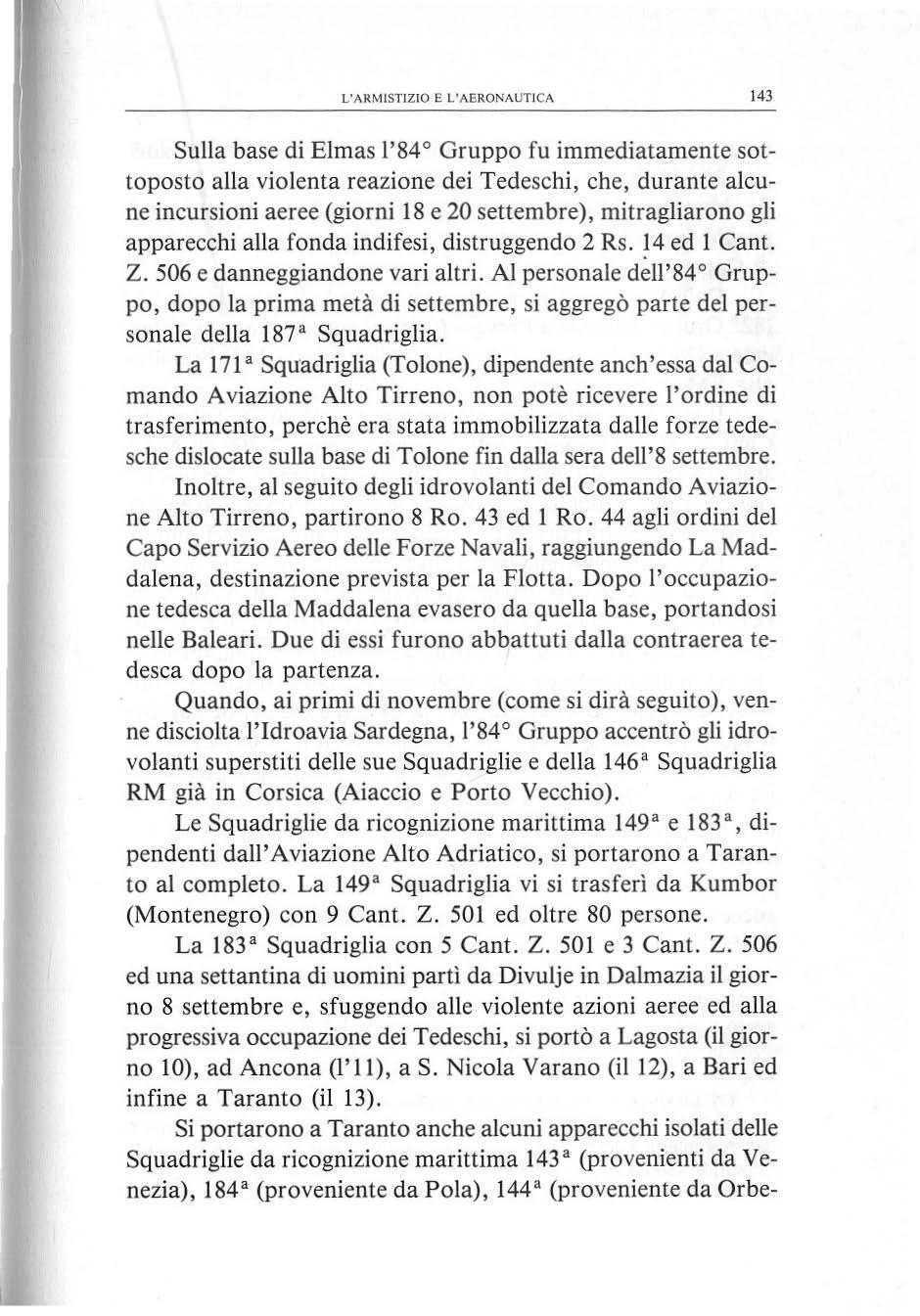
tel10), ecc .. Un idrovolante Cant. Z. 501 della 14ga Squadriglia RM (Aviazione Basso Tirreno), partito da Vigna di Valle, fu abbattuto dalla contraerea il giorno 14; 6 uomini dell'equipaggio furono ricuperati in mare da una nave inglese al largo di Capri.
Dall'Aviazione Grecia dipendevano la 139a Squadriglia RM (82° Gruppo) di sede a Prevesa (Grecia) con due Sezioni distaccate a Corfù ed Argostoli (is. di Cefalonia) e la 147a Squadriglia RM di sede in Egeo.
Il giorno 9 settembre, riuscirono a ripiegare a Taranto 1 Cant. Z. 501 della Sezione di Corfù e 2 Cant. Z. 506 da Argostoli, trasportando 30 persone complessivamente. Nessun aereo della 139a Squadriglia riuscì a partire da Prevesa, avendole i Tedeschi messo fuori uso tutti gli aerei il giorno 8 settembre.
La 147a Squadriglia passò attraverso movimentate vicende.
Alla data dell'armistizio aveva sede a Lero ed aveva in carico 8 Cant. Z. 506 e 4 Cant. Z. 501, dei quali 3 Cant. Z. 501 erano distaccati a Rodi. Il giorno 11 settembre, quando Rodi era già in mano tedesca, uno degli apparecchi di quella Sezione riuscì a fuggire ed a raggiungere la base ing lese di Alessandria d'Egitto, donde iniziò subito la collaborazione con gli Alleati. Anche gli aerei di Lero iniziarono subito l'attività a fianco degli Alleati, subendo forti perdite da parte dei Tedeschi, e tale attività continuarono fino al loro progressivo esaurimento avvenuto ai primi di ottobre 1943.
In complesso, gli idrovo lanti che affluirono al Sud, in tempi successivi, superarono la cinquantina fra Cant. Z. ~06, Cant. Z . 501 e Rs. 14.
Verso la metà del settembre 1943, la situazione dei velivoli a disposizione dell'Aeronautica nelle Puglie e in Sardegna era la seguente (7):
(7) La situazione è desunta dall'allegato 1 al Foglio 57 /S04 del 15 settembre 1943. Esaminando la situaz ione, si tenga presente che tutti i reparti dell'Aeronautica erano allora in via di riordinamento o di ricostituzione e quindi, se si esclude parte della caccia e dei reparti idrovolanti, in quei primi giorni successivi all'armistizio la disponibilità di velivoli per l'impiego
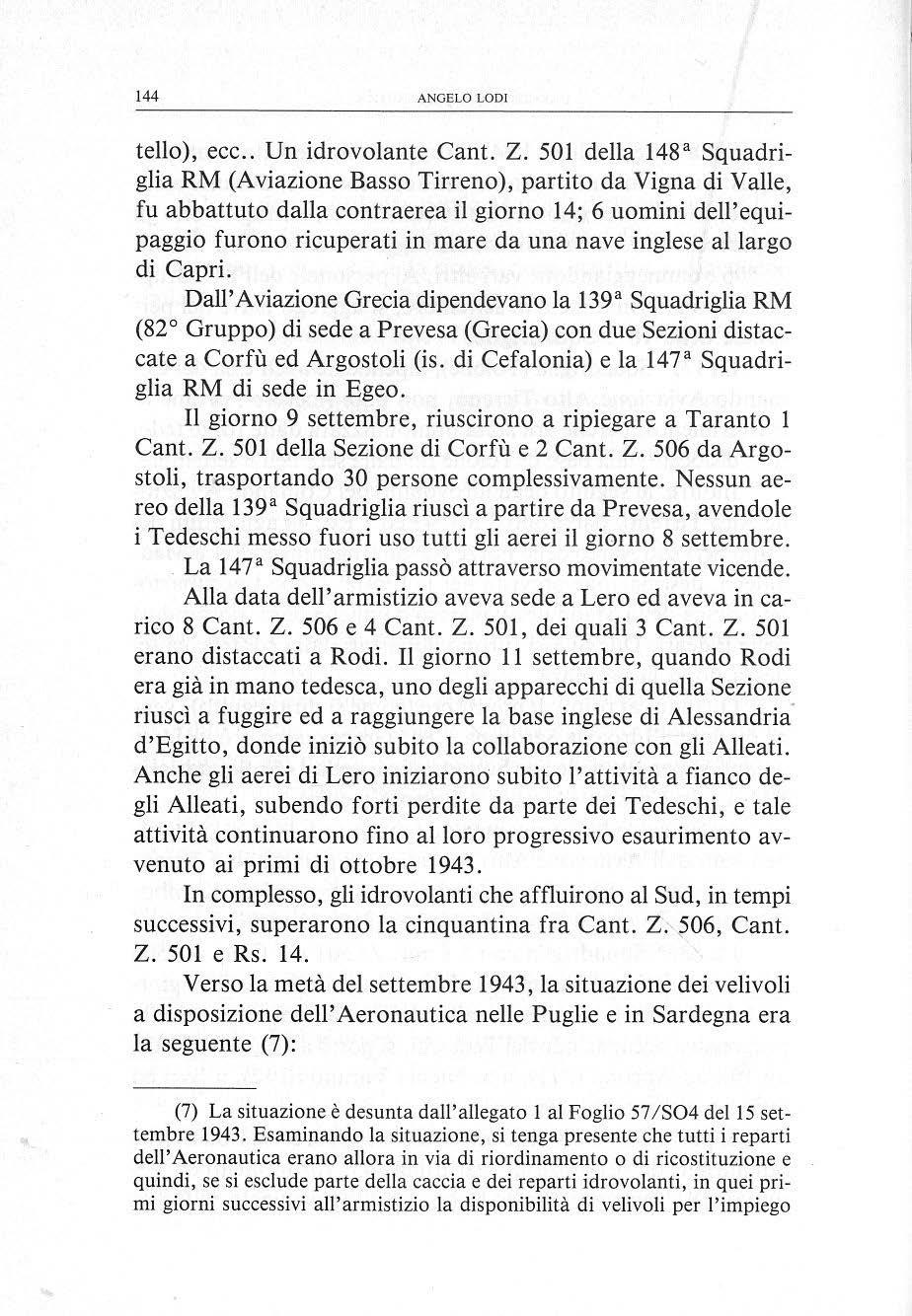
Velivoli di linea efficienti :
(Mc. 205, Mc. 202, Re. 2001)
(Re. 2002)
era piu ttosto scarsa. Come diciamo altrove , il loro impiego ebbe inizio immediatamente dopo 1'8 sett embre e dovet t e essere assai spess o limitat o appunto per deficienza dì apparecchi, come , per ese mpio , durante le operazio ni di appoggio alle isole Eolie; comunque, tale disponibilità era inferiore a quella che potr ebbe a prim a vista apparire d a un sommario esam e dei tota li Co nside razi oni analo g he val gono per la suc cessiv a situazione del 30 set tembre.
(18) La s ituazione è de s unta da uno specchio trasmesso dal Superaereo al Coma ndo S upremo in data 30 settembr e 1943. P e r la Sicilia manca l'efficien za velivo li.

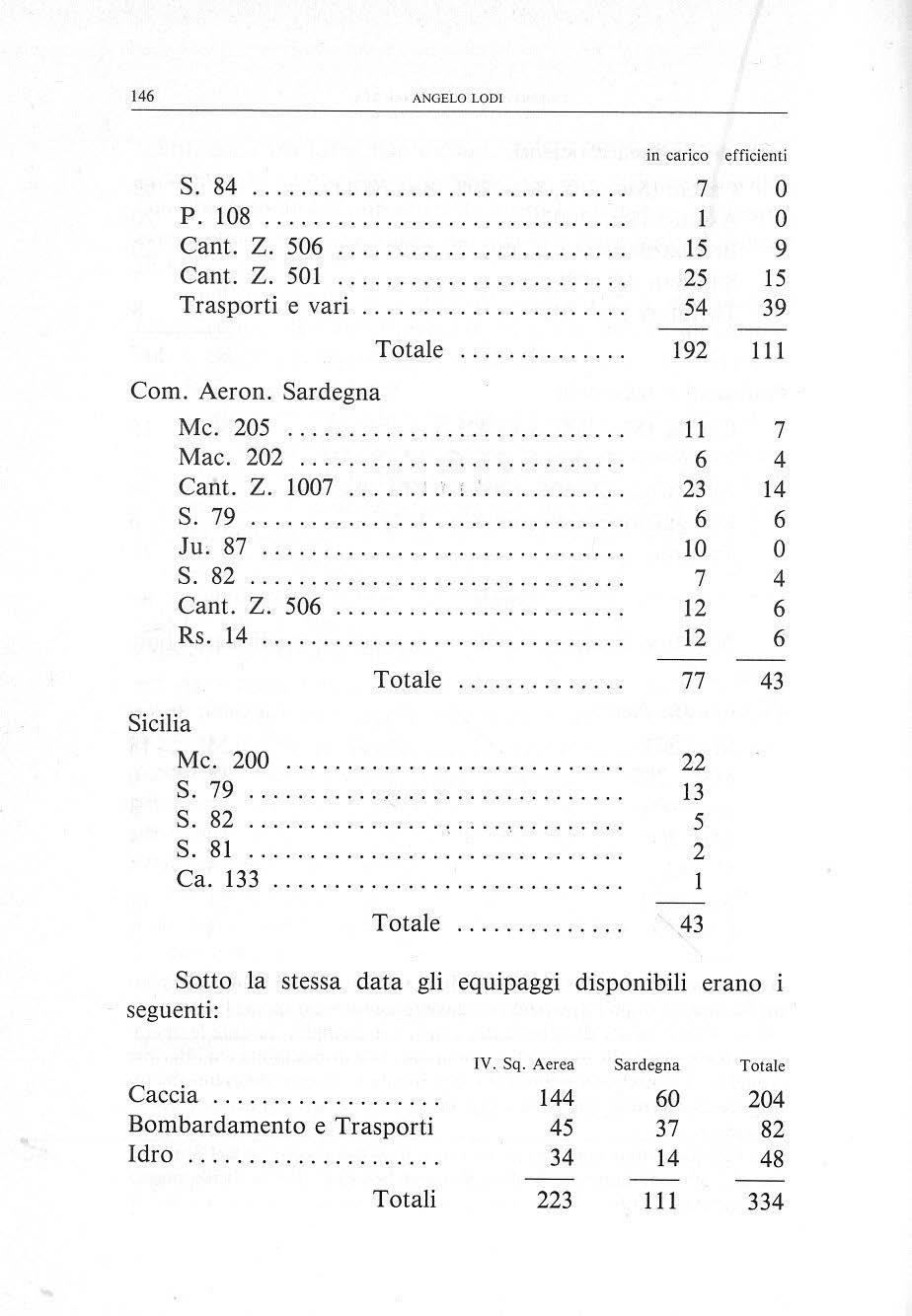
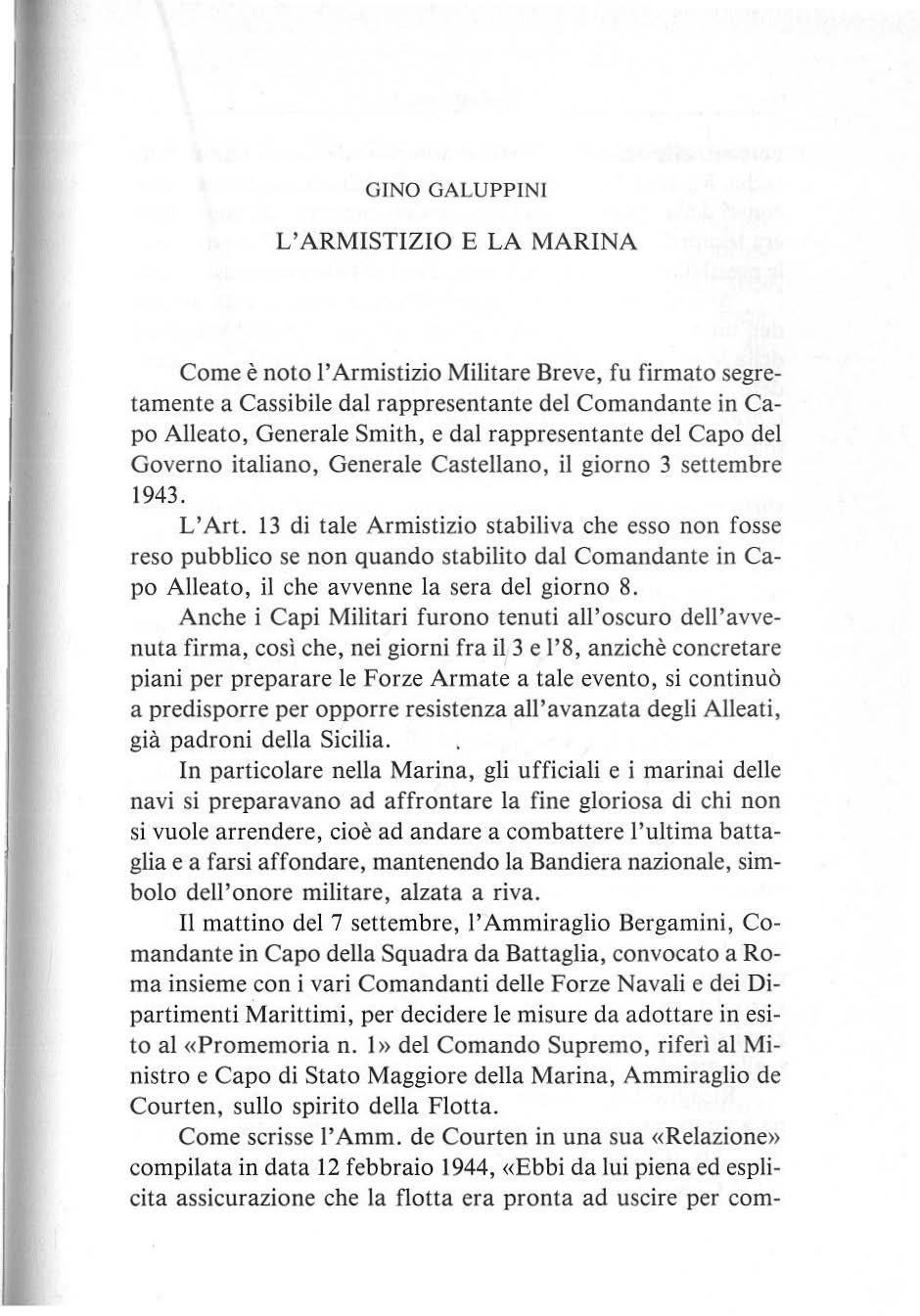
Come è noto l'Armistizio Militar e Breve, fu firmato segreta ment e a Cassibile dal rappresentante del Comandan te in Capo Alleato, Generale Smith, e dal rappresentante del Capo del Governo italiano, Generale Castellano, il giorno 3 settembre 1943.
L'Ar t . 13 di tale Armistizio stabiliva che esso non fosse reso pubblico se non quando stabil ito dal Comandante in Capo Alleato, il che avvenne la sera del giorno 8. Anche i Cap i Militari furono tenuti all'oscuro dell'avvenuta firma, così che, nei giorni fra il 3 e 1'8, anzichè concretare piani per preparare le Forze Armate a tale evento, si continuò a predisporre p er opporre resistenza all'avanzata degli Alleati, già padroni della Sicilia .
In particolare nella Marina , gli ufficiali e i marinai delle navi si preparavano ad affrontare la fine gloriosa di chi non si vuole arrendere, cioè ad andare a combattere l'ultima battag lia e a farsi affondare, mantenendo la Bandiera nazional e, simbolo dell'onore militare, alzata a riva.
Il mattino del 7 settembre, l'Ammiraglio Bergamini, Comandante in Capo della Squadra da Battaglia, convocato a Roma in sie me con i vari Comandanti delle Forze Navali e dei Dipartimenti Marittimi, per decidere le mi sure da adottare in esito al « Promemoria n. 1» del Comando Supremo, riferì al Ministro e Capo di Stato Maggior e della Marina, Ammiraglio de Courten, sullo s pirito della Flotta.
Come scrisse l'Amm. de Courten in una sua « Rela zione»
compilata in data 12 febbraio 1944, «Ebbi da lui piena ed esplicita a ss icurazione che la flotta era pron ta ad uscire per com-
battere nelle acque del Tirreno Meridionale la sua ultima battaglia . Mi disse che Comandanti ed Ufficiali erano perfettamente consci della realtà cui sarebbero andati incontro, ma che in tutti era fermissima la decisione di combattere fino all'estremo delle possibilità. Gli equipaggi erano pieni di fede e di entusiasmo».
Ancora il mattino del 8 settembre, essendo giunta notizia dell'imminente sbarco degli alleati, il Capo di Stato Maggiore della Marina aveva ordinato all' Amm. Bergamini di far accendere le navi e di tenersi pronto a muovere alle ore 14.00 «per il previsto intervento offensivo nella zona di sbarco.» da effettuarsi il mattino del giorno 9 settembre.
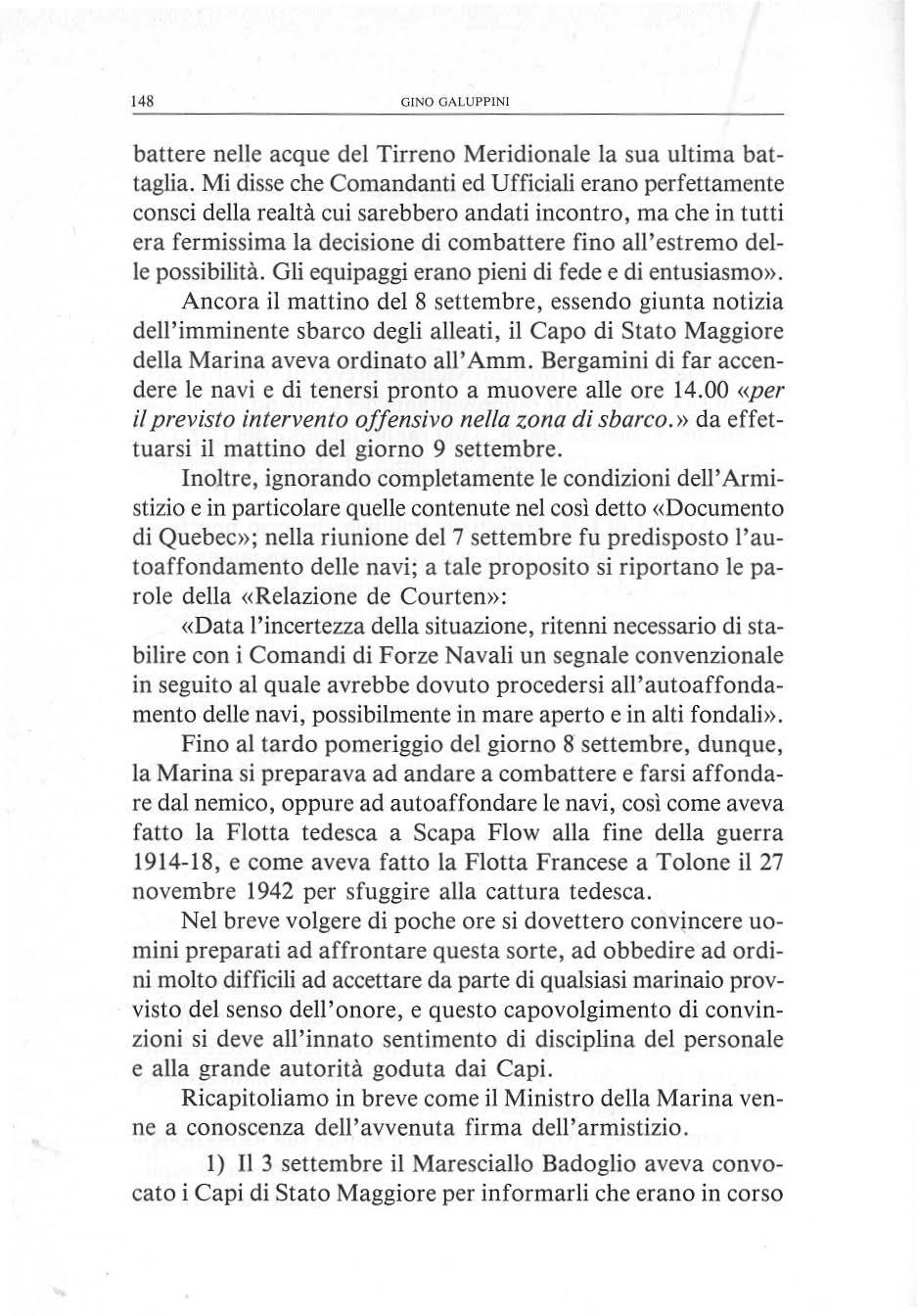
Inoltre, ignorando completamente le condizioni dell'Armistizio e in particolare quelle contenute nel così detto «Documento di Quebec»; nella riunione del 7 settembre fu predisposto l ' autoaffondamento delle navi; a tale proposito si riportano le parole della «Relazione de Courten»:
«Data l'incertezza della situazione, ritenni necessario di stabilire con i Comandi di Forze Navali un segnale convenzionale in seguito al quale avrebbe dovuto procedersi all'autoaffondamento delle navi, possibilmente in mare aperto e in alti fondali».
Fino al tard o pomeriggio del giorno 8 settembre, dunque, la Marina si preparava ad andare a combattere e farsi affondare dal nemico, oppure ad autoaffondare le navi, così come aveva fatto la Flotta tedesca a Scapa Flow alla fine della guerra 1914-18, e come aveva fatto la Flotta Francese a Tolone il 27 novembre 1942 per s fuggire alla cattura tedesca.
Nel breve volgere di poche ore si dovettero convincere uomini preparati ad affrontare que s ta sorte, ad obbedire ad ordini molto difficili ad accettare da parte di qualsiasi marinaio provvisto del senso dell'onore, e questo capovolgimento di convinzioni si deve all'innato sentimento di di sciplina del personale e alla grande autorità goduta dai Capi.
Ricapitoliamo in breve come il Ministro della Marina venne a conoscenza dell'avvenuta firma dell'armistizio .
1) Il 3 settembre il Mare sciallo Badoglio aveva convocato i Capi di Stato Maggiore per informarli che erano in corso
trattative per concludere l'armistizio, ma che la notizia doveva esser mantenuta segreta.
2) Il pomeriggio del 5 settembre il Generale Ambrosio, Capo di Stato Maggiore Generale, aveva chiesto all' Amm. de Courten una moto silurante per trasportare da Gaeta a Ustica degli ufficiali italiani e prendere degli ufficiali inglesi e americani da t rasportare a Roma per le trattative di armistizio, aggiungendo che la sua proclamazione sarebbe avvenuta fra il 10 e il 15. Comunicò inoltre che il grosso della flotta avrebbe dovuto dislocarsi a Maddalena, dove era possibile si rifugiasse il Re co n par te del Governo.
3) A mezzogiorno del 6 settemb re il Comando Supremo comunicò ai Capi di Stato Maggiore il «Promemor ia n. 1» che, pur non facendo cenno all'armistizio, conteneva le disposizioni da prendere in caso di atti di ostilità armate da parte delle forze germaniche.
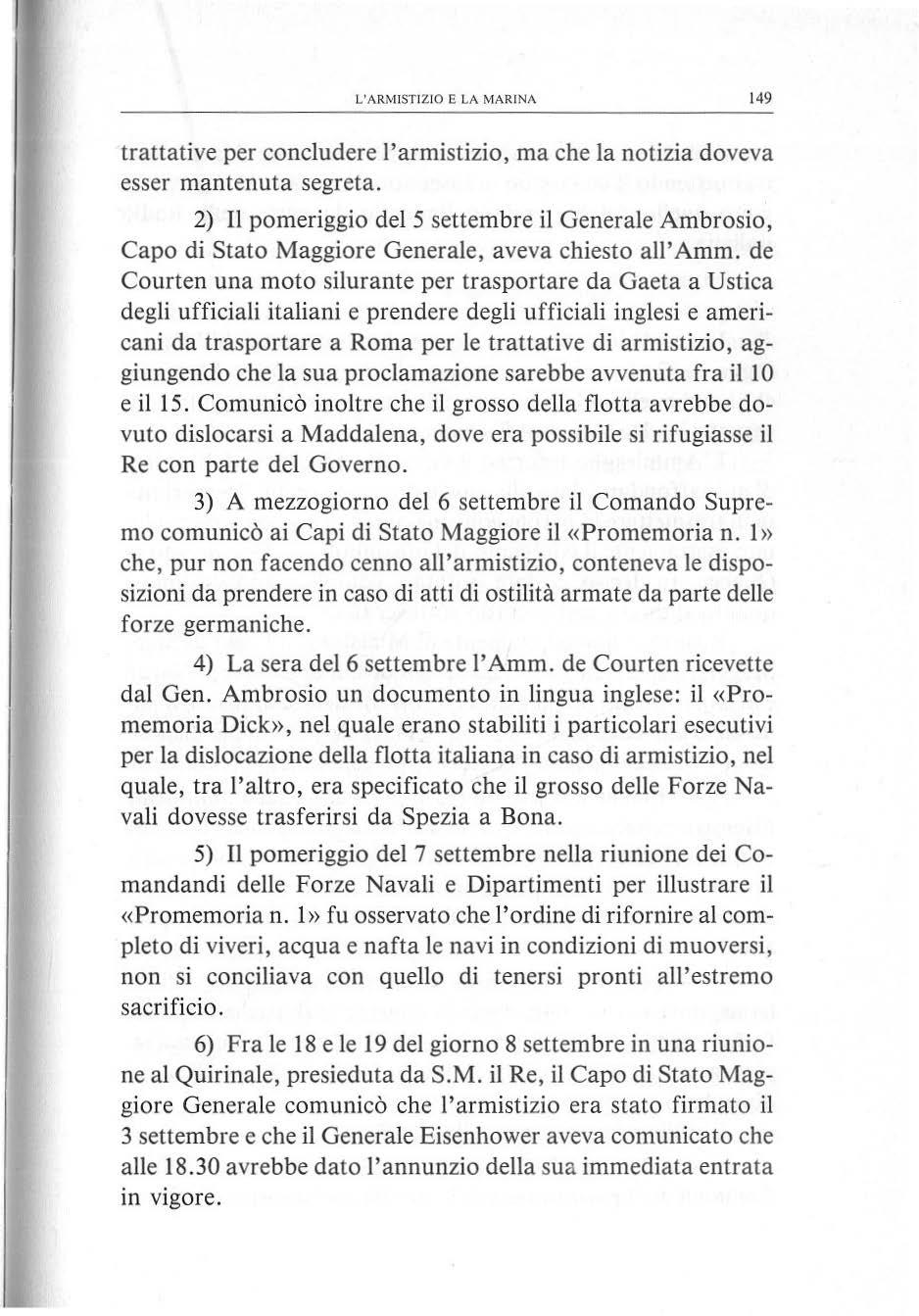
4) La sera del 6 settembre l' Amm. de Courten ricevette dal Gen. Ambrosia un documento in lingua inglese: il «Promemoria Dick», nel quale erano stab ili t i i particolari esecutivi per la dislocazione della flotta italiana in caso di armistizio, nel quale, tra l 'altro, era spec ificato che il grosso delle Forze Navali dovesse trasferirsi da Spezia a Bona.
5) Il pomeriggio del 7 settembre nella riunione dei Comandandi delle Forze Navali e Dipartim enti per illustrare il «Pro memoria n. 1» fu osservato che l'ordine di rifornire al completo di viveri, acqua e na fta le navi in condizioni di muoversi, non si conciliava con quello di tenersi pronti all'estremo sacrificio.
6) Fra le 18 e le 19 del giorno 8 settembre in una riunione al Quirinale, presieduta da S.M. il Re, il Capo di Stato Maggiore Gen era le comunicò ch e l'armistizio era stato firmato il 3 settembre e che il Generale Eisenhower aveva comunicato che alle 18 .30 av r ebbe dato l'annunzio della sua immediata entrata in vigore .
Nel corso della riunione si seppe che Radio Algeri stava trasmettendo il messaggio di Eisenhower, cui alle 19 .45 fece seguito quello del Maresciallo Badoglio da parte della Radio italiana.
Le condizioni di armistizio vennero comunicate all'Ammiraglio de Courten in una riunione dei Capi di Stato Maggiore che seguì quella del Quirinale, nella stessa occasione gli. fu consegnato il «Documento di Quebec».
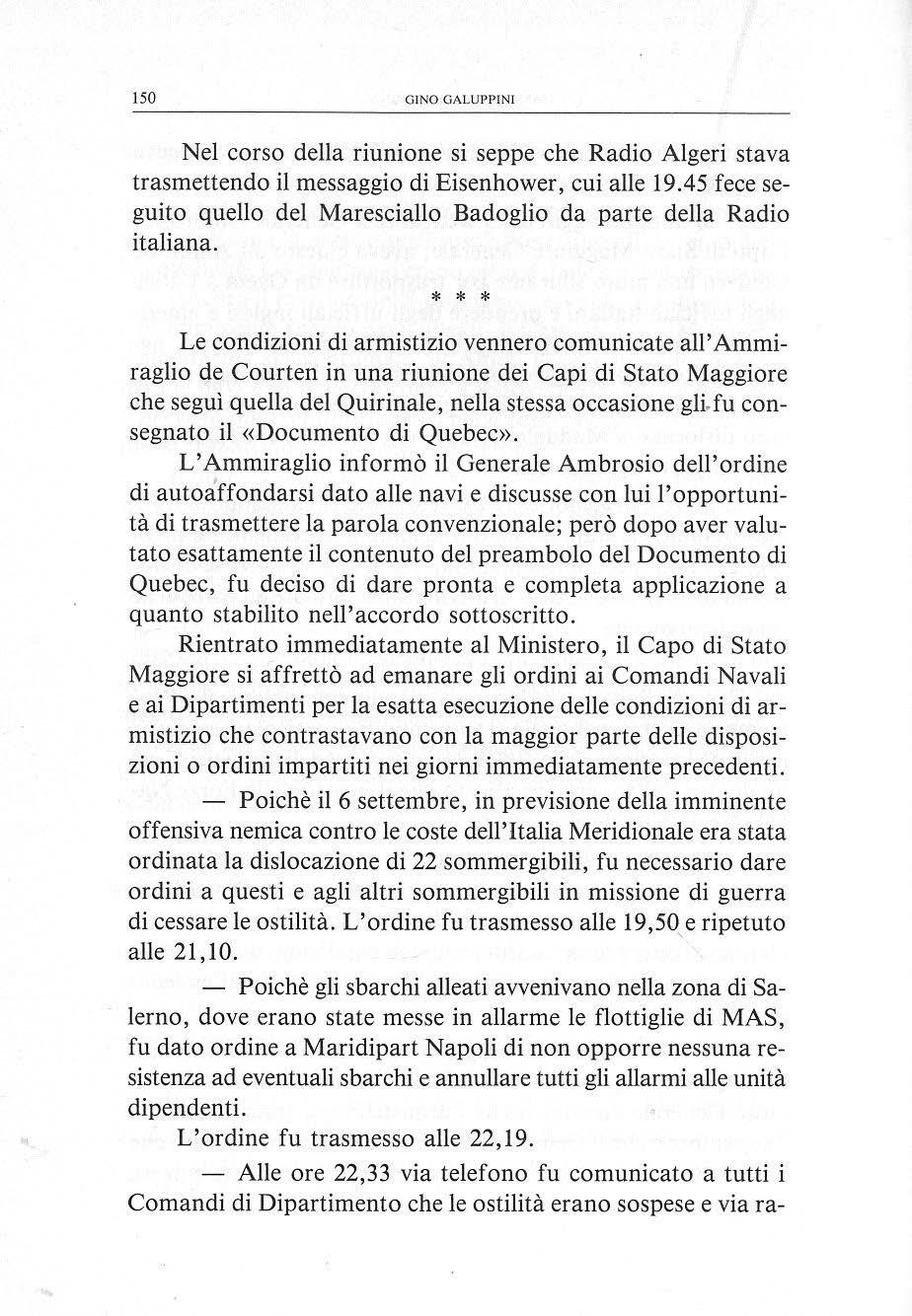
L'Ammiraglio informò il Generale Ambrosio dell'ordine di auto affondarsi dato alle navi e discusse con lui l'opportunità di trasmettere la parola convenzionale; però dopo aver valutato esattamente il contenuto del preambolo del Documento di Quebec, fu deciso di dare pronta e completa applicazione a quanto stabilito nell'accordo sottoscritto.
Rientrato immediatamente al Ministero, il Capo di Stato Maggiore si affrettò ad emanare gli ordini ai Comandi Navali e ai Dipartimenti per la esatta esecuzione delle condizioni di armistizio che contrastavano con la maggior parte delle disposizioni o ordini impartiti nei giorni immediatamente precedenti.
- Poichè il 6 settembre, in previsione della imminente offensiva nemica contro le coste dell'Italia Meridionale era stata ordinata la dislocazione d i 22 sommergibili, fu necessario dare ordini a questi e agli altri sommergibili in missione di guerra di cessare le ost il ità. L'ordine fu trasmesso alle 19,50 e ripetuto alle 21,10.
- Poichè gl i sbarchi alleati avvenivano nella zona di Salerno, dove erano state messe in a ll arme le flottigl ie d i MAS, fu dato ordine a Maridipart Napoli di non opporre nessuna resistenza ad eventuali sbarchi e annullare tutti gli allarmi alle unità dipendenti.
L'ordine fu trasmesso alle 22, 19.
- Alle ore 22,33 via telefono fu comunicato a tutti i Comandi di Dipartimento che le ostilità erano sospese e via ra-
dio la stessa comunicazione fu fatta a tutte le unità militari e mercantili in navigazione, ordinando di raggiungere i porti di destinazione.
- Alle ore 22,34 fu trasmesso a tutti i Comandi Marina a terra, sia in territorio nazionale che in territori extra metropolitani, che le navi tedesche dovevano essere lasciate partire, secondo gli ordi ni che avrebbero ricevuto dai loro comandi.
P er quanto riguarda il trasferimento della Flotta, no n fu emanato nessun ordine scritto o telegrafico perchè, data la situazione venuta a crearsi, l'Ammiraglio de Courten volle telefonare personalmente all'Ammiraglio Bergamini dopo il rientro dal Quirinale.
Riportiamo quanto scr itto nella citata «Relazione de Courten»:
«Presi contatto telefonico con l' Amm. Ber gam ini, giacchè mi appariva urgente ed indispensabile esaminare la situazione morale della Squadra da Battaglia, la quale, essendo pronta ad andare a combattere e quindi portata a quella temperatura che era indispensabile per affrontare una prova suprema, veniva a trovarsi da un momento all'altro nelle condizioni di dovere invece praticamente consegnarsi nelle mani del nemico. L' Amm. Bergamini, colto di sorpresa sia dalla notizia dell'armistizio, sia delle conseguenze che ne deriv avan o nei riguardi della flotta, fece presente che lo stato d'animo de gli Ammiragli e Comandanti sottordini, che egli aveva convocato non appe na reso noto alla radio l'armisti zio, erano unanimamente orientati verso l 'autoaffondam ento delle navi.
Gli risposi che si richiedeva da loro un sacr ificio ancora più grande: quello di adempiere lealmente ed a qualunque costo alle dure condizioni dell'armistizio. Questo sacrificio amarissimo avrebbe potuto portare in avvenire grande giovamento al Paese. Gli prospettai l'opportunità di partire al più presto co n la Squad ra per La Maddalena, dove era già tutto predisposto per l'ormeggio, in modo da sottrarr e subito le navi alla minaccia tedesca, all a influenza dell'ambiente di terra, e alle ri-
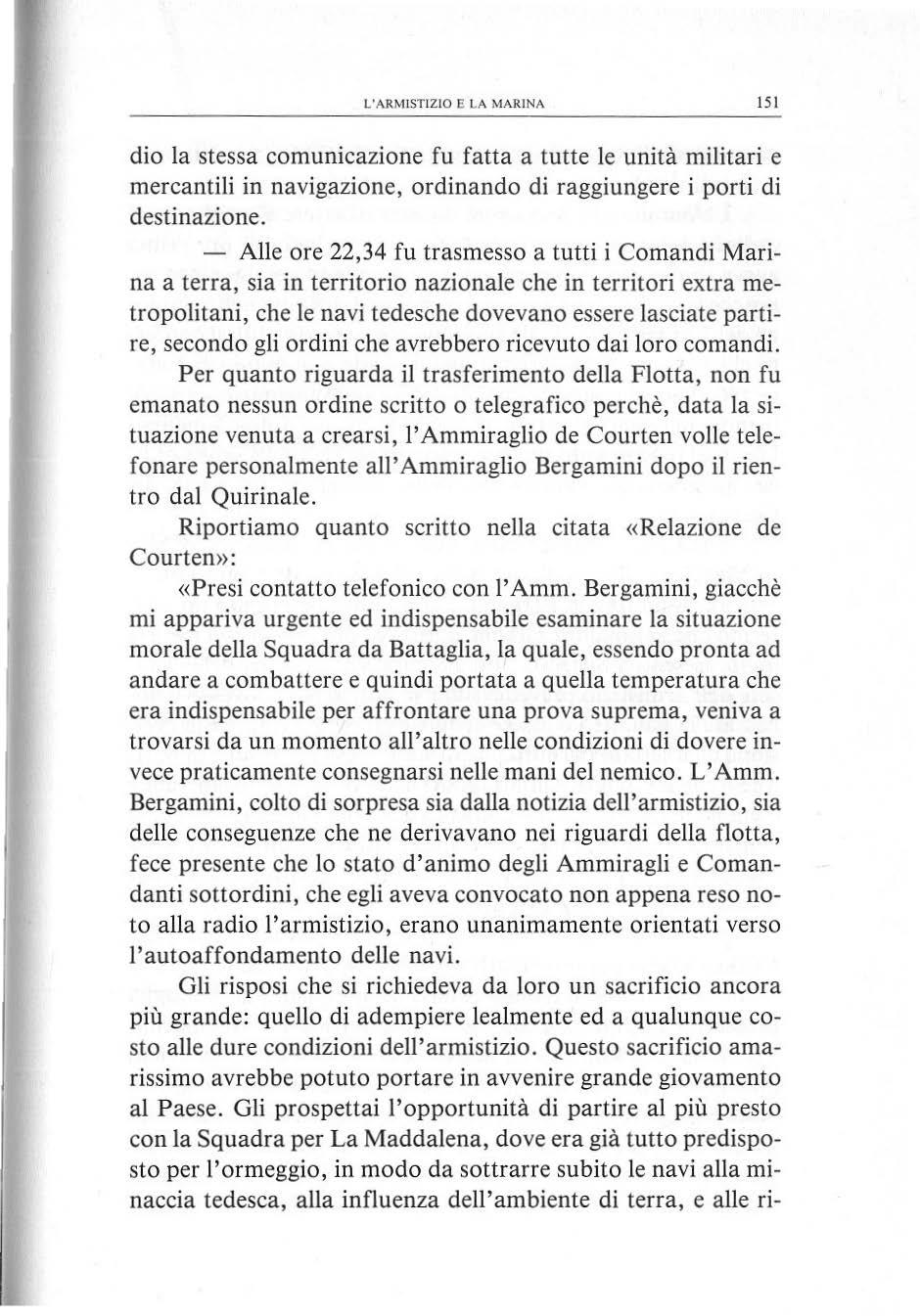
percussioni di discussioni e contatti fra Stati Maggiori ed equipaggi di unità diverse».
L'Ammiraglio Bergamini dovette riflettere alquanto sugli ordini telefonici ricevuti, dato che solo un paio di ore prima aveva convocato gli Ammiragli e Comàndanti per dare loro conoscenza di quanto gli era stato ordinato a Roma nella riunione del 7 settembre. In tale riunione era stato ribadito il concetto che nessuna nave avrebbe dovuto cadere in mani straniere, nè tedesche nè inglesi, e che all'ordine convenzionale «Raccomando massimo riserbo» le navi dovevano autoaffondarsi. L'autoaffondamento doveva essere eseguito anche senza ordine specifico, su valutazione della situazione da parte dei Comandanti.
Poco dopo riprese il colloquio telefonico con Capo di Stato Maggiore. Riprendiamo dalla «Relazione de Courten».
«L'Ammiraglio Bergamini dopo qualche minuto mi confermò che la Squadra sarebbe partita al più presto con tutte le unità presenti a Spezia ... Lo assicurai che nessuna delle clausole dell'armistizio prevedeva che le nostre navi dovessero abbassare la bandiera o essere cedute e gli comunicai che la decisione di accettare l'armistizio era stata presa per ordine di S.M. il re e che il Grande Ammiraglio Thaon de Revel, insuperabile esempio di dirittura e di sentimento dell'onore militare, mi aveva confortato col suo prezioso parere. Gli disse infine che a La Maddalena, il giorno successivo, avrebbe trovato gli ordini per la sua successiva linea di azioni».
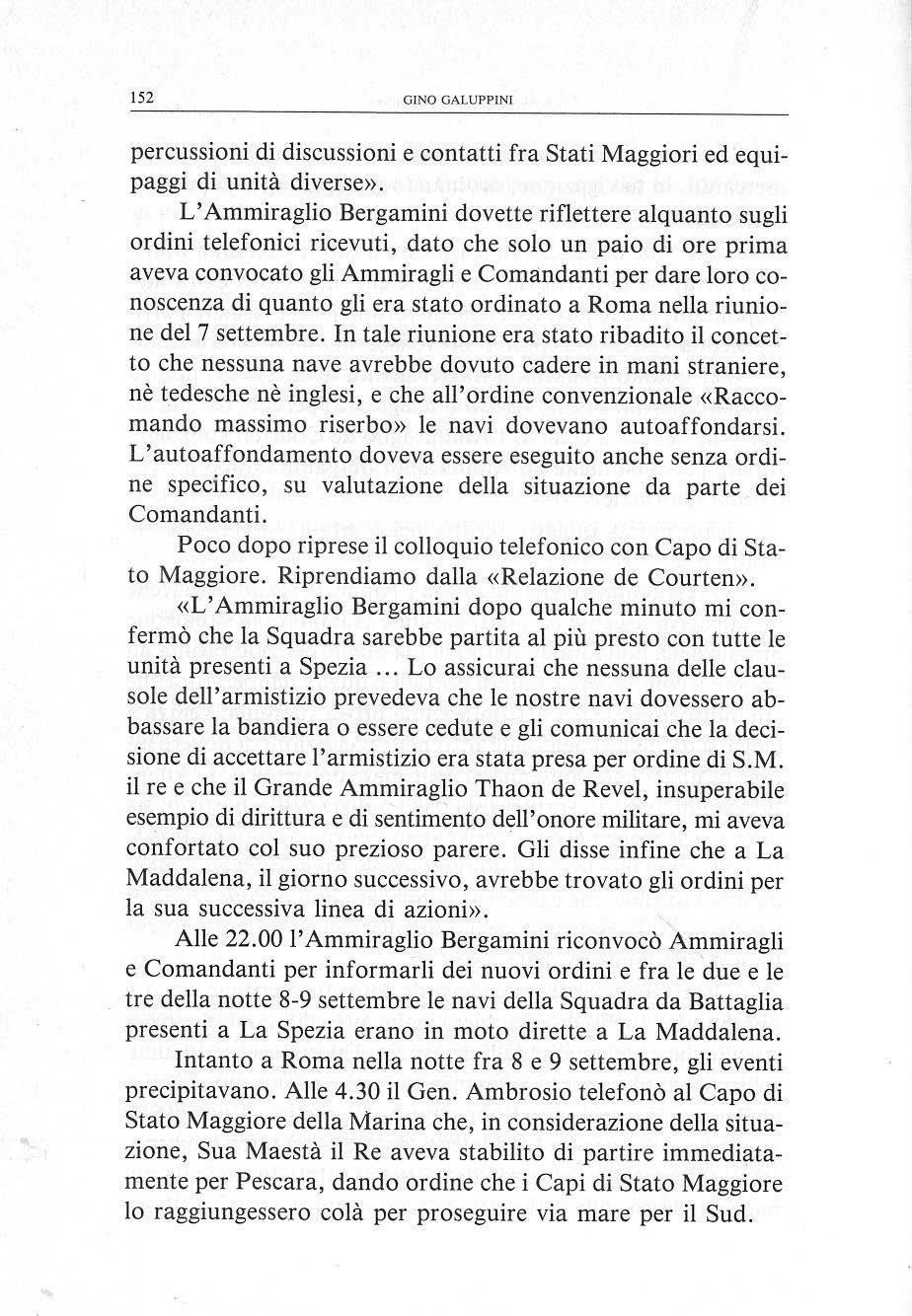
Alle 22.00 l'Ammiraglio Bergamini riconvocò Ammiragli e Comandanti per informarli dei nuovi ordini e fra le due e le tre della notte 8-9 settembre le navi della Squadra da Battaglia presenti a La Spezia erano in moto dirette a La Maddalena.
Intanto a Roma nella notte fra 8 e 9 settembre, gli eventi precipitavano. Alle 4.30 il Gen. Ambrosie telefonò al Capo di Stato Maggiore della Marina che, in considerazione della situazione, Sua Maestà il Re aveva stabilito di partire immediatamente per Pescara, dando ordine che i Capi di Stato Maggiore lo raggiungessero colà per proseguire via mare per il Sud.
Alle ore 06.00 partirono messaggi radio per l'incrociatore leggero Scipione Africano, che era a Taranto, e per le corvette Scimitarra, che era a Brindisi, e Baionetta, che era a Pola con l'ordine di dirigere ad alta velocità per Pescara per imbarcare un «alto personaggio».
Alle 6.42 fu inviato ali' Ammiraglio Da Zara, comandante la 5a Divisione Navale dislocata a Taranto, l'ordine di trasferirsi a Malta, ordine che fu ritrasmesso dal Comando della 5 a Divisione alla corazzata Giulio Cesare che si trovava a Pola, alle ore 09.00.
Impartite le necessarie disposizioni ai suoi diretti collaboratori, alle ore 06.30 del 9 settembre l'Ammiraglio de Courten lasciò Roma in automobile, diretto a Pescara, dove incontrò il Maresciallo Badoglio. Intanto il Re e il suo seguito si erano trasferiti a Ortona.
La prima nave che giunse a Pescara delle tre chiamate alle 6 di quel mattino, fu la corvetta Baionetta (comandante T.V. Pedemonti) che, partita da Pola, vi arrivò alle 21.05, imbarcò il Maresciallo Badoglio e l'Ammiraglio de Courten e proseguì per Ortona giungendovi circa a mezzanotte. Alle ore O1. 1O del 1O settembre, la corvetta Baionetta con a bordo il Re e il suo seguito per un totale di 57 persone, lasciò Ortona, raggiungendo Brindisi alle 16.00 del pomeriggio, dove la famiglia reale fu provvisoriamente sistemata nella palazzina alloggi del Comando Marina.
Scipione Africano e Scimitarra, giunti a Pescara rispettivamente alla mezzanotte del 9 e alle 7 del 10, furon fatte proseguire per il Sud, lo Scipione di scorta al Baionetta, la Scimitarra per Taranto.
Dopo la partenza del Ministro della Marina da Roma, Supermarina continuò nella sua azione di comando e, pur avendo inviato un messaggio alle ore 06.31 a tutte le autorità di terra e di bordo, nel quale si diceva che truppe tedesche marciavano su Roma, che era previsto di non poter più comunicare, si invitavano i Comandi ad eseguire lealmente, per ordine del Re, le clausole dell'armistizio.
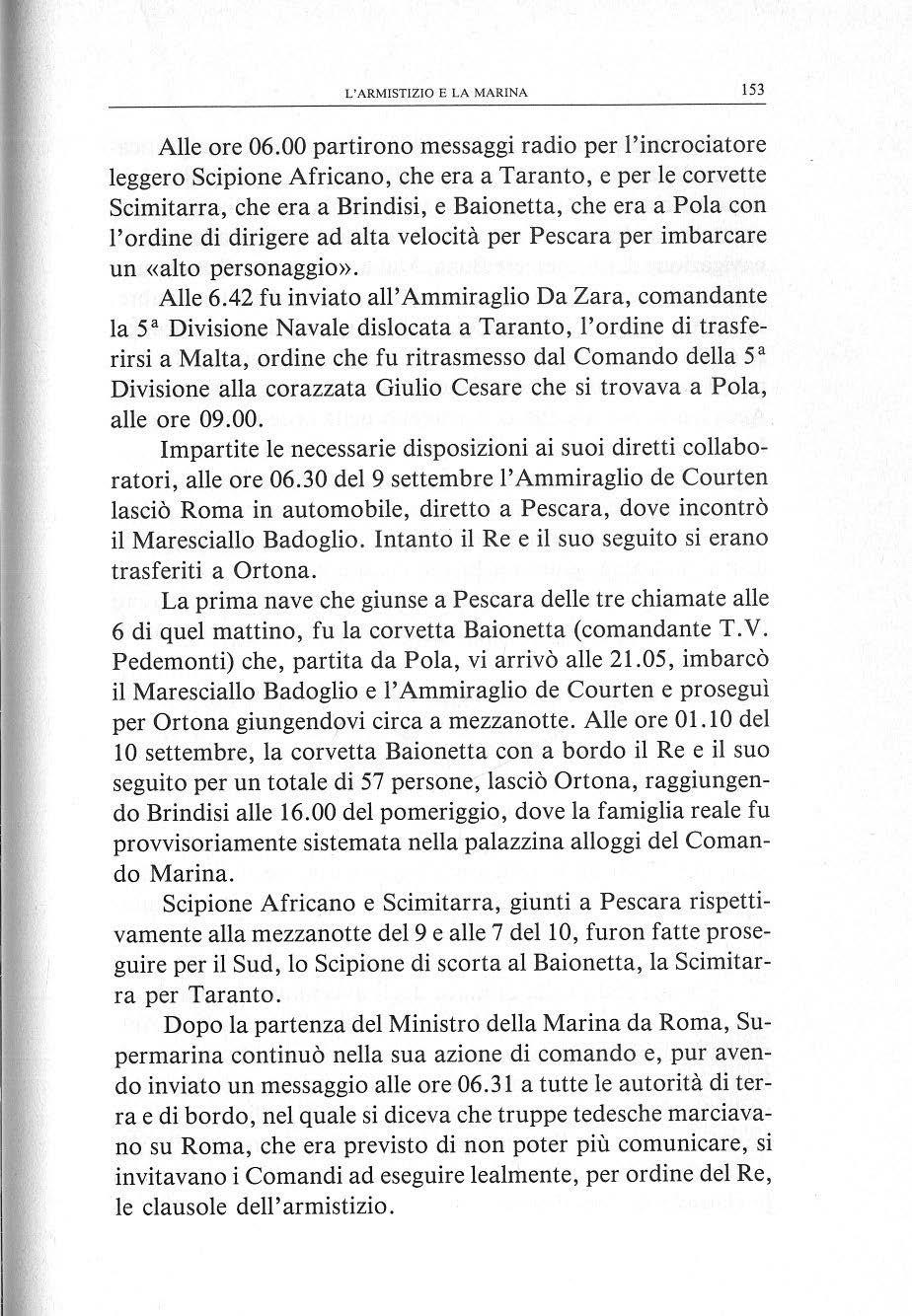
Siccome però le clausole suddette erano ignorate praticamen t e dalla totalità dei destinatari di tale messaggio; alle 12.30 Supermarina trasmise un messaggio circolare in cui erano riassunte le condizioni di armistizio e si dava ordine alle navi in navigazione di raggiungere Bona, Malta o Augusta. Questo messaggio fu ripetuto più volte, fino alle ore 00.38 del 10 settembre.
Uno degli ordini particolari che si ritiene dover ricordare, fu quello impartito alle motonavi Saturnia e Vulcania, che erano a Trieste, di dislocarsi a Venezia per imbarcare gli allievi della Accademia Navale che si trovavano nella sede decentrata del Lido, quelli effettivi, e di Brioni, quelli di complemento.
Per la cronaca, mentre il Saturnia, giunto a Venezia circa a mezzanotte del 9 settembre, riuscì a partire alle 12.30 del 10 con 635 allievi e personale dell'Accademia e a raggiungere Brindisi; il Vulcania, giunto a Brioni circa a mezzogiorno del 10, imbarcò gli allievi di complemento, che p~rò furono sbarcati il giorno 11, così che per la maggior parte finirono internati in Germania.
Un altro ordine speciale trasmesso alle 9.26 del 9 settembre fu il seguente: «Da Supermarina a tutte le unità in navigazione. alt. Non eseguite eventuali ordini di dirottamento se nel testo non figura la parola convenzionale MILANO».
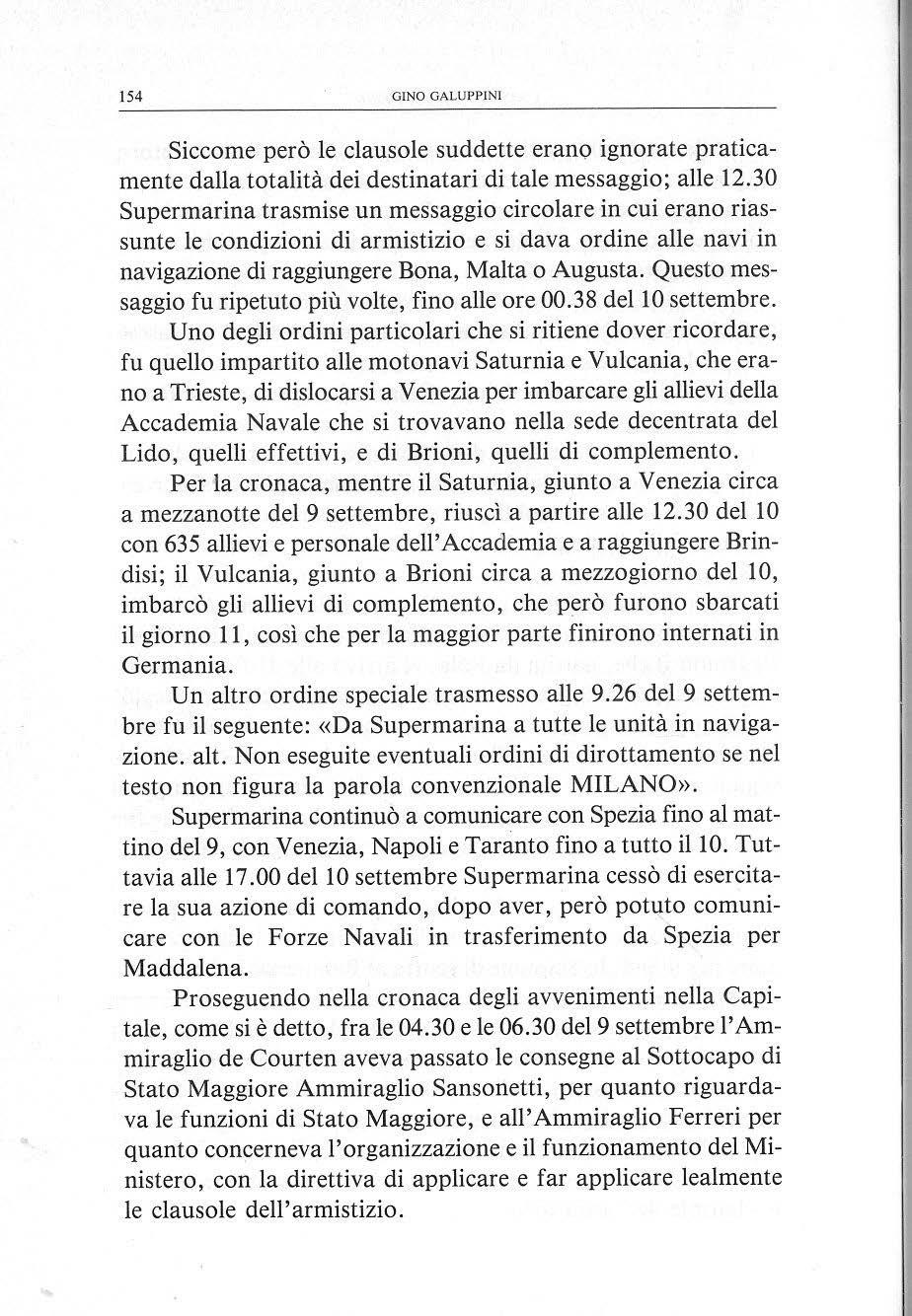
Supermarina continuò a comunicare con Spezia fino al mattino del 9, con Venezia, Napoli e Taranto fino a tutto il 10. Tuttavia alle 17 .00 del 10 settembre Supermarina cessò di esercitare la sua azione di comando, dopo aver, però potuto comunicare con le Forze Navali in trasferimento da Spezia per Maddalena.
Proseguendo nella cronaca degli avvenimenti nella Capitale, come si è detto, fra le 04.30 e le 06 . 30 del 9 settembre l' Ammiraglio de Courten aveva passato le consegne al Sottocapo di Stato Maggiore Ammiraglio Sansonetti, per quanto riguardava le funzioni di Stato Maggiore, e all'Ammiraglio Ferreri per quanto concerneva l'organizzazione e il funzionamento del Ministero, con la direttiva di applicare e far applicare lealmente le clausole dell'armistizio.
Il giorno 9 settembre nessuno mancò di presentarsi in servizio al Ministero, il cui edificio sin dal 1° agosto 1943 era stato sistemato a difesa; anche Supermarina, che dal 1° febbraio si era trasferita nella sede protetta di Santa Rosa, fra il 7 e il 9 settembre si era trasferita negli uffici del Ministero.
Ciò avvenne a tempo, perchè il 10 settembre i tedeschi occuparono le installazioni di Santa Rosa, inclusa la stazione radiotrasmittente che alle 17 .09 effettuò l'ultima trasmissione. Il giorno 9 anche le altre due stazioni trasmittenti della Marina, quella di San Paolo e quella di Monterotondo erano state occupate dai tedeschi.
Provvidenzialmente nell'ambito dei preparativi di difesa del Ministero era stata sistemata in uno dei cortili una stazione radio autocarrata che permise sia di intercettare dispacci, sia ripetere ai Comandi periferici le direttive già trasmesse da Santa Rosa a partire dalle 12.30 del giorno 9.
L'attività di questo centro radio terminò la sera del 13 settembre.
Ancora dalla stazione di Santa Rosa il mattino del 10 settembre il Maresciallo Caviglia fece trasmettere allo Scipione Africano, che si trovava a Brindisi, un messaggio diretto al Re, nel quale chiedeva pieni poteri per trattare col Maresciallo Kesselring.
La risposta del Re, ritrasmessa dallo Scipione, fu ricevuta alle 16.34, ma poichè l'ultimatum di Kesselring scadeva alle 17 .00, i Capi Militari avevano già deciso di accettarne le condizioni. Fu nominato Comandante della Città Aperta il Generale Calvi di Bergolo, e per ciascuna Forza Armata fu nominato un Commissario, che per la Marina fu l'Ammiraglio Ferreri.
Uno dei primi ordini dei tedeschi fu quello dello scioglimento degli Stati Maggiori, così che l'Ammiraglio Sansonetti dispose che gli ufficiali dello Stato Maggiore Marina rimanessero nelle loro abitazioni in attesa di disposizioni, istituendo un servizio di un ufficiale di guardia per ogni ufficio per la custodia dei documenti.
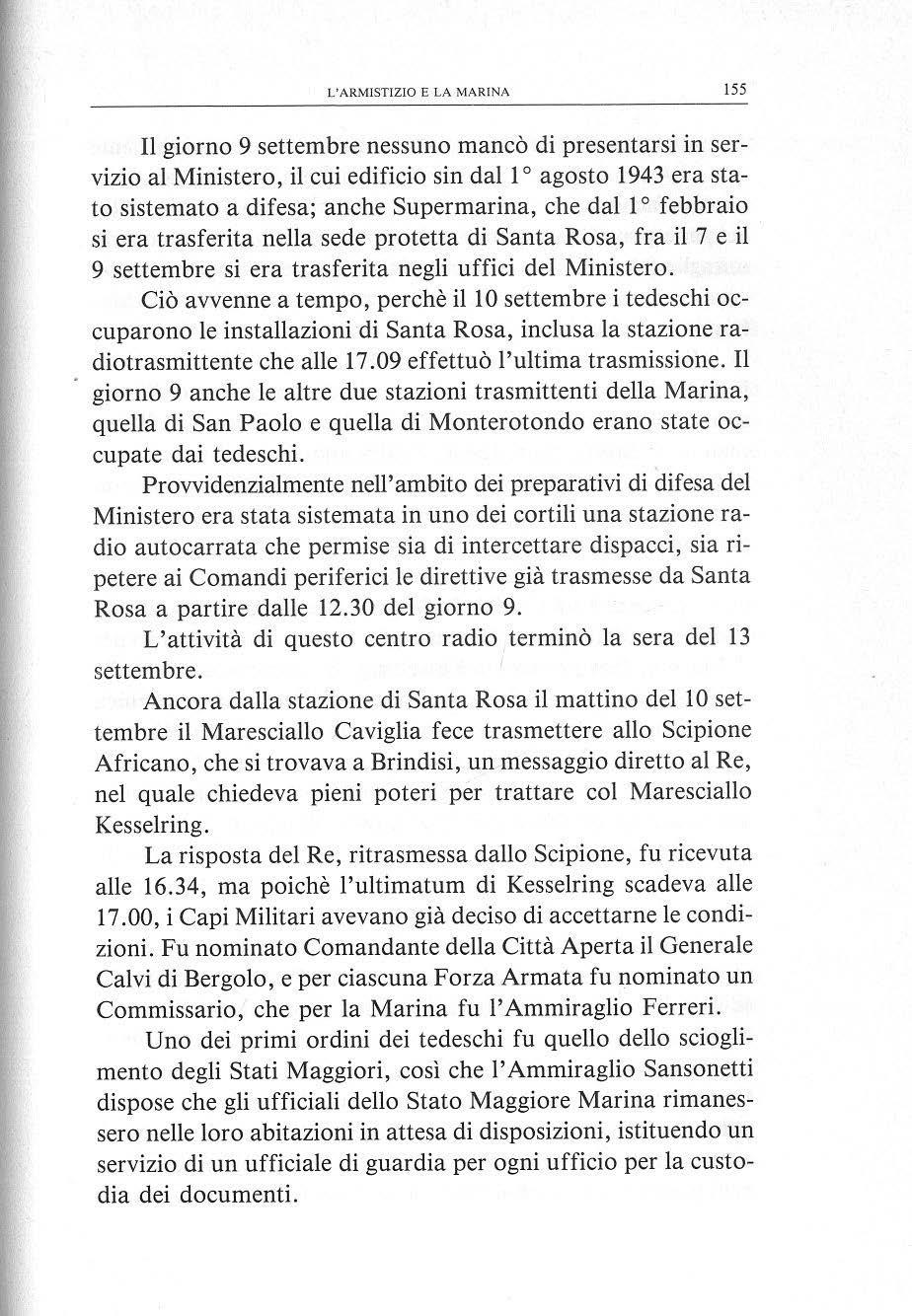
Il giorno 12 settembre, l'Ammiraglio Sansonetti, insieme con i 3 Ammiragli di Armata presenti a Roma: Cavagnari, .Riccardi e Jachino, si recò dal Grande Ammiraglio Thaon de Revel per esporgli la situazione e chiedere consiglio. Il vecchio Ammiraglio (83 anni) rispose che ogni ufficiale doveva agire secondo coscienza: la sua coscienza gli diceva di rimanere fedele al giuramento di fedeltà al Re.
Il mattino del 13 settembre, l'Ammiraglio Sansonetti riunì al Ministero tutti gli ufficiali e ribadì il concetto di libertà di agire secondo coscienza, e ricordò che una forma di collaborazione indiretta coi tedeschi, svolta allo scopo di mantenere in vita l'organismo tecnico e amministrativo della Marina, non era da ritenersi in contrasto con gli impegni di onore presi col giuramento.
Nei giorni seguenti le autorità tedesche eseguirono varie forme di pressione sui Capi della Marina e sui singoli ufficiali per invitarli a collaborare. L'Ammiraglio Ferreri, Commissario per la Marina, fece presente a Kesselring che non era ammissibile che fossero interpellati i singoli fuori dell'autorità gerarchica e che eventuali trattat ive dovevano essere svolte con lui. Le trattative si svolsero, ma non si venne a nessun accordo.
Fu fatta la massima resistenza alla consegna alle autorità tedesche degli elenchi degli ufficiali presenti nella Capitale, i cui ruoli furono poi dis trutti.
Il 23 settembre fu costituito il Governo della Repubblica Sociale.
L'Ammiraglio Sansonetti, in conseguenza di questo evento, ritenne incompatibile la sua presenza a Roma e lasciò la città il 25 settembre, diretto al Sud dove giunse dopo 23 giorni di difficile viaggio.
L'Ammiraglio Ferreri il 30 settembre lasciò la carica di Commissario per la Marina, sos tituito dall'Ammiraglio Falangola, che aveva aderito alla Marina Repubblicana. Prima però aveva avuto la possibilità di congedare tutt i gli ufficiali richiamati presenti nella capitale, con un mese di assegni; inoltre aveva
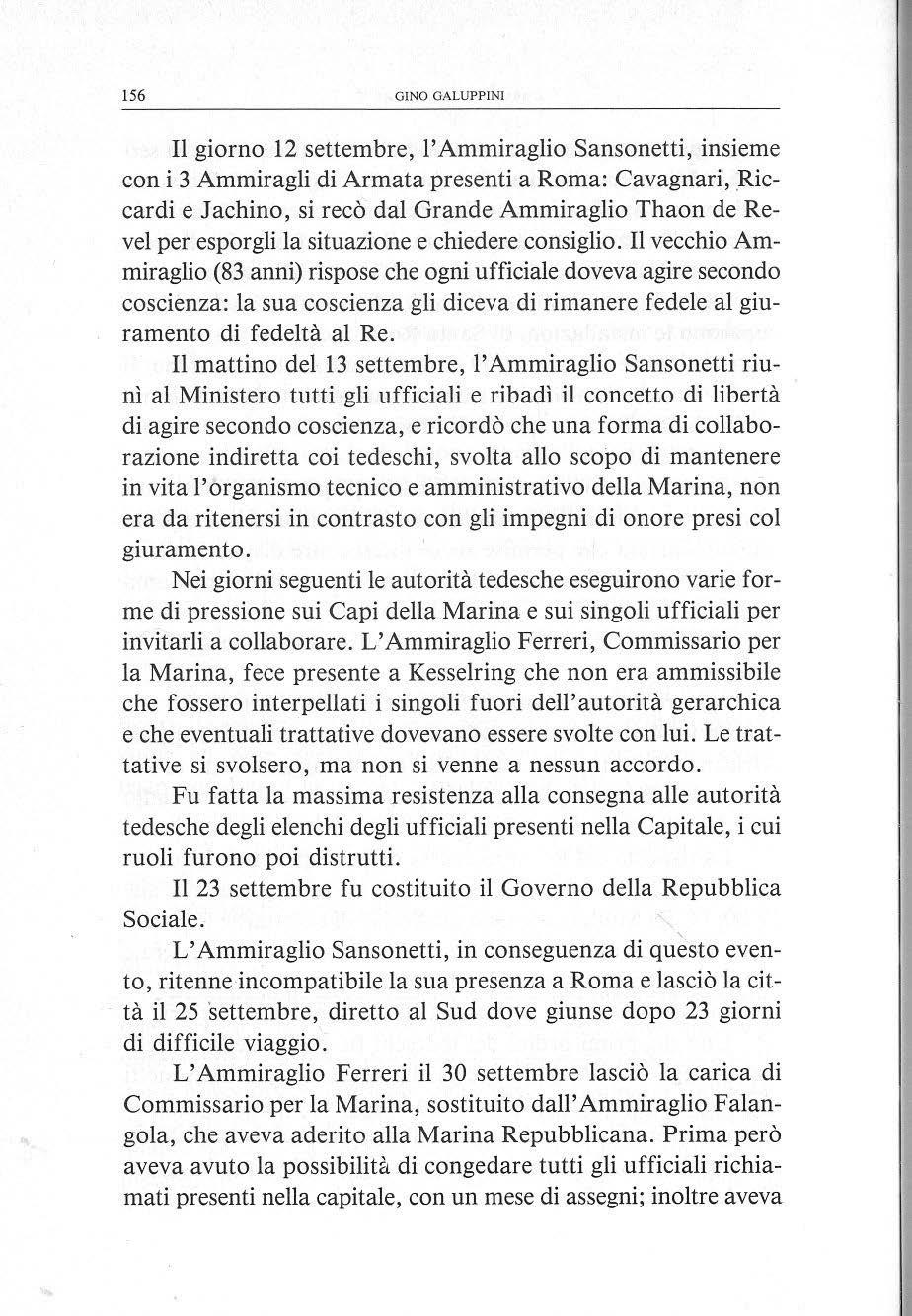
disposto il pagamento di 3 o 2 mensilità anticipate di stipendio agli ufficiali, sottufficiali e militari di Roma.
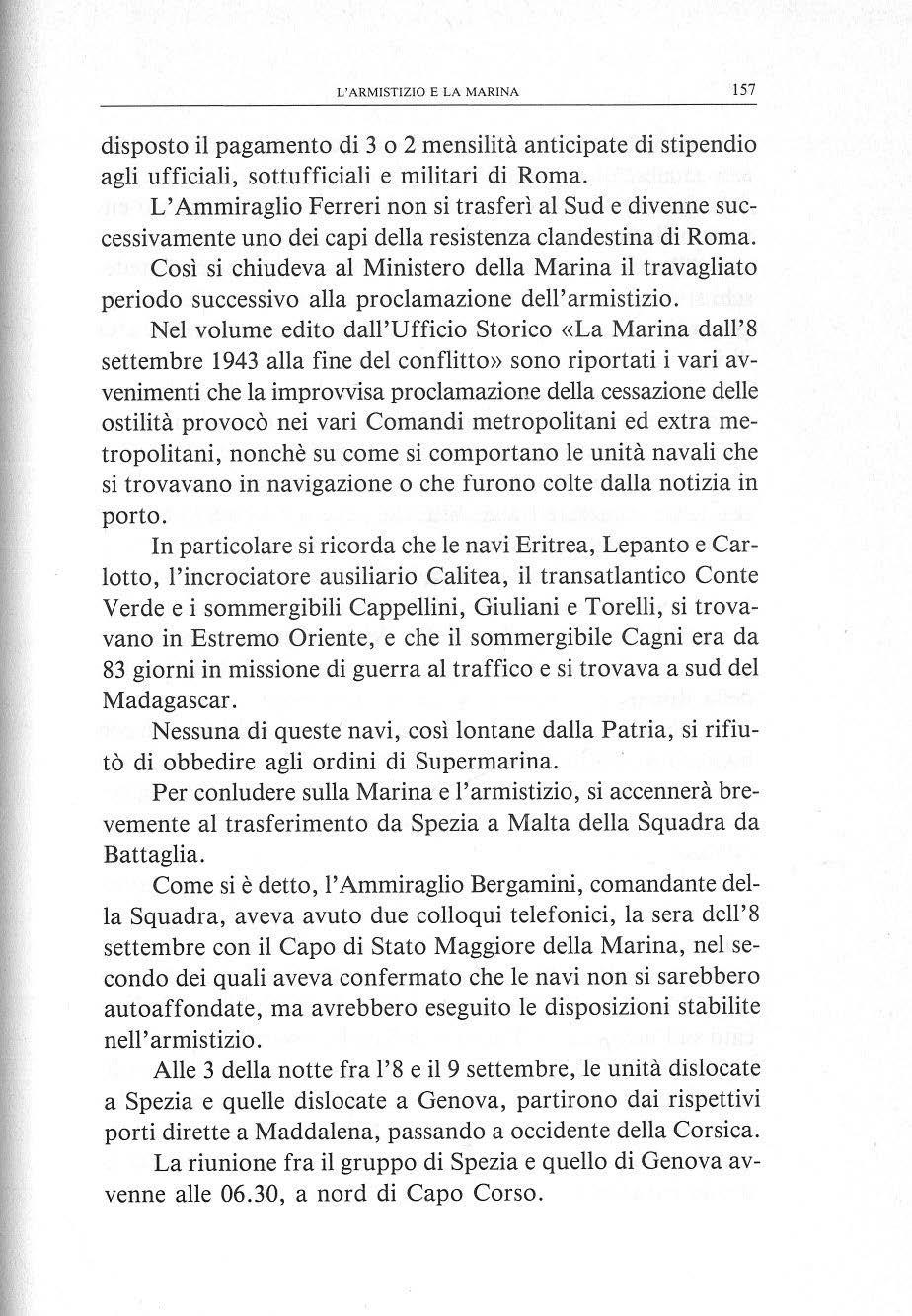
L'Ammiraglio Ferreri non si trasferì al Sud e divenne successivamente uno dei capi della resistenza clandestina di Roma.
Così si chiudeva al Ministero della Marina il travagliato periodo successivo alla proclamazione dell'armistizio.
Nel volume edito dall'Ufficio Storico «La Marina dall'8 settembre 1943 alla fine del conflittm> sono riportati i vari avvenimenti che la improvvisa proclamazione della cessazione delle ostilità provocò nei vari Comandi metropolitani ed extra metropolitani, nonchè su come si comportano le unità navali che si trovavano in navigazione o che furono colte dalla notizia in porto.
In particolare si ricorda che le navi Eritrea, Lepanto e Carlotta , l'incrociatore ausiliario Calitea, il transatlant ico Conte Verde e i sommergibili Cappellini, Giuliani e Torelli, si trovavano in Estremo Oriente, e che il sommerg ibile Cagni era da 83 giorni in missione di guerra al traffico e si trovava a sud del Madagascar.
Nessuna di queste navi, così lontane dalla Patria, si rifiutò di obbedire agli ordini di Supermarina.
Per conludere sulla Marina e l'armistizio, si accennerà brevemente al trasferimento da Spezia a Malta della Squadra da Battaglia.
Come si è detto, l'Ammiraglio Bergamini, comandante della Squadra, aveva avuto due colloqui telefonici, la sera dell'8 sette mbre con il Capo di Stato Maggiore della Marina, nel secondo dei quali aveva confermato che le navi non si sarebbero autoaffondate, ma avrebbero eseguito le disposizioni stabilite nell'armistizio.
Alle 3 della notte fra 1'8 e il 9 settembre, le unità dislocate a Spezia e quelle dislocate a Genova, partirono dai rispettivi porti dirette a Maddalena, passando a occidente della Corsica.
La riunion e fra il gruppo di Spezia e quello di Genova avvenne alle 06.30, a nord di Capo Corso.
Alle 12.10 le unità si misero in linea di fila, con i cacciat orpediniere di scorta sui due lati e le torpediniere a proravia della formazione. Poco dopo fu accostato sulla sinistra per en-· trare nelle Bocche di Bonifacio.
Alle 13 .16 Supermarina, venuta a conoscenza che i tedeschi si erano impadroniti di Maddalena, con un radiomessaggio ordinò alla Forza Navale di non avvicinarsi alla Base e di dirigere per Bona.
Questo messaggio fu ricevuto sulla Roma alle 14.24 erapidamente decifrato, così che l'ordine di invertire la rotta fu dato alle 14.45, mediante accostata ad un t empo , per conseguenza la formazione si venne a trovare ordinata in senso inverso, con le tre corazzate Italia, Vittorio Veneto e Roma in testa, e la Roma in terza posizione.
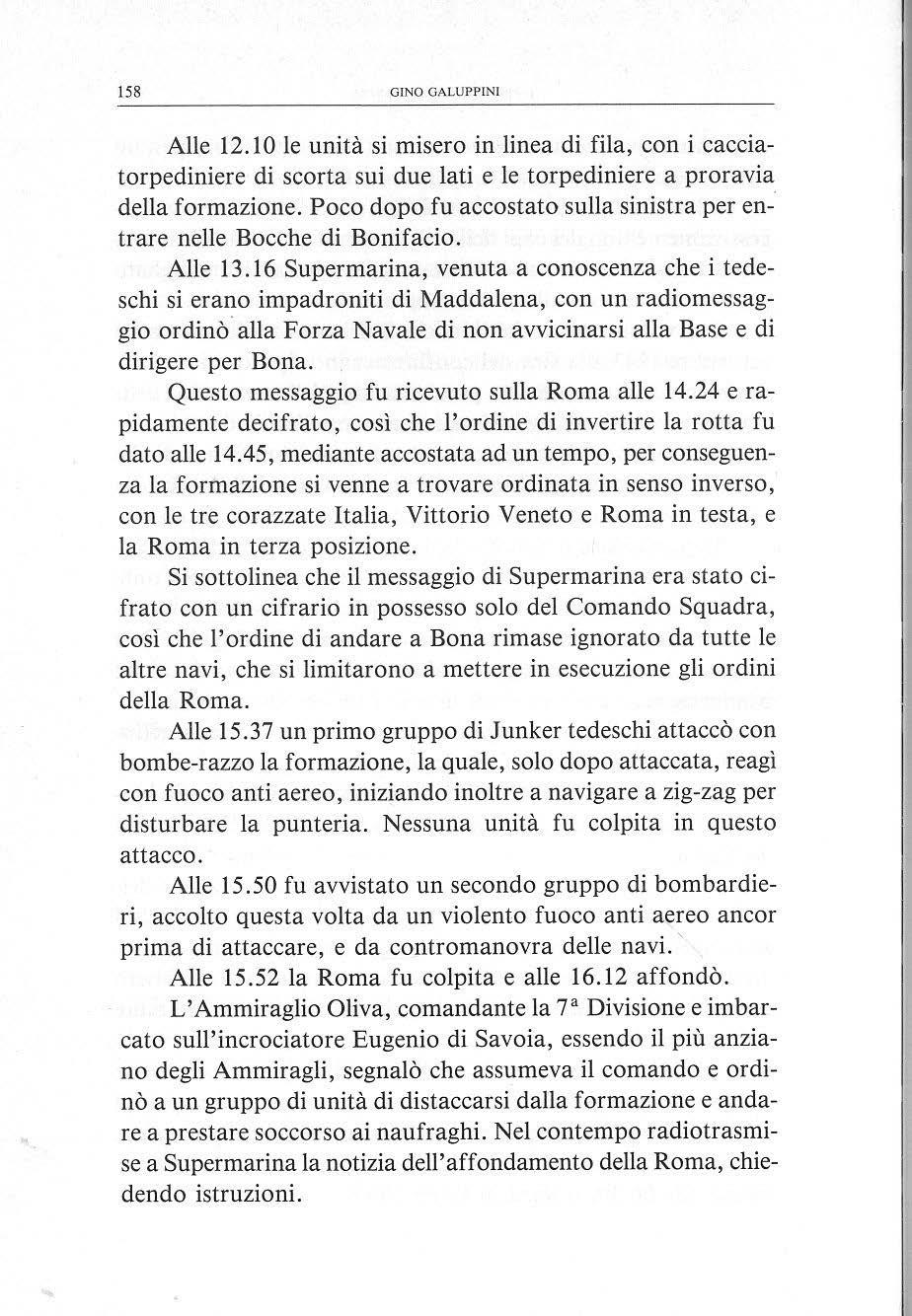
Si sottolinea che il messaggio di Supermarina era stato cifrato con un cifrario in possesso solo del Comando Squadra, così che l'ordine di andare a Bona rimase ignorato da tutte le altre navi, che si limitarono a mettere in esecuz ione gli ordini della Roma.
Alle 15.37 un primo gruppo di Junker tedeschi attaccò con bombe-razzo la formazione, la quale, solo dopo attaccata, reagì con fuoco antiaereo, iniziando inoltre a navigare a zig-zag per disturbare la punteria. Nessuna unità fu colpita in questo attacco.
Alle 15.50 fu avvistato un secondo gruppo di bombardieri, accolto questa volta da un violento fuoco anti aereo ancor prima di attaccare, e da contromanovra delle navi.
Alle 15.52 la Roma fu colpita e alle 16.12 affondò.
L'Ammiraglio Oliva, comandante la 7a Divisione e imbarcato sull'incrociatore Eugenio di Savoia, essendo il più anziano degli Ammiragli, segnalò che assumeva il comando e ordinò a un gruppo di unità di distaccarsi dalla formazione e andare a prestare soccorso ai naufraghi. Nel contempo radiotrasmise a Supermarina la notizia dell'affondamento della Roma, chiedendo istruzioni.
Alle 18.40 giunse la risposta di Supermarina con la conferma dell'ordine di andare a Bona, che, come già detto, non era conosciuto dall'Ammiraglio Oliva e dalle altre unità della Squadra.
Dopo i due primi attacchi aerei e l'affondamento della Roma vi furono altri quattro attacchi aerei di bombardieri tedeschi e una bomba colpì la corazzata Italia, riducendone la velocità.
Alle 21.07 la Squadra prese la rotta per Bona.
Durante la navigazione l'Ammiraglio Oliva ritrasmise a tutte le unità il testo del proclama trasmesso il mattino alle 1.50 dalla stazione di Santa Rosa, proclama in cui l'Ammiraglio de Courten invitava tutte le navi ad eseguire lealmente le clausole dell'armistizio , le quali non comportavano nè la cessione delle navi, nè l'abbassamento della bandiera.
Alle 7 del mattino del 10 settembre le navi alzarono il segnale del «Pennello nero».
Alle 8.38 fu avvistata una formazione navale inglese, e alle 09.10 prese imbarco sull'Eugenio di Savoia un gruppo di ufficiali e marinai inglesi, composto dal Capitano di Vascello Brownrigg, Capo di Stato Maggiore dell'Ammiraglio Cunningham, con un ufficiale e tre segnalatori, che prese la guida della formazione italiana, la quale si mise in coda alla formazione inglese di cui facevano parte le navi da battaglia Warspite e Valiant, dirigendo per Malta, dove giunse il mattino del giorno 11 settembre.
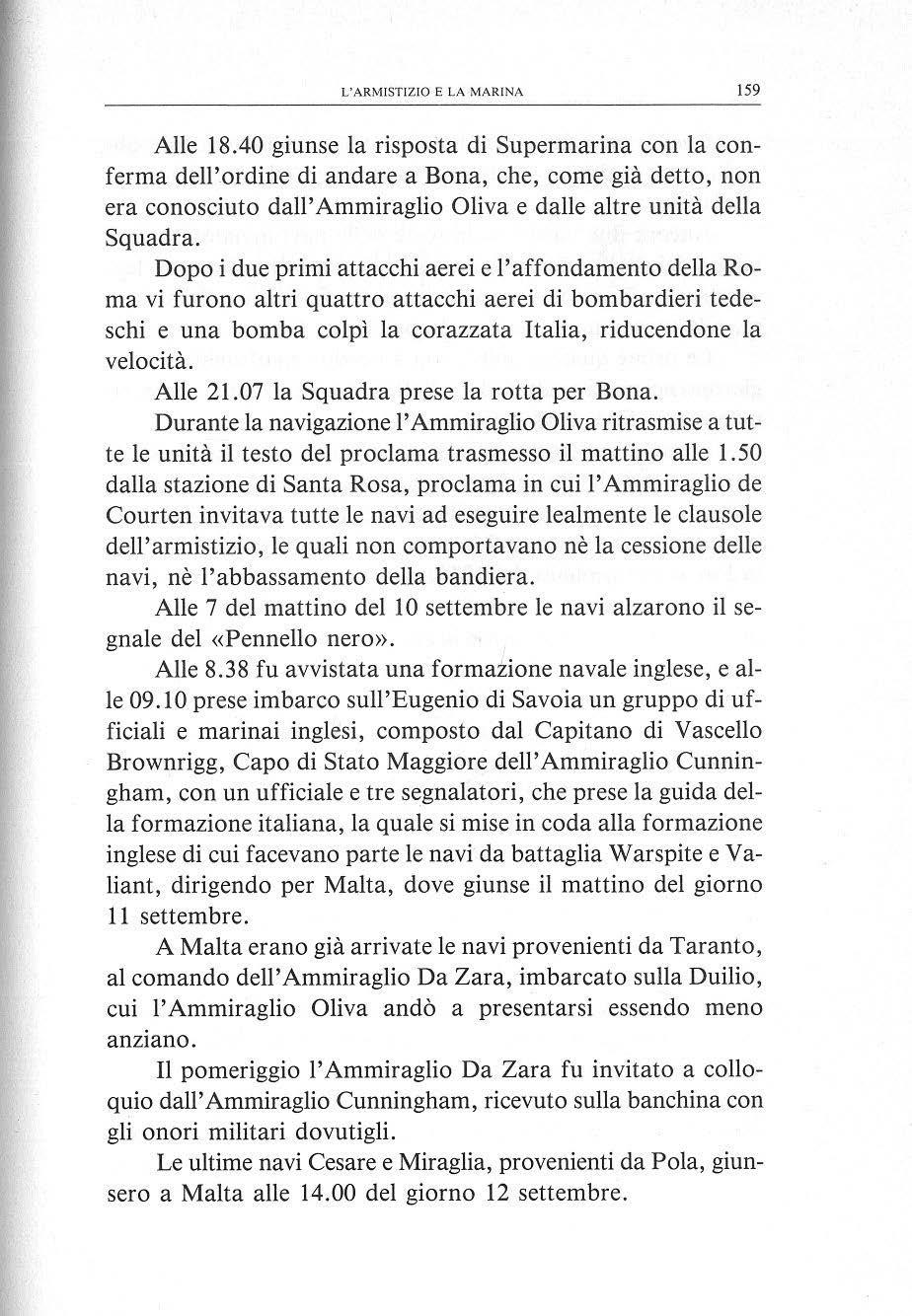
A Malta erano già arrivate le navi provenienti da Taranto, al comando dell'Ammiraglio Da Zara, imbarcato sulla Duilio, cui l'Ammiraglio Oliva andò a presentarsi essendo meno anziano.
Il pomeriggio l'Ammiraglio Da Zara fu invitato a colloquio dall'Ammiraglio Cunningham, ricevuto sulla banchina con gli onori mi li tari dovutig li .
Le ultime navi Cesare e Miraglia, provenienti da Pola, giunsero a Malta alle 14.00 del giorno 12 settembre.
Così le navi della Marina avevano disciplinatamente obbedito agli ordini ricevuti, in osservanza delle condizioni di armistizio.
Ancora due parole sulla sort~e delle navi inviate al salvatagg io dei naufraghi della Roma, che erano l'incrociatore leggero Attilio Regolo, i caccia Mitragliere, Fuciliere e Carabiniere, e le torpediniere Pegaso, Impetuoso e Orsa.
Le prime quattro unità, con a bordo i naufraghi, si rifugiarono nei porti neutrali delle Baleari dove furon internate, rimanendovi fino al 15 gennaio 1945.
Pegaso, Impetuoso e Orsa, senza naufraghi, si rifugiarono anche essi alle Baleari per mancanza di nafta: Pegaso e Impetuoso si autoaffondarono il mattino del 11 settembre, l'Orsa invece fu internata e seguì la sorte delle altre unità rientrando in Patria nel gennaio del 1945.

Per co mpr endere co me e in quali condizion i si giunse all' ar mistizio fra l'Italia e gli alleati, è indispens abil e tracciare un sia pure sintetico quadro delle scelte strategiche italiane che porta rono alla sconfitta.
Come è no to il Von Claus ewitz affer mò che « la guerra è la co n tinuazione della politica con altri mezzi». Mussolini andò ancora più in là affermando l'assoluta identità fra guerra e politi ca e negando in pratica qualsiasi autonomia a lla strategia.
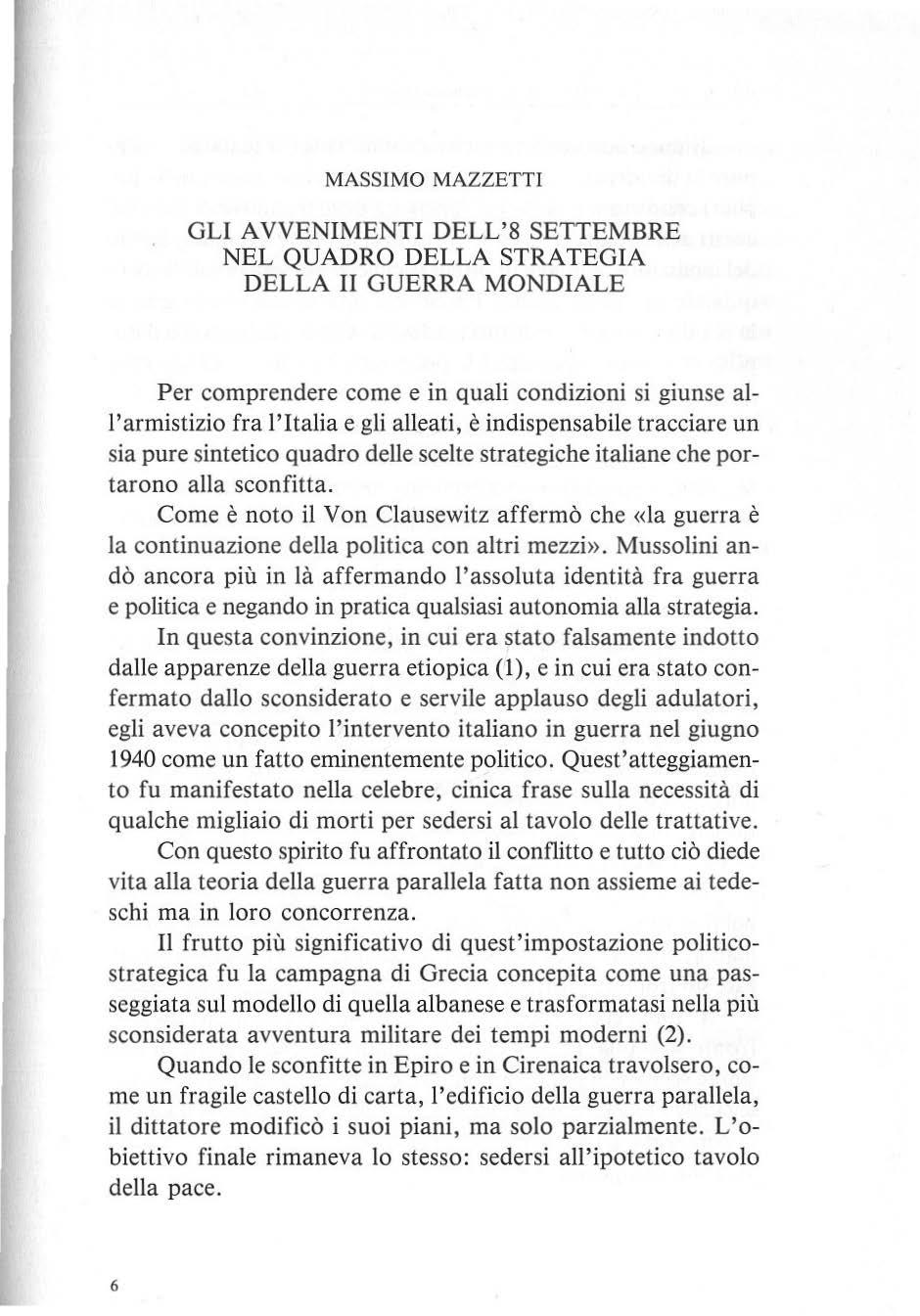
In questa conv inzione, in cui era stato falsamente indotto dalle apparenze della gue rra e t iopica (1), e in cui era stato confermato dallo sconsiderato e servile applauso degli adulatori, egli aveva c on cepito l'intervento italiano in guerra nel giugno 1940 come un fatto eminentemente politico . Quest 'atteggiamento fu manifestato nella ce leb re , ci ni ca frase sull a necessità di qualche migl iaio di morti per se dersi al tavolo delle trattative.
Con questo spirito fu affron tato il conflitto e tutto ciò diede vita alla teo ria della guerra parallela fatta non assieme ai tedesch i ma in loro concorrenza.
Il frutto più sign ifi cat ivo di quest'impostazione politicostrategica fu la cam pagn a di Grecia concepita come una passeggiata s ul modello di qu ella albanese e trasforma tas i n ella più sco nsiderata avventura militare dei tem pi moderni (2).
Qu and o le sco nfitt e in Epiro e in Cirenaica travolsero, come un fra gile castello di car ta, l' ed ificio della guerra parallela, il dittatore modi fic ò i suoi piani, ma solo parzialmente. L'obiettivo finale rimaneva lo stesso: sedersi all'ipotetico tavolo della pa ce.
Il duce non credeva ad una totale vittoria tedesca, e neppure la desiderava; voleva giungere nel miglior modo, nelle migliori condizioni possibili all'apertura delle trattative di pace nel corso delle quali, svolgendo il ruolo a sè più congeniale, quello del mediatore, contava di ottenere ciò che non era possibile conquistare armi alla mano. Perciò era opportuno che la guerra la conducessero soprattutto i tedeschi. Ciò avrebbe avuto il duplice effetto di risparmiare le potenzialità italiane e di logorare quelle germaniche.
Solo in questa prospettiva, che vedeva nella guerra un fatto eminentemente politico, si spiegano decisioni che, sul piano militare, apparirebbero altrimenti incomprensibili, come, ad esempio, l'invio di un corpo di spedizione e, successivamente, di una intera armata italiana sul fronte russo. Ed è in questo quadro che va inserita la valorizzazione di Rommel da parte del duce.
Infatt i la presenza di questo generale tedesco, così bene accetto a Hitler, era la migliore garanzia che l'appoggio germanico alle operazioni mediterranee non sarebbe venuto meno. Questa linea politico-strategica che probabilmente appariva astutissima al suo ideatore e che nei fatti si rivelerà fallimentare, portò, da un lato alla nomina di Rommel a comandante di quasi tutte le forze italiane presenti in Cirenaica, dall'altro, all'avvio di un'incredibile «guerra al risparmio».
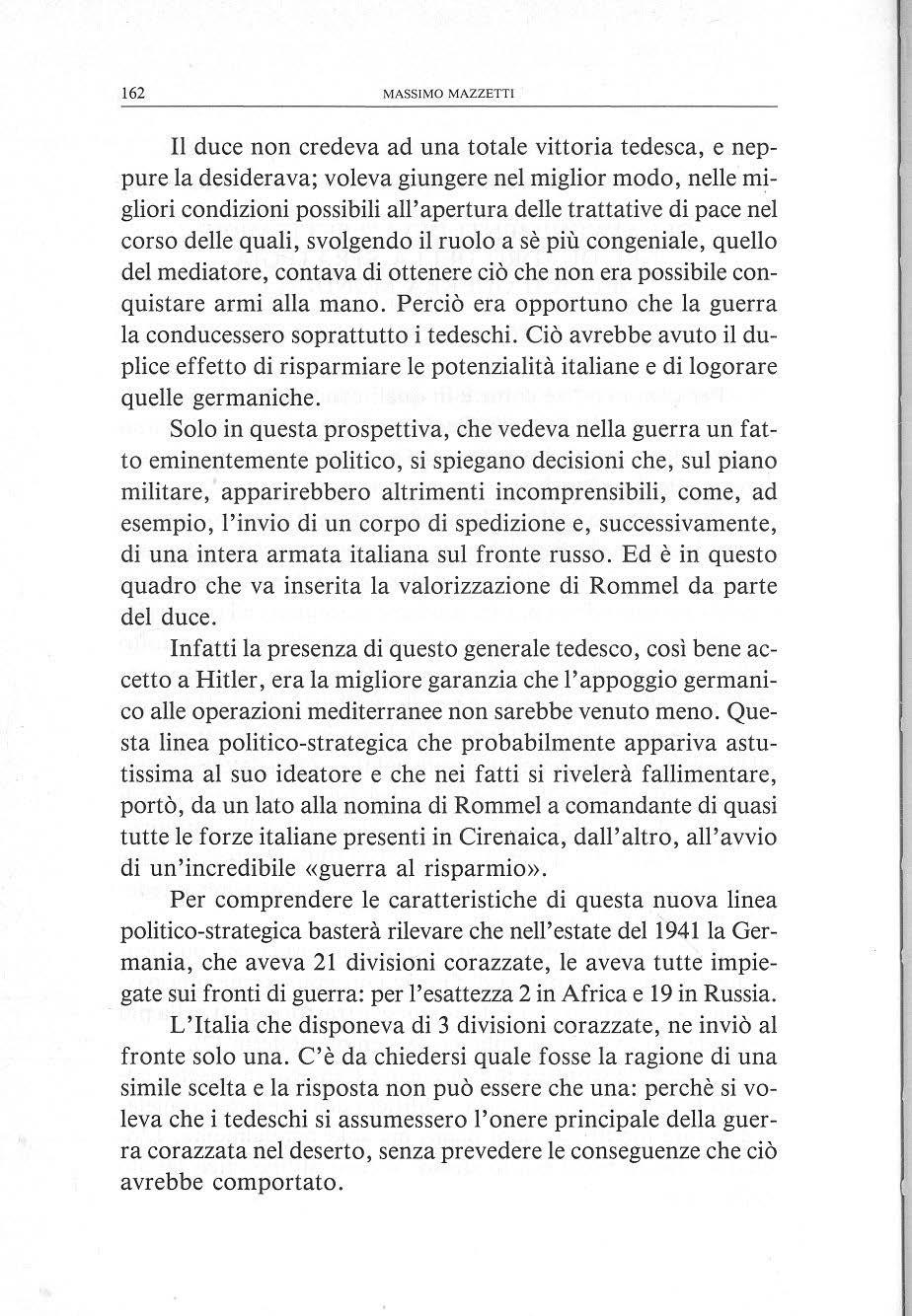
Per comprendere le caratteristiche di questa nuova linea politico-strategica basterà rilevare che nell'estate del 1941 la Germania, che aveva 21 divisioni corazzate, le aveva tutte impiegate sui fronti di guerra: per l'esattezza 2 in Africa e 19 in Russia.
L'Italia che disponeva di 3 divisioni corazzate, ne inviò al fronte solo una. C'è da chiedersi quale fosse la ragione di una simile scelta e la risposta non può essere che una: perchè si voleva che i tedeschi si assumessero l'onere principale della guerra corazzata nel deserto, senza prevedere le conseguenze che ciò avrebbe comportato.
Infatti questa decisione, a breve termine, ci rese dipendenti dall'iniziativa di Rommel e quindi germanica anche in un teatro di guerra come quello libico che doveva essere di esclusiva competenza italiana. A lungo termine poi, ha permesso l'affermarsi e il consolidarsi di una sorta di congiura storiografica attuata in solido, dai nostri ex nemici e dai nostri ex alleati, secondo cui se i tedeschi erano battuti si trasformavano istantaneamente in italiani mentre se erano gli italiani a vincere diventavano immediatamen t e tedeschi.
Questo indirizzo di subordinazione totale della strategia alla politica spiega i continui inte r venti dello Stato Maggiore Generale che, nei con t rasti fra il comando italiano e il comando germanico in Africa, dà, con una sola eccezione, sempre ragione ai tedeschi, prescindendo da un'oggettiva analisi della situazione.
La svolta della guerra in Africa Settentrionale è costitui t a, come è noto , dalla battaglia di E l Alamein. Tuttavia, ancora più importante del r isultato dell ' epico scontro, per la sorte del conflitto, fu il quasi contemporaneo sbarco anglo-americano nell'Africa Settentrionale francese.
Quest'operazione era stata preparata di lunga mano da alcuni patrioti francesi noti con il nome di «Gruppo dei cinque» che riuscì ad ottenere importanti adesioni fra le autorità civili e militari e a costituire un'imponente organizzazione clandestina.
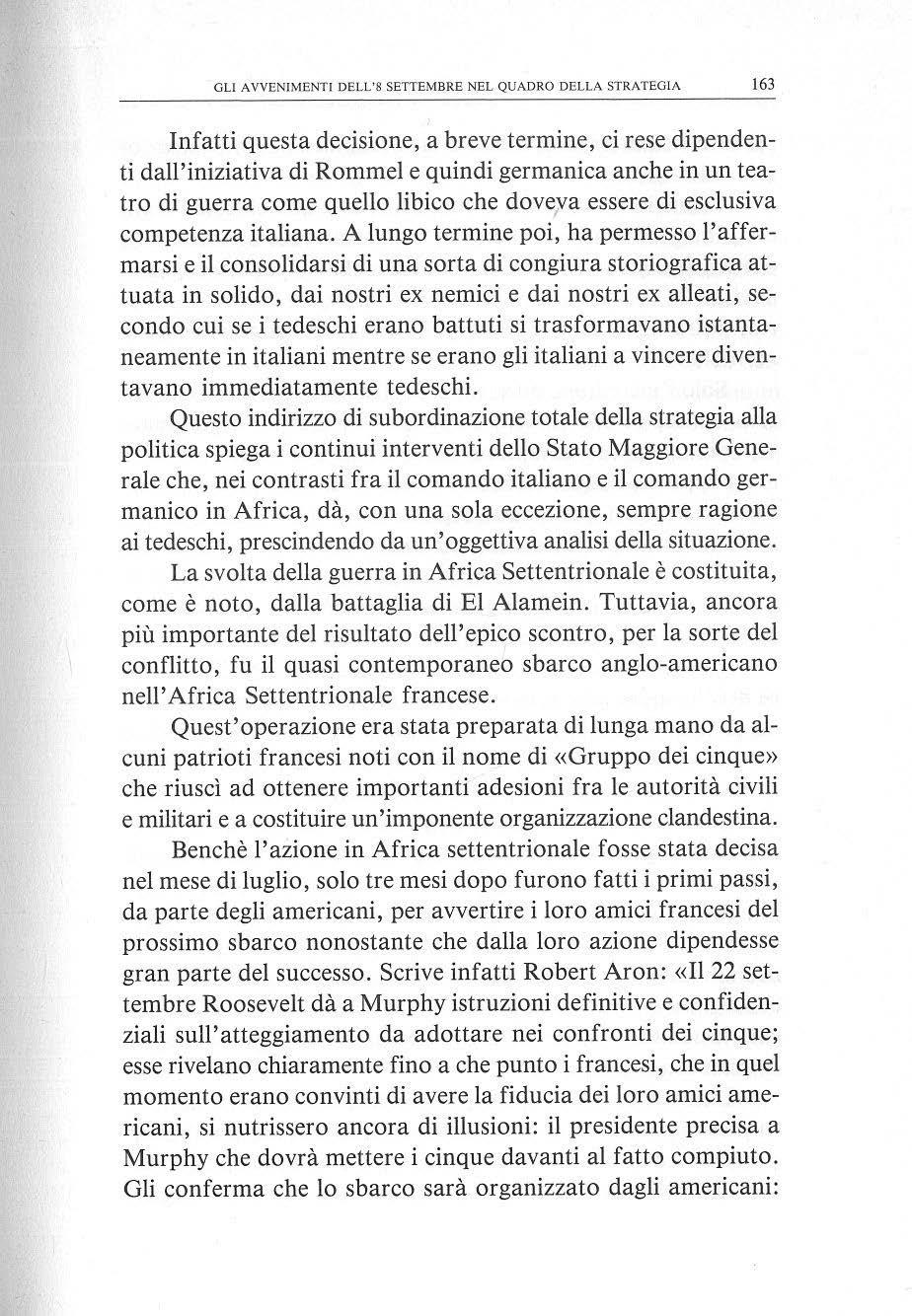
Benchè l'azione in Africa settentrionale fosse stata decisa nel mese di luglio, solo tre mesi dopo furono fatti i primi passi, da parte degli americani, per avvertire i loro amici francesi del prossimo sbarco nonostante che dalla loro azione dipendesse gran parte del successo. Scrive infatti Robert Aron: «Il 22 settembre Roosevelt dà a Murphy istruzioni definitive e confidenziali sull'atteggiamento da adottare nei confronti dei cinque; esse rivelano chiaramente fino a che punto i francesi, che in quel momen t o erano convinti di avere la fiducia dei loro amici americani, si nutrissero ancora di illusioni: il presidente precisa a Murphy che dovrà mettere i cinque davant i al fatto compiuto .
Gli conferma che lo sbarco sarà organizzato dagli americani:
i francesi manterranno soltanto la sovranità e l'amministrazione civile» (3). .
Venne inoltre precisato che, come avevano chiesto i francesi, la spedizione sarebbe stata esclusivamente americana (il che era falso) e infine veniva prescritto che «i francesi saranno avvisati 24 ore prima soltanto e, se Murphy lo ritiene necessario, potrà informarli dei luoghi dove approssimativamente si verificherà lo sbarco» (4).
Solo l'incredibile dilettantismo strategico di Roosevelt poteva concepire che fossero sufficienti 24 ore per organizzare un'operazione così complessa quale quella che veniva richiesta al «gruppo dei cinque». Robert Murphy, il console generale americano ad Algeri, per quanto digiuno anch'egli di cose militari, trovandosi sul posto, si rendeva ben conto della impossibilità di realizzare un simile piano in così poco tempo; ma solo il 1° novembre riuscì a strappare l'autorizzazione di Eisenhower ad avvertire gli amici francesi (5).
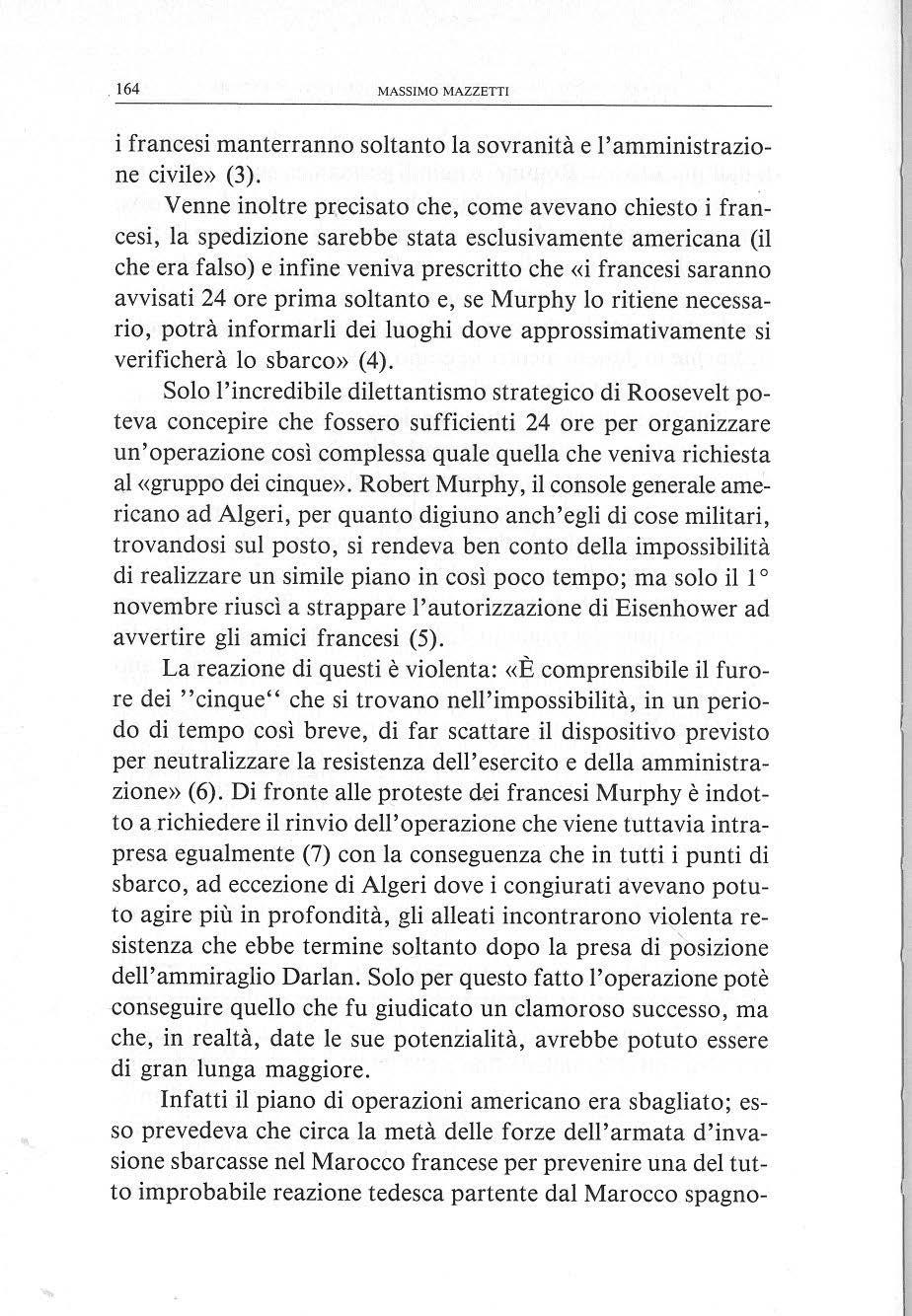
La reazione di questi è violenta: «È comprensibile il furore dei "cinque" che si trovano nell'impossibilità, in un periodo di tempo così breve, di far scattare il dispositivo previsto per neutralizzare la resistenza dell'esercito e della amministrazione» (6). Di fronte alle proteste dei francesi Murphy è indotto a richiedere il rinvio dell'operazione che viene tuttavia intrapresa egualmente (7) con la conseguenza che in tutti i punti di sbarco, ad eccezione di Algeri dove i congiurati avevano potuto agire più in profondità, gli alleati incontrarono violenta resistenza che ebbe termine soltanto dopo la presa di posizione dell'ammiraglio Darlan. Solo per questo fatto l'operazione potè conseguire quello che fu giudicato un clamoroso successo, ma che, in realtà, date le sue potenzialità, avrebbe potuto essere di gran lunga maggiore.
Infatti il piano di operazioni americano era sbagliato; esso prevedeva che circa la metà delle forze dell'armata d'invasione sbarcasse nel Marocco francese per prevenire una del tutto improbabile reazione tedesca partente dal Marocco spagno-
lo, mentre nessuno sbarco era previsto ad est di Algeri. Ciò ebbe per conseguenza da un lato il fatto che gli alleati subirono gravi ed inutili perdite nell'azione compiuta in Marocco, dall'altro che gli italo-tedeschi poterono occupare tranquillamente la Tunisia pur disponendo di forze estremamente esigue. Quest'ultimo fatto fece sì che la guerra in Africa durasse fino al maggio del 1943.
Mentre ancora si combatteva accanitamente in Africa Settentrionale i massimi dirigenti anglo-americani si riunirono in conferenza a Casablanca dove Roosevelt, con il consenso di Churchill, lanciò la formula della «resa incondizionata» a cui avrebbero dovuto sottostare le potenze dell'Asse.
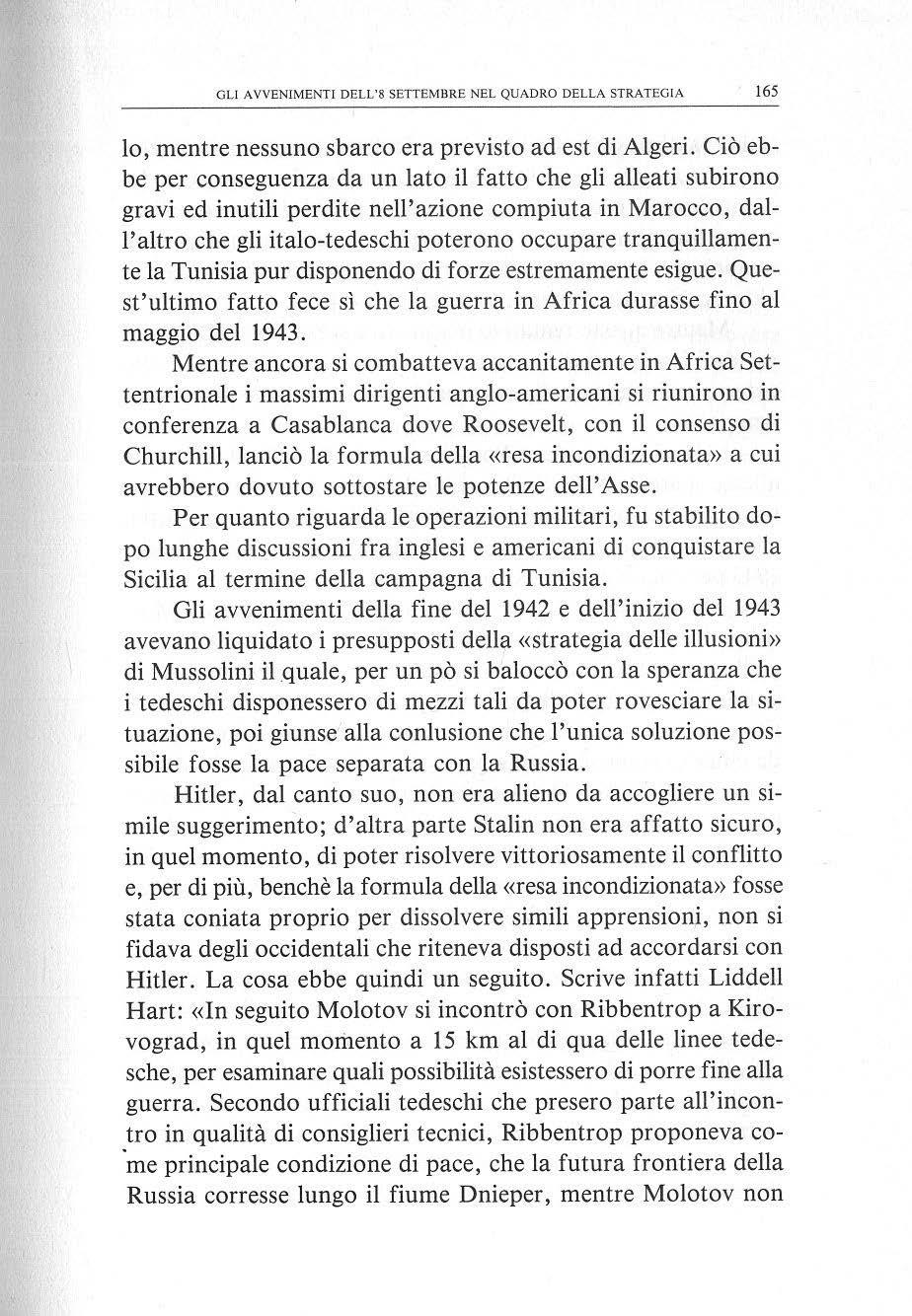
Per quanto riguarda le operazioni militari, fu stabilito dopo lunghe discussioni fra inglesi e americani di conquistare la Sicilia al termine della campagna di Tunisia.
Gli avvenimenti della fine del 1942 e dell'inizio del 1943 avevano liquidato i presupposti della «strategia delle illusioni» di Mussolini il quale, per un pò si baloccò con la speranza che i tedeschi disponessero di mezzi tali da poter rovesciare la situazione, poi giunse alla conlusione che l ' unica soluzione possi bile fosse la pace separata con la Russia.
Hitler, dal canto suo, non era alieno da accogliere un simile suggerimento; d'altra parte Stalin non era affatto sicuro, in quel momento, di poter risolvere vittoriosamente il conflitto e, per di più, benchè la formula della «resa incondizionata» fosse stata coniata proprio per dissolvere simili apprensioni, non si fidava degli occidentali che riteneva disposti ad accordarsi con Hitler. La cosa ebbe quindi un seguito. Scrive infatti Liddell Hart: «In seguito Molotov si incontrò con Ribbentrop a Kirovograd, in quel momento a 15 km al di qua delle linee tedesc he, per esaminare quali possibilità esistessero di porre fine alla guerra. Secondo ufficiali tedeschi che presero parte all'incon_tro in qualità di consiglieri tecnici, Ribbentrop proponeva come principale condizione di pace, che la futura frontiera della Russia corresse lungo il fiume Dnieper, mentre Molotov non
si diceva disposto a prendere in considerazione alcuna soluzione che non prevedesse il ripristino delle frontiere originali. La discussione si protrasse a lungo per la difficoltà di conciliare queste due posizioni così lontane e fu infine interrotta quando sembrò che la notizia dell'incontro fosse trapelata giungendo all'orecchio delle potenze occidentali» (8).
Mentre questo tentativo maturava e si esauriva, non restava, dati i rapporti di forza nel Mediterraneo, alle forze italotedesche, che tentare di contenere la crescente pressione angloamericana.
L' 11 giugno cadeva Pantelleria e il 10 luglio due armate alleate sbarcavano in Sicilia. L'andamento della lotta divenne ben presto disperato per la disparità delle forze contrapposte. Ciò affrettò la crisi del regime fascista che cadde il 25 luglio 1943 per l'azione della Corona. Questa si servì, e sul momento sembrò una manovra riuscitissima, del voto sfavorevole a Mussolini del Gran Consiglio del Fascismo che suonava condanna dell'operato del dittatore. Ciò venne fatto nel tentativo di scongiurare il pericolo della guerra civile. Nelle prime ore infatti la situazione si presentava ricca di non poche incognite: restava da chiarire come avrebbe reagito il partito fascista che disponeva di ben 7 .000.000 di iscritti, oltre che di un proprio esercito di cui bisognava pur tenere conto anche se si trattava di un modesto numero di reparti, per altro non sempre molto efficienti. Come avrebbero poi reagito i tedeschi in caso di scontro fra l'esercito e la milizia?
La situazione intorno a Roma presentava inol tre carattere di particolare delicatezza: a nord della città stazionavano infatti la 3 a divisione moto - corazzata germanica e la divisione corazzata «M» della milizia. Quest'ultima unità aveva, per la verità, l'organico di una divisione moto-corazzata tedesca, disponendo di un solo battaglione carri; era tuttavia composta da elementi scelti e aveva un folto gruppo di istruttori tedeschi che potevano assicurare l'impiego di carri e d'artiglieria. Se una sola delle due unità fosse avanzata verso la capitale sarebbe stata
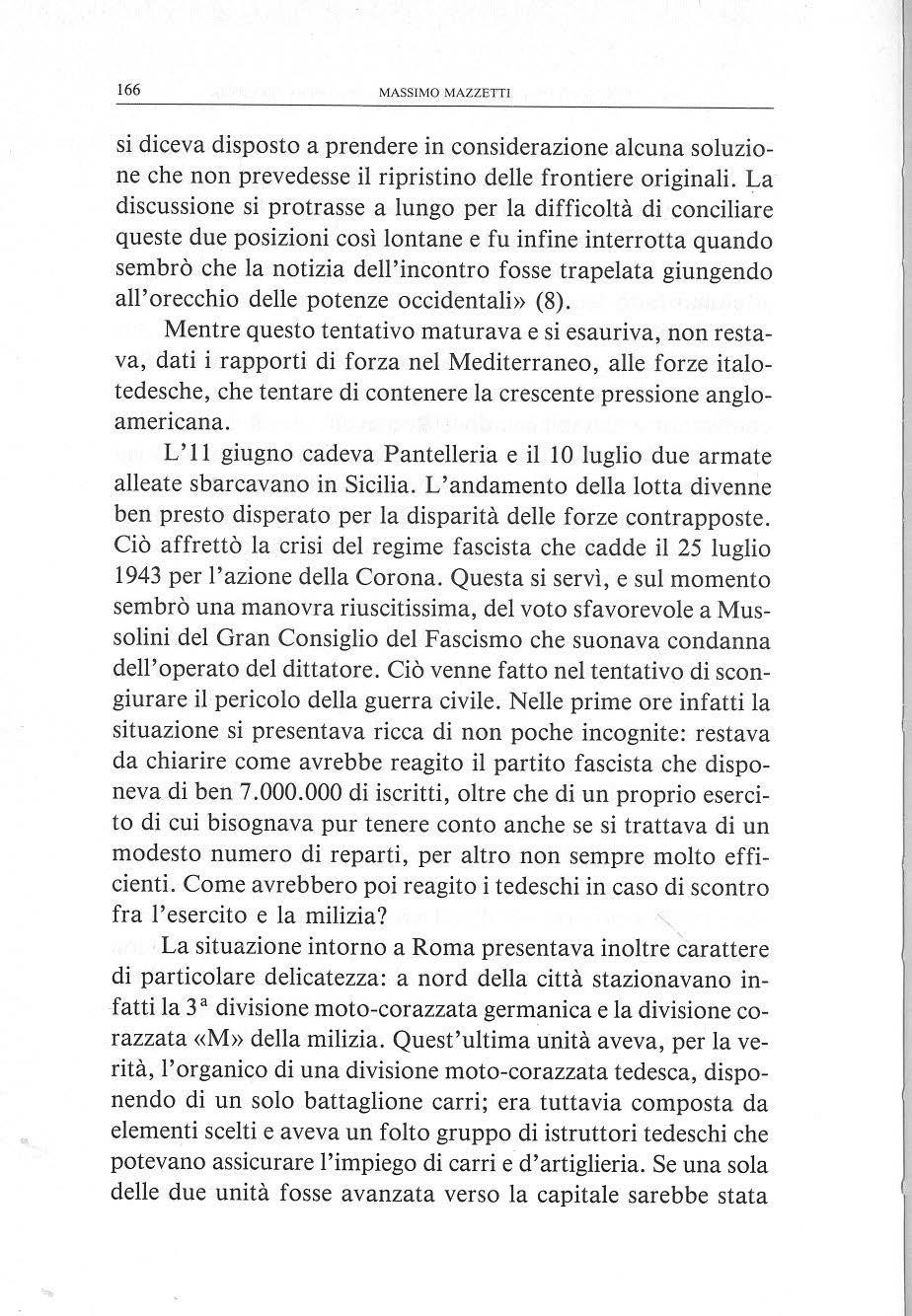
fermata sull'anello difensivo esterno dalle truppe che presidiavano Roma e attaccata alle spalle dalla divisione corazzata «Ariete» che stava scendendo da nord. Più complessa si sarebbe presentata la situazione se entrambe le divisione avessero marciato sulla capitale.
Questa possibilità non sfuggì ad alcuni dei militari assegnati all'ambasciata germanica che cercarono di far muovere verso Roma la divisione «M»; la manovra non riuscì sia perchè non fu presa molto sul serio dall'ambasciatore, sia per l'atteggiamento lealista del generale Galbiati, Capo di Stato Maggiore della milizia. Il partito fascista si dissols e rapidamente mentre in quasi tutte le città d'Italia si svolgevano manifestazioni a favore del nuovo Governo. Con ciò veniva evitato il pericolo che la caduta di Mussolini provocasse una guerra civile.
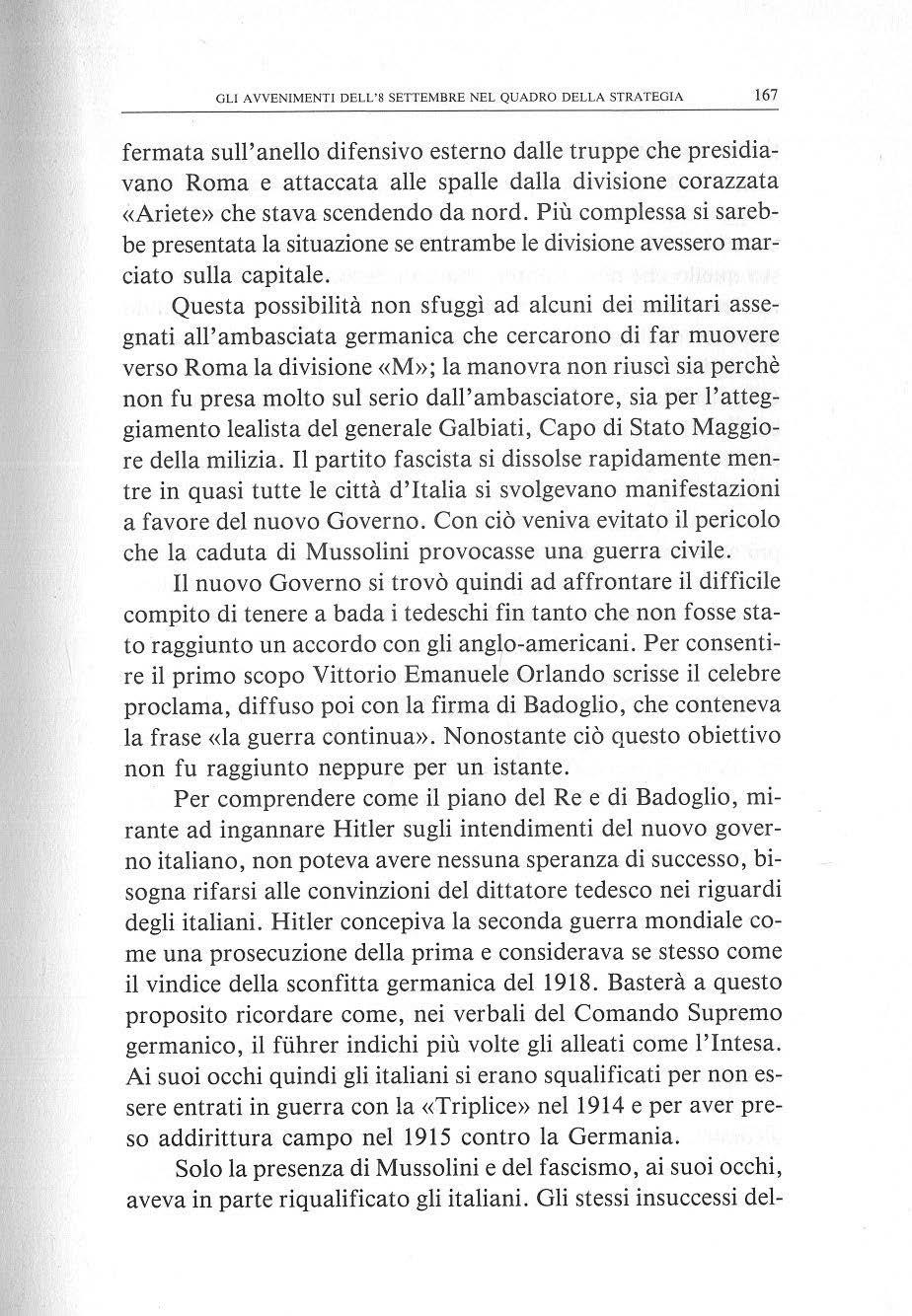
Il nuovo Governo si t rovò quindi ad affrontare il difficile compito di tenere a bada i tedeschi fin tanto che non fosse stato raggiunto un accordo con gli anglo-americani. Per consentire il primo scopo Vittorio Emanuele Orlando scrisse il celebre proclama, diffuso poi con la firma di Badoglio, che conteneva la frase «la guerra continua». Nonostante ciò questo obiettivo non fu raggiunto neppure per un istante.
Per comprendere come il piano del Re e di Badoglio, mirante ad ingannare Hitler sugli intendimenti del nuovo governo italiano, non poteva avere nessuna speranza di successo, bisogna rifarsi alle convinzioni del dittatore tedesco nei riguardi deg li italiani. Hitler concepiva la seconda guerra mondiale come una prosecuzione della prima e considerava se stesso come il vindice della sconfitta germanica del 1918. Basterà a questo proposito ricordare come, nei verbali del Comando Supremo germanico, il fiihrer indichi più volte gli alleati come l'Intesa. Ai suoi occhi quindi gli italiani si erano squalificati per non essere entrati in guerra con la «Triplice» nel 1914 e per aver preso addirittura campo nel 1915 contro la Germania.
Solo la presenza di Mussolini e del fascismo, ai suoi occhi, aveva in parte riqualificato gli italiani. Gli stessi insuccessi del-
la strategia mussoliniana nei primi mesi della guerra venivano fatti risalire alla incompleta fascistizzazione dello Stato. Il .20 maggio del 1943 il dittatore tedesco così ricordò alcuni suoi incontri con Mussolini: «Egli mi disse improvvisamente - È giusto quello che dite, Fiihrer, ma non devono esserci più poteri nell'esercito. Ma cosa credete, Fiiher, che si possa fare quando si hanno degli ufficiali che ... hanno delle riserve nei confronti del regime dello Stato, dell'idea su cui s'impernia lo Stato?Costoro dicono di avere delle riserve perchè sono ufficiali. Dicono, nel momento in cui si viene a parlare dell'idea dello stato, in cui si pone la ragione di Stato: "Noi siamo monarchici, noi siamo per il Re''. Qui sta il problema; ciò che ci differenzia. Così si presentava il probléma già allora nel 1941; e ancora più acutamente si era presentato nel 1940, il 28 ottobre, quando io tornai ... Allora egli disse tutto a un tratto: - Vedete, io ho fiducia nei miei soldati, ma non ho alcuna fiducia nei miei generali, non posso averla. - Questo mi ha detto, mentre stava fallendo l'offensiva contro la Grecia e contro l'Albania» (9).
Se Mussolini, le cui responsabilità per lo sciagurato attacco alla Grecia sono indiscutibili, cercava di circoscriverle dichiarando la propria diffidenza per i generali, il suo collega germanico ne nutriva una viviss ima, che coinvolgeva in blocco tutti gli italiani. Il 7 novembre 1942 gli fu annunciato che una grande flotta d'inva sione anglo-americana stava entrando nel Mediterraneo; il fiiher, vagliando i possibili obiettivi di tale spiegamento di forze, formulò questa previsione: «Il nemjco sbarcherà stanotte nell'Italia centrale, dove non incontrerà nessuna resistenza poichè non ci sono truppe germaniche e gli italiani scappano» (10). Eppure, in quello stesso momento, le divisioni italiane di fanteria, che avevano tenacemente difeso le proprie posizioni durante tutta la battaglia di El Alamein, benchè vilmente abbandonate da Rommel nel deserto, continuavano a combattere nonostante la loro situazione disperata. Il 19 maggio 1943, sei giorni dopo che la prima armata italiana si era arresa per ordine per ordine superiore dopo una brillantissima re-
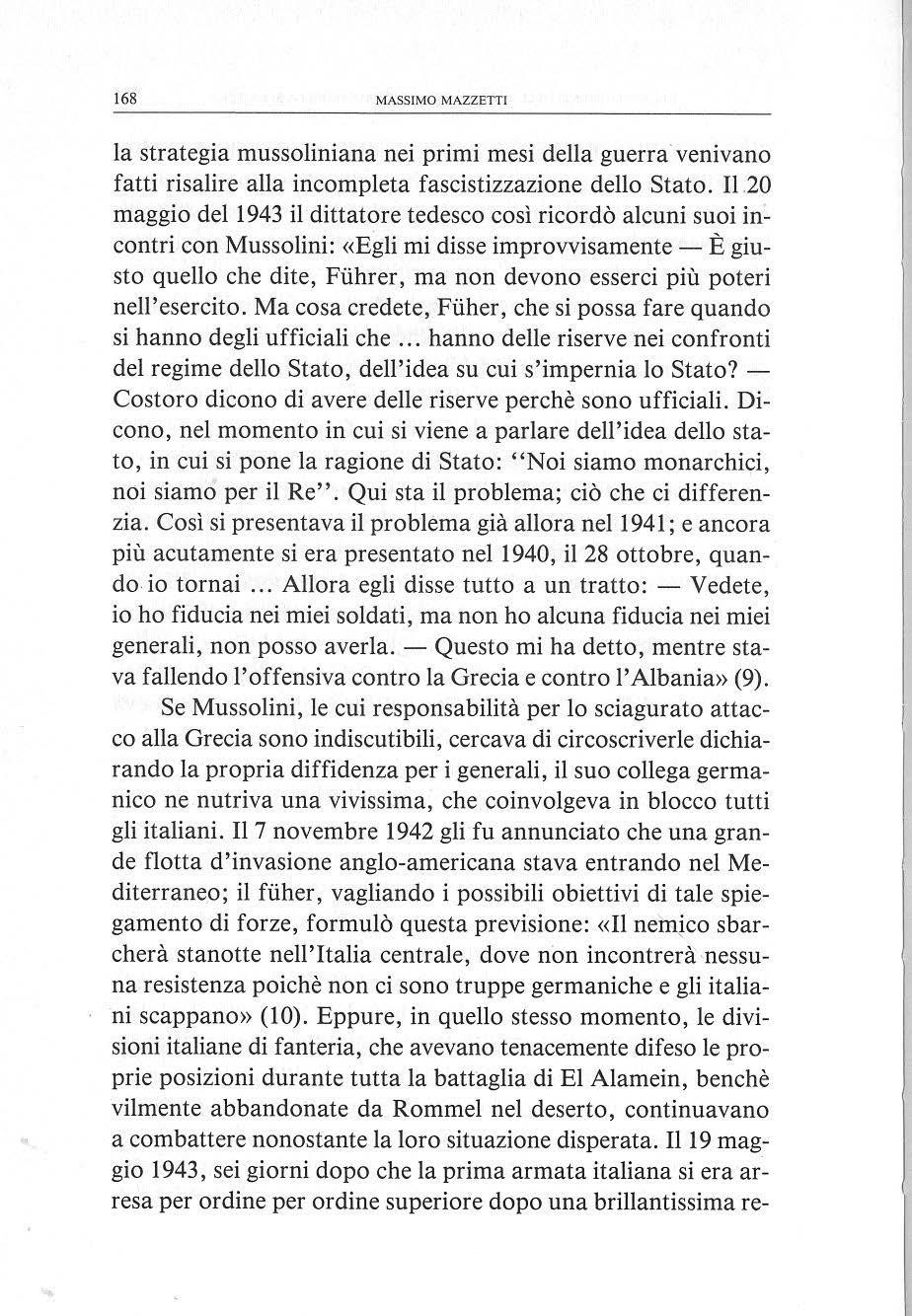
sistenza protratta ben oltre la resa delle meglio armate ed equipaggiate truppe tedesche, Hitler affermava: «Degli italiani non c'è da fidarsi» (11).
La responsabilità della mancata affidabilità degli italiani, ovverosia della loro mancata fascistizzazione totale, veniva imputata alla monarchia. Già il 20 maggio il dittatore tedesco, rendendosi conto lucidamente che la posizione del suo collega italiano era scossa e che le sue stesse energie fisiche declinavano, si poneva il problema: «Poichè la casa reale potrebbe sciogliere l'apparato rivoluzionario fascista, allora come ritiene egli che si comporterebbe il popolo italiano? Oppure, che cosa prevede nel caso che la casa reale prenda tutto il potere? È difficile dirlo. A Kessheim, quando siamo stati insieme, egli mi disse a un tratto: - Mio Fuhrer, non so, io non ho un possibile successore nella rivoluzione fascista. Come capo del governo un successore si potrebbe trovare, ma non ve ne è alcuno da mettere alla testa della rivoluzione fascista - .» (12).
Di fronte a questa situazion e, non certo ottimale per lui, Hitler si mosse rapidamente sul piano militare e su quello politico. Sul piano militare fece mettere allo studio il piano «Alarich» per l'invasione dell'Italia concentrando nella zona di Monaco una poderosa armata al comando di Rommel. Sul piano politico cercò di varare una soluzione che l'addetto militare a Roma, generale von Rintelen, sintetizzò così: «Tutto il potere al Duce, accantonamento della dinastia, impiego di più rilevanti rinforzi tedeschi sotto un supremo comando germanico» (13).
Non d eve sorprendere se una simile linea politica trovò consenziente il solo Farinacci che, anche per questo, fu preso in seria considerazione a Berlino come possibile successore di Mussolini alla testa della rivoluz ione fascista.
Questo te n tativo di pesante ingerenza germanica nelle vicende in terne it aliane era causato dalla decisione di Hitler di giocare, nel caso fossero fallite le trattative con i sovietici, l ' ultima carta con una offensiva in Russia. Da un punto di vista strategico complessivo, si trattava di una decisione senz'altro
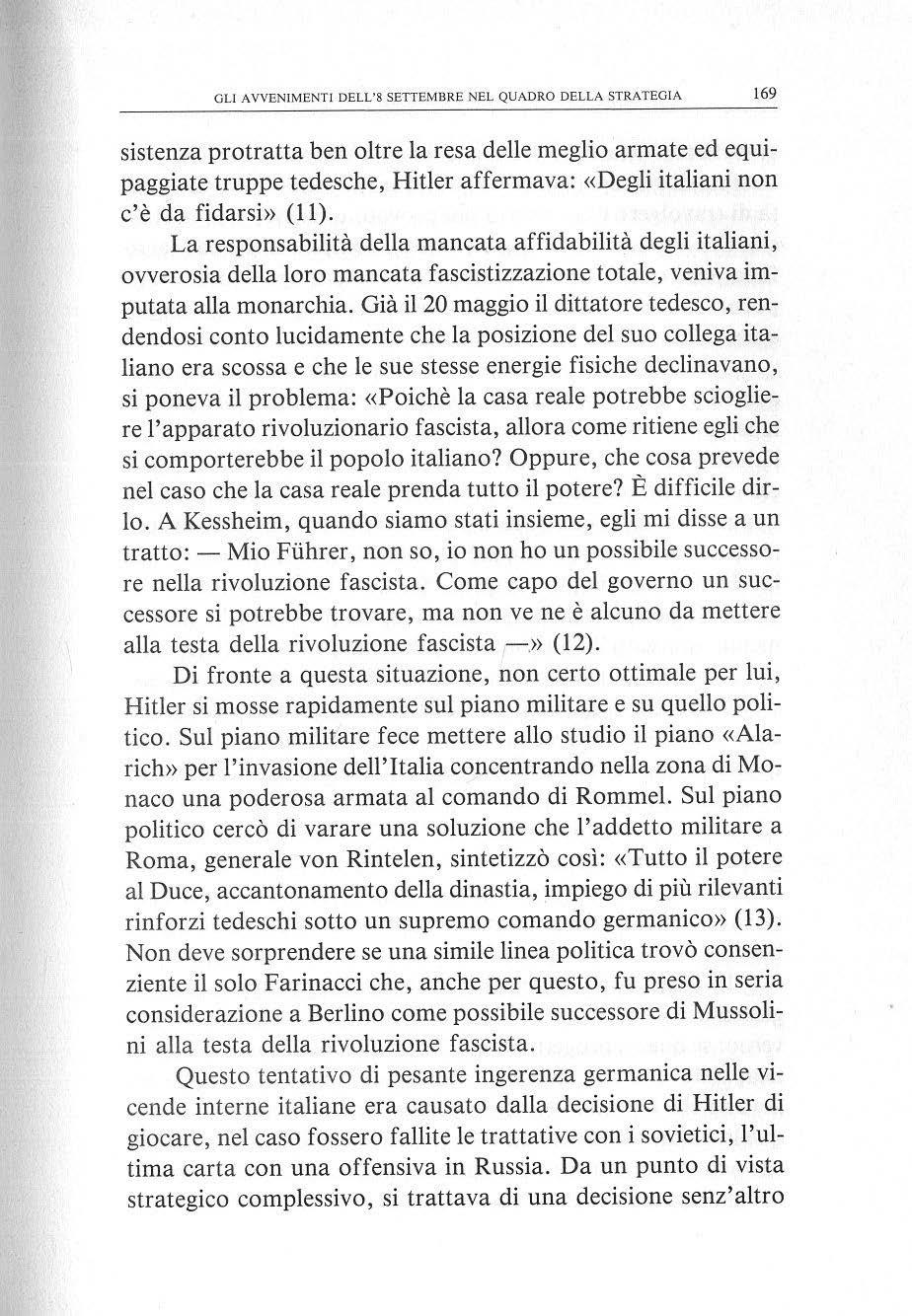
giustificata: infatti, se vi era ancora per l'Asse una qualche probabilità di vincere la guerra, questa era connessa alla possibilità di travolgere l'avversario più provato e scosso, cioè la Russia. Ciò implicava però per l'Italia un compito di grande sacrificio, cioè quello di far fronte, con le sole proprie forze e con pochi rinforzi tedeschi, alla formidabile pressione angloamericana.
In un'alleanza che fosse stata veramente vitale e perpetua, come i propagandisti si sforzavano di presentare quella italotedesca, un simile compito di sacrificio avrebbe potuto essere richiesto ad un alleato, ma questo non era il caso dell'Asse: perciò i dirigenti tedeschi ritennero ancora una volta che fosse più opportuno tenere celati i loro piani agli italiani cercando al contemp o di estendere quanto più possibile la loro influenza in Italia. È difficile alla lu ce di questi fatti criticare il desiderio italiano di sganciarsi dalla Germania. A tal proposito ha giustamente osservato il Faldella: «un'alleanza, per essere fedele nella buona come nell'avversa fortuna, deve svilupparsi nell'osserva nza leale di impegni d'ordine morale, politico, economico e militare, ed invec e la Germania li violò tutti» (14). Date queste premesse, Hitler non si ingannò neppure per un istante su quanto stava avvenendo a Roma: «si trattava di una rivolta partita dalla casa reale e dal Maresciallo Badoglio, dunqu e da gente che da tempo ci era avversa» (15). In quanto alle in tenzioni del governo affermò subito: «dichiararono di voler continuare a combattere, ma è un tradimento! Dobbiamo essere bene in chiaro, si tratta di un vero tradimento!» (16) .
Il fiihrer dispose subito che la 3 a div isione moto-corazzata germanica marciasse su Roma per arrestare il Re e il nuovo governo; se questo progetto non fu immediatamente messo in pratica, si dovette alla resistenza dei capi militari i quali non ritenevano che i 42 semoventi, di cui disponeva in quel momento quella unità, bastassero ad aver ragione degli italiani, tanto più che non vi erano truppe tedesche impiegabili in combattimento fra la Toscana e il Brennero. I comandi militari germanici ri-
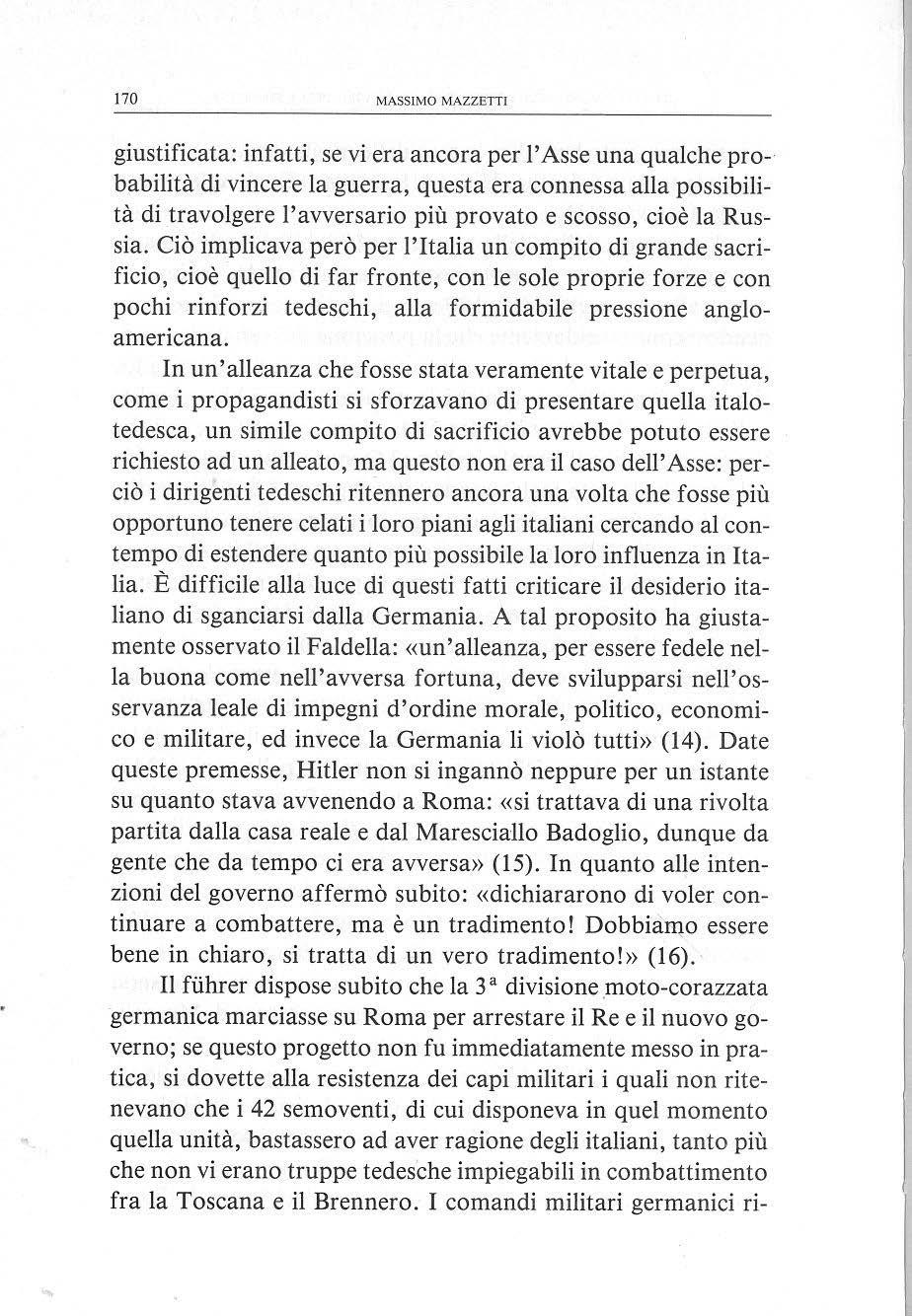
tennero che prima di agire fosse opportuno rinforzare le truppe tedesche in Italia, per cui fu ordinato alle divisioni di Rommel di mettersi in movimento verso l'Italia settentrionale. La seconda divisione paracadutisti venne trasportata d'urgenza a sud di Roma, mentre le unità carriste della 3 a divisione motocorazzata venivano convenientemente rinforzate.
A giudizio del Comando Supremo Tedesco la situazione sarebbe stata estremamente pericolosa fino a che le truppe di Rommel non si fossero stanziate nell'Italia settentrionale; fino a quell'epoca si riteneva che il «tradimento» italiano poteva isolare tutte le trupp e tedesche nell'Italia centrale e meridionale, come pure quelle che combattevano in Sicilia. Già a poche ore dal rovesciamento di Mussolini, le unità germaniche incominciavano a transitare per i passi alpini.
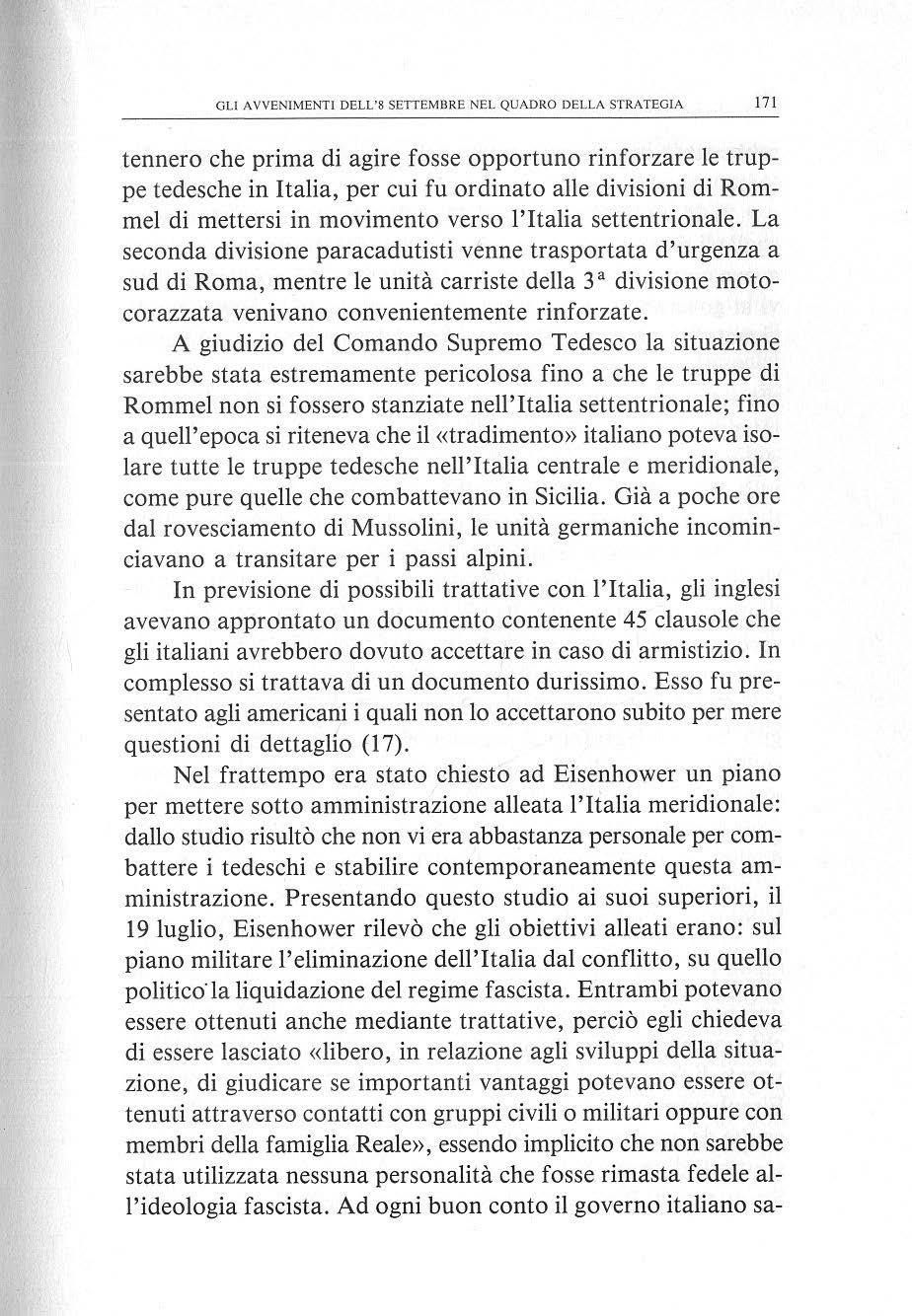
In previsione di possibili trattative con l'Italia, gli inglesi avevano approntato un documento contenente 45 clausole che gli italiani avrebbero dovuto accettare in caso di armistizio. In complesso si trattava di un documento durissimo. Esso fu presentato agli americani i quali non lo accettarono subito per mere questioni di dettaglio (17).
Nel frattempo era stato chiesto ad Eisenhower un piano per mettere sotto amministrazione alleata l'Italia meridionale: dallo studio risultò che non vi era abbastanza personale per combattere i tedeschi e stabilire contemporaneamente questa amministrazione. Presentando questo studio ai suoi superiori, il 19 luglio, Eisenhower rilevò che gli obiettivi alleati erano: sul piano militare l'eliminazio ne dell'Italia dal conflitto, su quello p0Iitico·1a liquidazione del regime fascista. Entrambi potevano essere ottenuti anche mediante trattative, perciò egli chiedeva di essere lasciato «libero, in relazione agli sviluppi della situazione, di giudicare se importanti vantaggi potevano essere ottenuti attraverso contatti con gruppi civili o militari oppure con membri della famig lia Reale», essendo implicito che non sarebbe stata utilizzata nessuna personalità che fosse rimasta fedele all'ideologia fascista. Ad ogni buon conto il governo italiano sa-
rebbe stato messo sotto tutela della commissione di controllo (18).
Il 25 luglio il Capo di S.M. dell'esercito americano Marshall gli rispose che, in base agli ordini del Presidente, egli non aveva autorità per discutere con gli italiani dei problemi relativi al governo militare, poteva solo richiedere la resa incondizionata (19). La notizia della caduta del duce provocò però grande animazione al quartier generale di Eisenhower; il 26 egli sottopose ai suoi superiori il testo di un proclama agli italiani che intendeva radio-diffondere. Il giorno seguente inviò quelle che, a suo avviso, erano le condizioni armistiziali da proporre all'Italia. Si trattav a di 10 punti che costituirono il primo testo di quello che passerà alla storia come il «corto armistizio» (20).
Nei giorni seguenti, sotto la pressione del comandante in capo del Mediterraneo, la posizione del governo di Washington, inizialmente ostile alle trat ta t ive, si fece più duttile: Roosevelt cominciava ad apprezzare i grandi vantaggi che sarebbero derivati sul piano militare dall'armistizio con l'Italia.
Diversa era la posizione inglese: Churchill, fin dal 26 luglio, aveva telegrafato al presidente americano: «ora che Mussolini se ne è andato, tratterei con qualsi asi governo italiano non fascista che fosse in grado di consegnare la merce» (21).
Quindi gli inglesi non ponevano in discussione l'idoneità di Badoglio a trattare l'armistizio, intendevano però che le condizioni di questo fossero quelle contenute nel loro documento, non quelle molto più miti proposte da Eisenhower. Churchill , propose una mediazione fra queste posizioni scrivendo : «Molte cose nella vita vengono risolte col sistema del two stage; per esempio un uomo non è impedito di dire- Vuoi sposarmi, carina? - perchè non ha in tasca il contratto matrimoniale stilato dagli avvocati di famiglia. Personalmente ritengo che le condizioni che Eisenhower può ora offrire sono molto più suscettibili d'essere capite da un rappresentante del governo italiano e pertanto suscettibili di immediata accettazione, della stesura legale dello Strumento di Resa, e faranno inoltre più bella figura se saran-
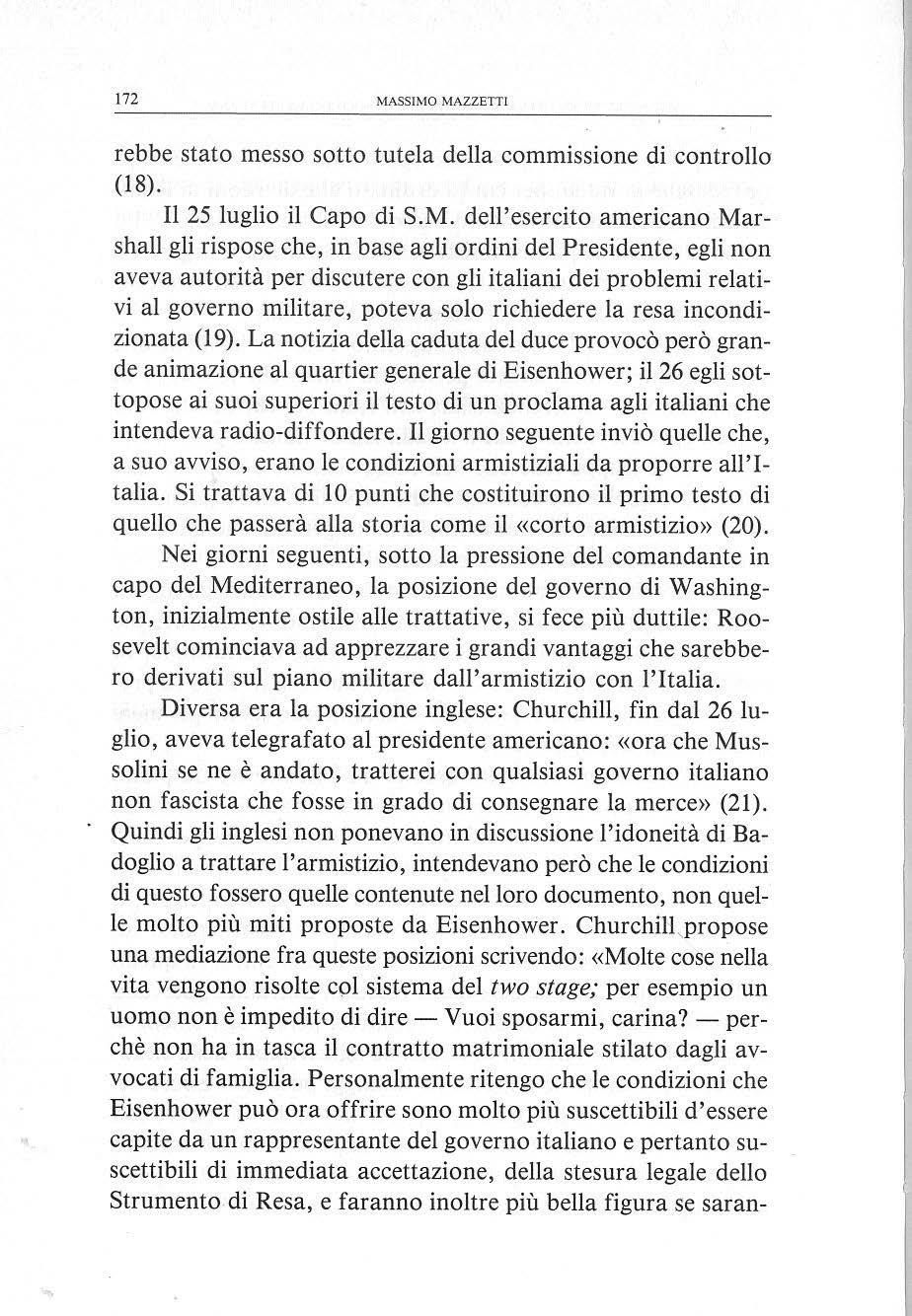
no pubblicate. Se riusciremo ad imporre condizioni di emergenza, questo sig nifica che gli italiani si saranno dati a noi a mani e piedi legati. Non ci sarebbe nulla di improprio da parte nostra se, in un periodo successivo, chiedessimo loro di darci la spazzatrice e le altre macchine di pulizia» (22).
Secondo la relazione ufficiale dell'esercito americano il Foreign Office non fece una grande accoglienza alla proposta di Churchill perchè Eden preferiva la resa incondizionata. In r ealtà il Ministro degli Esteri britannico aveva già espresso precedent eme nte la propria avversione alla proposta di ottenere una resa iniziale sulla base delle sole condizioni militari , cui sare bbe seguita l'accettazione di condizioni politiche ed econ omich e. Cosa sarebbe infatti accaduto se il Governo italiano avesse rifiutato di firmare il secondo docum ento? A giudizio di Eden erano necessar i, fin dall'inizio, termini precisi, comprendenti sia le condizioni militari sia quelle politiche. Agli occhi d el Ministro degli Es teri britannico il programma in two stage (due tempi) propos t o dal Primo Ministro, avrebbe potuto anche non realizzarsi. Per essere sicuri infatti che un simile piano avesse successo, era indispensabile che gli italiani fossero consegnati agli anglo-americani «mani e piedi legati», come aveva scritto Churchill, ma perchè ciò avvenisse non era opportuno aiu t are l'Italia a sga11:ciarsi rapidamente dalla Germania, almeno fintanto che gli inglesi non avessero indotto gli americani a proporre, come unico documento armistiziale, quello preparato da loro.
Parlando alla Camera dei Comuni a fine luglio, Churchill illustrò così il programma britannico: «Noi, per usare una frase corrente, dovremmo lasciar cuocere per un poco gli italiani nel loro brodo e accendere al massimo il fuoco allo scopo di accelerare il corso degli eventi fino a che otterremo dal loro governo, o da chiunque possieda la necessaria autorità , soddisfazione a tutte le nostre indispensabili richieste, per condurre la guerra contro il nostro principale e capitale nemico, che non è l'Italia ma la Germania» (23). In quanto a come cuocere gli italiani, il Primo Ministro britannico aveva delle idee ben pr ecise: una massiccia serie di bombardamenti indiscriminati.

Mentre le forze aeree del Mediterraneo attaccavano quasi giornalmente le località di una qualche importanza dell'Italia meridionale, i bombardieri di stanza in Gran Bretagna tornarono attraverso le Alpi per colpire le grandi città del Nord: Milano fu attaccata quattro volte da una forza complessiva di 916 bombardieri pesanti, Torino 3 volte da 380 quadrimotori e Genova una volta sola da 73 bombardieri pesanti (24).
Uno studioso italiano che si è particolarmente interessato del bombardamento strategico alleato nella II Guerra mondiale, ha trovato incomprensibile tanto accanimento ed ha osservato : «Se non si voleva dare una mano agli italiani perchè si t raessero d'impaccio da soli, pazienza, ma non era davvero il caso di colpire con furia selvaggia quand'essi, come aveva detto Churchill, non avevano voluto la guerra a fianco di Hitler. Invece gli alleati, e assai di più gli inglesi che gli americani, come vedremo, si accanirono più contro l'Italia già agonizzante di Badoglio , di quanto s'erano accaniti contro l'Italia di Mussolini» (25).
Il motivo del durissimo atteggiamento inglese è da ricercare nel fatto che gli americani non avendo all'epoca, interessi mediterranei erano di fatto più sensibili alle immediate esigenze militari, mentre per i britannici la liquidazione dell'Italia come grande potenza mediterranea, costituiva uno degli obiettivi di guerra; e se Churchill, in considerazione dei suoi obiettivi balcanici, sempre uffici_almente negati ma sempre tenacemente perseguiti, era disposto anche a qualche concessione, non altrettanto lo erano Eden e la gran parte del gabinetto britannico.
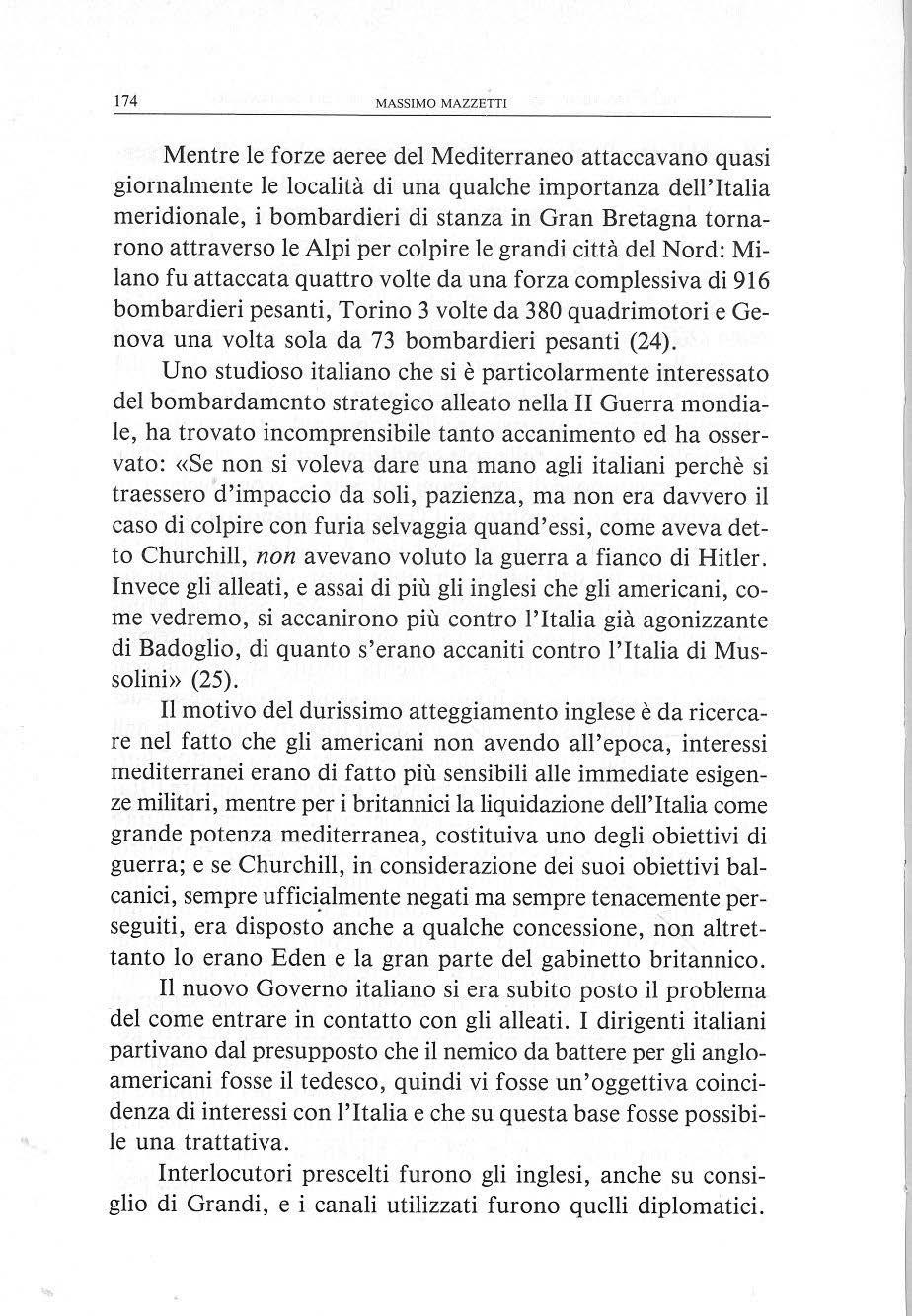
Il nuovo Governo italiano si era subito posto il problema del come entrare in contatto con gli alleati. I dirigenti italiani partivano dal presupposto che il nemico da battere per gli angloamericani fosse il tedesco, quindi vi fosse un'oggettiva coincidenza di interessi con l'Italia e che su questa base fosse possibile una trattativa.
Interlocutori prescelti furono gli inglesi, anche su consiglio di Grandi, e i canali utilizzati furono quelli diplomatici.
Frattanto una delle maggiori preoccupazioni di Churchill era proprio quella di evitare i contatti diretti fra americani e italiani.
Il 31 luglio, rispondente ad una richiesta pontificia, il governo italiano comunicò alla Segreteria di St ato vaticana che era stata presa la decisione di dichiarare Roma «città aperta». Il 2 agosto il delegato apostolico a Washington chiese al sottosegretario di Stato americano quali erano le condizioni che gli alleati riteneva necessarie per il riconoscimento di Roma «città aperta». Roosevelt telegrafò a Churchill il giorno seguente «credo che ci troveremmo in una difficile situazione se dovessimo respingere la richiesta di proclamare Roma città aperta» (26).
Il Primo Ministro britannico rispose il 4 agosto con un t elegramma nel quale, tra le altre molte affermazioni contraddittorie, si sosteneva : «Indubbiamente la loro speranza (dei dirigent i italiani) è che l'Italia sia riconosciuta come territorio neutrale e Roma potrebbe essere la prima rata; tenendo presente che Badoglio, stando a tutte le nostre informazioni, soprattutto le più segrete, continua a ripetere ai t edeschi e ai giapponesi che la guerra continuerà e che si terrà fede ai patti, e che addirittura ripete queste dichiarazioni alla radio, noi non dovremmo, a mio parere, dare loro il minimo incoraggiamento» (27).
A parte il fatto della patent e contraddizione contenuta nel documento, poichè la condizione di neu tralità era evidentemente in contrasto con quella di continuare la guerra, quest'ultima aff~rmazione relativa all'orientamento del Governo italiano appare invero sorprendente visto che, già dal giorno prima, Churchill sapeva che un emissario autorizzato da Badoglio aveva preso contatti con l'ambasciata britannica di Lisbona. Era evidente che il governo inglese non desiderava che fossero continuate le trattative per il riconoscimento di Roma città aperta perchè vi era il pericolo che, tramite il Vaticano, si mettessero in contatto italiani e statunitensi prima che gli inglesi riuscissero a fare accettare, a questi ultimi, il loro documento. Anche i contatti fra l'emissario italiano, marchese d' Ayeta, e l'ambasciatore inglese in Portogallo, furono presentati dal Primo Ministro in-
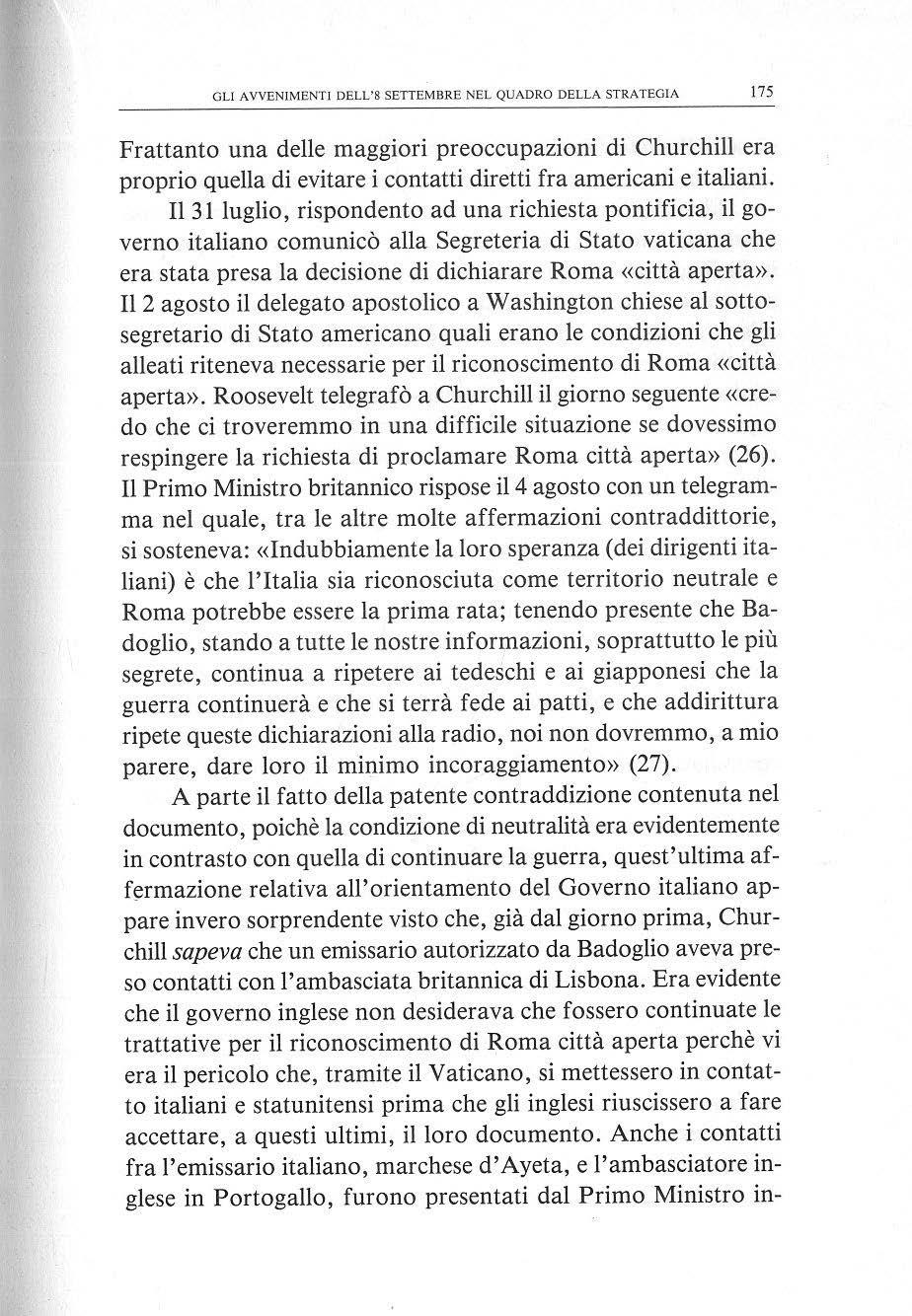
glese al Presidente americano come «la preghiera che noi si salvi l'Italia dai tedeschi e da sè stessa il più presto possibile» (28). Churchill non fece alcun cenno alle importanti notizie militari comunicate da d'Ayeta e ciò per un motivo ben preciso: in Sicilia, dopo i primi momenti di euforia per la rapida avanzata della 7a armata americana su Palermo e la caduta del fascismo, i comandi alleati si attendevano il rapido collasso delle forze italiane, tanto più che, nella marcia su Palermo e nel successivo rastrellamento nella Sicilia occidentale, gli uomini di Patton avevano catturato, o messo fuori combattimento, poco meno di 56.000 uomini, quasi tutti italiani. Gli anglo-americani non considerarono però che gli autoveicoli catturati erano solo 359, non si resero conto cioè che i prigionieri erano quasi tutti delle scalcinatissime divisioni costiere le quali, essendo prive di automezzi con cui sottrarsi alla cattura, non avevano potuto far altro che arrendersi. Una volta però che le unità italiane superstiti furono schierate sulla nuova linea difensiva , su un t erreno cioè che impediva agli anglo-americani di sfruttare la loro superiorità in mezzi corazzati, invece del previsto crollo la resistenza si irrigidì tanto da far scrivere qualche giorno dopo al compilatore del diario storico del comando di Eisenhower: «La speranza di un rapido collasso in Italia è svanita ora che si è accertato che gli italiani resistono con maggiore energia e si battono duramente» (29). Gli anglo-americani continuarono bensì ad avanzare, ma solo perchè a seguito degli avvenimenti del 25 luglio, il comando delle forze germaniche dell'isola, che fino a quella data intendeva difendere il térreno palmo per palmo, ebbe l'ordine di sgomberare uomini e materiali oltre lo stretto, ripiegando lentamente. Le unità italiane, non essendo in grado da sole di tenere la linea , dovettero adeguarsi.
Di fronte a questa situazione, assai diversa da quella che aveva previsto e sperato, Eisenhower premè su Washington perchè gli fosse concesso, in eventuali trattative, di utilizzare il proprio documento. Alla fine di luglio il governo inglese accettò questo testo con qualche modifica, ma solo nel caso di un'«im-
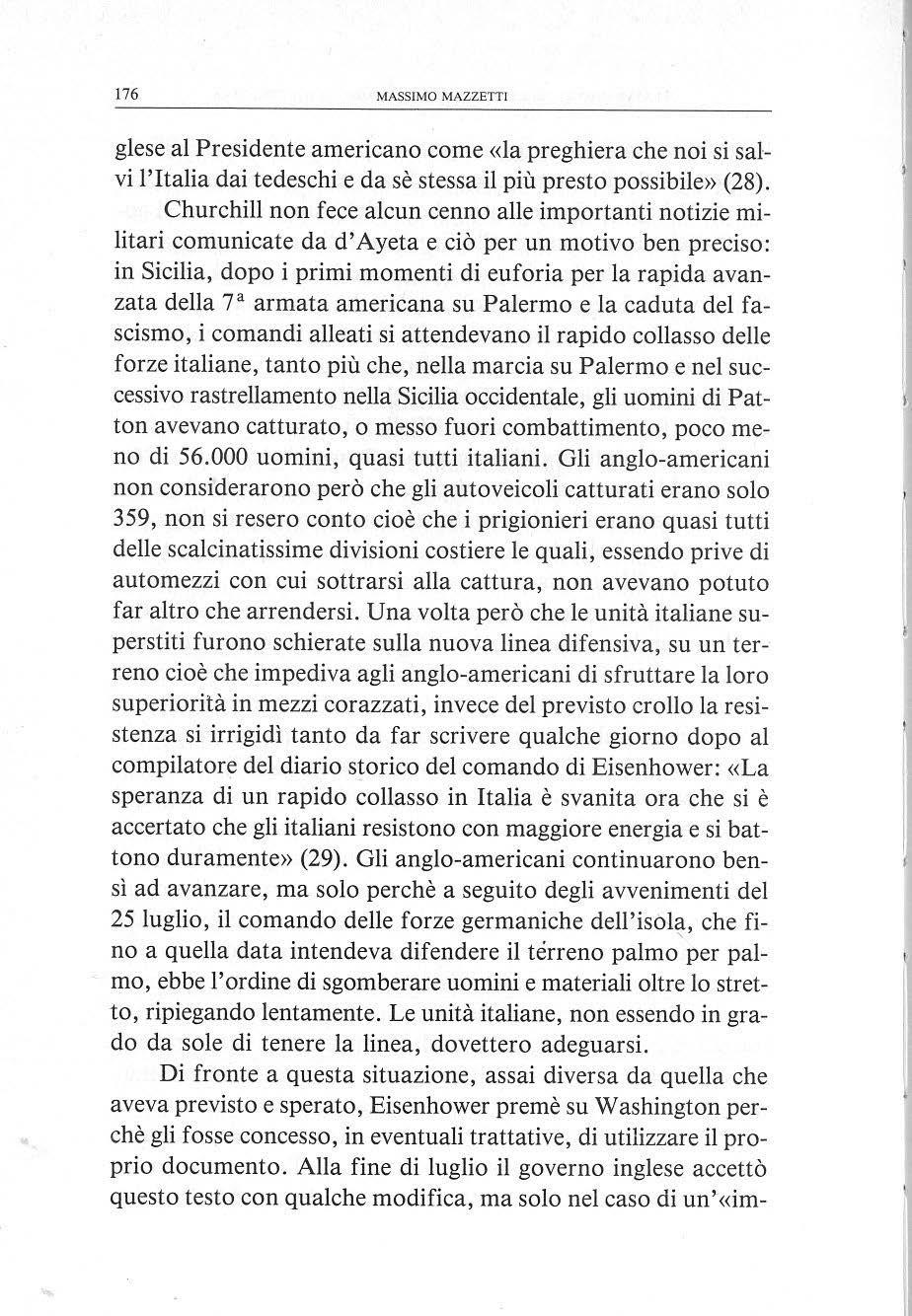
mediata emergenza». Come documento definitivo i britannici continuavano ad insistere su quello da loro approntato. Era quindi essenziale, per i progetti inglesi, che gli italiani non entrassero in contatto con il comando in capo del Mediterraneo, cosa che sarebbe inevitabilmente avvenuta se Churchill avesse trasmesso a Roosevelt le informazioni militari fornite da d'Ayeta.
Date queste premesse, neppure il secondo emissario italiano, il console generale a Tangeri Alberto Berio, ottenne molto successo. Eguale sorte sarebbe toccata al terzo emissario, generale Castellano, se la sua missione non fosse stata contemporanea alla conferenza anglo-americana di Quebec. Infatti, durante questo incontro, i britannici trovarono i loro alleati tutt'altro che arrendevoli. Gli statu niten si si erano co nvinti che i britannici non credevano seriamente all'attacco oltre la Manica, ed ottennero il primo successo concordando che l'operazione sare bbe stata diretta da un loro generale e non da un ingles e, come fino ad allora era stato stabilito.
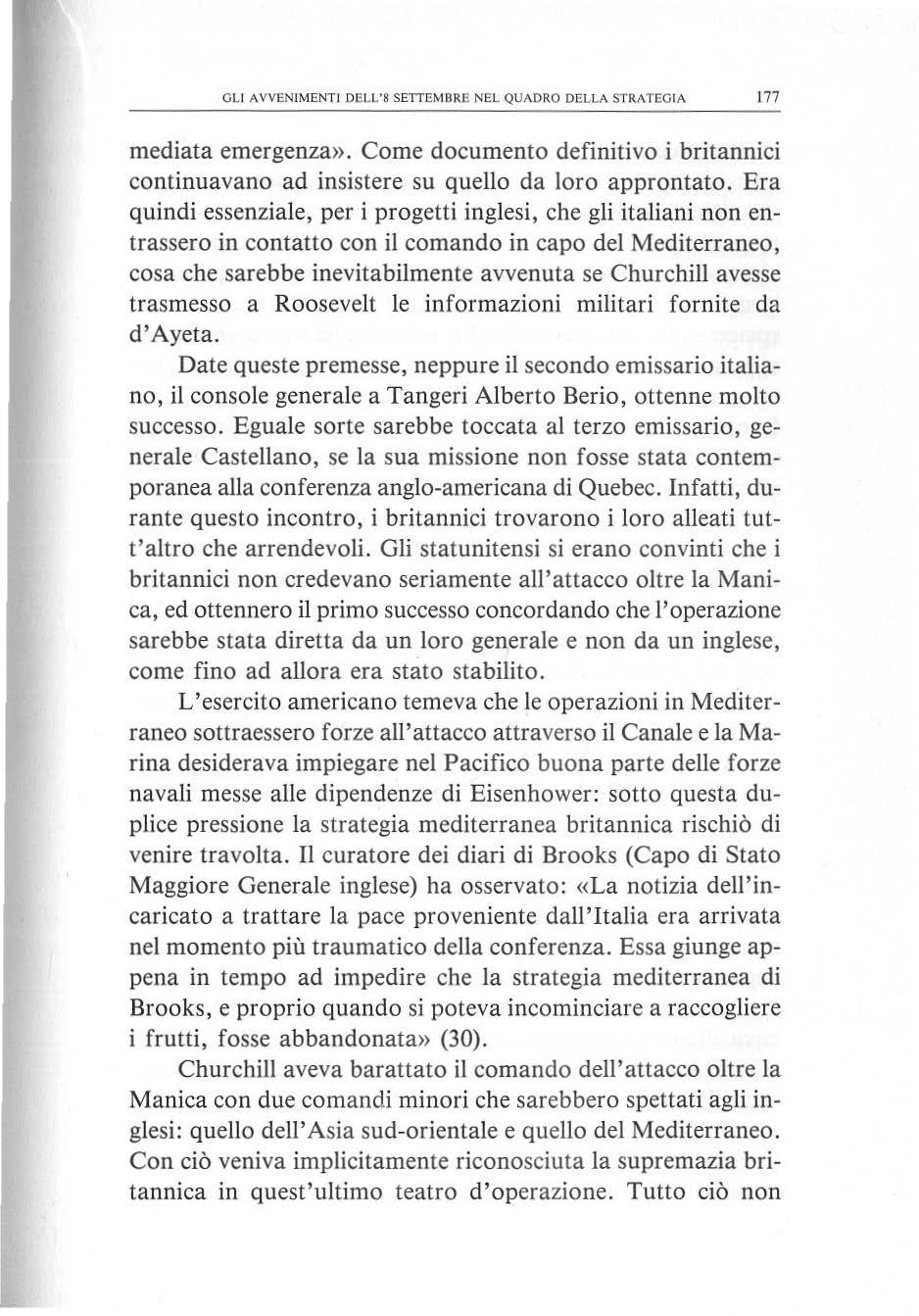
L'esercito americano temeva che le operazioni in Mediterraneo sottraessero forze all'attacco attravers o il Canale e la Marina desiderava impiegare nel Pacifico buona parte delle forze navali messe alle dipendenze di Eisenhower: sotto questa duplice pressione la strategia mediterranea britannica rischiò di venire travolta. Il curatore dei diari di Brooks (Capo di Stato Maggiore Generale inglese) ha osservato: «La notizia dell'incaricato a trattare la pace proveniente dall'Italia era arrivata nel momento più traumatico della conferenza. Essa giunge appena in tempo ad impedire che la strategia mediterranea di Brooks, e proprio quando si poteva incominciare a raccogliere i frutti, fosse abbandonata » (30).
Churchill aveva barattato il comando dell'attacco oltre la Manica con due comandi minori che sarebbe ro spettati agli inglesi: quello dell'A sia sud-orientale e quello del Mediterraneo. Con ciò veniva implicitamente ricono sciuta la supre mazia britannica in quest'ultimo teatro d'opera zione . Tutto ciò non
avrebbe avuto un gran valore se i programmi fossero stati ridimensionati. Il Primo Ministro inglese, vista in pericolo la linea strategica che sosteneva da anni, non esitò un istante a «valorizzare» i telegrammi dell'ambasciatore a Madrid che annunciavano l'arrivo di Castellano, servendosene per far prevalere la sua tesi. Certo così facendo Churchill sapeva di dare un dispiacere ad Eden e a molti altri ministri del suo governo, ma se la strategia mediterranea fosse stata abbandonata l'Inghilterra avrebbe subìto un danno ben maggiore. A questo punto Roosevelt chiese ed ottenne che il delegato italiano fosse messo in contatto con Eisenhower. Dopo di ciò le trattative poterono avere inizio.
Il 19 agosto i delegati inglesi e italiani si incontrarono a Lisbona. Frattando continuò la pianificazione per lo sbarco sulla penisola. Nella seconda metà di agosto, tuttavia, si verificò un brusco mutamento negli orientamenti britannici che, mentre fino a quel momento erano stati estremamente audaci (avendo mostrato il desiderio di sbarcare il più a nord possibile, concentrando a questo scopo nel Mediterraneo ben cinque portaerei di scorta), divennero estremamente cauti, opponendosi anche ad uno sbarco a nord di Napoli . La causa di questo brusco mutamento va ricercata nel fatto che, attraverso la macchina ultra, gli inglesi riuscivano a decifrare i messaggi segreti del nemico ed erano quindi venuti a conoscenza dell'ordine impartito da Hitler a Kesselring, in base al quale egli doveva , in caso di armistizio italiano, spostare verso nord tutte le truppe germaniche distruggendo le unità italiane per poi tenere la linea degli Appennini insieme alle forze di Rommel. ·
Bisogna considerare qual'era la valutazione di Alexander circa gli orientamenti dei dirigenti italiani: «Il minimo che sperassero era che i tedeschi sarebbero stati costretti ad evacuare tutta l'Ita lia a sud degli Appennini, la successiva <<linea gotica». In tal caso l'autorità del regio Governo sarebbe continuata nella maggior parte del paese, la capitale sarebbe stata garantita, le forze armate italiane, benchè ridotte, sarebbero ri -
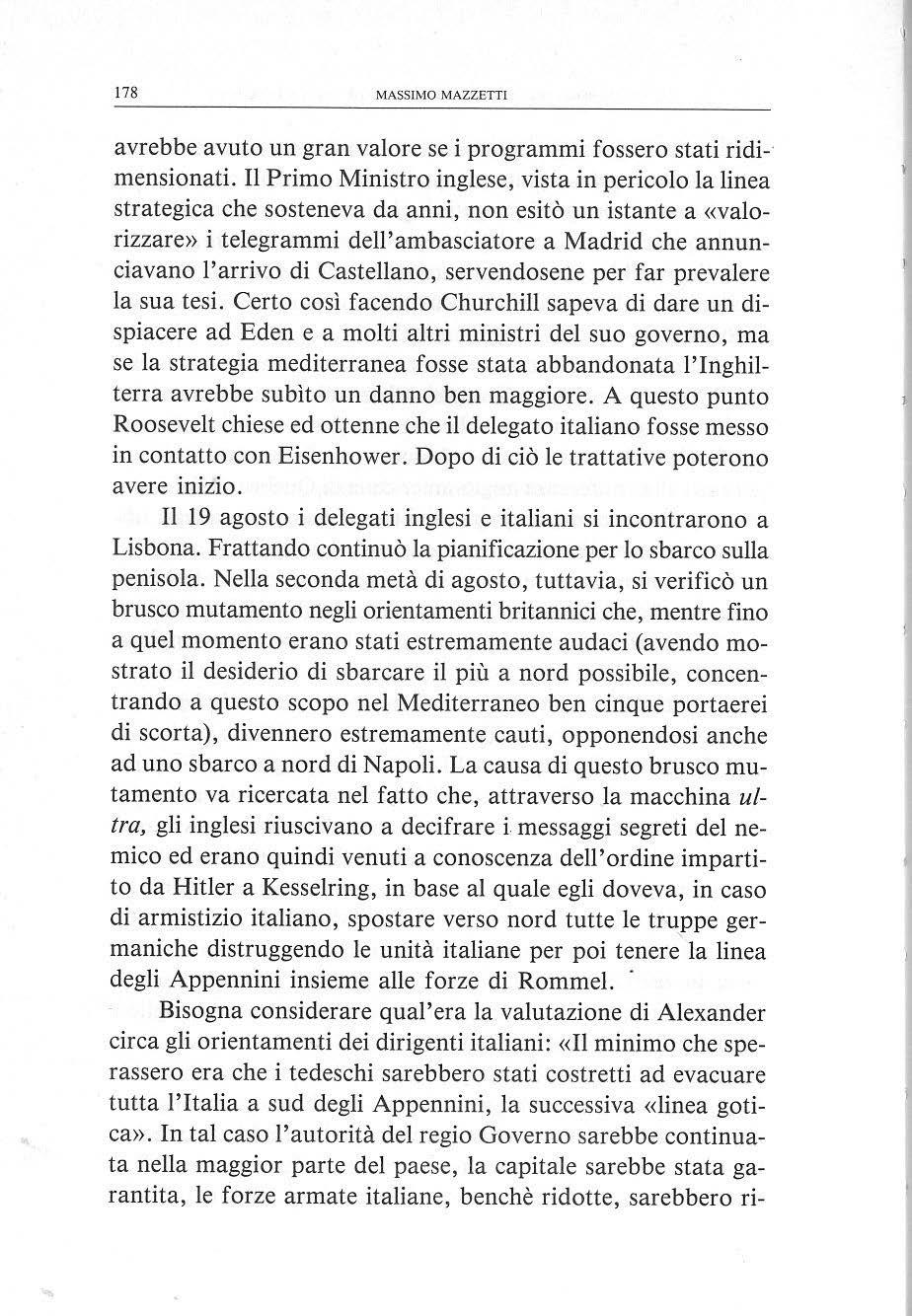
maste in piedi, la posizio ne del Comando Supremo impregiudicata e l'Italia sarebbe stata in grado di occupare il suo posto fra le Nazioni Unit e» (31).
Se questi intendimenti si fossero·realizzati, sarebbe svanita ogni speranza d'imporre la firma dello «Strumento di Resa», come temeva Eden. I piani dei tedeschi, i quali, come si è visto, erano perfettamente noti ai comandanti britannici, fugavano questo pericolo; avrebbero provveduto loro, ritirandosi verso nord, a liquidare l'esercito italiano: era quindi in opportuno disturbarli in questa operazione, visto che avrebbero lavorato «per il Re di Prussia» o più precisamente, in questo caso, per Sua Maestà Britannica. L'id ea di sbarcare a nord di Napoli fu quindi abbandonata. Fu scelto per lo sbarco il golfo di Salerno: una deci sione sia strategicame nte che tatticame nte infelice.
Il 31, in Sicilia , vi fu un nuovo inco ntro fra i rappresentanti anglo-americani e il generale Castellano; in esso il delegato italiano presentò una serie di richieste del suo governo: che gli alleati sbarcassero non meno di 15 divisioni, la maggior parte delle quali a nord di Roma, e so lo dopo questo sbarco l'Italia avrebbe proclamato l'armistizio . Per gli anglo -americani si trattava di condizioni inaccettabili: le 15 divi sioni non erano disponibili, lo sbarco principale doveva avv en ire a Salerno, e la capitolazione italiana era indispensabile pr eme ss a all' effettuazione d ello stesso.
L'incontro fu meno cordia le del precedente, ma dopo una giornata di vivaci di sc ussioni, poichè i rappresentanti alleati dovevano concludere ad ogni costo, la sera furono infine promesse le 15 divisioni richieste dagli italiani, però in due rate: prima 6 (che c'erano) e poi altre 9 (che non c'erano) contemporaneamente alla dichiarazione dell'armistizio. Gli sbarc hi sarebbero avvenuti a sud di Roma, gli alleati avrebb ero, oltre a ciò, lanciato una divisione avio-trasportabile presso Roma. Dal canto suo Eisenhower giun se alla conclusione che il Governo italiano stesse per cro llare e decise di affrettare i tempi per lo sbarco.
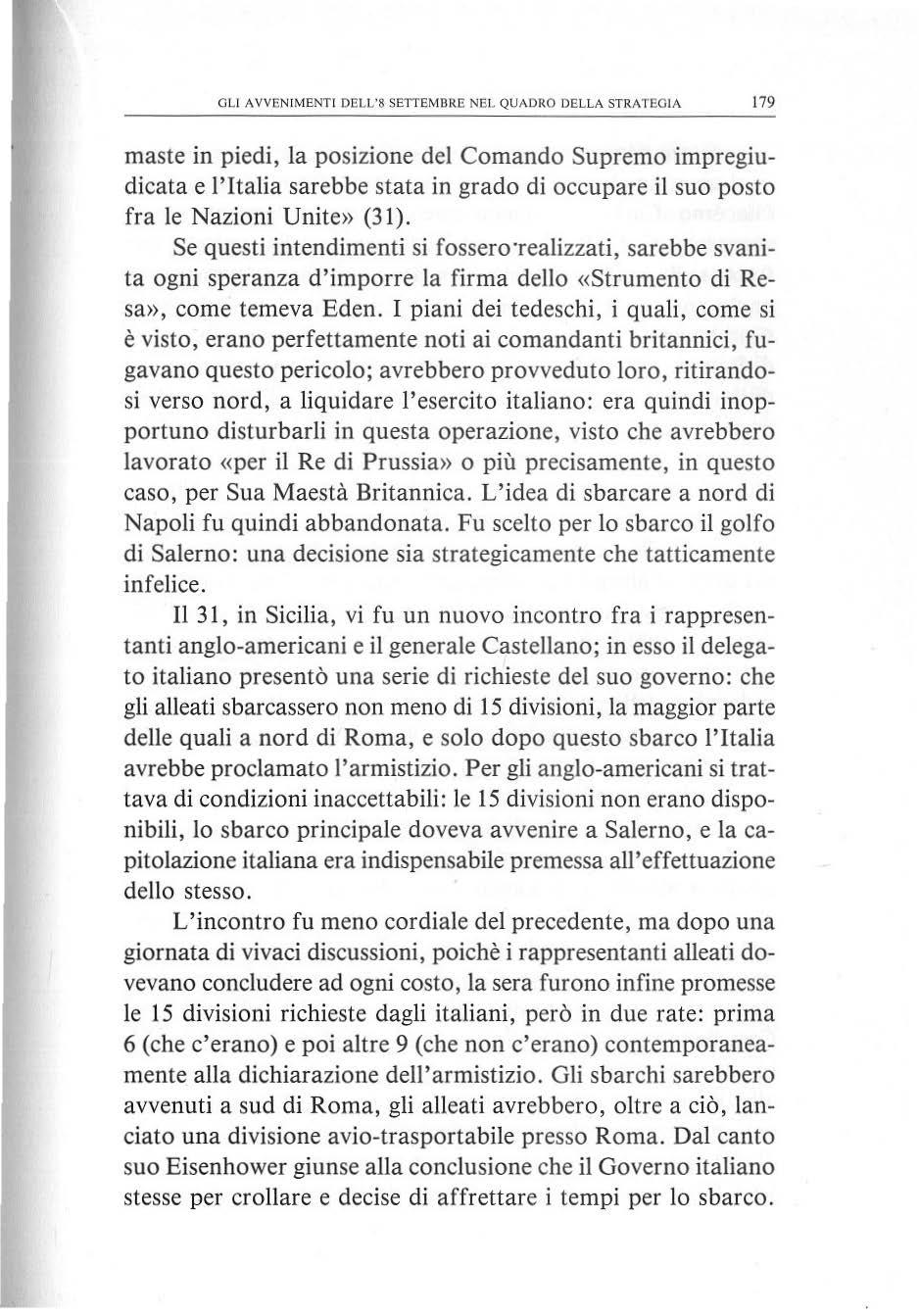
Al suo ritorno a Roma, il generale Castella no non ottenne quel successo che forse si aspettava. Sta di fatto che il generale Giacomo Carboni, comandante il corpo d'armata motocorazzato (C.A.M.), in caricato della difesa della capitale , non fu per nulla soddisfatto della mancata accettazione da parte degli anglo-americani dello sbarco a nord di Roma. Carboni, abilissimo navigatore politico (era stato uomo di fiducia nell'ordine di Baistrocchi, di Padani, di Ciano e in quel momento lo era di Badoglio), non era stato altrettanto ansioso di dimostrare il proprio va lore sul campo. Il compito che le forze ai suoi ordini avrebbero dovuto svolgere negli intendimenti del loro comandante fu così riassunto: «II corpo moto-corazzato avre bbe dovuto, con la parte meno mobile delle sue divisioni, schierate largamente nelle vicinanze non immediate di Roma, contrastare per qualche giorno a forze tedesche attaccanti l'accesso alla capitale, mentre la parte più mobil e e corazzata del Corpo d' Armata si sarebbe spostata celermente per distrarre l'attenzione tedesca e dare man forte al promesso sbarco anglo-americano in località della costa t irrenica tanto vicino a Roma da pot er giungere in tempo a salva re la cap itale dall'occupazione tedesca» (32).
In sintesi, nell'ipotesi di uno sbarco a nord di Roma, mentre tre divisioni italiane di fanteria avrebbero impedito alla seconda divisione di paracadutisti germanica di entrare nella capitale, Carboni, con almeno due divisioni moto-corazzate, avrebbe attaccato a terg o la 3a divisione granatieri già impegnata frontalmente dagli anglo-americani. Nel complesso un'operazione di tutto riposo. Comprens ibilmente Carboni si diede da fare perchè il piano non venisse in sostanza modificato; così Castellano ripartì per la Sicilia avendo l'esplicito ordine di Ambro sio di ottenre che il secondo sbarco, q uello contemporaneo alla dichiarazione di armistizio, avvenisse a sud della capitale, ma «a portata di Roma». Quando il delegato italiano giun se al comando alleato, si svolse una nuova commedia degli equivoci. Gli anglo-americani ritenevano che il Castellano fosse giun-
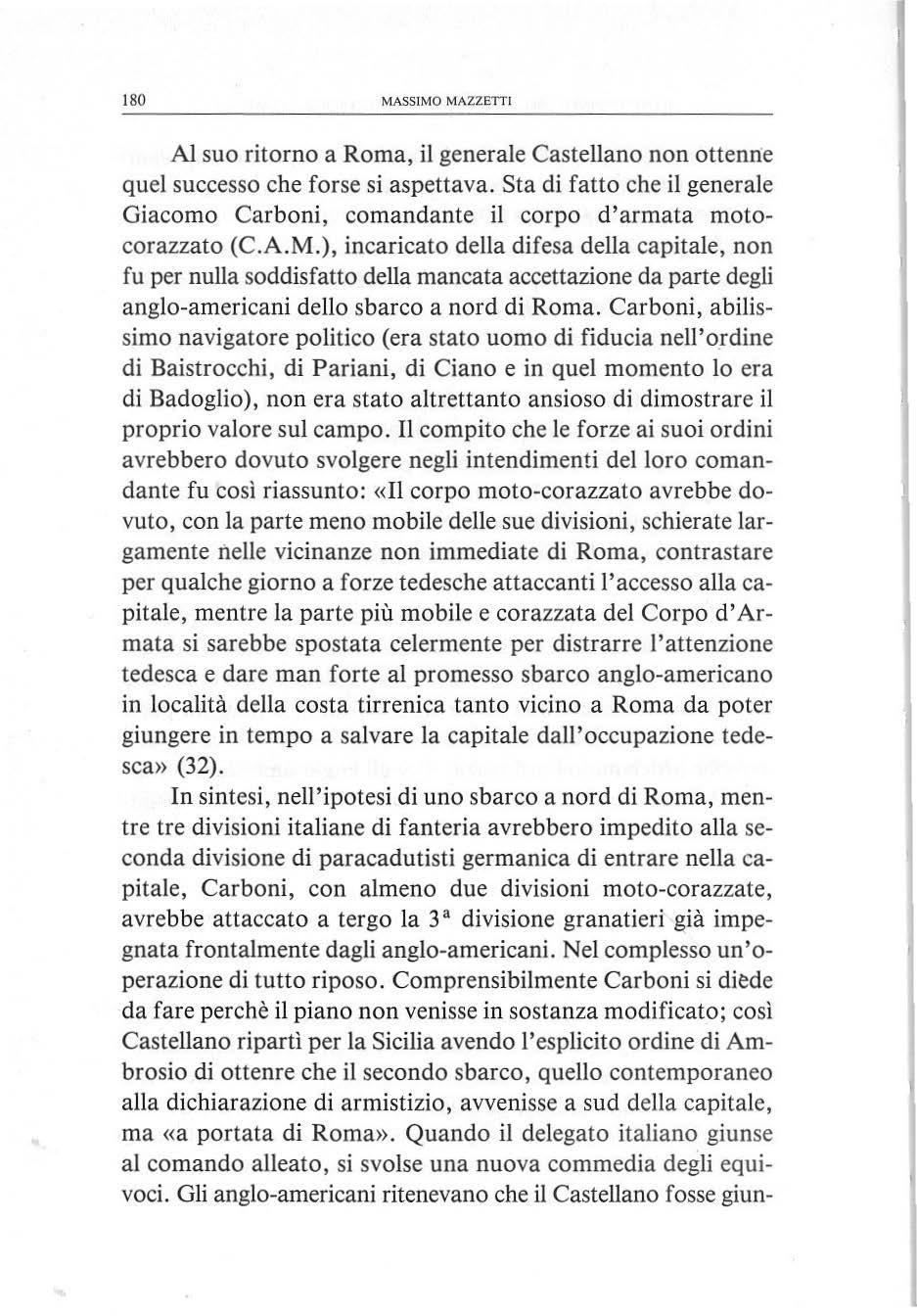
to per firmare il testo dell'armi stizio; da parte italiana, invece , si riteneva che fosse sufficiente l'accettazione telegrafica del giorno precedente. Gli alleati non compresero che il disguido era stat o causa t o dalla precipitazione con cui avevano trattato la cosa e pensarono che si trattasse di una manovra italiana per ottenere nuove concessioni.
Si divisero quindi le parti secondo un cliché già sperimentato : le minacce gli inglesi, le blandizie gli americani. Così Alexander minacciò i delegati italiani e Bedell Smith, Capo di Stato Maggiore di Eisenhower, si abbandonò a promesse che sapeva di non poter mantenere; co sì Castellano telegrafò a Roma che le richieste di Ambrosia erano accettate e l'autorizzazione venne. L'estrema resistenza italiana aveva però indo tto Ei senhower ad evitare di cercare di far firmare il documento preparato dagli inglesi che nel frattempo era stato approvato anche dal governo americano.
Quando però, alla firma dell'armistiz io , si passò all'esame dei piani operati vi, i rappre sentanti italiani dovettero constatare non solo la irriducibile ostilità inglese, ma anche che gli intendimenti operativi degli alleati erano alquanto diversi da quanto era stato promesso ed anche da quanto era stato convenuto ufficialmente. Castellano, invece di irrigidirsi, com'era suo dovere, pr eferì ricorrere ancora ai patteggiamenti, anche perchè sognava di giocare un ruolo non seco ndario a fianco di Ambrosio, che avrebbe dovuto recitare la parte d i De Gaulle. Alla fine di tutt o ciò lo spregiudicato delegato italiano inviò una serie di documenti a Roma, accompagnati da una sua lettera ad Ambrosia, in cui, contrariamente a quanto fino ad ora è stato sostenuto, era scritto:
a) che Badoglio era bruciato presso gli anglo-am ericani per cui lui [Ambrosia] doveva tener si pronto a raggiungere P alermo per recitarvi la parte di De Gaulle;
b) che, per imprescind ibili esigenze operative alleate, la procl amazion e d ell'armistizio doveva avvenire contemporaneament e al primo dei due grossi sbarch i e non al secondo, com'era stato in pr ece denza sta bilito;
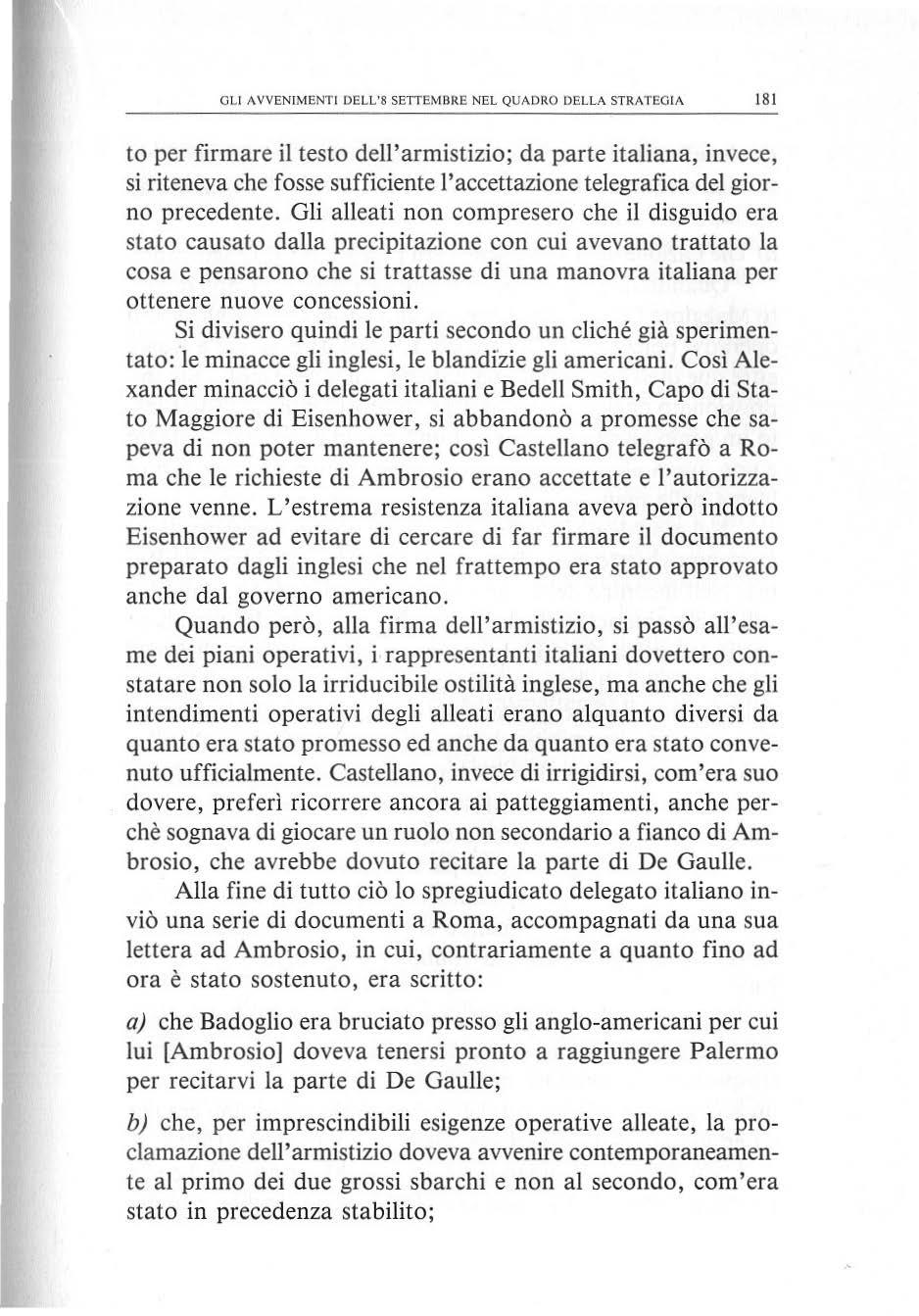
e) che gli alleati avrebbero comunque inviato, al più tardi en.: tro una settimana dal primo sbarco, una divisione corazzata ad Ostia;
d) che l'azione anglo-americana era prevista per il 12 settembre. Quando questo documento giunse a Roma il Capo di Stato Maggiore Generale non si preoccupò gran che per gli aspetti operativi poichè entro la data del 12 sarebbero giunte a Roma altre due divisioni di fanteria italiane. Fu invece molto più impressionato dagli aspetti politici. Ambrosio non sarà forse stato un genio annibalico, ma era un vecchio e quadrato soldato e non aveva alcuna ambizione gaullista. Quindi rimise il problema nelle mani del sovrano.
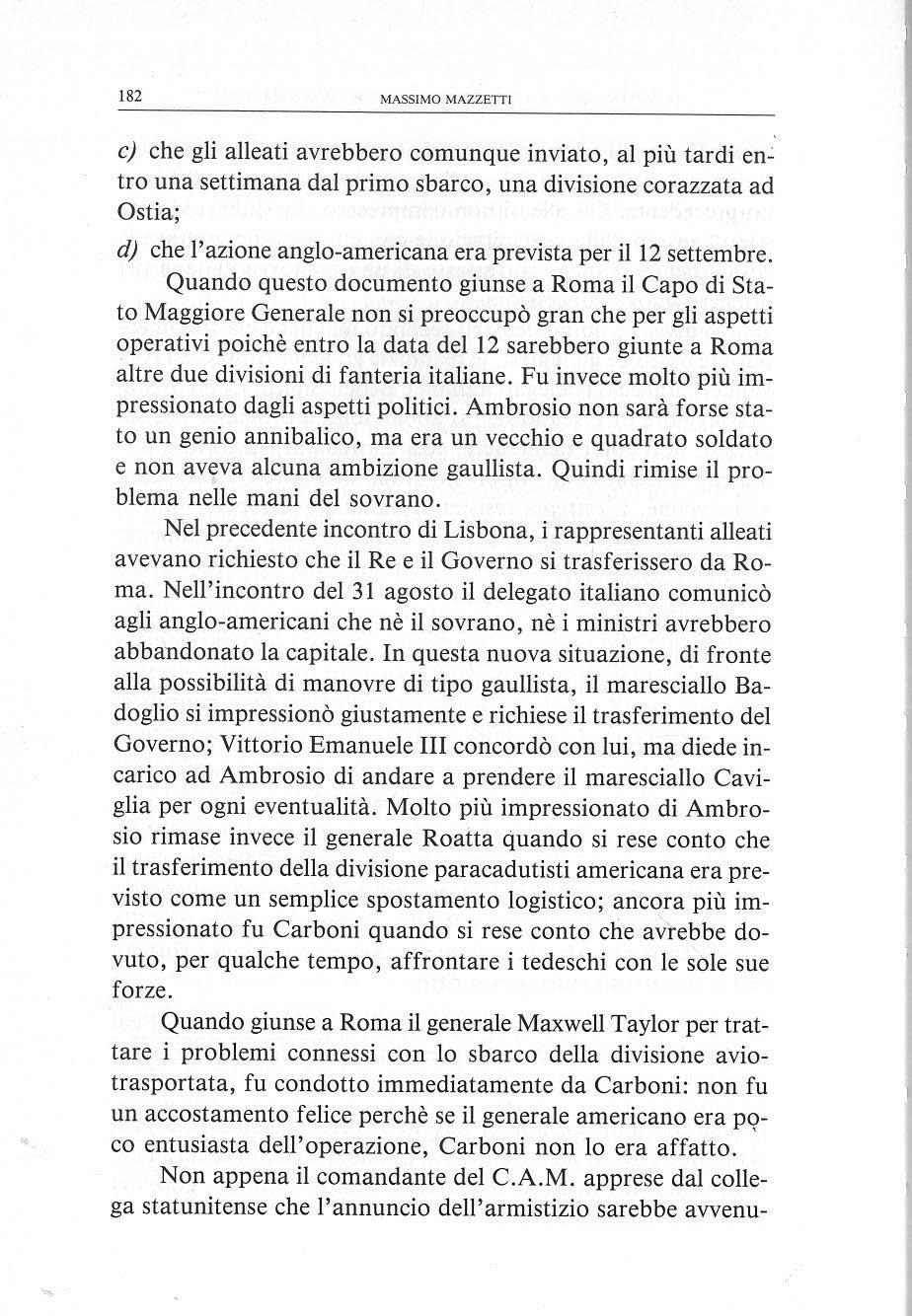
Nel precedente incontro di Lisbona, i rappresentanti alleati avevano richiesto che il Re e il Governo si trasferissero da Roma. Nell'incontro del 31 agosto il delegato italiano comunicò agli anglo-americani che nè il sovrano, nè i ministri avrebbero abbandonato la capitale. In questa nuova situazione, di fronte alla possibilità di manovre di tipo gaullista, il maresciallo Badoglio si impressionò giustamente e richiese il trasferimento del Governo; Vittorio Emanuele III concordò con lui, ma diede incarico ad Ambrosio di andare a prendere il maresciallo Caviglia per ogni eventualità. Molto più impressionato di Ambrosio rimase invece il generale Roatta quando si rese conto che il trasferimento della divisione paracadutisti americana era previsto come un semplice spostamento logistico; ancora più impressionato fu Carboni quando si rese conto che avrebbe dovut o, per qualche tempo, affrontare i tedeschi con le sole sue forze.
Quando giunse a Roma il generale Maxwell Taylor per trattare i problemi connessi con lo sbarco della divisione aviotrasportata, fu condotto immediatamente da Carboni: non fu un accostamento felice perchè se il generale americano era pqco entusiasta dell'operazione, Carboni non lo era affatto.
Non appena il comandante del C.A.M. apprese dal collega statunitense che l'annuncio dell'armistizio sarebbe avvenu-
t o 1'8 anzichè il 12 settem bre , scavalcand o t u tti i suoi superiori dir ett i, si recò da Badoglio e lo indu sse a rinunciare all'in vio della divi s ione americana.
Il giorno seguente il Comando Supremo itali an o riteneva che a ncora vi fosse lo sp azio per una trattativa ch e accordasse le es igenze alleate con le proprie, rinviando lo s b ar co e l'annunzio dell' armistizio. Eisenh ower non era però disposto a m odificare i s uoi piani; influì forse su ll'att eggiamen to del comandante allea to la conosce nza, attraverso le decrittazioni dei messagg i tedeschi, del fatto che lo sc hieram ento previsto per l'aggressio ne all'Italia era p re ssochè ultimato.
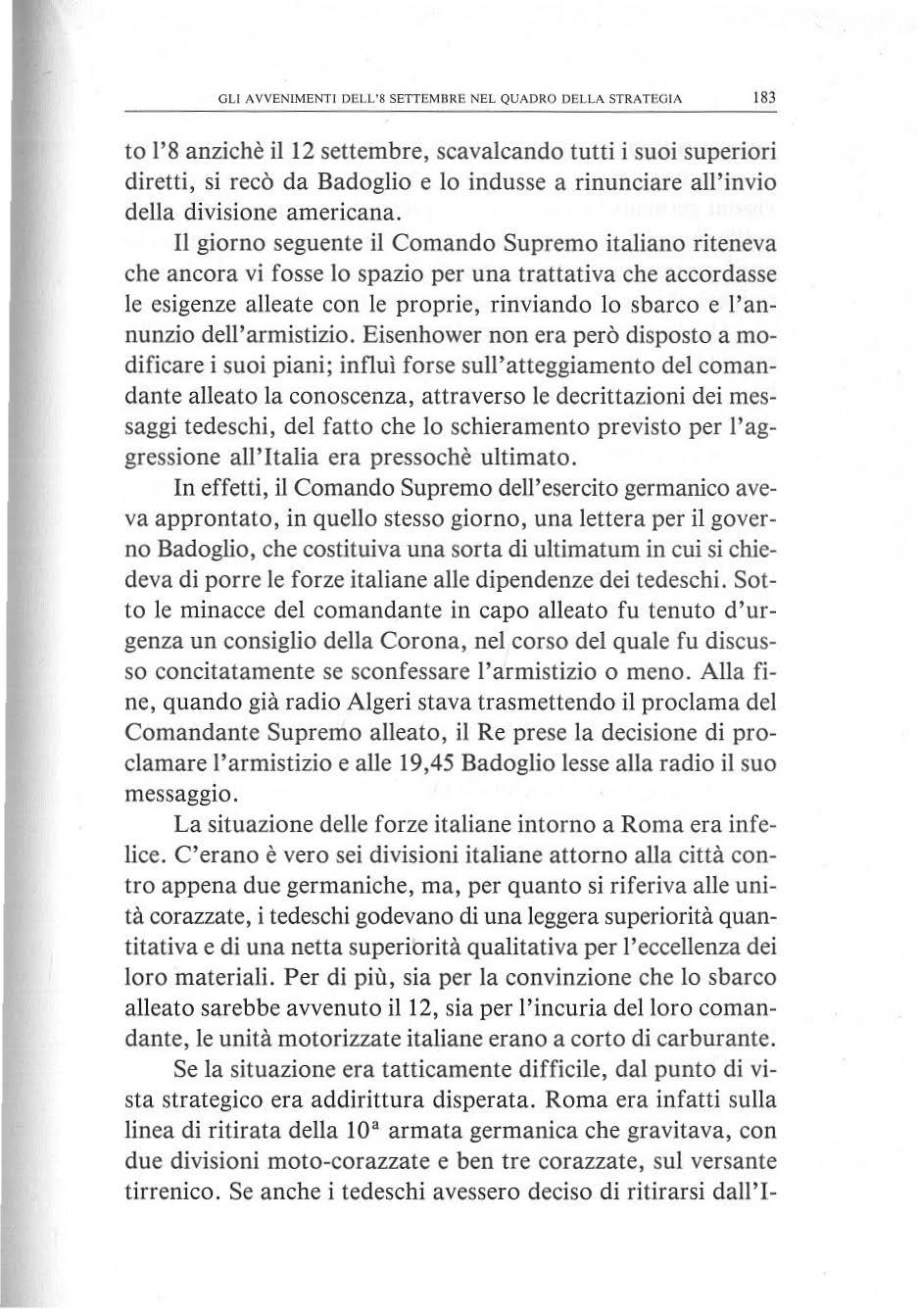
In effetti, il Comando Supremo dell 'ese rcito germanic o aveva a ppront ato, in qu ello stesso g iorno, una letter a per il governo Badoglio, che cost ituiva una so rta di ultimatum in cui si chiedeva di porr e le forze ita liane alle dipendenze dei tedesc h i. Sotto l e minac ce del comandante in capo a ll e ato fu tenuto d'urgenza un co n sig lio della Corona, nel corso del quale fu discusso concitatamente se scon fe ssare l'armist izio o m eno. All a fine, quando già radio Algeri stava t rasm etten do il proclama del Comandante Supremo alleato, il Re prese la deci sione di proclamare l'armistizio e alle 19,45 Badoglio lesse alla rad io il suo m ess aggio.
La situazion e d ell e forze ita liane in torno a Roma e ra in f elice. C'erano è vero sei divisioni italiane attorno alla città contro a ppena due germaniche, ma, per quanto si riferiva alle unità corazzate, i tedeschi godevano di una leggera superiorità quanti tat iva e di una netta s uperiorit à qualitativa per l'eccellenza dei loro materiali. Per di p iù , sia per la convinzione che lo sbarco alleato sarebbe avvenuto il 12 , sia per l'i ncuria del loro comand ante, le unit à motori zzate itali ane erano a corto di carburante.
Se la si tua zion e era tatt ica m ente difficile, dal p u nto di v is ta s trategico era addirittura di s perata. Roma era infatti su lla lin ea di ri t ir ata della 10 3 armata ge rmanica che grav itava , con du e divisioni moto-corazzate e ben tr e corazzate, su l ver sante tirrenico . Se anche i tedeschi avessero d ecis o di ritirarsi dall'I-
talia meridionale per trasferirsi a Nord, avrebbero dovuto necessariamente passare per Roma. Anche nel caso che le due divisioni germaniche stanziate nei pressi della capitale, sorprese dall'annuncio dell'armistizio, si fossero subito ritirate verso nord, restava pur sempre a sud di Roma una forza tale da avere inevitabilmente ragione delle unità italiane.
Quale che potesse essere la reazione iniziale dei tedeschi, era evidente che, una volta riavutisi dalla sorpresa, non avrebbero esitato ad attuare l'ordine di Hitler che imponeva la distruzione dell'esercito italiano.
Se i rapporti di forza erano disastrosi, la situazione psicologica del Comando Italiano era ancora peggiore. Montgomery, commentando una frase di Foch , ha scritto: «Sarei d'accordo sul fatto che una battaglia è perduta solo quando il comandante in capo si è formato questa convinzione, ma un giudizio equilibrato è essenziale» (33).
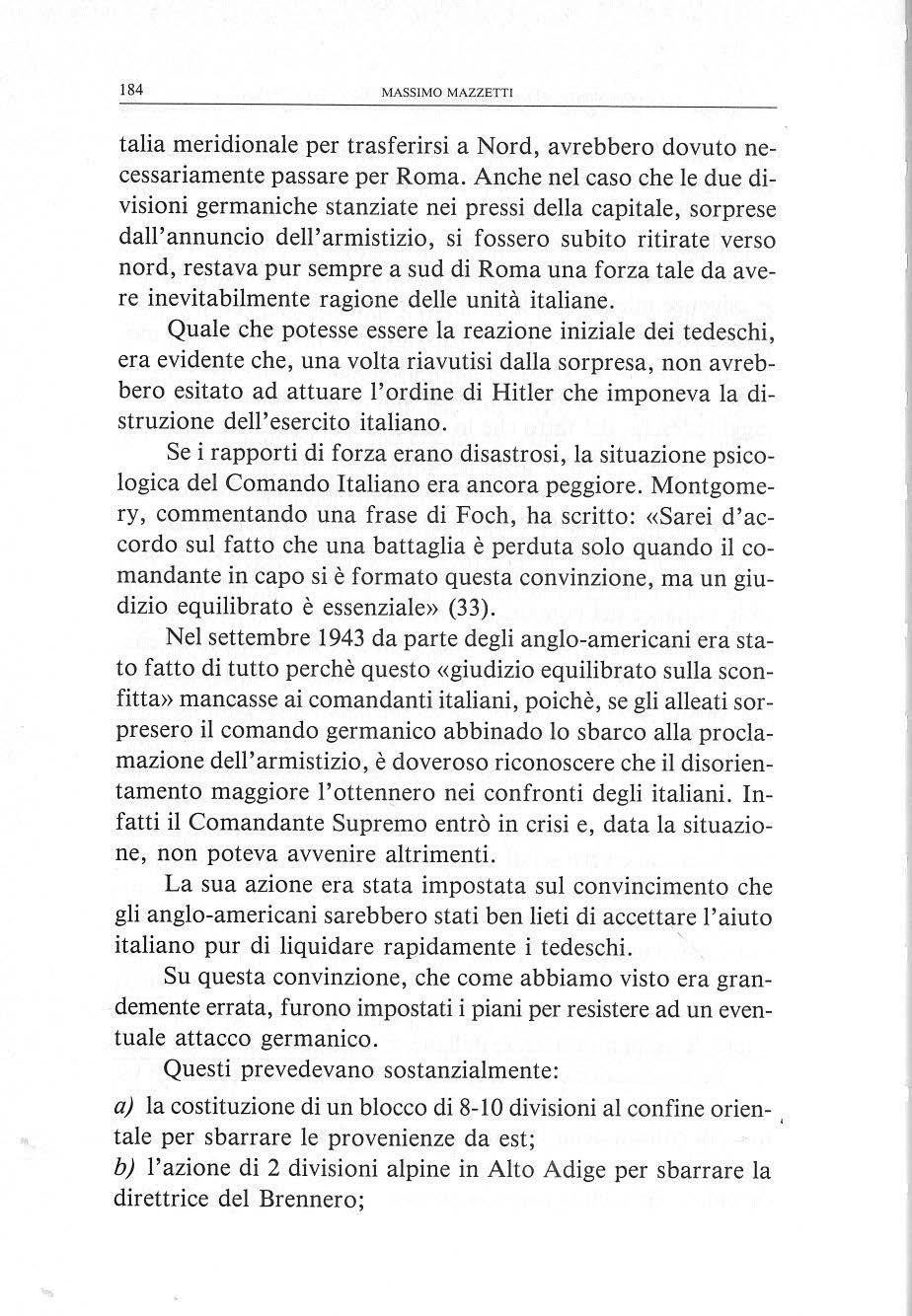
Nel settembre 1943 da parte degli anglo-americani era stato fatto di tutto perchè questo «giudizio equilibrato sulla sconfitta» mancasse ai comandanti italiani, poichè , se gli alleati sorpresero il comando germanico abbinado lo sbarco alla proclamazione dell'armistizio, è doveroso riconoscere che il disorientamento maggiore l'ottennero nei confronti degli italiani. Infatti il Comandante Supremo entrò in crisi e, data la situazione, non poteva avvenire altrimenti.
La sua azione era stata impostata sul convincimento che gli anglo-americani sarebbero stati ben lieti di accettare l'aiuto italiano pur di liquidare rapidamente i tedeschi. '
Su questa convinzione, che come abbiamo visto era grandemente errata, furono impostati i piani per resistere ad un eventuale attacco germanico.
Questi prevedevano sostanzialmente:
a) la costituzione di un blocco di 8-10 divisioni al confine orien- . tale per sbarrare le provenienze da est;
b) l'azione di 2 divisioni alpine in Al t o Adige per sbarrare la direttrice del Brennero;
e) il ripiegamento dalla Francia meridionale della 4a Armata che occupando i passi alpini avrebbe sbarrato le provenienze da ovest.
Ciò avrebbe incapsulato le forze germaniche presenti in Italia, mentre tre blocchi di divisioni avrebbero protetto l'uno la capitale, gli altri due Taranto e La Spe z ia garantendo la sicurezza della flotta e assicurando il possesso di due porti di grande importanza strategica. Da questa concezione operativa nasceva la richiesta fatta, tramite Castellano, da Ambrosio agli alleati di sbarcare con 15 divisioni a nord di Roma. Nonostante che il centro di gravitazione dell'azione fosse stato spostato dagli alleati dal nord al sud della capitale, il piano aveva ancora qualche possibilità di riuscit a. Ma l'ancicipo della comunicazio ne della conclusio ne dell'armistizio lo compromi se definitivamente. I comandi periferici non erano stati ancora sufficientemente orientati, le due divisioni attese a Roma non erano giunte e il co n centramento delle forze del blocco orientale aveva avuto appena un inizio di attuazione. Per qualche ora ci si cullò nell'illusione che, data la contemporaneità dell'armistizio e dello sbarco alleato, i tedeschi si sarebbero ritirati verso nord senza comb att ere; ma quando le iniziative ge rmanich e dimostrarono la vanità di una simile speranza, e il generale Carboni, con grossolana ed erronea valutazione della situazione, avvertì che le sue truppe sta vano per essere sopraffatte, non restò altro che ordinare un precipitoso sgombero del governo e della famiglia Reale. Tuttavia, anche in questo frangente il generale Roa tta riuscì a dare un ordine se nsato: quello dello spostamento delle truppe mobili esistent i intorno a Roma verso l'Abruzzo.
Infatti, la comparsa sul versante adriatico di consistenti forze moto-corazzate italiane, avrebbe avuto importanza risolutiva per lo sviluppo della campagna. I tedeschi avevano in quel momento in Puglia, so lo una d ebole divisione di paracadutisti su cinque battaglioni, che non avrebbe potuto far altro che ripiegare verso l'Appennino per coprire le sp alle delle truppe te-
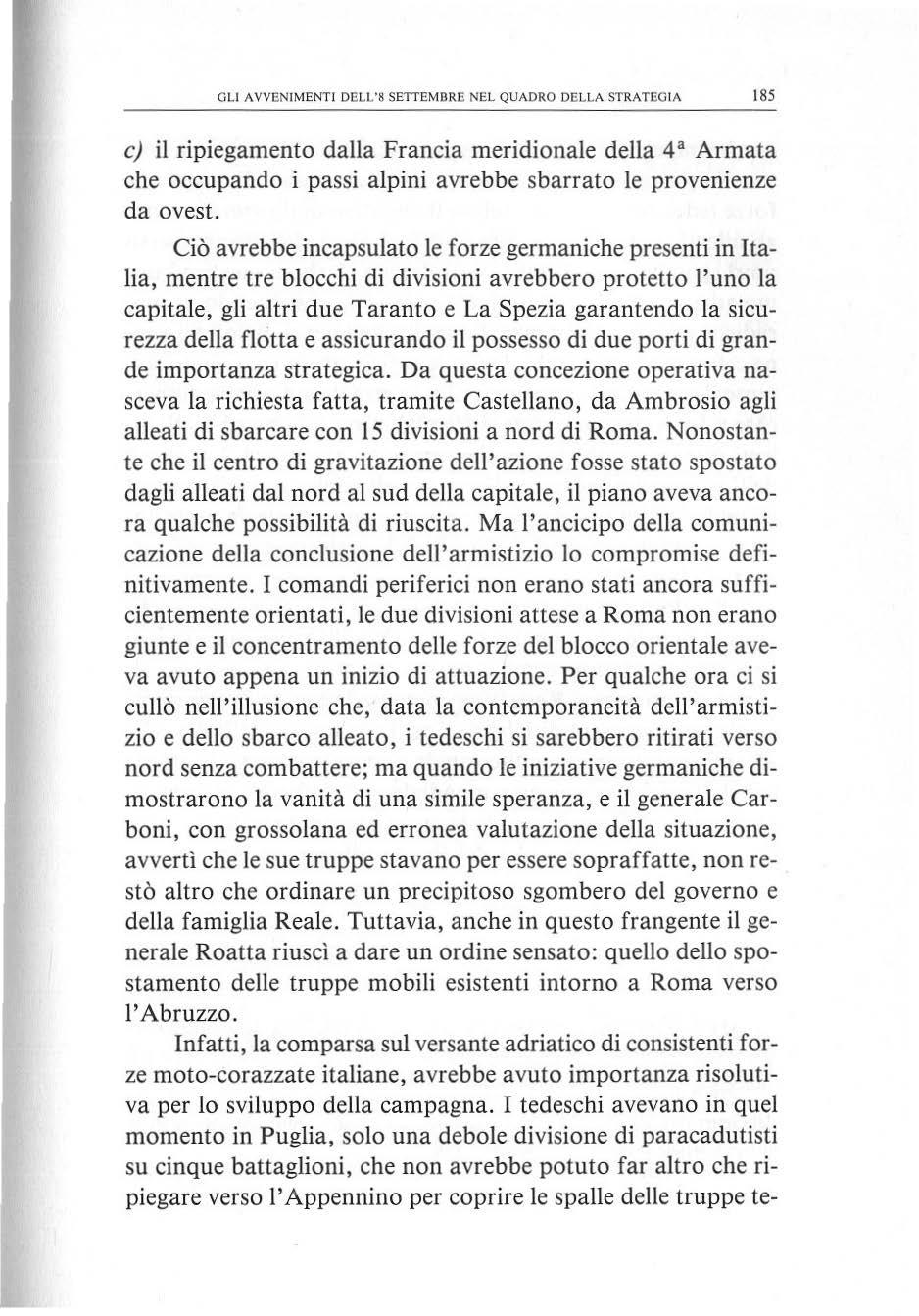
desche impegnate contro gli anglo-americani a Salerno. La dorsale Adriatica sarebbe rimasta così libera fino a Pescara e le forze tedesche, una volta fallito il tentativo di rigettare in mare gli alleati, non avrebbero potuto fare altro che ritirarsi verso nord sgomberando l'Italia centrale; ma Carboni non era l'uomo adatto per attuare un simile piano. Fu così che, dopo sporadiche e isolate resistenze, l'esercito italiano si dissolse o venne catturato dai tedeschi. Il suo sacrificio aveva conseguito soltanto il risultato di permettere alla 5a armata americana di sbarcare a Salerno senza tante difficoltà. Con ciò entrambi gli alleati ottennero ciò che desideravano: gli americani il successo dell'offensiva nonostante l'errata scelta della zona di sbarco, gli inglesi il venir meno di ogni potere contrattuale da parte italiana e conseguentemente l'inevitabile sottoscrizione dell' «armistizio lungo».
Risultati che per il momento potevano apparire notevoli, visto che i tedeschi intendevano ritirarsi sull'Appennino ToscoEmiliano; ma le cose cambiarono rapidamente non appena, alla fine di settembre, Ke sselring convinse Hitler dell'opportunità di resistere a sud di Roma. Così la campagna d'Italia, che avrebbe potuto essere molto rapida e considerevolmente affrettare la fine della II guerra mondiale, si trasformò in una sfibrante guerra di .logoramento in cui si impantanarono per sempre i programmi balcanici del Primo Ministro inglese.
(1) Sull'influenza, in rea ltà nefasta, per la condotta delle operazioni che ebbe Mussolini durante la campagna d'Etiopia, si veda il nostro La politica militare italiana fra le due guerre mondiali, Salerno, 1974 - pp. 169-186.
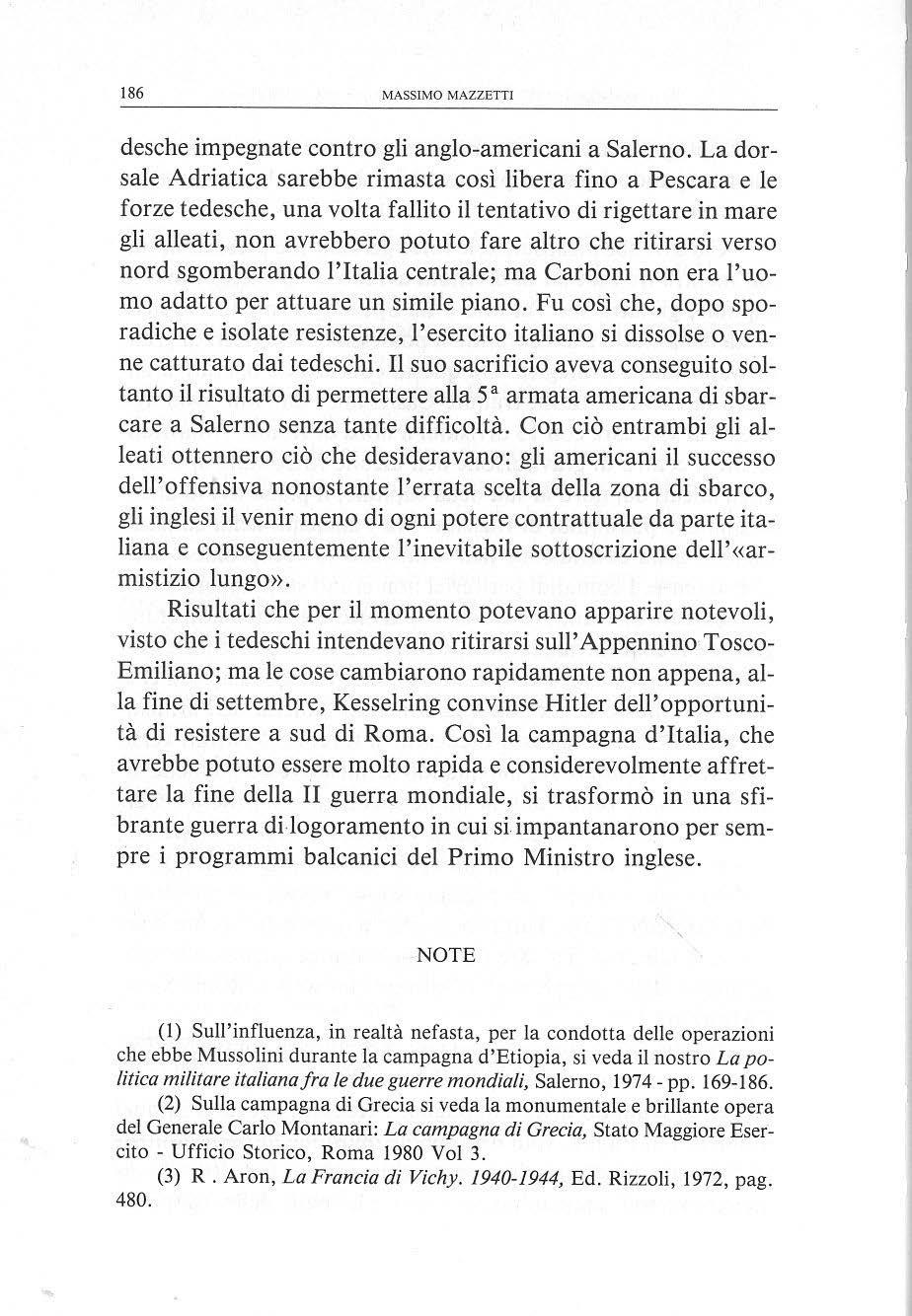
(2) Sulla campagna di Grecia si veda la monumentale e brillante opera del Generale Carlo Montanari: La campagna di Grecia, Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico, Roma 1980 Voi 3.
(3) R. Aron , La Francia di Vichy. 1940-1944, Ed . Ri zzoli, 1972, pag. 480
(4) Ibidem
(5) Ibidem pag. 481; R . Murphy, Un diplomatico un prima linea, Milano 1967, pag. 179 e ss.;
(6) R. Aron, op. cit., pag. 481
(7) R. Murphy, op. cit., pag. 180- 181
(8) B. H. Liddell Hart, Storia Militare della seconda Guerra Mondiale, Milano 1970, pag. 685
(9) Hitler Stratega, a cura di H. Herber, Milano 1966, pag. 154 .
(10) Cfr . A. Speer, Memorie del terzo Reich, Milano 1971, pag. 325.
(11) Hitler Stratega, op. cit., pag. 117.
(12) Ibidem, pag . 153 .
(13) E . Von Rintelen, Mussolini l'alleato, Roma 1952, pag . 201.
(14) E. Faldella, L'Italia nella seconda guerra mondiale, Bologna 1959, pp. 648 -649
(15) Hitler Stratega, op. cit., pag. 217.
(16) Ibidem, pag. 213 .
(17) vedi M. Mazzetti, L'armistizio con l'Italia in base alle relazioni ufficiali anglo-americane, in <<Memorie Storiche Militare 1978», Ufficio Storico SME, Roma , pp. 70-71.
(18) United States Army in World War Il Civil Affairs, Soldiers become Governos, a cura di H. L. Coles e A. K. Weinbery, Washington 1964, pag. 223
(19) Ibidem, pp. 223 -224 .
(20) United States Army in World War II, The Mediterranean Theater of Operations: Sicily and the Surrender of Italy, a cura di A. N. Garland e H. M. Imyth, Washington 1965, pag. 271.
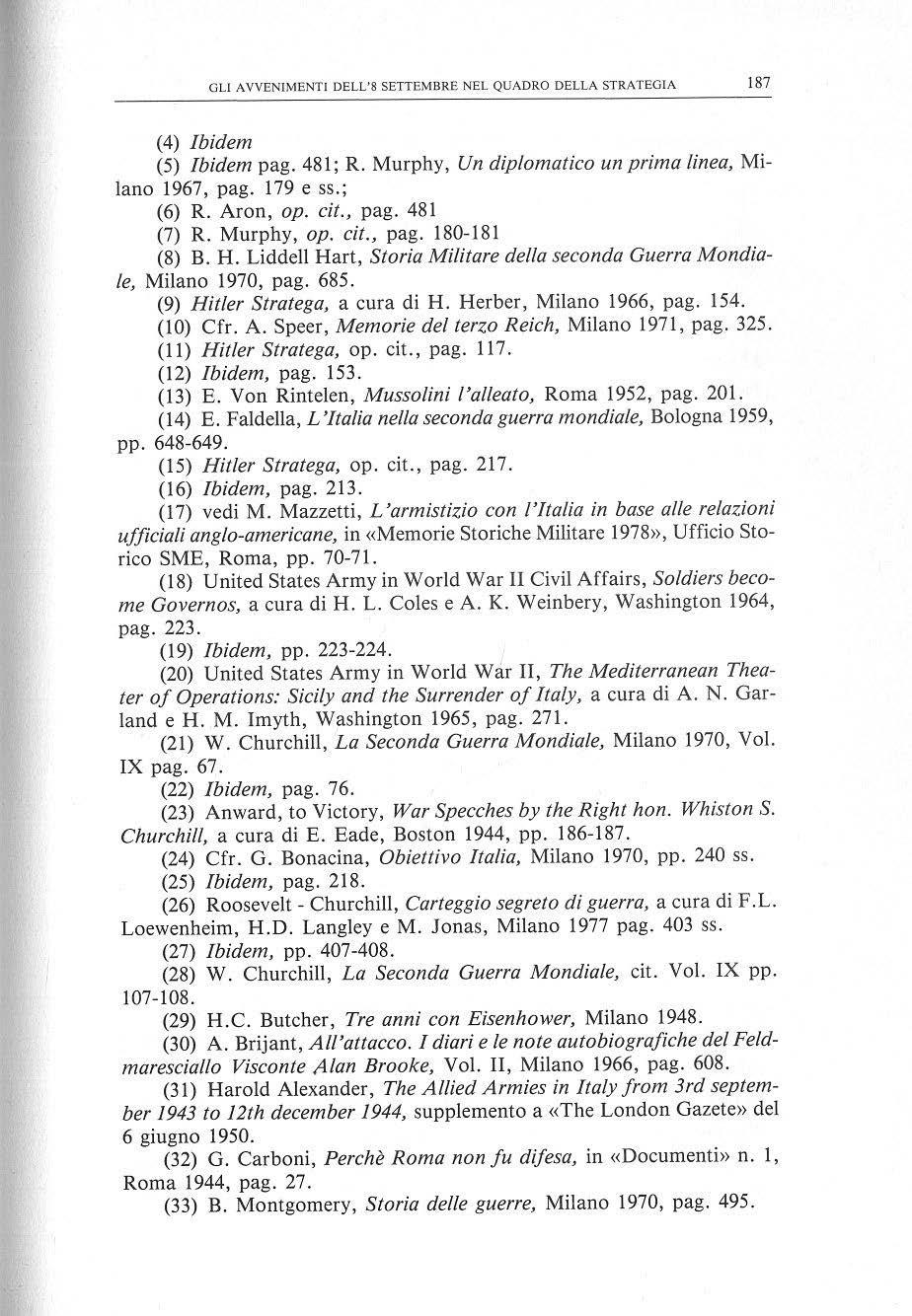
(21) W. Churchill, La Seconda Guerra Mondiale, Milano 1970, Vol. IX pag. 67 .
(22) Ibidem, pag 76.
(23) Anward, to Victory, War Specches by the Right hon . Whiston S. Churchill, a cura di E. Eade, Boston 1944, pp. 186- 187.
(24) Cfr. G. Bonacina , Obiettivo Italia, Milano 1970, pp. 240 ss.
(25) Ibidem, pag. 218.
(26) Roosevelt - Churchill, Carteggio segreto di guerra, a cura di F.L. Loewenheim, H .D. Langley e M . Jonas, Milano 1977 pag. 403 ss .
(27) Ibidem, pp. 407-408.
(28) W . Churchill, La Seconda Guerra Mondiale, cit. Voi. IX pp. 107-108
(29) H . C . Butcher , Tre anni con Eisenhower, Milano 1948 .
(30) A. Brijant, All'attacco I diari e le note autobiografiche del Feldmaresciallo Visconte Alan Brooke, Voi. II, Milano 1966, pag. 608.
(31) Harold Alexander, The Allied Armies in Italy from 3rd september 1943 to 12th december 1944, supplemento a «The London Gazete» de l 6 giugno 1950.
(32) G. Carbon i , Perchè Roma non fu difesa, in «Documenti» n. 1, Roma 1944 , pag . 27.
(33) B. Montgomery, Storia delle guerre, Milano 1970, pag. 495.
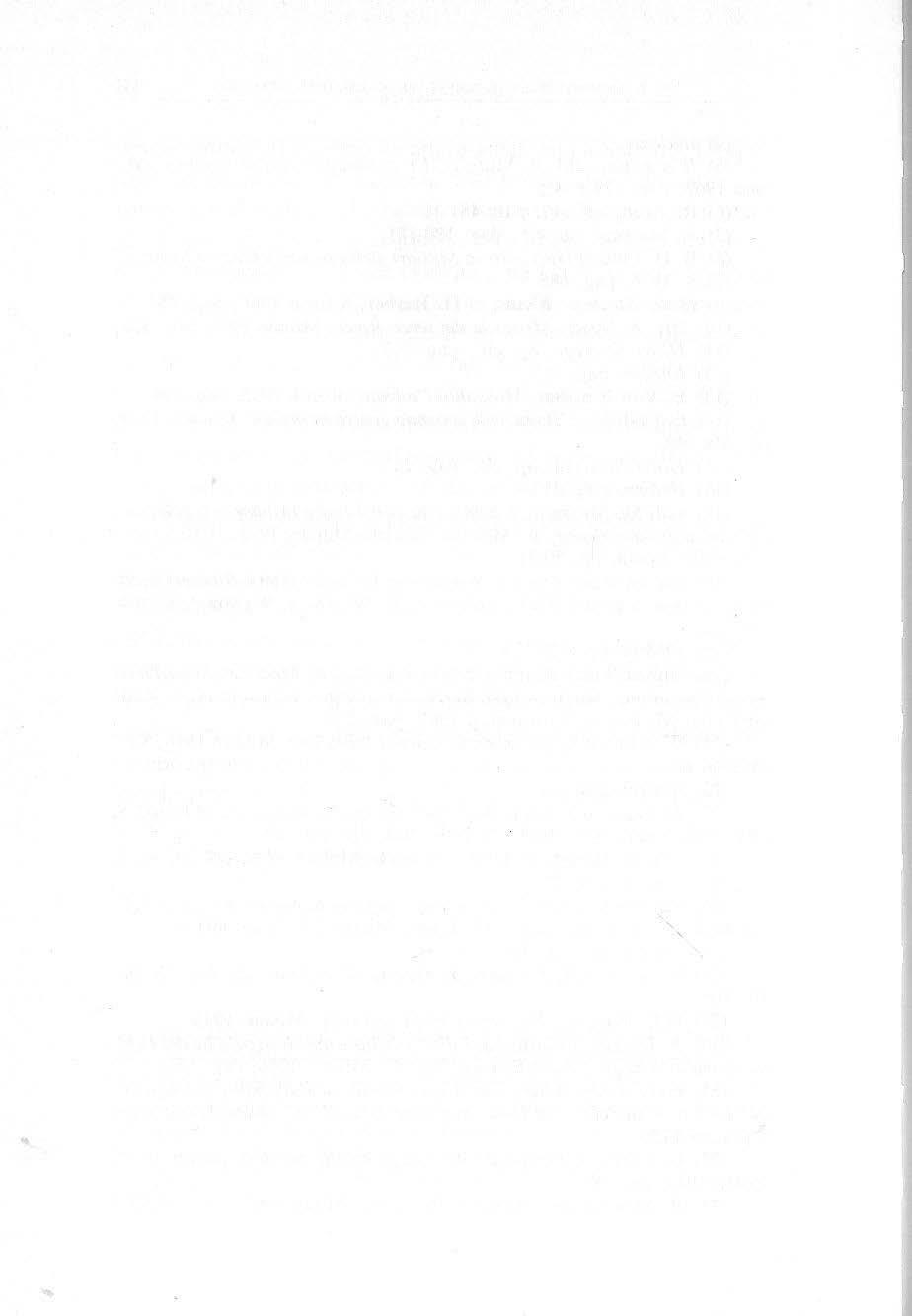
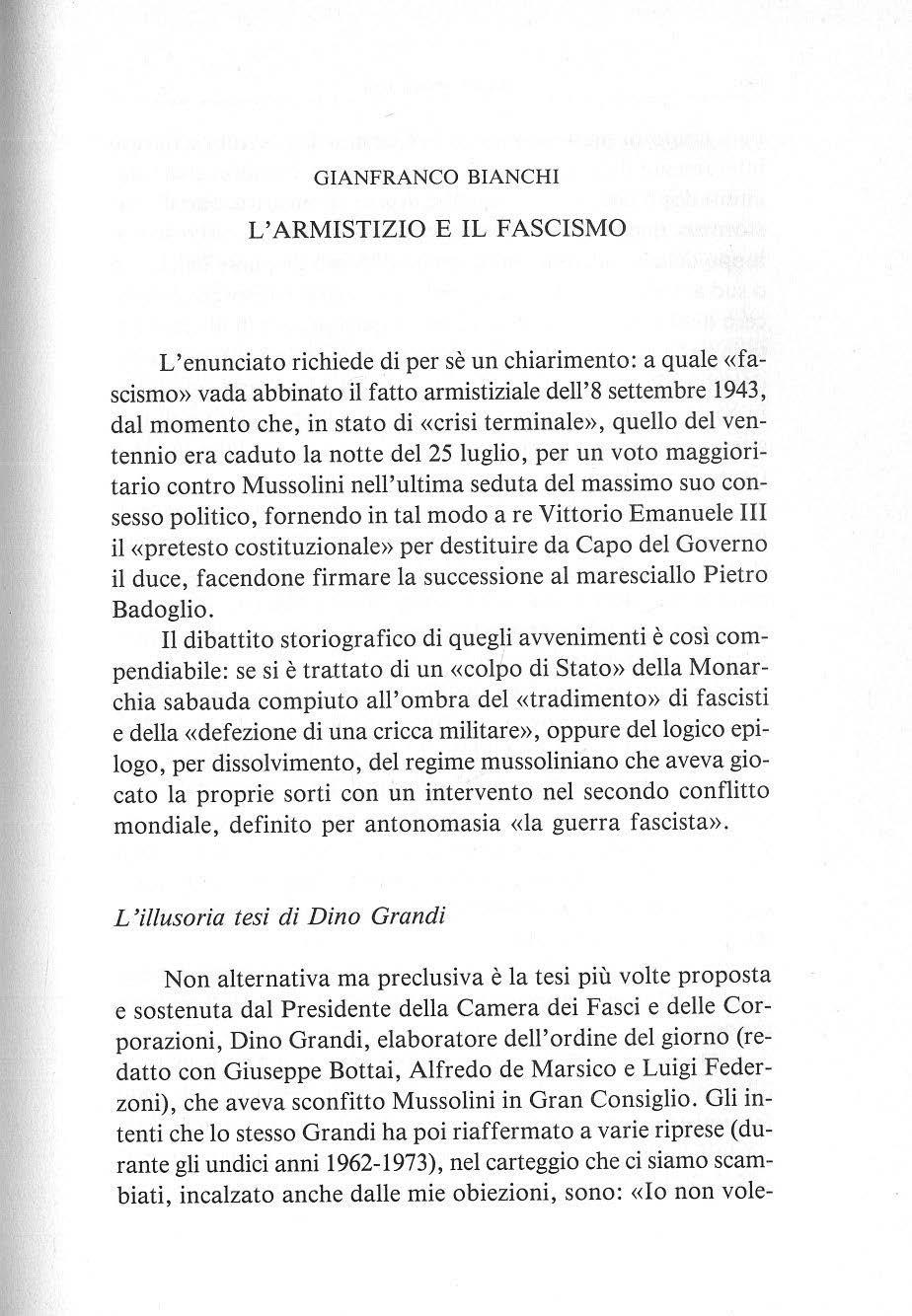
L'enunciato richiede di per sè un chiarimento: a quale «fascismo» vada abbinato il fatto armistiziale de11'8 settembre 1943, dal momento che, in stato di «crisi terminale», quello del ventennio era caduto la notte del 25 luglio, per un voto maggioritario contro Mussolini nell'ultima seduta del massimo suo consesso politico, fornendo in tal modo a re Vittorio Emanuele III il «pretesto costituzionale» per destituire da Capo del Governo il duce, facendone firmare la successione al maresciallo Pietro Badoglio.
Il dibattito storiografico di quegli avvenimenti è così compendiabile: se si è trattato di un «colpo di Stato» della Monarchia sabauda compiuto all'ombra del «tradimento» di fascisti e della «defezione di una cricca militare», oppure del logico epilogo, per dissolvimento, del regime mussoliniano che aveva giocato la proprie sorti con un intervento nel secondo conflitto mondiale, definito per antonomasia «la guerra fascista».
Non alternativa ma preclusiva è la tesi più volte proposta e sostenuta dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Dino Grandi, elaboratore dell'ordine del giorno (redatto con Giuseppe Bottai, Alfredo de Marsico e Luigi Federzoni), che aveva sconfitto Mussolini in Gran Consiglio. Gli intenti che lo stesso Grandi ha poi riaffermato a varie riprese (durante gli undici anni 1962-1973), nel carteggio che ci siamo scambiati, incalzato anche dalle mie obiezioni, sono: «Io non vole-
vo il colpo di mano complice la Corona. Ciò avrebbe falsato interamente il carattere della nostra azione. I militari, sopraggiunti dopo che il Sovrano ebbe deciso, si incaricarono di trasformare quello che nei nostri intendimenti doveva essere lo sviluppo della situazione, in un colpo di Stato da paese balcanico o sud americano. Questi capi militari codardi e disprezzabili fecero di più: mentre la nostra preoccupazione era di liberare l'Italia dalla guerra concentrando le responsabilità solamente sul decaduto Regime fascista, furono essi ad addossarle agli italiani con la frase ''la guerra continua''. Le responsabilità di una guerra che la popolazione non aveva voluto e «dalla quale il Gran Consiglio intendeva liberarli».
Inoltre Grandi pensava a un immediato cambiamento di fronte per mettere gli angloamericani da vanti al fatto compiuto e, quindi, porli nell'impossibilità di chiedere la «resa senza condizioni» decisa alla Conferenza di Casablanca, perchè ormai superata: così avremmo fatto causa comune con loro, contro le truppe di Hitler.
Una settimana prima, nell'incon t ro col duce a villa Gaggia, il Fuhrer aveva sostenuto l'impossibilità di inviare i rinforzi richiesti dal generale Ambrosio. Invece il 26 luglio, forzato il Brennero nella notte, reparti germanici in formazione di combattimento irrompono nell'Alto Adige e, incuranti di reazioni e proteste italiane, impongono di far proseguire i loro convogli verso il Sud, lasciando presidi a guardia delle più importanti opere viarie, assumendo il controllo delle centrali teJefoniche, telegrafiche ed elettriche.
Era illusione di Grandi che gli Alpini stessero arroccati dietro il «Vallo del Littorio», pronti e fedeli al motto «di qui non si passa».
Attraverso la riviera ligure di Ponente, per il Cenisio e per il Piccolo San Bernardo stavano calando le Divisioni tedesche, frammiste a reparti delle SS e a quelli della Guardia del corpo «Adolf Hitler». Senza preavviso, una Divisione paracadutisti arrivò dalla Francia fino a sud di Roma. Alle proteste del ge-

nerale Ambrosio, l'addetto militare germanico nella Capitale e il maresciallo Kesselring rimasero evasivi.
In questa prospettiva, seguirono i due incontri diplomatici e militari italo-tedeschi al Brennero e a Bologna, con reciproco fallito tentativo di ingannare l'interlocutore, perfettamente convinto del contrario di quanto gli veniva detto.
Nel frattempo, Grandi continuò a ritenersi adatto e idoneo (e lo ripeterà anche di recente, benchè la documentazione storico-militare e diplomatica abbia comprovato che le determinazioni prese dagli Angloamericani erano irreversibili), a «contattare>> i Capi missione di Madrid e di Lisbona per negoziare una nostra uscita «indolore» dalla «guerra fascista».
A onor del vero, è la stessa opinione che Grandi aveva manifestato a Badoglio con una lettera autografa datata O porto 27 settembre 1943: «Desidero farti pervenire l'espressione della mia solidarietà . Questa dichiarazione non è determinata da alcun altro sentimento o motivo se non quello che deve anima- . re e sospingere tutti gli italiani: il dovere di raccogliersi silenziosamente e fedelmente intorno al Re ed al suo Governo in quest'ora così grave per il presente e per l'avvenire della nostra Patria.
«Credo di avere servito il mio Re ed il mio Paese. Nessun altro sentimento o pensiero mi hanno guidato quando ho preso personalmente la decisione con tutti i rischi e le responsabilità, di restaurare la Costituzione attraverso l'unico organo che la legge contemplava, e alla prima occasione in cui si presentava possibile. E ciò perchè l'Italia possa schierarsi attivamente a fianco della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Il che apparirà ancora più evidente il giorno in cui l'Italia sarà liberata col diretto contributo, per merito del valore dei nostri so ldati, da la tirannia tedesca e anche da coloro che sotto la protezione delle armi tedesche hanno oggi instaurato una pseudo-repubblica anarchica, dimostrando in quest'ora di sventura nazionale di essere animati non da amore di Patria, ma da cieco odio di fazione» (1).
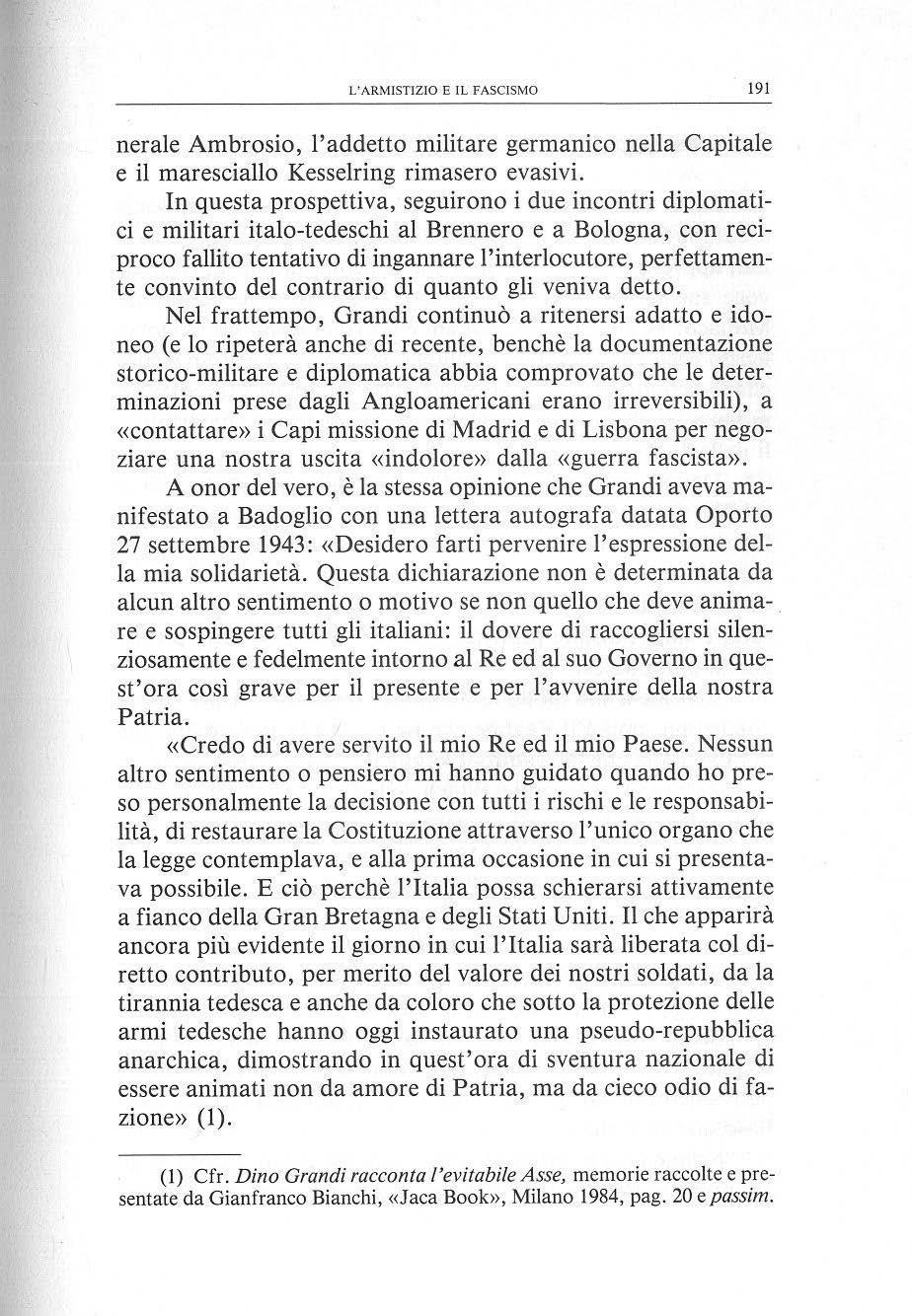
Dalla Germania dove era stato trasvolato dalla prigionia a Campo Imperatore con uno scenografico rapimento, Mussolini, appreso che Hitler lo avrebbe rispedito in patria, con una voce spenta e dal tono irriconoscibile, così dice da RadioMonaco: «Camicie nere, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio ecco che di nuovo vi giunge la mia voce e sono sicuro che la riconoscerete : è la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della Patria».
Dopo accenni a fatti personali, passa all'esame delle responsabilità fasciste e non. «Anzi, mentre rivendichiamo in pieno le nostre responsabilità, vogliamo precisare quelle degli altri, a cominciare dal Capo dello Stato. È la stessa monarchia che durante tutto il periodo della guerra, pur avendola il Re dichiarata, è stata l'agente principale del disfattismo e della propaganda antitedesca».
Evocate a suo modo le premesse, conclude: «Date queste condizioni, non è il Regime che ha tradito la monarchia, ma la monarchia che ha tradito il Regime». Quattro i nuovi doveri: «1) riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri Alleati; 2) preparare senza indugio la riorganizzazione delle nostre Forze Armate intorno alla formazione della Milizia; 3) elim inare i traditori in particolar modo quelli che fino alle 21,30 del 25 luglio militavano talora da parecchi anni nelle file del Partito e sono passati nelle file del nemico; 4) annientare le plutocrazie parassitarie e fare del lavoro, finalmente, il soggetto dell'economia e la base infrangibile dello Stato».
Sempre da una stazione radio del Terzo Reich, e dopo il secondo rabbuffo di Hitler, Mussolini annuncia di assumere nuovamente «oggi, 15 settembre 1943, la suprema direzione del Fascismo in Italia».
Nomina Alessandro Pavolini «alla carica provvisoria di segretario del Partito Repubblicano Fascista»; ripristina «tutte

le istituzioni del Partito con i seguenti compiti: a) appoggiare efficacemente e cameratescamente l'esercito german ico che si batte su l suolo italiano contro il comune nemico; b) dare al popolo immediata, effettiva assistenza morale e materiale; e) riesaminare la posizione dei membri del Partito di fronte al colpo di Stato della capitolazione e del disonore, punendo esemplarmente i vili e i traditori». Ordina pure «la ricostituzione di tutti i reparti e le formazioni speciali della Milizia Volontaria per la Sicurezza dello Stato» il cui comando verrà affidato al generale Renato Ricci, più noto come capintesta dell'Opera Nazionale Balilla.
Il 17 settembre «il PFR libera gli ufficiali delle Forze Armate dal giuramento fatto al re, il quale, capitolando e abbandonando il suo posto, ha consegnato la Nazione al nemico, trascinandola nella vergogna e nella miseria».
Il 1° ottobre il maresciallo Rodolfo Graziani parla al Teatro Adriano di Roma agli ufficiali dell'ex regio esercito. Come scriverà il proconsole di Hitler, vo n Rahn, a opporsi a Badoglio e al Re per aderire alla Repubblica di Salò costui «un pò vi fu spinto e vi scivolò». Comunque, il suo primo discorso contro «l'infedeltà e il tradimento che hanno deturp ato la bandiera d'Italia» è un atto di fede nel nazi fascismo.
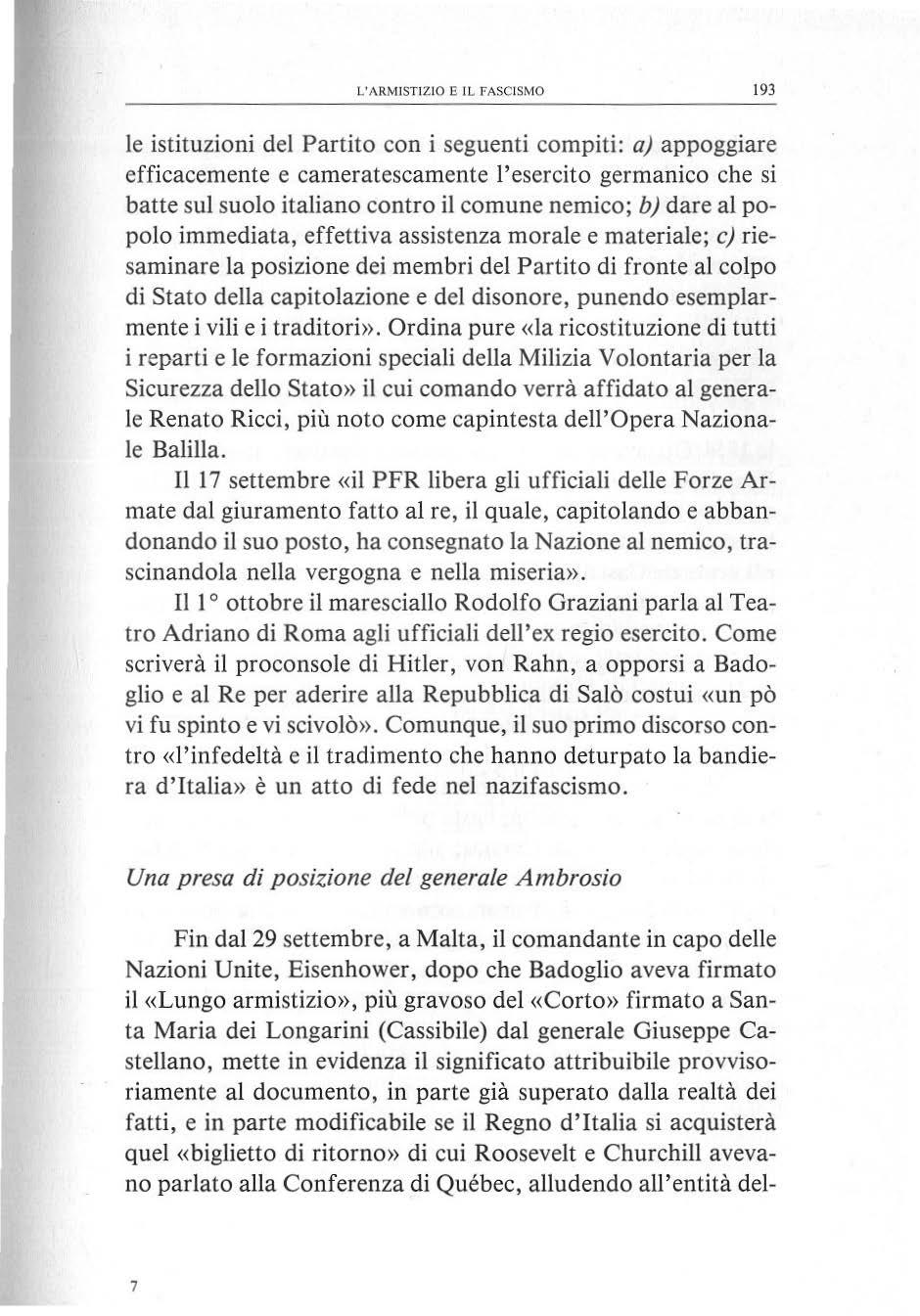
Fin dal 29 settembre, a Mal ta, il comandante in capo delle Nazio ni Unite, Eisenhower , dopo che Badoglio aveva firmato il «Lungo armi stizio» , più gravoso del «Corto» firmato a Santa Maria dei L ongarini (Cassibile) dal generale Giuseppe Castellano, mette in evidenza il significato attribuibile provvisoriamente al documento , in parte già superato dalla realtà dei fatti, e in parte modificabile se il Regno d'Italia si acquisterà quel «biglietto di ritorno» di cui Roosevelt e Churchill avevano parlato alla Conferenza di Québec, alludendo all ' entità del-
l'effettiva collaborazione, poi denominata «Co-belligeranza». In particolare Eisenhower aveva fatto riconoscere a Badoglio che i militari italiani erano già oggetto di offesa bellica tedesca alla quale si doveva reagire con una dichiarazione di guerra. Oltretutto affinchè quanti già si battevano alla macchia non fossero considerati e trattati come «franchi tiratori». Di recente è stato ripetuto che l'intralcio alla dichiarazione di guerra al Terzo Reich sarebbe dovuto a Vittorio Emanuele III. Risulta invece da un documento originale «Segreto» su carta intestata «Comando Supremo» con numero di protocollo 1854/0p, avente in indirizzo il duca Acquarone, ministro della Real Casa e per oggetto la «Dichiarazione di guerra alla Germania», che le riserve provenivano dal generale Vittorio Ambrosio, Capo dello Stato Maggiore, che testualmente scriveva: «Il generale Castellano mi ha trasmesso copia della lettera 240 in data 2 c.m. trasmessa a V.E .. Le comunico in merito il mio punto di vista.
« 1) I vantaggi degli Alleati per la nostra dichiarazione di armistizio sono stati di per se stesso enormi. Se avessimo avuto la nostre Divisioni fra Salerno e le Puglie invece che a Roma, non sarebbero mai sbarcati.
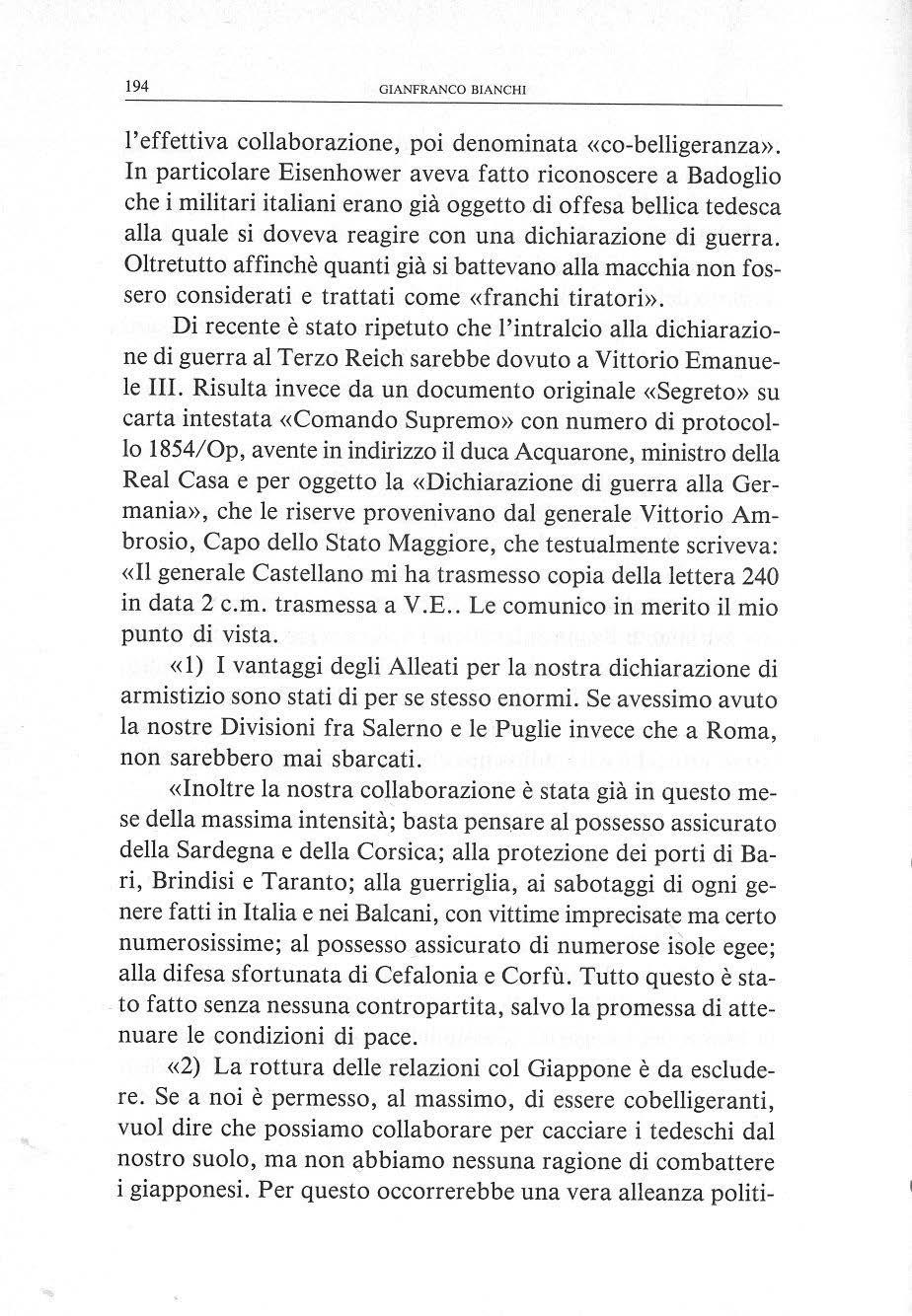
«Inoltre la nostra collaborazione è stata già in questo mese della massima intensità; basta pensare al possesso assicurato della Sardegna e della Corsica; alla protezione dei porti di Bari, Brindisi e Taranto; alla guerriglia, ai sabotaggi di ogni genere fatti in Italia e nei Balcani, con vittime imprecisate ma certo numerosissime; al possesso assicurato di numerose isole egee; alla difesa sfortunata di Cefalonia e Corfù. Tutto questo è stato fatto senza nessuna contropartita, salvo la promessa di attenuare le condizioni di pace.
«2) La rottura delle relazioni col Giappone è da escludere. Se a noi è permesso, al massimo, di essere cobelligeranti, vuol dire che possiamo collaborare per cacciare i tedeschi dal nostro suolo, ma non abbiamo nessuna ragione di combattere i giapponesi. Per questo occorrerebbe una vera alleanza politi-
ca, che non è concessa. La rottura delle relazioni col Giappone, preludio della guerra, cagionerebbe l'invio della nostra flotta a combattere nel Pacifico, ed è questo che loro vogliono e che noi non dobbiamo permettere mai, senza alleanza politica.
«3) La dichiarazione sarebbe in realtà sfruttata .a nostro danno dalla propaganda fascista, in quanto la guerra verrebbe dichiarata da un Governo che ha giurisdizione, per modo di dire, su sette province, che non ha esercito, nè aeronautica, e che ha una flotta comandata dall'ex nemico. La nostra dichiarazione di guerra sarebbe per conseguenza semplicemente platonica.
«4) Alle prossime operazioni su Roma, parteciperanno sì e no 5000 uomini. La sorte dei prigionieri sarà certo dolorosa, ma saranno in numero assolutamente tr"ascurabile di fronte a decine di migliaia che sono morti, o fucilati o di stenti.
«5) Il rimettere sotto la nostra sovranità i territori occupati, fa più comodo agli Alleati che a noi, perchè si disinteresseranno di tutto (viveri, carbone, ordine pubblico, ecc.). Però il provvedimento, nonostante quanto sopra, sarebbe per noi certamente importante, perchè ci consentirebbe di riannodare gradatamente le fila di tutti i servizi del nostro Paese, a mano mano che viene liberato.
«6) Di alleanza politica non è il caso di parlarne, come è detto chiaramente nella lettera dei Capi di Stato.
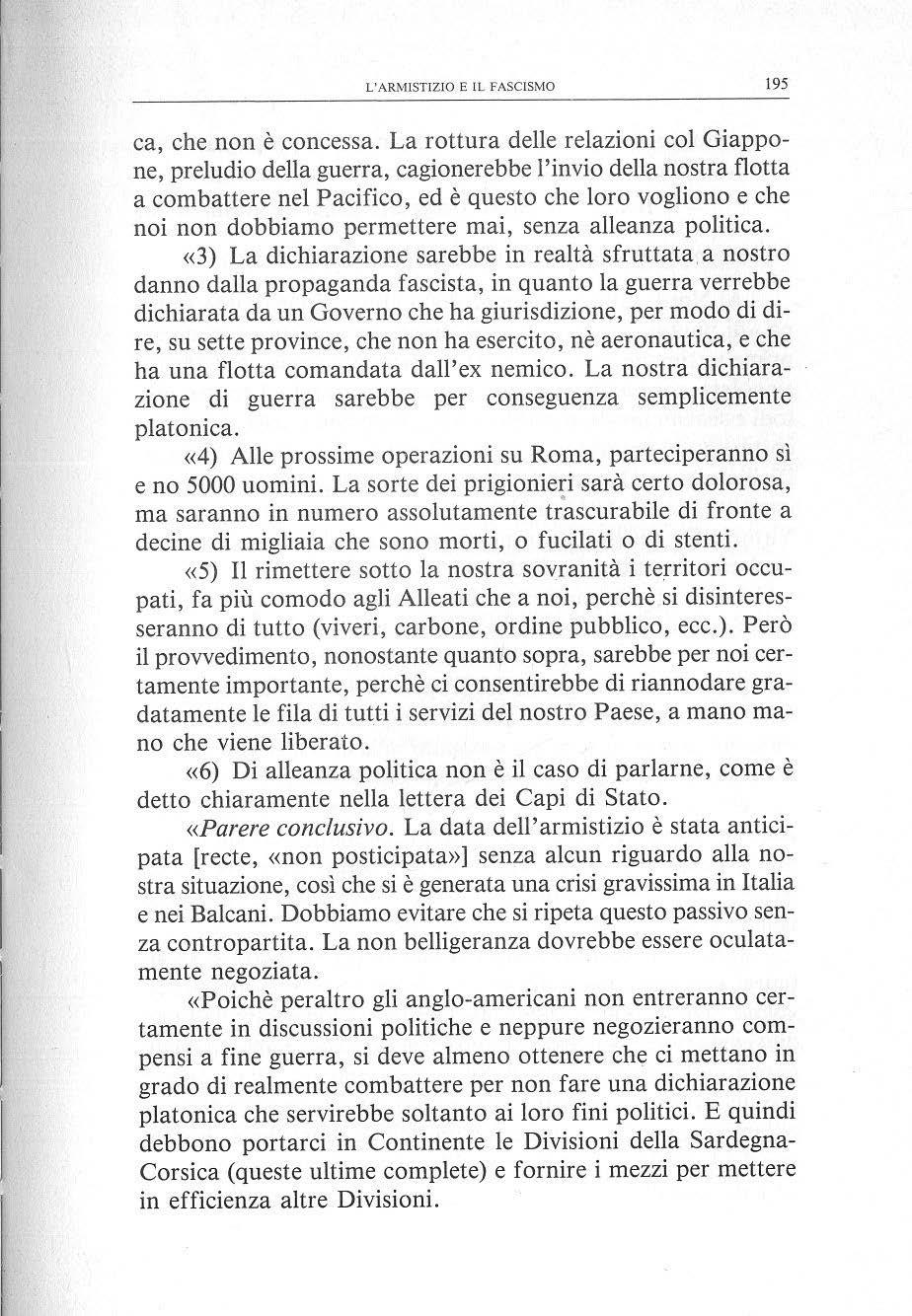
«Parere conclusivo. La data dell'armistizio è stata anticipata [recte, «non posticipata»] senza alcun riguardo alla nostra situazione, così che si è generata una crisi gravissima in Italia e nei Balcani. Dobbiamo evitare che si ripeta questo passivo senza contropartita. La non belligeranza dovrebbe essere oculatamente negoziata.
«Poichè peraltro gli anglo-americani non entreranno certamente in discussioni politiche e neppure negozieranno compensi a fine guerra, si deve almeno ottenere eh~ ci mettano in grado di realmente combattere per non fare una dichiarazione platonica che servirebbe soltanto ai loro fini politici. E quindi debbono portarci in Continente le Divisioni della SardegnaCorsica (queste ultime complete) e fornire i mezzi per mettere in efficienza altre Divisioni.
«Inoltre non dovrebbe essere permessa la propaganda comunista. Niente rottura col Giappone senza alleanza politica. Il Capo di Stato maggiore generale Ambrosio».
I punti antifascisti nei primi «repubblichini»
Al Nord, intanto, la immediata apparizione di una stampa «di punta» neofascista non ancora sottoposta - in quelle prime settimane - a controllo ministeriale rivela coincidenze singolari, per scelta di temi, critiche e riprovazioni contro metodi e sistemi invalsi durante il Ventennio con quelle che allora costavano ai «mormoratori» e agli antifascisti, la relegazione, l'esilio o la condanna del Tribuna le speciale; lo stesso che, ancora il 23 luglio 1943, emise l'ultima sentenza quando ormai Vittorio Emanuele III, in nome del quale si pronunciavano i verdetti, aveva deciso di disfarsi di Mussolini.
La spontanea parola d'ordine sembrava diventata «mai più quel fascismo»! Un fascismo - in realtà l'unico storicamente esistito in concreto in quegli anni del Regno d'Italia - che aveva lasciato proliferare i germi del proprio disfacimento con le nomine dall'alto di immeritevoli e di incapaci, di arrivisti e di tesserati infedeli al giuramento stampato sulla loro tessera del PNF, oltre che di monarchici «potenzialmente traditori».
Ma se per costoro auspicate e promesse erano dure sanzioni, neppure Mussolini poteva esimersi da responsabilità per essersi circondato «dei peggiori tra i fascisti», e di avere lasciato persistere, con le promozioni a scelta, un <<clan» badogliano nell'Esercito.
Esiste pure un fondo costituito da numerose relazioni spontanee, accorate e piene di rancori, destinate a Mussolini «redivivo»: una documentazione che merita di essere tolta dall'inedito come farò in successive pubblicazioni. Essa comprova quanto genuino fosse il «grido di dolore e di vendetta» di cui si fece eco nei primi numeri «II Fascio» foglio ricomparso a Milano
all'annuncio della riorganizzazione delle Camicie nere all'insegna del Littorio repubbl icano: «Mai più quel fascismo, purnirne i responsabili!».
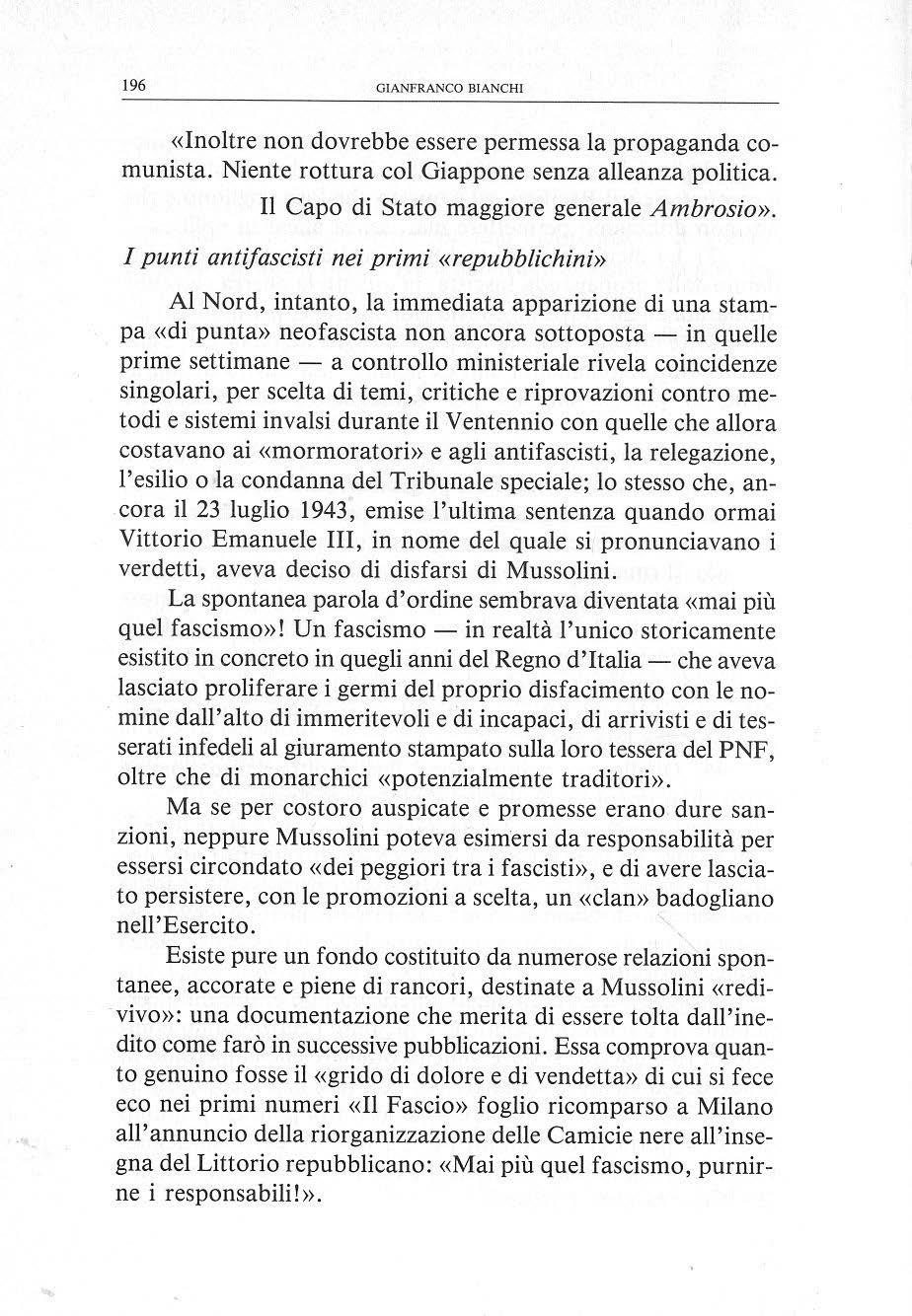
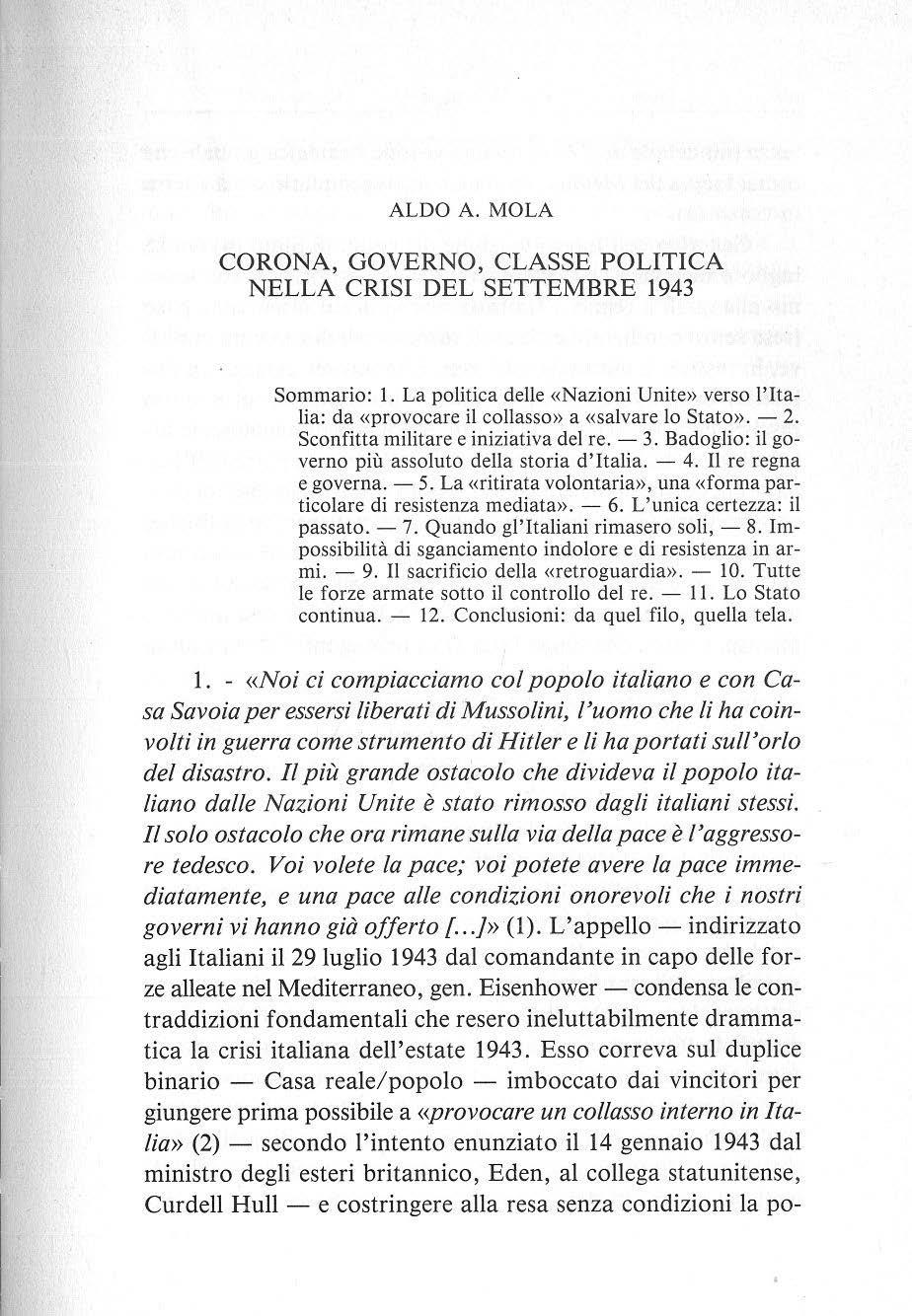
Sommario: I . La politica delle «Nazioni Unite» verso l'Italia: da «provocare il collasso» a «salvare lo Stato». - 2. Sconfitta militare e iniziativa del re. - 3 Badoglio: il governo più assoluto della storia d'Italia. - 4. Il re regna e governa . - 5. La «ritirata volontaria>>, una «forma particolare di resistenza mediata». - 6. L'unica certezza: il passato. - 7. Quando gl'Italiani rimasero soli, - 8 . Impossibilità di sganciamento indolore e di resistenza in armi. - 9. Il sacrificio della «retroguardia». - 10. Tutte le forze armate sotto il controllo del re. - 11. Lo Stato continua. - 12. Conclusioni: da quel filo, quella tela.
1. - «Noi ci compiacciamo col popolo italiano e con Casa Savoia per essersi liberati di Mussolini, l'uomo che li ha coinvolti in guerra come strumento di Hitler e li ha portati sull'orlo del disastro. Il più grande ostacolo che divideva il popolo italiano dalle Nazioni Unite è stato rimosso dagli italiani stessi. Il solo ostacolo che ora rimane sulla via della pace è l'aggressore tedesco. Voi volete la pace; voi potete avere la pace immediatamente, e una pace alle condizioni onorevoli che i nostri governi vi hanno già offerto[ .]» (1). L'appello - indirizzato agl i Italiani il 29 luglio 1943 dal comandante in capo delle forze alleate nel Mediterraneo, gen. Eisenhower - condensa le contraddizioni fondamentali che resero ineluttabilmente drammatica la crisi italiana dell'estate 1943. Esso correva sul duplice binario - Casa reale/popolo - imboccato dai vincitori per giungere prima possibile a <<provocare un collasso interno in Italia» (2) - secondo l'intento enunziato il 14 gennaio 1943 dal ministro degli esteri britannico, Eden, al collega statunitense, Curdell Hull - e costringere alla resa senza condizioni la po-
tenza più debole dell'Asse, in una visione strategica globale che ormai faceva del Mediterraneo un teatro secondario della guerra in corso (3).
Generico nell'interpretazione del colpo di Stato (4) del 25 luglio e mendace nell'ostentazione delle «onorevoli condizioni» alle quali il regno d'Italia avrebbe potuto ottenere la pace (resa senza condizioni e clausole armistiziali duramente punitive, in realtà), il messaggio del gen. Eisenhower perseguiva l'obiettivo di spingere la crisi italiana, dopo la caduta del governo fascista e l'arresto del «duce», all'epilogo ragionevolmente attendibile: la richiesta unilaterale di armistizio da parte dell'Italia. Per contro, come era stato il punto d'intreccio (non di convergenza) tra forze diverse e contrastanti prospettive politiche, così la caduta del governo Mussolini aveva aperto la via non già a un processo univoco, dalle cadenze scontate (richiesta d'armistizio, democratizzazione interna ... ), bensì a una nuova e più aspra fase della lunga lotta fra i protagonisti della caduta del regime e le forze cui essa assicurava nuovo spazio: gli uni e le altre operanti su impulsi di remota germinazione e con prospettive molto più vaste di quanto lasciasse intendere l'incombenza della guerra in corso, con la quale, nondimeno, tutti dovevano pur fare i conti (5).
I sondaggi condotti da singoli personaggi della Corte e da esponenti della dirigenza politico-economica italiana per verificare la disponibilità delle Nazioni Unite a favorire l'usci ta del regno dalla guerra - preminentemente diretti verso il}terlocutori britannici, a conferma dell'ottica italocentrica della guerra prevalente nella tradizione diplomatica nazionalista che insisteva nel considerare il Mediterraneo quale centro dell'attenzione mondiale (6) - pur nel loro costante fallimento (7) avevano fatto comprendere che gli anglo-americani non erano affatto disposti ad avallare - con l'avvio di trattative - la persistenza di un governo fascista o erede politico diretto di quello mussoliniano. L'intransigenza precedentemente ostentata dagli Alleati nei confronti dei regime faceva però gioco al nuovo go-
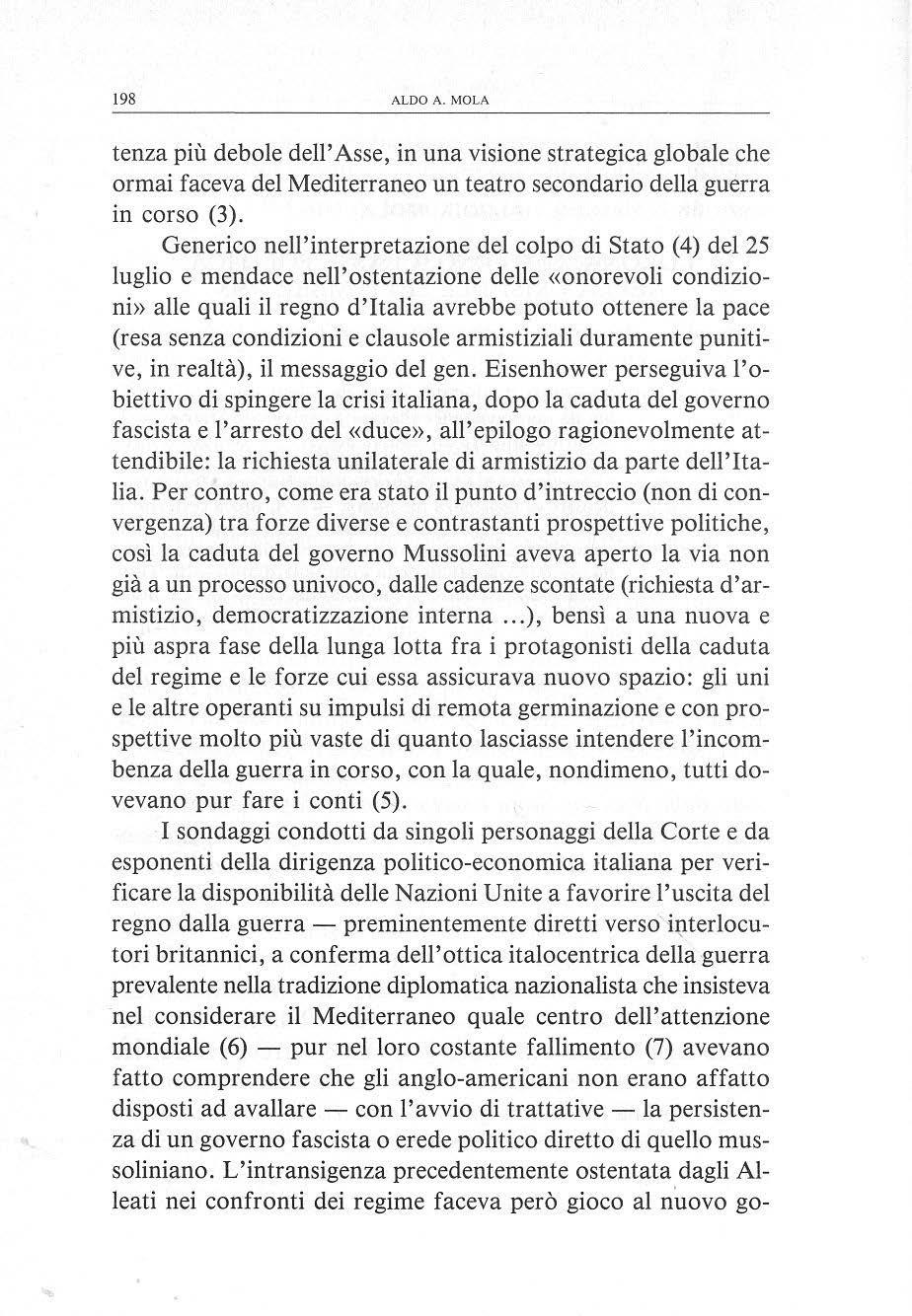
verno italiano, cui sarebbe bastato poco per risultare differente rispetto al precedente. Se ne colsero subito i rilevanti riflessi in merito all'assetto istituzionale, che - come più avanti meglio diremo - costituiva il fulcro del corso politico in via di svolgimento in Italia. Infatti, se ancora nel maggio 1943 il dipartimento di Stato degli Usa riteneva che alla proclamazione della resa «le prerogative della Corona dovessero essere sospese» (8), dopo il 25 luglio il premier britannico Winston Churchill s'affrettò a dichiarare alla Camera dei Comuni, a Londra, che sarebbe stato «un grave errore da parte delle potenze liberatrici, Inghilterra e Stati Uniti, nel momento in cui la situazione italiana [era] in questa situazione aperta, fluida, agire in modo da abbattere e distruggere l'intera struttura ed espressione dello Stato» (9), ovvero la monarchia e il governo del re, pur sì poco rappresentat ivo, composto com'era di militari e «tecnici». A datare dal 1° agosto 1943 , in sintonia col nuovo orientamento nei confronti della situazione italiana, cessava dunque l'impiego, da parte anglo-americana, dell'epiteto di «fascista» sino a quel momento largamente usato per bollare il governo Badoglio, né Vittorio Emanuele III sarebbe più stato liquidato come «piccolo re idiota» (10).
2. - Colti di sorpresa dal colpo di Stato del 25 luglio, gli anglo-americani non avevano tardato a constatare l ' assenza di forze adeguatamente organizzate e immediatamente alternative rispetto al blocco attestatosi al potere. Badoglio, inoltre, proprio con la ferma repressione delle manifestazioni di piazza (11), mostrò di riuscire a tenere la situazione interna sotto controllo : obiettivo - era da credere - tanto più agevole da conseguire quando il governo di Roma non fosse più stato alle prese con la guerra e avesse potuto dedicare tutte le sue energie alla riorganizzazione del Paese . Risultava in tal modo confermata la valutazione formulata sin dal 9 febbraio 1943 da Curdell Hull circa la perdurante debolezza degli antifascisti non monarchici
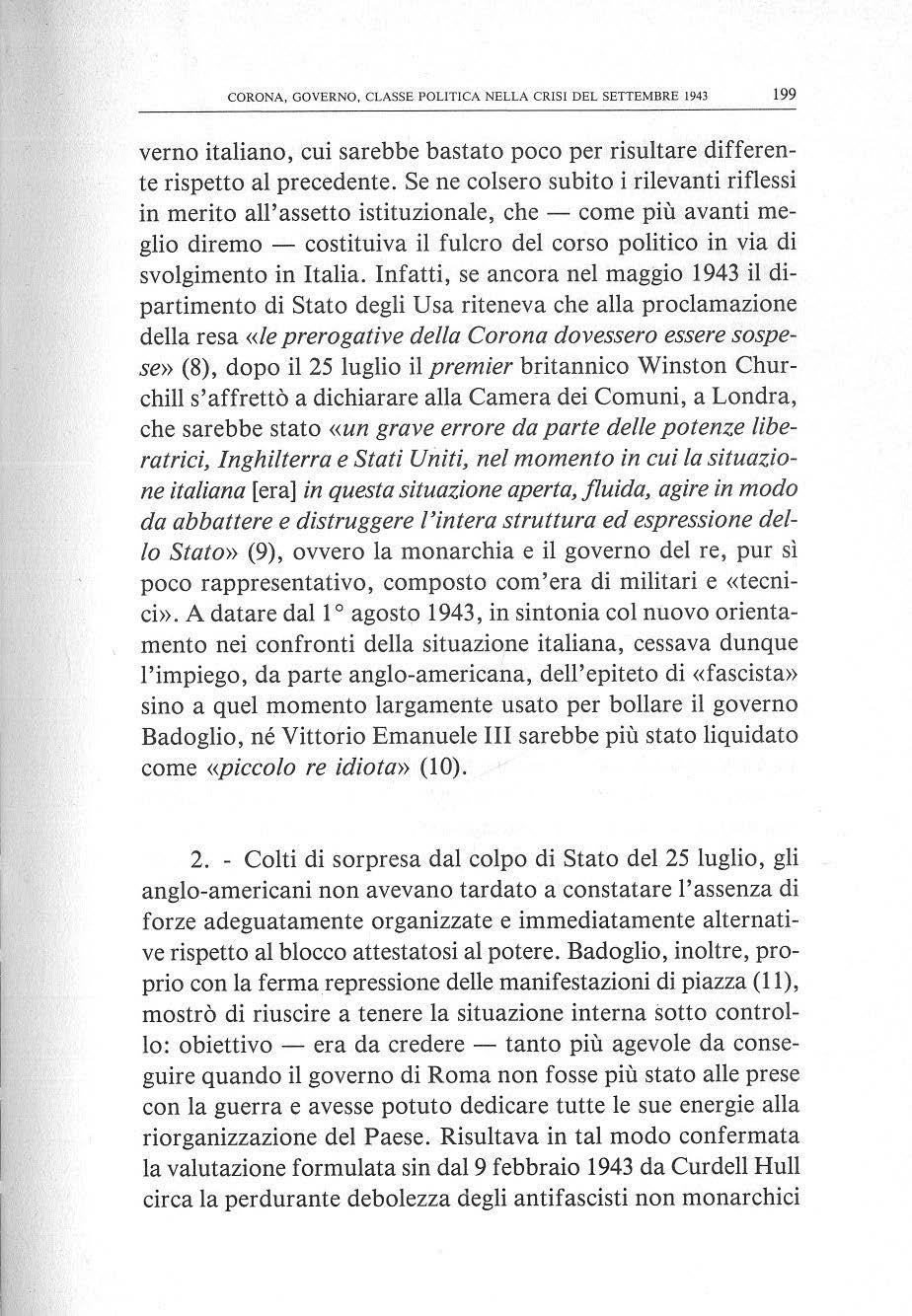
e la solidità, al contrario, di Casa Savoia - «distinta da Vittorio Emanuele III» (12) - attorno alla quale si aggregavano aristocratici, conservatori, esercito, imprenditori, sicché tutto lasciava prevedere ch'essa potesse «conservare il potere sovrano almeno durante il periodo interinale fra il Regime fascista e il suo successore definitivo» (13).
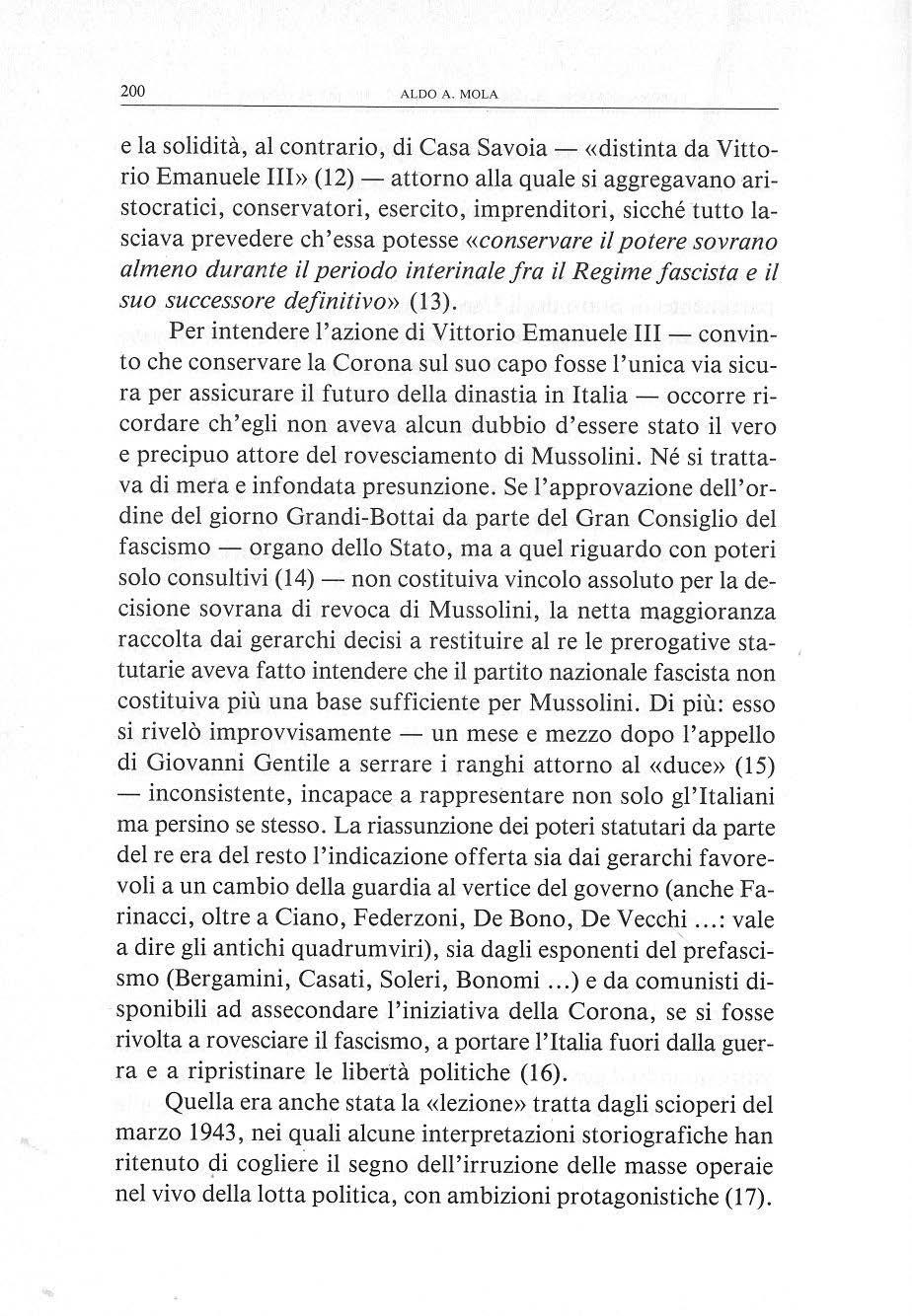
Per intendere l'azione di Vittorio Emanuele III - convinto che conservare la Corona su l suo capo fosse l'unica via sicura per assicurare il futuro della dinastia in Italia - occorre ricordare ch'egli non aveva alcun dubbio d'essere stato il vero e precipuo attore del rovesciamento di Mussolini. Né si trattava di mera e infondata presunzione. Se l'approvazione dell'ordine del giorno Grandi-Bottai da parte del Gran Consiglio del fascismo - organo dello Stato, ma a quel riguardo con poteri solo consultivi (14) - non costituiva vincolo assoluto per la decisione sovrana di revoca di Mussolini, la netta maggioranza raccolta dai gerarchi decisi a restituire al re le prerogative statutarie aveva fatto intendere che il partito nazionale fascista non costituiva più una base sufficiente per Mussolini. Di più: esso si rivelò improvvisamente - un mese e mezzo dopo l'appello di Giovanni Gentile a serrare i ranghi attorno al «duce» ( 15) - inconsistente, incapace a rappresentare non solo gl'Italiani ma persino se stesso. La riassunzione dei poteri statutari da parte del re era del resto l'indicaz ione offerta sia dai gerarchi favorevoli a un cambio della guardia al vertice del governo (anche Farinacci, oltre a Ciano, Federzoni, De Bono, De Vecchi ... : vale a dire gli antichi quadrumviri), sia dagli esponenti del prefascismo (Bergamini, Casati, Soleri, Bonomi ... ) e da comunisti disponibili ad assecondare l'iniziativa della Corona, se si fosse rivolta a rovesciare il fascismo, a portare l'Italia fuori dalla guerra e a ripristinare le libertà politiche (16).
Quella era anche stata la «lezione» tratta dagli scioperi del marzo 1943, nei quali alcune interpretazioni sto riografiche han ritenuto ~i cogliere il segno dell'irruzione delle masse operaie nel vivo della lotta politica, con ambizioni protagonistiche (17).
In realtà, mentre taluno - come l 'amministratore delegato della Fiat, Vittorio Valletta, mirava a ricondurre la protesta nei tradizionali confini della contesa sa lariale (18), la vasta partecipazione all'agitazione di iscritti ai sindacati fascisti indicò che se la soluzione della crisi doveva essere politica, questa andava cercata nell'intervento di una forza in grado di mediare al di sopra dello stesso partito di Mussolini, senza peraltro consegnare il Paese a un antifascismo dai contorni ancora indecifrabili (19). Le dimensioni assunte dagli scioperi, dunque, condussero semmai all'ampliamento e al consolidamento del fronte disposto ad assecondare l'inizia tiva della Corona. Da parte sua il sovrano era perfettamente a conoscenza dell'avversione nei confronti della guerra diffusa in ogni ceto; ma - com'ebbe a riferire il Capo di Stato Maggiore Generale, Pietro Badoglio, nella seduta del Comando supremo del 5 giugno 1940 - non ne era affatto preoccupato. Proprio Vittorio Emanuele III - disse il maresciallo dell'impero - gli aveva ricordato di aver ricevuto nella primavera del 1915 «fasci di lettere contro la guerra» (20), ma non se n'era lasciato condizionare, a differenza dell'ex presidente Giolitti, che perciò non godeva affatto della memore ammirazione del re, secon do la ripetuta testimonianza di Dino Grandi (21).
Il re non aveva dunque dovuto attendere gli scioperi per sapere che cosa effettivamente pensassero e s'attendessero le cosiddette «masse» o per constatare che il regime non contava affatto sul generale «consenso»: condizione, codesta, che non aveva costituito un vincolo neppure per i governi susseguitisi nei primi ventidue anni del suo regno. Nel giudizio del re l'irrequietezza di alcuni ambienti notabilari (senatori, grandi imprenditori, banchieri ... ) faceva par te di quei «fenomeni interni dell'organismo nazionale, i quali - spiegava Vittorio Emanuele III - assomigliano molto a ciò che nell'organismo sono le digestioni, le malattie, le guarigioni, ma non si elevano a fattori determinanti della politica estera», cioè «dell'azione dello Stato in relazione alla politica degli altri Stati» (22): sola «politi-
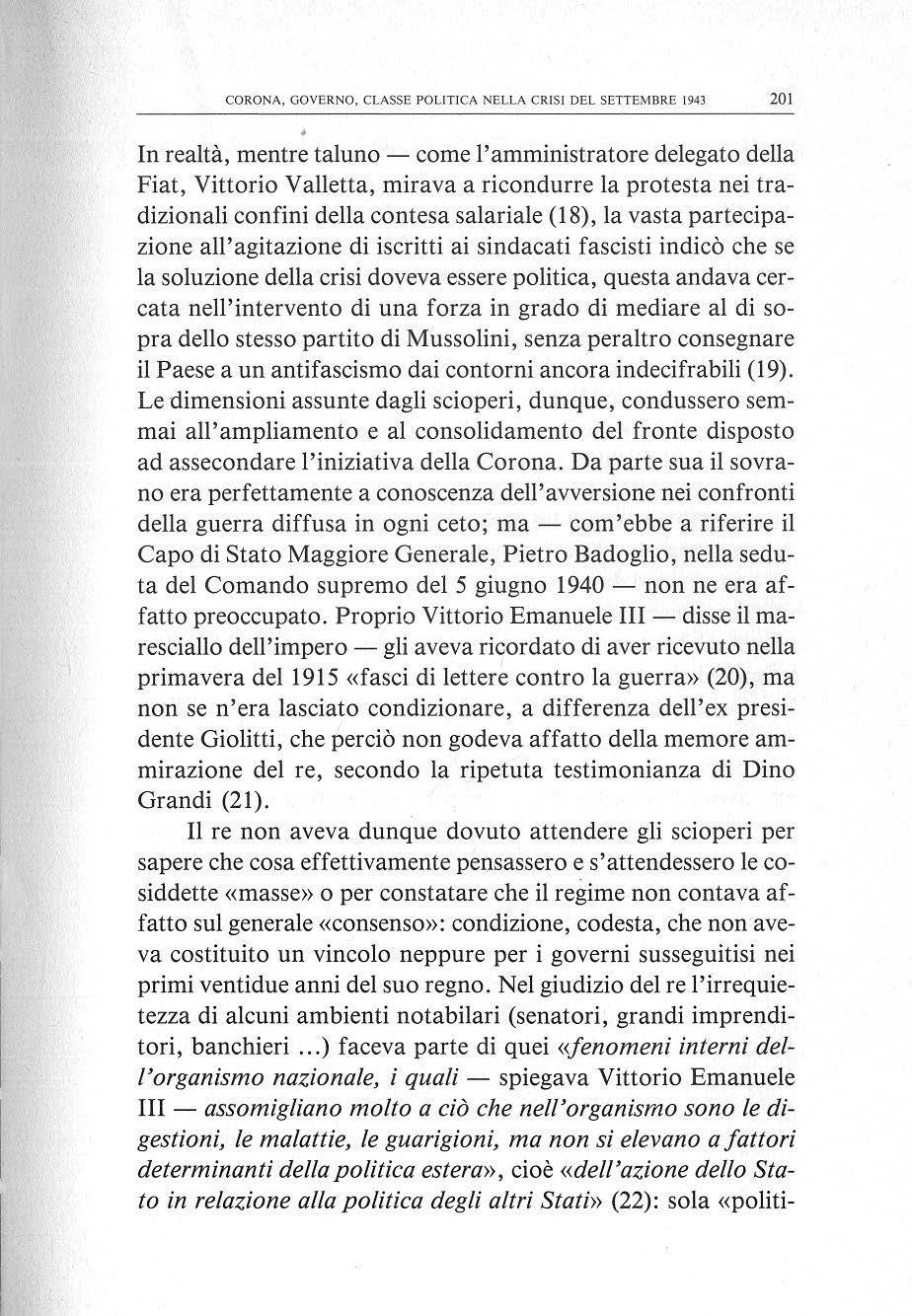
ca» meritevole di attenzione, l'unica atta a consegnare alla storia l'azione dei singoli e i destini dei popoli.
Che anche fra i conservatori prendessero a serpeggiare malumori contro il sovrano e persino affiorassero venature di repubblicanesimo non era in fine motivo di soverchia preoccupazione per un sovrano che più volte, nel corso dei suoi quarantatrè anni di regno, aveva veduto anche i mazziniani più animosi e gli spiriti più indipendenti farsi strenui sostenitori della Corona, quando questa s'era rivelata unico potere effettivamente capace di far superare all'Italia le crisi più impegnative. Non erano infatti divenuti «uomini del re» i radicali d'inizio Novecento, i Barziali e Bissolati (23), i Nitti e i Meda, Arturo Labriola e D'Annunzio? La parlamentarizzazione e l'ascesa al governo del fascismo non s'erano altresì tradotte in una massiccia conversione d~ proposito d'eversione a lealismo monarchico (per quanto interessato)?
Antichi avversari e guardinghi fiancheggiatori erano stati conciliati alla Corona, in passato, con argomenti convincenti: i vistosi progressi sociali e i successi in politica estera dell'età giolittiana e, nel corso della grande guerra, le vittorie militari e la disperata resistenza dopo Caporetto, quando Filippo Turati aveva dichiarato che anche per i socia li sti la patria era sul Piave. Nel luglio 1943, però, il re non aveva da offrire che una grave sconfitta su molti fronti, la perdita delle colonie (comprese quelle conquis.tate prima del fascismo), la prospettiva di perpetua sudditanza nei confronti di un alleato arrogapte e prepotente e, in alternativa, l'invasione del territorio metropolitano, a conclusione di una guerra non desiderata dal Paese e poco gradita a una parte consistente della stessa classe dirigen t e. Poiché, malgrado la paziente attesa del re e dei capi militari, Mussolini non era riuscito a ottenere che un massiccio sforzo germanico capovolgesse le sorti belliche nel Mediterraneo, per Vittorio Emanuele III l'unica via per afferrare nuovamente il controllo della situazione era portare l'Italia fuori dalla guerra: cioè giocare la sconfitta a vantaggio di una rapida stabi liz-
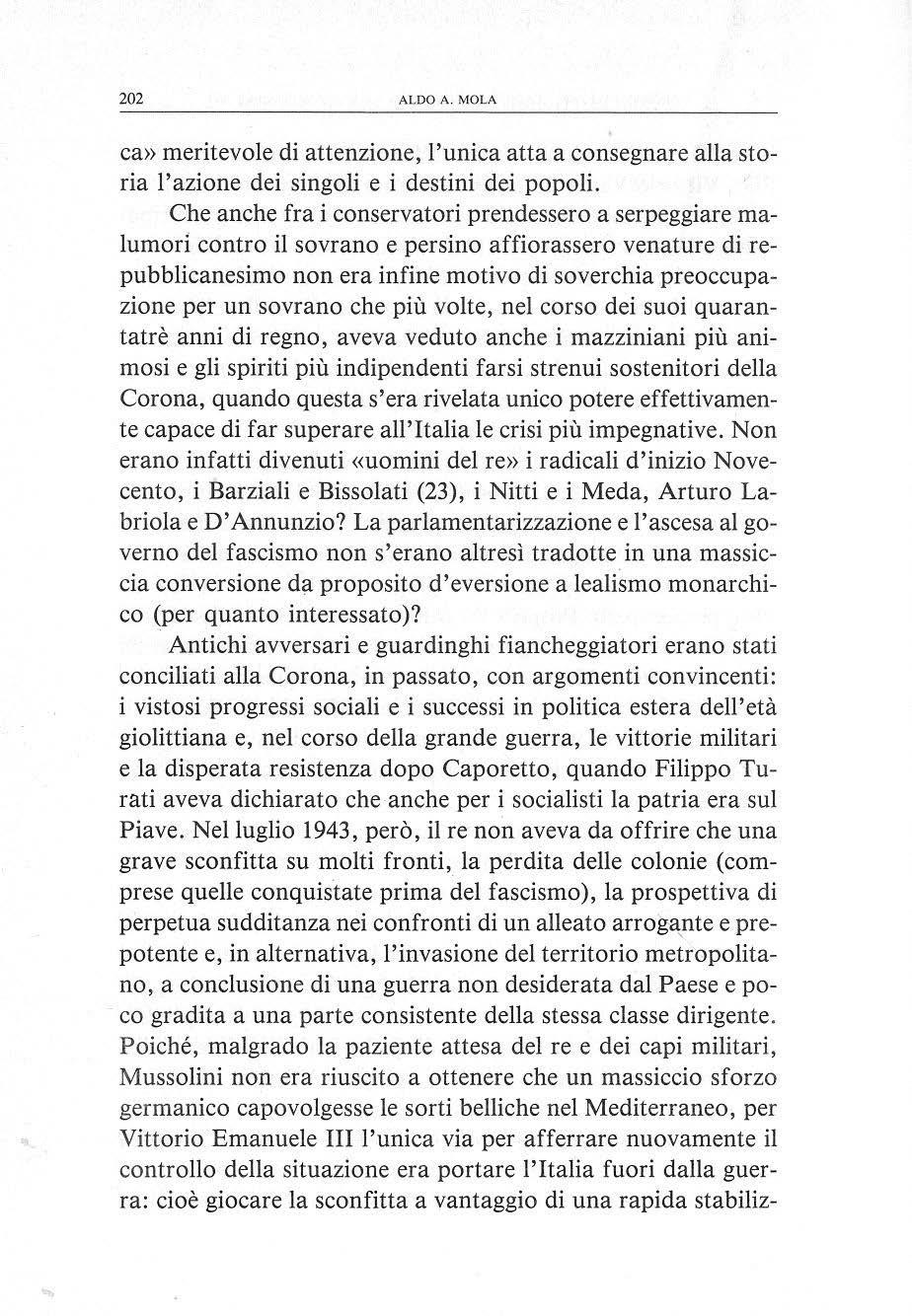
zazione interna, così da riprendere libertà d'iniziativa nelle relazioni internazionali. Su quella strada il re sapeva di poter contare anche sul concorso - convinto o per forze maggioredi molti strenui avversari dell'istituto monarchico, cui però non fosse venuto meno il senso della realtà in cui versava l'Italia: alle prese, com'era, con vincitori (non «liberatori») ben decisi a farle pagare a caro prezzo tre anni di guerra, taluni remoti circoscritti successi , persino le prove di valore militare, e a cancellarla per sempre dal novero delle «potenze», sia pure di seconda fila.
3. - Il 25-26 luglio il sovrano aveva mostrato di aver recuperato l'iniziativa e un'autonomia d'azione più ampia di quanta gliene avrebbero volentieri riconosciuta gli antifascisti, nel timore di rimanerne succubi, e di quanta fossero disposti a conferirgliene i gerarchi, intesi a dissociarsi da Mussolini, e i generali, ormai consci della sconfitta. La repentina drastica revoca del potere a Mussolini, l'ordine d'arresto sulla soglia dell'augusta dimora e la designazione di Badoglio - anziché di Caviglia (24), come suggeriva Grandi, o di un politico bene accetto all'antica guardia liberaldemocratica - confermavano che il re perseguiva un disegno suo, ispirato alla tradizione sabaudadonde i Lamarmora, Menabrea, Pelloux ... - assai più che dettata dal panico per le agitazioni operaie o dalle pressioni dei gerarchi e degli esponenti del riaffiorante antifascismo liberaldemocratico (25).
Sorprende, pertanto , la sorpresa di quanti hanno cercato nell'azione governativa dei quarantacinque giorni ciò ch'essa non poteva contenere. La liquidazione del Partito nazionale fascista e degli organi che ne ripetevano la presenza nello Stato - Gran Consiglio, Camera dei fasci e delle corporazioni, Milizia ... - non comportava la «democratizzazione», bensì volgeva a ripristinare il sistema di potere configurato dallo Statuto albertino, cui infatti s'appellavan o, in varia misura, le diverse «cospirazioni» convergenti, dimentiche della flessibilità, nella pratica attuazione, delle norme statutarie, ripetutamente adattate, dopo il 1848, alla reformatio in pejus.
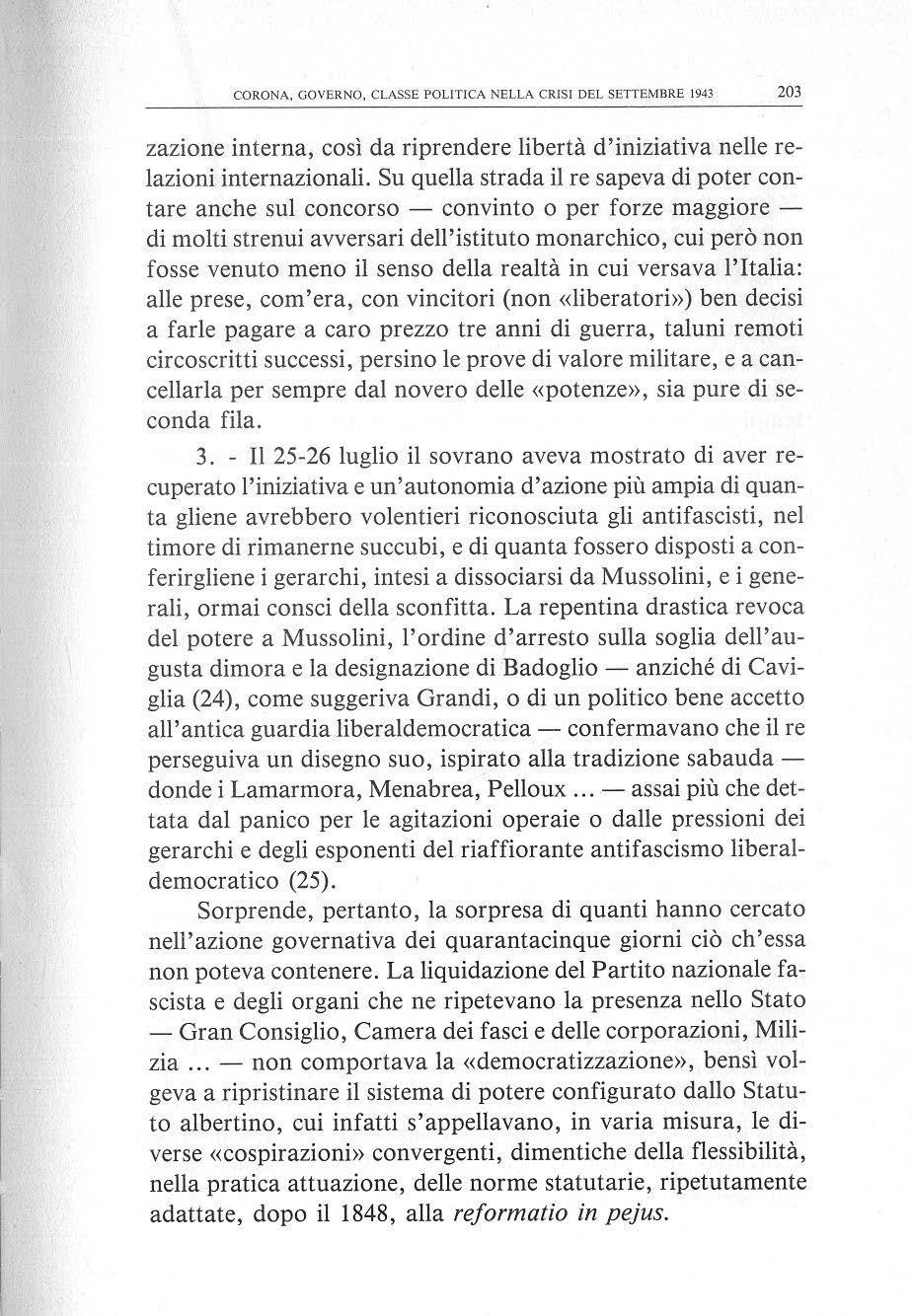
Il governo Badoglio - non va dimenticato - operò nel quadro dei poteri configurati dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2663, sulle attribuzioni e prerogative del capo del governo, e dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, che riconobbe al governo la facoltà di emanare leggi, cioè di rendere ordinario ciò che in passato era stato straordinario: l'eccezionalità dei poteri condensati nelle mani del governo in stato di guerra (26). Del resto, nell'estate 1943 - quando la guerra c'era davvero - dovevano e potevano esser rese operanti le prerogative invalse in tempi anche meno calamitosi. «Governo del re» - composto da militari e da alti funzionari - fra tutti i provvedimenti consentiti dalla potestà pressoché assoluta di cui era rivestito, il ministero Badoglio prese le sole misure che il maresciallo riteneva atte ad allentare l'ostilità degli antifascisti (la liberazione dei prigionieri politici, tra nne anarchici e comunisti, in primo tempo) e attuò un oculato movimento di prefetti e alti burocrati, ostentato quale o ffensiva epuratrice da una stampa che, investita a sua volta da profondi sommovimenti, moltiplicava aggettivi e avverbi intorno ai magri sostantivi dei mutamenti effettivamente operati nell'assetto dello Stato (27). Giova ricordare, a conferma, che la prima legge organica sull'epurazione della pubblica amministrazione dal fascismo venne datata il 27 luglio: ma del 1944, non dell'anno precedente.
La repressione armata dalle manifestazioni popolari di esultanza per il rovesciaµiento del governo di Mussolini - da liquidare come nemico in battaglia, secondo le note disposizioni - nei giornali ebbe un'eco nettamente inferiore rispètto alle mosse guerresche del maresciallo contro gl'illeciti profitti di regime. Dietro quei «panni sporchi», stesi a gara da molti che pur avevano sino alla vigilia impastato le veline del Minculpop, l'azione effettiva del governo Badoglio rimase, non meno di quella del suo predecessore, al riparo dalle ingerenze (giudicate indebite) delle correnti antifasciste, aspiranti all'immediata realizzazione del programma «pace, libertà, riforma delle istituzioni».
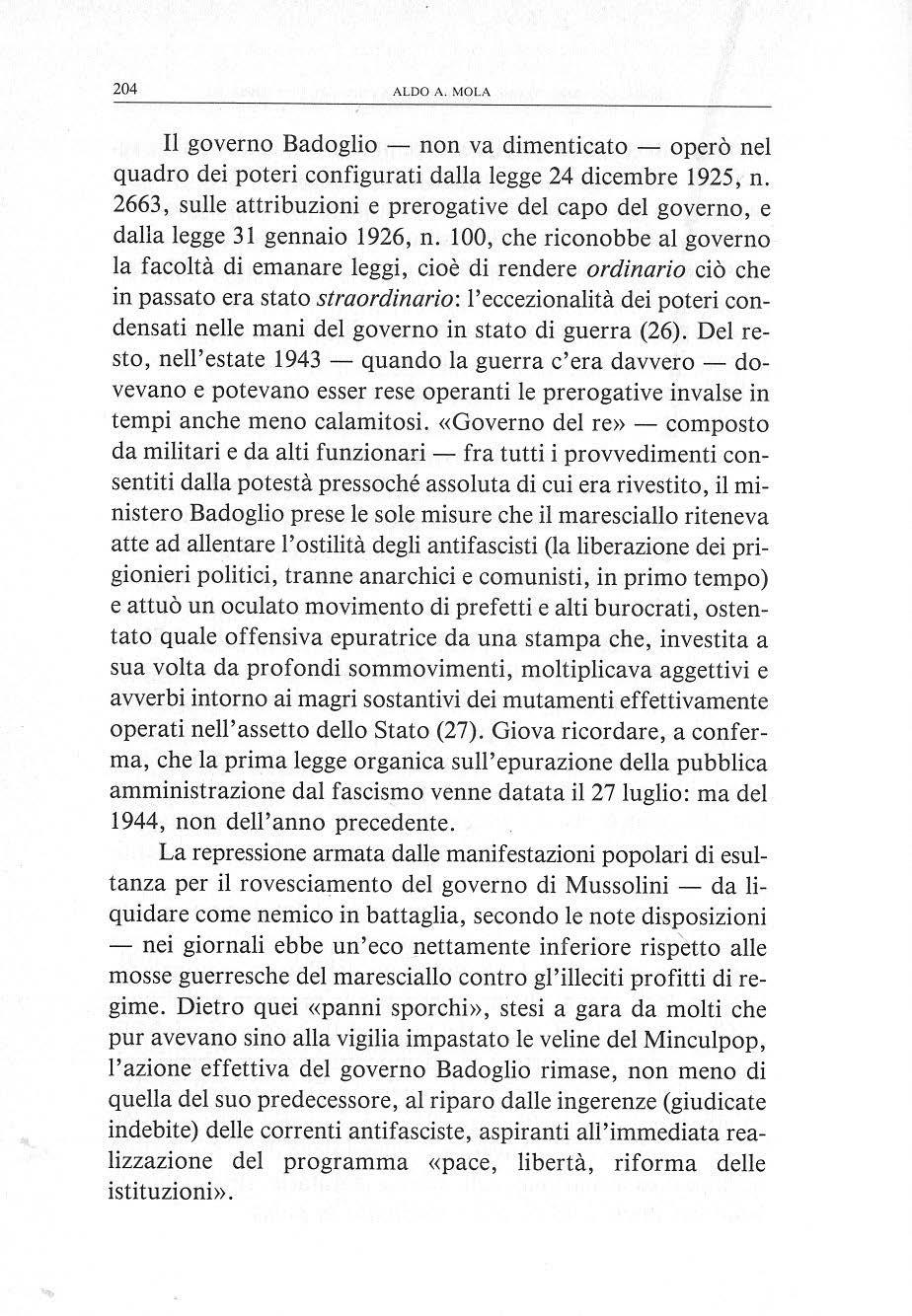
Sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni (contro il suggerimento di Grandi, che proponeva di depurarla dai rappresentanti del Pnf, serbando viva e valida l'Assemblea dei consiglieri «economici» (28)), per effetto dell'art. 48 dello Statuto anche il Senato regio e vitalizio (di lì a poco definito «sudicio» da Benedetto Croce, che n'era pur membro attivo da anni (29)) risultava giuridicamente impedito e procrastinato sino a quando, quattro mesi dopo la fine della guerra, non fosse stata eletta la nuova Camera, promessa col RDL 2 agosto 1943, ovvero sine die (30).
4. - Per quanta convinzione ciascuno ponesse nella rappresentazione del proprio ruolo a nessuno sfuggiva l'epilogo verso il quale volgeva la scena italiana dall'agosto 1943: la richiesta unilaterale d'armistizio per la palese mancanza di risorse e di volontà adeguate a reggere lo sforzo di una guerra nella quale il Paese era stato cacciato, non senza sporadici entusiasmi, tre anni addiet ro, nell'illusione di una vittoria rapida , senza costi soverchi. Perciò, mentre da un canto ostentava di soccorrere il debole alleato, Hitler trasferì nella penisola quindici divisioni germaniche (31) e fece approntare i piani per la cattura del re e del governo. Da parte sua, mentre dichiarava di «continuare la guerra» a fianco della Germania sino alla vittoria finale, quest'ultimo lasciava che la guerra continuasse da sécon tragico seguito di bombardamenti aerei sulle maggiori città - e volgeva propositi ed energie a predisporre lo «sganciamento» dall'ingombrante alleato per l'ora dell'armistizio, non senza ordinare, intanto, la più ferma resistenza contro l'avanzata anglo-americana attraverso la Sicilia e lungo la Calabria (32).
Dal canto loro, anche gli anglo-americani continuarono a «recitare» sino in fondo la parte di «nemici»: raddoppiando le incursioni (con perdite, per gl'Italiani, nettamente superiori a quelle subìte prima del 25 luglio) e riservando un trattamento
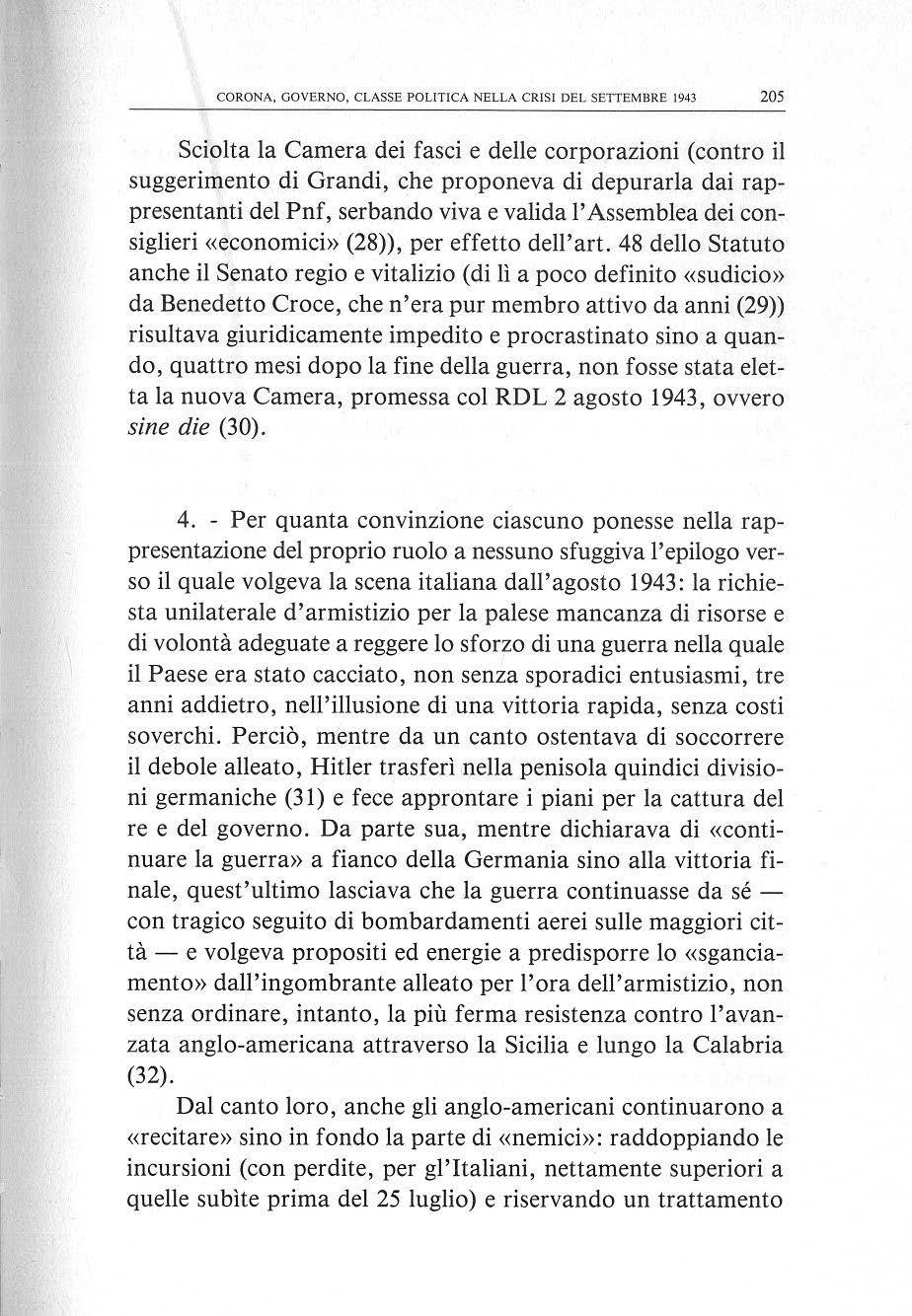
anche più duro nei confronti dei militari italiani, catturati in numero così rilevante da crea re non lieve imbarazzo al vincitore. A quel modo gli «alleati» spingevano alle corde un avversario che da oltre un anno ricorrentemente inviava segnali, a vario livello di competenza e attendibilità, per far conoscere la propria di sp onibilità a trattare la resa, a condizioni non umilianti. Questa t rama - non solo ieri indagata con intenti prevalentemente scand a listici e solitamente giudicata secondo criteri estranei alla storiografia - divenne pi.ù fitta col fallimento dei sondaggi tentati da Badoglio attraverso canali diplomatici tradizionali e si fece frenetica dopo il rientro da Lisbona del gen. Giuseppe Castellano (33) (27 agosto 1943), là inviato per stabilire i preliminari della trattativa armistiz iale. Quando scrisse che furono i militari - non i diplomatici, né altri - a tenere in pugno le fila dei contatti infine approdati alla resa, come già i generali erano stati gl i autori del vero 25 luglio, Castellano intendeva dire che il protagonis ta dell'estate 1943 fu il re tornato, a norma dell'art. 5 dello Statuto, alla guida dell'unica forza organi zza ta del Paese: l'esercito .
Nello scenario dei rapporti di forza fissati dal crollo del regime fascista, il governo Badoglio figurò come il meno sta nel più: e non perché il maresciallo fosse a sua volta «con le stellette» e quindi soggetto alla disciplina mili tare che lo voleva, in ultimo, agli ordini del re, secondo il criterio cui Badoglio stesso ricors e la mattina del 9 settembre per imporre al principe Umberto d'intrupparsi nel regio corteo da Roma a Pescara (34), bensì perché - liquidata la Camera dei deputati, paralizzato pertanto il Senato, inconvo cabili i comizi, sciolto il partito fascista senza che una legge ripristinasse la lib ertà d'associazione politica - il governo rispo se esclus ivamente al re, come mai era accadu to dall'av vento dello Statuto, ché lo scioglimento della Camera in nessun caso aveva creato una vacanza di poteri né modificato così alla radice i rapporti di forza tra gli organi dello Stato. In assen za di strumenti di mediazione tra questo e il «popolo» - di lì gli appelli radiofonici del re e del capo
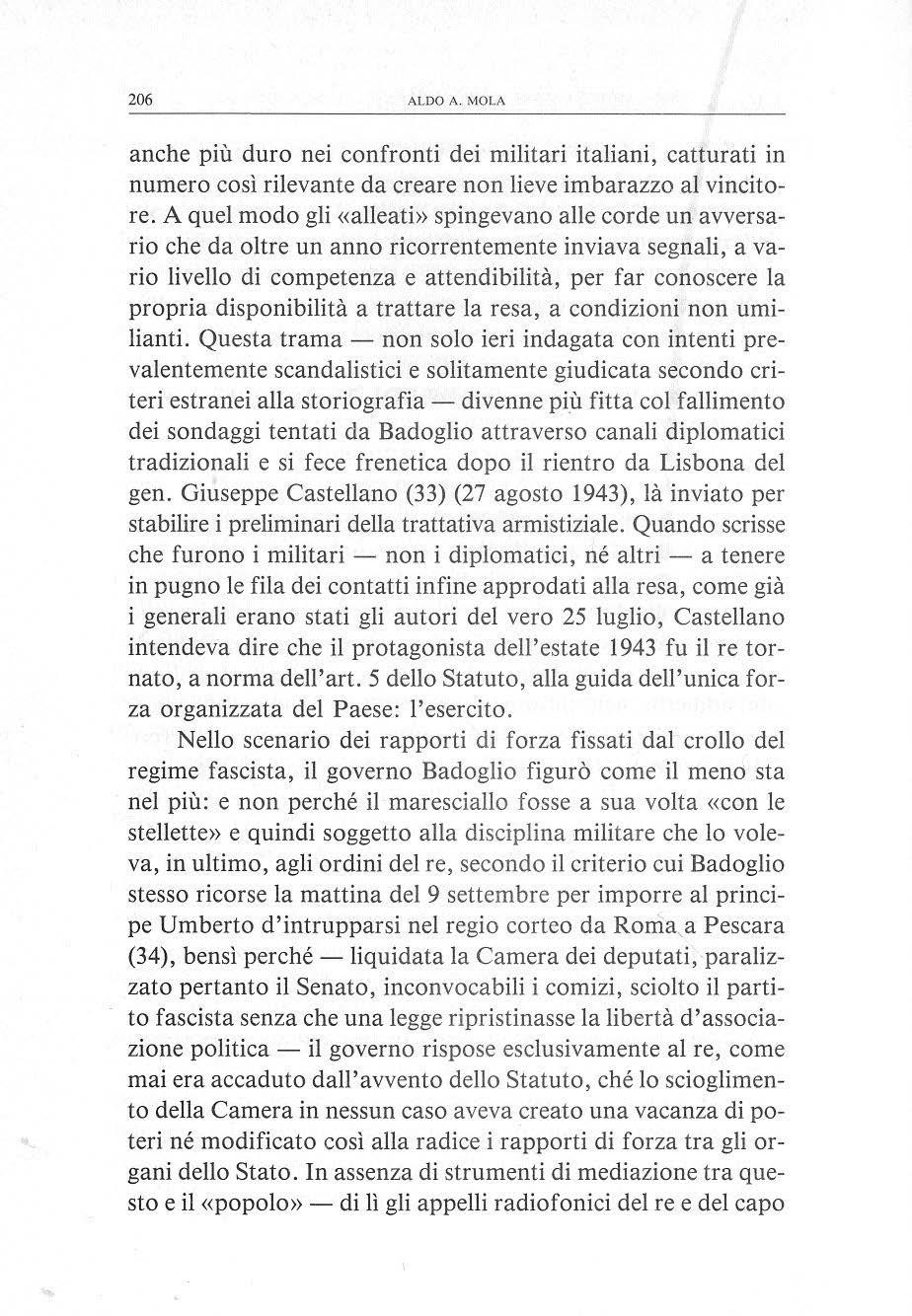
del governo direttamente rivolti agl ' ltaliani, nella tradizione, dura a morire, dei mussoliniani «dialoghi con la folla» - il sovrano fu il perno delle decisioni determinanti in spregio all'obliviato principio secondo il quale il re regna e non governa.
Minutamente aggiornato sulle trattative in corso tra gli emissari militari e i rappresentanti delle Nazioni Unite, fu il re, non altri, a suggellare l'assenso dell'Italia alla resa sigla t a a Cassibile il 3 settembre 1943 (35). Malgrado la durezza delle sue clausole, lo strumento firmato dal gen. Castellano per il re comportava l'inapprezzabile pregio di abilitare la Corona a garante della sua esecuzione. Badoglio era, infatti, «Capo del governo italiano» - come figurava in calce all' «armistizio corto» (36) - in forza della nomina regia e in stretta osservanza del1 ' art. 65 dello Statuto, senza preliminare indicazione da parte di alcun organo dello Stato o forza politica organizza t a.
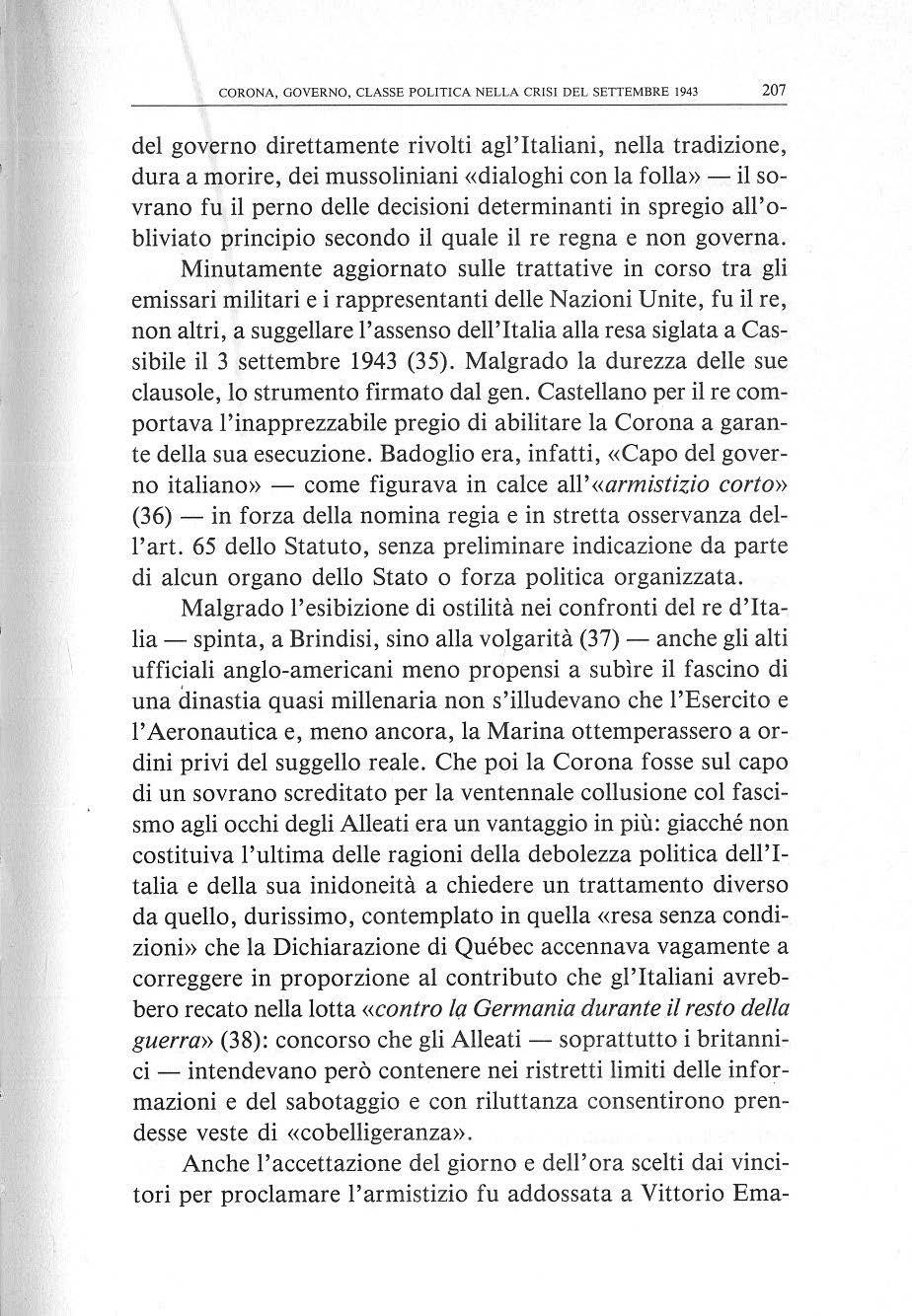
Malgrado l'esibizione di ostilità nei confronti del re d'Italia - spinta, a Brindisi , sino alla volgarità (37) - anche gli alti ufficiali anglo-americani meno propensi a subìre il fascino di una dinastia quasi millenaria non s'illudevano che l'Esercito e l'Aeronautica e, meno ancora, la Marina ottemperassero a ordini privi del suggello reale. Che poi la Corona fosse sul capo di un sovrano screditato per la ventennale collusione col fascismo agli occhi degli Alleati era un vantaggio in più: giacché non costituiva l'ultima delle ragioni della debolezza politica dell'Italia e della sua inidoneità a chiedere un trattamento diverso da quello, durissimo, contemplato in quella «resa senza condizioni» che la Dichiarazione di Québec accennava vagamente a correggere in proporzione al contributo che gl'Italiani avrebbero recato nella lotta «contro la Germania durante il resto della guerra» (38): concorso che gli Alleati - soprattutto i britannici - intendevano però contenere nei ristretti limiti delle informazioni e del sabotaggio e con riluttanza consentirono prendesse veste di «cobelligeranza».
Anche l'accettazione del giorno e dell' o r a scelti dai vincitori per proclamare l'armistizio fu addossata a Vittorio Ema-
nuele III, al termine del consulto fra Badoglio, i ministri delle tre armi, il capo di Stato Maggiore Generale, Roatta, il gen. Carboni, il ministro della Real Casa, duca d' Acquarone, impropriamente ricordato come «Consiglio della Corona» (39). Se nessuno - militare, politico, imprenditore, intellettuale ... - s'era veramente adoprato per impedire a Mussolini di dichiarare l'intervento dell'Italia in guerra, peraltro sancito dai previsti avalli normativi, anche tra fine agos t o e 1'8 settembre si verificò una vasta e sempre più affannosa fuga dalle respon sabilità per lasciare che un uomo solo e una sola istituzione, secondo un antico e non spento costume, si facessero infine carico delle decisioni ultime: così da coprire tutti e, al tempo st esso, da accollarsi l'onere degli eventi, dinanzi al Paese e alla st oria, secondo la condotta che, attraverso il tempo, aveva veduto avvinghiarsi alla monarchia il giacobino Crispi e il reazionario Pelloux, il t rasformista Depretis e le speranze degli stessi aventinisti.
5. - Giunto a Brindisi, Vittorio Emanuele III dichiarò di esservisi trasferito per seguire il suo governo (40). Il sistema dei poteri configurato dallo Statuto albertino conteneva tale ambiguità: che il re figurasse non responsabile di gesti da lui stesso ordinati a un governo che non poteva non eseguirli. Ha però osservato giustamente Carlo Ghisalberti che «né la forma scritta dello Statuto albertino, né, quel che più conta, l'applicazione pragmatica dello stesso fatta in età liberale, avevano mai potuto autorizzare la genesi di una visione garantistica della monarchia>> (41).
In effetti a Brindisi il re non aveva affatto seguìto il governo, bensì, semmai, il suo solo capo, Badoglio, e quei pochi ministri militari che, abbarbicati al maresciallo, non avevano subìto la sorte d'essere «dimenticati» a Roma (42). Anzi, a Brindisi i titolari dei ministeri si ritrovarono in numero insufficiente a costituire una regolare seduta del governo: sicché ai vuoti si dovette ovviare con supplenze, surroghe e nomine la cui le-
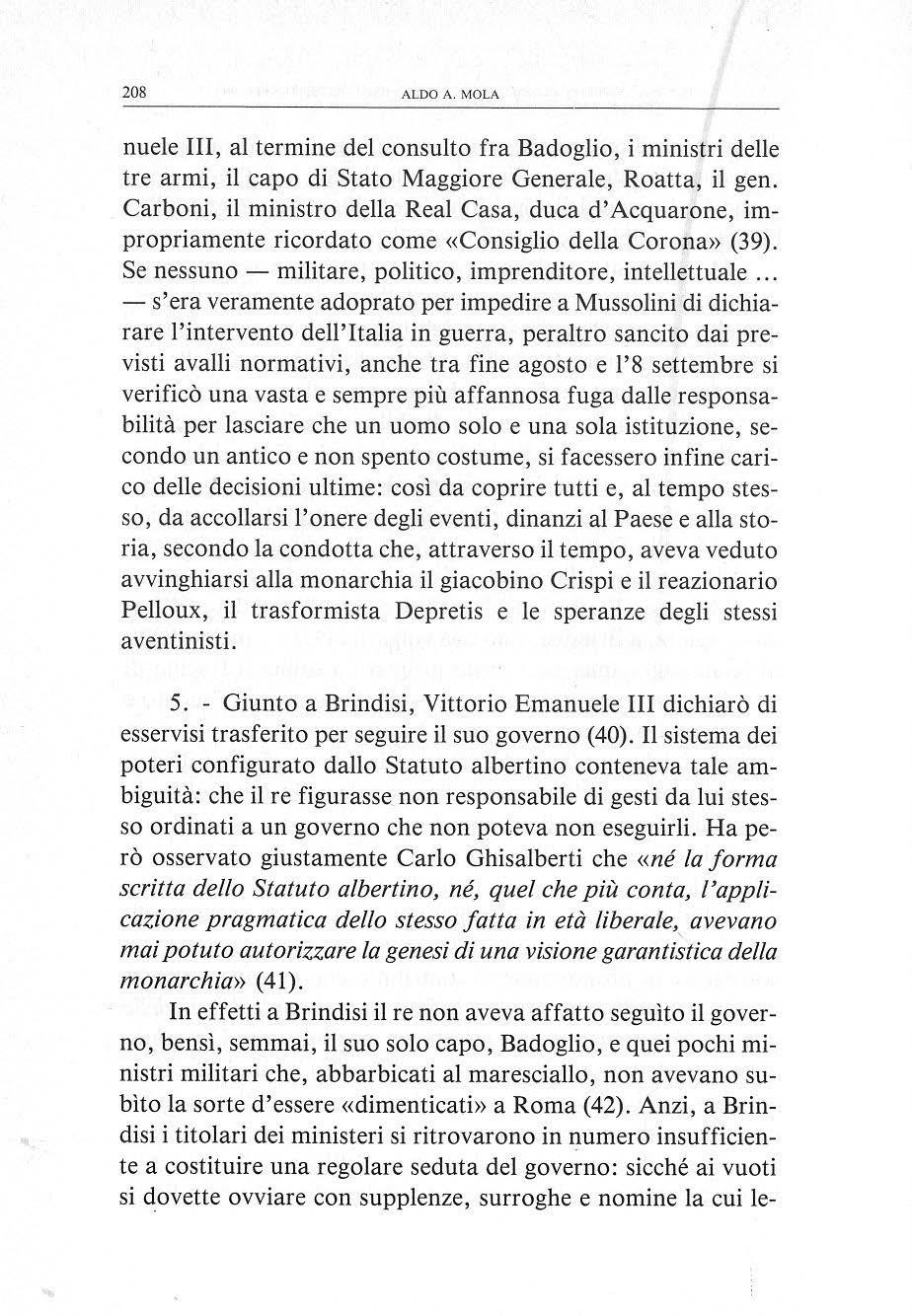
gittimità presenta rilevant i motivi di dubbio. Quando però non si voglia ridurre quel trasferimento da Roma a Pescara e a Brindisi a una somma di precipitose viltà - come sostenuto dalla diffusa polemistica - o rimpicciolirlo a una «fuga» patteggiata col comandante delle forze germaniche, Albert Kesselring (secondo quanto venne sostenuto da Ruggero Zangrandi (43), con molta convinzione ma senza prove convincenti), e ci si prefigga, in vece, di spiegare le ragioni profonde di quella scelta, occorre porsi dal punto di vista dei suoi attori e domandarsi quali criteri l'abbiano dettata e quali scopi essi si proponess ero di conseguire.
Constatata l'impossibilità di arroccarsi nella capitale, mancate le condizioni militar i necessarie per prendere la testa di uno schieramento a difesa dinanzi alle armi germaniche in pross imità di Roma, la condotta del re non fece che ricalcare il modulo di comportamento proprio di una dinastia cresciu t a fra le battaglie (44) e più vo lte ricorsa al ripiegamento a difesa in un centro minore dello Stato, in a t tesa che il corso della guerra · o i dissidi tra i nemici ribaltassero le sorti del conflitto e ne rendessero cercata l'alleanza: criterio sperimentato con successo da sovrani celebrati quali grandi capitani - da Enrico IV di Francia a Federico II di Prussia - e infine raccomandato da Karl von Clausewitz nel cap. XXI del libro sesto del suo cele.bre Vom Kriege, ove viene spiegata l'opportunità della «ritirata volontaria all'interno del paese come una forma particolare di resistenza mediata, per mezzo della quale il nemico deve andare in rovina non tanto per effetto della spada del difensore , quanto a causa dei suoi propri sforzi», in assenza, dunque, «di una battaglia decisiva». È pur vero che von Clausewitz avrebbe preferito difendere «sanguinosamente ogni palmo di terreno con una resistenza continua e misurata» (avendo in mente l'esempio di Kutuzov); eg li non escludeva, tuttavia, decisioni più drastiche, benché «normalmente il popolo e l'esercito [e, aggiungiamo noi, molti «storici»] non distinguano la ritirata libera e razionale da quella piena di precipitazione e di intral-
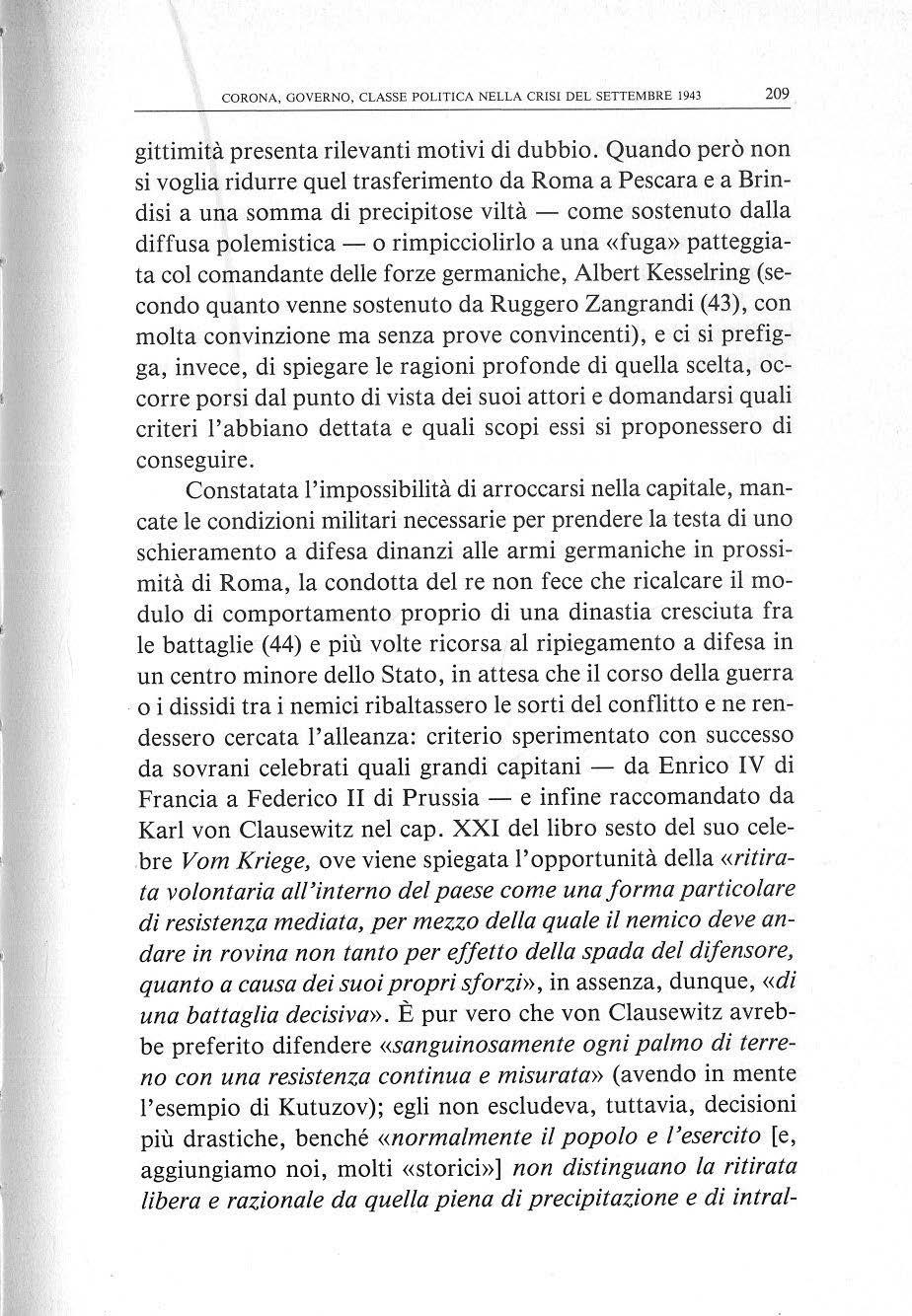
cio, né se il piano sia stato adottato avvedutamente in previsione di sicuri vantaggi, oppure se è il risultato del timore che ispirano le armi nemiche»: circostanze, codeste, nelle quali «l'esercito perderà facilmente la fiducia nel suo capo ed anche in se stesso» (45).
Non fu però per mero ossequio alla trattatistica bellica che la ritirata del re, del capo del governo, dei ministri militari e dello Stato Maggiore ebbe per conseguenza lo sbandamento del1' esercito (a differenza di quanto accadde per la marina e l'aviazione).

6. - Il dibattito sul crollo dell'esercito, oltreché sulla pretesa «viltà» del sovrano e dei capi militari, s'è imperniato sull'intempestività della data di proclamazione dell'armistizio. Mentre alcuni affermano che l'anticipo di quattro giorni sul 12 settembre, suggerito dal gen. Castellano sulla scorta di erronee elucubrazioni intorno a un sibillino accenno fattogli dal gen. Bedell Smith (46), impedì allo Stato Maggiore di tenere sotto controllo la situazione, - sì da elevare la «fatalità>> a protagonista della fase cruciale della crisi italiana-; altri hanno ribadito che anche lo sfascio del regio esercito va imputato al «tradimento>> dei suoi capi, solleciti solo della propria personale salvezza.
La prima spiegazione risponde all'intento di liberare da qualsiasi imputabilità quanti, per cariche ricoperte e mezzi di, sponibili, erano responsabili delle decisioni (ovvero di non aver deciso), e a quello, di altro segno politico, ma non meno diffuso, di dissolvere l'intera vicenda in una generica «desistenza» degl'ltaliani a causa dell'incontenibile proromp ere dell'antica predilezione per la pace (quante volte era stato ripetuto, nei secoli, che gli Italiani non si battono e non sanno battersi!).
La seconda spiegazione - prevalente nella storia, come nella stori ografia (47) - risulta a sua volta non meno deludente, giacché, apparentemente valida nella sua applicazi9ne al circo-
scritto momento della ritirata da Roma a Pescara, in realtà isola la crisi dell'estate 1943 dal corso complessivo della storia dell'Italia uni ta e dal quadro dei poteri definitosi nel tempo col consenso - per adesione o costrizione - del «popolo», nelle sue diverse componenti.

Dev'essere invece percorsa altra via, sì da restitu ir e ai fatti dell'8-12 settembre il significato, autentico, di «verifica» della natura e dell'assetto del regno e, al t empo stesso, di «lezione», che non ci sembra sia stata compresa né posta a partito negli anni seguenti, neppure con l'ins t aurazione della Repubblica, nè con l'accelerazione della sua ormai incombente decomposizione. È nell'ambito degli equilibri di potere configurati dallo Statuto - e depauperati, come già s'è detto, dai provvedimenti eccezionali del governo pressochè monocratico del maresciallo Badoglio - che assumono peso effettivo le personali propensioni dei protagonisti (48), i cui singoli atti venivano a mancare di vaglio, controllo, correttivi, per l'inesistenza o la paralisi degli organi che avrebbero dovuto o potuto almeno parzialmente provvedervi. Su tali premesse va fondato l'esame degli eventi seguitisi dal rientro da Lisbona del gen. Castellano all'arrivo del re a Brindisi.
Le condizioni armistiziali poste dagli anglo-americani non chiedevano al governo italiano di schierare le forze armate a fronte dell'ex alleato, bensì la cessazione delle ostilità e l'acquartieramento dell'esercito, in attesa di disposizioni, la consegna delle flotte, navale e aerea, in basi designate, e di tenere sotto controllo le vie di comunicazione e le artrezzature produttive. Due clausole - la 8 e la 11- risultavano ambigue e contraddittorie: «immediato richiamo in Italia delle Forze Armate italiane da ogni partecipazione nella guerra in qualsiasi zona in cui si trovino attualmente impiegate» e «il Comandante in Capo delle Forze alleate avrà pieno diritto di imporre misure di disarmo, di smobilitazione e di smilitarizzazione», mentre la 9, richiedendo «garanzia da parte del Governo italiano che se necessario impiegherà tutte le sue forze disponibili per assi-
curare la sollecita e precisa esecuzione di tutte le condizioni di armistizio», lasciava intravvedere, nello spirito della Dichiarazione di Québec, la prospettiva, inseguita da Castellano, di una cooperazione immediata tra esercito italiano e Forze alleate. Sennonché le previsioni sull'effettiva risposta germanica alla proclamazione dell'armistizio rimanevano divise tra la speranza che i tedeschi «filassero al nord» - coltivata non dai soli itali ani, ma anche, almeno in alcune fasi, dallo stesso Comandante in capo alleato, gen. Eisenhower - e il timore di doverne fronteggiare l'aggressione armata. Solo i fatti - in particolare i modi nei quali sarebbe stata attuata la coincidenza fra annunzio dell'armistizio da parte alleata, sua proclamazione da parte del governo italiano e sbarco anglo-amer ican o in Italia - avrebbero potuto sciogliere le incertezze, perché le contromisure delle forze germaniche sarebbero state prese co n diretto riferimento al teatro d'operazioni configurato dalle mosse del nemico assai più che da quelle dell'ex alleato.
Il passo della Dichiarazione di Québec (punto 5) in cui si diceva che dai porti del Nord la navi italiane avrebbero dovu to recarsi «a sud della linea Venezia-Livorno» non era certo fatto per chiarire le idee sulle reali in tenzioni degli anglo-americani, i cui disegni (anche n ella prospettiva più au dace e ottimistica) ricadevano comunque molto a sud di tale linea .
A rendere più confusa la predisposizione delle misure con le quali fronteggiare le r eaz ioni tedesche alla dichiarazione d'armistizio contribuiva la reciproca sopravvalutazion e coltivata da Itali ani e Alleat i in merito alle rispettive dotazioni in uomini e mezzi: mentre il governo di Roma era convinto (o voleva credere) che i vincit ori fossero perfettamente in grado di balzare in forze al nord di Roma (errore nel quale era stato indotto dagli Alleati, che lasciarono intendere di poter davvero gettare nella battaglia le quindici divisioni richieste dagl'Italiani), gli angloamericani, che avevano saggiato in Sicilia la capacità di resistenza dei reparti italiani, ritenevano che il governo di Roma fosse in condizione, lasciata la capitale, di tenere il controllo
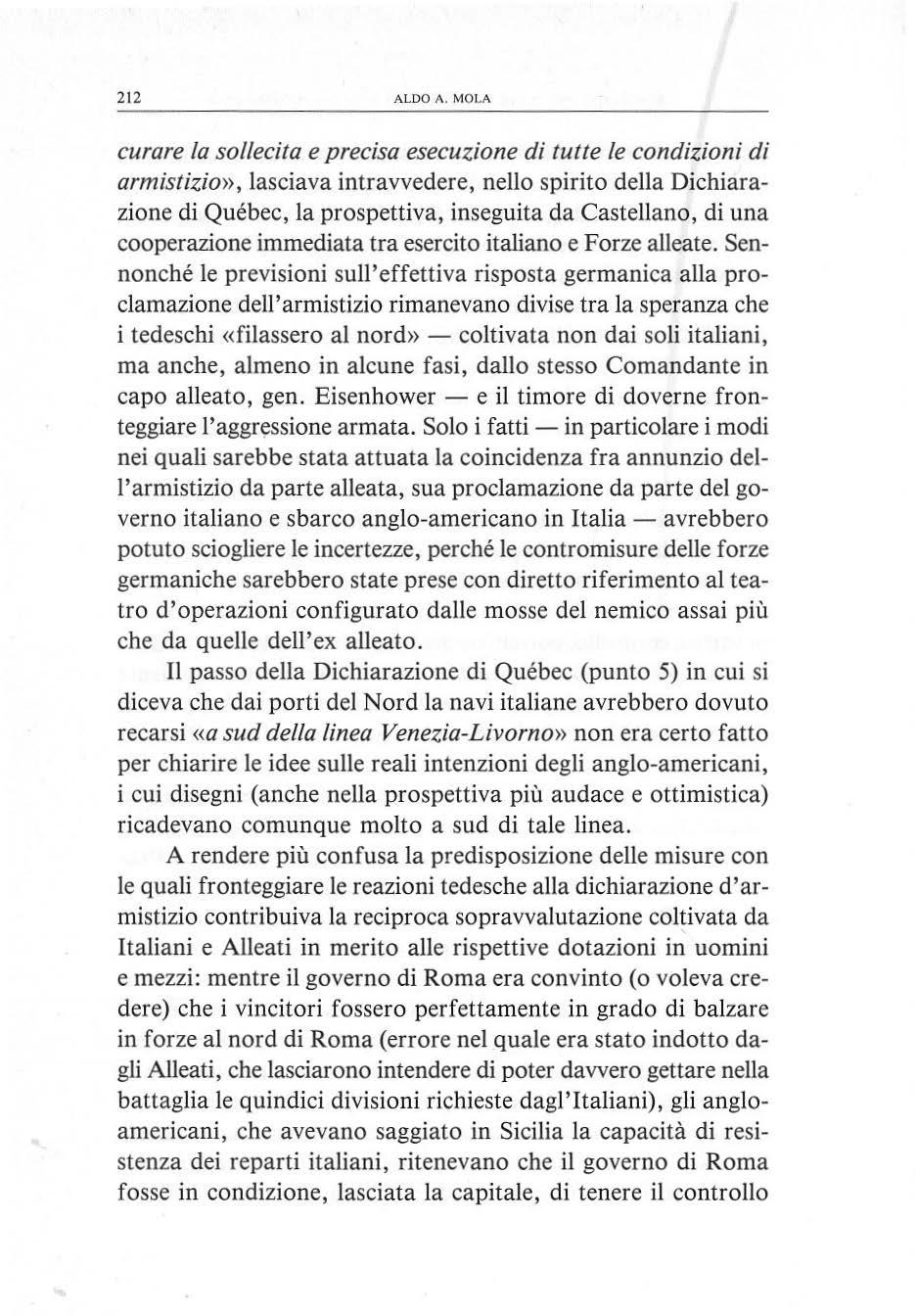
dell'Italia meridionale, mentre i tedeschi compivano la ritirata almeno sino alla dorsale appenninica tosco-emiliana, secondo i propositi prevalenti a Berlino e dei quali i comandi alleati erano a conoscenza grazie alla decrittazione dei messaggi in codice corsi, al riguardo, nel campo avversario.
7. - La realtà era però tutt'altra: né gli anglo-americani intendevano impiegare le forze promesse - ormai in parte destinate alla lunga preparazione dell'operazione «Overlord», in programma per la primavera 1944 -, né comunque eran disposti ad arrischiare i propri reparti nella penisola prima che il governo di Roma avesse neutralizzato le sue ancora temute forze con l'ordine di eseguire le condizioni armistiziali. Per parte loro, gl'ltaliani non potevano dilatare a piacere i tempi fra la persistenza dello schieramento a fianco dell'alleato germanico, la proclamazione dell'armistiz io e l'applicazione delle sue clausole in linea col documento di Québec, secondo il quale essi avrebbero agito contro i t edeschi, le loro proprietà , i movimenti delle loro truppe, d'in tesa e con l'apporto delle Nazioni Unite, impegnate a recare «tutto l'aiuto possibile».
Constatare che gl'Italiani rimasero dunque vittime del «gigantic bluff» abilme n te (49) giocato da Eisenhower non significa certo proporre una condanna del comportamento angloamer icano, né dimenticare che era stata l'Italia a entrare in guerra a fianco della Germania contro le Nazioni Un ite e non viceversa : mira, bensì, a una valutazione meno emotiva e faziosa, né ideologicamente inquinata, della sequenza degli eventi e delle loro ragioni.
Né basta rassegnarsi ad ammettere che gli anglo-americani non dovevano particolari riguardi nei confronti del vinto; occorre invece domandarsi se non avrebbe recato loro più sicuro vantaggio fare maggior conto dell'apporto del regno d'Italia per battere la Germania in un teatro ormai secondario del conflitto mond iale, ma non del tutto irrilevante per la sua c o ntiguità con la regione balcanica, altrimenti consegnata all'egemonia dell'URSS, come d i fatti avvenne (50).
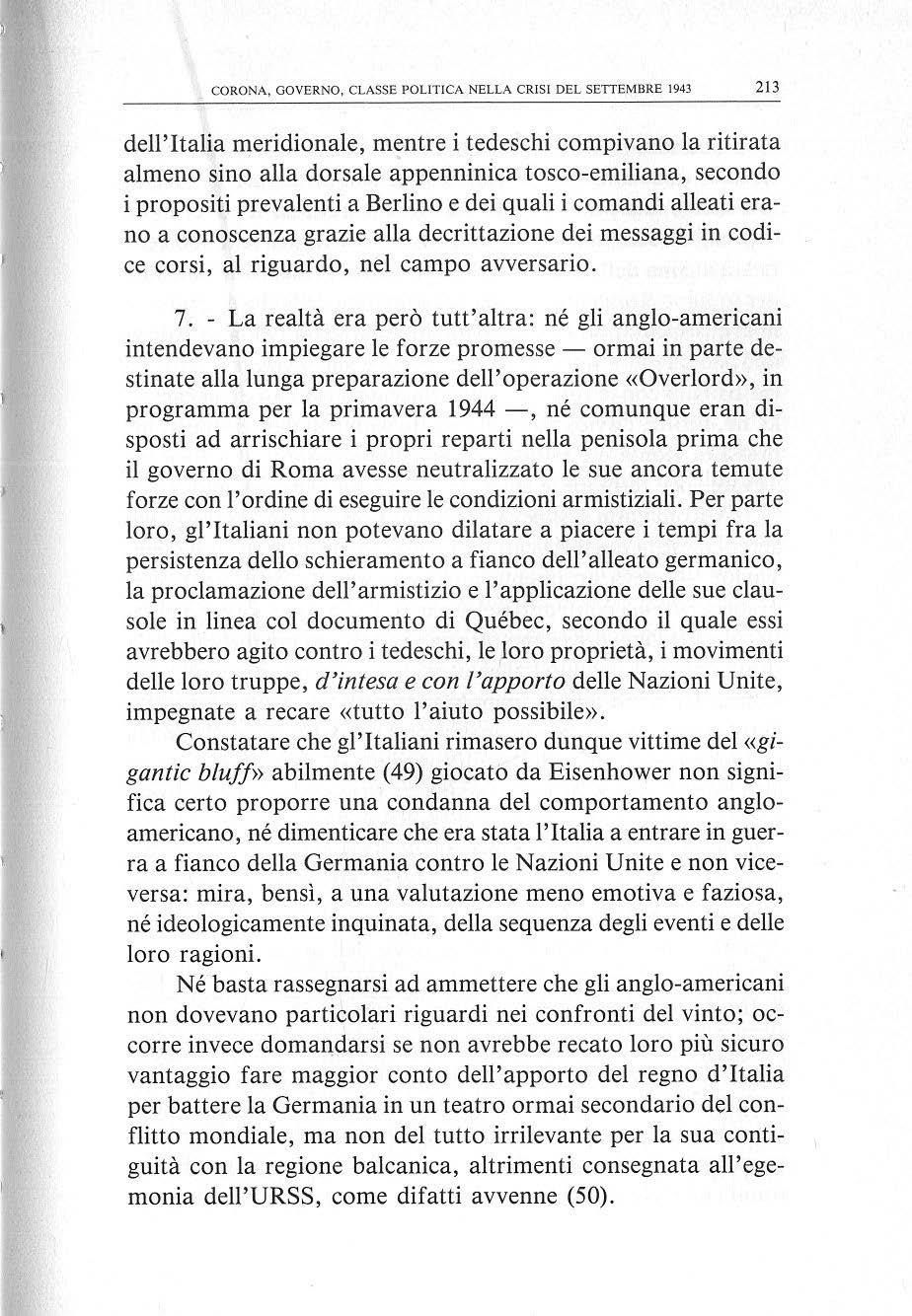
Quando, la sera dell'8 settembre 1943, Vittorio Emanuele III accettò di subire la proclamazione dell'armistizio, anticipata rispetto alle previsioni su cui s'erano fondati il governo e i capi militari italiani, era ormai chiaro che non si sarebbe verificata alcuna delle cond izioni pochi giorni prima fatte balenare per indurre Roma alla rapida accettazione delle dure condizioni armistiziali: non lo sbarco anglo-americano nell'alto Adriatico, né quello a nord di Roma, o nelle sue vicinanze, così da far sistema con le forze armate schierate a ridosso della capitale, né, infine, l'aviosbarco di una divisione di paracadutisti nei pressi di Roma e l'afflusso di artiglierie pesanti alla foce del Tevere, per fermare le divisioni corazzate germaniche. A Roma non si sapeva che l'unica operazione di trasporto aereo aìlestita dagli Alleati -e fermata all'ultim'ora dal gen. Taylor - aveva un intento ancora una volta ostile (51), non di soccorso, nei confronti del governo italiano: era perciò chiaro che gl'Italiani dovevano fare da sé. Nell'ora più difficile della storia unitaria, perduto l'alleato essi non poterono contare, tutto sùbito, su alcun amico, neppure interessato. Nella sfiduciata desolazione voluta dai vincitori - cui premeva che il primo tra i Paesi costretti alla resa risultasse umiliato, a mònito per gli altri minori alleati della Germania - furono prese le decisioni supreme: l'allontanamento del sovrano e del governo dall'indifendibile capitale, alla volta di una plaga sgombra da ex alleati non meno che da ex nemici, e il rinvio dell'ordine d' applicazione delle direttive contenute nelle «memorie operative» (52) diramate in vista della proclamazione dell'armistizio .
È stato osservato che tali scelte rispondevano a criter i tradizionali della diplomazia sabauda: l'attendismo - ribadito con la procrastinazione, sino all'estremo, dell'attuazione di misure che, mentre dovevano premunire per il futuro, ne compromettevano altresì il corso -e il ripiegamento sul «sacro egoismo», cui già si era ispirata la condotta del regno dalla co n flagrazione europea, nell'agosto 1914, a Versailles. Aggiungiamo ch e ent rambi quei criteri risultano produttivi per uno Stato fo r te e co n
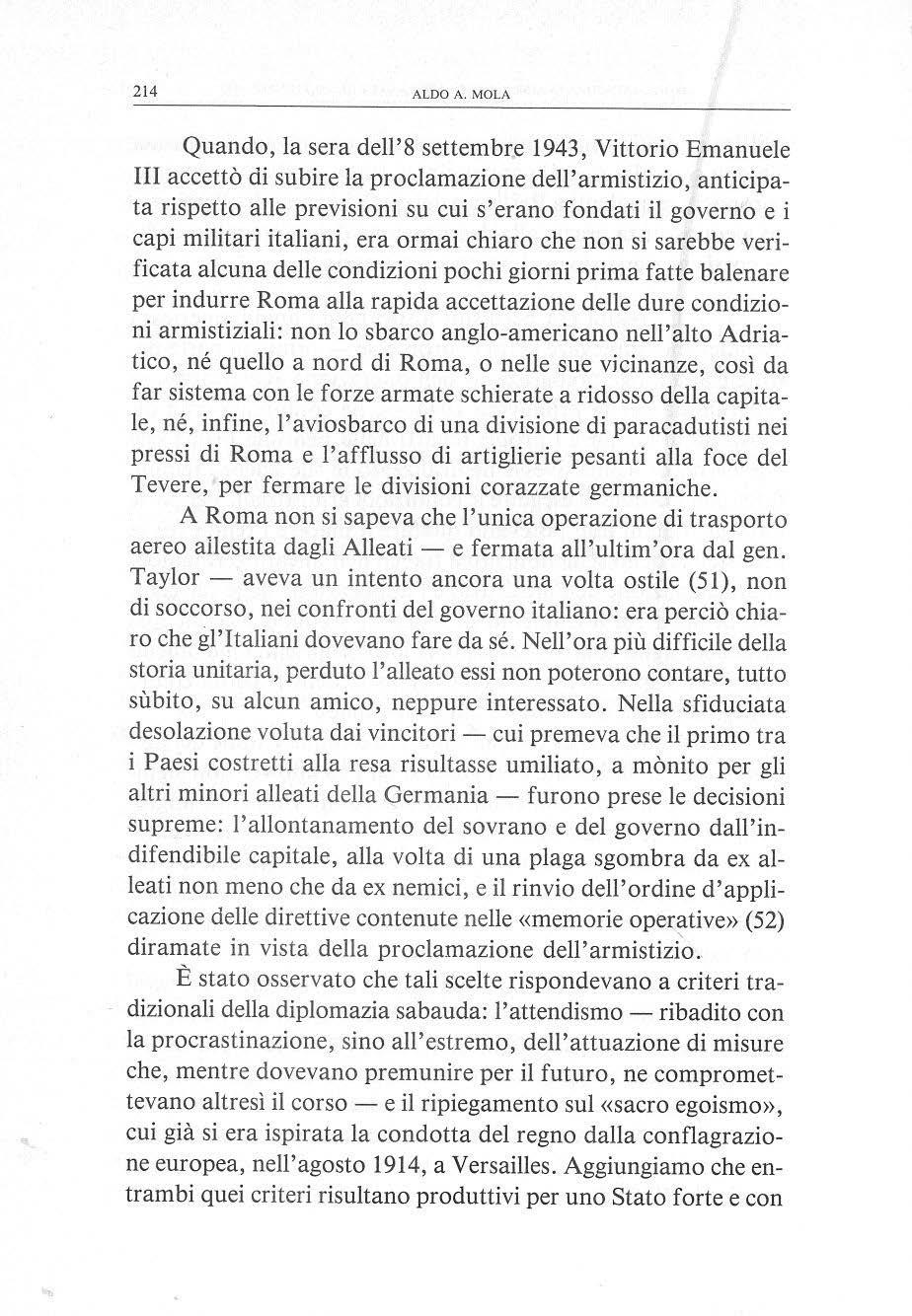
effettiva possibilità di scelta tra le parti in conflitto: riescono invece causa di maggiori rischi e, spesso, di grave danno quando sian fatti propri da un Paese costretto a subire gli eventi, senza spazio di libera manovra, quale appunto era l'Italia all'inizio del settembre 1943.
Per il sovrano, nondimeno, armistizio significava cessazione delle ostilità e riaffermazione dell'incolumità dello Stato: non era, cioè, la premessa per un immediato ribaltamento di fronte (suggerito da Dino Grandi e piu a vanti sollecitato da Badoglio per impulso degli Alleati). A trattenere il re dall'operare un vero e proprio «voltafaccia» non fu, però, l'imbarazzo per le attestazioni di lealtà nei confronti della Germania ribadite sino all'ultima ora (53), né il tormento interiore per la sorte dei famigliari vittime della rappresaglia hitleriana, quanto il proposito di trattare i futuri impegni dell'Italia su basi più forti rispetto a quelle consentite dalla sconfitta e determinate dalle catastrofiche conseguenze di un armistizio cui il governo pervenne tenendone quanto possibile all'oscuro gli alleati di ieri e, forzatamente, l'opinione pubblica e le forze organizzate del Paese, a cominciare dalle Forze Armate.
Troppe ragioni, infatti, impedivano che per l'Italia - occupata dagli eserciti dei due fronti in lotta e divi sa dalla contrapp osizione tra ideologie sanguinosamente ostili - armistizio significasse annunzio di pace anziché, come di fatto accadde, preambolo di una seconda difficile fase di guerra, esterna e interna.

Il «sacro egoismo» altro non era, dunque, che l 'aspetto più appariscente della cautela cui Corte e governo ispiravano le proprie mosse, nell'interesse del Paese non meno che proprio, vista l'inattendibilità delle promesse fatte dagli anglo-americani.
Così - non va dimenticato - il trasferimento a Pescara e a Brindisi fu anche una eloquente risposta agli Alleati che avevano proposto al sovrano di rifugiarsi su un bastimento, sotto tutela del vincitore, in una posizione incomparab ilmente più debole rispetto a quella recuperata da Vittorio Emanuele III e dal governo nel «regno del Sud».
Le difficoltà incontrate dagli anglo-americani nel risalire la penisola dopo lo sbarco a Salerno, andato a un passo dal fallimento per !'irruente reazione germanica, dimostra che non erano inesatte le stime rapidamente fatte dal re e dai suoi colla boratori in merito alla indifendibilità di Roma e alla opportunità di affrontare, con i propri soli mezzi, la controffensiva che i tedeschi avrebbero scatenato a replica di quella dichiarazion e di guerra alla Germania cui molti sollecitavano il g o verno italiano senza valutarne appieno le pur prevedibili conseguenze per l'esercito e le regioni sott o controllo nemico.
s· . El usa la cattura da par te dei germanici, rifiutato il ricovero sotto l 'ala troppo protettrice delle Nazioni Unite, benché militarmente sconfitto il capo dello Stato italiano poteva asp irar e alla riaffermazione della sovranità nazionale, raccogliend one gl'immediati vantaggi sul terreno, decisivo, dei rapporti internazionali. L'amara consapevolezza della disparità fra i mezzi necessari a co st ituire una situazione politica nuova (la dichiarazione di guerra a lla Germania) .già aveva imposto d 'imper niar e la «Memo ria op. 44», compilata fra il 22 agosto e il 2 settembre, sul rifiuto di prendere l'iniziativa militare co ntro l'ex alleato e di non considerare l'ex nemico come nuovo, sicuro, immediato cobelligerante.
Qu ella dir ett iva illumina il retroterra sul quale si formarono le decisioni del re, di Badoglio e dei vertici militari nella notte tra 1'8 e il 9 settembre. Alla proclamazione dell'armistizio le singo le armate dell'esercito italiano erano sc hierate secondo piani concorda ti con gl i alti com andi germanici (e quindi noti nei dettagli all'ex allea t o): in quasi tutti i casi gl'italiani erano a contatto di fuoco co n i tedeschi, largamente inseriti o recent e mente penetrati all'interno dei loro dispiegamenti, con moto accelerato dopo il 25 luglio dal Tr entino lungo la penisola e spec ialmente a Roma e nei suoi dintorni, ove gli «sfusi» erano causa di par tico lar e preoccupazione (54). I vertici militari italiani sapevano che i germanici conoscevano bene le risor se - in uomi-
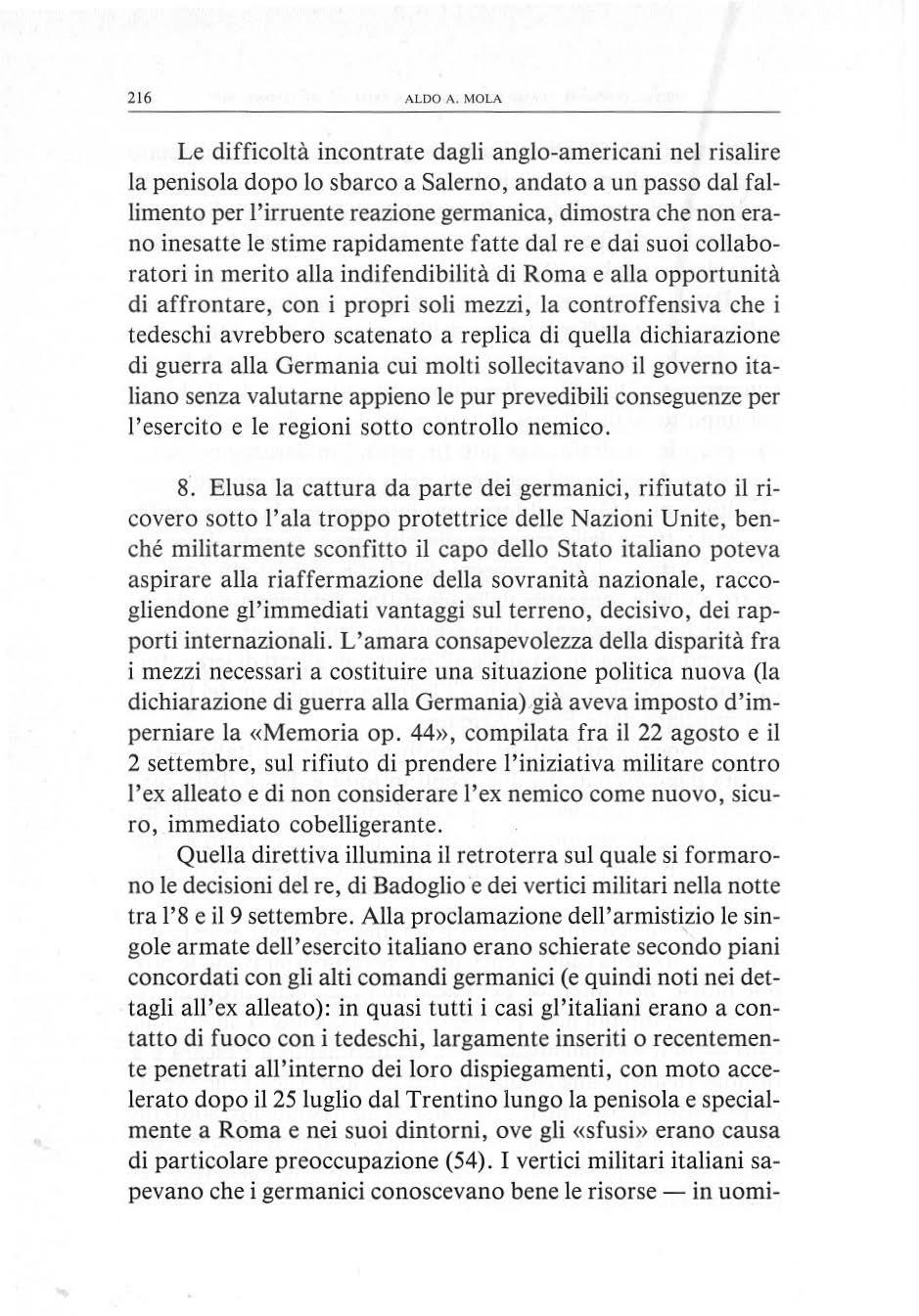
ni e mezzi - sui quali essi potevano contare: Roma aveva subordinato l'intervento in guerra a massicce forniture belliche tedesche e per tre anni aveva combattuto con mezzi in larga misura forniti dall'alleato, decisivi per alcuni settori qualificati. Esclusa qualsiasi possibilità di successo di un'eventuale improvvisata aggressione generale dell'esercito germanico da parte italiana, anche lo sganciamento dall'ex allea t o si presentava niente affatto agevole, scontato, indolore, nel quadro di un conflitto che lasciava pochi margini alla neutralità e nel cui ambit o procacciarsi dotazioni belliche era assillo quotidiano. L'appropriazione dell'armamento degli it aliani, usciti dalla guerra, da parte dell'ex alleato, che proseguiva la lo t ta, in molti casi aveva, inol t re, il carattere di un ragion evo le risarcimento o di restituzione dei prestiti in est in t i (55).
Che fare, dunque, nell'impos sibilità di attaccare e di sganciarsi se non met t er;s i nella condizione di non dover contra t taccare con forze impari, senza poter contare sul s occorso dei vincitori e con incert e pros pe tt ive di dùrevole resistenza? A quanti ripetono che il governo avrebbe dovuto ordinare alle armat e di ripiegare nella penisola e di attestarsi in ordine di combattimento a posta e fulcro di una resistenza di massa contro l'occupazione nazista , va ricordato che alla fine del 1943 gli effettivi delle «bande» armat e costituitesi nell'Italia centro-settentrionale non superavano i 6.000 uomini: che era quanto poteva essere alimenta t o da un territorio quale la penisola, diffusamente urbanizzato e sovrappopolato, niente affatto adatto alla «guerra per bande» nell'età della motorizzazione (56).
9. - Oltre a quelle tecniche, anche ragioni politiche sconsigliavano al governo del re d'impartire gli ordini che tanta parte della storiografia ha rinfacciato alla monarchia e a Badoglio di non aver saputo né voluto dare. Già nel 1922, quando la «marcia su Roma» ancora poteva essere fermata con la proclamazione dello stato d'assedio, venne fatto sapere al re che l'esercito rimaneva fede le, ma era meglio non metterlo alla pro-

va. Sarebbe stato più agevole tentare la stessa prova dopo quattro lustri di fascistizzazione dell'esercito e dopo tre anni d'indottrinamento, durante i quali la guerra a fianco della Germania era stata predicata a ufficiali e soldati come un'alleanza ideologica e, più ancora, di civiltà? Lo stesso Eisenhower, profondo conoscitore della «mentalità» militare, avanzò ripetutamente forti dubbi, sulla possibilità che davvero bastasse un ordine regio per ottenere che tutti i reparti volgessero le armi contro l'ex alleato col quale molti soldati italiani avevano cameratescamente condiviso anni di guerra (57).
· Ora, la monarchia, che aveva sempre temuto la sedizione militare quale pessimo tra i mali, aveva buoni motivi per non provocarla essa stessa chiedendo l'impossibile, con suo sicuro detrimento e ponendosi nell'obbligo di dovere un giorno celebrare quei massicci processi per alto tradimento nei riguardi di quanti avessero rifiutato di ottemperare all'ordine, non mai aperti nei confronti delle forze armate della Repubblica·Sociale perché radicate in una loro pur discutibile legalità.
La Corona aveva risposto all'ordine del giorno Grandich'essa stessa aveva implicitamente sollecitato - lanciando l'appello all'unità nazionale. Per attingerla occorreva però far scendere rapidamente il sipario sui vent'anni di regime, eludere qualsiasi contrasto ideologico e pertanto evitare di spaccare il Paese sulla «questione fascista» che si preferiva considerare chiusa con le misure decretate dal governo Badoglio nei giorni immediatamente successivi al 25 luglio.
Trascorse quarantott'ore dalla proclamazione dell'armistizio, risultò a suo modo riuscita l'operazione fondamentale per la salute dello Stato: salvare la testa delle forze armate, il re, il capo del governo, i vertici militari, che da tempo avevano preso il controllo delle trattative con le Nazioni Unite e cui sarebbe ora spettato di trovare idonee soluzioni di compromesso con l'ex alleato per non provocarne la reazione armata.
Come in tutte le battaglie perdute, che non si voglia trasformare in catastrofe generale e definitiva, anche in quel caso
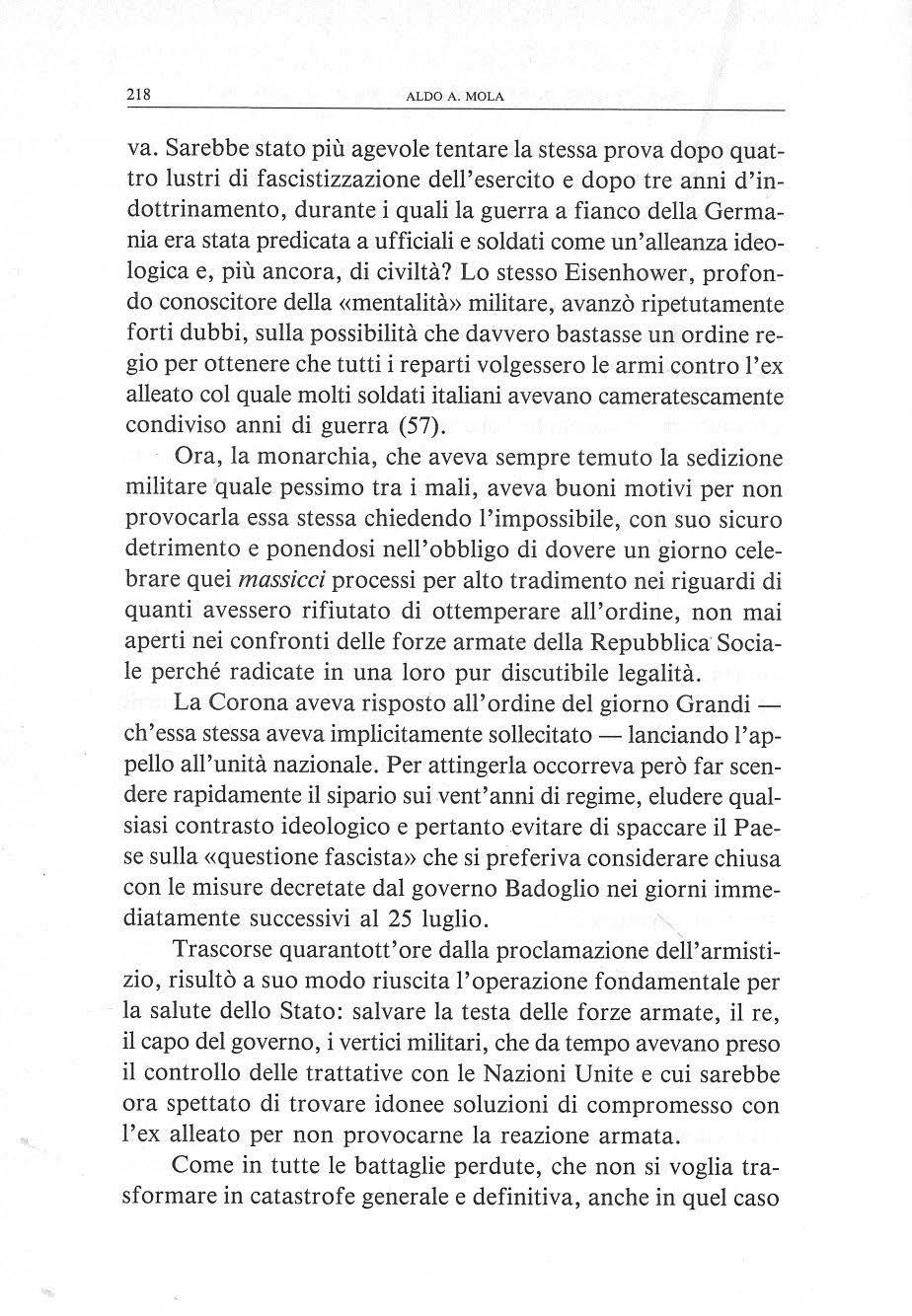
la salvezza della testa dell'esercito s ' accompagnò al sacrificio della retroguardia: sennonché, per le circostanze sopra ricordate, era tale pressoché l'intero esercito italiano, mescolato con l'ex alleato - imminente nemico -, privo di mezzi per un'adeguata difesa e impossibilitato a schierarsi in ordine di combattimento se non rischiando di moltiplicare a dismisura la tragedia di Cefalonia, sì da trasformare l'armistizio nel massacro di inter e armate, chiuse in sacche di resistenza l ' una dall'altra isolata, condannate a esaurire rapidamente le proprie scorte, senza ser ia possibilità di rifornimento da parte dei «vincitori» che impiegarono poi diciotto mesi per portare a livelli non meramente simbolici gli aiuti al movimento armato di resistenza ne l nord Italia, i cui effettivi erano tanto meno consistenti e più concentrati rispetto alle armate schierate dall'Italia nel settembre 1943. La sorte inflitta dai tedeschi a polacchi, russi, jugoslavi, bulgari - sterm inati in massa - lasciava pochi margini d'illusione sul trattamento che Hitler avrebbe ora riservato agli Italiani se questi stessi gliene avessero offerto il destro con una dichiarazione di guerra, prima che la costituzione della RSI bene o male, vi facesse scudo. Paradossalmente, proprio la mancanza di direttive - che sarebbero potute essere sol o di resistenza armata contro i germanici - mise dunque i comandi nella condizione di suggellare lo sbandamento dei reparti con l'ordine di scioglimento (58): unica formula atta a liberare i soldati dall'imputazione di diserzione dinanzi al nemico in armi, prima o poi diversamente lanciata contro le centinaia di migliaia di uomini delle armate degradate a retroguardia di uno schieramento il cui quartier generale, rifiutato l'impari scontro, aveva preso stanza a Brindisi, più lontano possibile dal pericolo di eliminazione sommaria. Parimenti, abbandonati a se stessi i comandi italiani poterono rapidamente imboccare la via di singol e trattative con gli occupanti, riuscendo a strappare - al di là di alcuni privilegi formali nelle modalità della resa (59) - la sa lvezza per la quasi totalità degli uomini, diversamente condannati a subi re la rappresaglia tedesca .
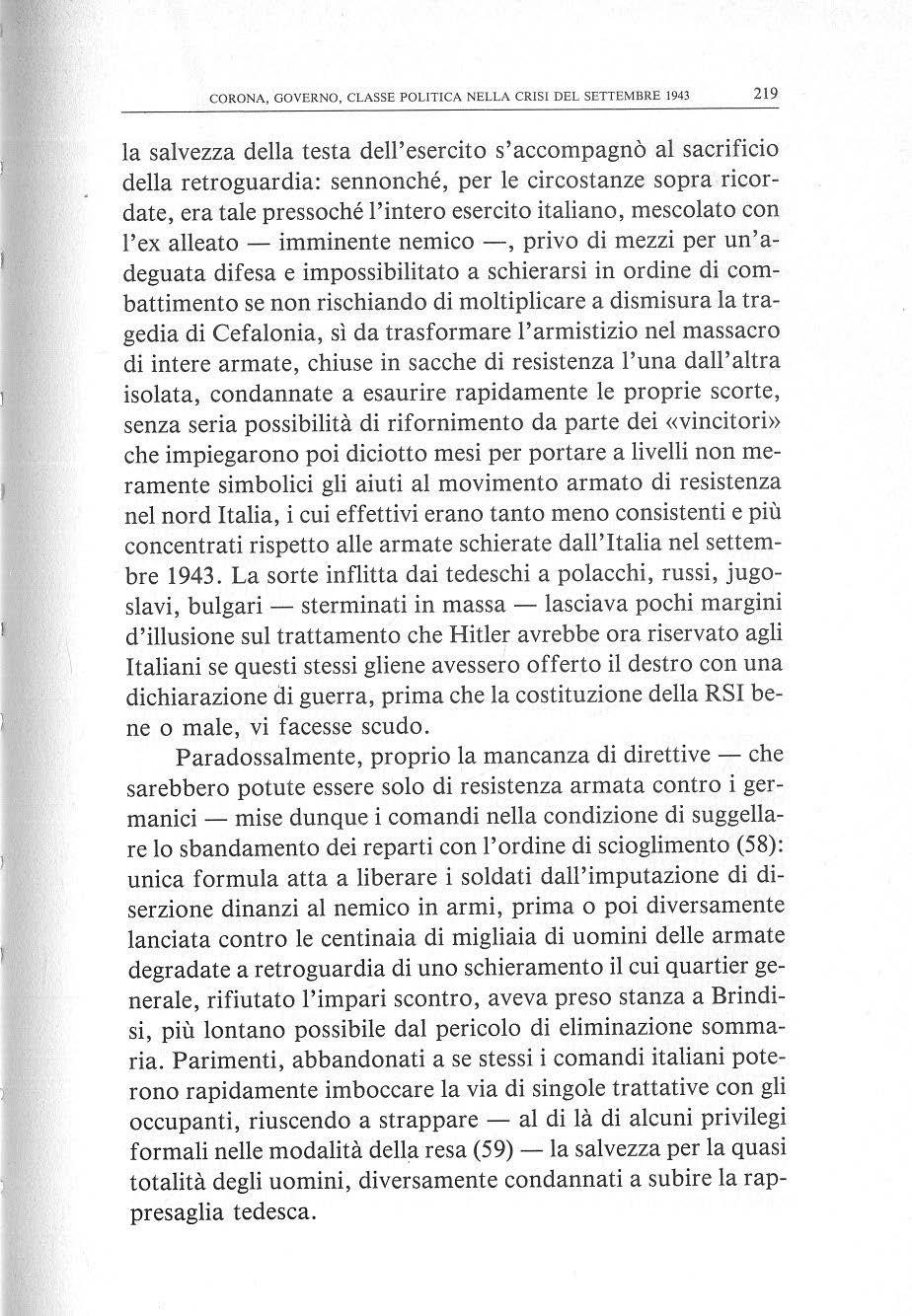
Dopo altri tre giorni, la notizia della liberazione di Mussolini dall'albergo-carcere del Gran Sasso e del suo trasferim ~nto in Germania - presumibilmente per prendervi la guida di uno Stato vassallo del Reich, come di fatto avvenne - agli occhi del governo del Sud conferì un preciso significato costruttivo all'odio che le misure germaniche di rappresaglia contro i militari italiani avrebbero suscitato nei confronti di quanto sapesse di nazifascista.
10. - Il modo del trasferimento del re, di Badoglio e dei capi militari da Roma a Brindisi costituisce verifica del modesto rilievo avuto dagli scioperi operai (del marzo e dell'agosto 1943) nella determinazione della condotta dei vertici dello Stato. La previsione che i tedeschi non si sarebbero ritirati dalla penisola senza colpo ferire o quanto meno senza depredarla di quanto po t esse occorrere alla loro guerra, affondando le mani nelle regioni industr ializzate del nord e nelle loro cospicue risorse agricole, non indusse infa t ti i protagonisti della vicenda - quasi tutti piemont esi, a cominciare dal sovrano, già «principe di Napoli» ma infine «conte di Pollenzo», e dal figlio, poi «conte di Sarre» -a mutar rotta, benché fosse chiaro che quella deci sione avrebbe potuto aprire un solco difficilmente colmabile fra la dinas t ia e alcuni fra gli ambienti tradi zionalmente a essa più fedeli. Se mai ve ne fosse stato bisogno quella era la dimostrazione che la Corona e i suoi uomini pensavano e agivano in una visione autenticamente nazionale del proprio ruolo, senza indulgen ze né predilezioni regionali. Parimenti inattendibile era l'ipotesi - affacciata a posteriori dal gen. Carboni e da una corrente storiografica -che il re incitasse gl'italiani a prendere l'iniziativa della resistenza armata.
Educato nel culto della tradizione sabauda, anziché farsi ispiratore di una insurrezione popolare, priva di seri sbocchi là dove l'esercito stesso veniva forzatamente sacrificato, Vittorio Emanuele III condivideva semmai il pensiero del conte di UìrSaluce che nella Enquéte sur la monarchie (un testo ben noto al sovrano) affermava: «laforce militaire doit étre entièrement
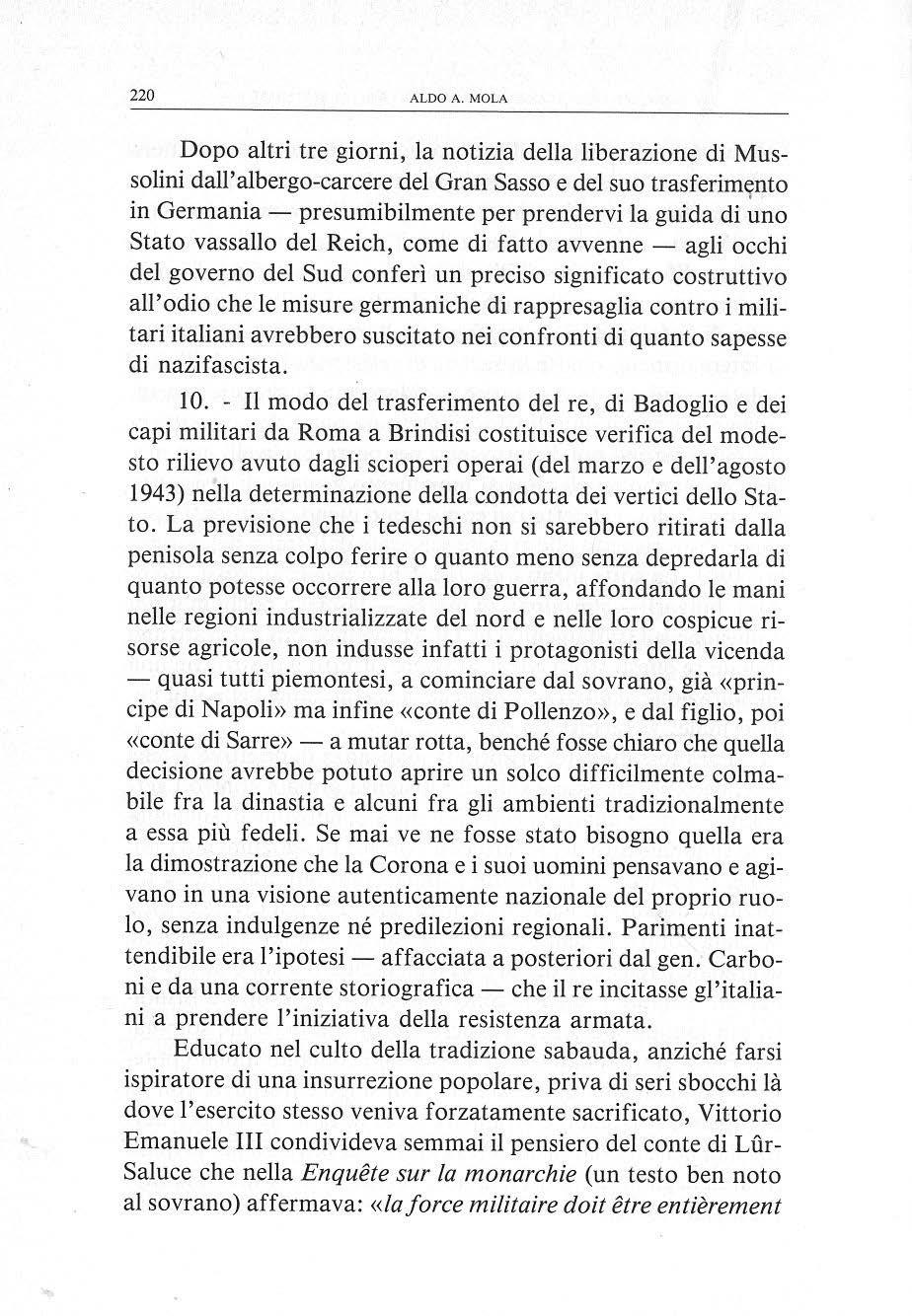
entre !es mains du souverain: il y a là un genre de responsabilité qu 'il doit se reserver. Il doit conserver sous sa seule autorité l'armée du pays», nella convinzione, del resto, che «le principe de la division du travail condamne le système de la nation armée» (60), reputata da Vittorio Emanuele III un residuo di mentalità ottocentesca, incompatibile con lo Stato moderno. In quell'ottica, e per una seconda più radicale considerazione, era impensabile che il principe di Piemonte potesse restare a Roma: ove avrebbe costituito un pericolo per la continui t à della dinastia se fosse caduto (com'era molto probabile) nelle mani dei tedeschi o se fosse stato indotto a porsi a capo di «volontari» oggettivamente antagonisti nei confronti del governo di un re secondo il quale «si regna uno per volta» (61). Umberto, in altre parole , doveva seguire il padre non ta n to per obbedienza alle gerarchie militari - ai cui occhi egli era ung enerale in ser vizio con incarico di comando effettivo (62) - bensì per impedire che, in c aso di morte o di impedimento fisico del padre - si creasse un vuoto di legittimità e il governo, in carenza della prevista sanzione regia dei suoi atti e costretto a fondarsi su basi extrastatutarie, scivolasse sul piano inclinato della illegit t imità, perdendo il privilegio che ne faceva altra cosa rispetto alla nascente Repubblica sociale it aliana. La presenza di Umberto a fianco del padre avrebbe anche scongiurato il r ischio che - dichiarato Vittorio Emanuele III impedito a esercitare la sua funzione (perché sotto quel controllo angloamericano che in una sentenza del 1954 venne invocato da un tribunale della Repubblica quale prova dell'assenza di legalità nell'Italia centro-meridionale (63)) - il principe venisse in qualche modo contrapposto al padre.
11. - Il 14 settembre - t re giorni dopo il reg i o radiome ssaggio di Brindisi - gli anglo-americani proposero a Vittorio Emanuele III di rivolgere un nuovo appello al Paese (64). A quel punto il sovrano poteva ritenere d'aver effettivamente a ssolto - attraverso la sua persona - il «dovere di preservare
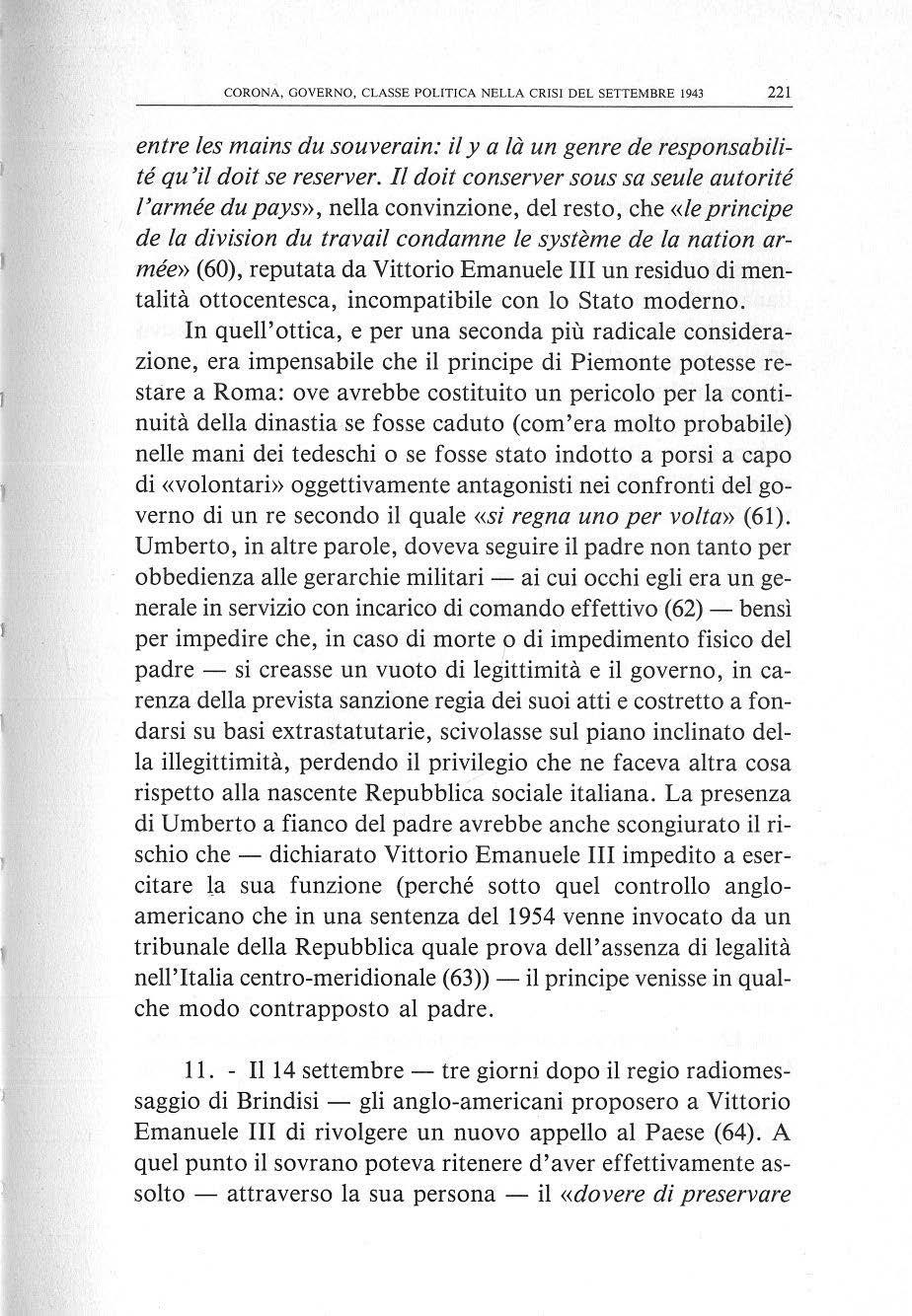
l'integrità [dello Stato], adottando immediatamente i provvedimenti che ne possono garantire la conservazione» (65) nella forma consona alla sua trad izione. Vittorio Emanuele aveva infatti ottenuto che i vincitori si rivolgessero alla Corona e al governo del re quali unici depositari dei diritti della nazione italiana. Dal punto di vista del suo concetto di sovranità, il re poteva quindi ritenere d'aver chiuso in attivo -o con un passivo di gran lunga inferiore a quanto fosse stato lecito temere nelle drammatiche ore fra la sera dell'8 e l'alba del 10 settembrela partita aperta mesi addietro per rimuovere Mussolini dal governo, smantellare il «partito unico» e predisporre lo sganciamento dell'Italia dalla guerra a fianco della Germania di Hitler. Se fino a quel momento aveva avuto pochi margini di manovra, dal 14 settembre e, poco oltre, con la proclamazione della Repubblica sociale, anche le Nazioni Unite si trovarono a percorrere una via obbligata: per restituire efficienza all'organizzazione civile, economica, militare in Italia, insomma per contare su uno Stato, dovevano rincalzare le basi dell'unico istituto che rappresentasse la continuità delle leggi, cioè la Corona.
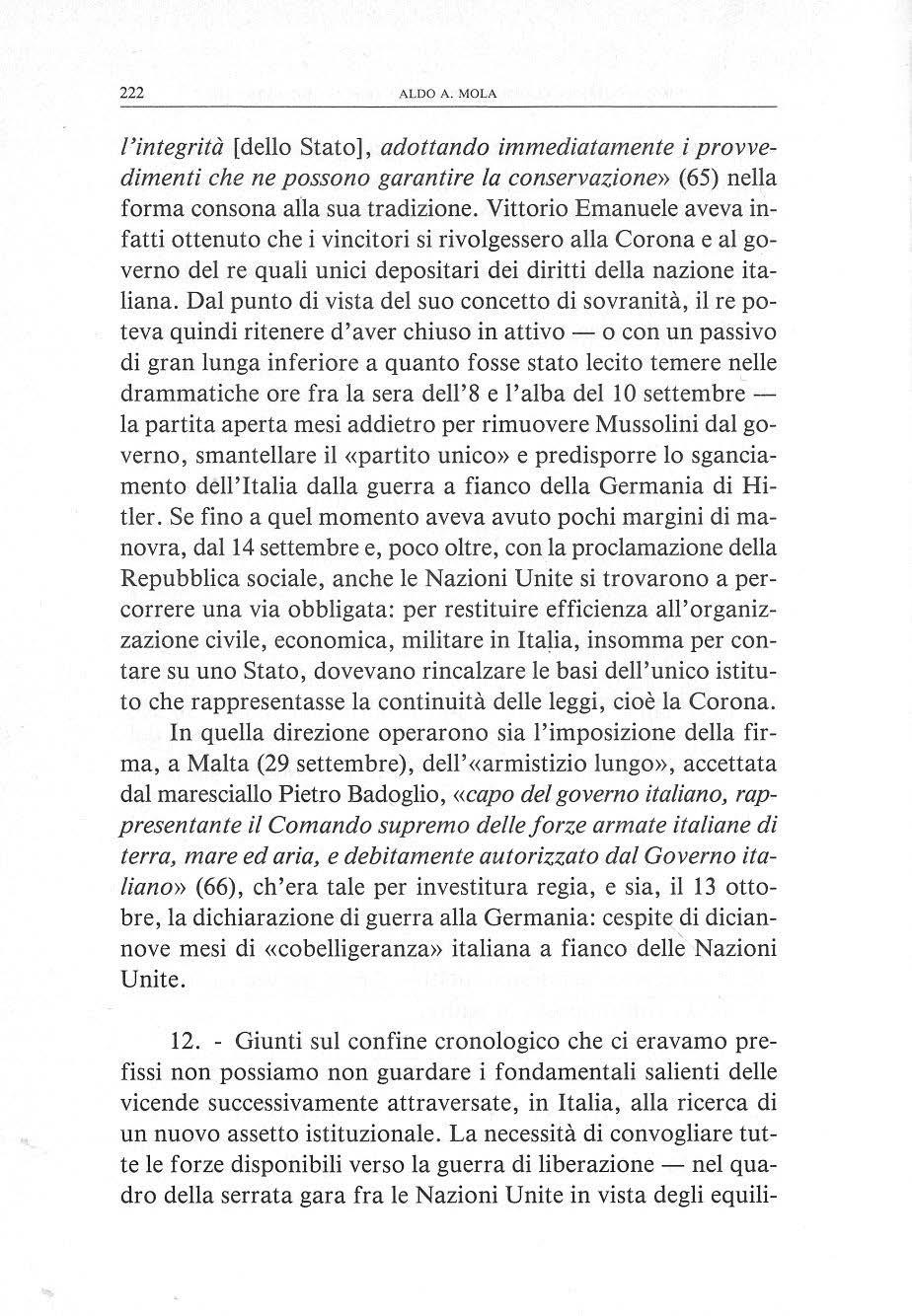
In quella direzione operarono sia l'imposizione della firma, a Malta (29 settembre), del!' «armistizio lungo», accettata dal maresciallo Pietro Badoglio, «capo del governo italiano, rappresentante il Comando supremo delle /orze armate italiane di terra, mare ed aria, e debitamente autorizzato dal Governo italiano» (66), ch'era tale per investitura regia, e sia, il 13 ottobre, la dichiarazione di guerra alla Germania: cespite di diciannove mesi di «cobelligeranza» italiana a fianco dellè Nazioni Unite.
12. - Giunti sul confine cronologico che ci eravamo prefissi non possiamo non guardare i fondamentali salienti delle vicende successivamente attraversate, in Italia, alla ricerca di un nuovo assetto istituzionale. La necessità di convogliare tutte le forze disponibili verso la guerra di liberazione - nel quadro della serrata gara fra le Nazioni Unite in vista degli equili-
bri post-bellici - condusse a quella «tregua istituzionale» che si tradusse in cospicuo vantaggio per la monarchia, anche perché la rinunzia all'esercizio dei poteri regali da parte di Vittorio Emanuele III, a differenza di quanto suggerito da Badoglio e da Benedetto Croce, non si tradusse in una reggenza - che sarebbe suonata condanna politica per il re e suo figlio (67)bensì nell'elevazione di Umberto a Luogotenente del re, come consigliato da Enrico De Nicola: preludio all ' assunzione della Corona dopo la tardiva abdicazione del maggio 1946. Il prolungamento della guerra oltre i più pessimistici timori dell'autunno 1943 non fece, poi, che rilanciare il prestigio della monarchia, che risaliva la penisola con gli Alleati e per molti divenne simbolo della liberazione. Si comprende, perciò , che la Corona abbia potuto riaffermare, col tempo, la sua centralità anche nella risorgente vita dei partiti, come mostr ò Ivanoe Bonomi quando si recò a rassegnare le dimissioni del suo governo al Luogotenente e non al Comitato centrale di liberazione nazionale, che riteneva di esserne il mandat ario. In quello stesso . clima di restaurazione potè aver luogo la nomina di un nuovo presidente del non più convocato Senato del regno e quella di un presidente della Camera, in attesa della convocazione dei comizi (68): segni esteriori grazie ai quali la forma de l potere assumeva ed esercitava potere sostanziale a van t aggio della Corona, cioè di una istituzione specialmente fondata su simboli e miti.
Quanto siamo andati dicendo non intende essere una giustificazione della condotta tenuta dal re, da Badoglio e dai vertici militari nel corso della crisi italiana dell'estate 1943, né insinuare ch'essi abbiano «fatto b ene» a precipitarsi da Roma a Brindisi lasciando allo sbando l ' esercito. Meno ancora ci preme contrapporre alle ricorrenti invettive contro la «viltà» dei militari l'ampia messe di fatti che pur costituiscono documento del prezzo pagato dalle Forze Armate in difesa del proprio Paese, sia con iniziative singole, sia affrontando con eroica determinazione le rappresaglie ordinate da Hitler (69) e sia accet-
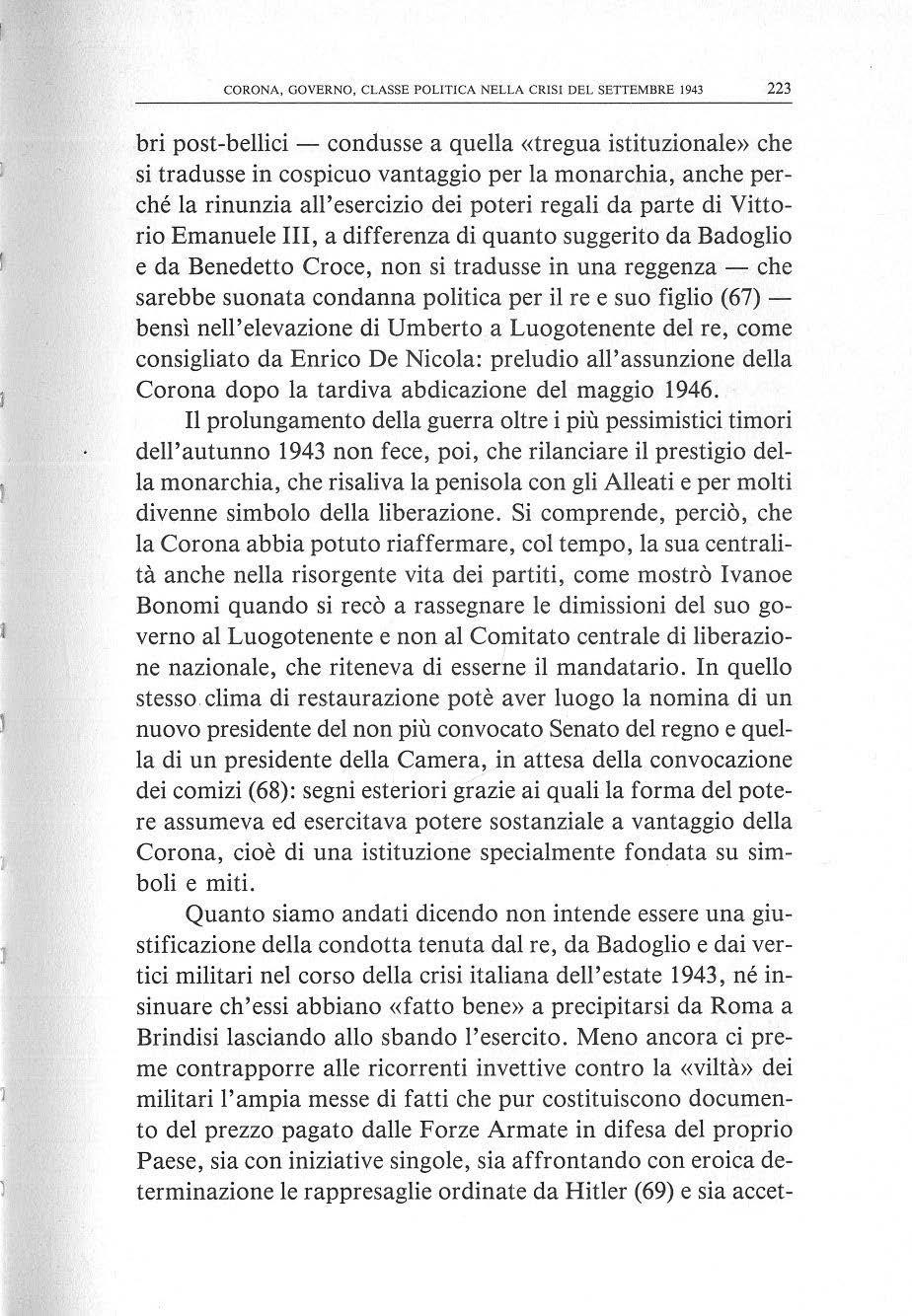
tando la deportazione in Germania, senza cedimenti nei confronti delle profferte di liberazione a patto d'inquadramento nelle file della Rsi. Semmai ve ne fosse bisogno, ripeteremo anche noi, con Croce, che l'ufficio della storia non è di formulare postume condanne o assoluzioni, bensì di spiegare per quali cagioni, tra le tante possibili, il corso storico abbia infine imboccato una sola direzione, giungendo a uno tra i tanti approdi che le premesse consentivano.
Abbiamo invece inteso descrivere il funzionamento di un assetto del potere, mostrandone la rigidità anche in presenza di una crisi gravissima. Come sarebbe stato politicamente ingenuo attendersi ch'esso funzionasse altrimenti, così risulta storiograficamente inconsistente l'addebito, da taluno mosso a quell'assetto - sorto con lo Statuto octroyé e deterioratosi per via, dapprima con l'avvento del fascismo al potere, poi col colpo di Stato del 25 luglio 1943 -, di non aver saputo investirsi delle aspirazioni politiche di forze a esso avverse e di non aver funzionato secondo i principi di una «democrazia» che gli era e gli sarebbe rimasta estranea. Non ci può attendere che un sistema dia frutti esogeni rispetto ai fini per i quali esso venne costruito. Non meno vano è poi pensare di modificarlo nei comportamenti lasciandone immutata la forma: tosto o tardi questa torna a generare la sostanza per la quale è stata ideata.
(1) Cit. in M. Toscano, Dal 25 luglio al/'8 settembre, Firenze, Le Monnier, 1966, pp. 177-78. «La campagna d'Italia» - ha osservato E. Aga Rossi, La politica degli Alleati verso l'Italia nel 1943, «Storia contemporanea», III, 1972, n. 4, p. 866 - [era iniziata] senza alcun piano né militare né politico a lungo termine, ma come risultato di successivi compromessi tra le diverse strategie inglesi e americane».
In merito all'ordinamento interno dell'Italia gli Usa erano, in generale, orientati a favore di un rinnovamento istituzionale profondo, mentre i britannici propendevano per accettare la differenziazione - proposta dal re e dal governo Badoglio - tra la Corona e il fascismo e conservare, per quanto possibile, le istituzioni esistenti, nel timore, espresso da Churchill
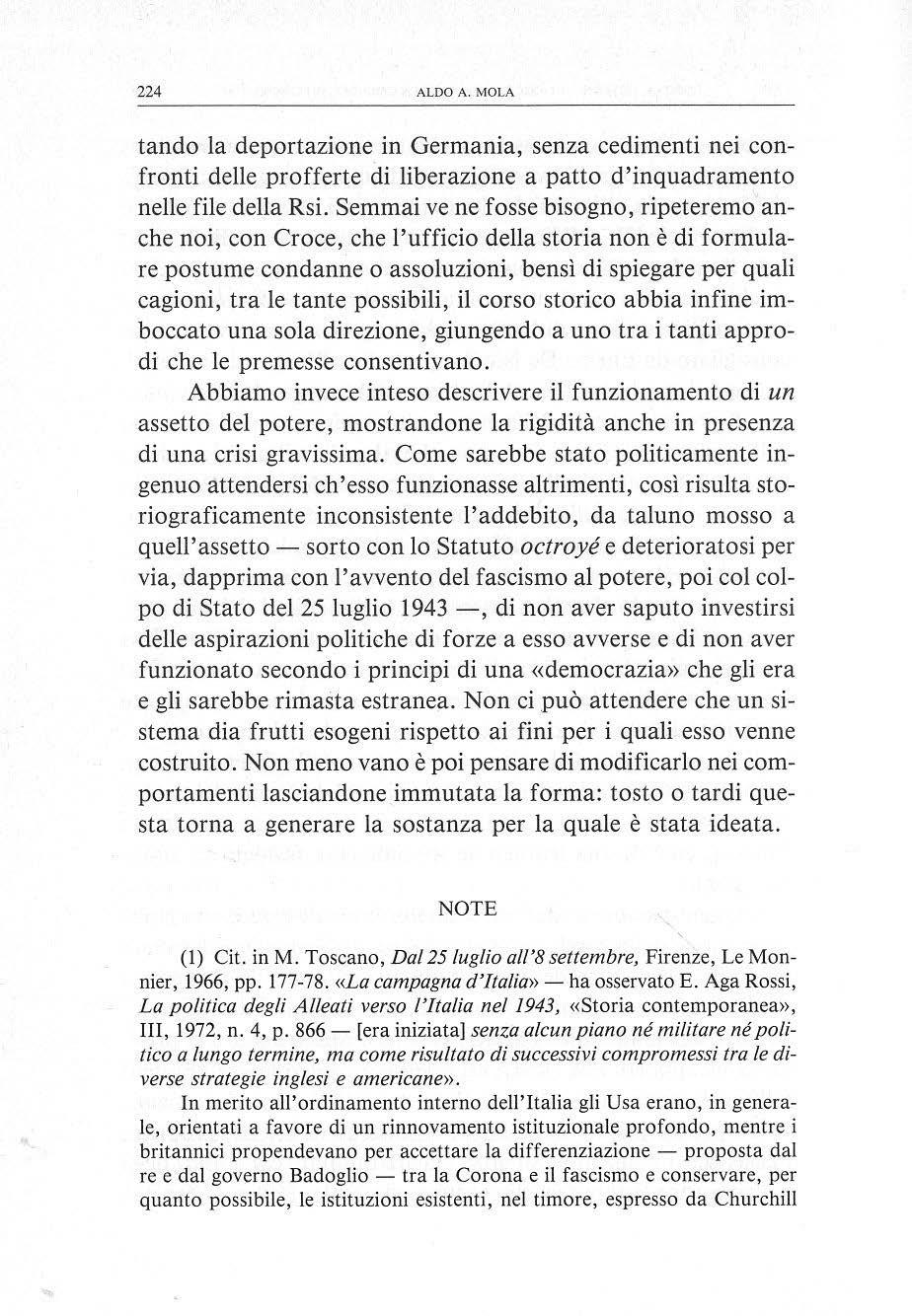
all'indomani del 25 luglio, che non vi fosse più nulla «tra il re e i patrioti raccolti attorno a lui( ... ) e il bolscevismo all'assalto». Per recenti rassegne storiografich e al riguardo, v. A. Varsori, Inghilterra e I talia, 1940-1943, «Nu ova anto lo g ia» f. 2147, lugli o-sette mbr e 1983 e E. Di No l fo, Quell'B settembre, ivi, f. 2148, ottobre-dicembre, ove comparve la relazione ripresa nel presente volume.
(2) « Il nostro obiettivo deve essere quello di cacciare l'Italia fuori della guerra il più rapidam ente possibile e ciò può essere realizzato quasi con lo stesso effetto, sia che l'Italia concluda una pace separata, sia che i risentimenti e i disordini all'interno del Paese raggiungano tali proporzioni che i Tedeschi siano costretti ed effettuare una occupazione totale»: ipotesi gradita a Londra perché Berlino avrebbe dovuto sostit uire con le proprie le truppe italiane su l fronte russo, in Francia e nei Balcan i , così da alleggerire le difese in vista dell'attacco anglo -americano sul fronte della Manica. « Pertanto - concludeva al riguardo Eden - il punto di vista del Governo di S.M. è quello che non dovremmo contare sulla possibilità di una pace separala, ma dovremmo mirare a provocare in Italia tali disordini da richiedere un'occupazione tedesca». A tale scopo veniva raccomandata l'intensificazione dei bombardamenti aerei sulle città italiane e della propaganda «disfattis ta». (M. Toscan o, op cit. pp. 14-17).
(3) M. Mazzetti, L'armistizio con l'Italia in base alle relazioni ufficiali anglo -americane, in Memorie storiche militari, 1978, Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Roma, 1978, p. 167.

(4) Tra gl'innume revoli argom enti giuridici concorrenti a lla defini zione del 25 luglio quale «colpo di Stato», a prova della frattura della continuità nel governo del Pae se, valga ricordare che la pras si stat utaria prevedeva che il presidente del consiglio dimissionario (nei caso, Benito Mussolini) controfirmasse il decreto di nomina del suo success ore, «assumendo perciò la responsabilità di una soluzione di massima della crisi ministeriale in accordo colle regole della correttezza costituzionale» (E. Crosa, La monarchia nel diritto pubblico italiano, Torino, Bocca, 1922, p. 124), pena, altrimenti, la nullità dell 'atto di nomina per la natura dei d ecret i regi: atti complessi nei quali dovevano concorrere la firma sovra na e quella di un ministro (Cro sa, op cit., pp. 34 e segg., e G. Maranini, Le origini dello Statuto albertino, Firenze, Vallecchi, 1926, pp. 230 e segg., a commento dell'art. 67 dello Statuto: « I ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro», combinato con agli artt. 5 e 6 dello Sta tuto stesso). Vedansi altresì C A. J emolo, Continuità e discontinuità costituzionale nelle vicende italiane del 25 luglio 1943, «Atti dell'Accademia dei Lincei. Classe scienze morali», II, 1947, n. 34, e E . Lodo lini , Le illegittimità del governo Badoglio . Storia costituz ionale del «quinquennio rivoluzionario» (25 luglio 1943 - 1 ° gennaio 1948), Milano, Gas tal di 1953.
(5) Per una rassegna storiografica sul crollo del regime, v. N Gallerano , Fascismo: la caduta, in Storia d'Italia, a cura di F. Levi, U Le vra, N
Tranfaglia, Firenze, la Nuova Italia, voi. 2°, 1978, pp. 489-500; L. Cortesi, Lotta politica e continuità dello Stato nel 1943, in «Movimento operaio e socialista>>, 1969, n. 4 . L'opera documentariamente più ampia sulla caduta del fascismo riamane G. Bianchi, 25 luglio: crollo di un regime, Milano, Mursia, I a ed. 1963; con più ampia prospettiva tematica, v . altresì F . W. Deaki n, Storia della repubblica di Salò, Torino, Einaudi, 1963.
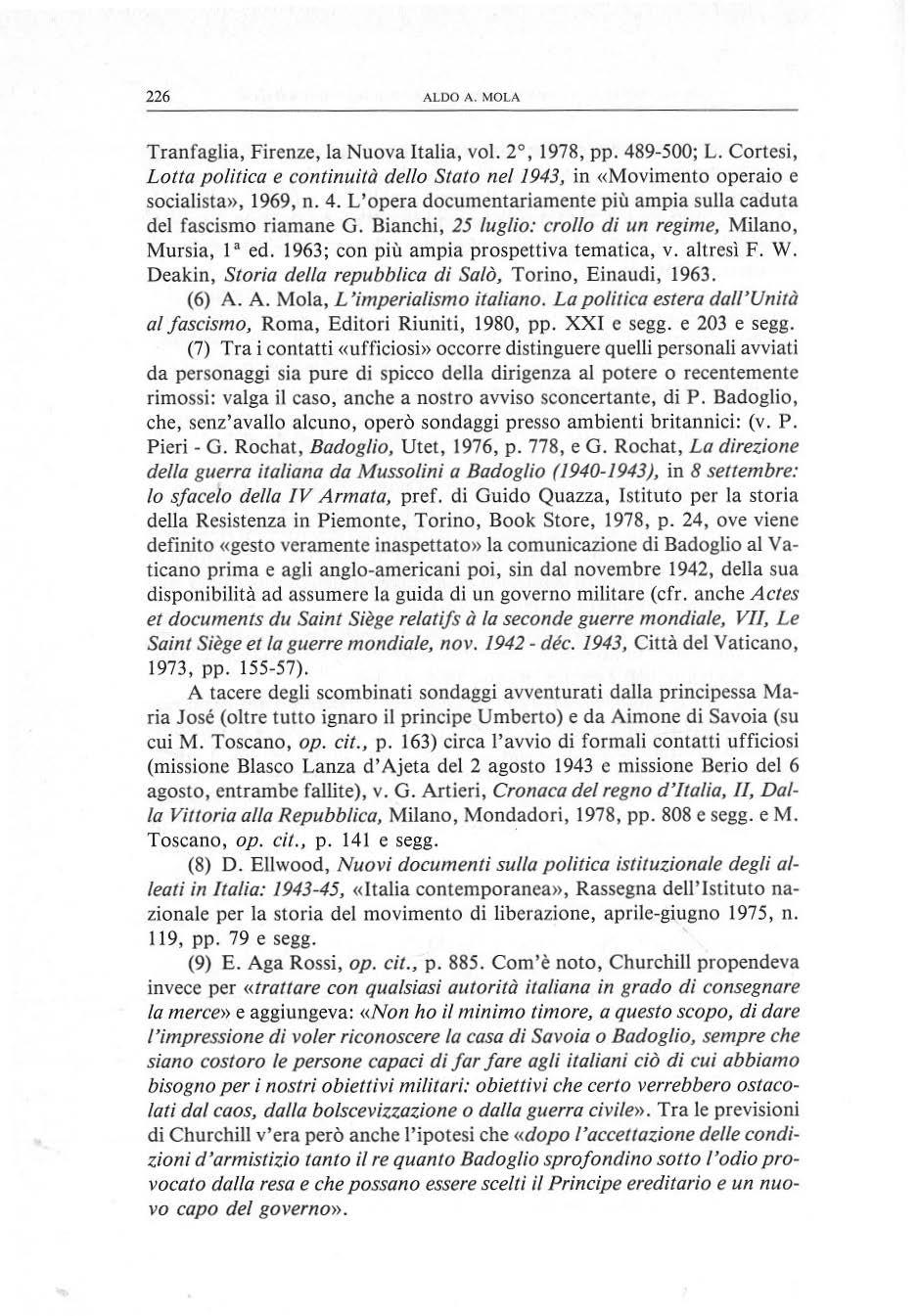
(6) A. A. Mola, L'imperialismo italiano. La politica estera dall'Unità al fascismo, Roma, Editori Riuni ti, 1980, pp . XXI e segg . e 203 e segg.
(7) Tra i contatti «ufficiosi» occorre distinguere quelli personali avviati da personaggi sia pure di spicco della dirigenza al potere o recentemente rimossi: valga il caso, anche a nostro avviso sconcertante, di P. Badoglio, che, senz'av allo alcuno, operò sondaggi presso ambienti britannici: (v. P. Pi eri - G. Rochat, Badoglio, Utet, 1976, p. 778, e G. Rochat, La direzione della guerra italiana da Mussolini a Badoglio (1940-1943), in 8 settembre: lo sfacelo della IV Armata, pref. di Guido Quazza, Istituto per la storia della Resistenza in Piemonte, Torino, Book Stare, 1978, p. 24, ove viene definito «gesto veramente inaspettato» la comunicazione di Badoglio al Vaticano prima e agli anglo-americani poi, sin dal novembre 1942, della sua disponibilità ad assumere la guida di un governo militare (cfr. anche Actes et documents du Saint Siège relatijs à la seconde guerre mondiale, VII, Le Saint Siège et la guerre mondiale, nov. 1942 - déc. 1943, Città del Vaticano, 1973, pp. 155-57).
A tacere degli scombinati sondaggi avventurati dalla principessa Maria José (oltre tutto ignaro il principe Umberto) e da Aimone di Savoia (su cui M. Toscano, op. cit., p. 163) circa l'avvio di formali contatti ufficiosi (missione Blasco Lanza d' Ajeta del 2 agosto 1943 e missione Berio del 6 agosto, entrambe fallite), v. G. Artieri, Cronaca del regno d'!Lalia, Il, Dalla Vittoria alla Repubblica, Milano, Mondadori, 1978, pp. 808 e segg. e M. Toscano, op. cit., p . 141 e segg.
(8) D. Ellwood, Nuovi documenti sulla politica istituzionale degli alleati in Italia: 1943-45, «Ita lia contemporanea», Rassegna dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione, aprile-giugno 1975, n. 119, pp. 79 e segg.
(9) E. Aga Rossi, op. cit., p. 885. Com'è noto, Churchill propendeva invece per «trattare con qualsiasi autorità italiana in grado di consegnare la merce» e aggiungeva: «Non ho il minimo timore, a questo scopo, di dare l'impressione di voler riconoscere la casa di Savoia o Badoglio, sempre che siano costoro le persone capaci di far fare agli italiani ciò di cui abbiamo bisogno per i nostri obiettivi militari: obiettivi che certo verrebbero ostacolati dal caos, dalla bolscevizzazione o dalla guerra civile». Tra le previsioni di Churchill v'era però anche l'ipotesi che «dopo l'accettazione delle condizioni d'armistizio tanto il re quanto Badoglio sprofondino sotto l'odio provocato dalla resa e che possano essere scelti il Principe ereditario e un nuovo capo del governo».
(10) Come Vittorio Emanuele III venne bollato in una trasmissione radiofonica per l'Europa dell'Office War Information il 26 luglio 1943. In proposito J .P. Diggins, L'America, Mussolini e il fascismo, Bari, Laterza, 1972, pp. 367-68.
(Il) Su cui AA.VV., L'Italia dei quarantacinque giorni: 25 luglio - 8 settembre 1943, Istituto nazionale per la storia del MLI, Milano, 1969. La ricerca compiuta dagli Autori di quel volume conclude con l'individuazione di 83 morti (43 dei quali il 28 luglio) 516 feriti e 2059 arresti, quale bilancio complessivo degli scontri fra dimostranti ed esercito all'indomani del 25 luglio; 10 morti, 20 feriti e 227 arresti per violazione del coprifuoco; 12 morti, 36 feriti e 169 arresti (distinti tra «fascisti» e «antifascisti») per incidenti verificatisi tra la folla. Il 3 agosto 1943 l'assistente del rappresentante personale del presidente degli Stati Uniti, Roos evelt, presso la S Sede, Tittmann osservava comunque che «il Governo Badoglio ha attualmente sotto controllo la situazione interna e il timore di disordini sociali è per ora cessato», aggiungendo che «tale Governo ha avuto fin dall'inizio l'appoggio del Vaticano» (M. Toscano , op. cit., p. 41). Sul sostegno profferto dalle organizzazioni cattoliche al governo Badoglio, T. Sala, Un 'offerta di collaboraz ione de/l'Azione Cattolica italiana al governo Badoglio (agosto 1943), «Rivista di storia contemporanea», Torino, Loescher, 1972, n. I; ma v. anche Mario Casella , L'Azione Cattolica alla caduta del fascismo, Roma, Studium, 1984.
(12) M. Toscano, op. cit ., p. 24. Sulla «grave debolezza dell'antifascismo ''politico", come si ripresenta nel paese nella prima meta del '43 e poi nelle settimane badogliane» insiste anche G. Quazza, Resistenza e storia d'Italia: problemi e ipotesi di ricerca, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 99. A sua volta - prendendo atto dello scarso seguito di cui i partiti si mostrarono capaci nell'estate 1943 - Giorgio Amendola parlò di fallimento dell'iniziativa popolare quale cau sa della «priorità dell'intervento reg io», sostanzialmente privo di realistiche alternative e che, pertanto, non può essere giudicato una sorta di controrivoluzione preventiva, bensì come unica iniziativa effettivamente atta ad avviare lo sganci amento dell'Italia dalla Germania (G. Amendola, Unità e socialismo, dibattito fra Amendola, Lelio Basso e Giancarlo Pajetta, «Rinascita», 1965, n. 22, 17 luglio, p. 16).
(13) M. Toscano, op. cit., p. 24.
(14) L'irrilevanza costituzionale della pronunzia del Gran Consiglio fu asserita, non senz a fondamento, da C. A . Biggini (v . L. Gariba ld i, Mussolini e il professore: vita e diari di Carlo Alberto Biggini, Milano, Mursia, 1983, pp. 60 e segg ). Ri tennero invece vincolante per la Corona il voto del Gran Consiglio altri costituzionalisti, fatti consultare dal re.
( 15) Non men o efficace fu l 'appello del PNF ai suoi maggio r i esponenti affinché galvanizzassero le «masse» con una massiccia sortita di oratoria patriottica. Negli ultimi mesi del regime si radicalizzò la differenza tra quanti invocavano una «seconda ondata» - cioè il ritorno all'intransigentismo dell e origi n i, ispirato da Roberto Far inacci - e quanti invece pro-
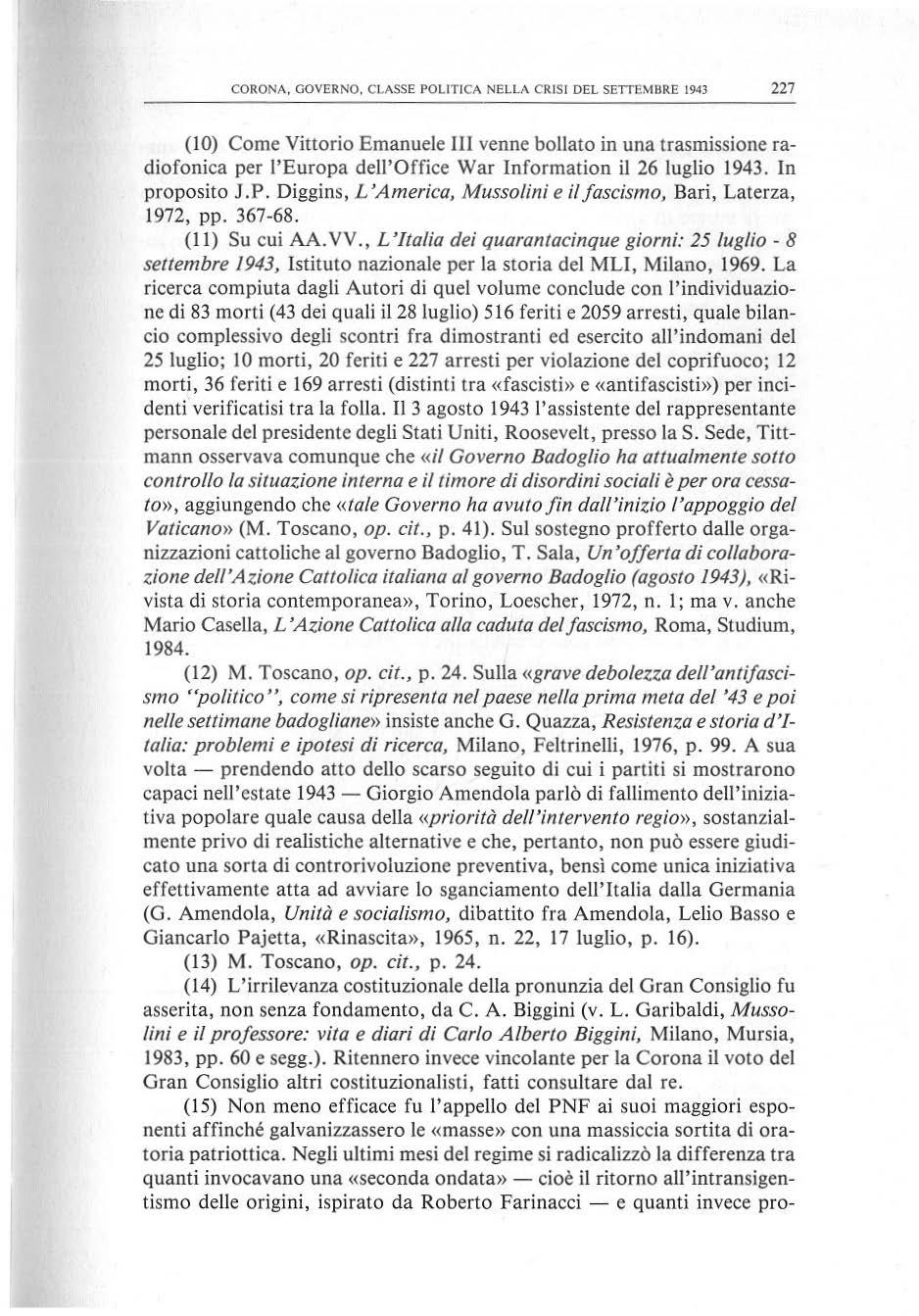
pendevano per la definitiva dissoluzione del fascismo nell'ambito della «nazione», come suggerivano, con l'antico capo del nazionalismo, Luigi Federzoni, i gerarchi Dino Grandi e Giuseppe Bottai. Quanto più il fascismo aveva mirato (o preteso) di assorbire in sé tutti gli aspetti vitali della nazione, tanto più esso doveva rinunziare a identificarsi con una sua sola corrente . In questo senso, anche storici d'orientamento antifascista (Luigi Salvatorelli, Giacomo Perticone ...) asserirono che il fascismo s'avviava ormai, nei suoi ultimi tempi, a riconoscere una qualche forma di «pluralismo» di tendenze, se non al riconoscimento pubblico dei partiti: soluzione, codesta, peraltro rifiutata anche da militanti antifascisti, fra i quali, Duccio Galimberti e Antonino Repaci, nel Progetto di costituzione confedera/e europea ed interna (ed. Torino -Cuneo, 1946), all'art. 56 proponevano: «È garantita la libertà di pensiero, ma è vietata la costituzione di partiti politici» (p. 71) .
(16) G. Vaccarino, Il 25 luglio . La crisi del fascismo, «Il movimento di liberazione in Italia», n. 72, 1963, n. 3, pp. 12 e segg
(17) Per una cauta equilibrata interpretazione C . Pinzani, L '8 settembre 1943: elementi ed ipotesi per un giudizio storico, «Studi storici», XIII, 1972, n. 2, pp . 289 e segg., ove si ricorda che ancora «nell'autunno del '43 le masse popolari erano sostanzialmente disorientate» (p . 334).
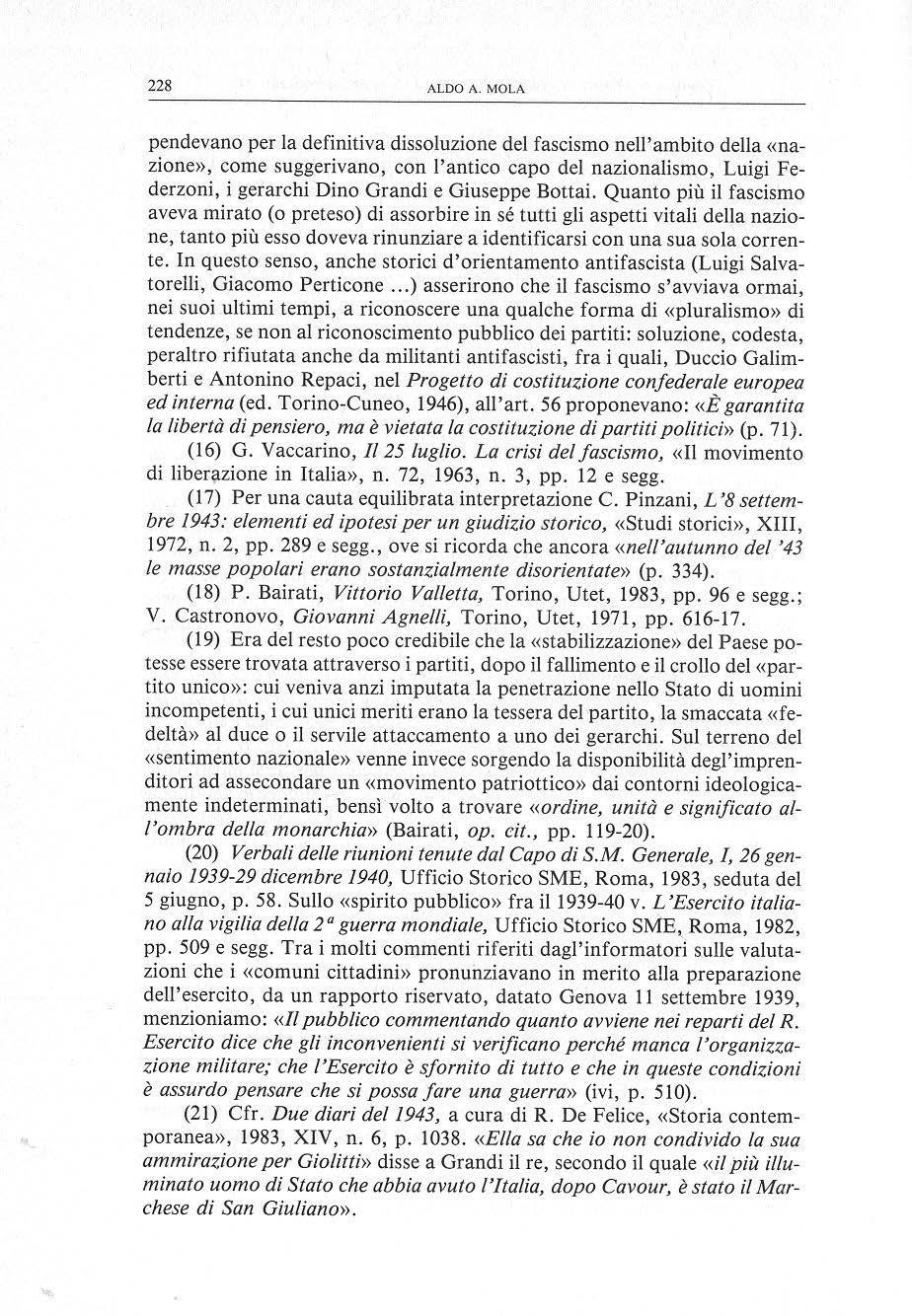
(18) P. Bairati, Vittorio Valletta, Torino, Utet, 1983, pp. 96 e segg . ; V. Castronovo, Giovanni Agnelli, Torino, Utet, 1971, pp. 616-17.
(19) Era del resto poco credibile che la «stabilizzazione» del Paese potesse essere trovata attraverso i partiti, dopo il fallimento e il crollo del «partito unico»: cui veniva anzi imputata la penetrazione nello Stato di uomini incompetenti, i cui unici meriti erano la tessera del partito, la smaccata «fedeltà» al duce o il servile attaccamento a uno dei gerarchi. Sul terreno del «sentimento nazionale» venne invece sorgendo la disponibilità degl'imprenditori ad assecondare un «movimento patriottico» dai contorni ideologicamente indeterminati, bensì volto a trovare «ordine, unità e significato all'ombra della monarchia» (Bairati, op. cit., pp . 119-20).
(20) Verbali delle riunioni tenute dal Capo di S . M. Generale, I, 26 gennaio 1939-29 dicembre 1940, Ufficio Storico SME, Roma, 1983, seduta del 5 giugno, p. 58 . Sullo «spirito pubblico» fra il 1939-40 v . L'Esercito italiano alla vigilia della 2a guerra mondiale, Ufficio Storico SME\ Roma, 1982, pp. 509 e segg . Tra i molti commenti riferiti dagl'informatori sulle valutazioni che i «comuni cittadini» pronunziavano in merito alla preparazione dell'esercito, da un rapporto riservato, datato Genova l 1 settembre 1939 , menzioniamo: «Il pubblico commentando quanto avviene nei reparti del R. Esercito dice che gli inconvenienti si verificano perché manca l'organizzazione militare; che l'Esercito è sfornito di tutto e che in queste condizioni è assurdo pensare che si possa fare una guerra » (ivi, p. 510) .
(21) Cfr. Due diari del 1943, a cura di R . De Felice, «Storia contemporanea>>, 1983, XIV, n. 6, p . 1038. «Ella sa che io non condivido la sua ammirazione per Giolitti>> disse a Grandi il re, secondo il quale «il più illuminato uomo di Stato che abbia avuto l'Italia, dopo Cavour, è stato il Marchese di San Giuliano» .
(22) D. Grandi, Pagine di Diario del 1943, in Due Diari, cit., p. 1040. Già ricordata da D. Grandi in una lunga intervista, la citazione era stata utilizzata da S. Bertoldi, Vittorio Emanuele III, Torino, Utet, 1970, pp. 382-83. Dello stesso v. altresì Contro Salò: ·vita e morte del regno d'Italia, Milano, Bompiani, 1984.
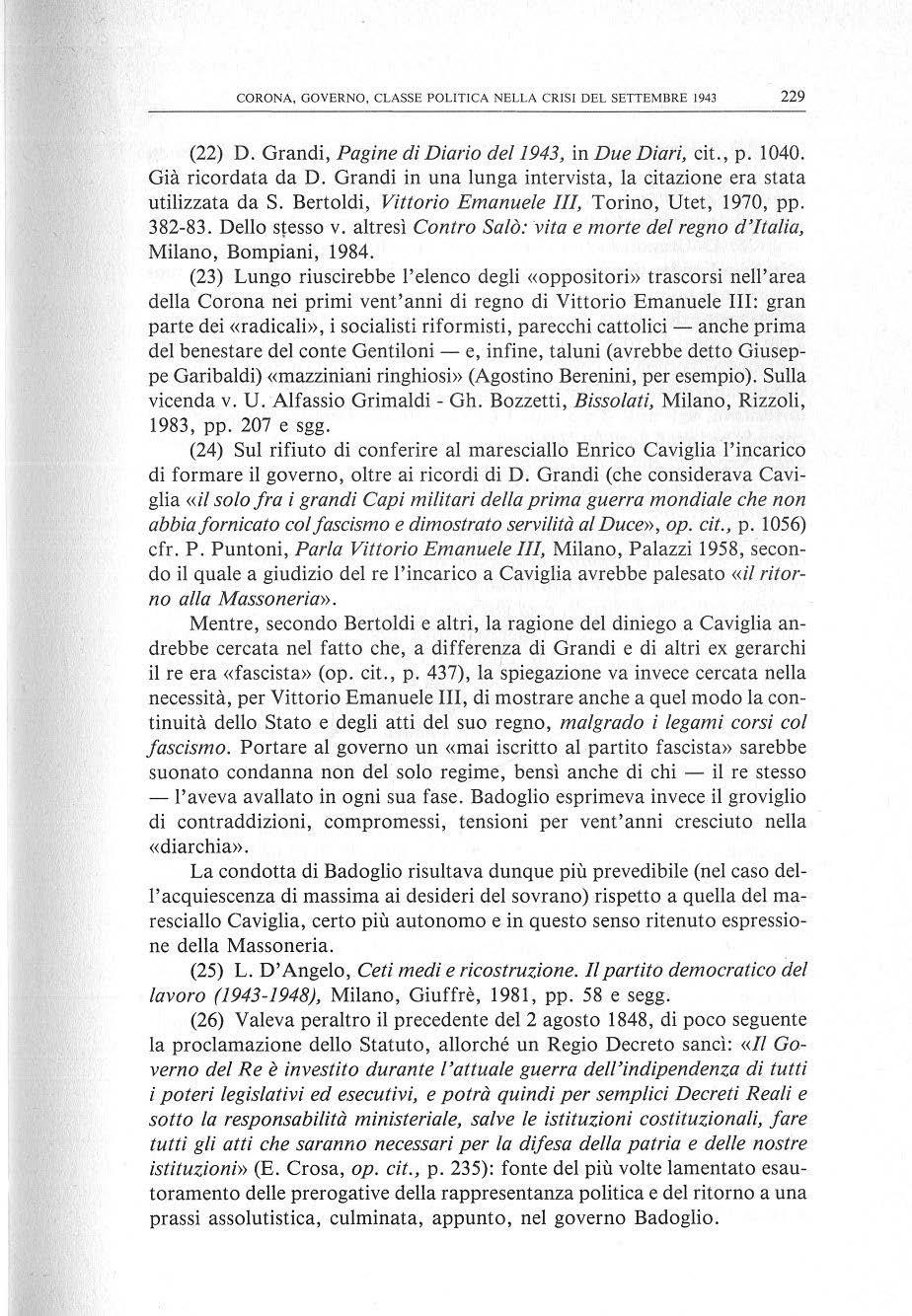
(23) Lungo riuscirebbe l'elenco degli «oppositori» trascorsi nell'area della Corona nei primi vent'anni di regno di Vittorio Emanuele III: gran parte dei «radicali», i socialisti riformisti, parecchi cattolici - anche prima del benestare del conte Gentiloni - e, infine, taluni (avrebbe detto Giuseppe Garibaldi) «mazziniani ringhiosi» (Agostino Berenini, per esempio). Sulla vicenda v. U. Alfassio Grimaldi - Oh. Bozzetti, Bisso/ali, Milano, Rizzoli, 1983, pp. 207 e sgg.
(24) Sul rifiuto di conferire al maresciallo Enrico Caviglia l'incarico di formare il governo, oltre ai ricordi di D. Grandi (che considerava Caviglia «il solo fra i grandi Capi militari della prima guerra mondiale che non abbia fornicato col fascismo e dimostrato servilità al Duce», op. cit., p. 1056) cfr P Puntoni, Parla Vittorio Emanuele III, Milano, Palazzi 1958, secondo il qua le a giudizio del re l'incarico a Caviglia avrebbe palesato «il ritorno alla Massoneria» .
Mentre, secondo Bertoldi e altri, la ragione del diniego a Caviglia andrebbe cercata nel fatto che, a differenza di Grandi e di altri ex gerarchi il re era «fascista» (op. cit., p. 437), la spiegazione va invece cercata nella necessità, per Vittorio Emanuele Ili, di mostrare anche a quel modo la continuità dello Stato e degli atti del suo regno, malgrado i legami corsi col fascismo. Portare al governo un «mai iscritto al partito fascista» sarebbe suonato condanna non del solo regime, bensì anche di chi - il re stesso - l'aveva a va llato in ogni sua fase. Badoglio esprimeva invece il groviglio di contraddizioni, compromessi, tensioni per vent'anni cresciuto nella «diarchia».
La condotta di Badoglio risultava dunque più prevedibile (n el caso dell'acquiescenza di massima ai desideri del sovran o) rispetto a quella del maresciallo Caviglia, certo più autonomo e in questo senso ritenuto espressione della Massoneria .
(25) L. D'Angelo, Ceti medi e ricostruzione. Il partito democratico del lavoro (1943 -1948), Milano, Giuffrè, 1981, pp. 58 e segg .
(26) Valeva peraltro il precedente del 2 agosto 1848, di poco seguente la proclamazione dello Statuto, allorché un Regio Decreto sancì: «Il Governo del Re è investito durante l'attuale guerra de/l'indipendenza di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, e potrà quindi per semplici Decreti Reali e sotto la responsabilità ministeriale, salve le istituzioni costituzionali, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni» (E Crosa, op. cit , p. 235) : fonte del più volte lamentato esautoramento delle prerogative della rappresentanza politica e del ritorno a una prassi assolutistica , cu lminata, appunto, nel governo Badoglio.
(27) Sul movimento dei prefetti operato dal governo Badoglio v. AA. VV., L'Italia dei quarantacinque giorni ... , cit., pp. 179 e segg. e C. Pavone, La continuità dello Stato : istituzioni e uomini, in AA . VV . , Italia 1945-48: le origini della Repubblica, Torino, Glappichelli, 1974, pp. 267-82.
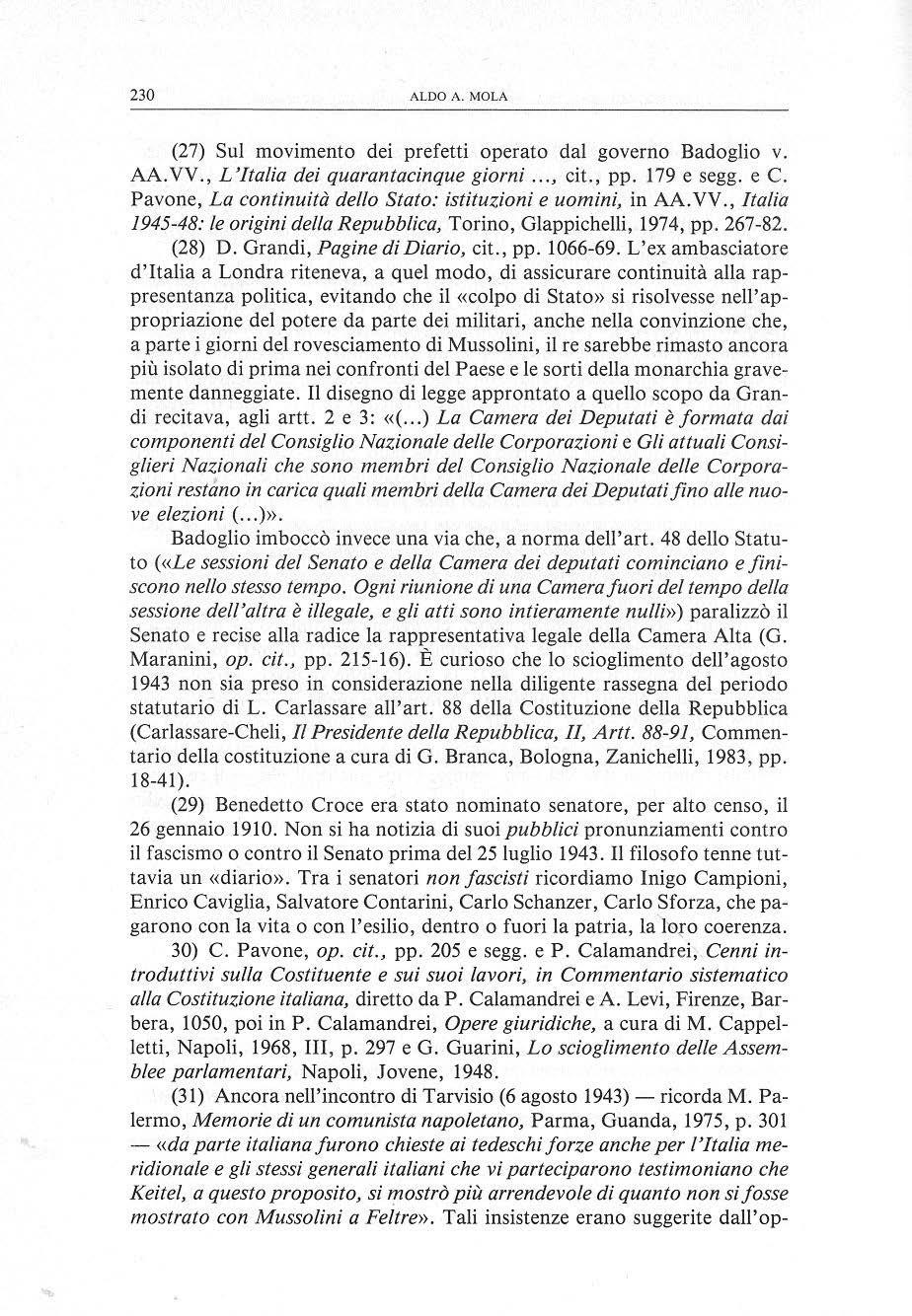
(28) D. Grandi, Pagine di Diario, cit., pp. 1066-69. L'ex ambasciatore d'Italia a Londra riteneva, a quel modo, di assicurare continuità alla rappresentanza politica, evitando che il «colpo di Stato» si risolvesse nell'appropriazione del potere da parte d ei militari, anche nella convinzione che, a parte i giorni del rovesciamento di Mussolini, il re sarebbe rimasto ancora più isolato di prima nei confronti del Paese e le sorti della monarchia gravemente danneggiate . Il disegno di legge approntato a quello scopo da Grandi recitava, agli artt. 2 e 3: «( ... ) La Camera dei Deputati è formata dai componenti del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e Gli attuali Consiglieri Nazionali che sono membri del Consiglio Nazionale delle Corporazioni restano in carica quali membri della Camera dei Deputati fino alle nuove elezioni ( )».
Badoglio imboccò invece una via che, a norma dell'art. 48 dello Statuto («Le sessioni del Senato e della Camera dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti sono intieramente nulli») paralizzò il Senato e recise alla radice la rappresentativa legale della Camera Alta (G Maranini, op. cit , pp. 215-16). È curioso che lo scioglimento dell'agosto 1943 non sia preso in considerazione nella diligente rassegna del periodo statutario di L. Carlassare all'art. 88 della Costituzione della Repubblica (Carlassare-Cheli, Il Presidente della Repubblica, Il, Artt. 88-91, Commentario della costituzione a cura di G. Branca, Bologna, Zanichelli, 1983, pp . 18-41).
(29) Benedetto Croce era stato nominato senatore, per alto censo, il 26 gennaio 1910 . Non si ha notizia di suoi pubblici pronunziamenti contro il fascismo o contro il Senato prima del 25 luglio 1943 . Il filosofo tenne tuttavia un «diario». Tra i senatori non fascisti ricordiamo Inigo Campioni, Enrico Caviglia, Salvatore Contarini, Carlo Schanzer, Carlo Sforza, che pagarono con la vita o con l'esilio, dentro o fuori la patria, la loio coerenza.
30) C. Pavone, op cit., pp 205 e segg e P Ca lamandrei, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, dir etto da P . Calamandrei e A. Levi, Firenze, Barbera, 1050, poi in P. Calamandrei, Opere giuridiche, a cura di M . Cappelletti, Napoli, 1968, Ili, p. 297 e G. Guarini, Lo scioglimento delle Assemblee parlamentari, Napoli, Jovene, 1948 .
(31) Ancora nell'incontro di Tarvisio (6 agosto 1943) - ricorda M . Palermo, Memorie di un comunista napoletano, Parma, Guanda, 1975, p. 301 - «da parte italiana furono chieste ai tedeschi forze anche per l'Italia meridionale e gli stessi generali italiani che vi parteciparono testimoniano che Keitel, a questo proposito, si f!ZOStrò più arrendevo/e di quanto non si fosse mostrato con Mussolini a Feltre». Tali insistenze erano suggerite dall'op-
portunità di allontanare qualsiasi sospetto sulle trattative armistiziali, ormai decise e avviate: il loro soddisfacimento, nondimeno, non poteva che aggravare la già disperata situazione dell'esercito italiano, tanto più che veniva a urtare contro l'opposizione italiana nei confronti dei tentativi germanici di accorrere, non richiesti, a «proteggere» la base navale di La Spezia, dalla quale furono respinti manu militari (D. Bartoli, L'Italia si arrende, Milano, Editoriale Nuova, 1983, pp. 149-50).
(32) A. Santoni, Le operazioni in Sicilia e in Calabria (luglio -settembre 1943), Roma, Ufficio storico SME, 1983.
(33) G. Castellano, Come firmai l'armistizio di Cassibile, Milano, Mondadori, 1945. Secondo quel generale - di cu i s i vedano anche La guerra continua, Milano, Rizzoli, 1963, e Roma kaputt. Contributo ad una discussione storica, Roma, Casini, 1967 - i militari presero la guida della liquidazione del fascismo perché «senza capi che le organizzino e senza armi per attuarle le rivoluzioni non si fanno» (p . 69) - ove dunque la fatidica parola, «rivoluzione», torna nella penna di un militare d'orientamento sicuramente conservatore, a conferma deJla perenne confusione delle linguee, successivamente, tennero in pugno le trattative armistiziali con gli angloamericani perché il governo «dormiva» (p. 80). A commento delle proposte di cui Castellano - sul quale v. S. Hoare, In missione speciale, Milano, Rizzoli, 1948 - e il gen . Zanussi - inviato all'insaputo di Castellano, con compito analogo, tanto da ingenerare legittimi sospetti sull'attendibilità degli emissari italiani - furono latori, M. Toscano, ribaltando sui militari l'insinuazione d'incapacità da costoro lanciata nei confronti dei diplomatici tradizionali, scrisse: «È bene che si sappia che l'assoluta inesperienza dello Stato Maggiore italiano circa la complessità delle operazioni aero-navali induceva ad auspicare con estrema facilità sbarchi nella penisola tecnicamente impossibili a breve scadenza» (op. cit., p. 46) . Sulla missione Zanussi si veda
G. Zanussi, Guerra e catastrofe d'Italia, voll. 2, Roma, Corso 1946 e, su altri sondaggi, E . Lanza D' Ajeta, Documenti prodotti a corredo della memoria presentata al Consiglio di Stato, Roma, Ferraiolo, 1946 e A. Berio, Missione segreta (Tangeri 1939-1943), Milano, Dall'Oglio, 1947. Uti le altresì la «testimonianza» del capo del governo: P . Badoglio, L'Italia nella seconda guerra mondiale, Milano, Mondadori, 1946: V. Vailati, Badoglio racconta, Torino, Ilte, 1955 e Id., Badoglio risponde, Milano, Rizzoli, 1958.
(34) G. Artieri, op. cit., p. 848. Lo stesso Artieri, pur non prevenuto nei confronti della Corona, definisce «odissea squallida e stravolta» il <<viaggio terrestre verso Pescara» (p. 856).
(35) L. Marchesi, Come siamo arrivati a Brindisi, Milano, Bompiani, 1969, p . 64: «Badoglio non aveva espresso un parere ben chiaro(. .. ) in ogni modo il re decise di accettare le condizioni».
(36) La versione italiana dei testi armistiziali e della Dichiarazione di Québec venne ripubblicata in «Relazioni Internazionali», 1983, n. 35, in occasione del Convegno internazionale «Otto settembre 1943: l'armistizio italiano 40 anni dopo» (Milano, Palazzo Clerici, 7-8 settembre 1983), i cui Atti sono raccolti nel presente volume.
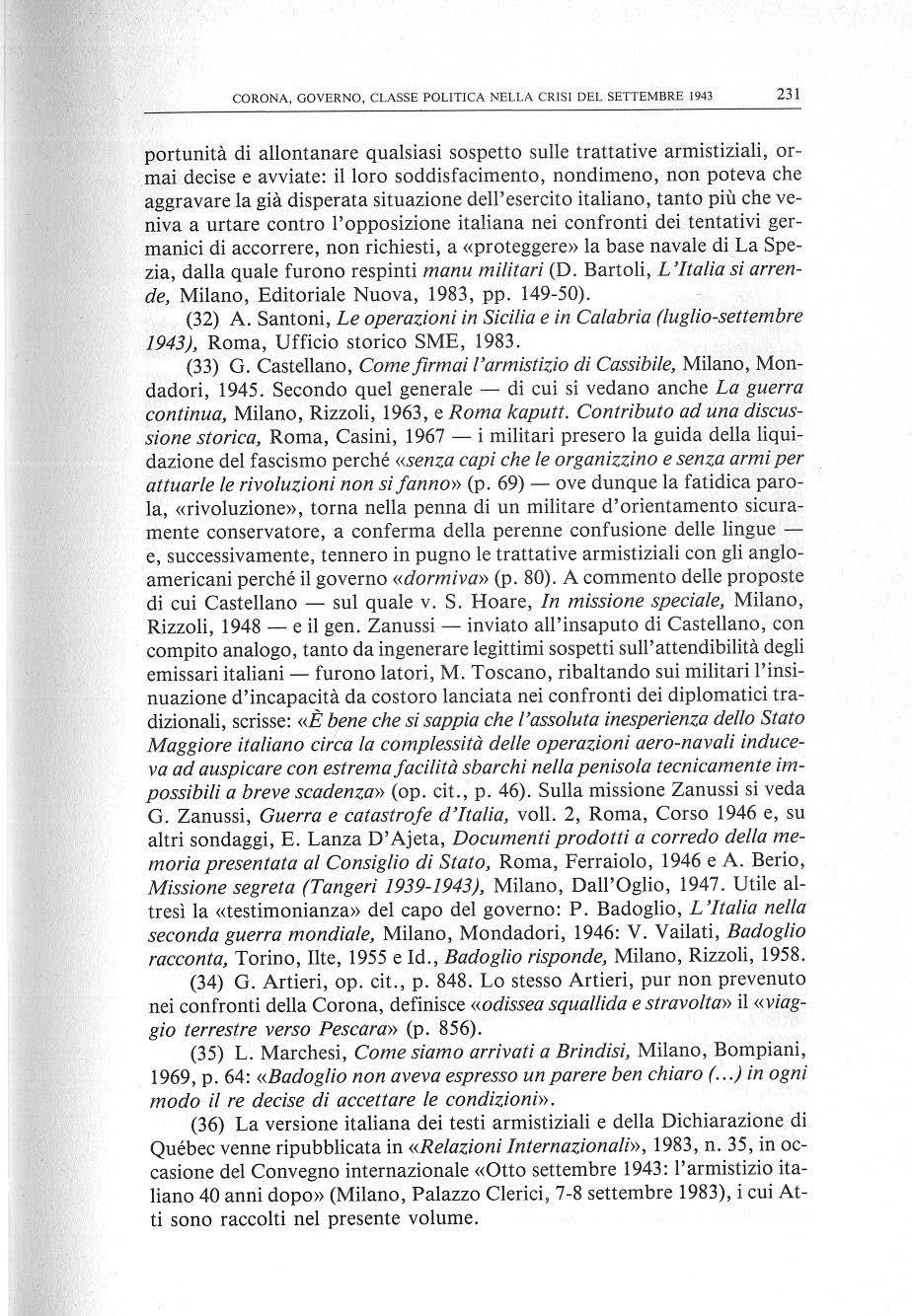
(37) G. Artieri, op cit , pp. 864 e segg: valutazione confermata anche dagli storici più prevenuti nei confronti della monarchia. Harold Mac Millan lamentò quell'attegg iamento «strano per un ufficiale britannico», osservando : «Forse è attorno alla monarchia che noi potremo in qualche modo mettere insieme un Governo» (The blast of War, 1939-1945, London, MacMillan, 1967).
(38) «Le condizioni di armistizio - recita il "Promemoria di Québec" - non contemplano l'assistenza attiva dell'Italia nel combattere i tedeschi. La misura nella quale le condizioni saranno modificate in favore dell'Italia dipenderà dall'entità dell'apporto dato dal Governo e dal popolo italiano alle Nazioni Unite contro la Germania durante il resto della guerra ., Le Nazioni Unite dichiarano tuttavia senza riser ve che ovunque le forze italiane e gli italiani combatteranno i tedeschi, o distruggeranno proprietà tedesche, od ostacoleranno i movimenti tedeschi, essi riceveranno tutto l'aiuto possibile delle forze delle Nazioni Unite ... »: la profonda diffidenza nei confronti del sospettato doppiogioco degl'Italiani e le difficoltà oggettive dissuas ero nondimeno gli anglo-americani dal fornire agli Italiani un supporto adeguato nel momento più difficile, cioè nei giorni immediatamente seguenti la proclamazione dell'armistizio, durante i quali l'esercito italiano venne abbandonato a se stesso, ovvero alla sconfitta e alla rappresaglia dell'ex alleato.
(39) Estraneo allo Statuto, tale istituto s'affacciò nei giorni della marcia di D'Annunzio su Fiume, come ricorda Luigi Federzoni, Italia di ieri per la storia di domani, Milano, Mondadori, 1967.
L'eterogeneità dei presenti alla riunione - oltreché, s'intende, la mancanza di qualsiasi formalità nella sua convocazione e nei su oi lavori, nel cui corso ebbe parte determinante il maggiore Luigi Marchesi - indica la natura ecceziona le, non istituzionale, di quel consesso, sul quale G. Carboni, Memorie segrete, 1938-1945, Firenze, Parenti, 1955; M. Roatta, Otto milioni di baionette. L'esercito italiano in guerra dal 1940-1944, Milano, Mondadori, 1946; L. Marchesi, op. cit., p. 102, e Appendice (pp. 163 e segg.), nonchè R. Zangrandi, L'Italia tradita, Milano, Mursia, 1971, pp. 134 e segg , col quale conco rdiamo ove scrive che «la definizione stessa di "Consiglio della Corona" è impropria» . '
(40) S . Bertoldi, op. cit., p. 452 . Circa gli antecedenti dell'armistizio e le ragioni che vi avevano orientato la condotta del re, v. altresì la lettera inviata da Vittorio Emanuele II al duca d' Acquarone, quando questi dovette difendersi dai procedimenti epura tivi a suo carico (ivi, p. 463) .
(41) C . Ghisalberti, Storia costituzionale d'Italia, 1848- 1948, Bari, Laterza, 1977 (2a ed.), vo i. 2°, p. 391. Secondo Ghisalberti dopo l'armistizio «la monarchia non aveva in realtà che limitati poteri anche perché buona parte del territorio sottratto all'occupazione tedesca era sotto il diretto governo militare anglo -americano» (p. 393) : essa conservò nondimeno tutte le prerogative, anche se, di fatto, dovette rassegnarsi a esercitarl e su spazi (territoriali e politici) più limitati.
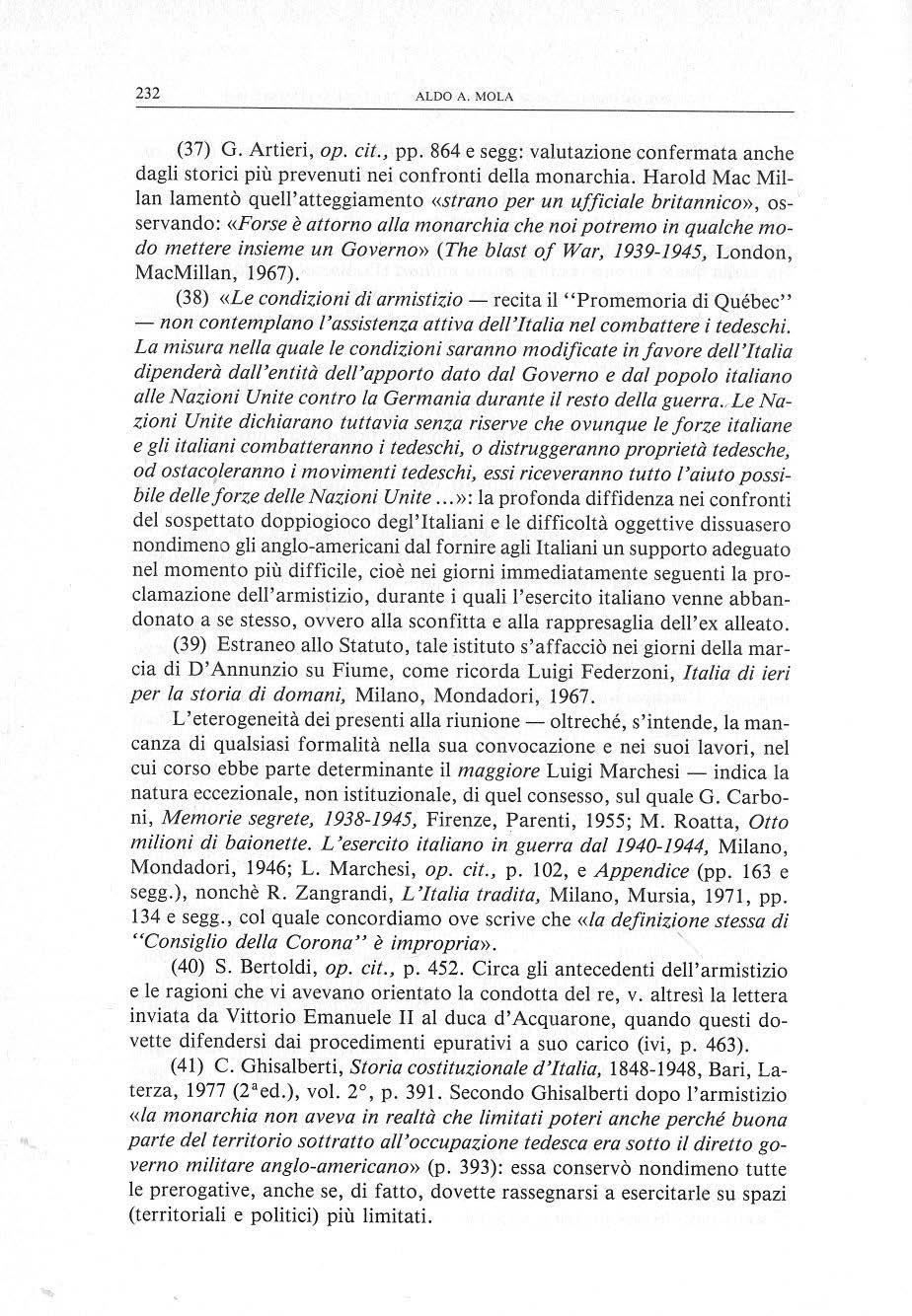
(42) Fu la sorte - clamorosa - del ministro degli esteri, Raffaele Guariglia: con la cui forzata ecliss i l'intero quadro del personale diplomatico veniva drasticamente ridotto a più rigida subordinazione rispetto al capo del governo (R . Guariglia, Ricordi, 1922-1946, Napoli, Esi, 1949). Sull'intero periodo fondamentale la testimonianza di E. Caviglia, Diario (aprile 1925 - marzo 1945), Roma, Casini, 1952.
(43) Sulla sua scia anche C. De Biase, L '8 settembre di Badoglio, Milano, Edizioni del Borghese, 1968, riecheggiant e , da altro versante, noti giudizi polemici di Gaetano Salvemini, contro la monarchia e Badoglio.
(44) Quella era l'immagine ch e d ella Casa sabauda era stata fissata da Davide Calandra nel ce lebre altorilievo bronzeo collocato nell'Aula dei Deputati , a Roma, quando, al culmine dell'età giolittiana , l'Italia tornava al programma di conquiste coloniali con l'impresa di Libia. Là tutti i conti, duchi e sovrani erano presentati in armi, a ricordare che militari e rano stati dalle origini e nei secoli la storia e la fortuna dei Savoia .
(45) K. Von Clausewitz, Della guerra, Milano, Mondadori, 1970 (su autori zz a zione dell'Ufficio storico SME, cui risale la 1a edizione in lingua italiana, Roma, 1942), p . 619. Molto significativamente secondo il grande stratega tedesco a quello sulla Ritirata all'interno del paese segue il capitolo sulla Guerra di popolo.
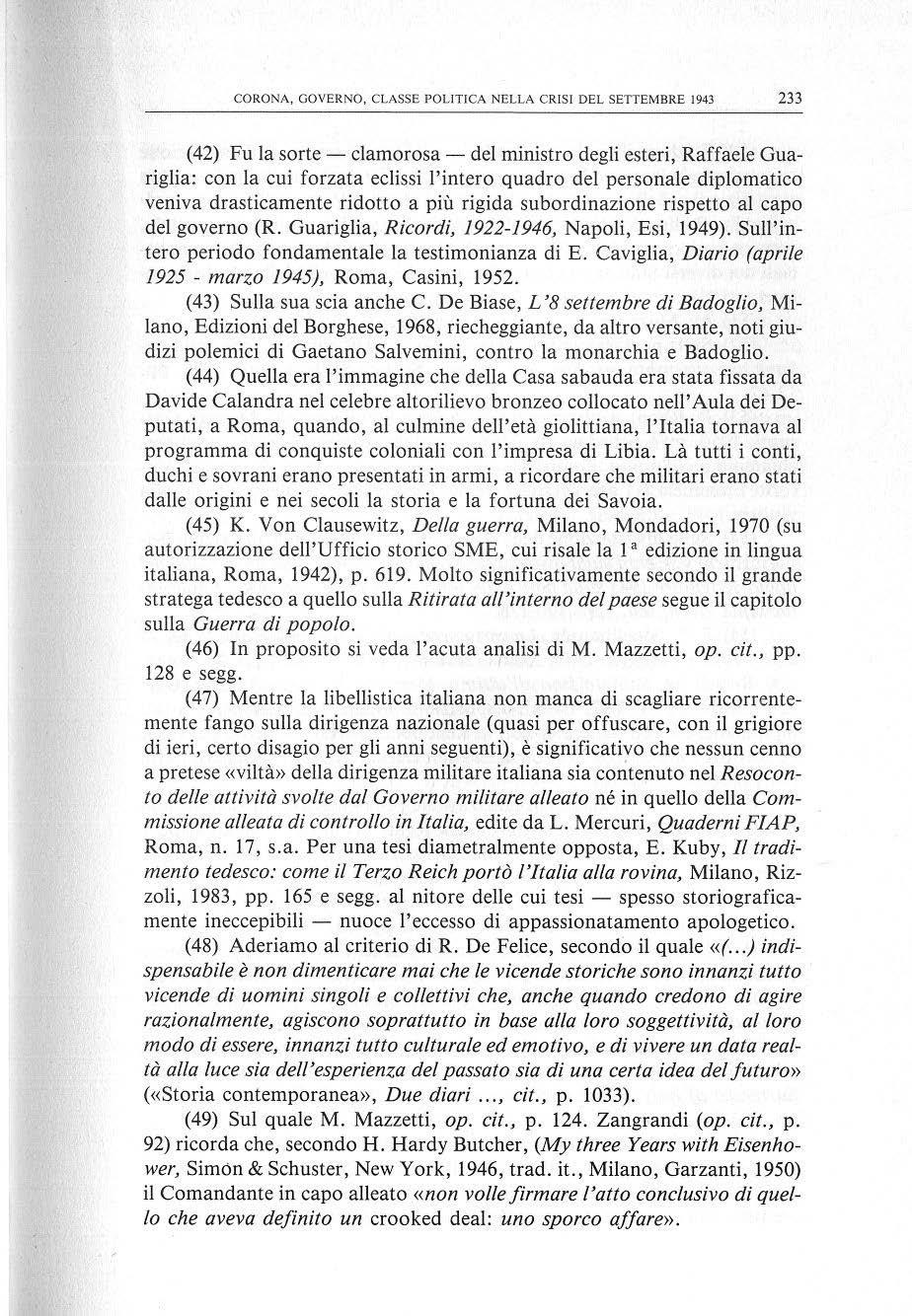
(46) In proposito s i veda l'acuta analisi di M. Mazzetti, op . cit ., pp . 128 e segg .
(47) Mentre la libellistica italiana non manca di scagliare ricorrentemente fango sulla dirigenza nazionale (quasi per offuscare, con il grigiore di ie ri, certo disagio per gli anni seguenti), è significativo che nessun cenno a pretes e «viltà» della dirigenza militare italiana s ia contenuto nel Resoconto delle attività svolte dal Governo militare alleato né in quello della Commissione alleata di controllo in Italia, edite da L. Mercuri, Quaderni FIAP, Roma, 11. 17, s . a. Per una tesi diametralmente opposta, E. Kuby, Il tradimento tedesco: come il Terzo Reich portò l'Italia alla rovina, Milano, Rizzoli, 1983, pp . 165 e segg . al nitore delle cui tesi - spesso storiograficamente ineccepibili - nuoce l'eccesso di appassionatamento apologetico.
(48) Aderiamo al criterio di R. De Felice, secondo il quale«(...) indispensabile è non dimenticare mai che le vicende storiche sono innanzi tutto vicende di uomini singoli e collettivi che, anche quando credono di agire razionalmente, agiscono soprattutto in base alla loro soggettività, al loro modo di essere, innanzi tutto culturale ed emotivo, e di vivere un data realtà alla luce sia dell'esperienza del passato sia di una certa idea del futuro» («Storia contemporanea», Due diari ... , cit., p. 1033).
(49) Su l qua le M. Mazzetti, op. cit., p. 124 . Zangrandi (op. cit , p. 92) ricorda che, secondo H. Hardy Butcher, (My three Years with Eisenhower, Simon & Schuster, New York, 1946, trad. it., Milano, Garzanti, 1950) il Comandante in capo alleato «non volle firmare l'atto conclusivo di quello che aveva definito un crooked dea! : uno sporco affare»
(50) Fu dopo il crollo dell'Italia - e, a l tempo stesso, dell'aspirazione britann ica a balzare sui Balcani - che Churchill trattò con Stalin la celebre «spartizione» delle quote d'influenza sui diversi Paesi dell'Europa sudorientale . Stalin accettò i criteri del premier britannico con riserva mentale, convinto - come ebbe a dichiarare allo jugoslavo Gilas - che i sistemi sociali dei diversi Stati sarebbero infine coincisi con quelli delle ideologie retrostanti gli eserciti vincitori, sin là dove questi fossero giunti .
(51) M. Mazzetti, op. cit., pp. 149 e segg.
(52) Sulla preparazione dell'armistizio v . Le operazioni delle unità italiane nel settembre-ottobre 1943, Ufficio Storico SME, Roma, 1975, pp. 13-47.
(53) R. Rhan, Ambasciatore di Hitler a Vichy e a Salò, Milano, Garzanti, 1950, ov'è ricordato (p. 266) che sul mezzogiorno de11'8 settembre, chiamato a colloquio, l'ambasciatore di Germania si sentì ripetere da Vittorio Emanuele III che l'Italia avrebbe tenuto fede all'alleanza sino alla vittoria.
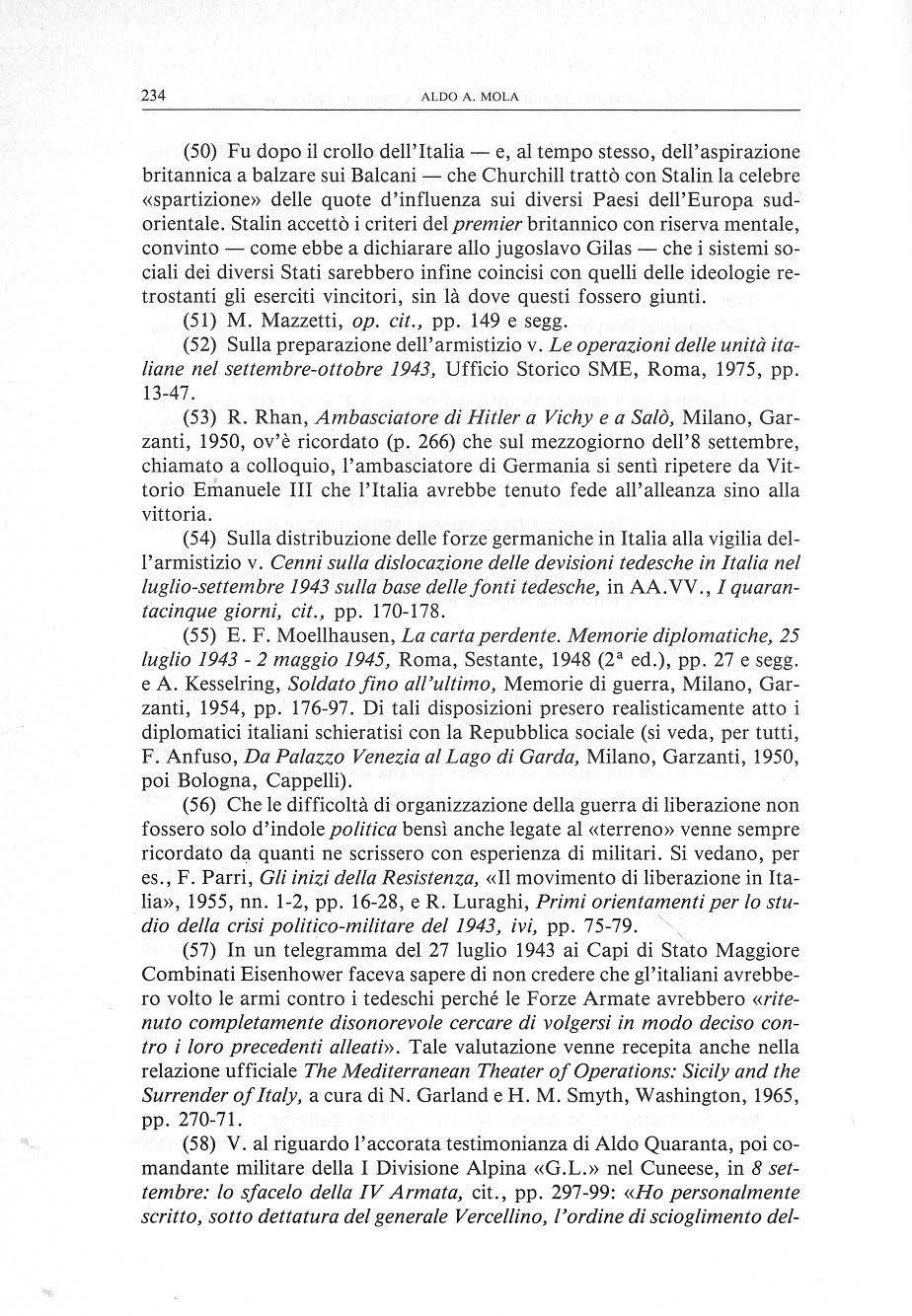
(54) Sulla distribuzione delle forze germaniche in Italia alla vigilia del1'armistizio v. Cenni sulla dislocazione delle devisioni tedesche in Italia nel luglio -settembre 1943 sulla base delle fonti tedesche, in AA.VV., I quarantacinque giorni, cit., pp . 170-178 .
(55) E. F. Moellhausen, La carta perdente Memorie diplomatiche, 25 luglio 1943 - 2 maggio 1945, Roma, Sestante, 1948 (2a ed.), pp. 27 e segg. e A. Kesselring, Soldato fino all'ultimo, Memorie di guerra, Milano, Garzanti, 1954, pp. 176-97. Di tali disposizionj presero realisticamente atto i diplomatici italiani schieratisi con la Repubblica sociale (si veda, per tutti, F. Anfuso, Da Palazzo Venezia al Lago di Garda, Milano, Garzanti, 1950, poi Bologna, Cappelli).
(56) Che le difficoltà di organizzazione della guerra di liberazione non fossero solo d'indole politica bensì anche legate al «terreno» venne sempre ricordato da quanti ne scrissero con esperienza di militari. Si vedano, per es ., F. P arri, Gli inizi della Resistenza, «Il movimento di liberazione in Italia», 1955, nn. 1-2, pp. 16-28, e R. Luraghi, Primi orientamenti per lo studio della crisi politico -militare del 1943, ivi, pp. 75 -79 . ,
(57) In un telegramma del 27 luglio 1943 ai Capi di Stato Maggiore Combinati Eisenhower faceva sapere di non credere che gl'italiani avrebbero volto le armi contro i tedeschi perché le Forze Armate avrebbero «ritenuto completamente disonorevole cercare di volgersi in modo deciso contro i loro precedenti alleati». Tale valutazione venne recepita anche nella relazione ufficiale The Mediterranean Theater of Operations: Sicily and the Surrender of Italy, a cura di N. Garland e H. M . Smyth, Wash ington, 1965 , pp. 270-71.
(58) V. al riguardo l'accorata testimonianza di Aldo Quaranta, poi comandante militare della I Divisione Alpina «G.L.» nel Cuneese, in 8 settembre : lo sfacelo della IV Armata, cit., pp . 297 -99: «Ho personalmente scritto, sotto dettatura del generale Ve rcellino, l'ordine di scioglimento del-
l'armata. Ricordo che il generale, con senso di responsabilità, ebbe a commentare il suo provvedimento con queste parole: "io sono un soldato; per me, in questo momento, i miei soldati sono virtualmente dei disertori. Voglio coprire la loro azione ed è per questa considerazione che ho dato l'ordine di scioglimento dell'armata", la quale in realtà, si era già spontaneamente sciolta prima dell'ordine stesso».
(59) L. Giaccone, Ho firmato la resa di Roma, Milano, 1973, pp. 146 e segg.; M. Caracciolo di Feroleto, «E poi?». La tragedia de/l'esercito italiano, Roma, Corso, 1946; E. Musco, La verità sul/'8 settembre, Milano, 1965 e, per inquadramento generale, F. Rossi, Come arrivammo all'armistizio, Milano, Garzanti, 1946.
Quanto alle traversie conseguite all'armistizio anche in settori ove meno pressante era la presenza germanica A. Basso, L'armistizio del settembre 1943 in Sardegna, Napoli, Rispoli, 1947; G. Magli, Le truppe italiane in Corsica prima e dopo l'armistizio del/'8 settembre 1943, Lecce, 1952, e, per un'ampia rassegna di «casi», M. Torsiello, Settembre 1943, MilanoVarese, C isalpino , 1963.
(60) Ch. Maurras, Enquete sur la monarchie, 1900-1909, Paris, Nuovelle Librairie Nationale, 1910, pp. 79 e 554.
(61) Sulla formazione d i Vittorio Emanuele III - a parte lo stucchevole L. Morandi, Come fu educato Vittorio Emanuele III, Torino, Paravia, 1903 (1 a ed. 1901) dal quale si trae comunque conferma che il re aveva più attenzione per i dettagli che per le idee generali - vedansi A . Consiglio, Vita di Vittorio Emanuele III, Milano, Rizzali, 1950; N. D'Aroma, Vent'anni insieme: V E. III e Mussolini, Bologna, Cappelli, 1957, P . Silva, Io difendo la monarchia, Roma, De Fonseca, 1946; S Bertoldi Vittorio Emanuele III, cit., e R. Bracalini, Il re «vittorioso»: la vita, il regno e l'esilio di Vittorio Emanuele III, pref. di U. Alfassio Grimaldi, Milano, Feltrinelli, 1980. Manca, nond imeno, un'opera adeguata alla personalità e al ruolo svolto dal re .
(62) G. Artieri, Umberto II e la crisi della monarchia, Milano, Mondadori, 1983, pp. 234 e segg.
(63) A. Pavone (op. cit., p 249) cita una sentenza - invero sconcertante - del tribunale supremo militare che il 26 aprile 1954, giudicando su un ricorso del comandante della legi one Tagliamento e di altri, condannati per l'ucci sione di 102 partigiani, affermava che nell'Italia meridionale, dopo 1'8 settembre «la sovranità di fatto, o meglio l'autorità del potere legale» era nelle mani degli alleati occupanti, i quali permanendo lo stato di guerra, erano «sempre giuridicamente il nemico», sicché a differenza dei soldati del «regno del Sud», de facto e de jure privi di vera indipendenza nazionale, solo quelli della Rsi si dovrebbe concludere agissero secondo leggi certe e fondate: conclusione che noi non condividiamo certo.
(64) Del resto sin dal 12 settembre 1943 la missione alleata presso Badoglio espresse la convinzione che fosse opportuno «concedere al governo Badoglio un riconoscimento formale» (E. Aga Rossi, op. cit . , p . 891). Po-
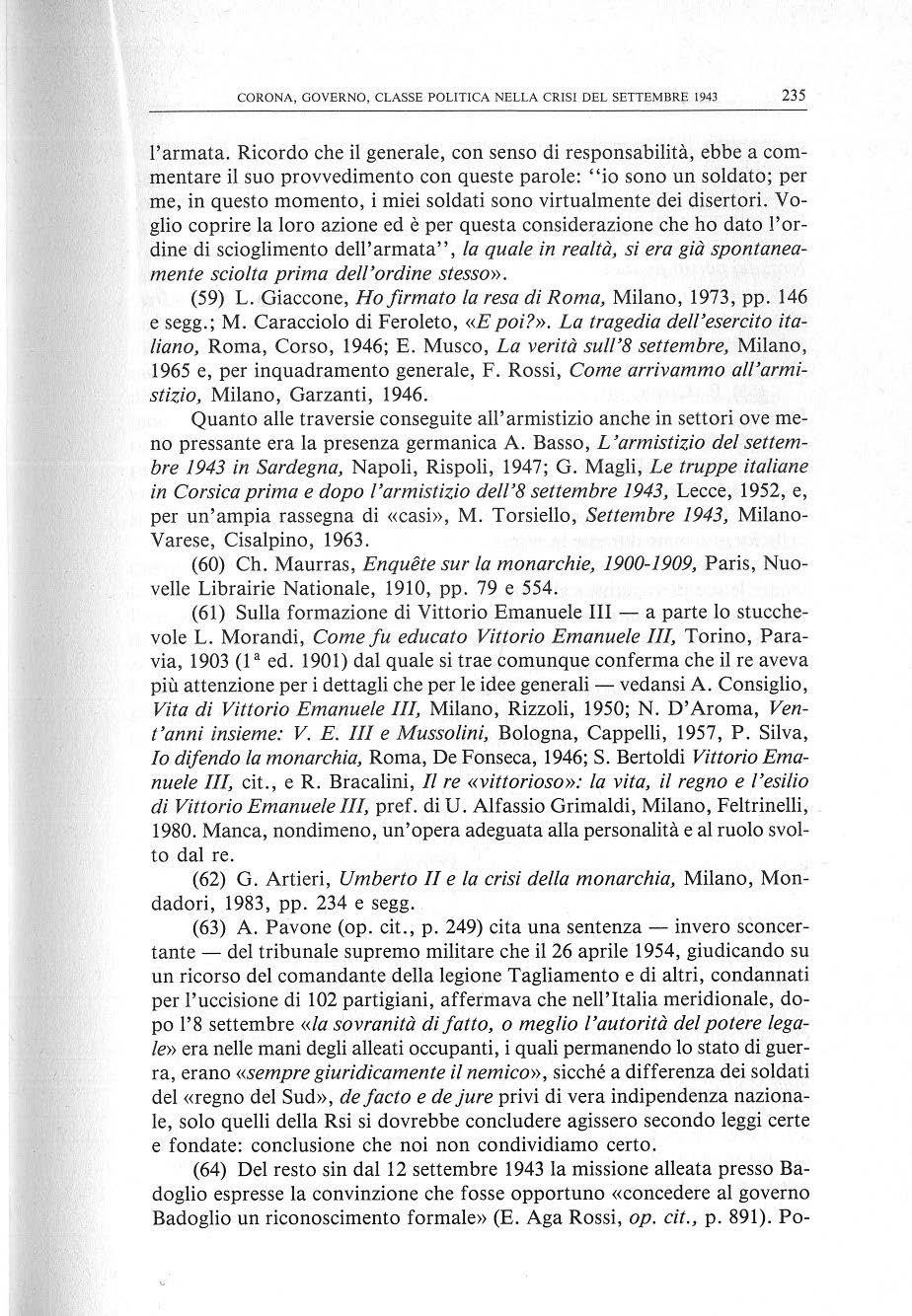
co appresso, il 18 settembre, Eisenhower, manifestava ai Capi di S .M. Combinati la convinzi on e che «l'importanza dell'amministrazione Badoglio [risiedesse] nella sua incontestata pretesa di legalità>> e avanzava alcune ipotesi di solu zione dei problemi istituzionali ita liani: «a) rafforzamento del carattere nazionale dell'amministrazione mediante l'inclusione di rappresentanti dei partiti politici(. ) b) un decreto che ristabilisca la precedente costituzione( .) c) eventuale possibile abdicazione del Re in favore di suo figlio o di suo nipote. (Ciò richiede un attento studio in quanto potrebbe risultare maggiormente popolare all'estero che presso il popolo italiano)( )» (M. Toscano, op cit., pp. 78-80).
(65) E. Crosa, op. cit., p. 57, ove vengono definiti i «doveri dello Stato».
(66) Oltre che in M. Toscano, op. cit., pp 93-106, lo si veda in «Relazioni Internazionali», 1983, n. 35, cit. e in questo stesso volume.
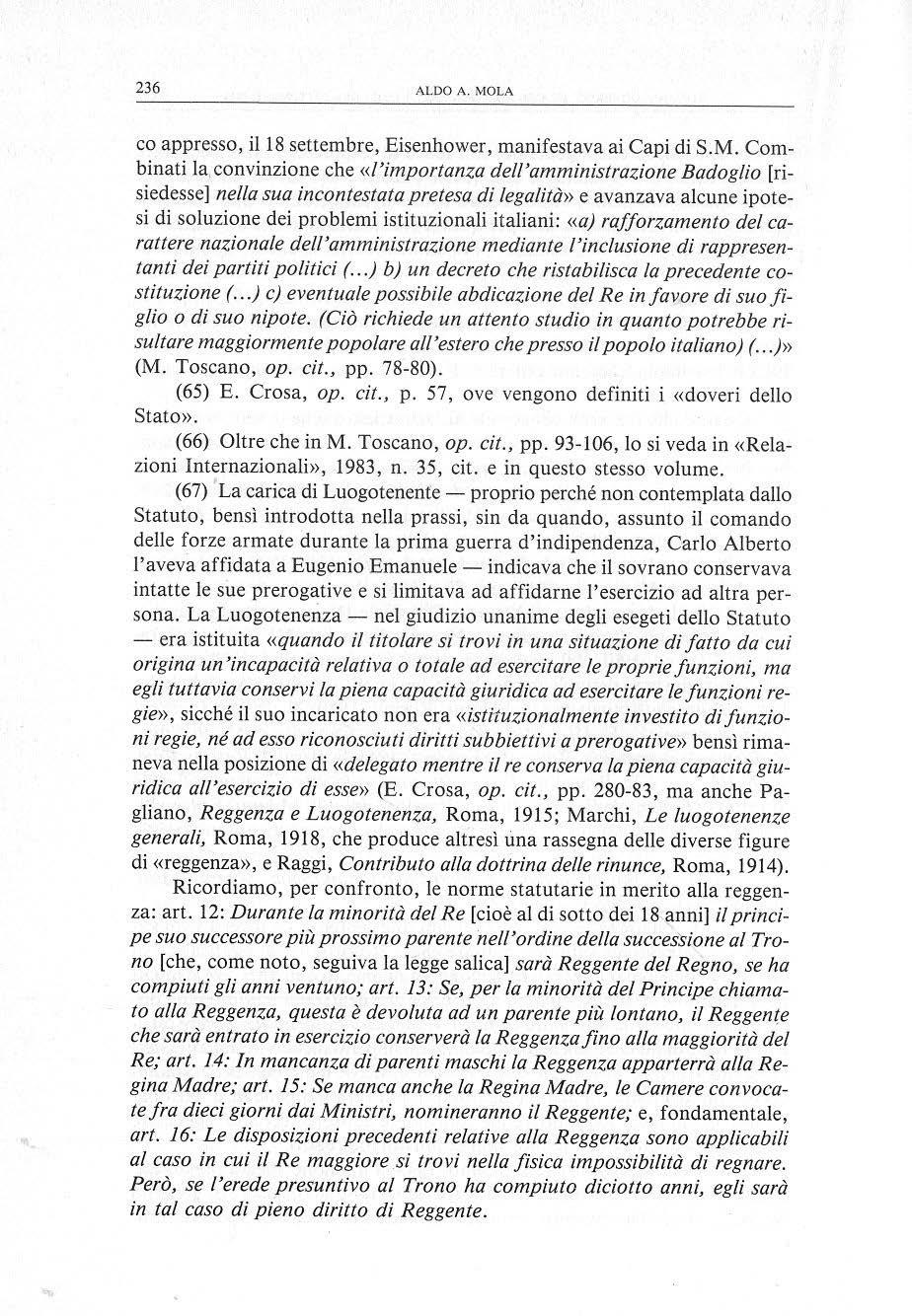
(67) La carica di Luogotenente - proprio perché non contemplata dallo Statuto, bensì introdotta nella prassi, sin da quando, assunto il comando delle forze armate durante la prima guerra d'indipendenza, Carlo Alberto l'aveva affidata a Eugenio Emanuele - indicava che il sovrano conservava intatte le sue prerogative e si limitava ad affidarne l'esercizio ad altra persona. La Luogotenenza - nel giudizio unanime degli esegeti dello Statuto - era istituita «quando il titolare si trovi in una situazione di fatto da cui origina un ' incapacità relativa o totale ad esercitare le proprie funzioni, ma egli tuttavia conservi la piena capacità giuridica ad esercitare le funzioni regie>>, sicché il suo incaricato non era «istituzionalmente investito di funzioni regie, né ad esso riconosciuti diritti subbiettivi a prerogative» bensì rimaneva nella posizione di «delegato mentre il re conserva la piena capacità giuridica all'esercizio di esse» (E. Crosa, op. cit., pp. 280-83, ma anche Pagliano, Reggenza e Luogotenenza, Roma, 1915; Marchi, Le luogotenenze generali, Roma, 1918, che produce altresì una rassegna delle diverse figure di «reggenza», e Raggi, Contributo alla dottrina delle rinunce, Roma, 1914).
Ricord iamo, per confronto, le norme statutarie in merito alla reggenza: art. 12 : Durante la minori tà del Re [cioè al di sotto dei 18 anni] il principe suo successore più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono [che, come noto , seguiva la legge salica] sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno; art . 13: Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggenfe che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re; art. 14: In mancanza di parenti maschi la Reggenza apparterrà alla Regina Madre; art . 15: Se manca anche la Regina Madre, le Camere convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente; e, fondamentale, art. 16: Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si t rovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo al Trono ha compiuto diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto di Reggente.
A differenza del Luogotenente, il Reggente era quindi il vero titolare dell'organo designato dalla costituzione a regnare in vece del re, con piena competenza e rivestito di tutte le prerogative regie. Dalla proclamazione dello Statuto mai s'era dato il caso che i poteri della Corona fossero trasferiti a un Reggente, sicché la dottrina se n'era occupata solo in astratto. Era comunque chiaro che il sovrano vivente dovesse far luogo al reggente solo previa dichiarazione d'impedimento fisico (malattia inabilitante e irreversibile : e non era il caso di Vittorio Emanuele III) o, peggio, di incapacità giuridica, possibile, secondo lo Statuto, solo se fosse stata sentenziata nelle forme previste - non dalle co lonne di qualc he giornale o nei pamphlets della disputa partitica - l'«alto tradimento>> del Sovrano nei confronti dello Stato: ipotesi, codesta, che avrebbe potuto prender corpo solo in condizioni del tutto diverse da quelle effettive, che vedevano invece il sovrano alla guida (non solo nominalmente) della rinascita nazionale e nelle quali, comunque, non solo le Forze Armate ma anche larga parte dei «volontari della libertà» si riconoscevano nel tricolore con Io scudo sabaudo .
L'orgoglio che, senza iattanza, Vittorio Emanuele III nutriva per i suoi quarantatrè anni di regno gli impediva certo d'accettare d'essere qualificato fisicamente incapace, né, meno ancora, politicamente «colpevole» per l'avvento di Mussolini a l governo - il cui esordio ebbe il voto favorevole di libera li, popolari, nazionalisti, demo-sociali .. . - e per la sua permanenza sul trono malgrado il delitto Matteotti, dopo il quale, infatti, il governo Mussolini aveva ancora ottenuto, oltre a quello dei fascisti e dei fiancheggiatori intruppati nel «listone», il voto favorevole di Croce e Giolitti, a tacer d'a ltri.
Sull'intera vicenda sempre utile Fr. Cognasso, I Savoia, Milano, Dall'Og lio, 1971, pp . 994 e segg.
(68) S. Cannarsa, Il Senato da/fascismo alla repubblica: agonia, morte e rinascita, Roma, La politica parlamentare, 1962, p . 37.
(69) D. Bartoli, op. cit ., passim .
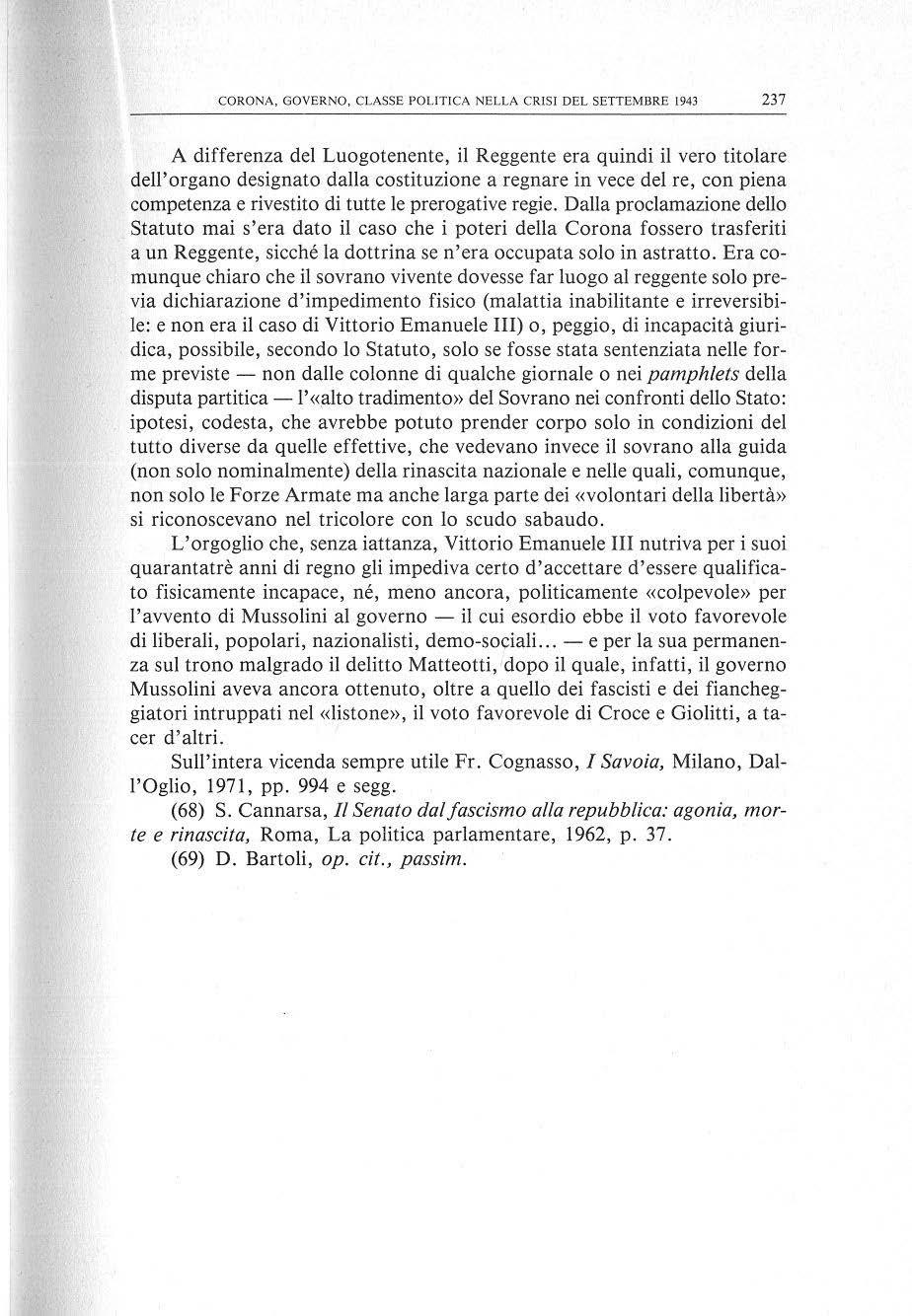
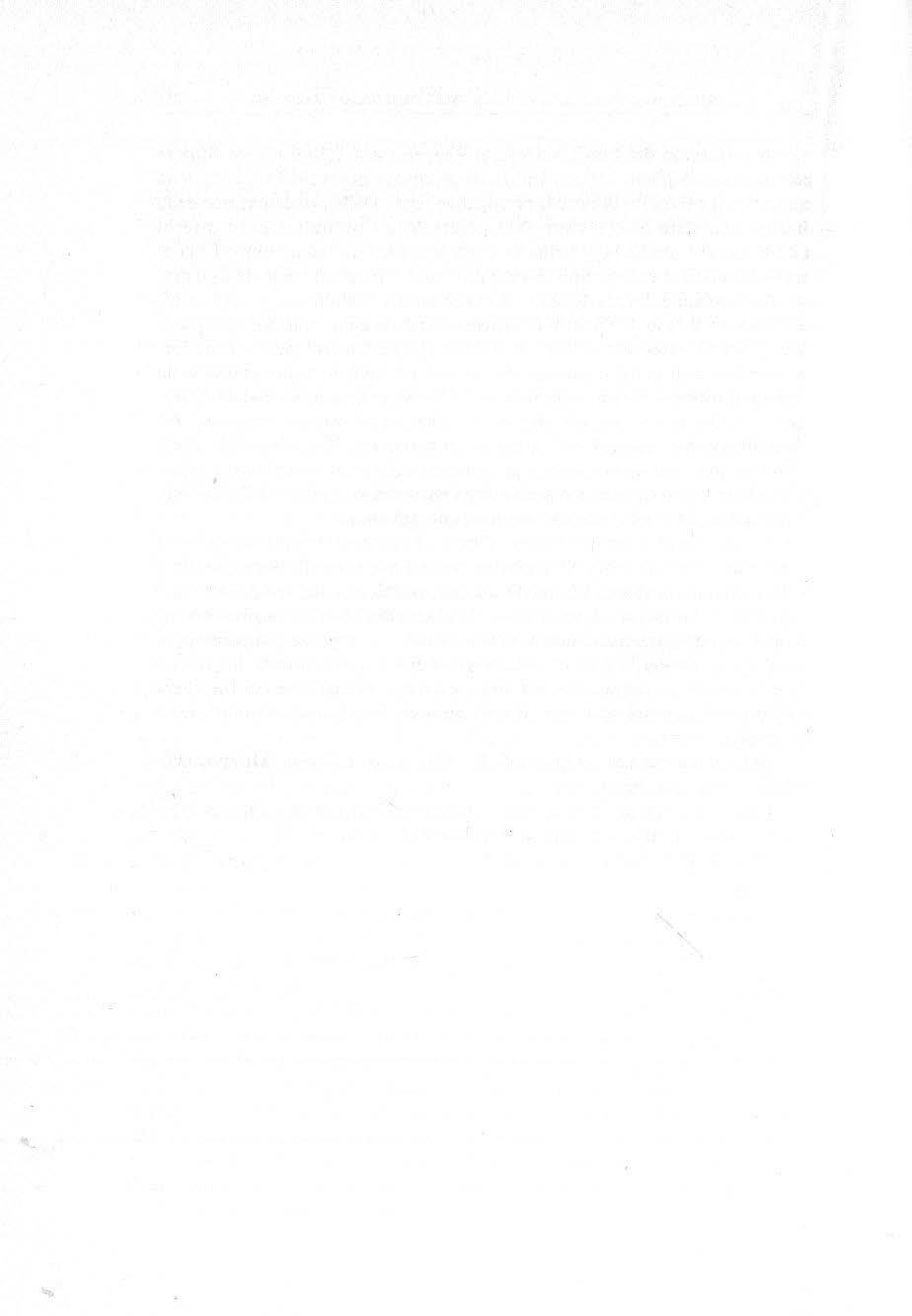
Nell'esaminare le reazioni degli esuli antifascisti agli eventi de11'8 settembre 1943 è necessario tener conto delle valutazioni che essi più in generale diedero della crisi del fascismo e dello stato italiano, crisi posta in evidenza dapprima dalle sconfitte militari, quindi dall'estromissione di Mussolini, dai «45 giorni>> badogliani, dall'armistizio, dalla dissoluzione delle forze armate e, infine, dalla fuga della famiglia reale da Roma. Questi avvenimenti infatti rappresentano gli elementi fra loro strettamente correlati di un unico- processo che aveva avuto inizio con il coinvolgimento italiano nel conflitto mondiale e che si sarebbe concluso solo nel dopoguerra.
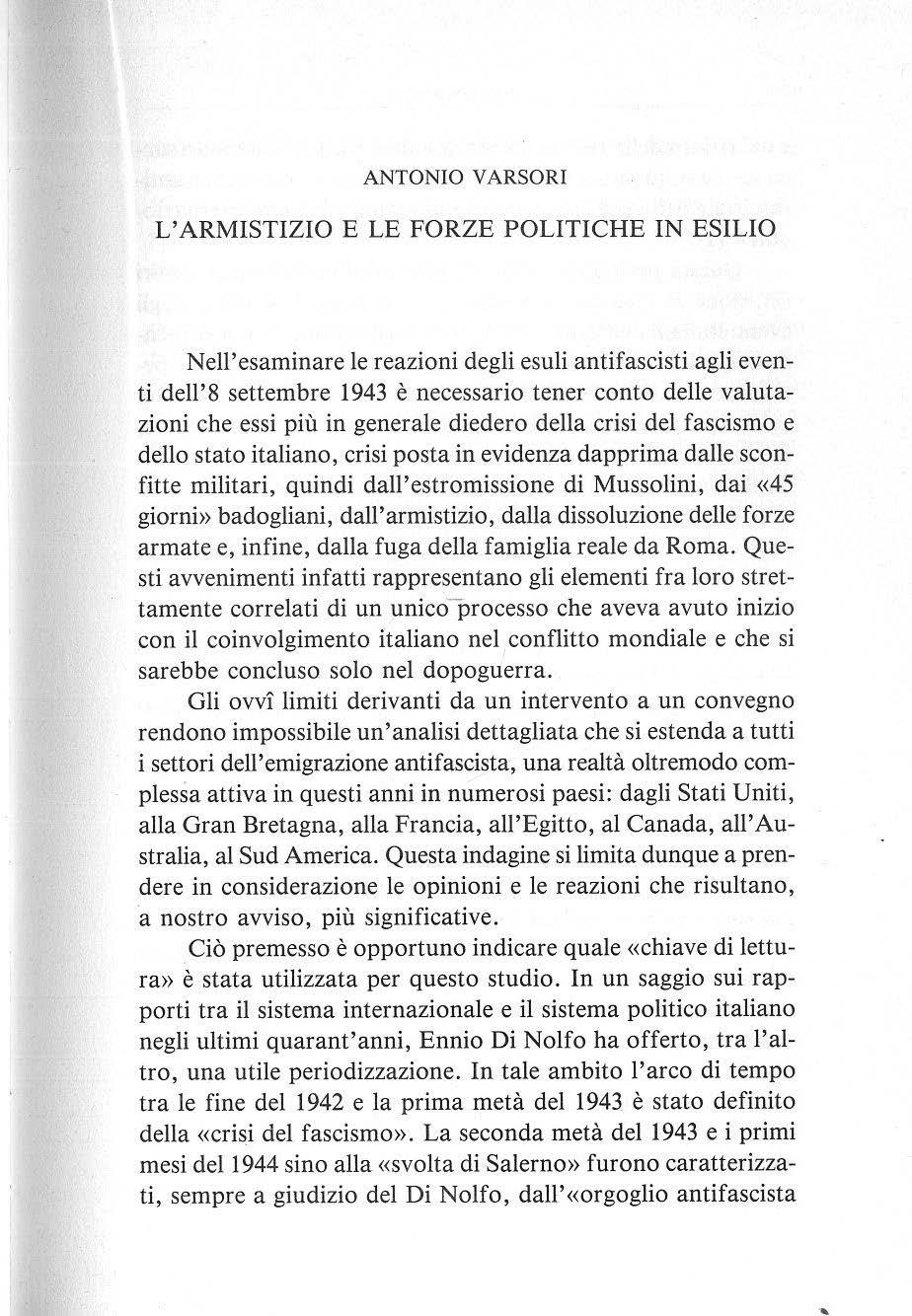
Gli ovvi limiti derivanti da un intervento a un convegno rendono impossibile un'analisi dettagliata che si estenda a tutti i settori dell'emigrazione antifascista, una realtà oltremodo complessa attiva in questi anni in numerosi paesi: dagli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, alla Francia, all'Egitto, al Canada, all' Australia, al Sud America. Questa indagine si limita dunque a prendere in considerazione le opinioni e le reazioni che risultano, ·a nostro avviso, più significative.
Ciò premesso è opportuno indicare quale «chiave di lettura» è stata utilizzata per questo studio. In un saggio sui rapporti tra il sistema internazionale e il sistema politico italiano negli ultimi quarant'anni, Ennio Di Nolfo ha offerto, tra l'altro, una utile periodizzazione. In tale ambito l'arco di tempo tra le fine del 1942 e la prima metà del 1943. è stato definito della «crisi del fascismo». La seconda metà del 1943 e i primi mesi del 1944 sino alla «svolta di Salerno» furono caratterizzati, sempre a giudizio del Di Nolfo, dall' «orgoglio antifascista
e dal rifiuto della realtà internazionale», mentre il periodo successivo è stato indicato come quello della «collaborazione antifascista e della subordinazione alla grande alleanza internazionale» (1).
Questa periodizzazione, nonchè l'opinione di altri auto r i (2), pone in luce la particolare rilevanza internazionale degli eventi italiani dell'estate 1943. Il 25 luglio prima - conseguenza in qualche modo diretta dello sbarco alleato in Sicilia (operazione <<Husky») - il 3 e 1'8 settembre poi erano infatti, non solo uno spartiacque nella vi t a politico-sociale della nazione, ma anche il sintomo di radicali mutamenti nella posizione internazionale dell'Italia. Quest'ultima scompariva definitivamente dal novero delle grandi po t enze e dal 1943 per un lungo periodo di tempo - certamente sino agli inizi degli anni '50essa sarebbe stata spesso considerata un «oggetto» di politica estera, più che un soggetto internazionale autonomo. Questa evoluzione contrastava con i mutamenti politici interni, con la fine della dittatura, con il seppur lento recupero da parte del paese delle libertà democratiche. D'altro canto, come lo stesso schema interpretativo proposto da Di Nolfo indica, l'antifascismo italiano stentò a rendersi conto di questa realtà e parve anzi avanzare per il futuro del paese soluzioni che si ponevano in contrasto con la strategia delle potenze alleate e con i nuovi equilibri internazionali in cui l'Italia si stava inserendo. Il futuro politico-istituzionale della nazione, messo in discussione proprio dagli eventi legati a11'8 settembre, si trovò al centro del dibattito fra i partiti antifascisti. Nell'azione e nei progetti di tali forze, sia nel regno del Sud , sia nell'Italia centro-settentrionale occupata dai nazisti , vi era quale primo obiettivo il completamento del processo avviato con il 25 luglio e con l'armistizio, ovvero la realizzazione di una «frattura» netta con il passato, quale premessa per la costruzione di un paese nuovo. Se in tale contesto la liberazione della penisola dai tedeschi e la distruzi one del fascismo di Salò erano esigenze ovvie e primarie, la maggioranza delle forze antifasciste concordava sulla necessità

di allontanare dal potere anche i due maggiori artefici del rovesciamento di Mussolini e dell'armistizio con gli anglo-americani, Vittorio Emanuele III e Pietro Badoglio. Ad essi infatti erano attribuite parte delle colpe del regime e l'incapacità di realizzare lo sganciamento dalla Germania.
Questo atteggiamento intransigente, anche se all'interno dell'antifascismo non mancavano significative sfumature, questa politica di contrapposizione alla monarchia e a Badoglio, ma anche agli alleati, permase sino all'aprile del 1944, sino a quando cioè con la «svolta di Salerno» e il nuovo atteggiamento assunto dal PCI, gran parte delle forze antifasciste dovettero piegarsi all'evidenza che gli avvenimenti politici italiani non erano che parte di un'evoluzione del sistema internazionale, caratterizzata da mutati equilibri, dall'affermarsi di nuovi predomini e, nel caso italiano , dall'interazione fra le scelte di Washington, di Londra e, in misura minore, di Mosca.
Un parziale rifiuto della realtà e delle implicazioni internazionali furono dunque fra gli elementi caratterizzanti la posizione degli antifascisti nella penisola di fronte agli eventi del1' estate 1943. Ma quali furono le previsioni, le interpretazioni, le reazioni di quei settori dell'opposizione a Mussolini, che avevano agito sino ad allora all'estero, spesso nelle capitali delle nazioni in guerra con l'Italia? Potevano essi aver acquisito, grazie ai contatti intrattenuti con i responsabili alleati, alla libertà goduta, alla possibilità di informazione attraverso una stampa libera, una visione più chiara del futuro ruolo dell'Italia? Compresero il significato internazionale degli avvenimenti italiani?
E quali conseguenze ne trassero? È su questo aspetto dell'atteggiamento degli esuli che questa indagine intende soffermarsi. Con l'occupazione della Francia da parte tedesca nell'estate del 1940 gli Stati Uniti erano divenuti ben presto il più importante centro di attività dell'emigrazione antifascista. In questo paese si erano rifugiate personalità quali Carlo Sforza, Alberto Tarchiani, Randolfo Pacciardi, don Luigi Sturzo, Ambrogio Donini, Giuseppe Berti; da alcuni anni inoltre Gaetano Salvemini dimorava e insegnava presso la Harvard University (3).
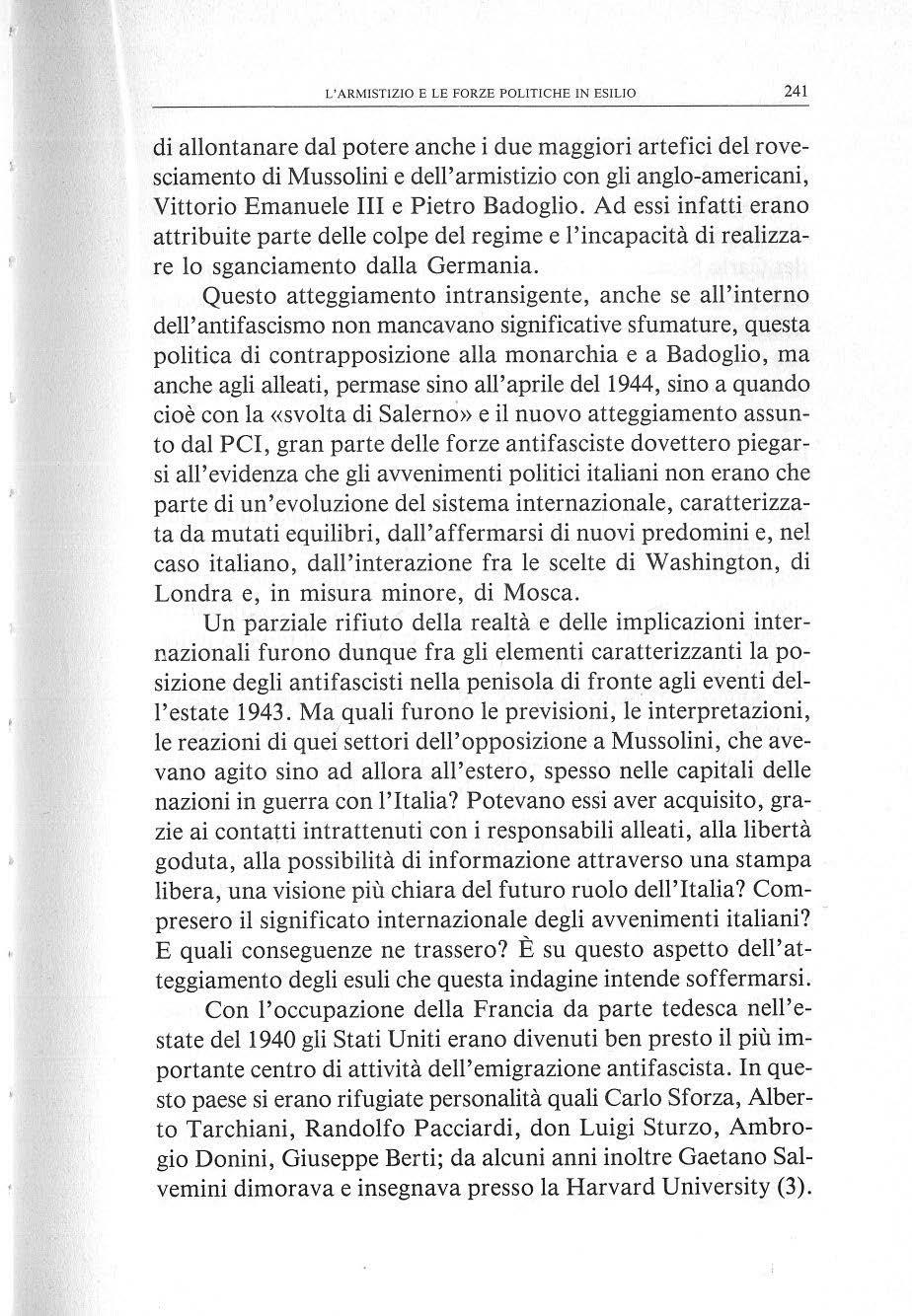
Come si è tentato di dimostrare in un recente volume (4), l'emigrazione antifascista nel continente americano, in particolare quei settori che si riconoscevano nell'azione del gruppo di tendenze liberaldemocratiche «Mazzini Society» e del suo leader Carlo Sforza, tentò di elaborare tra il 1941 e il 1942 un preciso progetto politico mirante a determinare l'assetto politico della penisola una volta scomparso il fascismo. Tale progetto, che prevedeva quali fasi intermedie la realizzazione di una sorta di governo in esilio (il Comitato nazionale italiano) e di una legione di volontari da affiancare alle truppe alleate, delineava per il periodo postbellico:
« .. .l'immagine di un'Italia defascistizzata, laica, ma non anticlericale, probabilmente repubblicana, in cui una nuova classe politica antifascista, ma legata alle migliori tradizioni del Risorgimento e della democrazia prefascista, fosse pronta, nel rispetto del sistema economico capitalista e delle esigenze della <<legge» e dell' «ordine», a concedere dall'alto al popolo italiano una sorta di New Deal» (5).
Questo progetto politico, di cui Sforza fu il maggiore interprete, ma che fu per qualche tem po convidiso da Salvemini e da Sturzo, non trascurava il contesto internazionale; presupponeva anzi un chiaro coinvolgimento dell'Italia postfascista nel sistema occidentale e una stretta.alleanza con gli Stati Uniti, di cui la penisola sarebbe divenuta una sorta di «junior partner» mediterraneo. Proprio da parte di Washington non vi fu però lo sperato appoggio alla creazione del Comitato nazionale e della legione di volontari. Inoltre lo stesso movimento antifascista fu presto condizionato da profondi contrasti, tra l'altro tra Sforza e Salvemini, che si manifestarono in merito alla questione dei rapporti con gli alleati.
Alla fine del 1942, mentre si avvicinava rapidamente una decisa evoluzione della situazione militare, nonchè politica, nel Mediterraneo, la strategia per la costituzione del Comitato nazionale e della legione falliva in modo evidente. Londra e Washington d'altro canto sceglievano di affrontare il «problema
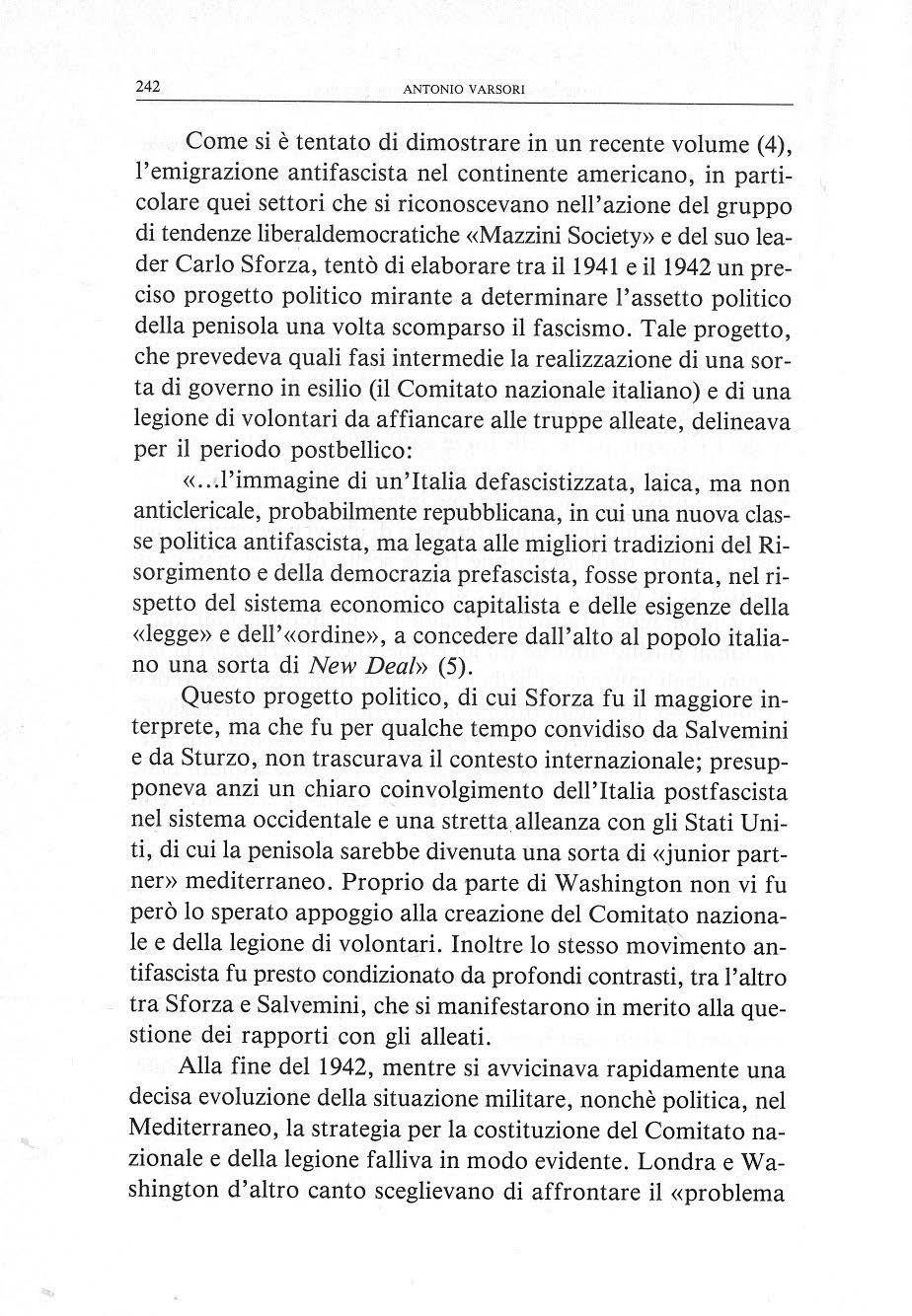
italiano» in un'ottica prevalentemente militare, puntando soprattutto all'eliminazione dell'Italia quale potenza belligerante. Questa scelta implicava l'accantonamento di qualsiasi piano che tenesse conto dell'emigrazione antifascista . La presa di posizione alleata non scoraggiò gran parte degli esuli. Questi ultimi attribuirono d'altronde l'atteggiamento anglo-americano a motivazioni transitorie ed essi dedicarono quindi una crescente attenzione agli eventi della penisola, rendendo note le loro posizioni e avanzando programmi e progetti.
Il tema dell'evoluzione della situazione italiana fu affrontato da Sforza nel maggio del '43 in un articolo dal titolo significativo «Resisterà l'Italia di fronte all'invasione?». In esso il conte sosteneva che prime conseguenze di uno sbarco alleato sarebbero state l'amichevole accoglienza da parte italiana dei liberatori e la rapida adesione dell'esercito alla causa alleata. Quanto ai fascisti, essi non avrebbero opposto alcuna seria resistenza, mentre Mussolini sarebbe fuggito, si sarebbe suicidato o sarebbe stato assassinato. Per ciò che concerneva la monarchia, anche il re sarebbe fuggito e il popolo italiano avrebbe finito con lo scegliere una forma di governo repubblicana. Il leader della «Mazzini Society» coglieva quindi con esattezza un elemento del futuro panorama italiano, la rapida dissoluzione del regime fascista, ma trascurava come alcuni gruppi di potere, che sino ad allora avevano collaborato con Mussolini, avrebbero potuto alfine trovare la forza per disfarsi del Duce e proporsi quali interlocutori degli alleati. In particolare egli sembrava sottovalutare la monarchia e l'esercito. Era questa sottovalutazione una forma di incomprensione della realtà italiana? La risposta è a nostro avviso solo parzialmente positiva. Sforza non dubitava dell'esistenza di una propensione britannica, ma non americana, al compromesso con le forze conservatrici italiane, fossero esse incarnate da Badoglio, da Vittorio Emanuele III o da Dino Grandi. Come egli aveva sostenuto sin dal 1941, però, Vittorio Emanuele poteva forse assicurare l'estromissione di Mussolini dal potere, ma non sarebbe stato in
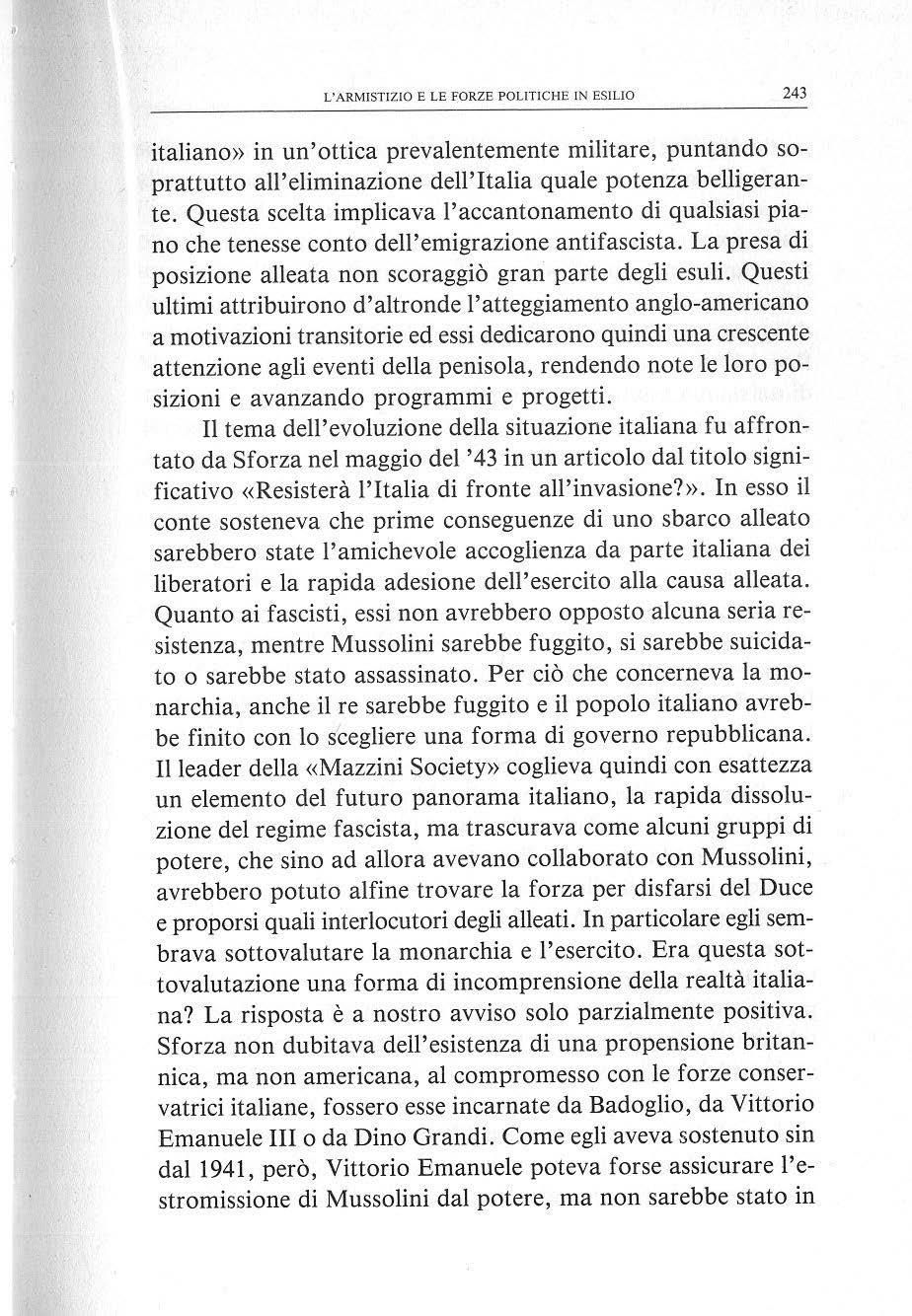
grado di porre le pr emesse per l'instaurazione di un fo r te regime democratico nel dopoguerra. Il permanere dei Savoia al potere avrebbe al contrario favorito il «disordine» polit ico e s ociale, preparando la stra da a una nuova dittatura. GU alleati dovevano perciò considerare quali interlocutori per l'Italia postfascista non il re e i s uoi seguaci, bensì l'antifascis mo liberaldemocratico. Il vero prob lema per Sforza non era dunque la fine del fascismo, data per cer ta e imminente, ma la creazione di un nuovo assetto istituzionale e politico del paese, assetto che dipendeva in lar ga parte dalle scelte alleate. Questa convinzione era implicita nelle paro le del conte, il quale scriveva:
«Gli italiani presteranno fede ad altri italiani onesti e rispettati - ma essi non presteranno fede a proclami stranieri.
La storia italiana è piena di proclami dei governi francese, inglese e austriaco fatti all'indomani della ca duta di Napol eone - proclami pieni di gra ndi promesse di unità e lib ertà, ma presto dimenticati appena il bisogno dell'aiuto italiano scomparve. Sebbene sia vero ch e gli italiani stanno pregando per la loro liberazione, des id ero avvert ire ancora una vo lta gli alleati che la strada verso una completa cooperazione da parte degli italiani deve essere preparata con cura » (6).
Sforza sott olineava dunqu e il ruolo che gli anglo-a m ericani avrebbero giocato nella fase deci siv a della cr isi italiana, ma sembrava nutrire la speranza di un possibile accordo fra l'an tifascismo e i governi alleati.
Se i progetti del conte apparivano condizionati da una certa caute la «dip lomatica » e da una voluta fiducia verso Was h ington e Londra, b en più esplicite erano le a nali si e le proposte prove nienti da altri settori dell 'em igrazi one antifascista negli Stati Uniti. Fra la primavera e l'estate de l 1943 Gae tano Salvemini, in collaborazione con un suo allievo, Giorgio La Piana , affrontò il «prob lem a Ita lia» in un lungo sagg io dal titolo «What to do with Italy» (o «La sorte dell'Italia) (7). I due antifascisti non na scondevano i loro intenti po lemici nei confronti della politica perseg uita sino a quel momento dagli anglo-americani ver-
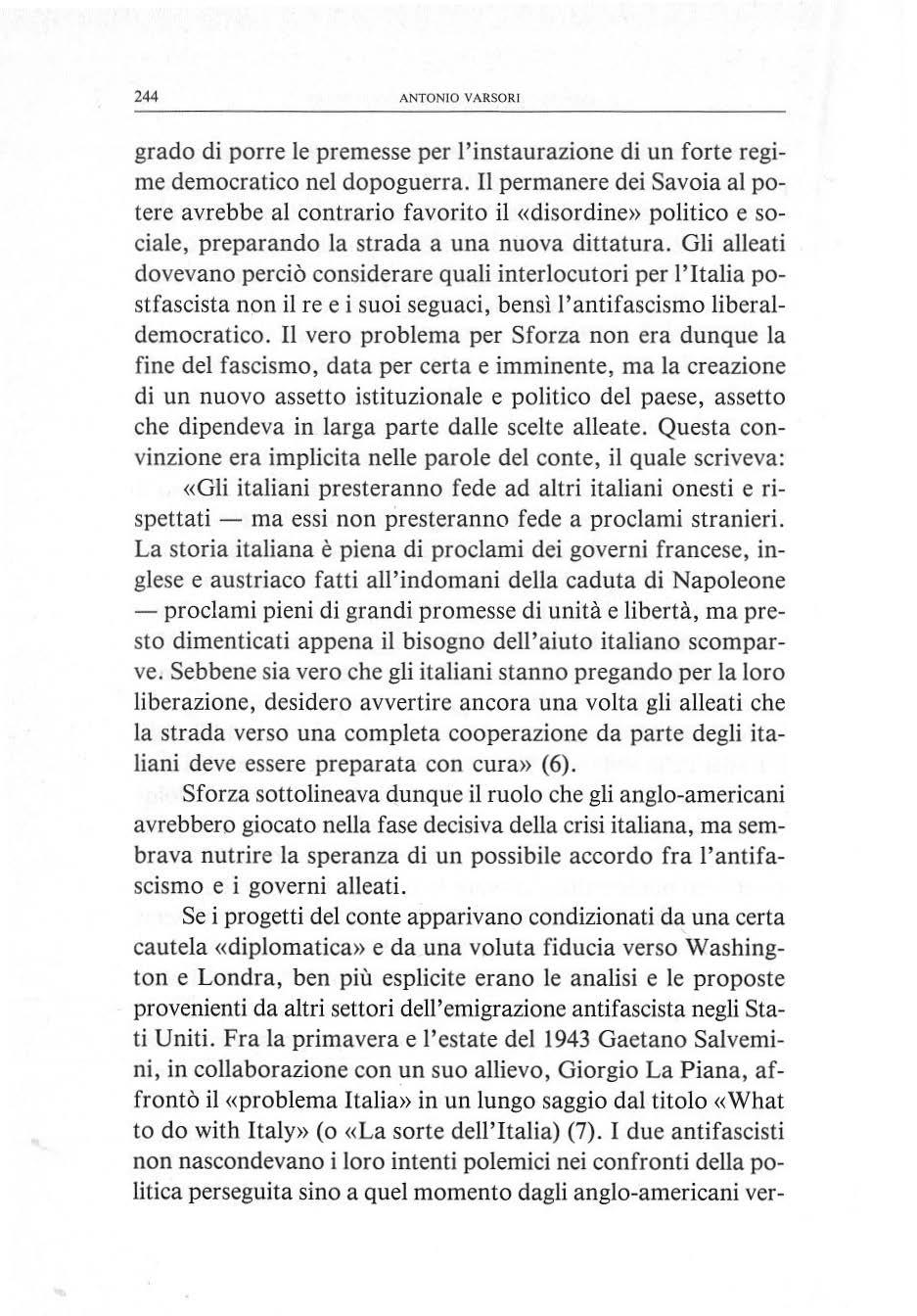
so la penisola. Essi per prima cosa denunciavano il pericolo che gli alleati mirassero a far uscire l'Italia dal conflitto attraverso l'instaurazione di un «fascismo senza Mussolini». A questo proposito l 'analisi di La Piana e di Salvemini mostrava alcune interessanti capac ità di previsione, ma anche alcuni evidenti errori di prospettiva. I due antifascisti non volevano prestar fede - come Sforza d'altronde - all'eventuale allontanamento di Mussolini a opera della monarchia e dell'esercito, ritenute entrambe istituzioni troppo compromesse con il fascismo e dunque incapaci di ribellarsi a esso. Ove invece le previsioni si rivelavano esatte era nel delineare lo scenario che avrebbe fatto seguito a un abbandono dell'Asse da parte dell'Italia. Scrivevano i due autori:
«Il giorno in cui il Governo italiano vacillerà nella sua f edeità all'alleanza tedesca sarà un momento doloroso perchè sarà anche il giorno nel quale la invisibile occupazione germanica diventerà interamente visibile» (8).
Non è questa la sede per analizzare in maniera dettagliata quanto scritto in «What to do with Italy», ma limitando le nostre osservazioni alle previsioni circa l'imminente crisi politica italiana, va sottolineato come Salvemini e il suo collaboratore indi viduas sero con una certa esattezza altri caratteri di tale crisi. Essi non condividevano l'ottimismo di maniera di Sforza e prevedevano che il crollo militare non sarebbe stato accompagnato da un'automatica liberazione del paese da parte alleata. Si prefigurava al contrario una dura lotta tra il movimento di opposizione al regime e le residue forze fasciste. Né ci si faceva soverchia illusione circa l'evoluzione della situazione militare:
«Per un pò di tempo i nostri giornalisti e strateghi in poltrona hanno riempito intere colonne di profezie piene di speranza e in apparenza logiche, secondo le quali i tedeschi avrebbero già deciso di abbandonare l'Italia al suo destino. L'Italia , osservarono detti strateghi, è diventata un peso, difficile com'è da difendersi contro l'invasione, perc iò i generali tedeschi sarebbero pronti a ritirarsi al di là del Brennero nel cuore dell'i-
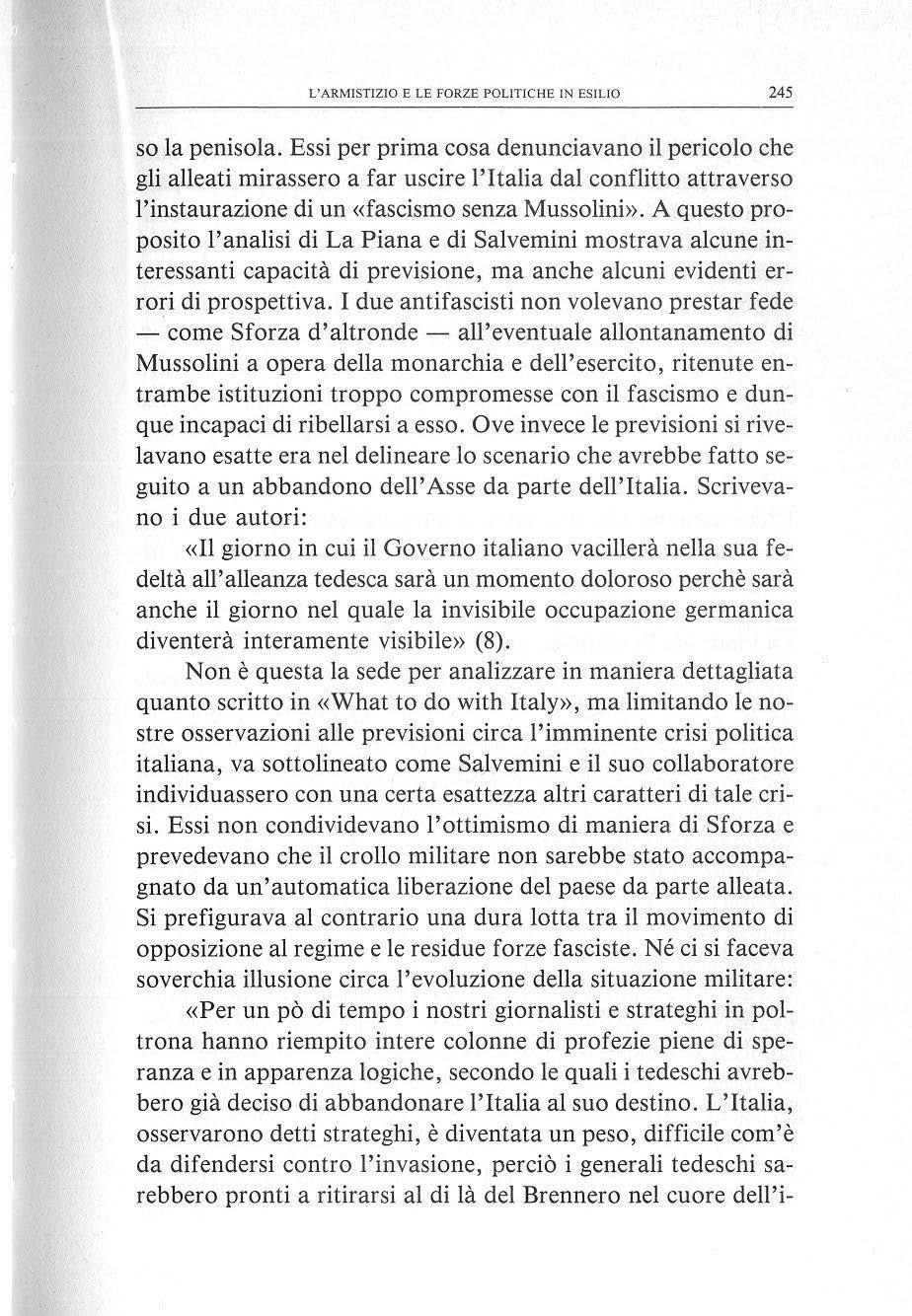
nespugnabile fortezza europea. Pascendosi nelle illusioni questi strateghi dimenticano che è nell'interesse tedesco, sia dal punto di vista militare, come dal punto di vista economico, di continuare a fare la guerra in territorio non tedesco fino a quando sarà possibile e che una ostinata difesa dell'Italia non è affatto impossibile. O per lo meno che si può fare della sua occupazione un'impresa lunga e difficile per gli alleati» (9).
Il realismo di Salvemini si spingeva oltre e si annunciava in modo ben più radicale rispetto alle enunciazioni di Sforza che il futuro dell'Ita lia sarebbe stato deciso dagli alleati; si scriveva infatti:
«Dopo aver fatto la loro resa <<militare», le potenze del1' Asse saranno costrette ad inchinarsi davanti a qualsiasi decisione «po li tica» che i vincitori possano imporre. Esse dovranno pure accettare incondizionatamente una pace imposta» (10).
Di fronte a questa eventua li tà le proposte di Salvemini e La Piana erano semplici: gli alleati dovevano accettare quali interlocutori per l 'Italia postfascista gli oppositori di Mussolini, questi a loro volta dovevano accettare un ridimensionamento del ruolo internazionale del paese, cercando però di preservare la piena indip ende nza di quest'ultimo di fronte a Washington e a Londra. Essi non si nascondevano la difficoltà di questo obiettivo e rifiutando ogni ipo tesi di compromesso puntavano sull'aiuto delle opinioni pubbliche anglosassoni e sui gruppi di pressione democratici e progressisti. In realtà - al pari di Sforza - gli au tori di «What to do w'ith Italy» non comprendevano su quale piano si stessero muovendo gli anglo-americani nel dete rminare il loro atteggiamento verso l'Italia. Di fronte all'approssimarsi della crisi del fascismo, Washington e Londra decisero di perseguire obiettivi di prevalente carattere militare. Se si rifiutava l'ipotesi del dialogo con il movimento antifascista, non era per una precisa scelta conservatrice imperniata sul mantenimento al potere del re, di un militare o di un fascista «moderato», quanto piuttosto per la regola «on engage et puis on voit». Né gli antifascisti potevano sapere che il meccanismo mi-
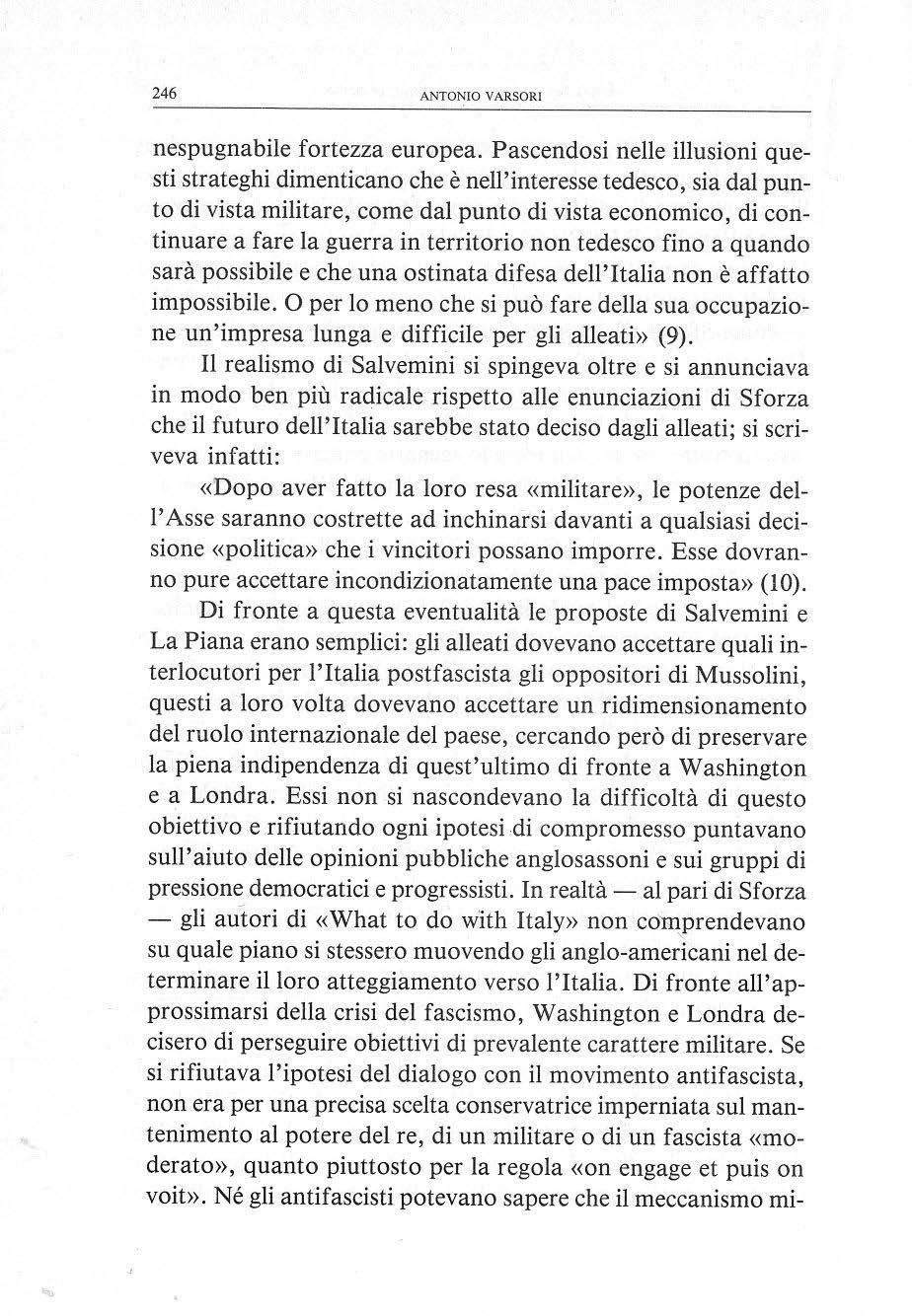
litare posto in atto dagli alleati, il quale avrebbe condotto all'aperto manifestarsi della crisi politica italiana, nasceva quasi casualmente attraverso il compromesso fra contrastanti indirizzi strategici. Basti ricordare come la decisione di estendere le operazioni dalla Sicilia al continente venisse presa solo agli inizi di giugno del '43 in un incontro tra Churchill e Eisenhower, come questa decisione fosse condizionata ai risultati di «Husky», come gli alleati affidassero dopo il 25 luglio la «gestione» dell'armistizio a Eisenhower, il quale avrebbe agito più sulla base di esigenze strategico-militari, che di progetti politici nei confronti dell'Italia (11).
Con tali premesse non deve stupire che il 25 luglio risu ltasse evento inaspettato sia a Washington, sia a Londra. La caduta del fascismo, al contrario, non colse impreparat i alcuni fra gli esuli italiani. Uno fra i primi a prendere posizione fu il conte Sforza, il quale la sera stessa del 25 luglio tenne nel suo appartamento di New York una conferenza stampa di fronte a numerosi giornalisti (12). Una serie di dichiarazioni del conte furono pubblicate sul «New York Times» il 30 luglio. Sfor z a sottolineava che primo obi_ettivo italiano doveva essere un rovesciamento di alleanze. Ma questa decisione non poteva essere presa, a suo avviso, da personaggi screditati quali il re e Badoglio, bensì da italiani antifascisti di sentimenti patriottici. Sforza, comunque, nel suo realismo, sembrava in part e comprendere le esigenze alleate: se da un lato cercava di dissipare un supposto timore di un pericolo rivoluzionario, dall'altro lasciava intravvedere la possibilità di un compromesso , anche se temporaneo, fra l'antifascismo e Badoglio. Egli inoltre ribadiva che solo l'eliminazione di Vittorio Emanuele III po t eva evitare all'Italia pericolosi rivolgimenti sociali e politici. Egli dichiarava:
«Opporsi a tali ipotesi al fine di favorire idee tradizionali di un ordine formale, che non è vero ordine perché basato sul tradimento, potrebbe significare non solo un allungamento del conflitto ma la creazione di quello stesso disordine di cui alcuni hanno più paura di quanto non abbiano di una guerra lunga» (13).
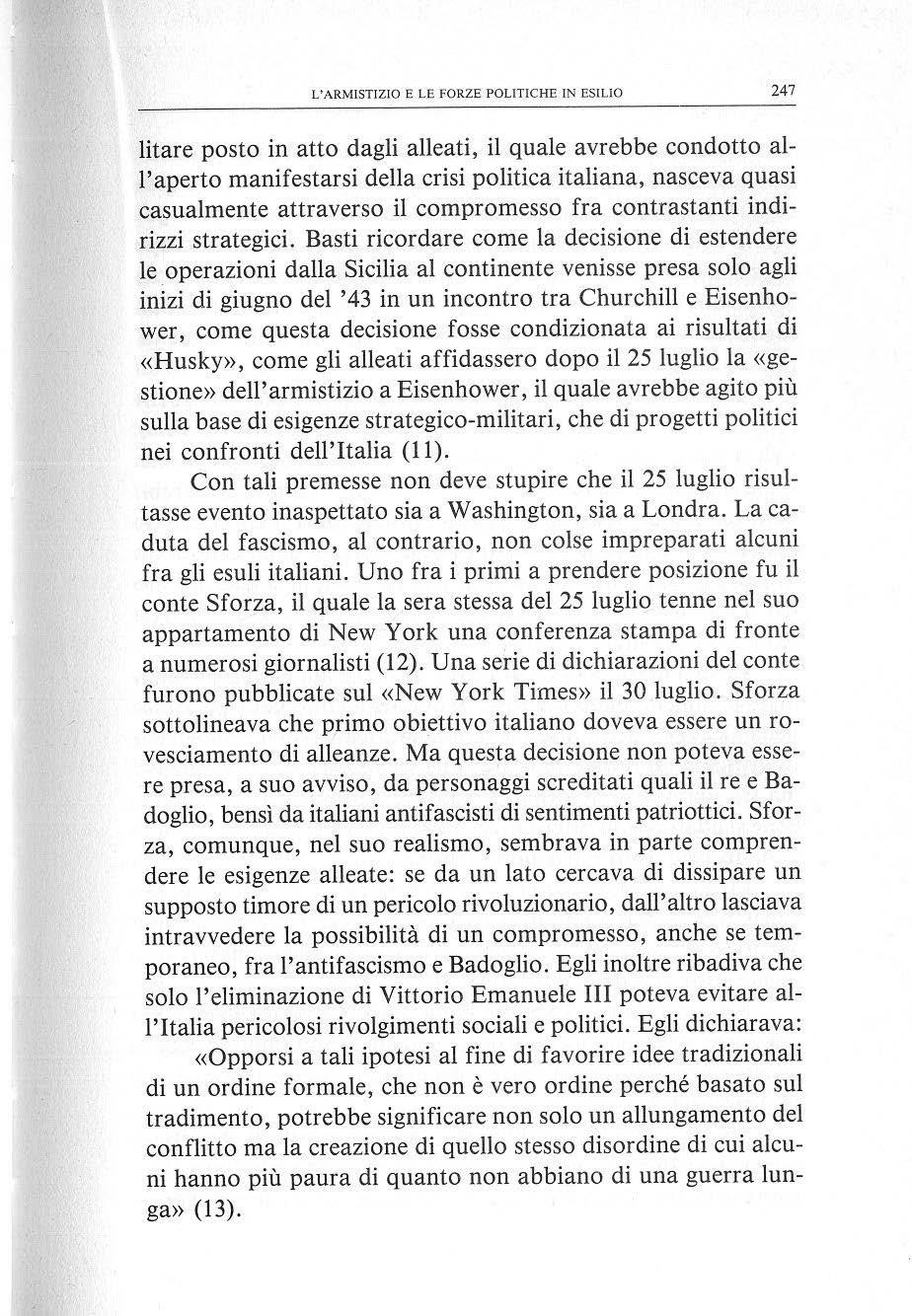
Quanto a Salvemini, questi si dimostrava ora più pessimista circa l'evoluzione della politica alleata verso l'Italia e soffermava l'attenzione sulla situazione venutasi a creare nella penisola con il nuovo governo Badoglio. Egli, in un articolo apparso su «New Repub lic» il 15 agosto, delineava con chiarezza la fine dell'esperimento dei «45 giorni» e le contradditorie conseguenze dell'armistizio. Lo storico partiva dalle seguen ti
premesse:
«Ch urchill e Roo sevelt stanno facendo in Italia due guerre si multanee. Una mira a otte ne re « la resa in condizionata», l'altra mira a prevenire la rivoluzione. Se la resa a discrezione fosse stata il loro unico scopo nell 'invadere l'Itali a, essi avrebbero cercato di creare le condizioni favorevoli a una vera rivoluzione, in seguito al collasso morale causato dalla caduta di Musso li ni. Ma nelle loro m enti e nelle loro azioni la guerra contro la rivoluzione interferisce con la guerra per la resa a discrezione e la paralizza» (14) .
Salvernini sopr avvalutava così l'in teresse americano e quello inglese, almeno in questa fase, a l mante n imento nella penisola d ella «legge» e dell' «ord ine », come so ttovalutava il ruolo delle motivazioni di ordine mi li tare nelle sce lte alleate, ma il dilemma tra «prevenzio n e de lla rivoluzione» e resa incondizionata bene si adattava all'alternativa che.si poneva al governo Badoglio. In pro posito Salvemini scriveva :
«Il Re e Badoglio no n possono fare né guerra né pace. Se rimangono fedeli a Hitler, il paese sarà di strutto dagli eserciti alleati. Se si stacca no da Hitl er, il paese sarà ancor più ferocemente d ist rutto dag li eserciti di Hi tler» ( 15).
No tava in oltre Salve mi ni come «i l Re e Bad og lio non si potessero arrendere incondizionatamente a Churchill e a Roosevelt , a meno che l'intera macchi na militare fascista non si «fosse disintegrata» ( 16).
Mentre Salvemini pu bbli cava qu esto articolo il Re e Bado glio avevano già imboccato la via c he a vre bb e condotto alla firma della resa di Cassi bile. Come lo st orico aveva in parte pre-
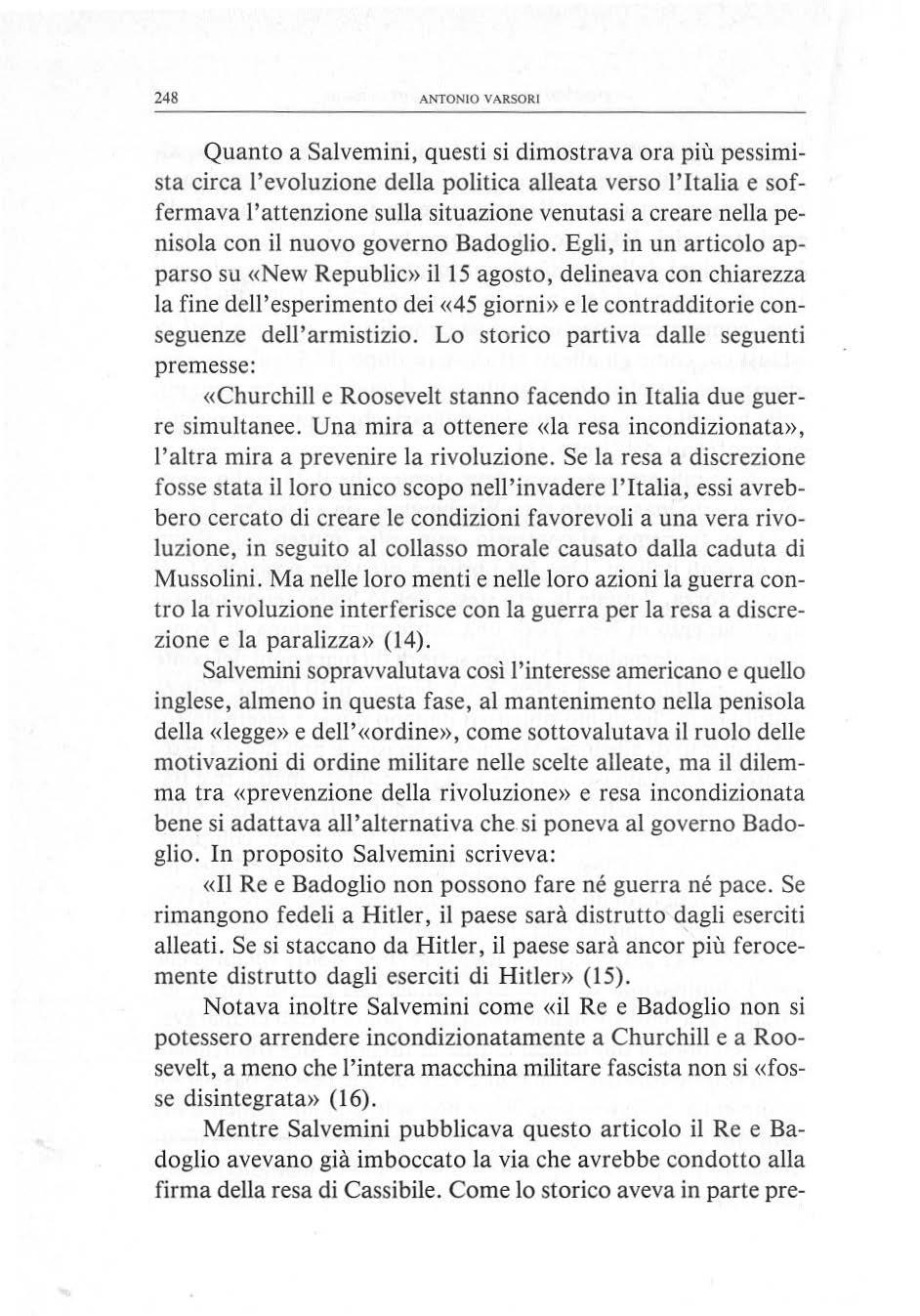
visto, la contraddittoria posizione di Vi tt orio Emanuele III e del capo del governo condusse al disastro de11'8 settembre, alla fuga da Roma, alla dissoluzione dell'esercito. La prima reazione di Salvemini a questi avvenimenti fu indica t iva dell'atteggiamento che sarebbe stato assunto da una parte dei fuoriusciti. Per molti fra essi 1' 8 settembre rappre sentava il definitivo fallimento delle tradizionali forze conserva trici italiane. Con l'armistizio e soprattutto con l'incapacità di realizzare in modo efficiente lo sganciamento dall'alleato tedesco la monarchia, ma anche gli altri gruppi di potere già compromessi col fascismo, avevano segnato la loro condanna: per loro non vi sarebbe stato più alcun valido ruolo da svolgere nella fu t ura Italia democratica. Quanto agli alleati, la loro decisione di continuare a dialogare con il re e con Badoglio, a dispetto dell'8 settembre , era un errore imperdonabile. Già il 14 settembre Salvemini scriveva:
« .. .la situazione in Italia cambia ogni qua r to d'ora e quel ch'era ragionevole ieri può diventare assurdo domani. Ma v i sono certi principi morali che possono e debbono servire da bussola permanen t e. Il Re e Badoglio dopo essere stati responsabili con Mu ssolini di tutte le sofferenze del popolo italiano in questa guerra sciagurata, hanno aggiun t o a tutti i loro vecchi delitti un delitto nuovo. Insieme con Mussolini essi avevano voluto il trattato di alleanza con la Germania. Quel trattato li obbligava a non fare un armistizio separato. Piuttosto che disonorarsi con l'armistizio separato, il Re doveva abdicare e Badoglio dimettersi. Altri non legati al passato e non loro dovevano sottomettersi all ' armistizio disastroso che essi avevano reso inevitabile. Anche la cobelligeranza avrebbe dovuto essere decisa da uomini nuovi che non avessero avuto doveri verso la Germania, e perciò avrebbero potuto negoziare la cobelligeranza a fronte alta, e non dai due miserabili aborti morali che si erano incatenati all'alleanza del 1939» (17).
Al di là dell'ovvia condanna morale, vi era nelle parole di Salvemini una condanna politica; ma quali erano dunque le so-
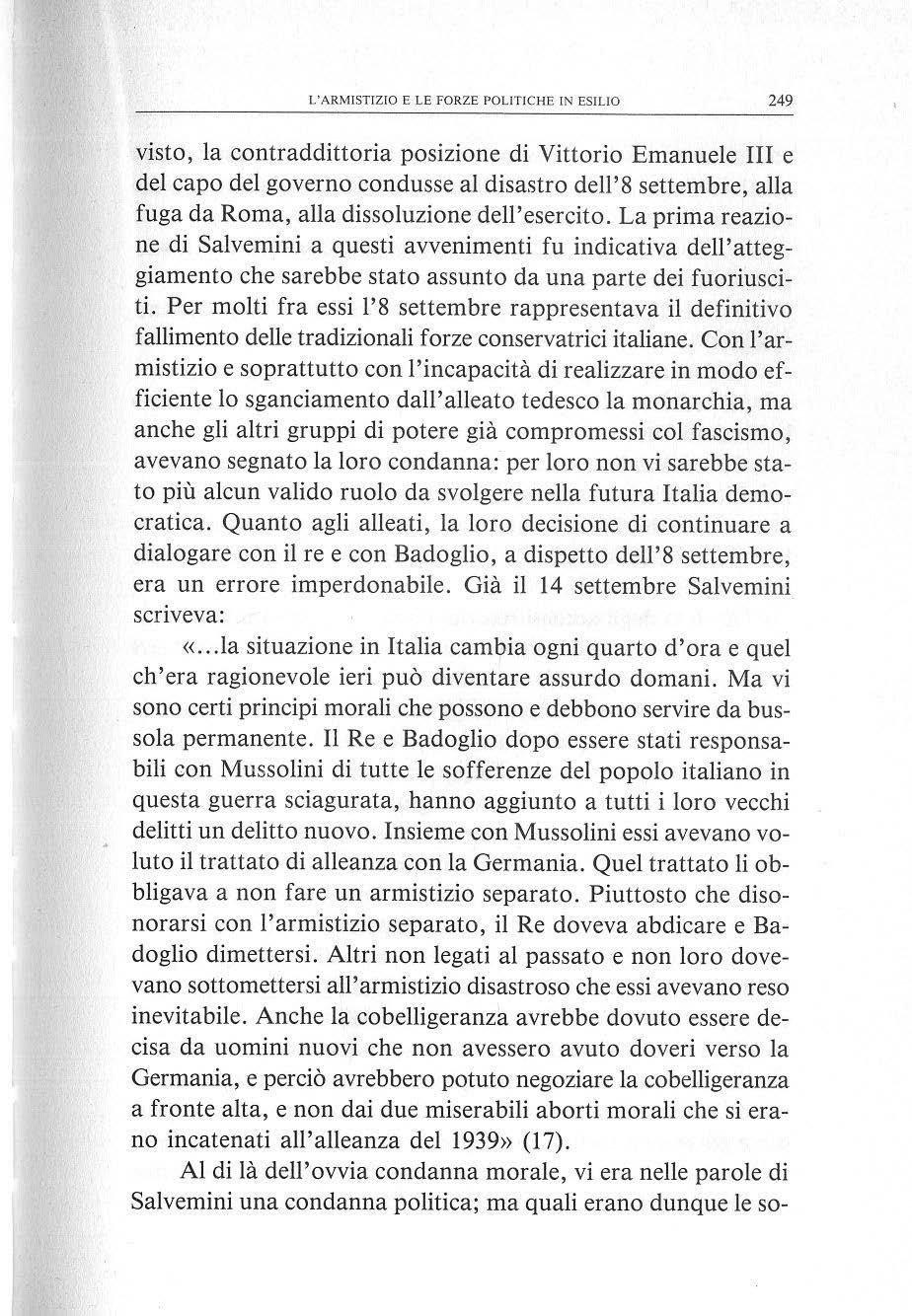
sti ricordare a questo proposito la reazione alla notizia dell'armistizio da parte dell'«Italia libera», l'organo repubblicano diretto da Randolfo Pacciardi:
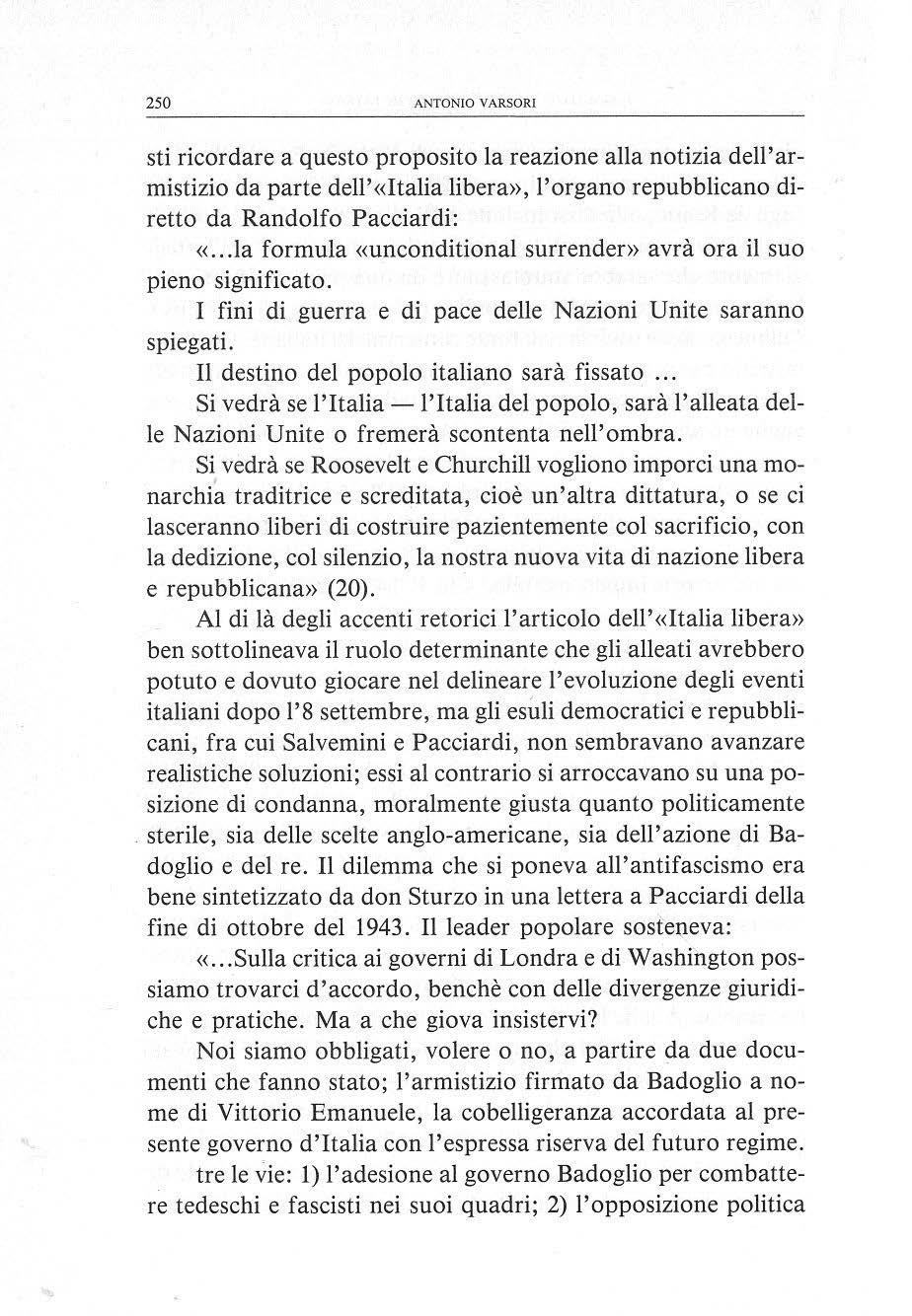
« .. .la formula «unconditional surrender» avrà ora il suo pieno significato.
I fini di guerra e di pace delle Nazioni Unite saranno spiegati.
Il destino del popolo italiano sarà fissato ...
Si vedrà se l ' Italia - l'Italia del popolo, sarà l'alleata delle Nazioni Unite o fremerà scontenta nell'ombra.
Si vedrà se Roosevelt e Churchill vogliono imporci una monarchia traditrice e screditata, cioè un'altra dittatura, o se ci lasceranno liberi di costruire pazientemente col sacrificio, con la dedizione, col silenzio, la nostra nuova vita di nazione libera e repubblicana» (20).
Al di là degli accenti re t orici l'articolo dell'«Italia libera»
ben sottolineava il ruolo determinante che gli alleati avrebbero potuto e dovuto giocare nel delineare l'evoluzione degli eventi italiani dopo 1'8 settembre, ma gli esuli democratici e repubblicani, fra cui Salvemini e Pacciardi, non sembravano avanzare realistiche soluzioni; essi al contrario si arroccavano su una posizione di condanna, moralmente giusta quanto politicamente . sterile, sia delle scelte anglo-americane, sia dell'azione di Badoglio e del re. Il dilemma che si poneva all'antifascismo era bene sintetizzato da don Sturzo in una lettera a Pacciardi della fine di ottobre del 1943. Il leader popolare sostel)eva:
« ... Sulla critica ai governi di Londra e di Washington possiamo trovarci d'accordo, benchè con delle divergenze giuridiche e pratiche. Ma a che giova insistervi?
Noi siamo obbligati, volere o no, a partire da due documenti che fanno stato; l'armistizio firmato da Badoglio a nome di Vittorio Emanuele, la cobelligeranza accordata al presente governo d'Italia con l'espressa riserva del futuro regime. tre le vie: 1) l'adesione al governo Badoglio per combattere tedeschi e fascisti nei suoi quadri; 2) l'opposizione politica
al governo Badoglio, ma lottare (come possibile) fascisti e tedeschi; 3) rinunziare ad ogni lotta pratica, usando solo il diritto di critica e protesta (Aventino)» (21).
Lo stesso Sturzo, sebbene con alcune significative sfumature, affermava implicitamente in questa stessa lettera di preferire la terza ipotesi, già scelta d'altro canto dal suo interlocutore e da Salvemini. Né si deve ritenere che questa posizione fosse prerogativa esclusiva degli esuli negli Stati Uniti, ché essa era condivisa ad esempio da alcune personalità antifasciste che avevano vissuto in esilio i mesi precedenti la crisi del regime e che erano rientrate in Italia solo con i «45 giorni». La loro posizione intransigente aveva già trovato espressione nel noto documento di Lione, siglato nel marzo da Emilio Lussu, Giuseppe Saragat, Giorgio Amendola e Giuseppe Dozza, quali rappresentanti di «GL», del PSI e del PCI (22). Se l'armistizio, gli even t i immediatamente successivi, l'atteggiamento alleato verso il re e Badoglio rafforzarono l'intransigenza di numerosi esuli, questi stessi elementi determinarono una significativa evoluzione nell'atteggiamento di altri fuoriusciti, in particolare di Sforza. Quest'ultimo si rese conto che la partita politica per il futuro dell'Italia si sarebbe giocata nella penisola, ma che i giocatori più forti restavano Washington e Londra. Sforza intuì inoltre che, per il momento, sia gli Stati Uniti, sia la Gran Bretagna annettevano particolare importanza al mantenimento al potere del re e di Badoglio, soprattutto di quest'ultimo. Solo accettando in tutto o in parte questo dato di fatto sarebbe stato possibile dare avvio al dialogo fra gli anglo-americani e l'antifascismo e il conte ritenne inoltre possibile conciliare le esigenze dei primi e gli obiettivi del secondo. In tale ambito diveniva opportuno dare un appoggio, per quanto condizionato e temporaneo a Badoglio - garanzia per gli alleati degli accordi militari - e posporre la discussione sul futuro dell'istituzione monarchica. Furono queste considerazioni le premesse della lettera indirizzata il 23 settembre da Sforza a Badoglio tramite l'assistente segretario di Stato A. A. Berle ed Ei-
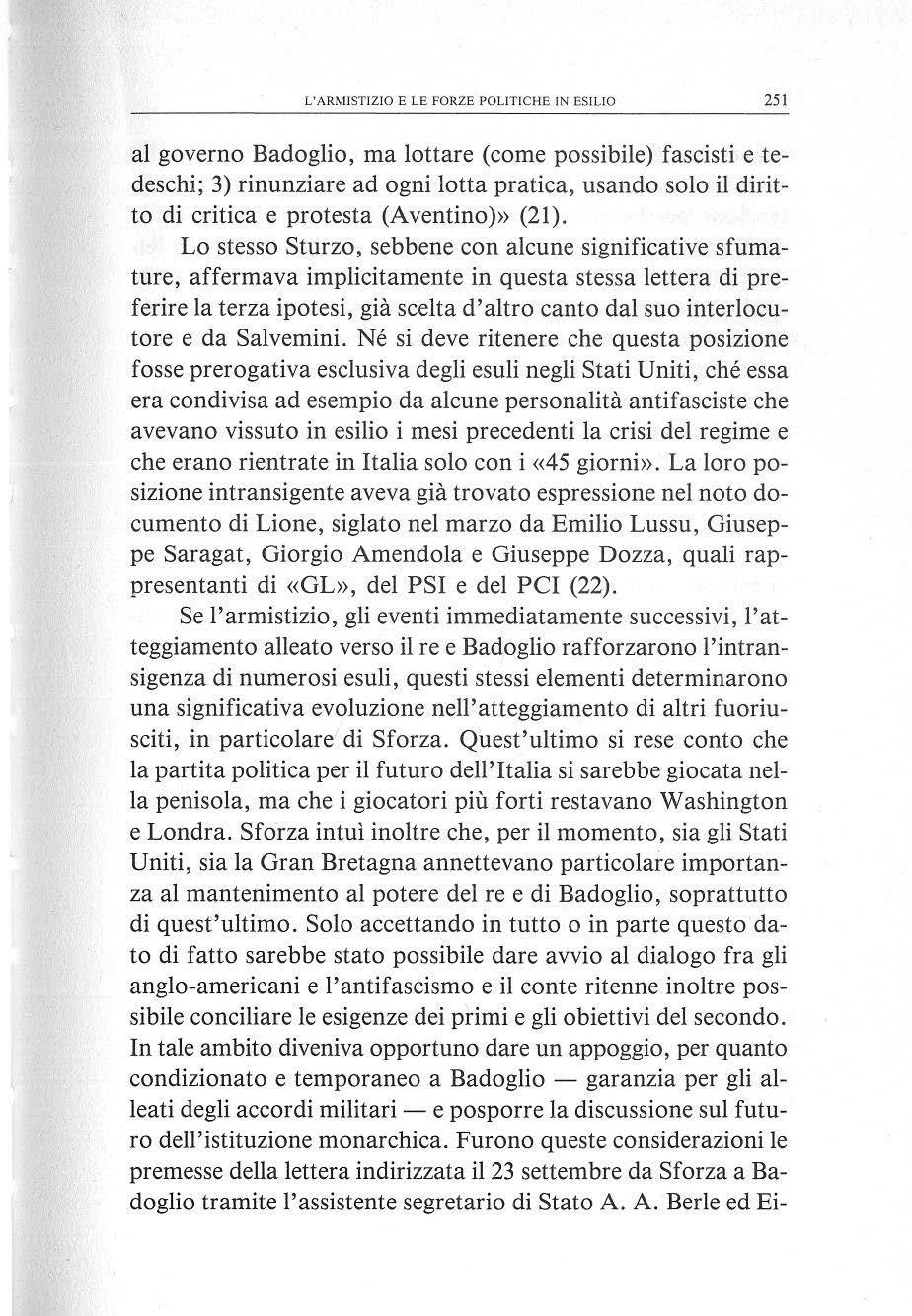
senhower. Questo documento, concordato con cura dal leader antifascista e dall'uomo politico americano merita qualche attenzione perchè aiuta a illustrare la interpretazione di Sforza degli eventi italiani. Nella lettera Sforza dichiarava di aver letto con interesse la dichiarazione rilasciata da Badoglio il 16 di quello stesso mese e nella quale il maresciallo aveva indicato come primo dovere di tutti gli italiani contribuire alla sconfitta della Germania e alla cacciata dei tedeschi dal paese. Anche Sforza riteneva dovere di ogni italiano, senza distinzione di partito o di fede politica, prendere parte alla lotta contro l'invasore nazista. Quindi egli sosteneva:
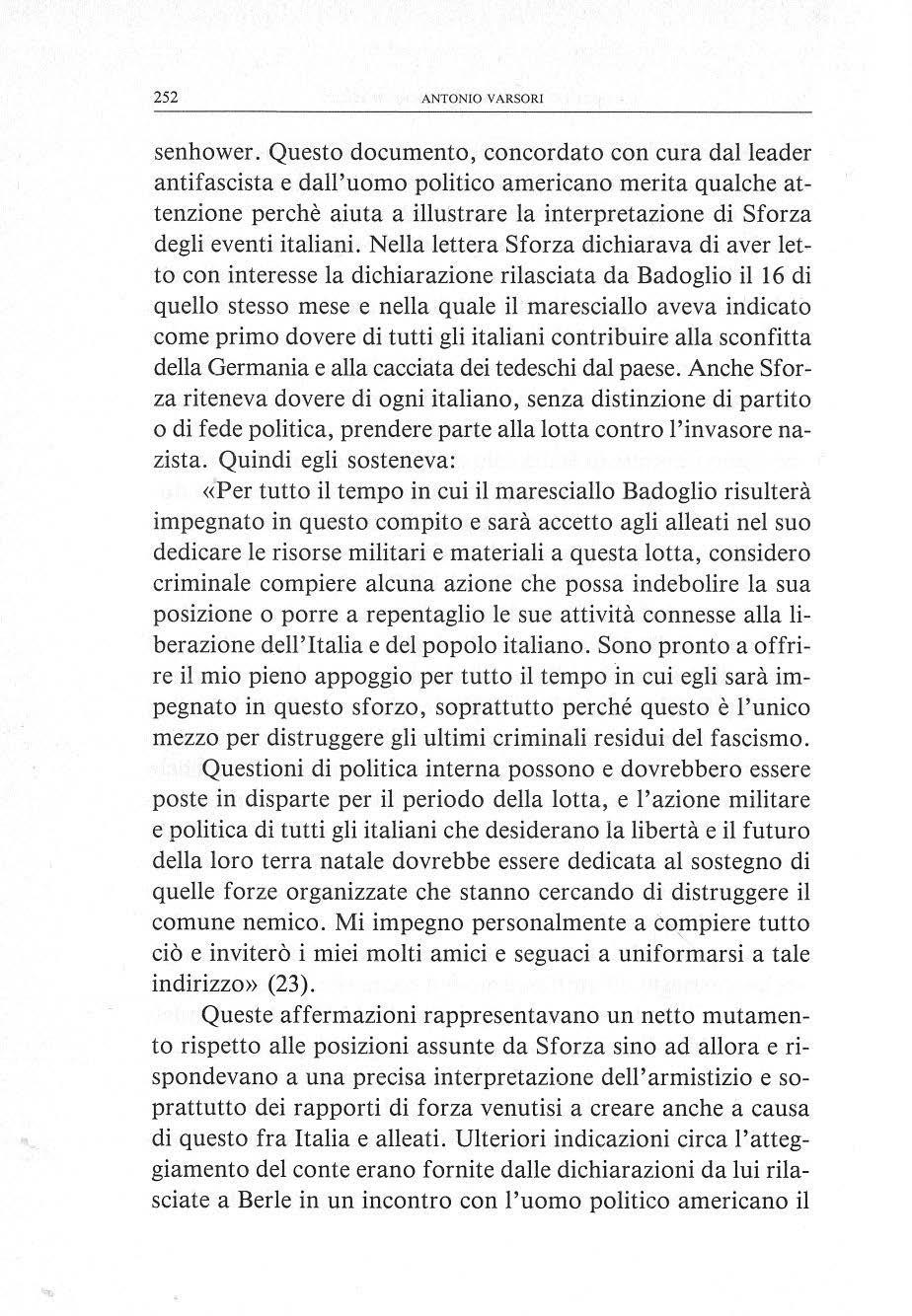
«Per tutto il tempo in cui il maresciallo Badoglio risulterà impegnato in questo compito e sarà accetto agli alleati nel suo dedicare le risorse militari e materiali a questa lotta, considero criminale compiere alcuna azione che possa indebolire la sua posizione o porre a repentaglio le sue attività connesse alla liberazione dell'Italia e del popolo italiano. Sono pronto a offrire il mio pieno appoggio per tutto il tempo in cui egli sarà impegnato in questo sforzo, soprattutto perché questo è l'unico mezzo per distruggere gli ultimi criminali residui del fascismo.
Questioni di politica interna possono e dovrebbero essere poste in disparte per il periodo della lotta, e l'azione militare e politica di tutti gli italiani che desiderano la libertà e il futuro della loro terra natale dovrebbe essere dedicata al sostegno di quelle forze organizzate che stanno cercando di distruggere il comune nemico. Mi impegno personalmente a compiere t utto ciò e inviterò i miei molti amici e seguaci a uniformarsi a tale indirizzo» (23).
Queste affermazioni rappresentavano un netto mutamento rispetto alle posizioni assunte da Sforza sino ad allora e rispondevano a una precisa interpretazione dell'armistizio e soprattutto dei rapporti di forza venutisi a creare anche a causa di questo fra Italia e alleati. Ulteriori indicazioni circa l'atteggiamento del conte erano fornite dalle dichiarazioni da lui rilasciate a Berle in un incontro con l'uomo politico americano il
22 settembre. Nel corso del colloquio Sforza aveva continuato a negare l'opportunità di un'unione nazionale intorno al re, ma aveva espresso un parere non del tutto negativo nei confronti di Badoglio; aveva anzi indicato alcuni elementi positivi nel curriculum del maresciallo che gli alleati avrebbero potuto sfruttare nella loro propaganda. Sforza inoltre aveva sostenuto: «Non pretendo che sia giunto il momento di abbattere la monarchia. Al contrario. Questo è un problema per il dopoguerra.
Ho semplicemente interesse per ciò che ritengo sia meglio al fine di vincere la guerra, niente altro. E so - da numerosissime fonti - che l'unanimità morale in Italia non sarà raggiunta attraverso un re discusso e disprezzato ma con l'unione attorno all'esercito e agli uomini - chiunque essi siano -che ne sono a capo. Perchè l'esercito è un dato di fatto - un dat o di fatto rispettato da tutti» (24).
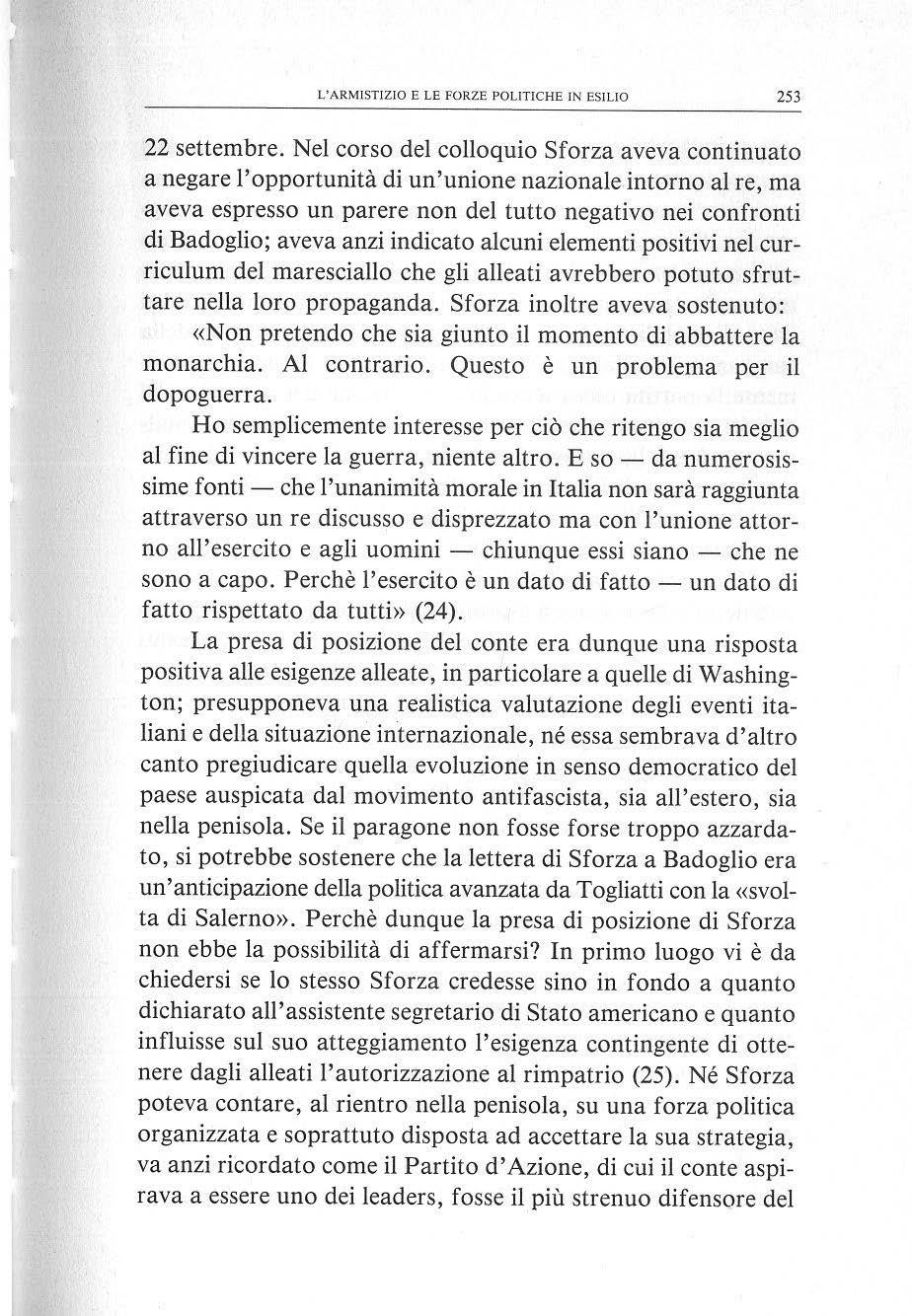
La presa di posizione del conte era dunque una risposta positiva alle esigenze alleate, in particolare a quelle di Washington; presupponeva una realistica valutazione degli eventi italiani e della situazione internazionale, né essa sembrava d'altro canto pregiudicare quella evoluzione in senso democratico del paese auspicata dal movimento antifascista, sia all'estero, sia nella penisola. Se il paragone non fosse forse troppo azzardato, si potrebbe sostenere che la lettera di Sforza a Badoglio era un'anticipazione della politica avanzata da Togliatti con la «svolta di Salerno>>. Perchè dunque la presa di posizione di Sforza non ebbe la possibilità di affermarsi? In primo luogo vi è da chiedersi se lo stesso Sforza credesse sin o in fondo a quanto dichiarato all'assistente segretario di Stato americano e quanto influisse sul suo atteggiamento l'esigenza contingente di ottenere dagli alleati l'autorizzazione al rimpatrio (25). Né Sforza
poteva contare, al rientro nella penisola, su una forza politica organizzata e soprattuto disposta ad accettare la sua strategia, va anzi ricordato come il Partito d'Azione, di cui il conte aspirava a essere uno dei leaders, fosse il più strenuo difensore del
rifiuto della situazione che si era venuta a creare nel regno del sud con l'armistizio (26). Va inoltre sottolineato il tiepido e contraddittorio appoggio americano all'azione del conte. Washington era disposta a favorire una soluzione di compromesso imperniata su un accordo tra Badoglio e Sforza per ragioni di carattere strategico-militare; una volta appurate l'incapacità italiana di mobilitare forze sufficienti per la prosecuzione della campagna d'Italia, nonché l'impossibilità di risolvere rapidamente la partita con i tedeschi, l'attenzione dei militari e dei politici americani verso le questioni italiane diminuì sensibilmente ed essi lasciarono in tal modo campo libero all'azione e agli interessi di Londra sino alla metà del 1944. Ben diversi sarebbero stati l'interpretazione inglese degli eventi italiani e l'atteggiamento verso Sforza (27).
Il paragone fra la lettera di Sforza a Badoglio e la «svolta di Salerno» ci conduce a esprimere alcune considerazioni sulle reazioni all'8 settembre da parte dei comunisti italiani operanti all'estero. Si è fatto cenno in precedenza alla presa di posizione sottoscritta da Dozza e Amendola a Lione nel marzo del '43. Essa, tra l'altro, indicava un atteggiamento intransigente verso ogni ipotesi di soluzione della crisi politica italiana attraverso un compromesso patrocinato dalla monarchia o dall'esercito, né gli estensori del documento di Lione sembravano aver tenuto conto delle esigenze strategiche e politiche anglo-americane. Questa scelta - confermata all'indomani dell'armistizio dall'operato del PCI nella penisola - risultava evidente da affermazioni quali:
«la pace, l'indipendenza, la libertà potranno essere conquistate solo dalla volontà del popolo. Il Partito Comunista d'Italia, il Partito socialista italiano, il movimento «Giustizia e Libertà» condannano le illusioni di coloro che aspettano la salvezza del paese da un repentino mutamento di condotta della monarchia o dallo sbarco in Italia di forze alleate» (28).
Interessanti diversità erano riscontrabili nella posizione assunta sin dall'autunno del 1942 dal mensile «Stato Operaio»,

pubblicato in quegli anni a New York, il quale, in un fondo redazionale, sembrava invece auspicare una sorta di politica di «concordia nazionale», avente quali precipui obiettivi la cacciata di Mussolini e la sconfitta della Germania hi t leriana. La rivista teorica del PCI collegava strettamente la crisi interna italiana alla crisi del ruolo internazionale del paese e affermava: «La tragica esperienza della guerra ha mostrato le cose nella loro realtà. Le fittizie conquiste del fascismo sono andate perdute. Invece della gloria è venuta la disfatta, una serie di catastrofi militari che hanno coperto di vergogna il paese. Invece della realizzazione degli ambiziosi sogni imperiali, l'asservimento alla Germania hitleriana che domina come uno stato vassallo il no stro paese. Gli italiani di tutti i partiti, di tutte le condizioni soc iali, ed i fascisti stessi si sono accorti della tragica ampie zz a di questa ,catastrofe nazionale. Come nazione indipendente l ' Italia è sparita dalla scena europea, sotto il prepotente tallone hitleriano» (29).
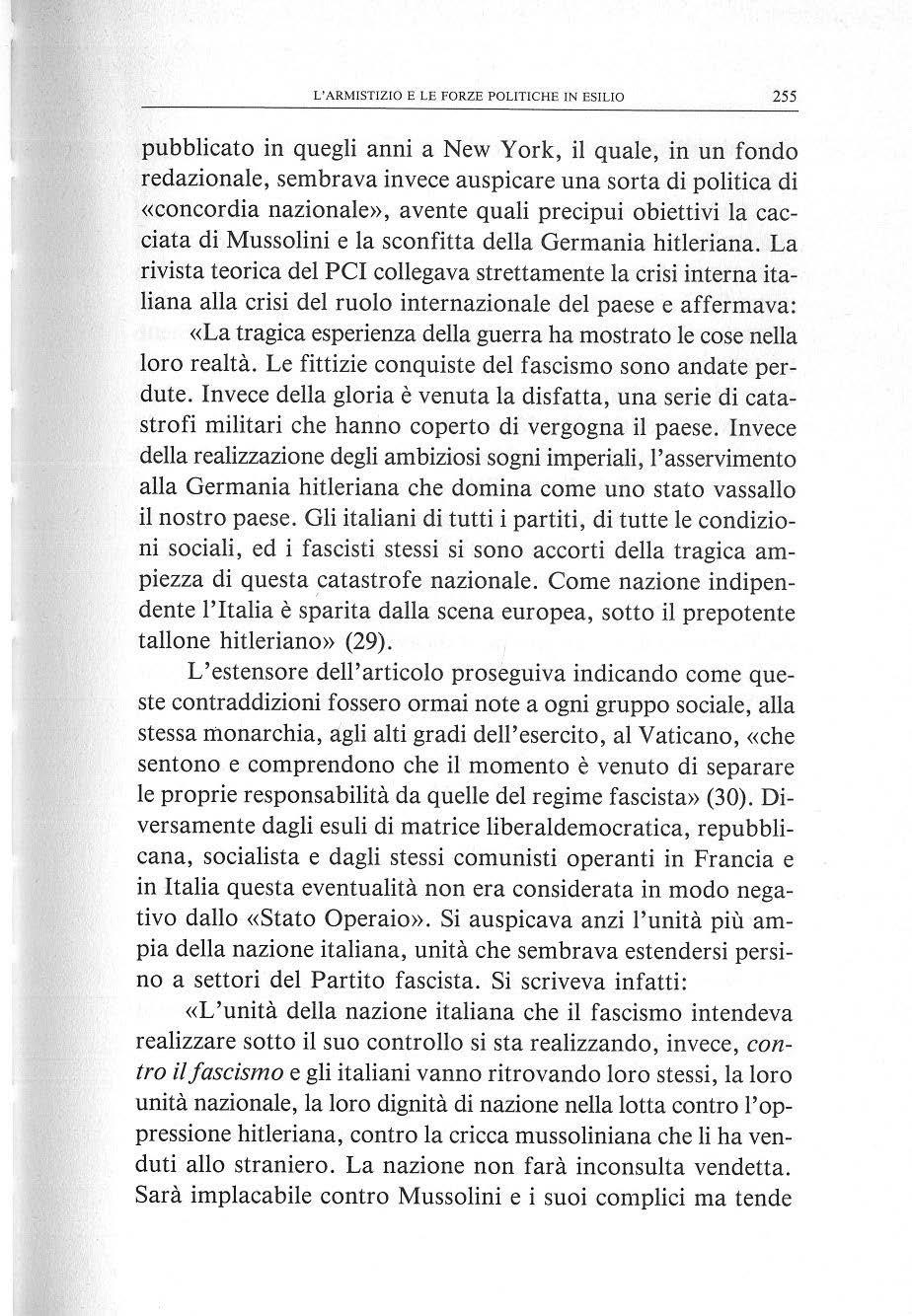
L'estensore dell'articolo proseguiva indicando come queste contraddizioni fossero ormai note a ogni gruppo sociale, alla stessa monarchia, agli alti gradi dell'esercito, al Vaticano, «che sentono e comprendono che il momento è venuto di separare le proprie responsabilità da quelle del regime fascista» (30). Diversamente dagli esuli di matrice liberaldemocratica, repubblicana, socialista e dagli stessi comunisti operanti in Francia e in Italia que st a eventualità non era considerata in modo negativo dallo «Stato Operaio». Si auspicava anzi l'unità più ampia della nazione italiana , unità che sembrava estendersi persino a settori del Partito fascista. Si scriveva infatti:
<<L'unità della nazione italiana che il fascismo intendeva realizzare sotto il suo controllo si sta realizzando, invece, contro il fascismo e gli italiani vanno ritrovando loro stessi, la loro unità nazionale, la loro dignità di nazione nella lotta contro l'oppressione hitleriana, contro la cricca mussoliniana che li ha venduti allo straniero. La nazione non farà inconsulta vendetta. Sarà implacabile contro Mussolini e i suoi complici ma tende
le mani agli italiani onesti che si staccano dal fascismo e vengono a lottare contro di esso» (31).
Obiettivo primo era dunque il rovesciamento di alleanze. Questa linea teneva ben conto della realtà internazionale e non trascurava che una vittoria militare era la prima meta dell'Unione Sovietica, ma un'affermazione dell'U.R.S.S. non poteva non avere conseguenze sul ruolo del PCI e, conseguentemente, sulla situazione italiana. La crisi del fascismo e della istituzione monarchica erano dunque momenti importanti, ma essi andavano inseriti in un più ampio contesto: la sorte della penisola d'altro canto non sarebbe stata determinata solo a Roma, o , in seguito, a Brindisi e a Salerno, ma anche a Washington, a Londra e a Mosca. Questo atteggiamento realistico trovò piena espressione nelle posizioni di Palmiro Togliatti, esule nell'Unione Sovietica. Già alla fine di aprile del 1943 egli, commentando in un radiomessaggio il rimpasto governativo effettuato da Mussolini due mesi prima, indicava il crescente isolamento del duce e sembrava attribuire solo a quest'ultimo ogni responsab ili tà per il coinvolgimento italiano nella guerra. Togliatti concludeva il suo discorso con un appello: «Questo concentramento delle ultime forze del fascismo attorno a Mussolini ha però anche il suo positivo. Gli italiani che sanno ragionare e comprendono i loro interessi individuali, di gruppo e nazionali, vedranno meglio, così, contro chi bisogna dirigere i colpi, chi deve essere buttato con disprezzo nell'immondezzaio, se si vuole che sia evitata all'Italia la peggiore delle catastrofi» (32).
Non deve stupire se anche dopo la cadutà di Mussolini l'attenzione di Togliatti si appuntasse sull'obiettivo della vittoria militare e, conseguentemente, sull'immediato «ralliement» italiano agli alleati. È in questa ottica che va valutata la dichiarazione del leader comunista del 3 agosto, nella quale egli auspicava le dimissioni di Badoglio e l'abdicazione del re; tali affermazioni non erano contraddittorie rispetto a quanto sostenuto in seguito dallo stesso Togliatti (33). Agli inizi di agosto del '43
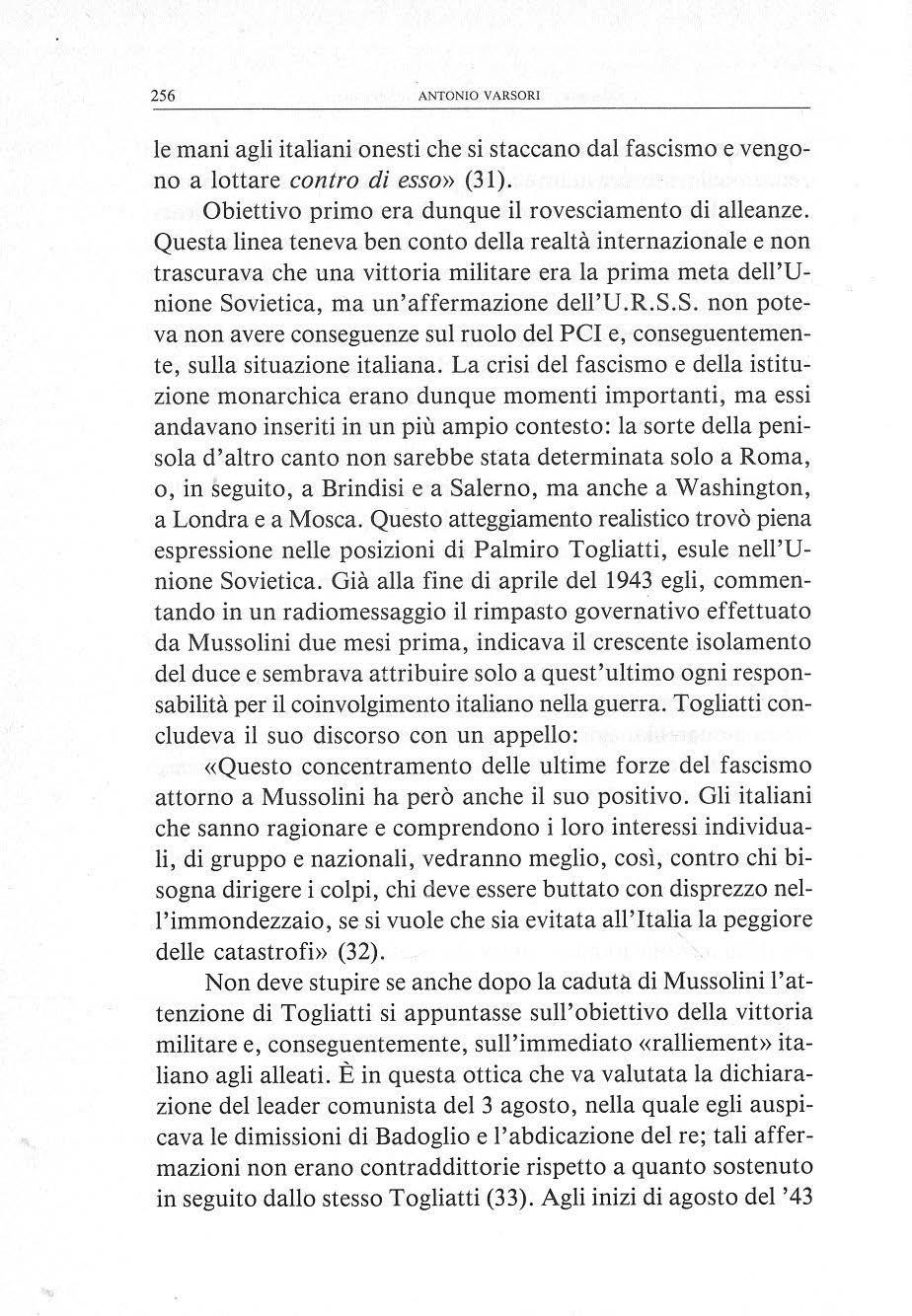
infatti Vittorio Emanuele III e il nuovo capo del governo sembravano voler proseguire nella guerra a fianco della Germania; le dichiarazioni di Togliatti rappresentavano dunque uno sprone nei confronti dei due responsabili italiani affinchè comprendessero che l ' allontanamento del duce non era una misura sufficiente e che un rapido rovesciamento di fronte era l'unica via d'uscita loro rimasta. L'8 settembre fu dunque per il leader comunista soprattutto il punto di partenza per una collaborazione fra tutte le forze ostili al fascismo nella lotta contro Mussolini e i tedeschi. Trasmettendo da Radio Mosca il 10 settembre
l'esponente del PCI affermava:
«L'Italia ha bisogno oggi di un nuovo governo il quale prenda nelle sue mani apertamente, senza esitazioni, la bandiera della difesa d'Italia con t ro la vile aggr essione hitleriana, pe r salvaguardare il sacro retaggio della nazione . Se il go verno Badoglio seguirà questa linea di difesa della nazione, il popolo gli darà il suo appoggio» (34).
Tale posizione sarebbe stata confermata in seguito da Togliatti, ad esempio in un articolo apparso sulla «Pravda» il 12 settembre e la cui rilevanza è stata indicata d~ Paolo Spriano. Scriveva tra l'altro Togliatti:
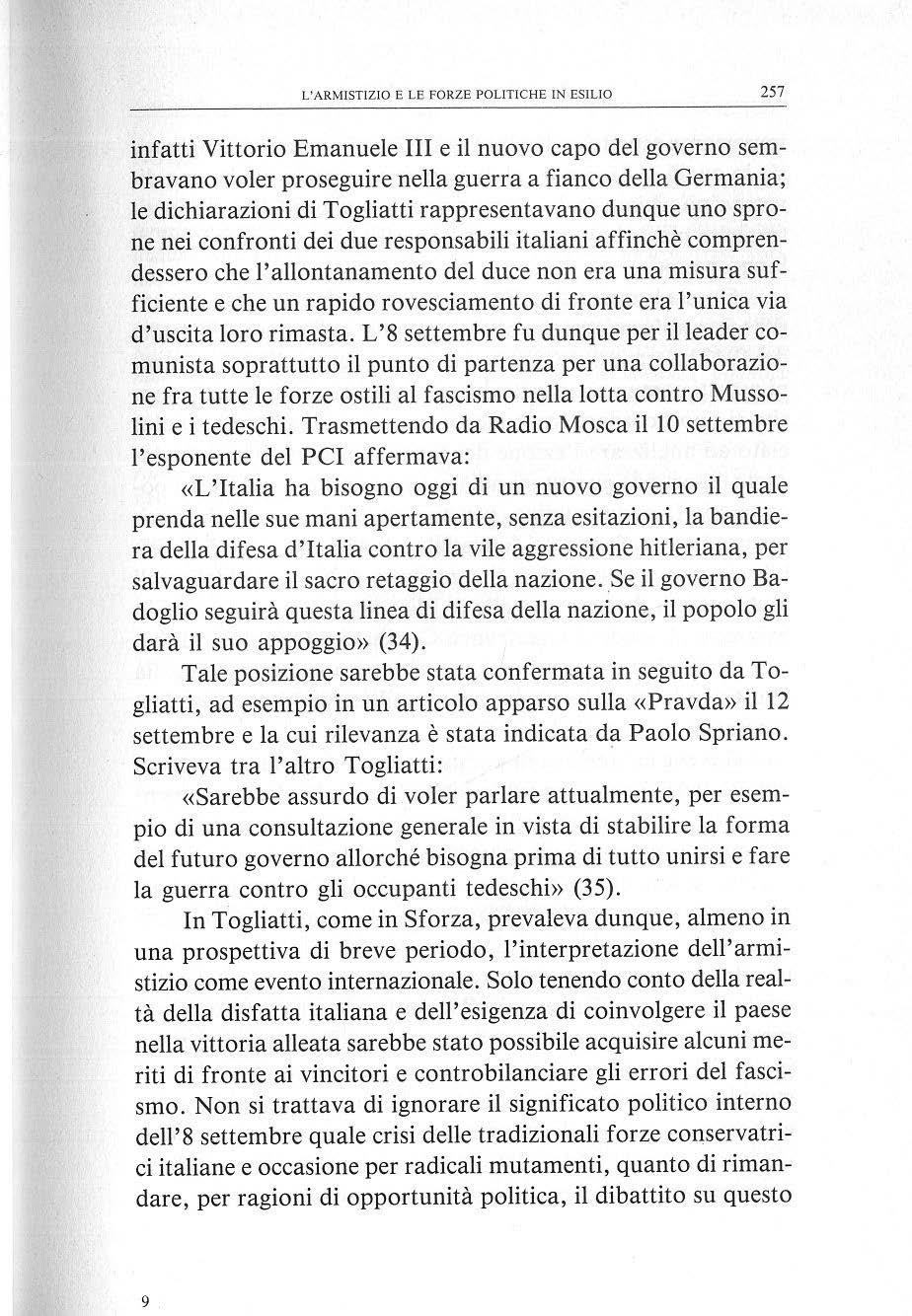
«Sarebbe assurdo di voler parlare attualmente, per esempio di una consultazione generale in vista di stabilire la forma del futuro governo allorché bisogna prima di tutto unirsi e fare la guerra contro gli occupanti tedeschi» (35).
In Togliatti, come in Sforza, prevaleva dunque, almeno in una prospettiva di breve periodo, l'interpretazione dell'armistizio come evento internazionale. Solo tenendo conto della realtà della disfatta italiana e dell'esigenza di coinvolgere il paese nella vittoria alleata sarebbe stato possibile acquisire alcuni meriti di fronte ai vincitori e controbilanciare gli errori del fascismo. Non si trattava di ignorare il significato politico interno dell'8 settembre quale crisi delle tradizionali forze conservatrici italiane e occasione per radicali mutamenti, quanto di rimandare, per ragioni di opportunità politica, il dibattito su questo
importante aspetto - ben presente sia nei progetti di Togliatti, sia in quelli di Sforza - al dopoguerra, quando anche una diversa e più chiara realtà internazionale avrebbe forse consentito scelte più precise e coerenti con gli obiettivi antifascisti di lungo periodo.
Questa breve analisi di alcune reazioni dell'emigrazione antifascista all'armistizio e, più in generale, agli eventi dell'estate del 1943 ha trascurato, anche per ovvie ragioni di spazio, alcuni aspetti comunque meritevoli di attenzione. A questo proposito si può ricordare come alcuni recenti studi abbiano cominciato ad analizzare l'azione del fuoruscitismo antifascista durante la seconda guerra mondiale, un tema sul quale sino a poco tempo fa restava unico, per quanto valido, punto di riferimento il noto «Storia dei fuorusciti» di Aldo Garosci. È possibile citare ora, fra gli altri, il contributo di Nicola Oddati sugli esuli in Gran Bretagna, quello di Elisa Signori sui fuorusciti in Svizzera, gli studi di Gianfranco Cresciani e Luigi Bruti Liberati sul fascismo e l'antifascismo rispettivamente in Australia e in Canada, nonchè alcuni lavori sull'emigrazione liberaldemocratica negli Stati Uniti (36).
Ciò che ci premeva in questa sede era di analizzare alcuni aspetti delle valutazioni sull'8 settembre e sulle sue conseguenze da parte di esponenti dell'emigrazione antifascista in rapporto al contesto internazionale, nonchè cogliere le differenze esistenti tra le posizioni di alcuni di essi, in particolare Sforza e Togliatti, e quelle espresse dall'antifascismo che si stava riorganizzando nella penisola. All'atteggiamento di quest'ultimo erano d'altronde vicini - come si è cercato di dimostrare - altri esuli, quali, ad esempio, Salvemini e Pacciardi. L'analisi condotta non pretende di essere esaustiva delle posizioni delle personalità prese in considerazione e quanto affermato ha soprattutto valore di stimolo per una più approfondita indagine sulle attività e sulla elaborazione teorica del movimento antifascista operante all 'estero, non trascurando come queste e gli stessi eventi italiani si inserissero in un ben preciso contesto internazionale.
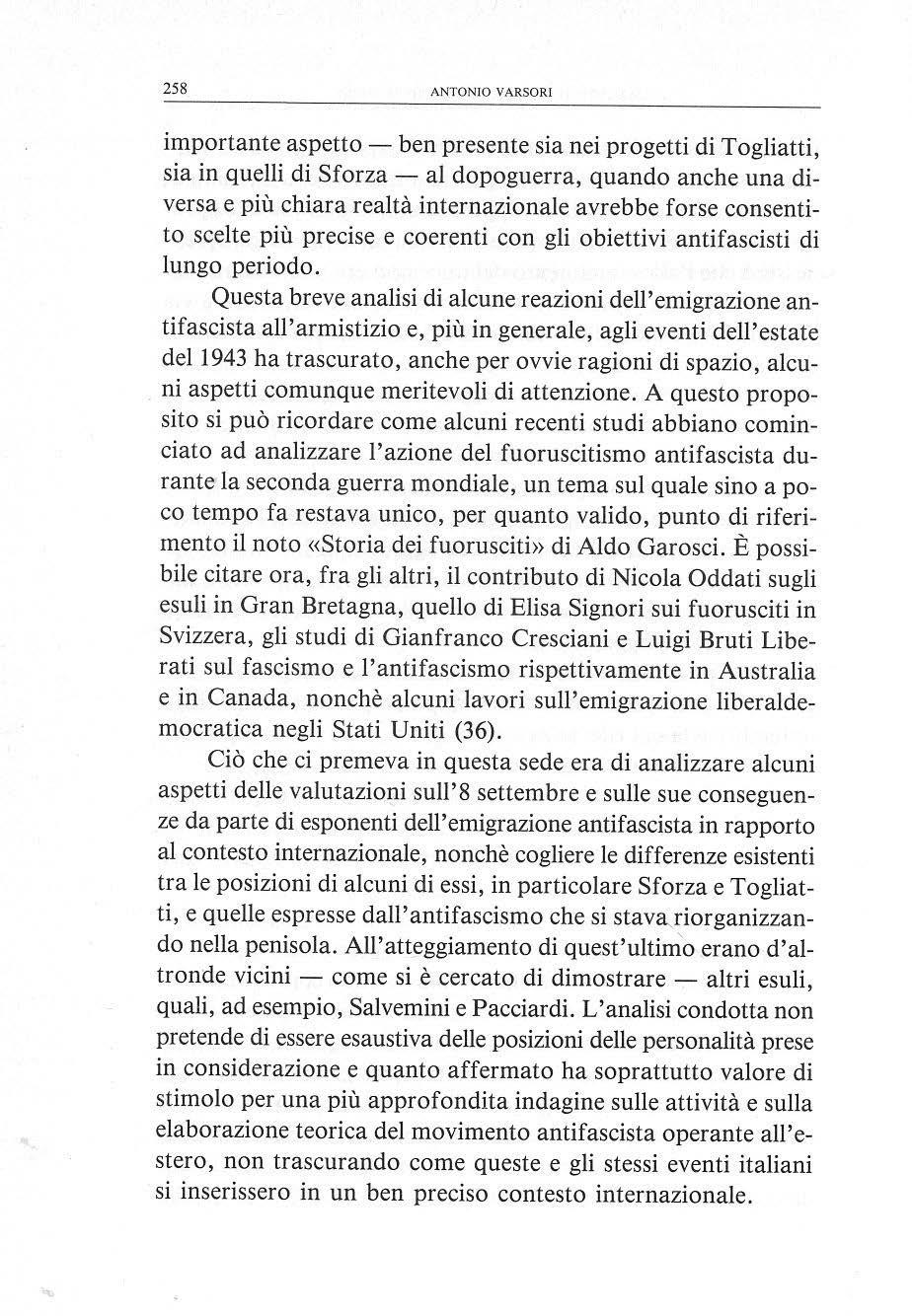
(1) E. Di Nolfo, Sistema internazionale e sistema politico italiano: interazione e compatibilità, in L. Graziano e S. Tarrow (a cura di), La crisi italiana, voi. I, Formazione del regime repubblicano e società civile, Torino, E inaudi, 1979, pp. 79 - 112.
(2) Cfr., ad esempio, le considerazioni in D. W. Ellw ood, L'alleato nemico. La politica dell'occupazione anglo-americana in Italia 1943-1946, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 48-63; E. Colletti, Collocazione internazionale dell'Italia dall'armistizio alle premesse dell'alleanza atlantica (1943 - 1947), in AA. VV., L'Italia dalla liberazione alla repubblica, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 30-49.
(3) Cfr. su queste personalità, tra l'altro, A. Garosci, Storia dei fuoriusciti, Bari, Laterza, 1953 e C. Delzell, I nemici di Mussolini, Torino, Einaudi, 1966, passim.
(4) A . Varsori, Gli alleati e l'emigrazione democratica antifascista (1940-1943), Firenze, Sansoni, 1982.
(5) Ibidem . p. 318.
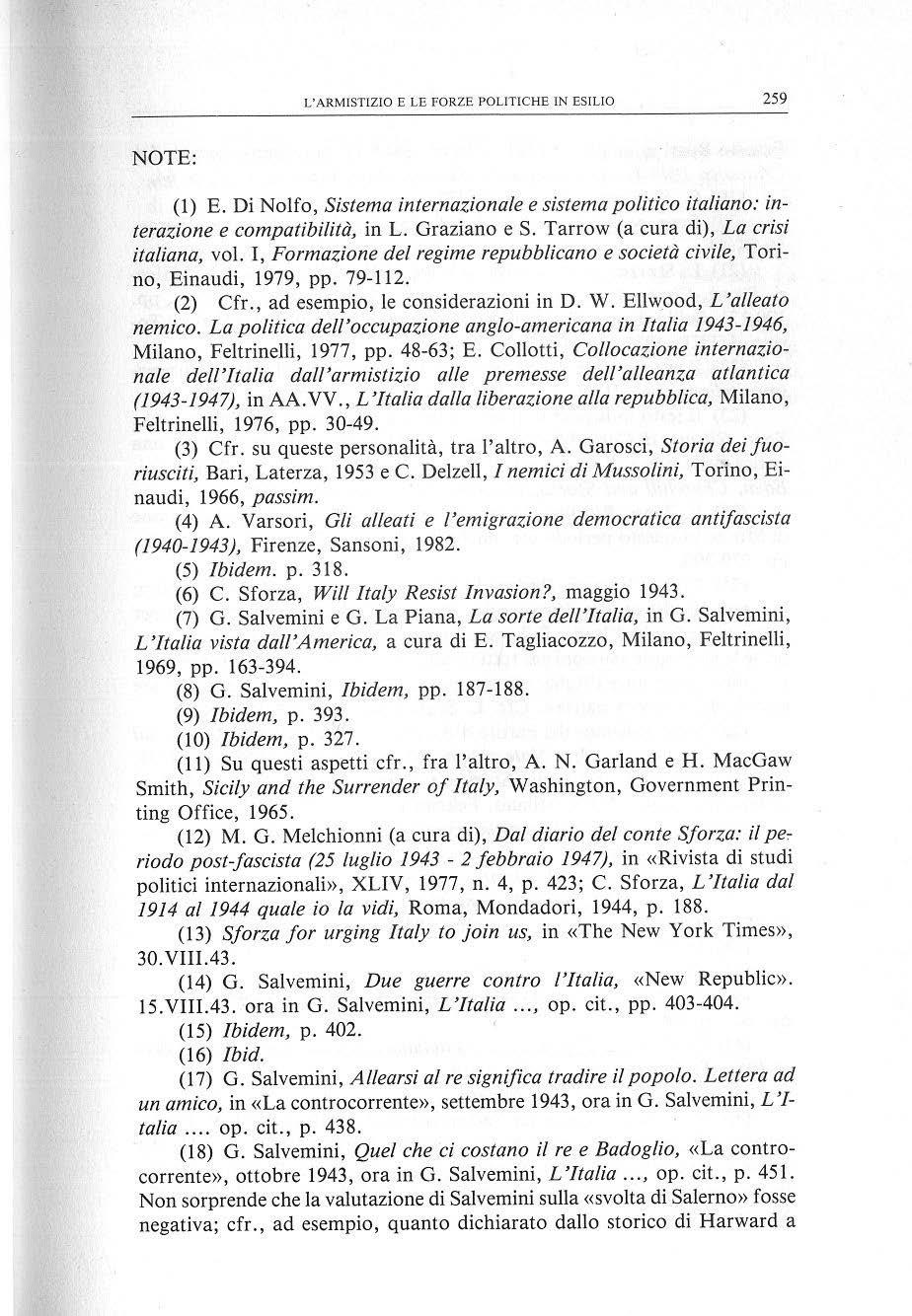
(6) C. Sforza, Wi/1 ltaly Resist Invasion?, maggio 1943.
(7) G. Salvemini e G. La Piana, La sorte dell'Italia, in G. Salvemini, L'Italia vista dall'America, a cura di E. Tagliacozzo, Milano, Feltrinelli, 1969, pp. 163-394
(8) G. Salvemini, Ibidem, pp 187-188
(9) Ibidem, p . 393.
(10) Ibidem , p. 327 .
(11) Su questi aspetti cfr ., fra l'altro, A. N. Garland e H. MacGaw Smith, Sicily and the Surrender of Italy, Washington, Government Printing Office, 1965.
(12) M. G. Melchionni (a cura di), Dal diario del conte Sforza: il pe, riodo post-fascista (25 luglio 1943 - 2 febbraio 1947), in «Rivista di studi polit ici internazionali», XLIV, 1977, n. 4, p. 423; C. Sforza, L'Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi, Roma, Mondadori, 1944, p. 188.
(13) Sforza for urging Italy to join us, in «The New York T imes », 30 Vlll.43.
(14) G . Salvemini, Due guerre contro l'Italia, «New Republic» . 15.Vlll.43. ora in G. Salvemini, L'Italia .. ., op. cit . , pp. 403 -404.
(15) Ibidem, p. 402.
(16) Ibid.
(17) G. Salvemini, Allearsi al re significa tradire il popolo. Lettera ad un amico, in «La controcorrente», settembre 1943, ora in G. Salvemini, L'Italia op. cit., p . 438.
(18) G . Salvemini, Quel che ci costano il re e Badoglio, «La controcorre nte », ottobre 1943, ora in G . Salvemini, L 'Italia , op . cit., p. 451. Non sorprende che la valutazione di Salvemini sulla «svolta di Salerno» fosse negativa; cfr., ad esempio, quanto dichiarato dallo storico di Harward a
Ernesto Rossi in una lettera del dicembre 1944, G. Salvemini, Lettere dall'America 1944-1946, a cura di A. Merola, Bari, Laterza, 1967, p. 64.
(19) G. Salvemini, Ibidem, p 452.
(20) Resa incondizionata del re e Badoglio, s.f., in «L'Italia Libera» , 16.IX.43.
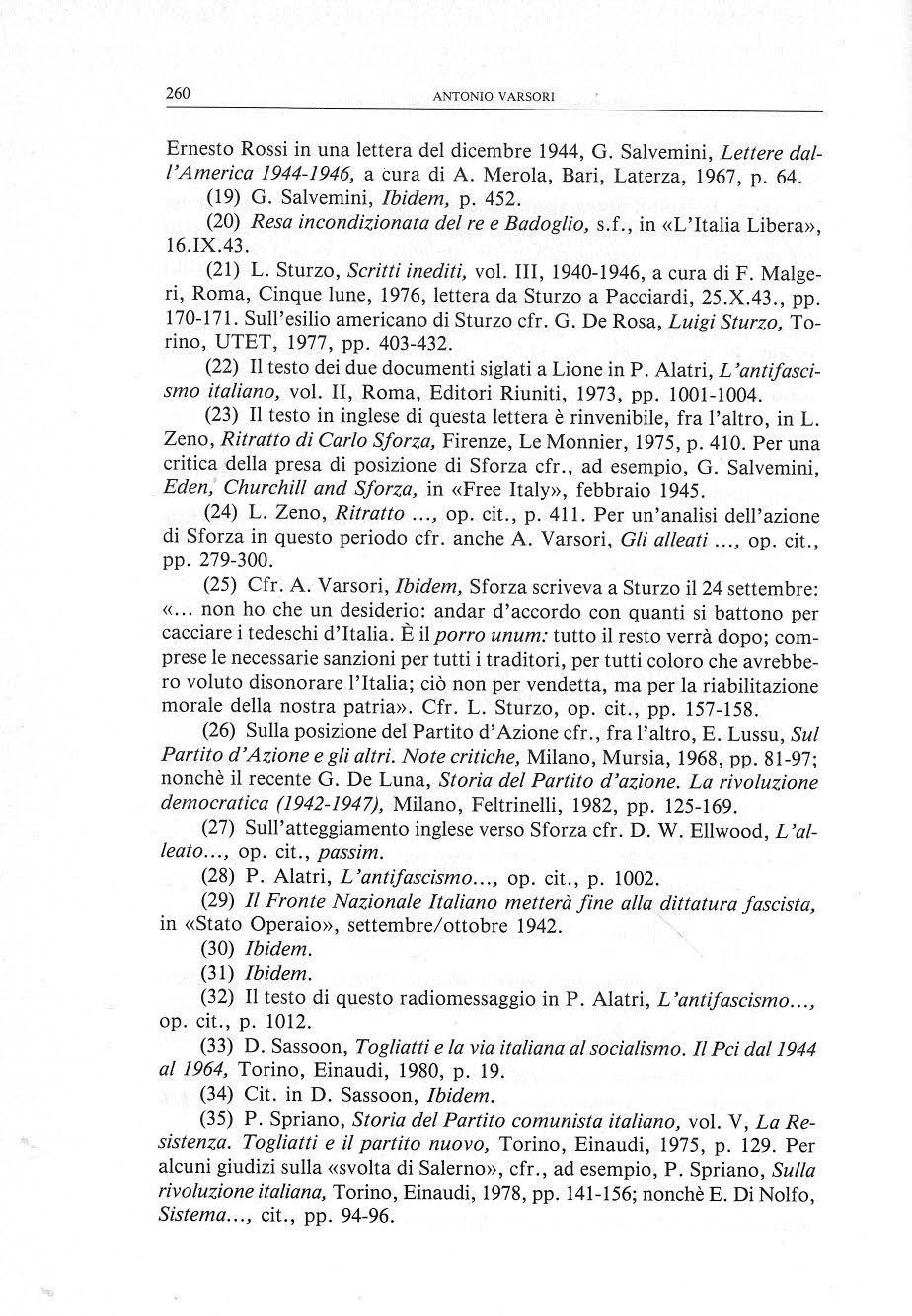
(21) L. Sturzo, Scritti inediti, voi. III, 1940-1946, a cura di F. Malg eri, Roma, Cinque l une, 1976, lettera da Sturzo a Pacciardi, 25 . X.43., pp . 170- 171. Sull'esilio americano di Sturzo cfr. G. De Rosa, Luigi Sturzo, Torino, UTET, 1977, pp. 403-432.
(22) Il testo dei due documenti siglati a Lione in P. Alatri, L 'antifascismo italiano, voi. Il, Roma, Editori Riuni t i, 1973, pp. 1001-1004.
(23) Il testo in inglese di questa lettera è rinvenibile, fra l'altro, in L. Zeno, Ritratto di Carlo Sforza, Firenze, Le Monnier, 1975, p. 410. Per una critica della presa di posizione di Sforza cfr., ad es empio, G. Salvemini, Eden, Churchill and Sforza, in <<Free Italy», febbraio 1945.
(24) L. Z eno, Ritratto , op. cit., p 411. Per un'analisi dell'azione di Sforza in questo periodo cfr. anche A. Varsori, Gli alleati .. . , op. cit. , pp 279- 300.
(25) Cfr. A. Varsori, Ibidem, Sforza scriveva a Sturzo il 24 settembre: «... non ho che un desiderio: andar d'accordo con quanti si battono per cacciare i tedeschi d'Italia. È il porro unum: tutto il resto verrà dopo; comprese le necessarie sanzioni per tutti i traditori, per tutti coloro che avrebbero vo lu to disonorare l'Italia; ciò non per vendetta, ma per la riabilitazione morale della nostra patria». Cfr. L. Sturzo, op. cit. , pp. 157-158.
(26) Sulla posizione del Partito d'Azione cfr., fra l'altro , E. Lussu, Sul Partito d'Azione e gli altri. Note critiche, Milano, Mursia, 1968, pp. 81-97; nonchè il recente G. De Luna, Storia del Partito d'azione. La rivoluz ione democratica (1942 - 1947), Milano, Feltrine lli, 1982, pp. 125-169
(27) Sull'atteggiamento inglese verso Sforza cfr. D. W. Ellwood, L 'alleato ... , op . cit., passim.
(28) P. Alatri, L'antifascismo ... , op. cit., p . 1002 .
(29) Il Fronte Nazionale Italiano metterà fine alla dittatura fascista, in «Stato Operaio», settembre/ottobre 1942.
(30) Ibidem.
(31) Ibidem .
(32) Il testo di questo radiomessaggio in P. Alatri, L'antifascismo ... , op. cit., p . 1012.
(33) D. Sassoon, Togliatti e la via italiana al socialismo. Il Pci dal 1944 al 1964, Torino, Ei naudi, 1980, p. 19.
(34) Cit. in D. Sassoon, Ibidem.
(35) P Spriano, Storia del Partito comunista italiano, voi. V, La Resistenza. Togliatti e il partito nuovo, Tori no, Einaudi, 1975, p. 129. P er alcuni giudizi sulla «svolta di Salerno», cfr., ad esempio , P . Spriano, Sulla rivoluzione italiana, Torino, Einaudi, 1978, pp. 141-156; nonchè E. Dì Nolfo, Sistema , cit., pp. 94-96.
(36) N. Oddati, Carlo Petrone: un cattolico in esilio 1939-1944, Roma, Cinque lune, 1980; I. Silone, Memoriale dal carcere svizzero, a cura di L. Mercuri, Roma, Lerici, 1979; R. Broggini, I rifugiati italiani in Svizzera e il foglio Libertà! Antologia di scritti 1944-1945, Roma, Cinque lune, 1979; E. Signori, La Svizzera e i fuorusciti italiani . Aspetti e problemi dell'emigrazione politica 1943-1945, Milano, Angeli, 1983; G Cresciani, Fascismo, antifascismo e gli italiani in Australia 1922-1945, Roma, Bonacci, 1979; L. Bruti Liberati, La società canadese e il fascismo : « View from a fire-proof house», in «Storia contemporane a», XIII, 1982, n. 4/5, pp. 877-908; J .P. Diggins, Mussolini and Fascism. The View from America, P rinceton (N J.), Princeton Uni v ersity Press, 1972; A . Varsori, Gli alleati ... , op. cit.
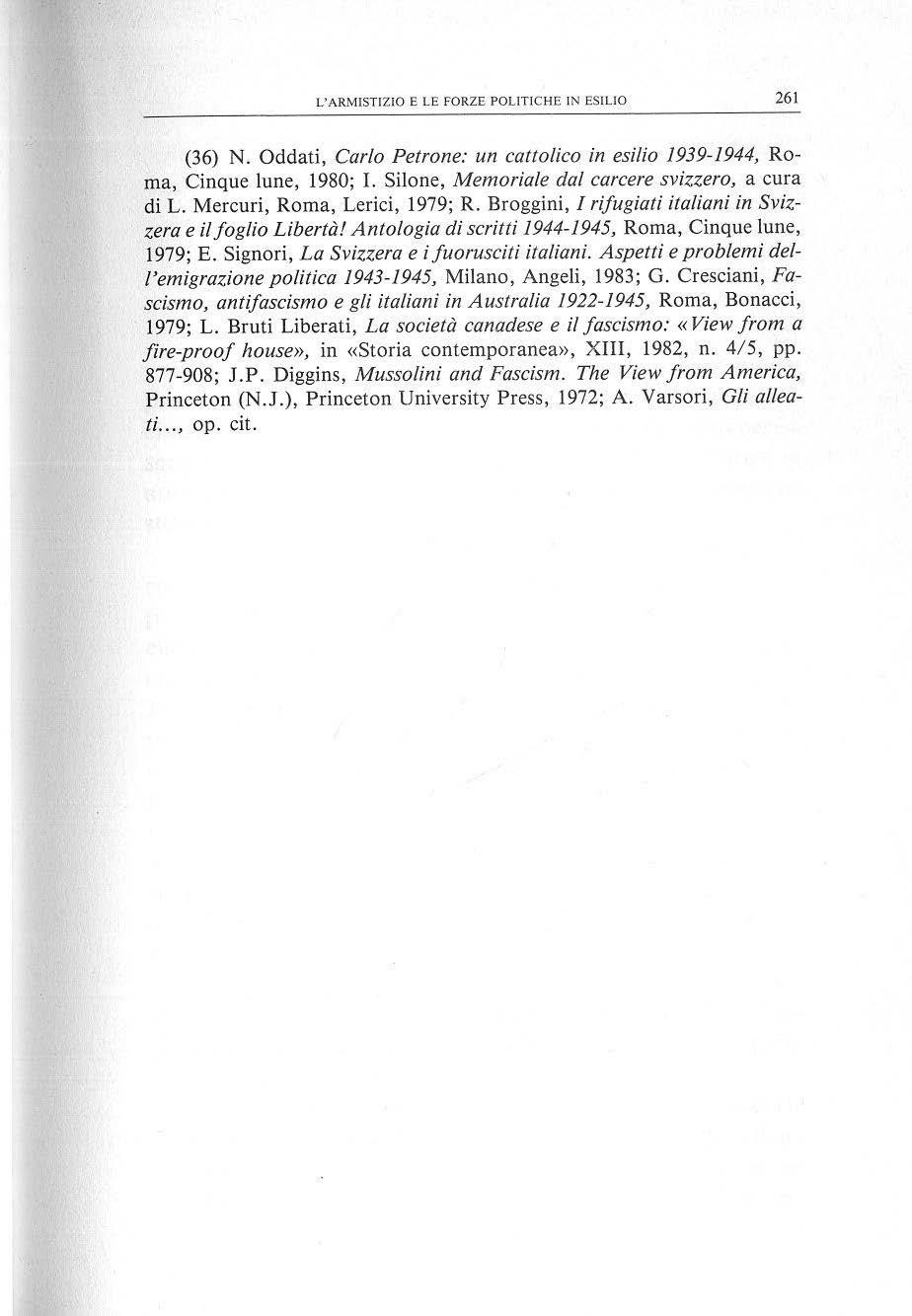

La Comunicazione dal titolo «armistizio e la nascita dei partiti politici» mi porta necessariamente ç1 compiere alcune precisazioni anche di carattere metodologico, rese del resto necessarie dall'ampio fermento di revisione ideologica e storica in atto da anni sia a livello di ricerca che di interpretazione storiografica.
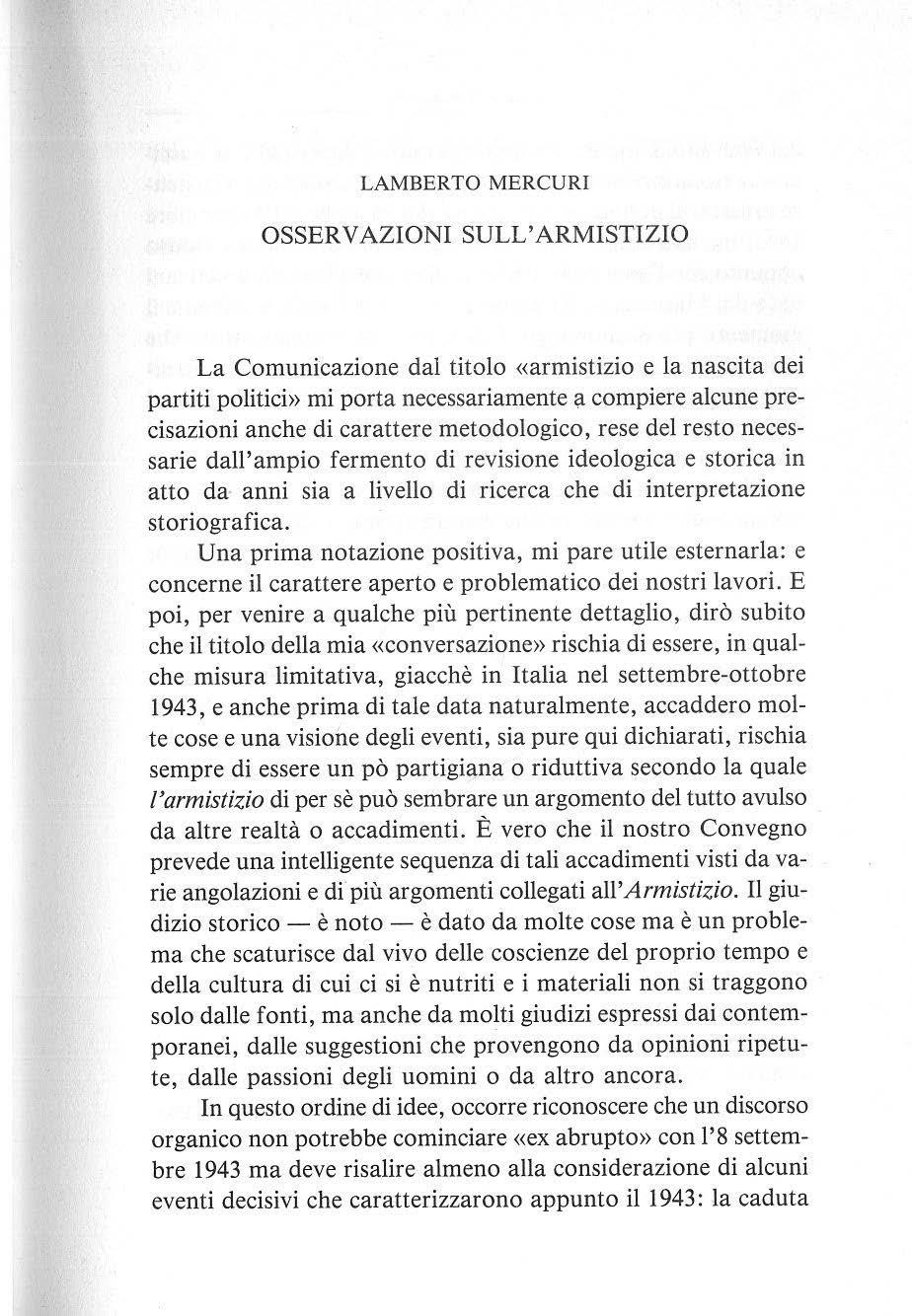
Una prima notazione positiva, mi pare utile esternarla: e concerne il carattere aperto e problematico dei nostri lavori. E poi, per venire a qualche più pertinente dettaglio, dirò subito che il titolo della mia «conversazione» rischia di essere, in qualche misura limitativa, giacchè in Italia nel settembre-ottobre 1943, e anche prima di tale data naturalmente, accaddero molte cose e una visione degli eventi, sia pure qui dichiarati, rischia sempre di essere un pò partigiana o riduttiva secondo la quale l'armistizio di per sè può sembrare un argomento del tutto avulso da altre realtà o accadimenti. È vero che il nostro Convegno prevede una intelligente sequenza di tali accadimenti visti da varie angolazioni e di più argomenti collegati all'Armistizio. Il giudizio storico -è noto - è dato da molte cose ma è un problema che scaturisce dal vivo delle coscienze del proprio tempo e della cultura di cui ci si è nutriti e i materiali non si traggono solo dalle fonti, ma anche da molti giudizi espressi dai contemporanei, dalle suggestioni che provengono da opinioni ripetute, dalle passioni degli uomini o da altro ancora.
In questo ordine di idee, occorre riconoscere che un discorso organico non potrebbe cominciare «ex abrupto» con 1'8 settembre 1943 ma deve risalire almeno alla considerazione di alcuni eventi decisivi che caratterizzarono appunto il 1943: la caduta
del fascismo, i <<quarantacinque giorni», l'Armistizio, la nascita o la ricostituzione dei partiti politici e l'inizio della Resistenza armata. Il periodo infatti che va dal 25 luglio all'8 settembre 1943, iniziato con la caduta del regime mussoliniano e chiuso appunto con l'annunzio dell'armistizio con gli anglo-americani dato dal Maresciallo Badoglio e firmato a Cassibile, rimane il momento più drammatico della nostra più recente storia che non sarebbe però del tutto chiaro se non si risalisse alla considerazione della guerra perduta, argomento già toccato da altri eminent i colleghi e da altri specialisti.
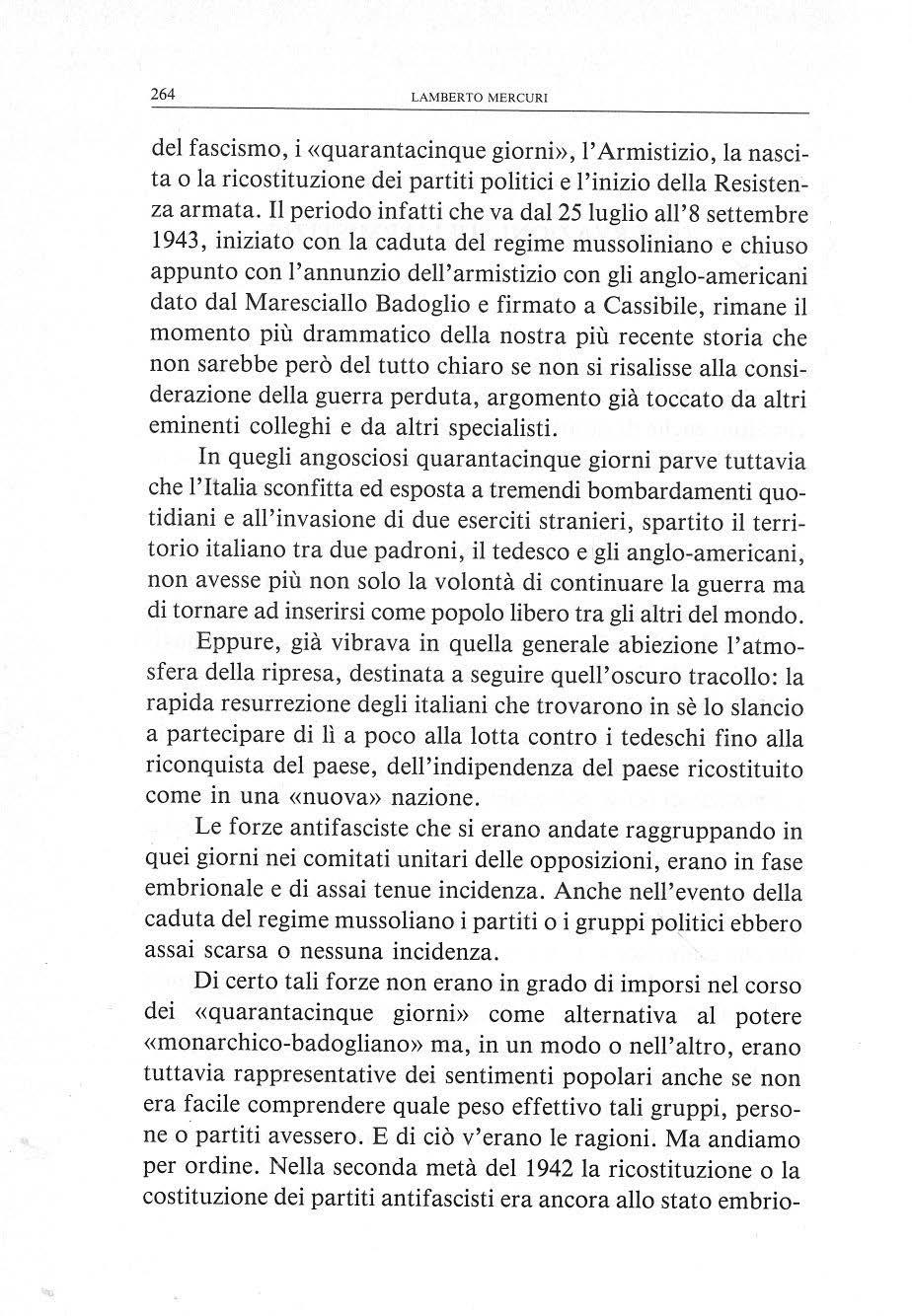
In quegli angosciosi quarantacinque giorni parve tuttavia che l'Italia sconfitta ed esposta a tremendi bombardamenti quotidiani e all'invasione di due eserciti stranieri, spartito il territorio italiano tra due padroni, il tedesco e gli anglo-americani, non avesse più non solo la volontà di continuare la guerra ma di tornare ad inserirsi come popolo libero tra gli altri del mondo.
Eppure, già vibrava in quella generale abiezione l'atmosfera della ripresa, destinata a seguire quell'oscuro tracollo: la rapida resurrezione degli italiani che trovarono in sè lo slancio a partecipare di lì a poco alla lotta contro i tedeschi fino alla riconquista del paese, dell'indipendenza del paese ricostituito come in una «nuova» nazione.
Le forze antifasciste che si erano andate raggruppando in quei giorni nei comitati unitari delle opposizioni, erano in fase embrionale e di assai tenue incidenza. Anche nell'evento della caduta del regime mussoliano i partiti o i gruppi politici ebbero assai scarsa o nessuna incidenza.
Di certo tali forze non erano in grado di imporsi nel corso dei «quarantacinque giorni» come alternativa al potere «monarchico-badogliano» ma, in un modo o nell'altro, erano tuttavia rappresentative dei sentimenti popolari anche se non era facile comprendere quale peso effettivo tali gruppi, persone o partiti avessero. E di ciò v'erano le ragioni. Ma andiamo per ordine. Nella seconda metà del 1942 la ricostituzione o la costituzione dei partiti antifascisti era ancora allo stato embrio-
nale e a renderla tale non era solo l'occhiuta vigilanza delle varie forze di polizia ma anche per una serie di difficoltà: di ristabilire antichi legami andati perduti o affievoliti nel corso del tempo e ancor più di stabilirne dei nuovi e l'affiorare, in non pochi casi, di divisioni anche profonde tra uomini che - uniti per tanti anni da un comune atteggiamento di critica e di opposizione al fascismo, adesso al momen to di prepararsi a passare all'azione, mostravano di risentire o sentire prospettive diverse e, talvolta, persino di giudicare diversamente i loro rispettivi comportamenti passati di fronte al fascismo. In realtà, più che di partiti, è giusto parlare e più propriamente, di gruppi sparsi nel paese e spesso neppure sistematicamente collegati tra di loro. Tra questi gruppi i più significativi erano, per un verso, quelli che in alcune maggiori città italiane raccoglievano i rappresentanti della vecchia classe politica liberale-democratica ai quali faceva capo un certo numero di antifascisti più giovani e di intellettuali che, non di r ado, avevano fatto in tempo a fare le loro prime esperienze politiche nei partiti e movimenti del periodo aventiniano, che avevano svolto successivamente una certa attività clandestina e che talvolta erano legati ai maggiori esponenti da vincoli di na tura familiare; e per altro verso quelli attorno ai quali si andavano ricostituendo, quasi sempre ad oprea di vecchi esponenti popolari, le file del partito cattolico. Un terzo polo era poi costituito dal nuovo Partito d'Azione che raccoglieva elementi, in generale, più giovani e di varia formazione ideologica-politica anche se i più significativi dirigenti di esso non si differenziavano molto, quanto a formazione ad ambienti frequentati in passato, dai loro coetanei gravitanti intorno ai vecchi esponenti liberal-democratici e, anzi, piuttosto spesso ne avevano condiviso fino a pochissimo temp o prima le posizioni.
Quasi inesistente a quest'epoca il Partito Socialista (le sue prime manifestazioni di vita risalgono all'estate 1942 e la sua effettiva ricostituzione avvenne più tardi) e quello repubblicano che avvenne in aree di forte tradizione repubblicana. Quan-
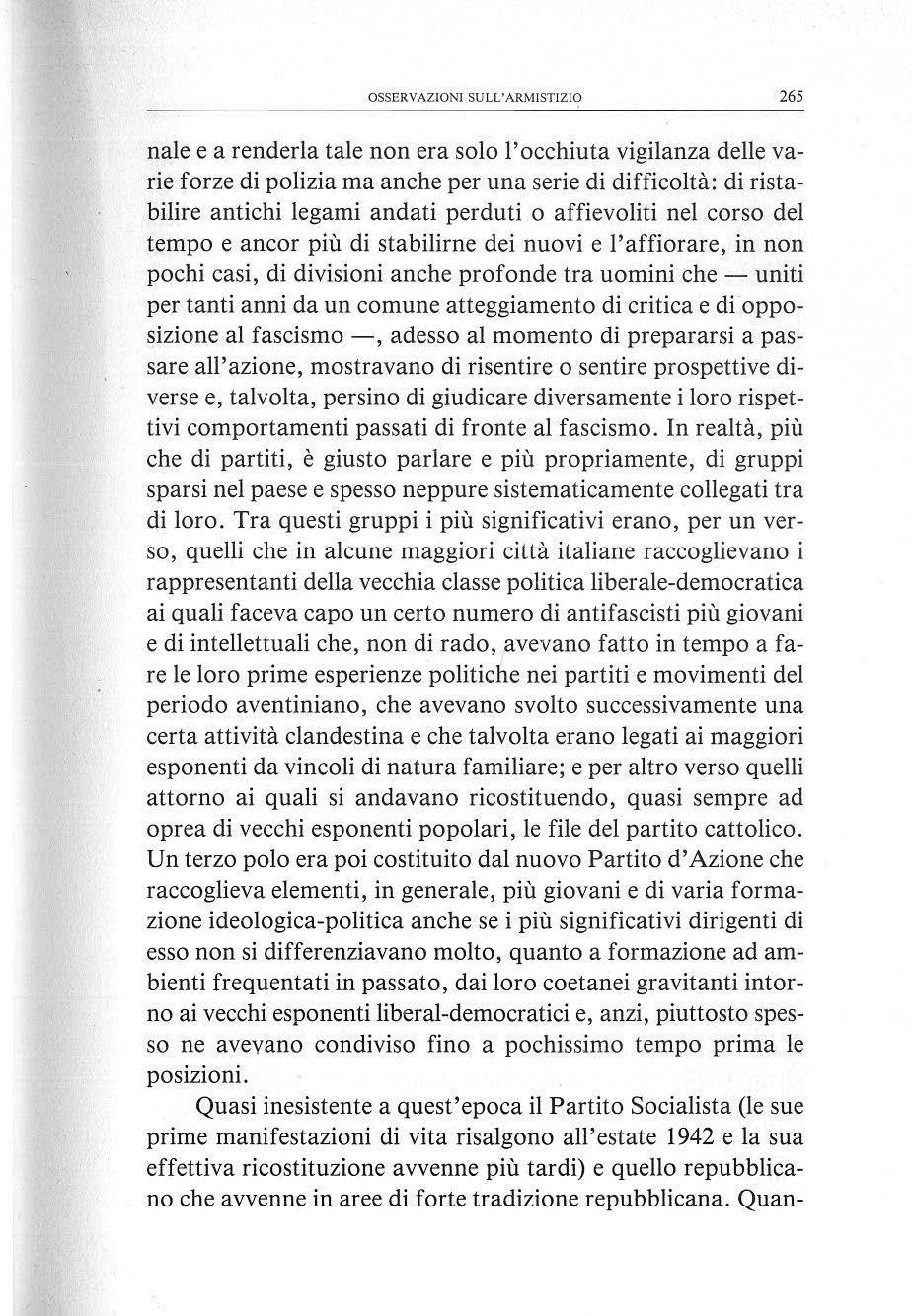
to al PCI - lo ha scritto Amendola - anch'esso aveva un'intelaiatura tutto sommato tenue tant'è che il 1° numero dell' Unità clandestino venne alla luce nel luglio. Ma i legami tra i vecchi compagni non erano stati recisi del tutto nel corso del tempo fascista. L'anno del processo ricostitutivo o lo stabilirsi e l'intensificarsi dei contatti stavano in un rapporto di causa-effetto con il precipitare della situazione militare: non è un caso che essi furono successivi alla vicende negative del fronte italotedesco in Africa settentrionale e anche ad alcuni eventi di politica internazionale. Mario Vinciguerra aveva colto bene, osservando come nel Mezzogiorno, nonostante tutto, una certa agitazione politica era stata mantenuta viva e che «l'ambiente nel suo complesso, era predisposto ad una resurrezione di superstiti persuasi ·che, passata la bufera, si sarebbe potuto riaprire al pubblico il vecchio albergo co n alcuni adattamenti imposti dalle circostanze» («Un'altra guerra continua» in Mercurio, A.II 0 , n. 9 , maggio 1945).
Tutte le forze politiche erano convinte che fosse urgente e possibile allontanare Mussolini dal potere e far uscire l'Italia dal conflitto. Ma l'accordo praticamente finiva qui: sui mezzi, le alleanze e gli obiettivi più particolari e soprattutto sull'atteggiamento da tenere verso i fascisti moderati e, cosa ancora più importante, verso Vittorio Emanuele III e lo stesso istituto monarchico, le posizioni erano diverse e le divisioni non erano solo tra le varie componenti dell'antifascismo ma vivevano anche all'interno di alcune di esse: di sicuro all'interno dei liberaldemocratici e, almeno, in un primo momento, degli stessi comunisti.
In quella situazione, era venuto al centro delle meditazioni dei rappresentanti delle forze politiche, (e già lo era stato negli anni dell'esilio e "della clandestinità" in patria) il problema delle strutture sulle quali si sarebbe dovuta ricostruire la «nuova» Italia. In quei momenti, convulsi e tragici, appariva abbastanza ipotizzabile la nuova organizzazione statuale come un vero e proprio «stato dei partiti» (e i fatti successivi si incari-
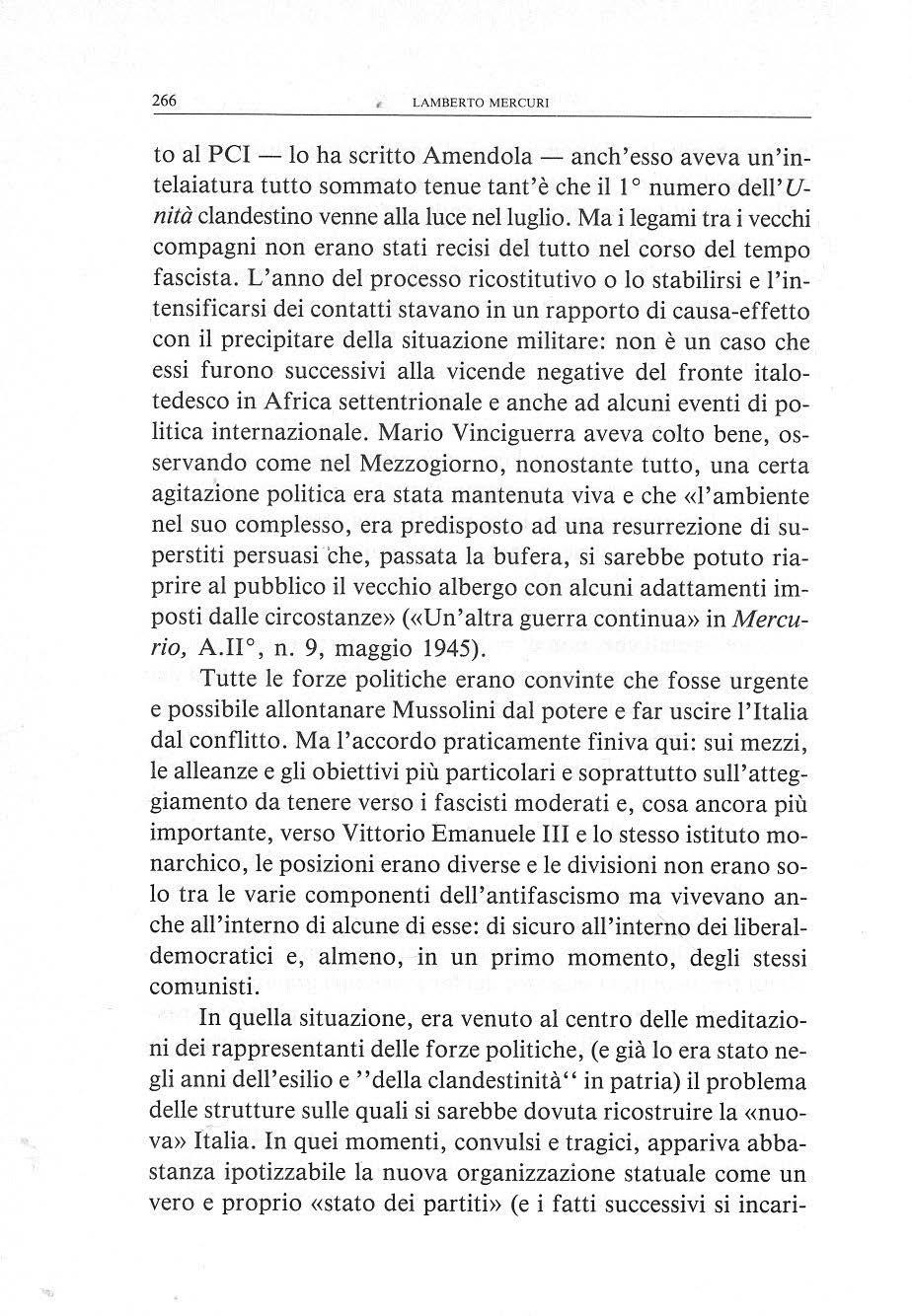
cheranno di dimostrare la fondatezza del fenomeno); quei gruppi (incunaboli dei futuri Comitati di Liberazione Nazionale) avevano chiesto al re un risoluto antinazista, ma il monarca fu contrario ad un cambiamento repentino della situazione; anzi era contrario a contatti con chi era fautore di ogni cambiamento, anche con gli esponenti del prefascismo che egli chiamava «revenants». In realtà, il comportamento delle autorità ufficiali italiane non fu certo specchio di una politica lineare ma piuttosto rivelatrice di una determinata militaresca mentalità: rovesciare l 'alleanza e combattere accanto all'ex nemico per non perdere di vista il salvataggio delle istitutzioni dinastiche e con esse il resto.
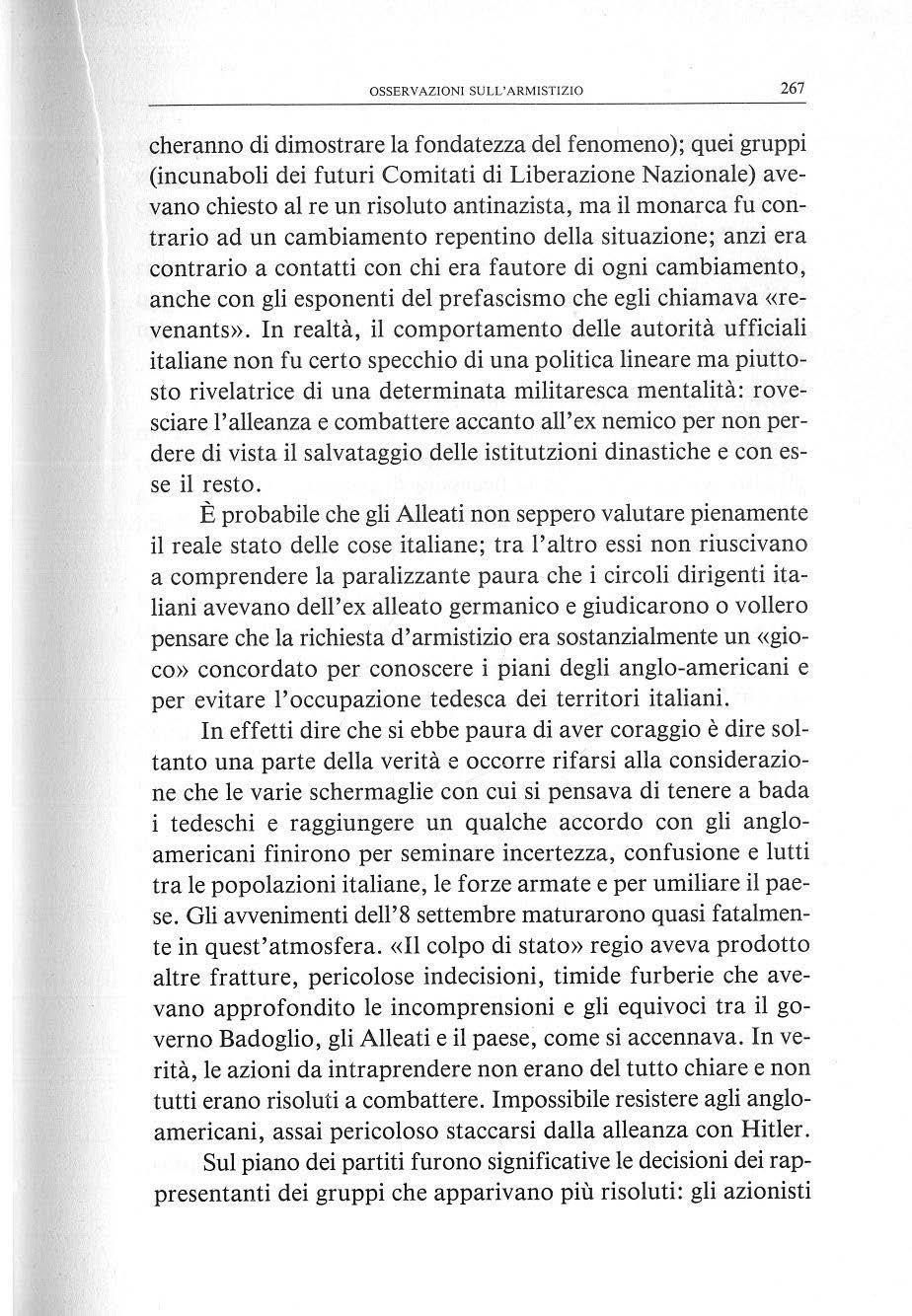
È probabile che gli Alleati non seppero valutare pienamente il reale stato delle cose italiane; tra l'altro essi non riuscivano a comprendere la paralizzante paura che i circoli dirigenti italiani avevano dell'ex alleato germanico e giudicarono o vollero pensare che la richiesta d'armistizio era sostanzialmente un «gioco» concordato per conoscere i piani degli anglo-americani e per evitare l'occupazione tedesca dei territori italiani.
In effetti dire che si ebbe paura di aver coraggio è dire soltanto una parte della verità e occorre rifarsi alla considerazione che le varie schermaglie con cui si pensava di tenere a bada i tedeschi e raggiungere un qualche accordo con gli angloamericani finirono per seminare incertezza, confusione e lu tti tra le popolazioni italiane, le forze armate e per umiliare il paese. Gli avvenimenti dell'8 settembre maturarono quasi fatalmente in quest'atmosfera. «Il colpo di stato» regio aveva prodotto altre fratture, pericolose indecisioni, timide furberie che avevano approfondito le incomprensioni e gli equivoci tra il governo Badoglio, gli Alleati e il paese, come si accennava. In verità, le azioni da intraprendere non erano del tutto chiare e non tutti erano risoluti a combattere. Impossibile resistere agli angloamericani, assai pericoloso staccarsi dalla alleanza con Hitler. Sul piano dei partiti furono significative le decisioni dei rappresentanti dei gruppi che apparivano più risoluti: gli azionisti
a Firenze (5-6 settembre) mentre i comunisti ri uni ti a Ro~a nei giorni 29 e 30 agosto 1943 avevano già costituito la loro direzione . La prima riunione di cui discorriamo fu rivelatrice di un «modello di maturazione politica e di tenuta morale di fare di quello scelto manipolo di intellettuali una delle forze conduttrici della Resistenza , sin quando avrebbe potuto resistere agli interni impulsi di divaricazione» (sono parole di Ferruccio Parri), e l'altra egualmente risoluta nel rivendicare il potere decisionale alle forze popolari e nel porre la necessità della lotta. Al di là di queste due storie parallele, si fa strada più in generale la scelta della guerra ai tedeschi. Naturale che anche gli altri partiti sentissero la necessità di combattere i tedeschi e l'appendice fascista che si andava riorganizzando in quei momenti grazie alle armi germaniche. Ma non furono soltanto i gruppi politici che sentirono la necessità della lotta: vi furono anche i militari, soprattutto nei gradi inferiori che presero la via dei monti e non gettarono le armi. Ma nel quadro del momento non è da sottovalutare un certo stato d'animo, piuttosto diffuso d'accettazione rassegnata degli eventi, che era nell'animo di una parte dei militari, e di non pochi cittadini, una sor ta di scelta del quieto vivere o anche della «neutralità» tra due invasori, tedesco e anglo-americano, che albergava in una non trascurabile parte delle popolazioni italiane.
A questo clima di attendismo o di neutralità a loro volta si piegarono anche alcuni esponenti dei partiti antifascisti convinti che era meglio non essere coinvolti in una vicenda da essi non sentita o avversata per non assumere responsabilità o pesanti eredità.
A parte quanto si è già osservato, in quei giorni non mancarono tuttavia i segni tangibili della rinata presenza dei gruppi politici. Anche per il gusto con il quale, attraverso comizi, improvvisati cortei e altre manifestazioni di giubilo, gli italiani assaporarono i frutti della libertà che avevano perduto vent'anni prima. Non furono numerosi, in realtà, coloro i quali valutarono correttamente che la caduta del fascismo si accompagna-
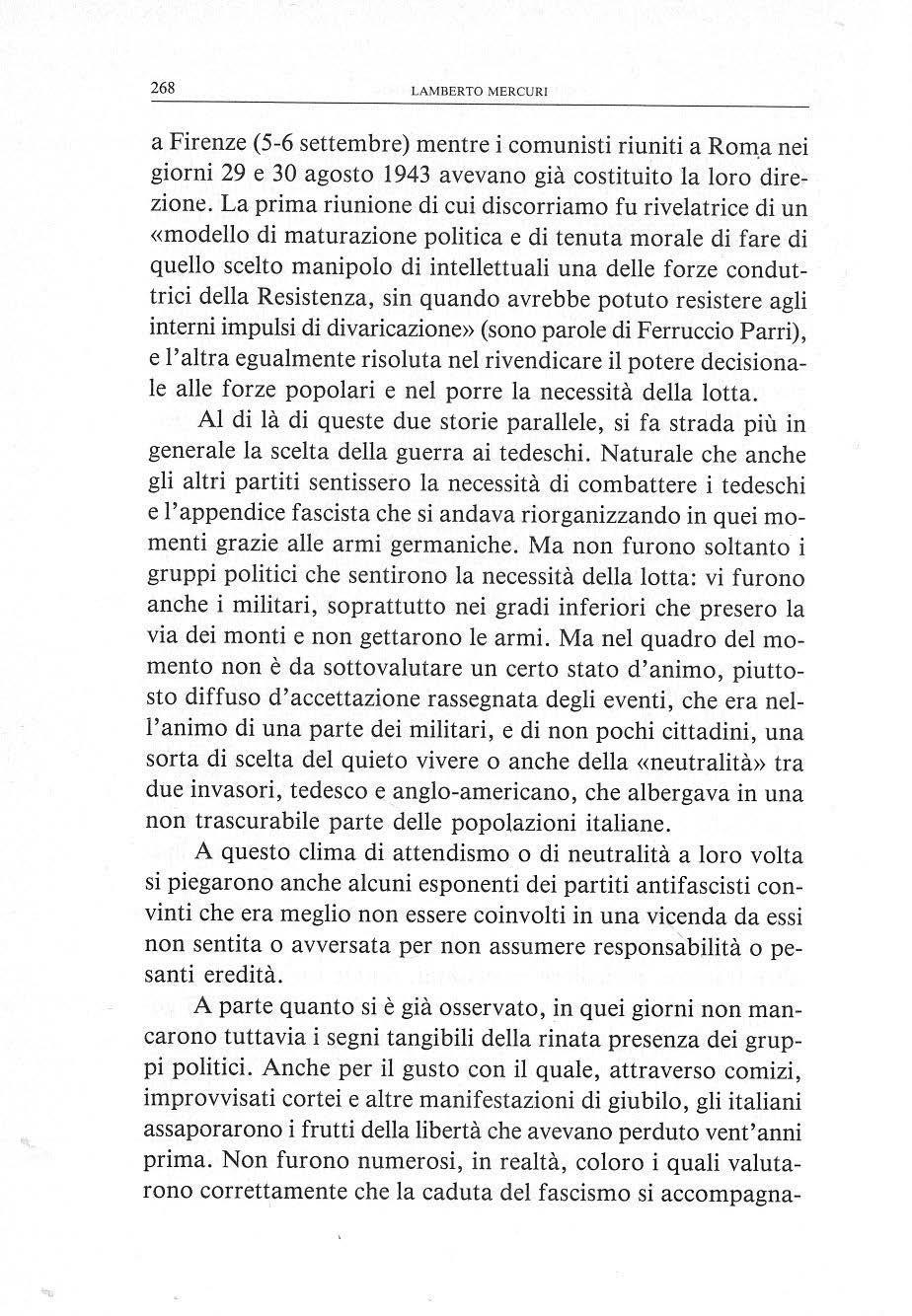
va al proclama del Maresciallo Badoglio «la guerra continua» e quali conseguenze tale comunicato avrebbe di lì a poco com portato.
A Roma, in Via Adda, il 9 settembre si riunirono alcuni rappresentanti dei partiti politici per dar vita, sull ' esempio di quanto già era avvenuto in Francia sotto l'occupazione germanica, al Comitato di Liberazione Nazionale.
Ecco il testo della decisione:
«Nel momento in cui il nazismo tenta di restaurare in Roma e in Italia il suo alleato fascista, i partiti antifascisti si costituiscono in Comitato di Liberazione Nazionale per chiamare gli italiani alla lotta e alla Resistenza, per riconquistare all'Italia il posto che le compete nel consesso delle Libere Nazioni».
L'indomani con l'aggravarsi della situazione militare della Capitale, il Comitato redige un appello alla resistenza armata del popolo, appello che sarà diffuso con tutti i mezzi possibili e in un generale stato di disfacimento. In un momento tragico e decisivo, la volontà unitaria di coloro i quali si dicevano rappresentanti delle diverse forze politiche organizzate puntava sulla guerra liberatrice contro la Germania nazista e contro l'appendice fascista salodina. I sei movimenti d'azione politica del CLN (la DC, il PC, il Pd' A, il PSI d'unità proletaria, la Democrazia del Lavoro e il PLI) seppero esprimers i allora e successivamente con abbastanza chiarezza sul futuro assetto democratico del paese con i seguenti obiettivi:
- riscattare l'Italia, combattendo, dallo stato di soggezione, come paese ex nemico dovuto alla resa incondizionata agli Alleati, dalla monarchia complice del regime fascista e procedere alla ricostruzione e al rinnovamento delle istituzioni e della società secondo principi e direttive di libertà e di giustizia che verranno poi sanciti nella Carta Costituzionale nel 1948.
Qui va fatta una ultima considerazione, sia pure di passata. Non ci sentiamo nè possiamo riprendere, qui per ragioni di tempo quanto è stato ripetutamente osservato e lamentato sul-
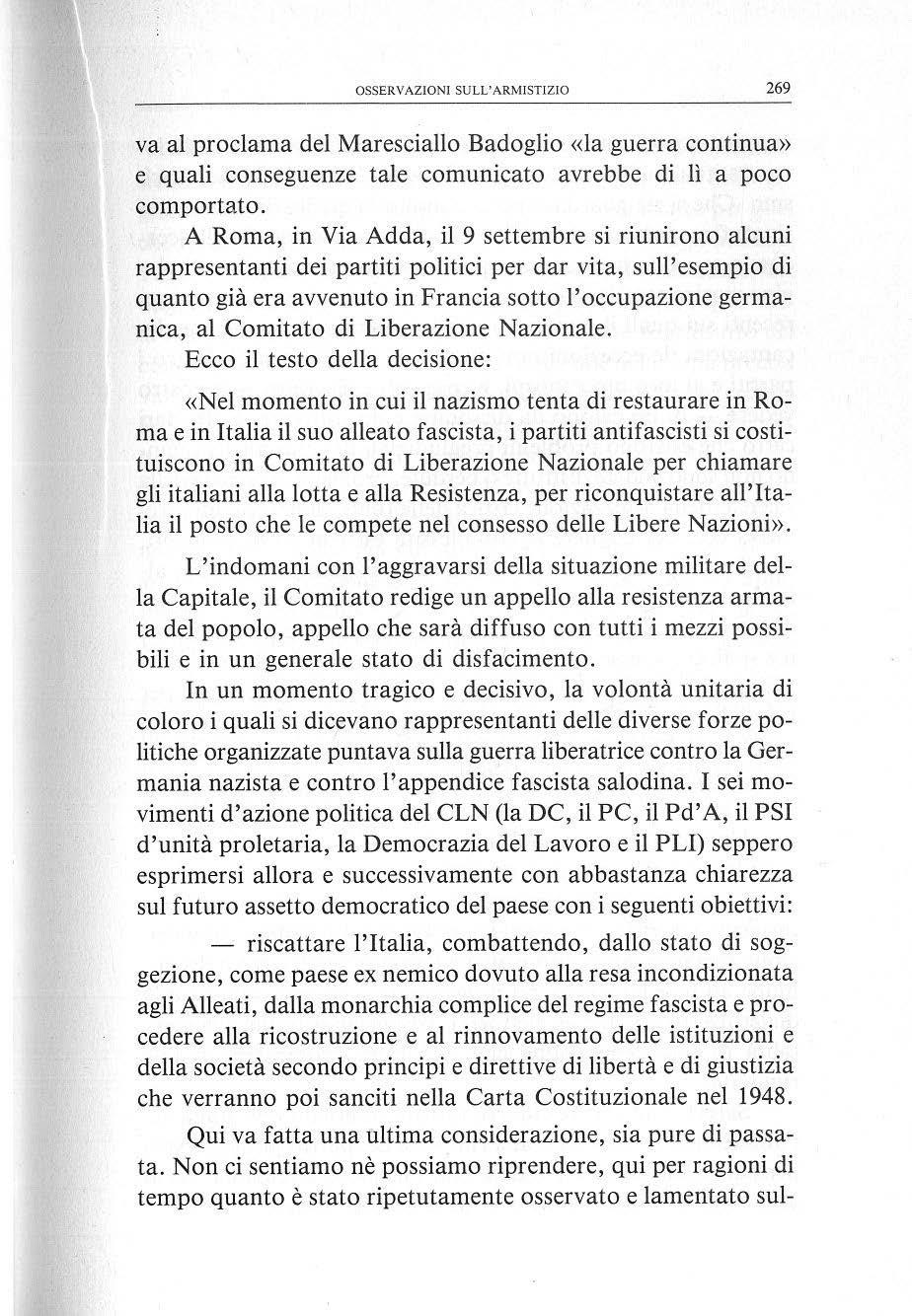
la mancan za di una storia organica dei partiti politici dalla loro costituzione o ricostituzione dopo il lungo tun ne l del fascism o. Che si sia guard ato poco o molto in quella direzione storiografica, forse anche per una tradizione d'ossequio all'accademia secon do la quale non possono diventar oggetto d'indagine storica temi appartenenti a periodi vicini o relativamente recenti sui quali il tempo non abbia operato le opportune decantazioni (le eccezioni non mancano, naturalmente) de ntro i parti ti e ai loro meccanismi, è cosa certa . Si tratta -a nostro vedere - di un campo da dissodare e da coltivare. È del pari certo che esistono problemi pregiudiziali di fonti anche quando non sono andate distrutte o perdute, problemi di tecnica della ricerca, della utilizzazione critica delle font i, di natura interpretativa ecc. per cogliere le complessità estreme degli elementi.
E così per quanto riguarda il tasso pagato per così dire alle ideologie nella interpretazione della storia italiana del secondo dopoguerra e dalla ricostituzione delle vicende dei partiti come si diceva spesso si è lasciato il compito ai politologi o ai sociologi (o come qualcuno osservava anche ai «tutto logi») per i quali l'esame dell'argomento è sembrato quasi sempre una cosa non ben definita che sta tra la atemporale e lo schemati co, o poco attenta al vaglio del dubbio metodico o peggio ancora condizionato da indirizzi provenienti da gerarchie partitiche.
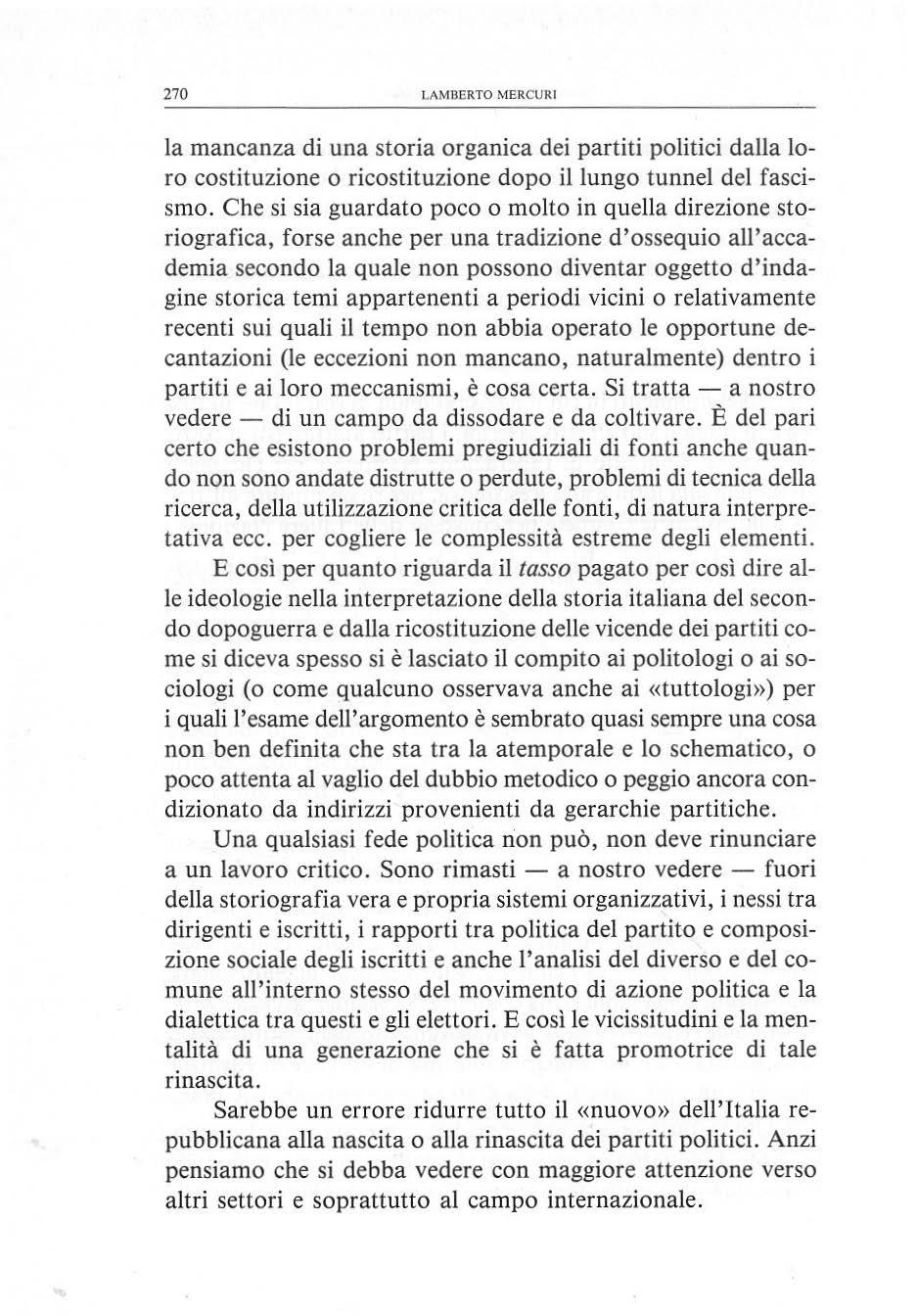
Una qual siasi fede politica rion può, non deve rinunciare a un lavoro cri tico. Son o rimasti -a nostro vedere - fuori della storiografia vera e propria sistemi organi zzat ivi, i nessi tra dirigenti e iscritti, i rapporti tra politica del partito e composizione sociale degli iscritti e anche l'analisi del diverso e del comune all'interno stesso del movimento di azione politica e la dialettica tra questi e gli elettor i. E cos ì le vicissitudini e la mentalità di una generazione che si è fatta promotrice di tale rinascita.
Sarebbe un errore ridurre tutto il «nuovo» dell'Italia repubblicana alla nascita o alla rinascita dei partiti politici. Anzi pensiamo che si debba vedere con maggiore attenzione verso altri settori e soprattutto al campo internazionale.
Ma non poco del cambiamento dell'Italia e della sua ascensione sociale lo si deve ai partiti politici, sia sul piano della ragione sia sul piano del pluralismo politico e soprattutto per quel che riguarda gli anni che vanno dal finire del 1943 agli inizi del 1950. È una storia che s'intreccia anche con il vecchiume, indugi e falsi schemi rivoluzionari, mitologie, chiasso, fughe dalla realtà, non sempre avvertite. Anche - forse soprattutto nel corso della Resistenza - il discorso potrebbe avere una precisa valenza. Comunque la si voglia vedere, la vicenda resis t enziale è anche storia di partiti e dei movimenti politici. In questa cornice, fatte le necessarie distinzioni storiche, ci potrebbe soccorrere il fatto che già nel corso della lotta si parlò e si tenne conto degli ideali, dei miti, delle passioni, della tradizione che sono anche criteri storici per cui non sarà facile negare che non vi siano state lacerazioni nella storia d'Italia: un salto tra Stato liberale e il fascismo e un altro tra fascismo e post-fascismo. Un mezzo, uno strumento di liberazione dal più recente passato. Quel che è avvenuto allora e negli anni successivi, cioè sui risultati positivi e negativi oppure sui ritardi st orici anche dei partiti italiani rispetto alla realtà politica e sociale (e a quella internazionale) è un altro discorso e tutto da discutere che esu~ la completamente dal compito che mi è stato qui affidato.
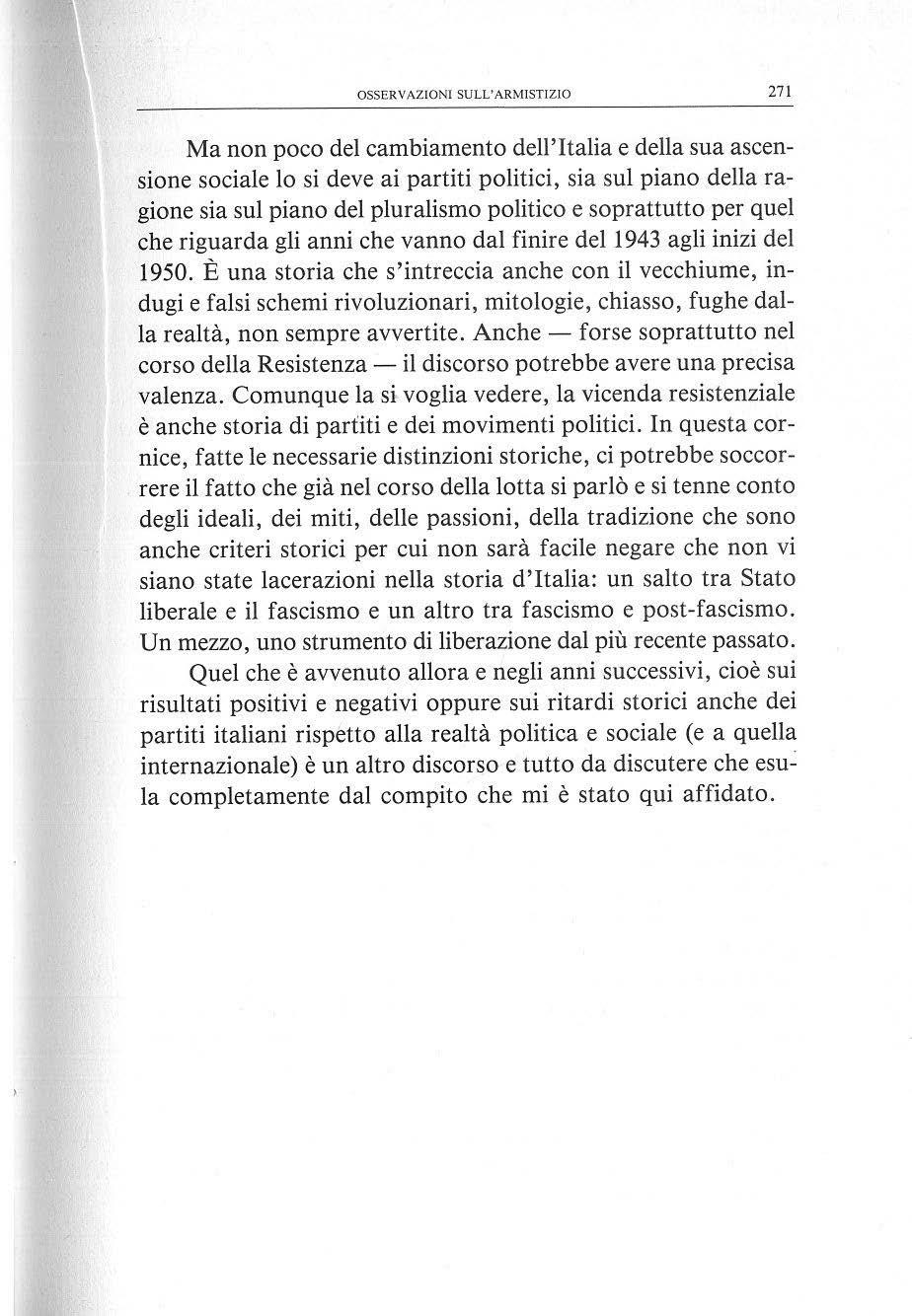
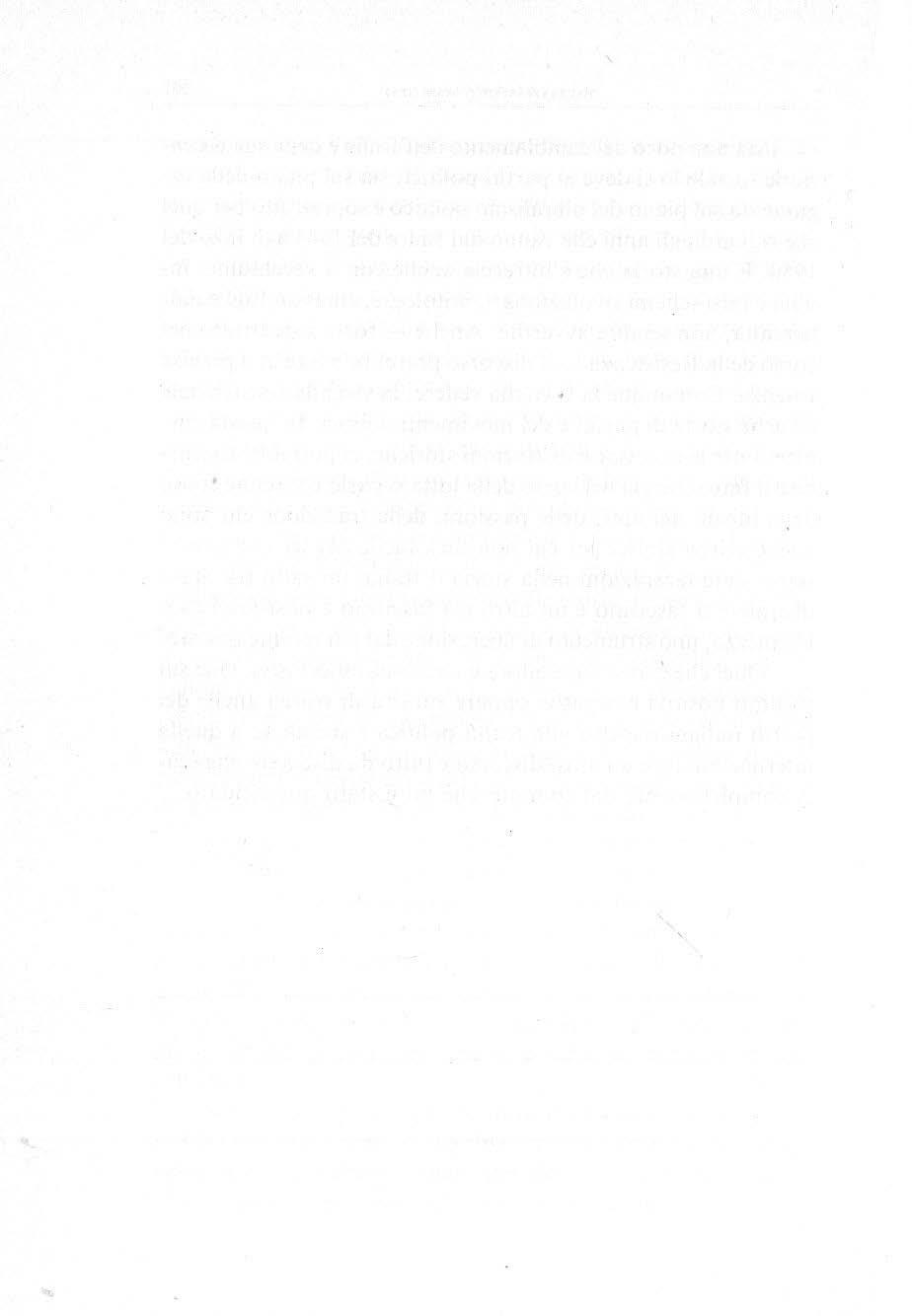
La politica americana del periodo di guerra nei confronti dell'Italia era condizionata da tre elementi chiave: i rapporti USA con la Gran Bretagna, con l'Unione Sovietica e la politica interna americana. I saggi di Di Nolfo e Ellwood hanno disegnato un buon quadro della politica di potere durante i negoziati per un armistizio italiano. Questo saggio esaminerà l'impatto delle considerazioni interne sulla politica di Franklin Delano Roosevelt, soprattutto per quanto riguarda la decisione del governo USA di chiedere la forma se non il fatto reale di una resa incondizionata prima con il governo inglese e poi con quello italiano.
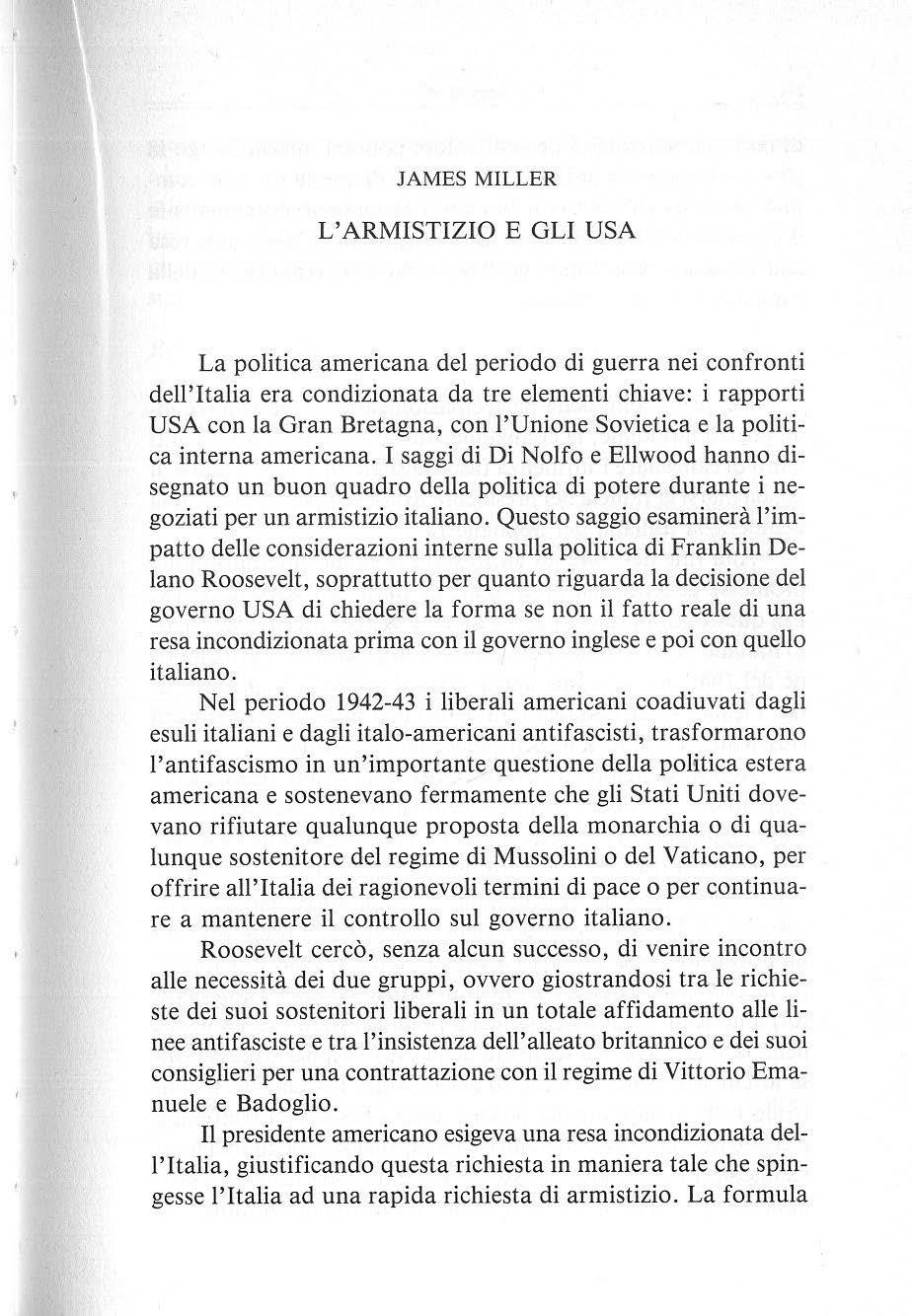
Nel periodo 1942-43 i liberali americani coadiuvati dagli esuli italiani e dagli italo-americani antifascisti, trasformarono l'antifascismo in un'importante questione della politica estera americana e sostenevano fermamente che gli Stati Uniti dovevano rifiutare qualunque proposta della monarchia o di qualunque sostenitore del regime di Mussolini o del Vaticano, per offrire all'Italia dei ragionevoli termini di pace o per continuare a mantenere il controllo sul governo italiano.
Roosevelt cercò, senza alcun successo, di venire incontro alle necessità dei due gruppi, ovvero giostrandosi tra le richieste dei suoi sostenitori liberali in un totale affidamento alle linee antifasciste e tra l'insistenza dell'alleato britannico e dei suoi consiglieri per una contrattazione con il regime di Vittorio Emanuele e Badoglio.
Il presidente americano esigeva una resa incondizionata del1'ltalia, giustificando questa richiesta in maniera tale che spingesse l'Italia ad una rapida richiesta di armistizio. La formula
di resa incondizionata p erse il valo re p olitico interno lun go la strada e l'in sistenza di Rooseve lt sull ' u so di questa formula complicò l e relazioni USA con gli inglesi e sc oraggiò notevolmente il go verno del re ne lla richi esta di armistizio. L'eventuale resa dell'Italia arrivava troppo tardi per ev itare la preparazione della campagna militar e italiana.
Nei primi anni della partecipazione americana alla seco nda guerra mondiale, la coalizione ant ifascista negli Stati U niti tentò di cancellare l'in flu en za fascista s ugli italo-americani e di guadagnar si la fidu cia del pr es idente Roosevelt per costrui re una democrazia italiana del do pog uerra.
Alla fine del 1942 gli antifascist i avev ano ottenuto molte promesse generali ma importanti da parte del governo USA. F ra queste garanzie era pre vista anch e la libera sce lta del popolo italiano della forma di governo del dop oguerra. P er ò a ll a fine del 1942 la coalizione antifascista si scio lse e i « prominenti», i lead er fasci sti anteguerra della comunità italo-ame r icana r iu sc irono a stabilire il loro precedente con trollo.
Allo stesso tempo il gov erno americano rifiutò decisa mente il piano d ei fuoriu sciti di stabilire un governo i ta liano in esilio e di rag giungere un accordo co n l'amministrazione di Vichy nel Nord Africa france se - il cosidetto Darlan D ea l - andando contro le pubblich e assicurazioni di una forte azione antifascista. Nella primavera d el 1943 il futuro de ll ' Italia diventò un probl em a pressante per i leader americani. Allo ste sso te mpo la guerra ideolo gica tra i liberali del New Deal e i conse rvatori am ericani sugli obiettivi della politica estera USA entrava nell a fase decisiva. La sconfitta della sini st ra americana p erm ise al Dipar t imento di Stato di riacquistare lent a mente il controllo sullo svi lupp o della politica estera USA. Nel fra t tempo il crollo dell'a ntifa sc ismo americano aprì la strada ad una nuova alleanza fra i leader dei lavo rator i ital o-americani e i «prominenti » per combattere il comunismo in Italia. Durante i 55
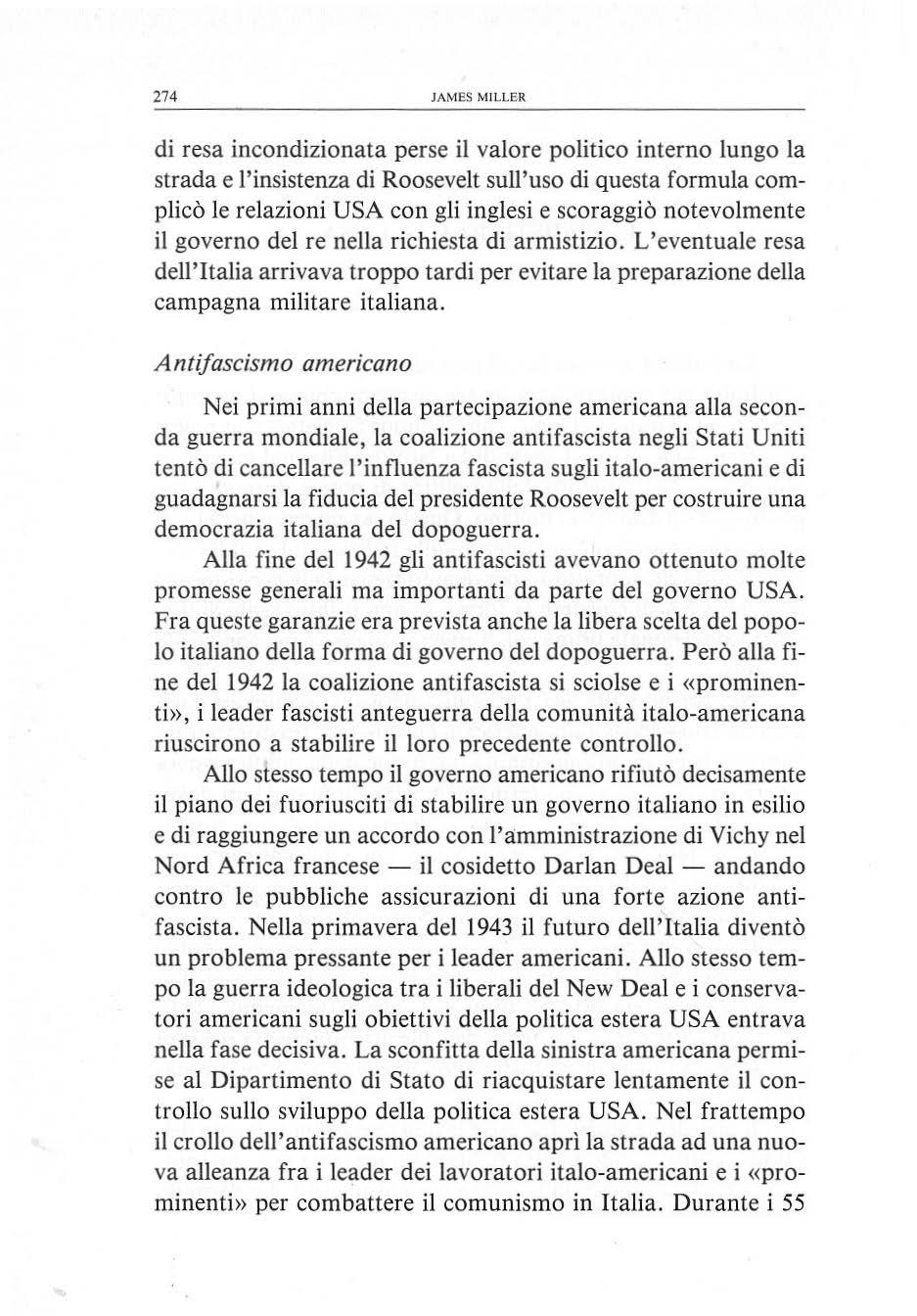
giorni che seguirono lo sbarco in Sicilia degli Alleati (10 luglio) e la resa italiana, la politica americana in Italia era pesantemente influenzata da quattro forti gruppi conservatori - il governo inglese, il Vaticano, la leadership militare alleata e il Dipartimento di Stato - senza una reale contropressione da parte della sinistra.
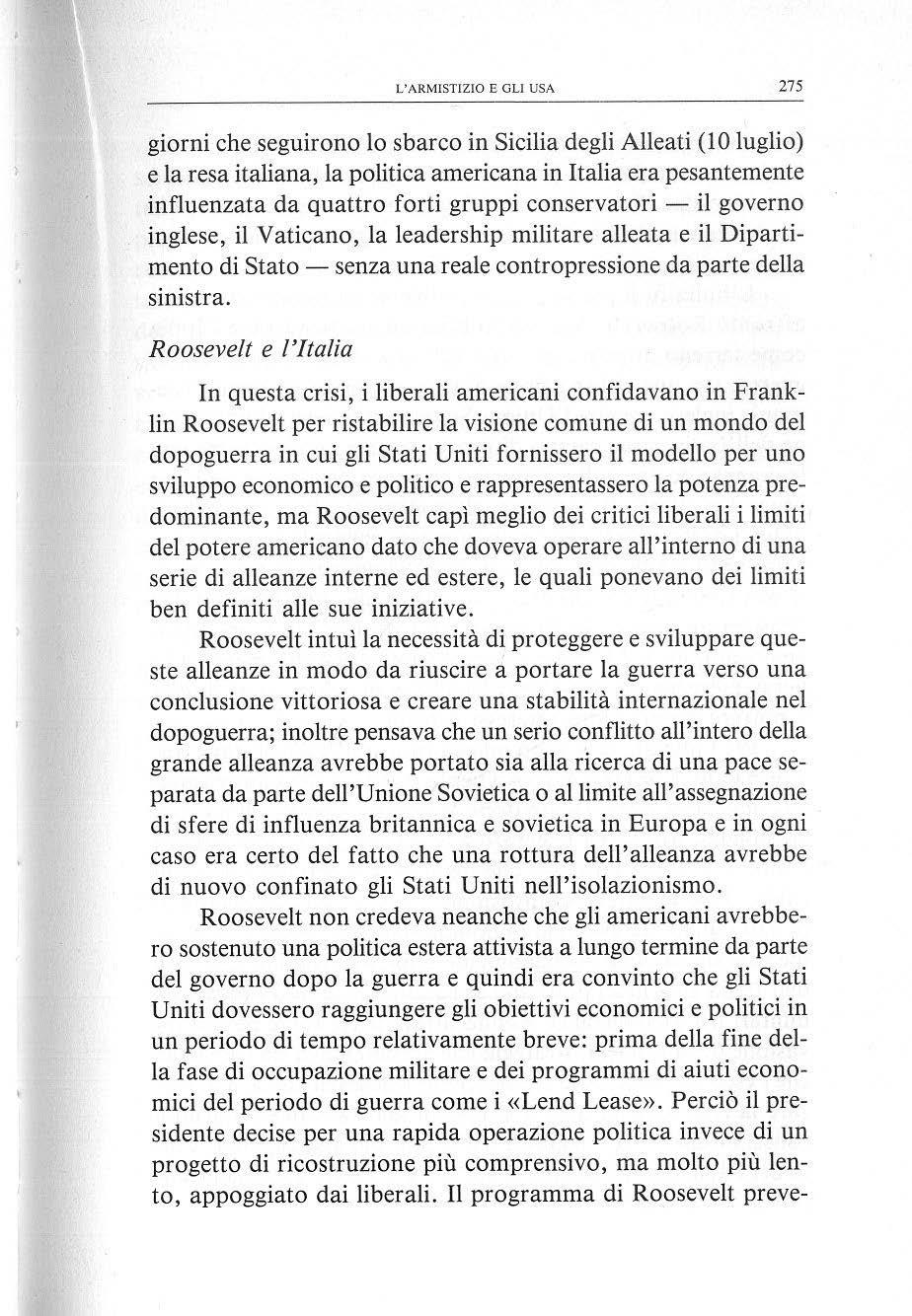
In questa crisi, i liberali americani confidavano in Franklin Roosevelt per ristabilire la visione comune di un mondo del dopoguerra in cui gli Stati Uniti fornissero il modello per uno sviluppo economico e politico e rappresentassero la potenza predominante, ma Roosevelt capì meglio dei critici liberali i limiti del potere americano dato che doveva operare all'int erno di una serie di alleanze interne ed estere, le quali ponevano dei limiti ben definiti alle sue iniziative.
Roosevelt intuì la necessità di proteggere e sviluppare queste alleanze in modo da riuscire a portare la guerra verso una conclusione vittoriosa e creare una stabilità internazionale nel dopoguerra; inoltre pensava che un serio conflitto all'intero della grande alleanza avrebbe portato sia alla ricerca di una pace separata da parte dell'Unione Sovietica o al limite all'assegnazione di sfere di influenza britannica e sovietica in Europa e in ogni caso era certo del fatto che una rottura dell'alleanza avrebbe di nuovo confinato gli Stati Uniti nell'isolazionismo.
Roosevelt non credeva neanche che gli americani avrebbero sostenuto una politica estera attivista a lungo termine da parte del governo dopo la guerra e quindi era convinto che gli Stati Uniti dovessero raggiungere gli obiettivi economici e politici in un periodo di tempo relativamente breve: prima della fine della fase di occupazione mi litare e dei programmi di aiuti economici del periodo di guerra come i «Lend Lease». Perciò il presidente decise per una rapida operazione politica invece di un progetto di ricostruzione più comprensivo, ma molto più lento, appoggiato dai liberali. Il programma di Roosevelt preve-
deva la soppressione dei governi fascisti e la punizione dei suoi leader, la creazione di governi democratici, aiuti economici a breve termine. I nuovi governi democratici avrebbero avuto la totale responsabilità di portare avanti il processo di ricostruzione sociale, politica ed economica.
L'Italia fu il primo grosso problema di ricostruzione che affrontò Roosevelt. Il governo britannico considerava l'Italia come terreno di prova per una strategia di guerra e di dopoguerra, per una ricostruzione di tip o conservatore sotto l'egemonia ingl ese, mentre l'Unione Sovietica tendeva ad una visione dell'Italia come campo di prova per una cooperazione con le potenze occidentali e come test di prova per le relazion i con i suoi due alleati. Il Vaticano, altro elementi chiave nei calcoli politici di Roosevelt, aveva un interesse particolare per l ' Italia come centro della religione cattolica ed appoggiava fermamente una restaurazione politica e sociale di tipo conservatore. Da considerare anche che la gerarchia cattolica USA, gli italoamericani, alcune banche e corporazioni e , naturalmente, i liberali esercitavano pressioni affinché ogni azione fosse diretta a portare avanti i loro interessi o piani.
Per i liberali, il gruppo maggioritario, l'Italia si stava trasformand o in terreno di prova per la politica estera americana. Nel novembre 1942, subito dopo le prime avvisaglie di una pace italiana, Roosevelt telegrafò a Stalin che dopo una vittoria lampo nel Nord-Africa - che ognuno si aspettava nei giorni subito dopo la vittoriosa invasione - gli Alleati avrebbero dato agli italiani un assaggio di bombardamento aereo ed il regime fascista sarebbe probabilmente crollato . Dopo la sconfitta dell'Italia gli Alleati potevano abbandonare le loro operazioni militari nel Mediterraneo e concentrare le tre forze per un'invasione della Francia, strategia che accontentava sia i sovietici che l'eser cito USA. Allo stesso tempo Roosevelt cercava di forza re la resa italiana date le pressioni del Vaticano sui gruppi conservatori che appoggiavano il regime per guadagnarsi l'ai uto del Papa, autorizzò i negoziati per accordare a Roma lo status di «Città aperta».
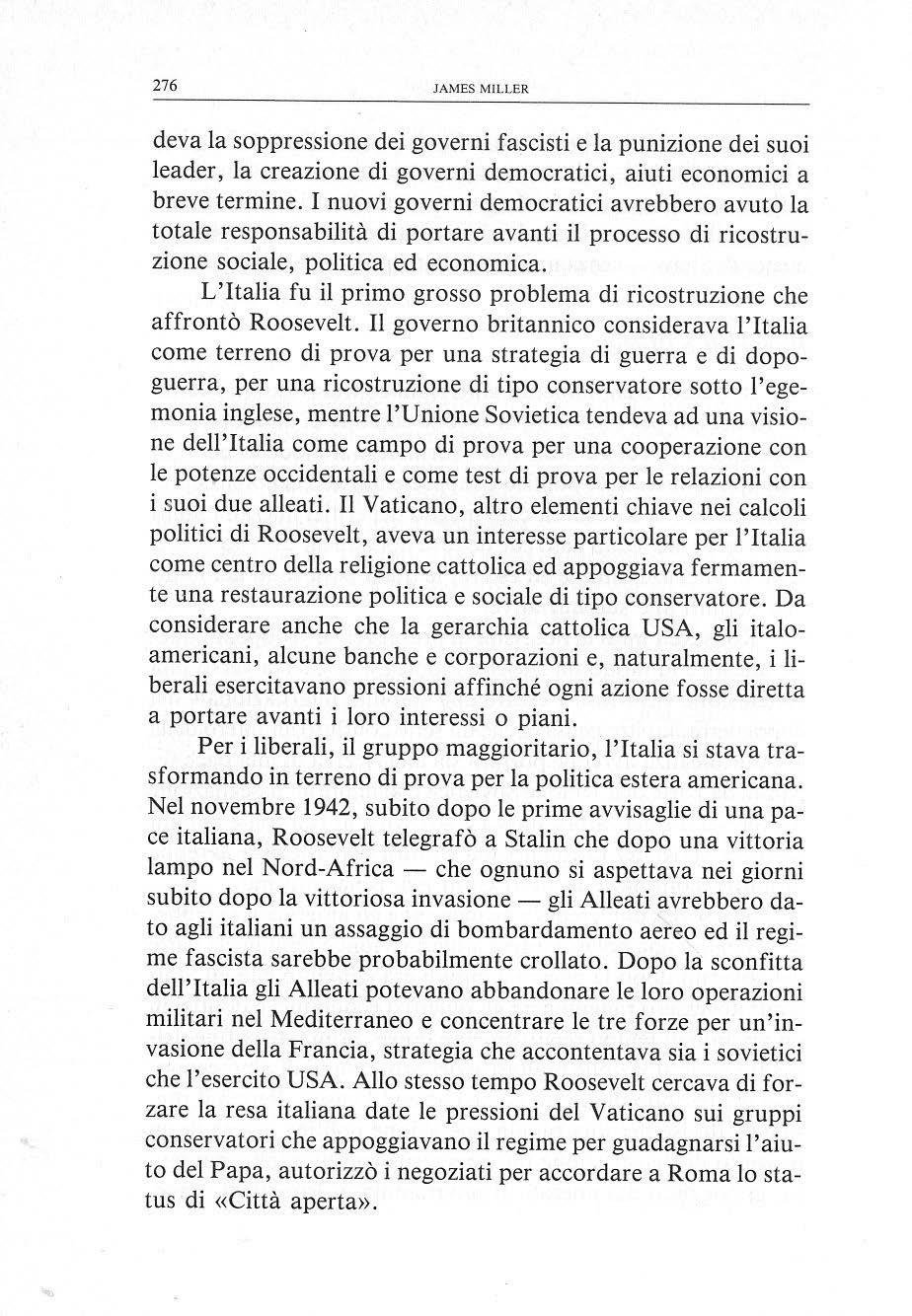
Alla conferenza di Casablanca (14-23 gennaio 1943), Roosevelt scambiò delle concessioni per la strategia militare con altre politiche degli inglesi, le quali avrebbero dato un indirizzo più liberale alla politica americana ed alleata e si trovò d'accordo con la richiesta inglese di continuare le operazioni militari nel Mediterraneo, il cui obiettivo era di forzare la caduta dell'Italia con un'invasione della Sicilia o della Sardegna. Il presidente abbandonò i piani militari USA per un assalto attraverso la Manica alla Francia in cambio di un accordo angloamericano sulla politica italiana. Churchill, da parte sua, concordò di non bombardare Roma senza il benestare americano ed anche sulla richiesta di resa incondizionata degli stati dell'«Asse». L'insistenza di Roosevelt su questa formula era, in buona parte, una risposta alla reazione interna al «Darlan Deal» e uno sforzo per ristabilire i legami del presidente con l'ala sinistra della coalizione politica. Comunque, come gesto politico, la richiesta di resa incondizionata fu un fallimento; questa politica infatti diede vita ad un vivace dibattito politico sugli effetti militari all'interno degli Stati Uniti. Una maggioranza di liberali americani, grati per l 'accordo Roosevelt-Churchill, chiedevano al presidente azioni antifasciste concrete invece di parole e in modo particolare insistevano sul fatto che una resa incondizionata doveva significare che gli Alleati avrebbero accettato la resa dei fascisti, ma una volta fatta avrebbero rimosso i fascisti o i loro alleati e sostenitori del potere. Nel caso dell'Halia ciò significava che gli Stati Uniti avrebbero evitato ogni contrattazione con il re o con chiunque a lui vicino. I liberali americani sapevano bene che qualunque gruppo avesse preso il potere nel periodo di transizione tra la resa incondizionata e la creazione di un nuovo ordine costituzionale si sarebbe trovato nella posizione di determinare la forma di governo dell'Italia del dopoguerra. Per questo motivo insistevano sul fatto che gli Alleati non potevano trattare sia con i fascisti che con i loro sostenitori dopo la resa, ma dovevano sostituire immediatamente la vecchia classe diri-
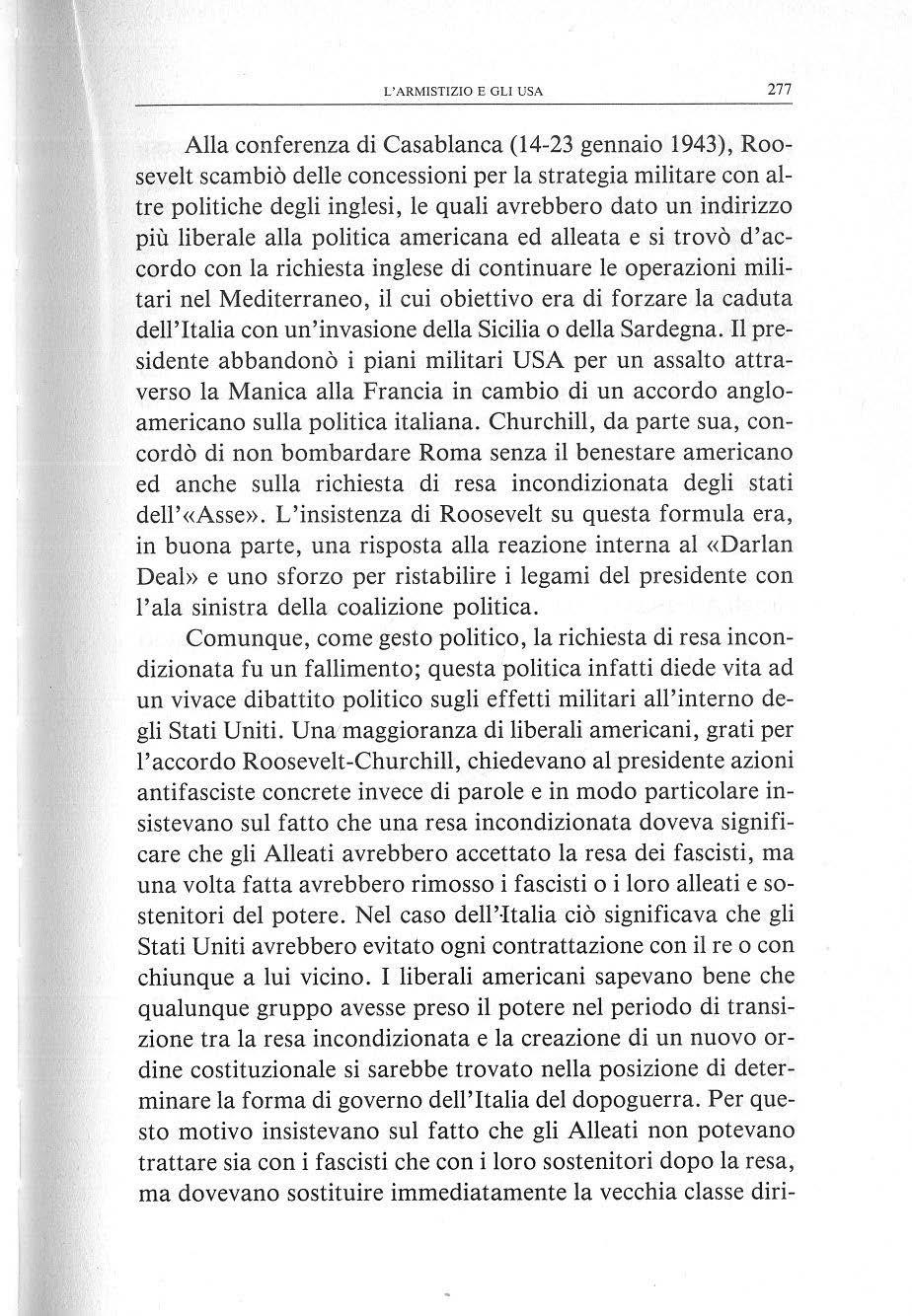
gente con i democratici italiani, fra i quali gli antifascisti in esilio. Tutti gli sforzi di Roosevelt rivolti ad una cooperazione con gli inglesi ed il Vaticano per una pianificazione prima e dopo la guerra, crearono un crescente senso di instabilità tra i liberali che erano convinti del fatto che entrambi mirassero alla creazione di governi reazionari nell'Europa liberata e si ritrovò così nella posizione di dover affrontare le crescenti richieste liberali per una ferma politica antifascista.
Nella primavera del 1943 Churchill arrivò a Washington per la quarta conferenza alleata di guerra e Roosevelt, come sempre, colse l'occasione per migliorare la sua immagine con gli elettori. I piani inglesi prevedevano la divisione della penisola italiana a Roma, secondo i quali ques t a strategia avrebbe obbligato i tedeschi a rinforzare massicciamente il fronte italiano e diminuire le pressioni sul fronte sovietico e insistevano che gli Alleati avrebbero raggiun t o il loro scopo con dispendio di tempo, uomini e materiali molto limitato. I programmatori civili e militari erano scettici: sul piano militare temevano che una campagna in Italia avrebbe seriamente ridotto le truppe e i materiali necessari per l'invasione attraverso la Manica. Sul piano politico, i leader americani sospettavano che l'obiettivo inglese fosse quello di creare un «fascismo senza Mussolini»: un governo debole e screditato di ex fascisti che sarebbe stato sotto il totale controllo della Gran Bretagna. Nonostante questi sospetti, gli inglesi furono in grado di ottenere dagli americani un accordo per continuare le operazioni militari nel Mediterraneo. Roosevelt sottolineò nuovamente il suo' impegno per una totale epurazione dei fascisti e nonostante la pubblica dichiarazione corteggiava Vittorio Emanuele come risposta alle forti pressioni militari inglesi. L'invasione dell'Italia, sarebbe dovuta avvenire con forze militari limitate e i leader militari alleati chiedevano che le forze armate militari venissero neutralizzate con un armistizio prima dello sbarco. Quindi Roosevelt cercò di scavalcare i leader conservatori italiani e allo stesso tempo di mantenere la fiducia dei suoi elettori liberali con la pro-
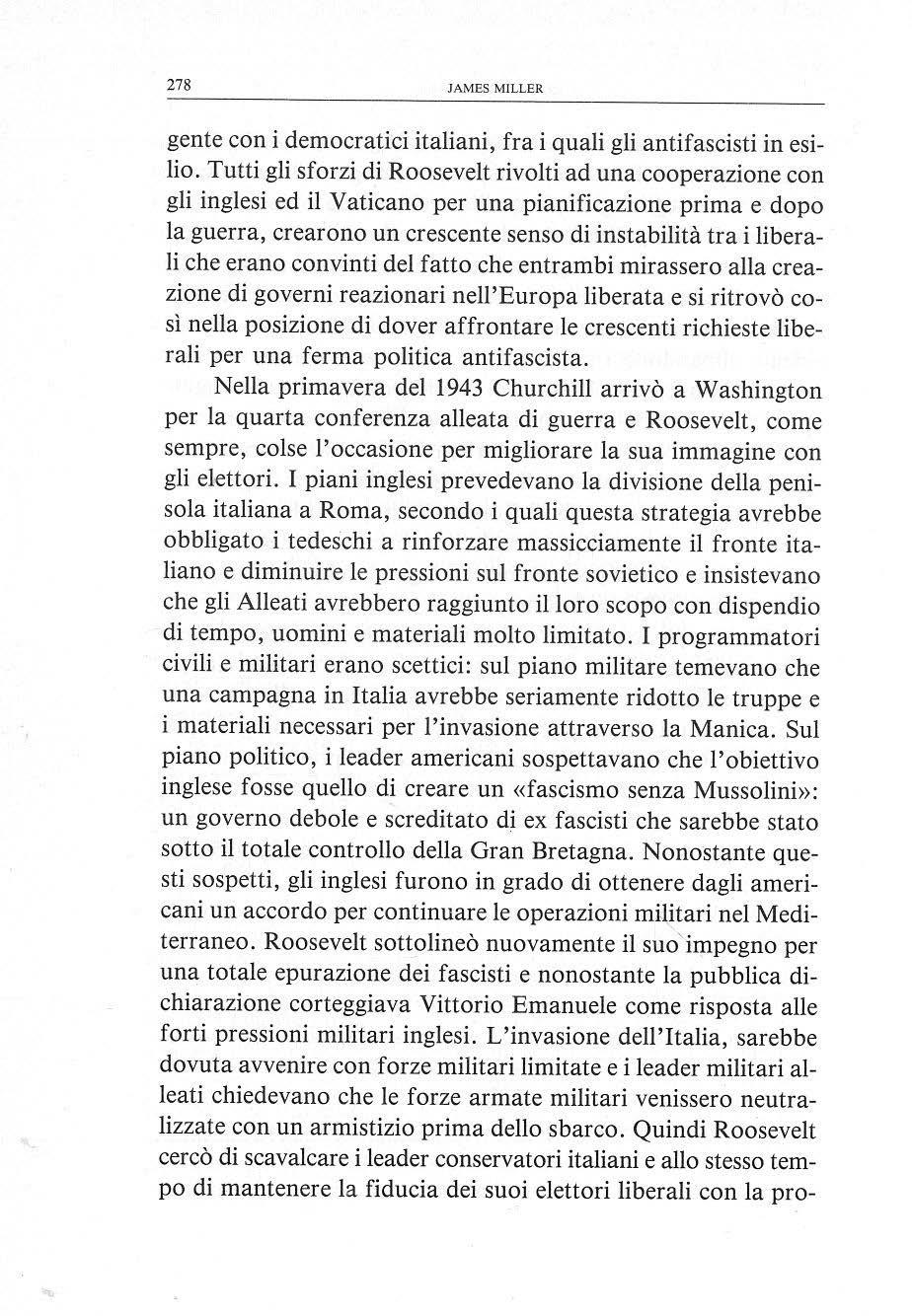
messa dell'epurazione. Quando, ad esempio, gli Alleati si impadronirono dell'isola di Pantelleria nel giugno del 1943, Roosevelt intraprese una strada pericolosa tra questi due obiettivi durante una conferenza stampa. Cominciò stabilendo una netta separazione tra il regime di Mussolini e il popolo italiano, dando la colpa della guerra al duce. Questa tattica era sia un segnale per il re che un'azione verso gli italo-americani. Ma anche i critici liberali intuirono il significato della dura condanna di Roosevelt limitata al regime di Mussolini. Per andare incontro alle loro richieste, Roosevelt affermò nuovamente l'impegno USA per una libera scelta degli italiani per la forma di governo del dopoguerra. In questo messaggio era implicito che gli Alleati non avrebbero mantenuto al potere per molto tempo dopo la resa nè il re nè i conservatori suoi fedeli. Sebbene questo approccio non potesse soddisfare i critici, Roosevelt non poteva delegare agli USA la sorte delle politiche antifasciste, favorite dalla sinistra americana. Il prezzo politico sarebbe stato troppo alto: abbandonare tutte le speranze di un colpo di mano contro Mussolini da parte del re e delle forze conservatrici che lo avevano sostenuto e inoltre la decisione di seguire una politica favorita dai liberali avrebbe sottinteso una rottura nell'alleanza con la Gran Bretagna. Tutto ciò che Roosevelt poteva fare era delegare agli stati anglo-sassoni la punizione dei vecchi fascisti ed anche questo prevedeva dei problemi notevoli con gli inglesi. In privato Roosevelt faceva pressione su Churchill per una completa epurazione dell'amministrazione civile e militare.
Il Dipartimento di Stato chiedeva di sostituire gli ufficiali compromessi con un governo ad amministrazione militare alleata in Italia. Era sicuro del fatto che questa politica avrebbe ridotto il disaccordo liberale e creato uno spazio di respiro durante il quale le forze italiane antifasciste avrebbero potuto riorganizzarsi e prendere il controllo del governo nazionale.
Sia il governo ing lese che parte della burocrazia americana si opposero alla politica di Roosevelt. çhurchill, il cui obiet-
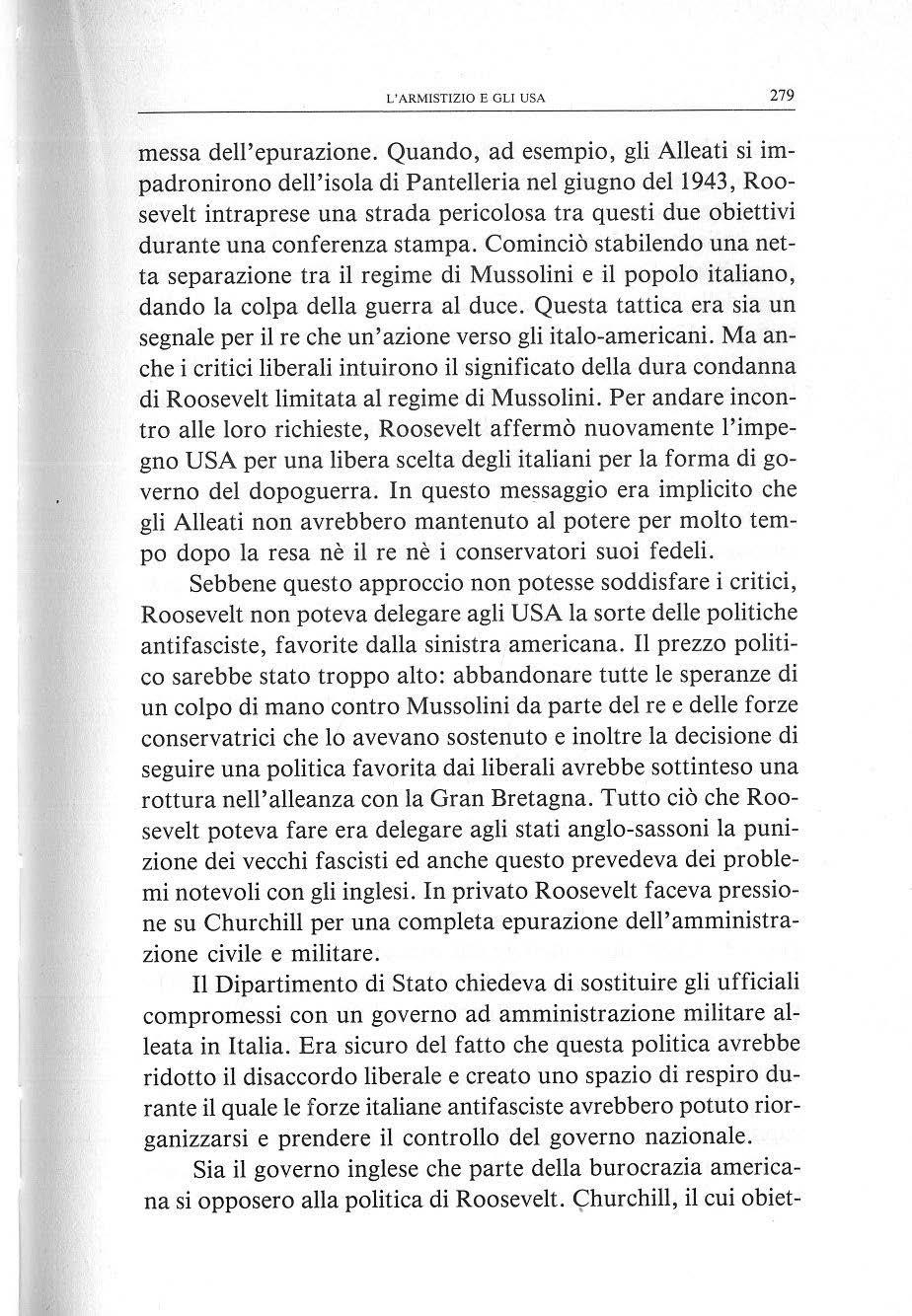
tivo era la creazione di un governo italiano debole sotto il controllo inglese, si oppose a questa epurazione totale sost enendo giustamente che tale operazione sulla burocrazia civile e militare italiana avrebbe sovraccaricato le forze del Governo Militare Alleato. Suggerì, invece, che il generale Eisenhower, come capo delle forze alleate nel Mediterraneo e come uno degli autori del «Darlan Dea!», decidesse il tipo di epurazione da attuare in Italia. Churchil1 era sicuro che Eisenhower avrebbe selezionato una defascistizzazione molto limitata e questa scelta avrebbe incontrato il favore del Dipartimento di Guerra USA.

Un'epurazione limitata avrebbe anche riscontrato approvazione all'interno del dipartimento di Stato, che stav a lentamente riconquistando il ruolo di leader nel concetto e nell'esecuzione della politica estera USA. I funzionari del dipartimento di Stato riconobbero l'importanza di avere un corpo di piani e informazioni per sostenere una politica di guerra coerente. Poco dopo l'inizio della guerra in Europa, i leader del Dipartimento di Stato avevano istituito un Comitato di Pianificazione del dopoguerra, i cui membri prov eniva no dagli strati più alti del Dipartimento di Stato e dei settori più influenti del popolo americano, che creò un corpo di incartamenti di politica e degli st udi di fondo dettagliati che influenzarono gran parte delle decisioni importanti del periodo di guerra americano.
Il Comitato cominciò a studiare la situazione italiana e il futuro dell'Italia durante gli ultimi mesi del 1942 e il 2 gennaio del 1943 il Sottocomitato per la Pianificazione Politica consigliò agli Alleati di permettere alla monarchia di formare il primo governo italiano dopo l'armistizio. I programmatori del Dipartimento di Stato erano d'accordo su l fatto che solo la monarchia aveva la possibilità di rovesciare Mussolini, di guidare l'Italia verso un armistizio con gli Alleati e di formare un governo che funzionasse nei primi giorni di confusione dopo la capitolazione del paese. Il Comitato per la Pianificazione riconobbe anche la probabilità che dopo un armistizio il re avrebbe usato il suo potere per impedire una libera scelta del popolo
italiano per la forma di governo del dopo guerra e per risolvere questo problema il Comitato consigliò agli Alleati di sottoporre il governo italiano alla supervisione e al controllo dei quartieri generali militari alleati e ai generali di «evitare ogni intromissione che potrebbe limitare una libera scelta degli italiani sulla loro futura forma di governo».
Sfortunatamente i programmatori non spiegarono come l' esercito avrebbe dovuto assolvere questi compiti piuttosto contradditori. Nel frattempo, Breckinridge Long, Assistente Segretario di Stato, elaborò insieme a un gruppo di diplomatici conservatori un primo piano per l'occupazione dell'Italia che utilizzava i consigli del Comitato di Pianificazione di escludere da ogni ruolo gli antifascisti in esilio nelle fasi iniziali dell'occupazione e della ricostruzione e allo stesso tempo sfidava la politica di Roosevelt della resa incondizionata. Questa sfida alla sua linea politica, proveniente all'interno del Dipartimento di Stato, fu un oltraggio per Roosevelt, che ordinò il trasferimento di quei diplomatici a lui non fedeli, privando così Long di ogni potere all'interno del Dipartimento di Stato. In seguito Roosevelt recuperò il progetto politico di dare in Ita lia un maggiore tono antifascista. Roosevelt insisteva sulla necessità di un'epurazione e rifiutava l'idea di un trattamento di riguardo per la monarchia; per quanto riguarda il futuro degli esiliati antifascisti, riconobbe il loro diritto a p a rtecipare alla ricostruzione e assicurò che gli Stati Uniti avrebbero sostenuto le loro richieste al momento giusto.
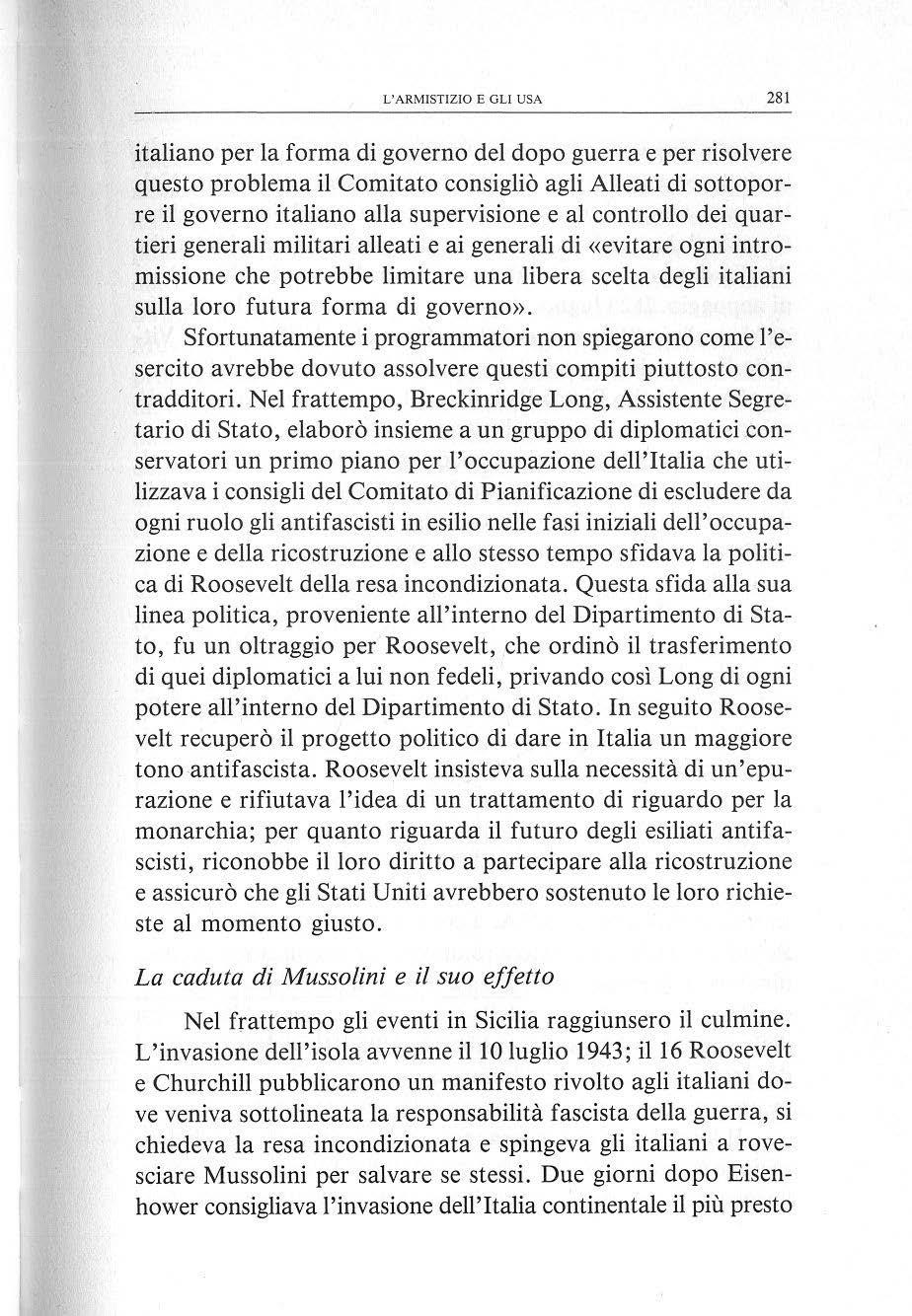
La caduta di Mussolini e il suo effetto
Ne l frattempo gli eventi in Sicilia ragg iunsero il culmine. L'invasione dell'isola avvenne il 10 luglio 1943; il 16 Roosevelt e Churchill pubblicarono un manifes t o rivolto agli italiani dove veniva sottolineata la responsab ili tà fascista della guerra, si chiedeva la resa incondizionata e spingeva gli italiani a rovesciare Musso lin i per sa lvare se stessi. Due giorni dopo Eisenhower consigliava l'invasione dell'Italia continentale il più presto
possibile dopo la caduta della Sicilia e il 19 luglio 500 aerei alleati attaccavano le installazioni militari intorno a Roma. Nello stesso tempo Mussolini si incontrava con Hitler a Feltre. Quando il duce fallì anche nel tentativo di convincere Hitler che l'Italia doveva ritirarsi dalla guerra, crollarono le ultime basi di appoggio. Il 25 luglio, dopo una rivolta contro la leadership di Mussolini all'interno del Gran Consiglio dei Fascismo, Vittorio Emanuele esonerò il duce e affidò il controllo del governo al maresciallo Pietro Badoglio e il nuovo governo cominciò subito a cercare il modo di uscire dalla guerra.
Il crollo di Mussolini provocò forti reazioni negli Stati Uniti, soprattutto tra gli italo-americani e i liberali. Sotto la guida del potente leader sindacalista Luigi Antonini, gli antifascisti moderati it alo-americani e i leader più importanti della comunità italo-americana si unirono per salvare l'Italia dal comun ismo, che è sempre stato considerato il pericolo più grande dalla maggioranza degli italo-americani. La nuova coalizione di Antonini divenne presto la forza di maggior peso nella politica italo-americana e la maggiore influente sulla formazione della politica di guerra americana verso l'Italia, mentre quegli antifascisti che rifiutarono un'alleanza con gli ex fascis t i si ritrovarono presto isolati con ben poca influenza sulla politica estera americana.
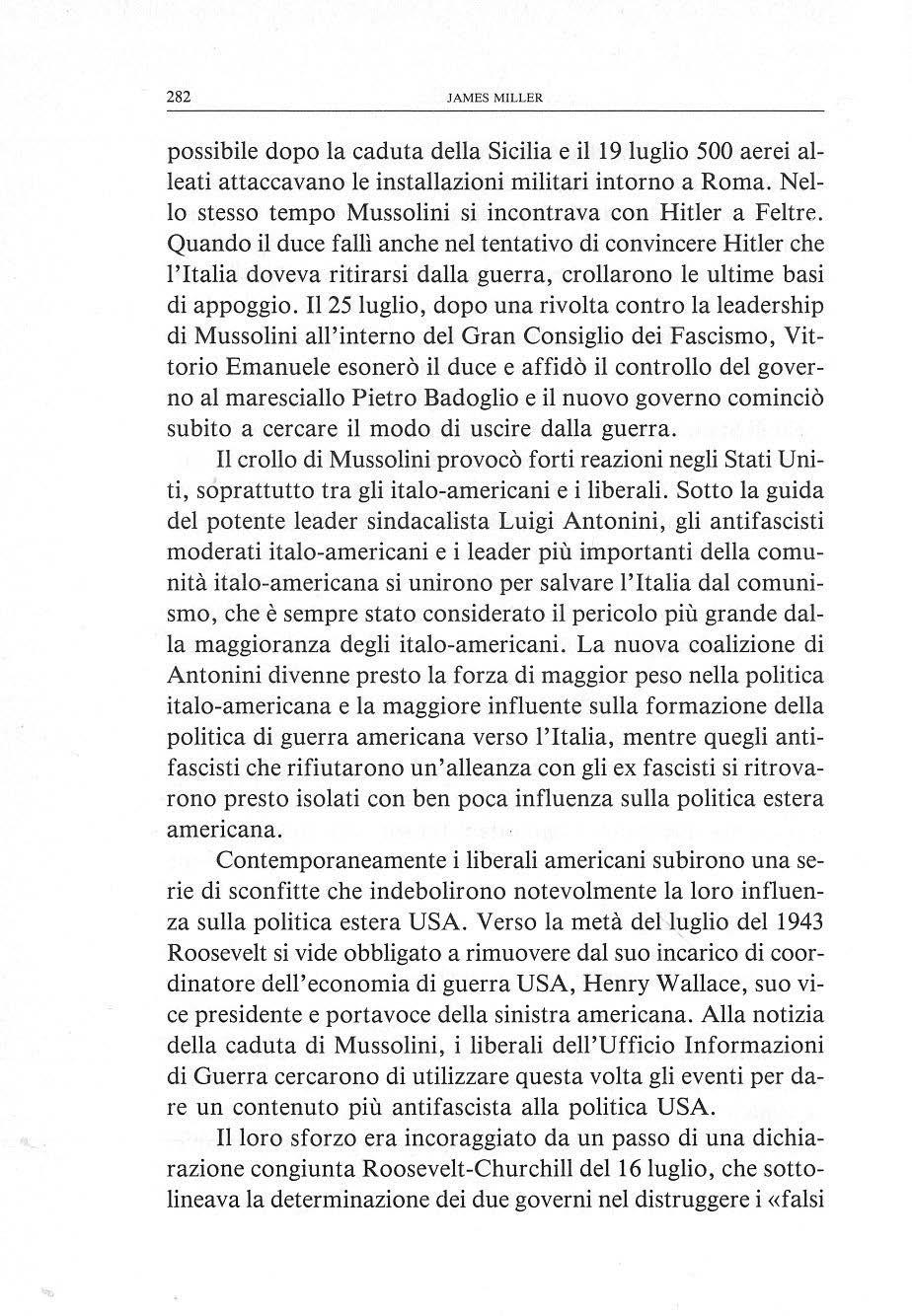
Contemporaneamente i liberali americani subirono una serie di sconfitte che indebolirono notevolmente la loro influenza sulla politica estera USA. Verso la metà del luglio del 1943 Roosevelt si vide obbligato a rimuovere dal suo incarico di coordinatore dell'economia di guerra USA, Henry Wallace, suo vice presidente e portavoce della sinistra americana. Alla notizia della caduta di Mussolini, i liberali dell'Ufficio Informazioni di Guerra cercarono di utilizzare questa volta gli eventi per dare un contenuto più antifascista alla politica USA.
Il loro sforzo era incoraggiato da un passo di una dichiarazione congiunta Roosevelt-Churchill del 16 luglio, che sottolineava la determinazione dei due governi nel distruggere i «falsi
leader e dottrine» che avevano portato l'Italia all'attuale situazione disastrosa. Uno speciale manifesto guida sulla situazione italiana pubblicato il 25 luglio poneva in risalto il fatto che la politica USA intendeva distruggere il fascismo sia che fosse guidato da Mussolini, sia da Badoglio e proseguiva riesaminando il ruolo di Badoglio nel fascismo e avvertendo che la caduta di Mussolini non significava la fine del fascismo. Questa linea di propaganda era completamente al di fuori della strategia alleata, i cui leader attendevano ansiosamente la richiesta per un armistizio dal nuovo governo italiano. Il Segretario di Stato Cordell Hull, per esempio, ordinò agli ufficiali del Dipartimento di Stato di evitare qualsiasi commento che avrebbe potuto indebolire la precaria posizione del nuovo governo.
Infatti, una trasmisione a onde corte del 25 luglio in cui un commentatore americano fece riferimento a Vittorio Emanele come il «piccolo re idiota» e a Badoglio come un «fascista di alto bordo» ebbe un impatto esplosivo a Washington. Il giorno seguente Roosevelt, durante una conferenza stampa, smentì rapidamente questa trasmissione; i conservatori nemici dell'Ufficio Informazioni di Guerra -e in particolar modo durante la conferenza - attaccarono duramente i liberali che intedevano mettere a tacere la propaganda antifascista. Nel giro di poche settimane Hull obbligò il Segretario di Stato Sumner Welles a dimettersi. La strada della sinistra americana all'interno della compagine governativa era già ben delineata al momento in cui iniziavano i negoziati per l'armistizio, mentre il potere di influenza dei gruppi conservatori, soprattutto quello inglese, si rinforzava notevolemente.
Nonostante gli sforzi compiuti per spingere l'Italia verso la resa, gli Alleati non erano pronti a ricevere la richiesta di un armistizio italiano quando questa finalmente arrivò. Come prima cosa bisogna dire che gli americani non erano certi di che cosa effettivamente significasse resa incondizionata, e comun-

que la vera ragione della confusione degli Alleati era il profondo disaccordo tra Stati Uniti e Regno Unito sulla politica italiana. I term ini di resa presentati dagli inglesi a metà giugno del 1943 non nominavano la resa incondizionata e ordinavano al comandante in capo degli Alleati di estendere il riconoscimento al governo italiano che si arrendeva. Gli americani rifiutarono questo testo e proposero il proprio che sospendeva dall'incarico il governo italiano e instaurava in tutta Italia un governo militare alleato. Questo piano fu rifiutato dagli inglesi e venivan o così a crearsi profondi disaccordi.
Il dibattito sulla politica italiana continuò per tutta l'estate del 1943; Churchill insisteva sulla necessità di sfruttare ogni offerta italiana e sottolineava che, per far sì che gli Alleati potessero guadagnare un vantaggio militare, dovevano tenersi pronti a trattare con qualunque governo fosse in grado di dare <<qualcosa di buono». Inoltre gli inglesi insistevano sul fatto che un governo militare alleato non avrebbe potuto governare l'Italia senza l'effettiva assistenza della burocrazia e del governo italiano. Quindi, secondo gli inglesi, gli Alleati avrebbero dovuto man tenere al potere il re e Badoglio e limitare al massimo qualunque epurazione del governo e della burocrazia. Questa logic a di ragionamento in contrò il favore di un certo numero di giornali americani , conservatori ma anche influenti. Roosevelt, da parte sua, non era d'accordo. Durante una trasmissione radiofonica del 28 luglio 1943, il presidente chiese nuovamente la resa incondizionata dell'Italia e avvertì il governo e il popolo italiani che l'offensiva militare sa rebbe continuata fino alla resa. Ancora una volta Roosevelt si impegnava per un'epurazione totale: «noi non verremo a patti con il fascismo in nessun modo, forma o maniera. Non permetteremo che rimanga alcuna traccia del fascismo». Ma due giorni dopo il presidente americano diede una precisa definizione del fascismo e disse ai giornalisti che avrebbe accettato una resa italiana da chiunque non fosse un «membrn determinato del governo fascista>>, aggiungendo poi che «un re o primo ministro attuale»
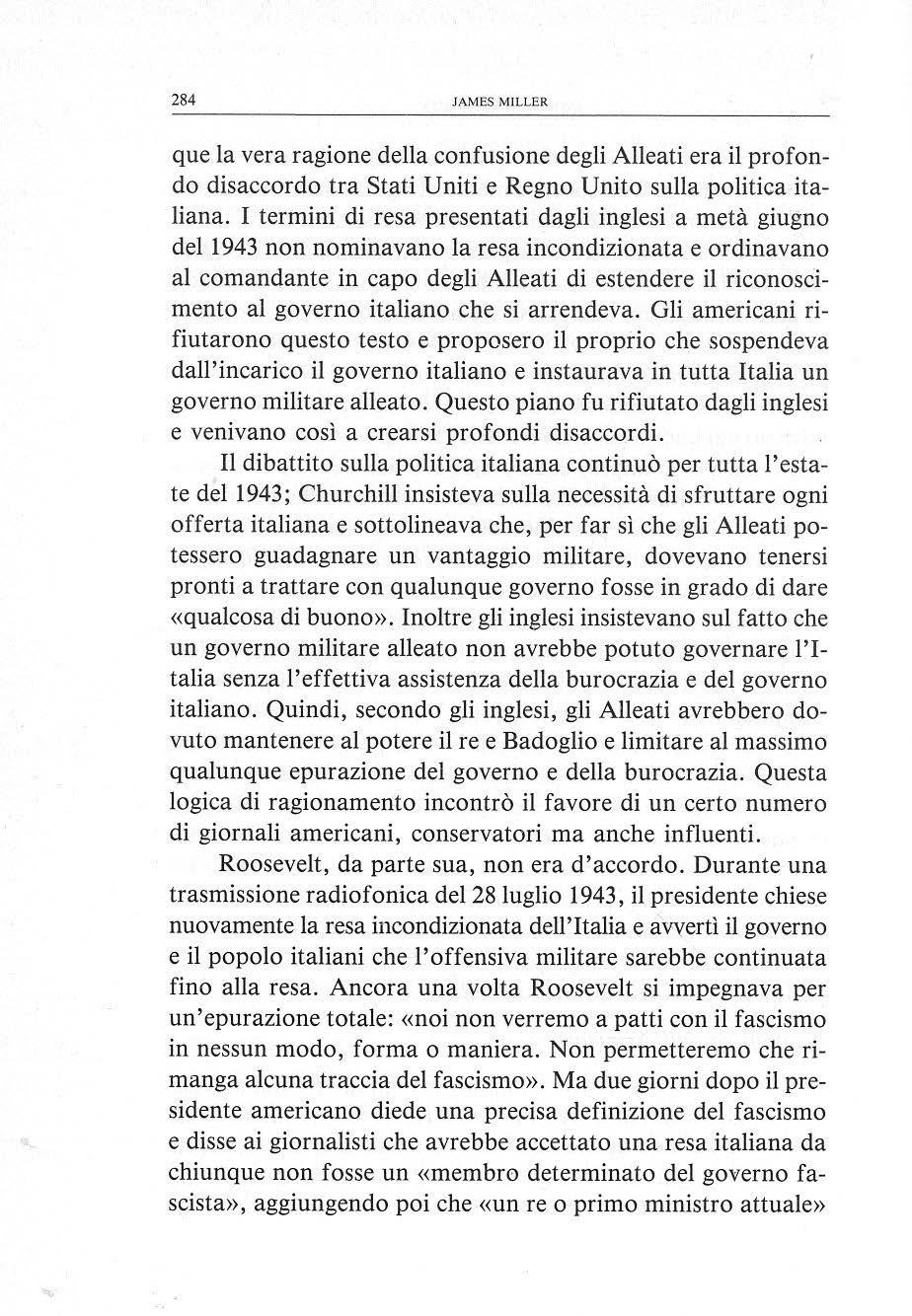
non erano fascisti. Roosevelt era pronto a trattare con qualunque governo italiano per poter accelerare la fine della guerra e «evitare l'anarchia»; i suoi commenti produssero una serie di critiche, così riassunti da Gaetano Salvemini: «Delle due guerre che Churchill e Roosevelt stanno combattendo - l'una in vista della «resa incondizionata» e l'altra contro «caos e anarchia» - nè l'una nè l'altra è fatta contro il re e gli altri responsabili delle sofferenze del popolo italiano ....
Si c'è il pericolo di caos e di anarchia in Italia; ma caos e anarchia intellettuale, morale esistono già a Londra e Washington».
Comunque dopo circa tre anni di continue sconfitte dei liberali e di continua crescita del potere dei conservatori all'interno del governo statunitense, l'influenza dei liberali era praticamente nulla, mentre, allo stesso tempo, l'influenza britannica sulla politica americana raggiungeva l'apice. Il primo ministro britannico replicava alle critiche di una battaglia con Badoglio col fatto che si trattava di una necessità strategica.
La resa
Comunque gli Alleati erano d'accordo sulla necessità di una campagna contro il re e Badoglio; gli attacchi dei liberali alla politica americana avevano creato degli intoppi all'accordo alleato sulla linea della politica italiana, ma non esisteva un accordo preciso sui termini dell'armistizio. Dal Foreign Office in. tanto sei funzionari stavano preparando la versione inglese del documento, che avrebbe dato alla Gran Bretagna un notevole controllo sulla vita politica ed economica della ormai sconfitta Italia.
Gli americani, invece, chiedevano un armistizio militare che avrebbe permesso un graduale riavvicinamento delle relazioni tra l'Italia e gli Alleati, dopo i cambiamenti sopravvenuti con la guerra; e con ciò gli americani dimostravano una sempre maggiore attenzione agli obiettivi inglesi sull'Italia.
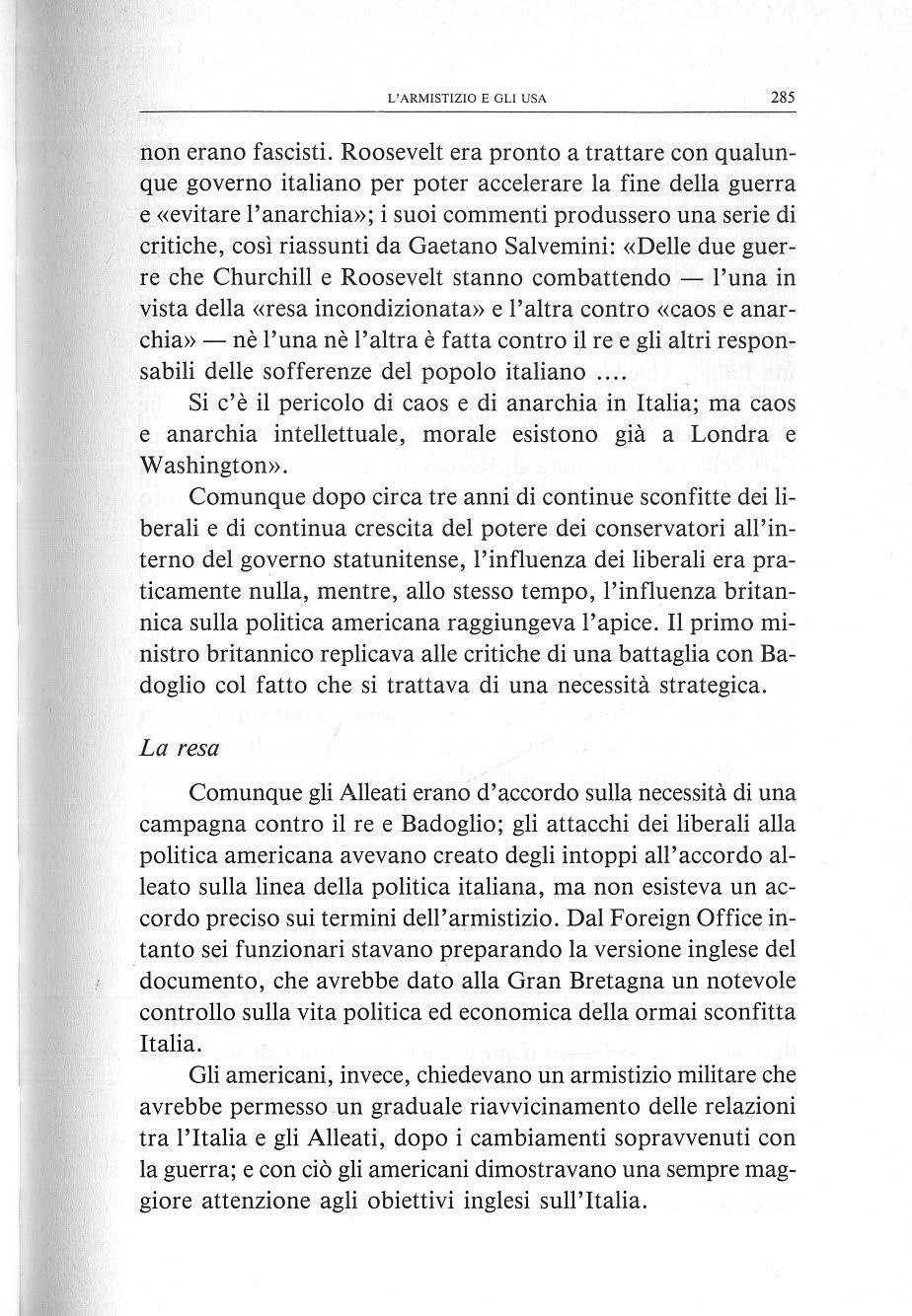
Sorse poi un altro problema di una certa importanza, quando il giornalista sovietico Ilya Ehrenburg, uno dei più conosciuti portavoce di Stalin, riferì ad un giornalista americano il 30 luglio che il rifiuto di Roosevelt del 26 lug li o di una propaganda antifascista contrariò seriamente il governo di Mosca.
Ehrenburg denunciò il fatto che gli alleati occidentali non avevano consultato l'Unione Sovietica a proposito del problema Italia e chiedeva se la campagna contro Badoglio fosse il preludio ad un accordo con Goring. In conseguenza al fatto che la cooperazione con l'Unione Sovietica era una delle pietre miliari della politica estera di Roosevelt, il presidente fece ogni sforzo possibile per riassicurare Stalin della sua fedeltà ai loro comuni obiettivi e alleanza.

Allo stesso tempo il re e Badoglio cominciarono a cercare il modo di uscire dalla guerra. Erano comunque rilu t tanti ad offrire una resa incondizionata in parte perchè sapevano che l'ala sinistra della stampa sia inglese che americana chiedevano una punizione per chiunque fosse legato a Mussolini, mentre le promesse di Roosevelt per uno speciale trattamento faceva ben poca presa sui leader italiani, che intuirono che una resa incondizionata sign ificava accettare la «giustizia del vincitore». In ogni caso avevano sempre meno opzioni e tempo: Hitler stava rinforzando le sue truppe in Germania e presto sarebbe stato in grado di muovers i co ntro gli ex alleati.
Presi fra due blocchi gli italiani preferirono il nuovo (gli Alleati) al vecchio già troppo ben conosciuto (Hit ler) e aprirono i contatti con gli Alleati; a metà agosto Badoglio dichiarò Roma «città aperta» e inviò segretamente il generale Castellano a Lis b ona per offrire la resa ital iana in cam b io de l diritto di combattere al fianco degli Alleati contro la Germania. Le notizie della missione di Castellano arrivarono a Quebec proprio quando Churc h ill e Rooseve lt iniziavano il loro incontro e rinnovavano le loro pressioni sugli Alleati per risolvere le loro divergenze sui termini che avrebbero dovuto essere offerti all'Ita lia e anche per stabilire come si sarebbero dovuti com-
portare con il regime di Badoglio dopo la resa. I leader americani si accorsero del pericolo di un accordo con il re e Badoglio dopo la rivolta interna contro la diplomazia FDR e dopo le pesanti critiche dell'Unione Sovietica, sempre sulla stessa politica; il Dipartimento di Stato avvertì che anche la minima cooperazione con Badoglio avrebbe aperto il vaso di Pandora dei problemi per gli Stati Uniti.
I sovietici avrebbero potuto sfruttare la politica alleata per imporre la loro democrazia e allo stesso tempo avrebbe costituito precedente per l'imposizione di governi anti democratici negli stati liberati dall'Armata Rossa. Inoltre, il riconoscimento del regime Badoglio avrebbe offerto loro una posizione da cui ostacolare ed anche limitare la possibilità degli Alleati di ricostruire uno stato italiano e di ristabilire la democrazia. Per evitare queste spiacevoli prospettive, il Dipartimento di Stato chiedeva di porre delle clausole per l'armisti zio che avrebbero garantito una libera scelta del nuovo governo agli italiani, posto il governo italiano sotto la supervisione degli Alleati dal momento della resa fino a che una assemblea costituente non avesse emesso una nuova costituzione e sospeso il potere della corona.
Gli inglesi si opposero strenuamente a queste proposte; Eisenhower era in attesa di istruzioni e di termini da presentare agli italiani, mentre il Dipartimento di Guerra americano era pronto ad accettare le obiezioni inglesi; il Dipartimento di Stato, invece, era fermo nelle sue convinzioni, bloccando i negoziati. La conferenza di Quebec terminò senza un accordo sulla questione chiave della politica italiana .
Come risposta a questa lotte con gli inglesi, invece, il Dipartimento di Stato cominciò a rivedere la sua linea politica riguardo agli esiliati italiani e gli americani scoprirono che gli esiliati erano un mezzo eccellente nella lo tta contro la monarchia e gli inglesi. I diplomatici americani decisero così di far ritornare i «fuoriusciti>> in Italia per controllare la posizione del governo Badoglio dopo la resa.
Alla fine di agosto gli Alleati finalmente sbloccarono la questione dell'armistizio, accordandosi su un documento puramente
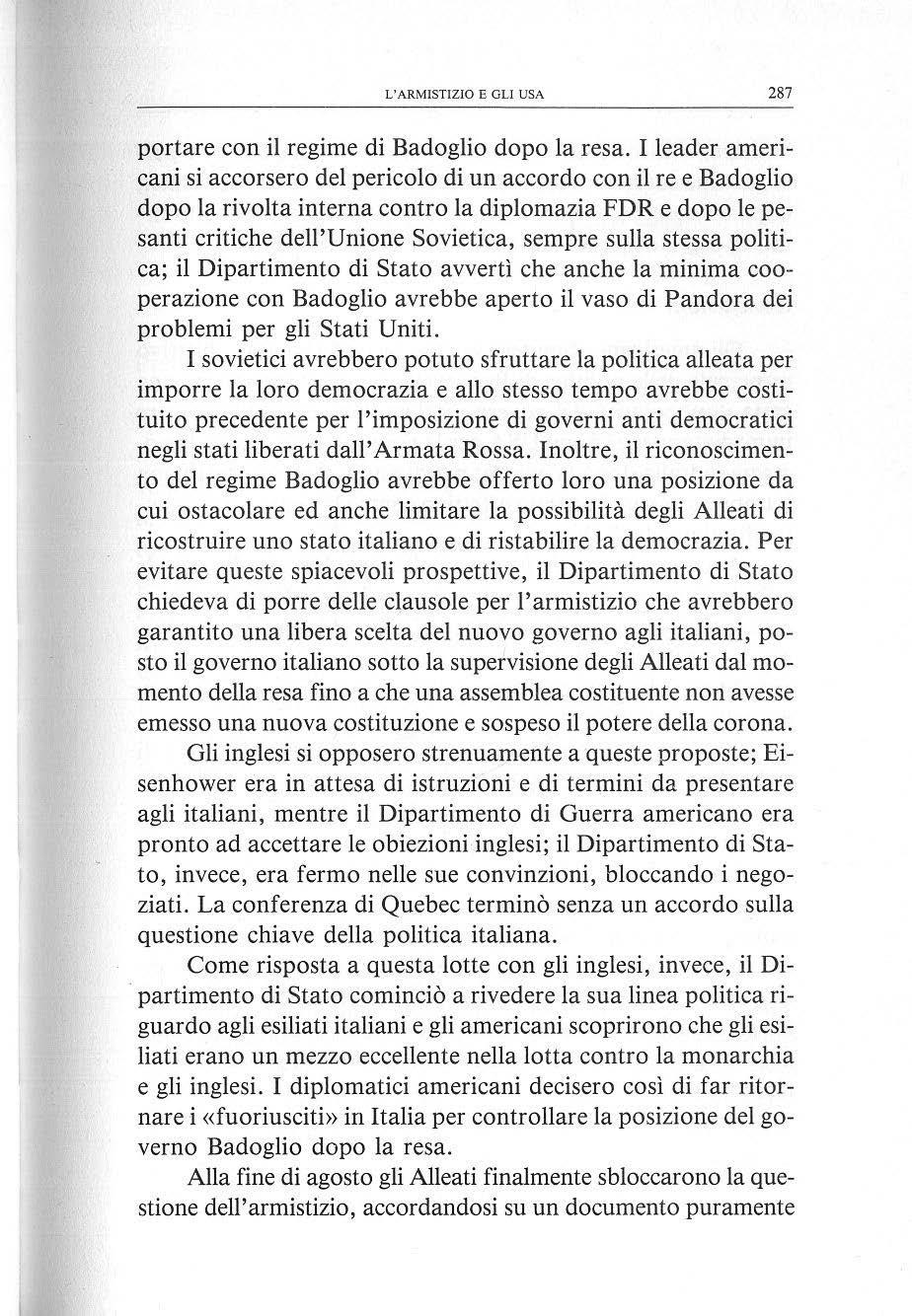
militare - il cosidetto «armistizio breve» - che avrebbe permesso una successiva aggiunta di termini politici ed economici, dopo un accordo alleato sulla politica. Il governo Badoglio firmò in segreto queste condizioni il 3 settembre 1943.
Gli americani ottennero la resa incondizionata, obietti v o principale della politica di Roosevelt, ma ottennero anche una certa impopolarità de l governo italiano che cercò di bloccare immediatamente i piani USA per la ricostruzione di una democrazia in Italia dopo la guerra; per di più, il governo del re non intraprese nessun impegno effettivo contro la Germania, aspettando aiuto dagli Alleati.
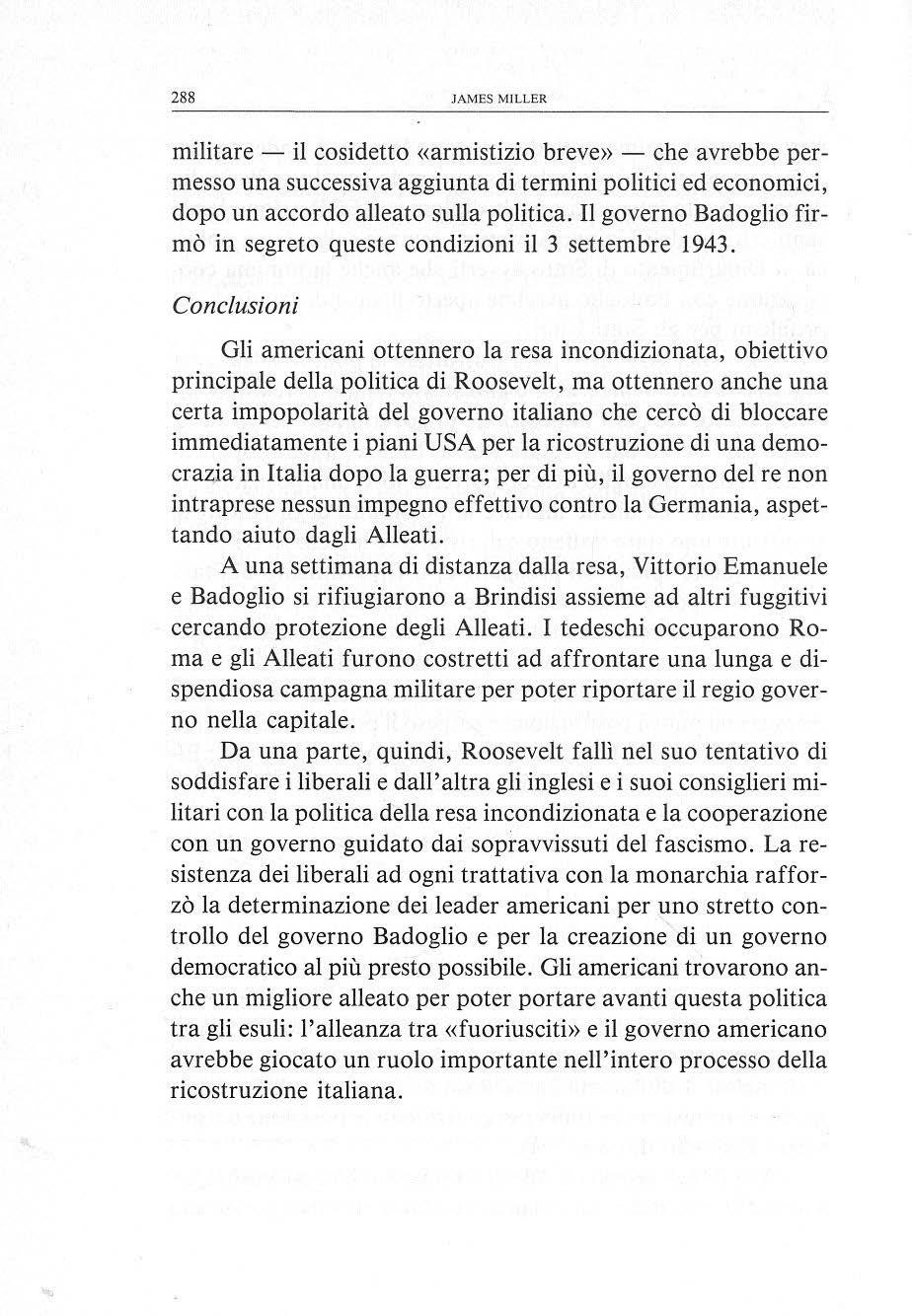
A una settimana di distanza dalla resa, Vittorio Emanuele e Badoglio si rifiugiarono a Brindisi assieme ad altri fuggi t ivi cercando protezione degli Alleat i. I tedeschi occuparono Roma e gli Alleati furono costretti ad affrontare una lunga e dispendiosa campagna militare per poter riportare il regio governo nella capitale.
Da una parte, quindi, Roosevel t fallì nel suo tentativo di soddisfare i liberali e dall'altra gli inglesi e i suoi consiglieri militari con la politica della resa incondizionata e la cooperazione con un governo guidato dai sopravvissuti del fascismo. La resistenza dei liberali ad ogni trattativa con la monarchia rafforzò la determinazione dei leader americani per uno stretto controllo del governo Badoglio e per la creazione cli un governo democratico al più presto possibile. Gli americani trovarono anche un migliore alleato per poter portare avanti questa politica tra gli esuli: l'alleanza tra «fuoriusciti» e il governo americano avrebbe giocato un ruolo importante nell'intero processo della ricostruzione italiana.
Le straordinarie vicende dell'8 settembre e dei giorni immediatamente prima e dopo confermano che la storia degli avvenimenti conserva tutto il suo fascino quando si tratta di svo lte così deci sive, così difficili da interpretare e così incalcolabili nel loro impatto c on la st oria di un popolo. La dichiarazione dell'armistizio tra le Nazioni Unite e l'Italia non rappresentò soltanto uno sviluppo ch iave nella st oria co ntemporanea italiana. Nella storia della Seconda guerra mondiale, nella storia dei rapporti fra i Tre grandi, nell'evoluzione dei rapporti fra politici e militari, in que st a fase della guerra, il momento costituì indubbiamente una pietra miliare nella creazione di nuovi equilibri e cli nuo vi rapporti di forze. Nelle pagine seguenti, non intendiamo raccontare anc ora una volta le tappe che hanno portato gli all eati al loro «accordo » con il governo italiano, nemmeno dal punto di vista del governo di Churchill e delle altre componenti della direzione politica strategica britannica. Quello che si intende fare, invece, è indicare i parametri di azione, i criteri che hanno gu idato il comportamento dei protagonisti ingle s i nel corso di questi giorni e settimane decisive. Mettendo in sieme documenti di archivio, la storia ufficiale, le numerose memorie ed autobiografie, le analisi posteriori degli storici politici e militari, è possibile distinguere, infatti, una ser ie di punti fermi nelle menti dei principali difensori del potere britannico che possono aiutare a comprendere le loro prese di posizione, i conflitti fra di loro e alcuni dei loro atteggiamenti nel ca ldo di que st a complicata situazione.
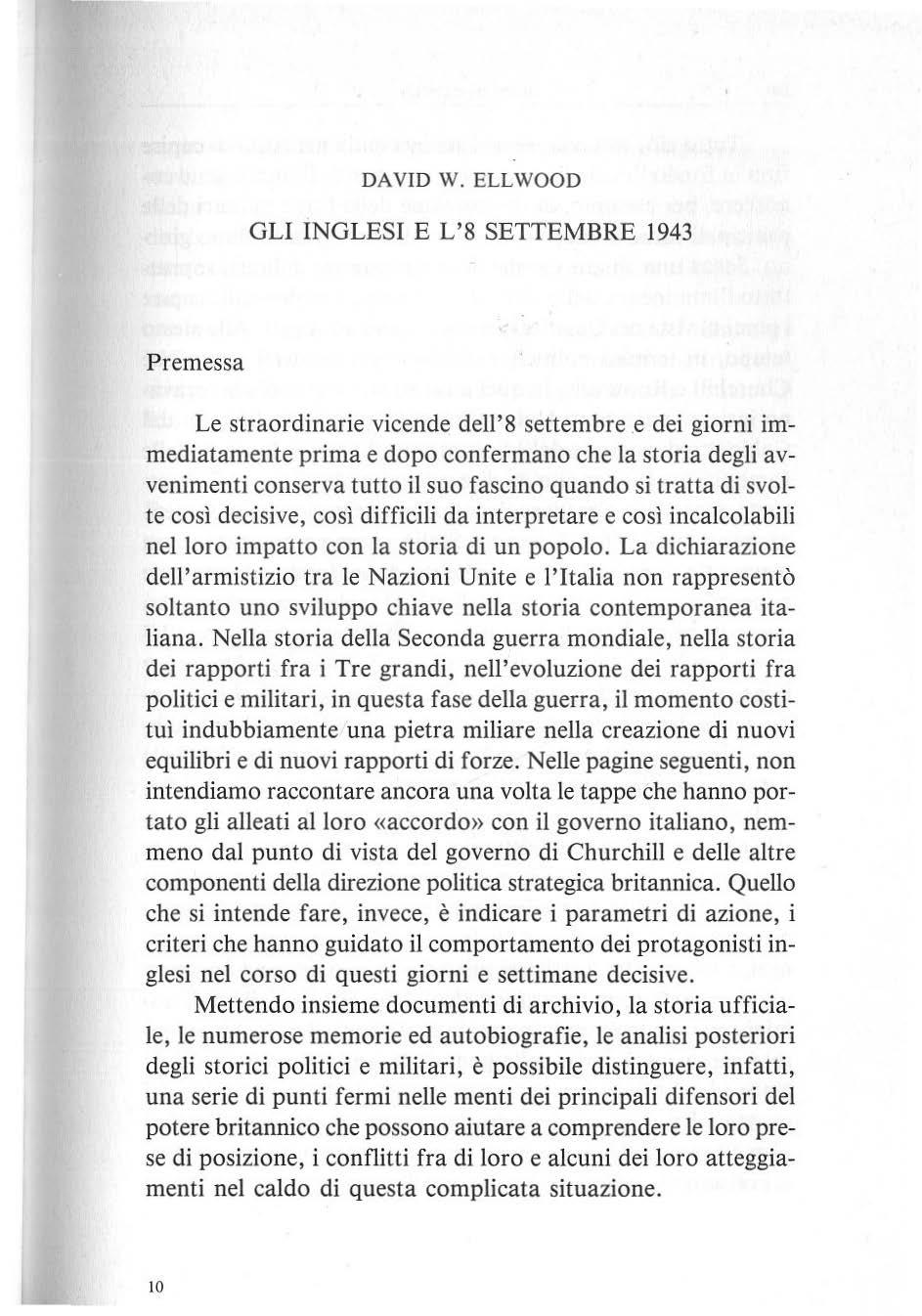
Tutto ciò, tuttavia, non ci solleva dalla necessità cli capire fino in fondo l'evoluzio ne degli avvenimenti. È importante conoscere, per esempio, la disposizione delle forze militari delle principali forze in gioco e la sua evoluzione giorno dopo giorno. Senza una chiara visi on e delle circ ostanze militari, soprattutto l'imminenza d ell o sbarco di Salerno, è impossibile cap ire i punti cli vista dei Quartieri generali alleat i ad Algeri. Allo stesso tempo, in termini politici, è obbligatorio rendersi conto che Churchill e Ro osevel t, in quel momento, vivevano e lavoravano insieme negli Stati U ni ti; Churchill q uindi era lontano dal Gabinetto di guerra e dal Ministero degli Esteri e lon tano dalle forze che avevano molto da dire su ll e vicende italiane. È altrettan to ne cessario ricordare l'evoluzione della pos izi one sovietica: proprio alla fine di agosto, Stalin aveva comunicato in un messaggio di rara asprezza un senso di profonda frustrazione rispetto ai modus operandi degli alleati inglesi e americani. La necessità immediata di ricostituire l'equilibrio politico con l 'Unione Sovietica, era un altro elemento pressan te, a breve termine, all'interno di questa situzione. Infine occorrerebbero conoscenze dettagliate sulla precisa posizione del governo italiano, sui rapporti al suo interno e sulla disposizione precisa delle forze strategiche, tattiche e diplomatiche che premevano sul Re, su Badoglio e sull'Alto comando da un'ora a ll'altra. Su quest'ultimo prob lema m olti dettagli rimangono da chiarire e, forse, non saranno m ai chiariti in modo co mpl eto. Occorre quindi sottolineare a que sto punto la drammaticità del contesto, la gra nde con fu sione che cir con da va le azioni di quasi tutti i protagonisti, il loro modo di assistere più o meno impotente ad un dramma di portata sconosciuta, incalcola bil e , la soggettività di uomini co involti in vicende in rapida evoluzione che avrebbero pot u to cambiare il corso della g uer ra. Il senso di intensa eccitazione ed agitazione traspare in quasi t utte le memorie scritte dai protagonisti d opo gli avvenimenti - sop rattutto quelli ingle si - ma ne ssu no ha mai preteso nei mesi e a nni success ivi che essi avessero un minimo di r eale controllo sug li avv enimenti o che
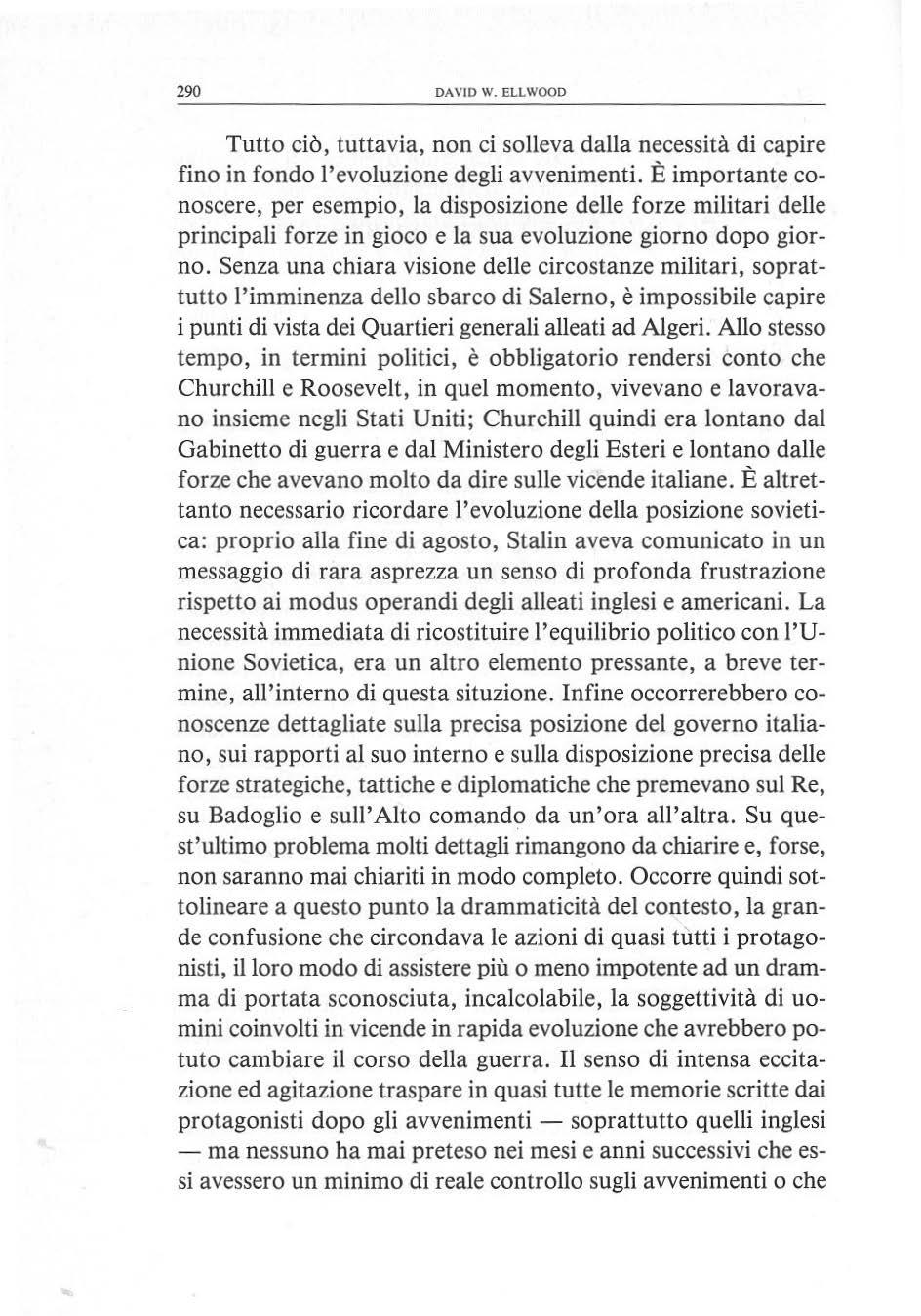
sapessero con più di un'ora o di un giorno di anticipo cosa sarebbe accaduto nell'immediato futuro o a breve termine. I pochi piani politici erano sa ltati o dovevano essere modificati radicalmente; i piani strategici erano di poca utilità e dovevano essere alterati di ora in ora con conseguenze imprevedibili. L'annuncio stesso dell'armistizio, 1'8 settembre, era un prodotto della confusione delle circostanze (essendo stata fatta il 3 settembre la firma sull'armistizio) e pochi erano gli uomini che sono riusciti a mantenere la calma e l'attaccamento a certi principi di fondo nel mezzo di questa situazione.
Da parte inglese i più calmi indubbiamente erano i funzionari del Foreign Office capeggiato dal loro Ministro, Anthony Eden. Lontani dalle vicende militari e dal caos della situazione romana, per non parlare dell'atmosfera di intensa emozione che si respirava nell'ambiente del Presidente e del Primo Ministro in Quebec, essi mantenevano fermi una serie di obiettivi stabiliti nei mesi precedenti che vedevano il risultato della guerra contro l'Italia in una visione a lungo termine. Il capo della democrazia americana presso il quartiere gnerale alleato, Robert Murphy, spiegò nelle sue memorie quale era il punto di vista degli inglesi come era stato a lui spiegato da Harold MacMillan, suo collega britannico: «Per gli inglesi il Mediterraneo fu un collegamento essenziale nel loro sistema imperiale e si preoccupavano seriamente per quello che sarebbe accaduto durante e dopo la guerra. Così essi sono arrivati (alla crisi italiana) con una visione completamente diversa dalla nostra. Per quasi tutti gli esperti americani, il Mediterraneo era un campo di battaglia temporaneo e poco di più ... ». Murphy insiste che l'unico modo di riconciliare questi due punti di partenza degli alleati anglosassoni era di improvvisare un compromesso, sia sul piano strategico che su quello politico, che è costato allo sfo rzo di guerra la capacità di incidere rapidamente e positivamente nei momenti crucia li , per esempio, dopo la caduta di Mussolini (1). Un altro esperto americano, William Reitzel, scrivendo pochi anni dopo la fine del conflitto, era più preciso: «Per la Gran Breta-
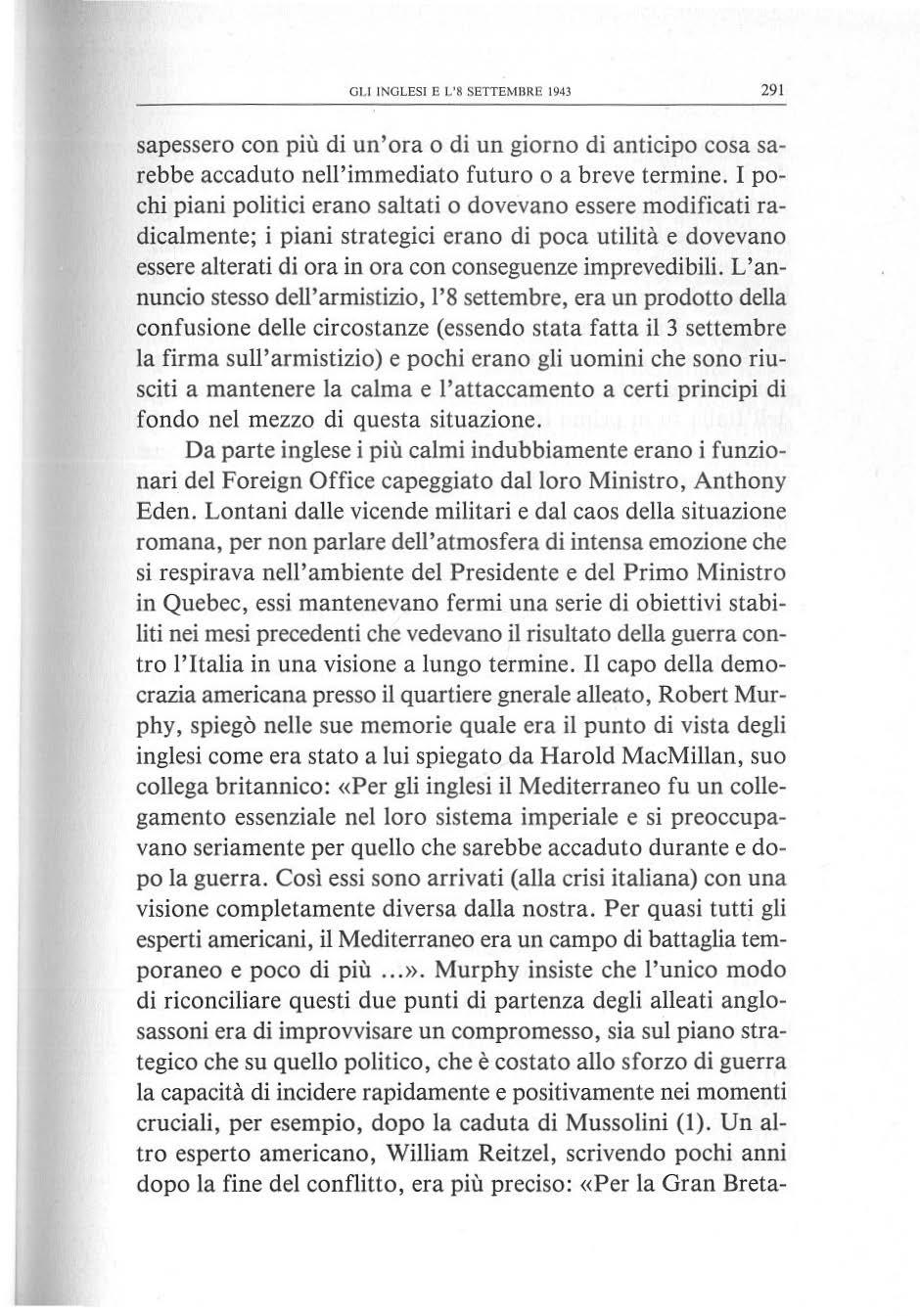
gna, la sconfitta dell'Italia rappresentò una categoria diversa di vittorie che non per gli Stati Uniti. Per i primi, si trattò di porre fine a quindici anni di confusioni politiche e preoccupazioni strategiche: era l'eliminazione di un rivale locale che aveva quasi raggiunto i suoi vantati obiettivi strategici. Rappresentò il passo decisivo e più grande in un processo di restaurazione di una posizione mediterranea che si era deteriorata ser iamente. Se la vittoria creò dei problemi, essa fornì anche delle opportunità pratiche. Per gli Stati Uniti, al contrario, la sconfitta dell'Italia fu in primo luogo una tappa della guerra contro la Germania. Era una sconfitta amministrata più con dispiacere e pena che non con rabbia. Si sentiva vagamente che l'Italia era stata liberata e che, in termini generali, bisognava incoraggiarla a ritornare alle su e tradizioni prefasciste » (2).
In realtà queste erano le premesse, non esplicite, della politica inglese verso l'Italia in questi mesi. Per quanto riguardava l'elaborazione di piani concreti e di scelte operative, il Foreign Offi ce si era preparato bene fin da giugno, se non prima. In tal modo il Ministero degli Esteri inglese prese la iniziativa in campo del tutto aperto: in nessun'altra parte del sistema britannico esisteva una capacità di pianificazione per una situazione come quella italiana e n emmeno nei mesi success ivi è mai emersa una strategia molto diversa da quella del Foreign Office. In altre parole, nè il Ministero della guerra, nè il Parlamento, nè nella stampa e nemmeno a livello del Primo Ministro è mai apparsa un'alternativa alla vis ione del Foreign Office e solo Churchill aveva il potere e le conoscenze per contrastare le loro scelte. Tuttavia, quando il Foreign Office faceva i suo i giudizi si riguardava la situazione strategica e geopolitica dell'Italia, nel suo insieme: la sua posizione e statu s nell 'arena internazionale, mentre non si tralasciava la situazione interna, di cui il Foreign Office sapeva molto poco. Eden e i suoi funzionari sapevano benissimo che le priorità essenziali erano quelle militari e che dovevano adattare la loro strategia all'evolversi della situazione militare. Inoltre, condividevano la visione della guerra
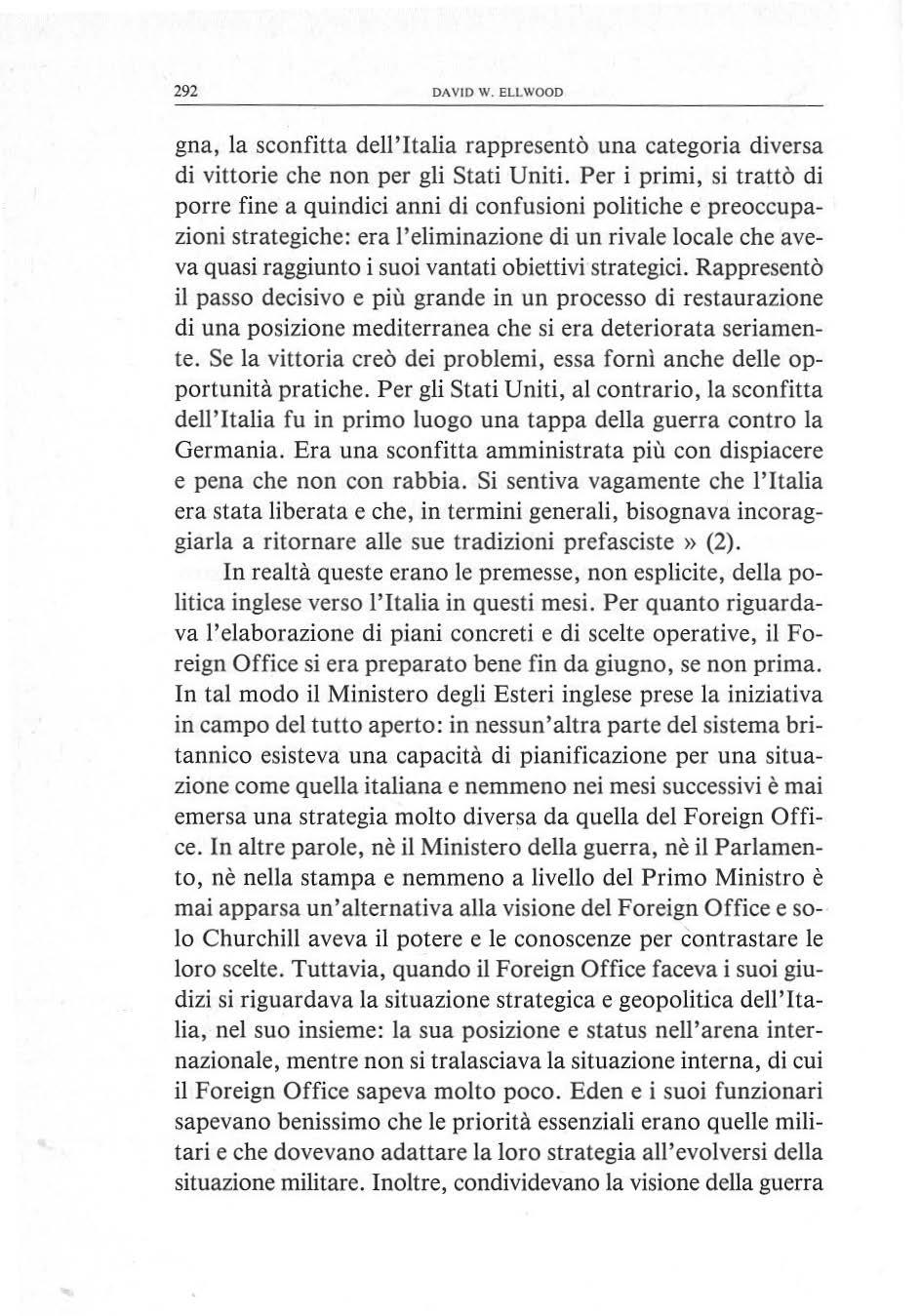
sviluppata da Churchill e confermata a Casablanca: una visione secondo la quale il teatro mediterraneo non solo era un passo fondamentale per la sconfitta della Germania a medio termine, ma anche un'alternativa vera e propria ai piani americani per un'invasione attraverso la Francia a breve termine. Su questo argomento - la cosiddetta strategia mediterranea degli inglesi - la discus sione è stata molto accesa negli anni successivi alla guerra. Nei termini in cui era designata secondo le decisioni di Casab lanca è essenzialmente fallita. Roma non è stata presa in poche settimane, i Balcani non sono stati liberati dai tede schi, la Turchia non è stata coinvolta nella guerra, il Mar Nero non è stato messo a disposizione degli alleati, la Germania non ha dovuto togliere grandi forze dal suo fronte orientale e, in fin dei conti, la guerra non è finita nel 1943 come sembrava possibile nel gennaio di quell'anno.
Tuttavia, bisogna riconoscere che la caduta di Mussolini e l'armistizio del1'8 settembre erano frutti grandi - forse gli unici di qualche importanza - quella strategia che, in quel momento, sembrò così co nferm ata, suscitando la grande soddisfazione del Primo Ministro e del governo inglese in generale per l'evoluzione degli avvenimenti di quei giorni . Per il Foreign Office, la resa dell'Italia significò l'inizio della fine della guerra, sicuramente in termini geopolitici, di una lun ga e travagliata definizione di obiettivi politici per il dopoguerra. Nessuno, con la possibile eccezione del lungimirante generale Smuts, aveva previsto quanto dura e lunga sarebbe stata la guerra in Italia. Era quindi con una certa urgenza che il Foreign Office premeva per l'imposizione delle sue priorità politiche. Nel modo in cui si è verificato il crollo italiano, il Forei gn Office vedeva la conferma della n atura essenzialmente avventuristica del regime di Mussolini, della falsità delle sue pretese. Elimi nar e l'Italia dalla scena internazionale - almeno come gran de potenza - era una premessa indiscussa della linea del Foreign Office. Sfruttare l'estrema debolezza ed umiliazione del momento dell'armistizio per ridimensionare una volta per sempre le pretese
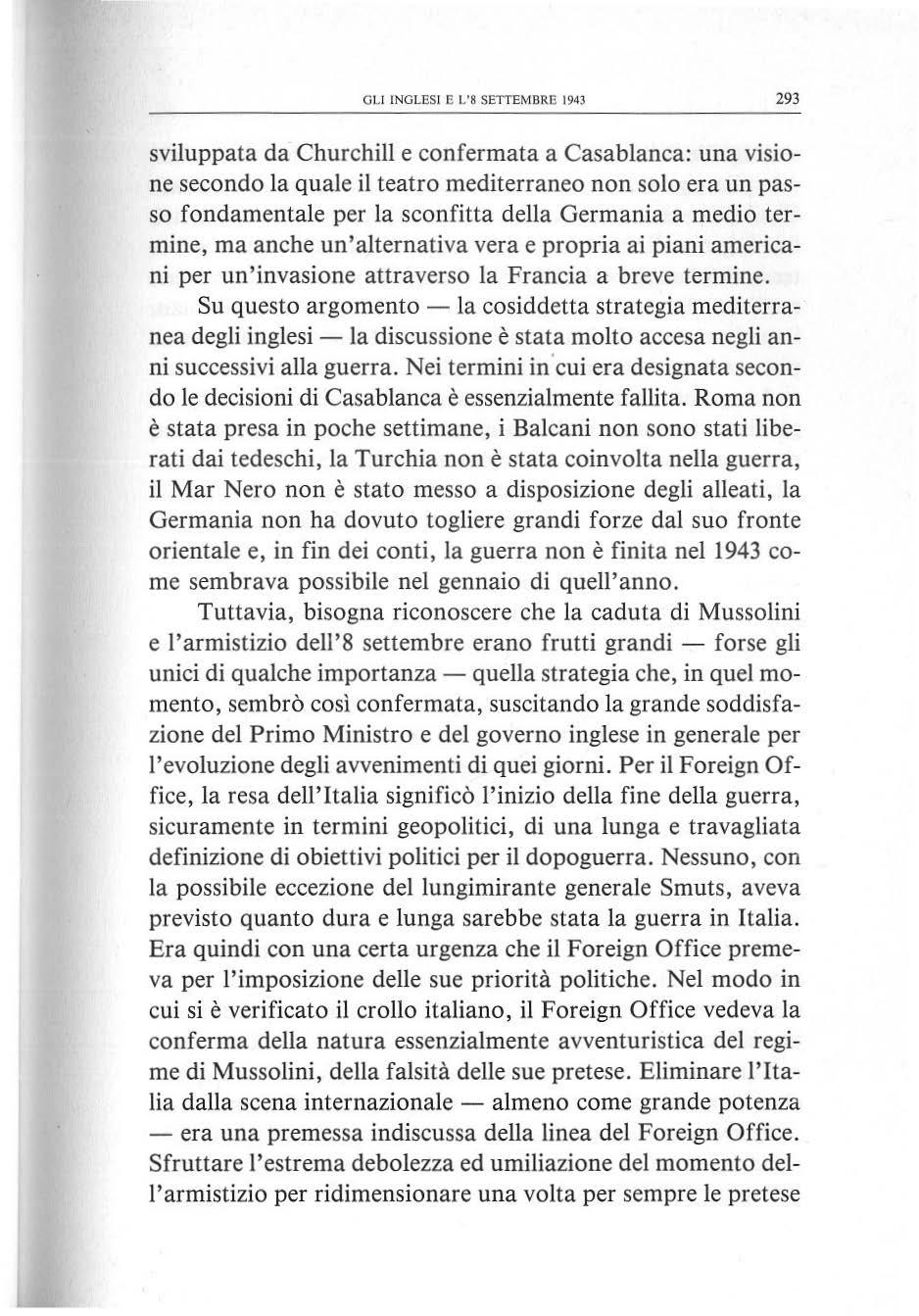
strategiche dell'Italia come potenza, era una priorità assoluta per il Foreign Office che spiega molti dei suoi argomenti ed anche il tono secondo cui questi argomenti venivano sostenuti nel1' emergenza di settembre. Il Foreign Office sa peva di non poter controllare l'evolversi della situazione sul posto, nemmeno mediante l'agente inglese supremo in loco, Harold Mac Millan, il quale era una designazione politica di Churchill. Ma con un piano a lungo termine già elaborato (e codificato nel cosiddetto Lungo armistizio) e con una serie di sei criteri di fondo nel giudicare la desiderabilità o meno di una determinata strada, essi spe ravano di avere il meglio nella lotta tattica fra le posizioni politiche e militari al momento della scelta decisiva per i futuri rapporti fra Italia e Nazioni Unite. Guardiamo più da vicino questi sei criteri.
Il Foreign Office e il Dipartimento di Stato erano convinti, nell'autunno del '43, che era giunto il momento di riprendere l'iniziativa politica nel campo - in senso largo - del comando alleato dalle mani dei comandanti militari. L'iniziativa stessa della Conferenza del Ministero degli Esteri, nel novembre success ivo, fu designata nella stessa ottica. Rispetto a Tito, alla situazione francese e ad a ltr i luoghi del mondo, secondo il Foreign Office, le priorità militari erano state imposte senza alcuna considerazione per gli interessi a lungo termine - presumibilmente invariati - della Gran Bretagna nelle varie situazioni: Il caso Darlan, nel Nord-Africa, sembrò solo co nferm are l'inettitudine dei militari di fronte a complesse scelte politiche. Una lotta dura ed aspra fra Algeri e Londra contraddistingueva per esempio la sit uazione della propaganda: i militari ridesignandolo spesso in nome di obiettivi a breve termine; il PWB e il PID del Foreign Office insistendo da Londra che
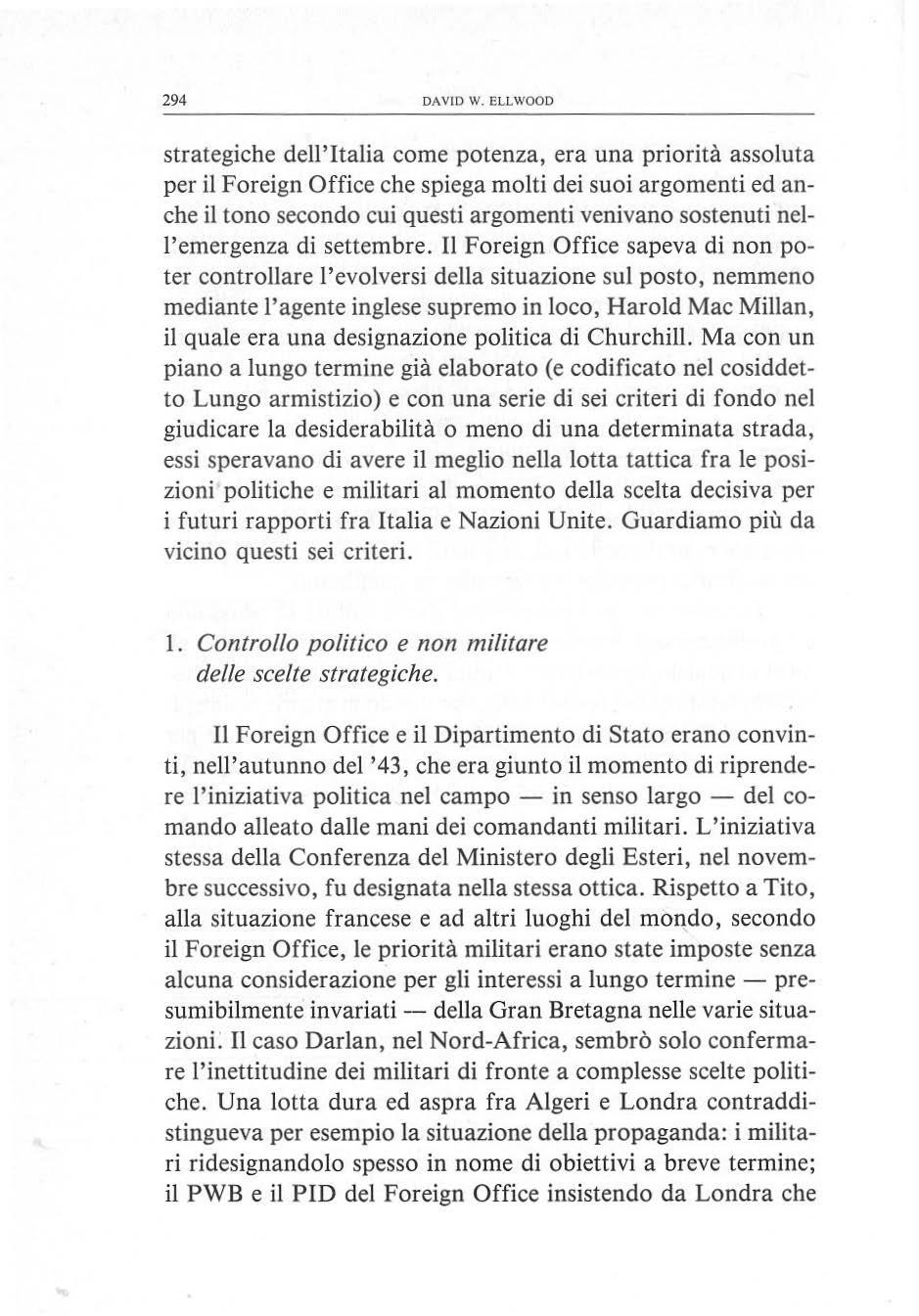
si dovevano imporre altre priorità di più ampio respiro. I londinesi diffidavano in particolare della tendenza americana di delegare al comandante in loco una fetta più o meno illimitata di autonomia decisionale, vecchia prassi americana che in questa occasione veniva rinnovata secondo l'abitudine di Roosevelt di rinviare all'ultimo momento (preferibilmente alla fine delle ostilità) le scelte politiche (3).
Ma la situazione militare nell'estate del '43 era alquanto delicata, con l'invasione della Sicilia completata in tempi non particolarmente brevi e poi con ogni indicazione che i tedeschi avrebbero rinforzato con grande efficienza il fronte del sudEuropa. Questo processo di rinforzamento, sempre più incalzante con il passare dei giorni, rappresentò un retroscena vivace che condizionò e preoccupò sempr e di più i comandanti militari nella loro lotta con le circostanze italiane. Sbarchi in Calabria e Salerno erano pianificati per la prima settimana di settembre e forti erano le pressioni di Churchill per quello che venne descritto come «lo sfruttamento della vittoria». Operando ai limiti estremi delle loro risor se, per quanto riguarda i mezzi di sbarco e di copertura aerea, le forze alleate dovevano raggiungere via mare il punto più a nord possibile della penisola italiana e poi, sparpagliarsi rapidamente ancora a nord, con l'intenzione di arrivare al più presto a Napoli, di catturare le basi aerea di Foggia e, infine, spingersi a Roma e ad Olbia. Con l'aumento della pressione tedesca a sud di Napoli, la posizione dell'Italia e soprattutto quelle delle sue forze armate divenne sempre più cruciale. Avrebbero partecipato o no alla lotta e allo sforzo angloamericano? Sarebbero rimasti in loco o addirittura a fianco dei tedeschi? Questi erano gli interrogativi immediati che i comandanti militari dovevano affrontare e che essi non potevano separare dalla s ituazione diplomatica dell'Italia. Il governo italiano, a quanto pare, considerò la propria posizione militare come la questione più urgente e mandò non un diplomatico ma un rappresentante del comando dei capi di Stato Maggiore, il generale Castellano, a trattare con gli alleati la par-

tecipazione mi,litare dell'Italia al loro fianco. Il Foreign Office notò che que st o perso naggio si recò in primo luogo dai rappr esentanti diplomatici della Gran Bretagna e degli Stati U niti. Ma i militari di Algeri avevano previst o una mo ssa del genere e perciò avevano preparato un breve armi st izio militare - il cos idd etto Armistizi o corto - per t rattar e imme di a tam ente una resa ita liana e la conv ersi one delle for ze italiane in appoggio tattico all'invasi one alleata di Sale rno. Con l'in tervento del Pr esidente, del Primo Ministro e dei capi di Stato Maggiore congiun ti a Washington, Alg er i fu autorizza ta a tratt are con Cas tell ano utilizzando l 'Armistizio corto. La co n segue n za fu il drammatico negoziato fra Castellano e Mon tanari da una parte, Bedell Smith e Strong dall'altra, la ser a del 19 agosto a Lisbona (4). Eppure, otto giorni dopo, da Quebec furono date istruzioni nuove le quali obbligavano Eisenhower ad applicare anche le 44 clausole dell'Armist izio lungo ed ottenere in tal modo la resa inco n dizio nata dell' esercito e dello Stato italiano. Tutto ciò fu la conseguenza della lotta fra E den da una p a rte , i militari dal1' altra, che aveva il s uo epicentro a Quebec. Ch ur chill, come al solito, oscillava fra una posizione ed un'alt ra, arrivando ad una s pecie di compromesso che implicava l'u so di entrambi gli armistizi. Vecchio combattente se stess o , la lotta fra poli ti ci e militari con t inuava a ll'interno della propria personalità, in un mom ento adottando le form e, le parole e le priori tà di Ed en, in un altro, sposando le tes i dei militari , segue ndo minuziosam ente l'evolu zi one della situazione tattica e rimproverando costantemente i suoi generali per la loro cautela ed ecc ess iva precau zion e.
La confusione generata dal conflitto di competenza fra politi ci e milita ri si vedeva anch e negli scarsi e poco realistici piani co struiti per il mantenimen t o dell'ordine nel paese invaso dopo le battaglie. Governo mili tar e, Commissione di controllo, Consiglio consulti vo per l ' It a lia erano tutt e nozioni inventate per raggiungere un compromesso di qualch e tipo fra gli elementi alleati in lotta. A br ev e termine, il comando di Algeri ha vin to
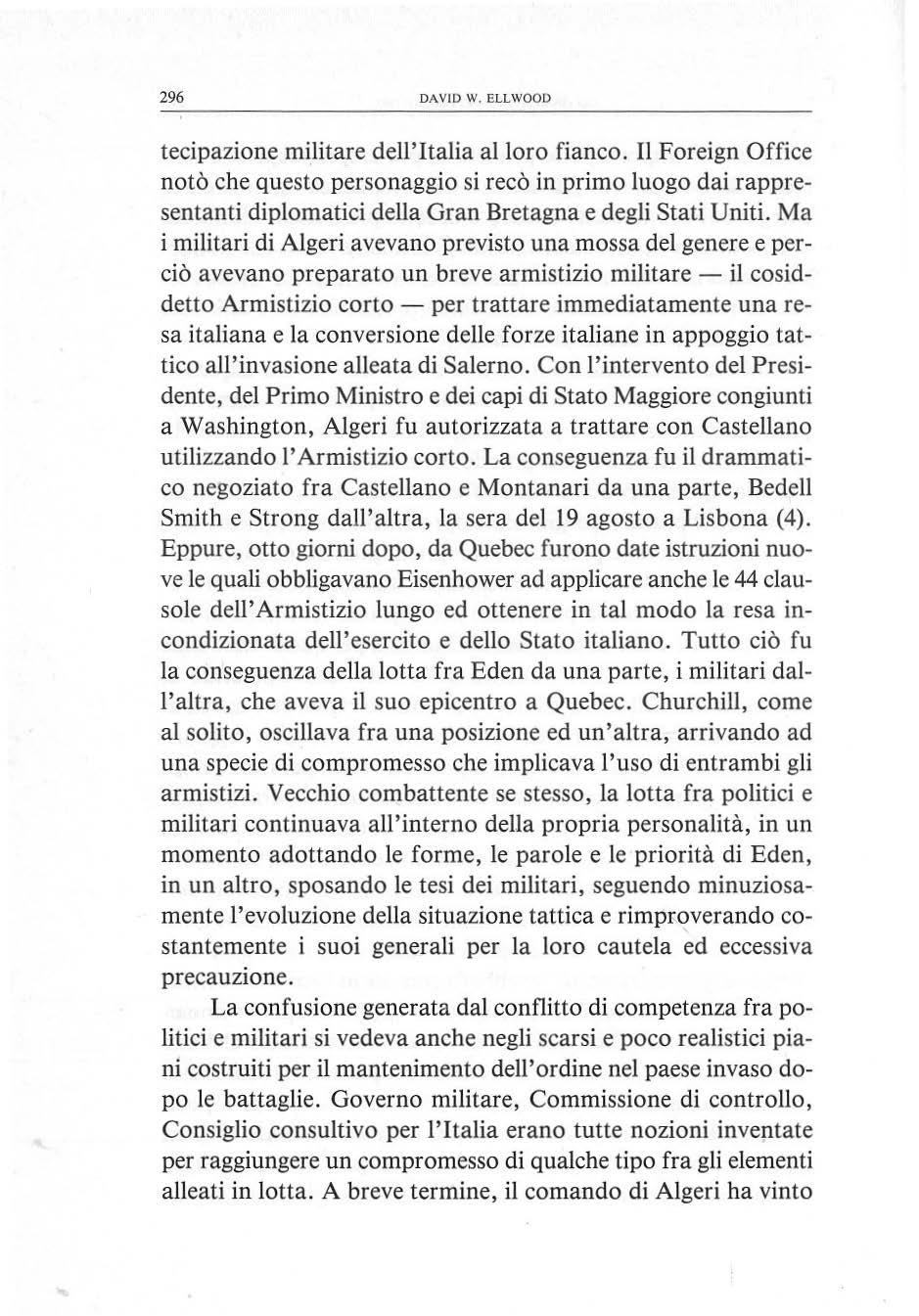
le battaglie più importanti. Pur dovendo applicare sia l'Armistizio corto che quello lungo, Eisenhower, MacMillan e Bedell Smith hanno lavorato nei limiti dei loro spazi di autonomia per ammorbidirne il funzionamento concreto e per rispettare l'esigenza italiana di mantenere uno spazio politico proprio. Lanascita delle idee di cobelligeranza fra settembre e ottobre del '43 rappresentò il culmino di questa evoluzione delle vedute del Quartiere generale alleat o e la massima estensione del suo potere. Pur dovendo cos truire a partire da novembre una vasta e complessa Commissione di controllo, secondo i desideri dell'armisti zio lungo , si fecero molti sforzi per ricostruire la capacità operativa e la legittimità dello Stato italiano. Inoltre, un altro fattore rinforzò la posizione di vantaggio dei militari: il desiderio dei sovietici di partecipare più o meno attivamente nel condurre la resa italiana. Volendo emarginare o ridurre al minimo la presenza sovietica in questo momento e in queste circostanze, Eden ed i suoi avevano il gioco facile nel dire che il comandante militare doveva determinare le relazioni della situazione senza intromissioni di potenze straniere o esterne. Rendendosi pienamente conto di questo loro vantaggio, Eisenhower, Mac Millan etc. formarono una posizione di forza unita ed efficiente in Algeri la quale, pur risentendo fortemente dei tentativi di condizionamento da parte del Ministero degli Esteri inglese e pur producendo una notevole confusione nella posizione alleata nel suo insieme - soprattutto sulla natura dei due armistizi, ha gestito con una certa efficacia la resa italiana.
Nè i nemici di guerra nè il Ministero degli Esteri inglese hanno mai dubitato sul fatto che l'Italia doveva arrendersi incondizionatamente. La resa incondizionata costituiva il principio organizzativo del lungo armistizio. I comandanti militari,
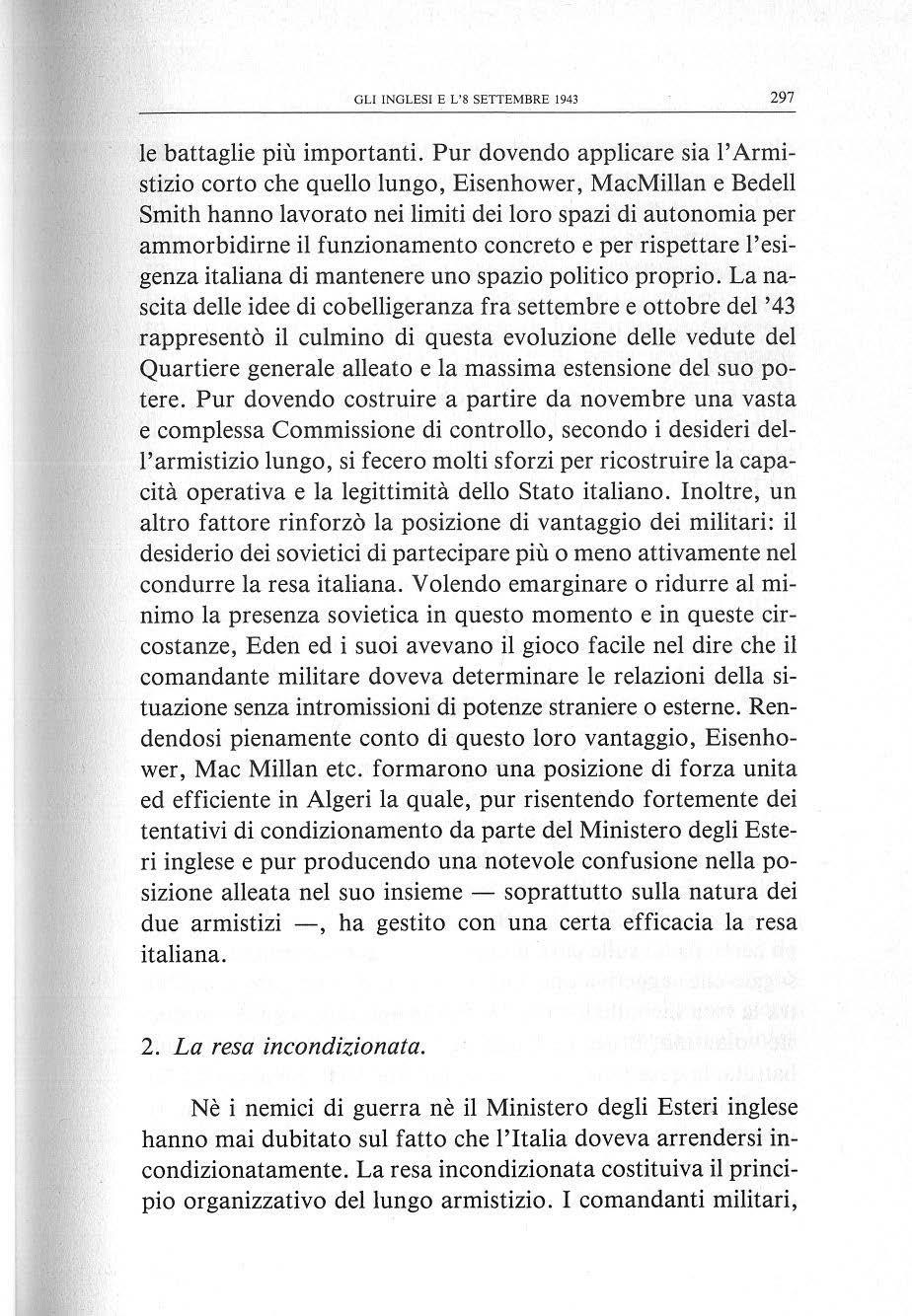
a l contrario, pensavano che uno strumento capace di suscitare la simpatia degli italiani per la causa alleata e, quindi, il loro aiuto in casi di invasione, doveva offrire una forma di resa «onorevole». Perciò essi ribadivano la differenza fra un armistizio puramente militare per garantire la fine delle ostilità e uno strumento di resa totale dello Stato e del governo del paese. Mentre, in sostanza, l'armistizio corto implicava la resa più o meno incondizionata delle forze armate, il documento non era usato pr questi fini e, secondo Eisenhower, doveva avere scopi puramente pratici ed utilitari. Ancora una volta troviamo Churchill in posizione di intermediario, dichiarando, in una nota lettera ad Eden del 9 agosto, che la pressione esagerata sulla resa incondizionata senza un minimo di prospettiva di misericordia poteva bloccare qualsiasi forma di resa (5). Fin dal 16 luglio , il comandante supremo aveva utilizzato u.na specie di promessa di resa onorevole nella sua propaganda verso l'Italia e, nella deliberazione di Quebec, veniva resa esplicita l'idea del «guadagnarsi il biglietto di ritorno» dell'ex nemico (6). A questo punto, le predisposizioni americane giocavano un ruolo fondamentale, ma gli americani non avevano piani o disposizioni precise per convertire queste disposizioni in un reale impatto sulla situazione. Il risultato era una regnante confusione e, dopo l'applicazione della firma italiana aWarmistizio lungo il 27 settembre, l'imprecisione più completa circondava la natura precisa dell'atto di resa dell'Italia. Secondo le memorie del direttore di propaganda britannica, Bruce Lockhart, venne lanciato dagli aerei alleati sulle città italiane un volant ino recante un messaggio che suggeriva una resa onorevole da una parte e dall'alt ra la resa incondizionata. Di fronte agli interrogativi su questo volan t in o , Bruce Lo ckhart non seppe far altro che dire una battuta : la questione , in fin dei conti, non veniva mai risolta (7).
Lo stesso conce tto di cobelligeranza, ancora una volta, rivelò tutta la sua a mbiguità quando si cercò di rispondere alla domanda se l 'Itali a si era arr esa incondizionatamente od onor evo lme n t e . Ch urc h ill ha sempre sostenuto che la messa a di-

sposizione della flotta italiana in sè costituiva un atto onorevole di partecipazione delle forze armate italiane a fianco degli alleati. I russi hanno sempre sostenuto le dure posizioni del Foreign Office e, in ogni contatto con l'Unione Sovietica, la formula applicata degli inglesi era quella della resa incondizionata. La forma e molti atti della Commissione di controllo alleato esprimevano il desiderio inglese di instaurare un regime di occupazione in Italia. Perfino dopo la dichiarazione di cobelligeranza, il Foreign Office diceva che - contro i desideri di Algeri - la parola «controllo» doveva rimanere nel titolo del nuovo organismo costruito per amministrare l'armistizio (8). Lo stesso sradicamento totale del fascismo, uno dei compiti ufficiali della commissione di controllo, era una conseguenza logica delle idee di resa incondizionata e, ripetutamente, gli esponenti inglesi di questa Commissione (che erano la maggioranza) dichiaravano, secondo i giudizi dei loro colleghi americani, che ·l'Italia era un nemico sconfitto in modo totale (9). Le proteste americane erano inutili: l'amministrazione era unica - inglesi e americani lavorando insieme con eguale responsabilità - e, quindi, si doveva prendere una unica direttiva. In pratica il grado di confusione era molto elevato. Le vicende diplomatiche e militari dell'8 settembre e soprattutto il comportamento di Eisenhower e dei suoi luogotenenti non si possono capire senza una piena comprensione del loro desiderio di ammorbidire, nei limiti del possibile, la applic a zione della fam igerata formula di Casablanca e del loro tentativo sempre più disperato di arruolare le forze italiane dalla propria p a rte nella emergenza della battaglia di Salerno. Il trucco di presentare prima l'Armistizio corto e poi quell o lungo, volu to dagli inglesi e poi approvato da Rooseve lt , deluse mo lto i comandanti sul luogo e creò uno stato di confusione e di incertezza nelle menti degli interlocutori italiani (10).
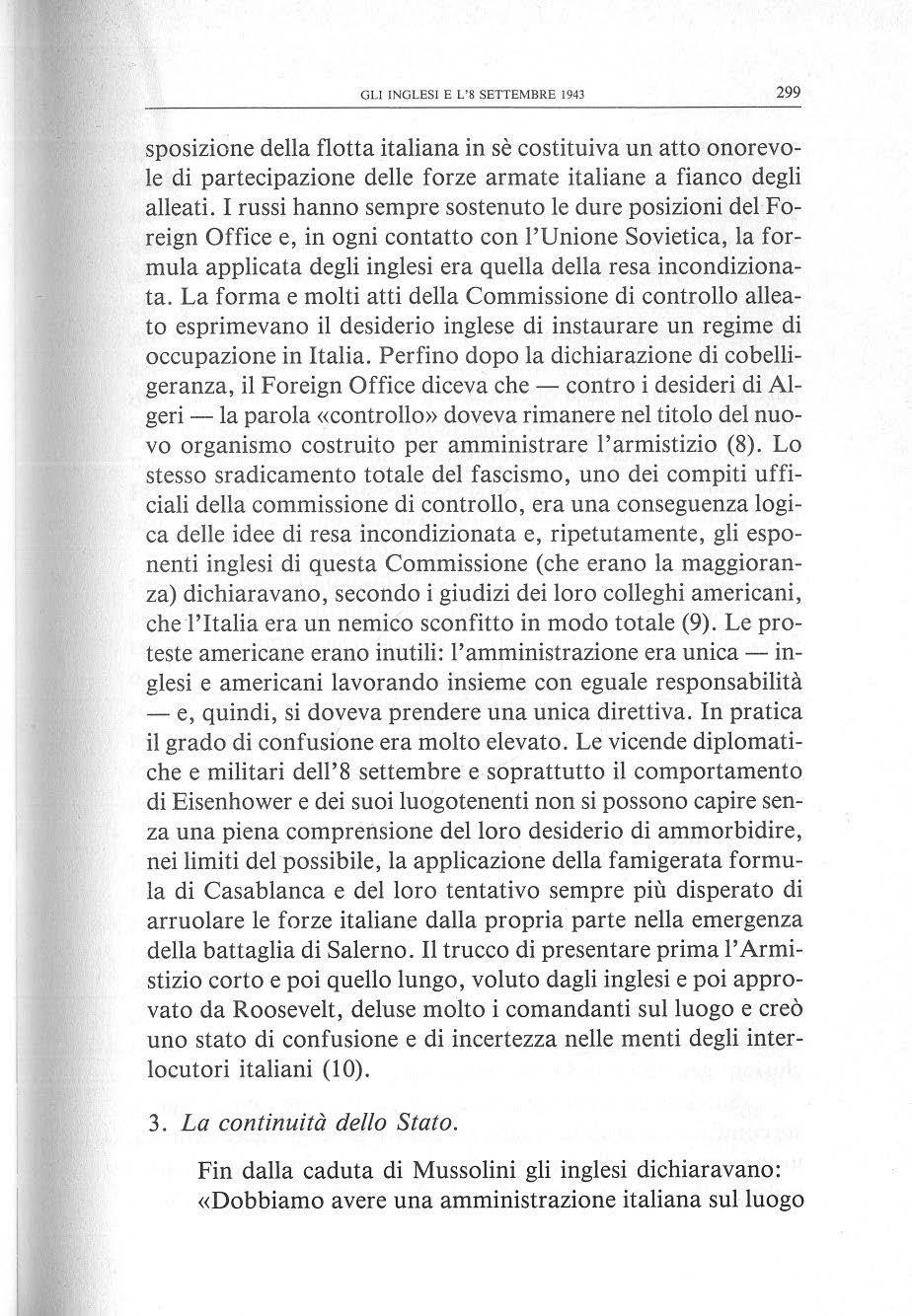
Fi n dalla cad ut a di Muss oli n i gli inglesi dic hia r av ano:
« Do b bi am o aver e u na am mini strazion e itali a na s ul luo go
con cui trattare». Il possibilismo di Churchill operava in questa sfera secondo la linea di un possibile negoziato con Badoglio e il Re senza pregiudizi per il futuro. In una lettera a Roosevelt del 31 luglio egli spiega: «La mia posizione è che, una volta scomparsi Mussolini e fascisti, io tratterò con qualsiasi autorità italiana in grado di consegnare la merce. Non ho alcun timore, a questo proposito, di riconoscere la casa SavoiaBadoglio, a condizione che essi siano quelli che possono obbligare gli italiani a fare quello di cui noi abbiamo bisogno per i nostri obiettivi di guerra. Questi obiettivi, sicuramente, sarebbero ostacolati dal caos, dal bolscevismo o dalla guerra civile. Non abbiamo alcun diritto di imporre delle difficoltà ulteriori alle spalle dei nostri soldati. Può darsi che, una volta accettato l'armistizio, sia il Re che Badoglio affondano nella vergogna della resa e che un luogotenente ed un nuovo Ministero possano emergere» (11). Mentre i sentimenti dell'opinione pubblica e del Parlamento in Inghilterra militavano sicuramente contro una trattativa prolungata per non riconoscere il governo Badoglio, il Foreign Office aveva previsto, fin dalla caduta di Mussolini le necessità politiche e diplomatiche che avrebbero reso necessarie la permanenza del Re e del suo Primo Ministro al vertice dello Stato. Mentre Churchill, nei primi istanti dopo la caduta di Mussolini, sognava una nuova Italia antifascista, il Foreign Office preparava un documento che il Primo Ministro aveva letto parola per parola nella sua dichiarazione alla Camera dei Comuni il 27 luglio. In quel momento ~hurchill dichiarò: «Noi non sappiamo cosa accadrà in Italia. Ora che Mussolini se n'è andato e una volta che il potere fascista è sicuramente ed inevitabilmente distrutto, saremmo incauti se dovessimo fare a meno di qualsiasi mezzo possibile per arrivare a conclusioni generali con la nazione italiana.
«Sarebbe un errore grave, quando l e vicende sono in queste condizioni flessibili, fluide, formative per le potenze venute in soccorso, Gran Bretagna e Stati Uniti, agire in modo tale da rompere l'intera struttura ed espressione dello Stato italiano».

La liberazione, continuò Churchill, doveva rimanere come tale e non trasformarsi in un sistema di occupazione con un governo tipo Quisling o in un sistema completo di amministrazione e di mantenimento della legge dell'ordine (13). Churchill non aveva mai nascosto il suo rispetto per le istituzioni monarchiche, persino nella versione italiana e, apparentemente, continuò a credere fino alla morte che soltanto Mussolini era responsabile del disastro italiano sul piano militare. Da questo punto di vista, 1'8 settembre fu imbarazzante per i disegni inglesi. Mentre la flotta era arrivata con grande rischio e gravi perdite in mano agli inglesi, lo Stato come tale era crollato e il Re ed il Primo Ministro si erano precipi t ati in una fuga umiliante verso la salvezza della costa orientale.

Quello che salvò il Re e Badoglio era l'aggravarsi della situazione militare da una parte e l ' assenza di un qualsiasi protagonista delle forze antifasciste capace di parlare in nome di un'altra Italia dall'altra. Con la scoperta dell'intenzione dei tedeschi di combattere metro per metro in Italia e con h presa di coscienza più o meno s im ultanea che le forze della Germania erano capaci di difendere i Balcani e di combattere in altre zone del Mediterraneo, ·la situazione strategica divenne sempre più delicata.
La conseguenza più diretta era la necessità di utilizzare sia le forze militari italiane che le nascenti forze della Resistenza fino ai limiti del possibile. In pratica i limiti del possibile erano estremamente ristretti , ma senza l'autorizzazione del Re e del Primo Ministro nessun rapporto con queste forze fu possibile. All'antifascismo italiano, a questo punto, si offrirono grandi opportunità. Ma a sfruttare l'occasione fu presente solo il conte Sforza il quale ritornò alla fine di settembre dagli Stati Uniti. Nessuno dei due grandi leaders e tanto meno Churchill prendevano s ul serio la credibilità politica del conte Sforza, vedendo in lui uno dei tanti pretendenti alla guida di un gruppo di forze politiche es tremament e ambigue ed evanescenti con legami debolissimi con la popolazione italiana (13). L'imprepara-
zio ne delle forze politiche ed antifasciste per l'appuntamento dell'8 settembre e del periodo successivo divenne a quel punto evidente. Ancora una volta fu la dichiarazione di cobelligeranza a coprire la confusione ed a salvare la faccia agli alleati anglosassoni ed allo Stato italiano. Vaghi erano gli aiuti dati e quelli richiesti; vaghi erano i diritti dello Stato ricostituito rispetto ai due armistizi che rimanevano in forza. L'Italia aveva la sua promessa di libere elezioni democratiche dopo la fine del conflitto. Nel frattempo il suo comportamento e status sarebbe stato giudicato secondo i risultati. Oltre i governi inglese ed americano non erano disposti ad andare, se non per costituire la Commissione di controllo alleato come impalcatura dello Stato tradizionale. All'infuori di essi, Churchill, Eden e soprattutto l'energico ambasciatore inglese nel Vaticano, Sir D' Arcy Osborne, vedevano soltanto anarchia, caos ed il rischio di «bolscevizzazione». Il capo dei bolscevichi, Giuseppe Stalin, intanto era un alleato temuto, rispettato e considerato ind ispensabile. Riconoscere il Re e Badoglio era una mossa che Churchill aveva promesso di non fare. Solo con le promesse più dure sui limiti ai diritti italiani e sull'applicazione inequivocabile degli armistizi, gli alleati anglosassoni erano riusciti ad ottenere il consenso sovietico alla cobelligeranza ed alla continuità del loro rapporto con il Re e con Badoglio (14).
4. Centralità dei rapporti con l'Unione Sovietica.
I termini essenziali del rapporto fra Gra n Bretagna e Unione Sovietica a questo punto della guerra eran o delineati con gran franchezza mediante uno scambio di lettere fra il generale Smuts e Churchill durante la fine di agosto e l ' in izio di settembre.
Affermando ripetutamente che gli sforzi d i guerra degli alleati angloamericani su terra erano assolu t amente insignificanti rispetto a quelli realizzati dall'esercit o ro sso, Smuts vedeva - p r endendo per scontato anche lu i l' immin ente fine dell a guer-

ra - pericoli sempre più visibili per l'equilibrio geopolitico fra l'Unione Sovietica e le altre potenze in Europa, una volta terminata la guerra. Egli sottolineava la contraddizione sempre più evidente fra le vaste risorse materiali che inglesi ed americani sembravano capaci di costruire ed il prodotto insignificante e misero di questi sforzi su terra (egli non metteva in dubbio le capacità della marina e delle forze aeree). Churchill replicava a Smuts, il 5 settembre, che non c'era da dubitare sul fatto che l'Unione Sovietica sarebbe divenuta una potenza suprema dopo la guerra e che si trattava, quindi , di riconoscere questa realtà ed imparare vivere con essa (15). Partendo da premesse simili , Anthony Eden , nel luglio del '43, aveva cominciato a disegnare sistemi di consulenza diplomatica e geopolitica con i ru ss i i quali avrebbero equilibrato la presenza deg li angloam erica n i nella sfera di conquista russa e , in modo simile, la presenza russa nelle zone di conquista angloamericana da quel momento della guerra in poi (16). Mantenere forme di collaborazione e di consulenza politiche con l'Unione Sovietica divenne l'asse centrale della condotta britannica. Sul piano della politica estera , Eden dichiarò nei giorni caldi di settembre che le porte dovevano essere mantenute aperte (17). Come mai, quindi, i russi hanno contribu ito così poco all'evolversi della situazione in Italia in quei tempi? I russi erano stati informat i, durante le settimane estive, dei disegni dell'armistizio britannico , e non si erano mai opposti ai suoi contenuti. Ma nel tentativo di venire incontro alle indicazioni di luglio di Eden, Stalin aveva proposto l'instaurazione di una commissione militare politica nel Mediterraneo per la sovrintendenza della liberazione ed occupazione dei territori nemici (18). Gli americani non potevano ac cett a re strutture soprannazionali simili, almeno non s e nza u n pro lungato dibattito politico in terno che Roose velt era d eterminato ad evitare a tutti i costi. Allo stesso tempo la p ro posta di Stalin per una commissione nel Medit errane o, me tteva in dubbio la catena di comando che passava direttam ent e d a l Presidente al Primo Ministro attraverso i capi di Stato Magg io re congiunti
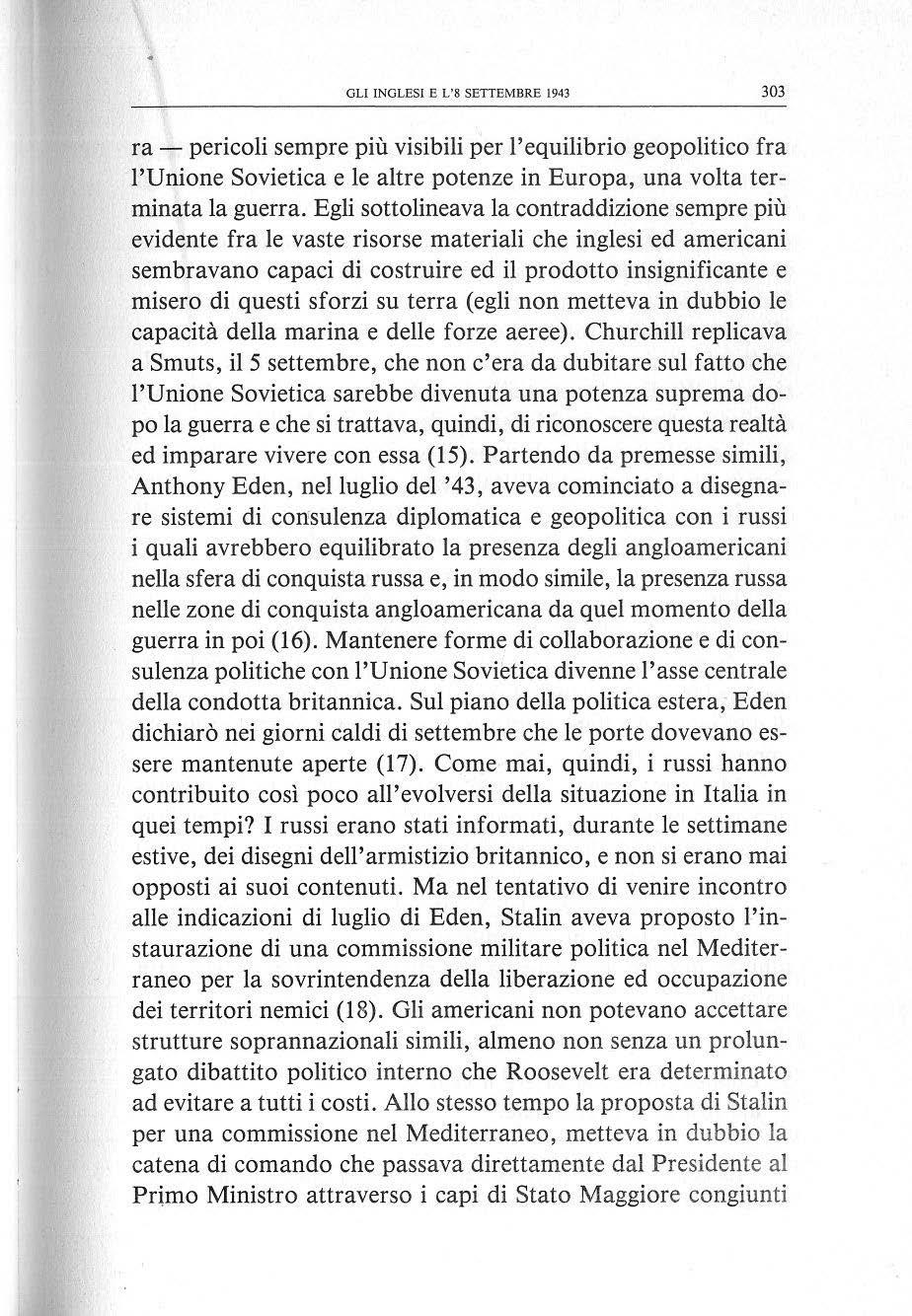
a Washington ai comandanti nel campo. Il 6 settembre, dopo diverse discussioni sull'argomento, in un discorso pubblico in Canada, Churchill sottolineò con vigore il valore del sistema dei capi di Stato Maggiore congiunti indicandolo come modello di controllo da seguire anche dopo la fine delle ostilità (19). Egli ribadì in privato che non era possibile condurre una battaglia e consultare i sovietici ogni momento. Nonostante la successiva inclusione di un delegato sovietico nel consiglio consultivo per I' Italia e la riconciliazione fra tutti gli alleati alla successiva conferenza dei Ministeri e dei Ministri degli Esteri a Mosca, la strada verso l 'esclusione di ogni reale partecipazione sovietica alla liberazione dell'Italia era a questo punto già avviata. In verità, a Londra si sperava di mantenere diversi canali aperti verso l'Unione Sovietica e di non pregiudicare alcun t ipo di accordo con i russi. Manca tuttora una visione complessiva dell'approccio inglese al problema della Russia nella seconda parte della seconda guerra mondiale e molte sono le indicazioni - la più famosa è quella dell'accordo di percentuali del dicembre ' 44 - che gli inglesi speravano fino alla fine in una specie di divisione delle sfere d'influenza dell'Europa nel momento più opportuno (20).
Ma la mancanza di forze strategiche britanniche e la dipendenza politica ed economica della Gran Bretagna dagli Stati Uniti non permettevan o agli inglesi di raggiungere alcun tipo d i accordo costruttivo anche se i sovietici l'avessero voluto. Una delle maggiori incognite dell'8 settembre riguarda il preciso atteggiamento delle autorità militare e politica americana e britannica intorno al problema sovietico al momento della resa italiana.
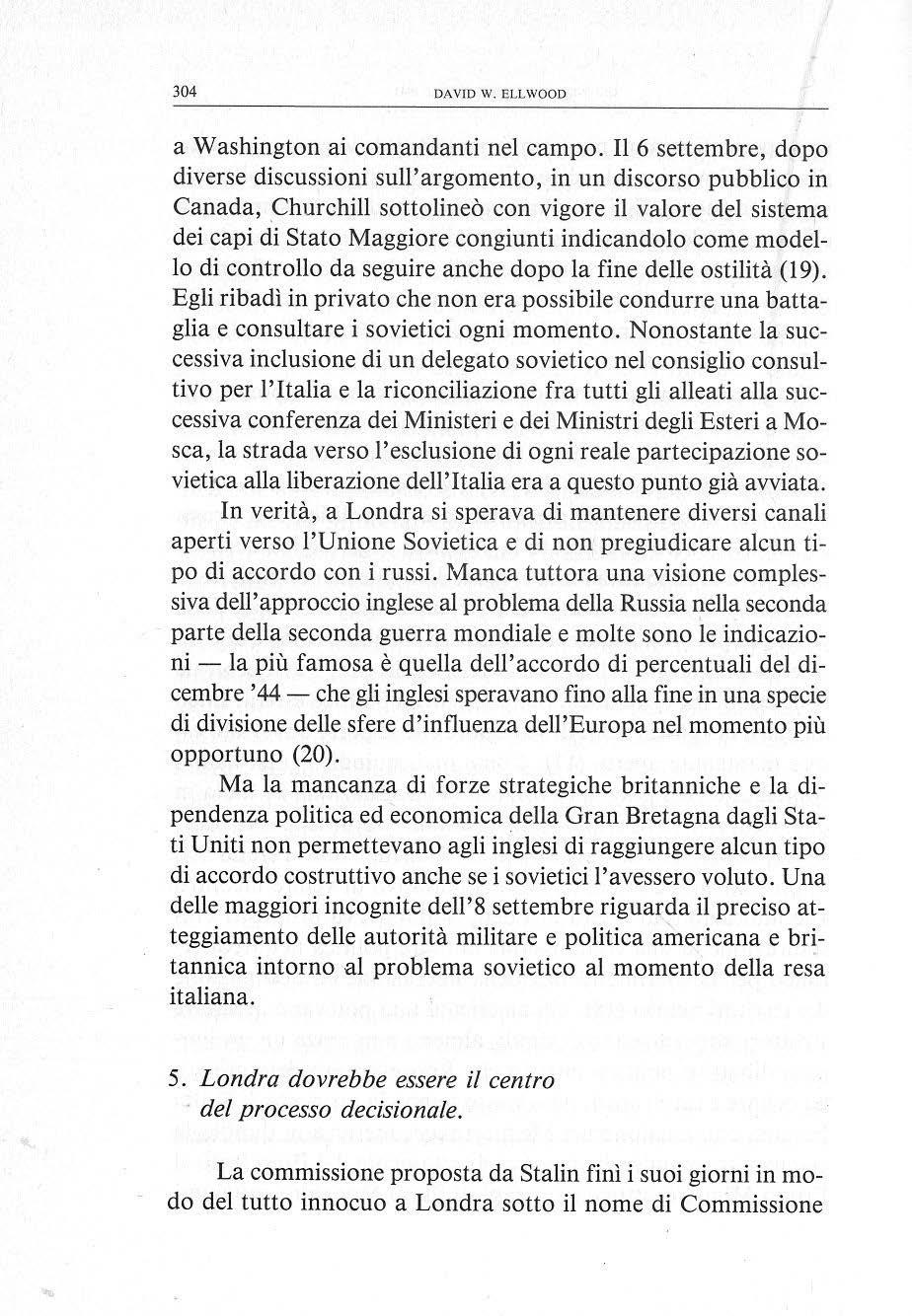
5. Londra dovrebbe essere il centro del processo decisionale.
La commissione proposta da Stalin finì i suoi giorni in modo del tutto innocuo a Londra sotto il nome di Comm issione
consultiva per l'Europa e questo fu uno dei pochi risultati che gli inglesi riuscirono ad ottenere dalla conferenza dei Ministri degli Esteri di Mosca. Nonostante la diffidenza per ogni processo decisionale fuori dalla propria por t ata, il Foreign Office non possedeva la forza politica di imporre altre scelte sul comando militare e tanto meno sull'amministrazione di Roosevelt. Tuttavia, nella burocrazia permanente di Whitehall perdurava la diffidenza alquanto profonda per i processi decisionali instaurati a Washington e ad Algeri. A Wa shington esistevano, oltre ai capi di Stato Maggiore congiunti, il Combined Civil Affairs Committee , comitato congiunto per gli affari civili, un organismo che doveva pianificare l'amministrazione dei territ ori nemici occupati. Questi comitati erano governati dai militari americani nei quali il War Office britannico ed il Foreign Office vedevano numerosi nemici. Mentre non si sa con molta precisione quale fosse lo stato dei rapporti tra Foreign Office e Dipartimento di Stato, non ci sono dubbi che riguardo al problema Italia il Foreign Office aveva poca pazienza per i punti di vista dell'Establishment di Washington. I militari della capitale americana sembravano incapaci di formulare un punto di vista realistico e unanime sul futuro dell'Italia. Gli americani non erano in grado di formulare la propria versione di un armistizio che non fosse quello di Eisenhower (21). Sopra ogni cosa e con un potere supremo ed assoluto regnava la figura di Roosevelt verso il quale i funzionari inglesi mostravano una commistione non insolita di rispetto, ammirazione e disprezzo. La battaglia furiosa intorno a Roosevelt tra isolazionisti ed internazionalisti contrastava enormemente con la forza unita dell'opinione pubblica inglese e sembrava dimostrare a Londra l'immaturità in politica internazionale dell'opinione pubb lica americana. Roosevelt stesso con la sua difficile ed ottusa insistenza nell'evadere i problemi politici, rinviandoli alla fine del conflitto per minimizzare i confli t ti e le possibilità di dibattito, confermava agli occhi del Foreign Office la presenza di certi impulsi demagogici e populisti. La lotta, a volte poco dignito-
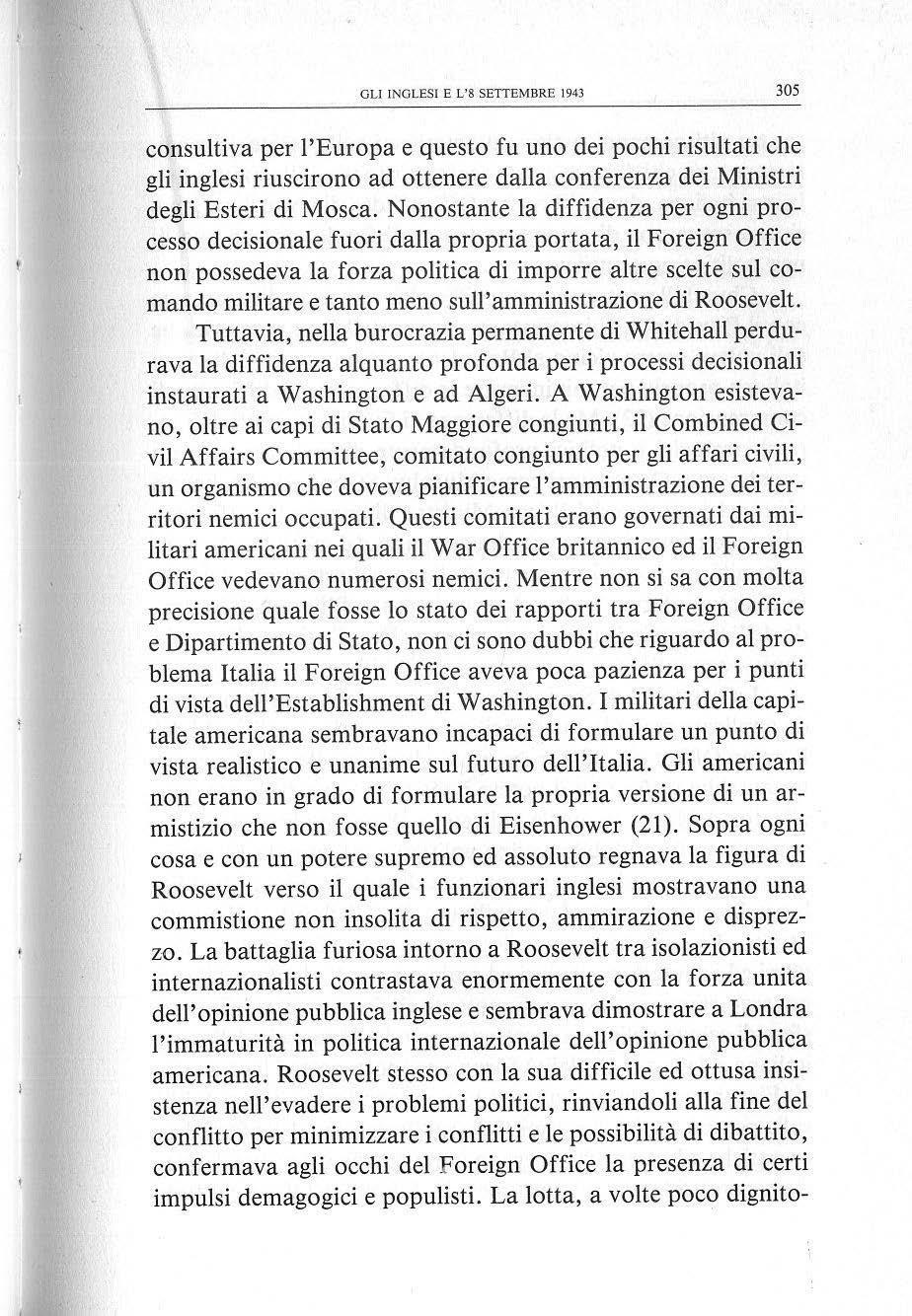
sa, tra alti comandi inglesi ed americani sulla s trategia mediterranea, su chi doveva essere senior partner e su lla natura della resa italiana , dava al Foreign Office l'idea di una azione americana senza una direzione strategica di fondo e senza una linea politica costruttiva.
Churchill superava queste difficoltà trattando direttamente con il Presidente. È interessante notare dalle sue memorie che egli voleva essere vicino al Presidente nel momento della resa italiana proprio per minimizzare le differenze e le difficoltà di comprensione (22). Ma le differenze di fondo, prodotti di interessi strategici e politici profondamente di ver si, rimanevano ugualmente. Osservatori come Murphy, Strong ed altri hanno visto nel tentativo del Primo Ministro di coprire le differenze ed i compromessi che ne risultavano uno dei motivi delle «opportunità perse» del momento italiano nel settem bre del '43. In realtà , fintantochè Londra persisteva nell'impossibile strada dell'egemonia britannica in questa s fera d'azione alleata, la con fusione e l'insuccesso erano inevitabili.
La proposta di Stalin di una Commissione mediterranea, da applicare secondo lui in Sicilia, era pericolosa agli occhi del Foreign Office per un altro motivo oltre a quello già presentato: avrebbe rinforzato il potere politico del quartiere generale alleato ad Algeri. In quella sede com e abbiamo visto, si era costru ita una formidabile equipe politico e militare da Eisenhower come comandante supremo con deputati politici MacMillan e Murphy e, sul piano militare, Bedell Smith e Kenneth Strong. Per questo gruppo, le trattative con Castellano e Zanussi ed i contatti pericolosi ed ambigui con Badoglio ed il suo governo rappresentavano un potente rinforzamento della loro s fera di azione politica, soprattutto quando l'annuncio della resa italiana e delle sue modalità furono condotte sotto i loro auspici. Eisenhower e la sua squadra non na scondevano i loro dubbi su lla procedura dei due armi stizi e sull'irrealismo delle forze burocratiche a Londra che avevano imposto una soluzione di questo genere, ai loro occhi ingannevole. Il Foreign Office contrat-
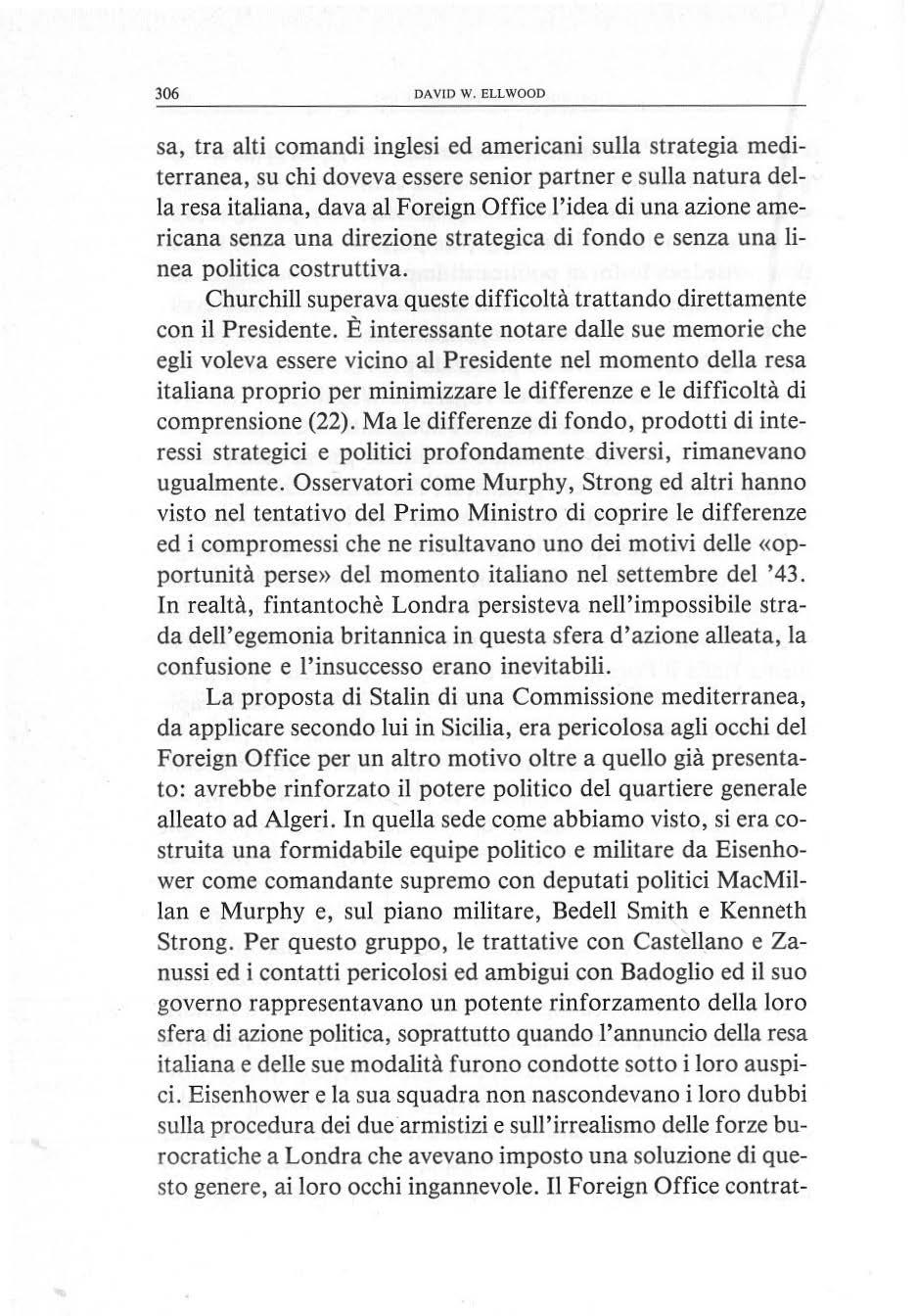
taccava, secondo i suoi piani, insistendo sulla costruzione del Consiglio consultivo per l'Italia che coinvolgeva gli alleati minori, soprattutto Grecia e Jugoslavia, con Francia ed i Dominions, nel governo dell'Italia. Probabilmente Eden ed i suoi funzionari avrebbero coinvolto i rappresentanti di questi paesi anche nella resa stessa ma non osavano; una tale mossa non poteva essere contemplata senza la diretta inclusione di un rappresentante sovietico.
6. L'Italia precedente per l'organizzazione del dopoguerra in Europa.
Non è storicamente chiaro in che misura le vicende italiane abbiano costituito un precedente reale per il trattamento delle altre zone dell'Europa liberate dalle forze del nazifascismo. È interessante constatare che l'occupazione della Germania, 18 mesi dopo, è stata condotta secondo una divisione rigorosa in zone di presidenza nazionale, a differenza del caso italiano dove regnavano le forze congiunte delle due potenze angloamericane. Al momento dell'8 settembre e nel periodo precedente e in quello successivo a questa data, le burocrazie permanenti di Washington e di Londra speravano che questa svolta potesse e dovesse rappresentare un precedente per i compiti in avvenire. Più che di precedente si trattava di una prova degli obiettivi, dei metodi e dei rapporti di forze all'interno del campo alleato intorno al problema di quali linee nazionali avrebbero prevalso nell'organizzazione del dopoguerra in Europa. I sovietici, indubbiamente, vedevano il caso italiano in term ini di precedenti. L'impossibile combinazione fra inglesi ed americani da una parte e Badoglio ed il Re dall'altra, era, secondo loro, la minaccia di un futuro accordo di qualsiasi tip o con i resti del regime nazista in Germania (24). Per organizzare i loro piani per i territori liberati, gli inglesi possede vano almeno due strutture di importanza particolare: The Administration of Territo-
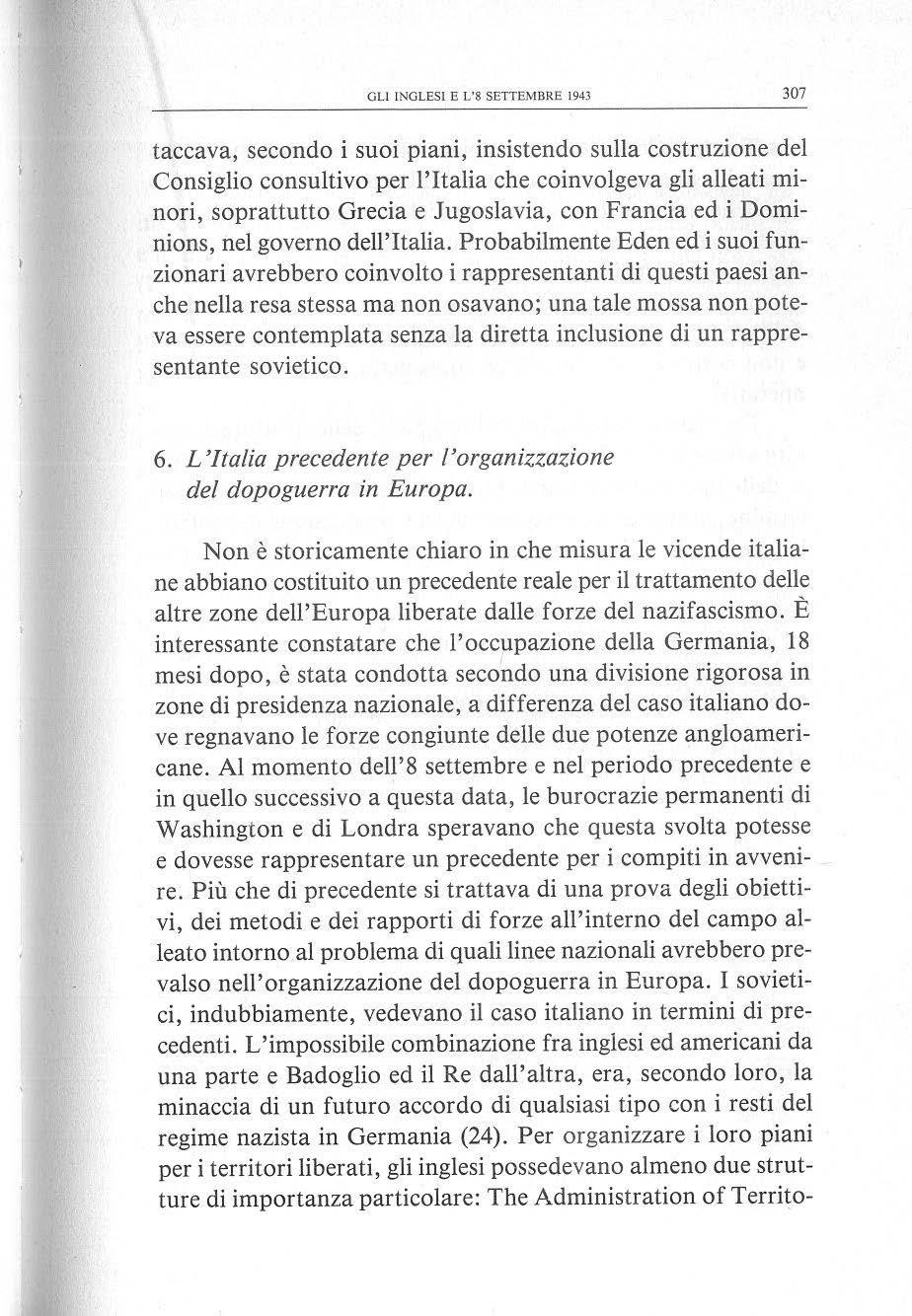
ries (Europe) Comrnittee, capeggiata da Attlee e condotta in presenza di osservatori americani; poi il Dipartimento dell'Economia della ricostituzione all'interno del Foreign Office. Gli americani, per conto loro, possedevano notevoli strutture di pianificazione della politica estera all'interno del Dipartimento di Stato e in organismi come il Council of Foreign Relations. Le loro delibere, al contrario, di quelle inglesi, erano piuttosto astratte e non costituivano uno sforze coordinato per produrre piani operativi.
Sappiamo poco degli sforzi compiuti, delle strutture di pianificazione inglesi e tanto meno del loro impatto sulla condotta delle operazioni in Italia. Indubbiamente il disegno a lungo termine, in special modo quello della Commissione di controllo, era in gran parte prodotto dall'ambiente dell' Administration of Ter ritories (Europe) Committee attraverso i funzionari competen ti del Foreign Office. Era un caso imbarazzante che gli alleati non potessero pubblicare nè l'Armistizio corto nè quello lungo. Essi non avevano dubbi circa la negatività dell'effetto che queste dure condizioni avrebbero prodotto sull'opinione pubblica. Il precedente it aliano era scoraggiante ed era, quindi, compito dei rappresentanti supremi politici di recuperare la situazione. Da qui ne risultò l'insistenza di Roosevelt e di Churchill su l fatto che la resa poteva avere i suo i aspetti onorevo li, c he gli italiani avevano la possibilità di riguadagnare il loro posto fra le nazioni mondiali e soprattutto che la promessa delle libere elezioni democratiche sarebb e stata mantenuta. Ma i dubbi inevitabilmente rimanevano. Quale era l'atteggiamento che rifletteva veramente quello angloamericano? Le condizioni durissime dell'armistizio, seppur modificato ambiguamente da Roo sevelt? Oppure le promess e e gli incoraggiamenti del Primo Ministro e del Presidente? Data l'impossibilità di capire la situazione all'interno dell'Italia, il precede nte politico costituito da questa esperienza è indubbiamente di scarso valore, visto col senno del poi.
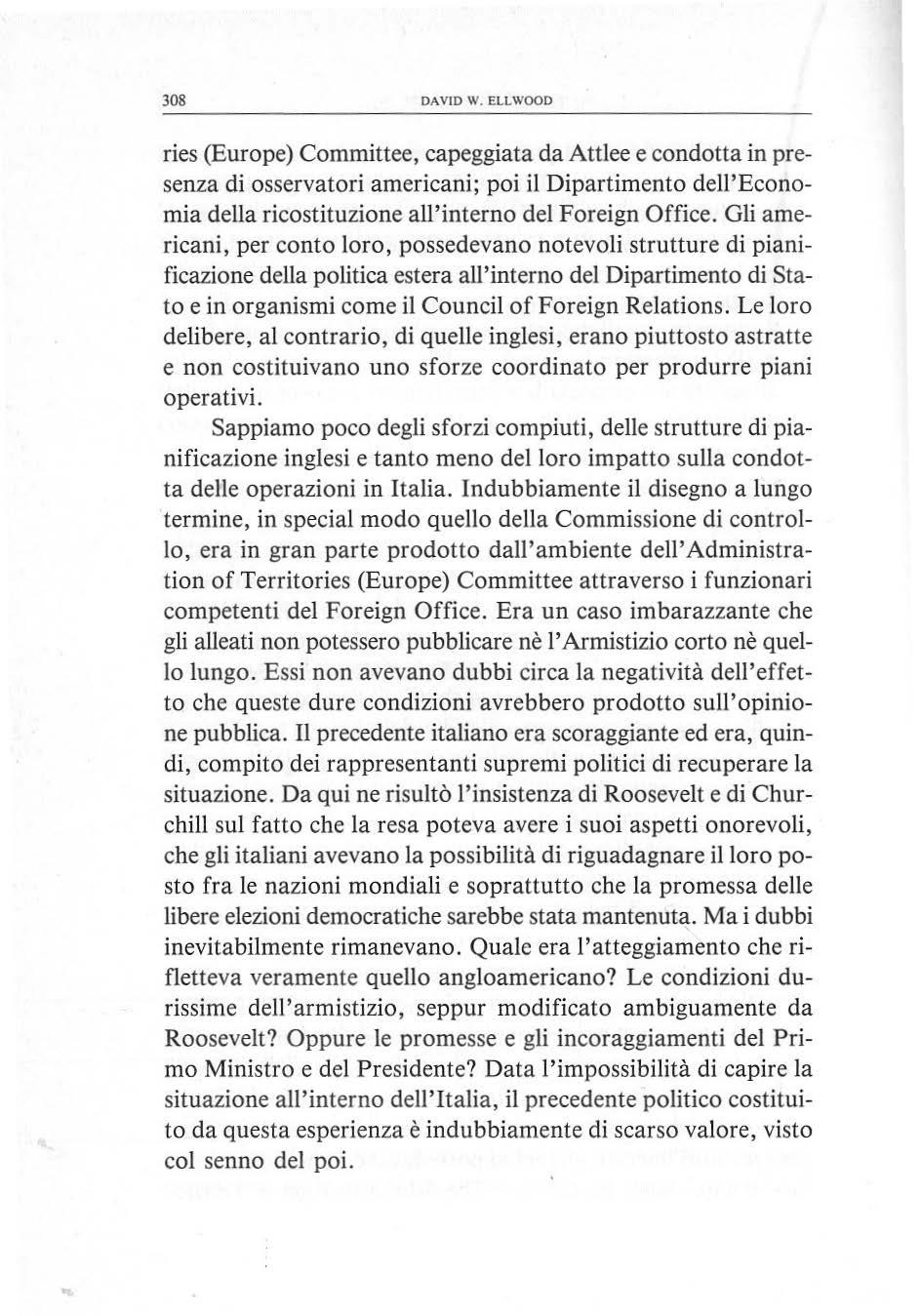
Nel giro di poche settimane, a partire dall'8 settembre, gli inglesi furono costretti ad ammettere che le difficoltà politiche e militari presenti in Italia erano molto più grosse del previsto (25). Sperando in un rapido avanzamento, l'eliminazione dei tedeschi, la sconfitta chiara ed inequivocabile degli italiani e poi l'instaurazione di una Commissione di controllo politico e militare per organizzare una rapida transizione verso una situazione di dopoguerra, gli alleati dovevano far fronte invece al nemico ben insediato, al concetto ambiguo di cobelligeranza e ad un popolo incerto se aiutare almeno le forze alleate. Non esisteva un unico, complessivo atteggiamento alleato per guidare l'opinione pubblica in Italia e dirigere la vita italiana su basi nuove. Nonostante la propaganda , la distanza fra le varie posizioni in campo era troppo grande per poter esprimere un punto di vista univoco e chiaro . Fra Londra e Washington, fra politici e militari, fra angloamericani e sovietici, troppe erano le poste in gioco per favorire un'atteggiamen t o semplice e diretto davanti al caos dell'agosto-settembre 1943.
Detto questo, bisogna sottolineare che le vicende di questi giorni richiedono tuttora ulteriori indagini per risolvere alcune delle più importanti incognite rimaste. Abbiamo indicato alcuni degli interrogativi riguardanti i rapporti con i sovietici. È chiaro che, all'interno del vertice italiano, il caos e l'incertezza di quelle settimane hanno lasciato questioni e dubbi che esigono una risposta. In particolar modo, la propaganda angloamericana di questo periodo meriterebbe una più ampia indagine. La sua evoluzione in relazione agli avvenimenti politici e militari, la sua oscillazione tra posizioni estremamente promettenti e la copertura di realtà ben più dure sono chiare. Occorrono un esame dettagliato delle vere prese di posizione all'interno della macchina propagandistica ed una spiegazione di come le lotte descritte in queste pagine si siano riversate sui fabbricatori di messaggi, di slogano per il consumo del popolo italiano. Il lavoro dei servizi di Intelligence rimane alquanto oscuro. In che modo
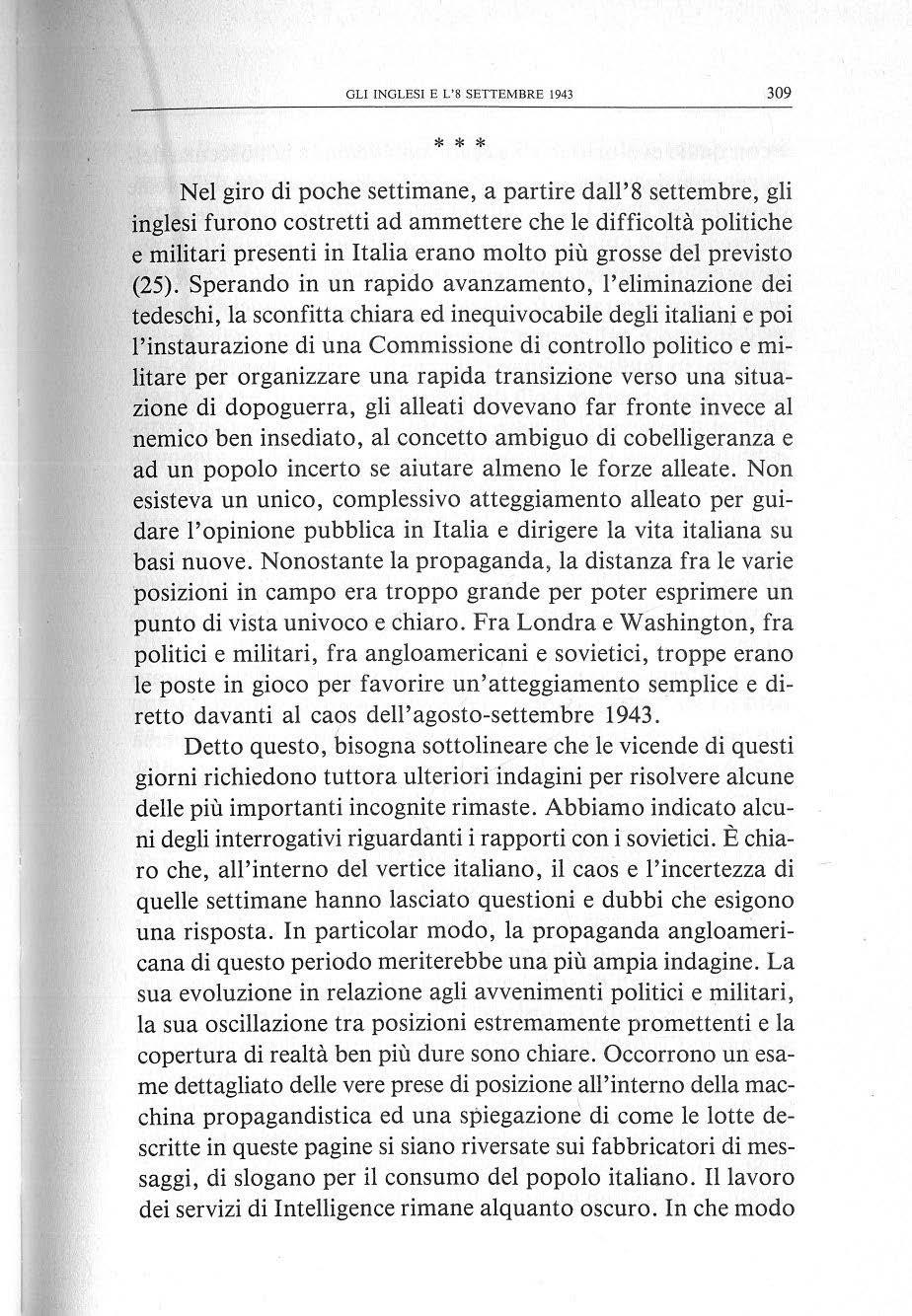
e con quale evoluzione gli alleati sono venuti a conoscenza dello sviluppo della presenza tedesca? Cosa hanno saputo della reale disposizione delle forze italiane e del rapporto tra forze italiane e tedesche? Quali erano le fonti angloamericane sulla situazione politica all 'interno del paese in questi tempi e come e in quale momento tali informazioni possono aver inciso sull'atteggiamento e sul comportamento degli alti comandi angloamericani in queste settimane? In campo inglese sarebbe necessario conoscere ancora più dettagliatamente i rapporti fra Churchill ed il gabinetto di guerra da una parte e il Foreign Office dall'altra, circa la questione italiana, soprattutto in rapporto al disegno degli armistizi e sulla loro elaborazione in relazione agli americani. I capi di Stato Maggiore britannici rappresentavano un altro polo del potere di Londra da indagare, mentre poche sono le indicazioni che hanno finora emesso sull'atteggiamento dell'opinione pubblica e del Parlamento su queste vicende.
L'atteggiamento di fondo ed il tono più normalmente usato del Foreign Office si possono ritrovare in un documento del 20 settembre che discuteva la proposta di cobelligeranza emersa dal quartiere generale di Algeri. Tale documento rappresentava una dura presa di posizione contro l'allargamento del campo alleato per includere il governo del Re e del Badoglio come desiderato da Eisenhower e da MacMillan. I paragrafi centrali del documento suonano come segue: «Noi abbiamo sempre previsto che il maresciallo avrebbe tentato di raggiungere lo status di alleato o di quasi alleato. È naturale che come parte di questa manovra egli disse in quel momento che l'Italia voleva dichiarare guerra alla Germania. Il maresciallo sa che solo in questo modo l'Italia può sperare di riguadagnare il suo posto nel mond o del dopoguerra. L'implicazione è che solo attraverso la concessione di questo status il maresciallo può organizzare il popolo italiano in una resistenza attiva contro i tedeschi. I capi di Stato inglesi sono assolutamente convinti che il valore degli italiani come combattenti attivi è trascurabile.
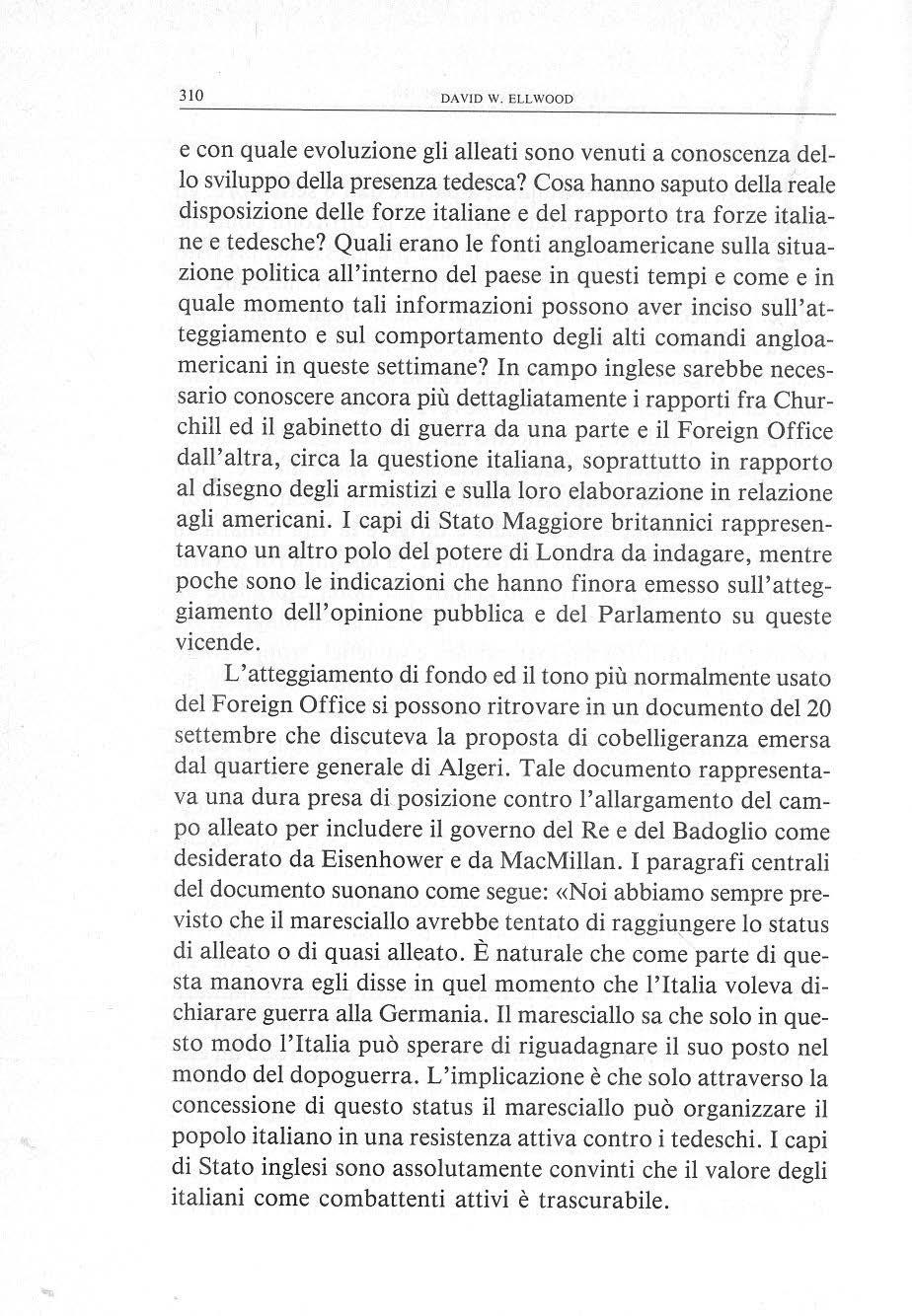
«Il generale Eisenhower ha presentato il caso come se l'alternativa consistesse in una belligeranza italiana attiva e mancanza di cooperazione, dichiarando che avere gli italiani come combattenti attivi potrebbe creare una differenza fra il successo completo ed il successo parziale nella campagna che abbiamo davanti in Italia.
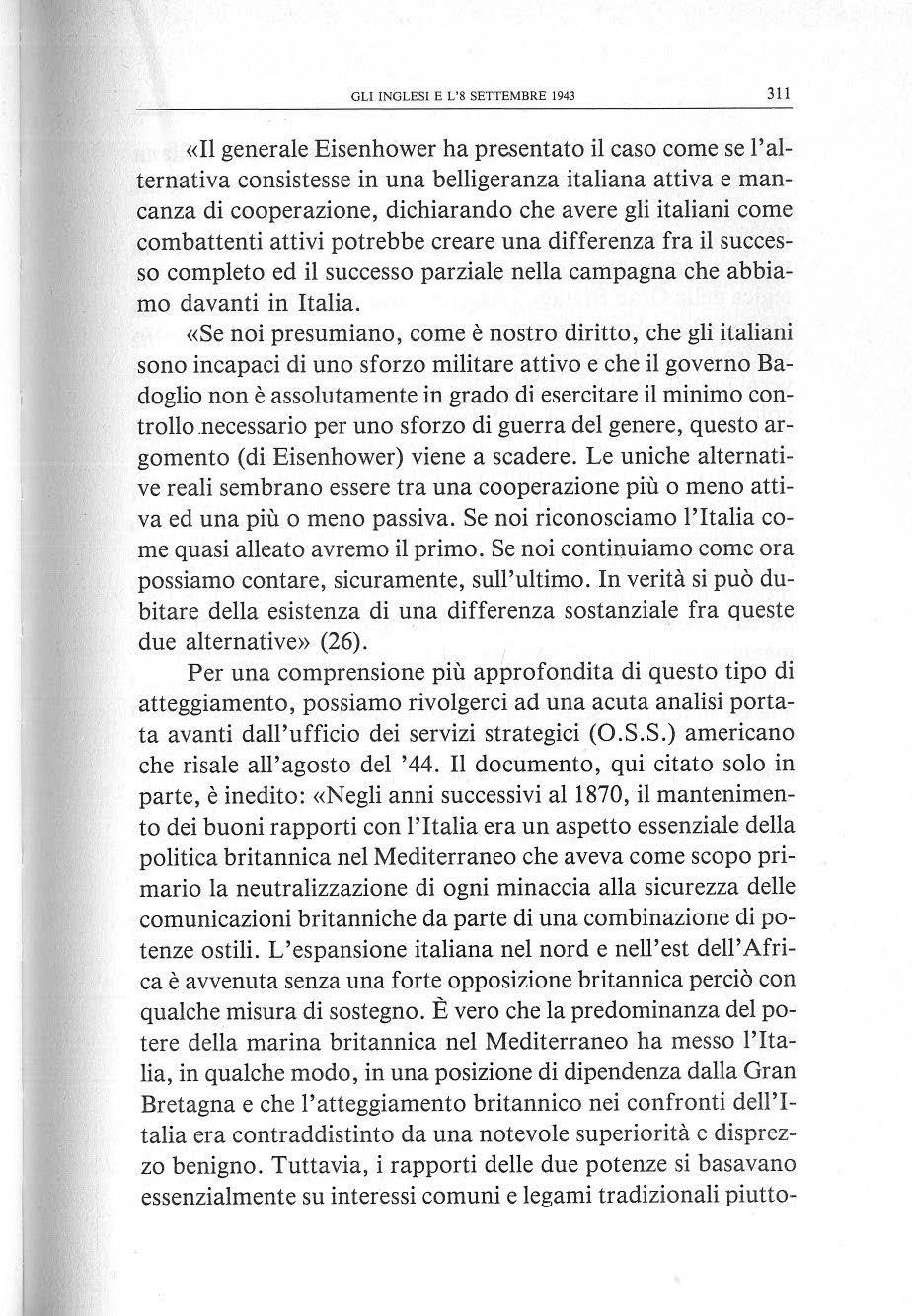
«Se noi presumiano, come è nostro diritto, che gli italiani sono incapaci di uno sforzo militare attivo e che il governo Badoglio non è assolutamente in grado di esercitare il minimo controllo .necessario per uno sforzo di guerra del genere, questo argomento (di Eisenhower) viene a scadere. Le uniche alternative reali sembrano essere tra una cooperazione più o meno attiva ed una più o meno passiva. Se noi riconosciamo l'Italia come quasi alleato avremo il primo. Se noi continuiamo come ora possiamo contare, sicuramente, sull'ultimo. In verità si può dubitare della esistenza di una differenza sostanziale fra queste due alternative» (26).
Per una comprensione più approfondita di questo tipo di atteggiamento, possiamo rivolgerci ad una acuta analisi portata avanti dall'ufficio dei servizi strategici (O.S.S.) americano che risale all'agosto del '44. Il documento, qui citato solo in parte, è inedito: «Negli anni successivi al 1870, il mantenimento dei buoni rapporti con l'Italia era un aspetto essenziale della politica britannica nel Mediterraneo che aveva come scopo primario la neutralizzazione di ogni minaccia alla sicurezza delle comunicazioni britanniche da parte di una combinazione di potenze ostili. L'espansione italiana nel nord e nell'est dell' Africa è avvenuta senza una forte opposizione britannica perciò con qualche misura di sostegno. È vero che la predominanza del potere della marina britannica nel Mediterraneo ha messo l'Italia, in qualche modo, in una posizione di dipendenza dalla Gran Bre t agna e che l'atteggiamento britannico nei confronti dell'Italia era contraddistinto da una notevole superiorità e disprezzo benigno. Tuttavia, i rapporti delle due potenze si basavano essenzialmente su interessi comuni e legami tradizionali piutto-
sto che su una qualsiasi forma di sottom issione italiana obbligata».
Ma con l'avvento del fascismo, continuano gli analisti de l1'0.S . S., tutto ciò era cambiato: «L'ascesa del governo fascista, simultanea al deterioramento notevole della posizione strategica della Gran Bretagna rispetto l'Italia - dovuto, in primo luogo, allo sviluppo di nuov e armi da guerra - tendeva a sovvertire le basi di questa amicizia anglo-italiana. Tuttavia, i governi inglesi degli anni '20 e '30 continuavano a to ll erare e talvolta ad in coragg iare la politica estera aggressiva del fascismo, forse pensando che l'Italia poteva essere tenuta a bada dalla flotta britannica. Nel frattempo, l'Italia conti nu ò ad essere un elemento utile per l'equilibrio del potere europe o. Questa situazione va integrata con la tendenza diffusa tra le classi elevate, di diverse nazioni democratiche, di considerare il fascismo una protezione contro la crescita di movimenti socia li radicali in Italia ed altrove . Gli inglesi non hanno voluto opporsi decisivamente alle aggressioni fasciste in Etiopia ed in Spagna: obiettivamente essi hanno favorito l'atta cco italiano alla Gran Bretagna ed alla Francia nel giugno del 1940».
Gli avvenimenti si erano evoluti a favore degli inglesi, co n risultati ormai evidenti: «la fine del patto d'acciaio, seg uita dalla dichiarazione di guerra di Mussolini, dall a sconfitta italiana e dalla sua resa incondizionata, per la pr im a volta, hanno me ss o il governo br itannico nella posizione di determina r e - unila teralmente - la base futura dei rapporti angl o- italiani. La preoccupazione per la rotta del Med it erraneo rimaneva una considerazione primaria della politica britannica nel sud dell'Europa. La Gran Bretagna, chiaram ente, era interessata a ricostituire una situazione di altri tem pi, qu ando l' Itali a non costitu iv a una importante mi n accia agli in teres si britannici.
«In teoria questo obiettivo poteva es sere raggiunto con due m eto di:
1) una cooperazione volontaria anglo-italiana, basata su interessi ed ideali comuni, come si era verificato nell'epoca prefascista.
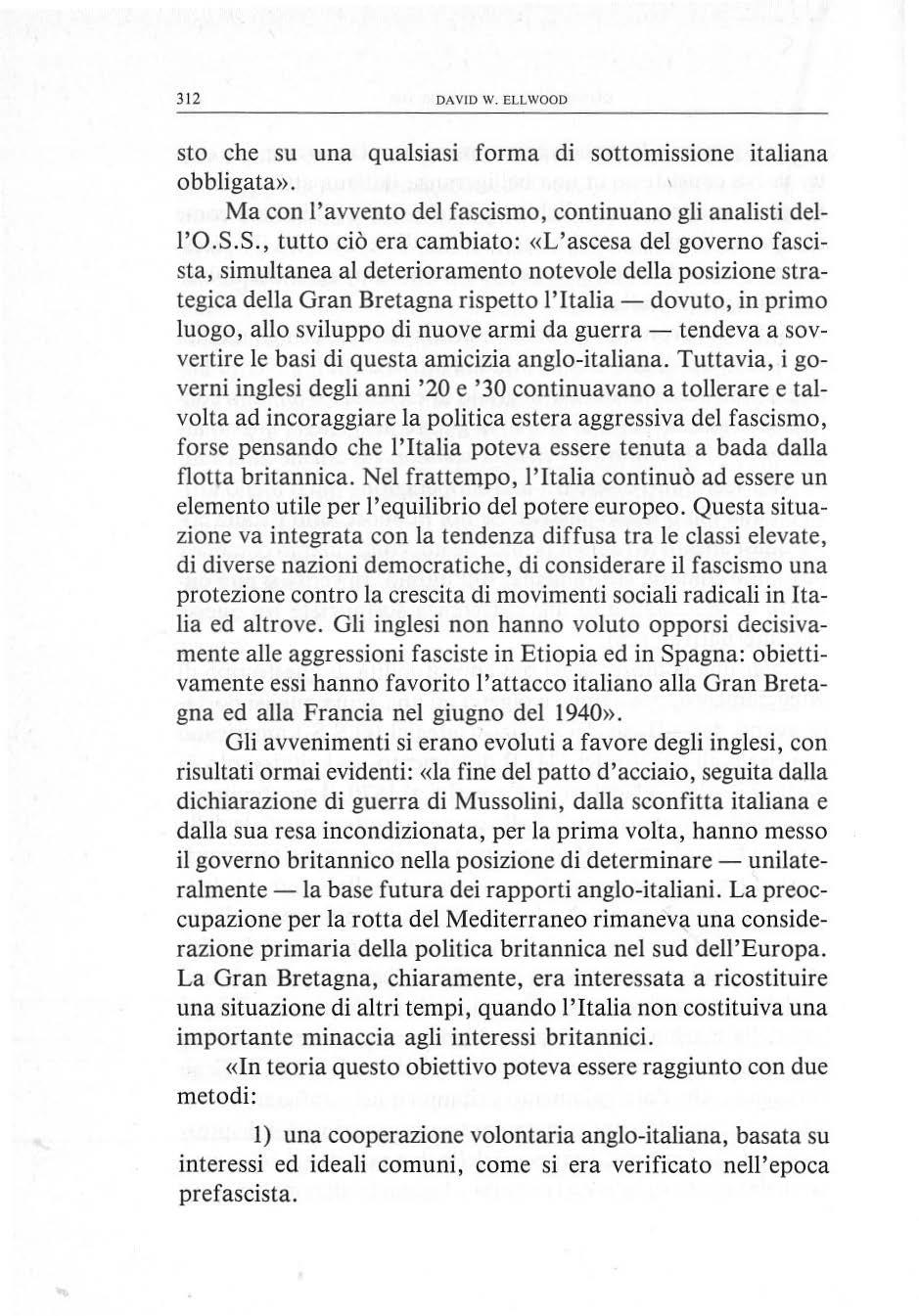
2) una cooperazione involontaria, basata sulla sottomissione completa di un'Italia indebolita in modo decisivo.
«Le tradizioni liberali britanniche puntavano verso la prima delle soluzioni, che avrebbe comportato degli sforzi per instaurare un governo democratico antifascista in Italia e la ricostituzione dei rapporti anglo -americani sulla base dell'amicizia storica e sugli interessi comuni su larga scala (equilibrio europeo, libertà dei mari, governo democratico etc.). Il governo britannico, apparentemente, ha preferito cercare di ridurre l'Itali a ad uno Stato dipendente.
«Facendo queste scelte, il governo britannico è stato fors e influenzato in parte dai timori di vedere cadere un'Italia democratica prima o poi sotto il dominio comunista, diventando un avamposto delle influenze sovietiche nel Mediterraneo. I critici dell'attuale governo britannico, mettendo in rilievo la sua pr esunta paura di movimenti popolari, la sua tendenza di cont are su gruppi economici e sociali che in altri tempi hanno collaborato con il fascismo, hanno descritto l'attuale politica britannica in Italia come mirante alla conservazione del «fascismo senza Mussolini» (27).
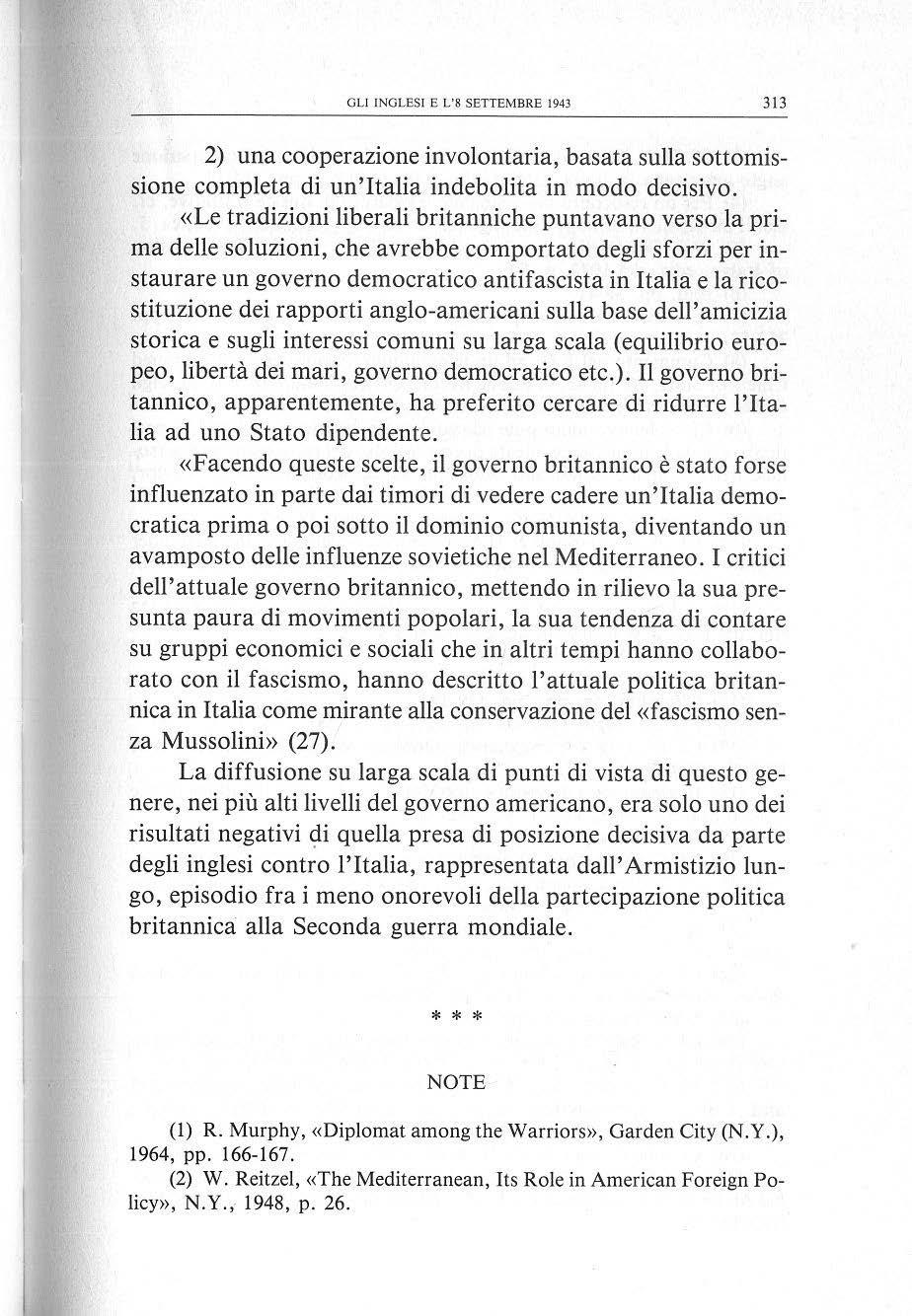
La diffusione su larga scala di punti di vista di questo genere, nei più alti livelli del governo americano, era solo uno dei risultati negativi çli quella presa di posizione decisiva da parte degli inglesi contro l'Italia, rappresentata dall'Armistizio lungo, episodio fra i meno onorevoli della partecipazione politica britannica alla Seconda guerra mondiale.
* * *
NOTE
(1) R. Murphy, «Diplomat among the Warriors», Garden City (N.Y.), 1964, pp. 166-167 .
(2) W Reitzel, «The Mediterranean, Its Role in American Foreign Policy», N. Y , 1948, p. 26.
(3) Cf. D.W. Ellwood, «L'Alleato nemico La politica dell'occupazione anglo -americana in Italia, 1943-1946», Milano, 1977, pp. 214-17.
(4) Per un resoconto normalmente trascurato di queste trattative, cf. Genl. Sir Kenneth Strong , «Intelligence at the Top», London, 1968, ca. 5.
(5) W.S. Churchill, «The Second World War», vol. 9, «The Invasion of Italy», ediz. del 1972, p. 89.
(6) Ibid. pp. 38-41.
(7) R.H. Bruce Lockhart, «Comes the Reckoning», Lon., 1947, pp. 252-53.
(8) Commento del F.O. ad un telegramma Eisenhower - Combined Chiefs of Staff, 16/10/43, in Public Record Office, Londra (PRO), Foreign Office Generale Correspondance (FOGC), fascicolo R/10350/6447/22.
(9) Cf. «Memorandum sulle relazioni anglo-americane in Italia (in particolare nella Commissione alleata di controllo)», del rappresentante personale del Presidente americano presso la Santa Sede, Myron C, Taylor, 15/10/44, in «Vaticano e Stati Uniti, 1939- 1952. Dalle carte di Myron C. Taylor», a cura di E. Di Nolfo, Milano, 1978, pp. 377-83 .
(10) Cf. A . N . Garland & H.McG Smyth, «Sicily and the Surrender ofltaly», volume nella serie, «The U.S. Army in World War II», pp . 448-50.
(Il) Churchill , op. cit., pp. 56-57.
(12) Il documento del F.O. si trova in PRO.FOGC. R/6793/6447/22 (tel. del F.O. a Washington del 24/7/1943).
(13) Churchill, op. cit., pp . 175 -177.
(14) Ellwood, op. cit., pp. 39-43 .
(15) Churchill, op . cit., pp. 112-14.
(16) Per i dettagli, Ellwood, op. cit., pp. 37-38.
(17) Cf. tel. F.O. -Ambasciata britannica a Mosca, 21/9/43, in PRO, FOGC, U/4447/3646/22.
(18) Il telegramma di Stalin è riprodotto in «Foreign Relations of the United States», 1943, Vol. 1, pp. 782- 83.
(19) Churchill, op. cit., p. 109. ·
(20) Cf. Graham Ross, «Foreign Office Attitudes to the Soviet Union, 1941-45», in Walter Laqueur, ed., «The Second World War. Essays in Military and Politica! History», Lon., 1982, pp 255-74
(21) Cf. Sir Llewellyn Woodward, «British Foreign Policy in the Second World War», Lon., 1962, pp. 230 -32 .
(22) Cf. A. Varsori, «Senior» o «Egual» Partner?» in Rivista di Studi Politici Internazionali, n 2, 1978, pp. 229-260.
(23) Churchill, op. cit., pp . 107-08.
(24) Cf. verbale di una conversazione entro Eden e Maisky, Ambasciatore sovietico a Londra, 22/6/43, in PRO, FOGC, R/6793/6447/22.
(25) Memorandum del F . O . «Relations with the Italian Government and Control Commission in ltaly», 4/10/43, in PRO, FOGC, R/10097/7447/22.
(26) Commento de l F.O del 20/9/43 in PRO, FOGC, R/8935/5880/22.
(27) OSS Report n. 2318, «Brit ish Policy in Italy», 15/8/44, in National Archives, Washington.D.C . , Record Group 226, OSS, Research and Analys is Branch.
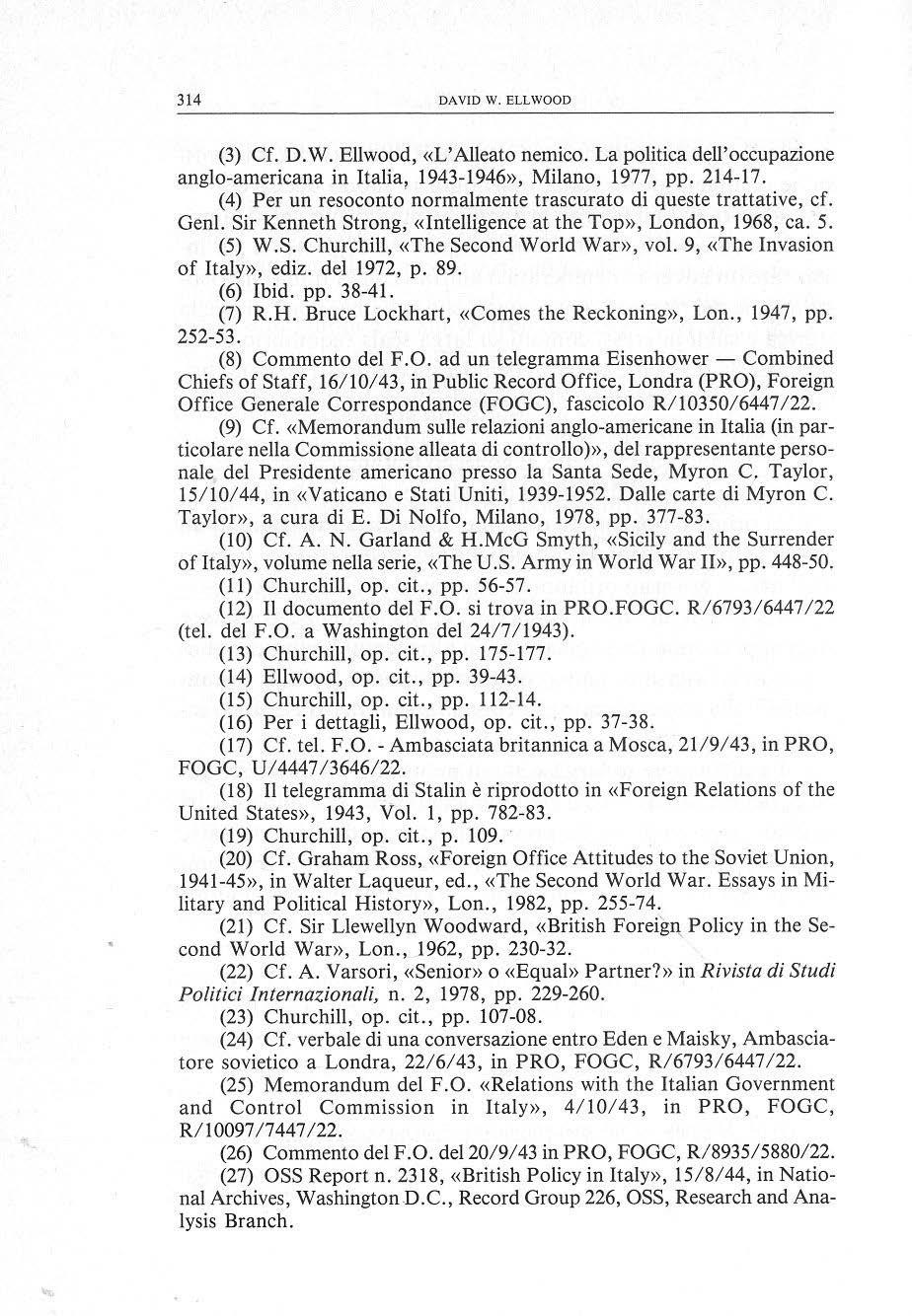
Darò un doppio punto di vista, dello storico che ha letto le opere di alcuni dei protagonisti di questo periodo, e del testimone, allora aspirante di fanteria coloniale, arrivato ad Algeri il 26 settembre 1943 alcuni giorni dopo gli avvenimenti.
I protagonisti
La vita diplomatica ad Algeri in quel periodo dell'estate 1943 è nelle mani di tre personalità, René Massigli del Comitato Francese di Liberazione Nazionale, Robert Murphy, console generale degli Stati Uniti ad Algeri che ha avuto un ruolo determinante in questo periodo, più Mac Millan, pare, sebbene il machiavellismo dei due uomini sia stato denunciato d.a diversi autori. (1).
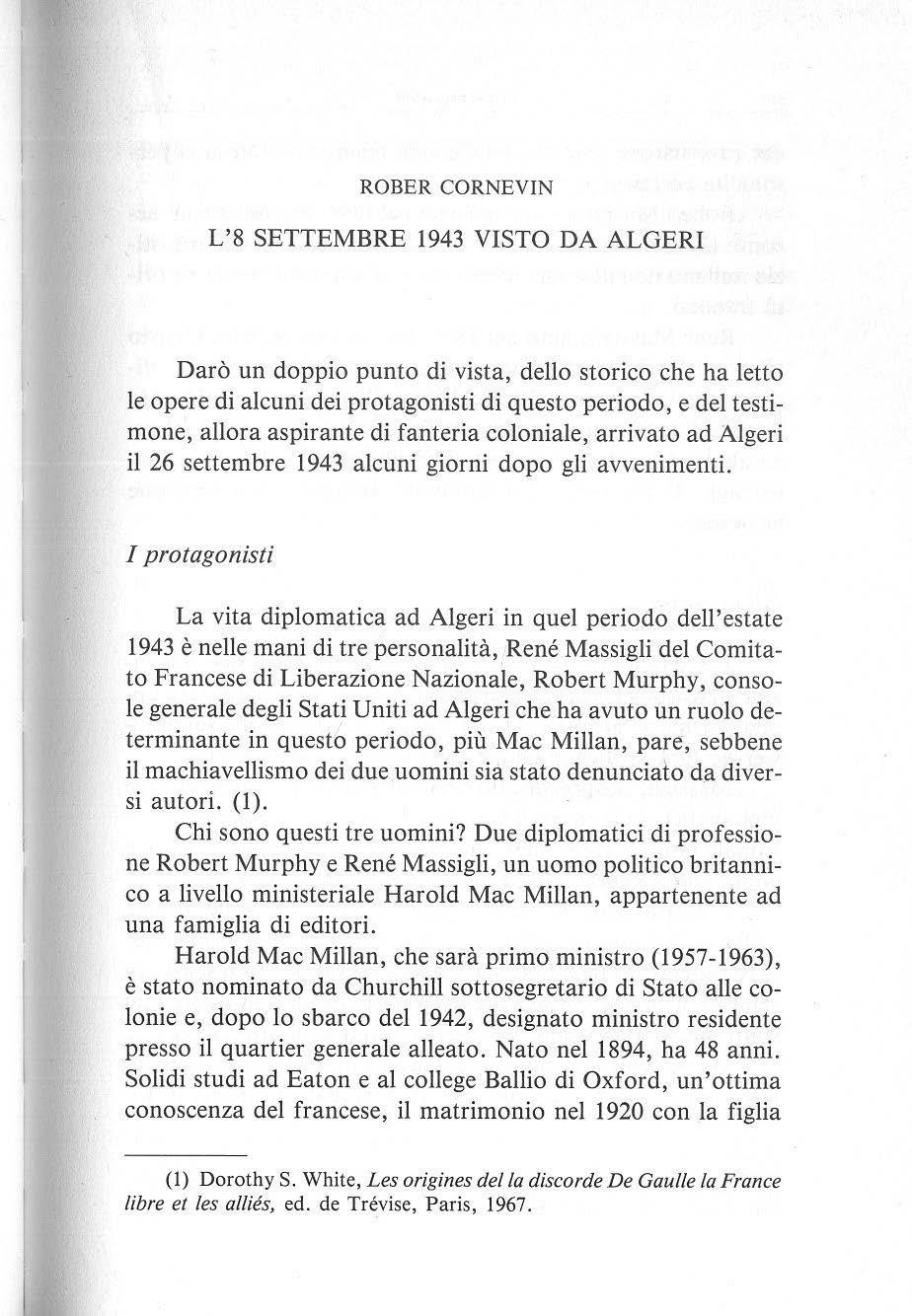
Chi sono questi tre uomini? Due diplomatici di professione Robert Murphy e René Massigli, un uomo politico britannico a livello ministeriale Harold Mac Millan, appartenente ad una famiglia di editori.
Harold Mac Millan, che sarà primo ministro (1957-1963), è stato nominato da Churchill sottosegretario di Stato alle colonie e, dopo lo sbarco del 1942, designato ministro residente presso il quartier generale alleato. Nato nel 1894, ha 48 anni. Solidi studi ad Eaton e al college Ballio di Oxford, un'ottima conoscenza del francese, il matrimonio nel 1920 con la figlia
(1) Dorothy S. White, Les origines del la discorde De Gaulle la France libre et !es alliés, ed. de Trévise , Paris, 1967.del governatore generale del Canada hanno formato una personalità eccezionale.
Robert Murphy, anch'egli nato nel 1894, ha lasciato un racconto (2) di questo periodo il cui capitolo dedicato all'armistizio italiano non dice una parola sui suoi rapporti con le autorità francesi.
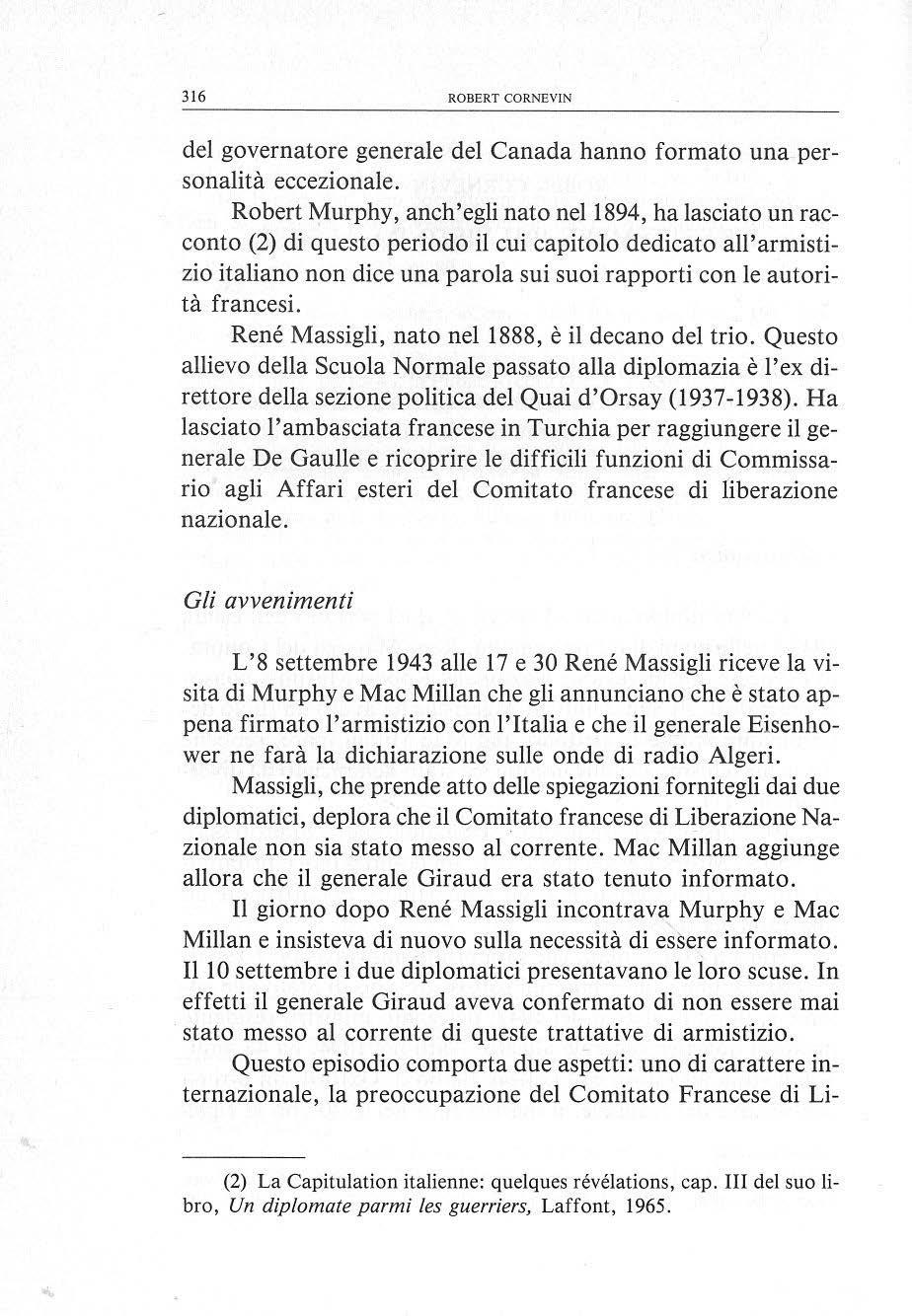
René Massigli, nato nel 1888, è il decano del trio. Questo allievo della Scuola Normale passato alla diplomazia è l'ex direttore della sezione politica del Quai d'Orsay (1937-1938). Ha lasciato l'ambasciata francese in Turchia per raggiungere il generale De Gaulle e ricoprire le difficili funzioni di Commissario agli Affari esteri del Comitato francese di liberazione nazionale.
L'8 settembre 1943 alle 17 e 30 René Massigli riceve la visita di Murphy e Mac Millan che gli annunciano che è stato appena firmato l'armistizio con l'Italia e che il generale Eisenhower ne farà la dichiarazione sulle onde di radio Algeri. Massigli, che prende atto delle spiegazioni fornitegli dai due diplomatici, deplora che il Comitato francese di Liberazione Nazionale non sia stato messo al corrente. Mac Millan aggiunge allora che il generale Giraud era stato tenuto informato.
Il giorno dopo René Massigli incontrava Murphy e Mac Millan e insisteva di nuovo sulla necessi tà di essere informato. Il 10 settembre i due diplomatici presentavano le loro scuse. In effetti il generale Giraud aveva confermato di non essere mai stato messo al corrente di queste trattative di armistizio.
Questo episodio comporta due aspetti: uno di carattere internazionale, la preoccupazione del Comitato Francese di Li -
(2) La Capitulation italienne : quelques révélations, cap. III del suo libro, Un diplomate parmi /es guerriers, Laffont, 1965 .
berazione Nazionale di essere tenuto al corrente di tutti i problemi sorti a livello della condotta della guerra; l'altro, di carattere «franco-francese» tra Giraudisti e Gollisti, che doveva concludersi con l'insediamento solitario del generale De Gaulle alla testa del Comitato francese di Liberazione Naz ionale prima ancora della fine delle operazioni in Corsica condotte dal generale Giraud.
È necessario segnalare l'importanza della partecipazione francese alle operazioni militari contro l'Italia. Indipendentemente dai combattimenti sul fronte delle Alpi precedenti l'armistizio italiano del 23 giugno 1940, le Forze Francesi Libere avevano combattuto in Eritrea al fianco delle truppe britanniche in particolare a Keren. In Libia la colonna Ledere (3) aveva preso Kufra, High el Kebir, Gatrun, Murzuk, Umir el Aeaneb, Brach, Ghadanies. La «Forze Ledere» aveva stabilito il 23 gennaio 1943 alle ore 17 il collegamento con 1'8a Armata arrivata 3 ore prima.
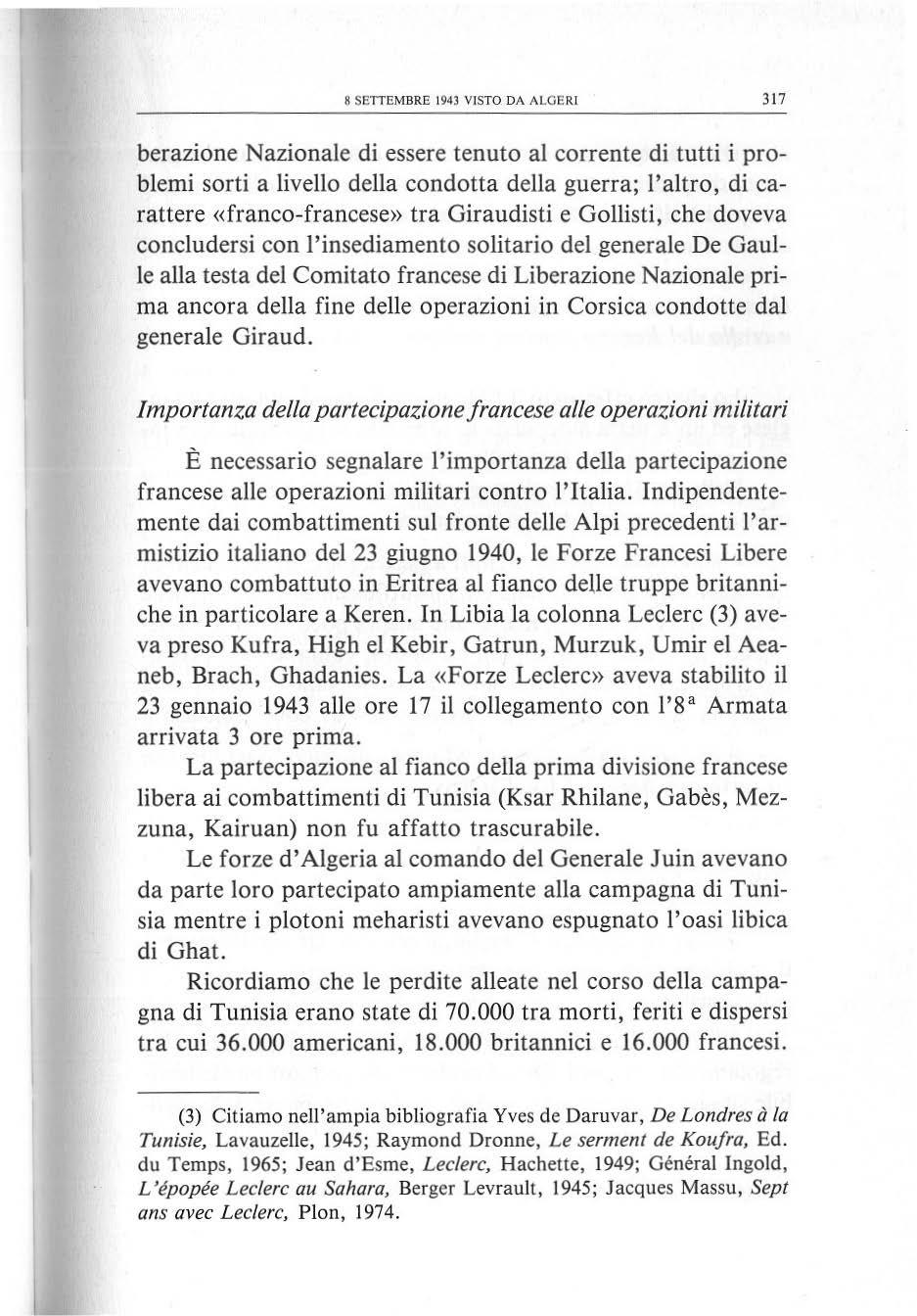
La partecipazione al fianco della prima divisione francese libera ai combattimenti di Tunisia (Ksar Rhilane, Gabès, Mezzuna, Kairuan) non fu affatto trascurabile.
Le forze d'Algeria al comando del Generale Juin avevano da parte loro partecipato ampiamente alla campagna di Tunisia mentre i plotoni meharisti avevano espugnato l'oasi libica di Ghat.
Ricordiamo che le perdite alleate nel corso della campagna di Tunisia erano state di 70.000 tra morti, feriti e dispersi tra cui 36.000 americani, 18.000 britannici e 16.000 francesi.
(3) Citiamo nel!' ampia bibliografia Yves de Daruvar, De Londres à la Tunisie, L avauzelle, 1945; Raymond Dronne, Le serment de Koufra, Ed . du Temps, 1965; Jean d'Esme, Leclerc, Hachette, 1949; Général lngold, L 'épopée Leclerc au Sahara, Berger Levrault, 1945; Jacques Massu, Sept ans avec Leclerc, Plon, 1974.
D'altra parte dei francesi amministravano il Fezzan. La presenza di francesi a fianco degli anglo-americani nella firma di un armistizio con l'Italia sembrava quindi naturale.
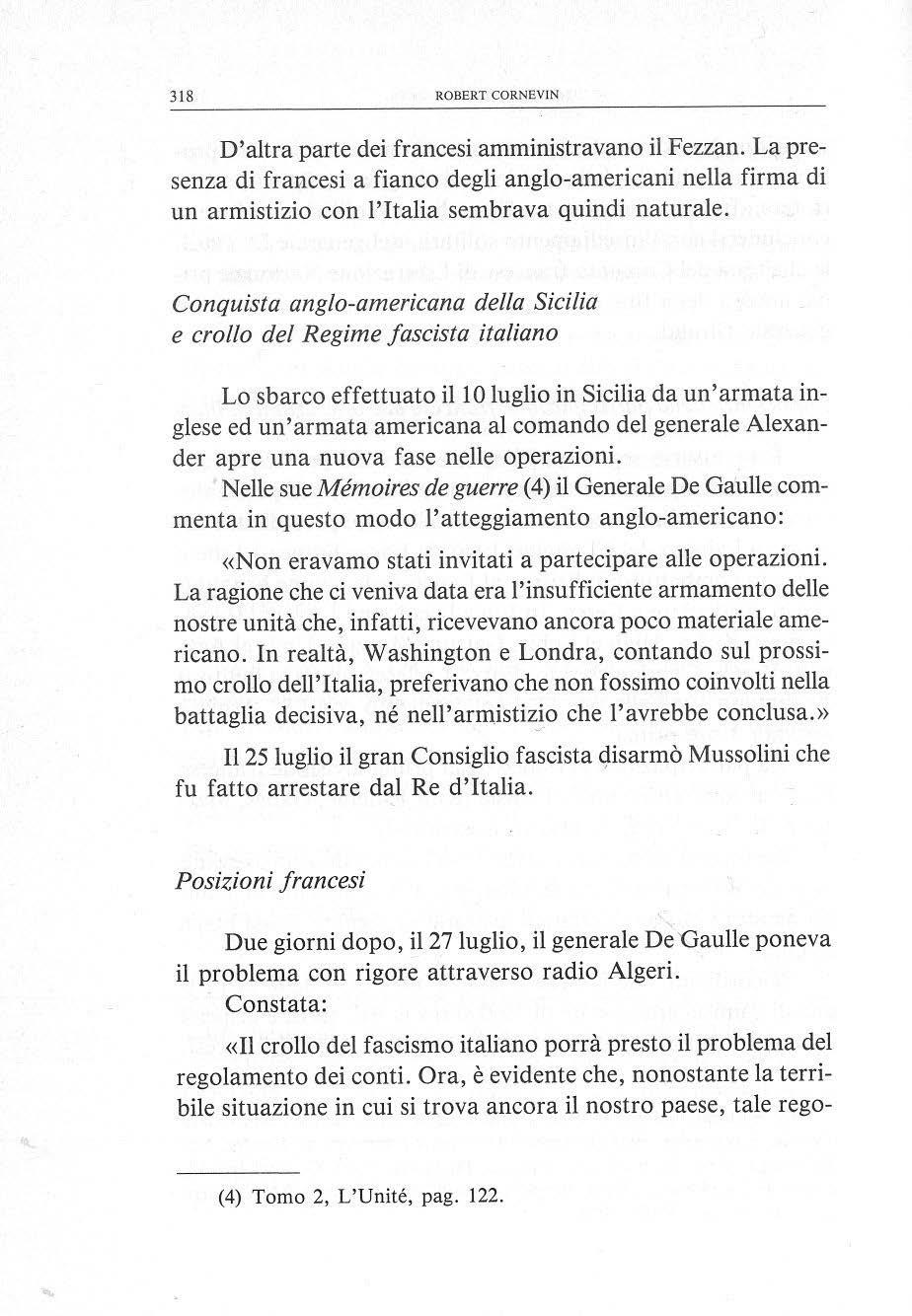
Conquista anglo-americana della Sicilia e crollo del Regime fascista italiano
Lo sbarco effettuato il 10 luglio in Sicilia da un'armata inglese ed un'armata americana al comando del generale Alexander apre una nuova fase nelle operazioni.
Nelle sue Mémoires de guerre (4) il Generale De Gaulle commenta in questo modo l'atteggiamento anglo-americano:
«Non eravamo stati invitati a partecipare alle operazioni. La ragione che ci veniva data era l'insufficiente armamento delle nostre unità che, infatti, ricevevano ancora poco materiale americano. In realtà, Washington e Londra, contando sul prossimo crollo dell'Italia, preferivano che non fossimo coinvolti nella battaglia decisiva, né nell'armistizjo che l 'avrebbe conclusa.»
Il 25 luglio il gran Consiglio fascista qisarmò Mussolini che fu fatto arrestare dal Re d'Italia.
Posizioni francesi
Due giorni dopo, il 27 luglio, il generale De 'Gaulle poneva il problema con rigore attraverso radio Algeri.
Constata:
«Il crollo del fascismo italiano porrà presto il problema del regolamento dei conti. Ora, è evidente che, nonostante la terribile situazione in cui si trova ancora il nostro paese, tale rego-
(4) Tomo 2, L' Unité, pag. 122 .
lamento non potrebbe essere né valido, né durevole, senza la Francia. Facevo capire, d'altra parte, che in questa partecipazione noi saremmo animati dal desiderio di riconciliazione piuttosto che dallo spirito di vendetta, poiché la vicinanza stretta e, in una certa misura, l'interdipendenza dei due grandi popoli latini restano, nonostante gli attriti del presente, gli elementi sui quali la ragione e la speranza dell'Europa non rinunciano a reggersi».
Conclude sottolineando il ruolo del Comitato francese di Liberazione nazionale dove si sta giocando l'esclusione del generale Giraud.
Il 2 agosto René Massigli consegna una nota a Mac Millan e a Murphy (5):

<<Algeri, 2 agosto 1943
Nel momento in cui si delinea l'eventualità di una prossima capitolazione italiana, che avrebbe per tutta l'Europa occupata e in particolare per la Francia delle vaste ripercussioni, il Comitato francese di Liberazione nazionale ha l'imperios o dovere di attirare l'attenzione dei governi americano e britannico sull'importanza essenziale di una partecipazione francese , prima ai negoziati dell'armistizio, poi alle deliberazioni e alle decisioni degli organismi cui spetterà di garantire l'esecuzione delle condizioni che verranno imposte all'Italia.
Il crollo del fascismo segna una prima e decisiva vittoria delle potenze democratiche. La nazione francese è fiera che il suo sforzo militare e i suoi sacrifici vi abbiano potuto contribuire e tutti i francesi, quelli dell'impero e quelli che sono ancora sotto il giogo nemico, vedrebbero con la più viva soddisfazione il Comitato di Liberazione partecipe domani alle trattative che consacreranno la disfatta italiana, poi la restaurazione di un regime democratico, ritenuta indispensabile dai governi americano e inglese.
(5) L'Unité, pag. 138.
Questa restaurazione, inoltre, implica la sparizione totale dell ' armatura giuridica dello Stato fascista. Soltanto a queste condizioni sarà possibile raggiungere uno degli scopi essenziali della guerra, e il popolo italiano potrà ritrovare tra le nazioni europee un posto degno di lui».
Indipendentemente da queste considerazioni, la richiesta del Comitato di Liberazione Nazionale trova nella protezione degli interessi francesi ampia giustificazione. Spetterà senza dubbio ad una commissione interalleata, nella quale sarebbe rappresentato il comando francese, elaborare le clausole di armist izio che, al momento opportuno, il .Governo italiano dovrebb e sottoscrivere. In tale commis sione la delegazione frances e farà valere le pr eoccupazioni del Comitato di Liberazione. È parso opportuno attirare fin d'ora l'attenzione su alcuni degli interessi francesi in causa:
a) innanzitutto è evidente che il territorio italiano deve poter servire immediatamente da base agli eserciti alleati per le loro operazioni, in particolare per la liberazione della Francia di cui le truppe italiane dovranno evacuare il territorio.
b) I prigionieri di guerra, del resto poco numerosi , i cittadini francesi prigionieri politici, dovranno essere immediatamente liberati.
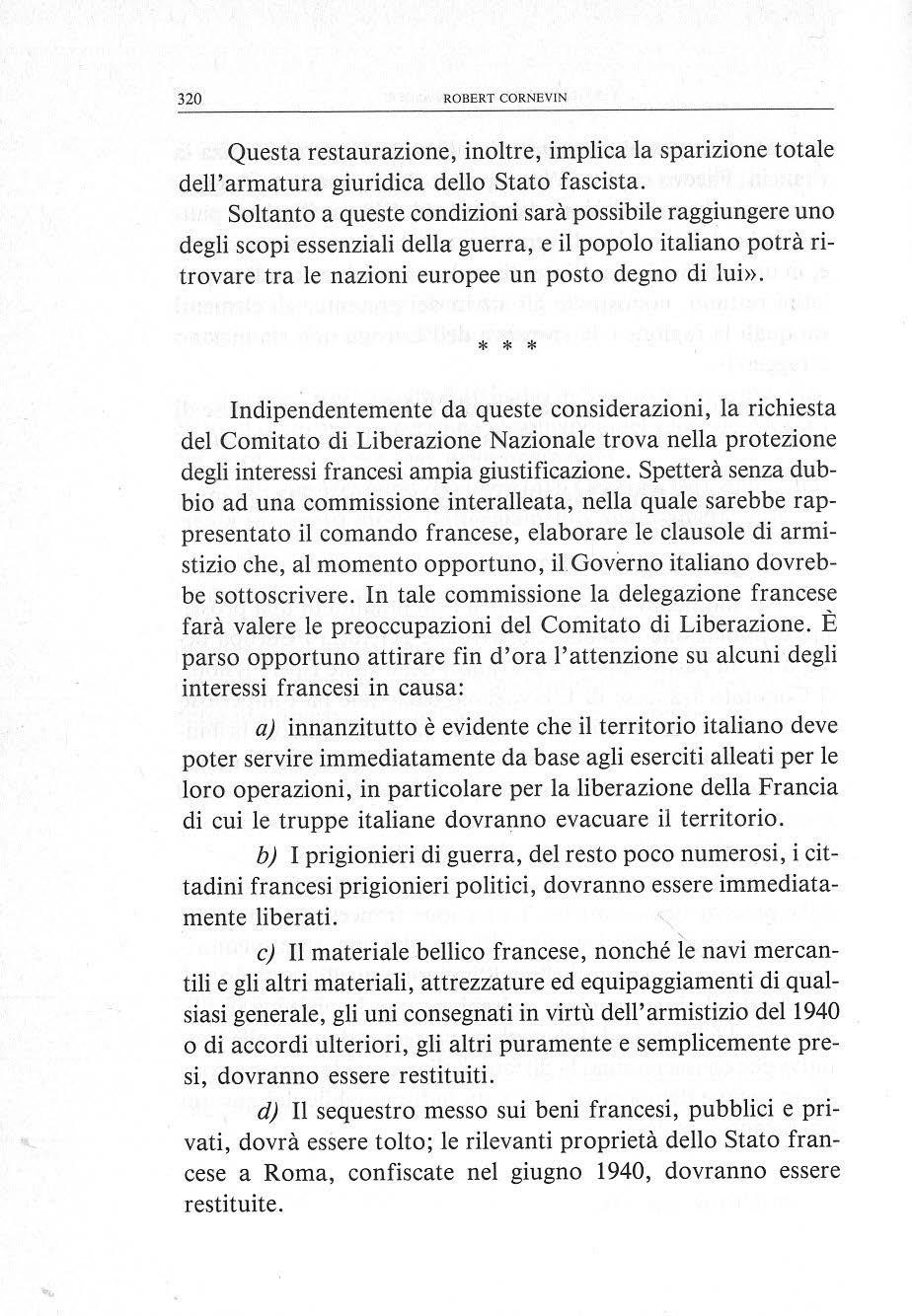
e) Il materiale bellico francese, nonché le navi mercantili e gli altri materiali, attrezzature ed equipaggiamenti di qualsiasi generale, gli uni consegnati in virtù dell'armistizio del 1940 o di accordi ulteriori, gli altri puramente e semplicemente presi, dovranno essere restitu iti.
d) Il sequestro messo sui beni francesi, pubblici e privati, dovrà essere tolto; le rilevanti proprietà dello Stato francese a Roma, confiscate nel giugno 1940, dovranno essere restituite.
Non può essere sfuggito ai governi americano e inglese che, se vi è la preoccupazione di fondare in futuro i rapporti francoitaliani su solide basi, senza le quali alcuna collaborazione durevole potrebbe instaurarsi, è necessario che, fin dall'inizio, la Francia abbia il suo posto nelle conversazioni che si terranno. Il Comitato Francese di Liberazione non dubita delle intenzioni dei governi alleati per quanto riguarda lo scopo da raggiungere.
Tuttavia i negoziati continuano tra emissari italiani, inglesi e americani in Portogallo e in Sicilia. Tutto avviene tenendo fuori le autorità francesi.
Ecco come il Generale De Gaulle riferisce i fatti (6):
«Il 29 agosto, Mac Millan e Murphy avevano consegna t o a Massigli un memorandum che prevedeva la resa degli italiani e che chiedeva al Comitato Francese di Liberazione "di accettare che in suo nome, così come in nome di tutte le Nazioni Unite , il Generale Eisenhower fosse abilitato a firmare con il Maresciallo Badoglio una convenzione di armistizio che coprisse tutti i bisogni degli alleati, in particolare quelli della Francia".
Il memorandum indicava i punti essenziali del documento e concludeva: "I governi del Regno Unito e degli Stati Uniti faranno il possibile perchè il Comitato Francese di Liberazione Nazionale invii, se lo considera, un rappresentante alla firma''. Avevamo risposto il 1° settembre con una nota che approvava che Eisenhower concludesse l'armistizio in nostro nome, così come in nome di tutti gli alleati e che chiedeva che ci fosse comunicato con urgenza il testo del progetto, dichiarandoci pronti ad inviare, a qualsiasi momento, un rappresentante del Comando francese là dove l'atto sarebbe stato firmato. Ecco dunque, per Londra e Washington, l'occasione di dimostrare se intendono considerare la Francia loro alleata a pieno titolo nelle definizioni successive che concluderanno le ostilità.
(6) L'Unité, pag 519-520.
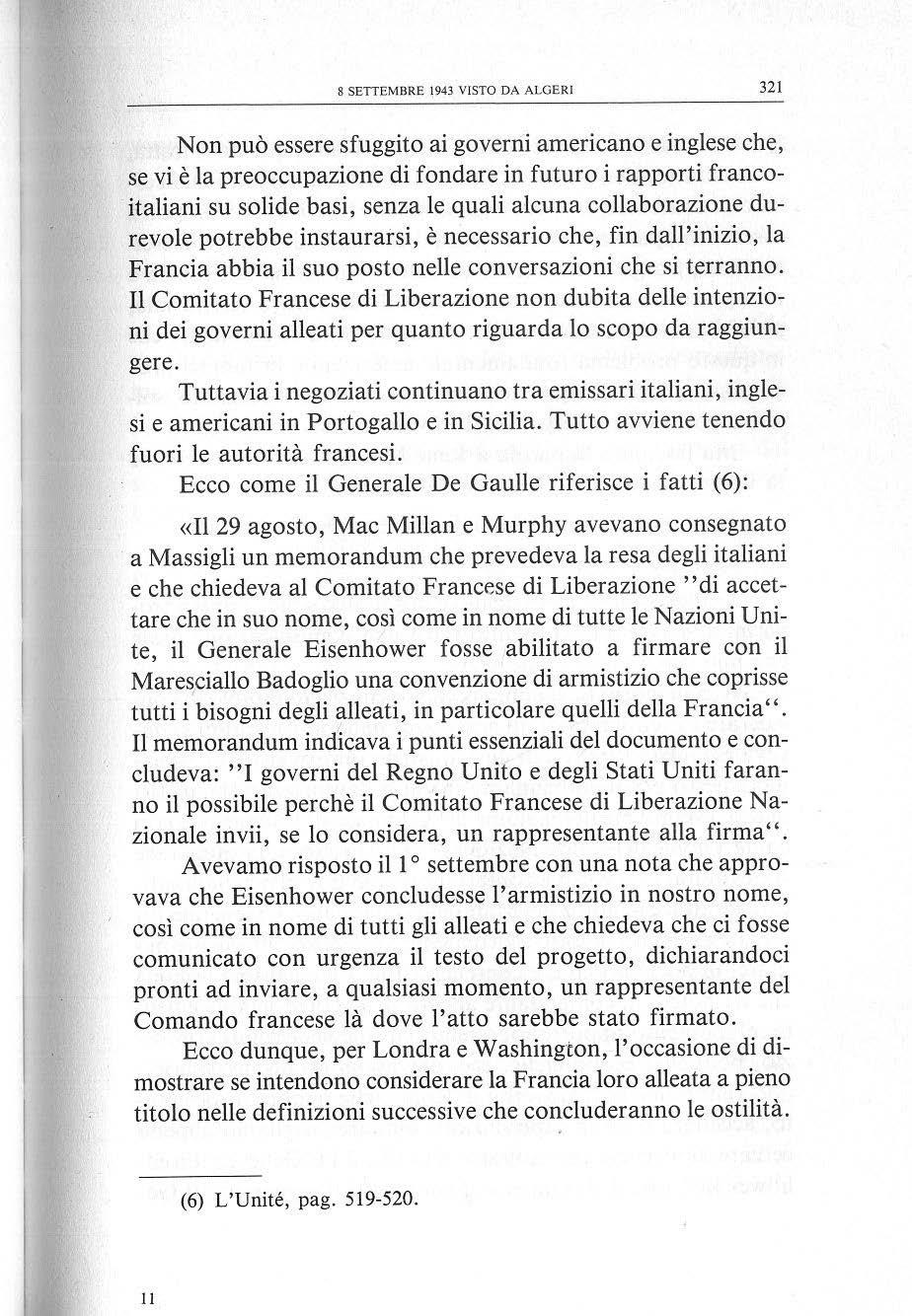
Questa occasione appare tanto più favorevo le in quanto si tratta, innanzitutto, dell'Italia, che forze francesi non hanno mai cessato di combattere, di cui è già noto che il territorio non potrà essere strappato ai tedeschi se nza il co ncor so del no stro esercito e che, tra gli Occidentali, ha come sola vici na la Francia e non potrebbe stabilire senza di essa il suo futuro terr itoriale, politico, economico, coloniale. Dovremo tuttavia constatare che in questo problema fondamentale americani e britannici procederann o senza scrup oli nei confronti del nostro Comitato, soltanto pochi giorni dopo averlo formalmente riconosciu to» .
Ma lasciamo la parola a René Massigli che 1'8 settembre fa il suo rapporto al Generale De Gaulle:
Rapporto di René Massigli al Generale De Gaulle.
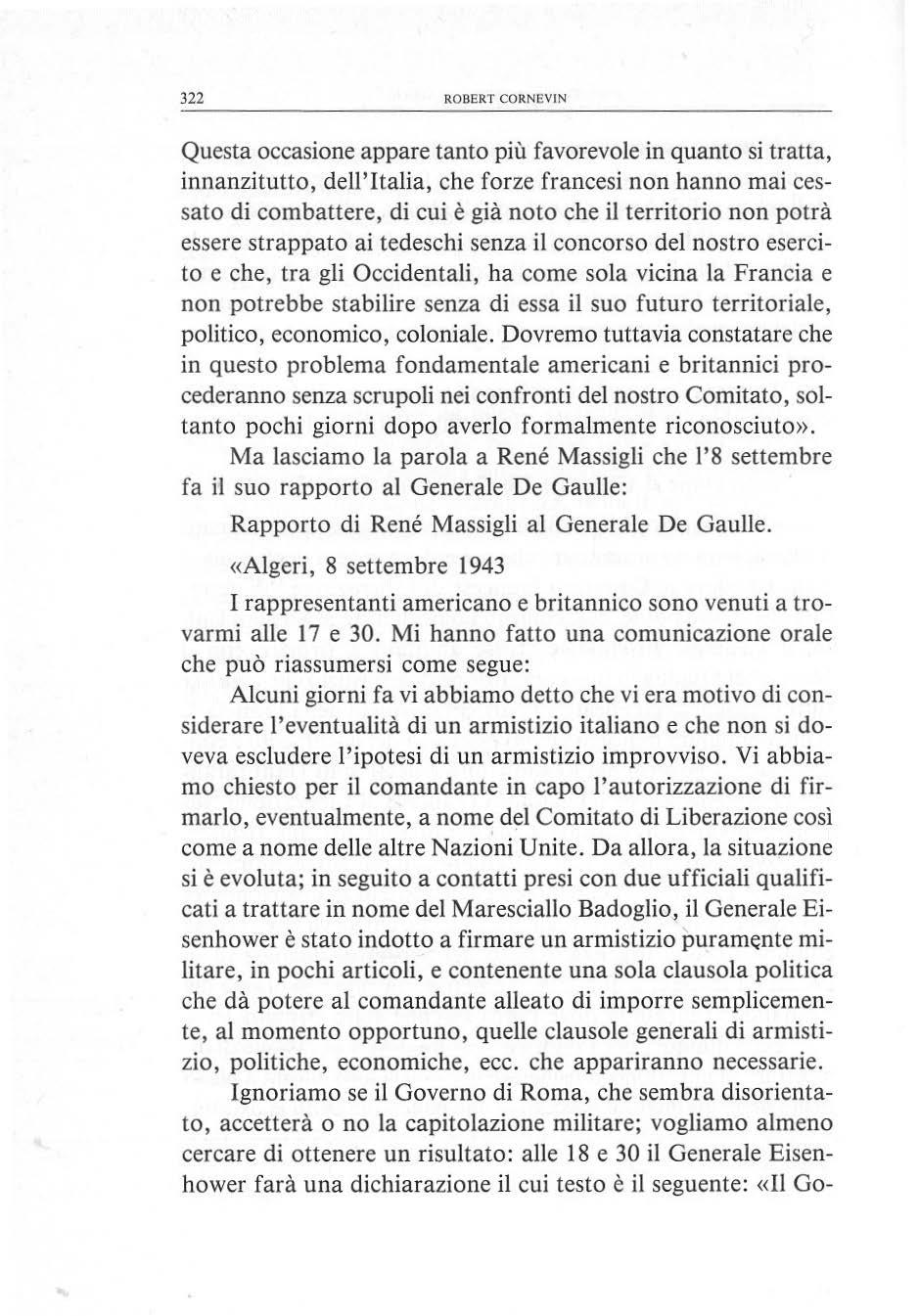
«Algeri, 8 settem br e 1943
I rappresentanti americano e britannico sono venuti a trovarmi alle 17 e 30. Mi hanno fatto una comunicazione orale che può riassumersi come seg ue:
Alcuni giorni fa vi abbiamo detto che vi era motivo di considerare l'eventualità di un armistizio italiano e che non si doveva escludere l'ipotesi di un armistizio improvviso. Vi abbiamo chie sto per il comandante in capo l'autorizzazione di firmarlo, eventualmente, a nome del Comitato di Liberazione così come a nome delle altre Nazioni Unite. Da allora, la situazione si è evoluta; in seguito a contatti presi con due ufficiali qualificati a trattare in nome del Maresciallo Badoglio, il Generale Eisenhower è stato indotto a firmare un armistizio puram~nte militare, in pochi articoli, e co n tenente una sola clausola politica che dà potere al comandante alleato di imporre semp licemente, al momento opportuno, quelle clauso le ge n erali di armistizio, pol itiche, economiche, ecc. che appariranno necessarie. Ignoriamo se il Governo di Roma, che sembra disorientato, accetterà o n o la capitolazione militare; vogliamo almeno cercare di ottenere un ri sultato : alle 18 e 30 il Generale Eisenhower farà una dichiarazione il cui testo è il seguente: «Il Go-
verno italiano ha capitolato senza condizioni. Come comandante in capo alleato, gli ho cuncesso un armistizio militare i cui termini sono stati approvati dai Governi britannico, americano e sovietico. Agisco in quèsto modo nell'interesse delle Nazioni Unite. Il Governo italiano si è impegnato a conformarsi senza riserve ai termini imposti.
L'armistizio è stato firmato dal mio rappresentante e da quello del Maresciallo Badoglio. Diventa effettivo immediatamente. Le ostilità tra le forze armate delle Nazioni Unite e le forze italiane cessano immediatamente. Tutti gli italiani che agiranno ormai per aiutare ad espellere l'aggressore tedesco dal suolo italiano avranno l'assistenza e l'appoggio delle Nazioni Unite».
« Questa dichiarazione sarà diffusa per radio allo scopo di gettare scompiglio nel momento preciso in cui inizierà una grande operazione, molto arrischiata, di sbarco. L'atto militare appena concluso è una manovra per cercare di ottenere un grande risultato militare».
Ho risposto a Murphy e Mac Millan che prendevo atto delle loro spiegazioni, ma che dovevo deplorare che non fossimo stati messi al corrente. Mac Millan mi ha interrotto per dirmi che il Generale Giraud era al corrente. Questa osservazione mi ha messo un pò a disagio e ha tolto certamente forza al seguito delle mie osservazioni. Dopo avere chiesto, senza ottenere una risposta precisa: "Quando si è firmato?" ho continuato dicendo che dovevo nondimeno deplorare che il Comitato non ne fosse stato confidenzialmente messo a parte. Eppure truppe francesi hanno partecipato alla campagna di Tunisia, hanno fatto dei prigionieri, ecc ....
L'effetto prodotto sul Comitato e l'opinione - qui e in Francia - sarà, temo, disastrosa. Una sola parola aggiunta alla dichiarazione avrebbe cambiato le cose. Tutto ciò che potevo aggiungere era insistere nel modo più serio perché non si continuasse a praticare lo stesso metodo e perché le clausole politiche dell'armistizio non ci fossero, un giorno, comunicate nello
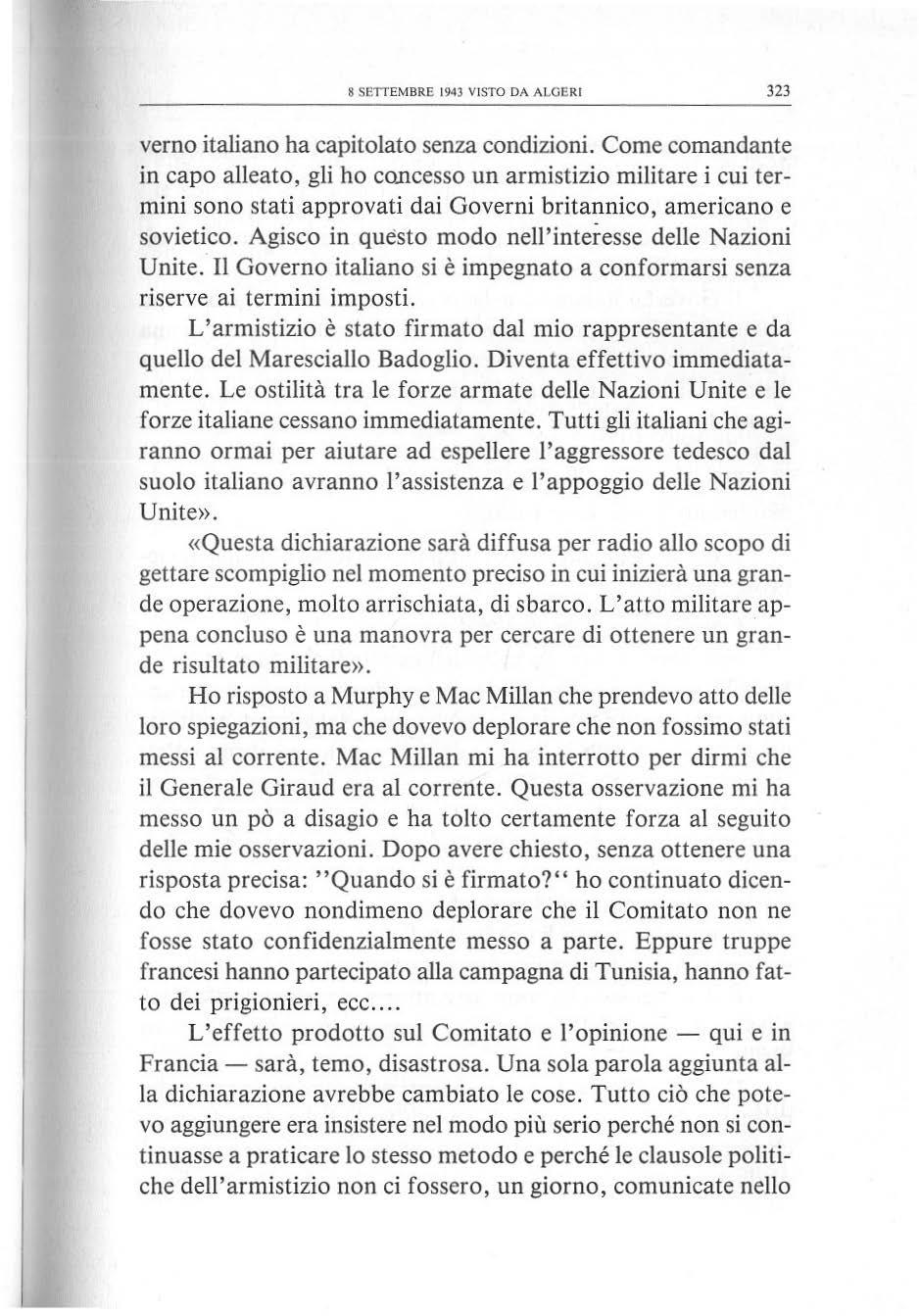
stesso modo. Era essenzial e che noi le conoscessimo in anticipo e che foss imo messi nelle condizioni di discuterle.
Mac Millan è allora entrato in lunghe e vaghe spiegazioni, insistendo sul carattere della manovra tentata ed esprimento inoltre, dei dubbi sul risultato finale.
Il Governo italiano è nelle mani dei tedeschi. La Gestapo è ovunque. Un gruppo di generali italiani tenta di ottenere una capitolazione militare e gli alleati sfruttano questo desiderio per di slocare il fronte itali ano e le retrovie tedesche. È tutto ciò che si può dire attualmente. Si potrà parlare di armistizio soltanto quando vi sarà un potere politico con cui trattare.
Ho preso atto di que ste spiegazioni supplem entari ed ho mantenuto le mie osservazioni».
Il giorno seguente nuo vo rapporto di René Massigli al Generale De Gaulle.
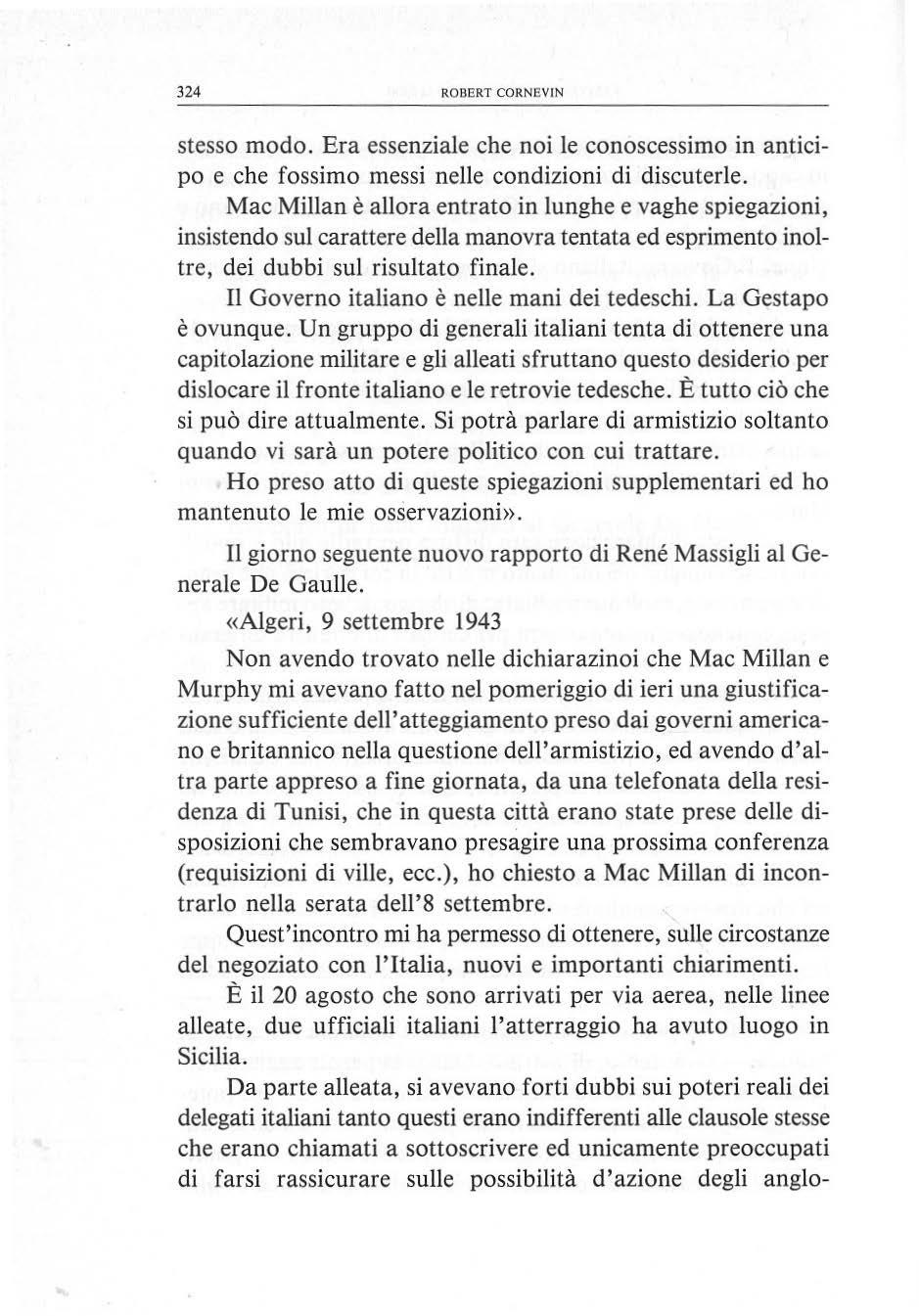
«Algeri, 9 settembre 1943
Non avendo trovato nelle dichiarazinoi che Mac Millan e Murphy mi avevano fatto nel pomeriggio di ieri una giustificazione sufficiente dell'atteggiamento preso dai governi americano e britannico nella questione dell'armistizio, ed avendo d'altra parte appreso a fine giornata, da una telefonata della residenza di Tunisi, che in questa città erano st ate prese delle disposizioni che sembravano presagire una prossima conferenza (requis izioni di vill e , ecc.), ho chiesto a Mac Millan di incontrarlo nella serata dell'8 settembre.
Quest'incontro mi ha permesso di ottenere, sulle circostanze del negoziato con l ' Italia, nuovi e importanti chiarimenti.
È il 20 agosto che sono arrivati per via aerea, nelle linee alleate, due ufficiali italiani l'atterraggio ha avuto luo go in Sicilia.
Da parte alleata, si avevano forti dubbi sui poteri reali dei delegati italiani tanto questi erano indifferenti alle clausole stesse che erano chiamati a sottoscrivere ed unicamente preoccupati di farsi rassicurare su ll e possibilità d'azione degli anglo-
americani. Peraltro, davano l'impressione di uomini dal morale spezzato e incapaci di qualsiasi reazione.
Soltanto il 3 settembre al mattino è stato depositato a Lisbona il documento che stabiliva la loro qualità di ministri plenipotenziari. Nel pomeriggio stesso l'accordo era firmato.
La tattica alleata ha implicato una gran parte di bluff. Si trattava, infatti, di utilizzare al massimo l'impressione prodotta dall'annuncio improvviso della capitolazione italiana per rafforzare le possibilità di successo dello sbarco.
Se il Comitato di Liberazione fosse stato consultato , sarebbe stato difficile, secondo Mac Millan, non consultare anche i greci, jugoslavi con tutte le possibilità di indiscrezioni che ne sarebbero derivate. Senza dubbio i russi ne sono stati messi a parte, ma vi era, per farlo, un interesse politico maggiore.
L'8 al mattino tutto sembrò rimesso in questione: gli italiani dichiaravano che le posizioni tedesche in Italia erano troppo forti, che essi stessi non avrebbero potuto liberarsi, ecc ...
È allora che gli alleati misero in atto un bluff audace. Su iniziativa di Mac Millan, è stato risposto ai plenipotenziari italiani che era troppo tardi per tornare indietro e che alle 18 e 30, come era stato convenuto, la dichiarazione del Generale Eisenhower sarebbe stata diffusa, seguita poi dal testo delle parole che il Maresciallo Badoglio doveva pronunciare due ore più tardi, secondo gli accordi presi.
Per quanto riguarda il futuro, Mac Millan dichiara che non si firma la convenzione di armistizio senza prima sapere se c'è un'autorità con cui poter trattare. In ogni caso non vi saranno discussioni con gli italiani.
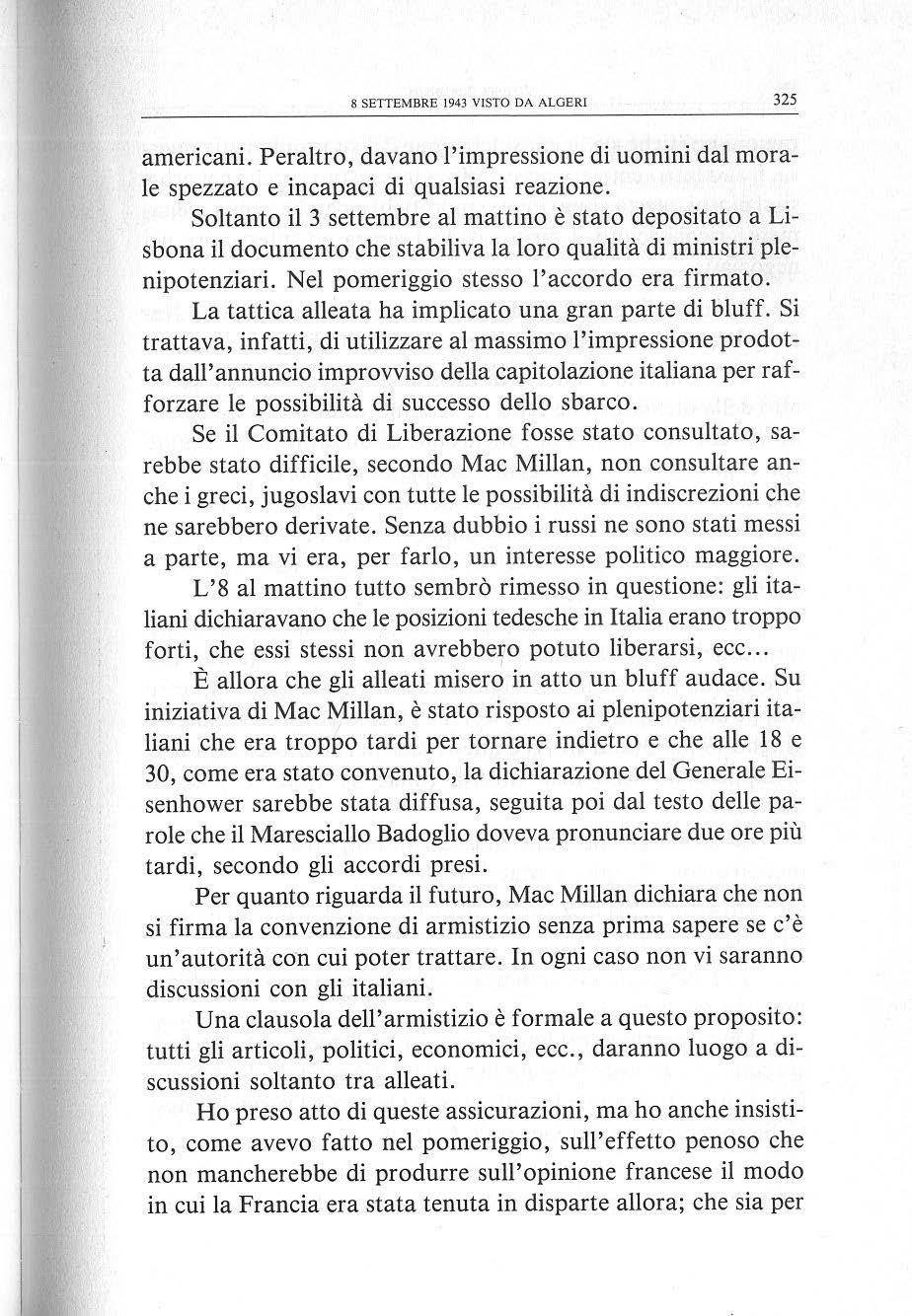
Una clausola dell'armistizio è formale a questo proposito: tutti gli articoli, politici, economici, ecc., daranno luogo a discussioni so ltanto tra alleati.
Ho preso atto di queste assicurazioni, ma ho anche insistito, come avevo fatto nel pomeriggio, sull'effetto penoso che non mancherebbe di produrre sull'opinione francese il modo in cui la Francia era stata tenuta in disparte allora; che sia per
ragioni politiche sia in considerazione del suo ruolo nella guerra, il suo intervento era necessario. Ho insistito perchè nei prossimi giorni questa situazione si modifichi e perchè venga pienamente riconosciuto il diritto della Francia ad intervenire nei negoziati>>.
A questo punto il Comitato Francese di Liberazione Nazionale pubblica il 9 settembre una dichiarazione.
«Il Comitato Francese di Liberazione Nazionale ha preso atto della dichiarazione fatta 1'8 settembre dal Generale Eisenhower che annunciava la conclusione di un armistizio militare con il governo del maresciallo Badoglio. Ha preso anche atto che in virtù di questa dichiarazione, le condizioni dell'armistizio avevano ricevuto la previa approvazione dei Governi della Gran Bretagna , degli Stati Uniti e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche».
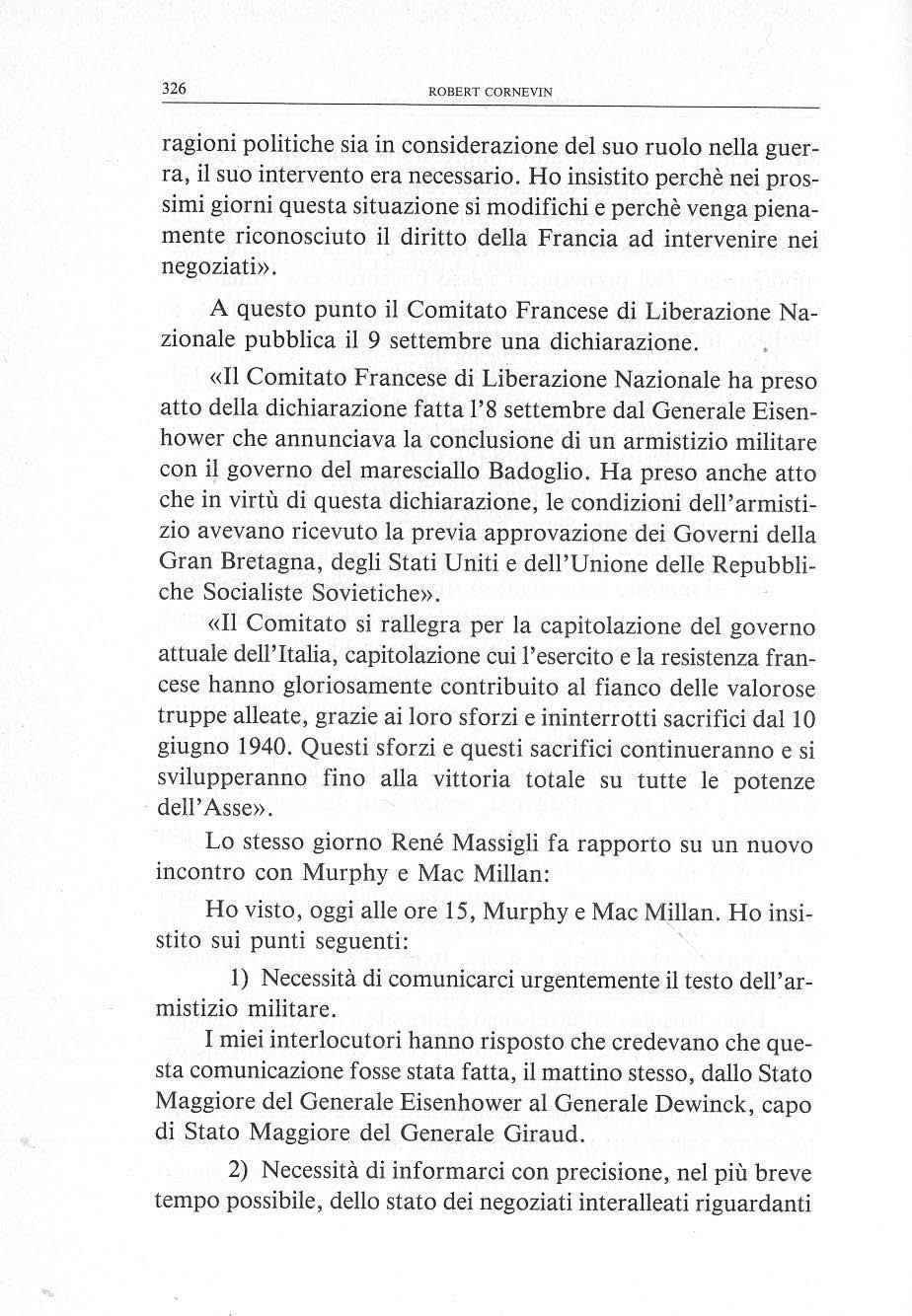
«Il Comitato si rallegra per la capitolazione del governo attuale dell'Italia, capitolazione cui l'esercito e la resistenza francese hanno gloriosamente contribuito al fianco delle valorose truppe alleate, grazie ai loro sforzi e ininterrotti sacrifici dal 10 giugno 1940. Questi sforzi e questi sacrifici continueranno e si svilupperanno fino alla vittoria totale su tutte le potenze · dell'Asse».
Lo stesso giorno René Mass1gli fa rapporto su un nuovo incontro con Murphy e Mac Millan:
Ho visto, oggi alle ore 15, Murphy e Mac Millan. Ho insistito sui punti seguenti: '
1) Necessità di comunicarci urgentemente il testo dell'armistizio militare.
I miei interlocutori hanno risposto che credevano che questa comunicazione fosse stata fatta, il mattino stesso, dallo Stato Maggiore del Generale Eisenhower al Generale Dewinck, capo di Stato Maggiore del Generale Giraud.
2) Necessità di informarci con precisione, nel più breve tempo possibile, dello stato dei negoziati interalleati riguardanti
le clausole politiche, finanziarie, ecc. dell'armistizio. Vorremmo vivamente ricevere il progetto al più presto possibile per essere in grado di formulare le nostre osservazioni in tempo utile.
3) Opportunità di una comunicazione pubblica, nel più breve tempo possibile, a Londra e a Washington, che sottolinei che è per ragioni particolari di segretezza derivanti dalla situazione militare che il Comitato non ha potuto essere informato riguardo i negoziati intavolati con il comando italiano; ma che non è affatto intenzione dei governi americano e britannico tenerli in disparte nègli affari italiani, e che il Comitato verrà quindi associato alle prossime tappe.
Murphy e Mac Millan hanno promesso di inviare immediatamente un telegramma in questo senso ai loro rispettivi governi.
Nel corso della conversazione, Murphy e Mac Millan mi hanno ridetto di essere convinti che il comando interalleato tenesse al corrente il comando francese dei negoziati.
Nella serata dello stesso giorno, ho visto successivamente Murphy e Mac Millan. Ho detto loro che il Generale Giraud aveva dichiarato, nella seduta del Comitato tenutasi alle ore 17, che contrariamente alle affermazioni .dei rappresentanti inglese e americano, non era mai stesso messo al corrente dei negoziati, e che ancora adesso non era a conoscenza delle clausole militari dell'armistizio.
Murphy mi ha risposto che credeva che queste clausole fossero state comunicate al Generale Giraud nella mattinata, ma che avrebbe verificato questo punto.
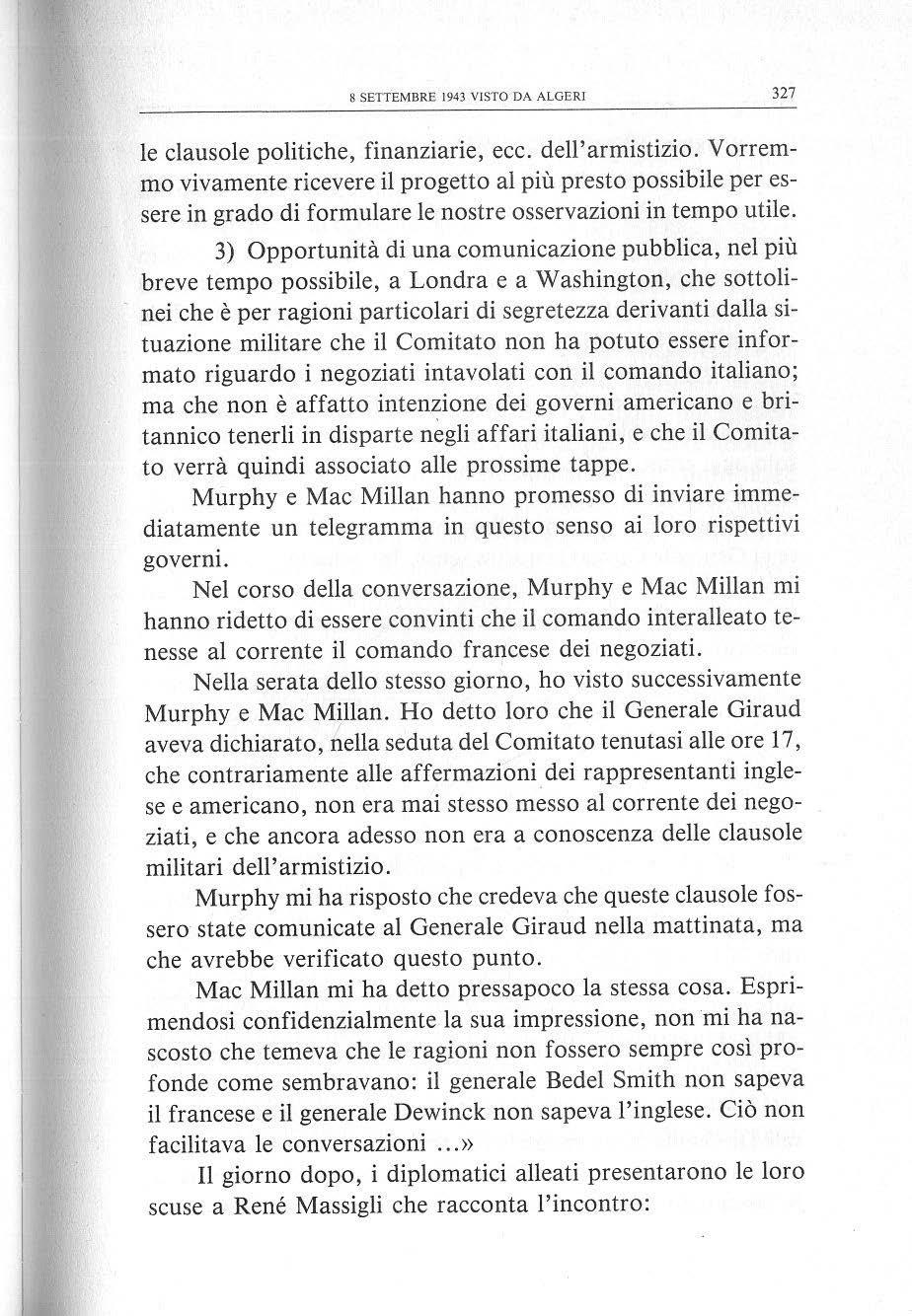
Mac Millan mi ha detto pressapoco la stessa cosa. Esprimendosi confidenzialmente la sua impressione, non mi ha nascosto che temeva che le ragioni non fossero sempre così profonde come sembravano: il generale Bedel Smith non sapeva il francese e il generale Dewinck non sapeva l'inglese. Ciò non facilitava le conversazioni ... »
Il giorno dopo, i diplomatici alleati presentarono le loro scuse a René Massigli che racconta l'incontro:
«A lgeri, 10 settemb r e 1943.
Ho incontrato Murphy e Mac Millan alle ore 14 e 45. Mi hanno fatto, l'uno e l'altro , una dichiarazione che può riassumersi così:
"Le abbiamo detto, l'altro ieri, che il comando francese era stato messo al corrente del nego z iato dell'armistizio. Tale era, infatti, la nostra convinzione.
In seguito alla comunicazione da Lei fattaci ieri, riguardo alla smentita formale del generale Giraud, abbiamo aperto un'inchiesta. Abbiamo constatato che ci eravamo sbagliati e che so lo oggi erano stati comunicati i termini dell'armistizio al comando francese.
Deploriamo questo malinteso. La preghiamo di presentare al Generale Giraud le nostre scuse. In vochiamo, a nostra disc olpa, il fatto che per dieci giorni siamo stati sottoposti ad un lavoro estremamente intenso che non ci ha permesso di verificare ciò che ci sembrava ovvio".
Ho preso atto di que ste spiegazioni. Resta l 'error e politico costituito dal fatto di tenere il Comitato di Liberazion e in disparte. Ho espresso la spe ranza che i prossimi atti permettessero di cancellare questo cattivo ricordo».
De Gaulle utilizza l'incidente per affrettare l'esclusione definitiva de l generale Giraud:
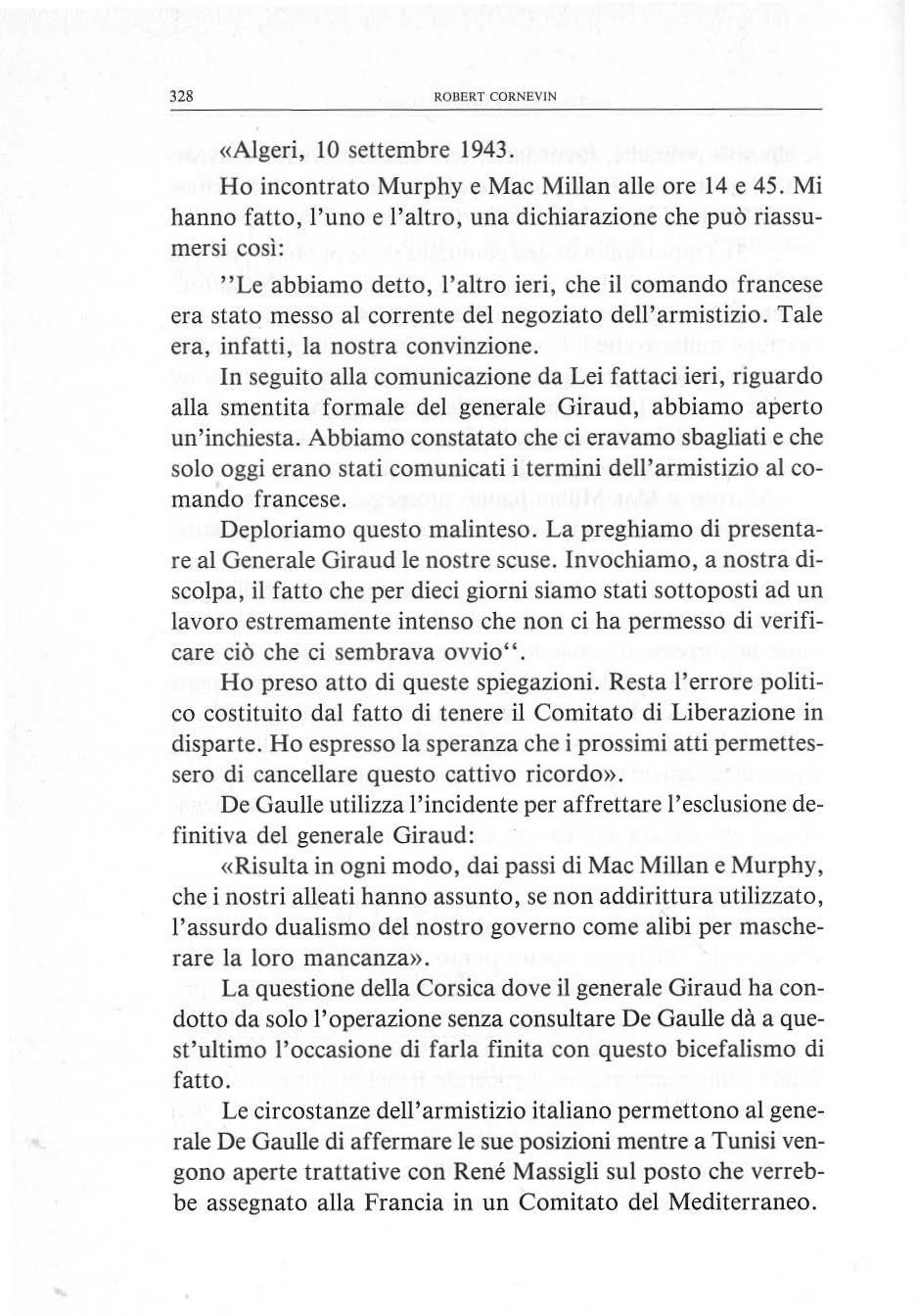
«Risulta in ogni modo, dai passi di Mac Millan e Murphy, che i nostri alleati hanno assunto, se non addirittura utilizzato, l'assurdo dualismo del nostro governo come alibi per mascherare la loro mancanza ».
La questione della Corsica dov e il gen erale Giraud ha condotto da solo l'operazione senza consultare De Gau lle dà a quest' ultimo l'occasione di farla finita con questo bicefalismo di fatto.
Le circostanze dell'armistizio italiano permettono al generale D e Gaulle di affermare le sue posizio ni mentre a Tunisi vengono aperte trattative con René Mass igli sul posto ch e verrebbe assegnato alla Francia in un Comita to del Mediterraneo.
Il suo telegramma a René Massigli del 14 settembre esprime queste preoccupazioni (7):
«Ho messo al corrente questa mattina il Consiglio della comunicazione fattami da Makins da par t e del Primo Ministro britannico in merito alla nostra eventuale ammissione al Comitato del Mediterraneo.
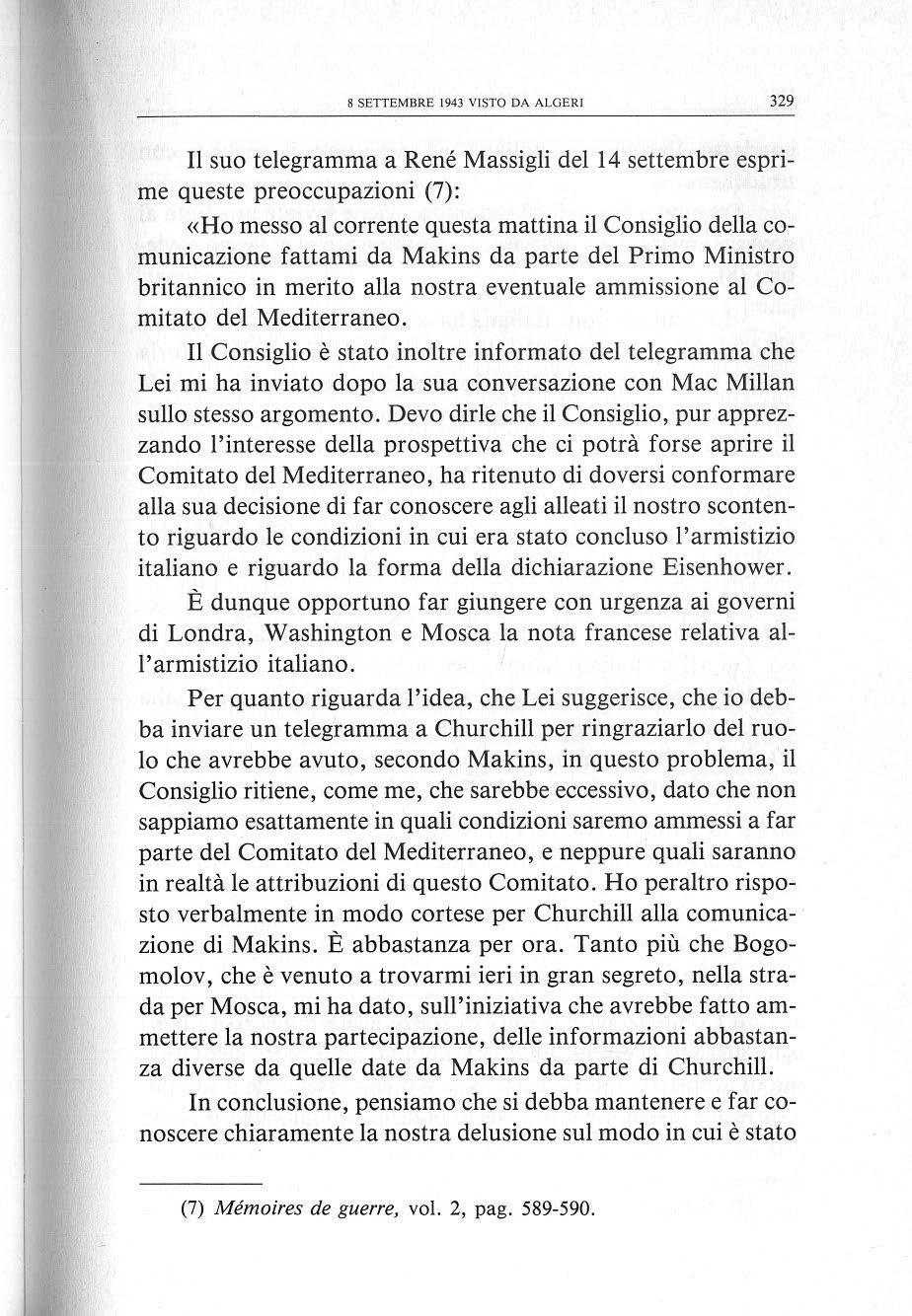
Il Consiglio è stato inoltre informato del telegramma che Lei mi ha inviato dopo la sua conversazione con Mac Millan sullo stesso argomento. Devo dirle che il Consiglio, pur apprezzando l'interesse della prospettiva che ci potrà forse aprire il Comitato del Mediterraneo, ha ritenuto di doversi conformare alla sua decisione di far conoscere agli alleati il nostro scontento riguardo le condizioni in cui era stato concluso l'armistizio italiano e riguardo la forma della dichiarazione Eisenhower.
È dunque opportuno far giungere con urgenza ai governi di Londra, Washington e Mosca la no t a francese relativa al1' armistizio italiano.
Per quanto riguarda l'idea, che Lei sugger isce, che io debba inviare un telegramma a Churchill per ringraziarlo del ruolo che avrebbe avuto, secondo Makins, in questo problema, il Consiglio ritiene, come me, che sarebbe eccessivo, dato che non sappiamo esattamente in quali condizioni saremo ammessi a far parte del Comitato del Mediterraneo, e neppure quali saranno in realtà le attribuzioni di questo Comitato. Ho peraltro risposto verbalmente in modo cortese per Churchill alla comunicazione di Maki ns. È abbastanza per ora. Tanto più che Bogomolov, che è venuto a trovarmi ieri in gran segreto, nella strada per Mosca, mi ha dato, sull'iniziativa che avrebbe fatto ammettere la nostra partecipazione, delle informazioni abbastanza diverse da quelle date da Makins da parte di Churchill.
In conclusione, pensiamo che si debba mantenere e far conoscere chiaramente la nostra delusione sul modo in cui è stato
condotto l'armistizio italiano ed aspettare il seguito con prudenza».
Tre giorni dopo, il 17 settembre, viene inviata una nota ai governi americano e britannico e comunicata al governo sovietico (8):
«La capitolazione italiana ha segnato una nuova e importante tappa sulla strada che deve portare gli alleati alla vittoria finale. Il Comitato di Liberazione Nazionale ne ha ricevuto la noti zia con una gioia tanto più viva quanto in tutte le fasi delle operazioni contro l'Italia le forze francesi hanno avuto la loro parte di sacrificio e di gloria. Ma il Comitato verrebbe meno alla sincerità cui devono essere improntati i rapporti tra alleati se lasciasse ignorare ai Governi americano e britannico la delusione provocatagli dalle condizioni nelle quali è stato concluso l'armistizio e dai termini della dichiarazione con la quale il generale Comandante in capo alleato lo ha annunciato al mondo. Gli affari italiani hanno, per la Francia, una importanza fondamentale. È per colpire e spogliare la Francia che l'Italia fascista è entrata in guerra. La Francia non ha mai cessato, dal 10 giugno 1940 , di partecipare alla lotta armata contro le forze italiane. È infine vitale per la Francia che quanto riguarda gli affari italiani non sia trattato senza la sua presenza. Il Comitato francese di Liberazione Nazionale ritiene che queste considerazioni, che aveva fatto valere nel suo memorandum del 2 agosto indirizzato ai Governi americano e britannico e comunicato al Governo sovie tico, gli diano il diritto di partecipare ai negoziati relativi all'armistizio.
Il Comitato ha il dovere di sottolineare la necessità per i suoi delegati di essere, fin d'ora, abilitati a far parte dell'Organo di armistizio interalleato . .Non è meno essenziale a suo parere essere me sso, fin d'ora, nelle condizioni di far valere il punto
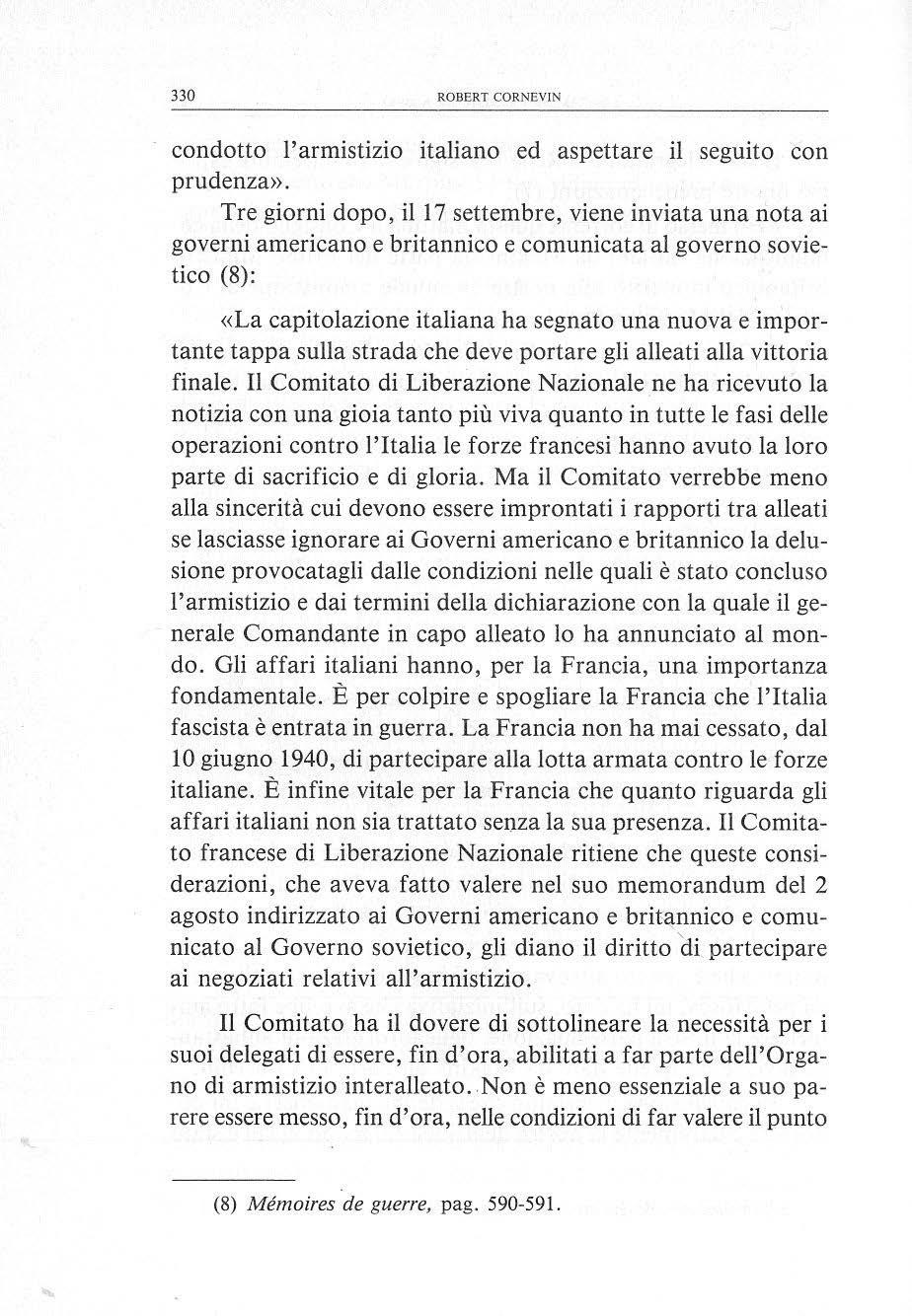
di vista francese, riguardo le clausole di ordine politico, economico e finanziario di cui deve essere importo il rispetto all'Italia. Il memorandum allegato alla presente nota precisa, a questo proposito, le rivendicazioni francesi già esposte nel documento del 2 agosto.
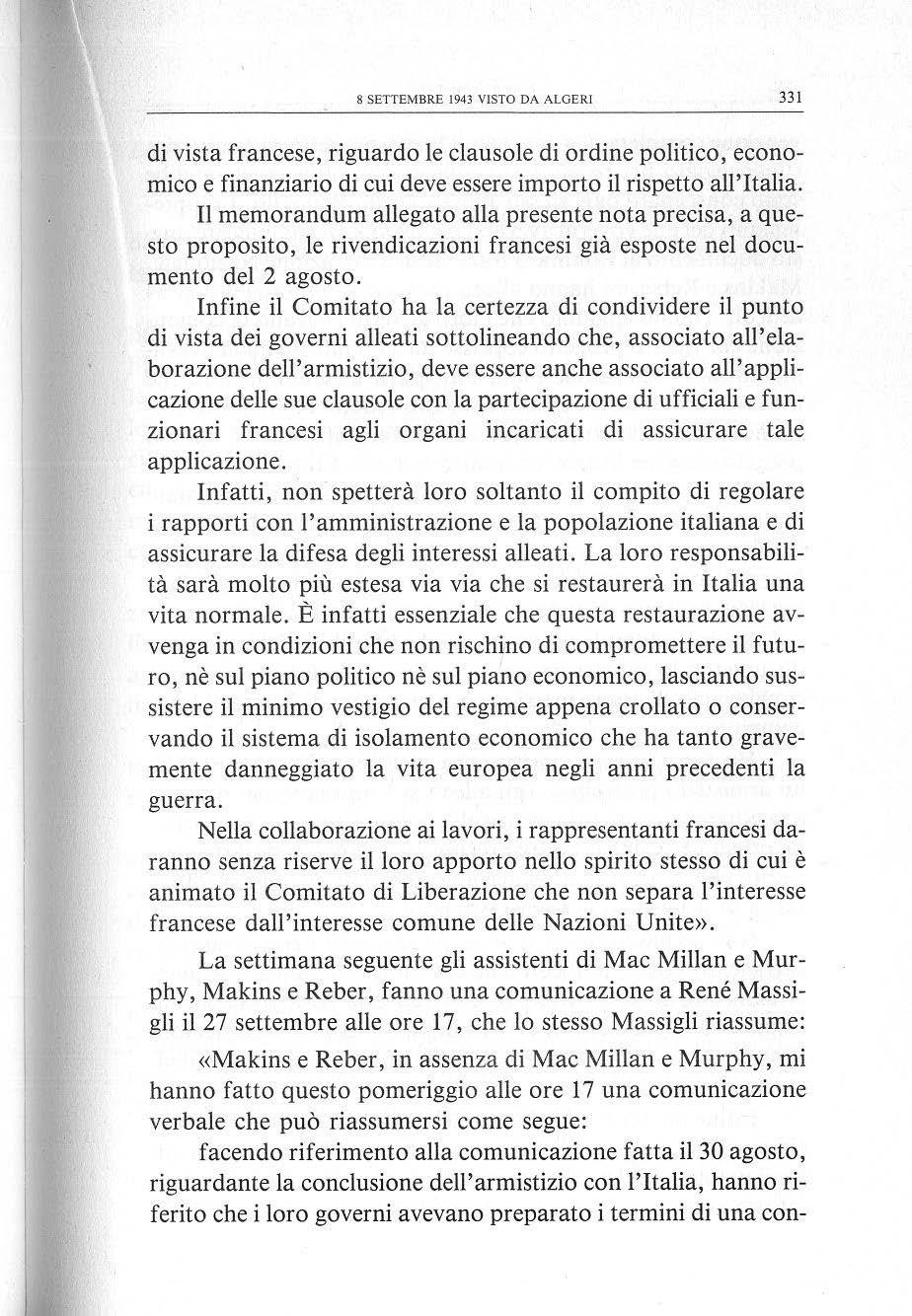
Infine il Comitato ha la certezza di condividere il punto di vista dei governi alleati sottolineando che, associato all'elaborazione dell'armistizio, deve essere anche associato all'applicazione delle sue clausole con la partecipazione di ufficiali e funzionari francesi agli organi incaricati di assicurare tale applicazione.
Infatti, non spette r à loro soltanto il compito di regolare i rapporti con l ' amministrazione e la popolazione italiana e di assicurare la difesa degli interessi alleati. La loro responsabilità sarà molto più estesa via via che si restaurerà in Italia una vita normale . È infatti essenziale che questa restaurazione avvenga in condizioni che non rischino di compromettere il futuro, nè sul piano politico nè sul piano economico, lasciando sussistere il minimo vestigio del regime appena crollato o conservando il sis t ema di isolamento economico che ha tanto gravemente danneggiato la vita europea negli anni precedenti la guerra.
Nella collaborazione ai lavori, i rappresentanti francesi daranno senza riserve il loro apporto nello spirito stesso di cui è animato il Comitato di Liberazione che non separa l'interesse francese dall'interesse comune delle Nazioni Unite».
La settimana seguen t e gli assistenti di Mac Millan e Murphy, Makins e Reber, fanno una comunicazione a René Massigli il 27 settembre alle ore 17, che lo stesso Massigli riassume: «Makins e Reber, in assen za di Mac Millan e Murphy, mi hanno fatto questo pomeriggio alle ore 17 una comunicazione verbale che può riassumersi come segue: facendo riferimento alla comunicazione fatta il 30 agosto, riguardante la conclusione dell'armistizio con l'Italia, hanno riferito che i loro governi avevano preparato i termini di una con-
venzione completa di armistizio. Questo progetto di armistizio, rimaneggiato per tener conto della nuova situazione, sarebbe stato consegnato oggi stesso al maresciallo Badoglio. I rappresentanti dei due governi avevano la missione di comunicare questo documento al Comitato francese di Liberazione Nazionale. Makins e Reber mi hanno allora consegnato un progetto in 44 articoli. Hanno aggiunto che i loro governi avevano la convinzione che questo progetto coprisse tutti i punti sui quali avevamo attirato l'attenzione e non anticipasse alcuna soluzione che avrebbe potuto essere contro le nostre vedute. Ho risposto sottolineando il mio stupore per essere stati informati di questo progetto così tardivamente, contrariamente a tutte le promesse che ci erano state fatte. La risposta è stata che vi erano state molte esitazioni a Londra e a Washington sulla procedura da ·seguite e che la decisione finale era appena stata presa. Al che ho replicato che avrebbero potuto comunicarmi per ogni evenienza i progetti, così come mi era stato promesso .
Riservandomi le osservazioni che potrebbe richiamare un documento la cui stesura non è semplice, ho fatto notare che rischiavamo di essere messi ancora una volta di fronte al fatto compiuto.
Ho fatto infine osservare che, nell'ipotesi considerata di un armistizio precipitoso, gli alleati si erano mostrati disposti a facilitarci almeno la presenza alla firma. Su questo punto non ho ottenuto alcuna risposta precisa. In compenso mi è stato ripetuto che la nostra partecipazione alla commissione mediterranea di armistizio doveva rassicurarci.
Non ho nascosto che queste spiegazioni mi apparivano insufficienti. Ho sottolineato che era un errore politico firmare attualmente un armistizio con il maresciallo Badoglio e che mi dispiaceva che a Londra e Washington avessero modificato a questo proposito il modo di vedere che mi era stato esposto qualche giorno fa.
Infine ho detto a Makins e Reber che mi riservavo di precisare e di completare le mie osservazioni nel momento 'in cui avrei potuto prendere conoscenza del documento di cui ero stato informato.»
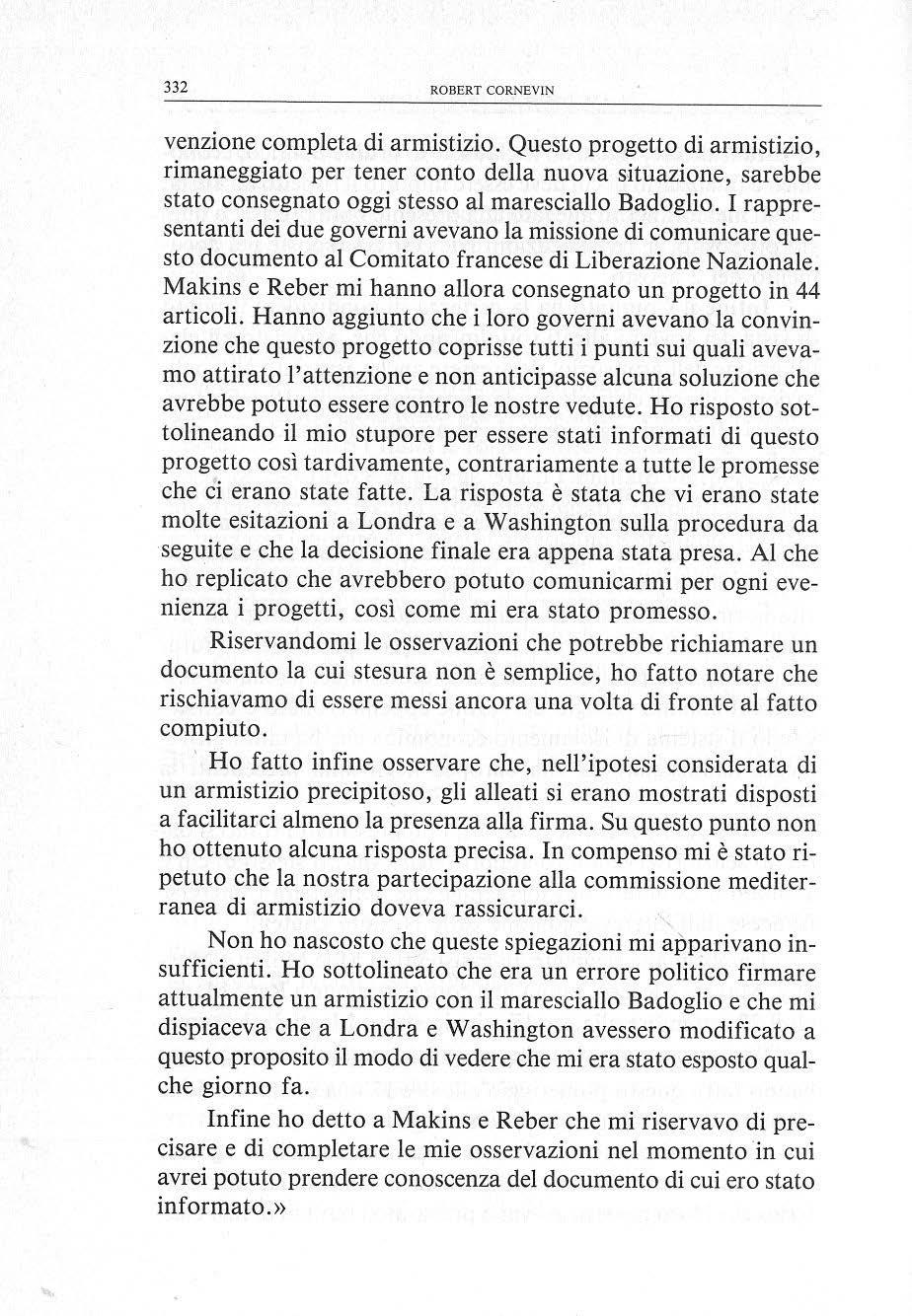
La Corsica era stata occupata dall'esercito italiano fin . dall' 11 novembre 1942 mentre la zona libera era occupata dalla Wehrmacht. · ·
All'inizio del 1943, Arthur Giovoni (10), responsabile politico del Fronte Nazionale, e François Vittori, responsabile militare, prendono contatto con un inviato del generale De Gaulle, Fred Scamaroni che, dal 1941, porta avanti un'azione di collegamento. Arrestato, torturato, quest'ultimo si suicida nella cittadella di Ajaccio. Da quel moment o tutto si svolgerà tra gli emissari di Giraud - in particolare dal marzo 1943 -, il comandante Colonna d'Istria e i rappresentanti (in maggioranza comunisti) del Fronte Nazionale.
Durante questo mese d'agosto delle trattative di armistizio, ufficiali italiani con simpatie antifasciste parteciperanno alla liberazione della Corsica. Il colonnello italiano Cagnoni incontra a Bastia Arthur Giovoni e gli èonsegna i piani del suo reggimento, incaricato di impedire lo sbarco alleato.
Giovoni, a bordo del sottomarino Casabianca, porta questi documenti ad Algeri (4 settembre), incontra il generale Giraud e riparte il 6 senza avere visto il generale D e Gaulle.
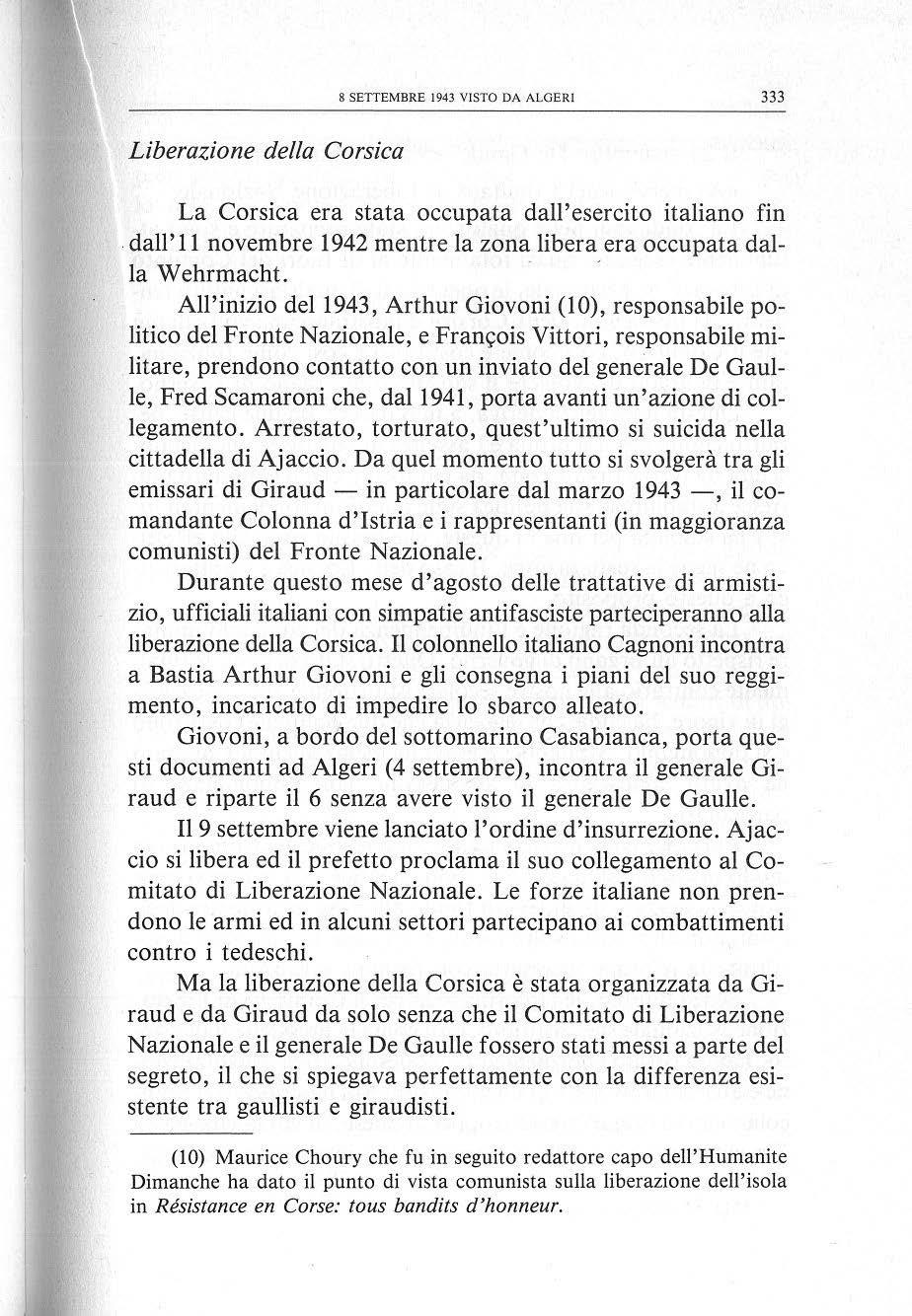
Il 9 settembre viene lanciato l'ordine d'insurrezione. Ajaccio si libera ed il prefetto proclama il s uo collegamento al Comitato di Liberaz ione Nazionale. Le forze italiane non prendono le armi ed in alcuni settori partecipano ai combattimenti contro i tedeschi.
Ma la liberazione della Corsica è stata organizzat a da Giraud e da Giraud da solo senza che il Comitato di Liberazione Nazionale e il generale De Gaulle fossero stati messi a parte del segreto, il che si spiegava perfettamente con la differenza esistente tra gaullisti e giraudisti.
(10) Maurice Choury che fu in seguito redattore capo dell'Humanite Dimanche ha dato il punto di vista comunista sulla liberazione dell'isola in Résistance en Corse: tous bandits d'honneur.
Il 25 settembre De Gaulle invia una nota (11):
«Ai membri del Comitato di Liberazione Nazionale: Le condizioni nelle quali sono state preparate e sono attualmente eseguite, quasi totalmente al di fuori del Comitato di Liberazione Nazionale, le operazioni di qualsiasi natura tendenti alla liberazione della Corsica dimostrano una volta di più che il Comitato, così come è costituito e così come funziona, non è in grado di svolgere il suo ruolo di organo di governo. Questa impotenza deriva , a mio parere, da due cause, peraltro coniugate. La prima è l'assenza di una direzione riconosciuta da tutti e organizza ta, da cui risulta che il Comitato non riesce a stabilire la sua politica sulle questioni fondamentali, o, se l'ha stabilita per una di queste, che nessun controllo effettivo ne segue la realizzazione. Il caso della Corsica è caratteristico a questo proposito.
La seconda ragione è l'indipendenza del comando militare rispetto all'organo di governo. Questo stato di cose, formalmente contrario alle nostre secolari istituzioni e alle nostre leggi in vigore, ha come conseguenza che due politiche coesistono e si oppongono. Molteplici e gravi incidenti di cui il Comitato ha avuto conoscenza lo stabiliscono con abbondanza di particolari.
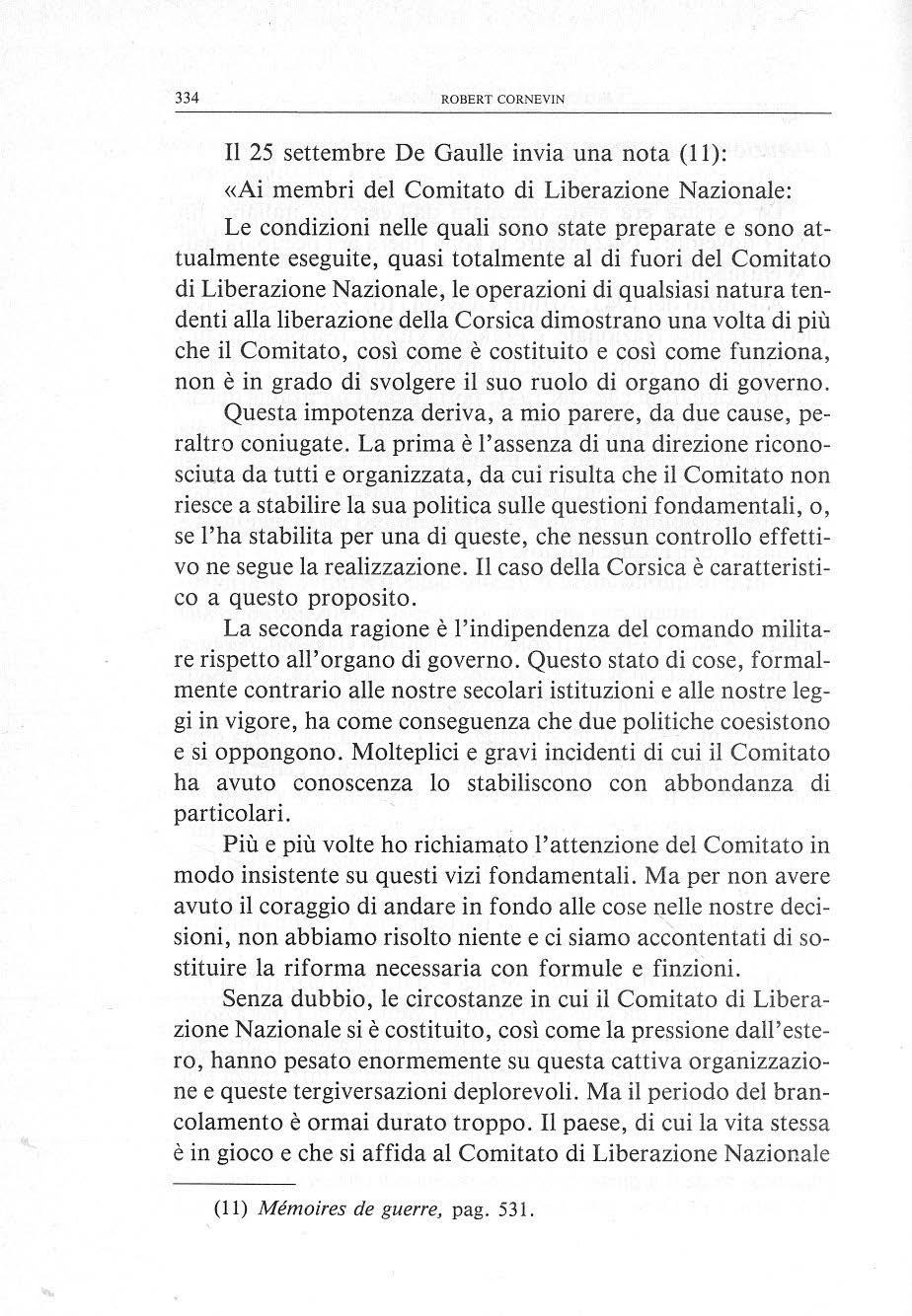
Più e più volte ho richiamato l'attenzione del Comitato in modo insistente su questi vizi fondamentali. Ma per non avere avuto il coraggio di andare in fondo alle cose nelle nostre decisioni, non abbiamo risolto niente e ci siamo accontentati di sostituire la riforma necessaria con formule e finzioni.
Senza dubbio, le circostanze in cui il Comitato di Libe razione Nazionale si è costituito, così come la pressione dall'e stero, hanno pesato enormemente su questa cattiva organizzazione e queste tergiversazioni deplorevoli. Ma il periodo del brancolamento è ormai durato troppo. Il paese, di cui la vita stessa è in gioco e che si affida al Comitato di Liberazione Nazionale
(11) Mémoires de guerre, pag. 531.
per dirigere i suoi sforzi nella guerra e preparare l'opera da compiere all'altezza della vittoria, non ci perdonerebbe di protrarl o oltre. Le responsabi li tà devono essere assunte e riconosciute. Quanto a me, non posso portare le mie più a lungo in tali condizioni» .
Il 4 ottobre, il generale De Gaulle va dal generale Giraud ( 12):
«Ne ll a serata dello stesso giorno vado dal comandante in capo per congratularmi, a nome del governo, della felice riuscita dell'operazione militare. L'aveva ordinata e avviata. Ne aveva assunto il rischio. Il merito era suo. Pur avendo operato con mezzi a scala ridotta, le difficoltà erano grandi poiché si doveva andare verso l'ignoto, a 900 chilometri dalle nostre basi, e combinare in un'unica azione degli elementi presi all'improvviso nell'esercito, la marina, l'aviazione» .
Fin dal 24 settembre, avevo detto alla radio di Algeri:
«Il paese e l'impero salutano i combattenti francesi in Corsica, ai quali il comandante in capo dell'esercito francese ha appena dato, sul terreno stesso, le istruzioni per gli scontri di domandi . A questi combattenti e ai loro capi, a coloro che si sono sollevati dal suolo corso per liberarsi e a coloro che sono stati ard itamente inviati dall'esercito, la marina, l'aviazione francese rinascenti, il Comitato di Liberazione Nazionale invia la testimonianza ardente dell'amore e dell'orgoglio della Francia».
Ma una volta fatta giustizia alle capacità militari del generale Giraud, era pur vero che si era comportato riei confronti del governo in un modo inamm iss i bile. Glielo ripetevo, quella sera, dopo essermi complimentato. «Lei mi parla di politica», disse - «si, risposi - perché facciamo la guerra. Ora, la guerra è una politica». «Mi s entiv a, ma non mi ascoltava».
Quat t ro giorni più tardi, 1'8 ottobre, De Gaulle va in Corsica e dalla pia zza del Municipio di Ajaccio dopo avere salutato i resistent i e i com battenti menziona l'Ita li a (13).
(12) Mémo ires de guerre, voi. 2, pag. 145.
(13) Mémoires de guerre, vol. 2, pag 147.

«Allora, osservando che la mia voce si levava "dal centro del mare latino " parlai dell'Italia. Sottolineai "a che punto erano assurde le ambizioni di un vicino latino spinto, ieri, in una mostruosa alleanza con la cupidigia germanica e che portava come pretesto la nostra decadenza per cercare di impadronirsi della Corsica." Ma dichiarai: "una volta resa giustizia, la Francia di domani non si irrigidirà in un atteggiamento di rancore verso una nazione che ci è affine e che niente di fondamentale dovrebbe separare da noi". * * *
L'armistizio italiano costituì una svolta nella guerra di cui i tedeschi riuscirono a limitare gli effetti strategici (14). Questo periodo costituisce una svolta anche per il Comitato francèse di Liberazione Nazionale. Finiranno ormai i giochi meschini subdolamente condotti da Murphy e Mac Millan grazie al bicefalismo Giraud-De Gaulle.
D'altra parte, la lib erazione della Corsica settore francese intralcia il progetto americano che figura in un memorandum riguardante la partecipazione francese all'amministrazione dei territori liberati nella Francia metropolitana, consegnato dal governo degli Stati Uniti al governo britannico e giunto a conoscenza del Comitato francese di Liberazione Nazionale (15).
Così il generale De Gaulle e il Comitato francese di Liberazione Naz ionale hanno saputo utilizzare al meglio la leggerezza e la goffagine degli alleati per affermarsi come soli interlocutori mentre il generale Giraud, che aveva realizzato con mezzi irrisori e in condizioni eccezionalmente abili la liberazione della Corsica veniva escluso da ogni responsabilità politica nel governo di Algeri. (14) Miltn S. Davis, Qui défend Rome?, Hachett e Littérature, 1972 (15) Mémoires de guerre, pag . 591-592.
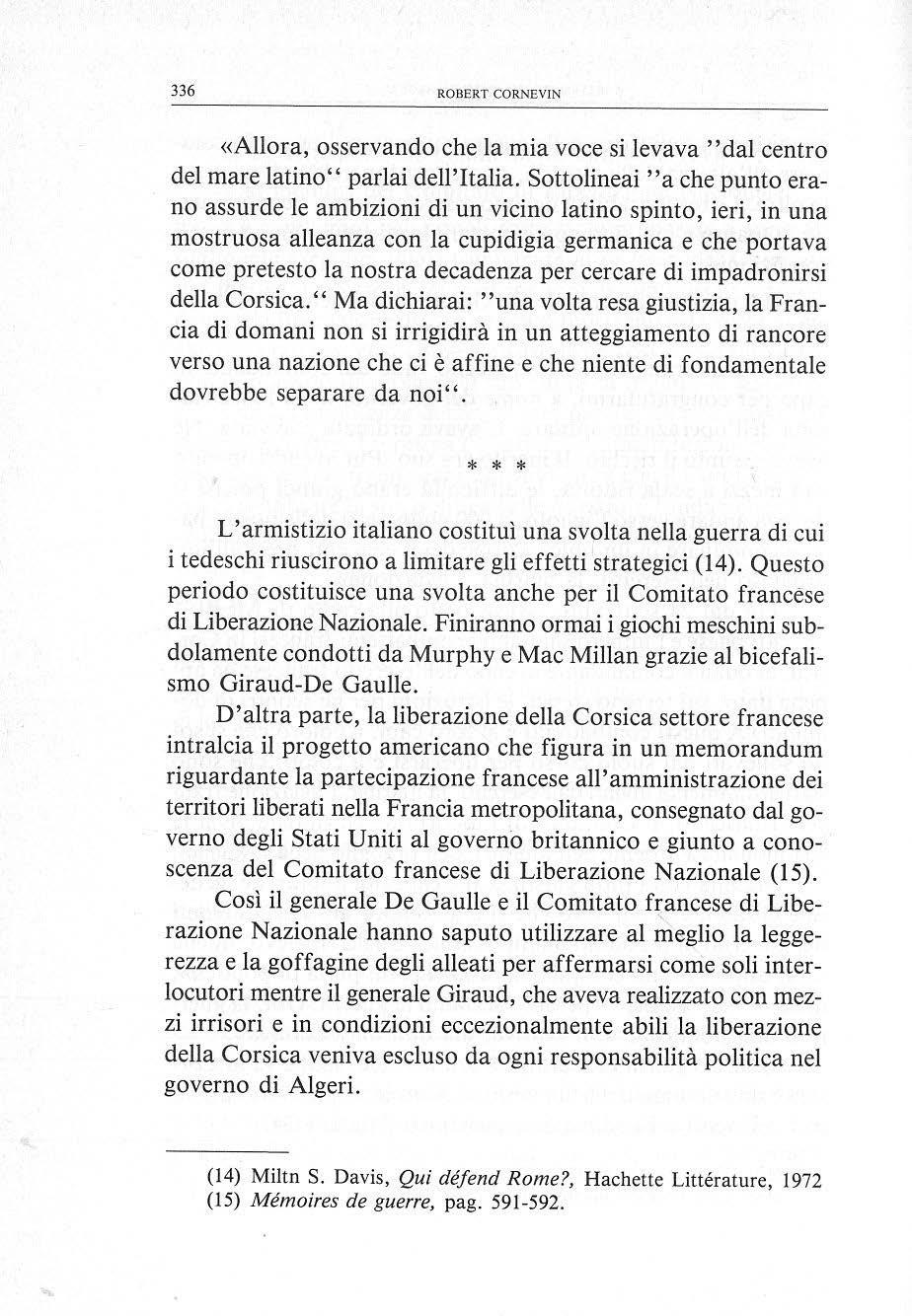
L'atteggiamento dei paesi nordici rispetto all'armistizio in Italia deve essere esaminato da una parte sotto l'aspetto dell'evoluzione generale della guerra mondiale e, dall ' altra, sotto quello dello sviluppo della situazione in ciascun paese nordico .
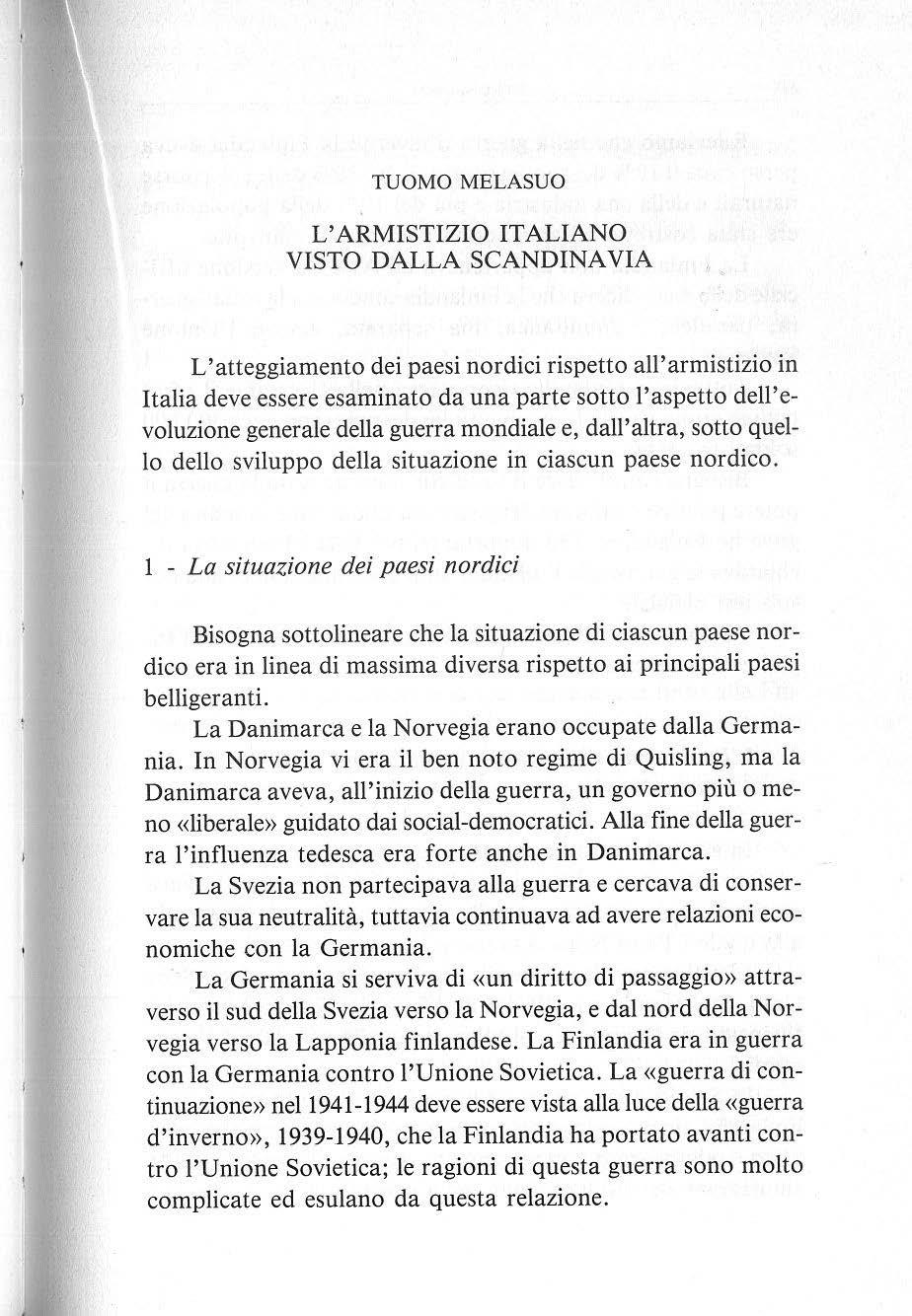
Bisogna sottolineare che la situazione di ciascun paese nordico era in linea di massima diversa rispetto ai principali paesi belligeranti.
La Danimarca e la Norvegia erano occupate dalla Germania. In Norvegia vi era il ben noto regime di Quisling, ma la Danimarca aveva, all'inizio della guerra, un governo più o meno «liberale» guidato dai social-d emocratici. Alla fine della guerra l'influenza t edesca era forte anche in Danimarca.
La Svezia non partecipava alla guerra e cercava di conservare la sua n eutralità, tuttavia continuava ad avere relazioni economiche con la Germania.
La Germania si serviva di «un diritto di passaggio» attraverso il sud della Svezia verso la Norvegia, e dal nord della Norvegia verso la Lapponia finlandese. La Finlandia era in guerra con la Germania contro l'Unione Sovietica. La «guerra di continuazione» nel 1941-1944 deve essere vista alla luce della «guerra d'inverno», 1939-1940 , che la Finlandia ha portato avanti contro l'Unione Sovietica; le ragioni di questa guerra sono molto complicate ed esulano da questa relazione.
Rileviamo che nella guerra d'inverno la Finlandia aveva perso circa il lOOJo del suo territorio, il 20/300Jo delle sue risorse naturali e della sua indu stria e più del lOOJo della popolazione era stata costretta ad abbandonare le regioni coinvolte.
La Finlandia non apparteneva all'Asse, la vers io ne ufficiale dello stato diceva che la Finla ndi a conduceva la «sua» guerra, parallela e simultanea, ma separata, contro l'Unione Sovietica.
Tuttavia la Finlandia riconosceva nella Germania il «fratello in armi» e nella Lapponia finlandese vi erano circa 300.000 s oldati tedeschi.
Bisogna sottolineare il fatto che durante tutta la guerra il potere politico e militare del paese era saldamente in mano del governo finlandese. Ciò nonostante, nel 1941 l'Inghilterra dichiarava la guerra alla Finlandia, non credendo quindi alla nostra tesi ufficiale.
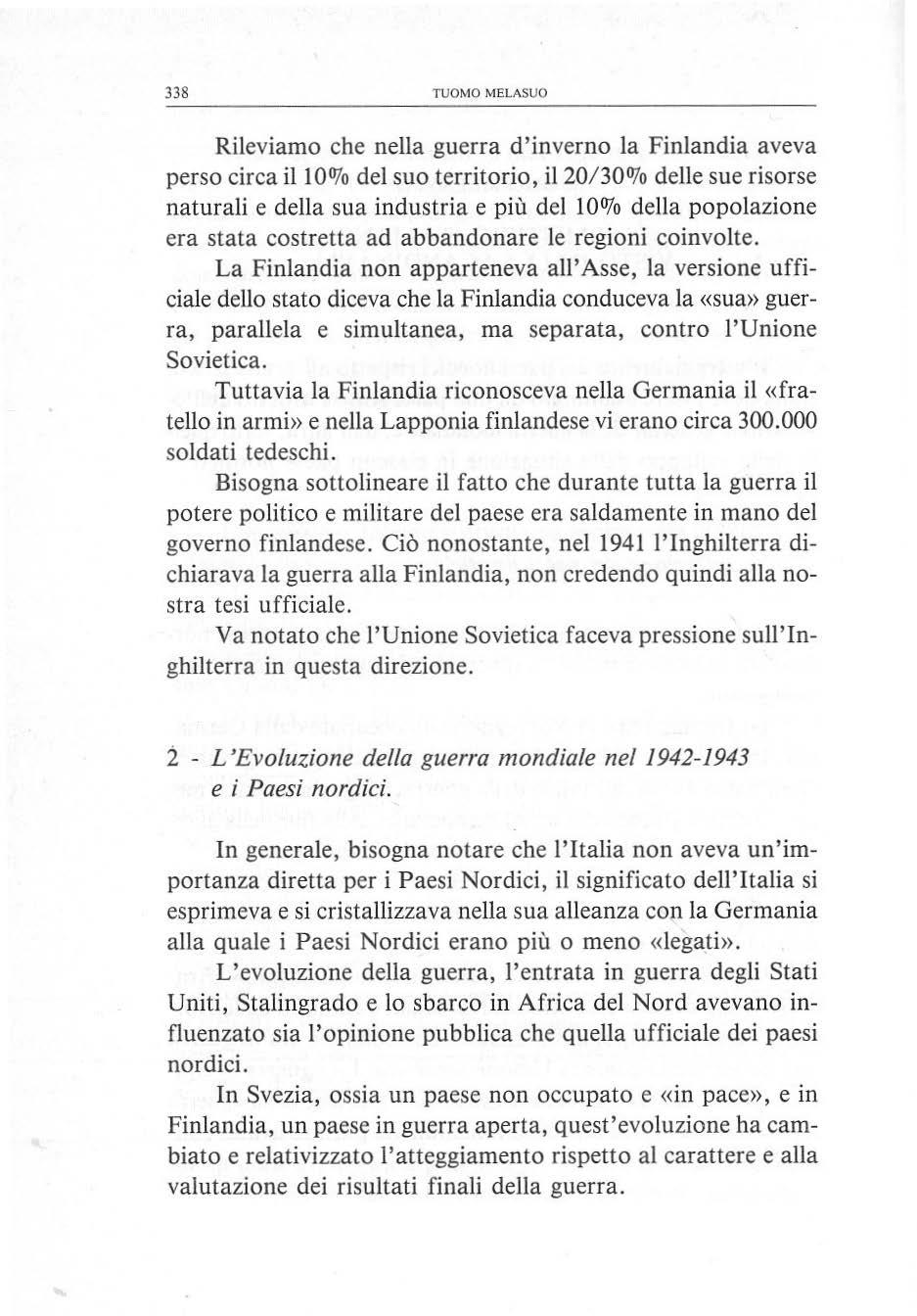
Va notato che l'Unione Sovietica faceva pressione sull'Inghilterra in questa direzione.
i - L'Evoluzione della guerra mondiale nel 1942-1943 e i Paesi nordici.
In generale, bisogna notare che l'Italia non aveva un'importanza diretta per i Paesi Nordici, il significato dell'Italia si espr im eva e si cristallizzava nella sua alleanza con la Germania alla quale i Paesi Nordici erano più o meno «legati».
L'evoluzione della guerra, l'entrata in guerra degli Stati Uniti, Stali ngrado e lo sbarco in Africa del Nord avevano influenzato sia l'opinione pubblica che quella ufficiale dei paesi nordici.
In Svezia, ossia un paese non occupato e «in pace», e in Finlandia, un paese in guerra aperta, quest'evoluzione ha cambiato e relativizzato l'atteggiamento rispetto al carattere e alla valutazione dei risultati finali della guerra.
Per quanto riguarda l'interno della Finlandia, tre fatti segnano l'evoluzione del suo atteggiamento:
1) la nascita e il rafforzamento della cosiddetta «opposizione della pace» nell'inverno 1942-1943;
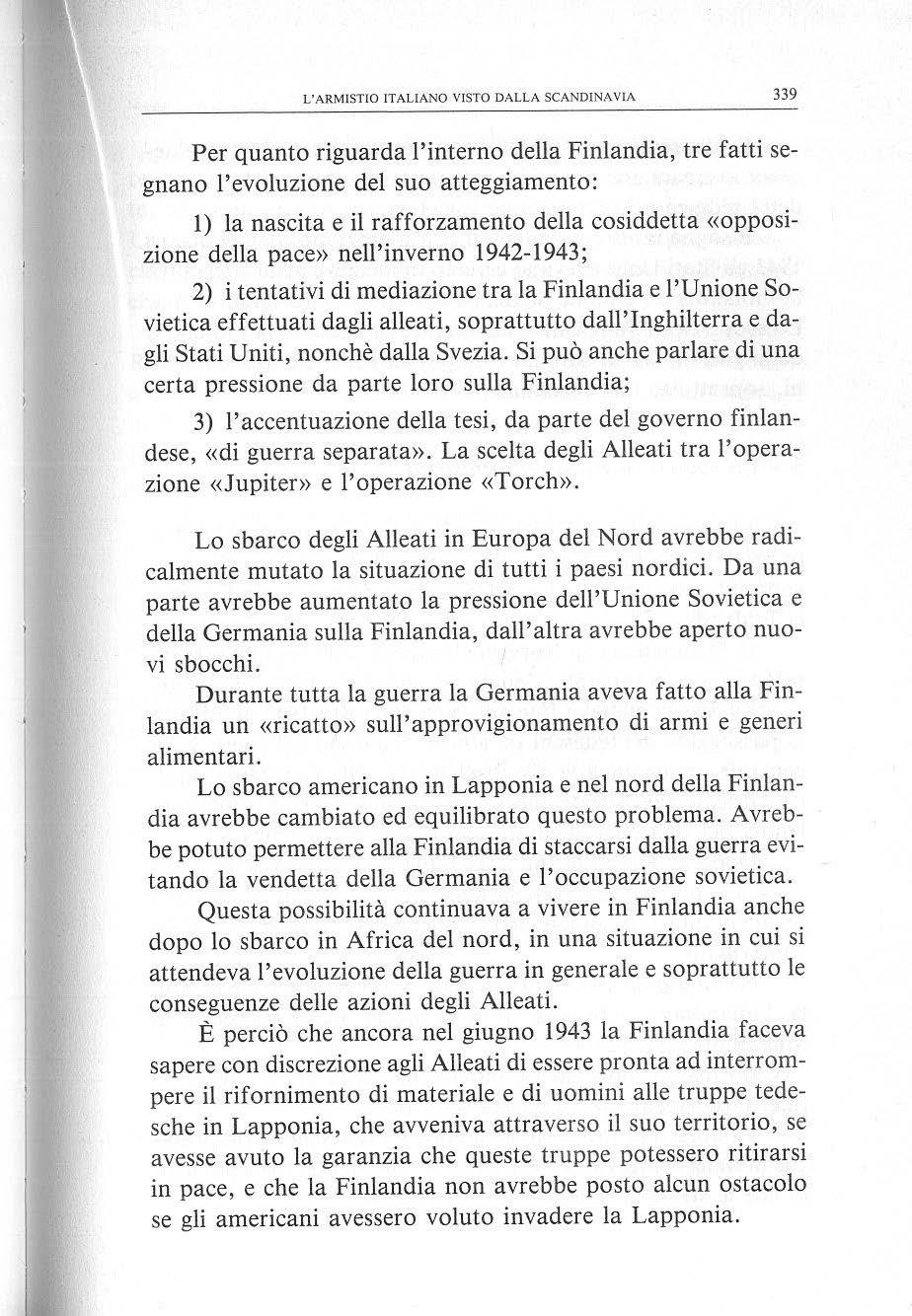
2) i tentativi di mediazione tra la Finlandia e l'Unione Sovietica effettuati dagli alleati, soprattutto dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, nonchè dalla Svezia. Si può anche parlare di una certa pressione da parte loro sulla Finlandia;
3) l'accentuazione della tesi, da parte del governo finlandese, «di guerra separata». La scelta degli Alleati tra l'operazione «Jupitern e l'operazione «Torch».
Lo sbarco degli Alleati in Europa del Nord avrebbe radicalmente mutato la situazione di tutti i paesi nordici. Da una parte avrebbe aumentato la pressione dell'Unione Sovietica e della Germania sulla Finlandia, dall'altra avrebbe aperto nuovi sbocchi.
Durante tutta la guerra la Germania aveva fatto alla Finlandia un «ricatto» sull'approvigionamento di armi e generi alimentari.
Lo sbarco americano in Lapponia e nel nord della Finlandia avrebbe cambiato ed equilibrato questo problema. Avrebbe potuto permettere alla Finlandia di staccarsi dalla guerra evitando la vendetta della Germania e l'occupazione sovietica.
Questa possibilità continuava a vivere in Finlandia anche dopo lo sbarco in Africa del nord, in una situazione in cui si attendeva l'evoluzione della guerra in generale e soprattutto le conseguenze delle azioni degli Alleati.
È perciò che ancora nel giugno 1943 la Finlandia faceva sapere con discrezione agli Alleati di essere pronta ad interrompere il rifornimento di materiale e di uomini alle truppe tedesche in Lapponia, che avveniva attraverso il suo territorio, se avesse avuto la garanzia che queste truppe potessero ritirarsi in pace, e che la Finlandia non avrebbe posto alcun ostacolo se gli americani avessero voluto invadere la Lappon ia.
Evidentemente in Finlandia maturava l'idea che fosse necessario creare una situazione in cui era possibile evitare la vendetta tedesca e l'occupazione sovietica.
Bisogna inoltre prendere in considerazione che nel marzo
1943 gli Stati Uniti avevano cercato di mediare nella guerra tra la Finlandia e l'Unione Sovietica offrendo i loro buoni uffici .
Lo scopo degli Stati Uniti, nel cercare di staccare la Finlandia dalla guerra, era di dare un esempio all'Italia e ai paesi balcani, soprattu tto alla Romania.
3 - Lo sbarco in Italia e l'armistizio
Lo sbarco degli Alleati, ma già la sua attesa, come ho detto prima, e l'armistizio con il governo di Pi etro Badoglio avevano influenzato i paesi nordici, e, più da vicino, la Svezia e la Finlandia.
In Danimarca e in Norvegia l'attività della resi stenza si era rafforzata e, in generale, l'opinione anti-tedesca era prevalente.
La Svezia metteva fine agli inizi di agosto 1943 al «diritto di passaggio» dei tedeschi sia a nord che a sud del paese, e, in generale, aumentava le distanze rispetto alla Germania; inoltre, insieme agli Alleati, faceva sempre più pressione su lla Finlandia per una pace separata con l'Unione Sovietica.
Dopo lo sbarco in Italia, la Finlandia andava accentuando la sua tesi di «guer ra separata»; per esempio il battaglione SS di volontari finlandese nell'estate del 1943 non era più stato confermato.
Nell'autunno 1943, malgrado le forti pressioni dei tedeschi, l a Finlandia si rifiutava di riconoscere «la repubblica di Mussolini».
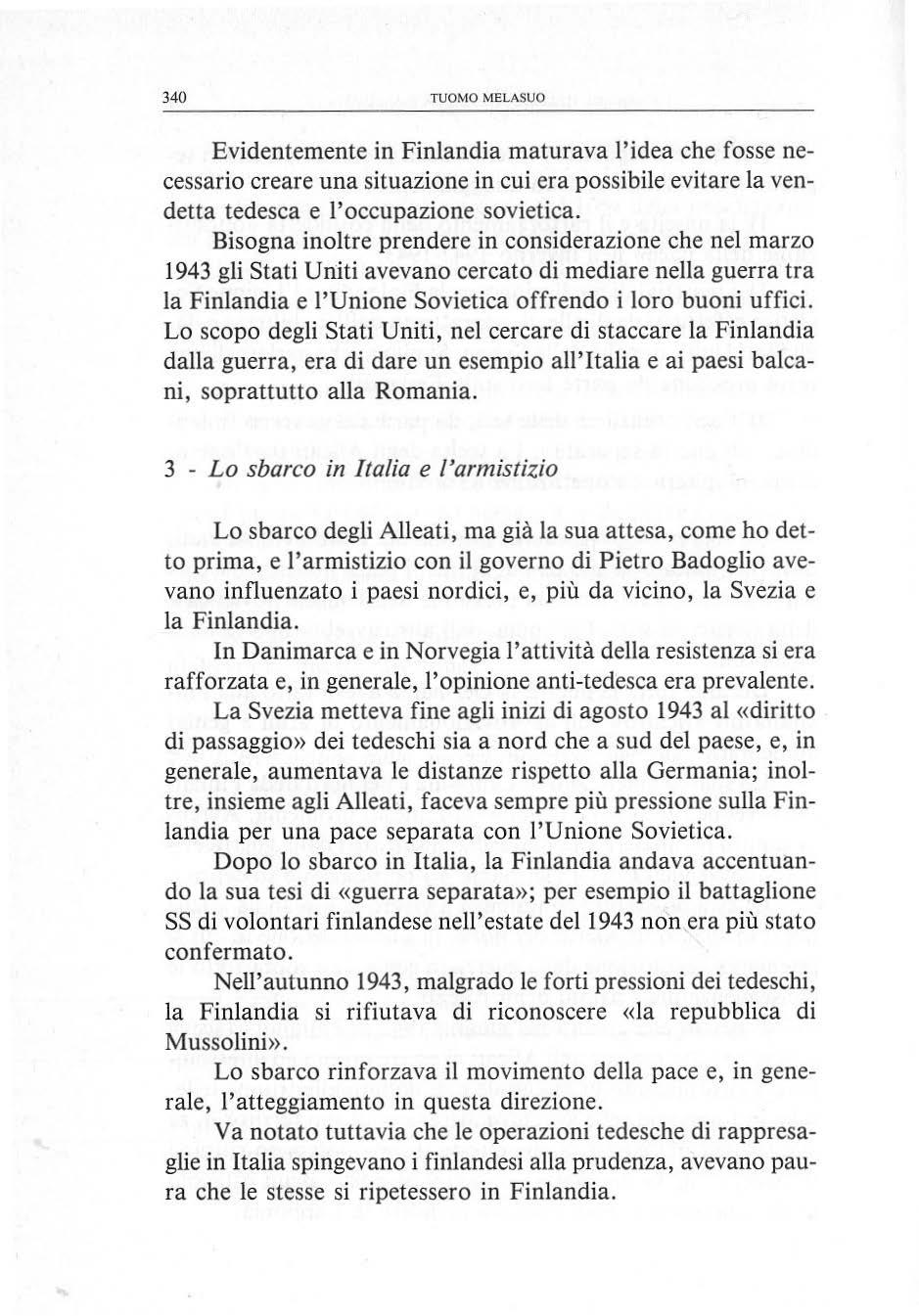
Lo sbarco rinforzava il movimento della pace e, in generale, l'atteggiamento in que sta dire zione .
Va notato tutta via che le operazioni tedesche di rappresaglie in Italia spingevano i finlandesi alla prudenza, avevano paura che le stesse si ripetessero in Finlandia.
Ma bisogna sottolineare che la situazione politica e militare della Finlandia rispetto alla Germania era relativamente forte. Si era in un certo senso rafforzata con lo sbarco in Italia. La Finlandia impegnava un numero rilevante di truppe sovietiche alla frontiera est, ed era la sola «democrazia occidentale» che combatteva al fianco della Germania.
Osserviamo che più tardi gli avvenimenti in Ungheria e in Romania avrebbero influenzato la Finlandia nello stesso modo e nella stessa direzione dello sbarco in Italia. Si cristallizzavano le esigenze di distacco dalla guerra e, nello stesso tempo, si faceva sentire la necessità di prudenza per la probabile rappresaglia tedesca.
La stampa finlandese dava relativamente molto spazio agli «avvenimenti» in Italia. In linea di massima la loro impo rtanza era capita ed espressa, soltanto la stampa dell'estrema destra cercava di sminuire il significato della «perdita» dell'Italia per la Germania.
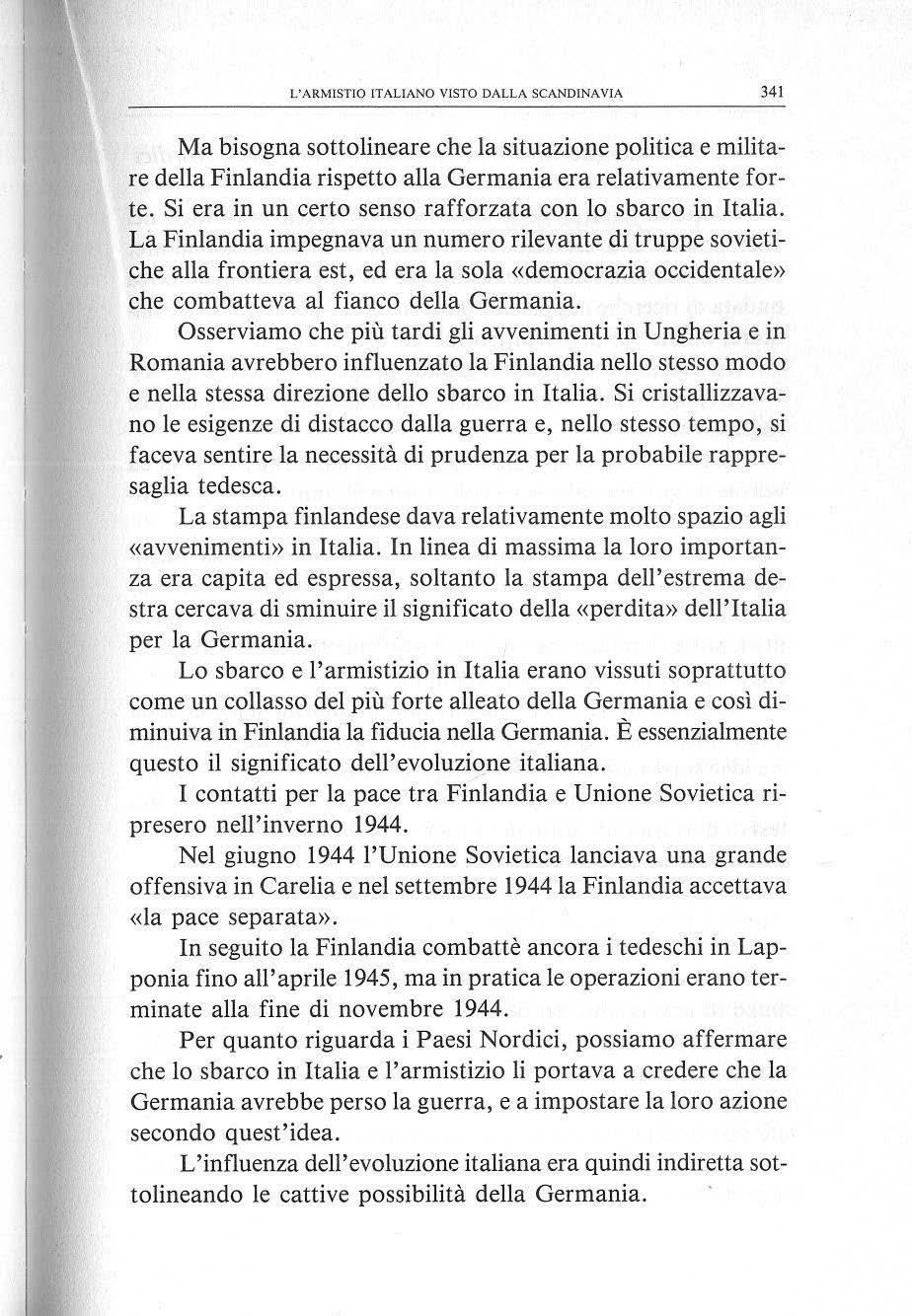
Lo sbarco e l'armistizio in Italia erano vissuti soprattutto come un collasso del più forte alleato della Germania e così diminuiva in Finlandia la fiducia nella Germania. È essenzialmente questo il significato dell'evoluzione italiana.
I contatti per la pace tra Finlandia e Unione Sovietica ripresero nell'inverno 1944.
Nel giugno 1944 l'Unione Sovietica lanciava una grande offensiva in Carelia e nel settembre 1944 la Finlandia accettava «la pace separata».
In seguito la Finlandia combattè ancora i tedeschi in Lapponia fino all'aprile 1945, ma in pratica le operazioni erano terminate alla fine di novembre 1944.
Per quanto riguarda i Paesi Nordici, possiamo affermare che lo sbarco in Italia e l'armistizio li portava a credere che la Germania avrebbe perso la guerra, e a impostare la loro azione secondo quest'idea.
L'influenza dell ' evoluzione italiana era quindi indiretta sottolineando le cattive possibilità della Germania.
4 - La seconda guerra e la ricerca storica nei Paesi Nordici
Dopo la guerra, negli anni 1950 e 1960 , aveva luogo nei paesi nordici una ricerca nella «tradizione» sulla storia militare.
Ma possiamo dire c he negli anni 1970 è ini ziata una nuova ondata di ricerche impostata, oltre che sulla stor ia politica e militare, anche sui problemi sociali ed economici.
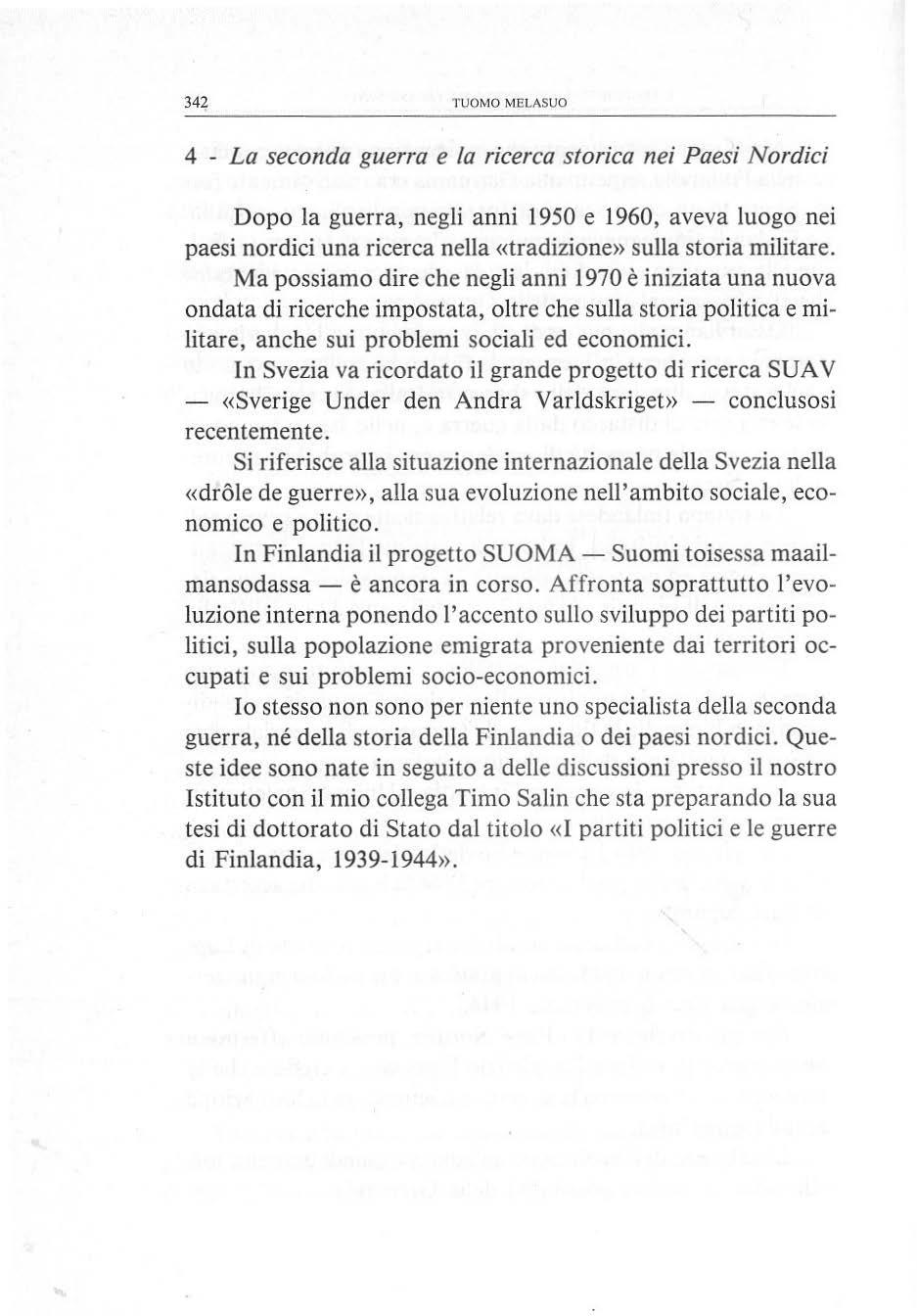
In Svezia va ricordato il grande progetto di ricerca SUAV - «Sverige Under den Andra Varldskriget» - conclusosi rec entemente.
Si riferisce alla situazione internazionale della Svezia nella «drole de guerre», alla sua evolu zione nell'ambito sociale, economico e poli tico.
In Finlandia il progetto SUOMA- Suomi toisessa maailmansodassa - è ancora in corso. Affronta soprattutto l'evoluzion e interna ponendo l'accento sullo svi lupp o dei partit i politici, sulla popolazione emigrata proveniente dai territori occupati e sui problemi socio-economici.
Io stesso non so no per niente uno spe ciali sta della sec onda guerra, né della storia della Finlandia o dei paesi nordici. Queste idee so no nate in seguito a delle discussioni presso il nostro Istituto con il mio collega Timo Salin che sta preparando la sua tesi di dottorato di Stato dal titolo «I partiti politici e le guerre di Finlandia, 19 39-1944».
La Sardegna era, secondo Emilio Lussu «la sola regione d'Italia dove la resistenza organizzata avrebbe immediato successo» (l). Secondo la sua opinione infatti i capi del Partito Sardo d'Azione che si era formato nell'isola nel 1921 e che erano stati ufficiali e sottufficiali nelle file della Brigata Sassari «erano quasi tutti in grado di diventare comandanti partigiani di organizzazioni popolari locali» (2). Egli partiva dunque da un presupposto tecnico, ma soprattutto dall'ipotesi che i leaders sardisti conservassero la volontà di battersi contro la dittatura e la capacità di trascinare con sè le masse dei contadini-pastori che li avevano seguiti nei fervidi anni del primo dopoguerra. Ipotesi ottimista che dimenticava il fatto che alcuni di loro avevano patteggiato col partito fascista ed erano poi entrati a farne parte in due successive fusioni nel '23; che altri, rimasti fedeli all'ideale autonomista, tacevano però da vent'anni sopportando la dittatura, e soprattutto dimenticava che gli uni e gli altri, trattando col fascio, avevano profondamente disorientato e deluso le plebi contadine sarde che erano ritornate all'antica fatalistica rassegnazione, tollerando il regime come sempre lo Stato, male necessario: il capitale di fiducia e di entusiasmo che i capi sardisti avevano dilapidato difficilmente avrebbero potuto farlo risorgere all'improvviso per una guerra di bande improvvisata contro fascisti e tedeschi di stanza nell'isola. Qualunque sia il giudizio sulle ipotesi di Lussu, è tuttavia in base ad esse, che egli si recò a Londra nella primav era del '42 pe r ottenere una collaborazione anglo-i t aliana ch e provocasse una formale dichiarazione politica del go verno b r it annico capace di dare al popolo italiano la sicurezza ch e la gu err a antifascista
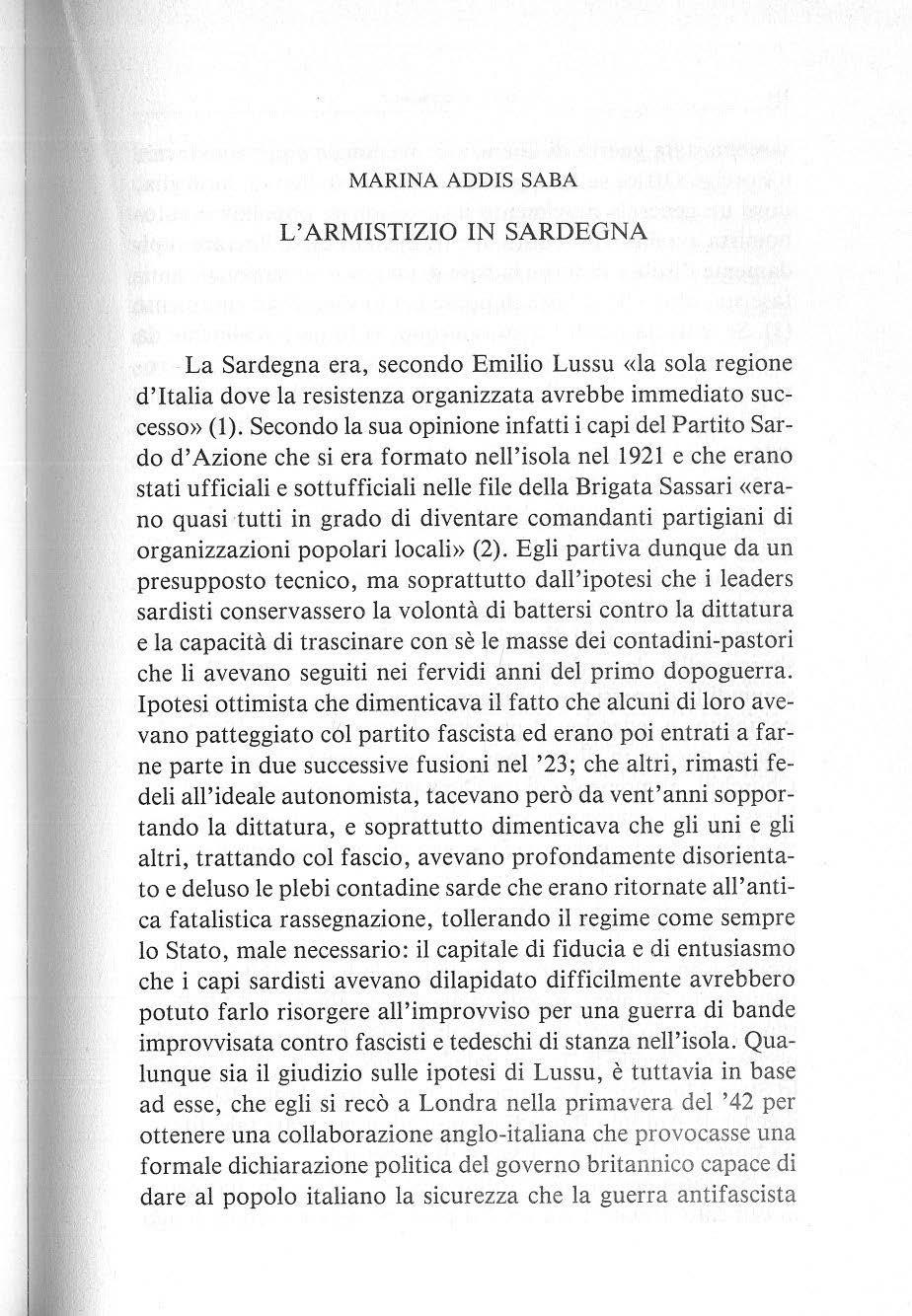
sareb be stata guerra di lib erazione nazionale e per convincere il Foreign Office su lla opportunità di uno sbarco in Sardegna, dove un generale movimento insurrezionale popo lare e autonomista avrebbe co nsentito alle truppe alleat e di liberar e rapidamente l'isola e di farn e la base di un governo nazionale antifascista, .oltre che la testa di ponte per lo sbarco sul continente (3). Se le trattative di Lu ssu fallirono, vi fu però realmente da parte degli alleati il progetto di uno sbarco in Sardegna; ne t roviamo traccia anche nelle memorie di Churchill il quale racconta che il generale Eisenhower riteneva che la Sicilia andasse attaccata solo se lo sc opo era quello di tenere aperte le vie di co municazione nel Mediterraneo, «se in vece il no stro vero scop o era l'invasione e la sconfitta dell'Italia, allora egli pensava che i nostr i obiettivi iniziali do vessero essere Sardegna e Corsica» (4).
Churchill non condivideva que sta tesi e prevalse infatti la decisione di sbarcare in Sicilia, ma si continuò anche ad accreditar e con opera z ioni diver sive presso il nemi co l'ipotesi di uno s bar co nell'isola sarda per provocare l'impegno in quella zona e quindi la dispersione del maggiore numero possibile di truppe italiane e tede sc he. Il progetto di uno sbarco in Sardegna ritornò ancora in discu ss ione, sempre secondo il racconto di Churchill, al momento di decidere se attraver sare lo st retto di Messina o «limitarci all'occupazione della Sardegna»; in quest'ultimo caso Eisenhower fa saper e che a vre bbe potu to essere pronto per i primi di ottobre (5).
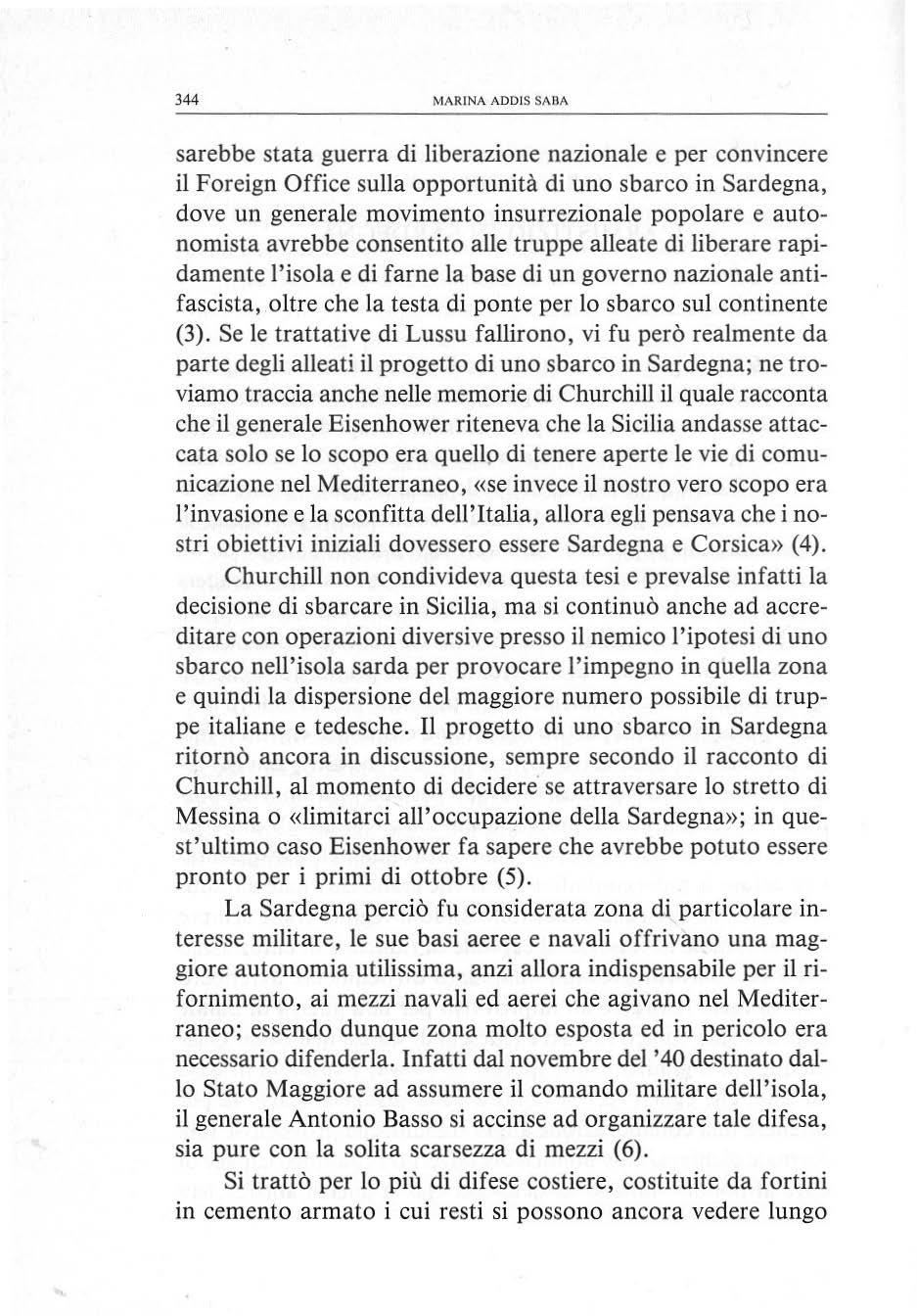
La Sardegna perciò fu considerata zona di particolare interesse militar e, le sue basi aeree e navali offrivano una maggiore autonomia utilissima, anzi allora indispensabile per il rifornimento, ai mezzi navali ed aerei che agivano nel Mediterraneo; essendo dunque zona molto esposta ed in pericolo era necessari o difenderla. Infatti dal no ve mbre del '40 destinato dallo Stato Maggiore ad assumere il comando militare dell'isola, il generale Antonio Basso si accinse ad organizzare tale difesa, sia pure con la so li ta scarsezza di mezzi (6).
Si trattò per lo più di difese costiere , costituite da fortini in cemento armato i cui resti si possono ancora vedere lungo
la costa sarda e di batterie antiaeree, poste a guardia dei porti, delle basi militari, dei depositi di viveri e di armi, dei posti infine che correvano maggiore pericolo di subire, come più tardi si dimostrò purtroppo nei fatti, i maggiori attacchi aerei. Aumentò anche, in occasione della temuta invasione, il numero delle truppe dislocate nell'isola. Il generale Basso, comandante delle forze armate nell'isola ebbe anche alle sue dipendenze un commissario civile, appositamente creato all'inizio del '43 nella persona di un prefetto. Vi erano nell'isola il XIII e il XXX Corpo d'Armata costituiti da una divisione mobile, una e più avanti due divisioni dislocate lungo la costa da nord a sud, una brigata costiera autonoma e reparti minori.
La preoccupazione maggiore, oltre a quella di un eventuale attacco nemico, era costituita, secondo il generale Basso, dalla difficoltà dei trasporti interni perchè gli automezzi erano vecchi e lenti: può essere tuttavia, questa del generale, una sorta di preventiva giustificazione per gli avvenimenti successivi.
Il 23 luglio il generale riceve un messaggio di Mussolini, autografo, che riportiamo in appendice. Preoccupato per le ripercussioni sfavorevoli che la lotta in Sicilia avrà per le popolazioni e le truppe della Sardegna il Duce si raccomanda a Bas. so perchè siano superati «eventuali stati d'animo negativi».
In tutta la breve missiva e nella chiusa finale dove ancora Mussolini fa uso delle sue sparate rettoriche «Ognuno sappia che la Sardegna è un bastione della Patria», c'è tuttavia la consapevolezza che i sardi sanno di essere particolarmente esposti ed hanno dunque particolari motivi di preoccupazione (7). Solo due giorni dopo il regime crolla miseramente ; le popolazioni sarde, nei giorni successivi, anche nell'illusione che la guerra abbia a cessare, festeggiano, come tutto il paese, la fine della dittatura; il prefetto che fungeva da commissario civile, perchè di nomina fascista viene esonerato dal governo Badoglio. In Sardegna era allora di stanza la 90 a divisione corazzata dell'esercito tedesco di circa trentamila uomini ben armati e meglio equipaggiati: essi avevano costituito depositi di viveri e di materiali
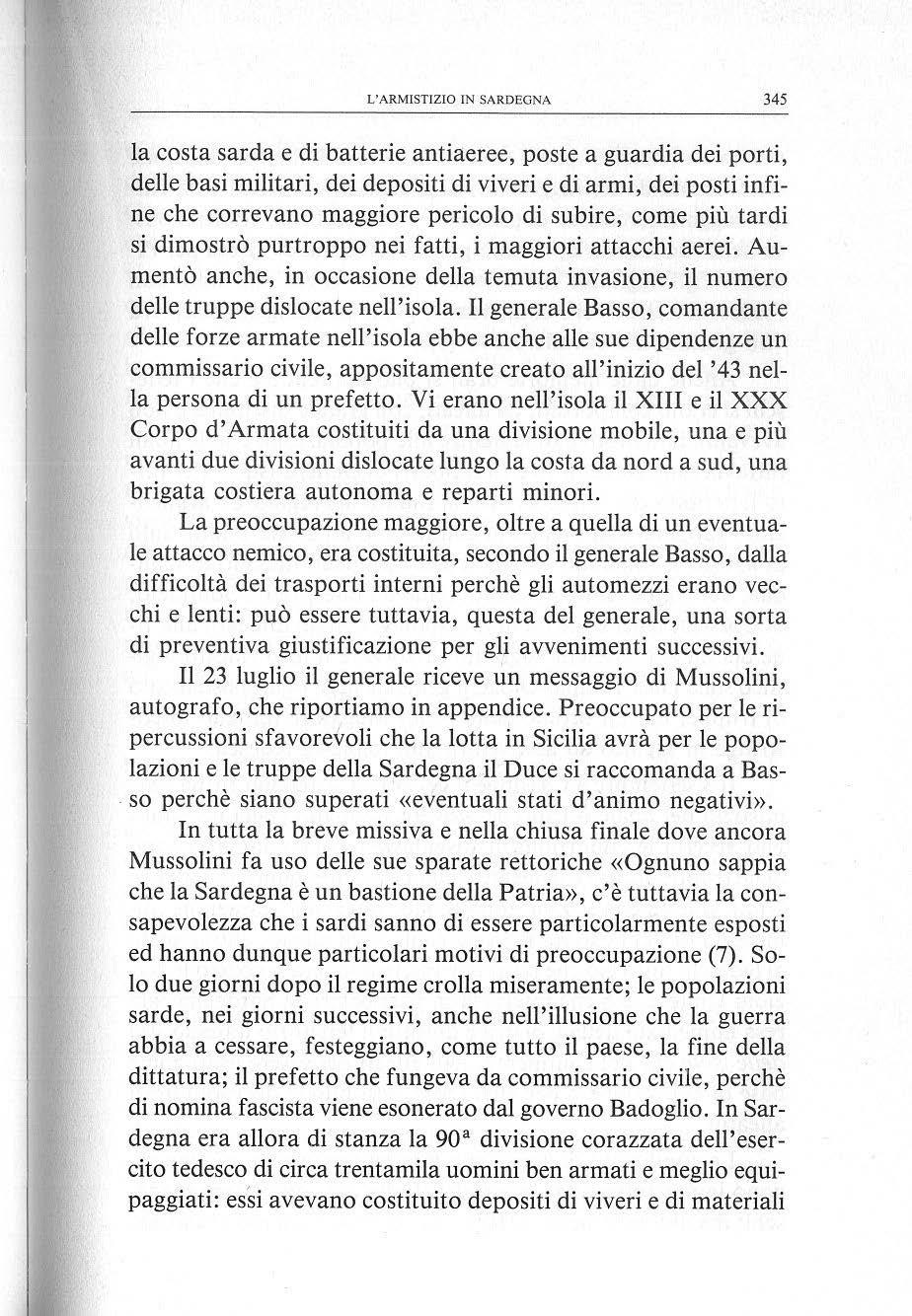
nei boschi vicini al paese di Monti, presso Olbia; la divisione era formata da tre reggimenti di granatieri corazzati e da cinque reggimenti costieri di pionieri e guastatori che, afferma Basso nelle sue memorie, «erano per me garanzia di difesa per l'isola». Egli aggiunge che nessuno screzio vi era mai stato con i tedeschi e che il loro comandante generale Lungenhausen era <<Un gentiluomo cavalleresco» (8).

Anche dalle memorie orali si può apprendere che i tedeschi si erano comportati, da alleati, con grande disciplina e non avevano dato motivo di lagnanze alle popolazioni, con le quali tuttavia non avevano stretto rapporti di cameratismo. Per tutto il periodo che intercorre tra la caduta del regime e l'armistizio, i rapporti con i tedeschi continuano ad essere buoni; solo in agosto il comando tedesco chiede a quello italiano di mandare dei militari italiani che facciano da interpreti a Bonifacio, in Corsica: il generale italiano risponde con un diniego; alla fine del mese i tedeschi vogliono rafforzare il loro ridotto logistico sulla linea Tempio -Olbia, il generale nega ogni spostamento di truppe, ma un ordine dello Stato Maggiore italiano lo costringe in seguito ad addivenire alla richiesta tedesca.
Il 3 settembre a Cassibile il generale Castellano firma l'armistizio nel quale il capo del governo italiano generale Badoglio accetta le condizioni di Eisenhower comandante in capo delle truppe alleate e delegato dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti; queste condizioni impongono, oltre alla cessazione immediata di ogni ostilità nei confronti degli alleati, che si neghi ai tedeschi tutto ciò che potrebbe essere adoperato contro le Nazioni Unite e, ciò che interessa in particolare la Sardegna, «la resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, sia delle isole che del continente, agli alleati per essere usati come base di operazione o per altri scopi, secondo le decisioni degli alleati».
Le condizioni di armistizio non contemplano, nè impongono la partecipazione attiva dell'Italia nel combattere i tedeschi; ma ambiguamente affermano che esse saranno modifica-
te in favore dell'Italia a seconda dell'entità dell'apporto «dato dal governo e dal popolo italiano alle Nazioni Unite contro la Germania durante il resto della guerra»; e ancora aggiungono che «ovunque le forze italiane o gli italiani combatteranno movimenti tedeschi, o distruggeranno proprietà tedesche, o ostacoleranno movimenti tedeschi, essi riceveranno tutto l'aiuto possibile dalle forze delle Nazioni Unite». Inoltre gli accordi, pur lasciando la natura precisa e l'entità dell'azione al giudizio di Badoglio, suggeriscono una resistenza passiva generale in tutto il paese e piccole azioni di sabotaggio speciale alle vie di comunicazione. La notte dello stesso 3 settembre atterrò ad Elmas un aereo militare con il tenente colonnello Donato Uberlin che viene accompagnato a Bortigali, sede del comando: egli porta a Basso uno stralc io della memoria 44, il famoso ordine scomparso dagli archivi dello Stato Maggiore; era, secondo il generale, un foglio dattiloscritto senza intestazione nè firma, che si raccomandava di distruggere. In esso, pur senza fare alcun cenno all'armistizio, si prefigura un possibile cambiamento radicale nei confronti dei tedeschi.
In caso di una eventuale aggressione tedesca si danno nella memoria una serie di consigli per prevenire ed affrontare gli attacchi e compiti specifici sono attribuiti per i diversi Comandi: per la Sardegna si dice «far fuori la 90a divisione germanica» (8). L'esecuzione della memoria deve avvenire o per ordine espresso delle au torità centrali, o per iniziativa dei comandanti locali . Il 7 settembre il comandante ammiraglio e il generale aereonautico dalla Sardegna sono chiamati a Roma dai rispettivi comandi: 1' 8 di sera il proclama di Badoglio giunge a Basso del tutto inaspettato: egli non ha alcuna informazione di ciò che avviene in altre parti, non riceve nessuna indicazione e anzi non può nemmeno confidarsi con nessuno dei suoi collaboratori perchè così impone la memoria 44.
Secondo il proclama di Badoglio bisogna reagire da qualunque parte venisse l'attacco: non si ha nemmeno il coraggio di indicare espressamente i tedeschi. I quali in Sardegna non
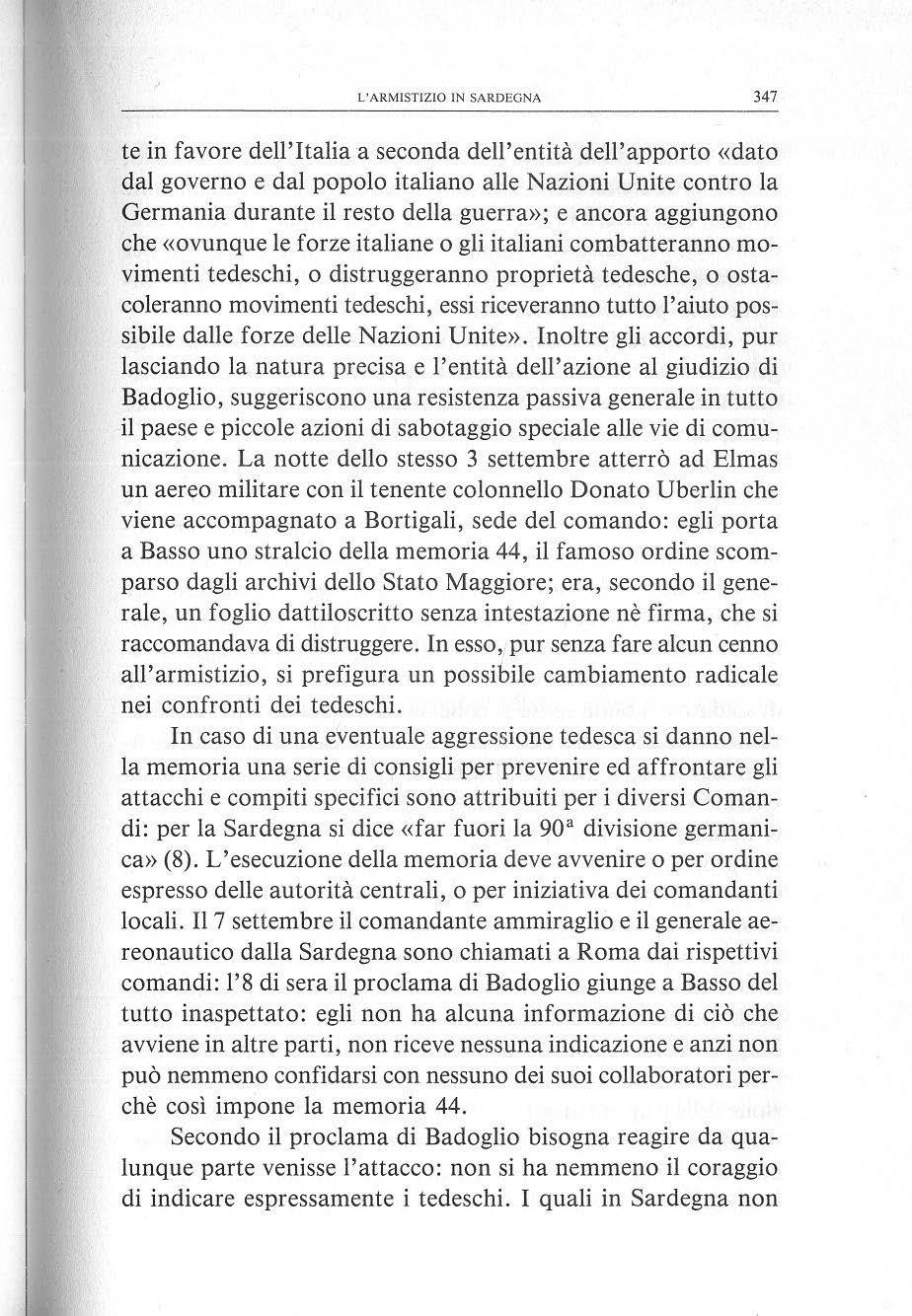
fannp alcun atto di ostilità alla proclamazione dell'armistizio, anzi la notte stessa dell'8 settembre Basso riceve dal comandante tedesco una lettera in cui lo si invita a continuare la collaborazione con l'ex alleato; l'italiano afferma di avere risposto per le rime e il tedesco - scusandosi - dichiara di avere fatto l'offerta solo per ordini ricevuti.
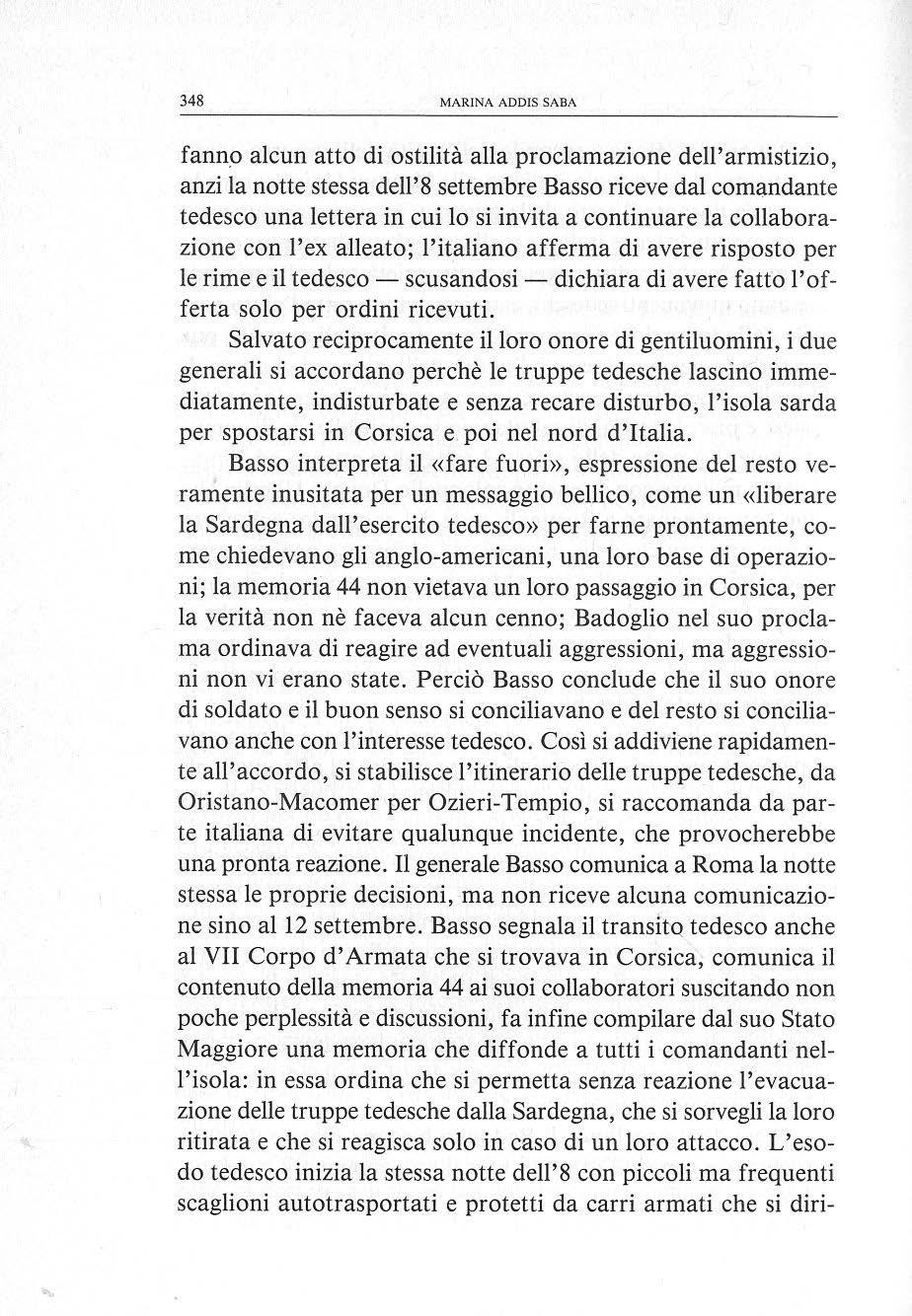
Salvato reciprocamente il loro onore di gentiluomini, i du e generali si accordano perchè le truppe tedesche lascino immediatamente, indisturbate e senza recare disturbo, l'isola sarda per spostarsi in Corsica e. poi nel nord d'Italia.
Basso interpreta il «fare fuori», espressione del resto veramente inusitata per un messaggio bellico, come un «liberare la Sardegna dall'esercito tedesco» per farne prontamente, come chiedevano gli anglo-americani, una loro base di operazioni; la memoria 44 non vietava un loro passaggio in Corsica, per la verità non nè faceva alcun cenno; Badoglio nel suo proclama ordinava di reagire ad eventuali aggressioni, ma aggres sioni non vi erano state. Perciò Basso conclude che il suo onore di soldato e il buon senso si conciliavano e del resto si conciliavano anche con l'interesse tedesco. Così si addiviene rapidamente all'accordo, si stabilisce l'itinerario delle truppe tedesche, da Oristano-Macomer per Ozieri-Tempio, si raccomanda da parte italiana di evitare qualunque incidente, che provocherebbe una pronta reazione. Il generale Basso comunica a Roma la notte stessa le proprie decisioni, ma non riceve alcuna comunicazione sino al 12 settembre. Basso segnala il transitQ tedesco anche al VII Corpo d'Armata che si trovava in Corsica, comunica il contenuto della memoria 44 ai suoi collaboratori suscitando non poche perplessità e discussioni, fa infine compilare dal suo Stato Maggiore una memoria che diffonde a tutti i comandanti nell'isola : in essa ordina che si permetta senza reazione l'evacuazione delle truppe tedesche dalla Sardegna, che si sorvegli la loro ritirata e che si reagisca solo in caso di un loro attacco. L'esodo tedesco inizia la stessa notte dell'8 con piccoli ma frequenti scagl ioni autotrasportati e protetti da carri armati che si diri-
gono verso Palau, porto d'imbarco per la Corsica. Intanto nell'isola de La Maddalena, prospicente a Palau, accadevano avvenimenti imprevisti. L'ammiraglio Brivonesi, al comando della piccola isola, era stato convocato a Roma e ricevuto la mattina dell'8 settembre dall'ammiraglio De Courten che gli impartì disposizioni re lative ad un eventuale ormeggio della flotta a La Maddalena e alla possibile presenza in quella sede della famiglia reale e di una parte del Governo. Si pensava infatti ad un trasferimento della famiglia reale e di alcuni ministri, protetti dalla flotta che doveva arrivare a La Spezia, ma gli alleati respingono la proposta di concentrare la flotta a La Maddalena e cade pertanto anche il proposito di trasferirvi il re. A La Maddalena vi erano già due corvette, la Danaide e la Minerva, il sommergibile Corridoni, la nave ospedale Sorrento, motozattere e navi sussidiarie di vario tipo. Brivonesi ritorna in areo in Sardegna e ha dallo stesso comandante tedesco Unes la notizia dell'armistizio e l'assicurazione che i tedeschi avrebbero iniziato i movimenti necessari a sgombrare La Maddalena. Brivonesi stesso si adegua agli ordini di Basso, anche se le forze italiane nella base navale erano molto superiori alle tedesche e avrebbero facilmente potuto avere la meglio.
La mattina del 9 settembre Brivonesi convoca tutt i gli ufficiali della rada per comunicare che si deve lasciare partire indisturbati i tedeschi.
Invece, appena rientrato al suo Comando dove si trovava con l'Ammiraglio Bona, preposto ai servizi della piazzaforte, viene sorpreso da un colpo di mano tedesco: i soldat i di Unes occupano la palazzina del comando, la stazione, il semaforo di Guardia Vecchia, i Comandi, il Commissariato e il circolo ufficiali .
L'azione tedesca fulminea e ben organizzata doveva essere stata già studiata in precedenza dal comandante tedesco assieme al colonnello Ranke, che tempo prima aveva ispezionato l'arcipelago con il pretesto di coordinare la difesa tedesca con quella italiana. Unes alle proteste di Brivonesi giustifica il col-
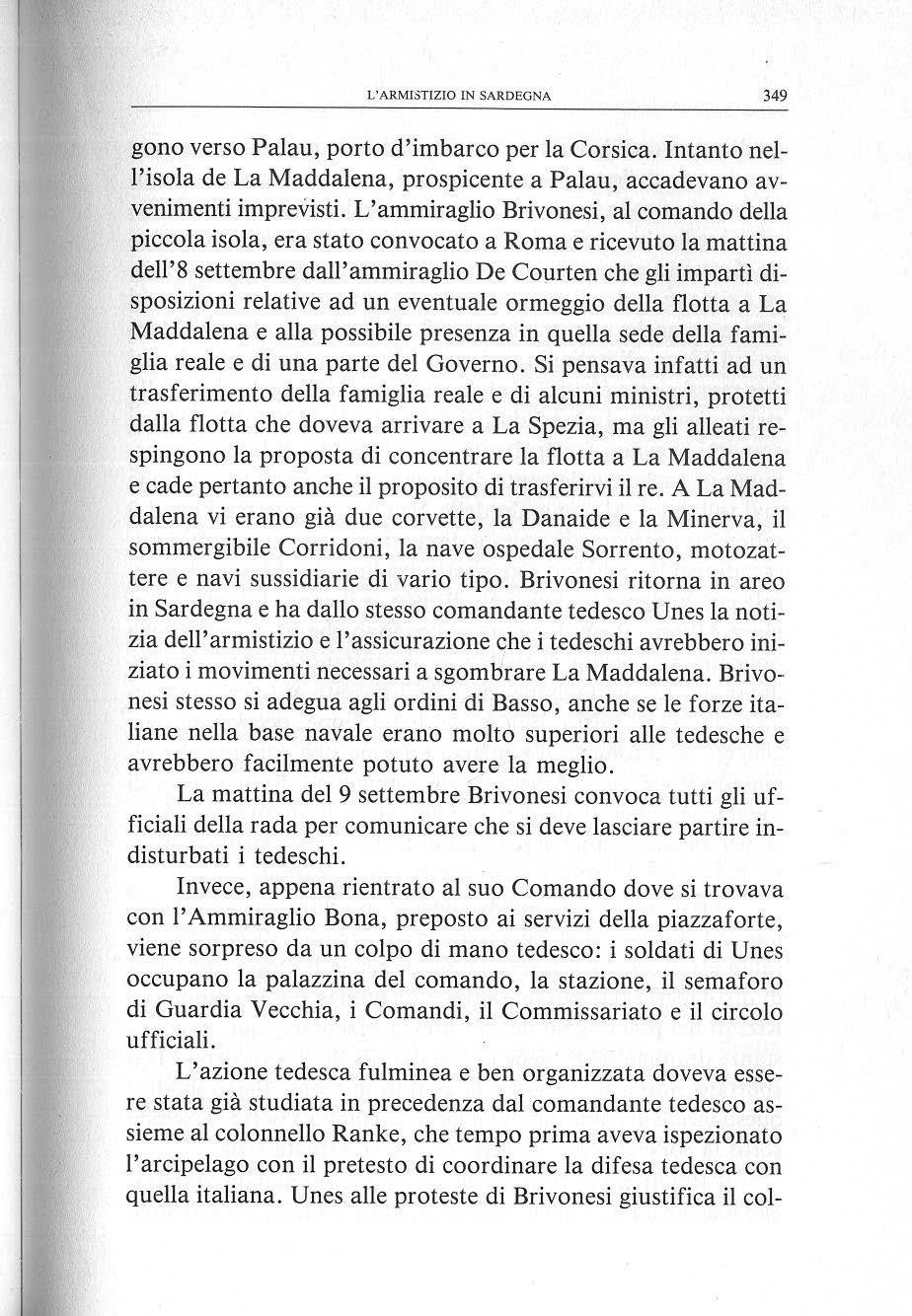
po di mano con il «tradimento» italiano e la necessità di garantire l'esodo delle truppe naziste (9) . Lo stesso giorno 9 settembre avvengono in Sardegna numerosi incidenti: nei pressi di Baressa i tedeschi, probabilmente per sequestare qualche automezzo, fermano numerosi cittadini, partono colpi d'arma da fuoco e rimane ucciso il diciasettenne Anselmo Lampus; i tedeschi attaccano anche un presidio del 403 ° battaglione sul ponte Mannu sul Tirso, gli italiani reagiscono: hanno sei feriti e i tedeschi due morti e otto feriti. Un altro episodio più grave turba quella stessa giornata. I paracadutisti della divisione Nembo, fascisti convinti avevano fraternizzato con i tedeschi, il loro comportamento anche con la gente del luogo era prepotente e dunque mal tollerato. Al comando della Nembo la notte tra 1'8 e il 9 settembre trascorre in agitate discussioni: per quasi tutti i paracadutisti l'armistizio è un nostro tradimento. Mentre il generale comandante la divisione, Ronco, e il capo di Stato Maggiore Alberto Bechi Luserna sostengono che bisogna tuttavia obbedire agli ordini di Badoglio, il capitano Rizzati, comandante del 12° battaglione, decide di passare ai tedeschi e, seguito da quasi tutti i militari del battaglione, occupa un parcheggio di automezzi a Ghilarza e forma una colonna che segue i tedeschi verso Macomer; il comandante Ronco cerca di raggiungerla per dissuadere i ribelli, viene fermato presso Macomer da una vent ina di paracadutisti che lo minacciano di morte, ma riesce a tornare sano e salvo al comando.
Questo episodio convince Bechi Luserna a tentare ancora: lasciata la sua base di Villanova Forru con un autista e due carabinieri di scorta si ferma presso il generale Basso che cerca di dissuaderlo dal suo tentativo e raggiunge poi la colonna di Rizzati nel pomeriggio dell' 11 presso Macomer; qui, in circostanze drammatiche, viene ucciso dai ribelli, il suo corpo è tra. sportato sino a S. Teresa e là gettato in mare. Basso giudica questi incidenti co'me questioni locali e si limita a porre la Nembo sotto la sorveglianza del XIII Corpo d'Armata (10).
Il 10 settembre Basso riceve comunicazioni dall'Ammiraglio italiano a La Maddalena e si affretta a trasmetterle allo Stato
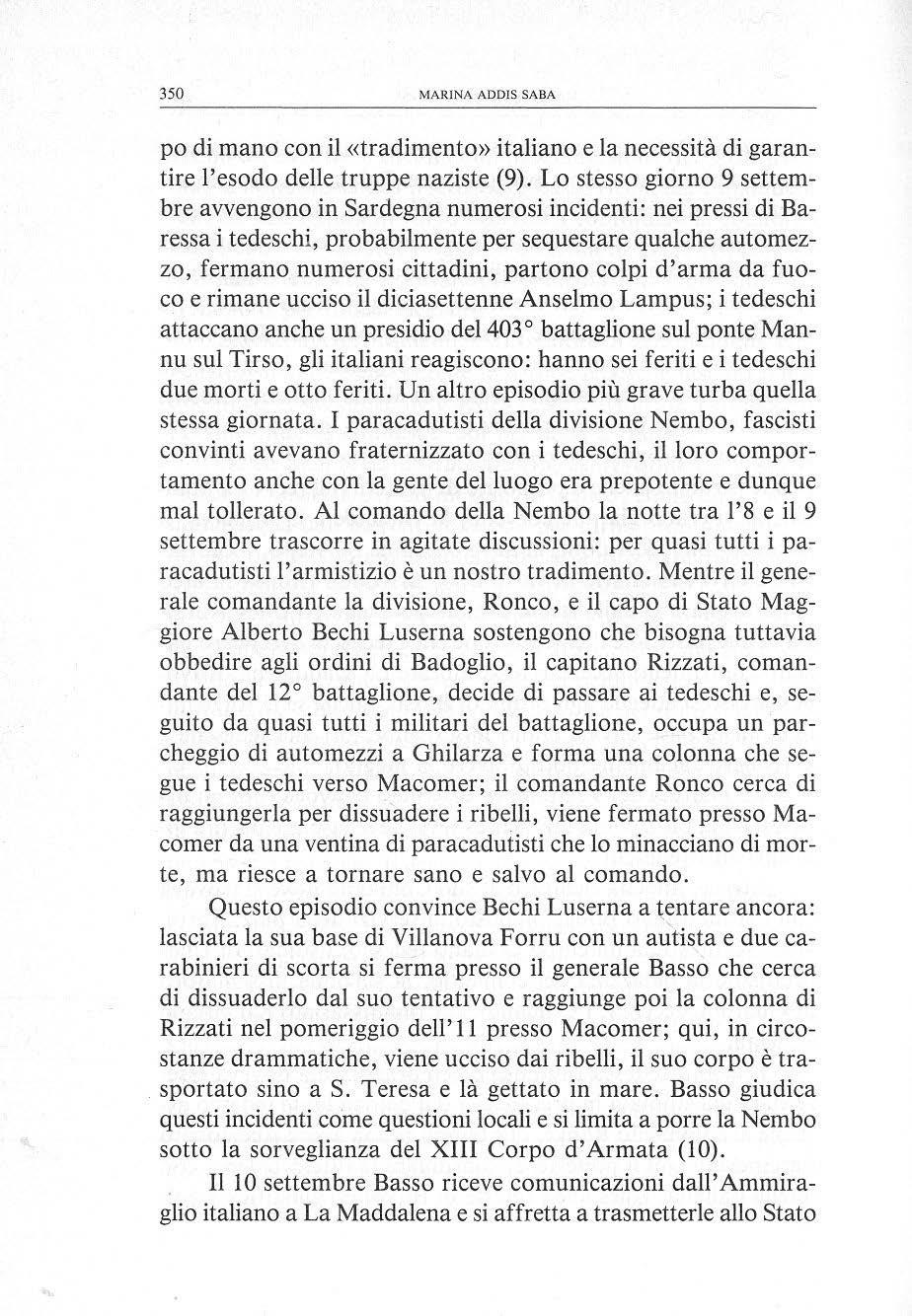
Maggiore, ma non ha alcuna risposta: si trasferisce allora da Bortigali, sede del comando, a Sassari per meglio seguire le operazioni, e in questa città riceve, alle 21 del giorno 11, un ufficiale inviato dall'Ammiraglio de La Maddalena che gli comunica le richieste tedesche: gli italiani devono consegnare le sei batterie dell 'estuar io e permettere la installazione di postazioni sulle banchine del porto, sia perchè i tedeschi possano rispondere agli attacchi alleati, sia per transitare verso la Corsica. Il generale sostiene di avere negato la consegna delle batterie e assicurato ancora il passaggio indisturbato; non fa cenno delle postazioni sulla banchina.
Nella giornata del 12 settembre il generale Basso ispeziona le truppe in Gallura; riceve intanto notizia che alcune batterie delle isolette intorno alla Maddalena, come quella di S. Stefano, hanno sparato sui tedeschi; il generale Lungenhausen chiede un colloquio a Basso per questi incidenti e per la mancata consegna delle batterie; quest'ultimo afferma di avere pensa to che la migliore tattica fosse quella di tergiversare e risponde che avrebbe ricevuto il nazista a Tempio il 14. Intanto arriva la sera del 12 a Bortigali, sede del Comando, un giovane sottufficiale inviato dal Capo di Stato Maggiore, il quale la mattina del giorno seguente si abbocca con Basso a Sassari: è il primo contatto con gli alti comandi su l continente dalla proclamazione dell'armistizio. Il racconto di Basso è romanzesco: il giovano estrae il messaggio dalla suola scucita dei suoi stivali e non risponde alle domande del generale, ma gli consegna l'ordine 5V firmato da Roatta, che diverrà poi il Maggiore capo d'accusa contro Basso. Esso impone: di attuare con massima decisione ed energia la memoria 44, facendo fuori rapidamente reparti e comandi tedeschi che si trovino comunque in Sardegna e in Corsica. «A tale uopo si rende indispensabile impedire passaggio 90a divisione tedesca dall'una all'altra isola».
Basso rit iene che impedire tale passaggio - ormai quasi ultimato dalle truppe tedesche - sia impossibile, tuttavia ordina al XXX Corpo d'Armata di proteggere la zona logistica
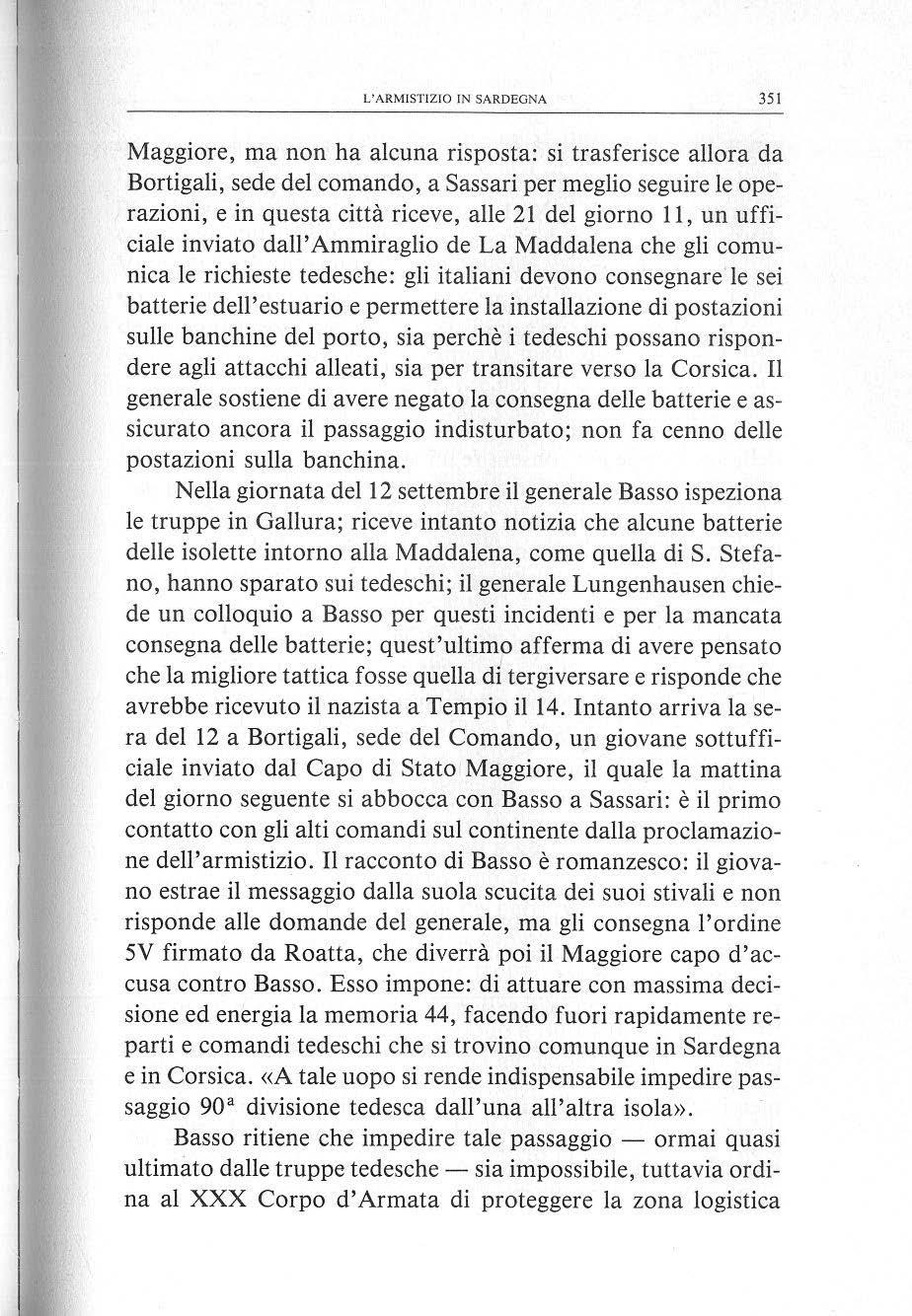
Olbia-Monti, pronto ad eventuali azioni offensive; la divisione Bari si doveva raccogliere, con un battaglione carri, nella zona Bonnanaro-Ozieri; il XIII Corpo doveva portarsi verso nord dell'isola con le divisioni Sabauda e Nembo per un eventuale rincalzo al XXX Corpo, mentre l'aviazione doveva tenersi pronta ad intervenire. Il generale risponde poi all'ordine 5V dando notizia de l fatto che i tedeschi occupano parte della La Maddalena e che, protetti da forti retroguardie corazzate, ripiegano verso la zona nord orientale della Sardegna dove è iniziato il passaggio per la Corsica; afferma che sono in corso movimenti delle sue truppe per consentire un attacco decisivo che prevede di potere attuare non prima del giorno 16. Aggiunge di non potere fare affidamento sulla divisione Nembo «che anzi deve essere controllata». Egli non fa cenno del fatto che la ritirata tedesca avviene col suo consenso, nè spiega perchè la Nembo deve essere controllata.
Il giorno 13 un ufficiale porta al generale un altro ordine , anch'esso a firma di Roatta, il 21 V, datato al 12 settembre, col quale si intima ancora più chiaramente che «i germanici devono essere considerati nemici e come tali distrutti senza la minima esitazione». Si impone anche di impedire l'ulteriore passaggio dei tedeschi in Corsica e si inizia ad assumere un tono accusator io nei confronti di Basso che, alla luce di quanto avvenuto in Italia e a La Maddalena, e dopo l'attacco aereo germanico alla nostra flotta, avrebbe dovuto «dare piena applicazione alla memoria 44, a prescindere da qua lsiasi atto germanico di ostilità in Sardegna e in Corsica». Gli a lti comandi contano sull'energia di Basso «per guadagnare il tempo perduto e far fu ori del tutto i tedesc hi qalle due isole e da La Maddalena».
Nella stessa giornata del 13 ha luogo una vera e propria battaglia a La Maddalena e a Palau. Nonostante i patteggiamenti dei comandanti , un gruppo di marinai italiani reagiscono ai tedeschi che si sono impossessati di una motozattera per portarla a Pa lau e serv irsene poi per lo spostamento in Corsica. La batteria di Punta Tegge è la prima ad aprire il fuoco con-
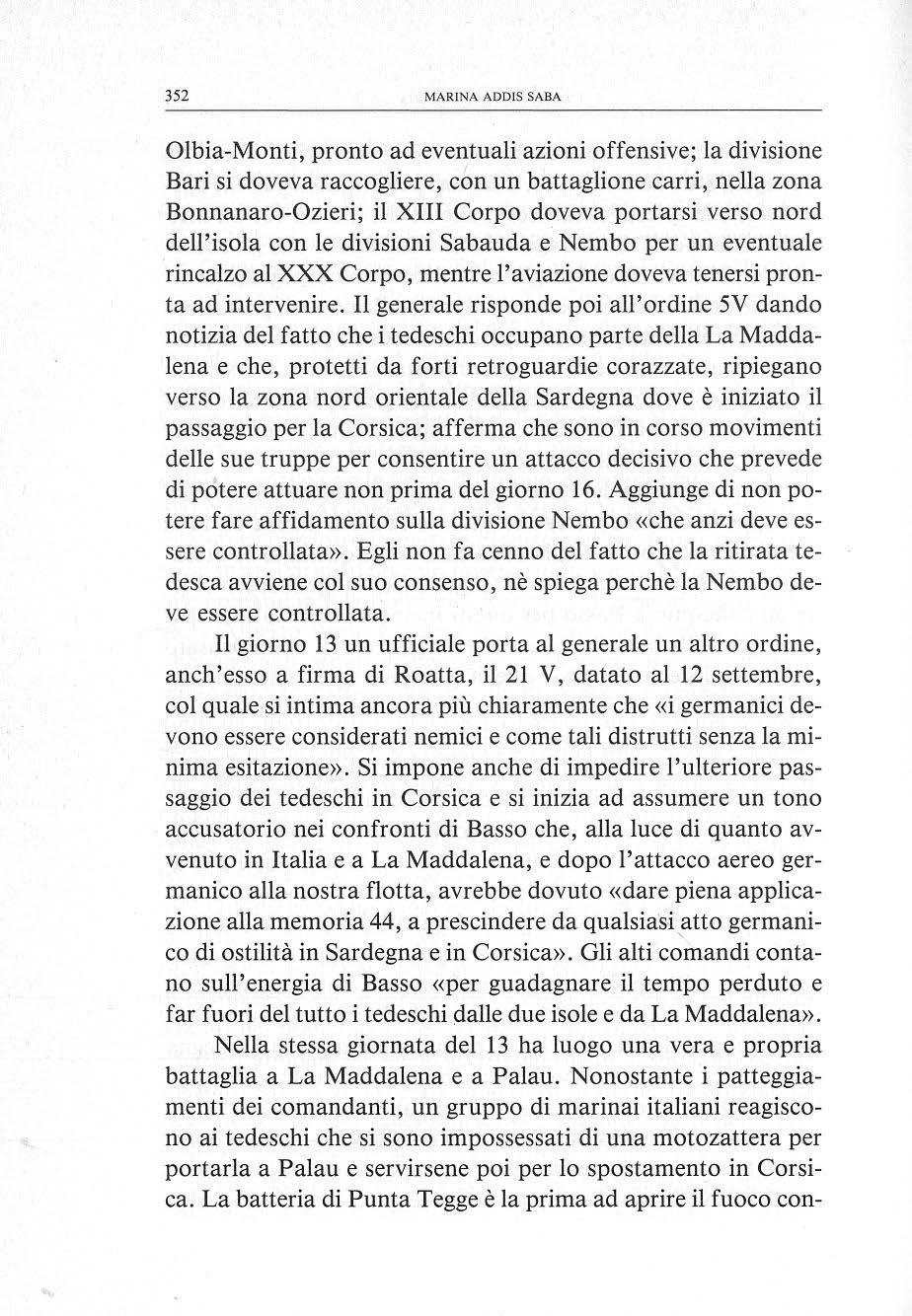
tro i tedeschi e presto colpi di cannone, di mitraglia e fuoco di fucili si estendono a tutte le batterie e alla cittadina. Gruppi sempre più numero si di marinai attaccano i tedeschi : assumono il comando, pur nell'improvvisazione della lotta, il capitano di Vascello Carlo Avegno, già comandante dell'Accademia di Livo rno, che morirà qu el giorno stesso combattend o per le strade e il sottotenente Rinaldo Vero nesi, che cadrà anche lui nel combattimento: entrambi avranno la medaglia d'oro alla memoria. Si combatte per quattro ore nei punti chiave dell'isola. I combattenti sono deci si a liberare i du e ammiragli e a cacciare i te desc hi dall'i so la: i tedeschi comprendono che gli italiani reagendo possono a vere la meglio nono sta nte le ar mi antiquate. Mentre si combatte nelle strade Brivonesi continua a trattare: si reca al semaforo della Guardia V ecc hia, che è in mani tedesche, e propone la cessazione del fuoco, il ristabilimento delle posizioni di partenza e lo scambio dei prigionieri; per interrompere gli scontri della fanteria deve anche recarsi di persona alla caser ma della Marina e alla Base nav ale, invocando la calma e so r veg liando poi lo sc ambio dei prigionieri; gli italiani ne avevano fatto circa 3560; 24 erano i morti italian i e 8 i tedeschi. I tedeschi si affr ett ano a lasciar e La Maddalena.
La mattina del 14 i due generali, Lungerhaus en e Basso, si incon tr ano a Tempio, con la cittadina presidiata dalle truppe tede sc he: il tedesco lamenta gli scontri de La Maddalena e ch ied e te mpo per lo sgom bero sino al 19; Bas so ri spo nde che l'inosservanza dei patti è stata da parte tedesca e pon e co me termine ultimo per lo sg ombero completo il giorno 17.
Il co lloquio non deve essere t roppo sg rad evo le se , co me è riferito, i due comandanti pranza no insieme.
Il generale Basso rientra intanto a Bortigali e afferma nelle sue memorie: «avevo dato il via all' azione offensiva il giorno 15 se ttembre ali' atto della partenza da Sassar i con (?rdine verbal e». Egli sostiene che aspettava che le truppe del XXX Corpo d'Armata attaccassero il 16 , ma ciò non avvenne, e che il 17 i tedeschi seppero abilmente sfuggire all'attacco perché il pas-
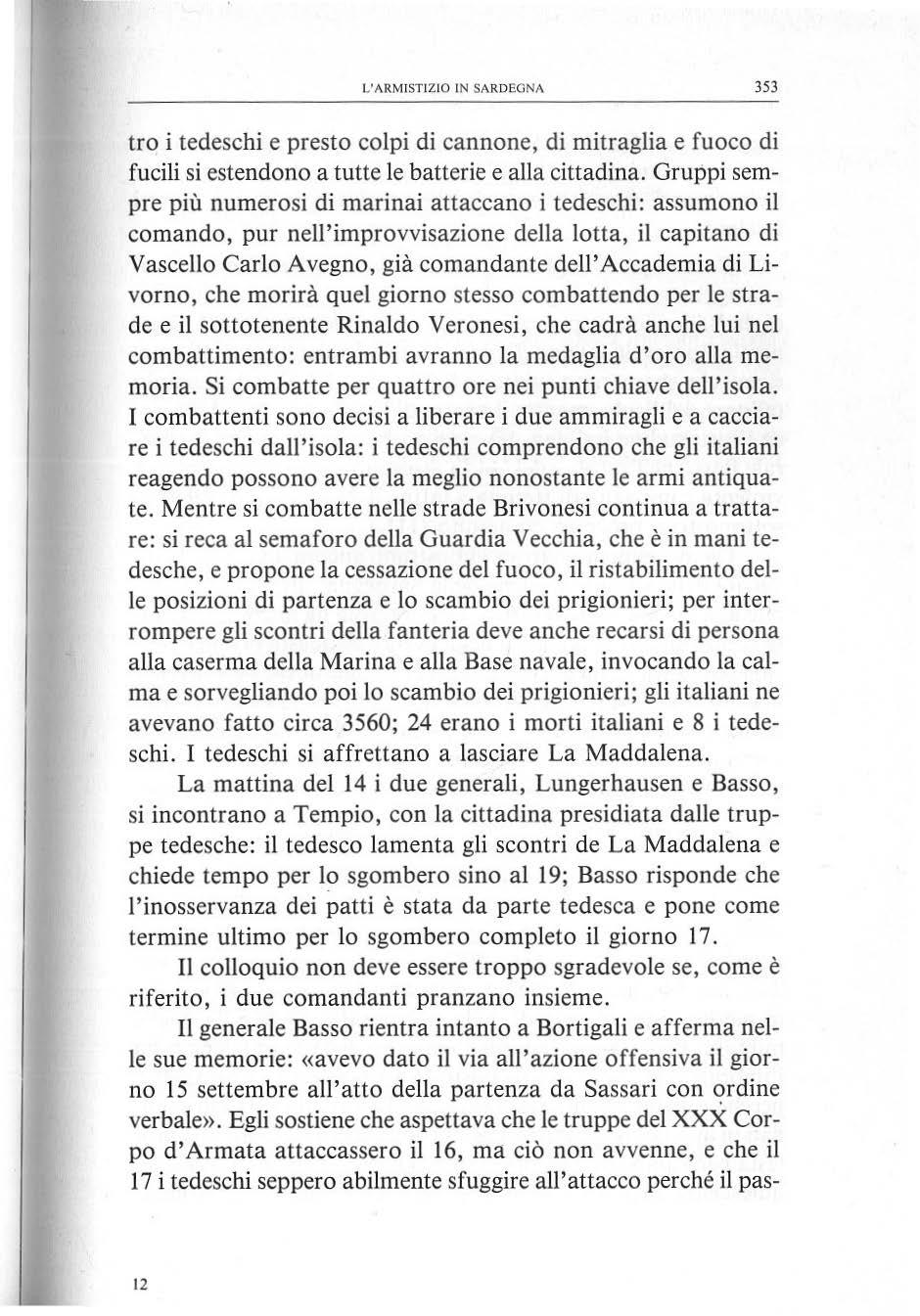
saggio in Corsica si trasformò in vera e propria fuga. Certo egli poteva comunicare il 18 agli alti comandi che la Sardegna e le isole minori erano libere: l'ultimo tedesco le aveva infatti lasciate.
Comunque si vogliano giudicare questi avvenimenti, bisogna aggiungere che il generale Basso ebbe in quel momento lodi da Badoglio e approvazioni dallo Stato Maggiore, che il generale Roosevelt, cugino del presidente e comandante degli americani che sbarcarono subito in Sardegna, gli lasciò il comando militare dell'isola, mentre il parere di Eisenhower era duro circa l'inettitudine italiana; bisogna anche ricordare che il generale Basso nell'ottobre del '44 fu arrestato e reso oggetto di una violenta campagna di stampa e infine il 28 giugno del 1946 fu sottoposto a processo ed assolto (11).
Gli avvenimenti narrati dimostrano ancora una volta la diversità delle vicende storiche della Sardegna, diversità imputabile alla posizione geografica: l'essere isola ha ancora una volta condizionato lo svolgersi degli eventi. A questa prima riflessione un'altra se ne può aggiungere. In questa rilevata diversità coesistono tuttavia entrambe le posizioni che l'esercito in quel momento di confusione ebbe a prendere: da una parte vi fu la «strenua» volontà di patteggiamento de l generale Basso, che, dapprima senza ordini, poi per meditata decisione evitò lo scontro frontale; dall'altra la «ribellione» agli ordini dei militari de La Maddalena, fanti e marina i , che, nel generale disorientamento, percepirono che non si poteva subire inerti la violenza tedesca e che combatterono e morirono, primi martiri di una resistenza ignorata, non tant o per co nsapevole antifascismo, quanto probabilmente per un senso dell'onore di uomini più che di soldati . Sarebbe interessante un confronto delle posizioni assunte in mer ito a questi ep isodi dalla storiografia civile e da quelle militare. Per quanto riguarda l'episodio della Maddalena si ha l 'impressione che sia stato posto in sordina dalla storiografia perchè si trattò di una resistenza combattuta da ufficiali e soldati in aperta disobbedienza agli ordini superiori: quas i una protesta per l'ambiguità e l 'incertezza degl i Alti Co m andi, per l'acquiescenza de i coma ndanti de ll e isole sarde Basso e Brivonesi.
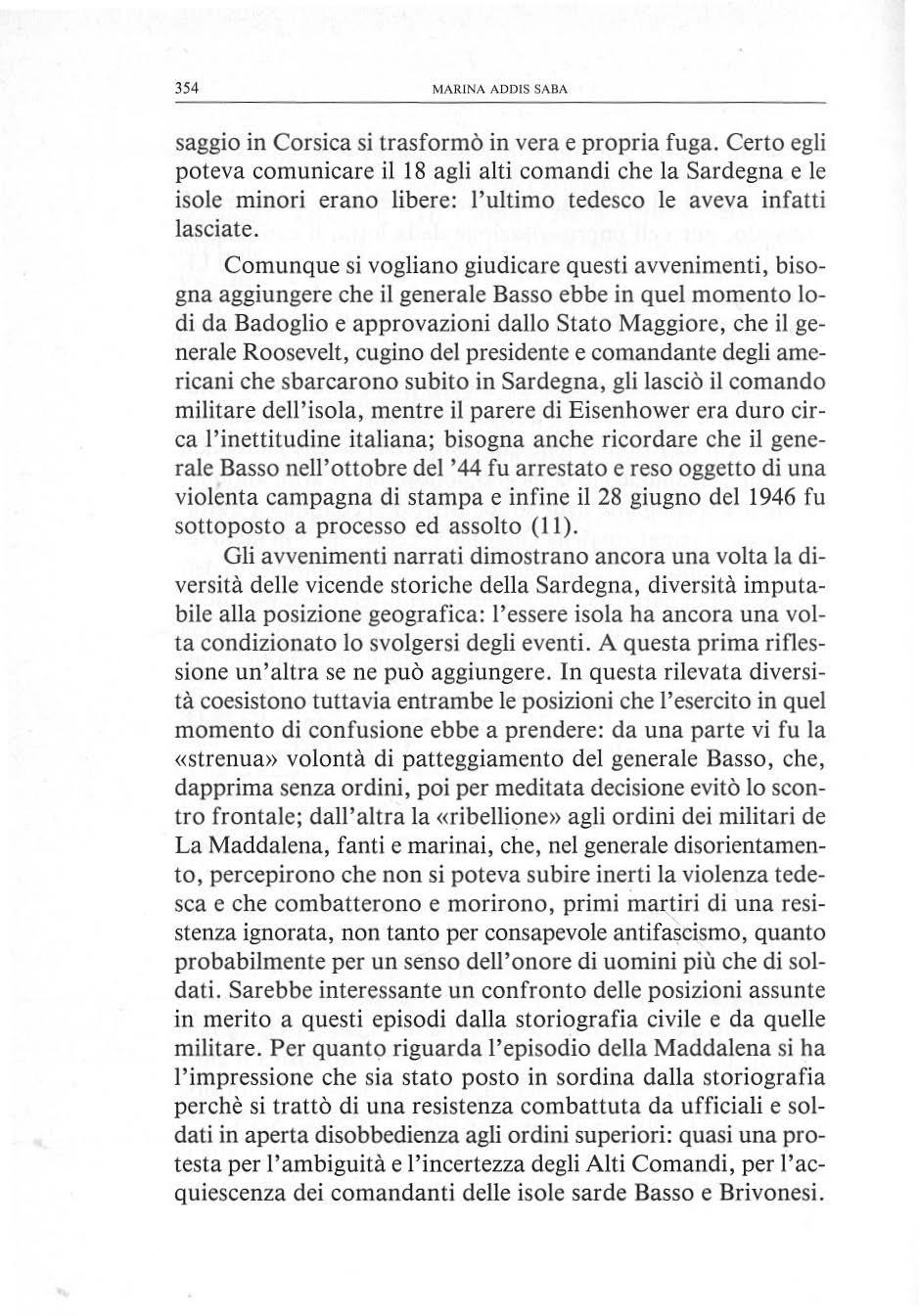
(1) E. Lussu , Diplomazia clandestina, Nuova Italia, Firenze, 1956 p. 29
(2) Ibidem
(3) Ibidem p. 56 e seg.
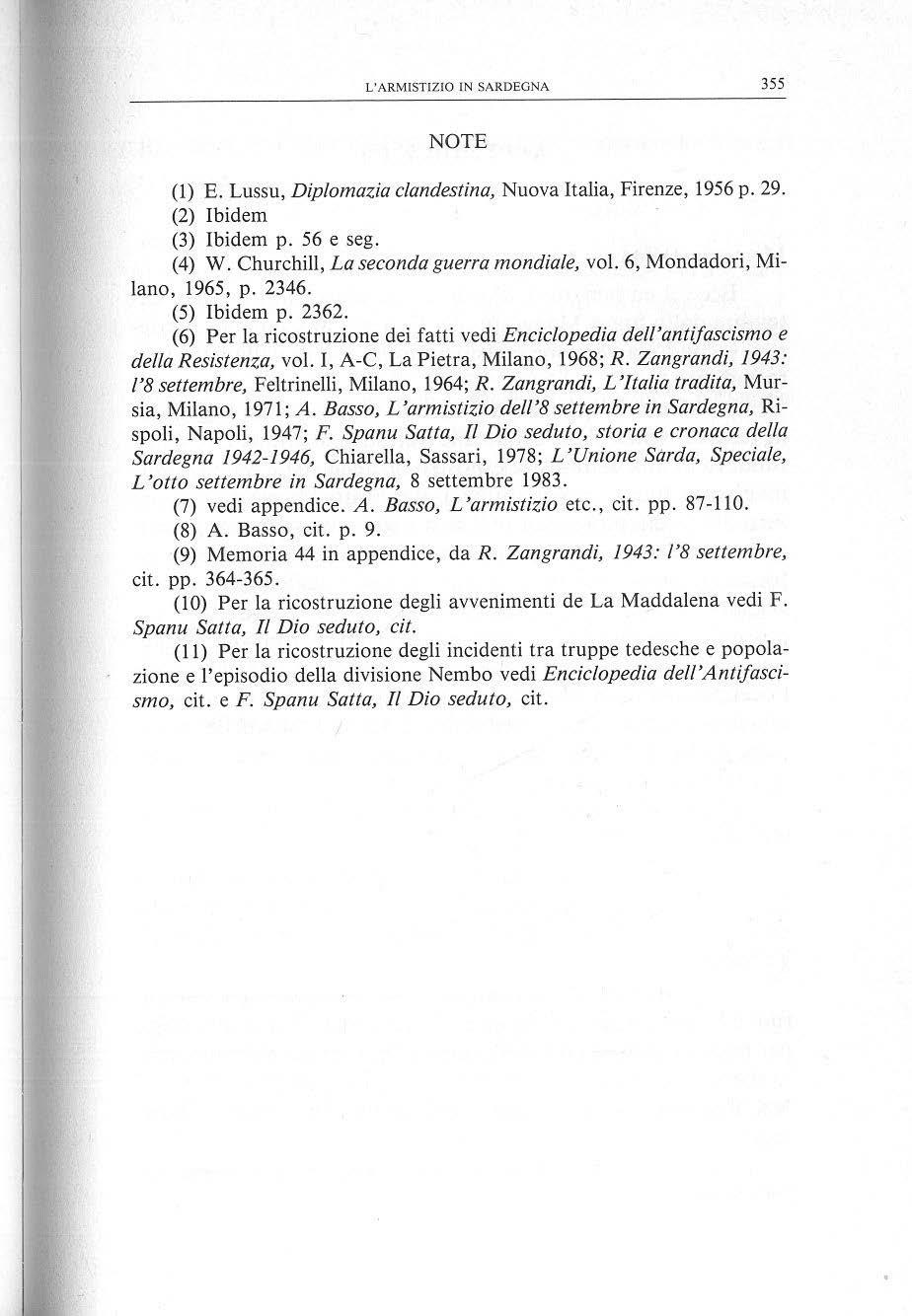
(4) W . Churchill, La seconda guerra mondiale, vo i. 6, Mondado ri , Mil ano, 1965, p. 2346.
(5) Ibidem p. 2362.
(6) Per la ricostruzione dei fatti vedi Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, vol. I, A -C, La Pietra, Milano, 1968; R Zangrandi, 1943: /'8 settembre, Feltrinelli, Milano, 1964; R. Zangrandi, L'Italia tradita, Mursia, Milano, 1971; A. Basso, L 'armistizio del/'8 settembre in Sardegna, Rispoli, Napoli, 1947; F. Spanu Salta, Il Dio seduto, storia e cronaca della Sardegna 1942-1946, Chiarella, Sassari , 1978; L'Unione Sarda, Speciale, L'otto settembre in Sardegna, 8 settembre 1983.
(7) vedi appendice. A. Basso, L'armistizio etc . , cit. pp . 87-110.
(8) A. Basso, cit. p. 9.
(9) Memoria 44 in appendice , da R. Zangrandi, 1943: /'8 settembre, cit. pp. 364 -365.
(10) Per la ricostruzione degli avvenimenti de La Maddalena vedi F . Spanu Satta, Il Dio seduto, cit.
(11) Per la ricostruzione degli incidenti tra truppe tedesche e popolazione e l'episodio della divisione Nembo vedi Enciclopedia dell'Antifascismo, cit. e F. Spanu Satta, Il Dio seduto, cit.
Ecco il contenuto dell'ordine diramato tra il 2 e il 5 settembre dallo Stato Maggiore dell'Esercito ai Comandi periferici, secondo la versione considerata più esatta dalla letteratura militare.
La Memoria ipotizzava il caso di una possibile aggressione tedesca, senza alcun cenno alle trattative di armistizio, si diffondeva in una dettagliata esp osi zione dello schieramento germanico in Italia, quale risultava allo Stato Maggiore alle ore zero del 2 settembre, poi indicava i seguenti «co mpiti generici»: evitare sorprese; vigilare e tenere le truppe alla mano; rinforzare la protezione delle co municazioni e degli impianti; sorvegliare i movimenti tedeschi predisporre colpi di mano per impossessarsi di depo siti di munizioni, viveri, car burante , materiale var io e centri di collegamento dei tedeschi, prevedendone l'occupazione o la distruzione; predisporre colpi di mano su obiettivi considerati vuln erab ili per le forze germaniche; presidiare edifici pubblici, depo siti, comand i , magazzini e ce ntrali di collegamento italiani.
I compiti specifici per i diversi Comandi di unità destinatari, erano ques ti :
II Armata (Slovenia, Croazia, Dalmazia): far fuori la 72 3 divisione tedesca; agire sui fianchi delle truppe germaniche alla frontiera orientale, per interrompere le comunicazioni da Tarvi sio al mare;
IV Armata (Provenza): raccogliere le divisioni «Pusteria» e «Taro» nelle valli Roja e Vermenagna, fronte ad Ovest, per interromp ere le comunicazioni dalla Francia all'Italia; agire specie sui fianchi delle trup pe germaniche in quella zon a (il XX Raggruppamento sciatori sul Moncenisio, Monginevro,
(*) Da Antonio Basso, L'armistizio de/1'8 settembre in Sardegna, Napoli, Rispoli, 1947.
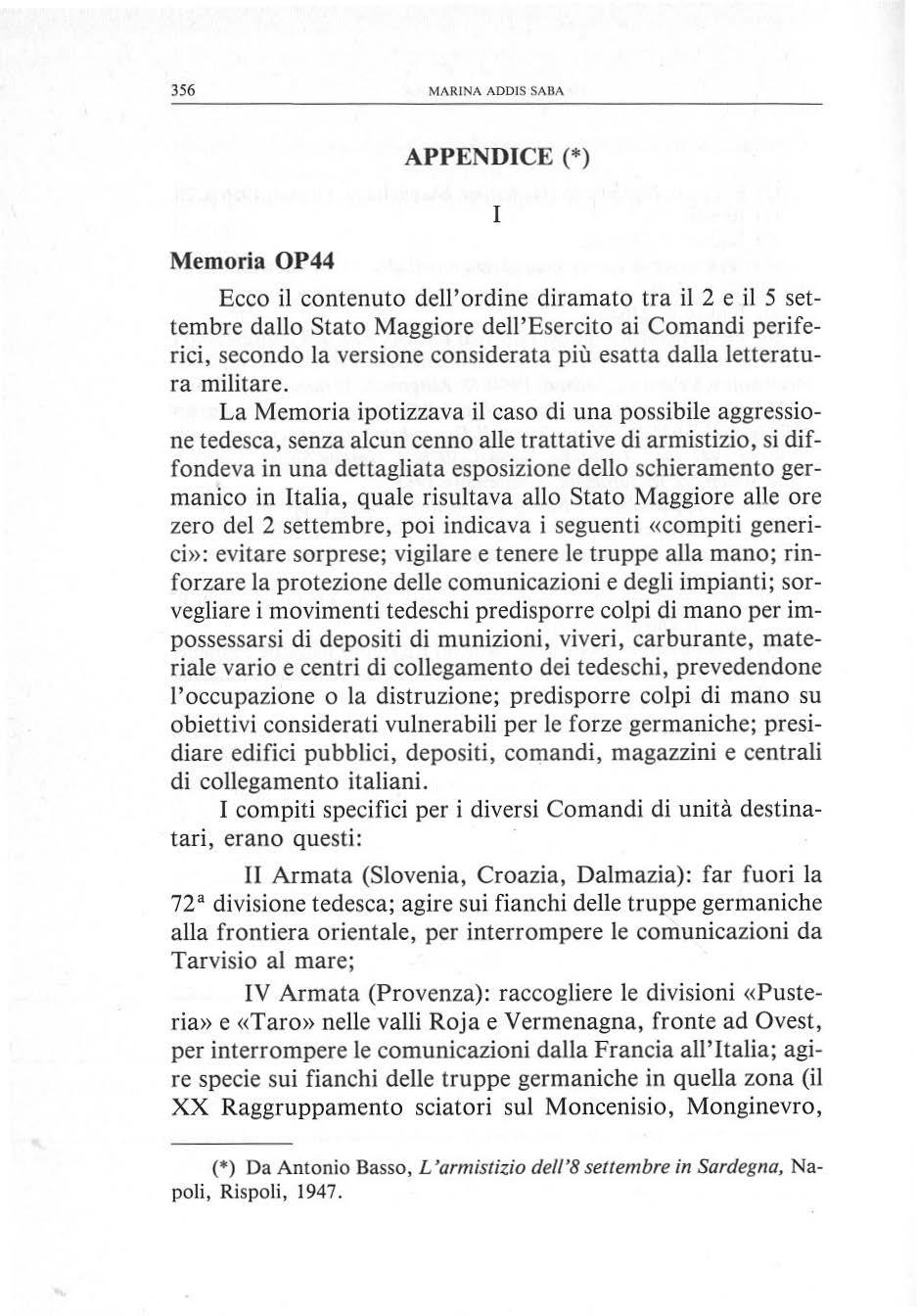
Bardonecchia, doveva sbarrare i valichi e interrompere la f erro via del Frejus);
V Armata (Liguria, Toscana, alto Lazio): il XXVI Corpo d'Armata, formato dalle divisioni «Al pi Graie» e «Rovigo», doveva tenere La Spezia, la divisione «Ravenna» nel grossetano, agire contro i reparti: e i magazzini settentrionali della 3 a divisione corazzata tedesca, dislocati tra Bolsena e Siena;
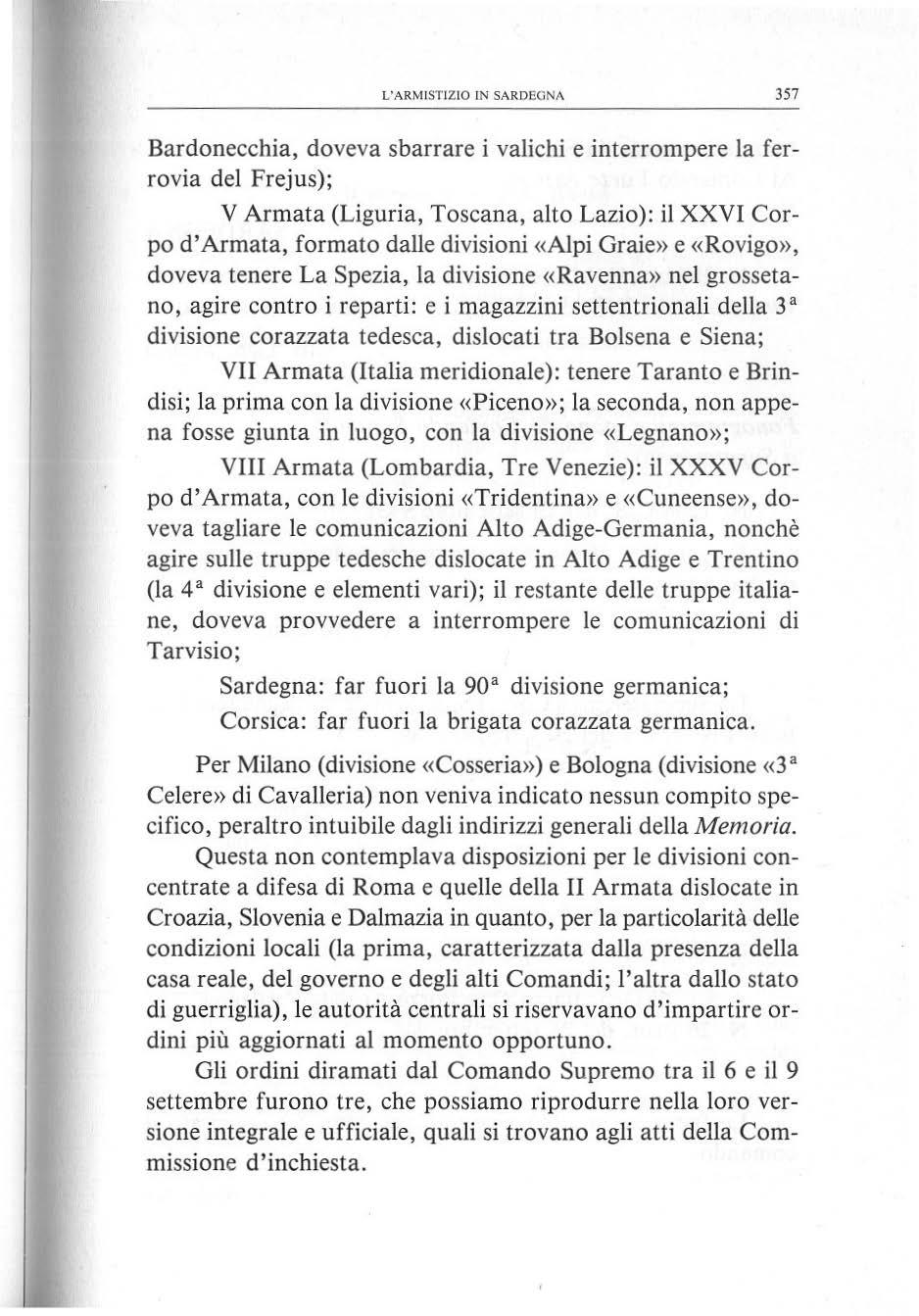
VII Armata (Italia meridionale): tenere Taranto e Brindisi; la prima con la divisione «Piceno»; la seconda, non appena fosse giunta in luogo, con la divisione «Legnano»;
VIII Armata (Lombardia, Tre Venezie): il XXXV Corpo d'Armata, con le divisioni «Tridentina» e «Cuneense», doveva tagliare le comunicazioni Alto Adige-Germania, nonchè agire sulle truppe tedesche dislocate in Alto Adige e Trentino (la 4a divisione e elementi vari); il restante delle truppe italiane, doveva provvedere a interrompere le comunicazioni di Tarvisio;
Sardegna: far fuori la 90a divi sione germanica;
Corsica: far fuori la brigata corazzata germanica.
Per Milano (divisio ne «Cosseria») e Bologna (divisione «3a Celere» di Cavalleria) non veniva indicato nessun compito specifico, peraltro intuibile dagli indirizzi generali della Memoria. Questa non contemplava disposizioni per le divisioni concentrate a difesa di Roma e quelle della II Armata dislocate in Croazia, Slovenia e Dalmazia in quan to, per la particolarità delle condizioni locali (la prima, caratterizzata dalla presenza della casa reale, del governo e degli alti Comandi; l'altra dallo stato di gu erriglia), le autorità centrali si riservavano d'impartire ordini più aggiornati al momento opportuno.
Gli ordini diramati dal Comando Supremo tra il 6 e il 9 settembre furono tre, che possiamo riprodurre nella loro versione in tegrale e ufficiale, quali si trovano agli atti della Commissione d' in chiesta.
Marconigramma da Superesercito Al Comando Forze Armate SARDEGNA
N. 186 op. V. M. del 19 settembre 943 - Mi compiaccio vivamente con V.E. et sue truppe per quanto comunicato.
f.to. Gen. Roatta
Fonogramma a mano da Comando Supremo a Superesercito
N. 1266 C.S. del 19 settembre 943.
Porgete Ecc. Basso et sue truppe mio vivissimo elogio per risultato conseguito.
f.to Gen. Ambrosia
Da Superesercito a Com. Forze Armate Sardegna (per Ecc. Basso ) N. 5/1/3 del 20 settembre 943 per comunicazione
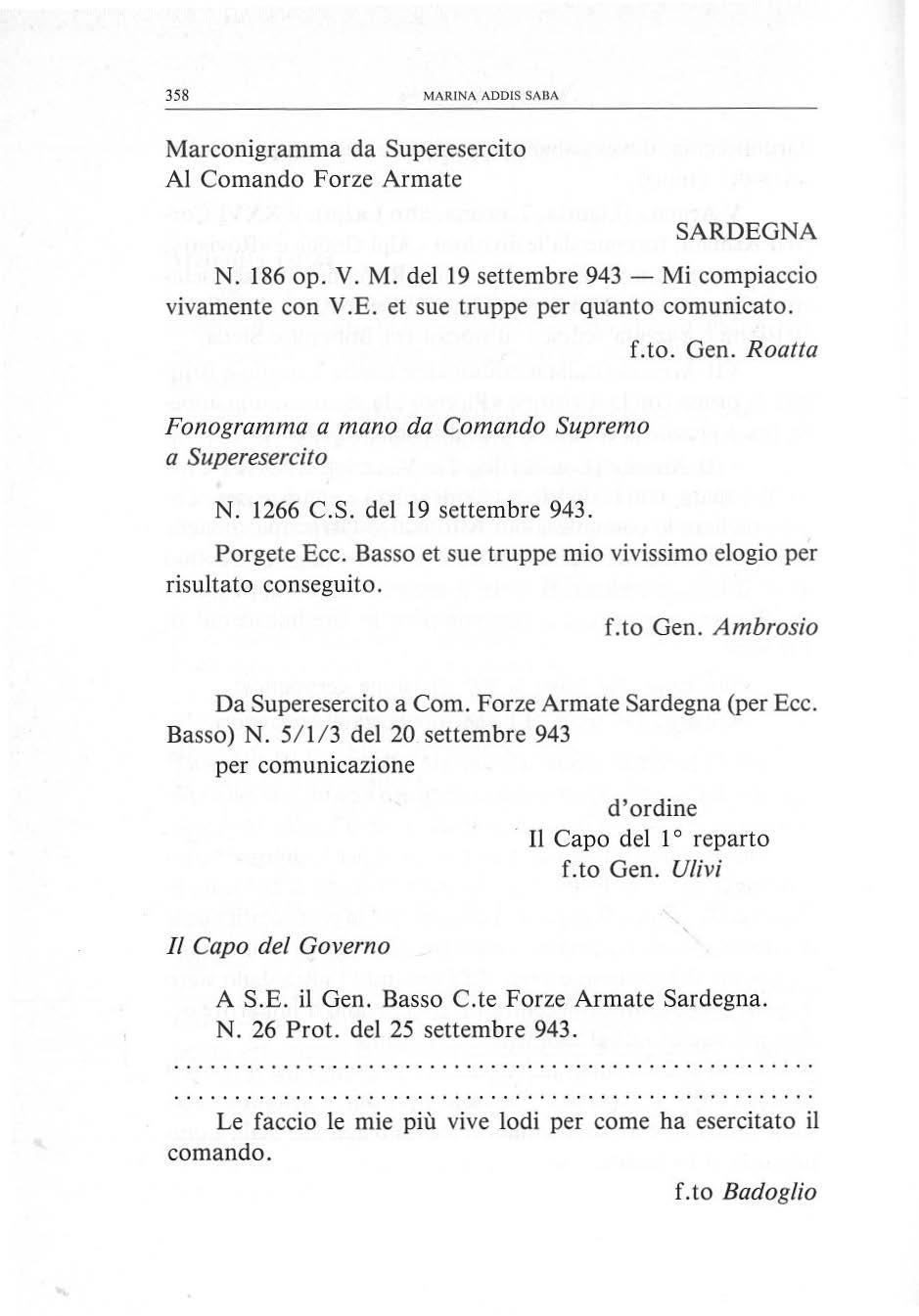
d'ordine
· Il Capo del 1 ° reparto
f.to Gen. Ulivi
Il Capo del Governo
A S.E. il Gen. Basso C.te Forze Armate Sardegna.
N. 26 Prot. del 25 settembre 943.
Le faccio le mie più vive lodi per come ha esercitato il comando.
f. to Badoglio
Il processo al geo. Basso
N. 7305 del processo Data 28 Giugno 1946

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Mil.re territoriale di Roma
composto dai signori:
Generale d'Armata NASI Guglielmo, Presidente
Dott. Comm. FACCINI Renato, Giudice Relatore
Ammir. desig. d'Armata PINI Vladimiro , Giudice
Gen. di C. d'Armata PACINI Leonida, Giudice
Gen. di C. d'Armata NASCI Gabriele, Giudice
Ha pronunciato la seguente
nella causa contro
1) BASSO Antonio fu Alfonso e fu Caprioli Giusepina, nato a Napoli il 27 giugno 1881 - Generale di C. d'Armata - detenuto.
Il 1° di omessa esecuzione di un incarico (art. 100 cod. pen. milit. di guerra) perché Comandante delle Forze Armate della Sardegna alla data dell'armistizio, senza giustificato motivo non eseguiva l'ordine di operazione 5 V a lui pervenuto il 12 Settembre 1943, ribadito dall'ordine 21 V a lui pervenuto il successivo giorno 13, di impedire ~l passaggio delle truppe tedesche dalla Sardegna alla Corsica;
il 2° . ............... . ........................
(1) Nel riportare in sentenza ho omesso tutto quanto riguarda il mio compagno di sventura (N. di A Basso)
Il Generale di C. d'Armata Basso Antonio, comandante delle FF.AA. della Sardegna dal novembre 1940; riceveva il 2 settembre 1943 a mezzo del T. Col. di S.M. Eberlin, un foglio di dispo siz ioni indicato col nome «Memoria 44» redatto dal Capo di S.M. esercito, Gen. Roatta, non datato e non firmato e che dopo la lettura doveva essere distrutto.
Il tenore del foglio, giusto gli appunti che il Basso potè prendere era il seguente (Vol. I allegato 1): (1)
«Considerate il caso ch e forze tedesche intraprendano di iniziativa atti di ostilità contro organi di governo (centrali o periferici) o contro forze armate italiane e con ca rattere di azione collettiva, intesa a rip ristinar e il vecchio regime e ad assumere il governo diretto .
«Te ndere: far fuori mezzi aeronautici, depositi carburanti, tagliare collegamenti, eliminare piccoli elementi sparsi.
«In genere: poche imprese ma buone.
«Sardegna: inizialmente far fuori le truppe tedesche esistenti successivamente tenersi pronti per gli altri impieghi.
A seguito di detta memoria il Basso died e dispo s izioni al suo uffici operazioni, perchè avesse accuratamente studiato e predisposto l'azione, prevedendo sia l'ipotesi della iniziativa da parte delle truppe italiane, sia la ipotesi della ini ziativa da parte delle truppe tedesche dislocate in Sardegna .
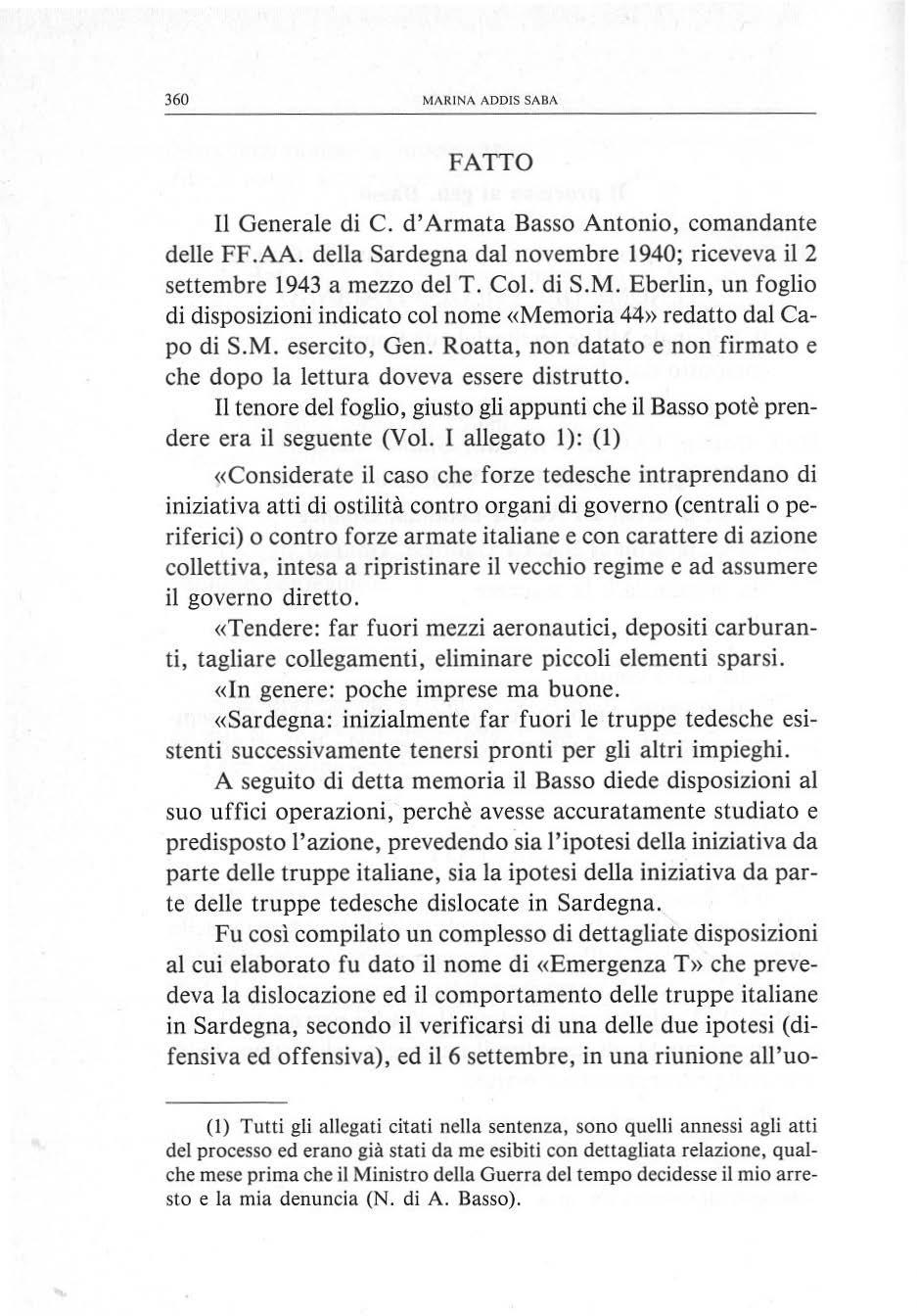
Fu così compilato un complesso di dettagliate di sposiz ioni al cui e laborato fu dato il nome di «Emergenza T» che prevedeva la dislocazione ed il comportamento delle truppe italiane in Sard eg na, secondo il verificarsi di una delle due ipotesi (difensiva ed offensiva), ed il 6 settem b re, in una riunione all'uo-
(I) Tutti gli allegati citati nella sentenza, sono quelli annessi agli atti del processo ed erano già stati da me esib iti con dettagliata relazione, qualche mese prima che il Ministro della Guerra del tempo decidesse il mio arresto e la mia denuncia (N. di A. Basso).
po indetta presso il suo comando in Bortigali, il Gen. Basso dava conoscenza dell'elaborato ai comandanti suoi dipendenti. La sera dell'8 settembre, alle ore 20.30, il Gen. Basso apprende dalla radio la notizia dell'armistizio secondo il quale occorreva «reagire ad ogni atto di ostilità»; la stessa sera il comandante delle truppe tedesche, Gen. Lungerhausen, invitava il Gen. Basso a far causa comune con i tedeschi, appellandosi al lungo cameratismo d'armi: dinanzi all'energico rifiuto del Gen. Basso, egli dichiarava essere proposito del comando tedesco di iniziare subito lo sgombero dell'isola per passare in Corsica. Il Gen. Basso faceva presente che non si sarebbe opposto all'attuazione del suddetto divisamento, purché da parte delle truppe germaniche non vi fosse stata alcuna provocazione contro quelle italiane.
Di ciò comunque egli informava subito il Superesercito, cui chiedeva se dovesse o non opporsi al movimento. Ma non aveva risposta o, quanto meno, questa non perveniva: si rinveniva però in una cassaforte del Ministero della Guerra, contenente carteggio riservato e segreto, l'appunto senza firma, del seguente tenore (foglio 13 - Vol. I): «Ore 2,00 Ecc. Roatta comunica che l'Ecc. Basso fa sapere che la 90a divisione germanica chiede di poter abbandonare la Sardegna in forma pacifica, chiede inoltre che siano restituite le batterie da 88 che sono state cedute a noi e che sono servite da personale italiano. L'Ecc. Ambrosio accoglie la richiesta».
Nella stessa sera invece, ad ora avanzata - 23,45 - il Gen. Basso riceveva da Superesercito operazioni il seguente telegramma: «In relazione armistizio non debbono essere contrastat i sbarchi anglo-americani».
Il giorno success ivo, il predetto Generale informava telefonicamente (ali. 4 vol. I) il Gen. Magli, comandante delle truppe italiane in Corsica del progetto tedesco di trasferimento in detta isola ed in questa comunicazione dava no tizia di essere in attesa di posizioni al riguardo da Superesercito, informando di , avere comunque predisposto per il concentramento nella zona
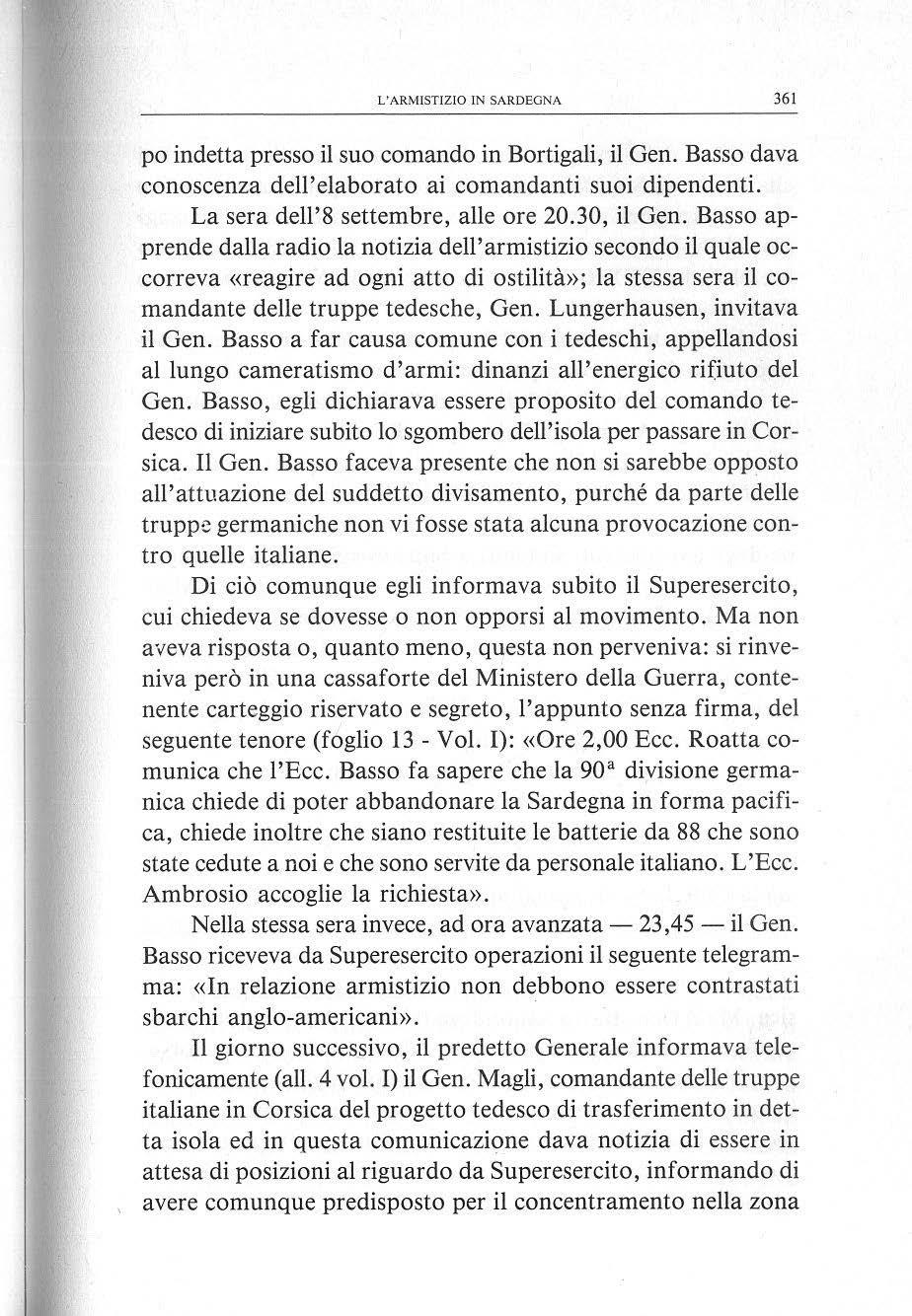
di Gallura delle truppe da lui dipendenti e di aver dato ordini alla Piazza di Maddalena di tenersi pronta per agire con le sue batterie, qualora avesse ricevuto ordine di impedire il passaggio. Ordini che risultano effettivamente impartiti il 9 settembre al C.do XXX Corpo ed a quello della Maddalena, come dagli all. 6 e 7 vol. I
Intanto nel mattino del 9 reparti tedeschi, con un improvviso colpo di mano occupavano il Comando marina, la stazione radio, nonché alcune batterie della Maddalena e catturavano altresì gli Ammiragli Brivonesi e Bona, mentre manifestazioni sediziose si verificarono presso alcuni reparti paracadutisti «Nembo». Il Gen. Basso il 10 chiedeva il concorso di forze navali (all. 10) e nello stesso giorno (all. 11) dava comunicazione degli avvenimenti suddetti a Superesercito. L'Ammiraglio Brivonesi era però già riuscito a mettersi in contatto col Ministero della Marina, che lo autorizzava a prendere direttamente accordi col comandante tedesco della Maddalena, ragguagliandone il Gen. Basso che a sua volta ne informava (all. 12) il Superesercito. Gli accordi presi dall' Amm. Brivonesi consistevano (all. 13) nell'impegno da lui preso di non compiere atti ostili contro le truppe tedesche che si transitavano in Corsica a condizione che fossero rimaste invariate le occupazioni già effettuate, e che non vi fossero stati attacchi di sorta contro le truppe italiane. Il giorno 10 i primi contingenti te deschi avevano già lasciato la Sardegna ed una brigata corazzata aveva già costituito un'ampia testa di sbarco a Bonifacio. Il Gen. Magli ne dava comunicazione (all. 17) al Gen. Basso, invitandolo a considerare la necessità che la divisione tedesca non passasse in Corsica. Ma il Gen. Bas so rispondeva (all. 18) che non poteva che confermare le decisioni prese, essendo il movimento in corso.
L' 11 settembre venivano da Marina Cagliari, intercettati incompletamente due marconigrammi a firma Roatta (all. 21), secondo i quali dovevano attuarsi le misure predisposte con la memoria 44 e le truppe germaniche doveva considerarsi come nemiche e quindi dovevano essere eliminate.
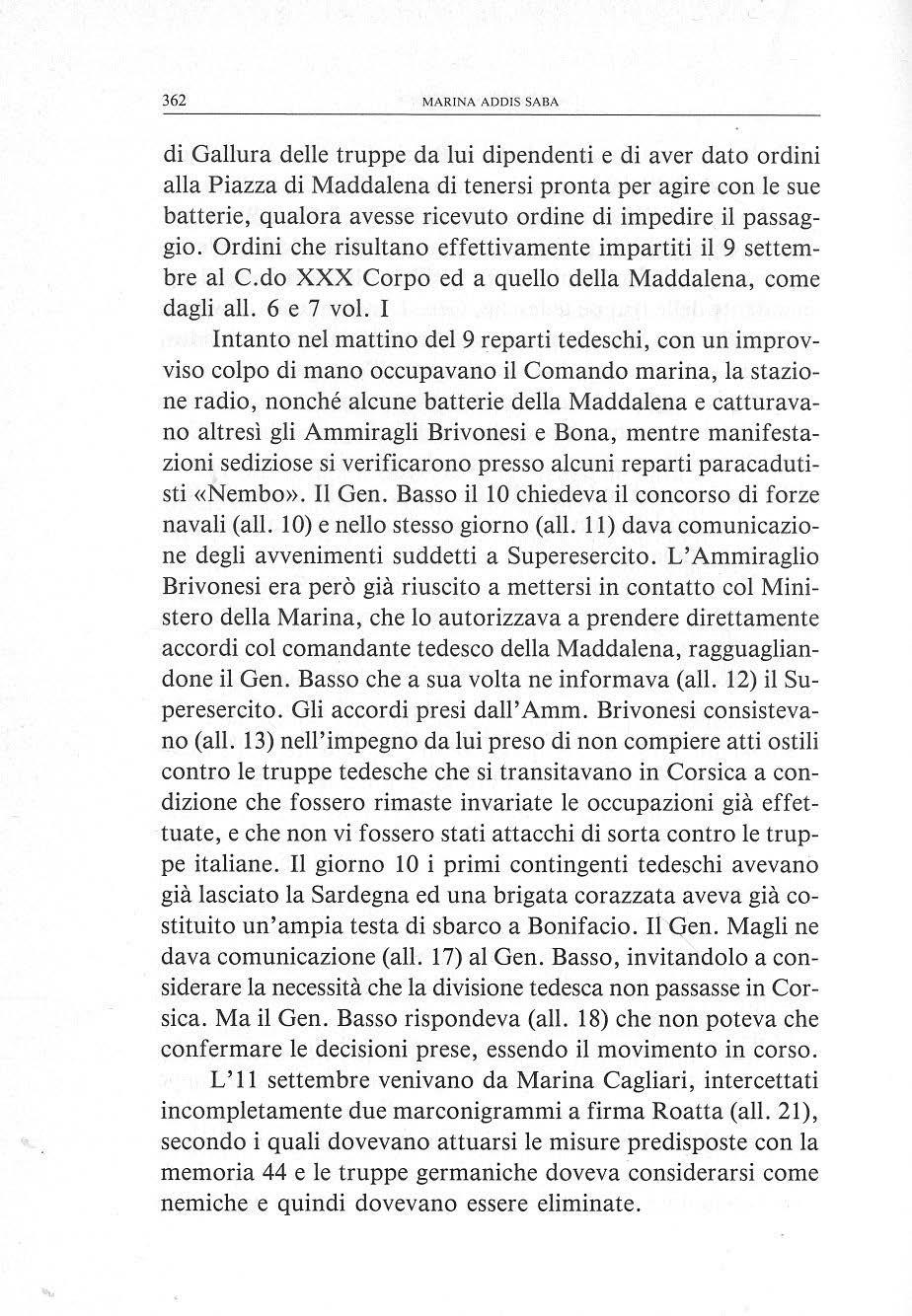
Il Gen. Basso si affrettava nello stesso giorno a chiedere a Superesercito chiarimenti al riguardo (all. 22) e confermava contemporaneamente ai reparti dipendenti (ali. 23) la necessità di seguir da vicino le truppe tedesche in modo da impedire un eventuale ritorno offensivo verso il Sud (all. 24).
Nel frattempo l' Amm. Brivonesi, in un colloquio col Gen.Lungerhausen, concordava le basi per un accordo di massima circa la situazione della Maddalena, che comunicava per l'approvazione del Gen. Basso (all. 25).
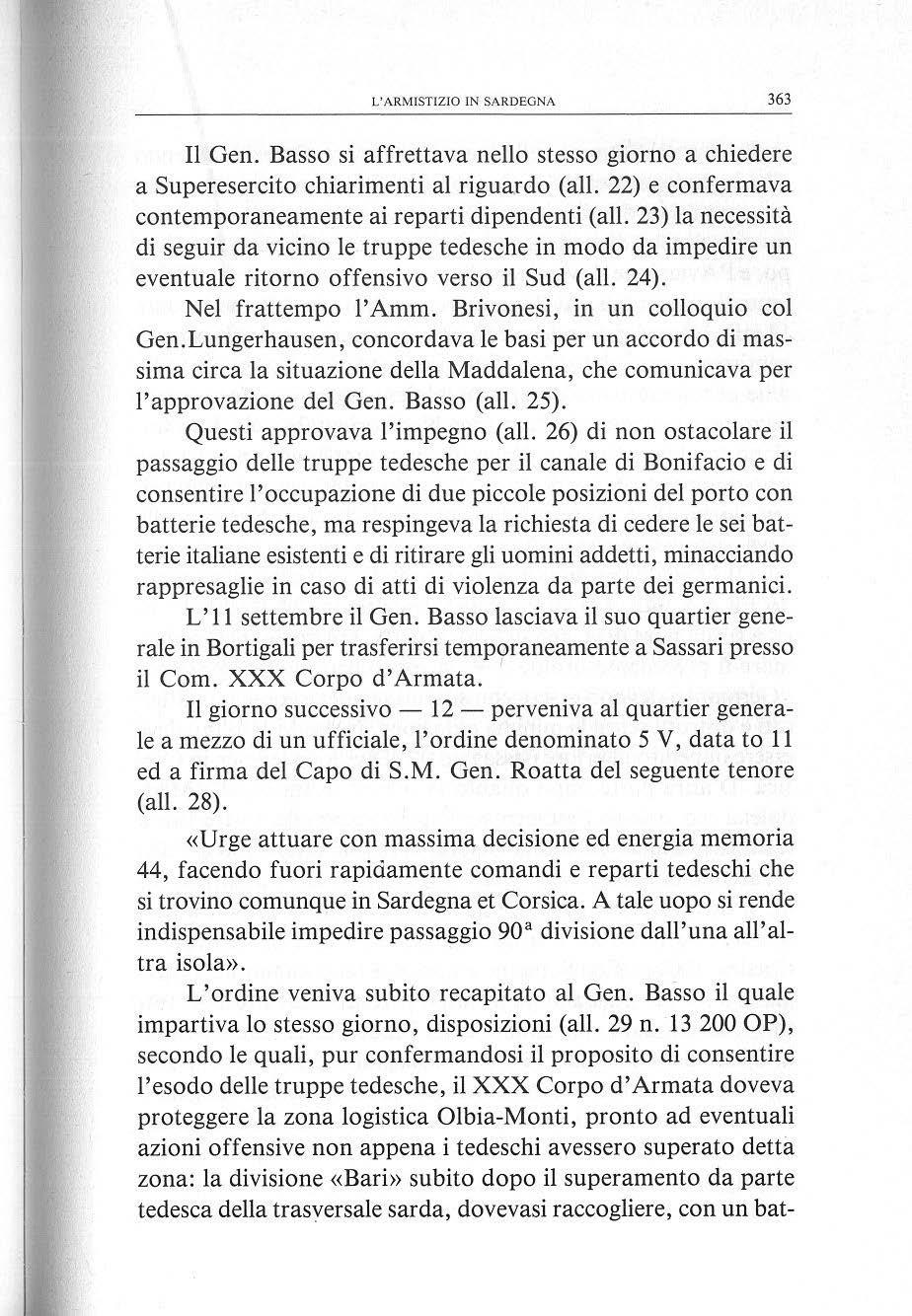
Questi approvava l'impegno (all. 26) di non ostacolare il passaggio delle truppe tedesche per il canale di Bonifacio e di consentire l'occupazione di due piccole posizioni del porto con batterie tedesche, ma respingeva la richiesta di cedere le sei batterie italiane esistenti e di ritirare gli uomini addetti, minacciando rappresaglie in caso di atti di violenza da parte dei germanici.
L' 11 settembre il Gen. Basso lasciava il suo quartier generale in Bortigali per trasferirsi temporaneamente a Sassari presso il Com. XXX Corpo d'Armata.
Il giorno successivo - 12 - perveniva al quartier generale a mezzo di un ufficiale, l'ordine denominato 5 V, data to 11 ed a firma del Capo di S.M. Gen. Roatta del seguente tenore (all. 28).
«Urge attuare con massima decisione ed energia memoria 44, facendo fuori rapiàamente comandi e reparti tedeschi che si trovino comunque in Sardegna et Corsica. A tale uopo si rende indispensabile impedire passaggio 90a divisione dall'una all'altra isola».
L'ordine veniva subito recapitato al Gen. Basso il quale impartiva lo stesso giorno, disposizioni (all. 29 n . 13 200 OP), secondo le quali, pur confermandosi il proposito di consentire l'esodo delle truppe tedesche, il XXX Corpo d'Armata doveva proteggere la zona logistica Olbia-Monti, pronto ad eventuali azioni offensive non appena i tedeschi avessero superato detta zona: la divisione «Bari» subito dopo il superamento da parte tedesca della trasversale sarda, dovevasi raccogliere, con un bat-
taglione carri Somua, nella zona Bonannaro-Ozieri, passando alla dipendenza del XXX Corpo; il XIII Corpo doveva spostare verso il Nord le Divisioni «Sabauda» e «Nembo», che passavano alle sue dipendenze in rincalzo eventuale del XXX Corpo, e l'Aviazione doveva tenersi pronta ad intervenire con tutti i mezzi disponibili. Al Superesercito poi il Gen. Basso in data 13 (all. 31) così rispondeva con una marconigramma cifrato urgentissimo precedenza assoluta: «Rispondo 5 V, truppe tedesche occupano parte piazza Maddalena e protette forti retroguardie corazzate ripiegano zona Nord orientale isola dove iniziano traghetto Corsica . Sono in corso movimento mie truppe per consentire attacco decisivo . Prevedo poterlo attuare non prima giorno 16. Nessun affidamento su divisione «Nembo» che deve anzi essere controllata».
Il 13 veniva recapitato a mezzo di altro ufficiale al Comando FF.AA. (ali. 37) altro ordine denominato 21 V, datato 12 ed a firma pure del Capo di S.M. Roatta, col quale, nel confermare il precedente ordine 5 V, si precisava quanto appresso: «Germanici devono essere considerati nemici e come tali attaccati e distrutti senza la minima esitazione. In modo assoluto deve essere impedito ulteriore passaggio 90a Divisione tedesca in Corsica. D'altra parte dopo quanto avvenuto in Italia, alla Maddalena ecc. e dopo l'attacco aereo germanico alla nostra flotta (fatti che, almeno in buona misura, debbono essere noti a V.E.) si sarebbe dovuto comprendere che in mancanza di altri ordini, si doveva dare piena applicazione alla memoria 44, a prescindere da qualsiasi atto germanico di ostilità ih Sardegna e Corsica. Il Comando Supremo e questo S.M. contano sulla energia di V.E. per guadagnare il tempo perduto e far fuori del tutto i tedeschi dalle due isole e dalla Maddalena. Circa il radio n. 06821 del Comando FF.AA. Sardegna ordierno, trasmesso vi a C agliari, faccio presente che non vennero inviati telegrammi a fir ma Roa tt a e d Ambrosie. Si tratta probabilmente dicorimnicazioni ap ocri fe , fatte dai germanici, giunti in possesso dei nostr i ci frari. Un nuovo sistema di cifrario viene inviato dal Comando Supremo a me zzo dell'ufficiale latore».
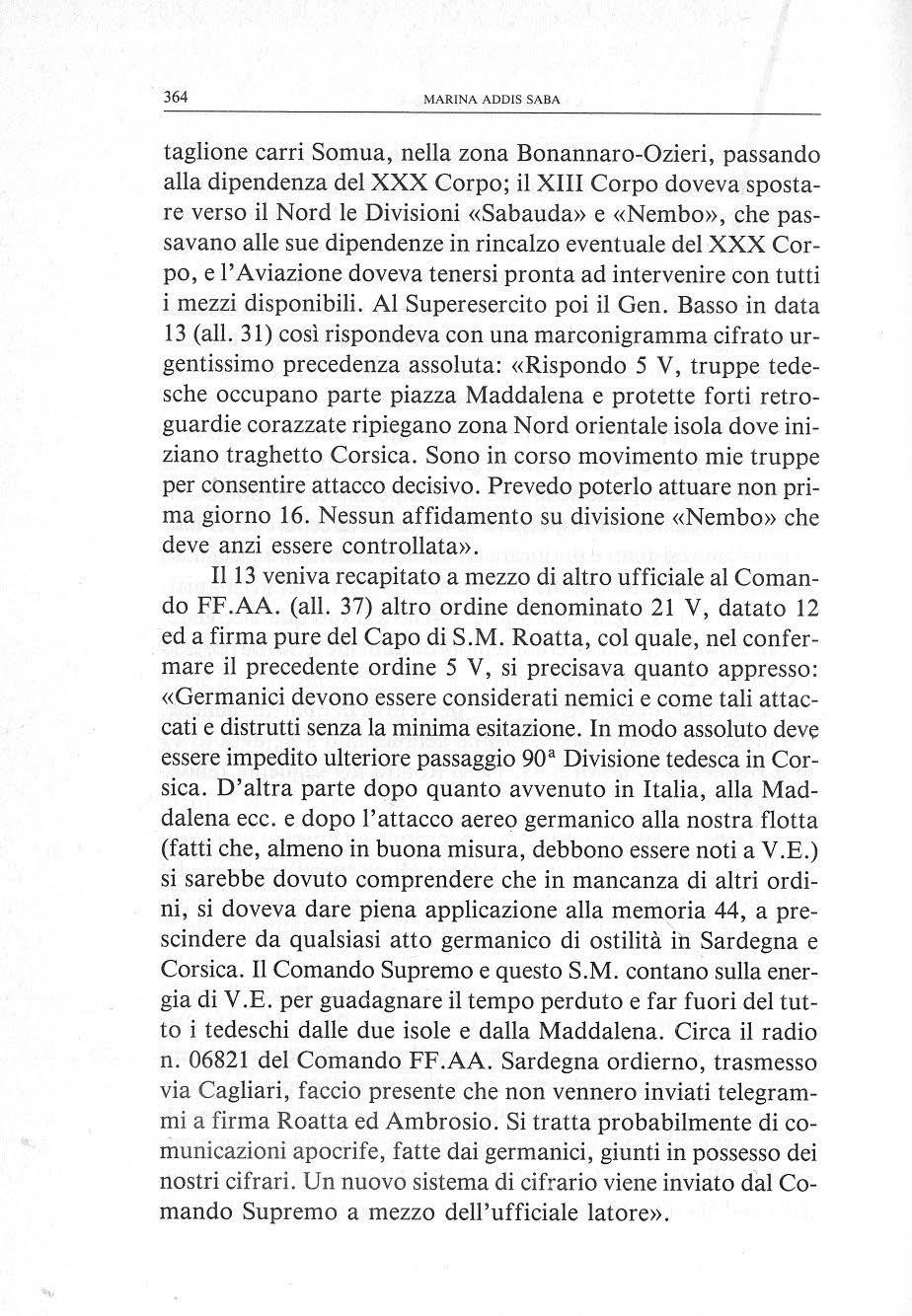
Nel frattempo, lo stesso giorno 13, a seguito di felice iniziativa del Magg. Barsotti sot tocapo di S.M. esercito presso C.do Marina, il 391 ° Batt.ne costiero ed alcuni reparti di marina, liberarono alla Maddalena, i due ammiragli, la stazione radio e le batterie.
Il 14 su richiesta del Gen. Lungerhausen, aveva luogo un incontro fra lui e il Gen. Basso a Tempio, nel quale si raggiungeva un accordo circa la sistemazione di Maddalena, mentre alle truppe tedesche veniva concesso un termine a tutto il 17 per il loro pacifico deflusso dalla Sardegna. Nella lettera con la quale (all. 38) il Gen. Basso dava notizie dell'accordo all'Ammiraglio Brivonesi, si precisava, tra l'altro, che le batterie non dovevano sparare contro i natanti che seguivano via Corsica sia di giorno che di notte, che occorreva evitare assolutamente malintesi od incidenti ed imporre ad ogni costo alle batterie della piazza l'esecuzione di detti ordini a tutto il giorno 17. A tale giorno, continuava la lettera, considereremo azione nemica qualsiasi tentativo di ritorno nelle isole dell'Arcipelago ed in Sardegna ed agiremo in conseguenza. Nostro compito principale è di farli fuori dalla Sardegna e dalle isole. Quando l'avremo raggiunto col metodo facilitativo, passeremo a quello della decisa e recisa resistenza.
Della situazione e delle ragioni per le quali non aveva ritenuto di agire altrimenti il Gen. Basso informava dettagliatamente lo S.M. con nota del 15 Sett. (ali. 39), allorquando cioè egli si allontanava da Sassari per restituirsi a Bortigali.
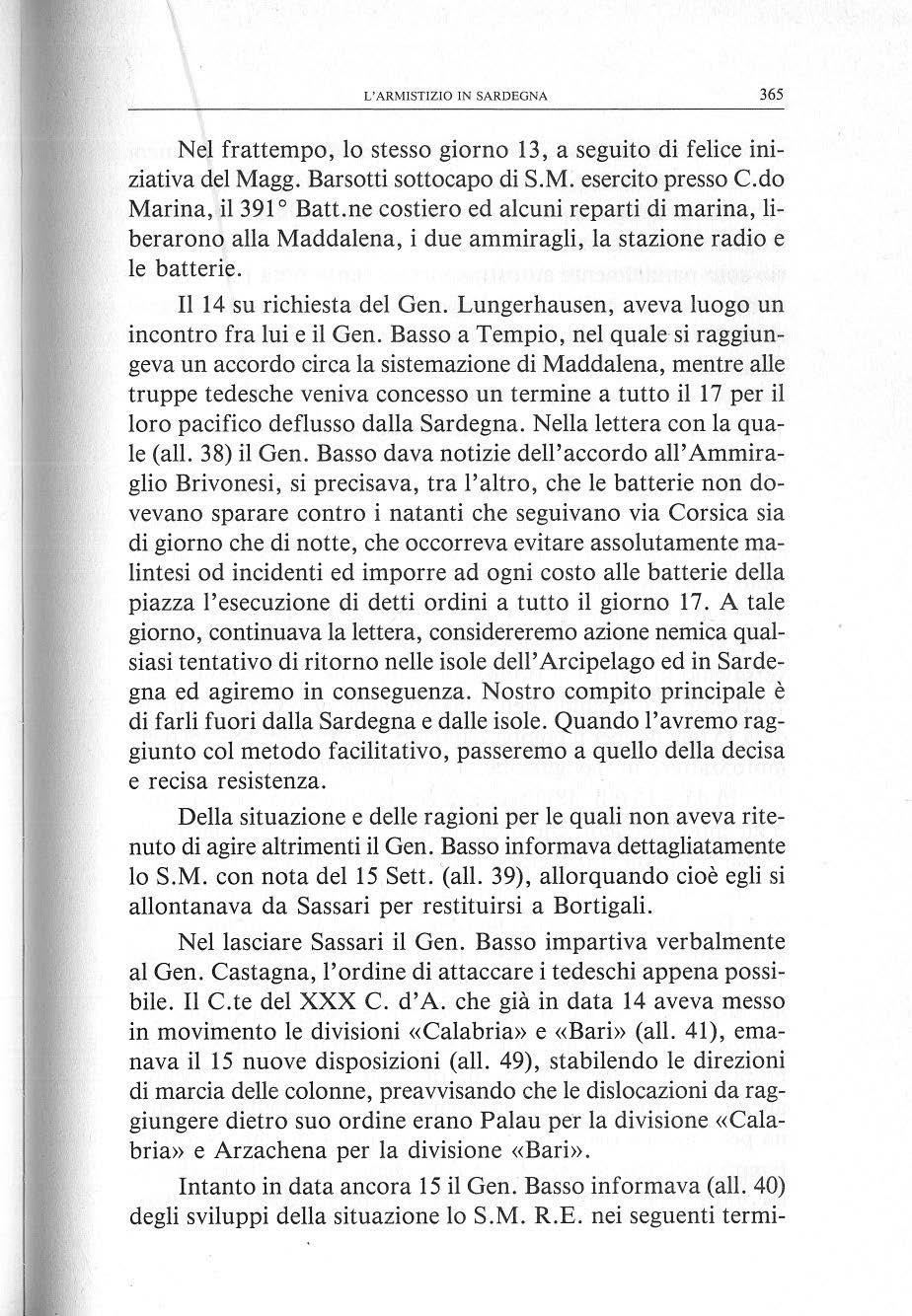
Nel lasciare Sassari il Gen. Basso impartiva verbalmente al Gen. Castagna, l'ordine di attaccare i tedeschi appena possibile. Il e.te del XXX C. d'A. che già in data 14 aveva messo in movimento le divisioni «Calabria» e «Bari» (all. 41), emanava il 15 nuove disposizioni (all. 49), stabilendo le direzioni di marcia delle colonne, preavvisando che le disloca zioni da raggiungere dietro suo ordine erano Palau per la divisione «Calabria» e Arzachena per la divisione «Bari».
Intanto in data ancora 15 il Gen. Basso informava (ali. 40) degli sviluppi della situazione lo S .M. R.E. nei seguenti termi-
ni: «Dopo scontri svoltisi nelle zone di Oristano-MacomerMores, tutta la maggior parte dell'isola è in nostro possesso. Germanici ripiegano precipitosamente nella Gallura, protetti retroguardie corazzate, incalzate da divisioni «Calabria» e «Bari» solo parzialmente autostrasportate causa nota povertà automezzi, e concludeva: per impedire trasferimento unità germaniche in Corsica è necessaria azione navale su stretto Bonifacio».
Ma lo stesso giorno 15 un evento si verificava che faceva ve ni r meno ogni motivo per temporeggiare ancora e cioè la distruzione di numerosi aeroplani italiani sul campo di Vena Fiorita ad opera delle truppe tedesche.
Infatti il C.do FF.AA. della Sardegna ordinava (all. 42) che da quel momento i militari tedeschi ancora nell'isola dovevano essere catturati e disarmati e disponeva con marconigramma diretto al C.do Marina in Maddalena (all. 43) che le batterie ai suoi ordini aprissero il fuoco con t ro i na t anti che attraversavano lo stretto di Bonifacio. Analoghe disposizioni venivano date al Comando dell'Aviazione che provvedeva pure in data 15 (ali. 44) per il bombardamento con nove apparecchi delle motozzattere in navigazione nelle Bo cche di Bonifacio.
In data 16 (ali. 48) precisava con telegramma diretto a tutt i gli enti dipendenti che tutti i tedeschi comunque rimasti nell'isola erano da considerarsi nemici e dovevano essere arrestati. Ma il movimento dei reparti del XXX Corpo sembrava lent o al Gen. Basso che verso mezzogiorno del 16 telefonava, sollecitandone l'azione. Successivamente con telescritto cifrato del 16 (ali. 52) il Gen. Basso confermava gli ordini dati per te lefono, disponeva che il mattino successivo le posizioni tedesche dovevano essere attaccate. Altre azioni di mitragliamento venivano predisposte per lo stesso mattino (all. 53 e 54) e si ripeteva anche (ali. 56) l'ordine di intervento delle forze della Maddalena per l'azione offensiva contro le truppe tedesche. Nel frattempo nella sua marcia verso Arzachena, la divisione «Bari» incontrava nella mattinata del 16 un reparto tedesco di retro-
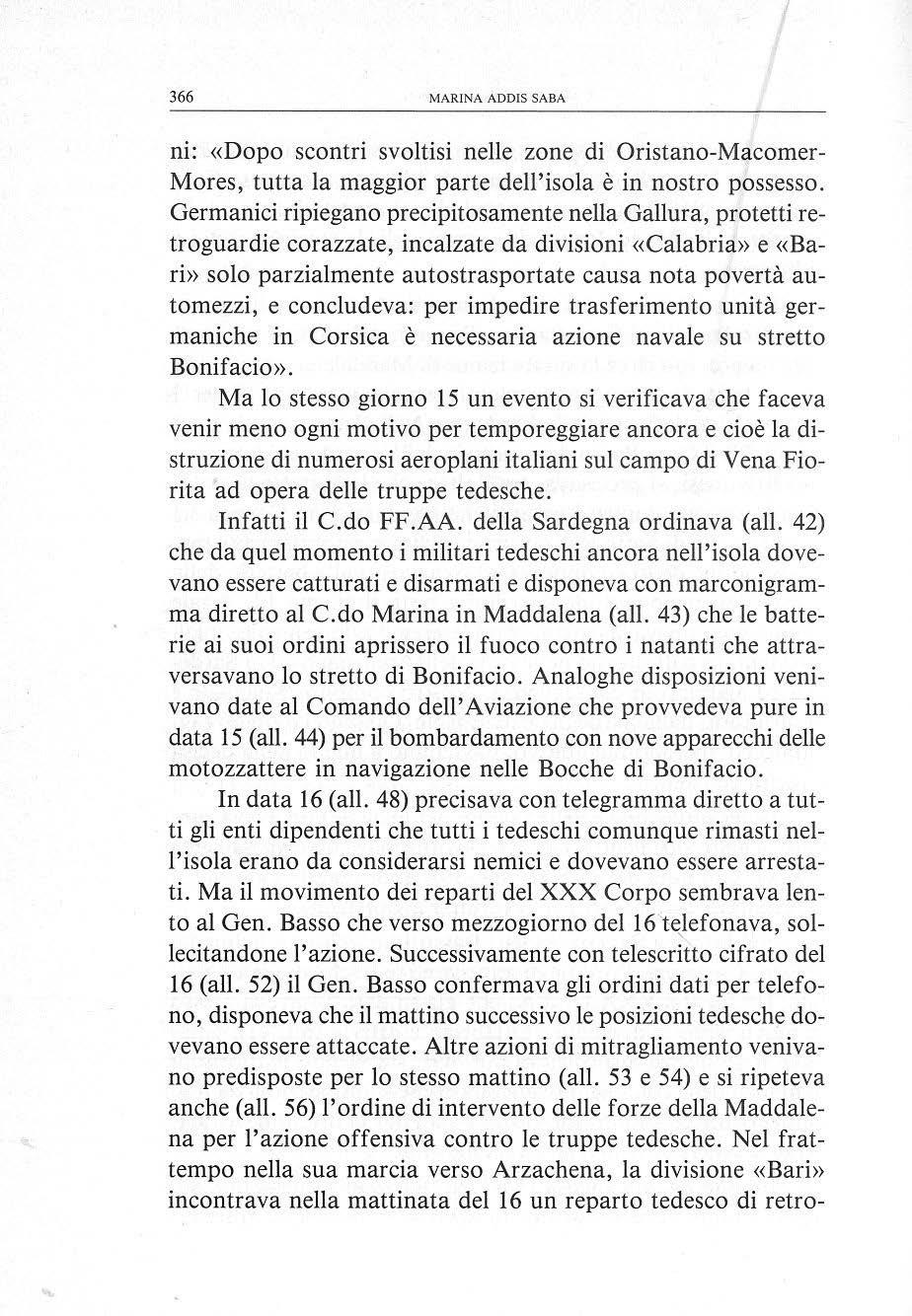
guardia, che avrebbe potuto opporre solo una debole resistenza; ma il Gen. De Nisio, Com.te la divisione era costretto ad arrestarsi in quanto per accordi intervenuti direttamente col Comando XXX Corpo d'Armata, il reparto tedesco era stato falcoltizzato a pernottare sul posto. In serata giungeva l'ordine di attaccare il mattino successivo, ma all'alba il reparto tedesco si era già allontanato. La div. «Bari» si rimetteva in marzia, ma quando, dopo una sosta a Cantoniera Cucone in attesa di ordini, giungeva a Palau nel tardo pomeriggio del 17, i tedeschi avevano già lasciato il porto.
Anche la div. Calabria avanzava lentamente, legata alle disposizioni del Gen. Castagna ed allorchè il 17 riceveva anch'essa l'ordine di iniziare l'azione per la conquista di S. Teresa di Gallura, l'altro porto di cui i tedeschi si servivano per l'imbarco, la città risultava già evacuata dalle ultime truppe tedesche.
Questi i fatti emergenti essenzialmen t e dai documenti esistenti dall'attuale processo, il quale fu iniziato a seguito di autorizzazione del Capo di Stato Maggiore Generale in data 7 novembre 1944 su domanda del Ministro protempore della Guerra.
L'istruzione fu svolta col rito formale e contro gli imputati fu emesso mandato di cattura che fu loro notificato il 24 marzo 1945. Nel corso della istruzione, sia negli interrogatori, sia nei fogli di lumi e nelle memorie, gli imputati protestarono sempre la loro innocenza, deducendo sostanzialmente di essersi trovati nella impossibilità di impedire l'esodo delle truppe tedesche dalla Sardegna.
Completata l'istruz io ne, i due generali, sulle conformi conclus ioni del P .M. venivano inviati al giudizio di questo Tribunale con sentenza 31 maggio 1945 per risponqere dei reati singolarmente loro ascritti come in epigrafe .
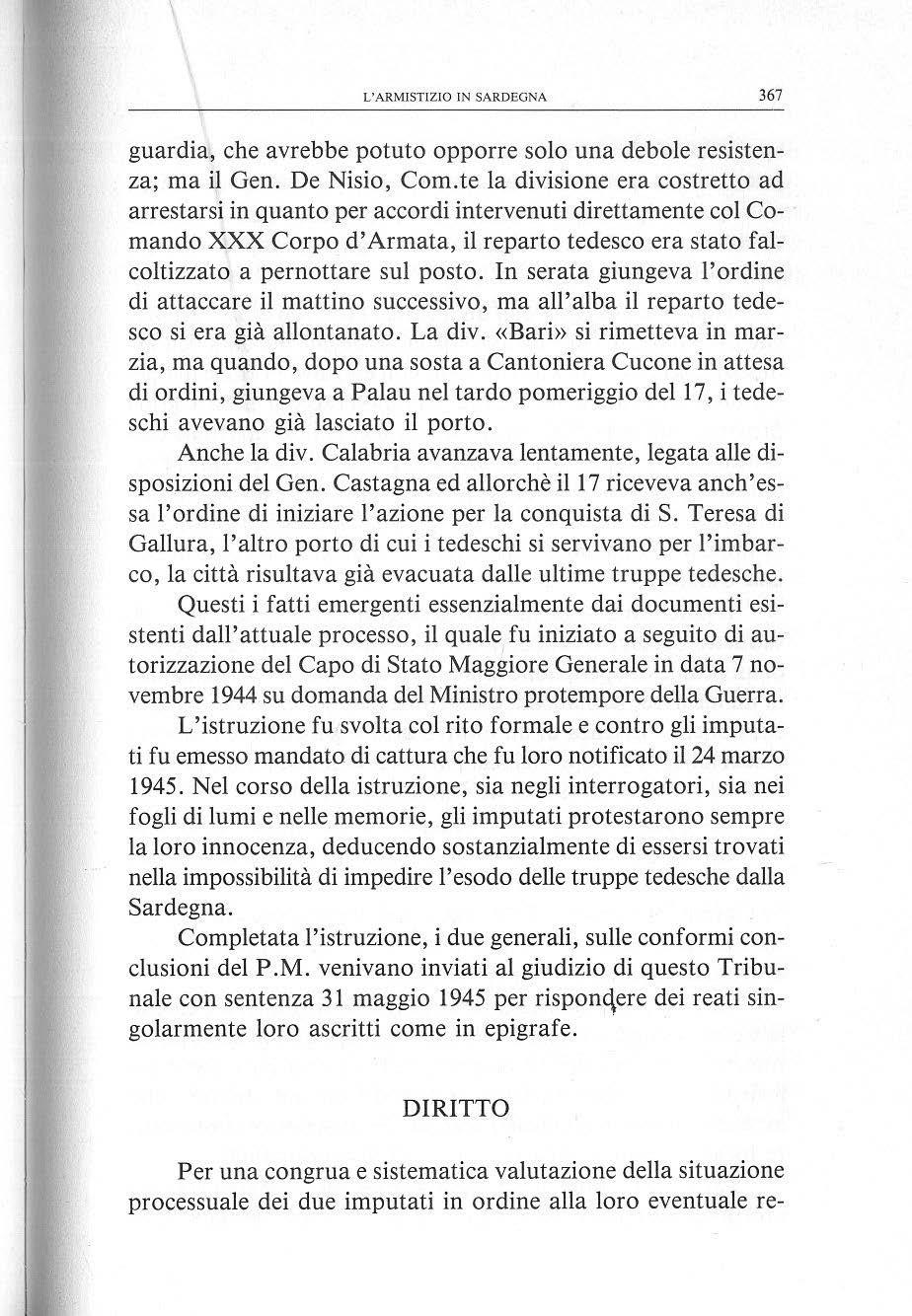
Per una congrua e sistematica valutazione della situazione processuale dei due imputati in ordine alla loro eventuale re-
sponsabilità, fà d'uopo esaminare partitamente le rispettive imputazioni, in quanto essi devono rispondere di due distinti reati.
Quello ipotizzato a carico del Gen. Basso nella sentenza di rinvio, e conforme del resto alla originaria imputazione, è così specificato:

«Omessa esecuzione di un incarico (art. 100 c.p . m.g.) perchè Comandante delle FF.AA. della Sardegna alla data dell'armistizio, senza giustificato motivo, non eseguiva l'ordine di operazione contenuto nella Memoria 44, non raccogliendo le gravi provocazioni tedesche, tra cui specialmente l'occupazione della Maddalena; e perchè nelle stesse circostanze non eseguiva l'ordine di operazione 5 V a lui pervenuto il 12 settembre 1943, ribadito dall'ordine 21 V a lui pervenuto il successivo giorno 13, di impedire il passaggio delle truppe tedesche dalla Sardegna alla Corsica».
E poichè per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 100 suddetto occorre il concorso dei seguenti elementi: la esistenza di un ordine di operazione militare, o comunque l'affidamento di un incarico; la mancata esecuzione dell'ordine o dell'incarico; nonchè l'assenza di un motivo atto a giustificare l'omessa esecuzione, fa d 'uopo ricercare attraverso le risultanze processuali la sussistenza o non dei suddetti requisiti.
Per quanto attiene alla mancata esecuzione dell'ordine di esercuzione della memoria 44, una prima considerazione si impone e cioè che non è stato possibile ricostruirne con precisione i termini nei quali la memoria si esprimeva, come ha dichiarato anche il Maresc. d'Italia Messe, per lungo tempo preposto al Comando dello St. Magg. Generale.
Comunque un primo dubbio potrebbe formularsi e cioè se la stessa, secondo il testo risultante dagli appunti in atto, possa ri tenersi come un vero e proprio ordine e non pure come un insieme di direttive impartite ai diversi Comandi militari, che avrebbero dovuto applicarle secondo le situazioni e contingenze locali, con una larga sfera cioè di discrezionalità;
Ad ogni modo è certo che l'azione dei Comandi italiani non poteva essere che di reazione ad atti di ostilità armata com-
piuti dalle forze tedesche; doveva però trattarsi di atti di particolare gravità sia perchè diretti eventualmente contro organi di governo (centrali o periferici) o contro forze armate italiane sia perchè doveva trattarsi non già di azioni isolate, ma di azioni collettive: l'azione delle forze tedesche, che avrebbe potuto giustificare una reazione di quelle italiane, doveva però presentarsi con caratteri di particolare pericolosità e gravità, in quanto cioè avesse i seguenti obiettivi: il ripristino del vecchio regime - l'assunzione del governo diretto.
Ben vero che per la Sardegna vi era una segnalazione particolare: «inizialmente far fuori le truppe tedesche esistenti, successivamente tenersi pronti per altri impieghi» ma, a prescindere dalla considerazione che non era ben chiaro il significato della espressione «far fuori» (interpret ata dal Gen. Basso come equipollente di espellere, mandar via, da altri, tra cui il suo capo ufficio operazioni T. Col. Martignago nel senso più esteso di eliminare in qualunque modo, annientare), non v'ha dubbio che essa doveva essere posta in relazione con la parte generale precedente e considerarsi cioè sempre subordinata al verificarsi delle condizioni ivi previste.
Una diversa interpretazione avrebbe portato ad un inizio di ostilità contro i tedeschi in un solo settore prima ancora del1' armistizio le cui trattative si svolgevano nel segreto più assoluto ed erano quindi ignote al Gen. Basso. Si verificò mai nel periodo 8-11 settembre, anteriormente cioè agli ordini 5 V e 21 V, taluno dei gravi eventi che avrebbero potuto autorizzare reazione da parte del Gen. Basso nel senso sopraindicato? La risposta, alla stregua di tutti gli elementi processuali, non può essere che negativa.

Lo stesso capo di imputazione parla solo di gravi provocazioni tedesche, che per verità in detto periodo furono molto modeste e cioè manifestazioni di atteggiamento di reparto singoli, e che, comunque non rientravano nelle prescrizioni della memoria 44.
Un solo episodio vi fu di notevole gravità - quello della Maddalena del 9 settembre - ricordato espressamente nel ca-
po imputazione, che non cessava però di essere, un caso isolato e ben deliminato, senza cioè alcuna di quelle pericolose e gravi diffico l tà che secondo la menzionata memoria, avrebbero potuto giustificare una reazione di vasta portata da parte del Com. FF.AA. della Sardegna. Al riguardo va ricordata la interferenza del Supermarina col quale l'ammiraglio Brivonesi Comandante della Piazza si era messo a contatto, e le difficoltà per non dire la impossibilità da parte del Comando FF .AA. di agevolare una reazione locale, che avrebbe potuto avere il presupposto nel passaggio di altre forze nell'isola, reazione che comunque avvenne e felicemente il 13 settembre da parte delle forze italiane esistenti nell'isola stessa .
Se però da parte del Gen. Basso non vi fu alcuna reazione apprezzabile per le ragioni sopraindicate, occorre invece tener presente che non solo egli si affrettò ad informare il Ten. Col. Eberlin - latore della memoria 44 - delle condizioni reali delle FF.AA. dell'isola in relazione ad un eventuale rovesciamento della situazione perchè ne avesse a sua volta reso edotto lo Stato Maggiore Esercito, ma con la «emergenza T» predi posta dal suo ufficio operazioni, in seguito alle direttive da lui impartite, egli vi inquadrava la sua azione eventuale nello esposto della mem o ria 44 e con la convocazio n e del 6 di tutti i comandanti alle sue dirette dipendenze e le disposizioni cautelative date, si mostrava compreso della gravità della situazione che da un momento all'altro poteva presentarsi.
Troppo generica era poi la espressione «reagite se attaccati» compresa nel proclama del Maresc. Badoglio dell'8 settembre, perchè potesse considerarsi impegnativa come un ordine tassat ivo e d'altra parte anche la sua att u azione non poteva essere che in funzione della situazione locale e dei mezzi a disposizione.
E la situazione locale, a prescindere da altre circostanze di cui poi si farà cenno, era caratterizzata dal proposito manifestato subito d opo la comunicazione ufficiale dell'arm istizio, dal Comandante le truppe tedesche di evacuare pacificamente l'i-
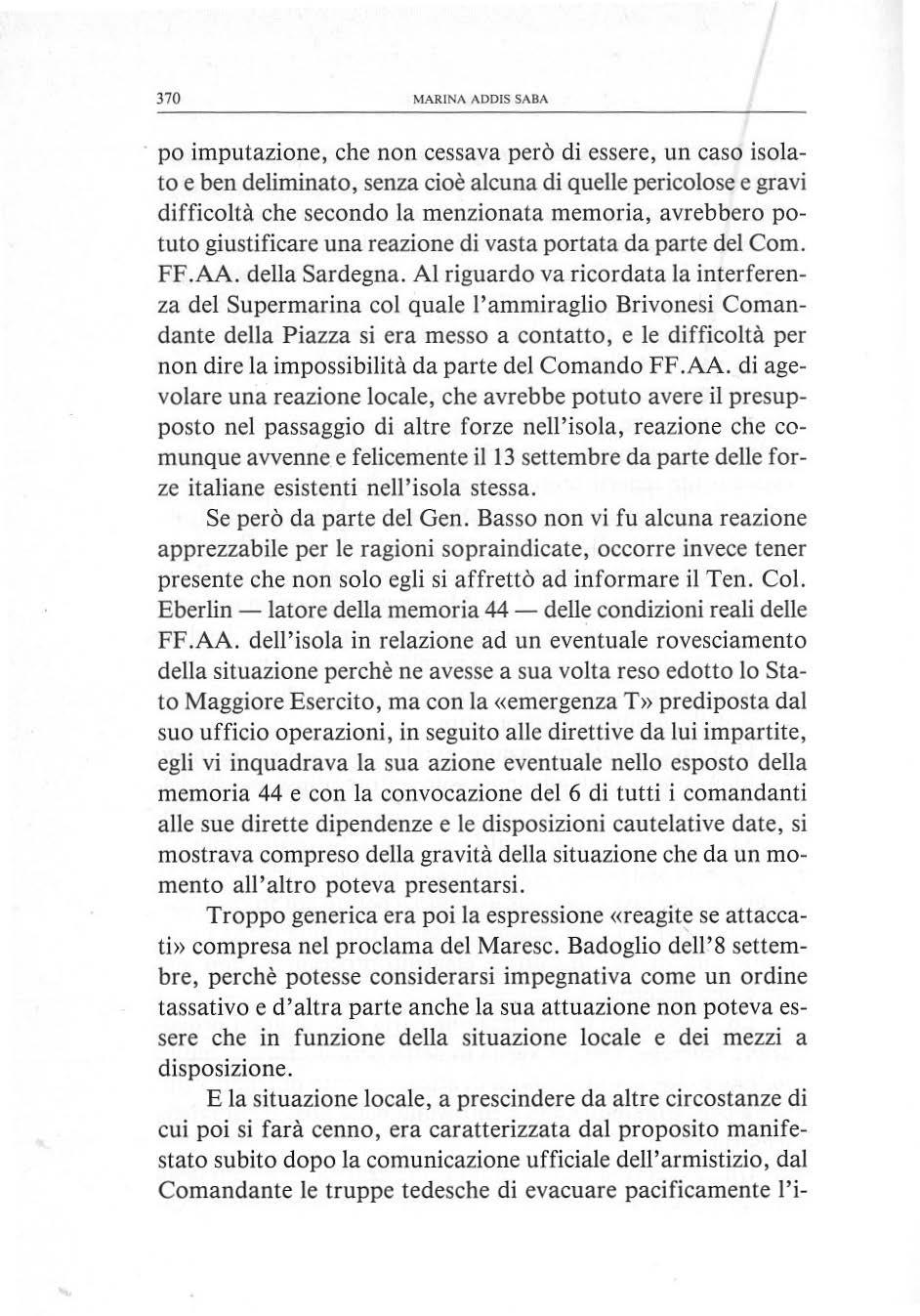
sola, e dall'adesione data al riguardo del Comando delle FF.AA. italiane, salvo diverso avviso del Comando Supremo, che come in narrativa si è ricordato, sebbene informato prontamente, nulla fece sapere, per quanto dall'appunto trovato in uno degli archivi del Ministero della Guerra, si possa ritenere che consenso vi sia stato anche da parte del Comando Supremo.
Prima pertanto della ricezione degli ordini 5 V e 21 V può sicuramente affermarsi che l'azione del Gen. Basso, non solo non può integrare gli estremi del reato ascrittogli nè quelli di altro reato, ma che essa non è suscettibile neppure di censura.
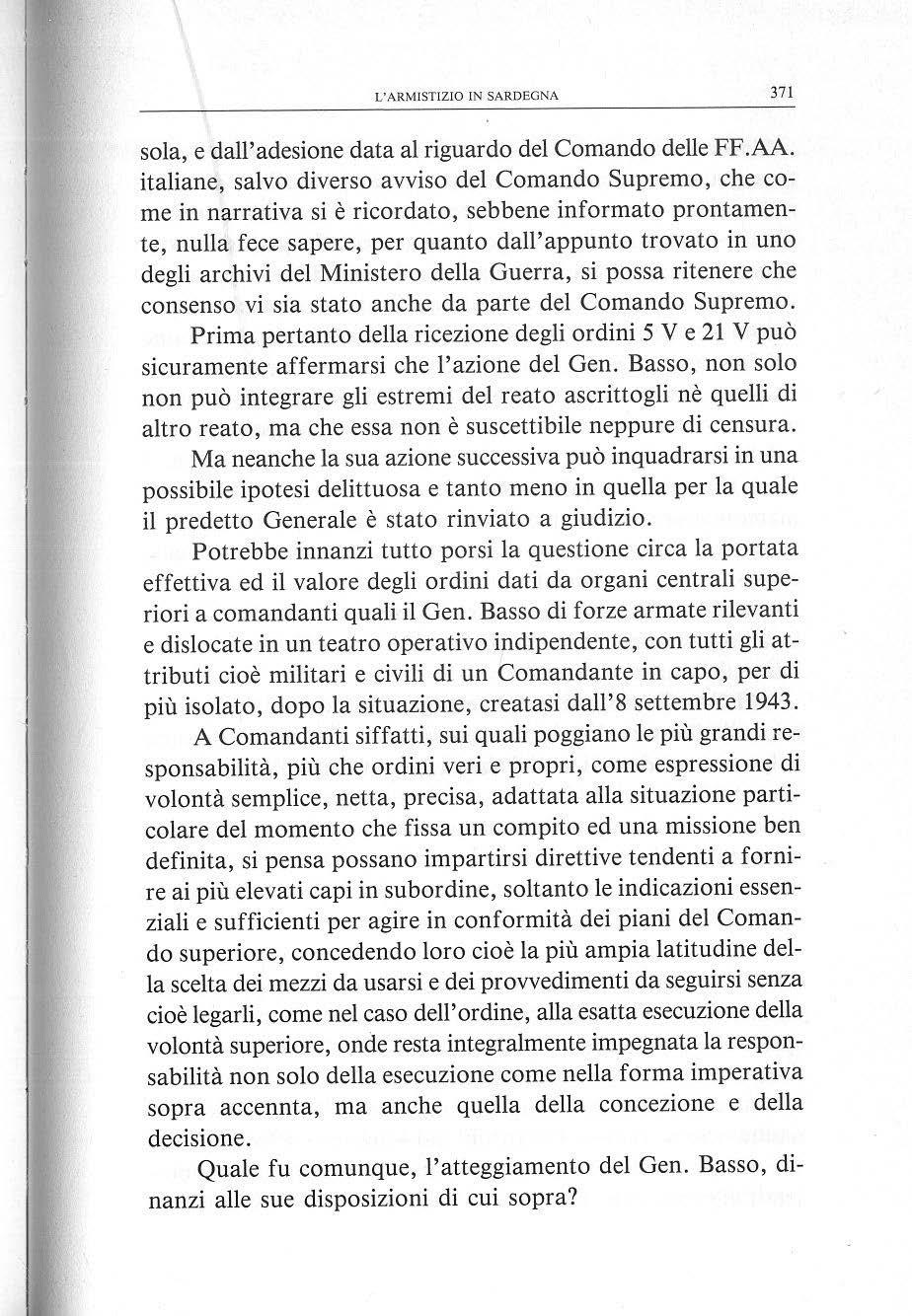
Ma neanche la sua azione successiva può inquadrarsi in una possibile ipotesi delittuosa e tanto meno in quella per la quale il predetto Generale è stato rinviato a giudizio.
Potrebbe innanzi tutto porsi la questione circa la portata effettiva ed il valore degli ordini dati da organi centrali superiori a comandanti quali il Gen. Basso di forze armate rilevanti e dislocate in un teatro operativo indipendente, con tutti gli attributi cioè militari e civili di un Comandante in capo, per di più isolato, dopo la situazione, creatasi da11'8 settembre 1943.
A Comandanti siffatti, sui quali poggiano le più grandi responsabilità, più che ordini veri e propri, come espressione di volontà semplice, netta, precisa, adattata alla situazione particolare del momento che fissa un compito ed una missione ben definita, si pensa possano impartirsi direttive tendenti a fornire ai più elevati capi in subordine, soltanto le indicazioni essenziali e sufficienti per agire in conformità dei piani del Comando superiore, concedendo loro cioè la più ampia latitudine della scelta dei mezzi da usarsi e dei provvedimenti da seguirsi senza cioè legarli, come nel caso dell'ordine, alla esatta esecuzione della volontà superiore, onde resta integralmente impegnata la responsabilità non solo della esecuzione come nella forma imperativa sopra accennta, ma anche quella della concezione e della decisione.
Quale fu comunque, l'atteggiamento del Gen. Basso, dinanzi alle sue disposizioni di cui sopra?
Non v'ha dubbio che, quanto meno in primo tempo, esso fu negativo, se non altro parzialmente, come si rileva dalle direttive impartite ai Comandi dipendenti il 12 sette mbre '43 (ordine op. 13200 all. 29 già riportato) secondo le quali si insisteva nel concetto di consen tire ancora l'esodo delle truppe tedesch e Via Palau-S. Teresa di Gallura, pur dando si precise disposizioni perchè se ne sorvegliasse continuamente la esecuzione e si fosse in ogni momento in condizioni di procedere ad immediata azione offensiva contro elementi che comunque avessero attuato un contegno provocatorio o avessero fatto uso delle armi e della forza. D 'altra parte, giusta i rilievi fatti in narrativa, il Gen. Basso, anche prima che fossero captati l' 11 settembre i marconigrammi incompleti da Marina Cagliari, andava modificando il suo originario orientamento, come risulta sia dalle disposizioni precauzionali impartite in quel periodo, sia dal suo t rasferim ento in Sassari, presso il C.do del XXX C. d' A., in località più vicin a cioè a quella in cui si stava effett uan do l'imbarco delle truppe tedesche.
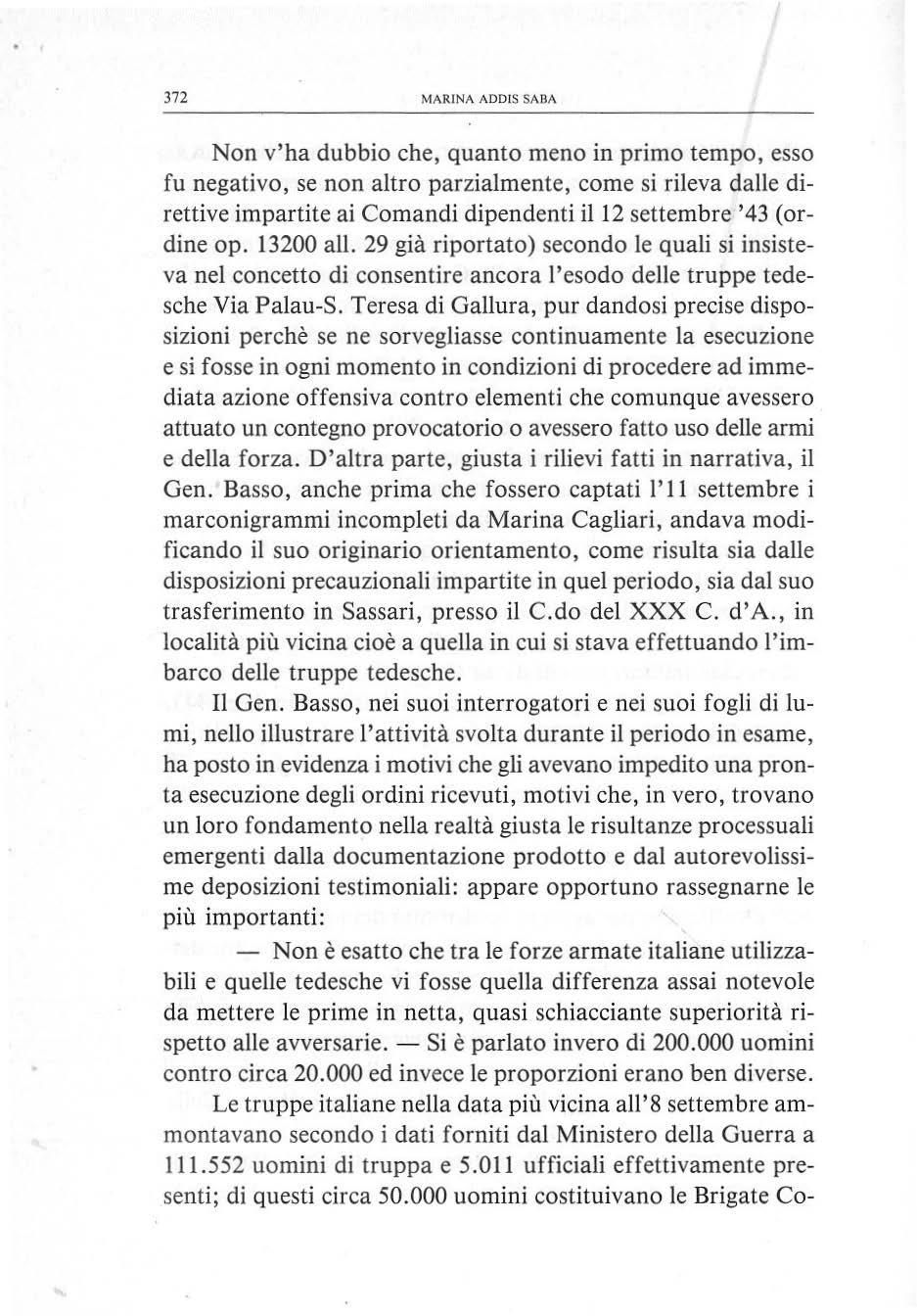
Il Gen. Basso , nei suoi interrogatori e nei s uoi fogli di lumi, nello illustrare l'a ttività svo lta durante il periodo in esame , ha posto in evidenza i motivi che gli avevano impedito una pronta esecu zione degli ordini ricevuti, motivi che, in vero, trovano un loro fondamento nella realtà giu sta le ri su ltanze processuali e merge nti dalla documentazione prodotto e dal autorevolissime depo sizioni test imoniali: appare opportuno rassegnarne le più importanti:
- Non è esatt o c he tra le forze armate italiane utilizzabili e quelle tedesche vi fosse quella differenza assai notevole da mettere le prim e in netta , quasi sc hiacciante s uperiorità rispetto alle avversarie. - Si è par lato in vero di 200. 000 uomini contro circa 20.000 ed in vece le proporzioni erano ben diverse .
Le trup pe italiane nella data più vicina all'8 se ttembre ammontavano secondo i dati forniti dal Ministero della Guerra a 111.552 uomini di truppa e 5.0 11 ufficiali effettivamente present i; di questi circa 50.000 uomini cost ituivano le Brigate Co-
stiere scaglionate in piccoli repar t i lungo la estesa costa dell'isola, fronte a mare: la loro composizione, inoltre, il loro scarso armamento e deficiente equipaggiamento rendevano assolutamente impossibile che fossero impiegate in veloci e continuate azioni di movimento fronte a terra.
Parecchia mig liaia di uomini erano impiegati negli svariati servizio, dimodochè si può calcolare a circa 45.000 la forza delle divisioni mobili utilizzabili (la Bari - la Calabria - la Sabauda), della divisione paracadutisti Nembo, del Raggruppamento motocorazzato Scalabrino.
Dette forze dovevano però considerarsi ulteriormente ridotte dalla defezione di una parte della divisione Nembo, forte di circa 9000 uomini, che aveva fatto causa comunque con i tedeschi.
Vi erano inoltre le legioni della M. V .S.N . ed i militi della Milmart sui quali non poteva eventualmente più farsi affidamento.
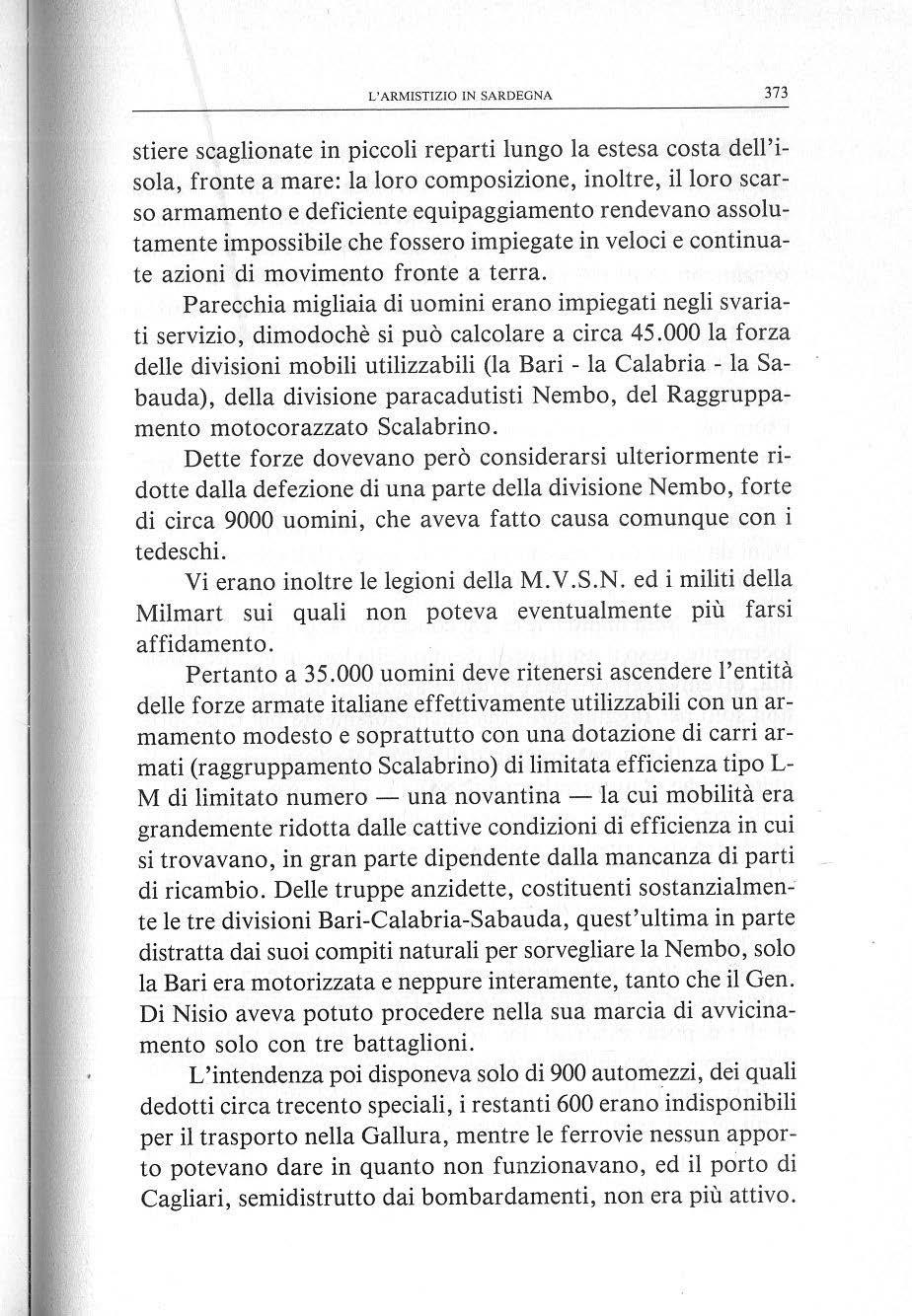
Pertanto a 35.000 uomini deve ritenersi ascendere l'entità delle forze armate italiane effettivamente utilizzabili con un armamento modesto e soprattutto con una dotazione di carri armati (raggruppamento Scalabrino) di limitata efficienza tipo LM di limitato numero - una novantina - la cui mobilità era grandemente ridotta dalle cattive condizioni di efficienza in cui si trovavano, in gran parte dipendente dalla mancanza di parti di ricambio. Delle truppe anzidette, costituenti sostanzialmen-· te le tre divisioni Bari-Calabria-Sabauda, quest'ultima in parte distratta dai suoi compiti naturali per sorvegliare la Nembo, solo la Bari era motorizzata e neppure interamente, tanto che il Gen. Di Nisio aveva potuto procedere nella sua marcia di avvicinamento solo con tre battaglioni.
L'intendenza poi disponeva solo di 900 autom~zzi, dei quali dedotti circa tr ecento speciali, i restanti 600 erano indisponibili per il trasporto nella Gallura, mentre le ferro vie nessun apporto potevano dare in quanto non funzionavano, ed il porto di Cagliari, semidistrutto dai bombardamenti, non era più attivo.
Di fronte invece si trovava una divisione corazzata tedesca rinforzata da una brigata da fortezza su 5 battaglioni ed altri minori reparti, fornita di potenti armi moderne automatiche e dotata di un gran numero di carr i armati che, dati gli accorgimenti usati dai germanici non è stato possibile precisare ma c he doveva oscillare tra i 200 ed i 300, di cui una trentina tipo Tigre e gli altri tutti di 20 tonn ellate con a bordo un cannoncino . Si trattava pertanto di un complesso or ganis mo militare armonico, potentemente armato e molto mobile, che con i suoi ventimila uomini circa rendeva ben ardua l'impresa che contro di esso avrebbe dovuto tentare il Gen . Basso. Ciò in specie a partire dal 12 settembre, dalla ricezione cioè dell'ordine 5 V, in quanto dal 9, come si è rilevato, erano iniziate le operazioni da parte dei tedeschi per il loro esodo dalla Sardeg na , sino allora non contrastato per le ragioni sopraindicate.
- Man mano che essi si concentravano e volgevano velocemente verso il nord, profittando della loro maggiore mobilità, diveniva sempre più difficile l'azione delle truppe italiane, non solo per raggiungerli, ma anche solamente per tallo narli .
- Il concentramento dell'80% dei rifornimenti sia alimentari che di munizionamento nella Gallura, e per la sua difficile configurazione orografica, la sua posizione a nord-est dell'iso la era stata predisposta inizialmente come ultimo baluardo difensivo nella eventualità della riuscita di uno sbarco delle truppe anglo-americane e del loro dilagare nella zona pianeggiante. Per questa rag ione il raggruppamento corazzato Scalabrino era colà dislocato con un reg gimento tedesco. Donde la necessità fatta presente nelle sue discolpe dal Gen. Basso, che i magazzini ed i depo sit i esistenti non fossero esposti a gravi danni e a di struzioni e che quindi la battaglia dovesse eventualmente accedersi oltre la linea principale del Tempio-Monti-Olbia lungo la quale essi erano prevalentemente sistemati.
- La situazione morale: da una parte le truppe tedesche, bene equipaggiate e meglio armate, dotate di un forte e
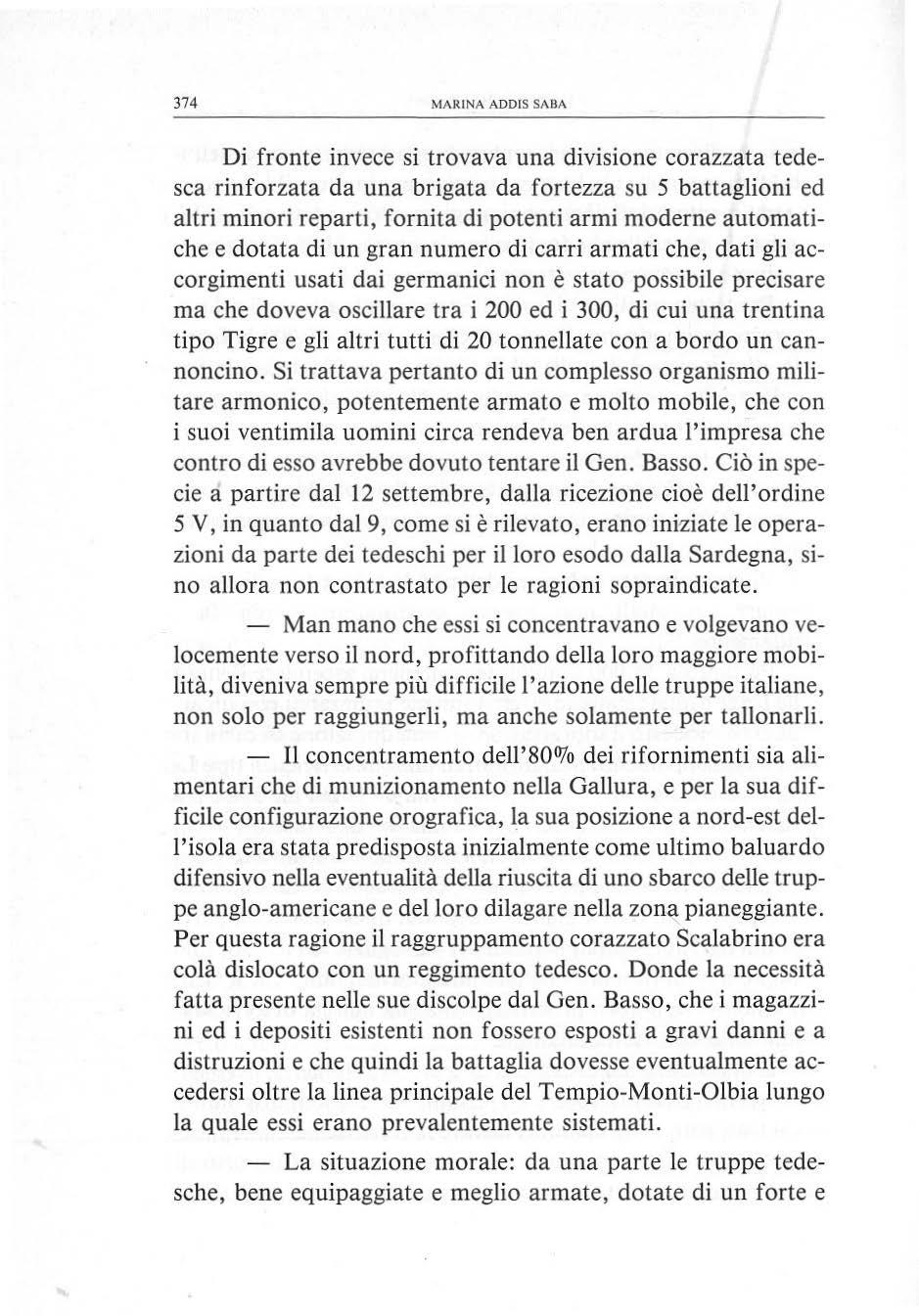
tradizionale spirito bellico, già preparate all'armistizio, dall'altra le truppe italiane male equipaggiate e peggio armate, costrette da un momento all'altro a cambiare di fronte di guerra e a considerare nemico l'alleato del giorno precedente, col quale a quanto emerge dalle concordi dichiarazioni dei testi, avevano generalmente vincoli di cameratismo.
Una espressione di questo stato d'animo aveva avuto la sua manifestazione nella defezione di alcuni reparti della Nembo, il che non aveva non potuto scuotere nel Gen. Basso la fiducia nella saldezza delle truppe tutte alle sue dipendenze, sì da renderlo molto cauto, per non dire titubante , nel loro impiego in una decisa azione offensiva.
La preoccupazione del Gen. Basso, che negli ultimi tempi rivestiva anche l'ufficio di Commissario civile della Sardegna, di risparmiare per quanto possibile all'isola ed ai.suoi abitanti, già così provati dai bombardamenti aerei e dalla interruzione delle comunicazioni col continente, che rendeva sempre più difficile provvedere all'alimentazione anche dei civili, tutti i gravi danni che sarebbero derivati alle persone ed alle cose da una guerra combattuta nell'isola, guerra che da parte dei ted eschi sarebbe stata indubbiamente condotta senza pietà.
La difficoltà della situazione era stata d'altra parte resa nota dal Gen. Basso ai Comandi superiori, anche precedentemente alla ricezione dei due ordini 5 V e 21 V, sia con le comunicazioni di cui in narrativa, sia con la lettera diretta in data 13 sett. 943 dal suo Capo di St. Magg. Col. Bruno Attilio (all. 32 - vol. II) al Generale Utili dello St. Magg. R.E. nella quale si spiegavano in modo abbastanza particolareggiato le ragioni dell'atteggiamento temporeggiatore del Comando FF.AA. di Sardegna, si precisava che l'esodo delle truppe tedesche dall'isola era considerata da esso Gen. Basso, una soluzione utile, perchè tra l ' altro, consentiva di fare dell'isola stessa, libera ed in mano alle nos t re truppe, una base sicura militare e politica per tutto il continente.
Lo stesso comportamento tenuto dal Gen. Basso in occasione del convegno che ebbe a Tempio col Gen. Lungerhausen

il 14 sett. 1943 e nel quale il primo continuò a manifestare il proposito di non ostacolare il proseguimento dell'esodo delle truppe tedesche dalla Sardegna e le stesse disposizioni date in conformità al Comando della pizza di Maddalena, possono essere considerate come una consegue nza della nece ssità di prender tempo, nella quale il Gen. Basso si era trovato, onde è da ritenere pienamente attendibile il suo assunto che la conferma degli accordi in tervenuti 1'8 sett. 943 era stata da lui data con una interiore riserva mentale, ta le ci oè da trarre profitto dalla prima occasione per palesare il suo vero proposito e passare ad azioni apertamento offensive, così come avvenuto dopo la distruzio ne degli aeroplani nell'aeroporto di Vena Fiorita operata dai tedeschi il 15 settembre .
Dopo il 15 infatti, le disposizioni impartite dal Gen. Basso erano in piena conformità con gli ordini 5 V e 21 V, sia perchè l'episodio di cui innanzi, che violava gli accordi intervenuti col Com.te tedesco, costituiva per esso Gen. Basso il miglior pretesto per un palese mutamento di condotta, sia perchè la zona logistica era stata lasciata dalle truppe tedesche, mentre quelle italiane avevano potuto avere in certo qual modo il tempo di attuare i movimenti e gli spostamenti previsti per quella che, secondo le sue intenzioni, doveva essere l'ultima fase dell'azione predisposta. Basterà al riguardo ricordare gli ordini decisi di attacco impartiti sia al Comando della piazza di Maddalena (all. 43) sia al C.do Aviazione (all. 44) sia al C.do XXX C. d' Arm. (all. 52, 53, 54) nonchè quelli di considerare i tede schi come nemici e di catturarli ovunque possibile (all. 48) in cui in narrativa si è fatto già cenno.
Rimarrebbe quindi solo, come .elemento apprezzabile ai fini della sussistenza della responsabilità penale del Gen. Basso, la sua condotta nel periodo 12-15 settembre, nel quale egli non eseguì le disposizioni di cui ai due ordini più volte menzionati.
Sostanzialmente una valutazione che escludeva una simile responsabilità, era già fatta dal Gen. Berardi e dal Maresc. Messe, allorchè concludevano le relazioni compilate a segu ito delle
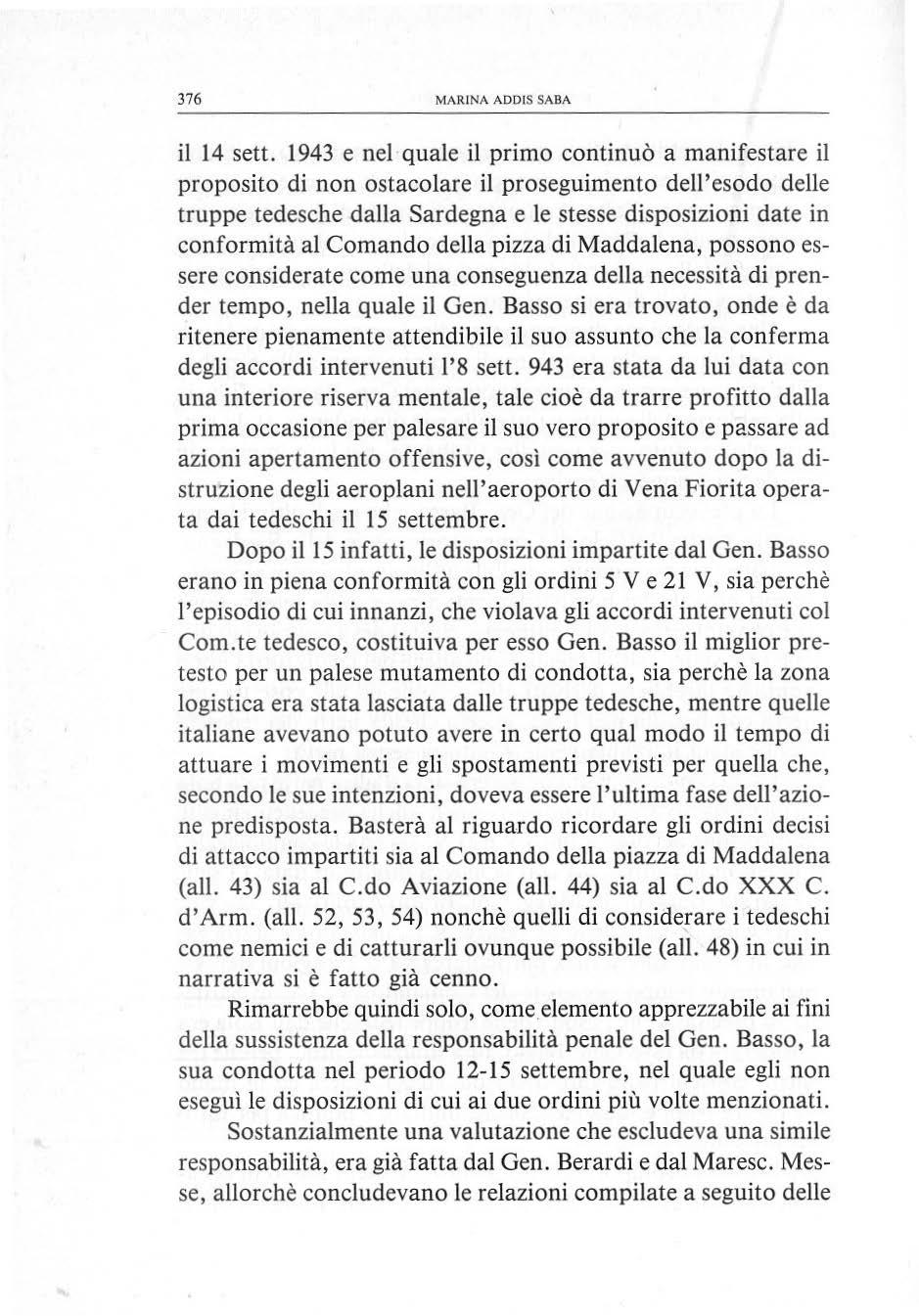
richieste superiormente disposte, col ritenere a carico del Gen. Basso solo una responsabilità disciplinare. Nè possono trascurarsi gli elogi che il Gen. Basso ebbe dal Maresc. Badoglio e dai Gen. Ambrosio e Roatta alla evacuazione della Sardegna, nonchè il fatto che il Gen. Basso dopo aver avuto per breve tempo anche il Comando delle Truppe italiane in Corsica, fu chiamato al C.do del C. d' A. della Campania, alla costituzione cioè di quei reparti i quali dovevano formare il nucleo dell ' esercito che combattè poi così valorosamente a fianco degli eserciti anglo americani.
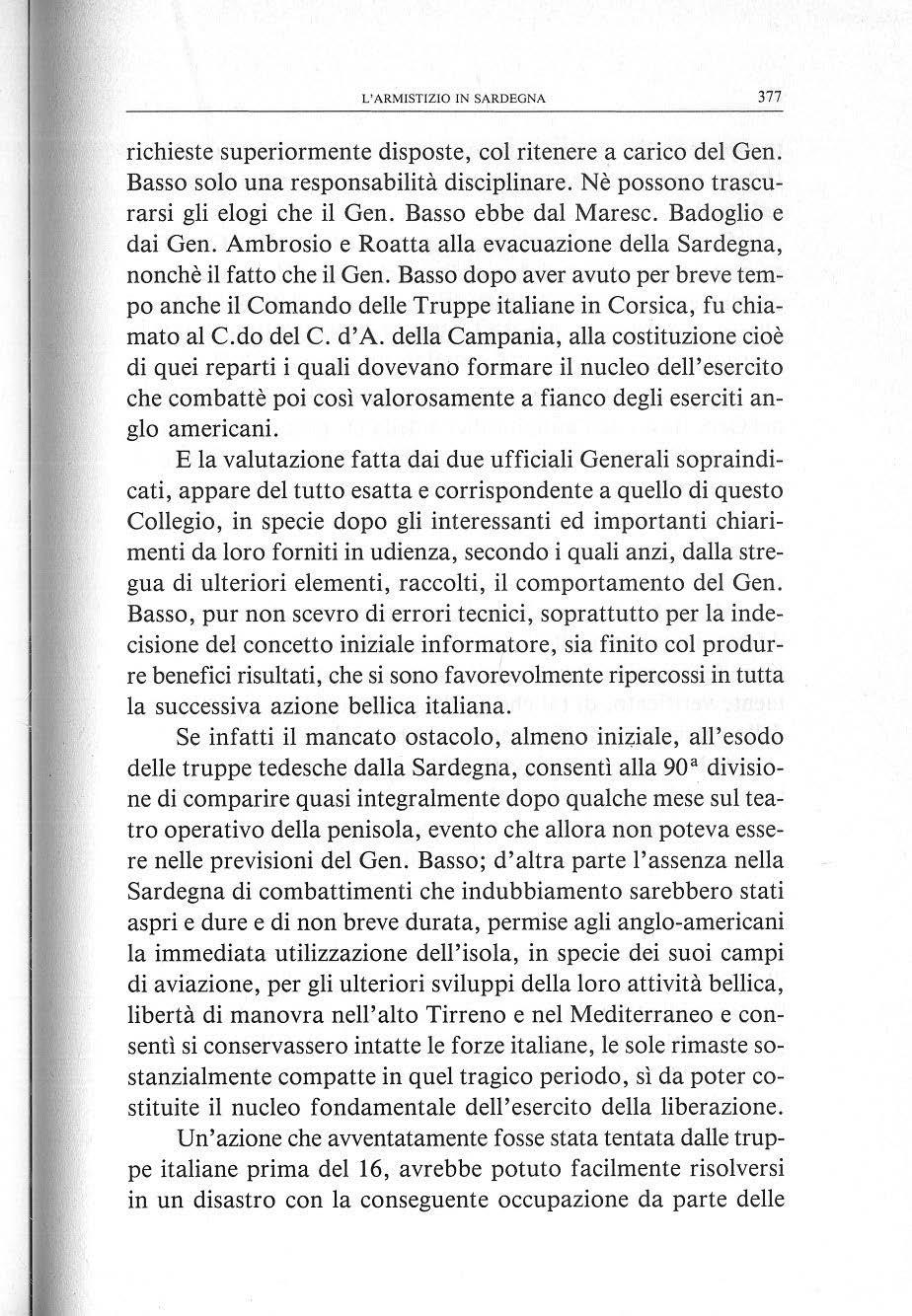
E la valutazione fatta dai due ufficiali Generali sopraindicati, appare del tutto esatta e corrispondente a quello di questo Collegio, in specie dopo gli interessanti ed importanti chiarimenti da loro forniti in udienza, secondo i quali anzi, dalla stregua di ulteriori elementi, raccolti, il comportamento del Gen . Basso, pur non scevro di errori tecnici, soprattutto per la indecisione del concetto iniziale informatore, sia finito col produrre benefici risultati, che si sono favorevolmente ripercossi in tutta la successiva azione bellica italiana.
Se infatti il mancato ostacolo, almeno ini¼iale, all'esodo delle truppe tedesche dalla Sardegna, consentì alla 90a divisione di comparire quasi integralmente dopo qualche mese sul teatro operativo della pen iso la, evento che allora non poteva essere nelle previsioni del Gen. Basso; d'altra parte l'assenza nella Sardegna di combattimenti che indubbiamento sarebbero stati aspri e dure e di non breve durata, permise agli anglo -americani la immediata utilizz a zione dell'isola, in specie dei suoi campi di aviazione, per gli ulteriori sv iluppi della loro attività bellica, libertà di manovra nell'alto Tirreno e nel Mediterraneo e consentì si conservassero intatte le forze italiane, le sole rimaste sostanzialmente compatte in quel tragico periodo, sì da poter costituite il nucleo fondamentale dell'esercito della liberazione.
Un'azione che avventatamente fosse stata tentata dalle truppe italiane prima del 16, avrebbe potuto facilmente risolversi in un disastro con la conseguente occupazione da parte delle
truppe tedesche, sia pure temporaneamente, dell'isola con tutte le prevedibili gravi conseguenze nell'economia della guerra nel settore italiano.
Sussistevano pertanto motivi giustificati perchè il Gen. Basso non ottemperasse ai due ordini e che essendo venuto meno un elemento non accidentale ma costitutivo del delitto di cui all'art. 100 c.p.m.g., il fatto attribuito al predetto generale non costituisce reato.
Eciò senza contare che la mancanza della consapevolezza nel Gen. Basso dell'antigiuridicità della propria condotta, incidendo sull'elementi subbiettivo, avrebbe anche sotto questoriflesso eliminato la sussistenza del reato.
Da parte della difesa si è richiesto l'assoluzione del predetto Generale con altra formula e cioè perchè il fatto non sussiste.
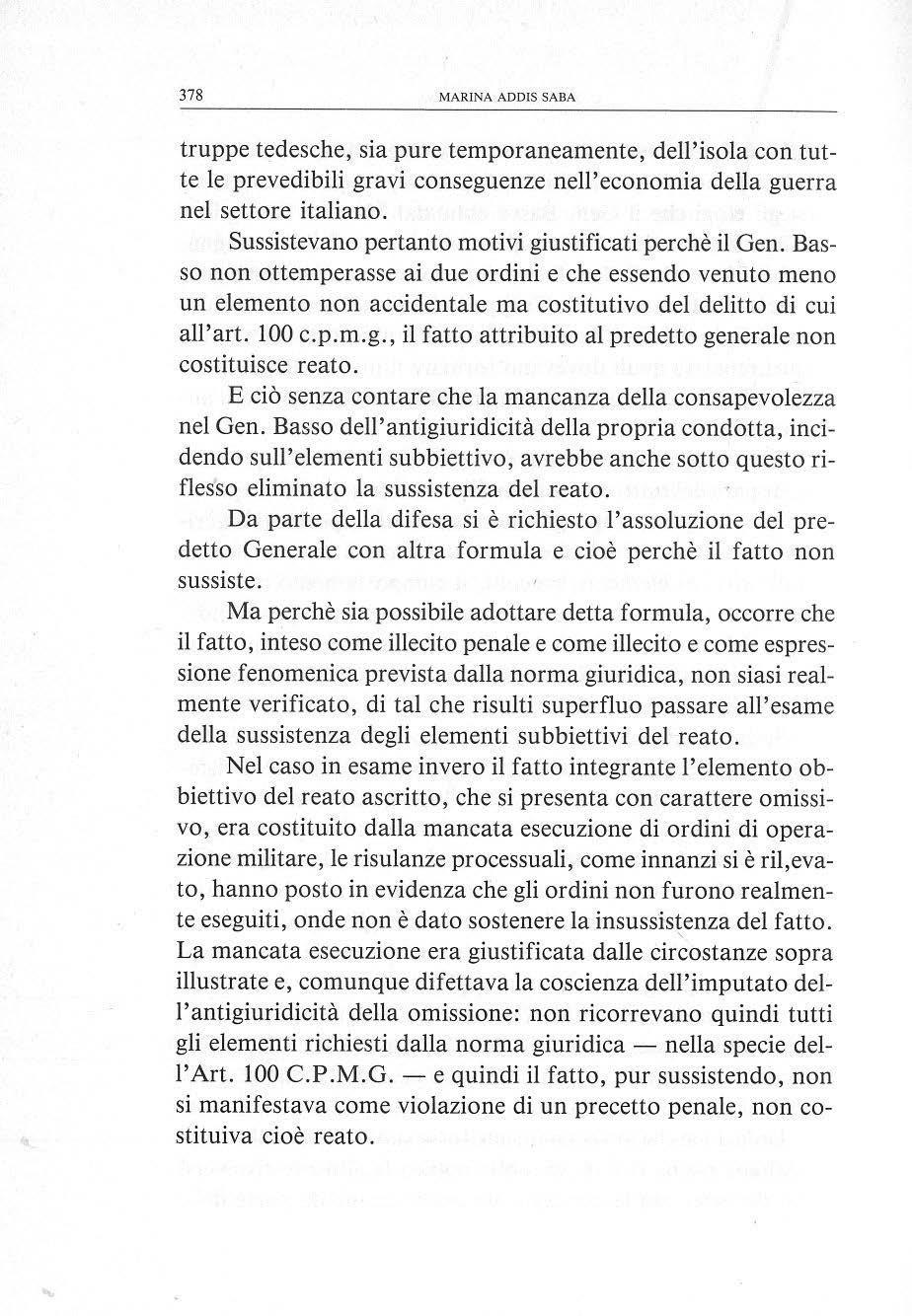
Ma perchè sia possibile adottare detta formula, occorre che il fatto, inteso come illecito penale e come illecito e come espressione fenomenica prevista dalla norma giuridica, non siasi realmente verificato, di tal che risulti superfluo passare all'esame della sussistenza degli elementi subbiettivi del reato.
Nel caso in esame invero il fatto integrante l'elemento obbiettivo del reato ascritto, che si presenta con carattere omissivo, era costituito dalla mancata esecuzione di ordini di operazione militare, le risulanze processuali, come innanzi si è ril,evato, hanno posto in evidenza che gli ordini non furono realmente eseguiti, onde non è dato sostenere la insussistenza del fatto.
' La mancata esecuzione era giustificata dalle circostanze sopra illustrate e, comunque difettava la coscienza dell'imputato dell'antigiuridicità della omissione: non ricorrevano quindi tutti gli elementi richiesti dalla norma giuridica - nella specie del1' Art. 100 C.P .M.G. - e quindi il fatto, pur sussistendo, non si rnanifestava come violazione di un precetto penale, non costituiva cioè reato.
· ASSOLVE
Basso Antonio e ...... dalle imputazioni specificate in epigrafe, per non costituire reati i fatti loro ascritti.
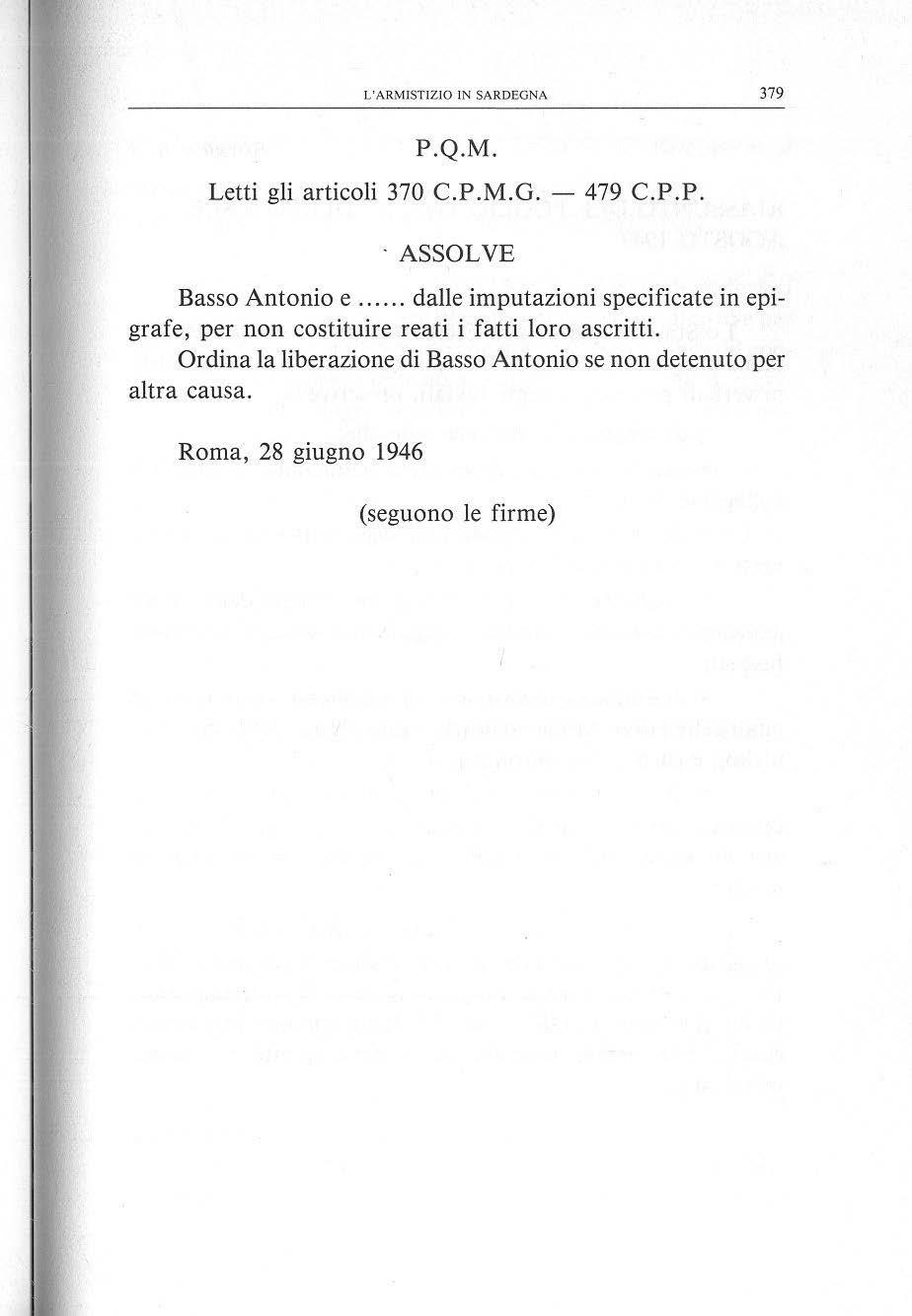
Ordina la liberazione di Basso Antonio se non detenuto per altra causa.
Roma, 28 giugno 1946
Lo Stato Maggiore dell'Esercito diramò nella prima settimana di agosto il foglio III C.T., in cui, a conferma degli ordii;ii verbali precedentemente inviati, prescriveva:
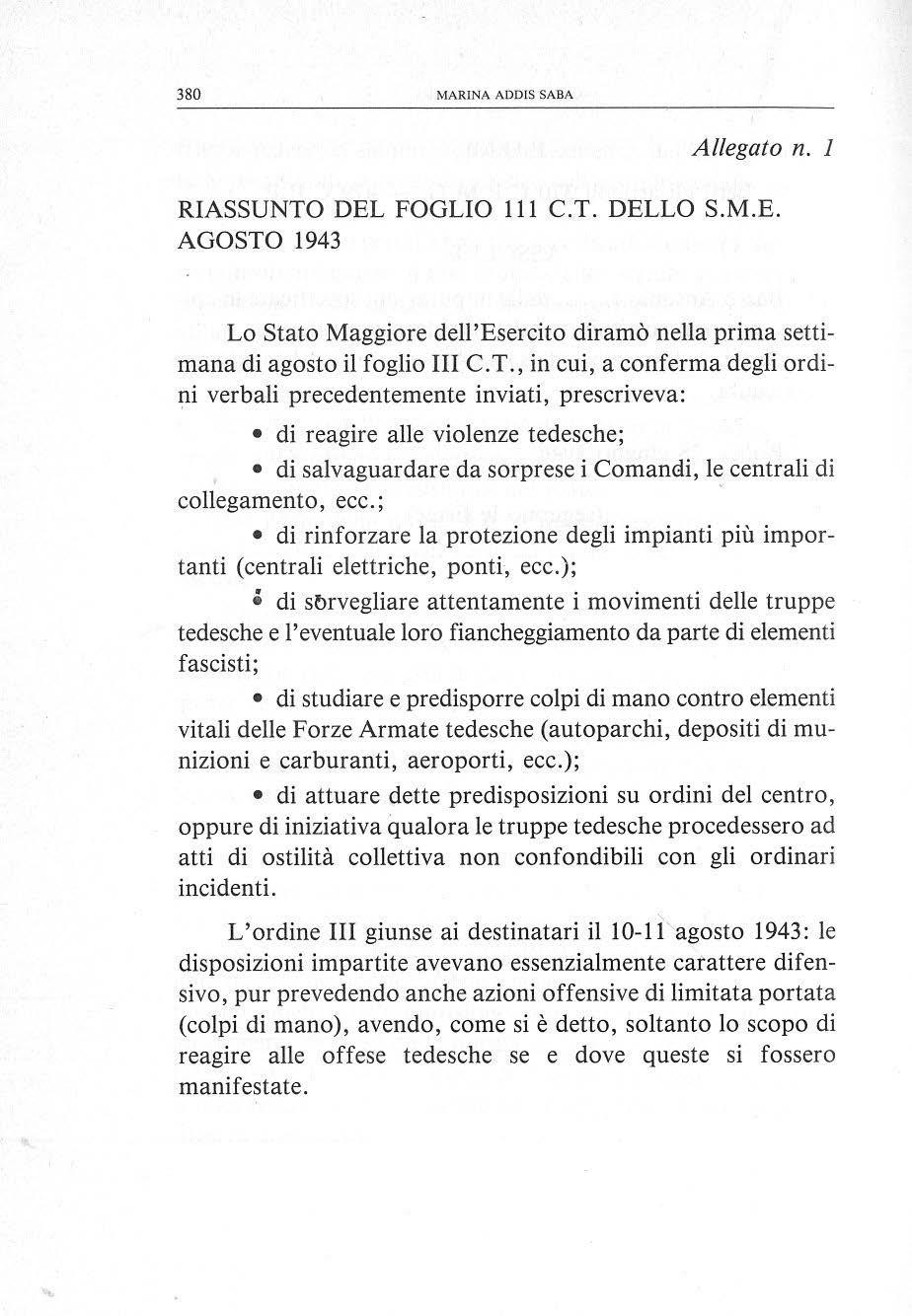
• di reagire alle violenze tedesche;
• di salvaguardare da sorprese i Comandi, le centrali d i collegamento, ecc.;
• di rinforzare la protezione degli impianti più impo rt anti (cen t rali elettriche, ponti , ecc.);
• di sorvegliare attentamente i movimenti delle trupp e tedesche e l'eventuale loro fiancheggiamento da part e di elemen ti fascisti;
• di studiare e predisporre colpi di mano contro elemen ti vitali delle Forze Armate t edesche (autoparchi, depositi di munizioni e carburanti, aeroporti, ecc.);
• di attuare dette predisposizioni su ordini del centro , oppure di iniziativa qualora le truppe tedesche procedessero a d atti di ostilità collettiva non confondibili con gli ordinar i incidenti.
L'ordine III giunse ai destinatari il 10-11 agosto 1943: le disposizioni impartite avevano essenzialmente carattere difensivo, pur prevedendo anche azioni offensive di limitata portata (colpi di mano), avendo, come si è detto, soltanto lo scopo di reagire alle offes e tedesche se e dove queste si fosse ro manifestate.
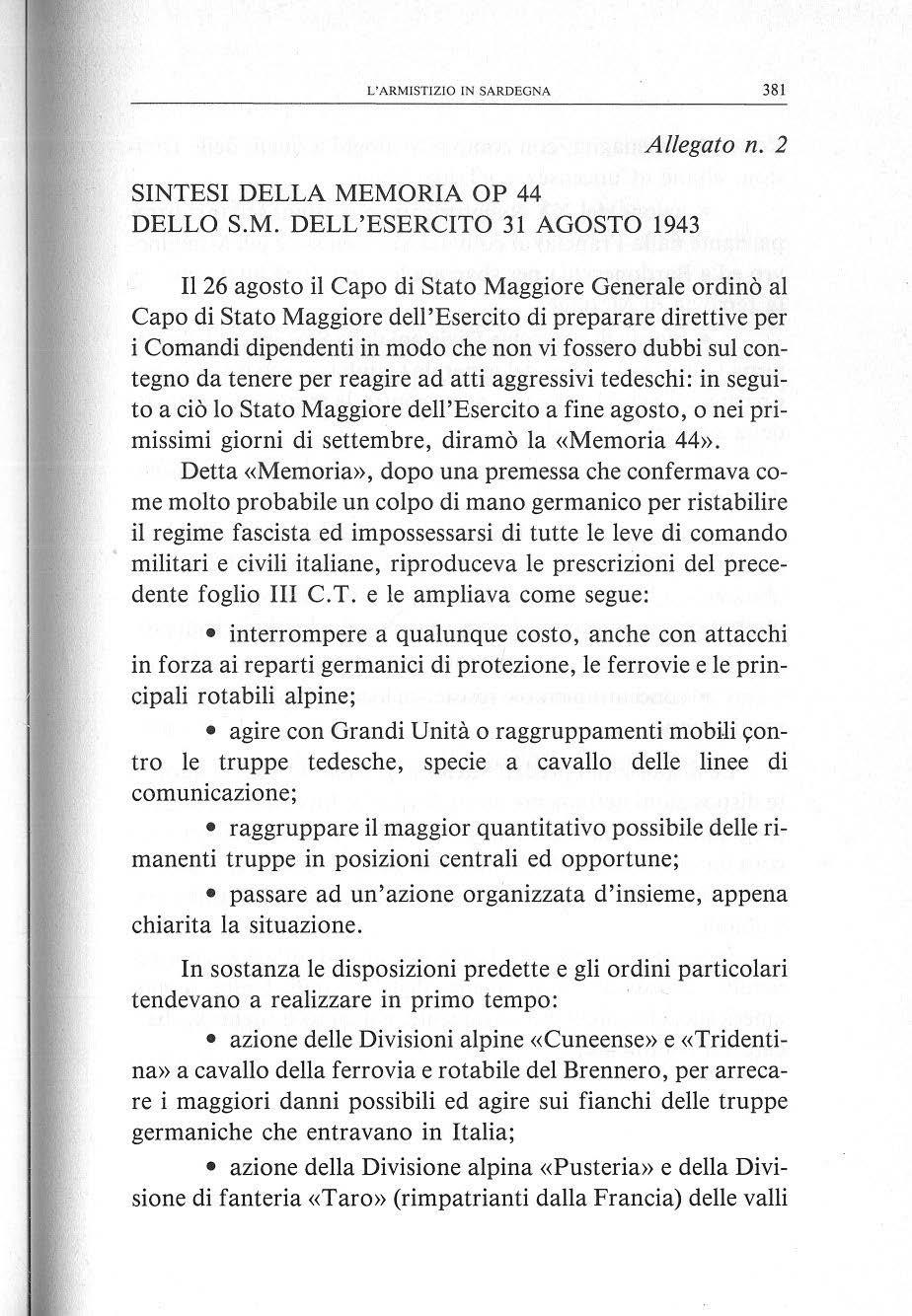
Il 26 agosto il Capo di Stato Maggiore Generale ordinò al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito di preparare direttive per i Comandi dipendenti in modo che non vi fossero dubbi sul contegno da tenere per reagire ad atti aggressivi tedeschi: in seguito a ciò lo Stato Maggiore dell'Esercito a fine agosto, o nei primissimi giorni di settembre, diramò la «Memoria 44» .
Detta «Memoria», dopo una premessa che confermava come molto probabile un colpo di mano germanico per ristabilire il regime fascista ed impossessarsi di tutte le leve di comando militari e civili italiane, riproduceva le prescrizioni del precedente foglio III C.T. e le ampliava come segue:
• interrompere a qualunque costo, anche con attacchi in forza ai reparti germanici di protezione, le ferrovie e le principali rotabili alpine;
• agire con Grandi Unità o raggruppamenti mobili çontro le truppe tedesche, specie a cavallo delle linee di comunicazione;
• raggruppare il maggior quantitativo possibile delle rimanenti truppe in posizioni centrali ed opportune;
• passare ad un'azione organizzata d'insieme, appena chiarita la situazione.
In sostanza le disposizioni predette e gli ordini particolari tende vano a realizzare in primo tempo:
• azione delle Divisioni alpine «Cuneense» e «Tridentina» a cavallo della ferrovia e rotabile del Brennero, per arrecare i maggiori danni possibili ed agire sui fianchi delle truppe germaniche che entravano in Italia;
• azione della Divisione alpina «Pusteria» e della Divisione di fanteria «Taro» (rimpatrianti dalla Francia) delle valli
Roja e Vermenagna, con compiti analoghi a quelli delle Divisioni alpine «Cuneense» e «Tridentina»;
• azione del XX Raggruppamento alpini sciatori (rimpatriante dalla Francia) ai colli del Moncenisio e del Monginevro ed a Bardonecchia per sbarrare le rotabili ed interrompere la ferro via di Modane;
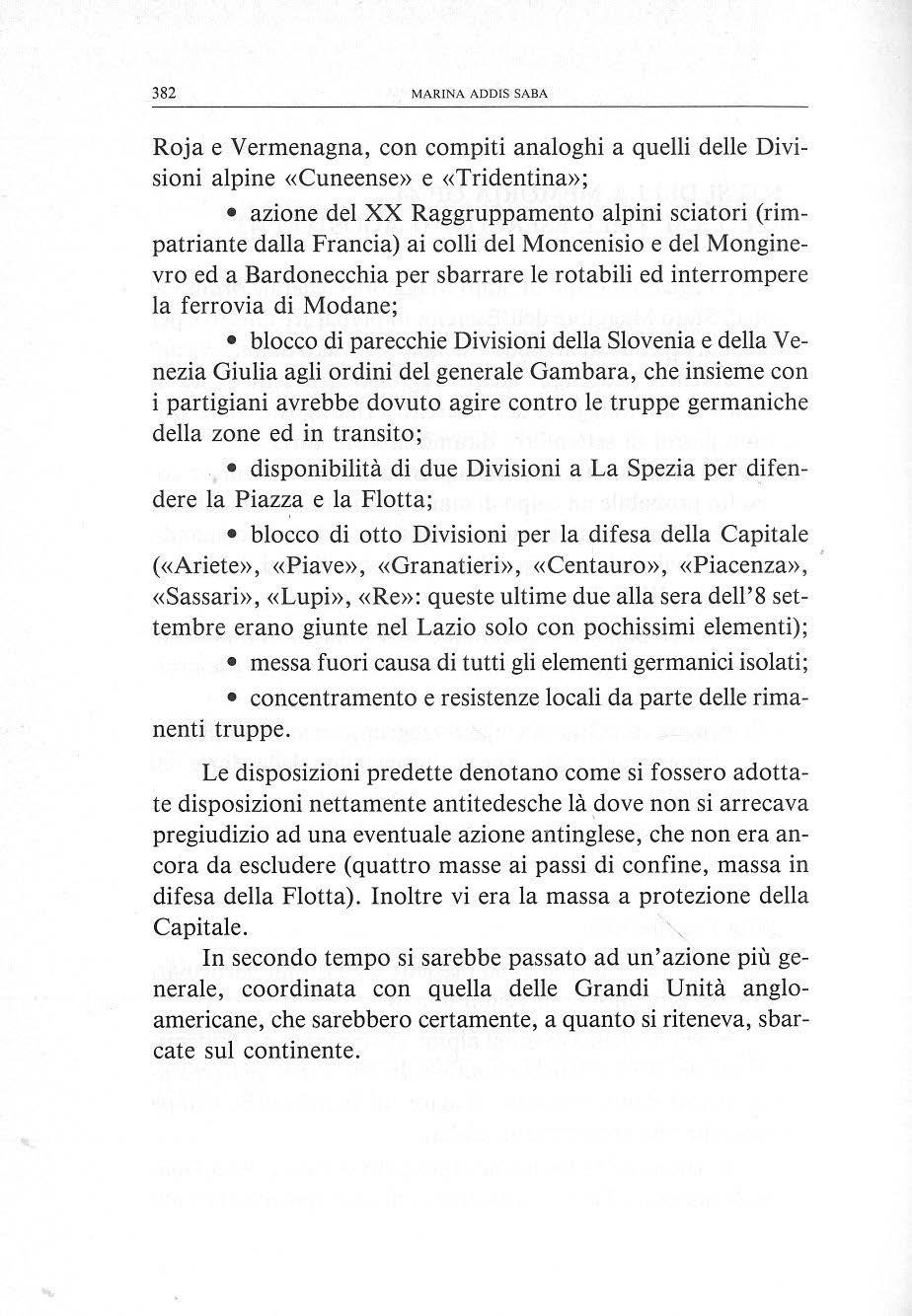
• blocco di parecchie Divisioni della Slovenia e della Venezia Giulia agli ordini del generale Gambara, che insieme con i partigiani avrebbe dovuto agire contro le truppe germaniche della zone ed in transito;
• disponibilità di due Divisioni a La Spezia per difendere la Piazza e la Flotta;
• blocco di otto Divisioni per la difesa della Capitale
(«Ariete», «Piave», <<Granatieri», «Centauro», «Piacenza», «Sassari», «Lupi», «Re»: queste ultime due alla sera dell'8 settembre erano giunte nel Lazio solo con pochissimi elementi);
• messa fuori causa di tutti gli elementi germanici isolati;
• concentramento e resistenze locali da parte delle rimanenti truppe.
Le disposizioni predette denotano come si fossero adottate disposizioni nettamente antitedesche là ,dove non si arrecava pregiudizio ad una eventuale azione antinglese, che non era ancora da escludere (quattro masse ai passi di confine, massa in difesa della Flotta). Inoltre vi era la massa a protezione della Capitale. ,
In secondo tempo si sarebbe passato ad un'azione più generale, coordinata con quella delle Grandi Unità angloamericane, che sarebbero certamente, a quanto si riteneva, sbarcate sul continente.
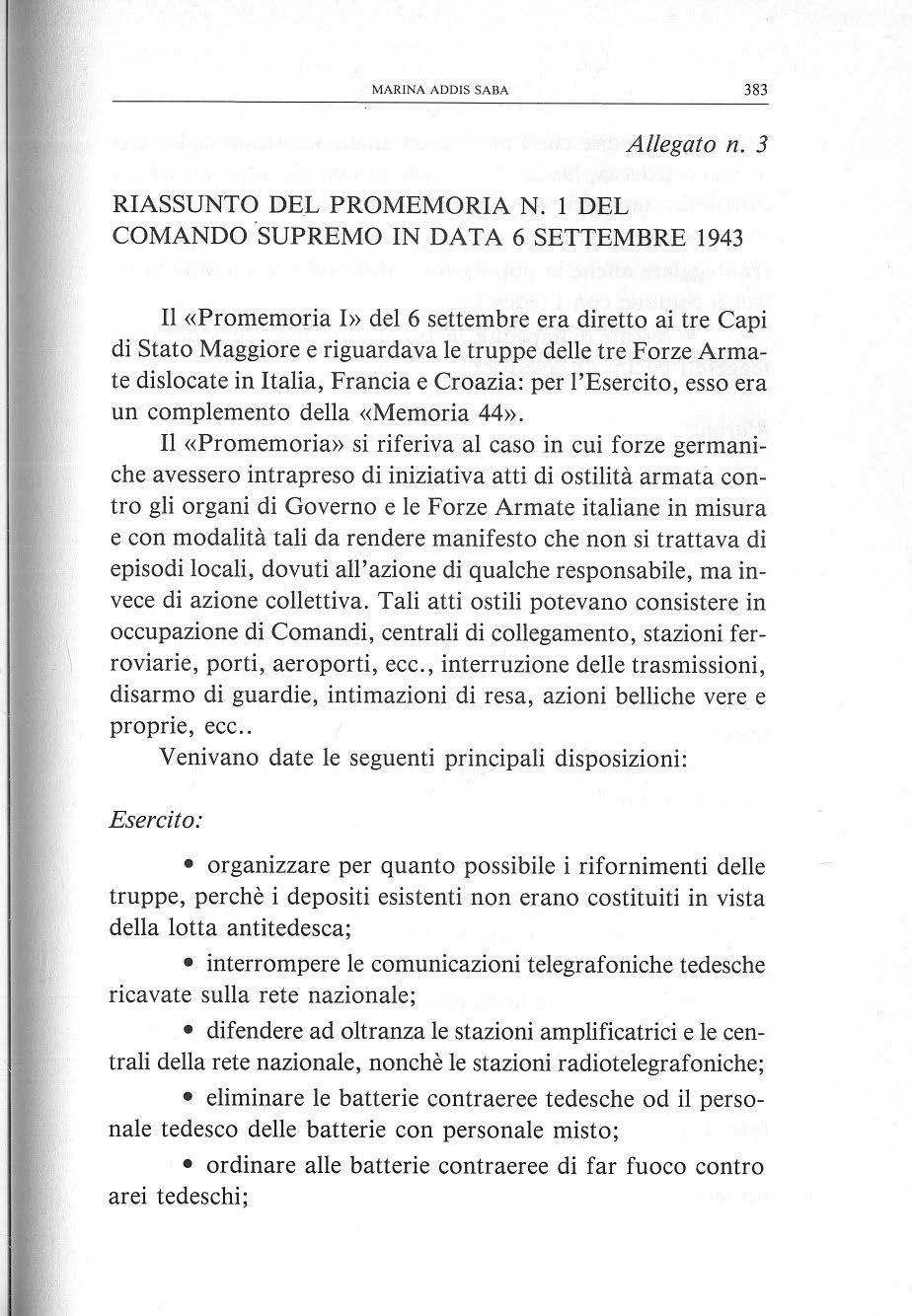
Il «Promemoria I» del 6 settembre era diretto ai tre Capi di Stato Maggiore e riguardava le truppe delle tre Forze Armate dislocate in Italia, Francia e Croazia: per l'Esercito, esso era un complemento della «Memoria 44».
Il «Promemoria» si riferiva al caso in cui forze germaniche avessero intrapreso di iniziativa atti di ostilità armata contro gli organi di Governo e le Forze Armate italiane in misura e con modalità tali da rendere manifesto che non si trattava di episodi locali, dovuti all'azione di qualche responsabile, ma invece di azione collettiva. Tali atti ostili potevano consistere in occupazione di Comandi, centrali di collegamento, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, ecc., interruzione delle trasmissioni, disarmo di guardie, intimazioni di resa, azioni belliche vere e proprie, ecc ..
Venivano date le seguenti principali disposizioni:
Esercito:
• organizzare per quanto possibile i rifornime nt i delle truppe, perchè i depositi esistenti non erano costituiti in vista della lotta antitedesca;
• inte r rompere le comunicazioni telegrafoniche tedesche ricavate sulla rete nazionale;
• difendere ad oltranza le stazioni amplificatrici e le centrali della rete nazionale, nonchè le stazioni radiotelegrafoniche;
• eliminare le batterie contraeree tedesche od il personale tedesco delle batterie con personale misto;
• ord inare alle b atter ie contraeree di far fuoco contro are i tedeschi ;
• impedire che i prigionieri anglo-americani cadessero in mano tedesca, lasciandoli anche in libertà, dopo aver loro distribuito un sufficiente quantitativo di viveri di riserva;
• tenere molto riuniti i reparti italiani in Alto Adige, per fronteggiare anche la popolazione allogena che avrebbe fatto causa comune con i tedeschi;
• cercare di impedire energicamen t e le distruzioni e proteggere i bacini idroelettrici.
Mar ina:
• catturare od affondare navi da guerra e mercantili tedesche;
• ordinare all e unità da guerra italiane di r aggiunger e i porti della Sardegna, della Corsica e dell ' Elba, oppu r e Sebenico e Cattaro;
• ordinare al naviglio mercantile italiano di raggiungere porti a sud della congiunzione Ancona-Li vorno;
• inutilizzare impianti logis t ici, arsenali, bacini di carenaggio, ecc.;
• mettere in istato di difesa le basi marittime, in accordo con l'Esercito.
Aeronautica:
• impadronirsi, in accordo con l'Esercito, degli aeropor ti totalmente tedeschi e misti, dando la precedenza a, quelli vicini a Roma;
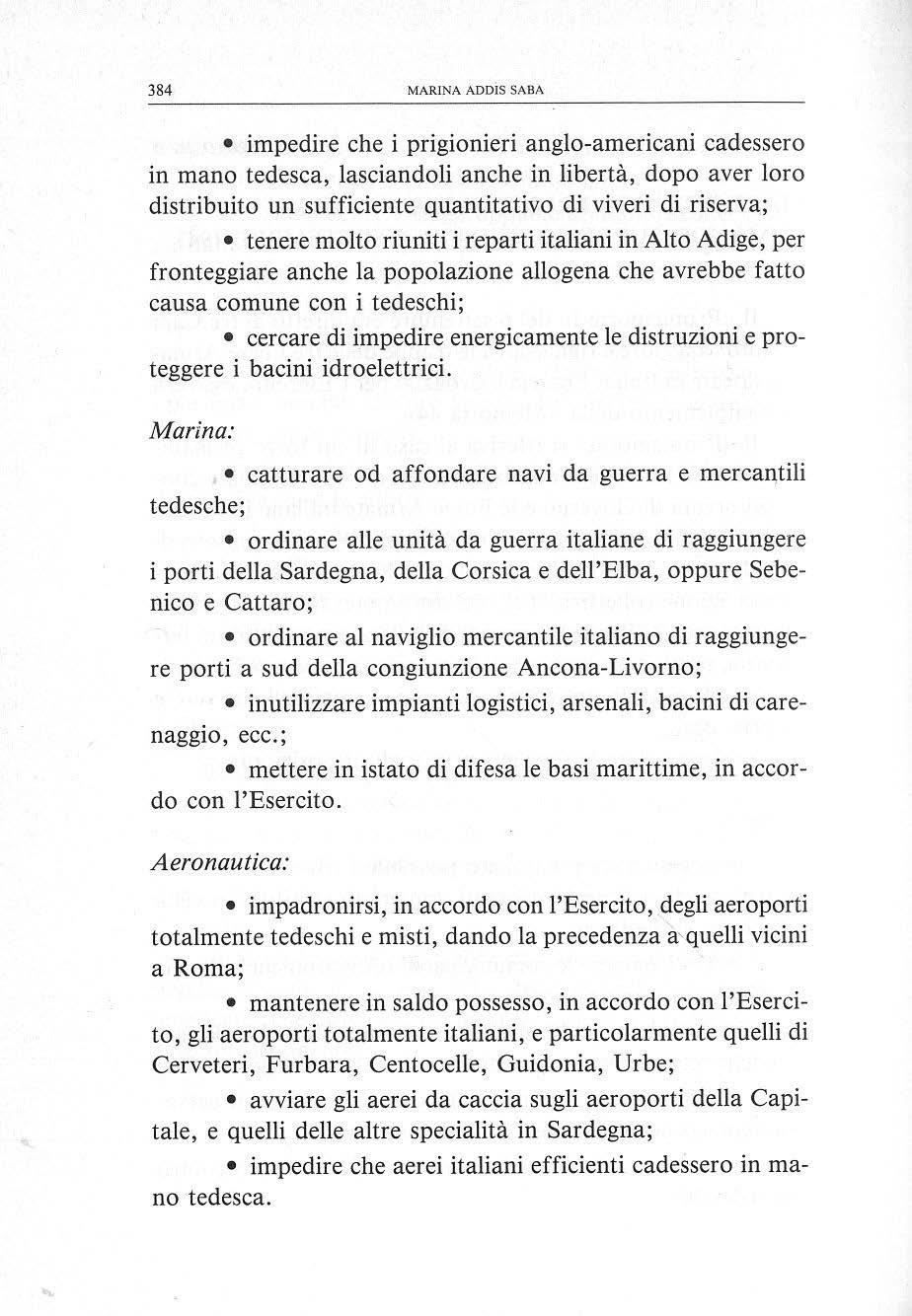
• mantenere in saldo possesso, in accordo con l'Esercito, gli aeroporti totalmente italiani, e particolarmente quelli di Cerveteri, Furbara, Centocelle, Guidonia, Urbe;
• avviare gli aerei da caccia sugli aeroporti della Capitale, e quelli delle altre specialità in Sardegna;
• impedire che aerei italiani efficienti cadessero in mano tedesca.
Gli ordini conseguent i al «Promemoria I» dovev ano esser e impartiti di urgenza e verbalmen t e ed avrebbero potuto essere attuati o per ordine dell'auto r ità cen t rale, o di iniziativa.
Il Promemoria considerava l ' aggressione tedesca indipendentemente dall'armistizio, po t endo detta aggressione avvenire in qualunque momento, e non fac eva cenno di un possibile armistizio così come non ne faceva cenno la «Memoria 44», di cui il Promemoria, per l'Esercito, era un complemento.
Era intenzione del Comando Supremo di far seguire un telegramma per estendere gli ordini del «Promemoria I» alla eventualità di un armistizio e per indicare il giorno 12 come limite massimo per avere t u tto a punto.
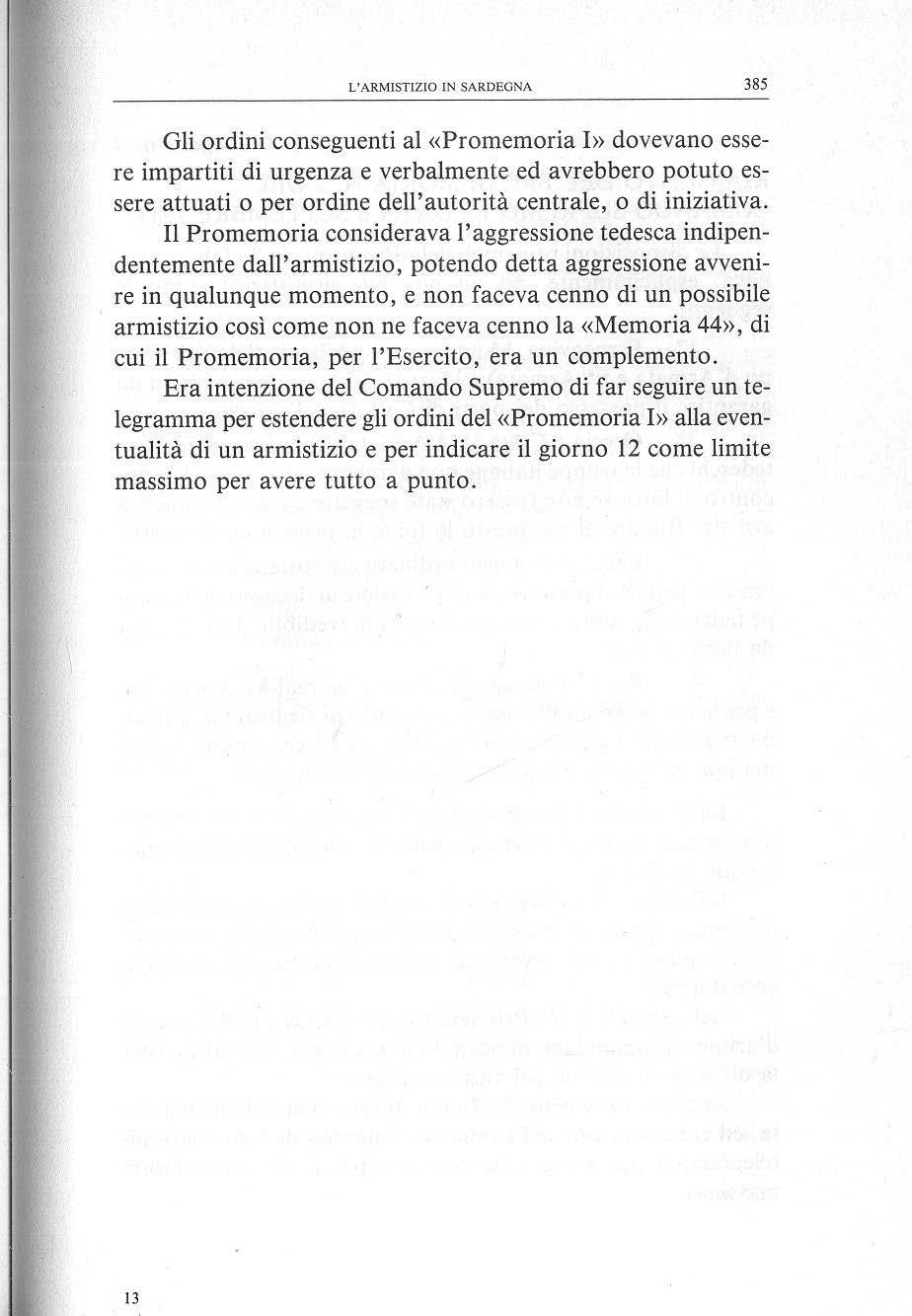
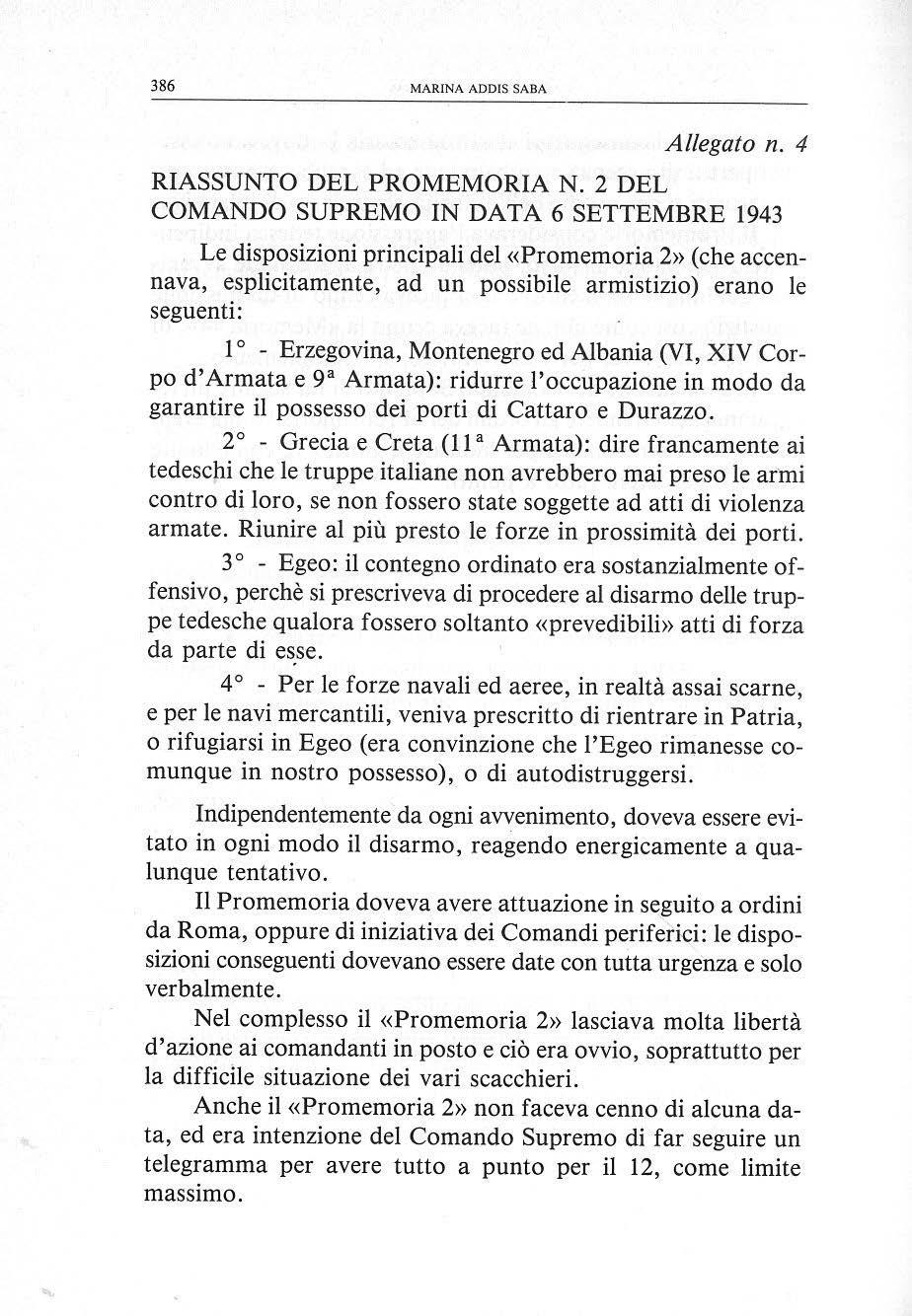
Le disposizioni principali del «Promemoria 2» (che accennava , esplicitamente, ad un possibile armis tizio) erano le seguenti:
I O - Erzegovina, Montenegro ed Albania (VI, XIV Corpo d'Armata e 9a Armata): ridurre l'occupazione in modo da garantire il possesso dei porti di Cattaro e Durazzo.
2° - Grecia e Creta (11 a Armata): dire francamente ai tedeschi che le truppe italiane non avrebbero mai preso le armi contro di loro, se non fossero state soggette ad atti di violenza armate. Riunire al più presto le forze in prossimità dei porti.
3° - Egeo: il contegno ordinato era sostanzialmente offensivo, perchè si prescriveva di procedere al disarmo delle truppe tedesche qualora fossero soltanto «prevedibili» atti di forza da parte di es.se.
4 ° - Per le forze navali ed aeree, in realtà assai scarne, e per le navi mercantili , veniva prescritto di rientrare in Patria, o rifugiarsi in Egeo (era convinzione che l'Egeo rimanesse comunque in nostro possesso), o di autodistruggersi.
Indipendentemente da ogni avvenimento, doveva essere evitato in ogni modo il disarmo, reagendo energicamente a qualunque tentativo.
Il Promemoria doveva avere attuazione in seguito a ordini da Roma, oppure di ini ziativa dei Comandi periferici: le disposizioni conseguenti dovevano essere date con tutta urgenza e solo verbalmente.
Nel complesso il «Promemoria 2» lasciava molta libertà d'azione ai comandanti in posto e ciò era ovvio, soprattutto per la difficile situazione dei vari scacchieri.
Anche il «Promemoria 2» non faceva cenno di alcuna data, ed era intenzione del Comando Supremo di far seguire un telegramma per avere tutto a punto per il 12 , come limite massimo.
La notizia della cessazione delle ostilità col nemico di ieri non poteva destare particolare stupore sulla popolazione siciliana che, stremata dai bombardamenti e dalle condizioni disperate, aveva già accettato, e di buon grado, l'occupazione del proprio territorio da parte delle truppe anglo-americane e l'insediamento dell'A.M.G.O.T. (Allied Military Government of occupied territories) nella città di Palermo. In questa occasione non si ebbero, quindi, le deliranti esplosioni di allegria con le quali i siciliani avevano accolto l'arrivo degli Alleati. Non mancarono, comunque, mapifestazioni di entusiasmo, in seguito alla diffusione della notizia. A proposito delle quali il Gayre scrive nel suo diario: «To-night Italy has capitulated. The Italian waiters in the mess (being an Anglo-American and not an English mess it has no army orderlies) danced for joy and went nearly mad. Children, despite the curfew, marched the streets beating tins and drums and shouting with glee. Dr. Thompson and I were surrounded by them in the Via Libertà. This must mean the move, in the near future, of AMGOT headquarters to Italy» (1).
In sostanza, come si rileva dal brano del Gayre, 1'8 settembre non aveva provocato altro che epidermiche ed ingenue reazioni popolari, peraltro assai modeste, con le quali, probabilmente, alcuni camerieri italiani dei club alleati e un gruppo di ragazzi avevano voluto guadagnarsi la simpatia degli Alleati.
Quando dunque, all'indomani dell'8 settembre, Sicilia Liberata, il quotidiano controllato dal P.W.B. (Psychological
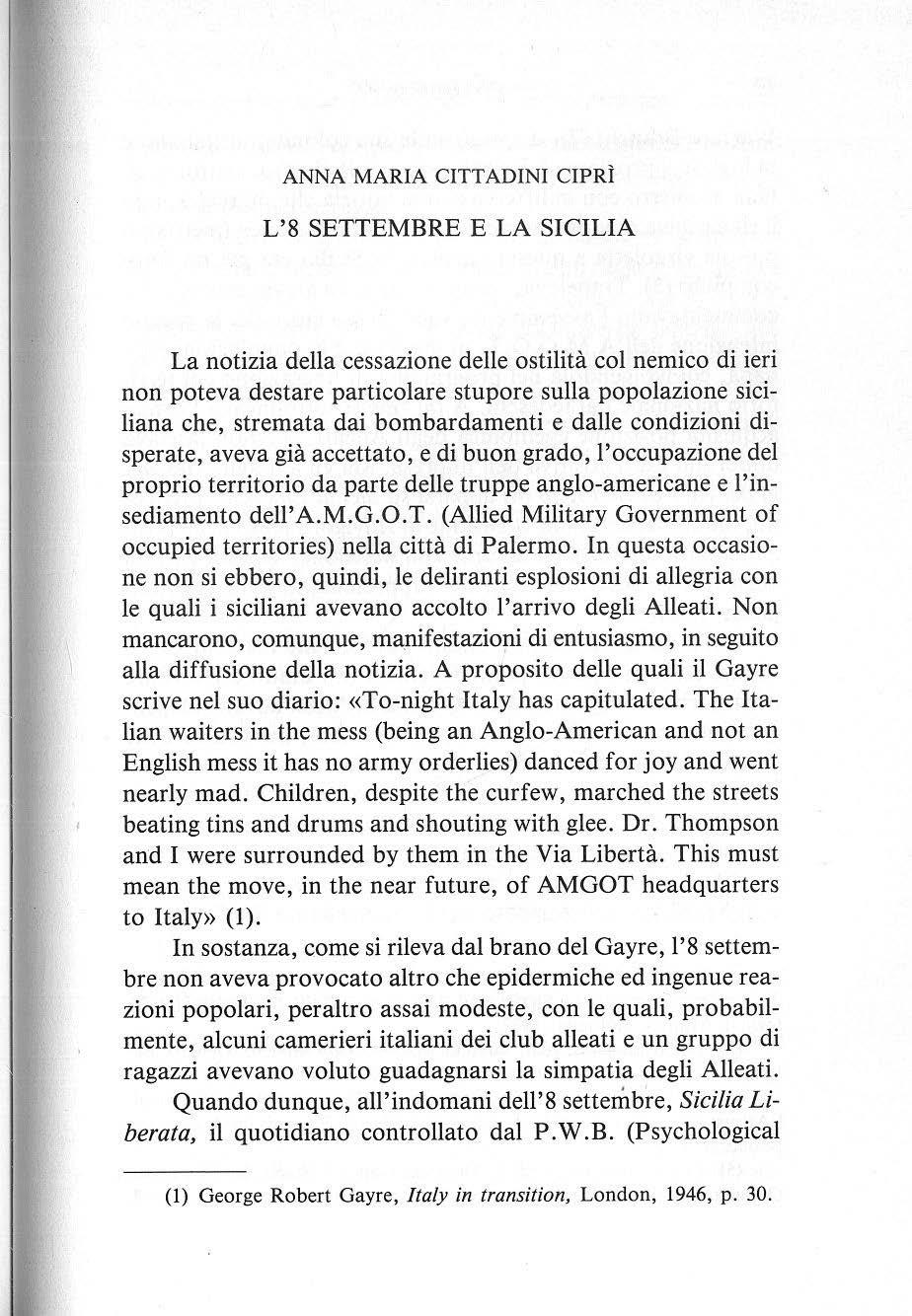 (1) George Robert Gayre, Ita/y in transition, London, 1946, p. 30.
(1) George Robert Gayre, Ita/y in transition, London, 1946, p. 30.
Warfare Branch) (2), dispiegò sulle sue colonne, in italiano e in inglese, i proclami di Eisenhower e di Badoglio, i lettori siciliani acco lsero con indifferenza una notizia che, in realtà, non li riguardava più, dal momento che la «liberazione» (mettiamo pure le virgolette a · questa parola), in Sicilia era già un fatto compiuto (3). Trapelava, ad ogni modo, da alcuni articoli, che commentavano l'avvenimento sullo stesso giornale, la precisa intenzione dell'A.M.G.O .T. di mobilitare la popolazione siciliana, coinvolgendola nel programma di liberazione del territorio nazionale dai tedeschi. A tal fine si sottolineava l'ormai acquisita posizione egemonica degli Alleati, che non lasciava dubbi sull'esito positivo dell'impresa. Ma gli ambigui Messaggi del Re e di Badoglio (4) apparsi su Sicilia Liberata, offrirono, indubbiamente, un'occasione di rinvigorimento delle posizioni antimonarchiche, assunte con decisione, sin dall'entrata degli Americani a Palermo, dai rappresentanti dei ricostituiti partiti politici.
Non mi soffermerò, a questo punto, sulle reazioni manifestate da tutti i partiti politici siciliani (mi limito a ricordare che il periodico democristiano L'Unità di Alessi dovette sospendere, almeno ufficialmente, le pubblicazioni, per ordine delle autorità alleate, colpite dalla violenza di un articolo che attaccava il «vergognoso» armistizio), dal momento che tale operazione è stata già ampiamente compiuta da Massimo Ganci e da altri storici (5); ma porrò l'attenzione sui rapporti intercorrenti tra il Governo Militare Alleato e due formazioni antagoniste, e cioè il M.I.S. (Movimento per l'Indipendenza Siciliana) e il
(2) Sul P. W .B. e, in generale, sulla presenza degli Alleati in Sicilia, vedi Lamberto Mercuri, La Sicilia e gli Alleati, in L'Italia fra Tedeschi e Alleati, Il Mulino, Bologna, 1973.
(3) Sull'argomento, vedi, Salvo Di Matteo, Anni Roventi, Denaro, Palermo, 1967, p. 125; Sicilia Liberata, n. 34, 9 settembre 1943.
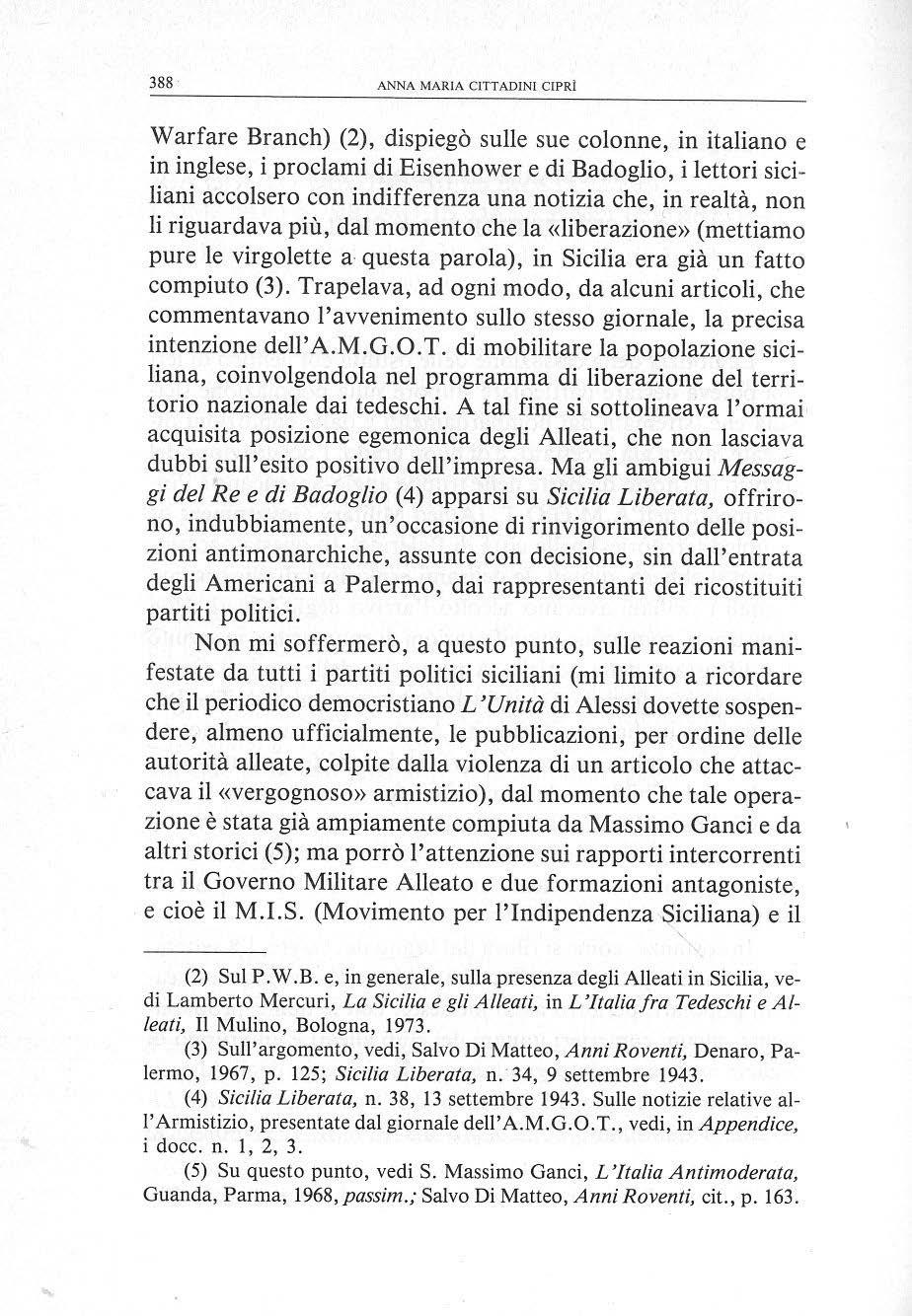
(4) Sicilia L iberata, n. 38, 13 settembre 1943. Sulle notizie relative ali' Armistizio, presentate dal giornale dell 'A. M .G .O. T., vedi, in Appendice, i docc . n. 1, 2, 3.
(5) Su questo punto, vedi S Massimo Ganci, L'Italia Antimoderata, Guanda, Parma, 1968, passim.; Salvo Di Matteo, Anni Roventi, cit., p. 163.
Partito d'Azione. Attraverso l ' analisi di tali rapporti è possibile, infatti, mettere a fuoco in modo esauriente la realtà politica siciliana di quel periodo.
Un Governo legato al solo nome di Badoglio, senza prestigio e poteri, rappresentava certamente un facile bersaglio sia per la volontà indipendentista di un Finocchiaro Aprile (leader del M.I.S.), pronto a rompere i ponti col Governo centrale, magari per costruirne di nuovi in direzione della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, sia per quella azionista di un Vincenzo Purpura, fondatore, con Antonino Ramirez, del P. d' A. in Sicilia.
I due leader siciliani, a ll eati nella lotta clandestina al fascismo sino al momento dell'arrivo degli Americani a Palermo, avevano già in quell'occasione scoperto le carte , dando inizio ad una polemica che diverrà sempre più accesa. La causa di t ale polemica va ricercata, indubbiamente, nelle di vergenze id eologich e insite nei due partiti che essi rappresentavano , ma il pr etes t o fu offerto concretamente dal fallimento d el piano insurrezionale, concordato tra Purpura e Finocchiaro Aprile (quest'ultimo fu ritenuto dal Purpura responsabile della mancata attuazione del piano), secondo il quale gli Alleati avrebbero dovuto trovare Palermo già liberata e nelle mani di un'amministrazione anti fascista (6).
Sin dal 22 luglio del '43 il volantino del Fronte Unico della Libertà, che salutava negli «Eserciti dell e Nazioni Unite ... la possente forza dell a D emocrazia Mondiale» rappresentava un blocco antifascista e antimonarchico di tutti i partiti, dal P. d' A. a l Partito Liberale, dal quale era escluso il M.1.S . Quest'ultimo, dal canto s u o, in quegli stessi giorni, chiedeva ai «Governi Alleati di consent ire la costituzione di un Governo Provvisorio Sicili ano», dal qua le sarebbe nato l'auspicato «Stato sovrano indipendente democratico a regime repubblicano» (7).
(6) Su questo punto, vedi Anna Maria Cittadini Ciprì, Il Partito d'Azione e la Questione Meridionale, EPOS, Palermo, 1982, pp . 105- 106.
(7) Ibidem, pp 109-110.
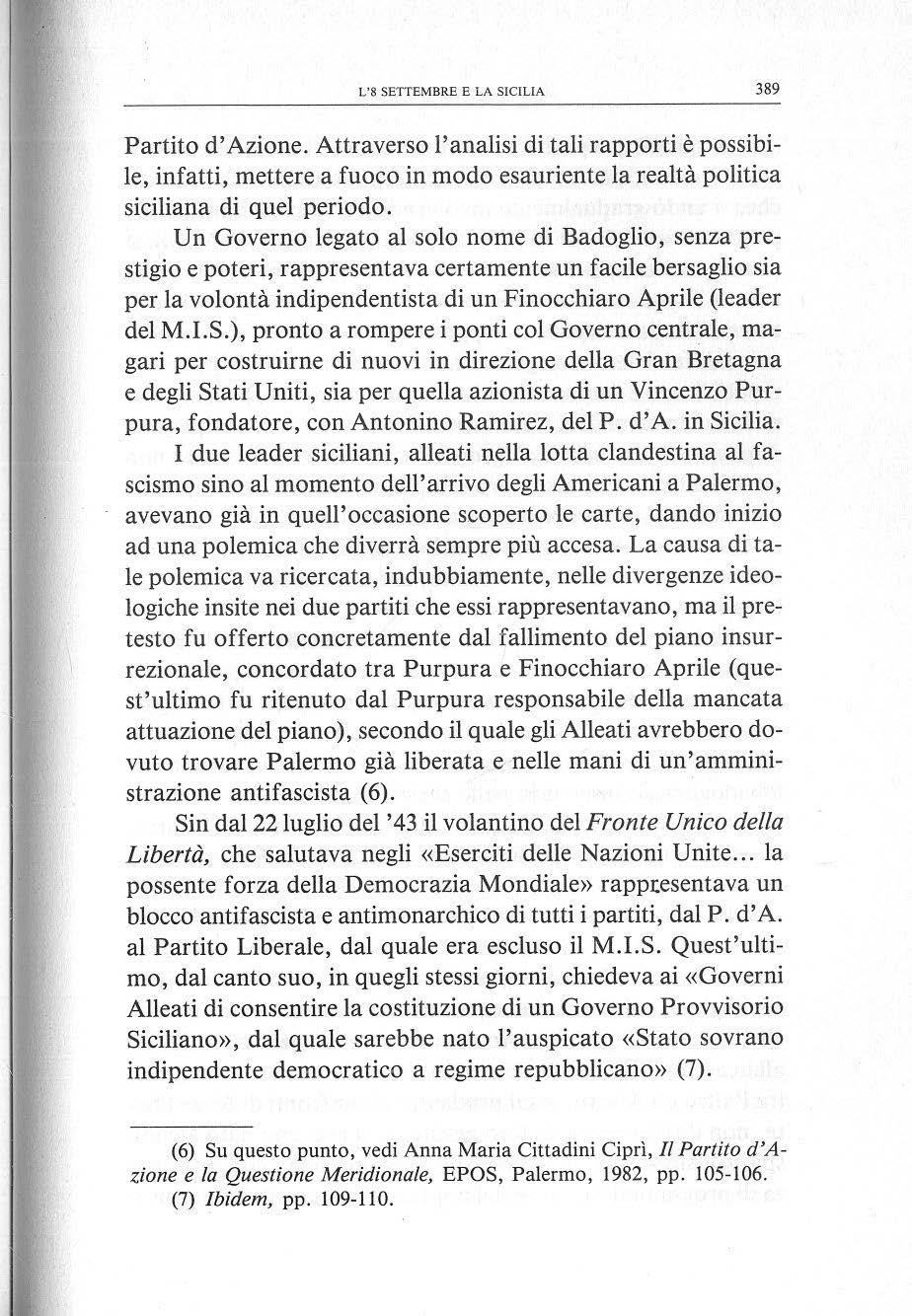
A questo proposito occorre precisare che l'indipendentismo siciliano, partito da posizioni repubblicane e democratiche, si andò gradualmente involvendo verso posizioni sempre più conservatrici. All'indipendentismo federativo del M.I.S. si venne sostituendo il separatismo, e cioè quel movimento che voleva il taglio netto con la presunta, futura realtà «bolscevica» dell ' Italia unificata. I rapporti tra M.I.S. e P. d ' A. siciliano, dall'iniziale convergenza, almeno formale , sulle posizioni repubblicane e democratiche, andarono, appunto , progressivamente deteriorandosi, man mano che il separatismo ripiegava su posizioni reazionarie . A proposito del P. d 'A. , viceversa, non va dimenticato che esso mirò sempre, con decisione, al principale obiettivo del proprio programma , costituito dall'inserimento costituzionale ed amministrativo dell ' isola nell'ambito del nuovo Stato democratico italianq, che uomini come Piero Calamandrei venivano elaborando.
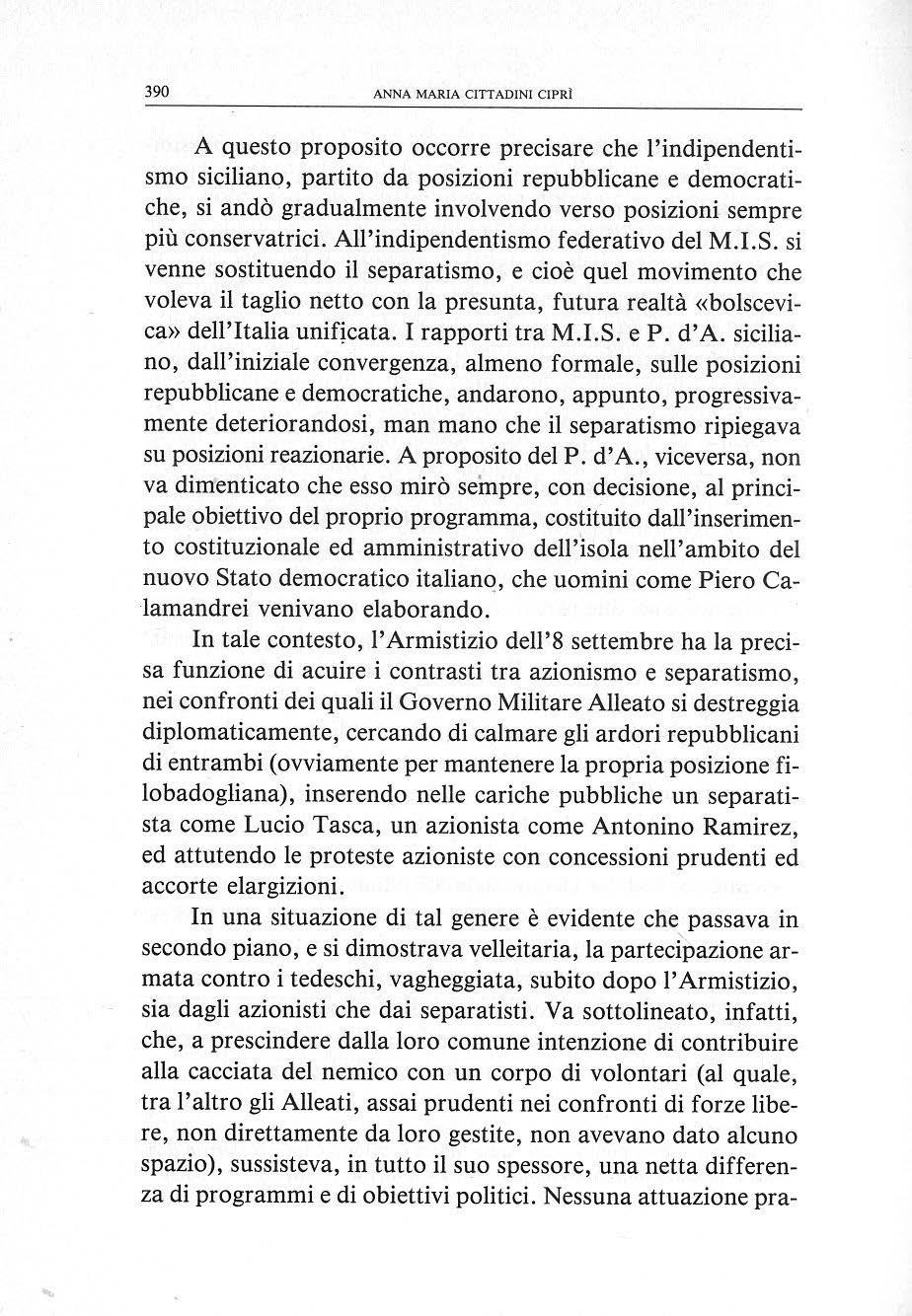
In tale contesto, l'Armisti zio dell'8 settembre ha la precisa funzione di acuire i contrasti tra azionismo e separatismo, nei confronti d ei quali il Governo Militare Alleato si destreggia diplomaticamente, cercando di calmare gli ardori repubblicani di entrambi (ovviamente per mantenere la propria posizione filobadogliana), inserendo nelle cariche pubbliche un separatista come Lucio Tasca, un azionista come Antonino Ramirez, ed attutendo le proteste azioniste con concessioni prudenti ed accorte elargizioni.
In una situazione di tal genere è evidente che passava in secondo piano, e si dimostrava velleitaria, la partecipazione armata contro i tedeschi, vagheggiata, subito dopo l'Armistizio , sia dagli azionisti che dai separatisti. Va sottolineato, infatti, che, a prescindere dalla loro comune intenzione di contribuire alla cacciata del nemico con un corpo di volontari (al quale, tra l'altro gli Alleati, assai prudenti nei confronti di forze libere , non direttamente da loro gestite , non avevano dato alcuno spazio), sussisteva, in tutto il suo spessore, una netta differenza di programmi e di obiettivi politici. Nessuna attuazione pra-
tica ebbe, in sostanza, di fronte alle necessità belliche, la proposta di cooperazione avanzata dagli indipendentisti a tutti i partiti «al di sopra di ogni ideologia e di ogni programma politico», a nome del popolo siciliano «interessato al trionfo della causa per cui combatte(vano) le Nazioni Unite e ... disposto a contribuire militarmente al trionfo della causa comune» (8). Tra l'altro, una simila prospettiva era, in realtà, ben poco accetta alla popolazione siciliana, assolutamente restia ad una ripresa della guerra. Come siano andate le cose su questo specifico argomento è noto. Ricorderò soltanto che, al momento della ricostituzione del regio esercito, allorchè cominciarono ad arrivare le cartoline di richiamo alle armi, una parte dell'Isola, soprattutto nella zona orientale, insorse. Addirittura si arrivò a proclamare alcune repubbliche locali, come quella di Agira.
A questo punto va rilevato che la decisione presa dal Comitato di Liberazione Nazionale, nell'ottobre del '43, di agire con fermezza «di fronte alla situazione creata dal re e da Badoglio» e di lasciare al popolo, a liberazione avvenuta, la scelta istituzionale, rispecchiava perfettamente le aspirazioni del P. d' A. siciliano, che fondava nella vittoria repubblicana le speranze di una palingenesi della Sicilia. Frattanto, la richiesta, avanzata dagli azionisti, di un immediato passaggio dell'Isola all'amministrazione italiana rifletteva la precisa intenzione di bloccare le manovre reazionarie dei separatisti, insediatisi nei principali organi dell'amministrazione pubblica siciliana, con l'appoggio degli Alleati (9).
Per concludere, desidero sottolineare che l'Armistizio dell'8 settembre innescava il confronto tra le due posizioni ideologiche e politiche che ho esaminato. E mentre l'una, e cioè il separatismo, costituiva pur sempre, come dice Massimo Ganci, nonostante la sua involuzione antidemocratica, «un pugno calato sul tavolo a sottolineare con forza un punto di vista», e cioè
(8) Ibidem, pp. 113-114; v. anche Salvo Di Matteo, Anni Roventi, cit., pp. 178-179 .
(9) Sull'argomento, vedi Anna Maria Cittadini Ciprì, cit., pp. 115-1 16.
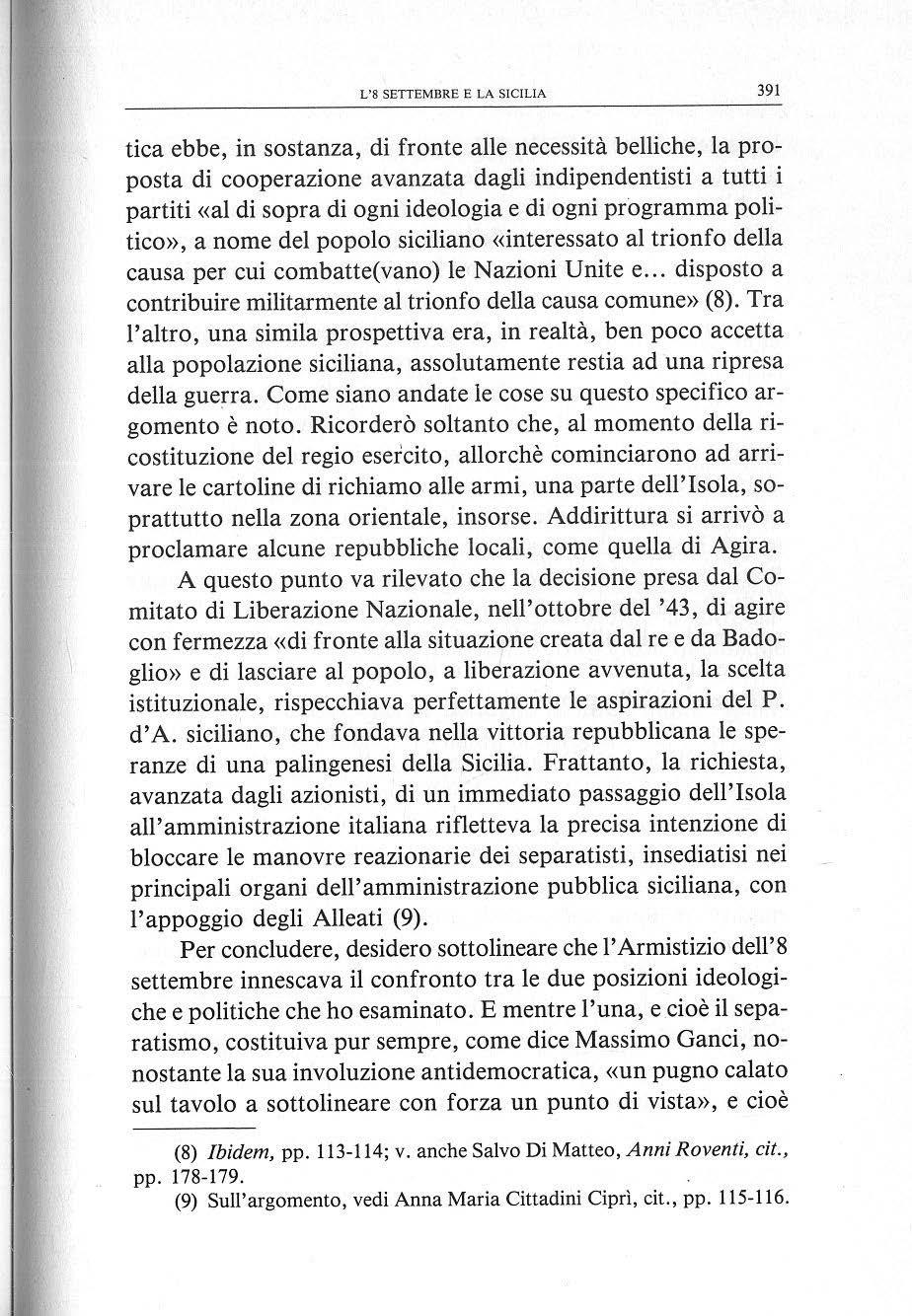
la contestazione radicale della vecchia struttura costituzionale derivata dalla soluzione moderata del Risorgimento; l'altra, e cioè il P. d'A., opponeva a questa posizione estremistica che, di fatto, si faceva garante dello statu quo, quella non secessionistica, ma ben più valida, con la quale il problema dell'Isola e di tutto il Mezzogiorno veniva risolto attraverso una nuova struttura costituzionale del Paese che all'accentramento sostituiva l'autonomia regionale di marca democratica.
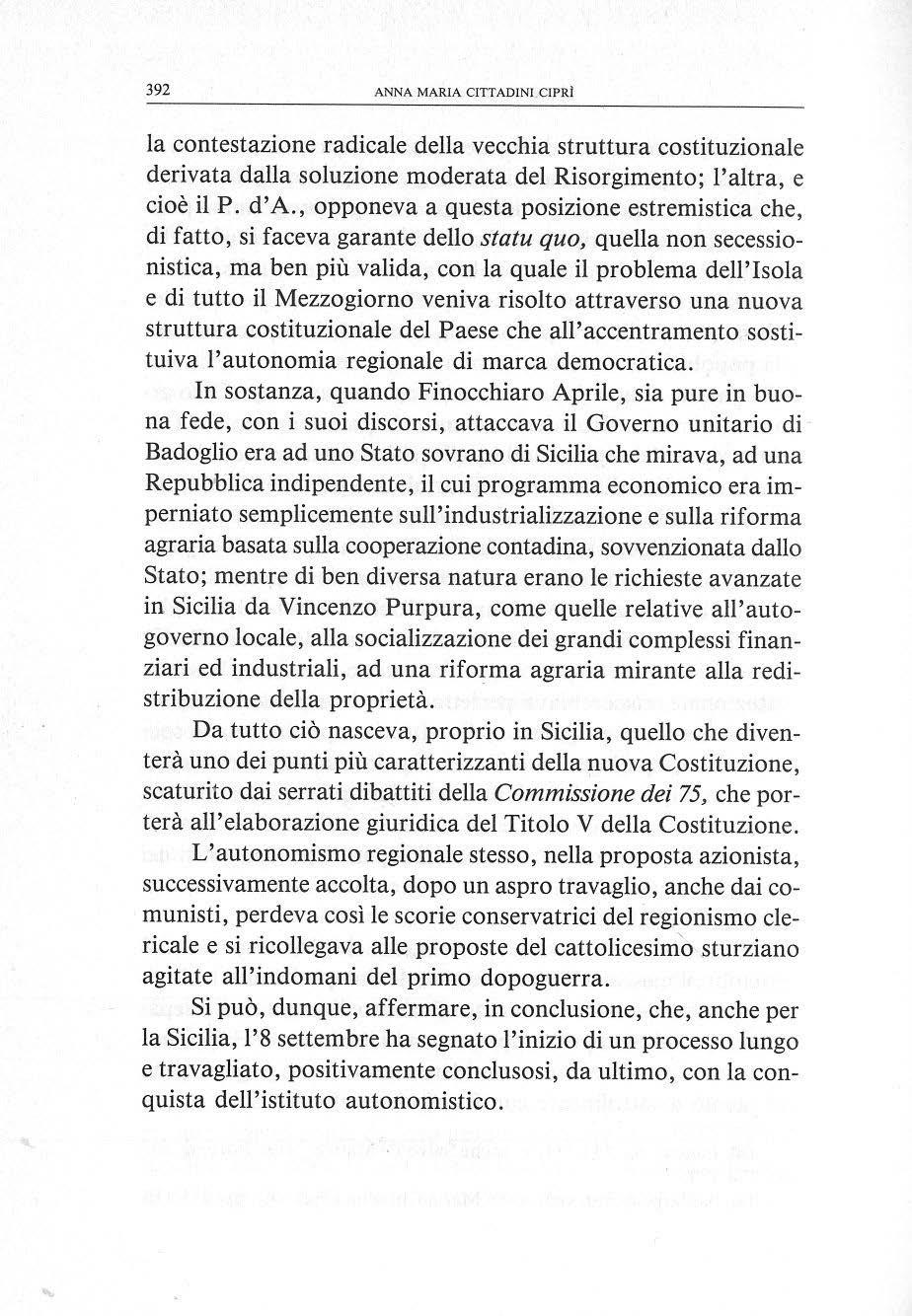
In sostanza, quando Finocchiaro Aprile, sia pure in buona fede, con i suoi discorsi, attaccava il Governo unitario di Badoglio era ad uno Stato sovrano di Sicilia che mirava, ad una Repubblica indipendente, il cui programma economico era imperniato semplicemente sull'industrializzazione e sulla riforma agraria basata sulla cooperazione contadina, sovvenzionata dallo Stato; mentre di ben diversa natura erano le richieste avanzate in Sicilia da Vincenzo Purpura, come quelle relative all'autogoverno locale, alla socializzazione dei grandi complessi finanziari ed industriali, ad una rifo~ma agraria mirante alla redistribuzione della proprietà.
Da tutto ciò nasceva, proprio in Sicilia, quello che diventerà uno dei punti più caratterizzanti della nuova Costituzione, scaturito dai serrati dibattiti della Commissione dei 75, che porterà all'elaborazione giuridica del Titolo V della Costituzione.
L'autonomismo regionale stesso, nella proposta azionista, successivamente accolta, dopo un aspro travaglio, anche dai comunisti, perdeva così le scorie conservatrici del regionismo clericale e si ricollegava alle proposte del cattolicesimo sturziano agitate all'indomani del primo dopoguerra.
Si può, dunque, affermare, in conclusione, che, anche per la Sicilia, 1'8 settembre ha segnato l'inizio di un processo lungo e travagliato, positivamente conclusosi, da ultimo, con la conquista dell'istituto autonomistico.
L'Armistizio fra gli Alleati e l'Italia (da «Sicilia Liberata», n. 34, 9 settembre 1943)
L'armistizio firmato oggi è soprattutto un armistizio militare nel senso più esteso della parola e cioè: da oggi le truppe alleate e le truppe italiane della terra, del mare e del cielo, non si combattono più.
Gli italiani non devono dimenticare però le dichiarazioni del Generale Badoglio e del Generale Eisenhower. Il Generale Badoglio, infatti ha detto che l'Italia è fermamente decisa a difendere la sua resa, cioè la libertà di ogni popolo a forgiare da sè il proprio destino; a governarsi da sè; a disporre liberamente del proprio avvenire, e che quindi ogni atto ostile di altre nazioni deve essere respinto a qualunque costo e con qualunque mezzo.
L'allusione del Generale Badoglio mentre è molto esplicita e categorica per quanto riguarda la decisione del governo è altrettanto chiara per quanto riguarda gli eventuali nemici che l'Italia potrebbe incontrare nell'affermazione della sua volontà di essere finalmente libera e indipendente.
Questi nemici altri non potrebbero essere se non i tedeschi.
Gli italiani questa vo lta non hanno nulla da te mere perchè alla decisione di Badoglio si associa la dichiarazione del Generale Eisenhower il quale h a promesso formalmente tutto il forte aiuto Alleato agli italiani che agiranno per scacciare i tedeschi dalla nostra terra. E che l'aiuto Alleato sia potente, decisivo, assolutamente tempestivo in tutte le ore ed in tutti i punti della penisola, si può dedurre facilmente dal fatto che oltre allo sbarco già effettuato in Calabria, gli Alleati, padroni assoluti del mare, possono sbarcare in qualsiasi luogo dell'Italia ed in qualsiasi ora tutte le vo lte che si verificasse la benchè minima resistenza da parte tedesca.
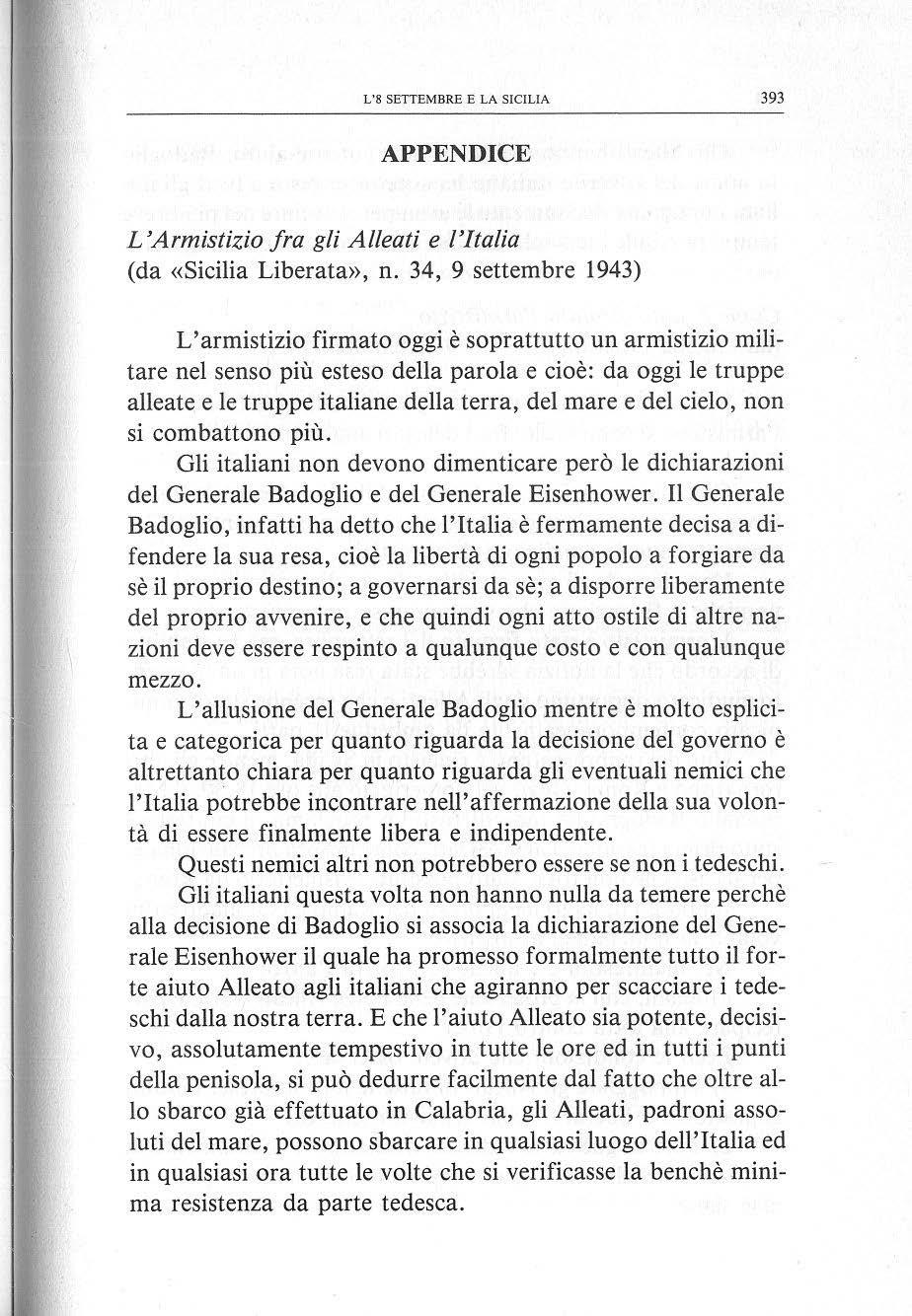
Gli Alleati hanno offerto il loro potente aiuto; Badoglio in nome del governo italiano ha accettato; resta a tutti gli italiani impugnare decisamente le armi per scacciare nel più breve tempo possibile i tedeschi che ci trascinarono in questa guerra.
Come è stato firmato l'armistizio (da «Sicilia Liberata», n. 34, 9 settembre 1943).
Le conversazioni che hanno portato alla conclusione del1' armistizio si sono svolte fra i d elegati anglo-americani e quelli italiani nel più assoluto riserbo.
Con l'approvazione dei Governi Alleati, il Generale Eisenhow er è stato autorizzato a trasmettere ai rappresentanti del Governo italiano le condizioni di armistizio.
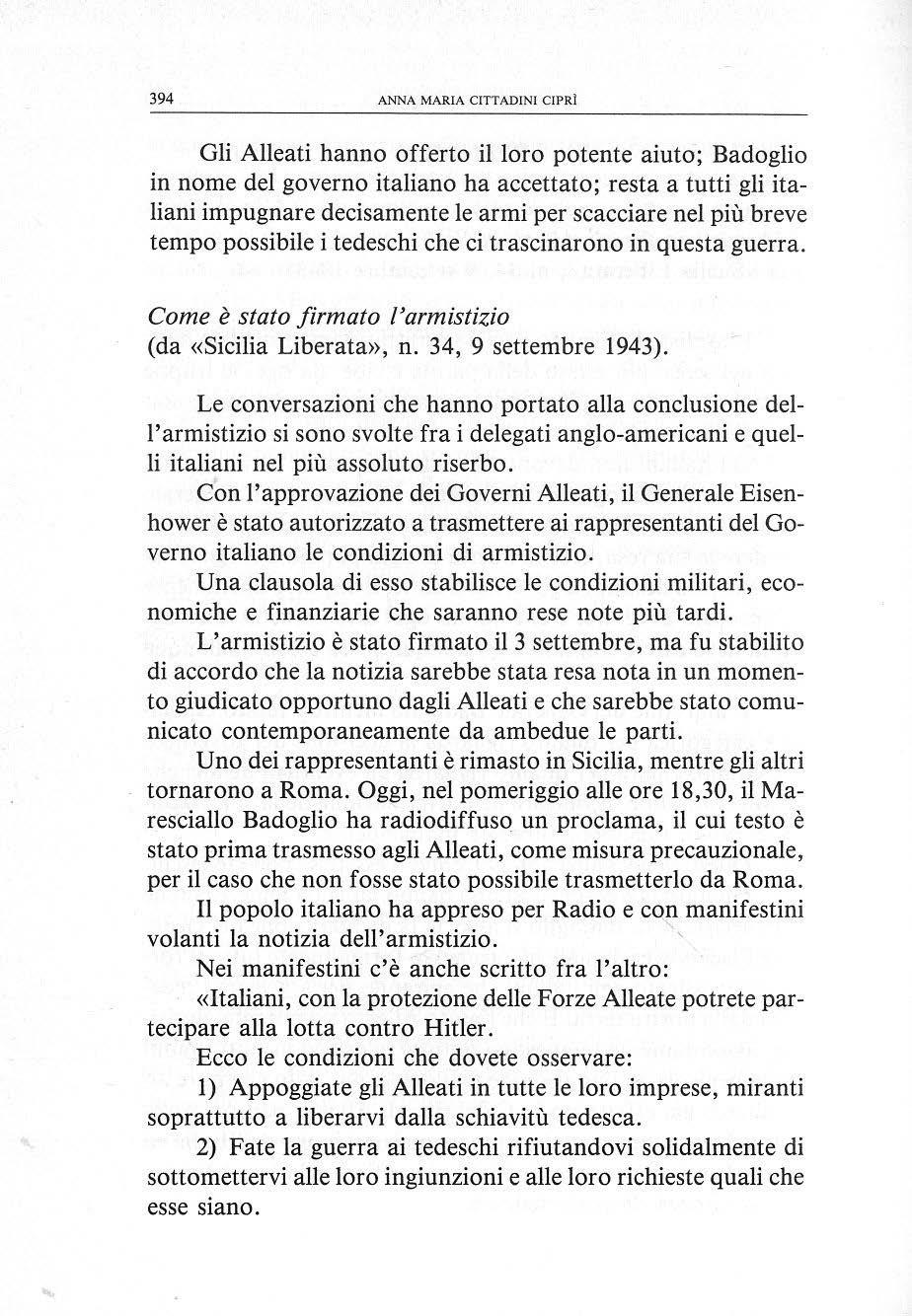
Una clausola di esso stabilisce le condizioni militari, economiche e finanziarie che saranno rese note più tardi.
L'armistizio è stato firmato il 3 settembre, ma fu stabilito di accordo che la notizia sarebbe stata resa nota in un momento giudicato opportuno dagli Alleati e che sarebbe stato comunicato contemporaneamente da ambedue le parti.
Uno dei rappresentanti è rimas to in Sicilia, mentre gli altri tornarono a Roma. Oggi, nel pomeriggio alle ore 18,30, il Maresciallo Badoglio ha radiodiffusq un proclama, il cui testo è stato prima trasmesso agli Alleati, come misura precauzionale, per il caso che non fosse stato possibile trasmetterlo da Roma.
Il popolo italiano ha appreso per Radio e con manifestini volanti la notizia dell'armistizio.
Nei manifestini c'è anche scritto fra l'altro:
«Italiani, con la protezione delle Forze Alleate potrete partecipare alla lotta contro Hitler.
Ecco le condizioni che dovete osservare:
1) Appoggiate gli Alleati in tutte le loro imprese, miranti soprattutto a liberarvi dalla schiavitù tedesca.
2) Fate la guerra ai tedeschi rifiutandovi solidalmente di sottomettervi alle loro ingiunzioni e alle loro richieste quali che esse siano.
Operai! La guerra attuale è una guerra di comunicazioni. Chi domina le comunicazioni vince la guerra .
Ferrovieri! Procurate che nessun treno con armati e materiali tedeschi possa passare la frontiera.
Marinai! Procurate che nessuna nave, che porti tedeschi o materiali di ogni genere, possa lasciare i porti italiani.
Lavoratori stradali! Procurate che nessun autocarro trasportante tedeschi possa attraversare le strade d'Italia.
Italiani! Fate ancora un solo sforzo eroico e, nella prossima settimana decisiva, potet e facilita r e agli Alleati il compito di vincere la guerra.
Alzare le bandiere della libertà (da «Sicilia Liberata», n. 35 , 10 settembre 1943)
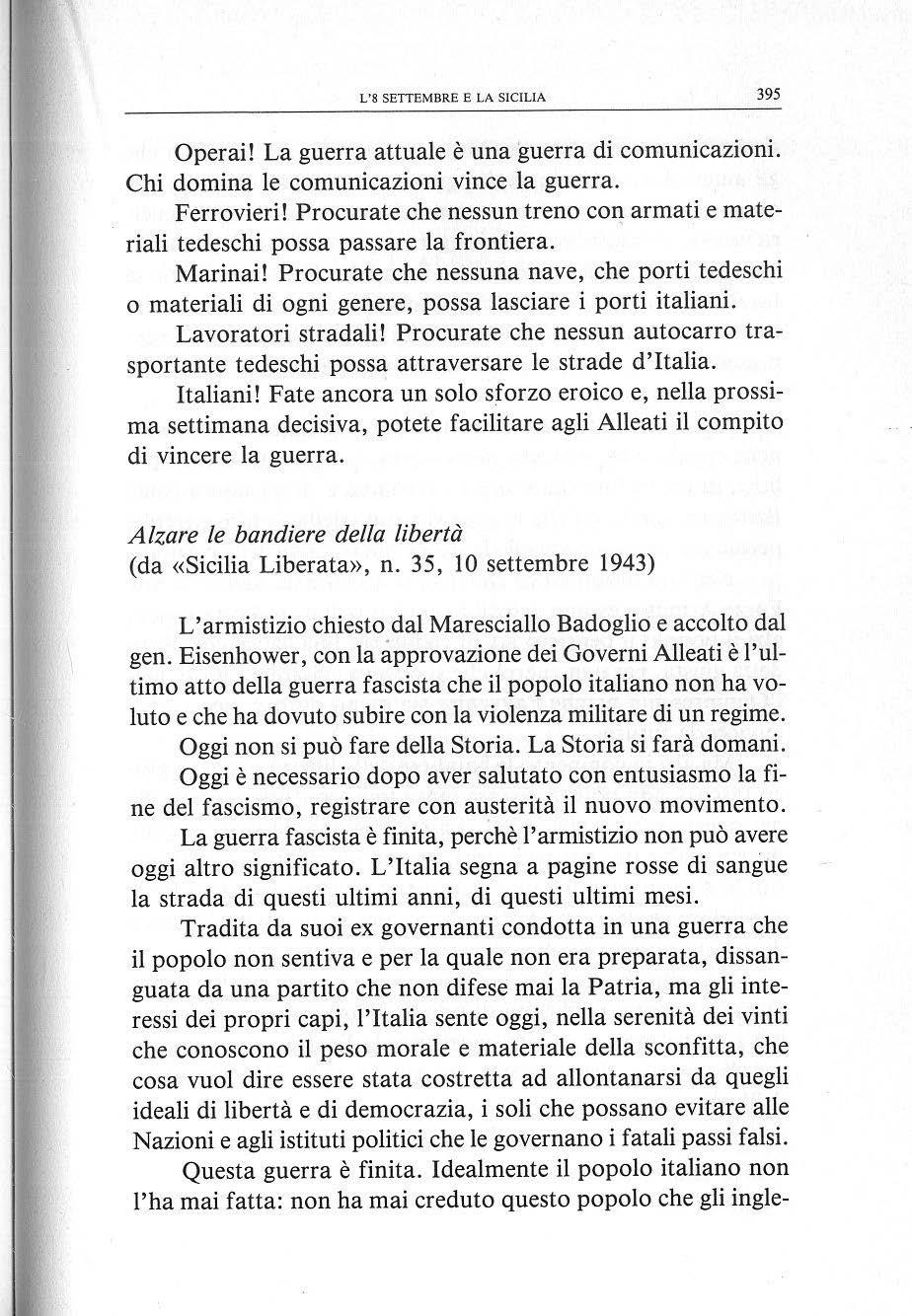
L'armis t izio chiesto dal Maresciallo Badoglio e accolto dal gen. Eisenhower, con la approvazione dei Governi Alleati è l'ultimo atto della guerra fascista che il popolo italiano non ha voluto e che ha dovuto subire con la violenza militare di un regim e. Oggi non si può fare della St oria. La Storia si farà domani. Oggi è necessario dopo aver salutato con entusiasmo la fine del fascismo, registrare con austerità il nuovo movimento.
La guerra fascista è finita, perchè l'armistizio non può avere oggi altro significato. L'Italia segna a pagine rosse di sangue la strada di questi ultimi anni, di questi ultimi mesi.
Tradita da suoi ex governanti condotta in una guerra che il popolo non sentiva e per la quale non era preparata, dissanguata da una partito che non difese mai la Patria, ma gli interessi dei propri capi, l'Italia sente oggi, nella serenità dei vinti che conoscono il peso morale e materiale della sconfitta, che cosa vuol dire essere stata costretta ad allontanarsi da quegli ideali di libertà e di democrazia, i soli che possano evitare alle Nazioni e agli istituti politici che le governano i fatali passi falsi.
Questa guerra è finita. Idealmente il popolo italiano non l'ha mai fatta: non ha mai creduto questo popolo che gli ingle-
si ci affogassero a Suez e Gibilterra, non ha mai creduto che gli americani - Nazione alla quale siamo legati da vincoli di sangue - fossero nostri nemici, non ha mai creduto che la guerra venisse condotta per raggiungere supremi ideali di giustizia. Non ha mai creduto queste cose il popolo: le ha subito con la forza, con la violenza, con l'inganno, dopo essere stato frodato di tutte le sue libertà, di tutti i suoi istituti parlamentari rappresentativi. La logica conclusione è venuta oggi: la guerra fascista è finita .
All'avvenire passerà più che il fatto militare che si perde nelle epoche e nelle pieghe della storia, la criminale azione politica di un regime che senza l'avvedutezza di un uomo come Badoglio, simbolo della tragica sfortuna della Patria, avrebbe potuto mettere a repentaglio la stessa vita secolare della Nazione. Nell'ora drammatica che l'Italia attraversa, mentre le sue Forze Armate cessano le ostilità contro il mai creduto nemico, alzi il popolo il pensiero a Chi cadde per una causa che gli fu detta giusta, per una guerra che si doveva evitare e confidi nell'Onnipresente perchè l'avvenire sia meno duro e meno tristi le vicende future.
Ma alzi in compenso le bandiere della libertà perchè il giogo fascista non poteva cessare senza una sconfitta militare. Se per questa sventurata Ita lia , campo di manovra di un regime di criminali e di im provvisatori, questo momento era necessario, lo si accolga con l'animo dei forti. E giuramento sia fatto che il domani dei nostri figli non sarà più attentato violentato da regimi politici di assassini e di devastatori.
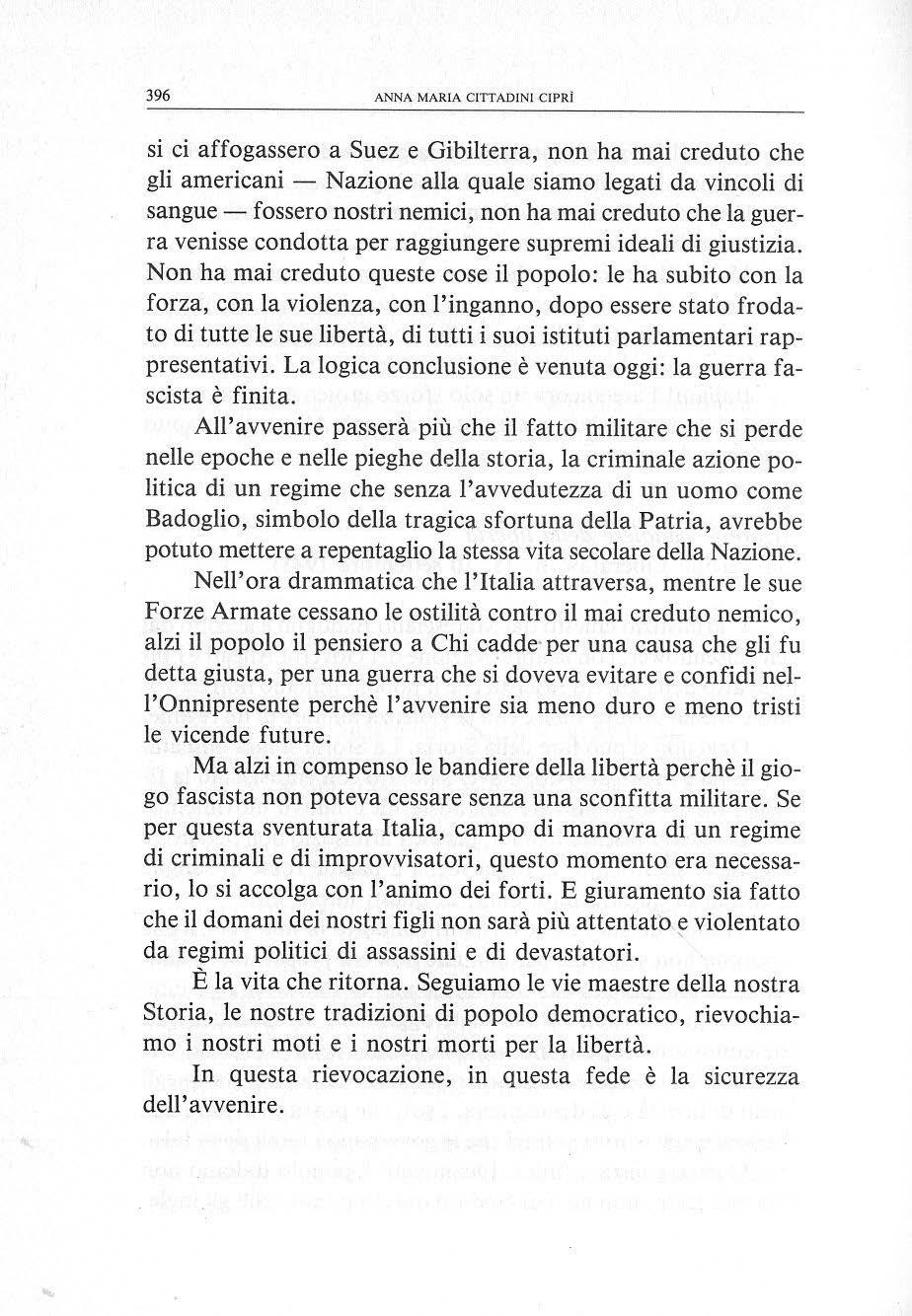
È la vita che ritorna. Seguiamo le vie maestre della nostra Storia, le nostre tradizioni di popolo democratico, rievochiamo i nostri moti e i nostri morti per la libertà.
In questa rievocazione, in questa fede è la sicurezza dell'avvenire.
Al momento dell'annuncio della conclusione dell'armistizio la situazione generale militare italiana annoverava tra i problemi più gravi ed irrisolti quello dei prigionieri di guerra che erano diventati legioni dopo la chiusura dei due grandi fronti africani, quello dell'Africa Orientale liquidato il 27 novembre 1941 dopo la resa dell'ultimo caposaldo italiano comandato dal gen. Guglielmo Nasi e il fronte dell'Africa settentrionale chiusosi il 13 maggio 1943 con la firma della resa delle superstiti forze italo-tedesche nella regione di Capo Bon, in Tunisia, da parte del comandante supremo generale Giovanni Messe. Questi due grandi campi di battaglia, e soprattutto il secondo che vide lo sforzo militare dell'Asse dall'inizio della guerra italiana fino a quasi tre anni dopo, produssero sia nelle fasi intermedie delle battaglie contrassegnate da due grandi avanzate nell'uno e nell'altro settore culminante rispettivamente con l'occupazione del Somaliland e nella marcia verso il Cairo, sia nella fase finale delle operazioni belliche un numero elevato di prigionieri di guerra. Detentori ne furono dapprima la Gran Bretagna e gli Stati collegati del Commonwealth, e successivamente al novembre 1942, gli Stati Uniti d'America e la stessa Francia rinata sotto le insegne della «France Libre» del gen. De Gaulle. Quanto all'altro grande fronte italiano, quello russo, la situazione si rivelava abbastanza simile anche se minore di ampiezza: infatti va ricordata quale potenza detentrice l'URSS la quale ebbe negli uomini dello CSIR prima e quindi dell' ARMIR ampia occasione di fare prigionieri di guerra italiani. Se questa era a grandi linee la situazione agli inizi di settembre 1943 non si deve credere che neppure allora mancasse-
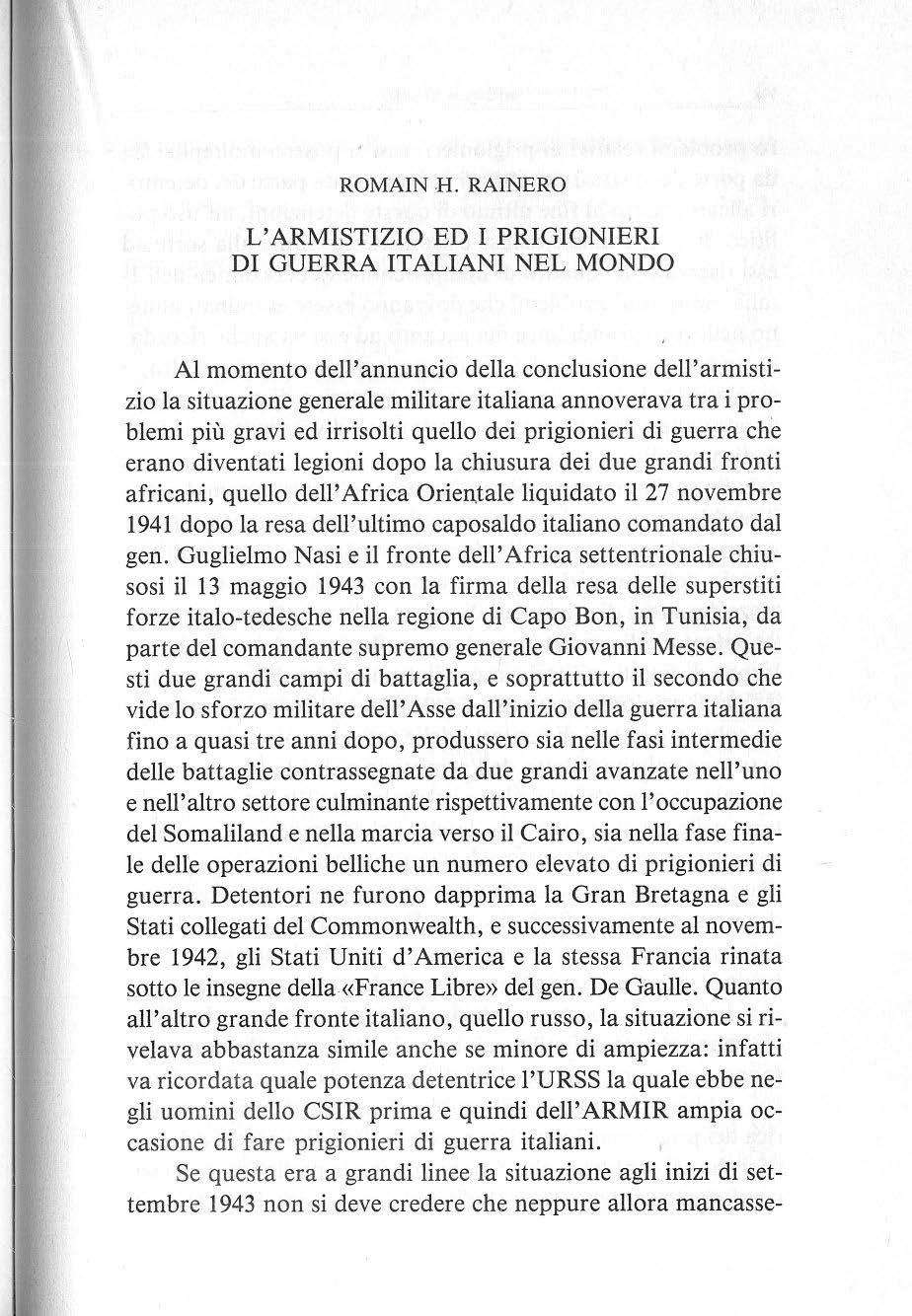
ro problemi relativi ai prigionieri: essi si posero molteplici sia da parte degli stessi ex-militari italiani sia da parte dei detentori alleati quanto al fine ultimo di queste detenzioni, all'uso politico di queste masse deluse e sconfitte ed infine alla sorte ad essi riservata nel quadro di una probabile «liberazione» dell'Italia. Sono tutti problemi che dovranno essere esaminati almeno nelle loro grandi linee ma accanto ad essi va anche ricordato un altro problema che andrà precisato, non certo risolto, e cioè quello della stessa consistenza numerica di questa massa di prigionieri dato che vi sono sostanziali divergenza tra le fonti disponibili.
Se vogliamo però abbraçciare in uno sguardo complessivo il problema che ci siamo posti e cioè quello dei prigionieri di guerra italiani attorno alla data-chiave rappresentata dall'annuncio dell'armistizio non possiamo non ricordare tra le potenze detentrici di prigionieri di guerra italiani la Germania, nuovo detentore di grande importanza nella storia del calvario doloroso di questi militari sia per il numero de i detenuti sia per il tipo di prigionia istaurato. I settori di «cattura» riguardavano solo i tre settori di contatto delle forze armate tedesche con le truppe italiane all'atto dell'armistizio e cioè la Francia meridionale, la regione balcanica e naturalmente l'Italia metropolitana nelle quali le truppe tedesche ebbero modo di compiere sostanziose razzie di militari italiani sbandati nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre. Il panorama degli Stati detentori di militari italiani si completa con l'evocaiione di prigionieri nelle mani di Stati balcanici quali la Jugoslavia, l' Albania, la Grecia, la Romania e la Bulgaria.
Infine, ma questa una storia di tutt'altro segno e significato, vanno ricordati i militari internati in Svizzera che continueranno a crescere fino alla fine della seconda guerra mondiale.
Abbiamo accennato al problema della dimensione numerica dei prigionieri italiani in possesso alle var ie potenze detentrici che è il problema che ci poniamo in via preliminare. Vi sono al riguardo delle notevoli divergenze secondo le varie fonti
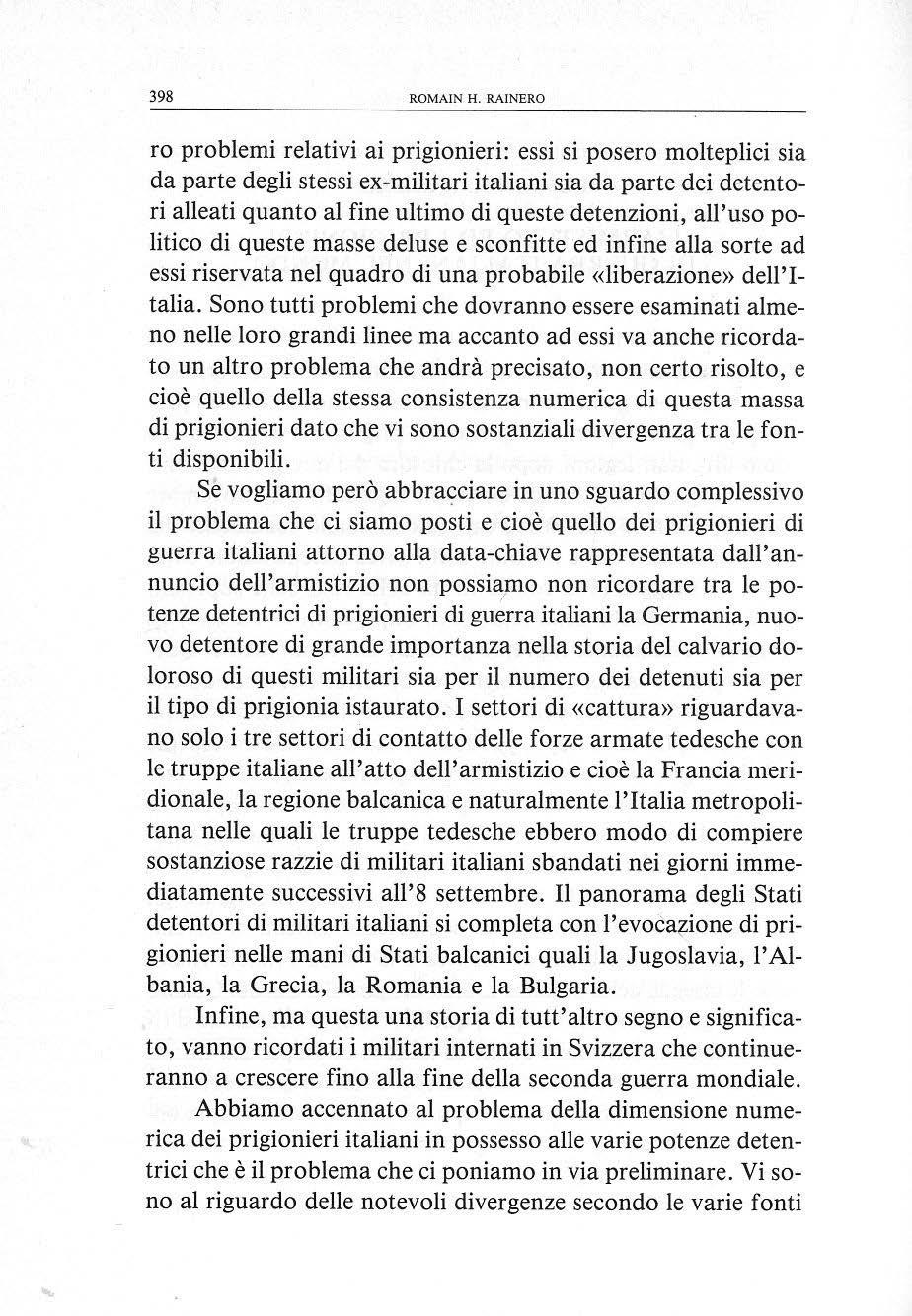
dovute per lo più , sia ai vari criteri con i quali questi elenchi sono stati compilati, sia al periodo al quale si riferiscono. In linea generale si può dire che la data dell'8 settembre è una data estremamente poco significativa per il calcolo del numero dei prigionieri poichè solo sono dati certi quelli relativi ai fronti da tempo liquidati e cioè quello dell'Africa Orientale e quello nordafricano; per il resto dei settori interessati, e sono molti ed importanti, dobbiamo rifarci al 1944 che è una data di relativo consolidamento delle varie masse di prigionieri. In linea preliminare conviene ricordare i dati del Ministero della Difesa a proposito dei tre detentori maggiori e cioè le cifre relative agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e Commonwealth ed alla «France Libre». Frutto di un ' accurata elaborazione di dati di vari e origini possiamo ritenere che questi dati siano realistici ed a ttendibili. Essi sono i
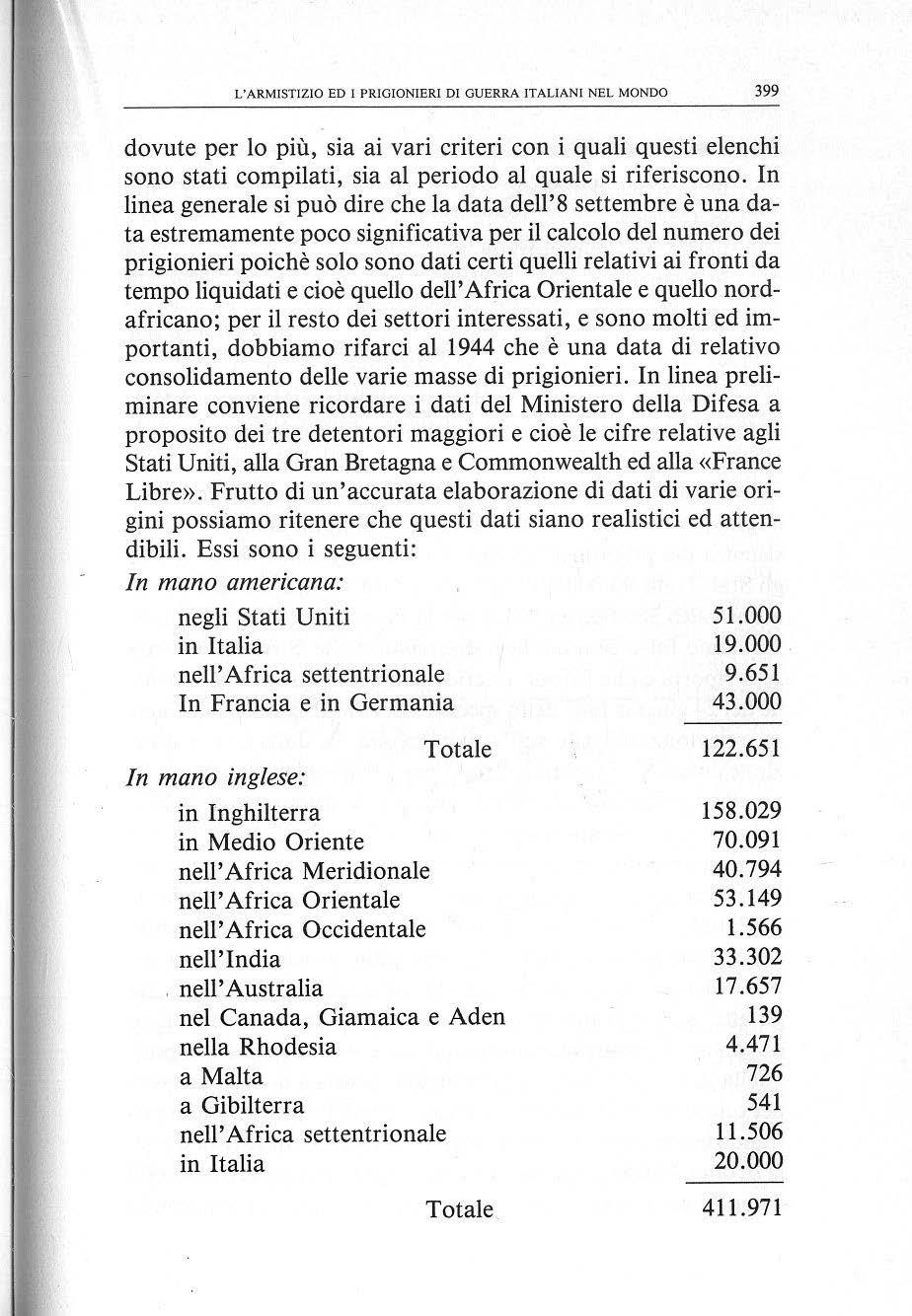
Abbiamo fatto cenno a dati divergenti; essi sono anch'essi di fonte ufficiale italiana e cioè dell'Alto Commissario per i prigionieri di Guerra gen. Pietro Gazzera che fornì nel giugno 1944 nel suo rapporto redatto per ordine del capo del governo Badoglio per informare il suo successore Bonomi della reale consistenza dei prigionieri di guerra cifre lievemente diverse. Per gli Stati Uniti 90.000 militari; per la Gran Bretagna ed il Commonwealth 360.000 ed infine per la Francia 40.000 prigionieri .
Abbiamo fatto cenno a lievi discrepanze che la relazione Gazzera riporta e che furono ulteriormente allargate dalla relazione del 24 giugno 1947 dello speciale Servizio Prigionieri di Guerra , relazione ufficiale sull'attività svolta fin dalla sua costituzione come Alto Commissariato per i Prigionieri di Guerra fino allo scioglimento del Ministero dell'Assistenza Post-bellica dal qual successivamente prese a dipendere (2); e queste discrepanze sono molto eloquenti sia per quanto riguarda il clima generale sia per la stessa gravità del problema. Rimangono da ricordare le cifre relative agli altri Stati detentori e specialmente dei due maggiori, l'URSS e la Germania. Anche qui, anzi soprattutto qui, le incertezze sono molte e vistose; sia gli uni, sia gli altri non avevano certamente quale prima preoccupazione di contare i propri prigionie r i italiani e molto spesso neppure quella di sottrarli alle dure condizioni generali di vita; proprio per questi motivi le continue fluttuazioni delle presenze non potranno certamente essere ulteriormente chiarite. In Russia si parla di oltre 70.000 prigionieri e nella Germania si parla di 630.000 detenuti nei Lager. Quanto agli Stati balcanici si ritiene che la
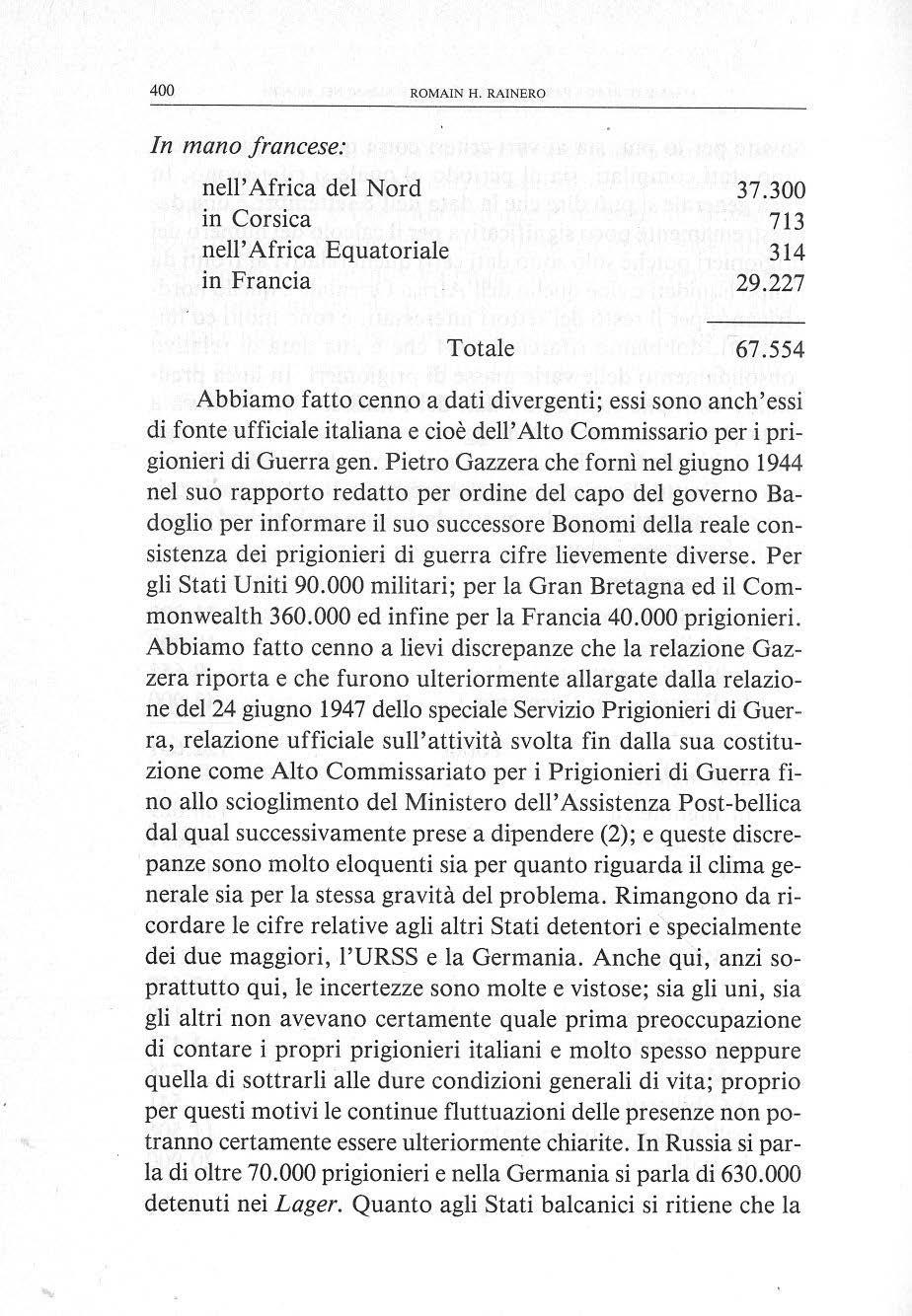
cifra di 106.678 avanzata da fonte militare italiana sia rappresentativa.
Come si vede da una rapida analisi di queste çifre si tratta di oltre un milione e trecentomila prigionieri di guerra i quali precedentemente catturati, o catturati attorno all'8 settembre, vedono la loro storia ruotare attorno alla data chiave dell'armistizio.
Definiti così a grandi linee la situazione numerica dei prigionieri e la sua evoluzione vale la pena di soffermarci non tanto sulle condizioni di vita e sulle privazioni che questa detenzione provocò nello spirito e nel fisico dei detenuti quanto piuttosto sull'aspetto particolare dei rapporti tra la vita politica e militare generale dell'Italia nell'andamento della guerra e la situazione nei vari campi di prigionieri. Vediamo di definire con l'ausilio di citazioni di specialisti dello studio della condizione di prigionieri e delle memorie dei prigionieri stessi la condizione psicologica generale che la perdita della libertà ed il salto nell'ignoto rappresentato dalla nuova condizione di coatto provocarono nel1' animo dei prigionieri. In genere il subentrare all'attivismo del militare in guerra la quiete avvilente del prigioniero provoca quella che oramai è definita una vera malattia e cio~ la «psicosi del reticolato». Spesso il combattente prigion iero non sa affront are la nuova situazione con la sommaria liquidazione della propria individualità attiva e nell'azione a volte prestigiosa, o quanto meno ritenuta tale, del passato immed iato; e ciò lo porta alla rivolta con propositi di fuga e di rifiuto da attuarsi magari con il suicidio:
« ... Gente che va e viene, che sosta cu ri o sando, ch e ride, che lancia lazzi, insulta. Al di quà noi. I eri ancora vivi e coscienti, oggi ridotti ad automi, a numeri che non hanno più il diritto di pensare, di parlare, di muoversi secondo una propria volontà. Una specie di lento soffocamento progressivo che stringe la gola . Trattengo a stento il bisogno di piangere. Vedo altri a ggirarsi inquieti da un reticolato all'altro, quali animali ingabbiati, quasi volessero convincersi che no, non può essere vero ... » (3).
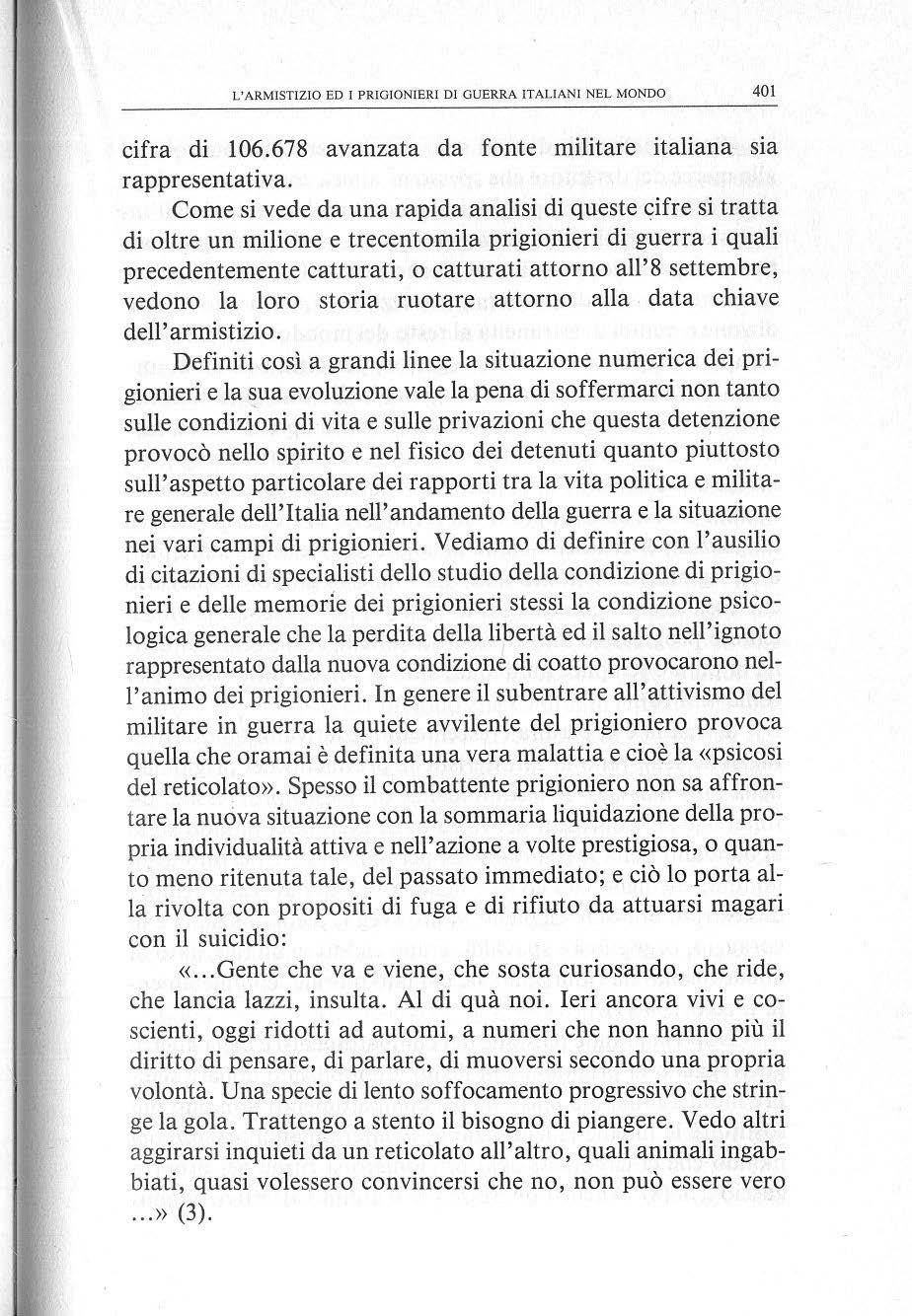
Spersonalizzati, distinti solo dal numero di matricola ed alla mercè del detentore che spesso ne ab u sa con avvilente derisione del prigioniero i prigionieri paiono molto lontani dall'interessarsi a l seguito di questa guerra ne ll a quale erano parte attiva e magari rilevante fino al giorno prima. Pertanto la prima re azione è quella dell'estrema tristezza per questa nuo va condizione e quindi di estraneità al resto del mondo: «La gente nei campi di prigionia non vive, vegeta o, per dirla con un autore russo, vive al limite della fisio logia » (4). Ed una altra testimonianza:« ... La vita che trascorrevamo era sempre la stessa, monotona ... » (5). Ed un altro ancora: « ... Costretto a vegetare, inutile a sè e agli a ltri ... in pochi metri quadrati di terreno: mille uomini chiusi ad esempio in un rettangolo di trecento metri di lunghezza per centocinquanta di larghezza. Nessuno saprà mai, e il prigioniero restituito alla vita non è in grado di spiegarlo che cosa scientifi came nte sia la «psicosi del retticolato» cioè il lento e progressivo annientarsi dell'intelligenza, scintilla divina in pura e semplice animali tà, sino al vertice infuocato della follia ... » (6).
L'apatia e la perdita crescente di iniziativa in qualsiasi situazione semb r ano le caratteristiche prevalenti dei pr igionieri nella lo ro massa; e le testimonianze di questo progressivo disinteresse nei confronti del resto degli eventi del mondo sono ab bond anti nella memorialistica dei reduci: « ... Perfino degli uomini, che nella vita civile e nelle nostre file avevano semp re dimostrato di essere elementi molto sveg li, pieni di azion e e di coraggio, org ogli osi e s pa vald i , erano caduti in un tale stato di abbattimento da ridursi, anche dal lato morale, completamente a zero ... » (7).
Dopo la grande tensione del combattimento e della guerra guerreggiata la prigionia con il suo immobilismo appare sempre intollerabile : «la tensione del combattimento non può più sostituire le lunghe elucubrazioni, le interminabili assenze del mondo ch e ci circonda; ogni prigioniero si ritrae nel proprio guscio ... » (8). Anche l'interesse p er il mondo affettivo e fami-
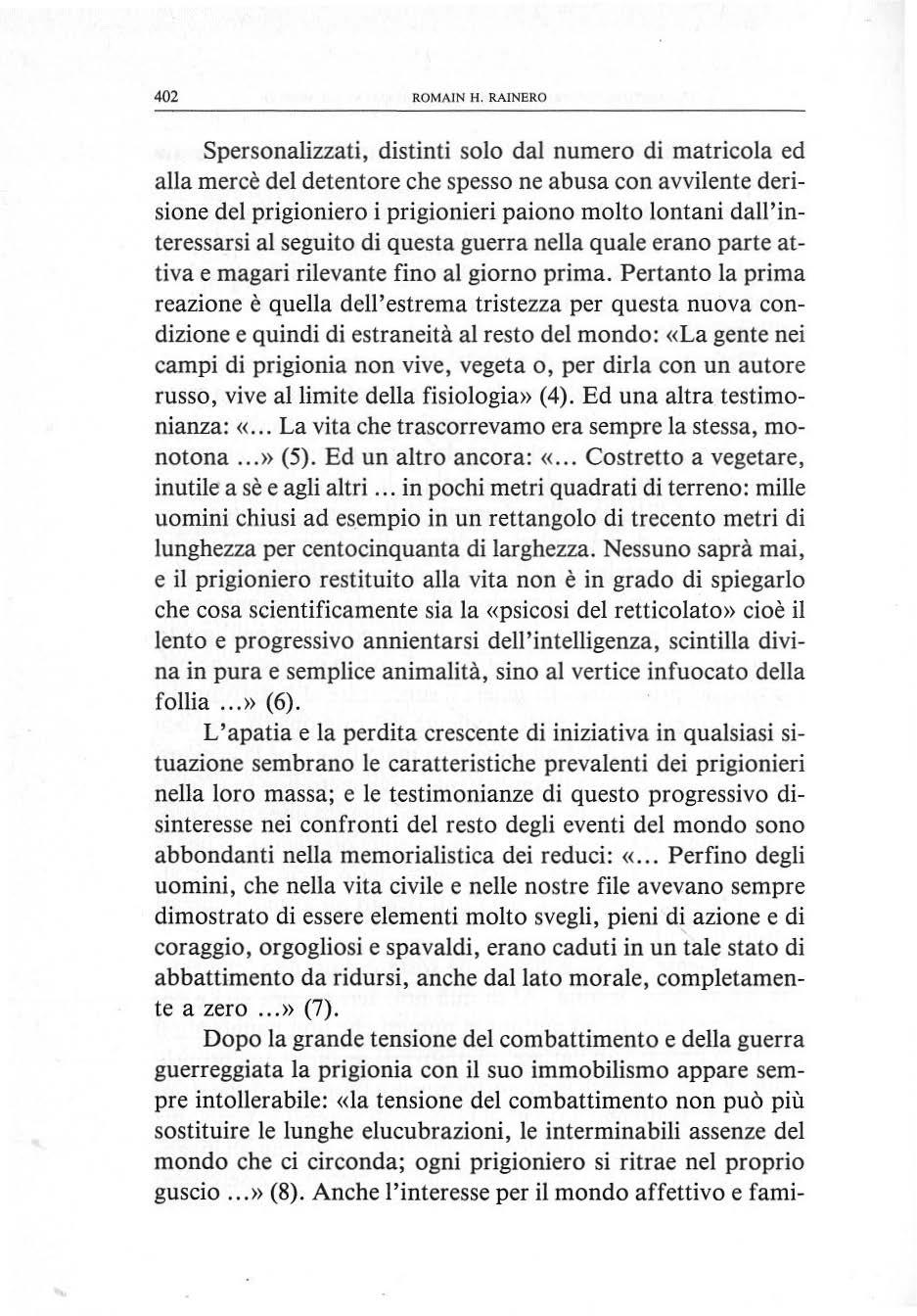
liare pareva dissiparsi nel nulla: « ... Non pensavo più a casa, non mi interessava più il resto del mondo, era come una cosa che non mi riguardasse dalla quali fo ss i dista ccato per s empr e come quando si lascia una località dove si ha la certezza di non to rnare .. . » (9).
Persino il pensare pare inutile: «Dimenticando tutto e vivendo come un orso non si sentono bisogni morali che non si potrebbero soddisfare» (10). Pers ino i rico rdi non paiono validi riferimenti: « ... lo vedevo di rado il cielo e il filo spin ato, stavo so lo , con gli occhi fissi a r ivivere giornate che sembravano lontane come se non fossero st ate della mia vita ... » (11) .
M a anche a questo riguardo, cioè riguardo all'atteggiamento dei prigionieri nei confronti del mon do esterno e quindi anche della gu erra che continuava senza di loro, gli ex-mili tari italiani subirono in via generale delle alternanze significative a seconda del periodo della cattura e a secondo dell' an damento del conflitto d i cui alla lo ntana avevano echi s offocati. Si può dir e in generale che anche al di là delle situazioni personali certamente grav i vi fos se n el periodo che Churchill chiamò « la loro ora più bella» cioè della massima affermazione bellica dell' Asse, specie nel Nord Africa, un certo tipo di sicurezza quanto alla sorte definiti v a della guerra ed all e s ue scelte di fondo acco mp agnasse il prigioniero di guerra. I nemici erano nemici; l'Ital ia era quella che si conosceva con il Duce ed il Re; ai prigioni eri era toccata una s orte amara ma sapevano abbastanza bene chi od iar e e chi celebrare nel loro cuore. Luigi Pignatelli oss ervò a questo riguardo che «salvo sporadiche eccezioni , latotalità (dei prigionieri) era favorevole alla guerra, ne seguiva gli sviluppi con intenso int eress e e, almeno so t to questo punto di v ista, sarebbe gravem e nte inesatt o dire che non nutr isse s entimenti fascist i e non riponesse la s ua pi ena fiducia in Mu ss olini, attribuendogli v irtù taumaturg iche che gli avrebbero permesso di cog liere la vittoria a l momento stabilito e di restaurare con successo la situazione anche dopo i peggiori rovesci ... » (12). In que sta prima fase gli antifascisti erano pochi ed incerti, che
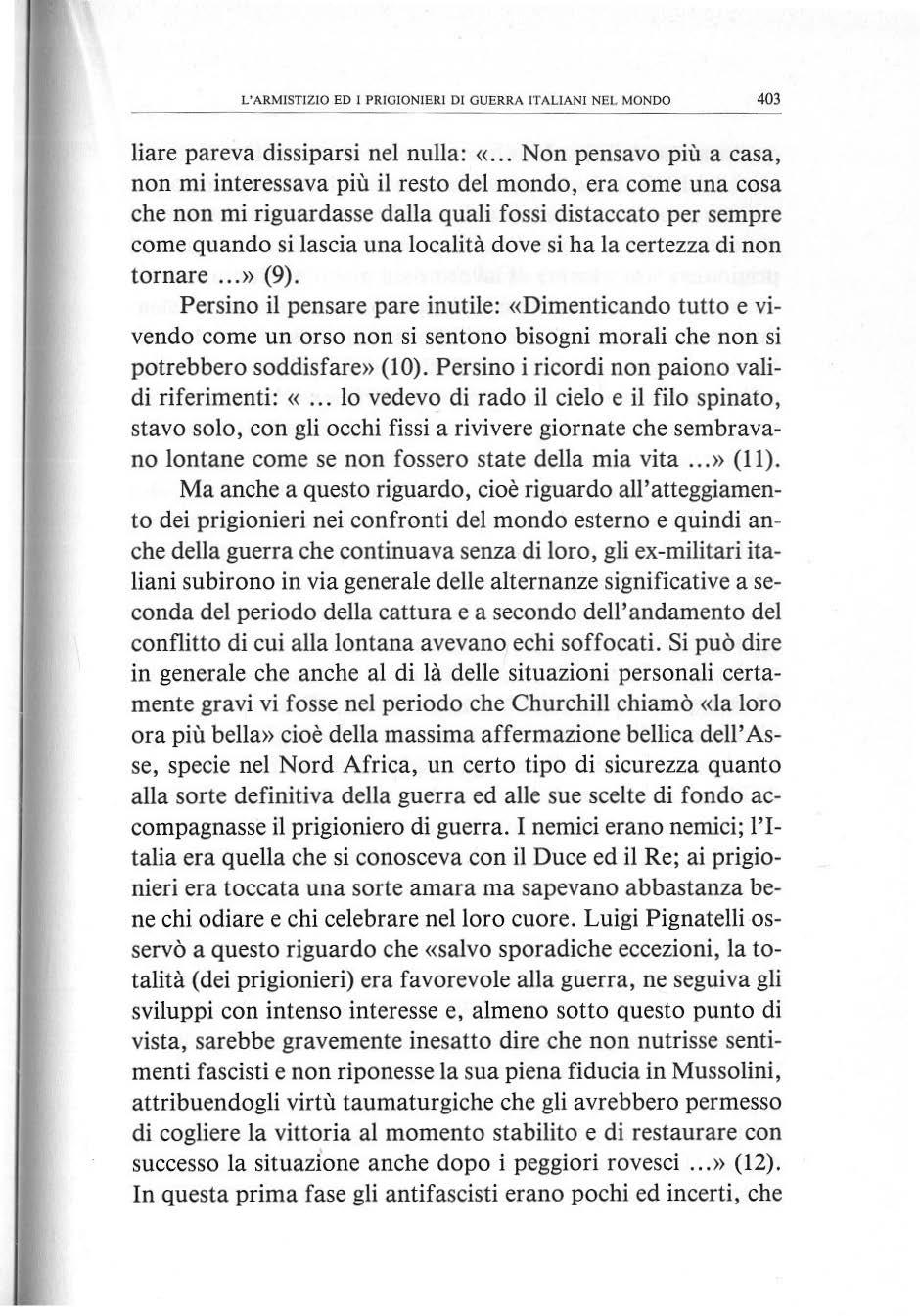
qualcuno ha definiti «le anim e smarrite, incert e» (13). Fino agli ini zi del 1943 anche da parte dei detentori l'azione politica pareva aver p oche probabilità di riuscita; questa azione mira va a creare sul piano immediato la possib ilità di avviare masse di prigionieri verso forme di lavoro e su l piano più lontano a favorire la nascita di mo vimen ti di opinione antifascista avvalendosi spesso anche dell'azione di fuoriuscit i italiani di fede antifascista. Questo per esemp io fu il caso dei prigionieri itali ani nelle mani sovietiche i quali ebbero attraverso l ' azion e dei comuni sti italiani stabilitisi da tempo a Mosca una «voce» ufficiale, cioè un periodico, «L'Alba» che definitosi «organo dei prigionieri italiani in Russia», che li esortava a separare il «loro» caso da quello delle gerarchie fasciste coinvolte nell e responsab il ità della guerra. In generale però sia questa sia altre azioni di tipo politico ideologico non ebbero molto successo. Nei campi di detenzione in Africa come in India ed altrove ogni ricorrenza patriottica serviva da occasione per ritemprare «l'orgog li o na zionale». Ben lo ricorda Ferdinando Bersani: « ... Alle ore 20 commemorazione del Natale di Roma e Festa d el Lavoro. Si cantano gli inni patri. Lo stesso avviene negli altri campi. Movimento insolito di pattuglie inglesi armate che cercano indi viduare chi canta . È la massa ... » (14). Addirittura i campi sono spesso i luoghi nei quali si manifestano gli irrigidimenti ideologici più sever i tra gli stessi prigionieri spess o vittime degli irriducibili fascisti alla ricerca di «colpevoli» e «trad itori » da punire. In attesa della «immancabile vittoria» que sti gruppi di fascisti ebbero spesso la mano lib era sui mo l ti altri inerti o delusi, troppo inerti e troppo delusi per reagir e collettivamente a questi ultimi s oprusi. Nota il Pini al riguardo: «Fra i pochi antifascisti e molte, troppe anime smarrite e indecise, i littori in attività di servizio ebbero cos ì buon gioco e non esitarono a giungere alla sopraffazione est rema: quella cioè di costituire tribunali speciali per registrare accuse e sentenze da portare in patria» (15). Molte testimonianze ce lo confermano:« ... Si riunivano in congreghe notturne e giudicavano fra loro i dissen-
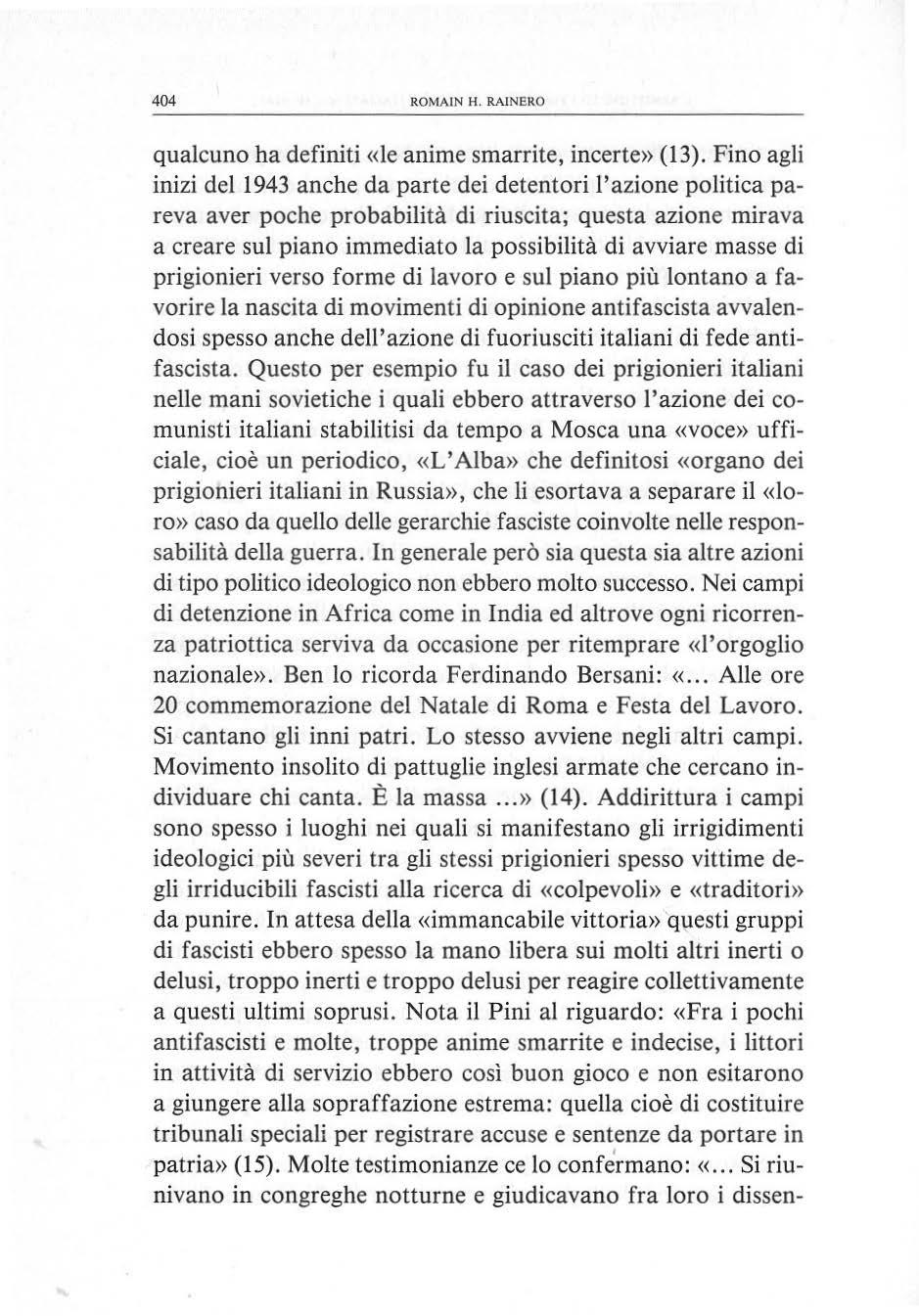
zienti: assolvevano, cçndannavano e compilavano strani verbali che nelle loro speranze, dopo l'immancabile vittoria, avrebbero dovuto portare un certo numero dei loro compagni di pena davanti al plotone di esecuzione» (16). E questa è la testimonianza dell'ultimo prefetto di Tripoli, Denti di Pirajno confermata nella sostanza da molti altri, non ultimo, l'ex corrispondente di guerra del «Corriere della Sera» Alfio Berretta costata nelle sue Memorie: «I fascisti dominarono i campi e li tennero in ferrea soggezione. Chi deviava, chi si ribellava era punito e le punizioni consistevano in atti di violenza inumana ... » (17).
Solo se si tiene presente questo clima si possono capire i molti problemi che assillarono anche sul piano interno i campi di prigionia che vivevano queste lotte interne e che talvolta ebbero modo di registrare prese di posizione che rasentavano l'assurdo. Quale il testo di una comunicazione di un «comando italiano» di un campo ad intenzione dei prigionieri:
«La Patria è una, indivisibile: l'Italia Fascista. Parlare oggi di antifascismo equivale accordarsi alla propaganda del nemico. Il nemico tende alla sc issione degli italiani proclamando di far guerra al Regime e non al popolo italiano.
Ormai è bolsa la propaganda nemica.
Per ignoranza si può abboccare.
Per malafede la si può accetttare.
In un campo di prigionieri di guerra non è ammissibile far questioni di Regime.
Il soldato ha combattuto per l'Italia una e fascista.
Un'arma il soldato prigioniero pos siede e deve adoperare: la fede.
Fede schietta che ha un nome: Patria - Italia Fascista.
Fede schietta che ha una forma: Disciplina.
Chi viola comunque la disciplina rende un servizio al nemico» (18).
Un simile documento non è l'unico del genere ma ha il pregio di essere forse l'ultimo di questo tipo ad essere emanato in quanto reca la data del 23 giugno 1943 ed anche se la sede nella
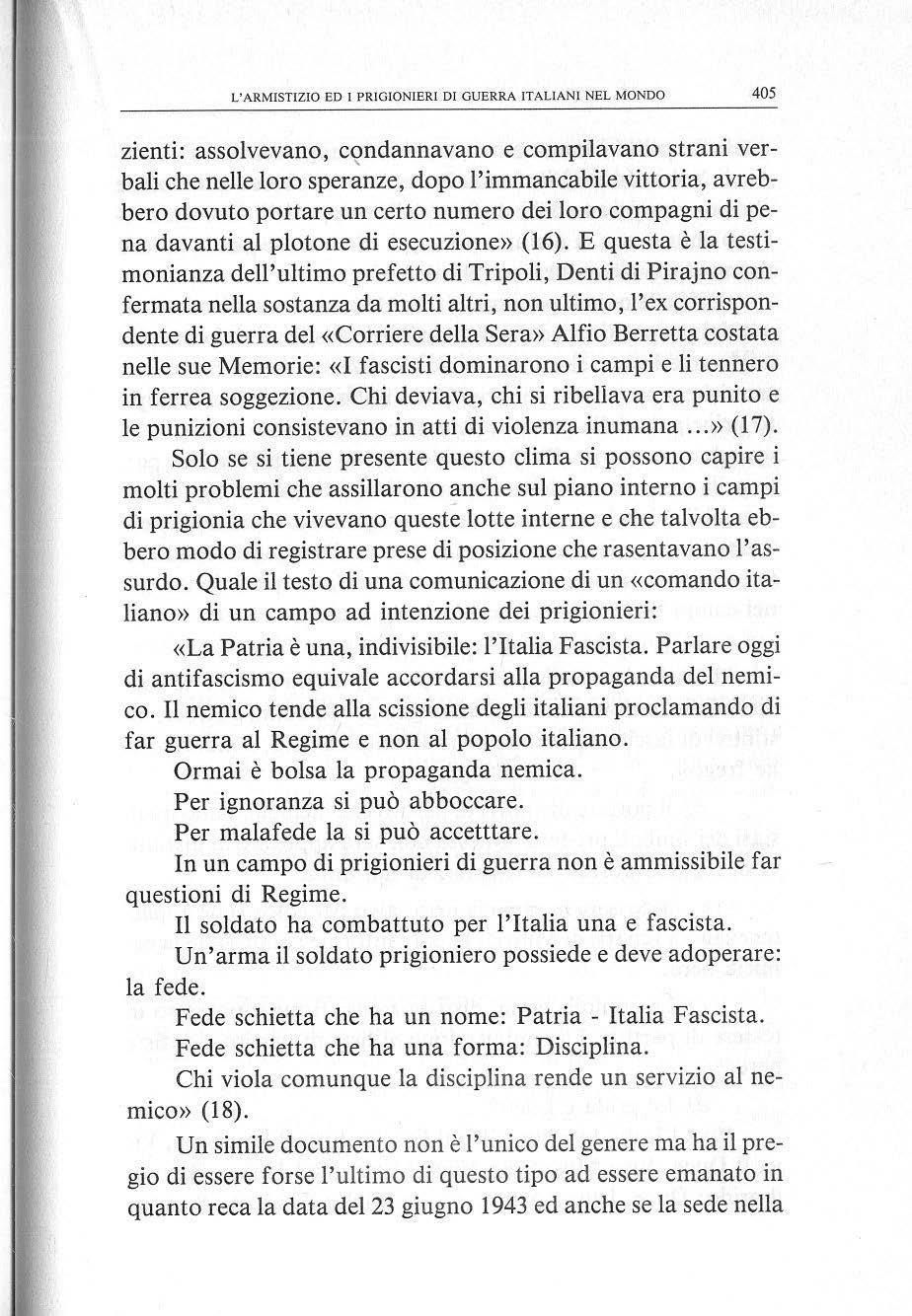
quale fu scritto è lontana dai campi di battaglia essendo il campo di Yol in India è in fondo la reazione rabbiosa alle notizie che pur giungev ano delle disfatte delle truppe dell'Asse che avevano chiuso con la disfatta poco più di un mese prima la loro drammatica avventura nel Nord Africa . Difficile quindi pensare ad una efficacia se non limitatissima dei propositi di «defascitizzazione» auspicati dai comandi anglo americani e che uno speciale documento delle autorità britanniche a proposito dei prigionieri italiani ritenevano compito principale della potenza detentrice. Ma questo obiettivo di «produrre un corpo d'italiani addestrati ad assumere la loro parte nella costruzione della nuova Italia» si rivelò a lungo irra ggiungibile vista la situazione nei campi (19). La stessa documentazione britannica ce ne offre la ripro va allorquando le autorità preposte ai campi dovettero codificare la serie dei divieti che nei campi dovevano aver esecuzione, e cioè:
a) L'esposizione di ogni forma di: Il fascio, la svastica, il sol levant e, le lettera P .N .F., le bandiere delle nazioni n emiche , immagini di Mussolini e Hitler, distintivi di fascio esclusi i membri di unità fascista, il motto «Me ne frego».
b) il portare distintivi di partito che includano uno qualsiasi dei simboli predetti. Questo rion sarà applicato ai distintivi di reparto portati da membri di tali unità.
e) indossare la camicia nera sa lvo per coloro che appartenevano a reparti di Milizia, la cui uniforme comprende la cami cia nera.
e) La compilazione, distribuzione, firma e possesso di tessere di partito. La compilazione di liste di partito e di li ste nere.
d) Le grida e i detti: Viva l'Italia fascista, Viva il Fasc io, Viva il Fascismo, Viva il Duce, Viva Mussolini, Viva l'Asse, Heil Hitler, Banzai; il grido: Duce, Duc e, A noi, eia eia Alalà; il saluto alla voce
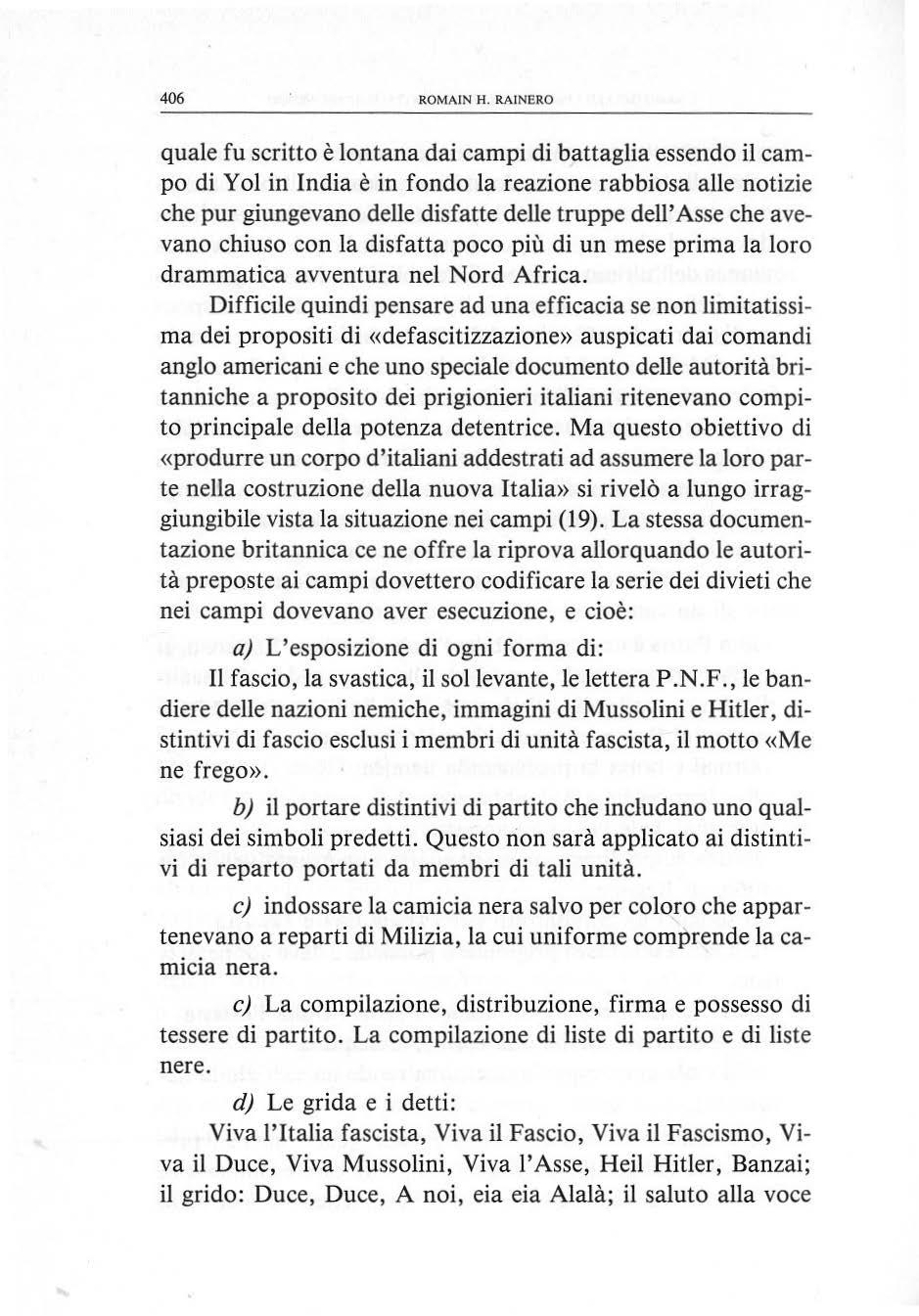
risposta per Mussolini, il richiamare «Il duce» e la risposta «Evviva» alla fine delle adunate, il canto di Giovinezza, il canto di Deutschland ueber alles, il canto dell'inno giapponese.
f) iscrizioni:
Ogni scritta riferita a cose britanniche o alleate o persone precedute dalla lett era «M» (che significa morte) e ogni scritta riferita a cose o persone italiane o di altri paesi nemici precedute da «Evviva» o dal sim bolo W. La scritta «Viva l'Italia», «Viva il Re» è permessa» (20).
Dall 'i n si eme della documentazione raccolta e qui solo in parte citata si può dire che la prima fase può essere ritenuta di sostanziale immobilismo politico dei prigionieri. Un'unica breccia potè aprirsi allorquando da parte di taluni detentori si diede la possibilità di passare dallo st ato di coatt i allo stato di «lavoratore» o come si diceva allora di «cooperante» . Anche in questo caso però l'irrigidimento iniziale fu notevole e l'affermazione riportata dal Pini secondo cui «co lui che in terra britannica fa nasce re anche una so la spiga di grano tradisce il duce e l'Italia» può dare la misura del rifiuto politico opposto a questa evoluzione (21). Altre testimonianze fanno apparire nella sua luce drammatica il problema che peraltro fu risolto dalle truppe dei detentori con provvedimenti autoritari di lavoro coatto. Nel rifiuto stava spesso un ragionamento politico generale di so lidarietà ver so chi era rima sto in pa t ria a combattere quegli stessi nemici che chiedevano il lavoro de l prigioniero: «Ogni passo fuori dal reticolato è un contributo al nemico. Tale affermazione potrà a prima vista sem brare apparente, invece era sostanzial e. Perchè alcuni mi rispondevano, esprimendosi così: ma io vado a raccogliere patate e questo è ammesso dalle leggi internazionali .. . Si, però ... al posto del negro, che raccoglieva patate, ci sei tu ... e forse! ... in Italia, quel negro sta distruggendo o saccheggiando la tua amata casa ... ed ancora di più ... approfitterà dei tuoi cari ... moglie, sorelle, ... figlie ... »(22).
Il problema del lavoro quando non era del tutto coatto ma veniva richiesto dal detentore con spontanea adesione del pri-
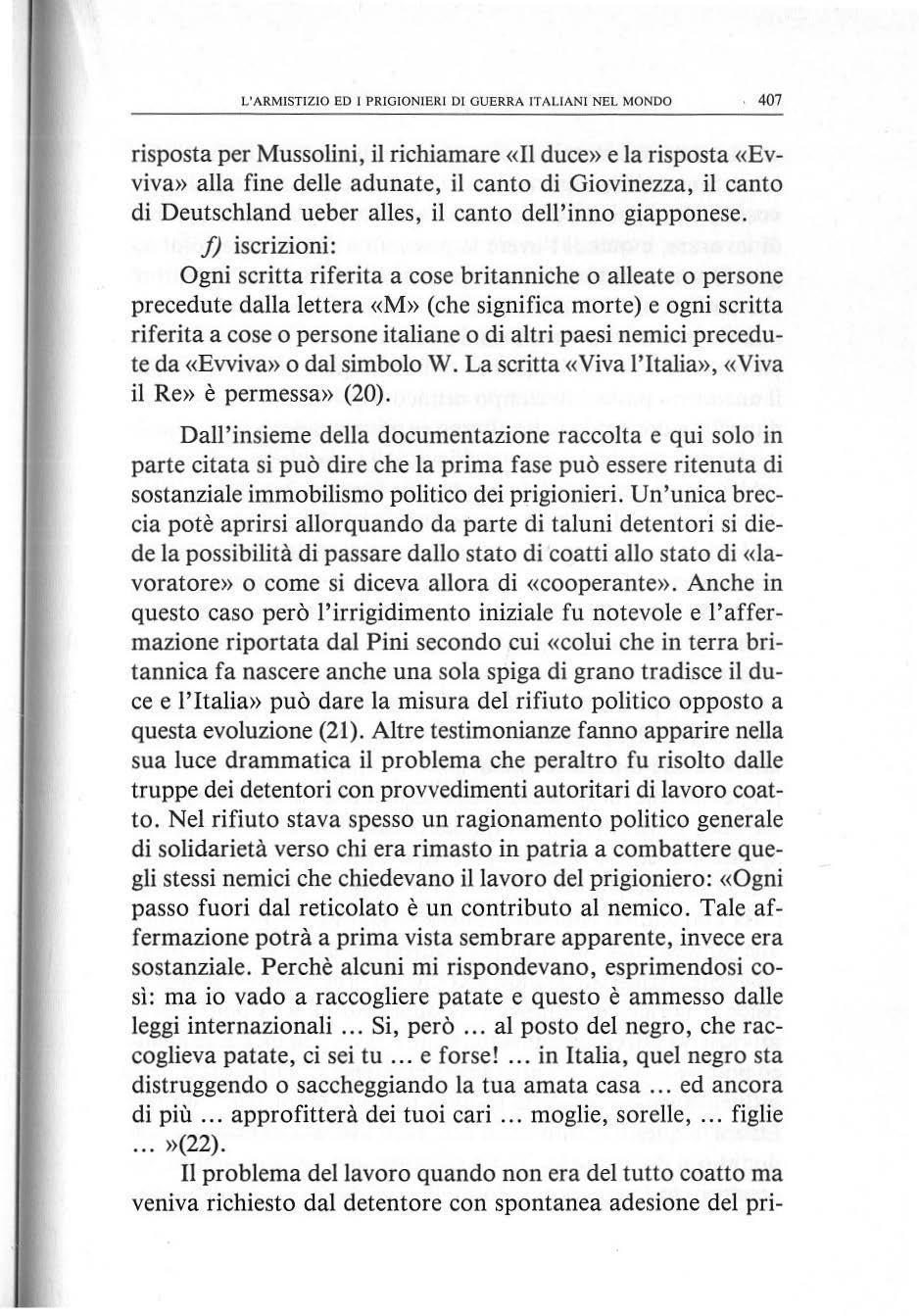
gioniero suscitò notevoli divisioni tra gli stessi prigionieri. Infatti mentre l'uso autoritario del prigioniero italiano non provocava conseguenze di tipo genera le, l'esprimere una volontà di lavorare , e quindi l'avere la possibilità di rifiutare coinvolgeva il sottoscrittore in un rapporto con il proprio detentor e che andava al di là dello status di prigioniero e lo poneva in una via intermedia verso l'uomo libero; i vari «prigionieri sulla parola» erano forse in quanto tali ed in quanto lavoratori per il «nemico» passati in campo nemico e quindi da ritenersi traditori? La domanda ebbe alterne risposte pratiche fino a quello che ritenuto il documento-chiave nella que sti one e cioè il cosiddetto «accordo di Eldoret» che fu firmato il 27 luglio 1942 dal gen. Guglielmo Nasi con le autorità britanniche nella sua veste di vice-governatore dell'Impero e di ufficiale di più alto grado tra i prigionieri italiani dopo la morte del duca d'Aosta, viceré d'Etiopia (23). In esso ogni prigioni ero veniva lasciato lib ero di accettare o no di lavorare per le autorità inglesi ma venivano legittimati co loro che si impegnavano in tali lavori. L'impegno portava alla «libertà sulla parola» e quindi ad una certa libertà del prigioniero che avrebbe potuto così riprendere una vita che li potesse emancipare da quella «patologia della prigionia» che mortificava tutti e tutti minacciava nel corpo come nello spirito. Anche in questa occasione il risvolto politico appare evidente con un doppio tipo di reazione: di consenso e di rifiuto. «Ognuno che non fosse contaminato dalla fede littori a applaudì al contratto, anche se ad esso non era estranea una convenienza logistica dei padroni di casa. Chi per cuore ed intelletto ri usciva a rendersi co nto del progressivo scadimento fisico e morale cui la lunga prigionia sottoponeva tanti giovani, riusciva altresì ad ammettere che il lavoro in un paese nemico potesse essere di natura tale da mantener si al di fuori d'ogni influenza su lle sorti della propria na zione in guerra ... » (24). Ed era in questo spirito che il gen. Nasi ave va concluso l'accordo; «ho il dovere, disse in un incontro con i prigionieri, di ricondurre in Patria degli uomini ancora validi, non degli sche-
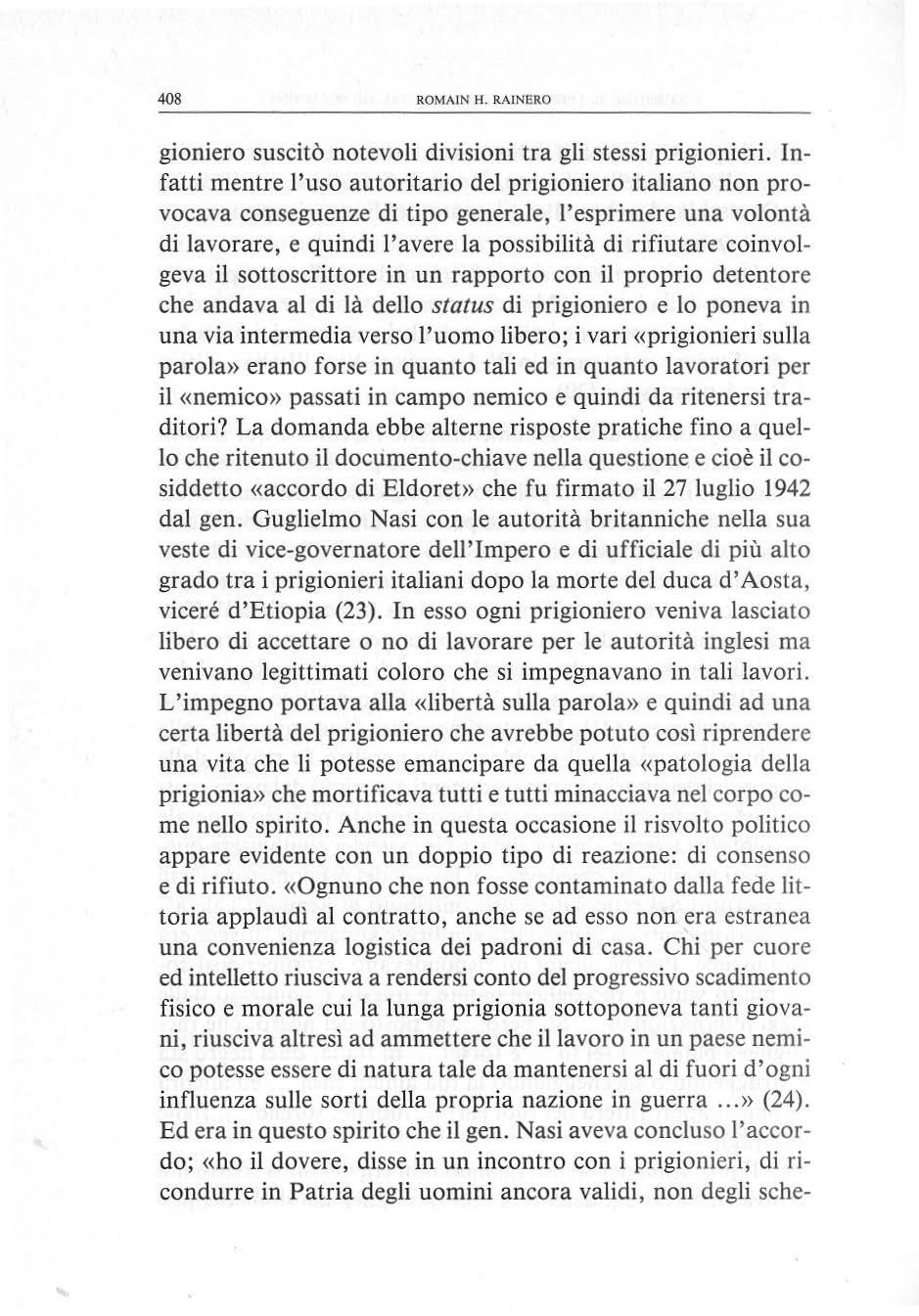
letri; quindi sulla base degli accordi intercorsi fra noi ed il comando inglese, uscite tranquilli dai campi, facendo lavori che non siano incompatibili col vostro onore di soldati e di italiani ... »(25). Non fu sempre capito questo atteggiamento e per molti nostalgici fascisti l'accordo di Eldoret era viziato di tradimento e pertanto chi lo sottoscriveva veniva sottoposto all ' ostracismo ed alle violenze di costoro che predicavano la non collaborazione assoluta con il nemico.
Abbiamo voluto accentuare con maggior attenzione a questi problemi non solo perchè si posero ad una quantità notevole di prigionieri italiani (essendo l'eccezione solo la Germania e l'URSS) ma perchè prefiguravano con le loro problematiche i molti problemi che l'evoluzione politica dell'Italia doveva rendere acuti nell'animo di ogni prigioniero militare e civile. Duratura tensione politica, quotidiana difficoltà di rapporti con le autorità detentrici, ignoranza permanente di ogni notizia sulla guerra ed infine assoluta impreparazione ad una corretta vita politica furono tutti elementi che resero in tutti i campi di prigionieri italiani drammatica la situazione all'annuncio della caduta del fascismo in Italia. Il 25 luglio rappresenta a questo livello una vera rivoluzione, una vera mutazione di fondo che sconvolse dalle basi l 'intero edificio sul quale lo sforzo bellico e la stessa sofferenza della prigionia era costruita. «Sebbene, osservò Luigi Pignatelli, molti di noi si andassero convincendo della trag ica situazione militare in cui si trovava il nostro paese e si rendessero conto delle insostenibili responsabilità ricadenti sul fascismo e sul suo capo per aver condotto la nazione alla disfatta, la n<:>tizia della caduta del fascismo giunse ai più inattesa e provocò, tra i prigionieri, reaz ioni assai diverse da quelle che ebbe nel Regno ... »(26). La notizia stessa della caduta del fascismo suscitò addirittura incredulità poichè le stesse sconfitte del!' Asse venivano attribuite alla propaganda nemica, così la caduta del fascismo pareva frutto di un'ennesima manovra di questo tipo. «Insensibili, ormai ed increduli alle bugie di tutte le radio-trasmittenti arrivammo ignari all'ormai famo-
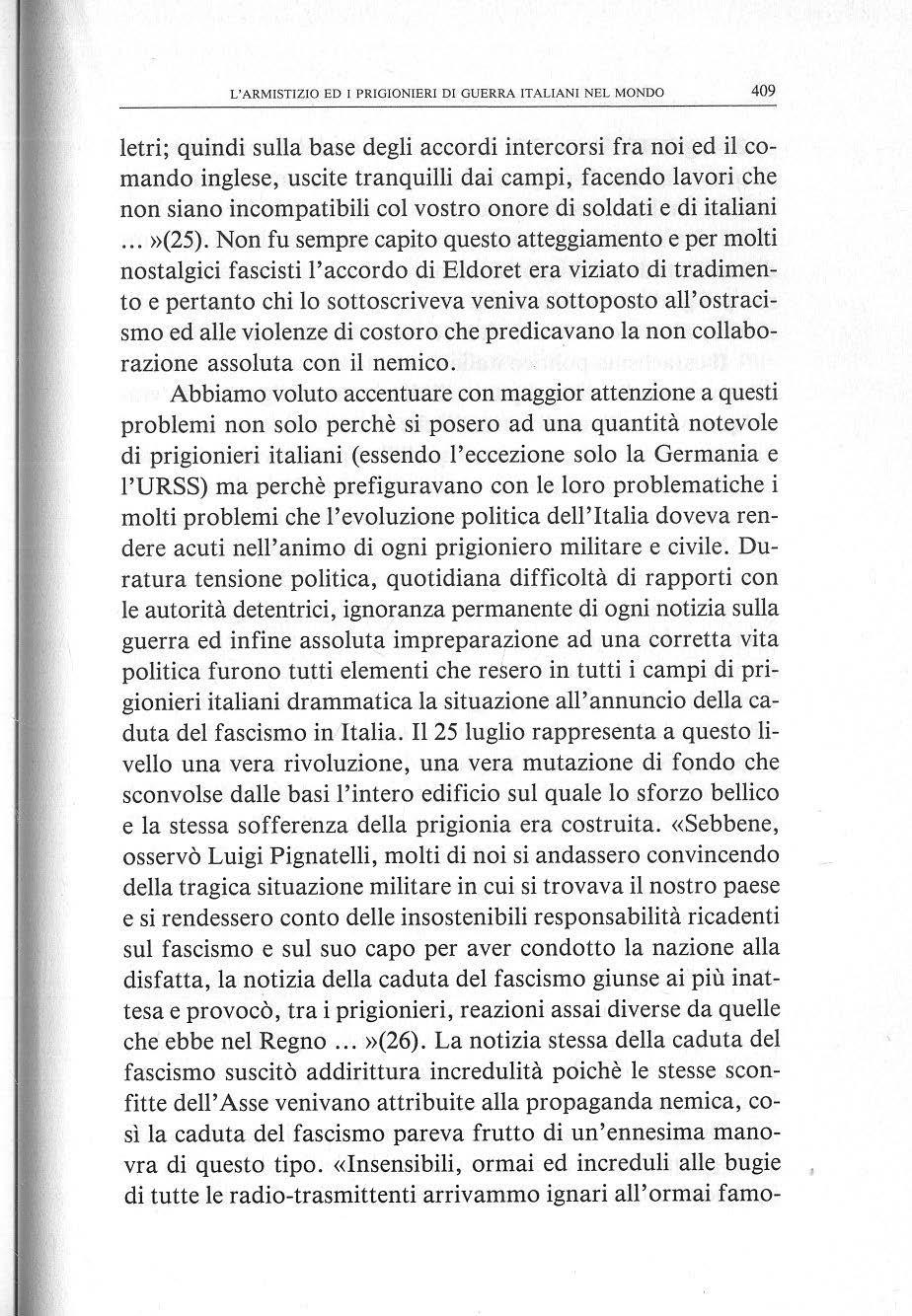
so 25 luglio 1943 ... » (27). Le perplessità ed il disorientamento di queste masse di prigionieri alle prese con una nuova realtà furono totali; « ... ed una mattina, scriveva dall'India Alfio Berretta, ritornando dalla conta, sentiamo tutti gli altoparlanti radio istallati da pochi giorni suonare la Marcia reale a non finire e poi gridare che Mussolini non c'è più. Alcuni dicono tradimento, altri meno rp.ale, ritorneremo subito a casa (28).
Il cataclisma politico italiano venne vissuto anche a livello di un vero crollo di ogni punto di riferimento; digiuni com'erano questi ex-militari di tutto ciò che avesse attinenza ai sistemi di democrazia parlamentare ai quali il re pareva voler ritornare con un nuovo «incarico» di governo al mar. Badoglio, la novità venne sentita senza il necessario bagaglio di riferimenti pr ecisi. L ' unico elemento che suonò familiare nel proclama di B adoglio che sigillava questa grande novità fu l'affermazione «la guerra continua» che quindi doveva significare che poco o nulla era cambiato quanto ai rapporti con i detentori: erano ancora nemici. Lo sbandamento vi fu, ma non provocò profon de divisioni tra le masse dei prigionieri. Ce lo conferma, tra gli altri, il Piccini che scrive: « ... il 25 luglio, anche se imprevisto e improvviso, non aveva prodotto divisioni o sbandamenti: era stato accettato da tutti, anche dagli ufficiali della Milizia e dalle Camicie nere che a v evano ubbidito all'ordine di mutare i distintivi dei fasci con le stellette. Si sperò da parte di ognuno "in una più chiara condotta di guerra e rinacque l'estrema fiducia nella buona stella italiana: il famoso Stellone ... » (29). Il riferimento al Re ed al militare chiamato a dirigere il governo, cioè al mar. Badoglio eran elementi di pacificazione degli animi ch e presero solo ad interrogarsi con nuove ansie sul proprio futuro . Da parte loro i detentori mostravano di gradire la caduta del fascismo in Italia anche se nulla o poco parve mutare nei loro atteggiamenti.
Di questi momenti tragici sono documenti coevi e convincenti quanto andavano sc rivendo nei bollettini dei vari campi i prigionieri che dovevano pure rende re conto dello loro scelte
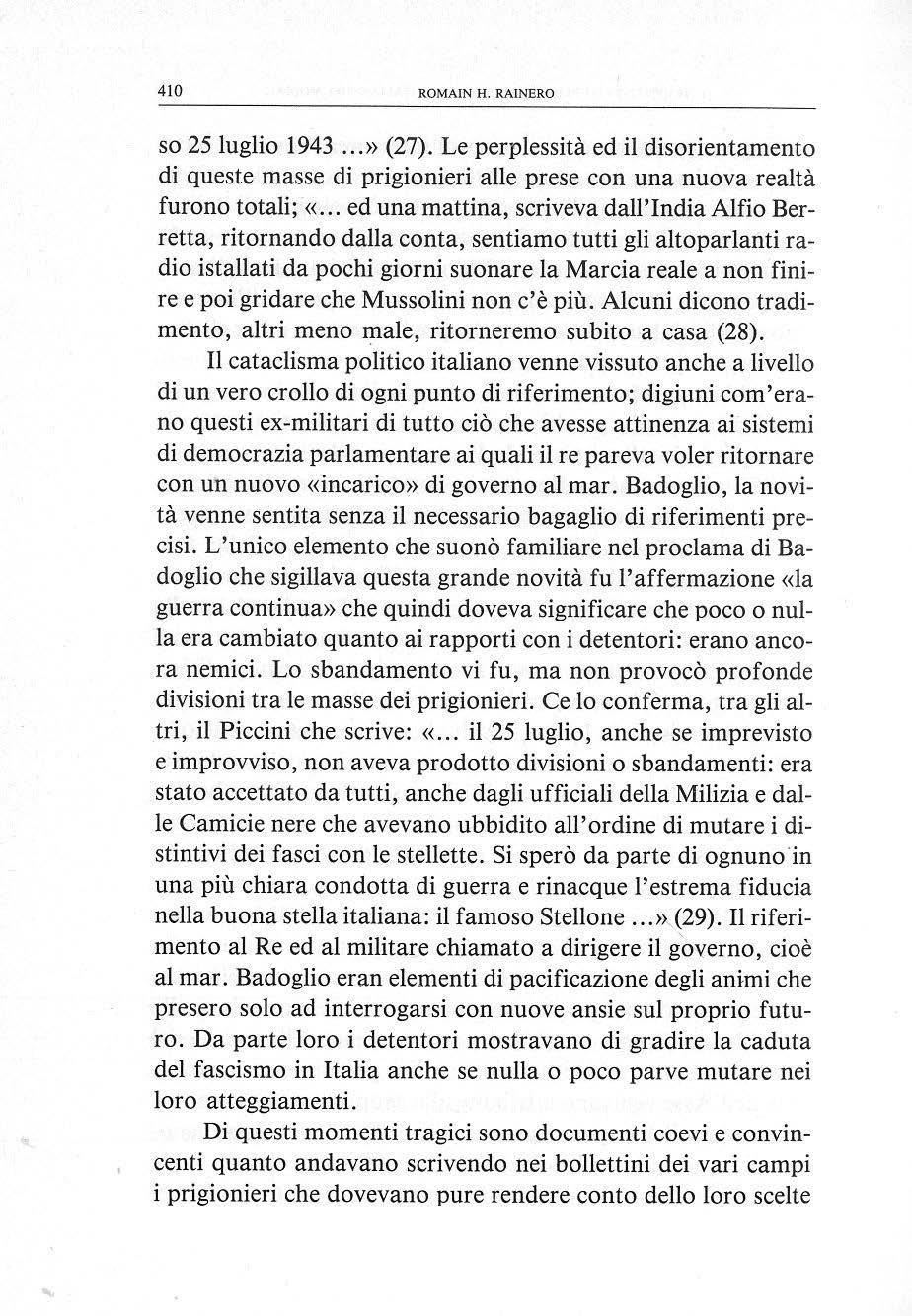
e quindi -delle novità italiane. Anche se tali pubblicazioni andavano soggette alle censure relative appare interessante notare che in questo breve periodo dei quarantacinque giorni l'antifascismo non ha difficoltà ad essere affermato e a gettare tra gli ex-militari un certo ponte di unanimità. Tutto ciò appare peraltro sospeso ad un filo che si spezzerà 1'8 settembre con l'annuncio della conclusione dell'armistizio con le Nazioni Unite.
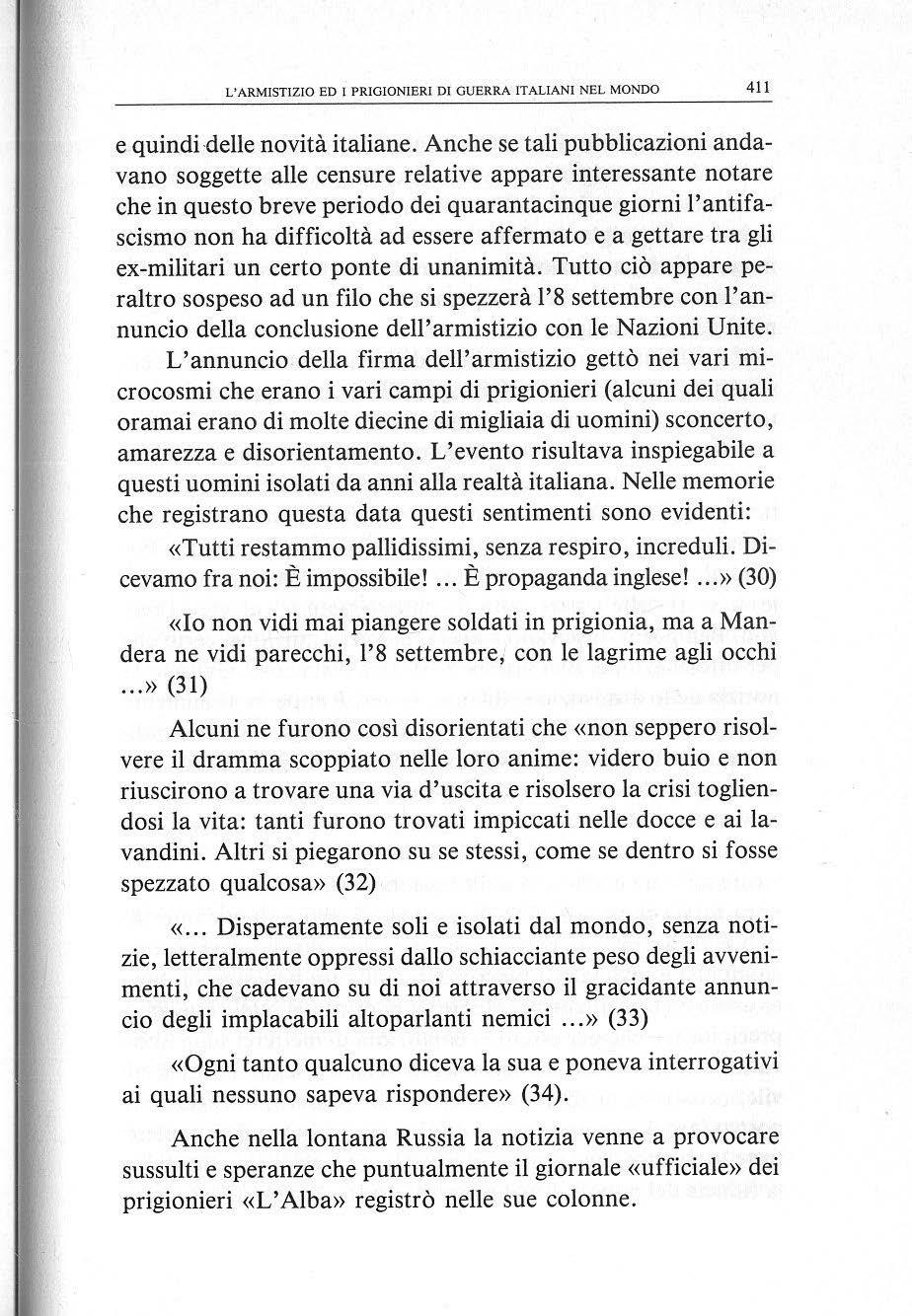
L'annuncio della firma dell'armistizio gettò nei vari microcosmi che erano i vari campi di prigionieri (alcuni dei quali oramai erano di molte diecine di migliaia di uomini) sconcerto, amarezza e disorientamento. L'evento risultava inspiegabile a questi uomini isolati da anni alla realtà italiana. Nelle memorie che registrano questa data questi sentimenti sono evidenti:
«Tutti restammo pallidissimi, senza respiro, increduli. Dicevamo fra noi : È impossibile! ... È propaganda inglese! ... » (30)
«Io non vidi mai piangere soldati in prigionia, ma a Mandera ne vidi parecchi, 1'8 settembre, con le lagrime agli occhi
» (31)
Alcuni ne furono così disorientati che «non seppero risolvere il dramma scoppiato nelle loro anime: videro buio e non riuscirono a trovare una via d'uscita e risolsero la crisi togliendosi la vita: tanti furono trovati impiccati nelle docce e ai lavandini. Altri si piegarono su se stessi, come se dentro si fosse spezzato qualcosa» (32)
« ... Disperatamente soli e isolati dal mondo, senza notizie, letteralmente oppressi dallo schiacciante peso degli avvenimenti, che cadevano su di noi attraverso il gracidante annuncio degli implacabili altoparlanti nemici ... » (33)
«Ogni tanto qualcuno diceva la sua e poneva interrogati vi ai quali nessuno sapeva rispondere» (34).
Anche nella lontana Russia la notizia venne a provocare sussulti e speranze che puntualmente il giornale «ufficiale» dei prigionieri «L'Alba» registrò nelle sue colonne.
Nuova spaccatura tra di essi tra coloro che si mostravano irriducibili nostalgici e quindi nemici dei detentori ad oltranza e coloro che convinti dell'imminenza della fine della guerra e quindi della prigionia si diedero a manifestazioni di euforia e magari di riconciliazione con le autorità dei campi. Passato il momento della novità nulla peraltro mutò nella vita dei prigionieri nei vari campi.
Pochi, troppo pochi ebbero della vicenda una visione costruttiva come la ebbe Luigi Pignatelli che ne seppe capire tutta l'importanza e tutta la portata:
La notizia dell'armistizio giunse come un fulmine a ciel sereno: molti avevano sperato che, eliminate le interferenze politiche, raggiunta fra gli italiani una maggiore concordia nel comune intento e restituito il comando delle forze armate a uomini di sicura esperienza militare e di alto ascendente personale, le sorti delle nostre armi avrebbero potuto volgere al meglio. Ben pochi riu scivano a avere, più per intui zione, certo che per informazione, una visione realistica della cose . Quando la notizia dello armi st izio si diffuse, la verità apparve finalmente tutta intera: coloro che per essere meglio degli altri in grado di valutare la situazione avevano il dovere di illustrarla ai loro compagni, non mancarono di compiere ogni sforzo affinchè la concordia che aveva sempre regnato fra noi non si spezzasse e ognuno comprendesse che il nostro paese, giunto alla catastrofe militare e alla resa a discrezione, si trovava bensì altermine fatale di un cammino di inganni, di errori, di millanteria, di pubblica e privata prepotenza, ma s'era altresì posto all'inizio di una nuova via da percorrere, dall'altra ben diver sa, tanto aspra ed erta quanto profondo il baratro nel quale eravamo precipitati; e che per essere in condizioni di metterci sulla nuova strada, confortati dal se ntimento della conseguita libertà civile, occorreva meditare sugli errori del passato, alleggerire il nostro fardello di non poche utopistiche aspirazioni, compiere tutte le rinunce che la patria ci avrebbe richiesto, riguadagnar e la fiducia dei popoli. Ripetevamo ai nostri compagni di prigio-
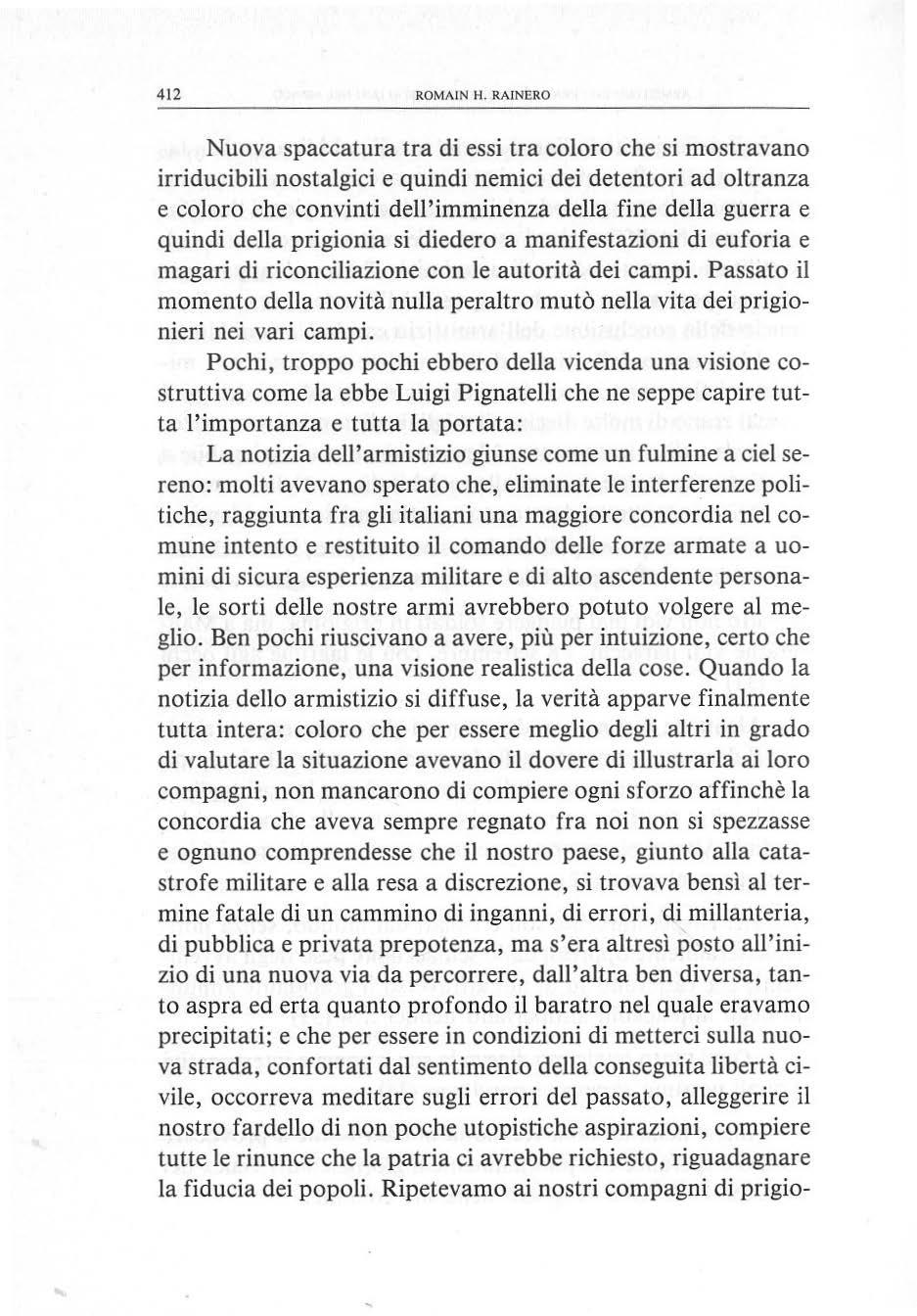
nia che se la sfortuna ci faceva trovare in quel tormentato momento , lontani dal nostro paese, anche da questa triste condizione potevamo trarre vantaggio, essendo dato più a noi che ai nostri connazionali di volgere, senza preoccupazioni immediate, senza minacce o pressioni, uno sguardo sereno sopra uomini e cose del passato, sopra i doveri nostri del presente, sopra l'avvenire.
Ai più la notizia portò solo sgomento, incredulità ed incertezza anche perchè sul piano concreto l'armistizio segnò l'inizio di disordinate manifestazioni da parte dei prigionieri e soprattutto ad una parve mutare: i prigionieri rimasero prigionieri ed i detentori sembravano acconciarsi a rimanere tali, quasi in eterno. Specie questi ultimi dimostra:r;ono una certa miopia o meglio una mancata politica d i apertura, di generosità che non doveva certo essere solo vista quale generosità vera e propria bensì intelligente uso d~lle occasioni offerte da questi uomini disposti, in questa nuova situazione, a costruire un nuovo avvenire alla loro patria. Invece si verificò ciò che Gabrio Lombardi ha definito con efficace immagine l'anelasticità degli alleati nei confronti degli italiani in generale e dei prigionieri in particolare. Procedure caute e lentezze burocra t iche congelarono, unendosi ad una certa diffidenza, la situazione politica dei prigionieri ai quali la convinzione generale di dover essere presto liberati si accompagnò spesso alla disponibilità di ritornare a combattere sotto le insegne regie questa volta contro i tedeschi che ancora occupavano e violentavano l'Italia. In questa luce il problema che si pose alle coscienze fu impostato in modo dinamico da molti ma l'immobilismo dei detentori non subì la sperata evoluzione. Se a questa situazione si aggiunge un insieme di reazioni sorte dopo la nascita della Repubblica sociale italiana nel Nord si possono avere gli elementi di fondo per capire l'evoluzione della situazione dei prigionieri vittime spesso di un comp lesso d i reazioni a situazioni pregresse ed a mancate evolu zioni. Pertanto la prospettiva prima che le dichiarazioni delle autorità italiane del Regno del Sud avevano fatto sorgere
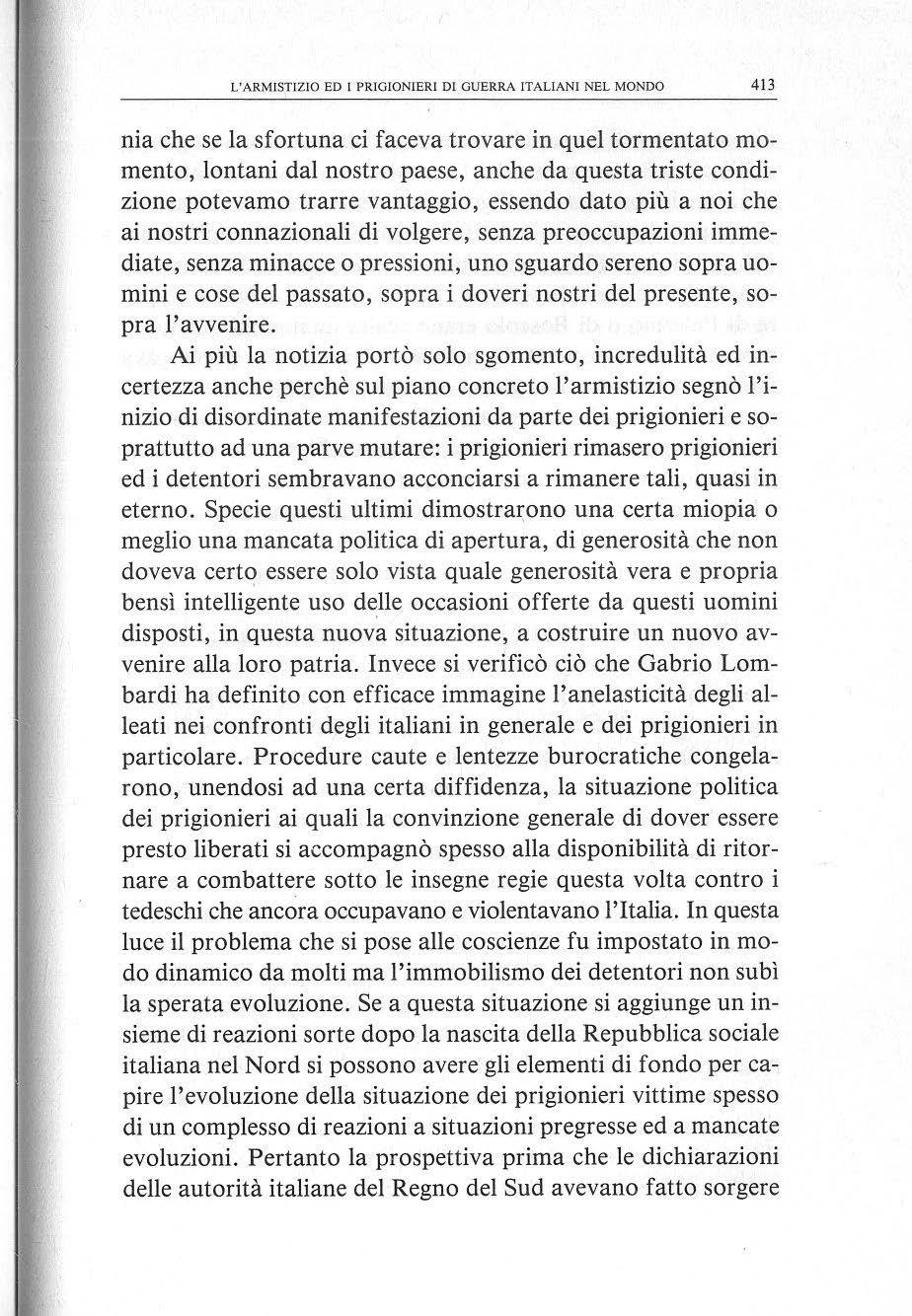
divennero labili e neanche la formale dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania del 13 ottobre venne sostanzialmente a mutare le cose. La cobelligeranza divenne un mito che nei vari campi si tradusse in varie fasi di politicizzazione, più acuta nei campi russi (35), e soprattutto nella famosa divisione tra cooperatori e non cooperatori. Per taluni prigionieri lo stupore di Palermo o di Boscolo erano realtà intangibili quanto ai rapporti con la potenza detentrice: «Come? - si interrogava il primo - sino a pochi giorni or sono gli inglesi erano i nostri aguzzini detentori? ... oggi alleati? ... » (36). Ed il secondo: « ... Anche ammesso che il Re fosse davvero schierato a fianco degli Anglo-americani, come avrei potuto io combattere insieme a loro; e magari contro i tedesc hi che mi avevano liberato dall'accerchiamento dell' Akarit? E, poi, di là c ' erano altri italiani che, sbag liassero o meno, continuavano pur semP.re una guerra che avevamo cominciata insieme ... » (37).
Divisi tra cooperatori e non cooperatori i prigionieri non ebbero grandi conseguenze pratiche nel loro status di fondo che rimase quello di prigionieri di guerra. I primi, i cooperatori, legati ad una dichiarazione che li emancipava da certe limitazioni (38) non ebbero peraltro la cosa che più stava loro a cuore e cioè la prospettiva ravvicinata di tornare a casa inserita come fu la loro opera ad attività locali che non li muoveva di molto dalla regione della precedente forma di prigionia. Per i secondi il dramma si complicava dalle misure di discriminazione che il detentore ritenne di dover adottare nei loro confronti accusandoli di essere «criminali» o «strong fascist» e quindi di essere pericolosi ad ogni effetto. In realtà i molti non-cooperatori riteneva no che la stessa scelta posta innanzi ai prigionieri fosse errata e come il gen. Ettore Scala pensavano: «Siamo soltan to prigionieri e soldati . Abbandoniamo ogni altra considerazione e lasciamo che gli eventi si compiano. Quando usciremo dai reticolati ciascuno prenderà la strada che meglio ritiene ... » (39). Ed un altro: «Non volevamo collaborare ... per un senso di dignità militare, civile e di amor patrio ... Questo nostro a tteg-
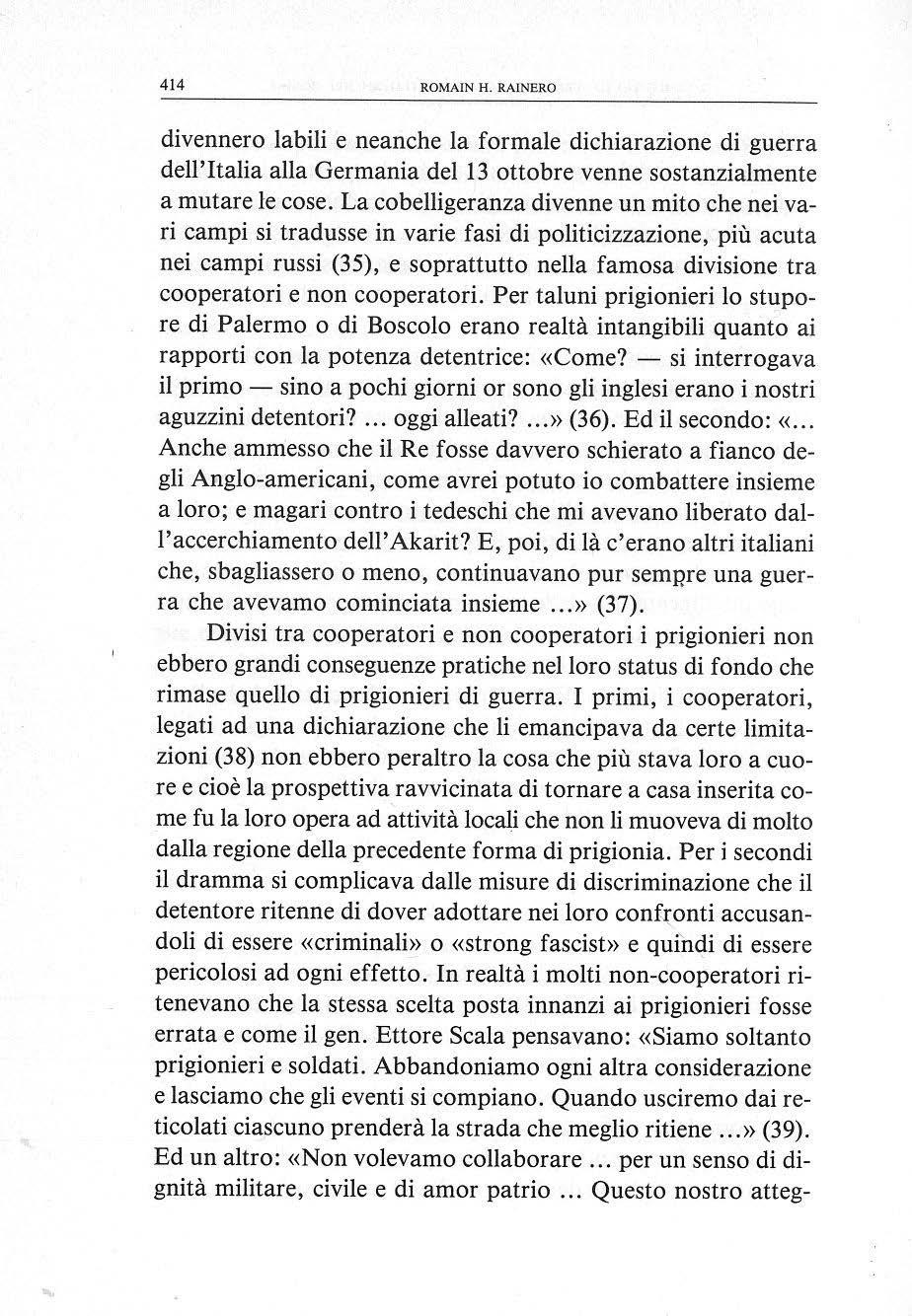
giament o avrebbe avuto certamente l'approvazione incondizionata dei nostri compagni d'arme caduti sui campi di battaglia ... » (40).
Il disorientamento non fu superato soprattutto perchè la stessa formula dell'armistizio, quella successiva della cobelligeranz a e quindi le novità italiane erano scaturite in un clima equivoco ed incerto ed in ogni caso erano e rimasero a lungo ali' oscuro i prigionieri di guerra che dovett ero aspettare la fine del '46 o gli inizi del '47 per ritornare liberi e per meglio capire che cosa era capitato all'Italia e agli italiani nel periodo del loro isolamento e quindi per tornare a vivere un'e sperienza di vita libera e democratica.
(1) Si veda anche P. Badoglio, L'Italia nella seconda gue rra mondiale, Milano, Mondador i , 1946, p. 260 ali. 5: prigionieri di guerra.
(2) Si tratta della Relaz ione final e sull'a ttività s volta dal Servizio Prigionieri di Guerra, in data 24 giugno 1946, all. 1, doc. ined. in Ministero della Difesa, Archivio dell'Ufficio Storico dello S.M. Es erci t o
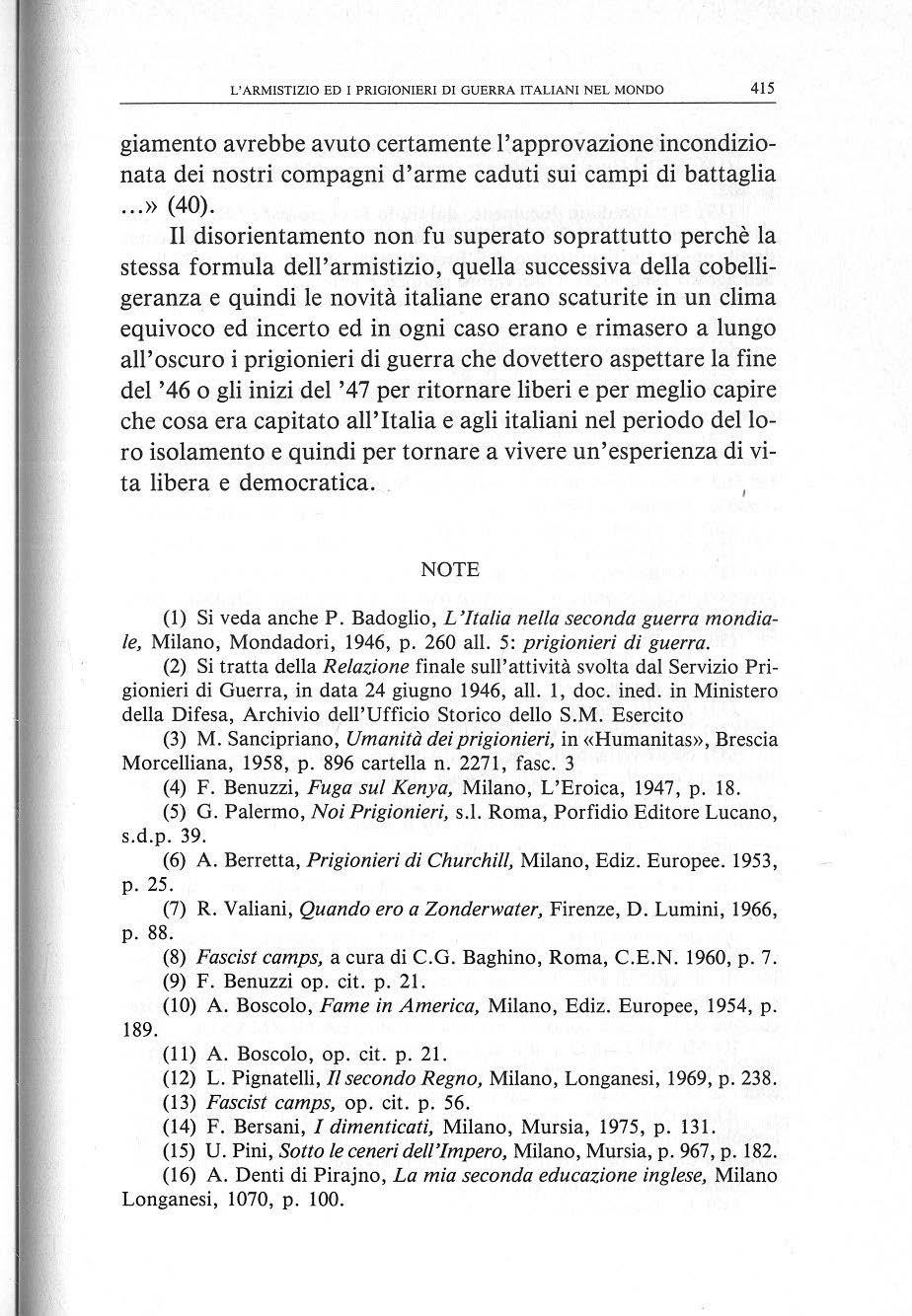
(3) M. Sancipriano, Umanità dei prigionieri, in «Humanitas», Brescia Morcelliana, 1958, p. 896 cartella n. 2271, fase. 3
(4) F. Benuzzi, Fuga sul Kenya, Milano, L'Eroica, 1947, p. 18.
(5) G. Palermo, Noi Prigionieri, s.l. Roma, Porfidio Editore Lucano, s .d.p. 39.
(6) A. Berretta, Prigionieri di Churchill, Milano, Ediz. Europee. 1953, p. 25.
(8) F ascist camps, a cura di C.G. Baghino, Roma, C .E.N . 1960, p. 7 .
(9) F . Benuzzi op. cit. p. 21.
(10) A. Boscolo, Fame in America, Milano, Edi z . Europee, 1954, p .
(7) R. Valiani, Quando ero a Zonderwater, Firenze, D. Lumini, 1966, p . 88. 189.
(11) A. Boscolo, op. cit. p. 21.
(12) L. Pignatelli, Il secondo Regno, Milano, Longanesi, 1969, p. 238.
(13) Fascist camps, op . cit. p. 56.
(14) F . Bersani, I dimenticati, Milano, Mursia , 1975 , p. 131.
(15) U . Pini, Sotto le ceneri dell'Impero, Milano, Mursia, p . 967, p. 182.
(16) A. Denti di Pirajno, La mia seconda educazione inglese, Milano Longanesi, 1070, p 100.
(17) A . Berretta, Tragedia di Burguret, Milano, Ceschina 1966, p. 25.
(18) A. Del Guercio, All'ombra dell'Himalaia, Milano, Gastoldi, 1955, p. 202.
(19) Si tratta di un documento dal titolo Background of Fascism, edito il 3 agosto 1942 da l Governo Generale dell'India di cui esiste una copi a datti!. presso l'ufficio storico dell'Esercito e che è stato anche pubblicato nell'agosto 1966 su «L'Osservatore politico e letterario».
(20) A. Del Guercio, op. cit. p. 54. Circolare di Yol (India) in data 18 aprile 1942.
(21) U . Pini, op. cit . p . 202.
(22) G . Pal ermo, op. cit . p . 89.
(23) Secondo altre fonti sarebbe stato firmato il 24 giugno 1943 (te stimonianza del gen. Luigi Riccardi, in L. Pignatelli, op. cit. p . 47).
(24) U. Pini, op. cit. p. 202 .
(25) Dichiarazioni del gen. Nasi del marzo 1943 al campo di Burguret nel Sud Africa riportate da L. Avanzini, Burguret verso l'inferno, Dom odossola, Antonioli, 1969, p. 75.
(26) L. Pignatelli, op. cii. p. 241.
(27) L. Avanzini, op . cit. p. 77.
(28) A. Berretta, op cii. p. 142.
(29) F . G. Piccinni, Africa senza sole, Prato, Soc. Edi t. Emiliana, 1964, p. 223.
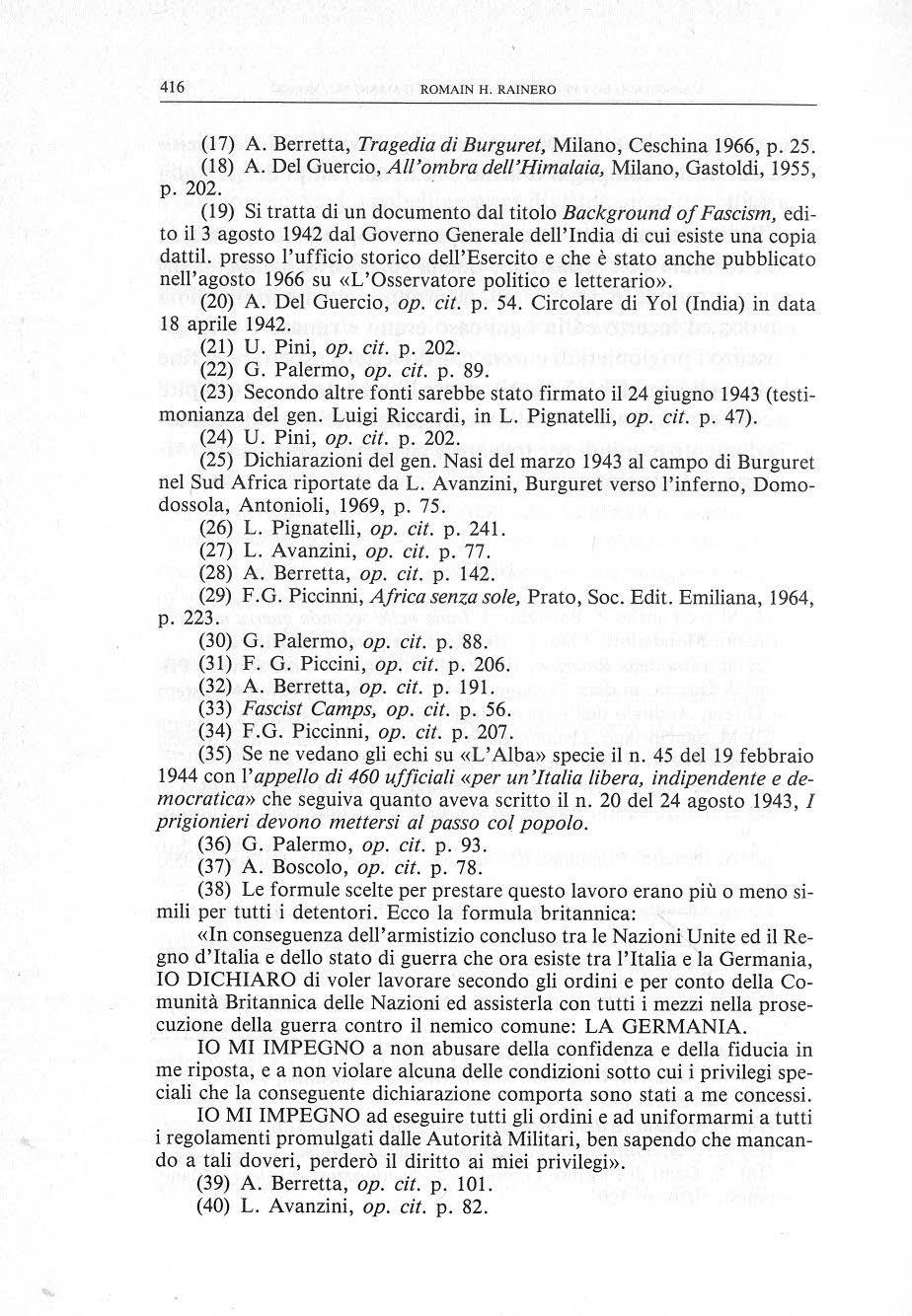
(30) G. Palermo, op . cit . p. 88 .
(31) F. G. Piccini, op. cit p . 206.
(32) A. Berretta, op. cit p 191.
(33) Fascist Camps, op. cit. p. 56.
(34) F .G. Piccinni, op. cit. p. 207.
(35) Se ne vedano gli echi su «L'Alba» specie il n. 45 del 19 febbraio 1944 con l'appello di 460 ufficiali «per un'Italia libera, indipendente e democratica» che seguiva quanto aveva scritto il n. 20 del 24 agosto 1943, I prigionieri devono mettersi al passo col popolo .
(36) G. Palermo, op cit p. 93.
(37) A. Boscolo, op. cit . p . 78.
(38) Le fo r mule scelte per prestare questo lavoro erano più o meno simili per tutti i detentori. Ecco la formula britannica :
«In conseguenza dell'armistizio concluso tra le Nazioni Unite ed il Regno d'Italia e dello stato di guerra che ora esiste tra l'Italia e la Germania, IO DICHIARO di voler lavorare secondo gli ordini e per conto della Comunità Britannica delle Nazioni ed assisterla con tutti i mez zi nella prosecuzione della guerra contro il nemico comune: L A GERMANIA.
IO MI IMPEGNO a non abusare della confidenza e della fiducia in me riposta, e a non violare alcuna delle condizioni sotto cui i privilegi speciali che la conseguente dichiarazione comporta sono stati a me concessi.
IO M I I MPEGNO ad eseguire tutti gli ordini e ad uniformarmi a tutti i regolamenti promulgati dalle Autorità Militari, ben sapendo che mancando a tali doveri, perderò il diritto ai miei privilegi».
(39) A Berretta, op cit p 101.
(40) L. Avanzini, op. cit. p. 82 .
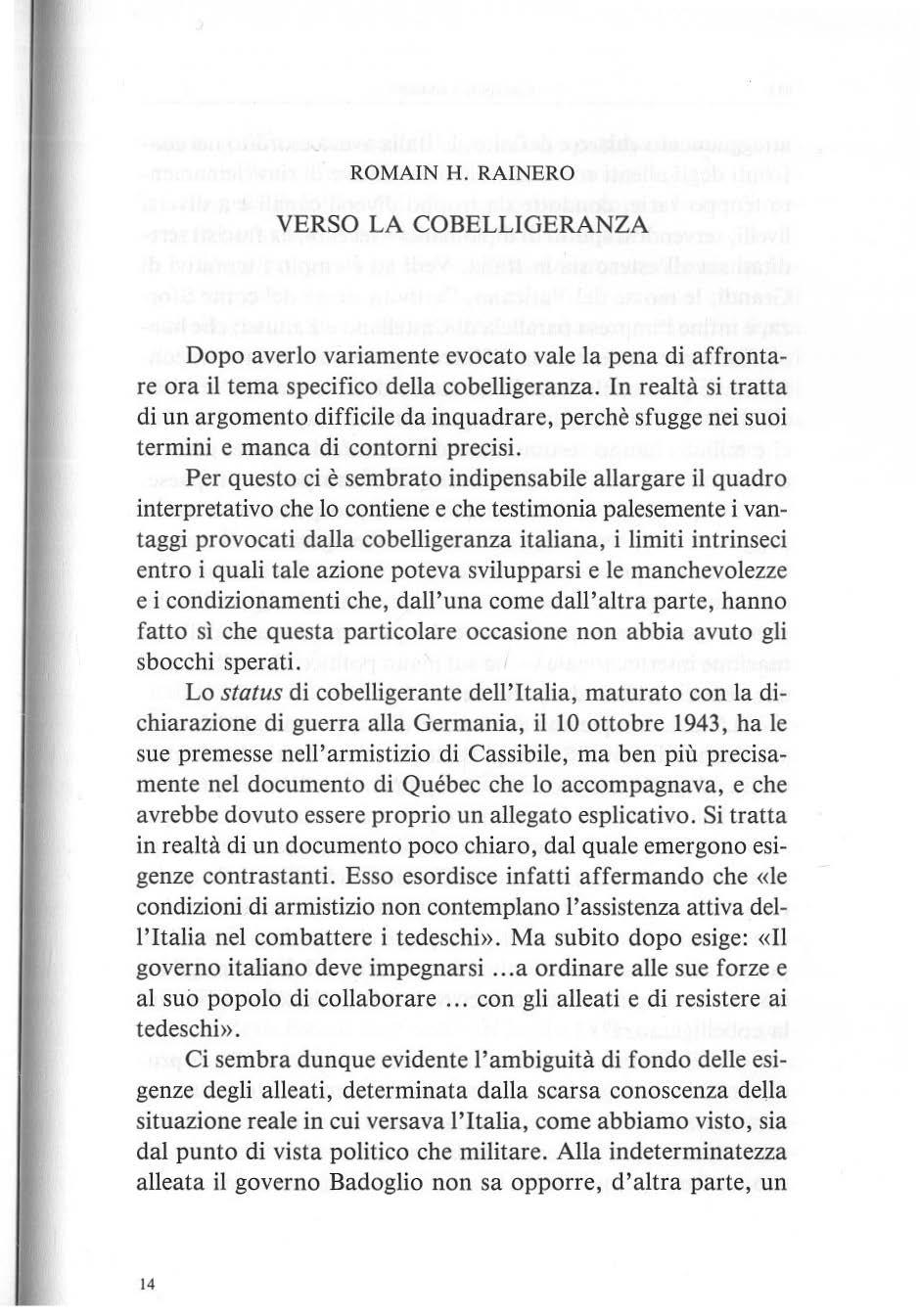
Dopo averlo variamente evocato vale la pena di affrontare ora il tema specifi co della cobelligeranza. In realtà si tratta di un argomento difficile da inquadrare, perchè sfugge nei suoi termin i e manca di contorni precisi.
Per questo ci è sembrato indipensabile allargare il quadro interpretativo che lo contiene e che testimonia palesemente i vantaggi provocati dalla cobelligeranza italiana , i limiti intrinseci entro i quali tale azione poteva svilupparsi e le manchevolezze e i condizionamenti che, dall'una come dall'altra parte, hanno fatto sì che questa particolare occasione non abbia avuto gli s bocchi sperati.
Lo status di cobelligerante dell'Italia, maturato con la dichiarazio ne di guerra alla Germania, il 10 ottobre 1943, ha le sue premesse nell'armistizio di Cassibile, ma ben più precisamente nel documento di Québec che lo accompagnava, e che avrebbe dovuto essere proprio un allegato esplicativo. Si tratta in realtà di un documento poco chiaro, dal quale emergono esigenze co ntrastant i. Esso esordisce infatti affermando che «le condizioni di armistizio non contemplano l'assistenza attiva dell'Italia nel combattere i tedeschi». Ma subito dopo esige: «II governo italiano deve impegnarsi ... a ordinare alle sue forze e al suo popolo di collaborare ... con gli alleati e di resistere ai tedeschi».
Ci semb ra dunque evidente l'ambiguità di fondo delle esigenze degli alleati, determinata dalla scarsa conoscenza della situazione reale in cui versava l'Italia, come abbiamo visto, sia dal punto di vista politico che militare. Alla indeterminatezza alleata il governo Badoglio non sa opporre, d'altra parte, un
atteggiamento chiaro e definito. L'Italia aveva esordito nei confronti degli alleati con una serie di iniziative di riavvicinamento troppo varie, condotte da tro ppo diversi canali e a diversi livelli, servendosi spesso di diplomatici «vecchi», ex fascisti screditati sia all'estero sia in Italia. Vedi ad esempio i tentativi di Grandi, le mosse del Vaticano , l'attività stessa del conte Sforza, e infine l'impresa parallela di Castellano e Zanussi; che hanno finito per alimentare la diffidenza generatasi nei nostri confronti. E per concludere: l'atto stesso della firma dell'armistizio di Cassibile, vicenda nella quale i nostri responsabili politici e militari hanno testimoniato della confusione, del panico, quasi smarrimento in cui gli eventi avevano portato il paese. Su queste premesse, dunque, male prospettate ma ancor peggio accolte, è venuta a inserirsi la cobelligeranza. Il suo valore viene ben presto vanificato da due elementi fortemente condizionanti: l'effettiva penuria di forze combattenti che l'Italia poteva mettere a disposizione, e il rapido mutamento della situazione internazionale - sia sul piano politico che militareche venne verificandosi alla fine del 1943.
L'Italia dunque non ebbe modo di trarre vantaggio da questo riconoscimento. Secondo Badoglio, esso costituiva la premessa ad un futuro prossimo accoglimento dell'Italia quale alleata delle forze anti-hitleriane: ma come nutrire questa disperata speranza, se nel momento cruciale non avevamo che truppe sbandate e poco armate da affiancare agli alleati? Se quanto rimaneva del nostro esercito si trovava disanimato e privo di comandi? Se si temeva d'altra parte che un riarmo avrebbe potuto alimentare una rivoluzione sovversiva? Se infine gli alleati avevano già da tempo deciso che all'Italia «dovrà bastare la cobelligeranza?»
Fra il deleterio attendismo dei nostri responsab ili e la prudente sfiducia degli anglo-americani, intanto, la situazione veniva mutandosi: le truppe germaniche si attestavano in Italia, rendendo sempre più ardua la liberazione e l'unificazione del suo territorio, e quindi l'efficacia della sua forza combattente

disponibile. L'interesse internazionale si spostava da un lato verso est, sulle trasformazioni che intervenivano nel settor e balcanico e nella Polonia, dall'altro verso ovest, dove si finiva di precisare l'urgenza dello sbarco in Normandia.
Da questi nuovi punti focali l'It alia rimaneva lontana. Essa continuerà bensì a dare il suo appor to - e doloroso - di co belligeran te, ma le forze alleate non hanno ormai più fretta di ripagarla. Ben altri inter essi ha suscitato la guerra. Ben altri e quilibri si stanno instaurando nel mondo, perchè le pretese di una nazione passata in pochi anni dalla non-belligeranza, alla guerra fattiva, alla co belli geranza possano essere accolte.
Tutta la storia degli ultimi mesi di guerra, fino al trattato di pace, stanno a confermarlo: quando l'Italia non si vede riconosciuto alcun credito dagli alleati per il mantenimento delle loro truppe sul nostro territorio; quando tutti possono avanzare diritti e pretese sui punti più delica ti delle nostre frontiere; quando, nonostante le ampie promesse varate dagli angloamericani ad H yde Park, il paese è continuamente soffocato dall'ingerenza dell a Commissione Alleata; quando i nostri rappresentanti so no tenuti lontani dalle trattative per la pace. Viene allora da domandarsi, con i commentatori dell'epoca (v. gli an nali di «P olitica Estera» del 1945 e 1946): «Che significato ha la cobelligeranza?>>
Essa è stata il riscatto con cui il no stro paese ha liquid ato le colpe precedenti. È stata la doverosa premessa, perchè potesse riaffacciarsi dignitosamente nel nuovo ordinamento internazionale qui, ancora con fatica, ricreare attorno a se i necessari legami di convivenza e di comunità di in teressi .
Disse Bonomi nel discorso indirizzato ai funzionari del Ministero degli Esteri, co nvo cati nel luglio 1944: « ... Perch è questa nostra cobelli geranza possa dare tutt i i suoi frutti, occorre che la nostra politica este ra la sorregga e la illumini ... Noi dobbiamo perseguire instancabilmente un fine chiaro e preciso: ricondurre la nostra politica estera nel solco antico e nella tradizione del nostro passato .. Bisogna volgerci verso quelle che fu-
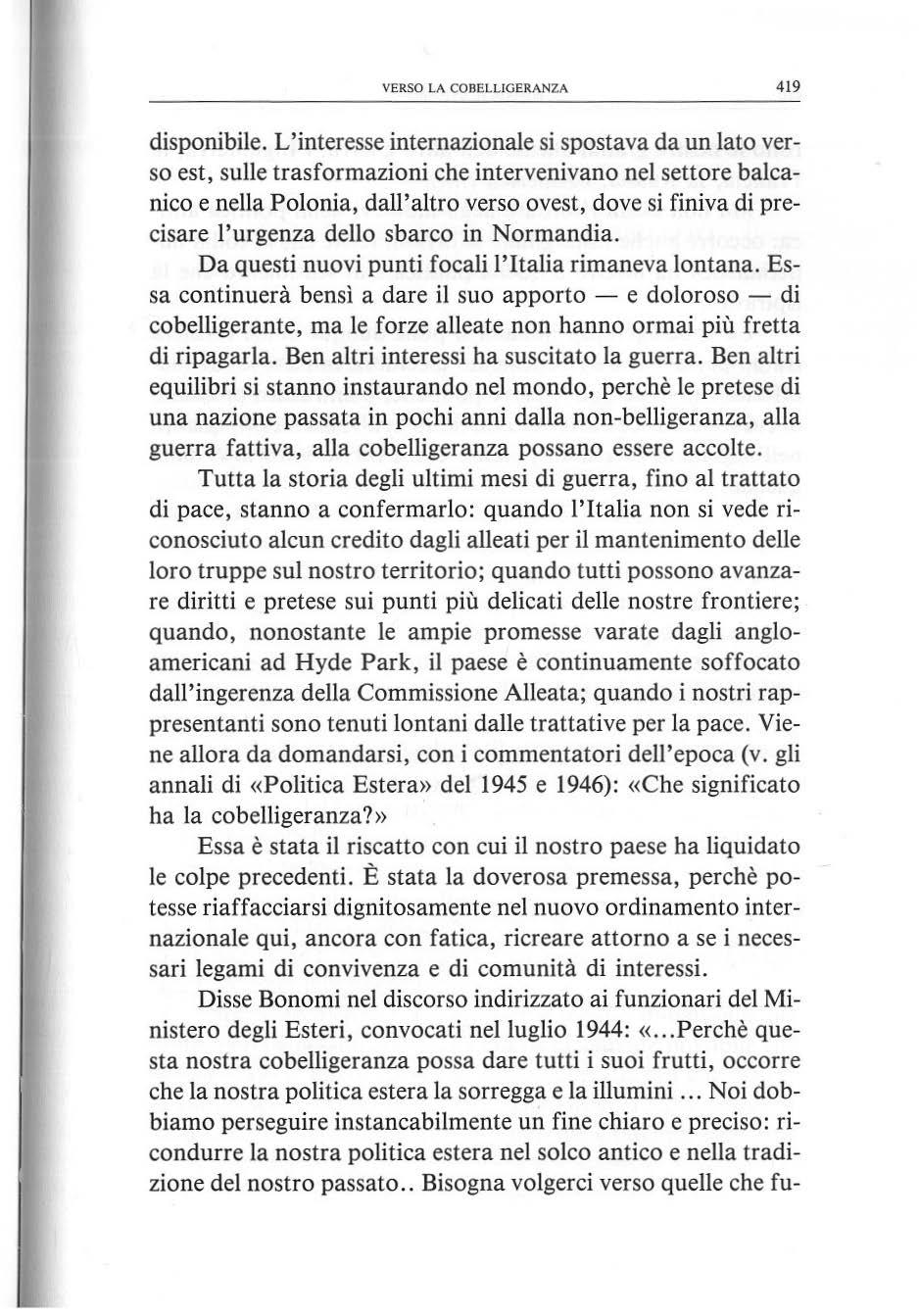
rono le nostre grandi alleate dell'altra guerra: l'Inghilterra, la Francia, la Russia, l'America ...
Ma non basta ritornare negli indiri zzi della politica antica: occorre anche rimarginare le orribili ferite c he la follia imperialistica ha inferto a quella politica e a l sentimento che la ispirava».
La cobelligeranza italiana si pone dunque come cerniera tra un passato che è riconosciuto esecrabile in tutte le sue manifestazioni dalle nuove forze politiche, e un futuro prossimo di cu i si riconosce l'artefice non tanto nell'Italia stessa, quanto nell'aggregato di grandi potenze che è uscito vittorioso dalla guerra.
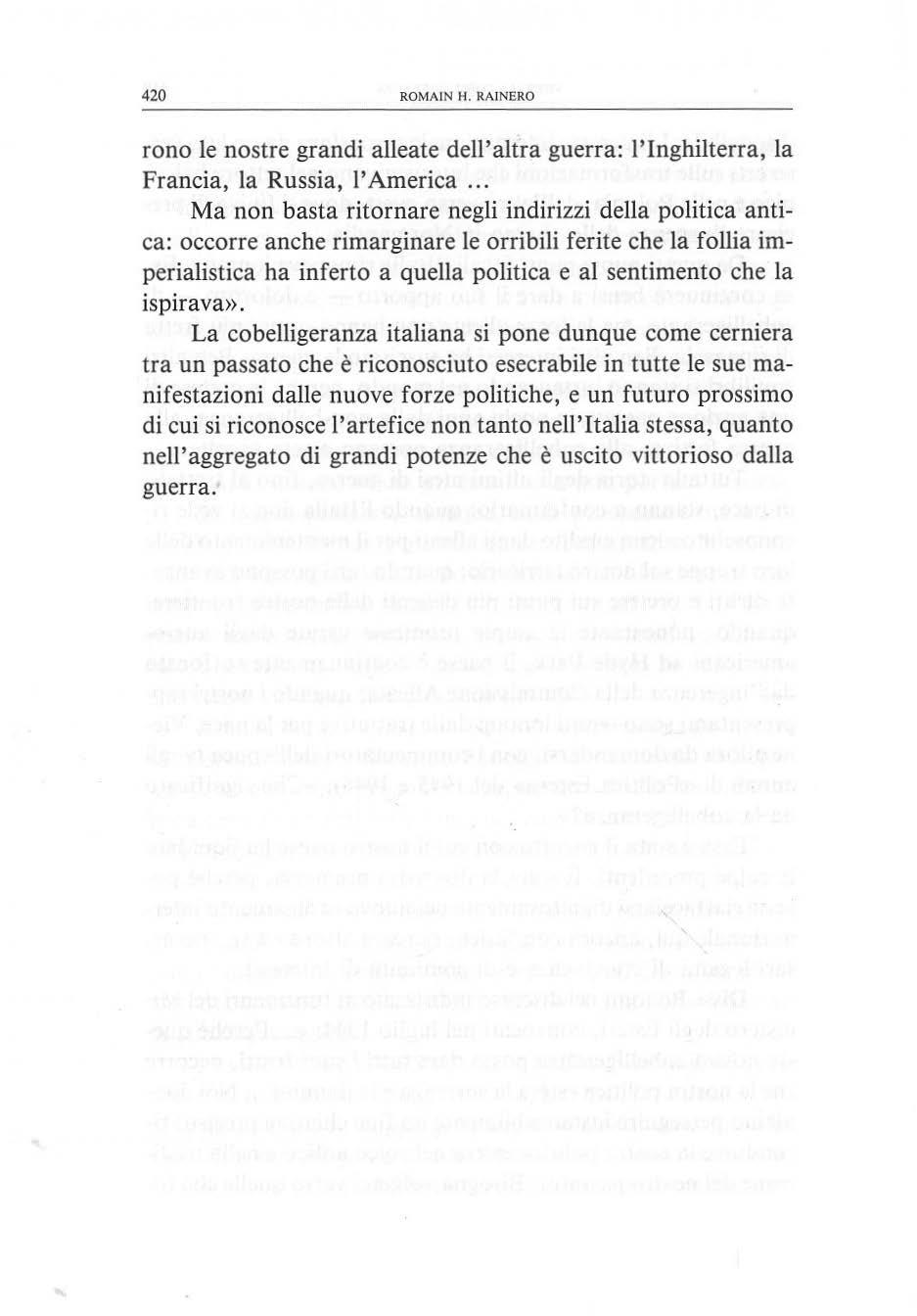
L'otto settembre 1943 gli angloamericani proclamarono improvvisamente al mondo la resa incondizionata che l'Italia cinque giorni prima aveva segretamente firmato a Cassibile.
Prima di noi, nel corso della seconda guerra mondiale, si erano già arrese una dozzina di nazioni: Finlandia Estonia Lituania Polonia, Norvegia Danimarca Olanda Belgio, Francia Jugoslavia e Grecia; infine si arrenderà anche la Germania.
Sono tutti eguali i macroscopici fenomeni militari e gli infiniti drammi umani che si verificarono, come da noi, così in tutte le altre nazioni all'atto dell'armistizio imposto dal vincitore. Una differenza fondamentale distingue però l'otto settembre italiano, il settembre nero, dalla disfatta di tutti gli altri Stati europei.
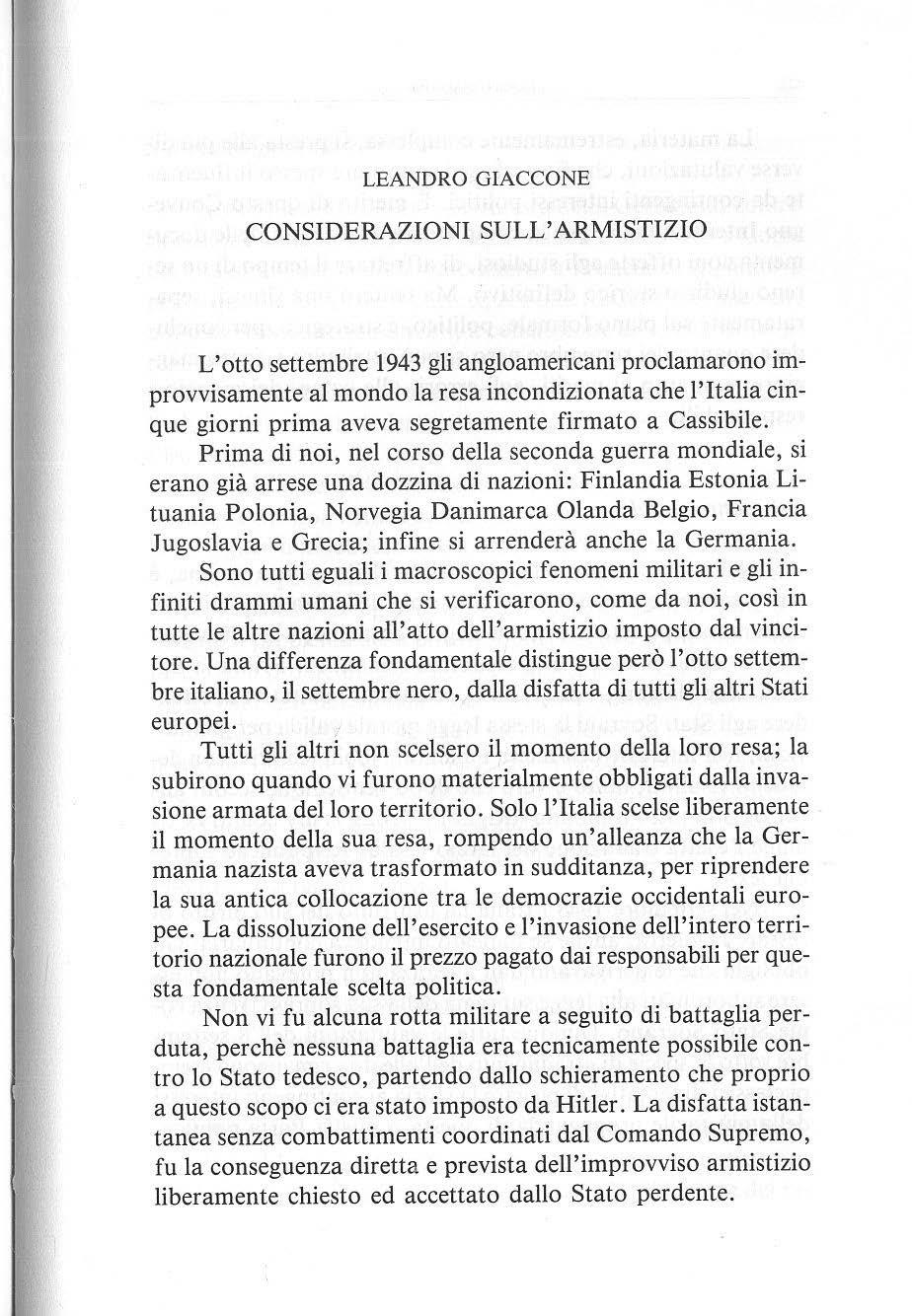
Tutti gli altri non scelsero il momento della loro resa; la subirono quando vi furono materialmente obbligati dalla invasione armata del loro territorio. Solo l'Italia scelse liberamente il momento della sua resa, rompendo un'alleanza che la Germania nazista aveva trasformato in sudditanza, per riprendere la sua antica collocazione tra le democrazie occidentali europee. La dissoluzione dell'esercito e l'invasione dell'intero territorio nazionale furono il prezzo pagato dai responsabili per questa fondamentale scelta politica.
Non vi fu alcuna rotta militare a seguito di battaglia perduta, perchè nessuna battaglia era tecnicamente possibile contro lo Stato tedesco, partendo dallo schieramento che proprio a questo scopo ci era stato imposto da Hitler. La disfatta istantanea senza combattimenti coordinati dal Comando Supremo, fu la conseguenza diretta e prevista dell'improvviso armistizio liberamente chiesto ed accettato dallo Stato perdente.
La materia, estremamente complessa, si presta alle più diverse valutazioni, che fino ad oggi sono state spesso influenzate da contingenti in teressi politici. È merito di questo Convegno Internazionale, per la completezza e la serietà delle documentazioni offerte agli studiosi, di affrettare il tempo di un sereno giudizio storico definitivo. Ma tenterò una sintesi, separatamente sul piano formale, politico, e strategico, per concludere quanto del settembre nero si può attribuire a forza maggiore, e quanto ai meriti, agli errori, alle colpe, dei maggiori responsabili.
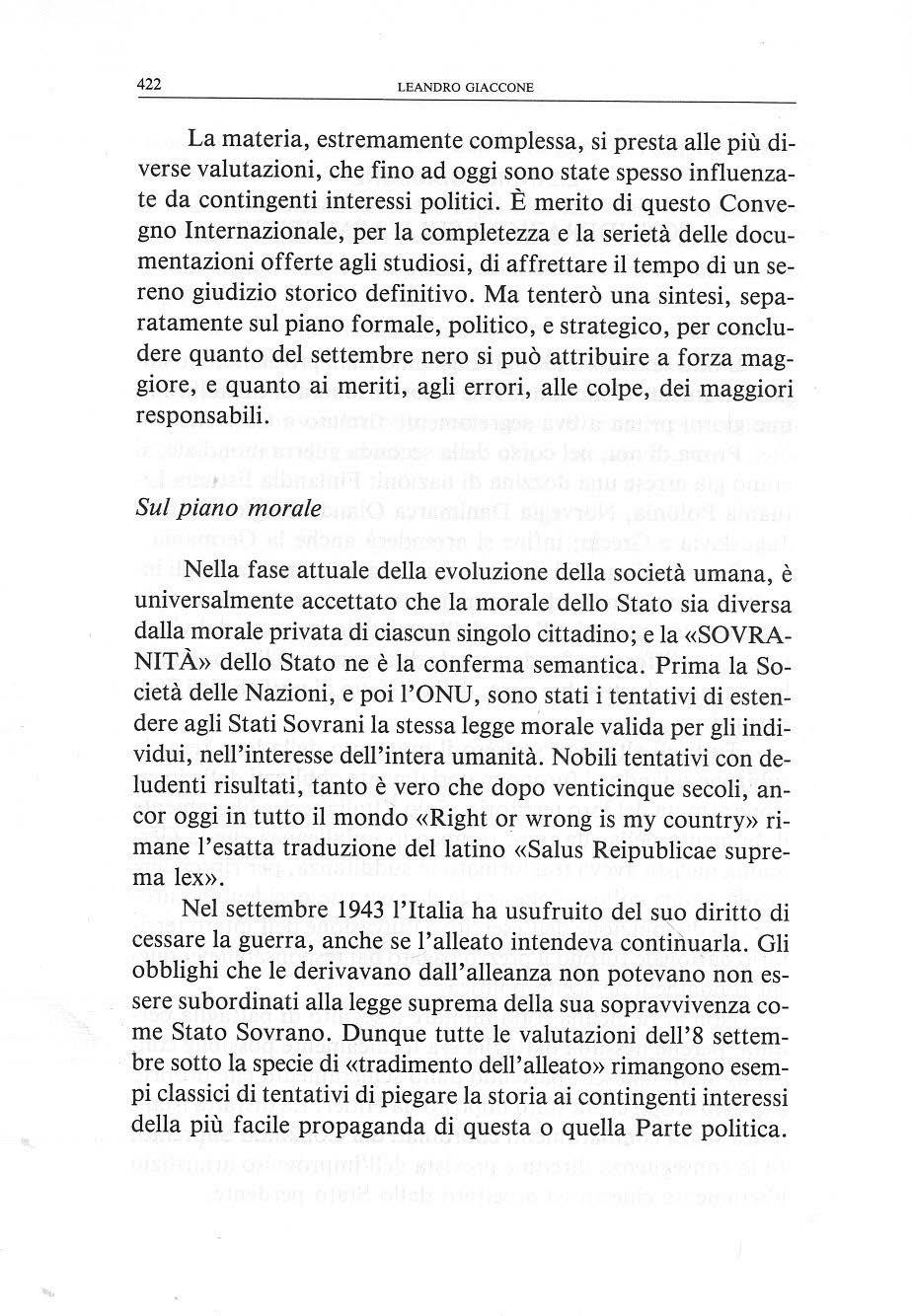 Sul piano morale
Sul piano morale
Nella fase attuale della evoluzione della società umana, è universalmente accettato che la morale dello Stato sia diversa dalla morale privata di ciascun singolo cittadino; e la «SOVRANITÀ» dello Stato ne è la conferma semantica. Prima la Società delle Nazioni, e poi l'ONU, sono, stati i tentativi di estendere agli Stati Sovrani la stessa legge morale valida per gli individui, nell' interesse dell'intera umanità. Nobili tentativi con deludenti risultati , tanto è vero che dopo venticinque secoli, ancor oggi in tutto il mondo «Right or wrong is my country» rimane l 'esatta traduzione del latino «Salus Reipublicae suprema lex».
Nel settembre 1943 l'Italia ha usufruito del suo diritto di cessare la guerra, anche se l'alleato intendeva continuarla. Gli obblighi che le derivavano dall'alleanza non potevano non essere subord inati alla legge suprema della sua sopravvivenza come Stato Sovrano. Dunque tut te le valu tazio ni dell'8 settembre sotto la specie di «tradimento dell'alleato» rimangono esempi classici di tentativi di piegare la storia ai contingenti interessi della più facile propaganda di questa o quella Parte politica.
Nel 1940, senza specifica richiesta della Germania, contro l'opinione della maggioranza degli italiani e della stessa Corona, Mussolini aveva dichiarato guerra a Francia ed In ghilterra per acquisire il diritto di partecipare alle trattative di pace che a suo avviso erano imminenti, a conclusione della guerra scoppiata l'anno precedente per la questione di Danzica. Lo scopo sostanziale dell'intervento, naturalmente non confessato, era di limitare l'egemonia tedesca, che si profilava assoluta su tutta l'Europa.
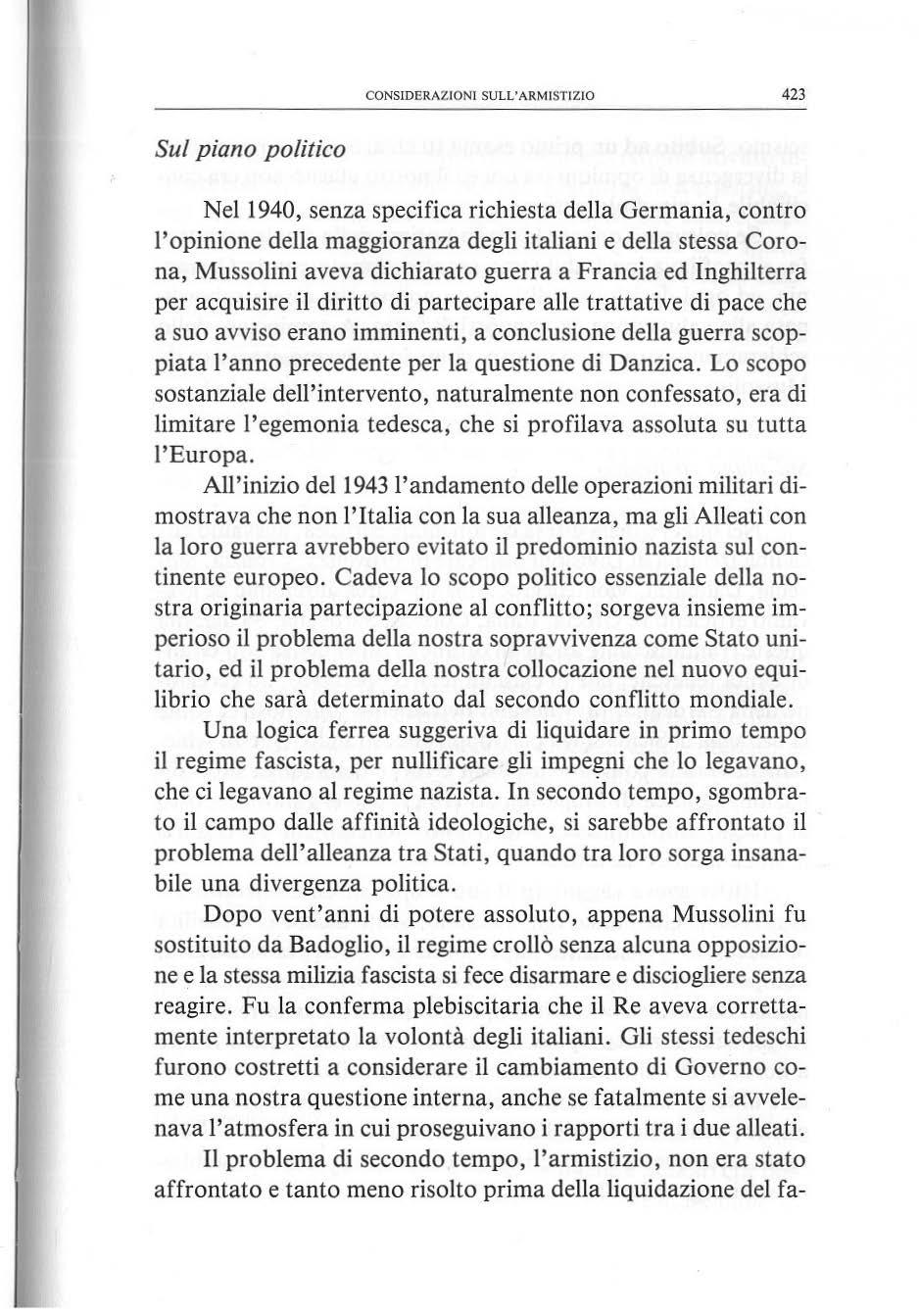
All'inizio del 1943 l'andamento delle operazioni militari dimostrava che non l'Italia con la sua alleanza, ma gli Alleati con la loro guerra avrebbero evitato il predominio nazista sul continente europeo . Cadeva lo scopo politico essenziale della nostra originaria partecipazione al conflitto; sorgeva insieme imperioso il problema della nostra sopravvivenza come Stato unitario, ed il problema della nostra collocazione nel nuovo equilibrio che sarà determinato dal secondo conflitto mondiale.
Una log ica ferrea suggeriva di liquidare in primo tempo il regime fascista, per nullificare gli impegni che lo legavano, che ci legavano al regime nazista. In secondo tempo, sgombrato il campo dalle affinità ideologiche, si sarebbe affrontato il problema dell'all eanza tra Stati, quando tra loro sorga insanabile una divergenza politica.
Dopo vent'anni di potere assoluto, appena Mussolini fu sostituito da Badoglio, il regime crollò senza alcuna opposizione e la stessa milizia fasc ista si fece disarmare e disciogliere senza reagire. Fu la conferma plebiscitaria che il Re aveva correttamente interpretato la volontà degli italiani. Gli stessi tedeschi furono costr etti a considerare il cambiamento di Governo come una nostra questione interna, anche se fatalmente si avvelenava l'atmosfera in cui proseguivano i rapporti tra i due alleati.
Il problema di secondo tempo, l'armistizio, non era stato affrontato e tanto meno risolto prima della liquidazione del fa-
scismo. Subito ad un primo esame fu chiaro che, in proposito, la divergenza di opinioni tra noi ed il nostro alleato non era conciliabile in via diplomatica.
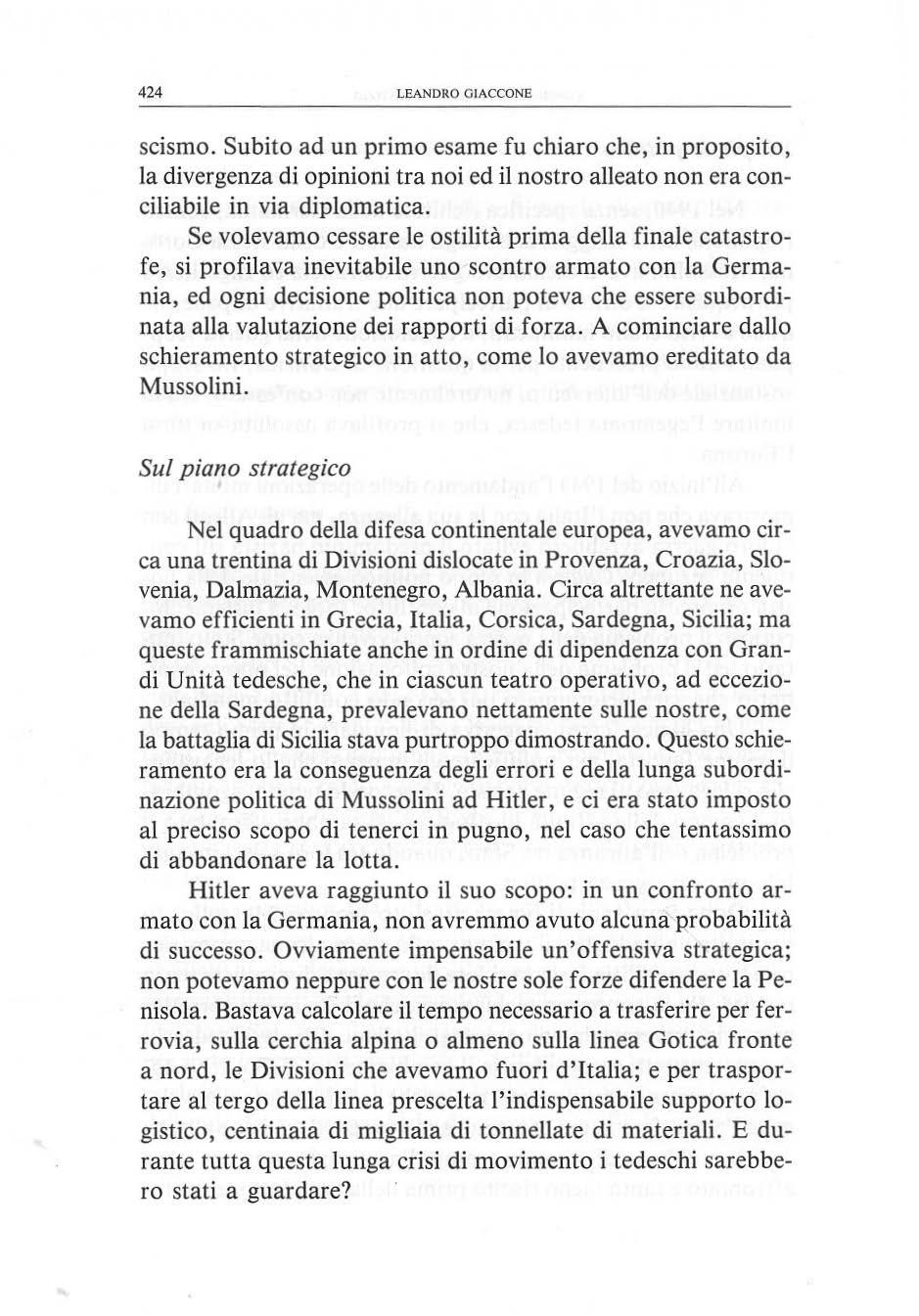
Se volevamo cessare le ostilità prima della finale catastrofe, si profi la va inevitabile uno scontro armato con la Germania, ed ogni decisione politica non poteva che essere subordinata a ll a valutazione dei rapporti di forza. A cominciare dallo schieramento str ategico in atto, come lo avevamo ereditato da Mussolini.
Sul piano strategico
Nel quadro della difesa continentale europea, avevamo circa una trent ina di Di vis ioni dislocate in Provenza, Croazia, Slovenia, Dalmazia, Montenegro, Albania. Circa altrettante ne avevamo efficienti in Grecia , Italia, Corsica, Sardegna, Sicilia; ma queste frammischiate anche in ordine di dipendenza con Grandi Unità tedesche, che in ciascun teatro operativo, ad eccezione della Sardegna, prevalevano nettamente sulle no stre, come la battaglia di Sicilia stava purtroppo dimostrando. Questo schieramento era la conseguenza degli errori e della lunga sub ordinazione politica di Mussolini ad Hitler, e ci era stato imposto al preciso scopo di tenerci in pugno, nel caso che tentassimo di abbandonare la lotta.
Hitler aveva raggiunto il suo scopo: in un confronto armato con la Germania, non avremmo avuto alcuna probabilità di successo. Ovviamente impensabile un'offensiva strategica; non potevamo neppure con le nostr e sole forze difendere la Penisola. Bastava calcolare il tempo necessario a trasferire per ferrov ia, sulla cerchia alpina o almeno su lla lin ea Goti ca fronte a nord, le Di visi oni che avevamo fuori d'Italia; e per trasportare al tergo della lin ea prescelta l'indi sp ensabile supporto logistico, centinaia di migliaia di t onnellate di materiali. E durante tutta que sta lunga crisi di movimento i tedeschi sare bb ero stati a guardare?
Ma non basta: contemporaneamente avremmo dovuto distruggere, o costringere alla ritirata, l'Armata di Kesselring, a sud degli Appennini, e l'Armata di Rommel che subito dopo il 25 luglio ci era piovuta in valle padana. Quanto allo spirito delle truppe, non era difficile immaginare l'angoscia la delusione la stanchezza di un esercito che si arrende al nemico, e la grinta dell'altro esercito che seguitando a combattere affronta l'infido alleato.
In base dunque alla situazione in atto, ed all'impossibilità di modificarla sostanzialmente in tempi brevi, il Governo e la stessa Corona dovettero scegliere se proseguire la guerra accanto alla Germania fino alla finale comune catastrofe, oppure se scindere il nostro destino dal destino dell'alleato nazista, accettandone subito le conseguenze, nel supremo futuro interesse della nazione. È stata questa tragica, fondamentale libera scelta che ha determinato, nel bene e nel male, tutta la successiva storia d'Italia.
Presa la decisione, era assolutamente necessario che non giungesse ad Hitler la minima prova concreta delle nostre trattative armistiziali, per evitare che egli ci costringesse ad interromperle. Ufficiali di collegamento tedeschi erano presenti in ogni nostro comando, e per conseguenza si mantenne il segreto con tutti, compresi gli Stati Maggiori centrali e periferici, compresi tutt i i comandanti di Grande Unità, a cominciare dall'Armata.
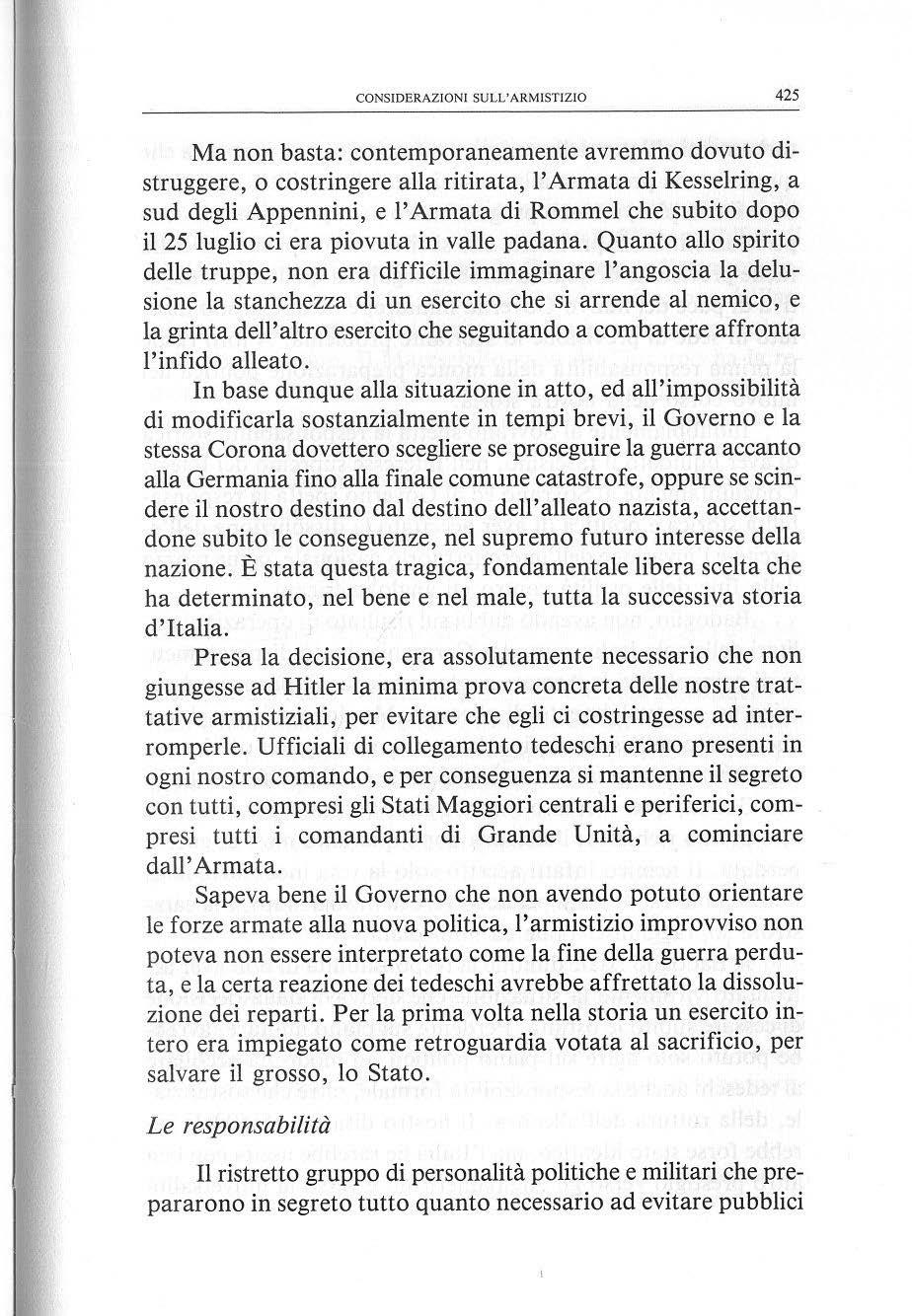
Sapeva bene il Governo che non avendo potuto orientare le forze armate alla nuova politica, l'armistizio improvviso non poteva non essere interpretato come la fine della guerra perduta, e la certa reazione dei tedeschi avrebbe affrettato la dissoluzione dei reparti. Per la prima volta nella storia un esercito intero era impiegato come retroguardia votata al sacrificio, per salvare il grosso, lo Stato.
Le responsabilità
Il ristretto gruppo di personalità politiche e militari che prepararono in segreto tutto quanto necessario ad evitare pubblici
turbamenti all'atto della caduta del fascismo, non ignorava che questa era la premessa alla cessazione delle ostilità. Assolsero bene il compito, ma non programmarono in precedenza il «dopo Mussolini». È probabile che si ritraessero spaventati dalla facile previsione di quanto sarebbe segu ito a qualunque iniziativa di pace del nuovo Governo militare; e ne lasciarono insoluto in sede di previsione lo scottante problema. A loro risale la prima responsabilità della monca preparazione politica del nuovo corso della nostra storia.
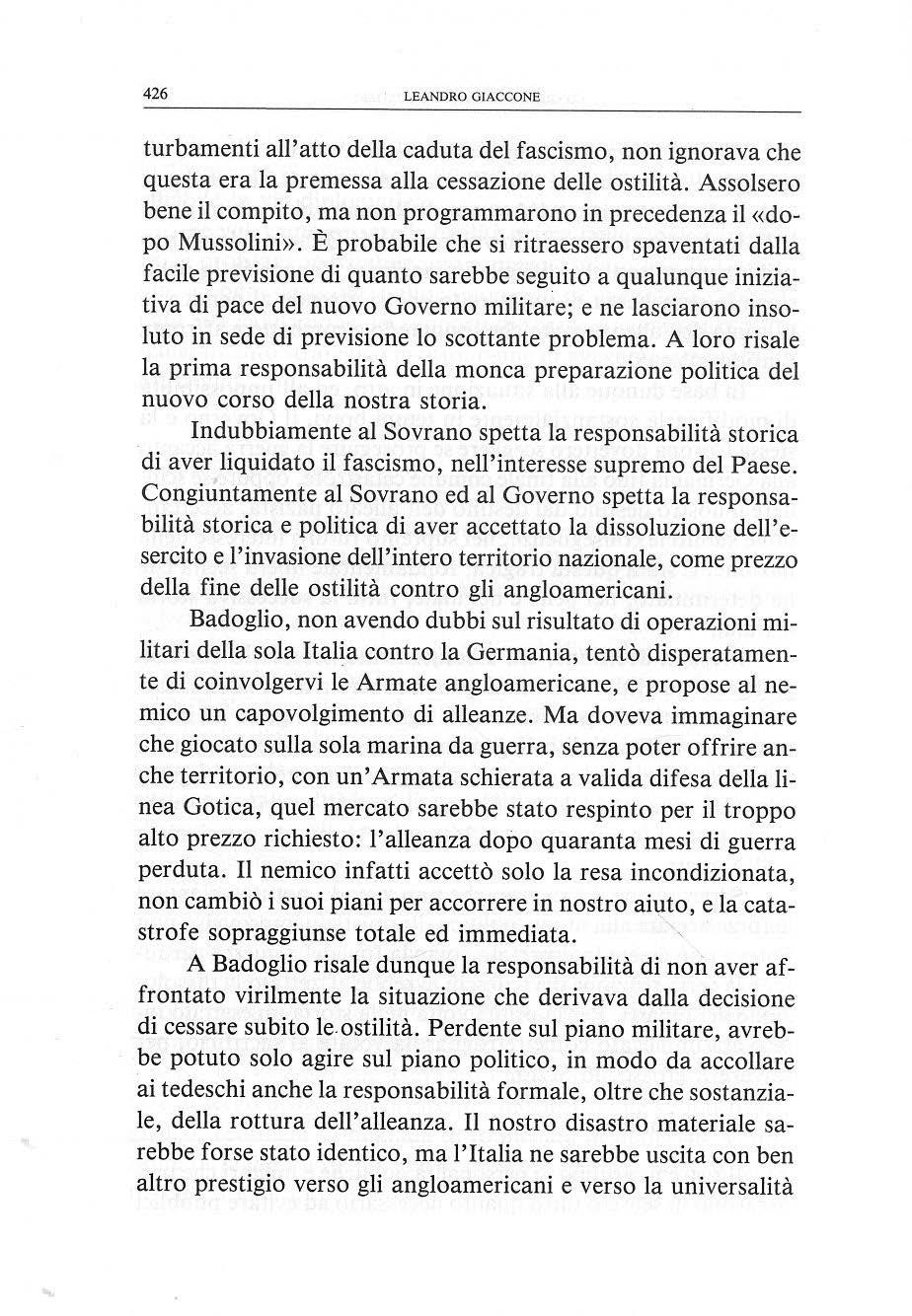
Indubbiamente al Sovrano spetta la responsabilità stor ica di aver liquidato il fascismo, nell ' interesse supremo del Paese. Congiuntamente al Sovrano ed al Governo spetta la responsabilità storica e politica di aver accettato la dissoluzione dell' esercito e l'invasione dell'intero territorio nazionale, come prezzo della fine delle ostilità contro gli angloamericani.
Badoglio , non avendo dubbi sul risultato di operazioni militari della sola Italia contro la Germania, tentò disperatamente di coinvolgervi le Arm~te angloamericane, e propose al nemico un capovolgimento di alleanze. Ma doveva immaginare che giocato sulla sola marina da guerra , senza poter offrire anche territorio, con un'Armata schierata a valida difesa della linea Gotica, quel mercato sarebbe stato respinto per il troppo alto prezzo richiesto : l'alleanza dopo quaranta mesi di guerra perduta. Il nemico infatti accettò solo la resa incondizionata, non cambiò i suoi piani per accorrere in nostro aiuto, e la catastrofe sopraggiunse totale ed immediata. ,
A Badoglio risale dunque la responsabilità di non aver affrontato virilmente la situazione che derivava dalla decisione di cessare subito le.ostilità. Perdente sul piano militare, avrebbe potuto solo agire sul piano politico, in modo da accollare ai tedeschi anche la responsabilità formale, oltre che sostanziale, della rottura dell'alleanza. Il nostro disastro materiale sarebbe forse stato identico, ma l'Italia ne sarebbe uscita con ben altro prestigio verso gli angloamericani e verso la universalità
dei suoi cittadini, compresi quelli sorpresi in armi dall'armistizio segreto (*);
Badoglio aveva impiegato l'esercito come copertura delle trattative armistiziali, dopo aver constatato l'impossibilità di impiegarlo unitariamente contro la Germania; e l'otto settembre egli sapeva anche che all'atto della comunicazione dell'armistizio l'ordine di «difendersi se attaccati» votava i reparti all 'o locausto tattico. Il Maresciallo capo del Governo ha la responsabilità di aver gettato sulle spalle di tutti gli ignari comandanti, dalle Armate ai Plotoni, la tragica scelta di sua esclusiva competenza: la resa anche ai tedeschi, o una lo tta disarticolata e senza speranza contro l'alleato, nel momento stesso in cui lo Stato si era arreso al nemico.
All'alba del 9 settembre infine, il Re, il Governo ed il capo di S.M. generale assunsero congiuntamente la responsabilità storica di NON DIFENDERE ROMA, per non coinvolgerla in azioni di guerra. A seguito di questa decisione il capo di S.M. dell'esercito ordinò al Generale Carboni di ritirare su Tivoli tutte le truppe dislocate nella zona di Roma. Carboni fu dunque l'unico comandante di Grande Unità che all'atto dell'armistizio ricevette un ordine scritto da suo superiore diretto . Ordine generico, incompleto, ma tecnicamente eseguibile e chiarissimo nelle sue implicazioni politiche e operative .
Accadde però che proprio questo Generale fin dall'alba del giorno 9 si rese irreperibile per incapacità di comando e personale viltà, lasciando tutta la pesante responsabilità operativa · al suo modesto capo di S.M .. Ricomparso a Tivoli nel pomeriggio, accettò di trattare un resa proposta dal nemico, che prometteva di non condurre prigioniere in Germania le truppe da lui dipendenti. Al mattino successivo infine Carboni ordinava al suo corpo d'armata ancora in via di ripiegamento su Tivoli, di rigirarsi e muovere all'attacco delle colonne tedesche intorno a Roma.
(*) Vedi le «Memorie segrete» del Generale Utili, venute alla luce nel settembr e 1982 su «Storia Illustrata (Milano, Mondadori).
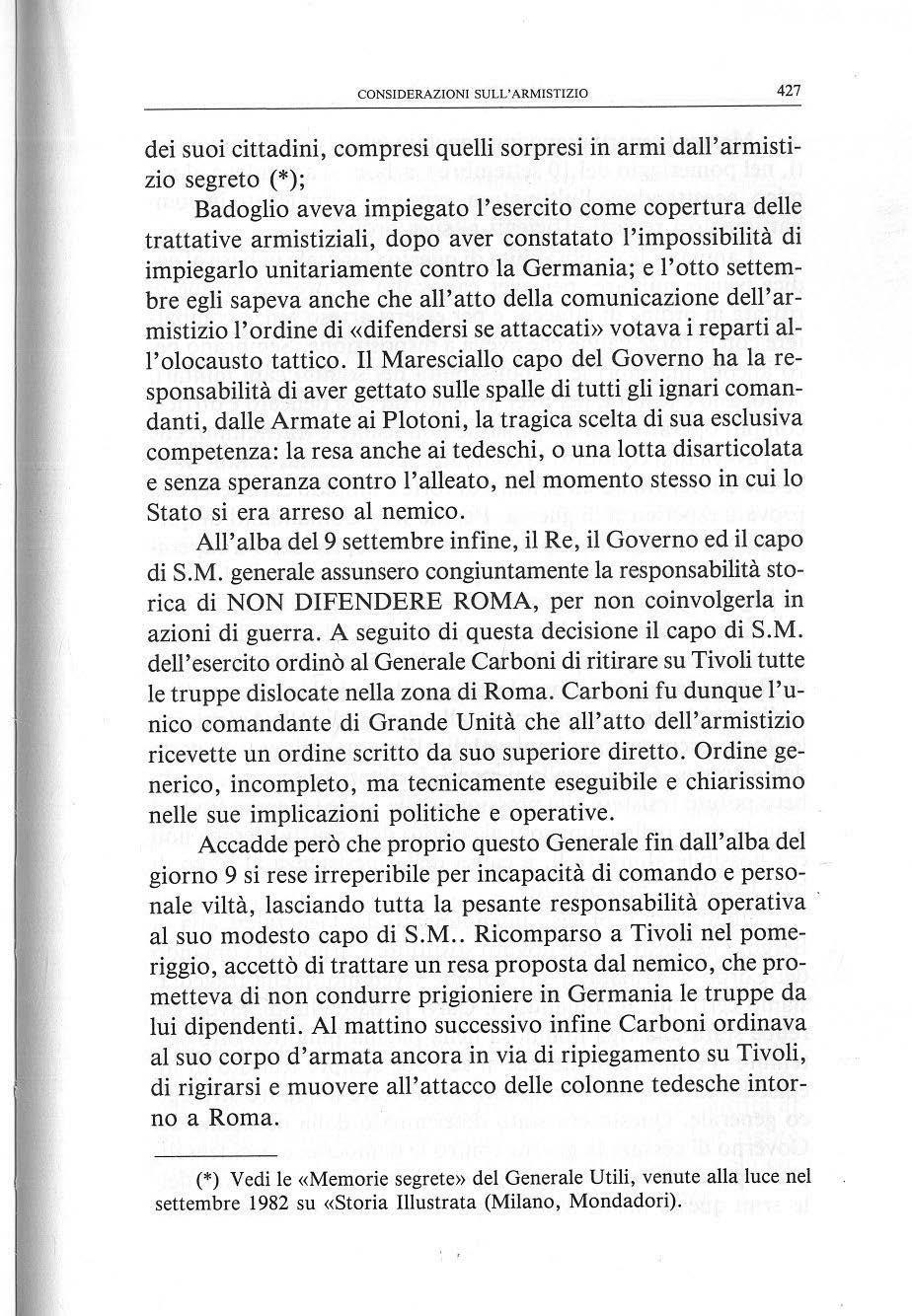
Mentre i reparti erano impegnati in questi caotici movimenti, nel pomeriggio del IO settembre Carboni si arrendeva al nemico, accettandone l'ultimatum, senza aver impiegato in combattimento i reparti efficienti ai suoi ordini.
Lampanti le resposabilità di questo Generale in base al codice penale militare, per aver capovolto un preciso ordine di ritirata in ordine di attacco, e per essersi arreso senza combattere con le forze valide che aveva a disposizione. Sembrano però ancora maggiori le responsabilità dei sommi capi militari, Ambrosio e Roatta, per aver affidato un così delicato e diffide compiti operativo ad un generale politicante e traffichino, che non aveva mai condotto in çombattimento Grandi Unità, invece che conferirlo ad un soldato di forte e limpido carattere, con provata esperienza di guerra. Perchè solo Comandanti di questo tipo, che in genere i politici non amano, riescono a superare le crisi supreme, vincendo o perdendo, ma senza mai scrivere pagine nere nella storia degli eserciti.
È certissimo che altri Generali italiani, al posto di Carboni, avrebbero espletato d'iniziativa l'ordine di ritirata dettato da Roatta in modo incompleto; avrebbero imbastito una battaglia in ritirata, come ordinato, allo sbocco di valle Aniene con le forze sicuramente impiegabili, l'intera «Piave» e parte dell' «Ariete». Con le spalle ai monti, facilitati dal terreno, avrebbero potuto resistere alla pressione delle forze tedesche fino ad esaurimento delle munizioni al seguito dei reparti. Perchè non era possibile alimentarli, a causa della inesistenza al tergo di basi logistiche precostituite.
Questo era il preciso intendimento del Generate Calvi di Bergolo nel caso avesse dovuto sostituire Carboni al comando del Corpo d'Armata. Tutti noi che vivemmo quella tragedia, siamo certi che al comando di Calvi la battaglia di Tivoli sarebbe stata una riga luminosa nella pagina buia dell'otto settembre. Fermo restando che si sarebbe sempre trattato di un episodio tattico, che non poteva modificare il quadro strategico generale. Questo era stato determinato dalla decisione del Governo di cessare la guerra contro le democrazie occidentali, pur sapendo di non essere in grado d"'imporre con la forza delle armi questa nostra volontà politica alla Germania nazista.
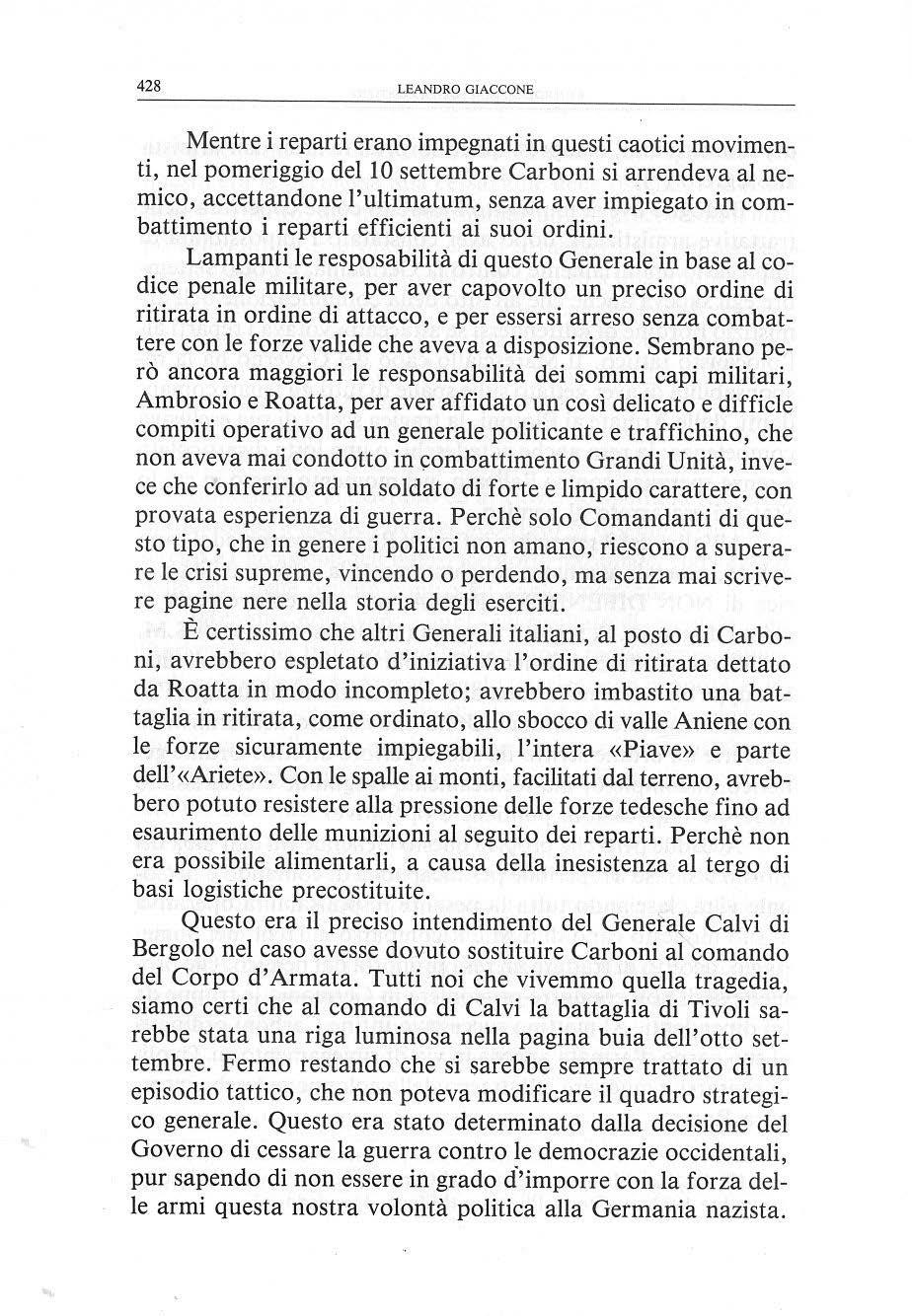
Questo nostro Convegno obbedisce a un intento ben definito, si prefigge una sua determinata linea da seguire. Giovanni Spadolini ne ha tracciato magistralmente le direttive, nell'aprire i nostri lavori: fare, direi, il punto della navigazione, della fortunosa navigazione intrapresa dalla ricerca e dalla critica · storica nei riguardi di un passato che, a quarant'anni di distanza, non si presenta ancora sotto una prospettiva storica, si muove ancora nelle agitate acque della polemica o dell'apologia. Se noi ripercorriamo il cammino della storiografia sull'8 settembre, assistiamo si a un progressivo processo di emancipazione dalle originarie posizioni di battaglia; ma è un processo lento, graduale (qualche gradino capita talora di scenderlo, anzichè di salirlo) e spesso non privo di contraddizioni. Furono, dapprima, le testimonianze di chi aveva recitato una parte in quel che era successo e sentiva, a cose fatte, il bisogno di difendersi o di accusare, col pretesto di un contributo alla ricerca della verità. Anche se, con l'andar degli anni, il tono si smorza, resta pur sempre il peccato d'origine, una tesi da sostenere, una causa da difend~re, una accusa da avanzare. Con la ripresa di studi in occasione del ventennale dell'armistizio, i segni di una svolta verso un'indagine obbediente ai criteri della ricerca storica e non agli impulsi della passione politica, si manifestano in piena evidenza. Basti citare ad esempio il volume del generale Ettore Musco, edito da Garzanti nel 1963, dal titolo «La verità sull'8 settembre». Un'opera che, si può dire, ha segnato una tappa, nella storiografia sull'8 settembre: nutrita di una solida documentazione, condotta con impeccabile rigore di metodo, costituisce un valido punto di riferimento a chi voglia segnare la rotta di questa fortunosa navigazione.

E come tale, ho ritenuto opportuno ricordarla. Perchè queste m~e brevi, succinte note non pretendono nemmeno lontanamente di tracciare un sia pur sommario schizzo di storia della storiografia in argomento; si propongono semplicemente di segnalare alcuni punti di riferimento che possono apparire particolarmente significativi. Ad esempio, l'ultima, in ordine di tempo (risale, a quanto mi risulta, a pochi mesi fa), la più recente delle opere in argomento, una brillante sintesi, una penetrante diagnosi, che ha già raccolto numerosi consensi: «L'Italia si arrende: la tragedia dell'8 settembre». Autore, Domenico Bartoli .
Una speciale attenzione merita l'ampio lavoro di Joseph Schroder, dedicato, appunto, a «L'uscita dell'Italia dalla seconda guerra mondiale, 1943» (Jtaliens Kriegsaustritt 1943, Gottingen 1969) che fa parte della Collana di studi e documenti per la storia della seconda guerra mondiale, a cura dell'Arbeitskreis fur Wehrforschung di Stoccarda. Un'ampia ricostruzione della vicenda dell'armistizio, condotta con rigore di metodo su di una solida base di ricerca, una vera miniera di dati e di documenti, che ha come centro di gravità il problema dell ' alleanza italo-tedesca; filo conduttore «le contromisure tedesche nello spazio italiano» («die deutsche Gegenmassnahmen im italienischen Raum», come dice il sottotitolo stesso del volume), con particolare riguardo ai due noti piani per il controllo militare «dello spazio italiano», il piano Alarich e il piano Achse, accuratamente elaborati in anticipo.
Ho sottolineato quest'ultima pubblicazione, perchè occupa un posto di primo piano nella «letteratura dell'atgomento», per la ricchezza dei dati, la complessità dell'impostazione. Il fatto poi che graviti sui rapporti con la Germania, le conferisce un particolare carattere e un particolare interesse. A questo proposito, valga segnalare l'opera parallela dell'austriaco . Kar1 Stahlpfarrer, sulle operazioni militari tedesche nelle Prealpi e sulle coste adriatiche («Die Operationszonen «Alpen Vorland» und «Adriatischen Kusten», Wien, 1969), che, del lavoro dello Schroder, costituisce una opportuna integrazione anche nei riguardi di un sensibilmente diverso angolo visuale.
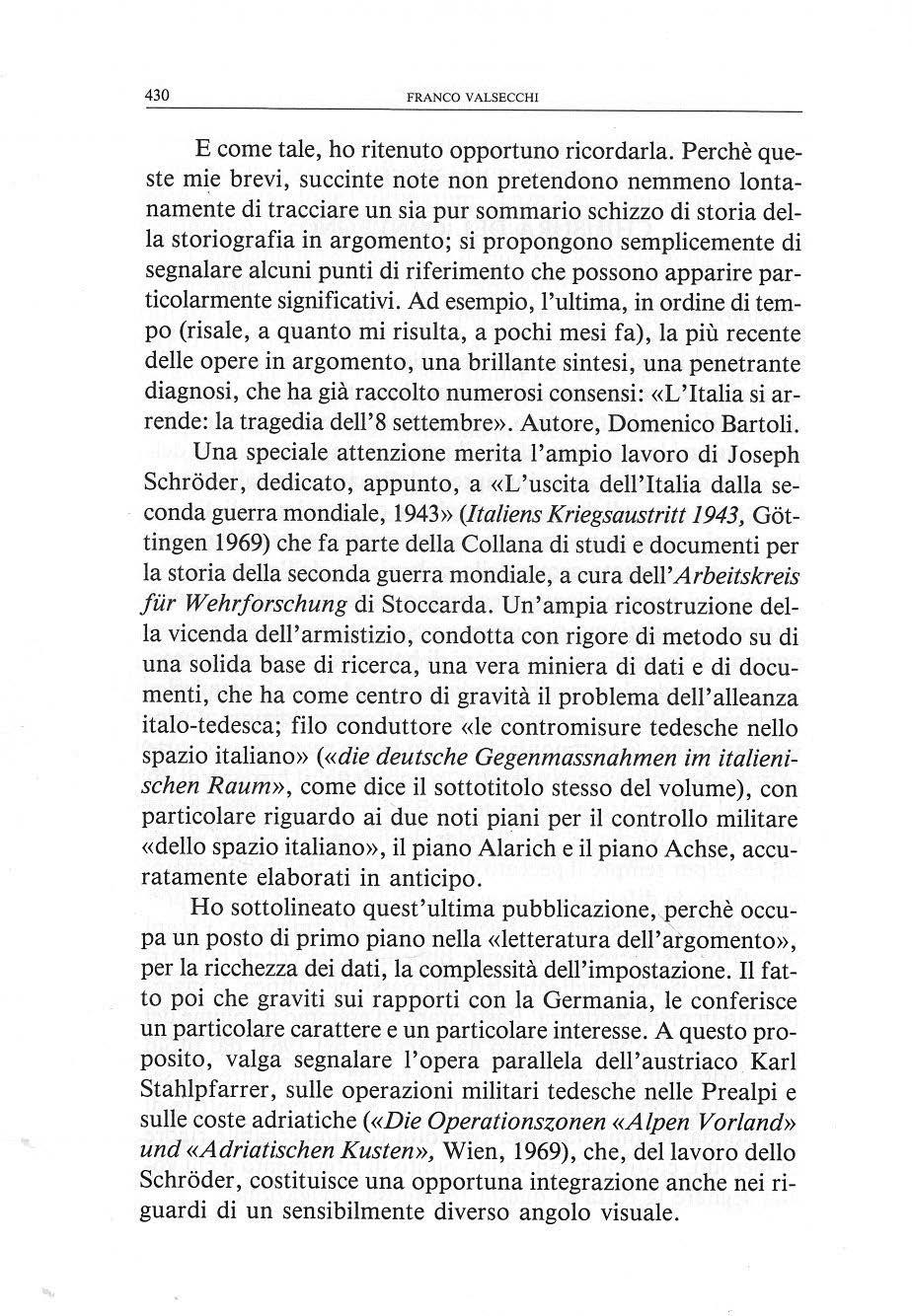
Di fatto, sin dall'inizio della guerra, grava, sull 'alleanza fra l'Ita lia fascista e la Germania nazista, l'ipoteca di una situazione incerta ed ambigua. I vistosi successi riportati dalle armi tedesche avevano suscitato in Mussolini, a conti fatti, più allarme che compiacimento. Quel che lo spinge a scendere in campo non è la solidarietà, ma la rivalità con l'alleato. E qui, valga ricordare una di quelle battute clandestine, espressione, autentica espressione di un'opinione pubblica che non poteva esprimersi altrimenti: «Mussolini si è attaccato alla coda del toro per non pigliar le cornate».

Una battuta che implica, se non un giudizio, certo uno stato d'animo verso l ' alleato tedesco: un senso di pericolo, data la sproporzione delle forze. Una singolare alleanza. All'insofferenza degli italiani risponde la diffidenza dei tedeschi, la loro sfiducia nell'efficienza dell'alleato, i loro dubbi sulla sua fedeltà.
L'Italia costituisce una pedina troppo importante, nella partita che si gioca in Europa, per non prendere le debite precauzioni. Vien preparato, in vista di possibili, prevedibili co mplicazioni, un piano di emergenza, il «piano Alarico»: un piano ben definito, sistematicamente concepito, secondo i canoni della Grundlichkeit germanica, di quel consequenziario andare fino in fondo che caratterizza la mentalità germanica. L'alleata Italia si tramuta in una specie di «sorvegliato speciale». ' Sopravviene il 25 luglio, la caduta, l'arresto di Mussolini. La macchina del piano Alarico si mette in moto; si provvede a un consistente aumento della «guarnigione» tedesca in Italia, a progressivi invii di truppe dalla Germania, in modo da tener sotto controllo quello che resta pur sempre un alleato, tanto più che agli interrogativi della politica italiana vengono ad aggiungersi quelli di uno sbarco anglo-americano, preludio di una «campagna d'Italia» che segnerebbe l'apertura di un nuovo fronte. All'annunzio dell'armistizio, 1'8 settembre, la risposta
è immediata: occupazione dell'Italia Settentrionale, dell'Emilia, d elle Marche, occupazione formale che v eniva a sancire l'oc-
cupazione di fatto già in atto dopo il 25 luglio: gli occupanti a ss umono il potere, le forze armate italiane residenti in loco son costrette alla resa. Il 9 settembre, all'indomani dell'annunzio dell'armistizio, si procede, da parte germanica, a un massiccio attacco a Roma; segue, il giorno dopo, l'occupazione. Il 12 settembre, liberazione di Mussolini; undici giorni dopo, il 23 settembre, a Salò, dove si era rifugiato Mussolini, proclamazione del nuovo Stato fascista, la Repubblica Sociale Italiana. Tirando le somme, lo Schroder viene alla conclusione che, a conti fatti, per la politica germanica, si può parlare di un successo, sia pure, come egli stesso lo chiama, un successo negativo, in quanto che la situazione italiana non era più quella di prima: l'alleato d'oggi, la repubblica di Salò, comprende nel suo territorio solo una parte della penisola; dal!' altra parte, nel Sud, il governo del re, il regno del Sud, base e campo di manovra degli eserciti inglese e americani per la loro «campagna d'Italia».
Certo è che, dato e concesso, se si vuole, questo successo negativo nei riguardi della Germania, non si può certo dire altrettanto per l'Italia, divenuta campo di battaglia, divisa in due fronti nemici in una spietata guerra civile. Da una parte, l'Italia che combatte sotto la bandi era della democrazia, a fianco delle Potenze dell'Occidente; dall'altra, l'Italia che combatte sotto la bandiera di un fascismo sopravvissuto a se stesso, al rimorchio della Germania nazista.
La «repubblichina» di Salò ... Si tratta, per c:;_hi vi parla, di un'esperienza vissuta: ero, in quegli anni, professore all'Università di Pavia. Permettete che, per un breve momento, al relatore subentri il testimone. La sensazione della fragilità del1'edificio dietro la facciata della retorica celebrativa ufficiale , era ormai un dato acquisito nell'opinione corrente. All'Università, le cariche accademiche portavano come etichetta d'obbligo la qualifica fascista, a cominciare dal rettore. Ma cosa si nascondeva sotto quell'ostentata etichetta? Al più, l'opportunismo di chi vuol coprire una carica, e si adatta a una qualifica
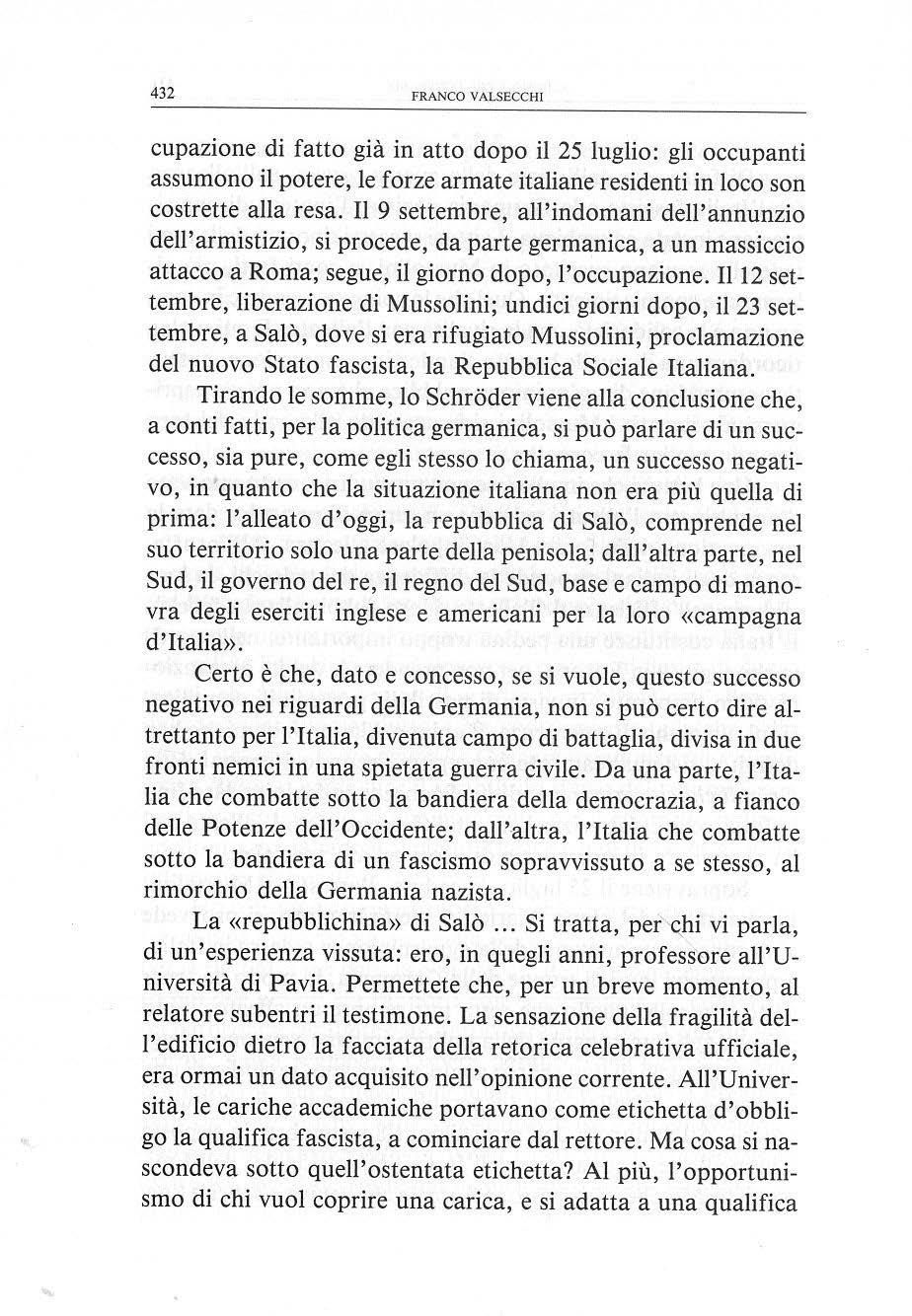
che considera puramente formale. Mi recai un giorno dal rettore «fascista», dietro incarico del CL~, per parlargli di alcune misure nei riguardi sia dei professori che degli studenti, che apparivano vessatorie e inopportune. «Vengo - esordii con una certa enfasi -a nome dell'al tra sponda». E lui, di botto: «ma qual'è l'altra sponda? Quale delle due è l'altra sp onda? Confesso che non ci capisco più niente». Ancora una vo ita, una prova del vuoto che si nascondeva sotto alla cortina del conformism o ufficiale.
Abbiamo già avuto occasione di rifarci ad una di quelle battute clandestine, co me autentica testimonianza di uno stato d'animo che non aveva nulla a che fare con l'ostentato ottimismo del regime. Una ne vorrei ricordare , una pregnante battuta che ria ssu meva drasticamente la paradossale sit uazion e nella quale si trovavano gli italiani nella «repubb li china»: «Se perdiamo siamo perdenti, se vinciamo siamo perduti». * * *
Sarei ritornato volentieri sull'argomento «Germania», se avessi avuto la possib ilità di discuterne con l'amico P eterse n, al quale era stata affidata, appunto, la relazione su «l 'armistizio e il Reich». Non si poteva fare scelta migliore. Collaboratore, da anni ormai , di quella vera e propria fucina di studiosi che è l'Istit uto Storico Germanico di Roma, è uno dei più quotat i conoscitori del periodo in questione, al quale ha dedicato importanti studi; vorrei ricordare, ai fini che qui ci interessano, il suo lavoro: «Hitle r e Musso lini: la difficile alleanza». Purtroppo, è stato tratt enuto a Roma da perentori impegni, e non è qui fra noi .
Me ne dispiace. L'argomento Germania rientra nel «d ialogo dei massimi problemi», per il no stro convegno; il non aver potuto se ntire un esperto come Petersen ha ap ert o, senza dubbio, una lacuna. « II dialogo dei ma ss imi problemi» ... Il problema dell 'alleato viene ad allinearsi, a livello parallelo, col pro-
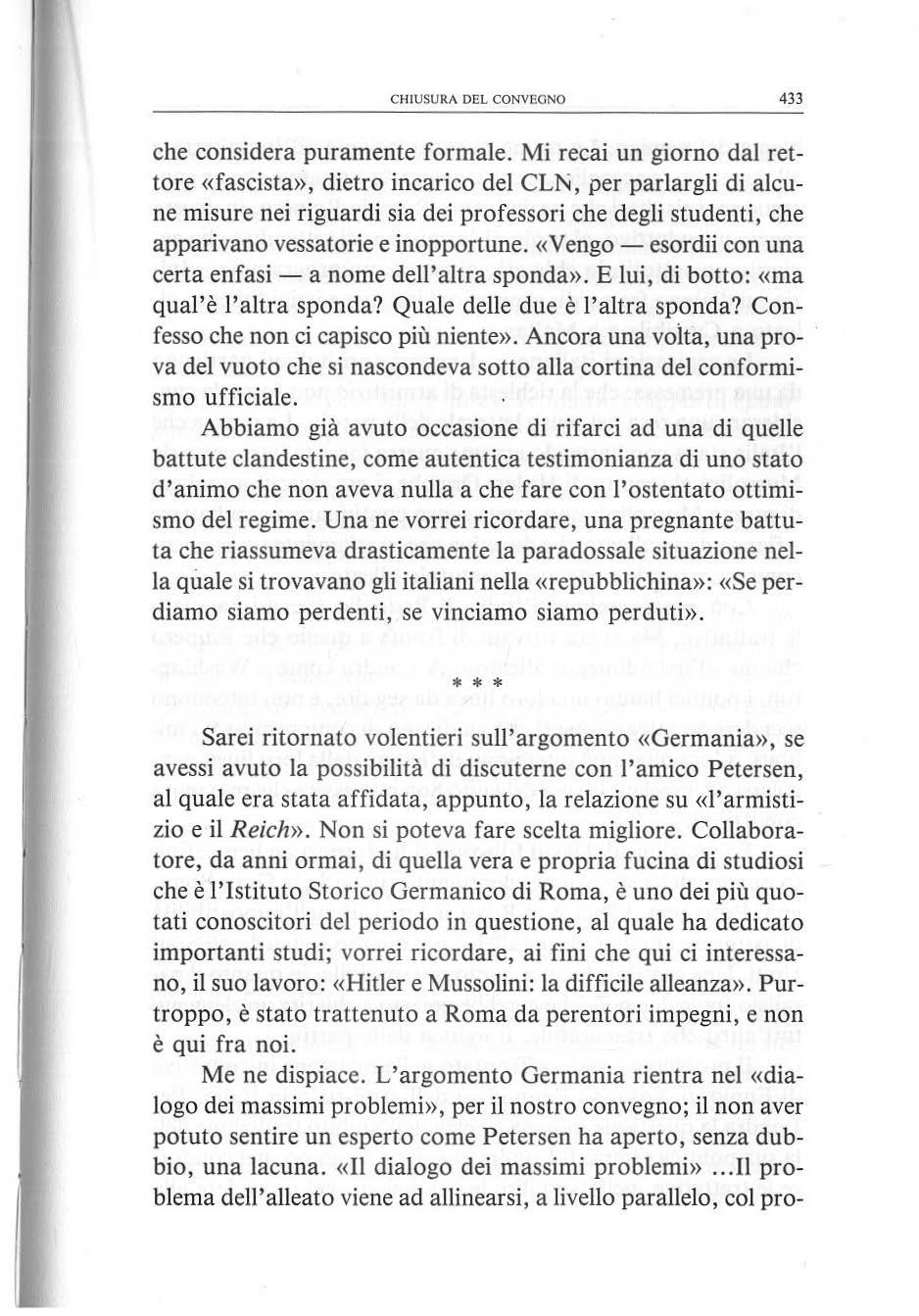
blema del nemico. Le prime avances italiane all' Inghilterra e all'America, le accoglienze che trovano, le trattative che ne conseguono, i risultati che ne derivano. Romain Rainero, in un suo saggio introduttivo, al titolo «L'armistizio di settembre» ha aggiunto un sottotitolo ch'è già, di per sè, un programma: «Inizia un dialogo fra sordi: aspirazioni italiane e irrigidimento alleato a Cassi bile e a Malta».

Le aspirazioni italiane ... I negoziatori italiani partivano da un a premessa: che la richiesta di armistizio non fosse da considerare una resa nel senso letterale della parola. La guerra che l'Italia stava combattendo era una guerra fascista intrapresa da Mussolini al seguito di Hitler. Ora che si era riusciti a togliere di mezzo Mussolini, non aveva senso continuare a combattere a fianco di un alleato che diveniva necessariamente un nemico, contro un nemico che era il naturale alleato.
Con questo animo, l'Italia di Badoglio aveva intavolato le trattative. Ma si era trovata di fronte a quello ch e Rainero chiama «l'irrigidimento alleato». A Londra come a Washington, i politici hanno una loro linea da segu ir e, e non intendono scendere ad atteggiamenti che giud icano di compromesso; i militari, a lor volta, non intendono deflettere dalla loro linea, vinco larsi ad impegni: la resa del vinto non può essere che resa senza condizioni.
La relazione di David Ellwood ci ha fornito un ben definito quadro della situazione, per quanto riguarda la Gran Bretagna. Putroppo, Elena Aga Rossi si è trovata nell'impossibilità di assolvere al co mpito parallelo, per quanto riguarda gli Stati Uniti. Una sensibile lacuna, tanto più sensibile , in quanto il parallelo fra le due politiche avrebbe portato a chiarire un elemento tutt'altro che trascurabile, il «gioco delle parti».
Il problema è stato affrontato nella relazione introduttiva di Ennio di Nolfo su l 'a nnun z io dell'armisti z io in Italia. Per Lond ra la que st ione italiana rientra nell'ambito tradizione della sua politica estera. È Londra che tiene il campo, nel condurre le trattative, nello stab ilir e le condizioni, nel procedere alla
loro esecuzione. Al realismo imperial e di Londra fa riscontro l'idealismo di Washington, l'intonazione messianica di stampo wilsoniano, l'America come custo de e campion e dell'idea demo cratica nel mondo, secondo la tradizione ormai acquisita della politica statunitense. Il che implica una alternativa fra intransigenza e comprensio ne, ben distinta dal realismo britannico .
In ghilter ra , Stati Uniti ... A completare il panorama internazionale, era in progetto, anzi in programma una relazione su «L'armistizio e la France libre»: i contatti, i rapporti, ipourparlers del nuovo Governo italiano con la Francia libera. Era stato designato come relatore Pierre Milza; ma della sua relazione non pervenne traccia al Co nve gno. Resisto alla tentazione di entrare in argomento; è un capitolo a sé, che ci porterebbe troppo lontano, in queste succinte note concl u sive.
Quello di cui ci stiamo occupa nd o ora è il vero e proprio regolamento dei cont i con gli avversari in campo, il «dialogo fra so r di», di cui parlava Rainero. Di fron t e all'atteggiamento britannico e americano, si manifesta, da parte italiana, un disorie ntamento sempre più palese, un c rescendo di incert ezza, di equivoci, che si riflette, dal tavolo delle trattative, su quanti hanno in mano, in Italia, le leve di manovra. Quella che si potrebbe chiamare « l 'organizzazio ne della sc onfitta», le misure da prendere, gli ordini da impartire a norma d'armistizio, si riso lve in un seguito di provvedimenti improvvisati, imbastiti sul momento, senza effettivo coord inam ento .
Con tutte le conseg uenze che ne derivano. La relazione di Massimo Mazzetti s u «L 'armistizio, la situazion e militare e la strateg ia generale», que lla del co lonn ello Bertinaria su «Gli armistizi del settemb re 1943. Comando Supremo ed esercito» hanno su scitato, l'avete visto, le più accese disc uss i oni. Si sono susseguite le più vio lente req ui sitorie contro il comportamento n el vertice delle forze armate, la loro inca paci tà di adottare una linea di co ndotta coerente e cons egu en te, nell'esecuzione delle misure che i comand i eran r iusciti ad adottare. Non rientra nei mie i compiti, qui, di recitare la parte del pubblico mini stero;
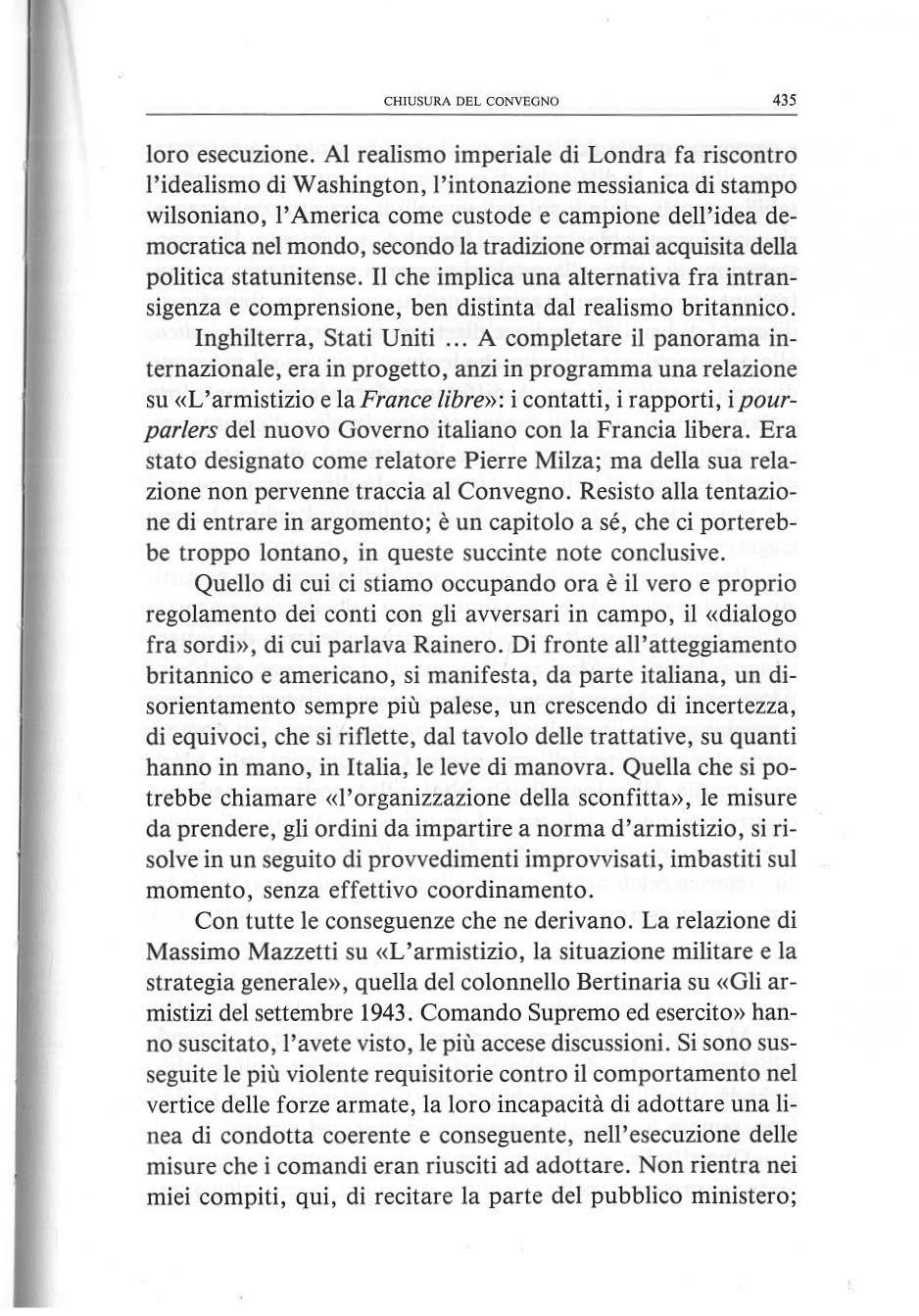
e nemmeno quella dell'avvocato difen sore. Solo una constatazione di fatto; la difficoltà di muoversi nel caos, gli insormontabili ostacoli, gli indissolubili vincoli di una situazione precaria e confusa che bloccava ogni libertà di movimento. Una co nstatazione di fatto, alla quale si accompagna tuttavia, una alt rettan to valida cons id erazione: n ell'assenza di un preordinato disegno , di ben definite lin ee direttive , il ricor so more italico, alle occasionali vie d'uscita che le sin go le situazioni potevano di volta in volta offrire. A differ enza dei tedeschi, con i loro elaborat i piani, ai quali fa ceva seguito, in caso d 'emerg enza, una sistematica esecu zio ne. Corse, in proposito, una battuta non priva di sapore: «I tedeschi sono stati, a l solito, troppo pesan ti nel provvedere ai fatti lo ro. E gli italiani, al solito, troppo leggeri».
Pesante, in compenso , fu il costo dell'op erazione armi stizio per gli italiani. Abbiam o fatto cenno a quello che er a costata a lle forze armate italiane l'occupazione tedesca del sette nt ri one d'Italia. La Marina e l'aeronautica pagaro no anch'esse il loro pre zz o. Ma un buon numero di navi e di aerei riuscirono a raggiungere le linee alleate, sia pure attraverso fortu n ose vicende. La relazione dell'ammiraglio G. Galuppini s ulla Marina, e quella del colonnello Casolini sull'Aeronautica seg uono passo passo questa odissea, ad un tempo, dell'uomo di studio e dell'uomo di mestiere, sen za cedere alle tentazioni di una faci le retorica celebrativa, nè a quelle di una non meno facile reto r ica in quisitoria .
* * *
Ma non s ono solta nto i militari, su l ba nco degli accusati. Gli errori, le colpe dei militari, risalgono, sovente, più in a lto, a chi dà gli ordini, non a chi li riceve , ai detentori, o ai titolari (non sempre le due ca tegorie coincidono), del potere.
Quest' Itali a, confinata, ormai, al Sud, questo «regno del Sud» , si presenta, nelle trattative d'armisti zio con gli antichi
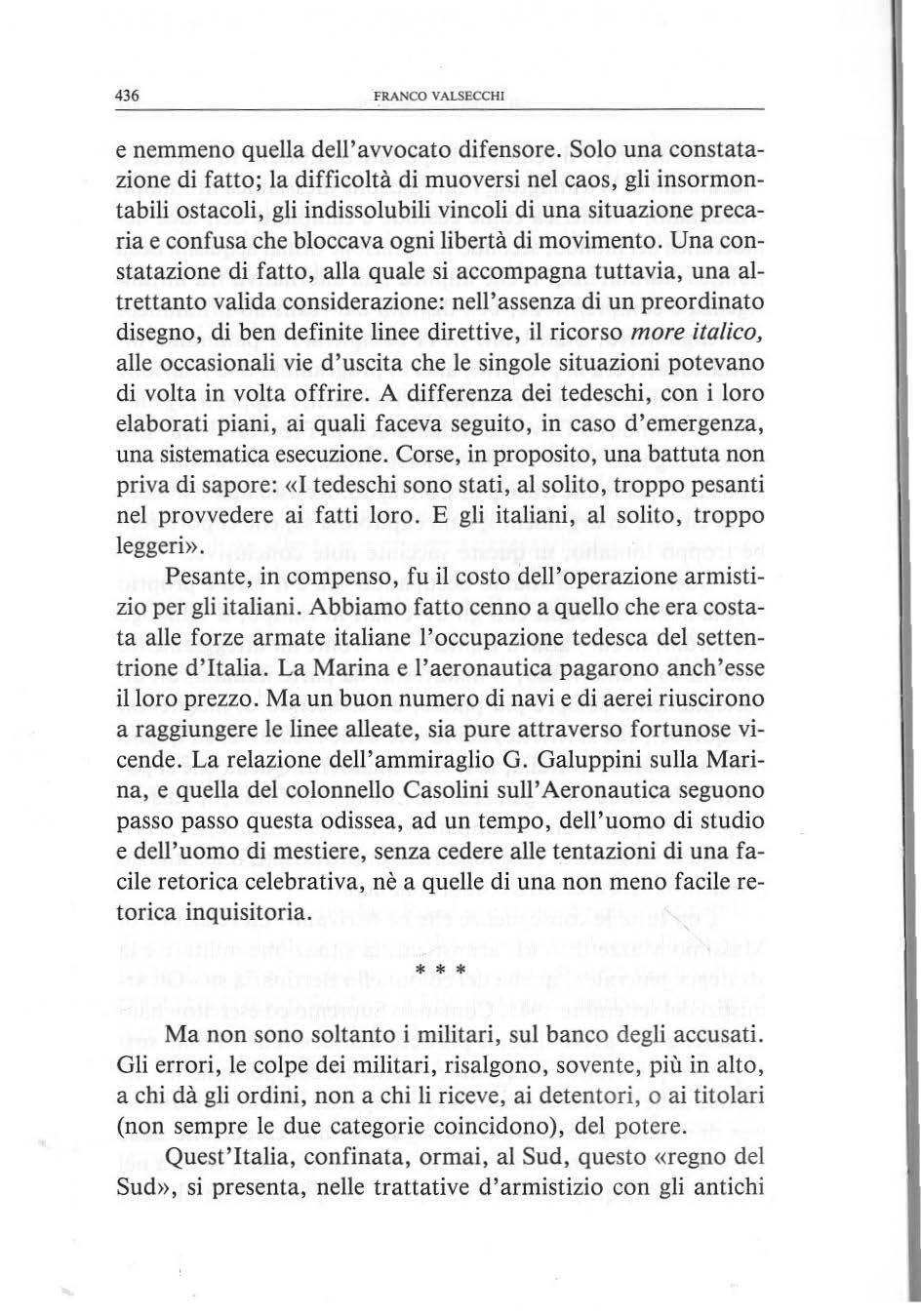
nemici, come un interlocutore, se non legittimo, legale. Il filo conduttore della penetrante relazione di Aldo A. Mola, riguardante «L'armistizio e la Casa reale» è la ricerca e l'interpretazione del «caso Vittorio Emanuele III». Una ricerca e una interpretazione coerenti e conseguenti, ben lungi dal tono di prammatica, dalla tediosa alternativa fra la requisitoria del pubblico ministero e la perorazione dell'avvocato difensore. Vittorio Emanuele III non era uomo da avventurarsi, nella situazione intricata e precaria nella quale si trovava, in rischiose manovre. L'unica via d'uscita egli la vede in un ostentato ritorno alla normalità, alla legalità, alle tradizioni costituzionali della sua Casa, nella speranza di ammorbidire così l'intransigente diffidenza dei nemici di ieri, degli alleati di domani, che grava come una pesante ipoteca svlle trattative d'armistizio.
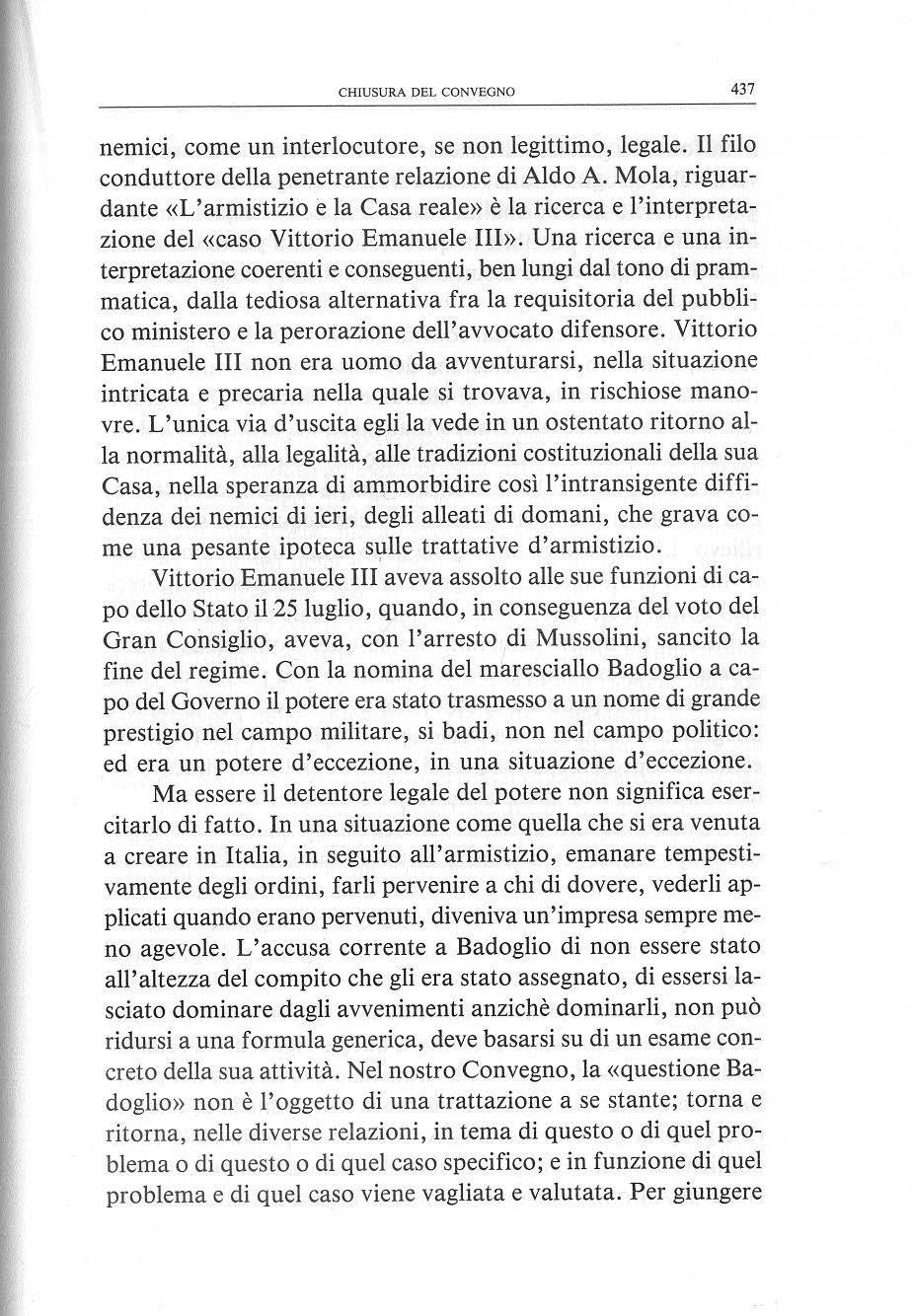
Vittorio Emanuele III aveva assolto alle sue funzioni di capo dello Stato il 25 luglio, quando, in conseguenza del voto del Gran Consiglio, aveva, con l'arresto di Mussolini, sancito la fine del regime. Con la nomina del maresciallo Badoglio a capo del Governo il potere era stato trasmesso a un nome di grande prestigio nel campo militare, si badi, non nel campo politico: ed era un potere d'eccezione, in una situazione d'eccezione.
Ma essere il detentore legale del potere non significa esercitarlo di fatto. In una situazione come quella che si era venuta a creare in Italia, in seguito all'armistizio, emanare tempestivamente degli ordini, farli pervenire a chi di dovere, vederli applicati quando erano pervenuti, diveniva un'impresa sempre meno agevole. L'accusa corrente a Badoglio di non essere stato all'altezza del compito che gli era stato assegnato, di essersi lasciato dominare dagli avvenimenti anzichè dominarli, non può r idursi a una formula generica, deve basarsi su di un esame concreto della sua attività. Nel nostro Convegno, la «questione Badoglio» non è l'oggetto di una trattazione a se stante; torna e ritorna, nelle diverse relazioni, in tema di questo o di quel problema o di questo o di quel caso specifico; e in funzione di quel problema e di quel caso viene vag liata e valutata. Per giungere
a un fondato giudi zio d'insieme, è all'intero ciclo del suo governo che bisogna rifarsi, sino a quel 10 giugno 1944, che segnò il ritorno alla normalità costituzionale - a quel tanto di normalità ch'era possibile in quel momento: il posto del maresciallo Badoglio venne assunto da un eminente uomo politico, Ivanoe Bonomi.
L'argomento esula dai confini del no stro convegno. Mirifaccio, piuttosto, a conclus i one del nostro lavoro, alle due relazioni finali, con le quali si chiude e si conclude il programma: la relazione di Gianfranco Bianchi su «L'armistizio e il fascismo», e quella di Romain Rainero su «Gli armistizi di settembre verso una cobelligeranza». Qui, è il significato stesso, è la portata storica dell' 8 settembre che acquista il suo pieno rilievo. L'8 settembre pone il suggello al 25 luglio rinnegando il vincolo di un'alleanza che gravava come una pesante ipoteca sul regime; mettendosi su lla via di un radicale cambiamento di fronte, di un aperto sc hieramento su que l fronte della democrazia, che aveva impegnato col fascismo una partita di vita e di morte . La repubblica di Salò, che avrebbe dovuto assumere il s ignificato di una restaurazione del regime, si risolve in un effimero espediente, che cerca di coprire con l'as serv imento allo straniero il suo sostanziale vuoto interiore.
Un mutamento di fro nte , si diceva, che, nelle sue origini, nei suo i sviluppi, non si basa certo sul vuoto. Il 25 luglio rispondeva ad uno stato d'animo che andava facendosi sempre più palese e imperioso. E 1'8 settemb re , il passaggio dalla gu erra che si ammantava delle ambizioni del regime, alla guerra di liberazione, permetteva a queste forze di prender e consistenza, di organizzarsi secondo le regole della rinascente democrazia.
Un particolare interesse presenta a questo riguardo la relazione di Lamberto Mercuri su « L'armistizio e la nascita dei par titi». Una evoluzione, questa, che trova nell'armistizio, una vera e propria galvanizzaz ione, ne l rientro in patria delle forze politiche in esilio (è, appunto, il t ito lo di una relazione, la relazione di Antonio Varsori). Eran le avanguardie di quella che
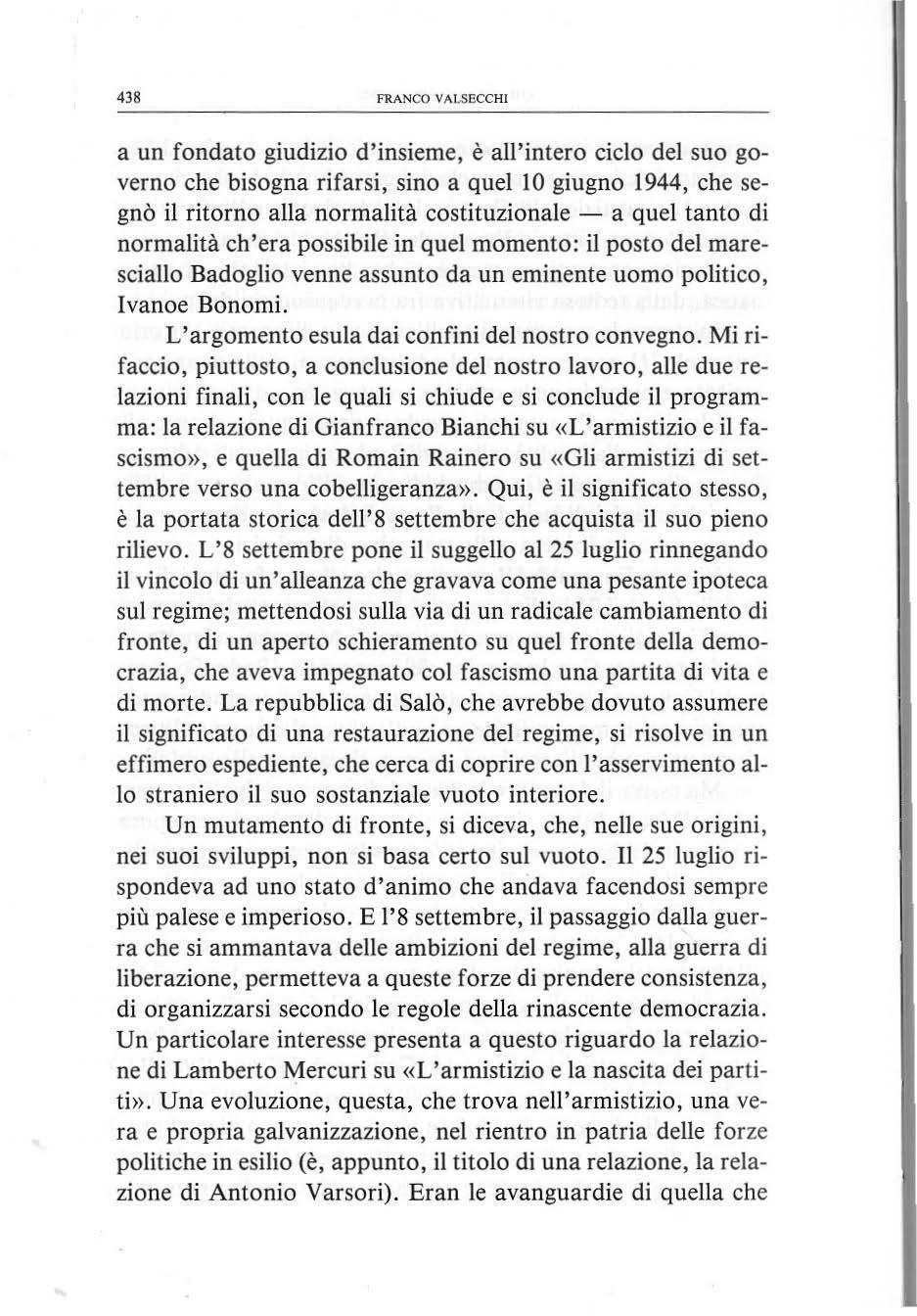
era stata l'opposizione militante al regime, ch e tornavano a prendere il loro posto di combattimento nella cost ru zione del nuovo edificio. Liev iti, fermenti, che si fanno intensamente sentire anche nei settori che la sorte aveva segregato dalla vita della nazione: significativa, in proposito, la relazione cli Romain Rainero su «L'armistizio nei campi di prigionia».
S'era proposto, il convegno, di dire una sua parola, di dare un suo contributo all'evoluzione in atto nella storiografia nei riguardi di uno ieri che, per le generazioni più mature, appartiene non alla storia, ma all'esperienza vissuta. Fare, come si è detto, il punto della navigazione storiografica, non con affermazioni teoriche, ma con un esempio concreto.
Ed ora, a lavoro compiuto, ritengo che in piena scienza e coscienza si possa affermare che lo scopo che ci siamo proposti, nel rigor e del metodo, nell 'ampiezza della ricer ca, nell'aggiornamento delle conclusioni, sia stato raggiunto.
Non mi resta che il dovere e il piacere di fare le mie più vive co n gratulazioni ai promotori, agli organizzatori di questo convegno, per aver saputo elaborare un programma al livello del compito che si erano prefisso, e di aver saputo scegliere dei collaboratori al livello del programma che avevano elaborato.
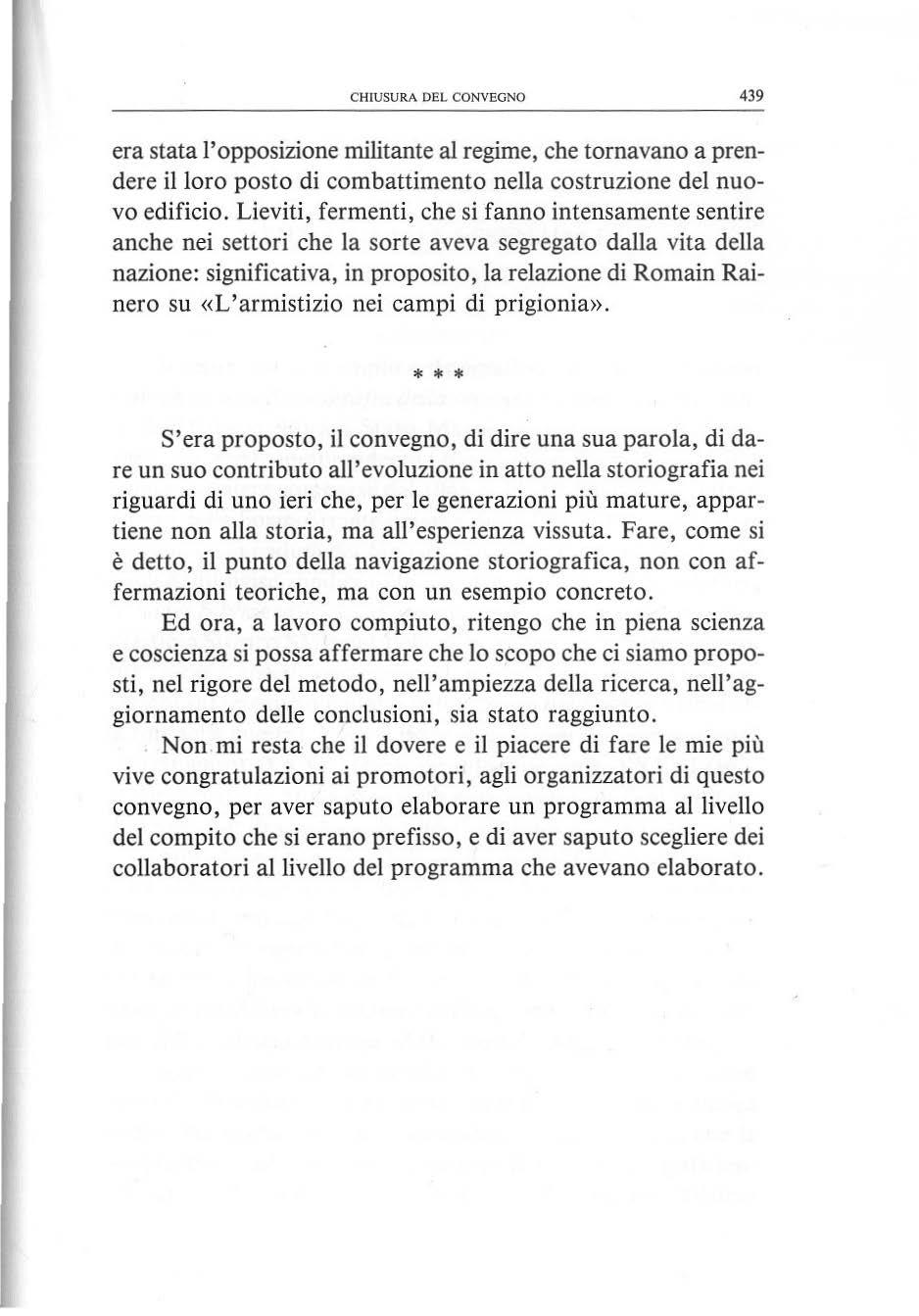
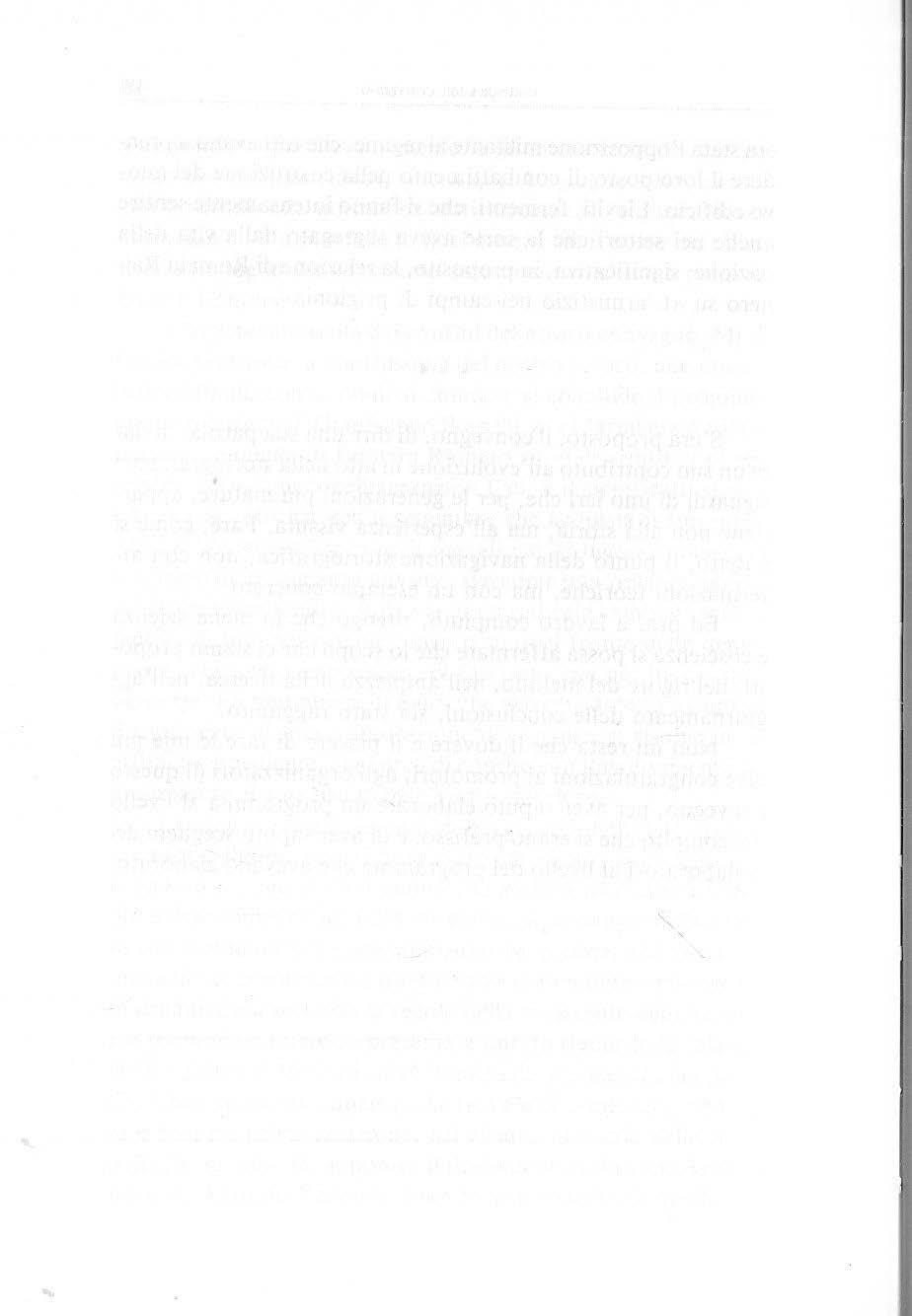
Il repertorio più ampio e sistematico sul tema in discor so è offerto dalla Bibliografia della seconda guerra mondiale edita dall'Ufficio Storico Stato Maggiore dell'Esercito (Roma, 1980, pp . 845), comprendente i titoli delle principali opere italiane e straniere comparse dal 1945 al 1975 e quelle degli Uffici Storici delle Forze Armate italiane sino al 1978. Benché né l'armistizio né la caduta del fa scismo figurino fra le 40 classi nelle quali è suddiviso l'indice di tale poderosa opera, sintesi dei sette Saggi bibliografici sulla seconda guerra mondiale editi dall'Ufficio Storico SME dal 1949 al 1976, non s arà difficile reperire i titoli di specifico interesse all'interno delle classi XIII (Operazioni sul territorio italiano dallo sbarco del 1943 in Sicilia alla fine della guerra), XXXII (Prigionia di guerra e campi di concentramento), XXXIII (Servizio informazioni), XXXVI (Biografie di capi di Stato Maggiore e di governi, di capi militari, di decorati o di caduti) e XXXVII (Memorie, diari, discorsi).
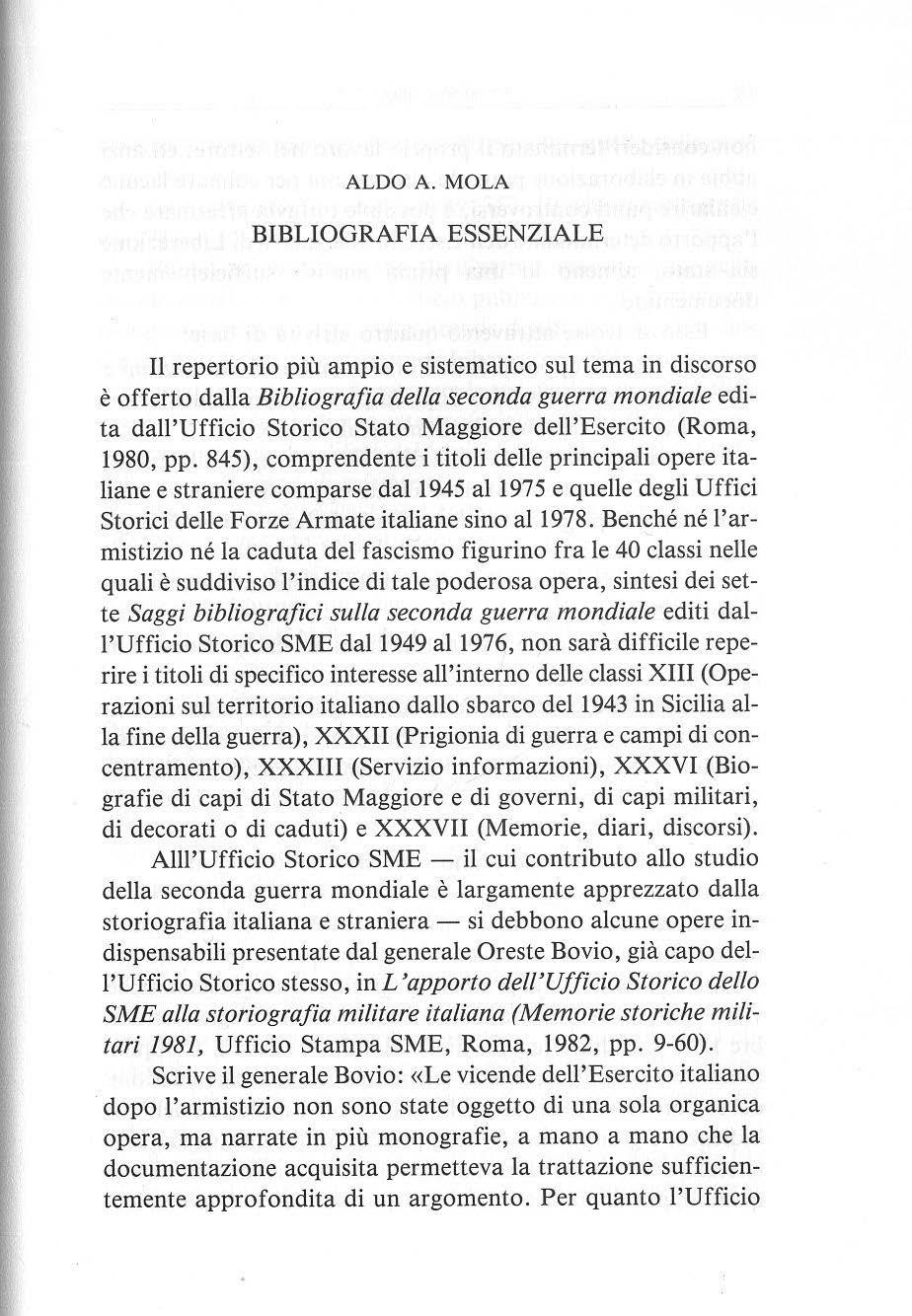
Alll'Ufficio Storico SME - il cui contributo allo studio della seconda guerra mondiale è largamente apprezzato dalla storiografia italiana e straniera - si debbono alcune opere indispensabili presentate dal generale Oreste Bovio, già capo dell'Ufficio Storico stesso, in L'apporto dell'Ufficio Storico dello SME alla storiografia militare italiana {Memorie storiche militari 1981, Ufficio Stampa SME, Roma, 1982, pp . 9-60).
Scrive il generale Bovio: «Le vicende dell'Esercito italiano ·dopo l 'armistizio non sono state oggetto di una sola organica opera, ma narrate in più monografie, a mano a mano che la documentazione acquisita permetteva la trattazione sufficientemente approfondita di un argomento. Per quan t o l'Ufficio
non consideri terminato il proprio lavoro nel settore, ed anzi abbia in elaborazione parecchi altri volumi per colmare lacune e chiarire punti controversi, è possibile tuttavia affermare che l'apporto determinante dell'Esercito alla guerra di Liberazione sia stato, almeno in una prima analisi, sufficientemente documentato.
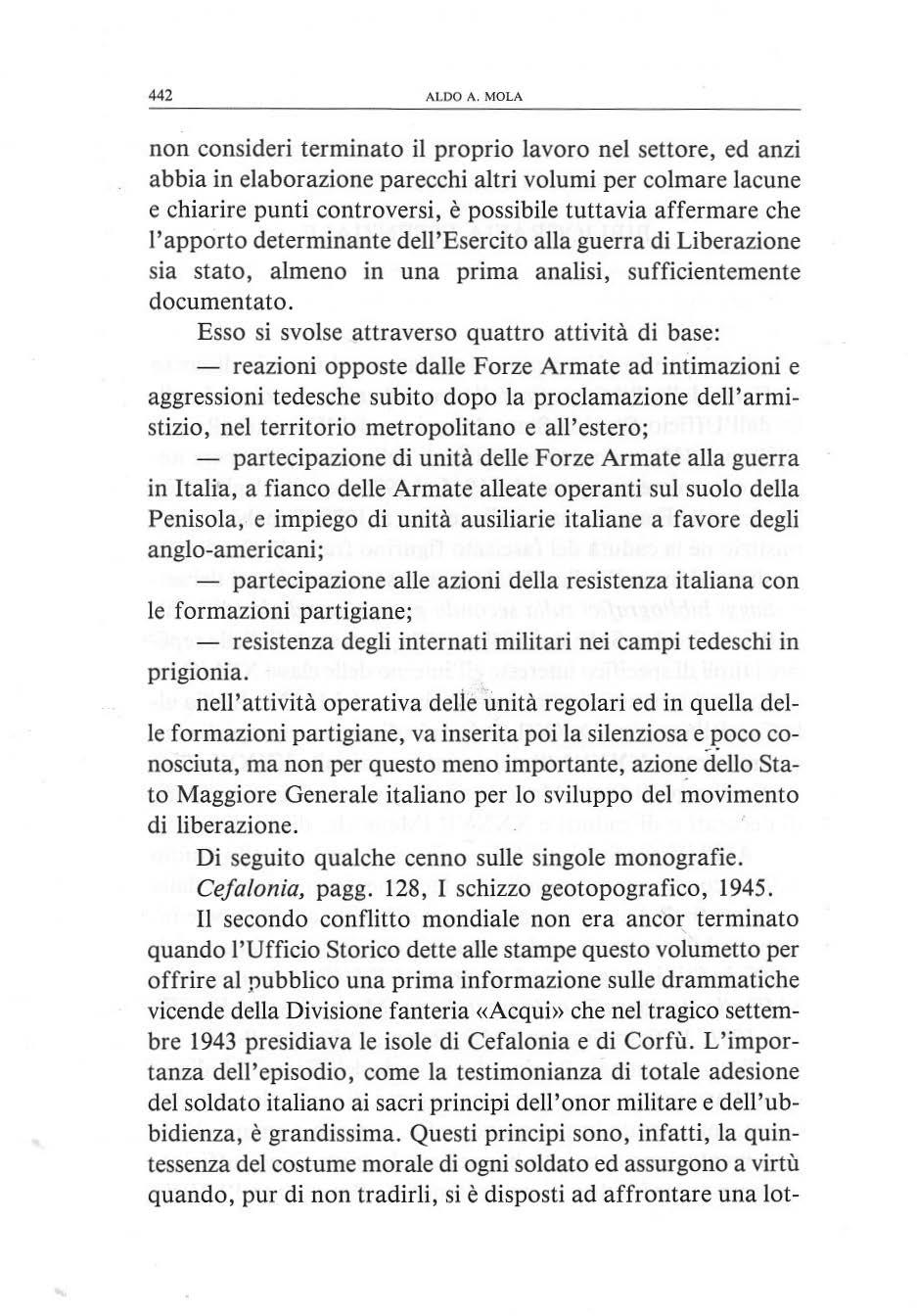
Esso si svolse attraverso quattro attività di base:
- reazioni opposte dalle Forze Armate ad intimazioni e aggressioni tedesche subito dopo la proclamazione dell'armistizio, nel territorio metropolitano e all'estero;
- partecipazione di unità delle Forze Armate alla guerra in Italia, a fianco delle Armate alleate operanti sul suolo della Penisola,. e impiego di unità ausiliarie italiane a favore degli anglo-americani;
- partecipazione alle azioni della resistenza italiana con le formazioni partigiane;
- resistenza degli internati militari nei campi tedeschi in prigionia.
nell'attività operativa delle unità regolari ed in quella delle formazioni partigiane, va inserita poi la silenziosa e _ l?oco conosciuta, ma non per questo meno importante, azione dello Stato Maggiore Generale italiano per lo sviluppo del movimento di liberazione.
Di seguito qualche cenno sulle singole monografie.
Cefalonia, pagg. 128, I schizzo geotopografico, 1945. Il secondo conflitto mondiale non era ancor terminato quando l'Ufficio Storico dette alle stampe questo volumetto per offrire al pubblico una prima informazione sulle drammatiche vicende della Divisione fanteria «Acqui» che nel tragico settembre 1943 presidiava le isole di Cefalonia e di Corfù. L'importanza dell'episodio, come la testimonianza di totale adesione del soldato italiano ai sacri principi dell'onor militare e dell'ubbidienza, è grandissima. Questi principi sono, infatti, la quintessenza del costume morale di ogni soldato ed as surgo n o a virtù quando, pur di non tradirli, si è disposti ad affrontare una lot-
ta senza scampo ed a pagare il prezzo più alto, quello della propria vita.
La riscossa dell'Esercito, pagg. 357, 10 schizzi cartografici, 1948.
Pubblicazione a carattere divulgativo, ma rispettosa nella sostanza della realtà; che l'Ufficio pubblicò per dare al Paese una prima informa zione sulle vicende dell'Esercito prima dell'armistizio e durante la Guerra di Liberazione. Nel volume, coerentemente con il t itolo, è sostenuta la tesi che 1'8 settembre 1943 segnò il punto finale di una catastrofe dalla quale l'Esercito seppe rinascere a diretta difesa del territorio nazionale e del diritto del popolo italiano di esistere.
Le operazioni delle Unità Italiane nel settembre-ottobre 1943, pagg. 765, 34 schizzi cartografici, 1975.
Il volume, che si apre con una trattazione degli antecedenti e reca, in chiusura, una densa appendice documentale, è artico lato in tre parti. Nella prima sono narrate le operazioni svoltesi sul territorio nazionale, n ella seconda quelle avvenute al di fuori, dalla Slovenia al Montenegro, dalla Corsica alla Grecia.
Ogni parte è suddivisa in cap itoli , intitolati ciascuno alle vicende di una Armata o di un Comando autonomo. La terza parte è dedicata agli internati, alle perdite, alle ricompense, al contributo che il risorgente Esercito, in concomitanza con suo impegno nella Guerra di Liberazione, diede al movimento clandestino della Resistenza.
L'azione dello Stato Maggiore Generale per lo sviluppo del Movimento di Liberazione, pagg. 191, 24 tavo le f.t., 1975.
Nel maggio 1945, pochi giorni dopo la conclusione della guerra in Italia, l ' Ufficio Informazioni dello Stato Maggiore Generale riassu ns e in una relazione densa di fatti e di cifre l'attività che il nostro massimo organo militare aveva svolto a sostegno del movimento partigiano nei territori occupati dai tedeschi.
La relazione, pubblicata dall'Ufficio nel triennale della Liberazione, documenta un'attività poco conosciuta e che servì
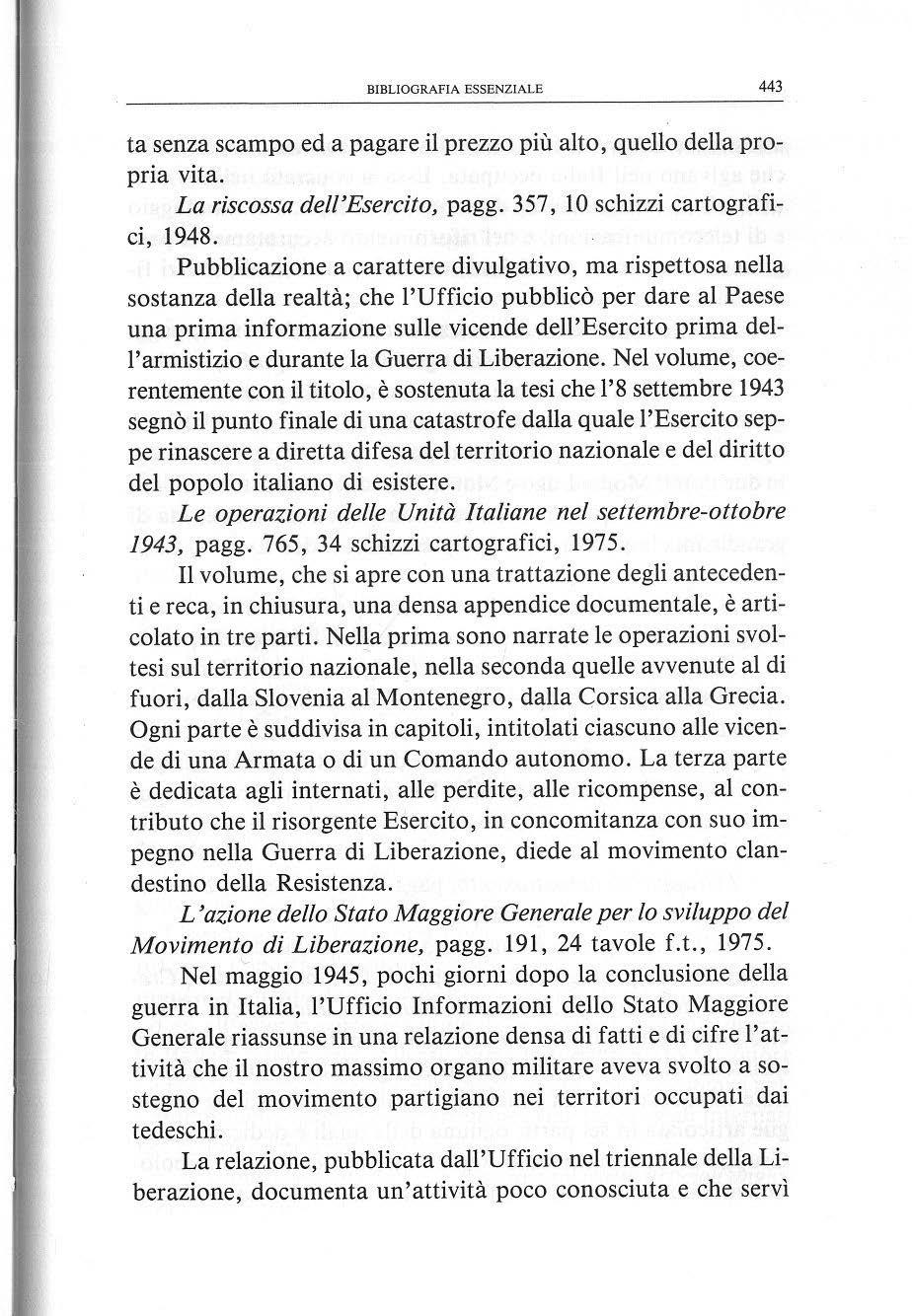
a sostenere materialmente e moralmente le formazioni partigiane che agivano nell'Italia occupata. Essa si concretò nell'in vi o di ufficiali di collegamento, di is.truttori di esperti di sabotaggio e di telecomunicazioni, e nel rifornimento accuratamente programmato di armi, munizioni, vestiario, medicinali, mezzi finanziari e di propaganda.
Il Raggruppamento motorizzato italiano (1943 -1944), pagg. 211, 56 allegati, 11 schizzi cartografici, 5 fotografie, 1949.
È la storia ampiamente documentata della prima unità rego lare dell'Esercito entrata in linea contro i tedeschi. L'attività operativa del Raggrupamento si può sintetizzare e riassumere in due nomi: Monte Lugo e Monte Marrone, combattimenti minori se visti nel quadro della seconda guerra mondiale, ma di grandissima importanza per la ripresa morale dell'Esercito e della Nazione.
Il Corpo Italiano di Liberazione (aprile-settembre 1944), pagg. 340, 68 allegati, 22 schizzi cartografici, 8 fotografie, 1950. Anche que s to volume è la storia rigorosamente do cumentata di un corpo di truppe italiane, il C.I.L., che operò con successo a fianco degli Alleati e che scrisse a Filottrano una bella pagina di storia militare. Le vicende del C.I.L., narrate sempr e con obiettività, chiariscono bene il clima d'incertezza dell'epoca e forniscono un contributo determinante alla con oscen za del periodo.
I Gruppi di Combattimento, pagg. 548, 82 all egati, 24 schizz i cartografici, 33 fotografie, 1951.
Nella monografia è contenuta la narrazione delle vicende di cui furono protagonisti i Gruppi di Combattimento ( Cremona, Friuli, Folgore, Legnano, Mantova, Piceno) che l'Esercito po tè mettere in ca mpo contro i tede schi solo dopo tenaci insistenze e laboriose discussioni con gli Alleati. Dopo alcune note introdutti ve sulla genesi dei reparti, la narrazione prosegue arti c olata in sei parti, o gnuna delle quali è dedicata ad un Gruppo di Combattimento. Opera molto accurata e scrupolosa ment e documen tata, è fondamen tale ai fini di una s icura in-
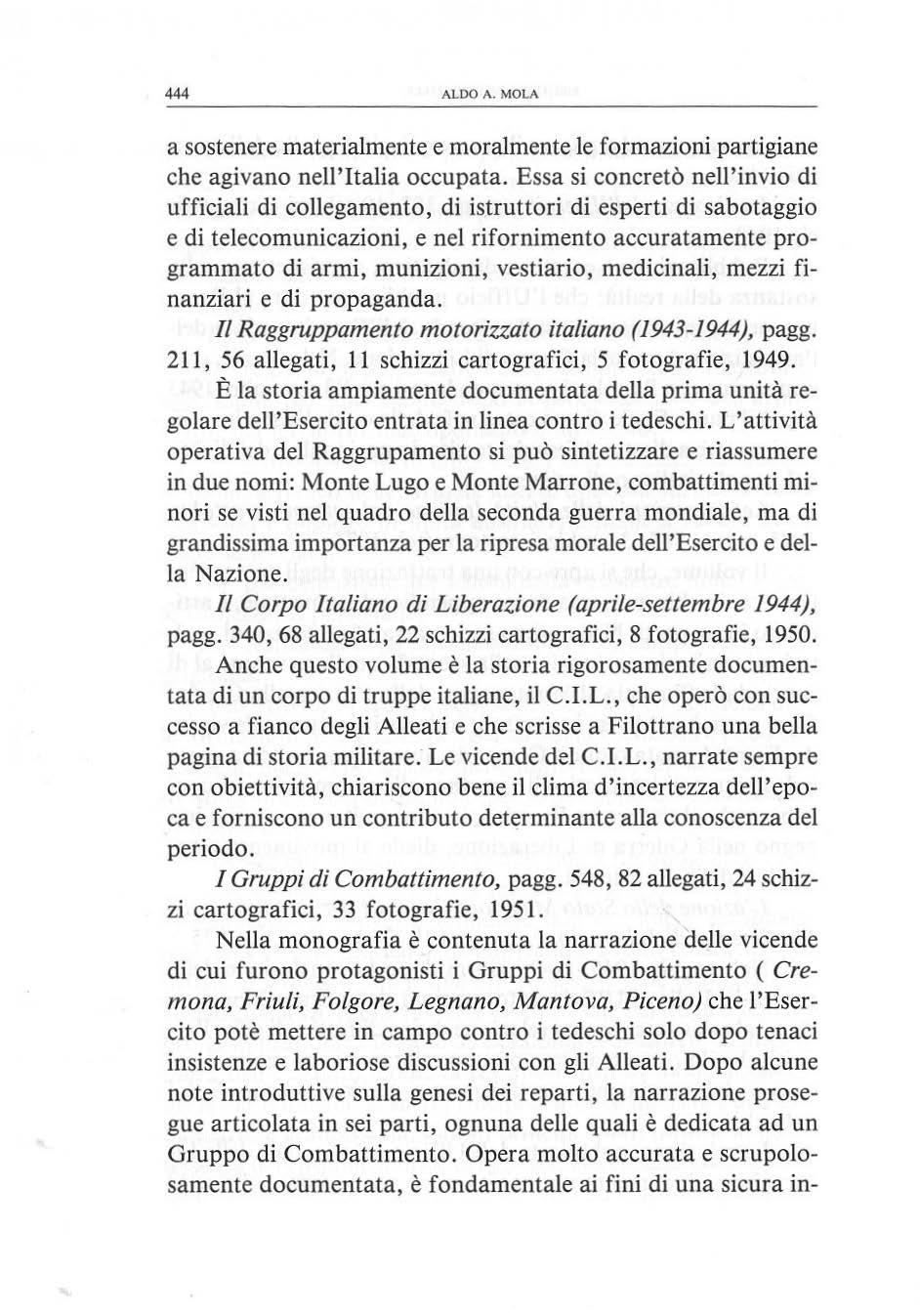
formazione sull'attiva partecipazione delle truppe italiane alla Guerra di Liberazione.
Le unità ausiliarie dell'Esercito italiano nella Guerra di Liberazione, pagg. 307, 54 allegati, 20 fotografie), 1977.
Il volume tratta delle Unità ausiliarie del nostro Esercito che vennero impegnate nella guerra di Liberazione. Se ne descrive l'opera apparentemente oscura , ma il cui rilievo si manifesta in tutta la sua evidenza sol che si rifletta sul peso che nel contesto delle guerre moderne ha il fattore logistico. Nel caso particolare poi l'attività delle Unità ausiliarie - che ripararono strade e ferrovie, porti ed aeroporti, comunicazioni telegrafiche e telefoniche, ripristinarono servizi sociali, bonificarono vaste zone minate - agevolò pure la ripresa e la normalizzazzione della vita civile, con benefici notevoli per l'intera popolazione.
La Guerra di Liberazione - Scritti nel trentennale, pagg. 223, 25 tavole f.t., 1976.
La pubblicazione riunisce gli articoli apparsi sulla Rivista Militare nel 197 5, opportunamente completati con stralci degli interventi effettuati dall'Ufficio a vari Convegni di studio sulla Resistenza.

La narrazione inizia rievocando la cronaca dei contatti che culminarono nell'armistizio di Cassibile, e mettendo in evidenza, con riferimenti ad una vasta documentazione, la gravità del1' equivoco sulla data dell'armistizio. Il volume procede in seguito con l'esame dell'apporto delle Forze Armate alla lotta per la Liberazione, incentrando l'indagine su quattro argomenti: reazione opposta alle intimidazioni ed alle aggressioni ted esche, immediatamente dopo l'armistizio, nel territorio metropolitano ed all'estero; partecipazione delle nostre Unità alla guerra in Italia a fianco degli Alleati; contributi dello Stato Maggiore Generale e partecipazione dei singoli militari alla resistenza nel1' ambito delle formazioni partigiane; resistenza degli internati nei campi di prigionia tedeschi.
L'armistizio con l'Italia in base alle relazioni ufficiali angloamericane, pagg. 107.
Trattasi di un ampio saggio di Massimo Mazzetti, inserito nelle Memorie storiche militari 1978, che analizza con grande rigore, sulla base di pubblicazioni uffidali anglo-americane spesso sconosciute in Italia, la genesi delle dure clausole dell'armistizio». * * *
La memorialistica ha occupato e continua ad occupare un posto di rilievo per la conoscenza della genesi delle trattative armistiziali e delle loro immediate conseguenze nel paese. Mentre manca la diretta testimonianza del sovrano (al di là di P . Pun- . toni, Parla Vittorio Emanuele III, Milano, Palazzi, 1958) e del principe di Piemonte (sul quale G. Artieri, Cronaca del Regno d'Italia: Il -Dalla vittoria alla Repubblica, Milano, Mondadori, 1978, e Umberto e la crisi della monarchia, ivi, 1983) rimangono essenziali B. Mussol ini , Storia di un anno. Il tempo del bastone e della carota (Milano, Mondadori, 1944) e i «ricordi» riversati dai protagonisti in opere variamente scaglionate negli anni, dapprima in chiave meramente autodifensiva, poi , talora, in una prospettiva di più ampio respiro, meno direttamente condizionata dal clima dell'inchiesta sulla mancata difesa di Roma (su cui I. Palermo, Storia di un armistizio, Milano, Mondadori, 1967, e M. Palermo, Memorie di un comunista napoletano, Parma, Guanda, 1975): G. Castellano, Comefirmai l'armistizio di Cassibile (Milano, Mondadori, 1945), La guerra continua (Milano, Rizzali, 1963 e Roma Kaputt. Contributo ad una discussione storica (Roma, Casini, 1967); B. Lanza D' Ajeta, Documenti prodotti a corredo della memoria presentata al Consiglio di Stato (Roma, Ferriaolo, ~1946): A. Berio, Missione segreta (Tangeri, agosto 1943) (Milano, Dall'Oglio, 1947); R. Guariglia, Ricordi, 1922-1946 (Napoli, Esi, 1949,); G. Zanussi, Guerra e catastrofe d'Italia (Roma, Corso, 1946) ; P. Badoglio, L 'Italia nella seconda guerra mondiale (Milano, Mondadori, 1946) , poi seguito da V. Vailati, Badoglio racconta (Torino, Ilte, 1955) e da Badoglio risponde (Milano, Rizzali, 1958) ; G. Carboni, Memorie segrete, 1935-1948. «Più che il dovere» (Firenze,

Parenti, 1955); M. Roatt a, Otto milioni di baionette. L'esercito italiano in guerra dal 1940 al 1944 (Milano, Mondadori, 1946); F. Rossi, Come arrivammo all'armistizio (Milano, Garzanti, 1946); L. Marchesi, Come arrivammo a Brindisi (Milano, Bompiani, 1969); E. Caviglia, Diario (aprile 1925- marzo 1945) (Roma, Casini , 1955); C. Senise , Quando ero capo della polizia (1940-1943) (Roma, Ruffolo, 1946); M. Soleri Memorie (Torino, Einaudi, 1949).
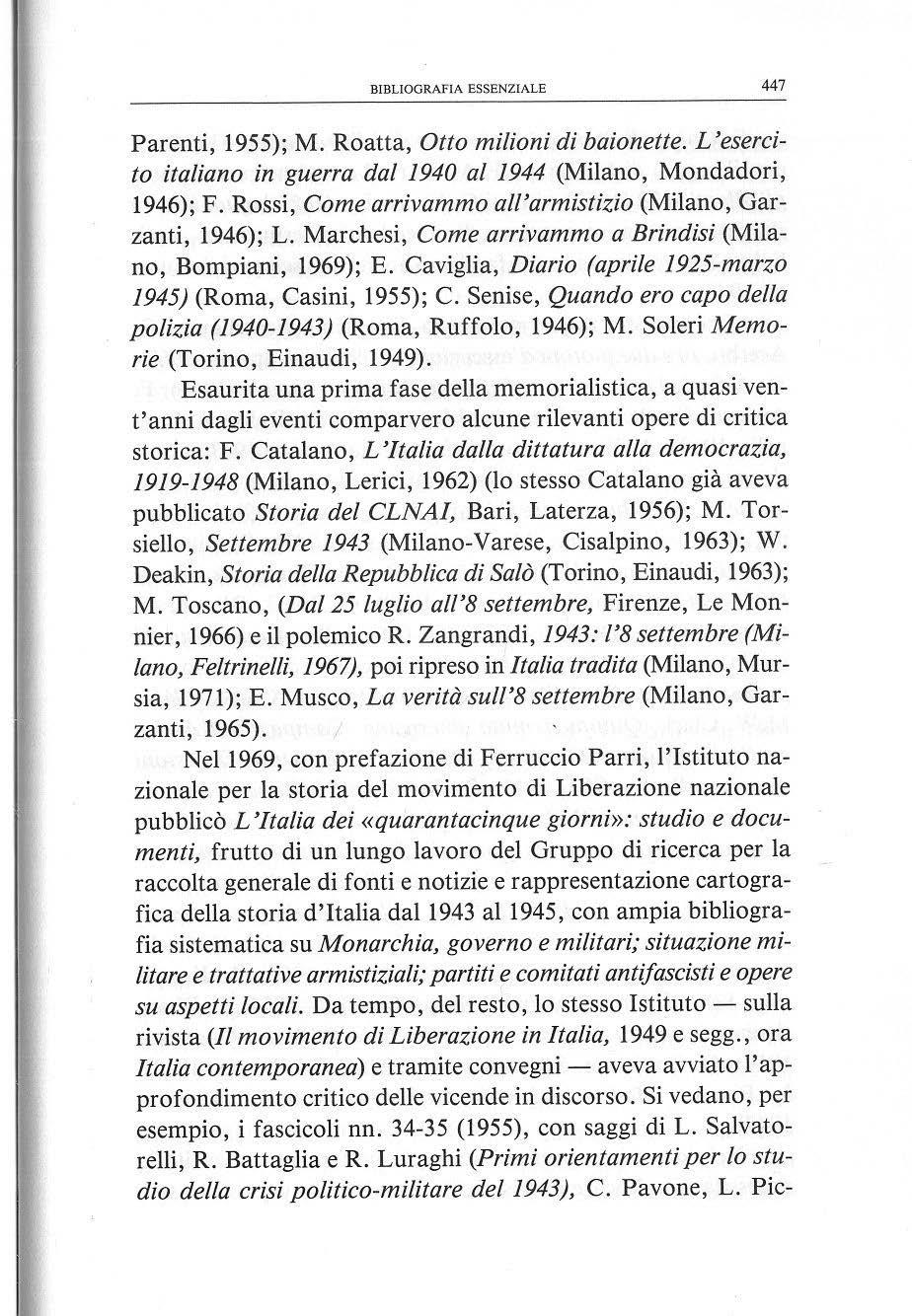
Esaurita una prima fase della memorialistica, a quasi vent'anni dagli eventi comparvero alcune rilevanti opere di critica storica: F. Catalano, L'Italia dalla dittatura alla democrazia , 1919-1948 (Milano, Lerici , 1962) (lo stesso Catalano già aveva pubblicato Storia del CLNAI, Bari, Laterza, 1956); M. To rsiello, Settembre 1943 (Milano-Varese, Cisalpino , 1963); W . Deakin, Storia della Repubblica di Salò (Torino, Einaudi , 1963) ; M. Toscano, (Dal 25 luglio all'8 settembre, Firenze, Le Monnier, 1966) e il polemico R. Zangrandi, 1943: 1'8 settembre (Milano, Feltrinelli, 1967), poi ripreso in Italia tradita (Milano, Mursia, 1971); E. Musco , La verità sull'8 settembre (Milano, Garzanti, 1965).
Nel 1969, con prefazione di Ferruccio Parri , l'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione nazionale pubblicò L'Italia dei «quarantacinque giorni»: studio e documenti, frutto di un lungo lavoro del Gruppo di ricerca per la raccolta generale di fonti e notizie e rappresentazione cartografica della storia d'Italia dal 1943 al 1945, con ampia bibliografia sistematica su Monarchia, governo e militari; situazione militare e trattative armistiziali; partiti e comitati antifascisti e opere su aspetti locali. Da tempo, del resto, lo stesso Istituto - sulla rivista (Il movimento di Liberazione in Italia, 1949 e segg., ora Italia contemporanea) e tramite convegni - aveva avviato l'approfondimento critico delle vicende in discorso. Si vedano, per esempio, i fascicoli nn. 34-35 (1955), con saggi di L. Salvatorelli, R. Battaglia e R . Luraghi (Primi orientamenti per lo studio della crisi politico-militare del 1943), C. Pavone, L. Pie-
cardi (Colpo di Stato e Movimento di Liberazione), 63 (1961), con il saggio di F. Parri e F. Venturi, La resistenza italiana e gli alleati, e 72 (1963) e in cui G. Vaccarino (1125 luglio: la crisi del fascismo), a integrazione di precedenti affermazioni, attribuisce il rovesciamento del fascismo anche agli scioperi del marzo 1943.
Tra le opere a quel momento disponibili ricordiamo: G. Acerbo, Fra due plotoni d'esecuzione (Bologna, Cappelli, 1968); D. Alfieri, Due dittatori di fronte (Milano, Rizzoli , 1948); F. Anfuso, Da Palazzo Venezia al Lago di Garda (Bologna, Cappelli, 1957); A. Basso, L'armistizio del settembre 1943 in Sardegna (Napoli, 1947); G. Bastianini, Uomini, cose, fatti. Memorie di un ambas ciatore (Milano , Vitagliano , 1959); I. Bonomi, Diario di un anno (Milano, Garzanti, 1947); G. Bianchi, 25 luglio (Milano , Mursia, 1963); A. Bryant, Tempo di Guerra (1939-1943) (Milano, L onganesi, 1960); C. Bozzi, Oltre la disfatta (Milano, Delfino, 1952); G . Cassinelli, Appunti sul 25 luglio (Roma , SAPPI, 1944); M . Caracciolo di Feroleto, «E poi?». La tragedia dell'esercito italiano (Roma, Corso, 1946); M.W. Clark, Quinta Armata americana. Campagna d'Africa e d'Italia (Milano, Garzanti, 1952); J. Di Benigno, Occasioni mancate (Roma, SEI, 1945); L. Federzoni, L'Italia di ieri per la storia di domani (Milano, Mondadori, 1967); G . Gorla, L 'Italia nella seconda guerra mondiale. Diario di un milanese, ministro del re nel governo di Mussolini (Milano, Baldini e Castoldi, 1958); E. Faldella, L'Italia nella seconda guerra mondiale. Revisione di giudizi (Bologna, Cappelli, 1959); G. Gigli, La seconda guerra mondiale (Bari , Laterza, 1964); A. Kesselring, Soldato fino all'ultimo (Milano, Garzanti, 1954); F. Rhan, Ambasciatore di Hitler a Vichy e a Salò (Milano, Garzanti, 1950); G. Perticone, Settembre '43 (Roma, Ed. Roma, 1944); L. Pivano, Meditazioni nella tormenta (Modena, Guanda, 1947).
Nel decennio seguente è stata più nettamente avvertita la necessità di collocare la crisi dell'estate 1943 in un visione sto-
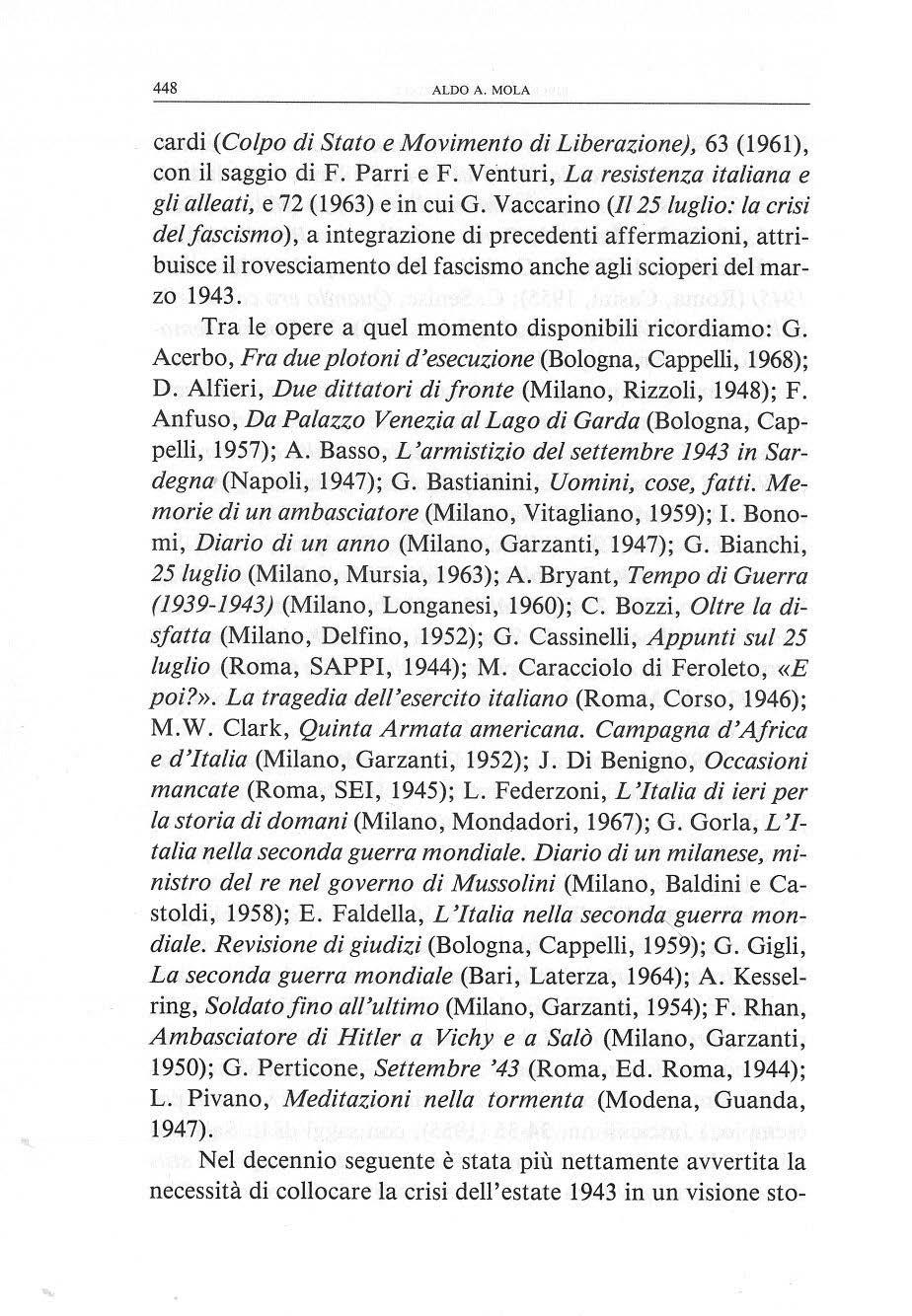
rica non più circoscritta al solo regime fascista (C. Pinzani, L '8 settembre 1943: elementi ed ipotesi per un giudizio storico, «Studi Storici», 1972, n. 2; e C. Pavone, La continuità dello Stato . Istituzioni e uomini, in AA . VV. Italia 1945-48, le origini della Repubblica, Torino, Giappichelli, 1974), né alle so le lotte intestine fra le diverse correnti del blocco monarchico-fascista o al conflitto tra queste e gli antifascisti (E. Aga Rossi, La politica degli alleati verso l'Italia nel 1943, «Storia contemporanea»; 1972, n. 4): tema, codesto, già affrontato da N. Kogan, L 'Italia e gli alleati. 8 settembre 1943 (Milano, Lerici, 1963) e, con ampia documentazione, da L. Mercuri, Resoconto delle attività svolte dal Governo militare alleato e dalla Commissione alleata di controllo in Italia, («Quaderni Fiap»; Roma, n. 17, s.a.), e nel quale va collocato anche il servizio informazioni svolto dagli italiani (sui cui F. Fucci, Spie per la liberrà, Milano, Mursia, 1983).
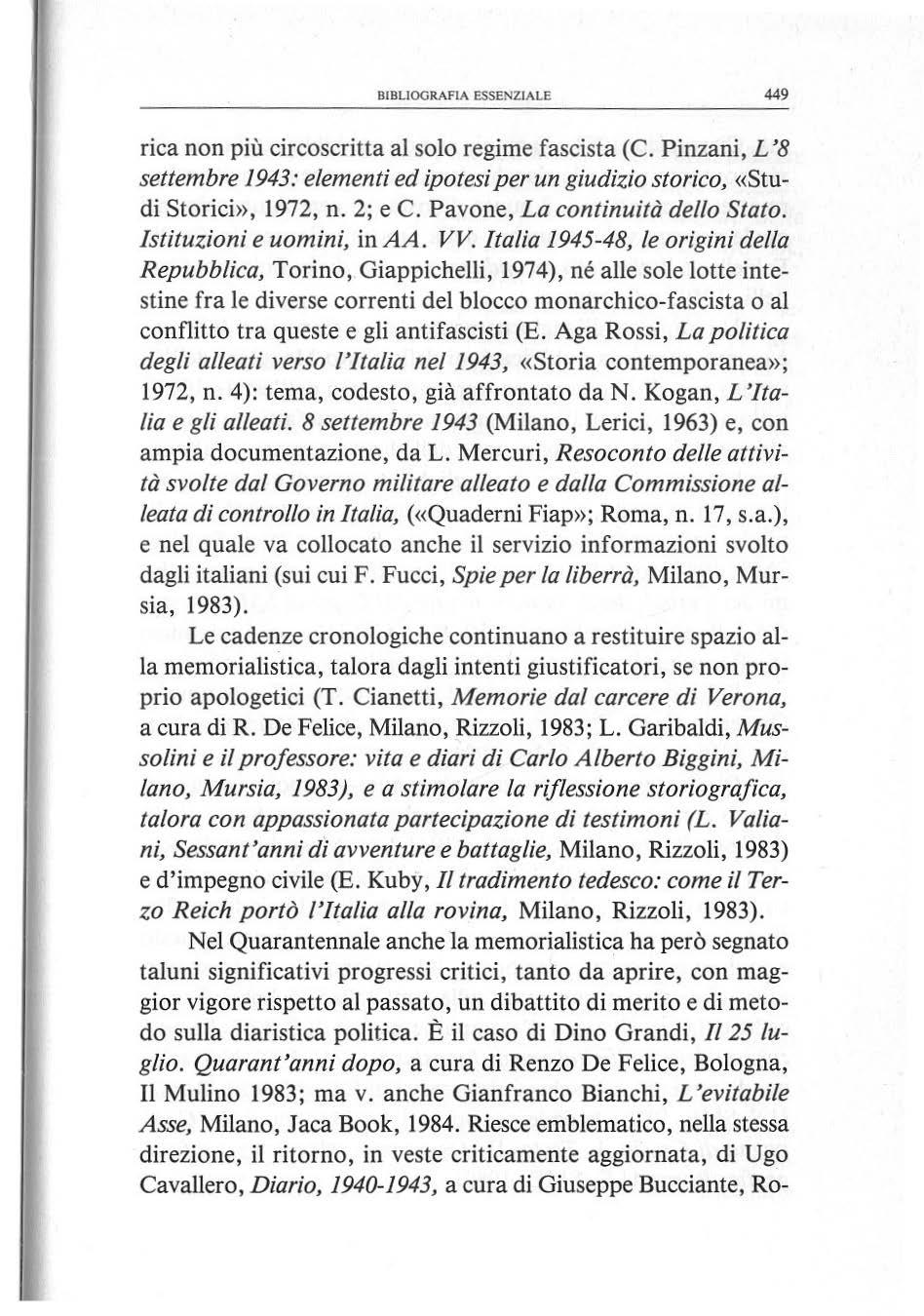
Le cadenze cronologiche continuano a restituire spazio alla memorialistica, talora dagli intenti giustificatori, se non proprio apologetici (T. Cianetti, Memorie dal carcere di Verona, a cura di R. De Felice, Milano, Rizzoli, 1983; L. Garibaldi, Mussolini e il professore: vita e diari di Carlo Alberto Biggini, Milano, Mursia, 1983), e a stimolare la riflessione sto riografica, talora con appassionata partecipazione di testimoni (L. Valiani, Sessant'anni dr avventure e battaglie, Milano, Rizzo li, 1983) e d'impegno civile (E. Kuby, Il tradimento tedesco : come il Terzo Reich portò l'Italia alla rovina, Milano, Rizzoli, 1983).
Nel Quarantenn ale anche la memorialistica ha però segnato taluni significativi progressi critici , tant o da aprire, con maggi or vig or e rispett o a l passato, un d ibatt ito di m erito e d i metodo sulla diari st ica polit ica. È il caso di Dino Grandi, Il 25 luglio. Quarant'anni dopo, a cu ra di Renzo De Feli ce, Bologn a , Il Mulino 1983; ma v . anche Gianfranco Bianchi, L'evitabile Asse, Milano, Jaca Book, 1984. Riesce emblematico, nell a stessa direzione, il ritorno, in veste criticame n te aggiornata, di Ugo Cavallero, Diario, 1940-1943, a cura di Giuseppe Bucciante, Ro-
ma, Ciarrapico, 1984 con ampia aggiornata bibliografia, cui rinviamo: tanto più utile giacché continua a mancare, nella misura attesa e necessaria, il punto di vista del gen. Ambrosio, pel quale occorre valersi tuttora della «testimonianza» in Emilio Faldella, L'Italia nella seconda guerra mondiale, Bologna, Cappelli, 1959, ad nomen.
Un impulso all'aggiornamento delle prospettive di lavoro è giunto altresì da pubblicazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito non direttamente concernenti la crisi dell'estate 1943 e tuttavia indispensabili per ricostruirne gli antefatti per quanto attiene la modesta preparazione delle Forze Armate ad affrontare la guerra e il contrasto tra gli Alti Comandi e il potere politico. Al riguardo, ricorderemo almeno L'esercito italiano alla vigilia della seconda guerra mondiale, Roma, Ufficio Storico, SME, 1982, con 52 documenti d'appendice, e i due primi volumi dei Verbali delle riunioni tenute dal Capo di SM Generale (16-}-1939/29-12-1940 e l-1-1941 /31-12-1941), coi quali iniziò la «Raccolta di documenti della seconda guerra mondiale» .
Sulla riorganizzazione dell'Esercito dopo 1'8 settembre v. Giuseppe Conti, Il primo raggruppamento motorizzato, (Roma, Ufficio Storico SME, 1984).
Questa vasta letteratura - s'intende - va poi posta a confronto con i tentativi di sintesi, quali, per es., la Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943 di G. Massobrio e G. Rochat (Torino, Einaudi, 1978) - ove 1'8 settembre è assunto a emblema di 'catastrofe -e Le Forze Armate di Lucio Ceva (Torino, Utet, 1981), con visione più articolata sul lungo periodo e copiosa bibliografia ragionata. Né potranno essere trascurati ulteriori apporti documentari sulle armi italiane nel periodo precedente la crisi (valgan d'esempio le pagine di S. Loi, Le operazioni delle Unità italiane in Jugoslavia, 1941-1943. Narrazione, documenti, con schizzi tipografici di Edoardo Loi, Roma, U .S. SME, 1978 e la poderosa opera di M. Montanari, La Campagna di Grecia, I, Testo; II, Documenti, III, Schizzi e fotografie, Roma U.S. SME, 1980).

Né meno utile risulta l'inquadramento della crisi militare del settembre 1943 nel contesto economico e politico tracciato da Francesco Perfetti in Il quadro politico e l'evoluzione della società italiana, Annali dell'Economia italiana, vol. IX, 1939-1945, Milano-Roma, IPSOA, 1983. Da tanta produzione - pur talora diseguale e di vario segno ideologico- , mentre risulta confermato l'interesse per una fase certo cruciale della storia nazionale, scaturisce netta la richiesta di una prospettiva cr itica meno immediatamente ispirata a propositi di giudizio morale sui protagonisti degli eventi, anche se la proposta di nuove prospettive di analisi e di valutazione continua talvolta a incappare in sentenze sommarie di drastica condanna. Ciò che tuttavia più preme è di capire se quel sistema istituzionale potesse effetti vamente reagire alla crisi in modo diverso e se davvero fossero praticabili linee alternative alla condotta scelta e seguita, con coerente fermezza , dal sovrano e dal capo del governo. Per non avere 1'8 settembreci sembra debba essere ricordato - non si sarebbe dovuto avere il corso storico precedente : posto il quale modalità, tempi e conseguenze dell'armistizio non possono più essere denunziati quali mostruosa conferma della nefanda pravità della Corona, come tuttavia accade di sentir fare con criterio scevro di fondamento storiografico, bensì vanno, correttamente , intesi quale perseguimento della continuità dello Stato, con esito positivo, visto il riconoscimento del «Governo del Sud» da parte delle Nazioni Unite e la sua diretta saldatura con quelli della seguente Repubblica italiana.
S'avverte nondimeno sempre più acuta la necessità di una sistemazione critica che, mentre tenga deb itamente conto del contesto bellico globale entro il quale maturarono il 25 luglio e 1'8 settembre, cerchi il senso di quegli eventi non più solo nella guerra allora in corso, nella fatiscenza del regime e nel movimento d i liberazione, bensì nel quadro del complesso intreccio istituzioni-società, che fa dell'8 settembre un momento caratteristico e rivelatore delle tare insite non nel solo «fascismm>
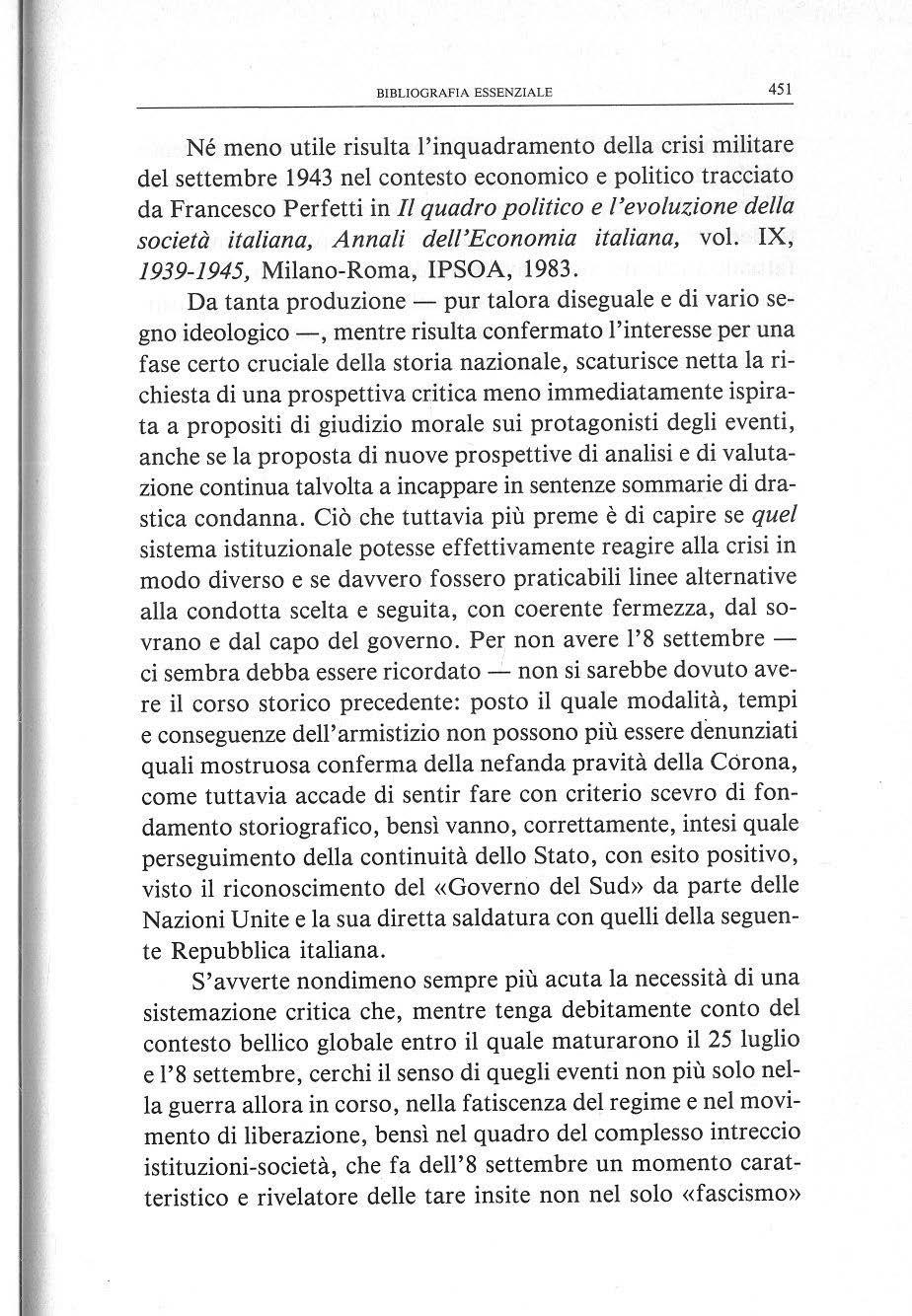
quanto piuttosto nello Stato monarchico uscito dal Risorgim ento e nella sua tentata restaurazione dopo il 25 luglio e nel corso dei tre anni seguenti, non senza pregiudizio per il rinnovamento democratico del paese sul piano i st ituzionale, normati vo e fattuale anche nel successivo periodo repubbli cano . È sopr attutto in questo senso che 1'8 settembre 1943 continua a costituire motivo di una riflession e attuale, cioè con immediato rife riment o all'Italia di oggi.