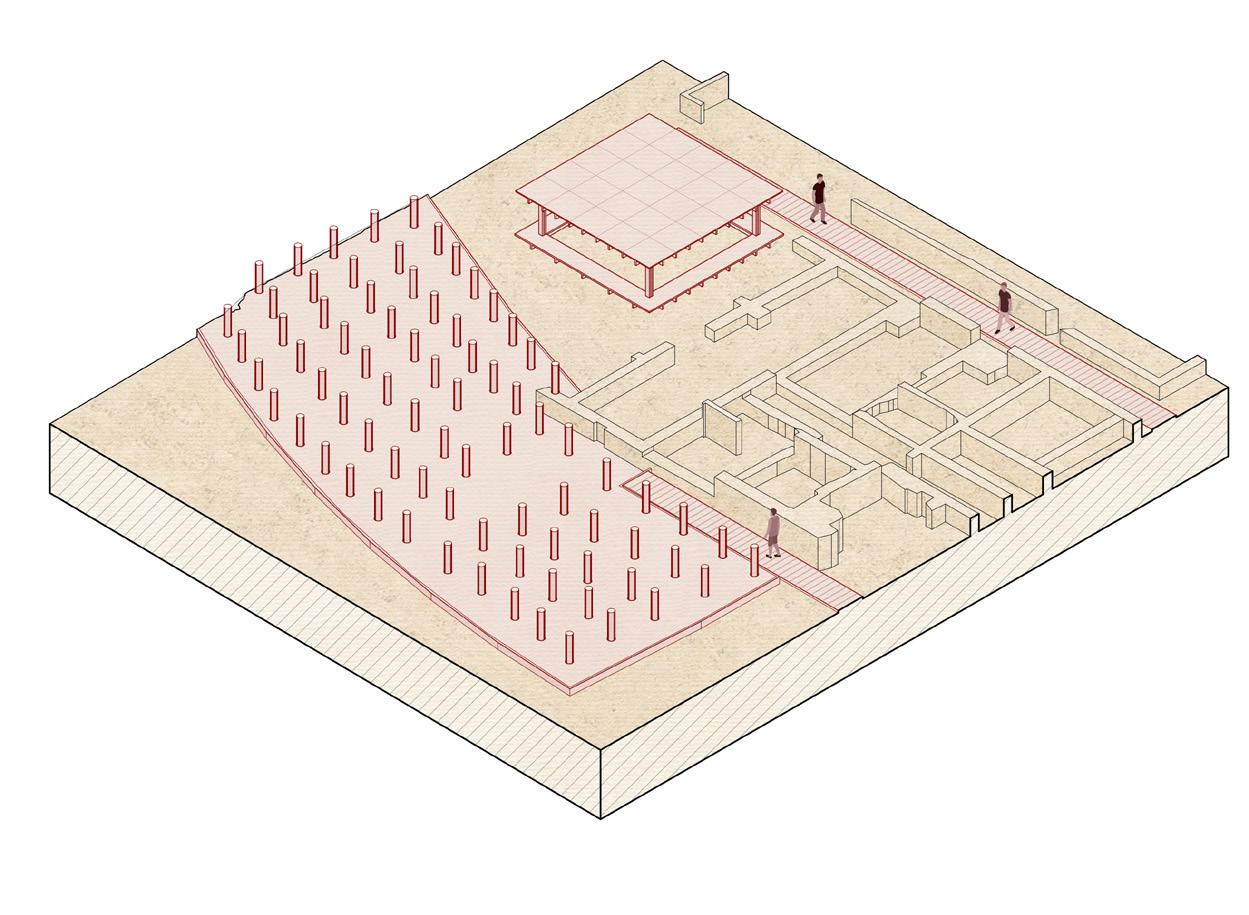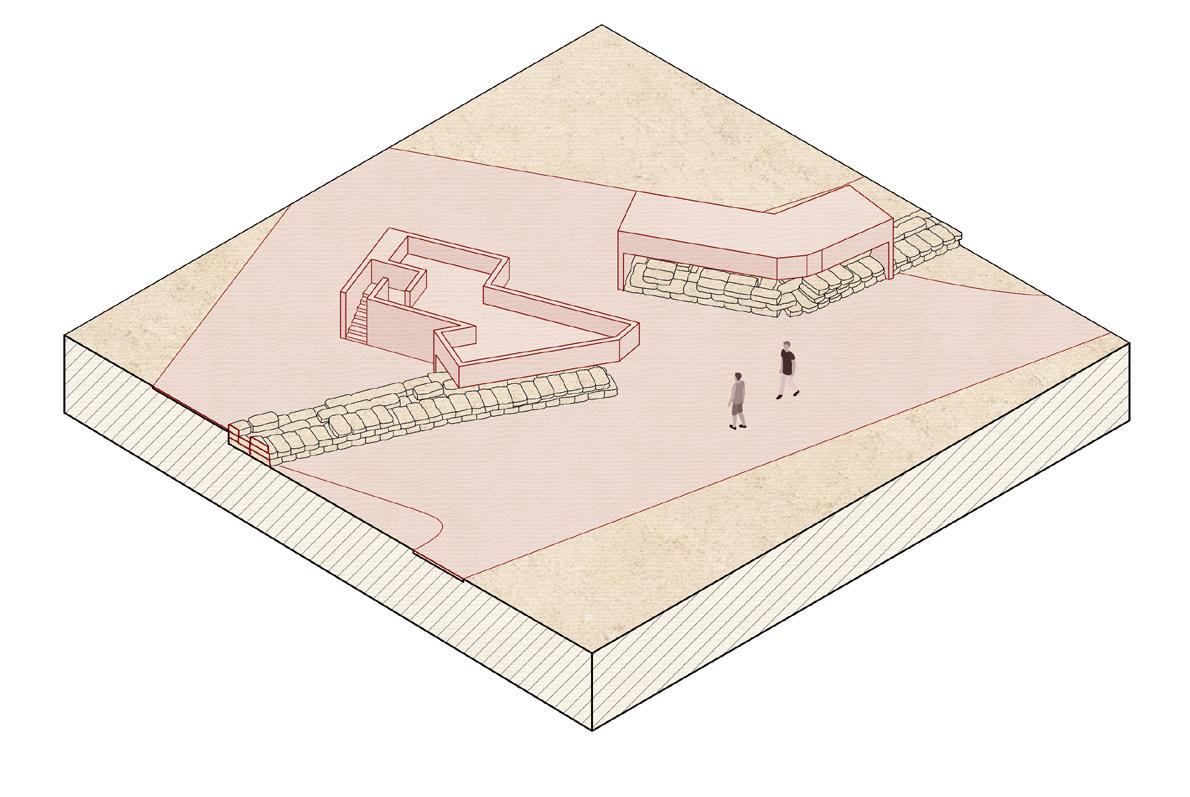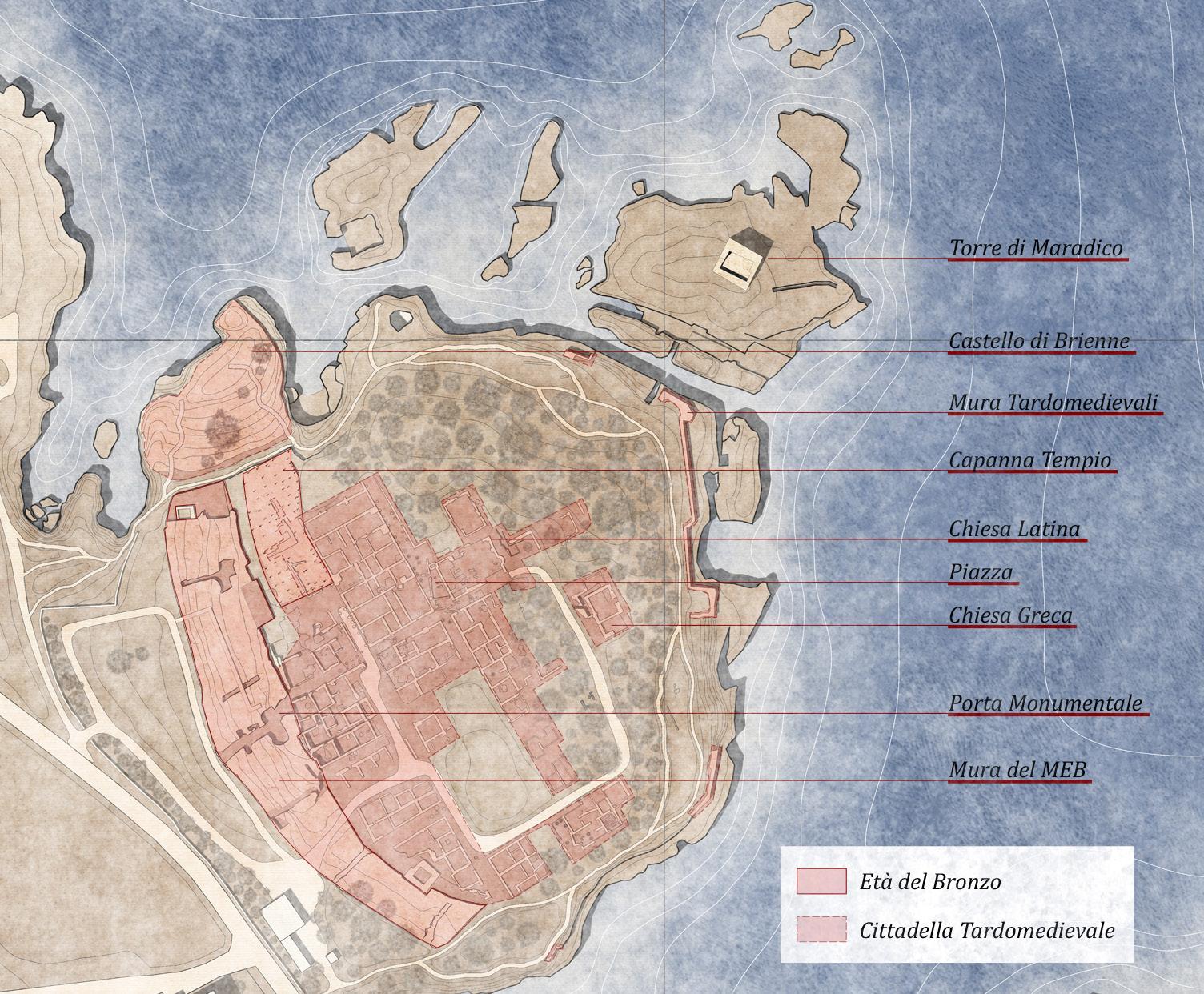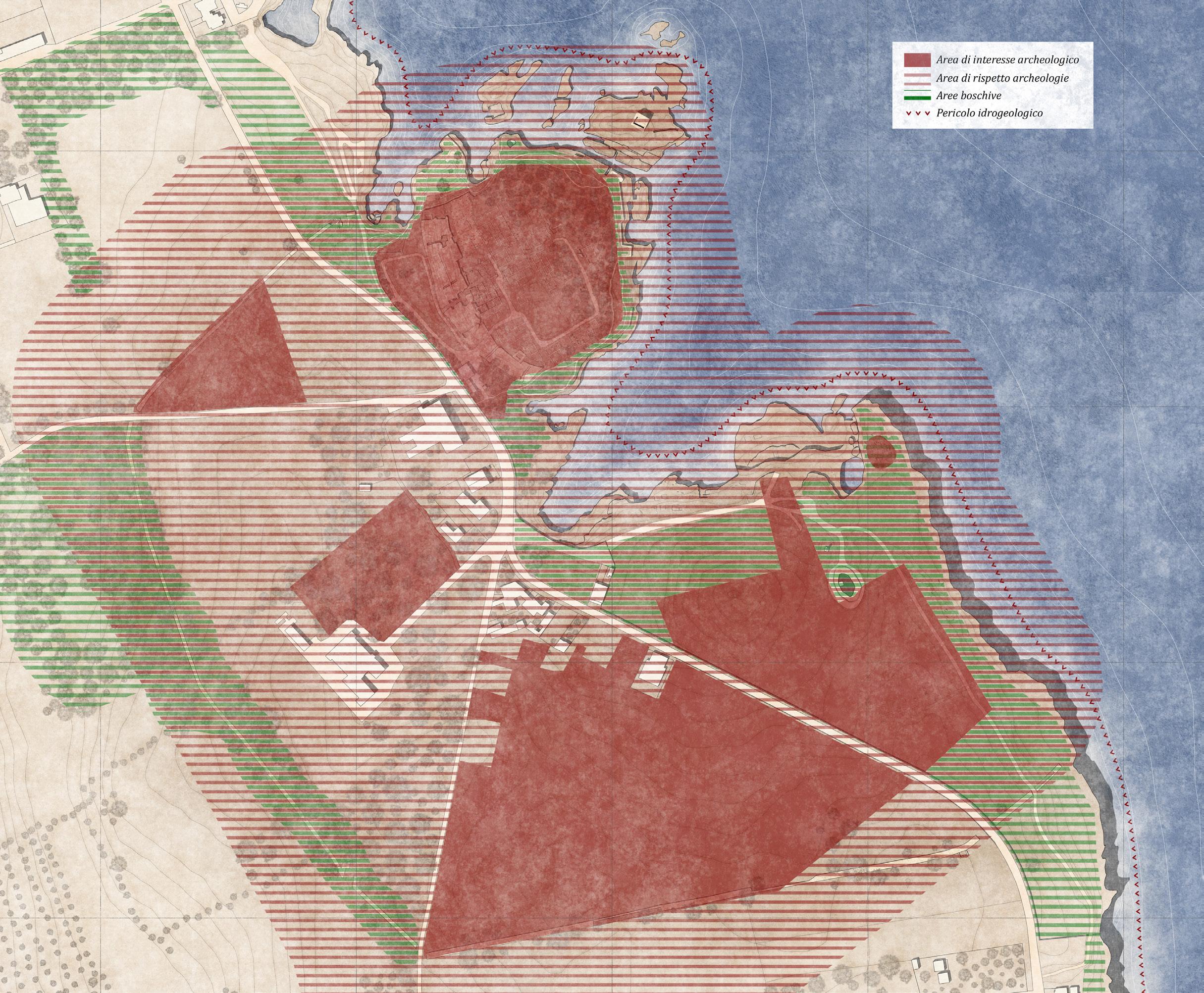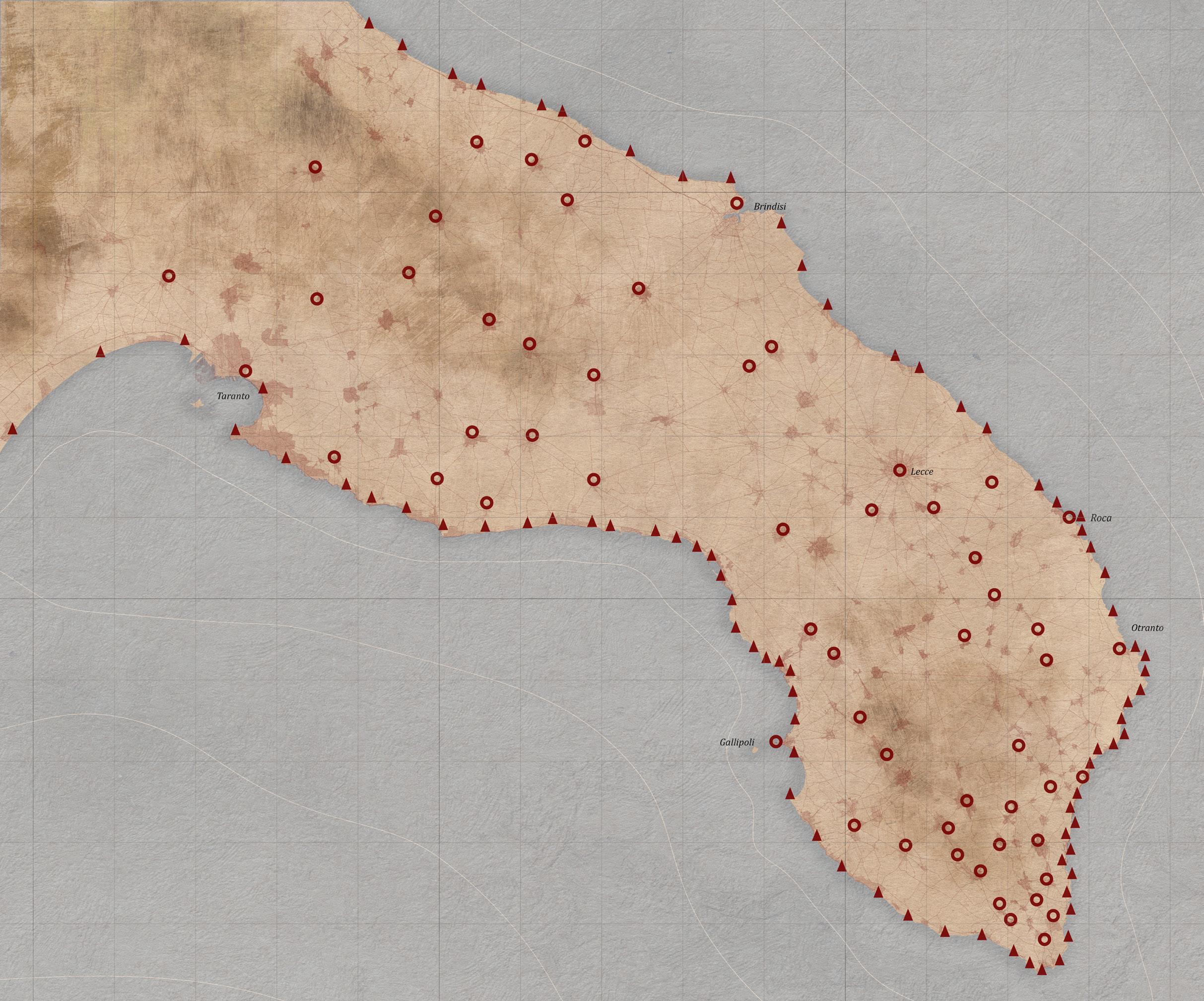Architettura per l''Archeologia Proteggere e salvaguardare un luogo antico con valenza storica, culturale e paesaggistica, non può e non deve sempre coincidere con la cristallizzazione all’interno di un recinto, di una teca invisibile, alla ricerca di un’immutata memoria di qualcosa che non è più, nella speranza di non perdere l’effetto emozionale provocato nell’osservatore. Chi scrive ritiene che la salvaguardia debba avvenire attraverso la ricucitura tra antico e moderno all’interno del paesaggio, grazie a una progettazione efficiente e consapevole, facendo così della stratificazione l’occasione utile per il miglioramento della qualità urbana, da ottenere tramite il riconoscimento di un ruolo innovativo al tessuto storico, un ruolo centrale nella conservazione e trasmissione dei valori culturali e urbani. In un territorio fortemente stratificato come quello europeo, italiano in particolare, c’è il bisogno di integrare strategie di progettazione, pianificazione urbana e conservazione affinché il patrimonio storico-archeologico, che siamo tenuti a tramandare, non sia solo oggetto di politiche prettamente turistiche, ma sia soprattutto reinserito all’interno della vita quotidiana della città e dei suoi abitanti. Il rapporto tra la progettazione architettonica e la pratica archeologica è sempre stato un tema trasversale alle due discipline sin dai loro albori, assumendo declinazioni differenti a seconda del periodo storico e della mutevole concezione e uso della storia da parte della società. Nonostante questo rapporto sia durato secoli, all’indomani della seconda guerra mondiale qualcosa provocò la separazione di queste due discipline, un tempo “sorelle”, che oggi sembrano parlare linguaggi differenti1. Questa spaccatura, provocata forse dall’incapacità dei diversi specialisti di collaborare mettendo da parte gli inutili campanilismi disciplinari, può oggi essere colmata instaurando un proficuo scambio di idee e competenze tra i diversi attori in campo. Diventa quindi fondamentale l’apporto della disciplina Architettura e Archeologia: quale futuro?
architettonica che, operando sotto forma di progetto a disposizione dell’archeologia, si pone come mezzo per recuperare e valorizzare quei rapporti interdisciplinari ormai degradati. Infatti, architettura e archeologia, nonostante i diversi modi di intervento e di interesse verso il materiale storico, trovano in esso un ampio terreno di scambio e incontro, in cui la collaborazione tra specialisti, appartenenti anche a diverse branche del sapere, diventa basilare per la configurazione di nuove prospettive per la ricucitura tra tessuto storico e contemporaneo, all’interno della quale il bene archeologico dovrà configurarsi non solo come elemento di pregio turistico ma come vero e proprio luogo portatore di qualità urbana e appartenente a un contesto territoriale più ampio con cui dovrà relazionarsi. L’importanza data al progetto di architettura in contesto archeologico per la valorizzazione e rifunzionalizzazione di quest’ultimo è argomento di dibattito fin dalla fine del XX secolo, quando la componente conservativa dell’architettura ha notevolmente preso il sopravvento negli interventi e nelle politiche. Francesco Venezia ci parla di una ‹‹separazione fatale›› avvenuta tra le due discipline nel momento in cui l’archeologia è entrata all’interno di una ‹‹sfera protetta››, separata dai luoghi dell’architettura, in cui si rispecchia la separazione tra il mondo delle rovine e il mondo del costruire. Ciò ha reso l’archeologia, nell’immaginario collettivo, una nemica dell’architettura e della città moderna2. Molti docenti e studiosi facenti parti di atenei di tutta Italia, negli ultimi decenni, si sono confrontati nuovamente sul tema della coesione tra archeologia e architettura, creando laboratori di progettazione tematici all’interno dei corsi magistrali, richiamando professionisti da tutto il mondo in sempre più frequenti call internazionali che cercano di dibattere su questo difficile tema ma anche di master e workshop organizzati da associazioni e da enti pubblici e
77