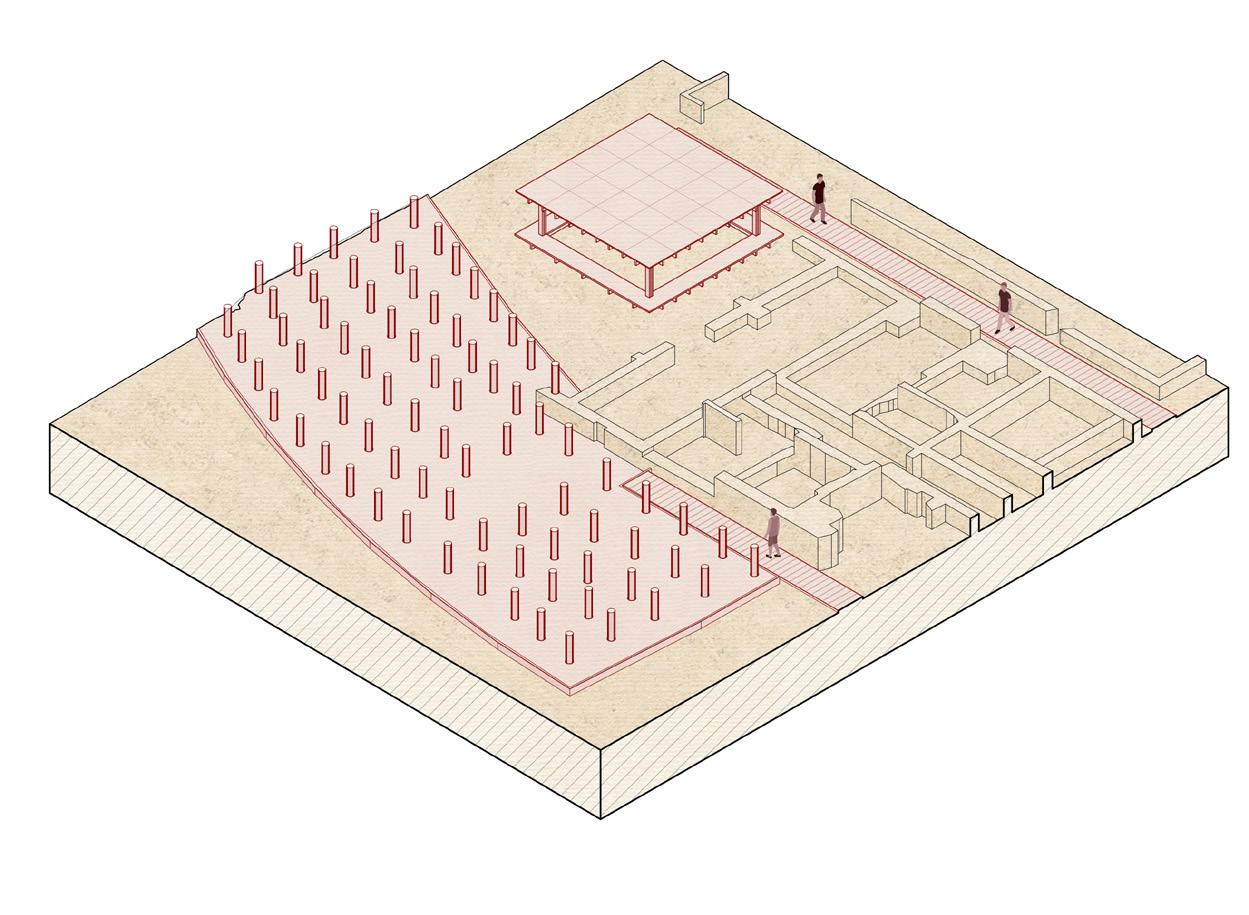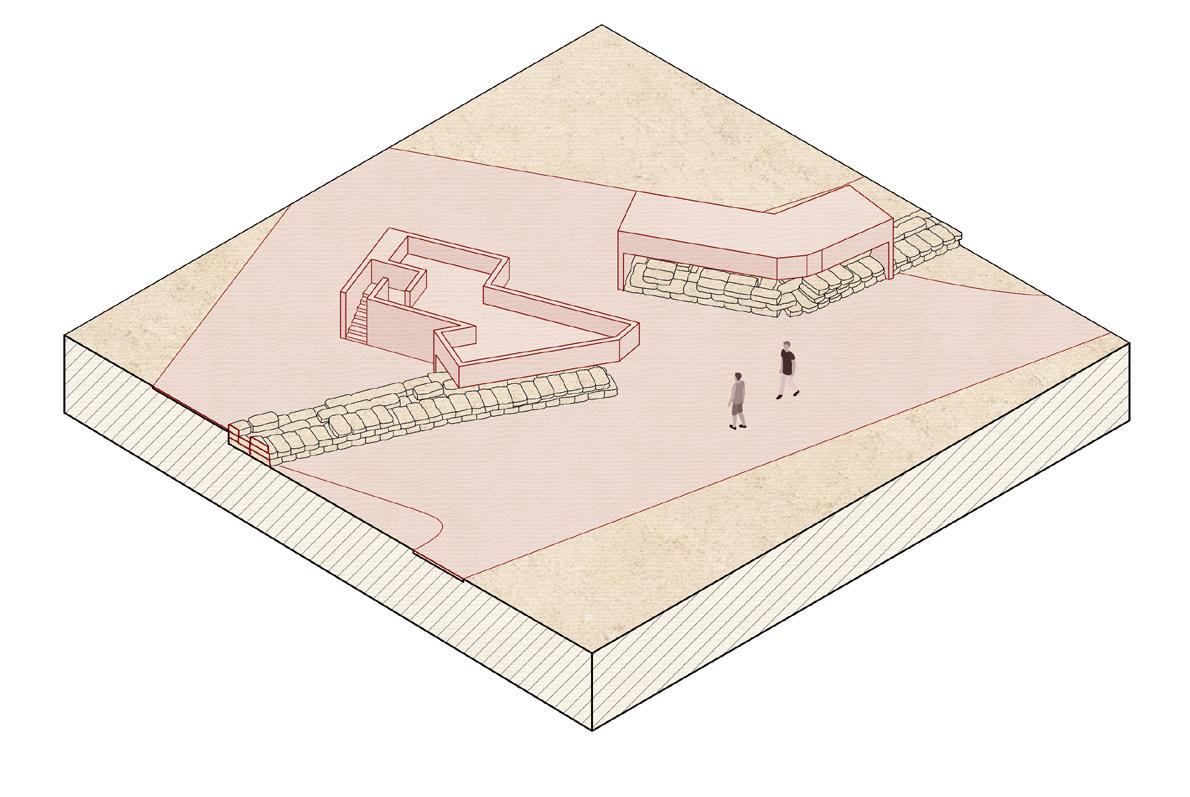3 minute read
Introduzione
Introduzione
Quello che oggi si presenta come uno dei luoghi più suggestivi e famosi del Salento, meta estiva di numerosi turisti attratti dalla Grotta Poesia Grande1, rinomato per le sue bellezze naturali e balneari, è da più di trent’anni oggetto di scavi e indagini archeologiche che cercano di ricostruirne la storia.
Advertisement
Nonostante l’area archeologica di Roca rimanga ai più sconosciuta, grazie agli sforzi profusi negli ultimi vent’anni da ricercatori (C. Pagliara, R. Guglielmino e T. Scarano) e istituzioni (Università del Salento, Comune di Melendugno e Soprintendenza dei Beni Archeologici), il sito è stato riconosciuto come uno dei più importanti di tutto il patrimonio archeologico protostorico del Mediterraneo2 .
Ciò che colpisce dell’insediamento di Roca è la storia che le evidenze archeologiche narrano: un racconto che è una stratificazione, originata dal susseguirsi di occupazioni e riedificazioni, ci consente di dividere in due fasi ben distinte temporalmente e intervallate da un unico periodo intermedio in cui le fonti e gli studi condotti dimostrano un quasi totale abbandono dell’area.
La prima fase di occupazione va dalla fondazione, probabilmente avvenuta nelle prime fasi del Bronzo Medio (XVII secolo a.C), al 276 a.C.3, quando la conquista romana del Salento comportò un grande riassetto territoriale che sembrò escludere Roca; la seconda fase invece inizia nel VII secolo d.C. con l’occupazione, da parte di monaci Greco-Bizantini, delle grotte carsiche presenti nel promontorio, abbraccia il periodo in cui il conte Gualtiero VI di Brienne edificò nell’area una cittadella fortificata (XIV secolo)4, per terminare con la distruzione della stessa per volere imperiale di Carlo V nel VI secolo d.C5 .
In questo arco di tempo di più di tremila e cinquecento anni il piccolo istmo ha vissuto profonde modificazioni e riassetti: ha subito attacchi in epoche antiche su cui storici e archeologi ancora cercano di far luce; è stato considerato come un luogo sacro da genti con credi differenti; è stato approdo e porto sicuro per popolazioni d’oltremare amiche, mentre per mano di popoli ostili, tra tutti gli Ottomani, ha conosciuto la distruzione. Considerata questa trama complessa, oggi di difficile lettura ai più vista la sovrapposizione e la mescolanza di numerose tracce archeologiche di periodi differenti, piuttosto che narrare il mero susseguirsi dei fatti, pare opportuno utilizzare proprio quelle evidenze oggi presenti come punti fermi e struttura attorno ai quali impostare un racconto critico di quest’area che renda conto della sua rilevanza.
Fig. 2 - Pagina precedente, linea del tempo riassuntiva.
Note Bibliografiche 1 La Grotta Poesia Grande è al centro dell’interesse turistico internazionale grazie a numerosi articoli comparsi su riviste come National Geographic che nel 2014 ha inserito l’area nella classifica delle mete turistiche pugliesi più ambite, o sul sito di settore travel365, che la inserisce tra le piscine naturali più belle al mondo. Ultima è la campagna pubblicitaria svolta da Nutella dove la grotta appare raffigurata su uno dei barattoli a edizione limitata che rappresentano le bellezze più importanti del nostro paese. 2 t. scarano, Roca I. Le fortificazioni della Media Età del Bronzo. Strutture Contesti Materiali, Claudio Grenzi Editore, Foggia, 2012, p.113. 3 Tale data fa riferimento alla conquista del Salento da parte dei Romani e non alla scomparsa o all’abbandono del centro abitato di Roca. Riguardo l’occupazione romana e i decenni immediatamente prima, a Roca, si hanno poche informazioni e reperti: per il momento le uniche tracce sono alcuni resti di struttura agricola in prossimità della porta Sud-Ovest delle mura Ellenistiche e alcune incisioni in latino all’interno della Grotta Poesia Piccola.
4 w. carrozzo, Terra Roce. Roca Nuova, storia di un passato ritrovato, Edizioni Esperidi, Monteroni di Lecce (LE), 2019, p. 11. 5 ibidem, p. 12
Fig. 3 - Tavola dei viaggi mitologici con tappa la Japigia: il racconto erodoteo narra del naufragio dei Cretesi in prossimità del Capo Japigio (Leuca); Enea, ancor prima di raggiungere la Sicilia, approda a Castrum Minervae (Castro) come raccontato da Virgilio nell'Eneide; i figli di Licaone re dell'Arcadia, dopo essersi alleati con il capo illirico Messapo, approdano sulle coste salentine dando vita alle popolazioni iapigie dei Messapi, Peucezi e Dauni.