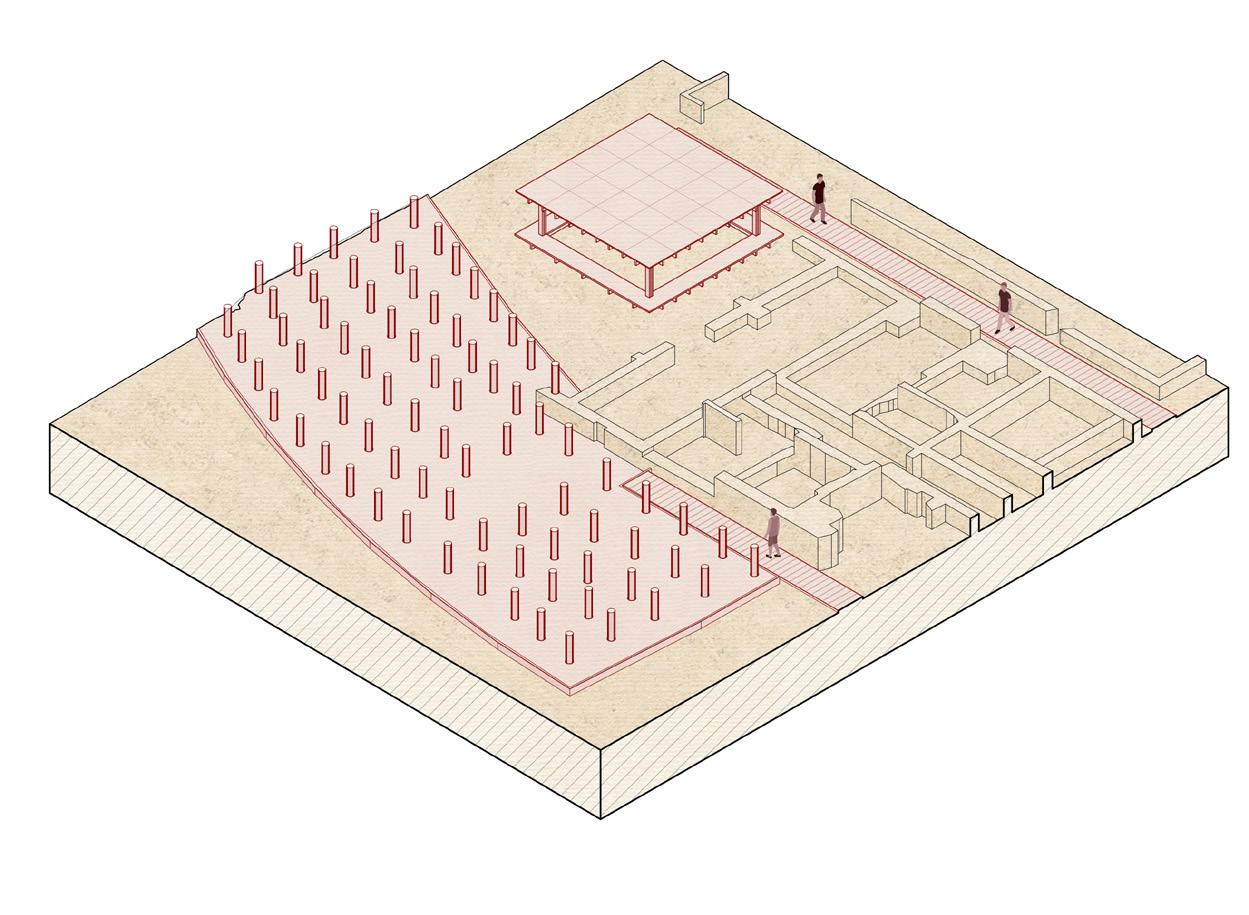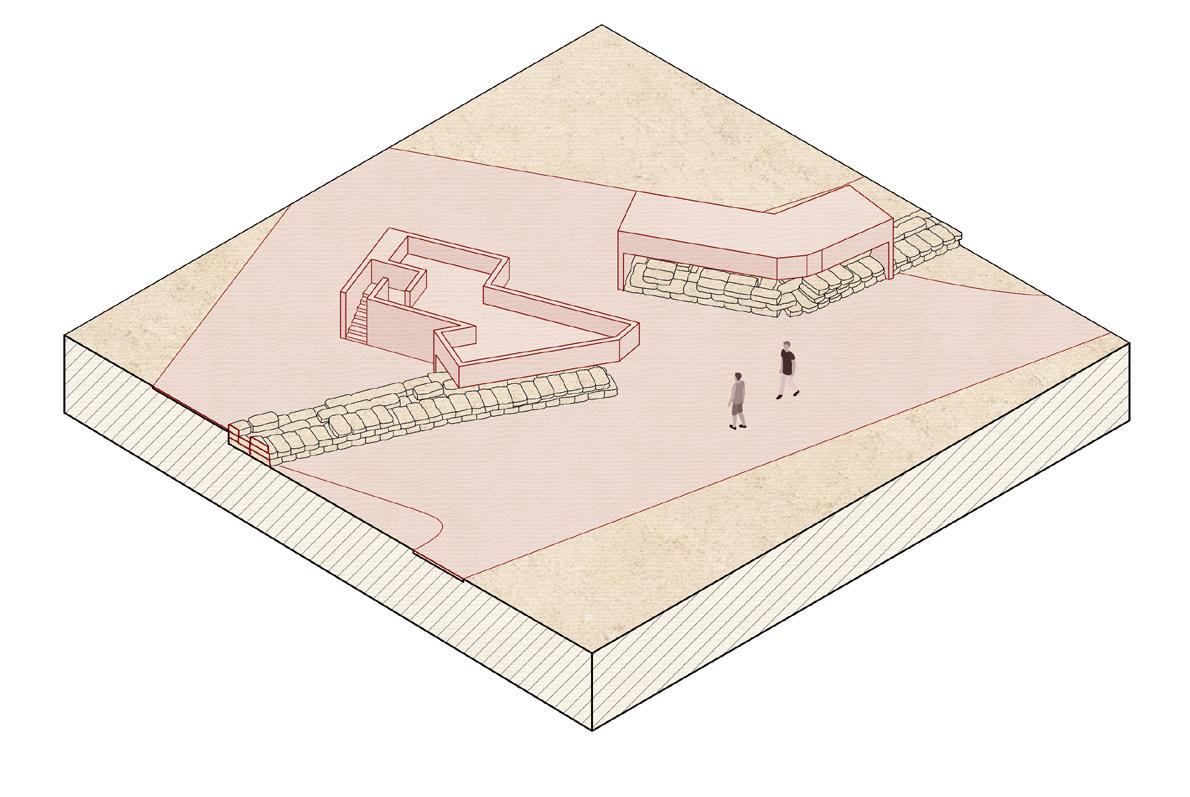5 minute read
La Grotta Santuario
La Grotta Santuario
Elemento di spicco dell’area archeologica è sicuramente il sistema delle grotte denominate “Poesia”: tre cavità carsiche collegate tra loro da sifoni e stretti corridoi invase totalmente dal mare; mentre quella intermedia rimane completamente coperta, nelle due grotte dette “Poesia Piccola” e “Poesia Grande” la calotta è crollata in tempi sconosciuti configurandole come delle piscine naturali.
Advertisement
Se, data la notevole notorietà raggiunta, la Poesia Grande è ormai meta di turisti e bagnanti in periodo estivo, la Poesia Piccola invece rappresenta un grande patrimonio epigrafico e archeologico perlopiù ancora intonso che fornisce preziose informazioni circa la lunga occupazione dell’area di Roca Vecchia durante le diverse epoche. Il toponimo del luogo basta da sé a rendere chiaro perché queste grotte furono utilizzate e abitate in età antica: infatti la parola «poesia» deriva dal greco pòsia, termine che indica l’acqua dolce, elemento presente nelle cavità carsiche che in antichità potevano facilmente essere sfruttate come sorgenti1 . La cavità della Poesia Piccola fu riscoperta nel 1983 da Cosimo Pagliara, storico ed epigrafista dell’Università del Salento, che raggiungendo la grotta a bordo di una piccola imbarcazione attraverso uno stretto cunicolo accessibile dal mare2, scoprì le innumerevoli testimonianze epigrafiche presenti sulle pareti: una superficie di quasi 600 mq in cui si susseguono iscrizioni in lingua messapica, greca e latina che si sovrappongono a figurazioni e disegni ben più antichi.
Lo studio di questi ultimi e la loro comparazione con fonti iconografiche simili, hanno permesso di porre ancora più indietro l’orizzonte temporale di occupazione del sito: alcuni disegni fanno parte di un sistema rappresentativo presente in altri contesti ipogei del Salento come la Grotta dei Cervi, manifestazioni artistiche coincidenti con le ultime fasi del Neolitico3; mentre altri segni potrebbero essere associati a periodi facenti parte del Tardo Paleolitico superiore4 . Tra le raffigurazioni parietali spiccano però alcuni simboli appartenenti al periodo protostorico e che potrebbero provare la presenza di rapporti talmente intensi tra l’insediamento di Roca e le popolazioni provenienti dal Mediterraneo Orientale da ibridarne la sfera sacra: sono ricorrenti i simboli in associazione della doppia ascia e del bucranio, schema iconografico tipicamente minoico5 che si riferisce a sacrifici animali, le cui tracce sono presenti all’interno dell’insediamento di Roca.
Le iscrizioni messapiche6 e latine, seppur successive di
Fig. 8 - Sezione della Grotta Poesia Piccola e del corridoio di accesso dal mare.
molti secoli alle raffigurazioni, mantengono il contenuto a vocazione sacra e cerimoniale, assumendo la forma di voti da parte di chi le incideva: scritte probabilmente risultate da riti per propiziare la fortuna per un lungo viaggio in mare. Anche se ancora poco indagate, vi sono rintracciabili alcuni elementi principali: le iscrizioni presentano caratteristiche votive e vi si possono spesso leggere i nomi propri delle persone che le effettuavano; nonostante la presenza di divinità celesti come Zis7, la maggior parte delle offerte vengono indirizzate alla figura di Taotor Andirahas, latinizzato poi in Tutor Andreius, la divinità ctonia cui era plausibilmente dedicata la grotta santuario8 .
Purtroppo non ci sono prove che confermino la pratica di particolari riti lungo il sistema carsico, né che diano indicazioni sui percorsi di accesso allo stesso o di eventuali processioni ivi tenutesi; non possiamo sapere se l’ingresso fosse dalla Grotta Poesia Grande o dal lungo corridoio che si imbocca dalla Poesia Piccola ma, sia sulla superficie di calpestio orizzontale di quest’ultimo (oggi sommersa per circa un metro e mezzo), sia lungo gli intradossi di alcune volte e gli elementi verticali, sono evidenti lavorazioni antropiche atte a facilitare l’entrata e il cammino lungo le grotte9 . La grande stratificazione di usi a valenza religiosa colpisce per la sua lunga continuità nei secoli, rappresentando oggi una delle più importanti prove delle varie fasi di sviluppo dell’insediamento di Roca, iniziato nel Neolitico e arrestatosi bruscamente dopo la conquista romana del Salento.
Fig. 9 - Ridisegno dei graffiti del periodo protostorico individuati da C. Pagliara all'interno della Grotta Poesia Piccola durante il primo sopralluogo nel 1983: un cerchio con raggi, una mano sinistra, un bucranio e un ascia (raffigurazioni di matrice egea) e due raffigurazioni probabilmente di animali.
Note Bibliografiche 1 c. pagliara, La Grotta Poesia di Roca. Note Preliminari in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie III, 17, no. 2, 1987, pp. 310-312. 2 Ibidem, pp. 268-270. 3 Ibidem, pp.324-325. 4 Il legame tra le raffigurazioni è chiaro confrontando le iscrizioni rilevate da Pagliara e riportate in La Grotta Poesia di Roca. Note Preliminari in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie III, 17, no. 2, 1987, tavv. L – LI – LII, e quelle presenti in p. graziosi L’arte dell’antica età della pietra, Sansoni, Firenze, 1956, tavv. 106 – 108. 5 r. guglielmino Presenze minoiche nel Salento. Roca e la saga di Minosse, in Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico, a cura di C. Ampolo, Vol. 1, Edizioni della Normale, Pisa, 2009, p. 484. 6 La lingua messapica utilizzava un alfabeto di derivazione greca, ma nonostante i numerosi studi specifici è ancora poco tradotta. Tra gli studiosi che più si sono concentrati sull’analisi dell’antica lingua messapica segnaliamo C. De Simone e S. Marchesini a cui rimandiamo per chi volesse approfondire tale argomento. 7 Zis era il nome della divinità più importante della religione messapica ed era inteso come divinità celeste. Voce: “Zis”, in Enciclopedia Treccani Online.
8 L’interpretazione delle iscrizioni messapiche all’interno della grotta è ampiamente trattata in c. de simone, Iscrizioni messapiche nella grotta della Poesia (Melendugno, Lecce), in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie III, 18, no. 2, 1988, pp. 325-415. 9 c. pagliara, op. cit., pp. 312-317.

Fig. 10 - Mappa di distribuzione degli insediamenti fortificati dell'Età del Bronzo e insediamenti rupestri anche più antichi. In alcuni di essi sono stati rinvenuti numerosi reperti di matrice egea a testimonianza dei profondi legamei e scambi tra autoctoni e popoli d'oltremare.