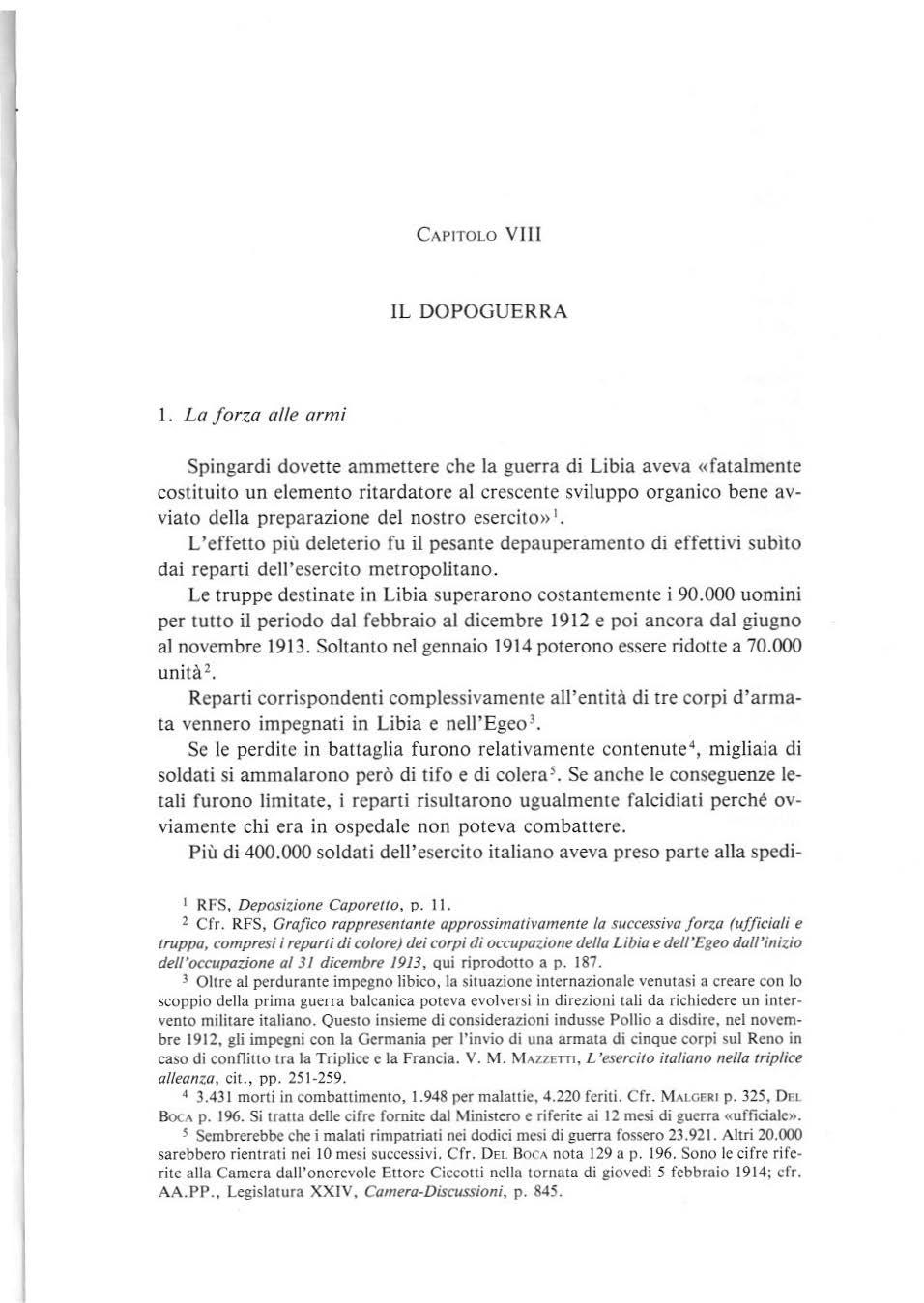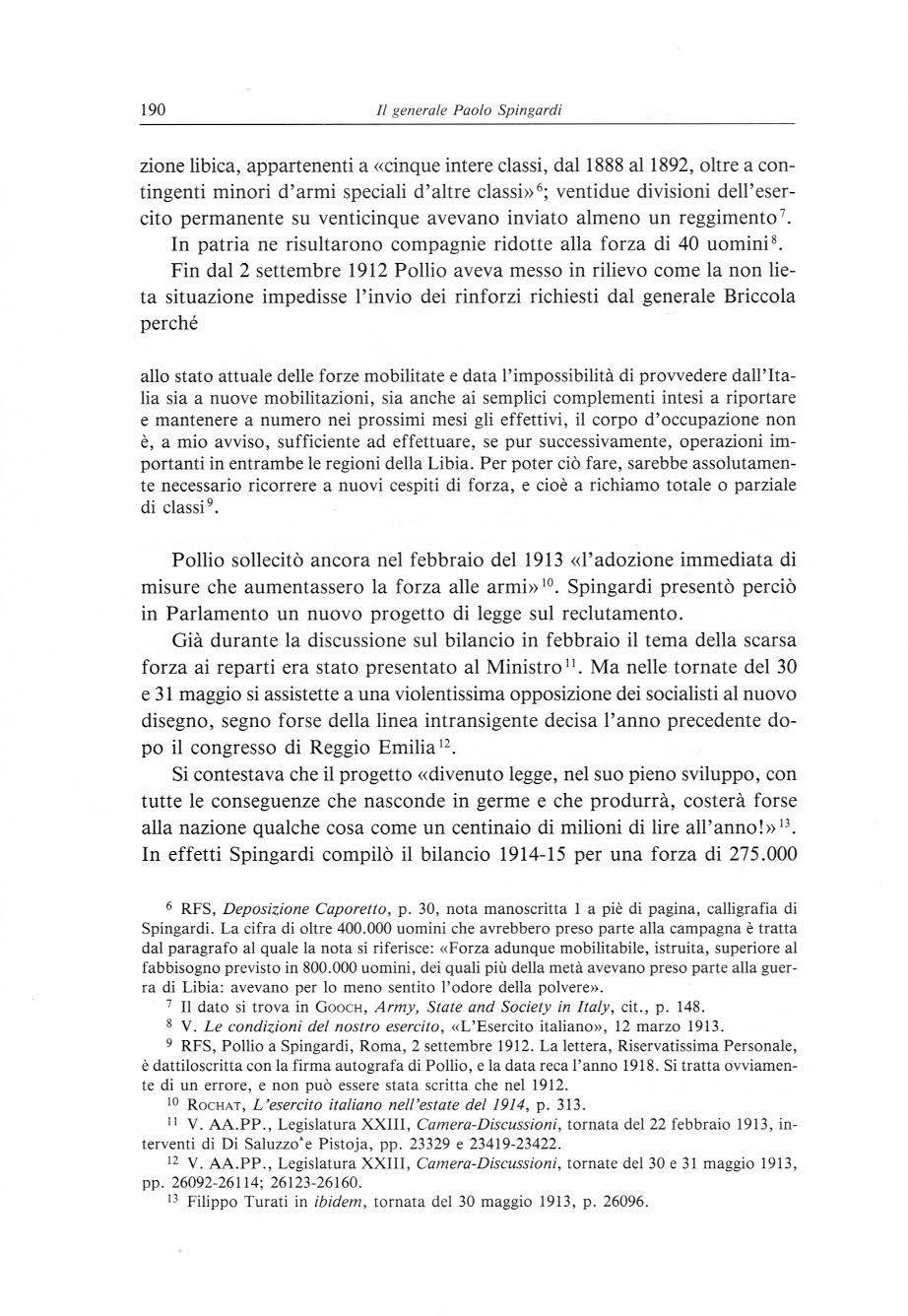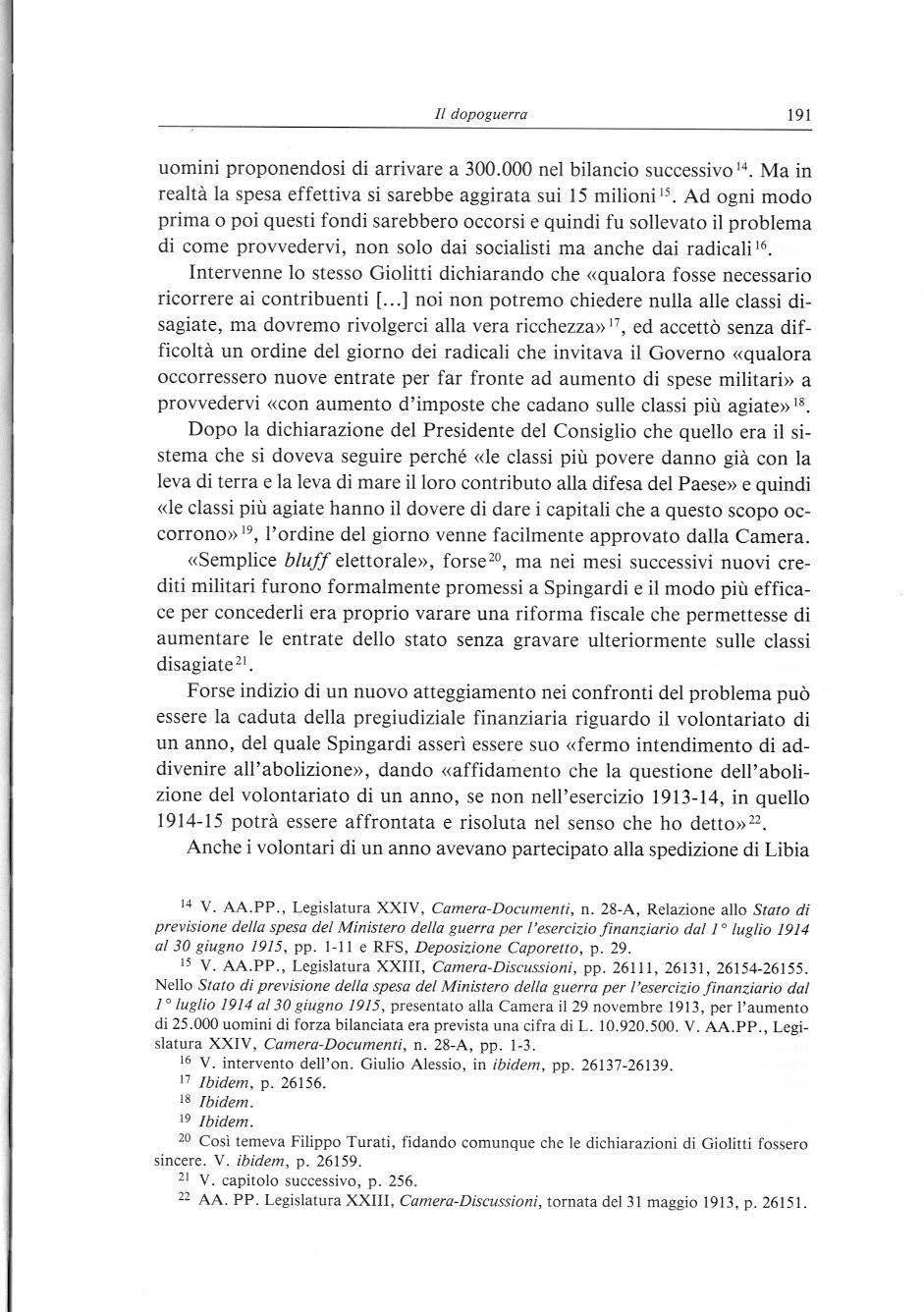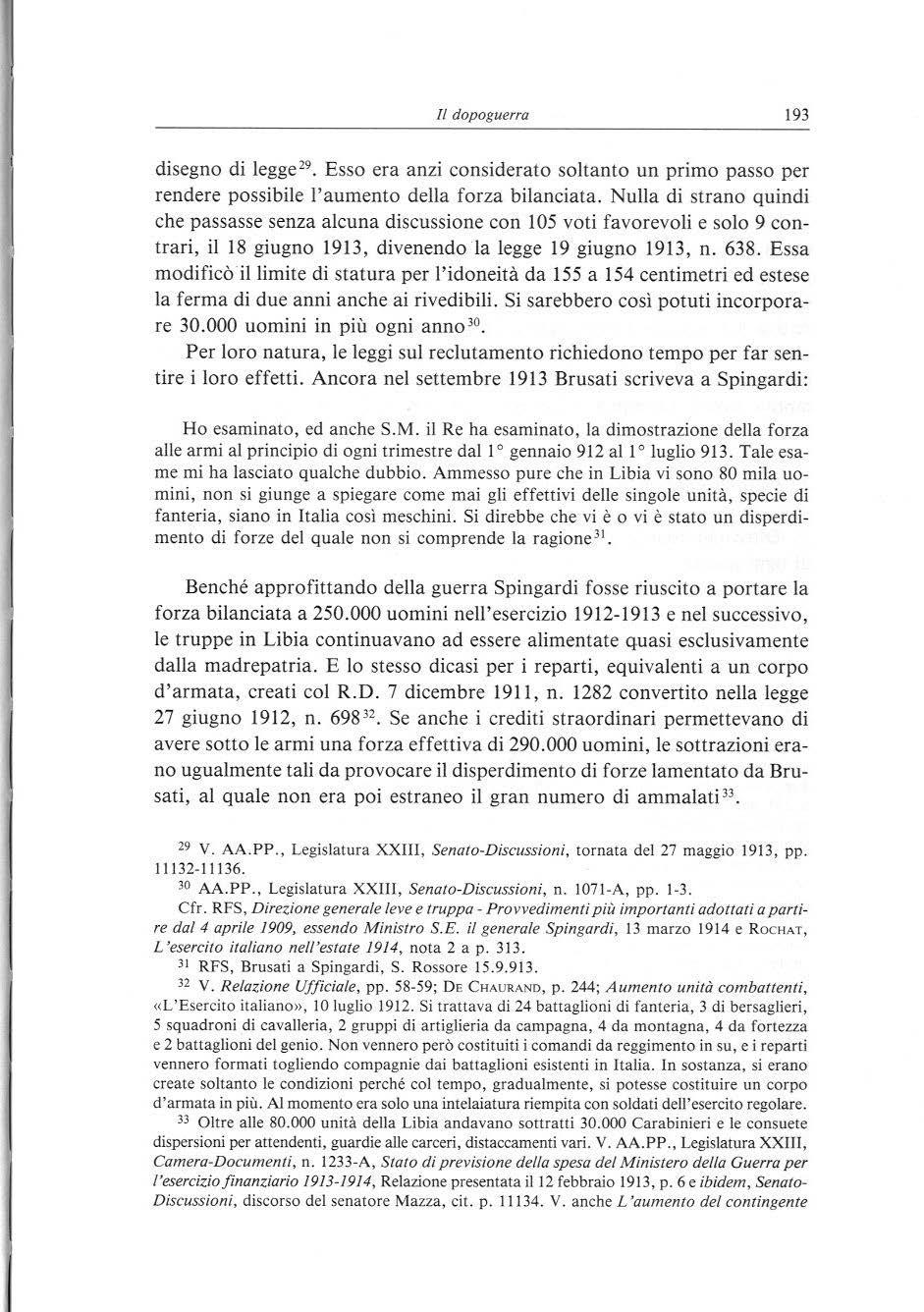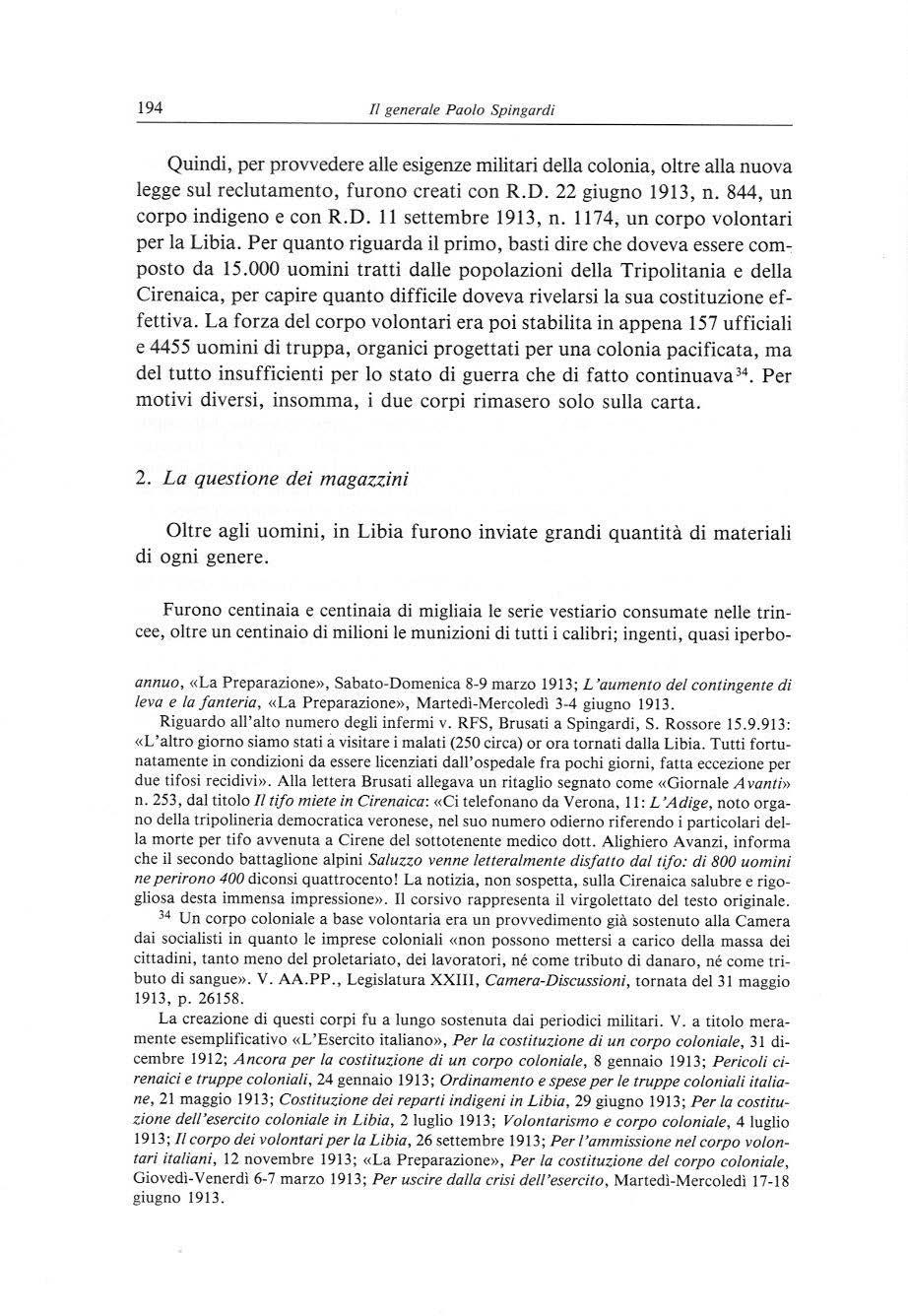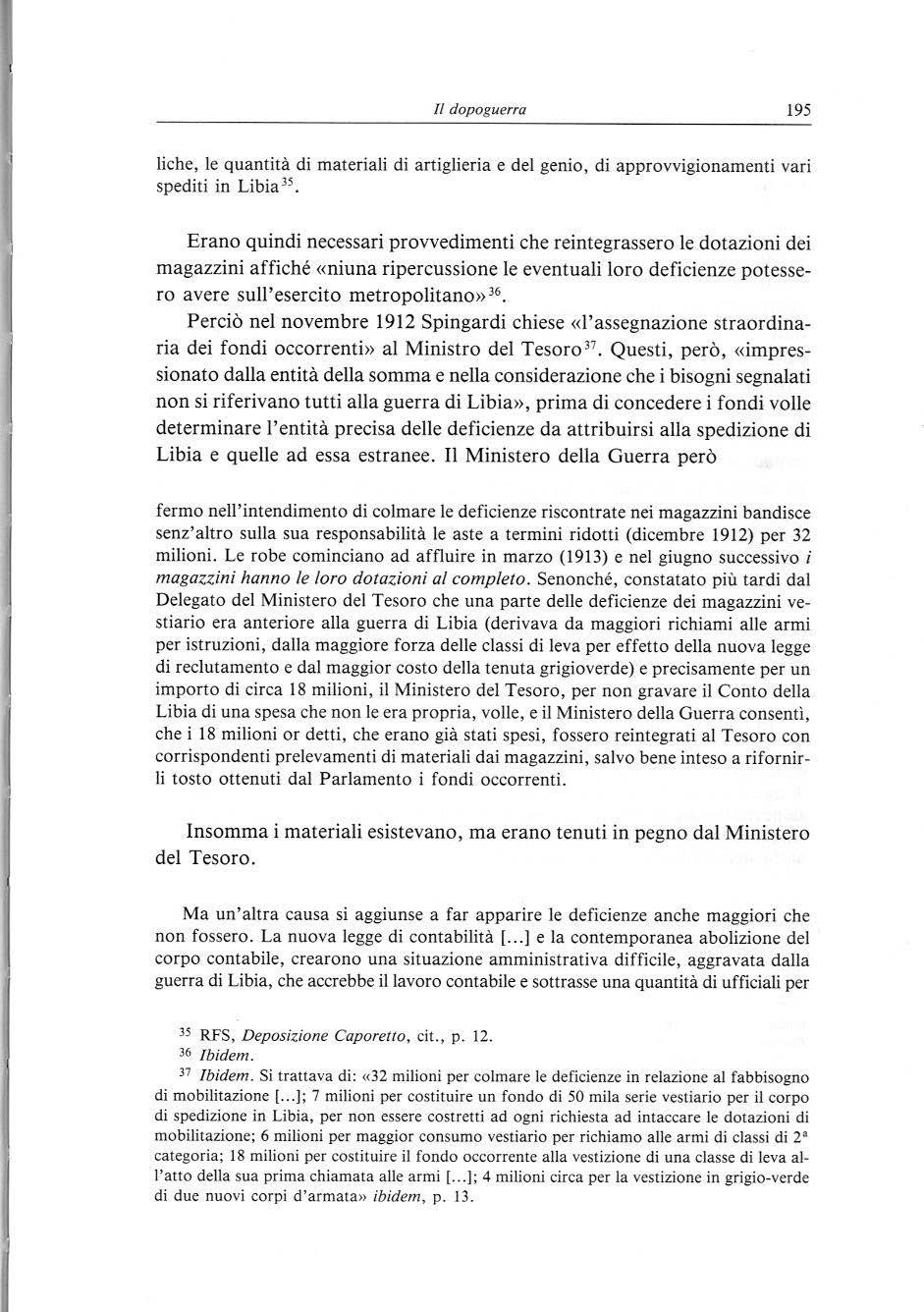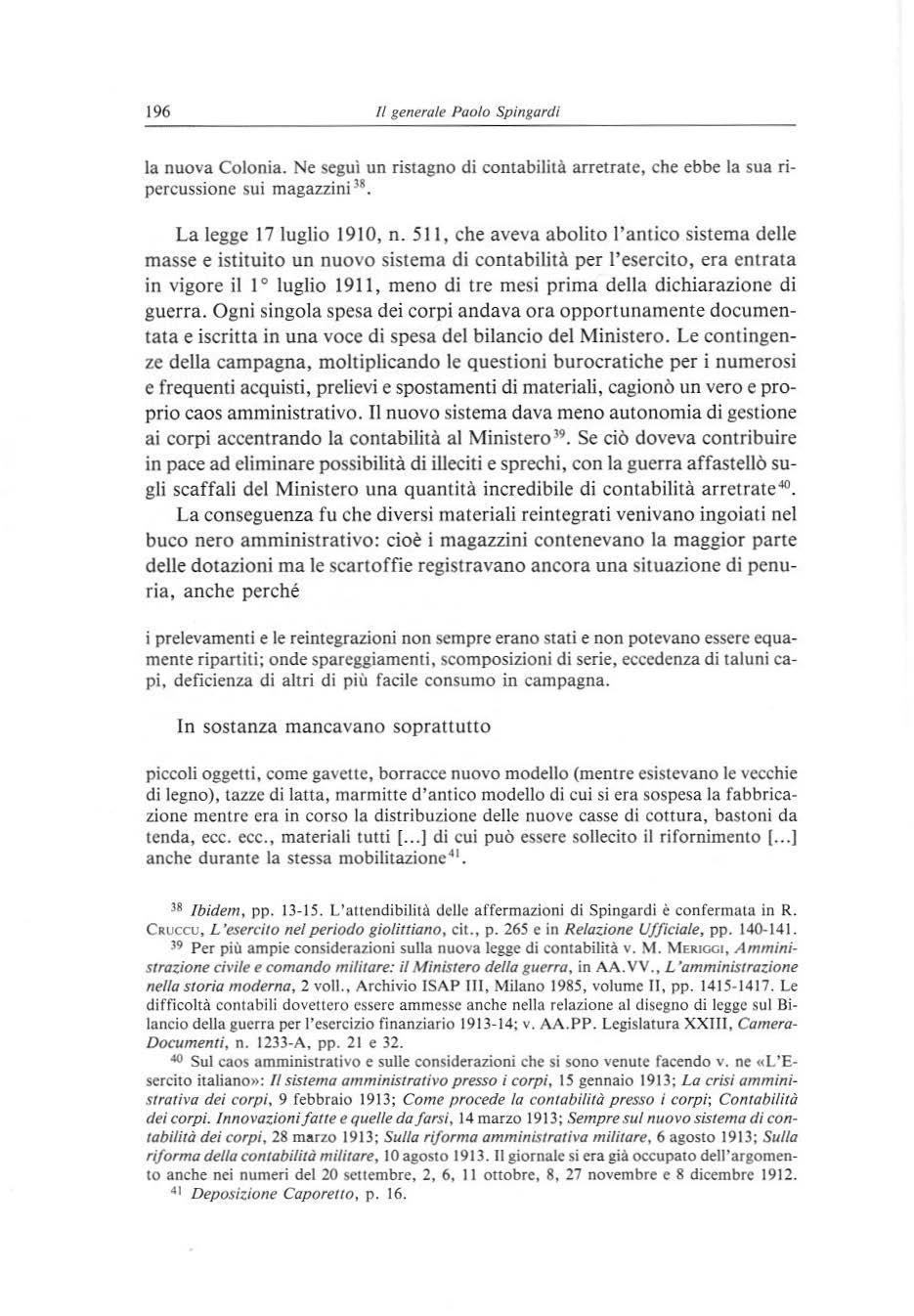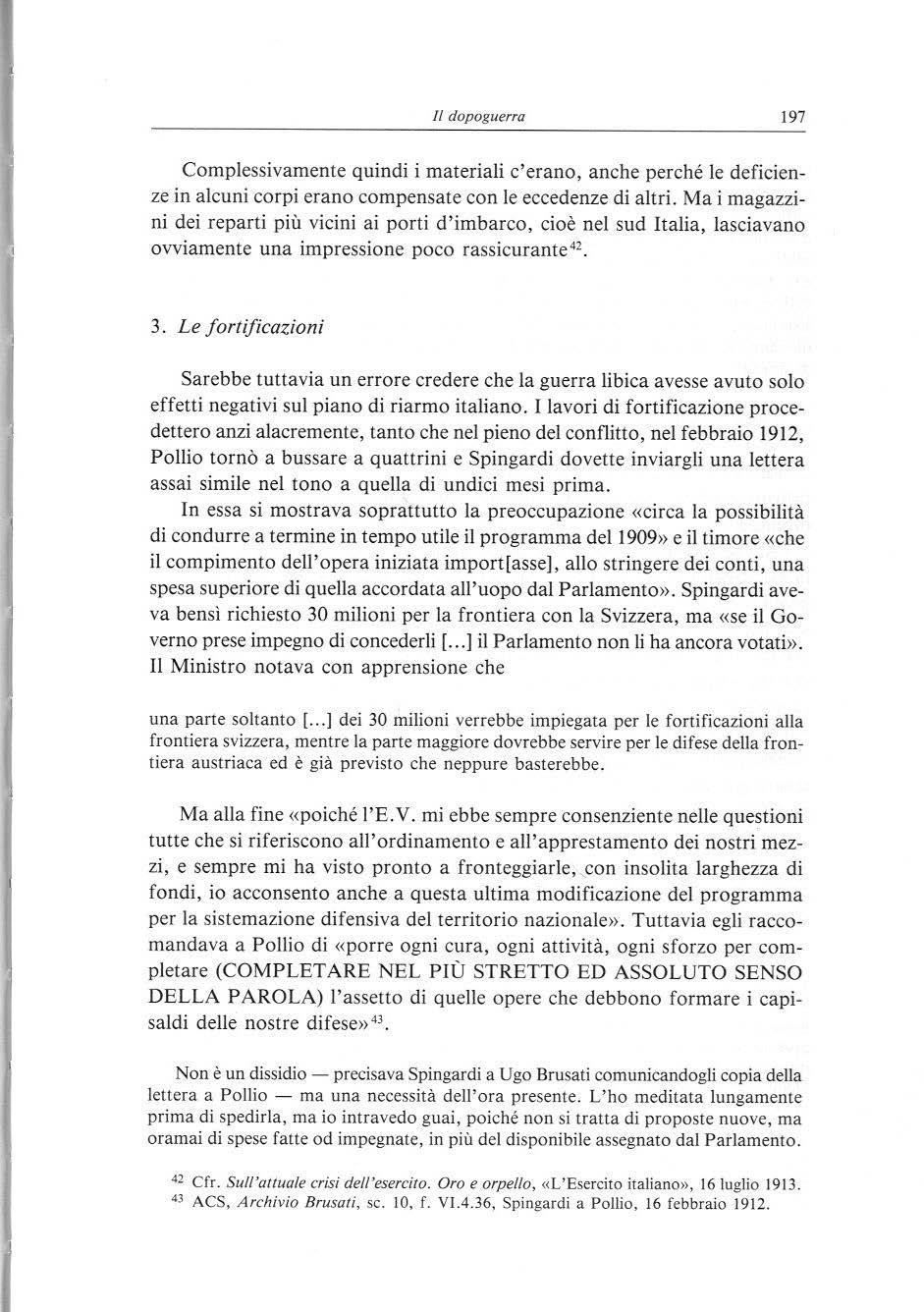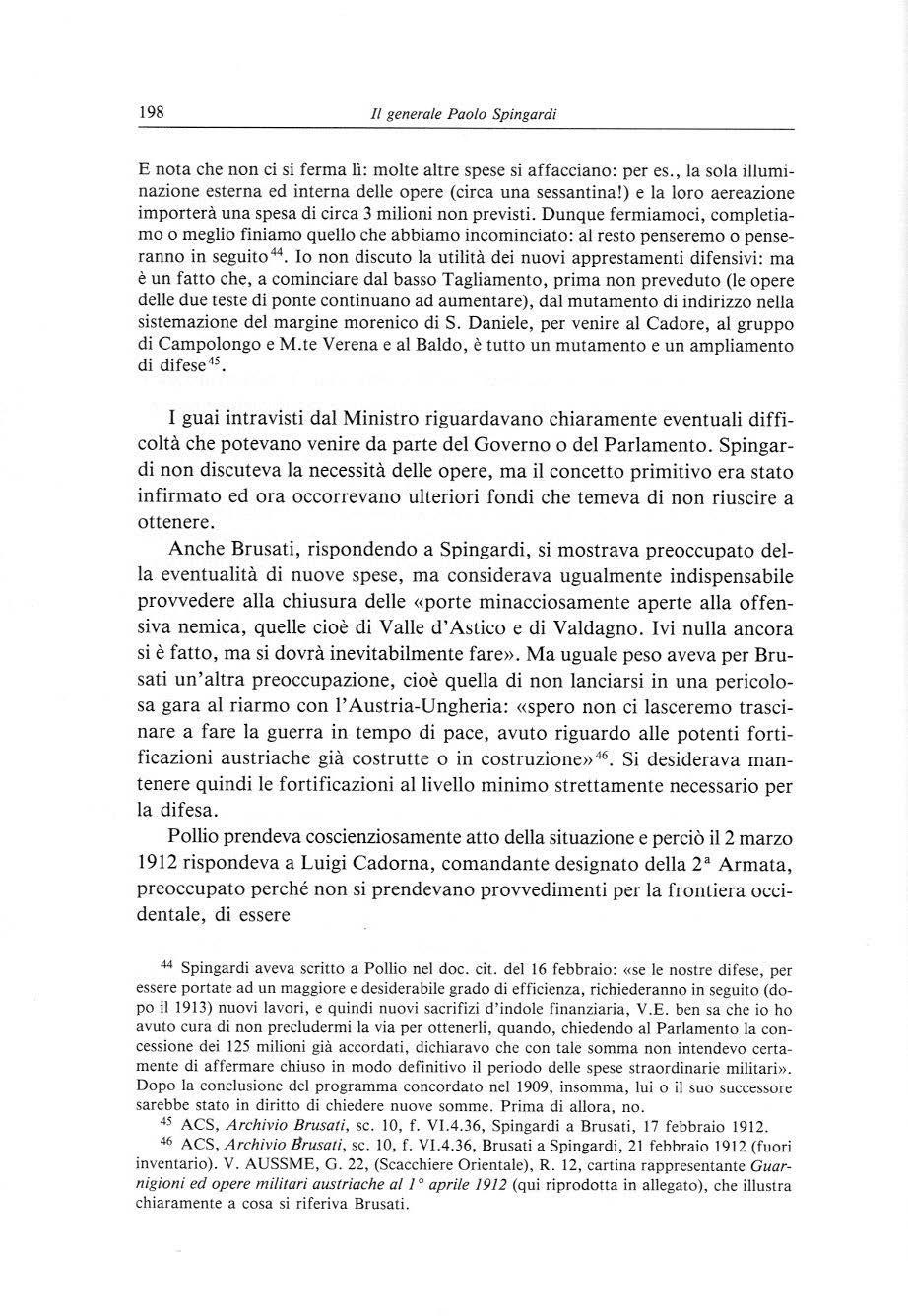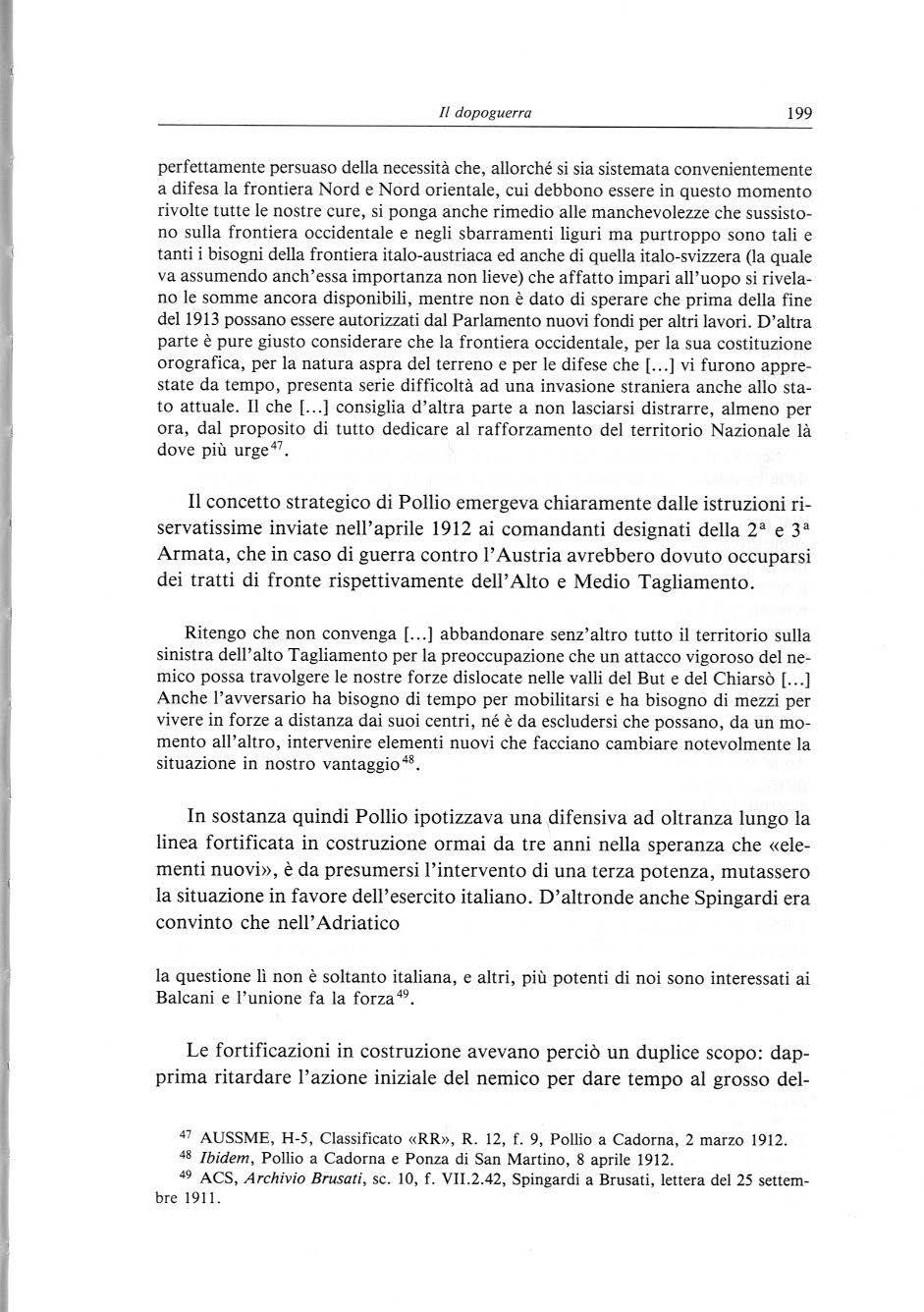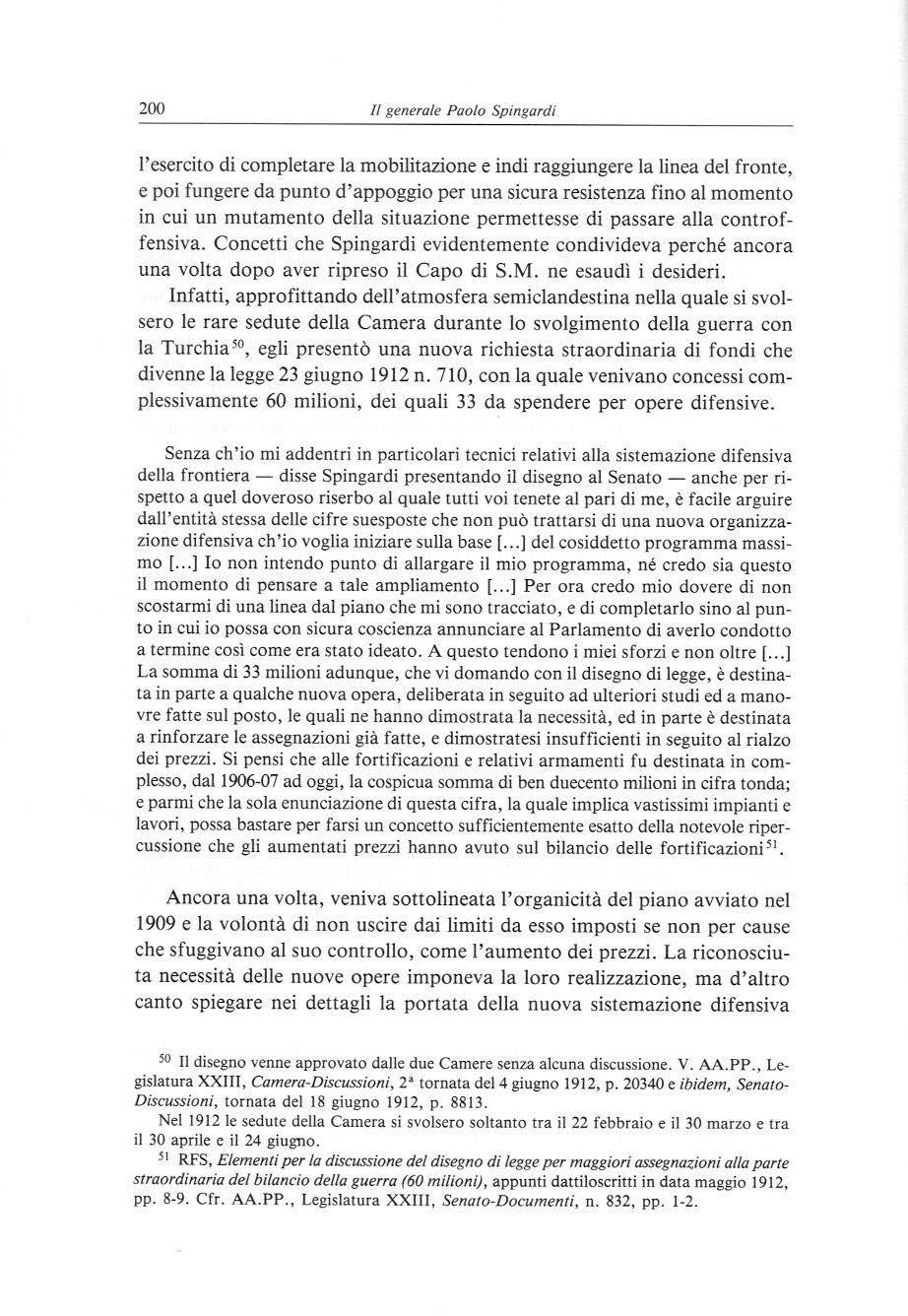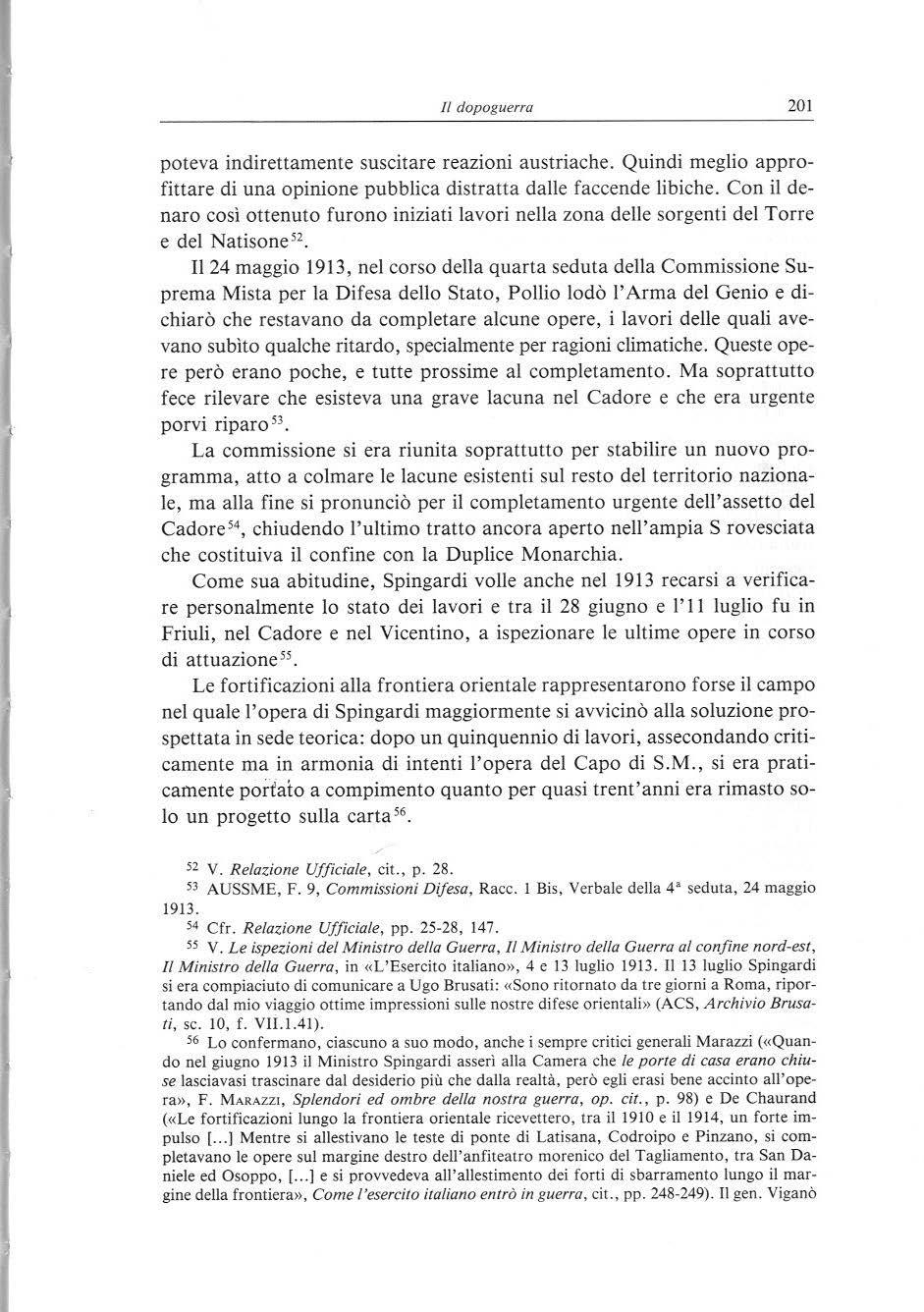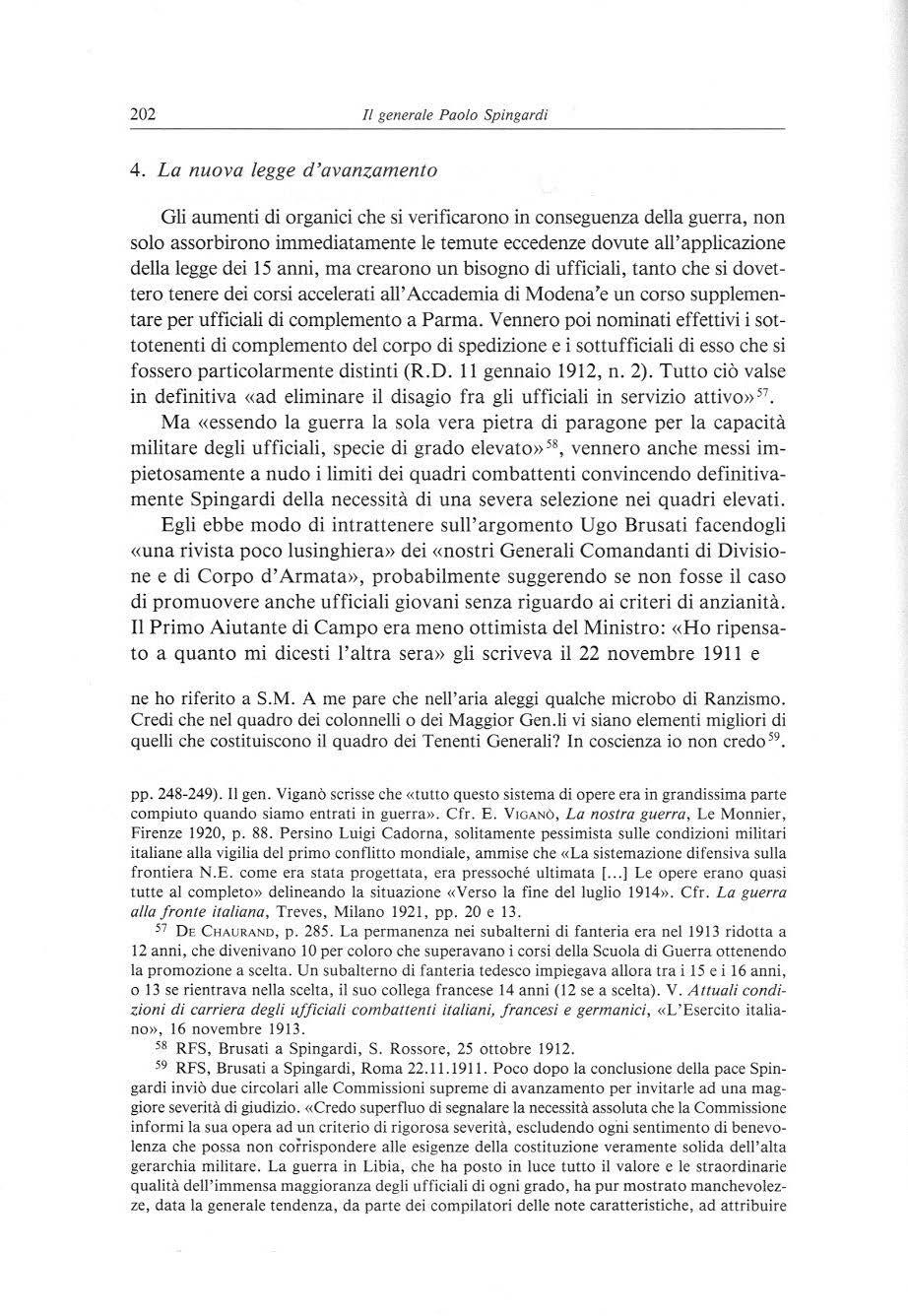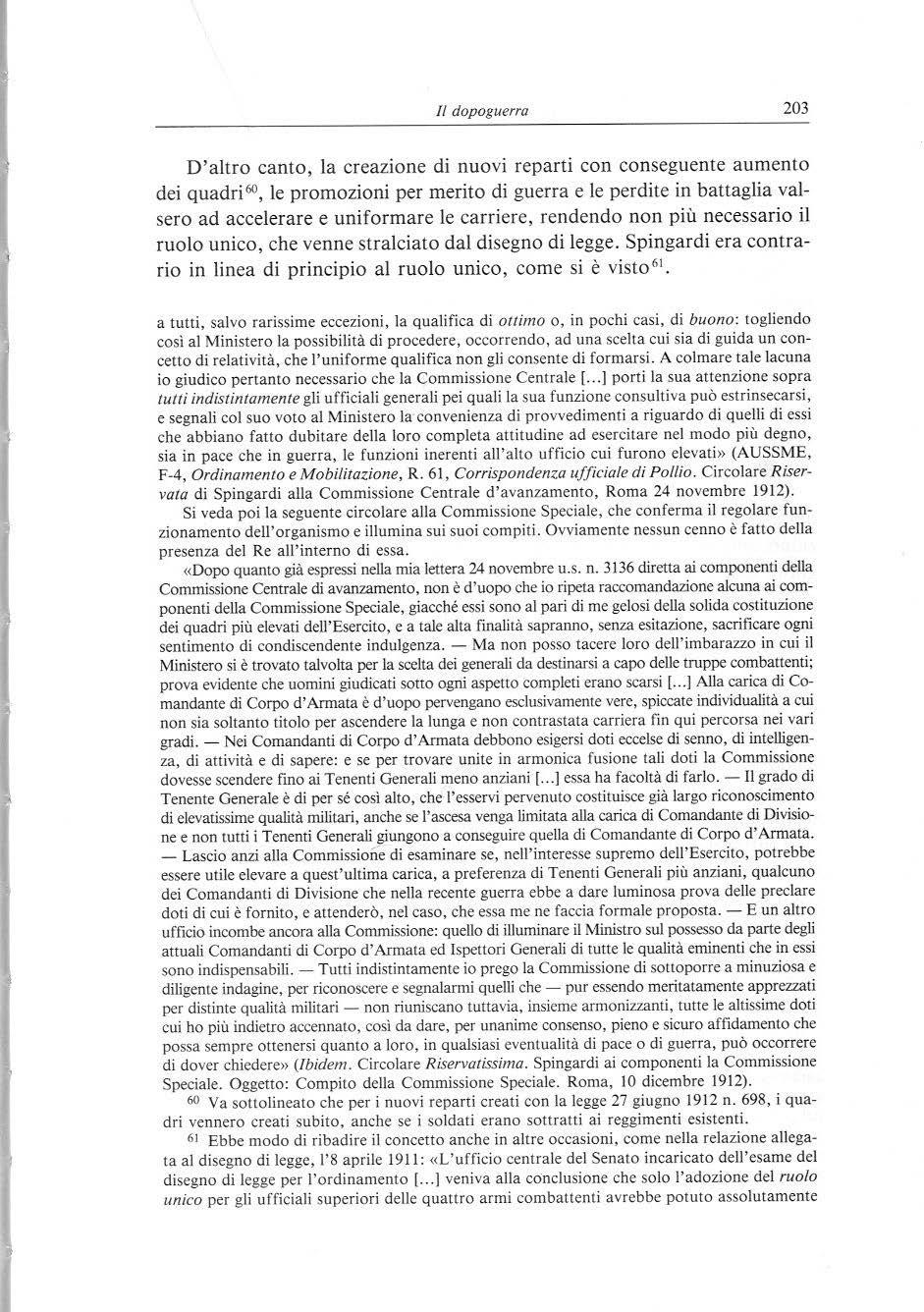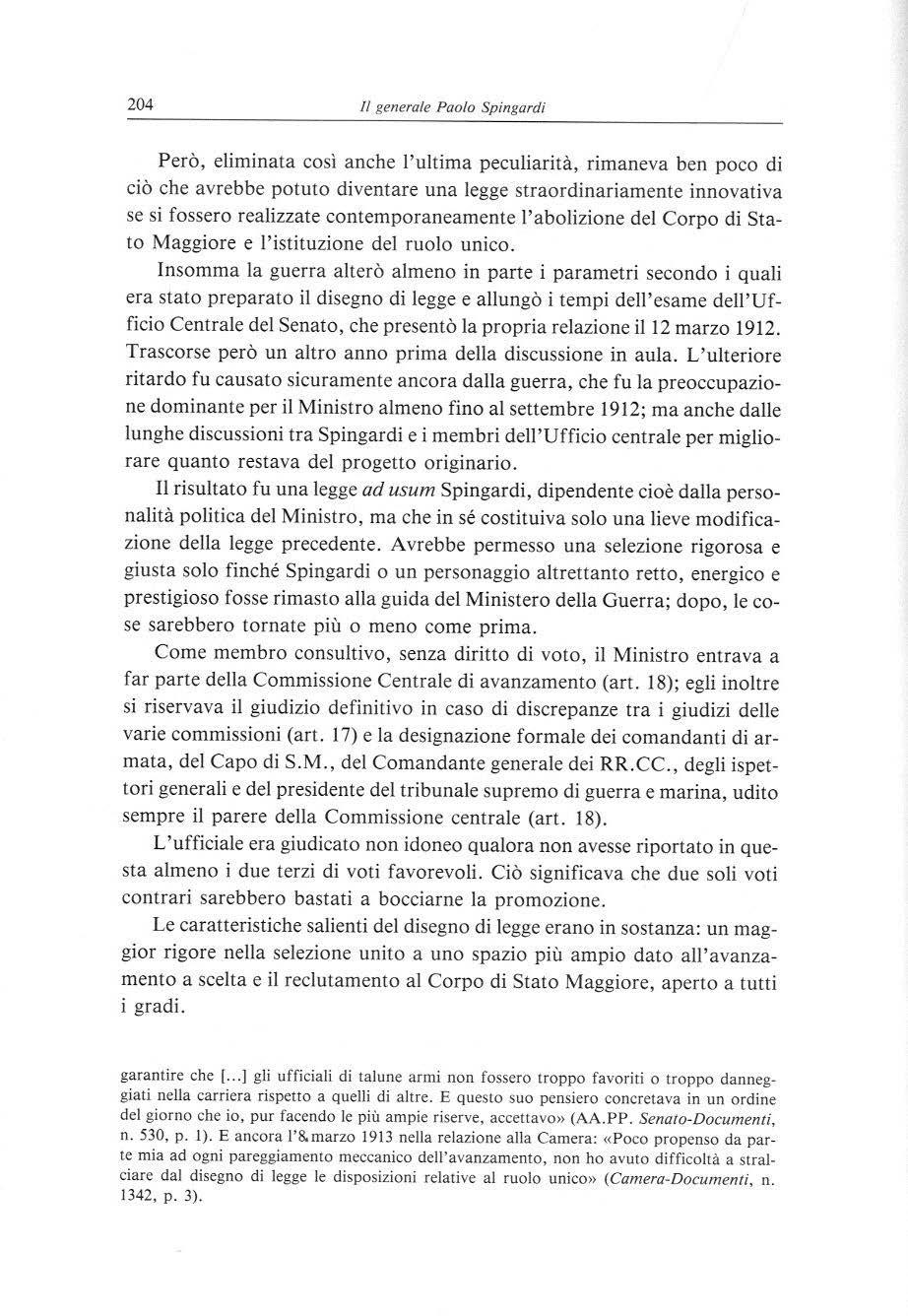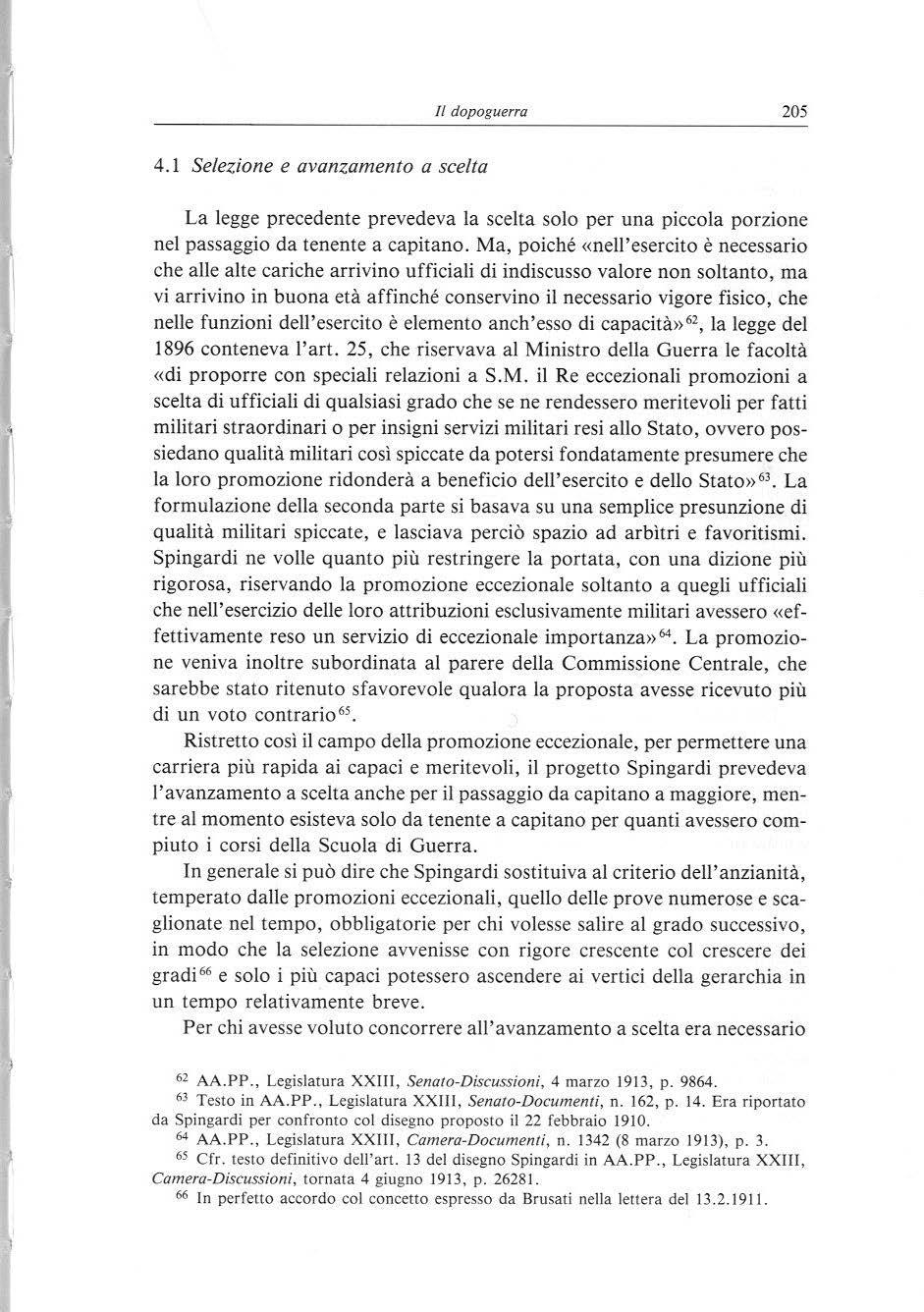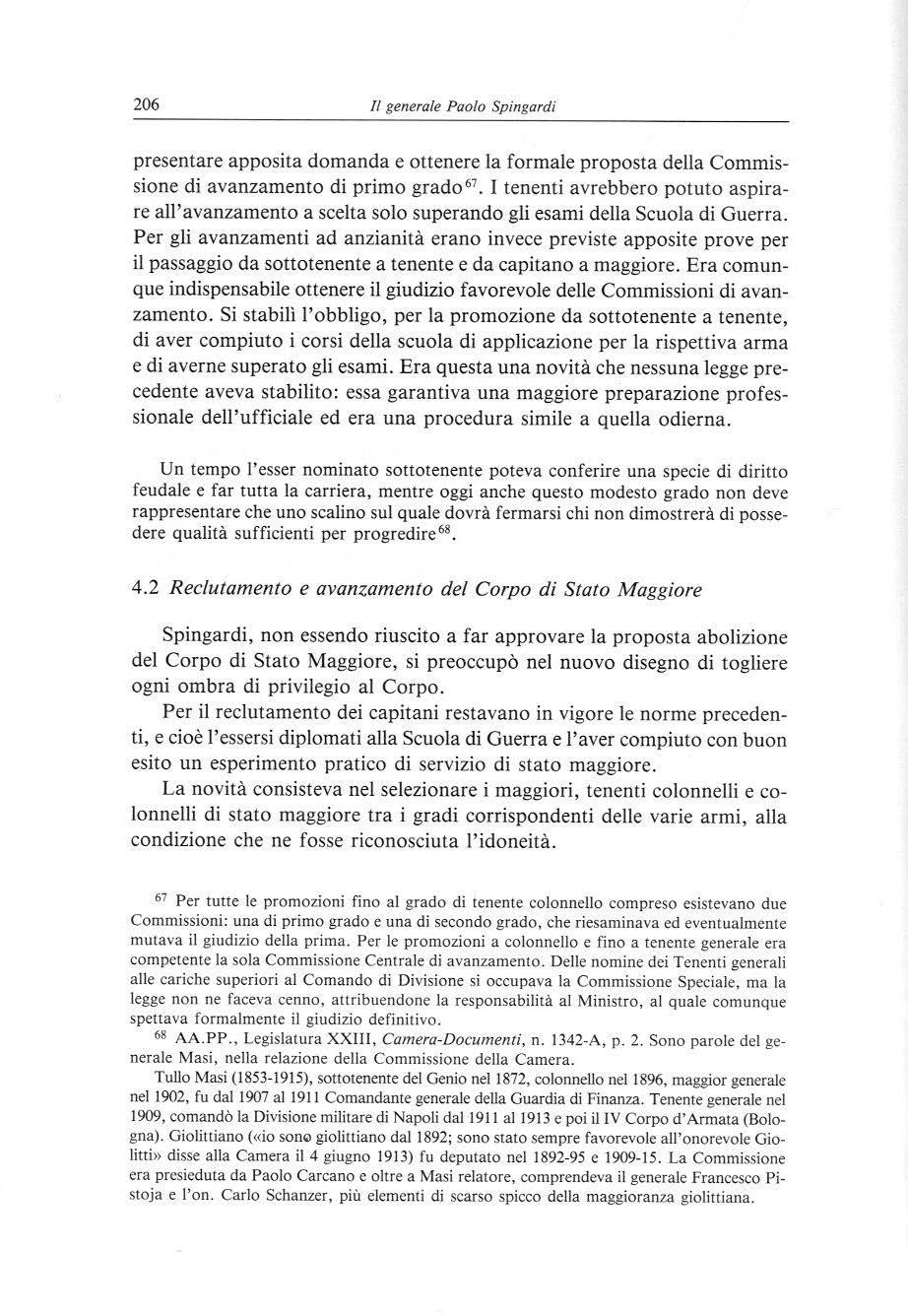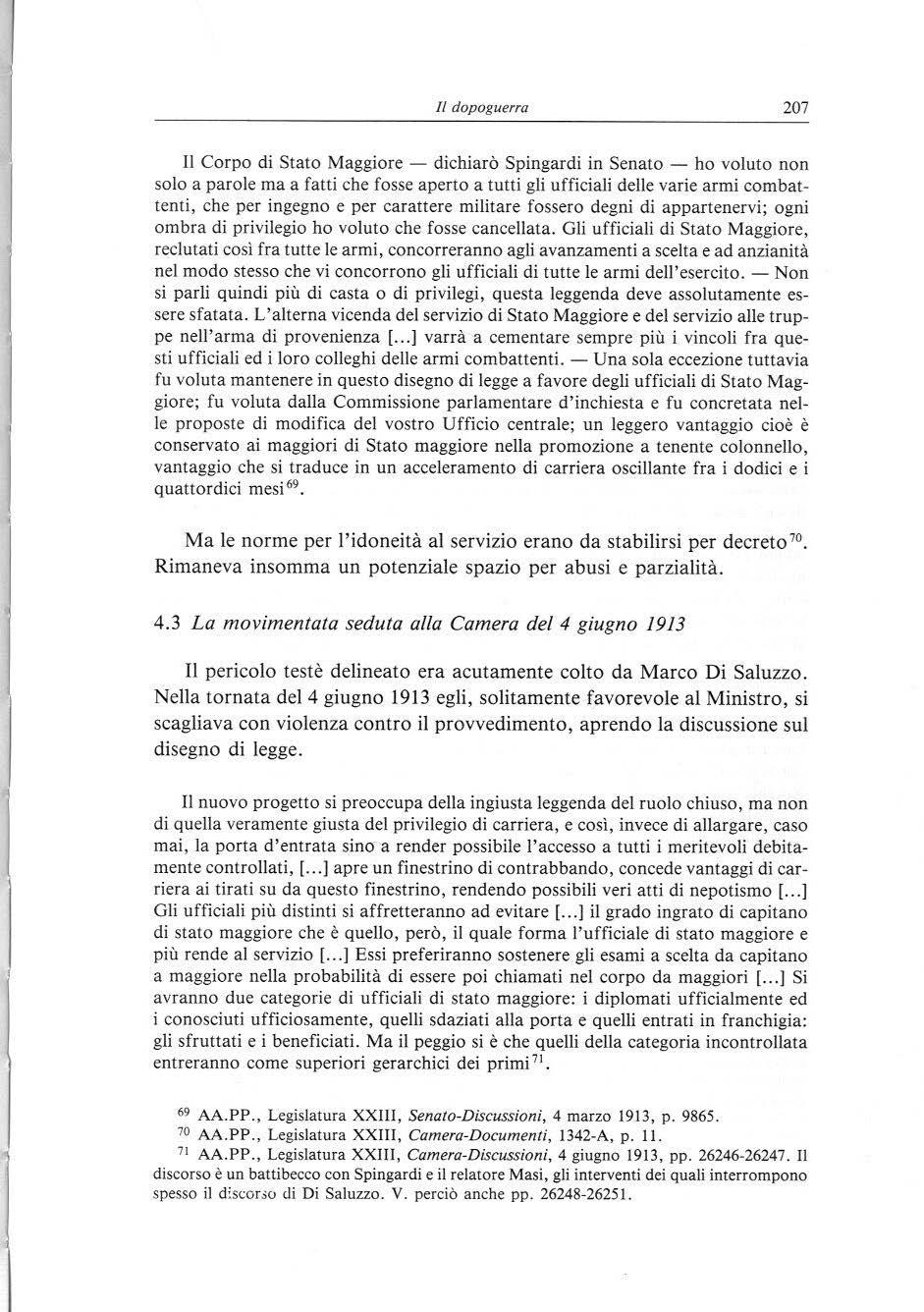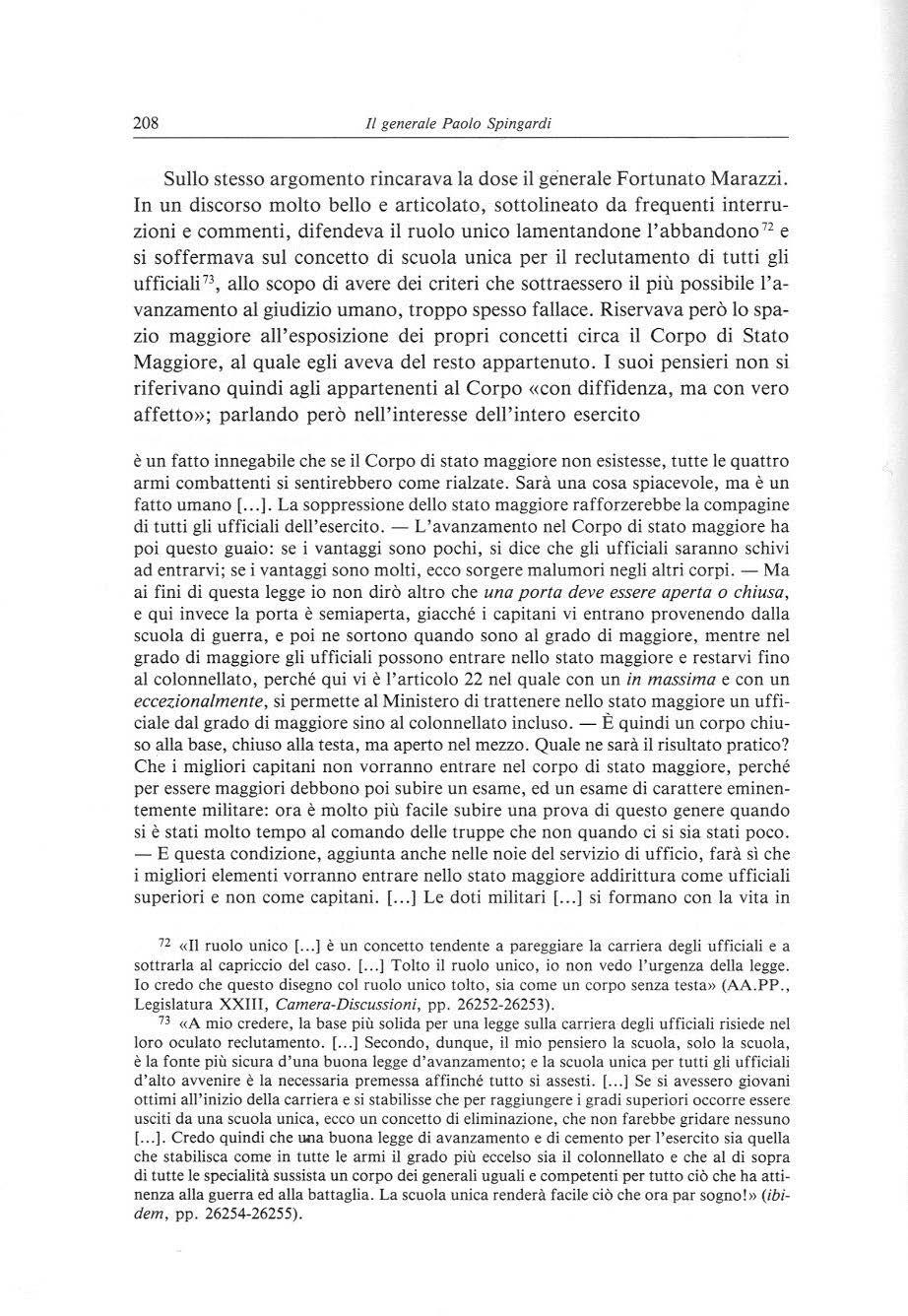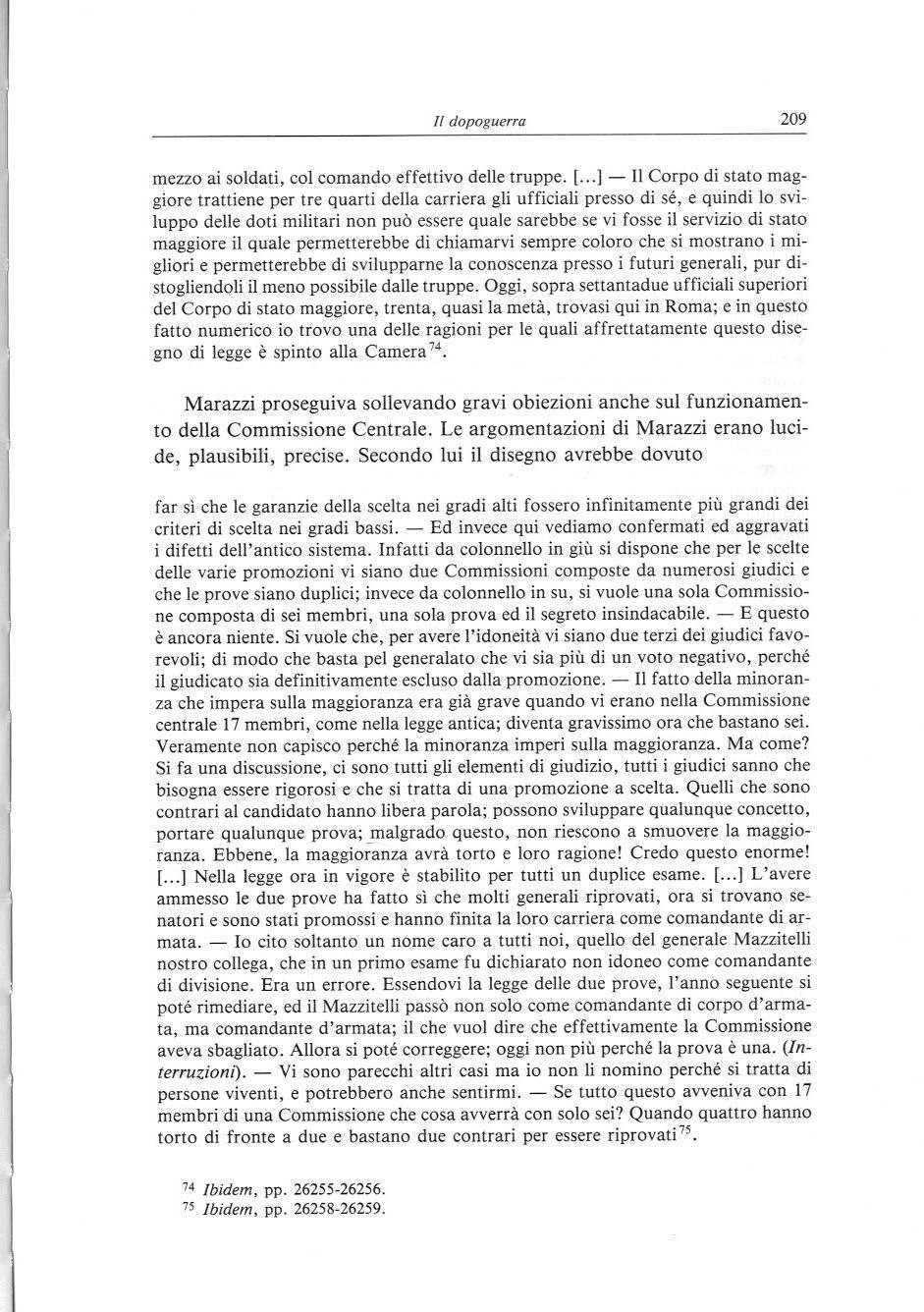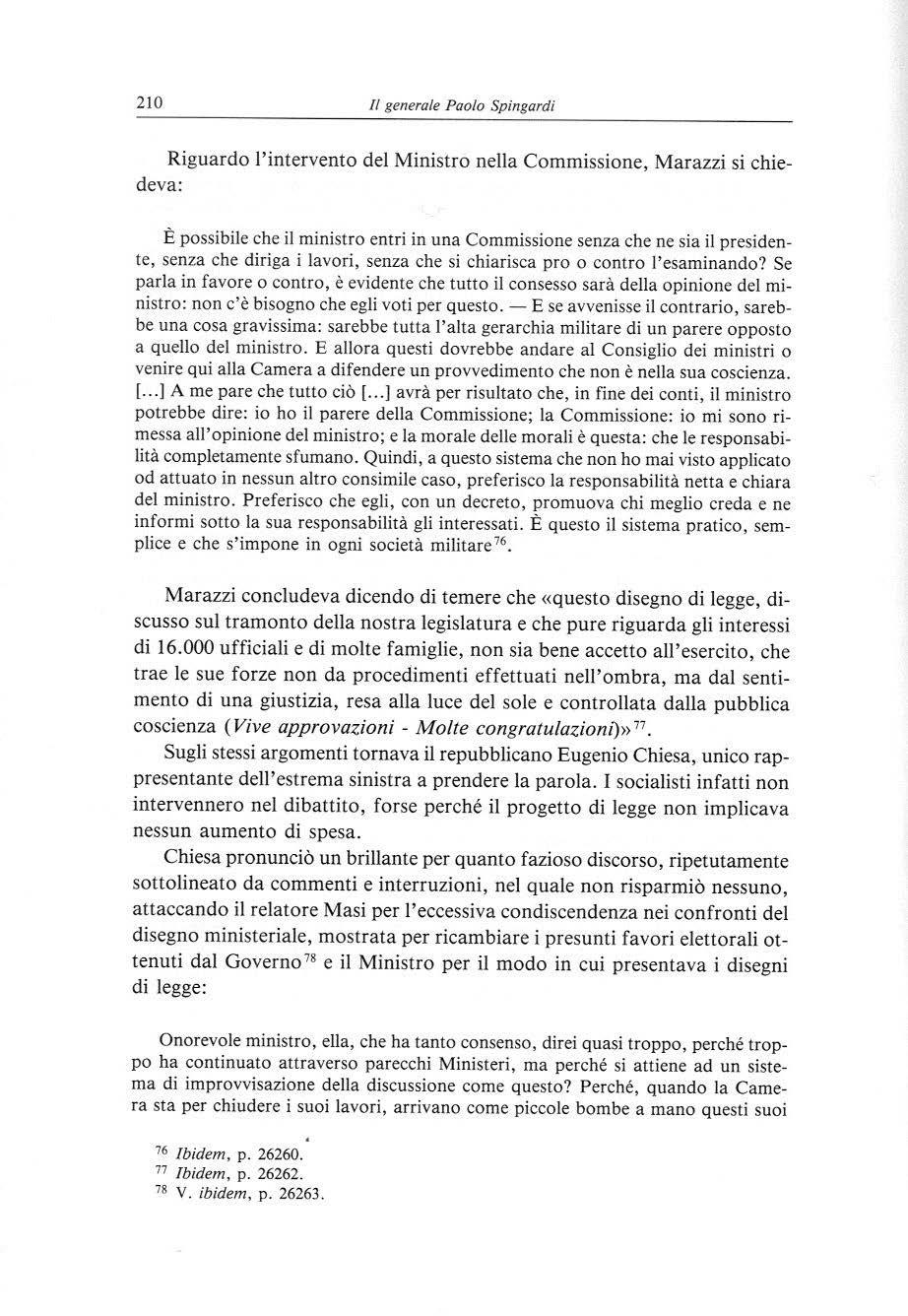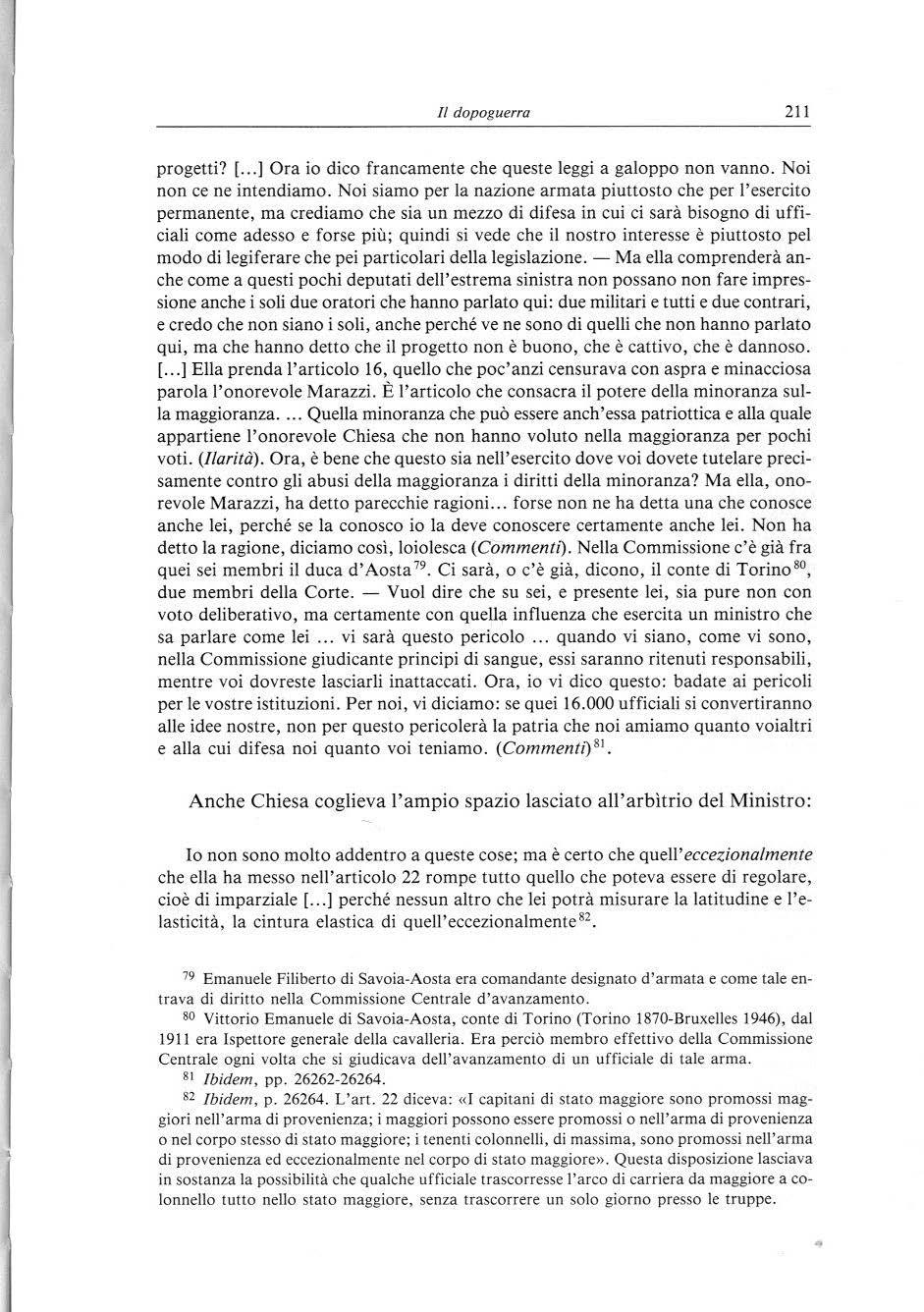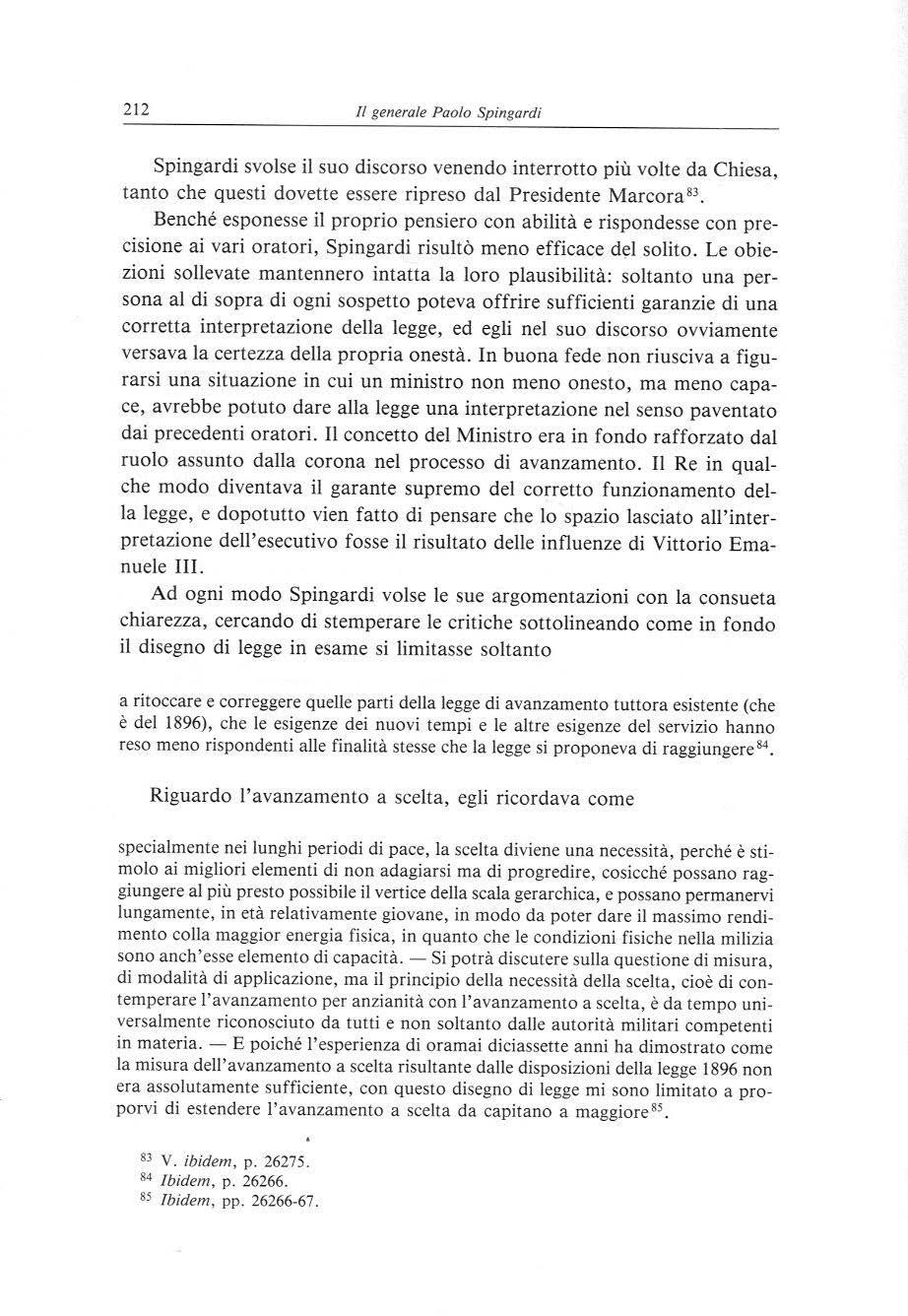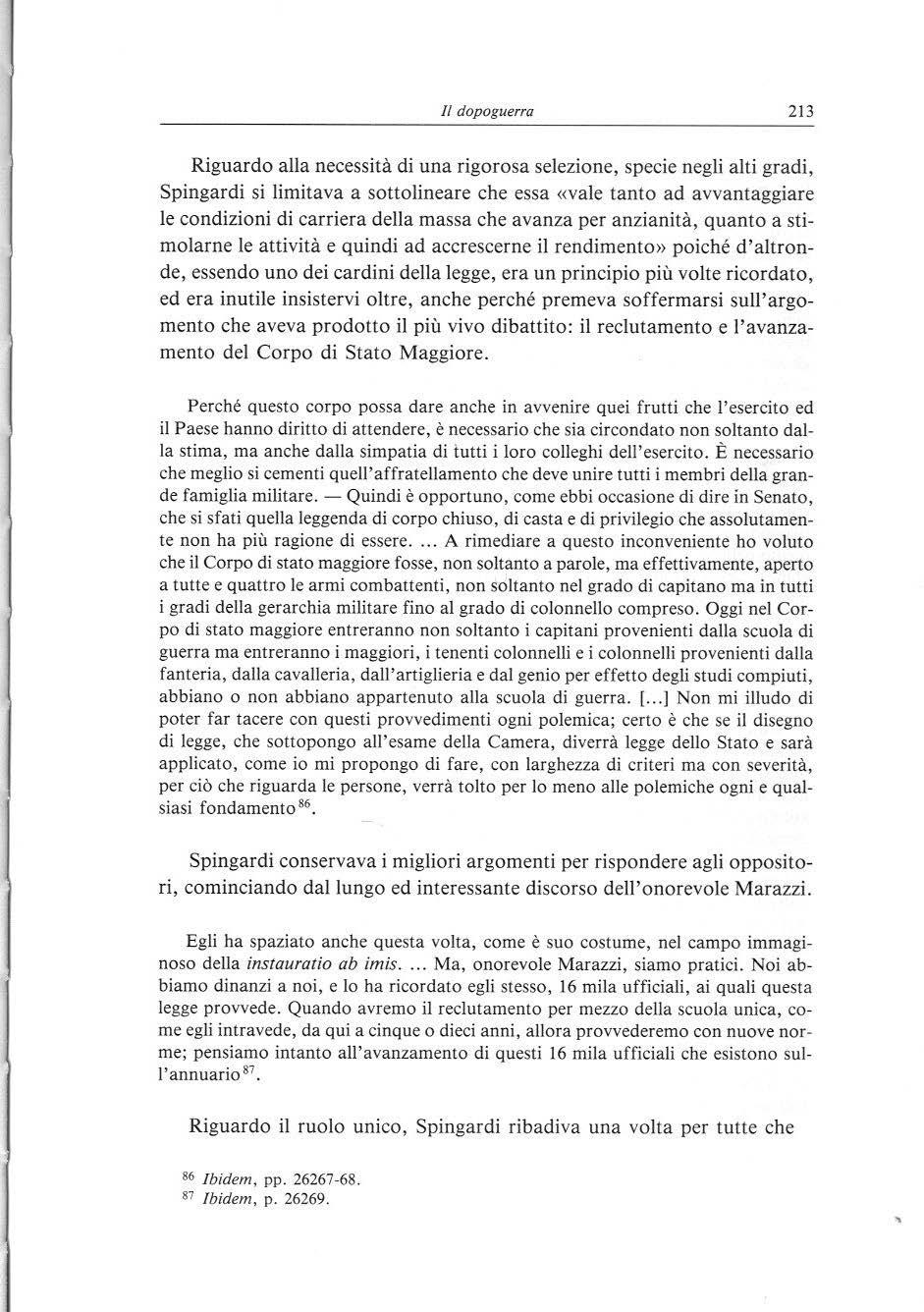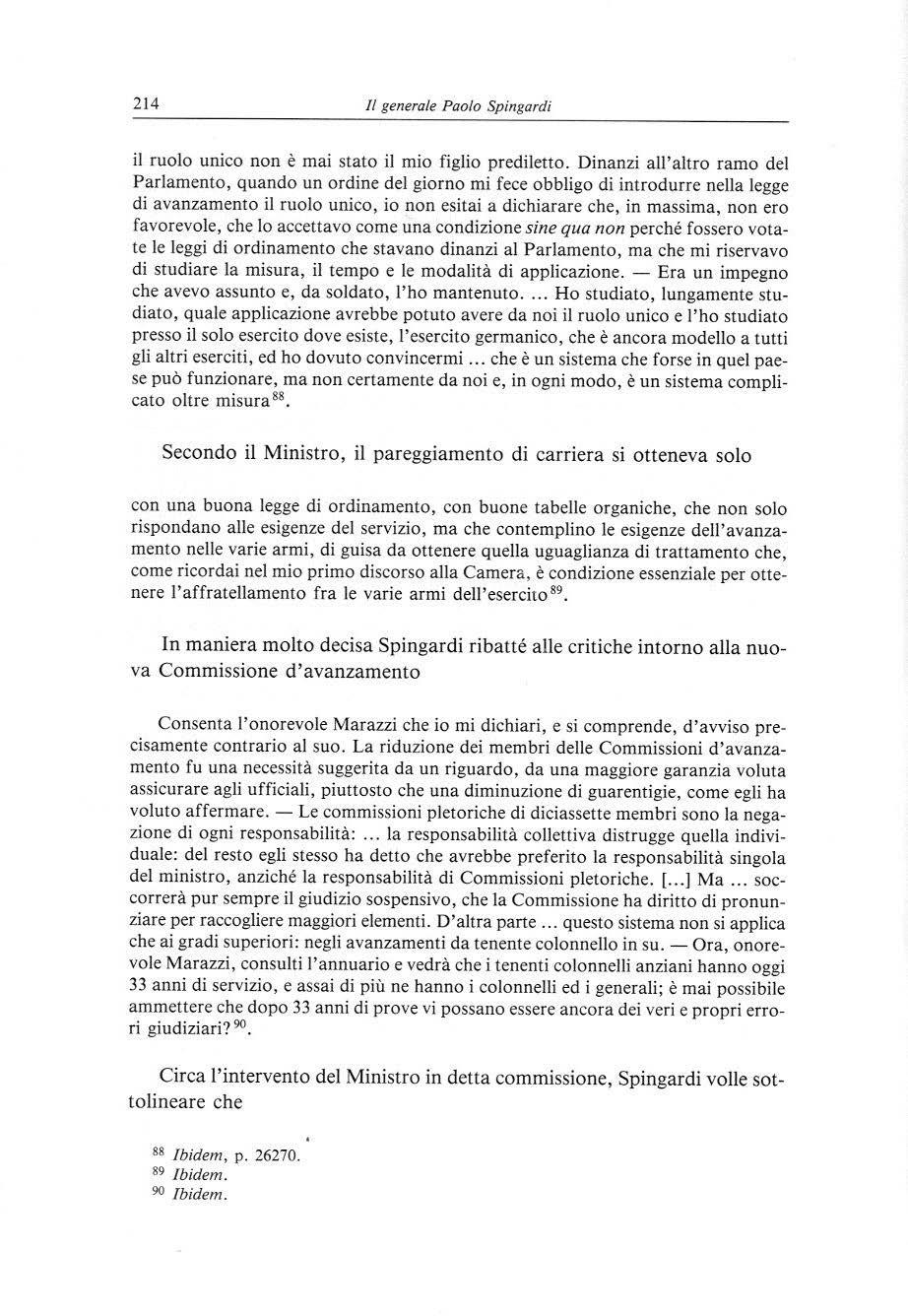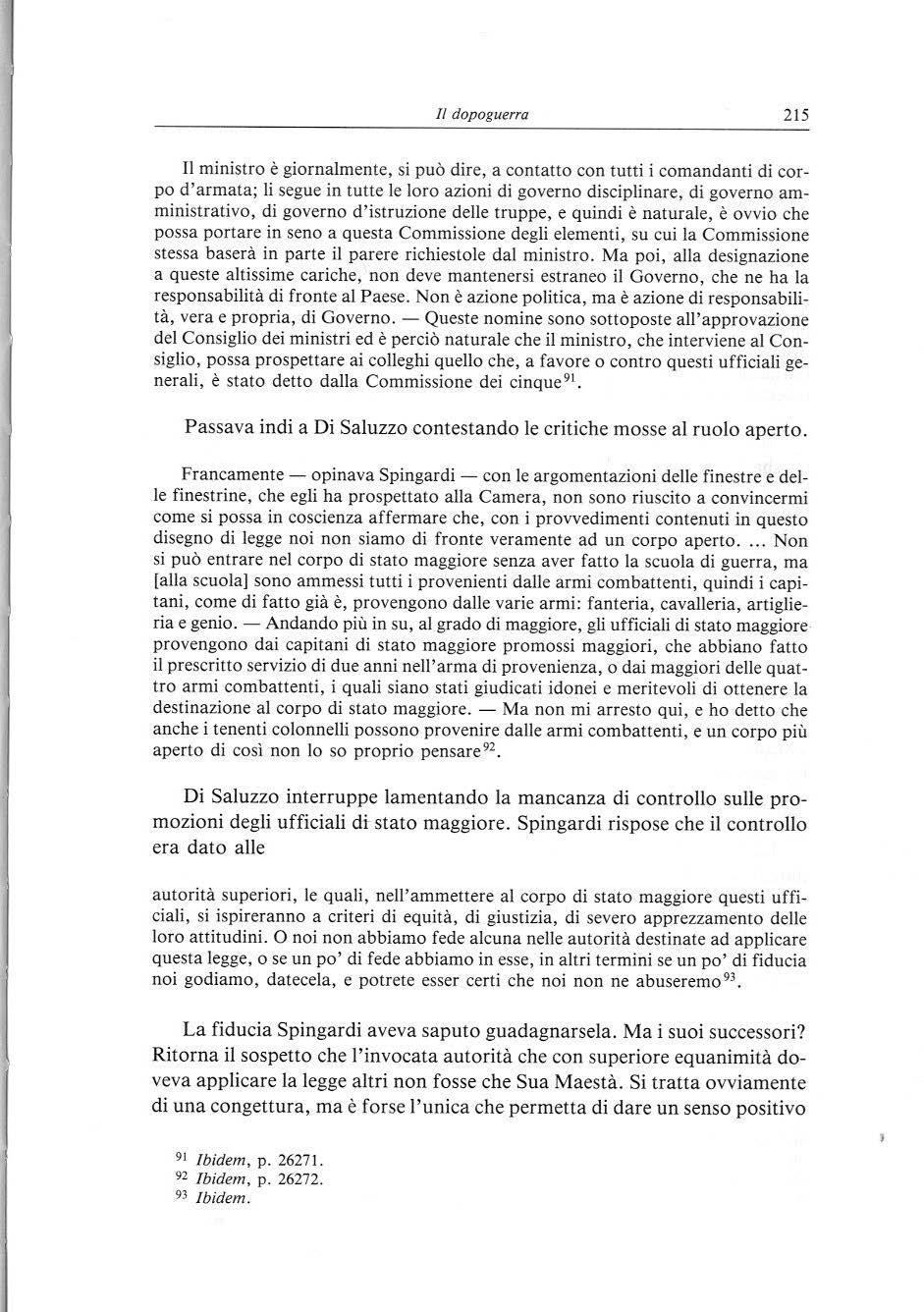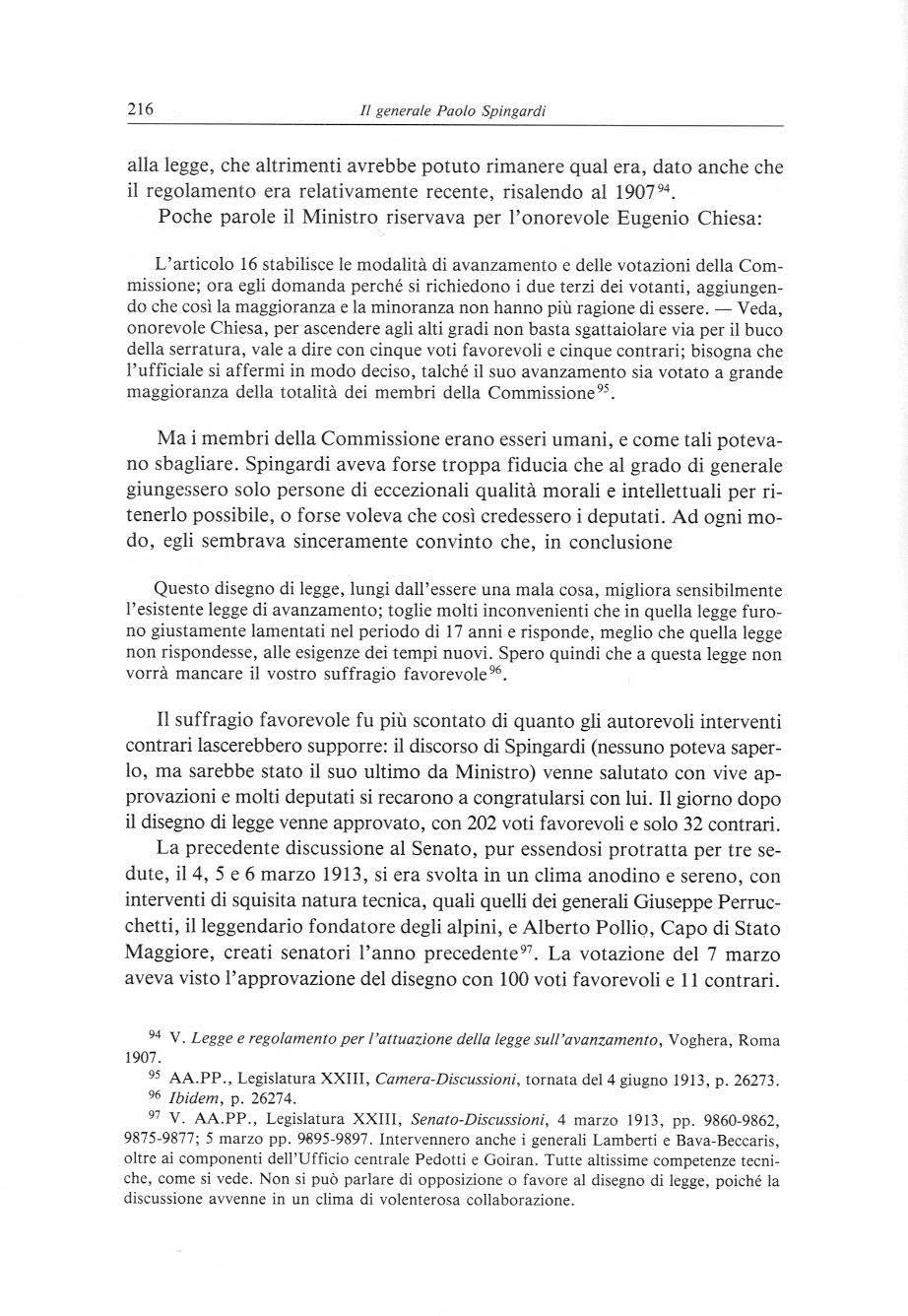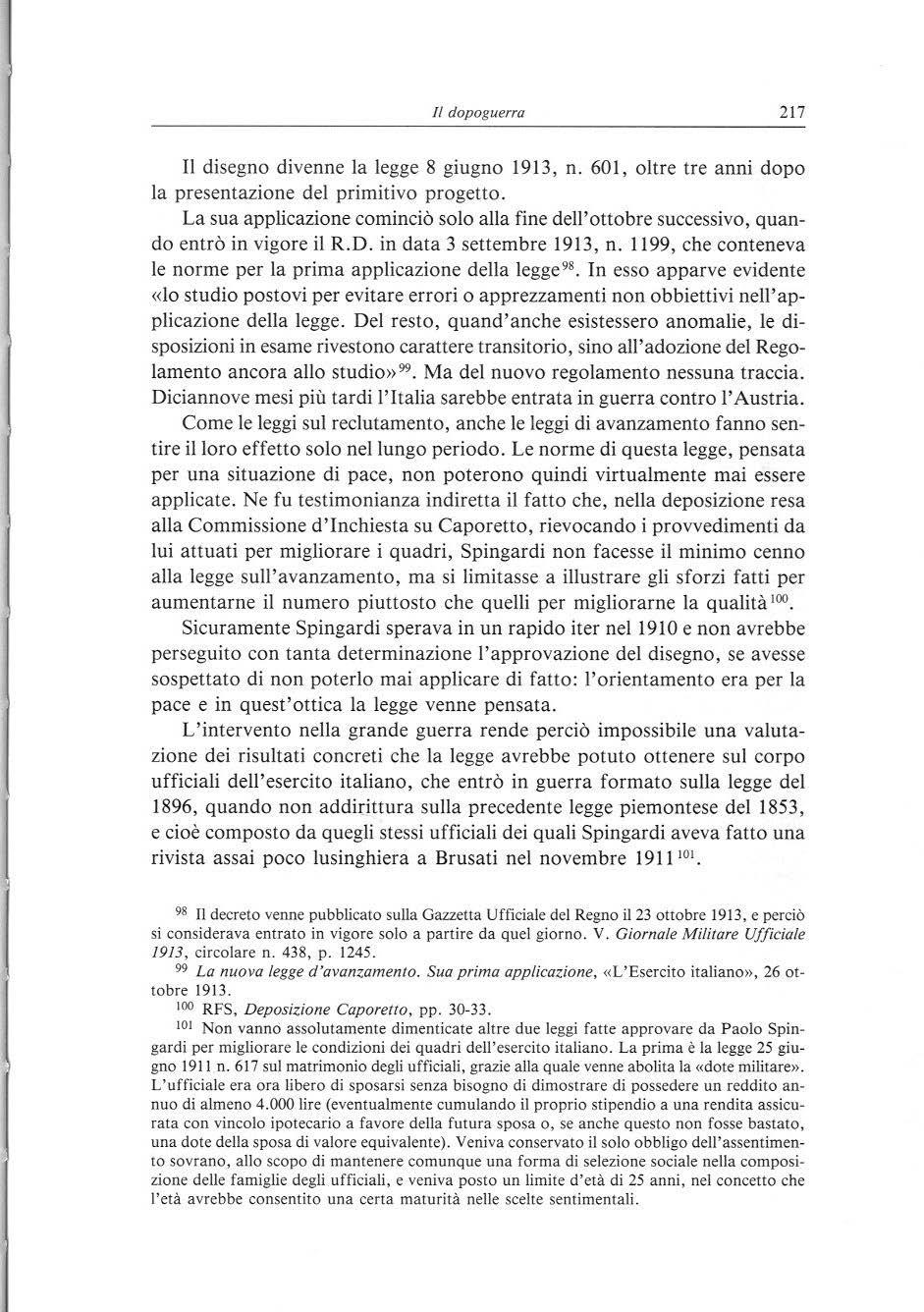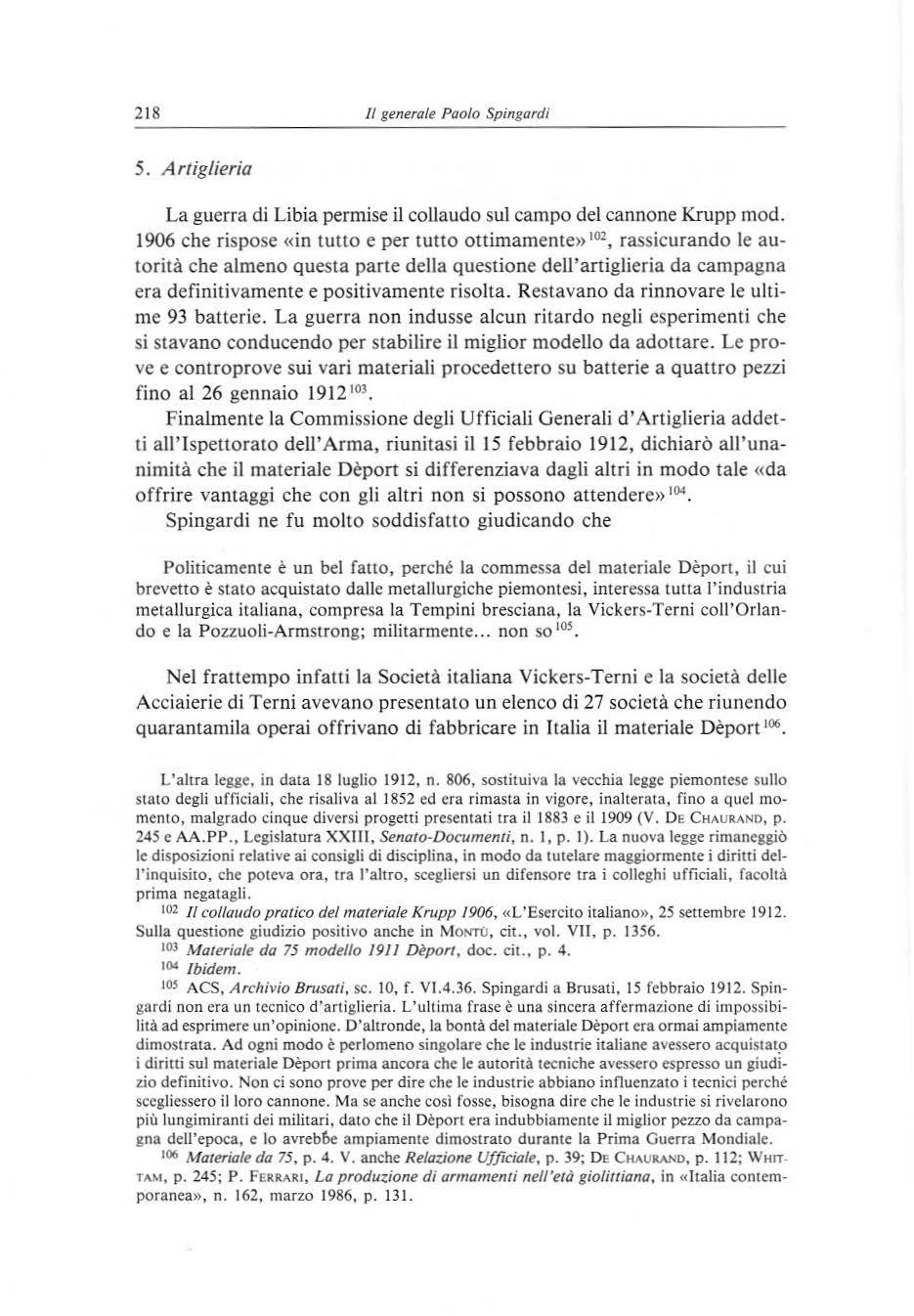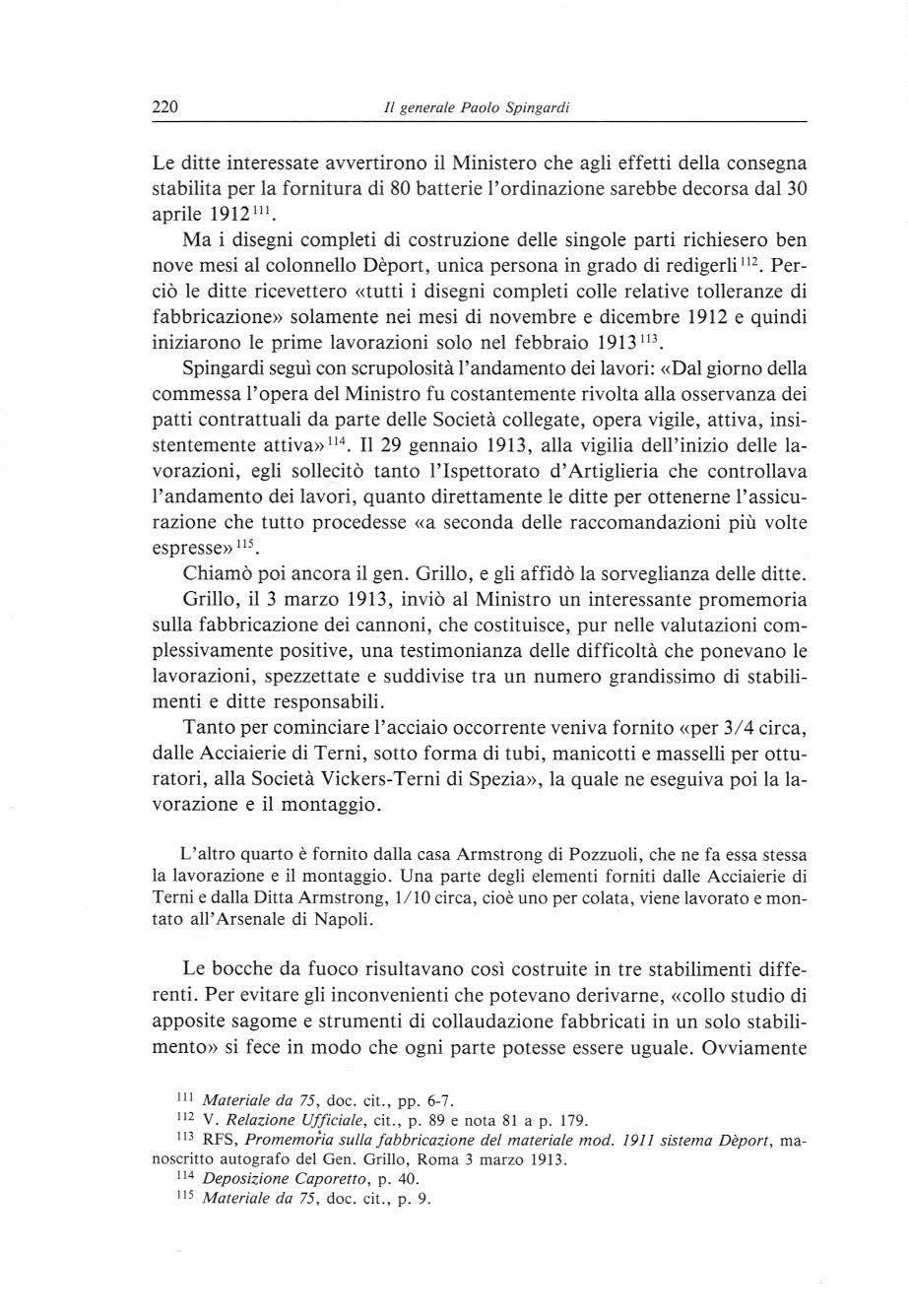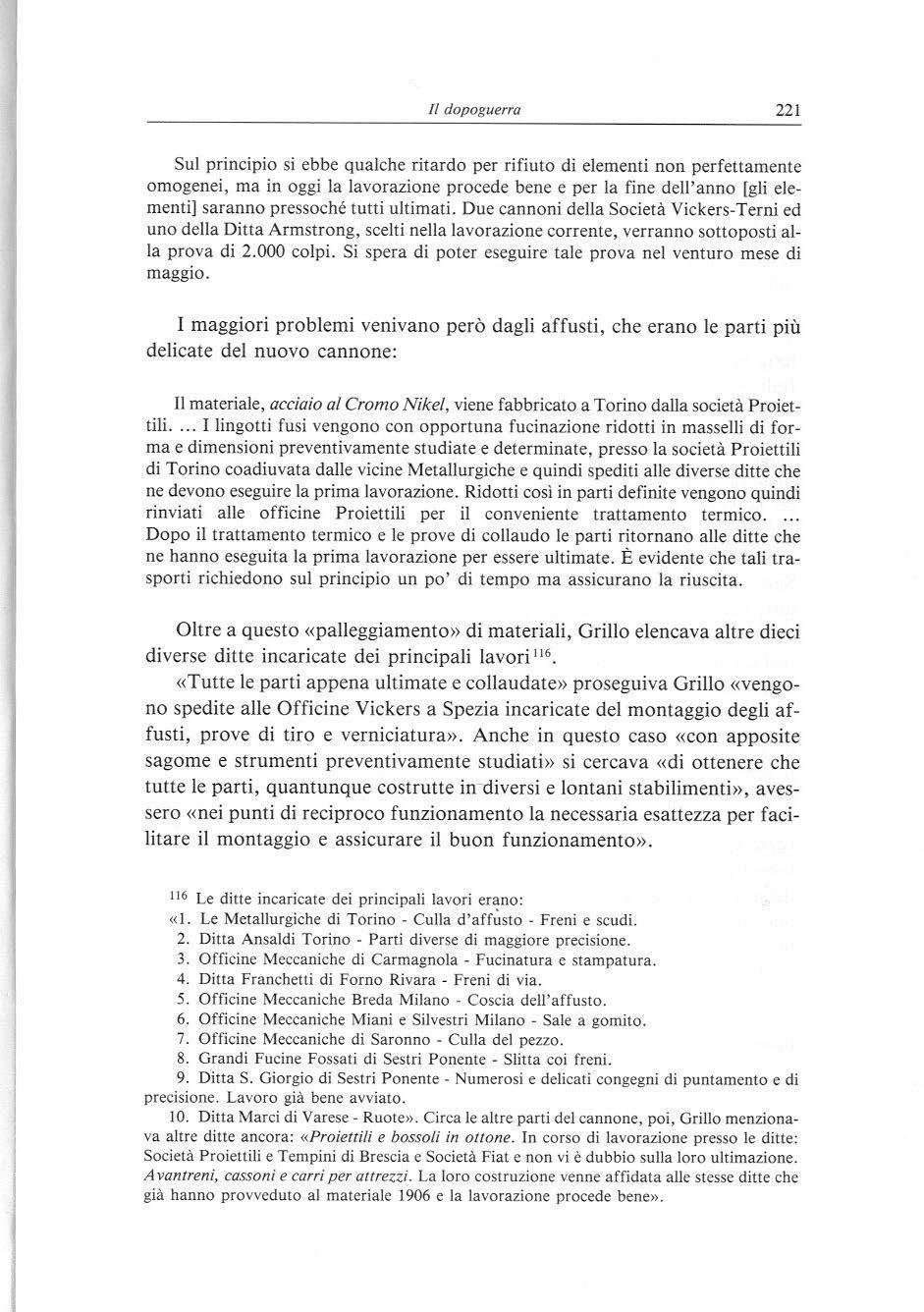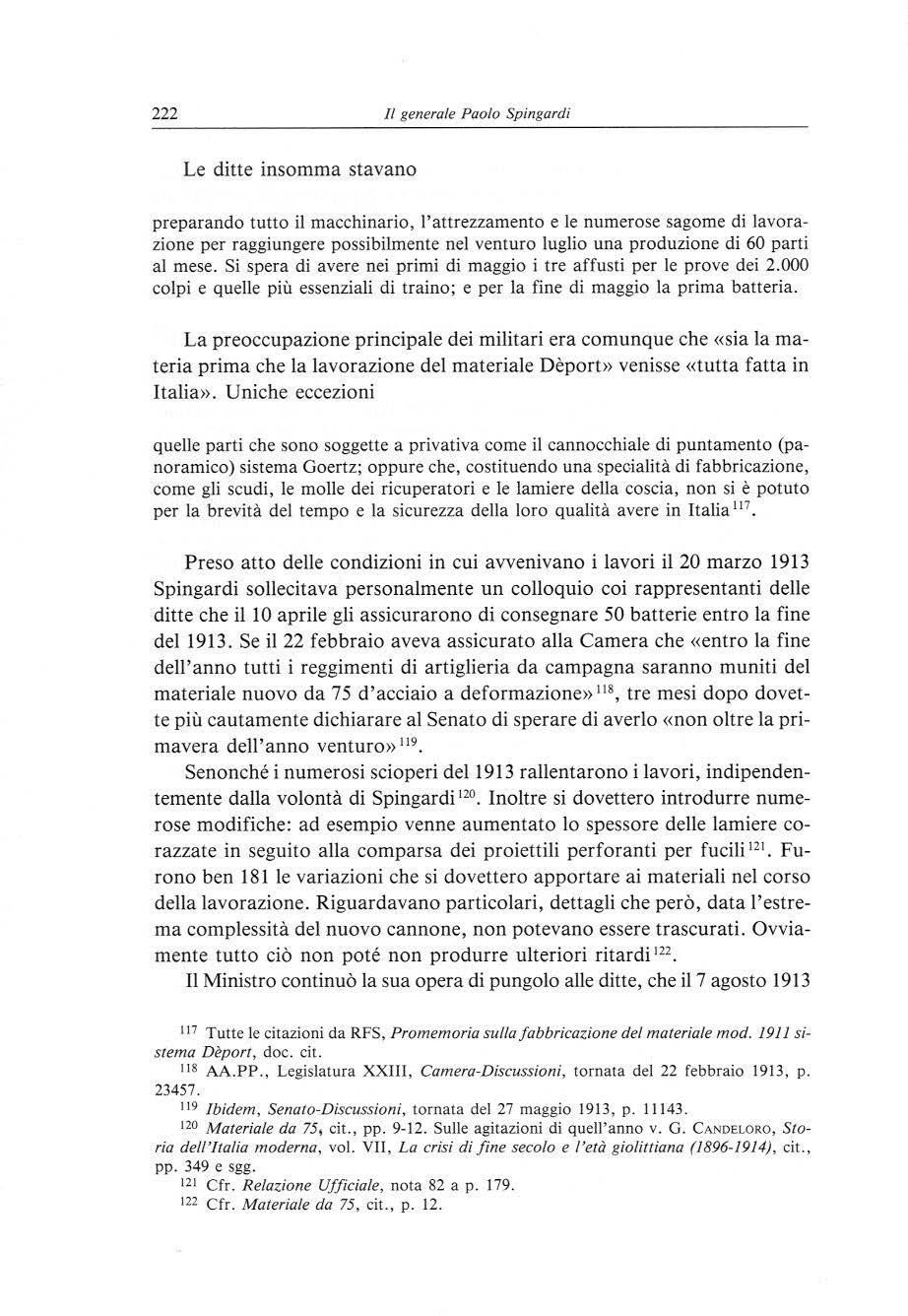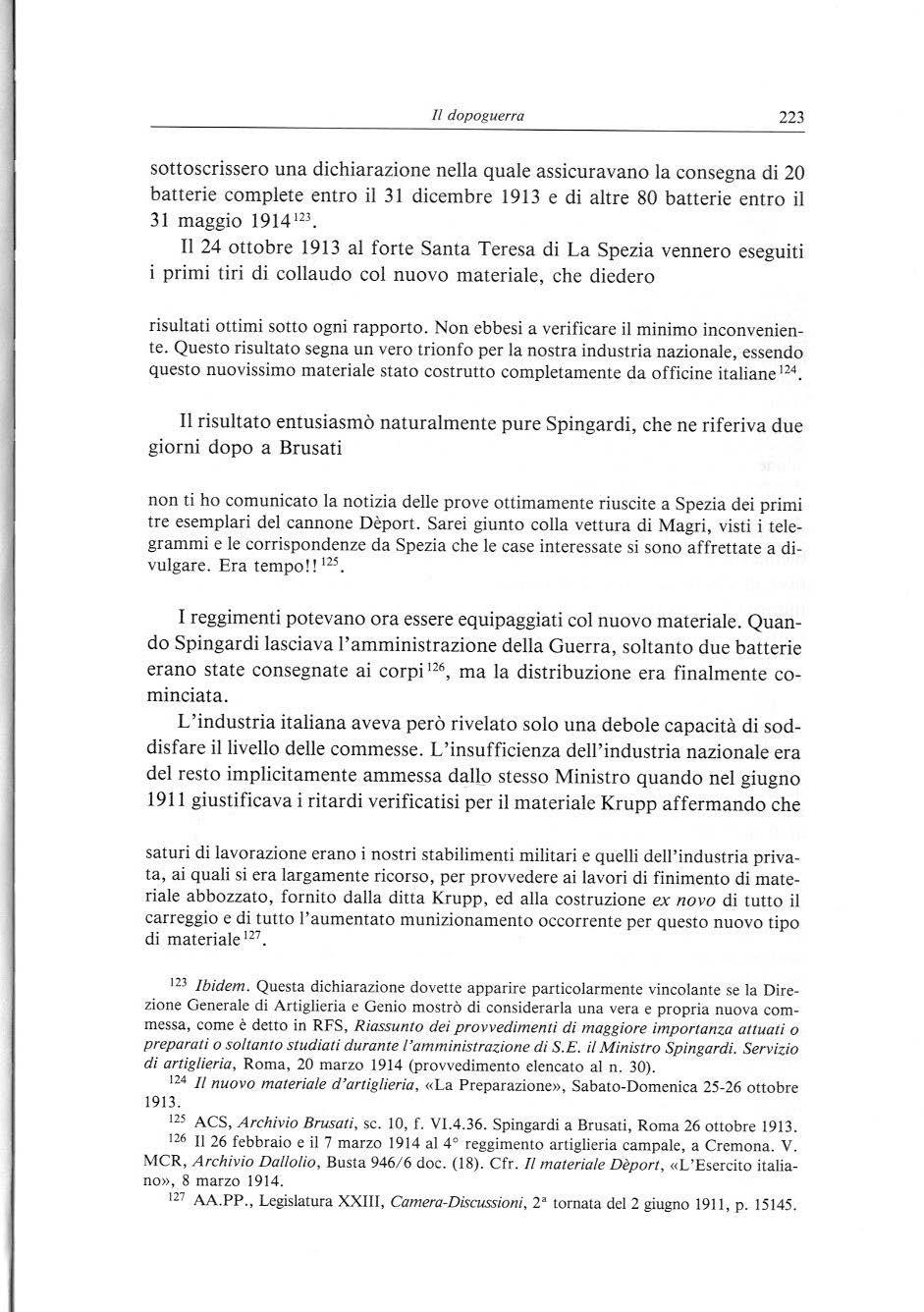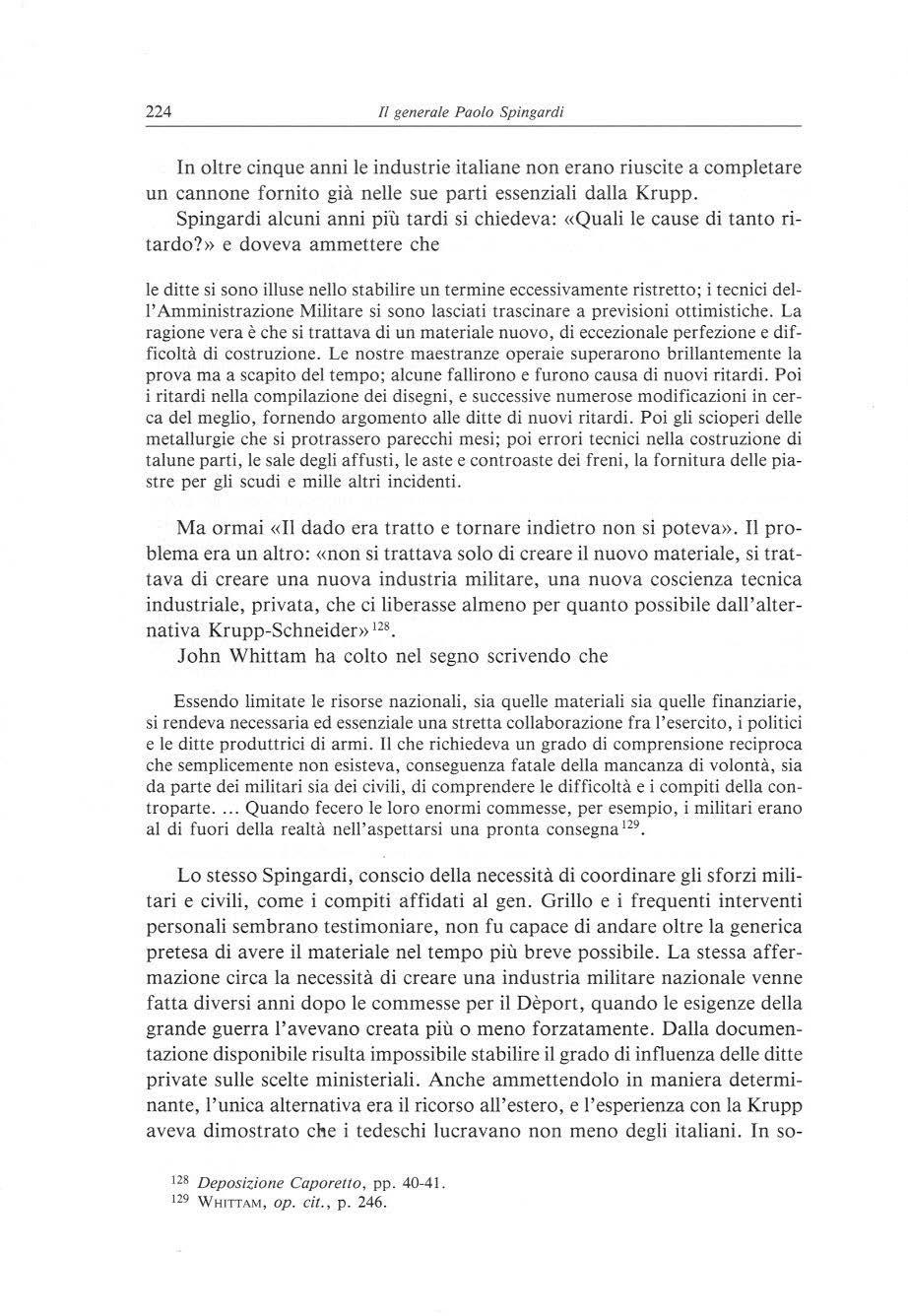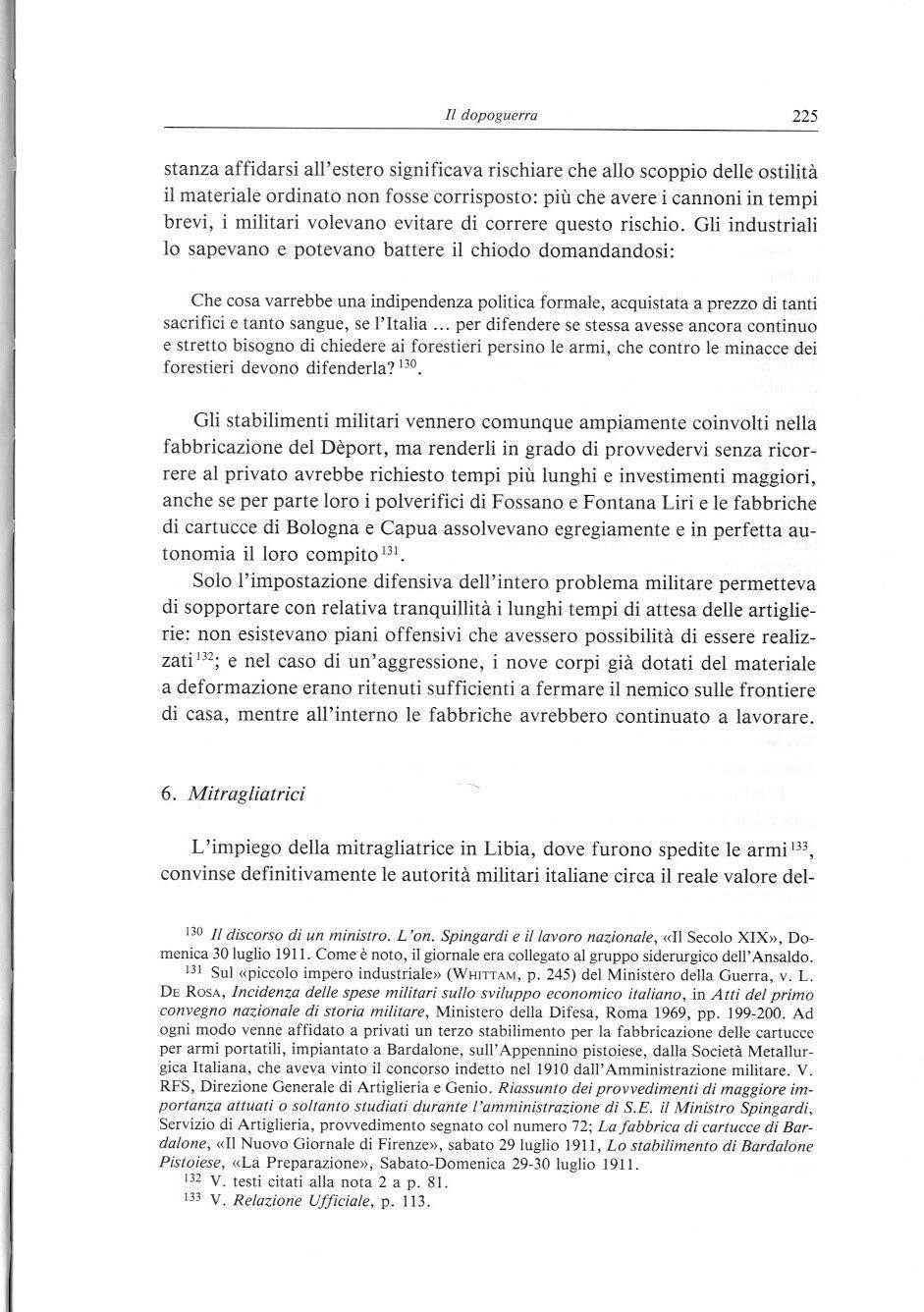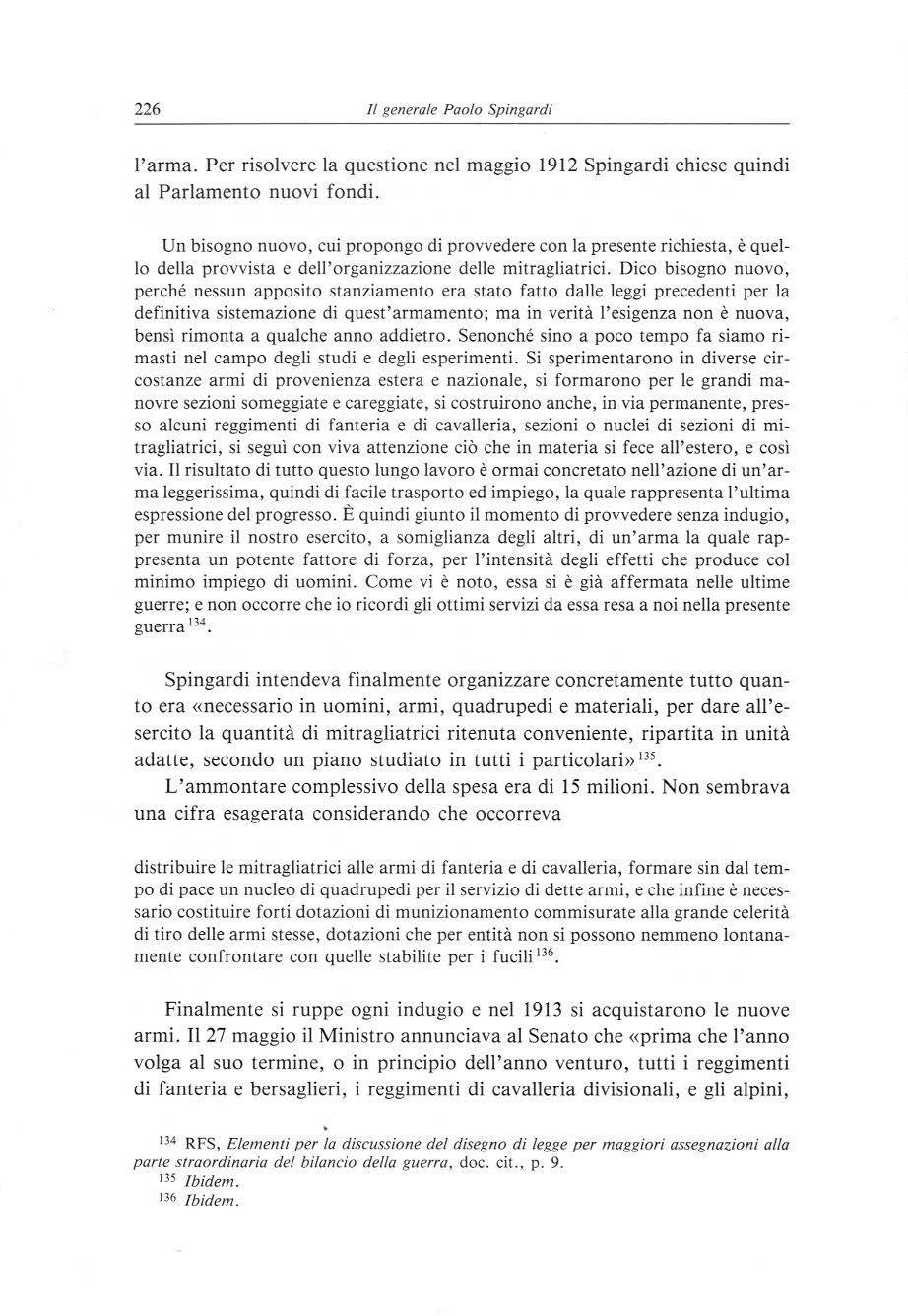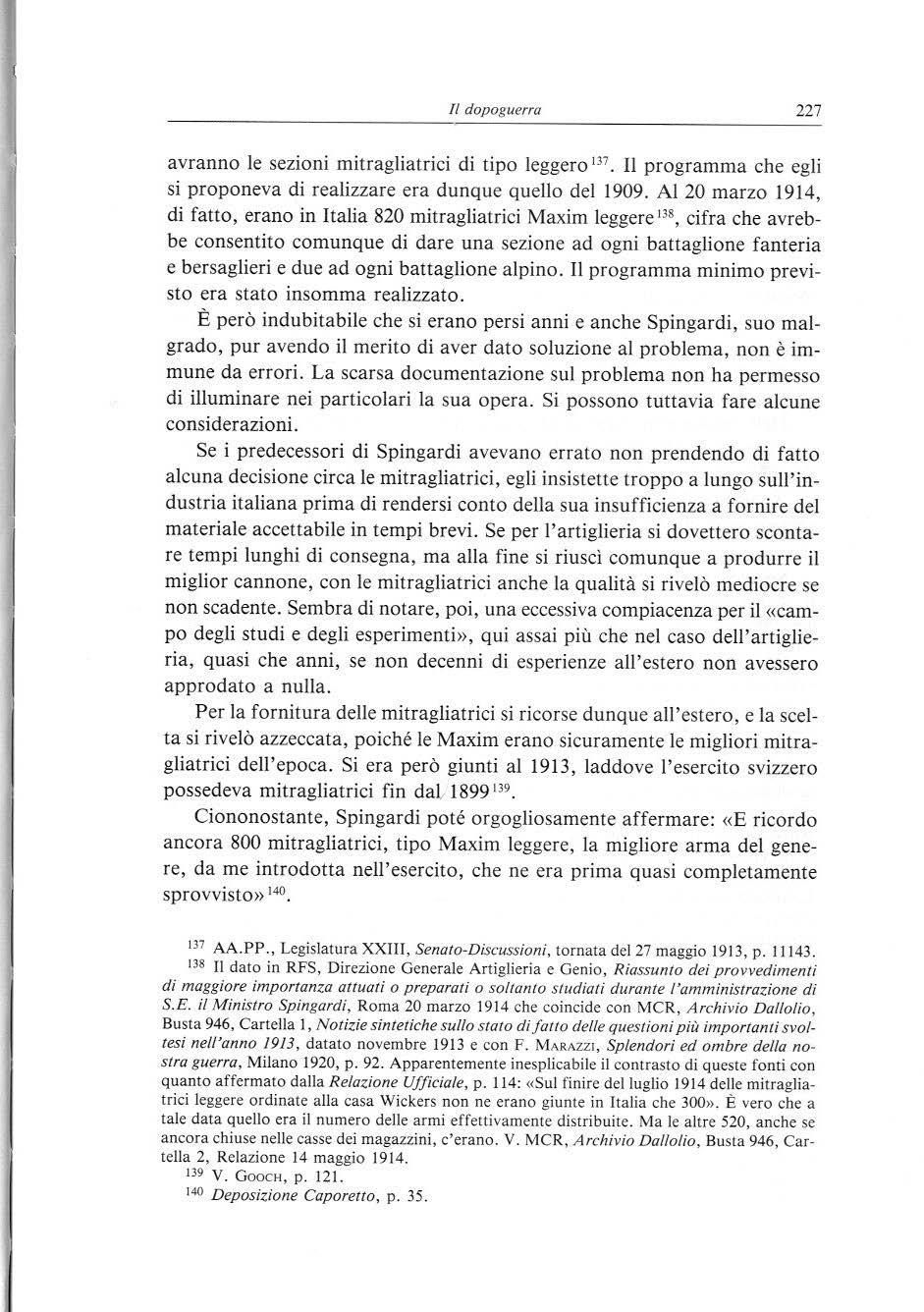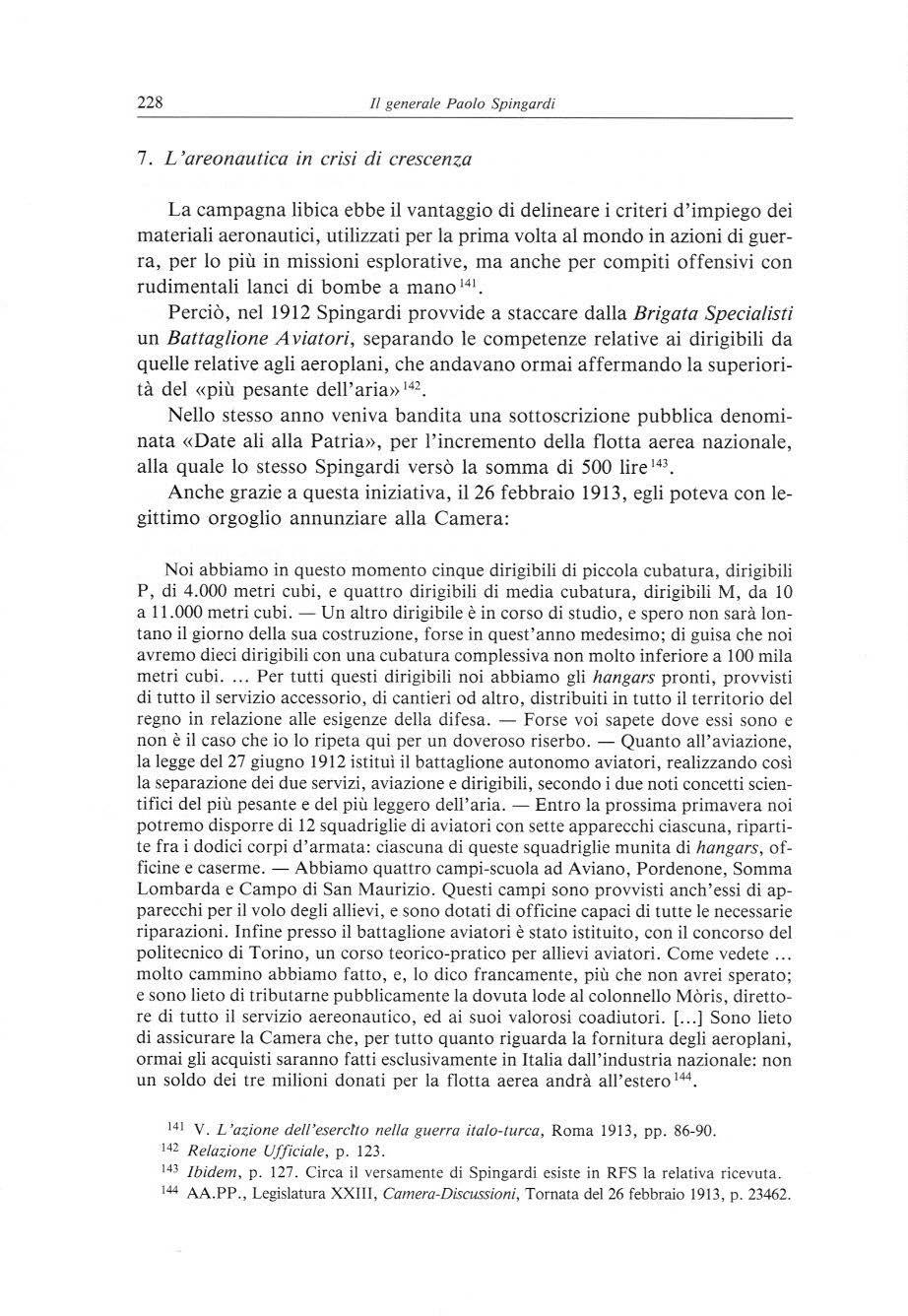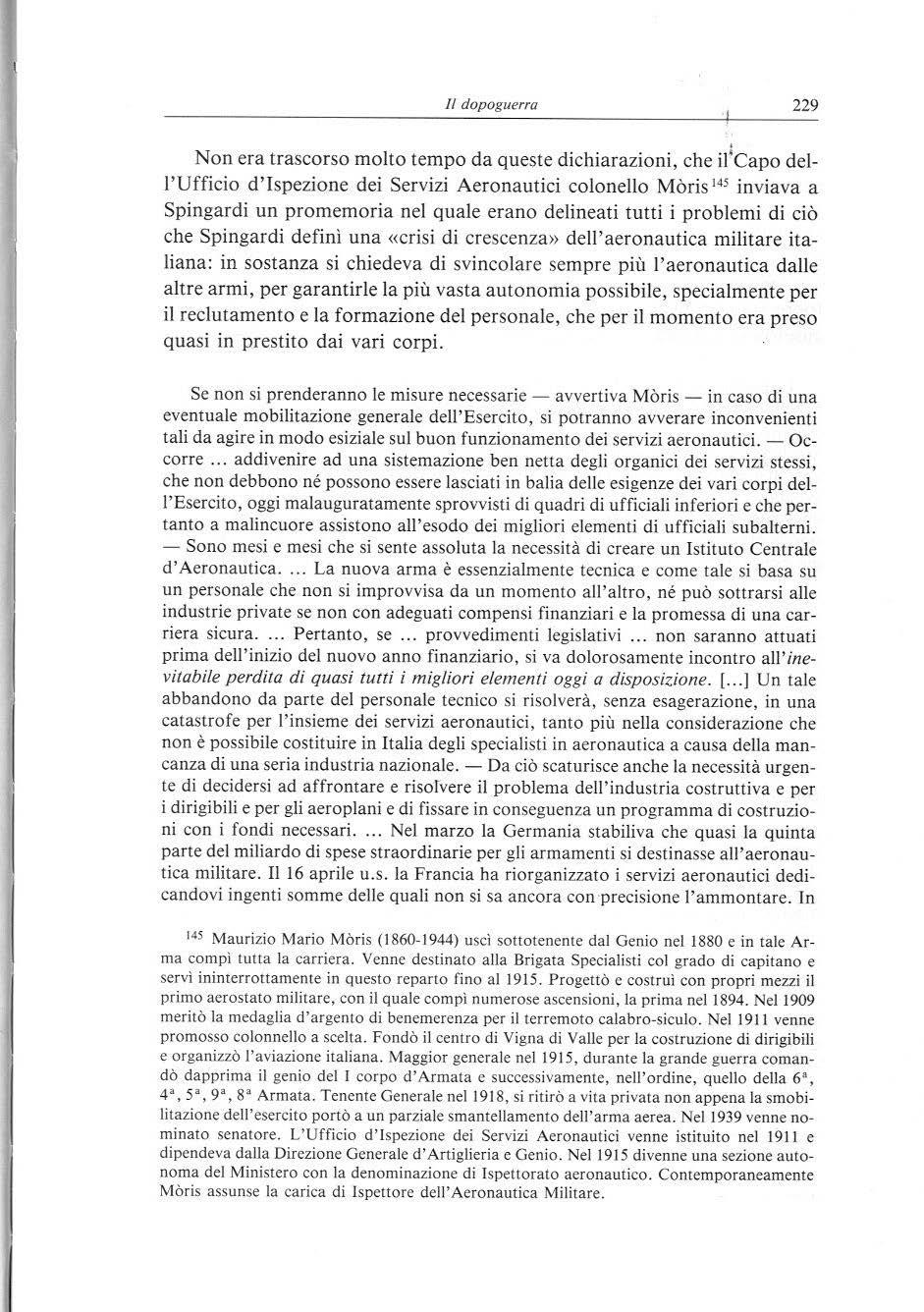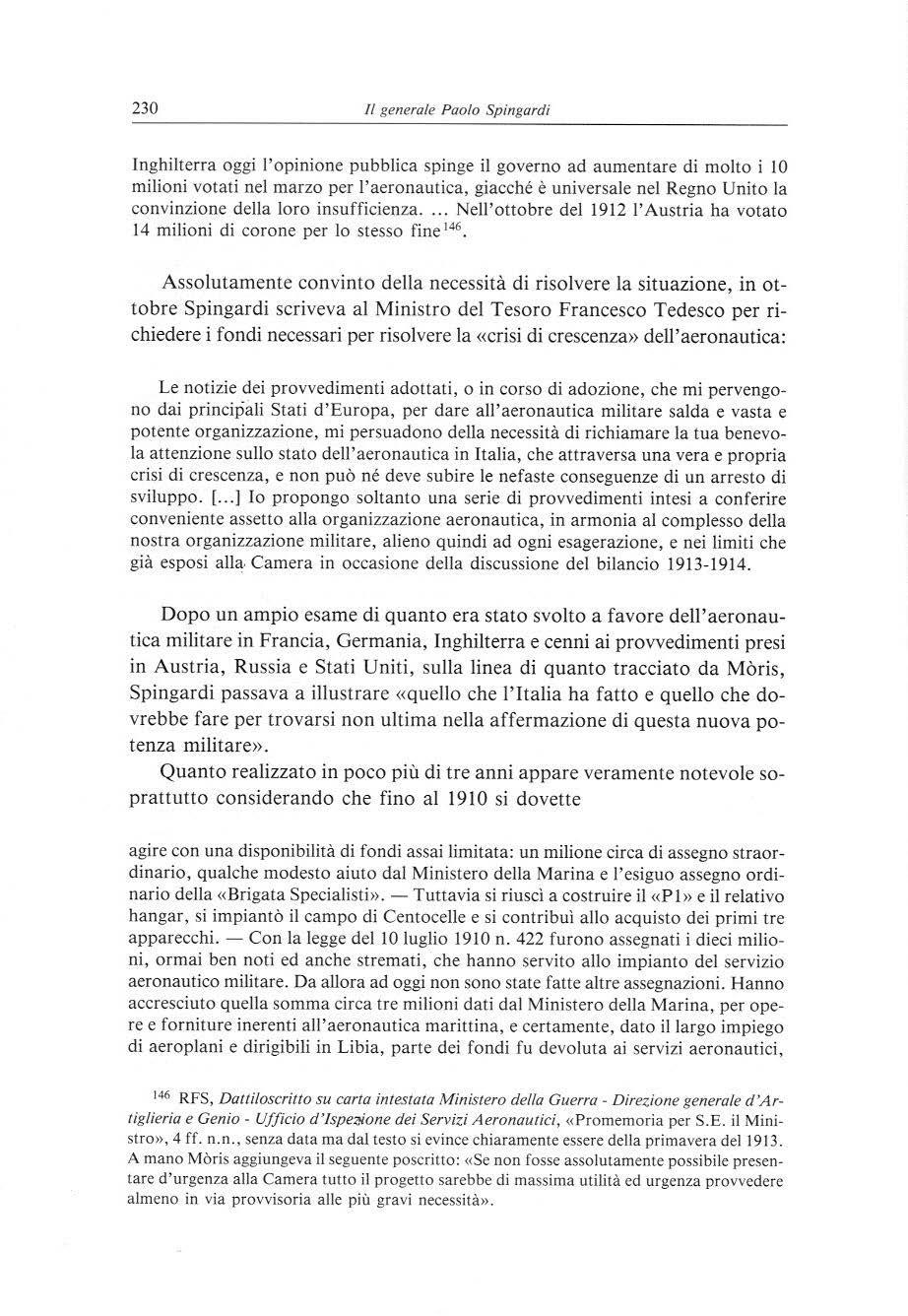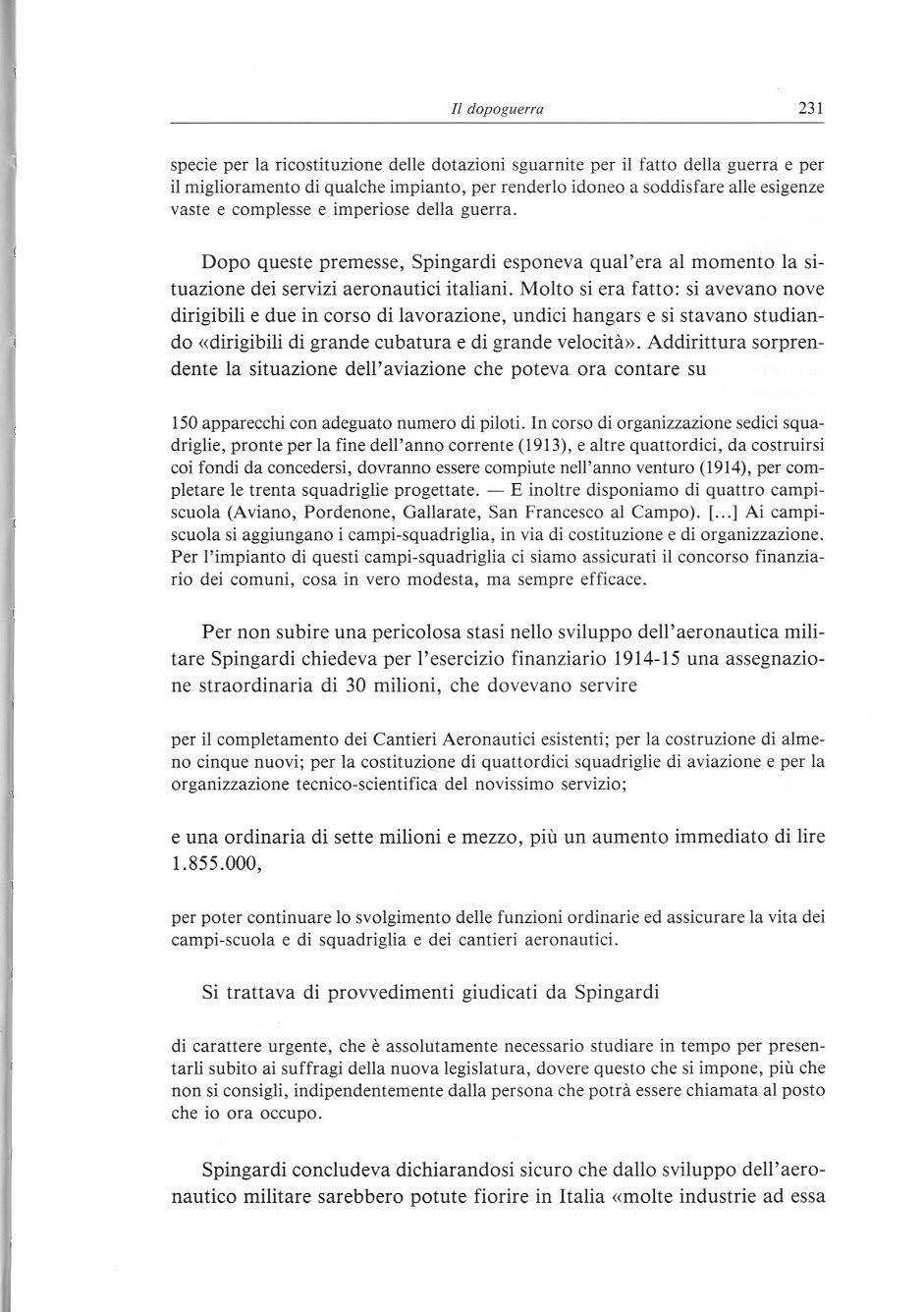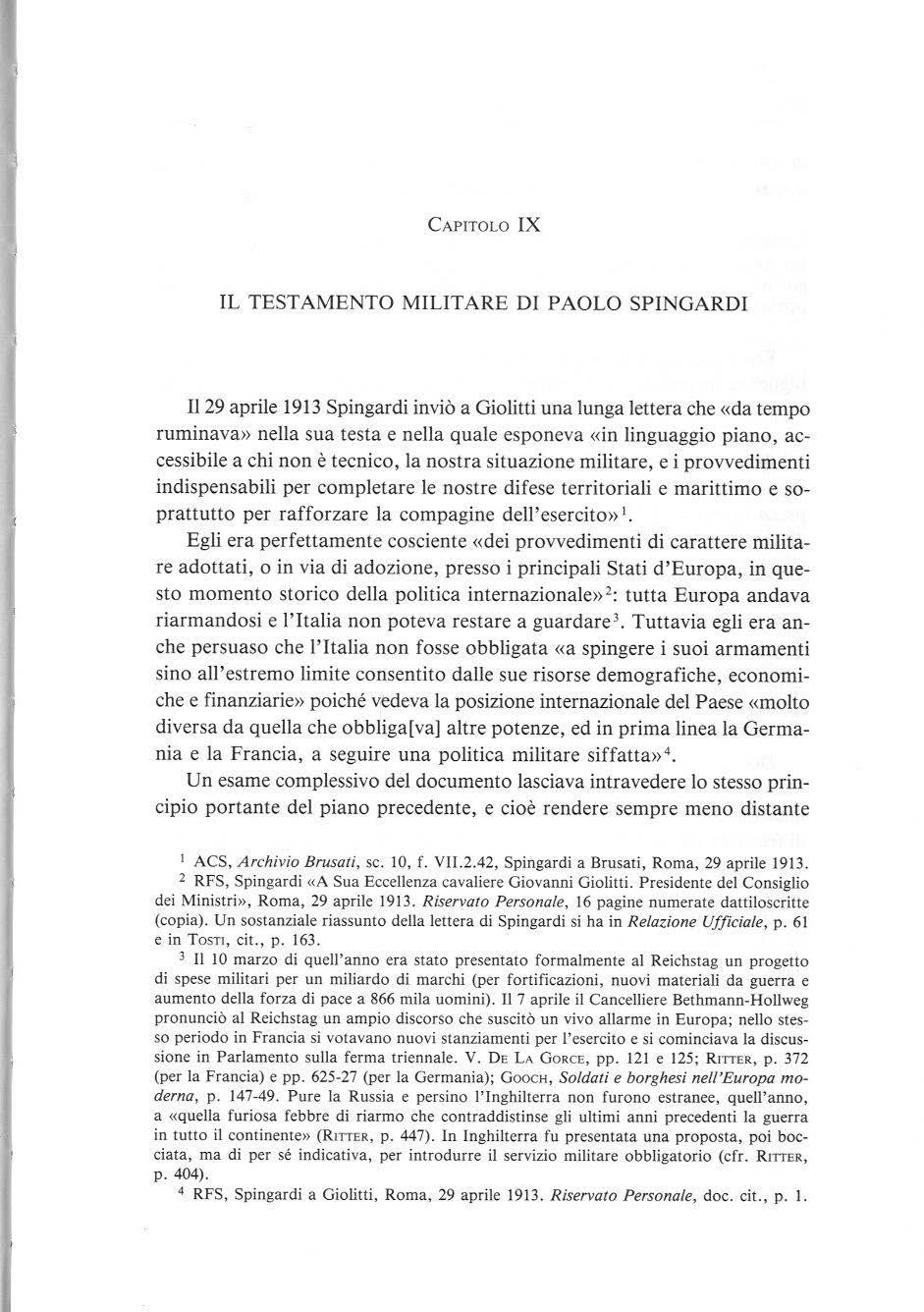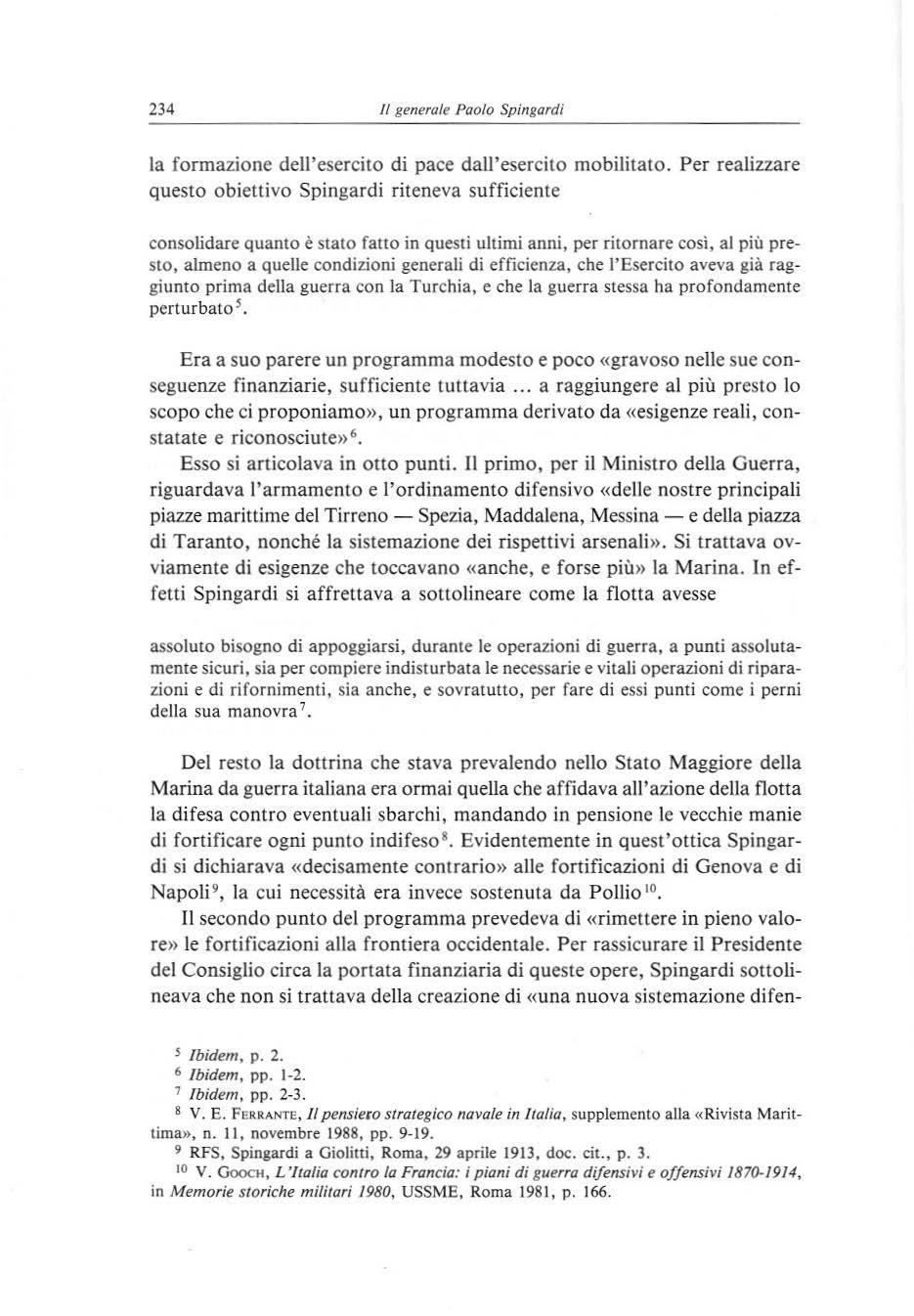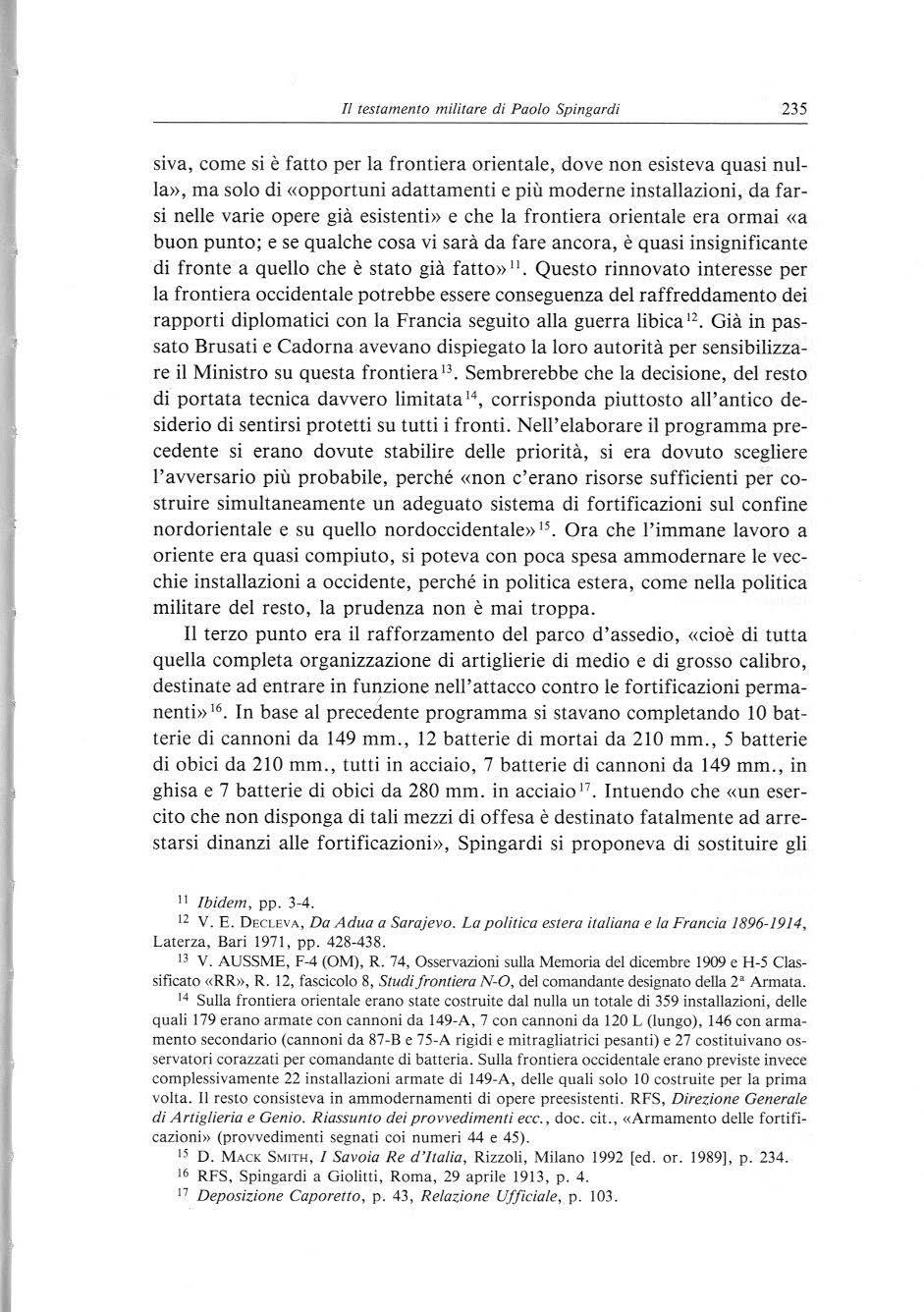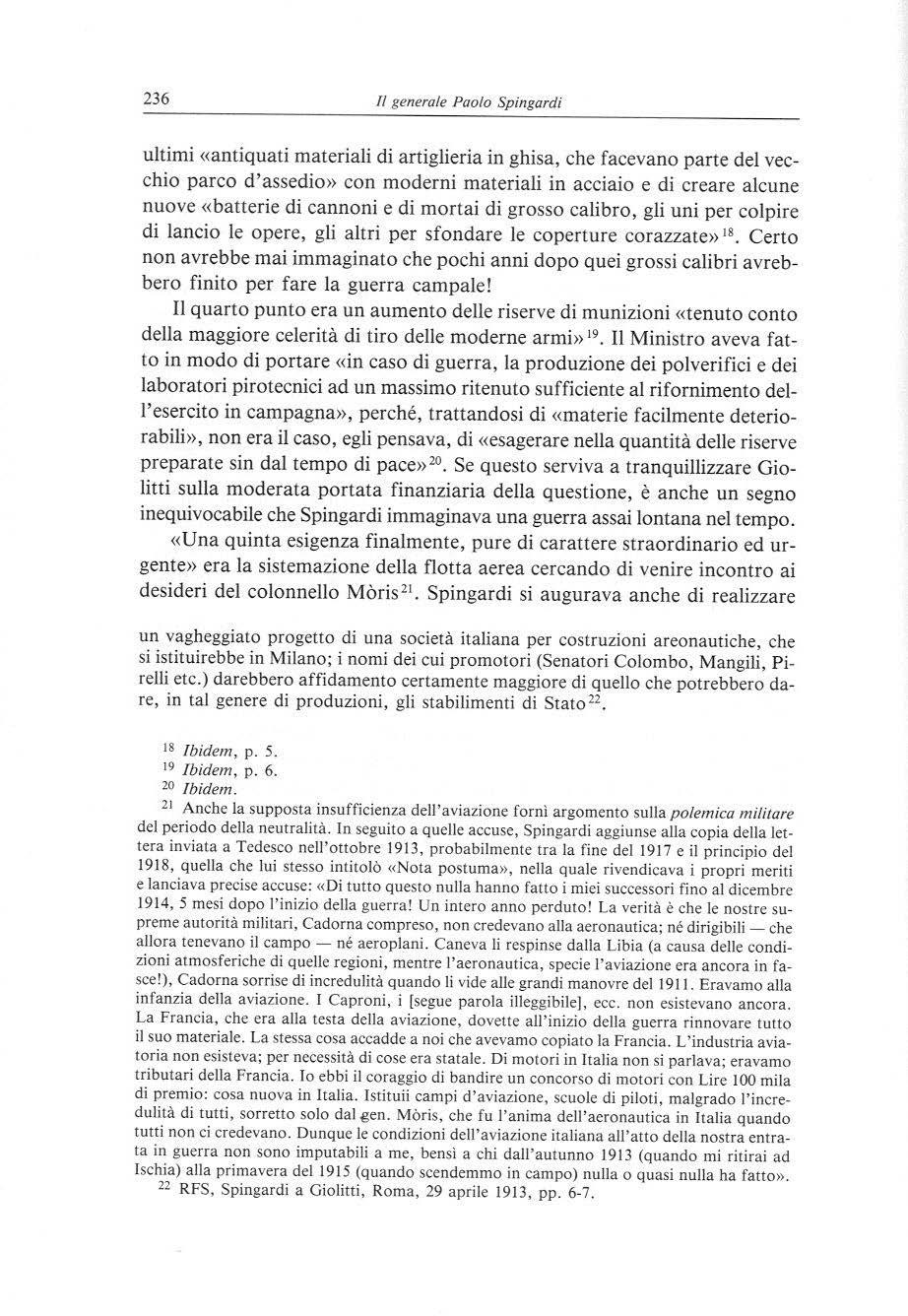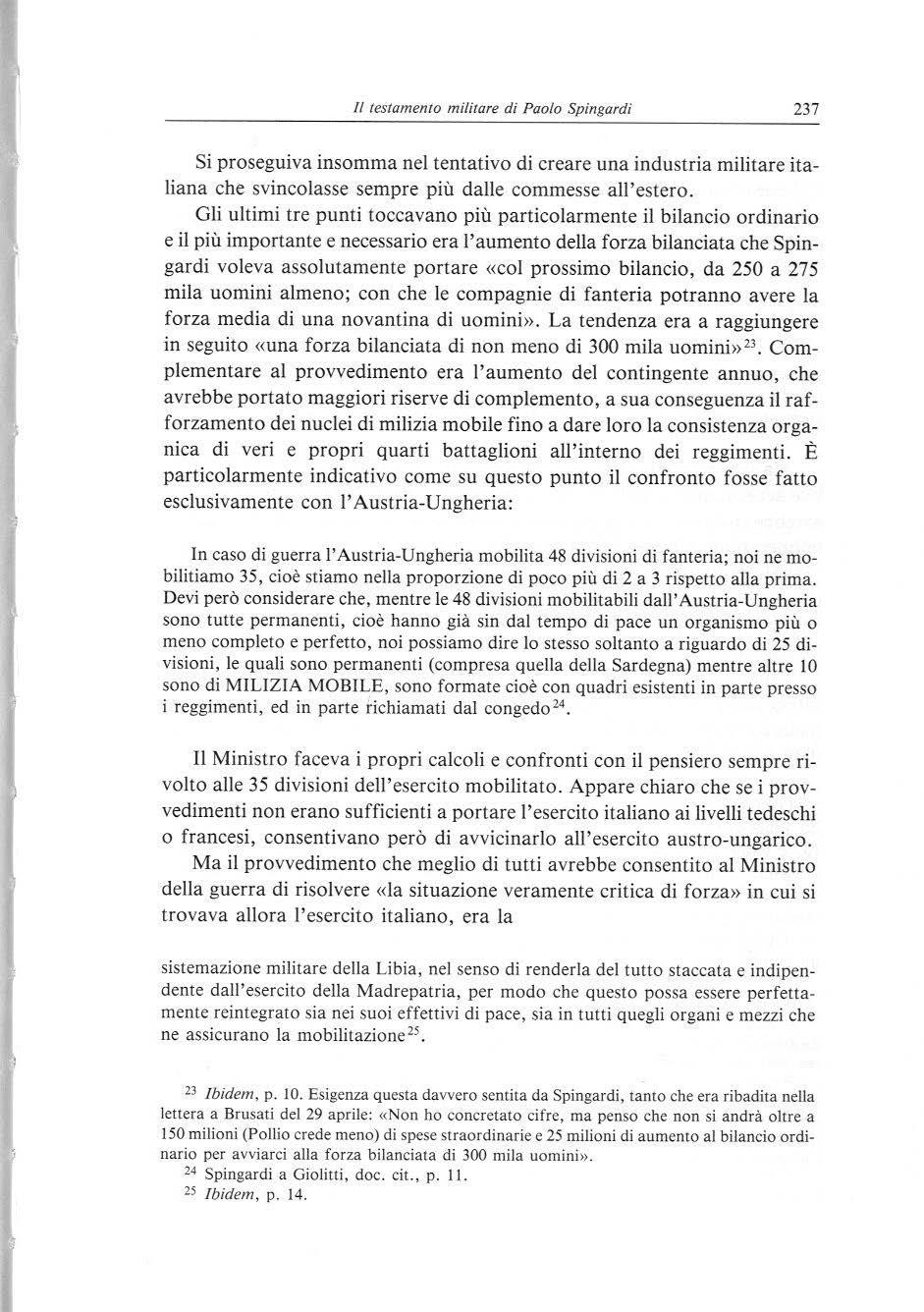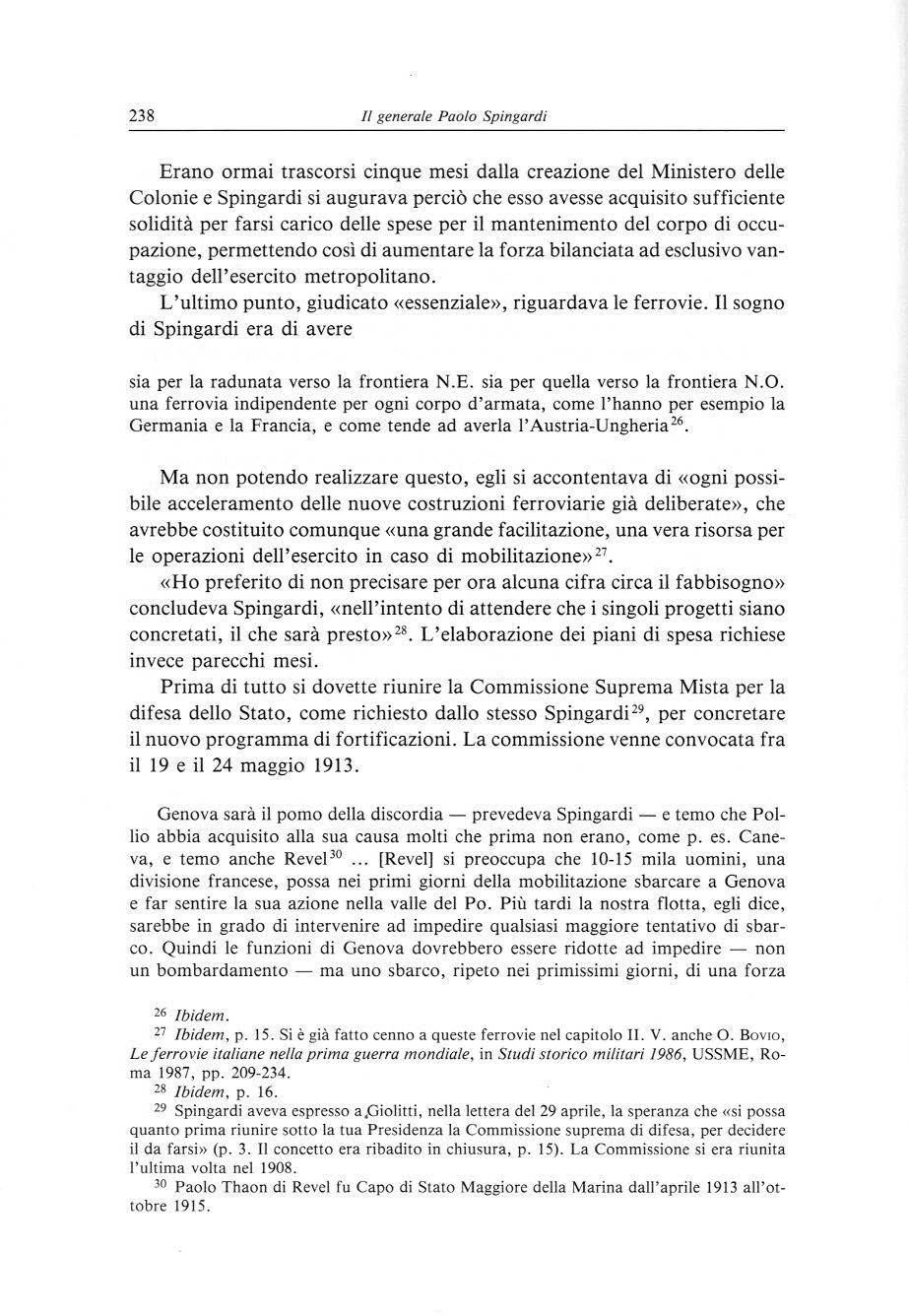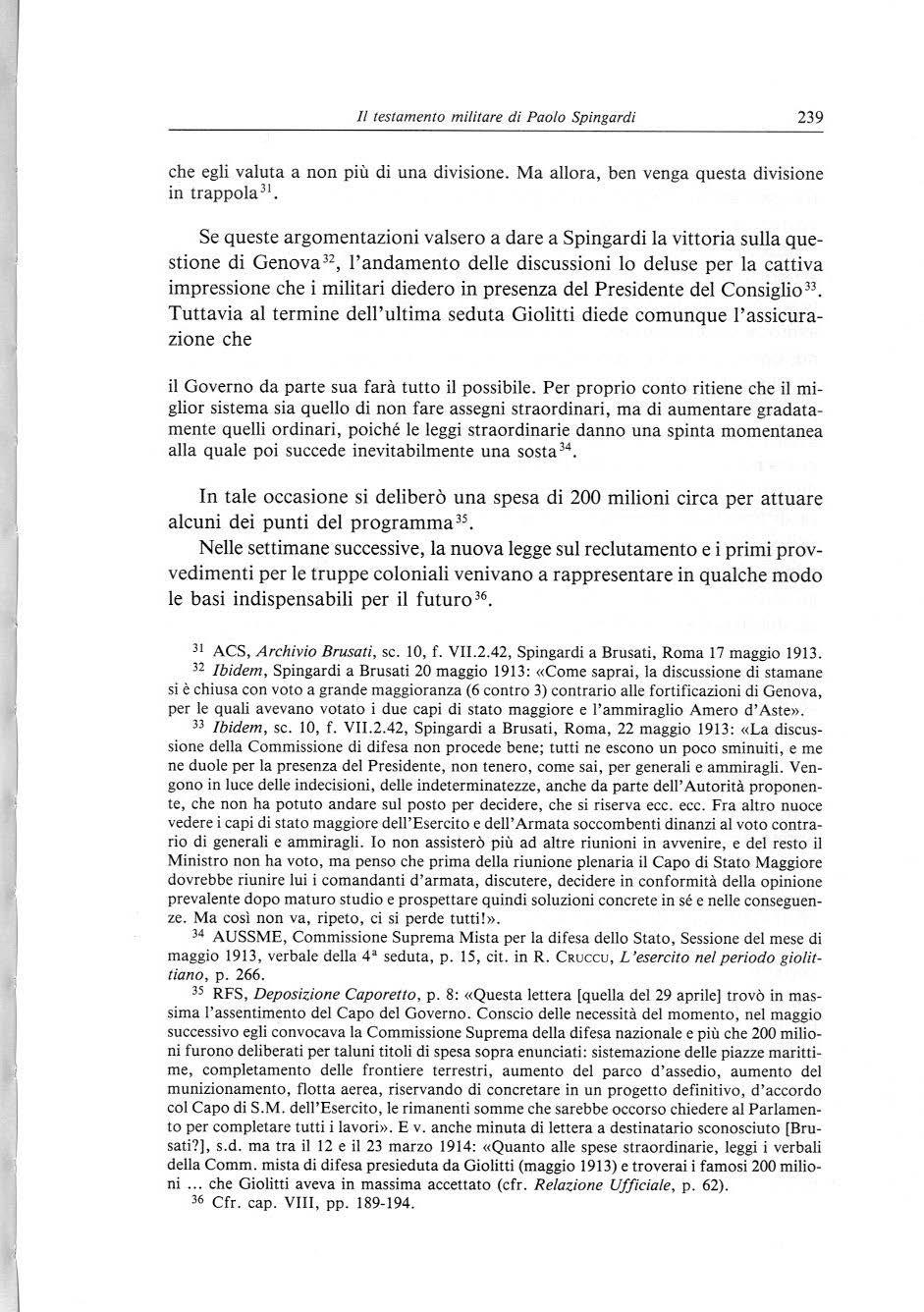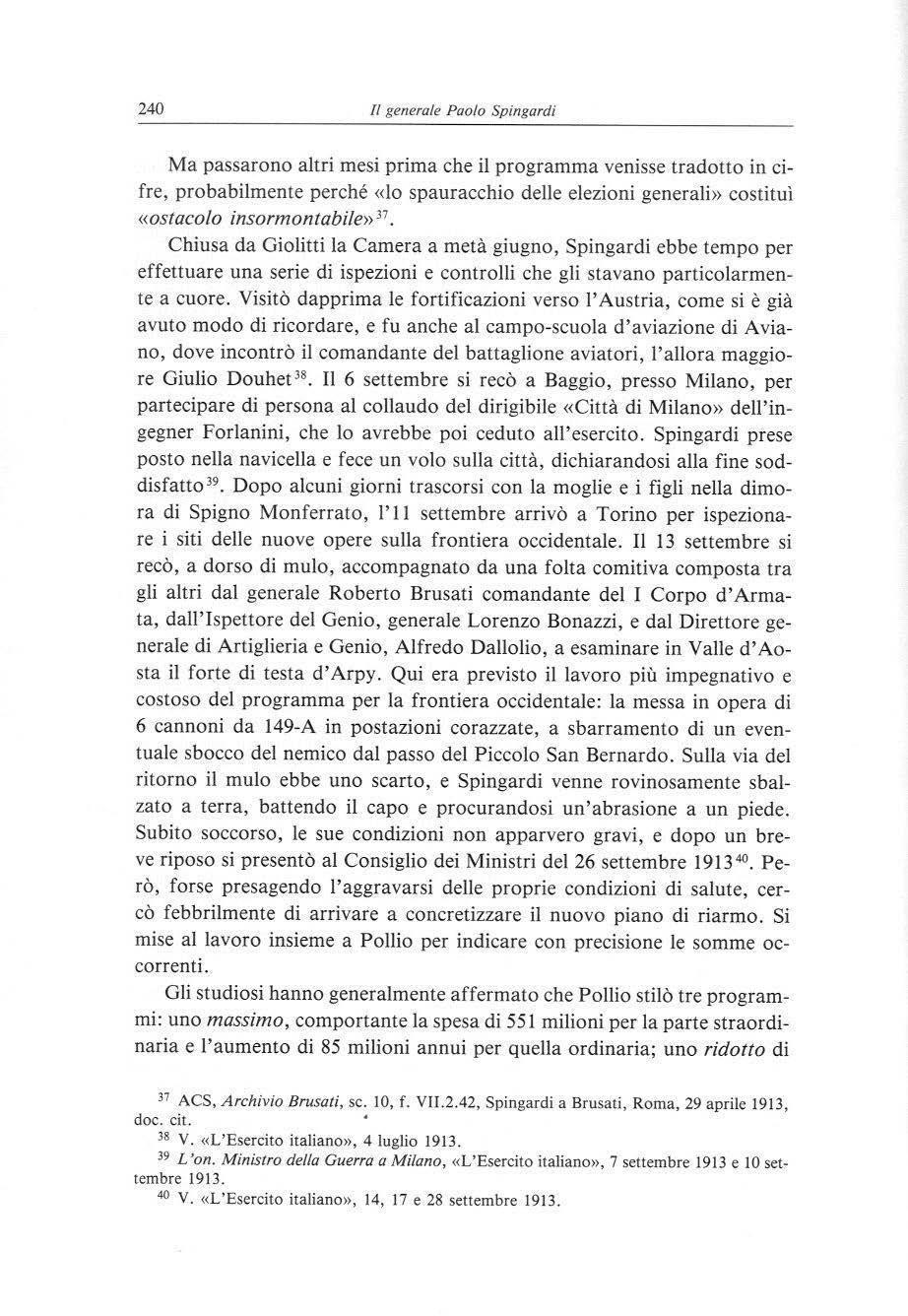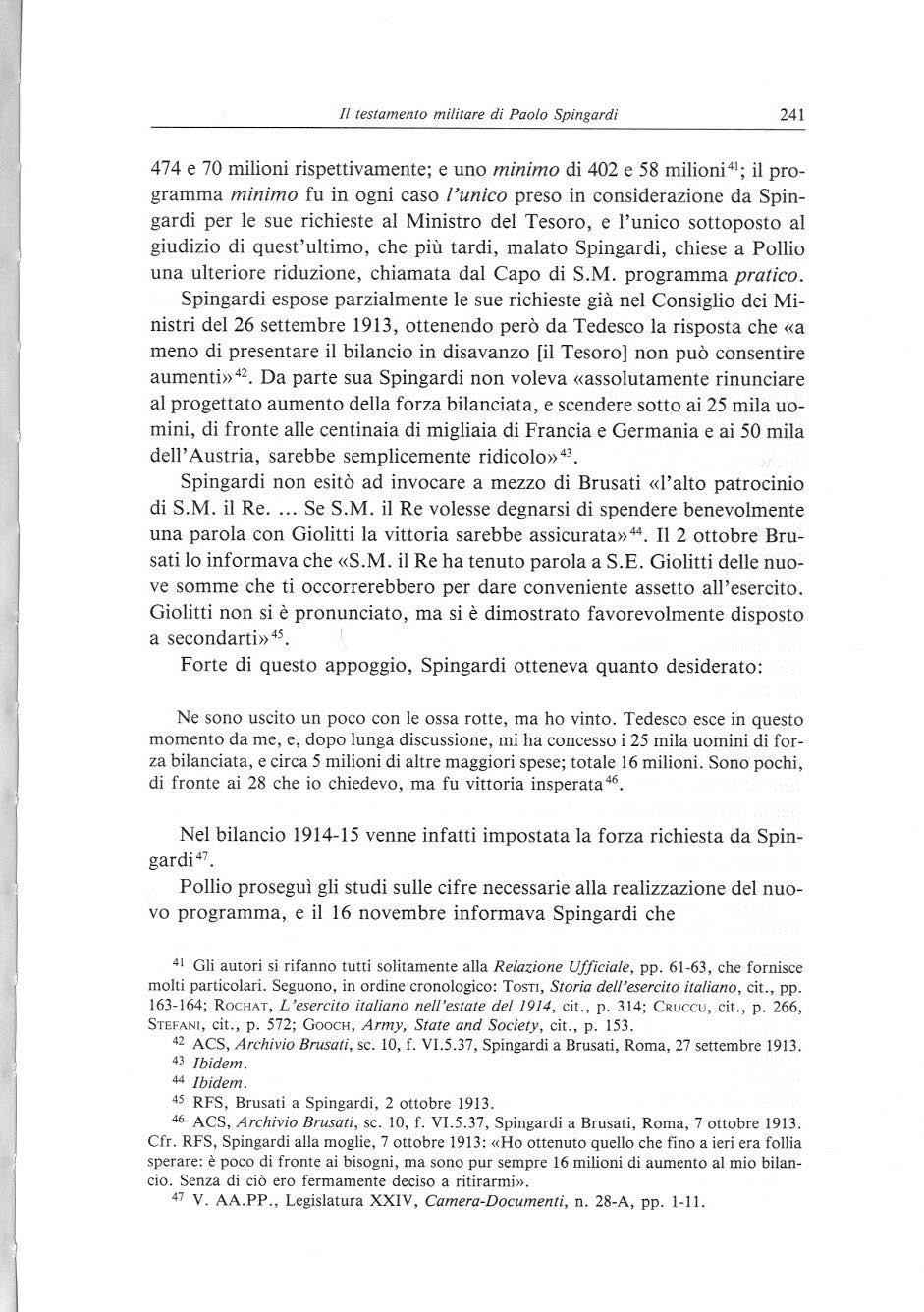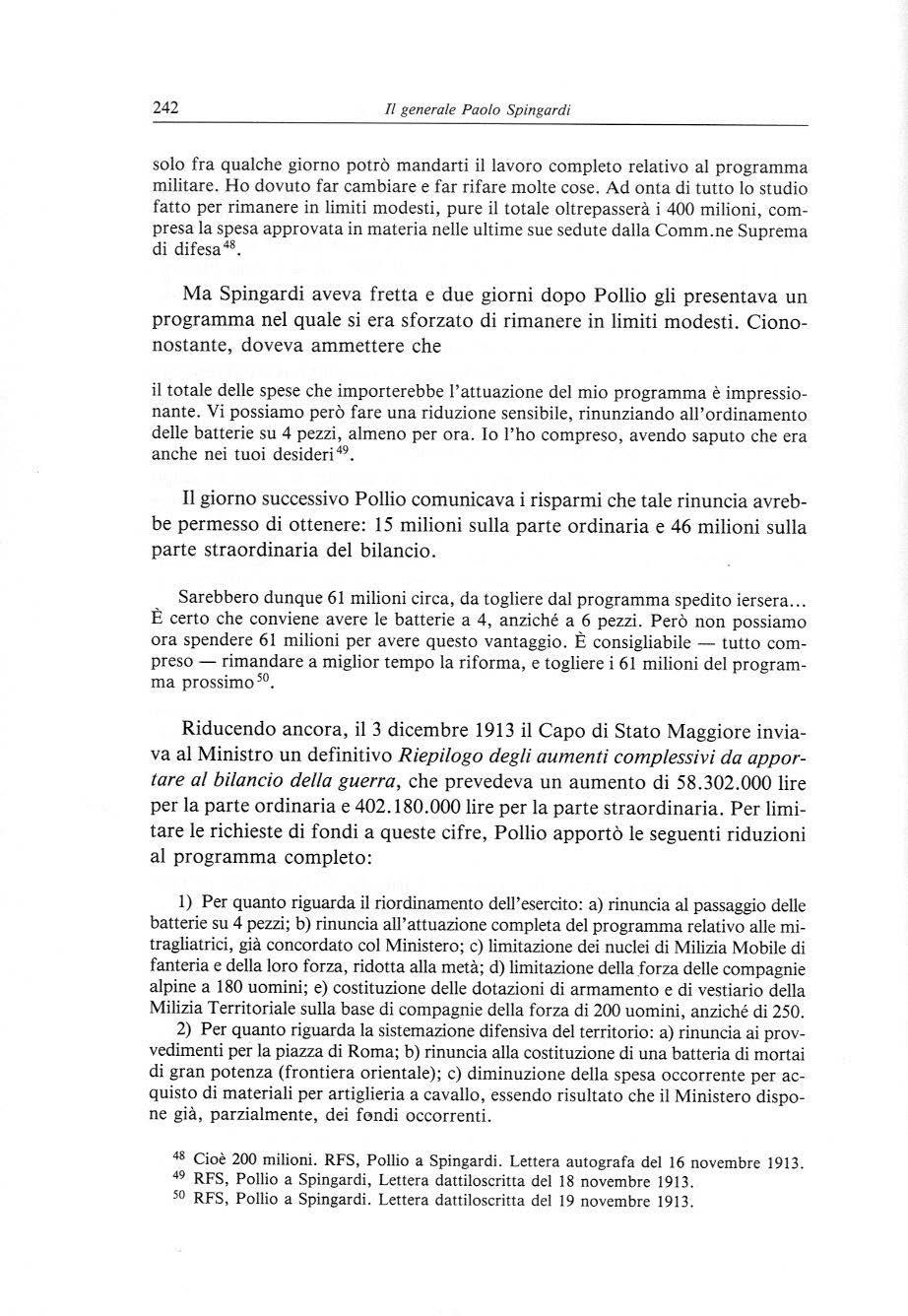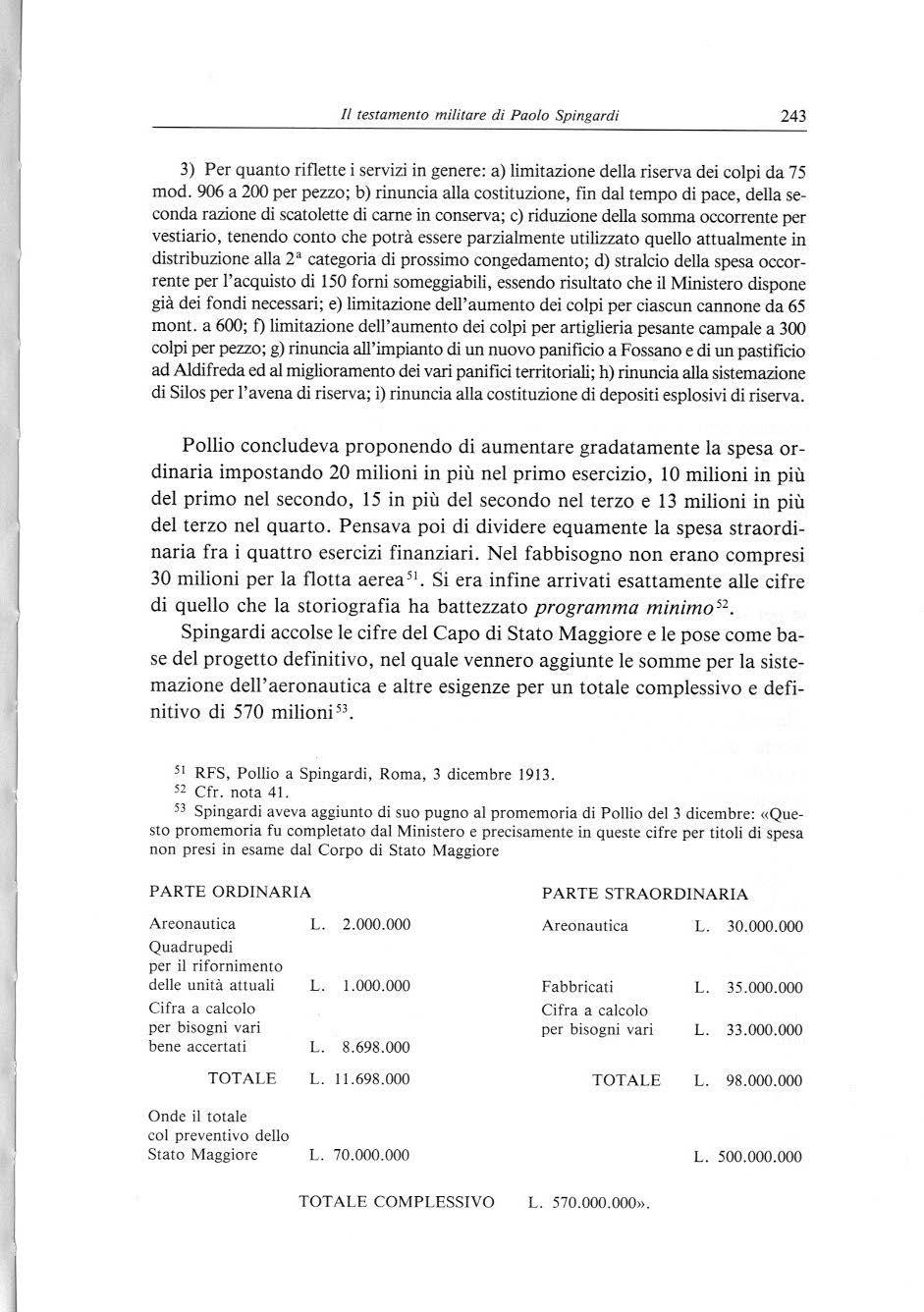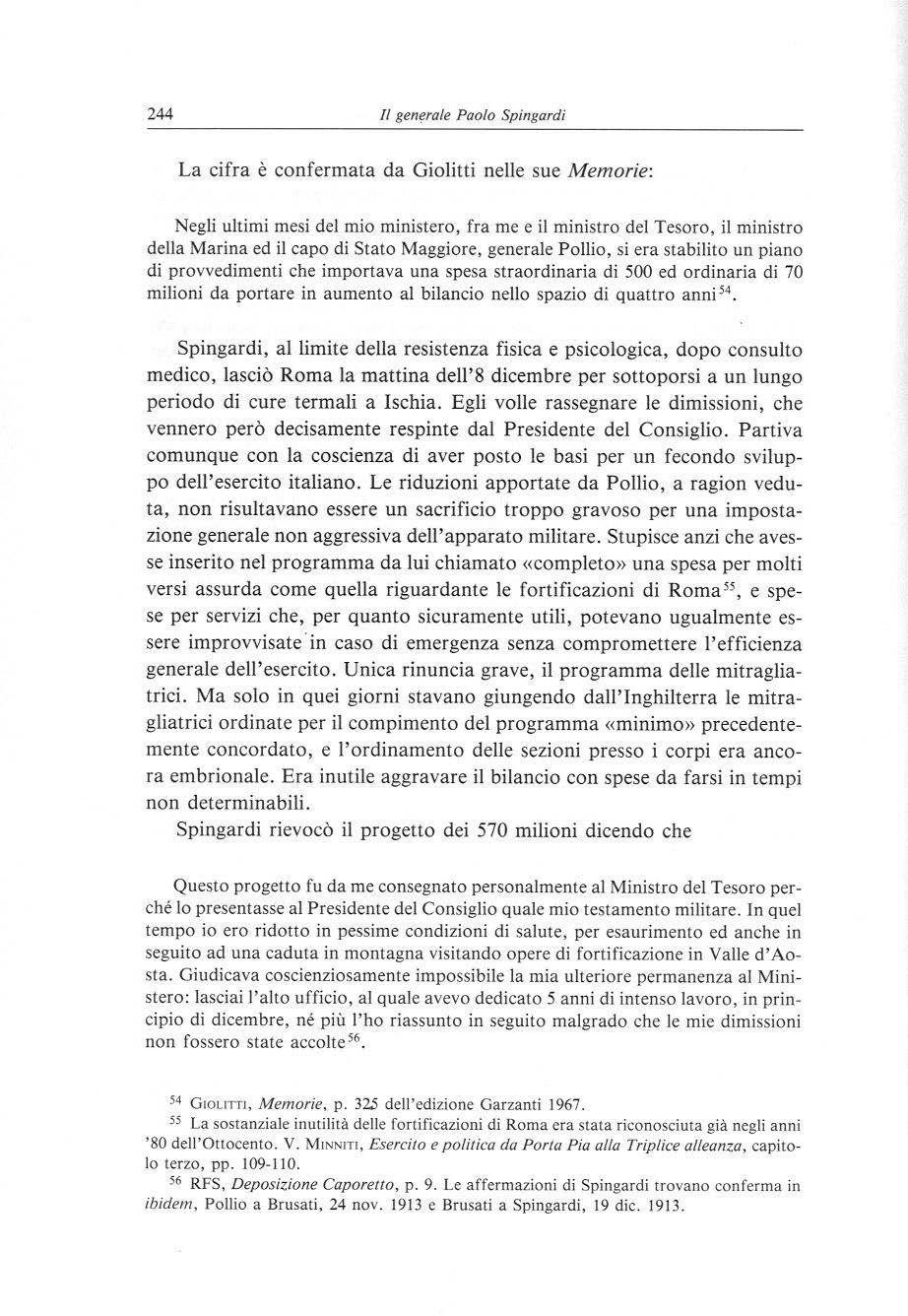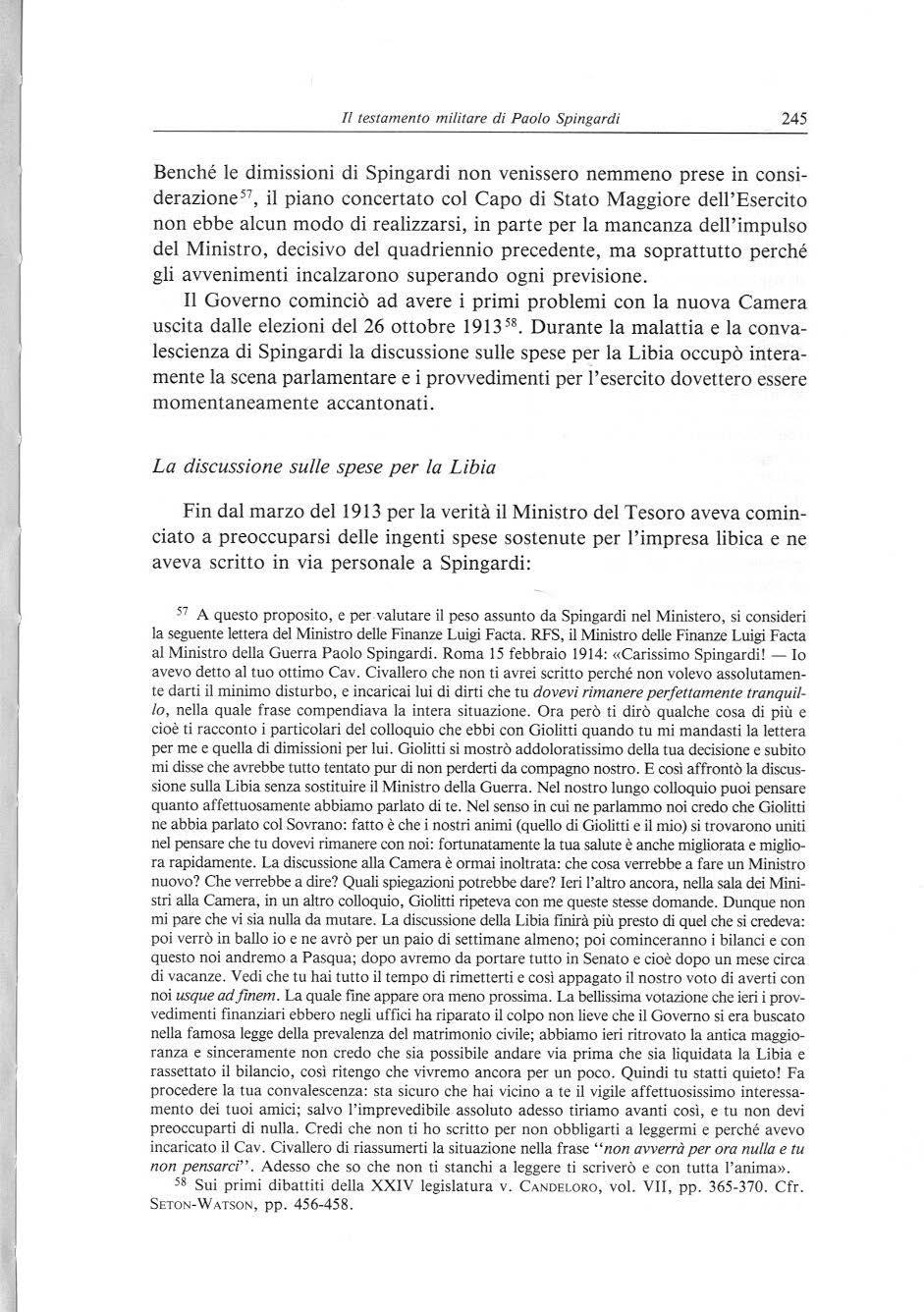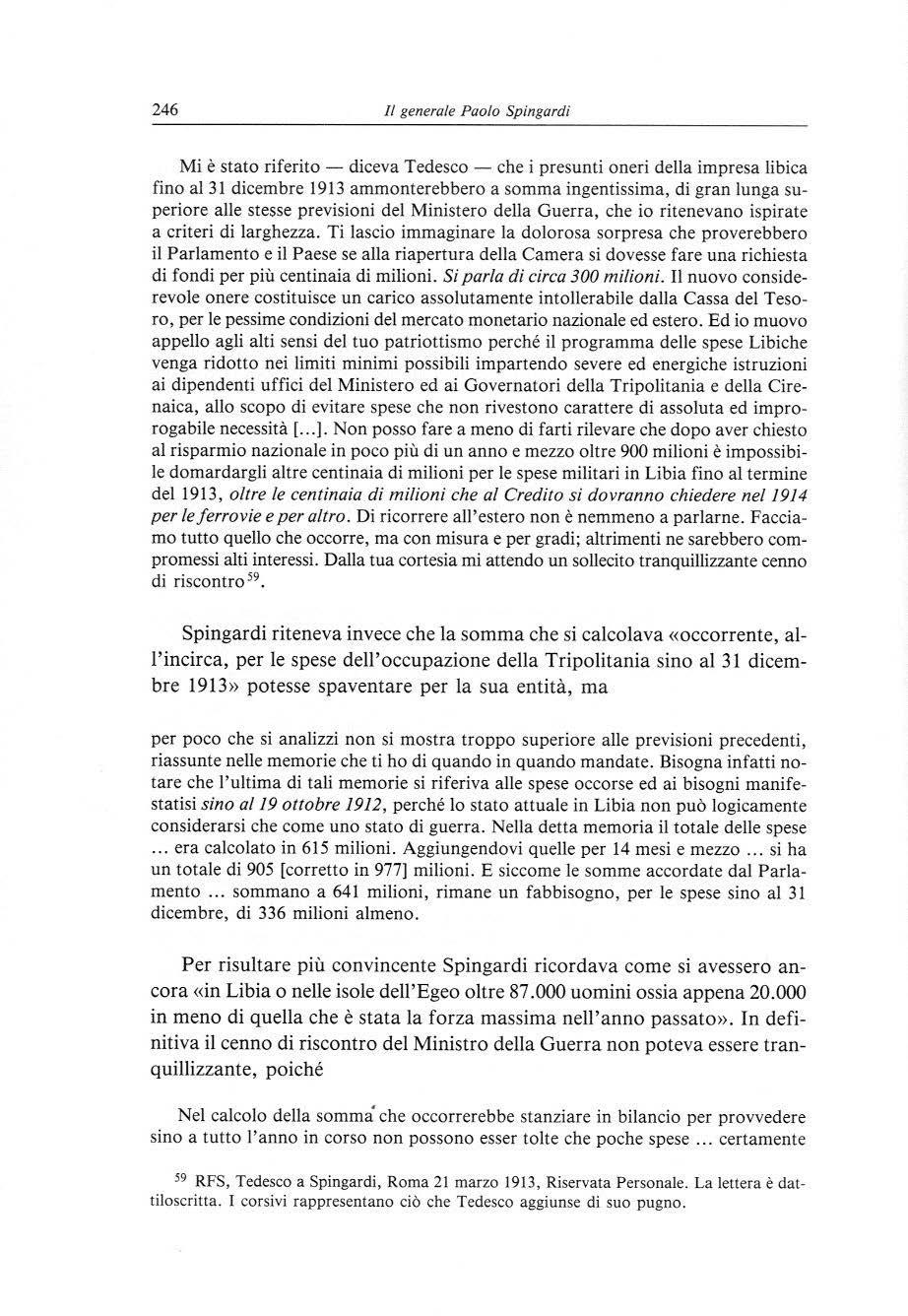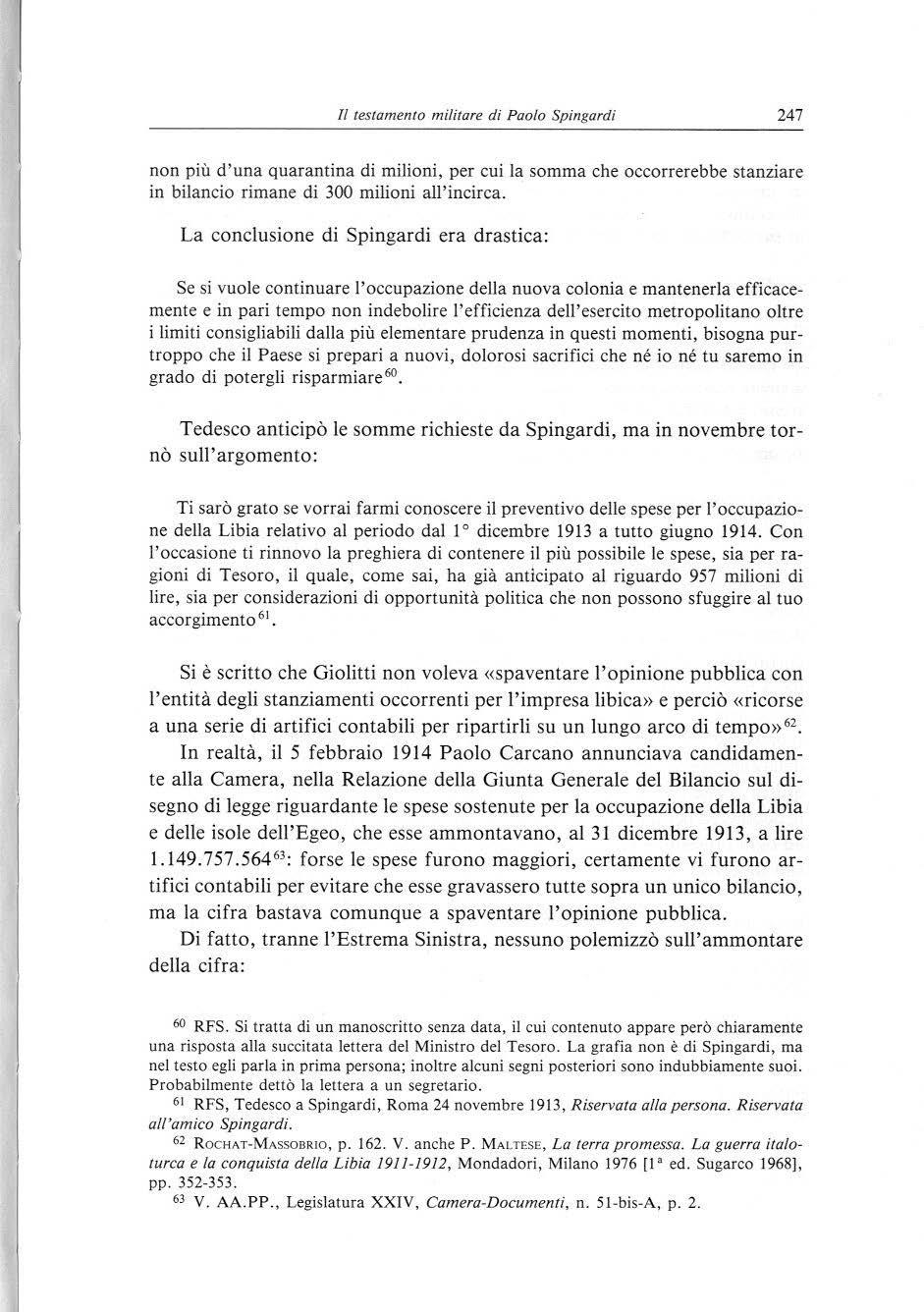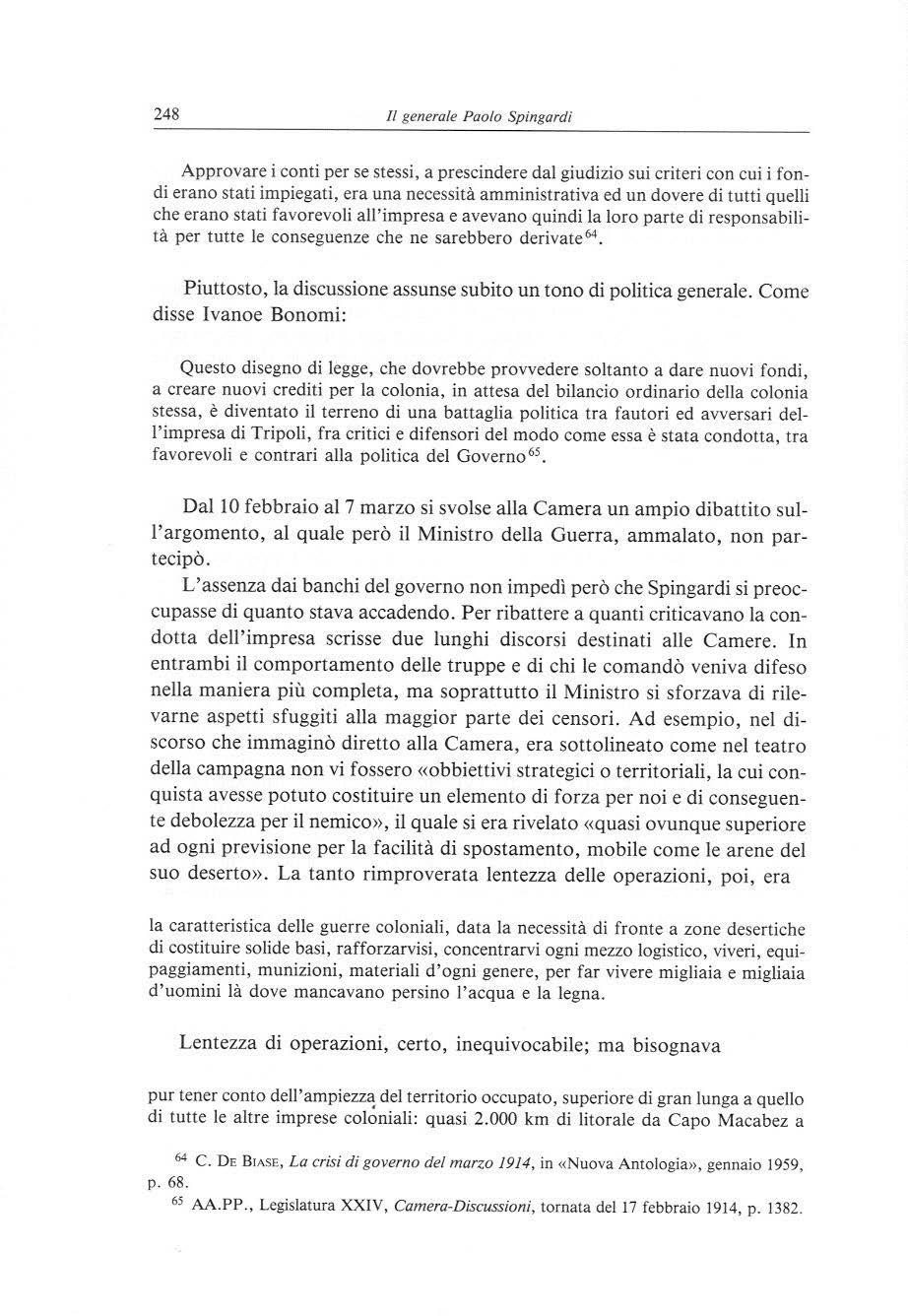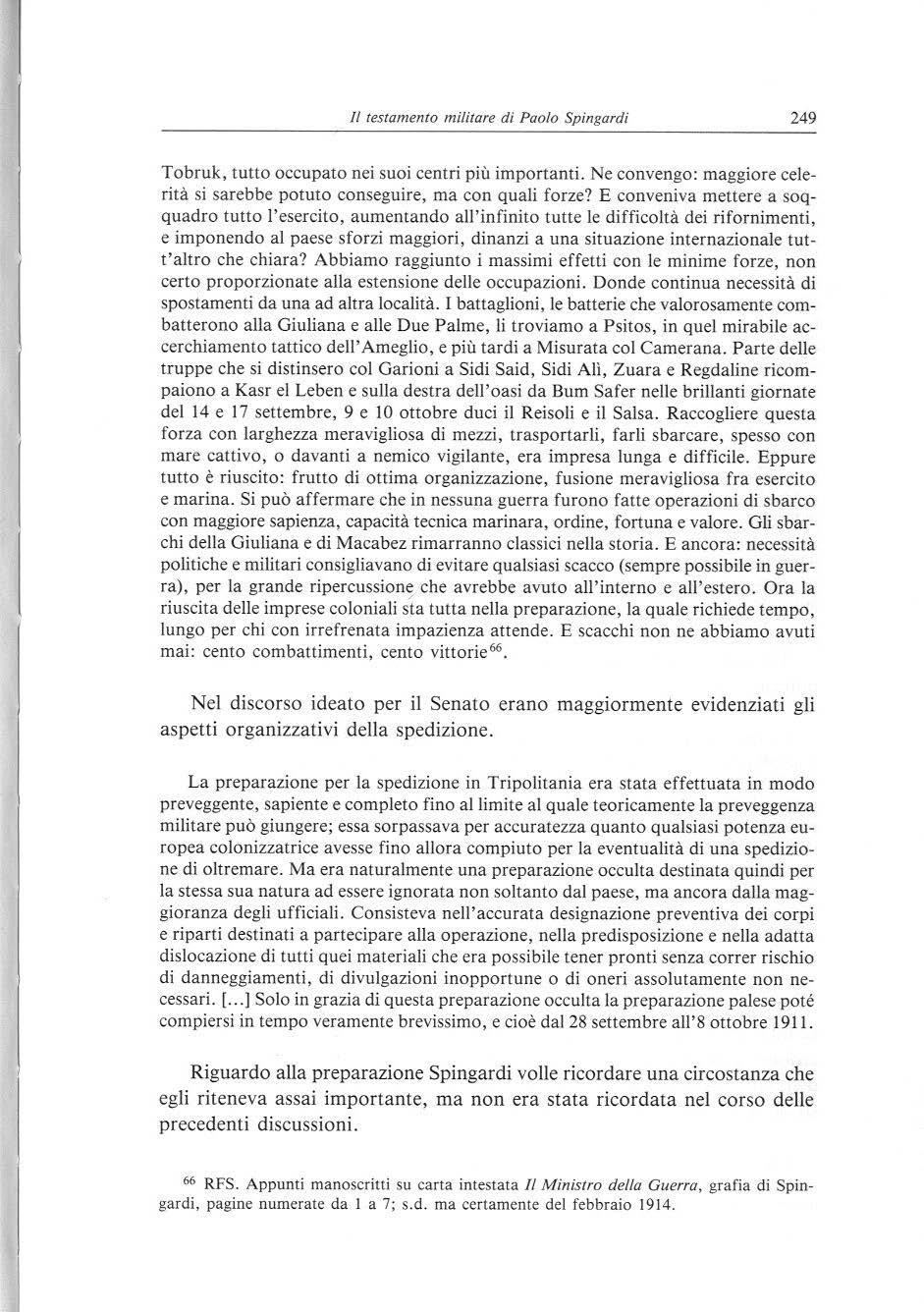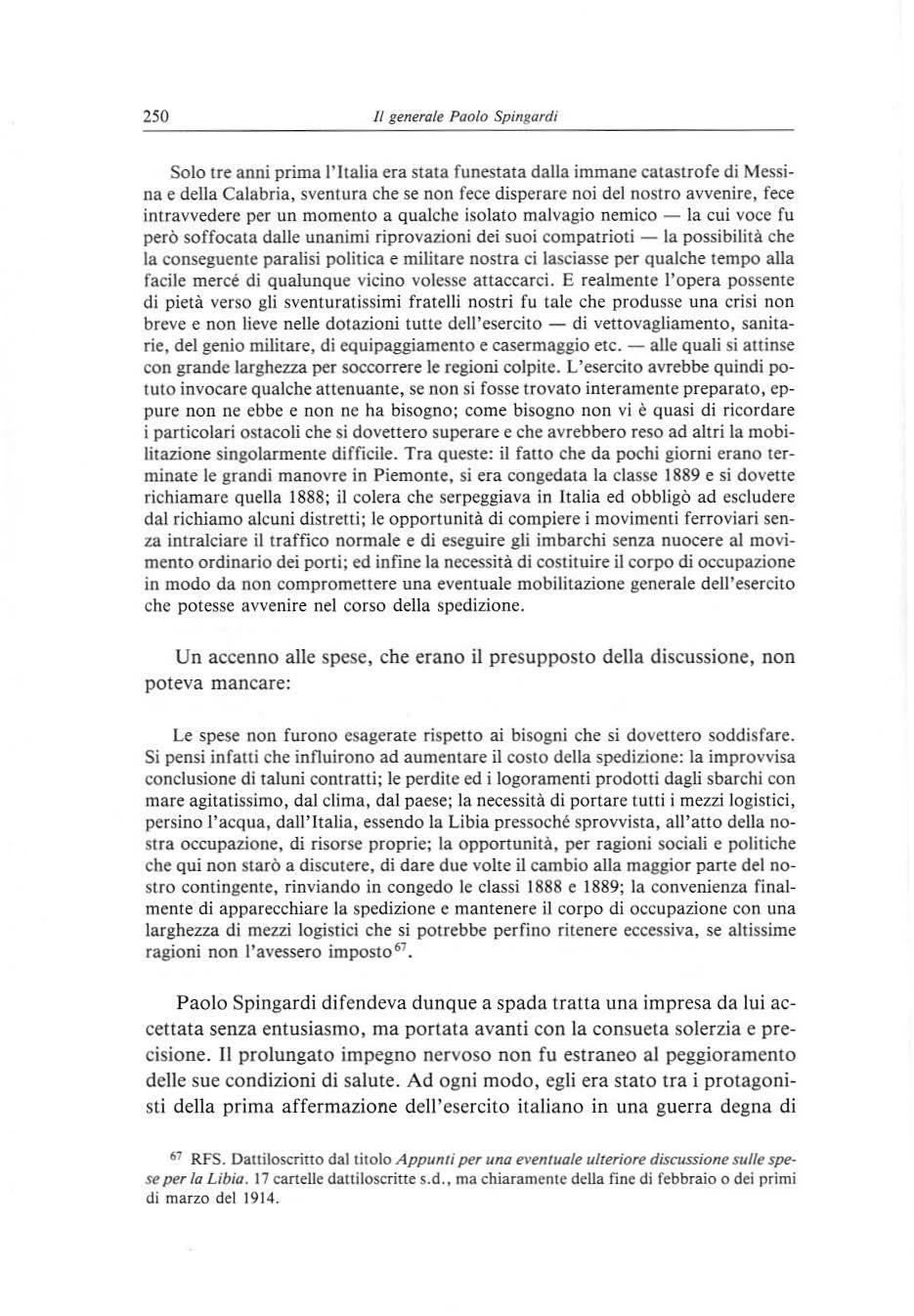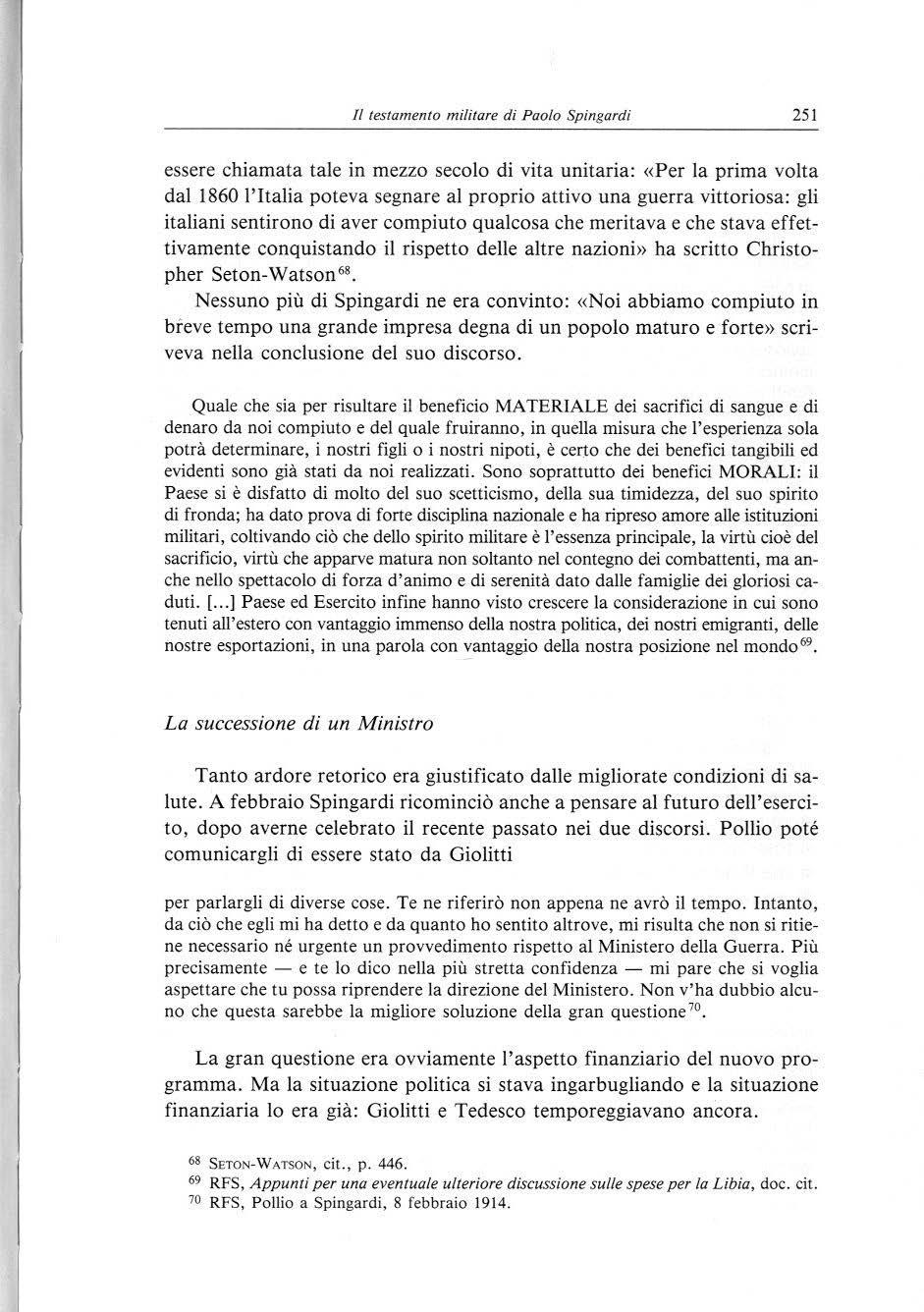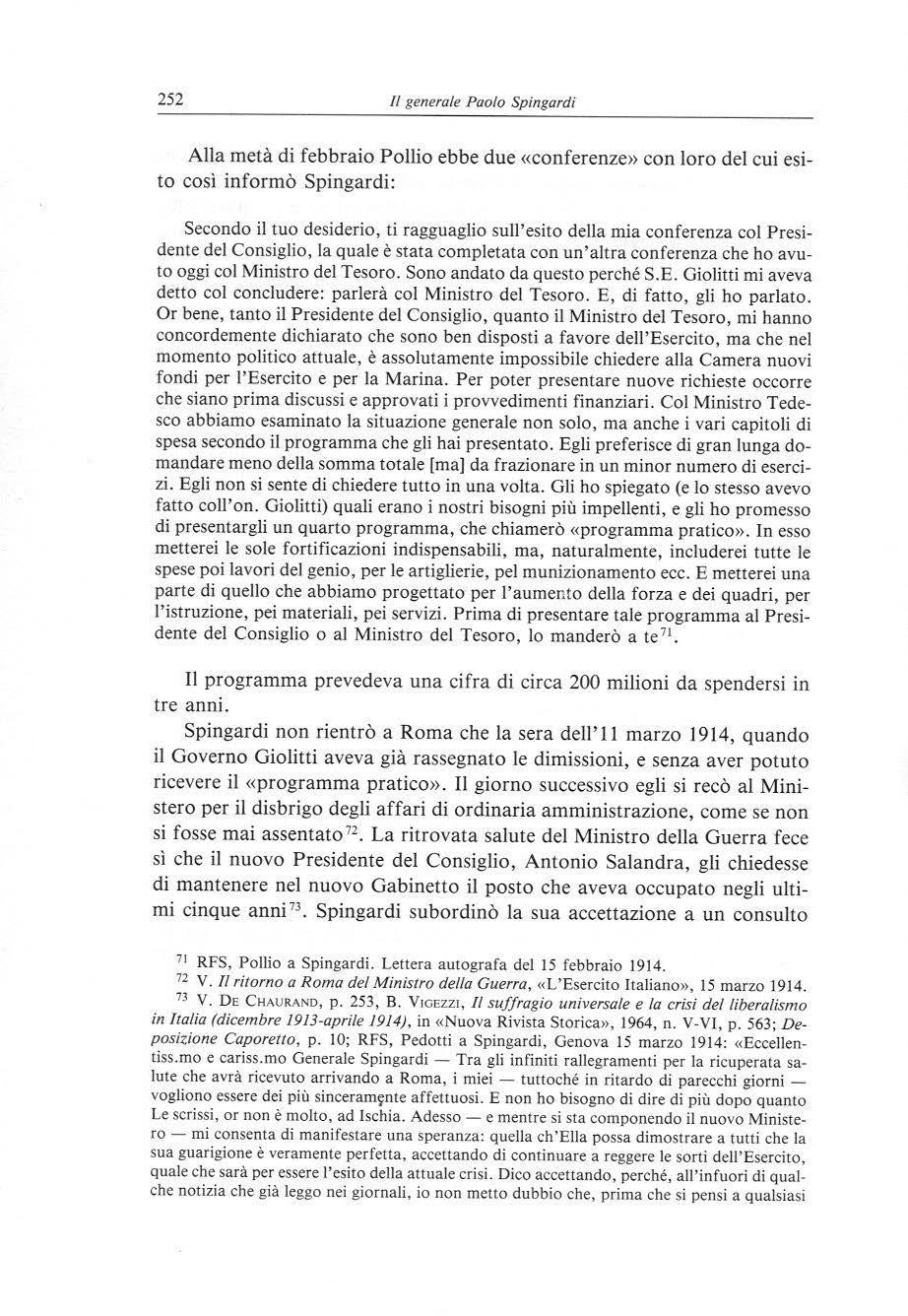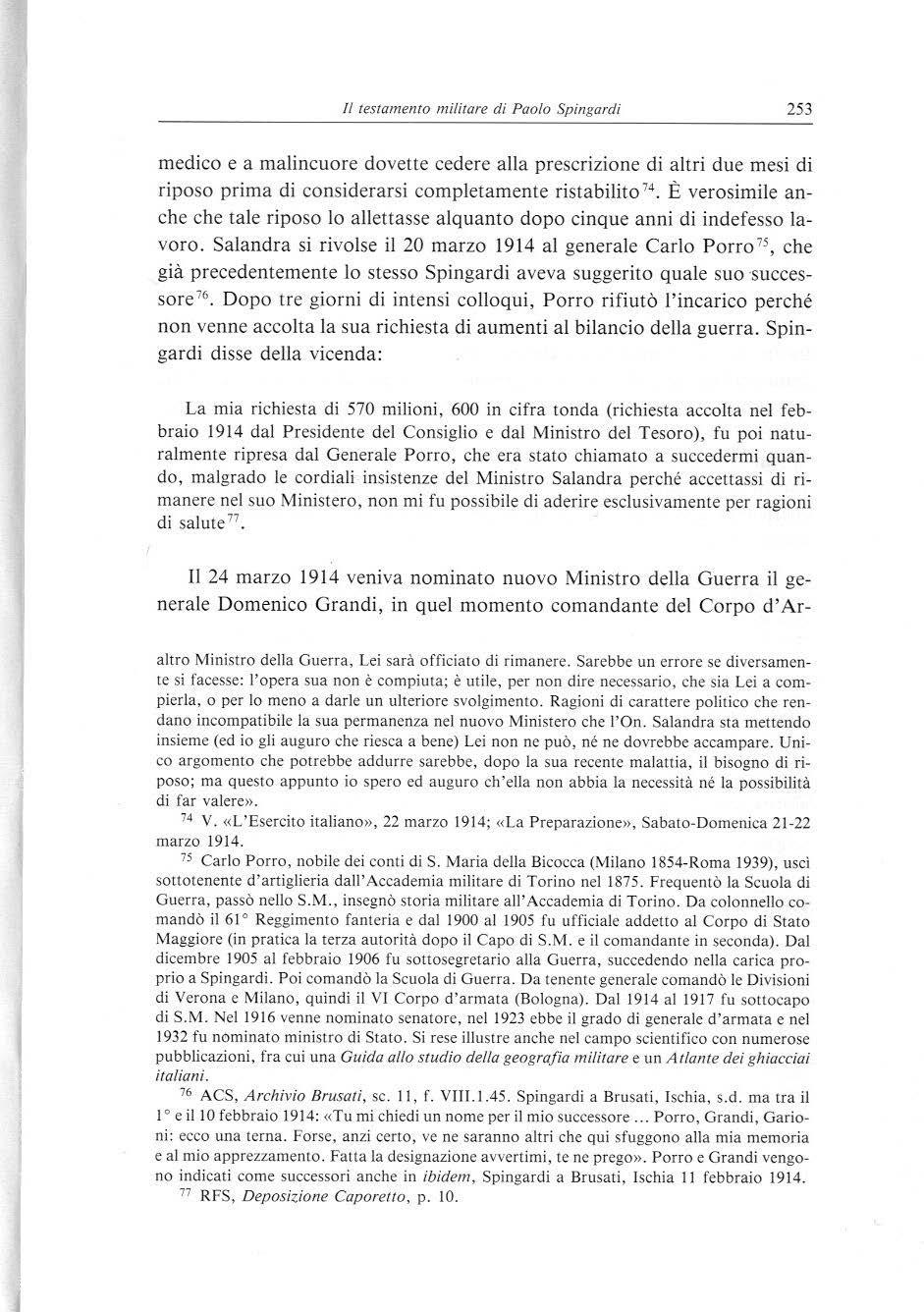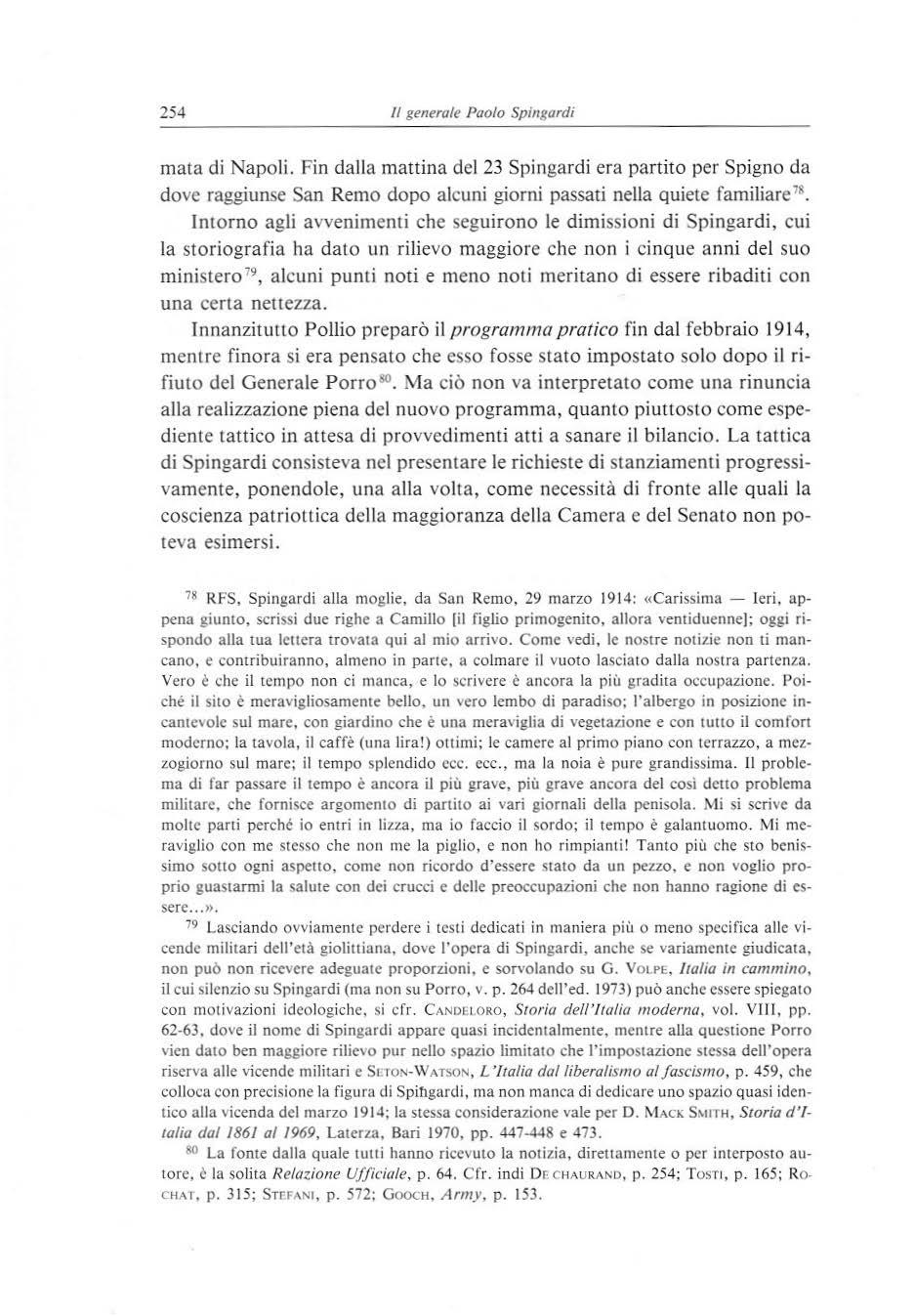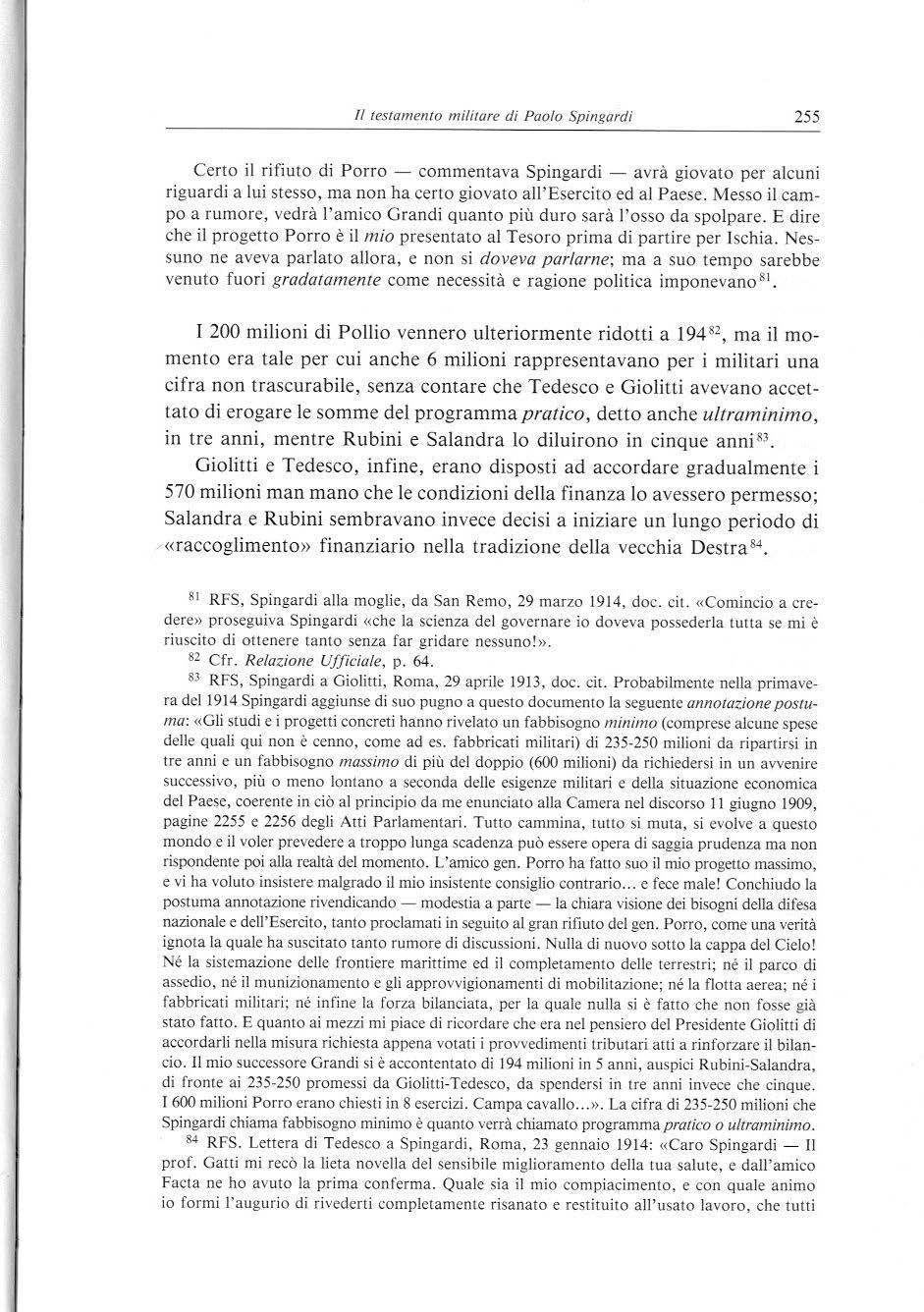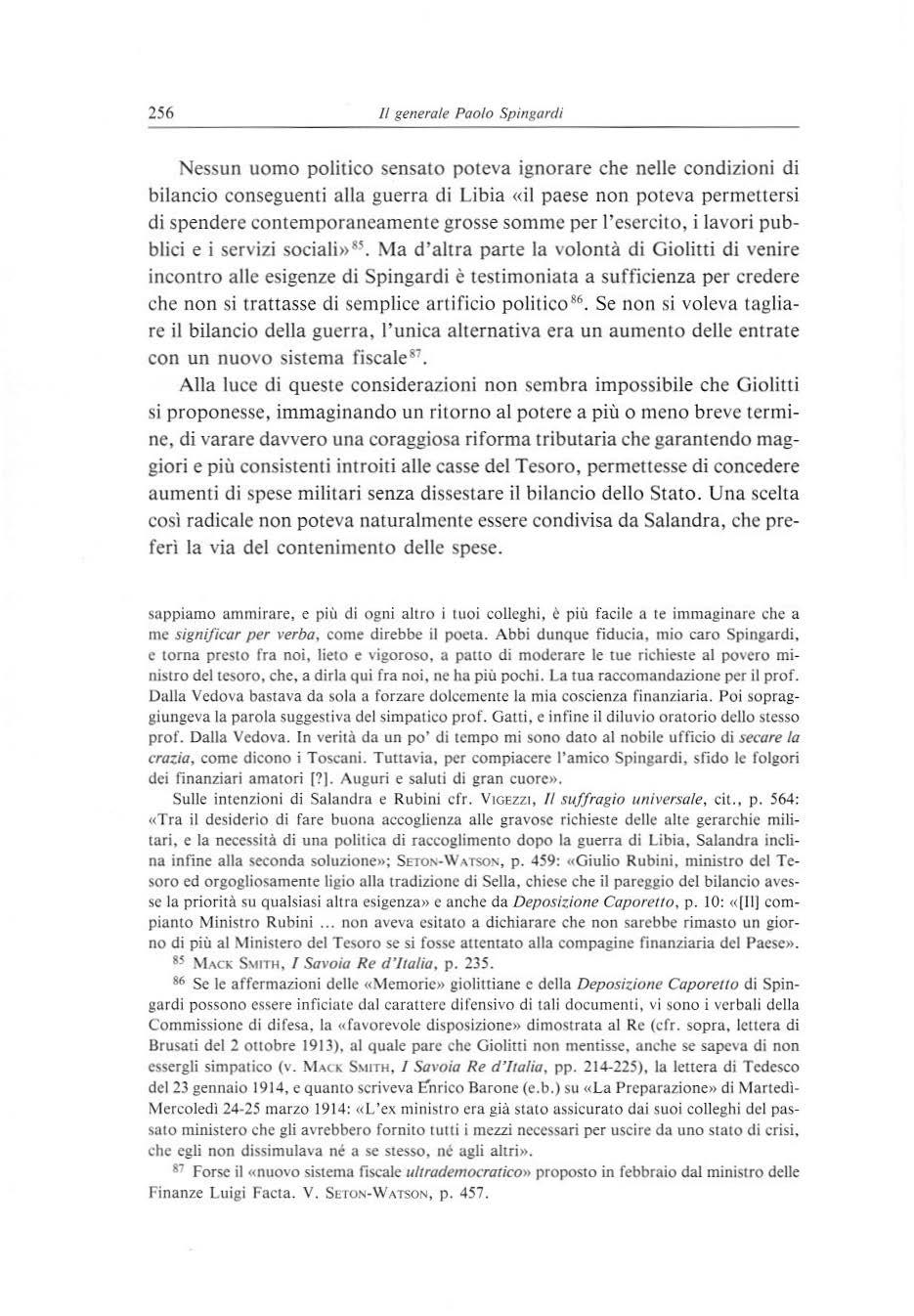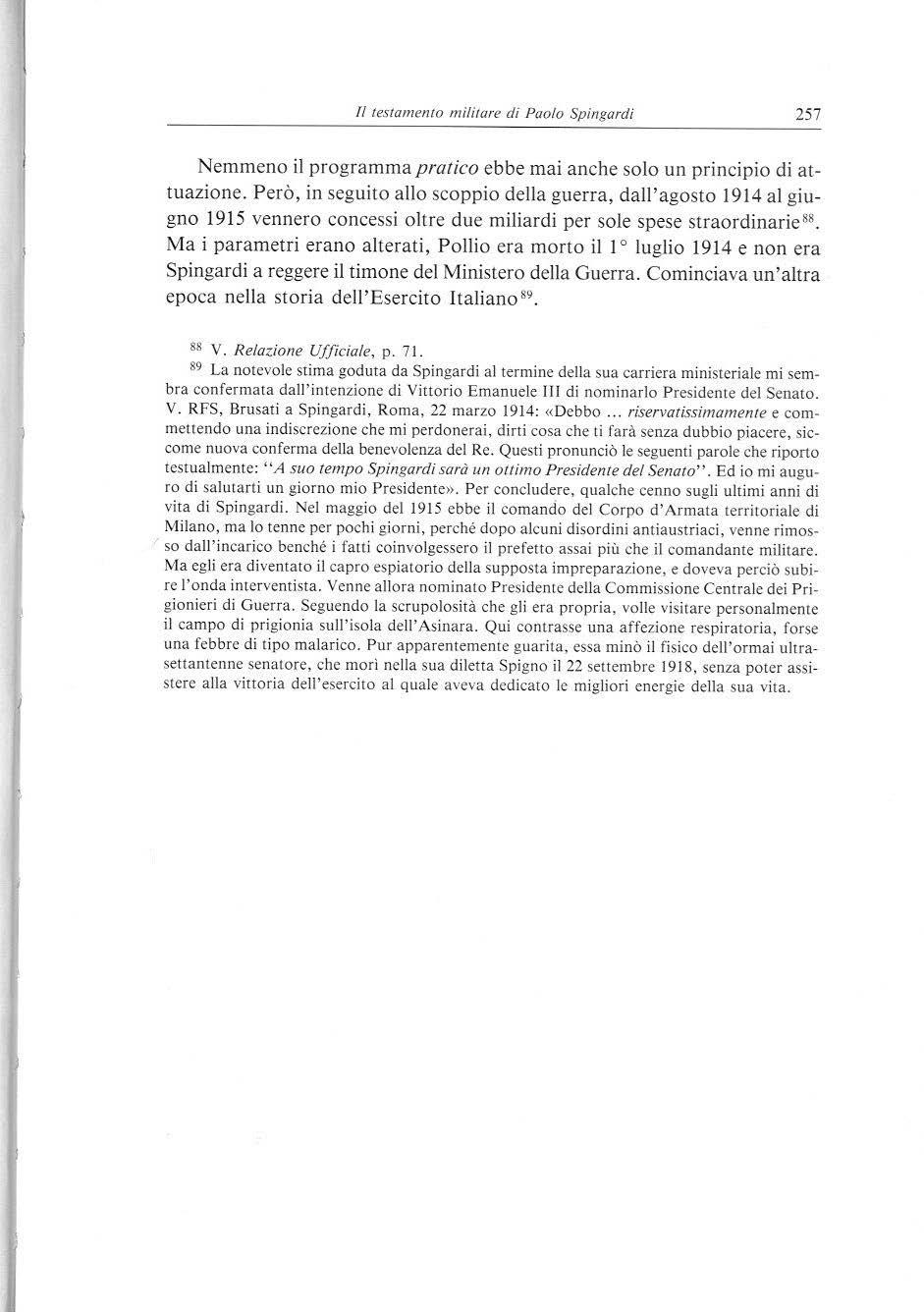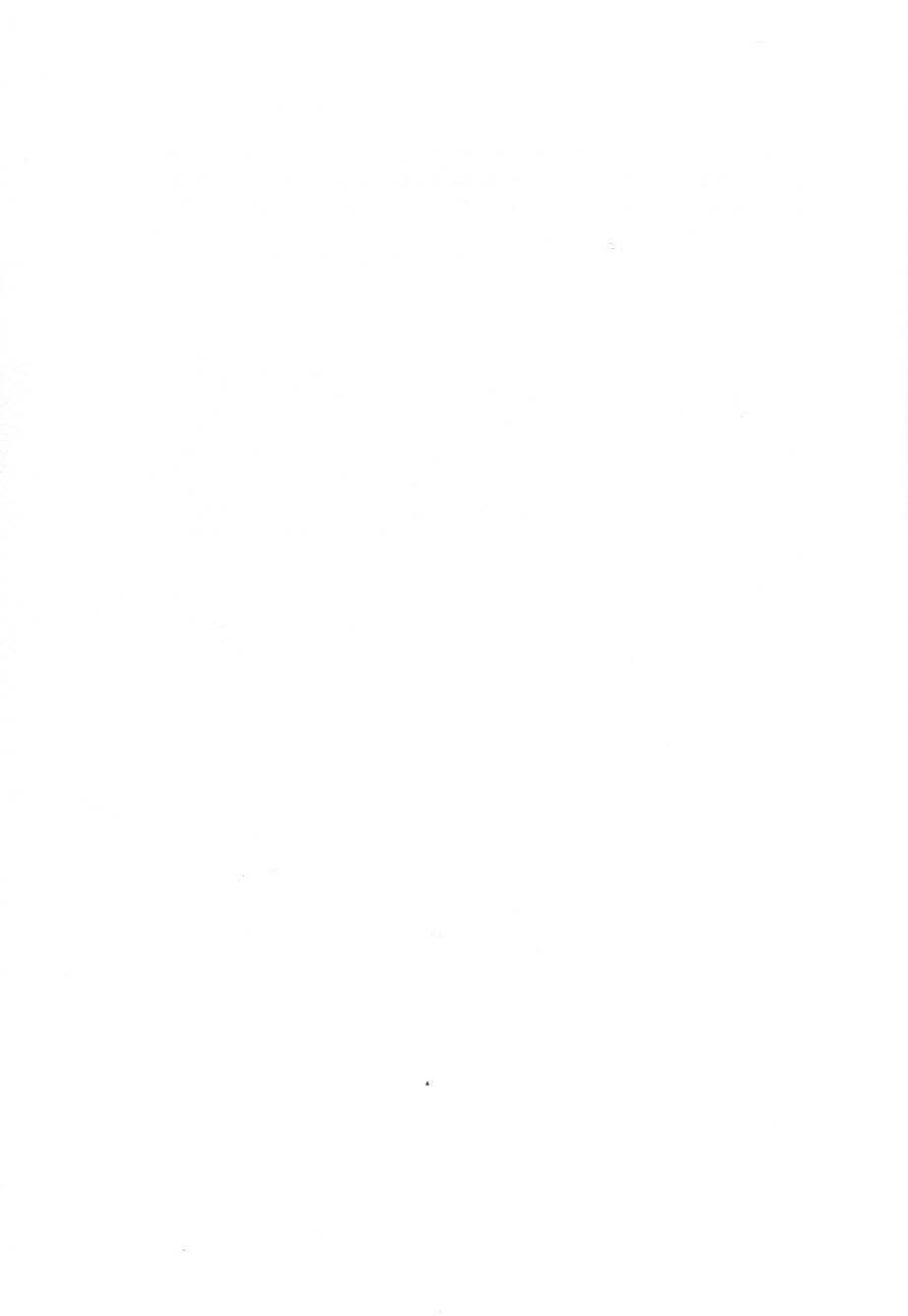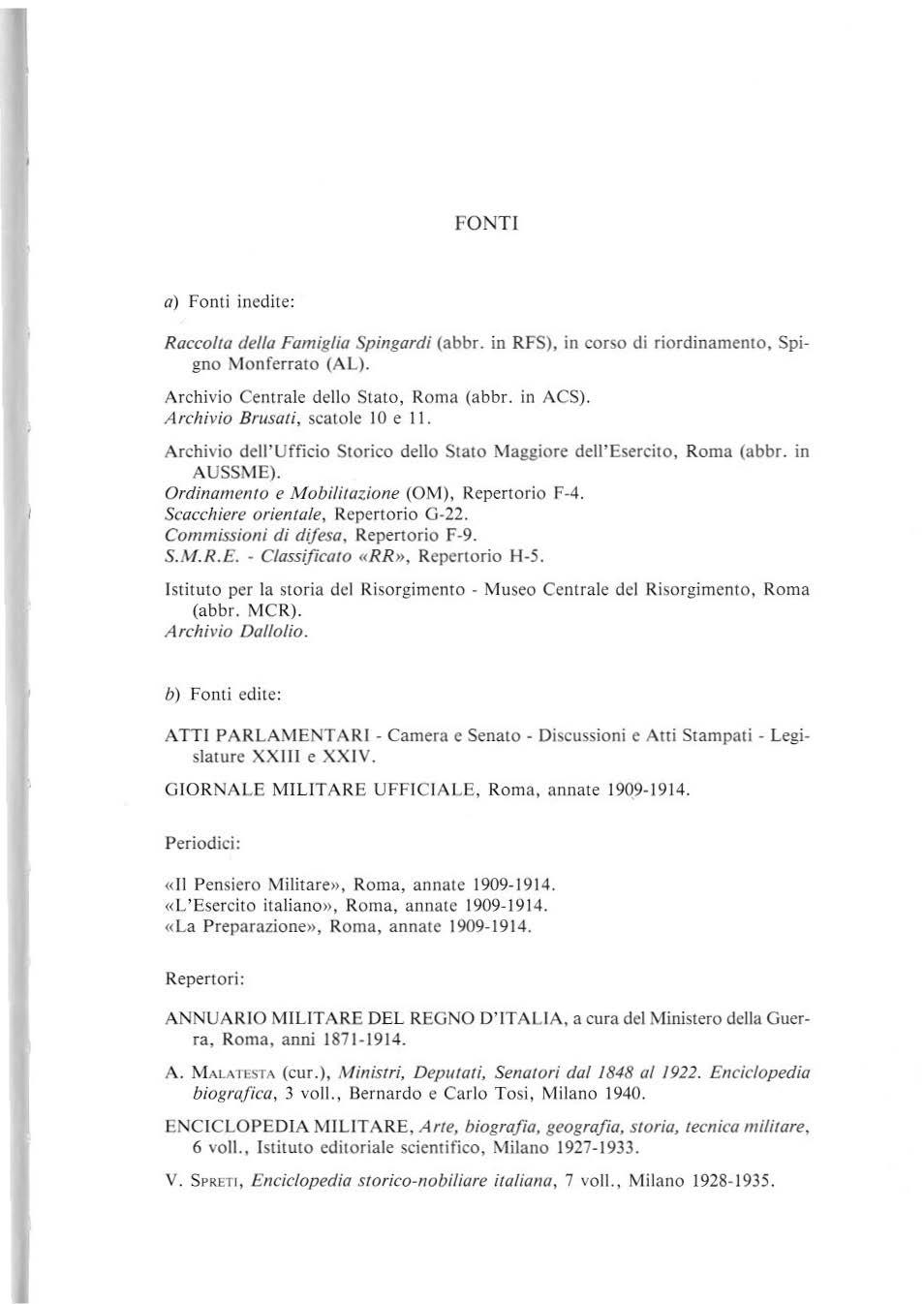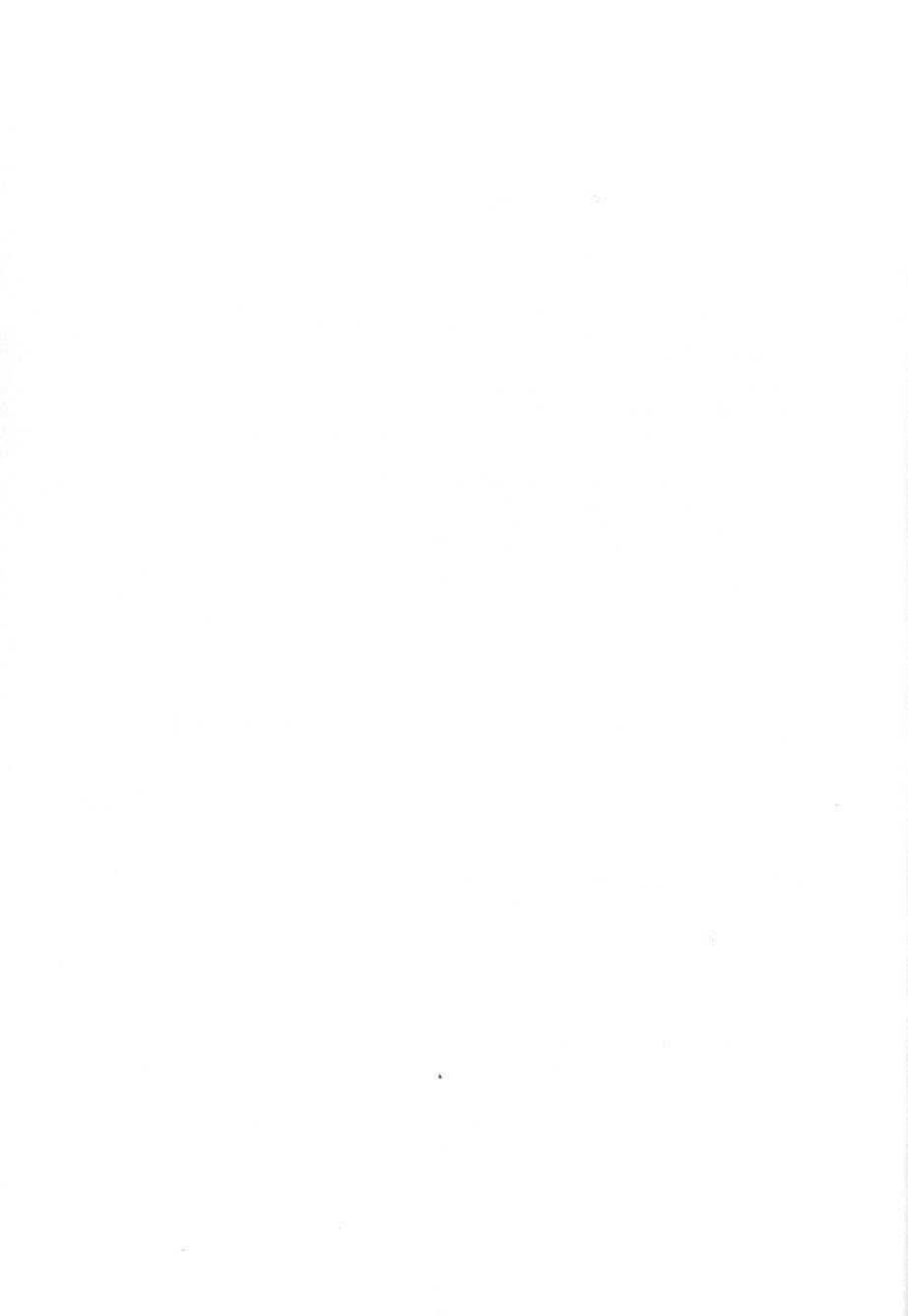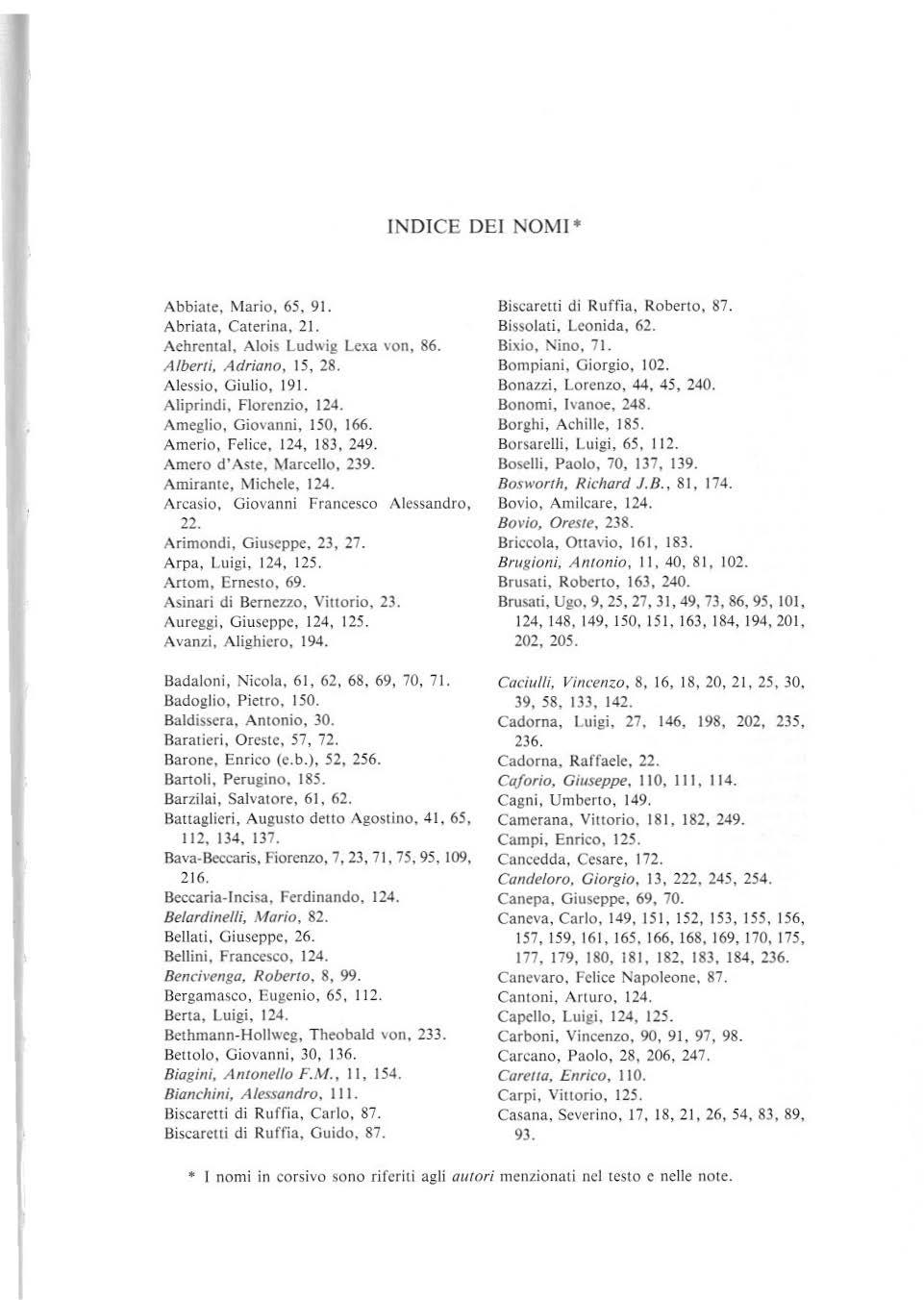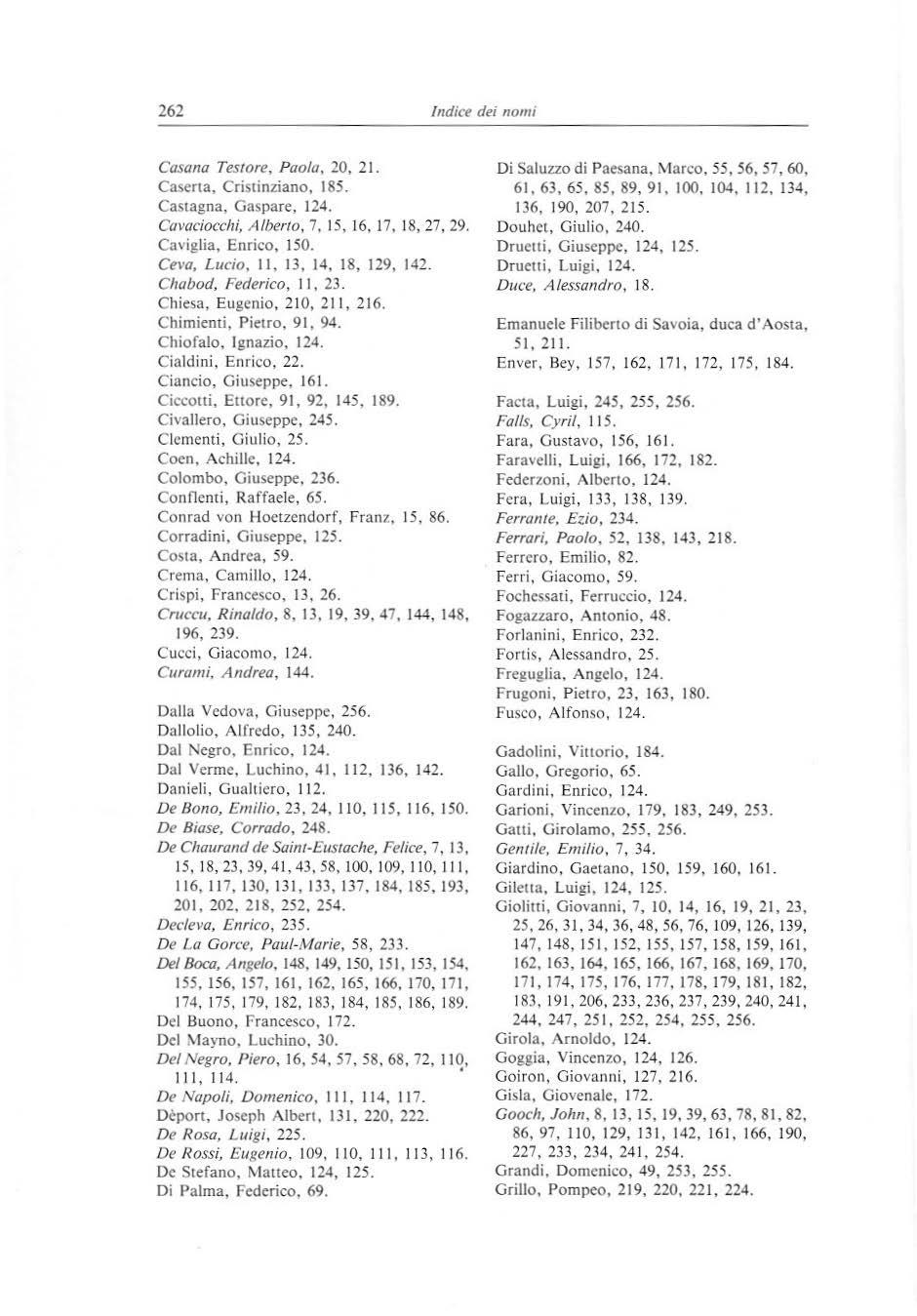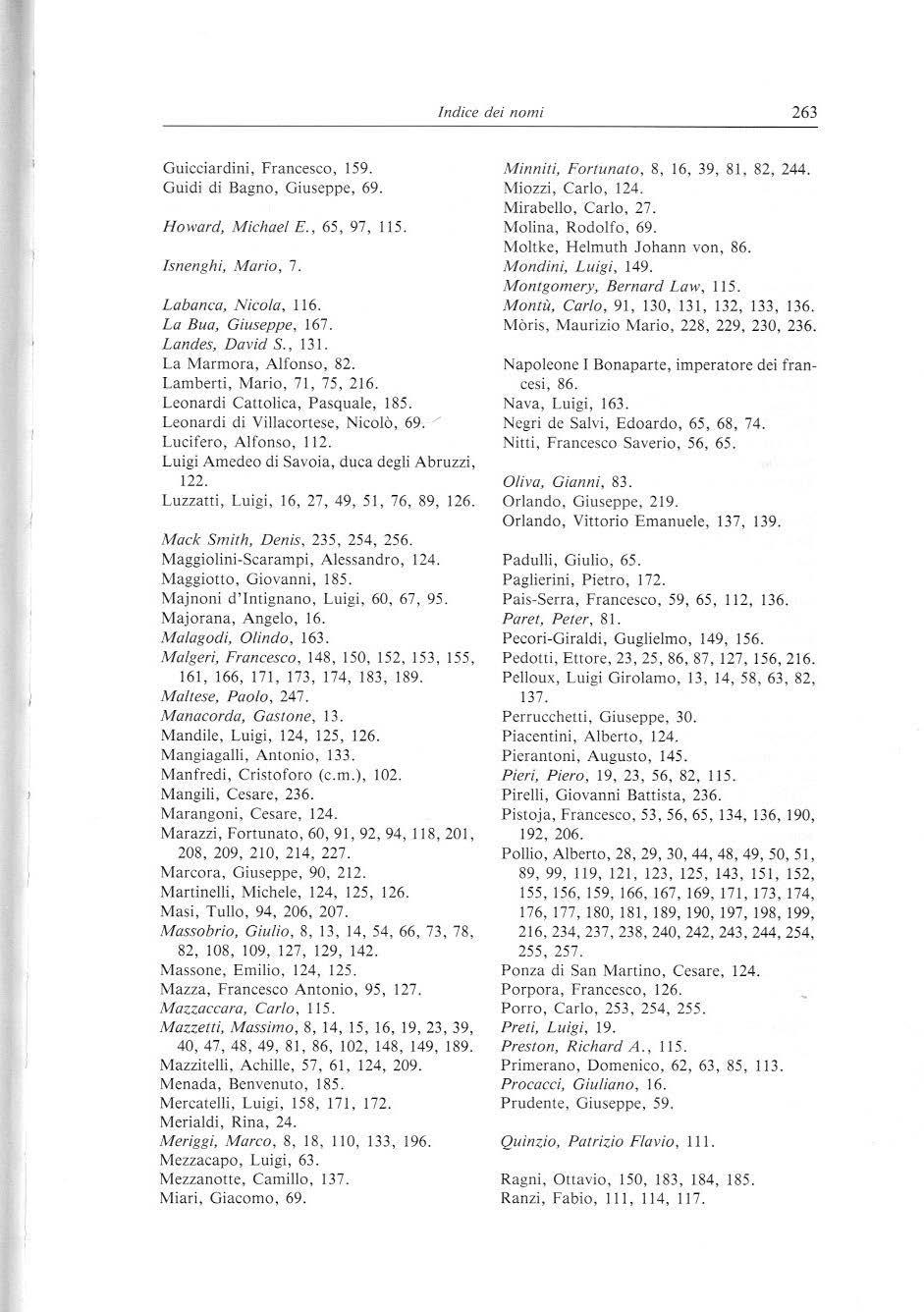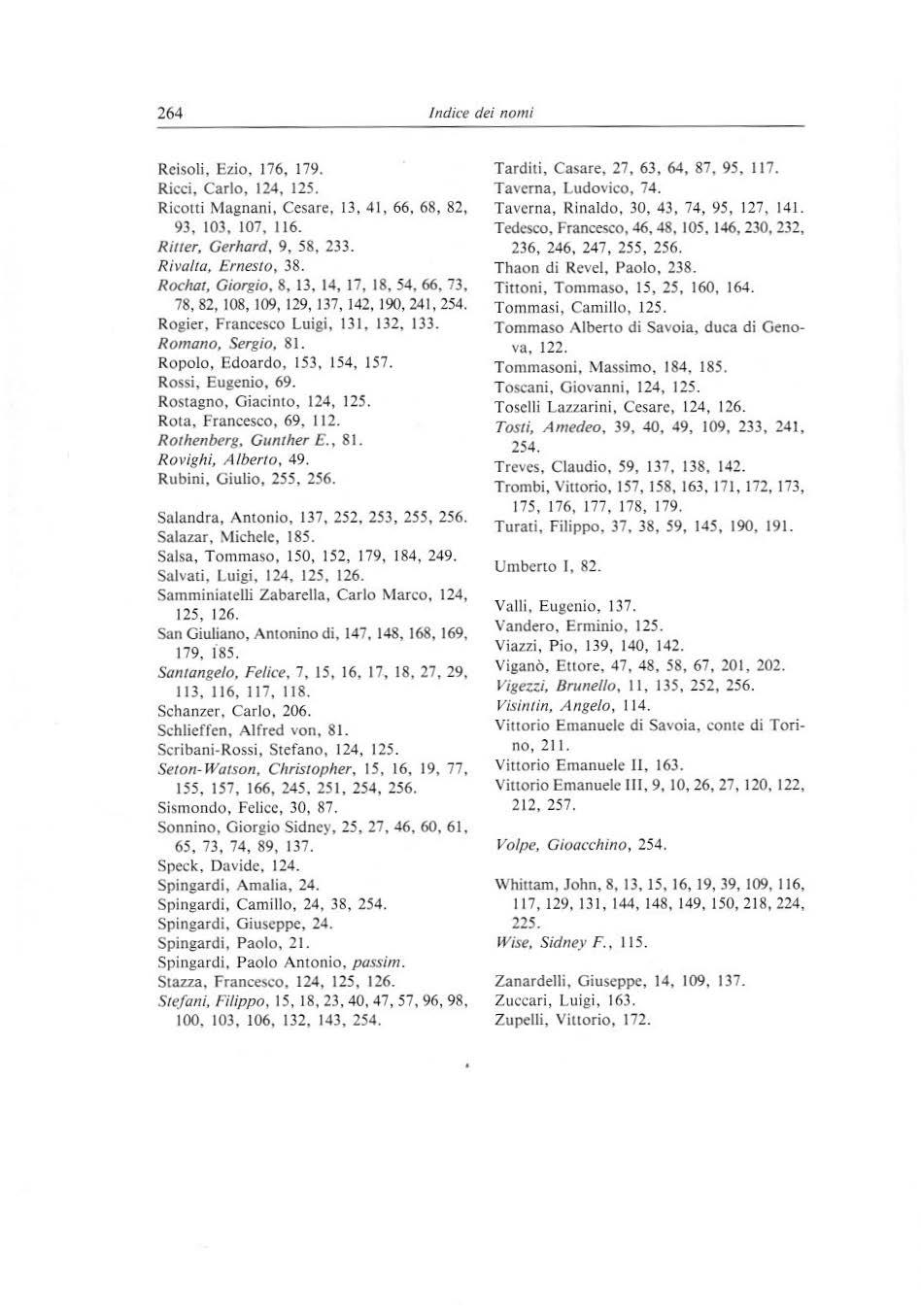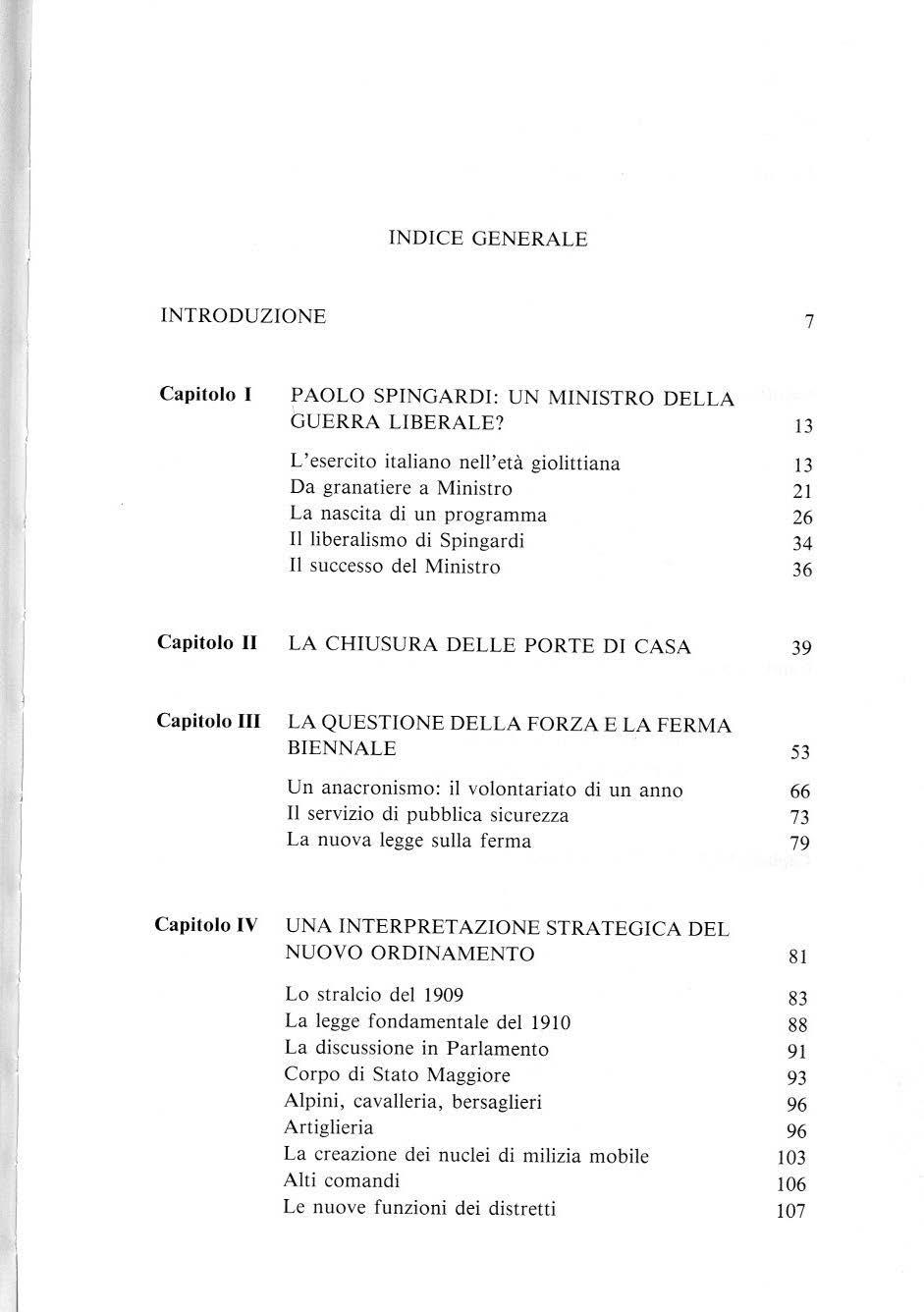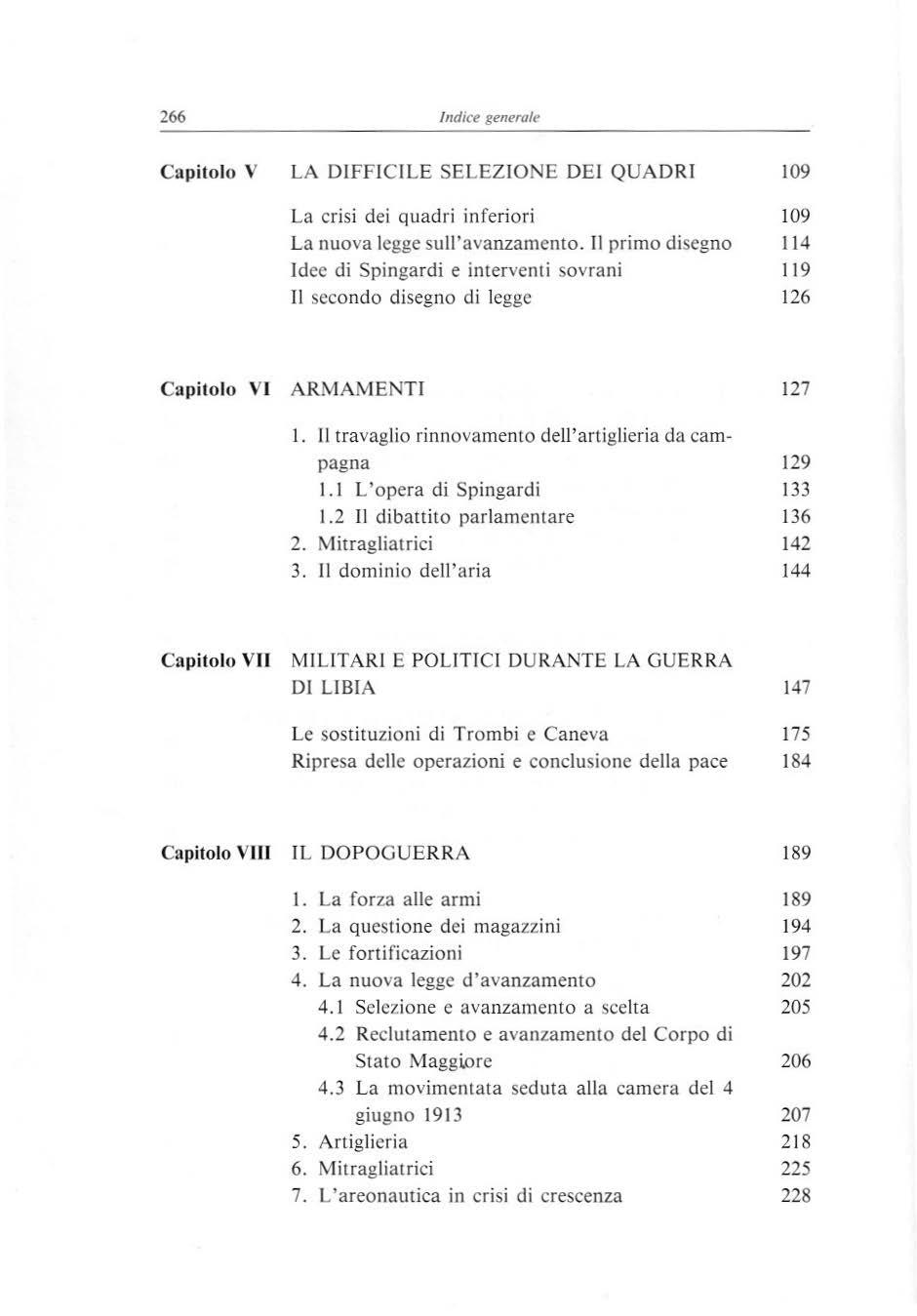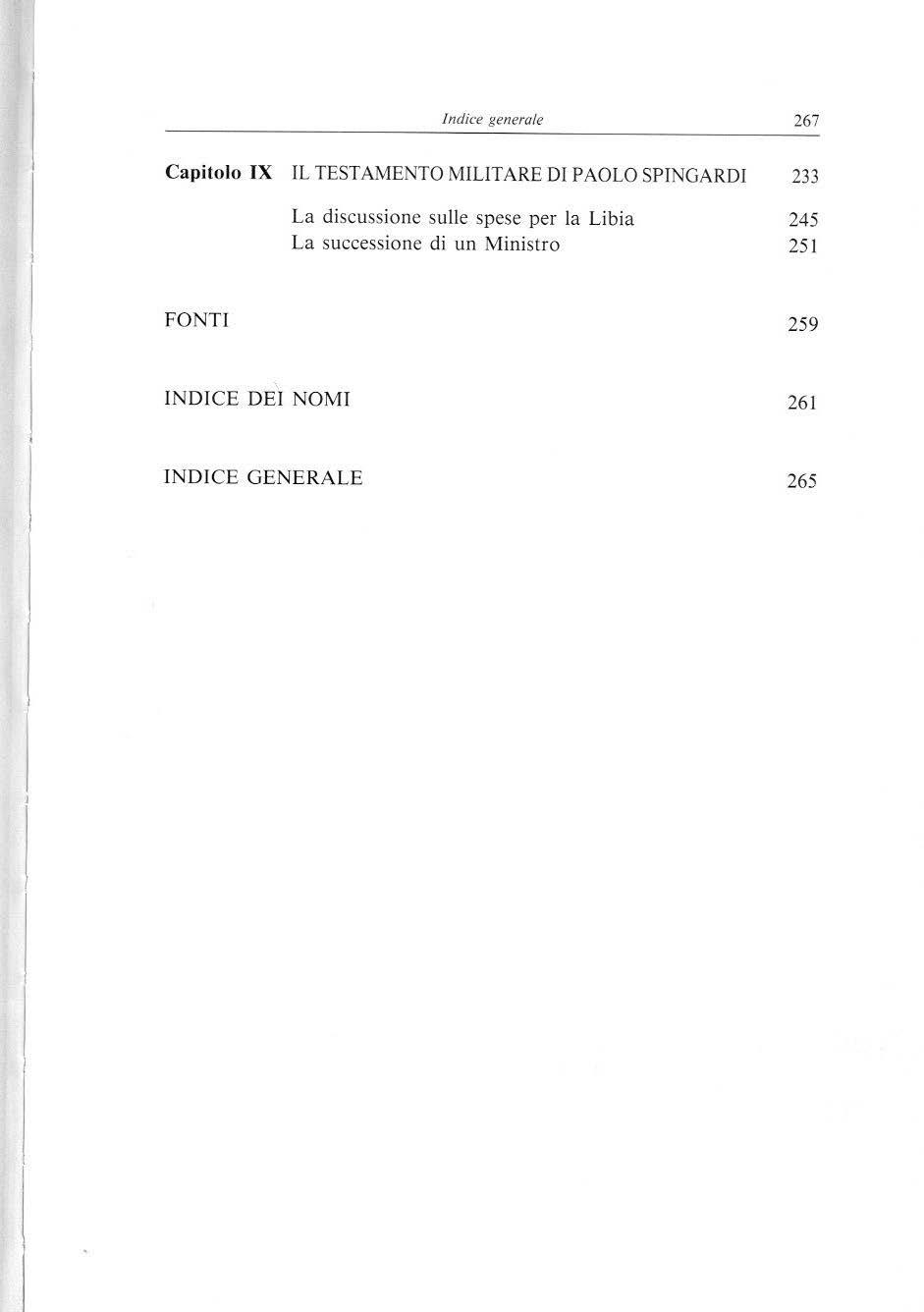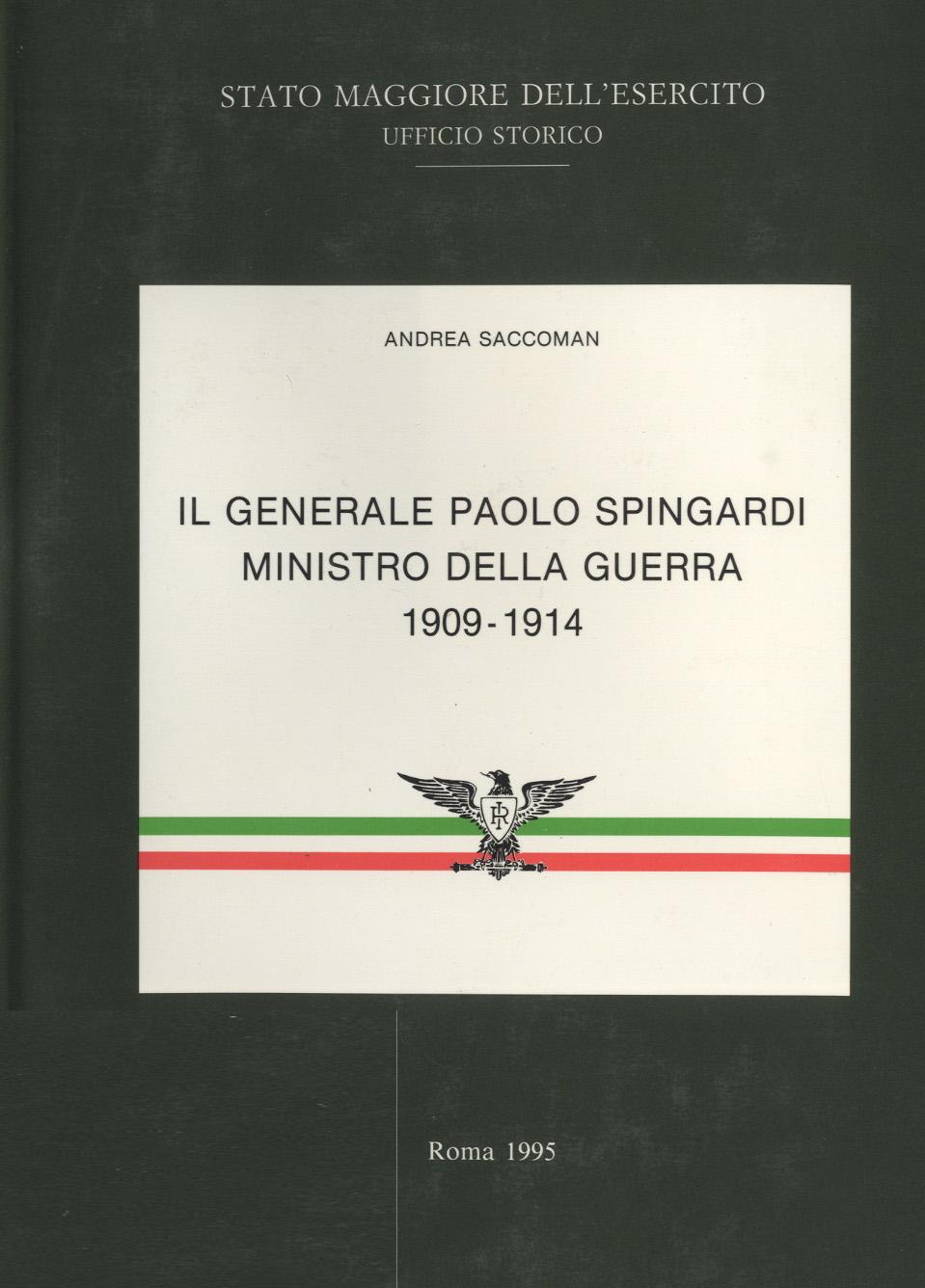
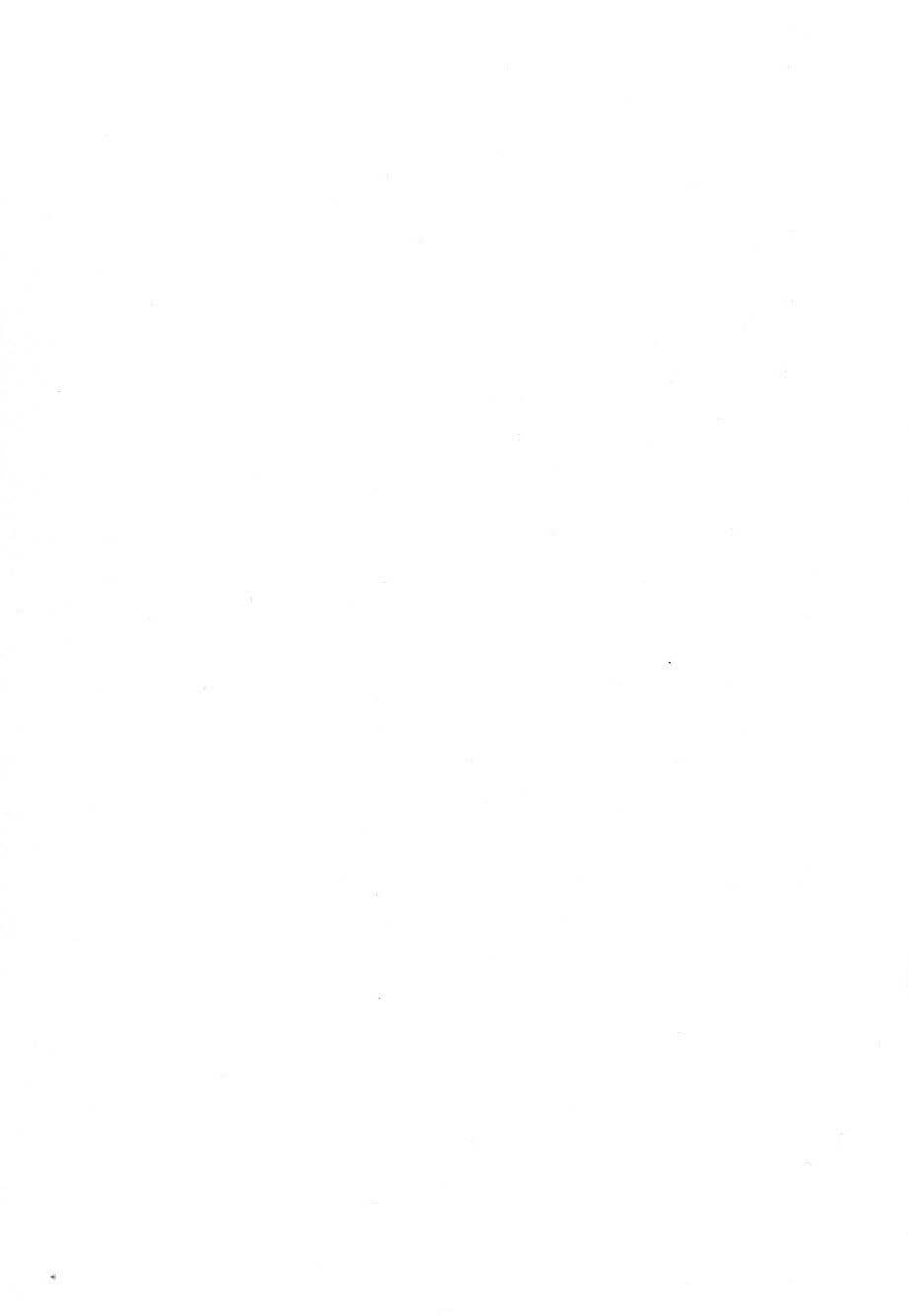

,. STATO MAGGI OR E DELL'ESERCITO U FFICIO STORICO AND RE A SACC OM AN IL GENERALE PAOLO SPINGARDI MINISTRO DELLA GUERRA (1909-1914) Roma 1995
PROPRIETÀ LETIERARIA

Tuili i dirilti riservati Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizzazione
© Copyright by Stato Maggiore dell'Esercito Ufficio Storico - Roma 1995
GTUS LA TERZA & FIGLI Spa - Industria Grafica - Via Zippitclli, 14,
Bari
PRESENTAZIONE
Con questo volume l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito non ha inteso derogare dalla linea editoriale perseguita ormai da tempo in merito ai lavori dal prevalente contenuto biografico.
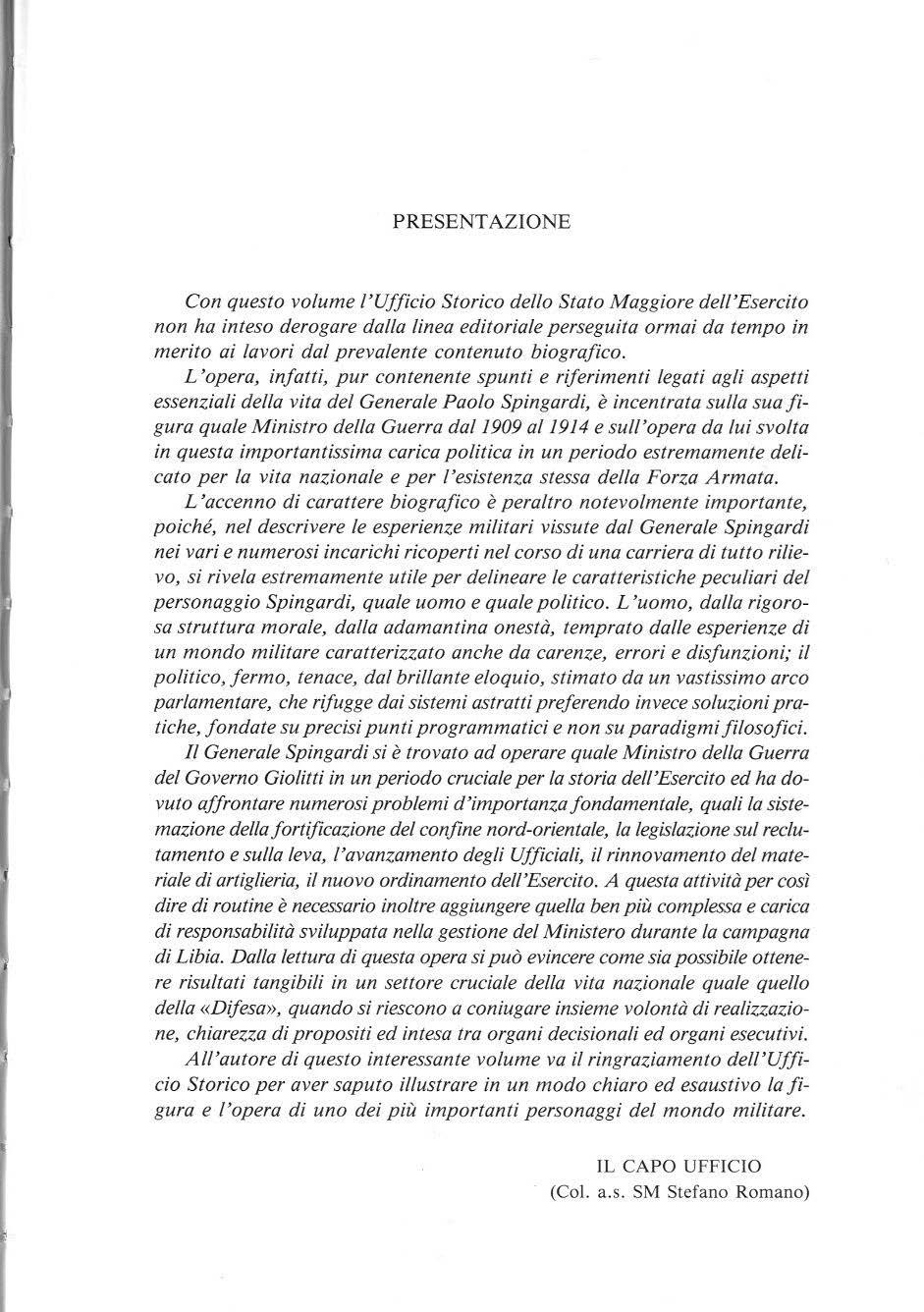
L'opera, infatti, pur contenente spunti e riferimenti legati agli aspetti essenziali della vita del Generale Paolo Spingardi, è incentrata sulla sua figura quale Ministro della Guerra dal 1909 al 1914 e sull'opera da lui svolta in questa importantissima carica politica in un periodo estremamente delicato per la vita nazionale e per l'esistenza stessa della F orza Armata.
L 'accenno di carattere biografico è peraltro notevolmente importante, poiché, nel descrivere le esperienze militari vissute dal Generale Spingardi nei vari e numerosi incarichi ricoperti nel corso di una carriera di tutto rilievo, si rivela estremamente utile per delineare le caratteristiche peculiari del personaggio Spingardi, quale uomo e quale politico. L'uomo, dalla rigorosa struttura morale, dalla adamantina onestà, temprato dalle esperienze di un mondo militare caratterizzato anche da carenze, errori e disfunzioni; il politico, fermo, tenace, dal brillante eloquio, stimato da un vastissimo arco parlamentare, che rifugge dai sistemi astratti preferendo invece soluzioni pratiche, fondate su precisi punti programmatici e non su paradigmi filosofici
Il Generale Spingardi si è trovato ad operare quale Ministro della Guerra del Governo Giolitti in un periodo cruciale per la storia dell'Esercito ed ha dovuto affrontare numerosi problemi d'importanza fondamentale, quali la sistemazione della fortificazione del confine nord-orientale, la legislazione sul reclutamento e sulla leva, l'avanzamento degli Ufficiali, il rinnovamento del materiale di artiglieria, il nuovo ordinamento dell'Esercito A questa attività per così dire di routine è necessario inoltre aggiungere quella ben più complessa e carica di responsabilità sviluppata nella gestione del Ministero durante la campagna di Libia. Dalla lettura di questa opera si può evincere come sia possibile ottenere risultati tangibili in un settore cruciale della vita nazionale quale quello della «Difesa», quando si riescono a coniugare insieme volontà di realizzazione, chiarezza di propositi ed intesa tra organi decisionali ed organi esecutivi.
All'autore di questo interessante volume va il ringraziamento dell'Ufficio Storico per aver saputo illustrare in un modo chiaro ed esaustivo la figura e l'opera di uno dei più importanti personaggi del mondo militare.
IL CAPO UFFICIO
(Col. a .s . SM Stefano Romano)

INTRODUZIONE
A proposito di storia militare è st ato scritto che essa «è storia di uomini, que ll i e non altri» 1 : esp r essione efficace che può in parte spiegare la scelta di dedicare una ricerca all'attività di un singolo personaggio non come semplice oggetto di erudizione biografica, ma quale osservatorio privilegiato per meglio comprendere i criteri dell'azione di governo , il posto che i militari e la preparazione alla guerra avevano nella prassi politica del liberalismo democratico, la mentalità della classe dirigente di un'epoca, insomma la politica m ili t are in que l periodo fondamentale nella storia dell'Italia contemporanea che fu giolittiana 2 •
Il generale Pao lo Spingardi, Ministro della Gue r ra dal 1909 al 1914, è sembrato la figura adatta, perché vicino a Giolitti, dal quale condivideva il programma politico e non pochi principi generali di azione, perché ebbe una vita min ister ia le singolarmente l unga e si tr ovò ad affrontare tutte le più importanti questioni riguardanti l'assetto mi litare nazionale.
Le pu bblicazioni che chiamano in causa la sua opera, lo fanno nell'ottica dell'intervento nella prima guerra mondiale, se si escludono il saggio dei co lonnelli Alberto Cavaciocchi e Felice Santangelo3, pubblicato nel 1910, e i l sagg io del generale Bava-Beccaris4, pubblicato nel 1911, che per ovvie ragioni cronologiche erano parziali. L'opera più ricca di informazioni è del resto il primo volume della Relazione Ufficiale dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell' E sercito 5 •
1 Mari o Isne nghi nel «Cor riere della Sera» del 3 sellembre 1993.
2 Le questioni re lative alla politica mi litare del periodo gio littiano sono state affrontate in maniera piuttost o li mitata Si veda ad esempio la bibliografia che conclude il libro di E. GENTILE, L'Italia giolittiana, Il Mu lino, Bologna 1990, pp. 239-257. Per quanto stilata senza pretese di completezza, essa offre un aggiornato panorama degli studi sull'età giolittiana. È significativo che non vi compaia un solo testo dedicato ai prob lemi mili t ari.
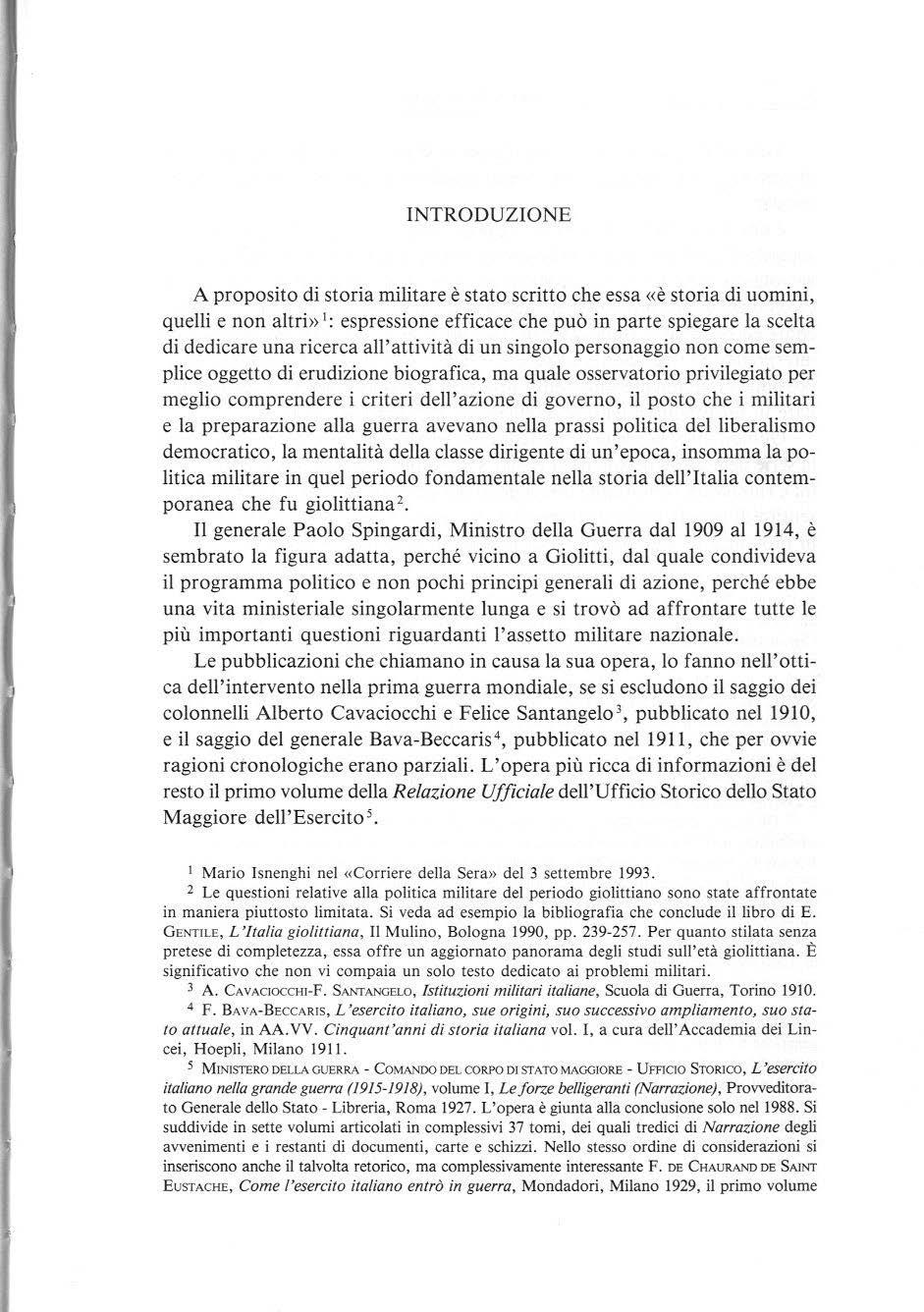
3 A CAvAc1occH1-F. SM'TANGELO, istituzioni militari italiane , Scuola di Guerra, Torino 1910.
4 F. BAVA-BECCARJS, L'esercito italiano, sue origini, suo successivo ampliamento, suo stato atluale, in AA. VV. Cinquant'anni di storia italiana voi. I, a cura dell'Accademia dei Lincei , Hoepl i, M ilano 1911.
s MINISTERO DELLA GUERRA - Co:,tANOO DEL CORPO or STATO MAGGIORE - UFFICIO STO RI CO, L'esercito italiano nella grande g uerra (1915- /9!8), volume I, Le/orze belligeranti (Narrazione), Provveditorato Generale dello Staro - Libreria , Roma 1927 L'opera è giunta alla conclusione solo nel 1988. Si suddivide in sette vol umi articolati in complessivi 37 tomi , dei quali tredici di Narrazione degli avvenimenti e i restanti di documenti, cane e schizzi. Nello stesso ordine di considerazioni si inseriscono anche il talvolta retorico, ma complessivamente interessante F DE CHAURAND DE SNNT EusrACHE, Come l'esercito italiano entrò in guerra, Mondadori, Milano 1929 , il primo volume
Volgendosi poi agli studi più recenti ci si imbatte in brevi saggi o atti di convegni, estremamente stimolanti a vo l te, ma per natura editoriale limitati 6
Conviene quindi sgombrar e il campo dagli equ ivoci: innanzi tutto lo sguardo di chi leggerà questo la voro non de ve andare verso il 1914, ma deve volgersi indietro, verso il 1909 o anche il 1896 , perché Paolo Spinga rdi cercò di risolvere problemi che da molti anni attendevano una s oluzi one, come ad esempio il rinnovamento dell'artiglieria, e in tale pro s pettiva va interpretata la sua azione. In secondo luogo si è cercato di lavorare il più possibile direttamente s ulle fonti, perché s i è rivelato l'unico modo per andare in profondità e tentare di chiarire i vari argomenti'.
Quindi, vista la scelta di partenza, diveniva essenziale pot er consultare la serie delle carte personali di Paolo S piogardi. Con un pizzico di fortuna mi è riuscito di contattare i discendenti del ge neral e, i quali mi hanno consentito di accedere a lla documentazione, conservata a Spigno Monferrato in provincia di Alessandria, e di prenderne accurata visione.
dell'onimo R. BENc1v ENGA, Saggio critico sulla nostra guerra, Tipografia Agostiniana, Roma 1930 e il più moderno e per ce rti versi fondamenta le G. ROCHAT, L'esercito italiano ne/l'estate del 1914, in «Nuov a Rivista Storica», anno XLV, fascicolo li , maggio-agosto 1961, pp. 295-348.
6 V. p.es., M. M e R1co1, Militari e istituzioni politiche nell'età gioliUiana, in «Clio», a. XXIll, 1987, n. I, pp. 55-92; V. CACI ULLI , L'amministrazione della guerra, l'esercito e la commissione d'inchiesta del 1907, in « Farestoria », a. XVI, 1986, n. 2, pp. 31 1-343; M. MA ZZETT I, L'esercito nel periodo g iolittiano (1900-1908) e R. CRuccu, L 'esercito nel periodo giolifliano (/909-1914), entrambi in AA.VV., L'esercito italiano dall'unità alla grande guerra, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (d'ora i n poi USSME) , Roma 1980, pp. 247-256 e 259-269 rispettivamente.
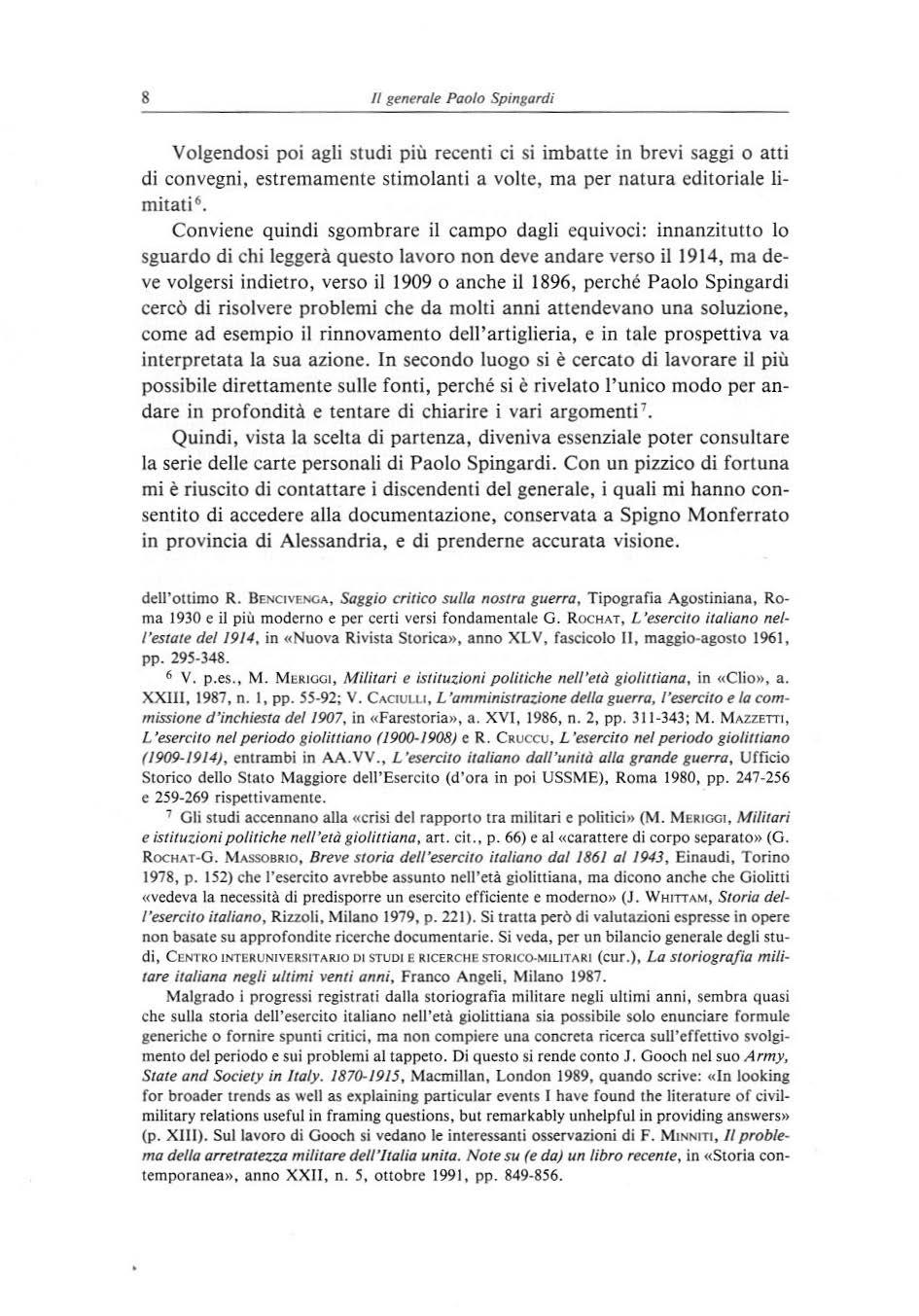
7 Gli studi accennano alla «c risi del rapporto tra militari e politici» (M. M ERIGGI, Militari e istituzioni politiche nell'età giolittiana , art. cit., p. 66) e al «carattere di corpo separato» (G. ROCHAT-0. M ASSOSRJO, Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943, Einaudi, Torino I 978, p. 152) che l'esercito avrebbe assunto nell'età giolittiana, ma dicono anche che Giolitti «vedeva la necess ità di predisporre un esercito efficien te e moderno» (J. WH1TTAM, Storia dell'esercito italiano, Rizzoli, Milano 1979, p. 221). Si tratta però di valutazioni espresse in opere non basate su approfondite ricerche documentarie. Si veda, per un bilancio genera le degli studi, CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RICERCHE STORICO-M ILITARI (cur.), La storiografia militare italiana negli ultimi venti anni, Franco Angeli, Milano 1987.
Malgrado i progressi registrati dalla storiografia militare negli ultimi anni, sembra quasi che sulla s toria dell'esercito italiano nell'età giolittiana sia possibi l e solo enunciare formule generiche o fornire spunti critici, ma non compiere una concreta ricerca sull'effettivo svolgimento del pe riodo e sui problemi al tappeto. Di questo si rende co nto J. Gooch nel suo Army, State and Society in ltaly. 1870-1915, Macmillan, London 1989, quando scri ve: «In looking for broader trends as well as explaining panicular events I have found the literaturc of civilmi l itary rel ati ons useful in framing questions, but remarkabl y unhelpful in providing answers» (p. Xlii). Sul lavoro di Gooch si vedano le interessanti osservazioni di F M1 NNITI, // problema della arretratezza militare dell'ltalia unita. Note su (e da) un libro recente, in «Storia contemporanea» , anno XXII, n. 5, ottobre 1991, pp. 849-856.
8
li generale Paolo Spingardi
A questa documentazione ho affiancato gli Atti Parlamentari, fonte tanto invocata ma solo parzialmente utilizzata dagli studiosi Il grande rispetto che Spingardi aveva per le Camere e la coerenza con la quale teneva fede a quanto dichiarava fanno sì che le sue idee, i suoi obiettivi, i suoi criteri d'azione siano proficuamente deducibili dai resoconti parlametari. Inoltre le discussioni e le relazioni ai disegni di legge sono assai ricche di dati e notizie interessanti e utili. Nel corso della ricerca è emersa la necessità di integrare questa base documentaria con altri carteggi che meglio definissero i rapporti del Ministro s ia con i colleghi di governo, sia con le autorità militari che coadiuvarono la sua azione. Indispensabile complemento ai documenti già consultati sono perciò divenute la carte del generale Ugo Brusati all'Archivio Centrale dello Stato, a Roma. Ho potuto così ricostruire buona parte della corrispondenza intercorsa tra il Ministro e il Primo Aiutante di Campo di Vittorio Emanuele IIl, e con essa molti dei criteri direttivi della gestione dell'esercito nel 1909-1914. Per approfondire importanti questioni tecniche ho infine consultato il fondo Dallolio presso il Museo centrale del Risorgimento e parte dei numerosissimi fondi dell'Ufficio Storico dello Stato Ma ggiore dell'Esercito .

Da questa ampia documentazione si è ricavato che Paolo Spingardi elaborò un programma organico, ed ebbe il tempo e i mezzi finanziari per cercare di realizzarlo . Perciò lo si è analizzato a fondo, per comprendere gli obiettivi del Ministro, i suoi metodi, le sue sce lt e
L 'azione del Ministro, nell'arco del quinquennio, fu energica, incisiva, importante e toccò ogni campo dell'amministrazione militare : dall'ordinamento al reclutamento, all'avanzamento degli ufficiali, all'armamento
La sua opera, grazie anche all'intesa ch'eg li riuscì a instaurare e mantenere con il Re, con il governo, con lo Stato Maggiore, e con i vari collaboratori, trasformò profondamente l'esercito italiano . Egli la vorò cercando di portare lo strumento che aveva tra le mani all'altezza dei tempi, rendendosi conto della altrui corsa agli armamenti, ma ritenendo anche che l 'Italia non potesse spingersi ai livelli di Francia e Germania.
Il lavoro che segue credo riesca a spiegare come il programma militare di Spingardi tendesse a portare l'eserc ito italiano ad un livello di non inferiorità rispetto a quello dell'esercito comune dell'Austria-Ungheria e come esso poggiasse inoltre sopra una strateg ia difensiva, non solo perché non vi erano né il tempo, né il denaro per rendere il dispositivo militare italiano in grado di condurre una guerra offensiva, ma soprattutto perché in I talia la ragione politica non abdicò mai ai piani militari, come avvenne invece in Germania 8 • E tra il 1909 e il 1914 i politici italiani non avevano nessuna intenzione di combattere una guerra europea.
Introduzione 9
8 Cfr. G. RITTER, / militari e la politica nella Germania moderna, voi. I, Da Federico il Grande alla prima guerra mondiale, Einaudi, T o rin o 1967, pp. 491 e segg.
Si pie garono però a quella che considerarono una fatalità, e cioè la conquista della Libia, un'impresa che Spingardi, se avesse potuto, avrebbe volenti eri evitato. Del resto i militari dotati di senso di responsabilità sono i primi a desiderare che si ricorra a ll e armi il più tardi possibile, perché la preparazione di un esercito è un fatto dinamico, in perpetuo divenire, e non è mai compiuta quando la guerra scoppia.
Si è tentato di dare del conflitto libico l'immagine che ne ricevette Spingardi attraverso le testimonianze che gli giungevano e le opinioni e gli umori che comunicava a colleghi e collaboratori, politici e militari. Il capitolo dedicato alla guerra è stato dunque steso utilizzando soprattutto i documenti personali di Spingardi, che offrono una scansione quasi quotidiana degli avvenimenti. Questo può spiegare il limitato ricorso alla storiografia s ull'argomento.
Si è poi cercato di rilevare con precisione le ripercuss ioni della guerra su lla politica militare italiana. Indubbiamente dopo la Libia si nota una certa ansia di riparare i gu as ti, le vicende si sovrappongono e si accavallano, talvo lta si ripresentarono gli stessi problemi, come quello della for za bilanciata, su i quali Spingardi tornò a imp eg nar si alla ric erca di una so luzi one soddisfacente.
Nel complesso i criteri che ispirarono la politica militare in quegli anni so no emersi abbastanza chiaramente
Determinati gli aspetti finanziari, Gi oli tti lasciò al Ministro della Guerra la più ampia lib ertà nell'impostazione e nella realizzazione del programma militare. Il Pr esidente del Consiglio non av eva com p ete nza specifica in quel campo e mostrò generalmente completa fiducia in Spingardi.
Questi, del r esto, mostrò di possedere un senso della misura, un'attenzione costante a commisurare gli obiettivi ai mezzi disponibili, una fiducia nella perfettibilità delle istituzioni, una graduali tà nell'applicazione delle misure e un rifuggire da ogni estremis mo, ch e facevano di lui un uomo di governo in grado di sv olgere una politica militare di stampo liberale.
Passando a considerazioni più generali, non si può mancare di sott olineare l'influenza del R e, che assumeva il carattere di un vero e proprio intervento concreto nel campo delle promozioni ai gradi più elevati, documentato in maniera inequivo ca bile. Vittorio Emanuele riuscì però ad agire sempre con grande tatto ed estrema discrezione .
Sul problema della dife sa nazionale si saldava ogni incrinatura della classe dirigent e: le brillanti votazioni ottenute dai disegni di legge Spingardi e le discussioni parlamentari testimoniano come solo i soc ialisti, nel 1909- 1914 almeno, fossero all'apparenza insensibili al problema militare. Ma anche loro votarono per il Ministro in una importante occasione, l'ado-
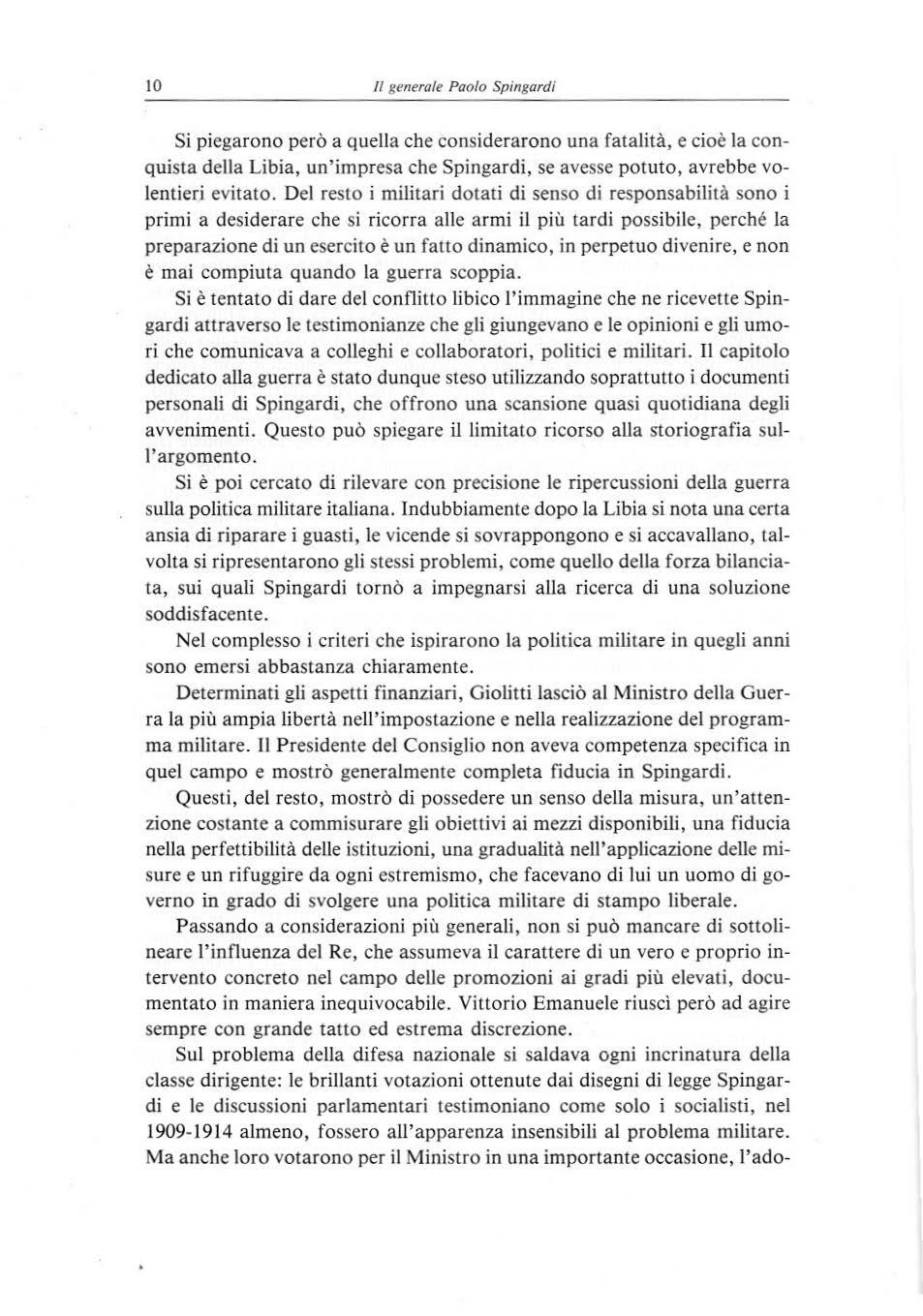
IO li generale Paolo Spingardi
zione della ferma biennale, perché pareva ispirata anche a criteri di equità sociale .
Rimangono comunque alcuni punti non del tutto chiariti. Non è stato possibile approfondire i rapporti tra il Ministero de11la Guerra e l'industria privata, per definire nei particolari il ruolo da questa assunto nella politica d elle commesse militari Anche a livello di semp li ce narrazione degli avvenimenti tecnici, comunque, solo una ricerca specifica potrà districare il complicato intreccio forniture-ordinamento - mobilitazione dell'artig li eria.
Usando una formula riassuntiva, si può dire c h e gli ingredienti della politica militare condotta in quegli anni furono equilibrio, buon senso e pragmatismo. L'esercito italiano raggiunse un apprezzabile grado di efficienza, tale da permettere di sostenere l'impegnativo sforzo della guerra di Libia e di conservare ugualmente basi adeguate per un eve n tuale ampliamento. In tutto ciò, i meriti ascrivibili alla persona di Paolo Spingardi non furono trascurabili.
Eppure eg li venne ugualmente messo <<alla gogna» durante l a po lemica militare 9 e non ebbe neanche la soddisfazione di vedere vittorioso in una grande guerra l'esercito per il quale aveva prodigato l'in tera esistenza, poiché si spense il 22 settembre 1918.
Federico Cha bod ha scritto che
In una determinata situazione, l'opera del si ngolo uomo d i Stato interviene sempre incidendo sul corso degli eventi( ) facendo sì che nella situazione ch'egli lascerà ai suoi successori rimanga impre ss a anche la sua orsa, maggiore o minore, questo è di volta in volta il segreto della storia 10 •
Dunque, anche se una storia della politica militare italiana nell'età giolittiana è ancora da scrivere, spero di avere, se non altro, rilevato l'orma che vi ha lasciato Paolo Spingardi.
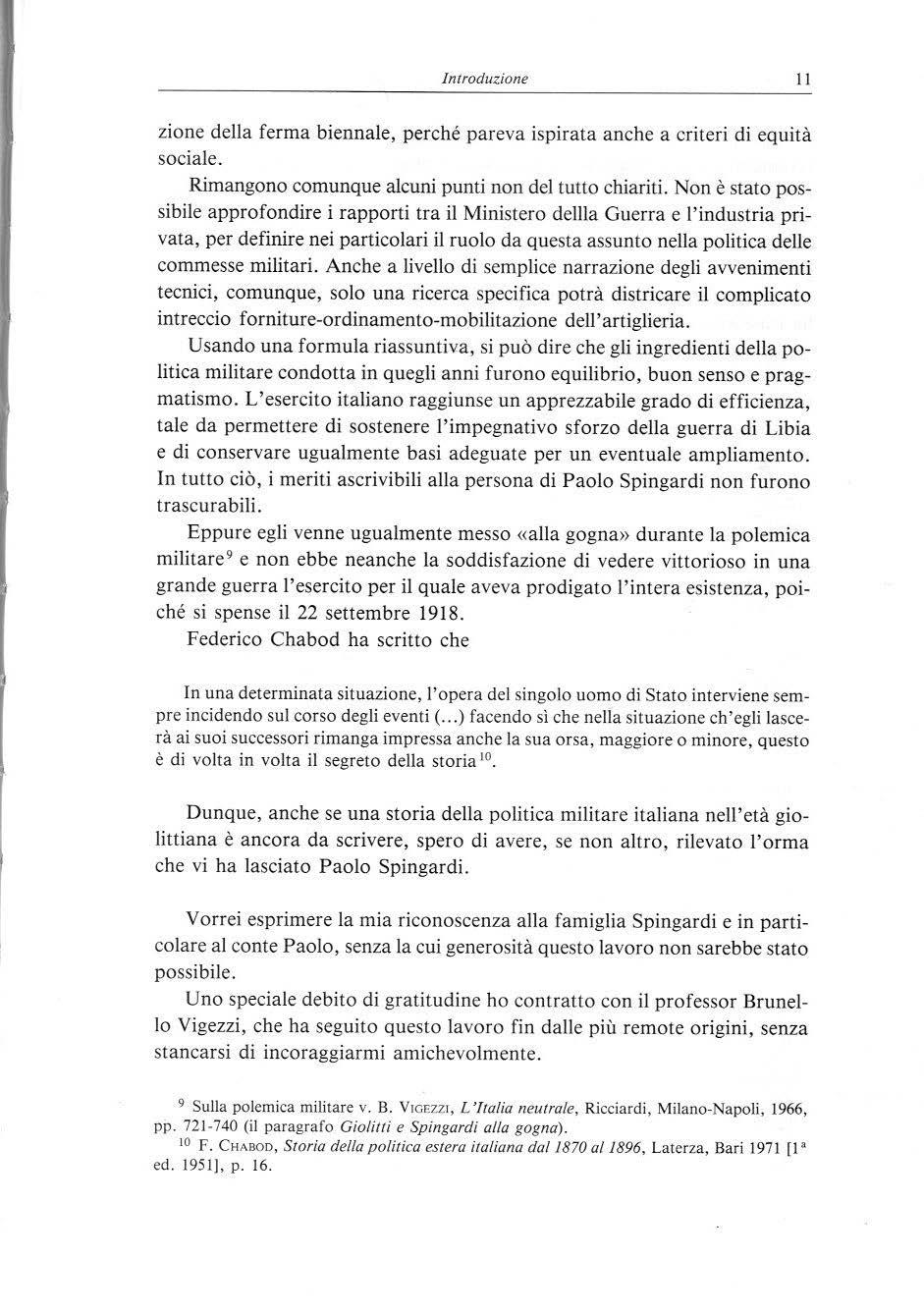
Vorrei esprimere la mia riconoscenza alla famiglia Spingardi e in partico lare al conte Paolo , senza la cui generosità questo lavoro non sarebbe stato possibile.
Uno speciale debito di gratitudine ho contratto con il professo r Brunello Vigezzi, che ha seguito questo lavoro fin dalle più remote orig ini , senza stancarsi di incoraggiarmi amichevo l mente
9 Sulla polemica militare v B. V 10 E12 r, L'Italia neutrale, Ricciardi, Mi lano-Napoli, 1966, pp. 721 -740 (i l parag ra fo Giolilfi e Spingardi alla gogna)
1° F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Later za, Bari 1971 [P ed . 1951). p. 16.
lniroduzione Il
Tra quanti mi hanno aiutato nel corso delle ricerche, e che ringrazio vivamente, vorrei ricordare il professor Antonello Biagini e il professor Lucio Ceva, che sono stati prodighi di preziosi consigli, il dottor Antonio Brugioni dell'Archivio de ll'Uffi cio Storico dello Stato Mag giore dell'E se rcito e il dottor Alberto Maria Arpino del Museo Centrale del Risorgimento.
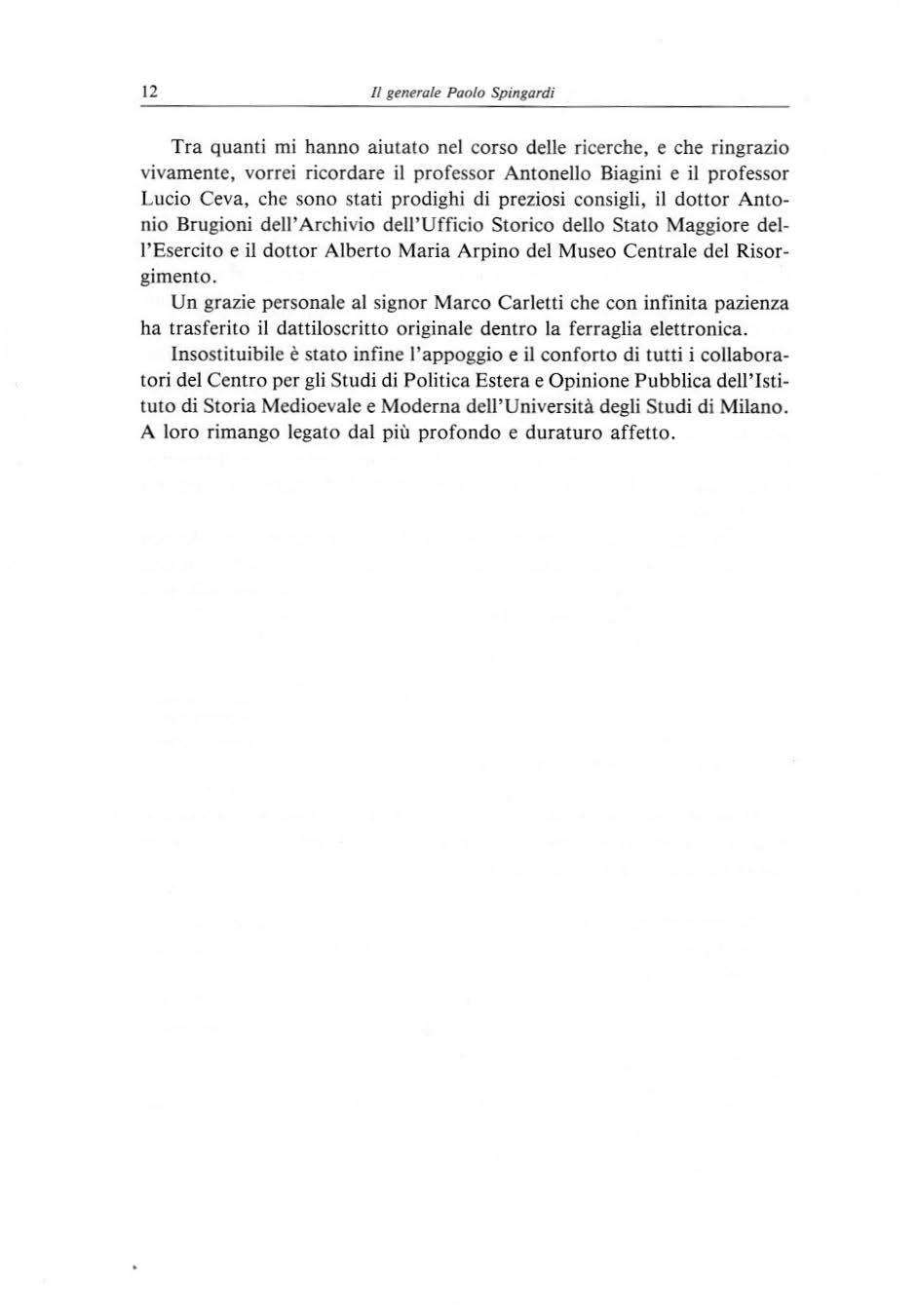
Un g razie personale al signor Marc o Carletti che con infinita pazienza ha trasferito il dattiloscritto originale dentro la ferraglia elettronica .
Inso stituibil e è stato infin e l'appoggio e il co nforto di tutti i collaboratori del Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica dell'Istituto di Sto ria Medioevale e Moderna dell'Università degli Studi d i Milano. A loro rimango legato dal più profondo e duraturo affetto.
12 li genero/e Paolo Spingordi
CAPITOLO I
PAOLO SPINGARDI: UN MINISTRO DELLA GUERRA LIBERALE?
L'esercito italiano nell'età giolittiana
Il disastro di Adua, oltre a decretare la fine politica di Francesco Crispi e dei suoi sogni imperialisti, gettò gravi ombre sulle capacità dei militari e ne mise in discussione il ruolo in una società all'interno della quale la loro immagine non aveva per la verità mai goduto di grande prestigio Cominciava così uno dei periodi più critici nella storia dell'esercito italiano.
«Per ricostituire l'esercito quasi in d issoluzione» 1, venne allora nominato Ministro della Guerra il competente generale Cesare Ricotti Magnani, che aveva già ricoperto la carica dal 1870 al 1876 e dal 1884 al 1887 : egjj progettò di ridurre le unità organiche senza diminuire il numero complessivo di uomini incorporati, al fine di rendere la struttura dell'esercito compatibile con le esigenze finanziarie senza me nomarne l'efficienza . Ma l'opposizione di Umberto I indu sse il generale a dimettersi2 .
Gli successe il generale Luigi P elloux, che , dovendo conservare una strut-
1 F. DE CriA URAND DE SAINT E usTACHE , Come l'esercito italiano e n t rò in guerra , Monda dori, Milano 1929, p . 19, che ha comunque la tendenza a calcare un poco le tinte .
2 Sulla vicenda V. M1N1 STEROOELLAGUERRA • COMANDO DEL COR PODI STATO MAGGIORE· UFfJ c10 StoR1co, L'esercito italiano nella grande guerra (1915 - 1918), volume I , Le forze belligeranti (Narrazione) (d'ora in poi Relazione Ufficiale), p. 7 , sintetica e neutrale; DE CHA URANO , op . cit., pp. 19-20, per un racco nto più amp io anche se talvolta im preciso; G . ROCHAT, L 'esercito italiano nell'estate del 1914, in « Nuova Ri vista Sto r ica», 1961, n ° 2, pp . 298-299, riprende De Chaurand; il rac.conto più am pio e documenta to risulta quello di G. MANACORDA, nell'introdu zione a L. PEL Loux , Que/ques souvenirs de ma vie, Ist it uto per la Storia del Risorgimen to, Roma 1967 , pp. xxxm.xxxvm . V. anche G. CMIDELO RO, Storia dell'Italia Moderna, voi. VII , La cris i di fine secolo e l 'età giolittiana (1896- 1914), Feltrinelli, Milano 1974, pp. 23-24, come sempre nitido e preciso; J. WH1ITAM, Storia dell'esercito ita liano , Rizzoli, M ilano 1979, pp. 205 - 207 . G . RoCHAT e G. MASSOBRIO in Breve sroria dell'esercito italiano dal 1861 al 1943 , Einaudi, Torino 1978, alle pp. 128-130 e nelle note dalla 3 alla 6 alle pp . 142- 143, offrono valu tazioni più personali e in teress an ti , anche se non sempre equilibrate; più m isurate le riflessioni di L. CEVA in L e forze armate, UTET, Torino 1981 , pp. 94-95; infine J. GoocH in Army, State and Society in Jtaly, 1870-1915 , Macmi llan, London 1989, pp. 98-100, aggiunge nuovi particolari che però non a lt e ran o la sostanza del discorso .
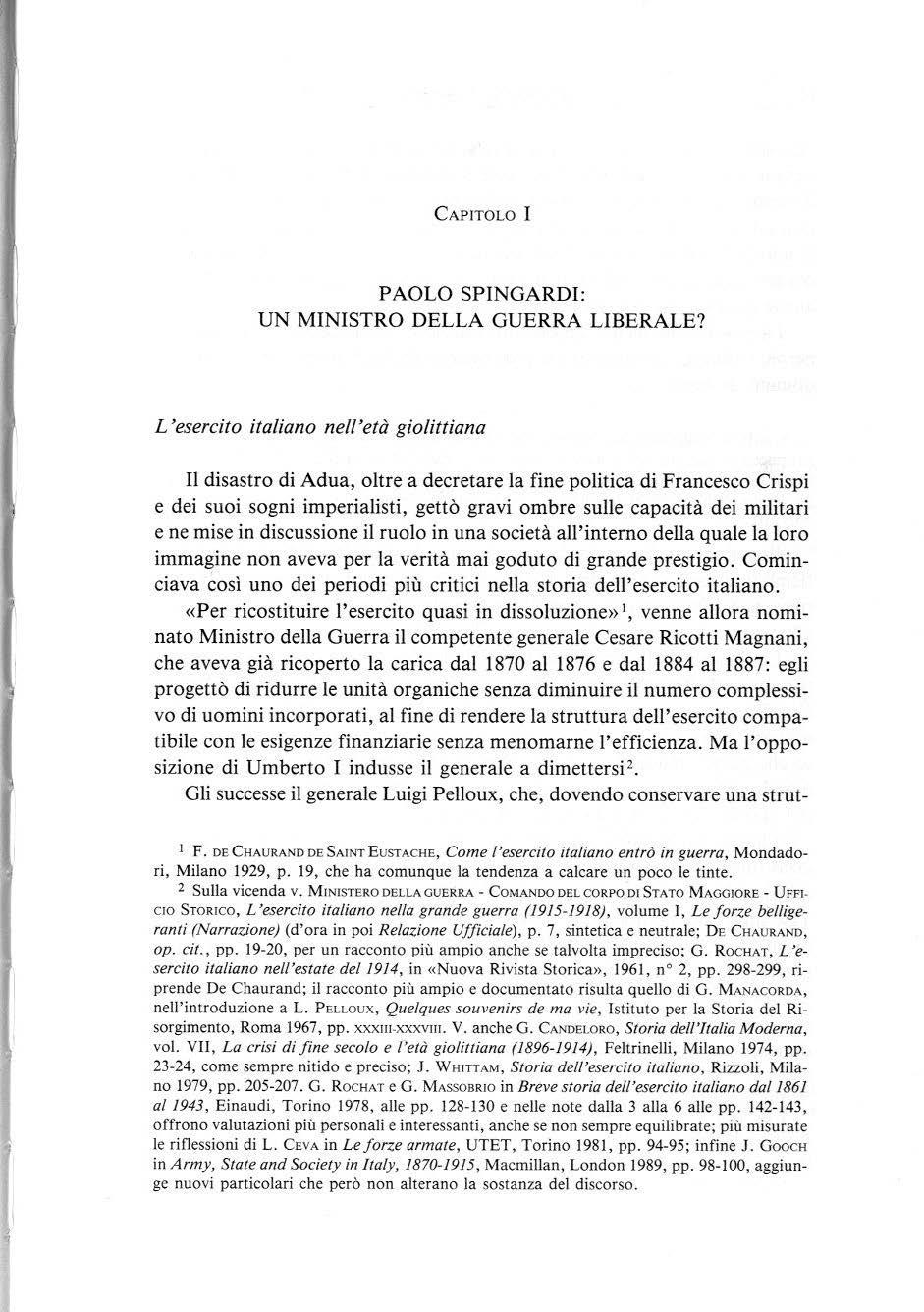
tura sulla quale la Corte non era disposta a transigere, e allo stesso tempo rimanere nei limiti del bilancio, ricorse a una serie di espedienti, il più noto dei quali fu il cosiddetto periodo «della forza minima», per cui si congedava a ottobre la classe anziana e si aspettava la primavera prima di chiamare la nuova classe. In questo modo, per diversi mesi dell'anno, i reparti rimanevano isc heletriti, inadatti non solo a compiere operazioni di guerra, ma anche qualsivoglia istruzione 3 •
La crisi di fine secolo aggravò la situazione accentuando il moto di generale sfiducia nell'esercito già manifestato dall'opinione pubblica all'indomani di Adua:
L'intera compagine era scossa dalla campagna antimilitarista che era di lagata nel paese e logorata nel morale dai frequent i interventi in operazioni di ordine pubblico. L'esercito italiano, su cui gravava il peso della sc onfi tt a africana, era ben lungi da essere nelle mig liori condizioni sia morali che materiali 4 •
Contemporaneamente si faceva sempre più critica la condizione degli ufficiali inferiori, a causa dei bassi stipendi e dell'estrema lentezza delle carriere, generando un diffuso malcontento che non giovava alla disciplina e allo spirito di corpo .
La sinistra ]jberale di Zanardelli e Giolitti salì al potere con una connotazione esplicitamente contrastante con la politica reazionaria di cui l'esercito era stato strumento e non esordì quindi con un aumento delle spese militari. La svolta liberale all'inizio del secolo non coinvo lse perciò l'esercito che parve chiudersi su sé stesso, perdendo sempre più i contatti con il mondo politico e la società civile. La tendenza fu in qualche modo favorita dal cosiddetto «co nsolidamento» del bilanc io 5 •
Varato con la legge 5 maggio 1901 n. 151, attuato a partire dall'esercizio finanziario che cominciava col I O luglio 190 l, esso assicurava all' amministrazione militare un tetto di 275 milioni di spese per ogni esercizio. Tal e stanziamento non poteva essere superato, ma nella gestione della somma il Ministero godeva d ella più ampia autonomia : la cifra concessa era prefissata, ma vi si potevano aggiungere i proventi delle alienazioni di aree, fab bricati e materiali militari e i ricavi di ogni economia che si fosse riuscit i a realizzare all'interno d e ll'ammini st razione della guerra. Il provvedimento «doveva garantire il governo da intempestive richieste di nuovi
3 Sulle economie di Pelloux v . CEVA, Le forze armate, cit. , p . 96.
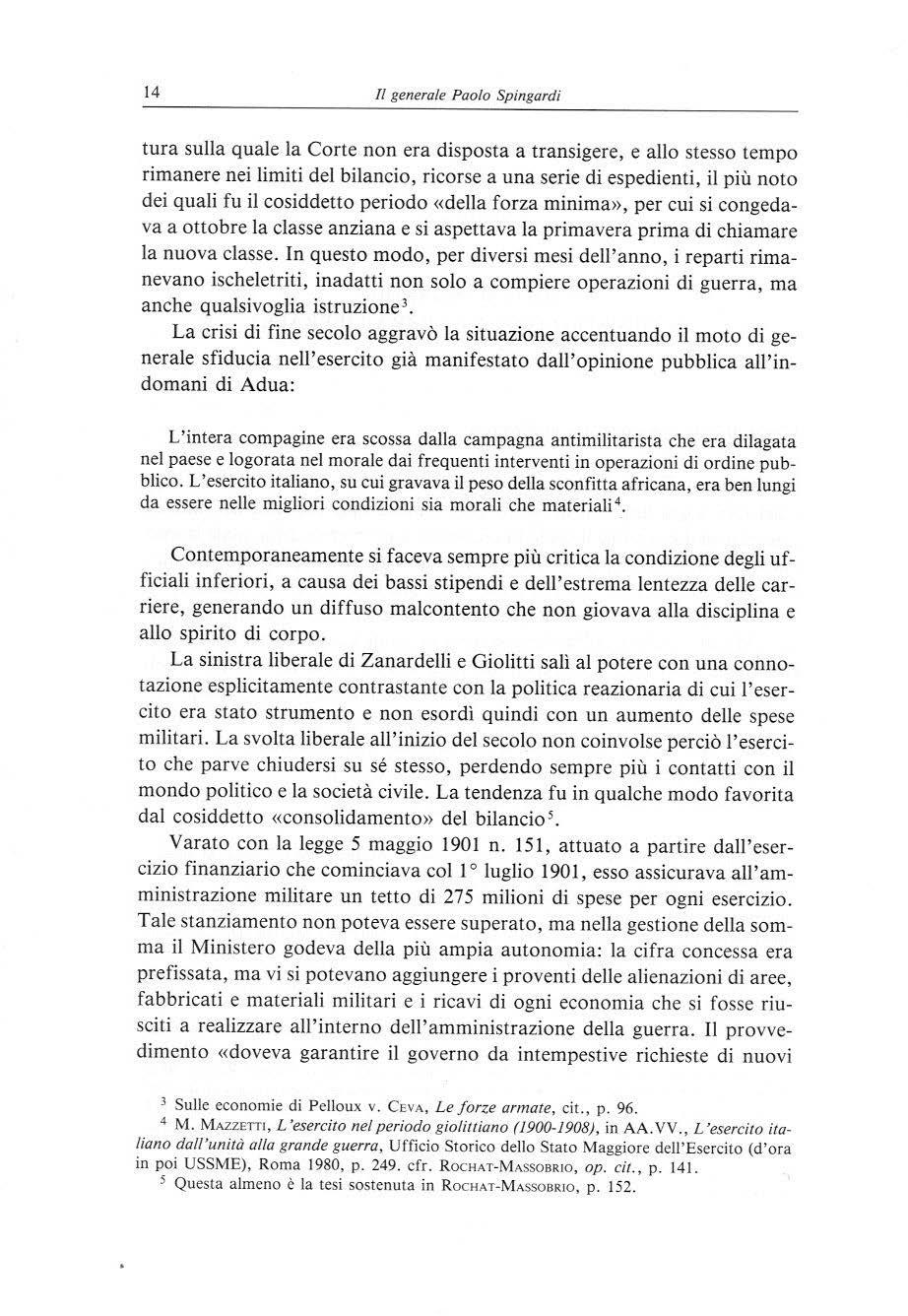
4 M. MA ZZETTI, L'esercito nel periodo giolilliano (1900 -1908), in AA. VV ., L'esercii o italiano da/l'unilà alla grande guerra, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Eserc i to (d'ora in poi USSME), Roma 1980, p. 249 cfr. RocHAT- M ASSOB RIO, op. cit , p. 141.
5 Questa almeno è la tesi sost enuta in RocHAT- MASSO BRIO, p 152
14 li
generale Paolo Spingardi
Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 15
impopolari stanziamenti, e le amministrazioni militari dalle ingerenze politiche» 6 ma di fatto
accentuò la sproporzione tra i mezzi assegnati al bilancio della g uerra e gli organici esistent i , tantoché ogni anno nel parlamento si udiva ripetere il dilemma: o aumentare i primi o diminuire i secondi 7 •
La sorta di paralisi che caratterizzava l'esercito all'aprirsi del nuovo secolo sembrava trovare un esempio nei lunghissimi tempi impiegati per riequipaggiare l'artiglieria da campagna malgrado le maggiori potenze avessero già felicemente avviato a soluzione il problema 8 •
Nel 1906, lo stesso anno in cui si tentava di risolvere quest'ultima questione sottoscrivendo un contratto con la casa tedesca Krupp, una nuova nube compariva sull ' inquieto orizzonte dell'esercito italiano. In AustriaUngheria veniva nominato capo d i Stato Maggior e dell'esercito l'italofobo Conrad von Hoet zendorf. Egli «si sentiva investito di una missione, quella di salvare la duplice monarchia, e per far questo riteneva assolutamente indispensabile intraprendere due guerre preventive: l'una contro la Serbia e il Montenegro, l'altra contro l'Italia» 9 e perciò
si mise tenacemente all'opera per ovviare alle deficienze dell'apparato militare austroungarico, con il confessato proposito di venire quanto prima ad un regolamen to di conti con l'Italia 10 .
Il 6 aprile 1907 egli presentava all'Imperatore il primo di diversi promemoria nei quali proponeva una guerra preventiva contro l'Italia 11
G li orientamenti ostili di Conrad non sfuggirono alle autorità militari italiane 12 Ma queste non sarebbero state in grado di imporre al governo i loro orientamenti; se qualcosa camb iò fu perché alcuni uomini politici si resero conto del potenziale pericolo, tanto che il Ministro degli Esteri, Tittoni,
6 Ibidem.
7 A. CAvA c 1occ H1-F. SANTAN GE LO, Istituzioni militari italiane, Scuola di Guerra, To r ino 1910, p. 23.
8 Cfr. Gooc H, Army, State and Society, c it., pp. 119- 120.
9 MAZZEIT J, L'esercito italiano nella triplice alleanza, ES!, Napo li 1974, p. 224.
10 Ibidem , p. 225. Sulla questione gli autori sono genera lmente concordi. Cfr. DE CHA URAND , cit., pp. 40-41; C. SEToN-WATSON, L'Italia dal liberalismo al fascismo, Laterza, Bari 1967, pp. 399-400; WH 11TAM , p. 237; F. STEFANI , La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'esercito italiano , voi. I, USSME , Roma 1984, p. 531; GoocH, p. 127.
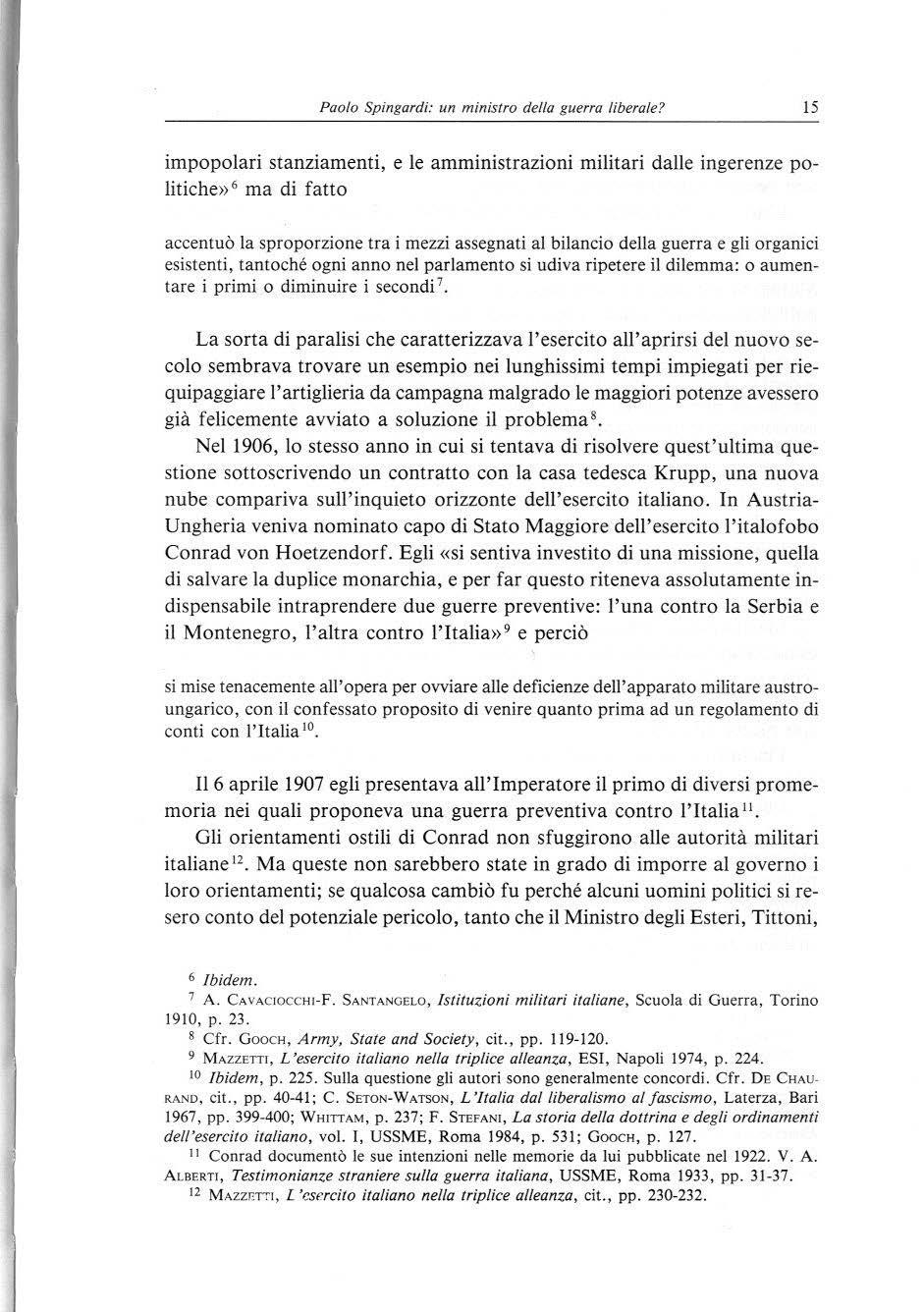
11 Conrad documentò le sue intenzioni nelle memorie da lui pubblicate nel 1922. V. A.
A L BERTI, Testimonianze straniere sulla guerra italiana, USSME, Roma 1933, pp. 31-37.
12 MA ZZJZTT1, L'esercito italiano nella triplice alleanza, cit., pp . 230-232
Il generale Paolo Spingardi
« fece sapere di essere favorevole a qualsiasi provvedimento militare purc hé non ve ni sse data pubblicità alla cosa» 13 •
L ' accordo t ra militari e politici non è però sufficiente a ristrutturar e un ese rcito , se manca il denaro. Ma anche le ri serve di indole finanziaria parvero risol versi il 29 gi ug no 1906 , quando il Ministro delle Finanze Angelo Majorana annunciava alla Camera la conversione della rendita del debito pubblico, sa pientemente preparata da Luigi Lu zzatti.
Dalle tribune del pubblico (... ) si levò un'ovazione, mentre i deputati di tutte le par ti si abbracciavano nell'emiciclo. L'incubo del dissesto finanziario , che aveva gravato sui primi anni di vita dello Stato unitario e che era ritornato a profilarsi nei g iorni oscu ri degli scandali bancari a catena, era definitivamente fugato e l 'Italia prendeva coscienza della sua incipiente prosperità 14
Negli anni successivi «il ministro delle Finanze ebbe a s ua disposizione un notevole avanzo con cui soddisfare appetiti che per d ece nni non e rano stati saziati» 15 , non ultimo qu ello della forza militare. Da quel momento le s pese per l 'esercit o cominci arono ad aumentare sensib ilm e nte in conness ione con i primi concreti provv ed imenti per un suo rafforzamento.
Ma era pas sato oltre un decennio senz a che alcun programma organico avess e a vuto modo di esse r e realizzato. I num erosi ministri che si succedettero « non poterono svolgere una attività particolarmente incisiva, do ve ndo limitare la loro azione es senzialmente a migliorare la struttura dell'e se rcito co n piccoli ritocchi» 16 •
Finalmente, nel corso del 1907, ve nnero varati alcuni provvedimenti c he ponevano le basi per un co nc reto svil uppo dell' appara to mi litare.
I bisogni dell'esercito e l'amministrazione de l suo bilancio erano divenuti
argom en to di discussioni sempre più vive in Parl amento e sulla stamp a militare e politica; non mancò qualche accenno di accusa relativa allo sperpero del pubblico denaro, cosicché il mini stero Giolitti decise di nominare una commissione par la mentare con l 'incarico di indagare tutto quanto concerne l 'organizzazio ne e l'amministrazione dei servizi dipendenti dal ministero della guerra 17 •
13 MAZZE'ITI, L'esercito nel periodo giofìlliano, cit., p. 254.
14 G . PROCACC I, Storia degli italiani, ed. Pugliese , Palermo 1971, p. 802 .
15 SETON-WATSON, op. cit., p. 303.
16 MAzzETTt, L'esercito nel periodo gioliuiano, cit. , p . 250. Gli sludiosi sono con cordi nel collocare nel 1907 una sorta d i s partiacqu e dell'età giolittiana, dal punto di vista della storia dell'esercito. Cfr. P . DEL N EO RO, La leva militare in Italia dall'unità alla grande guerra, in Esercito, Stato e Società, Cappelli, Bologna 1979 , p. 221; WHITIAM, cit., p. 237; F. M1 NN rT1, Esercit o e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, Bonacci, R oma 1984, p. 192; V. CACIULLI , L'amministrazione della guerra, l'esercito e la commissione d'inchiesta del 1907, in « Fares toria», anno V (1985), n. 2, p. 7.
17 CAVACIOCC HI-SANTANOELO , Cit., p. 23

16
Paolo Spinga rdi: un ministro della guerra liberale? 17
La Commissione d'inchiesta per l'esercito venne istituita con legge 6 giugno 1907 n. 287 e proseguì i suoi lavori per tre anni, compilando otto relazioni, l'ultima delle quali venne pubblicata il 30 giugno 1910 . Nominata col compito di «valutare le effettive necessità dell'esercito e riformarne l'ordinamento», la Commissione mise in luce notevoli deficienze nell'assetto difensivo delle frontiere , nel ri equipaggiamento dell'artiglieria e nelle carriere degli ufficiali, finendo così per «determinare le esigenze della difesa nazionale, indipendentemente dalla loro portata finanziaria» 18 •
Con la legge 14 luglio 1907 n. 496, poi, fu autorizzato un aumento degli stanziament i straordinari per 60 milioni, ripartiti in quattro esercizi finanziari, ponendo così fine al bilancio consolidato .
In dicembre venne varata una nuova legge sul reclutamento che «concorse molto al consolidamento delle istituzioni militari» 19 • Il provvedimento avrebbe consentito di incorporare un maggior numero di iscritti alle liste di leva, prima esonerati per motivi di famiglia. In virtù dell'espediente della forza minima, solo nei periodi di forza massima i soldati presenti alle armi erano pari alla forza bilanciata. Ma negli ultimi tempi, per effetto della povertà del contingente di leva, anche nei periodi di forza massima la forza media presente si era mantenuta molto inferiore a quella bilanciata. La legge 15 dicembre 1907 n. 763 permetteva, una volta attuata, non solo di mantenere per tutto il tempo dell'anno la forza bilanciata, ma anche di aumentarla all'occorrenza 20 •
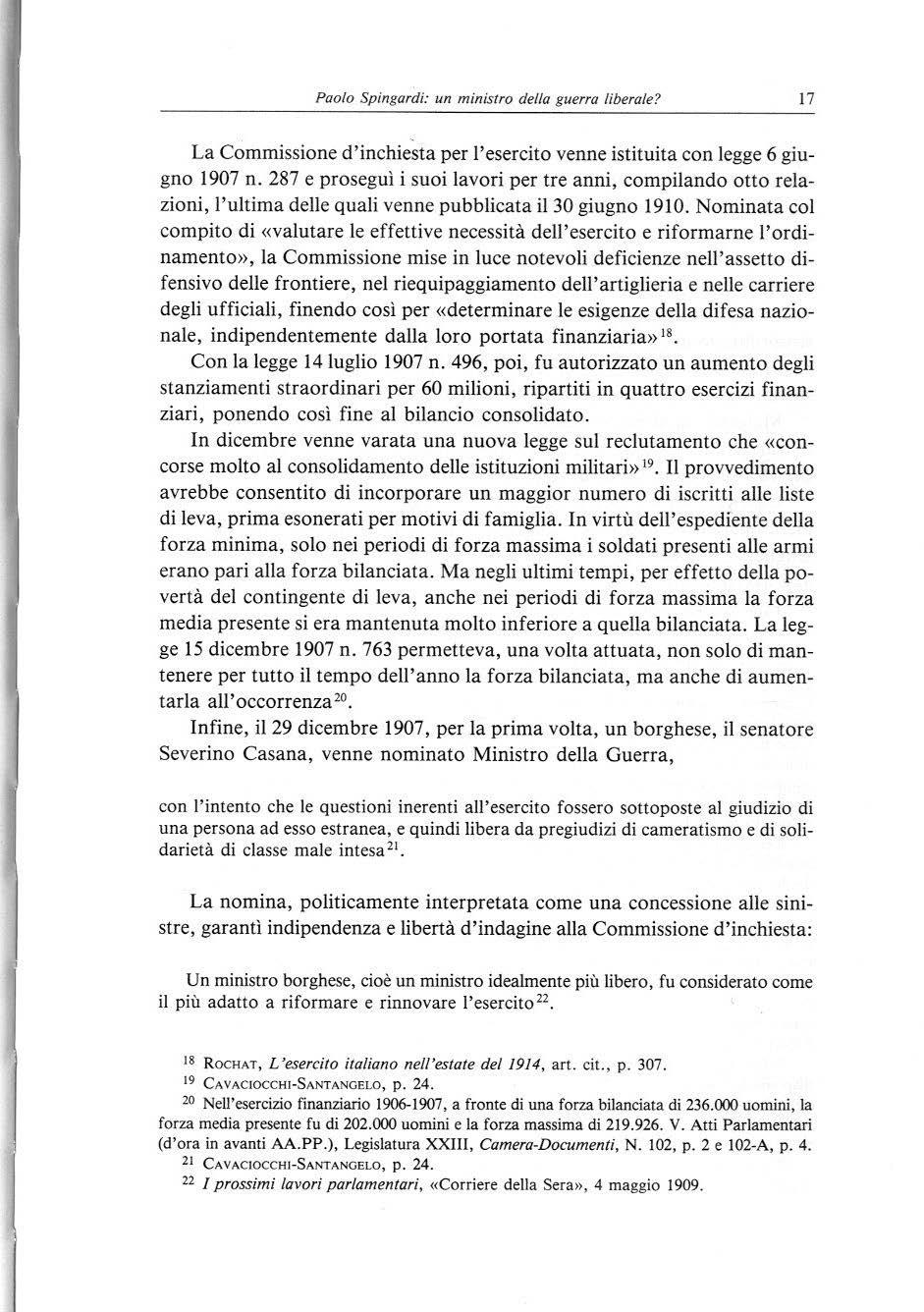
Infine, il 29 dicembre 1907, per la prima volta, un borghese, il senatore Severino Casana, venne nominato Ministro della Guerra,
con l'intento che le q ue st ioni inerenti all'esercito fossero sottoposte al giudizio di una persona ad esso estranea, e quindi libera da pregiudizi di cameratismo e di solidarietà di classe male intesa 21 •
La nomina, politicamente interpretata come una concessione alle sinistre, garantì indipendenza e libertà d'indagine alla Commissione d'inchiesta:
Un ministro borghese, cioè un ministro idealmente più libero, fu considerato come il più ada tto a riformare e rinnovare l'esercito 22
18 RocHAT, L'esercito italiano nell'estate del 1914, art. cit., p. 307.
l9 CAVAClOCCHI-SANTANGELO, p. 24.
20 Nell'esercizio finanziario 1906-1907, a fronte di una forza bilancia ta di 236.000 uomini, la forza media presente fu di 202.000 uomini e la forza massim a d i 219.926. V. Atti Parlamentari (d'ora in avanti AA.PP.), Legislatura XXIII, Camera-Documenti, N. 102, p. 2 e 102-A, p 4.
2l CAVACIOCCH I-SANTANGELO , p , 24.
22 I prossimi lavori parlamentari, « Corriere della Sera», 4 maggio 1909.
Il 1908 cominciò con queste premesse. Casana si sforzò di rendere più fluidi i rapporti tra militari e politici, riplasmando la Commissione Suprema Mista per la Dife sa dello Stato e le funzioni del Capo di Stato Ma gg iore e creando il Consiglio dell'esercito, tre istituzioni che permettevano nel complesso di assicurare co ntinuità d'indirizzo alla politica militare e costituire un sicuro punto di riferimento anche per un ministro non tecnico 23 •
La legge 5 luglio 1908, n . 361 concesse poi un ulteriore stanziamento st raordinario di 223 milioni ripartiti fra i vari esercizi fino al l 916 -17. Non so lo l'era del consolidamento era definitivamente tramontata, ma i fondi stavano diventando sempre più consistenti.
Malgrado qualche polemica 24, l'esercito sembrava avviarsi con una certa tranquillità verso un sistematico riordinamento e una graduale soluzione dei vari problemi che lo affliggevano.
Casana si stava impegnando nella formulazione di un programma organico, quando l'annessione della Bosnia-Erzegovina da parte dell'Austr iaUngheria, nell'ottobre del 1908, impresse una brusca e inaspettata svolta agli avvenimenti 25 •
Fino a quel momento l'Italia si se ntiva garantita in ogni direzione, spe-
2,3 La Commissione suprema mista per la difesa dello stato era un organo consultivo creato nel 1899 per trattare le più importanti questioni relative all'assetto difensivo del territorio. Co mposta inizia lmente di soli militari, con la riforma di Casana la commissione venne a comprendere: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Guerra, Ministro della Marina, Capo di S .M dell'Esercito, Capo di S.M della Marina , i 4 generali comandanti designati di armata, i 4 ammiragli comandanti designati di forza navale, S.A.R. il Duca di Genova. La co mmissione avrebbe dovuto riunirsi una volta all'anno , ma dopo il 1908 venne convocata nuovamente so lo nel maggio 1913. V. Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (d'ora in poi AU SSME) F. 9, Commissioni difesa, Racc. 1bis.
Il consiglio dell'esercito era composto da: Ministro della Guerra, sottosegretario di Stato alla Guerra , Capo di S.M. dell'Esercito, i 4 generali comandanti designati d'armata; a seconda dei casi potevano venire ch iamati a farne parte gli ispettori generali delle varie armi. La periodicità delle convocazioni era di tre volte l'anno.
Sulla nascita della carica di capo di Stato Maggiore nel 1882 e i decreti 4 marzo 1906 n. 86 e 5 marzo 1908 n. 77 che ne riplasmarono le attribuzioni v. STEFANt, cit., pp. 310-314; CEVA, Ministro e Capo di Stato Maggiore, in« uova Amologia», a. 121, o. 2160, 1986, pp. 112- 136 e idem, Capo di Stato Maggiore e politica esrera al principio del secolo, in «Il Politico», marzo 1987, pp. 123-135. Per le altre istituzioni vedi Relaz ione ufficiale, p. IO e note 6 e 14 alle pp. 48 e 50; CAVA CIOC CIII -SAN TANG ELO , pp. 59-60; CAC'IULU, art. cit., pp. 316-317.
24 La più nota fu il cosiddetto caso Rogier- Mangiagalli, derivato dalla collocazione in disponibilità dei due generali ritenuti responsabili dei ritardi nel riequipaggiamento dell'artiglieria campale. Per i particolari v D ECHAU RANO, pp. 111-112; CACtULl.l, pp. 327-333; M. M ER IGGI, Militari e istituzioni politiche nell'età giolittiana, in «Clio», anno XXIII (1987), n. I, pp. 76-80.
25 Sulla crisi internazionale seguita all'annessione della Bosnia v. A. D uCE, La crisi bosniaca del 1908, Giuffrè, Milano 1977.
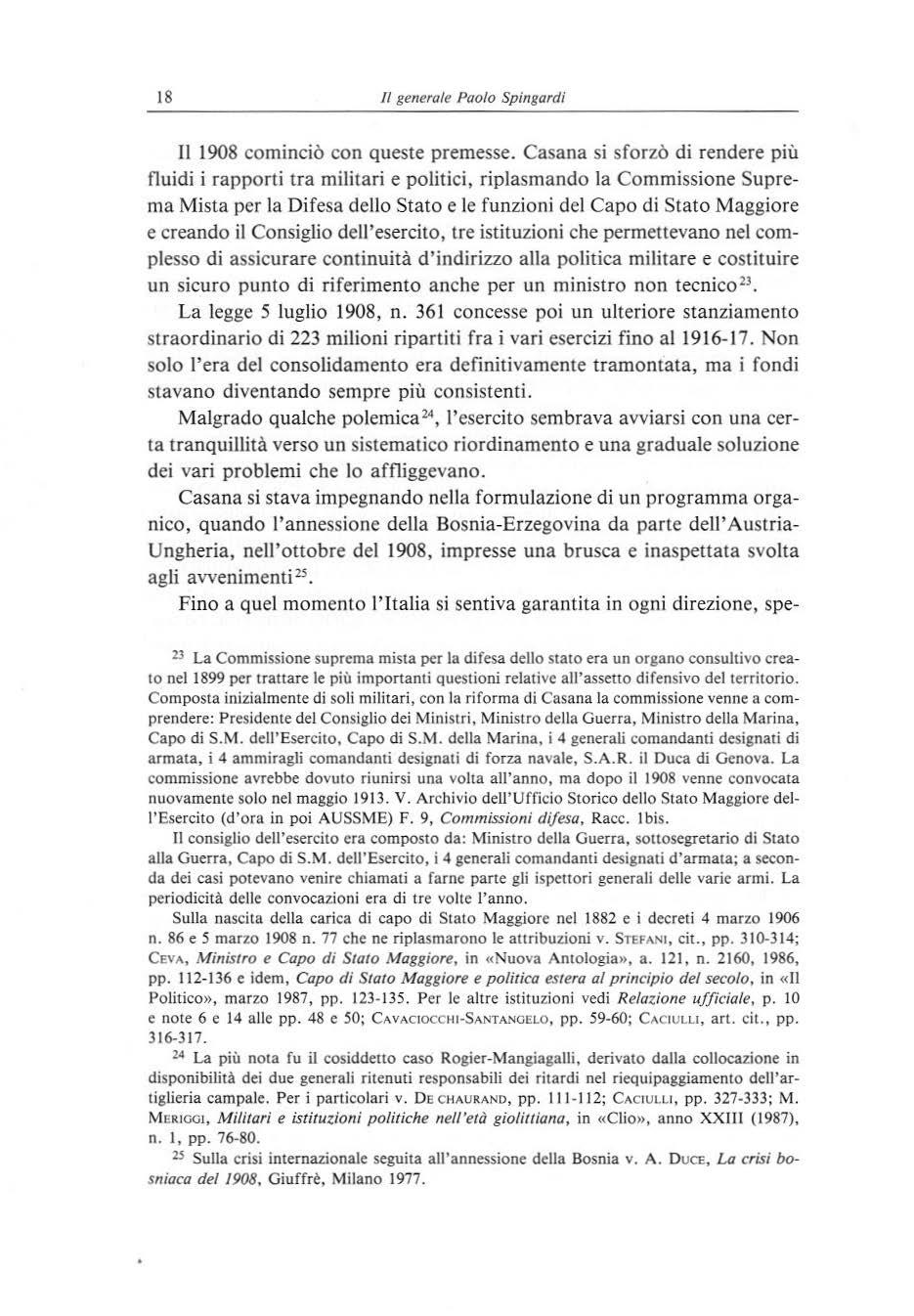
18
li generale Paolo Spingardi
Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 19
cialmente dopo il riavvicinamento alla Francia e la nota inglese del 1902, stante la formale solidità della Triplice Alleanza, rinnovata anch'essa quell'anno26 .
Nello stesso tempo, la scarsa affida bilità bellica dell'alleata poteva sconsigliare Germania e Austria -Ungher ia dallo scatenare un conflitto europeo 21 .
Non è da escludere che anche considerazioni di qu esto tenore abbiano indotto a trascurare lo strumento militare nei pr im i anni de l secolo. Ma poiché la crisi bosniaca chiarì che a Vienna poco importava de ll a posizione italiana , anche l'ultima eventuale remora veniva a cadere: la stessa disinvo ltura mostrata nell'incorporarsi la Bosnia, la D uplice Monarchia avrebbe potuto usare per una aggressione nei confronti dell'Ita lia 2 8 • E in tal caso il paese non sarebbe stato in grado di difendersi .
Ad aggravare ulteriormente la situazione giunse, nel dicembre del 1908, il terremoto di Messina e Reggio Calabria. Esso ebbe effetti negativi anche sull'esercito, intaccandone profondamente i magazzini e sconvolgendone l'organizzazione logistica per l'opera di soccorso prestata alle popolaz ioni
colpite:
Dai magazzini militari( ) esistenti in Calabria e Sicili a furono tolte tutte le provviste di gallette d i viveri di ri serva( ) Il Ministero della guerra ha poi fatto trasmettere due mi li on i e mezzo di scato le di carne e razioni di galletta, più centomila tra coperte, lenzuola e pagliericci, cucine da campo, forni da campagna e venti ospedali con tutte le suppellettili e i materiali di mobilitazione ( )Tutto ciò fu fatto per
26 Cfr. MAZZETTI, L'esercito nel periodo giolittiano (1900-1908), cit., p. 250.
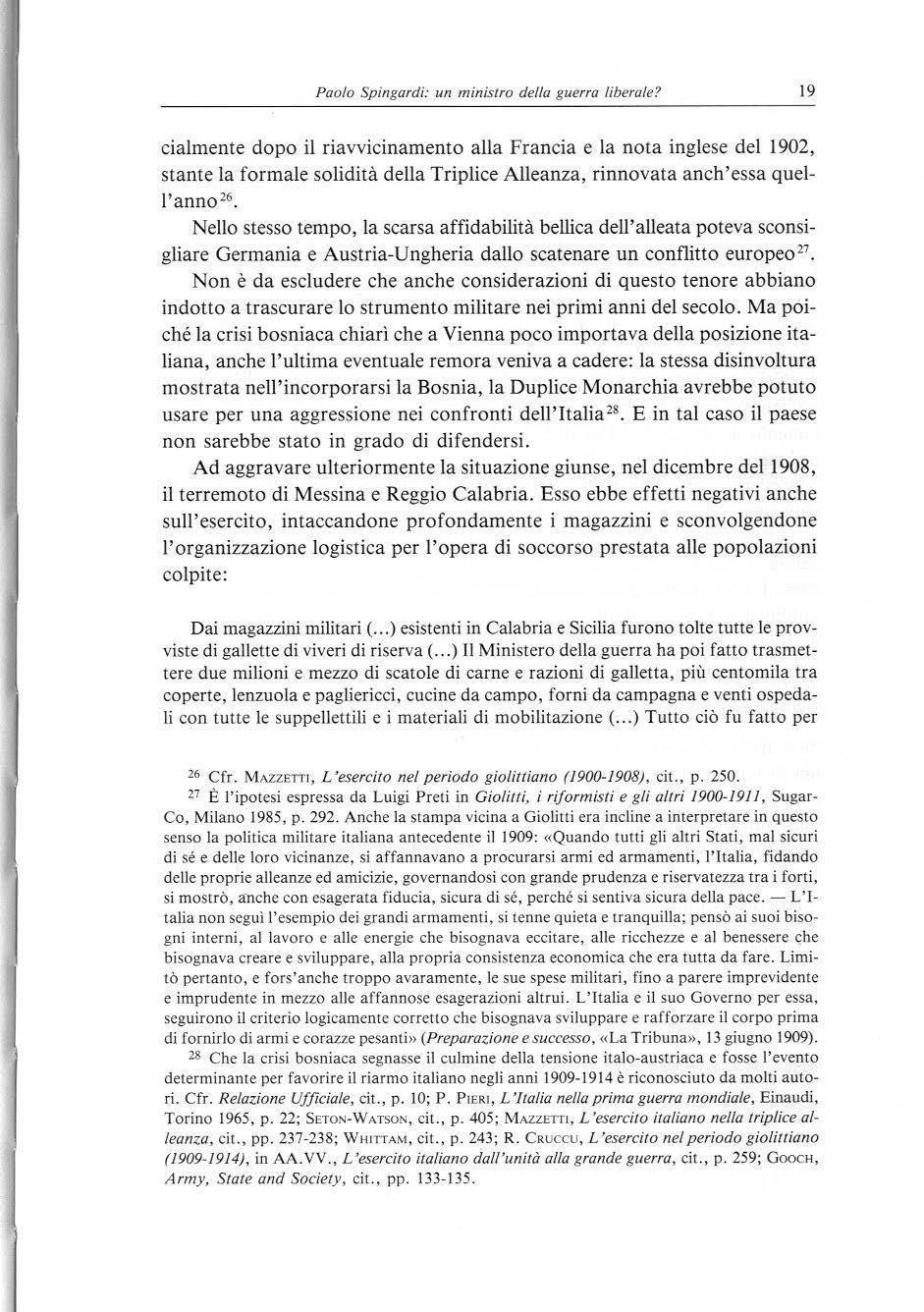
27 È l'ipotes i espressa da Luigi Preti in Giolitti, i riformisti e gli altri 1900-1911 , SugarCo, Milano 1985, p. 292 . Anche la stampa v icina a Giolitti era incline a interpretare in questo senso la politica militare i taliana antecedente il 1909: «Quando tutti gli altri Stati, mal sicuri di sé e delle loro vicinanze, si affannavano a procurarsi armi ed armamenti, l'Italia, fidando delle proprie alleanze ed amicizie, governandosi con grande prudenza e riservatezza tra i forti, si mostrò, a nche con esagerata fiducia, sicura di sé, perché si sentiva sicura della pace. - L'Italia non seg uì l 'esempio dei grandi armamenti, s i tenne quieta e tranquilla; pensò ai suoi bisogni interni, al lavoro e alle energ ie che bisognava eccitare, alle ricchezze e a l benessere che bisognava creare e svil uppare, al l a propria consistenza economica che era tutta da fare. Limitò pertanto, e fors'anche troppo avaramen te, le sue spese militari, fino a parere imprev idente e imprudente in mezzo alle affannose esagerazioni altrui L'Italia e il suo Governo per essa, seguirono il criterio logicamente corretto che bisognava sviluppare e raffor zare il corpo prima di fornirlo di armi e co razze pesanti» (Preparazione e successo, <<La Tribuna», 13 giu gno J909)
28 Che la crisi bosniaca segnasse il culmine della tensio ne ita lo -austriaca e fosse l'evento determinante per favorire i l riarmo ital iano negli anni 1909-1914 è riconosciuto da molti autori. Cfr. Relazione Ufficiale, cit., p. IO ; P P1ER1, L'Italia nella prima guerra mondiale, Einaud i, Torino 1965, p. 22; SETON-WATSON, cit., p. 405; M ,\ZZETI1, L 'eserci10 ilaliano nella triplice alleanza, cit., pp . 237-238; WH1 TTAM, cit., p . 243; R. CRUccu , L'esercito nel periodo gio/ifl iano (1909-1914), in AA. VV ., L'esercito italiano dall'uni1à alla grande guerra , cit., p. 259; GoocH, Army, State and Sociecy, cit., pp 133-135.
far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite e delle truppe di soccorso, le quali non potevano nulla trovare s ui luoghi danneggiati 29
Se l'ipotetica aggressione fosse avvenuta in quel momento il paese sarebbe stato alla mercé del nemico poiché l'esercito era impreparato ad affrontarla, dato che i primi provvedimenti dovevano ancora produrre i loro effetti, senza contare i numerosi problemi ancora da risolvere. Un esercito in grado di garantire almeno la legittima difesa del suolo patrio diveniva una necessità sempre più inderogabile.
Nei primi mesi del 1909, mentre le posizioni di Austria e Serbia andavano irrigendosi, la posizione di Casana diveniva sempre più incerta, e un mutamento si verificava in Parlamento, dove tutti, tranne i soci ali st i, divennero più malleabili di fronte all'ipotesi di nuove spese militari3° e disponibili a concedere som me che in un'atmosfera di maggiore serenità non avrebbero concesso.
Le riforme impostate nel 1907, che si sperava, forse, di sviluppare con calma, e magari in silenzio, sull'onda degli avvenimenti interni e internazionali dovevano essere realizzate al più presto e co l clamore dell'opinione pubblica, o almeno questa poteva essere l'impressione. Si se ntiva l'esigenza di qualcuno che sapesse imprimere la necessaria energia all'opera di riforma. Vi era una adeguata disponibilità finanziaria e bisognava approfittare del momento favorevole nel Pa ese e nel Parlamento. 11 ministro borghese non sembrava possedere prestigio e decisione s uffi cienti per imporsi alle Camere nella richiesta di fondi, e a lle ge rarchi e affin c hé lavorassero in armonia di intenti con le autorità politiche. Ci vo leva una personalità ri sol uta e dalla riconosciuta competenza, in grado di ras sicurare i deputati circa il buon impiego dei nuovi, cospicui, fondi straordinari che sarebbe stato inevi tabile richiedere.
li problema dell'esercito è in questo momento arduissimo , sia per le opere da eseguire, sia per la giustizia interna da imporre, applicare e garantire per tutti ( ) Ma perché qu est i scopi possano raggiungersi, bisogna procedere con eccezionale energia , bi sogna possedere una volontà deci sa e rapida nelle decis ioni , bisogna essere pro vvisti di grande forza di iniziativa, di re sistenza contro gli ostacoli tradizionali,
29 f soccorsi. Quel che fece l'Esercito per i danneggiali Invio per IO milioni di razio ni medicinali ecc , «Co rriere della Sera», lun ed ì 11 gennaio 1909.
30 Su lla posizione di Casana , v. P CASANA TESTORE, Un n otabile della terza flalia, in« uova An1ologia», N . 21 36 (ottobre-dicembre 1980), pp. 293-295 e V. CAc 1uLu, Il ministro borghese della guerra, in « Ricerche Storich e>>, a. XVI ( 1986), n. 2, pp. 334-338. TI nuov o c lima par la ment are si desume chiaramente nell'ampia discussione sui nuovi stanziamenti nel giugno 1909. V perc iò AA.PP., Cam era-Discusssioni, Tornate dell'8, 9, 11 e 12 giugno 1909, pp . 2081-2329.
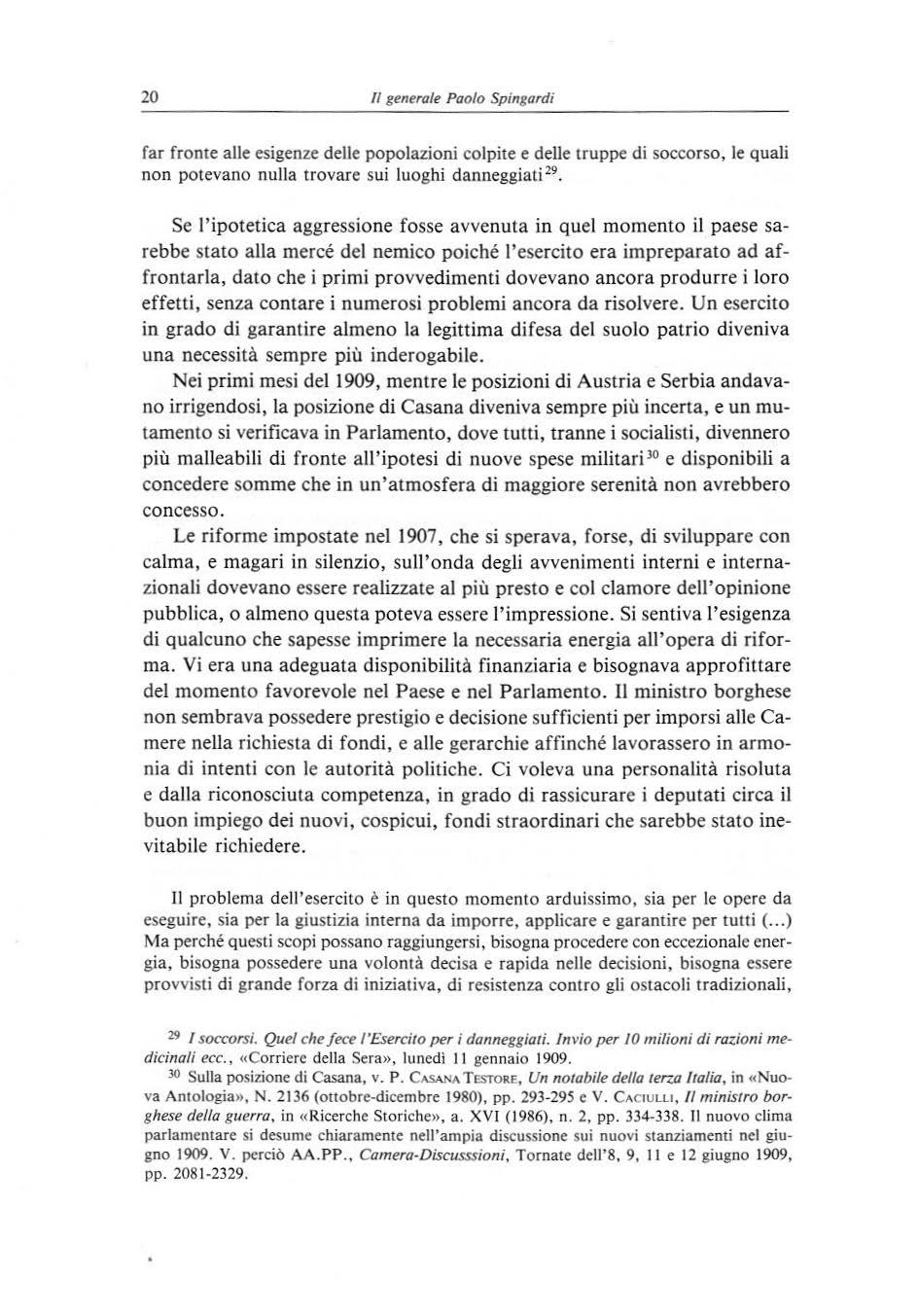
20 li
generale Paolo Spingardi
Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 21
di fermezza nello spezzarli: bisogna, in una parola, avere certe doti eminenti che s'impongano a tutti. Ora l'on. Casana ( )non ha avuto sino da principio la visione chiara del compito suo, si è lasciato soverchiare dalle cose e dai fatti. La fiducia che tutti avevano nel ministro borghese, in un ministro riformatore e rinnovatore, è andata a poco a poco svanendo durante un anno di prova, e oggi non vi è forse nessuno che creda che l'on . Casana possa rifarsi e imporsi 31 •
Di fronte a tutto ciò il ministro borghese finiva per rappresentare un contrasto, del quale è difficile valutare la portata, tra militari e civili 32 , ma soprattutto pareva inadeguato per realizzare in tempi brevi un programma in grado di risolvere i numerosi problemi tecnici, concreti, che giacevano sul tappeto 33 •
Conscio di non godere più degli appoggi necessari, Casana rassegnò le dimissioni il 31 marzo 1909, lo stesso giorno in cui la crisi bosniaca giungeva all'epilogo con il riconoscimento dell'annessione da parte del governo russo, che aveva appoggiato la Serbia.
A questo punto a successore di Casana andava scelto un militare che avesse una esperienza tanto di comando quanto di amministrazione, che fosse conosciuto dal Parlamento e dai membri del Governo, e gradito alla Corona e alle gerarchie. Sicuramente seguendo quest'insieme di considerazioni, Giolitti consultò subito l'allora Comandante dell'Arma dei Carabinieri, tenente generale Paolo Spingardi .
Da granatiere a Ministro
P aolo Antonio Spingardi era nato il 2 novembre 1845 a Felizzano, in quella che nel Regno di Sardegna era l'Intendenza Generale di Alessandria . Il padre, anch'egli di nome Paolo, faceva l'esattore comunale, e la madre, Caterina Abriata, era una solida donna di casa piemontese: «gente forte, laboriosa e patriottica», li avrebbe descritti il figlio 34 •
31 La situazione del ministro Casona, «Corriere della Sera», 31 marzo 1909
32 Secondo P. CASANA T ESTO RE le alte sfere militari «osteggiarono sempre il nuovo ministro» art. cit., p. 289 . Però questo non impedì all'azione di Casana di avere una certa efficacia in campo disciplinare. V. CAc1utt1, art. cit., p. 333.
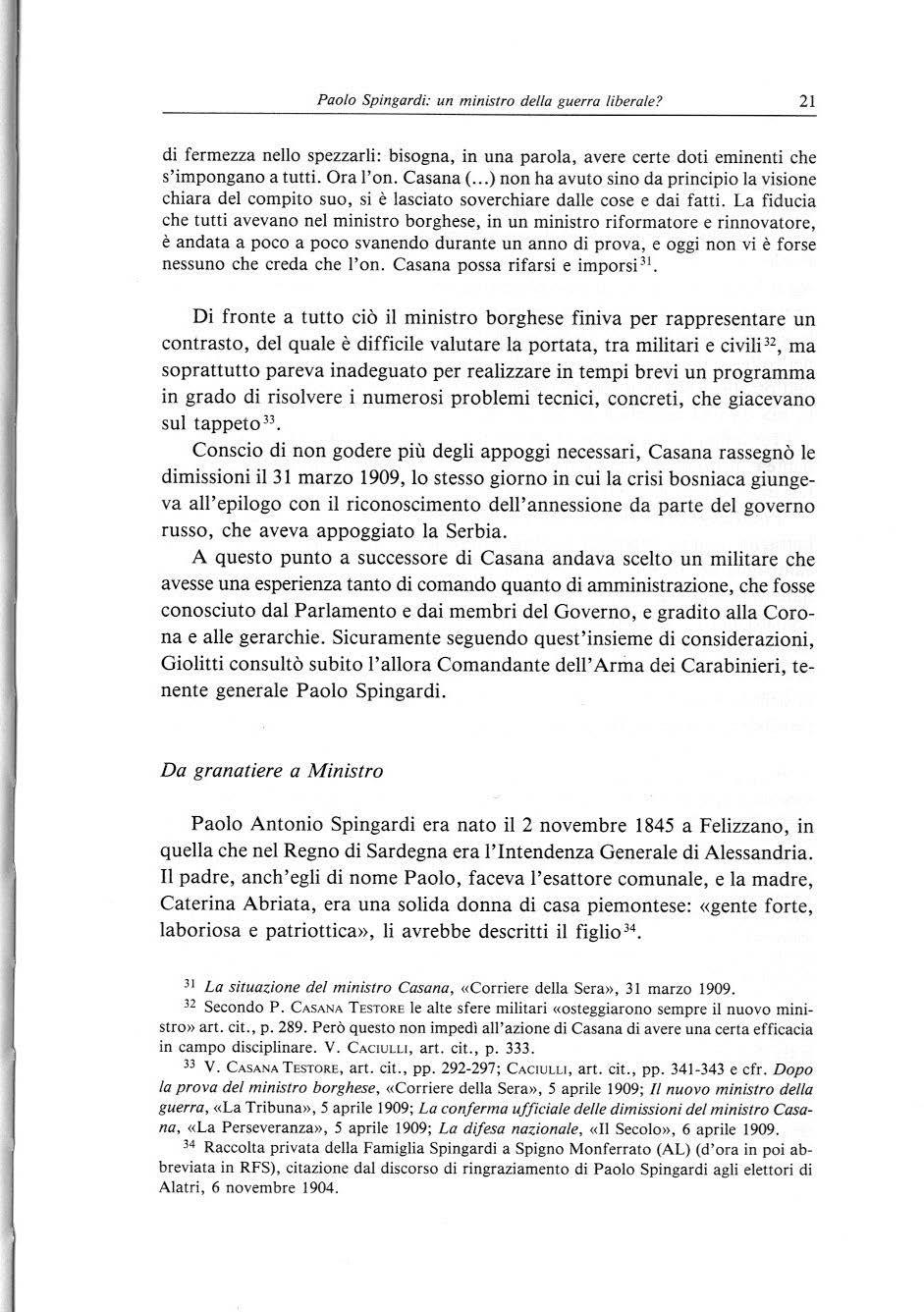
33 V. CASANA T ESTORE, art. cit., pp. 292 -297; CAc1uw, art. cit., pp. 341-343 e cfr. Dopo la prova del ministro borghese, «Corriere della Sera», 5 aprile 1909; li nuovo ministro della guerra, «La Tribuna>}, 5 aprile 1909; La conferma ufficiale delle dimissioni del ministro Casona, « La Perseveranza », 5 aprile 1909; La difesa nazionale, «li Secolo», 6 aprile 1909.
34 Raccolta privata della Famiglia Spingardi a Spigno Monferra to (AL) (d'ora in poi abbreviata in RFS) , citazione dal discorso di ringraziamento di Paolo Spingardi agl i e lettori di A l atri , 6 novembre 1904.
Il generale Paolo Spingardi
Gli Spingardi erano originari di Bi stagno, sempre nell'intendenza di Alessan dria, e discendevano dal casato di Giovanni Francesco A le ssandro Arcasio , i nsigne giurista del XVIII seco lo.
Compiuti i primi tre anni di studi elementari nel paese natìo, il piccolo Paolo venne inviato a Torino presso il Collegio Convitto Na zion ale, dove seguì l'itinerario di studi fino al conseguimento della licenza liceale. Non proveniva da una famiglia di trad izioni militari e st ud iò in un collegio civile, quando non era raro anche per le famiglie borghesi spedire i giovinetti nei collegi militari. La decisione di entrare alla Scuola Militare di Modena nell'ottobre 1864 non se mbrerebbe quindi derivare da influenze ambientali, ma da una autentica vocazione mi li tare.
Terminati i corsi modenesi, Paolo Spingardi riceveva i ga lloni da sottotenente e incominciava la carriera al 6° reggimento « Granatieri di Napoli» 3s. Un mese dopo, la guerra all'Austria.
Poteva essere un glorioso battesimo del fuoco, l'occasione per applicare in battaglia quanto imparato in diciannove mesi di studi. Ma, come si sa, la camp agna de l 1866 non fu certo un episodio felice per le armi italiane. Per quanto riguardava il sottote nente Sp in gardi, poi, il 6° Gr a n at ieri era stato assegnato alla 17 a Di visione comandata dal generale Raffaele Cadorna, all'interno del I V Corpo agli ordini del generale Cialdini, che rimase dietro il Po ed avanzò nel Veneto solo quando questo cominciava ad essere sgombrato dagli austri aci, sconfitti dai pruss iani a Sadow a il 3 luglio. Di conseguenza non fu possibile al giovane ufficiale partecipare né assistere alla battaglia di Custoza.
3S Le noliz.ic suj primi anni di vita e sulla carriera del gcn. Spingardi, qui come più avanti, sono state lraLte dai documenti in RFS. Per la carriera m ilitare da uno Specchio caratteristico datato 28 novembre 1889. Il contenuto di questi «Specchi» era tenuto rigorosamente celato agli ufficiali che ne erano oggetto. Assai interessanti quindi i dati contenuti e i pareri espressi su Spingardi dai suoi superiori: «Statura m. 1,76. Molto robusto, molto svelto, molto resistente a qualsiasi fatica. Di buona vista. Di bell'aspetto e molto prestante nella persona( ... ] percepisce molto prontamente ed ha mente lucida e molto buon senso . Ha buonissima memoria ed è molto rinessivo [ ... ] D'ind o le moderata, aperta e gioviale. Risoluto, energico e perseverante. Di carattere leale, generoso, delicato, conciliante e molto sensibile[... ) Disciplinatissimo, calmo, molto autorevole, di molto sangue freddo. Affezionatissimo alla carriera militare [ ) Ha conseguito la licenza liceale. Ha buona e svariata cultura generale. Conosce bene la lingua italiana e scrive con sti le cmaro cd elegante. Conosce e parla bene la lingua francese ed abbastanza bene la tedesca. Spec ialmente versato in geografia e topografia. Disegna bene in topografia [... ) Conosce bene le leggi e i regolamenti militari in genere e benissimo il servizio di Stato Maggiore e le istruzioni, le esercitazioni ed il servizio dell'arma di fanteria [.. . ) Molto studioso. Tiene buoni cavalli e cavalca molto bene e con passione[ . .. ] Nel disimpegno delle funzion i che gli vennero affidate sia per lavori d'ufficio, sia per ricognizioni e studi di difesa, sia alle gran di manovre, dimostrò ognora zelo, intell igenza, tatto, e resistenza alle fatiche [ ... ] Comandò per due anni un battag lione fanteria tanto in guarnigione quanto ru campi riportando la piena soddisfazione dei superiori. Ha tutta l'idoneità pratica che si richiede in un ufficiale di Stato Maggiore [ ... ) Molto volonteroso, esano, ed attivissimo. Ha moltissima cura dell'uniforme. Squisitamente educato, mantiene un contegno perfettamente corretto coi cittadini. Molto stimato ed amato da tutti».
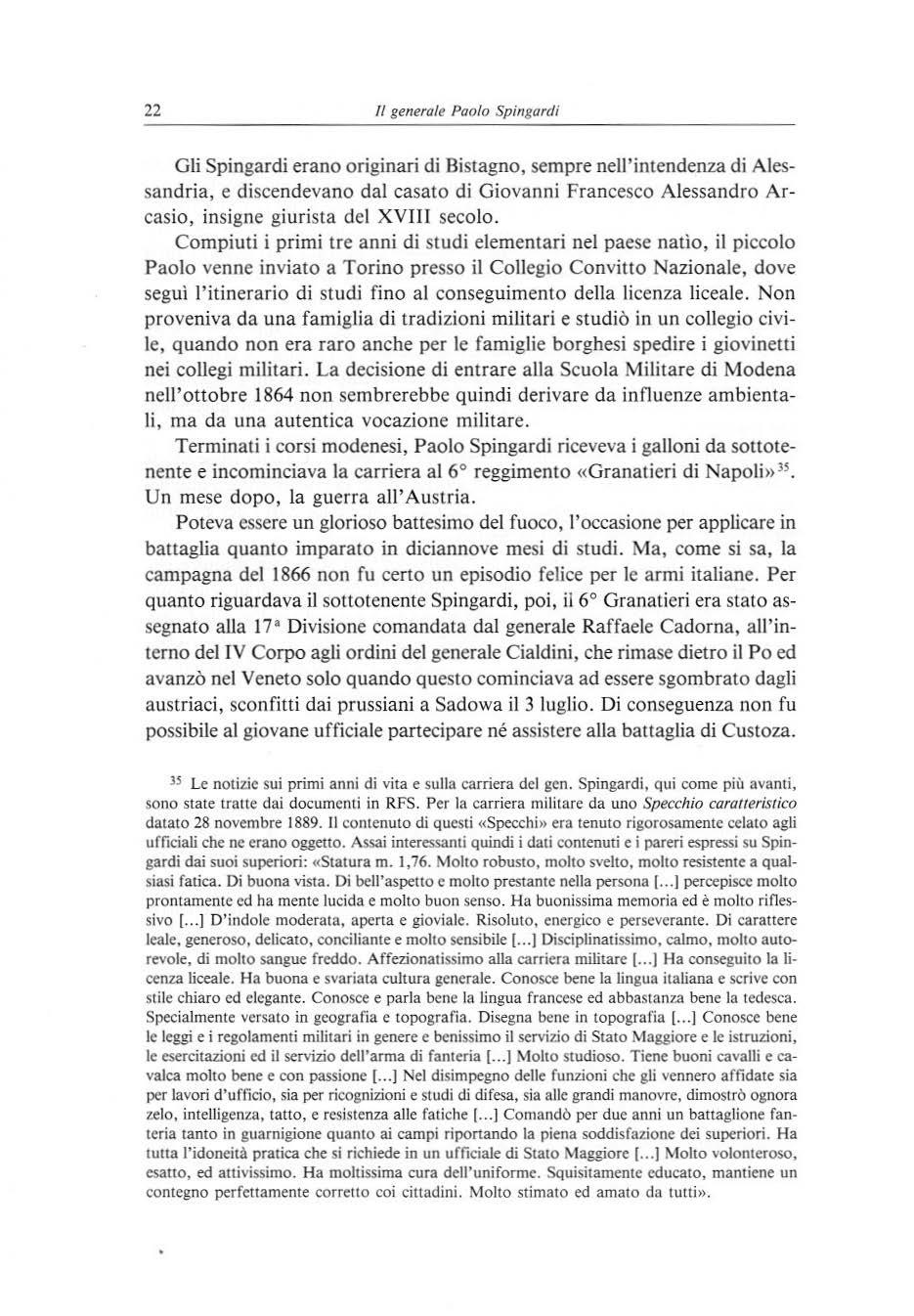
22
Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 23
Dopo la guerra, il governo, nella corsa al pareggio del bilancio, cominciò a ridurre drasticamente le spese militari:
Tra il perpetuarsi del disavanzo con alcune divisioni di più, ed il pareggio con alcune divi sioni di meno, la forza dell'Italia, pur di fronte all'estero, stava nel pareggio 36 •
Quanti cercavano sicurezza sociale ed economica abbandonarono non appena possib ile i quadri 37 • Paolo Spingardi invece rimase La scelta fatta gli costò un inizio di carriera alquanto lento: passarono oltre sei anni e mezzo prima che gli ottenesse il grado di tenente, nel dicembre 1872.
Non è da escludere che la de lusione della campagna del 1866 e l'iniziale lentezza della carriera abbiano contribuito a formare in lui la convinzione della necessità d i migliorare da un lato la selezione dei quadri superiori, e dall'altro la carriera degli ufficiali inferiori; convinzione che egli avrebbe cercato di tradurre in atto una vo l ta divenuto ministro
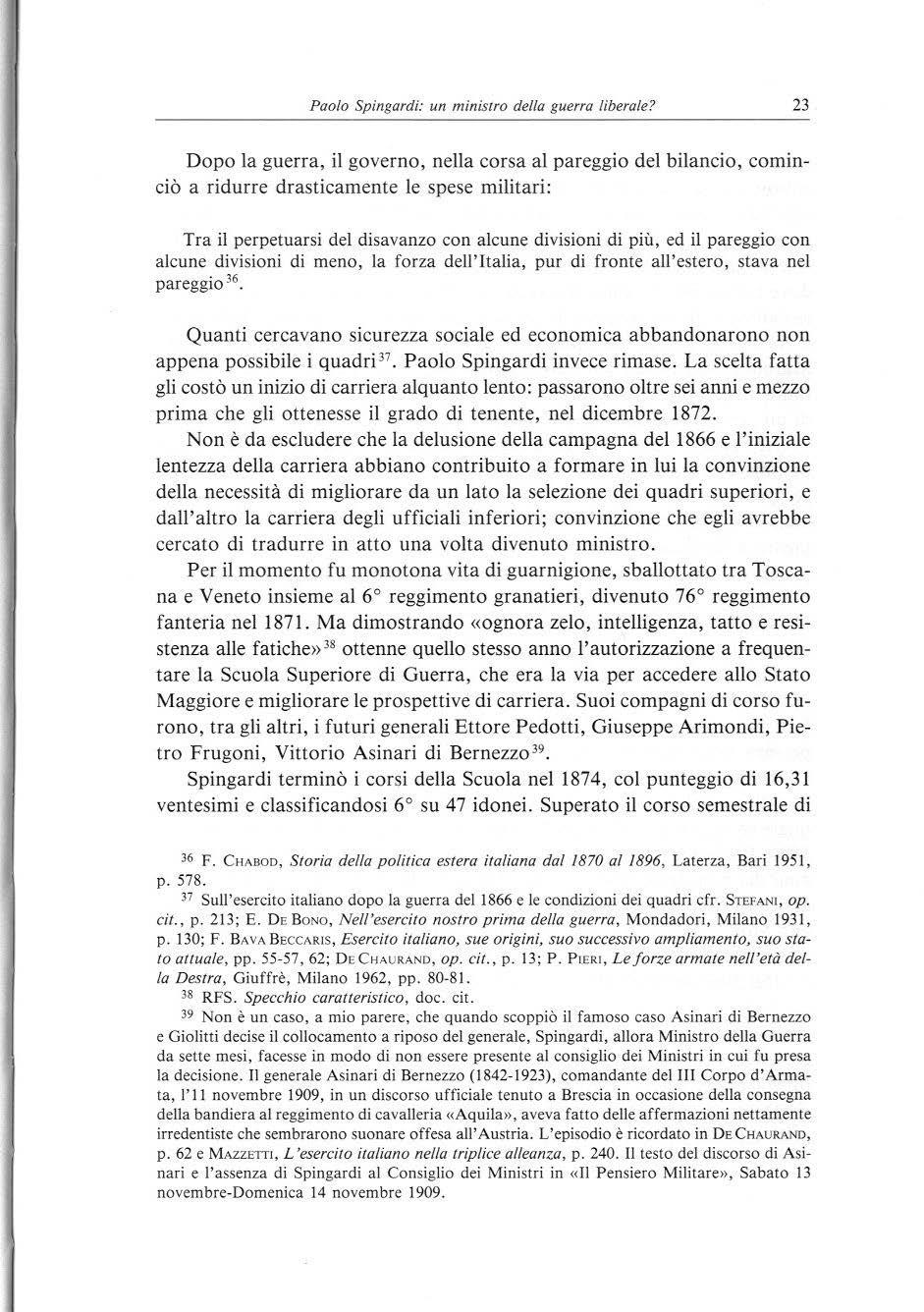
Per il momento fu monotona vita di guarnigione, sballottato tra T oscana e Veneto insieme al 6 ° reggimento granatieri, divenuto 76° reggimento fanteria nel 187 1. Ma dimostrando «ognora ze lo, i n telligenza , tatto e resistenza alle fatiche» 38 ottenne qu ello stesso anno l'autorizzazione a frequentare la Scuola Superiore di Guerra, che era la via pe r accedere allo Stato Maggiore e migliorare le prospettive di carriera. Suoi compagni di corso furono, tra gli altri, i futuri generali Ettore Pedotti, Giuseppe Arimondi, Pietro Frugoni, Vittorio Asinari di Bernezzo 39 • Spingardi terminò i corsi della Scuola nel 1874, col punteggio di 16,31 ventesimi e classificandosi 6 ° su 47 idonei. Superato il co r so semestrale di
36 F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Laterza, Bari 1951, p. 578.
37 Sull'esercito italiano dopo la guerra del 1866 e le condizioni dei quadri cfr. STEFANI, op. cit., p. 213; E. D E BoNo, Nell'esercito nos1ro prima della guerra, Mondadori , Mi l ano 1931, p. 130; F. BAVA B ECCAIUS , Eserci10 italiano, sue origini, suo successivo ampliamento, suo stato a//uale, pp . 55-57, 62; D EC1-JA URAND, op. cii , p. 13; P. P1.ER1, Le forze armate nell'età della Destra, Giuffrè, Milano 1962, pp. 80-81.
38 RFS . Specchio caratteristico, doc. cit.
39 Non è un caso, a mio parere, che quando scoppiò il famoso caso Asinari di Bernezzo e Giolitti decise il collocamento a riposo del generale, Spingardi, allora Ministro della Guerra da sette mesi, facesse in modo di non essere presente al consiglio dei M in istri in cui fu presa la decis ione. Il generale Asinar i di Berne zzo (1842 - 1923), comandante del I II Corpo d'Armata, l ' I I novembre 1909, in un di sco rso ufficiale tenuto a Brescia in occasione della consegna della bandiera al reggimento di cavalleria «Aq uila>>, aveva fatto delle affermazioni nettamente irredentiste che sembrarono suonare offesa ali' Austria. L'episodio è ricordato in DE CttAURANO, p. 62 e MAZZ ETT I, L 'esercito italiano nella triplice alleanza, p. 240. Il testo del disc.orso di As inari e l'assenza di Spingardi al Consiglio dei Ministri in «Il Pen siero Militare », Sabat0 13 novembre - Domenica 14 novembre 1909.
prova per il servizio di Stato Maggior e presso il Comando del Corpo, passò definitivamente a farne parte. D opo una decina di mesi trascorsi presso gli uffici del comando della Divisione militare di Verona, nel marzo I 876 ve nne chiamato al Comando de l Corpo di S.M. e, in virtù della sua abilità nelle levat e e nella lettura delle carte, destinato alla sezione topografico-militare, dove rimase per sei anni. Il lavoro principale co nsistette per lui in attente ricognizioni lungo territori di confine, con numerosi soggi orni in Francia e Au str ia-Ungheria. Divenne così esperto specialmente dei tratti Bru ckMarbur go -Zagabria e Tarvisio-Trieste-Pola, lungo quella frontiera che durante il suo Ministero si sa rebbe impegnato a difendere con la costruzione di un completo sistema di fortificazioni.
Nell'agosto de l 1877 ottenne la promozione a capitano e nel 1882 venne destinato in servizio di stato maggiore presso la D ivisione militare di Firenze. Qu i rimase fino al 1884 , allorché, promosso maggiore, comandò per du e anni un battaglione del 56° reggimento fanteria, dapprima in di staccammento a Desen zano sul Garda, poi alla sede del corpo a Torino.
La via verso sempre più prestigiose destina zio ni era ormai sbloccata per il maggiore Spingardi: il 29 agosto 1886 venne comandato alla Scu ola di Guerra in qualità di professore titolare della cattedra di topografia e, altermine dell'anno accadem ico, destinato al Ministero della Guerra, divenendo nel lu g lio 1887 Capo Sezione pres so il Segretariato generale, dove rimase per oltre cinque anni, iniziando così la particolare formazione professionale di militare al servizio del Ministero, che gli avrebbe dato una speciale competenza nelle questioni amministrative.
Tenente colonnello nel 1888, il 10 settembre 1890 sposò Rin a Merialdi, di anti ca e nobile famiglia di Roccagrimalda. Fu un matrimonio felice dal quale nacquero tre figli: Ca milio nel I 892, Amalia nel I 895 e Giuseppe nel 1896. Paolo Spingardi fu sempre molto legato alla famiglia, e anche negli anni del ministero, quando non poteva averla accanto a sé a Roma, non appena riusciva a permettersi qualche giorno di libertà, raggiungeva Spigno Monferrato, c he aveva eletto a sua dimora, per godersi la compagnia della moglie e dei figli.
Dal dicembre 1892 all'ottobre 1896 fu apprezzato comandante in seconda della Scuola di Guerra di To rino 40 , dalla quale venne trasferito al comando del 13 ° reggimento fanteria, che aveva sede nella stessa città, per esercitarvi il biennio di comand o di truppa prescritto per gli ufficiali di Stato Maggiore, dato che nel 1893 era diventato colonnello.
D al giugno 1898 al settembre 1900 fu nuovamente presso il Ministero della Guerra, in qualità di Dirett ore Generale dei Servizi Amministrativi.

24 li
generale Paolo Spingardi
40 Cfr. D E B ONO, p. 90.
Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 25
Maggiore generale nel 1899, gli venne affidato il comando della Brigata Bas1/icata, di stanza a Rom a, finché nel novembre 1903 fu nominato sottosegretario di Stato alla Guerra con il ministro Pedotti: carica che ricoprì durante i successivi governi Giolitti, Tittoni e Fortis.
Di fronte alla Camera l'incarico principale del sottosegretario consisteva nel rispondere, in qualità di Commissario Regio, alle interrogazioni rivolte al Minis tro della Guerra. Spingardi ebbe così modo di affinare le doti che più tardi lo avrebbero reso apprezzato oratore.
Alle elezioni politiche del 1904 si presentò candidato governativo nella circoscrizione di Anagni, riuscendo eletto a larga maggioranza al primo scrutinio 41 •
Spingardi fu a lungo fedele a Giolitti, al quale si diceva <<legato da profonda riconoscenza, perché a lu i debbo la mi~ fortuna politica» 42 • Ne condivideva anche il programma, tanto che nel discorso elettorale arrivava a sottoscriverlo senza riserve:
Nella relazione colla quale l'eminente uomo di stato che regge in questo momento le redini del Governo, ha sottoposto alla sanzione del Sovrano il decreto di scioglimento della Camera dei Deputati e di convocazio ne dei collegi elettorali .. . sta l'intero ed es pli cito programma del governo, a voi ben noto, e poiché al governo mi onoro di appartenere, è ovvio che a quel programma pienamente sottoscriva 4 3
Alla caduta del ministro Pedotti, nel dicembre 1905, si dimise dalla carica di sottosegreta rio; il 16 marzo 1906, però, fu eletto alla Camera, coi voti dei parlamentari giolittiani, a far parte della cosiddetta «Commissione dei Dodici», organismo voluto da Sonnino per l'esame dei disegni di legge a carattere militare 44 •
Spingardi vi r estò solo poche settimane perché ai primi di aprile, con la promozione a tenente generale, venne destinato al comando della Di visione militare di Messina, lasciando R oma dopo avervi trascorso otto anni. Vi sarebbe comunque tornato nel febbraio 1908, quando venne nominato
41 Gli elettori iscritti nel Collegio di Anagni erano 3642. I votanti furono 2582. Spingardi venne eletto con 1813 voti. Il suo a vversar io , avv. Giulio Clementi, ottenne 718 voti. Cfr. « L'Ernico», bimensile di Anagni, del 12 novembre 1904.
42 Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Archivio Brusati, Se. 11, f. VIII.l.45. Spingardi a Brusati, lettera la cui data risulta indecifrabile, ma che il tes to permette di far risalire senza dubbi ai primi di d icembre del 1913. 1 rapporti tra i due vennero raffreddandosi a partire dal gennaio 1915, quando Giolitti avrebbe voluto ch e Spingardi intervenisse energicamente in Senato a difendere la politica militare del suo Governo, mentre Spingardi giudicò « dovere dell'ora presente non intorbidare le acque della concordia unive rsale » (ibidem, se 11, f. VIII.2.46, Spingardi a Brusa ti, 1° gennaio 1915).
43 RFS , d iscorso agli elettori di Anagni, manoscritto datato I O novembre 1904.
44 Cfr. CACI ULl. l, li ministro borghese de/fa guerra , art ci t., p. 339.
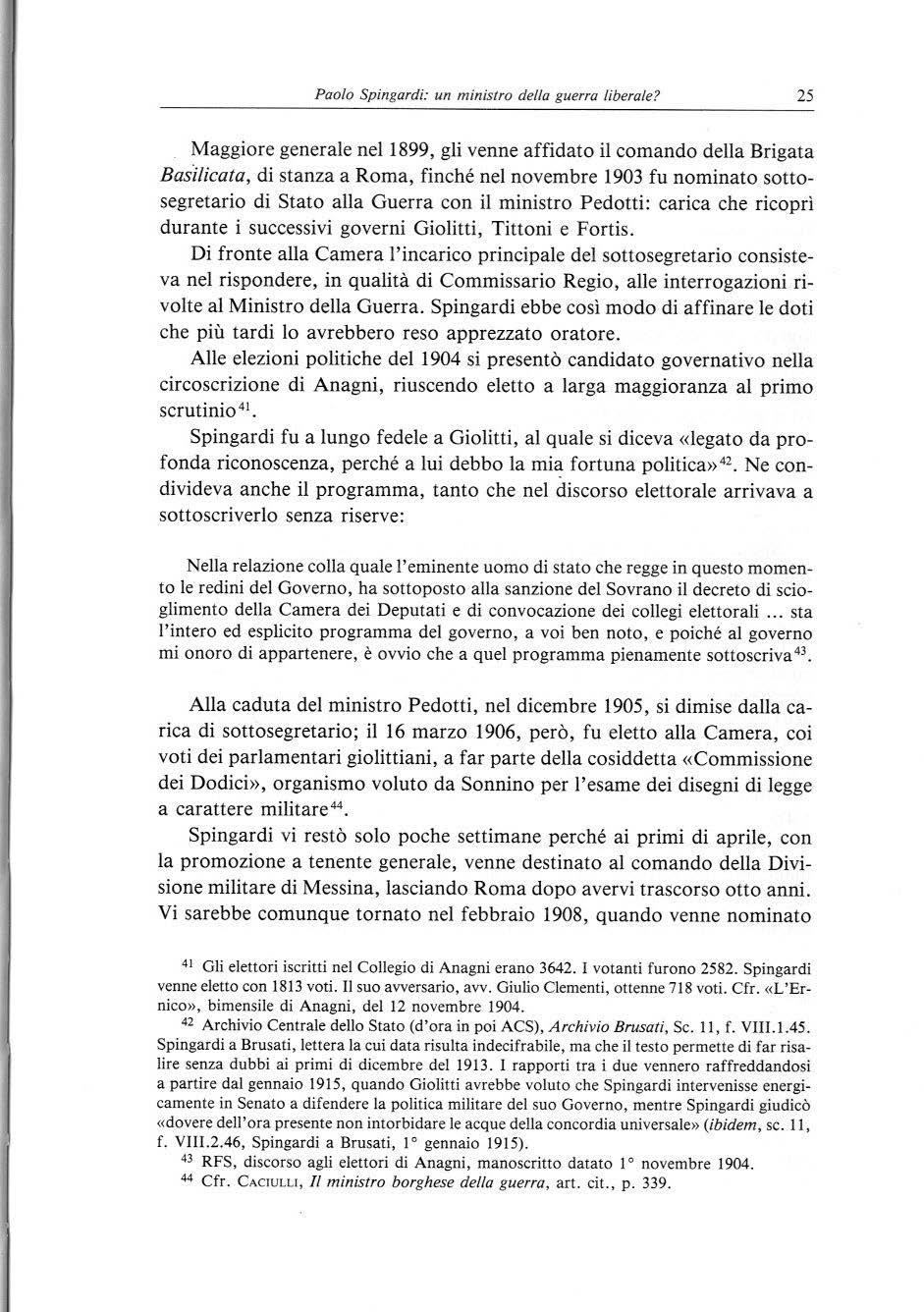
li
generale Paolo Spingardi
Comandante Generale dei Carabinieri Reali, dopo che Giolitti si era mostrato in soddisfatto dell'operato del Geo . Giu se ppe Bella ti 45 •
L'ascesa di Spingardi ai più alti gradi era coincisa con la crescita della figura politica dello statista di Dronero È ovvio che Giolitti avesse avuto modo di apprezzare il generale quando questi aveva ricoperto la carica di sottosegretario nel suo secondo Governo, è però possibile che i due si conoscessero fin dai tempi in cui Spingardi era Capo-Sezione al Ministero della Guerra e Giolitti Ministro delle Finanze nel secondo governo Crispi. Ad ogni modo, Giolitti non ebbe dubbi quando si trattò di sostituire il dimi ssionario Casana e nei primi giorni di aprile del 1909 contattò il generale e gli offrì il portafoglio della Guerra.
La nascita di un programma
Spingardi dichiarò immediatamente la sua disponibilità, ma volle subordinare l'accettazione dell'incarico a un colloquio
col Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e col Mini stro del Tesoro, a meglio chiarire il breve cenno da Lei fattomi ieri suJl'entità del fa bisogno e sui mezzi che possono essere messi a disposizione. - Mi semb ra più che utile, necessario, togliere di mezzo ogni eventuale cau sa di dissenso, conciliando quanto più possibile le esigenze della difesa e del bilancio dello Stato, in questo quarto d'ora in cui la questione militare è assurta alla più alta importanza 46 •
Ottenute le desiderate garanzie 47 , Spingardi entrò in carica il 4 aprile 1909.
Egli si recò dapprima dal Re, che secondo il dettato statut ario era il comandante supremo di tutte le forze di terra e di mare. Educato militarmente, Vittorio Emanuele III non i ntendeva rinunciare a tale prerogativa. D'altra parte gli ordini del Re venivano trasmessi all'esercito tramite il Ministro
45 Ibidem, nota 76 . P robabilmente Giolitti ne aveva parlato con Spingardi già da qualche mese, come si evince dalla seguente lettera del Presidente del Consiglio al Comandante della Divisione Militare di Messina in RFS datala 21 novembre 1907: «Ella forse, e a ragione, sarà meravigliato di non aver più ricevuto alcuna mia lettera. - Ciò dipende da che per necessità di attendere il nuovo regolamento ogni provvedimento sul Comando dell'Arma fu rimandato al I O gennaio prossimo . - Del resto su quanto Le scrissi vi è pieno consenso di Sua Maestà e del Ministro della Guerra».
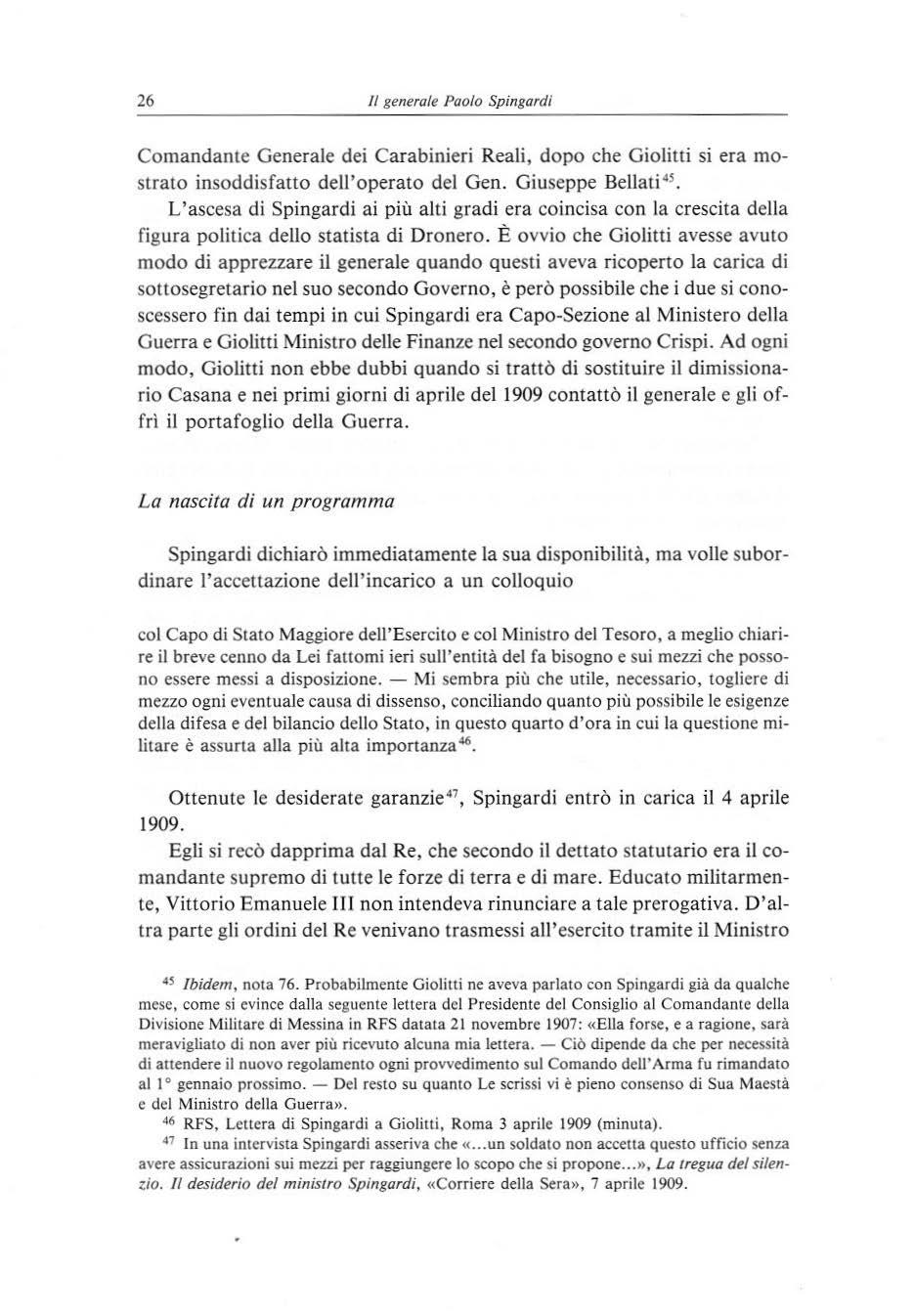
46 RFS, Lettera di Spingardi a Giolitti, Roma 3 aprile 1909 (minuta).
47 In una intervista Spingardi asseriva che « un soldato non accetta questo ufficio senza avere assicurazioni sui mezzi per raggiungere lo scopo che si propone » , la tregua del silenzio. li desiderio del ministro Spingardi, «Corriere della Sera», 7 aprile 1909.
26
Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 27
della guerra, che era, in tempo di pace, la più alta autorità militare dopo il sovrano 48 •
Spingardi veniva a svolgere un ruolo importante anche come interprete dei desideri del Re. Per sonaggio chiave nella vicenda dei rapporti tra la Corona e il Mini stro della Guerra fu il Primo Aiutante di campo, generale Ugo Brusati 49 • L ui, più che il Sovrano, trattava direttamente col Ministro, dando suggerimenti ed esprimendo critiche, a volte personali, più spesso di chiara ispirazione regale Tramite il fedele Primo Aiutante, Vittorio Emanuele III si occupava di tutti i problemi dell'esercito, anche i più minuti , ma la sua ingerenza nelle competenze del Ministro rimase sempre molto discreta. Certamente Spinga rdi ottenne il benestare per la sua azione, tanto che, recatosi nell'ufficio del Primo Aiutante dopo l'udienza col Re, Brusati gli augurò «di essere il Mirabello dell'esercito» 50 • Si limitò ad augurarglielo, non glielo assicurò e lo stesso Spingardi nelle crisi di governo agì sempre come se avesse dovuto lasciare il posto che occupava. Ma vi rimase anche con Sonnino e Luzzatti. Il favore sovrano è insomma un elemento che accompagnò Spingardi lungo tutta la sua permanenza al Ministero della Guerra 51 •
48 Sui rapporti Sovrano-Ministro in campo militare v. CAvAcroccHr-SANTANGELO, cit., p. 50.
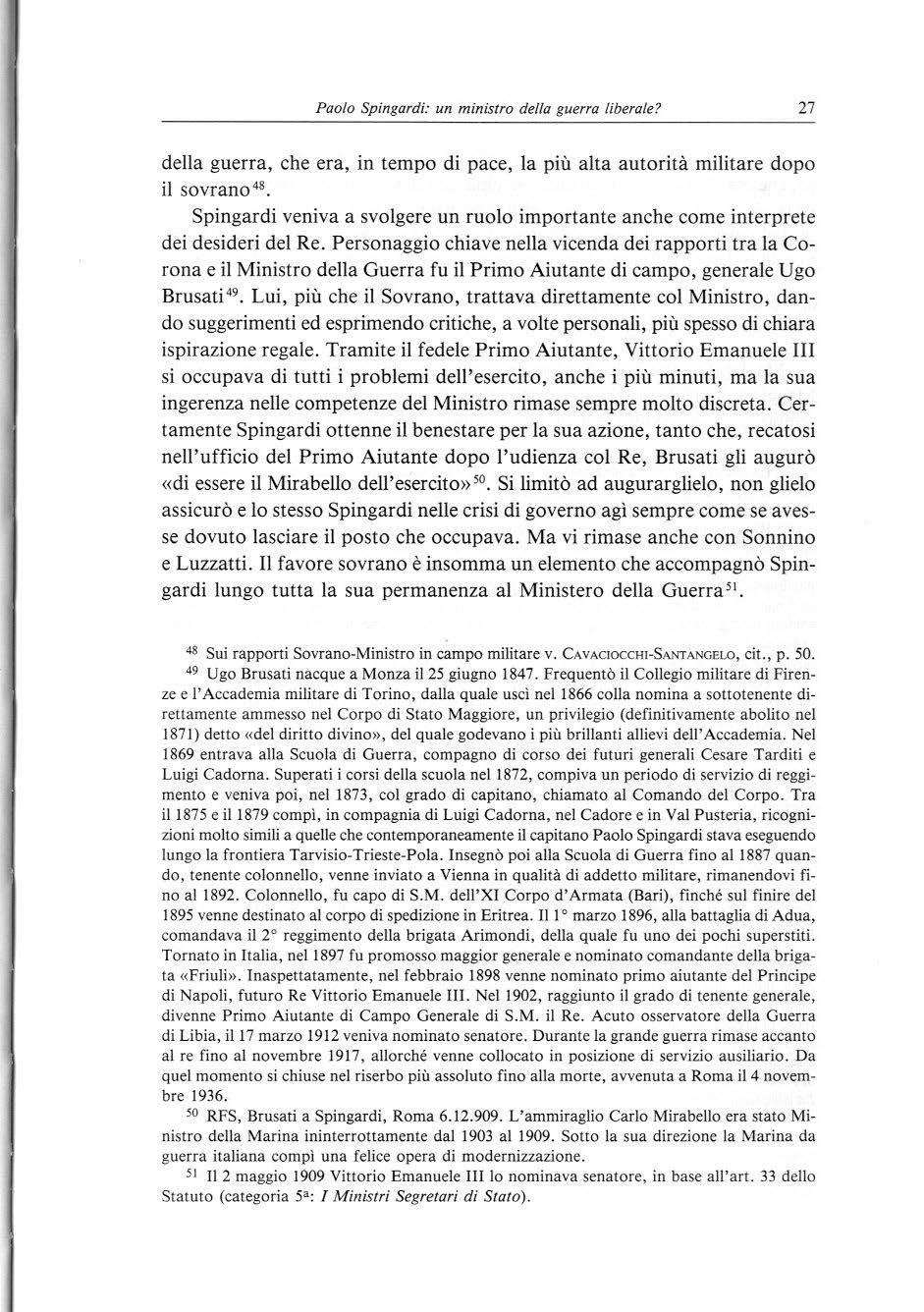
49 Ugo Brusati nacque a Monza il 25 giugno 1847. Frequentò il Collegio militare di Fir enze e l'Accademia militare d i Torino, dalla quale uscì nel 1866 colla nomina a sottotenente direttamente ammesso nel Corpo di Stato Maggiore, un privilegio (definitivamente abolito nel 1871) det to «del diritto divino», del quale godeva no i più br illan ti allievi dell'Accademia. Nel 1869 entrava alla Scuola di Guerra, compagno d i corso dei futuri generali Cesare Tarditi e Luigi Cadorna. Supera ti i corsi della scuola nel 1872, compiva un periodo di servizio di reggimento e veniva poi, nel 1873, col grado di capitano, chiamato al Comando del Corpo. T r a i l 1875 e il 1879 compì , in compagn ia di Luigj Cadorna, ne l Cadore e in Val Pusteria, ricognizioni molto simi li a que!Je che contempor aneamente il capitano Paolo Spingardi stava eseguendo lu ngo la frontiera Tarvisio-Tries te- Pola Insegnò poi alla Scuola di Guerra fino al 1887 quando, tenente co l onnello, venne inviat0 a Vienna in qualità di addetto mi litare, rimanendovi fi. no al 1892. Colonnello, fu capo di S.M. dell'XI Corpo d'Armata (Bari), finché sul finire del 1895 venne destinato al corpo di sped i zione in Eritrea. Il 1° marzo 1896, alla bat taglia di Adua, c omandava il 2 ° reggimento della brigata Arimondi, della quale fu uno dei pochi superstiti. Tornato in Italia, nel 1897 fu promosso maggior generale e nominato comandante della br igata «Friuli». Inaspettatamente, nel febbraio 1898 venne nominato primo aiutante del Principe di Napoli, futuro Re Vittorio Emanuele Ili. Nel 1902, raggiunto il grado di tenente generale, d ivenne Primo Aiutante di Campo Generale d i S.M. il Re. Acuto osser vatore della Guerra di Libia, il 17 marz.o 1912 veni va nominato senatore. Durante la grande guerra rimase accanto al re fino al novembre 191 7, allorché venne collocato in posizione d i serv iz io ausiliario. Da quel momento si chiuse nel riserbo più assoluto fino alla morte, avvenuta a Roma il 4 novembre 1936
so RFS, Brusati a Spingardi , Roma 6.12.909. L'ammiraglio Carlo Mirabello era stato M inistro della Marina ininterrottamente dal I 903 al 1909 Sotto la sua direzione la Marina da guerra italiana comp ì una felice opera di modernizzazione.
sr Il 2 maggio 1909 Vitto r io Emanuele III lo nominava senatore, in base all'art. 33 dello Statuto (categoria sa: / Ministri Segretari di Stato).
Il generale Paolo Spingardi
In quei primi giorni di aprile egli si recò nuovamente dal Ministro del T esoro, che era allora Paolo Carcano, per chiarire i particolari dell'accordo di massima già raggiunto circa i maggiori stanziamenti al bilancio della Guerra 52 • Fu probabilmente una discussione lunga e vivace se fu «speciale fatica» per il generale considerare sufficienti le cifre promesse dopo aver strappato l'impegno che al così detto scapito delle masse e ai danni del terremoto (. .. ) avrebbe provveduto il Tesoro, all'infuori degli stanziamenti (... ) votati dal Par lamento 53 •
Ma dopo questa fat ica poté recarsi con animo più sereno dal Capo di Stato M aggiore, tenente generale Alberto Po1Jio 54 • I due si conoscevano da lungo tempo 55 , e ciò rendeva più facili e fecondi i rapporti di lavoro.
52 La discussione probabilmente avvenne nel Consiglio dei Ministri di martedl 6 aprile 1909, che si occupò «quasi esclusivamente di questioni militari». V. li problema militare. In attesa del programma del ministro Spingardi, «Il Secolo», 7 aprile 1909.

53 RFS. Spingardi a Giolitti , 14.7.1909 (minuta). Le masse erano le somme di denaro occorrenti per determinate voci di spesa relative alla vita quotidiana del reggimento (rancio, vestiario, quadrupedi, ecc.). Ogni anno il Tesoro dava a l Ministero della Guerra una cifra per il loro pagamento. Per ogni singola massa i comandant i di Corpo ricevevano poi dal Ministero un assegno pari all'ammontare previsto per la massa stessa, per es. una cifra pari al costo medio del soldat o moltiplicato per le giornate di presenza Ma se, per l'aumento dei prezzi o semplicemente per cattiva amministrazione, i costi superavano l'ammontare della cifra ricevuta, il Ministero doveva coprire le passività col cosiddetto scapito delle masse.
S4 Nato a Caserta il 2 1 aprile 1852, entrato giovanissimo nel Collegio militare della Nunziatella di Napoli , sottotenente di artiglieria dall ' Accademia militare di Torino all'età d i soli diciotto anni, Alberto Po llio condusse una delle più rapide e brillanti carriere militari nella storia dell 'Italia unita. Dopo gli studi alla Scuola di applicazione di Artiglieria e Genio sempre a Torino, fu p r o
mosso tenente nel 1872. Frequentata la scuola di Guerra nel triennio 1875- 1878 e uscitone primo del suo corso, entrò da capitano nel corpo di Stato Maggiore Alternando il servizio al corpo coi consueti comandi di truppa, divenne maggi ore nel 1884 e comandò per due anni un battaglione nel 42 ° reggimento fanteria. Dal 1887 al 1891 fu tra gli aiutanti di campo d i Umbert o I. Tenente colonnello dal 1888, tra il 1891 e il 1892 fu capo di S.M. della Di visione militare di Palermo. Dal 1892 a l 1897 fu addetto militare a Vienna. Al suo ritorno, venne nominato comandante del 40° reggimento fanteria, avendo raggiunto già nel 1893 il grado di colonnello. Maggiore generale nel 1900, all'età di 48 anni, comandò la brigata Siena (sede a Cuneo). Tenente generale nel 1906, comandò successivamente le Divisioni mi litari di Cagliari e Genova, finché nel giugno del 1908 venne nominato Capo di Stato Maggiore dell'esercito ital iano Sono stati pubblicati quattro studi di storia militare scritti da Pollio. A due di essi è ancora oggi impossibile rinunciare per chiunque si interessi agli argomenti in essi affrontati Si iratta di Custoza 1866, pubblicato nel 1903, e Waterloo, pubblicato nel 1906. Ad ogni modo, la personatà e i principi di Pollio emergono meglio negli a ltri due lavori: Napoleone/, che r accoglie il testo di due conferenze di presidio tenute a Livorno nel 1901 e La campagna invernale del 1806-07 in Polonia, scritto di getto tra il 1906 e il 1907 coll'intenzione di sottoporlo a ulteriori revisioni che non poterono esser compiute e pubbli cato postumo solo nel 1935. (Generale A. Pollio, Napoleone/, conferenze di Presidio tenute a Livorno il 7 ed il 14 marzo 1901 , off Tipografica di A. Debatte, Livorno, 1901; La campagna invernale del 1806-07 in Polonia. Studio critico, La Libreria dello Stato, Roma, 1935)
Senatore nel 1912, Pollio mori il 1° luglio 1914 per un improvviso attacco cardiaco. Notizie biografiche su Pollio in A. ALBERTT, L'opera di S.E. il generale Poi/io e l'esercito, Roma, 1923 e COMANDO DEL CORPO D I STATO M AGG IORE, / capi di S.M. dell'esercito. Albeno Poi/io, Roma, 1935.
55 Sicuramente da prima del 1904, dati i toni amichevoli della seguente lettera: «Carissimo Spingardi! - Gradisci le mie più vive felicitazioni per la tua elezion e a deputato, felicitazioni che
28
-
Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 29
Le disposizioni legislative facevano del Capo di Stato Maggiore il principale collaboratore del Ministro della Guerra riguardo «gli studi di tutto quanto concerne la preparazione alla guerra (truppe, servizi, assetto difensivo del territorio)». Egli e r a poi tenuto a proporre al Ministro ciò che riteneva opportuno «in rapporto alla preparazione alla guerra e che interessi leggi, regolamenti, o comunque il bilancio della guerra» 56 •
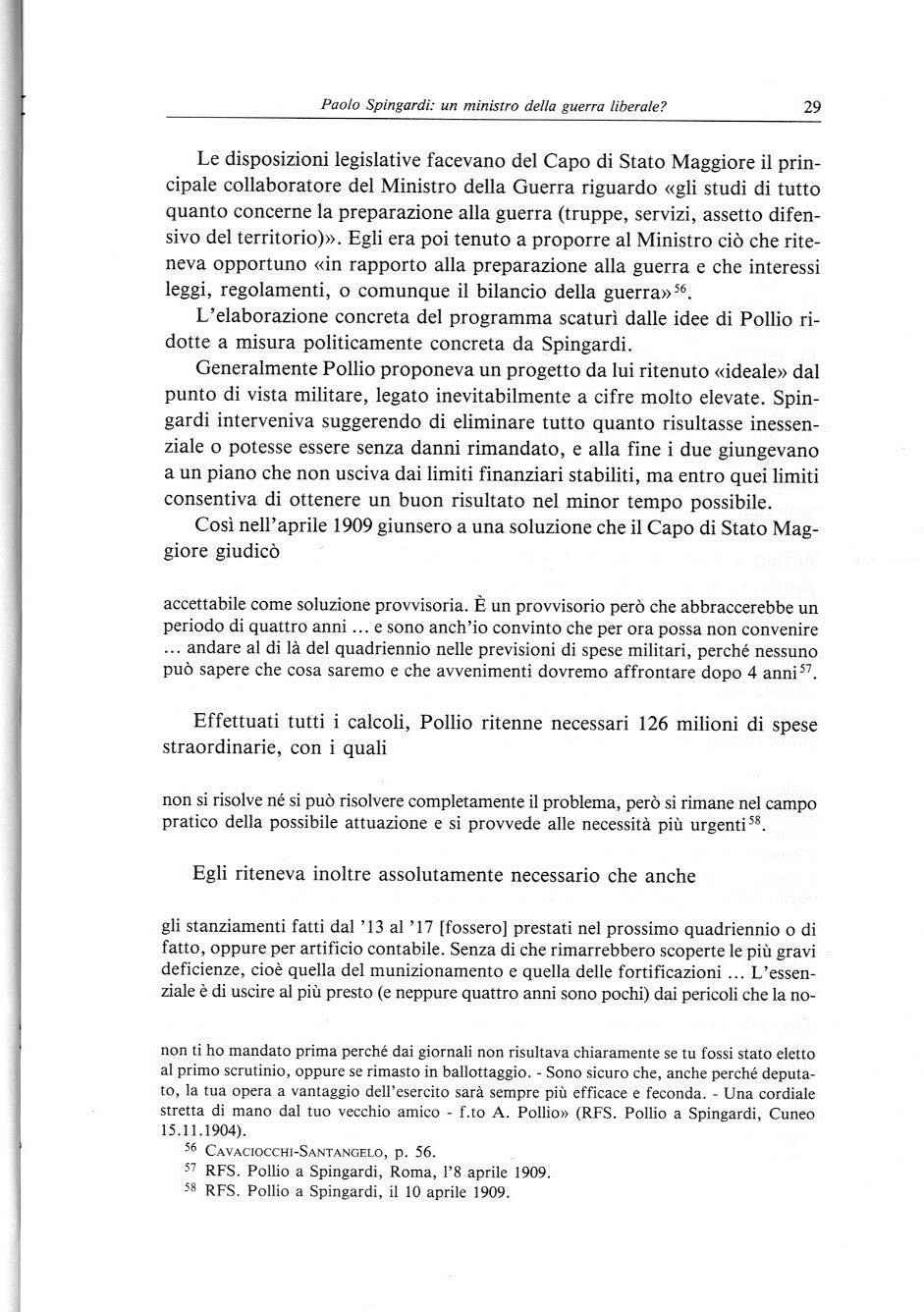
L'elaborazione concreta del programma scaturì dalle idee di Pollio ridotte a misura politicamente concreta da Spingardi.
Generalmente Pollio proponeva un progetto da lui ritenuto «ideale» dal punto di vista militare, legato inevitabilmente a cifre molto elevate. Spingardi interveniva suggerendo di eliminare tutto quanto risultasse inessenziale o potesse essere senza danni rimandato, e alla fine i due giungevano a un piano che non usciva dai limiti finanziari stabiliti, ma entro quei limiti consentiva di ottenere un buon risultato nel minor tempo possibile
Così nell'aprile 1909 giunsero a una soluzione che il Capo di Stato Maggiore giudicò
accettabile come soluzione provvisoria. È un provvisorio però che abbraccerebbe un periodo di quattro anni .. . e sono anch'io convinto che per ora possa non convenire andare al di là del quadriennio ne lle previsioni di spese militari, perché nessuno può sapere che cosa saremo e che avvenimenti dovremo affrontare dopo 4 anni 57
Effettuati tutti i calcoli, Pollio ritenne necessa r i 126 milioni di spese straordinarie, con i quali
non si risolve né si può risolvere completamente il prob lema, però si rimane nel campo pratico della possibile attuazione e si provvede alle necessità più urgenti 58 •
Egli riteneva ino l tre assolutamente necessario che anche
gli stanziamenti fatti dal '13 al 'I 7 [fossero) pres tati nel prossimo quadriennio o di fatto, oppure per artificio contabile. Senza di che ri marrebbero scoperte le più gravi deficienze, cioè quella del munizionamento e quella delle fortificazioni L'essenziale è di uscire al più presto (e neppure quattro anni sono pochi) dai pericoli che la no -
non ti ho mandato prima perché dai giornali non risultava chiaramente se tu fossi stato eletto al primo scrutinio, oppure se rimasto in ballottaggio. - Sono sicuro che, anche perché deputato, la tua opera a vantaggio dell ' esercito sarà sempre più efficace e feconda - Una cordiale stretta di mano dal tuo vecchio amico - f.to A. Pollio» (RFS. Pollio a Spingardi, Cuneo 15. 11.1904).
56 CA VA CIOCC HI - S ANT AN GELO, p. 56.
57 RFS. Pollio a Spingardi , Roma, 1'8 aprile 1909
58 RFS. Pollio a Spingardi , il IO aprile 1909.
li generale Paolo Spingardi
stra impreparazione ci farebbe correre in caso di guerra Quello che maggior mente prem eva era di esporre un programma organico sul quale, da parte mia, non ritorn erei Ho la coscienza di aver indicato con abbas tanza esattezza quello che nelle s ue linee generali dovrebbe essere assunto come programmma del quadriennio 1909- 1913 59
Forn e ndo qu esti par eri al Ministro, Pollio gli riferiva che avrebbe fatto le stesse comunicazioni alla Commissione d'inchiesta e che riguardo i punti essenziali del programma «la Commissione d'inchiesta, a quanto mi risulta, sarebb e nello stesso ordine di idee da me indicato» 60 •
La Commissione fu infatti insieme al Capo di S.M. l'interlocutore al quale Spingardi fece maggiore riferimento per conoscere con esattezza i settori sui quali era necessario inter ve nire.
Nell'aprile 1909 essa a veva già presentato tre re laz ioni , contenenti le conclusioni sui problemi più importanti e c io è la difesa dei confini, il nuovo materiale dell'artiglieria da campagna e l'ordinamento dell'esercito.
Le relazioni erano il frutto di meticolose indagini durante le quali i Commissari non manca vano di ricordare agli ufficiali interrogati lo «st retto ed assoluto obbligo che hanno di dire tutta la verità alla Commissione, e la grave responsabil ità che incorr e rebbero se ne tace~ero una parte» 6 1 •
La Commissione ebbe quindi u n ruolo concreto nell'elaborazione del programma, non fosse al tro perché fornì a Spingardi e Pollio preziosi elementi di v alutazione che avrebb ero altrimenti richiesto troppo tempo per esse r e raccolti 62 • Ancora nel 1918, del resto, Spingardi affermava che, allo sco ppiare della prima guerra mondiale, l'esercito italiano si trovava
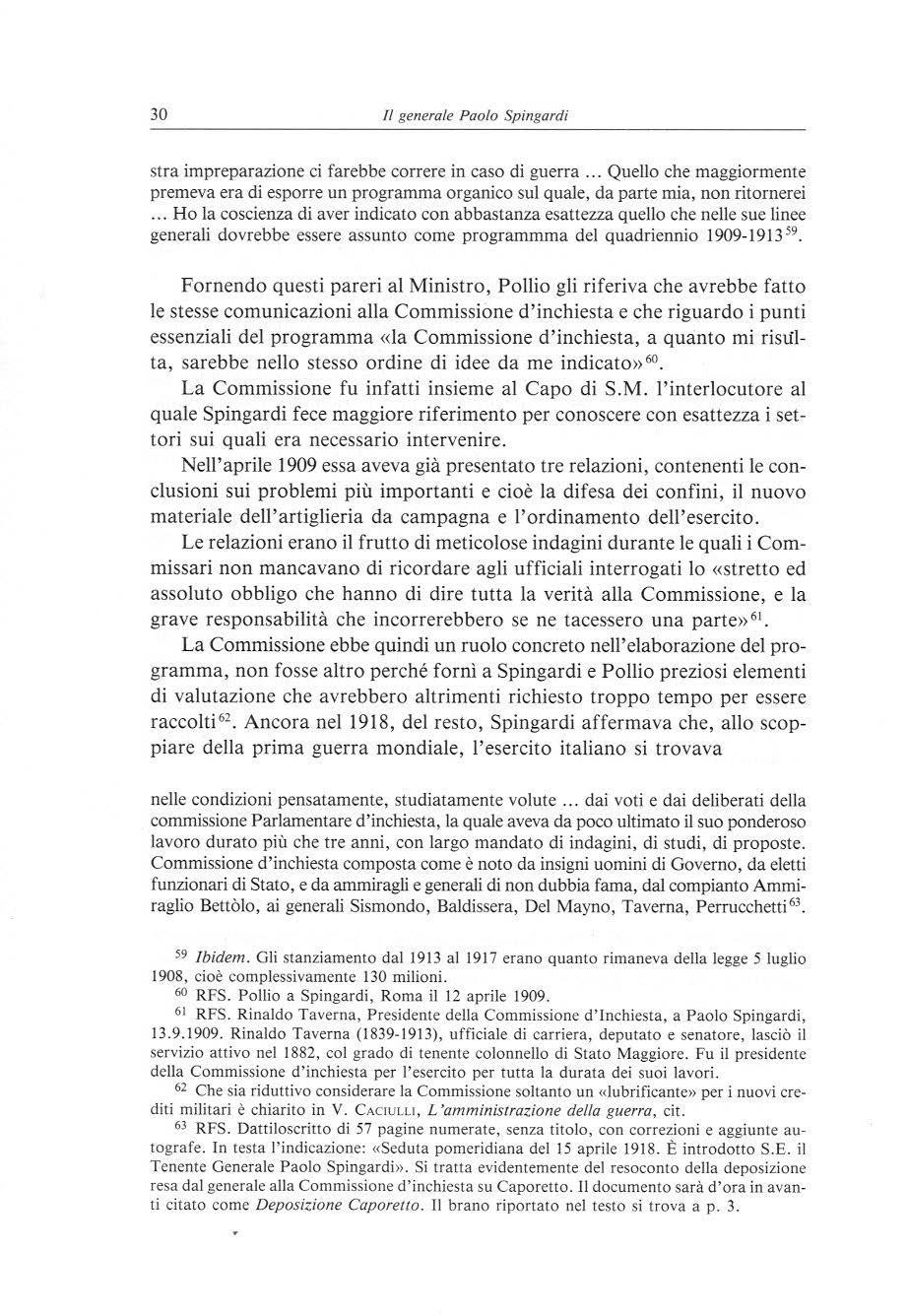
nelle cond iz ioni pensa tamente, stu diatame n te volute .. . dai voti e dai deliberati della commissi on e Parlamentare d'inchiesta, la quale aveva da poco ultimato il suo ponderoso lavoro durato più c h e tre anni, con largo manda to di indagini, di studi, di propost e . Commissione d'inchiesta composta come è noto da insigni uomini di Governo, da eletti funzionari di Stato, e da ammiragli e generali di non dubbia fama, dal compian to Ammiraglio Bet tòlo , ai generali Sismondo, Baldissera, Del Mayno, Taverna, Perrucchetti 63 .
59 I bidem. G li stanz iamento dal 19 13 al 1917 erano quanto rimaneva della legge 5 luglio 1908, cioè complessivament e 130 milioni.
60 RFS. Pollio a Spi ngardi , Roma il 12 ap r i le 1909.
61 RFS. Ri naldo Taverna , Presidente della Comm is sione d'Inchiesta, a Pao lo Spi ngard i, 13.9.1909 Rinaldo Taverna (l 839- 1913), ufficiale di carriera, deputato e senatore, lasciò i l se r vi z io att i vo nel 1882, col grado di tenente colonnello d i Stato Maggiore Fu i l presidente della Commissione d'inch i esta pe r l'esercito per tutta la durata dei suo i la vo ri.
62 Che s i a r idutt ivo cons iderare la Commissione soltanto un «lubr ificante» per i nuovi crediti mil itari è ch iar ito in V. CA c1uu1 , L 'amminis1razione della guerra , cit.
63 RFS . Datt iloscritto di 57 pagine numerate, senza titolo, con correz ion i e agg iunte auto grafe . In testa l ' indi cazione: «Sed uta pomeridiana del 15 apri le 19 18 . È in trodotto S .E. i l Tenente G enerale Paolo Spingardi » S i tratta evidentemente del resoconto della deposizione resa dal generale alla Commiss i one d'inchiesta su Caporetto. Il documento s arà d'ora i n avanti cita to come Deposizione Caporetto. Il brano riportato nel testo s i t r ova a p. 3.
30
Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 3 1
Raccolti tutti gli elementi era necessario presentarsi davanti alle Camere per ottenere l'approvazione dei desiderati stanziamenti. Giolitti aveva sospeso le sedute il 3 aprile, per le vacanze pasquali. Sp inga r di ebbe così un mese per preparare il disegno di legge e il discorso programmatico per le successive d isc ussioni parlamentar i .
Nel progetto presentato alla Camera il 4 maggio era richiesto un aumento di 125 milioni per le spese straordinarie, praticamente la cifra desiderata da Pollio , e di 25 milioni per le spese ordinarie
La d isc ussione in aula g iunse nella seconda sett imana di giugno. Vi era grande attesa per il discorso del Ministro .
Il prob lema dell'ordinamento dell'esercito e dell'aumento del bilancio mili tare si presenta oggi in condizioni st raordinariam e nte fa vo revoli ad una buona soluzione. Il paese ha dimostrato di volere assolutamente un esercito più forte e fra gli uomini politici di q uasi tutti i partiti s i è formato un con se nso largo e profondo in questo senso [. .. ) L'attes a per i progetti , i propositi e i criteri del n uovo minis tro è pertanto vivissima: vivissima no n soltanto per q uel che rig uarda la parte finan ziaria dei provvedimen ti ma anche per q uanto concerne l'organismo e la vi t a interna dell'esercit o [... ] Vedremo il nuovo ministro all'opera : e dall'opera effett iva che egli svo lgerà lo giudicheremo 64
Nella seduta del\' 11 giugno 1909 la Camera
presenta un aspetto imponente Tutte le tribune sono gremite. Da quella della Rea l corte assiste il gene r ale Brusa t i, pr i mo a iutante del Re. Nel si lenz io vigi le e attento della camera si leva a parlare i l ministro della guerra 65
Sp ingardi espose fina lmente il tanto a t teso programma . Egli prendeva atto dei dibattiti che la questione m ilitare aveva suscitato in Parlamento e fuori, dichiarando non essere la sua intenzione discostarsi dalle «assennate conclusion i» d ella Commissione d'inchiesta
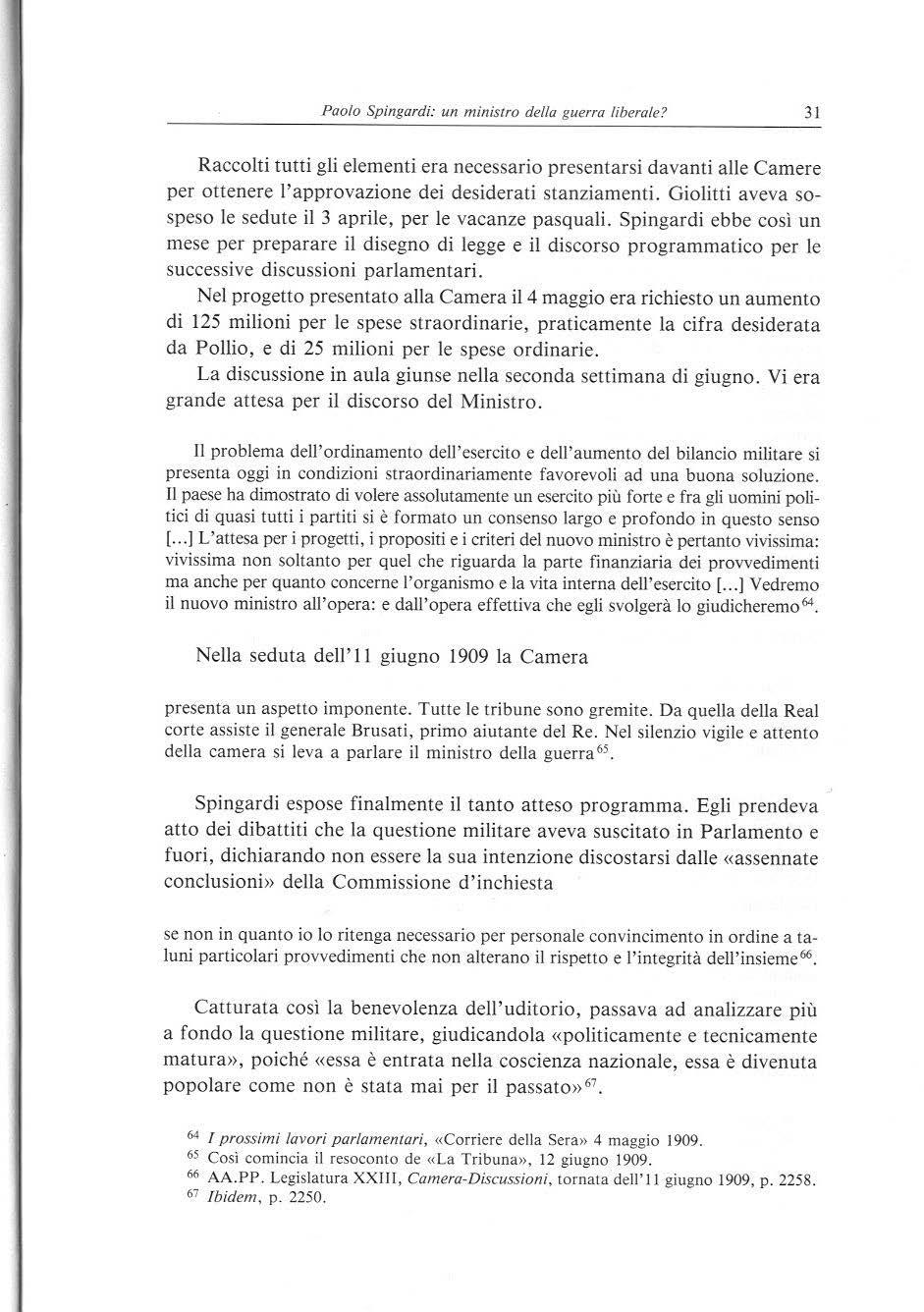
se non in quanto io lo ritenga nece ss ario per personale co n vincimento in ordine a taluni particolari pro vve diment i che non a lterano il rispetto e l' i ntegrità dell ' ins ieme 66 •
Catturata così la benevolenza dell'uditorio, passava ad analizzare più a fondo la questione m il itare, giudicandola «politicamente e tecnicamente matura», poiché «essa è entrata nella coscienza nazionale, essa è divenuta popolare come non è stata mai per il pa ss ato» 67 •
64 l prossimi favori parlamentari, «Corriere della Sera» 4 m aggio 1909.
65 Così com incia il resoconto de «La Tribuna» , 12 giugno 1909.
66 AA PP . Leg islatu ra XXIII , Camera-Discussioni, tornata dell' 11 giugno 1909, p. 2258
67 I b idem, p 2250.
li generale Paolo Spingardi
Gli obiettivi del ministro erano precisi e concreti poiché i bisogni dell'esercito erano ormai «tali che l'indugiare più oltre a provvedervi avrebbe potuto compromettere la consistenza medesima dell'esercito e della nostra difesa» 68 • Speciale cura fu rassicurare i deputati che le somme che venivano concesse erano sufficienti a svolgere il programma presentato .
Il ministro vi può con sicura coscienza affermare che con i mezzi richiesti dal presente disegno di legge, e con quelli che furono votati dal Parlamento in passato, si può fare effettivamente fronte a tutto un complesso programma bene determinato, studiato nei suoi minuti partico lari dai corpi tecnici, sotto la diret tiva del capo di stato maggiore dell'esercito, concretato in c ifre d'accordo con gli uffici amministrativi, e, quel che più impona, controllato, vagliato in ogni sua parte dalla vos tra comm issione d'inchiesta parlamentare 69 •
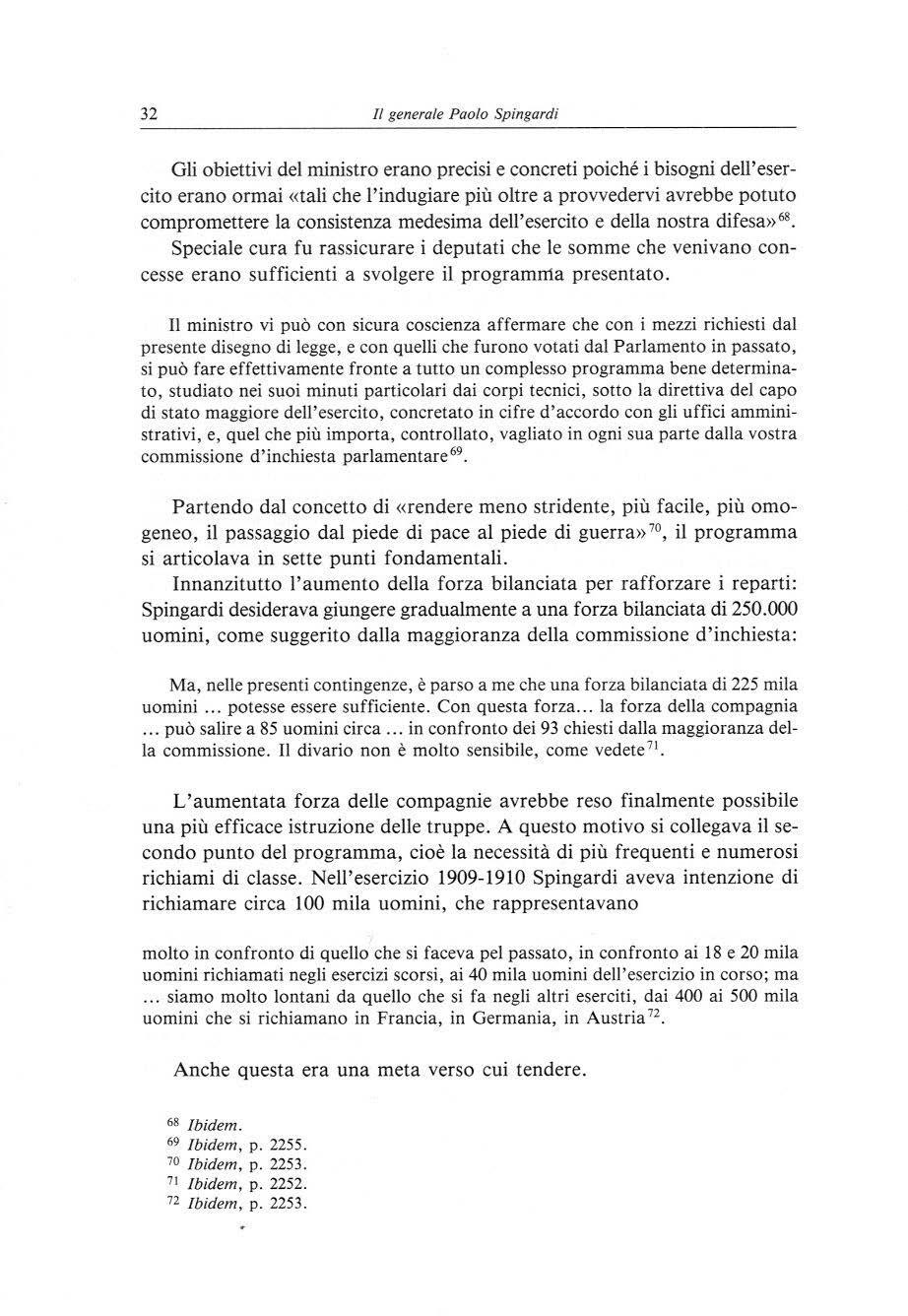
Partendo dal concetto di «rendere meno stridente, più facile, più omogeneo, il passagg io dal piede di pace al piede di guerra» 70 , il programma si articolava in sette punti fondamentali .
Innanzitutto l'aumento della forza bilanciata per rafforzare i reparti: Spingardi desiderava giungere gradualmente a una forza bilanciata di 250.000 uomini, come suggerito dalla maggioranza della commissione d'inchiesta:
Ma, nelle presenti contingenze, è pars o a me che una forza bilanciata di 225 mila uomini potesse essere sufficiente. Con questa forza la forza della compagnia ... può salire a 85 uomini circa ... in confronto dei 93 ch iest i dalla ma ggioranza de lla commissione. Il divario non è molto sensibi le, come vedete 7 1 •
L 'aumentata forza delle compagnie avrebbe reso finalmente possibile una più efficace istruzione delle truppe. A questo motivo si collegava il secondo punto del programma, cioè la necessità di più frequenti e numerosi richiami di classe. Nell' esercizio 1909-1910 Spingardi aveva int enzione di richiamare circa 100 mila uomini, che rappresentavano
molto in confronto di quello che si faceva pel passato, in confronto ai 18 e 20 mila uomini richiamati negli esercizi scorsi, ai 40 mila uomini dell'esercizio in corso; ma siamo molto lontani da quello che si fa negli altri eserciti, dai 400 ai 500 mila uomini che si richiamano in Francia, in Germania, in Austria 72 •
Anche questa era una meta verso cui tende re.
68 Ibidem.
69 Ibidem, p. 2255
10 Ibidem, p 2253.
11 Ibidem, p. 2252.
n Ibidem, p. 2253.
32
Spingardi si prefiggeva poi «d i provvedere alla completa sistemazione territoriale difensiva delle nostre frontiere terrestri e marittime, di chiudere le porte di casa» 7 3 •
Posso assicurare - diceva più avanti il Ministro - che gli enti competenti e l'onorevole comm issione d'inchiesta sono concord i nell'additare il fabb isogno complessivo per fortificazio ni e relativi armamenti in 180- 190 milioni. Ed una somma precisamente corrispondente viene stanziata dal Ministero della guerra nelle sue proposte. So no 182 i milioni che co i precede nti e coll'attuale stanziamento furono assegnati a ll e fortificaz ion i ed al loro armamento 74
Il Ministro si proponeva anche, genericamente, di provvedere all'armamento ed al munizionamento del nostro esercito in re lazione ai più moderni portati della meccanica e della balistica, in relazione ai moderni modi di combattere, sull 'esempio d i quanto hanno fatto o stanno facendo i principali eserciti europei
assicurando po i con più precisione che in un «pe riodo re lativamente breve di tempo noi saremo in grado di sost ituire tutto il materiale da 87 B con materiale 906 a deformazione» 75 •
Un punto riguardava la riduzione della ferma, argomento sul quale si appuntava grande attenzione e si attendeva una presa di posizione da parte dell'autorità competente P erciò Spingardi assunse forma le imp eg no di presentare
alla ripresa de i lavori parlamentari u n disegno di legge il qua le sancisca co n la fe rma biennale per tutte le armi il principio dell'uguaglianza de l tributo che tutti i c itt adini devono pagare alla Patria 76
Ultimi punti del programma riguardavano l'ordinamento dell' esercito e l'avanzamento degli ufficiali:
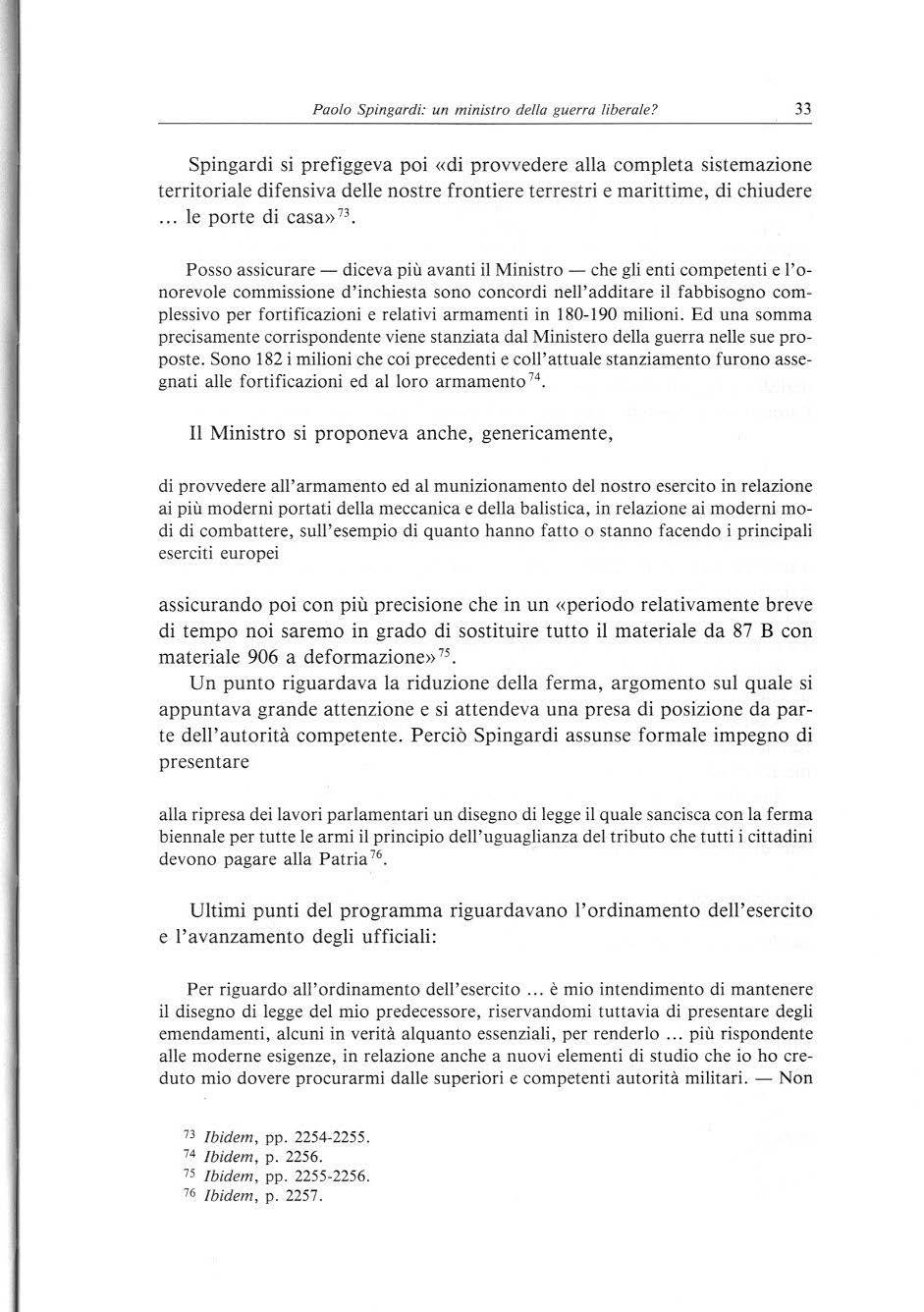
Per riguardo all'ordinamento del.l'esercito è mio intendimento di mantenere il disegno di legge del mio predecessore, riservandomi tuttavia di presentare degli emendamenti, alcuni in verità alquanto essenziali, per rende rlo più ri spon d ente alle moderne esigenze, i n re lazione anche a nuovi elementi di studio c he io ho creduto mio dovere procurarmi dalle s u periori e competenti a utorit à militari. - No n
13 Ibidem, pp 2254-2255
14 Ibidem, p 2256.
7 5 Ibidem, pp. 2255 - 2256.
7 6 Ibidem, p. 2257.
Paolo
Sping ardi: un ministro d ella g uerra libe rale ? 33
li generale Paolo Spingardi
meno essenziali modificazioni io mi propongo di apportare alle leggi che regolano l'avanzamento nell'esercito( ] una delle mie prime cure è stata quella di ris olv ere, o per lo meno cercare di risol ver e ... la crisi della carriera degli ufficiali inferiori [... ] Assicurare a t utti gl'idonei ... u na modesta ma s icu r a carriera; consentire in giusta misura ad u na sch iera di eletti per forte ingegno e per qual ità essenzi a li di carat t ere di ascendere più rapidamente verso il ve rtice della piramid e [... ] sono qu esti i princip i fondamentali ai quali ho informato il disegno di legge che mi riservo di presentare prossimamente alla camera 77
Ma oltre ai punti del programma, il discorso del Ministro conteneva indizi di un orientamento politico abbastanza preciso, importanti per capire l'animo col quale egli si accingeva all'opera di ristrutturazione dell'esercito.
Il liberalismo di Spingardi
Duttile, aperto, abile oratore, Spingardi apparve su bito alla Camera, «usa a trovar si davanti in qualità di ministri della guerra degli uomini impicciati a districare due parole » 78 , diverso dai suo i predecessori . Sicuramente i lunghi anni trascorsi in servizio a l Ministero avevano lascia to in lui l'abi t ud ine ad avere concezioni meno limi tate delle questioni militari ad alto livello.
Il generale aveva una vis ione della realtà non molto di ss imile da quella di Giolitti 79
Come il Presidente del Consiglio egli rifuggiva dai sistemi astratti e preferiva le so luzioni pratiche, ad e ren ti alla realtà, fondate su punti programmatici precisi più che s u principi fi lo sofici .
Fin dal 1904 Spingardi si era dichiarato d'accordo con Giolitti riguardo la «più ampia libertà per tutt i nei limiti della legge » concependo tale libertà mai disgiunta dall 'ordine
necessità s uprema del vivere c ivile, senza la quale la causa istessa della libertà sarebbe in breve ora compromessa e perduta, e con ess a andrebbero frustrati i benefici effetti che da una s aggia e gra dual e evo lu zione debbono e poss ono indubbiamente attendersi 80 .
Proprio la fiducia nella graduale perfettibilità delle istituzioni è il primo aspetto da so tt olinea r e nel bel di sc orso alla camera del giugno 1909. Una fiducia che lo portava a plaudire al «buon senso popolare italiano» che
77 l b idem, pp. 22 57- 58.
78 Così l' «Avan t i!>) del 13 g iugno 1913 , notando appunto il contras to tra Spingardi e i suoi pr edecessor i.
79 Sul li bera li smo d i Giolitti, v . E. G ENTILE, L'Italia giolitliana, Il Mu lino , Bologn a, 1990, pp. 2 7-28 e 31-3 3
80 RFS. D iscorso agli elettori di A nagn i, d oc. cit.
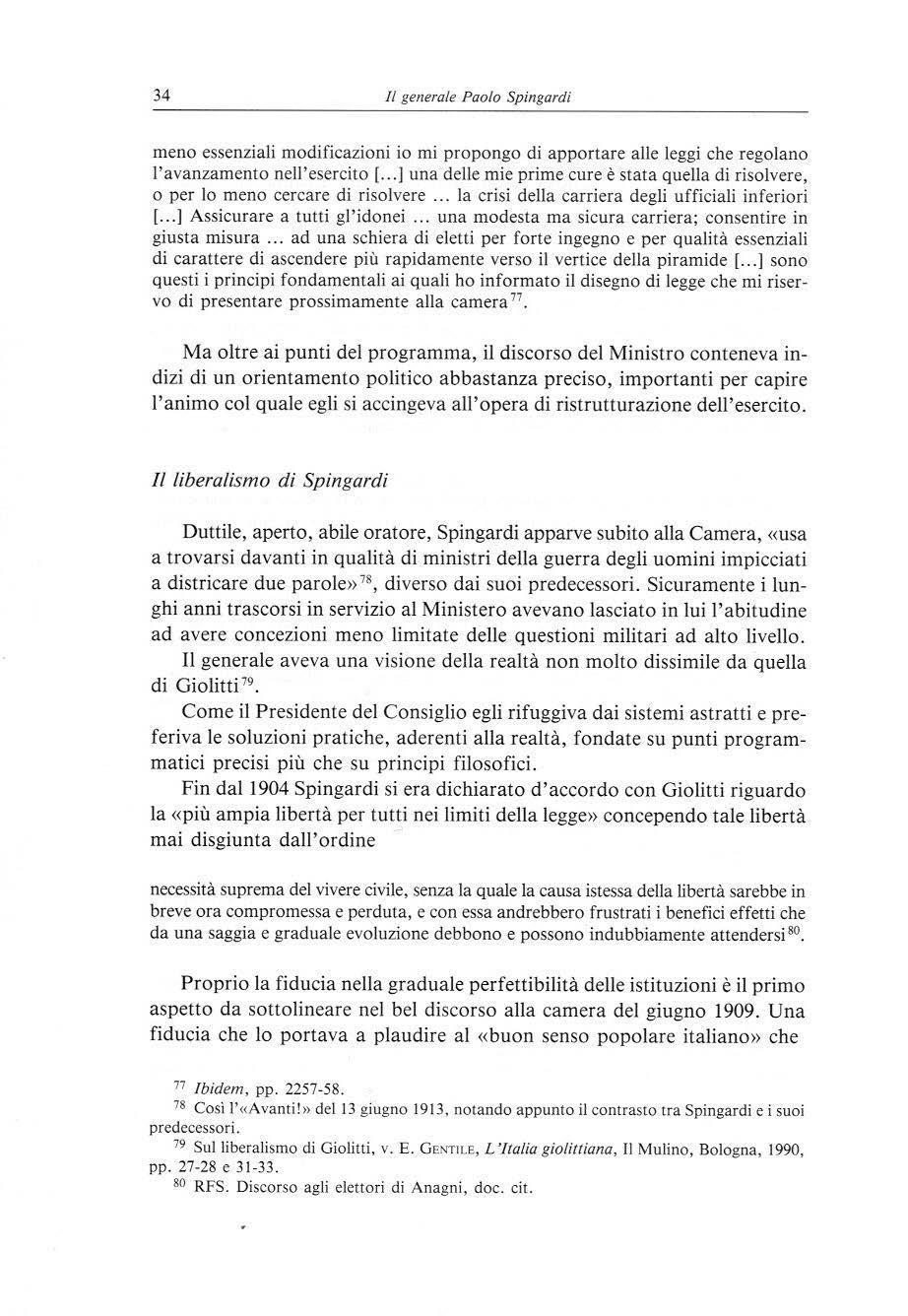
34
Paolo Spingardi: u n ministro della guerra liberale? 35
trionfando di tutte le esagerazioni, tanto in s enso mili t arista, quanto in senso contrario, ha reso giustizia alle istituzioni militari, lealmente ed onestamente riconoscendo l'imprescindibile necessità ed il grande valore economico della loro funzione protettiva 8 1•
Spingardi era quindi portato a respingere ogni instauratio ab imis, cercando invece di migliorare l'esistente nella convinzione che
l'organizzazione militare di un paese è il risultato storico di un lento e progressivo accumularsi e adattarsi di elementi di varia natura, ciascuno dei quali ha la sua ragion d'essere, e che non si potrà radicalmente sconvolgere senza compromettere le compagine dell'insieme 82 .
Fiducia che richiedeva senso della misura e continua ricerca del g iusto mezzo, evidenti nella preoccupazione di adeguare le esigenze della difesa al bilancio dello Stato: «con g li stanziamenti che sono messi a disposizione dell'Amministrazione militare, si può riso lvere in modo soddisfacente il problema della nostra difesa» rassicurava il Ministro. Ne derivava un programma «battezzato minimo a l cospetto di un programma massimo di là da venire» ma che condotto a compimen t o
nel più breve tempo possibile, darà al nostro e sercito e alla nostra difesa tale efficienza, che l'Italia potrà assidersi tranquilla nel consesso delle grandi potenze, rispettata non solo, ma, occorrendo, anche temuta 83
Giolittiana sembrerebbe poi la volontà di evitare
così nell'esercito, come in qua lsiasi istituzione civile, que ll a i nfluenza deleteria che vi esercita il malcontento , che smorza qualunque più sana iniziativa e che atrofizza qualunque più vi t ale fun zione 84
Insomma eliminando il malcontento Spingardi riteneva possibile un miglior funzionamento delle istituzioni. E non si può mancare di notare come, ferma restando l'assoluta fedeltà alla monarchia, comune del resto a tutti i militari e all'intera classe politica liberale, uno dei tratti caratte r istici di Spingardi ministro è il rispetto delle istituzioni parlamentari, il senso di avere una precisa responsabilità di fronte ad esse Eg li desiderava sempre
81 AA.PP. Le g islatura XXIII Camera-Discussioni , lornata dell' 11 giugn o 1909, p. 2251.
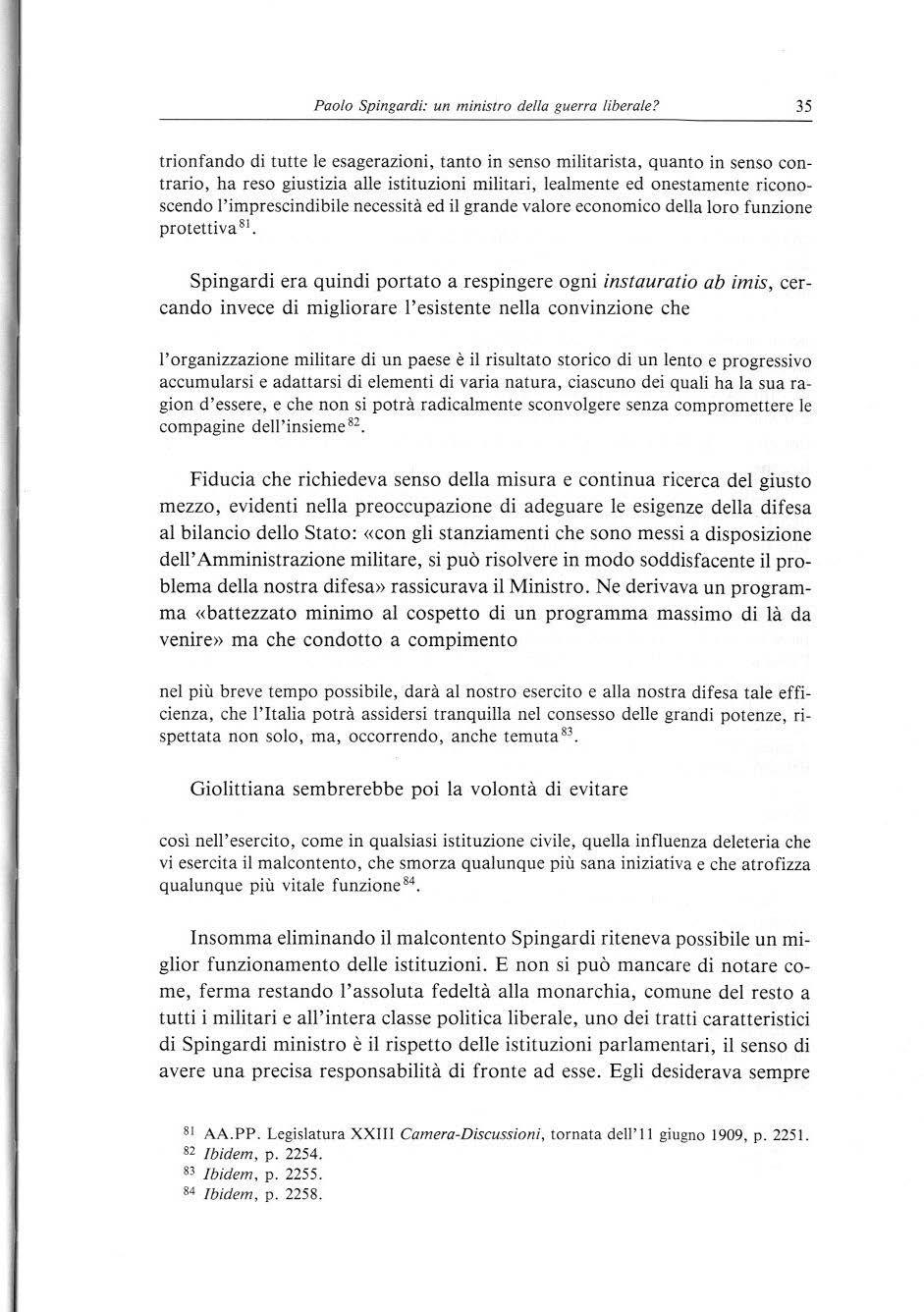
82 Ibidem, p . 2254.
83 Ibidem, p. 2255.
84 Ibidem , p 2258.
Il
generale Paolo Spingardi
la sanzione delle camere ai suoi progetti, e non pensò mai di avvalersi dei soli decreti reali, che pure utilizzò quando le circostanze ve lo spinsero.
I suoi discorsi apparivano schietti e sinceri, da persona che mantiene ciò che promette e promette solo ciò che sa di poter mantenere: «Per me, soldato, una virtù sola comprendo e posseggo: la fede nei patti» dichiarava anche in privato 85 •
Va comunque sottolineato che non si sono rintracciate prese di posizione su questioni al di fuori delle competenze strettamente inerenti all'incarico ricoperto. Rimane quindi qualche interrogativo sulla natura del liberalismo di Spingardi, ma non si può negare che la sintonia di vedute tra Giolitti e il suo Ministro della Guerra fosse notevole ed abbia rappresentato uno dei motivi della fiduc ia riposta dallo statista di Dronero nel generale di Felizzano .
Il quale sapeva comunque da parte sua guadagnarsi la fiducia della Camera e concludere brillantemente il suo intervento, anche se con un inev itabile tocco di retorica, invocando la concordia di tutto il paese:
Nella famiglia, nella scuola, nella stampa, nei comizi, ovunque il popolo si raccolga a t u te la di particolari interessi, s otto diversa veste, sotto diversa fede, non una paro la suoni avversa alla patria ed alle sue armi. - In tal guisa s i educhi e s i tempri l'anima collettiva di esso, così da prepararlo con mirabile disciplina di intelletti e di cuori alle prove, che l'avvenire ci può riserbare. Soltanto allora, onorevoli collegh i , credetelo, l'esercito e la nostra valorosa marina, stret t i da comunanza di intenti, coscienti della accresciuta loro efficienza, orgogliosi della considerazione onde il paese li circonda , sentiranno di essere, e saranno di fatto, il più sicuro presidio del suo onore e dei suoi a l ti interess i 86
Il successo del lvfinistro
In privato, alcune settimane più tardi, Spingardi confermava la sostanza di queste parole, scr ivendo: «Ho bisogno di lavorare tranquillo, ho bisogno dell'appoggio di tutti » 87 •
E davvero l'appoggio, o perlomeno l'a pprovazione, di tutti, se si prescinde dall'estrema sinistra, egli ottenne dopo il suo discorso. Appena ebbe terminato di par lare si ebbero applausi vivissimi e prolungati da tutte le part i della Camera; moltissimi deputati andarono a congratularsi con lui, al punto che la seduta dovette essere momentaneamente sospesa 88 •
85 R FS. Spin gardi a Gio litt i, 14.7 .1909 (minuta).
86 AA. PP. Legislatura XXIII , Cam era-Discussioni , Tornata dell'll gi ugno 1909, p. 2259.
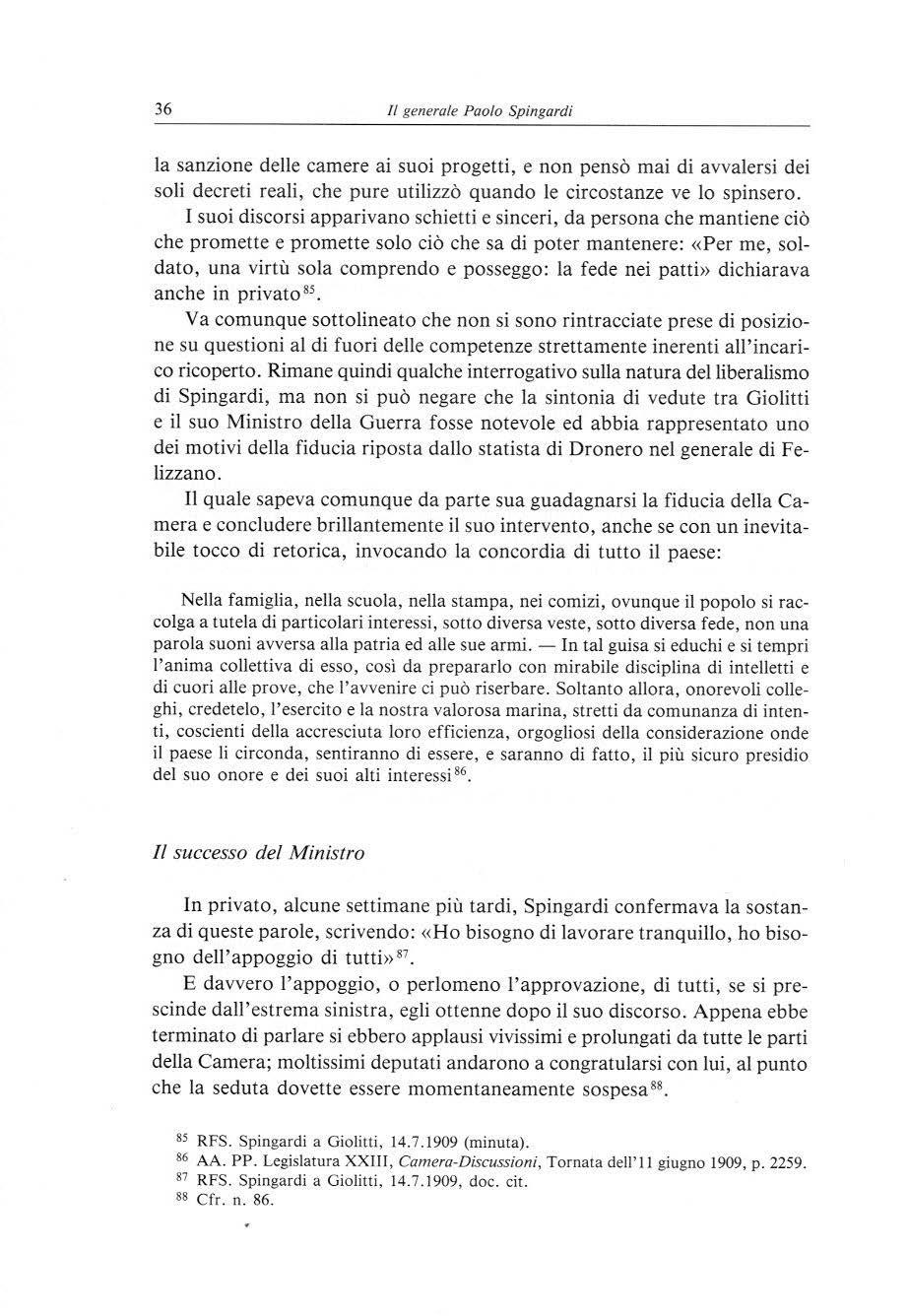
87 RFS. Sp ingardi a Giolitti, 14 7 .1909, doc. cit.
88 C fr . n 86.
36
Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 37
I giornali di ogni tendenza riconobbero i successo ottenuto e so prattu tto l'eloquio e la personale simpatia del Ministro, tanto che persino !'«Avanti!» non poteva fare a meno di notarne le qualità e lo stesso Filippo Turati s i lasciava sfuggire una significativa battuta: «La pessim a causa non meritava un così buon avvocato>> 89 Evidente era soprattutto la sorp re sa per un ministro della guerra di così spiccate qualità oratorie:
nessun ministro della guerra eb be mai negli ultimi anni la virtù di conquistare d'un tratto, come i l generale Spi ngardi, la simpatia e la fid ucia della Camera 90
Il giudizio più ent usiasta veniva dalla giolittiana «Tribuna », che dopo aver ripreso i temi della simpatia e dell'eloquio del Ministro, concludeva sottolineando le qualità «libera li>> insite nel programma:
Ma il ministro Spingardi seppe anche la moderazione : miglioramento dell'esercito sì, ma miglioramento adatto alle nostre forze economiche; il programma mass imo s i svo lgerà nel tempo, egli si contenta di esser l' es po sito re e l'esecutore di que l programma minimo che progredisce e non precipita, che migliora e non compromette, che spende ma non spande né sciupa; che appare legittimo e necessario per la nostra difesa e la nostra dignità, ma non si affaccia spavaldo né tracotante né provocante . Anche la misura del suo discorso, come nei provvedimenti concertati d'accordo col gabinetto, anche la misura fu cagione di successo 91
Di fronte a una tale unanimità di consensi non stupisce che il disegno di legge che concedeva gli stanziamenti richiesti venisse approvato dalla Camera mercoledì 16 giugno 1909 con soli 25 voti contrari e dal Senato lunedì 28 giugno 1909 con appena 3 vot i contrari, divenendo la legg e 30 giugno 1909, n.404.
Essa dava anche facoltà al Ministro del Tesoro di provvedere ai pagamenti eccedenti gli stanziamenti di bilancio con gli ordinari mezzi di tesoreria . In altri termini si poteva spende r e in un so lo esercizio la cifra prevista per più eserc iz i: veniva così messo in atto l'espediente auspicato da Pallio.
89 V. « Avanti!» del 13 giugno 1909; la battuta di Turati è riportata dal «G iorna le di Sicilia» dell'I 1- 12 giugno 1909 e dalla «Gazzetta del Popolo>} del 12 giu gno 1909.
90 Idee chiare e parola efficace, «Corriere della Sera», 12 giugno 1909. Cfr. L 'impressione del discorso del ministro Spingardi, «Il Secolo», 12 giugno 1909 e// successo di Spingardi, «La Stampa», 12 giugno 1909.
91 Preparazione e successo, « La Tribuna», 13 g iugno 1909 . V . anche « Il Nuovo Giornale di Firenze», Sabato - Domenica 19-20 giugno 1909 : <<. •• !'on. Spingardi è sembrato ai più, anche agli avversari sistematici, quello che suol dirsi l'uomo della situazione» (corsivo nel testo) e « Il Messaggero», Sabato 12 g iugno 1909.
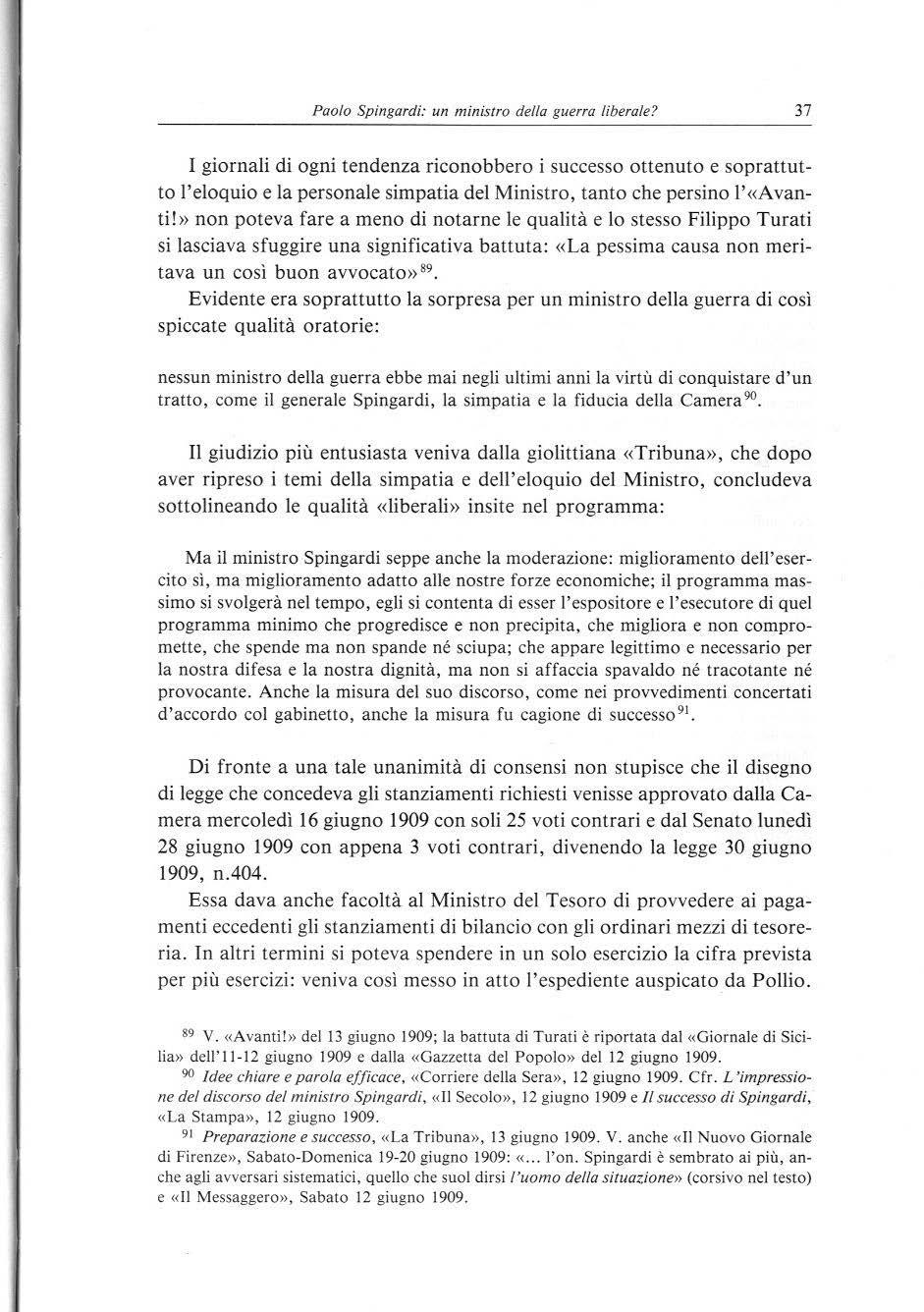
li
generale Paolo Spingardi
Spingardi cominciava insomma il suo mandato sotto i migliori auspici e poteva quindi con fiducia affrontare i problemi che la realizzazione del programma gl i avrebbe posto 92 •
92 Le doti oratorie di Spingardi, ve nnero così sinteti zzate in una più tarda pubb l icazione : « Ebbene , fatta q u alche ecce zi one, lo Spingardi pare a noi l'oratore militare meno incomple to Si aggiunga che lo Spingardi è corretto e non si t rova mai in lit ig io con la grammat ica [ . .) Quell a del nostro attuale Ministro della Guerra non sarà eloquenza granitica, tutta d i un pezzo, fus a I periodi non saranno cesellati e cinc ischiati alla toscana. Ma lo ripetiamo, s i t ratta di eloquenza buona, epperò non molto comune. Non ripetizioni, non sbandament i, n on slegature, non l acune, non dec lamazioni nei discors i dell'on. Spingardi. Breve: è l'eloquenza che non dispi ace a noi e nemmeno (la qual cosa maggiormente importa) alla Camera e al Sena to, che[ ... ] ascoltano sempre i l generale Spingardi con deferenza grande», E. R1 vALTA, Come parlano i Deputati. Sessanta profili oratori. Con prefazione di C.A Cortina,, «La Ri vista Po liti· ca e Par l amentare» Edi t rice, Roma 19 13.
Spingard i, esprimendo compiac i mento pe r l'accoglienza fatta ai suoi discorsi parlamentari del giugno 1909 fornì la sua spiegazi one del successo d i tanta eloquenza in un passo di una lettera alla moglie del 27 gi ugno 1909 (in RFS): «[ . .. ] Poco dopo le tre andai a l Ministero e non ne usci i che alle 8 e un quarto. Bella domenica, che io aveva sognata quale compenso al tri onfo di ier i. Sicuro, un vero trionfo, più significativo di quello alla Camera, per quanto non s i a stato rilevato dai giorna li, che delle sedute de l Senato poco si occupano [ ... ] Il breve discorso (Camillo d ice 30 minuti) sottolineato fin dal pr incipio da vive approvazioni , si ch iuse con tale salva di app lausi continuati per più minuti, che i l Senato non ricorda l'eguale per niun Minist ro de ll a Guerra. Per donami la poca modestia, ma ho scritto per te, che ne sarai l iet a, fo rse più che non lo sia stato io stesso. Non ti nascondo che ne ero preoccupata: l'am bi ente severo del Senato è t u tt'a l tra cosa che la Camera. E se sono riuscito a far vibrare quei vecchion i, forse ho saputo suonare la nota giusta. Comincio a credere che più che i l contenuto dei miei discorsi mi giovi il modo d i porgere, il suono della voce, e soprattutt o i l parlare sped i to, il filare dritto del discorso senza consultare appunti»
Filippo Tu r ati, una fonte non sospetta d i benevolenza nei confronti dei mi litari , di sse di Spingardi che «l'eloquenza[. .. ] fa di lu i il generale ed i l ministro della guerra più par lamentare che sia mai stato in Ita l ia» (AA.PP., Camera-Discussioni, Tornata del 30 maggi o 1913, p. 26101).

38
CAPITOLO II
LA CHIUSURA DELLE PORTE DI CASA
L'assetto difensivo della frontiera era il punto del programma che implicava il più rilevante sacrificio finanziario 1 , e fu anche il primo a cui il Ministro dedicò le sue cure.
Erigere apprestamenti difensivi nei pressi di un confine non era cosa che si potesse fare in segreto: le opere in muratura erano facilmente osservabili e se anche potevano essere mimetizzate non era facile nascondere il movimento di operai e il trasporto di grandi quantità di materiali necessari alle costruzioni. Quindi la decisione di fortificare una frontiera diveniva un messaggio abbastanza esplicito nei confronti dello Stato confinante poiché ipotizzava un conflitto possibile, e non poteva essere presa a cuor leggero. Dopo l'unità la costruzione di fortificazioni si era attuata quasi esclusivamente alla frontiera con la Francia 2 , e che la necessità di sbarrare la frontiera friulana fosse stata riconosciuta già nel I 880 dal Comitato di Stato Maggiore non aveva scosso gli animi. Si continuò negli anni a vagare nel campo degli studi anche se da parte austriaca si erano iniziati lavori di fortificazione nel Trentino fin dal 1897 3 •
Dieci anni dopo, il rinato interesse per l'esercito non mancò di occuparsi della difesa della frontiera con la Duplice Monarchia .
Nel maggio 1908 la Commissione Suprema Mista per la Difesa dello Stato definì un programma specifico seguendo i criteri indicati dalla Commissione d'Inchiesta 4 •
1 L'importanza della sistemazione difensiva della frontiera è ge neralmente r iconosciuta dalla storiografia. V. Relazione Ufficiale, pp . 25 -28, 147-148; DEC HAURAND , op. cii. , pp . 119- 121;
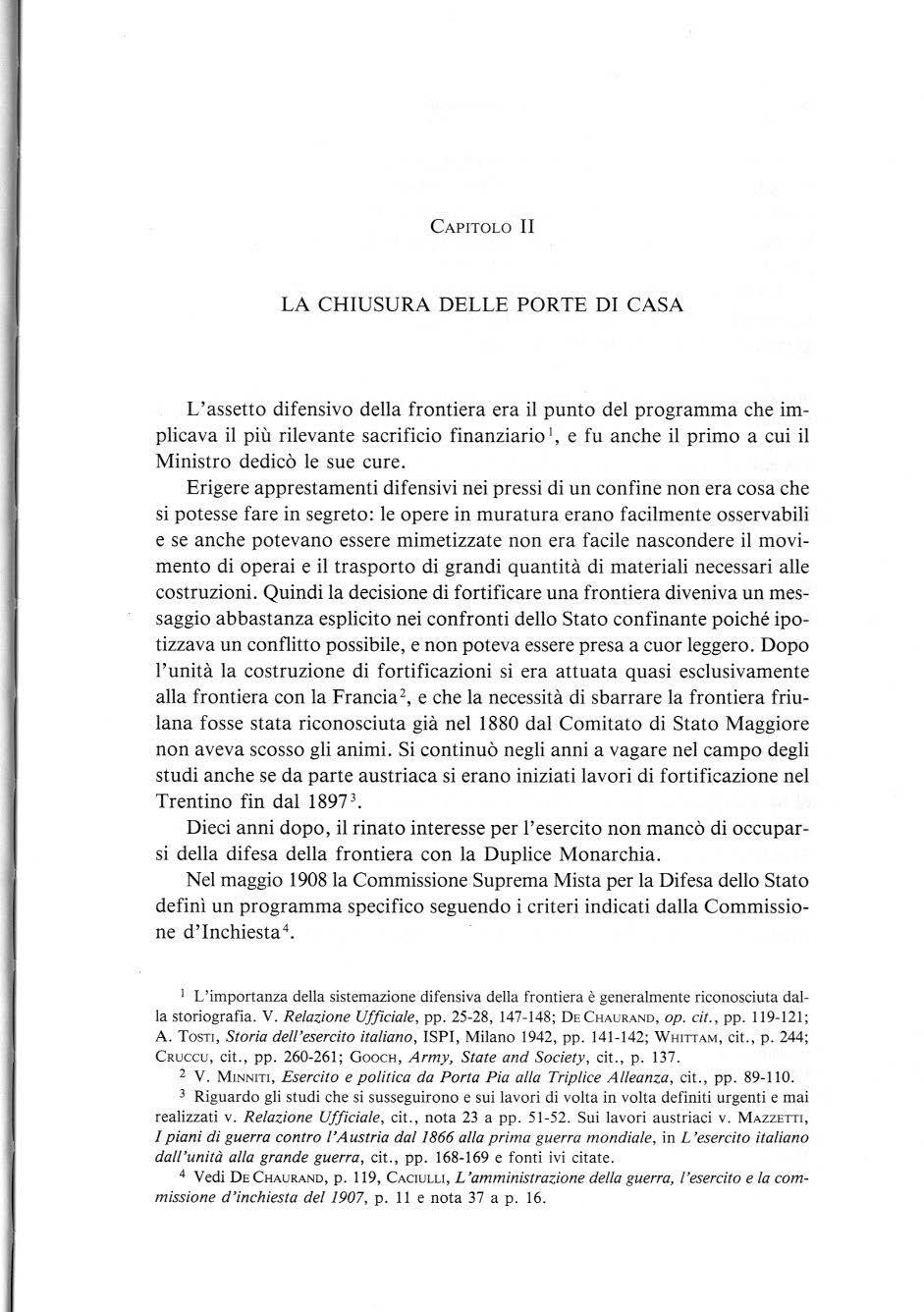
A. Tosn , Storia dell'esercito italiano, ISPI, Milano 1942, pp. 141- 142 ; W H1TTAM, cit., p. 244; CR ucc u, cit., pp 260-261; GoocH, Army, State and Society, cit., p. 137.
2 V. MINN ITI , Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, cit., pp. 89 - 110.
3 Riguardo gli studi che si susseguirono e sui lavori d.i volta in vo lta defin.iti urgenti e mai realizzati v. Relazione Ufficiale, cit., nota 23 a pp. 5 1-52. Su i lavori austriaci v MA ZZETTI , I piani di guerra contro l 'Austria dal 1866 alla prima guerra mondiale, in L'esercito italiano dall'unità alla grande guerra , cit., pp. 168-169 e fonti ivi citate.
4 Vedi DE CHA URAND, p. 119, CACT ULLI, L'amministrazione della guerra, l'esercito e la commissione d'inchiesta del 1907, p Il e nota 37 a p. 16.
Il programma prevedeva una sistemazione completa dell'arco di confine dallo Stelvio al Monte Grapp a e della zona del Cadore e delle prealpi carniche 5 • Rigua r do l'ultimo tratto aperto di frontiera si decise però «c he le opere sul Tagliamento avessero carattere occasionale e che nulla fosse fatto per sbarrare la frontiera del basso Friuli» 6 •
La deci sione era quasi certamente in collegamento con i piani dello Stato Maggior e che prev edev ano la radunata dell'esercito italiano, in caso di guerra, lungo le rive del Piave. Infatti,
dopo la campagna del 1870 spec ialm ente, era divenuto quasi assioma che chi prima mobilita vince: onde una gara in tutli gli eserciti per st udiare e limitare nel lempo, a scapito talvolta dell'ordine e della regolarità, tutte le predisposizioni di mobilitazione Esse precisavano, giorno per giorno, ora per ora, le singole operazioni che ciascun reparto od ente da mobilitarsi doveva compiere. Un giorno di guadagno era un elemento di vittoria! 7
Partendo da questo assunto si era costretti ad abbandonare al nemico parte del territorio nazionale allo sco po di guadagnare il tempo necessario a compiere la propria mobilitazione, dato che quella dell'esercito austroungarico era più rapida. Anzi le fortificazioni in progetto servivano proprio a concedere «tempo e tranquillità per compiere le due più gravi operazio ni che precedono la guerra , la mobilitazione e l'adunata» 8 Senza queste fortificazioni si sarebbe altrimenti dovuto arretrare Io schiera mento addirittura fino ali' Adige , come previsto in passato 9 •
D ate le condizioni contava soprattutto fortificare la frontiera dallo Stelvio al M . Grappa, per pas sare alla controffensiva non appena terminata la radunata, e «so ltanto quando si fosse ultimata la sistemazione difensiva del Trentino sarebbe stato possibile prendere in esame la possibilità di spostare il sistema difensivo più ad oriente» 10 •
Ne l dicembre 1908 11 , una volta ottenuti i fondi della legge 5 luglio 1908 finalmente cominciarono i lavori. Essi procedettero però «con molta len -
5 Vedi S1't FANI, p. 543.
6 MAzzE'1T 1, L'esercito nel periodo gioli11iano, ciL., p. 255.
7 RFS. Deposizione Caporel/o, p. 27. V. anche le interessanti osservazioni di A. BR uc 10N1, Piani strategici italiani alla vigilia dell'intervento nel primo conflillo mondiale, in Studi storico-militari 1984, USSME, Roma 1985, pp. 287-293.
8 Deposizione Caporeuo, p. 26.
9 V. MA ZZcTr1, / piani di guerra contro l'Austria, cit., pp. 162- 165; D E CHAURANO, p. 117 .
Questa soluzione era stata proposta alla Commissione Suprema Mista anche nel 1908: cfr. MAZZETIJ, L'esercito nel periodo gioliuian o , p. 255.
10 MA ZZElTl , / piani di guerra contro l'Austria, p. 170.
11 Vedi Relazione Ufficiale, p 27; T osr1, p. 141 ; SrEFANJ, p. 544.
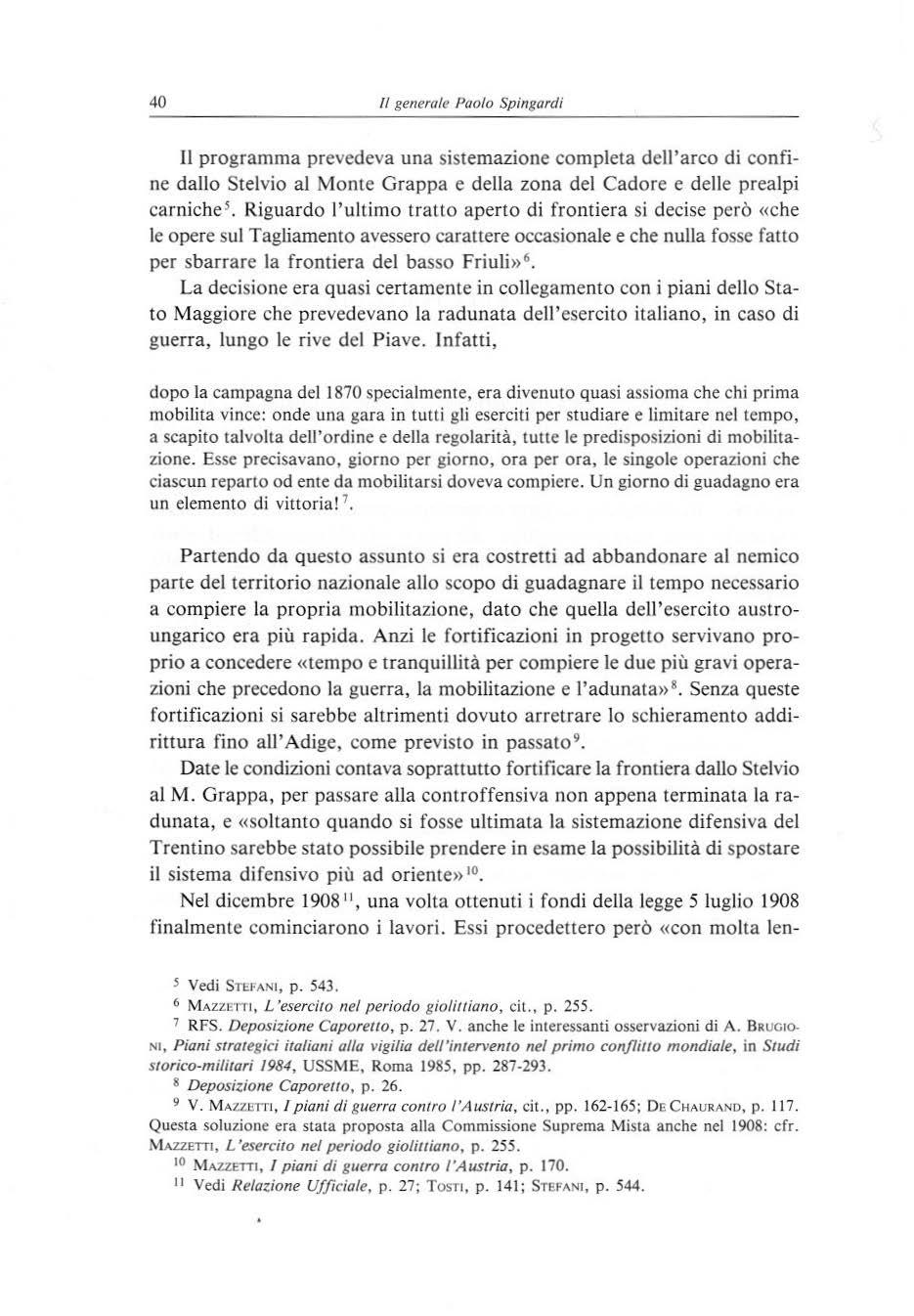
40 li gener(J/e
P(Jo/o Spingardi
tezza, per non suscitare sospetti nel governo austriaco>> 12 • Quasi certamente anche la stagione invernale influì, dato che si trattava per lo più di lavori da eseguirsi in montagna .
La questione della difesa dei confini aveva assunto grande rilevanza anche in Parlamento. Spingardi, in nome del programma minimo, accettava il piano in corso, ottenendo altri fondi per la sua attuazione, incoraggiato da deputati convinti che
il nostro Paese, dotato com'è di un ' amp io se micerchio di frontiera, non può a meno di provvedere a una proporzionata sistemazione di forti di sbarramento e di lavor i difensivi sino a che sia vero che il preparare le difese territoriali in modo adatto alla su a postura topografica e alla sua importanza politica voglia dire preparare pel Paese un avvenire sicuro e assicurargli viemmeglio i benefici della pace 13 .
Ma le parole che più mossero l'assemblea furono quelle pronunciate dal generale Luchino Dal Verme, che con calore esortava il Ministro alla difesa dello stato:
La front iera nord-orientale d'Italia è una delle più difficili, per non dire la più difficile frontiera che si trovi io Europa[ ] Faccio all'onorevo le Ministro una sola raccomandazione. Chiuda la porta di casa. Quando l'eventuale nemico è assai più forte di noi è vano fare assegnamento s ul valore, ma è necessario impedire che il più forte ci assalga; e come noi non abbiamo nessuna intenzione di aggredire, è di suprema necessità di s barrare la porta di casa 14 •
Sospinto dal successo parlamentare, Spingardi volle imprimere alle costruzioni il ritmo più rapido possibile, e a tal scopo emanò apposite direttive, diramate con una circolare del 7 luglio 1909, nella quale, dopo aver preme sso che per l'esercizio finanziario 1909-1910 le assegnazioni disponibili ammontavano a 60 milioni, era sottolineata la necessità di
1° Intensificare i lavori e le provviste sino al limite massimo permesso dal tempo tecnico. In tale intento ... occorre preparare la cosa in maniera che alla riapertura
12 D E CHA U RAND, p. I 19.
13 AA.PP. Leg. XXIII Camera-Documenti, Stampato N. 102-A, p. 7. Le parole erano del giolittiano Augusto Battaglieri.
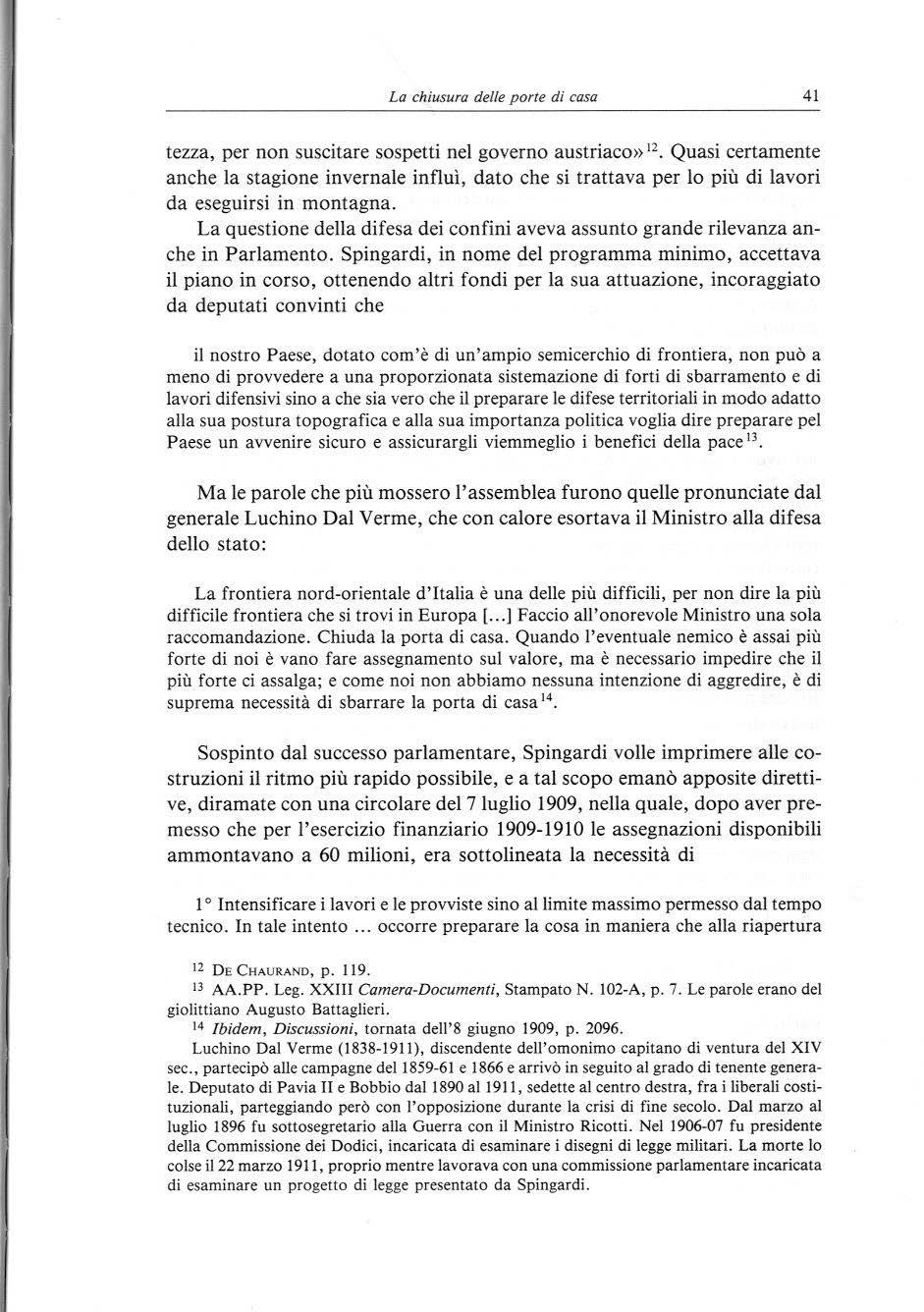
14 Ibidem , Discussioni, tornata dell'8 giugno 1909, p. 2096.
Luchino Dal Verme (1838-1911), discendente delJ'omonirno capitano di ventura del XIV sec., partecipò alJe campagne del 1859-61 e 1866 e arrivò in seguito al grado di tenente generale. Deputato di Pavia II e Bob bi o dal J890 al 191 I , sedette a l centro destra, fra i liberali costituzionali , parteggiando però con l'opposizione durante la crisi di fin e secolo. Dal marzo al luglio 1896 fu sottosegretario alla Guerra con il Ministro Ricotti. Nel 1906- 07 fu presidente della Commissione dei Dodici , incaricata di esaminare i disegni di legge militari. La morte lo colse il 22 marzo 191 1, proprio mentre lavorava con una commissione parlamentare incaricata di esam inare un pro getto di legg e presentato da Spingardi.
La chiusura delle porte di casa 41
li generale Paolo Spingardi
della stagione lavorativa del prossimo anno solare i lavori possano essere iniziati senza ritardo, per profittare di tutto il tempo utile. - 2° Sfruttare tutte le risorse dei nostri stabilimenti e della industria privata del Paese, e ricorrere all'estero per quelle sole provviste che per ragioni tecniche od economiche non sia conven ien te di fare in Italia. - 3° Coordinare i lavori del G enio ... con le provviste delle relative installazioni, per modo che le opere possano essere armate non appena ultimati per cìascuna di esse i lavori in muratura. - Procedere quindi se nza indg.io a tutti gli a ltri preparativi (munizionamento, tiro preparato, ecc.) necessari per mettere le opere in grado di funzionare al più presto 15 •
Per gli stessi motivi ed anche per senso di parsimonia, il Mini stro invitava il Genio a dare
nei lavori relativi a ciascuna opera, l'as soluta precedenza alle parti vitali ed essenziali di esse, cìoè a quelle parti che una volta ultimate permettono all'opera di funzionare, sia pure non perfettam ente , mentre si procede al finimento degli accessori. - Nei riguardi delle maggiori economie, sia di denaro che di tempo, si eviteranno tutti i lavori che possano dirsi di lusso, in quanto poco o nulla contribuiscono alla consiste nza dell'opera, ma più s pecialmente servono ad abbel lirl a 16 •
Spingardi si rendeva conto dell'immane opera che ci si accingeva a compiere e dell'importan za decisiva che vi assumeva l'elemento tempo. Egli voleva evitare per quanto possibile intempestive richieste di fondi al P arlamento, che avrebbe potuto credere di essersi lasciato ingannare dal Ministro che aveva detto le cifre concesse essere «co mmi surate al fabbisogno relativo al programma concordato col comando del corpo di stato maggiore». Ri sparmiare su l superfl uo doveva rendere più sicuro il risp etto dei termini finanziari , perciò
ogni eventua le nuova proposta di spesa non potrà esser e favorevolmente accolta, salvo il caso che la medesima possa essere contenuta entro la disponibilità del quadriennio, mercé corrispondenti economie che fossero per verificarsi in qualche lavoro od in qualche provvista in co nfronto del preventivo , o mercé proventi di alienazioni 17 •
Probabilmente agganciandosi a quest'ultima indicazione, Pollio decise di appo rt are una variazione al programma secon do un'idea c he gli stava particolarmente a cuore. D a fine stratega qual era, era andato convincendosi
lS AUSSME. F-4, Ordinamento e mobilitazione (OM), R. 74. Circolare riservata N. 6949. li Ministro della Guerra Alla Direzione affari generali, alla Direzione generale d'artiglieria e genio, alla Direzione generale dei servizi fogisrici e amministrativi, al Comando del Corpo di Stato Maggiore, in data 7 luglio 1909
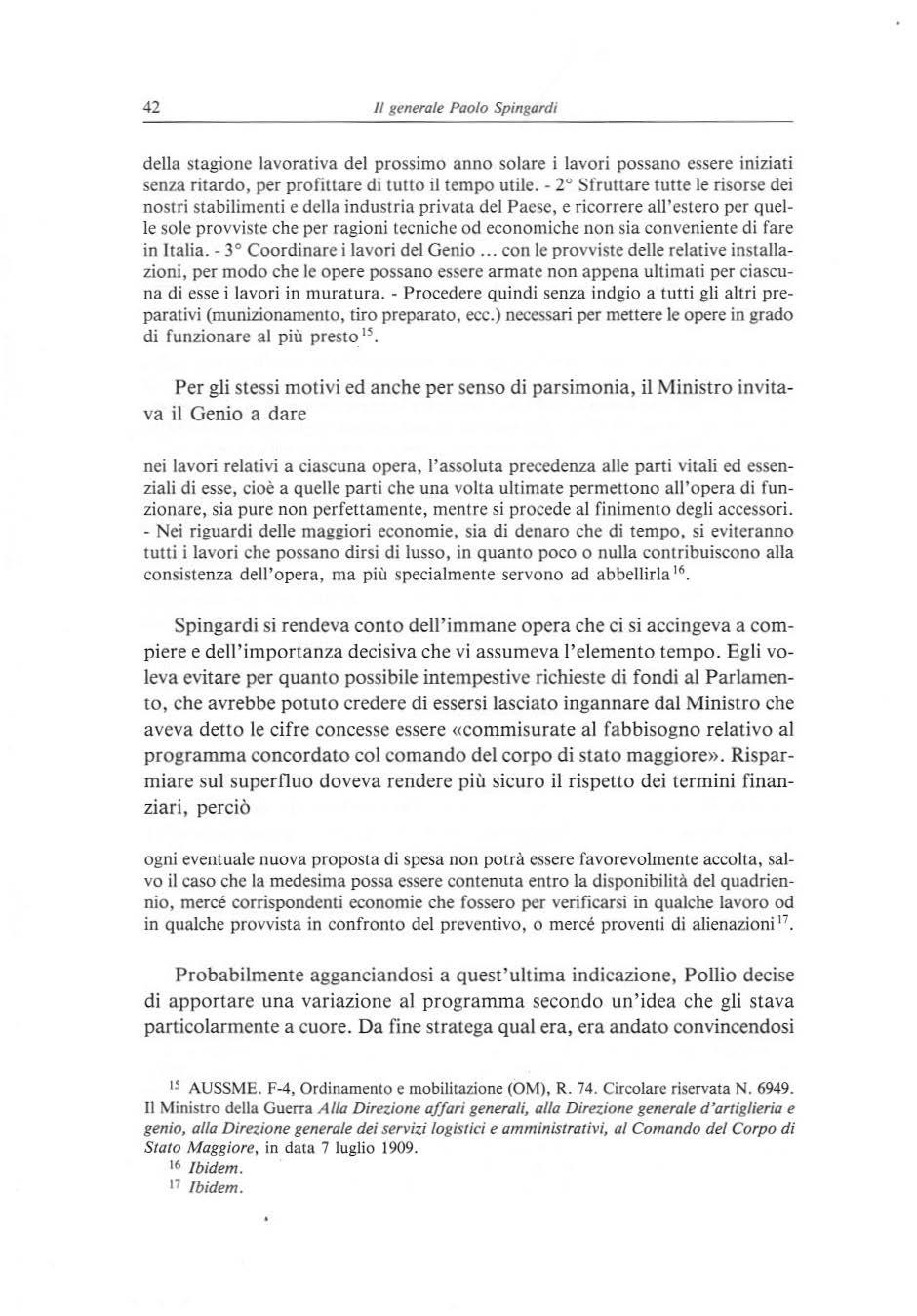
16 Ibidem.
17 Ibidem.
42
che non si poteva permettere al nemico di riversarsi liberamente o quasi nella pianura fr iulana senza che tale scelta causasse contraccolpi negativi nel Paese e nell'esercito. D'altro canto, le insufficienti comunicazioni ferrov iarie esistenti al di là del Piave non permettevano di sp in gere l 'intero dispositivo di r adunata al Ta gliamento . Non era nemmeno possibile utilizzare il corso di questo fiume come possente antemurale, « per le cond izioni idrografiche di qu esto fiume , spaventoso in piena, di nessun valore difensivo in magra [ ] e per il lar ghissimo suo greto, c he forma vari rami, attraverso i quali sono frequenti i guadi» 18 •
Pollio pensò quindi a una difesa basata su truppe mobili che agissero utilizzando le fortificazion i come appoggio alla manovra . Il grosso dell'esercito avrebbe così avuto il tempo di schierars i al T agliamento dopo aver completato le operazioni di mobilitazione e radunata al Piave .
L'a ttuazione del nuovo piano implicava necessariamente una espansione del programma concordato in aprile col Ministro. Ma Pollio evidentemente ritenne di poter attuare le proprie idee economizzando sul fronte trentino per realizzare le nuove opere nel Basso Friuli.
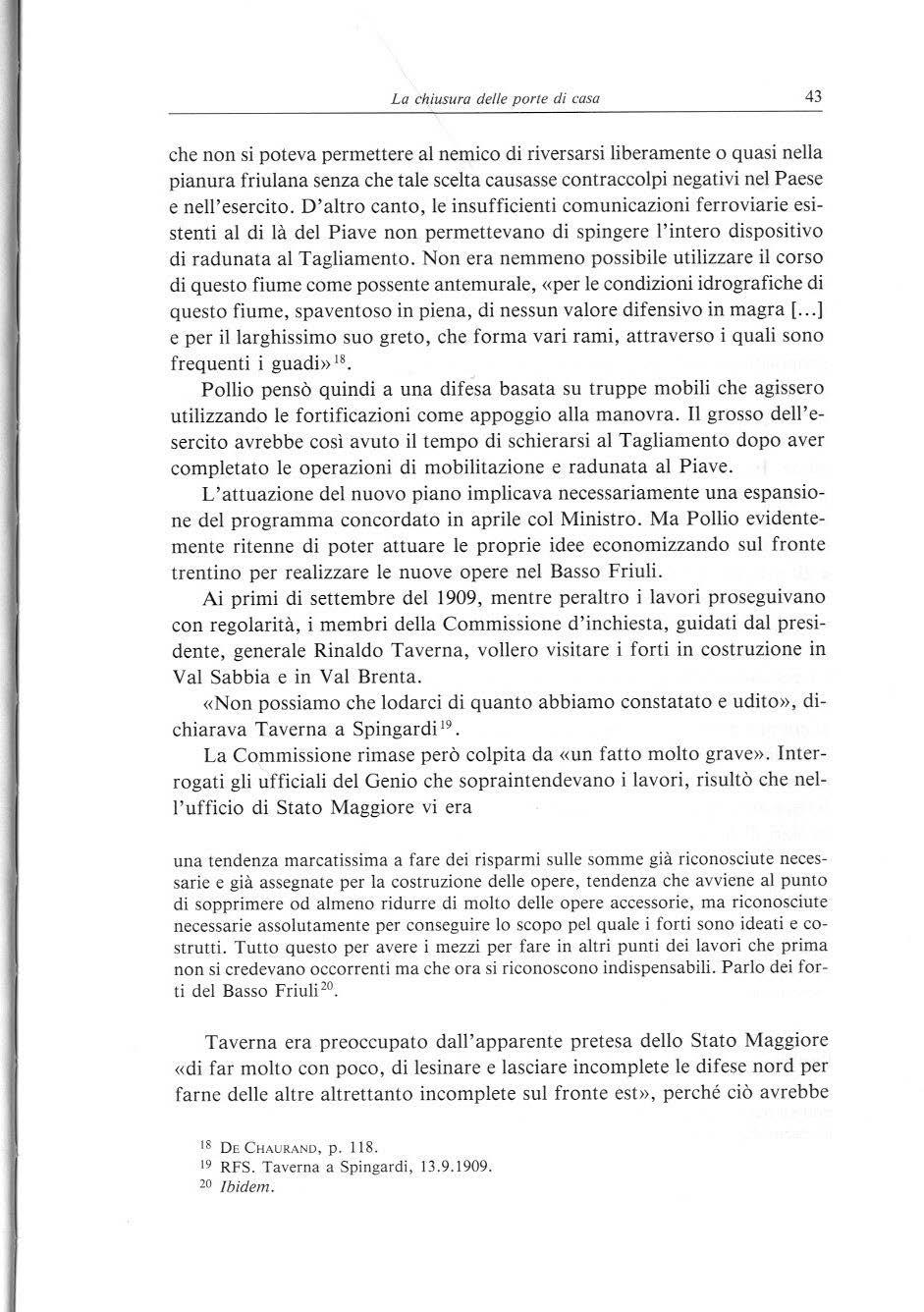
Ai primi di settembre del 1909, mentre peraltro i lavo ri proseguivano con regolarità, i membri della Commissione d'inchiesta, guidati dal presidente, generale Rinaldo Taverna, voJlero visitare i forti in costruzione in Va l Sabbia e in Val Brenta.
«Non possiamo che lodarci di quanto abbiamo constatato e ud ito», dichiarava Taverna a Spingardi 19 •
La Commissione rimase però colpita da «un fatto molto grave» . Interrogati gli u fficia li del Genio che sopraintendevano i lavori, risultò che nel\ ' u fficio di Stato Maggiore vi e ra
una tende n za marcatissima a fare dei risparmi s ulle somme già r iconosciute necessarie e già assegnate per la costruzione delle opere, tendenza che avv iene al punto di sopprimere od almeno ridurre di molto delle opere accessorie , ma riconosciute necessarie assolutamente per consegu ire lo scopo pel quale i forti sono ideati e costrutti . Tutto questo per avere i mezzi per fare in altri punti dei lavor i che p ri ma non si credevano occorrenti ma che ora si riconoscono i nd ispensabili. P arlo dei fo rti del Basso Friuli 20
Taverna era preoccupato dall'apparente pretesa dello Stato Maggiore <<di far molto con poco, di lesinare e la sciare incomplete le difese nord per farne delle altre altrettanto incomple te sul fronte est», perché ciò avrebbe
18 D E CHA URAND, p. 118.
19 RFS. Taverna a Spingardi, 13.9.1909.
20 Ibidem.
La chiusura d elle porte di casa 43
condotto «inevitabilmente ad aver tutto imperfetto e per conseguenza inferiore allo scopo pel quale venne ideato». Dato che il Governo << quando chieseal Parlamento i fondi per le fortificazioni, disse sempre che quelle somme erano state giudicate sufficienti dalla nostra commissio ne », se le fortificazioni per il basso Friuli richiedevano altre grosse somme «non è più corrispondent e alla realtà la relazione nostra, e non so se potremo, noi Commissione, starcene zitti» 21 •
Viene in effetti da domandarsi perché Pollio non avesse esposto i suoi propositi in aprile quando aveva definito il programma di difesa assieme a Spi n gardi. Innanzitutto la parte r elativa alle fortificazioni era stata decisa nel maggio 1908, prima cioè che Pollio assumesse la carica di Capo di S.M. Forse non riteneva fosse il caso di modificarlo mentre era in corso di attuazione. Inoltre il concetto di difesa ma novrata che era alla base del nuovo progetto, non se mbrava richiedere cos truzioni di g rande costo; probabilmente si riteneva sufficiente un miglioramento delle opere occasionali che, co me si è visto, erano già previste Non è infine da escludersi che Taverna e gli ufficiali del Genio interpellati tendessero a sopravvalutare la portata d elle economie suggerite da Spingardi nella circolare di luglio, e giudicassero quindi necessario quanto lo Stato Maggiore, seguendo il concetto di Spingardi, considerava «di lusso». Questo era in sostanza anche il parere dell' I spettore generale del Genio, Lorenzo Bonazzi, interpellato da Spingardi per capire più a fondo la questione . Bonazzi ammetteva che effettivamente vi era una diversità di vedute circa «l'armamento secondario delle opere che si stanno eseguendo in Val Brenta»: mentre il Genio riteneva «che tale armamento debba avere una data composizione», lo Stato Maggiore «ne preferisce altra quantitativamente inferiore». Ma s i trattava in fondo di «particolari di lieve momento». Bonazzi assicurava il Ministro che
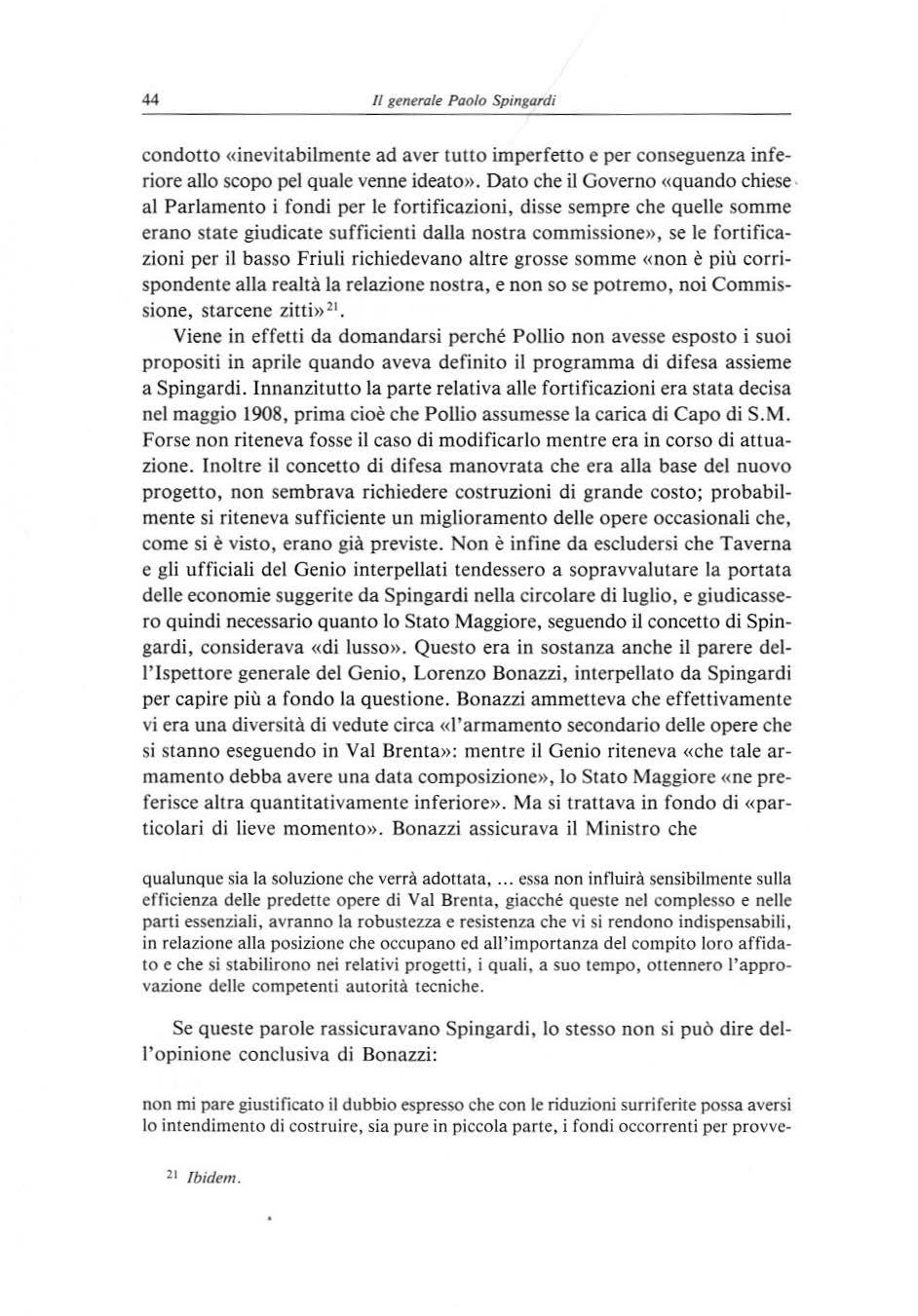
qualunque sia la so luzion e che verrà adottata, ... essa non influirà se nsibilmente sulla efficienza delle predette opere di Val Br enta, giacché queste nel complesso e nelle parti essenziali, avranno la robustezza e resistenza che vi si rendono indispensabili, in relazione alla posizione che occupano ed all'importanza del compito loro affidato e che si stabilirono nei relativi progetti, i quali, a suo tempo, ottennero l'approvazione delle competenti autorità tecniche.
Se queste parole rassicuravano Spingardi, lo stesso non si può dire dell'opinione conclusiva di Bonazzi:
non mi pare giustificato il dubbio espresso che con le riduzioni surriferite possa aversi lo intendimento di costruire, sia pure in piccola parte, i fondi occorrenti per provvc-
44 li
generale Paolo Sping ardi
21 Ibidem.
dere alla costruzione delle opere da erigersi a difesa dell'aperta frontiera del Friuli, dappo iché mentre tali opere avranno costo elevantesi a pjù milioni, ciò che potrebbe ricavarsi dalle precitate riduzioni ascenderebbe solo a poche diecine di migliaia di lire e quindi a so mma affatto trasc u rabile rispet to al costo suindicato 22 •
Sta di fatto che quelle opere si stavano effettivamente costruendo, e se il loro cost o era tanto elevato, non si trattava certo di un problema da trascurare, tanto più che Taverna sosteneva che vi era
il più ammirevole e completo disaccordo tra lo Stato Maggiore, l'Artiglieria e il Genio circa la difesa de l Friuli parte bassa. Si discute molto e non si conclude nulla . Ora pare a me che sia tempo di finirla. li paese crede che si provveda alla sua difesa efficacemente, g uai se si accorge che non si sa prendere una decisione 23 .
Spingardi dovette rimanere non poco perplesso, dato che nessuno sembrava notare che le opere che si stavano costruendo non erano previste e apparivano per di più di notevole consistenza. Per chiarire i suoi dubbi non pose tempo in mezzo e con piglio caratteristico della sua personalità si recò a ispezionare le loc alità incrim ina te .
È veramente una fortuna che tu vada a vedere con i tuoi occhi quello che avviene nei nuovi forti - gli scrisse Taverna - perché le mie informazioni non collimano intieramente con le tue .. . sarà pure molto bene che t u ve da il Friuli ... Quello che importa è c he si addivenga a una decisione e che Stato Maggiore, Artiglieria e Genio si pongano una buona volta d'accordo definitivamente ... La tua v isi ta nel Veneto sa rà una vera fortuna per la difesa del paese 24
Profondo conoscitore del tratto di frontiera in questione, Spingardi si convinse della opportunità di fortificare il Basso Friuli. A questo punto era però•necessario ottenere nuovi fondi . Dato che non era intenzione del Minist r o chiedere nuovi stanziamenti st raordinari al Parlamento, perché troppo recente era la concessione di rilevanti somme con la legge del 30 giugno, b isognava ricorre r e agli stanziamenti degli eserciz i successivi, come La stessa legge consentiva . Ma bisognava ottenere l'approvazione del Ministro del
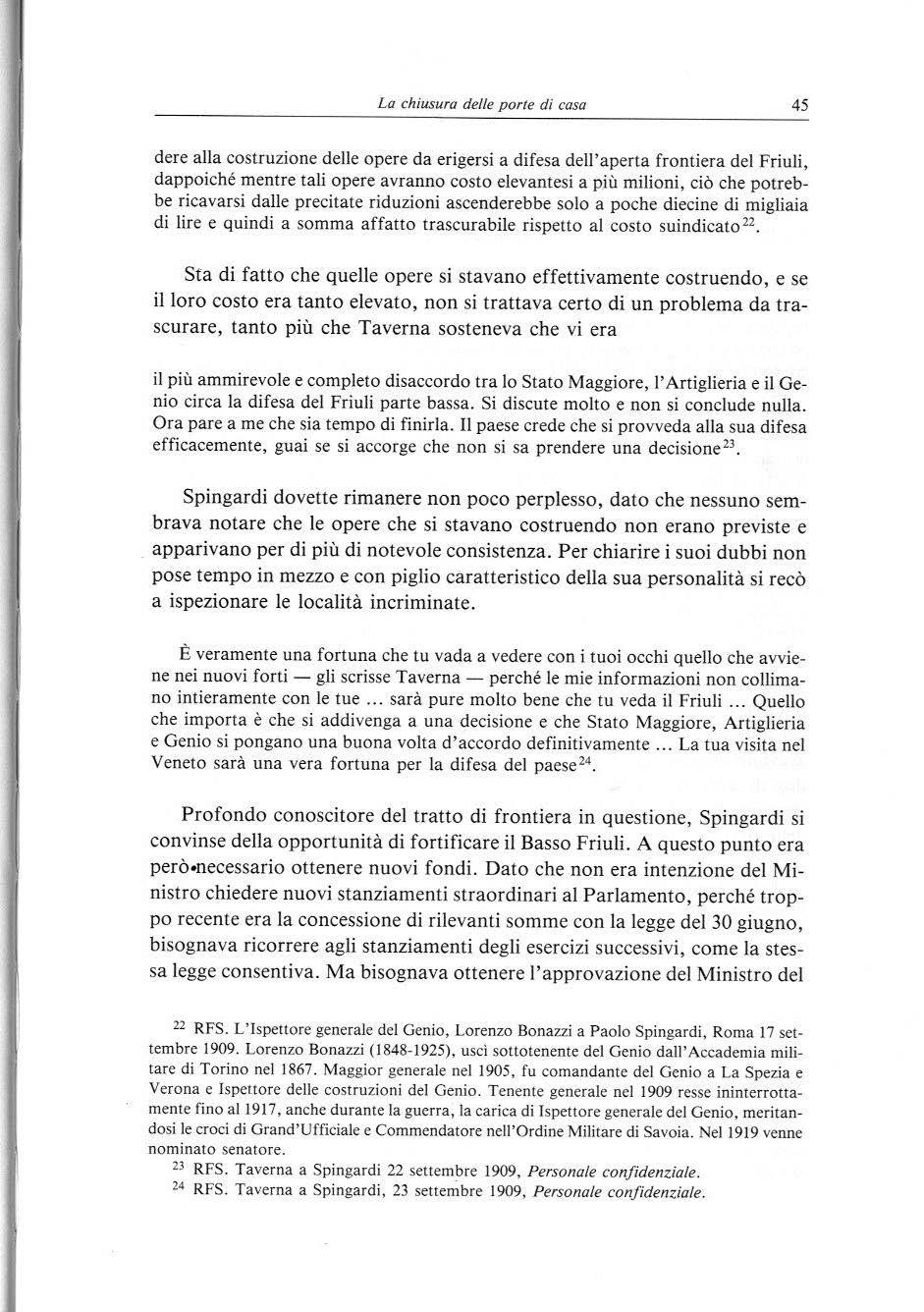
22 RFS. L'Ispettore generale del Genio, Lorenzo Bonazzi a Paolo Spingardi, Roma 17 settembre 1909 Lorenzo Bonazzi (1848-1925), usci sottotenente del Genio dall'Accademia mi l itare di Torino nel 1867 Maggior generale nel 1905, fu coma ndant e del Genio a La Spezia e Verona e I spetto r e delle cosiruzioni del Genio. Tenente generale nel I 909 resse ininterrottamente fino al 1917 , anche durante la guerra, la carica di Ispettore generale del Genio, meritandosi le croci di Grand'Ufficiale e Commendatore nell'Ordine Militare di Savo ia Nel 1919 venne nominato senatore.
23 RFS Taverna a Spingardi 22 settemb re 1909, Personale confidenziale.
24 RFS Taverna a Spingardi, 23 settembre 1909, Personale confidenziale.
La chiusura delle porte di casa 45
Tesoro, altrimenti la cosa risultava impossibile. Con discreta accortezza politica, Spingardi pensò di approfittare del nuovo Governo Sonnino, per sottoporgli una «Memoria sui bisogni dell'amministrazione della guerra e sulla situazione del suo bilancio» nelJa quale dichiarava di sperare di pote r
far fronte completamente ad una più potente organizzazione difensiva del Basso Friuli, in confronto di quanto erasi stabilito in passato; ciò allo scopo di ch iudere con fortificazioni permanenti di t ipo moderno la cosiddetta PORTA APERTA. All'uopo gli uffici tecnici, sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore, hanno già compiuto g li studi ed ini ziato anche, in parte, i lavori. Si calcola che il fabbisogno relativo, così per le costruzioni come per gli armamenti, verrà coperto con corrispondenti economie ricavabili mediante modificazioni dei progetti di altre opere, specialment e della frontiera occidentale[ ) Nell'ottobre u s il comando del corpo di stato maggiore propose al Ministro alcune var ian ti all'asset to difensivo in corso di attuazione [ ) variant i concretate in seguito ad ulteriori studi ed ai risultati del viaggio di stato maggiore del 1909, che, come è noto, ebbe luogo ne l Friuli. Esse consistevano, in sostanza, in spostamenti di sede di talune opere già in massima deliberate (ad es. Tricesimo invece di Buja; Fagagna invece di M. Ragogna), e in partico lari di ordinamento e consistenza delle opere stesse (ad es. teste di ponte, con installazioni in cupole, a Codroipo e Latisana) [ ]Altre economie si ha poi fiducia di realizzare anche nei lavori del genio, sfron dando i progetti delle opere di tutto il superfluo, diretto più all'abbellimento che alla vera e propria consistenza di esse 25
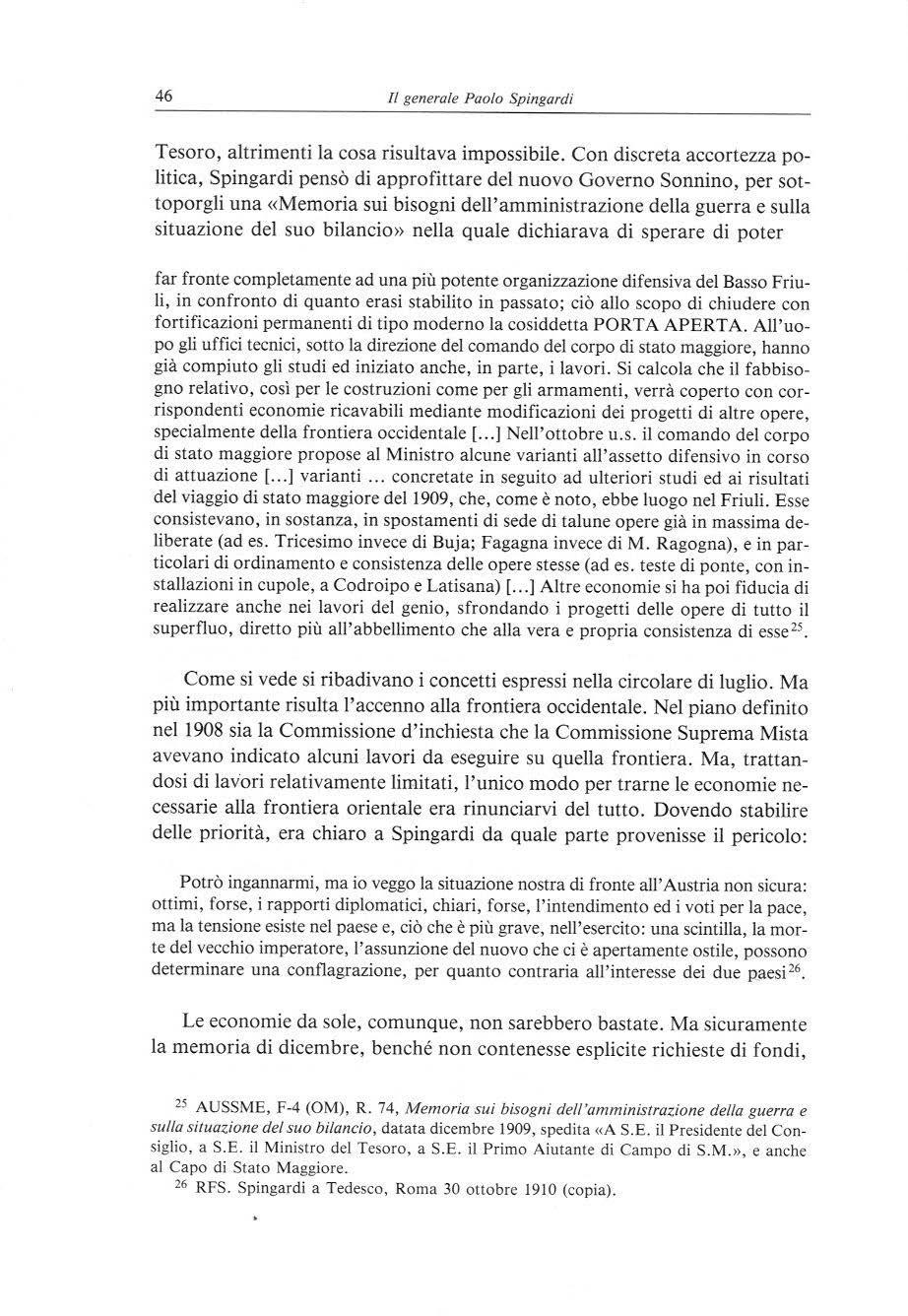
Come si vede si ribadivano i concetti espressi nelJa circolare di luglio. Ma più importante risulta l'accenno alla frontiera occidentale. Nel piano definito nel 1908 sia la Commissione d'inchiesta che la Commissione Suprema Mista avevano indicato alcuni lavori da eseguire su quella frontiera Ma, trattandosi di lavori relativamente limitati, l'unico modo per trarne le economie necessarie alla frontiera orientale era rinunciarvi del tutto. Dovendo stabilire delle priorità, era chiaro a Spingardi da quale parte provenisse il pericolo:
Potrò ingannarmi, ma io veggo la situazione nostra di fronte aU' Austria non sicura: ottimi, fo r se, i rapporti diplomatici, chiari, forse, l'intendimento ed i voti per la pace, ma la tensione esiste nel paese e, ciò che è più grave, nell'esercito: una scintilla, la morte del vecchio imperatore, l'assunzione del nuovo che ci è apertamente ostile, possono determinare una conflagrazione, per quanto contraria all' in teresse dei due paesi 26 •
Le economie da sole, comunque, non sarebbero bastate. Ma sicuramente la memoria di dicembre, benché non contenesse esplicite richieste di fondi ,
25 AUSSME, F-4 (OM), R. 74, Memoria sui bisogni dell 'amministrazione della guerra e sulla si tuazione del suo bilancio, datata dicembre 1909, spedùa « A S. E. il Presidente del Cons iglio, a S.E. il Mini str o del Tesoro, a S. E . il Primo Aiutante di Campo di S .M. », e anche al Capo di Stato Maggiore.
26 RFS . Spingardi a Tedesco, Roma 30 ottobre 1910 (copia).
46 li
generale Paolo Spingardi
funse in qualche modo da lubrificante, dato che nello stesso mese Spingardi sanzionò il progetto di P ollio 27 •
I lavori cominciarono nel maggio del 1910, dato che la stagione invernale portava solitamente a una stasi 28 • Contemporaneamente si svolse in Friuli, proprio nelle località da fortificare, una importante manovra coi quadri di quattro Corpi d'Armata, diretta dal generale designato d'armata Ettore Viganò.
Nella Relazione sulla manovra che gli venne consegnata, Spingardi ebbe modo di constatare l'applicazione dei principi strategici ai quali l'intero sistema difensivo era ispirato.
L'ipotesi operativa era la seguente:
Si è supposto che la guerra fra l'Ita li a e l'Impero austro-ungarico, della quale nella manovra si sono studiati gli atti che si sarebbero svolti nel Friuli durante un primo periodo di una ventina di giorni, sia stata dichiarata nel maggio del 1911, anziché nel maggio del 1910, in cui la manovra ve n ne effettivamente eseguita. Si è fatta questa supposizione perché la predisposizione fortificatoria per la difesa di quella regione di frontiera è attualmente - anno 1910 - così arretrata, che ora non si potrebbe tener conto, in una manovra, dell'efficacia di quell'elemento di difesa; mentreché da qui a un anno, invece, le costruzioni e gli armamenti saranno così avanzati, che tutte quelle opere potrebbero venire u tilizzate per la guerra: ricorrendo, se mai, alla determinazione di sospendere la continuazione dei lavori di carattere permanente, per sostituirvi lavori speditivi, se ciò fosse necessario per la detta utilizzazione.
Si immaginava che la dichiarazione di guerra avvenisse nelle prime ore della notte sopra il 16 maggio. La situazione qua le risultò nelle prime ore del pomeriggio del 5 giugno preludeva a una battaglia che avrebbe dovuto condurre il partito nazionale alla vittoria.
Il concetto fondamenta le dell'assetto fortificatorio del Friuli - osservava il generale Viganò - è questo: stab ilire sulla si n istra del medio e basso Tagliamento un tale complesso di batterie corazzate e di appostamenti di artiglierie, che le truppe di copertura ... destinate a quella frontiera, vi trovino appoggio per opporsi validamente a che l'avanguardia nemica si accosti al fiume, per effettuarne il passaggio e per preparare gli sbocchi, sulla de st ra del fiume stesso, alle masse maggiori che arriveranno laggiù più tardi per invadere la pianura veneta, e per mettere, in seguito, le masse maggiori del nostro esercito, quando fossero arrivate al Tagliamento, in così buona situazione strat egica iniziale, da poter dare battaglia, con fondate speranze di successo, a que ll a notevole parte dell'esercito nemico che certamente si sarà frattanto adunata sulla des t ra dell'Isonzo. - Cotesto assetto comprenderà opere
27 Cfr. CRu ccu, pp. 260- 261; STEFANI, pp. 543 - 544; Relazione Ufficiale, p. 28; MAZZETI1, I piani di guerra, p. 174.
28 V. «La Preparazione», Giovedì -Venerdì 28-29 luglio 1910, Giovedl -Venerdì 27-28 ottobre 1910.
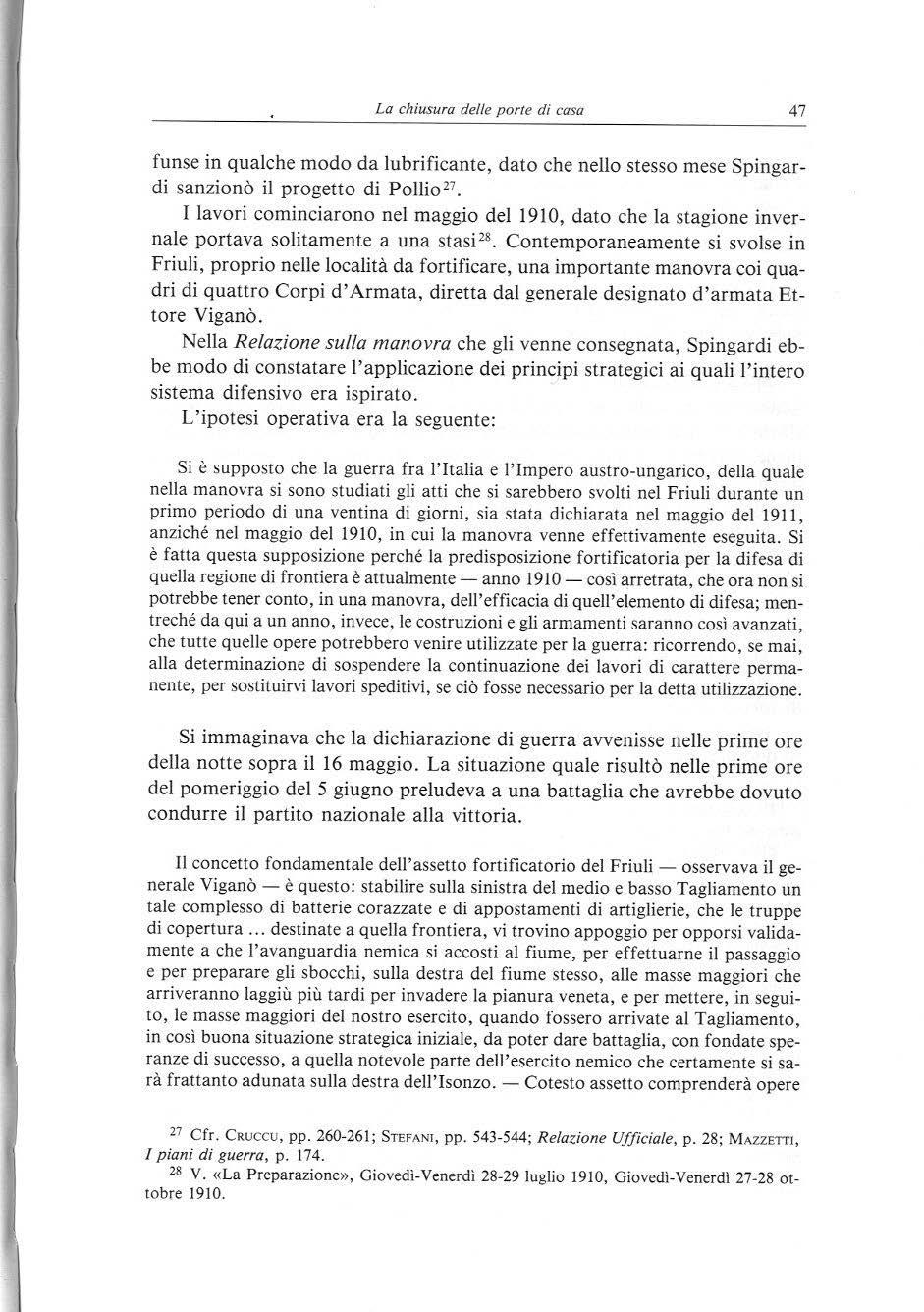
La chiusura delle porle di casa 47
li generale Paolo Spingardi
ed appostamenti destinati: a sbarrare la linea Pontebbana; a costituire una vasta piazza d'armi, per raccolta di masse combattenti, nell'apparato morenico che divide l'antico e il nuovo sbocco nel piano del Tagliamen to dalla pianura udinese; e a coprire, con due g randio se teste di ponte verso est, tutto il basso Tagliamento. - Ne risulteranno due grandi fronti difensive, disposte a tenaglia: l'una, rivolta a sud-est, coprirà il passo di Pinzano ... e si attaccherà alla zona montana che è incisa daU'alto Torre; l'altra sarà costituita ... da due grandiose teste di ponte: l'una coprirà il Passo di Codroipo[... ] mentre l'altra coprirà il passo di Latisana, e si stenderà a sud di tanto da poter avere azione sulla foce del Tagliamento, ove potrebbero effettuarsi sbarchi di truppe nemiche 29
Spingardi non mancò di far sentire il suo impulso e il 15 luglio iniziava una «minuziosa visita alle costruzioni al confine, per le quali dimostrò la sua soddisfazione» 30. Le ispezioni del Ministro durarono complessivamente due settimane, durante le qual i conferì, oltre che con Pollio , con l'Ispettore delle truppe da montagna e con il comandante del V corpo d'armata. Spingardi ne approfittò anche per visitare Antonio Fogazzaro, vecchio amico di famiglia.
L 'andamento dei lavori aveva ormai preso il ritmo desiderato e il Ministro della Guerra poteva rassicurare il collega del Te soro di avere «i mezzi sufficienti per condurre innanzi con la voluta intensità e celerità lo svolgimento del programma per la difesa orientale, anche se completata da opere non prevedute» 31 .
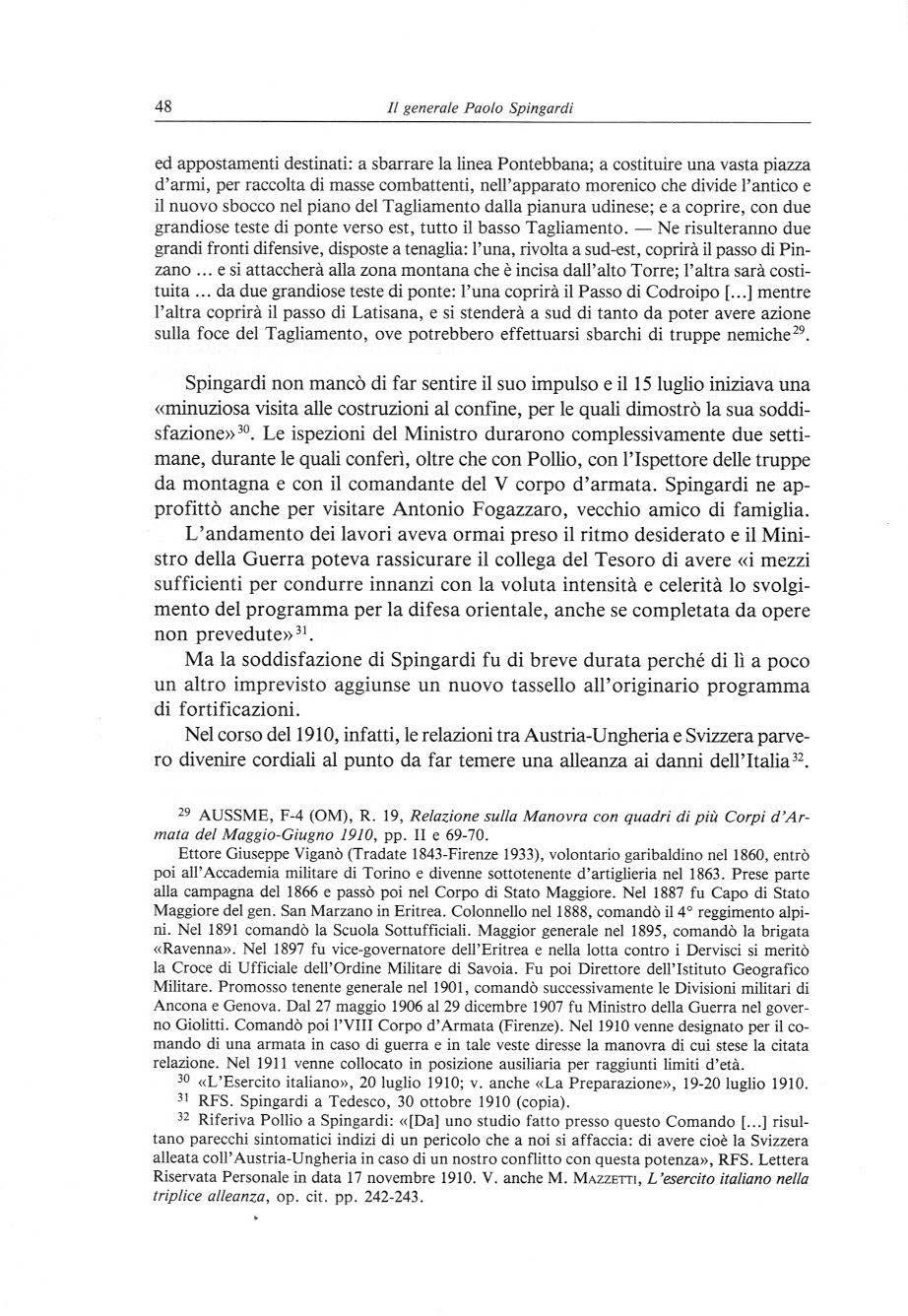
Ma la soddisfazione di Spingardi fu di breve durata perché di lì a poco un altro imprevisto aggiunse un nuovo tassello aJl'originario programma di fortificazioni.
Nel corso del 191 O, infatti, le relazioni tra Austria-Ungheria e Svizzera parvero divenire cordiali al punto da far temere una alleanza ai danni dell'Italia 32 •
29 AUSSME, F-4 (OM), R. 19 , Relazione sulla Manovra con quadri di più Corpi d'Armata del Maggio-Giugno 1910, pp. Il e 69-70.
Ettore G iuseppe Viganò (Tradate 1843-Firenze 1933), volontario garibaldino nel 1860, entrò poi all'Accademia militare di Torino e divenne sottotenente d'arti glieria nel 1863. Prese parte alla campagna del 1866 e passò poi nel Corpo di Stato Maggiore. Nel 1887 fu Capo di Stato Maggiore del gen. San Marzano in Eri trea Colonnello nel 1888, comandò il 4° reggimento alpini. Nel 1891 comandò la Scuola Sottufficiali. Maggior generale nel 1895, comandò la brigata « Ravenna» . Ne l 1897 fu vice-governatore dell'Eritrea e nella lotta contro i Dervisci si meritò la Croce di Ufficiale dell'Ordine Mili tare di Savoia. Fu poi Direttore dell'Isti tuto Geografico Militare. Promosso tenente generale nel 1901, comandò successivamente le Divisioni militari di Ancona e Genova. Dal 27 maggio 1906 al 29 dicembre 1907 fu Ministro della Guerra nel governo Giolitti. Comandò poi l'VIII Corpo d'Armata (Firenze). Nel 1910 venne designato per il comando di una armala io caso di guerra e in tale veste diresse la manovra di cui stese la citata relazione. Nel 191 I venne collocato in posizione ausiliaria per raggiunti limiti d'età.
30 «L'Esercito italiano», 20 luglio 1910; v. anche «La Preparazione», 19-20 luglio 1910.
31 RFS. Spingardi a Tedesco, 30 ottobre 1910 (copia).
32 Riferiva Pollio a Spingardi : «[Da] uno stu dio fatto presso questo Comando [... ) risultano parecchi sintomatici indizi di un pericolo che a noi si affaccia: di a vere cioè la Svi zzera alleata coli' Austria-Ungheria in caso di un nostro conflitto con questa potenza», RFS. Lettera Riservata Personale in data 17 novembre 1910. V. anche M. MA ZZETI1 , L'esercito italiano nella triplice alleanza, op. cit. pp. 242-243.
48
Pollio ideò quindi un programma di difesa della frontiera svizzera in base al quale nel 1911 cominciarono i lavori difensivi sul saliente ticinese 33 • A causa delle «opere rese necessarie per far fronte alla nuova ed imprevista situazione creata dalla Svizzera» 34 , il capo di S.M. fu costretto a chiedere nuovi fondi per un ammontare di 30 milioni. «Ed anche questa richiesta non lasciai insoddisfatta » sospirò Spingardi, che riuscì ad ottenere dal Governo Luzzatti l'autorizzazione ad iniziare i lavori prima che il Parlamento concedesse i fondi 35 :
II Governo si è indotto a prendere l'impegno anzidetto perché seriamente preoccupato della situazione nuova creata dall'atteggiamento imprevisto assunto dalla Svizzera, atteggiamento che consigliava a provvedere di fortificazioni anche la frontiera italo -elvetica per parare il pericolo che, in caso di guerra, quella potenza non rimanesse neutrale ma operasse contro di noi 36
Pollio rilevava
con grandissima soddisfazione come l'E. V. si proponga di far approvare il programma di difesa del territorio, concretato da questo comando per premunirsi verso la front iera svizzera. - Per rendere ancora più evidente la necessità dell'attuazione di quel programma, ho l'onore di riferire che il 23 gennaio u.s., giovandomi della circostanza che i quattro comandanti designati di armata erano qui convenuti per prender e parte alle sedute del Consiglio dell'esercito, li ho riuniti e ho loro sottoposta la questione del nostro assetto difensivo verso No rd, tenendo conto della situazione politica. - S.A.R. e le L.L. E.E i comandanti di armata approvarono all'unanimità le misure difensive da me proposte 37 .
33 Il capo della missione militare italiana alle grandi manovre svizzere del 1911, gen. Domenico Grandi, rilevava nella sua relazione che «Da tutto l ' in sieme appare che la Svizzera tende a migliorare l'ottimo elemento che già possiede, per raggiungere nel caso di un conflitto europeo, uno scopo ben definito, sia esso l'imposizione ad ogni costo del rispetto della propria neutra lità, ovvero , ciò che appare più probabile, l'eventuale sua cooperazione con altra potenza a i danni di una terza». Doc riportato in MAZZETII, L'esercito italiano nella triplice aUeanza, op cit., p. 243. Cfr anche A. Rov10H1 , Un secolo di relazioni militari tra Italia e Svizzera. /861-1961, USSME, Roma 1987, p. 129. Domenico Grandi (1849 - 1937), partecipò alla campagna del 1870 quale sottotenente di fanteria. Nel 1890 fu in Africa. Colonnello nel 1896, coman dò il 12° reggimento fanteria. Nel 1898 fu capo di stato Maggiore del VII Corpo d'Armata. Da maggiore generale comandò la brigata «Lo mbardia » e da tenente generale le divisioni di Padova e di Roma. Nel 1911 ebbe il comando del X Corpo d'Armata. Succedette a Spingardi quale Ministro della Guerra il 24 marzo 1914 e rimase in carica fino ali' 11 ottob re dello stesso anno. Subito dopo riebbe il comando del X corpo, col quale entrò in guerra co ntro l'Austria. Deputato per due legislature, nel 1914 venne nominato senatore.
34 RFS. Spingardi a Pollio, 9 marzo 191 l, dattiloscritto Riservatissimo Personale nel quale il Ministro rievocava le vicende relative alla concessione dei fondi per la realizzazione del programma di la vo ri per la sistemazione difensiva permanente della frontiera.
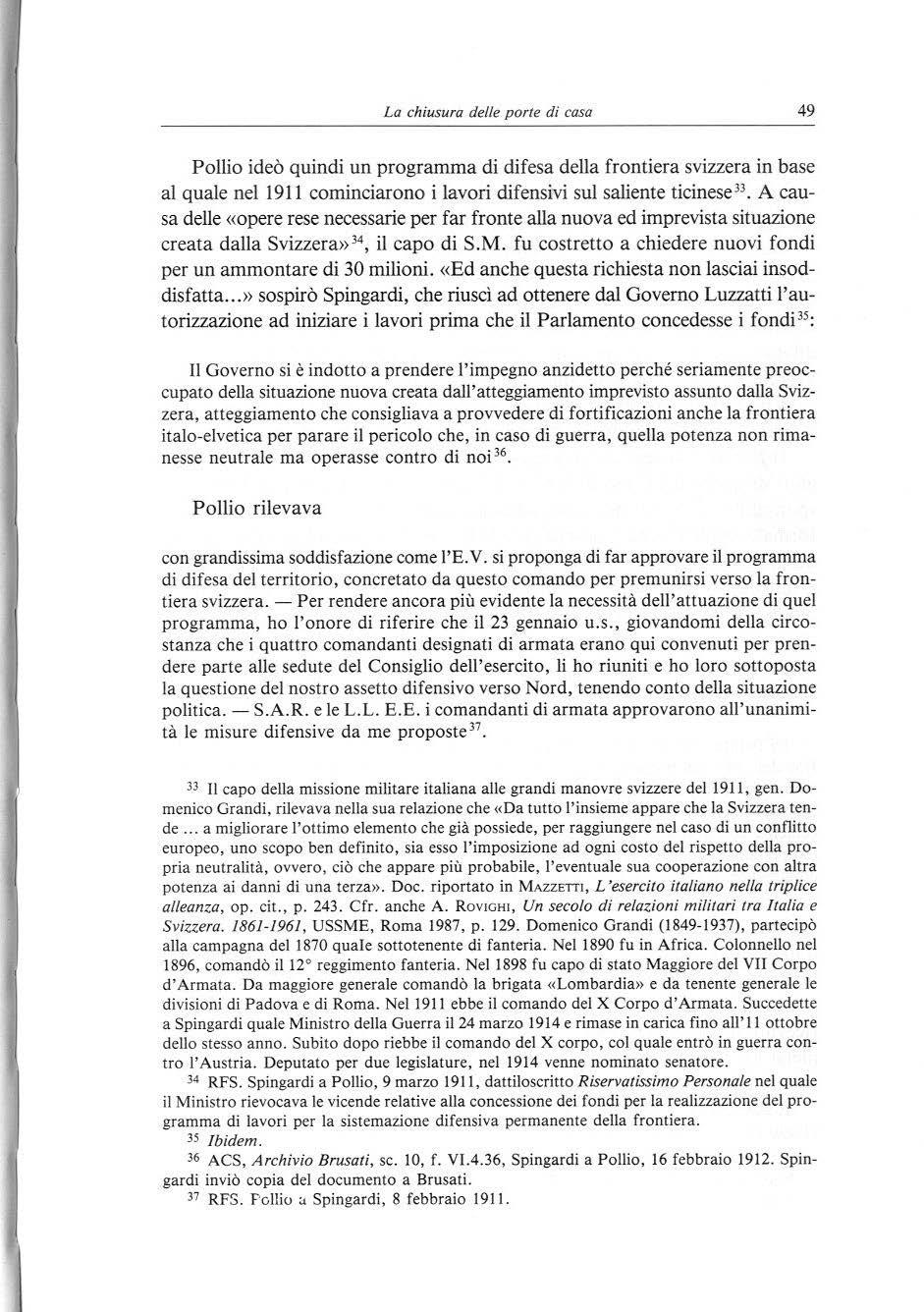
3S Ibidem.
36 ACS, Archivio Brusati, se IO, f. Vl.4.36, Spingardi a Pollio, 16 febbraio 1912. Spingardi inviò copia del documento a Brusati.
J7 RFS. f'ollio :i Spingardi, 8 febbraio 191 I.
La chiusura delle porte di casa 49
Il generale Paolo Spingardi
Ma al momento di ricevere la formale richiesta, Spingardi si sentì dire che i 30 milioni richiesti sarebbero stati sufficienti solo «a colmare le principali tra le lacune esistenti, e che ad altre necessità si dovrà provvedere più tardi» 38 •
Il Ministro non poteva consentire a questo modo di agire del Capo di Stato Maggiore e lo richiamò ad un maggiore senso della misura dichiarandogli con garbo ma senza mezzi termini di trovare ingiustificata questa «d ichiarata necessità di nuove somme per completare la nostra organizzazione difensiva, dopo i sacrifizi non indifferenti che il Paese ha fatto per il Suo Esercito» e che non poteva « nascondere le preoccupazioni che nutr[iva] circa la portata finanziar ia che minaccia di assumere questo allarg am ento delle basi su cui era dapprima impostato il nostro assetto difensivo» 39 •
Il Ministro si sentiva since ram ente gravato di responsabilità ben maggiori di quelle del Capo di S . M. «di fronte al Parlamento e al Paese, respo nsabilità che, nel mio caso odierno, sono rese più gravi dall'impegno formale, esplicito che, consenziente V .E. , io ebbi a prendere nella tornata dell' 11 giugno 1909: e cioè di fare, coi fondi richiesti, effettivamente fronte a tutto un complesso programma ben determinato»; non voleva in alcun modo tradire la fiducia che la Camera e i colleghi di Gov erno avevano riposto in lui approvando il programma di difesa nei termini esposti nel 1909. E pe r rimanere entro quei limiti Spingardi cercava di coinvolgere nella respons abilità il Capo di Stato Maggiore:
Di fronte al Paese noi abbiamo assunto l'impegno di completare, prima della fine del 1913, un programma che, per quanto minimo, è armonico, e che, attuaro completamente, può dare quella relativa sicurezza che certamente non darebbe un più vasto sistema difensivo al quale non sa premmo per ora come provvedere eff icacem ente con uomini e con mezzi e tanto meno potremmo completare nei limiti d i tempo concessi dall'odierna situazione politica; situazione in base alla quale, principalmente, il programma minimo venne concretato.
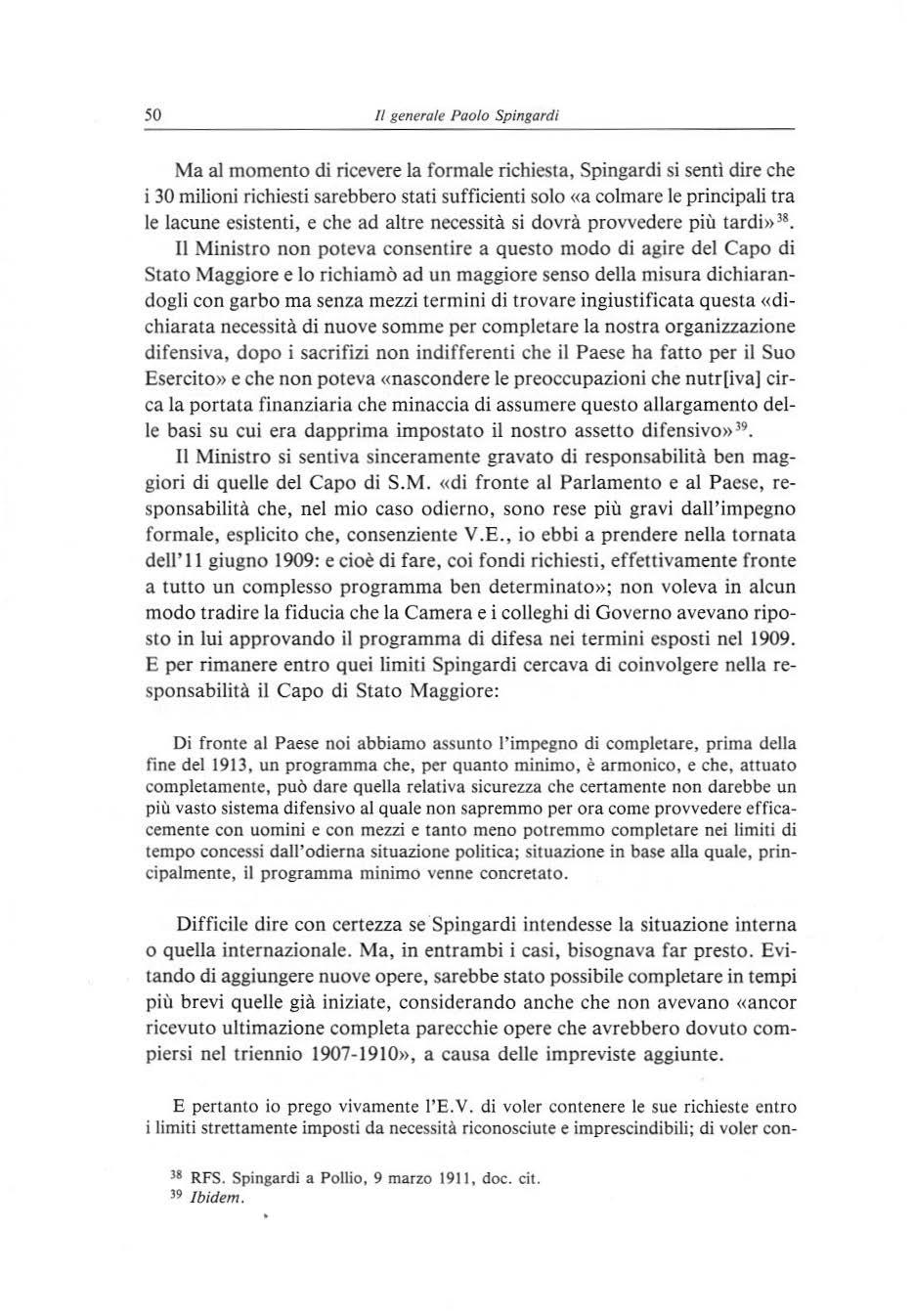
Difficile dire con certezza se Spingardi intendesse la situazione interna o quella internazionale. Ma, in entrambi i casi, bisognava far presto. Evita ndo di aggiungere nuove opere, sarebb e stato poss ib ile completare in tempi più brevi quelle già iniziate, considerando anche che non avevano «ancor ricevuto ultimazione completa parecchie opere che avrebbero dovuto compiersi nel triennio 1907-1910», a causa delle impreviste aggiunte.
E pertanto io prego vivamente l'E. V. di voler contenere le sue richieste e ntro i limiti strettamente imposti da necessità riconosciute e imprescindibili; di voler con-
50
38 RFS Spingardi a Pollio, 9 marzo 191 I, doc. cit. 39 Ibidem.
siderare che spesse volte il meglio è nemi co del bene[ . .. ]. Sempre d'accordo p ertanto con V. E ne l provvedere a ciò che è necessario per il bene dell ' esercito (e ne ho dato ripetute prove nello ammettere con in solita la rghezza moltissime richieste di fondi che, pur non gravando direttamen te s u l bilancio strao rdinario, danno luogo a nuove spese) debbo però necessariamente resis tere quando si tratti di oltrepassare un limite che il Ministro è nelle m igliori condizioni per stabilire e precisare, perché il Ministro, pur tene ndo conto pr incipalm ente d elle esigenze militari, non può p erò fare astrazione da altre considerazioni, di carattere politico ed economico 40
Pollio rientrò nei ranghi e mercé il suo «continuo e sapien te impulso all'apprestamento difensivo della nostra frontiera orientale », del quale Spingardi si teneva informato attraverso le relazioni della Direzione del Genio 41 , ne l corso del 19 11 «molto [fu] il lavoro fornito, e notevole la spinta ricevuta dall e opere rimaste arretrate nello scorso anno» 42 • Durante l'estate, tanto Spingardi quanto Pollio e S.A.R. il Duca d'Aosta, comandante della 3 a armata, compirono ult er iori m eticolose ispez ioni ai confin i per constatare lo st ato dei la vori, dichiarandosi soddisfatti 43 • L'assetto fortificatorio, man mano c he s i re alizzava, rivelò «le modificaz io ni sostanziali subite dal pr im itivo programma di difesa» che era andato «successivamente ed ininterrottamente» allargandosi. Secondo quel programma, infatti, le artiglierie da 149 millime tri poste in t orri corazzate, che avrebbero dovuto essere 127 , erano diventate, «per effetto dei successivi aumenti», 213, «s enza contare altri 12 affusti a perno cent rale Arm strong: sono state cioè pressoché r addoppiate>> . L 'opera che si stava realizzando era davvero « molto più vasta di quella progettata ini zia lm e n te» 44 • Ma per l'efficac e difesa dell e fron t iere le fo r t i ficazioni non erano che il primo indi spensab il e pass o. I nsiste ntemente i giorna li militari sostennero la necessità della costruzione di due linee ferroviarie strategiche che dovevano facilitare la mobil ita zion e e la radunata e permettere anche l' adeguato supporto log istico all'esercito schierato. Le linee erano la Ostiglia-LegnagoCamposampiero-Treviso e la Sacile-Pinzano, detta la «p edemontana » . Dopo lunghe diatribe tra gli enti locali, il Ministero dei Lavori Pubblici e il Ministero della Guerra, che si trascinarono per t utt o il l 910 e buona parte del L9J 1, e dopo una interpellanza dei parlamentari veneti al Presidente del Consiglio Luigi Lu zzatti, nel luglio del 1911 ve nne dato il benestare eco -
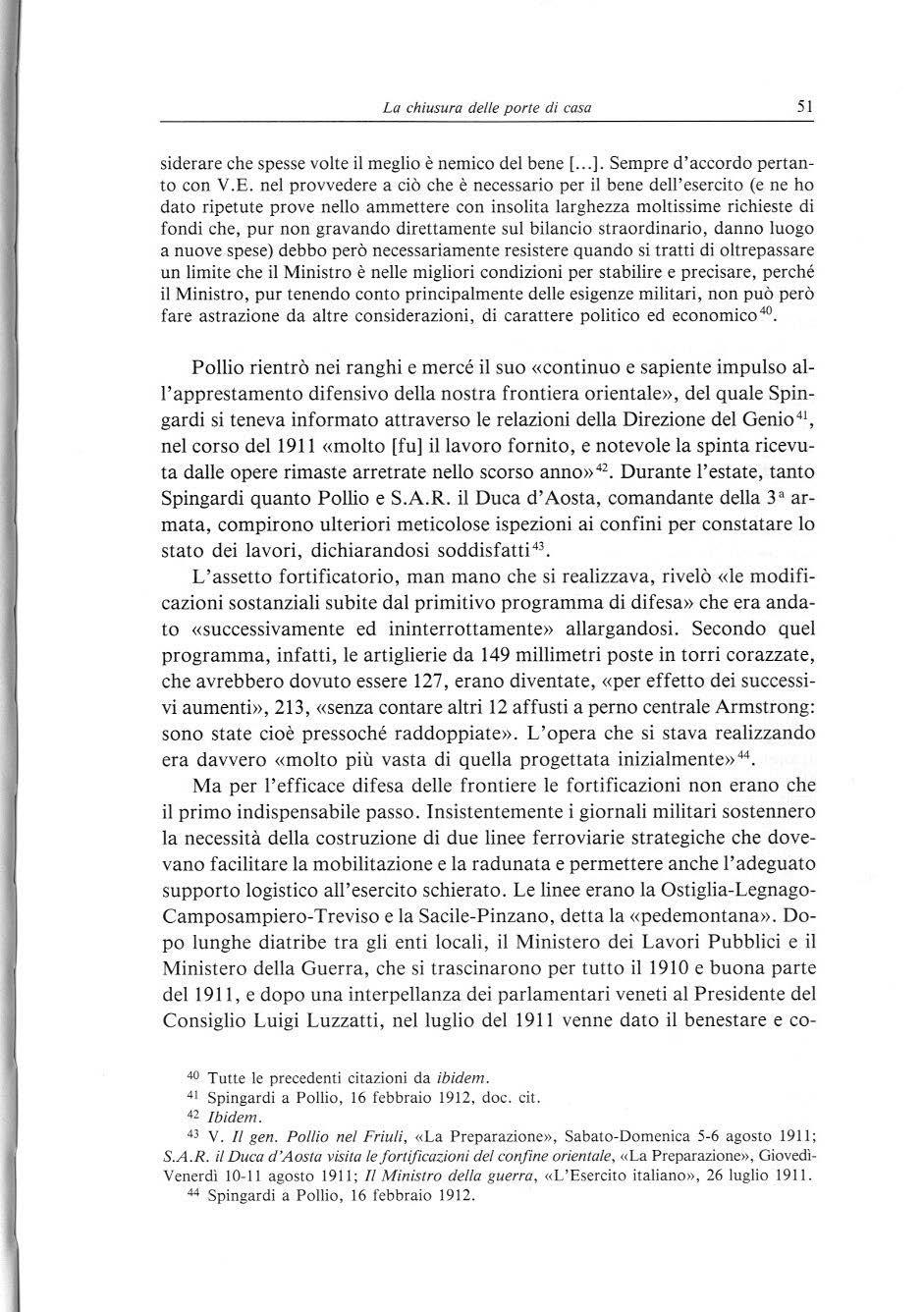
40 Tu tte le precedenti c itazio ni da ibidem.
4 1 Spi ngardi a Po ll io, 16 febb ra io 19 12, doc. cit.
42 I bidem.
43 V. // gen. Pallio nel Friuli , «La Preparazione», Sabato -Domenica 5-6 agosto 1911; S A .R. il Duca d 'Aosta visita le fortificazioni del confin e o rienwle, « La Preparazione», GiovedìVenerdì 10- 11 agosto 19 11; li Ministro della guerra , «L' Esercito ital ian o» , 26 luglio 1911.
44 Spingard i a Pollio, 16 fe bbraio 1912
La chiusura delle porte di casa 51
Il generale Paolo Spingardi
minciarono i rilievi per la loro costruzione. Nel frattempo erano anche cominciati i lavori per il tronco Motta di Li venza-Casarsa e Pi eve di CadoreBelluno 45.
Ma le lin ee di comunicazione non dovevano essere garantite dalle sole ferrovie, e insieme alle opere in muratura, tutta una rete stradale era in corso di costruzione per garantire efficaci comunicazioni per e tra le fortificazioni 46
La lentezza con cui procedevano i lavori fe rroviari indusse inoltr e il Ministro a prendere in considerazione l'uso di autocarri per semplificare le funzioni devolute ai treni e arrivare a quella che fu definita una «rivoluzione dei trasporti» 47 • Nel novembre 19 10 effettivamente, il Ministero ordinava all'industria civile 600 camions per l'e sercito 48 , secondo il concetto di devolvere «alla rotaia i compiti più gravi dei grandiosi trasporti, agli autocarri il completamento modernamente possibile ed indispensabile alle operazioni militari 49 • Era l'inizio della motorizzazione dell'esercito italiano 50 • Ma il fattore più importante per una efficace difesa era rappresentato dai soldati . E l'elemento uomo fu proprio il problema che Spingardi affrontò dopo le fortificazioni e contemporaneamente alla loro cos truzione.
4 5 V. la serie di articoli intitolati Nel Friuli e pel Friuli del direttore de «La Preparazione», Enrico Barone (che si firmava e b.), nei numeri di Sabato-Domen ica 22-23 ottobre 19 10, Giovedì - Venerdì 27-28 ottobre 1910, Giovedì-Ve ne rdì 3 -4 novembre 1910, Sabato-Domenica 24 -25 dicembre 19 10, Sabato -Domenica 13-14 maggio 1911 e altri sullo stesso tema nei numeri di Martedl-Mercoledì 17-18 gennaio 1911, Martedì-Mercoledì 21-22 febbraio 1911, MartedìMercoledì 23-24 maggio 191 I. E così pure «L'Esercito italiano» dell' 1 1, 16, 20, 23, 25 febbraio , 2 e 16 marzo, 3 aprile, 22 maggio, 3, 10 e 22 luglio 1910. 46 Ibidem.
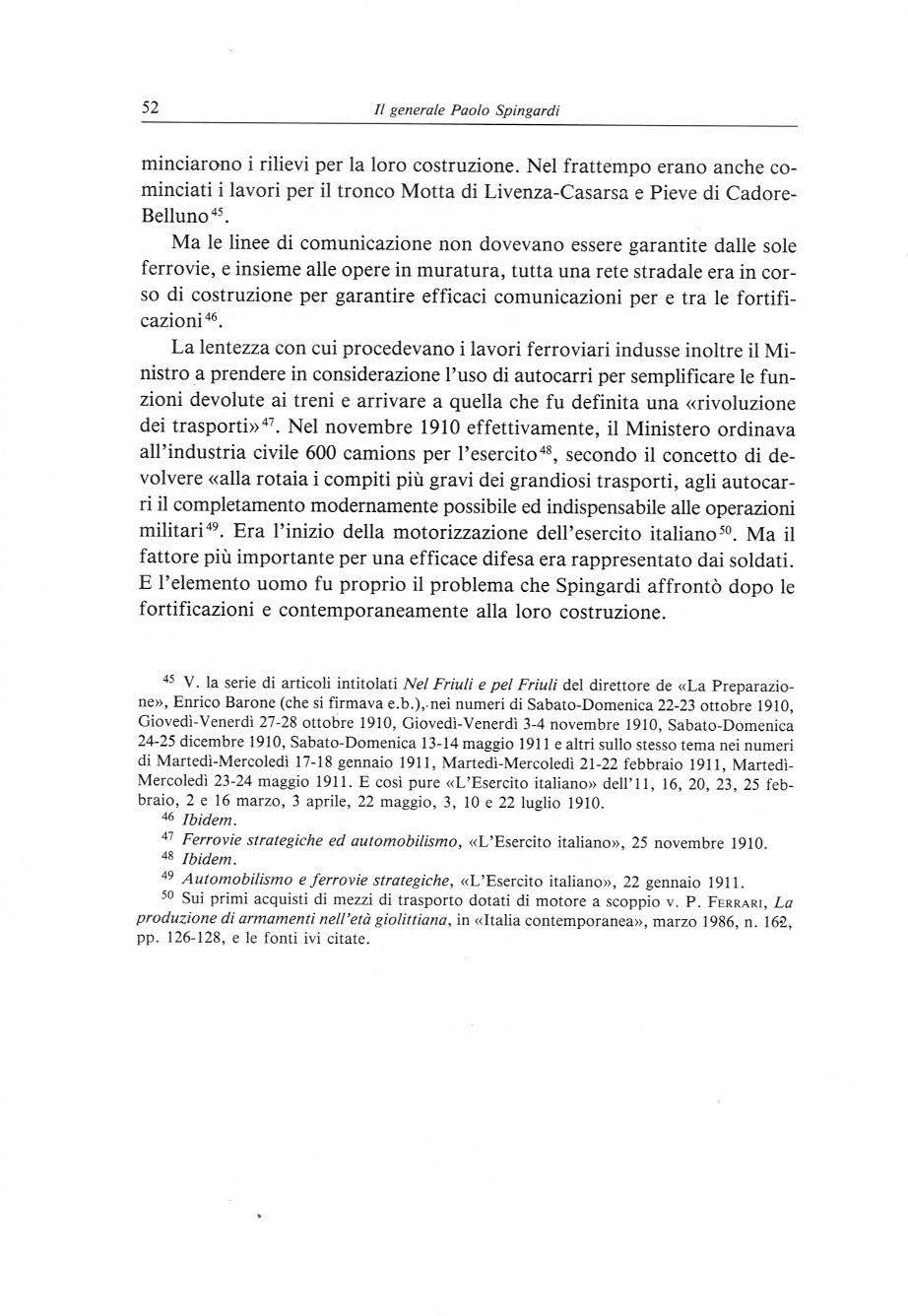
47 Ferrovie strategiche ed automobilismo, «L'Esercito italiano>>, 25 novembre 1910. 48 Ibidem.
4 9 Automobilismo e ferrovie strategiche, « L'Esercito ita liano», 22 gennaio 1911. so Sui primi acquisti di mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio v. P. F E RRAR1, La produzione di armamenti nell'età giolittiana, in «Italia contemporanea», marzo 1986, n. 162., pp. 126- 128, e le fonti ivi citate.
52
LA QUESTIONE DELLA FORZA E LA FERMA BIE NNALE
Nei primi anni del Novecento «non tanto per deficienza di stanziamenti in bilancio, quanto per scarso rendimento delle classi di leva» la forza media della compagnia era scesa nell'esercito italiano fino «ad un minimo di 65 uomini; e, se si tien conto delle esigenze dei servizi [... ] degli ammalati e di altre cause, la forza presente all'istruzione veniva ad essere ridotta alla metà», con conseguenze profondamente negative per l'addestramento dei quadri e della truppa 1 •
Il reclutamento «che è la base, il fondamento primo della costituzione degli eserciti», era regolata da una legge «nell'applicazione della quale circa metà del contingente era esente per titoli di famiglia» tanto che, dai 101.793 idonei della leva sui nati nel 1877, si di scese nel 1906 ai 66.836 della leva sui nati nel 1886 2 • Le dimensioni del problema arrivarono al punto che il Ministero della Guerra si trovò ad avere una forza effettivamente presente alle armi inferiore alla forza bilanciata 3 • Per porre rimedio a una situazione che rischiava letteralmente di dissanguare l'esercito, il 15 dicembre 1907 veniva approvata una nuova legge sul reclutamento che, riducendo i titoli di esenzione, fece salire il contingente effettivamente incorporabile a 106 000 uomini, oltre a una seconda categoria superiore a 20 mila uomini,
1 AA.PP. Legislatura XXIII , Camera-Discussioni, tornat a dell'II giu gno 1909, p. 2252 e ibidem, Documenti, N 102, p. 2. Nel corso dell'esercizio finanziario 1905- 1906 la forza media presente della compagnia di fanteria e ra stata di 71 uomini: nel 1906-1907: 66 uomini: nel 1907-1908: 65 uomini; nel 1908-1909: 80 uomini ci rca (per effetto della legge 15 d icembre I 907). Cfr AA.PP., Legis latu ra XXIII, Camera -Documenti, N. 102, p 2, nota (1). Si tenga presente che l'organico di guerra della co m pagnia e ra di 250 uomini. A titolo di con fro nto si consideri che l'Austr ia-Unghe r ia aveva u n organico normale della compagnia s ul piede di pace di 105 uomini : la Francia di I 15 : la Germania di 143: la Russia di I 12. Cfr. RFS , Prospetto presentato dal senatore Mazza per fa discussione del disegno di legge: stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanz iario 1913 -14, riferentesi agli organici ANTER IO RI allo scoppio della prima guer ra balcan ica (ottobre 1912).
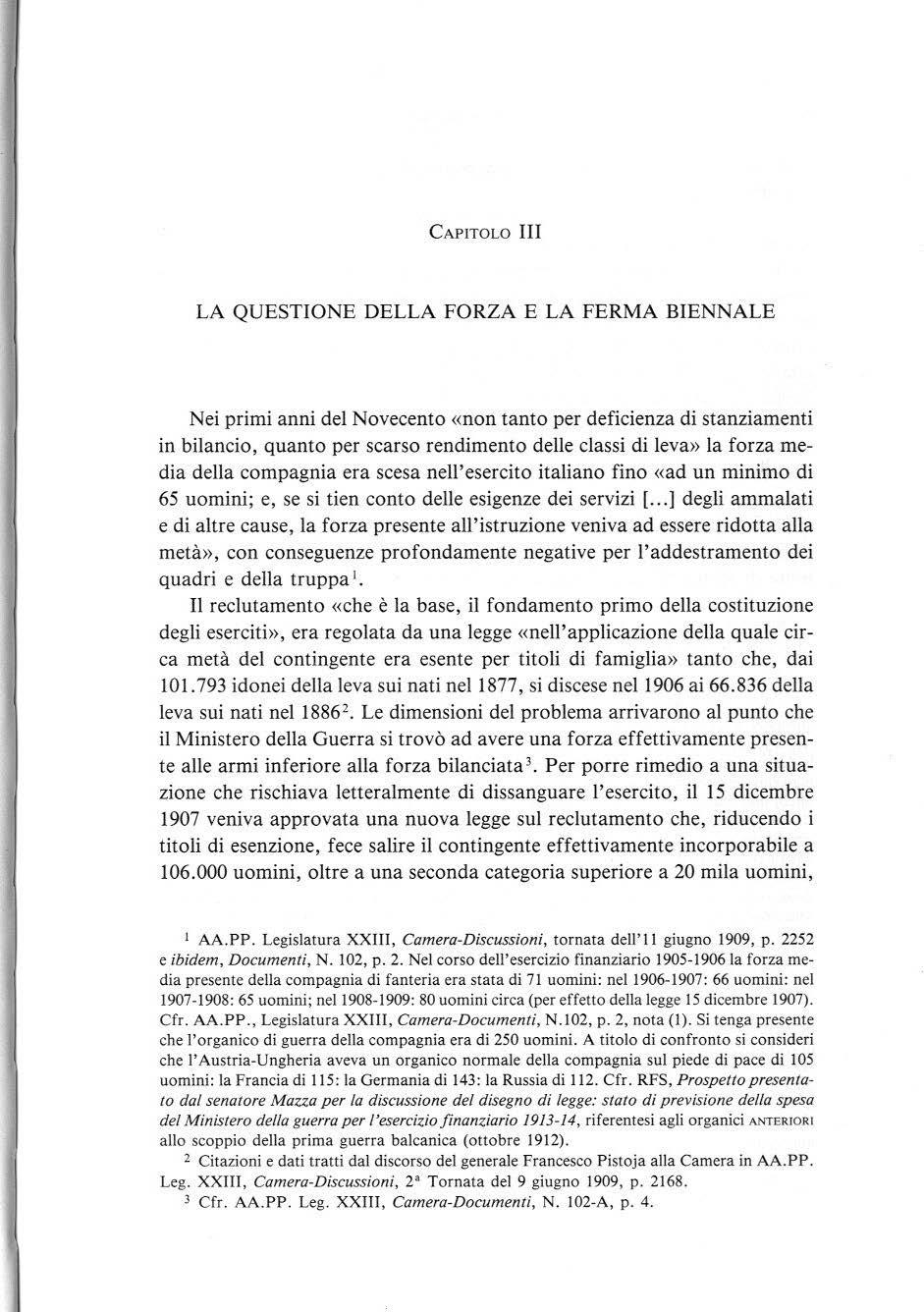
2 Cit azioni e dati tratti da l discorso del generale Francesco Pi stoja alla Camera in AA.PP. Le g XXIII, Camera-Discussioni, 2• T ornata del 9 giugno 1909 , p. 2168.
J Cfr AA.PP Leg XXIII , Camera -Documenti, N. 102-A, p. 4.
CAPITOLO III
Il generale Paolo Spingardi
quando venne applicata per la prima volta alla leva su i nati nel 1888 nell'autunno 1908 4 •
Spingardi arrivava dunque al Ministero della Guerra quando la legge cominciava appena a funzionare
Per evitare che circostanze impreviste ricreassero a più o meno breve termine la vecchia situazione, uno dei primi provvedimenti del nuovo Ministro fu un decreto che stabi li va nuovi elenchi delle infermità e malattie 5 , ottenendo così una forte riduzione del numero dei riformati e rivedibi li. Unito alla legge d el 1907, il provvedimento portò il «tasso di militarizzazione» al livello più alto fino allora conosciuto in Italia 6 • Garantito con questi provvedimenti l'indi spensa bile serbatoio di potenziali so ldati, Spingardi si proponeva di conseguire «un notevole aumento di uomini istruiti ed utili in caso di guer r a» attraverso l'aumento della forza bilanc iata e dei richiami di classi in congedo per istruzione 7 •
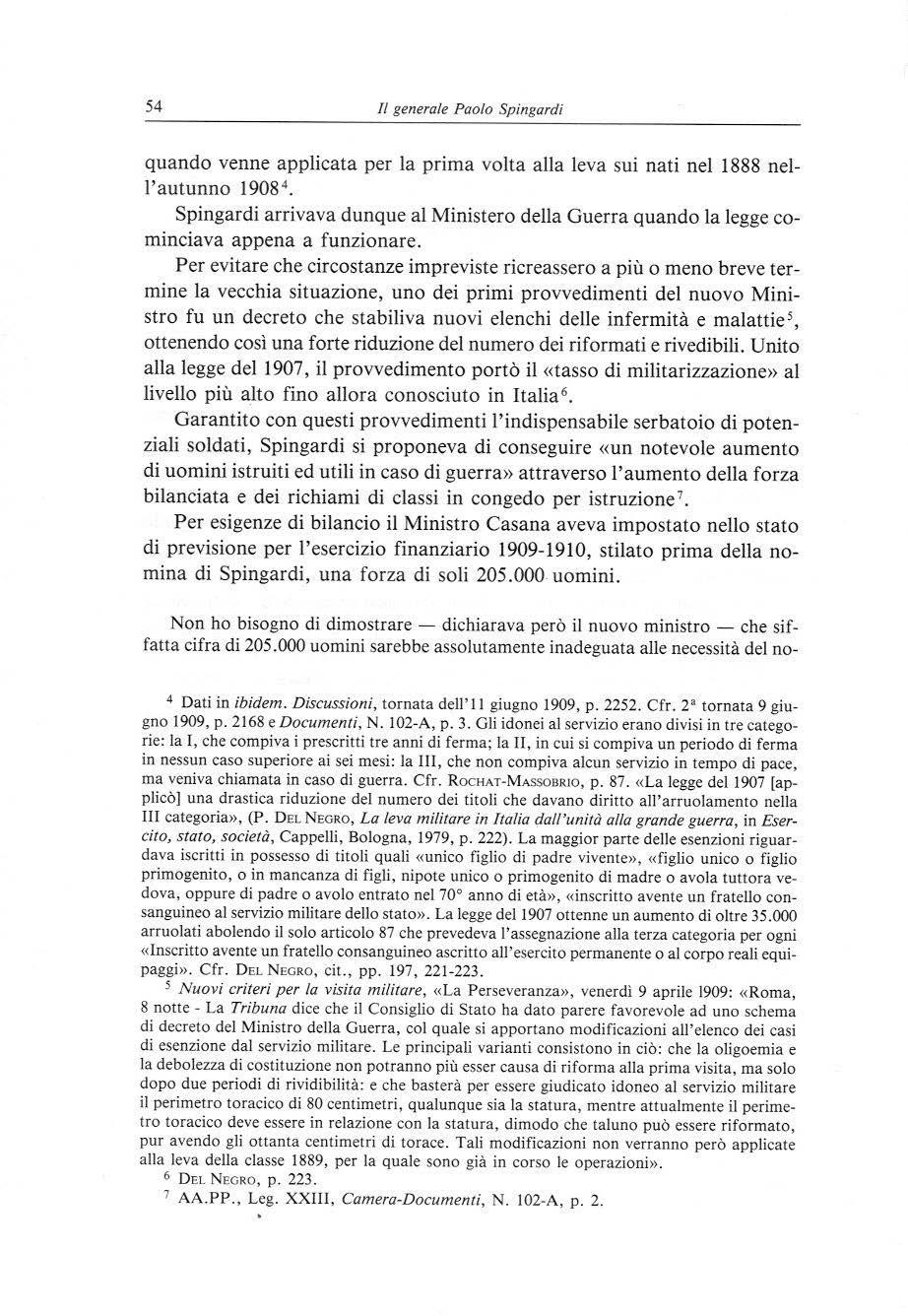
Per esigenze di bilancio il Ministro Casana aveva impostato nello stato di previsione per l 'esercizio finanziario 1909- 19 10, st ila to prima della nomina di Spingardi, una forza di so li 205.000. uomini.
Non ho bisogno di dimostrare - dichiarava però il nuovo ministro - che siffatta cifra di 205.000 uomini sarebbe assolutamente inadeguata alle necess ità del no -
4 Dati in ibidem. Discussioni, tornata dell' 11 giugno 1909, p. 2252. Cfr. 2• tornata 9 giugno 1909, p. 2168 e Documenti, N. 102- A, p. 3. Gli idone i al servizio erano divisi in tre categorie: la I , che compiva i prescritti tre ann i di ferma; la II, in cui si compiva un periodo di ferma in nessun caso super iore a i sei mesi: la Ili , che non compiva alcun servizio in tempo di pace, ma veniva chiamata in caso di guerra . Cfr . RocHAT- MASS08RIO, p. 87 . « La legge del 1907 [applicò) una drastica riduzione del numero dei titoli che davano diritto all'arruolamento nella Ili categoria », (P DE1..NEGRO , La leva militare in Italia dall'unità alla grande guerra, in EsercitO, stato, società, Cappelli, Bologna, 1979, p. 222). La maggior parte delle esenzioni riguardava iscr itti in possesso di titoli q uali «unico figlio di padre vive nt e», «figlio unico o figlio primogenito, o in mancanza di figl i, nipote unico o primogenito di madre o avo la tuttora vedova, oppure di padre o avolo entrato nel 70° anno di età», «inscritto avente un fratello consanguineo al servizio mi litare dello sta to». La legge del 1907 ottenne un aumento di oltre 35 .000 arruolati abolendo il solo articolo 87 che prevedeva l' assegnaz ione alla terza categoria per ogni «Inscritto a vente un fratello consanguineo ascritto all'esercito permanente o al corpo reali equipaggi». Cfr DE1..Ne0Ro, cit., pp. 197, 221-223
5 Nuovi criteri per la visita militare, «La Perseveranza», venerdì 9 aprile 1909: «Roma, 8 no t te - La Tribuna dice che il Consiglio d i Stato ha dato parere favorevole ad uno schema di decreto del Ministro della Guerra, col quale si apportano modificazioni all'elenco dei casi di esenzione dal servizio militare. Le principali va rianti consistono in ciò: che la ol igoemia e la debolezza di costituzione non potranno più esser causa di riforma alla prima visita , ma solo dopo due periodi di rividibilità: e che basterà per essere giudicato idoneo al servizio mi litare il per imetro toracico di 80 centimetri, qualunque sia la statura, mentre attua lmente il perimetro toracico deve essere in relazione con la statura, dimodo che talu no può essere r iformato, pur avendo gli ottanta cent im etri di torace. Tali mod ifica zioni non verranno però app licate alla leva della classe 1889, per la quale sono già in corso le operazioni».
6 DEL NEG RO, p. 223.
7 AA.PP., Leg. XXIII, Camera-Documenti, N. 102-A, p. 2
54
stro esercito. In discussioni parlamentari infatti, come pure nella relazione dell'onorevole commissione d'inchiesta per l'esercito, è stato accennato ad una forza molto superiore. Eppertanto vi richiedo che per l'esercizio 1909-1910 la forza bi lanciata sia portata a 225.000 uomini, che rappresenta l'indispensabile, sino a tanto che i nuovi ordinamenti non avranno avuto attuazione . Con detta forza bilanciata le compagnie di fanteria potranno avere una forza media annuale di una ottantina di uomini, ed u na normale di oltre 85, per circa IO mesi dell'anno, durante cioè il periodo di forza massima, mentre in corrispondenza del periodo di forza minima sarà presente a1Je armi la 2 • categoria, che servirà appunto a colmare in parte i vuoti prodotti dal congedamento 8
L 'aumento di 26 milioni per il bilancio ordinario del Ministero della Guerra richiesto da Spingardi serviva in gran parte a coprire le spese derivate dall'aumento della forza bilanciata .
I richiami di classe dovevano invece servire a garantire un buon livello di addestramento dei soldati in congedo che avrebbero dov u to rafforzare i reparti dell'esercito in caso di guerra. «Mentre negl i ese r cizi 1905 - 1906, 1906- 1907 e 1907- 1908>> ricordava Spingardi «furono effettuati richiami di poca entità (rispettivamente di circa uomin i 30.000, 18.000 e 28.000), nell'esercizio 1908 - 1909 furono richiamati o ltre 40 000 uomini» e dichiarava di voler effettuare richiami di classi su scala molto più vasta a partire dal1'esercizio finanziario 1909- I9 J 0 9 •
La questione era particolarmente sentita dai militari che sed evano in Parlamento.
Marco Di Saluzzo , uffic iale e membro di quasi tutte le commission i incar icate di esaminare i progetti di legge a carattere militare p r esentati dal Ministro Spingardi, si compiaceva che il Mini stro s i proponesse
di dare ai richiami u na maggiore estensione : ordine di idee in cui era entrata pure molto o p portunamente la Commissione d'inchiesta . [. . . ) Ma non basta che si effettuino i richiami: bisogna anche che si presentino i richiamati. Ora, se noi diamo uno sguar d o retrospet t ivo su ciò che è successo per i richiami effettua t isi negli anni precedenti, t rov iamo che: ne l 1904 s u 33 mila richiamat i mancarono 14 m il a; ne l I 905 su 62 mila mancar ono 25 mi la; ne l 1906 su 43 mila mancarono 20 mila; nel 1907 su 69 mila mancarono 35 mi la; nel 1908 su I IO mi la mancarono 50 mila . - Insomma il 50 per cento dei richiamati non s i presentò - e a propos i to Di Saluzzo !amen -
8 Ibidem N. 102, p.2. La seconda categoria veniva chiamata so litamente per un per iodo di istruz ione di tre mesi t ra la metà di agosto e la metà di novembre, cioè nell'intervallo tra il congedamento della c lasse anziana e la chiamata della nuova leva. Era questo il cosiddetto «pe riodo di forza minima» e la chiamata della seconda categoria doveva servire ad attenuare l'inconveniente di quello che era consider ato un periodo di crisi per tutti gli eserciti. Tendenza costante di Spingardi fu comunque da un lato la r id uzione del periodo di forza minima fino ad annullarlo, dall'altro far compiere alla 2• categoria il servizio di sei mes i , cioè il mass imo previsto dalla legge. V. Relazione Ufficiale, pp. 73 -74 e nn 30 e 31 alle pp. 173 - 174.
9 AA.PP., Legislatura XXIII , Camera- Documenti, N. 102, p 2.
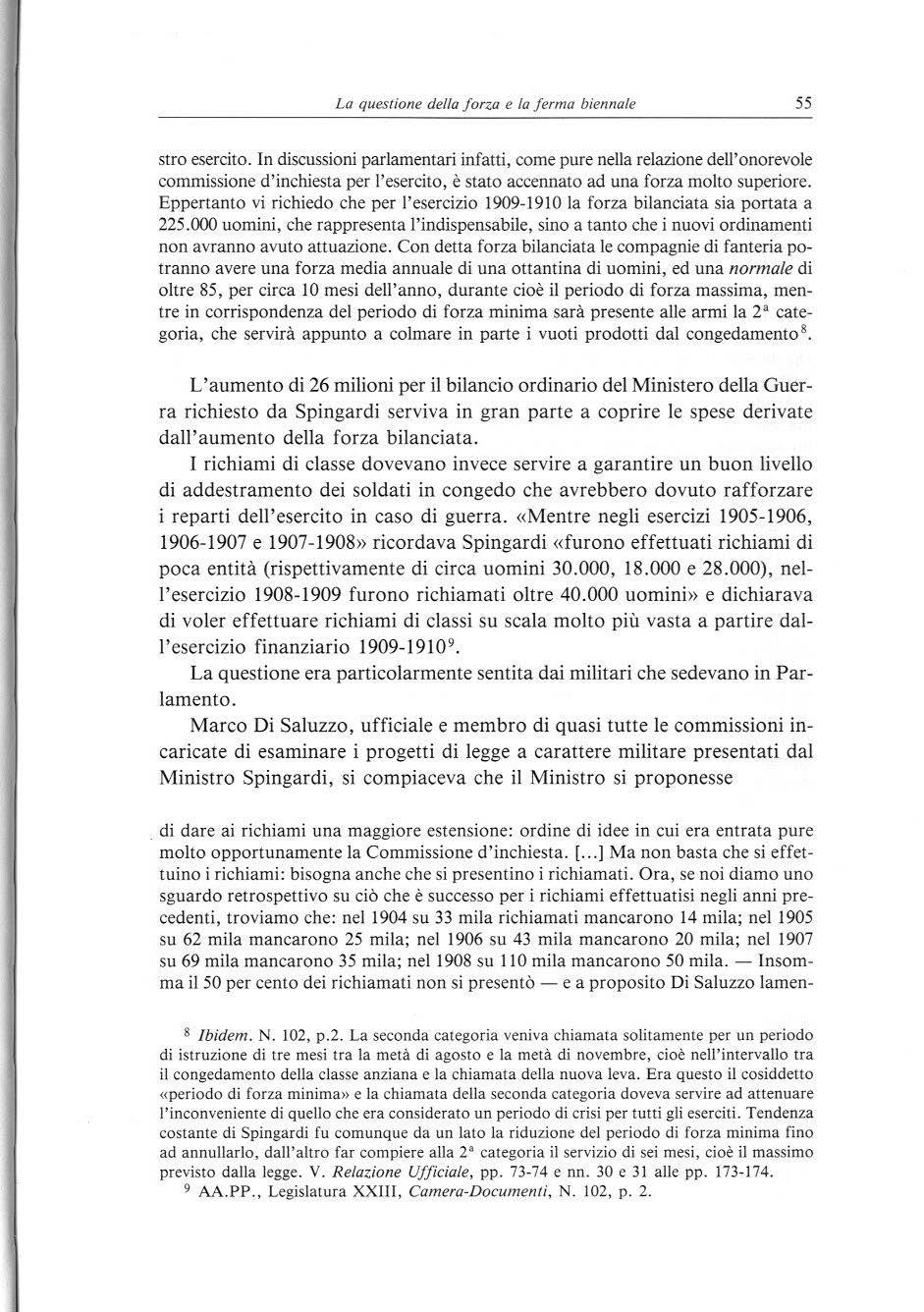
La questione della forza e la ferma biennale 55
generale Paolo Spingardi
tava il guaio dell'emigrazione che - produce molti vuoti nelle file dei nostri richiamati; e non si vede quale rimedio si possa portare, in tempo di pace, a questo stato di cose. Tutt'al più, per vedere in quali acque si navighi , per vedere quale sia la parte di forza in congedo che ci possa mancare, e per prowedere in conseguenza, se occorrerà, a qualche spostamento d i classe nelle diverse linee, sarebbe opportuno ricorrere a quel sistema di chiamate di contro!Jo (... ] in forza del qual sistema gl'indivi d ui in congedo dovrebbero presentarsi, in determinati period i , in dati centri, per dar conto della loro prese n za in patria . [. .. ] È certo che conviene asso lutamente aumentare i ric hi ami, per gli a n ni venturi. [. .. ] Se , in tema di richiami, paragon iamo ciò che succede da noi con quel che succede all'estero , il paragone è sconfortante. - In q uest'anno l'Austria ric hiama 7. 000 ufficiali, 430 .000 uomini e 19.000 cavalli, anche perché in Austria c'è il sistema di affidare i cavalli ai privati; la Francia 480 000 uomini e 10 000 ufficiali e la Germania 380.000 uomini: noi ne richiamiamo soltanto 160 .000 d ei quali , per le ragioni che ho accennato, possiamo appena far conto ch e se ne presenteranno 90 mila '° ·
Si trattava comunque, evidentemente, di un notevole passo avanti rispetto al passato.
Il competente generale P istoja, p iù volte relatore delle leggi che ogni anno si votavano p er le operaz ioni di leva, riportava cifre assai simili.
Bisogna abbondare nei r ic hiami, mentre in ciò siamo assa i deficienti a d i fferenza di quanto fanno gli altri stati. [ .. . ] La F rancia richiam a a d esso più d i 500 mila uom i ni , cioè 360 mila riservisti e 150 mila terri t oriali, d ei quali no i da 20 anni non ne r ich iamiamo alc u no 11 ; l'Aust r ia richiama 40 [ma voleva sicuramente dire 400] mila uomini annualmente. - Ora perché le manovre e le esercitazioni di campagna siano proficue, bisogna p r ecisamente che in quel periodo le uni tà e i r eparti r aggiungano approssimativame n te la forza di guerra: a ltrimenti una vera e propria istruzione non si può avere 12
10 AA.PP. Leg. XX III , Camera -Discussioni, 8 giugno 1909, pp. 2087 -2088. Marco Di Saluzzo Di Paesana (I 866- 1928), di nobile famiglia piemontese, frequentò l' Accademia militare di Torino uscendone ufficiale d'Artiglieria . F requentata la scuola di Guerra, divenne un brillante ufficiale di Stat o Maggiore, ma si congedò col grado di capi tano. Depu t ato dal 1904 a l 1919, poi nominato senatore, alla Camera sedette al centro. Richiamato per la grande guerra raggiunse il grado di colonnello. Dal giugno a l novembre 1919 fu sottosegretario ali' Ass istenza militare e Pensioni d i guerra nel primo m inistero Nit ti e dal giugno 1920 al luglio 1921 fu sottosegretario agli Esteri nel ministero Giolitti.
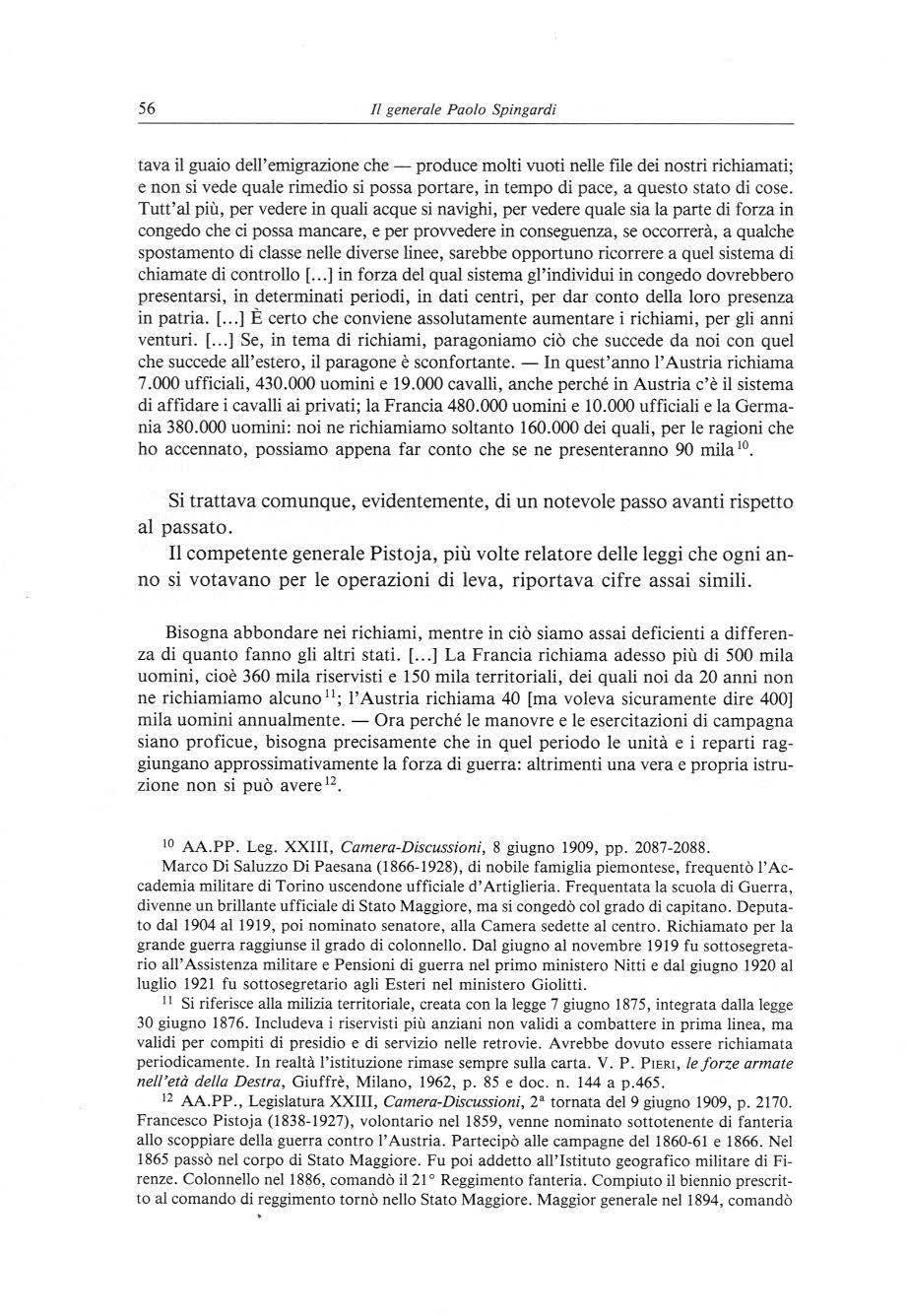
11 Si riferisce alla milizia terri toriale, creata con la legge 7 giugno I 875, integrata dalla legge 30 giugno 1876. Includeva i riservisti più anziani non validi a combattere in prima linea, ma validi per compiti d i presidio e di servizio ne lle retrovie . Avrebbe dovuto essere richiamata periodicamente. In realtà l'istituzione ri mase sempre sulla car ta. V. P. P1ERJ , /e/orze armate nell'età della Destra, Giuffrè, Milano, 1962, p. 85 e doc. n . 144 a p .465.
12 AA.PP., Legislatura XXIII, Camera-Discussioni , 2• tornata del 9 giugno 1909, p. 2170. Francesco Pistoja ( 1838 - 1927) , vo lontario nel 1859, venne nominato sottotenente d i fanter ia allo scoppiare della guerra contro l'Austria. Partecipò alle campagne del 1860-61 e 1866. Nel 1865 passò nel corpo di Stato Maggiore. Fu poi addetto all'Istituto geografico militare di Firenze. Colonnello nel 1886, comandò il 2 1° Reggimento fanteria. Compiuto il biennio prescritto al comando di reggimento tornò nello Stato Maggiore. Maggior generale nel 1894, comandò
56
Il
Il generale Mazzitelli rafforzava l'argomento collegandolo con la forza bilanciata:
Non è possibile, senza una certa consistenza di uomini sotto le armi, fare le istruzioni. Ma come provvedere? Ci vor rebbe non più la forza bilanciata di 225 mila ma quella di 250 mila voluta dalla Commissione d'inchiesta. Ma i quattrini mancano. Ebbene, io mi contento dei 225.000 purché s i adotti un rimedio, ed è quello dei richiami, ma dei richiami abbondanti. - Il ministro della guerra ci ha prom essi questi richiami abbondanti e sono sicuro che egli terrà la sua promessa; ma in che modo saranno abbondanti? Relativamente agli anni passati che sono stati nulli, meschini, mentre noi dobbiamo regolarci sempre su quello che si fa altrove, in questa faccenda della forza, perché la forza è tutta una cosa relativa. [ ] [Francia e Germania] hanno eserciti di 600.000 uomini, ne chiamano so tto le armi 400 o 500 mila ed ecco che hanno, per qualche tempo, l'esercito di un milioncino. - Ahimè! quanto noi siamo lontani da questo! Avremo 225.000 uomini, non so quanti ne chiamerà il ministro, farà, ripeto, tutto quello che potrà fare, ma non sarà abbastanza 13 •
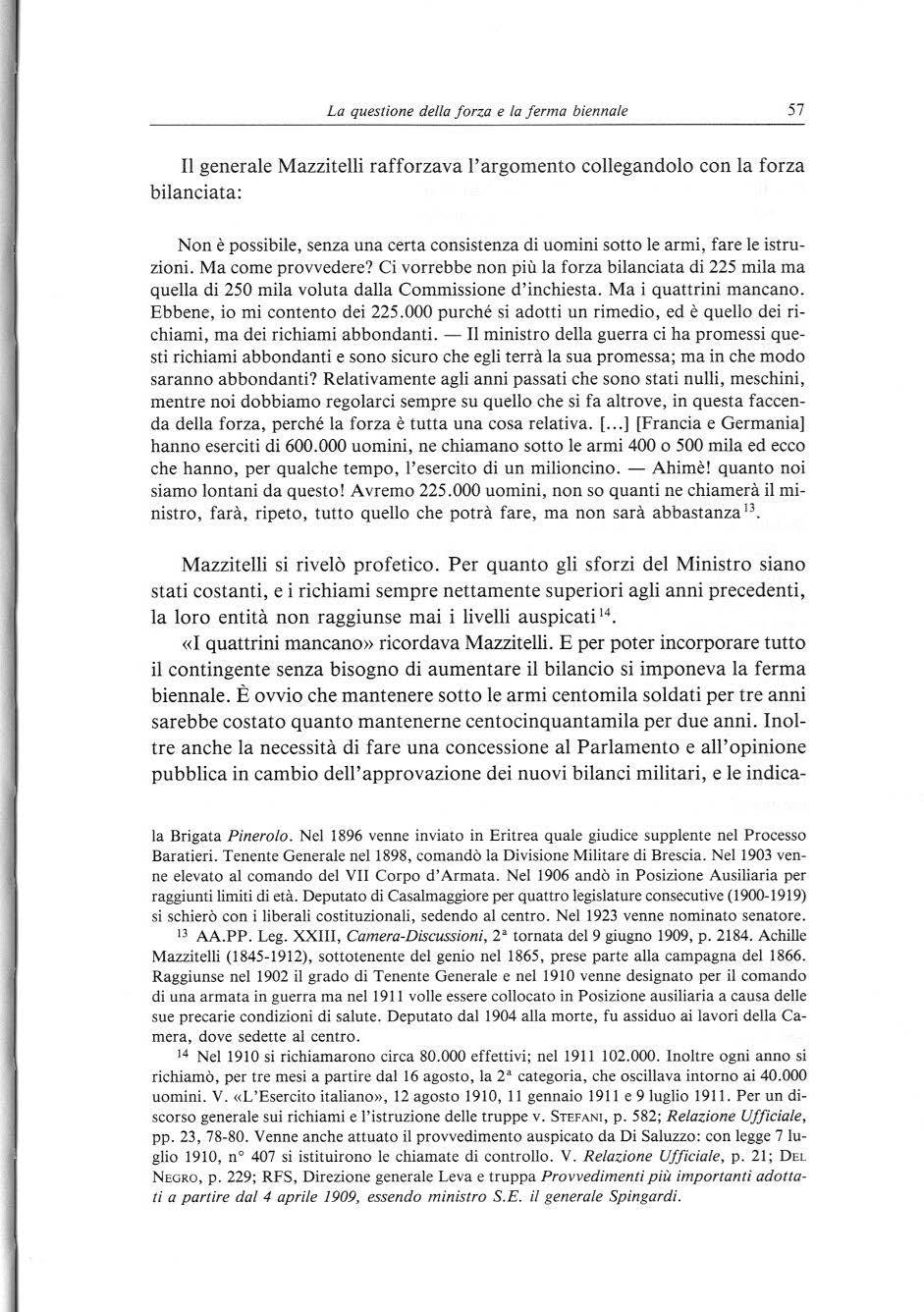
Mazzitelli si rivelò profetico. Per quanto gli sforzi del Ministro siano stat i costanti, e i richiami sempre nettamente superiori agli anni precedenti, la loro entità non raggiunse mai i livelli auspicati 14 •
«I quattrini mancano» ricordava Mazzitelli. E per poter incorporare tutto il contingente senza bisogno di aumentare il bilancio si imponeva la ferma biennale. È ovvio che mantenere sotto le armi centomila soldati per tre anni sarebbe costato quanto mantenerne centocinquantamila per due anni. Inoltre anche la necessità di fare una concessione al Parlamento e all'opinione pubblica in cambio dell'approvazione dei nuovi bilanci militari, e le indica-
la Brigata Pinerolo. N el 1896 venne inviato in Eritrea quale giudice supplente nel Processo Baratieri. Tenente Generale nel 1898, comandò la Divisione Militare di Bresc ia. Nel 1903 venne e levato al comando del Vll Corpo d'Armata. Nel 1906 andò in Posizione Ausiliaria per raggiunti limiti cli età. Deputato di Casalmaggiore per quattro legi slature consecutive (1900-1919) si schierò con i liberali costituzionali, sedendo al centro. Nel 1923 venne nominato senatore
13 AA.PP. Leg. XXIII, Camera -Discussioni, 2• tornata del 9 giugno 1909, p. 2184. Achille Mazzitelli (1845 - 1912), sottotenente del genio nel 1865, prese parte alla campagna del 1866. Raggiunse nel 1902 il grado di Tenente Generale e nel 1910 venne designato per il comando di una armata in guerra ma nel 191 I volle essere collocato in Posi zione ausiliaria a causa delle sue precarie cond iz ioni di salute . Deputato dal 1904 alla morte, fu assiduo ai lavori della Camera, dove sedette al centro.
14 Nel 1910 si richiamarono circa 80.000 effettivi; nel 1911 102.000. Inoltre ogni anno si richiamò, per tre mesi a partire dal 16 agosto, la 2• categoria, che oscillava intorno ai 40 000 uomini. V. « L 'Eserci to italiano», 12 agosto 1910, 11 gennaio 1911 e 9 luglio 191 I. Per un discorso generale sui richiami e l' istruzione delle truppe v. STEFANI, p. 582; Relazione Ufficiale, pp. 23, 78-80. Venne anche attuato il provvedimento auspicato da Di Saluzzo: con le gge 7 luglio 1910, n° 407 si istituirono le chiamate di controllo. V. Relazione Ufficiale, p. 21; D EL NEGRO, p. 229; RFS, Direzione generale Leva e truppa Provvedimenti più importanti adottati a partire dal 4 aprile 1909, essendo ministro S.E. il generale Spingardi .
La questione della forza e fa ferma biennale 57
li
generale Paolo Spingardi
zioni che venivano dalla Commissione d'inchiesta sull'esercito, fecero sentire il loro peso sulle decisioni del Ministro 15 •
Fi n dal 1905, quando la ferma biennale fu adottata in Francia, la Camera si era dimostrata sensibile al problema, con una proposta formale di ridurre la ferma a 24 mesi per le armi a cavallo e 18 per le altre armi, ma non se ne fece nulla 16 • In Germania la fe rm a biennale vigeva per la fanteria fin dal 1893 n
Nel febbraio 1907, in sede di presentazione del disegno di legge sul reclutamento, il Ministro Viganò propose che ad esso fosse unita l'adozione della ferma biennale 18 Ma la legge sul reclutamento venne stralciata dalla legge sulla ferma biennale «perché allora, sopra tutto, urgeva risanare i nostri effettivi da quel costa nte e gravissimo depauperamento annuale a cui essi andavano soggetti» 19
L'argomento tornava nel I 908, proposto dall'onorevole Pi stoja nella relazione sul disegno di legge per la leva dei nati nel 1888 20 •
Spingardi adottava senz'aJtro, nel 1909, in via ammin istrativa, la ferma di due anni per tutte le armi, congedando la classe anziana in servizio 21 Ma si trattava di una prassi normale, essendo facoltà del Ministro della Guerra il congedare anticipatamente i sold ati sotto le armi per rientrare nei limiti di spesa. Nella realtà dei fatti, a causa dei tagli effettuati al bilancio dell'amministrazione della guerra a partire dal 1891, quasi tutti i soldati di leva avevano compiuto fino al 1909 una ferma non superiore ai 24 mesi2 2• Fino a quel momento l'espediente, attuato per la prima volta da Pelloux, sottintendeva però il proposito di tornare alla ferma triennal e non appena il bilancio Io avesse consentito. Spingardi ritenne invece fosse g iun to il momento di dare sanzione legale alla ferma biennale: nel giugno 1909 faceva
15 V . DEL NEGRO, pp . 224-225 . Il 26 maggio 1909 la commissione a veva presentato la sua
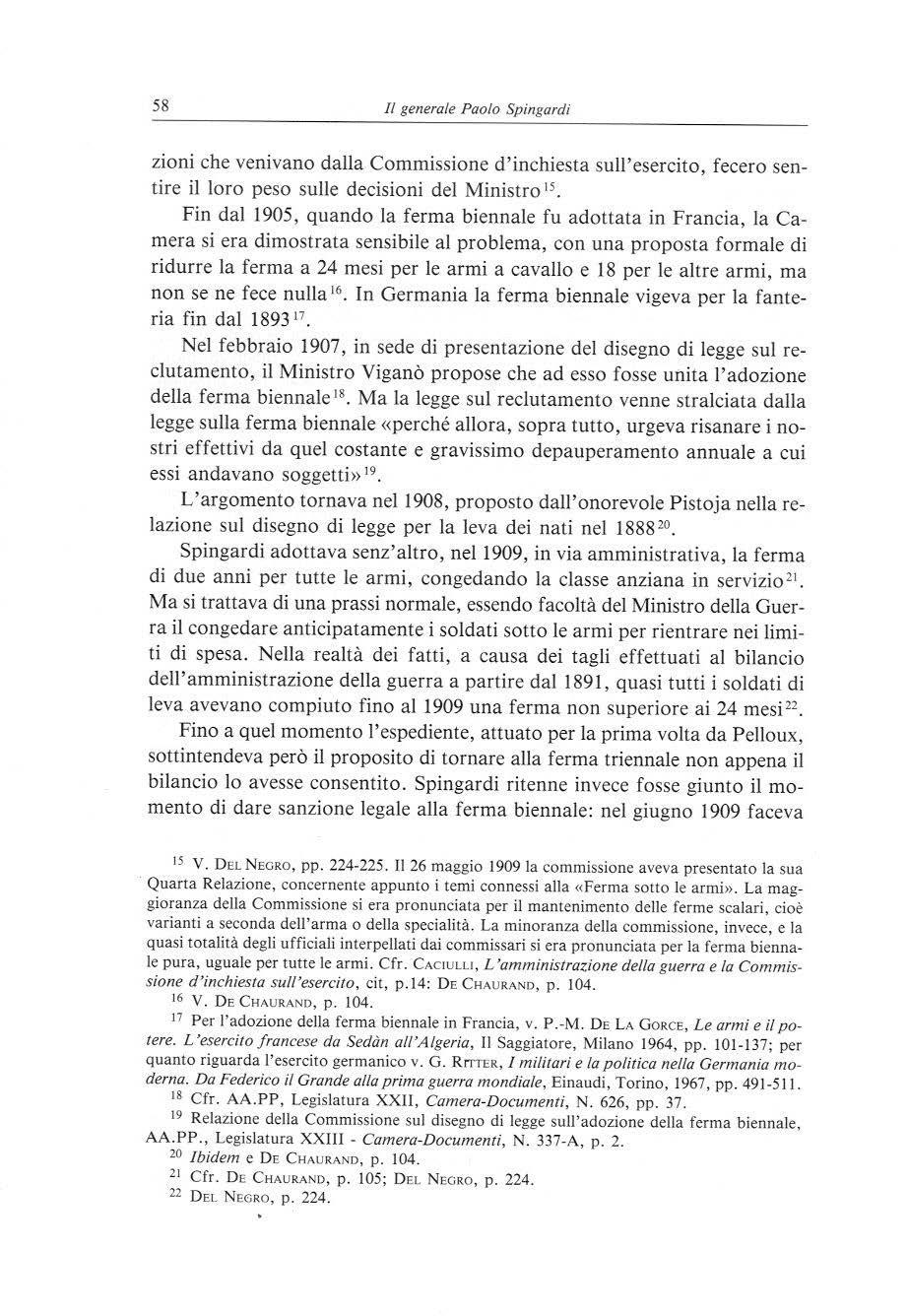
· Quarta Relazione, concernente appunto i temi connessi all a «Ferma sotto le armi». La maggioran z a della Commissione si era pronunciata per il mantenimento delle ferme scala r i, c i oè varianti a seconda dell'arma o della specia l ità. La minoranza della commissione, invece, e la quasi totalità degli ufficiali in terpella ti dai commissari si era pronunciata per la ferma biennale pura, uguale per tutte le armi . Cfr. CA c 1u Lu , L'amministrazione della guerra e la Commissio n e d'inchiesta sull'eserci to, c it, p 14: D E CHA URAND, p. 104.
l6 V. DE CHA URAND, p. 104.
17 Per l 'adozio ne della ferm a bienna le in Francia, v P.-M DE LA GoRCE, Le armi e il potere. L'esercito francese da Sedàn all'Algeria, Il Saggiatore, Milano 1964, pp 101-137; per quanto riguarda l ' esercito germanico v. G RrrTER, i militari e /apolitica nella Germania moderna. Da Federico il Grande alla prima guerra mondiale, Einaudi, Torino, 1967, pp 491-51 I.
18 Cfr. AA.PP, Legislatura XXII, Camera- Documenti, N. 626, pp. 37.
19 Relazione della Commissione sul disegno di legge sull'adozione della ferma biennale, AA.PP., Legislatura XXIII - Camera -Documenti, N. 337-A, p. 2.
20 ibidem e DE CHAURAND, p. 104
21 Cfr. D e CttAURAND, p. 105; DEL NEGRO, p. 224
22 DEL NE0 RO, p. 224
58
quindi annunziare dal sottosegretario Giuseppe Prudente l'intenzione di presentare un apposito progetto di legge 23 •
Il clima parlamentare era del resto oltremodo favorevole. Già presentando la relazione su l bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1909-1 910
il deputato Pai s-Serra diceva nella seduta del 4 giugno 1909:
Ritiene adunque il nostro re latore che la questione della ferma biennale, e per conside razioni di ordine sociale, e per ragioni tec niche, e per le condizioni di bilancio è pienamente matura per essere attuata 24
Nel dibattito sui maggiori stanziamenti e sul bilancio del ministero della guerra, i richiami circa l'opportunità della ferma biennale furono i più ricorrenti negli interventi degli oratori Il deputato Di Saluzzo esponeva chiaramente la questione:
Per l'elemento uomo un buon passo si è fatto con la legge del 15 dicembre 1907. Prima di esso noi perdevamo annualmente, nei nostri effettivi di mobilitazione, 38 mila uomini. Con esso, non solo abbiamo rimediato a questa lacuna, ma ci s iamo posti in grado di poter effettuare, senz'altro, la ferma biennale. La quale (possono compiacersene tutti coloro che la caldeggiarono per ragioni d'indole sociale , certamente non trascurabili, come possono e debbono rassegnarsi tutti coloro che l'avversavano per esagerati scrupo li tecnici) esce ora dal campo delle dispute teoriche e si impone con l'evidenza dei fatti. Si impone tanto che, se volessimo mantenere la ferma triennale, con l'attu ale contingente annuo, si sarebbe obbligati, data la forza bilanciata che abbiamo, a conge dare annua lmente un numero di uomini maggiore di quello che verrebbe sotto le armi.
23 V. AA.PP. Legislatura XXIll - Camera-Discussioni, tornata del 4 giugno 1909, p. 1899
Si trattava della risposta a una interrogazione presentata da ventuno deputat i, t ra i quali i più noti erano Treves, Turat i, Andrea Cos ta, Giacomo Ferri, al Ministro della Guerra «per sapere se in tenda presentare un d isegno di legge sulla ferma biennale» Prudente rispondeva: «Rispondo agli onorevoli in terroganti che il Ministe ro ha deciso di presentare quanto prima alla Camera un disegno di legge relativo alla ferma biennale (Vive approvazioni)». Giuseppe Prudente (1848-1910) sottotenente di fan ter ia nel 1866, frequentò successivamente la Scuola di Guerra e passò nello Stato Maggiore. Rag giun to il grado di colonnello nel 1894, comandò il 4° Reggimento bersaglieri. L' anno success ivo venne inviato a Berlino quale addetto mi l itare. Promosso Maggiore Generale nel 1900, comandò la Brigata Bergamo fino al 31 agosto di quell'anno quando fu nominato Comandante della scuola Militare di Modena, mantenendo l 'incarico fino al 1902. Nel 1907 venne promosso Tenente Generale. Pur non essendo né deputato né senatore, il 16 dicembre 1908 fu nominato sottosegretario di stato alla Guerra, reggendo la carica fino alla morte, avvenuta il 4 giugno del 1910
24 AA.PP., L eg . XXIII, Camera-Documenti, N. 28-A e 28-bis-A, p. 27. Francesco PaisSerra (1837 -1 924), di nobile famiglia sarda combatté con Garibaldi raggiungendo il grado di colonnello Deputato di Sassar i e Ozieri dal 1882 al 19 19, alla Camera sedeva all 'estrema sin istra, ma generalmente votava a favore del governo. Volontario nel 1915 seppe mer itarsi una medaglia di b ronzo e nel 19 18 la promozione a maggior generale.
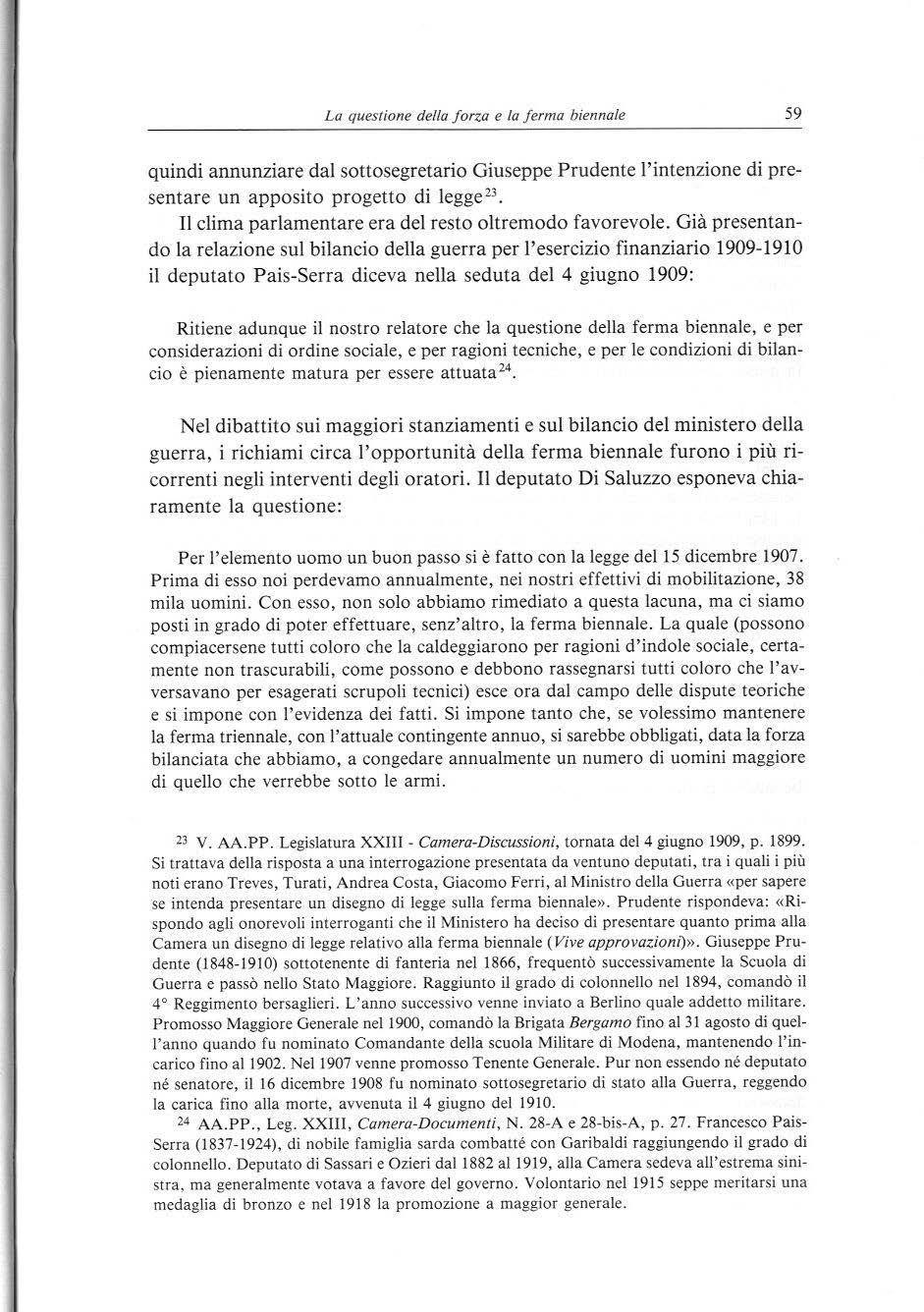
La questione della forza
ferma
59
e la
biennale
il generale Paolo Spingardi
Egli si dichiarava dunque deciso fautore della ferma biennale perché in verità io comprendo una ferma biennale del tipo francese, in cui tutti fanno due anni di servizio, comprendo una ferma biennale del tipo tedesco in cui la sola cavalleria fa tre anni di servizio, ma gli altri ne fanno due; ma non comprendo la ferma biennale nella quale una parte del contingente che non sia di cavalleria debba fare tre anni di servizio . - Allora non è più ferma biennale, ma è la ferma scalare pura e semplice che abbiamo ora in attuazione. Anche adesso una parte del contingente fa tre anni di servizio, una parte due e una parte uno solo 25 E la ferma biennal e in queste condizioni diventa una vera finzione.
Di Saluzzo teneva a sottolineare che la ferma biennale non andava assolutamente considerata come un
compenso accordato al Paese per la maggiore estensione data alJ'obbligo di servizio [ ] La ferma biennale è la conseguenza automatica del fatto che il contingente annuo è aumentato in relazione alla forza bilanciata che abbiamo: è, per servirmi di un'immagine, il piattello di una bilancia che si solleva per il maggior peso caricato sull'altro, ma non è un corrispettivo che si accordi al paese perché sia esteso l'obbligo di servizio 26
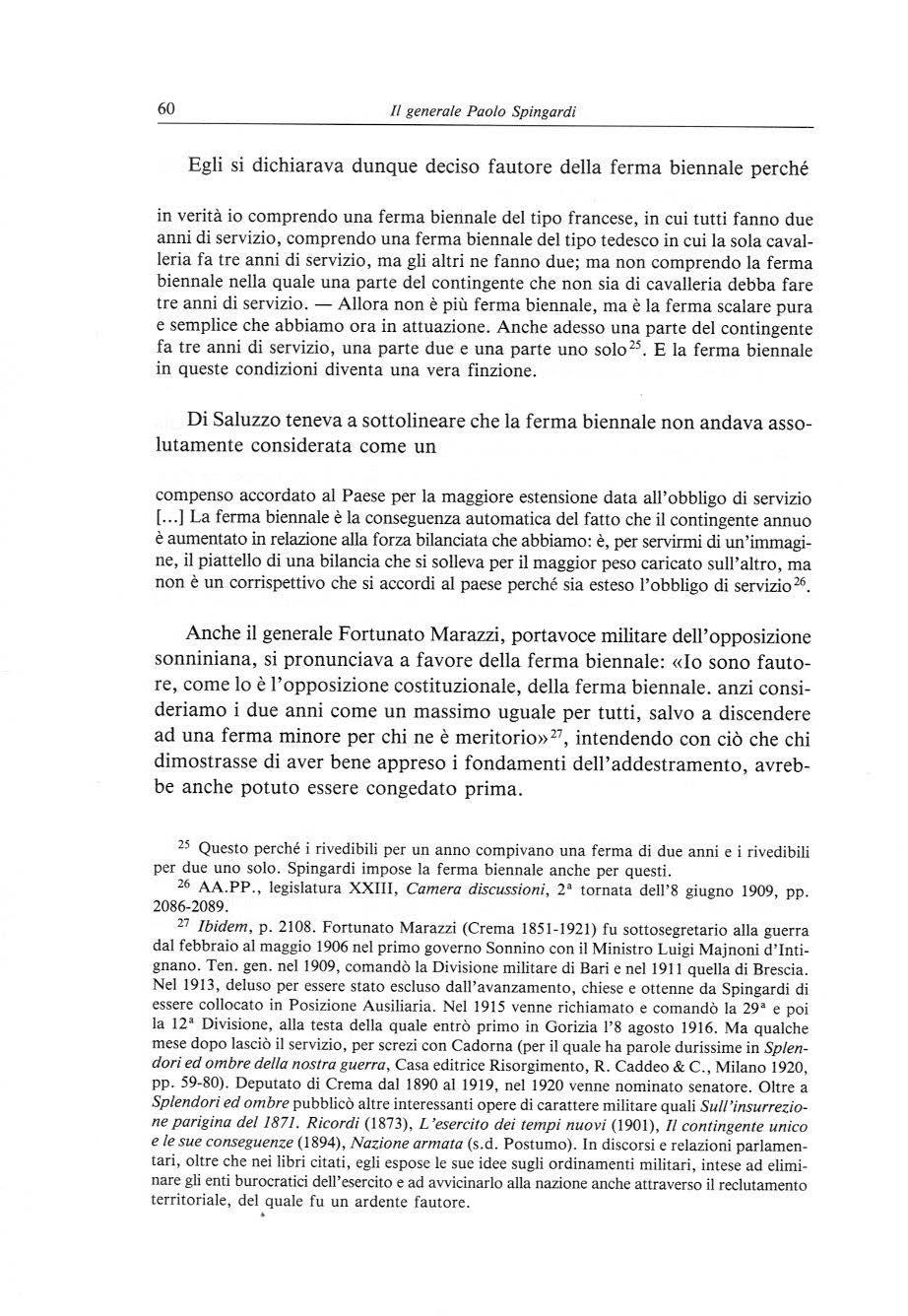
Anche il generale Fortuna to Marazzi, portavoce militare dell'opposizione so nniniana, si pronunciava a favore della ferma biennale: «Io sono fautore, come lo è l'opposizione costituzionale, della ferma biennale. anzi consideriamo i due anni come un massimo uguale per tutti, salvo a discendere ad una ferma minore per chi ne è meritorio» 27 , intendendo con ciò che chi dimostrasse di aver bene appreso i fondamenti dell'addestramento, avrebbe anche potuto essere congedato prima.
25 Questo perché i rivedibili per un anno compivano una ferma di due anni e i rivedibili per due uno solo Spingardi impose la ferma biennale anche per questi.
26 AA.PP., legislatura XXIII, Camera discussioni, 2• tornata dell'8 giugno 1909, pp. 2086 -2089.
27 Ibidem, p. 2 108 Fortunato Marazzi (Crema 1851-1921) fu so ttosegretario alla guerra dal febbraio al maggio 1906 nel primo governo Sonnino con il Ministro Luigi Majnoni d'Intignano Ten gen. nel 1909, comandò la Divisione militare di Bari e nel 191 I quella d i Brescia. Nel 1913, deluso per essere stato escluso dall'avanzamento , chiese e ottenne da Spingardi di essere collocato in Posizione Ausiliaria. Nel 1915 venne richiamato e comandò la 29" e poi la 12• Divisione , alla testa della quale entrò primo in Gorizia 1'8 agosto 1916. Ma qualche mese dopo lasciò il servizio, per screzi con Cadorna (per il quale ha paro le durissime in Splendori ed ombre della nostra guerra, Casa editrice Risorgimento, R. Caddeo & C ., Milano 1920, pp. 59-80). Deputato di Crema dal 1890 al 1919, nel 1920 venne nominato senatore. Oltre a Splendori ed ombre pubblicò altre interessanti opere di carattere militare quali Su/l'insurrezione parigina del 1871. Ricordi (1873), L'esercito dei tempi nuovi (1901), l i contingente unico e le sue conseguenze (1894), Nazione armata (s.d Postumo). In discorsi e re lazioni parlamentari, oltre che nei libri citati, egli espose le sue idee sugli ordinamenti militari, intese ad eliminare gli enti burocratici dell'esercito e ad avvicinarlo alla nazione anche attraverso il reclutamento territoriale, del quale fu un ardente fautore
60
Il 9 giugno 1909 interveniva ancora un altro deputato militare, il gen. Mazz itelli. Come già Di Saluzzo egli intendeva sottolineare come la ferma biennale non dovesse essere considerata il corris pettivo della legge sul reclu tamento, ma derivasse da motivazioni esclusivamente tecniche. P er Mazzitelli la ferma biennal e era
una necessità assoluta, non per le ragioni dette da alcuni, cioè come co rri spettivo della maggiore gravezza della legge sul reclutamento che fu votata [... ] Voglio la ferma di due anni non come corrispettivo qualsiasi, ma perché maggiore si a il numero dei cittadini chiamati all'esercito, per is truirsi e prepararsi a lla guerra, affinché, a pari bilancio, cioè a pari forza bilanciata, si possa avere un esercito più numeroso, od a pari forza d 'esercito, si possa avere un esercito più vigoroso, più giovane: poiché è evidente che, se noi, ogni anno, istruiremo una classe più numerosa, avremo bisogno di un minor numero di classi: e qu i ndi faremo assegnamento specialmente sui giovani, con quegli effetti, anche economici e sociali, c he t utti comprendono 28•
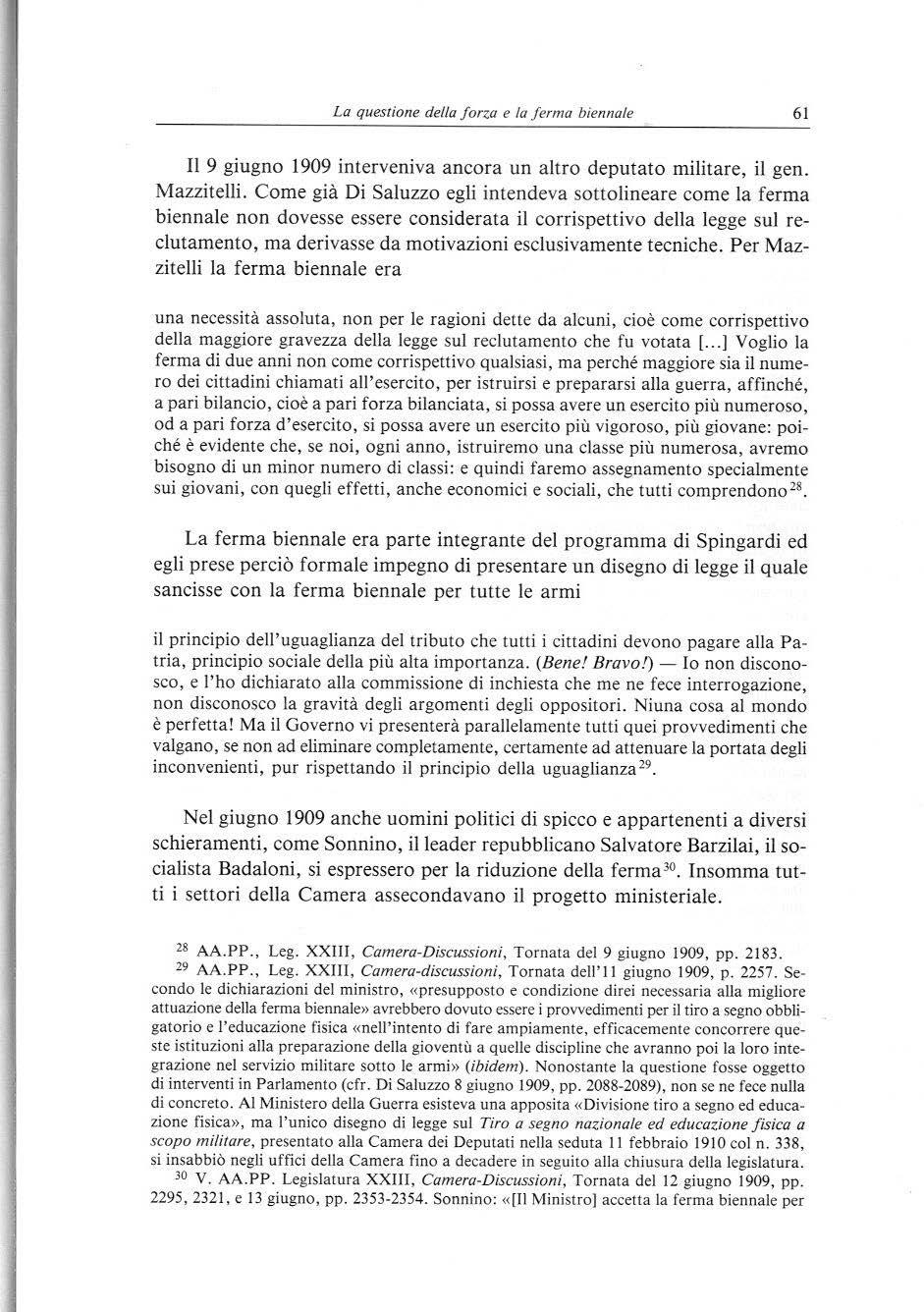
La ferma biennale era parte integrante del programma di Spingardi ed egli prese perciò formale impegno di presentare un disegno di legge il quale sancisse con la ferma biennale per tutte le armi
il principio dell'uguaglianza del tr ibu to che tutti i citta di ni d evono pagare alla Patria, principio sociale della pi ù alta importanza. (Bene! Bravo!) - Io non disconosco, e l'ho dichiarato alla commissione di inchiesta che me ne fece interrogazione, non disconosco la gravità degli argomenti degli oppositori. Niuna cosa al mondo è perfetta! Ma i l Governo vi presenterà parallelamente tutti quei provvedimenti che val gan o, se non ad eliminare completamente, certamente ad attenuare la portata degli inconve ni e nti , p ur rispettando il principio d ella uguaglianza 29
Nel giugno 1909 anche uomini po li tici di sp icco e appartenenti a diversi schieramenti, come Sonnino, il leader repubblicano Salvatore Barzilai , il socialista Badaloni , si espressero per la riduzione della ferma 30 In somma tutti i settori della Camera assecondavano il progetto min ister iale.
28 AA.PP., Leg XXIII , Camera-Discussioni, Tornata del 9 giugno 1909, pp 2 183
29 AA.PP., Leg. XXIII, Camera-discussioni, Tornata dell' J l giugno 1909, p. 2257. Secondo le dichiarazioni del ministro, «presupposto e condizione di rei necess aria alla migliore attuaz ione della ferma biennale» avrebbero dovuto essere i provvedimenti per il t iro a segno obb ligatorio e l'educazione fisica « nell'in tento di fare ampiamente, efficacemente concorr ere quest e ist ituzion i a ll a preparazione della gioventù a quelle d iscipline che avranno poi la loro integra zione nel servizio militare sotto le armi » (ibidem) Nono s ta n te la questione fosse oggetto di interventi in Pa rlamen to (cfr. D i Saluzzo 8 gi ugno 1909, pp. 2088 -2089), non se ne fece nulla di concreto Al Ministero della Guerra esis teva una apposita « Divi s ione tiro a segno ed educazione fisica», ma l'unico disegno di legge sul Tiro a segno nazionale ed educazione fisic a a s copo militare, presen ta to alla Camera dei Deputati nella seduta 11 febbraio 19 10 co l n. 338, si insabb iò negli uffici della Camera fino a deca dere in seguiro a ll a ch ius ura della legislatura.
30 V. AA.PP. Leg islatura XXIII , Camera-Discussioni, Tornata del 12 giugno 1909, pp 2295, 2321, e 13 giugno , pp. 2353-2354. Sonnino : « [Il Mini st ro) accetta la ferma biennale per
La
61
questione della forza e la f erma biennale
Il generale Paolo Spingardi
Anche al Senato, nella discussione del 26 giugno, il problema ebbe modo di emergere come uno dei più sentiti. Ma qui, al contrario che alla Camera dei Deputati , sorsero obiezioni che preannunciavano l'opposizione che un anno dopo sarebbe sorta in alcuni settori, coerentemente col carattere conservatore della Camera Alta . Che si esprimesse pare r e favorevole o contrario, era comunque messa in luce l'importanza dell'argomento e quanto fosse sentito dalle diverse componenti politiche.
Contrario si dichiarava l'ex capo di Stato Maggiore Dom enico Primerano soprattutto per il timore che al congedo di una classe non rimanessero sufficienti truppe addestrate sotto le armi, che non ci fosse abbastanza tempo per forma r e i sottufficiali e i gradua t i di truppa e addestrare le armi speciali :
La tendenza, la vedo, con rincrescimento, è per la ferma biennale, pe rché fa credere a molti che se ne possa conseguire economia nelle spese e vantaggi socia li, il che non è La ferma biennale s ign i fica in sostanza avere due contingenti di leva sotto le armi in pace; ma con due contingenti di leva, quando si congeda una classe, che cosa resta dell'esercito? E fino a quando non è addestrata la classe nuova, che consistenza ha l 'esercito? Come provvedere ai quadri di bassa forza, alle armi speciali: cavalleria, genio, artig li eria, zappator i di fanteria? 31
tutte le armi; e me ne rallegro » Barzilai: «Altro coefficiente della debolezza militare, la resisten za tenace dei m inistri della guerra alle riforme, delle qual i ieri, in verità, l ' onorevole Spingardi disse accoglierne qualcuna, non priva d'importanza: per esempio, l a ferma biennale, che l a commissione d'inchiesta aveva accolto ma fino ad un certo punto. Mi compi accio che il ministro del l a guerra sia andato al di là di quel punto». Badaloni: «Finché un nuovo ordinamento m ilitare, quell'ordinamento militare che, sino a quando duri l a necessità delle armi, noi vagheggiamo: un ordinamento militare il quale non separ i il soldato dal ci ttadino, e il cittad ino dalla famigl ia : finché questo nuovo ordinamento mi litare non sia possibile, noi crediamo che bisogni temperare con tutti i mezzi la gravezza del servizio militare : e innanzi tutto bisogna r idur re la ferma Ho preso atto con grande sodd isfaz io ne delle dichiarazioni da voi [l' altro]ier i fatte alla Camera e dell'impegno preso (leggo le vostre parole): 'di presentare un d i segno d i legge che riconosca, con l'obbligo della fe rma biennale per tutte le armi, il pr incip io dell'uguaglianza del tributo che tutti i cittadini debbono pagare alla patria'. - Ma, onorevole ministro, io r icordo non so l o una promessa ministeriale, ma anche un disegno di legge minister iale, il quale consacra va lo stesso principio e del quale, al pari di me, voi conoscete la sorte.
- Ebbene, in nome degli interessi superior i de l nostro paese, io vi prego di vo lere tradurre sollecitamente in atto i propositi dei quali avete daw notizia alla Camera . - Noi, è vero, siamo mossi da ragion i , da preoccupazioni di indo le soc ial e; ma fo r tunatament e, sul ter reno della riduzione della ferma, l'inte resse sociale e l ' interesse militare, invece di opporsi, concordano e si fortificano a vicenda. Quello che è per noi necessità socia le, è per voi necessità militare».
Nicola Badaloni ( 1854- 1945) deputato dal 1886 al 1890e dal 1892 al 1919, nel 1920 fu nominato se natore. Laureato in medicina e ch irurgia a Bologna, fu medico condotto a Trecenta (in provincia di Rovigo), aiuto d i materia medica all'Università di Padova, libero docente d i clinica medica a Perugia e di patologia specia le med ica a Napoli. Organizzò le leghe socia liste del Polesine. Appartenente al gruppo social ista di Bi sso l ati, uscì con lui dal partito nel 1912 .
5. Domenico Primerano nacque a Napoli il 29 marzo 1829. Studiò alla scuola militare della Nunziatella entrando poi nelle file dell'esercito borbonico come ufficiale di artiglier ia. Nel 1861 entrò
3 1 AA.PP. Leg. XXIII - Senato-Discussioni, Tornata del 26 giugno 1909, pp. 824-82
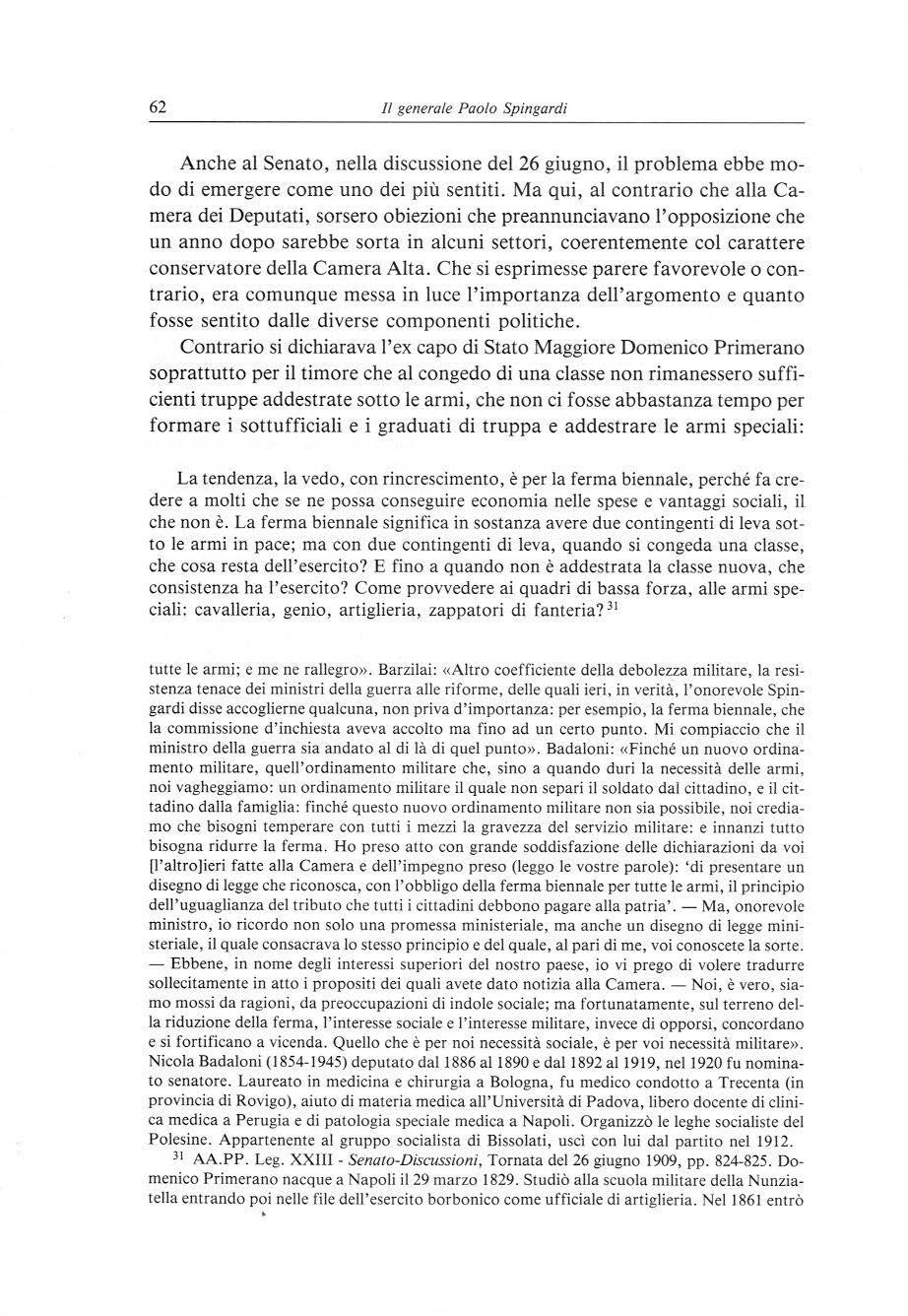
62
P er ovviare a questi rischi era necessario secondo lui che tutti rimanessero
vent isette o ventotto mesi sotto le armi [ . ] perché allora si potrebbe congeda re una classe quando la nuova leva ha ricevuto già una certa istruzione di t re o quattro mesi, e così al congedamento della c lasse anziana non avverrebbero crisi, e la forza media delle compagn ie r im arrebbe poco variata, senza pretendere di arr i vare ai centoquaranta uom in i per compagnia in tempo di pace, come si trovan o in altr i eser c it i (. ] l o in sisto su questo gravissimo argomento pe r ché, secon do me pre domina t utti g li altri, ed è la b ase fondamentale de ll a buona costituzione di ogni esercito 32
Eppure erano ben pochi i so ld at i che compivano tre iutieri anni di fe rma. Lo am mettev a lui stesso dic en do che col sistema vigente «og ni anno una parte del conti n gente è ascritto alla ferma di tre anni che finisce per ridursi a 30 mesi ed un'altra di due anni che si riduce a 18 m es i )) E ra la realtà delle co se da quasi venti anni e gli inconvenienti p a ventat i da P rimerano o non si era no ve ri ficati o nessuno se ne era mai lamentato. Il vecchio genera le era ev id entemente legat o a concezioni ormai superate circa l'addestramento d e l personale e non esisteva, alla lu ce dei fatti, un valido motivo tecnico per opporsi all'adozione della ferma biennale. La quale d'altronde non era poi così lontana da quei ve nti sette o vent otto mesi auspicati da Prim erano.

Il generale Tarditi era invece favorevole alla riduzione della ferma perché tale
è la vo lontà del paese, non è so ltanto il parere di pochi [. . . ] E il Governo non può rifiutarsi a questa vo lontà . - [ ] Del res t o creda, o n orevo le senatore Primerano, che nell'esercito è ugualmente sent ita la necessità di questa ri duzione , e d à appr ov ata . - Interpelli gli ufficiali infe ri or i , q ue lli che ed ucano direttamente il sold ato: e da tu tt i sent irà come si de bba ridu rre la ferma - L'onor. se na tore Primerano ha anche accen na to alla convenienza di tenere alle armi t re cont in genti . Ma come potrebbe farlo il ministro della guerra? È imp o ssi b ile Do vr e bb e forzatament e ricorrere a dei ri pieghi , perché il bil ancio non lo permette; opp ure d ovre bb e sacrificare altri
nell'esercito italiano co l grado di magg iore di Stato Maggio re. Partecipò alla campagna del 1866 e in quella del 1870 fu capo di Stato Maggiore del corpo d'occupazione di Roma e si guadagnò la c r oce di cavaliere dell'Ordine Mi litare di Savo ia Nel I871 fu nomina to co lonnello e comandò il 58 ° Reggimento fante r ia. Dal marzo 1876 al marzo 1878 ricoprì la carica di Segre tario Generale a l Ministero della Guerra. Dimessosi da ll a carica in segui to a!Ja cadu ta del Minist ro Mezzacapo , comandò la 29 • Bri gata di fan teria (era stato promo sso maggiore generale nel 1877). Promosso Tenente Generale nel 1884, coma ndò le Di vis io ni militari di Genova e Milano, d ivenendo nel 189 1 comandante del III Corpo d'Armata. Nel 1893 ven ne nom inalo capo di Stato Maggiore dell' Eserc ito, carica che r icoprì fino a l lug lio 1896, quando ven ne collocato in Posizione Ausiliaria dal Mini stro PeJJoux in seguito alla c ris i segu ita alla sconfitta di Adua (cfr. GoocH, Army, State and Society, cit., pp. 99-100) Deputato nella XIII legislatura ( I 876 -1 880), venne nominato senat ore nel 1894. Morì a Roma il 26 feb brai o 19 1 1. 32 AA. PP ., Leg. XXIII, Senato-Discussioni, torna ta del 26 giu gno 1909, p 825.
La questione della forza e fa ferma biennale 63
migUoramenti di grande vantaggio per l'esercito. - Di guisa che, vecchio di anni e di servizio, mi dichiaro partigiano della ferma ridotta, della ferma dei due anni 33 •
Si erano così delineati gli schieramenti dell'anno seguente: la quasi totalità della Camera favorevole al progetto, considerato ormai non più differibile; e una fetta consistente del Senato irriducibilmente avversa al progetto sostanzialmente per la temuta insufficienza dei due anni a formare i soldati delle armi a cavallo.
Incoraggiato comunque dal clima generale nettamente favorevole alla riforma, Spingardi presentava alla Camera il progetto di legge I' 11 febbraio 1910.
Oltre ovviamente a ridurre la ferma a due anni per tutte le armi, si cercava di limitare i temuti inconvenienti per le armi a cavano, che richiedevano un più lungo periodo di istruzione di base. Fino a quel momento i soldati di leva destinati alle armi a cavallo ven ivano estratti a sorte. Col pratico risultato che un buttero della Maremma poteva finire in fanteria e un gondoliere veneziano in cavalleria. Gli inconvenienti del metodo erano aggravati dal fatto che i soldati di cavalleria, essendo assoggettati a ferma più lunga, non avevano obbligo di richiami. Così che, anche ammettendo che nei tre anni passati sotto le armi il gondoliere avesse imparato a cavalcare, è lecito supporre che, in caso di guerra, trascorsi molti anni dal servizio militare senza aver più cavalcato, egli avesse completamente dimenticato ogni insegnamento. Spingardi, insieme all'adozione della ferma biennale, secondo una concezione mo lto moderna volle si indirizzassero alle armi i coscritti secondo le loro particolari attitudini, cioè arruolando nelle armi a cavallo chi, per particolari mansioni della vita civile, fosse ragionevolmente già abituato al contatto coi cavalli ovvero chi per part icolare costituzione fisica potesse essere ragionevolmente ritenuto più adatto al servizio in cavalleria.
C he un periodo di istruzione di circa due anni s ia s uffi ciente a formare il so lda to nelle armi a piedi - egli diceva nella relazione che precedeva il disegno di leggenessuno ormai mette più in dubbio, così come per la altrui come per la esperienza nostra. [...] Ma è pure opinione dei tecnici - alla quale io accedo - per quanto da taluni controversa, che una is t ruzione di due anni sia sufficiente anche per le armi a cavallo ove a tali armi vengano assegnati individui veramente adatti e per la costituzi on e fisica e per la professione esercitata. Se non che una tale assegnazione pre-
33 AA.PP. Leg. XXIII, Senato -Discussioni, pp. 827-828. Cesare Tarditi (1842-1913), sottotenente di fanteria nel 1861, partecipò alle campagne del 1866 e del 1870. Colonnello nel 1888, comandò il 10° Reggimen to bersaglieri. Nel 1891 combatté in Eritrea. Nominato Maggior Generale nel 1896, fu sottosegr eta rio aUa Guerra dal giugno 1898 al gennaio 1900. T enente Generale nel 1903 , comandò la Divisione mili tare di Ravenna e poi quella di Napo li fino al I 907 , allorché fu collocato in Posizione Ausiliaria a vendo raggiunto i limiti di età prescritti per i Tenenti Generali . Venne nominato senatore nel 1909.
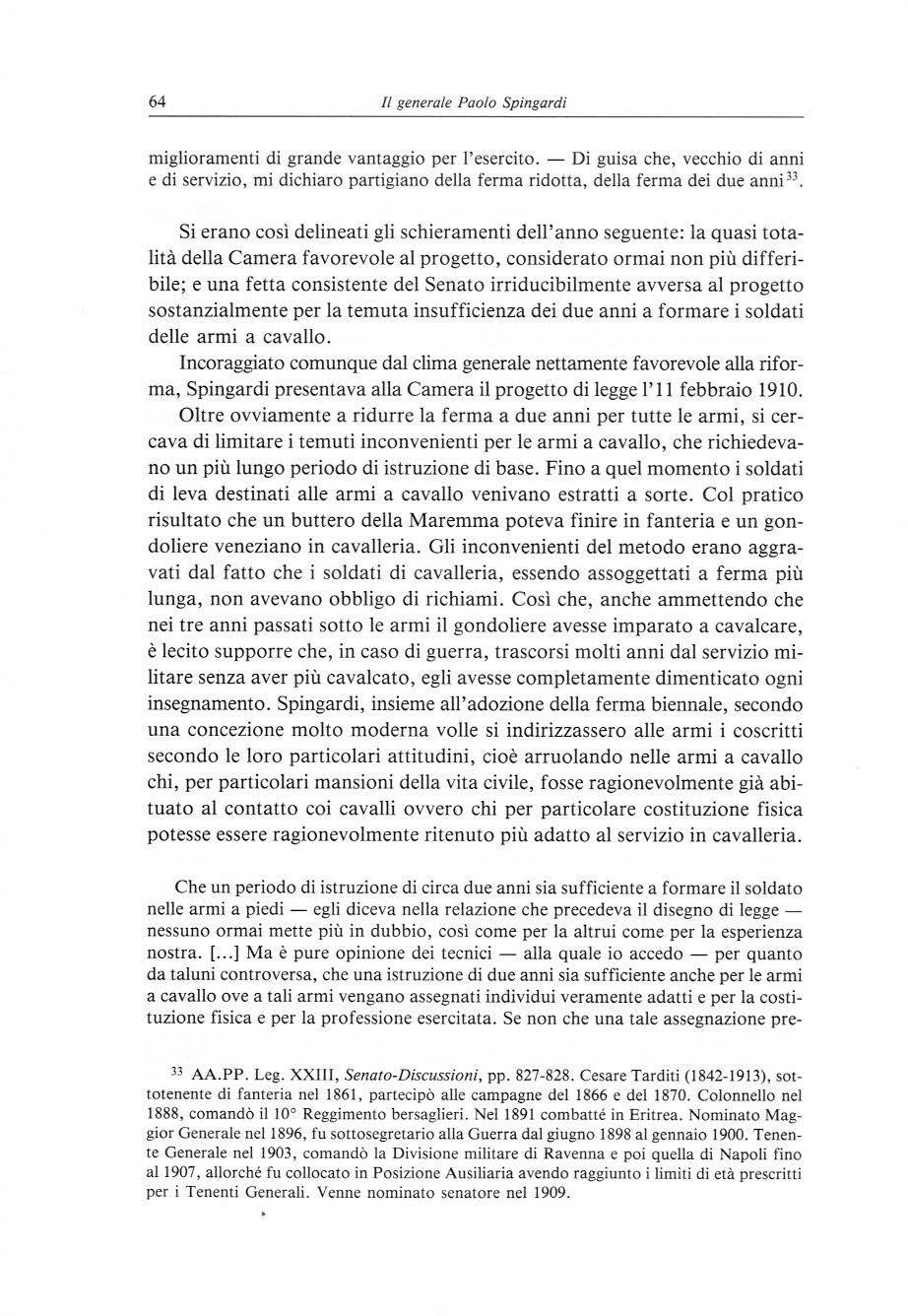
64
li generale Paolo Spingardi
La questione della forza e la ferma biennale 65
suppone di poter fare la scelta delle reclute liberamente, su tutto il contingente, prescindendo affatto dal criterio cieco del numero avuto in sorte: e l'abbandono definitivo di questo criterio, a sua volta, è possibile solo se l'obbligo di servizio alle armi sia effettivamente uguale per rutti. - Ne deriva che le preoccupazioni per le armi a cavallo cui potrebbe dar luogo, per l'abbreviamento della istruz ione, l'adozione della ferma biennale, sono dissipate in virtù della parificazione per tutti dell'obbligo del servizio alle armi 34 •
La Commissione parlamentare incaricata dell'esame del disegno di legge appoggiò pienamente il Ministro:
Uguagliata la durata del servizio colla ferma biennale, e venuto meno l'obbligo di mandare in cavalleria i coscritti che avessero estratto i numeri più alti (era del resto questa una ingiustificata rinunzia che lo stato compiva a danno della razionale assegnazione dei soldati alle varie armi in ragione delle loro attitudini fisiche) è certo che si avrà il vantaggio di una migliore scelta di uomini per la cavalleria 35 •
La ferma per la cavalleria fu argomento ampiamente dibattuto alla Camera 1'8, 9 e IO giugno 1910, ma i discorsi al riguardo sfociavano tutti nel mero tecnic ismo 36 D'altronde solo elementi molto specifici potevano essere portati a sostegno della tesi che due anni fossero o non fossero sufficienti a formare un soldato di cavalleria . Il tempo si sarebbe incaricato di dimostrare non solo, o non tanto, che due anni erano sufficienti, ma che la stessa arma di cavalleria era ormai superata di fronte ai mezz i della guerra moderna 37 •
34 AA PP., Leg. XXIII, Camera documenti, n. 337, p I.
35 Ibidem, n. 337-A, p 5. Facevano parte della commissione eletta dagli Uffici della Camera, o ltre ai militari Pistoja, presidente della commissione stessa, Pais-Serra, e Di Saluzzo, relatore, e il giolittiano Augusto Battaglieri (1854-1929), che era comunque anche lui capitano della riserva: Gregorio Gallo (1878-?), segretario della commissione, deputato di sinistra ma senza più precisa collocazione politica: il marchese Luigi Borsarelli di Rifreddi (1856-1936), fedele giolittiano che avrebbe retto la carica di sottosegretario agli Esteri dal marzo 1914 al giugno 1919; Raffaele Conflenti ( I 859-19 I 4), personaggio di scarso spicco del gruppo di Sonnino; il radicale Mario Abbiate (1872-?), che nel 1920 sarebbe divenuto Ministro dell'Industria e Commercio e po i del Lavoro nel Governo Nitti: Eugenio Bergamasco (1858-?), giolittiano, cessò di far parte della commissione allorché venne nominato sottosegretario per la Marina nel marzo 1910. Interessante notare come, eletta durante il governo Sonnino, la commissione comprendesse un solo membro appartenente allo stesso gruppo politico del Presidente del Consiglio.
36 Cfr. per tutti, i discorsi degli onorevoli Negri De Salvi 1'8 giugno e Padulli il 9 giugno, contrari alla ferma biennale per la cavalleria, e Di Saluzzo il 9 giugno, che invece difendeva il disegno di legge, in AA.PP., Leg. XXIII, Camera -Discussioni, pp 8118 -8125, 8177 -8180, 8182-8185. Giulio Padulli (1869-1933), deputato per cinque legislature (1909 - 1929), poi senatore, come ufficiale di cavalleria combatté in Africa nel 1895-96, ma lasciò il servizio attivo prima di ascendere agli alti gradi. Alla Camera prese posto a destra. Costituitosi il Partito Popolare Italiano, vi aderì e a tale gruppo Parlamentare si iscrisse, ma ne fu espulso nel l 923 per il suo atteggiamento favorevole al Partito fascista.
37 Cfr. M. HowARD, La guerra e le armi nella storia d'Europa, Laterza, Bari 1978, p. 206: «[I cavalieri) si cullavano nella speranza che la maggior potenza di fuoco dell'artiglieria d'appoggio
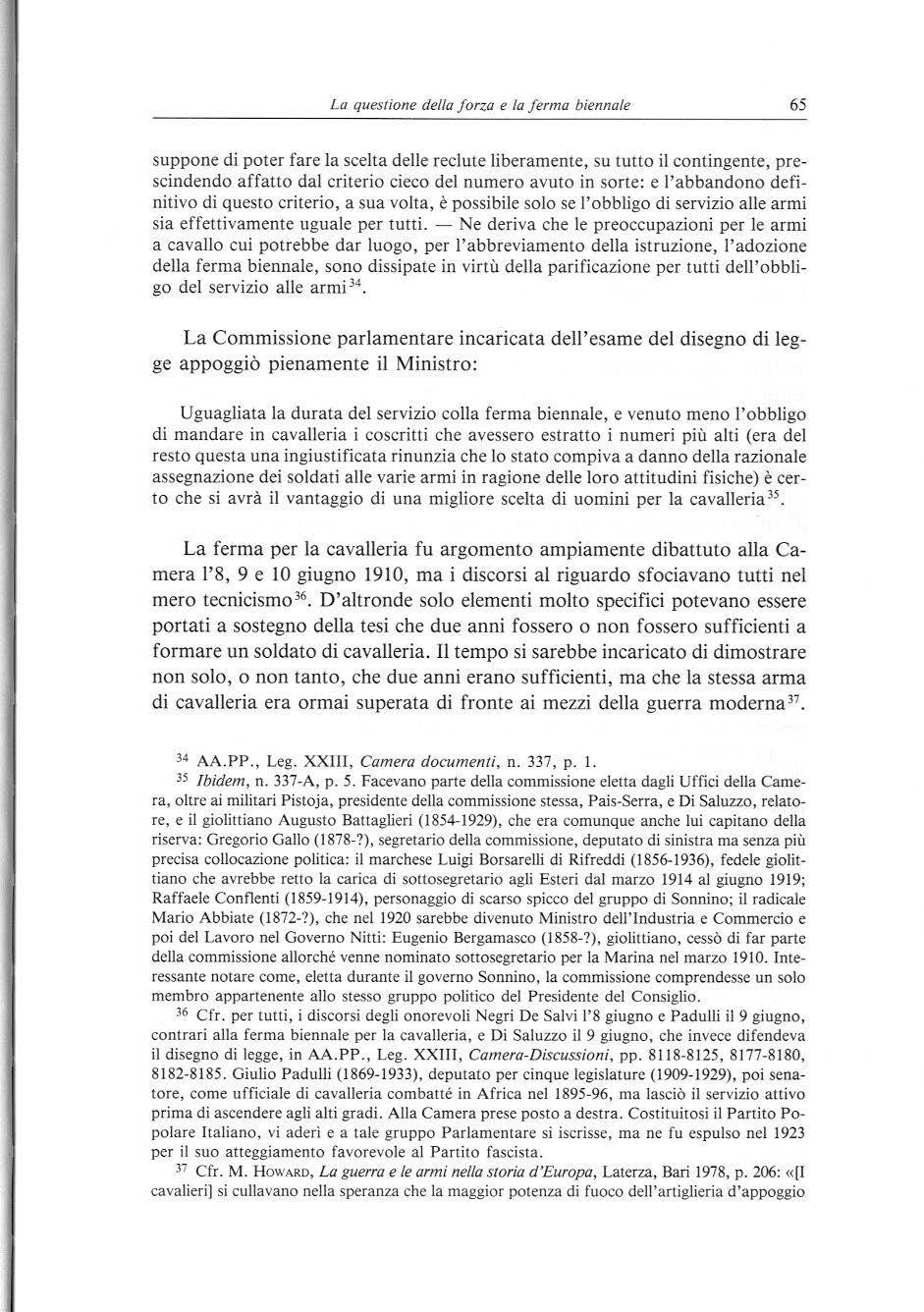 Il generale Paolo Spi'!gardi
Il generale Paolo Spi'!gardi
Dalla relazion e della commissione emergevano però due altre questioni di ben maggiore rilevanza: il volontariato di un anno e l'uso delle truppe in se rvizio di pubblica sicurezza.
Un anacronismo: il vo lontariato di un anno
Si trattava di un istituto creato dal Ministro Ricotti nel 1871 mutuandolo dall'esempio prussiano. Versando una cifra, che durante il Ministero Spingardi era di 1500 lire per la fanteria e 2.000 per la cavalleria, senza alcun altro titolo, il volontario otteneva la facoltà di rinviare il servizio militare fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, e poi di ridurlo a un solo anno prestato in un reggimento di sua scelta e concluso con un esame che consentiva la nomina a sottotenente o sergente in congedo . Il vo lontariato di un anno avrebbe dovuto fornire, senza spesa per l'erario (anzi con un introito di diver si milioni), i quadri di complemento necessari all'atto della mobilitazione. Questa almeno era la funzione di istituzion i simi lari in Germania e in Austria-Ungheria. Ma mentre l'esercito tedesco e quello austriaco ne trassero migliaia di preparati ufficiali di complemento, in Italia divenne un puro privilegio del censo che permetteva ai figli di fam iglie abbienti di prestare un servizio militare alquanto più lieve. Inoltre non esisteva nessun obbligo di ottenere l'idoneità come ufficiale o sottuffic iale, tanto che moltissimi volontari si congedavano co l grado di caporal e 38 • La commissione relatrice sul disegno di legge per la ferma biennale dedicava un intero paragrafo all'argomento, affermando esplicitamente la propria contrarietà all'ist ituto, considerato un privilegio intollerabile:
avrebbe saputo neutralizzare la accresciuta efficacia del fuoco d i fanter ia Pensavano che i progressi dell'allevamento equino avrebbero fornito rimonte capac i di superare senza stroncarsi le aumentate d istanze d i carica Quindi nel 19 14 tutti gli eserciti europe i entra rono in campagna con grossi corpi di cavalleria armati di lancia e di sci a bola, addestrati a caricare sul campo di battaglia e a sfruttare uno sfondamento. Nei grandi spazi dell ' Europa orientale, dove i fronti rimasero discontinui, la ca valleria fu imp iegata efficacemente ma sui fronti dell'Europa occidentale bastarono poche set timan e per ch iarire a tutti che la cavalleria era diventata un costoso anacronismo. Persino nei compiti di esploraz ione era destinata ad essere sostituita da unità di motociclisti o blind ate)>.
38 Cfr R ocHAT-M ASSO BRJO, p. 88. «Il gio va ne doveva arruolarsi come volontario a diciassette anni , prim a cioè dell'assegnazione per sorteggio alla prima o alla seconda ca tegor ia (questo era l'uruco svantaggio impostogli, perché la seconda categoria comportava di fatto l'esonero), po i poteva rinviare il servizio militare fino al ventiseiesimo anno d ietro esborso di una tassa, che g li dava anche il diritto di far passare nella terza categoria (esonero totale) un suo fratello (una specie di faci litazione per le famiglie numerose, purché abbienti) A titolo di paragone, la retribuzione [annua) di un funzionario statale della carriera direttiva era in iz ia lmente di 1800 lire , quella di un usciere di 1000 lire, quella d i un direttore generale di 8000 lire» (ibidem, nota 9 a p. 102).
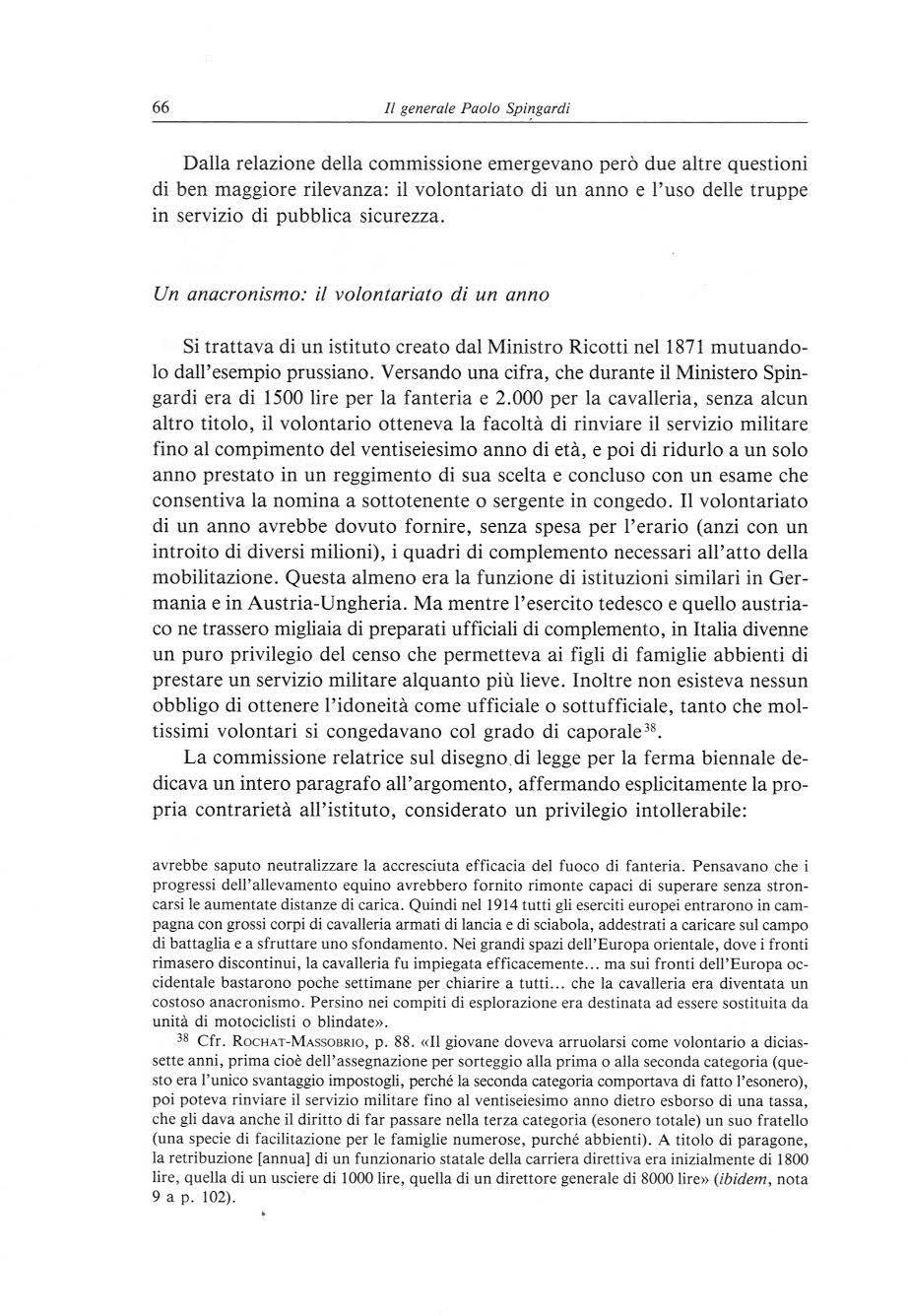
66
È questo un istituto, del quale la vostra commissione concordemente pensa che sia un vero anacronismo e costituisca un vantaggio a pagamento non comportabile, in nessun modo, dai moderni tempi e dalla moderna concezione degli obblighi del cittadino di fro n te al servizio m ilit are. - L'Italia è la so la nazione, o r mai, che si ostini a conserva r e que sto non commendevole privi legio de l censo, la cui conservazion e ancor meno si comprende in un paese come il nostro, dove le istituzioni hanno una base più sch ie ttamente democratica , che non presso altri stat i, in cui il volonta r iato di un anno è fondato su criteri ben più democ ratici. - Non si può paragona r e, infa tti, al volontariato italiano di un anno né quello austriaco né quello germanico : entramb i si informano ad un concetto p iù elevato e non mercantile .Più elevato, perché richiedono maggiori t itoli di stu dio e importano l'o b bligo di fare l'ufficiale di complemento e di compiere in t ale qualità determinate prove di servizio: non mercantile, perché altro è far pagare una somma raggu ardevole per l 'abbreviazione del servizio come si pratica da noi, altro è, come in Aust ria e in Germania, richiedere che il vo lontario si mantenga a sue spese e tutt'a l più per la cavalleria pagh i l 'uso del cavallo. - Si not i poi che in entrambe qu este nazioni vige il prov vedimento di accor d are il volon t ar iato di un anno gratuito a q u eg li inscritti meno abbient i , che presentino ott i m i t ito li di stu d io . - Che presso di noi all'ostinazione ne l conservare questo istitu to non corrispo nd a un'egualmente profonda convinzione della sua legittimità, può servire di prova il fatto che già s i è pensato ad abolirlo (progetto Mai noni) o a modificarlo (progetto Viganò) . Nel progetto Viganò il vo lontariato di un anno era bensì parzialmente ed irrazionalmente conserva t o, in modo che ad esso potessero accede re determinate categorie di iscritti agiati non muniti di titoli di studio: ma quasi paralle lamente a q u esto conservato privilegio del censo ne era istituito uno per l'istruzione, concedendosi che g li in scritti istruiti po tessero rapidamente acquistare i galloni da sergente e pur rapidamente passare da questi a ll e sp alline di sottote nen te semp re comp ie ndo i l servizio di leva S i aveva, per tal modo, anche il vantaggio di ass icurare all' esercito u n la rgo recl u tamento di ufficiali di comp le mento. - Il mantenimen to dunque di tale anacron istico istituto ( ] non può essere sp iegato che da ragioni finanziarie, e c ioè dalla considerazione de l reddito che per esso deriva allo Stato. - Ma non sarebbe, anzitu tto, suffic iente d i fesa quella de l redd i to né pare alla vostra Comm iss ione che su esso si possa pi ù fare un grande affidamento Che se il volontariato d 'un anno poteva allettare, in tempo di ferma triennale , i coscritti ag iati, sfuggenti così al lungo gravame del se rvizio militare, mino r e sarà la sua forza di adescamento col regime della ferma biennale 39 .
P erciò la commiss ione proponeva un o rdin e del giorn o nel quale invitava il Ministro a modificare l'istituto sostituendo a l pagamento il titolo di st udio quale criterio di ammiss ione a l volontariato, e istituendo l'ob bligo di prestare servizio quale ufficiale di comp lemento . Se poi il governo non avesse vo lu to rinunciare a un in troito utile, la commissione avanzava la proposta di istituire «la tassa militare , che sarebbe una tassa sul ce nso e sarebbe pagata, oltre i lim iti d'un certo reddito , dai figli unici assegnati alla terza categoria», raccomandandone lo stud io «allo zelo illuminato dell'onorevole ministro» 40 •
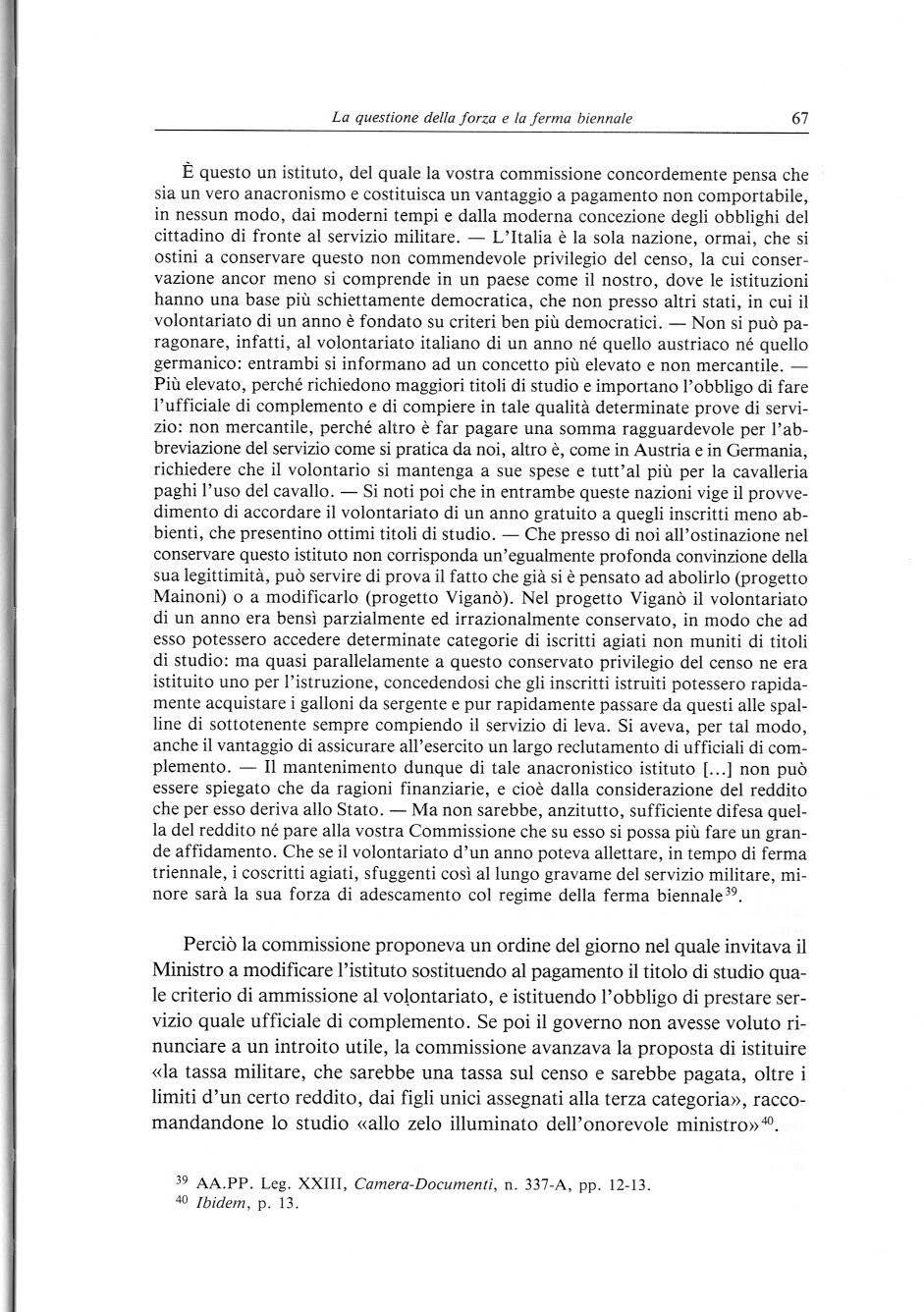
La questione della forza e la ferma biennale 67
39 AA.PP. Leg. XXIII, Camera-Documenti, n. 337- A, pp 12- 13. 40 Ibidem , p 13
Se attuata, la tassa militare sarebbe stata la prima imposta di tipo progressivo nella storia d'Italia. Non stupisce che la proposta sia caduta nel vuoto : la stessa classe sociale che tanto deprecava il vo lontariato di un anno poco gradiva una maggiore imposizione fiscale 4 1 •
Com unqu e, dal punto di vista strettamente militare, fin dal 1882 esistevano a ppositi corsi per ufficiali di complemento, e perciò l'unica eventuale utilità d el volontariato di un anno non sussisteva più. Anche agli occhi dei militari insomma il tanto deprecato istituto non aveva molto significato. Inoltre l'introito derivante dal vo lontariato andava neIJe casse del Tesoro e quindi non era nemmeno di immediato vantaggio per l'amministrazione della guerra .
Tanto da destra quan to da sinistra si invocò l'aboli zi one, o perlomeno che, «s e il privilegio ha da essere, sia per gli studiosi, e non per il censo e si conceda il volontariato non a i ricchi ignoranti, ma a quelli che avessero raggiunto un titolo re lativamente elevato di studi» 42
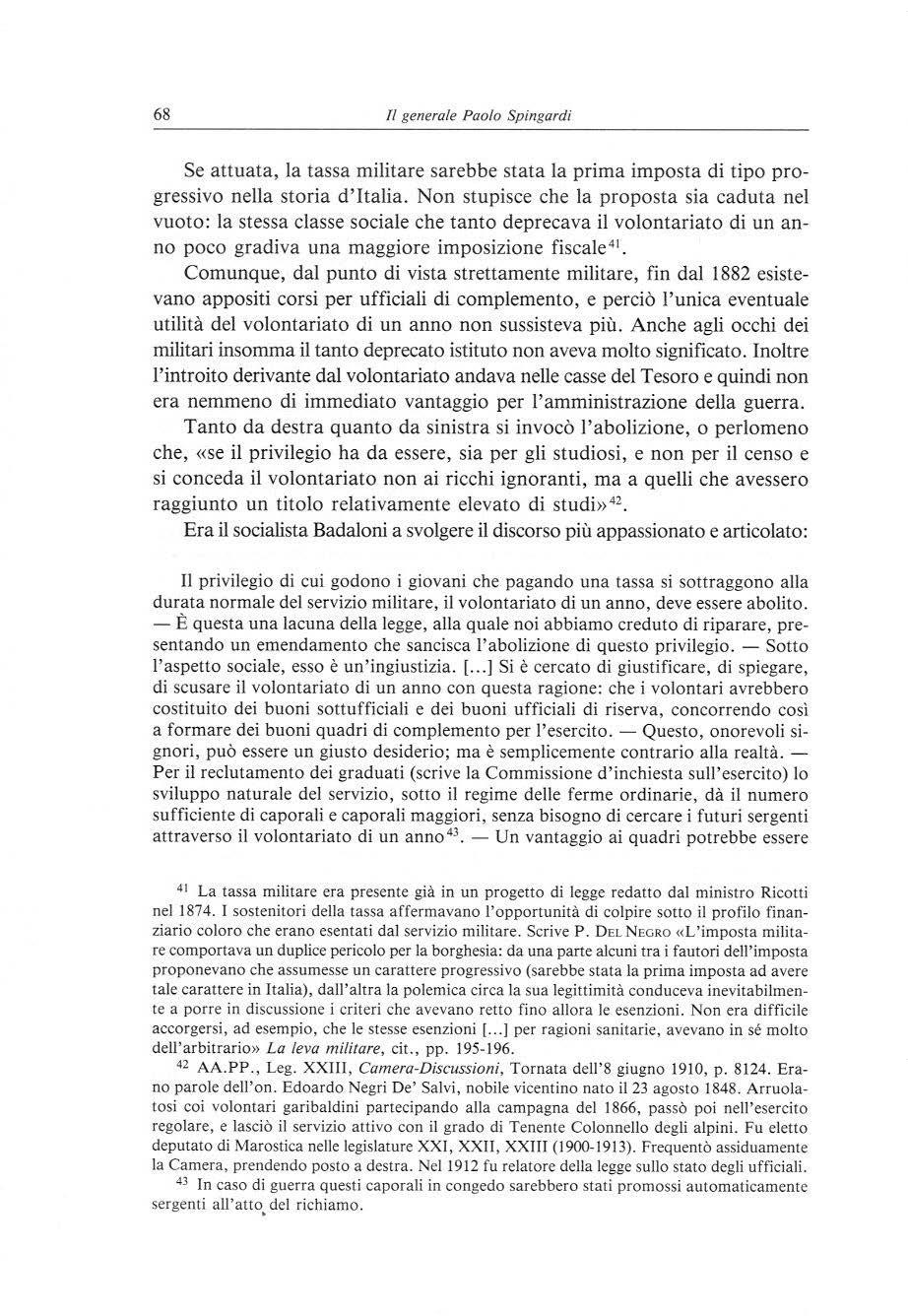
Era il socialista Badaloni a svolgere il discorso più appass ionato e articolato :
Il privilegio di cui godono i giovani che pagando una tassa si sottragg ono alla durata normale del se rviz io militare, il volontariato di un anno, deve essere abo ljto. -È questa una lacuna della legge, alla quale noi abbiamo c reduto di riparare, presen ta ndo u n emendamento che sanc isca l 'abolizio ne di questo privile gio. - Sot t o l 'aspetto socia le, esso è un' i ngiustizia . [. .. ] Si è cercato di giustificare, di spiegare, di sc usare il volontariato di un anno con que sta rag io ne : che i volon ta ri avrebbero cost ituito de i buon i sott u fficiali e dei buoni ufficiali di riserva, concorrendo così a formare dei buoni quadri di comp le mento per l'esercito - Questo, onore vo li signo ri, può essere un giusto desiderio; ma è se mp li cemente contrario alla realtà.P er il reclutamento dei grad uati (scr ive la Commissi one d'inchiesta sull 'es erci to) lo svil up po nat ura le del se r vizio, so tto il regime delle fe rme or di narie, dà il numero sufficiente di capo r a li e caporali mag gio ri , senza bisogno di cercare i futuri sergenti attraverso il volontar iato di u n an no 43 - Un vantaggio ai quadri potrebbe essere
41 La tassa mi l itare e ra presente già in un progetto di legge redatto dal mini st r o Ri cotti nel 1874. I sosteni t ori della tassa affe r mavano l'opportun ità di col pi re sotto i l profilo finanziario coloro che erano esentati dal servizio militare Scrive P. D EL N EG RO «L'impost a mi litare comportava un duplice perico lo per la borghesia: d a una parte alcuni t ra i fautori d ell 'imposta proponevano che assumesse un carattere progress ivo (sar eb be stata la pr ima i mposta ad avere tal e carattere in Italia), dall'altra la polemica c irca l a s ua legittimità cond uce va i nevitab ihn ente a porre in di sc ussione i cri teri che avevano re t to fino allora le esenzioni. Non era difficile accorgersi, ad esempio, che le s tesse esenzioni [ ) per ragioni sanitarie, avevano in sé mo l to dell'arbi t rar io» La leva militare, cit., pp. 195-196
42 AA.PP., Leg. XXIII , Camera-Discussioni, Tornata dell'8 giugno 19 10 , p. 8124 Erano parole dell'on Edoar do Negri De' Salvi, nobi le vicentino nato i l 23 agosto 1848. Arruolatos i co i volontari garibaldini partecipando alla campagna del 1866, pass ò po i ne ll 'ese rcito regolare, e lasciò il servizio attivo con i l grado di Tenente Colonnello degli alpini. Fu e letto deputa to d i Marostica nelle legis latu re XXI , XXII , XXIII ( 1900-1913). Freque nt ò assiduamente la Camera, prendendo posto a dest ra. Ne l 1912 fu re latore della legge sull o stato degli ufficiali
43 In caso di guerra questi caporali in congedo sarebbero s ta ti promossi automaticamente sergenti all'atto, del r ich iamo
68
li generale Pa olo Spingardi
dato dai vo lo ntari di un anno, se essi fossero in grado di prestare servizio come ufficiali di com ple mento. - Ora [ ] dal 1898 al 1908, su 19.304 volontari d'un anno, sa la Camera quanti raggiunsero la nomina a sottotenenti di complemento? Seicentoventidue. - Non basta: s u 16.558 volontari di un anno, sa la Camera che ve n e furono 7.436 che non risultarono idonei che per il grado di caporale? [... ] Qual'è quella recluta che, avendo com piuto il corso dell'istruzion e ele mentare, non sia in grado di conquistare in un anno la nomina a caporale? -E solo perché codesta recluta ha potuto pagare una tassa, deve avere il diritto di a ssolve re iJ suo se rvi zio verso la patria in dodici mesi, a differenza degli altri cittadini? - Ma , allora, qual'è la ragione che può essere invocata per mantenere questa istituzione nel nostro ordinamento militare? [ . . . ] La ragione fondamentale, la ragione che non si dic e [ ... ] è il privilegio della classe agiata, che sotto la speciosità di ragioni che non hanno consistenza, si vu ol mantenere, e contro il quale noi sorgiamo, li eti di vede re in questo movimento l'opera nostra assecondata da colleghi che siedono in altri set tori della camera 4 4 •
Un emendamento nel se nso indicato da Badaloni era proposto anche da un gruppo di otto deputati di orientamenti ideologici alquanto diversi dal socialismo 45 •
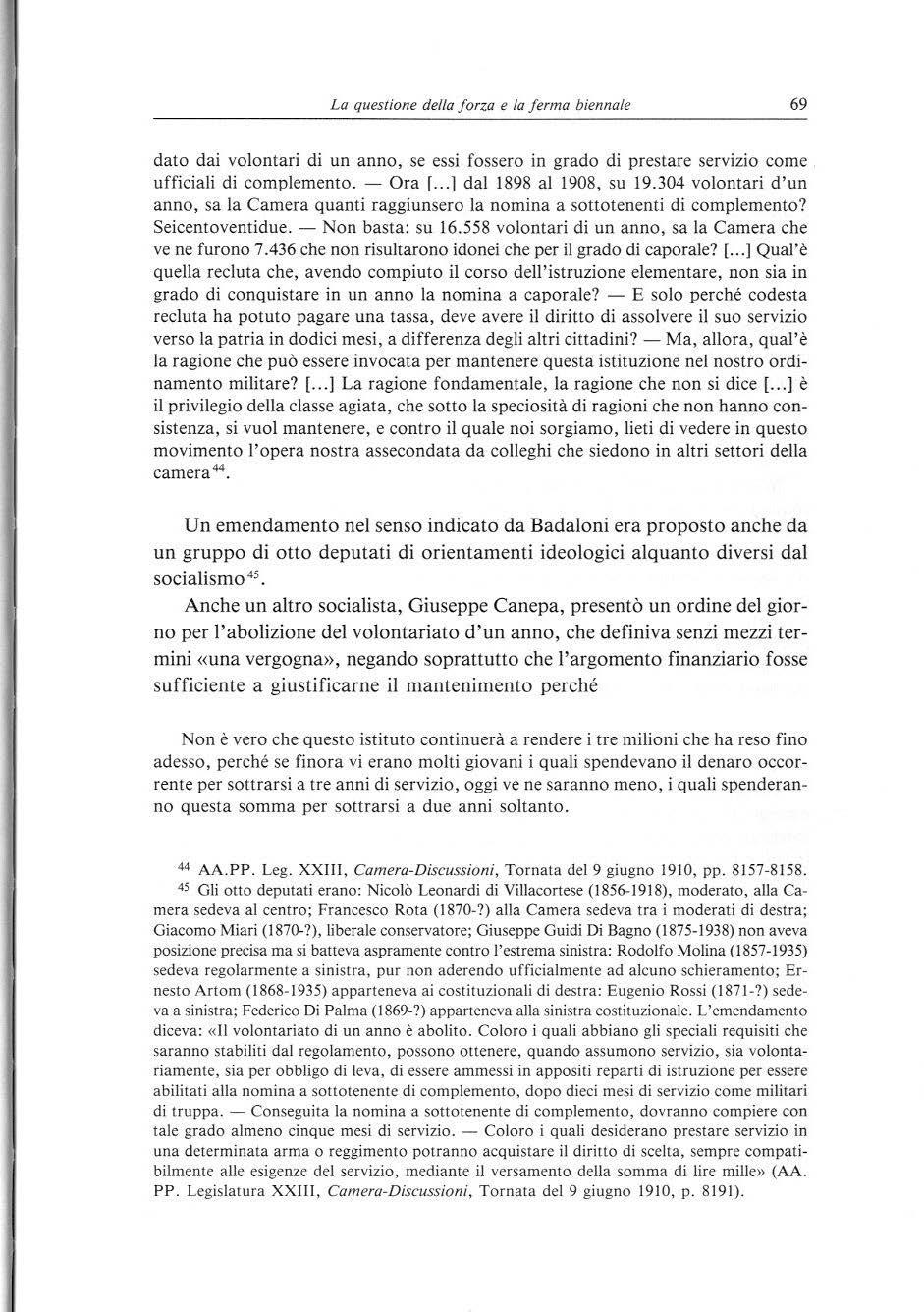
Anche un altro socialista, Giuseppe Can epa, presentò un ordine del giorno per l'abol izione del volontariato d'un anno, che definiva senzi me zzi termini «una vergogna», negando soprattutto che l'argomento finanziario fosse suffic iente a giustificarne il mantenimento perché
Non è vero che questo ist ituto continuerà a rendere i tre milioni che ha reso fino adesso, perché se finora vi erano molti giov ani i quali spendevano il denaro occorrente per sottrarsi a tre anni di serv i zio , oggi ve ne saranno meno, i quali spen deranno questa somma per sott ra rs i a due anni soltanto .
44 AA.PP. Leg. XXIII, Camera-Discussi oni, Tornata del 9 gi ugno 19 10, pp 8 157 -8 158
45 G li otto deputati erano: Nicolò Leonardi di Villacortese (1856-1918), moderato, alla Camera sedeva al centro; Francesco Ro ta (1870-?) all a C a mera sedeva tra i moderati di destra; Giacomo Miari (]870- ?), liber ale conservatore; Giuseppe Guidi Di Bagno (1875- 1938) non aveva posizione p recisa ma si batteva aspramente con t ro l'es t rema sinistra: Rodolfo Molina ( 18 57-1 93 5) sedeva regolarmente a s ini stra, pur non aderendo ufficialmente ad alcuno schieramento; Ernesto Artom (1868 - 1935) apparteneva ai costituzionali di destra: Eugenio Rossi (I 871 - ?) sedeva a si ni stra; Federico Di Palma (1869- ?) apparteneva alla sinistra costituzionale. L'emendamento diceva: «Il vo lont a r iato di un anno è abolito. Coloro i quali abbiano gli special i requisiti che saranno stabi lit i dal rego lamento, possono ottene re, quando assumono servizio, sia vo lont ariamente, sia per obbligo di leva, di essere ammessi in appositi reparti di istruzione per essere abi l itati alla nomina a sottotenente di complemento, dopo dieci mes i di servizi o come militari d i truppa . - Consegu i ta la nom ina a sottotenente d i complemento, dovranno compiere con tale grado almeno cinque mesi di se r vizio. - Co loro i qual i desiderano prestare se r vizio in una determinata arma o reggimento potranno acquistare il diritto di sce lta, sempre compat ibilmente alle esigenze del servizio, med iant e i l versamento della somma di lire mille» (AA. PP. Legislatura XXIII, Camera-Discussioni, Tornata del 9 g iugno 1910, p 8191)
La questione della fo rza e la ferma biennale 69
Il generale Paolo Spingardi
L'osservazione era giustificata; ma soprattutt o, sec ondo Canepa, quando spendiamo per l'esercito circa trecento milioni, quando la spesa che facciamo per l'armata di terra e di mare ammonta quasi a mezzo miliardo, allora è evidente che una questione di due o tre milioni non può portarsi di fronte ad una questione di alta moralità come quella del volontariato 46
Spingardi espose il suo pensiero con la consueta sempl icit à, franchezza e soprattutto efficacia, ottenendo l'effetto di far ritirare tutti gli emen damenti e ordini del giorno sul volontariato 47 , che rischiavano altrimenti di ritardare l'iter della legge sulla ferma biennale, principale obiettivo in quel momento:
Io non posso a meno di dichiarare, tecnicamente, militarmente parlando che il volontariato di un anno oggi è un anacroni smo Non ha assolutamente più ragione d i essere (Vive approvazioni) . li volontariato di un an no, creato quarant'anni addietro, al tempo del trapasso dalla legge di reclutamento antica alla nuova legge, che toglieva l'affrancazione per danaro, costituiva un ponte di passaggio alle idee nuove, quasi come un compenso per renderne meno brusca l'applicazio ne. - D'altra parte, il vo lontariato di un anno doveva anche provvedere alla formazione di un discreto contingente di ufficiali di complemento. - Le cifre che vi ha letto l'onorevole Badaloni vi avranno convinto come q uesto seco ndo scopo s ia stato solo parzialmente ottenuto. Parrebbe quindi giunto il momento di abolire questa istituzione.
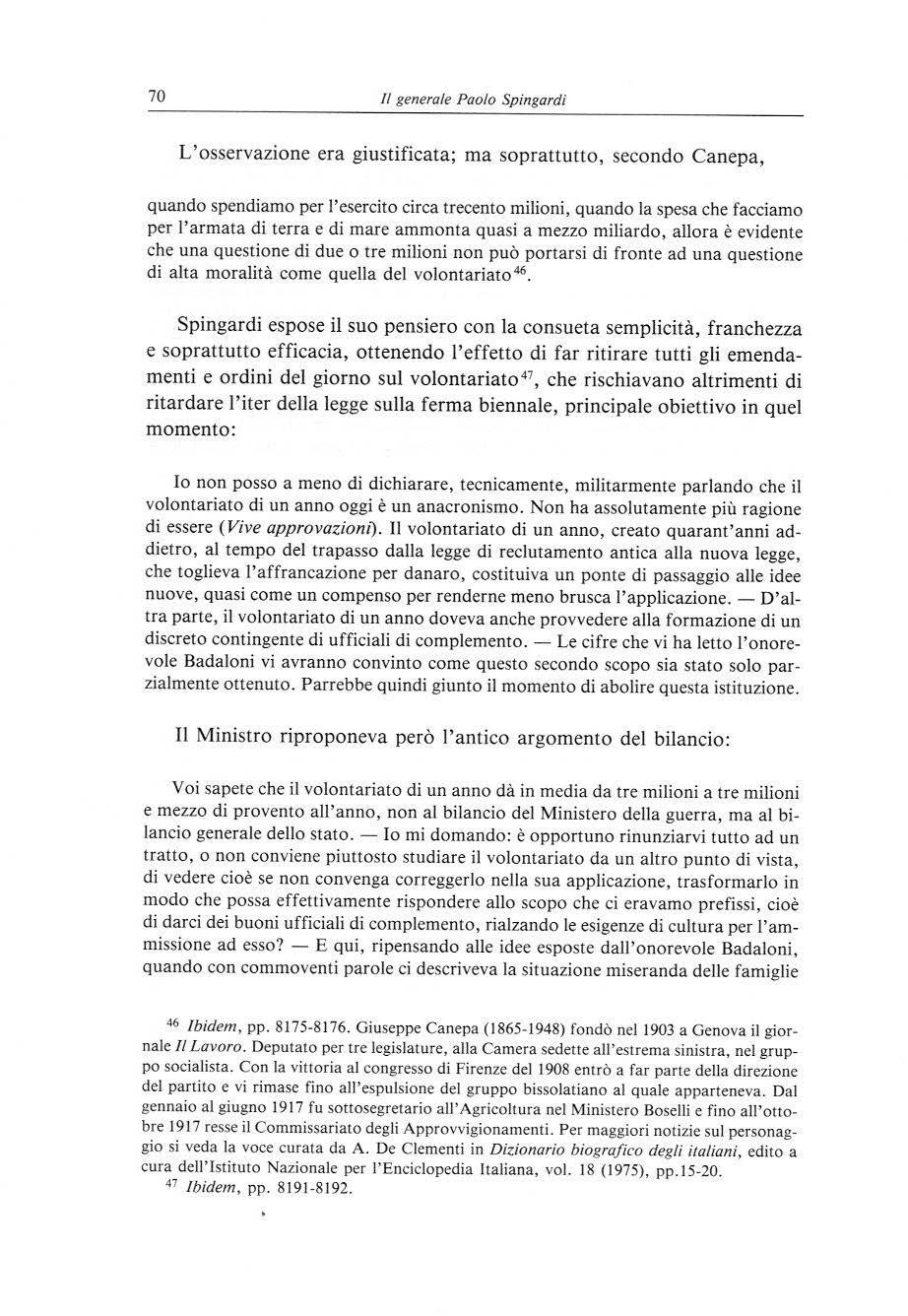
Il Minist r o riproponeva però l'antico argomento del bilancio:
Voi s apete che il volontariato di un anno dà in media da tre milioni a tre mi lioni e mezzo di provento all'anno, non a l bilancio del Ministero della guerra, ma al bilancio generale dello stato. - Io mi domando: è opport uno rinun ziarvi tutto ad un tratto, o non conviene piuttosto studiare il volontariato da un altro punto di vista, di vedere cioè se non convenga correggerlo nella sua applicazione, trasformarlo in modo che possa effett ivamente rispondere a ll o scopo che ci eravamo prefissi, cioè di darci dei buoni ufficiali di complemento, ri alzando le esigenze di cu ltura per l'ammission e ad esso? -E qui, ripensando alle idee esposte dall'onorevole Badaloni, quando con commoventi parole ci desc riveva la s ituazione miseranda delle famiglie
46 Ibidem, pp. 8175-8 176 Giuseppe Canepa (1865 - 1948) fondò nel 1903 a Genova il giornale Il Lavoro. Deputato per tre legis lature, alla Camera sedette all'estrema sinistra, nel gruppo soc ialista. Con la vittoria al congresso di Firenze del J 908 entrò a far pane della direzione del partito e vi rimase fino al l'espulsione del gruppo bissolatiano al quale appa rteneva. Dal genna io al giugno 1917 fu sottosegretar io all'Agricoltura nel Ministero Boselli e fino all'ottobre 1917 resse il Commissariato degli Approvvigionamenti. Per maggiori notizie su l personaggio si ve d a la voce curata da A. De Clement i in Dizionario biografico degli italiani, ed ito a cura dell'Istituto Nazionale per l'Enciclopedia Italiana, voi. 18 (1975), pp.15-20.
41 Ibidem, pp 8191-8192.
70
dei militari richiamati alle armi 4 8 , che solo scarsamente ci è consentito s us sidia re , io mi domando se non sia il caso di vedere se questo provento non possa essere devoluto a que sto generoso scopo, e allora l'isti tuzion e del volontaria to di un anno, a prescindere da ogni ragio ne tecnica militare, potrebbe avere una giustificazione sociale. - lo prego per conseguenza l'onorevole Badaloni dì non vole re ora insistere sulla questione dell'abolizione del volontariato di un anno. Lo dichiaro , entro nel suo ordine d'idee ed assumo l 'impegno dì studiare se non si possa indirizzare il volontariato a que st 'a ltro scopo, a cui ho accennato un momento fa 49
Voci favorevoli all'abolizione si levarono anche al Senato . Anzi gli oratori contrari alla ferma biennale furono i più ferventi sostenitori dell'abolizione del volontariato di un anno.
11 generale Bava-Beccaris, pur affermando di ritenere la legge « imperfetta inquantoché non dà affidamento che si assicuri la permanenza nelle file dell'esercito di un sufficie nte nucleo di graduati molti per numero e buoni per qualità», si dichiarava favorevole all'aboli z ione del volontariato, anche se in chiave polemica. Infatti egli non gradiva che si motivasse la necessità della legge sulla ferma biennale con «il rispetto che si deve avere al principio di giustizia, affinché tutti i soldati abbiano gli stessi obblighi di servizio» e se la legge sulla ferma biennale doveva proprio essere motivata da motivi di giustizia sociale, egli allora esortava: «abo li te il volontariato di un anno perché altrimenti non fate una legge veramente democratica» 50 • Gli si associava il generale Lamberti :
Come ben dis se il collega Bava-Beccaris, per pura ragione di bilancio ci ostiniamo a tenere in vit a il volontariato di un anno, vero privilegio aristocratico, tanto meno comprensibile in un momento in cui da ogni parte si afferma dì volere tutto democratizzare. Vero è che il numero dei concorrenti al vo lontariato, una volt a approvata la ferma biennale, andrà sensibilmente restringendosi a quei pochissimi che non troveranno sprecato il denaro occorrente pur di procurarsi un'altra piccola diminuzione negli obblighi militari. Ma avremo così ancor più accentuato il deplorevole privilegio, in quanto che al vo lon tariato di un anno non accorreranno più che i grandi favoriti dalla fortuna, portati per natura a t ut to mettere in opera per ostentare le loro ricchezze, e per profittarne senza scrupolo, pur di sottrarsi al più piccolo materiale disagio 51 •
48 V. Ibidem, pp. 8151-8152.
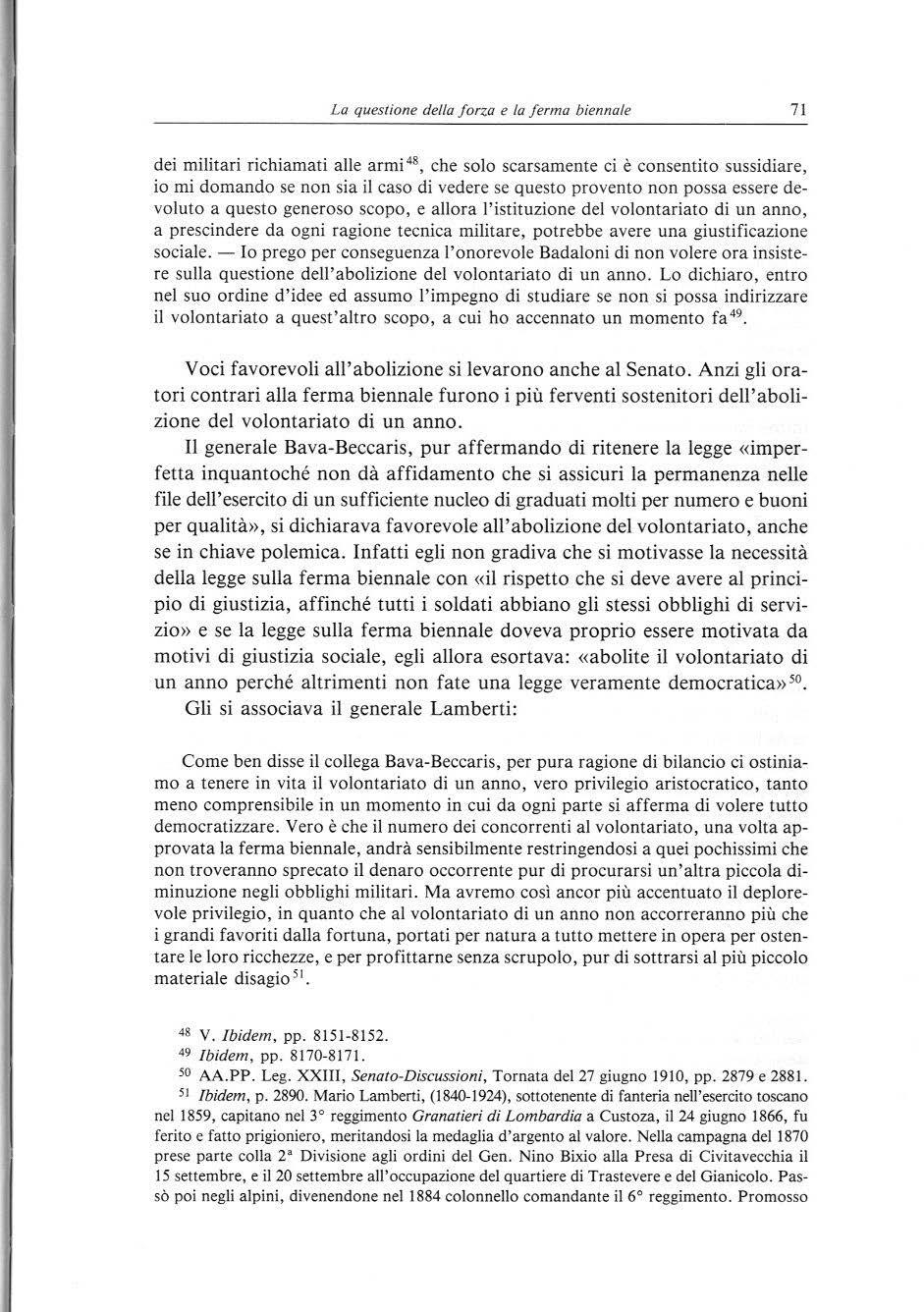
4 9 Ibidem , pp. 8 170 -8171.
50 AA.PP. Leg. XXIII, Senato-Discussioni, Tornata del 27 giugno 1910, pp. 2879 e 2881.
51 Ibidem, p. 2890. Mario Lamberti, (1840- 1924), sottotenente di fanteria nell'esercito toscano nel 1859, capitano nel 3° reggimento Granatieri di Lombardia a Custoza, il 24 giugno 1866, fu ferito e fatto prigioniero , meritandosi la medaglia d 'arge nto al valore. Nella campagna del 1870 prese parte co lla 2• Divi s io ne agli ordini del Gen Nino Bixio alla Presa di Civitavecchia il 15 settembre, e il 20 settembre all'occupazione del quartiere di T rastevere e del Gianicolo. Passò poi negli alpini, divenendone nel 1884 co lonnello comandante il 6° reggimento. Promosso
La
7]
questione della forza e la ferma biennale
Il generale Paolo Spingardi
Spingardi da parte sua riaffermò la disponibilità all'abolizione del tanto deprecato istituto:
Occorre coraggiosamente sopprimere quegli istituti che[ ) più non trovano fondamento nella coscienza nazionale e non rappresentano che ingiustificati privilegi [ ] L'aboliz ion e del volontariato d'un anno, la ri duzione della ferma dei carabinieri e degli a ltri mi litari rafferma t i sono questioni mature che conviene ormai affrontare e conviene che l'iniziativa di esse parta naturalmente da ch i in q ue sto momento ha l'onore ·di essere a capo dell'esercito 52
Malgrado queste affermazioni, Spingardi non prese alcun provvedimento immediato 53 • Res ta da capire il suo punto di vista. Da militare egli considerava evidentemente il volontariato di un anno un argomento del tutto secondario. E di fatto, dal punto di vista squisitamente numerico, lo era 54 • Che senso aveva creare una possibile causa di attrito col Ministro del Teso ro per un migliaio di soldati ogni anno, quando più comp lessi e urgenti problemi restavano da risolvere? Va ino l tre sottolineato che pur godendo dell'indiscusso privilegio di compiere un solo anno di servizio e per di più in un reggimento di loro scelta, i vo lontari di un anno dormivano, mangiavano e compivano le esercitazioni come gli altri so ldati e con gli altri so ldati, condividendone disagi e fatiche 55 , benché suscitando qualche ovvia invidia. D 'altronde il servizio di leva è sempre stato sede di privilegi e ingiustizie più o meno palesi. Casomai è da chiedersi se l'Italia del 1910 avesse davve ro bisogno indispensabile di quei due - tre milioni l'anno provenienti dal volontar ia to . Difficile dare una risposta univoca . Anche Spingardi, come si è visto nel capitolo precedente, non disdegnava affermazioni da «politica della lesina», tipica della classe politica piemontese. Non stupirebbe quindi che rinunciare anche solo a quel tutto sommat o modesto introito potesse essere considerato un sacrificio da evitare, se possibile.
Maggior generale nel 1890, comandò la Brigata Pavia. Su richiesta del generale Baratieri , il 16 gennaio 1896 venne nominato Vicegovernatore dell'Eritrea. A l ui toccò il compito di telegrafare a Roma l'infausta not izia della sconfitta di Adua, il 2 marzo 1896, e di stendere la relazione ufficiale della battaglia, pubblicata nel maggio dello stesso anno Rimase in colonia fino al settembre del 1896. Nel 1897 fu Promosso Tenente generale e inviato a comandare la Divisione mi l itare di Padova: nel 1902 comandò l'XI C.d'A. (Bari) e nel 1907 l'Vlll (Firenze). Nel 1908 venne collocato in Posizione Ausiliaria per raggiunti limiti di età e il 3 giugno dello stesso anno nominato senatore per la 14• categoria (Uffic iali generali di terra e di mare). Richiamato in servizio nel 1915 , tenne per tutto il periodo della g rande guerra il comando del C. d'A. T err itoriale di Napoli.
52 AA.PP Leg. XXIII , Senato -Discussioni, Tornata del 27 giugno 1910, p. 2899.
53 Per i successivi sv il uppi delJa vicenda, v. cap VIII, pp. 191-192
54 Dal 1871 alla guerra mond i ale si ebbe una media annua di millecinquecento volon tar i. V. D EL NEGRO, p. 195.
55 V. L'abolizione del volontariato di un anno, «L'Esercito italiano», 12 marzo 1914.
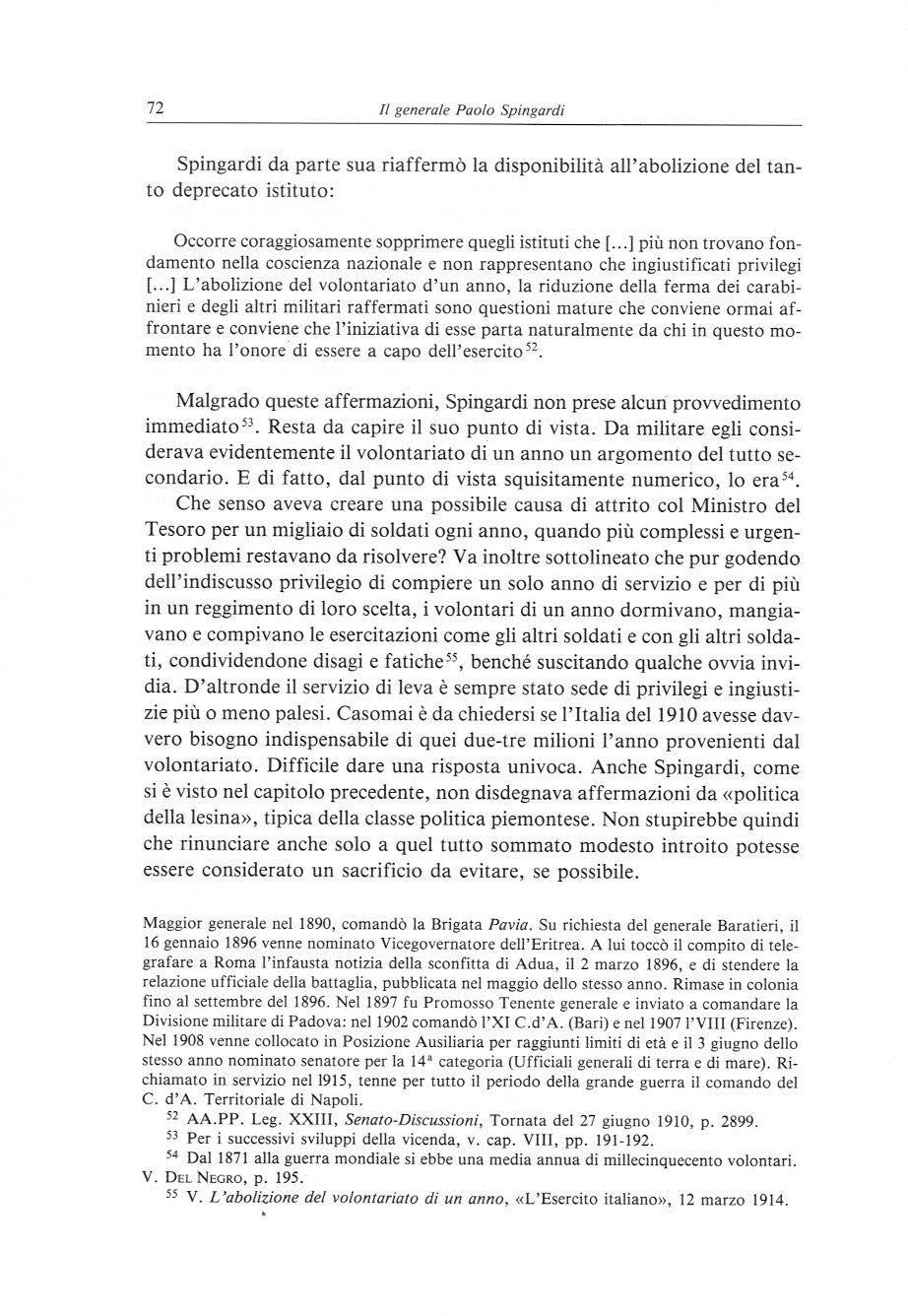
72
li servizio di pubblica sicurezza
L'uso di truppe per mentenere l'ordine pubblico era considerato normale dagli uomini di governo fin dagli inizi della storia unitaria 56
L 'at teggiamento neutrale dello stato nei confronti delle lotte tra capitale e lavoro, del resto, era un postulato della politica di Giolitti. Ma altro suo postulato era che l'ordine andava comunque mantenuto e perciò nell'età giolittiana si fece abbondantemente ricorso all'esercito per controllare scioperi, manifestazioni e dimostrazioni.
Pur convinto che l'ordine fosse un bene supremo del vivere civile, Paolo Spingardi era innanzitutto un militare, e come qualsiasi militare, considerava ogni momento che vedeva le truppe impegnate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico un momento sottratto all'addestramento . Inoltre le spese indotte da questi servizi ricadevano sul bilancio del Minist ero della Gu erra, anche se erano richieste dal Ministero dell'Interno tramite i prefetti. Si trattava insomma di denaro che non poteva essere utilizzato per più specifiche spese di preparazione bellica, quali si supponeva dovessero esser e le spese del Ministero della Guerra. Un Ministro della Guerra a veva quindi dei buoni motivi per opporsi a un ta le uso dei suoi so lda ti.
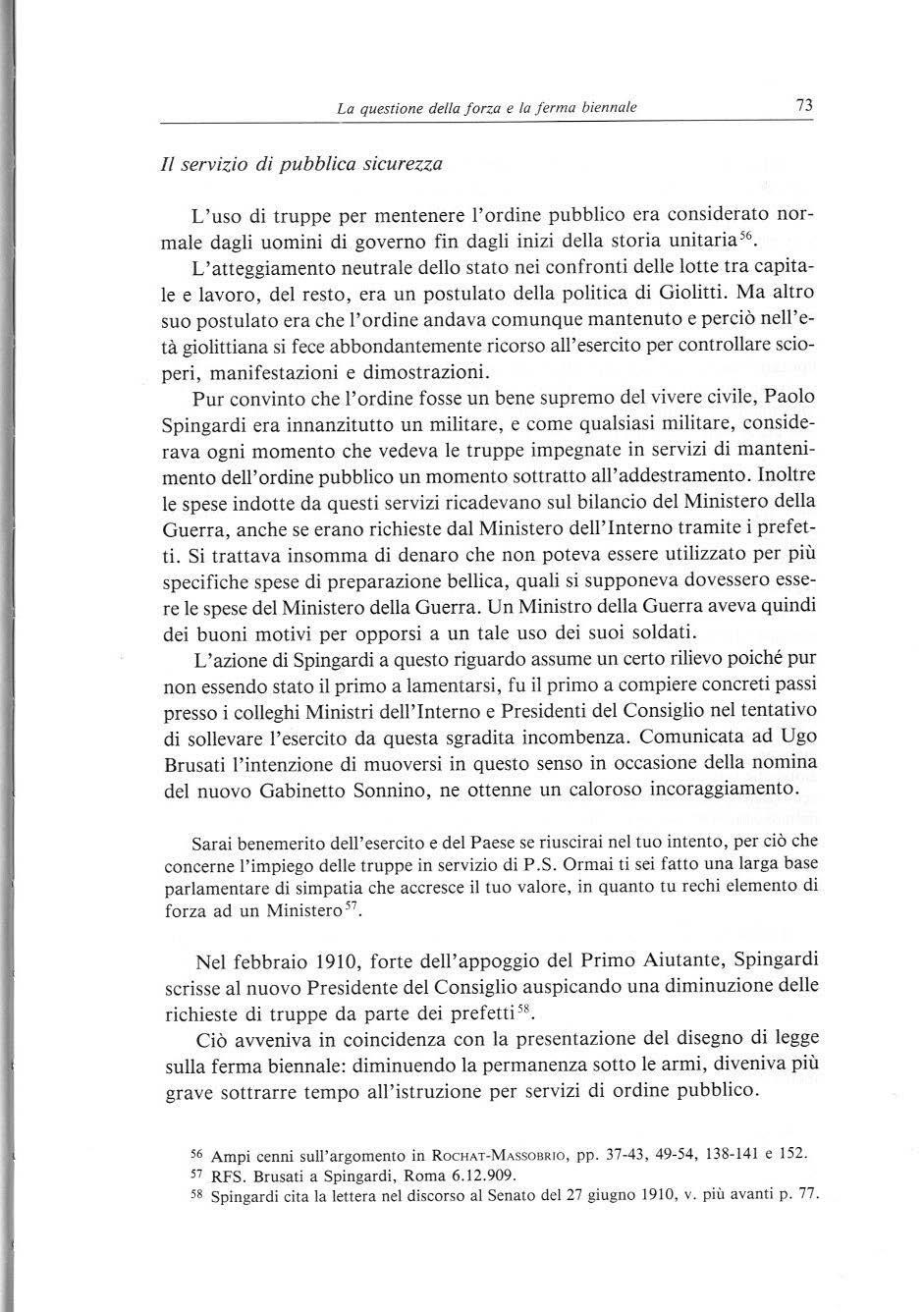
L'azione di Spingardi a questo riguardo assume un certo rilievo poiché pur non essendo stato il primo a lamentarsi, fu il primo a compiere concreti passi presso i co lleghi Ministri dell'Interno e Presidenti del Consiglio nel tentativo di sollevare l'esercito da questa sgradita incombenza. Comunicata ad Ugo Brusati l'intenzione di muoversi in questo senso in occasione deUa nomina del nuovo Gabinetto Sonnino, ne ottenne un caloroso incoraggiamento.
Sarai benemer ito dell'esercito e del Paese se riuscirai nel tuo intento, per ciò che concerne l'impiego delle truppe in servizio di P .S Ormai t i sei fatto una larga base parlamentare di simpat ia che accresce il tuo valore, in quanto tu rechi e lemento di forza ad un Ministero 57 •
Nel febbraio 1910, forte dell'appoggio del Primo Aiutante, Spingardi scrisse al nuovo Presidente del Consiglio auspicando una diminuzione delle richieste di truppe da parte dei prefetti 58
Ciò avveniva in coincidenza con la presentazione del disegno di legge sulla ferma biennale: diminuendo la permanenza sotto le armi, diveniva più grave sottrarre tempo all'istruzione per serv izi di ordine pubblico.
S6 Ampi cenni sull'argomento in Ro c HAT -M ASS0 8R1 0 , pp. 37-43, 49-54, 138-141 e 152.
57 RFS. Brusati a Spingardi, Roma 6.12.909.
58 Spingardi cita la le t tera nel discorso al Senato del 27 giug no 19 10, v. più avan t i p 77.
La questione della forza e fa ferma biennale 73
Il generale Paolo Spingardi
Purtroppo non si è reperita documentaZione per conoscere quale sia stata la risposta di Sonnino, ma in ogni caso egli non restò in carica abbastanza per soddisfare le richieste di Spingardi. Questi ripresentò però la questione nelle aule parlamentari durante la discussione del disegno di legge sulla ferma biennale, incoraggiato dai molti interventi basati sul suo stesso ordine di idee. Cominciò l'on. Negri De Salvi, c he 1'8 giugno 1910 osservava che sare bbe stato auspicabile
limitare i casi in cui l'esercito interviene in servizi di pubblica sicurezza Questi servizi sono dannosi non soltanto all'istruzione, ma anche al morale del giovane soldato il quale , in alcune circo s tanze, deve sop portare insulti atroci ed anche lesioni, con grave danno del prestigio militare 59 .
Le preoccupazioni dei militari era no soprattutto di carattere professionale (l'istruzione e il mora le d ella truppa) e non certo di carattere socia le o umanitario. Non bi sog na certo aspettarsi la considerazione, per esempio, di quanto fosse sproporzionato l'uso di soldati in assetto di guerra per fronteggiare popolazioni civili per lo più disarmate.
In quest'ordine di idee il 9 giugno l'on. Ludovico T averna citava interessanti dati che traeva da una delle relazioni della Commissione d'inchiesta. Ricordava che nel I 907
per causa del se rvizio di pubblica sicurezza, andarono perdute per l'istruzione ben 2.898.500 giornate individuali di presenza, e che reparti delle varie armi persero completamente, per la stessa causa, 13.475 giornate utili per la loro istruzione, con una proporzione che sale al 19 per cento per le truppe di cavalleria e in alcuni reparti al 65 per cento delle giornate destinate alle istru zioni di compagnia. Due corpi di cavalleria perdettero oltre il 92 per cento delle giornate destinate al le istruzioni di squadrone. Un corpo di fanteria e due di cavalleria non poterono eseguire affatto la istruzione di battaglione e di mezzo reggimento; e dieci corpi dell'arma predetta perdettero oltre il 70 per cento delle giornate destinate al tiro collettivo, istruzione della massima importanza.
Considerando che queste cifr e erano tali da non richiedere alcun commento anch 'eg li concludeva che non si sarebbe più dovuto richiedere alle truppe il servizio di pubblica sicurezza,
il quale, mentre impedisce loro di attendere a quella istruzione a cui sono chiamate, non accresce il prestigio dei nostri soldati e li chiama a compiere funzioni che certamente non rendono popolare l'esercito 60 •
59 AA.PP. Leg. XXIII , Camera-Discussioni, p. 8123.
60 Ibidem, p. 8165. Ludovico Taverna (1879-1926), nobile milanese, figlio del generale Rinaldo Taverna, venne avvialo alla carriera militare, ma lasciò pres10 il servizio a1tivo. Deputalo di Desio durame la XXlll e XXIV Legi sla tura (1909 - 1919), alla Camera sedette a destra, tra i moderati.

74
Gli sforz i di Spingardi per migliorare la non felice situazione furono infruttuosi, a giudicare dal tono rassegnato con cui dichiarava:
Dispensate l'ese rci to da qualunque servizio territoriale, da qualunqu e servizio di ordine pubb lico, da qualunque distaccamento, raccog lie te le membra dei reggimenti, sparse ovunque co n danno dell'istruzione e della disciplina, ed io v i dico che con un anno so lo di ferma otterreste più di quello c he attualmente otteniate con due anni. Ma [ ... ] ad ogni momento abbiamo attriti fra capitale e lavoro, ad ogni piè sospinto controversie di partiti popolari e clerica li , dissidi su t utta la linea, dimost ra zioni e controdimos t razioni, e l'intervento dell'eserc it o è fatale, e l' ese rcito, per quanto lo deplori, deve necessariamente intervenire - L'esercito è fatto per la guerra, siamo tutti d'accordo, ma è fatto anche per mantenere l'ordine interno. È una disgraziata situazione, è un do loroso compito che spetta all'esercito, ma è anche u n sacrosanto dovere c h e deve com p iere, e in queste condizioni non è da farsi assolutamente delle illusioni che si possa ottenere la vagheggiata astensione dell'esercito dall'intervento in t ut te queste controversie [ ] - L'eserc ito, pu r troppo, sarà sempre chiamato a portare, diciamo cos i, la parola d'ordine con la forza [ ] Ad ogni modo [... ] su questo argomento, fin dal primo g iorno c h e io ho av uto l'ono re di s alire a questo posto, ho portato la mia specia le attenzione. Io ve nivo da un co mando di divisione dove il servizio d'ordine p ubb lico è all'ordine del giorno: io venivo dall a povera Messina, pochi mesi prima che il grave flagello la colp isse Orbene, io avevo là quattro reggimenti di fanteria, vi erano dei momenti dell'anno in cui io a vevo 42 distaccamenti! Dico 42 distaccamenti! In gran parte di plotoni, pochi di compagnie . - È possibil e l'istruzione, è possibile la disciplina in questo sparpagliamento di forze? No, assolutamente! - Epp u re, per quanti sfo rz i io abbia fatto, per quante lettere umilianti, per quante preghiere io abb ia rivolto a ll 'autorità centrale ed ai prefetti, non mi è stato possibi le neppure di ridurne uno! E me ne rendo perfettamente ragione. - Colpa di nessuno, colpa della situazione: ma il fatto è questo 6 1 •
La discussione al Senato, il 27 giugno, proseguì sulle stesse li nee . Il primo a prendere la parola fu il generale Fiorenzo Ba va-Beccaris, che di mantenimen to dell'ordine sicurame nt e se ne intendeva Egli si augu rava che Spingardi riu scisse «ad impedire l'uso e l'abuso delle truppe» per il servizio di pubblica sicurezza. Ma non si faceva illu sioni perché, secondo lui, gli sciope r i
hanno quasi sempre un substrato politico; è una forma di rivolta che ag ita le masse, abilmente sfruttate dai partiti, cui conviene, per i loro fini, rendere il serviz io sotto le armi penoso e antipat ico al sol dato. E temo che ques ta de p lo r evo le co ndizion e anziché a migliorare vada sempre più a peggiorare 62
Il general e L amberti era di simile avviso:
6 1 AA.PP. Leg XXIII, Camera-Discussioni, pp. 8169 -8170 62 AA.PP Leg XXIII, Senato-Discussioni, pp 2880 -2881.
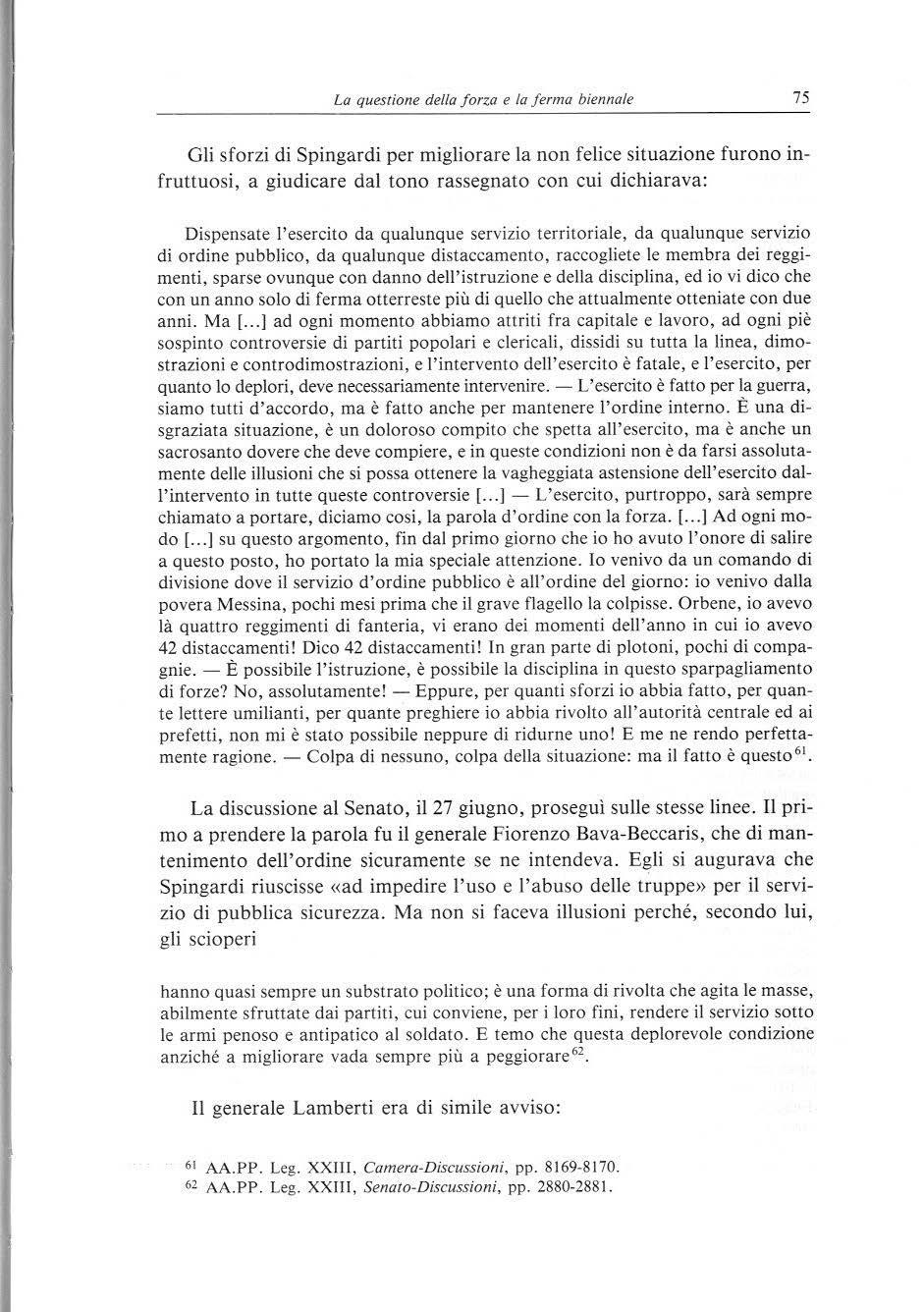
La questione della forza e la ferma biennale 75
Il generale Paolo Spingardi
I perturbamenti dell'ordine pubblico non riusciremo a toglier li per diversi anni, e l'impiego della truppa sarà costantemente per ciò richiesto, onde insufficiente il tempo per la sua istruzione e soprattutto per educarla all'ordine, al dovere, al sacrificio 6 3 •
Questi oratori si espressero contro la ferma biennale, e il problema del servizio di pubblica sicurezza diventava un elemento a favore della loro tesi: se si spendeva tanto tempo per affrontare la piazza, due anni di ferma diventavano insufficienti a garantire la preparazione della truppa .
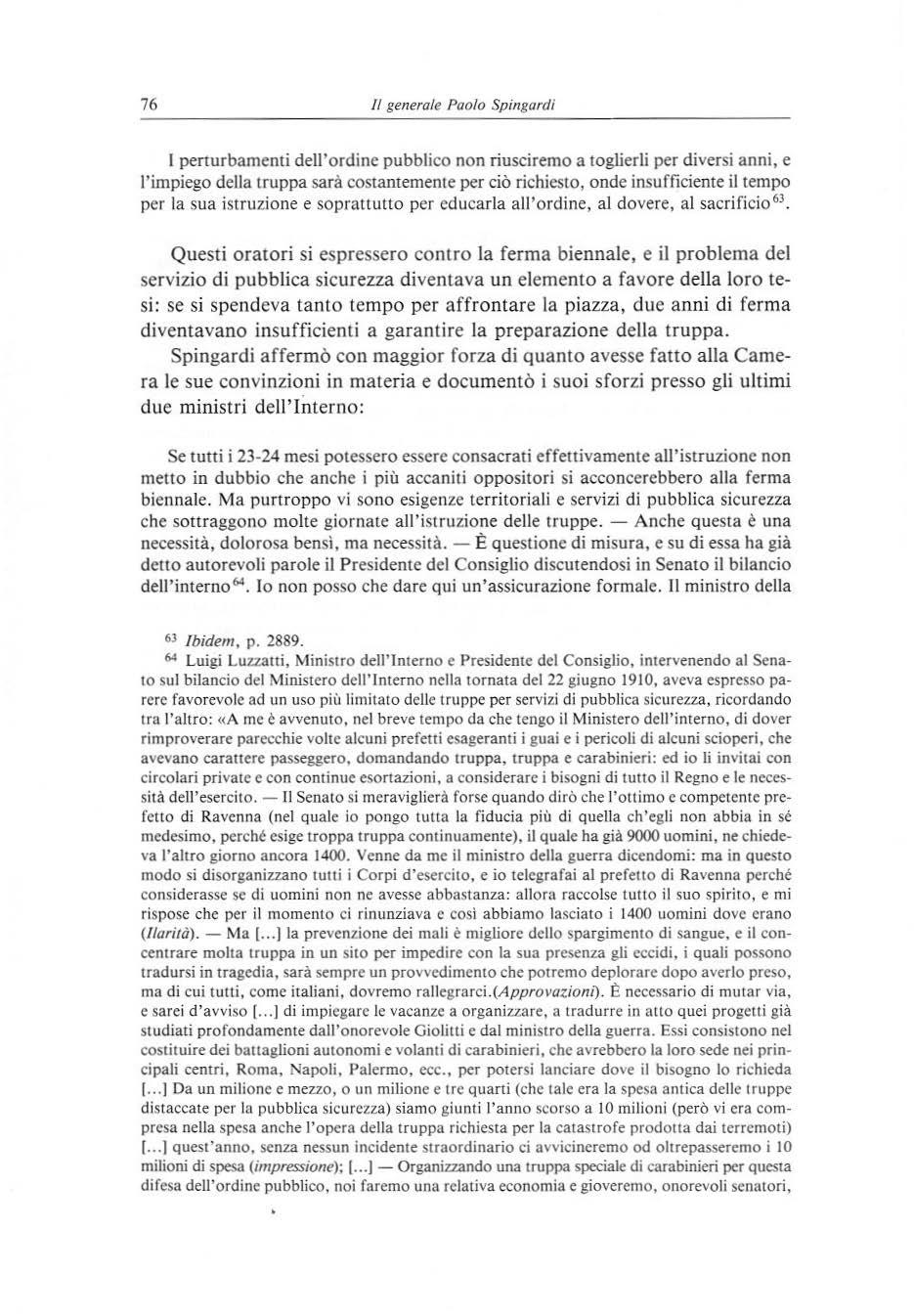
Spingardi affermò con maggior forza di quanto avesse fatto alla Camera le sue convinzioni in materia e documentò i suoi sforzi presso gli ultimi due ministri dell'Interno:
Se tutti i 23-24 mesi potessero essere consac rati effettivamente all'istruzione non metto in dubbio che anche i più accaniti oppositori s i acconcerebbero alla ferma biennale. Ma purtroppo vi sono esigenze territoriali e ser vizi di pubblica sicurezza che sott raggono molte giornate all'istruzione delle truppe. - Anche questa è una necessità, dolorosa bensl, ma necessità. - È questione di misura, e su di essa ha già deuo autorevoli parole il Pr esi dente del Co nsiglio discutendosi in Senato il bilancio dell'interno 64 • Io non posso che dare qui un'assicurazione formale. Il ministro della
63 Ibidem , p. 2889.
6.s Luigi Lu zzatti, Ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio, intervenendo al Senato sul bilancio del Ministero dell'Interno nella tornata del 22 giugno 1910, aveva espresso parere favorevole ad un uso più limitato delle truppe per servizi di pubblica sic urezza, ricordando tra l 'altro : «A mc è avvenuto, ne l breve tempo da che tengo il Ministero dell'interno, di dover rimproverare parecchie volle alcuni prefetti esagerami i guai e i pericoli di alcuni scioperi, che avevano carattere passeggero, domandando truppa, truppa e carabinieri: ed io li invitai con circola ri pri vate e con continue esortazioni, a considerare i bisogni di tutto il Regno e le necessità dell'esercito. - li Senato si meraviglierà forse quando dirò che l'ottimo e competente prefetto di Ravenna (nel quale io pongo tutta la fiducia più di quella ch'egli non abbia in sé medesimo, perché esige troppa truppa continuamente), il quale ha già 9000 uomini, ne chiedeva l'altro giorno ancora 1400. Venne da me il ministro della guerra dicendomi: ma in questo modo si disorganizzano tutti i Corpi d'esercito, e io tel egrafai al prefetto di Ravenna perché cons iderass e se di uomini non ne avesse abbastanza: allora racco l se tutto il suo spirito, e mi rispose che per il momento c i rinunziava e così abbiamo lasc iato i 1400 uomini dove erano (llarità). - Ma [ ) la prevenzione dei mali è migliore dello spargimento di sangue, e il concentrare molta truppa in un sito per impedire con la sua presenza gli eccidi, i quali possono tradursi in tragedia, sarà sempre un provvedimento che potremo deplorare dopo averlo preso, ma di cui tutti, come italiani, dovremo rallegrarci (Approvazioni). È necessario di mutar via, e sare i d'avviso f ) di im piegare le vacanze a organizzare, a tradurr e in atto quei progetti già stud iati profondamente dall'onorevole Giolitti e dal mfoistro della guerra. Essi consistono nel costituire dei battaglioni autonomi e volanti di carabinieri, che avrebbero la loro sede nei principali centri, Roma, Napoli, Palermo, ecc., per potersi lanciare dove il bisogno lo richieda
[ ) Da un milione e mezzo , o un milione e tre quarti (che tale era la spesa antica delle truppe distaccate per la pubblica s icurezza) siamo giu nti l'anno sco rso a IO milioni (però vi era compresa nella spesa anche l'opera della truppa richiesta per la catast rofe prodotta dai terremoti)
[ ] quest'anno, senza nessun incidente straordinario ci avvicineremo od oltrepasseremo i IO milioni di spesa (impressione); [ ) - Organizzando una truppa speciale di carabinieri per questa difesa dell'ordine pubblico, noi faremo una relativa economia e gioveremo , onorevo li sena tori,
76
guerra, cioè , non tral ascerà di spiegare tutta la sua influenza non solo perché nell'impiego della truppa in ser vizio di pubblica sicurezza la misura non sia oltrepassata, ma anche perché i distaccamenti siano ridotti e perché il servizio territorial e sia limitato allo stretto indispensab il e. Se il Senato me lo consente, darò lettura di alcuni brani di lettere scritte al ministro dell'interno recentemente, i quali stanno ad attestare quanto io ritenga im po r tante che l'esercito sia distratto il meno possibile nei servizi di ordine pubblico , non soltanto per r agioni di ordine materiale, ma anche per ragioni di ordine morale . - Nel mese di feb braio di quest'anno io scrivevo al ministro dell'interno: «Mentre per necessità di vario genere la durata del servizio è ormai ridotta al minimo strettamente indispensabile, l'istruzione è d ivenuta sempre più difficile, l'educazione del soldato richiede sempre più diligenti e assidue cure. E ciò non è assolutamente compatibile coi conti n ui movimenti da un luogo all'altro, con i frazionamenti e i frammischiament i cui bisogna ricorrere ogni giorno per corrispondere a richieste dell'autorità politica - In queste cond izion i è evidente che qual unque pratica tendente a spostamenti permanenti di truppe, a impianto di nuovi distaccamenti ordinari ecc. , non potrebbe avere presso questo Ministero alcun esito favorevo le, ed è evidente essere o rmai indispensabile di applicare strettamente il principio di ricorrere all'eserci t o pel servizio di ordine pubb lico nei soli casi di assoluta e imprescindib il e necessità, e mantenendo q uella misura che purtrop po è stata mo lte volte trascur ata. Si tratta di un radicale mutamento nella linea di condotta che finora è stata seguita: esso è però necessario nell'interesse supremo dell'esercito e del P aese, e q uesto M inistero non può sperar e per ottenerlo che nel personale ed ener gico intervento dell'E.V . il cui alto patriottismo non può certamente farla rimanere ind ifferente di fronte alla grave situazione che ho creduto mio assoluto dovere di rappresentarle» -E più oltre, recentemente, in occasione dei moti di Ravenna 65 , io scrivevo una lunga lettera al ministro
all'esercito e anche ai Reali carabinieri; perché questo distaccare continuamente i carabinieri dalJe loro sedi, dove sono necessari , per mandarli in servizio di pubblica sic urezza nelle altre parti d'Ita lia guasta anche il loro sp ir ito di corpo, spoglia le città e i luoghi minori che ne hanno bisogno, dei loro presidi na t ura l i. E si vive in questo continuo allarme che per andare a difendere un luogo dove la sicurezza pubblica è turbata, si provoca il turbamento nelle città disert a t e, e l'esercito se ne deteriora, come pure se ne risente l'arma dei carabinieri e il corpo delJe guardie di pubb Jjca s icurezza. (Benissimo). Bisogna qui ndi creare questi battaglioni mobili. Ciò non impedirà d .i adoperare l'esercito nei momenti partico larmente difficili, ma non lo si adoprerà [ .. .] pei consueti disordini ai quali s iamo abituati nel nostro paese . - Spero che se il s enato darà l'autorità del suo appoggio a questa proposta , raggiungeremo l'intento di non accrescere le spese e diminuiremo le occasion i di dist urbare la riform a dell'eserc ito che è nel cuo re di t ut t i noi, perché l'onore dell'ese rc ito e il suo collegamento colle necessi tà economiche del paese è il sospiro d i tutti quanti gl'Italiani. (Approvazioni vivissime)>>. (AA.PP., Senato -Discussioni , Tornata del 22 giugno 1910, pp. 2787 -2788). Malgrado le pro messe , almen o per il momen to i battaglioni mobi l i dei carabinieri non videro la luce (v . / battaglioni mobili dei RR. Carabinieri, «La Preparazione», G iovedì-Venerd ì 29-30 dicembre 1910).
65 N el 19 10 in Romagna esplose un violento conflitto tra mezzadri e braccianti su lla proprietà e il controllo delle trebb iatr ici: «Le leg he dei br accia n t i volevano assicurare alle macchi-ne possedute dalle loro cooperative il monopol io della trebbiatura in tutta la regione , e i mezzadri si opposero, decisi a conservare le proprie macchine e a impiega r le con reciproche prestazioni di lavoro [ ] La lot ta si concluse con la vittor ia dei mezzadri che conservarono le loro t rebbiatrici, ma non prima che il governo Luzzatli fosse stato costretto a i nviare truppe per reprimere le v iolenze» (SETON-WATSON , pp . 353-354) .
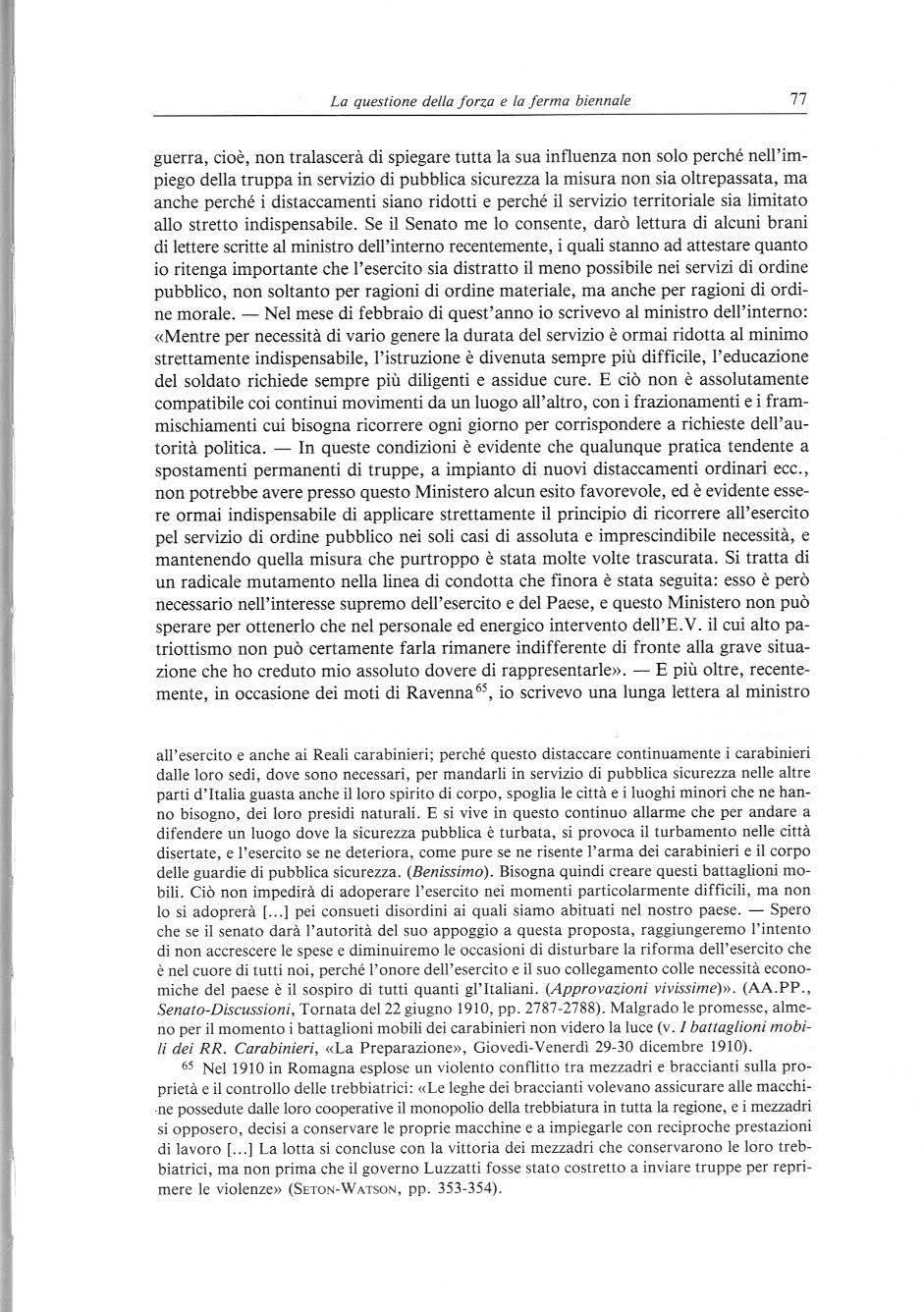
La questione della forza e la ferma biennale 77
Il generale Paolo Spingardi
dell'interno e aggiungevo di mio pugno queste parole: «[ ... ) si persuada V.E. che un cambiamento di indirizzo si impone. Mai come in questi ultimi tempi si è abusato dalle autorità politiche nella richie sta di tr upp e in servizio di ordine pubblico».
- Veda il Senato che io sono perfettamente nell'ordine di idee testé espresso da alcu ni oratori, sulla necessità che ne!Je frequenti competizioni fra capitale e lavoro o in altri turbamenti dell'ordine interno, l'esercito sia più parcatamente usato. E spero che, dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. Presidente del consiglio, se non interament e, almeno in parte riusciremo a evitare questo inconveniente 66 •
Non si dimentichi che, quale ex Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Paolo Spingardi aveva una pa r ticolare sensibilità oltre che una specifica competenza per questi problemi . Ma purtroppo non riuscì a impedire che le truppe fossero massicciamente impiegate per il mantenimento dell'ordine pubblico anche dopo qqesti espliciti interventi 67 , con quanta gioia del Ministro della Guerra si può facilmente immag inare.
In sostanza anche durante l'amministrazione del generale Paolo Spingardi l'esercito fu obbligato a soste nere il ruolo repressi vo che manteneva dai tempi dell'unità: «Le truppe di leva continuarono a essere il principale stru mento di controllo della piazza e il ric orso alle armi si ver ific ò ancora con triste frequenza» 68 • È comunque sign ificativo l'impegno col quale il Ministro della Guerra cercò di opporsi a una tale politica 69 •
66 AA.PP. Legislatura XXlll, Senato-Discussioni, tornata del 27 giugno 1910, pp. 2891 -2892.
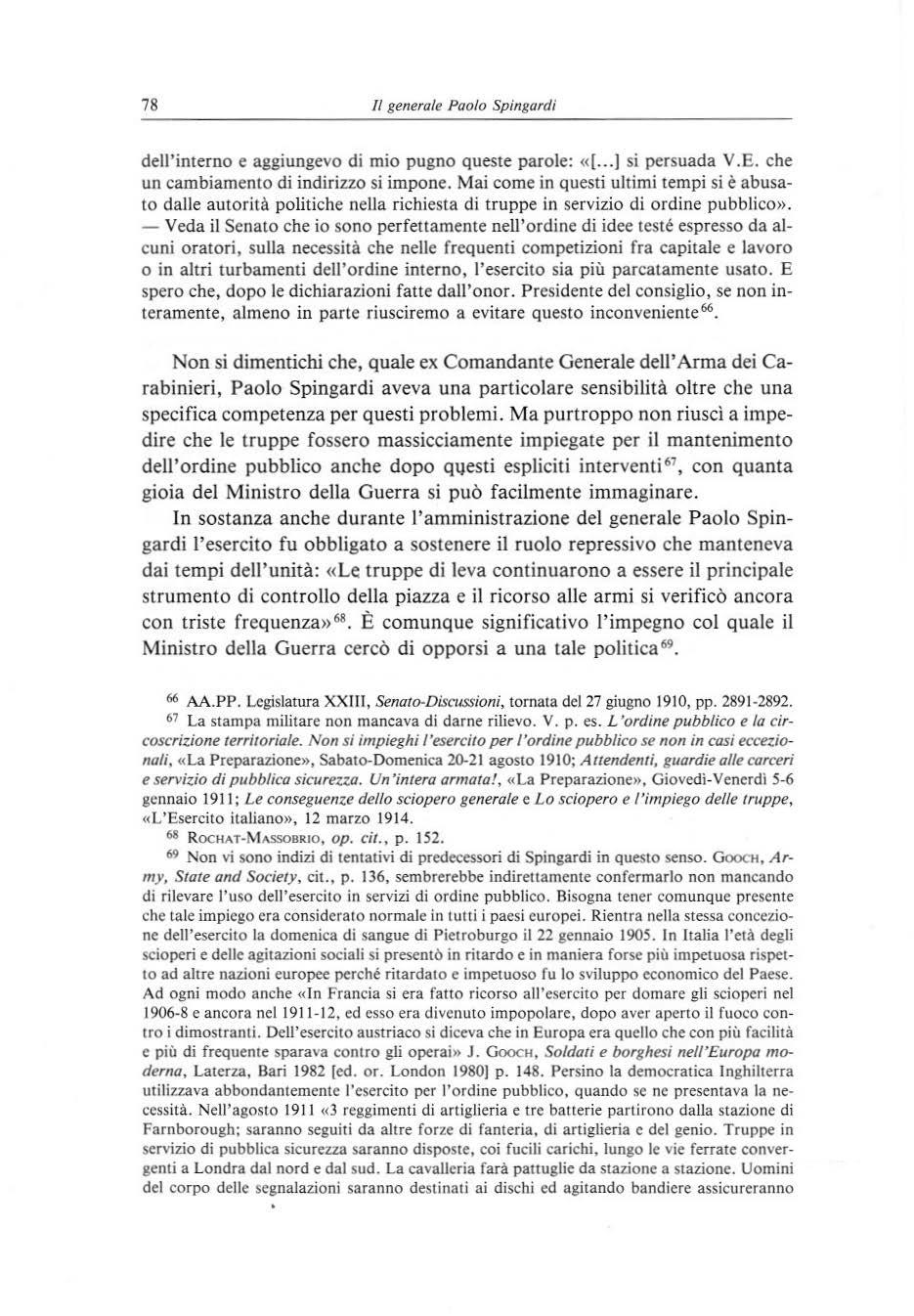
67 La stampa militare non mancava di darne rilievo. V. p. es L ' ordine pubblico e la circoscrizione terriroriale. Non si impieghi l'eserciro per l'ordine pubblico se non in casi eccezionali, «La Preparazione», Sabato-Domenica 20-21 agosto 1910; Auendenri, guardie alle carceri e servizio di pubblica sicure:r.za. Un 'intera armara!, «La Preparazione », Giovedì - Venerdì 5-6 gen naio 1911; Le conseguenze dello sciopero generale e Lo sciopero e l'impiego delle /ruppe, «L'Esercito italiano», 12 marzo 1914.
68 R OCHAT·M ASSOBRIO, op. cii., p. 152.
69 Non vi sono indizi di tentativi di predecessori di Spingardi in questo senso. GoocH, Army, State and Society, cit., p. 136, sembrerebbe indirettamente confermarlo non mancando di rilevare l'uso dell'esercito in servizi di ordine pubblico. Bisogna tener comu nqu e presente che tale impiego era considerato normale in tulti i paesi europei. Rientra nella stessa concezione dell'esercito la domenica di sa ngue di Pi etro burgo il 22 gennaio 1905. In Italia l'età degli sciope ri e delle agitazioni sociali si presentò in ritardo e in maniera forse più impetuosa rispetto ad altre nazioni europee perché ritardato e impetuoso fu lo sviluppe econo mico del Paese . Ad ogn i modo anche «In Franc ia si era fatto ricorso all'eserc ito per domare gli scioperi nel 1906-8 e ancora nel 19 1 1- 12, ed esso e ra divenu to impopolare, dopo aver aperto il fuoco contro i dimostranti. Dell'esercito austriaco s i diceva che in Europa era quello c he con più facilità e più di frequente sparava contro gli operai» J. G oocH, Soldati e borghesi nell'Europa moderna, L aterza, Bari 1982 [ed. or. London 1980) p. 148. Persino la democratica In ghilterra utilizzava abbondantemente l'esercito per l'ordine pubblico, quando se ne presentava la necess ità . Nell'agosto 191 I «3 reggimenti di artiglieria e tre batterie partirono dalla stazione di Farnborough; sara nno seguiti da altre forze di fanteria, di artiglieria e del genio . Truppe in servizio di pubblica sicurezza saranno dispeste, coi fucili carichi, lungo le vie ferrate convergenti a Londra dal nord e dal sud . La cavalleria farà pattuglie da sta.Zione a stazione . Uomini del co rpo delle segnalazioni sa ranno destinat i ai dischi ed agitand o bandiere assicureranno
78
La nuova legge sulla ferma
La discussione di questi argomenti, importanti ma non strettamente inerenti al disegno di legge, dimostra come il principio della ferma biennale fosse assolutalmente maturo per essere sanc ito legalmente.
Il 10 giugno 1910 la Cam era approvò il disegno di legge con 207 voti favorevoli, compresi i soci alisti, e soltanto 14 contrari. Erano però presenti solo 221 deputati su 508. Più che un segno di opposizione, era un segno di quanto fosse data per scontata l'approvazione.
Il Senato approvò il disegno il 28 giugno 1910 con 69 voti favorevoli e 35 contrari, confermando le opposizioni alle quali si è accennato .
La nuova legge, emanata il 30 giugno 1910 col n ° 362, oltre alla riduzione della ferma, istituiva il rimborso delle spese di viaggio per gli iscritti indigenti che si recavano al Consiglio di Leva; il riassoldamento per i militari di cavalleria e di artiglieria a cavallo con la concessione di una speciale indennità e la facoltà di far assegnare alla seconda categoria un fratello consanguineo , i corsi accelerati per allievi caporali. Veniva inoltre confermata al Ministro della Guerra la facoltà di lasciare in licenza strao rdinaria, in attesa di congedo illimitato, un adeguato numero di reclute di prima categoria qualora per maggior rendimento della leva la forza media presente fosse risultata superiore alla forza fissata nella legge di bilancio. Queste reclute avevano però l'obb ligo di prender parte alla prima chiamata della 2 3 categoria e nell'anno successivo ad un richiamo alle armi per istruzione 70 • P e r l' esecuzione della legge era inoltre fissato un aumento nel bilancio del Ministero della Guerra di lire 3.100.000 grazie al quale, tra le altre cose, si elevò di 5.000 unità la forza bilanciata portandola così a 230.000 uomini: un altro J"lSSO per il rafforzamento quantitativo dell'esercito, uno degli obiettivi primari del Ministro.
il regolare andamento dei treni. Da Aldershot partiranno 25.000 uomini ... » , Le larghe misure militari adottate dal governo inglese per lo sciopero generale, «La Preparazione», GiovedìVenerdì 17-18 Agosto 19 1I. Si noti che la notizia era una semplice agenzia, data senza commenti, e collocata nel giorna le come se si trattasse di avvenime nti senza alcun carattere di eccezionalità.
70 Per il testo definitivo della legge, AA.PP. Legislatura XXIII, Senato-Discussioni, tornata del 27 giugno 1910, pp . 2903-2904 .
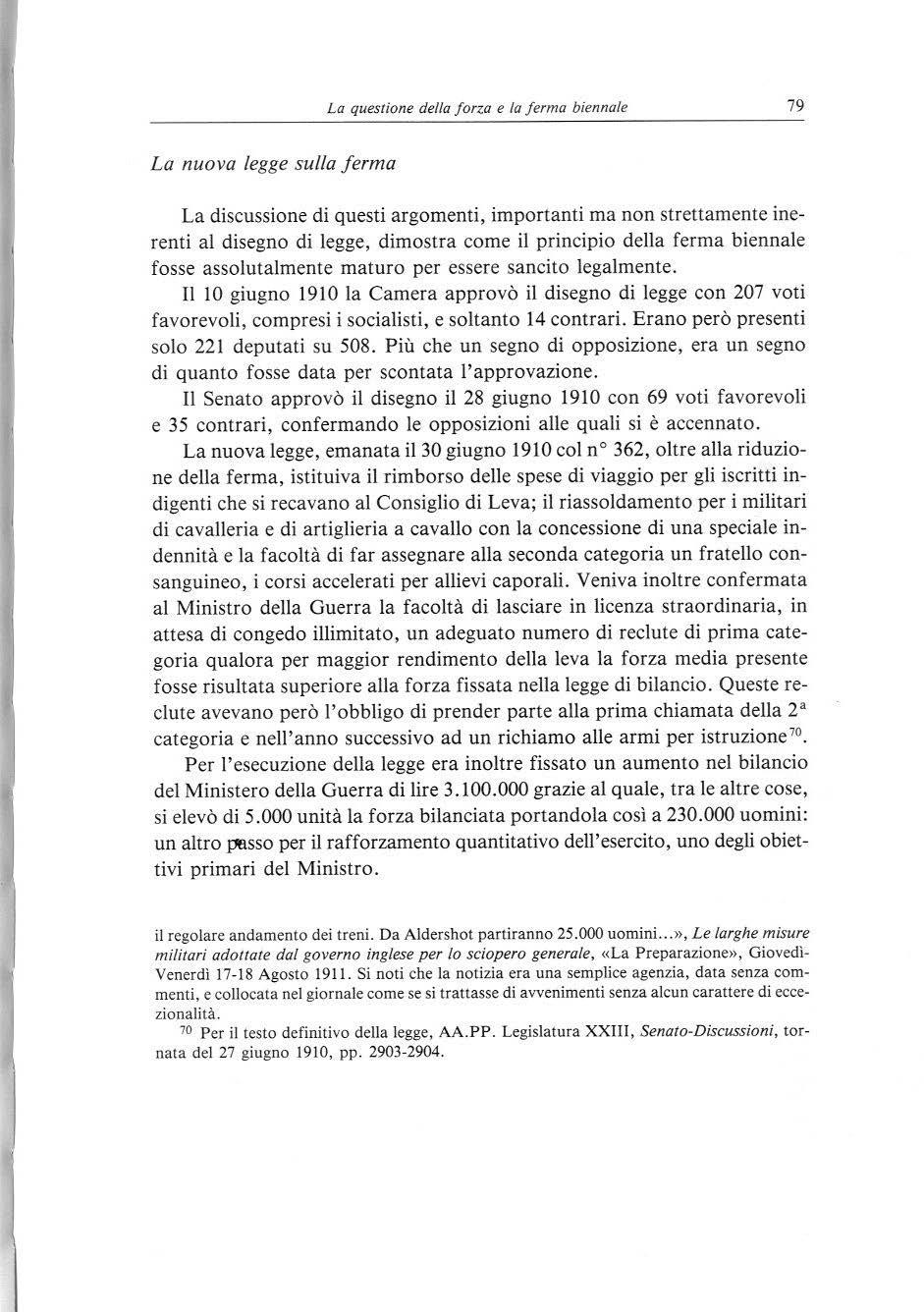
La questione della forza e la ferma biennale 79

CAPITOLO IV
UNA INTERPRETAZIONE STRATEGICA DEL NUOVO ORDINAMENTO
L'ordinamento è una operazione dell'organica, una delle quattro branche fondamentali dell'arte militare (le altre tre sono la strategia, la tattica e la logistica). Per esso si dà forma alla massa del personale reclutato in modo da rendere l'esercito un complesso equilibrato di molti organi di diversa conformazione e grandezza, aventi ciascuno il proprio compito particolare, ma tutti convergenti verso uno scopo unico e comune. Lo si può quindi definire come
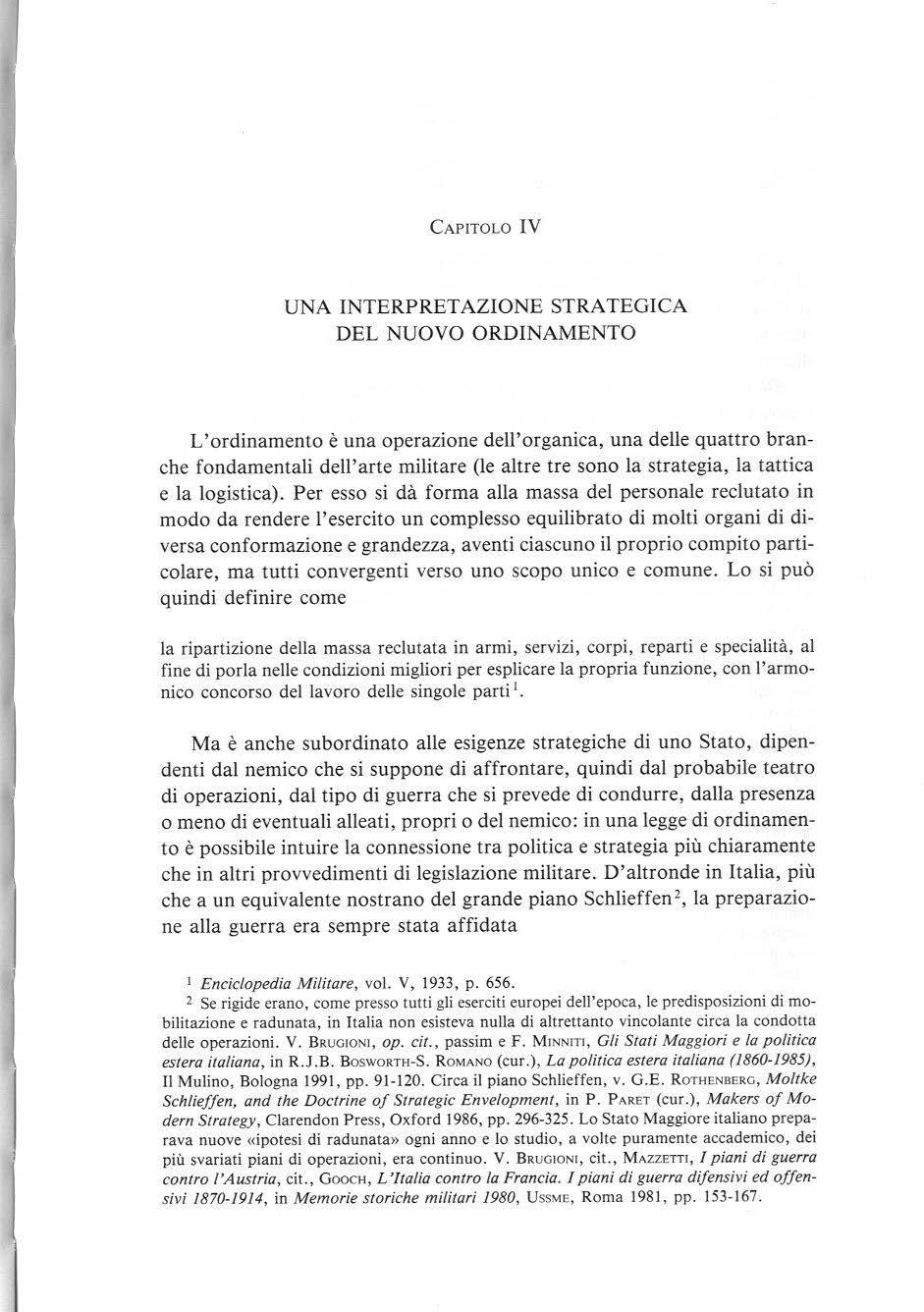
la ripartizione della massa reclutata in armi, servizi, corpi, reparti e specialità, al fine di porla nelle condizioni migliori per esplicare la propria funzione, con l'armonico concorso del lavoro delle singole parti 1 •
Ma è anche subordinato alle esigenze strategiche di uno Stato, dipendenti dal nemico che si suppone di affrontare, quindi dal probabile teatro di operazioni, dal tipo di guerra che si prevede di condurre, dalla presenza o meno di eventuali alleati, propri o del nemico: in una legge di ordinamento è possibile intuire la connessione tra politica e strategia più chiaramente che in altri provvedimenti di legislazione militare. D'altronde in Italia, più che a un equivalente nostrano del grande piano Schlieffen 2, la preparazione alla guerra era sempre stata affidata
1 Enciclopedia Militare, voi. V, 1933, p. 656.
2 Se rigide erano, come presso tutti gli eserciti europei dell'epoca, le predisposizioni di mobil itazione e radunata, in Italia non esisteva nulla di altrettanto vinco lant e circa la condotta delle operazioni. V. BR uo10N 1, op. cit., passim e F. M1NN 1T1, Gli Stati Maggiori e la politica estera italiana, in R J B. BoswoRTH-S. RoMANO (cur.) , La politica estera italiana (1860 -1985), Il Mulino, Bol ogna 1991 , pp 91-120. Circa il piano Schlieffen, v. G.E. ROTHENBE RG, Moltke Schlieffen, and the Doctrin e of Strategie Envelopment, in P. PARET (cur.), Makers of Modem Strategy, Clarendon Press, Oxford 1986, pp 296-325. Lo Stato Maggiore italiano preparava nuove «ipotesi di radunata» ogn i anno e l o studio, a volte puramente accademico, dei più svariati piani di operazioni , era continuo. V. BR uo 10N1, cit., MAZZETTI, / piani di guerra contro l'Austria, cit., G ooc H, L'Italia contro la Francia. I piani di guerra difensivi ed offensivi 1870-1914, in Memorie storiche militari 1980, USSME, Roma 1981, pp. 153-167.
Il generale Paolo Spingardi
in gran part e, ad un processo, palese nel suo svolgimento, di creazione e revisione dell'ordinamento, vale a dire all'opera ricorrente di inquad ramento della forza armata 3 •
In somma, l 'ordinamento era un indicatore abbastanza preciso d e l tipo di gue rra che i militari italiani si aspettavano di combattere. Spingardi non si staccò d a questa tradizion e quando, contemporan ea mente ai provvedim enti per aumentare la forza , presentava an ch e quelli relativi al suo inquadramento.
Ormai ness uno metteva in discu ssio ne l' or dinam e nto fondamental e dell 'esercito su dodici corpi d'armata e venticinque divisioni, sancito nel 1882 4 •
Era però assolutamente necessario consolidare quanto esisteva allo scopo di « rendere meno stridente, più facile, più omo ge neo, il passaggio dal piede di pace al piede di guerra» secondo le parole di Spingardi, e adeguare la st ruttura alle nuove esigenze strategiche.
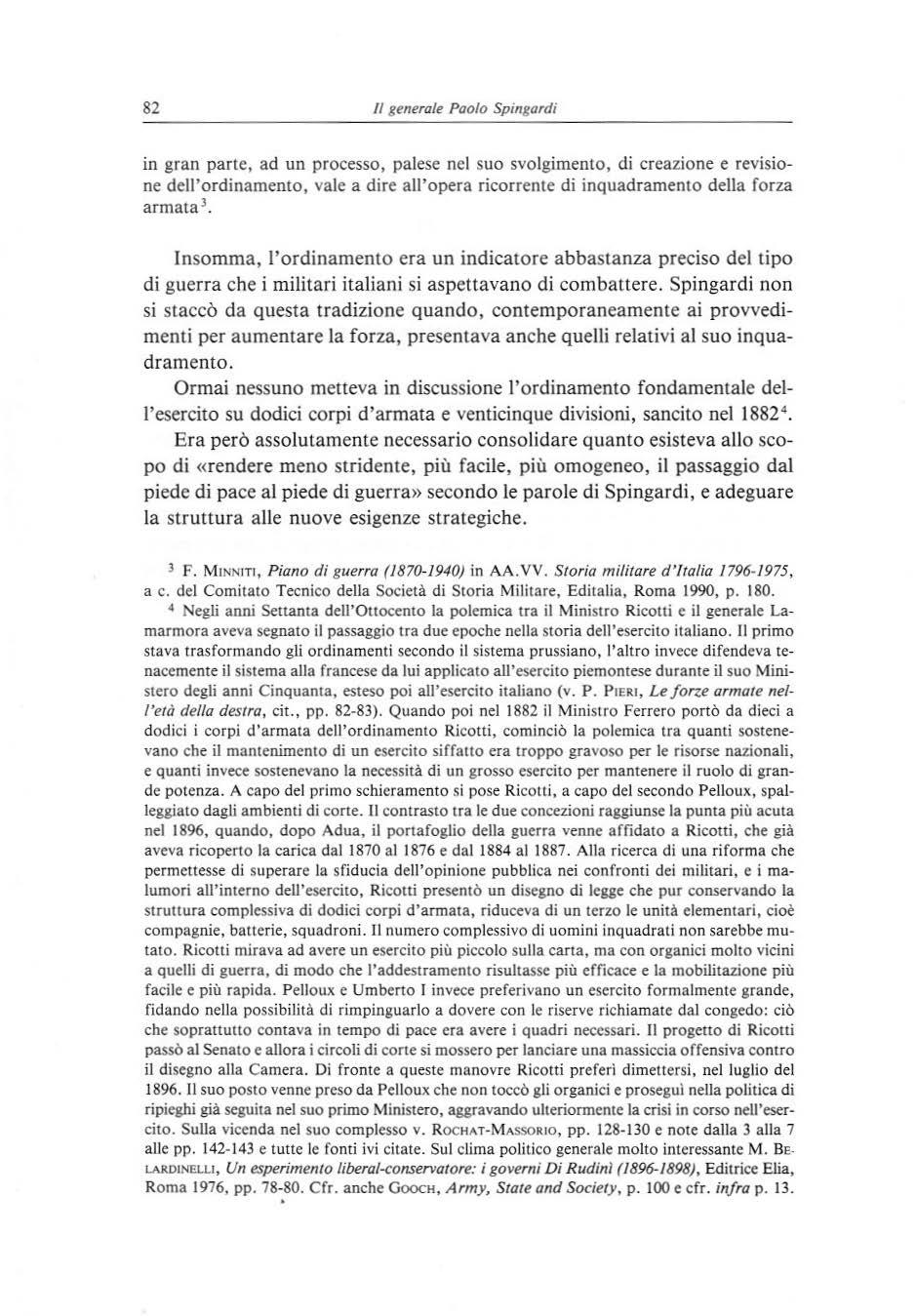
3 F. M1NNJT1, Pian o di guerra (1870-1940) in AA.VV Storia militar e d'ltalia 1796-1975, a c. del Comitato Tecnico della Società di Storia Mili tare, Editalia, Rom a 1990, p. 180.
4 Negli anni Settanta dell'Ottocento la polemica tra il Mini stro Ricotti e il generale Lamarmora aveva segnato il pass aggio tra due epoche nella storia dell'esercito italiano. li primo stava trasform a ndo gli ordinamenti second o il s is tema prussiano, l'altro inv ece difendeva tenacemente il sistema alla francese da lui ap plicato all'esercito piemontese durante il suo Ministero degli anni Cinquanta, esteso poi all 'esercito italiano (v. P. P1eR1, Le fon.e armare n ell'e t à della destra, ci t. , pp. 82 -83). Qua ndo poi nel 1882 il Ministro Ferrero portò da dieci a dodi c i i co rp i d 'arma ta dell'ord inamento Ricotti, cominciò la po lem ica tra quanti sosten evano che il mantenimento di un esercito siffatto era troppo gravoso per le risorse nazionali, e quanti invece sostenevano la necessità di un grosso ese rcito per mantenere il ruolo di grand e potenza. A ca po del primo schieramento s i pos e Ricott i, a capo del secondo Pelloux, s palleggiato dagli ambie n t i di corte. Il contrasto tra le due concezioni raggiunse la punta più acuta nel 1896, quando, dopo Adua, il portafoglio della guerra venne affidato a Ricotti, che già a veva ricoperto la carica dal 1870 a l 1876 e dal 1884 al 1887. All a ricerca di una riforma che perm ettesse di su perar e la sfi ducia dell'opinione pubbli ca nei confronti dei militari, e i malumori all'interno dell'eserci10, R icotti presen1ò un disegno di legge che pur conservando la struttura complessiva di dodici corpi d'armata, riduceva di un terzo le unità elementari, cioè compagnie, bat te rie, sq u ad roni. Il numero complessivo di uomini inquadrati non sar ebbe mutato. Ricotti mirav a ad avere un esercito più picco lo sulla cana, ma con organici molto vicini a quelli di guerra, di modo che l'addestramento risultasse più efficace e la mobilitazione più facile e più rapida. P e ll oux e Um berto I in vece preferivano un eserc ito formalmente gra nde , fidando nella possibilità di rimpinguarlo a dovere con le riserv e richiamate dal congedo: ciò che so prattutto contava in tempo di pace era avere i quadri necessari Il progetto di R icolti passò al Senato e allora i circoli di corte si mossero per lanciare una massiccia offensiva contro il disegno alla Camera. Di fronte a queste m ano v re Ricotti preferì dimett ers i , nel lu g lio del 1896. Il suo posto venne preso da Pelloux che non toccò gli organici e prosegui nella politica d i ripieghi già seguita nel suo primo Ministero, aggravando ulteriormente la crisi in corso nell'esercito. Sulla vicenda nel suo complesso v ROCHAT-MASSORIO , pp. 128-130 e note dalla 3 alla 7 alle pp. 142- 143 e tutte le fonti ivi cita te. Sul clima politi co gene ra le molto interessante M. Be. LAR.OINELLI, Un esperimento liberal-conservatore: i governi Di Rudinì (18 96-1 898), Edi trice Elia , Roma 1976, pp. 78 -80. Cfr. anche GoocH, Army, State and Society, p. 100 e cfr infra p. 13
82
.
Lo stralcio del 1909
Il predec esso re di Spingardi, il senatore Severino Casana, il 29 marzo 1909, due giorni prima di dimettersi, aveva presentato alla Camera un disegno di legge che modificava l'ordinamento dell'esercito in coerenza con le prime conclusioni della Commissione d'inchiesta.
Giunto al potere, Spingardi stralciava dal progetto quanto gli pareva più urgente , cioè i provvedimenti riguardanti gli alpini, la cavalleria e l'artiglieria da montagna.
Mentre cominciava il programma di fortificazioni alla frontiera orientale, si rafforzavano i corpi più adatti alla difesa di tale frontiera. La filosofia stessa della specialità faceva degli alpini i naturali difensori delle montagne che delimitavano il territorio nazionale. Data la caratteristica di unica specialità dell'esercito a reclutamento territoriale, erano anche in grado di mobilitarsi prima degli altri reparti; la cavalleria, in virtù della propria mobilità, poteva coprire e muoversi lungo la frontiera minacciata non appena indetta la mobilitazione.
Alcuni passi della relazione dell'Ufficio centrale del Senato spiegavano l'impostazione generale del disegno:
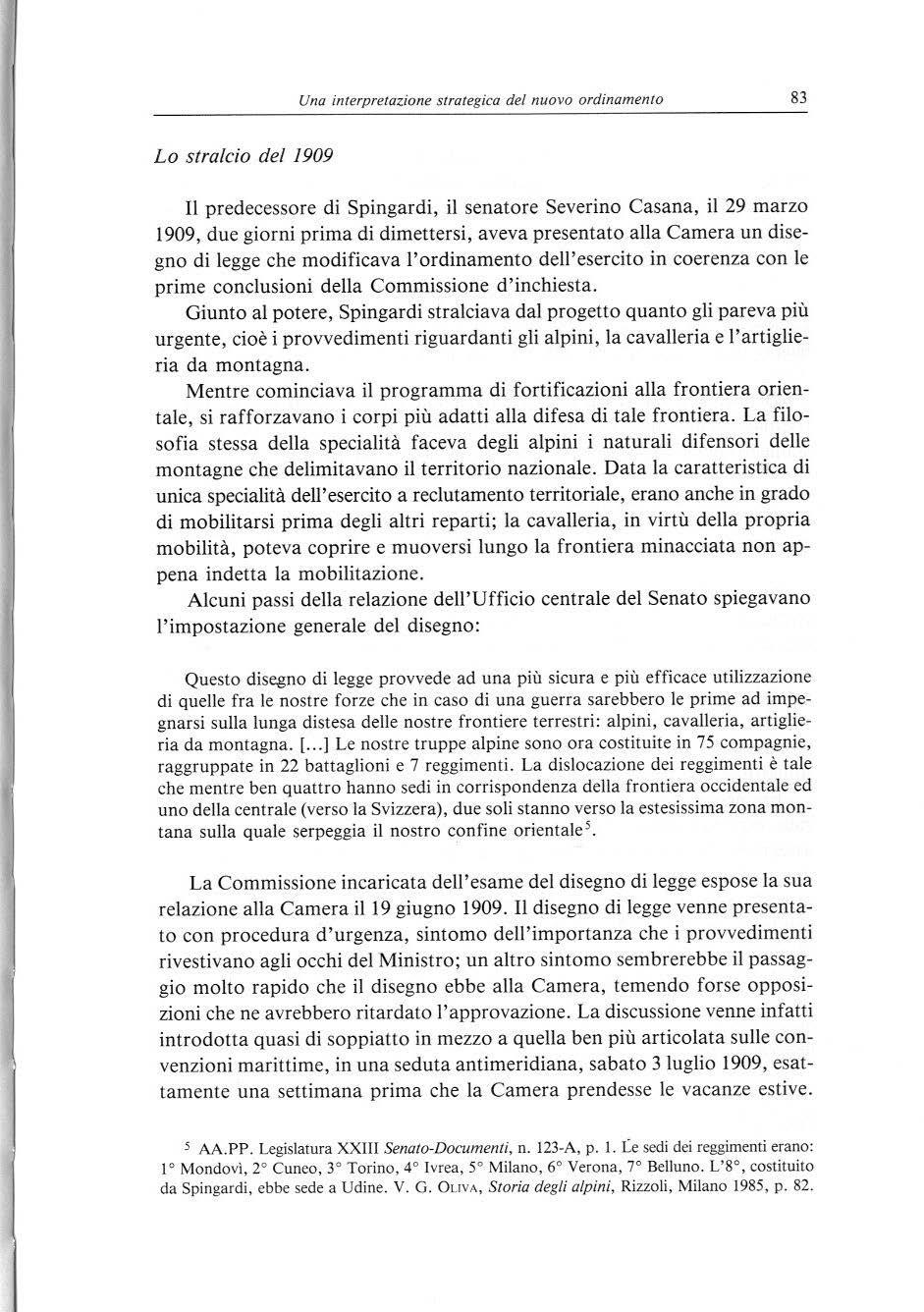
Questo disegno di legge provvede ad una più sicura e più efficace utilizzazione di quelle fra le nostre forze che in caso di una guerra sa rebbero le prime ad impegnarsi sulla lunga distesa delle nost re frontiere terrestri : alpini, cavaller ia, artiglieria da montagna. [...] Le nostre trupp e alpine sono ora costituite in 75 compagn ie, raggruppate in 22 ba ttag lioni e 7 reggimenti. La dislocazione dei reggimenti è tale che mentre ben quattro hanno sed i in corrispondenza della frontiera occidentale ed uno della centrale (verso la Svizzera), due soli stanno verso la estesissima zona montana sulla quale serp eggia il nostro co nfine orientale 5 •
La Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge espose la sua relazione alla Camera il 19 giugno 1909. Il disegno di legge venne presentato con procedura d'urgenza, sintomo d ell' importanza che i provvedimenti rivestivano agli occhi del Ministro; un altro sintomo sembrerebbe il passaggio molto rapido che il di segno ebbe alla Camera, temendo forse opposizioni che ne avrebbero ritardato l'approvazione. La discuss ione venne infatti introdotta quasi di so ppiatto in mezzo a quella ben più articolata sulle convenzioni marittime, in una seduta antimeridiana, sabato 3 luglio 1909, esattamente una settimana pr ima che la Camera prendesse le vacanze estive.
5 AA.PP. Legislatura XXIII Senato-Documenti, n. 123-A, p. 1. Le sed i dei reggimenti erano: 1° Mondovì, 2° Cuneo, 3° Torino, 4 ° Ivrea, 5° Milano, 6 ° Verona , 7° Belluno. L ' 8 ° , costitu ito da Spingardi, ebbe sede a Udine V G. OuvA,
Una interpretazione strategica del nuovo ordinamento 83
Storia degli alpini, Rizzoli, Milano 1985, p. 82
In un 'a ula semivuota, ne ss uno intervenne, né in genera le, né nella discussione s ugli articoli. Nel pomeriggio dello stesso 3 luglio , in una seconda tornata , il testo d e l disegno venne appro vato con 208 voti favorevoli e 45 contrari e immediatamente presentato al Senato 6 •
Qui, il 3 luglio appunto, Spingardi spiegava di voler
lasciare immutato, nella sua ossatura generale, l'ordinamento delle nostre forze annate , già rispondente in massima alle suprem e necessità del paese, evitando così ogni crisi, sempre funesta al progressivo e sicuro sviluppo della nostra potenzialità militare 7 •
D i fronte a una situazione internazionale non del tutto serena, non si rischiava di impiantare un nuovo ordinamento con il lungo periodo di assestamento delle nuove st rutture che ciò avrebbe implicato.
A costo anche di sacrificare personali convincimenti sul migliore assetto ideal e dell'esercito nostro, nessuno sconvolgimento si vuol portare al suo ordinamento, reso ormai tradizionale da una quasi trente nnale esistenza 8 •
Per gli alpini l'aumento effettivo consisteva in tre so le compagnie, distribuite però tra 26 battaglioni anziché 22, aJlo scopo di « migliorare la ripartizione di que sti sulla lun ga distesa della frontiera montuosa, ed ottenere così maggiore elasticità e prontezza di impiego» 9 • I reggimenti aumentavano da sette a otto.
Per la cavalleria il discor so era più complesso. La forza dell'arma sarebbe pas sa ta da 144 a 145 squadroni, con un aumento numerico di un solo squadrone.
Era però pre visto che, per l'esplicazione dei se rvizi di ricognizione avanzata, esplo razion e e copertura, ogni co rpo d'armata ave ss e organicamente assegnato un reggimento di cavalleria. Nel 1909 esistevano 24 reggimenti di cavaJJeria, tutti a sei sq uadroni. Tolti i 12 da assegnare ai corpi d ' armata, i 12 rimanenti non erano giudicati sufficienti a formare le divi sioni indipendenti, c he p er prime avrebbero dovuto a cco rrere aJla frontiera in caso di guerra, e la riserva a disposizione del comando su pr e mo.
P erc iò Spiogardi riten ev a fosse nece ssario
disporre di un maggior num ero di reggiment i da assegnare alle divisioni di cavalleria indipendenti, senza ridurre quelli che conviene lasciare colle grandi unità dell'esercito.
6 V. AA.PP. Legislatura XXIII Camera - Discussioni, 1• e 2• tornata di s abato 3 luglio 1909, pp. 3547 e 3594.
7 AA.PP. Leg. XXIII Senato - Documenti, n. 123, p. I.
8 Ibidem, n 324, p. 2
9 I bidem, n. 123 , p. 2.
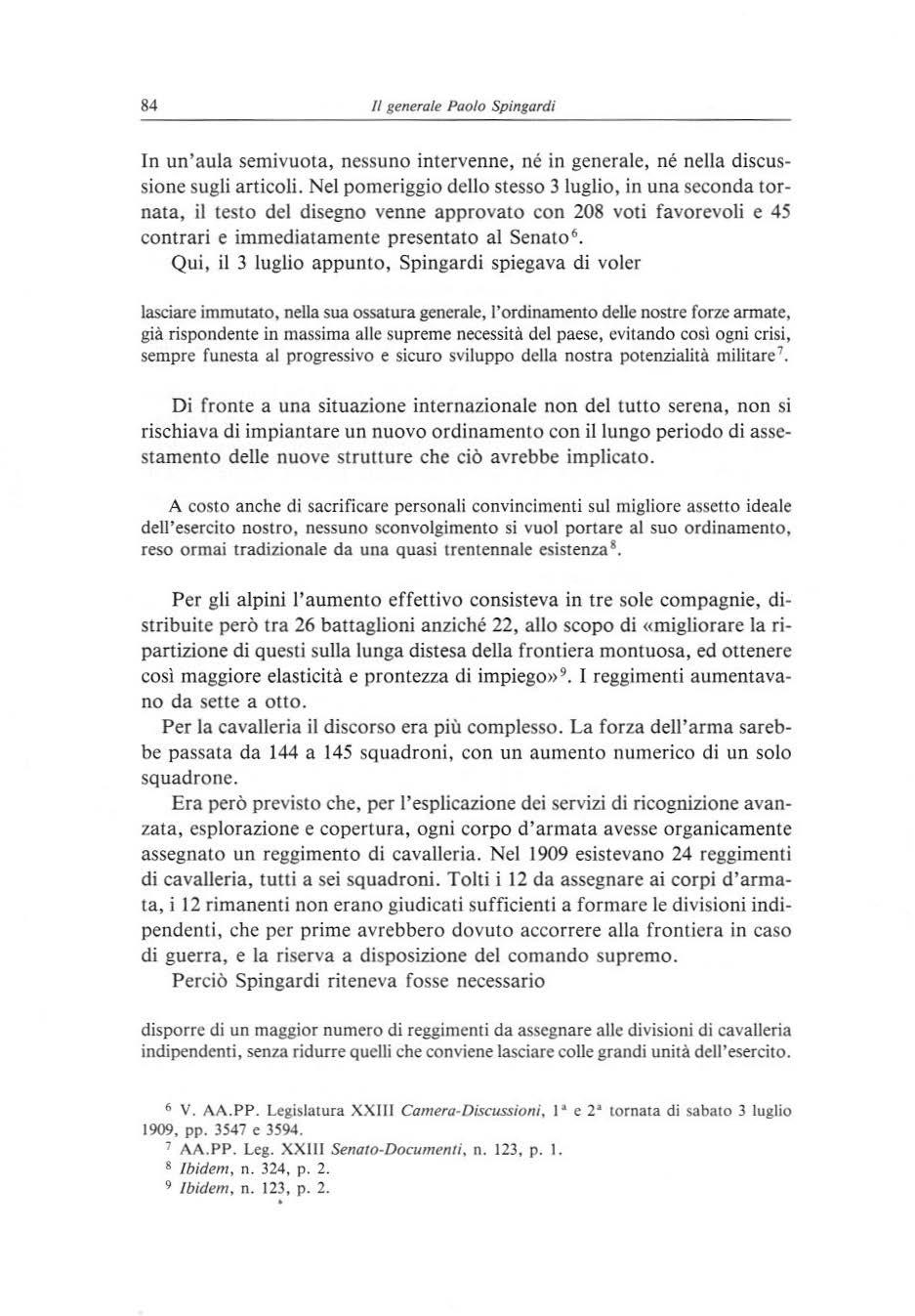
84
Il generale Paolo Spingardi
Ciò si è potuto ottenere ri d ucendo il numero degli sq uadroni che compo ngono il regg im ento, formando così, coll'aggiunta di un solo squadrone, cinque nuovi reggimenti 10 •
Come correttamente disse Marco Di Saluzzo nella relazione alla Camera, l'aumento dei cinque reggimenti di cavalleria portato dal disegno di legge costi tui va una vantaggiosa soluzione
del seguente important e problema: fermo rimanendo, o quasi, il numero totale deg li squa droni di cui disponiamo, aver modo di costituire adeguatamente le grandi unità ind ipendenti di cavalleria, quelle, cioè destinate a coprire la fron t ie ra in caso di mobilitazione 11
In Senato si ebbero pareri contrastanti sul nuovo ordinamento della cavalleria, pareri rivelatori loro malgrado del concetto sottinteso dal disegno di legge.
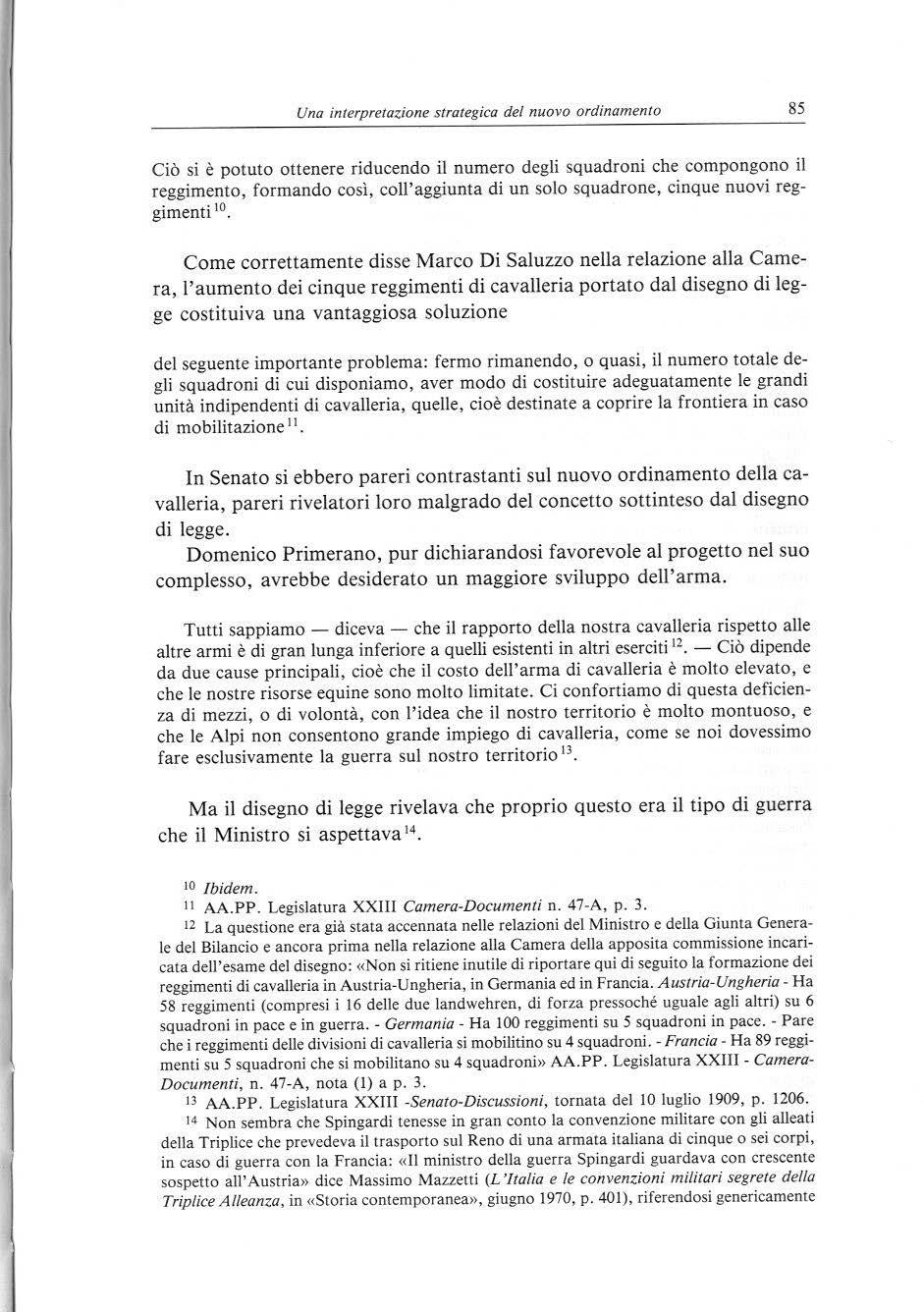
Dom e nico Primerano, pur dichiarandosi favorevole al progetto nel suo complesso, avrebbe desiderato un maggiore sviluppo dell'arma .
Tutti sappiamo - diceva - che il rapporto della nostra cavalleria rispetto alle altre armi è di gran lunga inferiore a quelli esistenti in altri eserciti 12 • - Ciò dipende da due cause principali, cioè che il costo dell'arma di cavalleria è molto elevato, e che le nos t re risorse equ ine sono molto limita te. Ci co nfortiamo di questa deficienza di mezzi, o di volontà, con l'idea che il nostro territorio è molto montuoso, e che le Alpi non consentono grande impiego di cavalleria, come se noi dovessimo fare esclusivamente la guerra sul nostro territorio 13
Ma il di segno di legg e rivelava che proprio questo era il tipo di guerra che il Ministro si aspettava 14 •
IO Ibidem.
11 AA.PP. Legislat ura XXIII Camera-Documenti n. 47 -A, p. 3 .
12 La questione era già stata accennata nelle relazioni del Ministro e della Giunta Generale del Bilancio e ancora prima nella relazione alla Camera della apposita commissione incaricata dell'esame del d isegno: «Non si ritiene inutile di riportare qui di segu i to la formazione dei reggimenti di cavalleria in Austr ia - Ungheria, in Germania ed in Francia. Austria-Ungheria - Ha 58 reggimenti (compresi i 16 delle due landwehren, di forza pressoché uguale agli altri) su 6 squadroni in pace e in guerra - Germania - H a 100 reggimenti su 5 squadroni in pace. - Pare che i reggimenti delle d iv isioni di cavalleria si mobilitino su 4 squadroni. - Francia - Ha 89 reggimenti su 5 squadron i che si mobili tano su 4 squadroni» AA.PP. Legislatura XXIII - CameraDocumenti, n. 47 -A, nota (1) a p. 3.
13 AA.PP. Legis latura XXIII -Senato-Discussioni, tornata del 10 luglio 1909, p. 1206
14 Non sembra che Spingardi tenesse in gran conto la convenzione militare con g li alleati della T riplice che prevedeva il trasporto sul Reno di una a r mata italiana di cinque o sei corpi, in caso di guerra con la Francia: «Il ministro della guerra Spingardi guardava con crescente sospetto a ll 'Austria>> dice Massimo Mazzett i (L'Italia e le convenzioni mili1ari segrete della Triplice Alleanza, in «Storia contemporanea>\ giugno 1970, p. 401), riferendosi genericamente
Una interpretazione
strategica del nuovo ordinamento 85
Spingardi
Il generale Ett ore Pedotti, relatore dell'Ufficio centrale del Senato, difese invece le proporzioni della cavalleria previste dal disegno di legge, confe rmandone l'orientamento sostanzialmente difensivo. Egli si rifece all 'autorità di Napoleone, il quale aveva detto che in Italia «la cavalleria conveniva fosse tenuta nei più stretti limiti possibili, e assegnava delle proporzioni che non differiscono gran fatto da quelle che effettivamente noi oggi abbiamo». Pedotti rimarcava il concetto che
se anche la fortuna ci assistesse e per una guerra qualsiasi noi potessimo varcare le frontiere, è sempre da tener presente come la zona alpina che circonda l'Italia sia molto profonda, e al di qua e ancora più al di là della linea di confine, a talché prima che l' esercito nostro potesse uscire nelle pianure dove l'arma di cavalleria è più utilmente impiegabile, assai ci vorrebbe 15 •
Si noti come si parlasse di «fortuna» e solo di possibilità di uscire dai confini. A Pedott i non veniva neanche in mente che si potesse agire offensivamente al di là dei confini nazionali; si intuisce semmai una concezione difensiva-controffensiva. N on sembra davvero un caso che contemporaneamente a queste discussioni parlamentari lo Stato Mag giore elaborasse un piano di g uerra che prevedeva una mobilitazione di 24 giorni con schieramento final e dell'esercito lungo il corso del Pi ave 16 •
al periodo anteriore al 1912, ma ci sembra il giudizio si adatti perfettamente allo spirito che informava il disegno di legge in esame. Nel dicembre 1908 l'ambasciatore tedesco a Roma «riferiva che il s uo collega austriaco temeva che non si potesse più contare sull'appoggio dell'Italia in caso d i complicazioni europee» (M. MAZZETTI, L'esercito italiano nella triplice alleanza, ci t. p. 239). Nei primi mesi del 1909 vi fu rono intense comunicazioni fra i capi di S.M. tedesco e austroungarico, Von Moltke e Conrad. «Nel corso d i questi contatti ( 1von Moltke aveva affermato che l'esercito i taliano non era in grado di compiere un'aggressione» (ibidem p. 240). Eppure, o forse proprio per questo, <<il 2 lugli o 1909 il volitivo Capo di Stato Maggiore austro-ungarico ripropose, in un memoriale ad Aehrental, la guerra preventiva contro l'Italia» (ibidem). Insomma, gli elementi per temere l 'Austria erano molti e concreti. Ma anche in periodi di non perfetto idillio con la Francia, circa la convenzione mili tare con la Ger mania Spingardi scriveva a Brusati: «Per conto m io contrario all'armata, anche se ridotta, dubito anche della utile efficienza di 40 sq uadroni, e quindi della utilità militare del loro invio di fronte alla impressione politica nel nostro paese» (ACS Archivio Brusati, se. 10 , f. VI.5.37, Sp ingardi a Brusati, lettera datata 15 ottobre (1913)).
15 AA.PP. Legis lat ura XXIII - Senato-Discussioni tornata del IO luglio 1909 , p. 1208 Ettore Pedo tti (1842-1919), volontario garibaldino nel 1859 e 1860, passò poi nell'esercito italiano. Prese parte alla campagna del 1866. Frequentata l a Scuola di Guerra passò nello Stato Maggiore. Come colonnello comandò il 46° Reggimento fanteria; da maggior generale la Brigata Forlì e la scuol a di Guerra. Da ten ente generale fu dapprima comandante in seco nda del corpo di Stato Maggiore, poi comandante della Divisione m ilitare territoriale di Roma e dell'XI e X Corpo d'Armata, finché nel novembre 1903 fu nominato Ministro della Guerra, tenendo l'incar i co fino al dicembre 1905 e nominando l'allora maggior generale Paolo Spingardi quale sottosegreta rio. Passò poi a comandare il I e infine i l IV Corpo d'armata fino al 1910, anno in cui lasciò il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Nel I 903 era stato nominato senatore.
V. J. GOOCH, Army, State and Society, cit., pp. 136-137 Cfr. MAZZETTI,/ piani di guerra contro l'Austria, cit., p. 174.
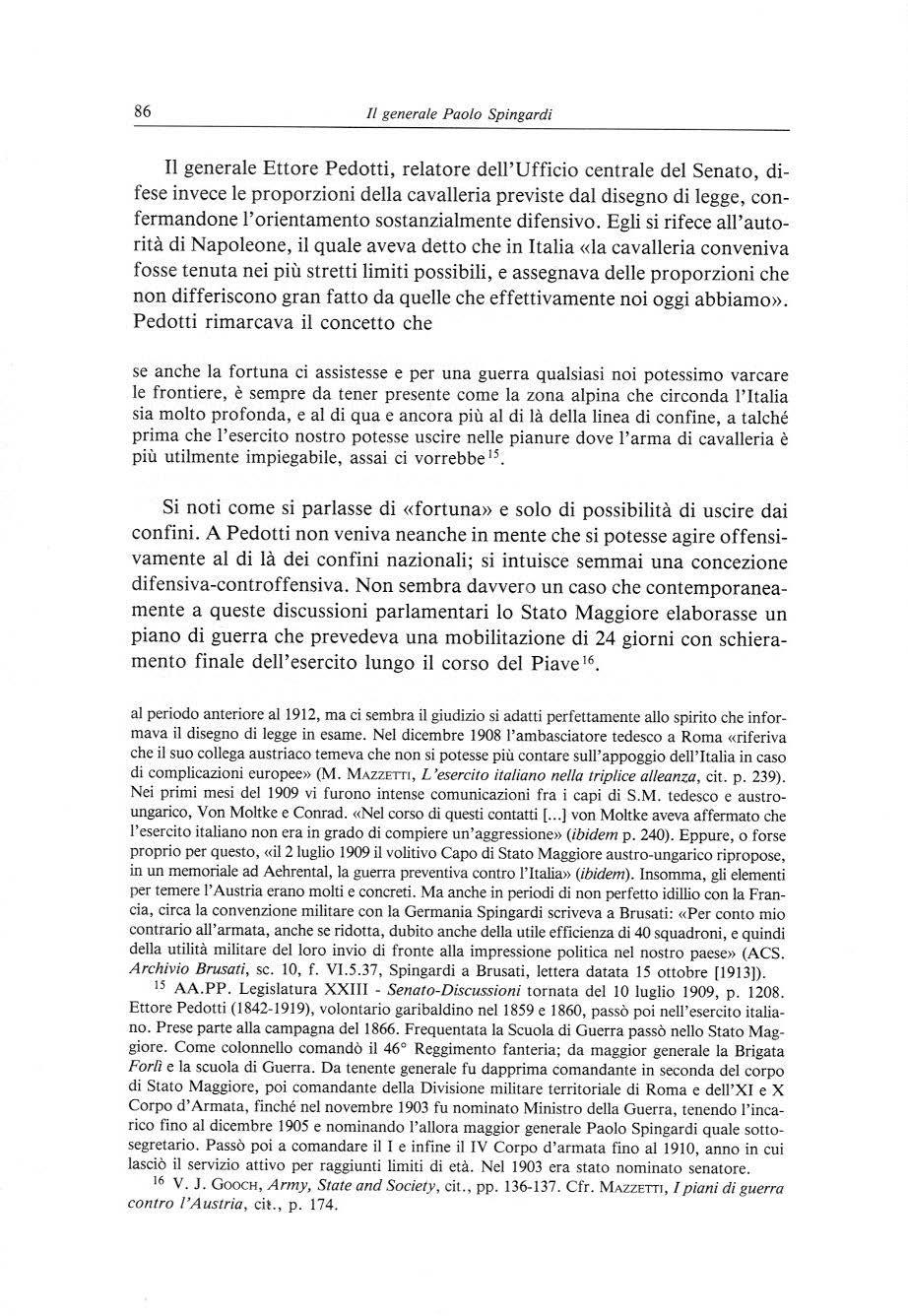
86
li generale Paolo
16
L'artiglieria da montagna subiva un aumento più consistente che non la cavalleria o gli alpini. Secondo Spingardi l'artiglieria da montagna doveva avere «u n conveniente sviluppo, perché, in qualsiasi ipotesi di guerra, una considerevole parte dell'esercito [avrebbe dovuto] operare in regioni di scarsa o difficile viabi li tà» 17 •
L'Ufficio centrale del Senato si trovava perfettamente d'accordo col Ministro 18 •
Dove il disegno di legge è assolutamente provvido - diceva la relazione, presentat a da Pedotti 1'8 lu glio 1909 - è in quanto ripara a una reale deficienza della quale abbiamo sin qui sofferto - quella della scarsa quantità dell'artiglieria da montagna. Ne abbiamo 15 sole batterie, di cui 12 costituite in reggimento, dis locato a Torino presso la frontie ra occidentale, e 3 forma nti una brigata ne l Veneto . - So no in numero assolutamente insufficiente rispetto alla grande distesa delle nostre frontiere montane nonché alla quantità delle forze che, i nd ip endentemente dalle truppe alpine, dovrebbero concorrere alla loro immediata difesa. Sono del tutto insufficient i, chi consideri la necessità nella qua le ci troveremmo di dover fare di quelle zone montane la più tenace difesa e se condotti ad operare oltre confine la lunga durata della lotta da sos te ner si sempre dentro i monti: e chi consideri ad un tempo, che di fronte alla prevalente importanza che l'artiglieria va assumendo nei combattimenti, sta la quasi im po ssib ilità d i servirsi nelle regioni montane delle artiglierie trainat e 19 •
Il disegno di legge proponeva la creazione di nove batterie da montagna in aggiunta alle quindici esistenti, distribuendo le ventiquattro batterie risu l tanti in due reggimenti.
Lunedì 12 luglio 1909 il disegno veniva approvato dal Senato con 78 voti favorevoli e 4 contrari e diveniva la legge 15 luglio 1909 n . 473.
Riassumendo, Spingardi aveva trovato 144 squadroni di cavalleria su 24 reggimenti: 7 reggimenti alpini con 22 battaglioni e 76 compagnie; 1 reggimento di artigl ie ria da montagna su 12 batterie più un gruppo (allora deno-
17 AA.PP. Leg XXIII - Senato-Documenti - n.123, p. 2.
18 L'Ufficio centrale era composto da tre tenenti generali (Ettore Pedotti, presidente e relatore; Felice Sismondo e Cesare T arditi) e un viceammiraglio (Felice Napoleone Canevaro , già Min istro della Marina nel giugno 1898 e Ministro degli Esteri fino al maggio 1899). L'unico borghese era Roberto Biscaretti di Ruffia (1845-1940), segretario dell ' Ufficio centrale del Senato, che in compenso era figlio di Carlo (1796 -1 889), uno dei più prestigiosi generali del Regno di Sardegna, membro della casa mil itare de l Re, e padre di Guido (1867-?), amm iraglio della Marina militare italiana, ferito e decorato durante la guerra italoturca. Ingegnere, promotore dell'Automobil Club d'Italia nel 1898 , tra i fondatori della FIAT nel 1899, Roberto Biscaretti dei conti di Ruffia apparteneva ad una delle più antiche casate piemontesi e fu sempre strettamente legato alla monarchia e agli ambienti di corte. Per magg iori informazioni sul personaggio v Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Encicloped ia italiana. voi. X, Roma, 1968, pp. 657 - 658.
19 AA.PP . Leg. XXlll - Senato -D ocumenti - n . 123-A , p. 2.
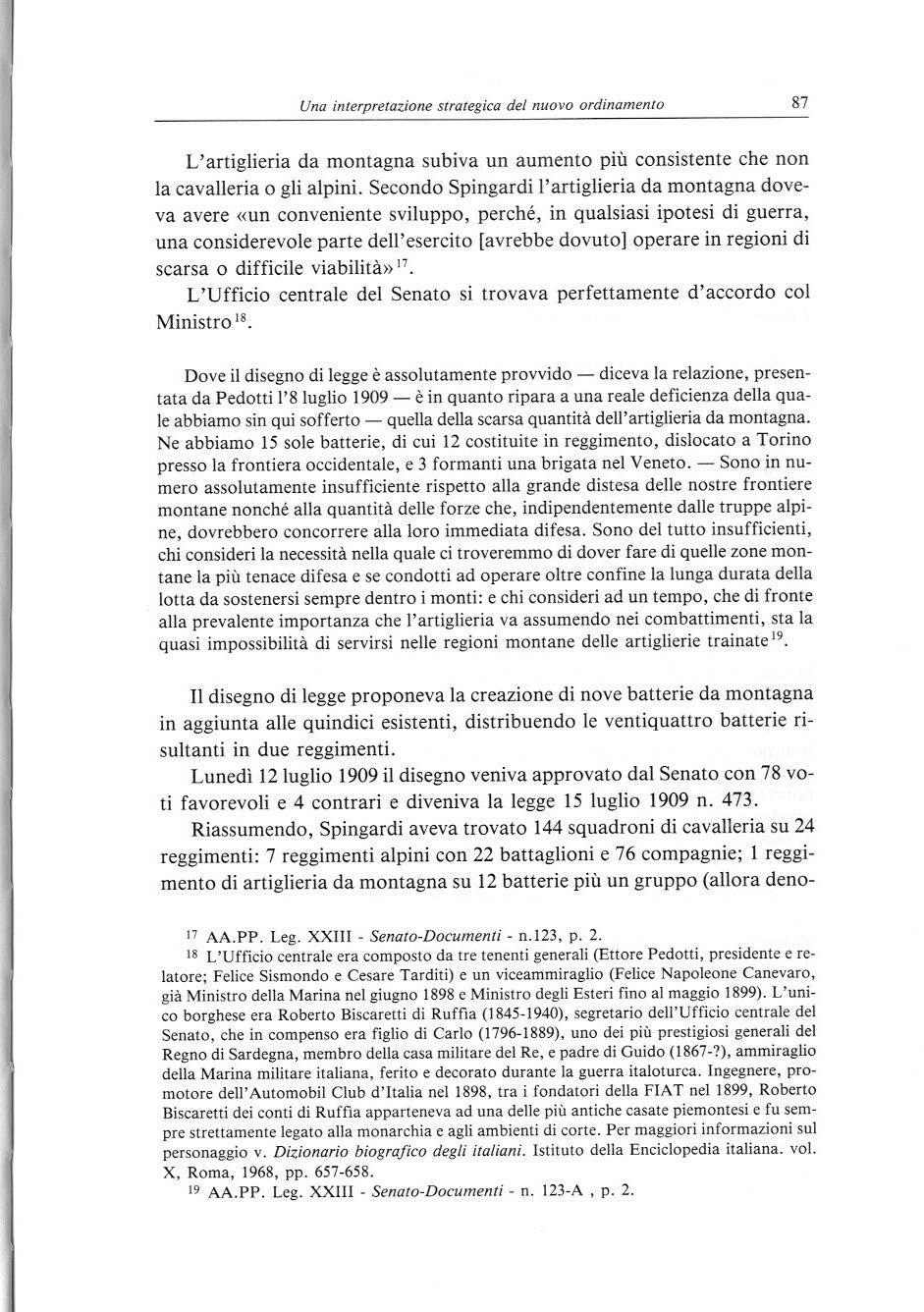
Una interpretazione strategica del nuovo ordinamento 87
minato brigata) autonomo di tre batterie; e aumentava il tutto rispettivamente a 145 sq uadroni distribuiti in 29 reggimenti a cinque anziché sei squadroni; 8 reggime n ti con 26 battaglioni e 78 compagnie; 2 reggimenti con 24 batterie.
La legge fondamentale del 1910
Nella seduta dell' 11 febbraio 19 10 Spingardi presentava alla Camera il progetto completo di modificazioni all'ordinamento, anch'esso con procedura d'urgenza.
Egli sapeva che, per poter passare quanto prima alla pratica attuazione dei provvedimenti, era necessario arrivare più veloce mente possibile all'approvazione, come gli ricordava il Capo di Stato Maggiore l' I I marzo:
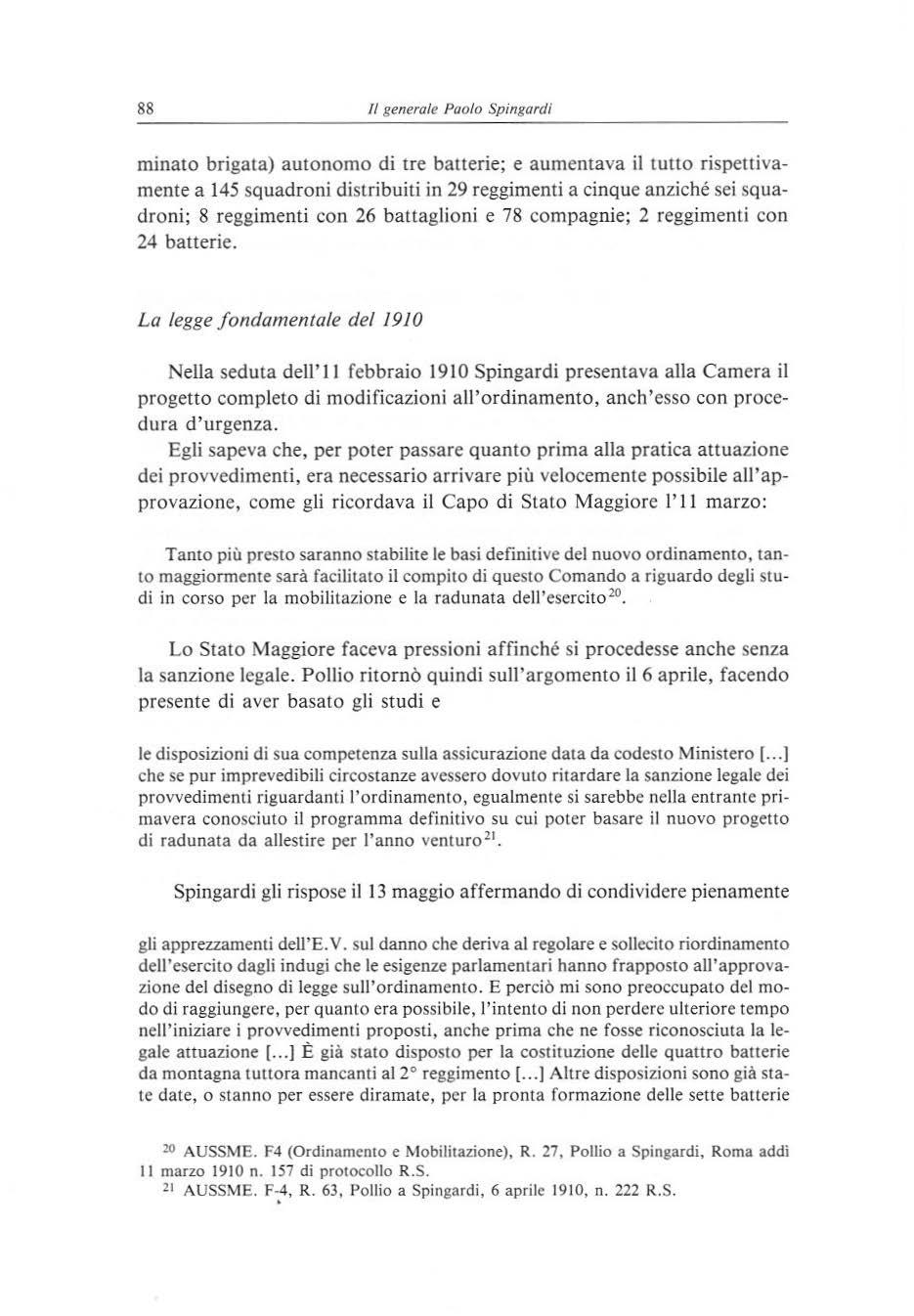
Tanto più presto saranno stabilite le basi definitive del nuovo ordina ment o, tanto maggiormente sarà facilitato il compito di questo Comando a riguardo degli studi in corso per la mobilita zione e la radunata de ll 'eserci to 20 •
Lo Stato Maggiore faceva pressioni affinché si procedesse anch e senza la sanz ion e legale. Pollio ritornò quindi sull'argomento il 6 aprile, facendo presente di aver basato g li studi e
le disposizioni di sua competenza sulla assicurazione data da codesto Ministero[ ] che se pur imprevedibili circostanze avessero dovuto ritardare la sanzione legale dei provved im enti riguardanti l'ordinamento, egualmente si sarebbe nella entrante pr imavera conosciuto il programma definitivo su cui poter basare il nuovo progetto di radunata da allestire per l'anno venturo 21
Spingardi gli rispos e il 13 maggio affermando di condividere pienamente
gli apprezzamenti dell'E. V. sul danno che deriva al regolare e solJecito riordinamento dell'esercito dagli indugi che le esigenze parlamentari hanno frapposto all'approvazio ne del disegno di legge sull'ordinam ento E perciò mi sono preoccupato del modo di raggiungere, per quanto e r a pos sibile, l'intento di non perdere ulteriore tempo nell'iniziare i provvedimenti proposti, anche prima che ne fosse riconosciuta la legale attuazione [ ... ] È già stato disposto per la costituzione delle quattro batterie da montagna tuttora mancanti al 2° reggimento[ ) Altre disposizioni sono già state date, o stanno per essere diramate, per la pronta formazione delle sette batterie
20 AUSSME. F4 (Ordinamcmo e Mobilitazione), R. 27, Pollio a Spingardi, Roma addi
11 marzo 1910 n. 157 di protocollo R.S.
21 AUSSME. F-.4 , R. 63, Pollio a Spingardi, 6 aprile 1910, n. 222 R.S.
88 li
genera l e Paolo Spingardi
da campagna presso i reggimenti 2 ° , 4 ° , 5° , 6 ° , 9 ° , 10° e 11 ° ( ... J Per l'artiglieria da fortezza sono pure state ordinate le necessarie indagini per conoscere quali locali sono fin d'ora disponibili per le nu ove unità da cost ituire ( ... ] si ha g ià alle arm i la forza necessaria perché le nuove unità possano subito raggiungere l'organico normale [ ... ] on riterrei opportuno ricorrere a decreti legge, i quali (... ] potrebbero s uscitare non buona impressione nell'ambiente parlamentare ora specialmente che la Commissione all'uopo nominata ha già iniziato l'esame del disegno di legge sull'ordinamento, e dà adito a sperare che il disegno di legge stesso possa assai presto essere portato alla pubblica discussione 22 •
Le vicende parlamentari avevano però messo la Commissione in una situazione non agevole, come efficacemente ricordava Di Sa luzzo nella relazion e presentata alla Camera il I O giugno 1910:
Le vicende parlamentari di quest'anno, diminuendo il tempo alla vostra Commissione per il doveroso e profondo esame del disegno di legge, hanno pure assottigliato e di molto quello che, dopo tale necessario esame, occorreva ancora al relatore per compiere la sua opera. Non sarà inutile, a chiarire quest'affermazione, che si indichi qui, sia pur brevemente, la storia del presente disegno di legge li quale fu presentato al Parlamento dal mini stro Casana nel principio dell'anno scorso (seduta del 29 marzo). Subentrato alla direzione del dicastero della guerra il generale Spingardi, ebbe questi a dichiarare che non lo avrebbe già ritirato, ma gli avrebbe solamente apportato degli emendamenti; onde la vostra Commissione dovette sospenderne l 'esame Ma, nelle ultime sedute dell'anno scorso, se ne stralciava dall'onorevole Spin gardi una parte: e questa concerne nt e gli alp ini e la cava ll eria - veniva presentata alla vostra approvazione e poteva essere quasi immediatamente tradotta in legge ed attuata (Legge 15 luglio 1909 n.473). el febbraio del corrente anno il ministro Spingardi presentava a sua volta gli annunziati emendamenti; li presentava, cioè, non appena si era riaperta la Camera, dopo la lun ga sosta che precedette la presentazione al Parlamento del Ministero Sonnino. La vostra Commissione iniziava allora l'esame di tali emendamenti, in confronto dell'attuale ordinamento e del progetto iniziale del ministro Casana: senonché la nuova crisi ministeriale veniva un'altra volta ad interrompere le riunioni della Commissione, le quali non furono riprese, se non col riaprirsi della Ca me r a, in seguito all'avvento al potere del Ministero Luzzatt i. Attraverso a tali vicende un progetto di legge, della mole e dell'importanza di questo, non poteva non sentire la necessaria iattura del tempo. Che se la permanenza dell'onorevole Spingardi al dicastero della guerra ha consentito una continuità d'indirizzo e la ripresa d'uno studio già due volte iniziato, e se la Commissione ha supplito alla ristrettezza del tempo, che per ineluttabilità di circostanze le veniva assegnato, con la frequenza e la durata delle sedute, così che essa ha la sicura coscienza di avere esaminato con cuna ponderazione e in ogni s ua parte il complesso disegno di legge, non può tuttavia non influire il danno dell'urgenza su questa relazione, a cui manca il tempo e l'agio di trattare con la dovuta ampiezza i singoli argomenti 23 •
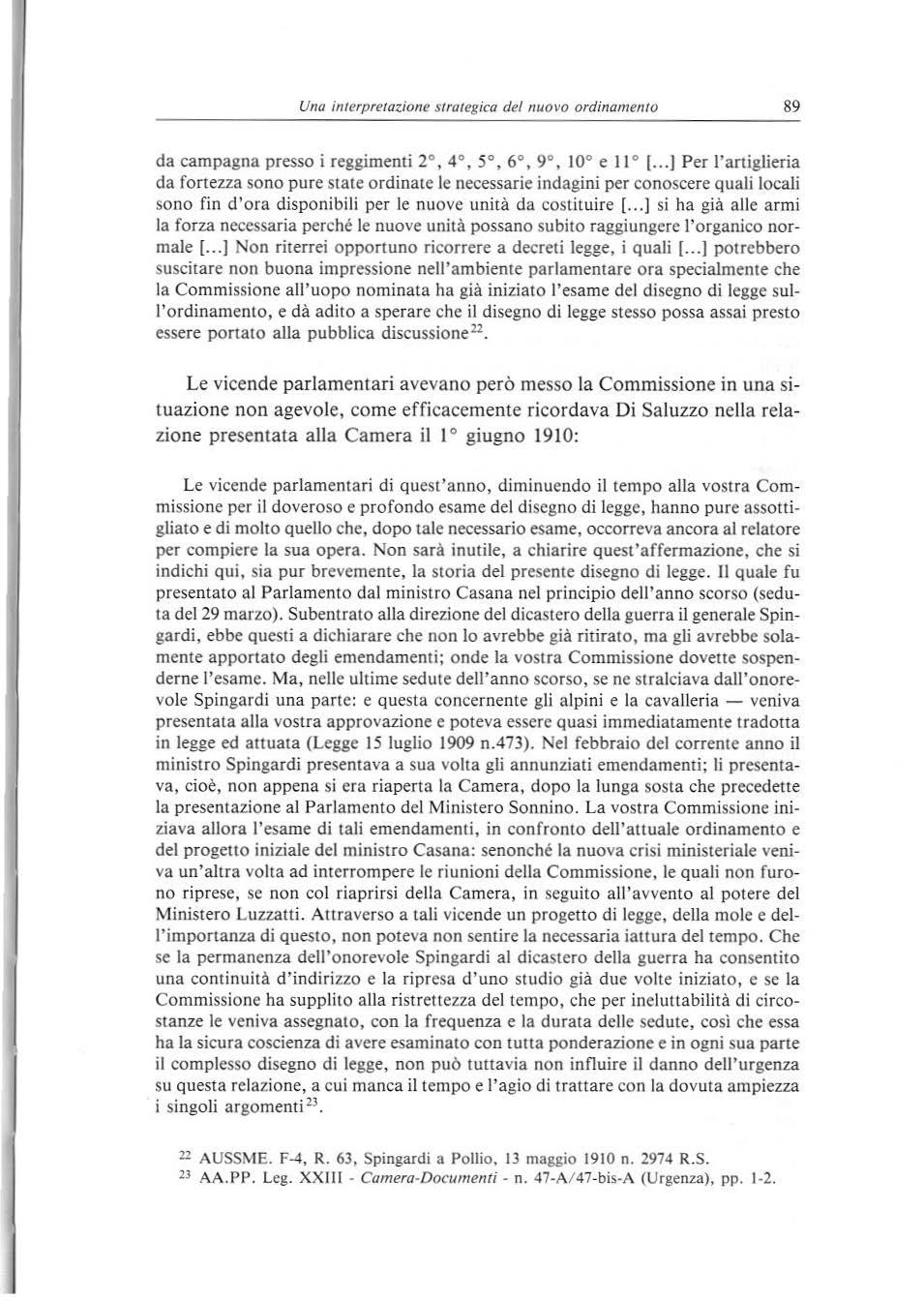
Una inle rpretazione s1rategica del nuovo ordinamen10 89
22 AUSSME. F-4, R. 63, Spingardi a Pollio, 13 maggio 1910 n. 2974 R S 2 3 AA.PP. Lcg. XXJII Camera -Documenti - n. 47-A / 47 - bis-A (Urgenza), pp. 1-2.
Il generale Paolo Spingardi
Se pure il disegno di legge non ebbe quindi un esame adeguato alla sua importanza, anche indipendentemente dalla volontà del Ministro di accellerare i tempi, le circostanze consentirono a Spingardi di accontentare il Capo di S . M. senza scavalcare l'autorità del Parlamento.
Ad ogni modo, per ridurre ulteriormente i tempi, egli fece porre il dibattito alla Camera all'ultimo posto nell'ordine del giorno di una straordinaria seduta domenicale, il 26 giugno 1910. Non solo: non essendosi potuto concludere il dibattito, inaspettatamente, in chiusura di seduta, alle ore 19.50, al fine di «esaurire la discuss ione dei disegni di legge concernenti il Ministero della Guerra», Spingardi chiese all'assemblea una seduta antimeridiana per le ore 9 del giorno seguente 24 •
La massima velocità fu dunque la caratteristica principale dell'iter parlamentare del progetto. Un simile atteggiamento non sembrerebbe derivare da scarso rispetto o malafede nei confronti della legale rappresentanza nazionale, ma dalla necessità riconosc iuta di far presto.
Si pensava anche non fosse il caso di oberar e la Camera d i lavoro sui particolari tecnici del progetto, degni di essere lasciati alla competenza dei militari. Se ne ricava forse un indizio nello stupo r e col quale Spingardi accolse le precise osse r vazioni tecniche del «profano» deputato Ca r boni: «L'onorevole Carboni ha trattato la questione delle batterie su sei o su quattro pezzi, e non vi nascondo che mi ha sorpreso la competenza con la quale egli, avvocato, credo, ne ha discusso qui» 25 •
Comunque anche al di fuori deg li amb ienti militari si comprendeva il bisogno di accelerare i tempi, tanto che il Presidente della Camera, il radicale Giuseppe Marcora, intervenne a sollecitare i deputati:
Se mi si consente di esprimere il mio pensiero, non tanto come Presidente della Camera, quanto come cittadino, dirò che desidero ardentemente che la discussione proceda nel modo più rapido: in modo che questo disegno di legge possa essere approvato prima che si prendano le vacanze: perché altrimenti si ritarderebbe, forse per un anno intero, la sua esecuzione (Approvazioni). Se noi lo approviamo adesso, anche se, per modificazioni introdottevi dal Senato, dovesse tornare alla Camera,
24 AA PP Leg. XXIII - Camera-Discussioni - tornata del 26 giugno 1910, p. 9136; Spingardi parla di «disegni>> perché anche il disegno di legge sulla ferma biennale si discusse in quei giorni, e a coroll ario della legge sull'ordinamento si discussero a l t ri progetti riguardo l'abo l izione delle masse, i personali civili tecnici di artiglieria e del Genio e un disegno riguardante l'istituzione di un corso superiore tecnico d'artiglieria, col quale in sostanza si separava la carriera tecnica dalla carriera combattente dell'arma di artiglieria allo scopo di formare degli ufficiali forniti di una altissima preparazione per la fabbricazione nostrana di bocche da fuoco . V. AA.PP. Legislatura XXTII, Camera - Discussioni, tornate del 25 , 26, 27 giugno 1910, pp. 9083 -9116, 9175 -9178.
2s Ibidem, p. ?142.
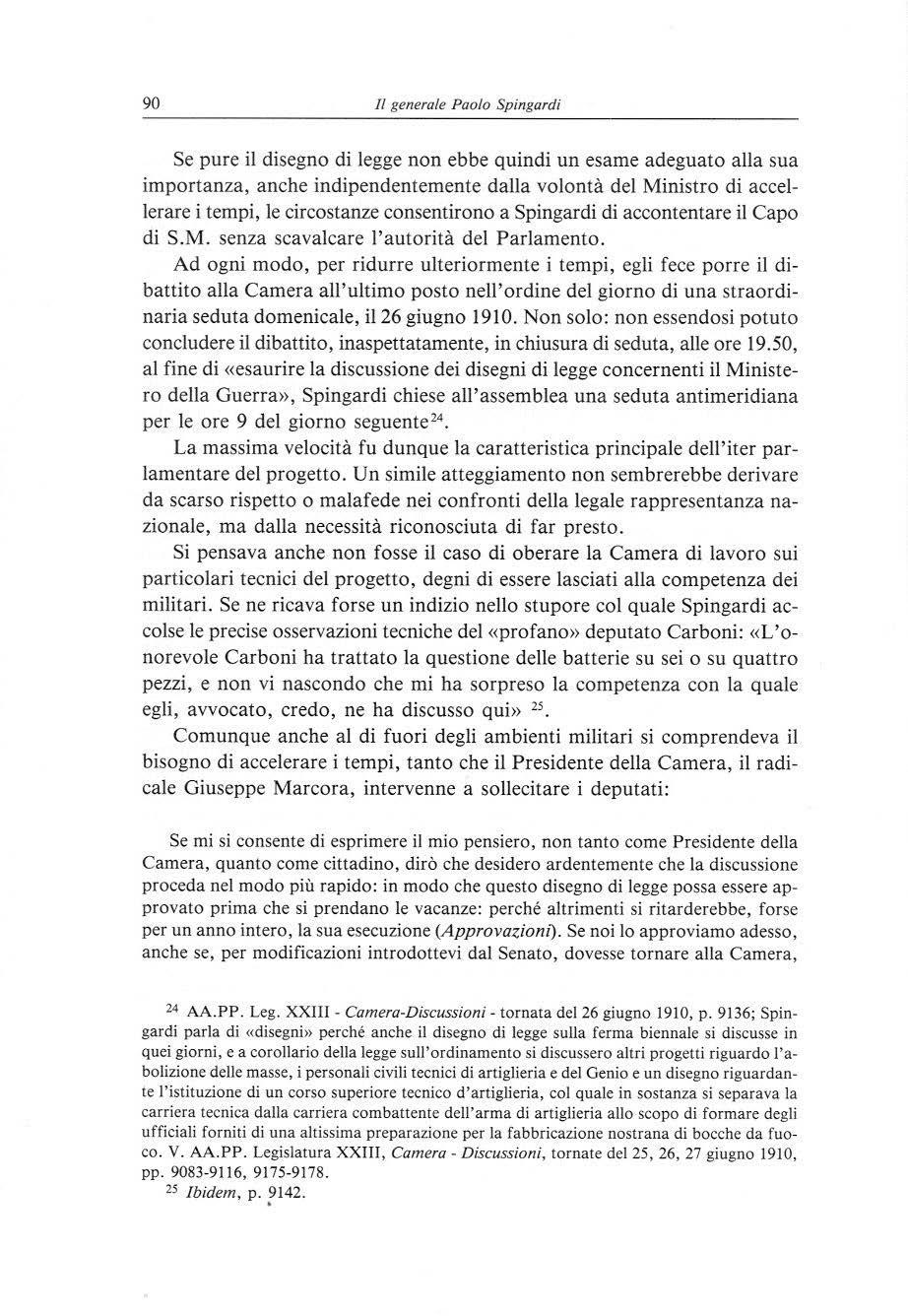
90
Una interpretazione strategica del nuovo ordinamento 91
potrebbe sempre essere tradotto in legge entro il mese di dicembre. Ma se ne rimettiamo la discussione a novembre , è probabile che si arrivi al periodo delle feste del cinquantenario senza ancora averlo approvato (Bene! Bra vo!). E sarà tan to tempo perduto per la migliore organizzazione della difesa nazionale (Vivissime approvaziom) 26 •
In verità i deputati Chimienti e Abbiate non mancarono di far timidamente notare la situazione un poco anomala, l'uno ritenendo che non si dovesse «chiamare la Camera a vot are in questa situazione, in una seduta con così scarso numero di colleghi intervenuti , [ ] in un argomento di tanta importanza», e all'altro non sembrando molto regolare «questa seduta antimeridiana, indetta d'improvviso ieri sera [... ]. Credo che non sia mai avvenuto, ed alcuni colleghi mi hanno manifestato la loro meraviglia» 27 , ma le loro osservazioni non ebbero seguito .
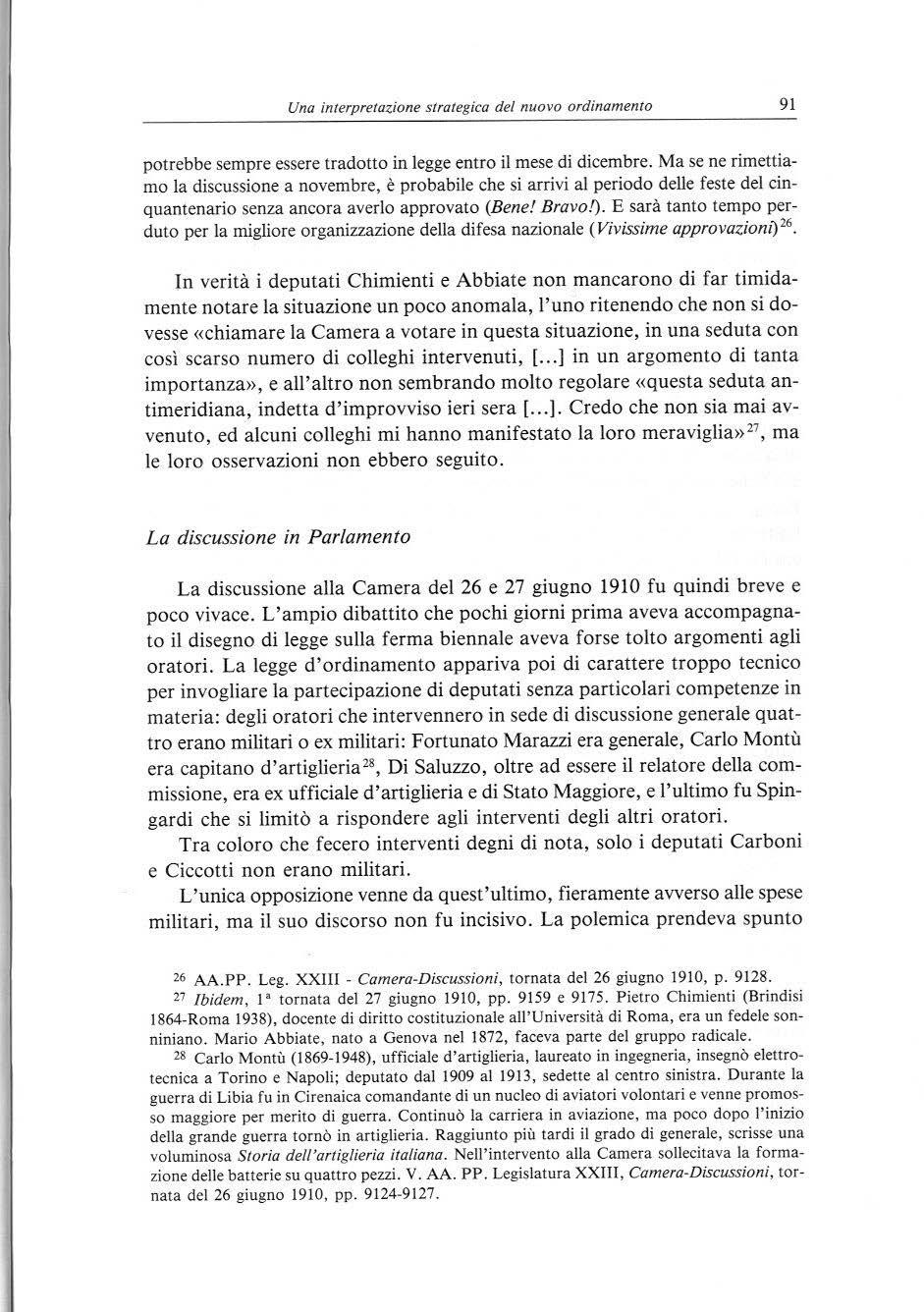
La discussione in Parlamento
La discussione alla Camera del 26 e 27 giugno 1910 fu quindi breve e poco vivace. L'ampio dibattito che pochi giorni prima aveva accompagnato il disegno di legge sulla ferma biennale aveva forse tolto argomenti agli oratori. La legge d'ordinamento appariva poi di carattere troppo tecnico per invogliare la partecipazione di deputati senza particola ri competenze in materia: degli oratori che intervennero in sede di discussione generale quattro erano militari o ex militari: Fortunato Marazzi era generale, Carlo Montù era capitano d'artiglieria 28 , Di Saluzzo, oltre ad esse re il relatore deUa commissione, era ex ufficiale d'artiglieria e di Stato Maggiore, e l'ultimo fu Spingardi che si limitò a rispondere agli interventi degli altri oratori.
Tra coloro che fecero interventi degni di nota, solo i deputati Carboni e Ciccotti non erano militari.
L'unica opposizione venne da quest'ultimo, fieramente avverso alle spese militari, ma il suo discorso non fu incisivo . La polemica prendeva spunto
26 AA PP. Leg. XXIII - Camera-Discussioni , tornata del 26 giugno 19 10, p. 9128.
21 Ibidem, P tornata del 27 giugno 1910, pp. 9159 e 9175. Pietro Chimienti (Brindisi 1864-R om a 1938), docente di diritto costituzi onale all'Università di Roma, era un fedele sonn iniano. Mario Abbiate , nato a Genova nel 1872, faceva parte del gruppo radicale.
28 Carlo Montù (1869-1948), ufficiale d'artiglieria, lau r eato in ingegneria, insegnò e lettrotecnica a Torino e Napo l i; deputato dal 1909 a l 1913, sedette al centro sinistra Durante la guerra di Libia fu in Cirenaica comandante di un nucleo d i aviatori volontari e venne promosso maggiore per merito di guerra. Continuò la carriera in aviazione, ma poco dopo l'iniz i o della grande guerra tornò i n artiglieria. Raggiunto p i ù tardi il grado di generale, scrisse una voluminosa Storia dell'artiglieria italiana. Nell'intervento alla Camera sollecitava la formazione delle batterie su quattro pezzi V. AA. PP. Legis l atura XXIII, Camera-Discussioni, tornata del 26 giugno 1910, pp 9124-9127.
Il generale Paolo Spingardi
dall'aumento del bilancio della guerra di 2 milioni e trecentomila lire per l'esecuzione della legge:
Se è esatto il calcolo fatto sui cons untivi e s ulle nuove proposte, ci avviciniamo, tra guerra e marina, comprese le spese d'Africa e i carabinieri, ai 586 milioni: una spesa inso ste nibile , che assorbe gran parte di quanto dovremmo dedicare a necessità più urgenti, a tutelare il patrimonio della nostra civi lt à nazionale, il patrimonio della salute materiale, spirituale e morale del nostro popolo 2 9 •
Ma tali argomenti non scossero la maggioranza 30 •
Il generale Fortunato Marazzi, pur favorevole al progetto, rimarcò con forza i postulati del suo credo circa l'ordinamento dell'esercito, che lui avrebbe voluto in pace essere «l'immagine perfetta di quello che sarebbe in guerra» e perciò «alle penne, ag li scaffali [dovevano subentrare] le pistole ed i cannoni». Economizzare sulla parte burocratica, insomma, a beneficio della parte combattente : «Create enti di battaglia sopp rimendo enti meno indispensabili», era infatti la sua esortazione, «e l'esercito troverà la via della vittoria » 3 1 • Ai suoi occhi riusciva evidente il carattere di guerra difensiva in ambiente montano contenuto implicitamente nel disegno di legge, e non mancava di sottolinearlo .
Aumentando d'un reggimento gli alpini, organizzando i ciclisti, organizzando le batterie da montagna e altre, si accenna effettivamente a quella pugna vivace nel cuore delle Alpi, alla difesa palmo a palmo del nostro territorio di confine da me sempre volu ta. In questo io non posso se non dare a lta lode al Ministro: sacr ifichi tutto alla difesa dei nostri confini, vi accumuli le opere mura li e le idrauliche, assecondi lo spirito battagliero di quelle popolazioni che altro non domandano che cannoni e fucili, incoraggi[ ... ) l'organizzazione di tutti i corpi volontari 32 •
29 AA.PP. Leg. XXIII, Camera-Discussioni, tornata del 26 g iugno 1910, p. 9136 30 Non che Ciccotti non cogliesse nel segno sostenendo che con l'aumento di 1200 ufficiali che la legge prevedeva (1241 per l'esattezza. V RFS. Deposizioni Caporetto, p. 31), si introduceva una spesa non indifferente, e cosi aumentando i reggimenti di artiglieria. Ma dall'altro lato aveva anch e ragione Spingardi quando sosteneva che parte delle spese, come per esempio quelle per caserme e alloggiamenti vari, era coperta coi fondi stanziati con la legge del 30 giugno 1909, e che, realizzandosi gli aumenti gradatamente, le nuove spese sarebbero risultate dilui te negli esercizi successivi, e sarebbero quindi risultate meno pesanti. V. l' intervento di Ciccotti in AA.PP., cit., p. 9132-9133 e la risposta di Spingardi in ibidem, tornata del 27 giugno 1910, pp. 9142-9143. Bisogna poi notare che Ciccotti aveva espresso gli stessi concetti pochi giorni prima, nella discussione sui fondi da concedersi per la flotta aerea, e quindi potevano apparire ora fuori luogo (v . più avanti, p. 145) .
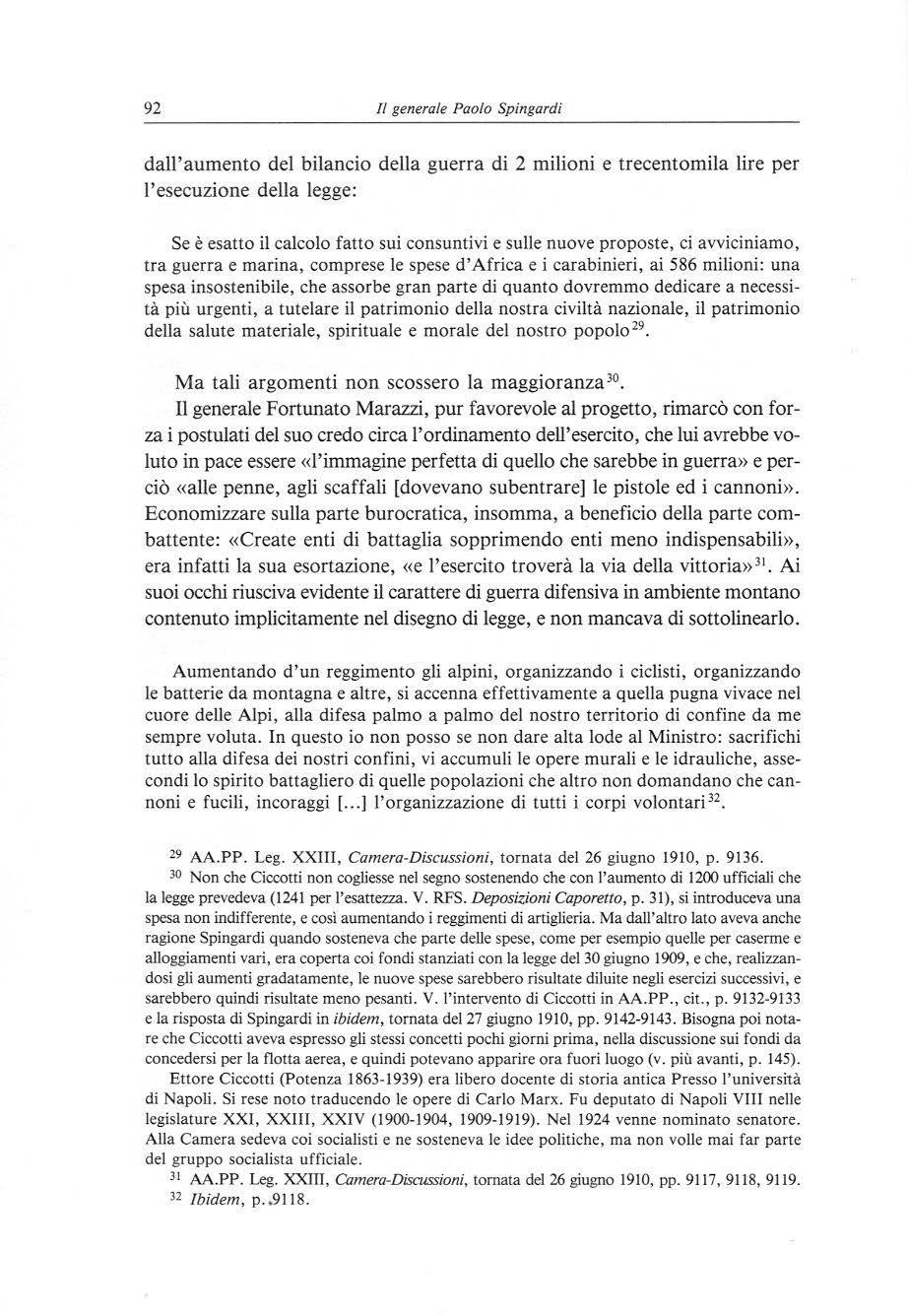
Ettore Ciccotti (Potenza 1863 -1939) era libero docente di storia antica Presso l'università di Napoli. Si rese noto traducendo le opere di C a rlo Marx. Fu deputato di Napoli VIII nelle legislature XXI, XXIII, XXIV (1900-1904, 1909-1919). Nel 1924 venne nominato senatore. Alla Camera sedeva coi social isti e ne sosteneva le idee politiche, ma non volle mai far parte del gruppo socialista ufficiale.
31 AA.PP. Leg. XXIIl, Camera-Discussioni, tornata del 26 giugno 1910, pp. 9117, 91 18, 9119.
32 Ibidem, p ,9118.
92
Il giorno dopo, lunedì 27 giugno 1910, Spingardi intervenne limitandosi a rispondere ai suddetti oratori con l'equilibrio che gli era proprio 33 • Il relatore Di Saluzzo chiuse la discussione generale con un discorso che fu una vera sintesi di storia degli ordinamenti dell'esercito italiano dalla sua costituzione fino al progetto in esame 34 • Egli concludeva l'excursus storico mettendo in rilievo un altro carattere del nuovo ordinamento:
Dunque le tappe principali [ ... ] percorse dal nostro esercito nel suo sviluppo, dal 1861 ad oggi , sarebbero : 1861, costituzione dell'esercito italiano; 1873, ord inamento Ricotti; 1882, costituzione di dodici corpi d'armata; 1887, completamento delle armi a cavallo. - Ora noi stiamo compiendo una nuova tappa di carattere evolutivo -integrativo [ ] Questa legge ripara alle deficienze dell'artiglieria e della milizia mobile. - In complesso considerata, q uesta legge non è una legge di aumento vero e proprio, è una legge di migliore assetto, come di migliore assetto era la legge dell'anno scorso concernente g li alpini e la cavaller ia 35 .
In effetti, il disegno Spingardi tendeva a riequilibrare l'ordinamento esistente, cercando di rendere l'esercito più pronto alla mobilitazione e più coperto nei settori carent i. Ma si trattava di un riequilibrio e di una copertura , come si vedrà dall'analisi dei singoli provvedimen t i, chiaramente miranti alla difesa della frontiera nord -orientale .
Corpo di Stato Maggiore
Il disegno concordato tra il Ministro e la Commissione subì un'unica rilevante modifica, relativa al Corpo di S t ato Maggiore 36 •

La questione era il riflesso di antiche polemiche sulle quali si avrà occasio ne di discorrere più oltre 37 •
33 Ibidem , l • tornata del 27 g iu gno 1910, pp. 9139 -9143 .
34 Ibidem, pp. 9144- 9145
35 Ibidem, p. 9145.
36 Per curios ità va ricord ato come venne mantenuto alla fanteria il suo nome tradizionale, che la commissione, riprendendo una id ea del progetto di Casana, propo neva di chiamare fucilieri. Osservò Spingardi tra l'approvazione generale: «Ora sul primo artico lo r ichiamo l'attenzione della Camera, avvertendo anche che la legge si discute per mio consentimento sul testo della Commissione. - In qualche punto di questo articolo il testo della Commissione differisce dal testo ministeriale specialmente in un punto [ ) dove cio è s i chiamano fucilieri i so ldat i della fanteria d i linea lo francamente non vedo la ragione per cui si debba cambiar nome alla fanteria. L 'ab biamo sempre chiamata così fino a questo momento e non c' è ragione di chiamarla fucilieri. - Voci. Ha ragione! Ha ragione!» (AA.PP. Leg. XXIII, CameraDiscussioni , 27 giugno 1910, p . 9153) . E così la fanteria mantenne il suo nome.
37 V. più avanti pp. 114-117.
Una interpretazione strategica del nuovo ordinamento 93
li generale Paolo Spingardi
A favore della proposta ministeriale, cioè per l'aboliÌione del corpo e la sua sostituzione con un semplice se rvizio di Stato Maggiore aperto a qualsiasi ufficiale che ottenesse l'apposito brevetto, si era schierato Marazzi 38 , ma già in sede di relazione Di Saluzzo si era mostrato contrario 39 , e ribadì nella discussione il suo parere : «La Commissione mantiene la sua proposta, alla quale spero che vorrà aderire anche l'onorevole ministro, di conservare cioè il Corpo di Stato Maggiore» 40 • Spingardi da parte sua si rimise al parere della Camera 4 1 , mentre il genera le Tullo Masi fece «formale proposta che [fosse] mantenuto fermo il testo proposto dalla Commissione» 42 • Ovviamente non tutti i deputati potevano discernere l'importanza o meno dell'argom ento, e perciò l'on. Chimienti si fece interprete di quei deputati
che non sono tecnici e che non hanno conoscenza completa di questo argome n to.
( ) Mentre il ministro propone la soppressione del Corpo di Stato Maggiore, e la commissione ne propone il mantenimento, il ministro viene poi a dichiarare che se ne rimette alla Camera. - È una questione importante, od è una questione di importanza così picco la che la si può lasc iare al giud izio della Camera? 43
E siccome Di Saluzzo minimizzava d icendo che era solo <<questione di uniforme», Chimienti concludeva: «Va bene, vuol dire che per lasciare tranquilla la mia coscienza, voto favorevo lm ente all'opinione che il ministro aveva prima, poiché si tratta di una questione di così poca importanza» 44 •
Di fronte al rischio Di Saluzzo tornò alla carica: «L'onorevole ministro non ha ostacolato affatto la proposta d e lla commissione, e non credo che si dorrà se questa proposta sarà approvata» 45 •
A questo punto una parola di Spingardi avrebbe potuto decretare la fine del Corpo di Stato Maggiore. Egli sembrava favorevole alla soppress ione, ma evidentemente gli premeva di più giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge. Se l'abolizione del Corpo di Stato Maggiore doveva diventare un ostacolo, e il battibecco tra Di Saluzzo e Chimienti sembrava essere un indizio in questo senso, il Ministro vi rinunciava senza rimpianti .
38 V. AA.PP. Legislatura XXIIl, Camera- Documenti, tornata del 26 giugno, pp. 9120-9122.
39 Ibidem, Documenti, 47-A / 47 - bis-A , pp. 11 - 14.
40 Ibidem, Discussioni , I° tornata del 27 giugno 1910, p. 9159.
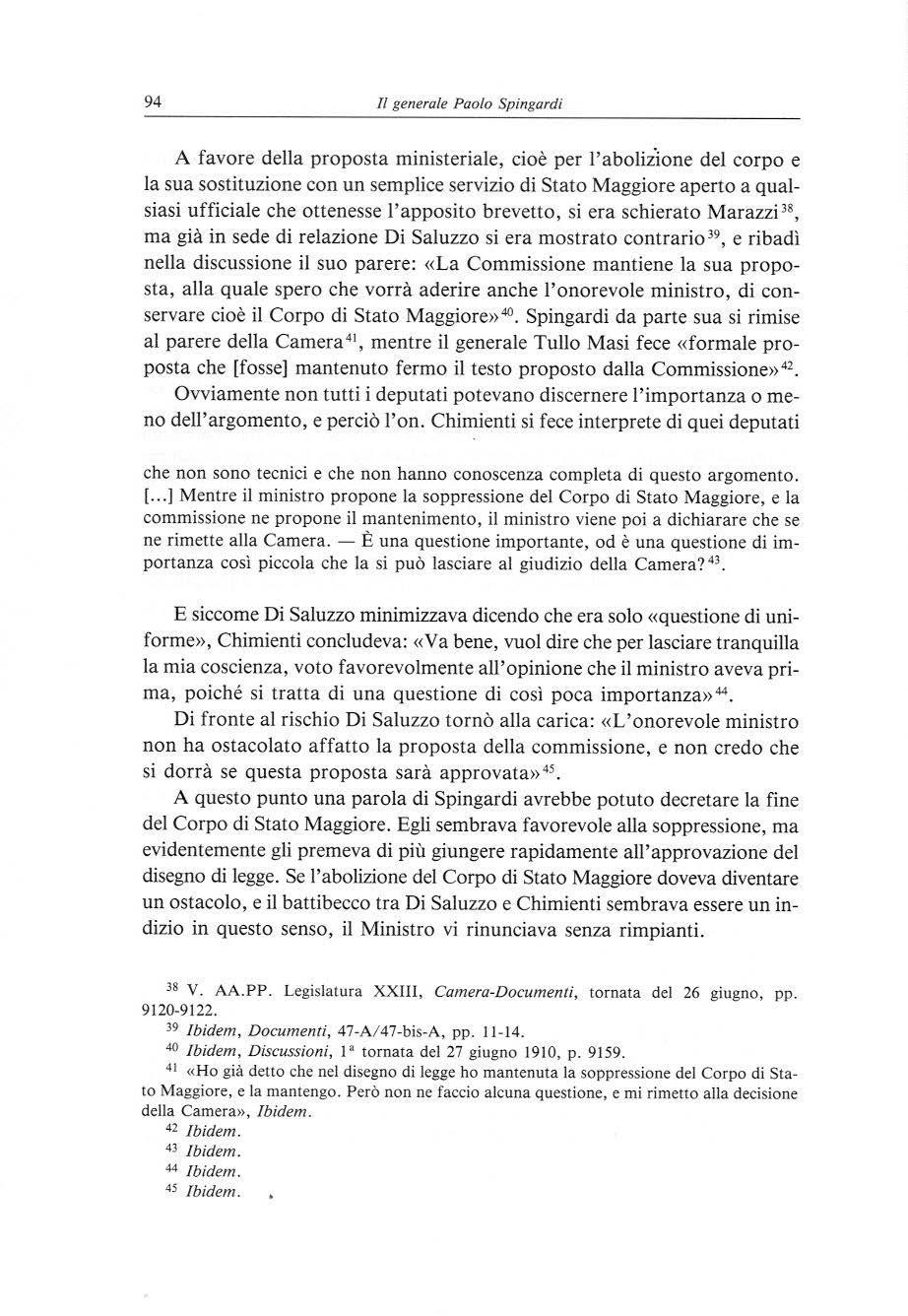
4 1 « H o già detto che nel di segno di legge ho mantenuta la soppressione del Corpo di Stato Maggio re, e la mantengo. Però non ne faccio alcuna questione, e mi rimetto alla decisione della Camera», Ibidem.
42 Ibidem.
43 ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
94
In Senato avrebbe poi dichiarato che pareri, o se si vuole pressioni, da parte di autorevoli istituzioni Io avevano spinto a rinunciare all'abolizione del Corpo.
Ero convinto che la soppressione del Corpo di Stato Maggiore[... ] non avrebbe recato alcun danno al servizio, nel mentre avrebbe attenuato quelle prevenzioni che [ ] portano una nota non simpatica nei riguardi di questo corpo. - In seguito, però, il parere contrario recisamente espresso dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito, avvalorato ancora da quello del Consiglio dell'esercito ed infine il voto della Camera dei deputati [ ... ] mi hanno indotto ad aderire all'abbandono del servizio di stato maggiore 46
La discussione proseguì e si chiuse in assoluta tranquillità. Nella 2a tornata dello stesso 27 giugno, il disegno era approvato con 214 voti favorevoli e 52 contrari.
Al Senato la discussione fu ancora più rilassata, in un clima in cui sembrava tutto già deciso 4 7 Tre soli interventi, del relatore generale Cesare Tarditi, di Spingardi in risposta, e del generale Luigi Majnoni d'Intignano, Presidente dell'Ufficio Centrale.
L'unico e lemento degno di nota fu un ordine del giorno, che chiedeva al Ministro di studiare l'applicazione del ruolo unico nell'avanzamento degli ufficiali superiori, approvato dal Senato e accolto dal Ministro 48 •
Il 12 luglio il disegno era approvato anche dal Senato con 80 voti favorevoli e 15 contrari, e diveniva infine legge dello Stato il 17 luglio 1910 col
Il 515 .
4 6 Ibidem, Senato-Documenti, n. 324, p . 2.
47 Spingardi aveva già provveduto ad appianare ogni divergenza con i membri dell'Ufficio Centrale. L'8 luglio 1910 scriveva a Ugo Brusati: «S tamattina sono finalmente riuscito a mettere d'accordo l'ufficio centrale del Senato (Bava, Majnoni, Mazza, Tarditi, Taverna) e le leggi militari potranno essere messe all'ordine del giorno per lunedì. Ho dovuto fare una concessione, accettando un ordine del giorno col quale mi si farà invito a studiare con modalità di forma e di tempo l'applicazione graduale del ruolo unico dal grado di maggiore in su. Mi metterò allo st udio durante le vacanze. Non ti so dire tutta la soddisfazione che ne ho provata. Da un pezzo non sono stato così allegro!» (ACS. Archivio Brusati, se I O f. Vl.4 36.).
Il giorno dopo Brusati rispondeva: « [ ... ] Mi rallegro vivamente con te, e provo anche personale vivissimo compiacimento, per la vittoria da te riportata all'ufficio centrale del Senato . E tanto più me ne rallegro data l'opera , che non so comprendere e non voglio qualificare, che per voce pubblica si attribuisce a due autorevoli deputati, opera intesa ad ostacolare in Senato , mediante propaganda, l'approvazione di un disegno di legge che la camera ha già approvato» (RFS. Brusa ti a Spingardi, 9.7.910). Non mi è riuscito di scoprire chi fossero i due deputati , ma l'episodio sottolinea l'importanza del disegno di legge, e in qualche modo giust ifica, dal punto di vista dei militari, il rapidissimo iter imposto al disegno di legge stesso.
48 AA.PP. Senato-Discussioni, pp.3477 -3479. Anche di questo si tratterà nel cap. V, par. 2.1.
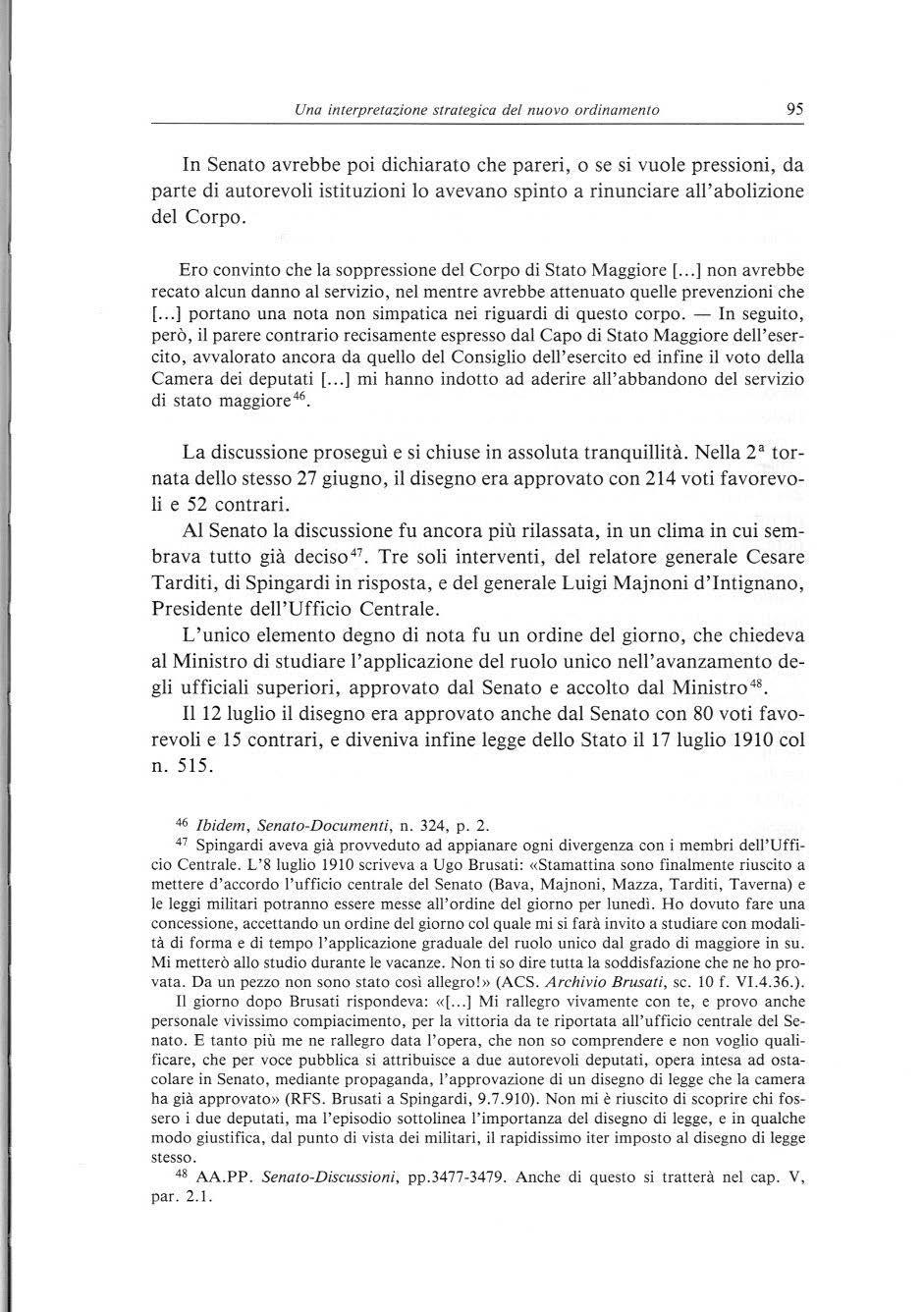
Una interpretazione strategica del nuovo ordinamento 95
Alpini, cavalleria, bersaglieri'
I criteri che informavano la legge erano gli stessi dell'anno precedente: si prevedeva un aumento complessivo di poche unità, ma si cercava di riordinare quelle esistenti in modo da dar loro maggiore celerità nella mobilitazione e maggior capacità di copertura della frontiera.
Si completarono le disposizioni dello stralcio del 1909 trasformando l'Ispettorato degli alpini in Ispettorato delle truppe da montagna. Fino a quel momento gli alpini avevano un ispettorato a sé, mentre l'artiglieria da montagna dipendeva dall'Ispettorato d'artiglieria. Ne derivava una non armonica preparazione all'ipotesi di una guerra in montagna. Vennero inoltre costituiti tre comandi di brigata alpina per «necessità di istruzione e di impiego», diceva genericamente Spingardi 49 • Ma è chiaro che i provvedimenti miravano a dare alle truppe da montagna maggiore compattezza e maggiore autonomia, per permette re loro di agire con la necessaria indipendenza nella difesa delle frontiere, acquisendo nel complesso quasi la consistenza d i un corpo d'armata .
Si crearono poi tre comandi permanenti di divisione di cavalleri a, che prima non esistevano. Anche questo provvedimento mirava a utilizzare nel miglior modo possibile i 17 reggimenti non destinati ai corpi d'armata. Se si considera che i tre comandi di divisione furono dislocati a Udine, Vicenza e Milano, sembra chiaro verso quale frontiera si pensava di far gravitare l'eventuale mobilitazione italiana 50
I 12 reggimenti bersaglieri esistenti, invece che su tre battaglioni di quattro compagnie, vennero riordinati su quattro battaglioni di tre compagnie, e un battaglione per reggimento (totale 12 battaglioni) sarebbe divenuto di ciclisti. Si aumentava così la celerità del corpo celere per eccellenza. Anche questo provvedimento rafforzava unità in grado di accorrere più velocemente alla frontiera non appena indetta la mobilitazione
Artiglieria
Le più importanti modificazioni che la legge apportava all'ordinamento dell'esercito riguardavano però l'arma di artiglieria 5 1 •
4 9 AA.PP. Leg. XXIII , Camera -Documenti, n. 47 - bi s , p 13.
50 La di slocazione dei comandi è riportata in STEFANl, ci t., nota 49 alle pp. 603 -604. Anche il nuovo reggi mento alpino creato l'anno precedente ebbe la propria sede a Udine. li nuovo reggimento artiglieria da montagna venne dislocato a Vicenza. Mi pare evidente il tentativo di dare consistenza all'armata d i copertura che appoggiandosi alle fortificazioni in costruzione doveva costituire il nerbo della difesa della frontiera.
51 «L'art igl ieria s ubi per effetto della legge n. 5 I 5 una vera e propria rivoluzione che coinvolse tutte le specialità ed incise profondamente sullo stesso ordinamento tattico dell'arma », STEFAN1 , cit., p. 579.
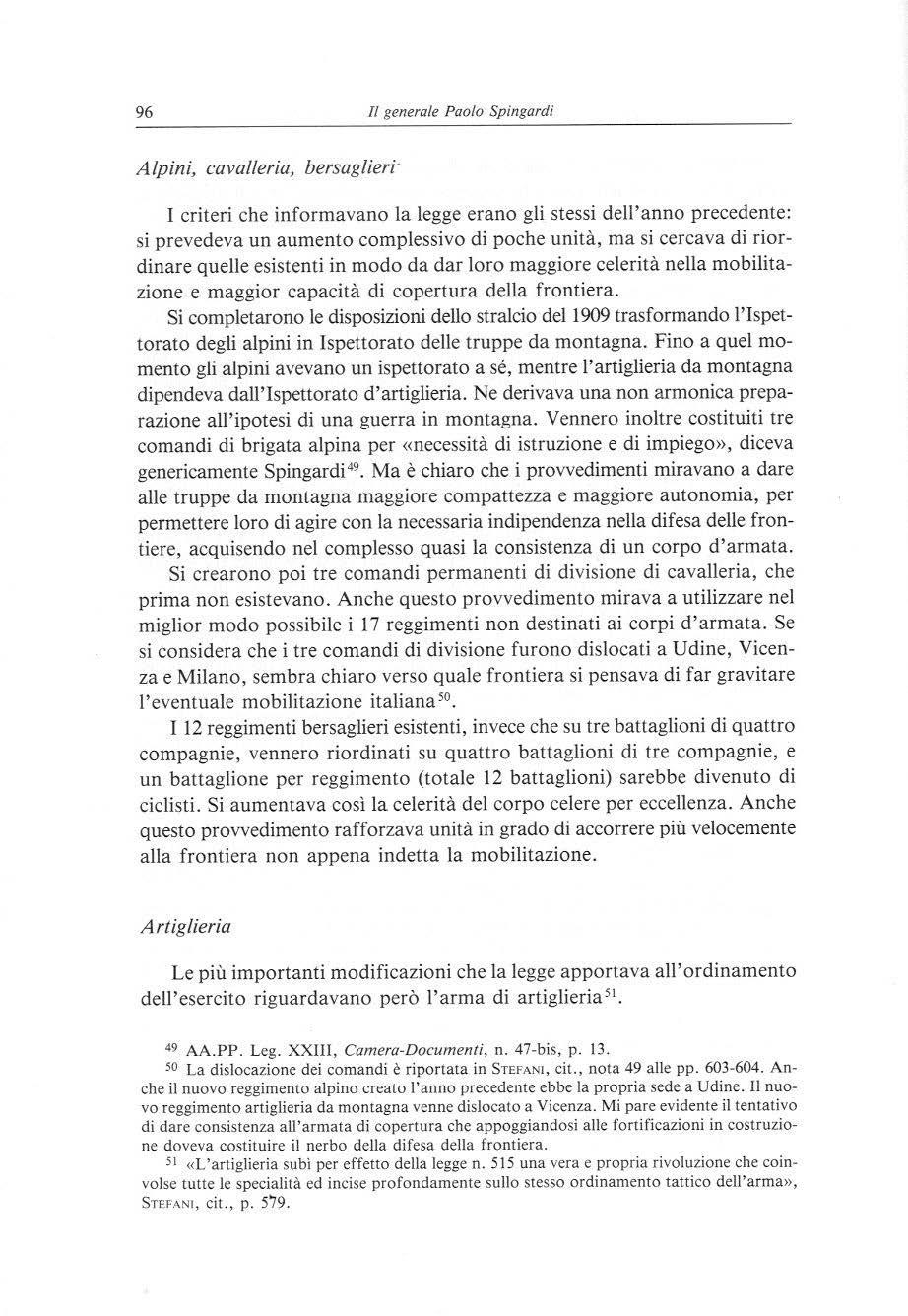
96
li generale Paolo Spingardi
Spingardi dichiarò di voler sorvolare sulla questione della costituzione della batteria, «se cioè si debba venire alla formazione su 4 pezzi, questione molto complessa, che, anche presso i maggiori eserciti esteri, il francese eccettuato, non è ancora stata affrontata» 52 ; qui invece si cercherà di analizzare un poco più a fondo la questione, c he conduce a riflessioni di non secondaria importanza .
Con l'entrata in servi zio del materiale di artiglieria a tiro rapido (a ff usto a deformazione) 53 cambiava il ruolo dell'artiglieria in battaglia:
L'aumento della gittata esonerava l'artiglieria da campagna dall a necessità di far fuoco a puntamento diretto da posizioni ravvicinate [ .. . ] I cannoni potevano ormai entrare in azione efficace da posizioni defilate e distanti sette-otto chilometri 54
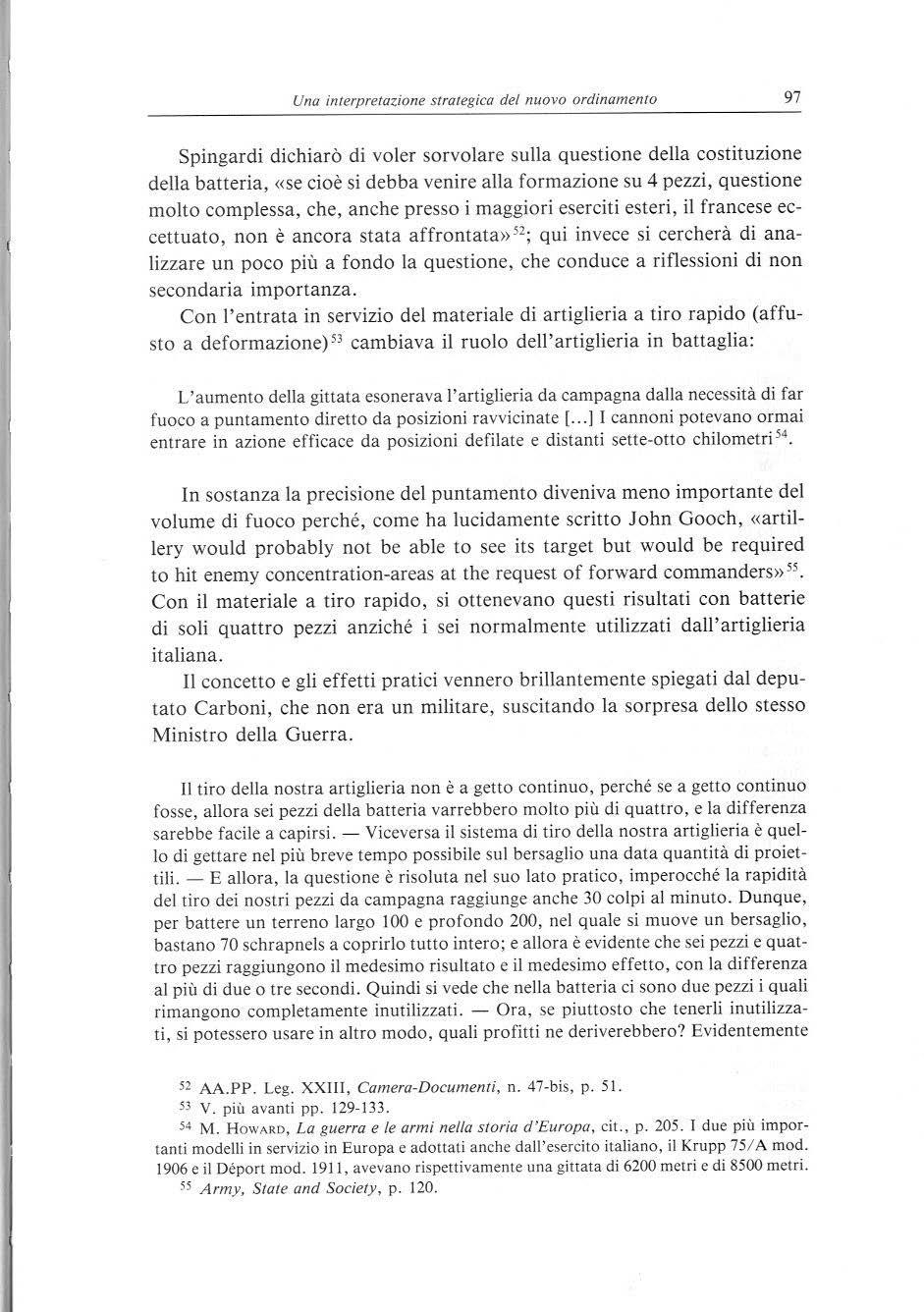
In sostanza la precisione del puntamento diveniva meno importante del volume di fuoco perché, come ha lucidamente sc ritto John Gooch, <<artiller y wou ld probably not be ab le to see its target but would be r equ ired to hit enemy concentration-areas at the request of forwa rd commanders» 55 • Con il materiale a t iro rapido, si ottenevano questi risultati con batterie di soli quattro pezzi anz iché i sei normalmente utilizzati dall'artiglieria italiana.
11 concetto e gli effetti pratici vennero brillantemente spiegati dal deputato Carboni, che non era un militare, suscitando la sorpresa dello stesso Ministro della Guerra.
li tiro della nostra artiglier ia non è a getto continuo, perché se a getto continuo fosse , allora sei pezzi de ll a ba tter ia va rrebbero molto più d i qua ttro , e la differenza sarebbe facile a capirsi . - Viceversa il sistema di tiro della nostra artigl ier ia è quello di gettare nel più breve tempo possib i le sul bersaglio una data quantità di proi ettili - E allora, la questione è riso lu ta nel suo lato pratico, im pero cch é la rap idità del tiro dei nostr i pezzi da campagna raggiunge anche 30 colpi al minuto. Dunque , per battere un terreno largo 100 e profondo 200, nel qua le si muove un bersaglio, bastano 70 schrapnels a coprir lo tutto intero; e allora è ev idente che sei pezzi e quattro pezzi raggiungono il medesimo risultato e il medes imo effetto, con la differenza al più di due o tre secondi . Quindi si vede che nella batteria ci sono due pezzi i quali rimangono completamente in ut ilizzati. - Ora, se piuttosto c h e tenerli inutili zzati, si potesse r o usare in altro modo, q u ali profitti ne deriverebbero? Evi d entemente
S2 AA.PP. Leg . XXIII, Camera-Documenti, n. 47-bis, p. 51.
53 V p iù avanti pp. 129-133.
54 M. HowARD, La guerra e le armi nella storia d'Europa, cit , p 205. I due più important i modelli in servizio in Europa e adottati anche dall'esercitO ita liano, il Krupp 75 / A mod.
1906 e i l Déport mod. 191 I, avevano rispettivamente una gittata di 6200 metri e di 8500 metri. ss Army, State and Society, p. 120.
Una interpretazione st rategica del nuovo ordinamento 97
li generale Paolo Spingardi
questi : che la nostra artiglieria aumenterebbe automaticamente di un terzo senza necessità di alcuna spesa; non solo, ma la batteria diverrebbe più agile, più sciolta, più facile e anche più comandabile 56
Già la Commissione che esa minò il progetto di legge e l'onorevole Montù nella stessa tornata avevano esortato il Ministro a passare alla formazione delle batterie su quattro pezzi 57 •
Sembra che l'oppor t uni tà di adottare la formazione su quattro pezzi fosse già stata sanzionata da Spingardi nel 1909, sebbene in via riservata, ma si dovette rinunziare ad includerla nel primo programma di riordinamento del1'esercito per ragioni di ordine finanziario 58 •
Le stesse motivazioni egli addusse per giustificare la sua rinuncia a tale riforma anche nel nuovo ordinamento, malgrado i suggerimenti in altro senso che gli erano sta t i fatti, come abbiamo visto
Io ho già avuto occasione di esprimere il mio convincimento circa il rendimento maggiore che un numero di pezzi può dare se ripartito in batterie di quattro anziché di sei. - Ma bisogna bene intenderci a questo riguardo. - Non possiamo scendere al di sotto delle attuali proporzioni di artiglieria, senza diminuire l'efficienza delle nostre grandi unità 59 Ed allora, per avere la batteria su 4 pezzi, bisognerebbe im itare la Francia, aumentando senz'a ltro le batterie del cinquanta per cento , ossia, siccome noi abbiamo 190 batterie, dovremmo aumentarle di un centinaio 6°. Né si può dire che potremo con ciò ridurne l'organico di pace, perché questo è determinato da ll 'es igenza de ll a istr uzione e dalla preparazione alla guerra. - Si pensi allora all'aumento di cavalli, di forza bi lanciata, che occorrerebbe, e sopra tutto poi agli ufficiali , ai capitani che sarebbe necessario di aggiungere all'organico portato dal pro getto attuale. Si pensi che non basterebbero dai dieci ai dodici milioni di so la spesa ordinaria : e si compren derà la necessità di soprassedere 61
Prescindendo dalle motivazioni finanz iarie, perché rinunciare a un ordin amento del quale si erano riconosciute l'utilità e la praticità dal punto di vista tecnico?
56 AA.PP. Legislatura XXTll, Camera-Discussioni, tornata del 26 giugno 1910, pp. 9127-9128 Vincenzo Carboni (Frosinone 1867 -Roma 1933), avvocato, fu eletto deputato di Frosinone nelle legislature dalla XXlll alla XXVl ( 1909 -1 924). Alla Camera sedeva tra i banch i della sin istra democratica.
57 V Ibidem, Documenti, n. 47-A/ 47 -bis -A, pp. 20-21 e Discussioni, pp. 9124-9125.
58 Così è detto nella Relazione Ufficiale, nota 90 a p. 179.
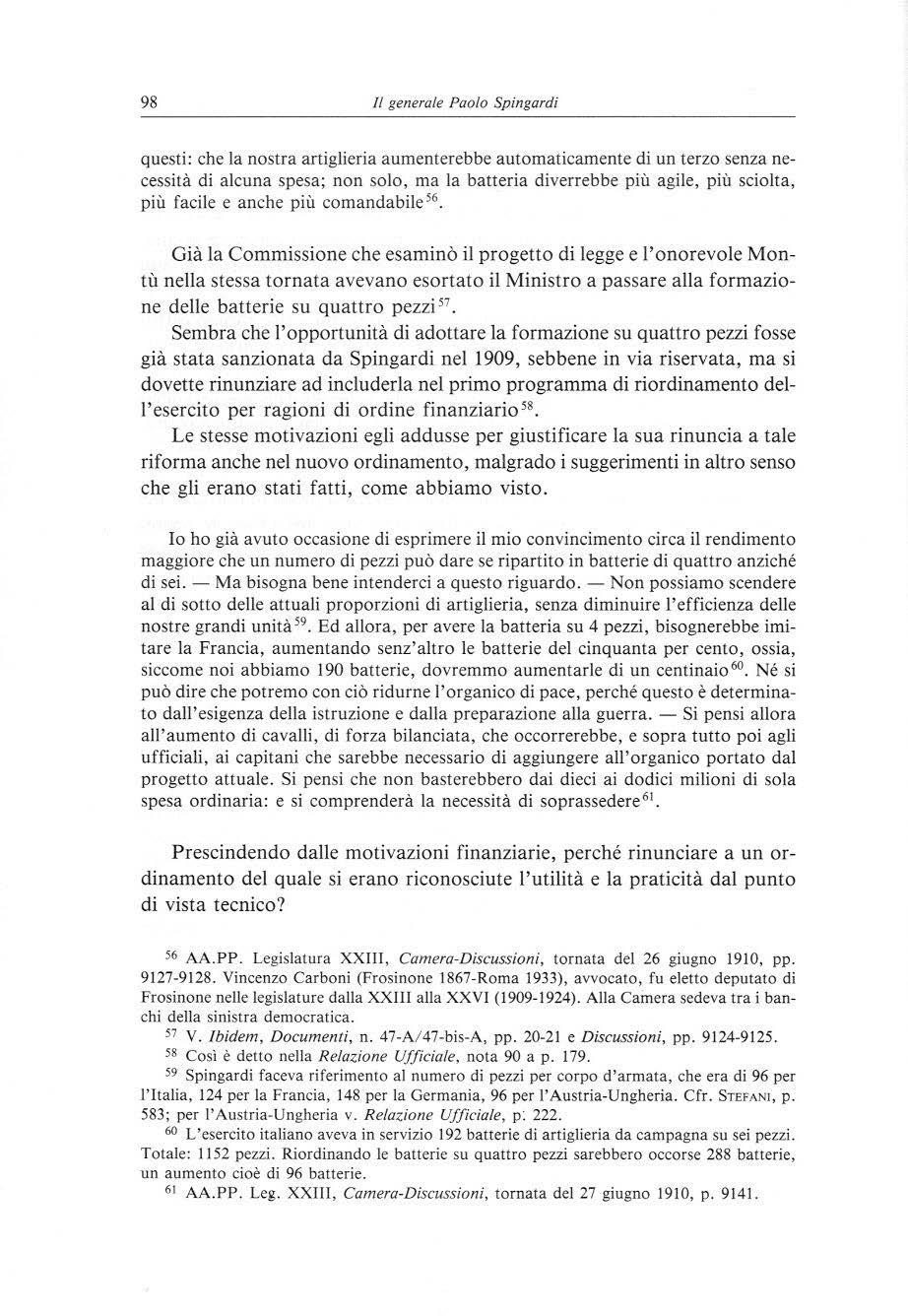
59 Spingardi faceva riferimenro al numero di pezzi per corpo d'armata, che era di 96 per l'ltalia , 124 per la Fra nc ia, 148 per la Germania, 96 per l'Austria- Ungheria. Cfr. STEFANI, p. 583; per l'Austria - Ungheria v. Relazione Ufficiale, p: 222 .
60 L'esercito italiano aveva in servizio 192 batterie di artiglieria da campagna su sei pezzi. Totale: J J 52 pezzi. Riordinando le batterie su quattro pezzi sarebbero occorse 288 batterie, un aumento c ioè di 96 batterie.
6 1 AA.PP Leg XXIII, Camera -Discussioni, tornata del 27 giugno 1910, p. 9141.
98
Plausibilmente si optò per la rinuncia all'auspicata riforma, perché si pensava di affrontare uno scenario di guerra nel quale l'in tervento di una forte artiglieria campale italiana non fosse necessario 62 •
La notevole e articolata potenza di fuoco garantita da un alto numero di batterie a quattro pezzi risultava più adeguata a una guerra offensiva, dove slanciarsi in avanti e aggredire col fuoco il nemico era una condizione essenziale per aprirsi rapidamente la via all'avanzata: ma diveni va meno importante se l'obiettivo era difendersi da una aggressione, resistendo al nemico sulle ben guarnite difese di casa propria
L'analisi delle disposizioni relative all'artiglieria induce ad altre riflessioni .
Le più profonde ed importanti modificazioni che questa legge apporta all'ordinamento dell'esercito riguardano l'arma d'artiglie ria - diceva Spingardi aJ Senato.Così grande e così irresistibile è la tendenza che in tutti gli eserciti moderni si è manifestata per un aumento dell'artiglieria sia presso le t ru ppe mobili che per le difese fisse, che noi non po tremo ce rto riman ere spettatori inerti e passivi, pur procedendo con tutta la possibile cautela e di sc rezione - E appunto affinché non abbiano a radicarsi convinzioni troppo pessimiste sulla proporzione della nostra artiglieria in confronto di quella di altri eserciti, io debbo assicurare che, se non possiamo competere, come numero di pezzi in relazione alle grandi unità da mobilitare, colla Germania e colla Francia 63 che hanno spinto i loro armamenti a limiti che a noi non è consentito di raggiungere, ci troviamo invece in condizioni pressoché pari a quella degli eserciti delle altre nazioni d'Europa 64
Avrebbe potuto un Ministro re sponsab il e fare tali dichiarazioni a cuor leggero, se Francia o Germania avessero fatto parte del novero dei probabili nemici? Ri spetto al numero di pezzi in organico l'esercito it aliano poteva reggere il confronto solo con l'Austria-Ungheria 65
62 Era opinione di Pallio che «le fortificaz ioni e le posizioni di frontiera sulle qua l i è presum ib il e che s i combatterà a lungo ci daranno un certo te mpo disponibile, e che l ' intervento di una forte artiglieria da campagna non sarà, in quel periodo, richiesto!» RFS. Pollio a Spingard i , 18 novembre 1913.
6 3 La Germania aveva 18 corp i di armata ognuno con una dotazione d i J 48 pezzi, totale 2664 pezzi: la Francia 16 corpi con 124 pezzi ognuno, to tale 1984
64 AA.PP Legislatura XXIII Senato-Do cumenti, n. 324, p. 6.
65 Era questo del resto il parere espresso anche da «L'Esercito italiano» nell'articolo Per la nostra artiglieria da campagna, su l numero del 21 agosto 191 0, dove, dopo le parole del ministro <<i n condizioni pressoché pari a quelle delle altre nazioni d'Europa» aggiungeva tra parentesi un eloquente «legg i Austria». Tra i l 1908 e il 1912 l' arciglieria da campagna austriaca rimase ordinata su 42 reggimenti di cannoni e 14 reggi men t i di obici tutti su 4 batterie a se i pezz i , per un totale di 1344 pezzi (v . Rela'l,ione Ufficiale, pp. 222 e cfr. le acute considerazioni di R. B eNC IVENGA, Saggio critico sulla nostra guerra, voi. I, Tipografia Agost in i ana, Roma 1930, pp. I 18-1 19; 132-136) L'Italia prima dell'ordinamento Spingardi aveva 24 r eggimenti su 8 batterie a 6 pezzi, totale 1152 pezzi. li nuovo ordinamemo non mutava il numero totale dei pezzi e aggiungeva 20 batter ie s u sei pezzi di art ig lier ia pesan te campale,
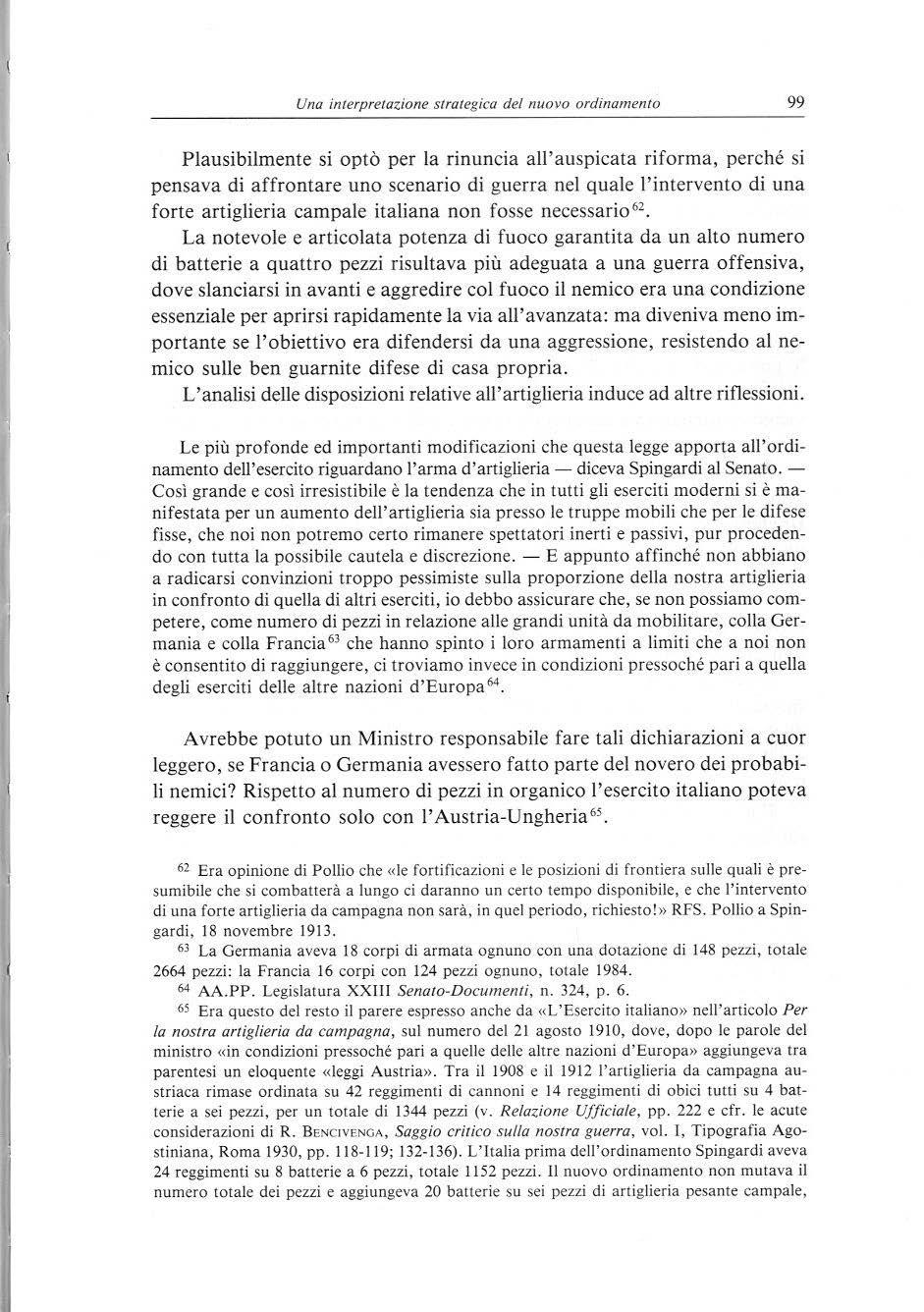
Una interpretaz ione strategica del nuovo ordinamento 99
Le nuove disposizioni raccoglievano tutta la cosiddetta «artiglieria a piedi », cioè non mobile, non trainata, che prima era separata in unità da costa e unità da fortezza, sotto l'unica denominazione di «artiglieria da fortezza», aumentandola di 15 compagnie, per un totale di 98 compagnie raggruppate in 10 reggimenti 66 , ordinati, secondo quanto disse il Ministro, «col criterio della dislocazione e d e l probabil e impiego delle unità che devono formarli» 67 • Dato che si trattava di «artiglieria destinata a presidiare le opere», la nuova denominazione evidenziava chiaramente il maggior peso che assumevano le unità destinate alla difesa dei forti terrestri piuttosto che costieri.
Spingardi motivava il provvedimento appunto in quanto «lo sviluppo che vanno continuamente assumendo le opere a difesa del territorio ha imposto, dopo maturo studio, un nuovo aumento delle unità destinate a presidiarle» 68 •
Le uniche opere a dife sa del territorio che si andavano continuamente sviluppando erano allora le fortificazioni alla frontiera con l'Au striaUngheria; le vecchie opere sulla frontiera con la Francia non giustificavano un simile aumento di organici.
Anche il regg imento artiglieria a cavallo, altro corpo celere, era rafforzato passando da sei batterie su sei pezzi a otto batterie su quattro pezzi, provvedimento che aumentava ulteriormente la maneggevolezza e la rapid ità di movimento della specialità 69
Infine venivano creati due reggimenti di artiglieria pesante da campo, specialità sconosciuta in Italia fino a quel momento, su venti batterie, 14 di obici e 6 di cannoni pesanti (rispettivamente 7 e 3 per reggimento) 70 • Già tra il 1907 e il 1909 l'Austria-Ungheria aveva dotato l'esercito comune d i 9 grupp i d i obici pesanti campa li per un totale di 50 pezzi 71 •
Il provvedimento più appariscente del nuovo ordinamento dell'artiglier ia fu portare, con la creazione di sole sette nuo ve batterie, i 24 reggimenti
cioè altri 120 pezzi. Anche se queste batter ie pesanti esistevano per il momento so lo sulla carta, il totale dei pezzi au striac i era il più vicino al numero di pezzi dell'esercito italiano. Sia chiaro che si sono considerate so lo le bocche da fuoco organicamente previste, e che nei depos i t i esisteva ovviamente un congruo numero d i batterie di riserva.
66 V. Relazione Ufficiale, p. 19; DE CHAURANO, pp. 87 - 88; STEFAN t, p. 579
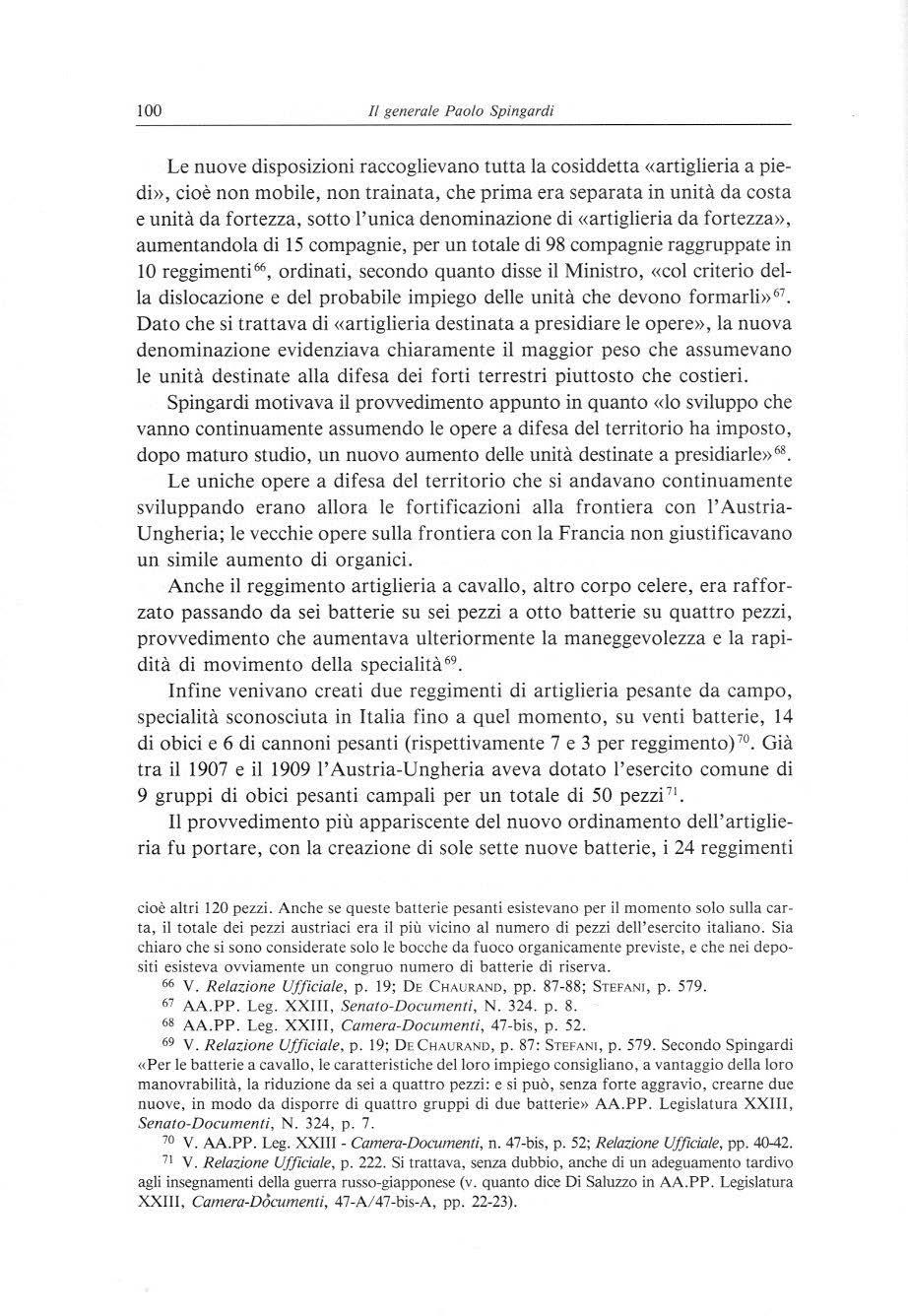
67 AA.PP. Leg. XXIII, Senato-Documenti, N 324 p. 8
68 AA PP Leg XXIII, Camera-Documenti, 47-bis, p. 52.
69 V. Relazione Ufficiale, p. 19; DEC HAURANO, p. 87: STEFANI, p. 579. Secondo Spingardi « Per le batterie a cavallo, le caratteristiche del lo ro impiego consigl iano , a vantaggio della loro manovrabilità, la r id uzione da sei a quattro pezzi: e si può, senza forte aggravio, crearne due nuove, in modo da disporre di quattro grupp i di due batterie» AA.PP. Legislatura XXIII, Senato -Documenri, N. 324, p. 7.
70 V. AA.PP. Leg. XXIII - Camera-Documenti, n. 47 -bis, p 52; Relazione Ufjìciale , pp. 4042
71 V. Relazione Ufficiale, p. 222. S i trattava, senza dubbio, anche di un adeguamento tardivo agli insegnamenti della guerra russo-giapponese (v quamo dice Di Saluzzo in AA.PP Legislatura XXIII, Camera-Dòcumenti, 47 -A / 47-bis -A, pp 22-23).
100
generale
li
Paolo Spingardi
Una interpretazione strategica del nuovo ordinamento 10]
di artiglieria da campagna esistenti a 36 per poter assegnare organicamente un reggimento su sei batterie ad ogni corpo di armata e uno su cinque batterie ad ogni divisione dell'esercito «per avvicinare l'ordinamento di pace a quello di guerra» 72 •
Spingardi motivò la scelta del nuovo ottimale ordinamento osservando giustamente che i reggimenti dell'ordinamento in vigore erano
esageratamente pesanti, dovendo mobilitarsi su otto batt erie [ ... ] e fornire inoltre i traini di t ut ti i servizi generali de i corpi d'armata e de ll e di vis ioni: tale pesantezza verrà poi ad aggravarsi dopo la completa distribuzione del nuovo mater iale così da fare dell'unità reggimento un organismo complesso che non trova riscontro nelle unità corrispondenti delle altre armi e degli altri eserciti. Si aggiunga poi che ta le formazione non risp onde a quella di guerra, dovendo ogni coppia degli attuali reggimenti formare tre raggruppamenti di batterie da assegnare organicament e a ciasc una delle due divisioni e alle truppe supplettive del corpo d'armata. Perciò laripartizione delle nostre batterie in 36, anziché in 24 reggime nt i, ri sponde doppiamente al concetto organico di una migliore costituzione dell'unità reggimento, e di una più raziona le assegnazione ne ll e formazioni di guerra 73 •
Secondo il parere del relatore della Commissione esamjnatrice, con questo provvedimento, «alleggerendosi la composizione d ei reggimenti, si ha come l'immagine di uno sgranchirsi delle gambe nel gran corpo artiglieresco, reso più agile a futuri movimenti di avanzata» 74 • A questo punto affermare senza esitazione che l'ordinamento Spingardi fosse «antiaustriaco» sarebbe arbitrario: come si è visto esso mirava sostanzialmente a rendere l' ese rcito italiano più agile e più pronto alla mobilitazione e a riequilibrare un dispositivo eccessivamente sbilanciato verso occidente. Però l'atteggiamento guardingo del Ministro verso l'Austria era esplicitato in più di una occasione 75 ; mi sembra poi che la natura intrinseca
72 AA.PP. Leg. XXIII , Camera-Documenti, n. 47- bis, p. 3
73 ibidem, p. 51. Identiche parole usava il Ministro nella relazione al Senato. Cfr. AA.PP Leg. XXJII, Senato - Documenti, n. 324, p. 6. ·
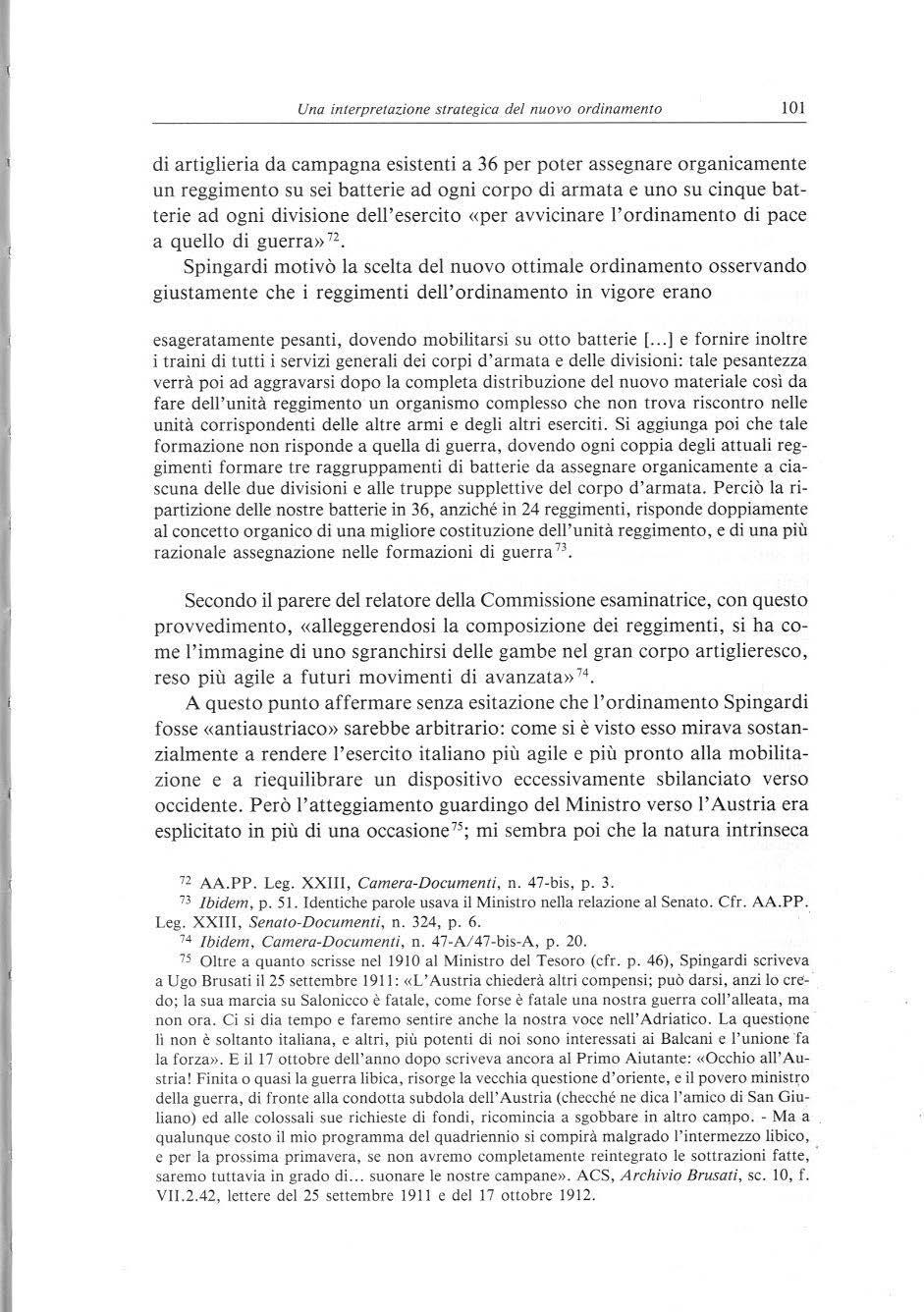
14 Ibidem, Camera-Documenti, n. 47 -A/47 - bis-A, p. 20.
75 Oltre a quanto scrisse nel 1910 al Minjstro del Tesoro (cfr p 46), Spingardi scr iveva a Ugo Brusati il 25 settembre 191 I: «L'Austria chiederà altri compensi; può darsi, anzi lo ere- · do; la sua marcia su Salonicco è fatale, come forse è fatale una nostra guerra coll ' alleata, ma non ora. Ci si dia tempo e faremo sent ire anche la nostra voce ncll ' Adriatico. La q uesti one li non è soltanto italiana, e altri, più potenti di noi sono interessati ru Balcani e l'unione "fa la forza>> E il 17 ottobre dell'anno dopo scriveva ancora a l Primo Aiutante: «Occh io ali' Austria! Finita o quasi la guerra l ibica, risorge la vecchia questione d'oriente, e il povero minist~o della guerra, di fronte alla condotta subdo la dell'Austria (checché ne dica l'armco di San Giuliano) ed alle colossal i sue r ichieste di fondi, ricomincia a sgobba re in altro ca111po. - Ma a qua lunque costo il mio programma del quadriennio si compirà malgrado l' inte rmezzo libico, e per la prossima primavera, se non avremo completamente re integrato le sottrazioni fatte, s aremo tuttavia in grado di suonare le nostre campane». ACS, Archivio Brusati, se. 10, f. Yll.2.42, lettere del 25 settembre 1911 e del 17 ottobre 19 12.
Il generale Paolo Spingardi
dello stesso ordinamento escludesse eventuali campagne offensive 76 , e quando i militari pensavano a una guerra difensiva, in Italia, l'eventuale avversario non era certamente la Francia 77 •
Ad ogni modo, orientamento antiaustriaco o semplice riequilibrio dei reparti che fosse nei propositi del Ministro, approvata la legge bisognava passare alla sua esecuzione. Fu un processo molto graduale. Lo stesso Spingardi ammetteva che «oggi i 36 reggimenti d'artiglieria, previsti dalla legge, non ci sono ancora, ed occorreranno tre o quattro anni, prima che si riesca a costituirli» 78 •
In effetti era necessario costruire nuova caserme, poiché le esistenti non erano sufficienti, e spesso divenne una vera gara tra i comuni per «accaparrarsi» i nuovi repart i 79 • Le costruzioni, poi, richiedevano ovviamente un certo periodo per essere compiute 80 •
Insomma, i primi sei reggimenti di artiglieria da campagna furono operativi solo dal 1° marzo 1912 81 • Alla stessa data si formarono i comandi dei due reggimenti di artiglieria pesante campale con le prime otto batterie di obici. In compenso le nuove compagnie e il nuovo reggimento alpin i e i nuovi reggimenti di cavalleria della legge 1909 erano operativi già dal 1° novembre 1909; il nuovo reggimento di artig li eria da montagna dal 1° giugno 1910. Il nuovo ordinamento per l'artiglieria da fortezza e l'artiglieria
76 Escludendo la nota co nven zione militare con la Germania (v. MAzzm1, L'Italia e le convenzioni militari segrete della Triplice Alleanza, art. cit.) non esisteva di fatto nessun piano dello Stato Maggiore che prevedesse l'offensi va . V. BRuo10N1, cit., pp. 283-284, 311-312 e passim.
77 Lo dimostrava ampiamente una serie di articoli apparsi su «La Preparazione» nel dicembre 1910 ad opera del maggiore di Stato Maggiore Cristoforo Manfredi, che scriveva celato sotto le iniziali c.m. V. La dislocazione barocca, Martedì-mercoledì 6-7 dicembre 1910: «La piazza d'armi dell'Italia dev'essere il Veneto giacché, per condiz ioni geografiche ineluttabili , una grande invasione può venirci solo di là » . Nel resto dell'articolo si spiegava come le condizioni della frontiera rendessero impossi bile una invasione dal lato francese. V. Le due frontiere, Martedì -Mercoledì 20-2 1 dicembre 1910; Da Occidente e da Oriente, Martedì-Mercoledì 27-28 dicembre 1910. Cfr. anche, sempre su «L a Preparazione», Le guarnigioni del Veneto, Giovedì-Venerdì J-2 dicembre 1910, articolo del generale Giorgio Bompiani, anch'egli del parere che «nel confronto fra le due frontiere, orientale e occidentale, se una delle due dovesse essere più fortemente guarnita, dovrebbe essere l'or ientale, non circondata come l'altra da una non inte rrotta asprissima barriera montana>>; e Sulla dislocazione delle truppe di copertura, Sabato -Domenica 29-30 aprile 191 I, a firma «Alfa» , dove s i ripetono i medesimi concetti lamentando !'«inutile» sbilanciamento verso occidente dello schieramento dei reparti.
78 AA.PP. Leg. XXIII, Camera-Discussioni, 1• tornata del 27 giugno 1910, p. 9164.
79 V. AUSSME, F-4 (OM), R. 27, dove è contenuta la documentazione relativa alle quest ioni sorte per l'attuazione del nuovo ord inamen to dell'artiglieria da campagna .
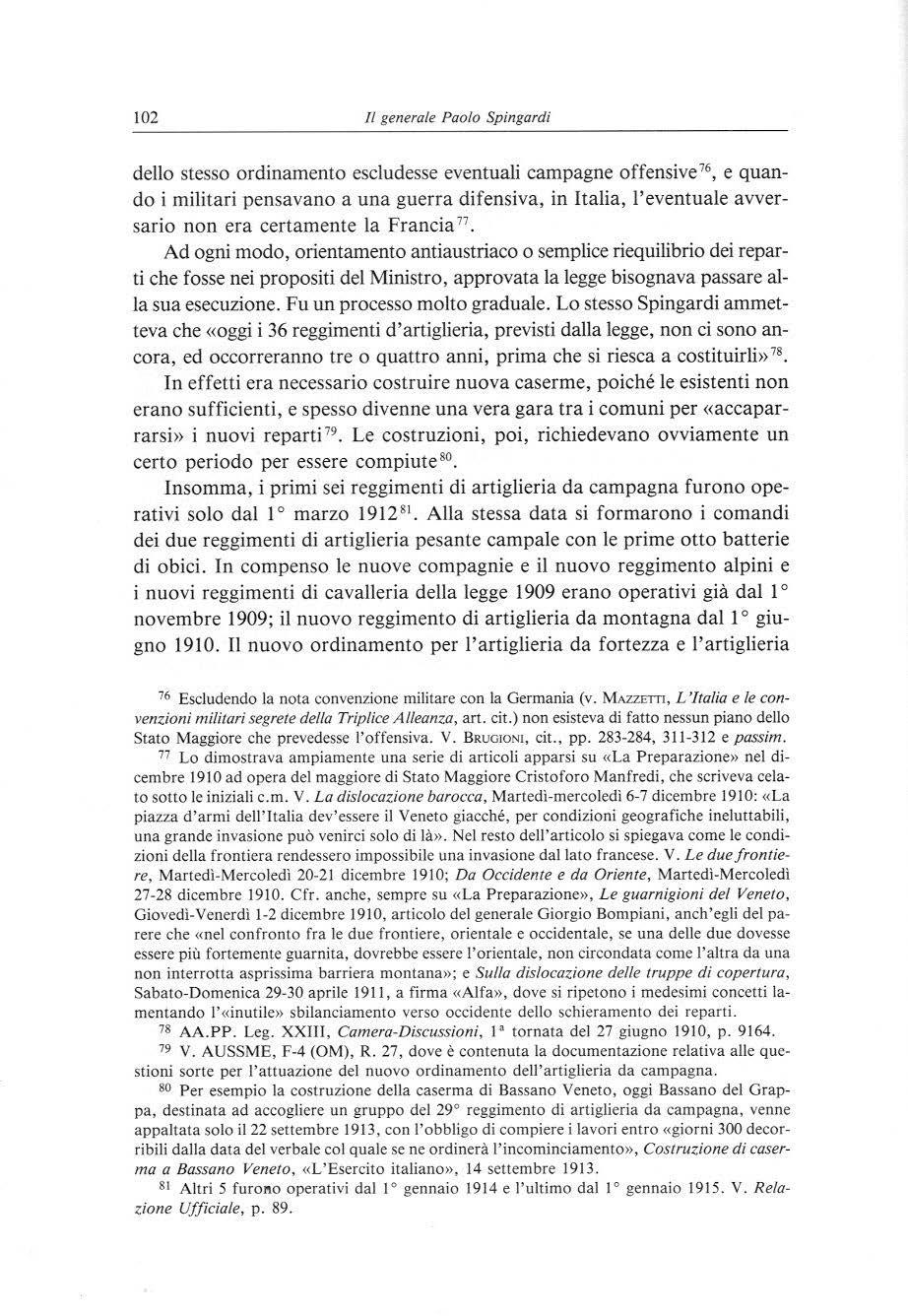
so Per esempio la costruzione della caserma di Bassano Veneto, oggi Bassano del Grappa, destinata ad accogliere un gruppo del 29 ° reggimento di artiglieria da campagna, venne appaltata solo il 22 settembre 1913 , con l'obbligo di compiere i lavor i entro «giorn i 300 d ecorribi li dalla data del verbale col quale se ne ordinerà l'incominciamento», Costruzione di caserma a Bassano Venero, «L'Esercito italiano», 14 settembre 1913.
8 1 Al tri 5 furol'lo operativi dal 1° genna io 19 14 e l'ultimo dal 1° gennaio 1915. V. Relaz ione Ufficiale, p. 89.
102
a cavallo cominciò a funzionare dal 1° settembre e dal 1° novembre 1911 rispettivamente 82 •
La creazione dei nuclei di milizia mobile
La milizia mobile, istituita nel 1873 dal Ministro Ricotti, doveva servire a costituire le unità che avrebbero rinforzato l'esercito al momento d e lla mobilitazione, inquadrando i riservisti più anziani ma ancora in pieno vigore fisico 83 in compagnie, battaglioni, regg imenti, fino a creare un vero e proprio «secondo esercito>> di dieci divisioni da affiancare alle 25 dell'esercito permanente in qualunque servizio di guerra . Ma fino al 1910 non esisteva in tempo di pace nessun tipo di organizzazione, nemmeno embrionale, di questa potenzia le forza combattente. I provved imenti per la milizia mobile si esaurivano nella designazione di ufficiali in se rvi z io attivo al comando delle unità da costituirsi in caso di guerra.
Spingardi si propose di creare fin dal tempo di pace «nuclei d i milizia mobile », cioè gruppi di 90 uomini per ogni reggimento di fanteria e 30 uomini per ogni battaglione di alpini che, in sieme con gli ufficiali loro assegnati, avrebbero costituito le basi fisse per la formaz ione delle unità da cr earsi all'atto della mobilitazione.
Tutte le sfumature del pensiero del Ministro erano da lui enunciate al Senato il 29 giugno I 9 1O esponendo la relaz ione sul disegno approvato alla Camera il giorno p rima.
8 2 Per le date di attuazione dei singo li provvedimenti V. STE FANI , nota 51 a p. 604; limitatamente alle truppe da montagna v. AUSSME, F-4 (OM), C 26, lspetlorato delle truppe da montagna. li tenente generale Ispettore delle truppe da moncagna, Ottavio Ragni, al Comando del Corpo di Stato Maggiore, Roma, 20 giugno 1909.
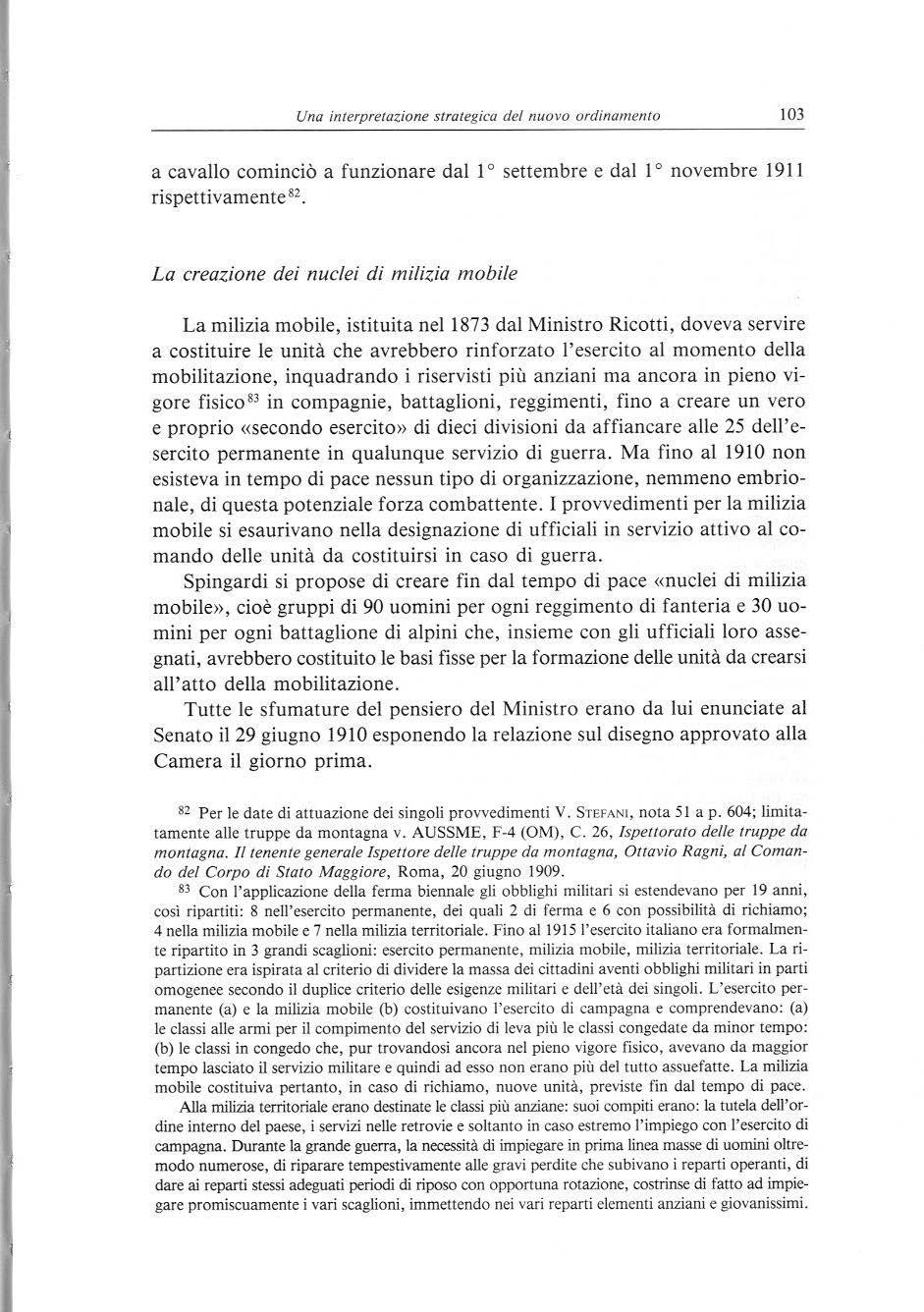
83 Con l'applicazione della fe rma biennale gli obbl ighi militari si estendevano per 19 anni, così ripartiti : 8 nell'esercito permanente, dei qual i 2 d i ferma e 6 con possibilità di richiamo ; 4 nella mi lizia mobile e 7 nella milizia territori ale. Fino al 191 5 l'esercito italiano era fo rmalm ente ripartito in 3 grandi scaglioni: esercito permanente, milizia mob ile, milizia territoria le . La ripartizione era ispirata al criterio di div idere la massa dei cittadini aventi obblighi militari in part i omogenee secondo il duplice criterio delle esigenze militari e dell'età dei singoli. L'eserc ito permanente (a) e la milizia mobile (b) costi tuivano l'esercito di campagna e comprendevano: (a) le classi alle armi per il compimento del servizio di leva più le classi congedate da minor tempo : (b) le classi in congedo che, pur trovandosi ancora nel pieno vigore fisico, avevano da maggior tempo lasciato il servizio militare e quindi ad esso non erano più del tutto assuefatte . La milizia mobile costituiva pertanto, in caso d i richiamo, nuove unità, previste fin dal tempo di pace.
Alla milizia territoriale erano destinate le classi più anziane: suo i comp iti erano: la tutela dell'ordine interno del paese, i servizi nelle retrovie e soltanto in caso estremo l' im piego con l'esercito di campagna. Duran te la grande guerra, la necessità di impiegare in prima li nea masse di uomini oltremodo numerose, di riparare tempestivamente alle gravi perdite che subivano i reparti operanti, di dare ai reparti stessi adeguati periodi di riposo con opportuna rotazione, costrinse di fatto ad impiegare promiscuamente i vari scaglioni, immettendo nei vari reparti elementi anziani e giovaniss imi.
Una interpretazione strategica del nuovo ordinamento 103
generale Paolo Spingardi
Attualmente - disse il Ministro - noi non abbiamo di fatto in tempo di pace alcuna organizzazione [ ] della milizia mobile; per cui all'atto di una mobilitazione occorrerà procedere alla formazione ex -novo di tutti i reparti che la compongono, perché di essi non esiste alcuna base organica. - Si hanno, è vero, in parte, alcuni ufficiali in serviz io attivo permanente, da des t inare alle nuove unità; ma questi, variamente spars i tra i corpi, comandi. scuole, ecc., non hanno che effimera relaz ione di dipendenza e collaborazione tra loro, in rapporto alla costituzione delle unità che dovranno inquadrare; così nessuna forza di coesione e di affiatamento ne deriva per la milizia mobile, su cui pure devesi fare grande assegnamento in qualsiasi ipotesi di guerra. - Intendo perciò dar vita, presso i reggimenti di fanteria e i battaglioni alpini, a solidi nuclei che inquadreranno i richiamati di questa milizia per costituire le unità organiche destinate a entrare in campagna. - Ho perciò preved u to l'aumento di ufficiali superiori, capitani e subaltern i delle varie armi pel comando dei nuclei, ai quali sarà poi assegnata una certa forza di truppa . - Nei reggimenti di fanteria il nucleo sarà per ora formato con 1 ufficiale superiore, 3 capitani, 3 subalterni e una forza di 90 uomini di truppa tra cui 3 sottufficiali e 9 tra caporali maggiori e caporali; ne i battaglioni alpini si avrà pure un p iccolo nucleo con 1 capitano, I suba lterno e 30 uominj di truppa di cui I sottufficiale e 3 caporali maggio ri o caporali . [ ... ] Confi do che gli aumenti aila forza bil anciata, che mi saranno consentiti dalle condizioni del bilancio genera le, mi permettano in avvenire di costituire tali nuclei ed unità senza ridurre la forza delle unità permanenti 84 .
Su quest'ultimo punto si era soffermata la Commissione relatrice, che per bocca di Di Saluzzo aveva evidenziato i due metodi che il Ministro poteva usare per la costituzione di tali nuclei:
O un metodo di economia, procedendo a quella formazione con uomini sottratti alle compagnie, o un metodo di lusso, aumentando il numero del contingente del relativo fabbisogno di uomini, fab bisogno che si può calcolare a 10.000 uomini circa. Nel primo caso, e cioè con un metodo di ripiego, si raggiunge bensì lo scopo dicostituire i vo lut i nuclei di milizia mobile, ma lo si ottiene a [ ] prezzo [ ] di depauperare le unità, proprio quando l'aumento del contingente annuo, ottenutosi con la legge del 1907, ci comincia a dare la possibilità, per tanto tempo sospirata, di avere queste unità sufficientemente robuste e tali da offrire un idoneo elemento di preparazione e di istruzione ai comandanti dei reparti. Nel secondo caso, e così con l'incorporazione di altri 10.000 uomini nel contingente, si andrebbe incontro ad una maggiore spesa che può essere calcolata in cin que mil ioni circa - Fra i due metodi l'onorevole ministro ha scelto ora quello della mi nore spesa. Ma esso, come
84 AA.PP. Legis latu ra XXIIl, Sena10- Documenti, n 324, pp. 3 -4. « Il sistema dei nuclei » puntualizzava Spingardi «è vantaggioso soltanto per la fanteria, dove è possibi le formare intorno a un nocciolo, anche di proporzioni limi tate , il reparto completo Ma per le altre armi, dove l'unità non può esistere se non ha almeno gli elementi indispensabili per la sua istruzione, occorre invece ricorrere alla costituzione di un certo numero di u1ùtà, non molto dissimili da quelle permanenti, che, sudd ividendosi poi all'atto della mobilitazione in più nuclei, possano dar v ita a un numero corrispondeme di unità mobilitate: così si è prevista la costituzione di 2 4 batter ie depQsito dalle quali s i trarranno gli e lementi per le batterie di milizia mobile» (ibidem, p. 4).
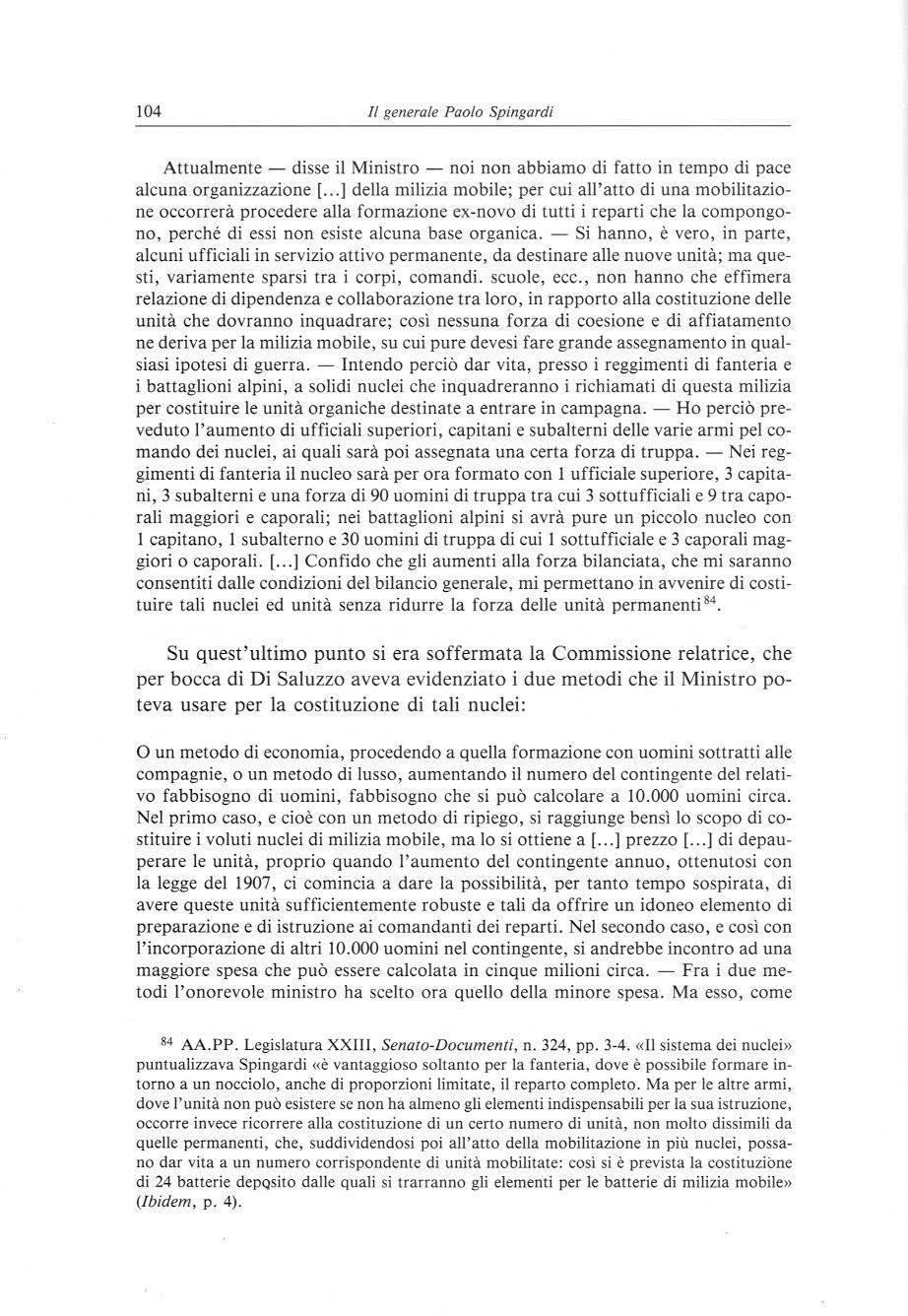
104
Il
Una in t erpretazione strategica del nuovo ordinamento 105
chiaro deve risultare da quanto si è esposto, non è che un ripiego ed il ministro stesso lo ammette. -[... ] La Commiss ione [ ... ] fa voti, adunque, che la nostra forza bilanciata, a llo scopo di avere allo stesso tempo e saldezza di reparti e i nuclei di milizia mobile, sia da 230 mila uomini portata a 240 mila 85 •
Spingardi optò per il sistema auspicato dalla Commissione: infatti nel bilancio 1911 - 1912 la forza bilanciata venne portata a 240.000 uomini 86 •
Va sottolineato che nell'o rdinamento precedente era prevista la quantità precisa dei reparti da costituire con gli elementi di milizia mobile 87 , ma
Spingardi eliminò nel suo disegno tale disposizione perché convinto che non fosse «conveniente rendere di pubblica ragione quali e quante saranno tali formazioni, il cui numero, d'altra parte, potrà vari are colla disponibilità della forza in congedo» 88 •
Questo riserbo rispondeva allo scopo di lasciare il nemico nell'incertezza circa l 'entità delle forze di riserva che si sarebbe trovato di fronte, e aveva quindi un seppur minimo carattere deterrente. Prima dei provvedimenti di Spingardi, esisteva solo una massa disordinata e poco o nulla addestrata di riservisti; la formazione dei nuclei di milizia mobile avrebbe richiesto
85 AA.PP. Legislatura XXIII, Camera-Documenti, n. 47-A/ 47 - bis -A, pp. 4-5. 86 V. RFS. Spingardi a Tedesc.o, 30/ 10/ 1910 (minuta): «Il nostro tallone di Achille sta nella nostra deficiente forza bilanciata. Noi abbiamo unità stremate di forza, specie dopo la creaz ione delle nuove unità di alpini, artiglieria e genio sanci ta dalla nuova legge di ordinamento . E questa forza è ancora ridotta dalla necessità di tenere maggiormente rinforzate per ovvie considerazioni le unità dislocate alla frontiera. Non parlo dei servizi territoriali, dell'ordine pubb l ico così spesso turbato, onde vien meno la preparazione alla guerra. Aggiungi la necessità di provvedere alla costituzione dei nuclei di M.M. per inquadrarvi quest'altro elemento di forza che fa parte integrante del nostro esercito di 1• linea, e che sottrae quindi nuovi elementi alle già scar se unità di fanteria. E potrei co nti nuare! Un aumento di forza bilanciata di almeno 10 mila uomini, reclamato da tutti i militar i competenti , ed anche dalla Commissione d'inchiesta, sarebbe provvedimento veramente saggio . E non occorrerebbero che cinque milioni circa». Per la forza bila nciata nei vari esercizi finanziari v. L'esercito e i suoi corpi. Sintesi storica, USSME, Roma 1971, p 276.
87 51 reggimenti di fanteria su 3 battaglioni, 20 battaglioni bersaglieri su 4 compagnie, 38 compagnie alpini. AA.PP. Legislatura XXIII, Camera -Documenti, N. 47- bis, p . 4. Per brevità si sono tralasciati i reparti di cavalleria, artigl ieria e genio pure previsti, per i quali v. ibidem.
88 AA.PP. Legislatura XXIII Camera -Documenti, n. 47-bis, p. 5. Al Senato disse: «S i è riconosciuto poi che non esiste alcuna necessità di stabilire per legge speciali limiti per le unità delle due milizie [si riferiva anche alla miliz ia territor iale], che non esistano di fatto in tempo di pace e che si dovranno formare so lo all'atto della mobilitazione; l a naturale limitazione nel numero di tali unità esiste g ià nella disponibilità della forza in congedo, che è rego lata da disposizioni legislative . - Si ottiene così il vantaggi o di non dover rendere di pubblica ragione l'ordinamento della nostra forza di seconda e terza l in ea, a simi l itudine di quanto si pratica negli altr i eserciti» (AA.PP. Leg. XXIII, Senato-Documenti, n. 324, p. 5). È comunque evidente che il sistema permetteva di formare un massimo di 94 nuclei di M.M. di fanteria di linea (ché tanti erano i reggimenti) e 26 nuc le i di alpin i (uno per battaglione), che a seconda della forza disponi bile potevano restare a l ivello di compagnia o crescere fino a diventare altrettanti reggimenti e battaglioni.
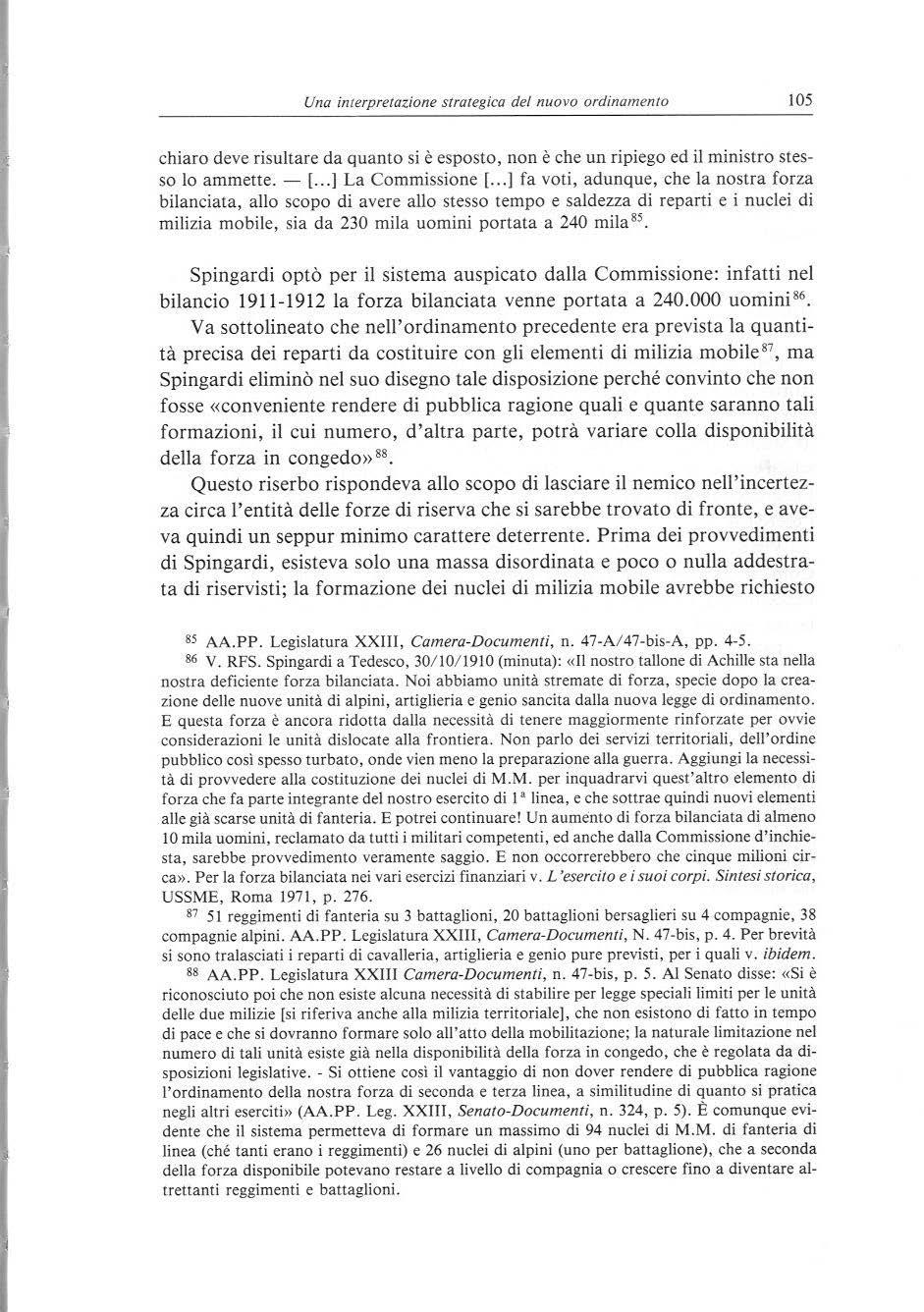
anch'essa un periodo di tempo non indifferente prima di essere completamente attuata 89 : insomma non erano truppe pronte a lanciarsi all'attacco di chicchessia. Anche da questi particolari sembra trasparire il carattere sostanzialmente difensivo dell'ordinamento Spingardi.
Alti comandi
Con la legge Spingardi venne data forma legale ad alcune importanti istituzioni nate con decreti reali e mai inserite nelle leggi di ordinamento Vennero riconosciuti la Commissione Suprema Mista pe r la Difesa dello Stato, istituita «per risolvere, in tempo di pace, le più importanti questioni concernenti la preparazione della difesa nazionale», e il Consiglio dell'Esercito, creato «per dare parere sulle più importanti questioni ri guardanti l'esercito» 90 •
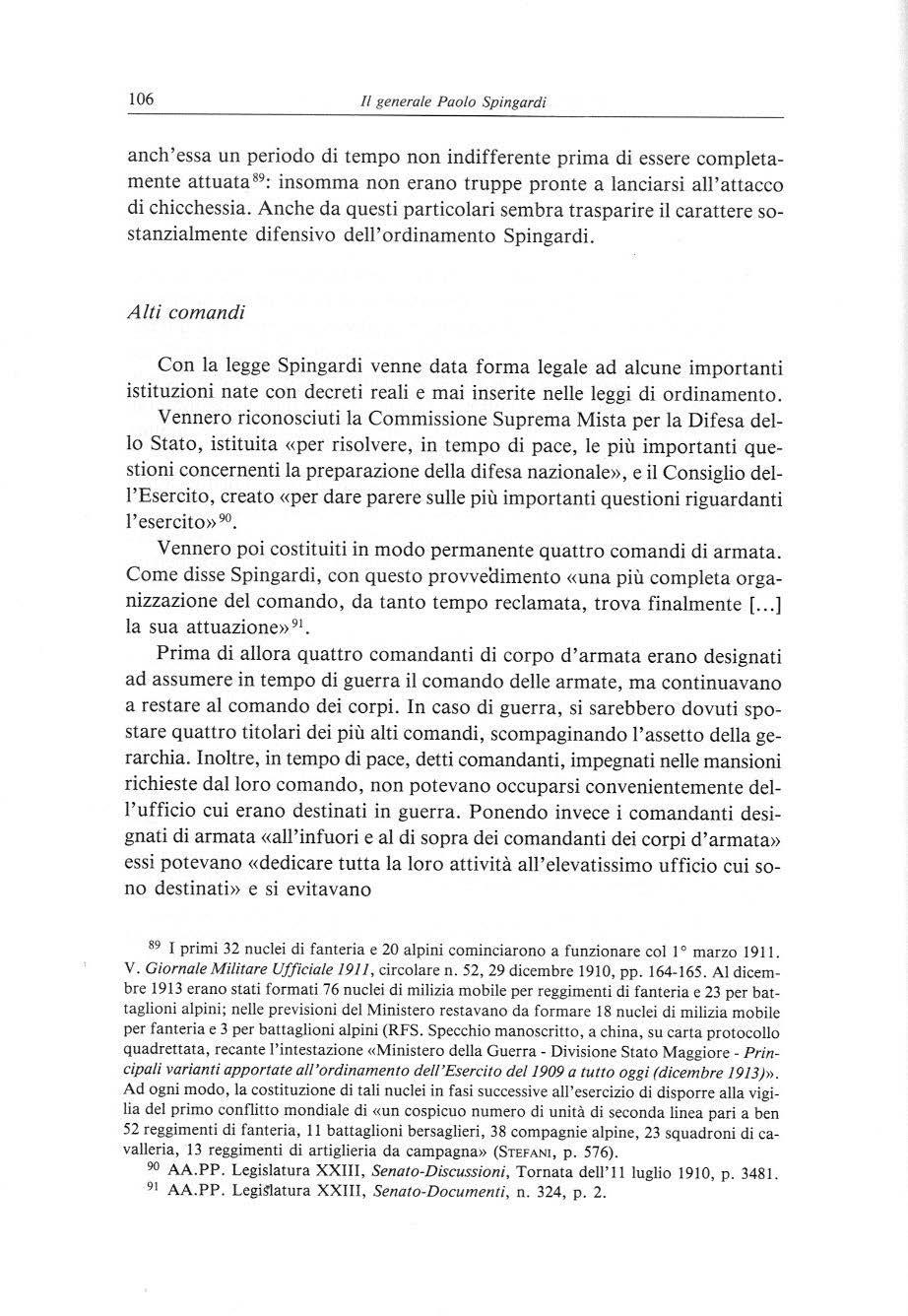
Vennero poi costituiti in modo permanente quattro comandi di armata. Come disse Spingardi, con questo provveè:iimento «una più completa organizzazione del comando, da tanto tempo reclamata, trova finalmente [. .. ] la sua attuazione» 91 •
Prima di allora quattro comandanti di corpo d'armata erano designati ad assumere in tempo di guerra il comando delle armate, ma continuavano a restare al comando dei corpi. In caso di guerra, si sarebbero dovuti spostare quattro titolari dei più alti comandi, scompaginando l'assetto della gerarchia. Inoltre, in tempo di pace, detti comandant i, impegnati nelle mansioni richieste dal loro comando, non potevano occuparsi convenientemente dell'u fficio cui erano destinati in guerra. Ponendo invece i comandanti designati di armata «all'infuori e al di sopra dei comandanti dei corpi d'armata» essi potevano «dedicar e tutta la loro attività all'elevatissimo ufficio cui sono destinati» e si evitavano
89 I primi 32 nuclei di fanteria e 20 alpini cominciarono a funzi onare co l I O marzo I 911 .
V. Giornale Militare Ufficiale 1911, circolare n. 52, 29 dicembre 1910, pp 164-165. AJ dicembre 1913 erano stati formati 76 nuclei di milizia mobile per reggimenti di fan teria e 23 per batta glion i alpin i; nelle previsioni del Ministero restav ano da formare 18 nuclei di mi lizia mobile per fanteria e 3 per battaglioni alpini (RFS Specchio manoscri tto, a china, su carta protocollo quadrettata, recante l'intestazione «Ministero della Guerra - Divisione Stato Maggiore - Principali varianti apportate all'ordinamento dell'Esercito del 1909 a tutto oggi (dicembre 1913)». Ad ogni modo, la costituzione di tal i nuclei in fasi successive all'esercizio di disporre alla vigilia del primo conflitto mondiale di «un cospicuo numero di unità di seconda linea pari a ben 52 reggimenti di fanteria, 11 battaglioni bersaglieri, 38 compagnie alpine, 23 squadro ni di cavalleria, 13 r eggimenti di artigl ieria da campagna» (STEfANI, p. 576).
90 AA.PP. Legislatura XXIII, Senato-Discussioni, Tornata dell'll luglio 1910, p. 3481.
91 AA.PP. LegiS!atura XXlll, Senato-Documenti, n. 324, p. 2.
106 lf generale
Paolo Spingardi
Una interpretazione strategica del nuovo o rdinamento 107
all'atto della mobilitazione, cioè nel periodo più delicato di una campagna, dannosissime sostituzioni nei titolari dei più elevati comandi. Con pregiudizio grave di quell'a ffiatamento e di quella reciproca conoscenza e fiducia tra i comandanti che si stabilisce nel tempo di pace, che è quanto dire durante la preparazione alla guerra 92
Le nuove funzioni dei distretti
Spingardi alleggerì enormemente il compito dei distretti, trasformandoli in puri e semplici centri di reclutamento, allo scopo di rendere sempre più agile la mobilitazione.
Il distretto venne creato nel 1872 da Ministro Rico tti col compito di liberare i reggimenti da tutte le attribuzioni territoriali. Fino allora, infatti, i r eggiment i non erano soltanto unità tattiche, ma erano caricati di tutta una serie di attribuzioni amministrative, quali quelle relative al reclutamento, l'inquadramento e lo smistamento dei richiamati, ecc. Con l'innovazione di Ricotti i reggimenti avrebbero potuto dedicarsi esclusivamente all'istruzione tecnica e tattica.
Negli anni successivi si attribuirono progressivamente ai corpi tutte le funzioni riguardanti il ricevimento dei richiamati e la costituzione delle unità di riserva, esonerandone i distretti 93 • Spingardi ritenne fosse giunto il momento di realizzare, secondo quanto suggerito anche dalla Commissione d'inchiesta
un'ultima semplificazione degli attuali organi di mobilitazione, col passare ai deposit i di fanteria quanto riguarda le formazioni di milizia territoriale, e col lasciare ai di stretti le sole attribuzioni di reclutamento. - Si potrà così ridurre l' organismo del d istretto ad una ben maggiore semplic ità : tolto il peso dei magazzini, il personale amministrativo (155 ufficiali contabili, 455 ufficiali d'ordine e 150 sott uffi cia li ), potrà essere grandemente ridotto (.. . ), il servizio matricolare dovrà essere g r andemente semp lificato col sopprimere le duplicazioni dei ruoli ora tenuti contemporaneamente da due enti diversi ; infine il personale ufficiale dei distretti, costituito da 132 ufficiali superiori, 176 capitani e 88 subalterni, nella quasi totalità in servizio attivo permanente, potrà gradatamente scomparire a beneficio de ll e forze vive dell'esercito, ed essere sostituito completamente da ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario, in numero però assai più modesto, sembrando sufficiente in media l'assegnazione di 1 ufficiale s u per iore e 2 capitani per ciascun distretto di reclutame n to: in tota le 88 ufficiali superiori e 176 capitani, con un ri sp armio di spesa, a riforma compiuta, di circa lire I . 700.000, pur senza tener conto de lle possibili
92 Ibidem. In sintonia col pensiero di Spingardi anche La designazione per gli alti comandi Per battere il chiodo, «La Preparazione», Martedì-Mercoledì 23-24 maggio 1911
93 V. AA.PP Legis latura XXIII, Senato-Documenti, n 324, pp 10-11 e Re/azione Ufficiale, nota 16 a p. 50.
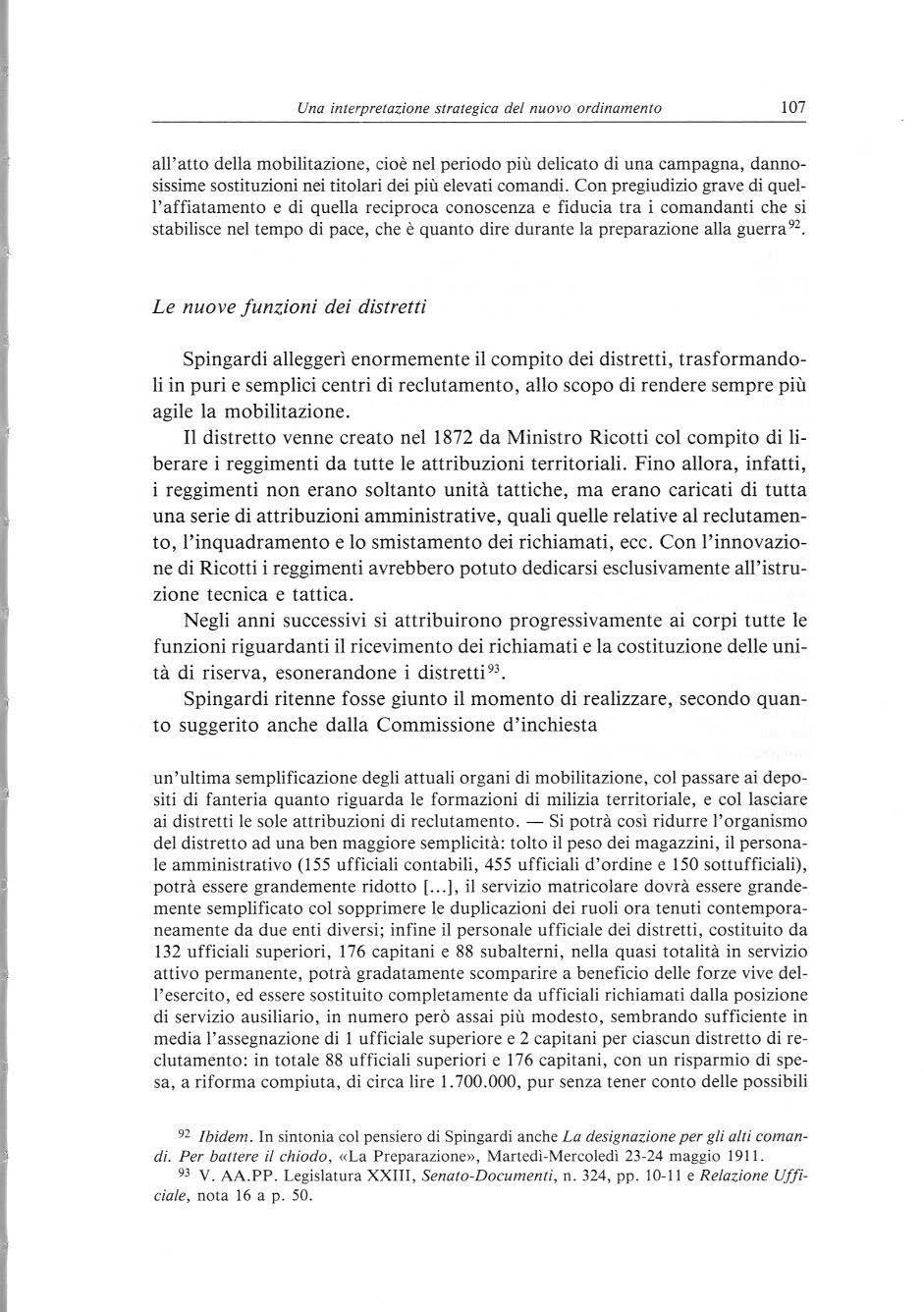
Il generale Paolo Spingardi
riduzioni nel personale d'ordine. - Si ha poi così modo di impiegare un certo numero di ufficiali che lasciano l'esercito attivo quando sono tuttora in grado di prestare un utile servizio sedentario 94.
Razionalizzata l'intelaiatura dell'esercito con il nuovo ordinamento e rafforzatane la fibra con l'adeguata quantità di soldati, era tempo di occuparsi di chi tale imponente struttura doveva comandare : gli ufficiali.
94 Ibidem, p. 11. Va infine ricordato come , con un sol tratto, conformemente al desiderio della commissione d'inchiesta, Spingardi cancellasse il sistema detto delle masse dei corpi, abolendo il corpo contabile e riordinando il corpo di commissariato, trasformando così l'intero sistema amministrativo dell'esercito (leggi 17 luglio 19 10 n . 511 e 17 luglio 1910 n. 531).
Il sistema delle masse di corpo «risaliva addirittura al tempo delle compagnie di ventura, quando il comandante e proprietario della compagnia riceveva una somma fissa per ogni guerriero che si impegnava a portare in combattimento, pensando con questa somma a tutti i suoi bisogni. Nell'esercito italiano ogni reggimento [... ) ammini~trava una seri e di masse: per il vitto dei soldati, ad esempio, il reggimento riceveva una somma fissa (quota giornaliera moltiplicata per il numero delle presenze) con la quale doveva provvedere a nutrire gli uomini rispettando la tabella ministeriale delle spettanze quotidiane . Anche le altre esigenze normali del reparto erano coperte da masse speci fiche (generale, vestiario, mensa sottufficiali, cavalli, ospedale,ecc.) nella cui gestione si rivelava la capacità del comandante e dei suoi collaboratori: le economie come i passivi realizzati, infatti, ricadevano sulla massa stessa , a suo vantaggio o svantaggio Erano però possibili compensazioni tra le varie masse, su cui poi il ministero poteva scaricare anche spese diverse. Il sistema era a ssai complesso, consentiva una certa autonomia ai comandanti di corpo ma non li liberava dal controllo superiore: era inoltre illegale, perché costituiva un'amministrazione parallela che esautorava quella previs t a dalle leggi sulla contabilità statal e» (ROCHAT-M ASS0B R1o, p. 77. V. anche Relaz ione Ufficiale p. 20 e nota 17 p. 51). Con le modificazioni introdotte da Spingardi, ai pag amenti si sarebbe da quel momento in poi provveduto con stanziamenti annuali in sede di bilancio del Ministero della Guerra . Il nuovo sistema entrò in vigore il I O luglio 191 I e s i rien t rò nella legalità Si creò però un vero e proprio caos contabile del quale si parlerà nel cap . VIII (v. p. 196) .
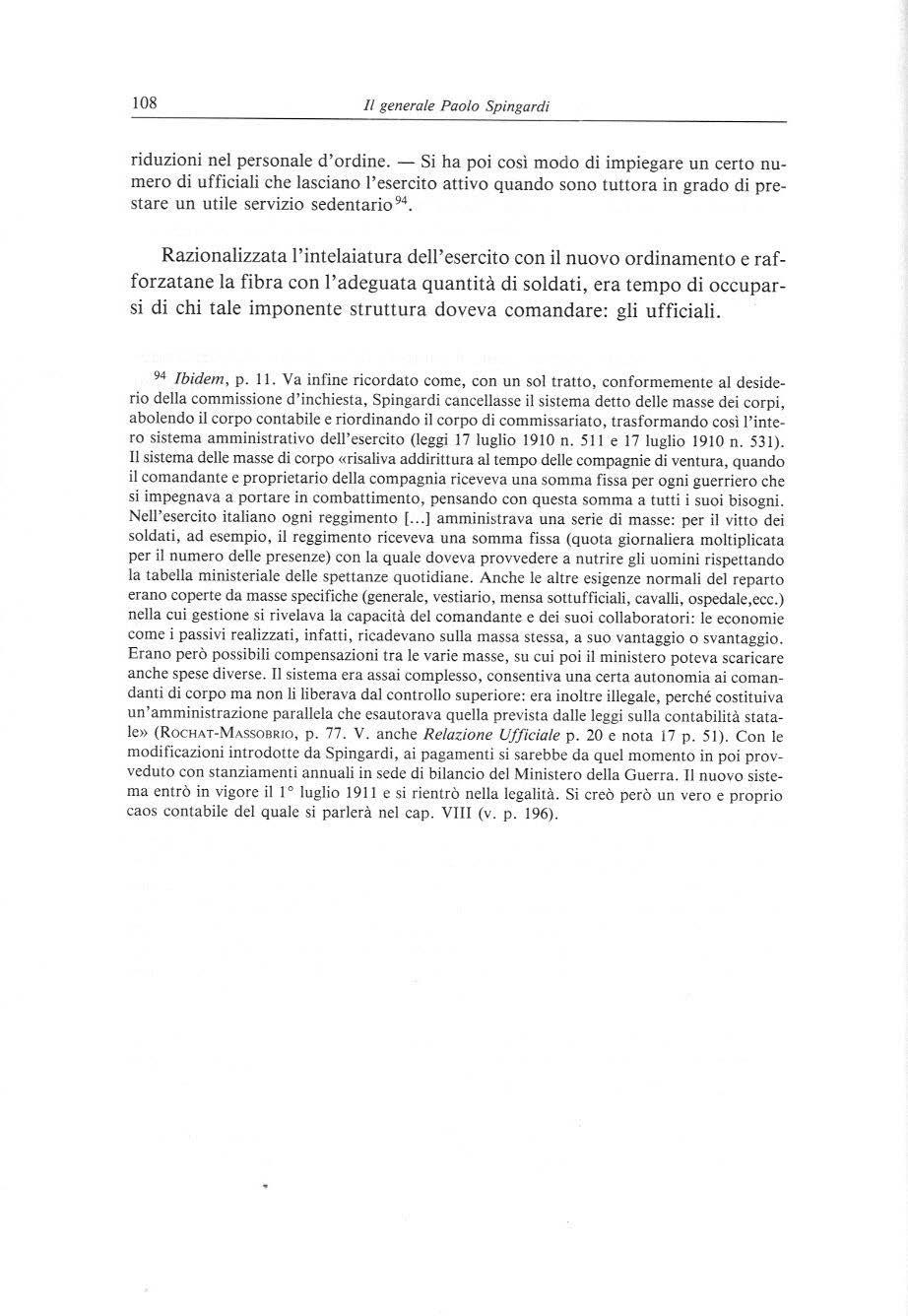
108
CAPITOLO V
LA DIFFICILE SELEZIONE DEI QUADRI
La crisi dei quadri inferiori
La legge 17 ottobre 1881 n 435 che istituiva la posizione di servizio ausiliario, favorendo l'allontanamento dai quadri «attivi>> di molti ufficiali maturi d'anni, e l'aumento di due corpi d'armata ne l 1882, provocarono da un lato
numerose promozioni che condussero ai gradi superiori ufficiali (. ] in età così giovane che per lungo tempo ne furono attenuate le eliminazioni per limiti di età; dall'altra parte si ebbero così numerose ammissioni, che nel quadriennio 1882-1885 furono ammessi nella sola arma di fanteria ben 3200 sotto tenent i 1 •
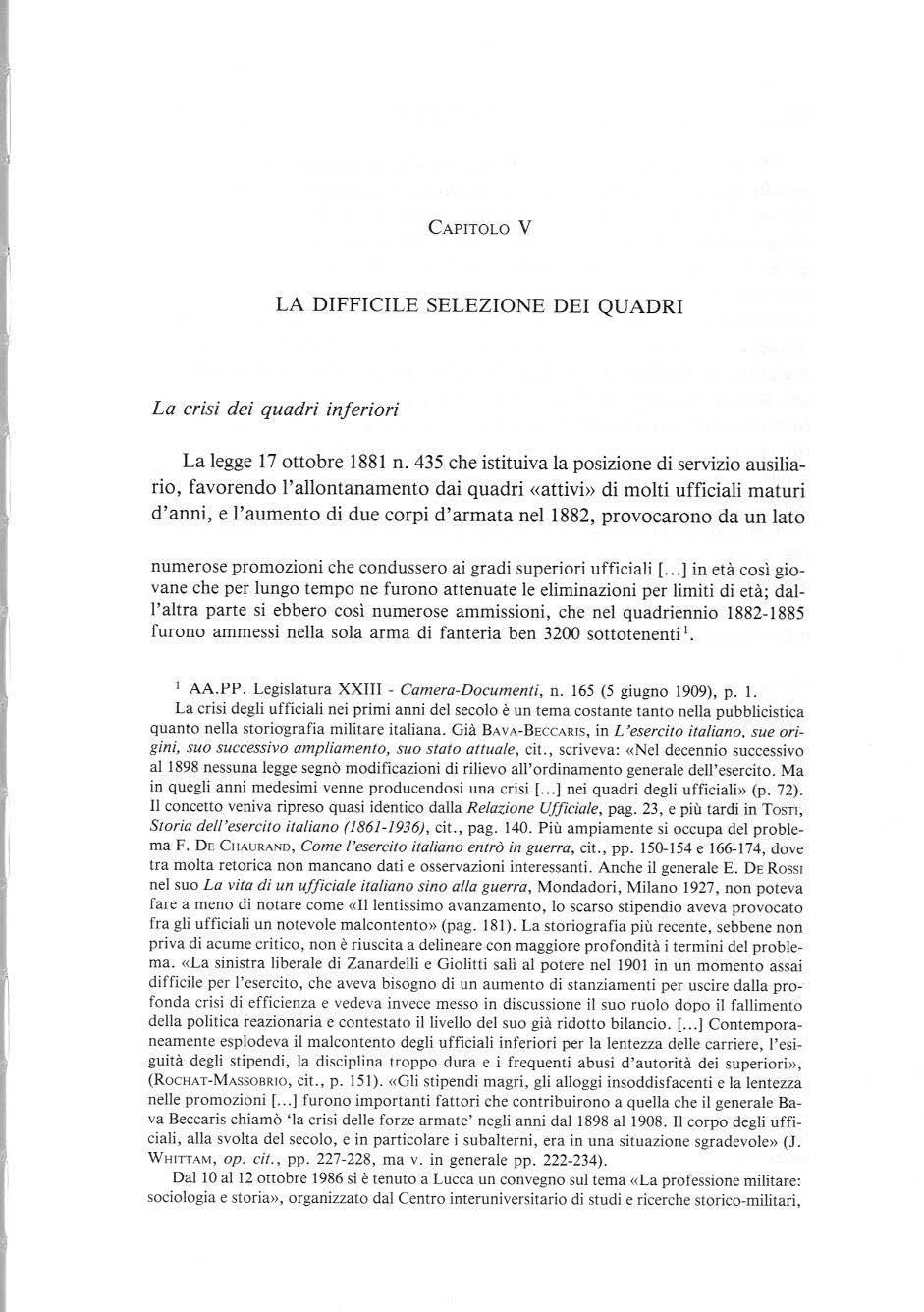
1 AA.PP. Legislatura XXIII - Camera-Do cumenti, n. 165 ( 5 giugno 1909), p. I.
La crisi degli ufficiali nei primi anni del secolo è un tema costante tanto nella pubblicistica quanto nella storio-grafia militare italiana. Già BAVA -BECCA RIS, in L'esercito italiano, sue origini, suo successivo ampliamento, suo stato attuale, cit., scri veva: «Nel decennio successivo al 1898 nessuna legge segnò modificazioni di rilievo all'ordinamento generale dell'esercito. Ma in quegl i anni medesimi venne producendosi una crisi [ ] nei quadri degli ufficiali» (p. 72). Il concetto veniva ripreso quasi id ent ico dalla Relazione Ufficiale, pag. 23, e più tardi in TOSTI, Storia dell'esercito italiano (1861 -1936), cit ., pag. 140. Più ampiamente si occupa del problema F. DE CHAURAND, Come l'esercito italiano entrò in guerra, cit., pp. 150-154 e 166- 174, dove tra molta retorica non mancano dati e osservazioni interessant i Anche il generale E D ERossi nel suo La vita di un ufficiale italiano sino alla guerra, Mondadori, Milano 1927, non poteva fare a meno di notare come « Il lent issimo avanzamento, lo sca rs o stipendio a veva provocato fra gli ufficiali un no tev ole malcontento» (pag 181). La storiografia più recente, sebbe n e non pr iva di acume cr itico, non è r iu scita a delineare con maggiore profondi tà i termini del problema « La sinistra libera le di Zanardelli e Giolitti salì al potere nel 1901 in un momento assai diffi c ile per l 'e sercito, che aveva bisogno di un aumento di stan ziamenti per uscire dalla profonda crisi di efficienza e vedeva invece messo in discussione il suo ruolo dopo il fallimento della politica reazionaria e contestato il livello del suo g ià ridotto bilancio. [ ] Contemporaneamente esp lodeva il malcontento degli ufficiali inferiori per la lentezza delle carriere, l'esiguità degli stipendi, la disciplina troppo dura e i frequenti abusi d'autorità dei super iori», (RocHAT-MASSOBR10, cit., p. 151). <<Gl i st ipen di magri, g l i alloggi insoddisfacent i e la lentezza nelle promozioni [ ) furono importanti fattori che cont r ibuirono a quella che i l generale Bava Beccaris chiamò 'la cris i delle forze armate' negli anni dal 1898 al 1908. Il corpo degli ufficiali, alla svo lta del secolo, e in particolare i suba l tern i, era in una situaz ione sgradevole» (J. WH1rrAM, op. cit., pp. 227-228, ma v. in generale pp. 222-234).
Dal IO al 12 ottobre 1986 si è tenuto a Lucca un convegno s ul tema « La professione militare: soc iologia e storia», organizzato dal Centro in te runivers i tario di studi e ricerche storico-militari,
Ma una volta esauritasi la spinta di questi provvedimenti, le carriere cominciarono a ristagnare Gli anni di permanenza nei gradi inferiori divennero molto lunghi rendendo sempre meno gradito il servizio del subalterno, che era allora molto pesante 2 • Stipendi tollerab ili per un ventenne appena uscito dall'Accademia o dalla Scuola militare, potevano risultare drammaticamente insufficienti a consentire un livello di vita decoroso per un tenente che avesse superato abbondantemente la trentina e desiderasse magari formarsi una famiglia o, peggio, fosse costretto a mantenere una famiglia irregolare o clandestina 3 • La legge 2 luglio 1896, n. 254, varata dal Ministro Ricot ti rimaneggiava i limiti di età per ciascun grado4, e mirava a uniformare quanto più possibile le carriere secondo il criterio dell'anzianità. Più che migliorare la situazione, la legge parve sancirla. Di fatto le carriere rimasero intasate e gli ufficiali infer iori vicini ai limiti di età si deprimevano sempre più.
Col nuovo secolo i sottotenenti degli anni Ottanta erano di ventat i capitani e maggiori, abbastanza giovani per non essere colpiti dai limiti di età a breve scadenza, ma con una anzianità di serv izio suffic ien te a consentire loro di occupare i primi posti nelle graduatorie e limitando quindi notevolmente le prospettive di avanzamento di quanti li seguivano .
i cui atti sono stati raccolti a cura di G. CAFORIO e P. DEL NEGRO nel volume Ufficiali e società. Interpretazioni e modelli, Franco Angeli, Milano 1988. Benché l'approccio sociologico occupi a mio avviso una proporzione eccess iva rispetto all'approccio più puramente storico, il vo lume rappresenta un importante progresso negli studi sulla materia. Sulla linea di studi delineata dal convegno si è inserito M. M ER 1GG1 col saggio L'ufficiale a Milano in età liberale in «Ri vista di storia contemporanea», fascicolo n. 4, (ottobre) 1988, pp 524-545. Particolarmen te attento ai problemi del corpo uffic iali è J. GooCH, Army, State and Society in /taly, cit. Per il periodo qui preso in considerazione v. pp. 124- 125 e 135-136.
Sui corsi accelerati che tra il 1881 e il 1884 permisero la nomina a sottotenente dopo soli sedici mesi di corso alla Scuola militare di Modena cfr. DE Rossi, cit., pp. 24-27: «Il mio corso di Modena, detto dei ,Mille , perché presso a poco tanti eravamo, ebbe il soprannome di scellerato, in opposizione a quello ufficiale di accelerato, tanti furono in seguito i rimossi, i revocat i , i dimes si» (p. 27); D E CHA URANO, c i t , pp. 150-151; E. D E BO NO, cit., pp. 76-77: «S i impastarono alla meglio dei sottotenenti i n sedici mesi , i quali andarono ai reggimenti sapendone ben poco. Per questo gius tam e n te i Corsi accelera t i furono poi comunemente chiamati Corsi Scellerati» (p. 77).
2 V. DE Ross i, p. 36; DE BoNo, pp. 256 -264.
3 Sul problema del matrimonio per gli ufficiali v. D E Rossi, pp. 55-56; D E BONO, pp. 159- 16 1;
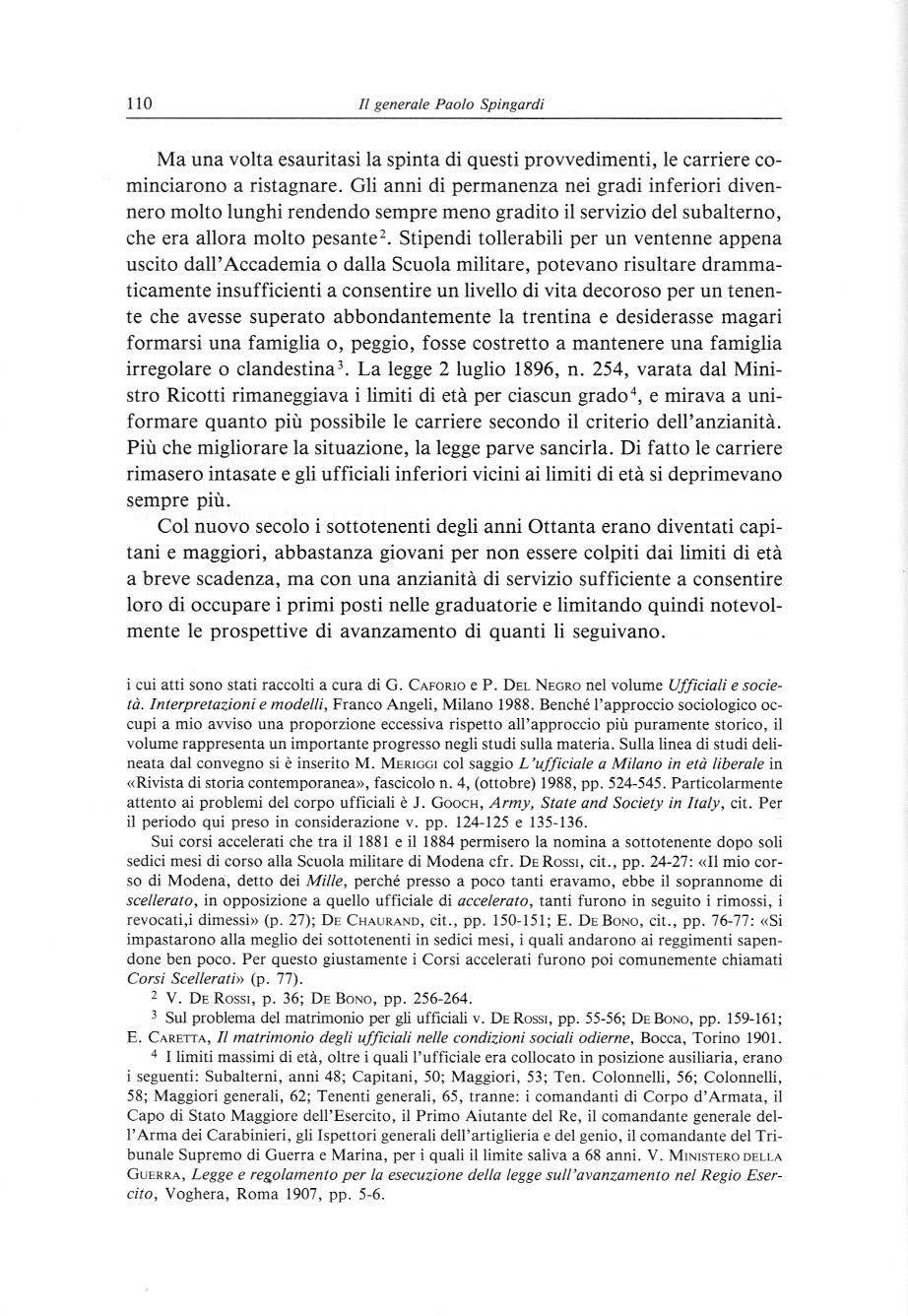
E. CAR ISTTA, Il matrimonio degli ufficiali nelle condizioni sociali odierne, Bocca, Torino 1901.
4 I limiti massimi di età, oltre i quali l'ufficiale era collocato in posizione ausiliaria, erano i seguenti: Subalterni, anni 48; Capitani, 50; Maggiori , 53; Ten. Colonnelli, 56; Colonnelli, 58; Maggiori genera l i, 62; Tenenti generali, 65, tranne: i comandanti di Corpo d'Armata, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Primo Aiutante del Re , i l comandante generale del-
1' Arma dei Carabinieri, gli Ispettori generali dell'artiglieria e del genio, i l comandante del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, per i quali il limite sal iva a 68 anni. V M1N1STERO OELLA
GU ER RA, Legge e regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamen10 nel Regio Esercito, Voghera, Roma 1907, pp. 5- 6.
110 Il
generale Paolo Spingardi
La difficile selez ione dei quadri lii
Specialmente in fanteria, dove il problema si manifestava in forma più acuta , i mugugni abituali divennero un malcontento che rischiava di incrinare la disciplina. Portavoce dei grognards si fece il periodico «Il Pensiero Militare» fondato nel 1903 dal capitano in aspettativa Fabi o Ranzi 5 • Vari provvedimenti parziali ottennero qualche beneficio: la legge del 1902 sulla promozione straordinaria a capitano di 400 tenenti di fanteria e sulla concessione ai capitani di fanteria della aspettativa speciale a domanda; e varie leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio Esercito che, aumentando gli emolumenti, migliorarono le condizioni materiali degli ufficiali inferiori 6.
Spingardi volle sciogliere l'ultimo nodo, l'avanzamento, secondo il principio di
ass icurare a tutti gli idonei una modesta ma sicura carriera; consentire in giusta misura ad una schiera di eletti per for te ingegno e per qualità essenziali di carattere di ascendere p iù rapidamente verso il vertice della piramide 7 •
Ebbe su questo punto anche l'appoggio di Fabio Ranzi, che sperava il Ministro rispondesse
coi fatt i alla suprema esigenza di far cessare ogni ragione di malcontento, ogni causa di dissidio fra le varie parti dell'esercito e fra i vari ordini della gerarchia Affermare che una buona legge d'avanzamento deve mirare , nell'interesse dell'esercito,
5 Lo st udio più ampio su Fabio Ranzi è quello di D. DE NAPO LI , Il caso Ronzi e il modernismo militare, in AA. VV., L'esercito italiano dall'Unità alla Grande Guerra, cit., pp. 221-244. Cfr. poi DE Rossi , cit., pp 181- 182; DE CHA URANO, cit., pp. 167-172; P. F. Q u1Nz10, La professione militare in «Armi e progresso» e in «Pensiero militare» Sociologia militare e dirillo militare in Fabio Ronz i , in G. CAFORIO e P. D EL NEGRO (cur.), Ufficiali e società, cit., pp. 525-533.
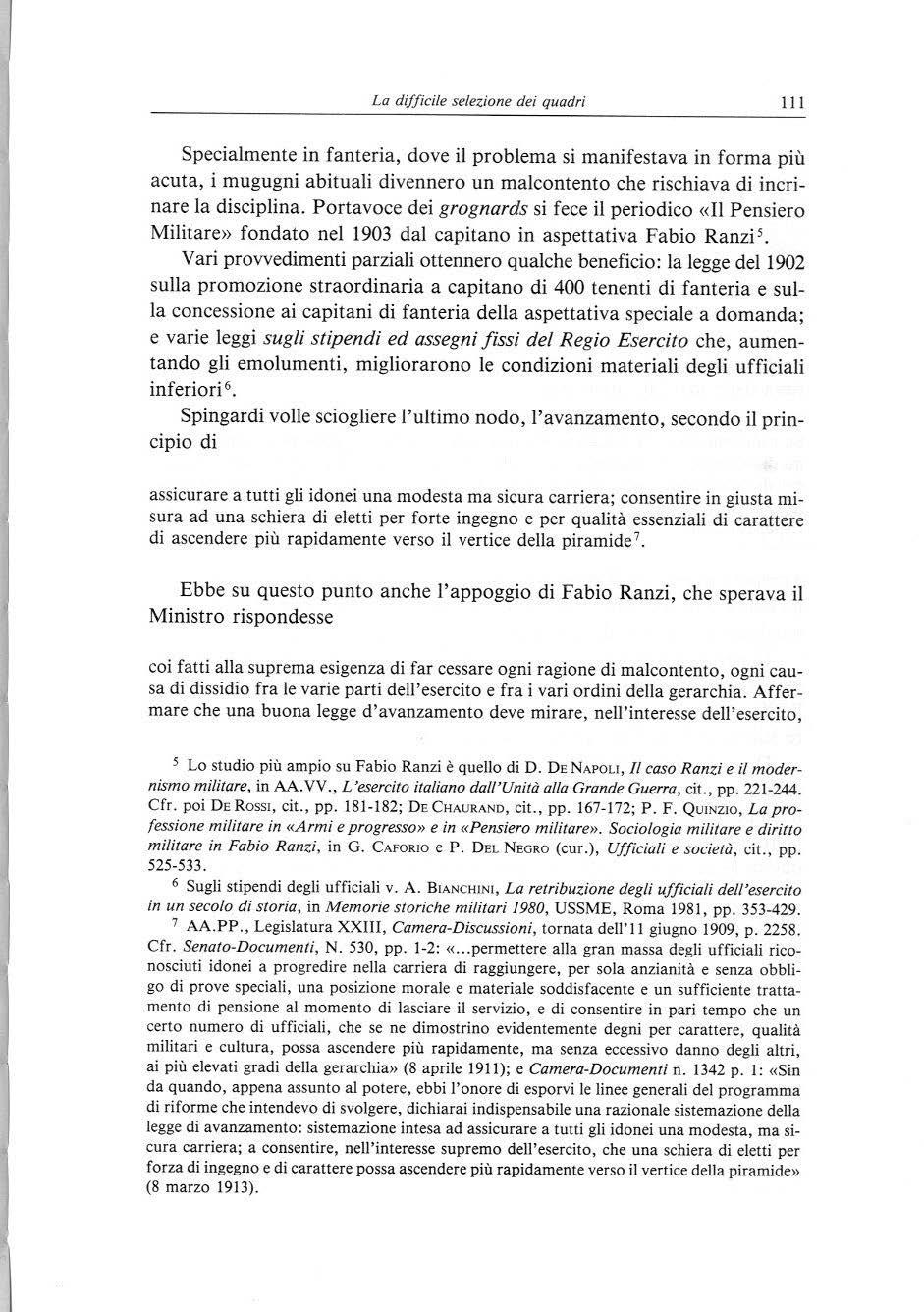
6 Sugli stipendi degli uffici ali v . A. BIAN CHINI, La retribuzione degli ufficiali dell'esercito in un secolo di storia, in Memorie s toriche militari 1980, USSME, Roma 198 1, pp. 353 -429.
7 AA PP. , Legislatura XXIII , Camera-Discussioni, tornata dell'l l giugno 1909, p. 2258.
Cfr. S enato-Documenti , N. 530, pp. 1-2 : « permettere alla gran massa degli ufficiali riconosciuti idonei a progredire nella carriera di raggiungere, per sola anzianità e s enza obbligo di prove speciali, una posizione morale e materia le soddisfa cen te e un sufficien t e t r attamento di pensione al momen to di l asciare il servizio , e di consentire in pari tempo che un certo numero di ufficiali, che se ne dimostrino evidentemente degni per carattere, qualità militari e cultura, possa ascendere più rapidamente, ma senza eccessi vo danno d egli altri, ai più elevat i g radi della gerarchia» (8 aprile 1911); e Camera-D ocumenti n. 1342 p. I: «Sia da quando, appena assunto al pot ere, ebbi l ' onore di esporvi le linee generali del programma di riforme che intendevo di sv olgere, dichiarai indispensabile una razionale sistemazione della legge di avanzamento: sistemazione intesa ad assicu rare a tutti gli idonei una modesta , ma sic ura carriera; a conse nti re, nell'interesse supremo dell'esercito, che una schiera di el etti per forza di ingegno e di carattere possa ascendere più rapidamente verso il vertice della piramide» (8 marzo 19 13).
a far salire rapidamente gli individui più meritevoli di raggiungere le vette del comando, ma dev e in pari tempo garantire a tutti una carriera modesta ma sicura, onde gli eletti si levino sopra una massa di soddisfatti, vuole dire sanzionare come programma di governo lo stesso concetto fondamentale di una buona legge d'avanzamento che noi, fin dal primo giorno che il Pensiero Militare è venuto alla luce, abbiamo tentato di esprimere con la formula: garanzia di una carriera sicura a tutte le capacità medie; vantaggi eccezionali alle capacità eccezionali ovunque si trovino e comunque si manifestino 8
Spingardi ben sapeva come da parecchio tempo si verificasse nella carriera degli ufficiali subalterni
un rallentamento che è cagione di disagio. Esso si fa specialmente sentire nelle armi di fanteria e di artiglieria, nelle quali il grado di capitano non si raggiunge che nel diciassettesimo anno di spalline, e nel corpo veterinario e in quello contabile, dove la permanenza nei gradi subalterni si spinge s ino a diciotto e a venti anni rispettivamente 9
e preparò quindi un disegno di legge che prevedeva la promozione a capitano dei tenenti con quindici anni di anzianità da ufficiale effettivo e la promozione a maggiore dei capitani con ventisette.
L'orientamento della Camera era favorevole alla soluzione prospettata da Spingardi, anche se la Commissione esaminatrice 10 ritenne opportuno limitarsi a uno stralcio per quanto rigua r dava i tenenti, rinvian do a ulteriore studio le disposizioni relative ai capitani .
Due considerazioni avevano suggerito questa soluzione: da un lato la chiusura ormai prossima dei lavori parlamentar i per le vacanze estive limitava il tempo a disposizione per discutere il provvedimento; dall'altro «mentre numerosi sono i tenenti i quali potranno subito godere del vantaggio recato da questa legge, non v'hanno per contro capitani in analoga condizione» 11 •
L a scelta r ispondeva del resto al concetto, diffuso nella gerarchia e condiviso dallo stesso Minist r o, che fosse necessario fare del grado di capitano «una posizione discreta e facile da raggiungersi, ma difficile a sorpassarsi
8 Per la co ncordia nell'esercito. L'unica via per giungervi, «Il Pensiero Militare », Mercoledì 16-Giovedì 17 giugno 1909.
9 AA.PP. Legislatura XXIII - Camera-Documenti, n. 165 (5 giugno 1909), p. l. Cfr. anche Relazione Ufficiale, nota 20 a p. 51, che dà tempi leggermente diversi riferiti però al 1907.
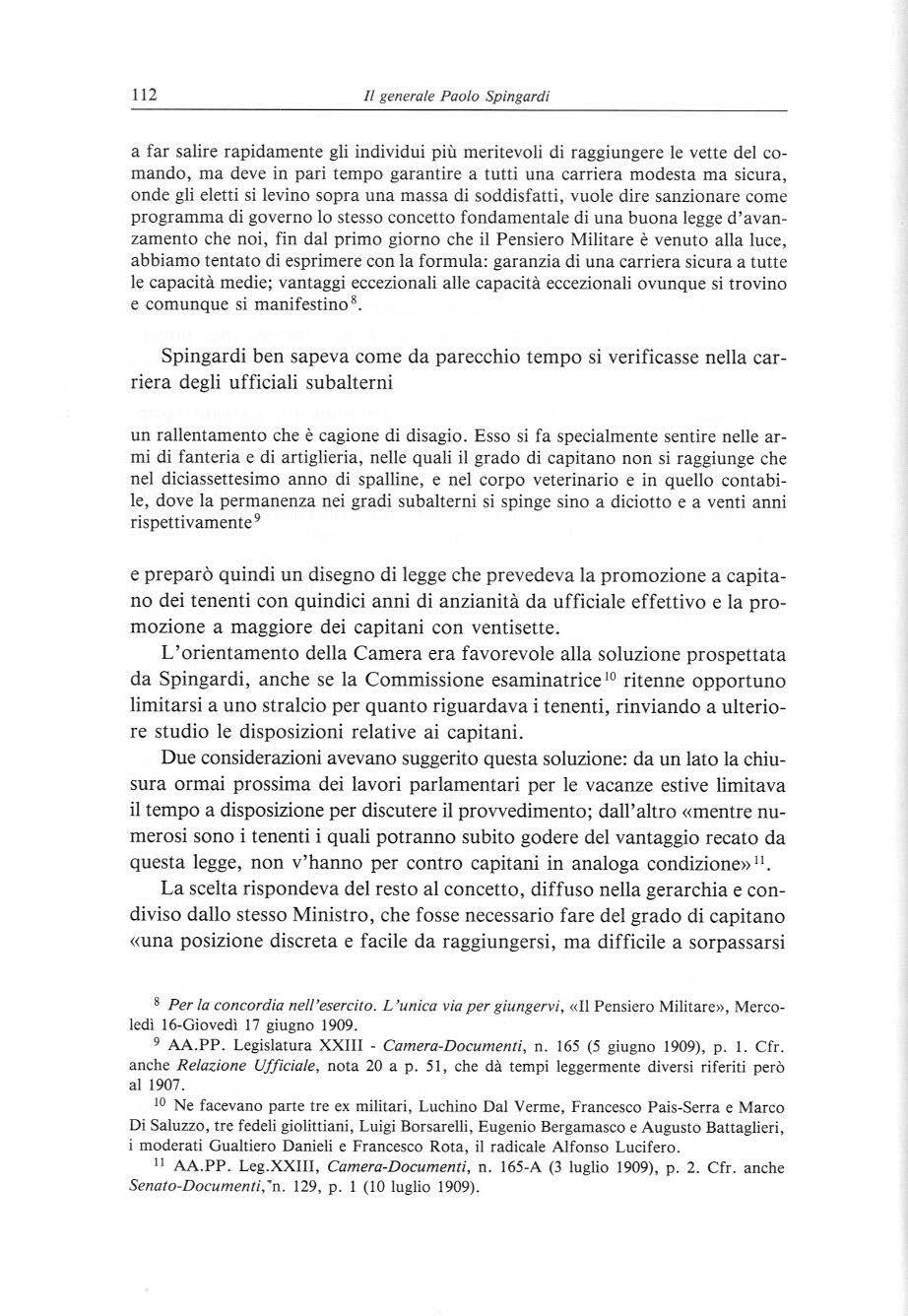
10 Ne facevano parte tre ex militari, Luchino Dal Verme, Francesco Pais -Serra e Marco Di Saluzzo, tre fedeli giolittiani, Luigi Borsarelli, Eugenio Bergamasco e Augusto Battaglieri, i moderati Gualtiero Danieli e Francesco Rota , il radicale Alfonso Lucifero.
11 AA.PP. Leg.XXIII, Camera-Documenti, n. 165-A (3 luglio 1909), p. 2. Cfr. anche Senato -Documenti,"n. 129, p. I ( IO luglio 1909)
112 li
generale Paolo Spingardi
da chi non dia ineccepibili e rigorose prove di peculiare capacità» 12 • Spingardi accettò infatti lo stralcio senza alcuna obiezione.
Il provvedimento aveva carattere transitorio ed eccezionale, poiché, affermava Spingardi, «sarà facile ottenere che verso il 1915 il grado di capitano possa essere raggiunto con 13 anni di spalline» 13 •
Al momento, però, si creava un certo numero di capitani in più nell'organico. Allo scopo di attenuare gli inconvenienti portati da tale es ubera nza (sostanzialmente di avere una massa di ufficiali con un grado relativamente elevato ma senza possibilità di svolgerne le attribuzioni), Spingardi prevedeva di estendere ai capitani di tutte le armi combattenti l'aspettativa speciale stabilita nel 1902 per i soli capitani di fanteria. Per facilitare poi l'uscita definitiva dai quadri dei non idonei, il ministro stabiliva «di concedere a coloro che si trovassero a disagio dopo una prima esclusione dall'avanzamento, di potere senz'altro ottenere il congedo provvisorio» 14 •
Vi fu ugualmente chi, come il generale Primerano, temette che il provvedimento avrebbe raJ!entato le promozioni negli anni successivi, provocando un ennesimo intasamento delle carriere, e non mancò di rilevarlo.
Il presente disegno di legge si ispira a un concetto, secondo me, affatto anormale, perché propone si facciano numerosa promozioni, senza che vi siano i posti vuoti da coprire. (... ] L'onorevole ministro dice: si tratta di una misura ecceziona le richiesta da ecceziona le ristagno di promozioni. Ma eccezionale non è, perché l'abbiamo adottata altra volta, e non è molto furono promossi d'un tratto 400 capitani in soprannumero con la conseguenza di un altro ristagno di carriera per tutti quelli che seguivano e che aspettavano la promozione a cap itano 15 •
Spingardi replicava assicurando che la portata e la durata del provvedimento,
spiccatamente temporaneo, sono ben lungi dall'essere quali il senatore Primerano s'immagina . Bastano poche cifre a convincere . - In questo scorcio dell'anno 1909
12 Cfr. F . S ANTANGELO, Reclutamento e avanzamento degli ufficiali negli eserciti italiano, francese, tedesco ed austroungarico, Tipografia Oliviero (a cura della Scuola di Guerra), Torino 1909, p. 118 e 12 1; e anche DE Rossi, cit., p 109. Spingardi si dichiarò «pienamente concorde colla Commissione parlamentare d'inchiesta per l'esercito nel ritenere che, fino a un certo limite della carriera, la grande maggioranza degli ufficiali possa e debba avanzare senza dare altre prove d'idoneità all'infuori di quelle fornite quotidianamente nella pratica del servizio E questo limite credo sia rappresentato dal grado di capitano, che viene raggiunto dopo un periodo di tempo non eccessivamente lungo di servizio da subalterno, e che dà all'ufficiale una posizione morale e materiale soddisfacente, e la sicurezza di un sufficiente t rattamento di pensione qua lora non debba progredire ulteriormente nella carriera» AA.PP. Legislatura XXIII, Senato-Documenti, n. 162, p. I (22 febbraio 1910).
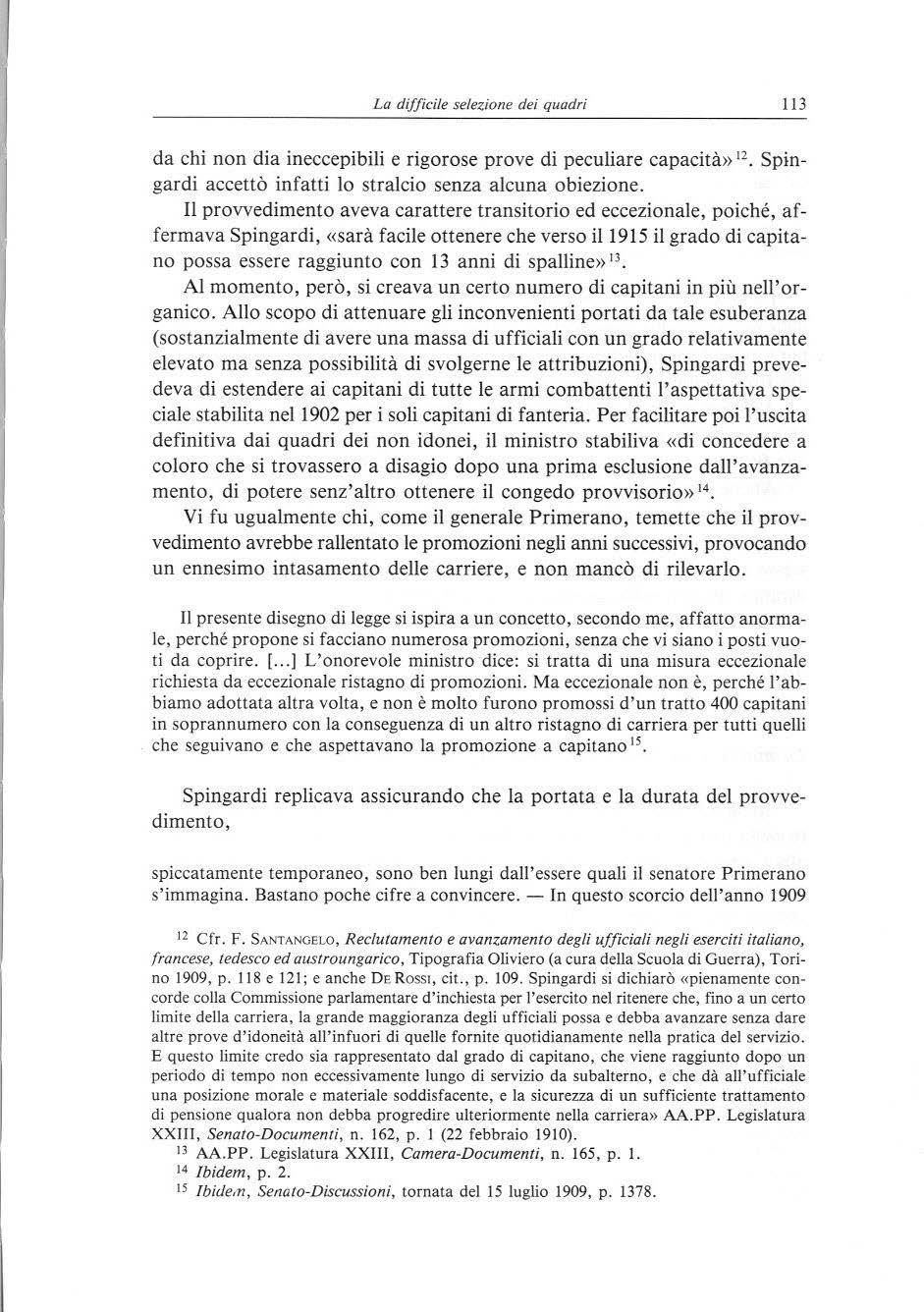
13 AA.PP. Legislatu r a XXIII, Camera-Documenti, n. 165, p. I.
14 Ibidem, p. 2.
15 Ibidem, Senato-Discussioni, tornata del 15 luglio 1909, p . 1378.
La difficile selezione dei quadri 113
noi verremo ad avere (parlo della fanter ia che rappresenta la massa degli ufficiali) 207 capitani in più nell'organico. Nell'anno 1910 ne avremo 142, nel 1911 soltanto 47 e nell'anno successivo la legge cesserà automaticamente di funzionare [poiché] le pr omozioni a capitano di fanteria avverranno prima de l quindicesimo anno per semplice effetto di vacanze in organico 16
Le nuove leggi di ordinamento portavano infatti un discreto aumento delle unità a livello compag nia e numerosi capitani sarebbero stat i utilizzati per l'inquadramento dei nuclei di milizia mobile: Spingardi riteneva insomma i provvedimenti organici suffici enti ad assorbire le eccedenze.
Ad ogni modo il disegno venne facilmente approvato dalla Camera il 10 luglio 1909 con 206 voti favorevoli e 42 contrari e dal Senato il 16 luglio con 96 voti favorevoli e 12 contrari (Legge I 9 lu glio 1909, n. 493).
Anche se mancano elementi sufficienti ad indagare con precisione la vita quotidiana degli ufficiali s ubalterni negli anni successiv i, semb ra che le lamente le diminuissero. Ranzi divenne una voce sem pre più isolata 17 e la stessa ufficiosa «Rivista Militare)), che sovente negli anni precedenti aveva ospitato articoli sulla questione, cessò di occuparsene 18 •
Risolta la spinosa questione dei subalterni, Spingardi rivolse l'attenzione ad una legge d'avanzamento che consentisse la migliore selezione dei quadri superiori.
La nuova legge sull'avanzamento Il primo disegno
Spingardi presentò un primo disegno di legge sull'avanzamento al Senato nella tornata del 22 febbraio 1910, undici giorni dopo aver presentato alla Camera il progetto sull'ordiname nto. In armonia con questo, infatti, era prevista l'abolizione del Co rpo di Stato Maggiore e la sua sostituzione con un semplice servizio di Stato Maggiore.
16 Ibidem, p. 1382.
17 Non appena i provvedimenti di Spingardi riso lsero il problema dei subalterni svuotando i contenuti della protesta, Ranzi camb iò atteggiamento attaccando talvolta du ram ente il Ministro. Trombato alle elezioni del 1913 , Ranzi vide diminuire drasticamente i l numero degli abbonati senza più avere la forza di aggregazione dimostrata negli anni 1903-1908.
V. Se vogliamo che viva il «Pensiero Militare», «Il Pens iero Mili tare», Domenica 23 novembre 1913; Il pensiero militare deve vivere, «Il Pensiero Militare», Domenica 7 dicembre 1913 e in generale tutti i numeri di quell'anno e del principio del successivo. V. anche D ENA POlr, cit., pp. 237 e 239.
18 V. A. V1s1 NT1N, La professione militare e il dibattito sul militarismo nella «Rivista Militare Italiana» in G, CAFORIO e P. DEL NEGRO (cur.), cit., pp. 503-524. Cfr. D EL N EG RO, La professione militare nel Piemonte costituzionale e nell'Italia liberale, in ibidem, pp. 222-223.
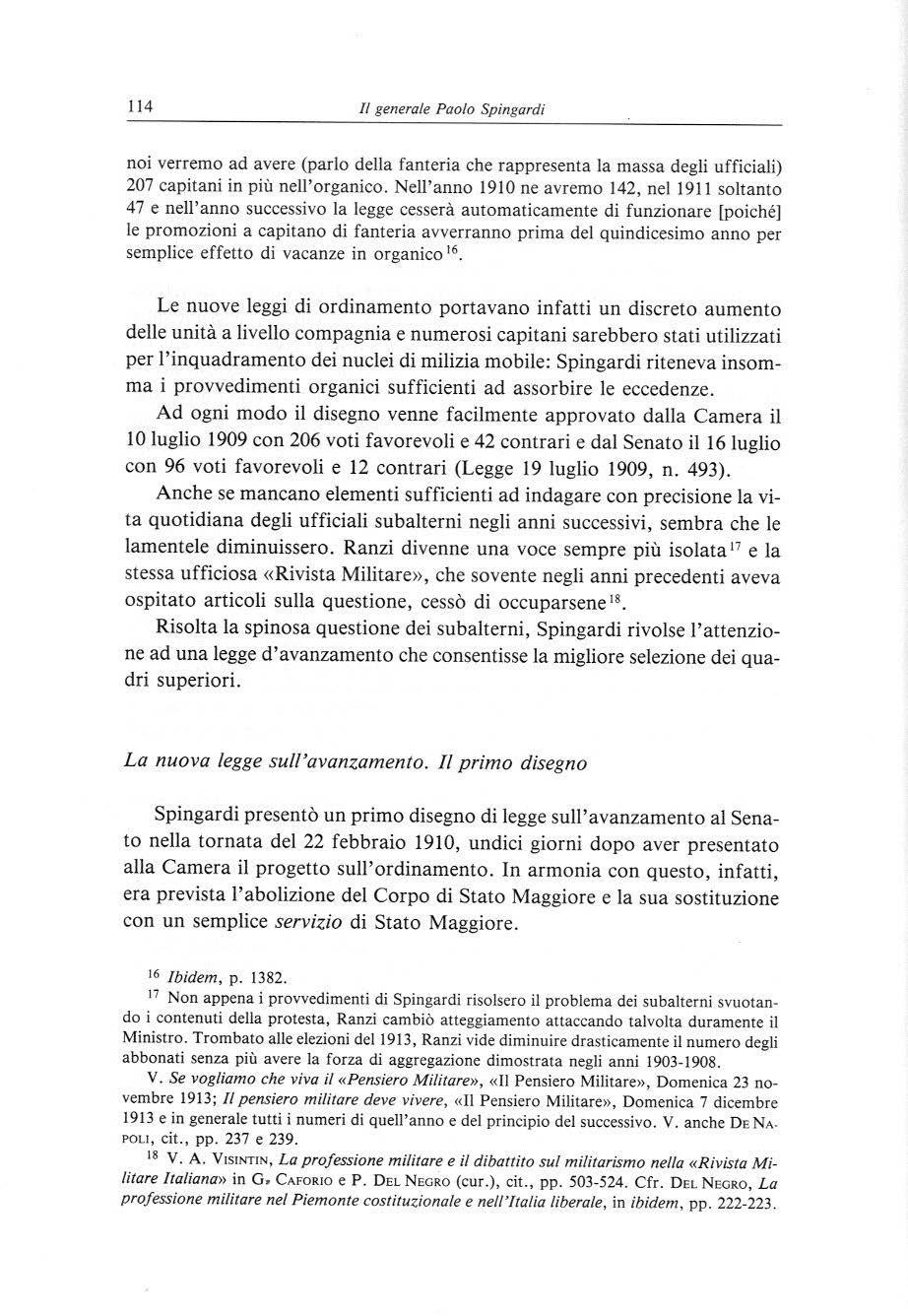
114
li generale Paolo Spingardi
Il Corpo Reale dello Stato Maggiore, istituito per la p r ima volta nel Regno di Sardegna nel 1796, e così denominato con R D 18 maggio 1850 19, ebbe un nuovo ordinamento con R.D. 11 marzo 1860 e venne ampliato con R. D . 24 gennaio 1861 20 •
La guerra del 1866 mise ugualmente in chiara luce « la deficiente cultura professionale e generale dei capi» 21 • Si pensò di porre rimedio a queste carenze con la creazione della Scuola di Guerra di Torino, istituita con R .D. 11 marzo 1867, che riuscì effettivamente, col tempo, a produrre «un complesso di ufficiali di Stato Maggiore omogeneo, idoneo e capace per le molteplici, gravi e difficili mansioni che ad essi sono devolute in pace e in guerra» 22 •
La Scuo la aveva lo scopo di elevare la cultura dei quadri, ma diveniva anche l'istituto di reclutamento per gli ufficiali di Stato Maggiore. Infatti tra i migliori allievi al termine dei corsi il Comando del Corpo individuava gli idonei all'ammissione nel Corpo stesso. Per invogliare gli ufficiali maggiormente dotati ad accorrere alla scuola, venivano offerti vantaggi di carriera a quanti ne uscivano, che variarono nel tempo ma nel periodo giolittiano si concretavano nella promozione a scelta da tenente a capitano: in termini pratici significava che gli ufficiali diplomati alla Scuola di Guerra diventavano capitani dopo aver trascorso nei gradi inferiori un periodo di tempo più breve rispetto ai colleghi che non avevano frequentato la scuola. Chi poi fosse entrato nel Corpo avrebbe visto la propria carriera ulteriormente accelerata da l fatto di essere iscritto per l'avanzamento in un ruolo diverso dalle altre Armi . Dato che solo ufficiali di Stato Maggiore erano destinati a particolari incarichi nei quali era più faci le mettersi in luce e ottenere promozioni (ad es. addetti militari, incaricati al Ministero della Guerra, ecc.) il tutto significava un guadagno di diversi anni nell'ascesa ai più alti gradi della gerarchia.
Cominciarono le polemiche, anche perché
19 Cfr P. P1 ER1, Le forze armate nell'età della destra, cit., p. 471, nota 2 V. anche C. MAZZACCARA, L'evoluzione del Corpo di Stato 1'1aggiore nei Regn i di Sardegna e d'Italia. Parte Prima: 1796- 1881 in Memorie storiche militari 1981, USSME, Roma 1982, pp. 349-378. Sulla crescente importanza degl i Stati Maggiori nel corso d e ll'Ottoce nto e il loro ruolo nella stor ia militare s i vedano B.L. MONTGOMERY di Alamein, S1oria delle guerre, Rizzoli, Milano 1970, pp. 700-709; H OWAR O, La guerra e le armi nella s loria d'Europa, cit., p. 191 e p.196; R.A. PR ESTON & S.F. W1sE , Storia sociale della guerra, Mondadori, Mil ano 1973 [ed. or 1970], pp 30 7-3 09; C. FALLS , L'arte della guerra , C appelli, Bologna 1965 [ed. or. 1961), pp. 77-81.
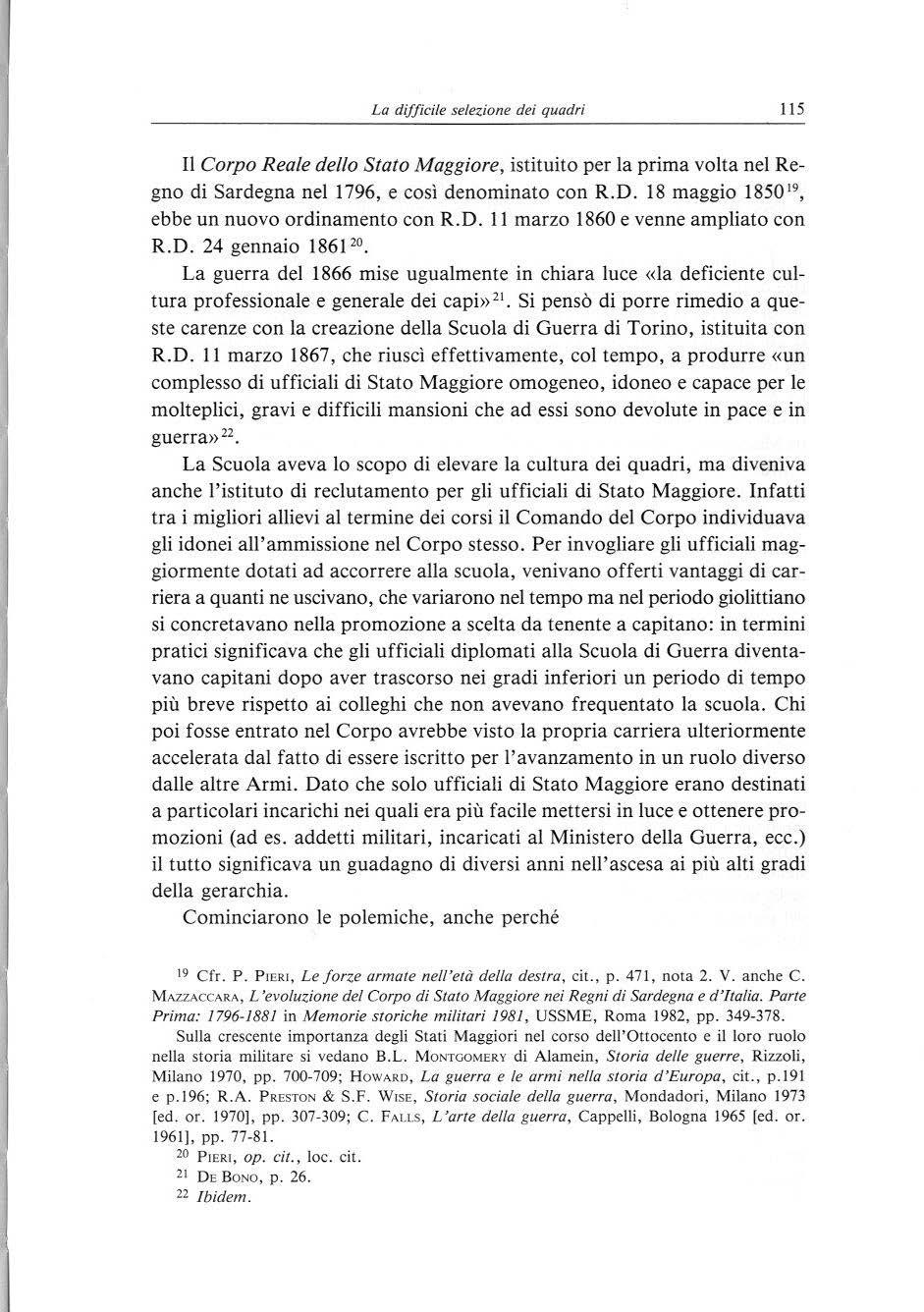
20 P1 ER1, op. cit., loc. c it.
2 I DE BONO, p. 26 . 22 i bidem .
La difficile selezione dei quadri 115
la massa degli ufficiali non poteva tollerare come un collega che andava a passare tre anni a Torino, schivandosi tutte le noie, le fatiche e le responsabilità del servizio dovesse poi avere vantaggi sentitissimi nelle promozioni 23 •
I toni più acuti vennero toccati tra il 1882 e il 1890. Fu allora un fiorire di opuscoli e articoli di giornali e riviste 24 • L'aumento organico di due corpi d'armata, se offriva interessanti possibilità di avanzamento a tutti gli ufficiali, proprio per questo rendeva più evidenti le differenze tra gli ufficiali di Stato Maggiore e gli altri. La creazione della carica di Capo di Stato Maggiore dell'esercito fin dal tempo d i pace, inoltre, accentrando in un unico vertice le funzioni prima divise fra il «Comitato di Stato Maggiore» e il «Comando del Corpo di Stato Maggiore», sembrava accentuare il carattere di «Olimpo», «setta», «oligarchia», che gli ufficiali delle altre armi attribuivano al Corpo 25 • Divenne opinione generale che gli ufficiali di Stato Maggiore «perdessero rapidamente ogni contatto con la realtà della vita militare, che venissero promossi troppo rapidamente e che la loro influenza, che giungeva dappertutto, fosse nociva ai veri interessi dell'ese r cito» 26 •
Nel 1896 la legge Ricotti sull'avanzamento stabilì che gli ufficiali di Stato Maggiore fossero isc r itti nei ruoli dell'arma di origine e seguissero le sorti di questa per l'avanzamento . Con questo provvedimento il Corpo di Stato Maggiore cessava formalmente di essere un corpo chiuso. Ciononostante, quando si consideri che non si può entrare nel corpo di Stato Maggiore se non attraversando la Scuola di Guerra; che il reclutamento è limitato solo al grado di capitano; che l'avanzamento a scelta è diritto acquisito pel solo fatto di appartenere al corpo; [ ] che, in pratica, certi determinati impieghi vengono affidati quas i s istematicamente solo agli ufficiali del corpo, tutte queste circostanze concorrono in certo qual modo a conferire al nostro corpo di stato maggiore le caratteristiche del sistema cosiddetto chiuso, tanto più che per i suoi ufficiali esiste una speciale uniforme 27 •
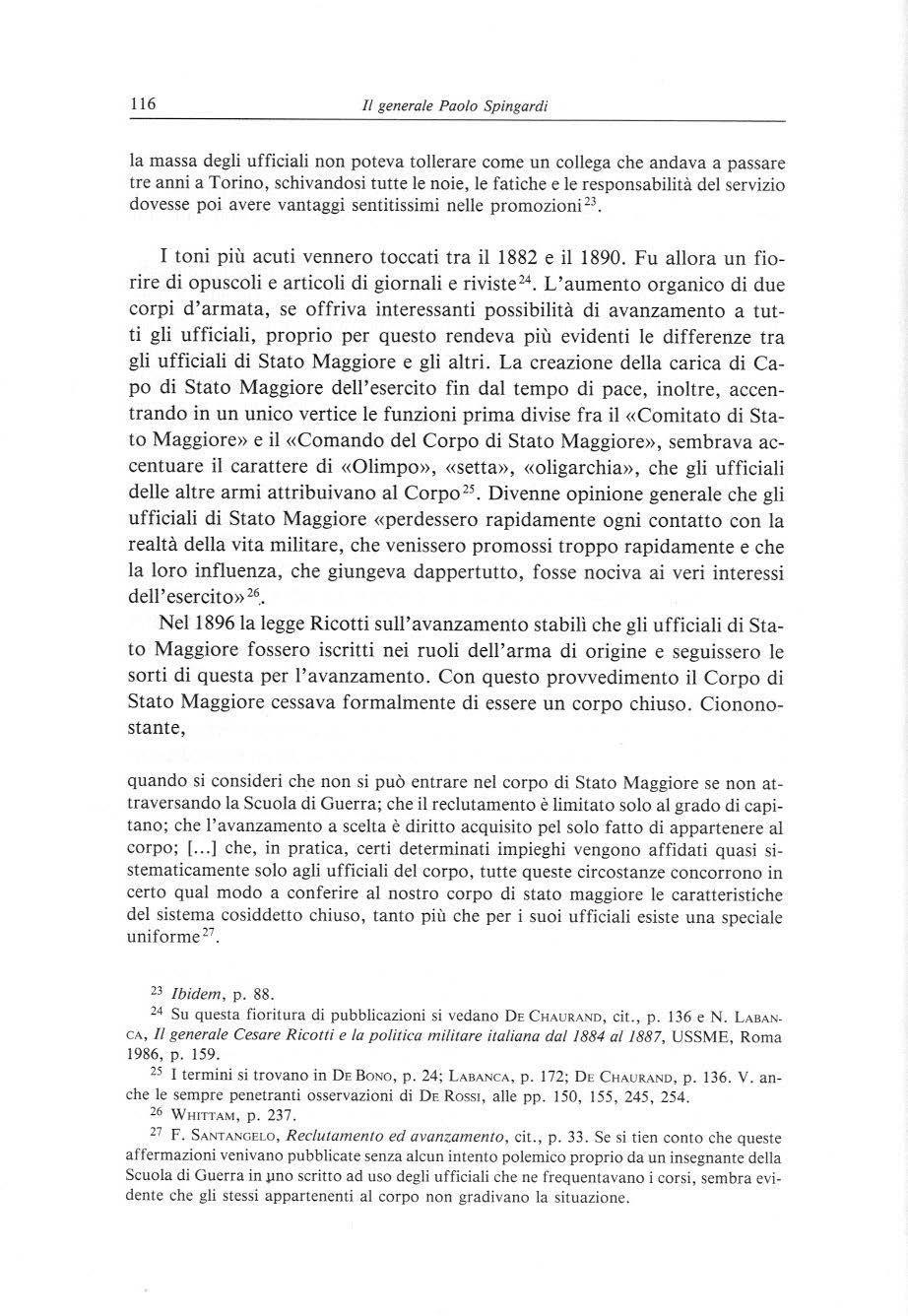
23 Ibidem , p. 88.
24 Su questa fiori t ura di pubblicazioni si vedano DE CHAURAND, cit., p. 136 e N. LABAN· CA , li generale Cesare Ricotti e la politica militare italiana dal 1884 al 1887, USSME, Roma 1986, p. 159.
2 s l termini si trovano in D E BoNo , p. 24; LA BANCA, p. 172; DE CHAURAND, p. 136. V. anche le sempre penetranti osservazioni di DE Rossi, alle pp. 150, 155, 245, 254.
26 W H!TIAM, p 237.
27 F. SANTANGELO, Reclutamento ed avanzamento, cit., p. 33. Se si tien conto che queste affermazioni venivano pubblicate senza alcun intento polemico proprio da un insegnante della Scuola di Guerra in l]no scritto ad uso degli ufficiali che ne frequentavano i corsi, sembra evidente che gli stessi appartenenti al corpo non gradivano la situazione.
116 li
generale Paolo Spingardi
la difficile s elezion e dei quadri 117
Sta di fatto che la polemica riprendeva forza nei primi anni del Novecento, alimentata da «Il Pensiero Militare)) di Fabio Ranzi, che fece del Corpo di Stato Maggiore e dei suoi ufficiali uno dei bersagli preferiti28
La Commissione Parlamentare d'inchiesta per l'e sercito aveva fatta propria la conclusione più radicale emersa nei lunghi anni di polemiche: e cioè quella di abolire il Corpo di Stato Maggiore sost ituendo ad esso un servizio di Stato Maggiore 29 •
Spingardi non esitò ad accogliere le proposte della Commissione nel disegno di legge sull'avanzamento, anche se pensava che
in realtà il Corpo di S t ato Maggiore come corpo a sé ha cessato di esistere fin da quando, nel 1896, gli ufficiali c h e ne facevano parte vennero iscritti nei ruoli dell'arma di provenienza, della quale seguono le sorti nell'avanzamen t o 30
Egli stesso aveva compiuto la carriera nel Corpo a partire dal 1874 Inso mma nella proposta di abolizione non voleva esservi nulla di
meno che riguardoso verso i dist int i ufficiali che vestono la divisa del Corpo, il cui lavoro intell igente e assiduo [ ] non può non essere altamente apprezzato da chi ha occasione di seguirlo da vicino in tutte le sue varie manifestazioni.
Ma Spingardi era convinto che il provvedimento facilitasse
quella maggiore larghezza di ammissioni che è consigliata dalla vostra Commissione d'inchiesta e facilita anche il p iù frequente ri torno a i corpi degli ufficiali addetti a ques to specia le servizio, ciò che d arà loro il va n taggio di acquistar e una maggiore pratica professio n ale ed anche quello, assai maggiore, di far meglio apprezzare dalla massa degli altri ufficiali gli speciali meriti per i quali furono designati per tale servizio 31
L'opposizione incontrata in occasione della discussione su ll a legge d'ordinamento aveva indo tto Spingardi a mantenere il Corpo di S.M., come si è visto 32
Per una questione ri solta lasciando le cose come stavano, se ne prese ntò un'altra che complicò i progetti del Ministro.
L'Ufficio centrale del Senato, per bocca del relatore generale Cesare Tarditi, giudicò doveroso «provvedere ai grad i degli ufficiali perché la carriera 28 Cfr. W
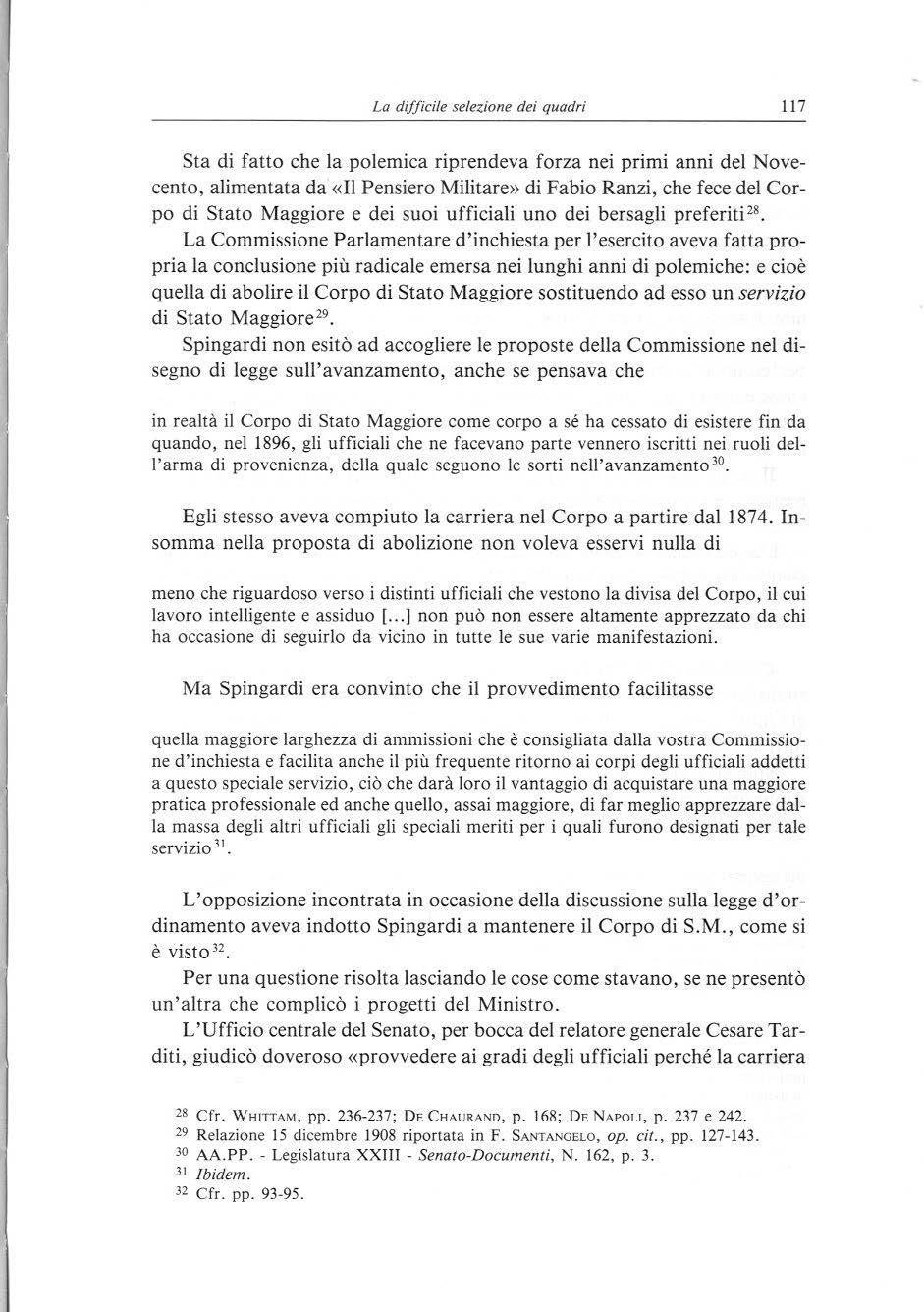
3J Ibidem.
32 C fr. pp. 93-95.
,
168; D E NAPO L I ,
H t TTAM, pp. 236-237; DE CHA URAND
p.
p. 237 e 242. 29 Re la zion e 15 d ice mbr e 1908 riportata in F. S ANTANGELO , op. cii., pp. 127- 143.
30 AA.PP - Leg islatura XXJII - Senato-Documenti, N 162 , p 3.
generale Paolo Spingardi
è differentissima nelle varie armi». Per eliminare questa differenza proponeva «l'adozione del ruolo unico per gli ufficiali superiori, da applicarsi naturalmente colle debite cautele». L'Ufficio centrale formulò quindi un ordine del giorno, sul quale Spingardi era pregato di volersi pronunciare 33 •
Nell'esercito italiano, nel quale non esisteva il ruolo unico, ogni ufficiale veniva iscritto, per l'avanzamento, in apposite tabelle in ordine di anzianità di servizio secondo l'arma di apparte'nenza (Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio). Ma poiché le eliminazioni non potevano avvenire in maniera perfettamente omogenea, a parità di anzianità da ufficiale, i tempi dell'avanzamento non erano gli stessi per ogni arma, e ciò creava malumori negli ufficiali dell'arma meno favorita (quella cioè in cui l'avanzamento era più lento).
Il ruolo unico consisteva nell'iscrivere tutti gli ufficiali delle armi combattenti in un'unica tabella senza distinzione fra arma e arma.
L'avanzamento dovrebbe procedere per a rma fino al grado di maggiore. Raggiunto questo grado tutti i maggiori verrebbero inscritti su di un ruolo unico i n ordine di anzianità e, salvo i casi di promozione a scelta , [... ] nessuno potrebbe essere promosso al grado superiore finché nelle altre armi siano dei più anziani di lui 34 •
Come spiegò con efficace immagine il generale Fortunato Marazzi, il ruolo unico «è come una barriera posta a metà di una corsa la qual e obblighi tutti i corridori a soffermarsi a metà cammino per poi riprenderlo quando tutti si sono soffermati ed allineati» 35 • Spingardi era naturalmente persuaso che l'avanzamento fosse una «questione grave in quanto tocca uno dei più vitali interessi degli ufficiali, la loro carriera» . P erciò aveva cercato
nel preparare le nuove tabelle organiche, di rispondere anzitutto alle vere e prop rie esigenze del servizio, ma ancora di non trascurare, in quanto possibile, la ripercussione che esse avrebbero avuto sull'avanzamento degli ufficiali delle varie armi. Ed è mio convincimento di essere riuscito ad ottenere una perequazione, se non rigorosamente assol ut a, tale però da eliminare in periodo di tempo non lungo ogni più stridente disparità di carriera 36 •
33 AA.PP. Legislatura XXIII, Senato -Discussioni, tornata dell'll luglio 1910, p. 3477. L'ordine del giorno djceva: « Il Senato, considerando che per l'avanzamen to degli ufficiali superiori delle varie armi combattenti sia conveniente l'adozione del ruolo unico da maggiore in avanti, confi da che tale ruolo sarà adottato nel t empo e con le modalità che le circostanze attuali dei quadri richiedono , e con apposite disposizioni da introdursi nel disegno di legge sull'avanzamento dell'esercito, già presentato al Senato» (ibidem).
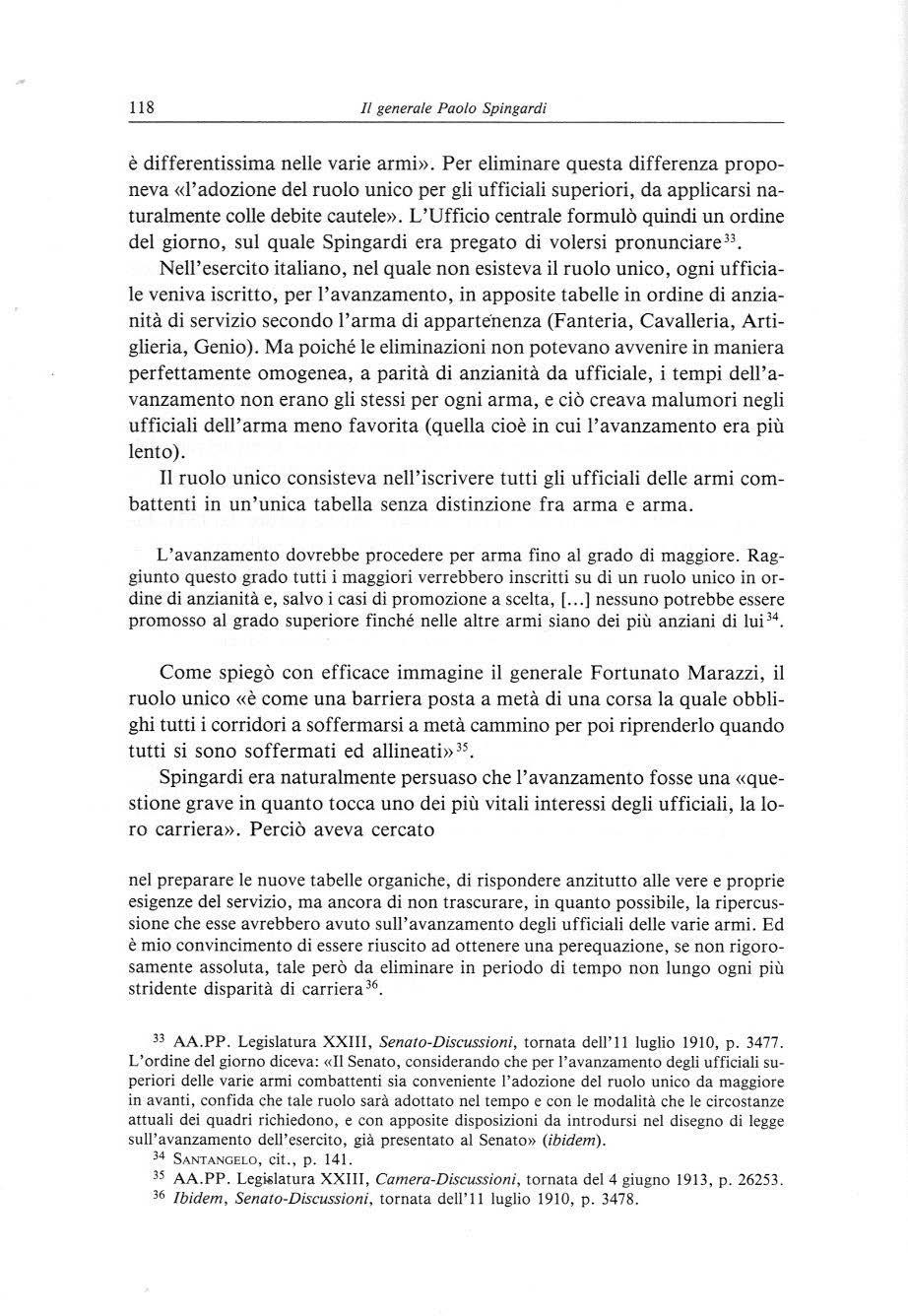
34 SANTANGELO, cit., p. 141.
35 AA.PP. Legii;latura XXITI, Camera-Discussio ni , tornata del 4 giugno 1913, p. 26253.
36 Ibidem, Senato-Discussioni, tornata dell'l l luglio 1910, p 3478.
118
Il
Egli riteneva che la perequazione delle carriere scaturisse automaticamente da una buona legge d'ordinamento. Ma non poteva ovviamente ignorare l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. E quindi, benché egli confessasse di non essere «molto favorevole all'applicazione immediata e rigorosa del ruolo unico», lo accettava ugualmente, ma «con riserva di introdurre opportune disposizioni nel disegno di legge di avanzamento che sta già dinanzi al Senato>>, dato che l'ordine del giorno lasciava «in facoltà del ministro di stu diarne l'attuazione colla modalità di tempo e di misura che la situazione del momento sarà per consigliare>> 37
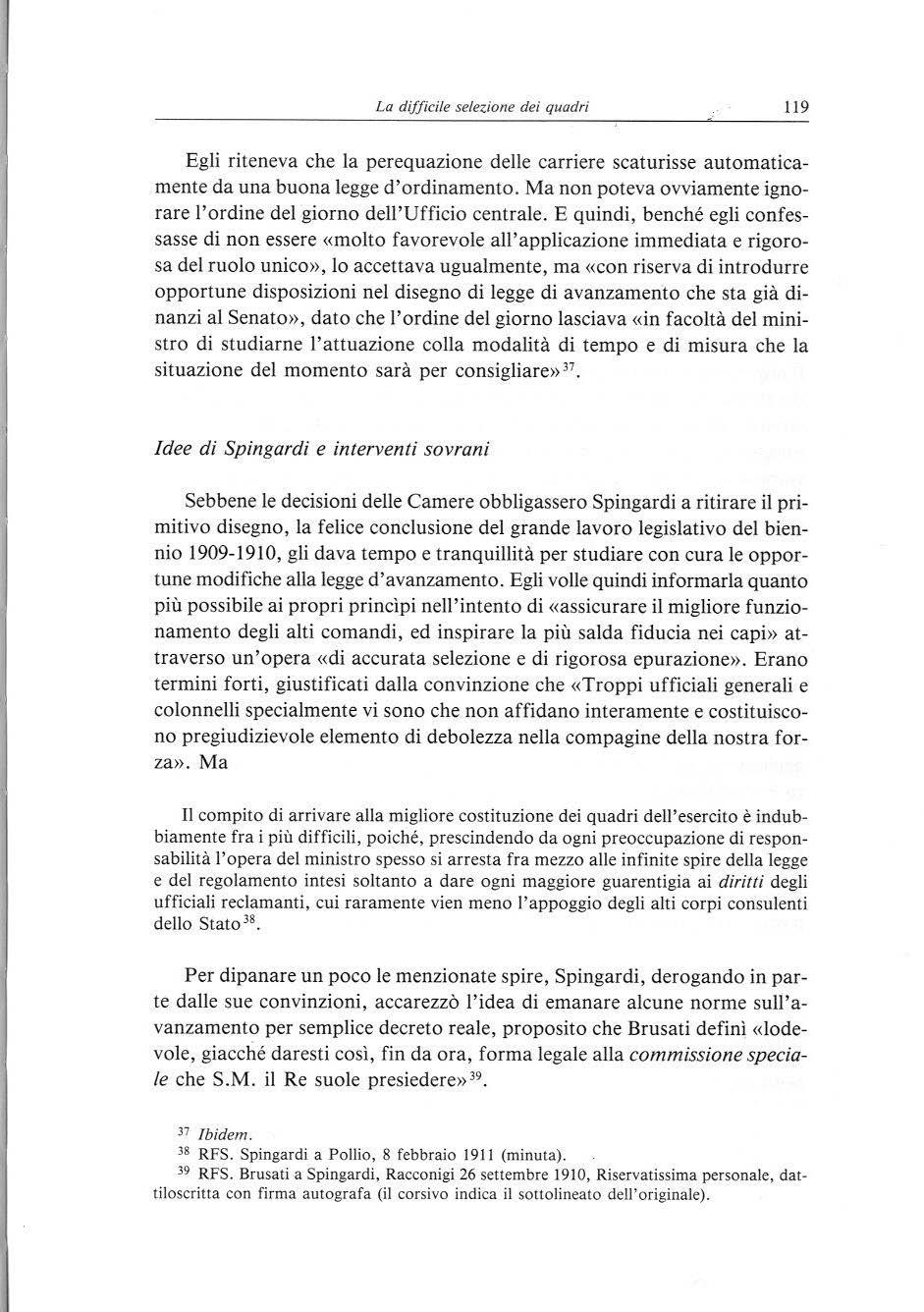
Idee di Spingardi e interventi sovrani
Sebbene le decisioni delle Camere obbligassero Spingardi a ritirare il primitivo disegno, la felice conclusione del grande lavoro legislativo del biennio 1909-1910, gli dava tempo e tranquillità per studiare con cura le opportune modifiche alla legge d'avanzamento . Egli volle quindi informarla quanto più possibile ai propri pr incìpi nell'intento di «assicurare il migliore funzionamento degli alti comandi, ed in spirare la più salda fiducia nei capi» attraverso un'opera «di accurata selezione e di rigorosa epurazione» . Erano termini forti, giustificati dalla convinzione che «Troppi ufficiali g enerali e colonnelli specialmente vi sono che non affidano interamente e co s tituiscono pregiudizievole elemento di debolezza nella compagine della nostra forza» . Ma
Il compito di arri vare alla migliore costituzione de i quadri dell'esercito è indubbiamente fra i più difficili, poiché, presci ndendo da ogni p reoccupazione di respons abilità l'opera del ministro spess o si arresta fra mezzo alle infinite spire della legge e del regolamento in tes i so ltanto a dare o gn i maggio re guarentigia ai diritti degli uffic iali re clamanti, cui raramente vi en meno l'appoggio degli alt i corpi consulenti dello Stato 38
Per dipanare un poco le menzionate spire, Spingardi, derogando in parte dalle sue con v in zioni, accarezzò l'idea di emanare alcune norme s ull'avanzamen to per semplice decreto r eale, proposito che Bru sat i definì « lodevo le, giacché dar est i così, fin da ora, forma legale alla commissione speciale che S.M. il Re suole presiedere» 39 •
37 Ibidem.
38 RFS. Spingardi a Pollio, 8 febbra io 191 J (minu ta)
39 RFS. Brusati a Sp in gardi, Rac coni gi 26 settembre 191 0, Riservatissima personale, datt iloscritta con fi rma autografa (il cors ivo indica il sottol ineato dell 'or iginale).
la difficile selezione dei quadri 119
Vittorio Emanuele III interveniva quindi in maniera diretta nel processo di avanzamento. La Commissione Speciale si occupava esclusivamente della nomina dei tenenti generali alle cariche superiori a quella di comandante di divisione e non era naturalmente in alcune modo menzionata nella legislazione vigente, «poiché ciò implicherebbe una questione costituzionale», ricordava giustamente Brusati 40 •
È evidente che un parere del Re, per quanto sommesso e distaccato, non poteva che condizionare pesantemente il processo di selezione dei -quadri. È impensabile vi fosse generale che osasse pronunciarsi di opinione contraria al Sovrano all'interno della Commissione. Vittorio Emanuele III si riservava un preciso campo di intervento personale nella nomina alle alte cariche militari: la Commissione Speciale è la testimonianza concreta della volontà di non rinunciare alla prerogativa statutaria di comandante supremo delle forze armate. In quest'ambito, il generale Brusati fungeva non solo da principale consigliere militare del Sovrano, ma anche da intermediario tra questi e il Ministro della Guerra. Diceva a Spingardi «forse S.M. stessa te ne avrà già tenuto parola>> 41 : se i colloqui tra Sovrano e Ministro della Guerra non erano certamente un evento straordinario, benché avessero carattere strettamente confidenziale e privato , il canale privilegiato di trasmissione della volontà sovrana al Ministro della Guerra rimaneva il Primo Aiutante. Grazie a lui, per tutta la durata dell'amministrazione Spingardi, Vittorio Emanuele III non si compromise mai con interventi espliciti, svolgendo un'azione estremamente di screta e si lenziosa. Bastavano un «inutile aggiungere che S.M. il Re ha letto la tua lettera» oppure un «il mio pensiero è condiviso da S M. il Re » in chiusura di una lettera perché Spingardi sapesse come regolarsi 42 • E la vicenda dell'avanzamento ne offre le prove più evidenti.
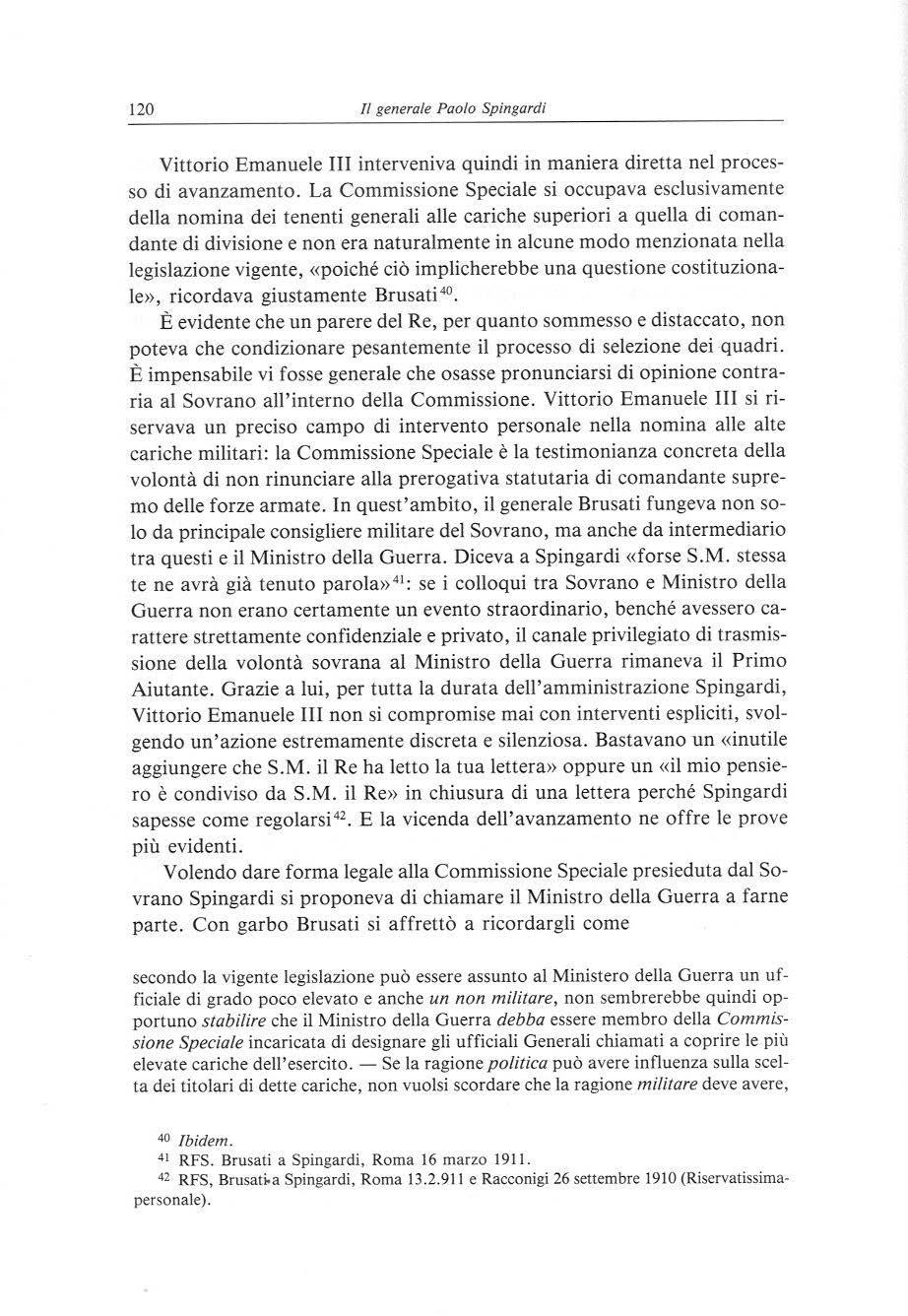
Volendo dare forma legale alla Commissione Speciale presieduta dal Sovrano Spingardi si proponeva di chiamare il Ministro della Guerra a farne parte. Con garbo Brusati si affrettò a ricordargli come
seco nd o la vigen t e legislazione può essere assunto al Ministero della Guerra un ufficiale di grado poco elevato e anche un non militare, non sembrerebbe quin di opportuno stabilire che il Ministro della Guerra debba essere membro della Commissione Speciale incaricata di designare gli ufficiali Generali chiamati a coprire le più elevate cariche dell'esercito. - Se la ragi one politica può avere influenza sulla scelta dei tito lari di dette cariche, non vuolsi scordare che la ragione militare deve avere, 40 Ibidem . 41
120
Il generale Paolo Spingardi
Spingardi,
Brusati-a Spingardi,
2.911 e Racconi
le).
RFS. Brusati a
Roma 16 marzo 191 I. 42 RFS,
Roma 13
gi 26 settembre 1910 (Riservatissimapersona
in modo assoluto, la prevalenza su quella; tantoché, in teoria, sembrerebbe cosa più logica lasciare al so lo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito la responsabilità di tale scelta. - Occorre notare poi che il titolare della carica di Ministro della Guerra, design ato spesso in base a considerazioni politiche di opportunità, potrebbe, se Ufficiale Generale, non possedere in modo spiccato qualità essenzialmente militari, potrebbe anche non essere ritenuto idoneo alla carica di Capo di Stato Maggiore dell' Esercito, di Comandante d'Armata , o di Comandante di Corpo d'Armata (non mancherebbero esempi da citare) 43 •
La diffidenza nei riguardi di eventuali nomine politiche al vertice del Ministero della Guerra è un indice del carattere di area riservata all'intervento regio che l'amministrazione militare conservava nell'Italia liberale. Solo gli addetti ai lavori avevano diritto di prendere parte ai più delicati processi decisionali sulla nomina delle alte cariche militari.
Il Ministro, d'altronde, si trovava nella non felice posizione di «paravento», data la irresponsabilità regia. Brusati ricordava a Spingardi come
al pari di te tutt i , o quasi, i Ministri della Guerra che ti precedettero affermarono la necessità di rigorosa se lezione nei gradi elevati della gerarch ia militare, per circondare gli alti comandi dell'indispensabile prestigio e della indispens abile autorevolezza . - Ma poi, a l caso pratico, forse appunto a cagione della personalità politica del Ministro, le buone intenzioni, per quanto solennemente affermate, rimasero intenzioni, se non corroborate dal parere di competente commissione alla quale il Ministro era estraneo e del quale copriva, in certa guisa, la responsabilità 44 •
Spingardi dovette quindi rinunciare all'idea di intervenire nella Commissione Speciale. Ma essendo suo preciso intento attribuire maggiori responsab ilità al Ministro in tema di selezione dei quadri, eg li decise per la
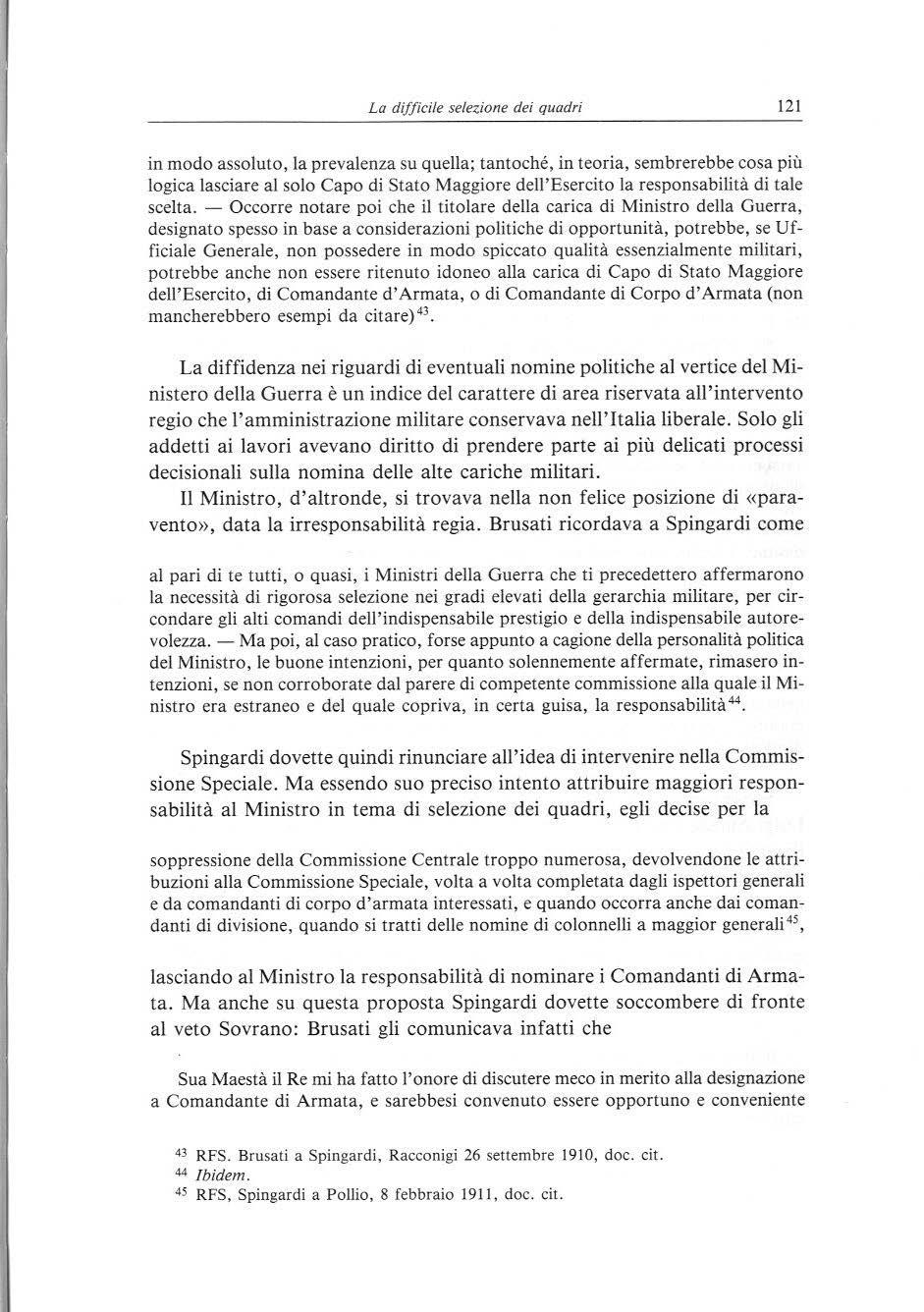
soppressione della Commissione Centrale troppo numerosa, devolvendone le attribuz ioni alla Commissione Speciale, volta a volta completata dagli ispettori generali e da comandanti di corpo d'armata interessati, e quando occorra anche dai comandan ti di div isione, quando si tratti delle nomine di colonnelli a maggior generali 45 ,
lasciando al Mini stro la responsabilità di nominare i Comandanti di Armata . Ma anche su questa proposta Spingardi dovette soccombere di fronte al veto Sovrano: Brusati gli comunicava infatti che
Sua Maestà il Re mi ha fatto l'o nore di discutere meco in merito alla designazione a Comandante di Armata, e sarebbesi convenuto essere opportuno e conveniente
43 RFS. Brusati a Spingardi, Racconigi 26 settembre 1910, doc. cit.
44 Ibidem.
45 RFS, Spingardi a Pollio, 8 febbraio 19 11, doc. cit.
La difficile selezione dei quadri 121
che tale designazione fosse fatta dalla Comm issione Centrale (che è costituita come l'attuale Commissione Speciale di Avanzamento, in seno alla quale interviene appunto il Sovrano) - Tu comprenderai che il lasciare soverchia ingerenza al Ministro (faccio astrazione dalla tua persona) i n siffatta delicata quistione, sarebbe pericoloso
e tornavano i già citati timori per un Ministro «presce lto per ragione politica e che potrebbe essere anche un non idoneo ad un alto Comando» 46 Spingardi dov ette ingoiare anche questo boccone, ma non mancò di sfogarsi con il Primo Aiutante:
Ho letto le tue osservazioni al [. .. ] disegno di legge sull'avanzamento e modificherò in conseguenza Con ciò l'argomento sarebbe esaurito, ma consentimi c he io versi ne l seno dell'amicizia poche considerazioni, dalle quali esu la qualunque senso di amarezza. - Anzitutto trattasi più di questione di forma che di sosta nza . È ovvio che nessun ministro della guerra , civile o militare, si attenterà mai a procedere alla nomina delle più alte autorità militari senza aver sentite le più alte autorità medesime, e soprattutto senza aver preso gli ordini d al Sovrano, che è il Capo Supremo dell'Esercito. Lo stesso ministro Casana nominò il Capo di Stato Maggiore Pollio, naturalmente dopo aver sentito chi di ragione e presi gli ordini di S.M. Ripeto è questione di forma, non di sostanza, ma la forma giova all'autorità e prestigio del Ministro, che viene così messo completamente in disparte, pur lasciandogliene la responsabi lità. - Egli può e deve mandar via i ge nera li, ma non può contribuire alla loro nom i na! - Aggiungi che il co ll ega della marina ha piena libertà d'azione nella nomina dei Comandanti delle forze navali, dei Comandanti dei dipartimenti marittimi, senza che la legge gli faccia obbligo di consultare nessuno. - Perché q uesta disparità di trattamento? 4 7 •
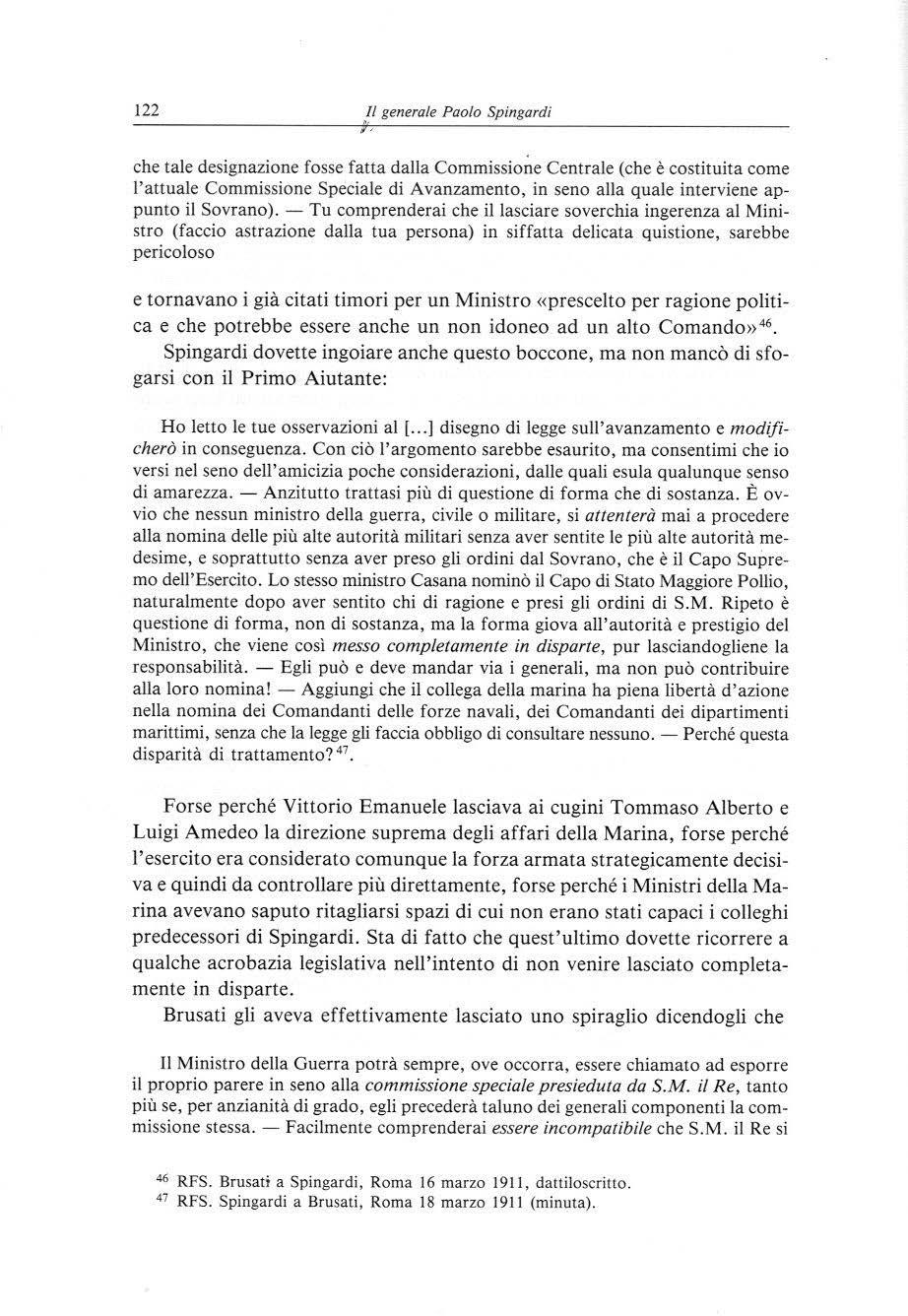
Forse perché Vittorio Emanuele lasciava ai cugini Tomma so Alberto e Luigi Am edeo la direzione suprema degli affari della Marina , forse perché l'esercito era considerato comunque la forza armata strategicamente decisiva e quindi da controllare più direttamente, forse perché i Ministri della Marina avevano saputo ri tagliarsi spazi di cui non erano stati capaci i colleghi predecessori di Spingardi. Sta di fatto che quest'ultimo dovette ricorrere a qualche acrobazia legislativa nell'intento di non ven ire la sciato completamente in disparte.
Brusati gli aveva effettivamente lasciato uno spirag lio dicendogli che
Il Ministro della Guerra pot rà sempre, ove occorra, essere chiamato ad esporre il proprio parere in se no alla commissione speciale presieduta da S.M. il Re, tanto più se, pe r anzianità di grado , egli precederà taluno dei generali componenti la commissione stessa . - Fac ilm ente comprenderai essere incompatibile che S.M. il Re si
122 p generale
Paolo Spingardi
46 R FS. Brusati a Spingard i, Roma 16 mar zo 1911 , datti lo sc ri tt o 47 RFS. Spingardi a Brusati , Roma 18 marzo 1911 (minuta)
trovi a presiedere una commissione di cui faccia parte il Ministro costi t uzionalmente responsabi le, il quale, in d ate evenienze, potrebbe, nelle votazioni, trovarsi nella minoranza e quindi nell 'i mbarazzo 48
Se proprio doveva accontentarsi di un posto come membro eminentemente consultivo, allora Spingardi lo volle all'interno della nuova Commissione Centrale d'avanzamento composta come la Commission e Speciale. In questo modo evitava qualsiasi imbarazzo la sciando la Commiss ione Speciale tutta per il Sovrano. Il R e infa tti non faceva parte del «d uplicato », nel quale il Mini st ro finiva così per divenire il componente più prest igi oso .
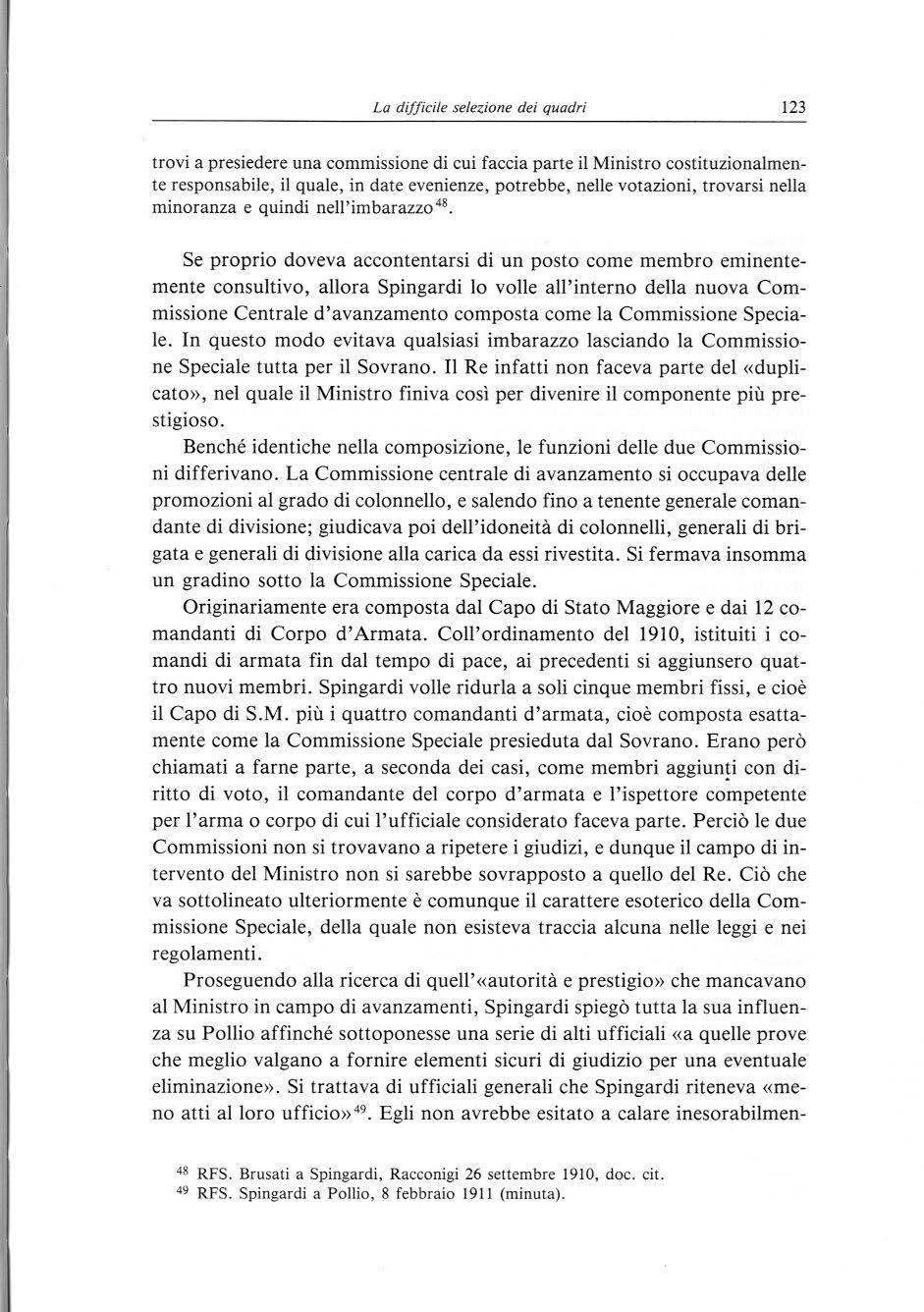
Benché identiche nella composizione, le funzioni delle due Commissioni differivano. La Commissi one centrale di a vanza men to si occupava delle promozioni al gra do di colon nello, e salendo fino a tenente generale comandante di divisione; giudicava poi dell'idoneità di colonnelli, generali di brigata e generali di division e alla car ica da essi rivestita. Si fermava insomma un gradi no sotto la Commissione Speciale.
Originariamente era composta dal Capo di Stato Maggiore e dai 12 comandanti di Corpo d'Armata Coll'ordinamen to d el 1910, istituiti i comandi di armata fin dal te mpo di pace, ai precedenti si aggiunsero quattro nuovi membri. Spingardi volle ridurla a soli cinque membri fissi, e cioè il Capo di S.M. più i quattro comandanti d'armata, cioè composta esattamente come la Commissione Speciale presieduta dal Sovrano. Erano però chiamati a farne parte, a secon da dei casi, come membri aggiunfi con diritto di voto, il comandante d e l corpo d'armata e l ' ispettor e com p etente per l'arma o corpo di cui l'ufficiale consi d erato face va parte. P erc iò le du e Commissioni non si trovavano a ripetere i giudizi, e dunque il campo di intervento del Mini st r o non si sarebbe sovrappo sto a quello del Re. Ciò che va sottol in eato ulteriormente è comunque il carattere esoterico della Commis s ione Sp ec iale, della quale non esisteva traccia alcuna nelle leggi e nei r egolamenti.
Proseguendo alla ricerca di quell' «autorità e prestigio » che mancavano a l Ministro in campo di avanzamenti, Spingardi spiegò tutta la sua influenza su Pollio affinché sottoponesse una serie di alti ufficiali «a quelle prove che meglio valgano a fornire elementi sicuri di giudi zio per una eve n tuale eliminazione » Si tratta va di ufficiali genera li c he Spingardi riten ev a « m eno atti al loro ufficio » 49 • Egli non a v rebbe esitato a calare in eso rabilmen-
RFS. Brusati a Sp in gardi, Ra cconigi 26 sette mb re 19 10, doc. cit. 49 R FS. Spinga rdi a Pollio , 8 feb braio 19 1I (minuta).
La difficile sel ezione dei quadri 123
48
Il generale Paolo Spingardi
t e la m a nnaia e senza alcun timore faceva i nomi 50 , perché, con espressione tipica della sua mentalità, si imponeva
la necessità di provvedere, non tumu ltariamente per non turbare il giusto equilibrio e generar e soverchia sfiducia, ma gra datamente, con costante volontà , se nza falsi rigua r di , avendo di mira so ltanto il fine alt issimo cu i s i vuo le e si deve giungere 51 , soste nuto in que st o an che d a Brusati, convinto c he
se le Comm issioni di avan zamen t o procedessero con r igoroso cr iter io alla esclusione dei meno idonei all'avanzamento , in guisa che la se lezione avvenisse co n r igore sempre crescente col crescere dei g ra di, avremmo ottimi quadri 52
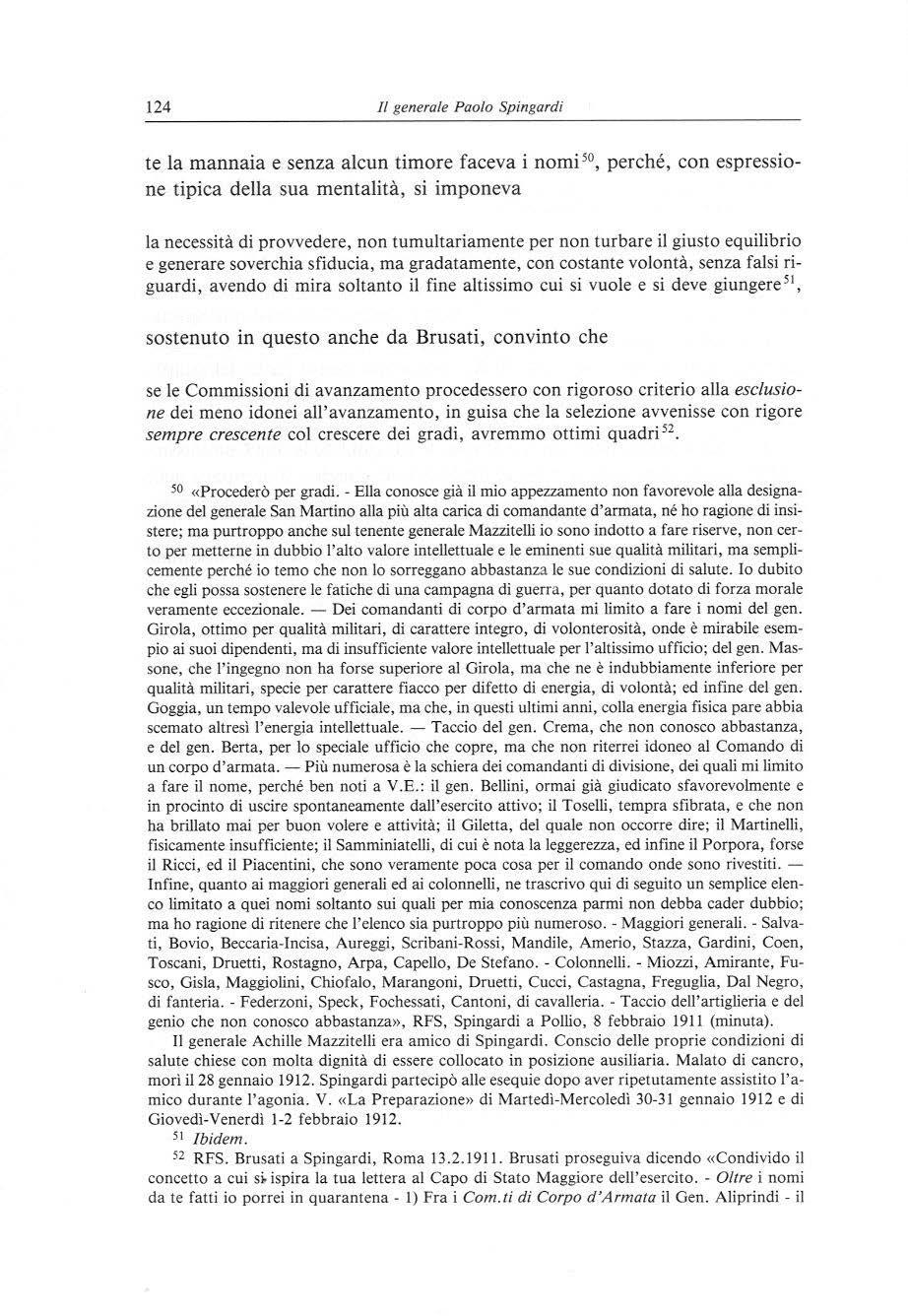
so «Procederò per gradi. - Ella conosce già il mio appezzamento non favorevole alla designazione del generale San Martino alla più alta carica di comandante d'armata, né ho ragione di insistere; ma pu rtroppo anch e sul tenente generale Mazzitelli io sono indotto a fare riserve, non certo per metterne in dubbio l'alto valore intellettuale e le eminenti sue qualità militar i, ma sempl icemente perché io temo che non lo sorreggano abbastanza le sue condizioni di salute. Io dubi to che egli possa sostenere le fa t iche di una campagna di guerra , per quanto dotato di forza morale veramente eccezionale. - Dei comandanti d i corpo d'armata m i l imito a fare i nomi d el gen. Giro la, o t timo pe r quali tà militari, di carattere integro , d i vo lonterosità , onde è mirabile esempio a i suoi d i penden ti , ma di in s u fficiente valore intellettuale per l'altiss imo ufficio; del gen. Massone, che l'ingegno non ha forse superiore al Giro la, ma che ne è i ndubbiamente inferiore per qualità militari, specie per carattere fiacco per difetto di energia, d i vo lontà; ed infine del gen. Goggia, un tempo valevole ufficiale , ma che , in questi u l timi anni, co ll a energia fisica pare abb ia scemato altresì l'energia intellettuale. -T accio del gen Crema, che non conosco abbastanza, e del gen Berta, per lo speciale ufficio che cop re, ma che non riterre i idoneo al Comando d i un corpo d'armata. - Più numerosa è la schiera dei comandanti di divisione, dei quali mi limito a fare il nome, perché ben not i a V.E.: il gen. Bel li ni, ormai già gi u dicat o sfavorevolmente e in p rocinto di uscire spontaneamente dall ' eserc ito a ttivo; il Toselli, tempra sfibrata, e che non ha brillato mai per buon volere e a t tività; il G iletta , del quale non occorre dire; il Martinelli, fi s icamente insuffic iente; il Samminiatelli, di c ui è nota la leggerezza, ed infine il Porpora, forse il Ricc i, ed il Piace nt ini, c he son o veramente poca cosa per il comando onde sono rives tit i.Infine, quanto ai maggiori generali ed ai colonnelli, ne trasc rivo qui di seguito un sempli ce elenco l imita to a quei nom i soltanto sui quali per mia conoscenza parrni non debba cad er d u bb io; ma ho ragion e di ritenere che l'elenco sia purtroppo più numeroso - Maggior i generali - Salvati, Bovio, Beccaria-I ncisa, Aureggi, Scribani-Rossi , Mandi le, Amerio, Stazza, Gardini, Coen, Toscani , Druetti, Rostagno , Arpa, Capello, De Stefano - Colo n nelli. - Miozzi, Amirante, Fusco, Gisla, Maggiolini, Chiofalo, Marango ni , D rue t ti, Cucc i, Castagna, Freguglia, Dal Negro, di fanteria - Federzon i, Speck, Fochessati, Cantoni, di cavaller ia. - Taccio dell'artiglieria e del genio che non conosco abbastanza», R FS, Spingardi a Pollio, 8 febbraio 1911 (minuta).
Il generale Ach ille Mazzitell i era amico di Spingardi Conscio delle proprie condizioni di sa lute chiese con molta dignità d i essere collocato in posi zione ausiliaria Malato di cancro, mo rì il 28 gen naio I 9 12 Spinga rdi partecipò alle esequie dopo aver r ipetutamente assistito l'amico durante l'agonia. V. «La Preparazione» di Marted ì- Mercoledì 30-3 1 gennaio 1912 e di Giovedì - Vene rdì 1-2 febbraio 1912
5 1 Ibidem.
13.2.1911 Brusati proseguiva dicendo «Condivido il concetto a cui s~ ispira la t ua lettera a l Capo d i Stato Maggiore dell'esercito. - Oltre i nom i da te fatti io porrei in quaran t ena - I) Fra i Com.ti di Corpo d'Armata il Gen. Aliprindi - il
52 RFS. Brusati a Spingardi, Roma
124
In sostanza la gestione dell'avanzamento degli ufficiali nell'esercito italiano si configurava come un rapporto trilaterale alquanto diseguale, nel quale il Mini stro elaborava proposte da sottoporre, tramite il fedele Primo Aiutante, al giudizio sovrano , inesorabilmente vinco lan te ; infine comunicava le decisioni al Capo di S.M per la loro attuazione.
In effetti il campo di intervento di Pollio era alquanto ristretto ed egli non poteva che accondiscendere usando toni smorzati, cercando quasi di giustificarsi con Spingardi dicendo
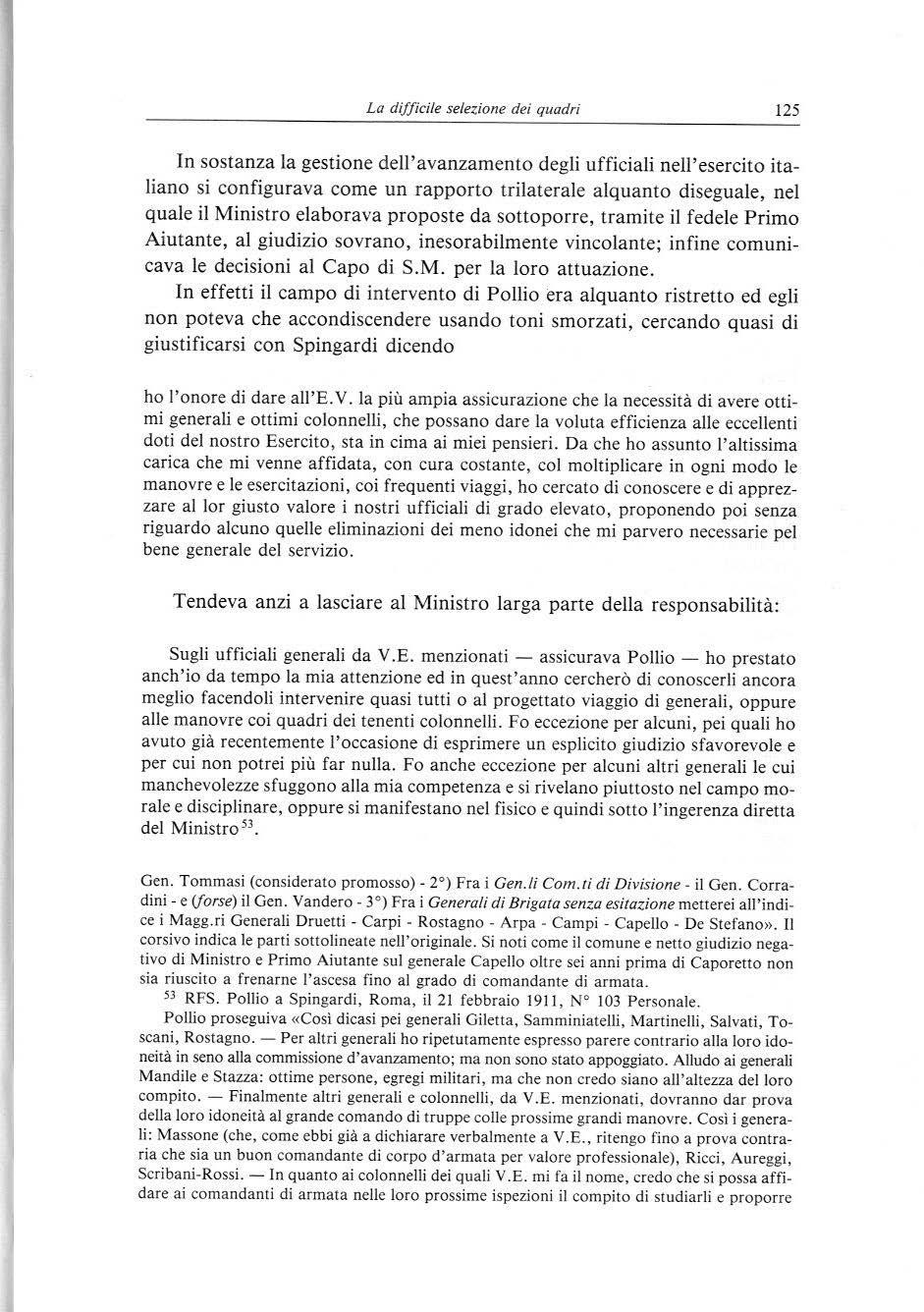
ho l'onore di dare all'E.V. la più ampia assicurazione che la necessità di avere ottimi generali e ottimi colonnelli, che possano dare la vo lu ta efficienza alle eccellenti doti del nostro Esercito, sta in cima ai miei pensieri. Da che ho assunto l'altissima carica che mi venne affidata, co n cura costante, col moltiplicare in ogni modo le manovre e le esercitazion i , coi frequenti viaggi, ho cercato dì conoscere e di apprezzare al lor giusto valore i nostri ufficiali di grado elevato, proponendo poi senza rigua r do alcuno quelle eliminazioni dei meno idonei che mi parvero necessarie pel be ne generale del servizio .
T endeva anzi a lasciare al Ministro larga parte della responsabilità:
S ugli ufficiali generali da V.E. menzionati - assicurava Pollio - ho prestato anch' io da tempo la mia attenzione ed in quest'anno cercherò di conoscer li ancora meglio facendoli intervenire quasi tutti o al progettato viaggio di genera li , oppure alle manovre co i quadri dei tenenti colonnelli. Fo eccezione per alcuni, pei quali ho avuto già recentemente l'o ccas ione di espr ime re un esplicito giudizio sfavorevo le e per cui non potrei più far nulla. Fo anche eccezione per alcuni a ltri generali le cu i manchevolezze sfuggono a ll a mia competenza e si rivelano piutt0sto nel campo mora le e discipl i nare, oppure si manifesta no nel fisico e quindi sotto l'ingerenza diretta del Ministro 53 •
Gen. T ommasi (considerato promosso) - 2 ° ) Fra i Gen li Com.ti di Divisione - il Gen. Corradini - e (forse) il Gen. Vandero - 3°) Fra i Generali di Brigata senza esitazione mettere i all'indice i Magg.ri Generali Druetti - Carpi - Rostagno - Arpa - Camp i - Capello - Dc Stefano». Il corsivo indica le parti sottolineate nell ' o r iginale. Si noti come il comune e netto giudizio negativo di Ministro e Primo Aiutante sul genera le Capello oltre sei anni prima di Caporetto non sia riuscito a frenarne l'ascesa fino al grado di comandante di armata.
53 RFS. Pollio a Spingardi, Roma , il 21 febbraio 19 1I, N° 103 Personale.
Pollio proseguiva « Così dicasi pei generali Giletta, Samm iniatelli, Martinelli, Salvati, Toscani, Rostagno. - Per altri generali ho ripetutamente espresso parere contrario alla loro idoneità i n seno alla commissione d'avanzamento; ma non sono stato appoggiato. Alludo a i generali Mandile e Stazza: ottime persone, egregi militari, ma che non credo s iano all'altezza del loro compito. - Finalmente altri generali e colonnelli, da V.E. menzionati , dovranno dar prova della loro idoneità al grande comando di truppe colle prossime grandi manovre. Così i generali: Massone (che, come ebbi già a dich ia rare verbalmente a V E., ritengo fino a prova contraria che sia un buon comandante di corpo d ' armata per valore professionale), Ricci , Aureggi, S cribaru -Rossi. - In quanto ai colonnelli dei quali V.E. mi fa il nome , credo che si possa affidare ai comandami di armata nelle loro prossime ispezioni il compito di studiarli e proporre
La difficile selezione dei quadri 125
generale Paolo Spingardi
In materia di avanzamento la figura del Capo di Stato Maggiore appare insomma sostanzialmente debole di fronte al Ministro, che rimaneva costituzionalmente il maggiore responsabile.
Il secondo disegno di legge
Il risultato di questi complessi rapporti fu il nuovo progetto di legge s ul!' avanzamento, presentato al Senato 1'8 aprile 1911, caduto il governo Luzzatti e varato il nuovo governo Giolitti.
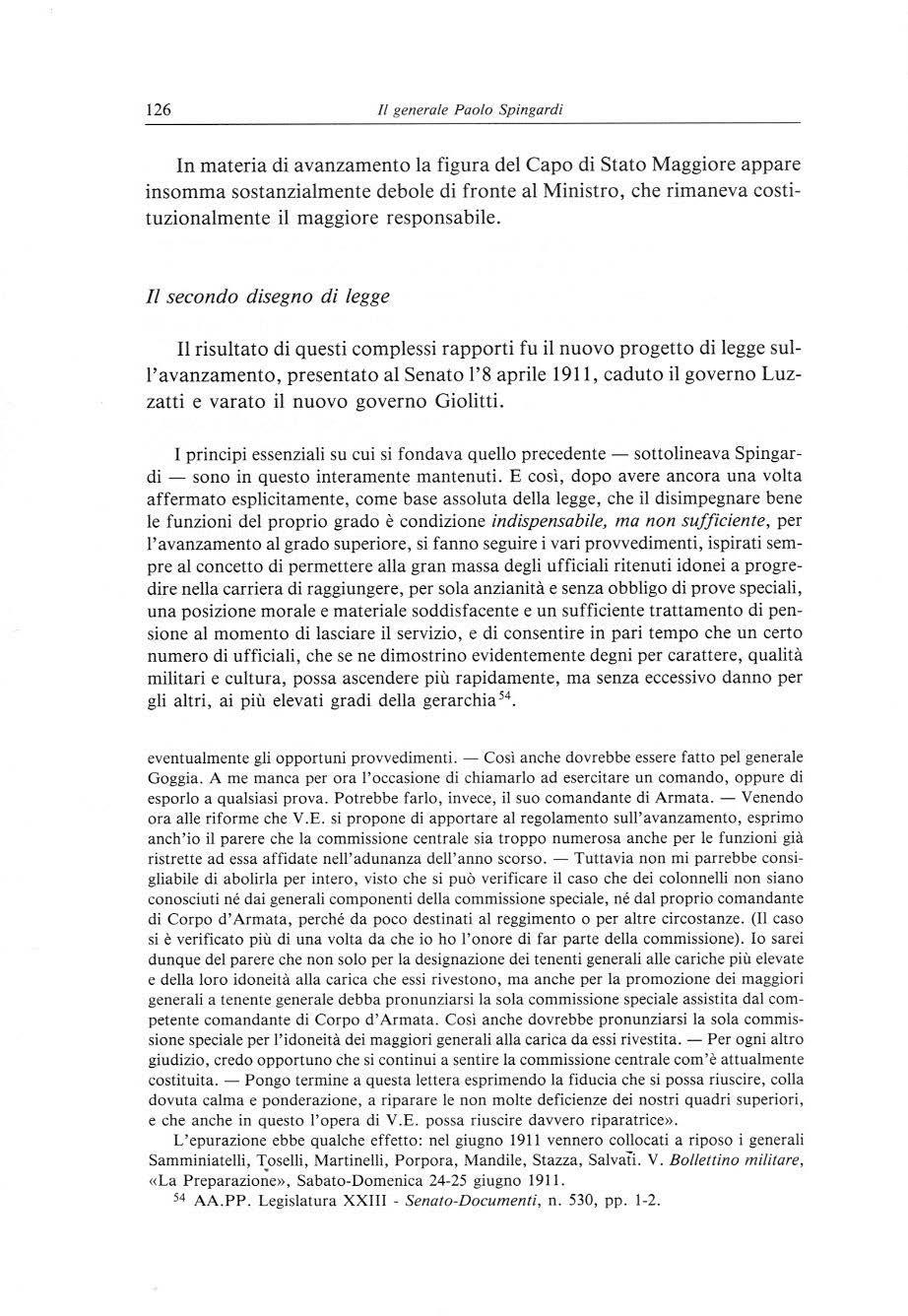
l principi essenzia li su cui si fondava quello precedente - sottolineava Spingardi - sono in questo int eramente mantenuti E così, dopo avere ancora una volta affermato esplicitamente, come base assoluta della legge, che il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore, si fanno seguire i vari provvedimenti, isp irati sempre al concetto di permettere alla gran massa degli ufficiali ritenuti idonei a progredire nella carriera di raggiungere, per sola anzianità e senza obbligo di prove speciali, una posizione morale e materiale soddisfacente e un sufficiente trattamento di pensione al momento di lasciare il servizio, e di consentire in pari t empo che un certo numero di ufficiali, che se ne dimostrino evidentemente degni per carattere, qualità militari e cultura, possa ascendere più rapidamente, ma senza eccessivo danno per g li altri, a i più elevati gradi della gerarchia 54 •
eventua lmente gli opportuni provvedimenti. - Così anche dovrebbe essere fatto pel generale Goggia. A me manca per ora l'occasione di ch iamarlo ad esercitare un comando, oppure di esporlo a qualsiasi prova. Potrebbe farlo, invece, il suo comandante di Armata. - Venendo ora alle riforme che V.E. s i propone di apportare al rego lamento sull'avanzamento, espr im o anch'io il parere che la commissione centrale sia troppo numerosa anche per le funzioni già ristrette ad essa affidate nell'adunanza dell'anno scorso. - Tuttavia non mi parrebbe consigliabile di abolirla per intero, visto che s i può verificare il caso che dei co lo nnelli non siano conosciuti né dai generali componenti della commissione spec ia le, né da l proprio comand ante di Corpo d'Armata, perché da poco destinati al regg imento o per altre c irco stanze (Il caso si è verificato più di una volta da che io ho l'onore di far parte della commissione). lo sarei dunque del parere c he non solo per la designazione dei tenent i generali alle cariche più elevate e della lo ro idoneità alla carica che ess i rivestono, ma anche per la promozione dei ma ggiori general i a tenente generale debba pronunziarsi la sola commissione speciale assistita dal competente comandante di Corpo d'Armata. Così anche dovrebbe pronunz ia rsi la sola commissione speciale per l'idone ità dei maggiori genera li alla carica da essi ri ves tita. - Per ogni altro giudizio , credo opportuno che si continui a sentire la commissione centrale com'è attualmente costit uita. - Pongo termine a questa lett.era esprimendo la fiducia che s i possa r iu scire, colla dovuta calma e ponderazione, a r iparare le non molte deficienze dei nostri quadri super io ri, e che anche in questo l'opera di V.E. possa r iu scire davvero ripa rat rice>>.
L'epurazione ebbe qualche effetto: nel giugno 1911 vennero collocati a riposo i generali Samminiatelli, Toselli, Martinelli, Porpora, Mandile, Stazza, Salvati. V. Bollettino militare, «La Preparazio~e», Sabato-Domenica 24 -2S giugno 19 1 1. 54 AA.PP . Legi s latura XXIII - Senato-Documenti, n. 530, pp . 1-2.
126
lf
L'Ufficio centrale del Senato inca r icato di esaminare il disegno risultò composto di alcune fra le più autorevoli personalità militari e cioè i generali Rinaldo Taverna, già Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiest a; Giovanni Goiran, già Direttore Generale dei servizi amminist r ativi al Ministero della Guerra; Felice Sismondo, Coman dante generale dei Carabinieri dal 1900 al 1904; Ettore Pedotti, Mi nistro della Guerra dal 1903 al I 905; Francesco Antonio Ma zza, veterano de ll e campagne del 1866 ed' Africa 1896 ed estensore della sentenza del processo Baratieri dopo la ba tt aglia di Adua .
Il del icato argom ento impose un attento esame de l d isegno di legge ed impegnò per lungo tempo i senatori. Lasciando questi al loro lavoro, Spingard i rivolse le sue atte nzioni al fondamentale campo degli armament i.
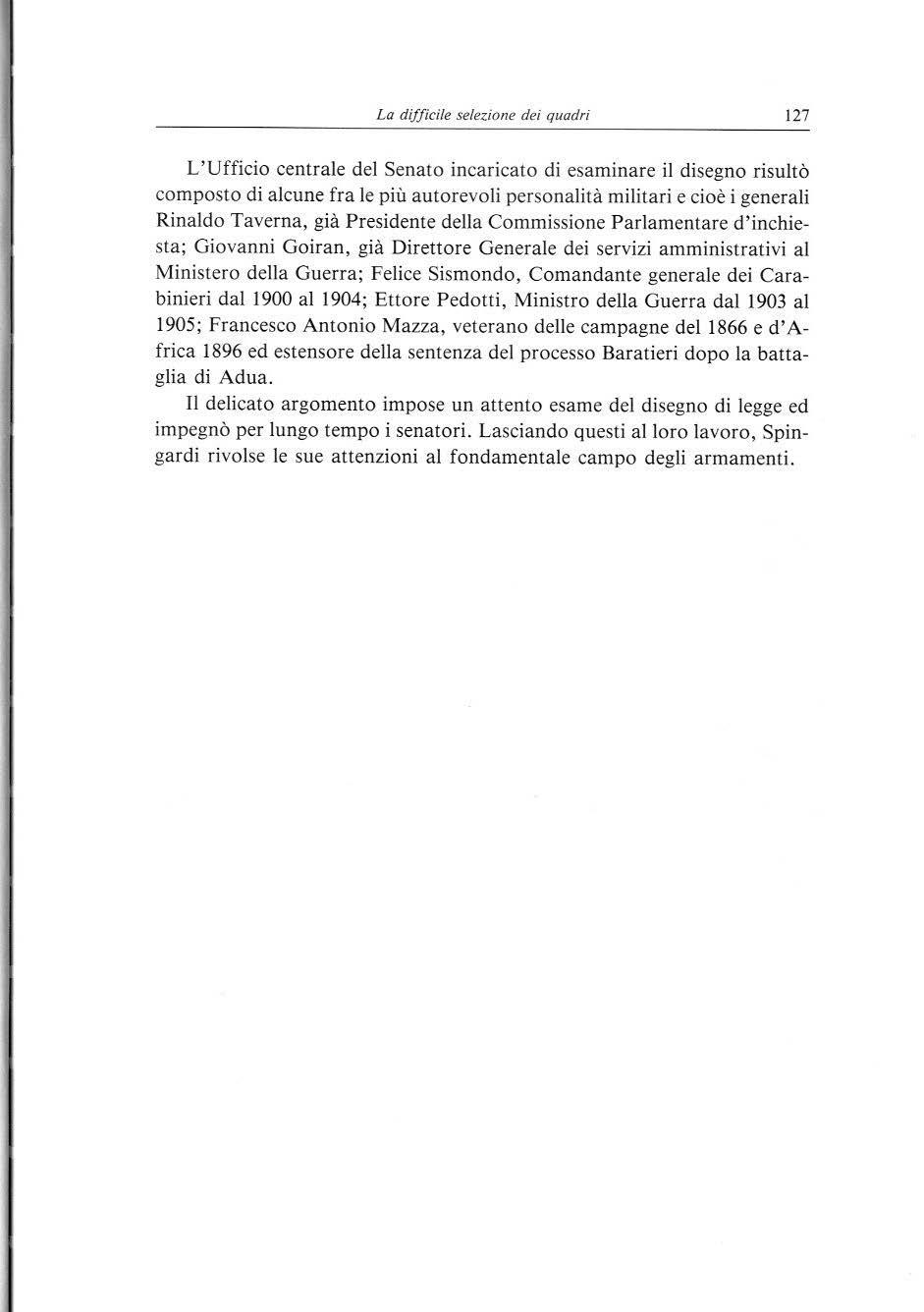
La difficile selezione dei quadri 127

.
ARMAMENTI
1. // travagliato rinno vamento dell'artiglieria da campagna
Nel 1961 Giorgio Rochat scriveva che
La lunga e travagliata sostituzione de l ma teria le dell'artiglieri a da campagna tra il 1898 ed il I 915 è la più nota di un a serie di dim ostrazioni dell ' in suffic ienza dell e au torit à mili tari , che d opo anni di esper imen ti e la success iva ad ozione di due divers i ti p i di cannone Krupp, cost rui t i in centinaia di batterie, ne l 1911 finalmente sceglievano l'ottimo ma teriale fr ancese Dèpor t, che la Francia imp ieg a va con successo fin dal 1897, ma che prima, per ragioni mai preci sate, era stato scartato r ipetutamente dai com petenti ita liani 1
Gli studiosi in genere concordano con la sostanza di questo giudizio 2 Nessuno però specifica, ad esempio, che il modello Krupp adottato nel 1906 era equivalente al Dèport quan to a celerità di tiro, potenza di fuoco e qualità balistich e generali, diffe ren do da esso per ess ere privo degli ampissimi setto ri di tiro verticali e orizzontali, che e rano la pecu liarietà del cannone francese rispetto a t utti gli altri Va inoltre sottolin eato che fu la lentezza delle forniture, a caratterizzare negativamente la dotazione dei nuovi armamenti, p i ù che il ritardo n elle sce lte: è vero che nel 1906 erano trascorsi no ve anni da quando l'affusto a deformazione era stato adottato in Francia, ma solo un paio da quando era stato ado ttato in Germania , e l'Aust ria -U ngheria era all'incirca nelle nostre condizioni 3
1 R OCHAT, L'esercito italiano nell'estate 1914, cit., p. 302. Cfr. R oCHAT-MASSOBRJO , ci t. , pp. 156 -57 e n. Il pp. 170-7 1.
2 Cfr. W HrTTAM, Storia dell'Esercito italiano, c it., p. 245; CEVA, Le forze a rmate, cit., p. 97 , GooCH, Army, State and Society, cit. pp. 119- 121.
3 V. AUSSME , F-4, C. 27, COMANDO DEL CORPO 01 STATO MACCJORE, Lo stato presente dell'artiglieria da campagna presso le potenze europee e presso alcuni altri stati, Roma 1906. Si tra tta di un opuscoletto a stampa d i 22 pagine, una pubblicazione fatta ad uso esclusivo dei comand i mi li ta ri (è repe ribi le in A USSME e nelle b iblioteche mi litari di pres id io), che documenta come la Ge rmania e l'In ghilte rr a avessero deciso l'adozione del nuovo materiale nel 1904 e ne pr evedessero il comp letam ento rispettivamente per la fine del 1906 e la primavera del 1907, mentre Rus sia e Austria- Ungheria aspettav a no il mate riale in costruzione nei propri stabilimen t i se n za s apere quando sarebbe stato d ist ribui to.

CAPITOLO VI
Ma mentre all'estero tra la scelta de l modello e la sua distribuzione ai corpi trascorse poco tempo, in Italia si dovettero attendere oltre cinque anni prima che fosse completata la distribuzione del Krupp / 1906 e quattro anni perché lo stesso avvenisse p er il D è por t/ 1911 , e per quest'ultimo determinante fu la sp in ta imposta dall'imminente partecipazione alla guerra europea 4
Vi è stata insomma, a mio patere, la tendenza ad accentuare eccess ivam e n te la questione dei Dèport, dando al lettore l 'impressione che nel 1914 l'esercito italiano fosse quasi sp ro vvisto di artiglierie moderne.
Consultando i documenti d'archivio si nota in realtà una not evole tranquillità da parte delle autorità competenti . A tutti gli effetti della mobilitazion e, a part ire dal 1° novembre 1911, no ve corpi d ' Armata dell'esercito permanente su dodi ci erano equipaggiati col materiale Krupp 75 / mod. 1906 5 • Il Krupp 75-A in do tazion e ai cor pi dal 1904, poi, era un cannone balisticamente eccellent e, che rappresentava comunque un progresso ris petto alle bocche da fuoco precedenti, tanto che «rese buoni servizi, impiegato in postazioni fisse, sia in Libia, sia nella guerra mondiale» 6 : ins omma, benchè non fosse proficuamente utilizzabile in campo aperto, i so ldi spesi pe r a dottarlo non si pos sono considera r e totalmente sprecati .
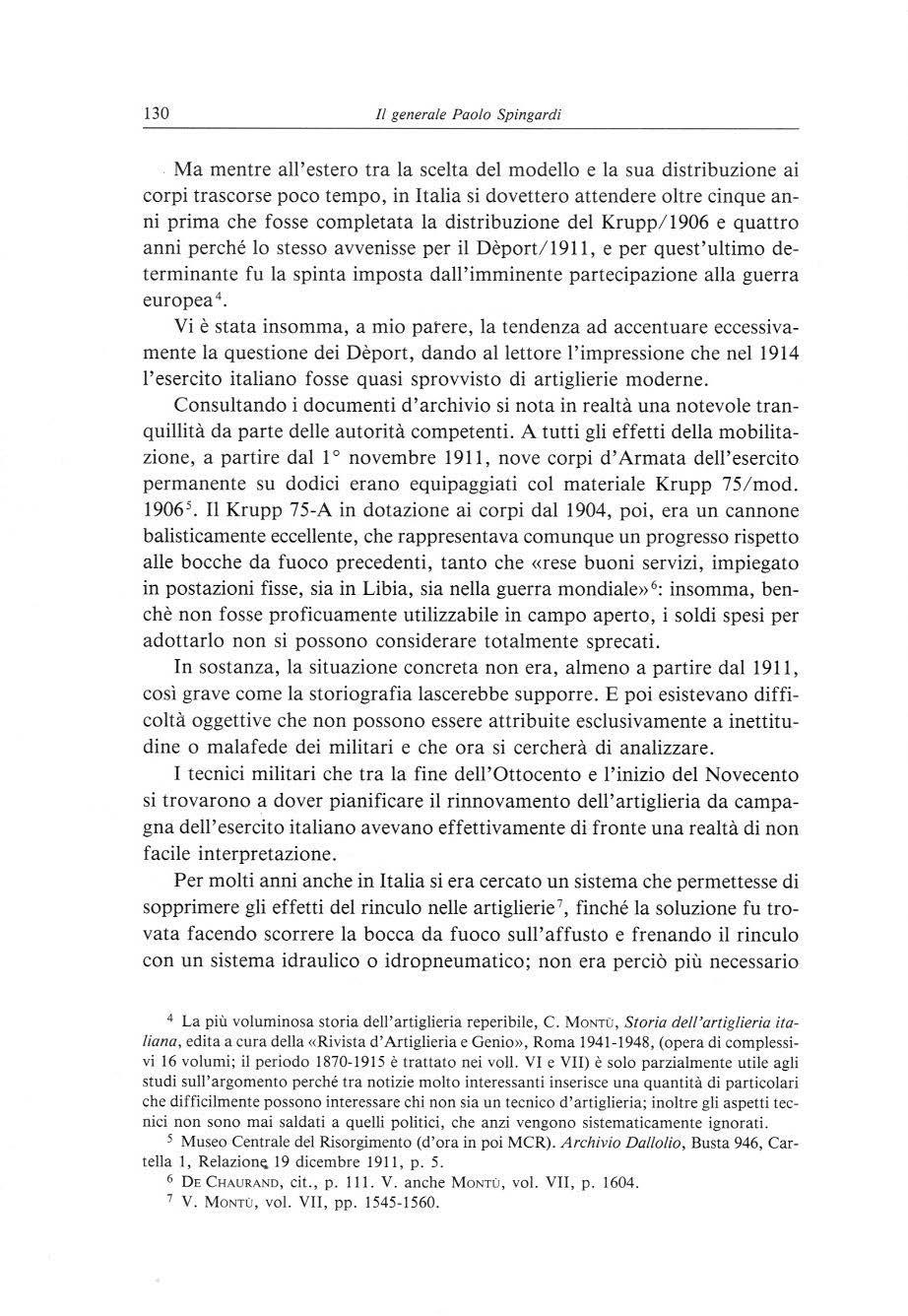
In sostanza, la situazione concreta non era, almeno a partire dal 1911 , così grave come la storiografia lascerebbe s upporre. E poi esistevano difficoltà oggettive che non possono essere attribuite esclusivamente a inettitudine o malafede dei militari e che o r a si cercherà di analizzare .
I tecnici militari che t ra la fin e dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si trovarono a dov e r pianificare il rinnovamento dell'artiglieria da campag na dell'esercito italiano avevano effettivamente di fronte una realtà di non facile interpretaz ione.
Per molti anni anche in Italia si era cercato un sistema che permettesse di sopprim e re gli effetti del rinculo nelle artiglierie 7 , finché la so luzione fu trovata facendo scorrere la bocca d a fuoco sull'affusto e fr enando il rinculo con un sist ema idraulico o idropneumatico; non era pe rciò più necessario
4 La più volum ino s a storia dell'artiglieria re peribile, C. Momù, Storia dell'art iglieria italiana, edita a cu ra della « Rivista d'Artiglier ia e Gen io », Roma 1941. - 1948, (oper a di c ompl ess ivi 16 vol u mi ; il periodo 1870- 1915 è trattato nei voli . VI e VII) è so lo parzial m e n te uti le agli stu di sull'a rgomento perché t ra notizie molto interessanti inserisce una quantità d i part ico lari che difficilmente posso no i nteressare chi non sia un tecnico d'artig lie ria; inoltre g li aspetti t ecnici non sono mai sa ldati a quelli politici, che anzi vengono sistemat icamente ignorat i.
5 Museo Centrale del Risorgimento (d'o ra in poi MC R) Archivio Dallo/io, Busta 946, Cartella I, Relazion<;. 19 d icembre 19 11, p. 5.
6 De CHAURAND, cit., p 1 11. V anche M oNTù , voi. VII, p. 1604.
7 V MONT ù , voi. VII, pp. 1545- 1560.
130
li generale Paolo Spingardi
ripetere le operazioni di puntamento dopo ogni colpo e ne guadagnava la velocità di tiro, con un minimo di 15 colpi effettivi al minuto (30 teorici), co ntro i 7 colpi al minuto dei cannon i ad affusto rigido. I serventi erano inoltre protetti dal fuoco nemico grazie ad uno scudo corazzato che la soppressione del rinculo permetteva di montare efficacemente sull'affusto. Intorno al 1894 l'allora capitano di artiglieria dell'esercito frances e Joseph Albert Dèpo rt perfezionò ulteriormente il sistema ottenendo un cannone che consentiva un largo sett ore di tiro vertical e e orizzontal e . Artiglierie costruite secondo i nuovi criteri vennero adottate dall' esercito francese nel 1897 e nel co rso dell'anno success ivo erano in servizio presso tutte le unità s. Co minciò quindi in Europa e in Italia un dibattito sulla convenienza o m e no dell'affusto a deformazione e per di ve rs i anni la Fra ncia rimase l'unica potenza ad averlo adottato integralmente 9 •
Biso gna poi con s iderare che il rapidissimo sv iluppo tecnologico verificatosi nell'ultimo trentennio dell'Ottocento , oltre ad aver gene ralizzato l'uso dell'acciaio nella fabbricazione dei materiali di artiglieria , da diversi anni aveva abituato al sorgere di bocche da fuoco sem pre più perfette e potenti, tra le quali era diffi ci le capire quale foss e realmente la migliore: «Soprattutto fra il 1890 e il 1910 i nuo v i modelli ve ni va no sfornati a un r itmo allucinante» 10 • In somma non era facile percepir e con esattezza l'efficacia dei nuovi cannoni, tanto più che le qualità che si ricercavano nell'artigli eri a da campagna erano innanzitutto la semplicità e la robustezza 11 •
Per ciò nel I 900 , dopo tre anni di esperimenti, l' ar t ig lieria italiana, che avev a in se rvizio du e modelli di ca nnone da campagna in bronzo compre sso e affusto rigido, il cos iddetto 87-B, <tdottato nel 1880, e il 7 -B, adot tato nel 1870 12 , decise di sos tituire quest'ultimo con un più moderno materiale
8 V. D ECHAU RAND, cit., p. 106; COMANDO DEL CORPO 0 1 STATO MAGG IORE, Lo s tat o p resente dell'artiglieria da campag na, cit., p. 9; F.L. ROGJ ER, La quest ione della artiglieria campale nel decennio 1896- 1906 e la relazione della Comm issione d'inchiesta , T i pografia Enrico Voghera, Roma 1908, nota 2 a pag. 6.
9 Cfr. D E CHAURAl'D, cii., p 107; M or-rrù, voi. VIJ, pp. 1568 e segg.
IO W HITTAM, p. 23 8. Sullo sviluppo tecnologico di fine Ottocento v. D.S. L\NDES, Prometeo liberato, Trasformazioni tecn o logiche e sviluppo industriale n ell'Europa occidentale dal 1750 ai g iorni nostri, E inaudi, Torino, 1978, pp. 325-467. Per quanto r ig ua rda più spec ificamente le tec niche d'aniglieria v. MONTÙ, voi. VI, pp. 58-69, voi. VII, pp. 1545-1690. Anche le opere citate alla nota seguente meuono in risalto il notevole sviluppo delle artiglierie nella seconda metà dell 'Onocento.
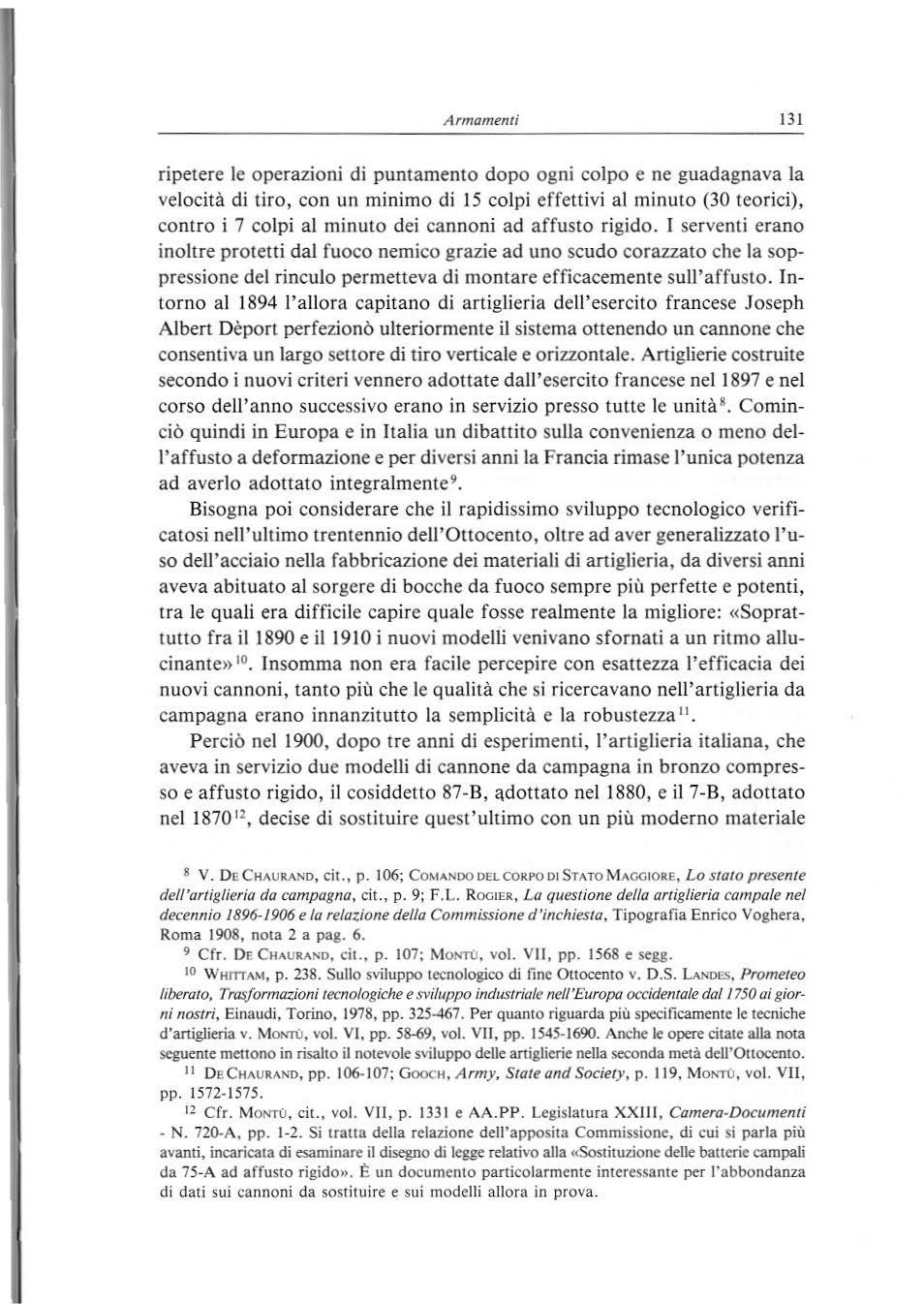
11 D ECHAURAND , pp. 106-107 ; G oocH, Army, State and Society, p. 119, M oN1ù, voi. VII, pp . 1572-1575 .
• 2 Cfr. M ONTù , cit. , vo i. VII, p. 133 1 e AA.PP. Legi sla tura XXIII, Camera-Documenti - N. 720-A , pp. 1-2. Si traua della rela zio ne dell'apposita Commissione, di cui si parla più avanti, incaricata di esaminare il disegno di legge relativo alla «Sostituzione delle batterie campali da 75 -A ad affusto r igido». È un documento parti colarme n t e intere ssa nte per l 'abbo ndanza d i dati sui ca nnoni da sosti tuire e su i m ode lli allora in prova
Armamenti 131
Il generale Paolo Spingardi
in acciaio: il Krupp 75-A ad affusto ancora rigido 13 • En tro il marzo 1904 la sostituzione del vecchio materiale col nuovo era compiuta 14 •
Ma nell'arco di un paio d ' anni le maggiori potenze optarono senza ulteriori esitazioni per l'adozione di materiali a deformazione 15 • A quel punto, risaltò l'assoluta obsolescenza del cannone da 87-B, che pure era st ato modificato nel 1898 per adeguarlo ai progressi della tecnica. Quindi nell'aprile 1906 si decise di sostituirlo con un cannone a deformazione: il Krupp 75 -A mod . 1906; la prima batteria giunse in I talia in novembre 16 •
Non era possibile dilazionare oltre l'adeguamento ai mutamenti tecnologici. Bisognava seg uire la tendenza dei pr incipali eserciti e uropei, perché era ormai chiaro che i nuovi cannoni avrebbero assicurato la vittoria su un esercito che ne fosse risultato sprovvisto, garantendo un volume di fuoco enormemente superiore. Una rapidità di tiro più che doppia rispetto ai cannoni ad affusto rigido, significava la distruzione dell'artiglieria avversaria prima che questa fosse in grado di sparare il secon do colpo 17 •
La Krupp forniva le bocche da fuoco complete e i relativi otturatori .
L'industria nazionale italiana provvedeva alla rifinitura e al montaggio dei restanti pezzi forn iti dai tedeschi sbozzati e isolati. Totalmente italiana era la fabbricazione del munizionamento e del carreggio 18 •
La seconda relazion e della Commissione d'inchiesta presentata il 23 giugno 1908, interamente dedicata al Nuovo materiale dei cannoni da campagna, mise in lu ce alcune indecisioni nei tentativi di riequipaggiamento del-
13 Cfr. Relazione Ufficiale p. 37; STEFANI, cit., p. 547.
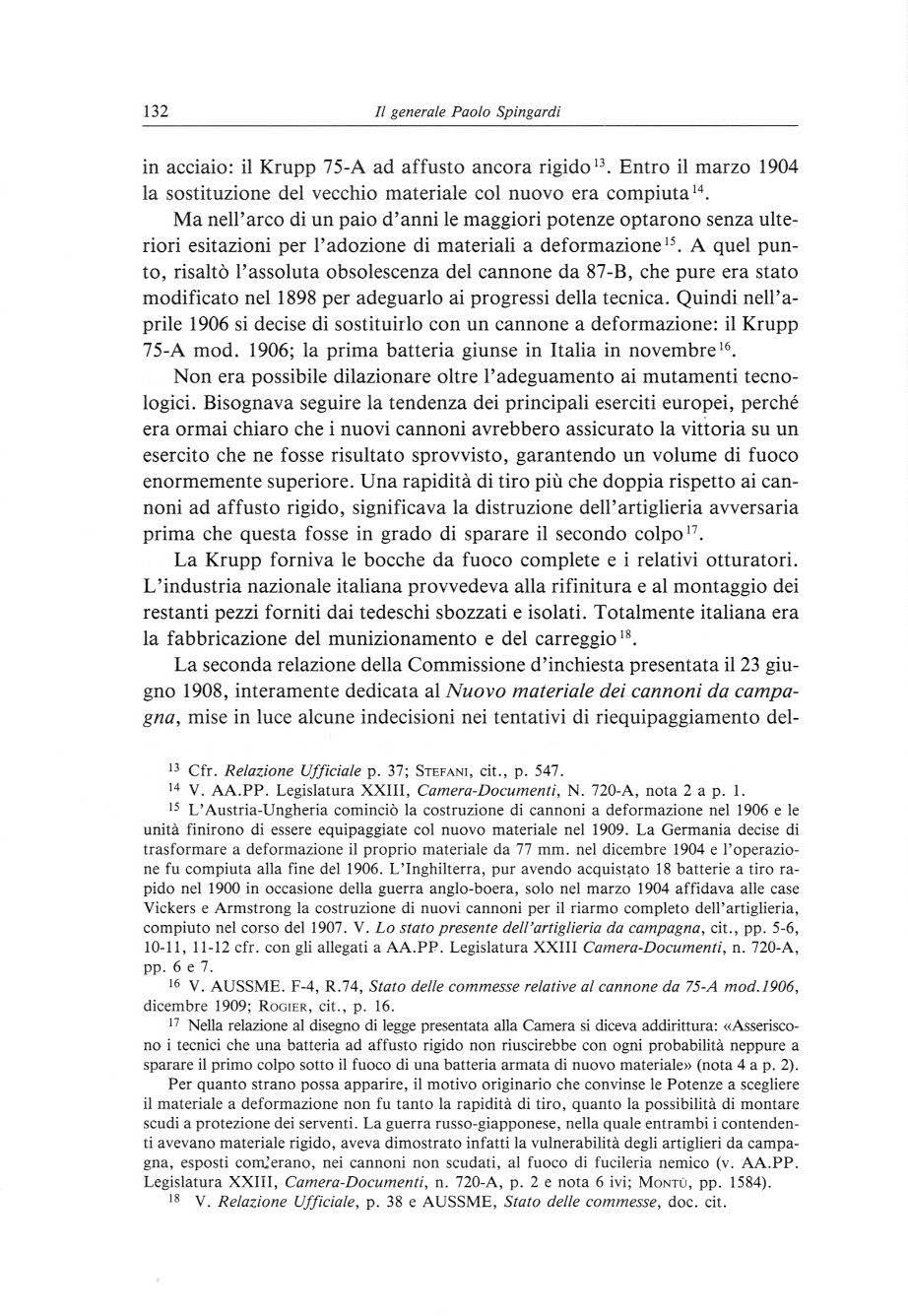
14 V. AA.PP. Legislatura XXIII, Camera-Documenti, N. 720-A, nota 2 a p. I.
15 L'Austria-Ungher ia cominciò la costruzione di cannoni a deformazione nel 1906 e le unità finirono di essere equipaggiate col nuovo materi ale nel 1909. La Germania decise di trasformare a deformazione il proprio materiale da 77 mm nel dicembre 1904 e l'operazione fu compiuta alla fine del 1906 L'Inghilterra, pur avendo acqu ist~to 18 batterie a tiro rapido nel 1900 in occasione della guerra anglo -boera, solo nel marzo 1904 affidava alle case Vickers e Armstrong la costruzione di nuovi cannoni per il riarmo comp leto dell'artiglieria, compiuto ne l corso del 1907. V. Lo stato p resente dell'artiglieria da campagna, cit., pp. 5-6, 10-11, 11-12 cfr. con g li allegat i a AA.PP. Legislatura XXIll Camera-Documenti, n. 720-A, pp.6e7.
16 V AUSSME. F-4, R. 74, Stato delle commesse relative al cannone da 75-A mod. /906, dicembre 1909; Roc1E R, cit., p. 16.
17 Nella relazione al disegno di legge presentata alla Camera si diceva addiri ttura : «Asseriscono i tecn ici che una batteria ad affusto rigido non riuscirebbe con ogni probabilità neppure a sparare il primo co lpo sorto il fuoco di una batteria armata di nuovo materia le» (nota 4 a p. 2)
Per quanto strano possa apparire, il motivo originario che convinse le Potenze a scegliere il materiale a defo rmazione non fu tanto la rapidità d i tiro, quanto la possibili tà di montare scudi a protezione dei serventi. La guerra russo -giapponese, nella quale entrambi i contendenti avevano mater iale rigido, aveva dimostrato infatti la v u lnerabilità degli artiglieri da campagna, esposti com;erano, oei cannoni non scudati, a l fuoco d i fuc ileria nemico (v AA.PP. Legislatura XXIII, Camera-Documenti, n. 720-A, p. 2 e nota 6 ivi; MONTù, pp. 1584).
18 V. Relazione Ufficiale, p. 38 e AUSSME, Stato delle commesse, doc cit.
132
l'artiglieria operati nei dieci anni precedenti 19 • A farne le spese furono i due ultimi ispettori generali d'artiglieria, i generali Francesco Rogier (che aveva ricoperto la carica dal 1902 al 1906) e Antonio Mangiagalli (dal 1906 al 1908), coll ocati in disponibilità senza troppi complimenti, originando così una polemica che si trascinò per parecchi mesi 20 e impose all'opinione pubblica il problema dell'artiglieria come «il problema principale e più travagliato di tutto il vasto programma militare» 21 •
1. 1 L'opera di Spingardi
Quando Spingardi giungeva al potere la polemica era terminata ma il problema dell'artiglieria restava. La situazione era anzi alquanto preoccupante, perché l'esercito italiano si sarebbe mobilitato con i cannoni rigidi 75 -A e 87-B, dato che nessuna batteria del nuovo cannone era stata ancora distribuita ai corpi.
Uno dei punti del programma del Ministro consisteva appunto nell'arrivare «in un periodo relativamente breve di tempo » alla completa sostituzione del materiale da 87-B con il cannone Krupp 75 -A mod. 1906 22 •
Nel corso del 1909 i nuovi modelli cominciarono ad essere distribuiti, ma in dicembre si trovavano in servizio solo 39 batterie per istruzione del persona le e nessuna per i corpi combattenti 23 •
Si sperava di assegnare tutti i pezzi per la primavera del 191!24, ma in realtà ancora i l 2 giugno 1911 Spingardi si limitò a dichiarare alla Camera che la sost ituzione del materiale da 87 bronzo col materiale da 75 Krupp mod. 1906 a deformazione era «oramai così prog redita, da poter affermare che tra pochi mesi sarà un fatto compiuto» 25
Un certo ritardo fu dovuto alla commissione d'inchiesta che tra il 1907 e il 1908 volle condurre accurate prove sul nuovo cannone avendone giudicato l'adozione non sostenuta da adeguata documentazione sperimentale. Ma alla fine il Krupp /1 906 risultò apprezzab il e sotto tutti gli aspetti26 •
19 V. CACIULLJ, L'amministrazione della guerra, l'esercito e la Commissione d'inchiesta del 1907, cit., pp. 11 - 13 e le fonti ivi citate.
20 Sul caso Rogier-Mangi agalli v DE CHAURAND, cit., pp. 111-112; CACJULLJ, Il Ministro borghese della guerra (1908 - 1909), in «R icerche Storiche», a . XVI , 1986, n. 2, pp. 327-333; M. M ERIGG I, Militari e istituzioni politiche nell'età giolittiana, cit., pp . 76-79 .
21 Sono paro l e pronuncia te alla Camera dal deputato radicale Luigi Fera in AA.PP. Legislatu ra XXIII, Camera-Discussioni, 2 ' tornata del 2 giugno 1911, p. 15140.
22 AA.PP. Legislatura XXTIT , Camera-Discussioni, tornata dell'll giugno 1909, p. 2250.
23 V. AUSSME, Stato delle commesse, doc. cit .
24 V. AUSSME, F-4, C.27, Promemoria a S.E il Ministro intorno allo stato delle lavorazioni ed alla graduale distribuzione del materiale da 75 modello 1906, n. 21187 di prot.
25 AA PP Legislatura XXIII, Camera-Discussioni, 2• tornata del 2 giugno 191 I, p. 15145
26 V. CACIU LLI, L'amministrazione della guerra, l'esercito e la commissione d'inchiesta, pp. 11-12, M oNTù , pp . 1595-1596.
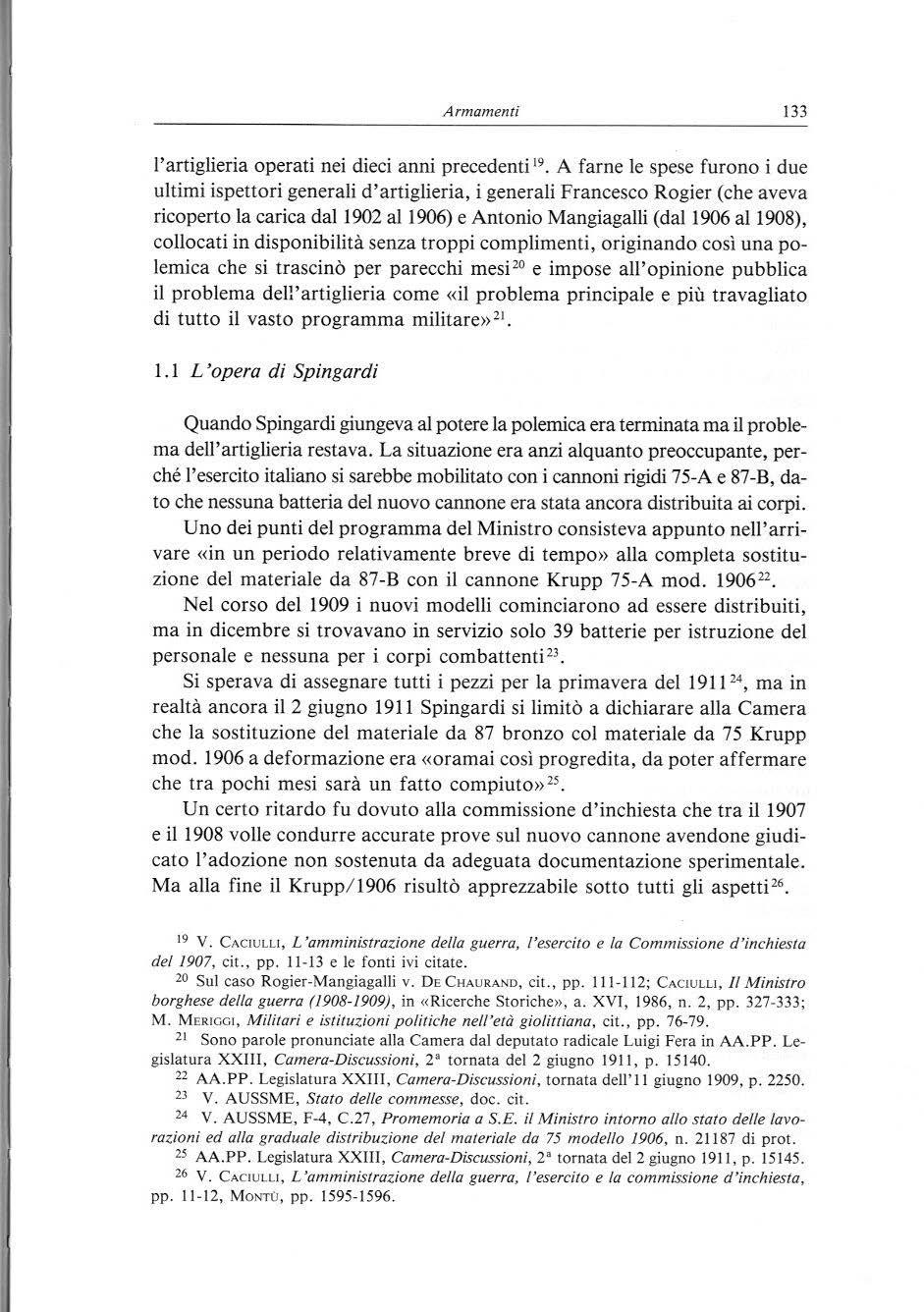
Armamenti 133
Inoltre la distribuzione dei pezzi avveniva seguendo rigorosamente leprescrizioni per la mobilitazione. Si trattava perciò di equipaggiare 242 batterie su 6 pezzi: 190 fo r mavano i 36 reggimenti dell'esercito permanente e 52 i 13 reggimenti della Milizia Mobile 2 7 •
Ma ciò che complicava l'opera era la necessità di proce de r e in m o d o che ogni Armata mobilitata avesse cannoni di un solo tipo . Q uindi, le unità costitutive della 1a, 3• e 4• Armata, tanto permanenti quanto di M ilizia Mob ile, vennero dotate del nuovo materia le, senza badare se esso andava a sostituir e 1'87- B o il 75 -A. Perciò, r imanevano ora in servizio anco r a 93 batterie ad affusto rigido, delle quali 48 armavano 9 reggimenti , una la batteria della Sardegna dell'esercito permanente e le altre tutto il resto della Milizia Mobile. Erano truppe appartenenti alla 2• Armata e a lle truppe a disposizione del Comando supremo 28 •
Infine, a partire dall'estate del 1910, la distribuzione del nuovo materiale si sovrappose all'opera di lenta formazione dei 12 nuovi reggimenti di artiglieria da campagna, creando un fitto intreccio di problemi re lativi agli accasermamenti e ai trasporti 29 •
Mentre era comunque avviato a so luz ione il problema del modello 1906, Spingardi si trovò ad affrontare quello relativo alla sos ti tuzione del materiale da 75 -A che aveva preso il posto del vecchio 7-B Fin da l 1906 erano in corso studi per modificarlo da rigido a deformazione, operazione che, se r iuscita, avrebbe consentito di risparmiare tempo e denaro . Perc iò nessuna spesa al rig uardo compariva nel programma del 1909, anche se il perspicace Marco Di Saluzzo ne aveva proposto l'immediata sostituzione con un nuovo cannone 30 •
L'onorevo le Di Saluzzo - spiegava Spingardi - ha accennato agli esperiment i che stanno per essere iniziati su di un cannone 75-A rigido, trasformato a deformazione dalla casa Creusot-Schneider, e si domanda se, per avventura, non potrebbe esser conveniente so prassedere a questa trasformazio ne, e se non convenga meglio di sostituire il materiale da 75-A rigido con a ltro materiale nuovo più leggero e me -
27 V. AUSSME, F-4, C.27, Specchio relativo alla distribuzione delle ba//erie da campagna al 2 maggio 1912. Per l 'esatt a comprensione delle cifre va tenu to presente che i reggimenti del la M.M. erano su 4 batterie (anziché 5 come l'esercito permanente), e che il 36° reggimento mobilitava con due batterie da campa gna e tre da mon tagna U na batteria era poi permanentemente disloca ta a Ozieri per la difesa della Sardegna.
28 AUSSM E, F-4 , C. 74, Ragg ruppam ento delle grandi unità in caso di radunata N.E., 22 maggio 1909. Cfr. ibidem, Specchio relativo alla distribuzione del materiale da campagna, doc . cit .
2 9 V. AUSMME, F-4 (OM), R. 27, dove è contenuto tutto il materiale relativo alle questioni so r te per l' attuazio ne del nuovo o rdin amento dell'artiglieria da campagna.
30 V. AA.PP., Legislatura XXIII, Camera -Discussioni, Tornata de11'8 giugno 1909, p. 2090.
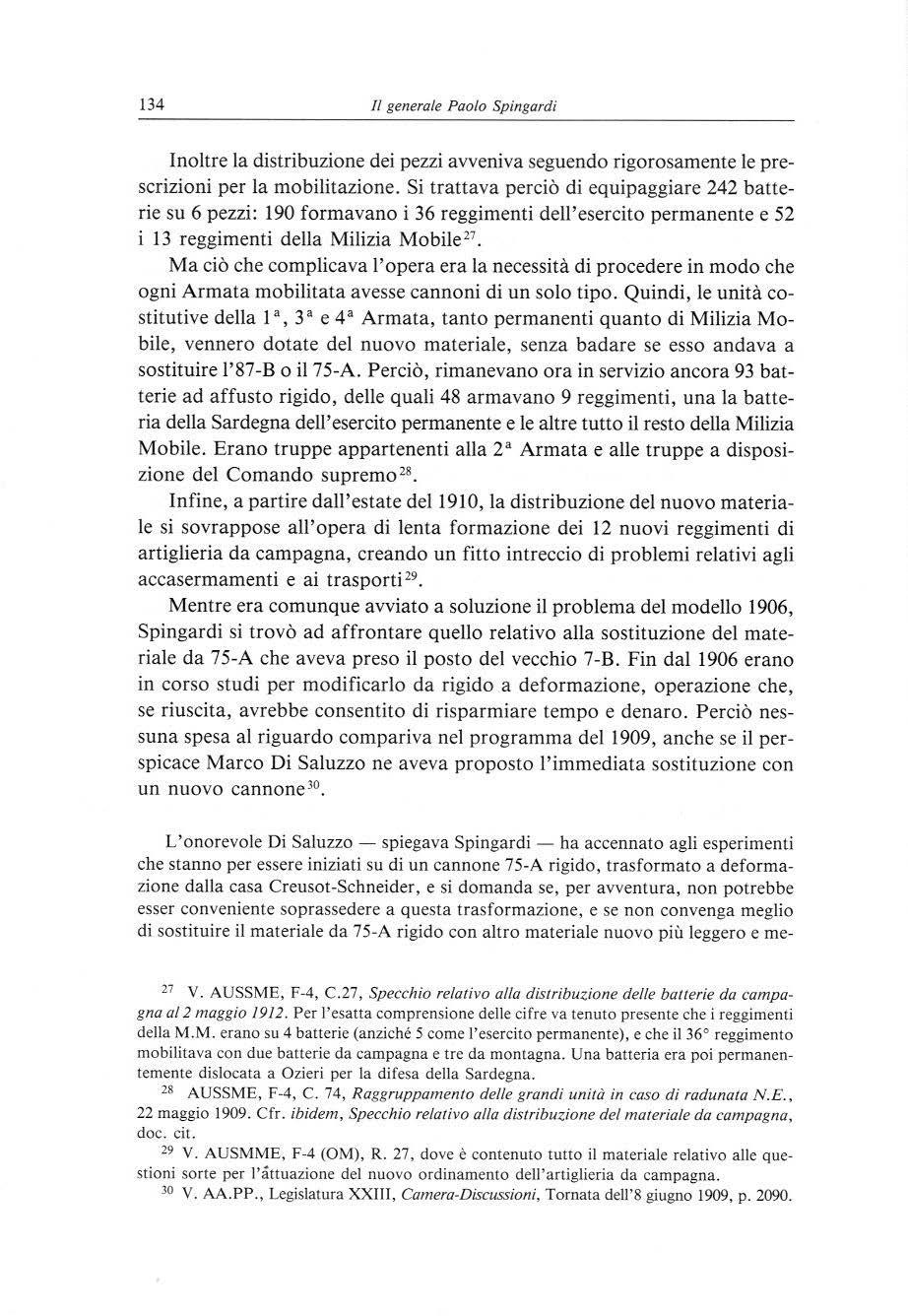
134
li generale Paolo Spingardi
glio rispondente ai terreni montuosi di gran parte della nostra Italia. Rispondo ( ] che la questione è ancora sub judice, e non sappiamo ancora quali saranno i risultati degli esper im e n ti in corso, tanto vero che nelle spese per armamento della nostra art iglieria, non è fatto cenno ancora della trasformazione o sostituzione di questo materiale da 75 -A rigido, c he la vostra Commissione d'inchiesta, del resto, ha riconosciuto come materiale di valore balistico veramente ottimo 31 •
Gli esperiment i, condotti al poligono di Ciriè vicino a Torino, dimostrarono l'impossibilità di trasformare il pezzo senza perderne inesorabilmente le qualità balistiche 32 • Spingardi dovette quindi pensare alla completa sostituzione e perciò il 18 dicembre 1910 presentò alla Camera un disegno di legge nel quale ven i vano richiesti 50 milioni da spendere in tre esercizi per sostituire le 93 batterie ancora ad affusto rigido con un nuovo materiale a deformazione del quale però ancora non si erano decisi né il modello né la ditta fornitrice 33 •
In ver i tà fin dall'ottobre 1908 il Ministero della Guerra italiano era entrato in trattative colla compagnia francese Des Forges de Chatillon Commentry et Neuves Maisons per la fornitura di una vettura-pezzo tipo Dèport, che giunse al poligono di Ciriè sul finire dell'agosto 1910 34 , e nel marzo 1911 la Commissione degli Ispettori di artiglieria esp r imeva parere favorevole all'adozione di quel materiale.
Ma gli stessi ispettori ritennero ugualmente necessarie «p iù complete ed esaurienti prove tecniche e di impiego mediante una batteria di prova su 4 pezzi» 35 •
31 Ibidem, Tornata Il giugno 1909, p. 2256.
32 L'ani ma della bocca da fuoco risultava deformata a l punto da renderla inutilizzabile dopo aver s parato 1300 colpi circa; V. AA.PP. legislatura XXIII, Camera-Documenti, Atto 720-A, p. 8.
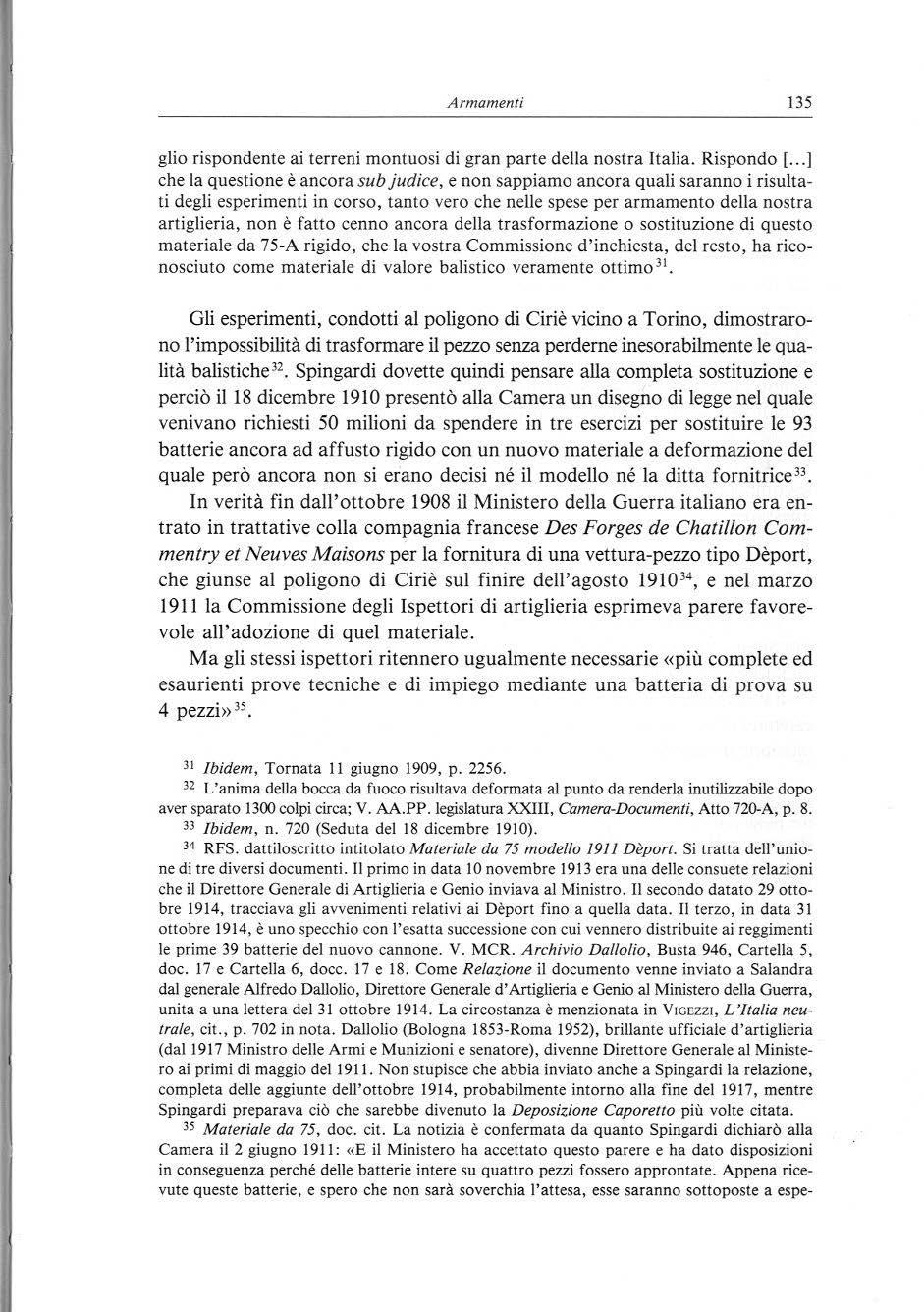
33 Ibidem, n. 720 (Seduta del 18 dicembre 1910).
34 RFS. dattiloscri tto intitolato Materiale da 75 modello 1911 Dèport . Si trat ta dell'unione di tre diversi documenti. Il primo in data 10 novembre 1913 era una delle consuete relazioni che il Direttore Generale di Artiglieria e Genio inviava al Ministro. Il secondo datato 29 ottobre 1914, tracciava gli avveniment i relativi ai Dèport fino a quella data. Il terzo, in da ta 31 ottobre 1914, è uno specchio con l'esatta successione con cui vennero distribuite ai reggimenti le pr ime 39 batterie del nuovo cannone V. MCR. Archivio Dallo/io, Busta 946, Cartella 5, doc. 17 e Cartella 6, docc. 17 e 18. Come Relazione il documento venne inviato a Salandra dal generale Alfredo Dallolio, Direttore Generale d'Artiglieria e Genio al Ministero della Guerra, unita a una lettera del 31 ottobre I 914. La circostanza è menzionata in VJGEZZ I, L'It alia neutrale , c it., p. 702 in nota. Dallolio (Bologna 1853-R oma 1952), brillante ufficiale d'artiglieria (dal 1917 Ministro delle Armi e Munizion i e senatore), divenne Direttore Generale al Min istero ai primi di maggio del 1911. Non stupisce che abbia inviato anche a Spingardi la relazione, completa delle aggiunte dell'ottob re 19 14, probabilmente intorno alla fine del 1917, mentre Spingardi preparava c iò che sa rebbe divenuto la Deposizione Caporetto più volte citata. 35 Materiale da 75, doc. cit. La notizia è confe rmata da quanto Spin gardi dichiarò alla Camera il 2 giu gno I 9 I I: «E il Ministero ha accettato questo parere e ha dato disposi zioni in conseguenza perché delle batterie intere su quattro pezzi fossero approntate. Appena ricevute queste bat terie, e spero che non sarà soverchia l'attesa, esse saranno sottoposte a espe-
Armamenti 135
Deciso a questo pun to a «dotare la nostra art iglieria di un materiale tale da assicurare che per lunghi anni non saremmo più stat i costretti a mutare l 'ar mamento » 36, Spinga rdi nominò una speciale commissione che gi udicasse in merito. L a commissione d ecise di attendere tutto il tem po nece ssario a ll e ulteriori espe rienze sul materiale D èport prima di esprimere un giudizio definitivo 37 • Si stabilì inoltre che tutte le prove avrebbero do vuto proced e re su batterie intere e non più s u pe zzi singoli; nell'aprile 1911 si decise pertanto di provare, assi eme alla batteria D è port , una analoga batteria Schneider 38 ; e in maggio si decise i nfine di sperimentare pure una batteria Krupp mod. 19 11, versione migliora ta del mod. 1906 già adottato . Dive ntò quindi ne cessa rio ordinare (e attendere) tre batt e rie di quattro pe zzi delle tre ditte 39 •
Si arrivò c osì alla discussione i n a ula del diseg no di legge prima che le co mpetenti a utorità tecniche avessero pronuncia to l'ultima parola su lla questione.
1.2 Il dibattito parlamentare
La Commissione inca ricata di esam inare il progetto risultò come al so li to estrem am ente vicina al punto di vista del Mini stro, composta com'era da sei militari e tre appartenenti alla maggioranza giolittiana . L 'unico tra qu esti dotato di una certa personalità politica era l'on . Au g usto Battaglieri, che era anche capitano dell a ri serva, e che comunqu e cessò anzitempo di fare parte d e lla Commissione in quanto nominato sottosegretario alle P oste e T elegrafi 40 . Non vi
rienze a fondo, e così finalmente l'amministrazione militare potrà prendere le sue decisioni con piena coscienza e con piena conoscenza di causa» (AA.PP. Legis latura XXIII, CameraDiscussioni, 2• tornata del 2 giugno 191 I, p. 15146).
36 AA.PP. Legislatura XXIII, Camera-Discussioni, 2• Tornata del 2 giugno 1911, p. 15146.
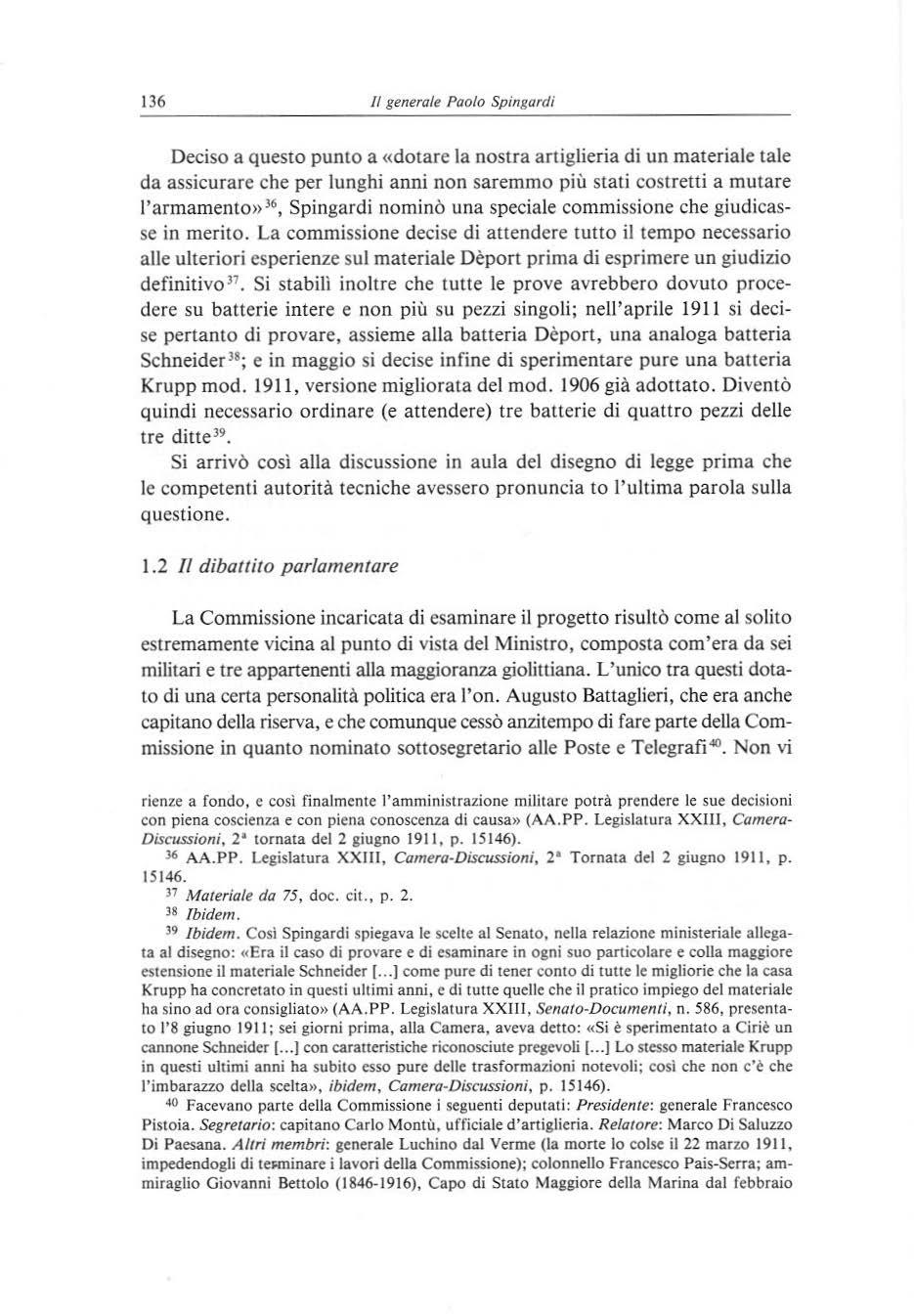
37 Materiale da 75, doc. cii., p. 2.
38 Ibidem.
39 Ibidem. Così Spingardi spiegava le scelte al Senato, nella relazione ministeriale allegata al disegno: « Era il caso di pro vare e di esaminare in ogni suo particolare e colla maggiore estensione il materiale Schneider [ ] come pure di tener conto di tutte le migliorie che la casa Krupp ha concretato in questi ultimi anni, e di tutte quelle che il pratico imp iego del materiale ha sin o ad ora consigl iato » (AA.PP. Legislatura XXIII, Sena to-Docum enti, n. 586 , presentato 1'8 giugno 19 11 ; sei giorni prima, alla Camera, aveva detto: «S i è sperimentato a Ciriè un cannone Schneider )... ] con caraneristiche ri conosciute pregevoli[... ] Lo stesso materiale Krupp in questi ultimi anni ha subito esso pure delle trasformazioni notevoli; così che non c ' è che l'imbarazzo della scelta », ibidem, Camera-Discussioni, p. 15146).
40 Faceva no parte della Co mmission e i seg uenti deput at i: Presidente: ge nerale Francesco Pistoia Segretario: capitano Carlo Montù, ufficiale d'artiglieria. R elatore: Mar co Di Sa luzzo Di Paesana. Altri membri: generale Luchino dal Verme (la mone lo colse il 22 marzo 1911, impedendogli di teRninare i lavori della Commissione); colonnello Francesco Pais-Serra; ammiraglio Giovanni Be ttole (1846-1916), Capo di Stato Maggiore della Marina dal febbraio
136 Il
generale Paolo Spingardi
furono opposizioni alle richieste del Ministro. La Commissione credette però opportuno introdurre nel disegno un articolo aggiuntivo, affinché in nessun caso le somme eventualmente erogate con l'approvazi one del detto disegno potessero venir spese per scopi diversi da quelli stabiliti 41 •
Se ciò da un lato sottolinea l'importanza e l'u rgenza che nell'ambiente non solo militare assumeva la questione dell'artiglieria, dall'altro era un tentativo di sottoporre le spese militari ad un più rigoroso controllo parlamentare 42 •
Ma restava il fatto c he si concedeva una cifra non indifferente senza sapere su quale cannone fare cadere la scelta e chi lo avrebbe fabbricato. No n mancarono infatti spunti polemici da parte delle opposizioni.
I socialist i proposero la sospensiva per bocca del loro leader Claudio Treves, che non lesinò affermazioni provocatorie:
È tutta una palinodia documentata que ll a della Commissione d'inchiesta, nella quale si stabiliscono le incertezze, le igno ran ze, forse non de l tut t o disinteressate, che hanno governato il nostro alto mandarinato militare in questa materia[ .] Abbiamo subìto il vassallaggio militare economico di casa Krupp, come su biamo quello politico del suo più illustre azion ista 43
La richiesta di sospensiva si basava chiaramente su l fatto che si chiedessero cinquanta milioni, senza che si fosse ancora deciso quale materiale adottare al posto del vecchio:
1896 al gennaio 1898, dall'aprile 1907al 31 marzo 1910 e infine nuovamente dal 27 aprile dello stesso anno fino a l 7 giugno 1911, fu Ministro della Marina per tre volte: dal maggio I 899 al giugno 1900 nel ministero Pelloux, dall'apr ile a l giugno 1903 nel ministero Zanardelli e infine dal dicembre 1909 al marzo 1910 nel ministero Sonnino. Aveva inoltre fatto parte della Commissione d'inchiesta per l'esercito. Deputato dal 1890 alla morte, sedet te a sinistra e votò sempre con la maggioranza giolittiana; Camillo Mezzanotte (1849-?), avvocato, deputato di Ortona e Chieti, appartenne al gruppo della democrazia liberale, sedendo a sinistra; Eugenio Valli (1853 - 1924), avvocato, deputato di Rovigo e Lendinara da l 1890 a l 1913 , allorché venne nomina to se natore. Pubblicista e conferenziere diresse «Il Venet o». Alla Camera sedette al centro sinistro votando sempre per il Governo; Augusto Battaglieri (1854-1929), fedele giolittiano Fu sottosegretario a lle Poste e Te legrafi dal marzo 19 11 a l novembre 1913; alla Marina dal novembre 1913 al marzo 1914, conservando la ca rica anche ne i success ivi ministeri Salandra e Boselli , fino al giugno 1917. Dal novembre 1918 al genna io 1919 fu sottosegretario ai Trasporti marittimi e ferroviari, e dal gennaio al giugno 1919 sottosegretario alla Guerra nel ministero Orlando.
41 AA.PP. Legislatura XXIII , Camera-Documenti, N. 720-A, p. 5.
42 Assai complessa è la questione delle spese militari, del modo in cu i venivano erogate, ripartite in bi lancio e spese dell ' amministrazione m ilitare e del controllo che su di esse poteva esercitare il Parlamento. Si rimanda a G. R octtAT-G. MASS08R 10, pp 66 -83, 11 1- 11 5, 124-128 , 153-157, e alla bibliografia ivi citata per un adeguato approfondimento del problema lungo l'intero periodo 1861 -1 914.
43 AA.PP. Legislatura XX!Il, Camera-Discussioni, 2 • torna ta del 2 giugno 1911, pp. 15135-15136.
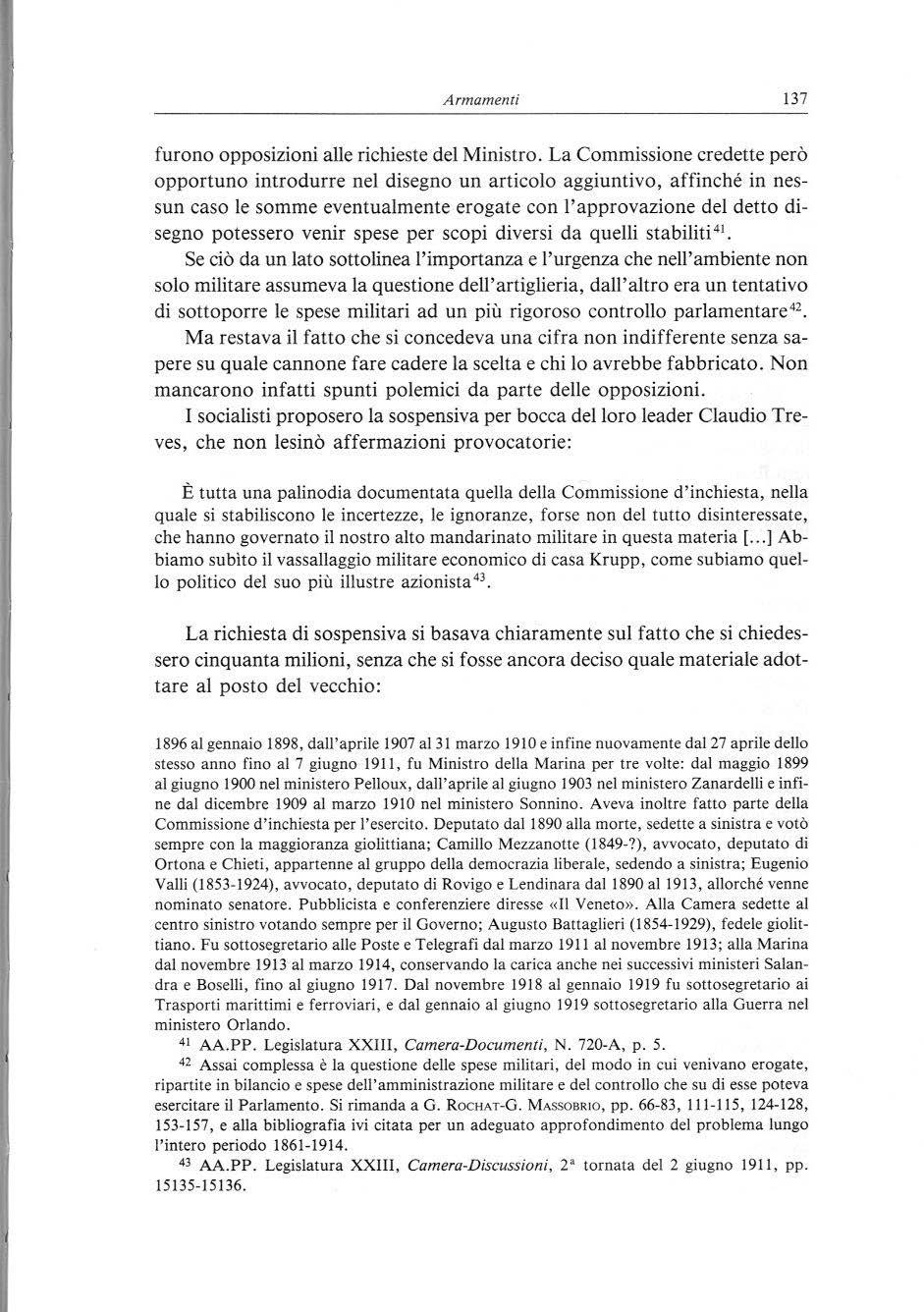
Armamenti 137
Dal momento che c'è tanta urgenza di sostituire quest'arma, - proseguiva Treves - ave te almeno pronta quella che volete sostituire? Parrebbe a noi, che non s iamo tecnici e che ragioniamo col semplice buon senso, che quando si fa la proposta di sostituire un'arma, si debba essere sicuri di possedere l'arma da sostituire, perché il concetto della sostituzione è stato semp re formato di due parti: ciò che c'è e ciò che s i deve sos t ituire . Ma il disegno di legge parla di sostit uzion e delle batterie da 75-A ma non parla di quelle che si debbono sostit uire 44 •
Quindi prima di concedere i fondi si dov eva decidere il modello da ado ttare e nel frattempo sospendere la discussione s ul disegno di legge.
Come dare torto a Treves? Il suo ragionamento era plausibile. Ma Spingardi doveva ottenere subito quel denaro perché non vi fossero pause tra la scelta del materiale e l'inizio della sua fabbricazio ne. Inoltre , vigendo allora il dogma della uniformità per l'armamento dell'artiglieria campale 45 , una delle condizioni poste ai modelli in prova era che avessero lo stesso munizionamento del Kru pp/1906 46 • Perciò munizioni e carreggio potevano esse re costruiti immediatamente, anche senza conoscere il cannone presce lto .
For se le industrie interessate all e commesse avevano interesse a vedere la posta su l piatto prima di impeg narsi , ma non vi sono elementi per sostenere che fossero in grado di condizionare fino a questo punto le scelte ministeriali 47 • R ig ua r do a Spingardi va detto che egli agì avendo di mi ra solo gli interessi dell'esercito; poté peccare forse di ingenuità, non di malafede . Di certo l'onestà p er sonale del Ministro non era minimamente messa in discussione, neanche dai socialisti.
Da parte loro i radicali, ormai aggiogati a l carro governat ivo, non avevano difficoltà ad appoggiare Spinga rdi , e a rigettare la sospensiva . L'on. Fera sottolineò l'atteggiamento del partito, che non contestava «la legittimità di mezzi di difesa», ma li voleva commisurati «a i limiti di sufficienza tecnica e di possibilità economica e di necessità politica». Un solo dubbio tur b ava l'animo dei radicali:
L'Amministrazione de ll a guerra si è attenuta ai voti ed alle prescrizioni rigorose che erano consacrate nelle pagine della relazio ne della Commiss ione d'inchiesta per l'esercito, o invece anche in que sto momento ripete gli errori del passato?
44 AA.PP. Legislatura XXIII, Camera-Discussioni, 2• tornata del 2 giu gno 191 I, p. 15 135
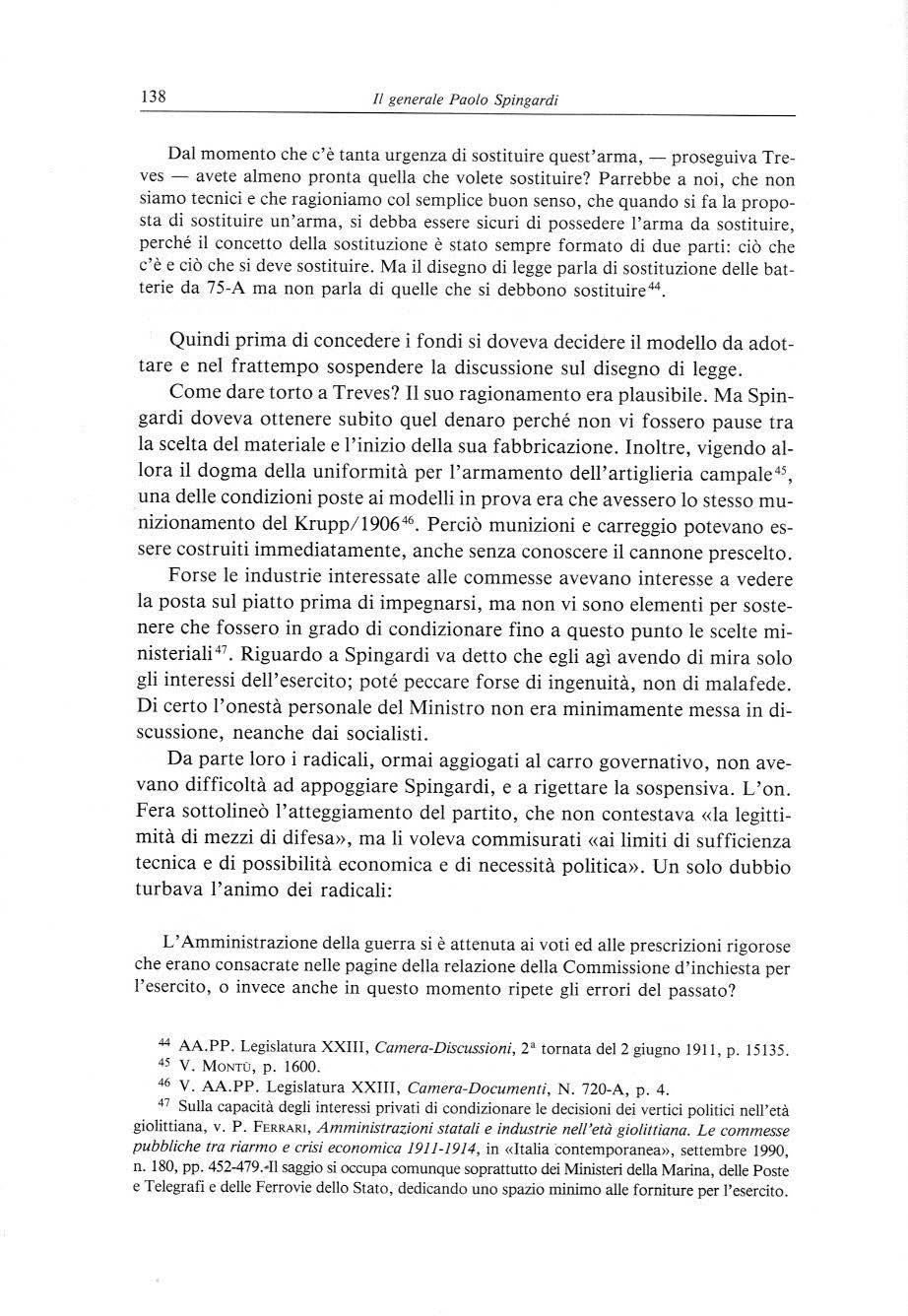
45 V. MONTÙ , p. 1600.
46 V. AA.PP. Legislatura XXIII , Camera-Documen1i, N. 720-A , p. 4.
47 Sulla capacità degli in teressi privati d i condizionare le dec isioni dei vertici politici nell'età giolittiana, v P. FERRAR!, Amministrazioni staia/i e industrie nell'età giolittiana. Le commesse pubbliche tra riarmo e crisi economica 1911 - 1914, in «Italia contemporanea», settembre 1990, n. 180, pp. 452-479.•II saggio si occupa comunque soprattutto dei Ministeri della Marina, delle Poste e Telegrafi e delle Ferrovie de llo Stato, dedicando uno spazio minimo alle forniture per l'esercito.
138 Il
generale Paolo Spingardi
Ma in sostanza facevano professione di piena fiducia nella persona élel Ministro della guerra:
Se ella, onorevole ministro, potrà finalmen te dirc i presce lto il tipo con il sussidio e con la partecipazione de i nostri st abilimen ti milita ri , se potrà darci affidamento, come la Commissione d'inchiesta richiedeva, che l'allestimento del materiale si farà nei nostri stabilimenti nazionali, noi radicali non avremo alcuna difficoltà di votare la richiesta di questi milioni 48 •
Nell'aula semivuota, oltre ai soc iali st i gli unici ad opporsi furono i repubblicani, per bocca del deputato Viazzi. A parte le ovvie affermazioni di principio 49 , Viazzi si augurava che il nuovo materiale non fosse fornito dalla Krupp perché « la casa Krupp c 'ispira e deve ispirarci particolari diffidenze per tutto quel tramestio di [ ... ] manovre diverse [... ] a tutto vantaggio pecuniario della casa tedesca».
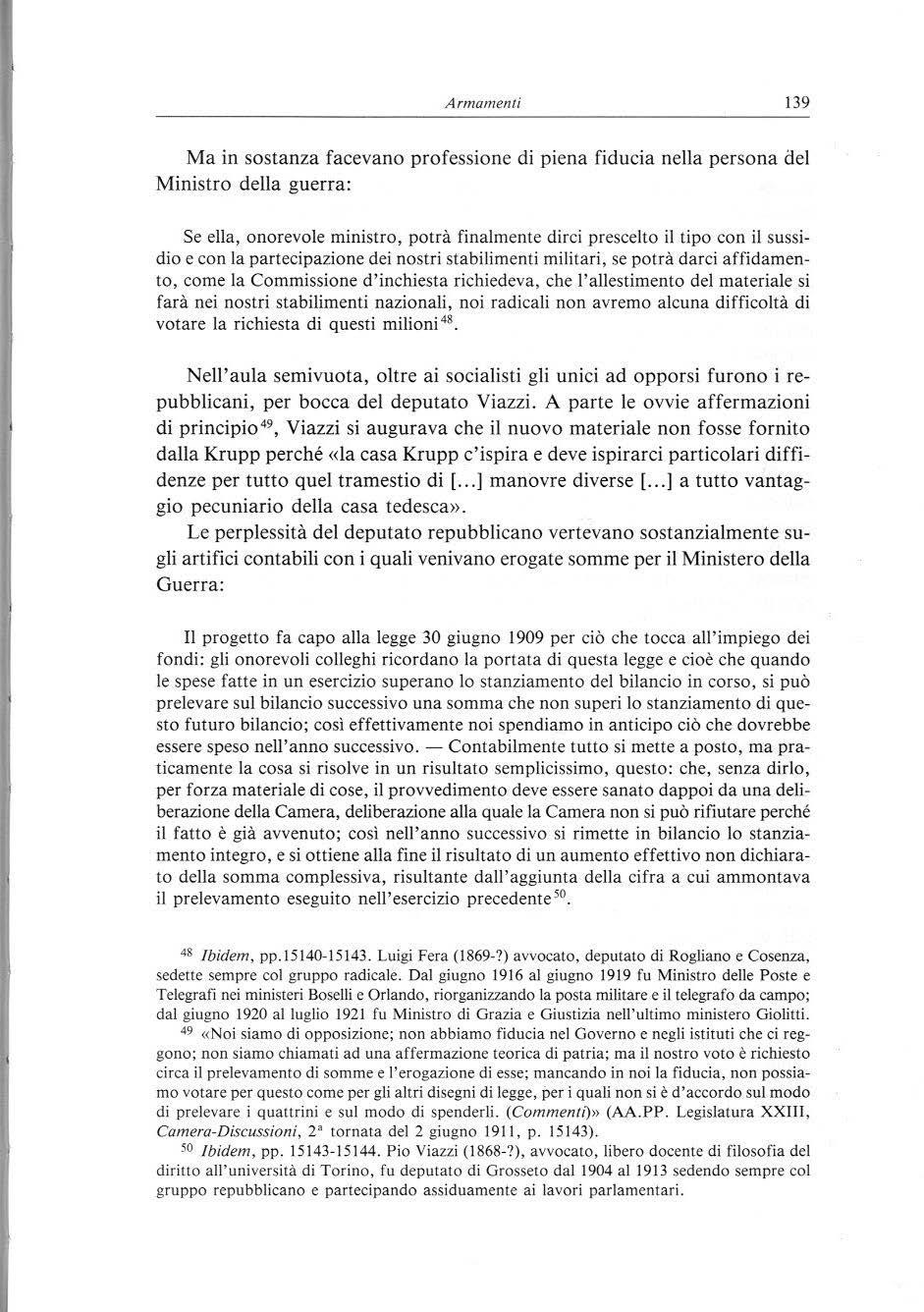
Le perplessità del deputato repubblicano vertevano sostanzialmente sugli artifici contabi li con i quali venivano erogate somme pe r il Ministero della Guerra:
Il progetto fa capo alla legge 30 giugno 1909 per ciò che tocca all'impiego dei fondi: gli onorevoli colleghi ricordano la portata di questa legge e cioè che quando le spese fatte in un esercizio superano lo stanziamento del bilancio in corso, si può pre levare su l bilancio s ucc essivo una somma c he non superi lo stanziamento di questo futuro bilancio; c osì effettivamente noi spen diamo in anticipo ciò che dovrebbe essere spe so ne ll' anno successivo . - Contabi lmente tutto si mette a posto, ma praticamente la cosa si riso lve in un risultato semp lici ssi mo , que sto : che , senza dirlo, per forza materiale di cose, il provvedime n to deve essere sanato dappoi da una de liberazione della Camera, deliberazione alla quale la Camera non si può rifiutare perché il fatto è già avvenuto; così nell'anno successivo si rimette in bilancio lo stanziamento integro, e si ottiene alla fine il risultato di un aumento effettivo non dichiarato della somma complessiva, risultante dall'aggiunta della cifra a cui ammontava il prelevamento esegui t o nell'esercizio precedente 50
4 8 Ibidem, pp.15140-15143. Luigi Fera (1869-?) avvocato, deputato di Rogliano e Cosenza, sedette sempre col gruppo radica le. Dal giugno 19 16 al giugno 1919 fu Min istro delle Poste e Telegrafi nei ministeri Bose lli e Or lando, riorganizzando la posta militare e il telegrafo da campo; dal giugno 1920 al lug lio 1921 fu Ministro di Grazia e Giustizia nell'ultimo ministero Giolitti.
4 9 «Noi siamo di opposizione; non abbiamo fiduci a nel Governo e negli ist itu t i che ci reggono; non siamo chiamati ad una affermazione teorica d i patria; ma il nostro vo to è richiesto circa il prelevamento di somme e l'erogazione di esse; mancando in noi la fiducia, non possiamo votare per questo come per gli a l tri d isegni di legge , per i quali non si è d'accordo sul modo d i prelevare i quattr ini e su l modo di spender li. (Commenti)» (AA.PP. Legislatura XXITI, Camera -Discussioni, 2• wrnata del 2 g iugno 19 11, p 15143)
so Ibidem, pp 151 43 -1 5 144 P io Viazz i (1868 - ?), avvocato, libero docente di filosofia del dir itto all'univers i tà di Torino, fu deputato di Grosseto dal 1904 al 1913 sedendo sempre col gruppo repubblicano e partecipando assiduamente ai la vori parlamentari.
Armamenti 139
La replica di Spingardi mirava a rassicurare i radicali e a tacitare le opposizioni. Ai soc ialisti ribatteva rammentando che le ditte italiane che ormai da anni stavano lavorando per allestir e il materiale Krupp erano riuscite, col tempo,
a formare una esperta maestranza; ma, a misura che la distribuzione del materiale Krupp si avvicinerà al suo compime nto [ ... ] il lavoro verrà mano mano diminuendo, fino a cessare, e noi sa remmo costretti a licenziare questa esperta maestra nza e quindi avremmo un numero st raordi nario di operai ai quali verrebbe necessariamente a mancare il lavoro.
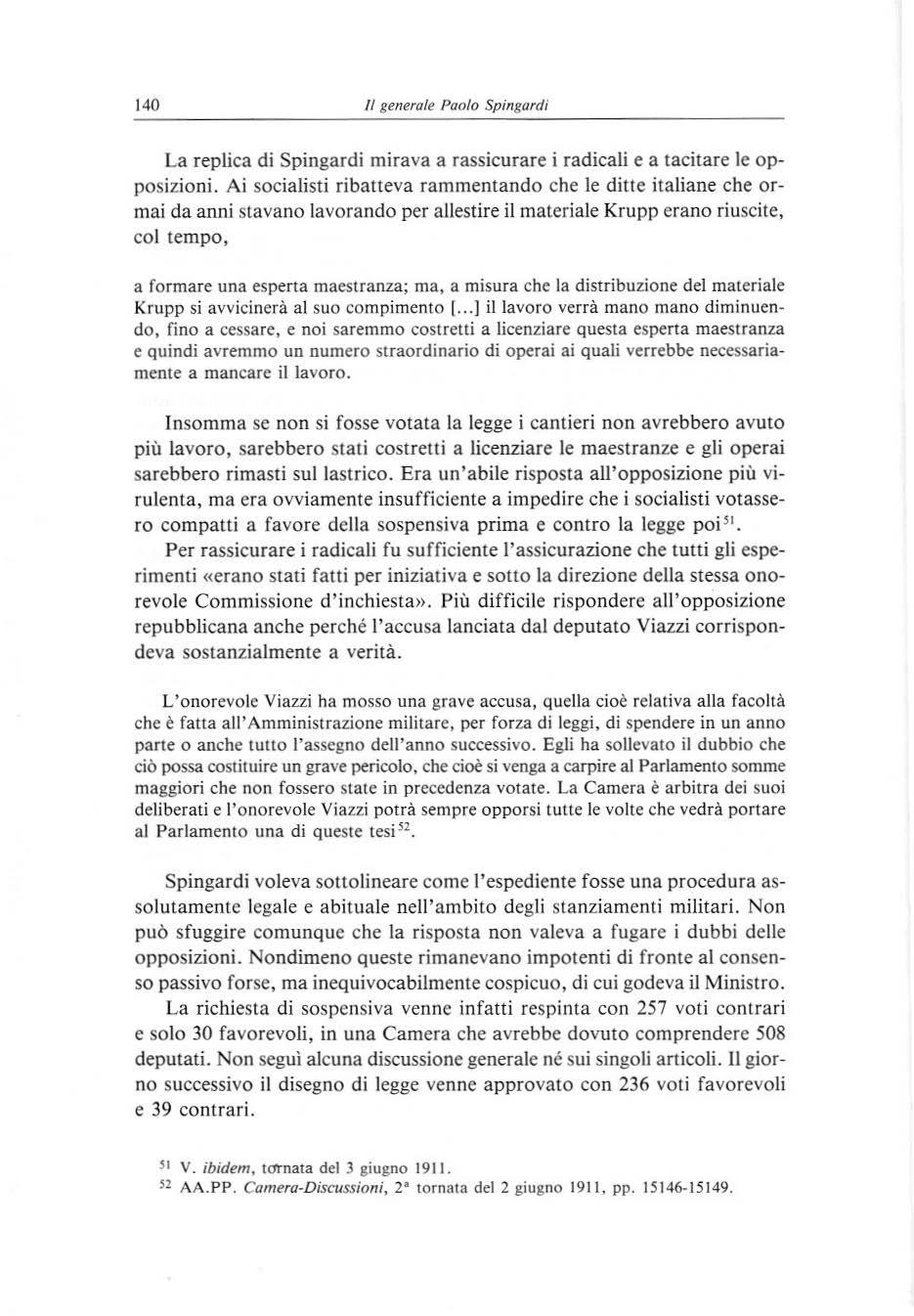
In somma se non si fosse votata la legge i cantieri non avrebbero avuto più lavoro, sare bbero stati costretti a licenziare le maestranze e gli operai sa rebbero rimasti sul lastrico. Era un'abile risposta all'opposizione più virulenta, ma era ovviamente insufficiente a impedire che i socia listi votassero compatti a favore della sospensiva prima e contro la legge poi 51 • P er rassicurare i radicali fu sufficiente l'assicurazione che tutti gli esperimenti «erano st ati fatti per iniziativa e sotto la direzione della stessa onorevole Commissione d'inchiesta». Più difficil e rispondere a ll 'o pposi zione repubblicana anche perché l'accusa lanciata dal deputato Viazzi corrispondeva sostanz ialmente a verità.
L'onorevole Viazzi ha mosso una grave accusa, quella cioè relativa alla facoltà che è fatta all'Amministrazione militare, per forza di leggi, di spendere in un anno parte o anche tulto l'assegno dell'anno successivo. Egli ha so!Jevato il dubbi o che ciò possa costituire un grave pericolo, che cioè si venga a carpire al Parlamento somme maggiori che non fossero sta te in precedenza votate. La Camera è arbitra dei suoi delibera t i e l'onorevole Yiazzi potrà sempre opporsi tutte le volte che vedrà portare al Parlamento una di queste tesi 52
Spingardi voleva sottolineare come l'espediente fosse una procedura assolutamente legale e abituale nell' ambito degli stanziamenti militari. Non può sfuggire comunque che la risposta non valeva a fugare i dubbi delle opposizioni. Nondimeno queste rimanevano impotenti di fronte al consenso passivo forse, ma inequivocabilmente cospicuo, di cui godeva il Ministro.
La richiesta di sospensiva venne infatti respinta con 257 voti contrari e so lo 30 favorevoli, in una Camera che avrebbe dovuto comprendere 508 deputati. Non seguì alcuna discussione generale né sui singoli articoli. il giorno successivo il disegno di legge venne approvato con 236 voti favorevoli e 39 contrari.
51 V. ibidem, tarnata del 3 giugno 1911.
52 AA.PP. Camera-Discussioni, 2 • 10rnata del 2 giugno 1911, pp. 15146-15149.
140
Il generale Paolo Spingardi
Al Senato, il 17 giugno 1911 , non solo non s i ebbe alcuna opposizione ma nemmeno alcuna discussione. Soltanto il generale Rin aldo Taverna, che era stato il relatore sul disegno di legge, intervenne molto brevemente per rivolgere al Ministro «una calda preghiera [... ] perché [... ] egli intervenga con la sua autorità e faccia una buona volta decidere in modo definitivo i signori tecnici, ricordando loro che il meglio è n emic o del bene», tra le approvazioni dei senatori 53 • Spingardi non poté che rassicurarlo che ciò corrispondeva «perfettament e al pensiero del ministro» 54 •
I tre articoli dei quali il disegno di legge si componeva passarono così come erano stati presentati 55 • Lunedì 19 giugno 1911 il disegno di legge veniva approvato dal Senato con 94 voti favorevoli e soltanto 8 contrari e divenne la legge 22 giugno 1911 n . 591.
Nel frattempo Spingardi aveva sollecitato l'Ispettorato di Artiglieria
affinché tutto sia studiato e predisposto in modo che nessun ritardo si abbia a verificare, e che nella definitiva soluzione si abbia la vis ione non di un continuo movimento verso il meglio, ma del fattore del tempo, in sé e nei suoi riflessi e delle vere esigenze della guerra nonché delle reali condizioni di impiego e di fuoco dell'artiglieria da campagna 56
Ma il Ministro pensava anche che «tutte le energie debbono cospirare nel senso di dar vita alla migliore soluzione» 57 e perciò il 17 agosto 19 Il l'Ispettorato d'Artiglieria completò un definitivo programma di prove sulle batterie dei tre tipi che «si contendevano la scelta» 58 • Le prove procedettero con regolarità nei mesi successivi.
Intanto, i cannoni Krupp/ mod . 1906 continuavano ad affluire ai corpi e finalmente le batterie previste secondo le prescrizioni di mobilitazione erano pronte dal 1° novembre 1911 59 , con grande soddisfazione di Spingardi:
Il ma te riale scelto fu ottimo; le prove, condotte a fondo dalla Commissione d'inchiesta, sarebbero certamente state fatte dall'Amministrazione mi li tare, e i difetti riscontrati, come accade sempre nell'adozione di materiali nuovi, sarebbero stati corretti, come di fatto lo furono, dai nostri ufficiali. Fu perduto molto tempo, è vero, ma assai più ne fece perdere la Commissione d'inchiesta, e ad ogni modo questa
53 AA.PP. Legis latura XXIll, Senato -Discussioni, tornata del 17 giugno 191 l, p. 5740.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 MCR, Archivio Dallo/io, Bu sta 946, Cartella Il , Spingardi all'Ispettorato Generale d'Artigl ieria, Roma 12 giugno 191 I.
57 Ibidem.
58 RFS , Deposizione Caporelfo, p. 37.
59 MCR. Archivio Dallo/io, Busta 946, Cartella I , Relazio ne 19 d icembre 191 l , p. 5.
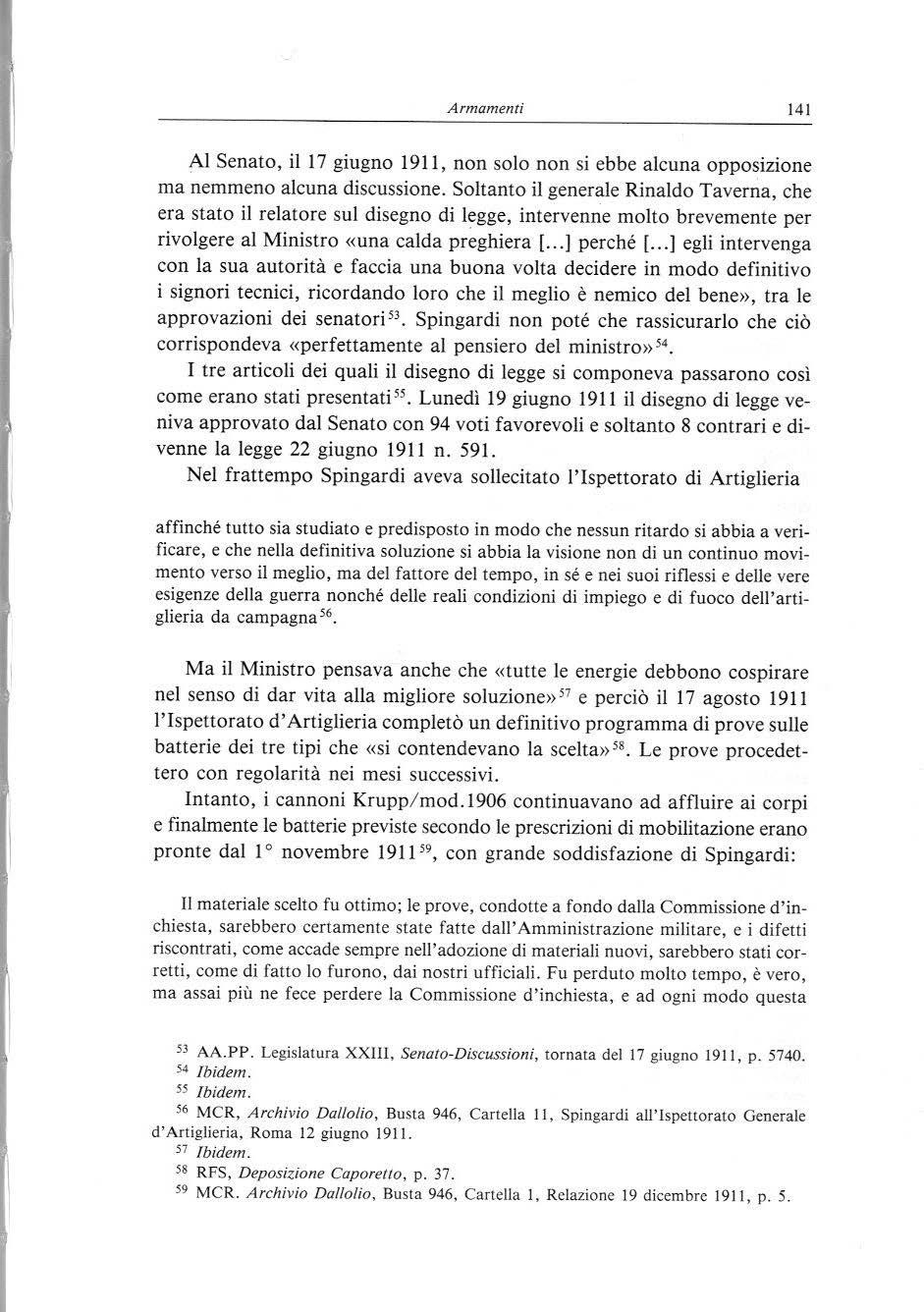
Armamenti 141
del tempo non è colpa delle persone, ma del sistema. Ed ora che siamo usciti immuni da quel periodo di crisi si può anche di sc utere se non sia stato un bene 60
In effetti il 75/906 continuò con buoni risultati a costituire parte dell'armamento dell'artiglieria da campagna italiana fino al 1943 6 1• Sembra alquanto inesatto quindi sostenere, come è stato fatto, che questo cannone fosse «riconosciuto inadeguato nel giro di pochi anni» 62 •
Spingardi poteva insomma tirare un sospiro di sollievo benché rilevasse una colpa «veramente grave: i contratti Krupp». Infatti, oltre ad aver garantito 21 milioni -oro ai tedeschi 63, essi « Furono una birbonata Per tacere dei prezzi elevati, ci siamo lasciati abbindolare, ci siamo dati legati mani e piedi a Krupp» 64 • Spingardi era suo malgrado nello stesso ordine di considerazioni di Treves e Viazzi: pare infatti che i limit i imposti all'autonomia di fabbricazione e alle possibilità di intervento degli italiani fossero stati notevoli 65• Forse proprio per questo da quel momento ogni cura fu posta dal Mini stro affinché la fabbricazione del nuovo cannone avvenisse totalmente in I ta lia e le autorità tecniche d'artiglieria avessero la più ampia facoltà di controllo.
2. Mitragliatrici
Benché in linea di principio la mitragliatrice fosse stata presa in considerazione dalle autorità tecniche fin dal 1896 per l'armamento dell'esercito italiano, ancora nel 1908 la Commissione d'inchiesta ne perorava l'adozione 66 notando che essa
60 ACS. Archivio Brusati. Se IO , f. VI.4.36. Spingardi a Brusati, 10 aprile 19 12.
6 1 V. C EvA, Le forze armate, cit., p. 97.
62 ROC HAT -M ASSODRJO, nota 11 a p. 170.

63 V. Materiale d'artiglieria da campagna Krupp, «L ' Ese rcito i taliano », 11 febb raio 1910.
64 Spingardi a Brusati, doc. cit.
65 CACIULLI, L'amminis1razione della guerra, p 12
66 Trovo condi visibile la valutazione di John Gooch, se riferita a prima del 1909: «The delay in providing che army w it h machine-guns, though less sp ec tacu lar [rispetto al r itardo ver ificatosi per l'artiglieria], was if anyth ing an even more culpab le examp le of maladminis tra t ion The want of them had been cruelly felt at Adua, and by 1907 Generai Dal Verme was lam enting the fact that the ital ians st ili dici not have them, although the Swiss had been using t hem since 1899. F in ally, machine- guns were brought in from Vickers in the autumn and winter of 1913» (Army, State and Society, p 121). La più particolaregg iata t ra ttazione s ull'adozione delle mitragliatric i è quella della R e lazione Ufficiale a lle pp. 28 -30 e 113- J I 7.
Spingardi non può, a mio parere, essere considera to respon sab i le di cattiva amministrazione nella ges tione del problema mitragliatrici, perché qui, forse più che in altri campi, egl i s i tro vò a dover dare' soluzio ne in tempi relativamente brevi a una questione che si trascinava da mo lt i anni.
142
li generale Paolo Spingardi
entrata da poco nell'armamento degli eserciti moderni, è l'arma da fuoco indispensabile a completare l'armamento delle truppe campali, tiene il suo posto naturale fra cannone e fucile; meno potente ma assai p iù mobile del primo , più potente, ma un po' meno mobile del secondo 67 •
Il programma Spingardi prevedeva l'assegnazione di una sezione (due mitragliatrici) per ogni reggimento di fanteria, bersaglieri e di cavalleria divisionale, e una per ogni battaglione alpini e bersaglieri ciclisti: in totale 324 armi 68 •
Poiché riunisce i due essenziali fattori della potenza e della mobilità, la mitragliatrice è diventata un potente sussidio delle artiglierie e della fucileria [ ... ) Ammaestrati dalla esperienza recente che di essa diede la guerra Russo-Giapponese gli eserciti degli altri Paesi già ne sono provveduti o stanno provvedendosene
aggiungeva la Relazione della Giunta Generale del Bilancio caldeggiando l'approvaz ione dello stanziamento relativo all'adozione del nuovo congegno 69
Avendo la Commissione d 'inchi esta espresso il voto di svincolare il più possibile l'Italia dall'industria straniera per quanto riguardava la fornitura di armamenti, venne sperimentato un modello di mitragliatrice italiana, la Perino, della quale furono ordinati 150 pezzi. Ma si verificarono gravi inconvenienti nel funzionamento dell'arma, e perciò essa venne tolta dall'impiego presso le truppe e destinata all'armamento secondario dei forti 70 Dopo altre prove su diversi tipi di mitragliatrici7 1 , nell'aprile del 1911 Spingardi , d'accordo con Pollio, decise finalmente di adottare un tipo di mitragliatrice Maxim prodotta dalla casa inglese Vickers per un totale di 1.204 armi, secondo un nuovo programma che doveva dare una sezione ad ogni battaglione di fanteria e bersaglieri tanto dell'esercito permanente che della milizia mobile; due sezioni per ogni battaglione alpino dell'esercito permanente e una per quelli della milizia mobile; una, come già previsto, ai reggimenti di cavalleria divisionali. La realizzazione del programma era prevista in tre tempi, compatibilmente con la disponibilità finanziaria 72 • Ma la guerra di Libia scoppiò prima che il primo tempo fosse compiuto .
67 Citato in AA.PP., Legi s latura XXIII , Camera -Documenti, n. 102-A, p 6
68 Cfr. l ' accenno in ibidem con Relazione Ufficiale , p. 29.
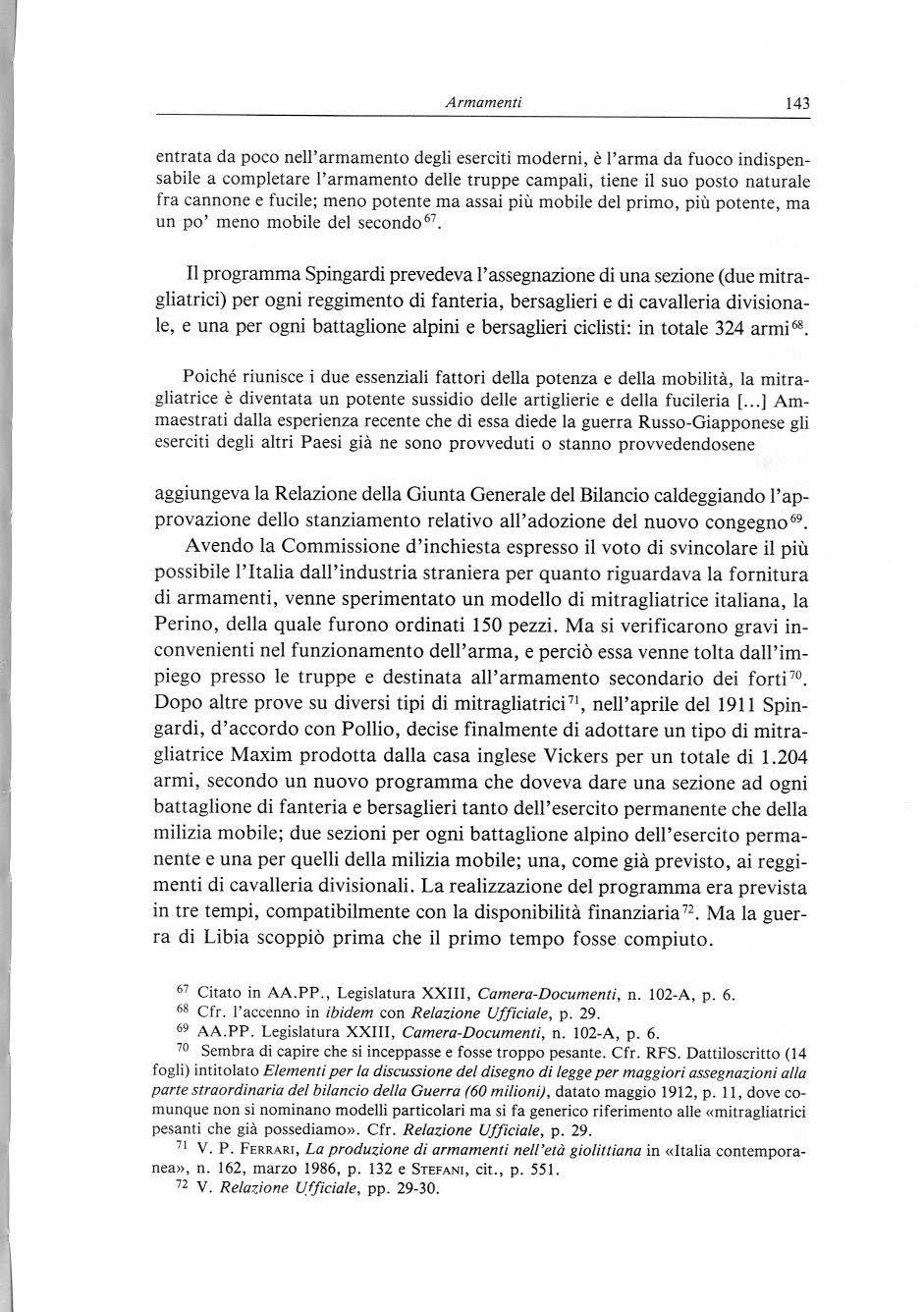
69 AA.PP. Legislatura XXIII, Camera-Documenti, n. 102-A, p. 6.
70 Sembra di capire che si inceppasse e fosse troppo pesante. Cfr. RFS. Dattiloscritto (14 fogli) intitolato Elementi per la discussione del disegno di legge per maggiori assegnazioni alla parte straordinaria del bilancio della Guerra (60 milioni), datato maggio 1912, p. 11, dove comunque non si nominano modelli particolari ma si fa generico riferimento alle « mitragliatrici pe san t i che già possediamo». Cfr. Relazione Ufficiale, p . 29.
7 1 V. P. FERRAR!, La produzione di armamenti nell'età giolittiana i n «Italia contemporanea», o . 162, marzo 1986, p. 132 e STEFANI, cit., p. 551.
72 V. Relazione V.ificiale, pp. 29 -30.
Armamenti 143
3. Il dominio dell'aria
Spingardi è da considerarsi il padre dell'aereonautica italiana: solo grazie ai provvedimenti da lui adottati a partire dal 191 O fu possibile impiantare una vera organizzazione aerea nazionale.
Le origini dell'aereonautica militare italiana vanno fatte risalire al 1894 quando, all'interno dell'Arma del Genio, venne costituita una «Brigata Specialisti» su due compagnie alla quale fu affidata la cura dei primi palloni aerostatici 73 Nel 1905 ufficiali della brigata pilotarono il primo dirigibile italiano. Nel 1907 vennero affidati alla brigata il servizio radiotelegrafico e l'impianto e sviluppo della specialità dirigibili. In quell'anno fu iniziata la costruzione del dirigibile semirigido P 1 che effettuò nel 1908 il primo volo. Nel 1909 vennero acquistati i primi aeroplani: un Farman e due Blèriot, affidati alla brigata 74 •
Paolo Spingardi con la legge 10 luglio 1910 n 422 otteneva 10 milioni per la costruzione di dirigibili, aeroplani, relativi impianti, lavori e trasporti ad essi connessi e indennità speciali al personale. Il disegno di legge ebbe un iter rapidissimo.
Il Ministro lo presentò alla Camera il 13 giugno 1910 con queste parole:
Sono noti, poiché la stampa ne dà notizie sempre più ampie e precise, i provvedimenti che s i vanno attuando all'estero in ordine alla organizzazione aerea, il cui elemento principale è per ora rappresentato dal dirigibile, mentre contemporaneamente proseguono con pertinacia coraggiosa veramente ammirevole gli studi e gli espe rimenti dell'aeroplano, aspirante anch'esso al primo posto nella conquista dell'aria 75
La creazione della nuova specialità veniva dunque presentata come conseguenza di quanto si andava facendo all'estero: la Camera veniva posta
73 Prima della legge di ordinamento del 1910 e ra no denominate Brigate le unità del Genio equivalenti del battaglione di fanteria.
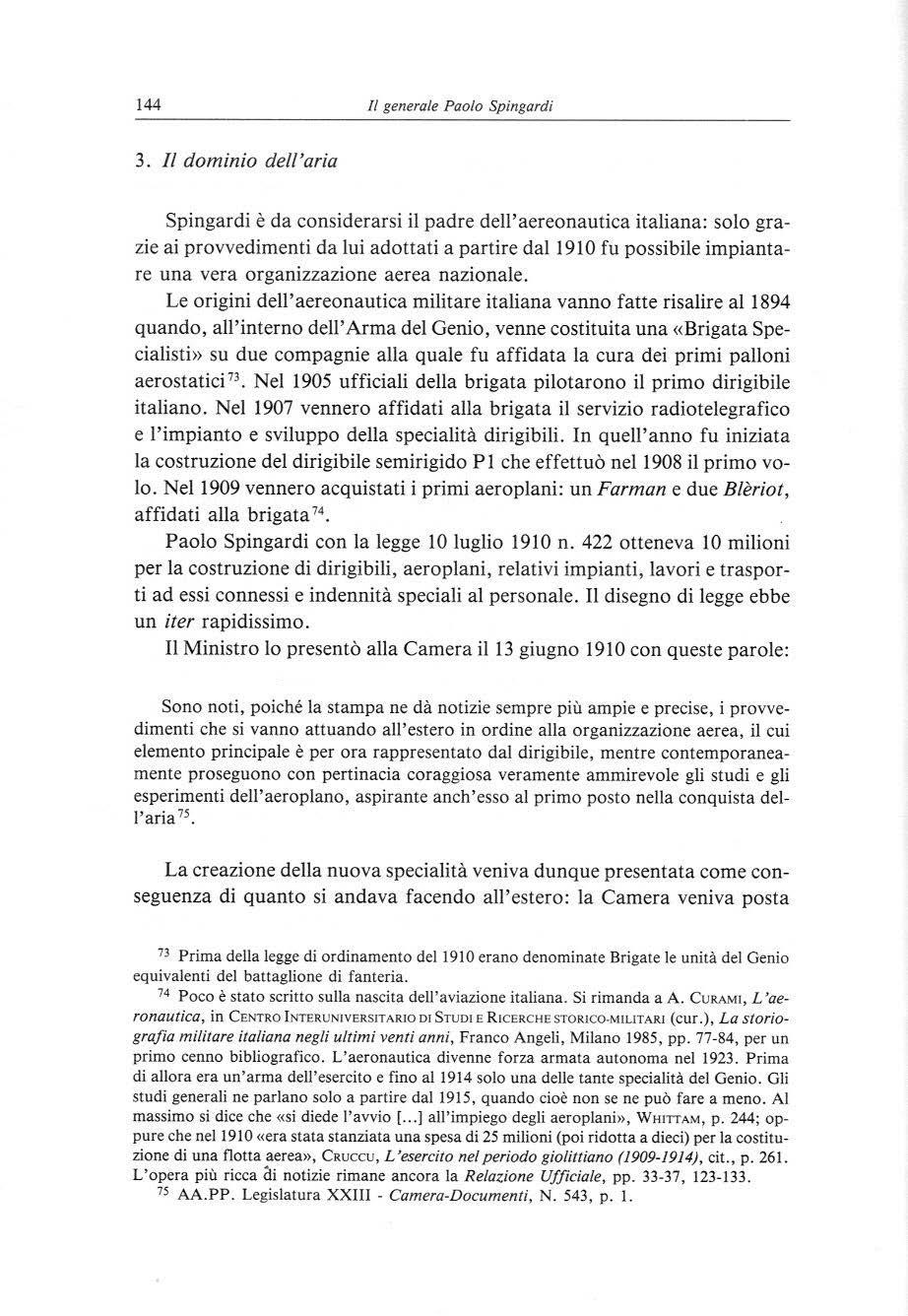
74 Poco è stato scritto sulla nascita dell'aviazione italiana. Si rimanda a A CURAMI, L'aeronautica, in CENTRO I NTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RI CERCHE STORICO -MILITARI (cur.), La storiografia militare italiana negli ultimi venti anni, Franco Angeli, Milano 1985, pp. 77 -84, per un primo cenno bibliografico. L'aeronautica divenne forza armata autonoma nel 1923. Prima di allora era un 'arma dell'esercito e fino al 1914 solo una delle tante specialità del Genio. Gli studi generali ne parlano solo a partire dal 1915 , quando cioè non se ne può fare a meno. Al massimo si dice che «si diede l' a vvio [... ] all'impiego degli aeroplani», WH 1TTAM, p . 244; oppure che nel 19 I O«era stata stanziata una spesa di 25 milioni (poi ridotta a dieci) per la costituzione di una flotta aerea», CRuccu, L'esercito nel periodo giolittiano (1909-1914), cit., p. 261. L'opera più ricca ai notizie rimane ancora la Relazione Ufficiale, pp. 33 -37, 123-133.
75 AA.PP. Le gislatura XXIII - Camera-Documenti , N. 543 , p. I.
144 li generale
Paolo Spingardi
di fronte alla necessità di non lasciare il Paese indietro rispetto alle altre Potenze, argomento certamente convincente per la maggior parte dei deputati.
La Giunta Generale del Bilancio, incaricata di esaminare il disegno di legge, presentò la propria relazione, invero brevissima e assai poco sostanziosa, il 23 giugno, concludendola riaffermando la consueta fiducia nel Ministro :
La Giunta del bilancio non ha creduto, per motivi evidenti di discrezione, di chiedere al ministro della guerra la specificazione del suo programma in tema di dirigibili e si è limitata a prendere atto della dichiarazione dell'onorevole ministro che è suo in tendimento di aumentare il numero e la potenzialità dei dirigibili e di perfezionarne la costruzione allo s copo di ottenere la maggiore facilità e sicurezza d'impiego 76 •
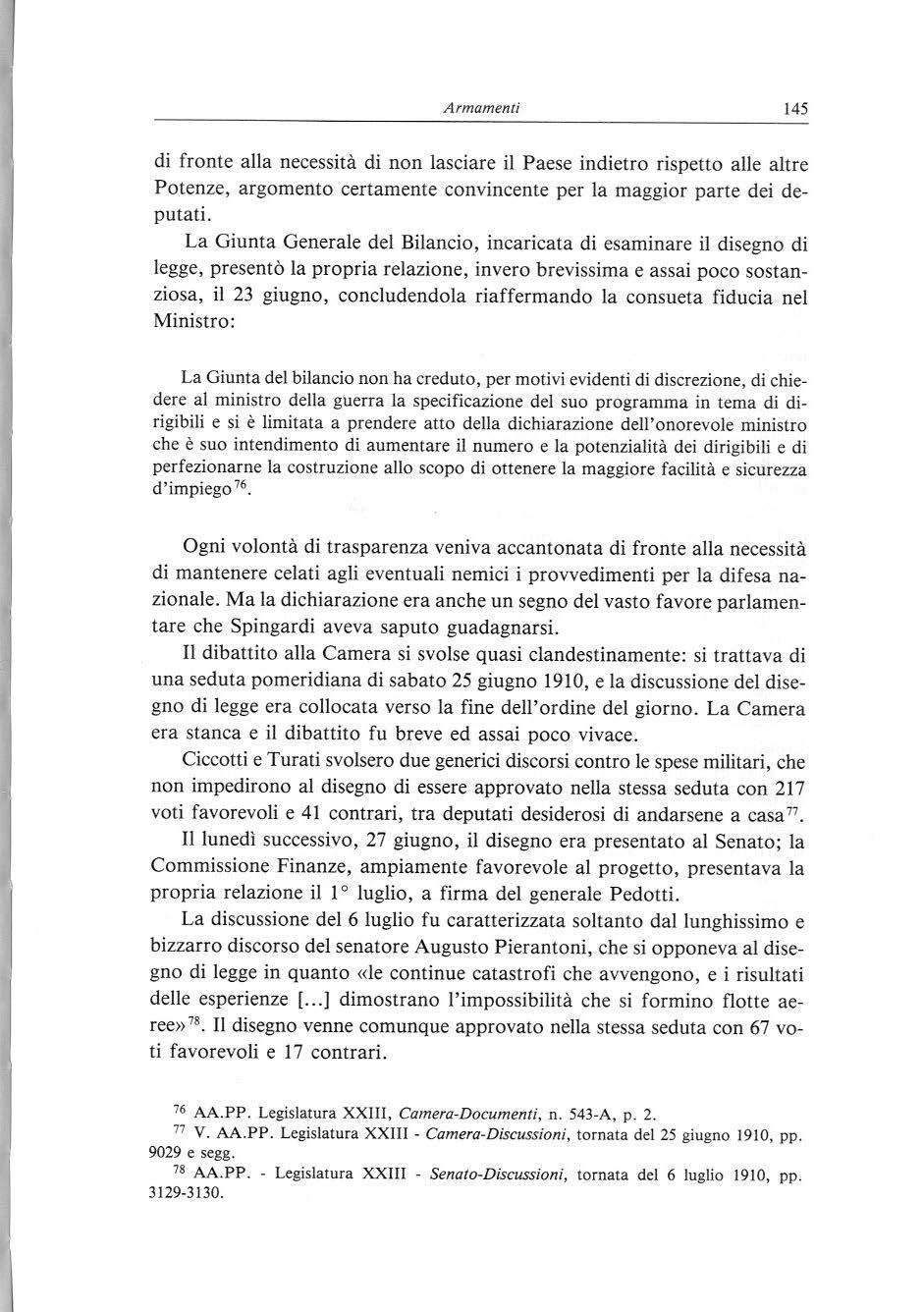
Ogni volontà di trasparenza veniva accantonata di fronte alla necessità di mantenere celati agli eventuali nemici i provvedimenti per la difesa nazionale. Ma la dichiarazione era anche un segno del vasto favore parlamentare che Spingardi aveva saputo guadagnarsi
Il dibattito alla Camera si svolse quasi clandestinamente: si trattava di una seduta pomeridiana di sabato 25 giugno 1910, e la discussione del disegno di legge era collocata verso la fine dell'ordine del giorno . La Camera era stanca e il dibattito fu breve ed assai poco vivace.
Ciccotti e Turati svolsero due generici discorsi contro le spese militari, che non impedirono al disegno di essere approvato nella stessa seduta con 217 voti favorevoli e 41 contrari, tra deputati desiderosi di andarsene a casa 77 •
Il lunedì success ivo, 27 giugno, il disegno era presentato al Senato; la Commissione Finanze, ampiamente favorevole al progetto, presentava la propria relazione il 1° luglio, a firma del generale P edotti.
La discussione del 6 luglio fu caratterizzata soltanto dal lunghissimo e bizzarro discorso del senatore Augusto Pierantoni, che si opponeva al disegno di legge in quanto «le continue catastrofi che avvengono, e i risultati delle esperienze [... ] dimostrano l'impossibilità che si formino flotte aeree» 78 • Il disegno venne comunque approvato nella stessa seduta con 67 voti favorevoli e 17 contrari.
76 AA.PP. Legislatura XXIII, Camera-Documenti, n. 543-A , p. 2 .
77 V. AA.PP. Legislatura XXIII - Camera- Discussioni , tornata del 25 giugno 19 10, pp. 9029 e segg.
78 AA.PP. - Legislatura XXIII - Senato-Discussioni, tornata del 6 lugl io 1910, pp 3129-3130.
Armamenri 145
Il generale Paolo Spingardi
Estremamente facile dunque il compito di Spingardi, che si era limitato ad un breve intervento nel quale aveva riaffermato la necessità di non essere da meno delle altre Potenze, così concluso con un tocco di retorica:
Sull'esempio de ll a Germania, la quale possiede oggi la più potente flotta aerea del mondo, la Francia, l'Austria, l'Inghilterra, la Russia, attivamente intendono a dotare i loro eserciti di questo nuovo fattore di vittoria nelle guerre dell'avvenire. Poteva, doveva l'Italia rimanere addiet ro ? All'alto senno ed al patrio t tismo del Senato la risposta. (Approvazioni vivissime) 79
In meno di quattro settimane, il disegno era divenuto legge: oltre ai 10 milioni appositamente concessi, essa consentiva al Ministero di disporre di una somma fino a 15 milioni anticipata dal bilancio successivo. Concretamente, quindi, Spingardi poté disporre di 25 milioni per attuare i suoi progetti.
Ottenuti i fond i, poiché mancava totalmente in Italia un'industria specializzata, s i procedette innanzitutto all'impianto di due appositi stabilimenti militari, uno per la costruzione di dirigibili, uno per la costruzione degli aeroplani 8°.
Quindi furono rapidamente acquistati all'estero 10 aeroplani e costruiti in Italia: 9 dirigibili con 7 cantieri e 2 aeroscali smontabili, 2 aerodromi , un campo di aviazione e una officina di produzione di gas idrogeno 81 •
Sempre nel 1910 venne fondata la prima scuola di volo, impiantata il 17 dicembre 1910 alla Cascina Malpensa, nella brughiera di Gallarate-Somma Lombarda-Turbigo 82 •
I lavori procedettero alacramente nel corso del 1911, tanto che alle grandi manovre che s i svolsero nel Monferrato alla fine di agosto presero parte degli aeroplani che, se suscitarono il so rri so incredulo di Cadorna 83 , dimostraro no che la nuova arma si stava felicemente affermando .
Meno di due mesi dopo, gli aerei italiani avrebbero svolto i primi voli di guerra della storia, in Libia.
79 Ibidem, p . 3143.
80 V. Relazione Ufficiale, p. 34.
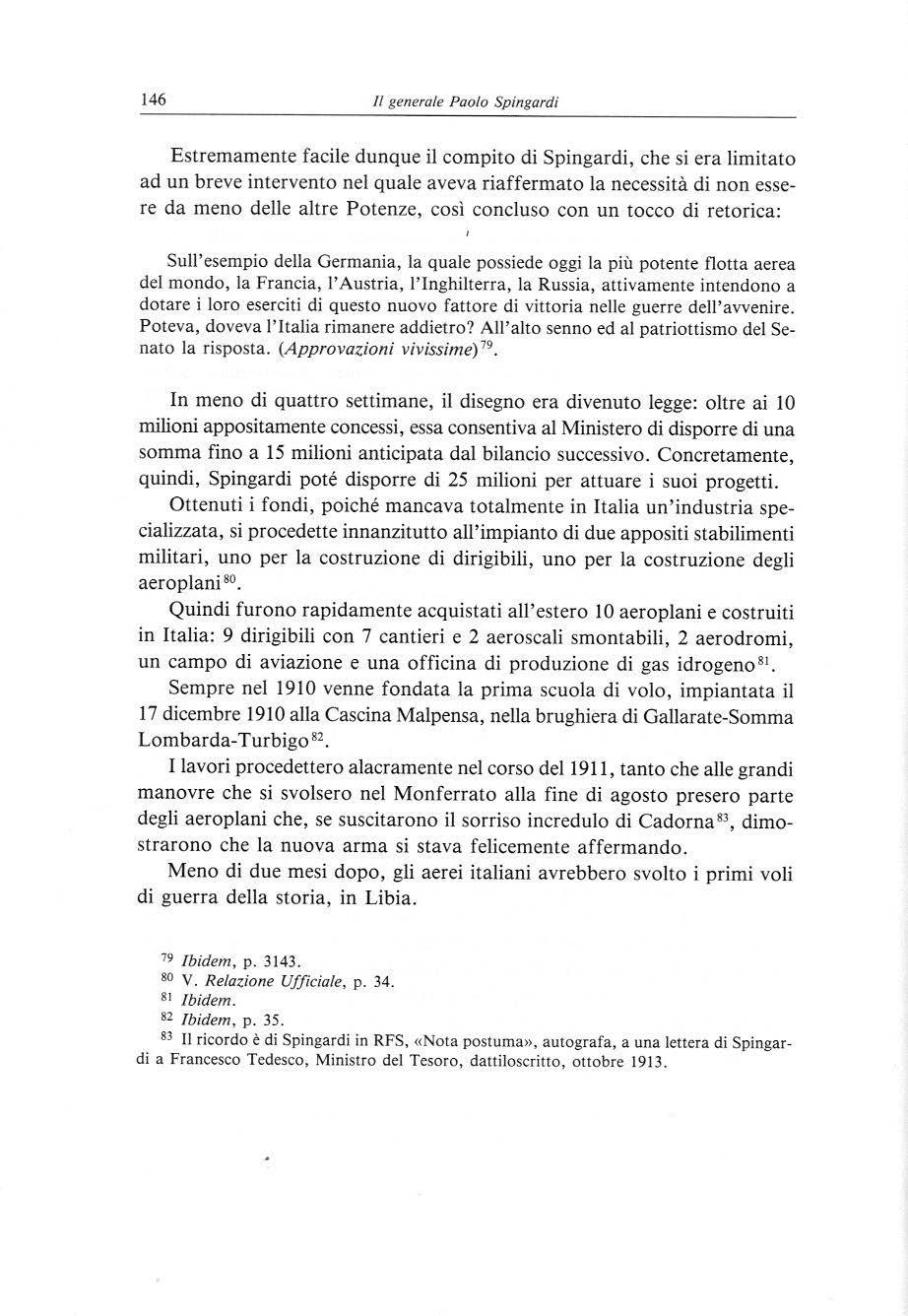
8 1 Ibidem.
82 Ibidem, p. 35.
83 Il ricordo è di Spingardi in RFS, «No ta postuma», autografa, a una lettera di Spingardi a Francesco Tedesco, Ministro del Tesoro,
146
dattilo scr itto, ottobre 1913.
C APITOLO VII
MILITARI E POLITICI DURANTE LA GUERRA DI LIBIA
Nel settembre del 1911 Spingardi poteva guardare con una certa soddisfazione a quanto si era realizzato nei due anni e mezzo precedenti. Spazzati via i malumori degli ufficiali inferiori, il Senato stava esaminando la nuova legge sull'avanzamento; ben avviate le fortificazioni, aumentata la forza bilanciata, anche l'ordinamento si stava avviando alla forma voluta e l'areonautica stava compiendo i primi, ma decisi, passi; si erano da poco ottenuti i fondi per concludere il rinnovamento dell'artiglieria da campagna .
Alla fine di agosto si erano svolte le grandi manovre (alle quali, insieme alle class i sotto le armi, partecipò una classe di richiamati) e il 2 settembre Spingardi poteva scrivere a Brusati:
Vidi subito Giolitti al mio arrivo a Roma: mi venne incontro co ll a più bella faccia di quest o mondo , ilare e sorridente , quasi volesse abbracciarmi!!! Si comp iacque imme nsamente del risultato delle grandi manovr e, lasciandomi in tendere che era sempre s tato nel suo pensiero che le manovre dovessero farsi ecc. ecc. Risposi confermando il risultato veramente eccezionale nei riguardi della s alute della truppa, sce ndendo anche a partico lari; gli dissi dei danni minimi, ad onta della zona secondo lui male scelta dal Capo di Stato Maggiore, ed infine della sapiente direzione impre ssav i da Pollio , e della gr ande utilità c he ufficiali e tru ppa ne avevano ricavata 1 •
Il giorno dopo Spingardi riceveva dal Mini stro degli E ste ri An tonino Di San Giuliano una lettera nella qual e , tra l'altro, quasi incidenta l mente, era scritto che « data la sit ua zione internazionale attuale, a me pare che l ' occupazione di Tripoli a breve scadenza d a parte nostra si imponga » 2 •
1 ACS. A rchivio Brusati, se 10, f. VI.4.36, Spinga rdi a Brusati, 2 / 9/ 911. Un'epidemia co lerica aveva a lungo messo i n forse l o svo lgimento de lle manovre. Per questo e a ltri parti colari sul.le manovre, a ll e q uali Spi n ga rdi fu quotidianamente presente, v. «La P reparazione», Sabato - Domenica 26-27 Agosto 19 11 e « L'Esercito italiano» , 27 agos t o 191 I , quasi i nteramente dedicati all ' argomento.
2 RFS Di San Giu liano a Spinga rdi da Fiuggi in d ata 3 settembre 19 1 I La lettera cosi prosegue: «C i ò può mutarsi, ma o ra la situazione mi pa re chi a ra in questo senso. Anche d i questo dovremo anzi tutto par larne t r a G io li tti , te e me. Vedo qu i ogni giorno G io li tii; parl iamo
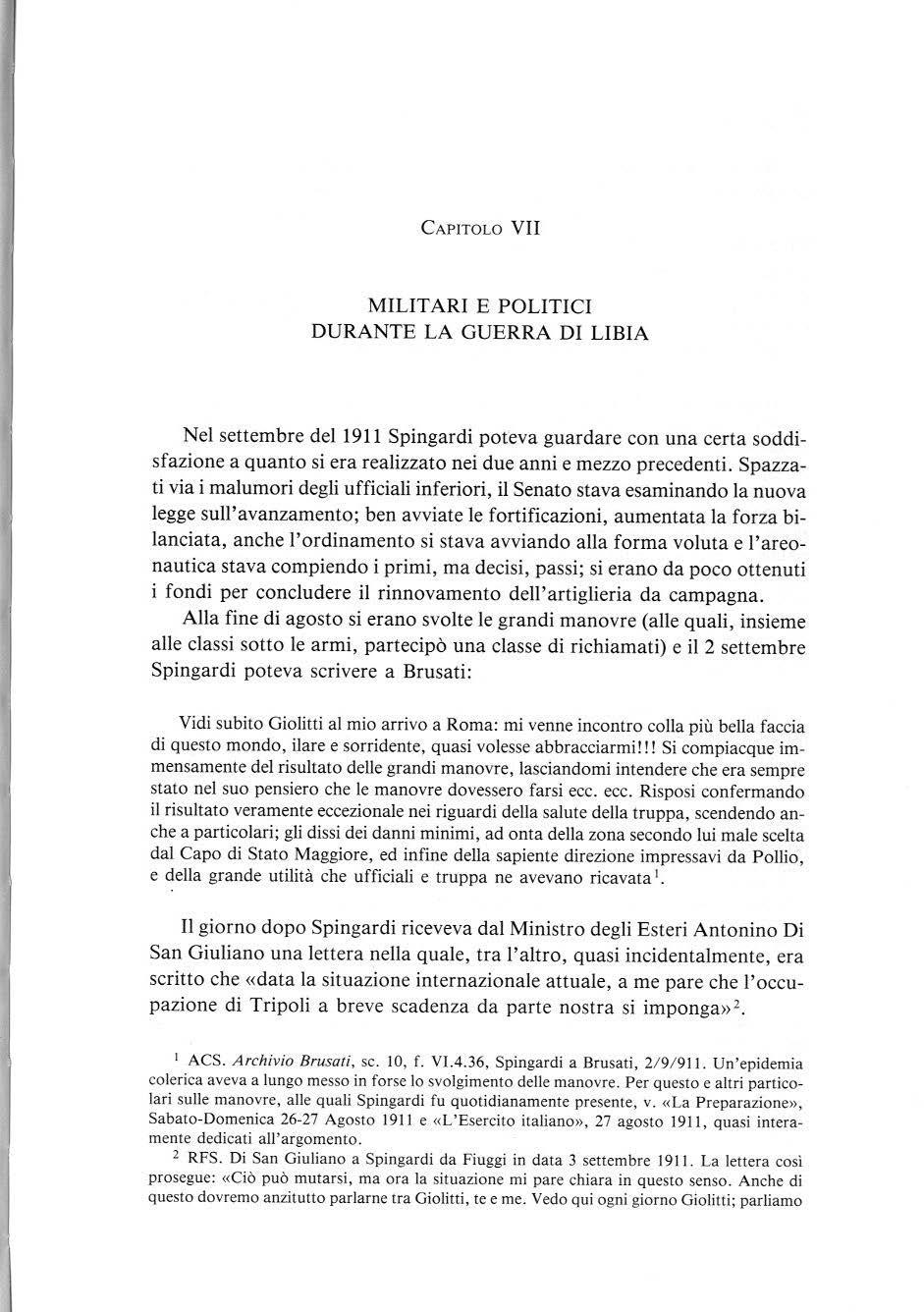
Ma la scadenza fu più breve di quanto il Ministro della Guerra si aspettasse o desiderasse, anche perché «per i generali che hanno una coscienza, tutte le guerre tendono a essere premature>> 3 e l'impresa libica veniva a interrompere la ben avviata opera di riorganizzazione dell'esercito, che solo la pace avrebbe permesso di completare adeguatamente. Il telegramma che il 18 settembre invitava a «far presto» colse Spingardi di sorpresa. Proprio il 3 settembre era stata congedata la classe di leva.
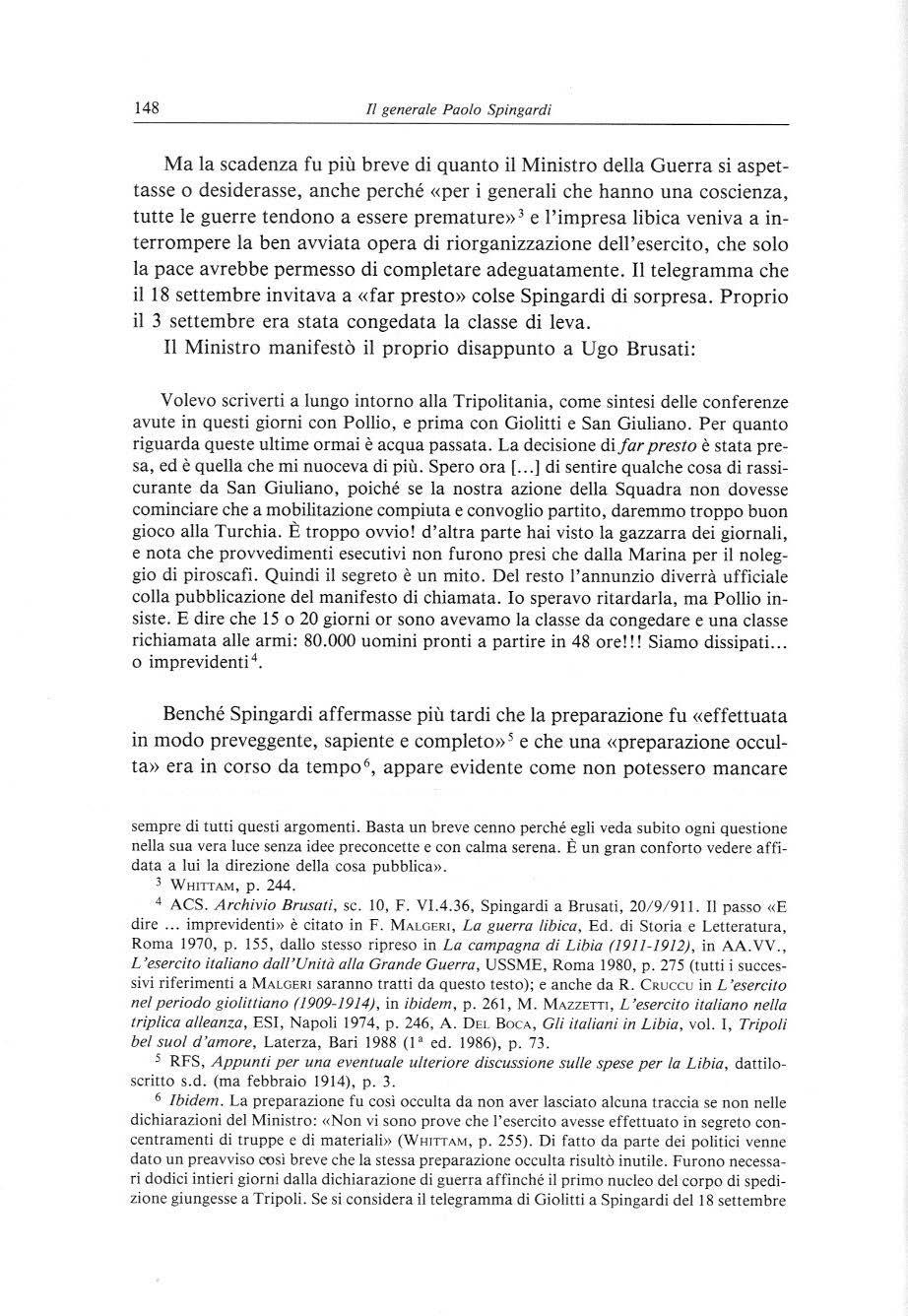
Il Ministro manifestò il proprio disappunto a Ugo Brusati:
Volevo scriverti a lungo intorno alla Tripolitania, come sintesi delle conferenze avute in questi giorni con Pollio, e p rima con Giolitti e San Giuliano. Per quanto riguarda queste ultime ormai è acqua passata La decisione di far presto è stata presa, ed è quella che mi nuoceva di p i ù . Spero ora [ ... ] di sentire qualche cosa d i rassicuran te da San Giuliano, poiché se la nostra azione della Squadra non dovesse cominciare che a mobilitazione compi uta e convoglio partito, daremmo troppo buon gioco alla Turchia. È troppo ovvio! d'altra parte hai visto la gazzarra dei giornali, e nota che provvedimenti esecut ivi non furono presi che dalla Marina per il noleggio di piroscafi. Quindi il segreto è un mito. Del resto l'annunzio diverrà ufficiale colla pub bli cazione del manifesto di chiamata. Io speravo ritardarla, ma Pollio insiste. E dire che 15 o 20 giorni or sono avevamo la classe da congedare e una classe richiamata alle armi: 80.000 uomini pronti a partire in 48 ore !!! Siamo dissipati. o imprevidenti 4 •
Benché Spingardi affermasse più tardi che la preparazione fu «effettuata in modo preveggente, sapiente e completo>> 5 e che una «preparazi one occulta» era in corso da tempo 6 , appare ev id ente come non potessero mancare
sempre di tutti questi argomenti. Basta un breve cenno perché egli veda subito ogni questione nella sua vera lu ce senza idee preconcette e con calma serena. È un gran conforto vedere affidata a lui la direzione della cosa pubblica».
3 WHJTIAM, p. 244.
4 ACS Archivio Brusa ti, se. lO, F. VI.4.36, Spingardi a Brusati , 20/ 9/ 911. Il passo «E dire imprevidenti» è citato in F. MA LGER I, La guerra libica, Ed. di Sloria e Letteratura, Roma 1970, p. 155, dallo stesso ripreso in La campagna di Libia (l9ll-/9!2), in AA.VV., L'esercito italiano dall'Unità alla Grande Guerra, USSME, Roma I980, p. 275 (tutti i successivi riferimen t i a MALGERI saranno tratti da questo testo) ; e anche da R. CR uccu in L'esercito nel periodo giolittiano (1909-1914), in ibidem, p. 261, M. MAZZETTI, L'esercito italiano nella triplica alleanza, ESI, Napoli 1974, p. 246, A. D EL BocA, Gli italiani in Libia, voi. I, Tripoli bel suol d 'amore, Laterza, Bari 1988 (I• ed. 1986), p 73
5 RFS, Appunti per una eventuale ulteriore discussione sulle spese per la Libia, dattiloscritlo s d. (ma febbraio 1914), p 3.
6 Ibidem. La preparazione fu così occulta da non aver lasciato alcuna traccia se non nelle dichiarazioni del Mini stro: « Non vi sono prove che l'esercito avesse effettuato in segreto concentramenti di truppe e di materiali» (WHITIAM, p. 255) . Di fatto da parte dei po litici venne dato un preavviso cosi breve che la stessa preparazione occulta risultò inutile. Furono necessari dodici intieri giorni dalla dichiarazione di guerra affinché il primo nucleo del corpo di sped iz ione giungesse a Tripoli. Se si considera il telegramma di Giolitti a Spingardi del 18 settembre
148 TI
generale Paolo Spingardi
inconvenienti, derivanti dalla non perfetta intes a t ra militari e politici sui te mpi della spedizione Ma di fronte alla decisione presa non rimaneva che piegarsi. Ri spondeva infatti Brusat i:

È un vero contrattempo spiacevole che tutto [...] si a scoppiato dopo il congedamento della classe anziana. Forse il ri t ardato congedamen to avrebbe dato luogo a nuove chiacchiere da parte dell ' antipa t rio tt ica nostra st ampa, mentre avrebbe avuto carattere precauziona le più che carattere a ggre ssivo. Ma ormai queste sono vane recriminazioni. Acqua p assata non macina pi ù 7 •
Spingardi non era entusiasta ma si piegò di fronte alla <<ineluttabile necessità» 8 e si mise alacremente al lavoro, cercando di rimanere costantemente informato attraverso tutti i canali possibili .
Dichiarata guerra il 29 settembre, la flotta italiana bombardò Tripoli il 3 ottobre. Il 5 ottobre la città venne occupata da 1732 marinai al comando del capitano di vascello Umberto Cagni, e da questi tenuta fino ali' l I ottobre, poiché solo a quella data sbarcarono i primi so ldati de l corpo di sped izione. La buona sorte arrise ai marinai di Cagni, contrariamente alle fosche previsioni di Brusati: «In fatto di ope r azioni di sbarco siamo ancora nella completa infanzia. La supposizione che i me zzi di cui di spone la marina possano bastare (eventualmente), mi sembra ingenua» 9 •
Si cercò di invi are in L ibia ufficia li generali che avessero già avuto esperienza di guerre coloniali Mol t i, tra i quali il comandante del corpo di spedizione Carlo Caneva, avevano partecipato alla campagna d'Africa del 1895 -1896. Ma di fatto nessuno era preparato al tipo di guerra che si combatté in Libia. Il timore di andare incontro a una sconfitta conferì un carattere di estrema prudenza alla condotta delle operazioni 10
191 I il vero or dine di mobilitazione s i ottengono 23 giorni: esattamente il tempo allora considerato n ecessario per mobi litare in caso di guerra (Cfr MAZZETTI, I piani di guerra contro l'Austria, cit., p. 174). La decisione di d ichiara re g uerra alla Turchia sembrerebbe presa da Giolitti senza avvertire i vertici mi litari. Si di rebbe c he Giolitti ignori i tempi del meccanismo di mobilitazion e dell'esercito i taliano e si aspetti che «un breve messaggio a llo Stato Maggiore avrebbe potuto essere trasfor mato quasi istantaneamente in una determinata operazione mil itare Per a lcuni, anche a l d i fuori dell'Italia cattolica, l'epoca dei mi racol i non era ancora pa ssata» (WHTTTAM, p 254). I militari, educati al rispetto dell'autorità, consid eravano il governo legittim amente investito da l Sovrano come loro superiore gerarchico, e perciò vi ubbid i vano ce rcando di seguire anche gli ordini d e lla cu i valid ità n on erano intimamente convint i Sul con cetto di «mobilitazione occulta» v. L. M0ND1 N1 , La p reparazione dell'esercito e lo sforzo militare nella prima guerra mondiale, in L'esercito italiano d all'Unit à alla Grande Guerra, cit., p 343
7 RFS Ugo Brusati a Paolo Spingardi da Ra ccon igi in data 23 settembre 1911.
8 Spingardi a Brusat i, 25 settemb re 19 11, c i t. in A. D EL Bo c A, op. cit., nota 1 14 a p. 77.
9 RFS, lettera d el 23 settembre 19 11, doc. ci t
10 Sui timori d i una replica di Adua cfr. DEL BocA, cit., pp. 124- 136 Carlo Caneva ( 1845 -1922) e ra comandante di regg imento ad Adua. Guglielmo Pecori Giraldi ( 185 6- 194 1) comandante della 1• Di v is ione i n Li bi a , aveva partecipato alle campagne eritree del 1887 , 1888,
Militari e politici durante la guerra di Libia 149
Il corpo di spedizio ne e ra composto soprattutto da so lda ti di le va, cosicc hé « le truppe non dimostrarono quella saldezza sotto il fuoco che cost ituiva la caratteristica dell e truppe rego lari da tempo sotto le armi» 1 1 e col prolungarsi del conflitto si creò l'inco nveniente di do ver necessariamente co ngedare le classi più anziane, con co nseguenti periodi di cris i tra il co ngedo di una cla sse e l'arrivo in Libi a della successiva Inoltr e, non volendosi alterare la s truttura dell'esercito metropolitano, casomai si fosse presentata l'e ve ntuali tà di una mobilitazione ge nerale, i reparti vennero prelevati in maniera più o meno uniforme dalle unità esistenti , col risultato di scompaginarle tutte. P rendere un co rpo d'armata e trasferirlo integralmente in Libia av re bbe lasciato undici so li corpi in Italia, ma tutti efficienti. Col s iste ma a d ott ato, rimanevano intatti sulla carta i dodici co rpi dell'ordinament o tradizionale, ma nessuno di essi con g li organici al completo 12 •
I primi g iorni videro l'afflusso regolare a Tripoli di altre truppe e l'occupazione di altri punti lungo la costa (Tobruk , il 4 ottobre; Dern a, il 16 ottobre; Ben gasi, il 20 ottobre; H oms, il 21 otto bre) 13 •
Ma all'alba del 23 ottobre 1911 un attacco turco sostenuto da una ins urrezione araba alle spalle delle po s izioni tenute dagli italiani nell' oasi di Tripoli, presso Sciara-Sciat, infli sse agli italiani « la più grave sconfitta dell'intera campagna libica » 14 e scate nò la repressione contro il suppo sto tra -
I 895-96, 1897 e dal I 903 al 1907 era s tat o comandante dell e truppe colonia li dell'Eritrea. Giovann i Ameglio (1854-1921 ), co mandante della 4 • Brigata, s i era messo in luce i n Afri ca dal 1887 al 1890 e p oi di nuo vo nel 1893 , 1895, 1896, 1897, ricevendo numerose decorazioni. Dal 1902 al 1905 partecipò alla campagn a in Estremo Ori ente. Ottavio Ra gni (18 52 -1 919) aveva fa llo la campa g na del 1895-96. To mmaso Salsa (18 57 - 191 3) s i era distin to in Eritrea dal 189 1 al 1895 e in C in a ne l 1900-1902. So lo una rice rca spec ifi ca potrebbe rende re conto di tutti gli ufficiali che parteciparono alla guerra di Libia e che potevano va ntare precedenti benemerenze in cam po coloniale. Tra chi in Libia non arrivò co me generale ricordiamo: Gaetano Giardino (1864-1935), arrivato in L ibia da tenente co l onnello , era già stato in Africa nel 1890-1893 meritandosi una medagl ia d'argento a Cassala; n el I926 venne nominato mare sci allo d'Itali a Altri futur i mar esc ialli d'Italia pas sa ro no attra ve rso la gu erra di Libia dopo essere st a ti pr ecedentemente in Erit rea e c ioè E mi lio Dc Bo no (1866-1944), in Li bia da tenente colo nnello , in Erit rea nel 1887, P ietro Badoglio (1871-1956) che ottenne in Libia la promozione a maggiore per merito di guerra ed era stato in A frica Oriental e nel 1896-97, ed Enrico Caviglia (1 862- 1945), colonnello in Libia, c he aveva partecip a to a ll e campagn e d'Afric a d el 1888- 89 e 1895-96.
11 WHITIAM, op cii.' p. 256.
12 V. MAJ.CERI , pp. 275-279 e s ui congedi delle class i p. 31 1 D EL BocA, ci t. , a p. 98 riporta il segu ente giudizio del gen. Bru sati : « Abbi amo formato un corpo di spedizione così come si for mano i gran d i reparti per le grandi manovre, di sordi nando, cioè, l'i ntero esercito per trarre qua e là gl i elementi necessari» tratto da App unti relativi alla guerra ila/o-turca, in ACS, A rc hivio Brusal i , se . 10, f. Vl -7-39. V. anche MALCER 1, pp. 280-283, dove so no riport ati amp i s tralci dei s udd etti Appunti.
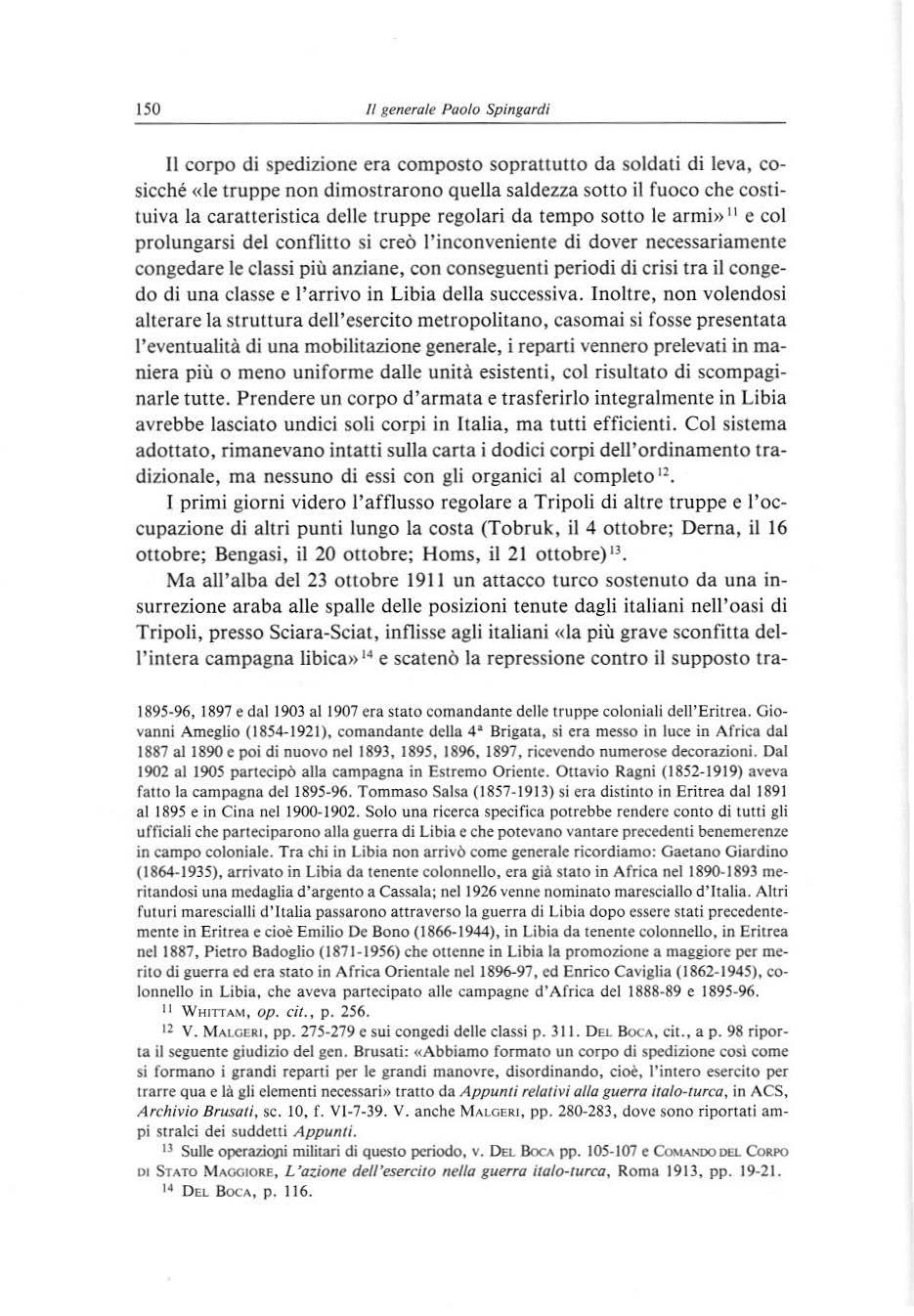
13 Sulle operaziopi militari di questo periodo, v. D a 8ocA pp. 105-107 e Co/.1M1)()DEJ. CoRPO
01 STATO M ACCIORE, L'azione dell'eserci10 nella guerra ila/o-turca, Roma 1913, pp. 19-21.
14 D EL BOCA, p. l 16.
150 Il
generale Paolo Spingardi
dimento degli arabi, fino a quel momento erroneamente creduti favorevoli ali' occupazione italiana 15
Le notizie giu nsero in Italia incomplete e frammentarie, responsabile forse Caneva che il mattino del 23 ottobre aveva inviato a Roma un teleg ramma «assai reticente, incompleto e ambiguo» 16 tanto che il giorno dopo Brusati si espresse in te rmini oltremodo tranqu illi :
Il telegramma di Canev a da te ieri mattina comunicatomi, e che diceva stamane pronunciato attacco che dura tuttora non destò in me alcuna apprens ione, visto il modo laconicamente semplice col quale la notizia era data, modo che lasciava supporre grande tranquillità in Caneva 17 •
Brusati faceva pieno affidamento sul suo vecchio compagno d'armi di Adua. Spingardi sembrava invece riflettere il clima di «angoscia e smarrimento >> 18 che regnava nel Governo in quei drammatici gi orni e così lo palesava al P rimo Aiutante:
Tu vivi in un ambiente alto e sereno , dove le questioni possono essere vagliate, pensate e riso lte con grande competenza, con eq uanimità di giudizio; con calma, sott ra tta a lla influenza dell'ambiente esterno . Qui no; a questa influenza dell'ambiente è difficile sottra rsi. Sono pareri multiformi e discordi di miei collaboratori del Ministero; sono g iudi zi di uomini polit ici, che popo lano le anticamere dei Minister i; sono inframettenze d i co ll eghi e super iori del gabinetto, di guisa che non è facile mantenersi in carreggiata 19 •
Le «inframettenze» dei «superiori del gabinetto>>, cioè di Giolitti, furono inevitabili per tutta la durata della campagna. Se la dir ez ion e tattica fu affidata al generale Caneva, a Roma la preminenza spettava a Giolitti, che sv ol se un ruolo attivissimo. Ma inn ega bilmente anche Sp inga rdi ebbe parte importante . Gli ordini formali erano compilati da Pollio , il quale però non agì mai senza essersi consultato con il Ministro ed averne otten u to il consenso . Spingardi a sua volta era in contatto costante con Ugo Brusati, dei cui pareri non si poteva non tener conto.
Nelle primissime ore del 26 ottobre 1911 i turco -arab i lanciarono un nuovo attacco. Le truppe italiane respinsero il nemico in poche ore. Ma il pericolo co rso indusse Caneva ad arretrare il fronte e a non avanzare di un solo metro 20 •
15 Sull ' episodio di Sciara Sciate la successiva repressione v. D EL BocA , cit., pp. 109- 123.
16 D EL Boc A, nota 7 1 a p. 116.
17 RFS , B rusa ti a Spingard i , 24 ottobre 191 I.
1s D EL BocA, nota 7 1 a p 116.
19 RFS, Spingardi a Brusa ti, 25 ottobre 1911 , minuta.
20 Sullo scontro detto di Henni -Bu Meliana del 26 ottobre e sulle decisioni di Caneva v. se mpre DEL Boc A, cit., p 117 e 124- 125.
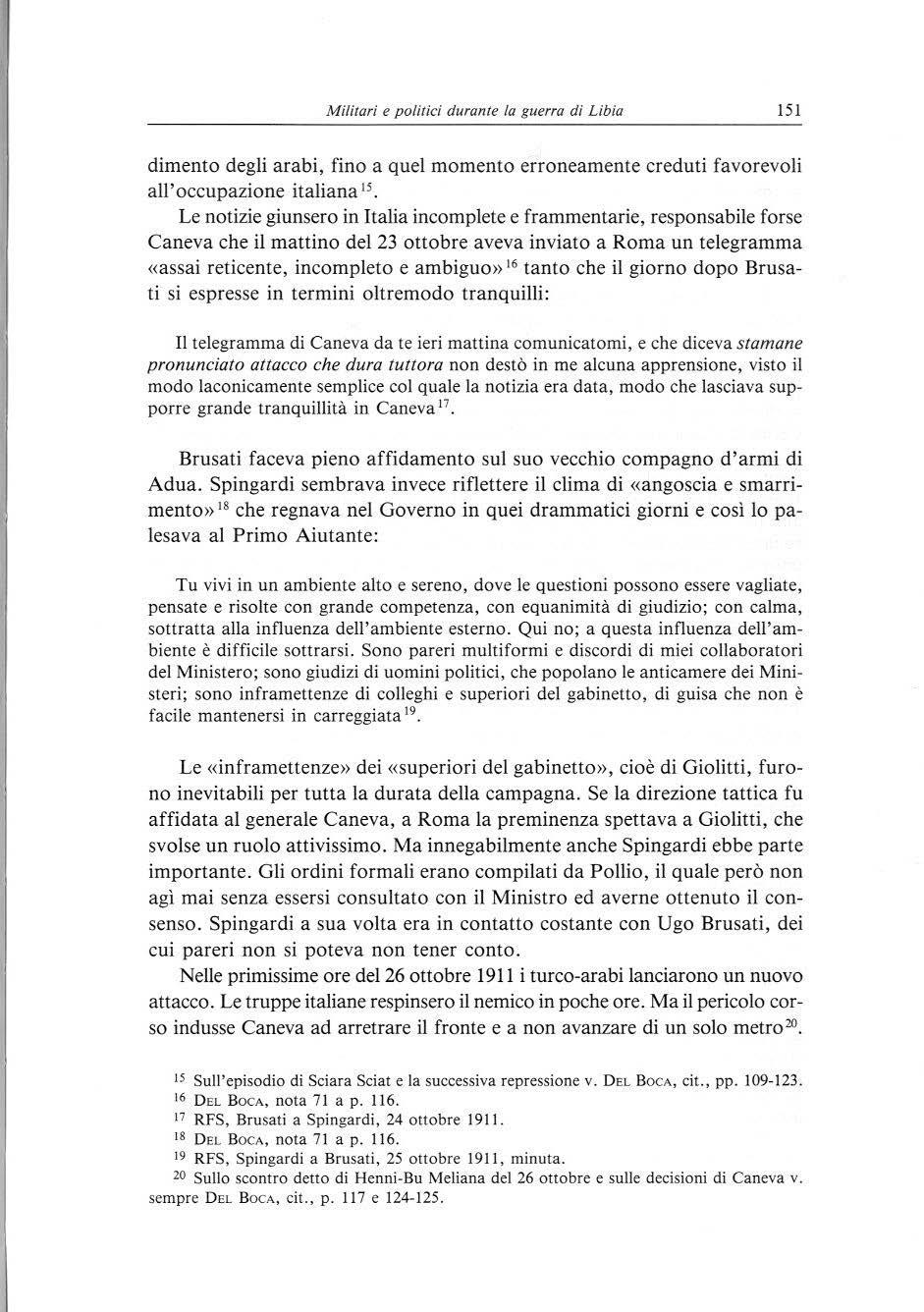
Milì1ari
e polilici durante fa guerra di Libia 151
Verso la fine di nov embre, non vedendo alcun progresso nelle operazioni militari, Giolitti tempestò Spingardi di lettere (e di comunicazioni a voce, è lecito supporre) contro i «generali da salotto e da tavolino» e contro Caneva che, secondo lui, si era «riaddormentato» e ricominciava «a mettersi nella condizione di non offendere ! » 21 • Di fronte alle argomentazioni del Presidente del Con siglio Spingardi decise di scriv ere a Caneva cercando di indurlo a una maggiore decisione :
Non è il Ministro che ti scrive; egli non può e non deve intervenire, E non è neppure il collega generale, che giudica sulla cana e sulle notizie incomplete, vere o false che sin qui gli giungono; ma è l'amico che ti dice : esci finalmente da questa inazione. Carità di Pat r ia ed il prestigio dell'Esercito lo esigono. Sono quaranta giorni che tu sei assediato da poche migliaia di arabo-turchi. La deficienza di forza, il tradimento degli arabi alle spalle nell'oasi, la città stessa non sicura hanno potuto giustificare la prudente e saggia tua attesa; oggi non più. Hai battaglioni per tenere l'oasi, altri per guardare la città, ed altri ed altri ancora per manovrare arditamente. Non soltanto Henni e Messri, ma più innanzi nell'oasi, ed Ain - Zara devono essere i tuoi obiettivi. Hai truppe ottime, che anelano di combattere Dunque che attendi? Io ho terminato tutte le mie cartucce in tua difesa! Pensa che tutti gli o cch i de l mo n do militar e so no volti a te: tutte le cancellerie europee attendono l'esito della tua ardita iniziativa 22.
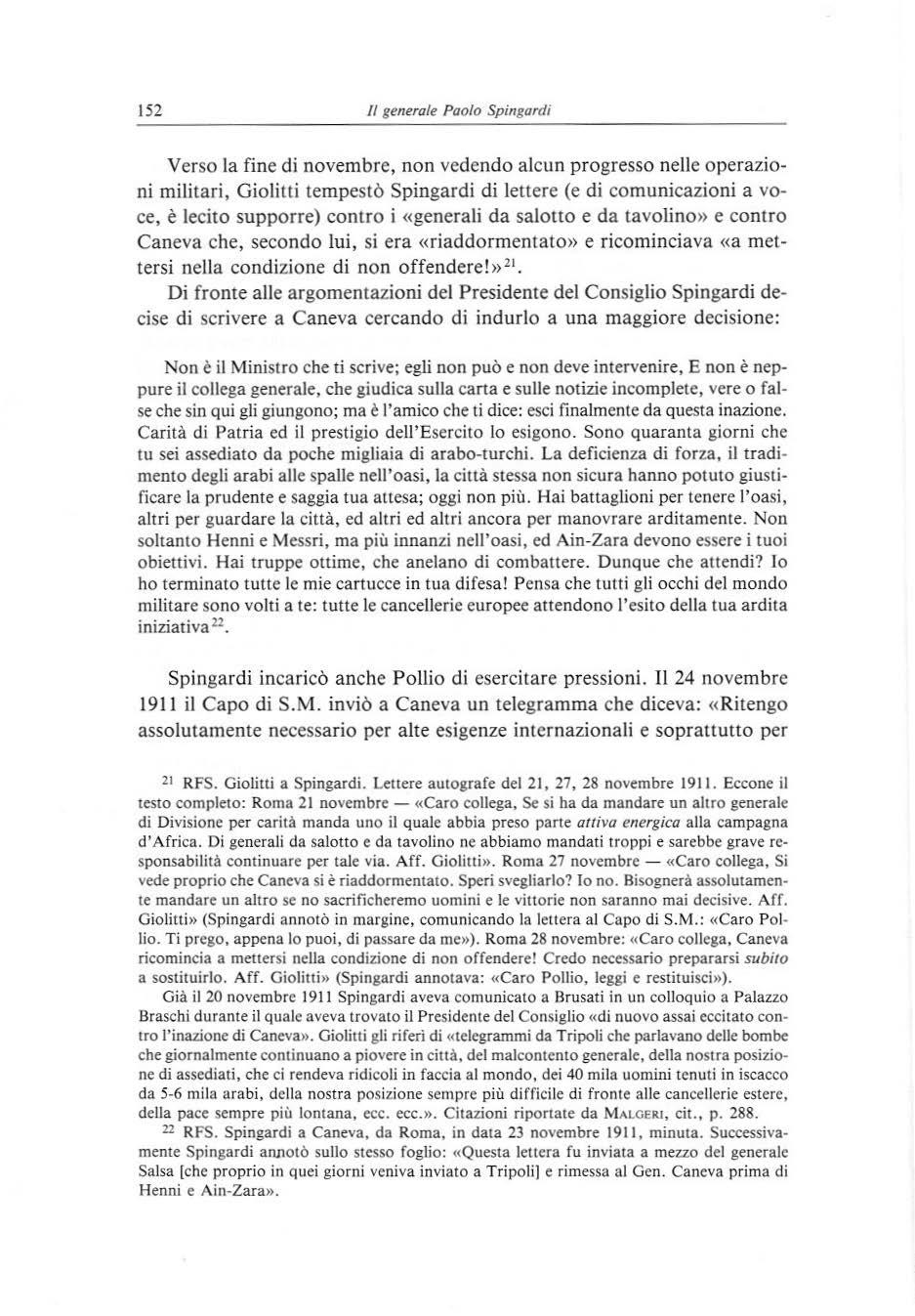
Spingardi incaricò a n che P ollio di esercitare pressioni. Il 24 novembre
I 911 il Capo di S.M. inviò a Caneva un telegramma che diceva: « R itengo assolutamente necessario per alte esigenze internazionali e soprattutto per
21 RFS. Giolitti a Spingardi . Lettere autografe del 21, 27, 28 novembre 1911. Eccone il testo completo: Rom a 21 novembre - «Caro collega, Se si ha da mandare un altro generale di Di visione per carità manda uno il quale abbia preso parte attiva energica alla campagna d'Africa. Di generali da salott o e da tavolino ne abbiamo mandat i troppi e sarebbe grave respo nsabili tà continuare per tale via. Aff. Gioliui». Roma 27 novembre - «Caro collega, Si vede proprio che Caneva si è riaddormentato. Speri svegliarlo? Io no. Bisognerà assolutamente mandare un altro se no sacrificheremo uomini e le vittorie non saranno mai decisive. Aff. Gio litti» {Spingard i annotò in margine, comunicando la lettera a l Capo d i S.M.: «C aro P o llio. Ti prego, appena lo puoi, di passare da me»). Roma 28 novembre: «Caro collega, Caneva ricomincia a mettersi nella condizione di non offendere! Credo necessario prepararsi subito a sostituirlo. Aff. Giolitti>} (Spingardi anno tava: «Caro Pollio, leggi e restituisci»).
Già il 20 novembre 1911 Spin gardi aveva co municato a Brusati in un colloquio a Palazzo Braschi durante il quale aveva trovato il Presidente del Consiglio «d i nuovo assai eccitato contro l'in azione di Caneva». Giolitti gli riferì di «telegrammi da Trip01i che parlavano delle bombe che giornalmente continuano a piovere in ciuà, del malcontento generale, della nostra posizione di ass ediati, che ci rendeva ridicoli in faccia al mondo, dei 40 mila uomini tenuti in iscacco da 5-6 mila ara bi , della nost ra pos izione sempre più d ifficile di front e alle cance ll e rie estere, della pace sempre più lontana, ecc. ecc.». Citazioni riportate da MALOERJ, cit., p. 288.
22 RFS. Spingardi a Caneva, da Roma, in data 23 novembre 1911, minuta. Successivamente Spingardi annotò sullo stesso foglio: «Questa lettera fu inviata a mezzo del generale Salsa (che proprio in quei giorni veniva inviato a Tr ipol i) e rimessa al Gen. Caneva prima di Henni e Ain-Zara».
152
li generale Paolo Spingardi
elevate considerazioni di ordine militare che senza indugio coi mezzi di cui attua lmente dispone proceda ad azione controffensiva risoluta efficace» 23 • Il testo del telegramma veniva comunicato da Spingardi, nella stessa giornata del 24, anche a Brusati, che commentava: «Con questo telegramma si impartisce un ordine. lo ritengo certo il successo» 24 •
Tant e pressioni raggiunsero lo scopo: all'alba del 26 novembre Caneva finalmente si mosse. Le truppe italiane rioccuparono le posizioni abbandonate in seguito agli avvenimenti del 23 e 26 ottobre. Il 4 dicembre un forte contingente turco -arabo venne sconfitto ad Ain-Zara, dodici chilometri fuori Tripoli 25 Le cose parevano mettersi al meglio, tanto che Brusati scriveva a Spingardi: «Sono tanto felice pel modo co l quale le faccende procedono in Tripolitania. Ne avevo ferma fede» 26 •
Gli avvenimenti successivi a Sciara Sciat avevano provocato in Europa una violenta campagna di stampa contro le «atrocità italiane in Libia » 27 • Brusati, che già a vev a espresso severi giudizi sulla stampa italiana agli inizi del conflitto 28 , non poteva essere che addolorato e infastidito dalle «false voci diffuse dai giornalisti malevoli» circa le «a troci tà attribuite ai nostri soldati» 29
Affinché ciò non si ripetesse Spingardi inviò a Tripoli un ufficiale di sua fiducia, il maggiore Edoardo R opo lo, coll'incarico di procedere a una sorta di epurazione tra i giornalist i e riferirne poi a lui.
Ropolo agì con fermezza e a quanto pare ottenne i risultati sperat i.
23 Copia del tel egramma fu inviata da Pollio a Spingardi. R FS, lettera di Pollio a Spingard i co n acclusa copia del telegramma in data 24 novembre 191 1. Il teleg ramma era il n. 3625 ci frato rosso.
24 RFS, Brusati a Spingardi, Roma 24 novembre 191 I.
25 V. DEL BOCA, pp. 130- 132.
2 6 RFS, Brusati a Spingard i , Roma 6 dicembre 191 I.
27 DEL BocA, cit., pp. 123-124; v. anche MALCERI , pp. 308-309.
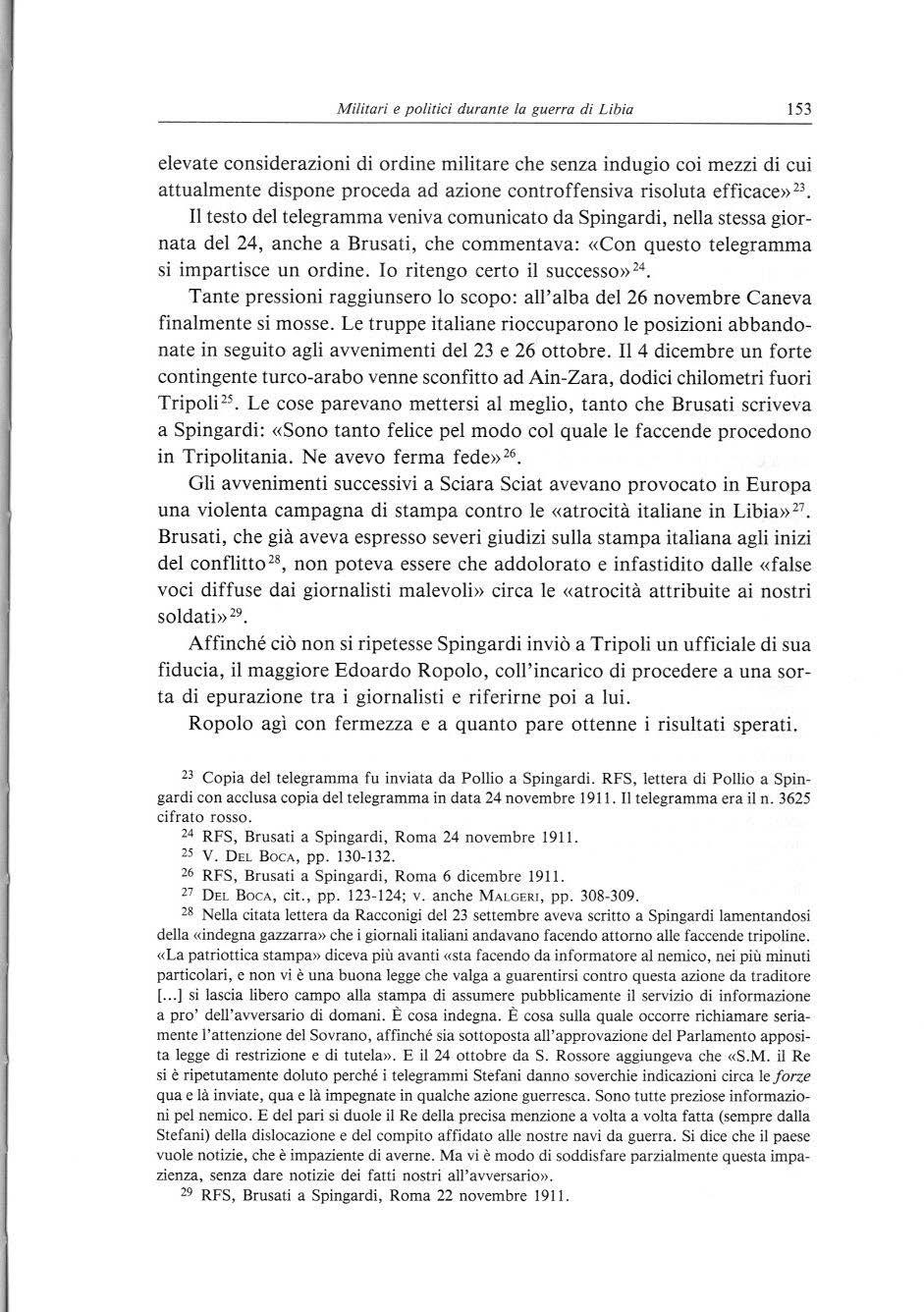
28 Nella citata l ettera da Racconigi del 23 settembre aveva scritto a Spingardi lamentandosi della «indegna gazzarra» che i gioroali italiani andavano facendo attorno alle faccende tripoline . «La patriottica stampa» diceva pii1 avanti <<sta facendo da informatore al nemico, nei più minuti particolari, e non vi è una buona l egge che valga a guarentirsi contro questa azione da trad itore [ ) si lascia libero campo alla stampa di assumere pubblicamente il servizio d i in formazione a pro' dell'avversario di domani. È cosa indegna. È cosa sulla quale occorre richiam are seriamente l'actenzi one del Sovrano, affinché sia sottoposta all'appro vazione del Parlamento apposita legge di restrizione e di tutela» . E il 24 ottobre da S . Rossore aggiungeva che «S.M. il Re si è ripetutamente doluto perché i telegrammi Stefani danno soverchie indicazioni circa le/orze qua e là inviate, qua e là impegnate in qualche azione guerresca. Sono tutte preziose informaz ioni pel nemico. E del pari si duole il Re della precisa menzione a volta a volta fatta (sempre dalla Stefani) della dislocazione e del compito affidato alle nostre navi da guerra. Si dice che i l paese vuole noti zie , che è im paziente di averne. Ma vi è modo di soddisfare parzi almente questa impazienza, senza dare notizie dei fatti nostri all'avversar io».
29 RFS , Brusati a Spingard i , Roma 22 novembre 191 I.
Militari e politici durante la guerra di Libia 153
generale Paolo Spingardi
Ho preso possesso del mio ufficio - riferiva - ed ho trovato una cinquantina di corrispondenti Italiani ed Esteri autorizzat i , per lo più amici nostri, da mettere ass ieme. Ma compito più difficile è stato quello di trovare i non autorizzati e cioè i veri nemici nascosti ed autori di tutti gli articoli diffamatori. Con pazienza li ho scovati, fatti venire qui, ammoniti, ed ora attendo i risultati dell'opera fatta. Per alcuni, come ad esempio due tedeschi, il Kay-Migiud ed il Kutschbach, nutro davvero speranza di essere riuscito, per du e o tre altri ne dubito assai, ed allora bisognerà ricorrere all' espul sione, unica misura efficace e temu ta da questi signori. Gli altri sono abbastanza buoni, e solo vi è lotta continua per non lasciarli telegrafare notizie inesatte, e ritardarne i dispacci. Ora però spero di essere a posto e che le cose procederanno meglio 30 •
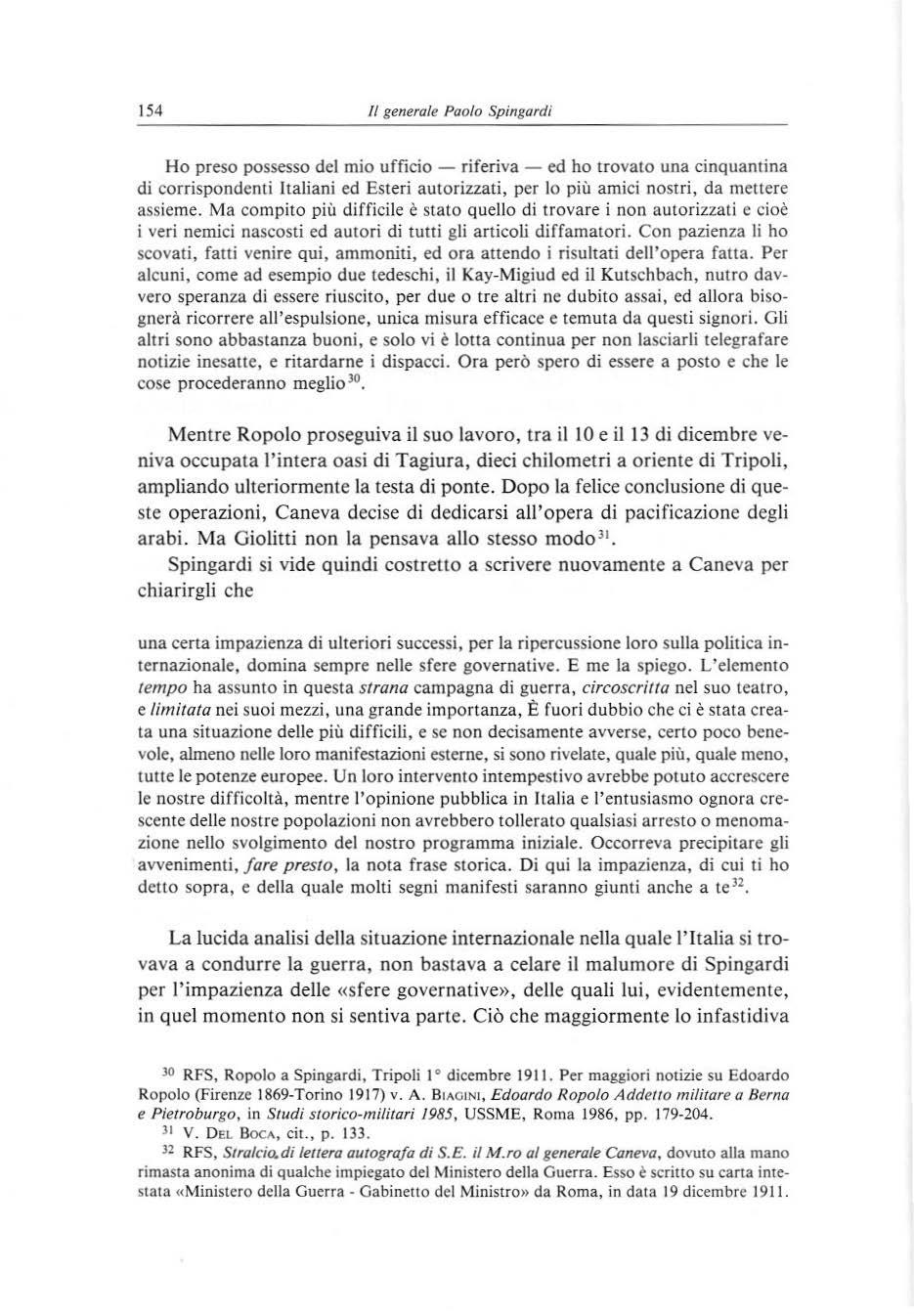
Men tre Ropolo proseguiva il suo lavoro, tra il I O e il 13 di dicembre veniva occupata l'intera oasi di Tagiur a, dieci chilomet ri a oriente di Trip oli, ampliando ulteriormente la testa di ponte. Dopo la felice conclusione di queste operazioni, Caneva decise di dedicarsi all'opera di pacificazione degli arabi Ma Giolìtti non la pensava allo stesso modo 31 • Spingardi si vide quindi costretto a sc rivere nuovamente a Caneva per chiari rgli che
una cena impa zienza di ulteriori successi, per la ripercussione loro sulla politica internazionale, domina sempre nelle sfere governative. E me la spiego. L'elemento tempo ha assunto in qu esta strana campagna di guerra, circoscrilta nel suo teatro, e limitata n ei s uoi mezzi, una g rande importanza, È fuori dubbio che ci è stata creata una situazione delle più difficili, e se non decisamente avverse, certo poco benevole, almeno nelle loro manifestazioni esterne, si sono rivelate, quale più, quale meno, tulle le potenze europee. Un loro intervento intempestivo avrebbe potuto accrescere le nost re difficoltà, mentre l'opinione pubblica in Ita li a e l'entu siasmo ognora cresce nte delle nostre popolazioni non avrebbero tolle rato qua lsiasi arresto o menomazione nello svolgimento del nostro programma iniziale. Occorreva precipitare gli avvenimenti, /are p resto, la nota frase storica. Di qui la impazienza, di cui ti ho detto sopra, e della quale molti segni manifesti saranno giunti anche a te 32 •
La lucida anali si della situazione internazionale nella quale l'Italia si trovava a condurre la guerra, non bastava a celare il malumore di Spingardi per l'impazienza delle «sfere governative», d ell e quali lui, evidentemente, in que l mom e nto non si se ntiva part e. Ciò che maggiormente lo infastidiva
30 RFS, Ropolo a Spingardi, Tripoli 1° dicembre 191 I. Per maggiori notizie su Edoardo Ropolo (Firenze I 869-Torin o 1917) v. A. B1A O IN1 , Edoardo Ropolo Addetto militare a Berna e Pietroburgo, in Studi storico-militari 1985, USSME, Roma 1986, pp. 179-204.
31 V. DEL B oc A, cit., p. 133.
32 RFS, Stralcio.di leuera autografa di S.E. il M . ro al generale Caneva, dovuto alla mano rimasta anonima di qualche impiegato del Ministero della Guerra. Esso è scritto su carta intes tata «Ministero della Guerra - Gabinetto del Ministro» da Roma, in data 19 dicembre 1911.
154
Il
nell'ingerenza dei politici nella condotta delle operazioni era il loro giud icare senza essere al corrente della reale situazione, ragionando con la più totale ignoranza di cose militari, pressati dalla «d ip lomazia, che, a to r to od a ragione, è tanta parte di questa campagna» 33 •
Sono noti infatti i limiti posti al teatro di operazioni, che avrebbe dovuto rimanere circoscritto al suolo libico , dalle potenze preoccupate di complicazioni balcaniche 34 •
Spingardi certo desiderava che si facesse presto «ma, badiamo» puntualizzava «i l fare presto andava e va inte so in questo senso : fare meno bene oggi, purché sicuramente, quello che sarebbe possibile fare benissimo domani». Insomma, fosse dipeso soltanto da lui, Spingardi avrebbe approvato la tattica temporeggiat rice di Caneva. Ma purtroppo l'impazienza si manifestava anche adesso nella occupazione di Zuara. Si ritiene che quella occupazione, che del resto era nel tuo pensiero fin dai primi giorni del tuo sbarco a Tripoli, possa essere un elemento di più per l'affermazione del nostro possesso, e si pensa inoltre possa in certa misura contribuire alla limitazione del contrabbando tunisino. - E quindi - Pollio provvederà all'invio di appos ito di staccamento delle tre armi, e tu, ove ragione militare non vi si oppo nga, vedi di drizzarne la prua ai nuov i lidi di Zuara il più presto possibile. Sarà una spi na di meno nel mio cuore! 35
Costretto a subire le costanti pressioni di Giolitti, Spingardi dovette sopportare parecchie spine nel cuore . A parte le lettere, le discussioni dovevano essere quotidiane e raggiungere punte di acuta tensione:
Tu non puoi neppure lontanamente immaginare - confessava a Caneva -le arrabbiature che mi piglio, e se non farai presto ad im porre la pace, correrai rischio, tornando in Italia, di non trovare più il Ministro della Guerra. Piccolo male del resto! 36
Pare in effetti che in quel periodo Spingardi non godesse più tutte le simpatie di Giolitti 37 • Nel frattempo continuarono ad affluire rinforzi dall'Italia:
Sono ora in Tripolitania e Cirena ica molte forze - comunicava Pollio - d'onde la necess ità de ll'i nvio di un altro comandante di Corpo d'armata: il gene rale Fru -
33 Ibidem. Avremo modo di vedere esempi d i reazione epi sto lare di Spingardi a queste ingerenze, che dimostrano come fossero poco g ra d ite anche in tempo di pace. Cfr. comunque MALG ER 1, cit., pp. 288 -289.
34 Soprattutto I' Austra. V. in proposito SETON- WATSON, pp 431-432 e 437, DEL BocA, cit., pp 96-97.

35 RFS, Stralcio di lettera autografa, doc. cit.
36 Ibidem
37 V MAlGERI, ci t ., p. 289 e doc. ivi citato
Militari e politici durante la guerra di Libia 155
Il
generale Paolo Spingardi
goni. Ed è ferma intenzione del Governo del Re di mobilitare e tener pronte a salpare al primo cenno altre importanti forze 38 •
In dicembre si ritrovavano in Libia, in più della prima spedizione (35.000 uomini): 55.000 uomini, 8 . 300 quadrupedi, 1.500 carri, 84 cannoni da campagna, 42 da montagna, 28 da assedio 39 , tanto che Pellio rassicurava Spingardi: « Po ssiamo, insomma, esser tranquilli. E pel momento non mi pare convenga fare altre spedizioni» 40 •
Il 19 dicembre avvenne la ricognizione di Bir Tobras, una puntata nel vuoto decisa, all'insaputa di Caneva, dal Gen. Pecori Giraldi e condotta dall'opportunista, ambizioso colonnello Gustavo Fara. Per puro caso l'operazione non si risolse in un disastro 41 •
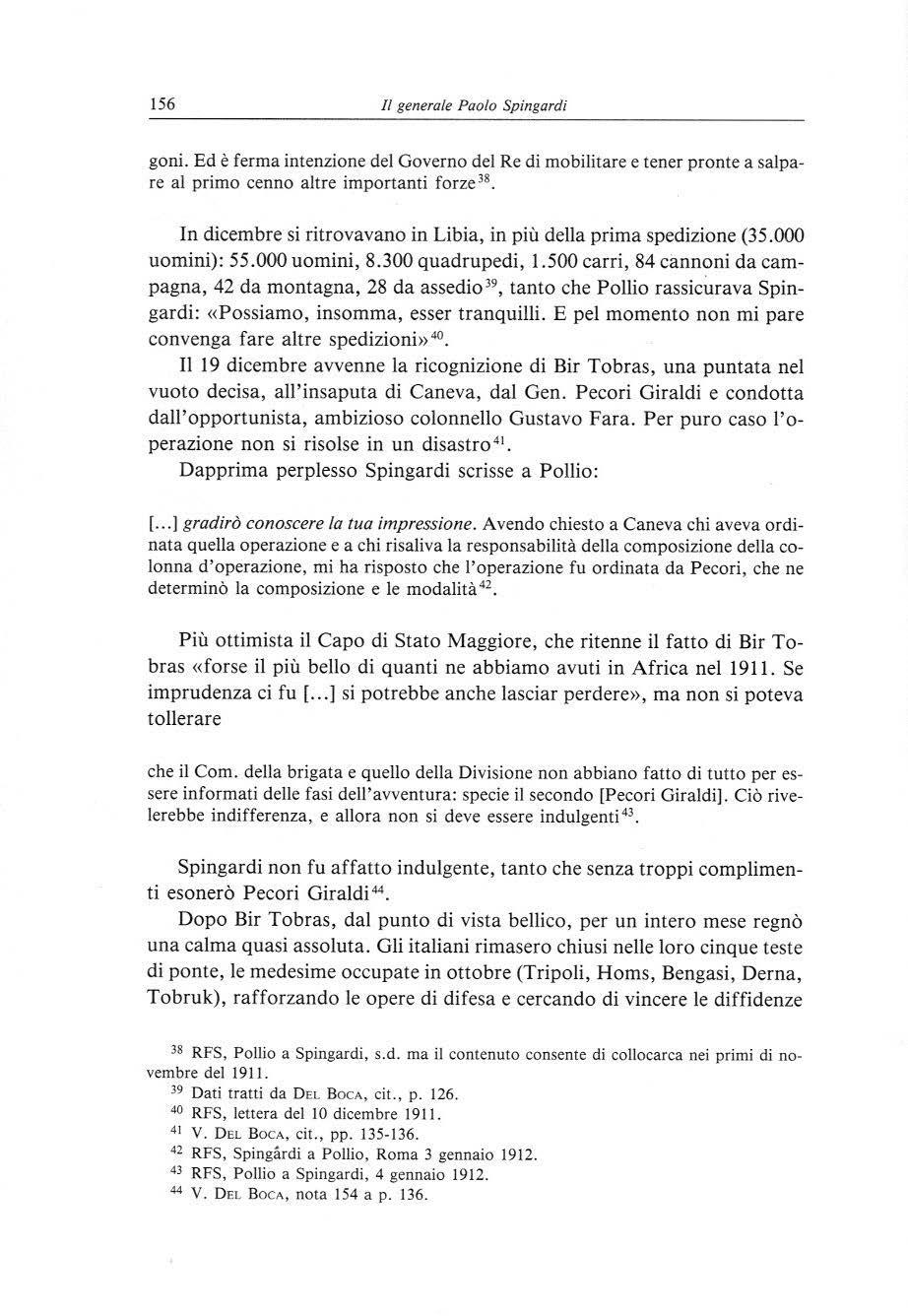
Dapprima perplesso Spingardi scrisse a Pellio:
( . . ] gradirò conoscere la tua impressione. Avendo chiesto a Caneva chi aveva ordinata quella operazione e a chi risaliva la responsabilità della composizione della colonna d'operazione, mi ha risposto che l'operazione fu ordinata da P ecori, che ne determinò la composizione e le modalità 4 2
P iù ottimista il Capo di Stato Maggiore, che ritenne il fatto di Bi r Tobras «forse il più bello di quanti ne abbiamo avuti in Africa nel 1911. Se imprudenza ci fu [ ... ] si potrebbe anche lasciar perdere» , ma non si poteva tollerare
che il Com. della brigata e que ll o della Divisione non ab b iano fatto di tutto per essere informati delle fasi de ll 'avventu ra: specie il secondo [Pecori Giraldi]. Ciò rivelerebbe indifferenza, e allora non si deve essere indulgent i 43
Spingardi non fu affatto indulgente, tanto che senza troppi complimenti esonerò Pecori Giraldi 44 •
Dopo Bir Tobras, dal punto di vista bellico, per un intero mese regnò una calma quasi asso l uta. Gli italiani rimasero chiusi nelle loro cinque teste di ponte, le medesime occupate in ottobre (Tripoli, Hom s, Bengasi, Derna, Tobruk), rafforzando le opere di difesa e cercando di vincere le diffidenze
38 RFS , Poltio a Spingardi, s.d. ma il con tenuto consente di collocarca nei primi di novembre del 1911.
39 Dati tra t ti da D EL BocA , cit. , p. 126.
40 RFS, lettera del 10 dicembre 1911.
4 1 V. DEL Boc A, cit., pp. 135-136
42 RFS, Sp ingardi a Pollio, Roma 3 gennai o 1912.
4 3 RFS, Pollio a Spingard i , 4 gennaio 1912.
44 V. D EL BocA, nota 154 a p. 136.
156
degli arabi 45 • Il nemico si limitava a condurre modeste azioni di disturbo e scompariva nel deserto prima di poter essere affrontato 46 • L'occupazione di Zuara dovette essere rimandata a causa delle avverse condizioni metereologiche (di fatto sarebbe avvenuta solo il 5 agosto 1912) 4 7 •
Anche Giolitti si placò, a giudicare dalle sue Memorie. Riferendosi a questo periodo scrisse :
li nemico era assolutamente incapace di attaccarci nei punti che noi avevamo occupati e for t ificati, ed ogni suo tentat ivo di attacco finiva sempre per essere fiaccato con sue gravi perdite; ma d'altra parte per noi era pure assai difficile e all e vo lte anche perico loso cercare d'inseguirlo nel deserto, dove le nostre truppe avanzandosi si esponevano a sofferenze ad a rischi, per le difficoltà del terreno, la penuria d'acqua e la mancanza di qualun que risorsa, e dove le sue squadre leggere riuscivano a dileguarsi davanti a ogni nostra mossa. L'opinione pubblica che non si rendeva abbastanza conto di tali condizioni, e del fatto che la guerra era ormai degenerata in guerriglia, si mostrava impaziente. A questa impazienza io non partecipavo 48 •
Giolitti faceva proprie le argomentazioni che i militari usarono con lui per giustificare la tattica prudente da essi adottata. Se l'impazienza ora era passata, sarebbe pe r ò tornata di lì a poco.
Spingardi approfittò delJa sosta nelle operazioni per assumere maggiori informazioni direttamente dalla Libia attraverso corrispondenze da lui stesso so llecitate 49 • Da Derna arrivò una lettera dello sconsolato gen. Vittorio Trombi.
Il presidio di Dema subiva dure prove a causa della speciale topografia del luogo. La città si trovava addossata ad una balza rocciosa che la dominava quasi a strapiombo e lungo la quale non esistevano accessi all'altopiano, fortemente inciso da spaccature e profonde e rosioni 50 • Date anche le avverse condizioni del tempo, era assai difficile agire offensivamente Inoltre nel setto re operava il più abile dei comandanti nemici, Enver Bey 51 • La lettera
45 V. DEL BocA, p. 157.
46 V. Ibidem e S ETON -WATSON, p. 436.
47 Sull'occupazione di Zuara v. L'azione de/f'esercito italiano ne/là guerra italo-turca, pp . 39-48.
48 Giovanni G1ourr1, Memorie della mia vita, Garzanti, Milano 1967 (l 3 ed. Treves 1922), pp. 246-247.
49 A Caneva, il 19 dicembre, aveva scritto: «Rinnovo la preghiera: quando ne hai il tempo scrivimi , a lungo, tutto quello che in rapporti di ufficio non si scrive: io non ho altre corrispondenze costà e non desidero di avere altro informatore che il comandante in capo Una sola lettera ho avuto, di Ropolo su i giornalisti!» RFS, doc. cit.
so V.L'azione dell'esercito, cit., p. 37 e le fo to ivi riprodotte che illustrano chiaramente la particolare natura del luogo.
51 Su Enver Bey, figura leggendar ia di soldato e avventuriero, v. DEL BOCA, cit., pp. 140-141 e ad indicem.
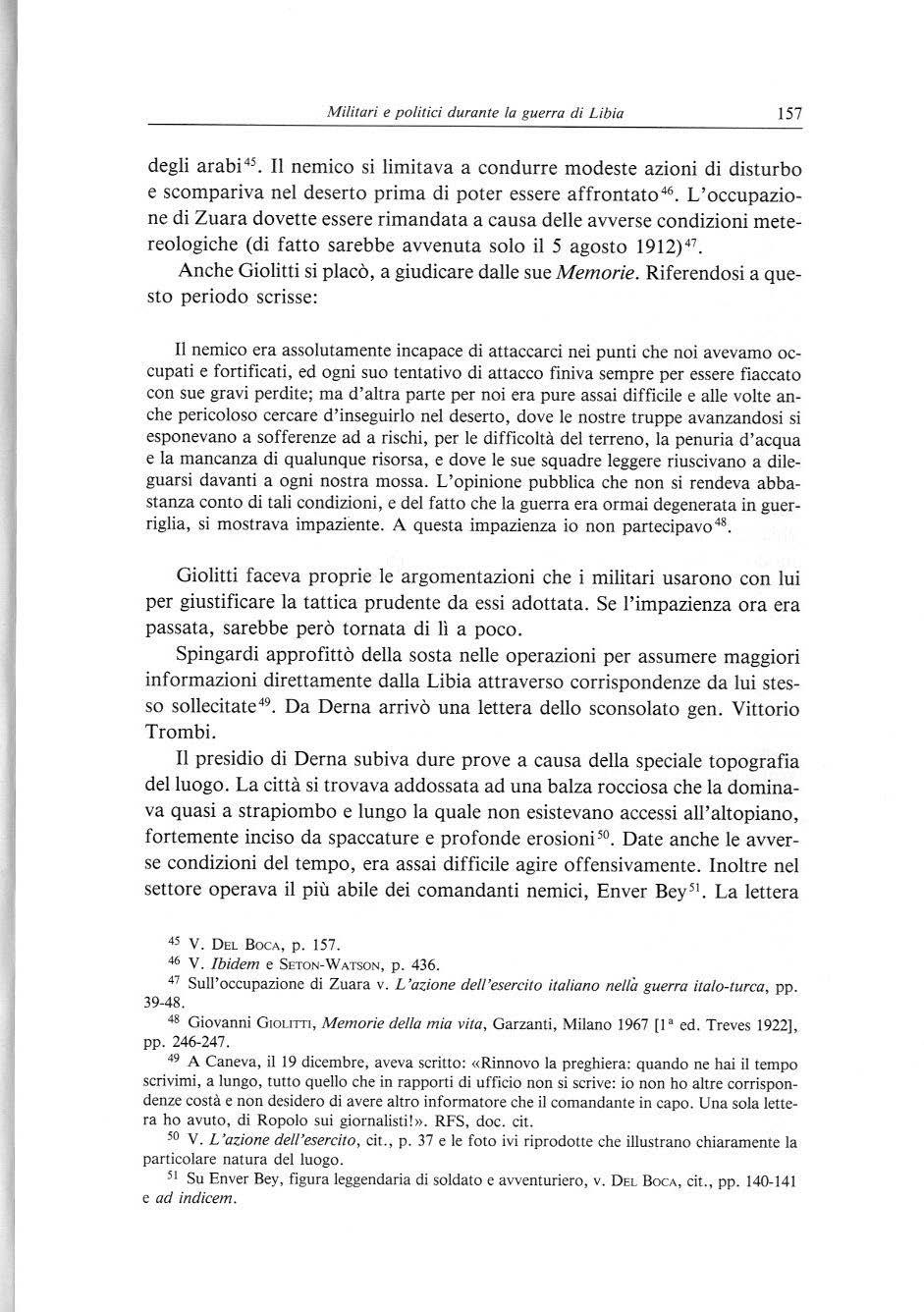
Militari e politici durante la guerra di Libia 157
generale Paolo Spingardi
di Trombi rappresenta una ulteriore testimonianza dei contrasti che dividevano militari e politici.
Qui ti unisco in copia e crono logicamente dispacçi avuti colla firma di Giolitti e la risposta da me fatta Leggili, giudicane la forma aspra e vedi se non sia il caso di avvertire i l Presidente del Consiglio che è bene sapp ia che il signor Mercatelli 52 ha una vecchia ruggine con me fino dalla Eritrea [... ] I dispacci qui uniti colla firma di Giolitti sono evide ntemente stile e farina del Mercatelli. Prega S.E . il presi d ente di non lasciare carta bianca al Mercatelli per ciò che riguarda Derna. In mezzo a tanti grattacapi e cose molto se rie alle quali devo accudire è ve r amente disgustoso avere questa goccia continua di fiele che avve lenando t i ti toglie serenità e calma 53 •
Non era che l'inizio del conflitto tra Trombi e Gio litti . Sp ingardi si sforzò a lungo di fungere da mediatore . Ma Giolitti dette evidenteme nte maggior ascolto a Mercatelli, poiché ai primi di agosto del 1912 Trombi venne richiamato in Italia e il suo posto a Derna preso dal generale R eisoli. Si avrà modo di tornare su lla vicenda .
Trombi insisteva sulle difficol tà logistiche e metereologiche che si trovava ad affrontare:
Qui abbiamo avuto una settimana di Na tal e pessima: vento, grandine, pioggia e freddo ci hanno maltrattato, impedito sbarco di materiale, imbarco di truppa per Tobruk, eppoi più di tutto hanno fatto so ffrire le truppe , specialmente il 26 ° , 7 ° e ba tt.e Edolo, i quali privi di baraccamenti (poiché non g iunto ancora il materiale domandato) e senza pag li a vivono ancora sotto le tende, mo lte delle quali il forte vento ha ridotto in brandelli La situazione qui è quale risulta dai miei rapporti; da questi appare anche quali siano i miei progetti pross i mi , t utti subordinati alla sistemazio n e d i una strada rotab ile, ora in costruz ione, che raggiungerà finalmente il sospirato altopiano 54
Mentre a D erna Trombi lavorava alla rotabile, a Tripoli si lavorava al porto; si restaurò la c ittà danneggiata da l bombardamento navale; si ricostruì l'acquedotto, in parte distrutto da una inondazione; si preparò il terreno per stendere i binari delle ferrovie per Gargaresc e Aio- Zara; si provvide all'illuminazione delle princ ip ali stra de ed edific i pubblici e si iniziò la costruzione di un Hangar per dirigibili 55 • Il 16 dicembre però, una bufera fece
52 Luigi Mercatelli, ex in viato de «La Tribuna>> in Africa Orienta le, era all'epoca capo servizio scampa presso il gabinetto del Presidente del Consiglio. V UN IVERSITÀ DEGLI STUDI DI LéC·
CE
• DIPARTIMENTO DI SC IENZE STORICHE E SOCIALI, La formazione della diplomazia nazionale (1861-19 I 5). Repertorio bio -bibliograjico dei fu nzionari del Ministero degli Affari Esteri, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Roma I 987, pp . 492-494 .
S3 RFS, T romb i a Spingardi, Derna , 26 dicembre 191 t.
54 Ibidem.
55 V. L'azione dell'esercito , pp. 80-93.
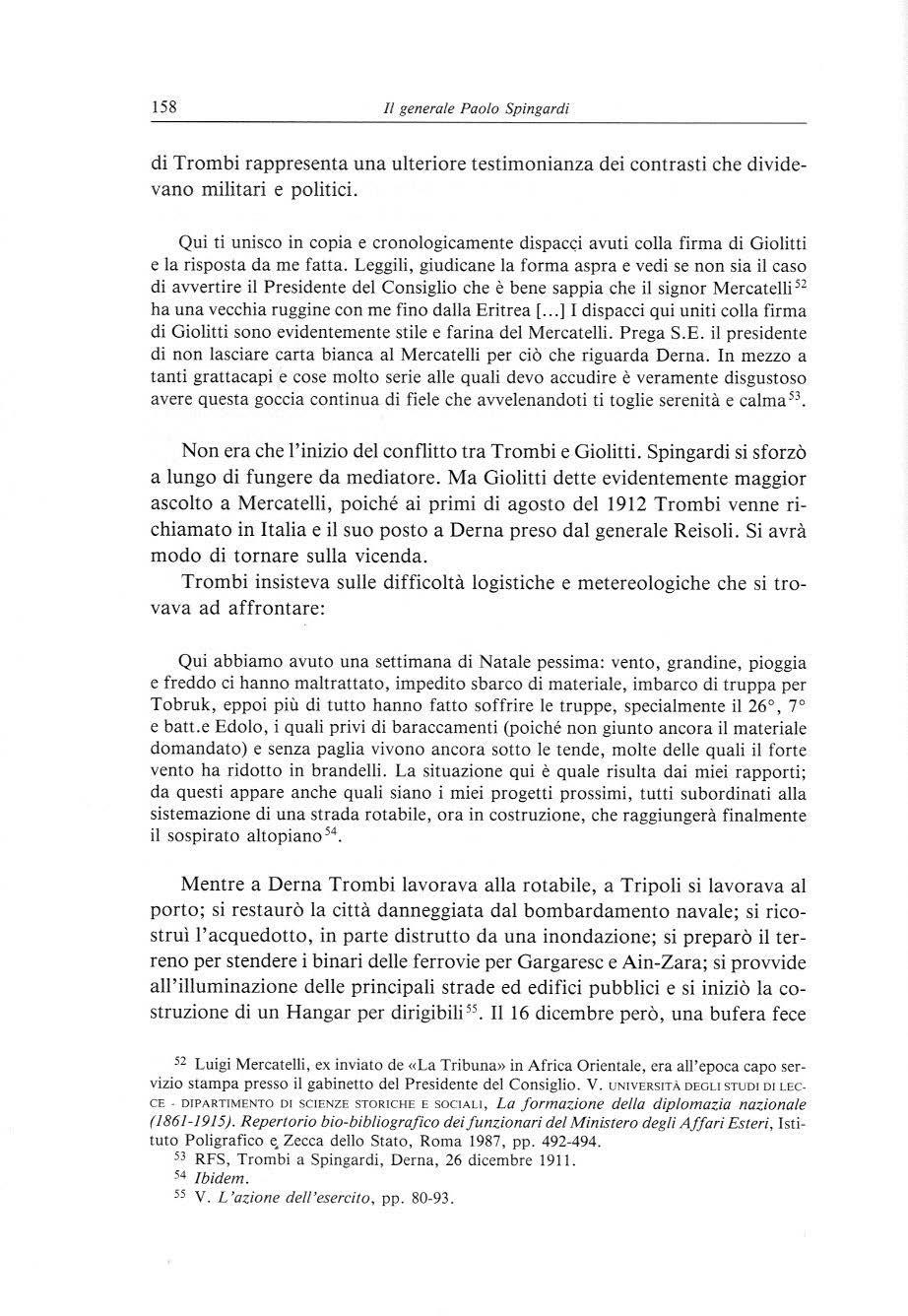
158
li
Militari e politici durante la guerra di L i bia 159
dell'hangar un ammasso di rottami: per questo motivo i dirigibili poterono iniziare i voli soltanto ai primi di marzo del 1912. Spingardi teneva partico larmente all'impiego di questi mezzi aeronautici, tanto che sperava fossero quanto prima in grado di «battere le vie del cielo - un'altra grande soddisfazione per l'aeronautica italiana - ed annientare - così s i diceva - fin l'ultimo fez turco in Tripolitania» 56 • Diversamente la pensava Pallio che non aveva esitato a sconsigliarne l'uso.
Finché siamo nelle attuali condizioni, cioè addossati alla città, e colla presente stagione, col terreno a ll agato, a me sembra poco opportuno mandare i dirigibili [... ] Se il governo e te volete far li andare è inutile discutere. Ma ho creduto mio dovere esporti le mie ragioni contro 57 •
Il vento per il momento diede ragione a Pollio, ma alla fine i dirigibili vennero comunque inviati in Lib ia . Il loro imp iego aveva un significato politico (dimost r are alla Turchia e al mondo la potenza tecnologica dell'Itali a) e psicolog ico (far vedere a i soldati c h e ogni mezzo era uti lizzato per agevolar e il loro compito) che olt r epassava le pu r r agionev ol i considerazioni di ordine squisitamente tatt ico, e che, sfuggito a Pollio, non sfuggiva a Spingardi.
Intanto il tempo passava, nulla accadeva e le autorità politiche desideravano successi decisivi
Il 19 gennaio 1912 il deputato sonniniano ed ex Ministro degli Esteri Francesco Guicciardini si recava da Pallio e gl i parlò «della nostra situazione in Tripolitania e della necessità di far presto» . Secondo il politico «il Gharian era la c h iave strategica e politica di tutta la Tripolitania»; secondo il mili t are, invece, «non vi sono chiavi e non vi è dominio stra t egico fuori della portata del cannone»: erano i punti di vista contrastanti che dividevano militari e po litici fin dall'in i zio della guerra «Non credo affatto di averlo convi nto!» concludeva P olJio scoraggiato eppure convinto delle proprie ragioni 58 •
Allo scopo di spiegare al Preside n te del Consiglio «le ragioni della lentezza con cui la guerra procedeva» 59 , Caneva i nviò a Roma il proprio Sottocapo di Stato Maggiore, l'allora tenente colonnello Gaetano Giardino, che compilò per Spingardi due promemoria nei quali venivano ill ustrati tutti i problemi che rendevano difficile una qualsiasi azione decis i va.
56 RFS, Stralcio di lellera autografa, doc. cit.
s7 RFS, Pollio a Spi ngardi, 18 novembre 191 I.
58 RFS, Pollio a Spingardi, 20 gennaio 1912
59 G1ou rr1 , Memorie, cit., p. 248
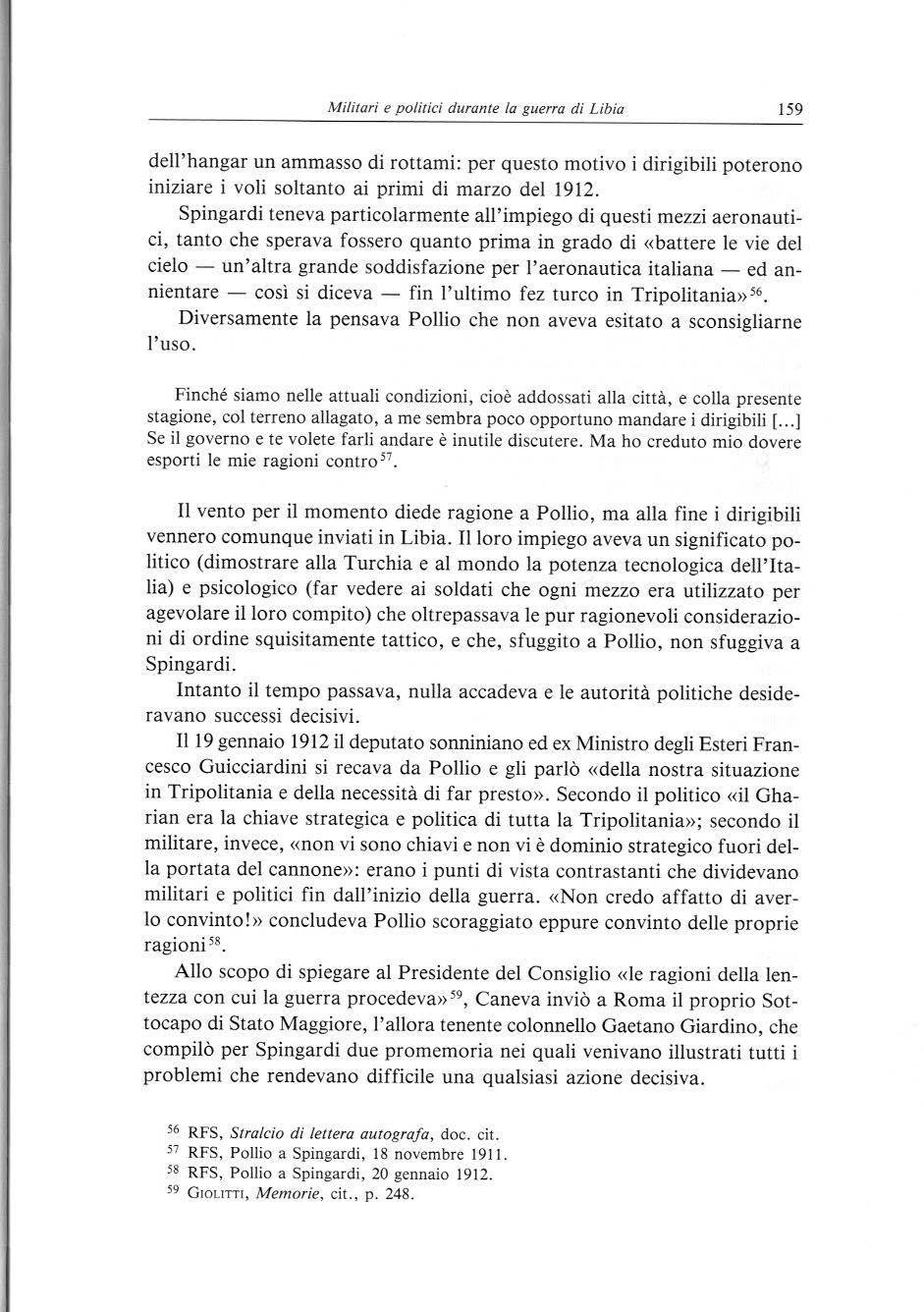 generale Paolo Spingardi
generale Paolo Spingardi
Con molto equilibrio e realismo Giardino metteva in evidenza la difficoltà di sottomettere gli arabi: «Tutte le tribù ci s ono ostili, e più o meno sono in armi contro di noi [... ]si assoggettano ad emigrare in massa nell'interno pur di non restare nel nostro dominio». Giardino illustrò chiaramente la tattica del nemico, che consisteva in non prestarsi ad alcuno scontro decisivo, e sottrarsi costantemente nello spazio illimitato del quale dispone. Le orde arabe, mobilissime , veloci, senza vincoli di basi e di linee di comunica zioni, sono inafferrabili come obiettivo di una operazione di guerra, e viceversa sono presenti ovunque per insidiare ed attaccare le nost r e basi e le nostre linee di comunicazioni per noi vitali.
Giardino elencava poi con precisione le condizioni nelle quali si sarebbe trovata ad operare una eventuale colonna avanzante verso l'interno. Tra tribù ostili, difficoltà nei rifornimenti, mancanza di « in formatori, guide pratiche, cammellieri, lavoratori indigeni, esploratori», con carte topografiche inutilizzabili, l'avanzata correva il rischio di risolversi in uno scacco, assai pericoloso perché poteva «creare un capo unico a tutte le orde arabe, con l'aiuto del fanatismo religioso, e porre le basi di una guerra araba lunga e difficile». E nemmeno l'avanzata avrebbe potuto procedere a tappe (allo scopo di limitare gli inconvenienti logistici). Infatti, data la lor o particolare mentalità, gli arabi avrebbero interp r etato ogni arresto «come un seg no di impotenza» e ne avrebbero tratto motivo di «aumento di aderenti e di più tenace ostilità» 60 • Giardino concludeva sconsigliando in sostanza l'avanzata. La preoccupazione dominante consisteva nel garantirsi da qualsiasi rovescio, tanto che si reputavano appena sufficienti 17 000 uomini, a fronte di forze turco -arabe stimate «da 12 a 15 mila>> uomini 61 • A completare la sua analisi, Giardino inviò a Spingardi un secondo promemoria nel quale calcolava tutti i mezzi necessari a compiere i cento chilometri di avanzata da Tripoli a Ga rian Si trattava di una enorme quantità di mezzi: per dare un'idea, si reputavano necessari non meno di 9.000 cammelli. Si chiedeva Giardino: «Ora, conviene fare un sim ile colossale sforzo di mezzi per una operazione senza obiettivo militare decisivo, ed eseguito con forze appena sufficienti a ga r antire da un rovescio?» 62 La risposta era ovviamente no.
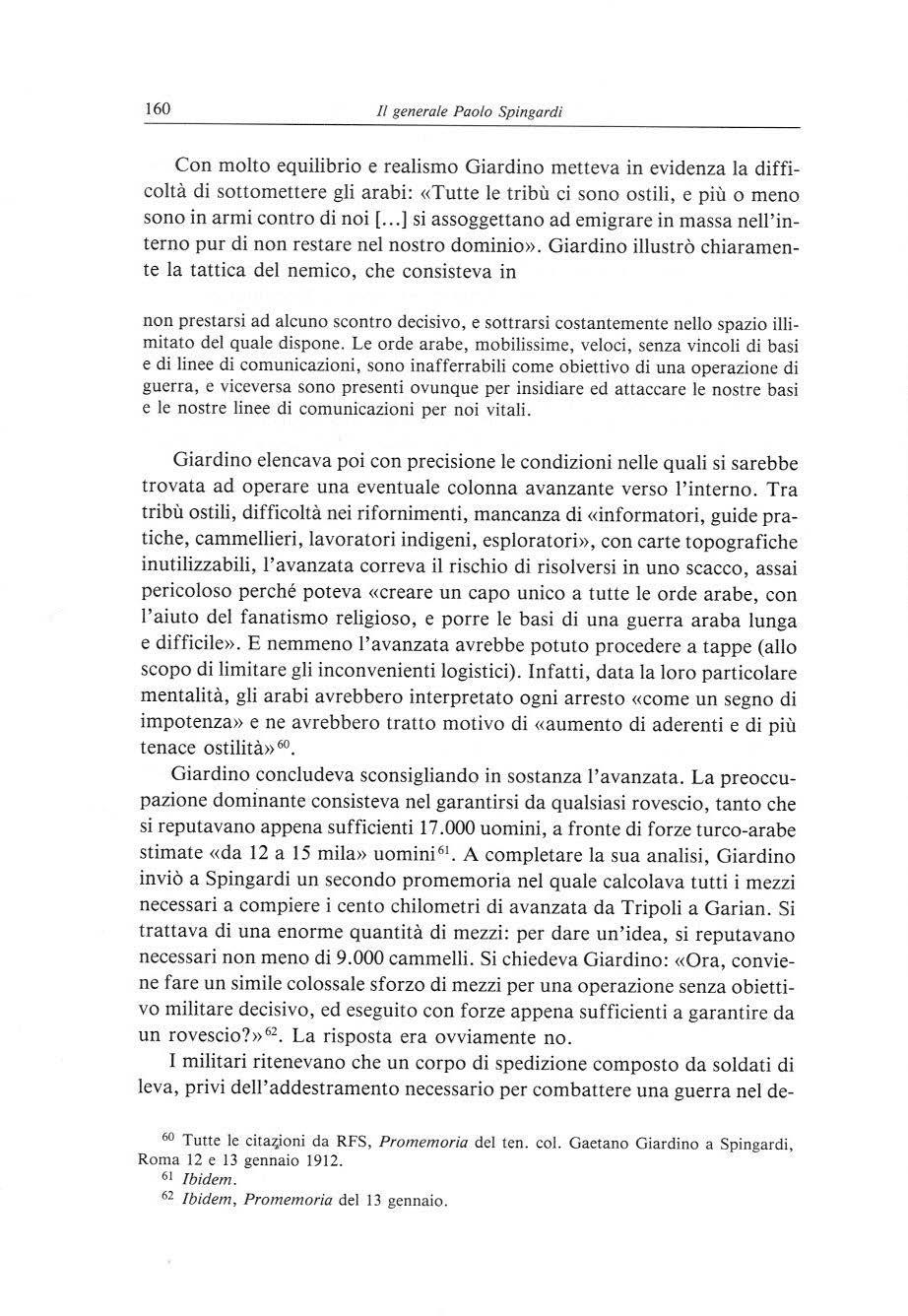
I militari ritenevano che un corpo di spedizione composto da soldati di leva, privi dell'addestramento necessario per combattere una guerra nel de-
60 Tutte le cita~oni da RFS , Prome moria del ten col. Gaetano Giardino a Spingardi, Ro ma 12 e 13 gennaio 1912.
61 Ibidem
62 Ibidem, Promemoria del 13 gennaio .
160
Il
serto, risultasse inadeguato per l'attuazione di operazioni su vasta scala che comunque, data la tattica adottata dal nemico, non avrebbero consentito di raggiungere risultati decisivi . L'Italia non aveva la tradizione che aveva permesso a Francia e Gran Bretagna di crearsi solidi eserciti coloniali. L'invio di truppe eritree e somale, benché se r visse a impressionare la popolazione musulmana 63 , non poteva sostituirsi se non in maniera molto limitata all'invio di truppe dalla madrepatr ia .
L 'insieme di questi fattori, oltre alla stag ione inclemente, valse a impo rre alle trupp e ital iane in L ibi a u na tattica estremamente pru d ente, tanto in Tripoli ta nia, quanto in Cirenaica 64
Spingardi, pu r avendo cercato di premere su Caneva per u n'azione più incisiva, era sostanzia lmente so lid ale con lui 6 5 • Si può c redere c he i promemoria di G ia r dino lo avessero convinto della plausibilità delle ragioni del comandante del corpo di spedizione Perciò, quando Caneva, ai primi di febbraio, venne chiamato a R oma per conferire col Presidente d e l Consiglio, si può pensare che l'appoggio di Spingardi non s ia stato ininfluente nel persuadere Giolitti a concedere a Caneva ancora un pò di fiducia 66 • Anche dall'ambiente di Corte, in verità, erano giunte a Spingardi lamentele su come si erano svolte le opera zioni in Libia . «Non ti sembra che nei combattimenti sinora avvenuti in Africa [ ] ab bi a fatto difetto lo spirito di offensiva ed abbia fatto quasi assoluto difetto la manovra?» domanda va Brusati, che di tutta la campagna fu attento spettatore . Egli ana li zzò il modo di combattere degli italian i in L ibia, ril evan do il grande spreco di munizioni, che andava a incidere negativamente su ll e sco r te in Ita)ja:
A Bengasi [... ) i turco -arabi avanzano in forze sino a circa d ue chil ometri dal nostro fronte difensivo corrispondente al setto r e A (Ameglio). Al solito si apre il fuoco coll'artiglieria, e poiché la distanza di tiro corrisponde a massima efficac ia il nemico s i arresta e poi si ritira Il comandante del settore vicino B (gen Ciancio) non si incarica di quanto avviene; egli non ha nemico di fronte eppure non tenta neppure d i uscire con un buon nerbo di forze dalla propria linea per cadere s ul fianco degli arabi che minacciano il fronte A. A Garga r esc h [... ] la co lonna Fara forte di circa 3.000 fucili, con quattro sq uadroni e con art iglieria, ha di fronte dapprima J50 circa beduini (così dice il teleg ramma ufficia le); più tardi le forze avversarie
63 V. D EL BO CA, pp 163 -1 64.
64 RFS, Trombi scriveva il 14 gennaio 19 12 : « Se il maltempo passa spero di fare qualche cosa di buono a scadenza non lontana; ma se ripiglia il vento, la piogg ia e il freddo (siamo arrivati a + 3) b isognerà attendere ancora». Bri ccola 1'8 febbra io 19 12: «A meno che esigenze politiche imponessero di affrettare le operazioni, il migliore consiglio è di attendere. Il tempo è il migliore alleato nelle oper azioni coloniali »
6 5 Cfr MA LGER 1, cit., p. 288
66 G ooCH , Army, State and Society, cit ., p. 145; D EL BocA p. 16 1; G 10 L1 TT1 p. 248.
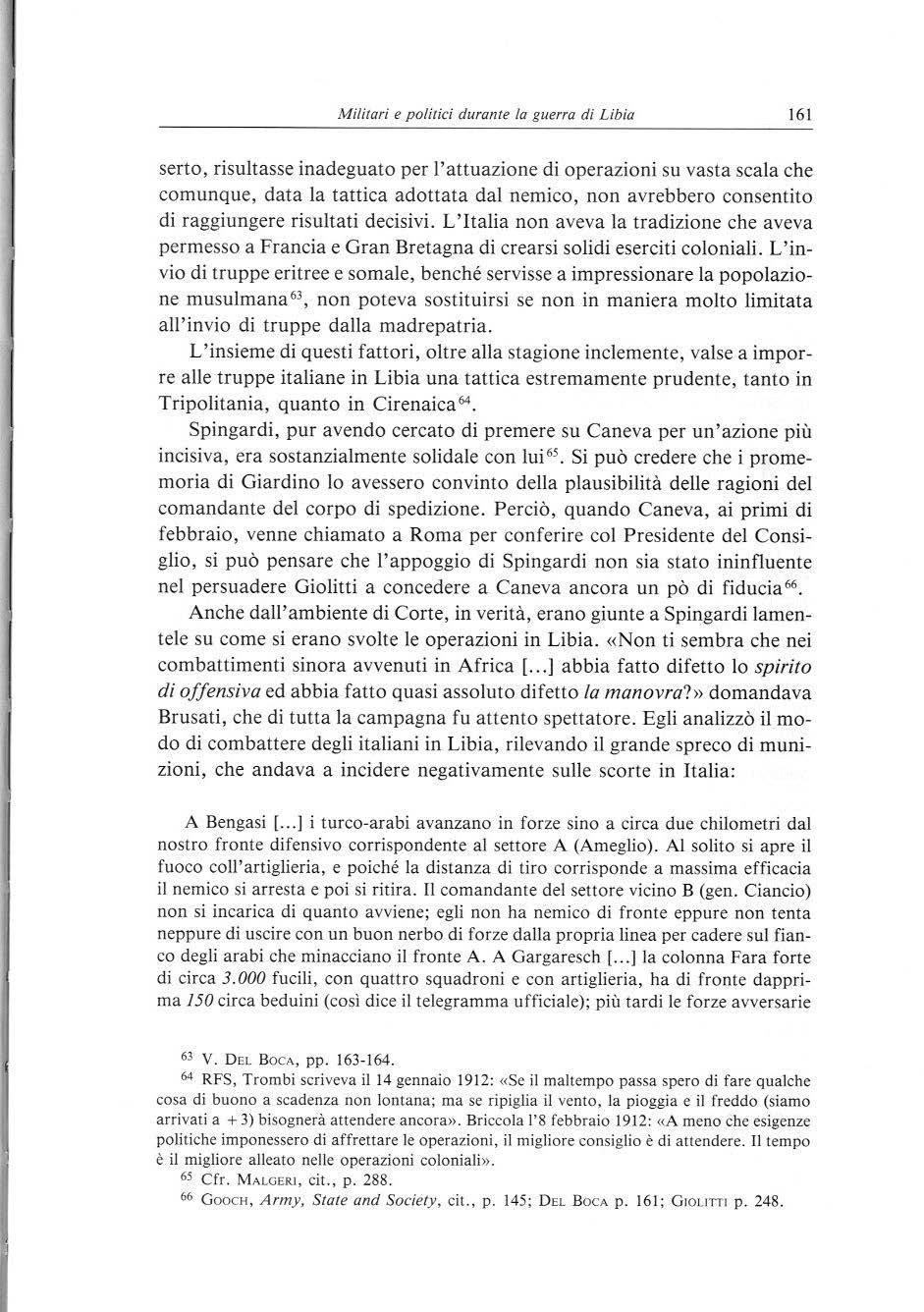
Militari e politici durante la guerra di Libia 161
Spingardi
aumentano e sono valutate (se non erro) a 600 arabo-turchi. I nostri ripiegano sull'orlo dell'oas i ed ivi sostengono e respingono l 'auacco. [ ] I nostri, da quanto risu lterebbe, inseg uono col fuoco, fuoco che in qu el terreno deve esse re stato necessariamente poco efficace [ ] Data la grande distanza alla quale si inizia anche il fuoco di fucileria, si specano munizioni con scarso effetto, e quasi direbbesi si voglia tenere il nemico lontano, quasiché già non si fosse sufficientemente mo s trato inaffe rrabile 67 •
Con la fine di febbraio, però, le truppe italiane ripresero l'ini ziativa. Si combatté a Homs, a Derna, a Tobruk, a Bengasi 68 • Il più importante di questi combattimenti fu quello detto delle «Due Palme », avvenuto nella zon a di Bengasi il 12 marzo 1912 e celebrato in Itali a come la più importante vittoria dall'inizio della campagna 69 •
Ma Gi olitti non si accontentava delle vittorie: voleva anche che esse fossero annunciate dai genera li nella forma più adatta:
Dopo 5 mesi di guerra i nostri generali non hanno ancora imparato neppure a scrivere un telegramma! È una inferiorità intellettuale veramente deplorevole. Da Derna 70 si telegrafa in modo da far credere che si sia avuta una sconfitta. Al Merg heb 71 si sa che avvenne un attacco e ora alle 5 dell'indomani neanche la Pr esidenza del Consiglio sa che cosa avvenne. Tittoni mi ha detto che all'estero si dice che noi abbiamo buoni soldati ma pessimi generali e che perciò poco conto si può fare del nostro esercito. Ed è purtroppo una verità che con dolore vedo confermata sempre più. Se non ci decidiamo a una epurazi one mandando via per insufficienza intellettuale i due terz i dei genera li, le spese militari saranno pur troppo spese improduuive! In Francia la no stra impoten za ad occupare la frontiera Tunisina ci rese addirittura ridicoli! Che non vi sia modo di utilizzare un esercito come il nostro? 72 •
Giolitti non pretendeva certo che i militari fossero dei letterati, ma almeno che sapessero comunicare notizie in modo che il Governo potesse rendersi conto con precisione degli avvenimenli. Ma lo espresse in termini che indussero Spinga rd i a un civilissimo sfogo, legittimo dopo cin que mesi di sop portazione. Costretto a scegliere tra politici e generali, la preferenza del Ministro della Guerra andava senza esitazione a questi ultimi:
li tuo pensiero sui generali dell'Esercito nostro mi era noto; ma oggi la penna ha varcato il segno, e credo anche il tuo pensiero. È vero quello che tu scrivi: i nostri
67 RFS , Brusati a Spingardi, Roma 24 gennaio 1912.
68 V. D F1, BocA, pp. 164- 166.
69 V. Ibidem, p. 166; L'azione dell'esercito, pp 33-35.
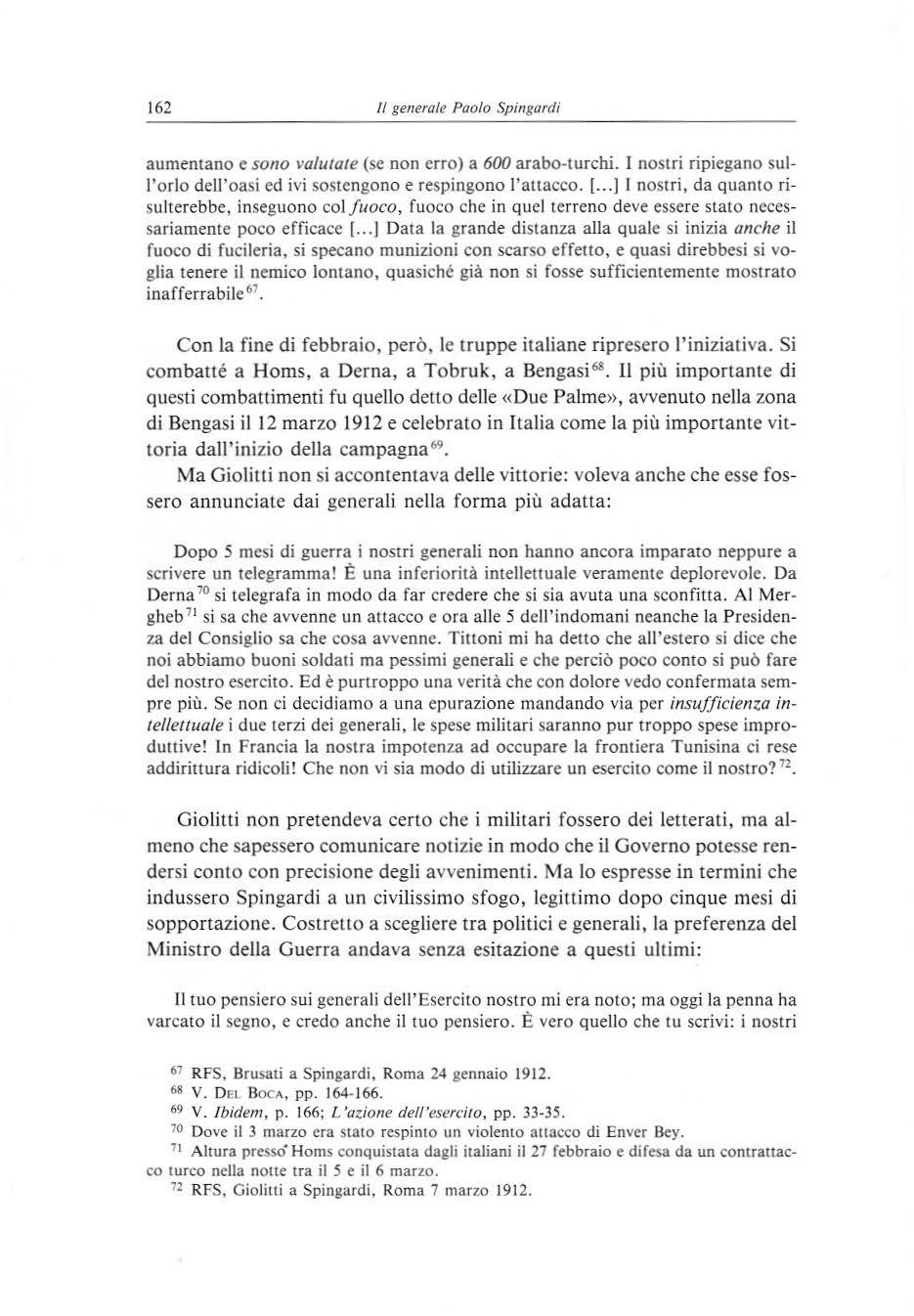
70 Dove il 3 marzo era s tato respinto un violento attacco di Enver Bey.
71 Altura presso Hom s co nquistala dagli italiani il 27 febbraio e difes a da un con1rattacco 1urco nella no1te tra il 5 e il 6 marzo.
72 RFS, Giolilti a Spingardi, Roma 7 marzo 1912.
162
li generale Paolo
generali non sapranno forse scrivere telegrammi, o dettare note diplomatiche come gli amici tuoi San Giu li a n o ed il Sig . Tittoni; non è il loro mestiere. Ma questo però sanno: in cinque mesi di singolare campagna hanno condotto alla vittoria semp re i nostri va lorosi soldati Non uno scacco! Nessun eserc ito del mondo può vantar e nella sua storia coloniale risultati simili , e tanto meno la Francia, di c ui Tittoni riporta lo strano giudizio raccolto non so dove. Non è all'indomani di due sangu inose vittorie che si possa dire questo. Crit iche se ne possono fare s u tutto e su tutti; io stesso ne ho fatte e non le tacqu i: è questione di misura. Il nostro Esercito, per fortuna d'Italia, è a nessun a ltro secondo in tutto e quando dico Esercito intendo capi e solda ti. Questo per dignità e coscienza mia dovevo dirti 73 • Spingardi, in realtà, era arrivato a prevenire lo stesso Presidente del Consig lio , poiché fin da gennaio aveva scritto a Trombi, «delicatamente e gentilmente» rimproverandolo per la forma dei telegrammi 74 : la pregnanza delle informazioni era importante anche per il Ministro della Guerra. Ri salta comunque il nervosismo di Giolitti e la scarsa considerazione da lui nutrita nei confronti della classe militare italiana 7 5 , e la deci s ion e con
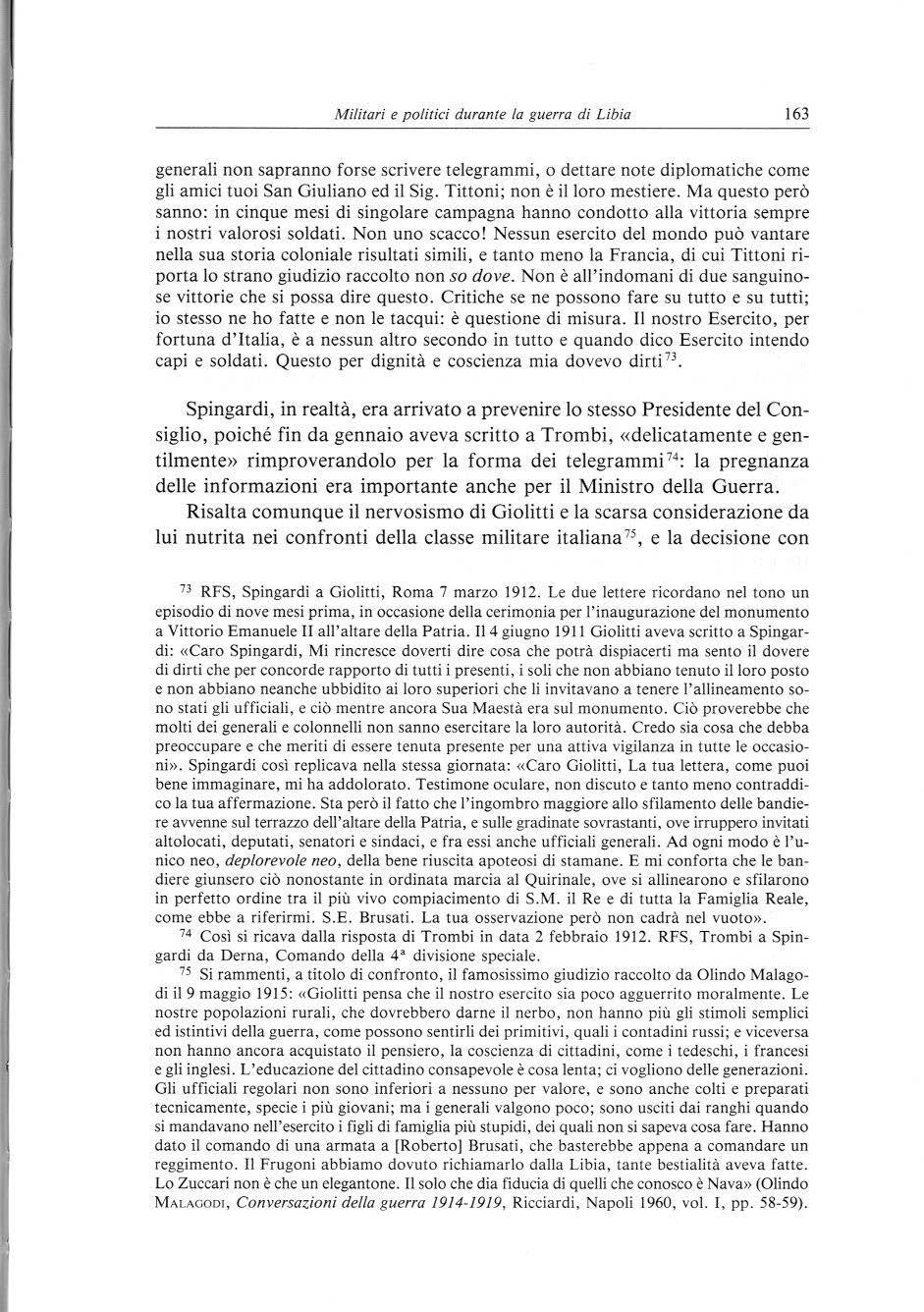
73 RFS, Spingardi a Gio l itti, Roma 7 marzo 1912 Le due lettere r icordano nel tono un episodio d i nove mesi prima, in occasione della cer im onia per l'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele li all'altare della Pa tria. Il 4 g iugno 19 1I Giolitt i aveva serino a Spingard i: «Caro Spingardi, Mi rincresce doverti dire cosa che potrà dispiacerti ma sento il dovere di d i rti che per concorde rapporto di tutti i presenti, i soli che non abb iano tenuto il lo ro posto e non abbiano neanche ubbidito ai loro superiori che li invitavano a tenere l 'allineamento sono stati g li ufficia l i, e ciò mentre ancora Sua Maestà era sul monumento. Ciò proverebbe che molti dei generali e colonnelli non sanno esercitare la lo ro auto rità. Credo sia cosa che debba preoccupare e che mer iti di essere tenuta presente per una att iva vigi lanza in tutte le occasioni» Spingardi così replicava nella stessa giornat a: «Caro Giolitti, La tua lettera, come puoi bene immaginare, mi ba addo lora to. Testimone ocu la re, non discuto e tanto meno contraddico la tua affermazione. Sta però il fatto che l'ingombro maggiore allo sfilamento delle bandiere avvenne sul terrazzo dell'altare della Patria, e sulle gradinate sovrastanti, ove irruppero invitati altolocati, deputati, senatori e sindac i, e fra essi anche uffic iali genera li Ad ogni modo è l'unico neo, deplorevole neo, della bene riuscita apoteosi di stamane. E mi conforta che le bandiere giunsero ciò nonostante in ord inata marcia a l Quirinale, ove si allinearono e sfilarono in perfetto ordine tr a il più vivo compiacimento di S.M. il Re e d i tutta la Famiglia Reale, come ebbe a riferirmi. S E. Brusati. La tua osservazione però non cadrà nel vuoto».
74 Così si ricava dalla risposta di Trombi in data 2 febbraio 1912. RFS, Trombi a Spingardi da Derna , Comando della 4• divisione speciale.
7 5 Si rammenti, a titolo di confronto, il famosissimo giudizio ra cco l to da Olindo Malagodi il 9 maggio 1915: «Giolitti pensa che il nostro esercito s ia poco agguerr ito mora lmente Le nostre popolazioni rurali, che dovrebbero darne il nerbo, non hanno più gli stimoli semplici ed istintiv i della guerra, come possono sentirli dei primitivi, quali i contadini russ i; e viceversa non hanno ancora acquistato il pensiero, la coscienza di cittad ini , come i tedesch i , i frances i e gli inglesi. L'educazione del c ittadino consapevo le è cosa lenta; c i vogliono del le generazioni Gli ufficiali regolari non sono inferiori a nessuno per valore, e sono anche colti e preparati tec nicamente, specie i più giovani; ma i generali va lgono poco; sono usc iti dai ranghi quando si mandavano nell'esercito i figli d i famiglia più stupidi, dei quali non si sapeva cosa fare. Hanno dato il comando di una a rma ta a [Roberto) Brusati, che basterebbe appena a comandare un reggimento. Il Frugoni abbiamo dovuto richiamar l o dalla Libia, tante bestialità aveva fatte. Lo Zuccari non è che un elegantone. Il solo che dia fiducia di quelli che conosco è Nava» (Olindo MA LACODI , Conversazioni della guerra 1914 - 1919, Ricciardi, Napo l i 1960, voi. I , pp. 58-59).
Militari e politici durante la guerra di Libia 163
la quale un militare, benché investito di funzioni politiche, difendeva la propria categoria attaccata da una forza «estranea».
Ciononostante si cercò di venire incontro ai desideri di Giolitti accelerando le operazioni: ripresero perciò studi per l'occupazione di Zuara.
Al solito, si manifestarono punti di vista contrastanti. li 10 marzo 1912, Tommaso Tittoni, all'epoca ambasciatore italiano a Parigi, si recò a colloquio da Spingardi . A vreb be voluto l'occupazione della baia e della penisola di Said-Ali, a occidente di Tripoli, verso il confine tunisino, e Zuara e Zanzu r. A Spingardi che obiettava che così si sarebbe estesa pericolosamente e inutilmente la base di operazione lungo la costa, Tittoni rispose scrivendogli che «le ragioni politiche e morali» erano preponderanti, e perciò gli pareva che «adott and o il progetto di esecuzione più facile della occupazione di Zuara dopo quella della penisola di Said-Ali si contemperino in giusta misura le conside razioni militari e le esigenze d 'ordine politico e morale». Ri velatore il linguaggio: i militari facevano solo «cons iderazioni », mentre i politici avevano «esigenze». E per Zanzur
a noi non dovrebbe riuscire difficile insediarci. Noi abbiamo accettato la sottomissione degli arabi di Zanzur. Non possiamo abbandonarli ai turchi. È per noi una questione di onore. L'occupazione di Zanzur ci sarà di valido ausilio nella propaganda presso gli arabi.
Non si discutono le questioni di onore, ma viene da domandarsi perché si sia ricercata la sottomissione di pop olazi oni prima di essere in grado di proteggerle da eve ntu ali ritorsioni dei turchi. Comunque, alle idee di Tittoni si opponeva nettamente il Capo di Stato Maggiore. Tittoni si era recato da Spin ga rdi proprio per fare in modo che anche Pollio riconoscesse l'opportunità che le esigenze d'ordine politico e morale si contemperassero con le considerazioni militari 76 •
Spingardi si sforzò di assume re una posizione equidistante tra i due contrastanti punti di vista, delineando in alcuni appunti un piano che prevedeva l 'occupazione di Zuara senza però sp in gersi fin dove avrebbe desiderato Tittoni.
Non condivido interamente il pensiero del Capo di Stato M.re. Ammetto che la occupazione progettata a Capo Macabez pres enti serie difficoltà, ma non in superabili, e c he quindi convenga di tentarla. Però mi domando se date queste difficoltà, e sopratt utto il dubbio sollevato dal Capo di Stato M.re circa la possibilità di far vivere convenientemente le nostre truppe in quella inospite plaga, non sia il caso
76 Tutte le cita1ioni da RFS, lettera di T ommaso Tiuoni a Spingardi in data IO marzo 1912, s u carta del Senato del Regno.
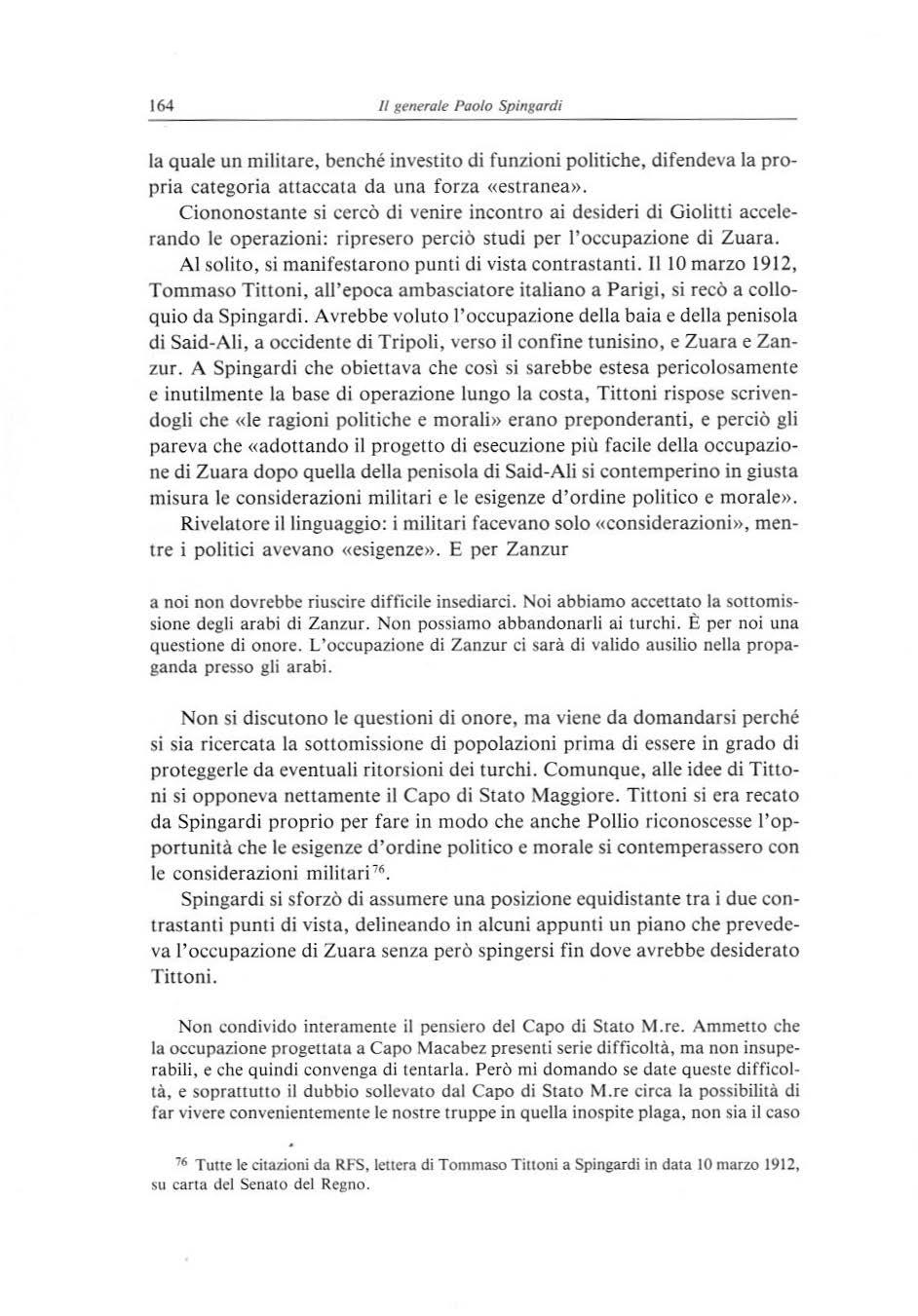
164 li
generale Paolo Spingardi
Militari e politici durame la guerra di Libia 165
di tornare alla idea prima di Zuara. Come azione s ulla carovaniera è quasi la stessa, anzi per certi riguardi maggiore. Si sbarra direttamente la carovanier a litoranea; si agi sce su lla b i forcazione a sud, a distanza poco maggiore che da Bu Chemez, e di più s i minaccia anche a Regdaline la carovaniera di Ben Gardanne. Lo sbarco a Zuara sarà forse più difficile, ma la so rpre sa e l'azione dei dirigibili possono re nderla possi bile s pecie se combinata con una minaccia d'azione da Tripoli verso l'interno, che richiami da quella parte le fo r ze t u rco -arabe. Ad ogni modo t ra tt isi di Ca po Macabez o di Zuar a io ri tengo che una occupazione da quella parte debba t entarsi : è evidente il duplice sc opo politico e militare d i grandissima im portan za 77 •
Il 22 marzo Giolitti tornò a palesare a Spingardi preoccupazioni circa le op inioni degli stranieri e per richiamare l'at te n zione del Ministro della Guerra sulla que st ione g li spedì lo st ralcio di una lettera che « persona autorevole, di nazionalità inglese, la qual e ha avuto occasione di seguire le nostre operazioni militari in Tripolitania>> aveva scritto a un suo amico criticando la condotta militare italiana 78 • Ancora una volta Spingardi si vide costretto a scrivere a Caneva per incitarlo all'azione:
Il nostro prest igio militare a Tripoli è moto d iscusso In altri term ini ancora una volta si lamenta la nostra.. . inazione ! E si dice che essa abbia , e forse ha di fatto, una grave ripercussione sulla politica estera. [... ] Que s to ed altro si dice qui, e pur t roppo si scrive di costà anche da ufficiali di var io grado ; e questo pur troppo ha presa e determina correnti di opin ione pubblica non favorevoli al nostro prestigio . Qu es to ho voluto dirti pe r ché t u lo sappia; ripeto, non il Ministro, è l' amico che ti sc ri ve : tu giudica e ... manda . Se parallelamente alla occupazione de l no t o punto della costa oc cidentale vi fosse qualche attività attorno a Tripoli l' effetto s arebb e ottimo 79 •
Pochi giorni dopo, le operazioni presero l'andamento auspicato Il 10 aprile infatti avvenne lo s barco sulla penisola di Macabez (o Bucamez o ElMachbez), tra Zuara e il confine tu ni sino 8°. Scopo dello sbarco era di ostacolare il cont r abbando di armi e materiali dalla Tuni sia. Occupata la penisola di Ferua e poi il fort in o di Bu-Chemesc, se ne fece una base per incursioni all'interno 81 •
77 RFS, Appunto autografo di Pa olo Sp ingar d i su carta de l l'vlinistero della Guerra, s.d. ma senza dub bio del marzo 1912 L'appunto te rmina va così: «Quanto a i mezzi e alle modal ità p roposte nulla da osser vare; ma dubito si possa pres to togliere 1'89° da Homs ; certo non ora. Bensì s i potrebbe mandare da T ripo li un a ltro reggimento a Homs col pre testo d i rinfo rzarne la di fesa , e poi farlo part ire d i là per la nuova impresa. Ma su ciò è g iudice so lo il Gene rale Caneva» .
78 R FS, Giolitt i a Sp ingard i, Roma 22 marzo 19 12 (P e rsona le)
79 R FS , Sp inga rdi a Caneva (Copia), Roma 30 marzo 1912.
80 V. D EL Boc A, p. 167, L 'azione dell'esercito italiano, p. 40.
8 1 V. L'az ione dell'esercito, p 41.
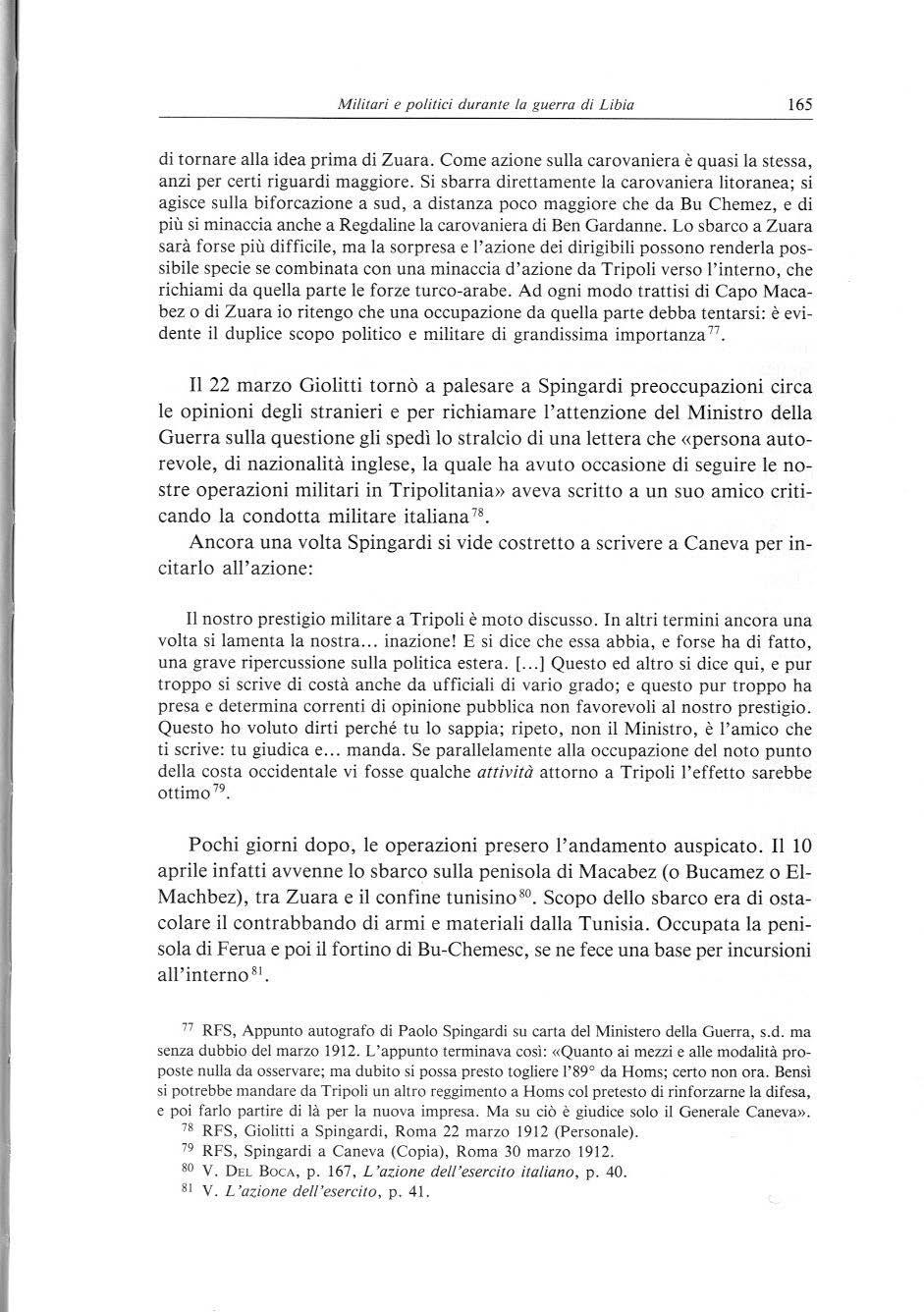
li generale Paolo Spingardi
Subito dopo lo sbarco Caneva telegrafò a Roma, forse aspettandosi un plauso per essere finalmente uscito dalla inazione. Spingardi trasmise il telegr amma a Giolit ti che osservò: « Dire al mondo ch e da sei mesi pen savamo a fare cosa riuscita così facile mi pare che non convenga» 82 • Stava diventando chiaro che se si voleva vincere la guerra sareb be stato necessario colpire la Tu rchia in un punto vu ln erabile fuori dalla Lib ia.
Fin dall'ini z io dell e ost ili tà si era co mb attuto anc h e nel Mar R osso . Di questo teatro di operazioni non esiste traccia alcuna tra le carte del generale Spingardi, a conferma del fatto che «Giolitti considerò il Mar R osso co me un suo esclusivo terreno di caccia» 83 , se n za coinvolgervi nemmeno il Ministro della Guerra . Ma neanche ne l Mar Rosso si ott ennero risultati decisivi.
Da tempo i militari, in special modo la Marina , premevano per spostare il cent ro dell'azione italiana verso le isole turche dell' Egeo 83 Una forte opposizi on e veniva però dall'A ustria 85 •
Al termine di serrate trattative, graz ie anche all'intervento tedesco, il Governo di Vienna acconsentì all'occupazione temporanea di tre isole dell'Egeo 86 .
Verso metà aprile venne pre sa la deci s ione definit iva, ma si d ovette ritardare di alcuni giorni per difficoltà nel reperire i piroscafi per il trasporto delle truppe e dei materiali: «Mi dispiace assai che i piroscafi si rendano disponibili con tanto stento . La nota operazione subi rà qualche ritard o; speriamo che si tratti soltanto di pochi giorn i» 87 •
Nell'ultima decade di aprile del 19 12 fu riunito a Tobruk, agli ordini del generale Ameg lio, un corpo di sped izion e che sbarcò a Rodi il 4 maggio Il p residio turco, che s i era ritirato nell'interno, si arrese aIJe ore 8 del
82 RFS, Gioliui a Spingardì, Roma 12 aprile 1912. li 1esto completo s uona così: «Caro collega, Ho letto il 1elegramma di Caneva. È una sua difesa ma piuttosto povera e non la pubblicherei perché non può farlo asso l vere ma tulio al più può fa r gli dare le circostanze attenuant i Dire al mondo che da sci mesi pensavamo a fare cosa r iuscita così facile mi pare che non convenga. Cor diali sa luti. Aff. Giolitti » . È facile ritenere che senza l'appoggio di Spingardi Caneva sareb be stato rimosso assai prima dell'agosto 1912.
83 DE1 BocA, nota 37 a p. 168.
84 Cosi affermano Da BocA, p. 169 e GoocH , p. 145: « Having failed 10 entice out the Turkish fleet , the ita l ian navy revened to an idea proposed at thc end of March by Admiral Fara velli to occupy thc Turkish Aegcan islands>>. 011 ho trovato ind izi che inducano a ri1e11ere Spingardi tra i fautori dell'impresa. In base a quanto conosciamo della sua personalità riteniamo pensasse che, agendo con più audacia in Lib ia, si sarebbe potuto risolvere ugualmente il conllitto senza creare altre complicazioni internazionali. Ad ogni modo non si oppose alle operazioni nell'Egeo .
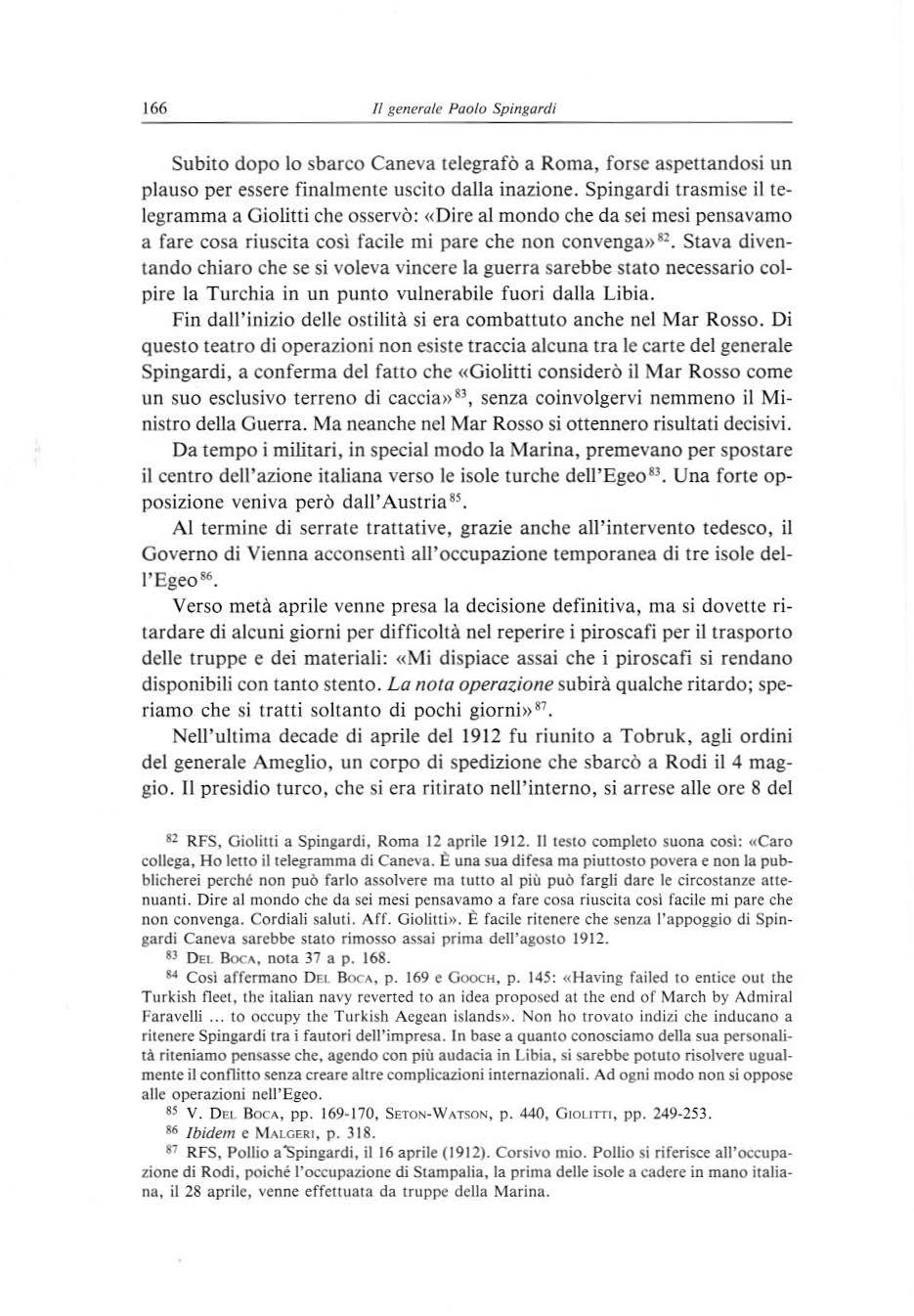
85 V. DE1 BocA , pp. 169-170, SETON-WA TSON , p. 440 , G1ourn, pp. 249-2 53.
86 Ibidem e M ALGERI, p. 318.
87 RFS , P ollìo a'Spingardi, il 16 aprile (1912). Corsivo mio. Polli o si riferisce all'occupazio ne di Rodi , poiché l'occupazione di Stampalia, la prima delle isole a cadere in mano italiana, il 28 aprile , venne effettuata da truppe della Marina.
166
17 maggio 19 12 88 • Di estremo interesse le istruz ioni c he Gi ol itti inviò a S pingardi circa il com portamento da tenersi non appena effettuata la conq uista dell'isola.
Su l culto raccoma nd erei il rispetto di tutti i culti e specialmente d el m u sulmano dove esiste, p erché sarebbe arma contro di noi se facessimo atti d i into ll eran za ve r so la popolazione musulmana. Corrispondenti di gio rn a li no n ne ammett erei alcuno in modo assoluto po ich é le corrispo ndenze che ecc itassero il mondo ellenico sarebber o perico lose e non vo rr ei una n u ova campagna di pretese atrocità dei solda t i. Il servizio sanitario deve lasciars i come è; noi pe n siamo so lo alle truppe Quanto al servizio p ostal e si vedr à il da fare dopo lo sb arco, e se si può si potrà anche utilizzare quello ch e es iste. Q uando la città sia occupata bisogna verificare s u bito le casse d ello st a t o per impedire o furti di sciacalli o le spedi z ioni di de n ar i al gove rno turco 89 •
Erano consi d erazioni legitt ime e d e notano una certa lungimiranza, ma sembrano anche p r eoccu p azion i burocratic he a lqu a nto premat u re , dato che i sol d ati italiani non avevano ancora messo pie d e sull'i s ol a.
Imm edia t amente do po lo sba rc o, Spi ngard i inviò a P ollio alcune osservazioni del Ministro degli Este ri sulle ope r azioni m il itari d a eseg u irsi in Lib ia a seguito d e ll a o ccu p azi o ne d i Ro di.
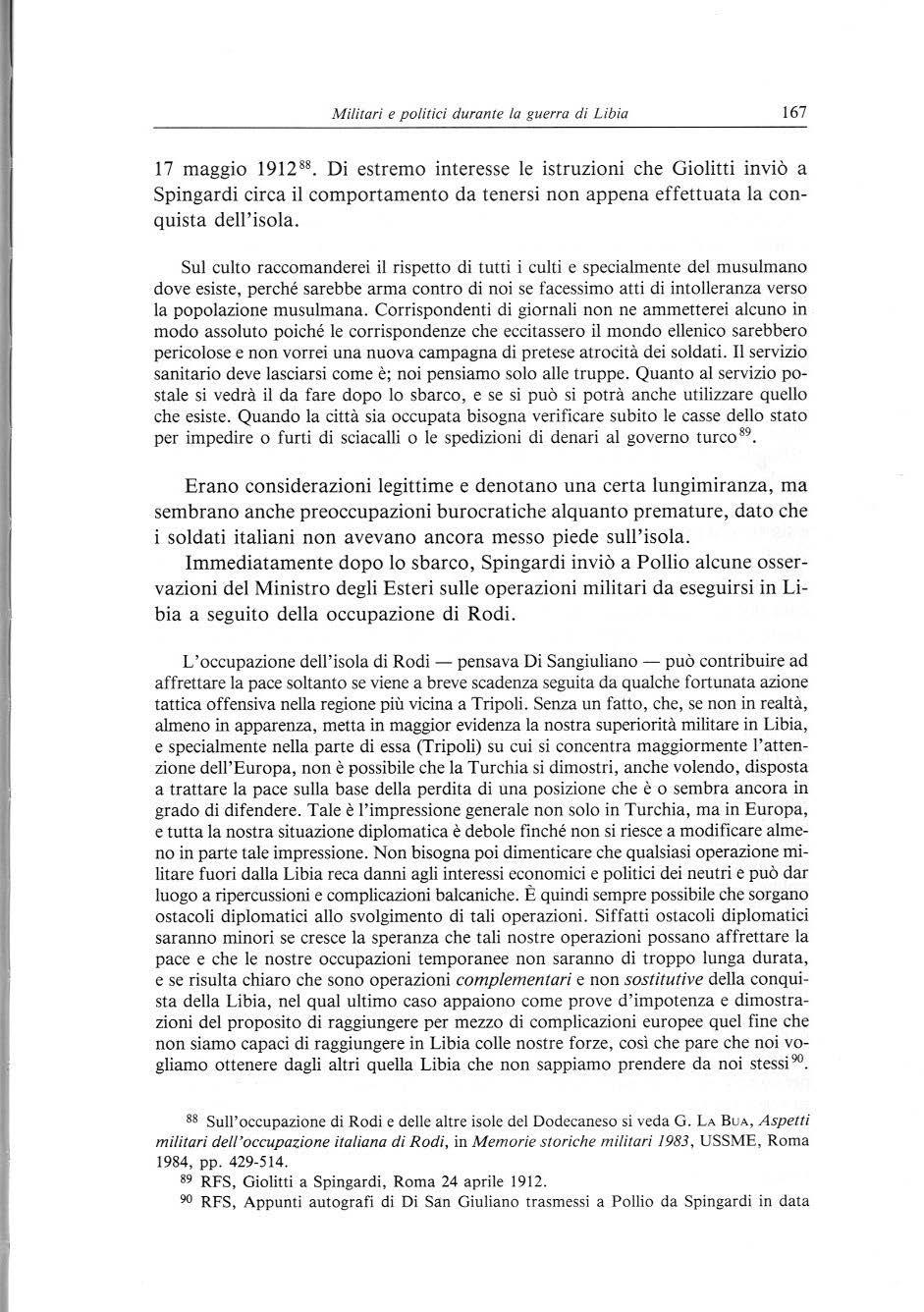
L'occ upazione dell'isola di R odi - pensava Di Sangiuliano - può contrib uire a d affrettare la pace soltanto se viene a breve scadenza seguita da q u alche fort u nata azione tat tica offensiva nella regione pi ù vicina a Tripoli . Senza un fatto, che, se non in realtà, almeno in apparenza, metta in maggior ev id enza la n ostra superi orit à militare in Libia, e specialm ente nella parte di essa (Tripoli) su cui si concentra maggiorme n te l 'at t enzio n e de ll 'Eu ropa, non è possib ile che la Turchia si dimostri, anche volendo, dis p osta a trattare la pace su ll a base d ella perdita di u n a posizione che è o sem b ra anco r a in g r ado di di fen d ere. Tale è l'impressione generale non so lo in Turch ia , m a in Eur o p a, e tu t ta la nostra situazione di pl omatica è debole finché n o n si riesce a modificar e almeno in parte tale impress io n e . Non b isog n a p o i dimenticar e che qualsias i ope razione militare fuori dalla L ibia reca danni agli interessi economic i e po li tici dei n eutri e p u ò dar luogo a ripercussioni e complicazion i balcanich e . È quin d i sempre possibile che sorgano ostacoli diplomatici allo svolgimento di t ali o p erazioni. Si ffatti ostacoli dip lomatici saranno nùnori se cresce la speranza che tali nostre oper azioni possano affr ettare la pace e ch e le nostre occupazio ni temporan ee non saranno di troppo lunga durata, e se risulta chi aro che sono operazioni complementari e no n sostitutive della conq uista della L i bia, nel qua l u lt imo caso appaiono come prove d'impotenza e d imostrazioni del prop o sito di raggiungere per mezzo di comp li cazioni europee quel fine che non siamo capaci di raggiungere in Libia colle nostre forze, così che pare c h e noi vogliamo o ttenere dagli altri que ll a L ibi a che non sappiamo pren d er e da noi stessiw.
88 S ull'occ upazione di Rod i e delle altre iso le de l Dodecaneso si veda G. LA Bu A, Aspetti militari dell'occupazione italiana di Rodi, in Memorie st orich e militari 1983, USSME, Roma 1984, pp. 429-514.
89 RFS, Giolitti a Spingar di, Roma 24 apr il e 1912
90 R FS, Appun ti autografi di Di San Giuliano trasmessi a Pollio da Spingard i in data
Milirari e politici durante la guerra di L ibia 167
Pollio, da persona intelligente qual'era (e dopo otto mesi durante i quali si era dovuto sorbire, suo malgrado, continue lezioni di politica estera), aveva intuito che le operazioni nell'Egeo non sarebbero bastate a placare l'ansia dei civili al governo e già il 2 maggio aveva scritto in via privata a Caneva per indurlo a temare qualcosa di almeno apparentemente risolutivo in Libia .
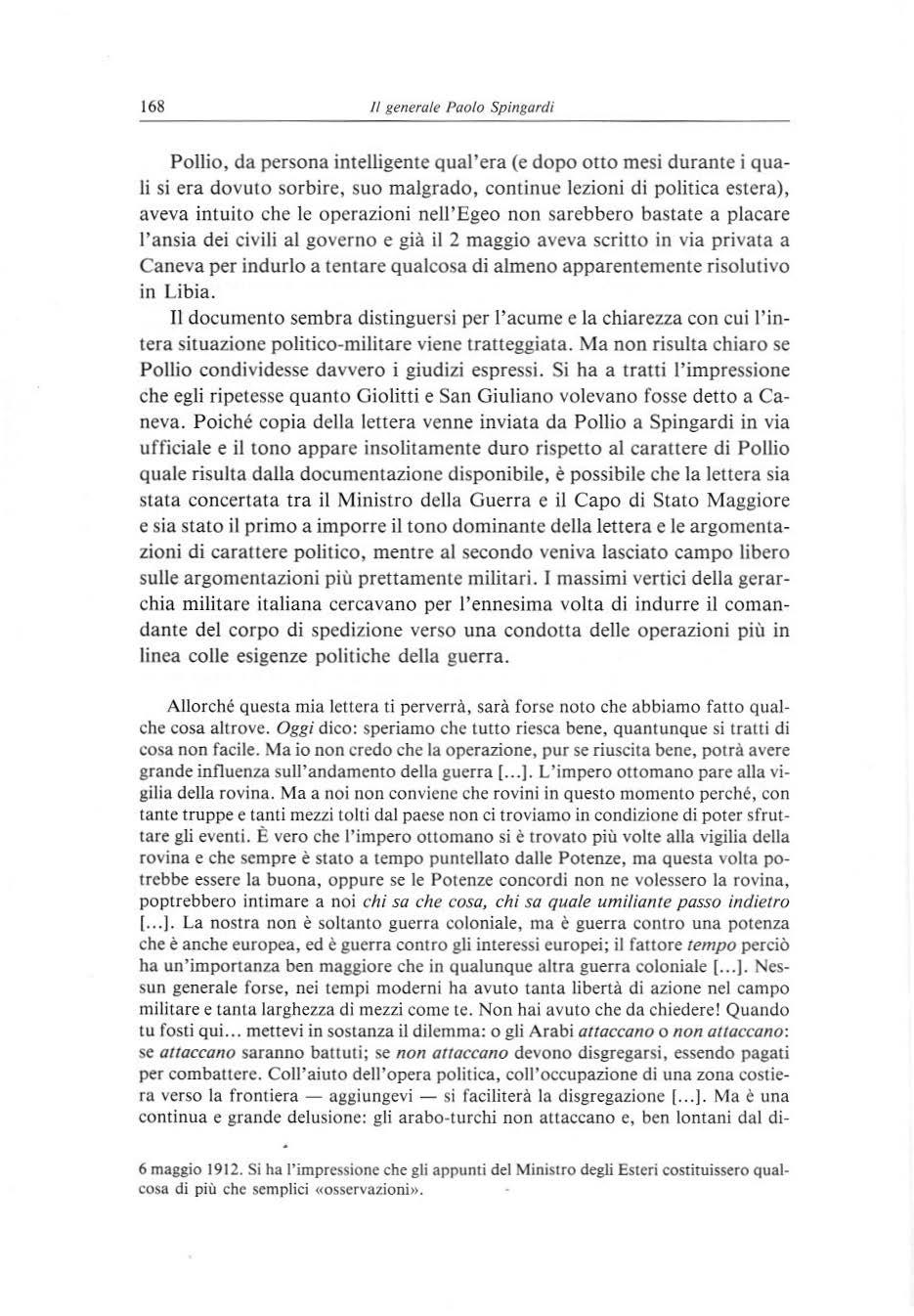
Il docum ento sembra distinguersi per l'acume e la chiarezza con cui l'intera sit uazione politico-militare viene tratteggiata. Ma non risulta chiaro se Pollio condividesse davvero i giudizi espressi. Si ha a tratti l'impressione che egli ripetesse quanto Giolitti e San Giuliano volevano fosse detto a Caneva. Poiché copia della lettera venne inviata da P ollio a Spingardi in via ufficiale e il tono appare insolitamente duro rispetto al carattere di Pollio quale risulta dalla docum entazione disponibile, è possibile che la lettera sia sta ta concertata tra il Ministro della Guerra e il Capo di Stato Ma ggiore e sia stato il primo a imporre il tono dominante della lettera e le argomentazioni di carattere politico, mentre al secondo veniva lasciato campo libero sulle argomentazioni più prettamente militari. J massimi vertici della gerarchia mi litare italiana cercava no per l'ennesima volta di indurre il comandante del corpo di spedizione verso una condotta delle operazioni più in linea colle esigenze politiche della guerra.
Allorché questa mia lette ra t i perverrà, sarà forse noto che abbiamo fatto qualche cosa altrove. Oggi dico: speriamo che tutto riesca bene, quantunque si tralti di cosa non facile. Ma io non credo che la operazione, pur se riuscita bene, potrà avere grande influenza sull'andamento della guerra[ ... ]. L'impero ottomano pare alla vigilia della rovina. Ma a noi non conviene che rovini in questo momento perché, co n tante truppe e tanti mezzi tolti dal paese non ci troviamo in condizione di poter sfruttare gli eventi. È vero che l'impero ottomano si è trovato più volte alla vigilia della rovina e che sempre è stato a tempo puntellato dalle Potenze, ma questa volta potrebbe es sere la buona, oppure se le Potenze concordi non ne volessero la rovina, poptrebbero intimare a noi c hi sa che cosa, chi sa quale umiliante passo indietro ( .. . ] . La no stra non è so ltanto guerra co loniale, ma è guerra contro una potenza che è anche europea, ed è guerra contro gli interessi europei; il fattore tempo perciò ha un'importanza ben maggiore che in qualunque altra guerra coloniale [... ). essun generale forse, nei tempi moderni ha avuto tanta libert à di azione nel campo militare e tanta larghezza di mezzi come te. Non hai avuto che da ch iedere! Quando tu fosti qui. .. mettevi io sostanza il dilemma: o gli Arabi attaccano o non attaccano: se attaccano saranno battuti; se non auaccano devono disgregar si, essendo pagati per combattere. Coll'aiuto dell'opera politica, coll'occupazione di una zona costiera verso la frontiera - aggiungevi - si faci literà la disgregazione [ ] Ma è una continua e grande delu sione: gli arabo -turchi non attaccano e, ben lontani dal di-
6 maggio 1912. Si ha l'impressione che gli appunti del Ministro degli Esteri costituissero qualcosa di più che se mplici «osse rvazioni »
168
Il generale Paolo Spingardi
sgregarsi, sono più forti o almeno più numerosi di prima. [... ] In guerra non si può cons iderare una situazione, sia pure invariata, in modo invariabile. [ ... ] L'opinione pubblica, che in Italia ha tanta influenza può modificarsi, può mutare Si può trovare lunga la guerra e si può trovare strano che tu abbia ch iesto tanti mezzi di trasporto per poi rimanere sempre nella stessa situazione dietro le trincee Già sulla stampa si crit ica, si disapprova. Siamo pienamente d'accordo che questo non deve fare impressione , ma d'altra par te essendo la guerra un atto politico per eccellenza, non è possibile fare astrazione dalla politica internaziona le e dalla po li tica interna. Ma facciamo pure astrazione da tutto questo, e consideriamo la situazione tua, esclusivamente tua, sotto l'aspetto politico militare. Non è proprio possi bile fare nulla per «aumenta r e il territorio da noi effettivamente occupato e per rialzare il nostro prestigio militare?». E questo a ll orché il nemico è tanto vicino a noi che una parte di esso ad es. quella che occupa Fonduk Toktar è quasi sotto il tiro delle opere di Gargaresch? Si dice che se andiamo in forze ad attaccarlo , esso non ci aspetterà e noi punteremo nel vuoto Ma quando è ciò avvenuto? E se noi rimanessimo dove saremo giunti, non otterremo con ciò lo scopo di allargare il territo rio da noi occupato e di aumentare il nostro prestigio militare? [ ] E se il nemico non attacca e si ritira non è importante moralmente far dire e dimostrare col fatto c he siamo padroni dei nostri movimenti? In conclusione dunque, caro Caneva, io credo che se lasciamo ancora passare alcune altre settimane e andiamo incontro alla feroce estate africana, non potremo far più nulla , e bisognerà allora aspettare l'autunno. E credo che si possa invece non aspettar o ltre e far qualche cosa per attuare o almeno avvicinarci agli obiettivi che ci siamo proposti 91
Do po otto mesi di campagna anche Pollio e Spingardi cominciavano a ritenere troppo prudente l'atteggiamento di Caneva . D a parte loro si era fatto il possibile per facilitarne il compito; gli erano state mandate tutte le truppe che aveva chiesto, e altre si era disposti a mandarne. Lo si era protetto dalle sfuriate dei politici, ma ora la situazione era divenuta assai difficile: «l'opinione pubblica può mutare» .. .
Caneva rispondeva con ragioni valide, ma non riusciva comunque a comprendere il peso che le question i di ordine internazionale avevano per Giolitti e Di San G iuliano, e che anche Spingardi, in fondo, comprendeva. Caneva anzi non si rendeva neanche conto della sua stessa posizione: a leggere tra le righe, la lettera di Pollio è un vero aut-aut.
Il coman dan te del corpo di spedizione opponeva argomentazioni plausibili, coglieva l'errore politico originario e cioè essersi «accinti ad una impresa difficile, necessariamente lunga» senza averne la chiara coscienza. Ma dato questo, Caneva persisteva nell'errore imputatogli da Pollio, e cioè di «considerare una situazione, sia pure invariata, in modo invariabile». Continuava infatti a ritenere necessario
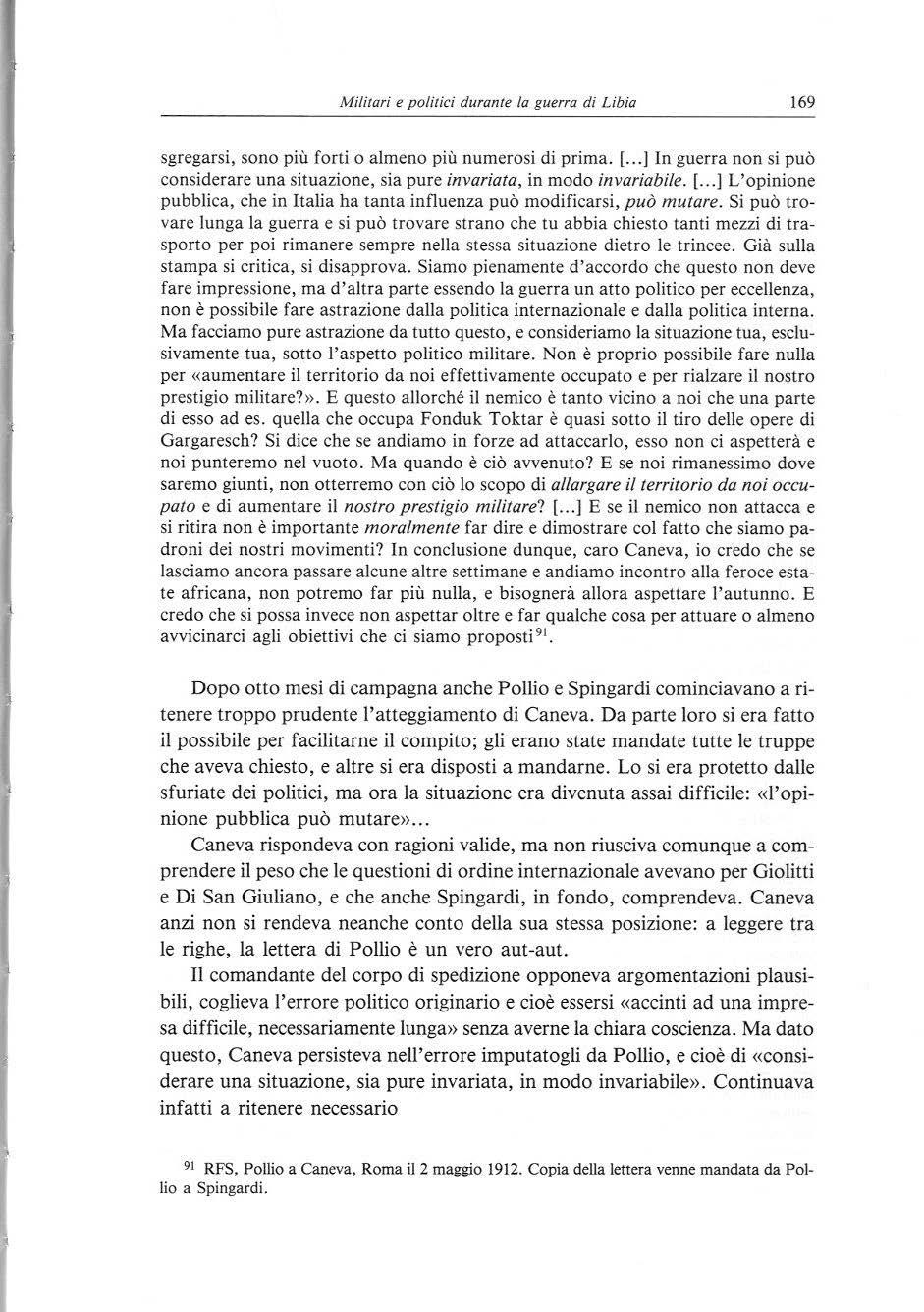
Militari e politici durante la guerra di Libia 169
91
RFS, Porno a Caneva, Roma il 2 maggio 1912. Copia della lettera venne mandata da Pollio a Spingardi.
che il paese sia illuminato e comprenda la portata della impresa alla quaJe si è accinto con tanto entusiasmo e disponga l'animo suo ad affrontare virilmente l'ineluttabile sacrific io di un lungo e tenace sforzo, abbandonando le chimere di soluzioni rapide e gloriose a grandi colpi militari che qui non possono condurre che a passi assai pericolosi.
Sbagliava nel porre il quesito «Ma se da principio, quando un colpo in Europa era possibile, rapido e decisivo, la guerra dovette essere localizzata in Libia, chi può ora rendere noi responsabili delJe conseguenze di questa limitazione? », perché era facilmente smentito: erano bastate poche cannonate della M ari na a P revesa, nel Mar Ionio, il 29 settembre 1911, a scatenare una ridda di proteste austriache. Era impossibile colpire la Turchia in Europa senza suscitare le reazioni delle Potenze 92 •
Ormai la fi du cia che Spingardi e Pollio avevano riposto in Caneva si affievoliva. Lo stesso Giolitti gli scrisse il 6 maggio, ancora una volt a lamentandosi dell'inazione che generava sfiducia nelle truppe e menomava la considerazione dell'Italia all'estero 93
L a lettera era scritta in perfetto accordo con Spingardi e forse dietro sua richiesta: «Seco ndo quanto si di sse stamane» gli comunicava «ho scri tto al Generale Caneva la lettera della quale ti unisco copia» e aggi un gev a: « La lettera, scritta tutta di mio pugno, è confidenziale» 94 • Quando ai primi di luglio Giolitti decise di sostituir e Caneva, non avrebbe trovato più alcuna resistenza da parte del Ministro della Guerra.
92 Le citaz ioni in RFS, Caneva a Pollio, Tripoli 9 maggio 1912. Sull'episodio di Prevesa e le successive reazioni austriache si veda il solito D EL BocA, pp. 96-97.
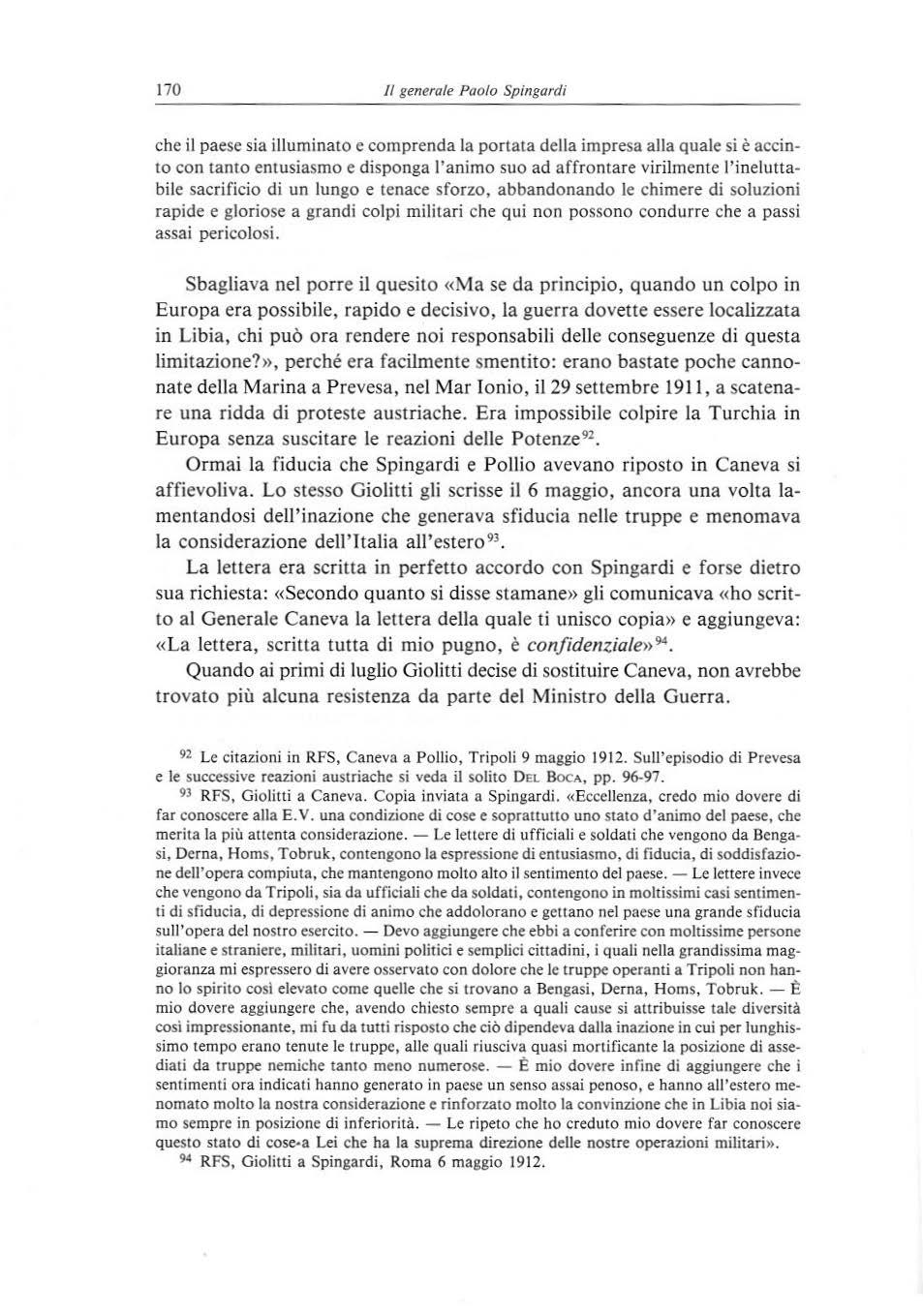
93 RFS, Giolitti a Caneva. Cop ia inviata a Spingardi. «Eccellenza, credo mio dovere di far conoscere alla E. V. una condizione di cose e soprattutto uno stato d'animo del paese, che merita la più attenta considerazione. - Le lettere di ufficiali e so ldati che vengono da Bengasi, Derna, Homs, Tobruk, contengono la espressione di entusiasmo, di fiducia, di soddisfazione dell'opera compiuta, che mantengono molto alto il sen timento del paese. - Le lettere invece che vengono da Tripoli, sia da ufficiali che da soldati, contengono in moltissimi casi sentimenti di sfiducia, di depressione di animo che addolorano e gettano nel paese una grande sfiduc ia sull'opera del nostro esercito. - Devo aggiungere che ebbi a conferire con moltissime persone italiane e s traniere, militari, uomini politici e sem pli ci cittadini, i quali nella grandissima maggioranza mi espressero di avere osservato con dolore che le truppe operanti a Tripoli non hanno lo spirito così elevato come quelle che si trovano a Ben gasi, Derna, Homs, Tobruk. - È mio dovere aggiungere che, avendo chiest0 sempre a quali cause si attribuisse ta le diversità così impressionante, mi fu da tutti risposto che ciò dipendeva dalla inazione in cui per lunghissimo tempo erano tenute le truppe, alle quali riusciva quasi mortificante la posizione di assediati da truppe nemiche tanto meno numerose. - È mio dovere infine di aggiungere che i sentimenti ora indicati hanno generato in paese un senso assai penoso, e hanno all'estero menomato molto la nostra con s iderazione e rinforzato molto la convinzione che in Libia noi siamo se mpre in posizione di inferiorità - Le ripeto c he ho c reduto mio dovere far conoscere questo stato di cose•a Lei che ha la suprema direzione delle nostre operazioni militari».
94 RFS, Giolitti a Spingardi, Roma 6 maggio 1912
170 li generale Paolo
Spingardi
Intanto il malumore dell'Austria preoccupava: Vienna aveva digerito con difficoltà l'allargamento della guerra all'Egeo. Inoltre, aveva dato il proprio consenso per l'occupazione di tre isole e l'Italia, invece, ne aveva occupate quattordici 95 •
L'atteggiamento dell'alleata infastidiva alquanto Pa lli o e, sicuramente, anche Spingardi: «Sapevamo benissimo[ ... ] tu e io», sc riveva amareggiato il Capo di S.M., «c he l'alleanza, nelle gravi contingenze in cui ci troviamo, agisce soltanto per le restrizioni che ci impone ! Che bella alleata!» 96 •
Fors'anche per influire sulla sit uazione diplomatica non favorevole, nel mese di giugno l'attività militare riprese in T ripolitania con una certa vivacità. Grazie ad una serie di operazioni coronate da discreto successo, la posizione degli italiani migl iorò considerevolmente 97 • Continuava invece ad essere critica in Cirenaica, spec ialmente nella zona di Derna, dove il generale Trombi era praticamente assediato dagli araboturchi al comando di Enver Bey. Sp ingardi lo aveva fino allora difeso, riuscendo anche a far modificare, a quanto sembra, il tono dei telegrammi di Giolitti / Mercatelli 98 •
95 V. MA lGERI, cit., p. 320, DEL BocA, p. 172.

96 RFS, Pollio a Spingardi il 29 / V/ 1912.
97 L'8 giugno avvenne lo scontro di Zanzur , un successo non sfrutta to dagli italiani: il 12 giugno si ebbe lo scontro detto dei «Monticelli di Lcbda» nel settore di Homs: un 'altra vittoria non sfrull ata. Il 16 giugno, allo scopo di estendere il controllo della costa tripolina in direzione del confine con la Tunisia, venne effettuato uno sbarco di sorpresa sulla costa di Misurata, settima testa di ponte itali ana in Libia; tra il 26 e il 28 giugno, nel settore di Zuara, venne allar gata la t esta di ponte di Bu Chemesch dopo il sa nguinoso combattimento di Sidi Said. Sulle operazioni militari di giugno v. D EL BocA, pp. 175-177 e L'ai.ione dell'esercilo, pp. 41-45, 54-57, 61-65.
98 V. RFS, Vittorio Trombi a Spingardi, 14 gennaio e 2 febbraio 1912. « Derna, 14 gennaio 1912. Eccell enza e mio am ico cari ssimo, Incomin c io col rin graziarti : I 0 ) perché mi sono accorto che il Presidente del Consiglio è st atO messo da te sull'avviso circa i te legrammi in forma poco corretta redatti dal Mercatelli. 2 ° ) perché non potevi essere più sollecito nell'inviarmi tutto ciò di cui abbi sog navo. Se non ho ancora tutto a terra, ne è causa il mare. 3 ° ) perché sei gentile e cortese sempre, anche nei momenti diffici li. Dopo le grazie devo farti anche due scuse: J 0 ) per aver rispost0 seccamente ad un tuo telegra mma nel quale mi avvisavi aver qua destinato un T.te Colonnello del Genio. 2° ) per non aver direno a te il telegramma in cui chiedevo la grazia di un condannato a morte. Giustifico queste mie colpe: l'offerta del T. Co l onnello del Genio mi veniva proprio in un momento critico, quando la inclemen za degli elemenii, la mancanza di legna da ardere , di legname per baraccamenti, di esp losivi per mine mi preoccupavano seriamente, né valeva allarmare il Governo . ben intendendo che il Governo non poteva calmare il mare, né creare un porto a Derna. Per la domanda di grazia ho pensato che nella mia qualità d i G. le investito anche dei poteri civili potes s i direttamente corrispondere con i l M.ro di Grazia e Giustizia. Da due g iorni il mare permette con relativa c,a lma lo sbarco dei materiali di baraccamento. Ciò ha rialzato di molto il morale delle truppe travagliate da 19 giorni di maltempo continuo, quale non ne abbiamo un'idea in Italia La salute delle truppe mi teneva in pensiero: ogni mattina i malati crescevano: erano in gran pane colpiti da febbri reumatiche, non gravi è vero, ma che diminuivano i disponibili degli effettivi già ridotti».
Militari e politici durante la guerra di libia 171
La ma ggior e importanza politica attribuita alla T ripolitania av ev a fino a quel momento fatto si che le operazioni in Ci renaica fosse ro te nu te in minore considerazione . Ma ora che la situazione pareva sis temarsi per il meglio a occidente, dall'Italia si cominciò a gu ardare con maggiore attenzion e alle vicende di Derna.
Si erano avute lamente le di ufficiali provenienti da qu el presidio. Spingardi ne informò Trombi, che se ne dolse profondamente :
Non ti nascondo il dolore che h o prov ato e provo dopo la lettura di quanto mi scrivi. Dopo le continue cure per fare quanto può riuscire giovevo le a l morale e al materiale dei miei dipendenti, ess er e così mal corri sposto, vi ene l'amaro alla bocca
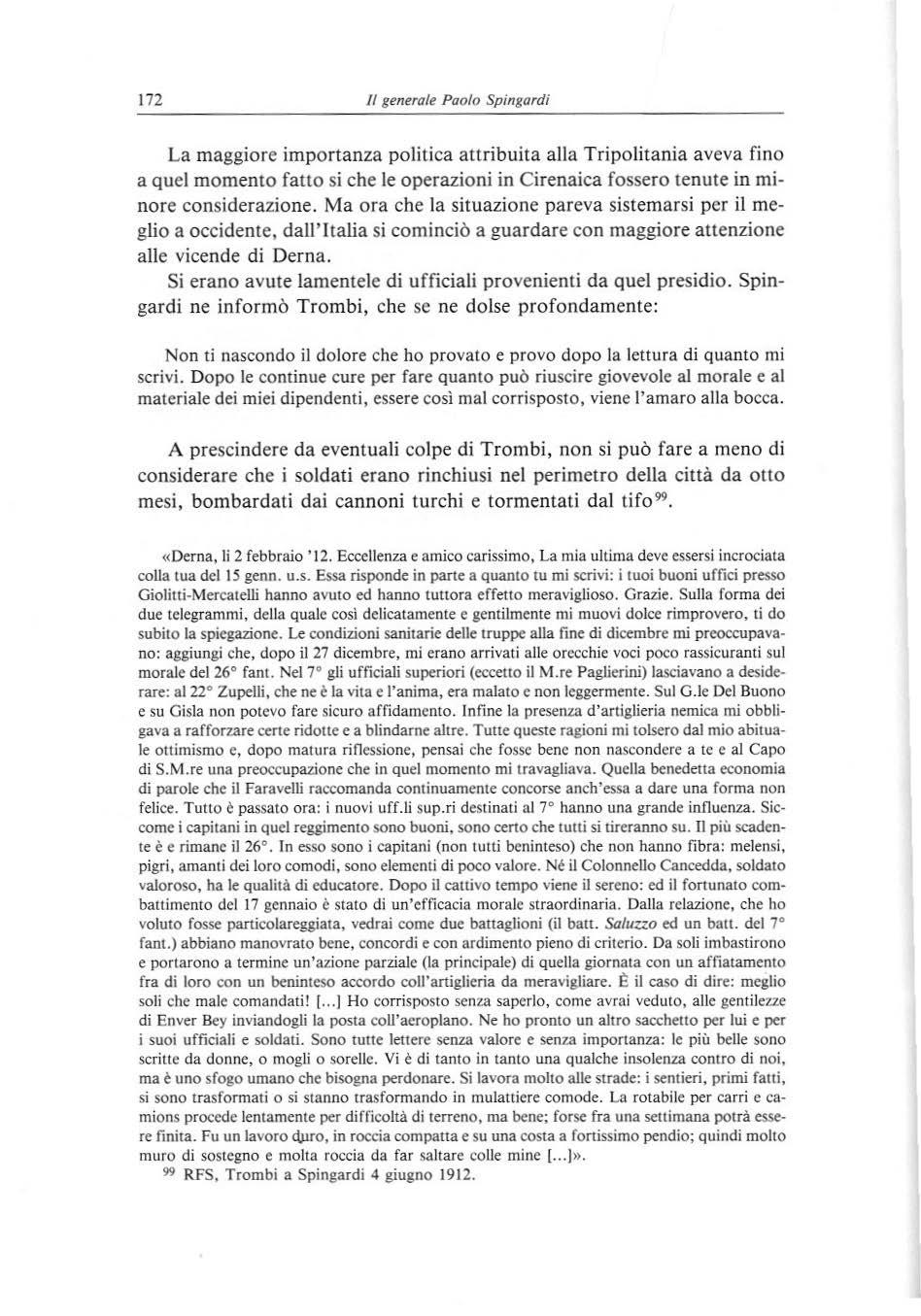
A pre sc ind ere da eventuali colpe di Trombi, non si può fare a meno di considerare che i soldati erano rinchiu si nel perim etro della città da otto mesi, bombardati dai cannoni turchi e tormentati dal tifo 99 •
«De rna, li 2 febbraio '12. Eccell enza e a mico carissimo, La mia ul tim a deve essers i incrociata colla tua del 15 genn. u.s. Essa risp0nde in parte a quanto mmi scrivi: i tuoi buoni uffici presso Giolitti-Mercatelli hanno avuto ed hanno tuttora effetto meraviglioso. Grazie. Sulla fo rma dei due telegrammi, della quale così delicatamente e ge ntilm e nte mi muovi dolce rimprovero, ti do subito la spiegazione. Le condizioni sanitarie delle truppe alla fine di dicembre mi preoccupavano: aggiungi che, dopo il 27 d icembre, mi erano a rrivati alle orecc hie voci poco rassicuranti su l morale del 26° fant. Nel 7 ° gli ufficiali superiori (eccetto il M . rc Paglierini) lasciavano a desiderare: al 22° Zupelli, che ne è la vita e l'anima, era malato e non leggermente. Sul O.le Del Bu ono e s u Gisla non p0tevo fare sicur o affida mento. infine la presenza d'artiglieria nemica mi obbligava a rafforzare certe ridotte e a blindarne altre. Tune queste ragioni mi tolsero dal mio abituale ottim ismo e, dopo matura rinessione, pensa i che fosse b en e non nascondere a te e al Capo di S.M. re una preoccupazione che in quel momento mi travagliava. Quella benedetta economia di parole che il Faravelli raccomanda continuamente concorse anch'essa a dare una forma non feli ce. Tutto è passato o ra: i nuo vi uff.li su p.ri destinati al 7° hanno una grande influenza. Siccome i capitani in quel reggimemo sono buoni, sono certo che tutti si tireranno su. Il più scadente è e rimane il 26 ° In esso sono i capitan i (non tutti beninteso) che non hanno fibra: mel ensi , pigri, amanti dei loro comodi, sono elementi di pOCO valore. Né il Colonnello Cancedda, soldato valoroso, ha le qualità di educatore. Dop0 il catùvo temp0 viene il sereno: ed il fortunato combattimen to del 17 gen nai o è stato di un'efficacia morale straord inari a. Dall a relazion e, che ho voluto fosse particolareggiata, vedrai come due battaglioni (il batt Sa/uzzo ed un batt. del 7° fant.) abbiano manovrato bene, concordi e con ardimento pieno di criterio Da soli imbastirono e portaro n o a te rmine un'azione parzi al e (la principale) d i quella giornata con un affiatamento fra di loro co n un beninteso accordo coll'artiglieria da meravigliare. È il caso di dire : meglio soli che male comandati! [ ) H o corri sposto senza saperlo, come avrai veduto, alle gen t ilezze di Enver Bey inviandogli la posta coll'aeroplano. Ne ho pronto un altro sacchetto per lui e per i suoi ufficiali e soldaù. Sono tutte lettere senza valore e senza importanza: le più belle sono scri tte da donne, o mogli o sorelle. Vi è di tanto in tan to una qualche inso lenza contro di noi, ma è uno sfogo umano che bisogna perdonare. Si lavora molto alle strade: i sentieri, primi fatti, si sono trasformati o si stanno trasformando in mul att iere comode. La rotabile per ca rri e cam ions p rocede lentamente per difficoltà di terreno, ma bene; forse fra una setùmana pOtrà essere finita. Fu un lavoro clµro, in roccia compatta e s u una costa a fortissimo pendio; quindi molto muro di sostegno e molta roccia da far sa ltare colle mine [ )»
99 RFS, Trombi a Spingardi 4 giugno 1912.
172 il
generale Paolo Spingardi
L'amarezza di Trombi giunse al punto di chiedere al Ministro di mandargli «qualcuno ad ispezionare, meglio a fare un'inchiesta, che la verità scaturisca e se io sono deficente mandatemi a quel paese» 100 • Spingardi si limitò a spedirgli una consolatoria lettera, ma dalla risposta che a questa diede Trombi si intravedono l'insofferenza del Mini stro per le continue inframettenze, e il co n cetto che le autorità civili si facevano d e i territori conquistati, trattati seco ndo le st e sse direttive burocratiche di una qualsiasi provincia della madrepatria:
Intravedo dalla tua che amarezze ne hai tu pure; non me ne meraviglio. Tutti vogliono dire la loro, tutti fanno gli strateghi, tutti credono di dare suggerimenti e di fare crit iche e quello che è peggio tutti credono, da lo ntano e senza conosce r e il terreno e gli abitanti, di avere la giusta visione delle cose. Tutti i giorni arrivano ispettori, contro -ispettori, commissari ecc. di servizi civili: si fermano tra un piroscafo e l 'altro, partono, e com'erano le cose prima così restano anche dopo. Non si vuo l capire che fino a tant o che la questione militare non sia risolta è un mettere il carro avanti ai buoi il voler considerare questi paesi coi criteri amministrativi di una o più prefetture italiane? Ho qui uno a studiare già il modo di inviare qui l'emigrazione ita li ana che dovrebbe andare in Am erica, ho un dot tore di scienze co loniali per progetti, ricerche etc. Altri sono già passati, altri verranno in seguito e tutto concorre a creare un caos, un affastellamento di pr ogetti, proposte che non possono ave r e né c apo, né coda [ .. .] . Per il tifo mi hanno inviato un me di co civile (ce ne era già un altro): forse credevano che quelli che ho (e ne ho dei veramente ottimi) non sapessero il loro mestiere? ( ... ] li Presidente del Consiglio che vuole, un giorno si un giorno no, avere il bollettino dei ma lati direttamente? JOt
Ferme dunque le cose in Ci renaica, nessun segno di cedime nto venendo dalla Tur ch ia pu r dopo l'o cc upazion e delle isole dell 'Egeo, P o llio venne convincendosi che fosse necessario procedere oltre in operazioni fuori dal terr itorio libico. Il 27 giugno 19 J2 scriveva a Spi ngardi in via ufficiale:
Pregiomi trasmettere a V.E. un foglio dell'addetto militare a Sofia nel quale sono riferite supposizioni turche intorno ad una sbarco italiano nella penisola del Kara Bo r oun di Smirne. Talj sup pos izio ni co llim ano , in gran parte, coll'idea alla quale io mi sono formato da tempo. Dopo aver occupato Chios, l'operazione supposta è la sola - ritengo fermamente - che, completa10 colla presa di Smirne, possa esercitare una grande pressione sul Turco ed o bbli gar lo a chiede r pace. È dol oroso, invece, c he da circa un mese e mezzo non si possa fare nemmeno un passo avanti nell'Egeo, co n grave scapito del nostro prestigio militare e politico.
100 Ibidem.
10 1 RFS, Trombi a Spingardi, Dema, li 18 gìugno 1912. In effetti il governo italiano «lemò di estendere subito il sistema fiscale e amministrativo vige nte in Italia ai territori conquistali, burocratizzando t utta la vita locale, ripetendo, naturalmente con le dovute differenziazioni , l'errore che all'indomani dell'unità venne compiuto con la piemontesizzazione del Mezzogìorno», MALGE RI, pp. 304-305 .
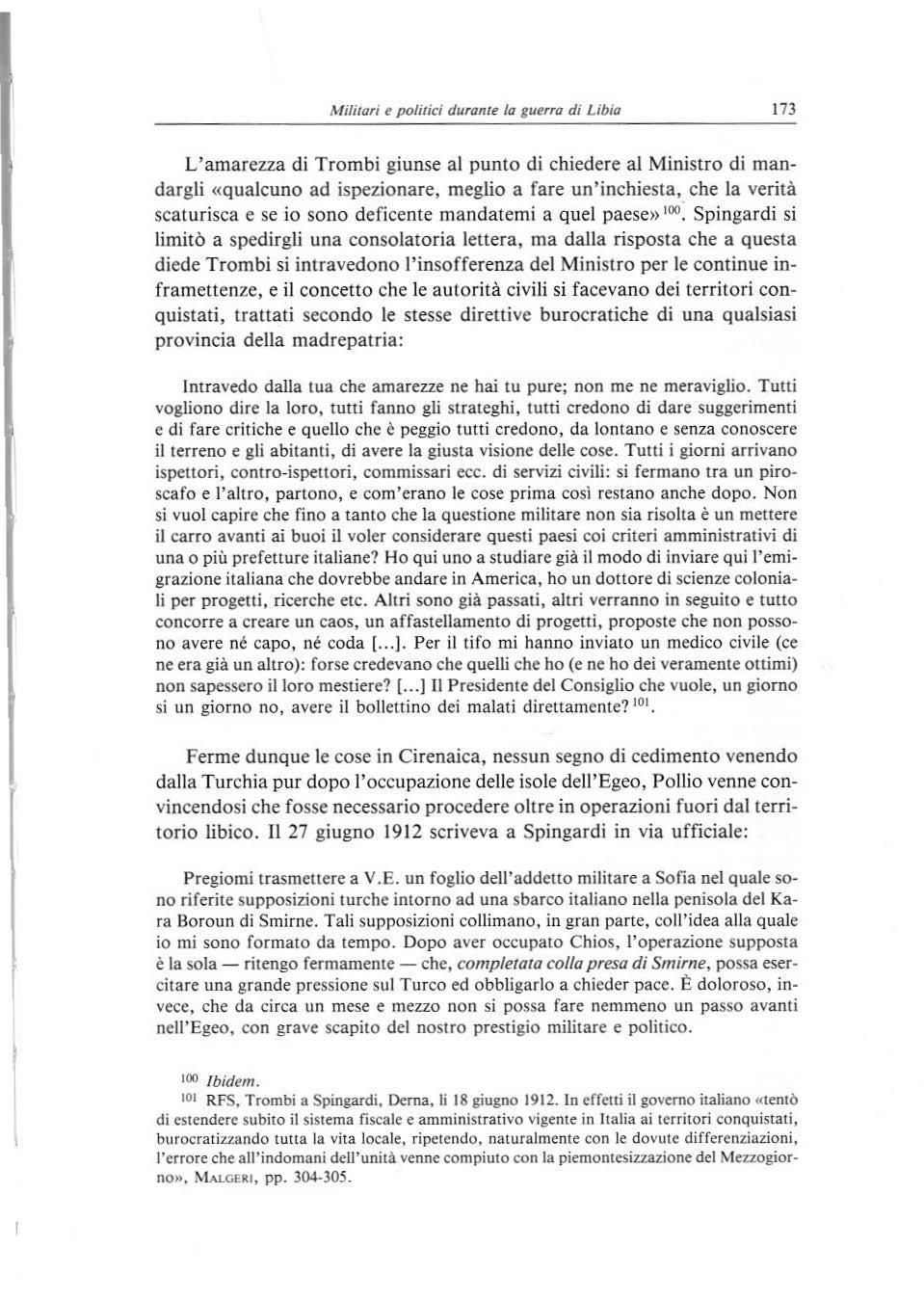
Militari e f)Qlitici durante lo guerra di Libia 173
Spingardi
Nettissima l'opposizione di Spingardi al progetto . Sullo stesso foglio inviatogli da Pollio annotò prima di restituirglielo:
Non ho bisogno di dire che, a prescindere da una eventuale occupazione di Chios, della cui opportunità politica non spetta a me di giudicare, dal punto di vista militare escludo r ecisamente la convenienza, anzi la possibilità della occupazione di Smirne, che non potrebbe essere tentata con forze inferiori a 2 corp i d'armata. Osserva inol tre che dalla penisola di Karabourun (punto di sbarco) a Smirne corrono parecchie tappe! 102 •
Spingardi non solo vedeva giusto dal punto di vista mi litare 103 , ma anticipava il rifiuto altrettanto reciso di Giolitti, al quale aveva dovuto inviare un Promemoria, steso da P oUio il 29 giugno, nel quale il progetto era più ampiamente esposto 104 •
Giolitti palesava a Spingardi paure comuni all'intera classe dirigente liberale di fronte non sol o all'alea dell'impresa di Smirne, ma ad ogni grosso rischio militare, perché un eventuale in success o
Per noi sarebbe una nuova Adua con t utte le ripercussioni interne ed estere. Ma poniamo che rie sca. Che noi, sacrificando migliaia di uomini, occupassimo Smirne. Che ne avverrebbe? A Smirne intanto vi sono solo interess i stranier i , specialmente di Inghilterra e Franc ia ; di interessi Turchi nessuno. Quindi o l'operazione resterebbe se n za grande effetto, non potendo poi noi senza altri 100 mila uomini occupare l'i n terno ; oppure avrebbe un contraccolpo nella compag ine interna della Turchia procurandone il di ssolvimento come lo Stato Maggiore accenna. Ora tutte le potenze d'Europa sono co ncordi nel non volere il dissolvimento della Turchia, che provocherebbe un conflitto europeo Si avvererebbe perciò quanto lo Stato Maggiore prevede, cioè la intimazione di tutte le potenze di fermarsi. Lo Stato Maggiore, con mia enorme meraviglia, dice che i/fermarsi difronte a tale intimazione non sarebbe limitazione. Ma fermarsi vorre bbe dire tornare indietro, abbandonare Smirne, dichiarare la Turchia vittoriosa, rialzarne le sorti, fare che trovi sub ito ab bondanti capitali, e noi ricadremmo nel novero d ei paesi sotto sorveglianza delle a ltre potenze. E quando si fosse fatto un accordo fra le potenze per salvare l a Turchia per logica conseguenza ci si intimerebbe di rinunciare alla sovran ità piena e intera su lla Libia contentandoc i di concessioni economiche . Le situazioni politiche hanno il loro logico sv olgimento e a noi si applicherebbe il guai ai vinti! Comprendo che la proposta dello Stato Maggiore dipende dal non conoscere le condizio ni dell'Europa, ed è nat urale che non l e conosca non essendo la diplomazia di sua competenza, ma anche
102 RFS , lf Capo di Stato Maggiore dell 'Esercito a S.E. il co mm. Paolo Sp ingardi, Tenente Generale Min istro della Guerra, n . 205 Personale Roma , il 27 giugno 1912. Le sottolineature, anche quelle al testo di Pollio, sono d i Spingardi.
103 La Turchia avevi! infatti concentrato a Smirne un forte contingente. Cfr. MALGE.R1, p . 322.
104 Si tratta naturalmente del medesimo promemoria menzionato in DEL BocA, p. 173 e r iportato in appendice a R.J .B. BoswoRTH, La politica estera dell'/fafia giolittiana, Editori Riuniti, Roma 1985 [ed. or. Cambridge 1979].
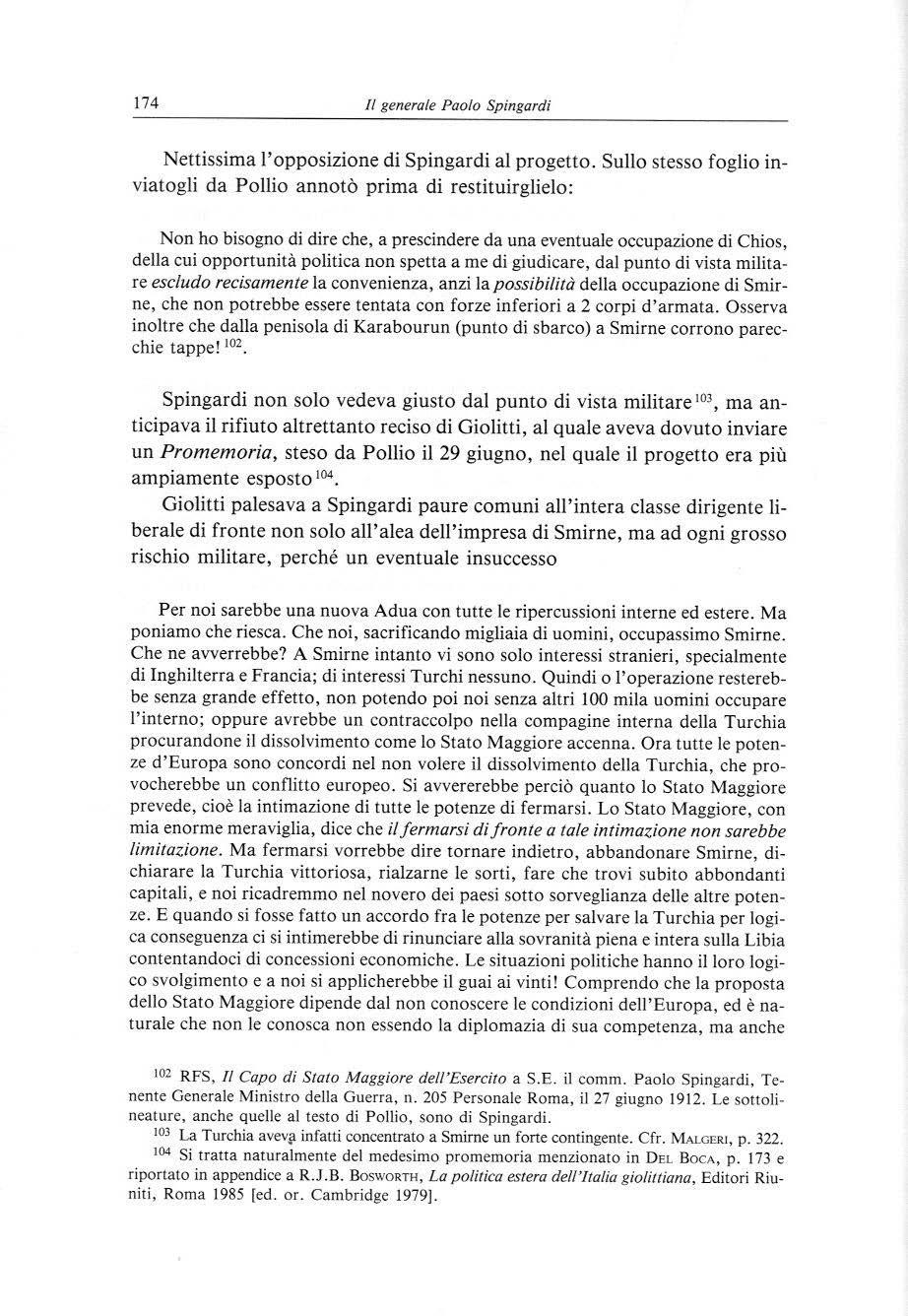
174
li generale Paolo
Militari e poliiici durante la guerra di Libia 175
la più superficiale nozio ne può bastare ad escludere la proposta. Lasciar cre dere alla Turchia che si farà è un bene perché la obbliga a spesa e le cagiona ansia; ma non penserei sul serio 105 •
Il progetto venne effettivamente agitato come spauracchio duran te le trattative di pace con la Turchia 106 • Al so lito Spingardi comunicò il Promemoria anche a Brusati, che, a quanto pare, non prese neppure in considerazione l'argomento 107, dato che con luglio e per tutto agosto, mentre la diplomazia vedeva l'inizio delle trattative, la scen a militare era occupata da due altri problemi: la situazione in Cirenaica, che avrebbe portato al «siluramento» del generale Trombi, e la sostituzione di Caneva.
Si è già accennato alla difficile posizione degli italian i a Derna. In luglio la situazione peggiorò. Enver Be y , grazie anche al contrabbando dall'Egitto, era riuscito a raccogliere dieci cannoni con i quali ogni giorno, a partire dal 16 luglio, bombardava la città e le fortificazioni degli italiani. Nella sola giornata del 21 luglio sparò seicento colpi 108 •
Per Giolitti la quotidiana beffa screditava l'intera impresa libica . Occo rre va desistere dalla difesa passiva, unica tattica attuata da Trombi, e prepararsi a sostituire quest'ultimo con un generale in grado di prendere l'iniziativa.
«[ Derna] fu sempre la posizione meno bene organizzata e meno bene di fesa» telegrafava a Spingardi il Presidente del Consiglio «Credo convenga mandare subito forze e prepararsi poi a mandare generale più abile e più energic o » 109 •
Pronta e asciutta la risposta di Spingardi: << È già stato provveduto invio rinforzi D erna» 1JO
Alcuni giorn i dopo, Giolitti tornava alla carica da Bardonecch ia , men-
105 RFS, Giolitti a Spi ngardi, Roma 1° luglio 19 12. Il corsivo rappresenta quanto nell'originale risulta sotto lineato due volte.
106 « La nostra in tenzione, ne l caso la guerra fosse ripresa, era di attaccare le fortificazioni di Sm irne, e di tagliare, nella Turchia europea , il nodo ferrorivario di Dedeagatch» (G1 0LrTI1 , Memorie, cit., p. 289).
101 V. RFS, lettera del 9 luglio 1912.
JOS Sulla situazione in Cirenaica in luglio e agosto v. DEL Boc A, pp. 181 - 183.
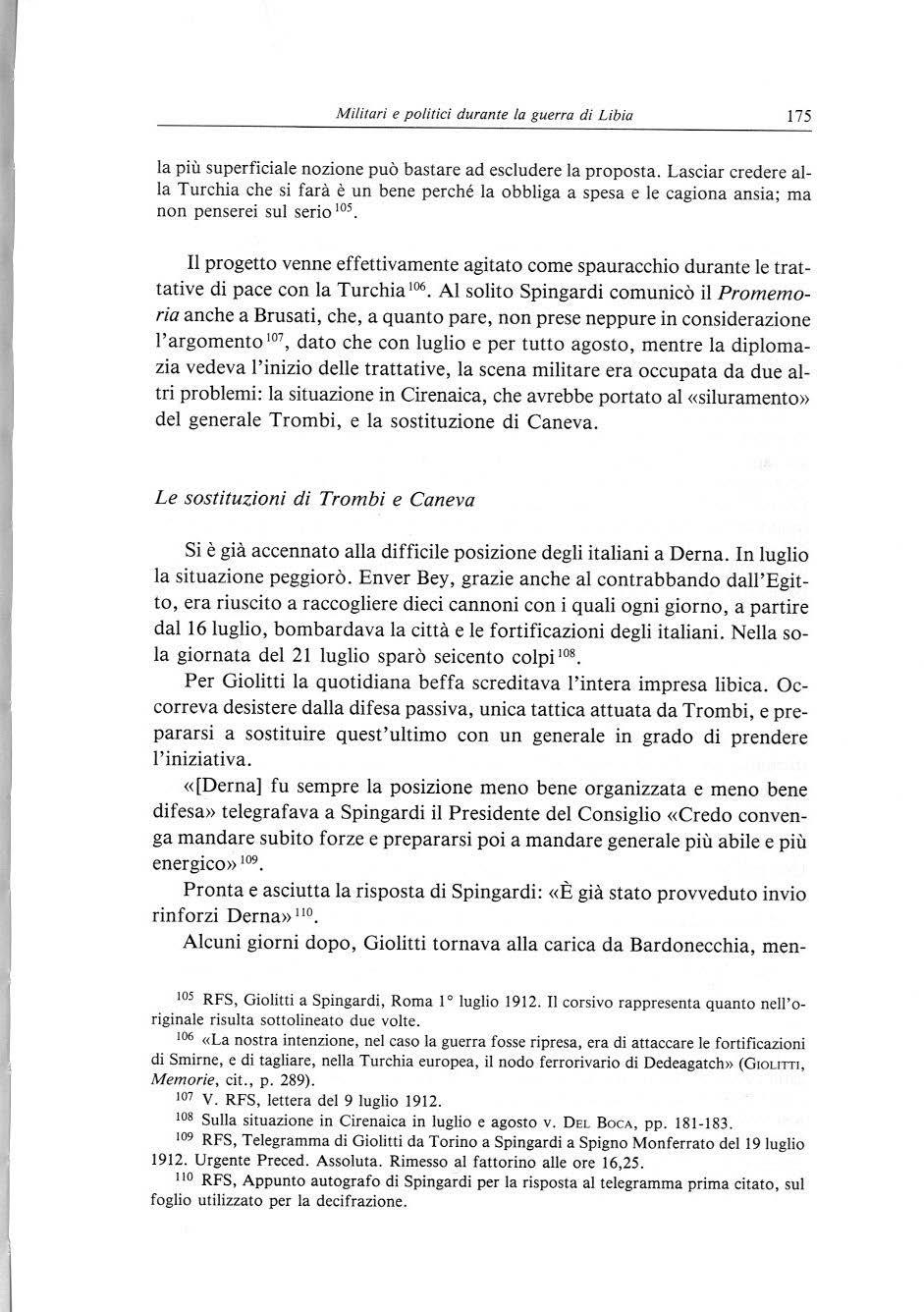
109 RFS, T e legramma di Giol i tti da Torino a Spingardi a Spigno Monferrato del 19 l uglio 1912. Urgente Preced. Assoluta . Rimesso al fattorino alle ore 16,25.
110 RFS, Appunto autografo di Spingardi per la risposta al telegramma prima citato, sul foglio utilizzato per la decifrazione.
Le sostituzioni di Trombi e Caneva
tre Spingardi era tornato a Roma da Spigno Monferrato per meglio seguire la situazione:
Condizioni Derna mi paiono gravi soprattutto come indizio insufficienza del comando che in dieci mesi e con molte forze è sempre nelle condizioni del primo giorno. Interesse della guerra non può mai sacrificarsi anche in minima parte a considerazioni personali. Ti prego vivamente di esaminare a fondo la questione 11 1 •
Rispondeva Spingardi:
La questione del comando a Derna aveva già fermato t utta la mia attenzione. Topograficamente è la zona più difficile di tutta la Libia ed il nemico vi è guidato dal capo più abile e che gode di maggior prestigio. La difensiva manovrata si imponeva qui più che a ltrove. A quanto mi risulta la sistemazione difen siva vi è stata fatta con giusto criterio e niun pericolo serio minaccia quel presidio. Tuttavia vi furono mandati quattro battaglioni di rinforzo per mano vrare anche offensivamente ove si presenti la occasione. Ad ogni modo non escludo una eventuale sostituzione di quel comandante, ma non improvvisa, che ad ogni modo non giungerebbe a tempo nella presente situazione e avrebbe certo sinistra ripercussione. Puoi essere certo che niuna considerazione personale mi t ratterrà dal prendere quei provvedimen ti che fossero del caso 112
Nessuna considerazione personale infatti trattenne il Ministro della Guerra, che si era ormai evidentemente convinto della necessità di sostituire Trombi. Vi fu il consueto scambio di vedute con Pollio: il Capo di S.M. consigliava di richiamare Trombi «per motivi di salute», ovviamente per attenuarne la prevedibile amarezza. «D'altra parte» aggiungeva «l'esame della corrispondenza tenuta da me con lui indica chiaramente che egli non ha avuto un lucido concetto di ciò che gli conveniva fare, e non ha saputo nulla di positivo sull'avversario» 113 • Trombi venne così sostituito dal generale Ezio Reisoli che nel corso del mese di agosto ricevette notevoli rinforzi .
La vicenda di Trombi merita di essere approfondita, perché di riflesso ne risultano illuminati i rapporti tra i vertici della classe militare italiana. Nel 1906 Trombi era entrato a far parte degli aiutanti di campo generali del Re. Allo scoppio della guerra si era prodigato attraverso le sue cono-
111 RFS, Giolitti a Spingardi, telegramma s.d. V. nota seguente per la datazione (Spingardi l'aveva decifrato sullo stesso foglio su l quale scrisse la risposta).
112 RFS , Appunti a matita costituenti la minuta probabilmente di una lettera (la forma non sembra quella di un telegramma) inviata da Spingardi «A S.E. Giolitti. Presidente del Consiglio. Bardoneccbia» (così in testa agli appunti). Non vi è data ma il contenuto permette di collocarli con una certa precisione tra il 19 e il 29 luglio 1912. Le «considerazioni personali» sono naturalmente un riferimento all'amicizia che correva tra Spingardi e Trombi.
11 3 RFS , Pollio a Spingardi il 7/ VIII / 1912.
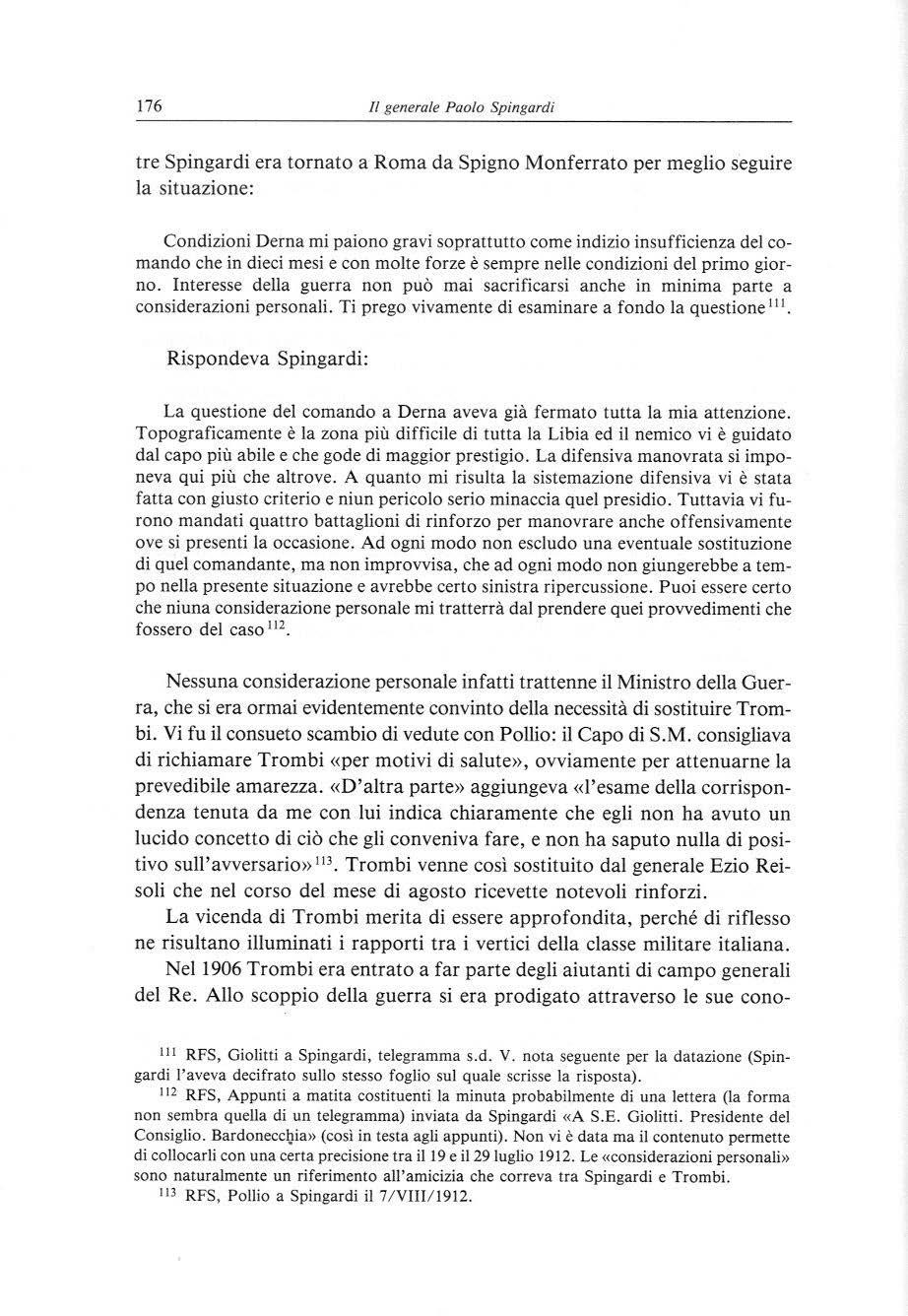
176
li generale Paolo Spingardi
scenze per ottenere di essere destinato in Libia 114 • Forse già questo elemento potrebbe aver contribuito a porlo in cattiva luce presso Giolitti. Anche Brusat i non approvò tale condotta e lo scrisse in maniera esplicita, definendo nel contempo una sorta di etica dell'ufficiale:
Sarebbe sta to assai meglio per lui se non avesse ripetutamente insistito per avere un comando presso di truppe mobilizzate. Le insistenze in s imìlì casi sono condannabili. Anzitut t o perché contrarie al retto sent ime nto di disciplina ed anche un po' alla modestia ; in secondo luogo perché contrarie al fatalismo al quale nella nostra carriera è d'uopo affidarci; in terzo luogo perché colui il quale chiede una destinazione speciale lascia quasi suppor re che egli ritenga di valere più degli altri suoi compagni 115 •
Sentimento di disciplina, modestia, fatalismo, umiltà: virtù che avrebbero dovuto caratterizzare chi sceglieva la carriera delle armi e che Trombi non aveva dimostrato di possedere in giusta misura . Giunto a Roma il 10 agosto, questi ebbe alcuni colloqui con Spingardi. Ne uscì convinto che la causa principale del suo richiamo fosse stata la sua «condotta politica nel reggere la cosa pubblica a Derna , non approvata dal Governo» 116 • Ma una settimana dopo, riflettendo, s i rese conto che anche l'insufficiente azione di comando fu causa del suo esonero ed ebbe un amaro sfogo con Spingardi:
Più il tempo passa e più mi sento prostrato dalla misura che mi ha colpito, sebbene faccia di tutto per dimenticare: non domando altro che di essere lasciato tranq uill o il più a lungo possibile per calmare il mio animo e poi decidere quello che farò nell'interesse mio e più di tutto nell'interesse dei miei figli. Pollio l'ho avuto sempre ostile dal dì che lasciai la Corte: ora egli ha quasi 8 anni da rimanere a quel posto, ha cioè troppo tempo a disposizione per ammazzare un uomo. Se Caneva non mi diede mai direttive, meno ancora fece Pollio nei nove mesi in cui fui laggiù 117 •
114 « Il Gen.le Trombi scrisse a me pure perché mi interessassi affinché in caso di spedizione guerresca egli fosse tra i designati a prendervi parte», sc risse Brusati nella lettera del 23 settembre I 9I I.
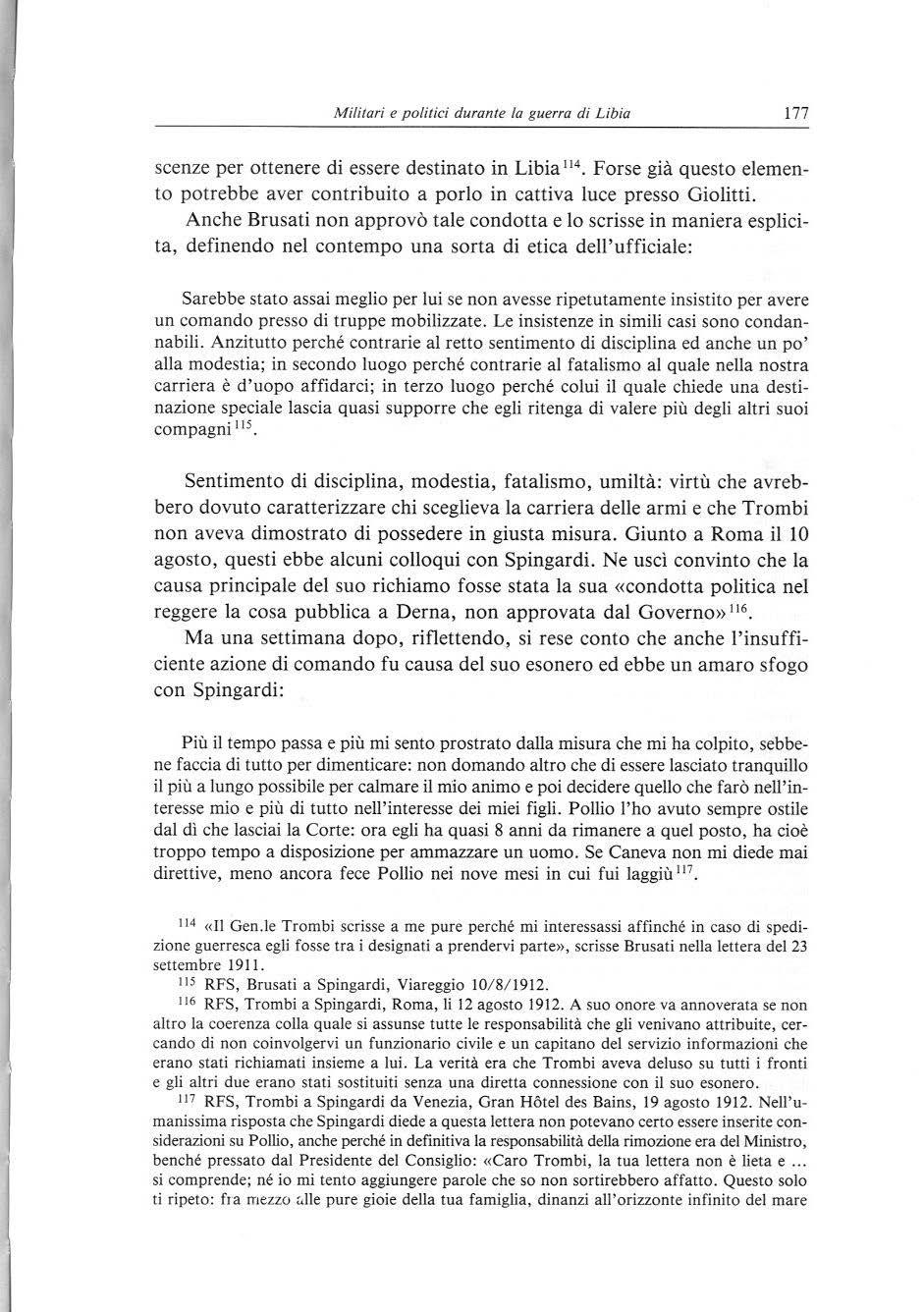
115 RF S, Brusati a Spingardi, Viareggio 10/ 8 / 1912
110 RFS, Trombi a Spingardi, Roma, li 12 agosto 1912. A suo onore va annoverata se non altro la coerenza colla quale si assunse tutte le respon sab ili tà che gli venivano attribuite, cercando di non coinvolgervi un funzionario civile e un capitano del servizio informa zioni che erano stati r ichiamati insieme a lui . La verità era che Trombi aveva deluso su tutti i fronti e gli altri due erano stati sostituit i senza una diretta connessione con il suo esonero.
11 7 RFS, T rombi a Spingardi da Venezia, Gran Hotel des Bains, 19 agosto 1912. Nell ' umanissima risposta che Spingard i diede a questa lettera non potevano certo essere inserite consi derazioni su Pollio, anche perché in definitiva la responsabilità della rim ozione era del Ministro , benché pressato dal Presidente del Consiglio: «Caro Trombi , la tua lettera non è lieta e ... si comprende; né io mi tento aggiungere parole che so non sortirebbero affat to . Questo solo ti ripeto: fra mezzo .:.Il e pure gioie della tua famiglia, dinanzi all'orizzonte infinito del mare
Militari e politici durante la guerra di Libia 177
generale Paolo Spingardi
Spingardi si preoccupò umanamente di consolare Trombi ma era convinto anche lui delle ragioni della sostituzione 118 •
Trombi era ancora in viaggio da Derna a Roma, che Giolitti rincarava la dose delle accuse, rivelando il notevole livello di preoccupazione cui si era giunti per la Cirenaica, e l'ossessione per l'immagine dell'Italia all'estero .
Per dani una idea del male che ci ba fatto la inazione di Trombi a Derna ti dirò ora che l'ambasciatore tedesco a Costantinopoli disse a persona, da cui lo so direttamente, che la nostra posizione in Cirenaica non è buona mentre è eccellente quella dei Turc h i. È una esagerazione che viene da persona non am ica nostra, ma la situazione di Derna la giustifica( ... ] Vedi di mandare ciò che vi è di meglio, e di preparare per la Cirenaica qualche azione efficace e clamorosa. e abbiamo bisogno 119 •
di Venezia - che non è quello infido di Derna - rinfranca la tua salute, distendi i tuoi nervi, calma il tuo spirito, come tu stesso mi scrivi, e poi e poi torna al tuo bel comando di Milano [Trombi era divenuito Comandante della Di visione Militare Territoriale di Milano poco prima di panire per la Libia) con quell'alto sentimento del dovere al quale hai sempre inspirata la tua vita di soldato. Ti stringo forte la mano. Porgi i miei devoti omaggi alla Contessa c bacia per me i tuoi bei figlioli P. Spingardi». Trombi tornò effettivamente al suo comando a Milano, che tenne fino al 1914, anno in cui passò nella riserva. Non ebbe alcun incarico durante la guerra contro l'Austria. Nella riserva raggiunse il grado di gen. di Corpo d'Armata nel 1924. Morì a Capannori, presso Lucca, nel 1934. Era nato a Modena nel 1854.
118 Il 14 agosto aveva scritto a Pollio che «il generale Trombi insiste a ritenere il suo richiamo do vuto esc lusivam ente al suo i ndirizzo po l itico non approvato dal capo del Governo. C iò non è esatto, ed è bene che il general e Trombi lo sappia. La prego quindi di voler riprendere in esame l'azione di comando spiegata dal prefat0 generale nelle varie contingenze nelle quali è venuto a trovarsi, ed [ 1 esprimere il suo pensiero in merito al complesso di ragioni che ne hanno determinato la sostituzione a Derna » (AUSSME, F-74, C. 61).
119 RFS, Giolitti a Spi ngardi da Bardonecchia 9 agosto I912. Lo stesso giorno telegrafava a Spingardi: « Da nota del nostro ambasciatore a Londra risulta che ambasciatore inglese a Costantinopoli riterre bbe che il governo turco non potrà mai aderire rinunzia alla! sovranità finché in Cirenaica gli italiani figurano assediati dalle forze turche in condizioni di inferiorità» (ibidem). Spingardi rispondeva per lettera il IO agosto: «Tu mi comunichi il telegramma di Imperia li il quale riferendo l 'op inione dell'ambasciatore in glese a Costantinopoli dic e non essere poss ibil e che Governo Turco rinunzi alla sovranità finché in Cirenaica gli italiani figurano assediati dalle forze turche in condizioni di inferiorità. È una opinione come un'altra. Ma, bada, la stessa cosa e con maggior ragione, forse, si diceva un giorno dai nostri ambasciatori per la Tripolitania. E venne Ain Zara, e vennero Tagiura e la occupazione intera dell'oasi; poi Gargaresch, e da ultimo Zanzur e Zuara. Non è più questione di assedio, e tuttavia l'op inione diplomatica estera non ha cambiato. Pretesto e null'altro. E andiamo in Cirenaica, e precisamente a Derna, oggetto delle maggiori critiche. Ti dissi già altra volta come là sia il terreno tatticamente più difficile di tutto il teatro di guerra, e come il nemico vi sia comandato dal capo più abile e più ardito e circondato da maggior prestigio. Ebbene quali risultati vi ha ottenuto questi? Tutti i suoi sforzi si sono infranti contro la formidabile nostra s istemazione difensiva e per molti mesi non ha ardito più di farsi innanzi. Ora ha ripreso delle insignificanti avvisaglie per qualche cannone che gli è giunto da Bengasi. Nessuna preoccupazione! Ma si dice: perché non andiamo noi a cercarlo? È un'idea, che può anche essere buona, ed io l'ho sempre pensato, ma non è scevra di pericoli , e sop rattutto non è a credere che qui attac cato e disperso il campo nemico vi si possa poi rimanere campati in aria. Ed egli ritornerà poi quando
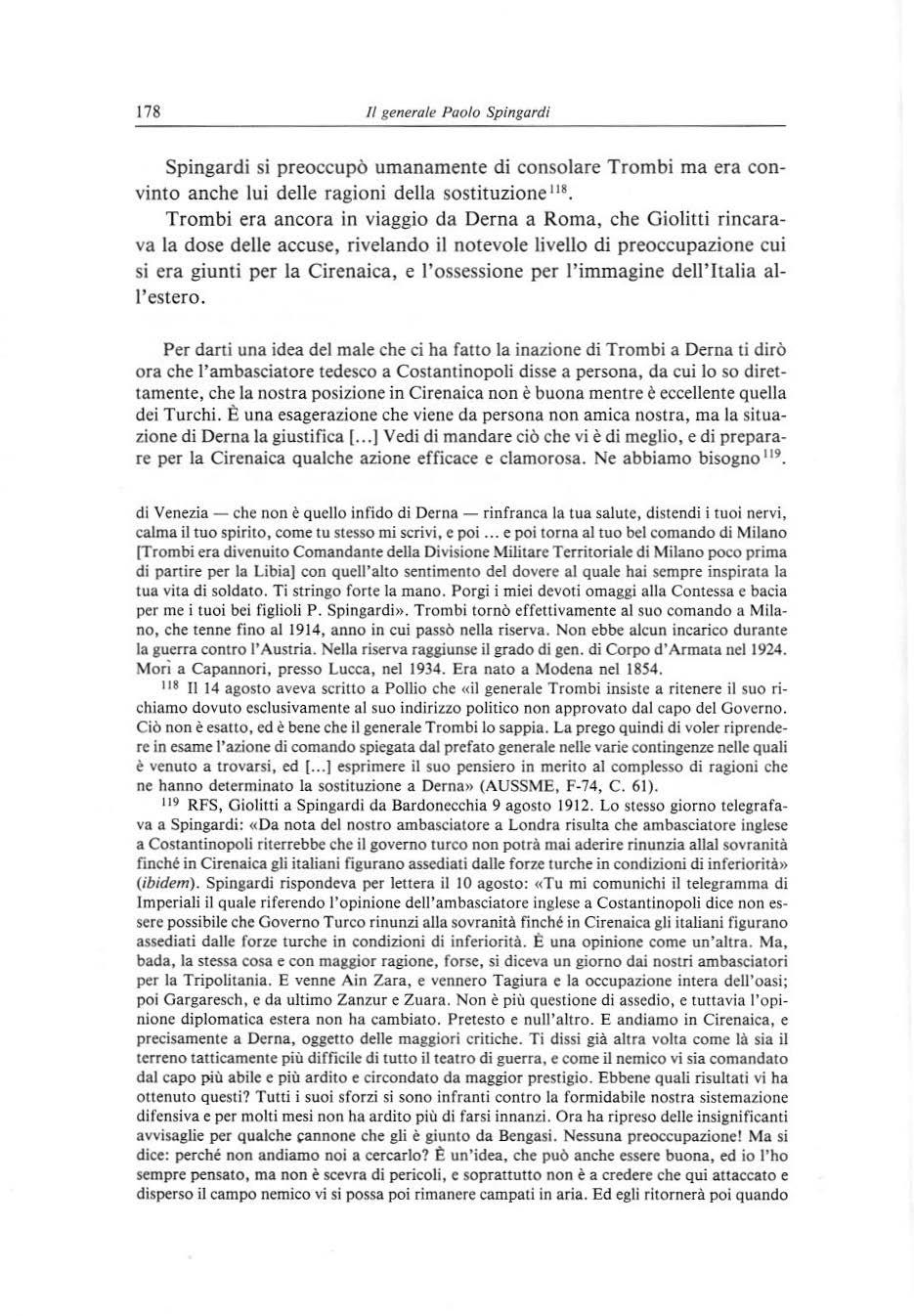
178
Il
Spingardi non perse tempo. A coadiuvare Reisoli inviò uno degli ufficiali più esperti nel campo delle guerre coloniali, il generale T ommaso Salsa 120 • Per assistere a una «azione efficace e clamorosa» si dovette comunque attendere il 14 settembre. Prima infatti fu necessario ricostruire moralm ente le truppe perché, come scris se Salsa, fino a quel momento avevano fatto «più gli operai che non i soldati» 121 •
La volontà del governo di imprimere alla guerra un nuo vo ritmo venne sottolineata dal richiamo di Caneva da Tripoli. La sostit uzione venne decisa da Spingardi e Giolitti fin dai primi giorni di luglio del 1912, ma fu resa ufficiale solo il 5 settembre. Spingardi comunicava la decisione a Brusati il 3 luglio in questi termini:
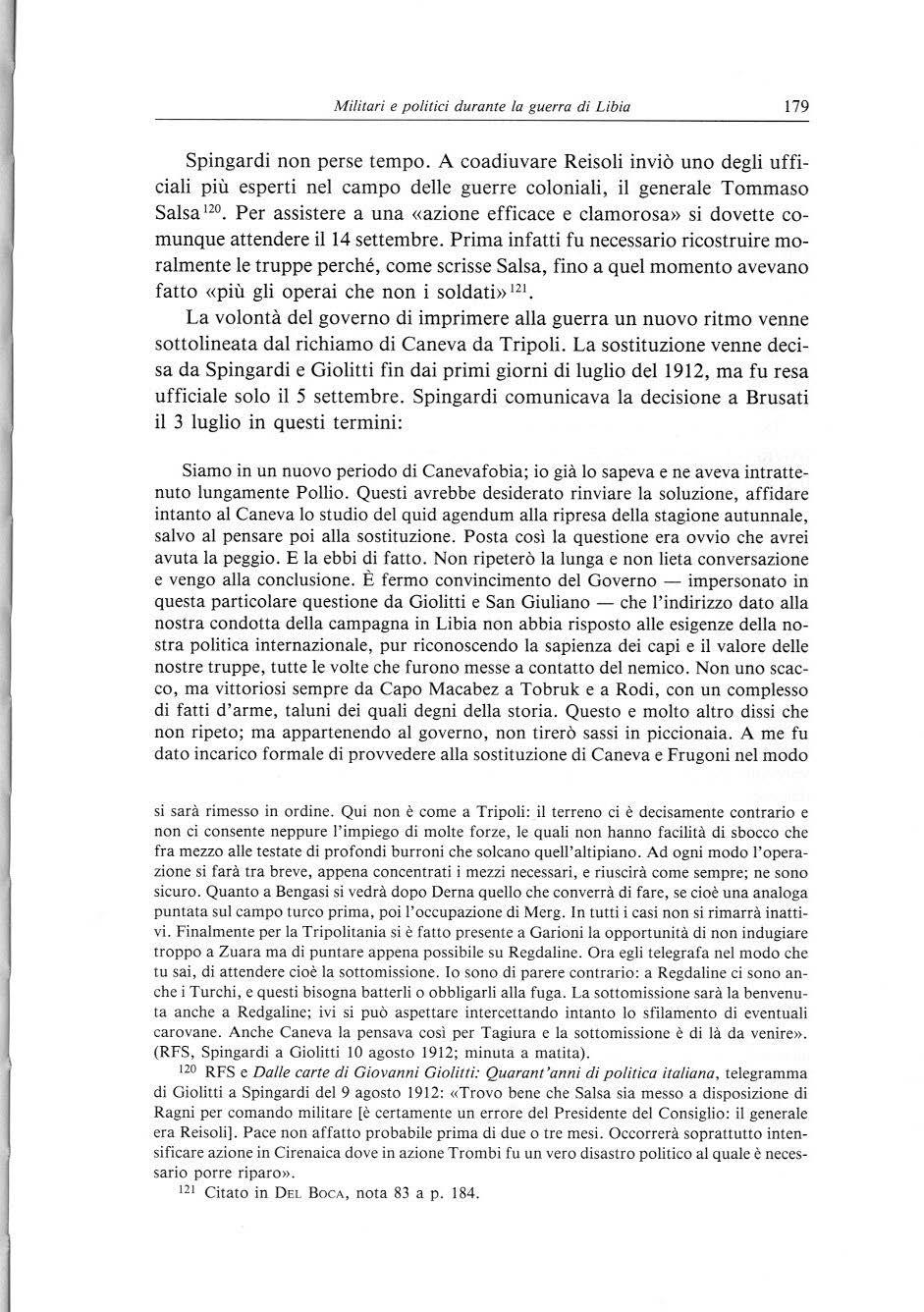
Siamo in u n nuovo periodo di Canevafobia; io già lo sapeva e ne aveva intrattenuto lungamente Pollio. Questi avrebbe desiderato ri nv iare la soluzione, affidare intanto a l Caneva lo studio de l quid agendum alla ripresa della stagione autunnale, salvo al pensare poi alla sostituzione. Posta così la questione era ovvio che avrei avuta la peggio. E la ebbi di fatto. Non ripeterò la lunga e non li eta conversazione e vengo alla conclus ione. È fermo convincimento del Governo - impersonato in questa particolare questione da Giolitti e San Giuliano - che l'indirizzo dato a ll a nostra condotta della campagna in Libia non abbia risposto alle esigenze della nostra politica internazionale, pur riconoscendo la sapienza dei capi e il va lo re de ll e nostre truppe, tutte le vo lte che furono messe a contatto del nemico. Non uno scacco, ma vittoriosi sempre da Capo Macabez a Tobruk e a Rodi, con un complesso di fatti d'arme, taluni dei quali degni della storia. Questo e molto altro dissi che non ripeto; ma appartenendo al governo, non tirerò s assi in piccionaia. A me fu dato incarico formale di provvedere alla sostituzione di Caneva e Frugoni ne l modo
si sarà rimesso in ord ine. Qui non è come a T r ipoli: il terreno ci è deci s amente contrario e non ci consente neppure l' impiego di molte forze, le quali non hanno facilità di sbocco che fra mezzo alle tes tate di profondi burroni che solcano quell'aWpiano. Ad ogni modo l'operazione si farà tra breve , appena concentrati i mezzi necessari, e riuscirà come sempre; ne sono sicuro. Quanto a Bengasi si ved rà dopo Derna quello che converrà di fare, se cioè una analoga puntata s ul campo turco prima, poi l'occupazione di Merg. In tutti i casi non si rimarrà inattivi. F ina lmente per la Tripolitania s i è fatto presente a Garioni la opportunità di non indugiare troppo a Zuara ma di puntare appena poss ib ile su Re gdal ine. Ora eg li te legrafa nel modo che tu sai , di attendere cioè la sottomissione. lo sono di parere contrar io: a Regdaline ci sono anche i Turchi, e questi bisogna batterli o obbligarli alla fuga. La souomiss ione sarà la benvenuta anche a Redgaline; ivi si può aspettare intercettando intanto lo sfilamento di eventuali carovane. Anche Caneva la pensava così per Tagiura e la sottom issione è d i . là da venire» . (RFS, Spingardi a Giolitti IO agosto 1912 ; minuta a matita) .
120 RFS e Dalle car;e di Giovanni Giolitti: Quarant'anni di politica italiana, telegramma di Giolitti a Spingardi del 9 agosto 1912: « Trovo bene che Sa lsa s ia messo a disposizione di Ragni per comando militare [è certamente u n errore del Presidente del Consiglio: il generale era Re isol i]. Pace non affatto probabile prima d i due o tre mes i. Occorrerà soprattutto intensificare azione in Cirenaica dove in az ione Trombi fu un vero disastro politico al qua le è necessar io porre riparo».
121 Citato in DEL Boc A, nota 83 a p. 184.
Militari e politici durante la guerra di Libia 179
li generale Paolo Spingardi
e nel tempo (non oltre luglio) che avrei creduto meglio. Ed io prego te di volere in mio nome prendere gli ordini di S.M. Come ti dissi più sopra, ho avuto occasione di intrattenermi sull'argomento col collega Pollio. Egli, al pari di me, ritiene che, al caso , meglio risponda la de stinazio ne di un comandante di corpo d'armata, che assuma ed eserciti ad un tempo il comando effettivo delle truppe ai suoi ordini, e che il generale meglio indicato possa essere il Ragni 122 •
In effetti, fin dal 28 novembre 191 I, in un altro periodo di «Canevafobia», Pollio si era dimostrato pronto a «procedere alla sostituzione» pur con tutte le riserve del caso e professando la più profonda stima per Caneva 123 •
Di qui la sorpresa di Spingardi quando il 5 luglio si vide recapitare una lettera nella quale il Capo di Stato Maggiore gli illustra va i motivi per i quali era contrario alla sostituzione.
Nel mentre ho preso atto della decisione del R O Governo di richiamare dalla Libia S.E. il Generale Caneva, mi consenta l'E. V. che io ripeta in forma ufficiale che mi pronunziai contrario a tale decisione quando essa mi fu annunciata [... ] .
· Le operazioni da noi eseguite in Libia per la loro ampiezza e grandiosità non hanno riscontro nella storia e che, caso unico nelle guerre coloniali, le nostre trup pe sono state costantemente vittoriose aggiungendo all'Italia moderna l'aureola di gloria che le mancava. E parte almeno del merito per tale fatto è da attribuire al generalissimo. Que sto, senza dubbio, non ha sempre apprezzato il fattore <<tempo» come doveva, sopr a ttutto per rispetto alla situazione internazionale Ciò gli fu più volte sc ritto ed egli avrebbe dovuto dargli maggior peso. Il G. Caneva però fu sem pre convinto profondamente che non erano le operazioni in Libia, per quanto a noi favorevoli, che potevano mutare la situazione internazionale. Ed in questo io sono del s uo parere 124 •
122 RFS , Spingardi a Brusati, Roma 3 luglio 1912. La lettera è una copia che Brusati unì alla s ua del 9 lu g li o.
123 RFS, Pollio a Spingardi, Roma addì 28 / 11/19 1I. Il testo completo s uona così: «Caro Spingardi! Restitui sco la lettera. Sono anch'io del parere che convenga procedere alla sostituzione Però credo che bisogna aspettare che s ia eseguita l' ope razione su Ain-Zara che il G. Caneva ha già studiato e sta preparando. È questione di giorni , come lo stesso G. Caneva t i telegrafò iersera E son sicuro che una vo lta decisa , il G. Caneva la farà bene come ha fatto bene l'operazione del 26 Eseguita l 'operazione di Ain Zara, si en tra in una nuova fase e il cambio del comandante supremo non offre più pericoli. Un cambio im mediato potrebbe comp romettere invece l' esito dell'impresa se fatta dal G. Frugon i che si crederebbe forse obbligato ad eccedere in se n so contrario al Caneva. E potrebbe forse ritardar la se deve eseguirla un nuovo comandante supremo il quale anche affret tando la partenza deve pure impiegare alcuni giorn i per andare a Tripoli e qualche giorno per orientarsi. Questo, ad ogn i modo, è il mio avviso. Devoti sa lu ti tuo aff. A. Pollio».
124 RFS, Il Tenente; Generale Capo di Stato Maggiore dell'Eserci to A. Pollio a S .E. il comm . Paolo Sp ingardi Tenente Gene rale Ministro della Guerra, Comando del Corpo di Stato Ma gg iore, Ufficio del Capo di Stato Ma ggiore dell'Esercito , n. 212 di proLocollo Riservato Personale . Oggetto: Richiamo di S.E. il G. Caneva. Roma, addì 5 luglio 1912.
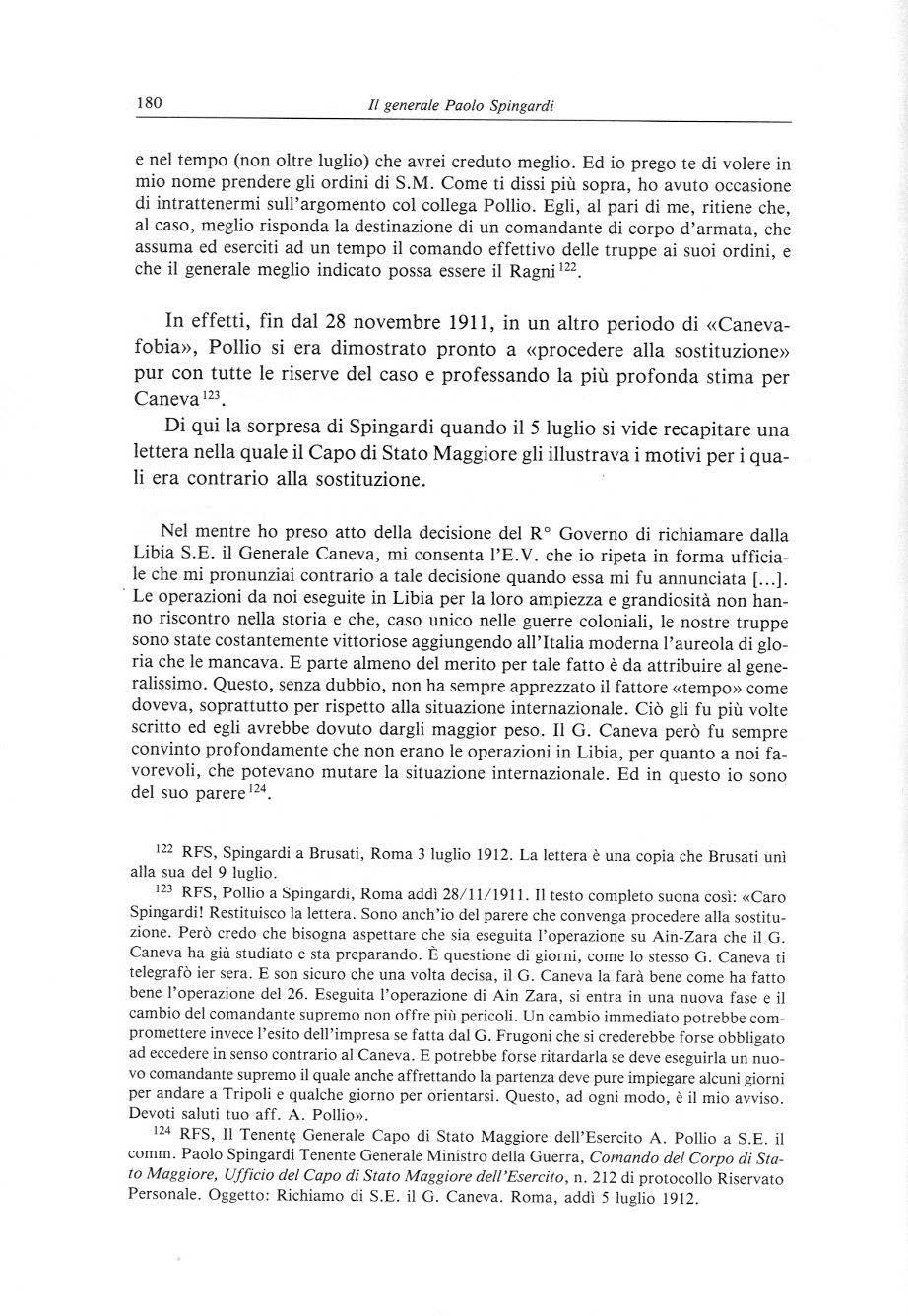
180
I precedenti colloqui avevano più che convinto Spingardi che P ollio fosse totalmente d'accordo sulla sostituzione di Caneva, e in questi termini ne aveva già parlato co l R e. Dunque la lettera gli procurò un certo imbarazzo. Quali le ragioni del cambiamento d i idea d i Pollio? Difficile dirlo . Bisogna comunque premettere che nemm en o Spinga r di appariva entusiasta all'idea della sostituzione, ma era venuto rendendosi conto che essa era imposta da esigenze politiche più che militari. La lettera di Pollio del 5 luglio sottolineava, più che l'accordo con Caneva sull'andamento imposto alla guerra, l'identità di vedute circa la necessità di ope r azioni più vicine al cuo r e della Turchia. Pollio faceva grande affidamento sul piano di conquista di Smirne 125• È probabi le quindi che il rifiuto del suo piano lo avesse profondamente deluso. Avvertito della d ecisione del governo di sostituire C aneva, avrebbe dapprima annuito, verbalmente, pr eso più o meno alla sprovvista. R iflettendo, si rese conto che con Caneva avrebbe perso il p iù importante alleato per l'attuazione de l suo piano. Alleato sotto un duplice aspetto : perché pensava che solo fuori dalla L ibia la Turchia potesse essere sconfitta in maniera decis iva, e perché con la sua condotta o ltremodo prudente e attendistica non faceva altro che accreditare tale teoria Col rigetto del suo Promemoria Pollio aveva dovuto ingoiare un amaro boccone . Anche solo per orgoglio non se la sentiva di ingoiarne un a ltro a distanza di pochi giorni!
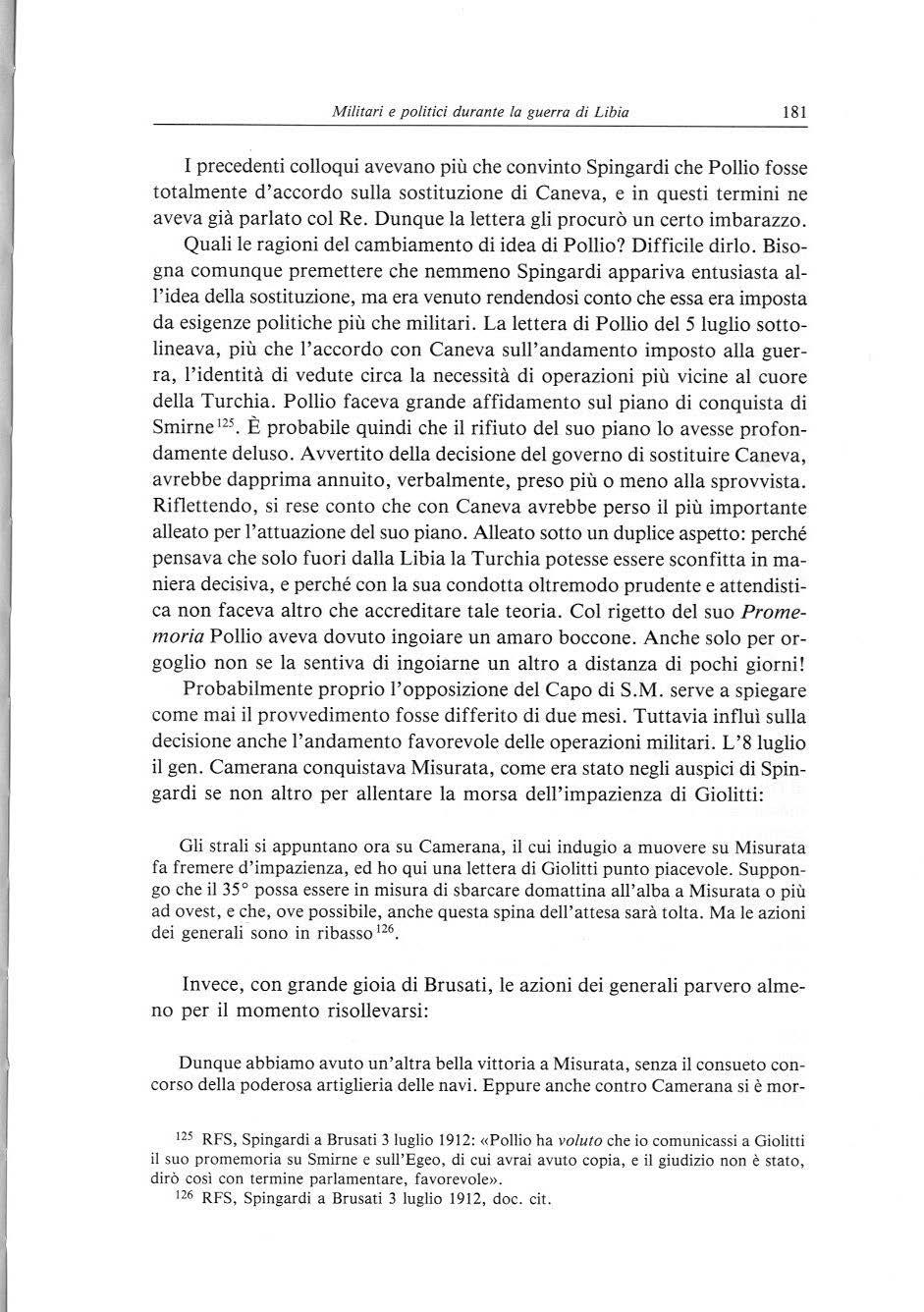
Probabilmente prop r io l'opposizione del Capo di S . M. serve a spiegare come mai il provvedimento fosse differito di due mesi. Tuttavia influì sulla decisione anche l'andamento favorevole delle operazioni militari. L'8 luglio il gen. Camerana conquistava Misurata, come era stato negli ausp ici di Spingardi se non altro per allentare la morsa dell'impazienza di Giolitti:
Gli strali si appuntano ora su Camerana, il cui indugio a muovere su Misurata fa fremere d'impazienza, ed ho qui una lettera di Giolitti punto piacevole. Suppongo che il 35° possa essere in misura di sbarcare domattina all'alba a Misurata o più ad ovest, e che, ove possibile, anche questa spina dell'attesa sarà tolta. Ma le azioni dei generali sono in ribasso 126
Invece, con grande gioia d i Brusati, le azioni dei generali parvero almeno per il momento risollevarsi :
Dunque abbiamo avuto un'altra bella vittoria a Misurata, senza il consueto concorso della poderosa artiglieria delle navi. Eppure anche contro Camerana si è mor-
125 RFS, Spingardi a Brusati 3 luglio 1912: «Pollio ha voluto che io comunicassi a Giolitti il suo promemoria su Smirne e sull'Egeo, di cui avrai avuto copia, e il giudizio non è staro, dirò così con termine parlamentare, favorevole».
126 RFS, Spingardi a Brusati 3 luglio 1912, doc. cit.
Militari e politici durante la guerra di Libia 181
morato, e si mormora, perché rimase tanti giorni inoperoso, si dice da chi sta qui comodamente a ragionare sdraiato in una comoda poltrona. Fu inoperosità laboriosa; la preparazione di conveniente e sicura base all'avanzata, fu garanzia di successo . Coi soli 9 battaglioni di cui disponeva dapprincipio, dovendo assolutamente lasciare guarnite le opere della base, non sa rebbe sta to prudente avanzare in terreno difficile, insidioso, per impossessarsi di regione molto popolosa e che si diceva difesa da forti nuclei arabo -turchi, colà ben trincerati. In questi momenti un 1/2 successo (non dico insuccesso) avrebbe avuto conseguenze gravissime, per reazione contro la mania di tutto esagerare. Camerana agì con senno attendendo che gli giu ngessero tre battaglioni di rinforzo, prima di agire decisivamente. L'indu gio ebbe il vantaggio notevole (sembrerà un paradosso) di consentire al nemico di afferrarsi al terreno, di illudersi di poterci respingere, di trattenerlo, insomma. E così le nostre valorose truppe poterono raggiungerlo, poterono batterlo so noramente, poterono avvolgerne l'ala sinistra, prima che, come di solito, si squagliasse al momento dell'attacco a fondo. Ma certe cose, certa gente, non le vuol capire. L'impazienza è l'esponente di nervi malati, se non di cervello leggero 127
Per tutto luglio si svolse poi il ciclo operativo che avrebbe condotto il 6 agosto alla occupazione di Zuara quasi senza colpo ferire 128 • Ma proprio il favorevole andamento delle operazioni permetteva di rendere meno doloroso il richiamo di Caneva.
Spingardi sottopose quindi a Giolitti uno schema di D ecreto Reale per l'es onero, ma ritenne «doveroso» che uno di loro ne informasse Caneva prima della pubblicazione
E nello stesso tempo mi pare altresì riguardo so che il Governo faccia pervenire al Oen. Caneva una parola di lode, almeno per quella parte dell'opera sua che ha indubbiamente riscosso il plauso ge nerale . Può essere stata deficiente la sua azione po litica, può essere stata disapprovata dal Governo centrale ed anche da una parte della pubblica opinione la lentezza con cui furono condotte le operazioni militari, ma è fuori dubbio che tutte le operazioni militari in Tripolitania furono sagg iamente predisposte e coronate da splendidi risultati, onde ebbe meritato plauso l'Esercito. - li difficile stà nella misura dell'elogio, e nella prova tangibile di esso: forse un titolo nobiliare che S.M. il Re volesse degnarsi di concedergli; forse una grande onorificenza nell'Ordine Militare di Savoia, come fu proposto dal collega della Marina per il Faravelli, che pure ebbe assai minori titoli; forse il Gran Cordone Mauriziano che ancora non ha. Qualche co sa ad ogni modo bis ognerà pur fare ora o poi a guerra finita. Ti scrivo di ciò perché la cosa interessa non solo il Ministro della Guerra, da cui il O.le Caneva dipende, ma il Capo del Governo, dal quale emana la sua più alta funzione civile-militare di Governatore della Tripolitania e Cirenaica 129 •
121 RFS, Bru sati a 'spingardi 9 luglio 1912.
128 V. L'azione dell'esercito, pp. 45-48 e D EL BocA, p. I 84.
129 RFS, Spingardi a Giolitti IO agosto 1912. Minuta a lapis.
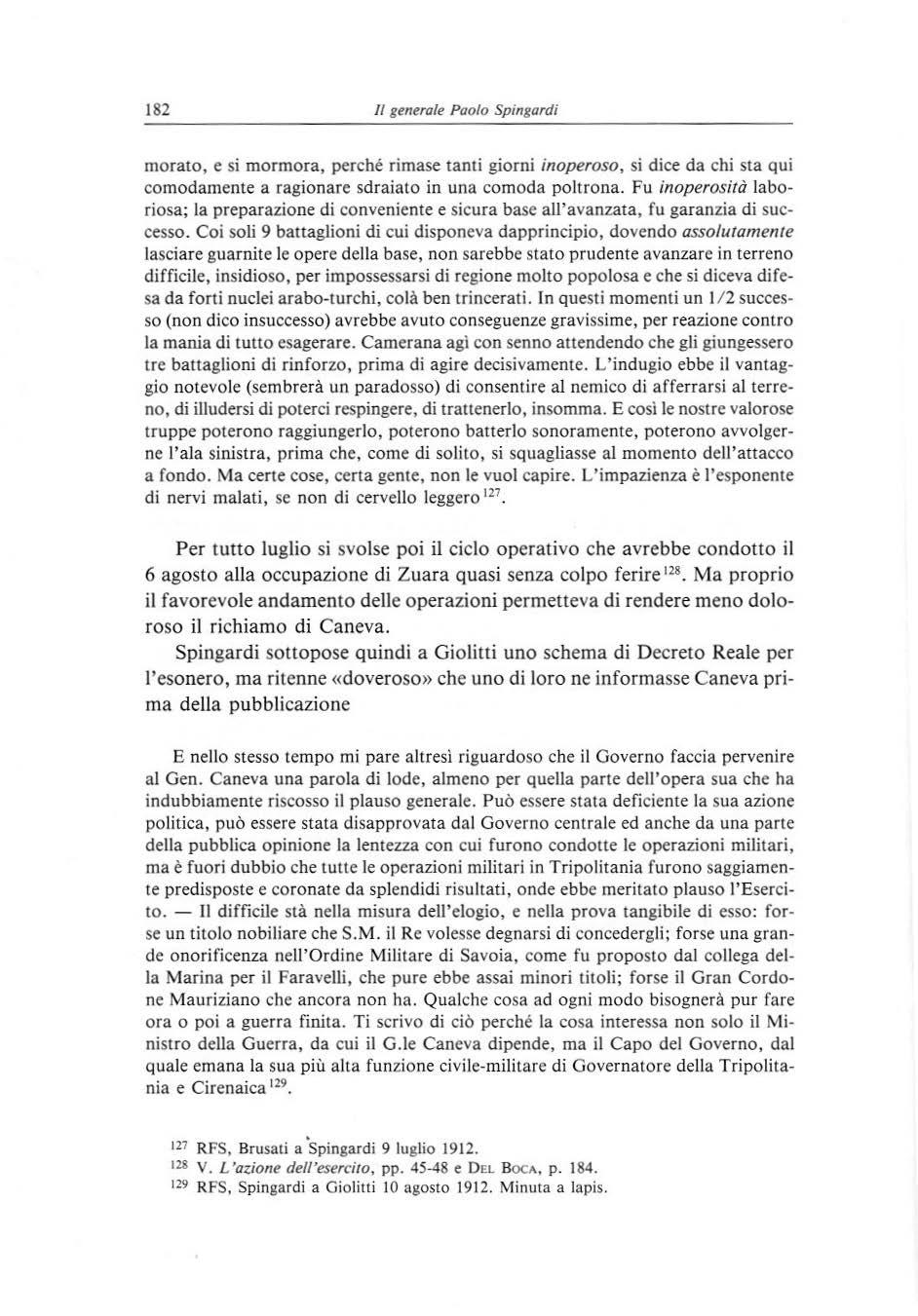
182 lf
generale Paolo Spingardi
Sulla questione regnò finalmente la più completa armonia tra il Ministro della Guerra e il Presidente del Consiglio:
Convengo - scriveva Giolitti - che prima di pubblicare il decreto che separa il comando della Cirenaica da quello della Tripoli tani a ed esonera dal comando il Gene r ale Caneva, sia convenien te che questi ne s ia informato da te; come pure convengo che il Governo debba dirigergli una parola di lode. Tu che meglio di me lo conosci puoi essere miglior giudice dei termini nei qua li scrivergli. Prima di ogni cosa però occorre informarne Sua Maestà, e poi il decreto dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri 130•
Il decreto venne quindi presentato a l R e che lo approvò 13 1 • Al decreto, opera di Spingardi, era allegata una breve relazione dello stesso che spiegava i motivi ufficiali del richiamo del generale Caneva:
Dieci mesi di esperienza hanno ormai dimos trato come ma le si possa da una sola autorità centrale residente in Tripoli esercitare una efficace azione dire tt iva, così nel campo militare come in quello politico -sociale, su tutta l'ampia distesa della costa libica occu pata in Tripolitania e in Cirenaica. A prescindere da ogni altra considerazione inerente alle diversità caratteristiche delle due regioni, basta por mente alla difficoltà dei rapporti per deficienza d i faci li e rapidi mezzi di comunicazione. li Go verno sarebbe per tanto venu t o nella de te rminazione di rendere le due amministraz ioni l'u na dell'altra indipende n te, facenti capo direttamente a Roma 132 •
Approvato il decreto dal Consiglio dei Ministri, Caneva venne richiamato da Tripoli il 31 agosto. Il 2 settembre venne emesso il Regio Decreto che lo esonerava dal comando supremo. Lo sostituivano due comandi indipendenti affidati al generale Ottavio Ragni in Tripo lit ania e al generale Ottavio Briccola in Cirenaica. Il comunicato ufficiale venne diramato il 5 settembre. A Caneva fu conferito il g rad o di generale d'esercito, il più alto nella gerarchia militare italiana dell'epoca 133 •
130 RFS, Giolitti a Spingardi, da Bardonecchia , 12 agosto 1912. La lettera prosegue così: « Garioni ha fatto veramente bene e per opera sua la nostra azione in Tripolitania ha preso indirizzo e ha dato risultati veramente so dd is facen t i. Quanto alla Cirenaica è inutile nascondersi che dopo la battagl ia delle Due Palme, opera di Amegli o, non si è fatto nulla. A Derna siamo assediati cioè in posizione inferiore, e poco decorosa. Co là si ebbero fino a 12 mila uomini e non si seppe far nulla tra nne che costruire dei ripari. Confessiamo pure che peggio di così non si poteva fare a Derna, e ciò per asso l uta deficienza del coman do. Speriamo che vi si rimedi perché quella deficienza ci reca politicamente grandissimo danno».
131 RFS, Brusati a Spingardi da Viareggio 26 agosto 1912: «Caro Spingardi, S.M. il Re , al quale comunicai l o schema di relazione e di R.D., che qui restituisco, relativi al Gen. Caneva, mi scrive che trova tali documenti assai ben fatti e che quindi li approva».
132 RFS , Schema di Regio Decreto su carta intestata // Ministro della Guerra allegato alla let tera di Brusati del 26 agosto .
133 V. DEL BocA, pp. 185-186.
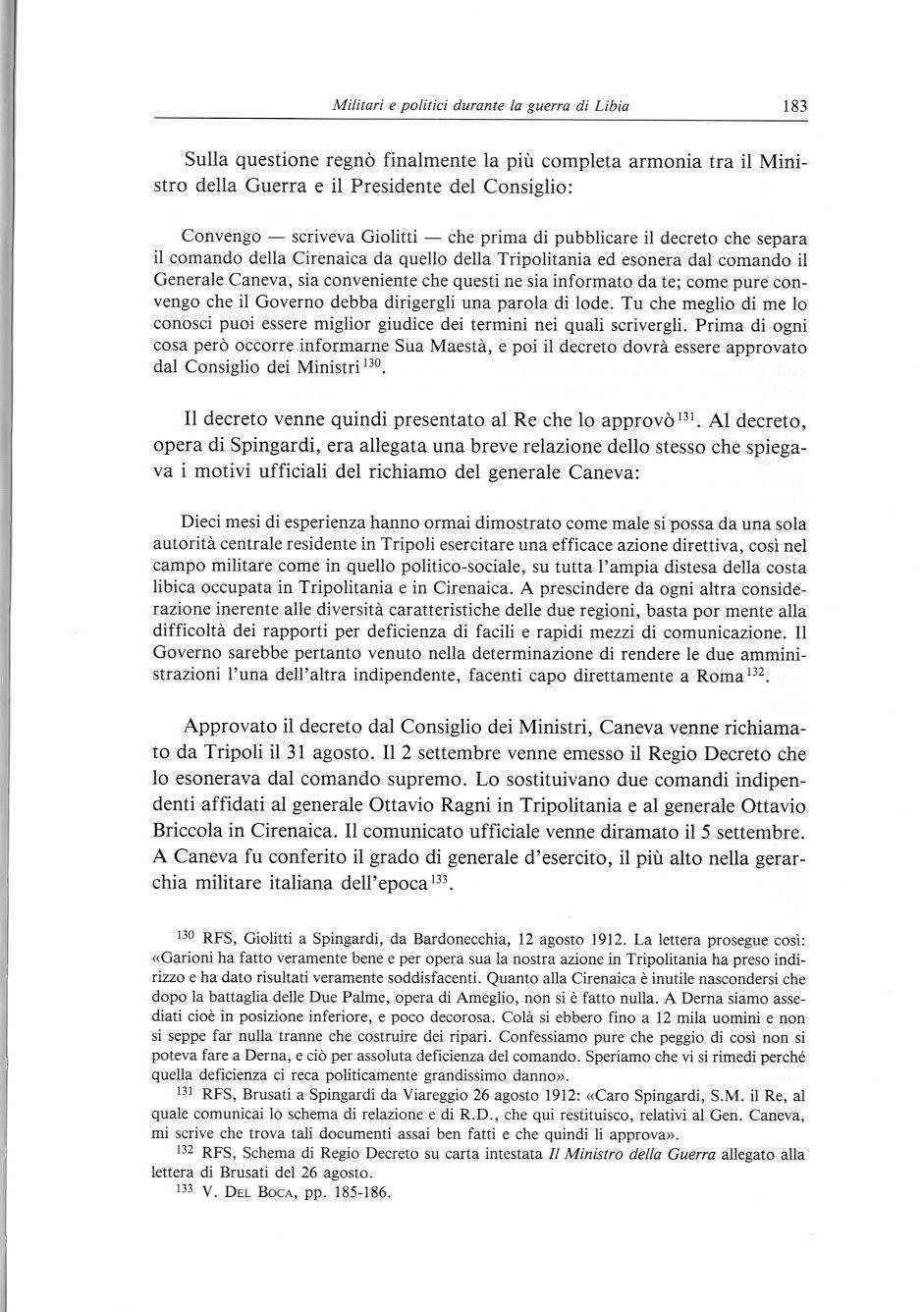
Mifirari e politici durante fa guerra di Libia 183
Il generale Paolo Spingardi
Ripresa delle operazioni e con clusione della pace
Eliminato Cane va , Giolitti chied ev a un 'az ione più efficac e 134 , dato anche che le trattati ve coi turchi in Svizzera procedevano faticosamente 135 • Un'invito ad agire più energicamente in Cirenaica p erve nne a Spingardi anch e dalla Cort e. Brusa ti infatti gli scriv eva il 26 di agosto:
Pare che l'attività degli arabi si ride sti a Ben gasi. Sarebbe desiderabile che anche colà s i facess e q ualch e cosa d a part e nos tra, se non altro per s mo rzare l'ardi mento del nemico che è giunto a colpire con fucilate perfino la baracca dei bagni degli ufficiali. Si di ce che E nver Bey (al quale mi pare si faccia da noi soverchia rèclame) sia g iunto nel ca mp o di fronte a Ben gasi; altri lo dice in viaggio pe r Ales sa ndria e Salonicco ove do vrebbe interveni re a un congresso di Giovani Turchi; altr i lo fa andare a Giarabub incont ro al Capo dei Senussi. Si a ciò che si vuole, sta di fatto che in C irenai ca siamo rimasti inattivi nelle s ingol e piazze, al pari o più che a T ri poli. Sa r e bbe ora di agire o di prepararsi ad agire 136 •
E finalmente si agì. Il generale Salsa il 14 se ttembre 1912 riu scì a sloggiare i tu rchi dalle pos izio ni dalle quali per du e mesi avevano bombarda to Derna e respinse tre giorni dopo un violento contrattacco che cercava di riconqui stare le posizioni perdute riuscendo, forse per la prima volta durante la guer r a, ad annientare il nemico 131 • Tre giorni dopo le t ruppe italiane ottennero un notevol e suc cesso anche nella zona di Tripoli , co n la battaglia di Sidi Bila I, seconda solo a Sc iara Sciat p e r num ero di perdite umane 138 •
134 RFS, Brusati a Spingard i , 9 luglio 1912.
13S v. D EL BocA , p. 186 e G1 0L1rn, pp. 278-279.
136 RFS , Brusati a Spingardi, da Viareggio, 26 agos10 1912. I Senussi erano gli appanenenti a una confra1ernita religiosa musulmana che es1endeva la sua influenza anche al campo pol i tico, econo mi co e soci ale, fo rnendo una solid a o rga ni zzazione e h garantì i l coo rdinamento unitar io alla resiste nza delle tribù sem in omad i dell'interno anche dopo il ritiro delle truppe mrche. Tutto ciò contribui a rendere ulteriormente difficile la penetrazione italiana in Cirenaica.
137 V. D EL BocA, p. 188 e L'azione dell'esercito, pp. 60-61.
138 DEL BOCA, pp. 189- 190 ; L'az ione , pp 65-66. Sull a battaglia di Sidi Bil a l, det ta anche seconda battaglia di Zanzur vi so no tre interessanti testimonianze tra le carte del generale Spingardi, due di P ollio e una di Brusati. Il 21 senembre, a caldo, Pollio commentava: « Possiamo esser fieri della nuova vittoria che è stata, forse, con quella del 26 onobre, la più co ntrasta ta e la p iù caramente con qu ista la , ed è anch e, forse , la più bella della campagna ! Le perdite sono penose: a me ha fatto senso quella di Gadolini, eccellente ufficiale, che fu il mio aiutante di campo. TI rapporto di Ra gni è di una lucidità veramente not evole, e De Ch aurand ha spiegato mtto il suo valore». Il 3 ottobre, p lacato l' iniziale entusiasmo, comunicava a Spi ngardi: «Ti mand o la relazione de l G. R agni sulla battaglia d i Sidi Bil a!. Essa è chiara e semplice (forse anche troppo). Non mi pare comp leta perché p.es non si parla del bau.ne del 23 ° che con 4 compagnie ha perduto cinque ufficiali (compreso il comandante) e 112 uomini di truppa. È un po' vago quello che si riferisce all'82 ; che te ne va co ll egato il 34° coUa dest ra d ell a brigata To mmaso ni. Il G Ragn i mi scrive (privatam ente) che ha lasciato la cosa nel vago perché non è ancora po1uto venire in chiaro del modo con cui hanno combauuto i due batt.ni di sinistra del reggimento e che
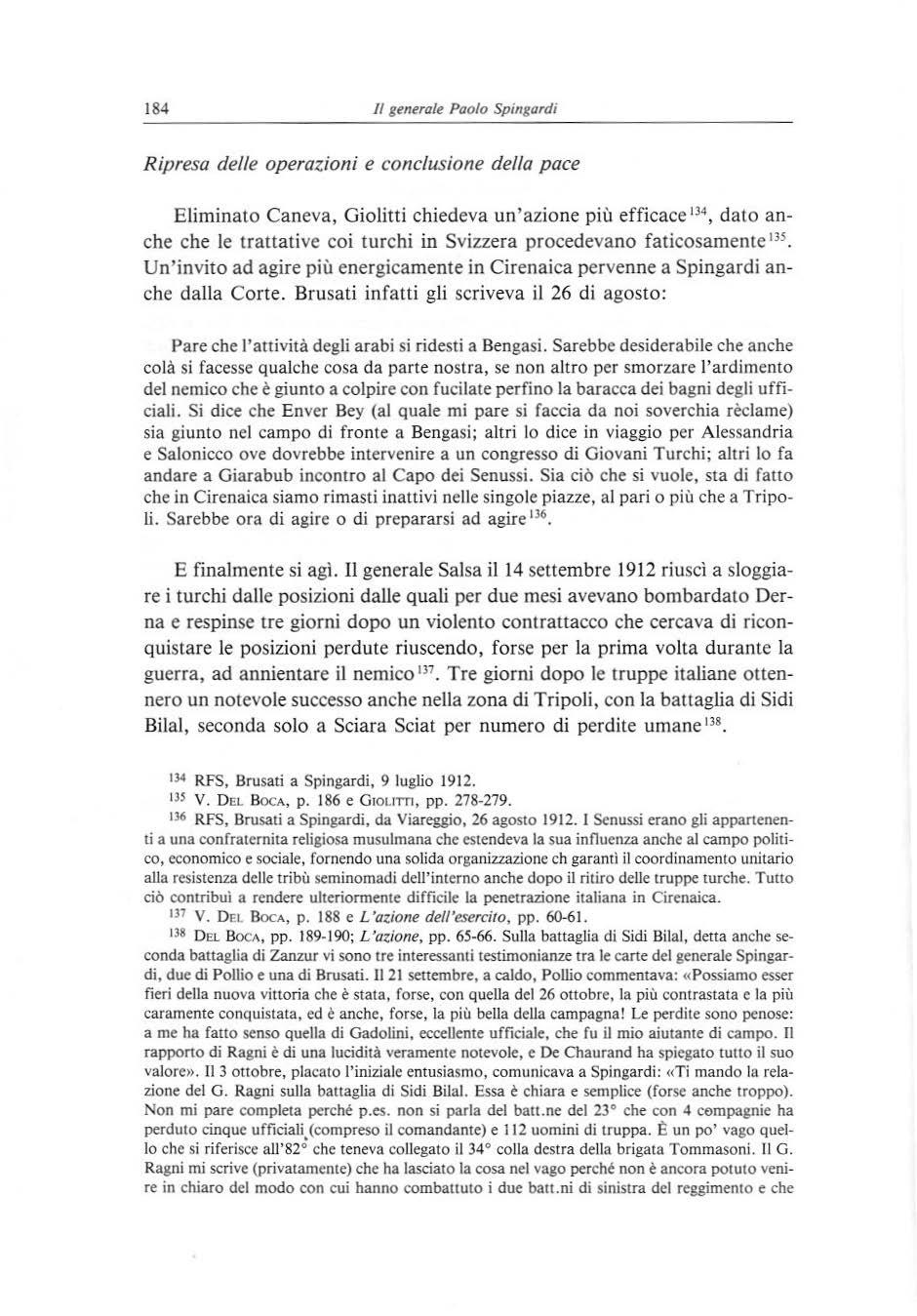
184
Queste operazioni non ebbero però influenza decisi va nell'indurre la Turchia alla pace . E ss a do vette cedere per l'aggravarsi della situ azione balcanica. Il 30 settembre gli Stati balcanici mobilitarono. L'8 ottobre il Montenegro dichiarava guerra, seguito il 17 ottobr e da Serbia, Bulgaria e Grecia. Il 18 ottobre 1912 il trattato di Ouchy metteva fine alla guerra italo -turca. La Turchia rinunciava alla sovranità sulla Libia e l'Italia si impegnava a evacuare le isole dell'Egeo non appena fosse compl etato il ritiro delle forze turche dalla Tripolitania e dalla Cirenaica 139 • Il 21 ottobre 1912 venne conferito a Spinga rdi, a Di San Giuliano e a l Ministro della Marina Leonardi Cattolica il Collare dell'Annunziata, la massima onorificenza di casa Savoia, per la vittoriosa condotta della guerra.
li trattato di pace non significò però la fine delle ostilità. I reparti turchi tornarono in patria, ma le tribù arabe, inquadrate da ufficiali regolari, continuarono a contrastare la penetrazione italiana.
In Tripolitania l 'occupazione fu gradualmente estesa vers o l' interno nei me s i suc cess ivi alla pace con la Tur ch ia. Nell'agosto del 1913 fu d eci sa la
vi ritornerà sopra . M i avverte intanto che urge nominare il nuovo comandante di corpo perché il tenente colonnello Ba r toti, comandante interin a l e , è assol utamente defic iente Impr ess iona il numero d e i dispersi. Già da parecchi giorni ho teleg rafa to a l G. Ragni pe rché ne prenda co n to Non v'è però da stupire che ve ne si ano tanti p erc hé si è combattuto nel fo lto di oas i da cui più tard i ci siam o ritirati per r estri ngere l 'occ u pazione ne l modo stabili t o a priori dal comandan te supr emo Il contr attacco delle meha ll e [tr ibù ] d i Suani Ben Aden è stato ce r to v io len t o (la re lazione non lo color isce a su f ficienza , forse) ma non deve aver durat o molto perché, di fatto, i due reggimenti d i M aggi otto (ch e hann o avute pe rdi t e quas i nu lle) furo n o poc o impegnati in combatt im ento. Il su cces s ivo attacco delle mehalle di F ondu e Garcia (?] fu facilmente respinto In r ealtà non mi pare che, prima di vince re, siamo giunti a quel momento in cui le possibi lità si pa reggiano fra gli avversari e basti po i una spinta per dar il t ra collo da una o dall'altra p arte. Il 6 ° , il 4 0 ° , l' Il O bersaglier i e a ltr i r iparti sono r im ast i quasi i nta t t i fino all'u l t im o». Infin e, da S. R osso re, Brusati scri veva il 25 ottobre: «Pe r incarico di S.M il R e ti restitui sco i docume nt i che Gli hai comu n icati , relativ i alla battaglia di Zanzur 2•. S.M . è d'avviso che essendo la guerra la so la vera p i etra d i par agone per la capaci tà militare d egli uf fic iali , specie di grado eleva to , e in vista di un in t e resse supremo dinanzi al quale scompaiono i r i guardi alle person e, si dovrebbero, senz'altro , elim inare dai quadri gli ufficiali che su campo di battagl ia di edero cattiva prova di sé Dovrebbesi quindi elim inare, nel caso presente, il T Co l. Bartoli, il Cap Menada, il Co l. Caserta, i general i S alazar e T ommasoni (il pr imo di questi d ue particolarmente) Così sol tanto si potranno avere negli alti comand i ufficiali c i rco ndati dalla sti ma e dalla fiducia d eg li infe r iori , fid u cia e st ima c h e costituiscono una forza inestimabile. Basti r i cordare, a questo proposito, l a bella prova fatta dall'82" fanteria allorché era comandato dal Col. Borghi, in confronto d e l modo disastroso col quale il Regg.to stesso s i comportò i l 20 settemb r e u s Il Re r ilevava pure la poca opportu nità di avere i nca r icato della inch iesta i l Gen De Chaurand , il quale a sua volta non aveva i l 20 settembre opportunamente e a tempo fatto se nti re la propri a azione di comando, per co r regger e i difetti d erivanti dall'estesissimo fronte di battaglia e da ll a scarsa ini z iativa e dalla imperizia dei Capi in sott'ord ine».
J39 Sul trattato V. D EL Boc A, pp . 19 1-1 96 .
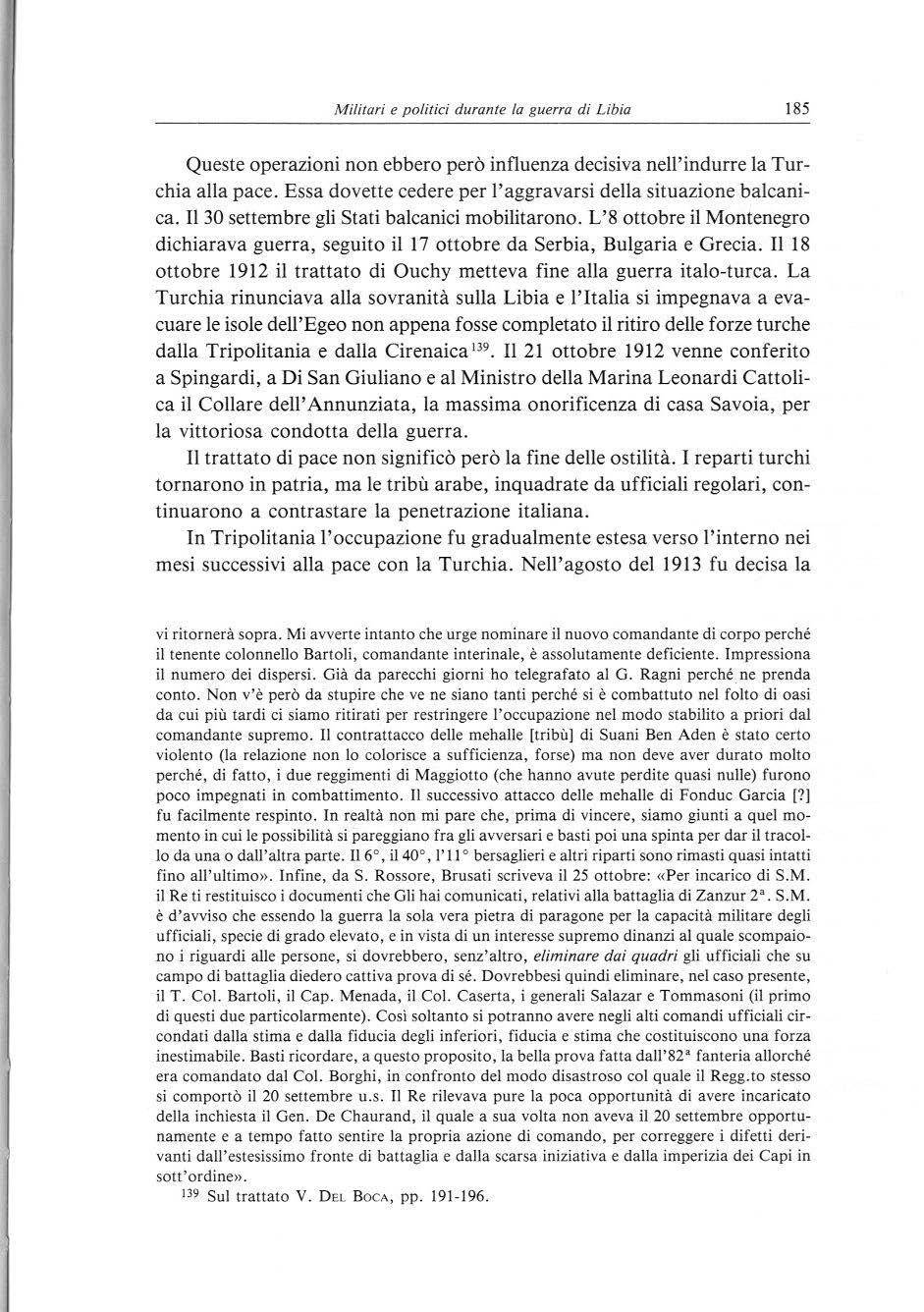
Militari e politici durante la guerra di Libia 185
Il generale Paolo Spingardi
spedizione nel lontano Fezzan, condotta a termine con successo nel marzo del 1914. Più difficile la penetrazione in Cirenaica. Benché numerosi successi parziali fossero ottenuti nei mesi successivi al trattato di Ouch y, al momento di lasciare il Mini stero Spingardi doveva accontentarsi di vedere la occupazione ancora limitata ai centri costieri 140 •

186
140 Sulla penetrazione in Trip0litania e Cirenaica v. D EL B ocA , pp. 205-260.
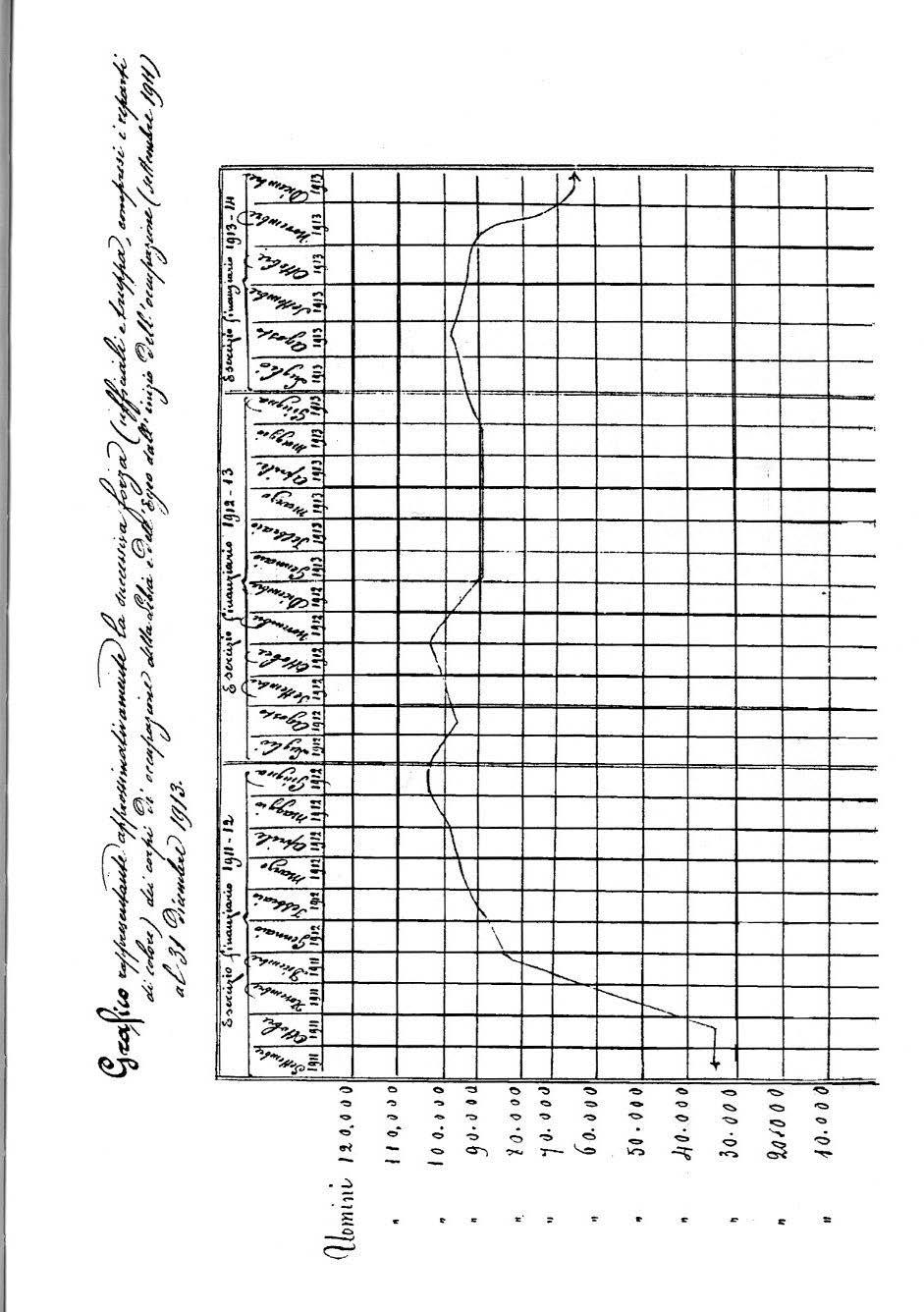
i~ J~ :~1 "§ {~ r .1 i: l " ,\ l, () *~\" -~ ~1 l 1,: . " ." 1~1 ii~ 01·· i.si -~ i f ..,, .,, .,. "' . o· ..,. ... .,; fN C> . C)e-' e ..,,,. ... o ""' 'O ,,:::, ""' -::, .,; e-., <:> ,,:::, <::, " '<::> ..,, ..;. ò ....,. "' . -::, è....,. '-.:o IO ,.. T"E .. . t ..

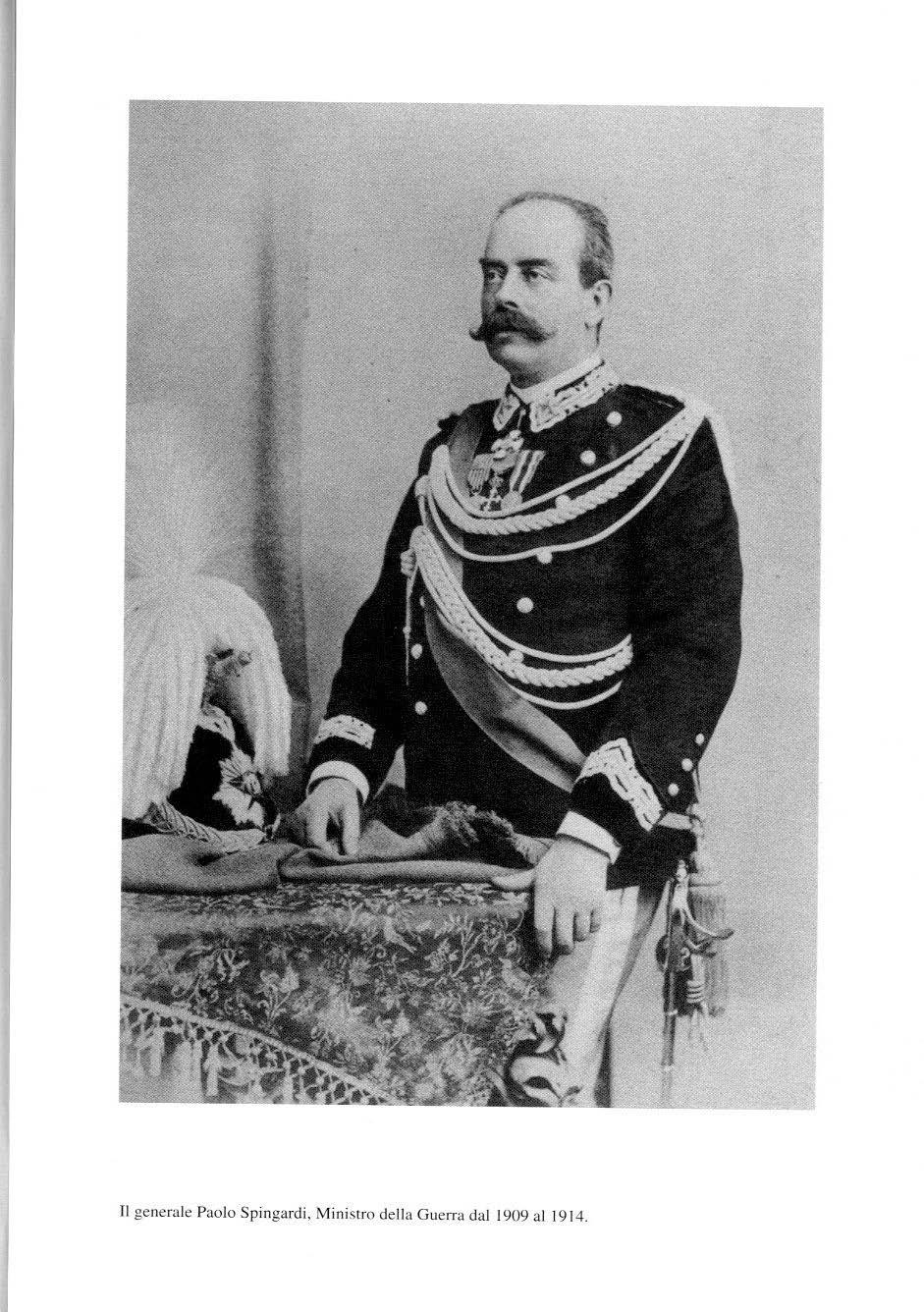 Il generale Paolo Sp inga rdi, M inist ro della Guerra dal 1909 al I 914.
Il generale Paolo Sp inga rdi, M inist ro della Guerra dal 1909 al I 914.
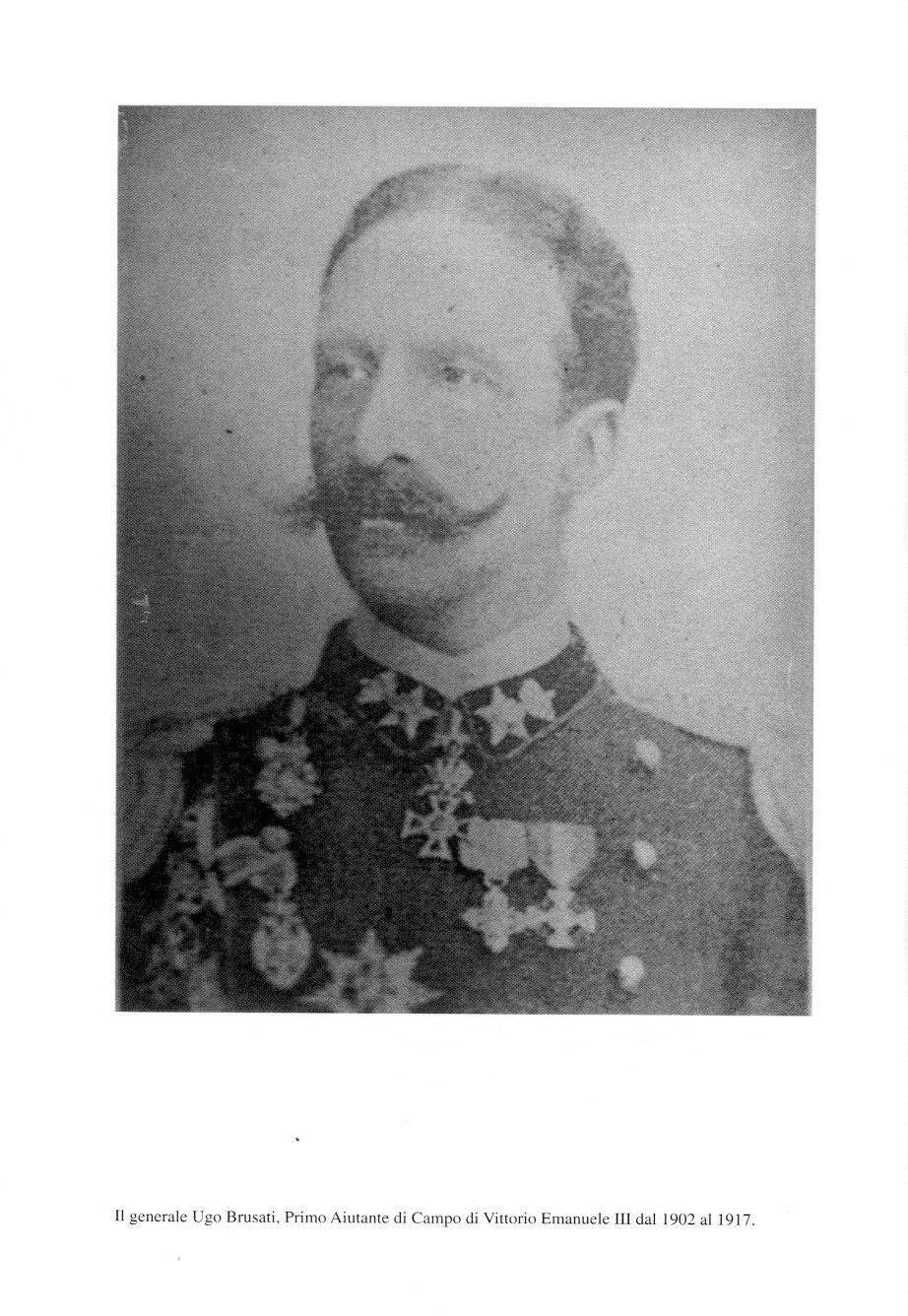
I l generale Ugo Brusati Prim o Aiutante di Campo di V i uori o Emanuele 111 dal 1902 al 1917
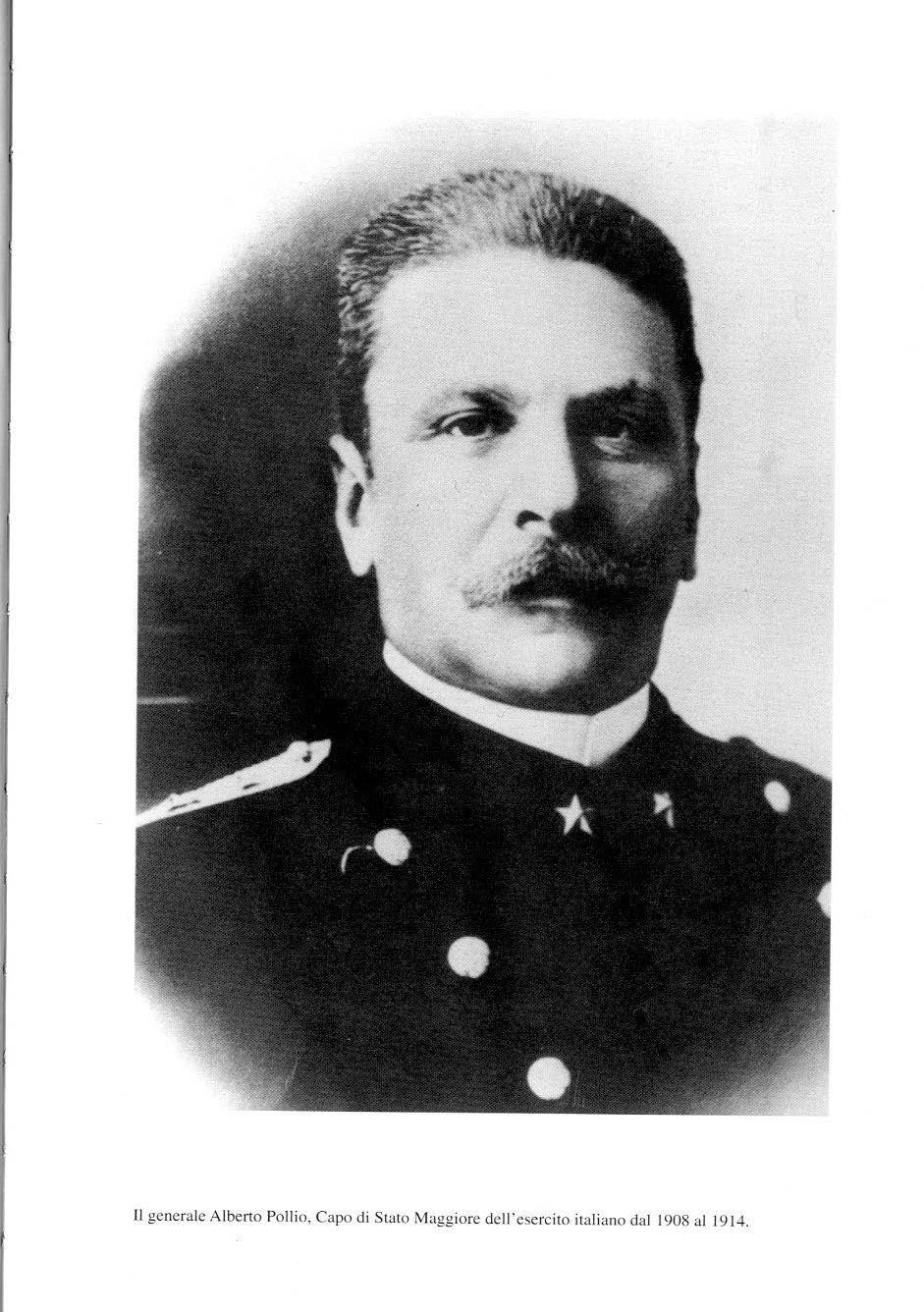 li genera le A lberto Poll io, Capo di Stato Magg iore dell'eserci w ital iano dal 1908 a l 1914.
li genera le A lberto Poll io, Capo di Stato Magg iore dell'eserci w ital iano dal 1908 a l 1914.
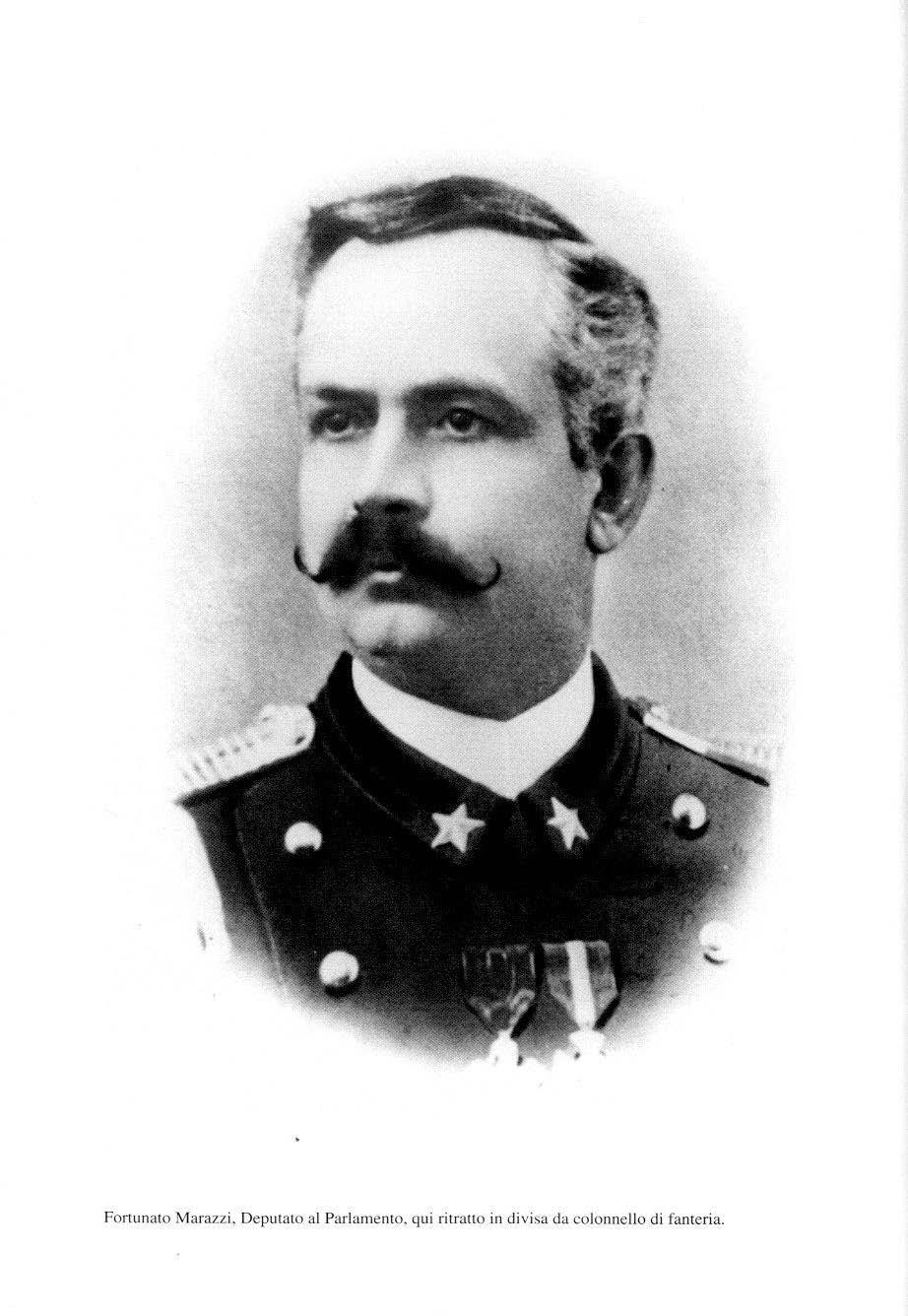 Fortunato Marazzi , De putalo al Par lamento. qui ritrailo in div is a da colonnello di fanteria.
Fortunato Marazzi , De putalo al Par lamento. qui ritrailo in div is a da colonnello di fanteria.
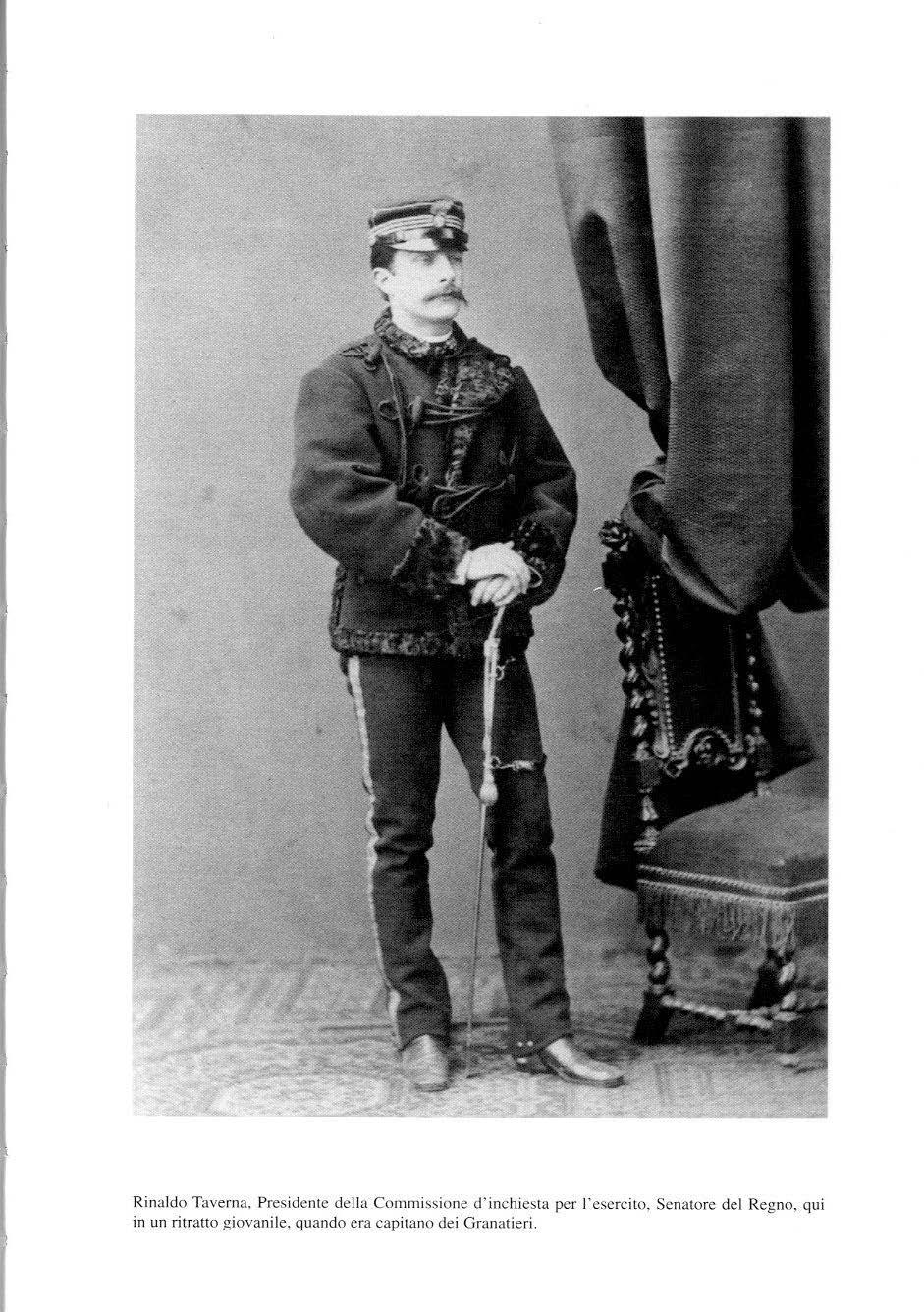 Rin al d o Taverna. Pres i dente dell a Comm i ssione d'inchi es ta per l'eserci tO , Senatore del Regno, qui in un ritratto giovan ile. qu an d o era cap it ano dei Granatieri
Rin al d o Taverna. Pres i dente dell a Comm i ssione d'inchi es ta per l'eserci tO , Senatore del Regno, qui in un ritratto giovan ile. qu an d o era cap it ano dei Granatieri
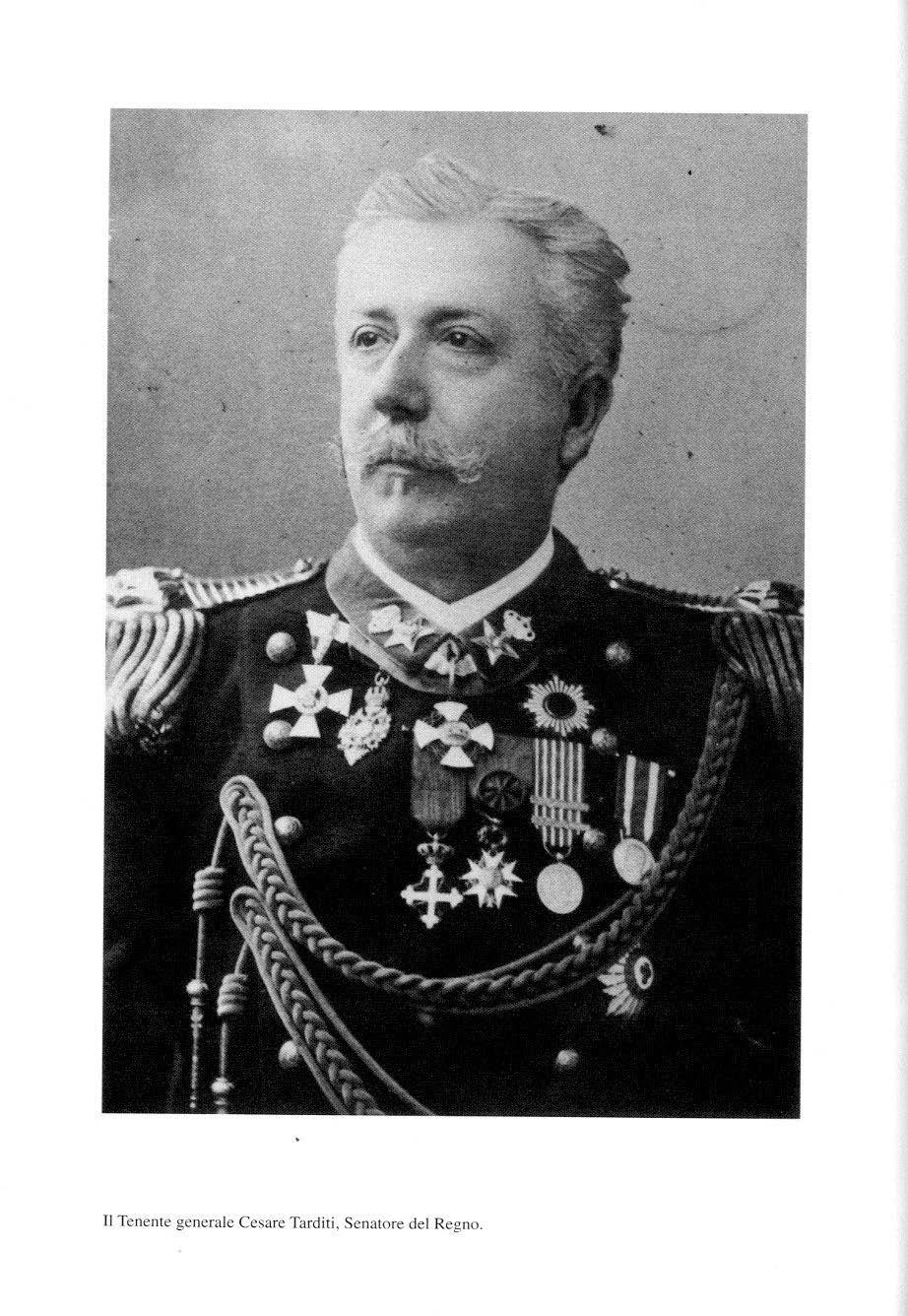 TI Teneme generale Cesa re Tarditi, Senatore del Regno.
TI Teneme generale Cesa re Tarditi, Senatore del Regno.
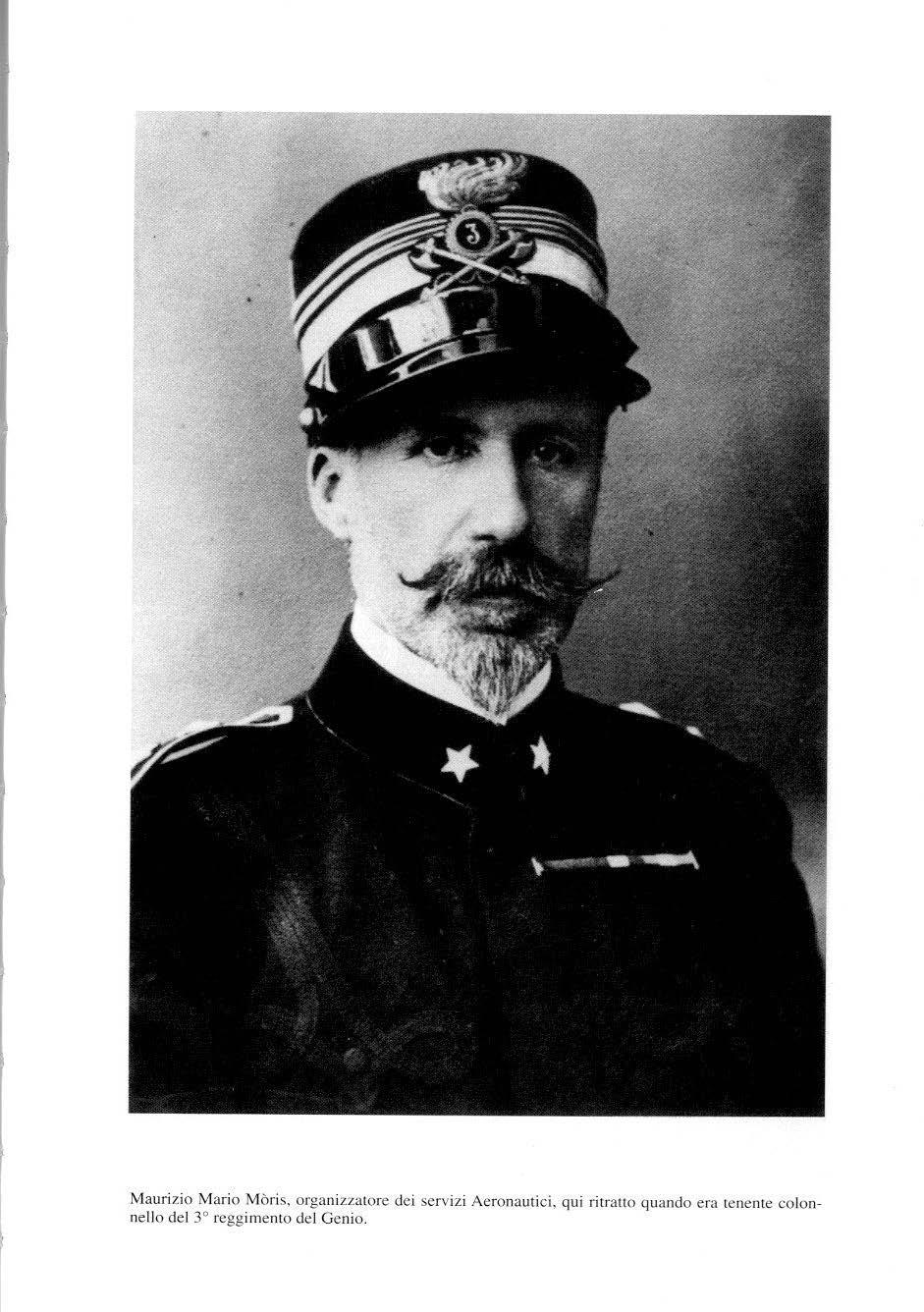 Mauri zio Mario Mòri s, organ i zzatore dei serviz i Aeronautici, qui ritrauo quando era tenente co l onnel l o del 3 ° regg i mento del Gen io.
Mauri zio Mario Mòri s, organ i zzatore dei serviz i Aeronautici, qui ritrauo quando era tenente co l onnel l o del 3 ° regg i mento del Gen io.
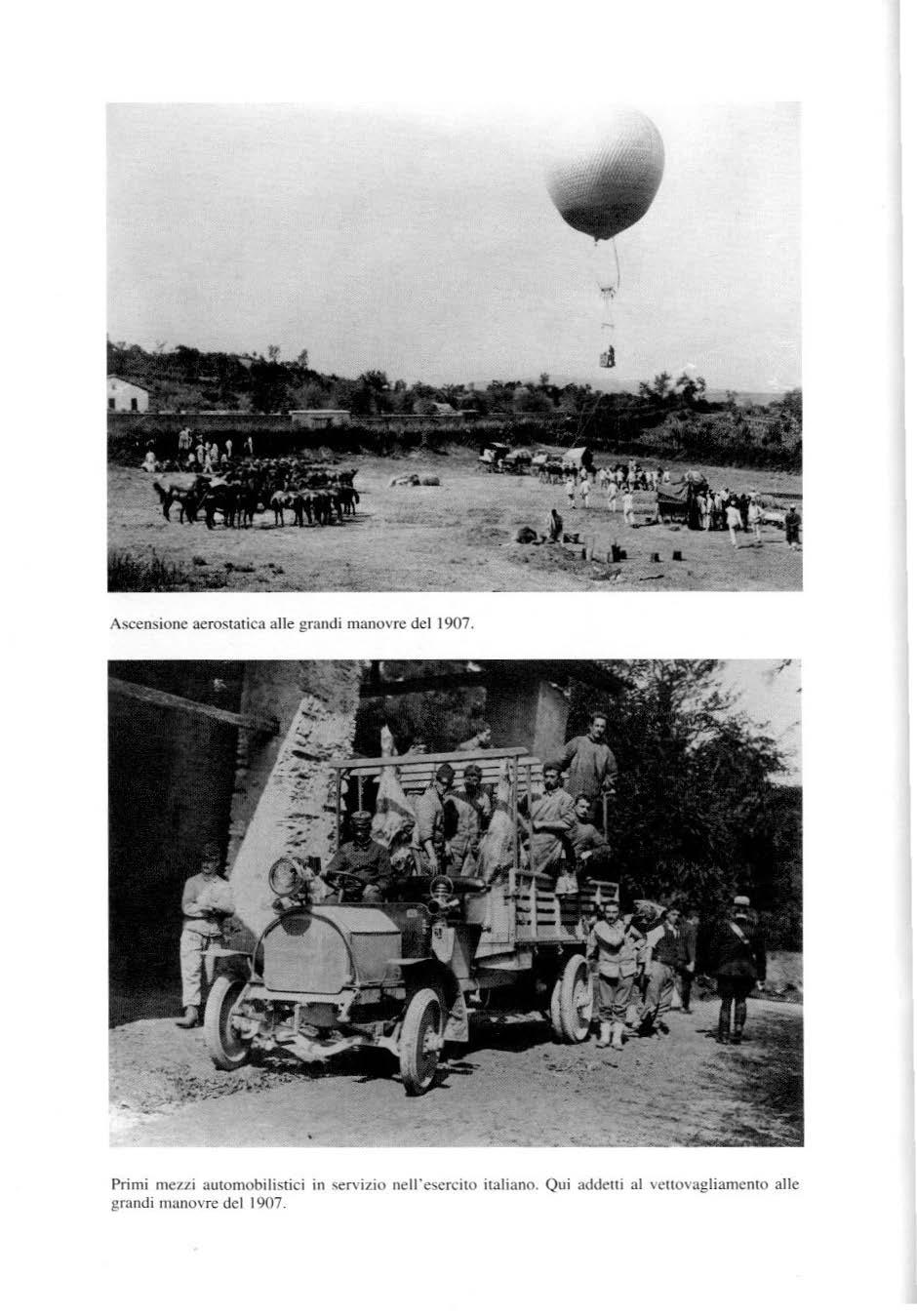 Ascensione aerostatica alle grandi manovre del 1907.
Primi meui automobilistici in ~ervizio nell'esercito italiano. Qui addeui al vettovagliamento alle grand i manovre del I907.
Ascensione aerostatica alle grandi manovre del 1907.
Primi meui automobilistici in ~ervizio nell'esercito italiano. Qui addeui al vettovagliamento alle grand i manovre del I907.

Ascensione i n p
o 191 4
allone Roma, gennai
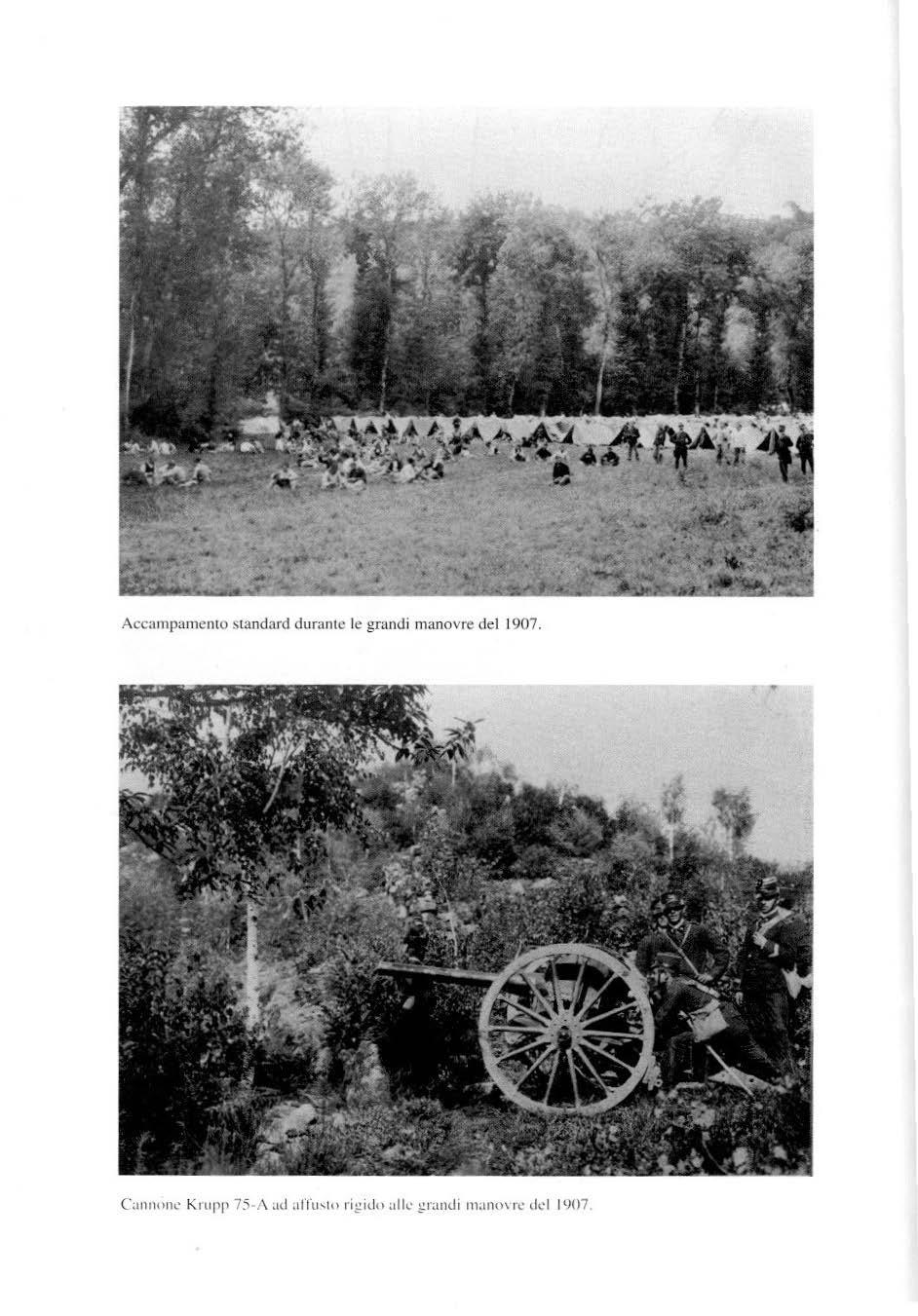
C.11111t111.:
Accampamen to s tand ard durante l e grand i manov re del 1907.
K , upp 75 -1\ ad ,ifft" l o ri g id o alk grandi mano, ro.: d.:! 1907
 Pezzo a de formaz i one K r upp da 75-A modell o 1906 al l e grand i manovre del 19 I l.
Pezzo a de formaz i one K r upp da 75-A modell o 1906 al l e grand i manovre del 19 I l.
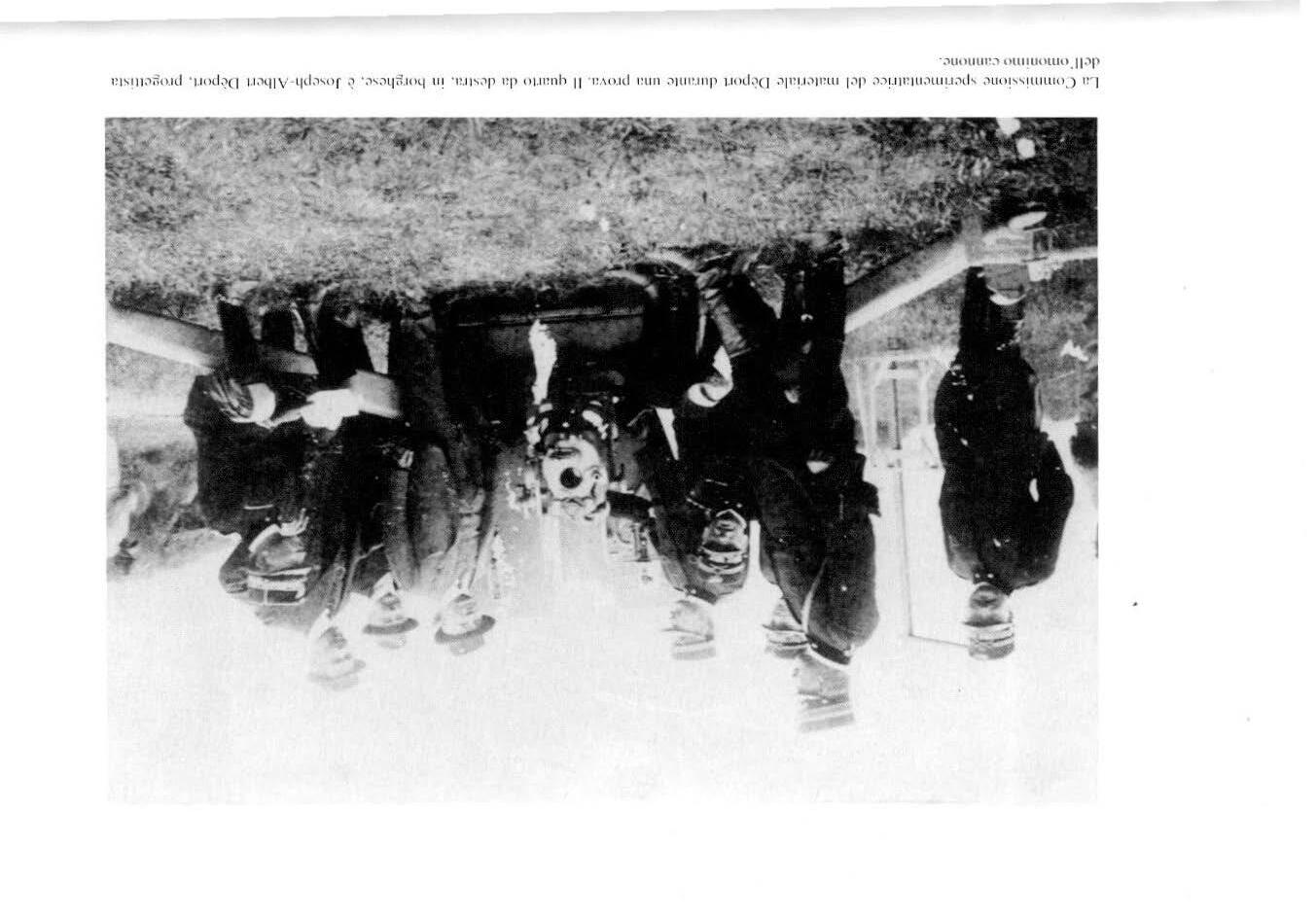
'.) é. '.) e '.) ~ ' [ f :: ':.J = ;:: ·-; !. ::: É e :: _j
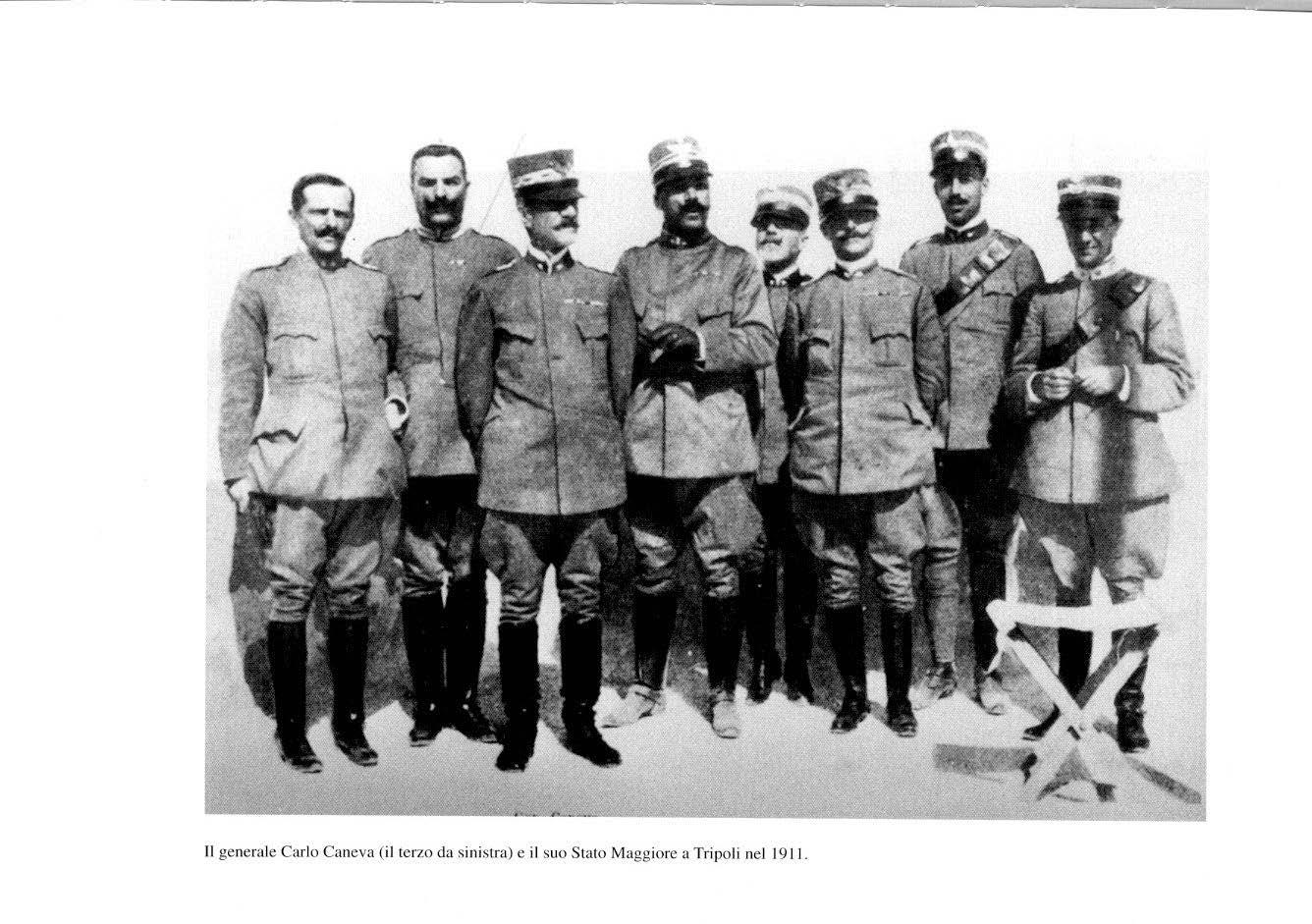 Il gene ra le Car lo Caneva (i l te rzo da s ini srra ) e il s uo Stato Maggio re a Tri p ol i ne l 19 I I.
Il gene ra le Car lo Caneva (i l te rzo da s ini srra ) e il s uo Stato Maggio re a Tri p ol i ne l 19 I I.
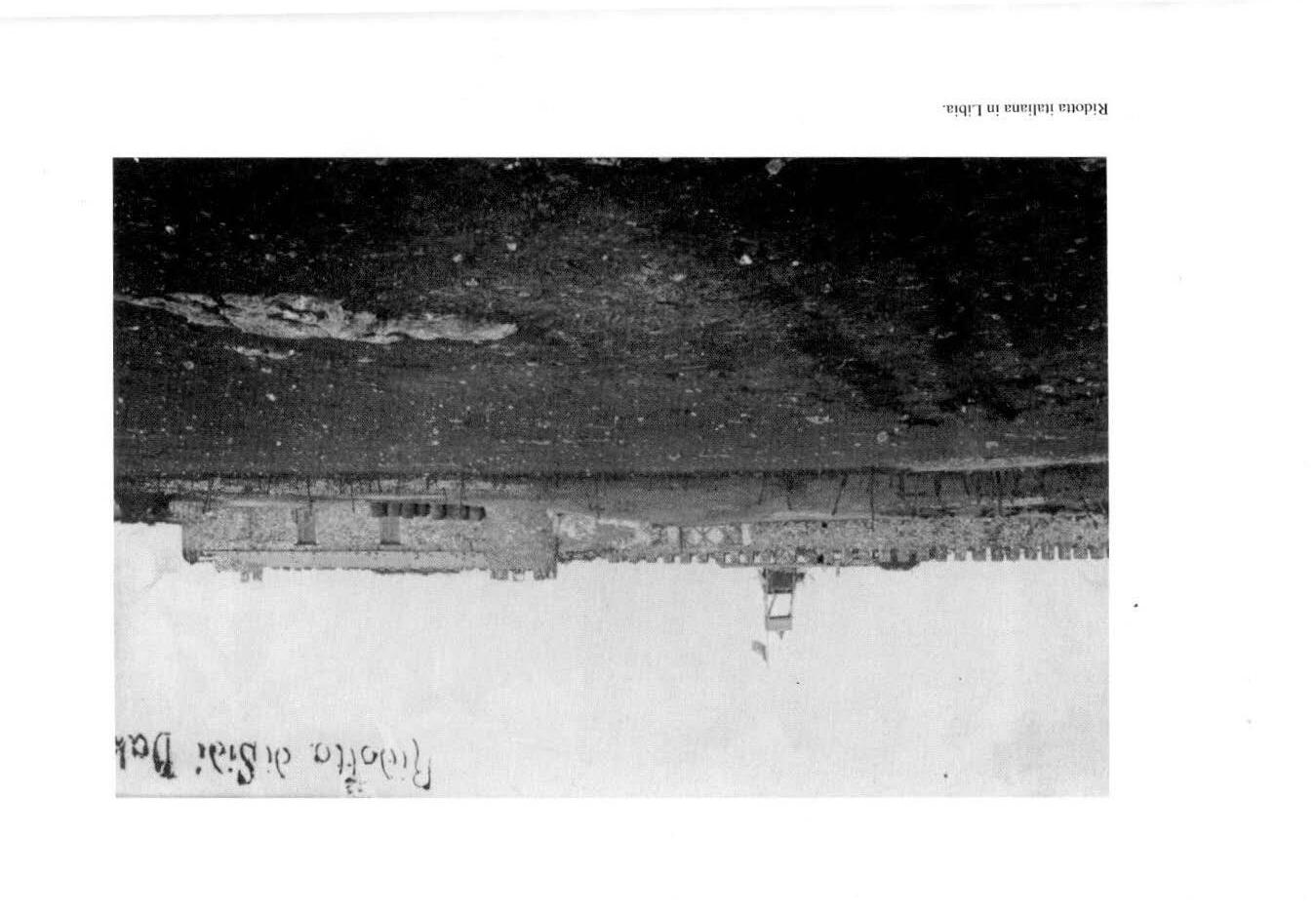
·- ·-....-:, e .,._J r t -·' Q
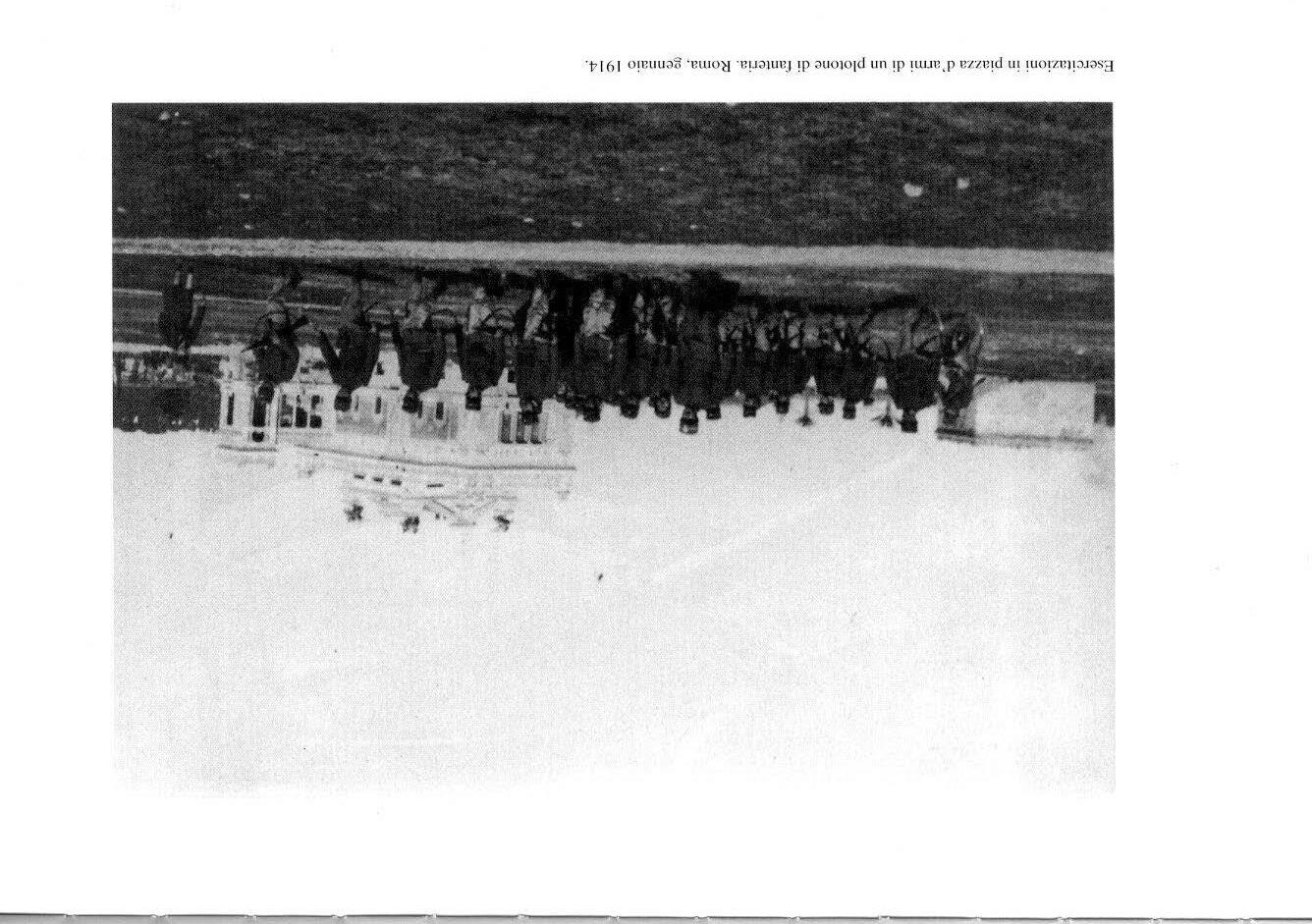
" :::, . E
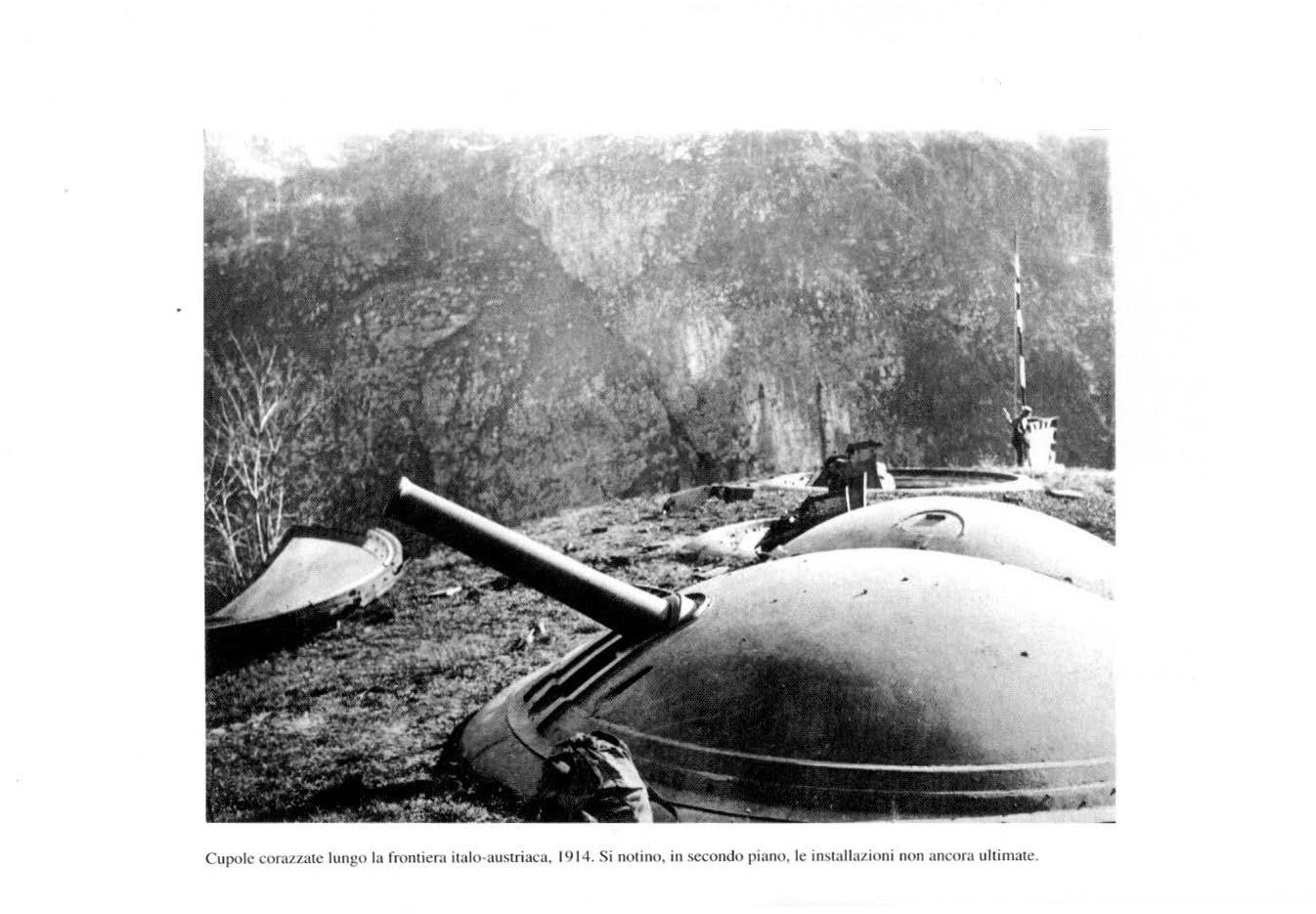 Cupol e corazzate lun go la fronti era i tal o -austriaca. 19 14. Si notin o. in seco nd o piano, l e installaJCioni non ancora ultimate.
Cupol e corazzate lun go la fronti era i tal o -austriaca. 19 14. Si notin o. in seco nd o piano, l e installaJCioni non ancora ultimate.
CAPITOLO VI ll
IL DOPOGUERRA
Spingardi dovette ammettere che la guerra di Libia aveva «fatalme nte costituito un elemento ritardatore al crescente sv ilu ppo organico bene avviato della preparazione del nostro esercito» 1 •
L'effetto più deleterio fu il pesante depauperamento di effettivi subito dai reparti dell'esercito metropolitano .
Le truppe destinate in Libia superarono costantemente i 90.000 uomini per tutto il periodo dal febbraio al dicembre 19 I 2 e poi ancora dal giugno al novembre 1913 . Soltanto nel gennaio 1914 poterono essere ridotte a 70.000 unità 2
Repart i corrispondenti complessivamente all'entità di tre corpi d'armata vennero impegnati in Libia e nell'Egeo 3 •
Se le perdi te in battaglia furono relativamente conte nu te4, migliaia di soldati si ammalarono però di tifo e di colera 5 • Se anche le conseguenze letali furono limitate, i reparti risultarono ugualmente falcidiati perché ovviamente chi era in ospedale non poteva combattere.
Più di 400.000 soldati dell'esercito italiano aveva preso parte alla sped i-
1 RFS, Dep osizione Caporetto, p. 11.
2 Cfr. RFS , Grafico rappresentante approssimativamente la successiva for;.a (ufficiali e truppa, compresi i reparti di colore) dei corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo dall'inizio dell'occupazione al 3/ dicembre /913, qui riprodotto a p. 187.
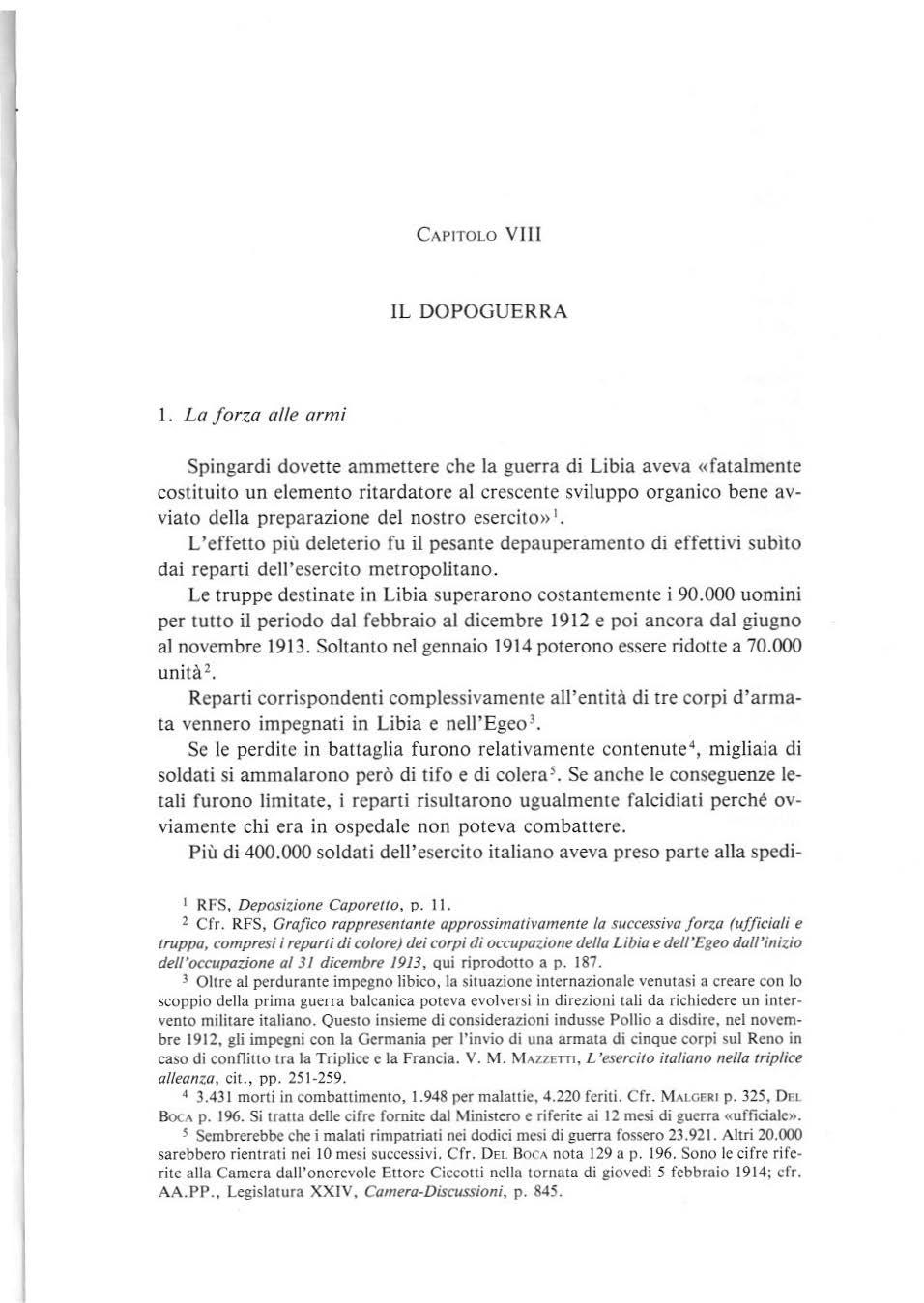
3 Oltre al perdurante impegno li bico, la situazione internazionale venutasi a creare con lo scoppio della prima guerra balcanica poteva evo lversi in direzioni tali da richiedere un intervento militare italiano. Questo insieme di considerazioni indusse Pollio a disdire, nel novembre 1912, gli impegni con la Germania per l'invio di una armata di cinque corpi sul Reno in caso di conflitto tra la Triplice e la Francia. V. M. MA 77ETII , L'esercito italiano nella triplice allean za, cit., pp. 251-259.
4 3.431 morti in combattimento, 1.948 per malattie, 4.220 feriti. Cfr MALGERI p. 325, D EL Boe" p. 196. Si traua delle cifre fornite dal Ministero e riferite ai 12 mesi di guerra « ufficiale».
5 Sembrerebbe che i malati rimpatriati nei dodici mesi di guerra fossero 23.921. Altri 20.000 sarebbero rientrati nei IO mesi successivi. Cfr. DEL Boe" nota 129 a p 196. Sono le c i fre riferite alla Camera dall'onorevole Ettore Ciccotti nella tornata di g iovedì 5 febbraio 1914; cfr. AA.PP., Legislatura XXIV, Camera-Discussioni, p. 845.
1. La /orza alle armi
Il generale Paolo Spingardi
zione libica, appartenenti a «cinque intere classi, dal 1888 al 1892, oltre a contingenti minori d'armi speciali d'altre classi» 6; ventidue divisioni dell'esercito permanente su venticinque avevano inviato almeno un reggimento 7 •
In patria ne risultarono compagnie ridotte alla forza di 40 uomini 8 •
Fin dal 2 settembre 1912 Pollio aveva messo in rilievo come la non lieta situazione impedisse l'invio dei rinforzi richiesti dal generale B riccola perché
a ll o stato attuale delle forze mobilitate e data l'impossibi li tà d i provvedere dall'Italia sia a nuove mobilitazioni, sia anche ai semplici complementi intesi a riportare e mantenere a numero nei prossimi mesi gli effettivi, il co r po d'occupazione non è, a mio avviso, s ufficiente ad effettuare, se pur successivamente, operazioni importanti in entrambe le regioni della Libia. Per poter ciò fare, sarebbe assolutamente necessario ricorrere a n uovi cespiti di forza, e cioè a richiamo tota le o parziale di classi 9
P o lli o sollecitò ancora nel febbraio del 1913 «l'ad ozione immediata di misure c h e aumentassero la fo r za a ll e armi» 10 • Spingardi presentò perciò in Parlamento un nuovo progetto di legge sul reclutamento.
Già durante la discussione sul bilancio in febbraio il tema de ll a scarsa forza ai reparti era stato presentato al Ministro 11 • Ma nelle tornate del 30 e 3 1 maggio si assistette a una violentissima opposizione dei socialisti al nuovo disegno , segno forse della linea intransigente decisa l'anno precedente dopo il congresso di R eggio Emil ia 12 • Si contestava che il progetto «divenuto legge, ne l suo p ieno sviluppo, con tut te le c o nseguenze che nasconde in germe e che p r odurrà, costerà forse alla nazio n e q u alche cosa come un centinaio di milioni di lire all'anno!» 13
I n e ffetti Spi n ga r di co mpilò il bilancio 1914-15 per una forza di 275.000
6 RFS, Deposizione Caporetto, p. 30, nota manoscritta I a piè di pa gina, calligrafia di Spingardi. La cifra di oltre 400.000 uomini che avrebbero preso parte alla campagna è tratta dal par agr afo al quale la nota si riferisce : «Forza adunque mobilitabile , istruita, superiore al fabbisogno previsto in 800.000 uomini, dei quali più della metà avevano preso parte alla guerra di Libia: avevano per lo meno sent ito l'o dore della polvere»
7 Il dato si trova in GoocH, Army, Sta1e and Society in J,aly, cit., p. 148
8 V Le condizioni del nos1ro esercito, « L'Esercito ital iano », 12 marzo 1913.
9 R FS , Pollio a Spingardi, Roma, 2 sette mbre 1912. La lettera, Riservatissima Personale , è datti loscritta con la firma autografa di Pollio, e la data reca l ' anno 1918. Si tratta ovviamente di un errore, e non può essere stata scritta che nel 1912.
10 RocHAT , L 'esercito italiano nell'estate del 1914, p. 313.
11 V AA.PP , Legislatura XXIII, Camera-Discussioni, tornata del 22 fe bbr aio 1913, interventi d i Di Salu zzo'e P istoja , pp. 23329 e 23419-23422
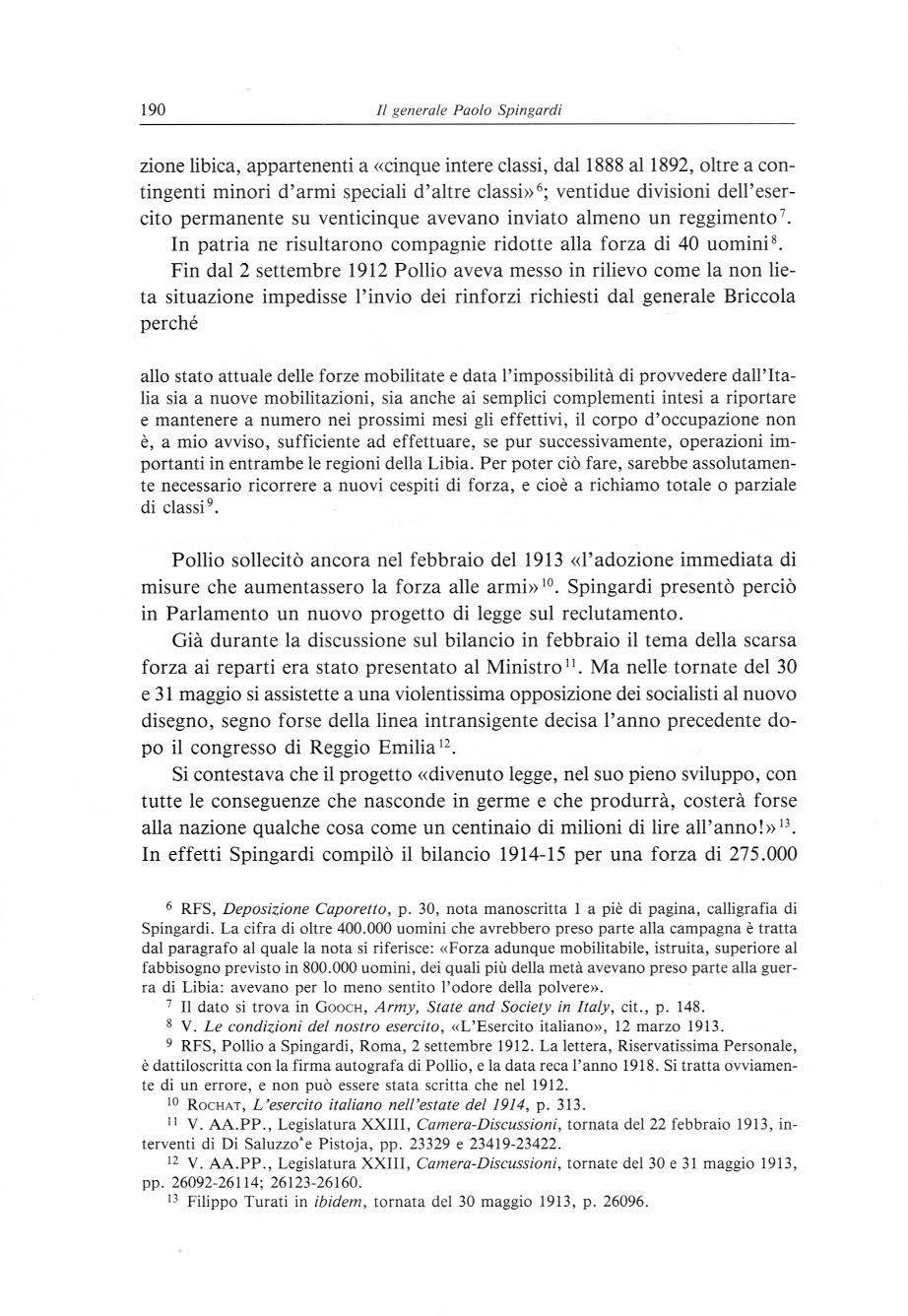
12 V. AA.PP. , Legislatura XXIII, Camera -Discussioni, torna te del 30 e 31 maggio 1913 , pp. 26092 -26114; 26123 -26160.
13 Filippo Tura t i in ibidem, tornata del 30 maggio 1913, p. 26096.
190
uomini proponendosi di arrivare a 300.000 nel bilancio successivo 14 • Ma in realtà la spesa effettiva si sarebbe aggirata sui 15 milioni 15 Ad ogni modo prima o poi questi fondi sarebbero occorsi e quindi fu sollevato il problema di come provvedervi, non so lo dai socialisti ma anche dai radicali 16•
Intervenne lo stesso Giolitti dichiarando che «qua lora fosse necessario ricorrere ai contribuenti [... ] noi non potremo chiedere nulla alle classi disagiate, ma dovremo rivolgerci alla vera ricchezza» 17 , ed accettò senza difficoltà un ordine del giorno dei radicali che invitava il Governo «qualora occorressero nuove entrate per far fronte ad aumento di spese militari» a provvedervi «con aumento d'imposte che cadano su lle classi più agiate>> 18 •
Dopo la dichiarazione del Presidente del Consiglio che quello era il sistema che si doveva seguire perché «le classi più povere danno già con la leva di terra e la leva di mare il loro contributo alla difesa del Paese» e quindi «le classi più agiate hanno il dovere di dare i capitali che a questo scopo occorrono>> 19 , l'ordine del giorno venne facilmente approvato dalla Camera.
«Semplice bluff elettorale», forse 20, ma nei mesi success ivi nuovi crediti militari furono formalmente promessi a Spingardi e il modo più efficace per concederli e ra proprio varare una riforma fiscale che permettesse di aumentare le entrate dello stato senza gravare ulteriormente sulle classi disagiate 2 1 •
Forse indizio dì un nuovo atteggiamento nei confronti del problema può essere la caduta della pregiudiziale finanziaria riguardo il volontar ia to di un anno, del quale Spingardi asserì essere suo «fermo intendimento di addivenire all'abolizione», dando «affidamento c he la questione dell'abolizione del vo lontariato di un anno, se non nell'esercizio 1913-14 , in quello 1914- 15 potrà essere affrontata e risoluta nel senso che ho d etto» 22 •
Anche i volontari di un anno avevano partecipato alJa spedizione di Libia
14 V AA.P P., Legis l atura XXIV, Camera- Documenti, n. 28 -A, Relazione allo Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1 ° luglio 1914 al 30 giugno /915, pp. 1-11 e RFS, Deposizione Caporello , p. 29.
15 V. AA.PP., Legis la t ura XXIII, Camera-Discussioni, pp. 2611 1, 26131, 26154- 26155. Nello Siato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'eserciz io finanziario dal 1 ° luglio 1914 al 30 giugno 1915, presentato alla Camera il 29 novembre 1913, per l'aumento di 25.000 uomini di forza bilanciata era prevista una cifra di L. 10.920 500. V. AA.PP., Legislatura XXIV , Camera-Documenti, n. 28 -A, pp . 1-3.
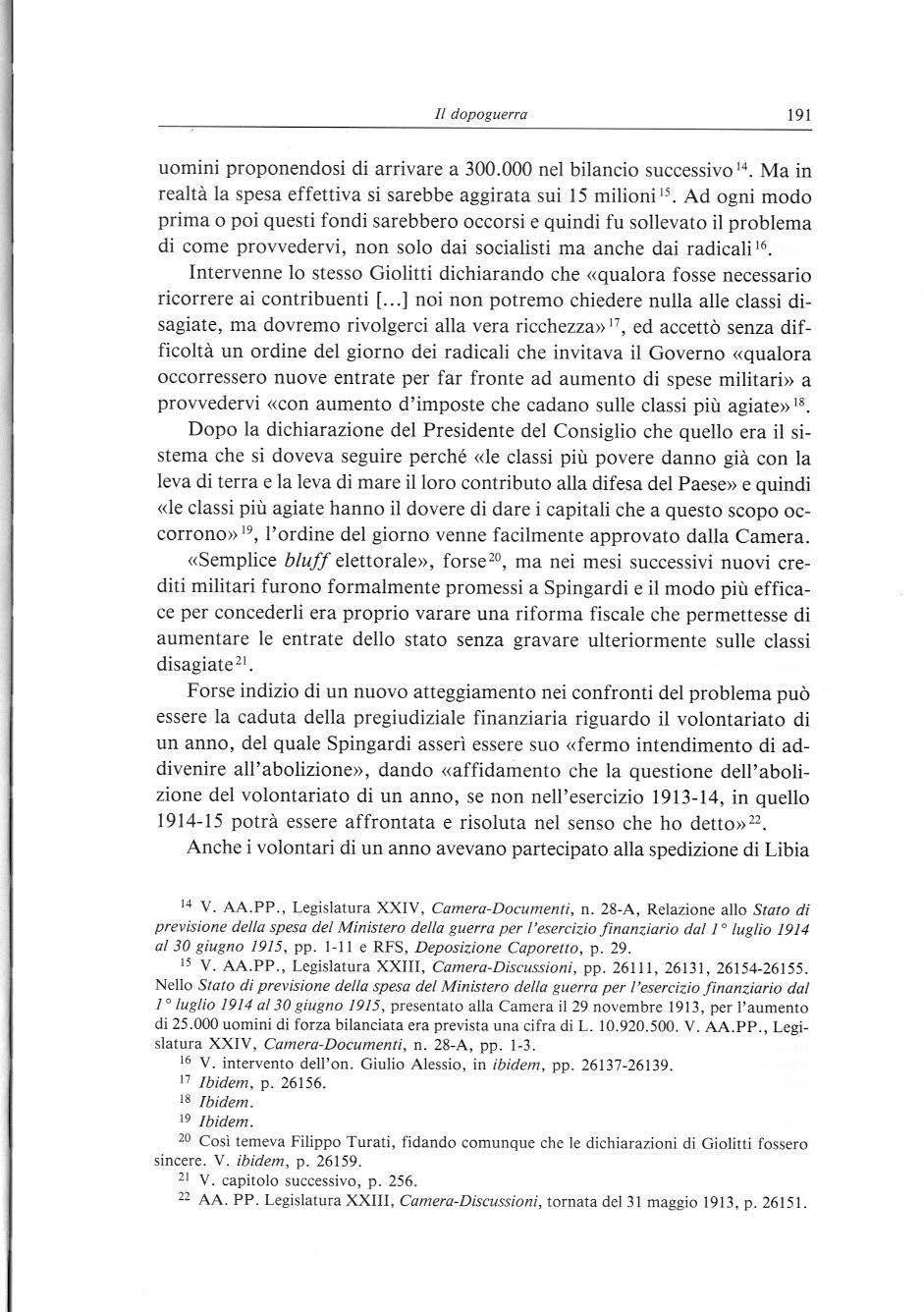
16 V . intervento dell'on. Giulio A l essio, in ibidem, pp. 26137 -26139.
17 Ibidem, p. 26156.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Cos ì temeva Filippo Turati, fidando comunque che le dichiarazioni di Gio l itt i fossero sincere. V. ibidem , p. 26159.
2 1 V. capito lo successiv o, p. 256.
22 AA. PP. Legisla t ura XXIII, Camera- Discussioni, tornata del 31 maggi o 19 13, p. 26151.
li dopoguerra 191
Il generale Paolo Spingardi
e continuavano a contribuire alle operazioni oltremare, perché seguivano in tutto la sorte dei rispettivi reparti 23 • Ciò contribuì indubbiamente a stemperare il carattere di privilegio dell'istituto e diminuì il numero degli aspiranti, ridotti nel 1913 a 1 340, così che si tenne un solo corso all'anno invece dei tradizionali due 24 • Il 21 dicembre 1913 l'atteso disegno di abolizione del volontariato venne finalmente presentato, benché le successive vicende politiche gli impedissero di avere seguito 25 •
Un'altra forte opposizione Spingardi dovette affrontare intorno al suo progettato terzo articolo, che prevedeva di aumentare a un anno il periodo di ser vizio applicabile alla seconda categoria. Nel 1912, per riparare ai vuoti provocati dalla Libia, il Ministero l'aveva chiamata per il massimo consentito, cioè sei mesi . Nel 1913, già era previsto che essa fosse chiamata per cinque mesi a partire dal 20 luglio 26 •
Venne sotto lin eata la condizione di figli unici della maggior parte degli appartenenti alla seconda categoria: la nuova disposizione avrebbe sottratto per un intero anno, quindi anche nei cruciali periodi della semina e del raccolto, l 'u nico sostegno per migliaia di famiglie 27 • Rimane il dubb io se la maggior parte dei figli unici appartenesse davvero a famiglie contadine, ma poiché l'opposizione p r oveniva da settor i diversi della Camera, Spingardi non esitò a lasciar cadere l'articolo 28 • Il disegno di legge venne infine approvato dalla Camera il 3 giugno 1913 con 191 voti favorevoli e 35 contrari.
Al Senato già discutendo il bilancio della Guerra il 27 maggio il generale Mazza aveva pronunciato un applaudito discorso sulla drammatica situazione della forza e perciò con piacere si era occupato della rela zi one su l
2 3 V. Tripoli, «L'Esercito i tal iano», 28 settembre 19 11.
24 V . Giornale Militare Ufficiale 1913, circolare n. 336, 6 agosto 1913, p. 1033. li numero dei volontari di un anno venne esposto da Spingardi alla Camera il 31 maggio 1913. V. AA .PP., Legisl atura XXIII, Camera-Discussioni, p. 26151.
25 Cfr. AA . PP ., Legislatura XXIV, Camera-Documenti, n. 56. La relazione ministeriale che accompagnava il di seg no d i legge esordiva con queste parole: «Signori! - L'oggetto del presente disegno di legge è già ben noto al Parlamento. Gli scopi , per i quali la legge del 19 l ug lio 1871 ist i tuì il volo nt ariato di un anno, sono venut i comp letamente a mancare : non più la necessità di attenuare gli effetti dell'abo lizione dell'affrancazione asso l uta da ogni servizio militare, allora dec retata, non più la necessità di p ro vvedere, per questo mezzo, al reclutamento degli ufficiali di complemento che è ora suffici entemente assicurato dalla ist ituzione degl i appositi corsi annua l i» . I p r im i co rs i per aJlievi ufficiali di complemento erano stati istituiti nel 1882 : dopo un corso di dod ici mes i, s i doveva prestare un servizi o di prima nomina di sette mesi.
26 V. AA . PP., Legislatura XXIII, Camera- Discussioni , tornata del 3 1 maggio 1913, p. 26128; Per la chiamata alle armi della 2° categoria della classe 1892 e Congedamenti e richiami di classi, « L 'Esercito italiano», 29 giugno 1913 e 2 luglio 1913 .
27 Il più efficace passaggio sull'argomento fu quello del generale Pistoja, in AA.PP. cir., p . 26128.
28 V ibidem, p 26153

192
disegno di legge 29 Esso era anzi considerato soltanto un primo passo per rendere possibile l'aumento della forza bilanciata . Nulla di strano quindi che passasse senza alcuna discussione con 105 voti favorevoli e solo 9 contrari, il 18 giugno 1913, divenendo la legge 19 giugno 1913, n. 638. E ssa modificò il limite di statura per l'idoneità da 155 a 154 centimetri ed estese la ferma di due anni anche ai rivedibili . Si sarebbero così potuti inco rporare 30 000 uom ini in più ogni anno 30 •
Per loro natura, le leggi sul reclutamento richiedono tempo per fa r se ntire i loro effetti. Ancora nel settembre 1913 Brusati scriveva a Spingardi:
Ho esaminato, ed anche S.M. il Re ha esaminato, la dimostrazione della forza alle armj al principio di ogni trimestre dal 1° gennaio 912 al 1° luglio 913. Tale esame mi ha lasciato qualche dubbio . Ammesso pure che in Libia vi sono 80 mila uomini, non si giunge a spiegare come mai gli effettivi delle singole unità, specie di fan t eria, siano in Italia così meschini . Si direbbe che vi è o vi è stato un disperdimento di forze del quale non si comprende la ragione 31 •
Benché approfittando della guerra Spingard i fosse riuscito a portare la forza bila n ciata a 250.000 uom ini nell'esercizio 1912-1913 e nel successivo, le truppe in Libia continuavano ad essere alimentate quasi esclusivamente dalla madrepatria E Io stesso dicasi per i reparti, equivalenti a un corpo d'armata, creati col R. D 7 d icemb r e 1911, n. 1282 conve rtito nella legge
27 giugno 1912, n . 698 32 • Se anche i crediti straord inari permettevano di avere sotto le armi una forza effettiva di 290 .000 uomini, le sottrazioni erano ug ualmente tali da provocare il disperdi mento di forze lamentato da Brusati, al quale non era poi estraneo il gran numero di ammalati 33 •
29 V. AA.PP , Legislatura XXIII, Senato-Discussioni, torna ta de l 27 magg io 1913, pp. 11132- 1 I 136.
30 AA.PP., Legislatura XXIII, Senato -Discussioni, n. 1071 - A, pp. 1-3.
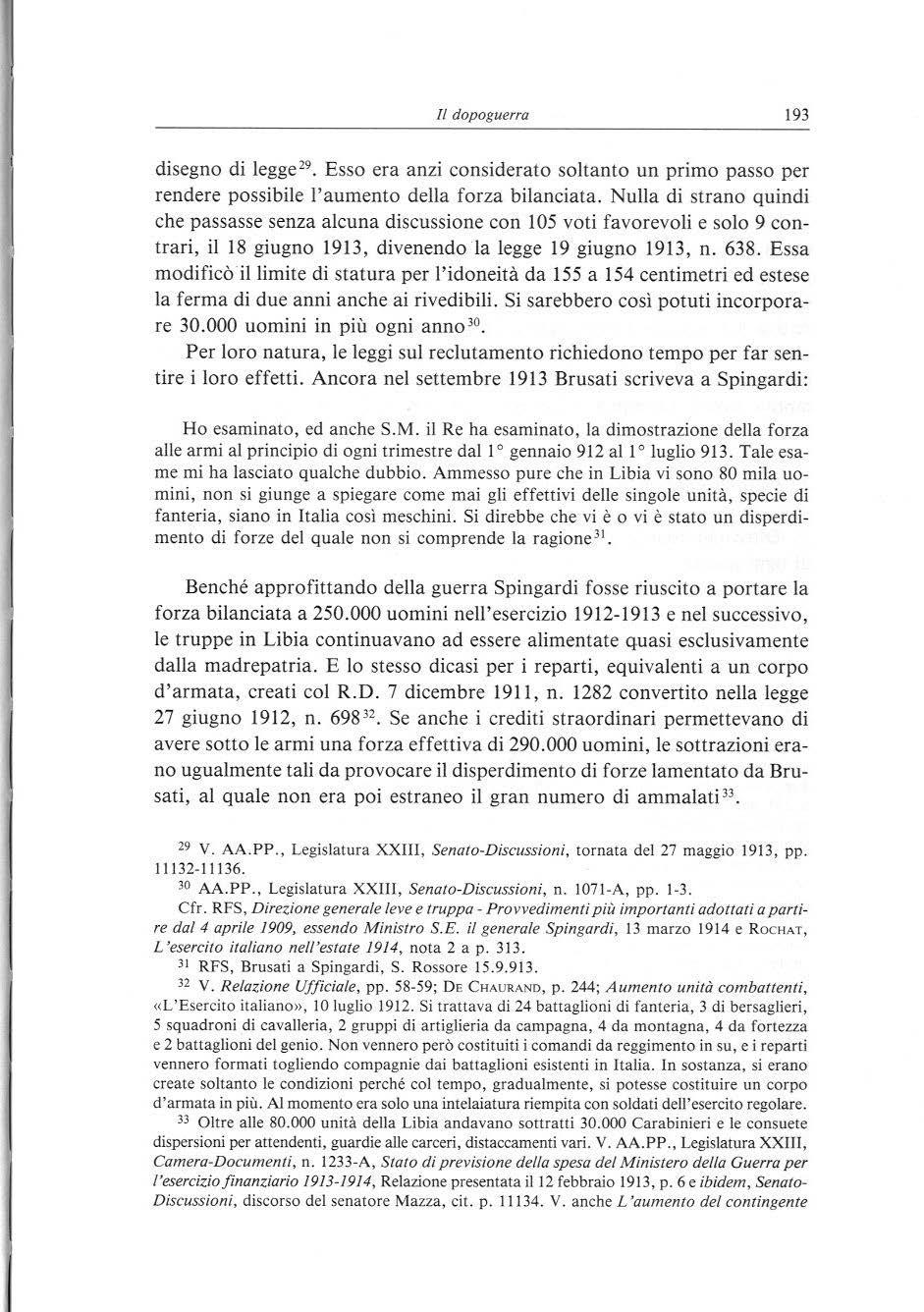
Cfr. RFS, Direzione generale leve e truppa - Provvedimenti più importanti adottati a partire dal 4 aprile 1909, essendo Ministro S.E. il generale Spingardi, 13 marzo 1914 e ROC HAT, l'esercito italiano nell'estate 1914, nota 2 a p 313
31 RFS, Brusati a Spingardi, S. Rossore 15.9.913
32 V. Relazione Ufficiale , pp. 58-59; DE CHA URAND, p 244; Aumento unità combattenti, «L'Esercito italiano», 10 luglio 1912. Sì trattava dì 24 battaglioni di fanteria, 3 di bersaglieri, 5 squadroni di cavalleria, 2 grupp i di artiglieria da campagna, 4 da montagna, 4 da fortezza e 2 battaglioni de l genio Non vennero però costituiti ì comandi da reggimento in su, e i reparti vennero formati togliendo compagnie da i battagl ioni esistenti ìn Italia. In sostanza, si erano create soltanto le condizion i perché col tempo, gradualmente, si potesse costituire un corpo d'armata in p iù. Al momento era solo una intelaiatura riempita con soldati delJ'esercito regolare.
33 Oltre alle 80.000 unità della Libia andavano sottratti 30.000 Carabin ieri e le consuete dispersioni per attendenti, guardie alle carceri, distaccamenti vari. V. AA. P P., Legislatura XX I 1I, Camera-Documenti, n. 1233- A , Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l 'esercizio finanziario /913-1914, Relazione presentata il 12 febbraio 1913, p. 6 e ibidem, SenatoDiscussioni, d iscorso del senatore Mazza, cit. p l 1134. V. anche l'aumento del contingente
Il dopoguerra 193
Quindi, per provvedere alle esigenze militari della colonia, oltre alla nuova legge sul reclutamento, furono creati con R . D. 22 giugno 1913, n. 844, un corpo indigeno e con R.D. 11 settembre 1913, n. 1174, un corpo volontari per Ja Libia. Per quanto riguarda il primo, basti dire che doveva essere com~ posto da 15.000 uomini tratti dalle popolazioni della Tripolitania e della Cirenaica, per capire quanto difficile doveva rivelarsi la sua costituzione effettiva. La forza del corpo volontari era poi stabilita in appena 157 ufficiali e 4455 uomini di truppa, organici progettati per una colonia pacificata, ma del tutto insufficienti per lo stato di guerra che di fatto continuava 34 • Per motivi di versi, insomma, i due corpi rimasero solo sulla carta.
2. La questione dei magazzini
Oltre agli uomini, in Libia furono inviate grandi quantità di materiali di ogni genere.
Furono centinaia e centinaia di migliaia le serie vestiario consumate nelle trincee, oltre un centinaio di milioni le munizioni di tutti i calibri; ingenti, quasi iperboannuo, «La Prepara zione», Sabato -Domenica 8-9 marzo 1913; L'aumento del contingente di leva e la fanteri a , «La Preparazione», Martedì-Mercoledì 3-4 giu gno 1913 Riguardo all'alto numero degli in ferm i v RFS, Brusati a Spingardi, S. Ro sso re 15.9.913: «L'altro giorno siamo stati à visitare i malati (250 circa) or ora tornati dalla Libia. Tutti fortunatamente in condizioni da essere licenziati dall'ospedale fra pochi giorni, fatta eccezione per due tifosi recidivi». Alla lettera Brusati allegava un ritaglio segnato come «G iornale A vanti» n. 253, dal titolo Il tifo miere in Cirenaica: «Ci telefonano da Verona, 11: L 'A dige , noto organo della tripolin eria democratica veronese , nel suo numero o diern o riferendo i particolari della morte per t ifo avvenuta a Cirene del sottotenente medico dott. Alighiero Avanzi, informa che il secondo battaglione alpini Sa/uzzo venne letteralmente disfatto dal tifo: di 800 uomini ne perirono 400 diconsi quattrocento! La notizia, non sospetta, sulla Cirenaica sa lubre e rigogliosa desta immensa imp ressione». Il corsivo rappresenta il virgo lettato del testo originale.
34 Un corpo coloniale a base volontaria era un provvedimento già sostenuto alla Camera dai socialis ti in quanto le impre se coloniali « non possono mettersi a carico della massa dei cittadini, tanto meno del pro letariato, dei lavor atori , né com e tributo di danaro, né come tributo di sangue». V. AA.PP., Legislatura XXlll , Camera-Discussioni, tornata del 31 maggio 1913, p. 26158.
La cr eazione di questi corpi fu a lungo sostenuta dai periodici militari. V. a titolo meramente esemplificativo «L'Esercito italiano», Per la costituzione di un corpo coloniale , 31 dicembre 1912; Ancora per la costituzione di un corpo coloniale, 8 gennaio 1913; Pericoli cirenaici e truppe coloniali, 24 gennaio 1913; Ordinamento e spese per le truppe coloniali italiane, 21 maggio 1913; Costituzione dei repa rti indigeni in Libia , 29 giugno 1913; Per la costituzione dell'esercito coloniale in Libia, 2 luglio 1913; Volontarismo e corpo coloniale, 4 luglio 1913; Il corpo dei volontari per la Libia, 26 settembre 1913; Per l'ammissione nel corpo volontari italiani, 12 novembre 1913 ; «La Preparazione», Per la costituzione del corpo coloniale , Giovedì -Venerdì 6-7 marzo I 913; Per uscire dalla crisi dell'esercito, Martedì-Mercoledì 17-18 giugno 1913
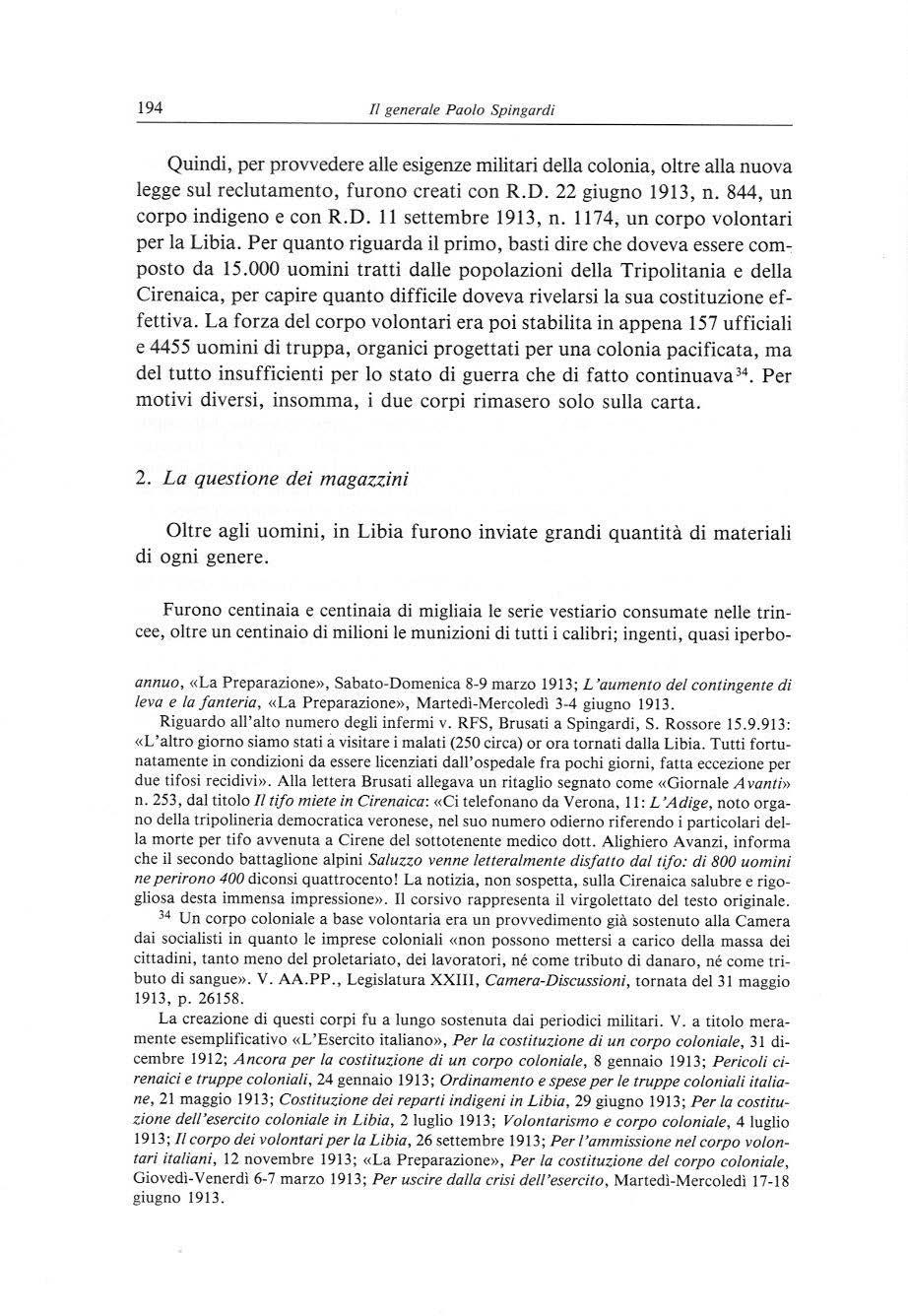
194
li generale Paolo Spingardi
liche, le quanti t à d i materiali di artiglieria e del ge ni o, di approvvigionamenti vari spediti in Libia 35 •
Erano quindi necessari provvedimenti che reintegrassero le dotazioni dei magazzini affiché « niuna ripercussione le event ua li loro deficienze potessero avere sull'esercito metropoli tano » 36 •
Perciò nel novembre 1912 Spingardi chiese « l'assegnaz ione straordinaria dei fondi occorrenti» al Ministro del Tesoro 37 • Qu esti, però, «impressionato dalla entità d ella somma e nella considerazione c he i bisogni segnalati non si riferivano tutti alla guerra di Libia», pr im a di concedere i fondi volle determinar e l'entità precisa delle d efic ienze da attribuirsi alla spedizione di L ibia e que lle ad essa estranee . Il Mi nistero della Guerra però
fe rmo nell'intendimento di colmare le deficienze riscontr ate nei magazzini bandisce senz'altro sul la sua responsabilità le aste a termin i ridotti (d icembre 19 12) per 32 milioni. Le ro be cominciano ad affluire in marzo (1913) e nel giugno successivo i magazzini hanno le loro dotazioni al completo. Senonché, constatato più tardi d al Delegato del Ministero del Teso r o che una parte delle deficienze dei magazzini vest iario era anter iore alla guerra di Libia (derivava da maggiori r ic hi ami alle armi per istruzion i , dalla maggiore forza delle classi di leva per effetto della nuova legge di reclutamento e dal maggior costo della t enuta g r ig iove r de) e precisamente per un importo di circa 18 milioni, il Ministero del T esoro, per non gr avare il Conto de ll a Libia di una spesa che non le era propria, volle, e il Ministero della Guerra consentì, che i 18 milioni or detti, che erano già stat i spesi, fossero reintegrati al Tesoro con corris pon denti prelevamenti di materiali dai magazzini, sa lvo bene inteso a rifornirli tosto ottenuti da l Parlamento i fondi occorrenti.
Insomma i materiali esistevano, ma erano tenuti in pegno dal Ministero de l Tesoro .
Ma un'altra causa si aggiunse a far apparire le deficienze anche magg ior i che non fossero . La n uova legge di contabilità [ . .. ] e la contemporanea abo lizione del corpo conta b ile, crearono una si tuazione amministrativa d iffi cile , aggravata dalla guerra di Libia, che accre bbe il lavoro contabile e sottrasse una quantità di ufficiali per
35 RFS, Deposizione Caporetto, cit., p. 12
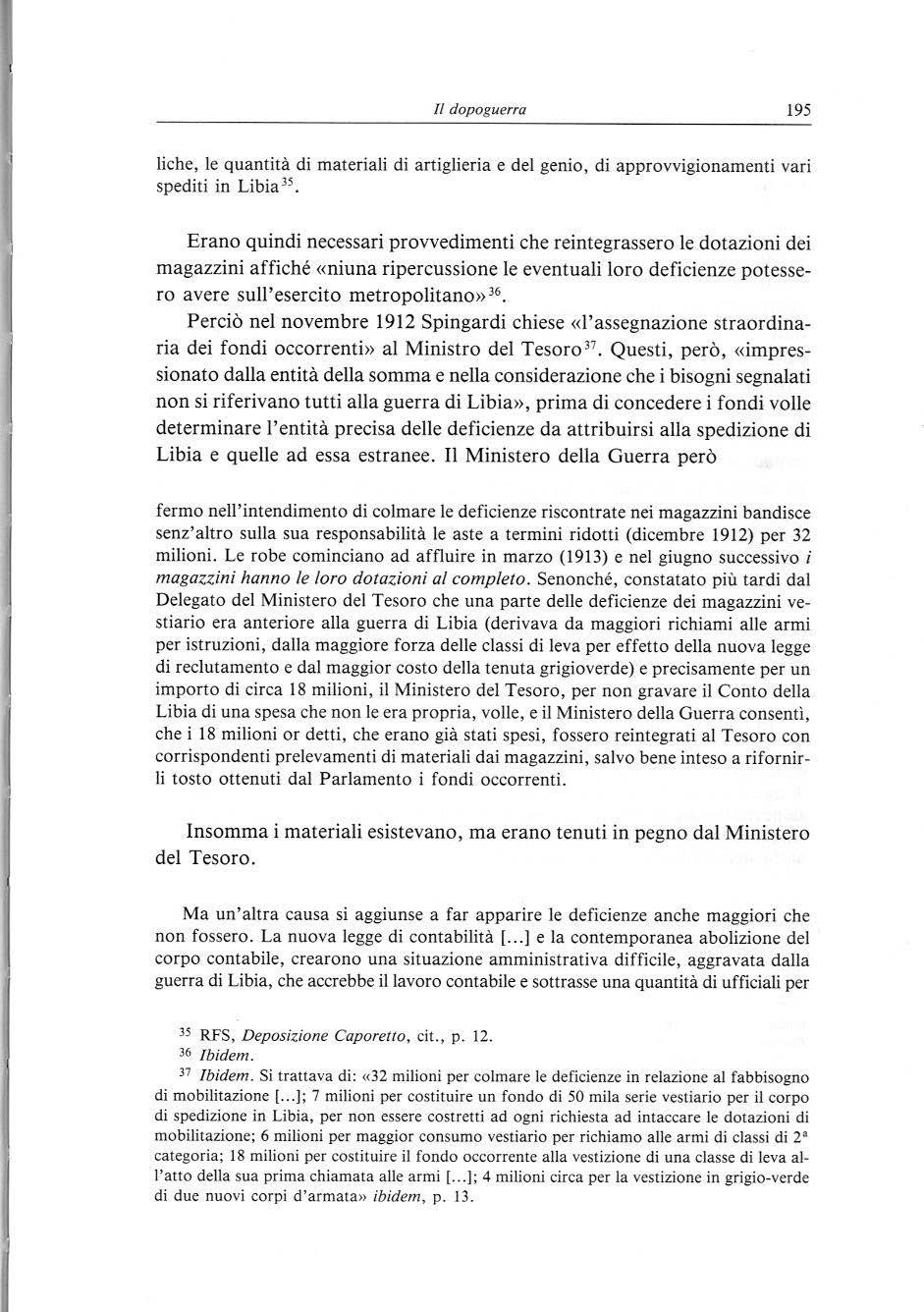
36 Ibidem.
3 1 I bidem. Si trat tava di: «32 mil ioni per co lmare le deficienze in relazione al fabb isogno di mobili tazione[ ]; 7 milioni per costituire un fondo di 50 mi la serie vestiario per il corpo di sped izione in Libia, per non essere costretti ad ogni richiesta ad intaccare le dotazioni di mobilitazione ; 6 milioni per magg ior co nsumo vestiario per richi a mo alle armi d i classi di 2• categoria; 18 milioni per costitu ire il fondo occorren te alla vest izione di una classe di leva all'atto della sua prima chiamata alle armi [. . . l; 4 mi lioni circa per la vest izione in grigio -verde d i due nuovi corpi d'armata» ibidem, p . 13.
li dopoguerra 195
la nuova Colonia. Ne seguì un ristagno di contabilità arretrate, che ebbe la sua ripercussione sui magazzini 38 •
La legge 17 luglio 1910, n. 51 l, che aveva abolito l'antico sistema delle masse e istituito un nuo vo sistema di contabilità per l'esercito, era entrata in vigore il I O luglio 191 l, meno di tre mesi prima della dichiarazione di guerra. O gn i s ingola spesa dei corpi andava ora opportunamente documentata e iscritta in una voce di spesa del bilancio del Mini stero Le contingenze della campagna, moltiplicando le questioni burocra tiche per i numerosi e frequenti acquisti, prelievi e spostamenti di materiali, cagionò un vero e proprio caos amministrativo. Il nuovo s iste ma da va meno autonomia di gestione ai corpi accentrando la contabilità al Ministero 39 Se ciò doveva contribuire in pace ad eliminare possibilità di illeciti e sprechi, con la guerra affastellò sugli scaffali del Minis tero una quantità incredibile di contabilità arretrate 40 •
La conseguenza fu che diversi materiali reintegrati venivano ingoiati nel buco nero am ministrativo: cioè i magazzini contenevano la maggior parte de lle dotazioni ma le scartoffie registravano ancora una situazione di penuria, anche perché
i prelevamenti e le reintegrazioni non sempre erano stati e non potevano essere equamente ripartiti; onde spareggiamenti, scomposizioni di serie, eccedenza di taluni capi, deficienza di altri di più facile consumo in campagna.
In sostanza mancavano soprattutto piccoli oggetti, come gavette, borracce nuovo modello (mentre esistevano le vecchie di legno), tazze di latta, marmitte d'antico modello di c ui si era sospesa la fabbricazione mentre era in corso la distri buzione delle nuove casse di co ttura , bastoni da tenda, ecc. ecc., materiali tutti [. .. ] di cui può essere sollecito il rifornimento [... ] anche durame la stessa mobilitazione 41 •
38 Ibidem, pp. 13 -15 L'attendibilità delle affermazioni di Spingardi è confermata in R. CRUccu, L'esercito nel periodo giolittiano, cit., p. 265 e in Relazione Ufficiale, pp. 140-141.
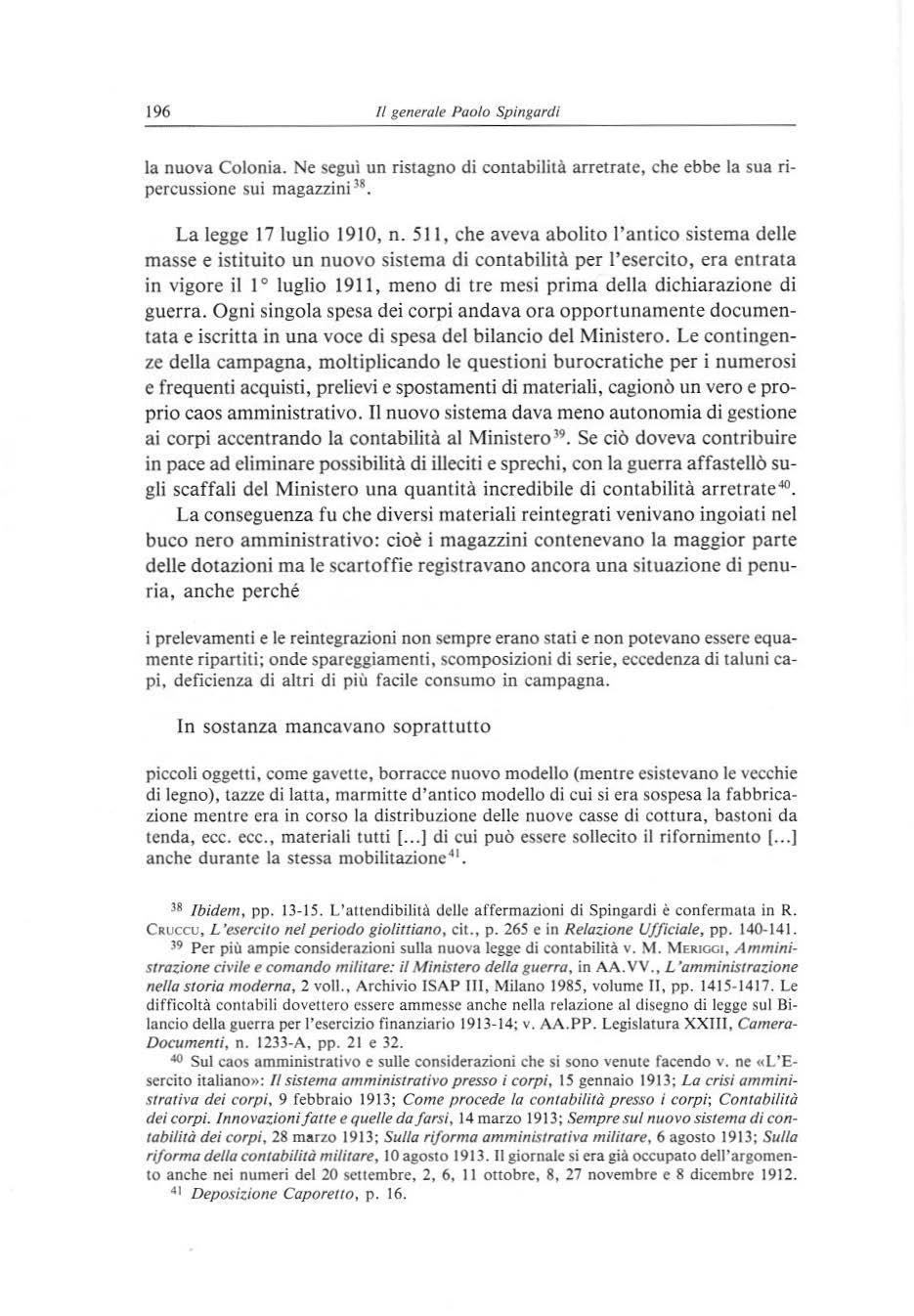
39 Per più ampie considerazioni sulla nuova legge di contabilità v. M. MERIGGI, Amministrazione civile e comando militare: il Ministero della guerra, in AA. VV., L'amministrazione nella storia moderna, 2 voli., Archivio ISJ\P lii, Milano 1985, volume Il, pp. 1415 - 1417. Le difficoltà contabili dovetter o essere amme sse anche nella relazione al disegno d i legge su l Bilancio della guerra per l'eserc izio finanz iario 1913-14 ; v. AA.PP Legislatura XXIII , CameraDocumenti, n. 1233-A, pp. 2 1 e 32.
40 Sul caos amministrativo e sulle considerazioni che si sono venute facendo v. ne «L'Eserc ito italiano»:// sistema amministrativo presso i corpi, 15 gennaio 1913; La crisi amministra tiva dei corpi, 9 febbraio 1913; Com e procede la contabilità presso i corpi; Contabilit à dei corpi. Innovazioni/afte e quelle da farsi, 14 marzo 1913 ; Sempre sul nuovo sistema di contabilità dei corpi, 28 marzo 1913; Sulla riforma amministrativa militare, 6 agosto 1913; Sulla riforma della contabilità militare, 10 agosto 1913. TI giornale si era già occupa10 dell'argomento anche nei numeri del 20 se11embre, 2, 6, 11 ottobre, 8, 27 novembre e 8 dicembre 1912.
41 Deposizione Capore110, p. 16.
196 li
generale Paolo Spingardi
Complessivamente quindi i materiali c'erano, anche perché le deficienze in alcuni corpi erano compensate con le eccedenze di alt r i. Ma i magazzini dei reparti più vicini ai porti d'imbarco, cioè nel sud Italia , lasciavano ovviamente una impressione poco rassicurante 42 •
3 . Le fortificazioni
Sarebbe tuttavia un erro r e credere ch e la gue rra lib ica avesse avuto solo effetti negativi su l piano di riarmo ita lia no. I lavori d i fortificazi one procedettero anzi alacremente, tanto che nel pieno del conflitto, n el febbraio 1912, P ollio tornò a bussare a quattrini e Spingardi dovette inviargli una lett era assai simi le ne l tono a quella di undici mesi prima. In essa si mostrava sop r att u tto la preoccupazione «circa la possibilità di condurre a termine in tempo utile il programma del 1909» e il timore «che il compimento dell ' opera iniziata import[asse], allo stringere dei conti, una spesa supe ri ore di quella accordata all'uopo dal Parlamento». Spingardi aveva bensì richiesto 30 mil ioni per la frontiera con la Svizzera, ma «se il Governo prese impegno di concederli [... ]il Parlamento non li ha ancora votati». Il Ministro notava con ap p rensione che
una parte soltanto [. ] dei 30 milioni verrebbe impiegata per le fortificazioni alla frontiera svizzera, mentre la parte maggiore dovrebbe servire per le d i fese della frontiera austriaca ed è già previsto che neppure basterebbe.
Ma alla fine «poiché l 'E .V. mi ebbe sempre consenziente nelle questioni tutte che si riferiscono all'ordinamento e all'apprestamento de i nostri mezzi, e sempre m i ha visto pronto a fronteggiarle, ,con insolita larghezza di fond i , io acconsento anc he a questa ultima modificazione del programma per la sistemazione difensiva del territorio naz ionale». Tuttavia egli raccomandava a Pollio di «porre ogn i cura, ogni attività, ogn i sforzo per completare (C O M P L ETARE NEL PIÙ STRETTO ED ASSO L UT O SENSO DE L LA PAROLA) l'assetto d i quelle opere che debbono formare i capisaldi delle nostre difese» 43 •
Non è un d issidio - precisava Spingardi a Ugo Brusati comunicandogli copia della lettera a Pollio - ma una necessità dell'ora presente. L'ho meditata lungamente prima di spedirla, ma io intravedo guai, poiché non si tratta di proposte nuove, ma oramai di spese fatte od impegnate, in più del disponibile assegnato dal Par lamento.
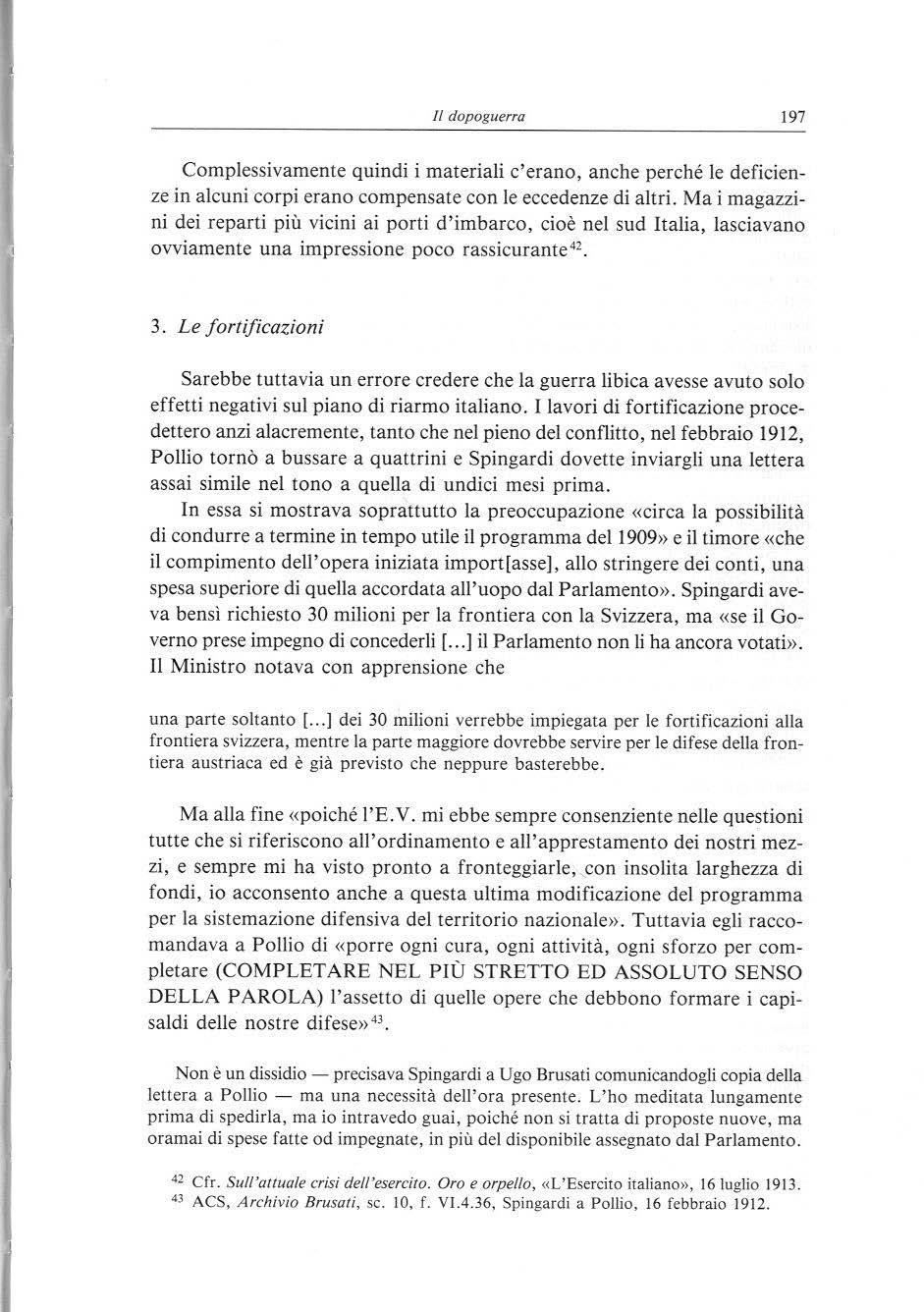
42 Cfr. Sull 'attuale crisi dell 'esercito. Oro e orpello, « L'Esercito italiano», 16 luglio 1913.
4 3 ACS, Archivio Brusati, se. 10, f. Vl.4.36 , Sp ingardi a Pollio , 16 febbraio 1912.
li dopoguerra 197
Il generale Paolo Spingardi
E nota che non ci s i ferma lì: molte altre s pese si affacciano : per es , la sola illuminazione estern a ed interna delle opere (circa una sessantina!) e la loro aereazione importerà una spesa di circa 3 milioni non previsti. Dunque fermiamoci, com pletiamo o meglio finiamo quello c he abbiamo incominciato: al resto pen se remo o penseranno in segui to 44 • Io non discuto la utilità dei nuov i a ppr estamen ti difensivi: ma è un fatto che, a cominciare da l basso Tagliamento, prima non preveduto (le opere delle due te ste di ponte continuano ad aumentare), dal mutamento di indiri zzo ne lla sistemazione del margine morenico di S. Danie le, per venire a l Cadore, al gruppo di Campolongo e M.te Ve ren a e al Baldo, è tutto un mutamento e un amp liam ento di dife se 45 •
I guai intravisti dal Ministro riguardavano chiaramente eventuali difficoltà che potevano veni r e da parte del Governo o del Parlamento. Spingardi non discuteva la necessità delle opere, ma il concetto primitivo era stato infirmato ed ora occorrevano ulteriori fondi ch e temeva di non riuscire a ottenere
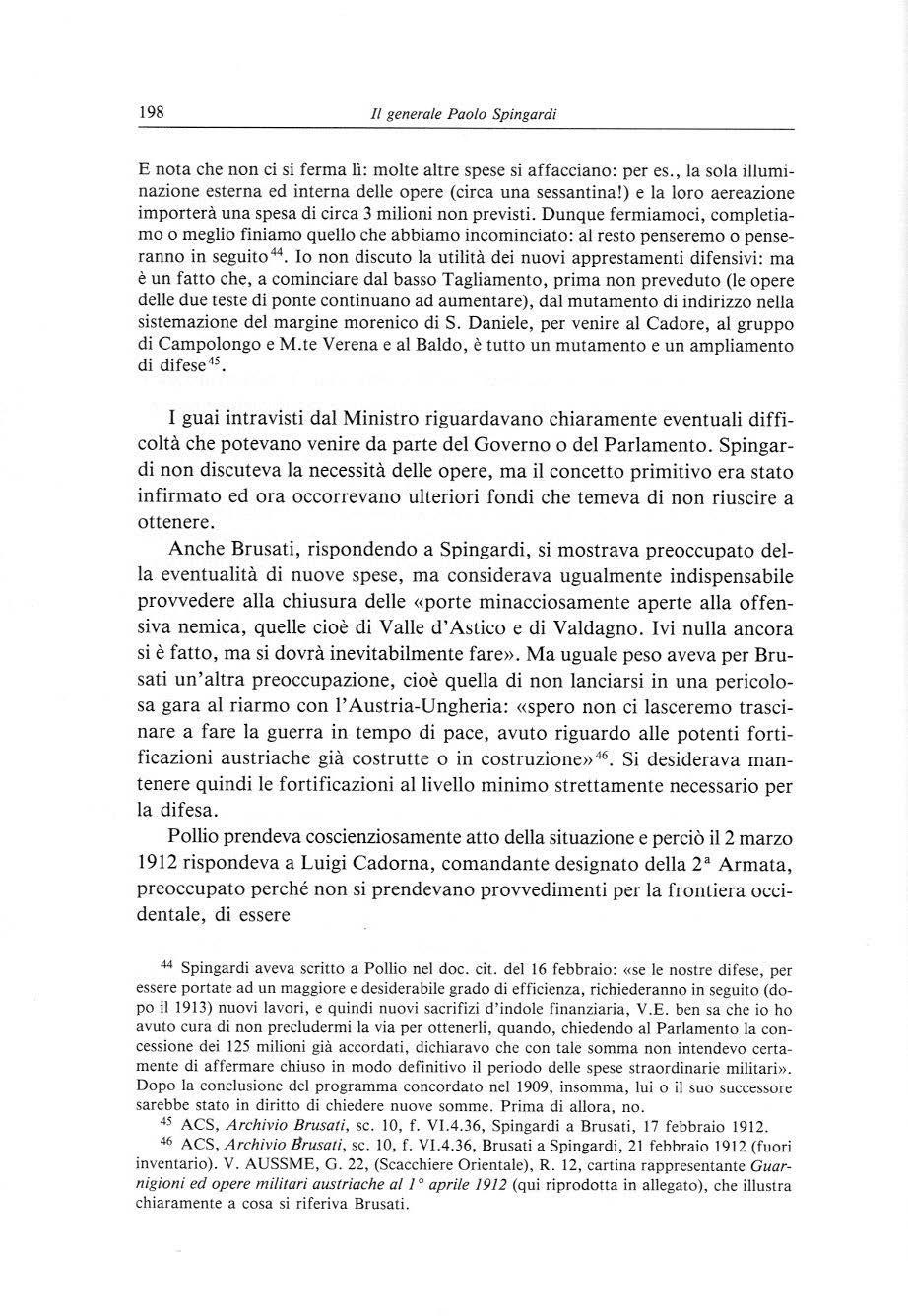
Anche Brusati, ri spondendo a Spingardi, si mostrava preoccupato della eventualità di nuo ve spese , ma considerava ugualmente indispensabile provvedere alla chiusura delle «porte minaccio samente aperte alla offensiva nemica, quelle cioè di Valle d'Astice e di Va ld agno. lvi nulla ancora si è fatto, ma si dovrà inevitabilmente fare». Ma uguale peso aveva per Brusati un'altra preoccupazione, cioè quella di non lanciarsi in una perico losa gara al riarmo con l'Austria -Ungheria: «spero non ci lasceremo trascinare a fare la guerra in tempo di pace, avuto riguardo alle potenti fortificazioni aus t riache già costrutte o in costruzione» "°. Si desiderava mantenere quindi le fortificazioni al li vello minimo strettamente necessario per la difesa.
Pollio prendeva coscienziosamente atto della si tuazione e perciò il 2 marzo 19 I 2 rispondeva a Luigi Cadorna, comandante designato della 2 a Armata, preoccupato perché non si prendevano provvedimenti pe r la front iera occidentale, di essere
44 Spingardi aveva scritto a Pollio nel doc. c it. del 16 feb braio : «se le nostre difese, per essere portate ad un maggiore e desiderabi le g rado di effic ie nza , richiederanno in seguito (dopo il 1913) nuovi lavor i, e qu ind i nuovi sacrifizi d'indole finanzia r ia, V .E. ben sa che io ho avuto cura di non precludermi la via per ottener li, quando, chiedend o al Parlamento la concessione dei 125 milioni già accordati , diclùaravo che con tale s omma non inte ndevo certamente di affermare chiuso i n modo defin itivo il periodo delle spese straordinarie milita r i». Dopo la conc lusione del programma concordato nel 1909, in somm a, l ui o il suo successore sarebbe st a to in di ritto d i chiede re nuove somme. Prima di allora, no.
45 ACS, Archivio Brusati, se . IO, f. Vl.4 . 36, Spingard i a Brusati, 17 febbraio 1912.
46 ACS, Archiv io Brusati , se. 10, f. VI.4 .36, Bru sa ti a Spingardi, 21 feb braio 19 12 (fuo ri i n venta rio) . V. AUSSME, G . 22, (Scacch iere Orientale), R . 12, cartina rappresentante Guarnigioni ed opere militari austriach e al 1° aprile 1912 (qu i r iprodotta in allegato), che illustra ch iaram ente a cosa si ri feriva Bru sat i.
198
perfettamente persuaso della necessità che, allorché si sia sistemata convenientemente a difesa la frontiera Nord e Nord orientale, cui debbono essere in questo momento rivolte tutte le nostre cure, si ponga anche rimedio alle manchevolezze che s us sistono sulla frontiera occidentale e negli sbarramenti liguri ma purtroppo sono tali e tanti i bisogni della frontiera italo -austriaca ed anche di quella italo -svizzera (la quale va assumendo anch'essa importanza non lieve) che affatto impari all'uopo si rivelano le somme ancora disponibili, mentre non è dato di sperare che prima della fine del 1913 possano essere autorizzati dal Parlamento nuovi fondi per altri lavori. D'altra parte è pure g iu sto considerare che la frontiera occidentale, per la sua costituzione orografica, per la natura aspra del terreno e per le difese che (... ) vi furono apprestate da tempo, presenta se rie diffi co ltà ad una invasione straniera anche allo stato attuale. Il che [ ... ] consiglia d'altra parte a non lasciarsi distrarre, almeno per ora, dal proposito di tutto dedicare al raffo r zamento del territorio Nazionale là dove più urge 47 •
Il concetto strategico di Pollio emergeva chiaramente dalle istruzioni riservatissime inviat e nell'aprile 1912 ai comandanti designati della 2a e 3a Armata, che in caso di gue rr a contro l'Austria avrebbero dovuto occuparsi dei tratti di fronte rispettivamente dell'Alto e Medio T agliamento.
Ritengo che non convenga [... ) abbandonare senz 'altro tutto il territorio sulla sinistra dell'alto Tagliamento per la preoccupazione che un attacco vigoroso del nemico possa travolgere le nostre fo rze dislocate nelle valli del But e del Chiarsò [ ) Anche l'avversario ha bisogno di tempo per mobilitarsi e ha bisogno di mezzi per vivere in forze a distanza dai suoi centri, né è da escludersi che possano, da un momento all'altro, intervenire e lementi nuovi che facciano cambiare notevolmente la situazione in nostro vantaggio 48 •
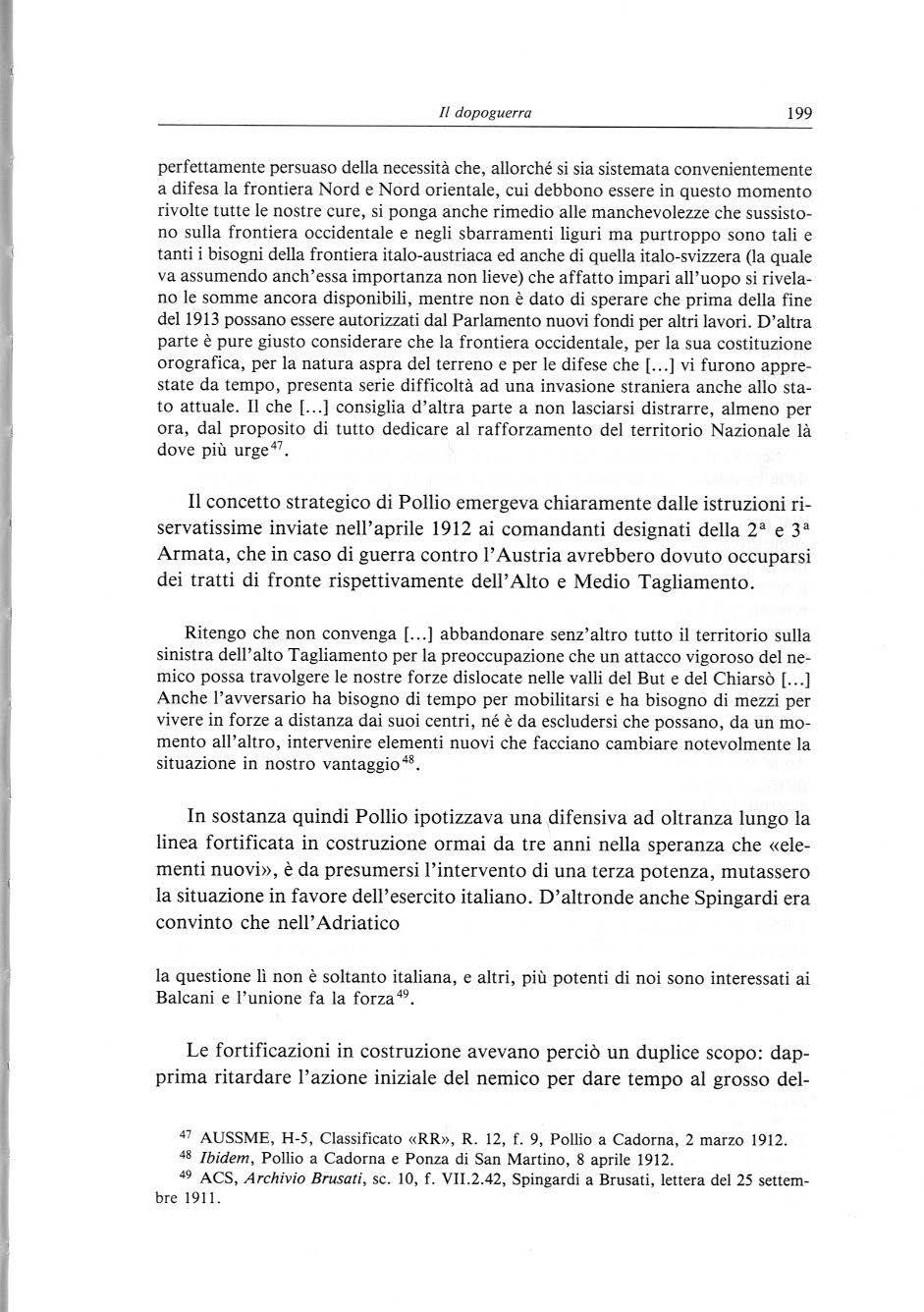
In sostanza quindi Pollio ipotizzava una difensiva ad oltranza lungo la linea fortificata in costruz ione ormai da tre anni nella speranza che «elementi nuovi», è da presumersi l'intervento di una terza potenza, mutassero la situazione in favore dell'esercito italiano . D 'altronde anche Spingardi era convinto che nell'Adr iatico
la questione lì non è soltanto italiana, e altri, più potenti di noi sono interessati ai Balcani e l'uni one fa la forza 49 •
Le fortificazioni in costruzione avevano perciò un duplice scopo: dapprima ritardare l'azione iniziale del nemico per dare tempo al grosso del-
47 AUSSME, H-5, Classificato «R R», R. 12, f. 9, Pellio a Cadorna, 2 marzo 1912
4 8 Ibidem, Pellio a Cadorna e Ponza di San Martino, 8 aprile 1912.
49 ACS, Archivio Brusati , se. IO, f. VII.2.42, Spingardi a Brusati, lettera del 25 settembre 191 I.
Il dopoguerra 199
l'esercito di completare la mobilitazione e indi raggiungere la linea del fronte, e poi fungere da punto d'appoggio per una sicura resistenza fino al momento in cui un mutamento della situazione permettesse di passare alla controffensiva. Concetti che Spingardi evidentemente condivideva perché ancora una vo lta dopo aver ripreso il Capo di S .M. ne esaudì i desideri. Infatti, approfittando dell'atmosfera semiclandestina nella quale si svolsero le rare sedute della Camera durante lo svolgimento della guerra con la Turchia 50 , egli presentò una nuova richiesta straordinaria di fondi che divenne la legge 23 giugno 1912 n. 710, con la quale venivano concessi complessivamente 60 milioni, dei quali 33 da spendere per opere difensive.
Senza ch'io mi addentri in particolari tecnici relativi alla sistemazione difensiva della frontiera - disse Spingardi presentando il disegno al Senato - anche per rispetto a quel doveroso riserbo al quale tutti voi tenete al pari di me, è facile arguire daU'entità stessa delle cifre suesposte che non può trattarsi di una nuova organizzazio ne difensiva ch'io voglia iniziare sulla base[ ] del cosiddetto programma massimo [... ] Io non intendo punto di allargare il mio programma, né credo sia questo il momento di pensare a tale ampliamento [ ] P er ora credo mio dovere di non scostarmi di una linea dal piano che mi sono tracciato, e di completar lo sino a l punto in cui io possa con sicura coscienza annunciare al Parlamento di aver lo condotto a termine così come era stato ideato . A questo tendono i miei sforzi e non oltre (...] La somma di 33 milioni adunque, che vi domando con il disegno di legge, è destinata in parte a qualche nuova opera, deliberata in seguito ad ulteriori st u di ed a manovre fatte sul posto, le quali ne hanno dimostrata la necessità, ed in parte è destinata a rinforzare le assegnazioni già fatte, e dimostratesi insufficienti in seguito al rialzo dei prezzi. Si pensi che alle fortificazioni e re lativi armamenti fu destinata in complesso, dal 1906-07 ad ogg i, la cospicua somma di ben duecento milioni in cifra tonda; e parmi che la sola enunciazione di questa cifra, la quale implica vastissimi impianti e lavo ri, possa bastare per farsi un concetto suffic ientemente esatto della notevole ripercussione che gli aumentati prezzi hanno avuto sul bilancio delle fortificazioni 51 •
Ancora una volta, veniva sottolineata l'organicità del piano avviato nel 1909 e la volontà di non uscire dai limiti da esso imposti se non per cause che sfuggivano al suo controllo, come l'aumento dei prezzi. La riconosciuta necessità delle nuove ope r e imponeva la loro realizzazione, ma d'altro canto spiegare nei dettagli la portata della nuova sistemazione difensiva
50 Il disegno venne approvato dalle due Camere senza alcuna discussione. V. AA . PP. , Legislatura XXJIT, Camera-Discussioni, 2• tornata del 4 giugno 1912, p. 20340 e ibidem, SenatoDiscussioni, tornata del 18 giugno 1912, p. 8813.
Nel 1912 le sedute della Camera si svolsero soltanto tra il 22 febbraio e il 30 marzo e tra il 30 aprile e il 24 giugno
51 RFS, Elementi per la discussione del disegno di legge per maggiori assegnazioni alla parte straordinaria del bilancio della guerra (60 milioni), appunti dattiloscritti in data maggio 1912, pp. 8-9. Cfr. AA.PP., Legislatura XXIII, Senato-Documenti, n. 832, pp. 1-2.
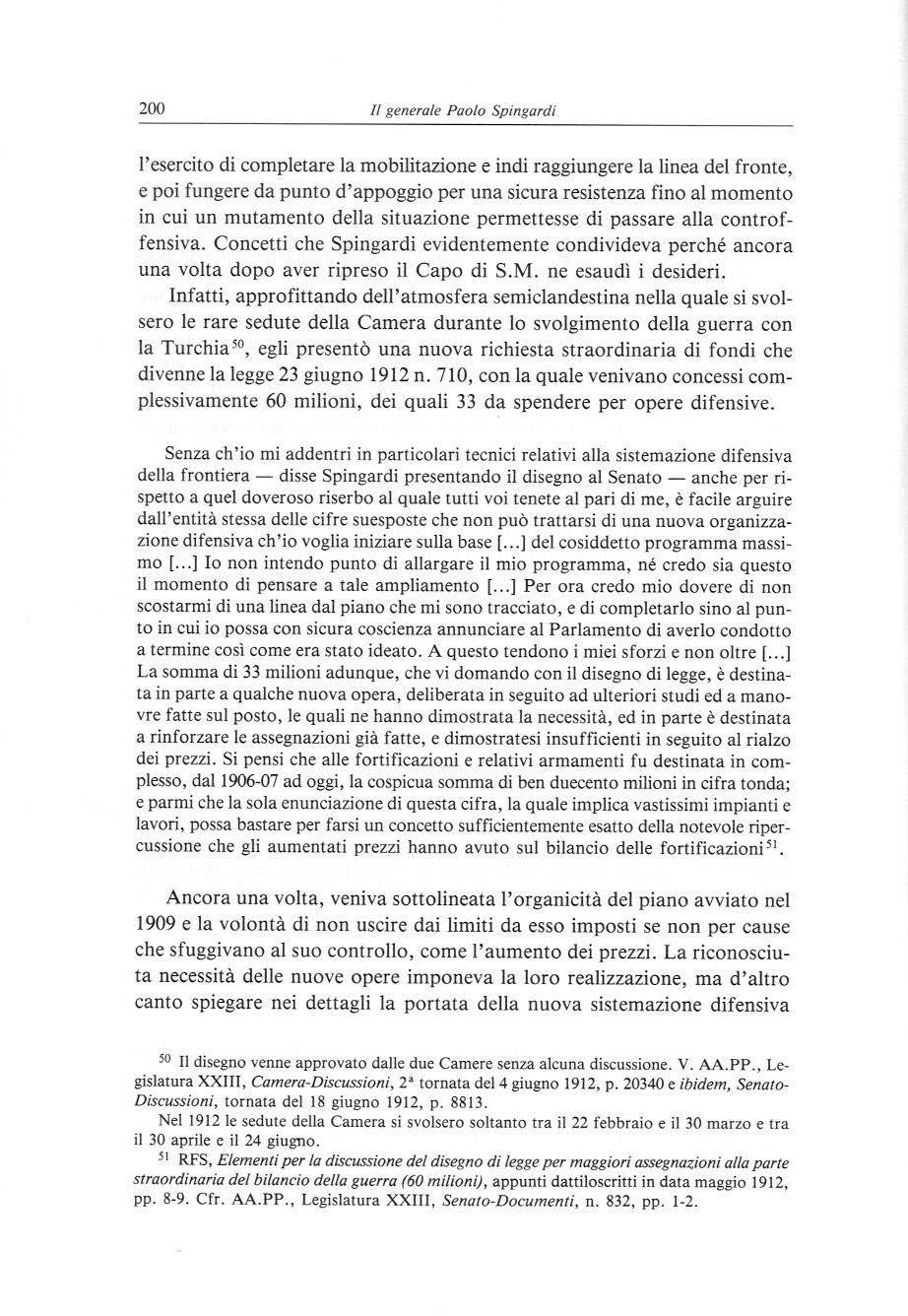
200
li generale Paolo Spingardi
poteva indirettamente suscitare reazioni austriache. Quindi meglio approfittare di una opinione pubblica distratta dalle faccende libiche. Con il denaro così ottenuto furono iniziati lavori nella zona delle sorgenti del Torre e del Natisone 52 •
Il 24 maggio 1913, nel corso della quarta seduta della Commissione Suprema Mista per la Di fesa dello Stato, Pollio lodò l'Arma del Genio e dichiarò che restavano da completare alcune opere, i lavori delle quali avevano subìto qualche ritardo, specialmente per ragioni climatiche. Queste opere però erano poche, e tutte prossime a l completamento . Ma soprattutto fece rilevare che esisteva una grave lacuna ne l Cadore e che era urgente porvi riparo 53 •
La commissione si era riunita soprattutto per stabi li re un nuovo programma, atto a colmare le lacune esistenti sul resto del territorio nazionale, ma alla fine si pronunciò per il completamento urgente dell'assetto del Cadore 54, chiudendo l'ultimo tratto ancora aperto nell'ampia S rovesciata che costituiva il confine con la Duplic e Monarchia.
Come sua abitudine, Spingardi volle anche nel 1913 recarsi a verificare personalmente lo stato dei lavori e tra il 28 giugno e l' 11 luglio fu in Friuli, nel Cadore e nel Vicentino, a ispezionare le ultime opere in corso di attuazione 55 •
Le fortificazioni alla frontiera orientale rappresentarono forse il campo nel quale l'opera di Spingardi maggiormente si avvicinò alla soluzione prospettata in sede teorica: dopo un quinquennio di lavori, assecondando criticamente ma in armonia di intenti l'opera del Capo d i S .M. , si era praticamente port'aio a compimento quanto per quasi trent'anni era rimasto solo un progetto sulla carta 56 •
52 V. Relazione Ufficiale, cit., p. 28.
53 AUSSME, F. 9, Commissioni Difesa, Racc. l Bis, Verbale della 4• seduta, 24 maggio 1913.
54 Cfr. Relazione Ufficiale, pp. 25-28, 147.
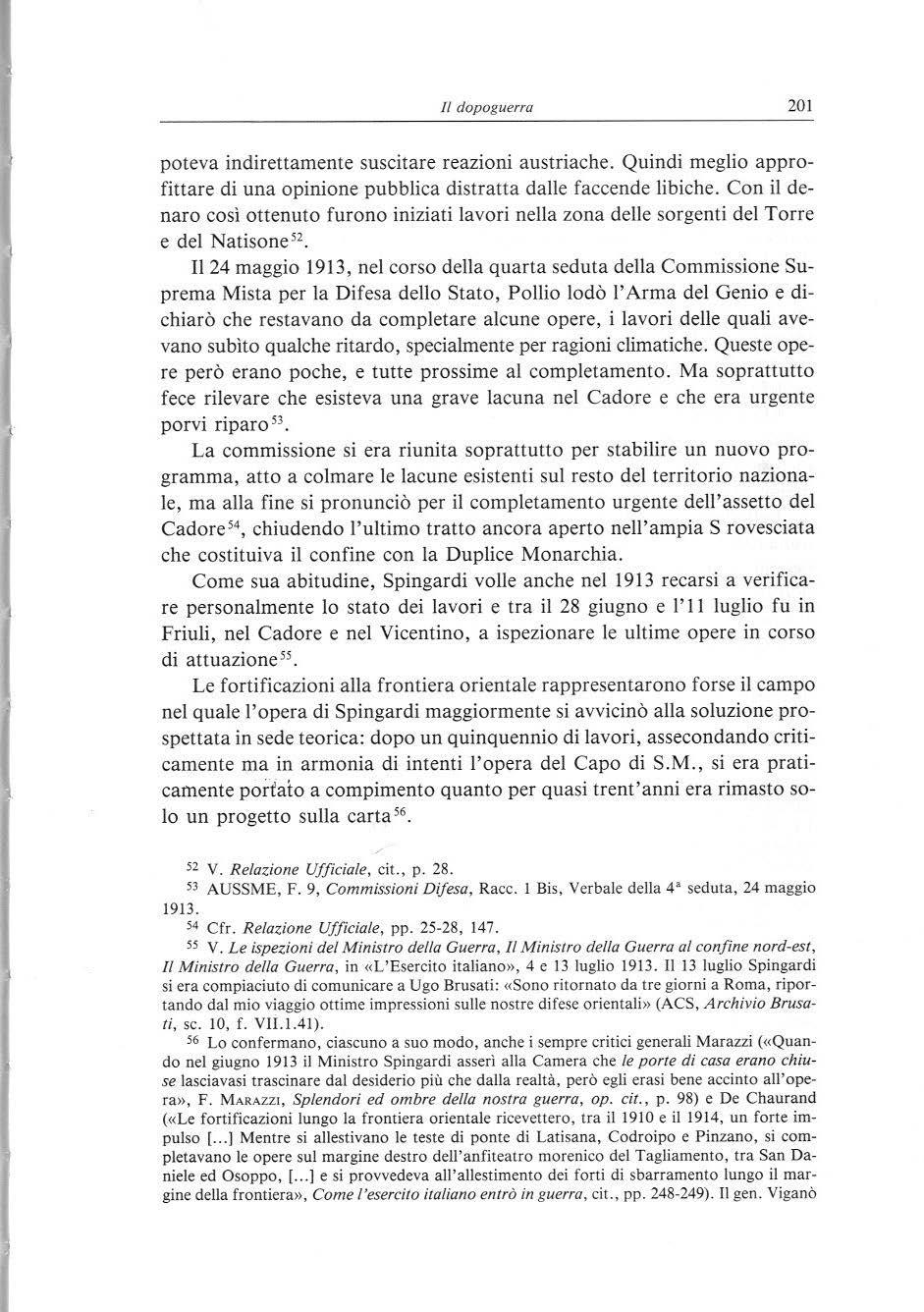
ss V. Le ispezioni del Ministro della Guerra, Il Ministro della Guerra al confine nord-est, Il Ministro della Guerra, in «L'Esercito italiano», 4 e 13 luglio 1913. Il 13 luglio Spingardi si era compiaciuto di comunicare a Ugo Brusati: «Sono ritornato da tre giorni a Roma, riportando dal mio viagg io ottime impressioni sulle nostre difese orientali» (ACS, Archivio Brusati, se. IO, f. VII.l.41).
56 Lo confermano, ciascuno a suo modo, anche i sempre critici generali Marazzi («Quando nel giugno 1913 il Ministro Spingardi asserì alla Camera che le porte di casa erano chiuse lasciavasi trascinare dal desiderio più che dalla realtà , però egli e rasi bene accinto all'opera», F. MARAZZ1, Splendori ed ombre della nostra guerra, op. cit., p. 98) e De Chaurand («Le fortificazioni lungo la frontiera orientale r icevettero, tra il 1910 e il 1914, un forte impulso [... ] Mentre si allestivano le teste di ponte di Latisana, Codroipo e Pinzano, si completavano le opere sul margine destro dell'anfiteatro moren ico del Tagliamento, tra San Daniele ed Osoppo, [ l e si provvedeva all'allest imento dei forti di sbarramento lungo il margine della frontiera», Come l'esercito italiano entrò in guerra, cit., pp. 248-249). 11 gen Viganò
li dopoguerra 201
4 La nuova legge d'avanzamento
Gli aumenti di organici che si verificarono in conseguenza della guerra, non solo assorbirono immediatamente le temute eccedenze dovute all'applicazione della legge dei 15 anni, ma crearono un bisogno di ufficiali, tanto che si dovettero tenere dei corsi accelerati ali' Accademia di Modena'e un corso supplementare per ufficiali di complemento a Parma. Vennero poi nominati effettivi i sottotenenti di complemento del corpo di spediz ione e i sottufficiali di esso che si fossero particolarmente distinti (R.D . 11 gennaio 1912, n . 2) . Tutto ciò valse in defi n itiva «a d eliminare il disagio fra gli ufficiali in servizio attivo» 57 •
Ma «essendo la guerra la sola vera pietra di paragone per la capacità militare degli ufficia li, specie di grado elevato» 58 , vennero anche messi impietosamente a nudo i limiti dei quadri combattenti convincendo definitivamente Spinga r di della necessità di una severa selezione nei quadri elevati.
Egl i ebbe modo di intrattenere sull'argomento Ugo Brusati facendogli «una rivista poco lusinghiera» dei «nostri Generali Comandanti di Divisione e di Corpo d'Armata», probabilmente suggerendo se non fosse il caso di promuover e anche ufficiali giovani senza riguardo ai criteri di anzianità.
Il Primo Ai u tante di Campo era meno ottimista del Ministro: « Ho ripensato a quanto mi dicesti l'altra sera» gli scriveva il 22 novembre 1911 e
ne ho riferito a S.M. A me pare che nell'aria aleggi qualche microbo di Ranz ismo. Credi che nel quadro dei colonnelli o dei Maggior Gen.li vi siano elementi migliori di quell i che costituiscono il quadro dei Tenenti Generali? In coscienza io non credo 59 •
pp. 248 -249) Il gen. Viganò scrisse che «tutto questo sistema di opere era in grandissima parte compiuto quando siamo entrati in guerra». Cfr E. V1GANò, La nostra guerra, Le Monnier, Fi renze 1920, p. 88. Persino Luigi Cadorna, so litamente pessimista su lle condizioni militari ita liane alla vigi lia del primo conflitto mondiale, ammise che «La sistemazione difensiva sulla frontiera .E. come era stata progettata, era pressoché ultimata [ ] Le ope re erano quasi tutte al completo)> delineando la s ituazione «Verso la fine del lu glio 1914». Cfr. La guerra alla fronte italiana, T r eves, Milano 1921, pp. 20 e 13.
57 DE CHAURAND, p. 285. La permanenza nei subalterni di fanteria era nel 1913 ridotta a 12 anni, che divenivano IO per coloro che superavano i corsi della Scuola di Guerra ottenendo la promozione a scelta Un subalterno di fanteria tedesco impiegava allora tra i 15 e i 16 anni, o 13 se rien trava nella scelta, il suo collega francese 14 anni ( 12 se a scelta). V Attuali condizioni di carriera degli ufficiali combattenti italiani, francesi e germanici, «L'Esercito italiano», 16 novembre 1913.
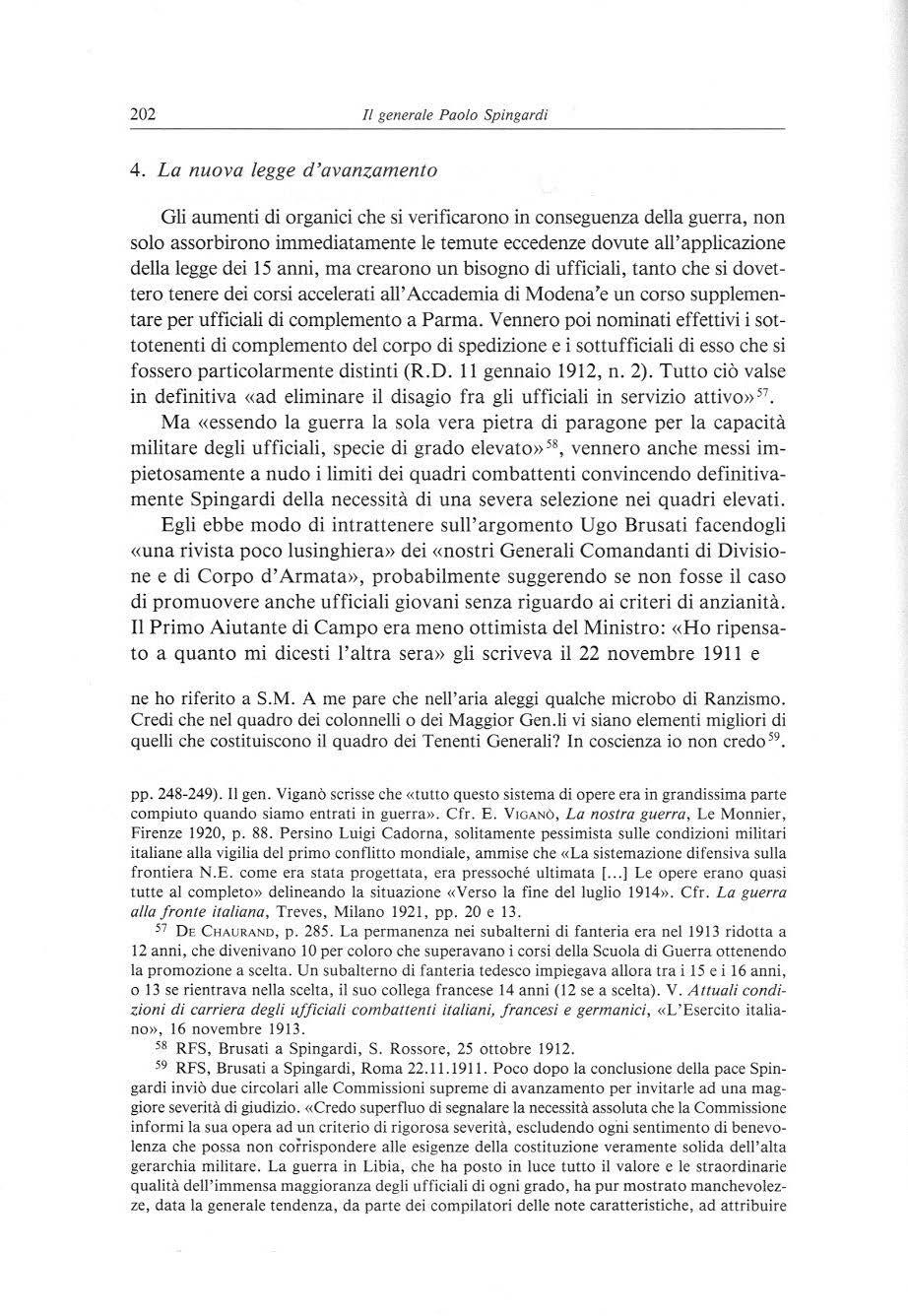
5 8 RFS, Brusati a Spingardi, S . R ossore, 25 ottobre 19 12
59 RFS, Brusati a Spingardi, Roma 22.11.1911. Poco dopo la conclusione della pace Spingardi inviò due c ircolari alle Commissioni supreme di avanzamento per invitarle ad una maggiore severità di giudizio. «Credo superfluo d i segnalare la necessità assoluta che la Commissione inform i la sua opera ad un criterio di rigorosa severità, escludendo ogni sentimento di benevolenza che possa non corri spondere alle es igenze della cost ituzione veramente solida dell'alta gerarchia militare. La guerra in Libia, che ha posto in luce t utto il va lore e le straordinarie qualità dell'immensa maggioranza degli ufficiali di ogni grado, ha pur mostrato manchevolezze , data la generale tendenza , da parte dei compilatori delle note caratteristiche, ad attribuire
202 li generale
Paolo Spingardi
D'altro canto, la creazione di nuovi r eparti con conseguente aumento dei quadri 6<>, le promozioni per merito di guerra e le perdite in battaglia valsero ad accelerare e uniformare le carriere, rendendo non più necessario il ruolo unico, che venne stralciato dal disegno di legge. Spingardi era contrario in linea di principio al ruolo unico , come si è visto 61 •
a tutti, sa l vo rariss ime eccezioni, la qualifica di ottimo o, in pochi casi, di buono: togliendo così al Ministero la possibilità di procedere, occorrendo, ad una scelta cui si a d i guida un co ncetto di relatività, che l'uniforme qualifica non gli consente di formarsi A colmare tale la c un a io giudico pertanto necessario che la Commissione Centra l e ( 1port i la sua attenzione so pra tulfi indistintamente gli ufficial i generali pei quali la sua funzione consultiva può estrinsecars i, e segnali col suo voto al Ministero la convenienza di provvedimenti a riguardo di quelli di essi che abbiano fatto dubitare della lo ro completa att itudine ad esercitare nel modo più degno, sia in pace che in guerra, le funzioni inerenti all'alto ufficio cui furono e levat i» (AUSSME, F-4, Ordinamento e Mobilitazione, R. 61, Corrispondenza ufficiale di Poi/io. C ircolare Riservata di Sp ingar d i alla Commissione Centrale d'avanzamento, Roma 24 n ovembre 1912).
Si veda poi la seguente circolare alla Commissione Speciale, che conferma il regolare funzionamento dell'organismo e illumina sui suoi co mpiti. Ovviamente nessun cenno è fatto della presenza del Re all'interno di essa.
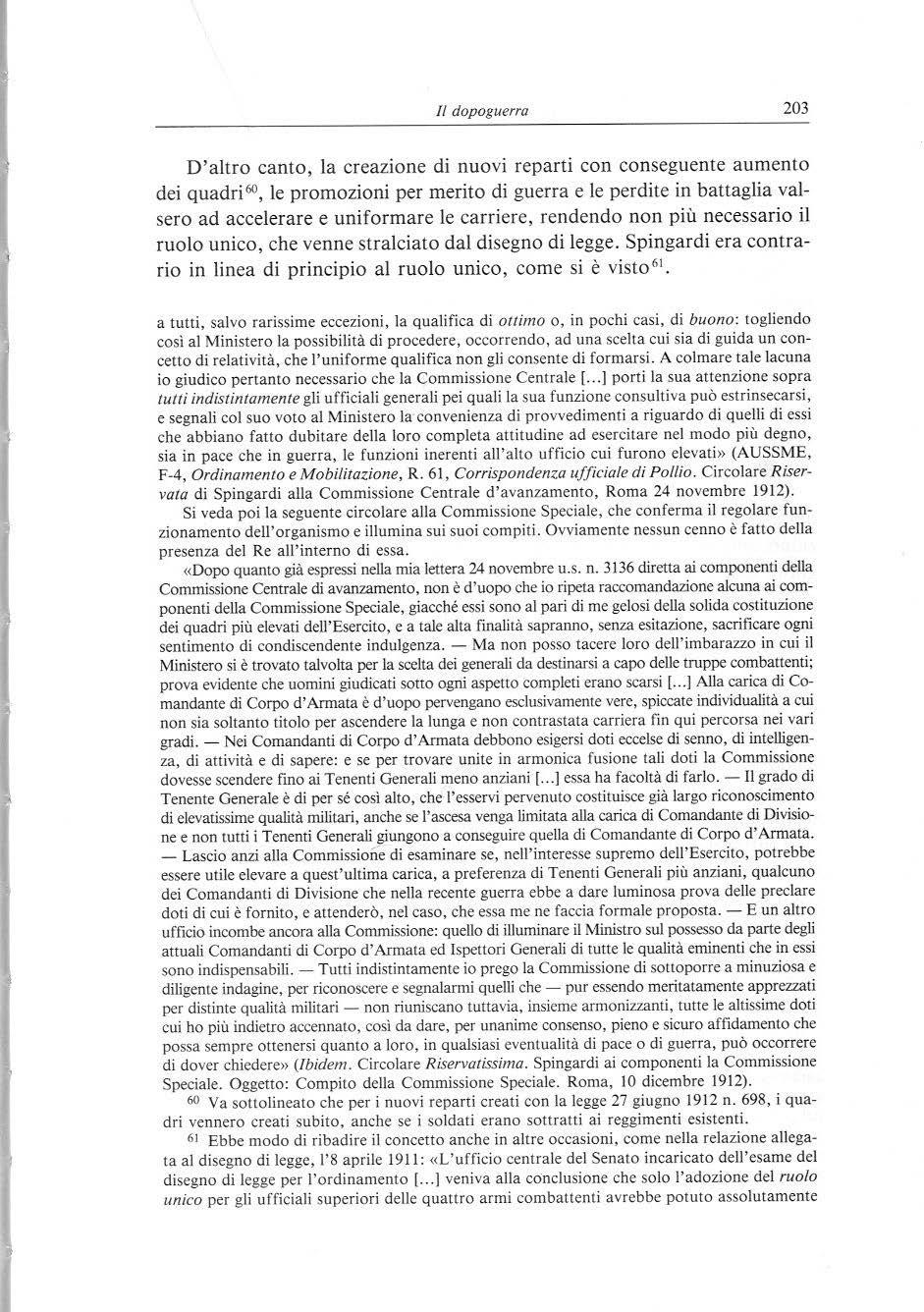
« Dopo quanto già espressi nella mia lettera 24 novembre u.s. n 3 l 36 diretta ai componenti della Commiss ione Cent rale di avanzamento, non è d'uop0 che io ripeta raccomandazione alcuna ai componenti della Commissione Speciale, giacché essi sono al pari di me ge losi della solida costituzione dei quadri più elevati dell'Esercito, e a tale alta finalità sapranno, senza esitazione, sacrificare ogni sentimento di condiscendente indu lgenza. - Ma non posso tacere loro dell' im barazzo in cui il Ministero si è trovato talvolta per la scelta dei generali da destinarsi a capo delle truppe combattenti; prova evidente che uomini giud icati sotto ogni aspetto comp leti erano scarsi [ ] Alla carica di Comandante di Corpo d'Armata è d'uopo pervengano esclusivamente vere, spiccate individualità a cui non sia soltanto titolo per ascendere la lunga e non contrastata carriera f in qui percorsa nei vari gradi. - Nei Comandanti di Corpo d'Armata debbono es igersi doti eccelse di senno, di intelligenza, di attività e di s apere: e se per t r ovare unite in armonica fusione tali doti la Commissione dovesse scendere fino ai Tenent i Generali meno anziani[ ... ] essa ha facol tà di far lo. - Il gr ado di Tenente Gene ra le è di per sé così alto, che l'esservi pervenuto costituisce già largo ri conoscime nto di elevatissime qualità militari, anche se l'ascesa venga limitata alla carica di Comandante di Divisione e non tutti i Tenenti Generali giungono a conseguire que ll a di Comandante di Corpo d'Armata.
- Lascio anzi aUa Commissione di esaminare se, nell'interesse s upremo dell'Esercito, potrebbe essere uti le elevare a quest'ultima carica, a preferenza d i Tenenti Generali più anziani, qualcuno dei Comandant i di Divisi one che nella recente guerra ebbe a dare luminosa prova dell e preclare doti di cui è fornito, e attenderò, nel caso, che essa me ne faccia formale proposta. - E un altro ufficio incombe ancora alla Commissione: queUo di illuminare il Ministro sul possesso da parte degli attuali Comandan ti di Corpo d'Armata ed Ispettori Generali di tutte le qualità eminenti che in essi sono indispensabili. - T utti indistintamente io prego la Commissione d i so uoporre a minuziosa e diligente indagine, per riconoscere e segnalarmi quelli che - pur essendo meritatamente apprezzati per distinte qualità militari - non riuniscano tuttavi a, insieme armonizzanti, tutte le altissime doti cui ho più indietro accennato, così da dare, per unanime consenso, pieno e s icuro affidamento che possa semp re ottenersi quanto a loro, in qualsiasi eventualità di pace o di guer ra, può occorrere di do ver chiedere» (Ibidem. Circolare Riservatissima. Spingardi a i componenti la Commissione Speciale. Oggetto: Compito della Commissione Speciale. Roma , IO dicembre 1912).
6() Va sotto lin ea to che per i nuovi reparti creati con la l egge 27 giugno 19 12 n. 698, i quadri vennero creati s ubi to, anche se i so ldati erano sottratti ai reggimenti esistenti.
6 J Ebbe modo di ribad ire il concetto anche in altre occasi oni, come nella relazione allegata al d isegno di legge, 1'8 aprile 191 I: <<L'uffic io centrale del Senato incaricato dell'es ame del disegno di legge per l'o rdinamento [ J veniva alla conclusione che solo l'adozione del ruolo unico per gl i ufficiali supe riori delle quattro armi combattenti avrebbe potuto assolutamente
lf dopoguerra 203
Però, eliminata così anche l'ultima peculiarità, rimaneva ben poco di ciò che avrebbe potuto diventare una legge straordinariamente innovativa se si fossero realizzate contemporaneamente l'abolizione del Corpo di Stato Maggiore e l'istituzione del ruolo unico.
I nsomma la guerra alterò almeno in part e i parametri secondo i quali era stato preparato il disegno di legge e allungò i tempi dell'esame dell'Ufficio Centrale del Senato, che presentò la propria relazione il 12 marzo 1912. Trascorse p erò un altro anno prima della discussione in aula L 'ulteriore ritardo fu causato sicuramente ancora dalla guerra, c h e fu la preoccupazione dominante per il Ministro almeno fi n o a l settembre 1912; ma anche dalle lunghe discussion i tra Spingard i e i membri dell'Ufficio centrale pe r migliorare quanto restava del progetto originario.
Il risu l tato fu una legge ad usum Sp i ngardi, dipendente cioè dalla personalità politica del Ministro, ma che in sé costituiva solo una lieve modificazione della legge precedente . Avrebbe permesso una selezione rigorosa e giusta solo finché Spingardi o un personaggio altrettanto retto, energico e prestigioso fosse rimasto alla guida del Ministero della Guerra; dopo, le cose sarebbero tornate più o meno come prima .
Come membro consultivo, senza diritto di voto, il Ministro entrava a far parte della Commissione Centrale di avanzamento (art. 18); egli inoltre si riservava il giudizio definit ivo in caso di discrepanze tra i giudizi delle var ie commissioni (art. 17) e la designazione fo r male dei comandanti di armata , del Capo di S . M., del Comandante generale dei RR.CC . , degli ispettori generali e del presidente de l tribunale supremo di guerra e marina, ud i to sempre il parere della Commissione centrale (art. 18).
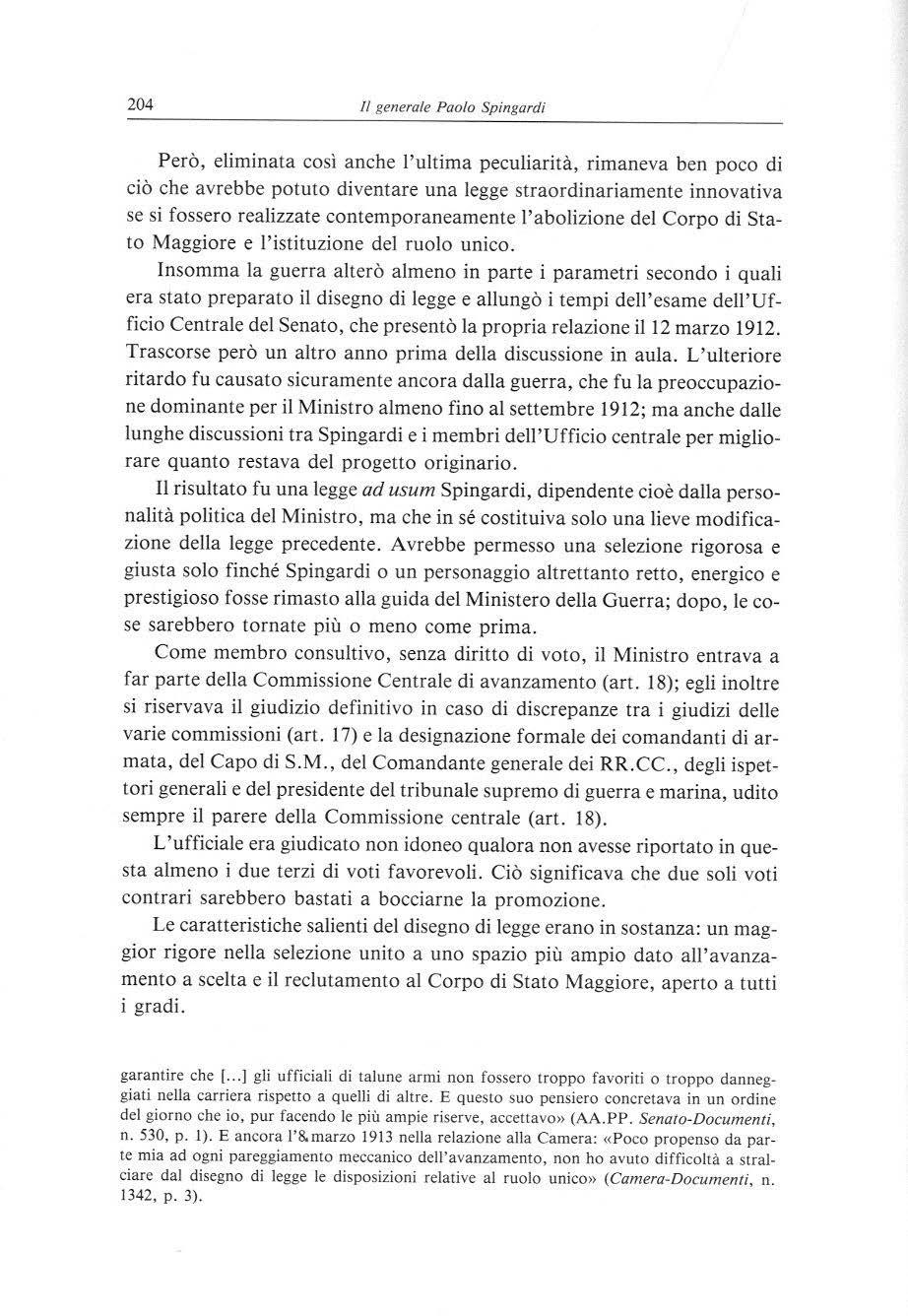
L 'ufficiale era giudicato non idoneo qualora non avesse riportato in questa almeno i due terzi di vot i favorevoli . Ciò significava che due soli voti contrari sarebbero bastati a bocciarne la promozione.
Le caratteristiche sa lienti del disegno di legge erano in sostanza : un maggior rigore nella selezione unito a uno spazio più ampio dato all'avanzamento a scelta e il reclutamento al Corpo di Stato Maggiore, aperto a tutti i gradi .
garantire che [ ) gli ufficiali di ta lune armi non fossero troppo favoriti o troppo danneggiati nella carriera rispetto a quelli di altre. E questo suo pensiero concretava in un ordine del giorno che io, pur facendo le più ampie riserve, accettavo» (AA.PP. Senato -Documenti, n . 530, p . I). E ancora !'& marzo I 913 nella relazione alla Camera: << Po co propenso da parte mia ad ogn i pareggiamento meccanico dell'avanzamento, non ho avuto difficoltà a stralciare dal disegno di legge le disposizioni rela tive al ruolo unico>> (Camera-Documenti, n. 1342, p. 3).
204
li generale Paolo Spingardi
4.1 Selezione e avanzamento a scelta
La legge precedente prevedeva la scelta solo per una piccola porzione nel passaggio da tenente a capitano . Ma, poiché «nell'esercito è necessario che alle alte cariche arri vino ufficiali di indiscusso valore non soltanto, ma vi arrivino in buona età affinché conservino il necessario vigore fisico, che nelle funzioni dell'e sercito è elemento anch'esso di capacità» 62 , la legge del 1896 conteneva l'art. 25, che ri se rvava al Ministro della Guerra le facoltà «di propo rr e con speciali relazioni a S M il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali di qualsiasi grado che se ne rendessero meritevoli per fatti mili tari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero po ssiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione ridonderà a beneficio dell'esercito e dello Stato» 63 • La formulazione della seconda parte si basava su una semplice presunzione di qualità militari spiccate, e lasciava perciò spazio ad arbìtri e favoritismi. Spingardi ne volle quanto più restringere la portata, con una dizione più rigorosa, riservando la promozione eccezionale so l tanto a quegli ufficiali che nell'esercizio delle loro attribuzioni esclusivamente militari avessero «effettivamente reso un servizio di eccezionale importanza» 64 • La promozione veniva inoltre subo rdinata al parere della Commissione Centrale, che sarebbe stato ritenuto sfavorevole qualora la proposta avesse rice vuto più di un voto contrario 65 •
Ri stretto così il campo della promozione eccezionale, per permettere una carriera più rapida ai capaci e meritevoli , il progetto Spingardi prevedeva l'avanzamento a scelta anche per il pas saggio da capitano a maggiore, mentre al momento esisteva solo da tenente a capitano per quanti avessero compiuto i corsi della Scuola di Guerra.
In generale si può dire che Spingardi sostituiva al criterio dell'anzianità, temperato dalle promo zioni eccezionali, quello delle prove numerose escaglionate nel tempo, obbligatori e p e r chi volesse sa lire al grado s uccessivo, in modo che la selezione avvenisse con rigore crescente col crescere dei gradi 66 e solo i più capaci potessero ascendere ai vertici della gerarchia in un tempo relativamente breve.
Per chi avesse v oluto concorre re all'avanzamento a scelta era necessario
62 AA.PP ., Legislatura XXIII, Senato-Discussioni, 4 marzo 1913, p. 9864.
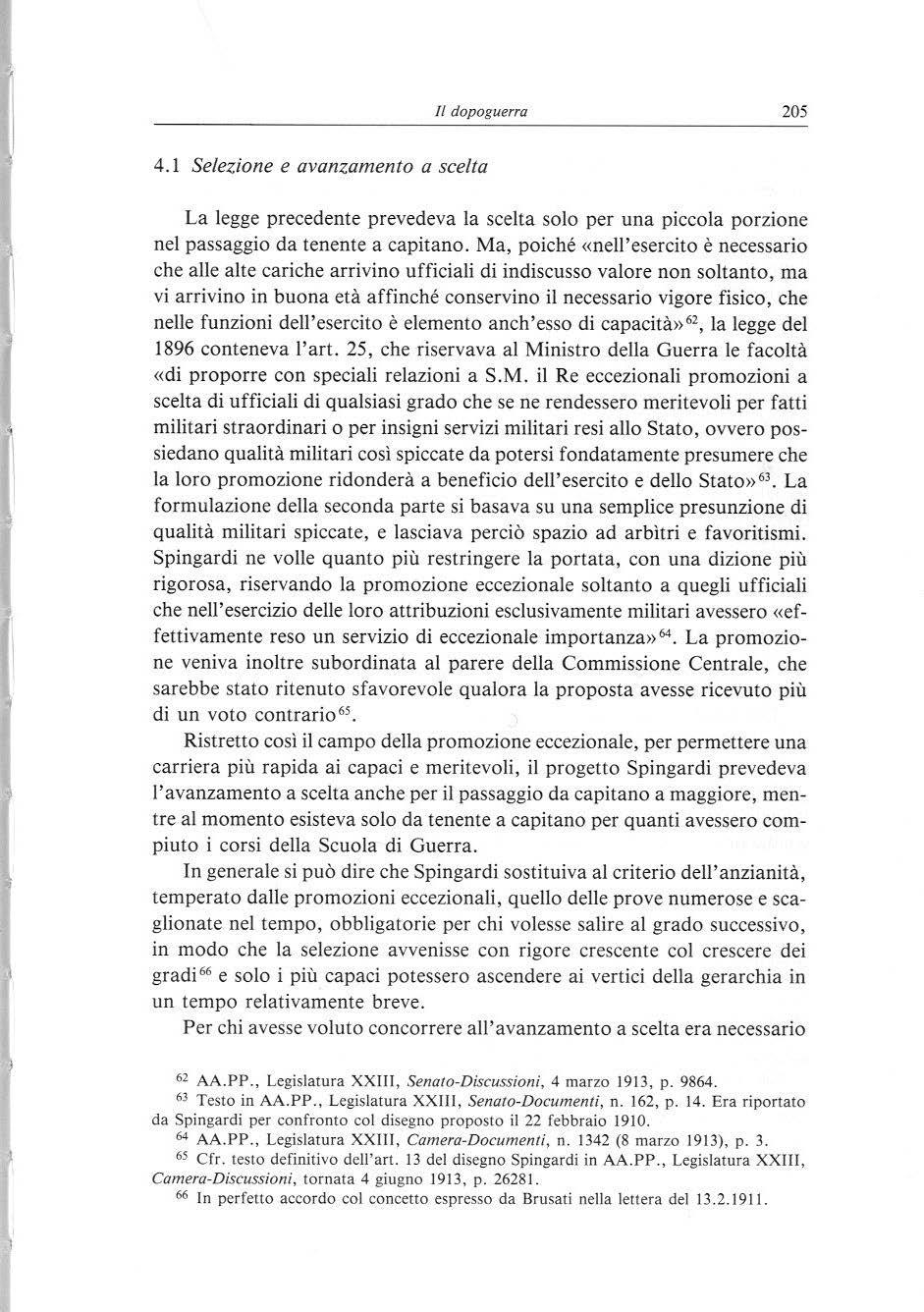
63 Testo in AA.PP. , Leg islatura XXlll, Senato-Documenti, n. 162, p. 14 Era r iportato da Spingardi per confronto co l disegno propos to il 22 febbraio 1910.
64 AA.PP., Legislatura XXIII , Camera-Documenti, n 1342 (8 marzo 19 13), p 3
65 Cf r. testo definit ivo dell'art. 13 del d isegno Spi ngar di in AA.PP ., Legislatura XXIII, Camera-Discussioni, tornata 4 giugno 191 3, p. 2628 1.
66 In perfetto accordo col concet to espresso da Brus a t i nella lettera del 13. 2. I9 I I.
Il dopoguerra 205
I l generale Pa olo Sp i ng ard i
presentare apposita domanda e ottenere la formale proposta della Commission e di avanzamento di pr imo grado 67 • I tenenti a vrebb ero po t ut o aspirare all'avanzamento a scelta solo superando gli esam i della Scuola di Guerra P er gli avanzamenti ad anzianità erano invece previste apposite prove per il passaggio da sottotenente a tenente e da capitano a maggiore. Era comunque indispensabile ottenere il gi udizio favo revo le delle Commissioni di avanzamento. Si stabilì l'obbligo , per la promozione da sottote nent e a tenente, di aver compiuto i corsi della scuola di applicazione per la rispettiva arma e di averne superato gli esami. Era q uesta una novità che nessuna legge pr ecedente ave va stabilito : es sa garantiva una maggiore preparazione professionale dell'ufficial e ed era una procedura s imile a quella odierna .
U n tempo l'e sser nominato sottotenen t e po t ev a conferire una spec ie di diri tto feudale e far tutta la carriera, ment re oggi anche questo mod esto grado non deve rappresentare c he uno scalino sul q ual e dovrà f ermar si chi non dimo strerà di pos sedere qualità s ufficien t i per pro gre dire 68 •
4.2 Reclutamento e avanz amento del Corpo di Stato Maggiore
Spingardi, non essendo rius cito a far approvare la propo st a abolizi one del Corpo di Sta t o Maggiore, si preoccupò nel nu o vo disegno di togliere ogni ombra di privilegio al Corpo
Per il reclu t am e nto dei capitani restavano in vigore le norm e pr ecedenti, e cioè l'esse rs i diplomat i alla Scuo la d i Guerra e l' aver compiuto con buon esito un esp e rimento pratico di s ervi zio di s tato maggio r e.
La novità consisteva nel selezionare i maggiori, tenen t i colonnelli e colonnelli di sta to ma ggiore tra i grad i corrispondenti delle varie armi, alla condizione che ne fo sse ricono sciu t a l'idoneità.
67 P er t u t te le pro mozioni fi no al gra d o di te n ente co l o nne llo co m p r eso esistevan o due Commissioni : un a d i p r i mo grado e u na d i secon d o g ra do , che r i esamin a va ed eve n tualmen te mu tava il giudizio dell a pr ima . Per le prom ozioni a co lonnello e fi n o a te ne nte gene ra l e era c o m petente la sola C omm iss io ne Ce n t r a l e di avanzamento . De ll e nomi ne d e i T ene n t i genera li a lle ca r iche s u per i ori al Co mand o d i D ivisi one s i occ upav a la Comm issione Spec iale , ma la le gge non ne faceva cenno , attr ibuendone la res p o n sabil i tà al M i nistro , a l quale comu nque sp ettav a formalmen te il g iud iz io de fi n i t ivo
68 AA .PP . , Legislatu r a XXIJI , Camera -Documenti, n . 134 2- A, p . 2. Sono paro le del gene r a le M asi, ne ll a re l azi one dell a Comm issione della Camera
Tullo Mas i ( 1853 -19 15) , sottotenente del Ge nio nel 1872, colo nnello nel 1896, maggior generale nel 1902, fu dal 1907 a l 1911 Comandante ge ne rale della Guardia di F inanza . T enente gene rale nel 1909 , comandò la Divisio ne mi li tare di Na poli dal 191 I a l 19 13 e po i il I V Corp o d ' Armata (Bo logna ). G iolittiano («io sonQ g ioli tti a n o dal 1892; sono sta to sem pre favo revo le a ll' onorevole Gioli tt i» disse all a Camera il 4 giugno 191 3) fu deputato n el 1892-9 5 e 1909-15 . La Comm iss ione e ra presieduta da Paolo C arcano e oltre a M asi re lator e, comp rendeva il ge neral e F r a ncesco Pis toja e l ' on. Car lo Schanzer, più e le me n ti d i scarso spicco d e lla maggio ranza gi oli ttiana .
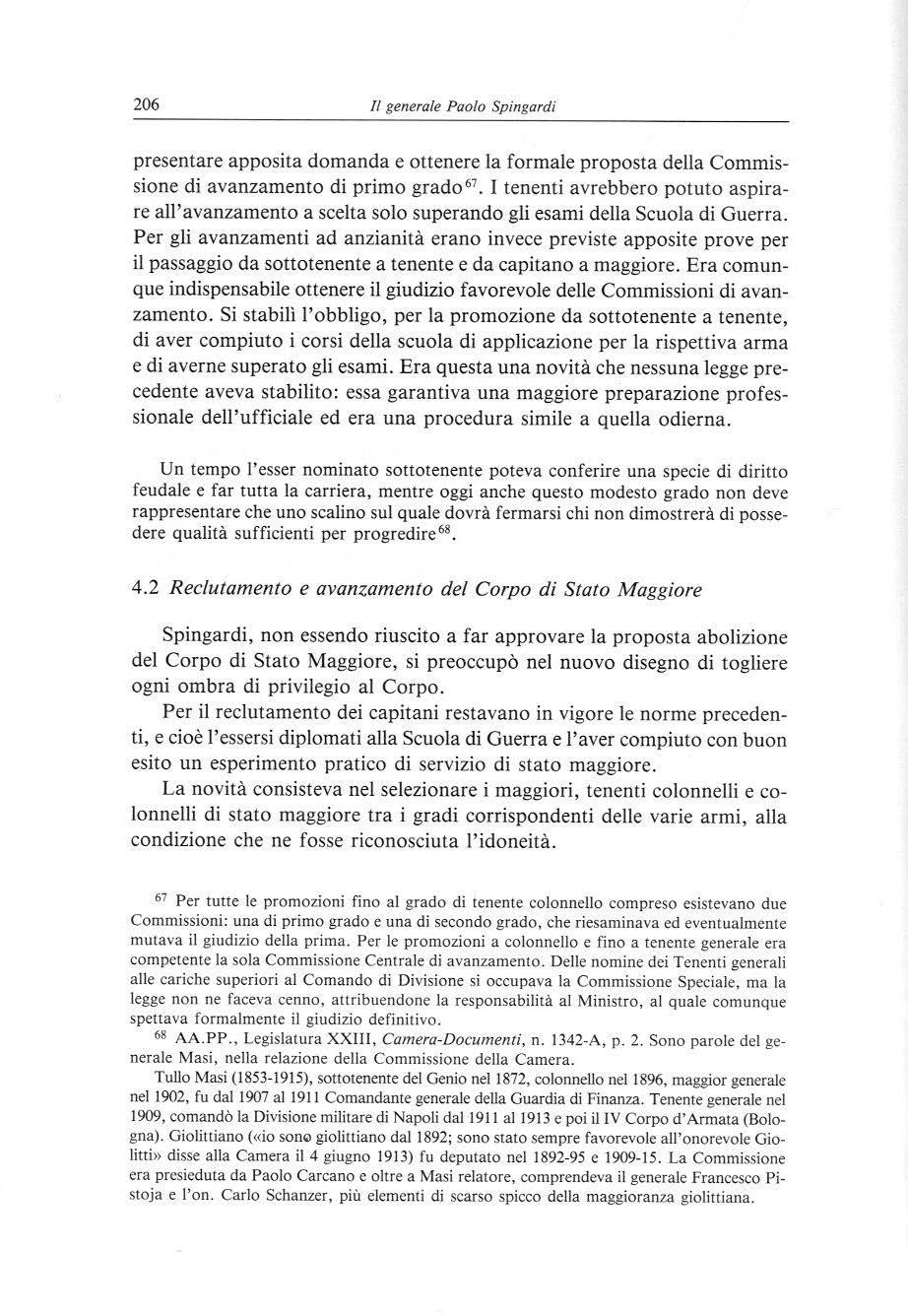
206
Il Corpo di Stato Maggiore - dichiarò Spingardi in Senato - ho voluto non solo a parole ma a fatti che fosse aperto a tutti gli ufficiali delle varie armi comba ttenti, che per ingegno e per carattere militare fossero degni di appartenervi; ogni ombra di privilegio ho voluto che fosse cancellata. Gli ufficiali di Stato Maggiore, recl uta ti così fra tutte le armi , concorre ranno agli avanzamenti a scelta e ad anzianità nel modo stesso c he vi concorrono gli ufficiali di tutte le armi dell'esercito. - Non si parli quind i più di casta o di privilegi, questa leggenda deve assolutamente essere sfatata. L'alterna vicen da del servizio di Stato Maggiore e del servizio alle truppe nell'arma di provenienza [ .] varrà a cementare sempre più i vincoli fra questi ufficiali ed i loro colleghi de ll e armi combattenti. - Una sola eccezione tuttavia fu vo l uta mantenere in questo dis egno di legge a favore degli ufficia li di Stato Maggiore; fu vo luta dalla Commiss ione parlamentare d'inchiesta e fu conc retata nelle proposte di mod i fica de l vostro Ufficio centrale; un leggero vantaggio cioè è conservato ai maggiori di Stato maggiore nella promozione a tenente co lonnello, vantaggio che si traduce in un acce leramento di carrie ra oscillante fra i dodici e i quattordici mesi 69 •
Ma le norme per l'idoneità al servizio erano da sta b ilirsi per decreto 70 • Rimane va insomma un potenziale spazio per abusi e parzialità.
4.3 La movimentata seduta alla Camera del 4 giugno 1913
Il pericolo testè delineato era acutamente colto da Marco Di Saluzzo. Nella tornata del 4 giugno 1913 egli, solitamente favorevole al Ministro, s i scagliava con vio lenza contro il provvedimento, apren d o la discussione sul disegno di legge.
Il nuovo progetto s i preoccupa della ingiusta leggenda de l ruo lo chiuso, ma non di quella veramen t e gius ta del pr ivilegio di carriera, e così, invece di allargare , caso mai, la po rt a d ' entra ta s in o a render possibile l ' accesso a tutti i mer itevoli debitamente controllati, [ .. .]apre un finestrino di contrabbando , concede vantaggi di carriera ai tirati su da questo finestrino, rendendo possibili veri atti di nepotismo [ ] Gli ufficial i più di stinti si affretteranno ad evitare [. ] il grado ingrato di capitano di stato maggiore che è quello, però, il quale forma l'ufficiale di stato maggiore e più rende al servizio [ ] Essi preferiranno sosten ere gli esami a scelta da capitano a maggiore nella probabilità di essere poi chiamati nel corpo da maggiori [ .. .] Si avranno due categorie di ufficia li di stato maggiore: i diploma t i ufficialmente ed i conosciuti ufficiosamente, quelli sdaziati a ll a porta e quelli entrati in franchig ia: gli sfruttati e i beneficiat i. Ma il peggio si è che quelli della categoria incontrollata entreranno come superiori ge rarchici dei primi 71 •
69 AA.PP. , Legis latura XXIII, Senato -Discussioni, 4 marzo 1913, p. 9865.
70 AA.PP. , Legislatura XXIII, Camera-Documenti, 1342-A, p. Il.
71 AA.PP., Legislatura XXIII, Camera -Discussioni, 4 giugno 1913, pp. 26246-26247. Il discorso è un battibecco con Spingardi e il rela tore Masi, gli interventi dei quali inter rompono spesso il d :sco rJo di Di Saluzzo V. perciò anche pp. 26248-26251.
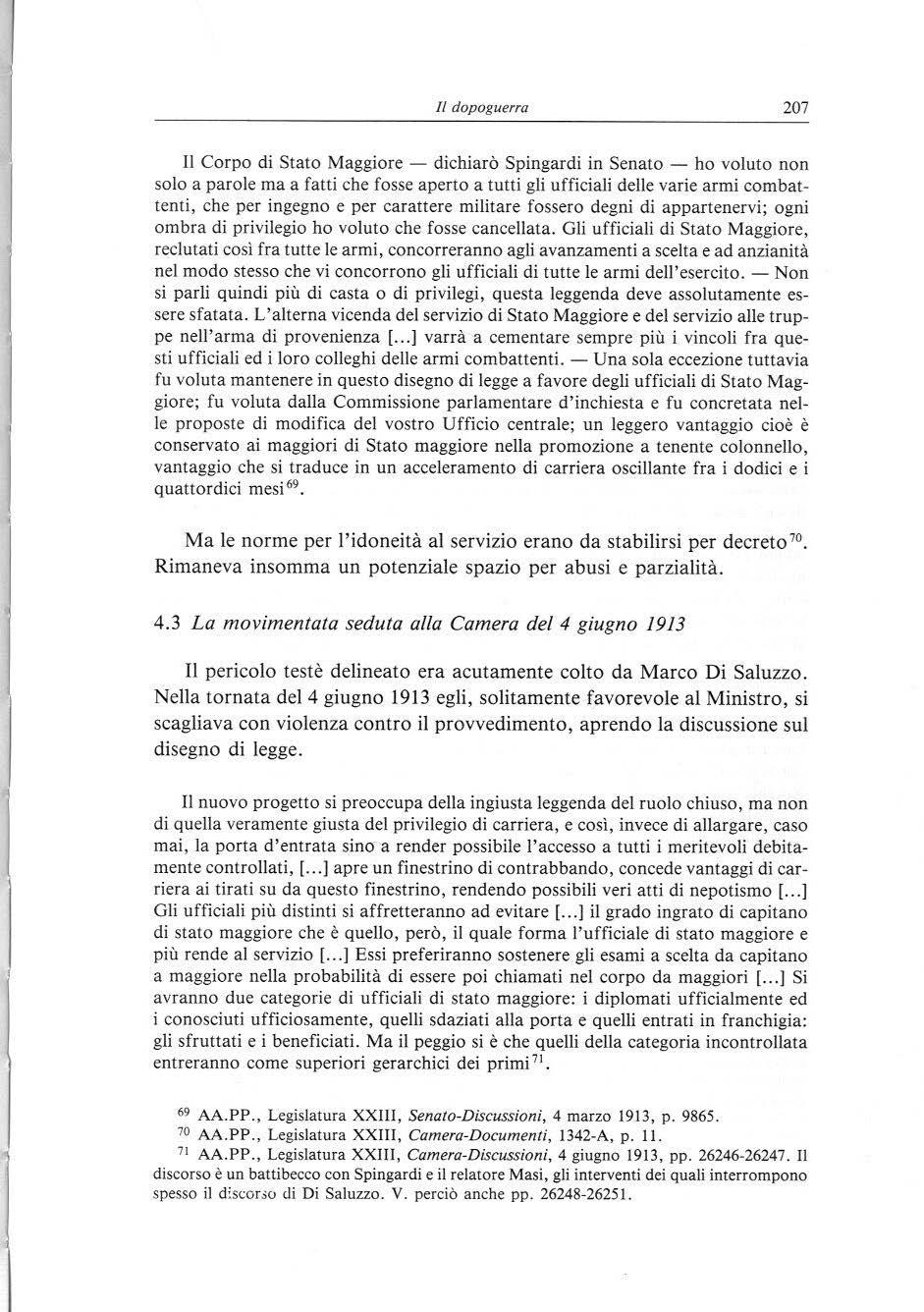
Il dopoguerra 207
Spingardi
Sullo stesso argomento rincarava la dose il generale Fortunato Marazzi. In un discorso molto bello e articolato, sottolineato da frequenti inte r ruzioni e commenti , difendeva il ruolo unico lamentandone l 'abba ndon o 72 e si soffe r mava sul concetto di scuola unica per il reclutamento di tutti gl i ufficiali 73 , allo scopo di avere dei criteri che sottraessero il più possibile l 'avanzamento al giudizio umano, troppo spesso fallace. Riservava però lo spazio maggiore all'esposizione dei propri concetti ci r ca il Co r po di Stato Maggiore, al quale egli aveva del resto appartenuto I suoi pensieri non si riferivano quindi agli appartenenti al Corpo «con diffidenza, ma con vero affetto»; parlando però nell' interesse dell' intero esercito
è un fa t to innegabile che se il Corpo di st ato maggio r e non esistesse, t u tte le q uattro armi com battent i si sentire b bero come r ialzate . Sarà una cosa sp iacevo le, ma è un fatto umano( . .. ] . La soppressione dello stato maggiore rafforzerebbe la compag ine di tutti gli ufficiali dell'esercito. - L'avanzamento nel Corpo di stato magg iore ha poi questo guaio : se i vantaggi sono pochi, si dice che gli ufficiali saranno schivi ad entrarvi; se i vantaggi sono molti, ecco sorgere malumori negli altri corpi - Ma ai fini di questa legge io non dirò altro che una porta deve essere aperta o chiusa, e qui invece la porta è semiaperta, giacché i capitani vi entrano provenendo dalla scuola di guerra, e po i ne sortono quan d o sono al grado di maggiore, mentre ne l grado di magg iore g l i ufficia li possono entrare nello stato maggio re e restarv i fino al co lonnellato, perché qui vi è l'articolo 22 nel quale con un in massima e con un eccezionalmente, si permette al Ministero di trattenere nello stato maggiore un ufficiale dal grado di maggiore sino al co lonnellato incluso . - È quindi un corpo chiuso alla base, chiuso alla testa, ma aperto nel mezzo. Quale ne sarà il risultato pratico?
Che i migl iori capitani non vorra n no e nt rare ne l corpo di stato maggiore , perc hé per essere maggiori debbono poi subire un esame, ed un esame di carattere em i nentemente militare: ora è mo lto p i ù facile subire una prova di questo genere quando si è stati molto tempo al comando delle truppe che non quando ci si sia stati poco.
- E questa condizione, aggiunta anche nelle noie del servizio di ufficio, farà sì che i migliori elementi vorranno entrare nello stato maggiore addirittura come ufficiali superiori e non come capitani . ( . .. ] Le doti militari [ ... ] si formano con la vita in
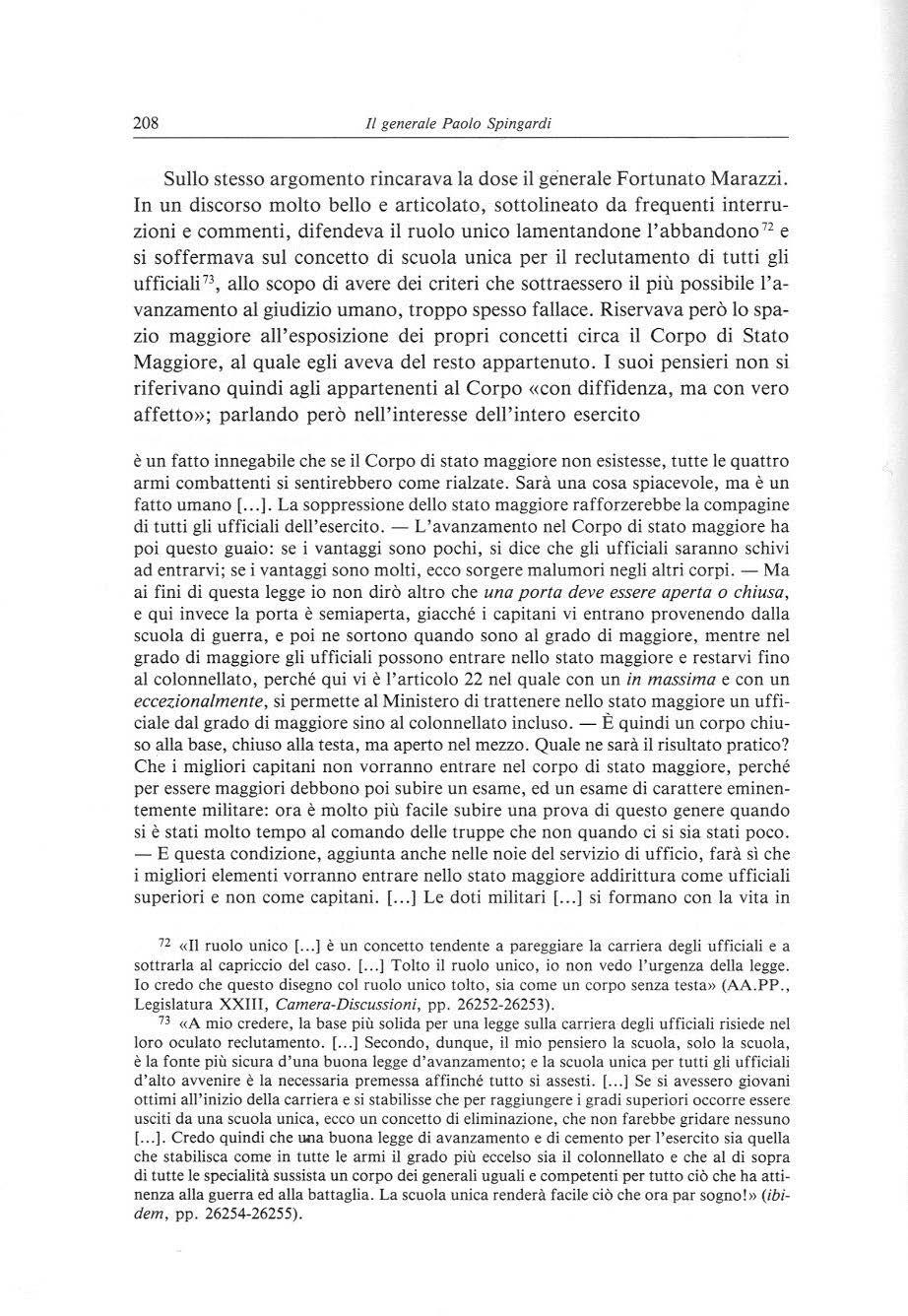
72 « Il ruolo un ico [... ] è un concetto tendente a pareggiare la carriera degli ufficiali e a sottrarla al capriccio del caso. [ ] Tolto il ruolo unico, io non vedo l'urgenza della legge. Io credo che questo diseg no col ruo lo unico tolto, sia come un corpo senza testa» (AA PP., Legislatura XXIII, Camera -Discussioni, pp . 26252-26253).
73 «A mio credere, la base più sol ida per una legge s ulla carriera degli ufficiali risiede nel loro oculato reclutamento . [. .. ] Secondo , dunque, il mio pensiero la scuola, solo la scuo la, è la fonte più sicura d'una buona legge d'avanzamento; e la scuola unica per tutti gli ufficia lj d'a lto avvenire è la necessar ia premessa affinché tutto si assesti. [ ] Se si avessero giovani ottimi all'in izio della carriera e si stabilisse che per raggiungere i gradi superiori occorre essere uscit i da una scuola unica, ecco un concetto di eliminazione, che non farebbe gridare nessuno [... ). Credo quindi che oo a buona legge di avanzamento e di cemento per l'esercito sia quella che stabilisca come in tutte le armi il grado più eccelso sia il colonnellato e che a l di sopra di tutte le specialità sussista un corpo dei generali uguali e competenti per tutt o ciò che ha attinenza alla guerra ed alla battaglia. La scuola unica renderà facile ciò che ora par sogno!» (ibidem, pp 26254- 26255).
208 li
generale Paolo
mezzo ai soldati, col comando effettivo delle truppe. [ ] - li Corpo di stato maggiore trattiene per tre quarti della carriera gli ufficiali presso di sé , e quindi lo sviluppo delle doti militari non può essere quale sarebbe se vi fosse il servizio di stato maggiore il quale permetterebbe di chiamarvi sempre coloro che si mostrano i migliori e permetterebbe di sv ilupparne la conoscenza presso i futuri generali, pur distogliendoli il meno possibile dalle truppe. Oggi , sopra settantadue ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore, trenta, quasi la metà, trovasi qui in Roma; e in questo fatto numerico io trovo una delle ragioni per le quali affrettatamente questo disegno di legge è sp into alla Camera 74 •
Marazzi proseguiva sollevando gravi obiezioni anche sul funzionamento della Commissione Centrale. Le argomentazioni di Marazzi erano lucide, plausibili, precise. Secondo lui il disegno avrebbe dovuto
far sì che le garanzie della sce lta nei gradi alti fossero infinitamente più grandi dei criteri di sce lt a nei gradi bassi . - Ed invece qui vediamo confermati ed aggravati i difetti dell'antico sistema. Infatti da colonnello in giù si dispone che per le scelte delle varie promozioni vi siano due Commissioni composte da numerosi giudici e che le prove siano duplici; invece da colonnello in su, si vuole una sola Commissione composta di sei membri, una so la prova ed il segreto insindacabile. - E questo è ancora niente. Si vuole che, per avere l'idoneità vi siano due terzi dei giudici favorevoli; di modo che basta pel generalato che vi sia più di un voto negativo, perché il giudicato s ia definitivamente escluso dalla promozione. - Il fatto della minoranza che impera sulla maggioranza era già grave quando vi erano nella Commissione centrale 17 membri, come nella legge antica; diventa gravissimo ora che bastano sei. Veramente non capisco perché la minoranza imperi sulla maggioranza. Ma come? Si fa una discussione, ci sono tutti gli elementi di giudizio, tutti i giudici sanno che bisogna essere rigorosi e che si tratta di una promozione a scelta. Quelli che sono contrari al cand idato hanno libera parola; possono sviluppare qualunque concetto, portare qualunque prova; malgrado questo , non riescono a smuovere la maggioranza. Ebbene, la maggioranza avrà torto e loro ragione! Credo questo enorme! [ ... ] Nella legge ora in vigore è stabi li to per tutti un duplice esame. [... ) L'avere ammesso le due prove ha fatto sì che molti genera li riprovati, ora si trovano senatori e sono stati promossi e hanno finita la loro carriera come comandante di armata. - Io cito soltanto un nome caro a tutti noi, quello del generale Mazzitelli nostro collega, che in un primo esame fu dichiarato non idoneo come comandante di divisione. Era un errore . Essendovi la legge delle due prove, l'anno segue nte si poté rimediare, ed il MazzitelE passò non solo come comandante di corpo d'armata, ma comandante d'armata; il che vuol dire che effettivamente la Commi ssione aveva sbagliato Allora si poté correggere; oggi non più perché la prova è una. (Interruzioni). - Vi sono parecchi altri casi ma io non li nomino perché si tratta di persone viventi, e potrebbero anche sentirmi. - Se tutto questo avveniva con 17 membri di una Comm issione che cosa avverrà con solo sei? Quando quattro hanno torto di fronte a due e bastano due contrari per essere riprovati 75 •
1 4 Ibidem, pp. 26255 -26256. 75 ibidem , pp. 26258-26259.
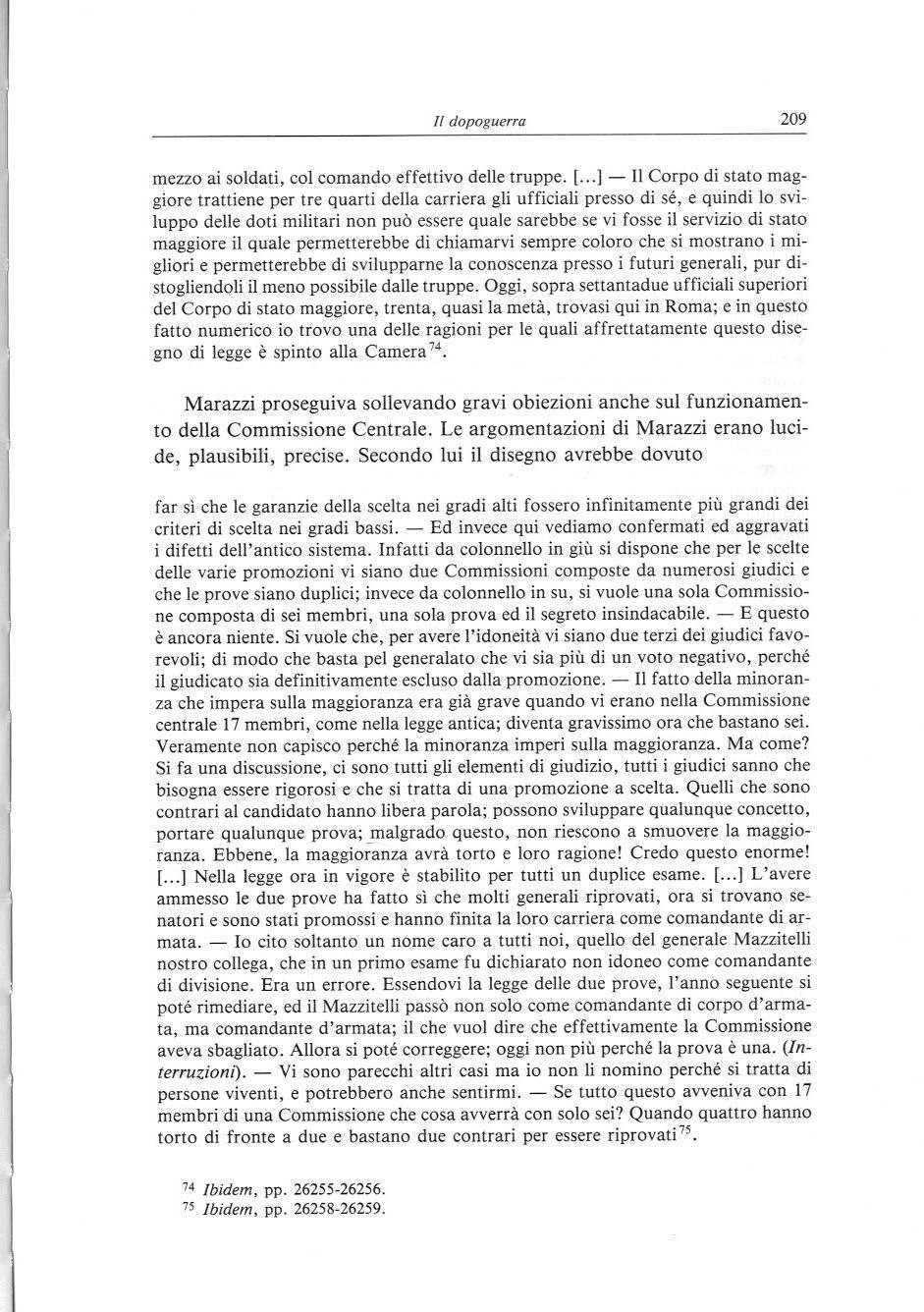
lf dopoguerra 209
Riguardo l'intervento del Ministro nella Commissione, Marazzi si chiedeva:
È possibile che il ministro entri in una Commissione senza che ne sia il pres id ente, senza che diriga i lavori, senza che si chiarisca pro o contro !'esaminando? Se parla in favore o contro, è evidente che tutto il consesso sarà della opinione del ministro: non c'è bisogno che egli voti per questo. - E se avvenisse il contrario, sarebbe una cosa gravissima : sarebbe tutta l'alta gerarchia militare di un parere opposto a quello del ministro . E allora questi dovrebbe andare al Consiglio dei ministri o venire qui alla Camera a difendere un provvedimento che non è nella sua coscienza.
[... ] A me pare che tutto ciò [ . .. ] avrà per risultato c he , in fine dei conti, il ministro potrebbe dire: io ho il parere della Commissione; la Commissione : io mi sono rimessa all'opinione del ministro; e la moral e delle morali è questa: che le responsab ilità comp letamente sfumano . Quindi, a questo sistema che non ho mai visto app licato od attuato in nessun altro consimile caso, preferisco la re sponsab ili tà netta e chiara del ministro. Preferisco che egli, con un decreto, promuova chi meglio creda e ne informi sotto la sua responsabilità gli interessati. È questo il sistema pratico, semplice e che s'impo ne in ogni società militare 76 •
Marazzi conc ludeva dicendo di temere che «questo disegno di legge, discusso sul tramonto della nostra legislatura e che pure riguarda gli in teressi di 16.000 ufficiali e di molte famiglie, non sia bene accetto all'esercito, che trae le sue forze non da procedimenti effettuati nell'ombra, ma dal sentimento di una giustizia, resa alla luce del sole e controllata dalla pubblica coscienza ( Vive approvazioni - Molte congratulaziom)» 77 •
Sugli stessi argomenti tornava il repubblicano Eugenio Chiesa, unico rappresentante dell'estrema sinistra a prendere la parola. I soc iali sti infatti non intervennero nel dibattito, forse perc hé il progetto di legge non imp li cava nessun aumento di spesa.
Chiesa pronunciò un brillante per quanto fazioso discorso, ripetutamente sottolineato da commenti e interruzioni, nel quale non risparmiò nessuno , attaccando il relatore Masi per l'eccessiva condiscendenza nei confronti del disegno ministeriale, mostrata per ricambiare i presunti favori elettorali ottenuti dal Governo 78 e il Ministro per il modo in cui presentava i disegni di legge:
Onorevole ministro, ella, che ha tanto consenso, direi quasi troppo, perché troppo ha cont inu ato attraverso parecchi Mini steri, ma perché si attiene ad un sistema di improvvisazione della discussione come questo? Perché, quando la Camera sta per chiudere i suoi lavori, arrivano come picco le bombe a mano questi suoi
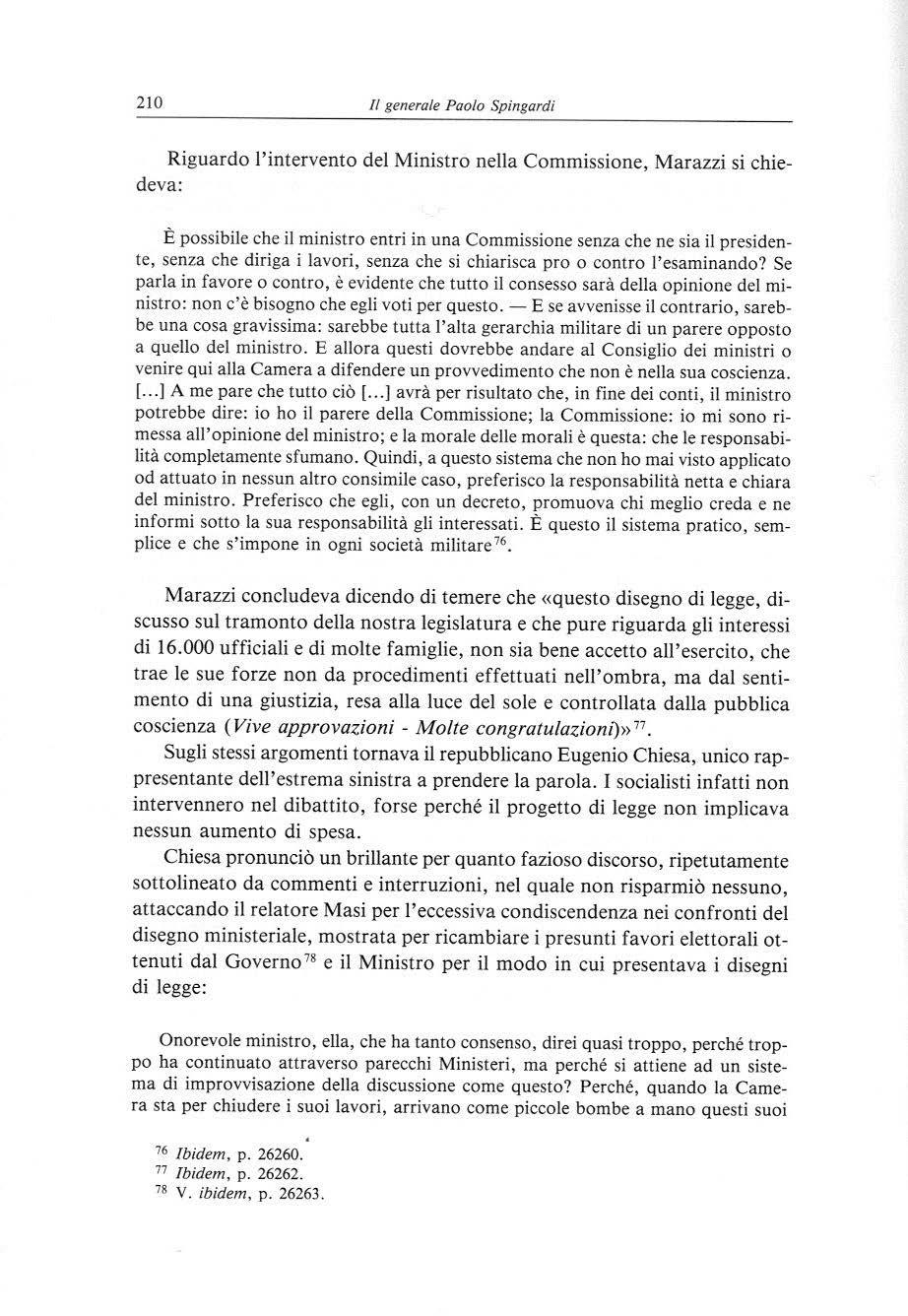
210 I l generale
Paolo Spingardi
76 Ibidem, p. 26260 77 Ibidem, p. 26262 78 V ibidem , p. 26263.
progetti? [...] Ora io d ico francamente che queste leggi a galoppo non vanno . Noi non ce ne intendiamo. Noi siamo per la nazione armata piuttosto che per l'esercito permanente, ma c r ediamo che sia un mezzo di difesa in cui ci sarà bisogno di ufficiali come adesso e fo r se più; quind i s i vede che il nostro interesse è piuttosto pe l modo d i leg i ferare che pe i particolari d ella legis lazione . - Ma ella comprenderà anc he come a q ues t i pochi dep ut ati dell'estrema sinistra non possano non fare impressione anche i soli due oratori che hanno parlato q ui: due militari e tutti e due contrari, e credo che no n siano i soli, anch e perché ve ne sono d i quelli che non hanno parlato qui, ma che han no detto che il progetto non è buono, che è cattivo, che è dannos o [ . . ] Ell a p renda l'a r ticolo 16, que llo che poc'anzi censurava con asp r a e minacciosa parola l'onorevole Marazzi. È l'articolo che consacra i l potere de ll a m ino r anza su lla maggioranza.... Quella minoranza che può essere anch'essa patrio tt ica e alla q uale appart iene l'onorevole Chiesa che non hanno volu t o nella maggioranza per pochi voti. (Ilarità) Ora, è bene che q uesto sia nell'esercito dove voi dovete tutelare precisamente contro gli abusi della maggioran za i diritti d ella minoranza? Ma ella, onorevole Marazzi , ha detto parecchie ragioni . .. forse non ne ha detta una che conosce anche lei, pe r ché se la conosco io la deve conoscere certamente anche lei. Non ha detto la ragione, diciamo così , loiolesca (Commenti) . Nella Commiss ione c'è già fra quei sei membri il duca d'Aosta 79 Ci sarà, o c'è già, dicono, il conte di Torino 8°, due memb r i della Co rte. - Vuo l d ire che su sei, e p r esente lei, sia pure non con vo t o de lib er ativo, ma certamente con quella influenza che esercita un mi ni stro che sa parlare come lei .. . vi sarà questo per ico lo . .. qua ndo vi siano, come vi sono, nella Commissione giudicante pr incipi di sangue, essi saranno riten u ti responsabili, mentre voi dovreste lasc iarli inattaccati Ora, io vi dico questo: badate ai pericoli per le vostre istituzioni. Per noi, vi dic iamo: se que i l 6.000 ufficia li si convertiranno alle i d ee nostre, non per questo pericolerà la patria che noi amiamo quanto voialtri e alla cui di fesa noi quanto voi t eniamo. (Commentt) 81 •
A nc he Ch iesa cog lieva l'ampio spazio lasciato all'arbìtrio del Ministro :
I o non sono molto addentro a queste cose; ma è c erto c he quell'eccezionalmente che ella ha messo ne ll 'a r ticolo 22 rompe tutto quello che poteva essere di regolare, cioè di imparziale[ . .. ] perché nessun altro che lei potrà misurare la latitud i ne e l'elasticità, la cintura elastica di que ll 'eccez ionalmente 82 •
79 Emanue le Filiberto di Savoia-Aosta era comandante designato d'armata e com e tale entrava d i d iritto nella Commiss ione Centrale d'avanzamento.
80 Vit torio Emanuele di Savoia-Aosta, conte di Torino (Torino 1870-Bruxelles 1946), da l 1911 era Ispettore generale della cavalleria Era perciò membro effettivo della Commissione Centrale ogni volta che si giudicava dell'avanzamento di un ufficiale d i tale arma.
&, Ibidem , pp. 26262 -26264.
82 Ibidem, p. 26264. L'art. 22 diceva: «I cap itani di staw maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza; i maggiori possono essere promossi o nell'arma di provenienza o nel corpo stesso di stato maggiore; i te nenti co lonnelli , di massima , sono promossi nell'arma di provenienza ed eccezionalmente nel corpo di stato maggiore». Ques ta disposizio ne lasciava in sos tanza la possibi lità che qualche ufficiale trascorresse l'arco di carriera da maggiore a colonnello tutto nello stato maggiore, senza trascorrere un so lo gio rno presso le truppe.
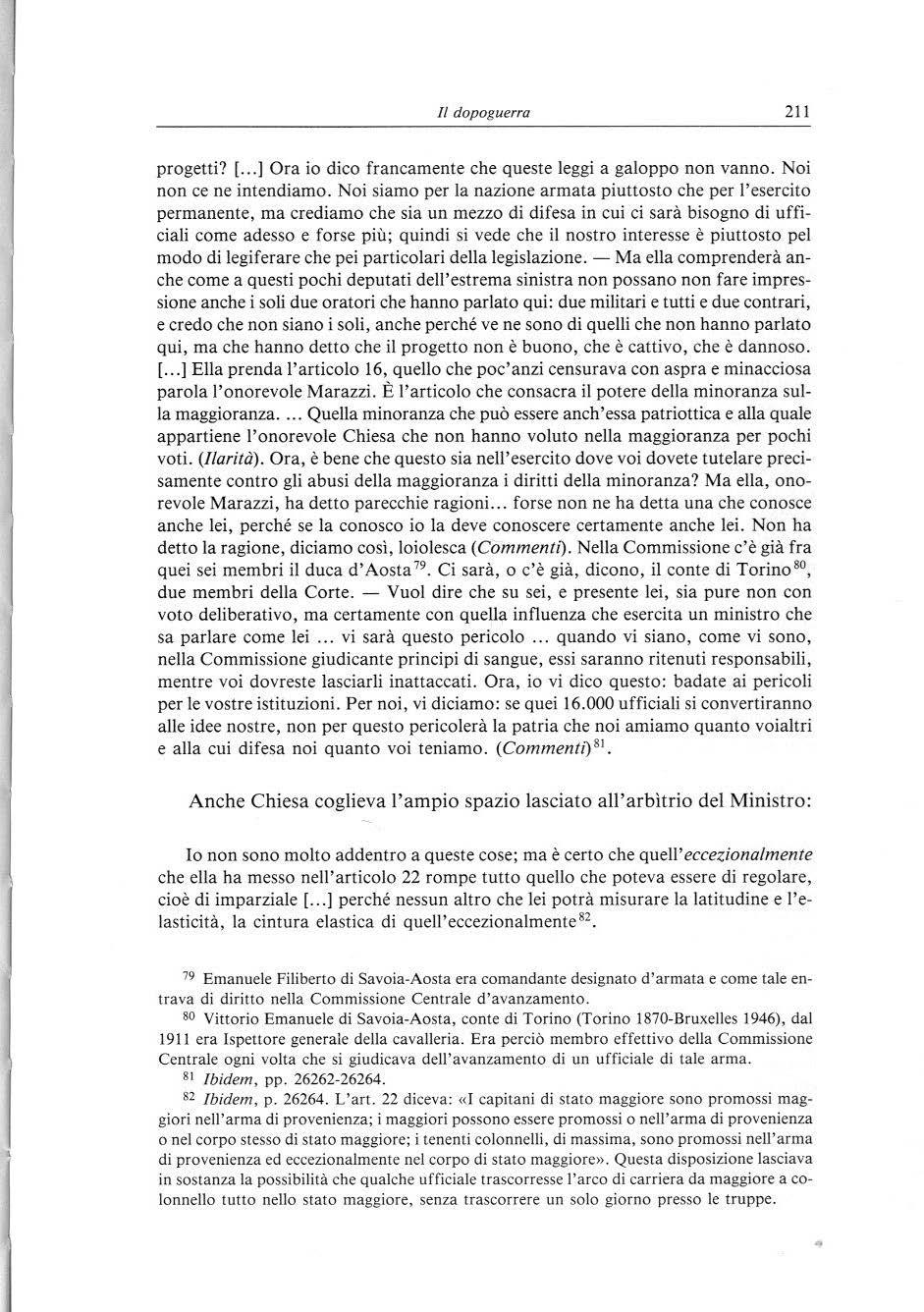
li dopoguerra 2 1 1
•
Il generale Paolo Spingardi
Spingardi svolse il suo discorso venendo interrotto più volte da Chiesa, tanto che questi dovette essere ripreso dal Presidente Marcora 83 •
Benché esponesse il proprio pensiero con abilità e rispondesse con precisione ai vari oratori, Spingardi risultò meno efficace del solito Le obiezioni sollevate mantennero intatta la loro plausibilità: so ltanto una persona al di sopra di ogni sospetto poteva offrire sufficienti garanzie di una corretta interpretazione della legge, ed egli nel suo discorso ovviamente versava la certezza della propria onestà. In buona fede non riusciva a figurarsi una situazione in cui un ministro non meno onesto, ma meno capace, avrebbe potuto dare alla legge una interpretazione nel senso paventato dai precedenti oratori. Il concetto del Ministro era in fondo rafforzato dal ruolo assunto dalla corona nel processo di avanzamento. Il Re in qualche modo diventava il garante supremo del corretto funzionamento della legge, e dopotutto vien fatto di pensare che lo spazio lasciato all'interpretazione dell'esecutivo fosse il risultato delle influenze di Vittorio Emanuele III.
Ad ogni modo Spingardi volse le sue argomentazioni con la consueta chiarezza, cercando di stemperare le critiche sotto lineando come in fondo il disegno di legge in esame si limitasse soltanto
a ritoccare e correggere quelle parti della legge di avanzamento tu tto ra esistente (che è del 1896), c h e le esigenze dei nuovi temp i e le altre esigenze del servi zio hanno reso meno rispondenti alle finalità stesse che la legge si proponeva di raggiungere 84 •
Riguardo l'avanzamento a scelta, egli ricordava come specialmente nei lunghi periodi di pace, la scelta diviene una necessità, perché è stimolo ai migliori elementi di non adagiarsi ma di progredire, cosicc hé possano raggi ungere al più presto poss ibile il vertice della scala gerarchica, e possano permanervi lungame n te, in età relativamente giovane, in modo da poter dare il massimo rendimento co lla maggior energia fisica, in quanto che le condizioni fisiche nella milizia sono anch'esse e lemento di capacità. - Si potrà discutere sulla questione di misura, di modalità di applicazione, ma il principio della necessità della scelta, cioè di contemperare l'avanzamento per anzian ità con l'avanzamento a sce lta, è da tempo universalmente riconosciuto da tutt i e non soltanto dalle autorità militari competenti in materia. -E poiché l 'esper ie nza di oramai diciassette anni ha dimostrato come la misura dell'avanzamento a sce lta risultante dalle disposizioni della legge 1896 non era asso lutamente sufficiente, con questo disegno di legge mi sono limitato a proporvi di estendere l'avanzamento a sce lta da capitano a maggiore 85 •
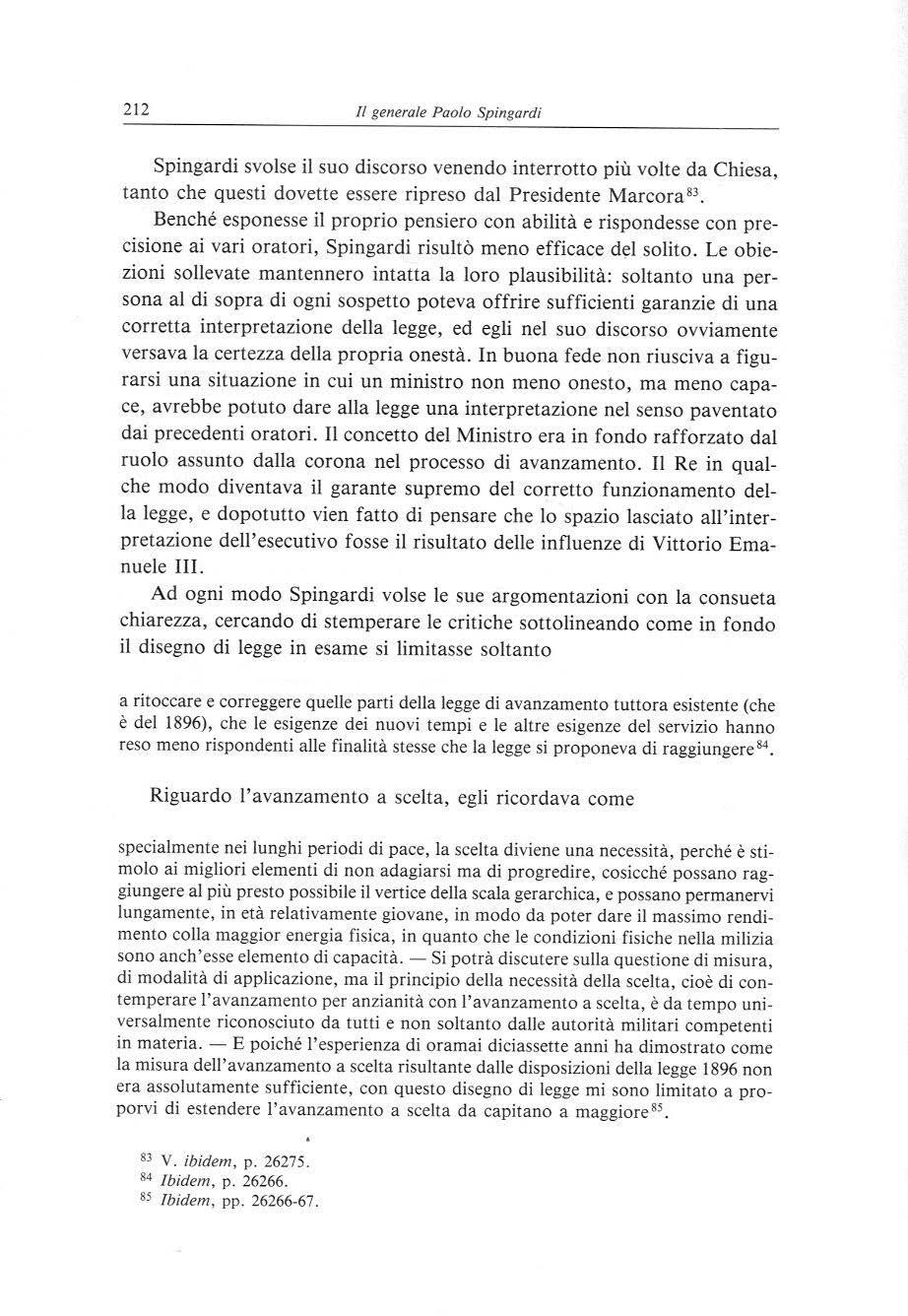
212
V. ibidem, p. 26275. 84 Ibidem, p. 26266. 85 Ibidem , pp. 26266-67.
83
Riguardo alla necessità di una rigorosa selezione, specie negli alti gradi, Spingardi si limitava a sottolineare che essa «va le tanto ad avvantaggiare le condizioni di carriera della massa che avanza per anzianità, quanto astimolarne le attività e quindi ad accrescerne il rendimento» poiché d'altronde, essendo uno dei cardini della legge, era un principio più volte ricordato, ed era inutile insistervi oltre, anche perché premeva soffermarsi sull'argomento che aveva prodotto il più vivo dibattito: il reclutamento e l'avanzamento del Corpo di Stato Maggiore.
Perché questo corpo possa dare anche in avvenire quei frutti che l 'eserci to ed il Paese hanno diritto di attendere, è necessario che sia circondato non soltanto dalla stima, ma anche dalla simpatia di tutti i loro co ll eghi dell'esercito. È necessario che meglio si cementi quell'affratellamento che deve unire tutti i membri delJa grande famiglia militare. - Quindi è opportuno, come ebbi occasione di dire in Senato, che si sfat i quella leggenda di corpo chiuso, di casta e di privilegio che asso lutamente non ha più ragione di essere A rimediare a que sto inconvenien te ho voluto che il Corpo di stato maggiore fosse, non soltanto a parole, ma effett ivamente, aperto a tutte e quattro le armi combattenti, non soltanto nel grado di capitano ma in tutti i gradi della gerarchia militare fino al grado di co lonnello compreso Oggi nel Corpo di stato maggiore entreranno non soltanto i capitani provenienti dalla scuola di guerra ma entreranno i maggiori, i tenenti colonnelli e i co lonnelli provenienti daJJa fanteria, dalla cavalleria, dall'artiglieria e dal genio per effetto degli studi compiuti, abbiano o non abbiano appartenuto alla scuola di guerra. ( ] Non mi illudo di poter far tacere con questi provvedimenti ogni polemica; certo è che se il disegno di legge, che sottopo ngo all'esame della Camera, diverrà legge dello Stato e sarà applicato, come io mi propongo di fare, con larghezza di criteri ma con seve rità, per ciò che riguarda le pe rsone, verrà tolto per lo meno alle polemiche ogni e qualsiasi fondamento 86 •
Spingardi conservava i migliori argomenti per rispondere agli oppositori, cominciando dal lungo ed interessante discorso dell'onorevole Marazzi.
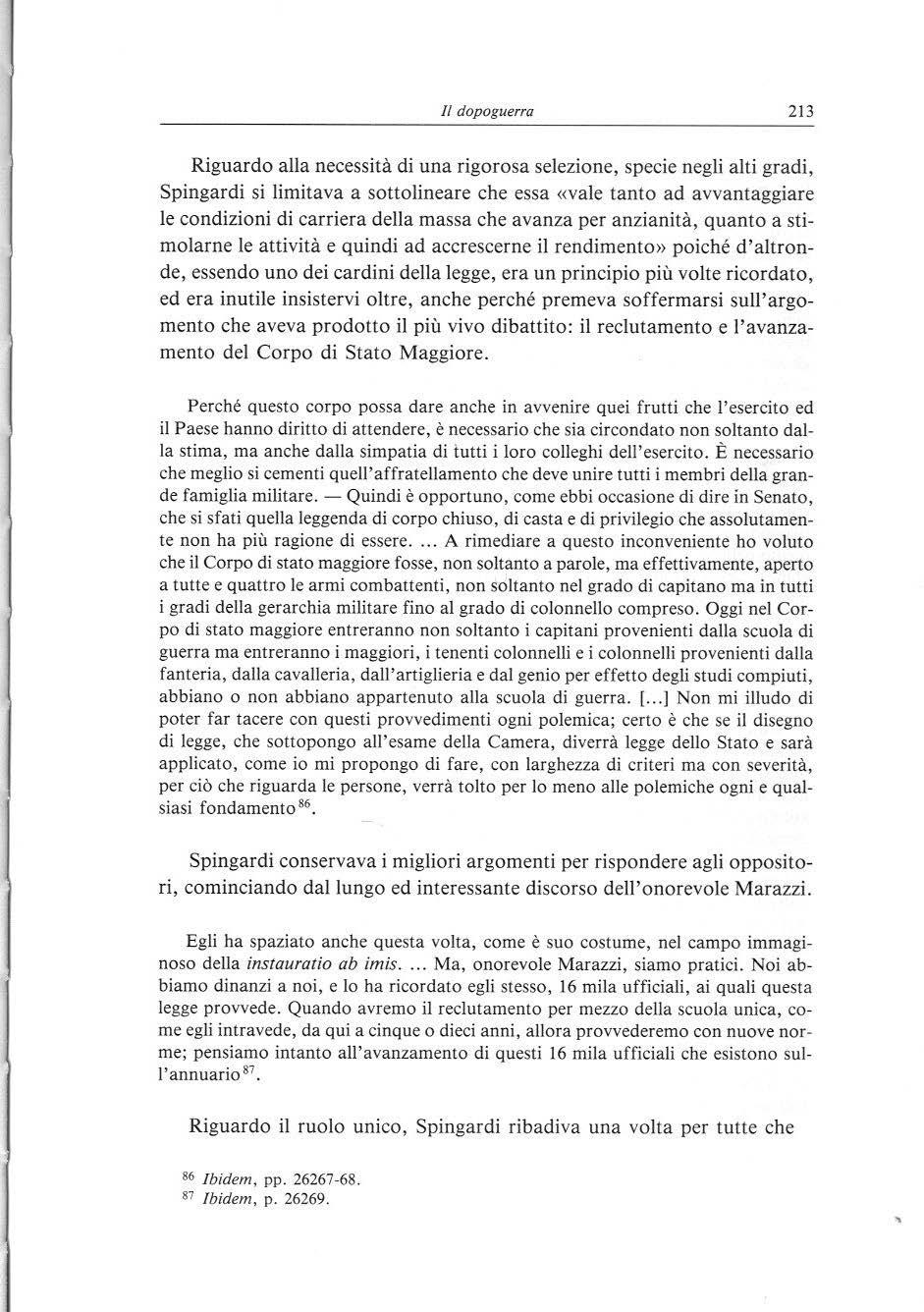
Egli ha spaziato anche questa vo lta , come è suo costume, nel campo immaginoso della instauratio ab imis ... Ma, onorevole Marazzi, siamo pratic i. Noi abbiamo dinanzi a noi, e lo ha ricordato eg li stesso, 16 mila ufficiali, ai quali que sta legge provvede. Quando avremo il reclutamento per mezzo deUa scuola unica, come egli intravede, da qui a cinque o dieci anni, allora provvederemo con nuove norme; pensiamo intanto all'avanzamento di q uesti 16 mila ufficiali che esistono sull'annuario 87
Riguardo il ruolo unico, Spingardi ribadiva una volta per tutte che
86 Ibidem , pp 26267 -68
87 Ibidem, p. 26269.
Il dopoguerra 213
il ruolo unico non è mai stato il mio figlio prediletto. Dinanzi all'altro ramo del Parlamento, quando un ordine del giorno mi fece obbligo di introdurre nella legge di avanzamen to il ruolo unico, io non esitai a dichiarare che, in massima, non ero favorevole, che lo accettavo come una condizione sine qua non perché fossero votate le leggi di ordinamento che stavano dinanzi a l Parlamento, ma che mi riservavo di stud iare la misura, il tempo e le modalità di applicazione. - Era un im pegno che avevo assunto e, da sol dato, l'ho mantenuto Ho studiato, lungamente st udiato, quale applicazione avrebbe potuto avere da noi il ruolo unico e l'ho studiato presso il so lo esercito dove esiste, l'e sercito germanico, che è ancora modello a tutti gli altri eserciti, ed ho dovuto convincermi che è un sistema che forse in quel paese può funzionare, ma non certamente da noi e, in ogni modo, è un sistema complica to oltre misura 88 •
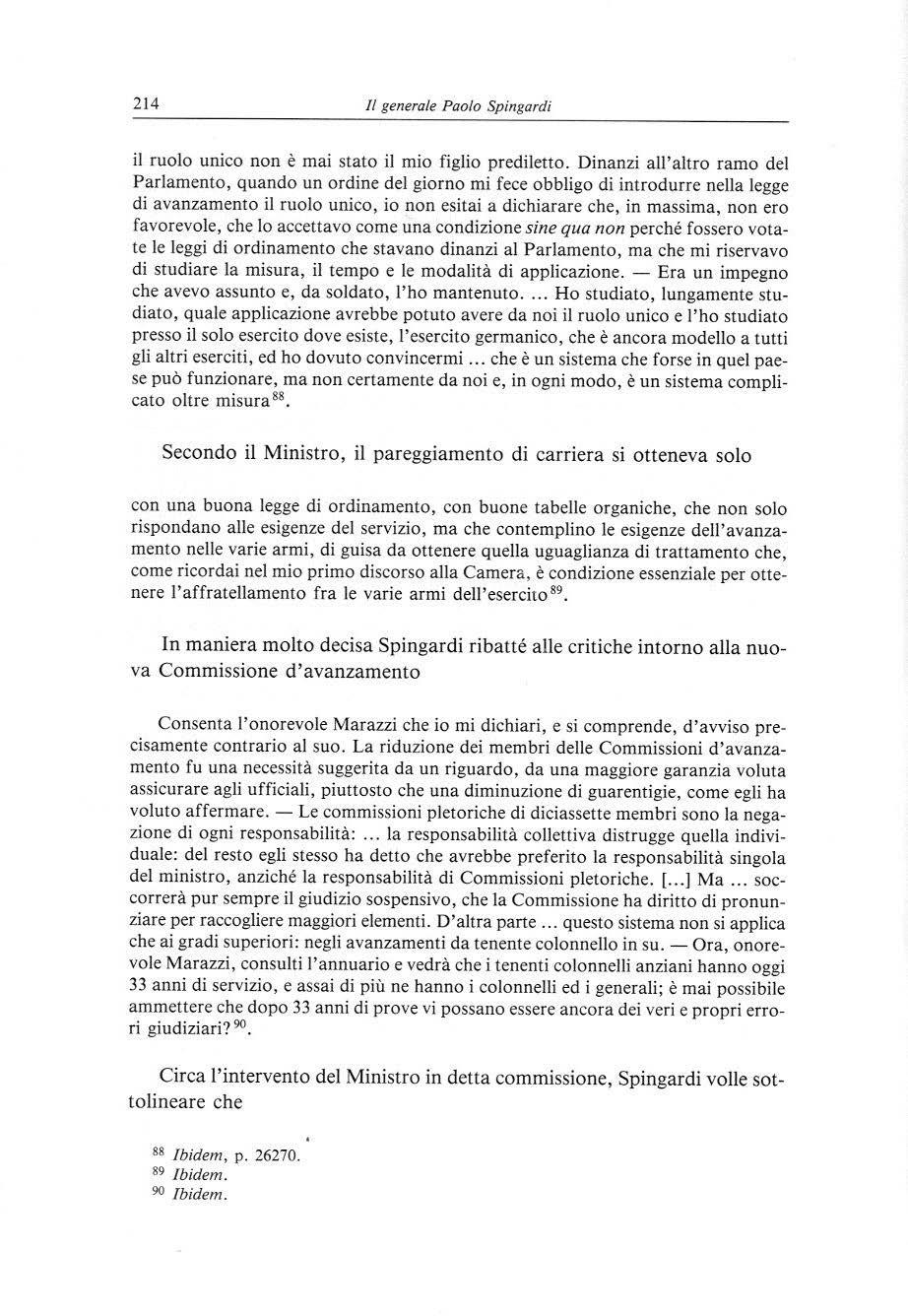
Secondo il Ministro, il pareggiamento di carriera si otteneva solo
con una buona legge di ordinamento, con buone tabelle organiche, che non solo rispondano alle esigenze del servizio , ma che contemplino le esigenze dell'avanzamento nelle varie armi, di guisa da ottenere quella uguaglianza di trattamento che, come ricordai nel mio primo discorso alla Camera, è condizione essenziale per ottenere l 'affratellamento fra le varie armi dell'esercito 89 •
In maniera molto decisa Spingardi ribatté alle critiche intorno alla nuova Commissione d'avanzamento
Consenta l'onorevole Marazzi che io mi dichiari, e si comprende, d'avviso precisamente contrar io al s uo. La riduzione dei membri delle Commissioni d'avanzamento fu una necessità suggerita da un riguardo, da una maggiore garanzia vol u ta assicurare agli ufficiali, piuttosto che una diminuzione di guarentigie, come egli ha voluto affermare. - Le commissioni pletoriche di diciassette membri sono la negazione di og ni responsabilità: . .. la responsabi li tà collettiva distrugge quella individuale: del resto egli ste sso ha detto che avrebbe preferito la responsabilità singola del ministro, anziché la responsabilità di Commissioni pletoriche. [... ] Ma ... soccorrerà pur semp re il giu di zio sospensivo, che la Commiss ione ha diritto di pronunziare per raccogliere maggiori elementi. D'altra p arte ... questo sistema non si applica che ai gradi superio ri: negli avanzament i da tenente colonnello in su. - Ora, onorevole Marazzi, consulti l'annuario e ve drà che i tenenti co lon nelli anziani hanno oggi 33 anni di servizio, e assai di più ne hanno i colonne lli ed i generali; è mai possibile ammettere che dopo 33 anni di prove vi possano essere ancora dei veri e propri errori giu d iziari? 90 •
214
li generale Paolo Spingardi
Circa l'intervento del Ministro in detta commissione, Spingardi volle sottolineare che 88 Ibidem, p 26270. 89 Ibidem. 90 Ibidem.
Il min istro è giornalmente, si può dire, a contatto con tutti i comandanti di corpo d'armata; li segue in tutte le loro azioni di governo disciplinare, di governo amministrativo, di governo d' istruzione delle truppe, e quindi è naturale, è ovvio che possa portare in seno a questa Commissione degli element i, su cui la Comm issione stessa baserà in parte il parere richiestole dal ministro. Ma poi, alla designazione a que ste altissime car ich e, non deve mantenersi estraneo il Governo, che ne ha la responsab ili tà di fronte al Paese. Non è azio n e politica, ma è azione di responsabilità, vera e propria, di Governo. - Queste nomine sono sottoposte all'approvazione del Consiglio dei ministri ed è perciò natura le che il ministro, che interviene al Consiglio, possa prospettare ai colleg hi quello che, a favore o contro questi ufficiali generali, è stato detto dalla Commissione dei cinque 91 •
Passava indi a Di Saluzzo contestando le critiche mosse al ruolo aperto .
Francamente - op in ava Spingardi - con le argomentazioni delle fi n est r e e delle finestrine, che egli ha prospettato alla Camera, non sono r i uscito a convincermi come si possa in coscienza affermare che, con i provvedimenti contenuti in questo disegno di legge noi non siamo di fronte veramente ad un corpo aperto .. .. Non si può entrare nel corpo di stato maggiore senza aver fatto la scuo la di guerra, ma [alla scuola] sono ammessi tutti i provenienti dalle anni combattenti, quindi i capitani, come di fatto già è, provengono dalle varie armi: fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Andando più in su, al grado di maggiore, gli ufficiali di stato maggioreprovengono dai capitani di stato maggiore promossi maggior i, che abbiano fatto il prescritto se r vizio di due anni nell'arma di provenienza, o dai maggiori delle quatt r o armi combattenti, i quali siano stati giudicati idonei e meritevoli di ottenere la destinazione al co rpo di stato maggiore - Ma non mi arresto qui, e ho detto che anche i t enent i colonnelli possono provenire dalle armi com ba ttent i , e un corpo più aperto di così non lo so propr io pensare 92 •
Di Saluzzo interruppe lamentando la mancanza di controllo sulle promozioni degli ufficiali di stato maggiore. Spingardi rispose che il controllo era dato alle
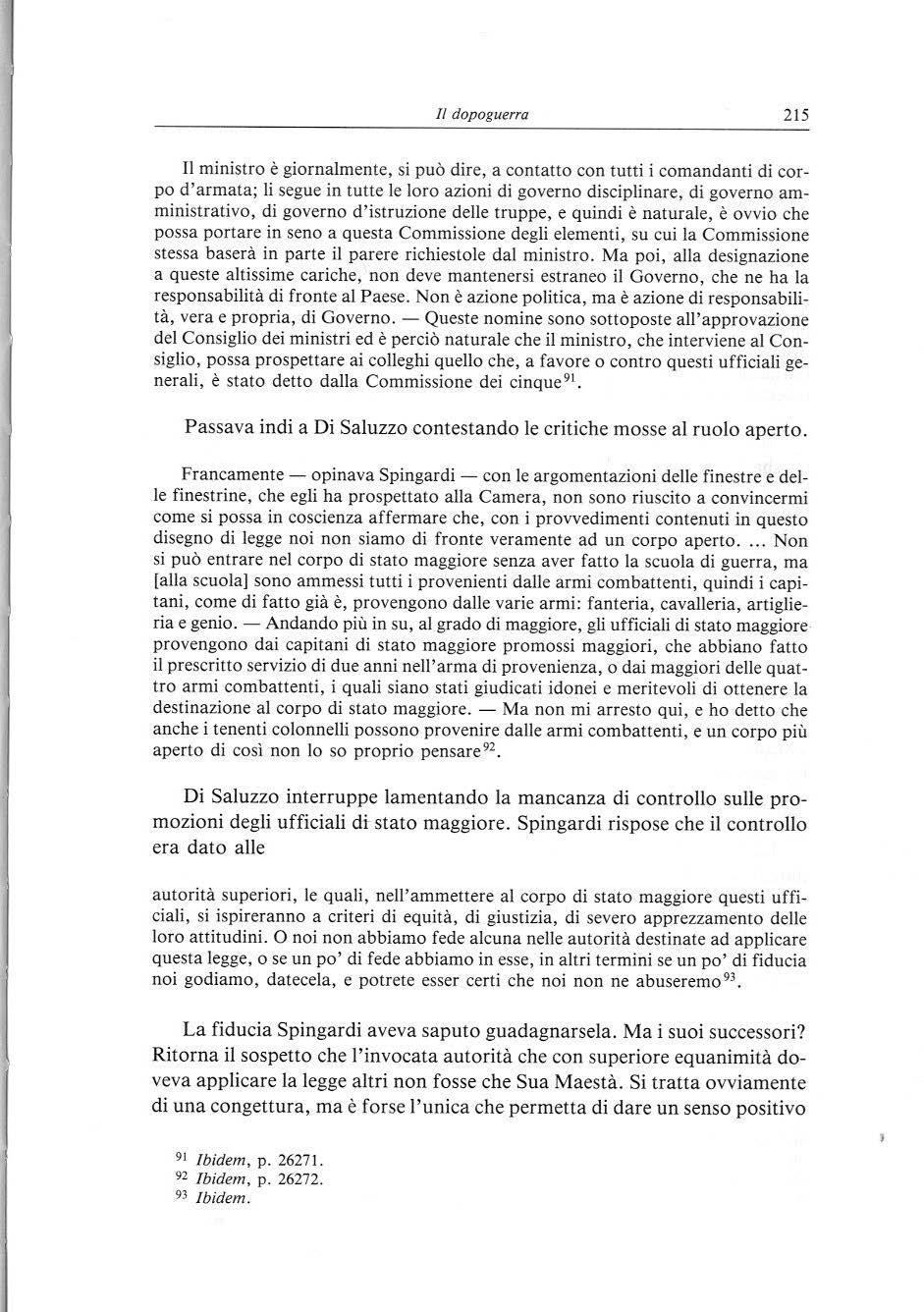
autorità superio ri , le q u ali, nell'ammettere al corpo di stato maggiore q u esti ufficiali, si ispireranno a criteri di equità, di gius t iz ia , di severo apprezzamento delle loro attitudini. O noi non abbiamo fede alcuna nelle autorità destinate ad applicare q uesta legge, o se un po' di fede ab b iamo in esse, in altr i termini se un po' di fiducia noi god iamo , datecela, e potrete esser cert i che noi non ne abuseremo 93 •
La fi ducia Spingardi aveva saputo guadagnarsela . Ma i suoi successori? Ritorna il sospetto che l'invocata autorità che con superiore equanimità doveva applicare la legge altri non fosse che Sua Maestà. Si tratta ovviamente di una congettura, ma è forse l'unica che permetta di dare un senso positivo
li dopoguerra 215
9 1 Ibidem, p. 2627 1. 9 2 Ibidem, p. 26272. 9 3 Ibidem.
alla legge, che altrimenti avrebbe potuto rimanere qual era, dato anche che il regolamento era relativamente recente, risalendo al 1907 94 • Poche parole il Ministro riservava per l'onorevole Eugenio Chiesa:
L'articolo 16 stabil isce le modalità di avanzamento e delle votazioni della Commissione; ora egli domanda perché si richiedono i due terzi dei vota nti, aggiungendo che così la maggioranza e la minoranza non hanno più ragione di essere . - Ve da, onorevole Chiesa, per ascendere agli alti gradi non basta sgattaiolare via per il buco della serratura, vale a dire con cinque vot i favorevoli e cinque contrari; bisogna che l'ufficial e si affermi in modo deciso, talché il suo avanzamento sia votato a grand e maggioranza della totalità dei membri della Commissione 95 •
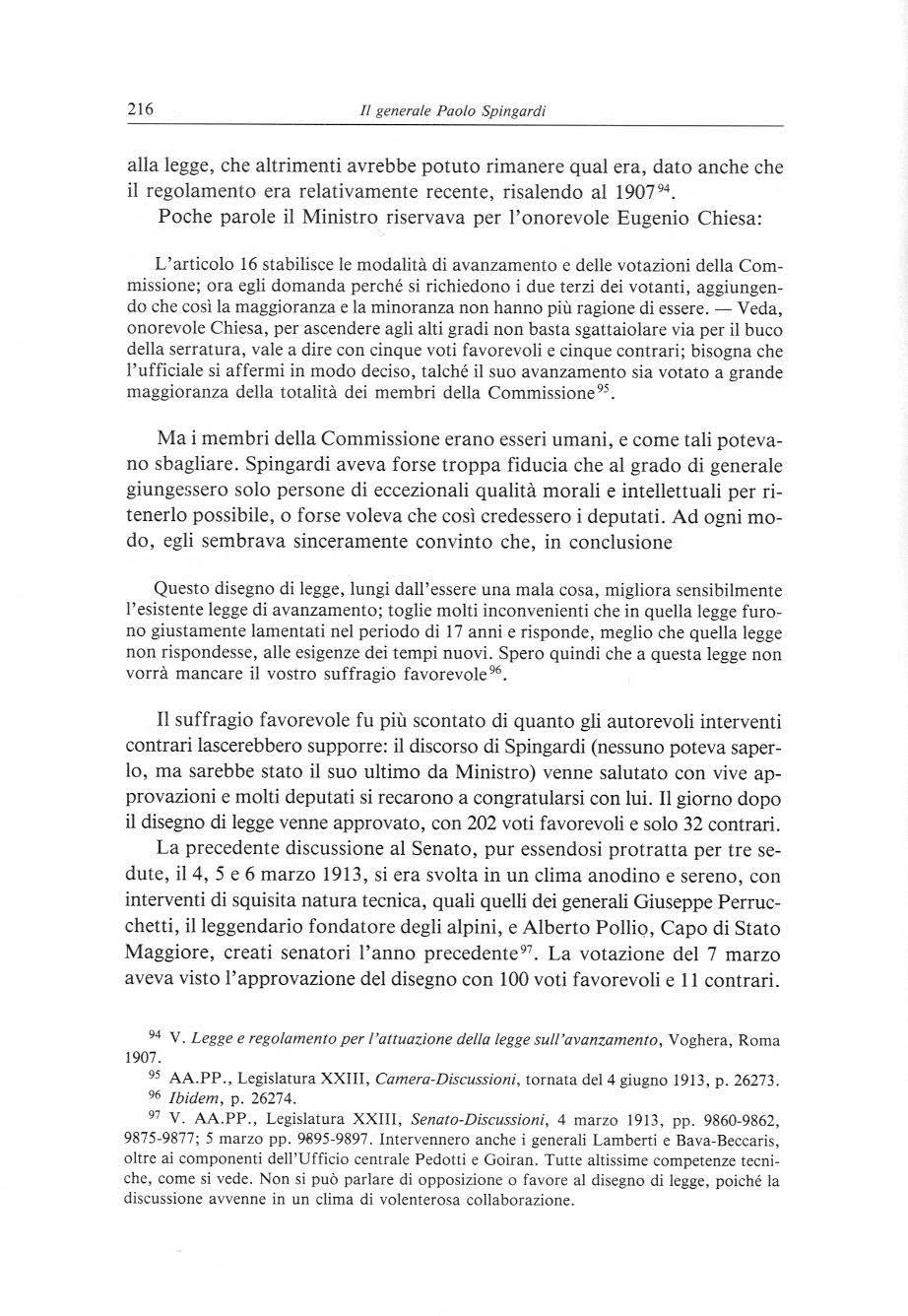
Ma i membri della Commissione erano esseri umani, e come tali potevano sbagliare . Spingardi aveva forse troppa fiducia che al grado di generale giungessero solo persone di eccezionali qualità morali e intellettuali per ritenerlo possibile, o forse voleva che così credessero i deputati. Ad ogni modo, egli sembra va sinceramente convinto che, in conclusione
Questo disegno di legge, lungi dall'essere una mala cosa, migliora sensibilmente l'esistente legge di avanzamento; toglie molti inconven ient i che in quella legge furono giustamente lam entati nel periodo di 17 anni e risponde, meglio che quella legge non rispondesse, alle esigenze dei tempi nuovi. Spero quindi che a questa legge non vorrà mancare il vostro suffragfo favorevole 96 •
Il suffragio favorevole fu più scontato di quanto gli autorevoli interventi contrari lascerebbero supporre: il discorso di Spingardi (nessuno poteva saperlo, ma sarebbe stato il suo ultimo da Ministro) venne salutato con vive approvazioni e molti deputati si recarono a congratularsi con lui. Il giorno dopo il disegno di legge venne approvato, con 202 voti favorevoli e solo 32 contrari.
La precedente discussione al Senato, pur essendosi protratta per t re sedute, il 4, 5 e 6 marzo 1913, si e ra svolta in un clima anodino e sereno, con interventi di squ isita natura tecnica, quali quelli dei generali Giuseppe Perrucchetti, il leggendario fondatore degli alpini, e Alberto Polliq, Capo di Stato Maggiore, creati senatori l'anno precedente 97 • La votazione del 7 marzo aveva visto l'ap provazione del disegno con 100 voti favorevoli e 11 contrari.
94 V. Legge e regolamen to per l'attuazione della legge sull'avanzamenro, Voghera, Roma 1907.
95 AA.PP ., Legislatura XXIII, Camera-Discussioni, tornata del 4 giugno 1913, p. 26273.
96 ibidem, p 26274.
97 V. AA.PP ., Legislatura XXIII, Senato-Discussioni, 4 marzo 1913, pp. 9860-9862, 9875 -9877; 5 marzo pp. 9895-9897. Intervennero anche i generali Lamberti e Bava-Beccaris, oltre ai componenti dell'Ufficio centra le Pedotti e Goiran. Tutte altissime competenze tecniche, come si vede. Non si può parlare di opposizione o favore al disegno di legge, poiché la discussione avvenne in un clima di volenterosa co ll aborazione.
216
li generale Paolo Spingardi
Il disegno divenne la legge 8 giugno 1913, n. 60 I, oltre tre anni dopo la presentazione del primitivo progetto. La sua applicazione cominciò solo alla fine dell'ottobre successivo, quando entrò in vigore il R.D. in data 3 settembre 1913, n. 1199, che conteneva le norme per la prima applicazione della legge 98 • In esso apparve evidente «lo studio postovi per evitare errori o apprezzamenti non obbiettivi nell'applicazione della legge. Del resto, quand'anche esistessero anomali e , le disposizioni in esame rivestono carattere transitorio, sino all'adozione del Regolamento ancora allo stud io » 99 • Ma del nuovo regolamento nessuna traccia Diciannove mesi più tardi l' Ita li a sa r ebbe entrata in guerra contro l'Austria . Come le leggi sul reclutamento, anche le leggi di avanzamento fanno sentire il loro effetto solo nel lungo periodo. Le norme di questa legge, pensata per una situazione di pace, non poterono quindi virtualmente mai essere applicate . Ne fu testimonianza indiretta il fatto che, nella deposizione resa aJla Commissione d'Inchiesta su Caporetto, rievocando i provvedimenti da lui attuati per migliorare i quadri, Spingardi non facesse il minimo cenno alla legge sull'avanzamento, ma si limitasse a illustrare gli sforzi fatti per aumentarne il numero piuttosto che quelli per migliorarne la qualità 100 • Sicuramente Spingardi sperava in un rapido iter nel 1910 e non avrebbe perseguito con tanta determinazione l'approvazione del disegno, se avesse sospettato di non poterlo mai applicare di fatto: l'orientamento era per la pace e in quest'ottica la legge venne pensata.
L'intervento nella grande guerra rende perciò imp ossibile una valutazione dei risu ltati concreti che la legge avrebbe potuto ottenere sul corpo ufficiali dell'esercito italiano, che entrò in guerra formato sulla legge del 1896, quando non addi(ittura sulla precedente legge piemontese del 1853, e cioè composto da quegli stessi ufficiali dei qual i Spingardi aveva fatto una rivista assai poco lusinghiera a Brusat i nel novembre 1911 101 •
98 Il decreto venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Re gno il 23 ottobre I913, e perciò si considerava entrato in vigore solo a partire da quel giorno. V. Giornale Militare Ufficiale 1913, circolare n. 438, p 1245.
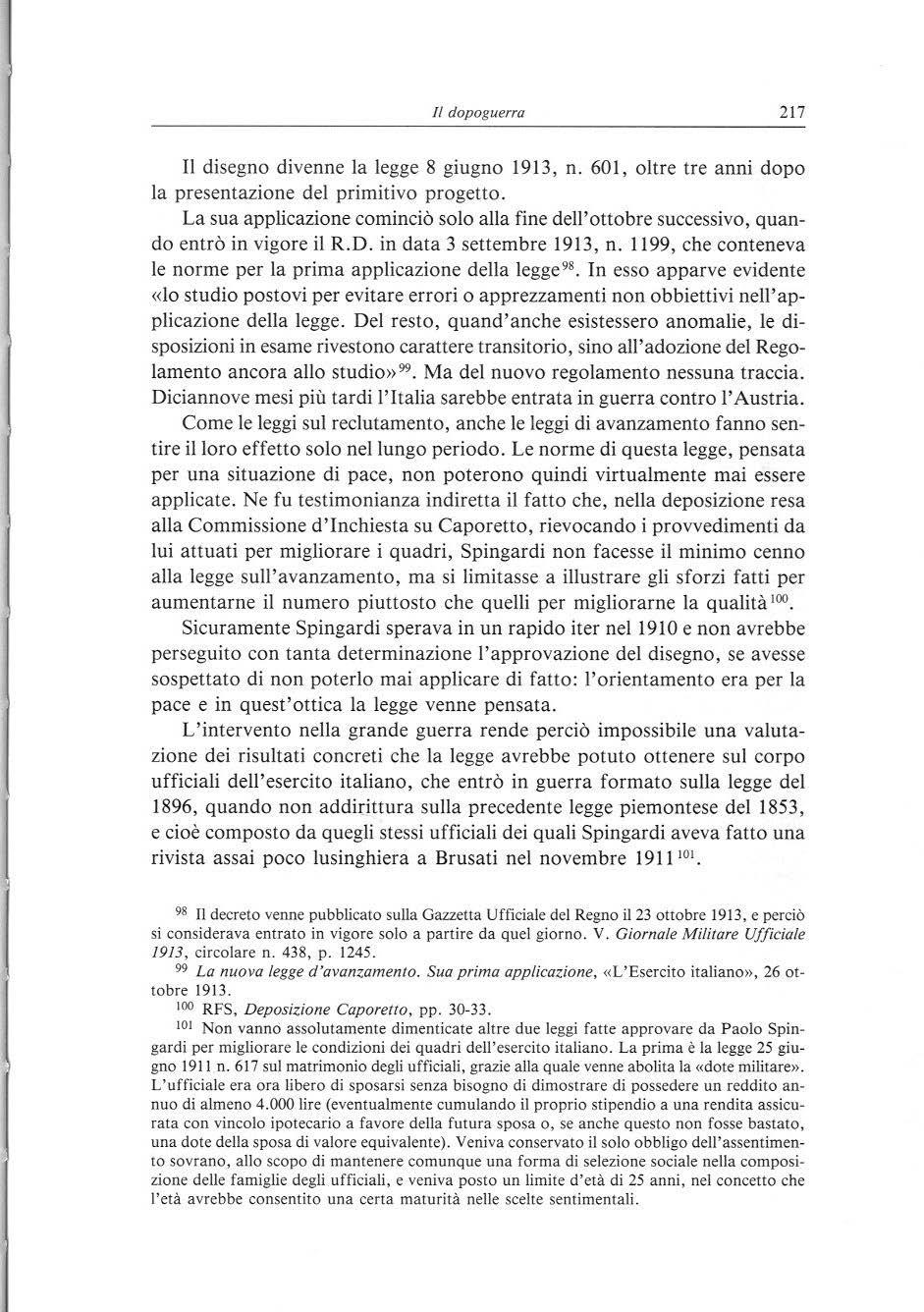
99 La nuova legge d'avanzamento. Sua prima applicazione, «L ' Eserci to italiano » , 26 ottobre 1913.
100 RFS, Deposizione Caporetto, pp 30-33.
101 Non vanno asso lutamente dimenticate altre due leggi fatte approvare da Paolo Spingardi per migliorare le condizioni dei quadri dell' eserci to italiano. La prima è la legge 25 giugno 191 1 n. 617 sul matrimonio degli ufficiali, grazie alla quale venne abolita la «dote militare» . L'ufficia le era ora libero di sposarsi senza bisogno di dimostrare di possedere un reddito annuo di almeno 4.000 lire (eventualmente cumulando il proprio stipendio a una rendita assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa o, se anche questo non fosse bastato, una dote della sposa di valore equivalente) Veniva conser vato il so lo obbligo dell'assentimenro sovrano, a ll o scopo di mantenere comunque una forma di selezione sociale nella composizione delle famiglie degli ufficiali, e veniva posto un limite d'età di 25 anni, nel concetto che l'e tà avrebbe consentito una certa maturità nelle scelte se ntimentali .
Il dopoguerra 217
Spingardi
5. Artiglieria
La guerra di Libia permise il collaudo sul campo del cannone Krupp mod. I 906 che rispose «in tutto e per tutto ottimamente » 102 , rassicurando le autorità che almeno questa parte della questione dell'artiglieria da campagna era definitivamente e positivamente risolta . R estavano da rinnovare le ultime 93 batterie. La guerra non indusse alcun ritardo negli esperimenti che si stavano conducendo per stabilire il miglior modello da adottare. Le prove e controprove sui vari materiali procedettero su batterie a quattro pezzi fino al 26 gennaio 1912 103 •
Finalment e la Commi ssione degli Uffic iali Generali d'Artiglieria addetti all' I spettorato dell'Arma, riunitasi il 15 febbraio I 912, dichiarò all'unanimità che il materiale Dèport si differenziava dagli altri in modo tale « da offrir e vantaggi che con gli altri non si possono attendere» 104 •
Spingardi ne fu molt o soddisfatto giudicando che
Poljticamente è un bel fatto, perché la commessa del materiale Dèpor t, il cui brevetto è stato acquistato dalle metallurgiche piemontesi, interessa tutta l'industria metallurgica it a liana , compresa la Tempini bresciana, la Yick ers-Terni coll'Orlando e la Pozzuoli-Armstrong; militarmente ... non so 105 •
Nel frattempo infatti la Società italiana Vickers-Terni e la società delle Acciaierie di Terni avevano presentato un elenco di 27 società che riunendo quarantamila operai offrivano di fabbricare in Italia il materiale Dèpo rt 106 •
L'altra legge, in data 18 luglio 1912, n. 806, sostituiva la vecchia legge piemontese sullo stato degli ufficiali, che r isaliva a l 1852 ed era rimasta in vigo re, inalterata, fino a quel momento, malgrado c inque diversi progetti presentati tra il 1883 e il 1909 (V. DE CHAURANO, p. 245 e AA.PP. , Legislatura XXIII, Sena/o-Documenti, n. I, p. I). La nuova legge rimaneggiò le disposizioni relative ai consigli di disciplina, in modo da tutelare maggiormente i diritti dell'inquisito, che poteva ora, tra l'altro, scegliersi un difensore tra i colleghi ufficiali, faco l tà prima negatagli.
102 ll colfaudo prat ico del materiale Krupp 1906, «L'Esercito italiano>), 25 settembre 19 l 2. Sulla questione giudizio positivo anche in MONTO, cit., voi. VII, p. 1356.
103 Ma1eriale da 75 modelfo /911 Dèport, doc. cit., p. 4.
104 Ibidem.
105 ACS, Archivio Brusali, se. 10, f. Vl.4.36. Spingardi a Brusati, 15 febbraio 1912. Spingard i non era un tecnico d'arti gl ieria. L'ultima frase è una sincera affermazione di impossibilità ad esprimere un'op inione. D 'a ltronde, la bontà del materiale Dèport era ormai ampiam eme dimostrata. Ad ogni modo è perlomeno singolare che le industrie italiane avessero acquistat_o i diritti sul materiale Dèport prima ancora che le autorità tecniche avessero espresso un giudizio definitivo. Non ci sono prove per dire che le industrie abbiano innuenzato i tecnici perché sceg liessero il loro cannone. Ma se anche cosl fosse, bisogna dire che le indu st ri e si rivelarono più l ungimiranti dei militari, daLO che il Dèport era indubbiamente il miglior pezzo da campagna dell'epoca, e lo avreboe ampiamente dimostrato durante la Prima Guerra Mondiale.
106 Ma1eriale da 75, p. 4. V. anche Relazione Ufficiale, p. 39; DE CHAuRANo , p. I 12; WHrr TAM, p. 245; P. FERRAR!, La produzione di armamenli nelf'elò giolittiana, in «Italia comemporanea», n. 162, marzo 1986, p. 131.
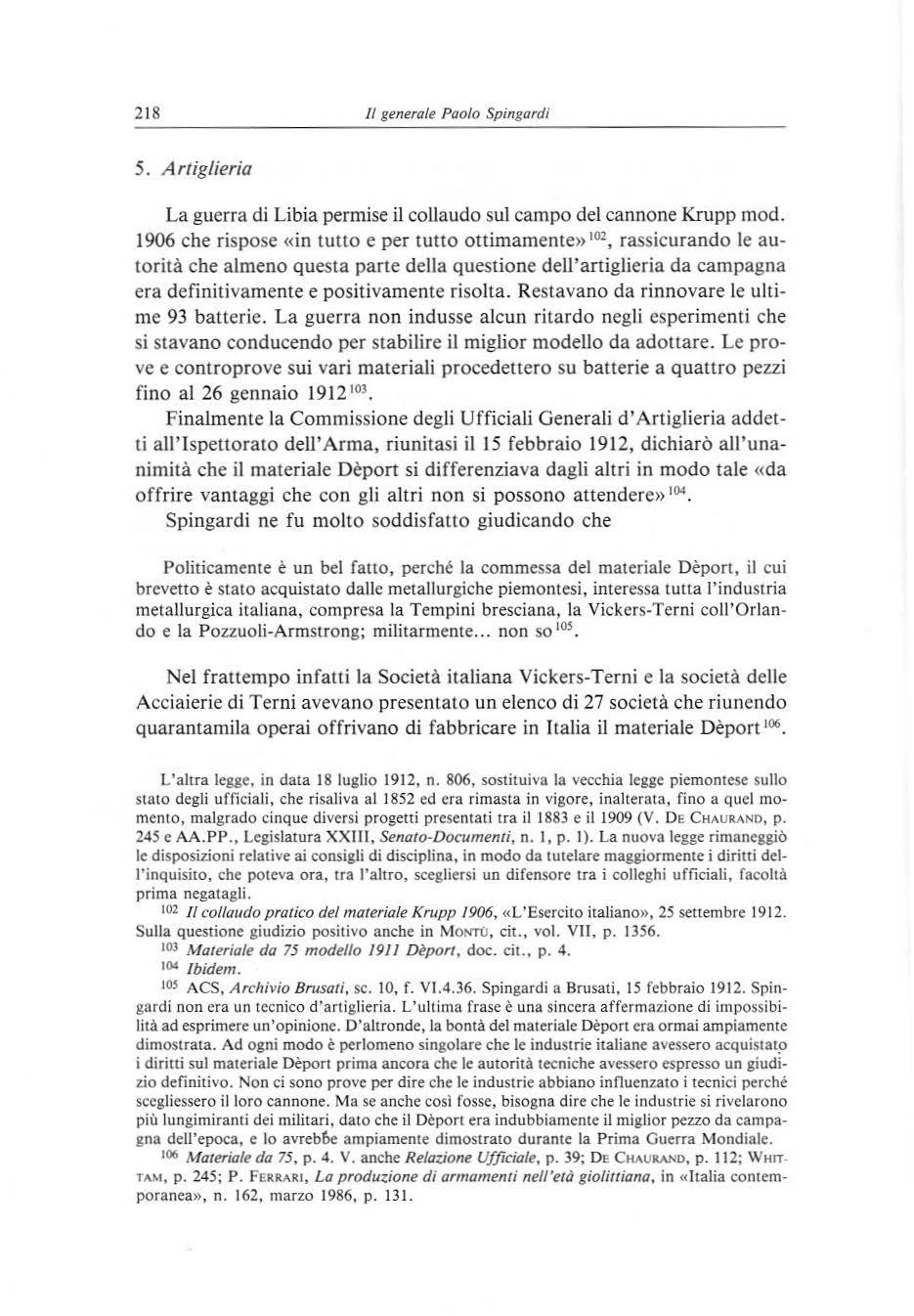
218
Il generale Paolo
L a Vickers e la società delle Acciaier ie di Terni si dichiararono addirittura pronte ad assumersi per tutte le altre ditte l'impegno di fornire le batterie occorrenti, iniziandone la consegna in un termine massimo di 23 mesi a partire dal giorno della firma della commessa . In realtà la dicitura era piuttosto contorta, di modo che i militari si illusero che la consegna potesse avvenire nel termine di quindici mesi 107 • Spingardi volle informazioni precise e inviò perciò un tecnico di sua fiducia, il generale Pompeo Grillo ios, a visitare gli stabilimenti interessati << per accertarne la capacità tecnica, la potenzialità di produzione» 109 : Grillo arrivò alla conclusione che il materiale sarebbe stato ult imato entro diciotto mesi dalla data di ord in azione 110 • Dopo aver consultato i vari Ispettori per assicurarsi che la scelta fosse davvero la miglior e dal punto di vista milita r e, Spingardi d ec ise di accordarsi per la fabbricazione del materiale Dèport . I niziate le t ratta t iv e con il consorzio di ditte italiane, il 29 marzo 1912 uno schema di contratto venne sottoposto al Consig lio dei Ministri, che autorizzò il Ministero della Guerra a procedere. Il 31 marzo 1912 si dava la relativa commessa al presidente della Vickers -Terni, ingegner Giuse ppe Orlando.
107 A Spingard i venne ass icurato testualmente che ((La Società Vikers [sic] Temi e la Società delle Acciaierie di Terni erano eventualmente pronte ad assumere per tu t te l'impegno di fornire le batterie c he occorrono, inizia ndo ne la consegna a partire dalla fine dell'ottavo mese da l dì che l'offerta loro sarebbe stata accettata, nel termine di 15 mesi», RFS, Quattro fogli dattiloscritti, n.n. , con firma autografa di Spingardi, su carta intestata Ministero della Guerra, Roma, addì 29 marzo 1912. Il contenuto dimostra che si tratta della relazione fatta al Consiglio dei Ministri per ottenere il benestare alla stipu la del contratto. Ora appare evidente che il brano citato si presta facilmente a due inter pretazion i : può voler dire che le ditte avrebbero consegnato i materiali in 15 mesi, oppure in 15+8 mesi. Se s i tien conto che le dit te vollero si stabilisse nel contratto come data di decorrenza il 30 apri le 1912, e si aggiungono 23 mes i, si arriva al marzo 1914, cioè l'e poca effettiva in cui le batterie com inciar ono ad essere consegnat e. Se poi si aggiunge che nessun procedimento legale fu in trapreso, né alcuna sanzione amministrativa fu comminata per la supposta inadempienza, mi sembra effett ivamente questa l'interp retazione corretta.
IOS Pompeo Grillo nacque a Pinerolo nel 1843 . Uscì sottotenente di artiglieria dall'Accademia mili tare di Torino nel 1862. Fece la campagna del 1866 col gr ado di tenente. Raggiunto il grado di colonnello nel 1893, venne nominato Direttore delle fonderie militari di Torino. Dal 1897 a l 1900 comandò il 6 ° Reggimento artig lieria da campagna Promosso maggior generale nel 1900 venne nomina to re Direttore s uperiore delle esperienze di artiglieria e due anni dopo Ispettore delle costruzioni d ' artiglieria , incarico che tenne fino al 1905 allorché , raggiunti i limiti di età, venne collocato in Posizione Ausiliaria, raggiungendo nel 1909, nel la riserva, il grado di tenente generale. Morì a Roma nel 1922.
109 Deposizione Caporetto, p. 38.
J IO Materiale da 75, p. 5. Anche su questo punto non si sono reper ite docu men tazioni che consentano di dire se vi furono pressioni su Grillo o se egli sempl icemente si sbagliasse. È anche vero che le espressioni linguistiche permettono interpretazioni diverse. <<i l materia le ultimato» richiedeva comunque poi altro tempo per essere consegnato ai corpi. Biso gna poi vedere se si riferissero solo ai cannoni o anche alle munizioni e a i carreggi. Ma se così fosse la questione assumerebbe un colorito ugualmente preoccu pante, dato che si tra ttava di munizioni e carreggio perfettamente identici a quelli già costru iti per il Krupp / 906.

Il dopoguerra 219
Le ditte interessate avvertirono il Ministero che agli effetti della consegna stabilita per la fornitura di 80 batterie l'ordinazione sarebbe decorsa dal 30 aprile 1912 111 •
Ma i disegni completi di costruzione delle singole parti richiesero ben nove mesi al colonnello Dèport, unica persona in grado di redigerli 112 • Perciò le ditte ricevettero «tutti i disegni completi colle relative tolleranze di fabbricazione» solamente nei mesi di novembre e dicembre 19 12 e quindi iniziarono le prime lavorazioni so lo nel febbraio 1913 113 •
Spingardi seguì con scrupo losità l'andam ento dei lavori: «Dal giorno della commessa l'opera del Ministro fu costantemente rivolta alla osservanza dei patti contrattuali da parte delle Società collegate, opera vigile, attiva, insistentemente attiva» 114 • II 29 gennaio 1913, alla vigilia dell'inizio delle lavorazioni, egli sollecitò tanto l'Ispettorato d'Artiglieria che controllava l'andamento dei lavori, quanto direttamente le ditte per ottenerne l'assicurazione che tutto procedesse «a seconda delle raccomandazioni più volte espresse» 11 5 •
Chiamò poi ancora il gen. Grillo, e gli affidò la sorveglianza delle ditte.
Grillo, il 3 marzo 1913, inviò al Ministro un interessante promemoria sulla fabbricazione dei cannoni, che costituisce, pur nelle valutazion i complessivamente positive, una testimonianza delle d ifficoltà che ponevano le lavorazioni, spezzettate e suddivise tra un numero grandissimo di stabi limenti e ditte responsabili.
Tanto per cominciare l'acciaio occorrente ve ni va fornito «per 3/4 circa, dalle Acciaierie di Terni, sotto forma di tubi, manicotti e masselli per otturatori, alla Società Vickers -T ern i di Spezia», la quale ne eseguiva poi la lavorazione e il montaggio .
L'altro quarto è fornito dalla casa Armstrong d i Pozzuoli, che ne fa essa stessa la lavorazione e il montaggio. Una parte degli elementi forniti dalle Acciaierie di Terni e dalla Ditta Armstrong, 1/10 circa, cioè uno per colata, viene lavorato e montato ali' Arsenale di Napoli.
Le bocche da fuoco risultavano così costruite in tre stabilimenti differenti . Per evitare gli inconvenienti che potevano derivarne, «collo studio di apposite sagome e strumenti di collaudazione fabbricati in un solo stabilimento>> si fece in modo che ogni parte potesse essere uguale. Ovviamente
Il i Materiale da 75, doc. cit , pp. 6-7.
112 V. Relazione Ufficiale, cit. , p. 89 e no ta 81 a p. 179.
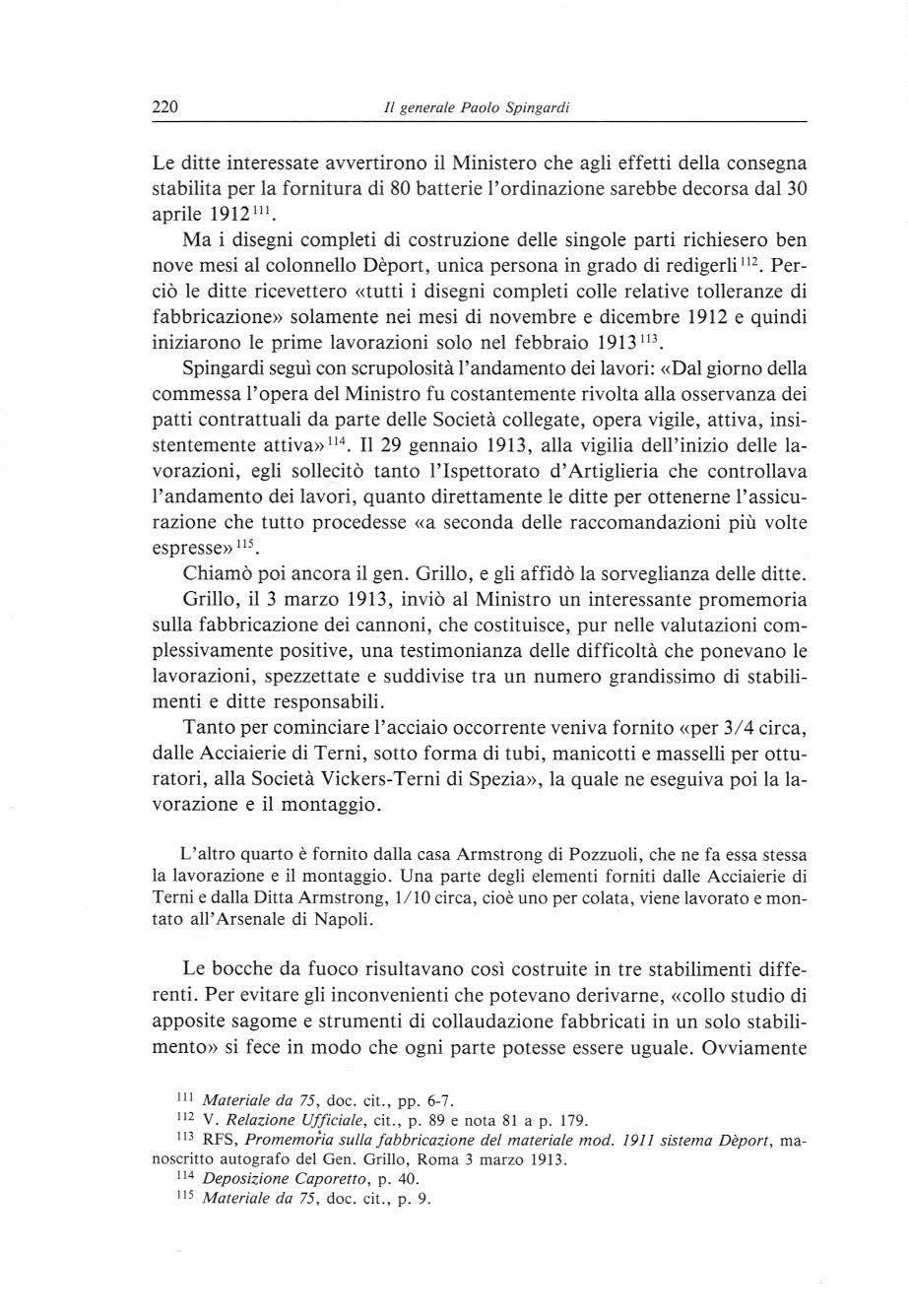
11 3 R FS, Promemoria sulla fabbricazione del materiale mod. 1911 sistema Dèport, manoscritto autografo del Gen. G r illo, Roma 3 marzo 1913.
114 Deposizione Caporetto, p 40.
11s Ma1eriale da 75, doc. cit., p. 9.
220 lf
generale Paolo Spingardi
Sul principio si ebbe qualche ritardo per rifiuto di elementi non perfettamente omogenei, ma in oggi la lavorazione procede bene e per la fine dell'anno [gli elementi ] saranno pressoché tutti ultimati. Due cannoni della Società Vickers- Terni ed uno della Ditta Armstrong, scelti nella lavorazione corrente, verranno sottoposti alla prova di 2.000 colpi. Si spera di poter eseguire tale prova nel venturo mese d i maggio.
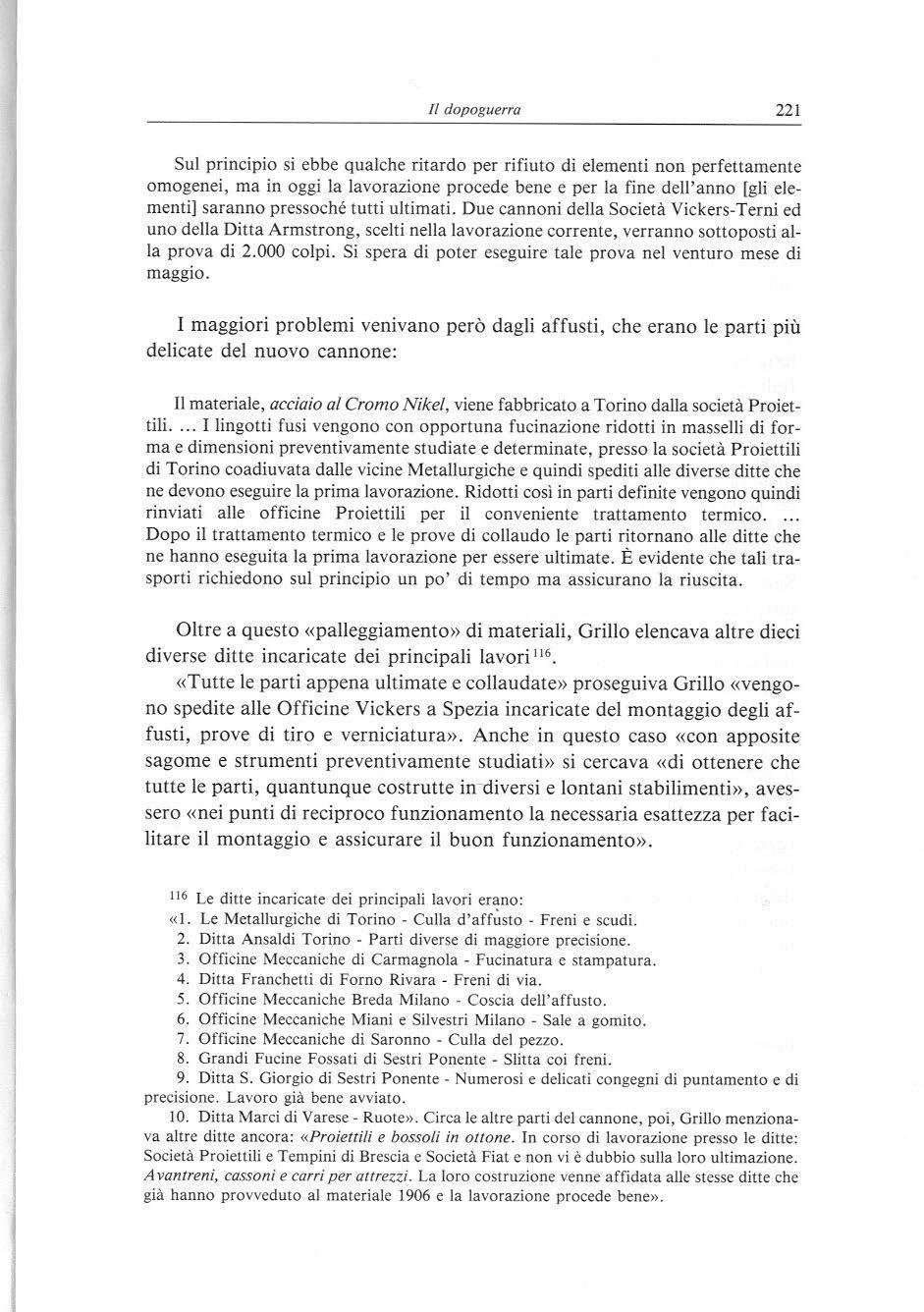
I maggiori problemi venivano però dag li affusti, che erano le parti più de licate del nuovo cannone :
Il ma t eriale, acciaio al Cromo Nikel, viene fabbricato a Torino dalla società Proiettili . ... I l ingott i fusi vengono con opportuna fucinazione ridotti in masselli di forma e dimens io ni preven t ivamente stud iate e determinate, presso la soc ietà Proiettili di Torino coadiuvata dalle vicine Metall urgiche e quindi spediti a ll e diverse ditte che ne devono eseguire la prima lavorazione . Ridotti così in parti definite vengono qui ndi rinviati a ll e offici ne Proiettili per il conven iente trattamento termico. Dopo il trattamento termico e le prove di collaudo le parti ritornano alle ditte che ne hanno eseguita la prima lavorazione per essere ultimate. È evidente che tali trasporti r ichiedono sul principio un po' di tempo ma assicurano la riuscita.
Oltre a questo «pa ll eggiamento» di mate r iali, Grillo elencava altre dieci diverse d itte incaricate dei principal i lavori 116 • «Tutte le parti appena ultimate e collaudate» proseguiva Grillo «vengono spedite alle Officine Vickers a Spezia incaricate del montaggio degli affusti, prove di tiro e verniciatura». Anche in questo caso «con apposite sag o me e st rumenti preventivamente studiati» si cercava «di ottenere che tutte le parti, quan t unq ue costrutte in-diversi e lon t ani stabilimenti», avessero <<nei punti d i r eciproco fun zi onamento la necessaria esattezza per facilitare il montaggio e assicurare il buon fun z io nam e nto».
116 Le d itte incaricate dei principa li lavor i erano:
«I . Le Met allurgiche d i T orino - Culla d'aff~sto - Freni e scudi .
2. Ditta Ansaldi Torino - Parti diverse di maggiore precisione.
3. Officine Meccaniche di Carmagnola - Fucinatura e stampatura
4. Ditta Fraochetti di Forno Rivara - Fren i di via.
5. Officine Meccaniche Breda Milano - Coscia dell ' affusto.
6. Officine Meccaniche M iani e Silvestri Milano - Sale a gomito.
7. Officine Meccaniche di Saronno - Culla del pezzo
8. Grandi Fucine Fossati di Sestri Ponente - Slitta coi freni.
9. Ditta S. Giorgio di Sestri Ponente - Numerosi e delicati congegni di puntamento e di precisione. Lavoro già bene avviato
I O. Ditta Marci di Varese- Ruote». C irca le altre parti del cannone, poi, Grillo menzionava a ltre d itte ancora: «Proiettili e bossoli in oilone. In corso di lavorazione presso le ditte: Società Pro iettili e Tempini di Brescia e Società Fiat e non vi è dubbio sulla loro ultimazione . Avantreni, cassoni e carri per attrezz i. La loro costruzione venne affidata alle stesse ditte che già hanno provveduto al materiale 1906 e la lavorazione procede bene».
Il dopoguerra 221
Il gen erale Paolo Spingardi
Le ditte insomma stavano
preparando tutto il macchinario, l'attrezzamento e le numerose sagome di lavorazione per raggiungere possibilmente nel venturo luglio una produzion e di 60 parti al mese. Si spera di avere nei primi di maggio i tre affusti per le prove dei 2 000 colp i e quelle più essenziali di traino; e per la fine di magg io la prima batteria .
La preoccupazione principale dei militari era comunque che «sia la materia prima che la lavorazione del materiale Dèport» venisse «tutta fatta in Ita lia». Uniche eccezioni
quelle parti che sono soggette a privativa come il cannocch iale di puntamento (panoramico) sis tem a Goertz; oppure che, costituendo una speciali tà di fabbricazione, come g li scudi, le molle dei ricuperatori e le lamiere della coscia, non si è potuto per la brevi t à del t empo e la s icurezza della loro qualità avere in Italia 117 •
Preso atto delle condizioni in cui avvenivano i lavori il 20 marzo 1913 Spingard i sollecitava personal mente un colloquio coi rappresentanti delle ditte che il 10 aprile gli assicurarono di consegnare 50 batterie entro la fine del 1913. Se il 22 febbraio aveva assicurato alla Camera che «entro la fine dell'anno tutti i reggimenti di artiglieria da campagna saranno muniti del materiale nuovo da 75 d'acciaio a deformazione» 118 , tre mesi dopo dovette più cautamente dichiarare al Senato di sperare di averlo «non oltre la primavera dell'anno venturo» 119 • Senonché i numerosi scioperi del 1913 rallentarono i lavori, indipendentemente dalla volontà di Spingardi 120 • Inoltre si dovettero introdurre num erose modifiche: ad esempio venne aumentato lo spessore delle lamiere cora zzate in seguito alla comparsa dei proiettili perforanti per fucili 121 • Furono ben 181 le variazioni che si dovettero apportare ai materiali nel corso della lavorazione Riguardavano particolari, dettagli che però, data l'estrema complessità del nuovo cannone, non potevano essere trascurati. Ovviamente tutto ciò non poté non produ rre ulteriori ritardi 122 •
Il Ministro continuò la sua opera di pungolo alle ditte, che il 7 agosto 1913
117 Tut te le citazioni da RFS , Promemoria sulla fabbrica z ione del materiale mod. 1911 sis 1ema Dèport, d oc c it.
11 8 AA.PP., L egislat ur a XXIII , Cam era-Discussioni , tornata d e l 22 febbraio 1913, p . 2345 7 .
119 Ibide m , Sena to-Discu ssio ni, to rna ta d e l 27 ma ggio 1913 , p. 111 4 3.
120 Materiale da 751 c it. , pp. 9-12. Sulle ag i tazioni di quell'anno v. G. C ANOELORO, S1 0ria d ell'Italia mode rna, voi. Vll , La cris i di fin e secolo e l 'e tà g iolitliana (1896- 1914), cit., pp. 349 e sgg
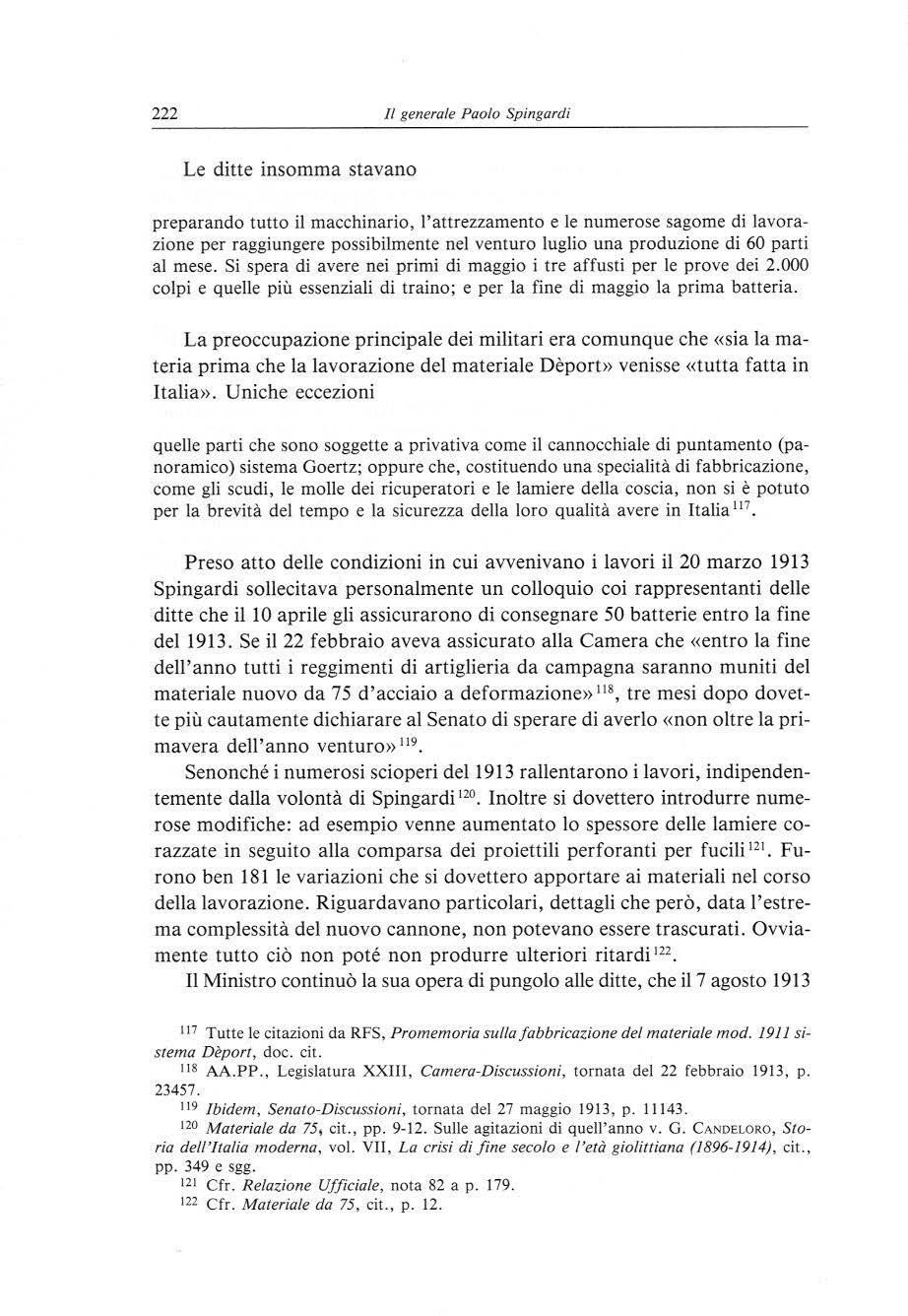
12
1 C fr R elazio ne Ufficiale , n ota 82 a p 179.
122 C fr . Materiale da 75 , c it., p. 12.
222
sottoscrissero una dichiaraz ione nella quale assicuravano la consegna di 20 batterie complete entro il 31 dicembre 1913 e di altre 80 batterie entro il 31 magg io 1914 123 •
Il 24 ottobre 1913 a l forte Santa Teresa di La Spezia ven nero eseguiti i primi tiri di collaudo col nuovo materiale, che diedero
risultati ottimi sotto ogni rapporto. Non ebbesi a verificare il mi nimo inconveniente Questo risultato segna un vero trionfo per la nostra industria naziona le, essendo questo nuovissimo materiale stato costrutto comp letamente da offic ine italiane 124 •
Il risultato entus iasmò natura lmente pure Spingardi, che ne riferiva due giorni dopo a Brusati
non ti ho comunicato la notizia delle prove ottimamente ri uscite a Spezia dei primi tre esemplari del cannone Dèport. Sarei giunto colla vettura di Magri, visti i telegrammi e le corrispondenze da Spezia che le case interessate si sono affrettate a divulgare. Era tempo!! 125 •
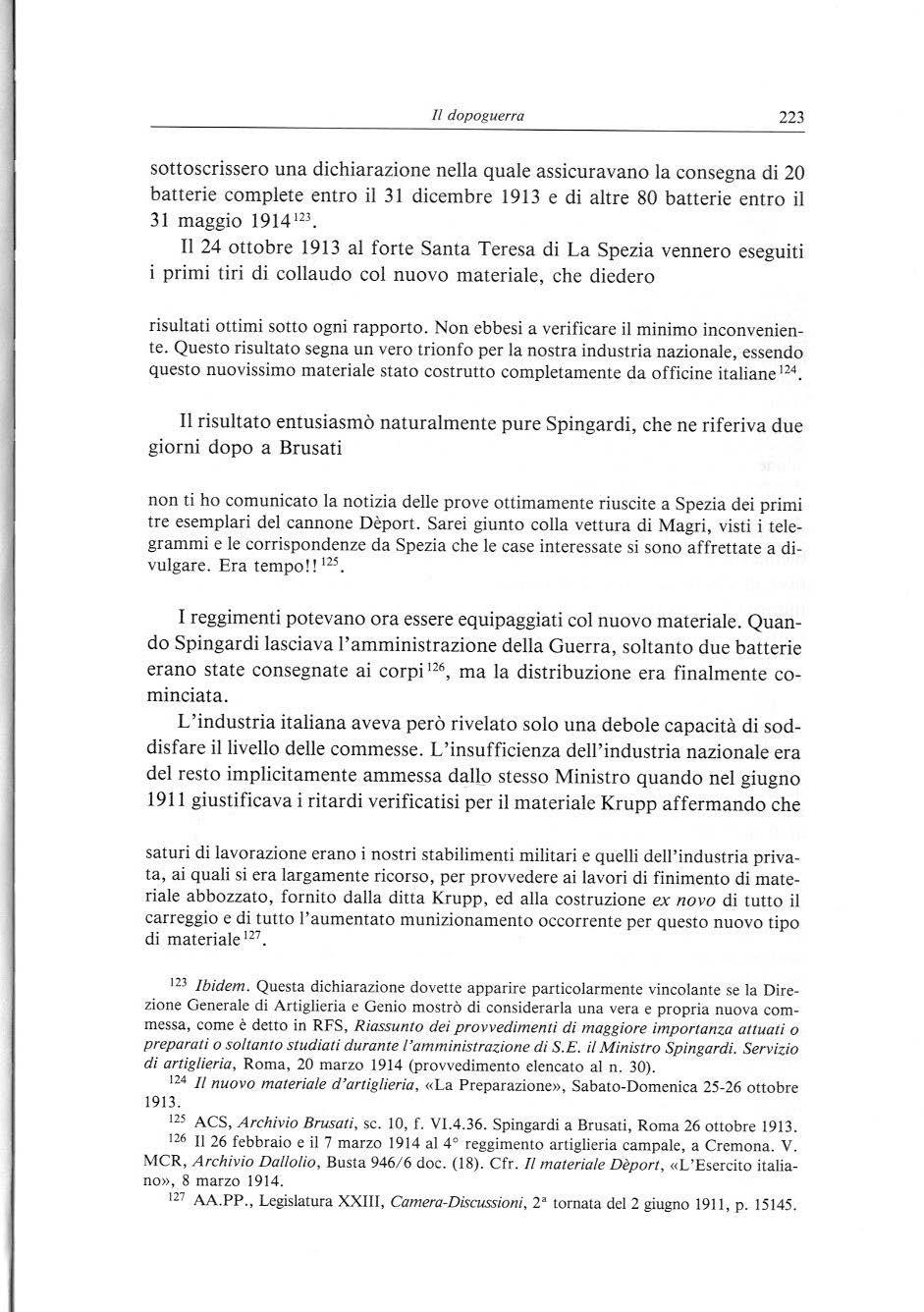
I reggimenti potevano ora ess ere equipaggiati col nuovo materiale. Quand o Sp ingardi lasc iava l'ammin istrazion e della Guerra, soltanto due batterie erano state consegnate a i corpi 126 , ma la distribuz ione era finalmente com inciata .
L'industria ital iana aveva però rivelato solo una deb ole capacità di soddisfare il livello delle commesse. L'insufficienza dell'industria naz ionale era d el resto implicitamente ammessa dall.9 stesso Ministro quando nel giugno
1911 giust i ficava i ritardi verificatis i per il materia le Krupp affer m ando che saturi di lavorazione erano i nostri stabi li menti militar i e quelli dell'industria privata, ai quali si era largamente ricorso, per provvedere ai lavori di finimento di materia le abbozzato, fornito dalla ditta Krupp, ed alla costruzione ex novo di tutto il carreggio e di tutto l'aumenta t o munizionamento occorrente per questo nuovo tipo di materiale 127 •
12 3 Ibidem. Questa dichiarazione dovette apparire partico larmente vincolante se la Direzione Generale di Artiglie ria e Genio mostrò di con side rarla una vera e propria nuova commessa, come è detto in RFS, Riassunto dei provvedimenli di maggiore importanza attuati o preparati o soltanto studiati durante l'amministrazione di S.E. il Ministro Spingardi Servizio di artiglieria, Roma, 20 marzo 1914 (provvedimento elencato al n. 30).
124 Il nuovo materiale d'artiglieria, «La Preparazione», Sabaco -Domenica 25-26 ottobre 1913.
125 ACS, Archivio Brusati, se. 10, f. VI.4.36. Spingardi a Brusa ti, Roma 26 ottobre 1913.
126 Il 26 febbraio e il 7 marzo 19 14 al 4° reggimento artiglieria campale, a Cremona V MCR, Archivio Dal/olio, Busta 946/6 doc. (18). Cfr. li materiale Dèport , «L'Eserci to italiano», 8 marzo 1914.
1 2 7 AA.PP., Legislatura XXIII, Camera-Discussioni, 2• tornata del 2 giugno 1911, p. 15145.
li dopoguerra 223
generale Paolo Spingardi
In oltre cinque anni le industrie italiane non erano riuscite a comp letare un cannone fornito già nelle sue parti essenziali dalla Krupp. Spingardi alcuni anni pfo tardi si chiedeva: «Quali le cause di tanto ritardo?» e doveva ammettere che
le ditte si sono illuse nello stabilire un termine eccessivamente ristretto; i tecnici del!'Amministrazione Militare si sono lasciati trascinare a previsioni ottimistiche . La ragione vera è che si trattava di un materiale nuovo, di eccezionale perfezio ne e difficoltà di costruzione. Le nostre maestranze operaie superarono brillantemente la prova ma a scap ito del tempo; alcune falli ron o e furono causa di nuovi ritardi. Poi i ritardi nella compilazione dei disegni, e successive numerose modificazioni in cerca del meglio, fornendo argomento alle ditte di nuovi ritardi. Poi gli scioperi delle metallurgie che si protrassero parecchi mesi; poi errori tecnici neJJa costruzione di talune parti, le sale degli affusti, le aste e controaste dei freni, la fornitura delle piastre per gli scud i e mille altri incidenti.
Ma ormai «II dado era tratto e tornare indietro non si poteva» . Il problema era un altro: «non si trattava solo di creare il nuovo materiale, si trattava di creare una nuova industria militare, una nuova coscienza tecnica industriale, privata, che ci liberasse almeno per quanto possibile dall'alternativa Krupp -Schneider» 128 •
John Whittam ha colto nel segno scrivendo che
Essendo li mitate le risorse nazionali, sia quelle materiali s ia quelle finanziarie, si rendeva necessaria ed essenziale una stretta collaborazione fra l'esercito, i politici e le ditte produttrici di armi. Il che richiedeva un grado di comprensione reciproca che semplicement e non esisteva, conseguenza fatale della mancanza di volontà, sia da parte dei militari sia dei civili, di comprendere le difficoltà e i compiti della controparte .. .. Quando fecero le loro enormi commesse, per esempio, i militari erano al di fuori della realtà nell'aspettarsi una pronta consegna 129 •
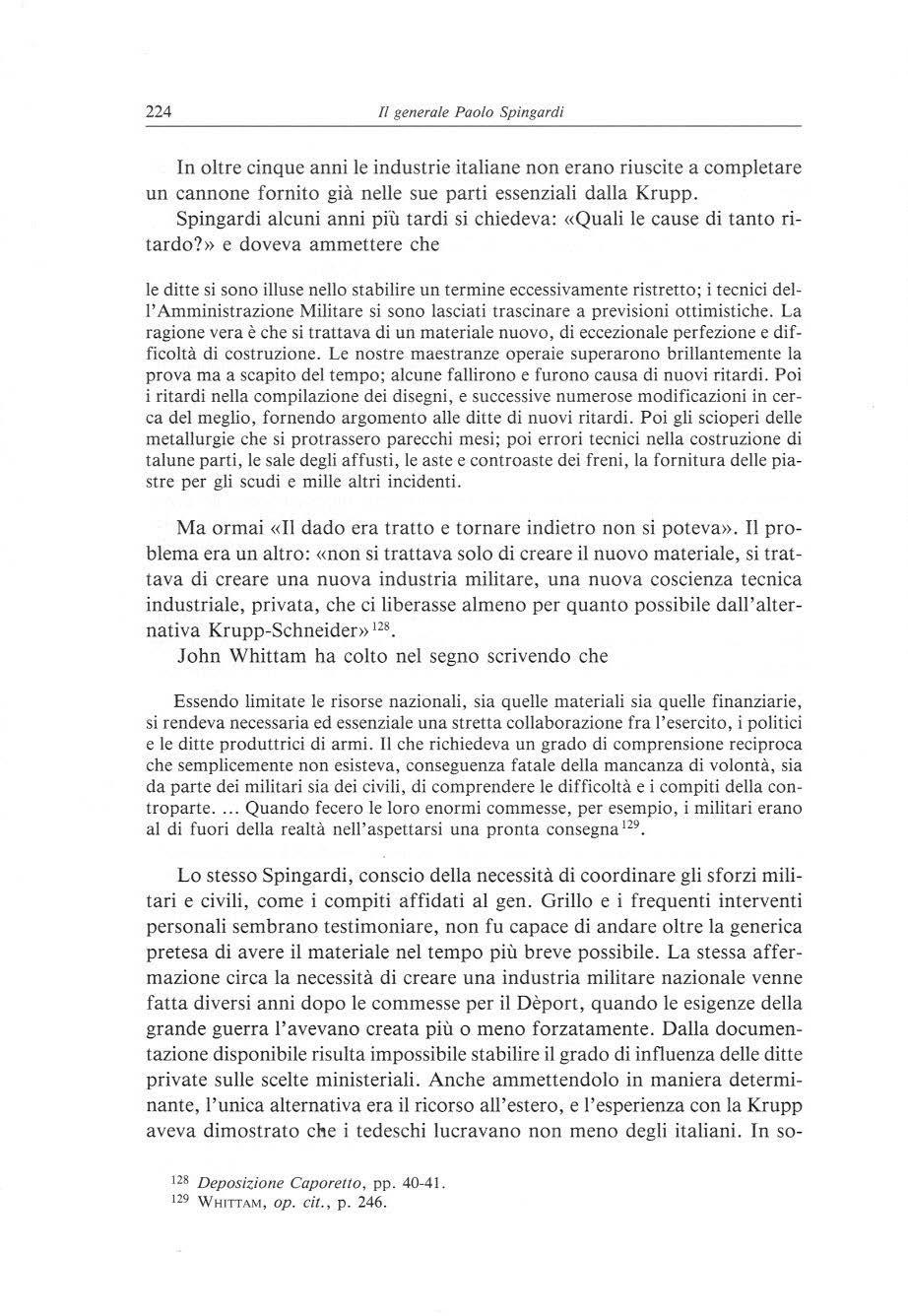
Lo stesso Spingardi, conscio della necessità di coordinare gli sforzi militari e civili, come i compiti affidati al gen . Grillo e i frequenti interventi personali sembrano testimoniare, non fu capace di andare oltre la generica pretesa di avere il materiale nel tempo più breve possibile. La stessa affermazione circa la necessità di creare una industria militare nazionale venne fatta diversi anni dopo le commesse per il Dèport, quando le esigenze della grande guerra l'avevano creata più o meno forzatamente. Dalla documentazione disponibile risulta impossibile stabilire il grado di influenza delle ditte private sulle scelte ministeriali. Anche ammettendolo in maniera determinante, l'unica alternativa era il ricorso all'estero, e l'esperienza con la Krupp aveva dimostrato cke i tedeschi lucravano non meno degli italiani. In so -
128 Deposizione Caporetto, pp 40-41.
129 WHtTIAM, Op. cit , p. 246
224
li
stanza affidarsi all'estero significava rischiare che allo scoppio delle ostilità il materiale ordinato non fosse corrisposto: più che avere i cannoni in tempi brevi, i militari volevano evitare di correre questo rischio. Gli industria li lo sapevano e potevano battere il c hiod o domandandosi:
Che cosa varrebbe una indipendenza politica formale, acquistata a prezzo di tanti sacrifici e tanto sangue, se l'Italia ... per difendere se stessa avesse ancora continuo e stretto bisogno di chiedere ai forestieri persino le armi, che contro le minacce dei forestieri devono difenderla? 130 •
Gli stabilimenti militari vennero comunque ampiamente coinvolti nella fabbricazione del Dèport, ma renderl i in grado di provvede rvi senza ricorrere al privato avrebbe richiesto tempi più lunghi e investimenti maggiori, anche se per parte loro i polverifici di Fossano e Fontana Liri e le fabbriche di cartucce di Bologna e Capua assolvevano egregiamente e in perfetta autonomia il loro compito 131 •
Solo l'impostazione difensiva dell'intero problema mil ita r e permetteva di soppor tare con relativa tranquillità i lunghi tempi di attesa delle artig lierie: non esistevano piani offensivi che avessero poss ibili tà di essere reali zzati 132 ; e nel caso di un'aggressione, i nove corp i già dotati del materiale a deformazione erano ritenuti sufficienti a fermare il nemico sulle frontiere di casa, mentre all'interno le fabbriche avrebbero continuato a lavorare
6. Mitragliatrici
L'impiego della mitragliatrice in Libia, dove furono spedit e le armi 133 , convinse definitivamente le autorità militari italiane circa il rea le valore del -
l 30 // discorso di un ministro. L 'on Spingardi e il lavoro nazionale, «Il Secolo XIX», Domenica 30 luglio 191 I. Come è noto, il giornale era collegato al gruppo siderurgico dell'Ansaldo
131 Sul «piccolo impero industriale>> (WH1TIAM, p. 245) del Ministero della Guerra, v. L. DE RosA, Incidenza delle spese militari sullo sviluppo economico italiano, in Atti del primo convegno nazionale di storia militare, Ministero della Difesa, Roma 1969, pp. 199-200 Ad ogn i modo venne affidato a privati un terzo stabil imento per la fabbricaz ione delle cartucce per armi portatili, impiantato a Bardalone, sull'Appennino pistoiese, dalla Società Metallurgica Ita liana, che aveva vinto il concorso i ndetto nel 19 10 dall'Amministrazione mil it are V. RFS, Direzione Generale di Artiglieria e Genio. Riassunto dei provvedimenti di maggiore importanza attuati o soltanto studiali durante l'amministrazione di S.E il Ministro Spingardi, Servizio di Artiglieria, provvedimento segnato col numero 72; La fabbrica di cartucce di Bardalone, «Il Nuovo Giorna le d i Firenze», sabato 29 luglio 191 I, Lo stabilimento di Bardalone Pistoiese, «La Preparazione», Sabato-Domenica 29-30 lu g lio 191 I.
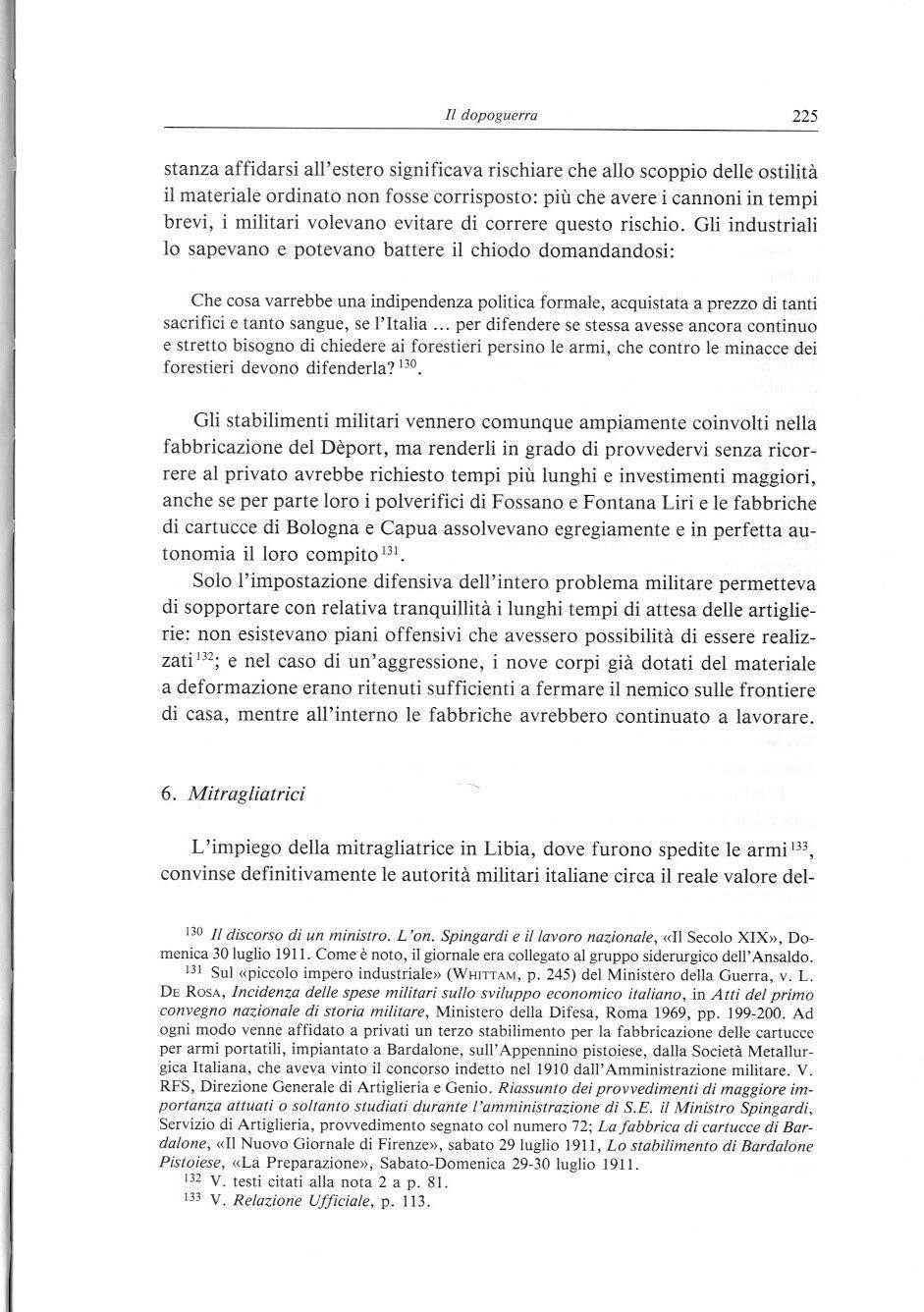
132 V. testi citati alla nota 2 a p 81.
133 V. Relazione Ufficiale, p 113.
li dopoguerra 225
Spingardi
l'arma. Per risolvere la questione nel maggio 1912 Spingardi chiese quindi al Parlamento nuovi fondi.
Un bisogno nuovo, cui propongo di provvedere con la presente richiesta, è quello della provvista e dell'organizzaz ione delle mitragliatric i Dico b isogno nuovo, perché nessun apposito stanziamento era stato farro da ll e leggi precedent i per la definitiva sis temazione d i quest'armamento; ma in veri t à l'esigenza non è nuova, bensì rimonta a qualche anno addietro Senonché sino a poco tempo fa siamo rimasti nel campo degli studi e degli esperimenti. Si sper i mentarono i n diverse circostanze armi di provenienza estera e nazionale, si formarono per le grandi manovre sezioni someggiate e careggiate, si costru irono anche, in via permanente, presso alcuni reggimenti di fanteria e di cavalleria, sezioni o nuclei di sezioni di mitragliatrici, si seguì con viva attenzione ciò che in mater ia si fece all'estero, e così via. Il risultato di tutto questo lungo lavoro è ormai concretato nell'azione di un'arma leggerissima, quindi di facile tras porto ed impiego, la quale rappresenta l' ultima espressione del progresso È quindi giunto il momento di provvedere senza indugio, per munire il no stro esercito, a somiglianza degli altri, di un'arma la quale rappresenta un potente fattore di forza, per l'intensità degli effetti che produce co l minimo imp iego di uomin i. Co me vi è noto, essa si è già affermata nelle ultime guerre; e non occorre che io ricordi gli ottimi servizi da essa resa a noi nella presente guerra 134 •
Spingardi in te ndeva finalmente organizzare concretamente tutto quanto era «necessario in uomini, armi, quadrupedi e materiali, per dare all'esercito la quantità di mitragliatrici ritenuta conveniente, ripartita in unità adatte, secondo un piano studiato in tutti i particolari» 135 •
L'ammontare complessivo della spesa era di 15 mi lioni. Non sembrava una cifra esagerata cons iderando che occorreva
distrib u ire le mitragliatrici alle armi di fanteria e di cavalleria, formare sin dal tempo di pace un nucleo di quadrupedi per il servizio di dette armi, e che infine è necessario costituire forti dotazioni di munizionamento commisurate alla grande celerità di tiro delle arm i stesse, dotazioni che per entità non si possono nemmeno lontanamente confrontare con quelle stab ili te per i fuc ili 136 •
Finalmente si ruppe ogni indugio e nel 1913 si acquistarono le nuove armi. Il 27 maggio il Mini stro annunciava al Senato che «prima che l'anno volga al suo termine, o in pr in cipio dell'anno venturo, tutti i reggimenti di fanteria e bersag lieri, i reggimenti di cavalleria divisionali, e gli alpini,
134 RFS , Elementi per la discussione del disegno di legge per maggiori assegnazioni alla parte straordinaria del bilancio della guerra, doc. cit., p. 9.
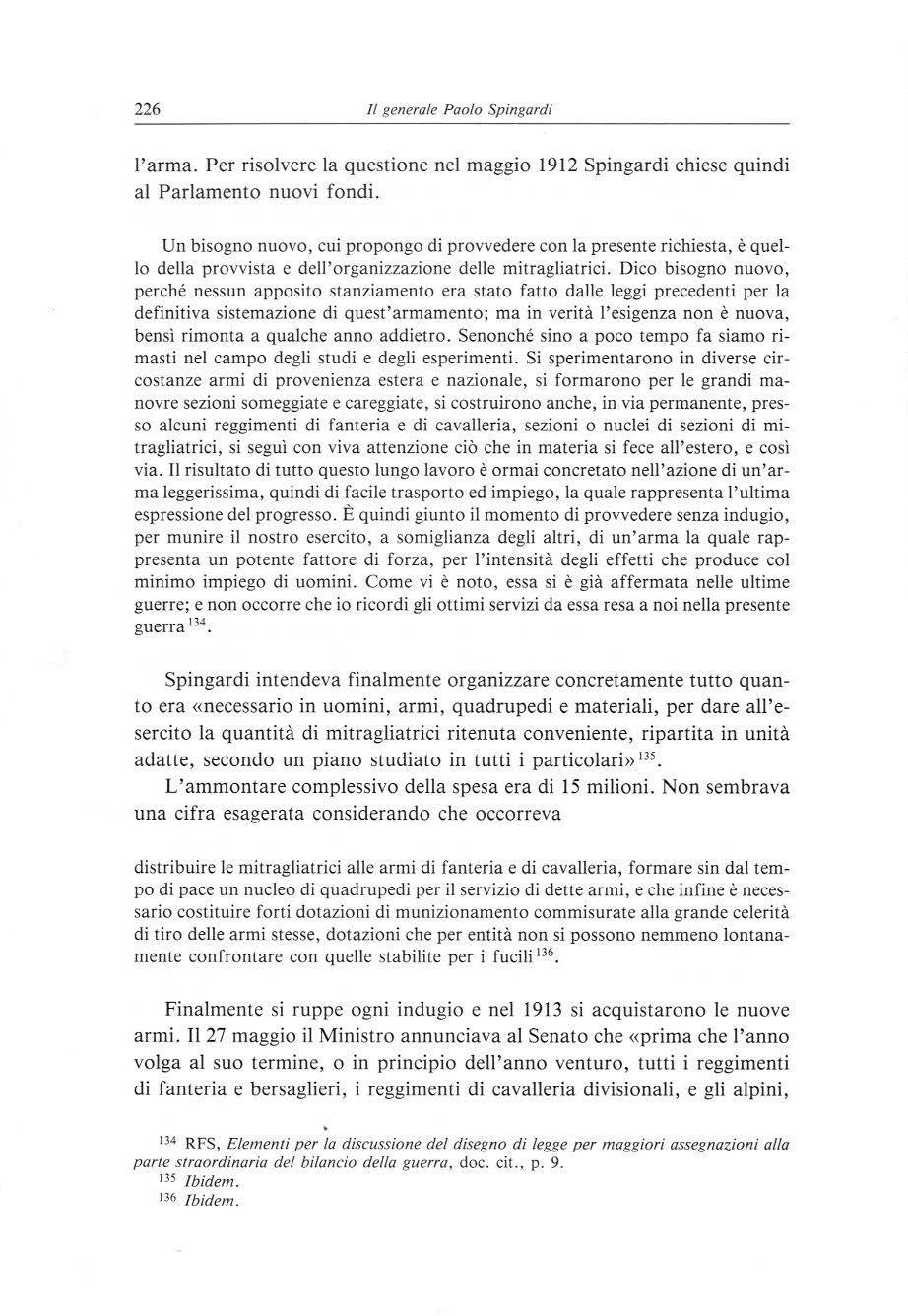
135 Ibidem.
136 ibidem .
226
li generale Paolo
avranno le sezioni mitragliatrici di tipo leggero 137 • Il programma che egli si proponeva di realizzare era dunque quello del 1909. Al 20 marzo 1914, di fatto, erano in Italia 820 mitragliatrici Maxirn leggere 138, cifra che avrebbe consentito comunque di dare una sezione ad ogni battag lione fanteria e bersaglieri e due ad ogni battaglione alpino. Il programma minimo previsto era stato insomma realizzato.
È però indubitabile che si erano persi anni e anche Spingardi, suo malgrado, pur avendo il merito di aver dato soluzione al problema, non è immune da errori. La scarsa documentazione sul problema non ha permesso di illuminare nei particolari la sua opera. Si possono tuttavia fare alcune considerazioni.
Se i predecessori di Spingardi avevano errato non prendendo di fatto alcuna decisione circa le mitragliatrici, egli insistette troppo a lungo sull'industria italiana prima di rendersi conto della sua insufficienza a fornire del materiale acc ettabile in tempi brevi. Se per l'artiglieria si dovettero scontare tempi lunghi di consegna, ma alla fine si riuscì comunque a produrre il miglior cannone, con le mitragliatrici anche la qualità si rivelò mediocre se non scadente. Sembra di notare, poi, una eccessiva compiacenza per il «campo degli studi e d egli esperimenti», qui assai più che nel caso dell'artiglieria, quasi che anni, se non decenni di esperienze all'estero non avessero approdato a nulla.
P er la fornitura delle mitragliatrici si ricorse dunque all'estero, e la sce lta si rivelò azzeccata, poiché le Maxim erano sicuramente le migliori mitragliatrici dell'epoca . Si era però giunti al 1913, laddove l'esercito svizzero possedeva mitragliatrici fin dal, 1899 139 • Ciononostante, Spingardi poté orgogliosame n te affermare: « E ricordo ancora 800 mitrag liatrici, tipo Maxim leggere, la migliore arma del genere, da me introdotta nell'esercito, che ne era prima quasi comp letamente sprovvisto» 140 •
137 AA.PP., Legislatura XXIII, Senato-Discussioni, tornata del 27 magi,,jo 19 13, p. 11143. l38 Il dato in RFS, Direzione Ge nerale Artiglieria e Genio , Riassunto dei provvedimen1i di maggiore importanza attuali o preparali o soltanto studiati durante l'amministrazione di S.E. il Ministro Spingardi, Roma 20 marzo 1914 che coincide con MCR, Archivio Dallo/io , Busta 946, Cartella 1, Notizie sintetiche sullo staio di fatto delle questioni più importanti svoltesi nell'anno 1913, datato novembre 1913 e con F MAl\AZZI , Splendori ed ombre della nostra guerra, Milano 1920, p. 92. Apparentemente inesplicabile il contras to di queste fon t i co n q uanto affermato dalla Relazione Ufficiale, p. I 14: «Su l fin ire del luglio 19 14 delle mitragliatrici leggere ordinate a lla casa Wickers non ne erano giun te in Italia che 300 » È vero che a tale data quello era il numero delle armi effellivamen te distribuite Ma le altre 520, anche se ancora chiuse nelle casse dei magazzini, c'erano. V MCR , Archivio Dal/olio , Busta 946, Cartella 2, Relazione 14 maggio 1914.
139 V. Goo c H, p )21.
140 Deposizione Caporetto, p. 35
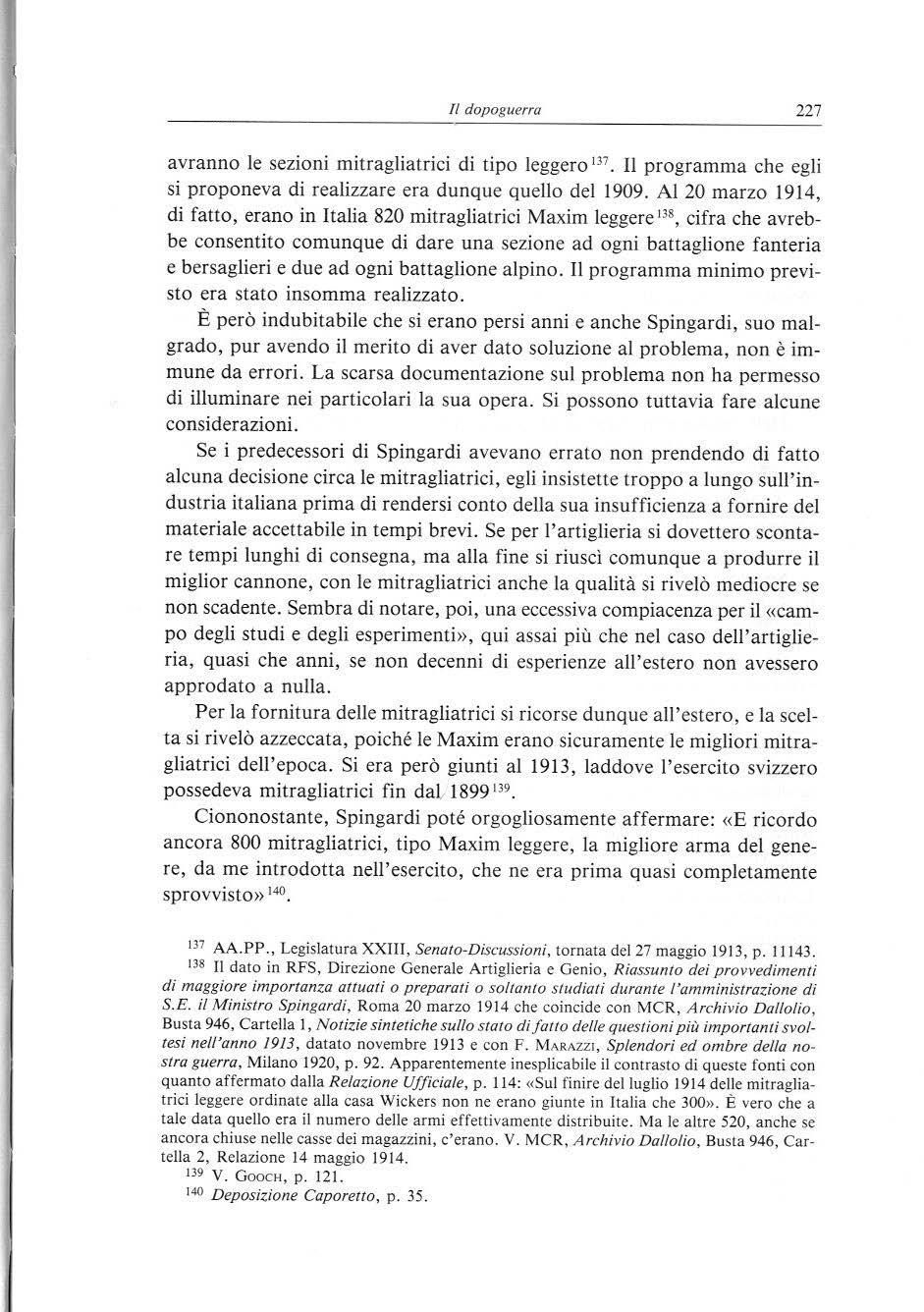
Il dopo guerra 227
7 L 'areonautica in crisi di crescenza
La campagna libica ebbe il vantaggio di delineare i criteri d'impiego dei materia li aeronautici, utilizzati per la prima volta al mondo in azioni di guerra , per lo più in missioni esplorative, ma anche per compiti offensivi con rudimentali lanci di bombe a mano 14 1 •
Perciò, nel 1912 Spingardi provvide a stacca r e dalla Brigata Specialisti un Battaglione Aviatori, separando le competenze relative ai dirigibili da quelle relative agli aeroplani, che andavano ormai affermando la superiorità del «più pesante de ll 'aria» 142 •
Nello stesso anno ven iva bandita una sottoscrizione pubblica denominata «Date ali alla Patria», per l'incremento della flotta aerea nazionale, alla quale lo stesso Spingardi versò la somma di 500 lire 14 3 •
Anche grazie a questa in iziativa, il 26 febbraio 1913, egli poteva con legittimo orgoglio annunziare alla Camera:
Noi abbiamo in questo momento cinq ue dirigibili di piccola cubatura, dirigibili P, di 4.000 metri cubi, e quattro diri gibi li di media cubatura, dirigibili M, da IO a 11.000 metri cubi. - Un a lt ro dirigibile è in corso di studio, e spero non sarà lontano il giorno della sua costruzione, forse in quest'anno medesimo; di guisa che noi avremo dieci dirigibili con una cubatura compless iva non molto inferiore a 100 mila metri cubi Per tutti questi dirigibili noi abbiamo gli hangars pronti, provvisti di tutto il servizio accessorio, di cantieri od altro, distribuiti in tutto il territorio del regno in relazione alle esigenze della difesa - Forse voi sapete dove essi s ono e non è il caso che io lo ripeta qui per un doveroso riserbo. - Quanto all'aviazione, la legge del 27 giugno I 9 12 istituì il battaglione autonomo aviatori, realizzando così la separazione dei due servizi, aviazione e dirigibili, secondo i due noti concetti scientifici del più pesante e del più leggero dell'aria. - Entro la prossima primavera noi potremo disporre di 12 squadriglie di aviator i con sette apparecchi ciascuna, ripartite fra i dodici co r pi d'armata: ciascuna di queste s quadriglie munita di hangars, officine e caserme. - Abbiamo qua ttro campi-scuola ad Aviano, Pordenone, Somma Lombarda e Campo di San Maurizio. Questi campi sono provvisti anch'essi di apparecchi per il volo degli allievi , e sono dotati di officine capaci di tutte le necessarie riparazioni. Infine presso il battaglione aviator i è stato istituito, con il concorso del politecnico di Torino, un corso teorico -pratico per allievi aviatori. Come vedete ... molto cammino abbiamo fatto, e, lo dico francamente, più che non avrei sperato; e sono lieto di tributarne pubblicamente la dovuta lode al colonnello Mòris, direttore di tutto il servizio aereonautico, ed ai suoi valorosi coadiutori. [ ] Sono lieto di assicurare la Camera che, per tutto quanto riguarda la fornitura degli aeroplani , ormai gli acquisti sa ranno fatti esclusivamente in Italia dall'industria nazionale : non un soldo dei tre milioni donati per la flotta aerea andrà all'estero 144 •
14 1 V. L'az ione dell'eserc!to nella guerra italo-turca, Roma 1913, pp . 86 -90 .
142 Relazione Ufficiale, p. 123.
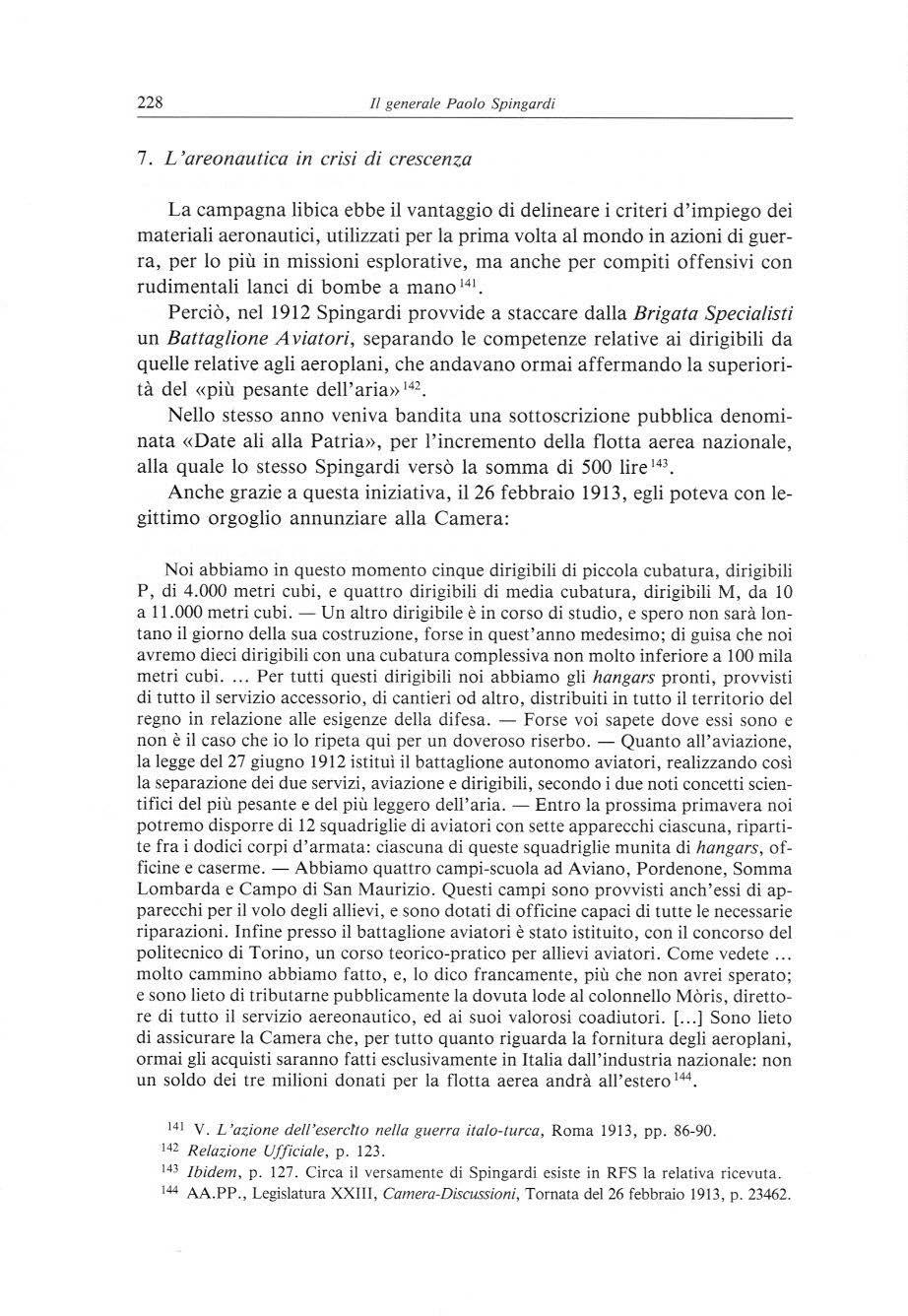
143 ibidem, p . 127 . Circa il versamente d i Spingardi esiste in RFS la rela t iva ricevuta .
144 AA.PP., Legislatura XXIII, Camera-Discussioni, T ornata del 26 febbraio 1913, p 23462.
228 li
generale Paolo Spingardi
Non era trascorso molto tem p o d a ques t e d ich iarazioni, che illCapo del1'Ufficio d' Ispezione dei Servizi Aeronautici colone ll o Mòris 145 inviava a Spingardi un promemo ri a nel quale erano delineati tu tti i problemi di ciò che Spingardi definì una «cris i di crescenza>> dell'ae ro na u ti ca mil ita re italiana: in sosta nza si chiedeva di svincola r e sempre più l' a er onau t ic a dall e altre a r m i , per gara nti r le la più vasta autonomia possibi le, spec ia lm e n te p er il reclutamento e la for m a zion e d e l personale, che pe r il momento era p r eso quasi in prestito dai vari corpi.
Se non si prenderanno le misure necessarie - avvertiva Mòris - in caso di una eventuale mobilitazione genera le d ell'Esercito, si potranno avver are inconve ni enti tali da agire in modo esiziale sul buon funzionamento dei servizi aeronaut ici. - Occorre addivenire ad una sistemazione ben netta degli organici dei se rvizi stessi, che non debbono né possono essere lasc iat i in bal ia delle esigenze de i vari corp i de ll'Esercito, oggi malauguratamente sprovvisti di quadri di uffic iali i nferiori e che pertanto a malincuore assistono all 'esodo dei migliori e lement i di ufficiali s u balterni. - Sono mesi e mesi che si sente assoluta la necessità d i creare un Istitu to Centrale d'Aeronautica La nuova a r ma è essenzialmente tecnica e come tale si basa su un personale che non si i mprovvisa da un momento all'altro, né può sottrarsi alle industrie private se non con adegua t i compens i finanziar i e la promessa di una carr iera sicura Pertanto, se provvedimenti legislativi non saranno attua t i p rima de ll 'in izio del n u ovo anno fina n ziario, si va dolorosamente incontro a li ' inevitabile perdita di quasi tutti i migliori elementi oggi a disposizione. [ ] Un ta le abbandono da parte del personale tecnico si risolverà, senza esagerazione, in una catastrofe per l'insieme dei servizi aeronautici, tanto più nella co nsiderazione che non è possibile costituire in Italia deg li specialisti in aeronautica a causa della mancanza di una seria industria nazionale. - Da ciò sca t urisce anche la necessità u rgente di decidersi ad affrontare e r isofvere il prob lema dell'i n dustria costruttiva e per i dirigibil i e per gli aeroplani e di fissare in conseguenza un programma d i costruzioni con i fondi necessari. ... Nel marzo la Germania stabiliva c h e q u asi la q uinta parte del miliardo di spese straordinarie per g li armamenti si desti n asse all'aeronautica militare . Il 16 apr ile u.s . la Francia ha rio r ganizzato i servizi aerona u tici ded icandovi ingenti somme delle quali non si sa ancora con-precis ione l'ammontare. In
14 5 Maurizio Mario Mòris (1860-1944) uscì sottotenente dal Genio nel 1880 e in tale Arma compì tutta la carriera. Venne destinato alla Brigata Specialisti col grado di capitano e servì ininterrottamente in questo reparto fino al 1915. Progettò e costruì con propr i mezzi il primo aerostato mil itare, con il quale compì numerose ascensioni, la prima nel 1894 Nel 1909 meritò la medaglia d 'argento di benemerenza per il terremoto calabro-sicu lo Nel 191 I venne promosso colonnello a scelta Fondò il centro di Vigna di Valle per la costruzione di di rigibili e organjzzò l'aviazione italiana Maggior genera le ne l 19 15, durante la grande guerra comandò dapprima il genio del I corpo d'Armata e success ivamente, nell'ordine, quello della 6 •, 4•, s•, 9•, 8' Armata. Tenente Genera le nel 1918, si ritirò a vita privata non appena la smobilitazione dell'esercito portò a un parziale smantellamento dell'a rma aerea Nel 1939 venne nominato senatore L'Ufficio d'Ispezione dei Servizi Aeronautic i venne istitu ito nel 191 I e dipendeva dalla Direzione Generale d'Artiglieria e Gen io Nel 1915 divenne una sezione autonoma del Ministero con la denominazione di Ispettorato aeronautico. Contemporaneamente Mòris assunse la carica di Ispettore del!' Aeronautica Mi litare.
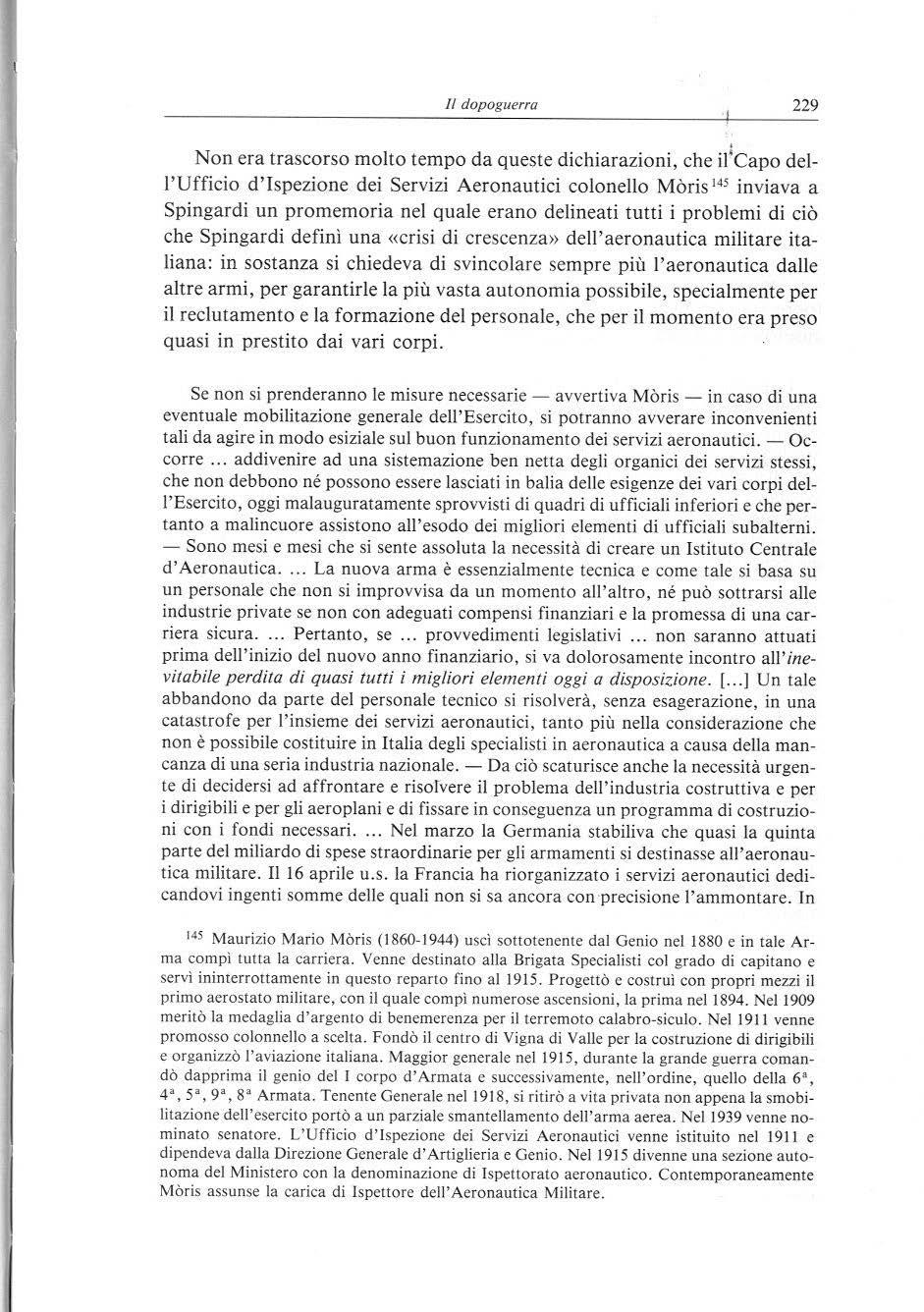
li dopoguerra 229
Il generale Paolo Spingardi
Inghilterra oggi l'op in ione pubblica spinge il governo ad aumentare di molto i 10 milioni votati nel marzo per l'aeronautica, giacché è universale nel Regno Unito la convinzione della loro insufficienza Nell'ottobre del 1912 l'Austria ha votato 14 milioni di corone per lo stesso fine 146 •
Assolutamente convinto della necessità di risol vere la situazione, in ottobre Spingardi scriveva al Ministro del Tesoro Francesco Tedesco per richiedere i fondi necessari per risolvere la «crisi di crescenza» dell'aeronautica:
Le notizie dei provvedimenti adottati, o in corso di adozione, che mi pervengono d ai principali Stati d'Europa, per dare all'aerona utica militare salda e vasta e pote n te organizzazione, mi persuadono della necessità di richjamare la tua benevola attenzione s ullo stato dell'aeronautica in Italia, che attraversa una vera e propria crisi di crescenza, e non può né deve subire le nefaste conseg u enze di un arresto di sv iluppo. [... ] lo propongo soltanto una ser ie di provvedimenti intesi a conferire co n veniente assetto alla organizzazione aeronautica, in armonia al complesso della nostra o rg anizzazione militare, alieno quindi ad ogni esagerazione, e nei limiti che già esposi alla. Camera in occasione della discussione del bi lancio 1913 - 1914.
Dopo un ampio esame di quanto era stato svolto a favore dell'aeronautica militare in Francia, Germania, Inghilterra e cenni ai provvedimenti presi in Austria, Ru ssia e Stati Uniti, su lla linea di quanto tracciato da Mòris, Spingardi passava a illustrare «quello che l'Italia ha fatto e quello che dovrebbe fare per trovarsi non ultima nella affermazione di questa nuova potenza militare ».
Quanto realizzato in poco più di tre anni appare veramente notevole soprattutto considerando che fino al 1910 si dovette
agire con una disporubilità di fondi assai Jjmitata: un milione circa di assegno straordinario, qualche modesto aiuto dal Ministero della Marina e l'esiguo assegno ordinario della «Brigata Specialisti». - Tuttavia si riuscì a costrui re il «Pl» e il relativo hangar, si impiantò il campo di Centocelle e si contrib uì allo acquisto dei primi tre apparecchi - Con la legge del 10 luglio 1910 n. 422 furono assegnati i dieci milioni, ormai ben noti ed anche st r emati, che hanno servito allo impianto del servizio aeronaut ico militare. Da allora ad oggi non sono state fatte altre assegnazioni Hanno accresciuto quella somma circa tre milioni dati dal M i nis t ero della Marina, per opere e forniture inerenti all'aeronaut ica marittina, e certamente, dato il largo impiego di aeroplani e dirigibili in Libia, parte de i fondi fu devoluta ai servizi aeronautici,
146 RFS, Dattiloscritto su carta intestala Ministero della Guerra - Direzione generale d'Arliglieria e Genio - Ufficio d'lspe~one dei Servizi Aeronautici, « P romemoria per S.E. il Ministro>>, 4 ff n n , senza data ma dal testo si evince chiaramente essere della primavera del 1913
A mano Mòri s aggiungeva i l seguente poscritto: <<Se non fosse asso lutamente possibile presentare d'urgenza alla Camera tutto il progetto sarebbe di massima utilità ed urgenza provvedere almeno in via provvisoria alle più gravi necessità».
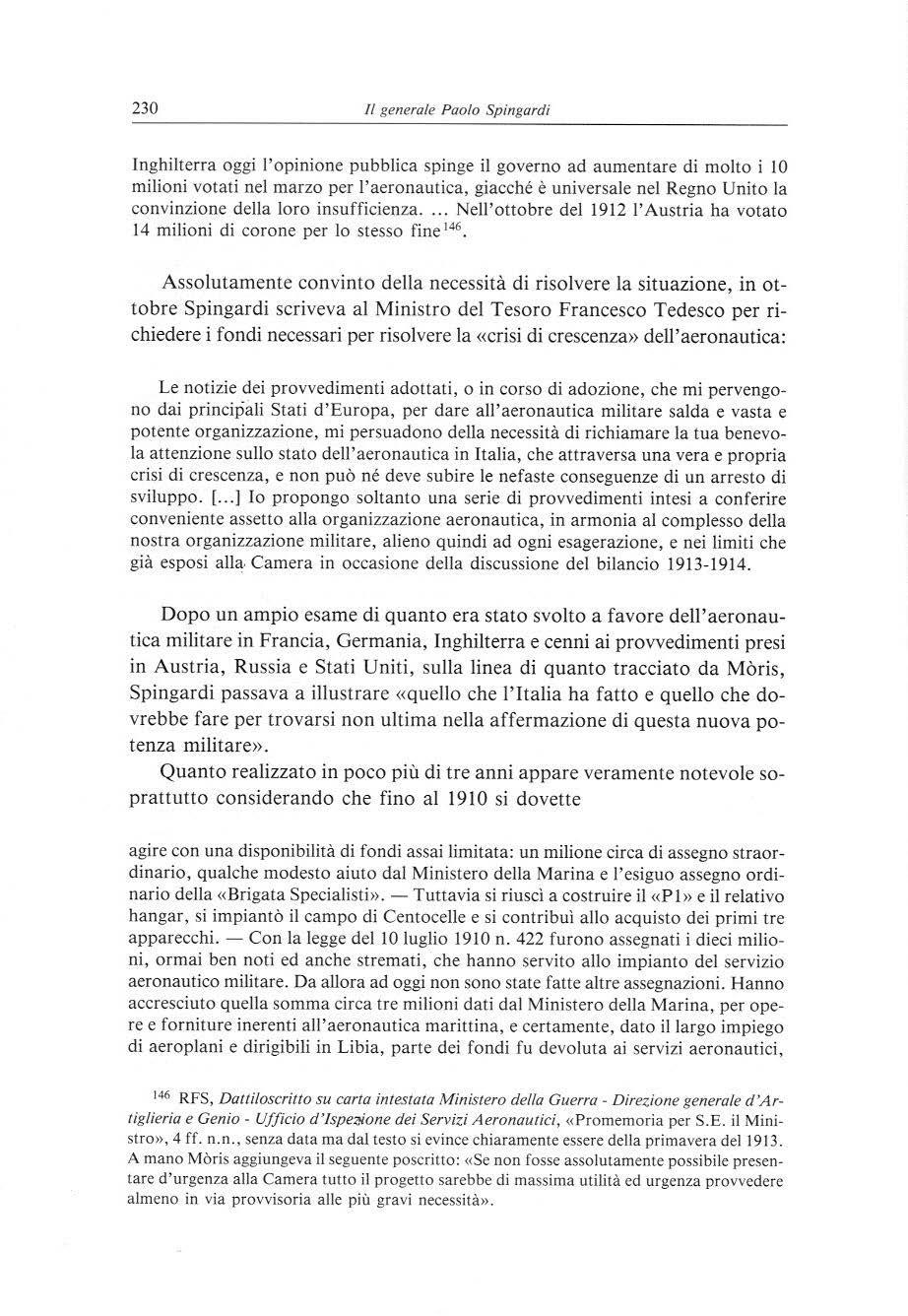
230
specie per la ricostituzione delle dotazioni sguarnite per il fatto della guerra e per il miglioramento di qualche impianto, per renderlo idoneo a sod disfare alle esigenze vaste e complesse e imperiose della guerra.
Dopo queste premesse, Spingardi esponeva qual'era al momento la situazione dei servizi aeronautici italiani. Molto si era fatto: si avevano nove dirigibili e due in corso di lavorazione, undici hangars e si stavano studiando «dirigibili di grande cubatura e di grande velocità». Addirittura sorprendente la situazione dell'aviazione che poteva ora contare su
150 apparecchi con adeguato numero di piloti . In corso di organizzazione sedici squadr iglie, pronte per la fine dell'anno corrente(! 913), e altre quattordici, da costruirsi coi fondi da concedersi, dovranno essere compiute nell 'anno venturo (1914), per completare le trenta squadriglie progettate. - E inoltre disponiamo di quattro campiscuola (Aviano, Pordenone, Gallarate, San Francesco al Campo). [ ... ] Ai campiscuola si aggiungano i camp i-s quadriglia, in via di costituzione e di organizzaz ione. Per l'impianto di questi campi -squadriglia ci siamo assicurati il concorso finanziario dei comuni, cosa in vero modesta, ma sempre efficace.
Pe r non subire una pericolosa stasi nello sviluppo dell'aeronautica militare Spingardi chiedeva per l'esercizio finanziario 1914- 15 una assegnazione straordinaria di 30 milioni, che dovevano serv ire
per il completamento dei Cantieri Aeronautici esistenti; per la costruzione di almeno cinque nuovi; per la costituzione di quattordici squadriglie di aviaz ione e per la organ izzazione tecnico-scientifica del novissimo servizio;
e una ordinaria di sette milioni e mezzo, più un aumento immediato di lire 1.855.000,
per poter cont inuare lo svolgimento delle funzion i ordinarie ed assicurare la vita dei campi -scuola e di squadriglia e dei cantieri aeronautici.
Si trattava di provvedimenti giudicati da Spingardi
di carattere urgente, che è assolutamente necessario studiare in tempo per presentarli subito ai suffragi della nuova legislatura, dovere questo che si impone, più che non si consigli , indipendentemente dalla persona che potrà essere chiamata al posto che io ora occupo .
Spingardi concludeva dichiarandosi sicuro che dallo sviluppo dell'aeronautico militare sarebbero potute fiorire in Italia «molte industrie ad essa
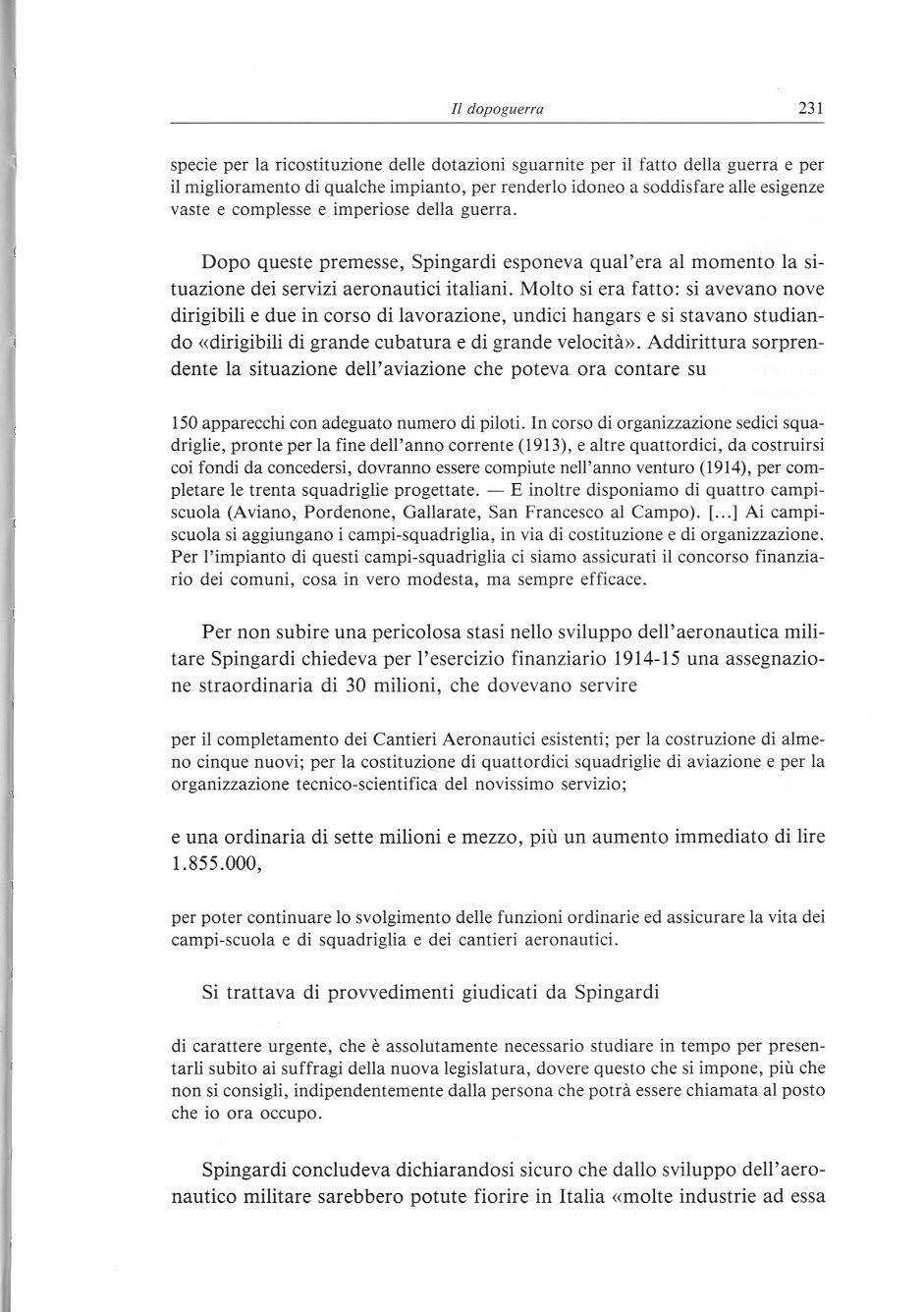
li dopoguerra 231
Il generale Paolo Spingardi
collegate, qua li la produzione di metalli leggeri ad alta resistenza, di motori leggeri, la fabbricazione di stoffe, di speciali strumenti di navigazione, di armi aeree, di apparecchi speciali radiotelegrafici, ecc » 147 •
Ma quando scriveva queste parole, Spingardi stava già pensando al futuro, al quadriennio 1913-1917, al nuovo p r ogramma che sarebbe divenuto il s uo testamento militare .
147 Tutte le citazioni da RFS, Spingardi a Tedesco, ottobre 1913 (non è indicato il giorno), 10 ff. datti lo scritti con firma autografa e l'indicazione autografa copia. I dirigibili erano denominati <<P. I - P. 2 - P 3 - P. 4 - P. 5 (tipo semirigido) M. 1 - M. 2 ed in corso di lavorazione: M. 3 - M. 4. 'Parseval ' (uno) - acqu istato quando i nostri dirigibili erano impegnati in L ibia. 'Città di Mi lano' (uno) - studiato e costruito dall'ingegnere Forlanini ». Gli hangars erano ubicati: «2 a Vigna di Valle, 2 a Campalto, I a Bosco Manrico, 1 a Ferrara, I a Jesi, I a Milano, 1 a Tor ino, I a Tripol i e 1 a Bengasi» (ibidem).

232
CAPITOLO IX
IL TEST AMENTO MILITARE DI PAOLO SPINGARDI
Il 29 aprile 1913 Spingardi inviò a Giolitti una lunga lettera che «da tempo ruminava» nella sua testa e nella quale esponeva «in linguaggio piano, accessibile a chi non è tecnico, la nostra situazione militare, e i provvedimenti indispensabili per completare le nostre difese territoriali e marittimo e soprattutto per rafforzare la compagine dell'esercito» 1 • Egli era perfettamente cosciente «dei provvedimenti di carattere militare adottati, o in via di adozione, presso i principali Stati d'Europa, in questo momento storico della politica internazionale» 2 : tutta Europa andava riarmandosi e l'Italia non poteva restare a guardare 3 • Tuttavia egli era anche persuaso che l'Italia non fosse obbligata «a spingere i suoi armamenti sino all'estremo limite consentito dalle sue risorse demografiche, economiche e finanziarie» poiché vedeva la posizione internazionale del Paese «molto diversa da quella che obbliga[va] altre potenze, ed in prima linea la Germania e la Francia, a seguire una politica militare siffatta» 4 • Un esame complessivo del documento lasciava intravedere Io stesso principio portante del piano precedente, e cioè rendere sempre meno distante
1 ACS, Archivio Brusati, se. 10, f. Vll.2.42, Spingardi a Brusati, Roma , 29 apri le 1913.
2 RFS, Spingardi «A Sua Eccellenza cavaliere Giovanni Giolitti. Presidente del Consiglio dei Ministri», Roma, 29 aprile 1913. Riservato Personale , 16 pagine numerate dattiloscritte (copia). Un sostanziale riassunto della lettera di Spingardi si ha in Relazione Ufficiale, p. 61 e in ToSTI, cit., p. 163.
3 li IO marzo di quell'anno era stato presentato formalmente al Reichstag un progetto di spese militari per un miliardo di marchi (per fortificazioni, nuovi materiali da guerra e aumento della forza di pace a 866 mila uomini) Il 7 aprile il Cancelliere Bethmann-Hollweg pronunciò al Reichstag un ampio discorso che suscitò un vivo allarme in Europa; nello stesso periodo in Francia si votavano nuovi stanziamenti per l'esercito e si cominciava la discussione in Parlamento sulla ferma triennale. V D E LA GoRcE, pp 121 e 125; R1rrER , p. 372 (per la Francia) e pp. 625-27 (per la Germania); Gooctt, Soldati e borghesi nell'Europa moderna, p. 147-49. Pure la Russia e persino l'Inghilterra non furono estranee, quell'anno, a «quella furiosa fe bbre di riarmo che contraddistinse gli ultimi anni precedenti la guerra in tutto il continente» (RtITER, p. 447). In Inghilterra fu presentata una proposta, poi bocciata, ma di per sé indicativa, per introdurre il servizio militare obb ligatorio (cfr. R.tnER, p 404).
4 RFS, Sp ingardi a Giolitti, Roma, 29 aprile 1913. Riservato Personale, doc. cit., p. I.
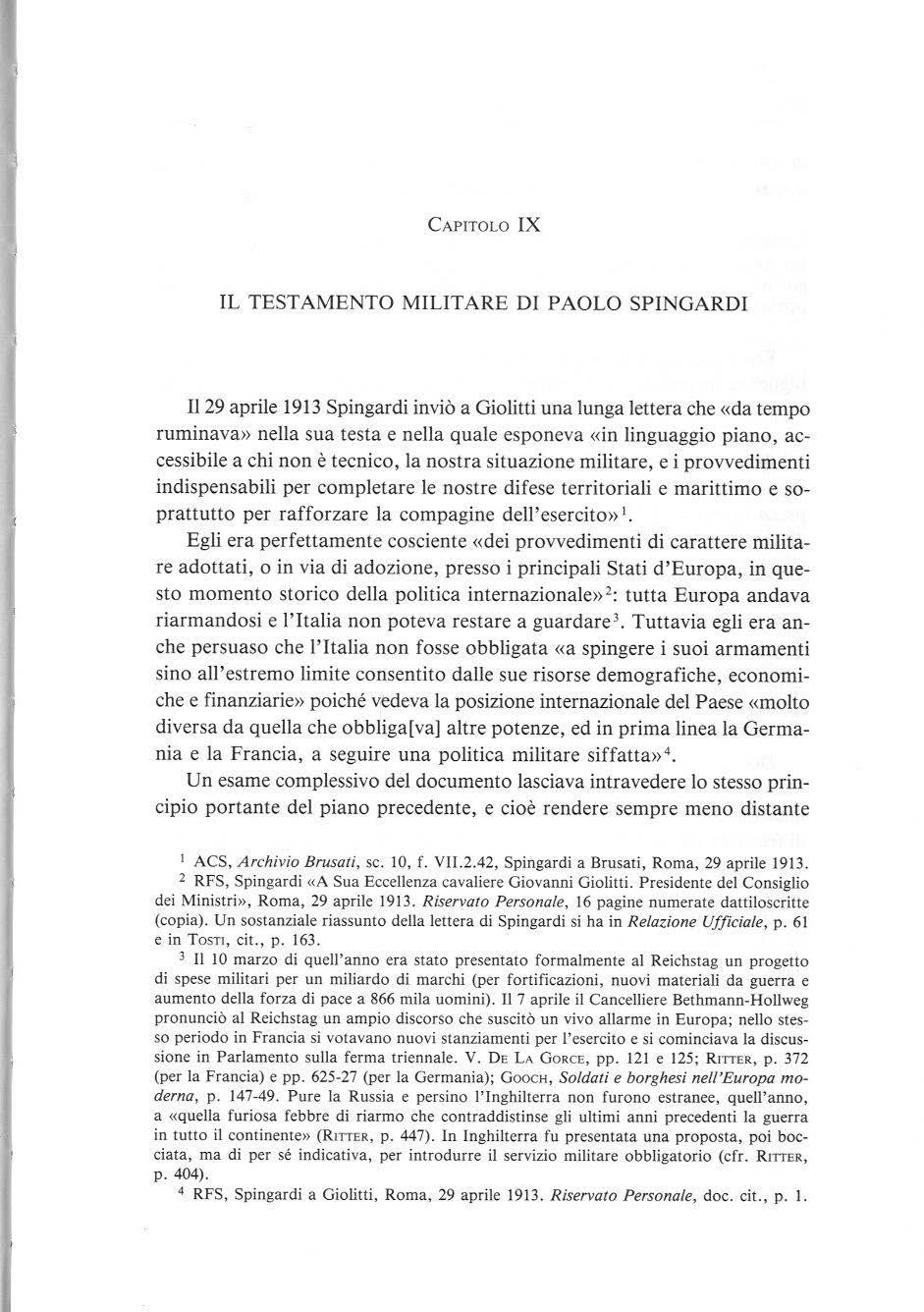
la formazione dell'esercito di pace dall'esercito mobilitato. Per realizzare questo obiettivo Spingardi riteneva sufficiente
consolidare quanto è stato fatto in questi ultimi anni, per r itornare così, al più presto, almeno a quelle condizioni generali di efficienza, che l'Esercito aveva già raggiunto prima della guerra con la Turchia, e che la guerr a ste ssa ha profondamente perturbato 5 •
Era a suo parere un programma modesto e poco «gravoso nelle sue conseguenze finanziarie, sufficiente tuttavia ... a raggiungere al più presto lo sco po che ci proponiamo», un programma derivato da «esigenze reali , constatate e riconosciute» 6 •
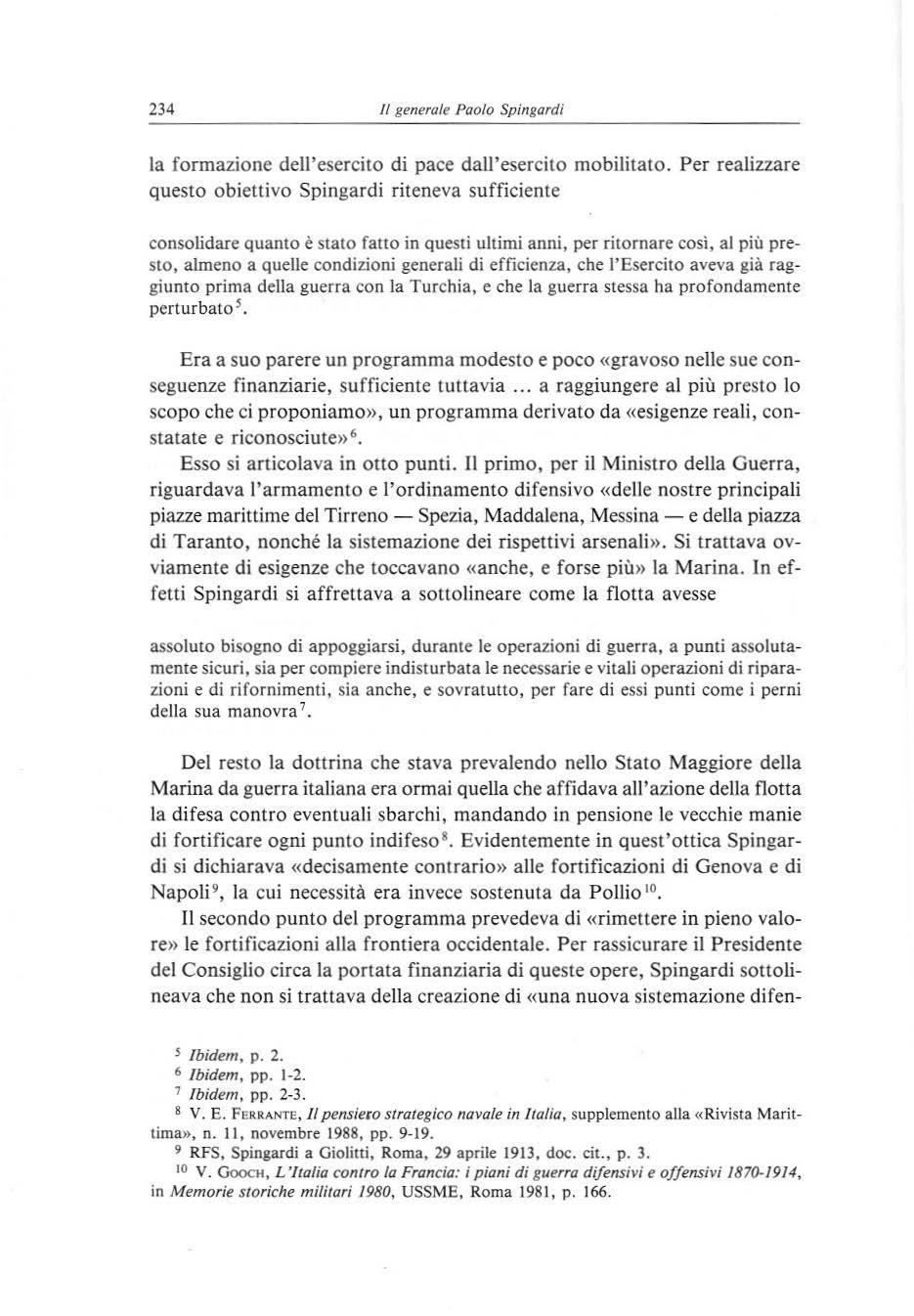
Esso si articolava in otto punti. Il primo, per il Ministro della Guerra, riguardava l'armamento e l'ordinamento difensivo «delle nostre principali piazze marittime del Ti rreno - Spezia, Madd alena, Messina - e della piazza di Taranto, nonché la siste mazion e dei rispettivi arsenali». Si trattava ovviamente di esigenze che toccavano «anche, e forse più» la Marina. In effetti Spingardi si affrettava a sottolineare come la flotta avesse
assoluto bisogno di appoggiarsi, durante le operazioni di guerra, a punti assolutamente sicuri, sia per compiere indisturbata le necessarie e vitali operazioni di riparazioni e di rifornimenti, sia anche, e sovra tutto, per fare di essi punti come i perni della sua manovra 7 •
D el re sto la dottrina che stava prevalendo nello Stato Maggiore della Marina da g uerra italiana era ormai quella che affidava all'azione della flotta la difesa contro eventuali sbarchi, mandando in pensione le vecchie manie di fortificare ogni punto indifeso 8 Evidentemente in quest'ottica Spingardi si dichiarava « decisamente contrario» alle fortificazioni di Genova e di Napoli 9 , la cui necessità era invece sostenuta da Polli o 10 •
Il secondo punto del programma prevedeva di «rimettere in pieno valore» le fortificazioni alla frontiera occidentale. P er rassicurare il Presidente del Consiglio circa la portata finanziaria di queste opere, Spingardi sottolineava che non si trattava della creazione di «una nuova sistemazione difen -
5 Ibidem , p. 2.
6 Ibidem, pp. 1-2.
7 Ibidem, pp. 2-3.
8 V. E. F ER RANTE, Il pensiero strategico navale in Italia, supplemento alla «Rivi sta Marittima», n. Il, novembre 1988, pp. 9-19.
9 RF S, Spingardi a Giolitti, Roma, 29 aprile 1913, doc. cit., p. 3.
10 V. G oocH, L'Italia contro la Francia: i piani di guerra difensivi e offensivi 1870-1914, in Memorie storiche militari 1980, USSME, Roma 1981, p. 166.
234
li generale Paolo Spingardi
siva, come si è fatto per la frontiera orientale, dove non esisteva quasi nulla », ma solo di « opportuni adattamenti e più moderne in sta llaz ioni, da farsi nelle varie opere già esistenti» e che la frontiera orientale era ormai «a buon punto; e se qualche cosa vi sarà da fare ancora, è quasi insignificante di fronte a quello che è stato già fatto » 11 • Questo rinnovato interesse per la frontiera occidentale potrebbe essere conseg uenza del raffreddamento dei rapp orti diplomatici con la Francia seguito alla guerra libica 12 • Già in passato Brus ati e Cadorna avevano di spiegato la loro autorità per sensibilizzare il Mini stro su questa frontiera 13 Sembrerebbe che la decisione, del resto di portata tecnica davvero limitata 14, corrisponda piuttosto all'antico desiderio di sentirsi prote tti su tutti i fronti. Nell'elaborare il programma precedente si erano dovute stabilire delle priorità, si era dovuto scegliere l'a vv ersario più probabile, perché «non c'erano risorse sufficienti per costruire simultaneamente un adeguato sistema di fortificazioni sul confine nordorientale e su quello nordoccidentale>>15 • Ora che l' immane lavoro a oriente era quasi compiuto, si poteva con poca spesa ammodernare le vecchie installazioni a occidente, perché in poli t ica este ra, come nella poli ti ca militare del resto, la prudenza non è mai troppa.
Il terzo punto era il rafforzamento del parco d'ass edio, « cioè di tut t a quella completa organizzazione di artiglierie di medio e di grosso calibro, destinate ad entra r e in fuJ1zione nell'attacco contro le fortificazioni permane n ti» 16 • In base al precedente programma s i st avano completando 10 batter ie di cannoni da 149 mm . , 12 batterie di mortai da 210 mm., 5 batterie di obici da 210 mm., tutti in acc iaio, 7 batterie di cannoni da 149 mm., in g hi sa e 7 batterie di obici da 280 mm. in acciaio 17 • I ntuendo che «un ese rcito che non disponga di tali mezzi di offe sa è de stinato fatalmente ad arrestarsi dinanzi alle fortificazioni >> , Spingardi s i proponeva di sostituire gli
11 Ibidem, pp. 3-4.
12 V. E . D ECLEVA, Da Adua a Sarajevo La politica estera italiana e la Francia 1896-/914, Laterza , Ba r i 1971, pp . 428 -438 .
13 V. AUSSME, F-4 (OM), R. 74, Osservazioni s ulla Memoria del dicem bre 1909 e H-5 C lassificato «RR», R. 12, fasci colo 8, Studi frontiera N -0, del comandante designato della 2• Arma ta.
14 Sulla frontiera orientale erano state costrui te dal nulla un totale di 359 insta llazioni, delle quali 179 erano armate co n cannon i da 149-A, 7 con can n oni da 120 L (lungo), 146 con armamento secondario (canno n i da 87- B e 75 -A rigid i e mitragliatr ic i pesa n t i) e 27 cos titu ivano osservatori corazzati per comandante di batteria. Sulla frontiera occ identale erano previste invece complessivamente 22 installazioni arma te di 149- A , delle quali solo IO costru ite per la prima vo lta. li resto consisteva in ammodernamenti di ope re preesistenti. RFS, Direzione Generale di Artiglieria e Genio. Riassunto dei provvedimenti ecc., doc . cit., « Armamento delle fortificazioni» (provvediment i segnat i coi numeri 44 e 45).
15 D. MACK SMtTH, 1 Savoia Re d'ila/io, Rizzoli, Milano 1992 [ed. or. 1989 ), p. 234.
16 RFS, Spingardi a G io litt i, Roma, 29 ap ril e 1913, p. 4.
17 Deposizione Caporetto, p. 43, Re/azione Ufficiale, p . 103.
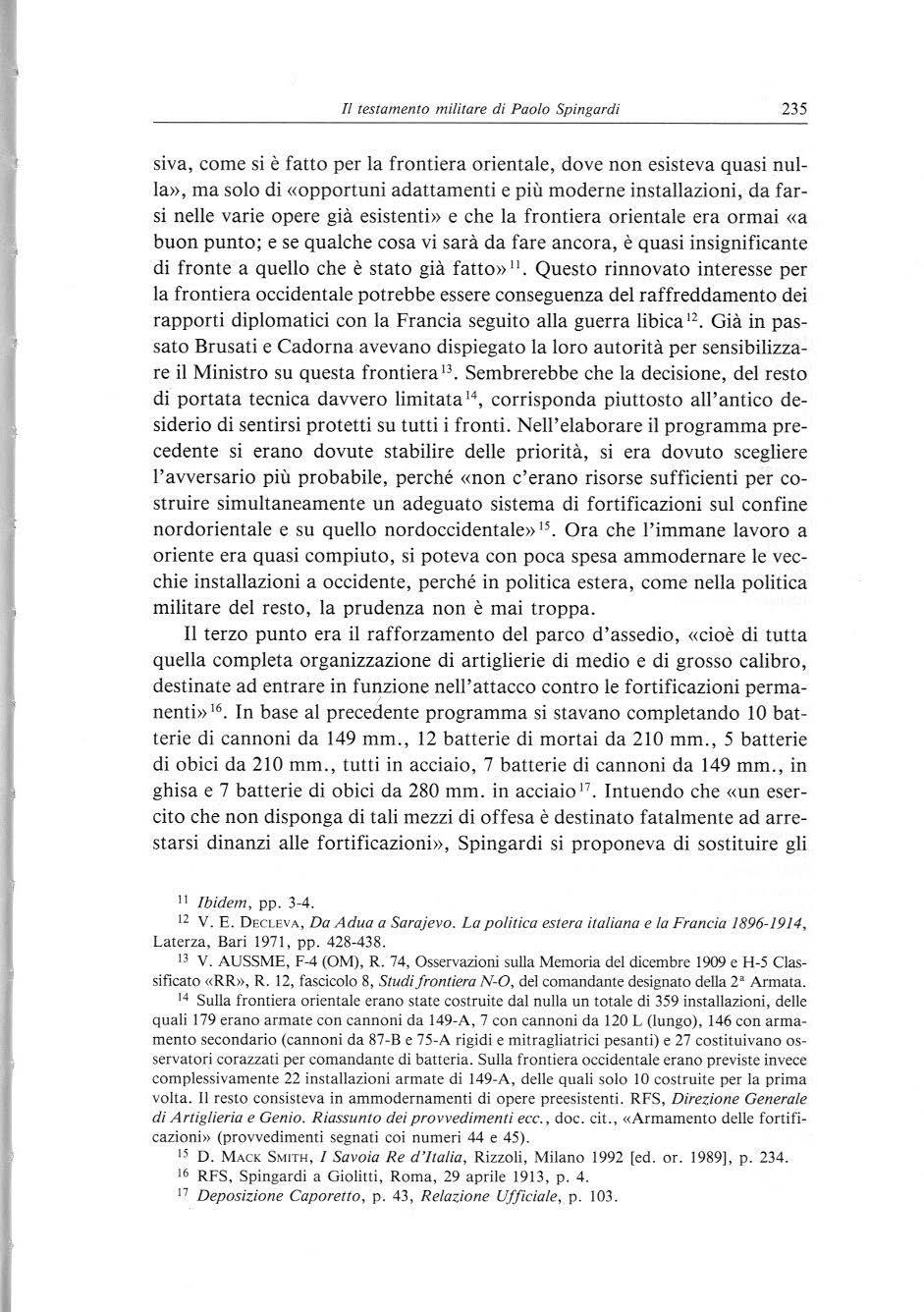
Il testamento mi/ilare di Paolo Spingardi 235
ultimi «antiquati materiali di artiglieria in ghisa, che facevano parte del vecchio parco d'assedio» con moderni materiali in acciaio e di creare alcune nuove «batterie di cannoni e di mortai di grosso calibro, gli uni per colpire di la ncio le opere, gli altri per sfondare le coperture corazzate» 18 • Certo non avrebbe mai immaginato che pochi anni dopo quei grossi calibri avrebbero finito per fare la g u erra campale!
Il quarto punto era un aum en to delle riserve di munizioni «tenuto conto della maggiore celerità di tiro delle moderne a r mi» 19 • Il Mi nistro aveva fatto in modo di portare «in caso di guerra, la produzione dei polverifici e dei laboratori pirotecnici ad un massimo ritenuto sufficiente al rifornimento del1' esercito in campagna», perché, trattandosi di «materie facilmente deteriorabili», non era il caso, egli pensava, di <<esage r are nella quantità delle ri serve preparate sin dal tempo di pace» 20 • Se questo serviva a tranquillizzare Giolitti sulla moderata portata finanziaria della questione, è anche un segno inequivocabile che Spingardi immaginava una guerra assai lontana nel tempo .
«Una quinta es igenza finalmente, pure di carattere straordinario ed urgente» era la sistemazione della flotta aerea cercando di venire incontro ai deside ri del colonnello Mòris 21 • Spingardi si augurava anche di realizzare
un vagheggiato progetto di una società italiana per costruzioni areonautiche, che si istituirebbe in Milano; i nomi dei cui promotori (Senatori Colombo, Mangili, Pirelli etc.) darebbero affidamento certamente maggiore di quello che potrebbero dare, in tal genere di produzioni, gli stabilimenti di S t ato 22 •
18 Ibidem, p. 5
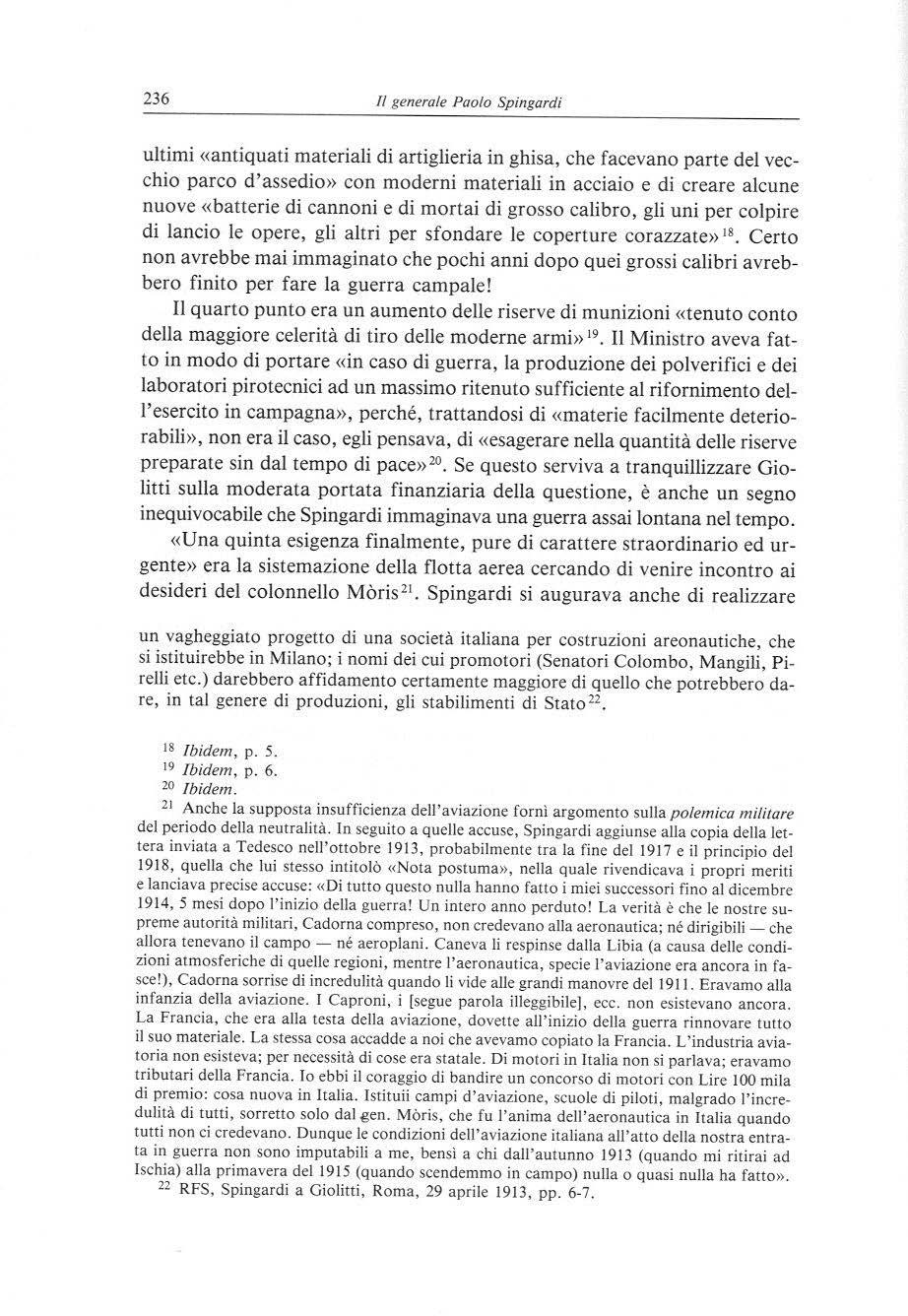
19 Ibidem, p. 6.
20 Ibidem.
21 Anche la supposta insufficienza dell'aviazione fornì argomento sulla polemica mi/ilare del periodo della neutralità. In seguito a quelle accuse, Spingardi aggiunse alla copia della lettera inv ia ta a Tedesco nell'ottobre 1913, probabi lmente tra la fine del 19 17 e il principio del 1918, quella che lu i stesso int itolò «Nota postuma», nella quale rivendicava i propri meriti e lanciava precise accuse: « Di tutto quesw nulla hanno fatto i miei successori fino a l dicembre 1914, 5 mesi dopo l'inizio della guerra! Un intero anno perduto! La verità è che le nostre supreme autorità militari, Cadorna compreso, non credevano al la aeronautica; né dirigibili - che allora t e ne vano il campo - né aeroplani Caneva li respinse dalla Libia (a causa delle condizioni atmos feriche di quelle regioni, mentre l'aeronautica, specie l'aviazione era ancora in fa. sce!) , Cadorna sorrise di incred u lità quando li v ide alle grandi manovre del 1911. Eravamo alla infanzia del la aviazione. l Caproni, i [segue parola illeggibile], ecc. non esis tevano ancora. La Francia, che era alla testa della aviazione, dovette all'inizio della guerra rinno vare tutto il suo materiale. La stessa cosa accadde a noi che avevamo cop iato la Francia . L'industr ia aviatoria non esisteva; per necessità di cose era statale. Di motori in Italia non si parlava; eravamo tributari della Francia . lo ebbi il coraggio di bandire un concorso d i motori con Lire 100 mila di premio: cosa nuova in Italia. Istituii campi d'aviazione , sc uole di piloti, malgrado l'in credulità di tutti, so rretto solo da l gen. Mòri s , che fu l'anima dell'aeronautica in Italia quando tutti non ci credevano Dunque le condizioni dell'aviazione ita liana all'atto della nostra entrata in guerra non sono imputabi li a me, bens ì a chi dall'autunno 1913 (quando mi ritirai ad Ischia) alla primavera del 1915 (quando scendemmo in campo) nulla o quasi nulla ha fatto>) , 2 2 RFS, Spingard i a Giolitti, Roma, 29 aprile 1913, pp. 6-7
236
li generale Paolo Spingardi
Si proseguiva insomma nel tentativo di creare una industria militare italiana che svincolasse sempre più dalle commesse all'estero.
Gli ultimi tre punti toccavano più particolarmente il bilancio ordinario e il più importante e necessario era l'aumento della forza bilanciata che Spingardi voleva assolutamente portare «col prossimo bilancio, da 250 a 275 mila uomini almeno; con che le compagnie di fanteria potranno avere la forza media di una novantina di uomini». La tendenza era a raggiungere in seguito «una forza bilanciata di non meno di 300 mila uomini» 23 • Complementare al provvedimento era l'aumento del contingente annuo, che avrebbe portato maggiori riserve di complemento, a sua conseguenza il rafforzamento dei nuclei di milizia mobile fino a dare loro la consistenza organica di ve ri e propri quarti battaglioni all'interno dei reggimenti È particolarmente indicativo come su questo punto il confronto fosse fatto esclusivamente con l'Austria -Ungheria:
In caso di guerra l' Austria-Ungheria mobilita 48 di visioni di fanteria; noi ne mobilitiamo 35, cioè stiamo nella proporzione di poco più di 2 a 3 rispetto alla prima. Devi però considerare che, mentre le 48 divisioni mobilitabili dall'Austria-Ungheria sono tutte permanenti, cioè hanno già sin dal tempo di pace un organismo più o meno completo e perfetto, noi possiamo dire lo stesso soltanto a riguardo di 25 divisioni, le quali sono permanenti (compresa quella della Sardegna) mentre altre 10 sono di MILIZIA MOBl LE, sono formate cioè con quadri esiste nt i in parte presso i reggimenti, ed in parte richiamati dal congedo 24 •
Il Ministro faceva i propri calcol i e confronti con il pensiero sempre rivolto alle 35 divisioni dell'esercito mobilitato. Appare chiaro che se i provvedimenti non erano sufficienti a portare l'esercito italiano ai livelli tedeschi o francesi, consentivano però di avvicinarlo all'esercito austro -ungarico. Ma il provvedimento che meglio di tutti avrebbe consentito al Ministro della guerra di risolvere «la situazione veramente critica di fo r za» in cui si trovava allora l'esercito italiano, era la
sistemazione militare della Libia, nel senso di renderla del tutto staccata e indipendente dall'esercito della Madrepatria, per modo che questo possa essere perfettamente reintegrato s ia nei suoi effettivi di pace, sia in tutti quegli organi e mezzi che ne ass icurano la mobilitazione 25 •
23 ibidem, p. 10. Esigenza questa davvero sentita da Spingardi, tanto che era ribadita nella lettera a Bru sati del 29 aprile: « Non ho concretato cifre, ma penso che non si andrà oltre a 150 milioni (Pollio crede meno) di spese straordinarie e 25 milioni di aumento al bilancio ordinario per avviarci alla forza bi lanciata di 300 mila uomini»
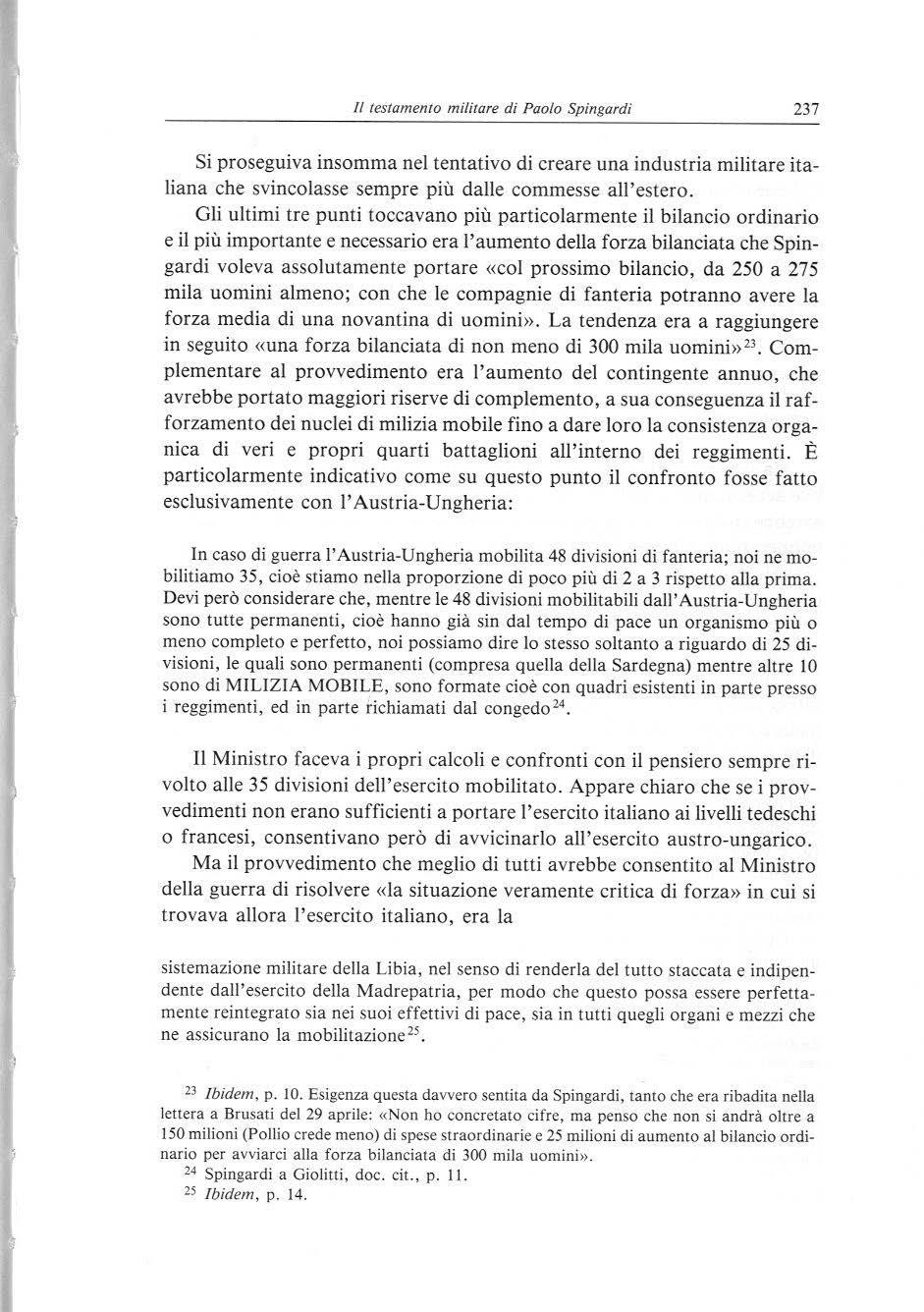
24 Spingard i a Gio litti, doc. cit , p. 11.
25 ibidem, p. 14.
li testamento militare di Paolo Spingardi 237
Spingardi
Erano ormai trascorsi cinque mesi dalla creazione del Ministero delle Colonie e Spingardi si augurava perciò che esso avesse acquisito sufficiente solidità per farsi carico delle spese per il mantenimento del corpo di occupazione, permettendo così di aumentare la forza bilanciata ad esclusivo vantaggio dell'esercito metropolitano.
L'ultimo punto, giudicato «essenziale», riguardava le ferrovie. Il sogno di Spingardi era di avere
sia per la radunata verso la frontiera N .E sia per quella verso la frontiera N .O. una ferrovia indipendente per ogni corpo d'armata, come l'hanno per esempio la Germania e la Francia, e come tende ad averla l'Austria-Ungheria 26
Ma non potendo realizzare questo, egli si accontentava di «ogni possibile acceleramento delle nuove costruzioni ferroviarie già deliberate>>, che av rebbe costituito comunque «una grande facilitazione, una vera risorsa per le operazioni dell'esercito in caso di mobilitazione» 27 •
«Ho preferito di non precisare per ora alcuna cifra circa il fabbisogno» concludeva Spingardi, «nell'intento di attendere che i singoli progetti siano concretati, il che sarà presto» 28 • L'elaborazione dei piani di spesa richiese invece parecchi mesi.
Prima di tutto si dovette riunire la Commissione Suprema Mista per la di fesa dello Stato, come richiesto dallo stesso Spingardi29, per concretare il nuovo programma di fortificazioni. L a commissione venne convocata fra il 19 e il 24 maggio 1913.
Genova sarà il pomo della discordia - prevedeva Spingardi -e temo che Pollio abbia acquisito alla sua causa molti che prima non erano, come p. es Caneva, e temo anche Revel 30 . • • [Revel] si preoccupa che 10-I 5 mila uomini, una divisione francese, possa nei primi giorni della mobilitazione sbarcare a Genova e far sentire la sua azione nella va lle del Po. Più tardi la nostra flotta, egb dice, sarebbe in grado di intervenire ad impedire qualsiasi maggiore tentativo di sbarco. Quindi le funzioni di Genova dovrebbero essere ridotte ad impedire - non un bombardamento - ma uno sbarco, ripeto nei primissimi giorni, di una forza
26 Ibidem
2 7 Ibidem, p. 15. Si è già fatto cenno a queste ferrovie nel capitolo Il. V. anche O. Bov10, Le ferro vie iialiane nella prima guerra mondiale, i n Siudi s1orico militari /986 , US SME , Roma 1987, pp 209-234
28 ibidem, p. 16.
29 Spingardi aveva espresso a ,G iolit ti, nella lettera del 29 apr il e, la sp eranza c he «s i pos sa quant o prima riunire sotto la t ua P res id e n za la Commissione s uprema d i difesa, per decidere i l da fa rs i>) (p. 3. Il concetto er a ribadi to i n chiu sura, p. 15). La Commissione s i era r iunita l ' ultima vol ta nel 1908
30 Paolo Thaon d i Revel fu Capo di Stato Maggiore della Mar i na dall'aprile 1913 all'o ttobre 1915.
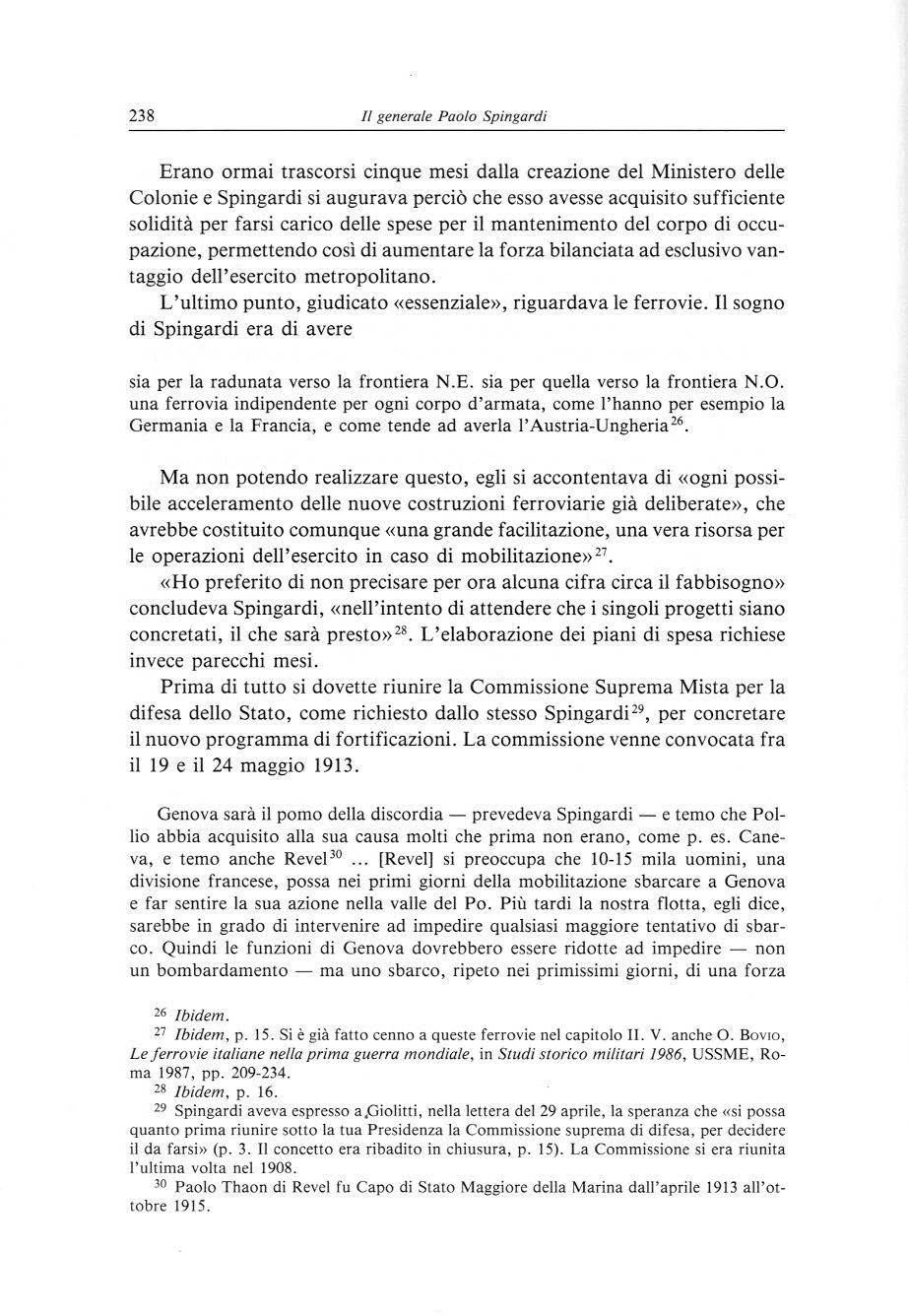
238
li generale Paolo
che egli valuta a non più di una divisione. Ma allora, ben venga questa divisione in trappola 31 •
Se queste argomentazioni valsero a dare a Spingardi la vittoria sulla questione di Genova 32 , l'andamento delle discussioni lo del us e per la cattiva impressione che i militari diedero in presenza del Presidente del Consiglio 33 • Tuttavia al termine dell'ultima seduta Giolitti diede comunque l'assicurazione che
il Governo da parte sua farà tutto il possibile. Per proprio conto rit iene che il miglior sistema sia quello di non fare assegni straordinari, ma di aumentare gradatamente quelli ordinari, poiché le leggi straordinarie danno una sp inta momentanea alla quale poi succede inevitabilmente una sosta 34 •
In tale occasione si deliberò una spesa di 200 milioni circa per attuare alcuni dei punti del programma 35 • Nelle settimane successive, la nuova legge sul reclutamento e i primi provvedimenti per le truppe coloniali venivano a rappresentare in qualche modo le basi indispensabili per il futuro 36 •
31 ACS, Archivio Brusati, se. IO, f. VII.2.42, Spingardi a Brusati, Roma 17 maggio 1913.
32 Ibidem, Spingardi a Brusati 20 maggio 1913: «Come sapra i, la discussione di stamane si è chiusa con voto a grande maggioranza (6 contro 3) contrario alle fortificazioni di Genova , per le quali avevano votato i due capi di stato maggiore e l'ammiraglio Amero d' Aste».
33 Ibidem, se. 10, f. VTI.2.42, Spingardi a Brusati, Roma , 22 maggio 1913: «La discuss ione della Commissione di difesa non procede bene; tutti ne escono un poco sminuiti, e me ne duole per la presenza del Presidente, non tenero, come sai, per generali e ammiragli. Vengono in luce delle indecisioni, delle i nd eterminatezze, anche da parte dell'Autorità proponente, che non ha potuto andare sul posto per decidere, che si riserva ecc. ecc. Fra altro nuoce vedere i capi di stato maggiore dell'Esercito e dell'Armata soccombenti dinanzi al voto contrario di generali e ammiragli. Io non assisterò più ad altre riunioni in avvenire, e del resto il Min istro non ha voto, ma penso c he prima della riunione plenaria il Capo di Stato Maggiore dovrebbe riunire lui i comandanti d'armata, discutere, decidere in conformità della opinione prevalente dopo maturo studio e prospettare quindi soluzioni concrete in sé e nelle conseguenze. Ma così non va, ripeto, ci si perde tutti !».
34 AUSSME, Commissione Suprema Mista per la difesa dello Stato, Sessione del mese di maggio 1913, verbale della 4 ' seduta, p. 15, cit. in R. CR uccu, L'esercito nel periodo giolitiìano, p. 266.
35 RFS, Deposizione Caporerto, p. 8: «Questa lettera [quella del 29 aprile] trovò in massima l'assentimento del Capo del Governo. Conscio delle necessità del momento, nel maggio successivo egli convocava la Commissione Suprema della difesa nazionale e più che 200 milion i furono deliberati per taluni ti toli di spesa sopra enunciati: sistemazione delle piazze marittime, comp letament o delle frontiere terrestri, aumento del parco d'assedio, aumento del munizionamento, flo t ta aerea , riservando di concretare in un progetto definitivo, d'accordo col Capo di S.M. dell'Esercito , le rimanenti somme che sarebbe occorso chiedere al Parlamento per completare tutti i lavori». E v anche minuta di lettera a destinatario sconosciuto [Brusati? ], s.d. ma tra il 12 e il 23 marzo 191 4: <<Quanto alle spese straordinarie, leggi i verbali della Comm mista di difesa presieduta da Giolitti (maggio 1913) e troverai i famosi 200 milioni . . . che Giolitti aveva in massima accettato (cfr. Relazione Ufficiale, p. 62).
36 Cfr. cap. VIII, pp. 189- 194.
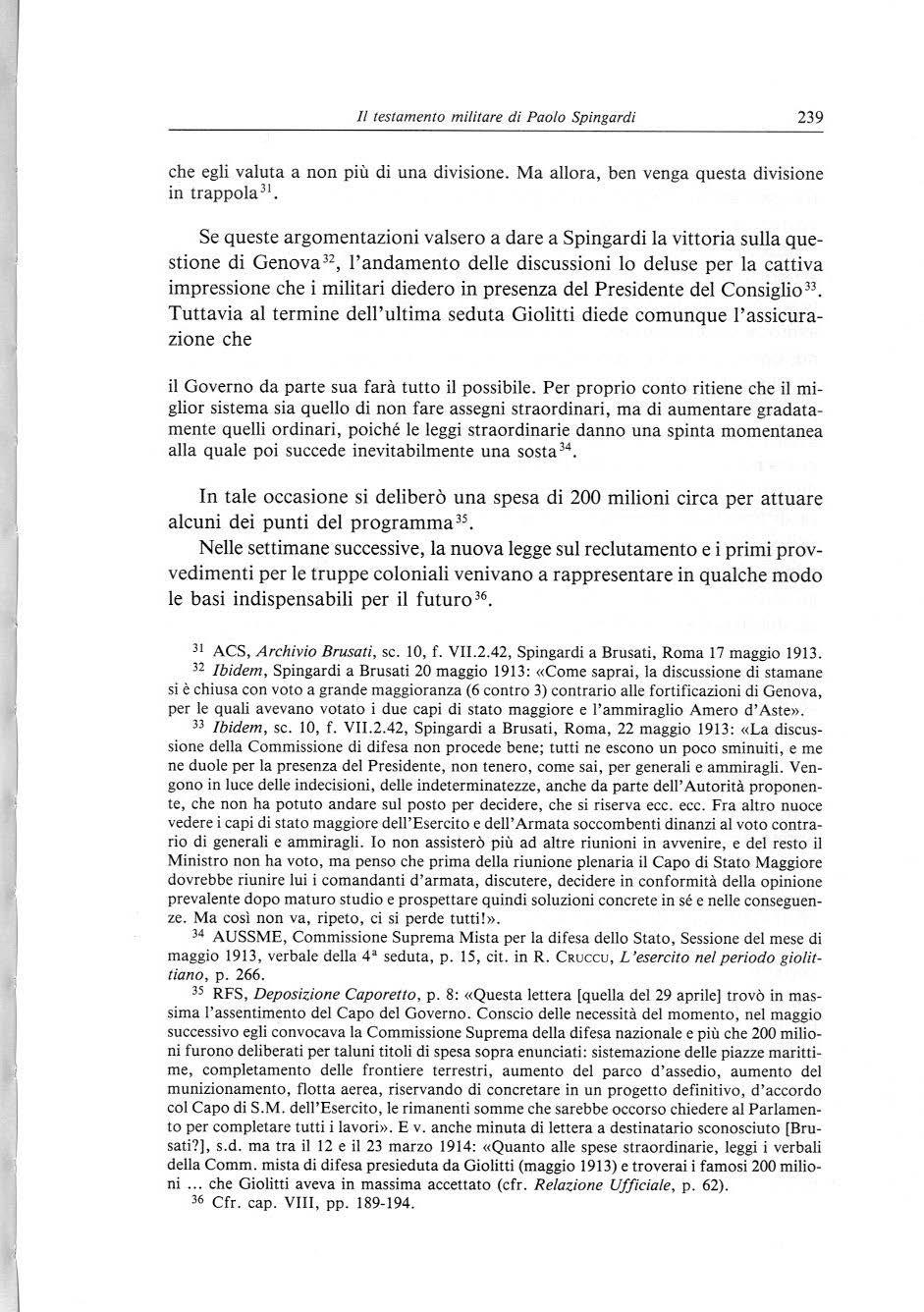
1 Il festamenro militare di Paolo Spingardi 239
Ma passarono altri mesi prima che il programma venisse tradotto in cifre, probabilmente perché «lo spauracchio delle elezioni generali» costituì «ostacolo insormontabile» 31 •
Chiusa da Giolitti la Camera a metà giugno, Spingardi ebbe tempo per effettuare una serie di isp ezioni e controlli che gli stavano particolarmente a cuore. Visitò dapprima le fortificazioni verso l'Austria, come si è già avuto modo di ricordare, e fu anche al campo -scuola d'aviazione di Aviano, dove incontrò il comandante del battaglione aviatori, l'allora maggiore Giulio Douhet 38 • Il 6 settembre si recò a Baggio, presso Milano, per partecipare di persona al collaudo del di r igibile «Città di Milano» dell'ingegner Forlanini, che lo avrebbe poi ceduto all'esercito . Spingardi prese posto nella navicella e fece un volo sulla città, dichiarandosi alla fine soddisfatto 39 Dopo alcuni giorni trascorsi con la moglie e i figli n ella dimora di Spigno Monferrato, l' 11 settembre arrivò a Torino per ispezionare i siti delle nuove opere sulla frontiera occidentale . Il 13 settembre si recò, a dorso di mulo, accompagnato da una folta comitiva composta tra gli altri dal generale Roberto Brusati comandante del I Corpo d'Armata, dall'Ispettore del Genio, generale Lorenzo Bonazzi, e dal Direttore generale di Artiglieria e Genio, Alfredo Dallolio, a esaminare in Valle d' Aosta il forte di testa d' Arpy. Qui era previsto il lavoro più impegnativo e costoso del programma per la frontiera occidentale: la messa in opera di 6 cannoni da 149- A in postazioni corazzate, a sbarramento di un eventuale sbocco del nemico dal passo del Piccolo San Bernardo. Sulla via del ritorno il mulo ebbe uno scarto, e Spingardi venne rovinosamente sbalzato a terra, battendo il capo e procurandosi un'abrasione a un piede. Subito soccorso, le sue condizioni non apparvero gravi, e dopo un breve riposo si presentò al Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1913 40 Però, forse presagendo l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, cercò febbrilmente di arrivare a concretizzare il nuovo piano di ria rmo. Si mise al lavoro insieme a Pollio per indicare con precisione le somme occorrenti.
Gli studiosi hanno generalmente affermato che Pollio stilò tre programmi: uno massimo, comportante la spesa di 551 milioni per la parte straordinaria e l'aumento di 85 milioni annui per quella ordinaria; uno ridotto di
37 ACS, Archiv io Brusati, se. 10, f. VIl.2.42 , Spingardi a Brusati , Roma, 29 aprile 1913, doc. cit.
38 V. «L'Esercito italiano», 4 luglio 1913.
39 L 'on. Ministro della Guerra a Milano, «L'Eserci to italiano», 7 settembre 1913 e IO settembre 1913.
40 V. «L'Esercito italiano » , 14, 17 e 28 settembre 1913.
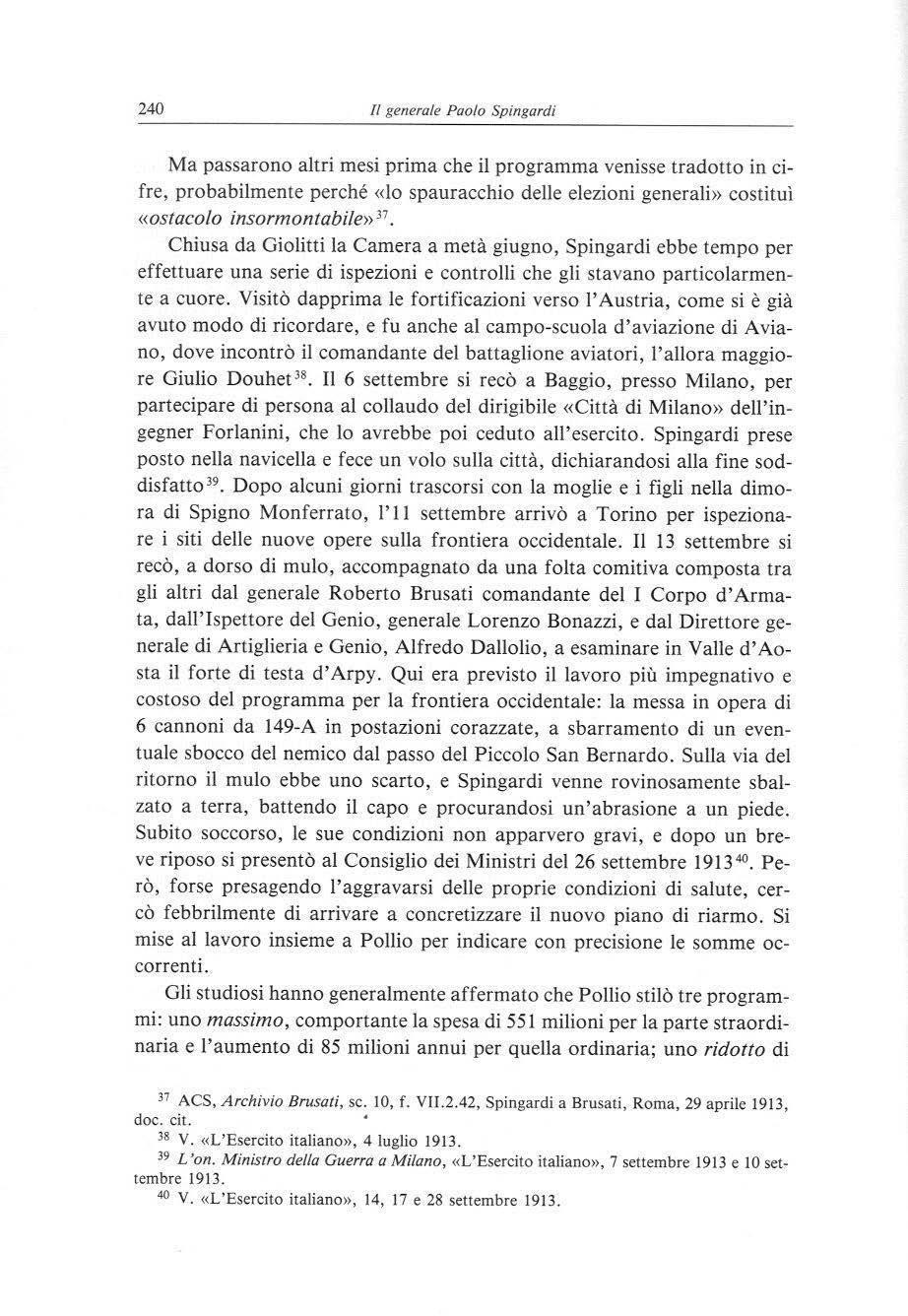
240 l i
generale Paolo Spingardi
•
474 e 70 milioni rispettivamente; e uno minimo di 402 e 58 milioni 41 ; il programma minimo fu in ogni caso l'unico preso in considerazione da Spingardi per le sue richieste al Ministro del Tesoro, e l'unico sottoposto al giudizio di quest'ultimo, che più tardi, malato Spingardi, chiese a Pallio una ulteriore riduzione, chiamata dal Capo di S.M. programma pratico. Spingardi espose parzialmente le sue richieste già n el Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1913, ottenendo però da Tedesco la risposta che «a meno di presenta r e il bilancio in disavanzo [il Tesoro] non può consentire aumenti» 42 • Da parte sua Spingardi non voleva «assolutamente rinunciare al progettato aumento della forza bilanciata, e scendere sotto ai 25 mila uomini, di fronte alle cent inaia di migliaia di Francia e Germania e ai 50 mila dell'Austria, sarebbe semplicemente ridicolo» 43 • Spingardi non esitò ad invocare a mezzo di Brusati «l'alto patrocinio di S.M. il Re Se S M il R e volesse degnarsi di spendere benevolmente una parola con Giolitti la vittoria sarebbe assicurata» 44 • Il 2 ottobre Brusati lo informava che «S.M il Re ha tenuto parola a S E Giolitti delle nuove somme che ti occorrerebbero per dare conveniente assetto all'esercito. Giolitti non si è pronunciato, ma si è dimostrato favorevolmente disposto a secondarti» 45 •
F orte di questo appoggio, Spingardi otteneva quanto deside r ato:
Ne sono uscito un poco con le ossa rotte, ma ho vinto. Tedesco esce in questo momento da me, e, dopo lunga discussione, mi ha concesso i 25 mila uomini di forza bilanciata, e circa 5 milioni di altre maggiori spese; totale 16 milion i. Sono pochi, di fronte ai 28 che io c hi edevo, ma fu vittoria insperata 46 •
Nel bilancio 1914-15 venne infatti impostata la forza richiesta da Spingardi47.
Pollio proseguì gli studi sulle cifre necessarie alla realizzazione del nuovo programma, e il 16 novembre informava Spingardi che
41 Gli autori si rifanno tutti sol itamente alla Relazione Ufficiale, pp. 61-63, che fornisce molti particolari Seguono, in ordine cronologico: TOSTI, Storia dell'esercito italiano, cit., pp. 163-164; R OCHAT , L'esercito italiano nefl'es1a1e del 1914, cit., p 314; CR uccu, cit., p. 266, STEFANI , cit., p. 572; GoocH, Army, State and Society, cit., p. 153
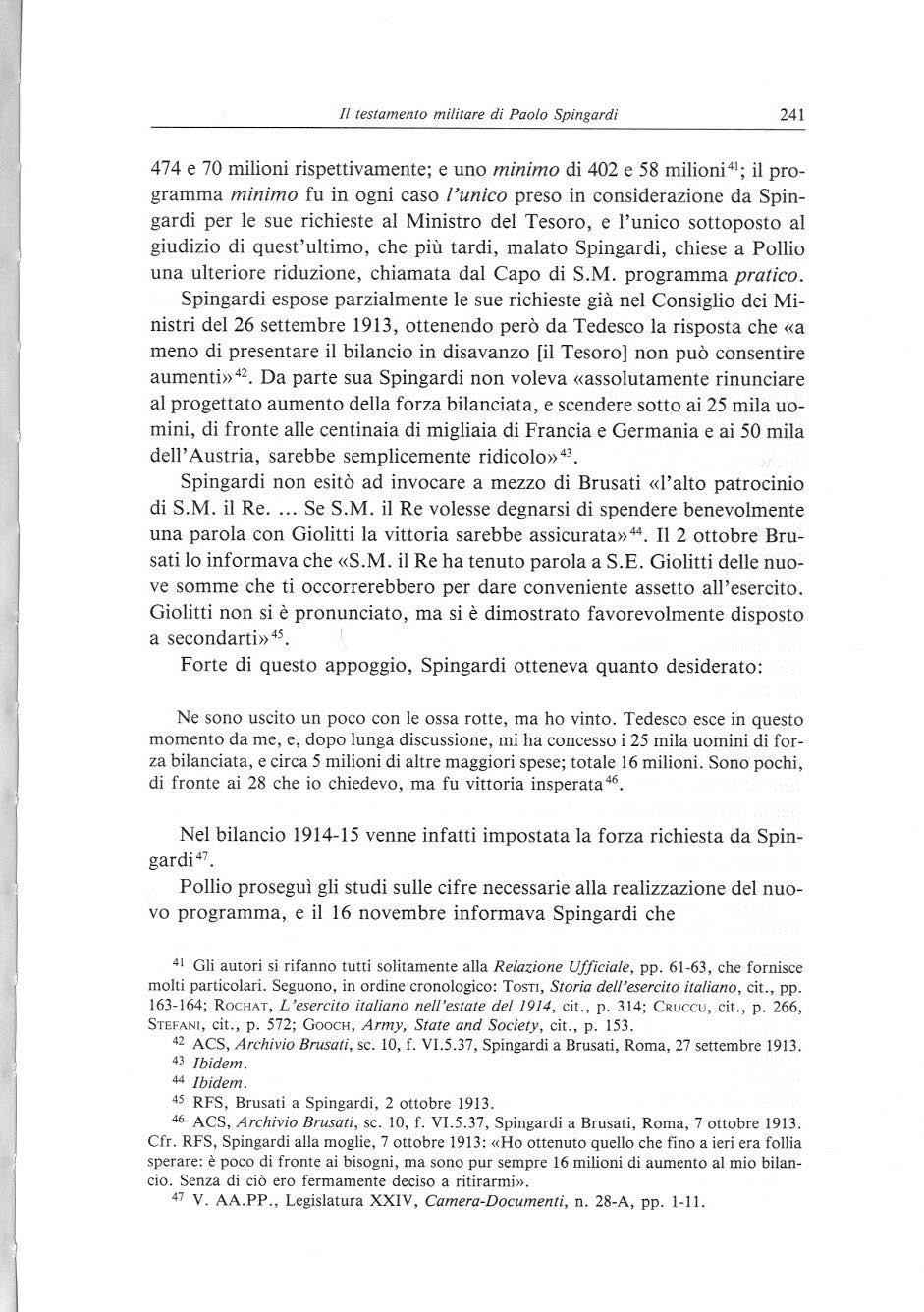
42 ACS, Archivio Brusati, se. IO, f. VJ.5.37 , Spingardi a Brusati, Roma, 27 settembre 1913.
43 Ibidem
44 Ibidem.
4 5 RFS, Brusati a Spingardi, 2 ottobre 1913.
46 ACS , Archivio Brusati , se. 10, f. VI.5.37, Spingardi a Brusati, Roma , 7 ottobre 1913 .
C fr. RFS, Spingardi alla mog lie, 7 ottobre 1913 : «Ho ottenuto quello che fino a ieri era follia sperare: è poco di fronte ai bisogni, ma sono pur sempre 16 milioni di aumento al mio bilancio Senza di ciò ero fer mamente deciso a ritirarmi»
47 V. AA.PP., Legislatura XXIV , Camera -Documenti, n. 28-A, pp. 1-1 1.
Il 1estamen10 militare di Paolo Spingardi 241
Il generale Paolo Spingardi
solo fra qualche giorno potrò mandarti il lavoro completo relativo al programma militare. Ho dovuto far cambiare e far rifare mo lte cose. Ad onta di tutto lo studio fatto per rimanere in limiti modesti, pure il totale oltrepasserà i 400 milioni, compresa la spesa approvata in ma teria nelle ultime sue sedute dalla Comm .ne Suprema di difesa 48 •
Ma Spingardi aveva fretta e due giorni dopo Pellio gli presentava un programma nel quale si era sforzato di rimanere in limi ti modesti. Ciononostante, doveva ammettere che
il totale delle spese che importerebbe l'attuazione del mio programma è impressionante. Vi possiamo però fare una riduzione sensibile, rinunziando all'ordinamento delle batterie su 4 pezzi, almeno per ora. Io l' ho compreso, avendo sap u to che era anche nei tuoi desideri 49 •
Il giorno successivo Pallio comunicava i risparmi che tale rinunc ia avrebbe permesso di ottenere: 15 milioni sulla parte ordinaria e 46 milioni sulla parte straordinar ia del bilancio.
Sarebbero dunque 61 milioni circa, da togliere dal programma spedito iersera È certo che conviene avere le batterie a 4, anziché a 6 pezzi. Però non possiamo ora spendere 61 milioni per avere questo vantaggio. È consig liabile - tutto compreso - rimandare a miglior tempo la riforma, e togliere i 61 milioni del programma prossimo 50 •
Riducend o ancora, il 3 dicembre 1913 il Capo di Stato Maggiore inviava al Ministro un definitivo Riepilogo degli aumenti complessivi da apportare al bilancio della guerra, che prevedeva un aumento di 58.302.000 lire per la parte ordinaria e 402 . 180. 000 lire per la parte straordinaria. Per limitare le richieste di fondi a queste cifre, Pallio apportò le seguenti riduzioni al programma completo:
1) Per quanto riguarda il riordinamento de!J'esercito: a) rinun cia al passaggio delle batterie su 4 pezzi; b) rinuncia all'attuazione comp leta del programma relativo alle mitragliatrici, già concordato col Ministero; c) limitazione dei nuclei di Milizia Mobile di fanteria e della loro forza, ridotta alla metà; d) limitazione della forza delle compagnie alpine a 180 uomini; e) costituzione delle dotazioni di armamento e di vestiario della Milizia Terr itoriale sulla base di compagnie della forza di 200 uomini, anziché di 250.
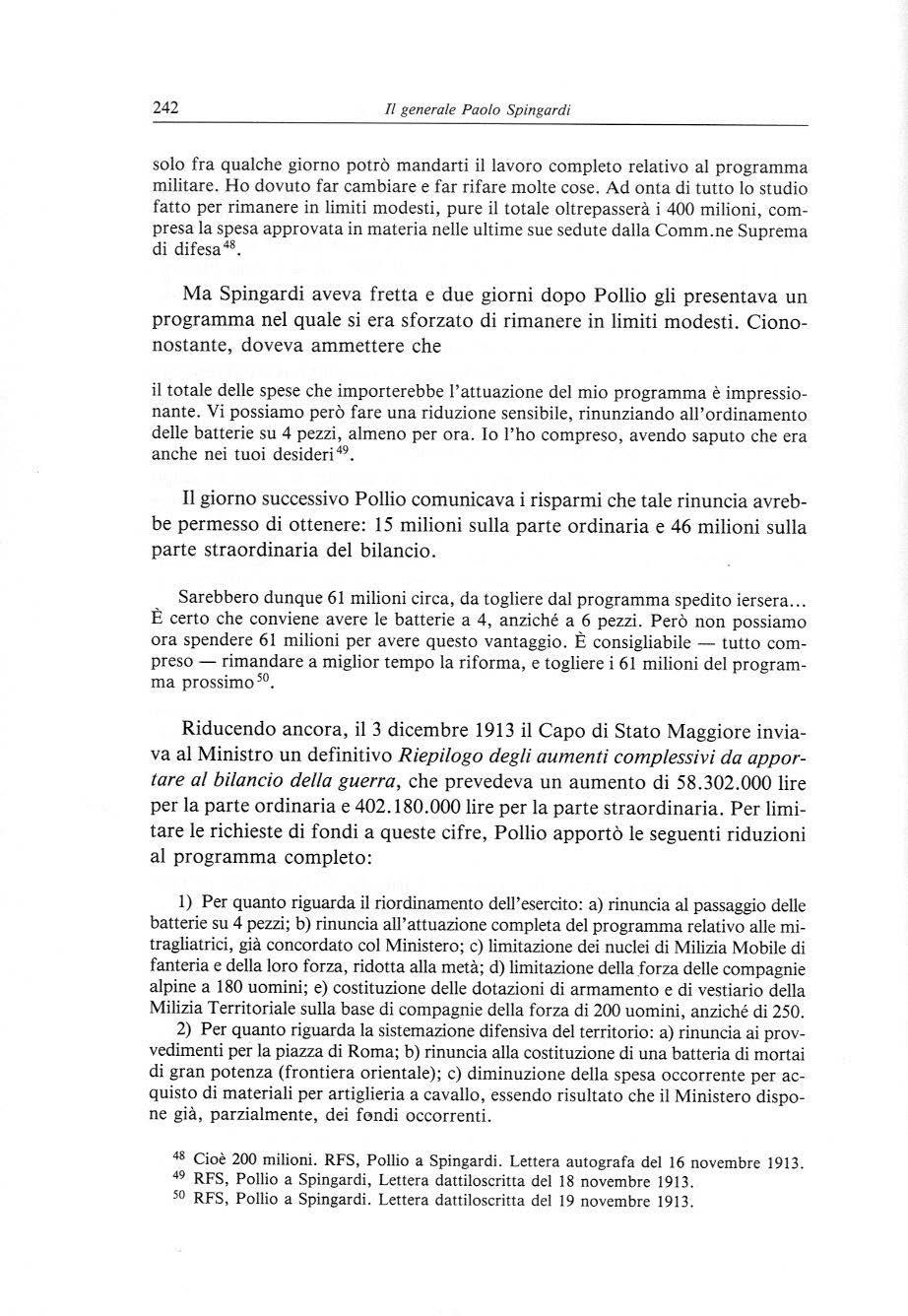
2) Per quanto riguarda la sistemazione difensiva del territorio: a) rinuncia ai provvediment i per la piazza di Roma; b) rinuncia alla costituzione di una batteria di mortai di gran potenza (frontiera orientale); c) diminuzione della spesa occorrente per acquisto di materiali per art iglieria a cavallo, essendo risultato che il Ministero dispone già, parzialmente, dei fondi occorrenti
48 Cioè 200 milioni. RFS, PoUio a Spingardi. Lettera au tografa del 16 novembre 1913.
49 RFS, Pallio a Spingardi, Lettera dattiloscritta del 18 novembre 19 13.
so RFS, Pallio a Spingardi. Lettera dattiloscritta del 19 novembre 1913.
242
3) Per quanto riflette i servizi in genere: a) limitazione della riserva dei colpi da 75 mod. 906 a 200 per pezzo; b) rinuncia alla costituzione, fin dal tempo di pace, della seconda razione di scatolette di carne in conserva; c) riduzione della somma occorrente per vestiario, tenendo conto che potrà essere parzialmente utilizzato quello attualmente in distribuzione alla 2• categoria di prossimo congedamento; d) stralcio della spesa occorrente per l'acquisto di 150 forni someggi abili, essendo risultato che il Ministero dispone già dei fondi necessari; e) limitazione dell 'aumento dei colpi per ciascun cannone da 65 mont. a 600; f) limitazione dell'aumento dei colpi per artiglieria pesante campale a 300 colpi per pezzo; g) rinuncia all'impianto di un nuovo panificio a Fossano e di un pastificio ad Aldifreda ed al miglioramento dei vari panifici territoriali; h) rinuncia alla sistemazione di SiJos per l'avena di riserva; i) rinuncia alla costituzione di depositi esplosivi di riserva.
Pallio concludeva proponendo di aumentare gradatamente la spesa ordinaria impostando 20 milioni in più ne l primo esercizio, IO milioni in più del primo nel secondo, 15 in più del secondo ne l terzo e 13 milioni in più del terzo nel quarto . Pensava poi di dividere equamente la spesa straordinaria fra i quattro esercizi finanziari . Nel fabbisogno non erano compresi 30 milioni per la flotta aerea 51 • Si era infine arrivati esattamente alle cifre di quello che la storiografia ha battezzato programma minimo 52 •
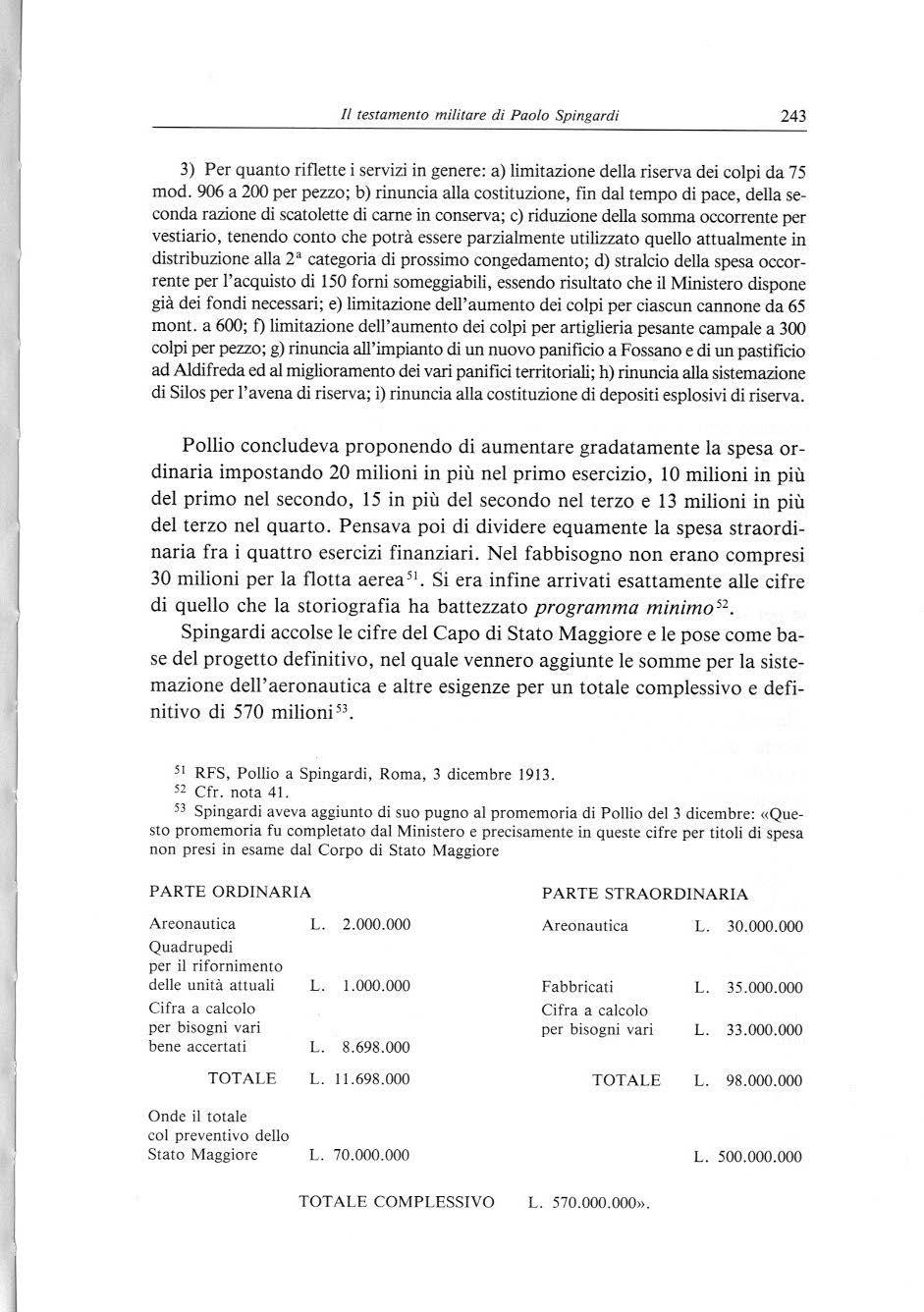
Spingardi accolse le cifre del Capo di Stato Maggio r e e le pose come base del progetto definitivo, ne l quale vennero aggiunte le somme per la sistemazione dell'aeronautica e altre esigenze per un totale complessivo e definitivo di 570 milioni 53 •
51 RFS, Pollio a Spingardi, Roma, 3 dicembre 1913.
52 Cfr. nota 41.
53 Spingardi aveva aggiunto di suo pugno al promemoria di P ollio del 3 dicembre: «Questo promemoria fu completato dal Ministero e precisamente in queste cifre per t itoli di spesa non pres i in esame dal Corpo di S tato Maggiore
// testamento militare di Paolo Spingardi 243
PARTE ORDINARIA PARTE STRAORDINARIA Areonautica L. 2.000.000 Areonautica L. 30.000.000 Quadrupedi per il rifornimento delle unità attuali L. J.000 .000 Fabbricat i L. 35.000 000 Cifra a calcolo Cifra a calcolo per bisogni vari per bisogni vari L. 33.000.000 bene accertati L. 8 698.000 TOTA LE L. 11.698 .000 TOTALE L. 98.000.000 Onde il totale co l preventivo dello Stato Maggiore L 70.000.000 L. 500.000. 000
TOTALE COMPLESSIVO L. 570.000.000».
Il generale Paolo Spingardi
La cifra è confermata da Giolitti nelle sue Memorie:
Negli ultimi mesi del mio ministero, fra me e il ministro del Tesoro, il ministro della Marina ed il capo di Stato Maggiore, generale P ollio, si era stabilito un piano di provvedimenti che importava una spesa straordinaria di 500 ed ordinaria di 70 milioni da portare in aumento al bi lancio nello spazio di quattro anni 54 •
Spingardi, al limite della resistenza fisica e psico logica, dopo consulto medico, lasciò Roma la mattina dell'8 dicembre per sottoporsi a un lungo periodo di cure termali a Ischia. Egli volle rassegnare le dimissioni, che vennero però decisamente respinte dal Presidente del Consiglio. Partiva comunque con la coscienza di aver posto le basi per un fecondo sviluppo dell'esercito italiano. Le riduzioni apportate da Polli o, a ragion veduta, non risultavano essere un sacrificio troppo gravoso per una impostazione gene rale non aggressiva dell'apparato militare . Stupisce anzi che avesse inserito nel programma da lui chiamato «completo» una spesa per molti versi assurda come quella riguardante le fort ificazioni di Roma 55 , e spese per servizi che, per quanto sicuramente utili, potevano ugualmente essere improvvisate 'in caso di emergenza senza compromettere l'efficienza generale dell'esercito . Un ica rinuncia grave, il programma delle mitragliatrici. Ma solo in quei giorni stavano giungendo dall'Inghilterra le mitragliatrici ordinate per il compimento del programma «minimo» precedentemente concordato, e l'ordinamento delle sezioni presso i corpi era ancora embrionale. Era inutile aggravare il bilancio con spese da farsi in tempi non determinabili.
Spingardi rievocò il progetto dei 570 milioni dicendo che
Questo progetto fu da me consegnato personalmente al Ministro del Tesoro perché lo presentasse al Presidente del Consiglio quale mio testame nto militare. In quel tempo io ero ridotto in pessime condizioni di salute, per esaurimento ed anche in segu ito ad una cad u ta in montagna visitando opere di fortificazione in Valle d' Aosta. Giudicava coscienziosamente impossi bil e la mia ulteriore permanenza al Ministero : lasciai l'alto ufficio, al quale avevo dedicato 5 anni di intenso lavoro, in principio di dicembre, né più l'ho riassunto in segu it o malgrado che le mie dimissioni non fossero state accolte 56 •
54 G1oun1, Memorie, p. 32.5 dell'edizione Garzanti I967.
55 La sostanziale inutilità delle fortificazioni di Roma era stata riconosciuta già negli anni '8 0 dell'Ottocento. V. M1NNITI, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice alleanza, capitolo terzo, pp. 109-110.
56 RFS, Deposizione Caporello, p. 9. Le affermazioni d i Spingardi trovano conferma in ibidem , Pollio a Brusati, 24 nov. 1913 e Brusati a Spingardi, 19 dic. 191 3
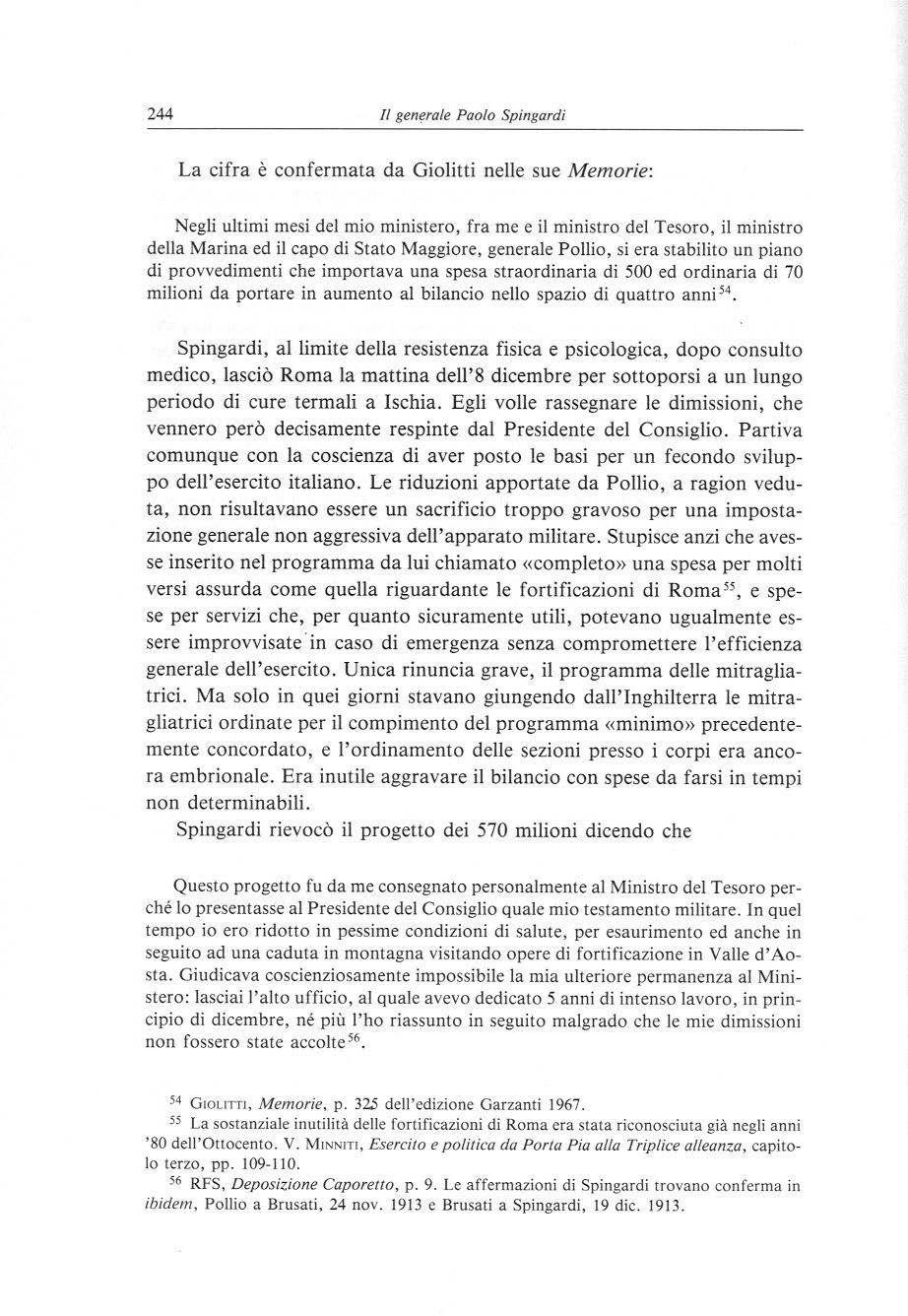
244
Benché le dimissioni di Spingardi non venissero nemmeno prese in considerazione5 7, il piano concertato col Capo di Stato Maggiore dell'Esercito non ebbe alcun modo di realizzarsi, in parte per la mancanza dell'impulso del Ministro, decisivo del quadriennio precedente, ma soprattutto perché gli avvenimenti incalzarono superando ogni previsione.
Il Governo cominciò ad avere i primi problemi con la nuova Camera uscita dalle elezioni del 26 ottobre 1913 58 • Durante la malattia e la convalescienza di Spingardi la discussione sulle s pe se per la Libia occupò interamente la scena parlamentare e i provvedimenti per l'esercito dovettero essere momentaneamente accantonati .
La discussione sulle spese per la .Libia
Fin dal marzo del 1913 per la verità il Ministro del Tesoro aveva cominciato a preoccuparsi delle ingenti spese sostenute per l'impresa libica e ne aveva scritto in via personale a Spingardi:
57 A questo proposito, e per valutare il peso assunto da Sp ingardi nel M inistero, si cons ideri la seguente lettera del Ministro delle Finanze Luigi Facta. RFS, il Ministro delle Finanze Luigi Facta al Ministro della Guerra Paolo Spingardi. Roma 15 febbra io 1914: «Carissimo Spingardi! - lo avevo detto a l tuo ottimo Cav. Civallero che non ti avrei scritto perché non volevo assolutamente darti il minimo disturbo, e incaricai lui di dirti che tu dovevi rimanere perfettamente tranquillo, nella quale frase compendiava la intera situazione. Ora però ti dirò qualche cosa di più e cioè ti racconto i particolari del colloquio che ebbi con Giolitti quando tu mi mandasti la lettera per me e quella di dimissioni per l ui. Giolitti si mostrò addoloratissimo della tua decisione e subi to mi disse che avrebbe tutto tentato pur di non perderti da compagno nostro. E così affrontò la discussione s ulla Libia senza sostitu ire il Ministro della Guerra. Nel nostro lungo colloquio puoi pensare quanto affettuosamente abbiamo parlato di te. Ne l senso in cui ne parlammo noi credo che Giolitti ne abbia parlato col Sovrano: fatto è che i nostri animi (quello di Giolitti e il mio) s i trovarono uniti nel pensare che tu dovevi rimanere con noi: fortuna tame nte la tua salute è anche miglior ata e migliora rapidamente. La discussione alla Camera è ormai inol trata : che cosa verr ebbe a fare un Mini st ro nuovo? Che verrebbe a dire? Quali spiegazioni potrebbe dare? Ieri l'al tro ancora, nella sala dei Ministri alla Camera, in un altro colloquio, Giolitti ripeteva con me queste stesse domande. Dunque non mi pare che vi sia nulla da mutare. La discussione della Libia finirà più presto di quel che si credeva: poi verrò in ballo io e ne avrò per un paio di settimane almeno; poi cominceranno i bilanci e con questo noi andremo a Pasqua; dopo avremo da portare tutto in Senato e cioè dopo un mese circa di vacanze. Vedi che tu hai tutto il tempo di r im etterti e così appagato il nostro voto di averti con noi usque ad finem. La quale fine appare ora meno prossima. La bellissima votazione che ieri i provvedimenti finanziari ebbero negli uffici ha riparato il colpo non lieve che il Governo si era buscato nella famosa legge della prevalenza del matrimonio civile; abbiamo ieri ritrovato la antica maggior anza e sinceramente non credo che sia possibile andare via prima che sia liquidata la Libia e rassettato il bi lancio, così ritengo che vivremo ancora per un poco Quindi tu statti quieto! Fa procedere la tua convalescenza : sta sicuro che hai vicino a te il vigile affettuosissimo interessamento dei t uoi amici; sal vo l' imprevedibile assoluto adesso tiriamo avanti così, e tu non devi preoccuparti di nulla. Credi che non ti ho scritto per non obbligarti a leggermi e perché avevo incaricato il Cav. Civallero di riassumerti la situazione nella frase "non avverrà per ora nulla e tu non pensarci". Adesso che so che non ti stanchi a leggere ti scriverò e co n t utta l 'anima» ss Sui primi dibattiti della XXIV legislatura v CANDElORO, voi. VII, pp. 365-370. Cfr. SETON - W ATSON, pp. 456 -45 8.
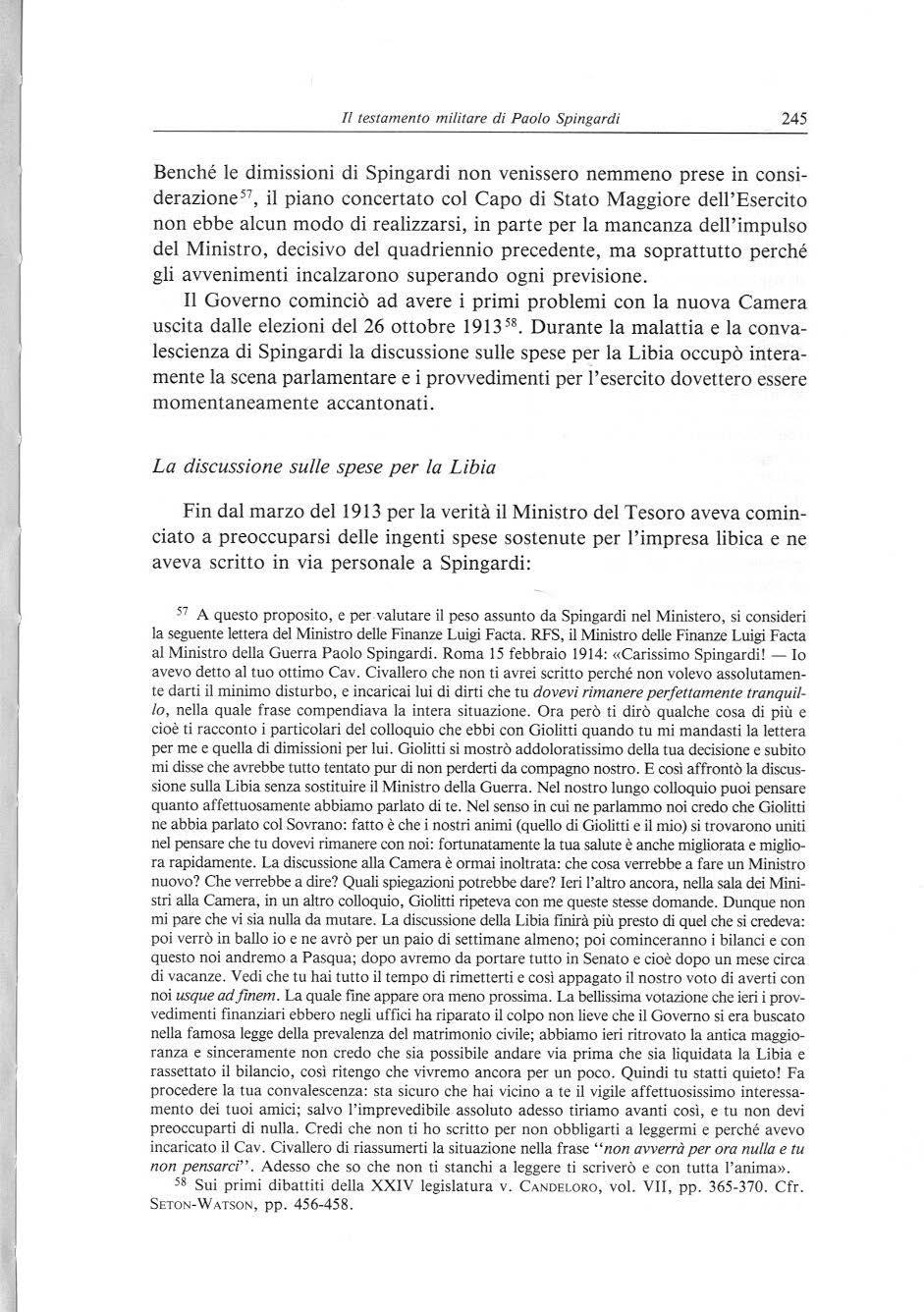
li testamento militare di Paolo Spingardi 245
Mi è stato riferito - diceva Tedesco - che i presunti oneri della impresa libica fino al 31 dicembre 1913 ammonterebbero a somma ingentissima, di gran lun ga superiore alle stesse previsioni del Ministero della Guerra, che io ritenevano ispirate a criteri di larghezza. Ti lascio immaginare la dolorosa sorpresa che proverebbero il Parlamento e il Paese se alla riapertura della Camera si dovesse fare una richiesta di fondi per più centinaia di milioni. Si parla di circa 300 milioni. Il nuovo considerevole onere costituisce un carico assolutamente intollerabile dalla Cassa de l Tesoro, per le pessime condizioni del mercato monetario nazionale ed estero. Ed io muovo appello agli alti sensi del tuo patriottismo perché il programma delle spese Libiche ve nga ridotto nei limi ti minimi possibili impartendo severe ed energiche istruzioni ai dipendenti uffici del Ministero ed ai Governa tori della Tripolitania e della Cirenaica, allo scopo di evitare spese che non rivestono carattere di assoluta ed i mprorogabile necessit à[ ]. Non posso fare a meno di farti rile vare che dopo aver chiesto al risparmio nazionale i n poco più di un anno e mezzo oltre 900 milioni è impos si bile domardargli altre centinaia di milioni per le spes e militari in Libia fino a l termine del 1913, oltre le centinaia di milioni che al Credito si dovranno chiedere nel 1914 per le ferrovie e per altro Di r icorrere all'estero non è nemmeno a parlarne. Facciamo t utto quello che occorre, ma con misura e per gradi; altrimenti ne sarebbero compromessi alti interessi. Dalla tua cortesia mi attendo un sollecito tranquillizzante cenno di riscontro 59 •
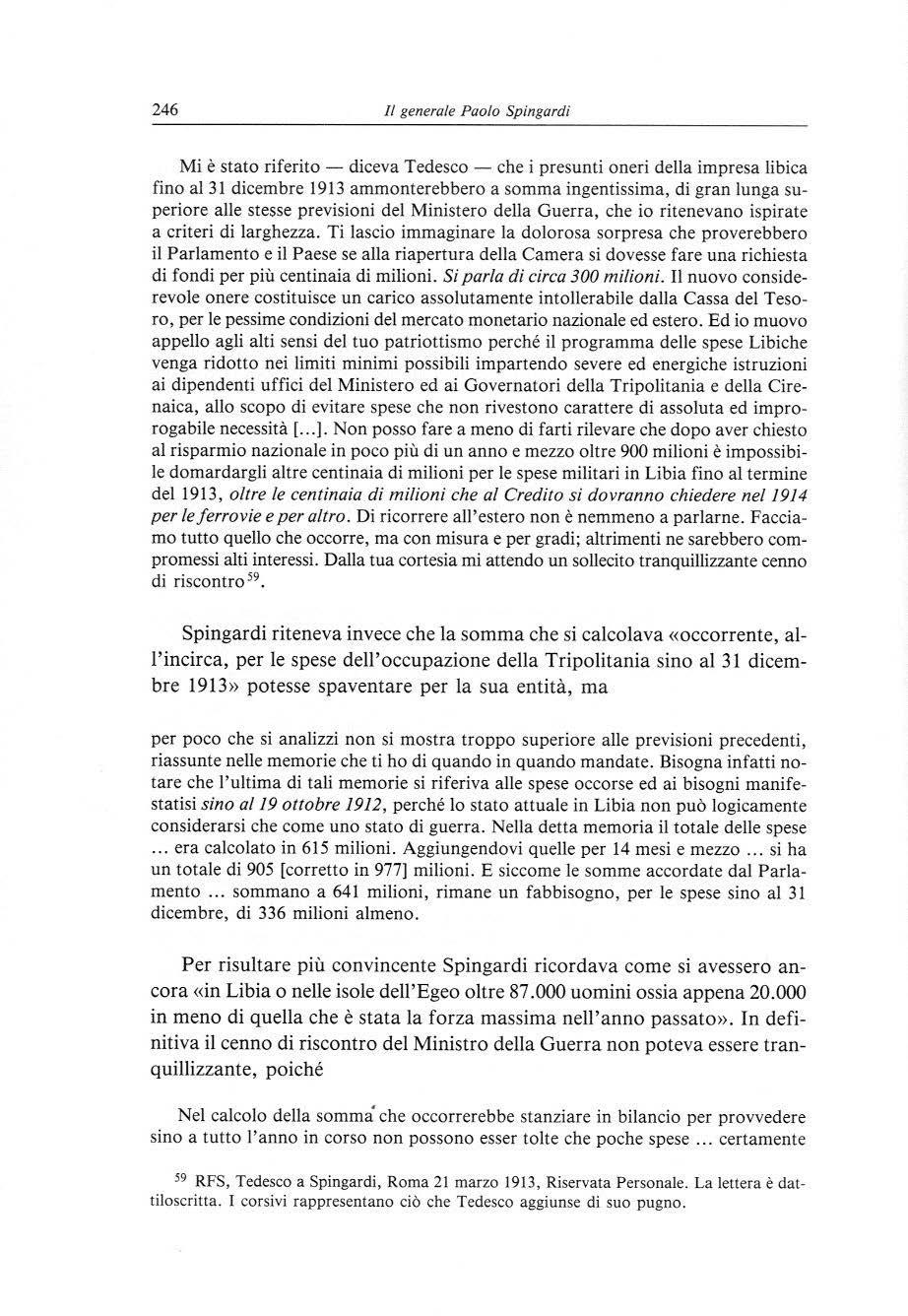
Spingardi riteneva invece che la somm a che si calcolava «oc corrente, all'incirca, p er le spese dell'occupazione della T ripolitania sino al 31 dicembre 1913» potesse spaventare per la sua entità, ma
per poco che si analizzi non s i mostra trop po superiore alle previsioni precedenti, riassunte nelle memorie che ti ho di quando in quando mandate . Bisogna infatti notare che l'ultima di tali memorie si riferiva alle spese occorse ed ai bisogni manifesta t isi sino al 19 ottobre 1912, per ché Io sta to attuale in Libia non può logicamente considerarsi che come uno stato di guerra. Nella detta memoria il totale delle spese era calcolato in 615 milioni. Aggiungendovi quelle per 14 mesi e mezzo si ha un totale di 905 [corretto in 977) milioni. E siccome le somme accordate dal Parlamento sommano a 641 milioni, rimane un fabbisogno, per le spese sino al 31 dicembre, di 336 milion i almeno.
Per risultare più convincente Spingardi ricordava come si avessero ancora «in Libia o nelle isole dell'Egeo oltre 87 .000 uomini ossia appena 20 .000 in meno di quella che è stata la forza massima nell'anno passato». In definitiva il cenno di riscontro del Ministro della Guerra non poteva essere tranquillizzante, poiché
Nel ca lcolo della somma che occorrerebbe stanziare in bilancio per provvedere sino a tutto l'anno in corso non posso no esser tolte che poche spese certamente
59 RFS, Tedesco a Spinga rdi, Roma 21 marzo 19 13, Riservata Personale. La lettera è dattiloscritta. I corsivi rappresentano ciò che Tedesco aggiunse di suo pugno.
246
Il generale Paolo Spingardi
non pi ù d'una quarantina di milioni, per cui la somma che occorrerebbe stanzia re in bilancio rimane di 300 milioni all'inc irca.
La conclusione di Spingardi era drastica:
Se si vuole continuare l'occupazione della nuova colonia e mante ne rla efficacemente e in pari tempo non indeb o lire l'efficienza dell'ese rcito metropo litano oltre i limi ti consigliabili dalla più elementare prudenza in questi momenti, bisogna purtroppo che il Paese si prepari a nuovi, dolorosi sacrifici che né io né tu saremo in grado di poterg li risparmiare 60
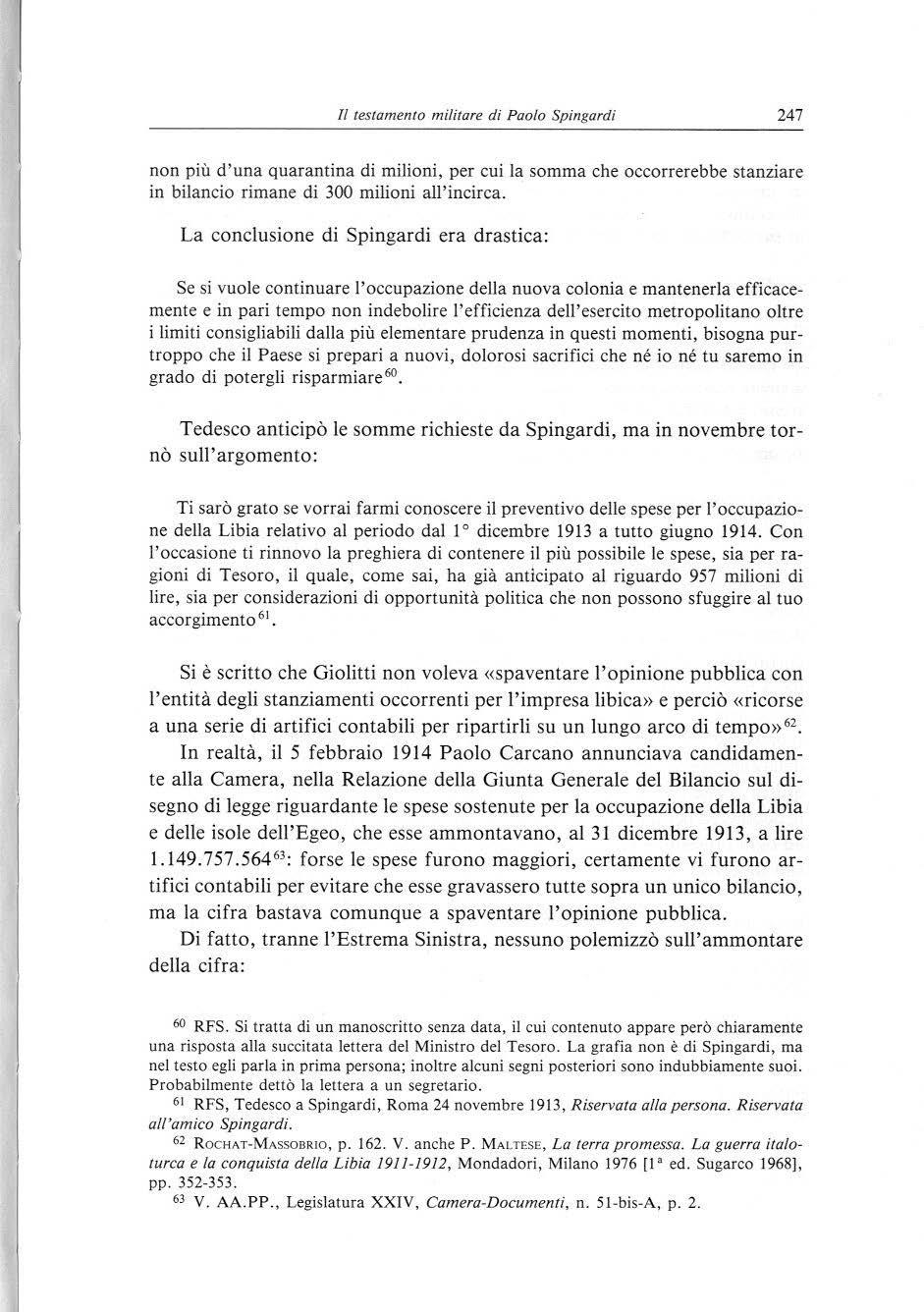
T edesco anticipò le somme richieste da Spingardi, ma in novembre tornò sull'argomento :
Ti sarò grato se vorrai farmi conoscere il preventivo delle s pese per l' occupazione della Lib ia re lativo al pe riod o dal 1° dicembre 19 13 a t ut to giugno 1914. Con l'occas ion e t i rinnovo la preg hi era di contenere il più possibile le s pese, sia per ragioni di Tesoro, il qual e, come sa i , ha già anticipato al rig uardo 957 milioni di li re, si a per con s iderazioni di opportunità politica che non possono sfuggire al tuo accorgimento 6 1 •
Si è scr itto che Giolitti non voleva <<spaventare l'opinione pubblica con l'entità degli stanziamenti occorrenti per l'impresa li b ica» e perc iò «ricorse a una serie di artifici contabili per ripartirli s u un lungo arco di tempo» 62 •
In realtà, il 5 febbraio 1914 Pa o lo Carcano annunciava candidamente alla Camera, ne lla Re laz ione della Giunta Generale del Bilancio sul disegno di legge riguardante le spese sostenute per la occupazione della L ibia e delle iso le d e ll'Egeo, che esse ammontavano, a l 31 di ce mbre 1913, a lire
1.149. 757 .564 63 : forse le spese furono maggiori, certamente vi furono artifici contabili per evitare che esse gravassero tutte sop r a un unico bi lancio, ma la cifra bastava comunque a spave n ta r e l'op inion e pubblica.
Di fatto, tranne l'Estrema Sinistra, nessuno polem izzò sull'ammontare della cifra:
60 RFS. Si t r a t ta di un manoscritto senza data, il cui co ntenu to appa re p e rò chia ramen te una risposta a ll a succita ta le t tera del Ministro del Tes oro. L a g rafia non è di Spingardi, ma nel tes to e gli par la i n p rima persona ; i nolt re alcuni segni poste r iori sono in dubbiamen te suoi. Proba bil me nt e d e t tò la lettera a un segretario.
6 1 R FS, Tede sco a Sp in gardi, Roma 24 n ovembre 191 3 , Riservata alla persona. R iservata all 'amico Spingar di.
62 R 0 CHAT- MASS0BR1o, p. 162 V. anche P. MA LTESE , La terra promessa La g u erra i1aloturca e la conquista della Libia 1911 - 1912, Mondadori, Mil an o 1976 [I " e d. Sugarco 1968 1, pp 352-353
63 V. AA PP , Legis la t u ra XXIV, Camera-Documenti, n. 51 - bis-A, p 2.
li testamen/O militare d i Paolo Spingardi 247
Approvare i conti per se stessi, a prescindere dal giudizio sui criteri con cui i fond i erano stati impiegati, era una necessità amministrativa ed un dovere di tutti quelli che erano stati favorevoli all'impresa e avevano quindi la loro parte di responsabilità per tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate 64 •
Piuttosto, la discussione assunse subito un tono dì politica generale. Come disse lvanoe Bonomi:
Questo disegno di legge, che dovrebbe provvedere soltanto a dare nuovi fondi, a creare nuovi crediti per la colonia, in attesa del bilancio ordinario della colonia stessa, è diventato il terreno di una battaglia politica tra fautori ed avversari dell'impresa di Tripoli, fra critici e difensori del modo come essa è stata condotta, tra favorevoli e contrari alla politica del Go verno 65 •
Dal 10 febbraio al 7 marzo si svolse alJa Camera un ampio dibattito sull'argomento, al quale però il Ministro della Guerra, ammalato, non partecipò.
L'assenza dai banchi del governo non impedì però che Spingardi si preoccupasse di quanto stava accadendo. Per ribattere a quanti criticavano la condotta dell'impresa scrisse due lunghi discorsi destinati alle Camere. In entrambi il comportamento delle truppe e di chi le comandò veniva difeso nella maniera più completa, ma sopratt utto il Ministro si sforzava di rilevarne aspetti sfuggiti alJa maggior parte dei censori. Ad esempio, nel discorso che immaginò diretto alla Camera, era sottolinea to come nel teatro della campagna non vi fossero «obbiettivi strategici o territoriali, la cu i conquista avesse potuto costituire un elemento di forza per noi e di conseguente debolezza per il nemico » , il quale si era rivelato «quasi ovunque superiore ad ogni previsione per la facilità di spostamento, mobile come le arene del suo deserto>>. La tanto rimproverata lentezza delle operazioni, poi, era
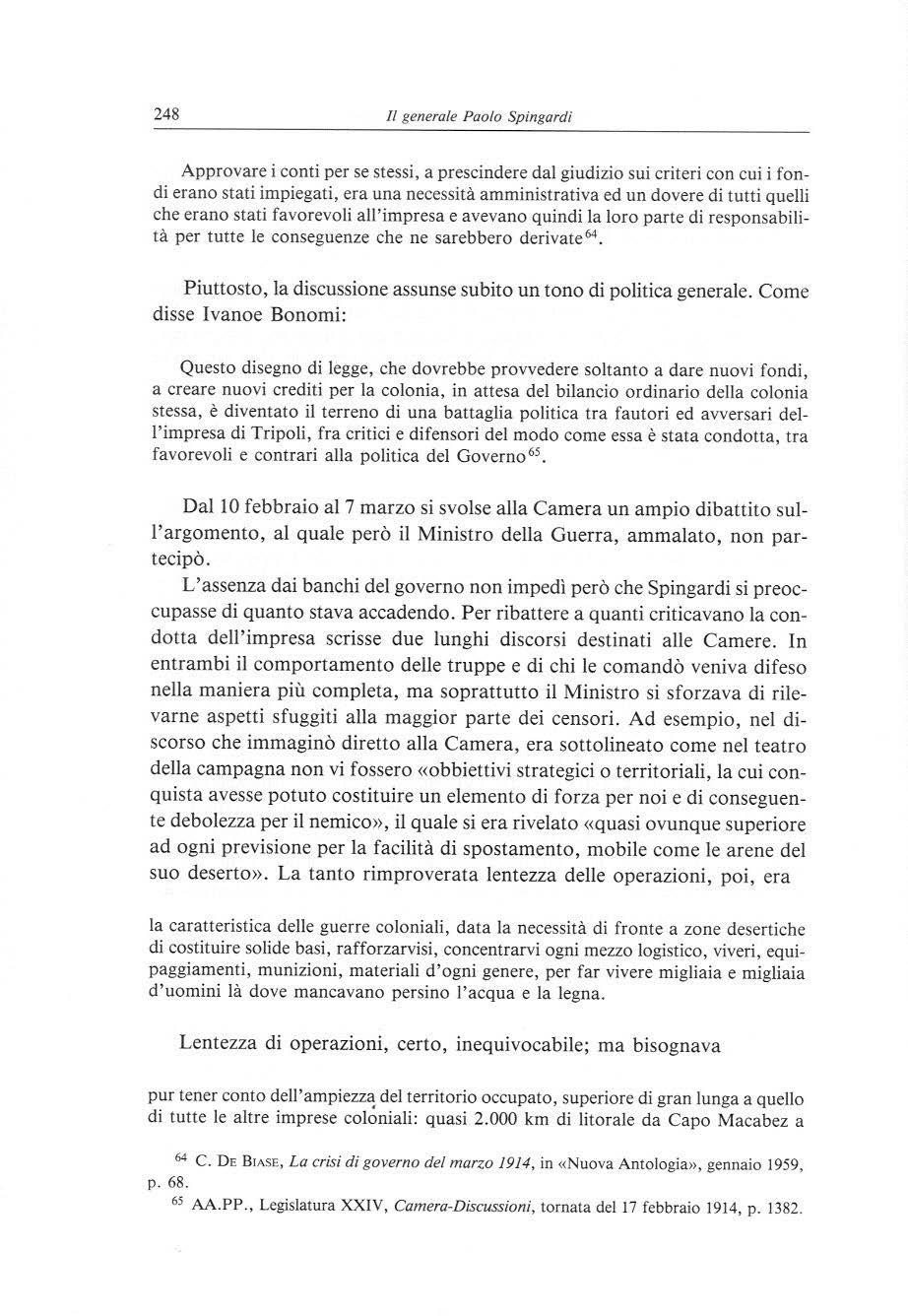
la caratteristica delle guerre colonia li, data la necessità di fronte a zone desertiche di costituire solide basi, rafforzarvisi, concentrarvi ogni mezzo logistico, viveri , equipaggiamenti, munizioni, materiali d'ogni genere, per fa r vivere migliaia e migliaia d'uomini là dove mancavano persino l 'acqua e la legna.
Lentezza di operazioni, certo, inequivocabile; ma bisognava
pur tener conto dell'ampiezza del territorio occupato, s uper iore di gran lunga a quello di tutte le altre imprese col~niali: quasi 2 000 km di litorale da Capo Macabez a
64 C. D E BIAS E, La crisi di governo del marzo 1914, in « Nuova Antologia» , gennaio 1959, p 68.
65 AA.PP., Legislat ura XXIV, Camera-Discussioni, tornata del 17 febb raio 1914, p. 13 82.
248
Il generale Pao lo Spingardi
Tobruk, tutto occupato nei suoi centri più importanti. Ne convengo: maggiore celeri tà si sarebbe potuto conseguire, ma con quali forze? E conveniva mettere a soqquadro tutto l'esercito, aumentando all'infinito tutte le difficoltà dei rifornimenti, e imponendo al paese sforzi maggiori, dinanzi a una situazione internazionale tutt'altro che chiara? Abbiamo raggiunto i massimi effetti con le minime forze, non certo proporzionate alla estensione delle occupazioni. Donde continua necessità di spostamenti da una ad altra località. I battaglioni, le batterie che valorosamente combatterono alla Giuliana e alle Due Palme, li troviamo a Psitos, in quel mirabile accerchiamento tattico dell' Ameglio, e più tardi a Misurata col Camerana . Parte delle truppe che si distinsero col Garioni a Sidi Said, Sidi Alì, Zuara e Regdaline ricompaiono a Kasr el Leben e sulla destra dell'oasi da Bum Safer nelle brillanti giornate del 14 e 17 settemb re, 9 e IO ottobre duci il Reisoli e il Salsa. Raccogliere questa forza con larghezza meravigliosa di mezzi, trasportarli, farli sbarcare, spesso con mare cattivo, o davanti a nemico vigilante, era impresa lunga e difficile. Eppure t utto è riuscito: frutto di ottima organizzazione, fusione meravigliosa fra eserci to e marina. Si può affermare che in nessuna guerra furono fatte operazioni di s barco con maggiore sap ienza , capacità tecnica marinara, ordine, fortuna e valore. Gli sbarchi della Giuliana e di Macabez rimarranno classici nella storia. E ancora: necessità politiche e militari consigliavano di evitare qualsiasi scacco (sempre possibile in guerra), per la grande ripercussione che avrebbe avuto all'interno e all 'estero . Ora la riuscita delle imprese coloniali sta tutta nella preparazione, la quale richiede tempo, lungo per chi con irrefrena ta impazienza attende. E scacchi non ne abbiamo avuti mai: cento combattimenti, cent o vittorie 66 •
Nel discorso ideato per il Senato erano maggiormente evidenziati gli aspetti organizzativi della spedizione.
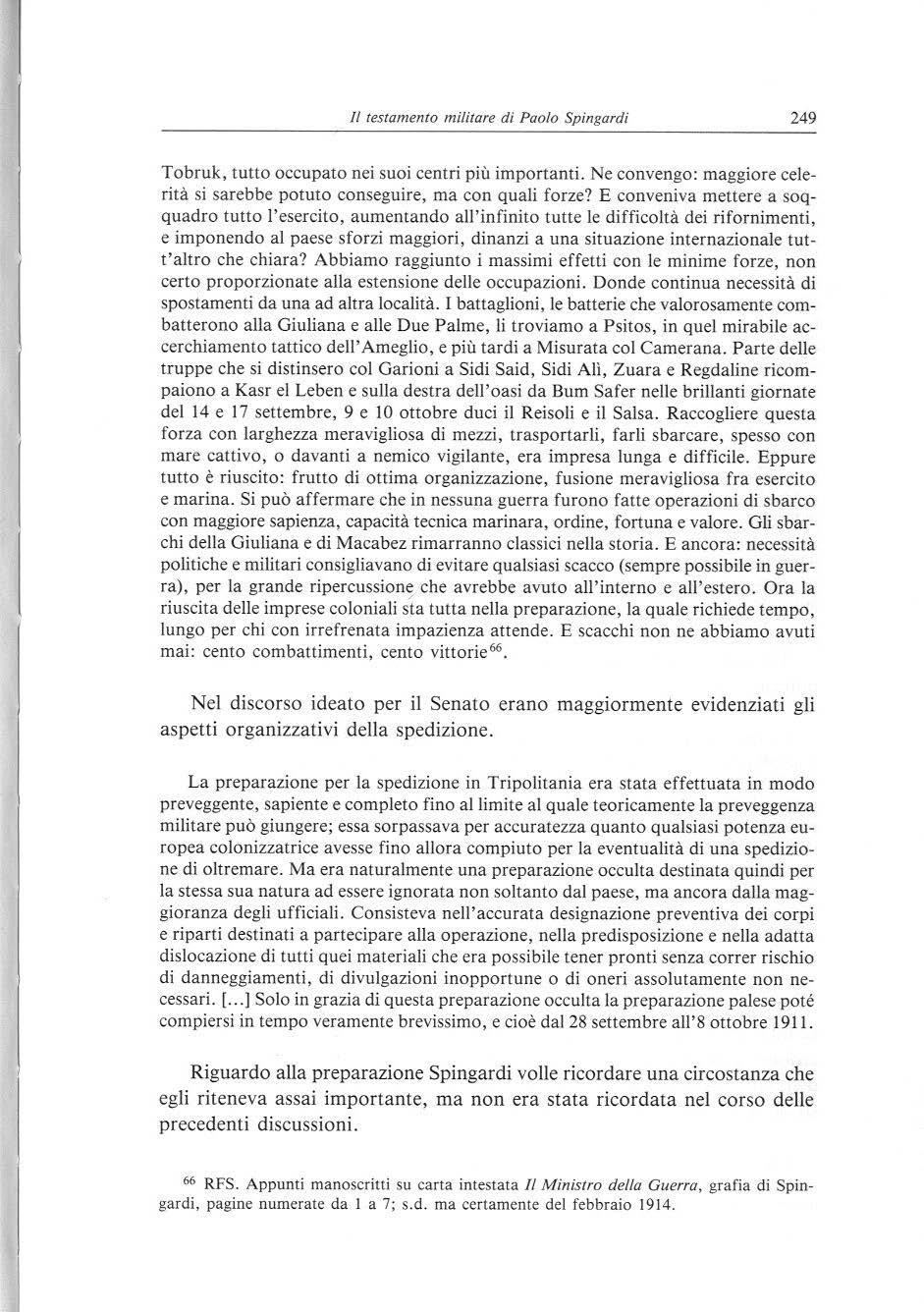
La preparazione per la spedizione in Tr ipolitania era stata effettuata in modo preveggente, sapiente e completo fino al limite al quale teoricamente la preveggenza militare può giungere; essa sorpassava per accuratezza quanto qualsiasi potenza europea colonizzatrice avesse fino allora compiuto per la eventualità di una spedizione di oltremare. Ma era naturalmente una preparazione occulta destinata quindi per la stessa sua natura ad essere ignorata non soltanto dal paese, ma ancora dalla maggioranza degli ufficiali. Consisteva nell'accurata designazione preventiva dei corpi e riparti des t ina t i a partecipare alla operazione, nella predisposizione e nella adatta dislocazione di tutti quei materiali che era possibile te ner pronti senza correr rischio di danneggiamenti, di divulgazioni inoppor tune o di oneri assolutamente non necessari. [... ) Solo in grazia di questa preparazione occulta la preparazione palese poté compiersi in tempo veramente brevissimo, e cioè dal 28 settemb re all'8 ottobre 191 I.
Riguardo alla preparazione Spingardi volle ricordare una circostanza che egli riteneva assai impor ta nt e , ma non era stata ricordata nel corso delle precedenti discussioni.
66 RFS. Appunti manoscritti su carta in testata Il Ministro della Guerra, grafia di Spingardi, pagine num erate da I a 7; s .d. ma certamente del febbraio 19 14 .
Il testamento militare di Paolo Spingardi 249
Solo tre anni prima l'ILalia era stata funestata dalla immane catastrofe di Messina e della Calabria, sventura che se non fece disperar e noi del nostro avvenire, fece intravvedere per un momento a qualch e iso lato malvagio nemico - la cui voce fu però soffocata dalle unanimi riprovazioni dei suoi compatrioti - la possibilità che la conseguente paralisi politica e militare nostra ci lasciasse per qualche tempo alla facile mercé di qualunque vicino volesse attaccarci. E realmente l'opera possente di pietà verso gli sventuratissimi fratelli nostri fu tale che produsse una crisi non breve e non lieve nelle dotazioni tutte dell'esercito - di vettovagliamento, san itarie, del genio militare, di equipaggiamento e casermaggio etc. - alle quali si attinse con grande larghezza per socco rrere le regioni colpite. L 'esercito avrebbe quindi potuto invocare qualche attenuante, se non si fosse trovato interamente preparato, eppure non ne ebbe e non ne ha bisogno; come bisogno non vi è quasi di ricordare i particolari ostacoli che si dovettero superare e che avrebbero reso ad altri la mobilitazione singolarmente difficile. Tra queste: il fatto che da pochi giorni erano terminate le grandi manovre in Piemonte, si era congedata la classe 1889 e si dovette richiamare que ll a 18 88; il co lera che serpeggiava in Italia ed obbligò ad escludere dal richiamo alcuni distretti; le opportunità di compiere i movimenti ferroviari senza intralciare il traffico normale e di eseguire gli imbarchi senza nuocere al movimento ordinario dei poni; ed infine la necessità di costituire il corpo di occupazione in modo da non compromettere una eventuale mobilitazione generale dell'eser ci to c he potesse avve nire n el corso della spedizione.
Un accenno alle spese, che erano il presupposto della discussione, non poteva mancare:
Le spese non furono esagerate rispetto ai bisogni che si dovettero soddisfare. Si pensi infatti che innuirono ad aumentare il costo della spedizione: la improvvisa conclusione di taluni contratti; le perdite ed i logoramenti prodotti dagli sbarchi con mare agitatissimo, dal clima, dal paese; la necessità di portare tutti i mezzi logistici, persino l'acqua, dall'Italia, essendo la Libia pressoché sprovvista, all'atto della nost ra occupazione, di risorse proprie; la opportunità, per ragioni sociali e politiche che qui non sta r ò a discutere, di dare due volte il cambio alla maggior parte del nostro contingente, rinviando in congedo le classi 1888 e 1889; la conve nienza finalmente di apparecch ia re la spedizione e mantenere il corpo di occupazione con una larghezza di mezzi logi stici che si potrebbe perfino ritenere eccessiva, se altissime ragioni non l'avessero imposto 67 •
Paol o Spinga rdi difendeva dunque a spada tratta una impresa da lui accettata senza entusiasmo, ma portata avanti con la consueta solerzia e precisione . Il prolungato impegno nervoso non fu estraneo al peggioramento d elle sue condizioni di sa lute. Ad ogni modo, eg li era stato tra i protagonist i della prima affermazione dell'esercito italiano in una guerra degna di
67 RFS. Dattiloscritto dal titolo Appunti per una eventuale ulteriore discussione sulfe spese per la Libia 17 cartelle dattiloscritte s.d., ma chiaramente della fine di febbraio o dei primi di marzo del 1914.
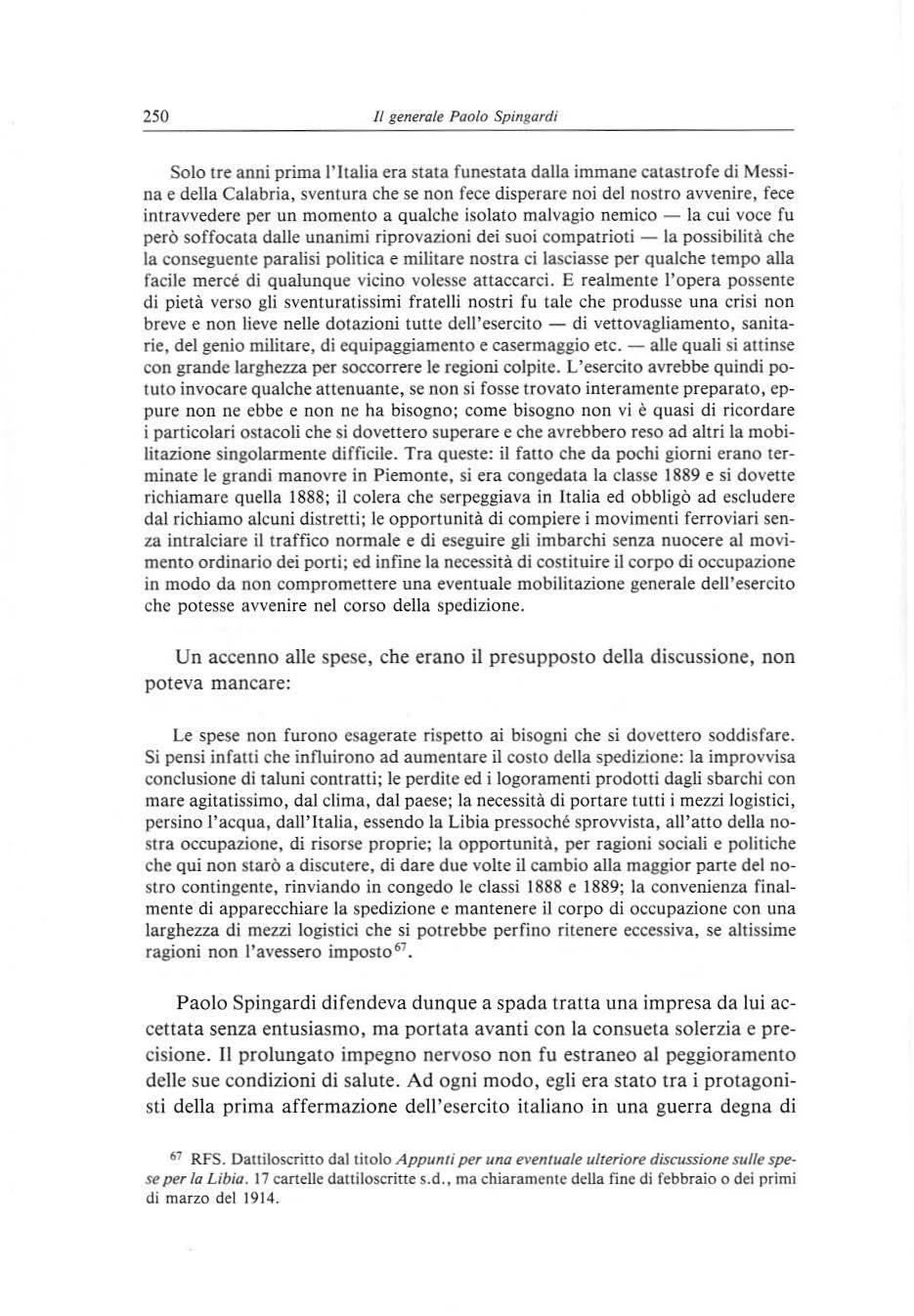
250
Il generale Paolo Spingardi
essere chiamata tale in mezzo secolo di vita unitaria: «Per la prima volta dal 1860 l'Italia poteva segnare al proprio attivo una guerra vittoriosa: gli italiani sentirono di aver compiuto qualcosa che mer itava e che stava effettivamente conquistando il rispetto delle altre nazioni» ha scritto Christopher Seton-Watson61l.
Nessuno più di Spingardi ne era convinto: «Noi abbiamo compiuto in breve tempo una grande impresa degna di un popolo maturo e forte» scriveva nella conclusione del suo discorso .
Quale che si a per risultare il beneficio MATERIALE dei sacrifici di sangue e di denaro da noi compiuto e del quale fruiranno, in quella misura che l' esperienza sola potrà determinare, i nostri figli o i nostri nipoti, è certo che dei benefici tangibili ed evidenti sono già stati da noi realizzati. Sono soprattutto dei benefici MORALI: il Paese si è disfatto di mo lto del suo scetticismo, della sua timidezza, del suo spirito di fronda; ha dato prova di forte disciplina nazionale e ha ripreso amore alle istituzioni militari, coltivando ciò che dello spirito militare è l'essenza principale, la virtù cioè del sacrificio, virtù che apparve matura non solt anto nel contegno dei combattenti, ma anche nello spettacolo di forza d'animo e di serenità dato dalle famiglie dei gloriosi caduti. [... ] P aese ed Esercito infine hanno visto crescere la considerazione in cui sono tenuti all'estero con vantaggio immenso della nostra politica, dei nostri emigranti, delle nostre esportazioni, in una parola con vantaggio della nostra posizione nel mondo 69 •
La successione di un Ministro
Tanto ardore retorico era giustificato dalle migliorate condizioni di salute A febbraio Spingardi ricominciò anche a pensare al futuro dell'esercito, dopo averne celebrato il recente passato nei due discorsi Pollio poté comunicargli di essere stato da Giolitti
per parlargli di diverse cose. Te ne riferirò non appena ne avrò il tempo. In tanto , da ciò che egli mi ha detto e da quanto ho sentito altrove, mi risulta che non si ritiene necessario né urgente un provvedimento rispetto al Ministero della Guerra. Più precisamente - e te lo dico nella più stretta confidenza - mi pare che si voglia aspettare che tu possa riprendere la direzione del Ministero. Non v'ha dubbio alcuno che questa sarebbe la migliore soluzione della gran questione 70
La gran questione era ovviamente l'aspetto finanziario del nuovo programma. Ma la situazione politica si stava ingarbugliando e la situazione finanziaria lo era già: Giolitti e Tedesco temporeggiavano ancora.
68 S ETON -W ATSON, Cit., p. 446
69 RFS, Appunti per una eventuale ulteriore discussione sulle spese per la Libia, doc. cit 70 RFS, Pollio a Spingardi, 8 feb braio 1914.
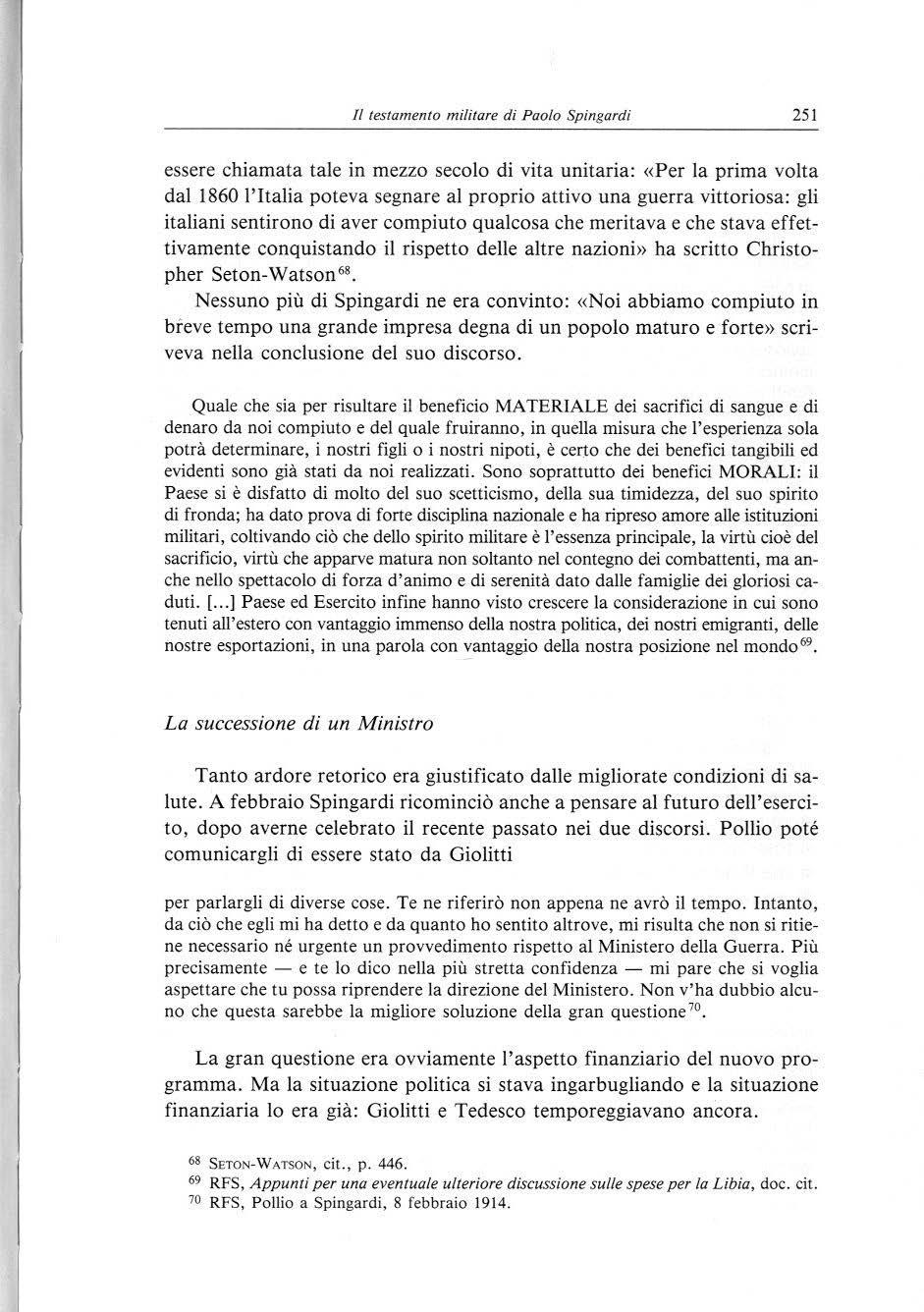
Il testamento militare di Paolo Spingardi 251
Il generale Paolo Spingardi
Alla metà di febbraio Pollio ebbe due «conferenze» con loro del cui esito così informò Spingardi :
Secondo il tuo desiderio, ti ragguaglio sull'esito della mia conferenza col Presidente del Consiglio, la quale è stata completata con un'altra conferenza che ho avuto oggi col Ministro del Tesoro. Sono andato da questo perché S.E. Giolitti mi aveva detto col concludere: parlerà col Ministro del Tesoro. E, di fatto, gli ho parlato. Or bene, tanto il Presidente del Consiglio, quanto il Ministro del Tesoro, mi hanno conco rdemente dichiarato che sono ben disposti a favore dell'Eserci to, ma che nel momento politico attuale, è asso lutamente impossib i le chiedere alla Camera nuovi fondi per l' Esercito e per la Marina. Per poter presentare nuove richieste occorre che siano prima discussi e approvati i provvedimenti finanziari. Col Ministro Tedesco abbiamo esaminato la sit uazion e generale non s olo, ma anche i vari capitoli di spesa secondo il programma che gli hai presentato. Egli preferisce di gran lunga domandare meno della somma totale [ma] da frazio nare in un minor numero di esercizi. Egli non si sente di chiedere tutto in una volta. Gli ho spiegato (e Io stesso avevo fatto coll'on. Giolitti) quali erano i nostri bisogni più impellenti, e gli ho promesso di presentargli un quarto programma, che chiamerò «prog ramma pratico». In esso metterei le sole fortificazioni indispensabili, ma, naturalmente, includerei tutte le spese poi lavo ri del genio, per le artiglierie, pe l munizionamento ecc. E metterei una parte di quello che abbiamo progettato per l'aumento della forza e dei quadri, per l'istruzione, pei materiali, pei servizi. Prima di presentare tale programma al Presidente del Consiglio o al Ministro del Tesoro, lo manderò a te 71 •
Il programma prevedeva una cifra di circa 200 milioni da spendersi in tre anni.
Spingardi non rientrò a Roma che la sera dell' 11 marzo 19 I 4, quando il Governo Giolitti aveva già rassegnato le dimissioni, e senza aver potuto ricevere il «programma pratico». Il giorno successivo egli s i recò al Ministero per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, come se non si fosse mai assentato 72 • La ritrovata salute del Ministro della Guerra fece sì che il nuovo Presidente del Consiglio, Antonio Salandra, gli chiedesse di mantenere nel nuovo Gabinetto il posto che aveva occupato negli ultimi cinque anni 73 • Spingardi subordinò la sua accettazione a un consulto
71 RFS , Pollio a Spingardi . Lettera autografa del 15 febbraio 1914.
72 V. Il ritorno a Roma del Ministro della Guerra, «L'Esercito Italiano», 15 marzo 1914.
73 V. DE CHA URAND , p 253, B. V1 GEzz1 , /I suffragio universale e la crisi del liberalismo in Italia (dicembre 1913-aprile 1914), in «Nuova Rivista Storica», 1964, n. V-VI, p. 563; Deposizione Caporetro , p. IO; RFS, Pedotti a Spingardi, Genova 15 marzo 1914: «Eccellentiss mo e cariss.mo Generale Spingardi - Tra gli infiniti rallegrament i per la ricuperata salu te che avrà ricevuto arrivando a Roma, i miei - tuttoché in ritardo di parecchi giornivogliono essere dei più sinceramçnte affettuosi. E non ho bisogno di dire di più dopo quanto Le scrissi, or non è molto, ad Ischia. Adesso - e mentre si sta componendo il nuo vo Minist ero - mi consenta di manifestare una speranza: quella ch'Ella possa dimostrare a tutti che la sua guarigi one è veramente perfetta, accettando di continuare a reggere le sorti dell'Esercito, quale che sarà per essere l'esito della attua le crisi. D ico accettando, perché, all'infuori di qualche notizia che già leggo nei giornali, io non metto dubbio che, prima che si pensi a qualsiasi
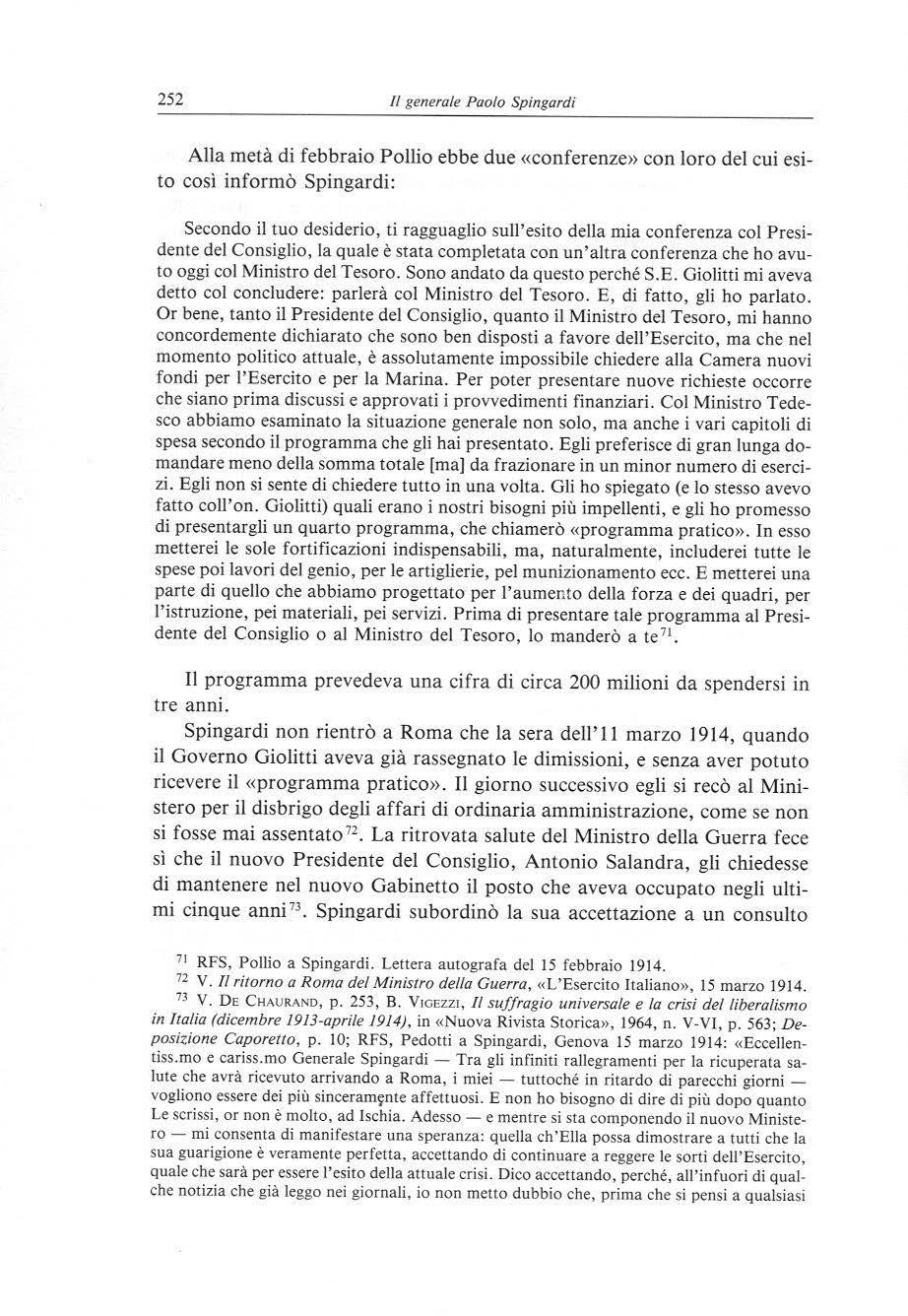
252
medico e a malincuore dovette cedere alla prescrizione di altri due mesi di riposo prima di considerarsi completamente ristabilito 74 È verosimile anche che tale riposo Io allettasse alquanto d o po c inq ue anni di indefesso lavo r o . Salandra si rivolse il 20 marzo 1914 al genera le Carlo P o rr o 7 5 , che già precedentemente lo stesso Spingard i aveva suggerito qua le suo ·successore 76 • D opo tre g iorni di intensi colloqu i , Po rr o rifiutò l'inca r ico perché non venne accolta la sua ri chi esta di aum ent i al bila nc io d ella guerra . Spingard i disse della vice n da :
La mia richiesta di 570 mi li oni, 600 in cifra t0nda (r ichiesta acco l ta ne l febb ra io 19 14 dal Presiden te del Consig lio e dal M inistro del Tesoro), fu poi natura lmente ripresa da l Generale Porro, che era stato chiamato a s uccede r mi quando, malgrado le cordiali ins istenze del Ministro Salandra perché accettassi di rimanere nel s uo Ministero, non mi fu poss ibile di aderire esclusivamente per ragioni di sa iute 77 •
li 24 marzo 1914 veniva nominato nuovo Ministro della Guerra il generale Domenico Gran di , in q uel momento comandante d e l Corpo d' Ar-
altro Ministro della Guerra, Lei sarà officiato di r iman ere. Sarebbe un errore se d iversame nte si facesse: l'opera sua non è compiuLa; è uti le, per non dire necessario, che sia Lei a compierla, o pe r lo meno a darle un ulteriore svolgimento. Ragioni d i carattere politico che rendano incompat i bile la sua permanenza nel nuovo Ministero che l'On Salandra s ta mettendo insi eme (ed io gl i auguro che riesca a bene) Lei non ne può, né ne dovrebbe accampare Unico argomento che potrebbe addurre sarebbe, dopo la sua recente ma lat tia, il bisogno di riposo; ma questo appun to io spero ed auguro ch'ella non abbia la necessit à né la possibilità di far valere».
74 V. «L'Esercito i taliano>>, 22 mar zo 19 14; «La Preparaz ione», Sabato-Domenica 21-22 marzo 1914.
75 Carlo Porro, nobi le d e i conti di S. Maria della Bicocca (Mi lano J 854- Roma I 939), uscì sottotenente d 'art iglieria dall'Accad em ia mi li tare di Torino nel 1875 Frequ entò la Scuola di Guerra, passò nello S.M., insegnò storia militare ali' Accadem ia di T orino Da co lonnello comandò il 6 1° Reggimento fanteria e dal 1900 al 1905 fu ufficiale addetto a l Corpo d i SLato Magg iore (in pratica la terz a autorità dopo il Capo d i S.M. e il comandame in seconda). Dal dicembre 1905 al febbraio 1906 fu sottosegretario alla Gu e rra, succedendo nella carica proprio a Spingardi Po i comandò la Scuola di Guerra Da teneme generale comandò le D ivis ion i di Verona e Milano , quindi il VI Corpo d'a rmaca (Bologna). Dal 1914 al 1917 fu sottocapo di S.M. Nel 1916 venne nom inato senatore, ne l 1923 ebbe il grado di gener ale d'a rma ta e nel I932 fu nominato m inistro di Stato. Si re se illustre anche ne l campo scien tifico con numerose pubblicazioni, fra cui una Guida allo studio della geografia militare e un Atlante dei ghiacciai italiani.
76 ACS, Archivio Brusati, se I 1, f. VTII. I .45. Spingardi a Bru sat i, Isch ia, s d. ma tra il I O e il 10 febb raio 1914: «Tu mi chiedi un nome per il m io successore Porro, Grandi, Garioni: ecco una terna. Forse, anzi certo, ve ne saranno altr i che qu i sfuggono alla m ia memor ia e al mio apprezzamemo. Fatt.a la designazione a vvert imi, te ne prego » . Porro e Grandi vengono indicat i come successori anche in ibidem, Spingardi a Brusati , Is chia 11 febbraio 1914.
77 RFS, Deposizione Caporetto, p. 10.
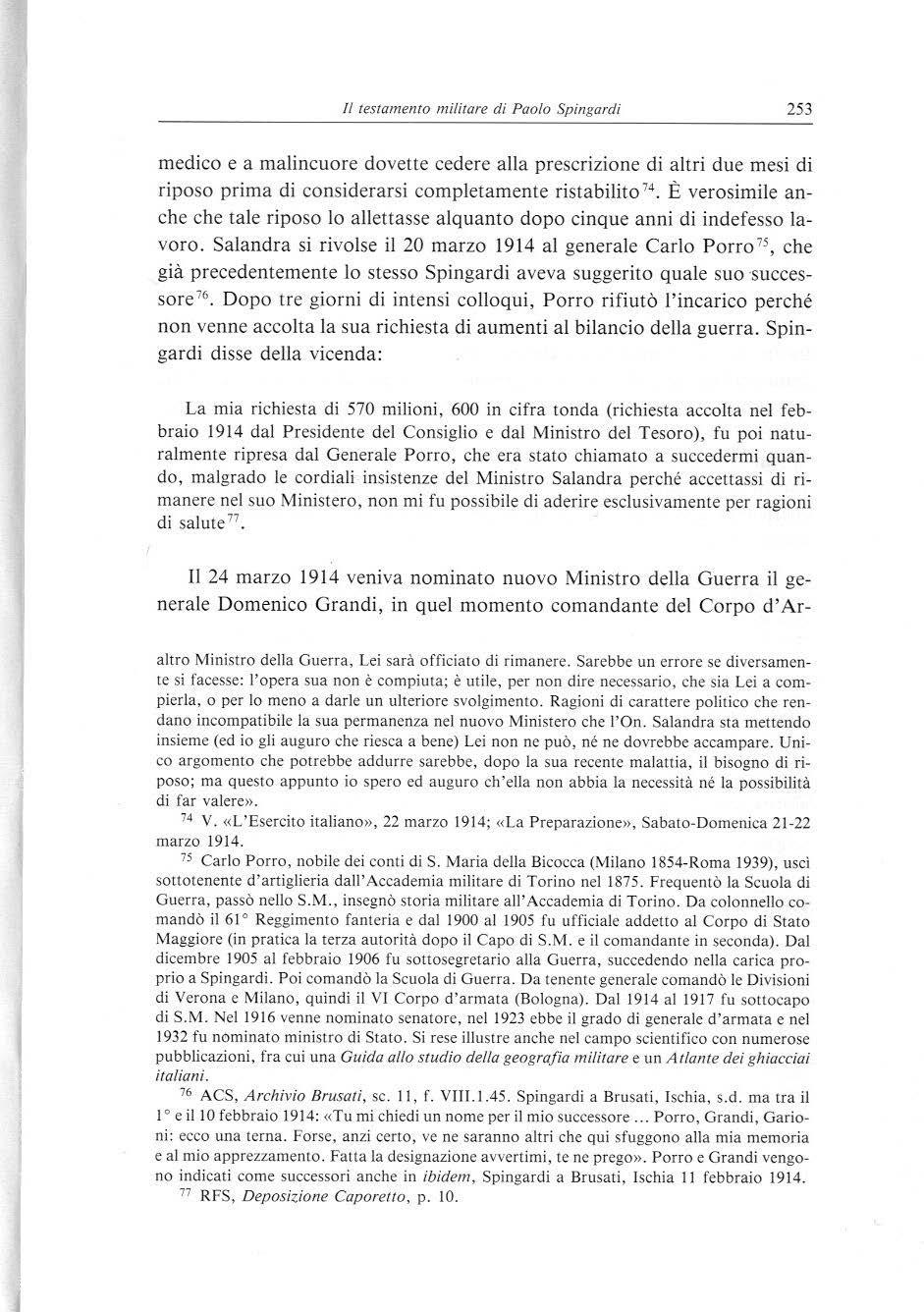
Il testamento militare di Paolo Spingardi 253
Il generale Paolo Spingardi
mata di Napoli. Fin dalla mattina del 23 Spingardi era partito per Spigno da dove raggiunse San Rem o dopo alcuni giorni passati nella quiete familiare 78 • Intorno agli avvenimenti che egu irono le dimi ssion i di Spingardi, cui la storiografia ha dato un rilievo magg iore che non i cinq u e anni del suo mini stero 79 , alcuni punti noti e meno noti meritano di essere ribaditi con una certa nettezza.
Innanzitutto PolJio preparò il programma pratico fin dal febbraio 1914, mentre finora si era pensato che esso fosse sta to impostato solo dopo il rifiuto del Gen erale Porro 80 Ma ciò non va interpretato come una rinuncia alla realizzazione piena del nuovo programma, quanto piuttosto come espediente lattico in attesa di provvedimenti atti a sanare il bilancio. La tattica dì Spingardi consisteva nel presentare le richieste di stanz iam enti progressivamente, ponendole, una alla volta, come necessità di fronte alle quali la coscienza patriottica della maggioranza della Camera e del Senato non poteva esimersi.
78 RFS, Spingardi alla moglie, da San Remo, 29 marzo 1914: «Car issima - Ieri, appena giunto, scrissi due righe a CamiUo [il figlio primogenito, allora ventiduenne]; oggi rispondo alla tua lettera uovata qui al mio arrivo. Come vedi, le nostre noti.de non ti mancano, e contribuiranno , almeno in parte, a co lmare i l v uoto lasc ia to dalla n ostra partenza. Vero è che il tempo non ci manca, e lo scrive re è ancora la più gradita occupazione Poiché il sito è meravigliosamente bello, un vero lembo di paradiso; l'albergo in posizione incantevole sul mare, con giardino che è una mera,iglia di vegeta1ione e con tutto il comfort moderno; la tavola, il caffè (una l ira!) ottimi; le camere al primo piano con terrazzo, a mezzogiorno s ul mare; il Lempo splend ido ecc. ccc . , ma la noia è pure gra nd issima . Il problema di far passare il tempo è ancora il più grave, più grave ancora del così dello problema militare, che fornisce argomento di partito ai vari giornali della penisola. Mi si scrive da molte parti perché io entri in liaa, ma io faccio i l sordo; il tempo è galantuomo Mi meraviglio con me stesso che non me la piglio, e non ho rimpiami! Tanto più che sto benissimo sotto ogni aspeuo, come non ricordo d'essere stato da un pezzo, e non voglio proprio guastarmi la salute con dei crucci e delle preoccupazioni che non hanno ragione di essere ».
79 Lasciando ovviamente perdere i testi d edicat i in man iera più o meno specifica alle v icende militari dell'età giolittiana. dove l'opera di Spingardi, anche se variamente giudicata, non può non ricevere adeguate proporzioni, e sorvolando su G. V OLPE, Italia in cammino, il cui silen.lio su Spingardi (ma non su Porro, v. p. 264 dell'ed. 1973) può anche essere spi egato con motivazioni ideo lo g ich e, si c fr. CANOH ORO , Storia dell'lta/i(I moderna, voi. Vili, pp. 62-63, dove il nome di Spingardi appare quasi incidentalmente, mentre alla questione Porro vien dato ben maggiore rilievo pur nello spazio limitato che l'impostazione stessa dell'opera riserva alle vicende mil itari e S1 10N-WATSON, L'Italia dal liberalismo al fascismo, p. 459, che colloca con prec isione la figura di Spi.bgardi, ma non manca di dedicare uno spaz io quasi id entico alla vicenda del marzo 1914; la stessa considerazione vale per D. MAcK SMn H, Storia d'Italia dal 1861 al 1969, Latcrt.a, Bari 1970, pp. 447-448 e 473.
so La fonte dalla quale tutti hanno ricevuto la notizia, direltamente o per interposto autore, è la solita Relazione Ufficiale, p. 64. Cfr. indi D F CHAURAND, p. 254; To5T1, p. 165; RoC HAI. p. 3 15 ; STr FANI, p. 572; GOOCH, Army, p. 153.
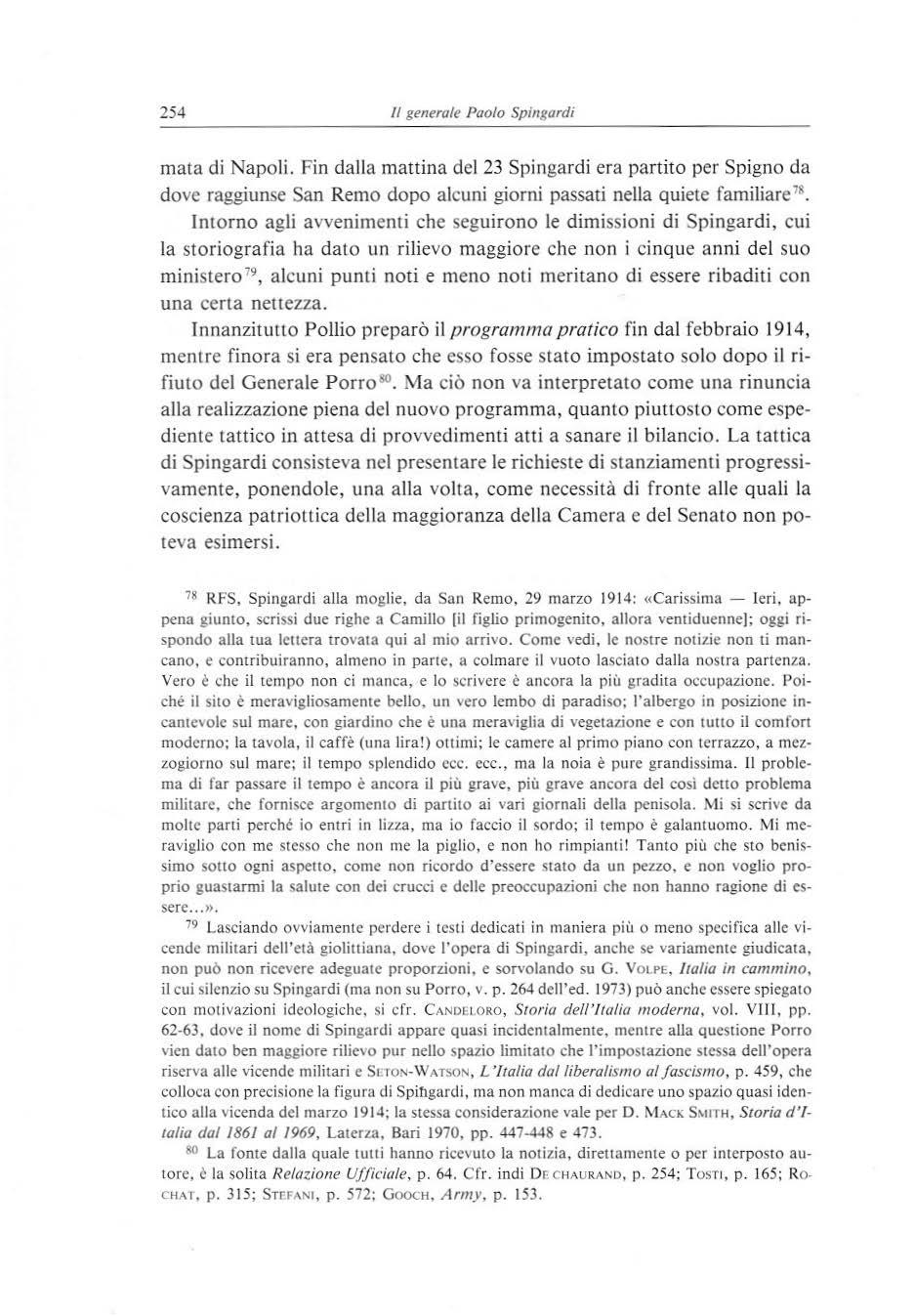
254
Certo il rifiuto di Porro - commentava Spinga r di - avrà giovato per alcuni r iguard i a lu i s tesso , ma non ha ceno giovato all'Esercito ed a l Paese. Messo il campo a rumore , ved r à l'amico Grandi quanto p iù duro sa rà l'osso da spo l pare. E dire che il progetto Porro è il mio presentato al Tesoro prima di partire per Isch ia. Nessuno ne a veva parlato allora, e non si doveva parlarne; ma a suo tem po s are bbe ve nu to f u or i gradatamen te come necess i tà e ragione po li tica imponevano 81 •
I 200 mi li oni di Pollio venne r o ulteriorm ente ridotti a 194 82 , ma il momento e ra ta le per cui anche 6 milioni rappresentavano per i mili t ari una cifra non trascurabile, senza contare che Tedesco e Giolitt i avevano accettato d i erogare le somme del programma pratico, de tto anch e ultraminimo, in tre anni, men t re Rubini e Sal a ndra lo diluirono in cinque anni 83 Giol itti e Tedesco, in fine, erano disposti ad accordar e gradualmente i 570 m ilion i man ma n o c h e le condizioni della finanza lo avessero perm ess o; Salan d ra e Rubi n i sembravano invece decisi a ini z iar e un lungo periodo di « r accoglimento» fi n anziario nella tradizione della vecchia Des t ra 84 •
81 R FS , Spingard i a lla moglie, da San Remo , 29 marzo 19 14, doc. c it. «Comincio acred ere» p r oseguiva Spingardi « ch e la scienza del governare io doveva posseder la tuua se mi è r iuscito di ot tenere t a n to senza far gridare nessuno!>}
82 Cfr R elaz ione Ufficiale, p 64.
83 RFS, Sp ingard i a Giolitti, Ro ma, 29 apr ile 1913, doc. ci t. Probabilmente nella primavera d el 1914 Spinga rdi aggiunse d i suo pugno a questo documemo la seguente annotazione pos1uma: «G li stud i e i p rogetti co nc reti hanno rivelato un fabbisogno minimo (compr ese alcune spese delle q ua li qui non è cenno, come ad es fa bbr icati milicari) d i 23 5-250 nù lioni da r ipart irsi in tre anni e un fabb isogno massimo di più de l dopp io (600 milioni) da ri chi ed ers i in un avvenire s uccess ivo, più o meno lontano a seconda delle esige nze mil itari e della si tuazione economica de l Paese, coerente in ciò a l principio da me enunc iaLO alla Camera nel d isco rso I 1 giugno 1909, pag in e 22 55 e 2256 degli Act i P a r lamenta r i. Tutto cammina, Lu tto s i muta, si evolve a questo mondo e i l vo le r prevedere a troppo lunga scade n za può essere opera di saggia prudenza ma non rispondente p0i alla r ealtà del momento L' anùco gen. Porro h a fano s uo il nùo progetto massimo, e v i ha vo luto insistere malgrado il mio insistente consiglio co ntrario . e fece male ! Co nchiudo la postuma an n otazione rivendicando - modestia a pane - la chiar a visione dei bisog ni della difesa nazionale e dell 'Esercito , tanto proclama ci in segu ito al gran ri fi uto del gen . Po rro , come una ve rità igno ta la quale ha suscitato tanto rumore d i discussioni . Nulla di nuovo sotto la ca pp a del Cielo! Né la sis temazione d e ll e frontie re marittime ed i l completamento delle terrestri; né il parco d i assedio, né il mullizionamcnto e g li approvvigionamenti d i mobilitazione; né la flotta aerea; né i fabb r icati m il icar i; né in fine la forza bila ncia ia, per la quale nulla si è fac t o che non fosse già s taco facto. E quant o a i mezzi mi piace di r icordare che era nel pen siero d el Presidente Giolicti di accordar li ne lla misura ri chi es ta appena votat i i provved im ent i t ributari atti a r in forza re il bilancio. li mio successore Grandi si è accontentato d i 194 m i lion i in 5 anni, auspici Rubini-Salandra, d i fronte a i 235-250 promessi da Gio litti -Tedesco, da spend ers i in tre anni invece che cinq ue. I 600 milio1ù Porro erano c h iesti in 8 eserci zi. Ca mpa cavallo » La cifr a di 235-250 milioni che Spin gardi chiama fabb isogno m inim o è quanto verrà c hia maco programma pratico o ultraminimo.
84 RFS Let tera d i Tedesco a Spingardi, Roma, 23 genna io 19 14: «Ca ro Spi nga rdi - Il prof. G a tci mi recò l a lie ta novell a del sens ibile miglioramenco della LUa salute, e dall'amico Facta ne ho avuto la pr ima conferma. Quale sia i l mio comp iacimento, e con quale animo io formi l'aug u r io d i r ivederti com p letamente r isanato e resti t u i co a ll 'usato lavoro, che tutti
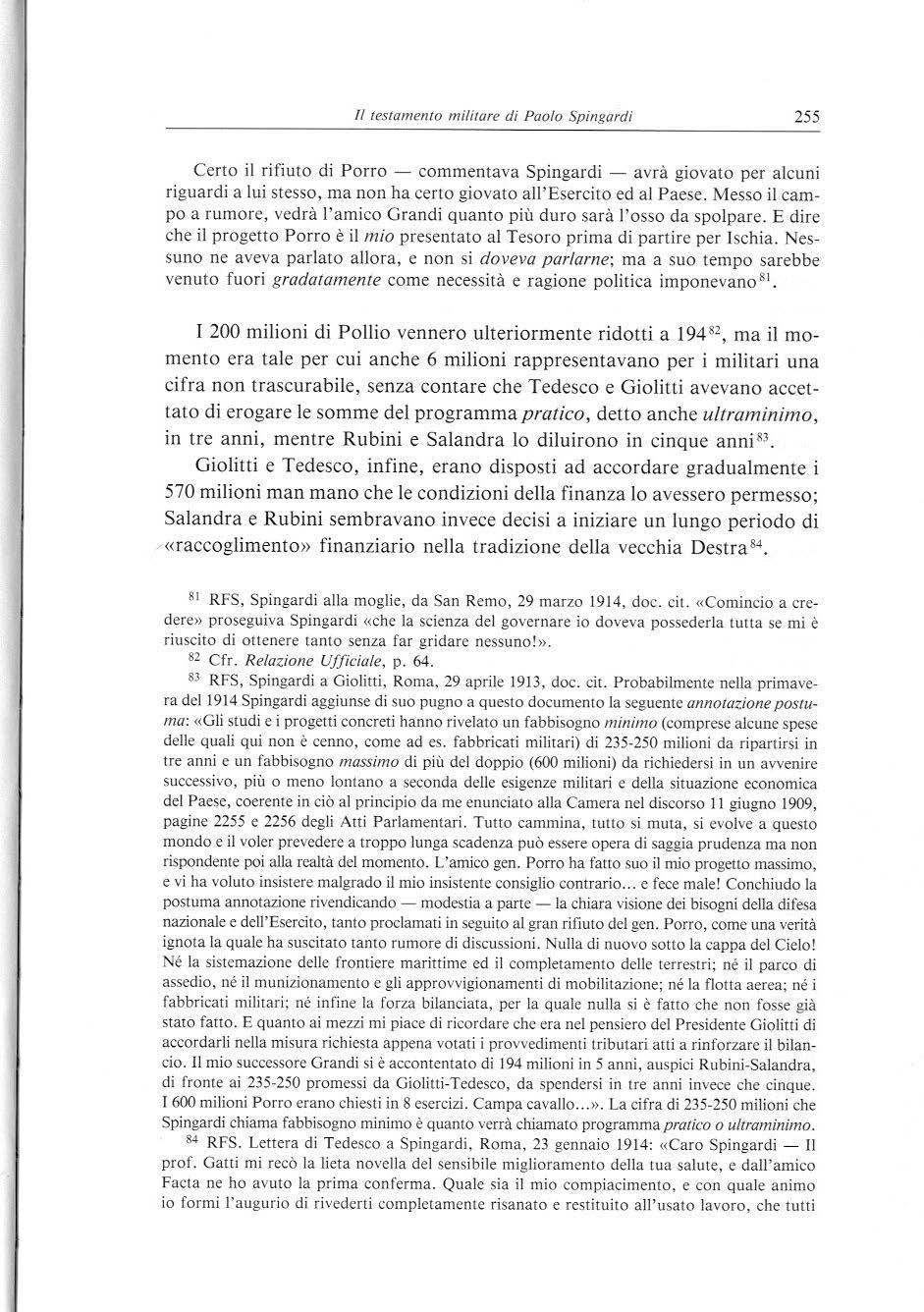
li testamen10 militare di Paolo Spingardi 255
Il generale Paolo Spingardi
Nessun uomo politico sensato poteva igno r are che nelle condizioni di bila nci o conseg u enti a ll a gue r ra di L i bia « il paes e n on potev a pe rm ette r si di sp endere contemporaneamente g r oss e s om me per l'esercito, i lavo ri p ubblici e i servizi sociali» 8 \ Ma d'altra parte la volontà di Giol i tti d i venire incontro alle esigenze di Spi n gardi è testimoniata a s u fficie nza p er crede r e c he non si tra ttasse di sem p lic e a r t ifici o po li tico 86 Se n o n s i voleva tag liare il bil ancio della g uerra, l'unica alterna t iva era u n aumento d elle ent rate con un nuovo istema fiscale 8 ;
A ll a luce di qu este co n s id erazioni no n sembra imp ossi bile ch e G io li tt i si p ro p on esse, imma g in a ndo un rito rn o a l pote r e a più o m e no br eve te rmine, di varare davvero una coraggiosa riforma tributaria che ga ra n tendo maggiori e più consistenti introit i alle casse del Tesoro, permettesse d i concedere aument i d i spese mili tar i senza di ssesta re il b il a nc io dell o Stato . Un a sce lta così ra d icale n o n po teva n at u ralme nte essere cond ivisa d a Sa land ra, che pr eferì la via del contenimento delle spese
sappiamo amm ir are, e più di ogni a l tro i tuoi co lleghi, è p i ù faci le a te immaginare che a mc significar per verba, come direbbe il poeta. Abbi dunque fiducia, mio caro Spingardi, e torna presto fra noi, lieto e vigoroso, a pa110 di moderare le lUe richieste al povero ministro del tesoro, che, a dirla qui fra noi, ne ha più pochi. La tua raccomandazione per il prof. Dalla Vedova bastava da sola a forzare dolceme n te la mia cosc ie nza f i nanz ia r ia Po i sop r a ggiungeva la parola suggest iva de l s impatico prof Galli, e infine i l d il uvio orator io dello stesso prof. Dalla Vedova . In verità da un po' di tempo mi sono dato al nobile ufficio di secare la cra,.ia, come dicono i Toscani. Tuttavia. per compiacere l'amico Spingardi, sfido le folgori dei finanziari amat0ri [?]. Auguri e saluti di gran cuore».
Sulle intenz ion i d i Sa l andra e R ubini cfr. V1cezz1, Il suffragio universale, c i t., p. 564 : «Tra il des iderio di fa re buona accoglienza alle gravose richies te delle alte gerarchie militari, e la necessità di una politica di raccoglimento dopo la guerra di Libia, Salandra inclina infine alla seconda solu.tione » ; SETo:--WA TSO:-., p. 459: « Giulio Rubini, ministro del Tesoro ed orgogliosamente ligio alla tradizione di Sella, chiese che il pareggio del bilancio avesse la prio r ità su qua lsi as i altra es igenza» e anc he d a Deposizione Caporello, p. 10: «l ii i compianto Ministro Rub ini non aveva esitato a dichiarare che non sarebbe rimasto un giorno di più al Ministero del Tesoro se si fosse attentato alla compagine finanziaria del Paese» .
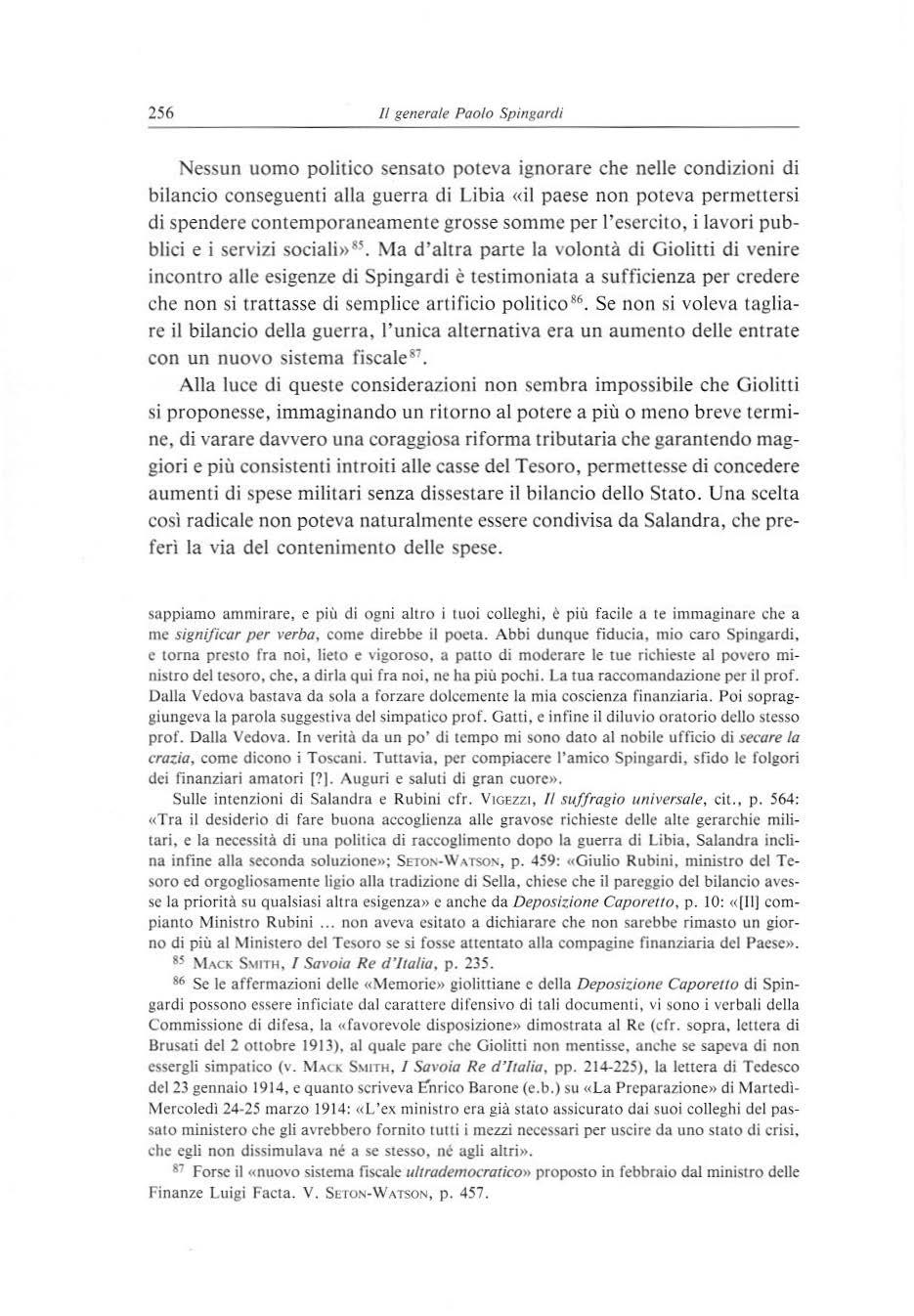
ss YIA C K S\II TH, l Savoia Re d'Italia, p. 235.
86 Se le affermazioni delle «Memorie» giolittiane e della Deposizione Caporetro di Spinga r di possono essere inficiale da l ca r attere d i fens ivo di ta li documenti, v i so n o i verba li dell a Commissione d i difesa, la « favorevole dispos izione» dimostrata al Re (cfr. sopra, lettera di Brusati del 2 ottobre I 9 I 3), al quale pare che Giolitti non mentisse, anche se sapeva di non essergli simpatico (v. MA<. 1. s~urn, I Savoia Re d'Italia , pp. 214- 225), la lenera di Tedesco del 23 gennaio 1914, e quanto scriveva E'nrico Barone (e.b.) su « L a Preparazione>) di MartedìMercoledl 24-25 ma r zo 19 14: «L ' ex min istro era g ià sta i o assicu ra to dai suoi co ll eghi de l pass ato ministero che gli avrebbero fornito tutti i mezzi necessari per uscire da uno stato di crisi, che egli non dissimulava né a se stesso, nt agli altri »
87 Forse il « nuovo sistema fiscale ullrademocratico» proposto in febbraio dal ministro delle Finanze Lu igi Facta V. St 10:-1 - WATSON, p. 457
256
Nemmeno il programma pratico e bbe mai anche s olo un principio di attu a zione. Però, in seg uito allo sco ppio de ll a guerra, dall'ago st o 1914 al gi ugno 1915 v ennero concessi o ltre due miliardi per sole spese straordinarie 88 • Ma i parametri erano alterati, Pollio e ra morto il 1° luglio 1914 e non era Spingardi a reggere il timo n e d el Minis tero d ella Guerra . Com inciava un'a ltra epo ca n e lla stor ia dell'Eserci t o I ta li ano 89
88 V. Relazione Ufficiale , p. 71.
89 La no tevole s tima goduta da Sp in ga rdi a l termine della sua ca rriera mini ste riale m i sembra confermata dall' i nten zione d i Vitto r io Eman ue le Ili d i nom inarlo P resi d en te del Senato. V. RFS , Bru s a t i a Sp ingardi , Roma, 22 mar zo 191 4: « Deb bo . .. riservatissimame111 e e commettendo u na indiscre zione c he mi pe rdon erai , d irti cosa che ti farà senz a d u bb io p iacere, s icco me nuova co nfe rm a d e lla benevolenza d el Re . Questi pronunciò le seguenti parole che ripo rto test ua lmente : "A suo tempo Spingardi sarà un ottimo Presiden1e del Senato". Ed io m i auguro d i saluca r ti un g iorno mio Presidente)) , P er conc ludere , qualch e cenno sug li ultimi anni d i vi ta d i Sp ingardi. el maggio del 191 5 ebbe il comando del Corpo d'Armata terri toriale di Mi la no, ma lo tenne pe r poch i g iorni, pe rché d opo alcun i d iso rdin i an tia u striac i, ven ne r imo sso dall' i ncar ico benché i fat ti coinvolgessero il pre fetto assai più che il comandante mil i tare. Ma egli era di venta to il ca p ro espiato r io d e lla s u pposta impreparaz ione, e doveva perciò subire l'onda i nte r ventista. Venne allo ra nom i nato P res id ente della Commiss ione Cen t ra le dei Prig io n ier i di Guerra. Se g uendo la scrupolosi tà c he gl i e ra propr ia, vo lle visitare personalmente il ca mpo di p rig io ni a sull'iso la d e ll' Asi nara. Qui contrasse una a ffezione re spi ra tor ia, forse u na f ebb re di t ipo malarico . Pur appa rentemente g ua r ita, essa m i n ò il fisico dell'ormai ulrrasett antenne se na tore, che mor ì n ella s ua d ile t ta Spigno il 22 set tembre 1918, senza poter ass istere alla vittor ia dell'ese rci to al quale aveva dedica to le migl io ri en e rg ie d ell a s ua vi ta.
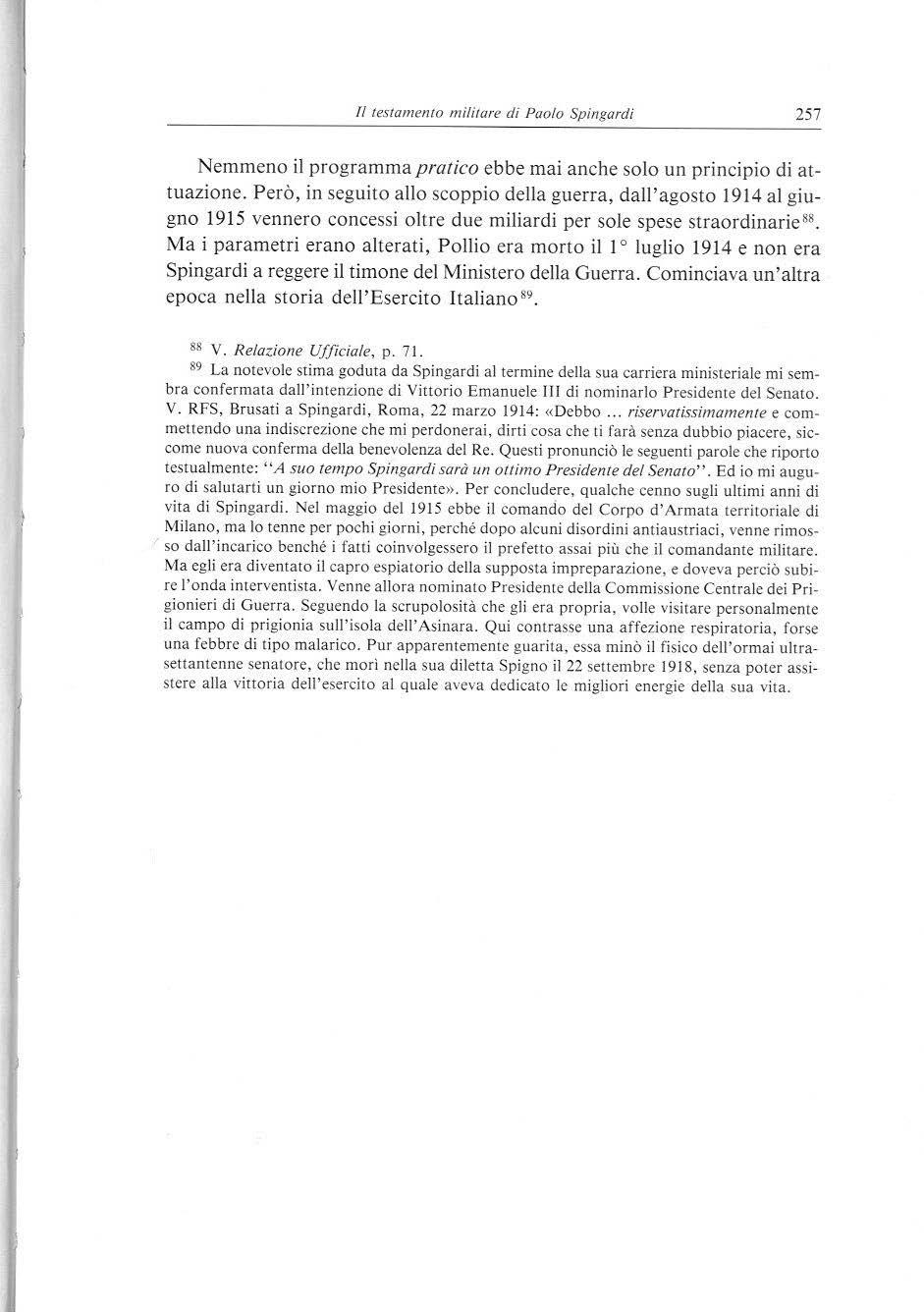
li testamento militare di Paolo Spingardi 257
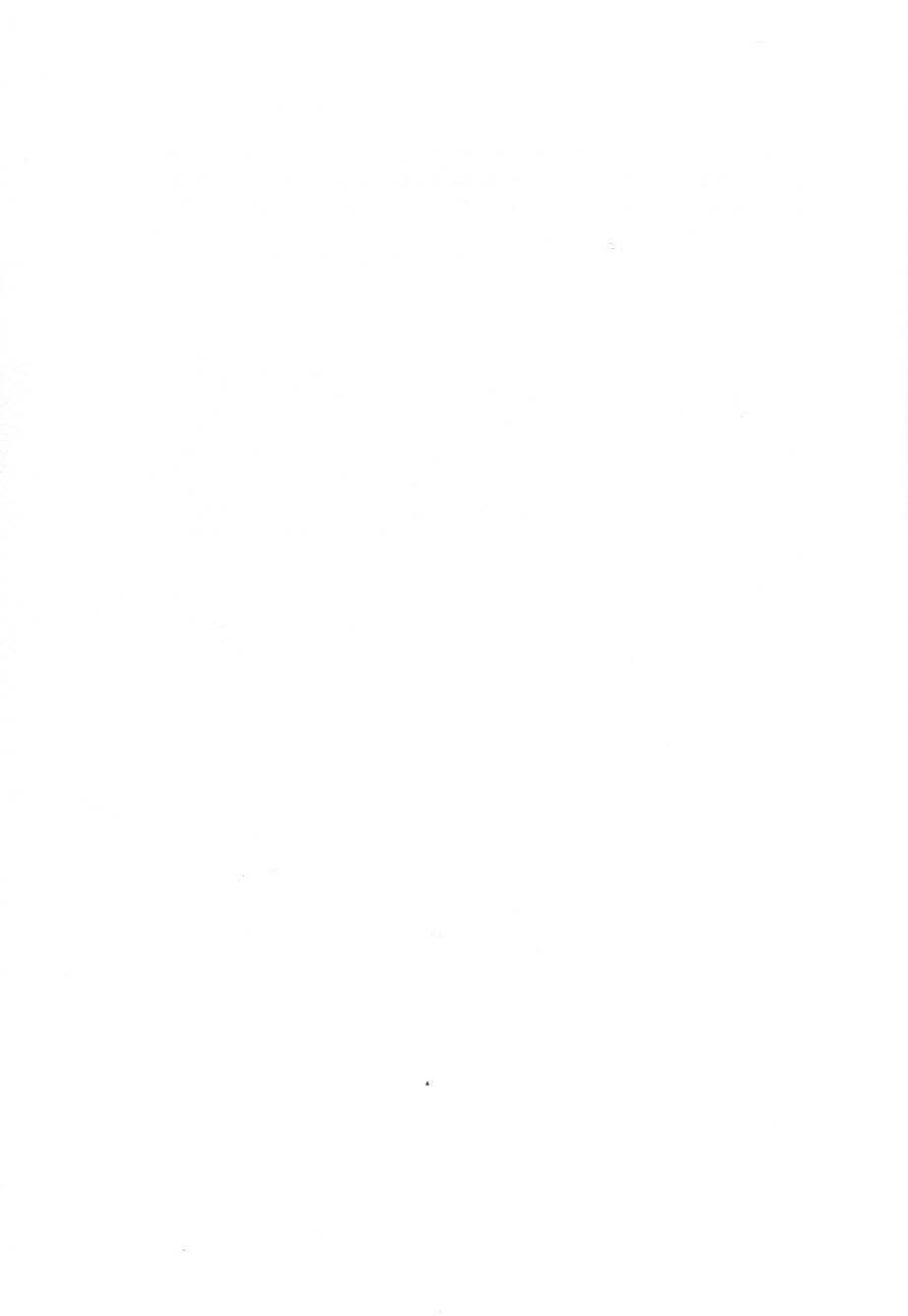
FONTI
a) Fonti ine dit e :
R accolta della Famiglia Spingardi (abbr. in RFS), in corso di rio r dinamenio, Spigno M onfe rra to (AL).
Archivio Ce ntrale dell o Stato, Rom a (a bbr. in ACS)
Archivio Brusati, scato le IO e 11.
Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, R oma (abbr. in A USS ME)
Ordinam e nto e Mobilita zione (OM), Repertori o F-4 . Scacchiere orienta le , Repe rto r io G-22.
Commissioni di difesa, Repert orio F -9.
S.M.R. E. - Classificato « RR », Repertorio H- 5.
Istituto per la sto ria de l Ri so r gi m e nto - Mu seo Centr al e d e l Ri sorgimento, Rom a (abbr. MCR) . A rchi vio Dallo/io
b) Font i e dit e :
ATTl PARLAME TA RI - Cam era e Senato - Discussioni e Atti Stampati - L egislature XXIII e XX I V.
GIOR AL E MILJ TA R E UFF IC IAL E, Rom a, a nnate 1909- 19 14.
P er iod ici:
« II Pen sie r o Militare», Roma, annat e 1909-1914.
« L'Esercito italiano », Roma, annate 1909-1914.
«L a P reparazione», Roma, annate 1909-1 914.
Repertori:
AN UARI O MILITARE DEL RE G NO D'ITALIA, a cura del Ministero de ll a Guerra, R oma, anni 1871-1914
A. M ALAl t STA (cur.), Minisrri, D epu tati, Senat ori dal 1848 al /922 . Enciclopedia biografica, 3 voli., Bernardo e Ca r lo Tos i, Milano 1940
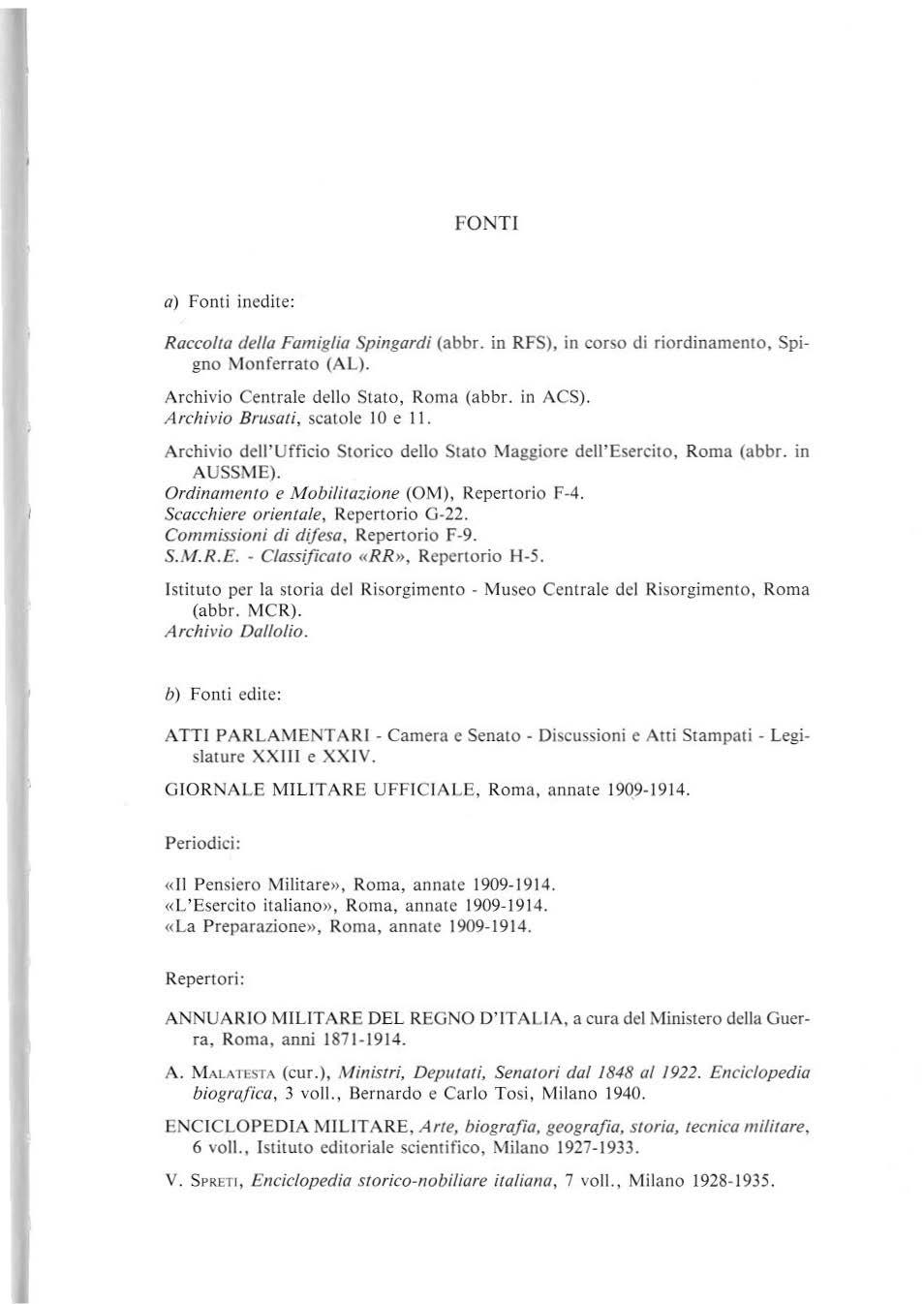
E CICLOPEDIA MILITARE , Arte, biografia, geografia, storia, tecnica militare, 6 voli., Istituto editoriale scientifico, Milano 1927-1933.
V. SP RE TI, Enc iclopedia sto rico-nobiliare italiana , 7 vo ll., Milano 1928-1935 .
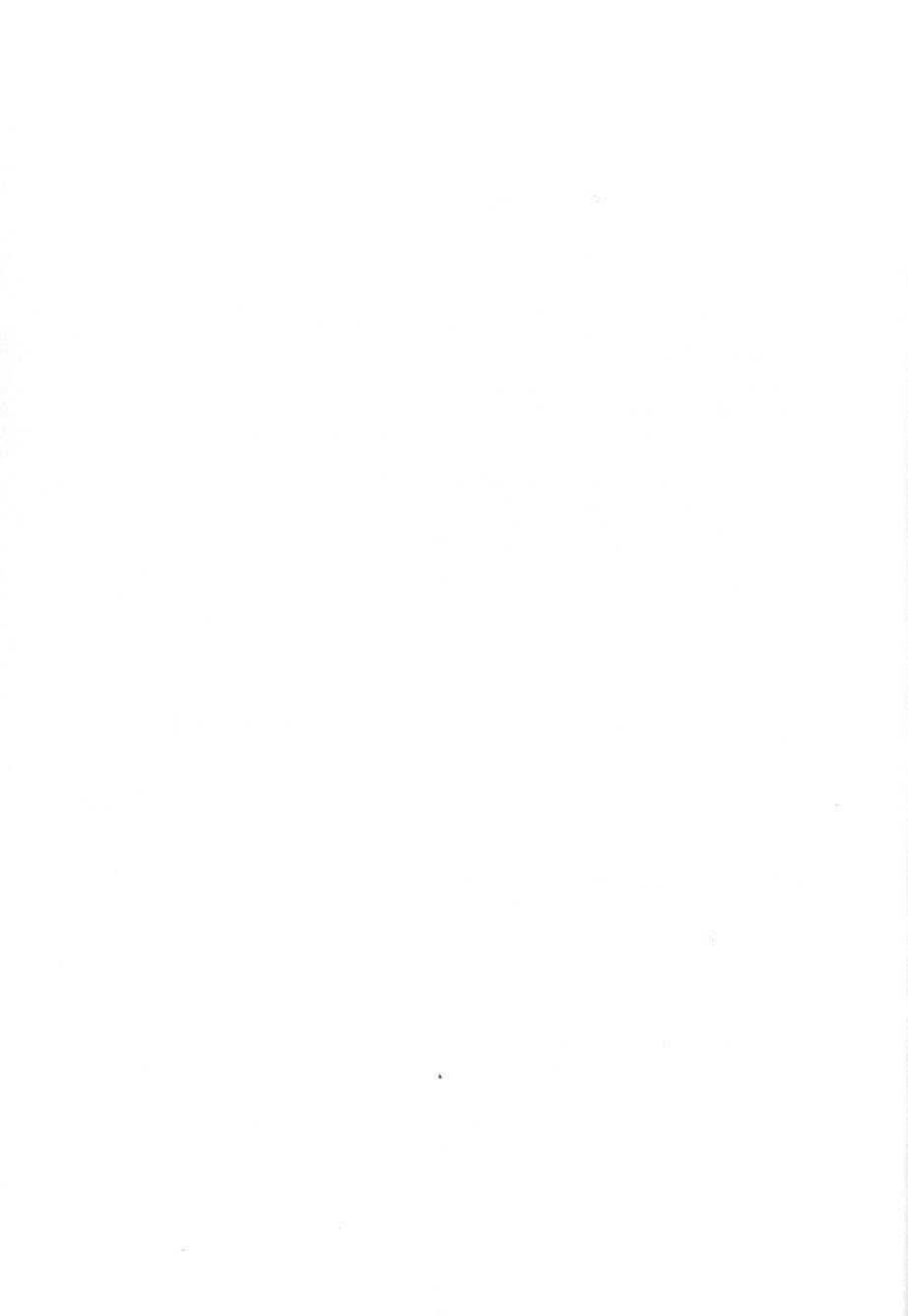
INDICE DEI NO MI*
Abbiate, Mari o, 65, 91.
Abriata , Caterina, 21.
Aehrental, Aloi s Ludwig Lexa ,on, 86.
Alberti, Adriano, 15, 28.
Alessio, G iul io, I 9 I.
Aliprindi, Florcnzio, 124.
Ameglio, Giovanni, 150, 166.
Ame rio, Fel ice, 124, 183, 249.
Amero d' Aste, Marcello, 239.
Arnirante, Michele, 124.
Arcasio, Giovanni Francesco Al essan dro, 22.
Arimondi, Giu~eppe, 23, 27.
Arpa, Luigi, 124, 125.
Anom , Ernesto, 69.
Asinari di Bern ezzo, Vittorio, 23.
J\ureggi, Giuseppe, 124, 125.
Avanzi, A lighiero, 194.
Badaloni , N icola, 61, 62, 68, 69, 70, 7 1.
Badoglio, Pietro, 150.
Bald issera, Am onio, 30.
Bara tieri, Oreste, 57 , 72.
Barone , Enr ico (e.b ), 52, 256.
Banoli, Perugino, 185.
Barzilai , Salvatore, 61, 62.
Bauag lier i, Augu sto detto Agostino, 41 , 65, 112, 134, 137.
Bava-Bcccaris, Fiorenzo, 7, 23, 7 1, 75, 95, 109, 21 6.
Beccaria-Incisa, Ferdinando, 124.
Belardi11elli, Mario, 82.
Bellati, Gi us eppe, 26.
Bellini, Francesco, 124.
Bencivenga, Roberto, 8, 99 .
Bergamasco, Euge n io, 65 . 112 .
Berta , Luigi, 124
Bethmann - Hollweg, T heobald von, 233.
Ben o lo, Gi o vanni, 30, 136.
8iagi11i, Antonello F.M., 11, 154.
Bianchini, Alessandro, 111.
Biscareui d i Ruff ia , Carlo, 87 .
Biscarctti di Ru ffia, Guido, 87.
Bisca retti di Ruffia, Roberto , 87
Bi sso lati, Leonida, 62.
Bixio, 'ino, 71 .
Bompiani, Giorgio, 102.
Bonazzi, Lorenzo, 44, 4 5 , 240.
Bonomi, lvanoe, 248.
Borghi , Achille , 185.
Borsare ll i, Luig i, 65, 11 2.
Boselli, Paolo, 70, 137, 139.
Bosworth, Richard J.8., 8 1, 174.
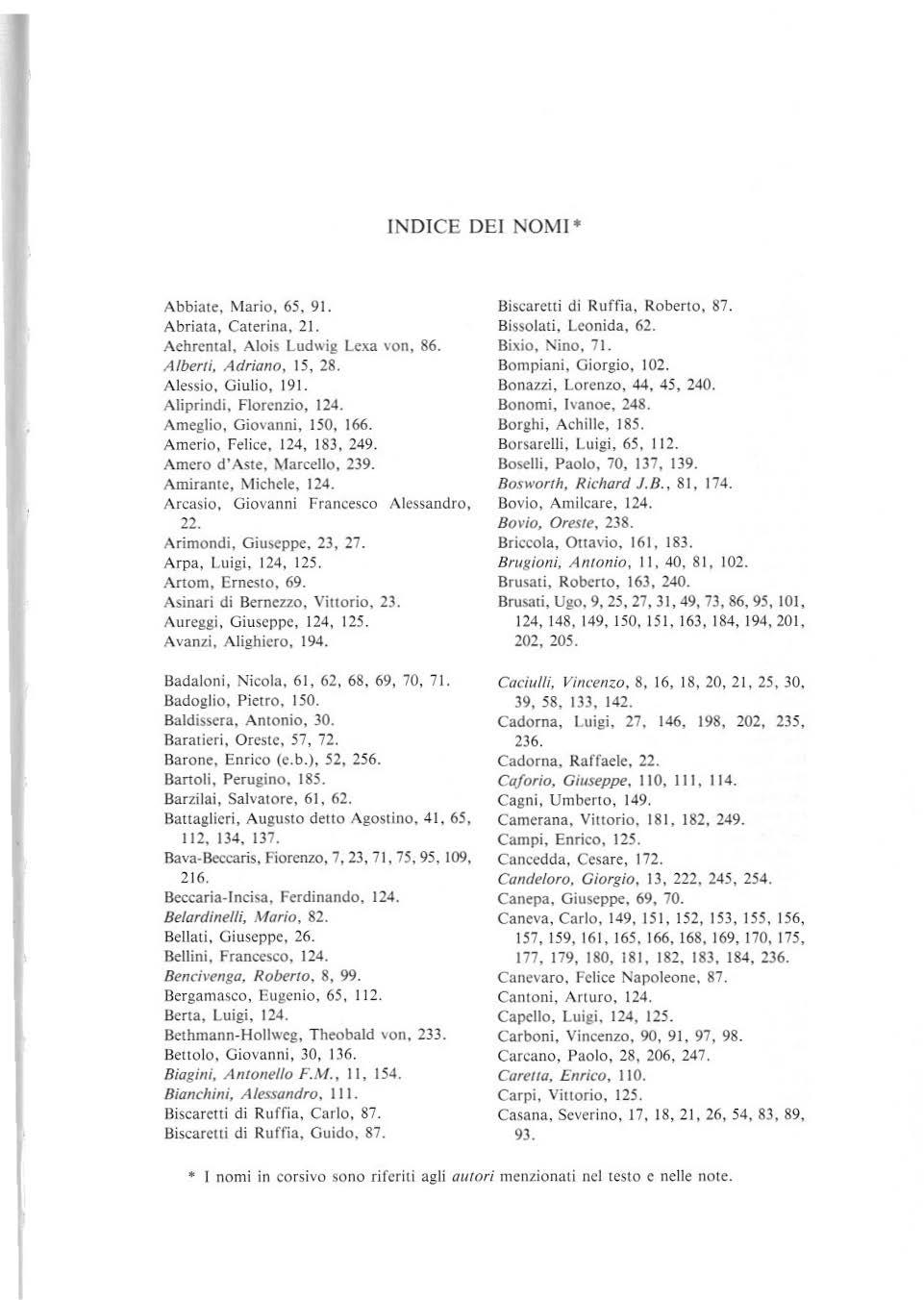
Bovio , Amil care, 124.
Bo vio, Ores1e, 238.
Briccola, Ouavio, 161, 183
Brugioni, Antonio, 11, 40 , 8 1, 102.
Brusaci, Roberto, 163, 240.
Bru saci, Ugo, 9, 25, 27, 31, 49, 73, 86, 95, 101, 124, 148, 149, 150, 151, 163, 184 , 194,201, 202, 205.
Caciulli, Vincenzo, 8, 16, 18, 20, 21, 25, 30, 39, 58, 133, 142.
Cadorna, Luigi, 27, 146, 198, 202, 235, 23 6.
Cadorna, Raffaele, 22.
Caforio, Giuseppe, 110, 111, 114.
Cagn i, Umberto , 149.
Camcrana, Vittorio, 18 1, 182, 249.
Campi, Enrico, 125.
Cancedda, Cesar e, 172.
Cande/oro, Giorgio, 13, 222 , 245, 254.
Canepa, Giuseppe, 69, 70.
Cancva, Carlo, 149,15 1, 152, 153, 15 5, 156, 157, 159, 16 1,165. 166, 168, 169, 170, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 236.
Canevaro, Felice Napoleone, 87.
Cantoni, Arturo, 124.
Capello, Luigi, 124, 125.
Carboni, Vincenzo, 90, 91, 97, 98
Carcano , Paolo, 28 , 206, 24 7 .
Carella, Enrico, 110.
Carpi, Vinorio, 125.
Casana, Sever ino, 17 18 , 21 , 26, 54, 83, 89, 93.
• I
i n co rs ivo so no ri fer iti
no
nomi
agli aLlfori menzionati nel cesto e nelle
te.
Casana Testore, Paola, 20, 21.
Caserta, Cristinziano, 185.
Castagna, Gaspare, 124.
Cavaciocchi, Alberto, 7, 15, 16, 17, 18, 27, 29.
Caviglia, Enrico, 150.
Ceva, Lucio, 11, 13, 14, 18, 129, 142.
Chabod, Federico, I I, 23.
Chiesa, Eugenio, 2 10, 21 1, 216.
Chimienti, Pietro, 91, 94.
Chiofalo, Ignazio, 124.
Ciald ini , Enr ico, 2 2
Ciancio, Giuseppe, 161.
Ciccotti, Ettore, 91, 92, 145, 189.
Civallero, Giuseppe, 245.
C lementi , Giulio, 25.
Cocn. Achille, 124
Colombo, Giuseppe, 236.
Conf1cnti, Raffaele, 65.
Conrad von Hoctzendorf, Franz, 15, 86.
Corradini, Giuseppe. 125.
Costa, Andrea, 59.
Crema, Camillo, 124
Crispi, Francesco, 13, 26.
Cruccu, Rinaldo, 8, 13, 19, 39, 47, 144, 148, 196, 239.
Cucci, G iacomo, 124.
Curami, Andrea, 144.
Dalla Vedova, Giuseppe, 256.
Dallolio, Alfredo, 135, 240
Dal ' egro, Enrico, 124.
Dal Verme, Luchino, 41, 112, 136, 142.
Dan ie li, Gualtiero, 11 2.
De Bono, Emilio, 23, 24, 110, 115, 116, 150. De Biase, Corrado, 248.
De Chaurand de Sain1-Eustache, Felice, 7, 13, 15, 18 , 23,39,4 1,43,58, 100, 109,110, li i, 116, 117,130, 131,133, 137,184,185,193, 20 I, 202, 218, 252, 254.
Decleva, Enrico, 235.
De La Coree, Paul-Marie, 58, 233.
Del Boca, Angelo, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155,1 56,157,161,162,165, 166,170,171, 174, 175, 179, 182, 183, 184 , 185, 186, 189.
Del Buono, Francesco, 172
Del \1ayno, Luchino. 30.
Del Negro, Piero, 16, 54, 57, 58. 68, 72, 110, 11 1, 114. '
De Napoli. Domenico, 11 1, 114, 117.
Dèport, Jo5eph Albert, 131, 220, 222
De Rosa, Luigi, 225.
De Rossi, Eugenio, 109, 110, 11 1, 11 3, 11 6.
De Stefano, Matteo, 124, 125.
Di Palma, Federico, 69.
Di Saluzzo di Paesana, Marco, 55, 56, 57, 60, 61,63,65,85,89,91, 100,104,112,134, 136, 190,207,215.
Douhct, Giulio, 240
Dructti, Giuseppe, 124, 125.
Drueui, Luigi, 124.
Duce, Alessandro, 18
Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, 51, 21 1.
Enver, Bey, 157, 162, I 71, 172, I 75, 184.
Facta, Luigi, 245, 255, 256.
Falls, Cyril, 1 15.
F a ra, Gusta vo, 156, I 6 1.
Faravelli, L uigi, 166, 172, 182.
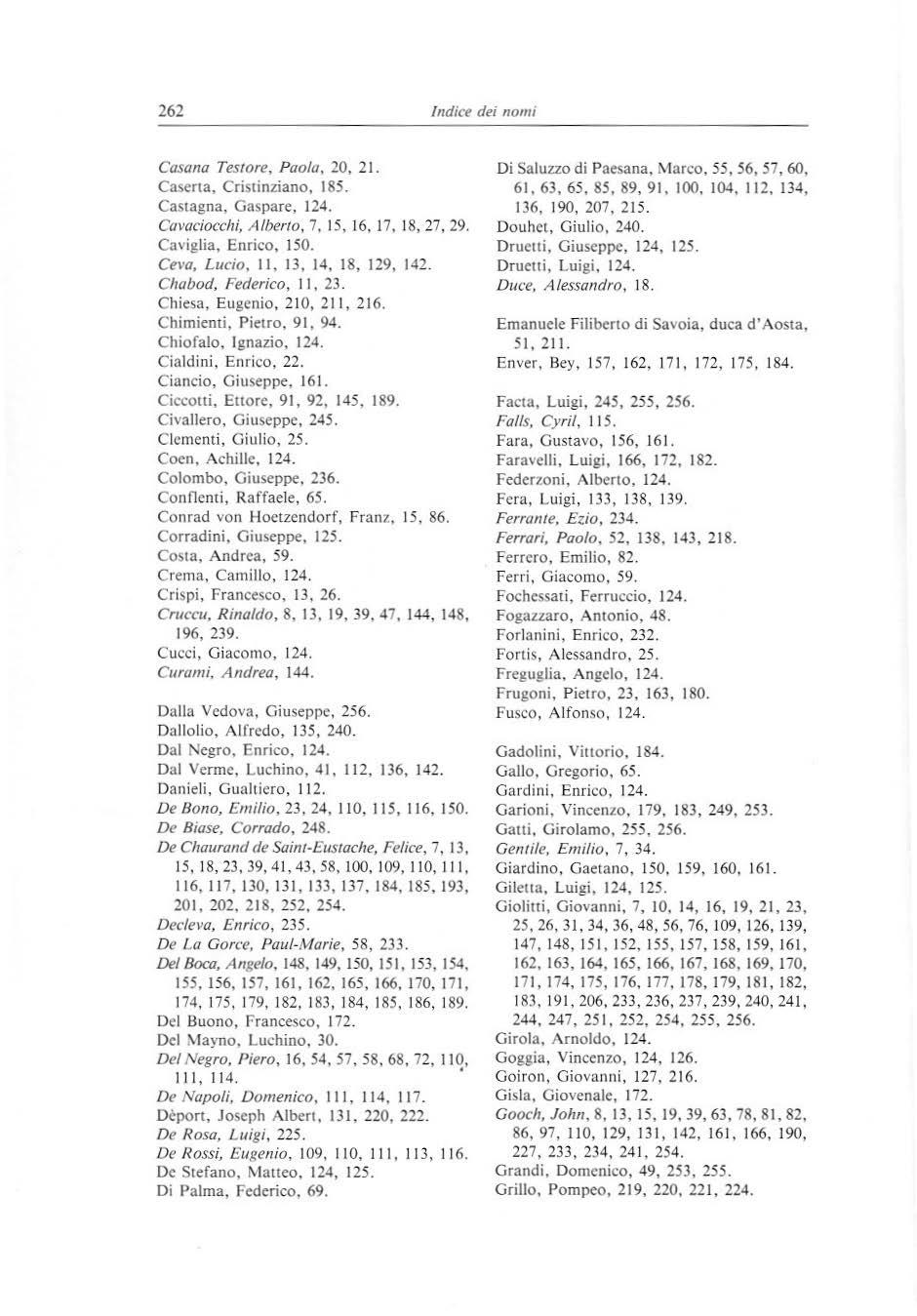
Feder1.0ni, Alberto, 124.
Fera, Luigi, 133, 138, 139.
Ferrante, Ezio, 234.
Ferrari, Paolo. 52, 138, 143, 218.
Ferrcro, Emilio, 82.
Fer ri, Giacomo, 59.
Fochessati, Ferruccio, l 24.
Fogaaaro, Antonio, 48.
Forlanini, Enrico, 23 2 .
Fortis, A le ssandro, 25.
Freguglia, Angelo, 124.
Frugoni, Pietro, 23, 163, 180.
Fusco, A lfo nso, 124 .
Gadolini, Vittorio, 184.
Gallo, Gregorio, 65.
G a rdini, Enrico, 124 .
Garioni, Vincen.:o, 179, 183, 249, 253.
Gatti. Girolamo, 255, 256.
Gentile, Emilio, 7, 34 .
Giard ino, Gaetano, 150, 159, 160, 161.
Giletta, Luigi, 124, 125.
Giolitti, Giovanni, 7, IO, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 31 , 34, 36, 48, 56, 76 , 109, 126, 139, 147, 148, 151, 152, 155. 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,174,175,176,177,178,179,181,182, 183, 191,206,2 33 , 2 36,237 ,2 39,240,24 1, 244. 247,251,252,254,255,256.
Girola, Arnoldo, 124.
Goggia, Vincenzo, 124, 126.
Goi ron, Giovanni, 127, 216.
Gisla, Giovenale, 172
Gooch, John. 8, 13, 15, 19, 39, 63, 78, 81, 82, 86, 97, 110, 129, 13 1, 142, 16 1, 166, 190, 227, 233, 234, 24 1, 254.
Grandi, Domenico, 49, 253, 255.
Grillo, Pompeo, 219, 220, 221, 224.
262
Indice dei nomi
Guicc ia rdini, Francesco, 159.
Guidi di Bagno, Giuseppe, 69
Howard, Michael E , 65, 97, 115
lsnenghi, Mario, 7.
La banca, Nicola, l l 6.
La Bua, Giuseppe, 167.
Landes, David S , 131
La Marmora, Alfonso, 82.
Lamberti, Ma rio, 7 I , 75, 216
Leona rd i Catto lic a, Pasquale, 185.
Leonardi di Vill acortese, Nicolò, 69 .
Luc ifero, A l fo nso , 11 2 .
Lu igi Amedeo di Savo ia, duca d egl i Abruzzi, 122.
L uzzatti, Lu ig i, 16, 27, 49, 51, 76 , 89, 126 .
Ma ck Smith, Denis, 235, 254 , 25 6
Maggiolin i-Scarampi, Alessandro, 124.
Maggio tto, Giovanni, 18 5.
Majnoni d ' Int ignano, Luigi, 60, 67, 95 .
Majorana , Angelo, 16 .
Malagodi, Olindo, 163.
Malgeri, Francesco, 148, 150, 152, 153, 155 , 16 1, 166, 17 1, 173, 174, 183, 189.
Mal!ese, Paolo , 247 .
Manacorda, Gas1one, 13.
Mandile, Lu igi , 124 , 125 , 126.
Mangia galli, Am on io, 133.
Manfredi, Cris t oforo (c .m.), 102.
Ma ngili, Cesare, 236.
Marangoni, Cesare, 124.
Marazzi, Fo rt un a to , 60, 9 1, 92 , 94, 118,201, 208, 209, 210, 214, 227.
l'Vla rco ra, G iuse ppe, 90, 212.
Martinelli, Michele, 124 , 125, 126.
Masi, Tullo, 94, 206, 207.
Mass obrio, Giulio, 8, 13, 14, 54, 66, 73, 78, 82, 108, 109, 127, 129 , 142.
Massone, Em ilio, 124, 125
Mazza, Francesco An tonio, 95, 127 .
Mazzaccara, Carlo, I I 5 .
MazzeUi, Massimo, 8 , 14, 15 , 16, 19, 23, 39, 40, 47, 48, 49, 8 1, 86, 102, 148, 149, 189.
Mazzitelli, Achille, 57, 61, 124,209
Menada, Be nvenu to, 185
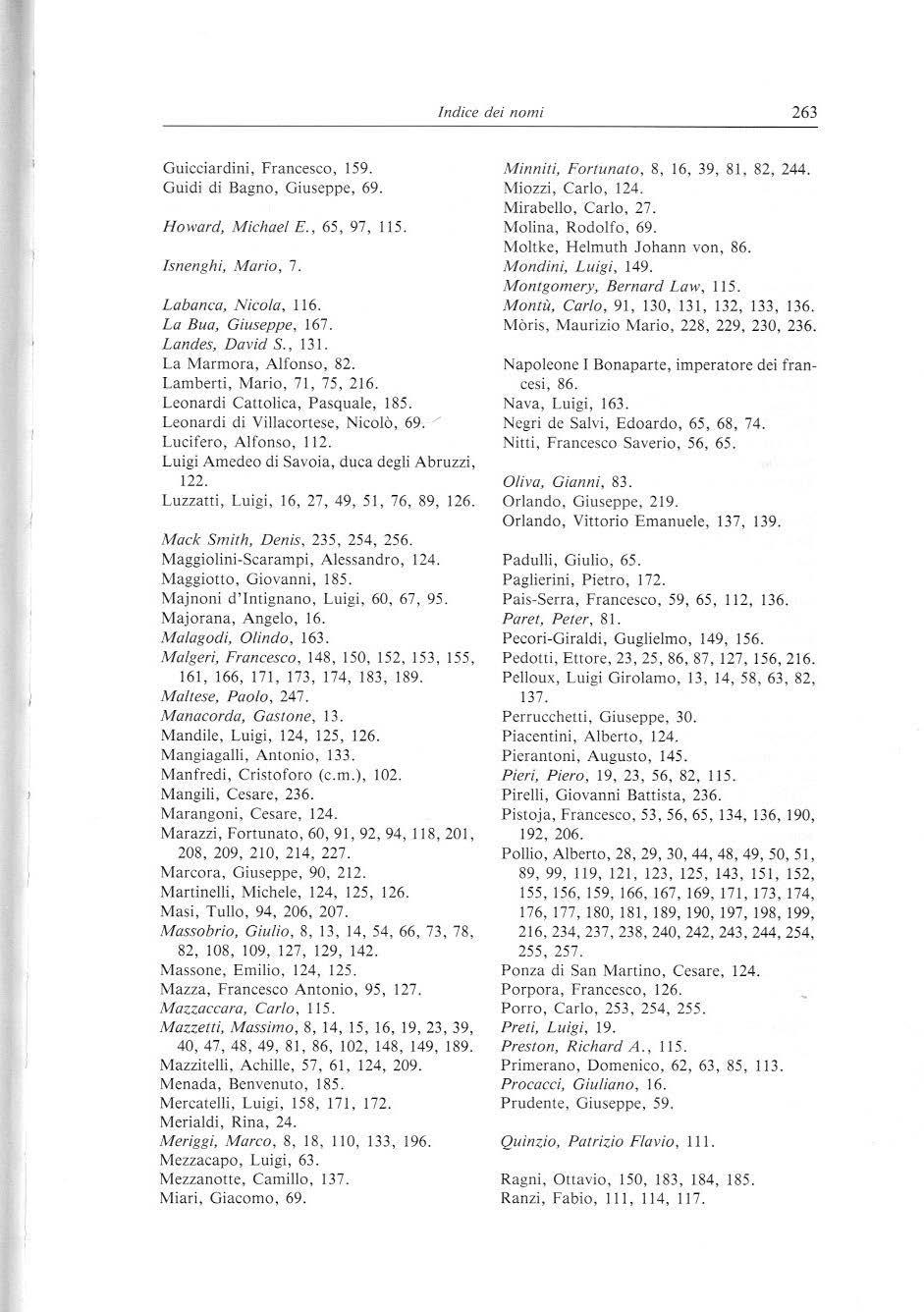
Mercatell i, Luigi, 158, 171, 172 .
Merialdi, Rina, 24.
Meriggi, Marco , 8, 18, 110, 133, 196 .
Mezzacapo, L u igi , 63.
lvlezzanotte, Cam illo, 137.
Miar i, G iacomo , 69
Minnili, Fortuna/o, 8, 16, 39, 81 , 82, 2 44 .
M iozzi, Car lo, 124.
Mira be lJo , Car lo, 27
Mol ina, Ro dolfo , 69.
Moltke , He lm u th Johann von, 86.
Mondini, Luigi, 149.
1Won1 go m e1y, Be rnard Law, 11 5.
Mon1ù, Carlo, 91, 130, 131, 132, 133, 136.
Mòri s, Mauri zio Mario, 228 , 2 29, 23 0, 236.
Napoleone I Bonaparte, imp e ratore de i fra nces i , 86 .
Nava , Luigi, 163 .
Negri de Salvi, Edoardo, 65 , 68, 74 .
N itt i, Francesco Saver io , 56, 65.
Oliva, Gianni, 83.
Orlando, Giu seppe, 219.
Orl ando, Vi uorio E manuele , 137, 139.
P a d u lli, Giulio, 65.
Paglierini, P ietro, 172.
P ais -Serra, Francesco, 59, 65, 112 , 136.
Parei, Pete r, 81 .
Pecori -Girald i, Gu gl ie lmo, 149, 156.
Pedoui, Etto re , 23 , 25, 86 , 87, 127, 156, 216.
P e ll oux, Lu ig i G i ro lamo, 13, 14, 58, 63, 82, 137.
P erruccheui, G iu seppe, 30.
Piacentini, A Iberto, 124
P iera ntoni, Augusto, 145.
Pieri, Piero , 19, 23 , 56, 82, 1 15.
Pirelli, Giovanni Battista, 236.
Pistoj a, Francesco, 53, 56, 65 , 134 , 136, 190, 192, 206
Poll io, A l bert o , 28, 29, 30, 44, 48 , 49, 50, 5 1, 89, 99, 119, 121, 123, 125, 143, 151 , 152, 15 5,156,159,166, 167, 169,171,17 3,174, 176, 177 , 180, 18 1, 189, 190, 197, 198, 199, 216, 234,237,238 , 240, 242, 243, 244, 2 54, 2 55 , 257.
Ponza d i San Martino , Cesare, 124.
P or pora, Fra nc esco, 126.
Porro , Carlo, 253 , 25 4, 255 .
Pre1i, Lu igi , 19
Preston, Richard A., I 15.
P rime rano, D omen ico, 6 2, 63, 85, I I 3.
Procacci, Giuliano , 16
Pruden te, Giuseppe, 59.
Quinzio, Pa1rizio Flavio , 111.
Ragni, Ottavio , I50, 183, 184, 185.
Ra n zi, Fabio, I li, 114, 117
Indice dei nomi 263
Rcisoli, Ezio, 176 , 179.
Ricci, Carlo, 124, 125.
Ricou i Magnan i , Cesare, 13, 4 1, 66. 68, 82, 93, 103, 107, I 16.
Ritter, Gerhard, 9, 58, 233.
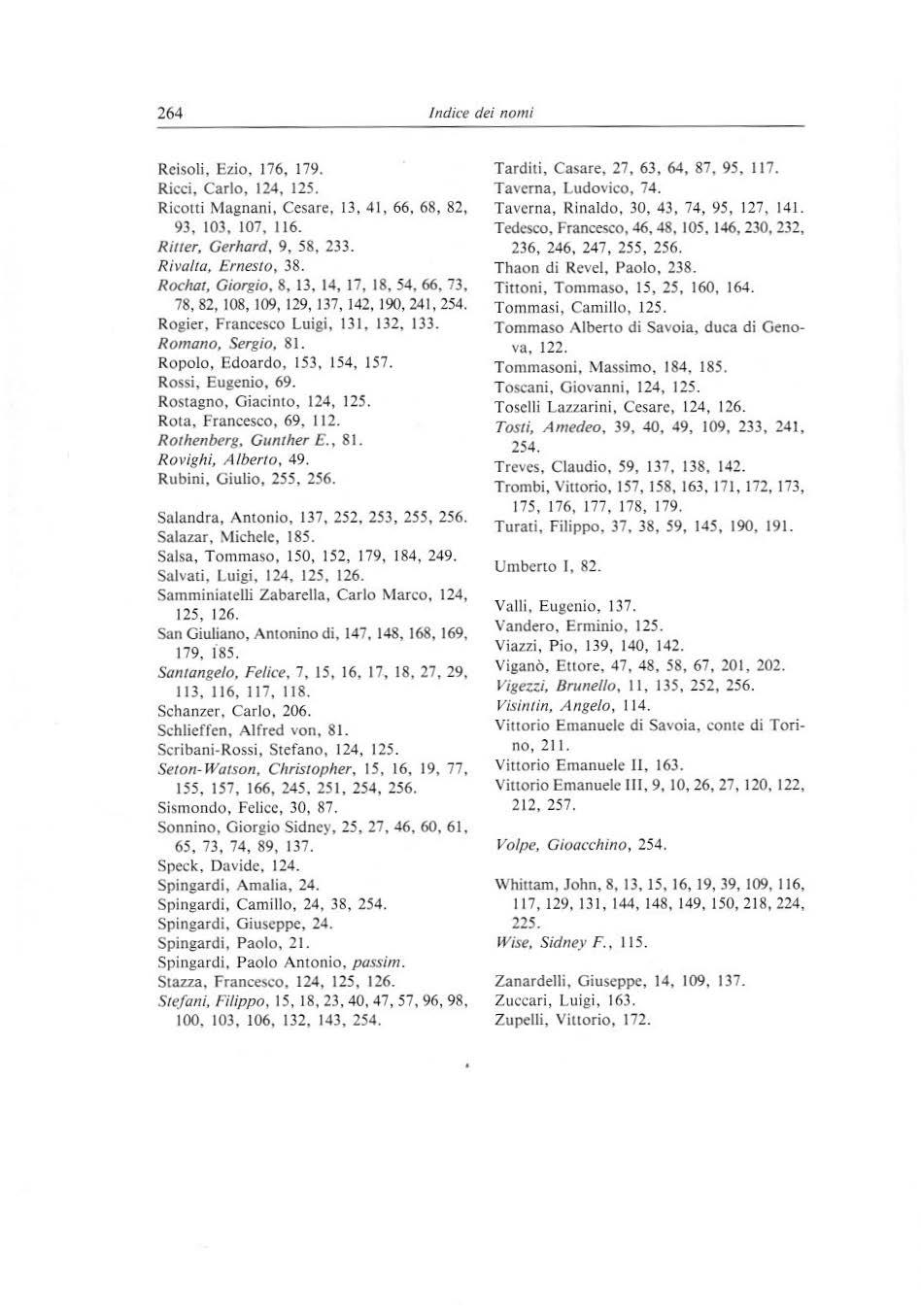
Rivolta, Ernesto, 38.
Rochar, Giorgio, 8, 13, 14, 17, 18, 54, 66, 73, 78, 82, 108, 109, 129, 137, 142, 190,241 , 254.
Rog ier , Francesco Luigi, 13 I, I32, 133.
Romano, Sergio, 81.
Ropolo, Edo ardo , 153, 154 , 157.
Rossi, Eugenio, 69.
Rostagno, Giacinto, 124, 125.
R ota, Francesco, 69, l 12.
Rorhenberg, Gunther E., 81.
Rovighi, Alber1 0, 49
Rubini, Giulio, 255, 256.
Salan d ra, Antonio, 137, 252, 253, 255, 256.
Salazar, Michele, 185.
Salsa , T o mma so, 150, 152, 179, 184,249.
Salvati, Luigi, 124, 125, 126.
Samminiatelli Zabarella, Carlo Marco, 124, 125, 126.
San Giuliano, Antonino di, 147. 148, 168, 169, 179, 185.
Sanrangelo, Felice, 7, 15, 16, 17, 18, 27, 29, 113, 116, 117, 118.
Schanze r , Carlo, 206.
Schlieffen, Alfred von, 81.
Scribani- Ro ss i, Stefano, 124, 125
Seron-Watson, Christopher, 15, 16, 19, 77, 155, 157, 166, 245, 251, 254, 256.
Sismondo, Felice, 30, 87.
Sonnino, Giorgio Sidney, 25, 27, 46. 60, 6 1, 65, 73, 74 , 89, 137.
Speck, Davide, 124.
Spingardi, Amalia, 24.
Spi ngardi , Camillo , 24, 38, 254
Spingardi. Giuseppe, 24.
Spingardi, Pa olo, 21.
Spingardi, Paol o Antonio, passim.
Stazza, Francesco, 124, 125, 126.
Sie/ani, Filippo, 15, 18, 23 , 40, 47 , 57, 96, 98 , 100, 103, 106, 132, 143, 254.
Tarditi, Casare, 27, 63, 64, 87, 95, 117.
Taverna, Ludovico, 74.
Taverna, Rin a ldo. 30, 43, 74, 95, 127 , 14 1.
T edesco, Francesco, 46, 48, 105, 146, 230, 232, 236, 246, 247, 255, 256.
T haon di Revel, Paolo, 238.
Tittoni, Tommaso, 15 , 25, 160, 164.
Tommas i, Ca m ill o, 125.
Tommaso Albeno di Savoia, duca di Genova, 122.
T ommasoni, .vtassimo, 184 , 185.
T oscani, Giovanni, 124, 125.
To se lli Lazzar i n i. Cesare, 124, 126 .
Tosti, Amedeo, 39, 40, 49, 109, 233, 241, 254.
T revcs, Claudio, 59, 137, 138, 142.
Trombi, Viuorio, 157,158,163,171, 172, 173, 175, 176, 177 , 178 , 179.
Turati, F ilippo, 37, 38, 59, 145, 190, 191.
Umberto I , 82 .
Vall i, Eu ge nio, 137.
Vandero, Erminio, 125.
Viazzi, P io, 139, 140, 142.
Viganò, Etto re , 47, 48, 58, 67, 201, 202.
Vige;;zi, Brunello, 11, 135, 252, 256.
Visin lin, Angelo, 11 4.
Vittorio Emanuele di Savoia, conte di Torino, 211.
Vittorio Emanue le 11 , 163.
Vittorio Emanuele 111, 9, IO, 26 , 27, 120, 122, 212, 25 7.
Volpe, Gioacchino, 2 54.
Whinam, John, 8, 13, 15, 16, 19, 39, 109, I 16, 117, 129, 13 1, 144, 148, 149,150, 218 ,224, 225.
Wise, Sidney F. , 115
Zanardelli, Giuseppe, 14, 109, 137.
Zucca ri, Luig i, 163.
Zupelli, Vittorio, 172.
264
Indice dei nomi
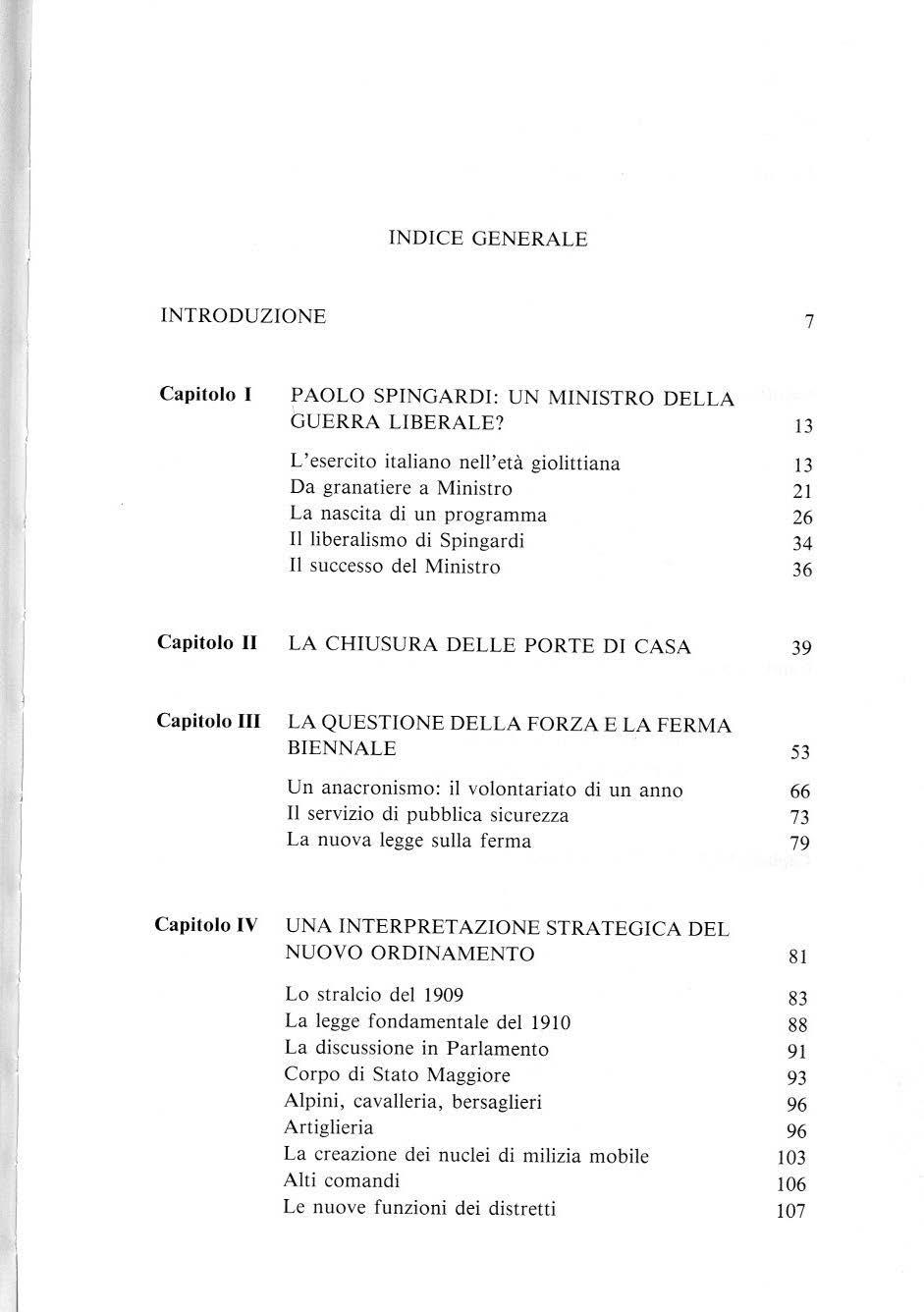
Ca pito lo I PAOLO SPINGARDI: UN MINISTRO DELLA GUERRA LIBERALE?
italiano nell'età gio littiana Da granatiere a Ministro La nascita di un programma Il liberalismo di Spingardi Il successo del Ministro
pito lo II LA CHIUSURA
DI CASA
pi to lo III LA QUESTIONE DELLA
E LA FERMA BIENNALE Un anacronismo: il volontariato di un anno Il servizio di pubblica sicurezza La nuova legge sulla ferma Capito lo IV UNA INTERPRETAZIONE STRATEGICA DEL NUOVO ORDINAMENTO Lo stralcio del 1909 La leg ge fondamenta le del 191 O La discussione in Pa rl amento Corpo di Stato Maggiore Alpini, cavalleria, bersaglieri Artiglieria La creazione de i nuclei di milizia mobile Alti comandi Le nuove funzioni dei distretti 7 13 13 21 26 34 36 39 53 66 73 79 81 83 88 91 93 96 96 103 106 107
INDICE GENERALE INTRODUZIONE
L'esercito
Ca
DELLE PORTE
Ca
FORZA
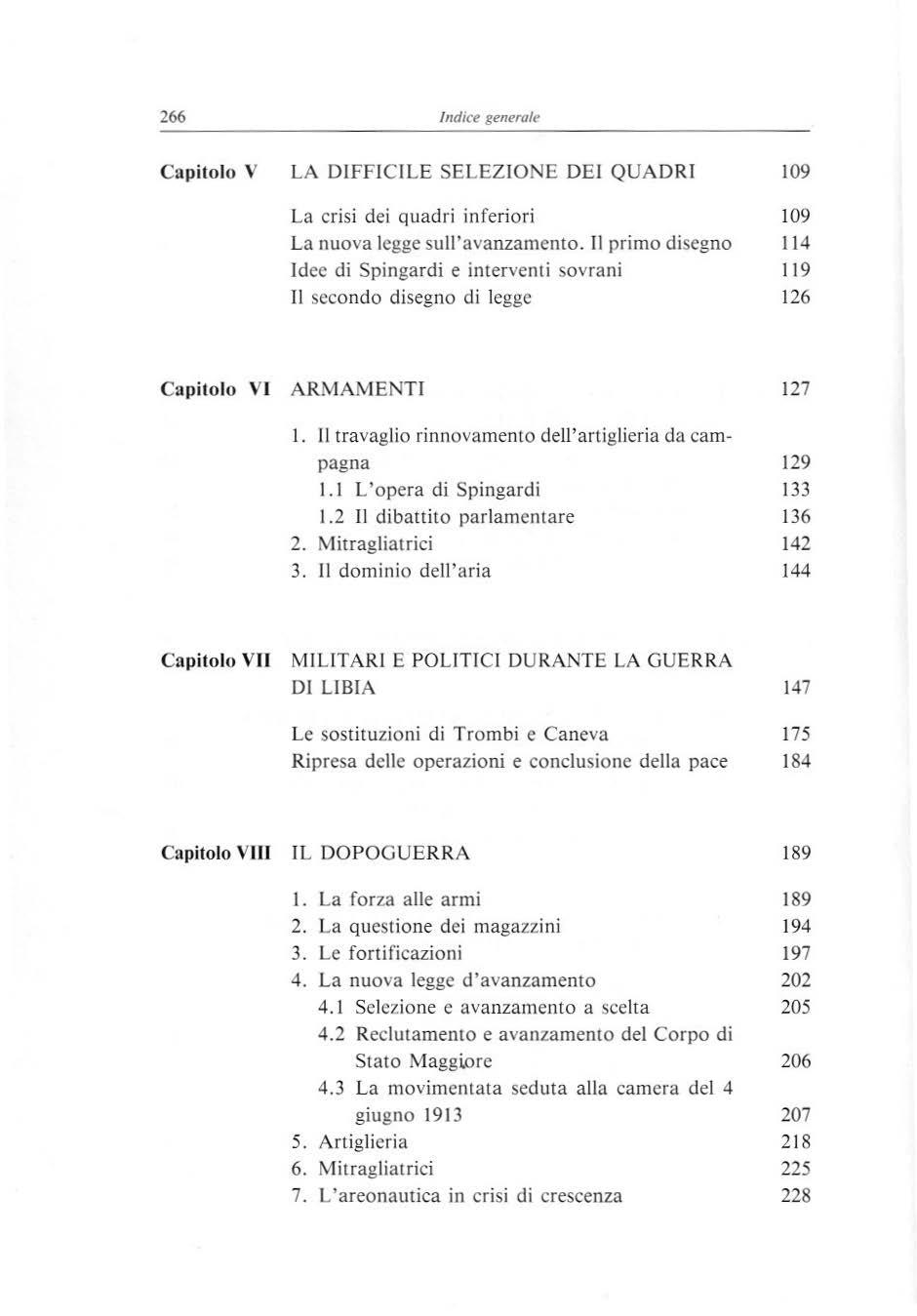
266 In dice generale Ca pitolo V LA DIF FI CILE SELEZIONE DEI QUADRI 109 La cr isi dei quadri inferiori 109 La nuova legge sull'avanzamento. Il primo disegno 114 Idee di Spingardi e interventi sovrani 119 TI econdo disegno di legge 126 Ca pitol o V I ARMAMENTI 127 I. li travaglio rinnovamento dell'artiglieria da campagna I. I L'opera di Spingardi 1.2 I l dibattito parlamentare 2. Mitragliatrici 3. li dominio dell'aria 129 133 136 142 144 C apitolo VII MILITARI E POLITICI DURANTE LA GUERRA Dl LIBIA 147 L e sostituzioni di Trombi e Caneva 175 Ripresa dell e operazioni e conclusione della pace 184 Ca pitol o VIII IL DOPOGUERRA 189 1. La forza alle armi 189 2. La questione dei magaz z ini 194 3. Le fortificazioni 197 4. La nuova legg e d'avanzamento 202 4.1 Selezione e ava nzam ento a scelta 205 4.2 Reclutamento e avanLamemo del Corpo di Stato Maggi.ore 206 4.3 La movimentata seduta alla camera del 4 giugno 1913 207 5. Artiglieria 218 6. Mitragliatrici 225 7. L'areonautica in crisi di crescenza 228
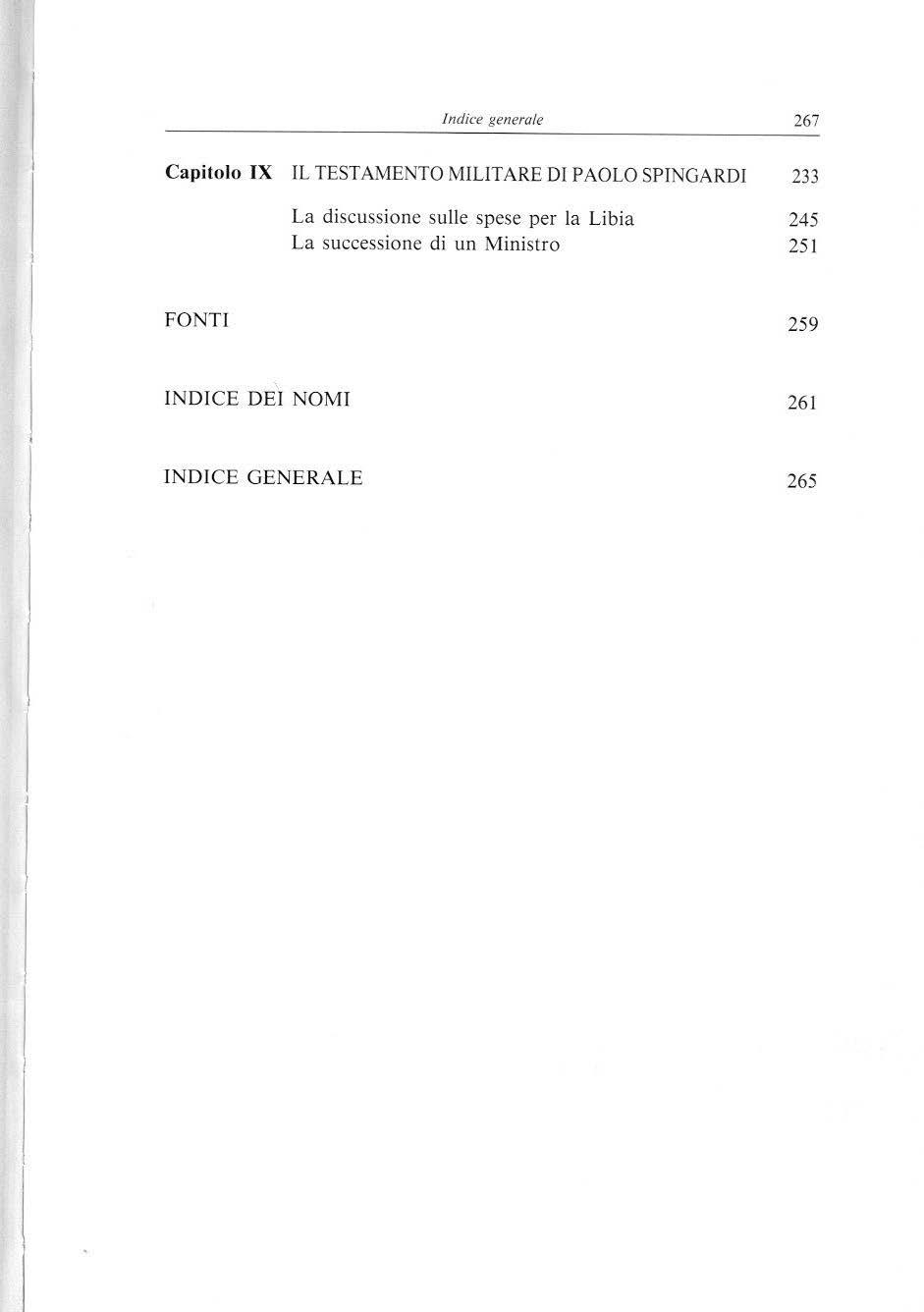
Indice generale Capi to lo I X IL TESTAME TO MILITARE DI PAOLO SPTNGARDI La discuss ione sulle spese p er la Li bia La successione di un Min istro F O NTI I N D ICE DE I NO M I INDI CE GE NER ALE 267 233 245 251 259 261 265
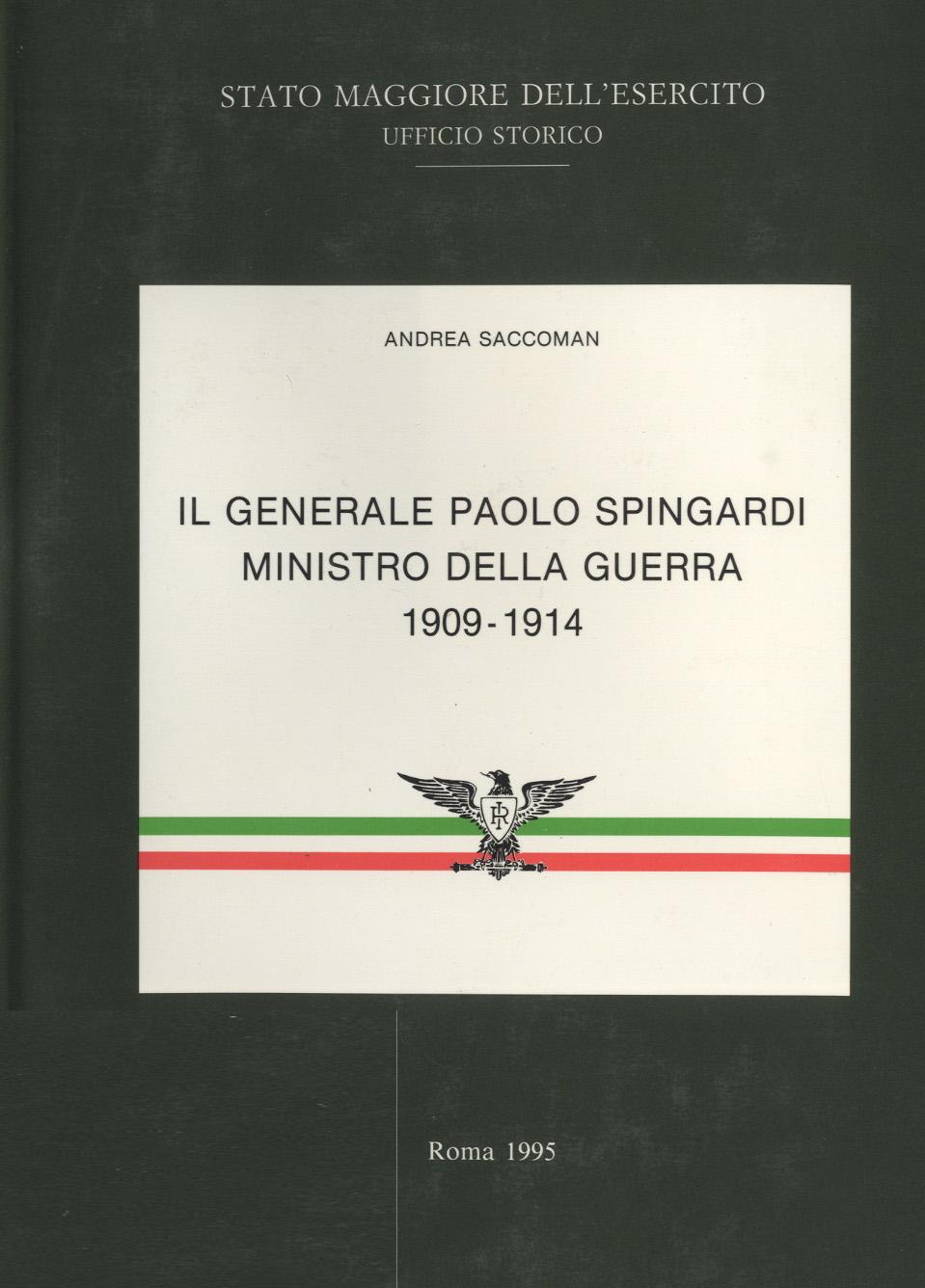
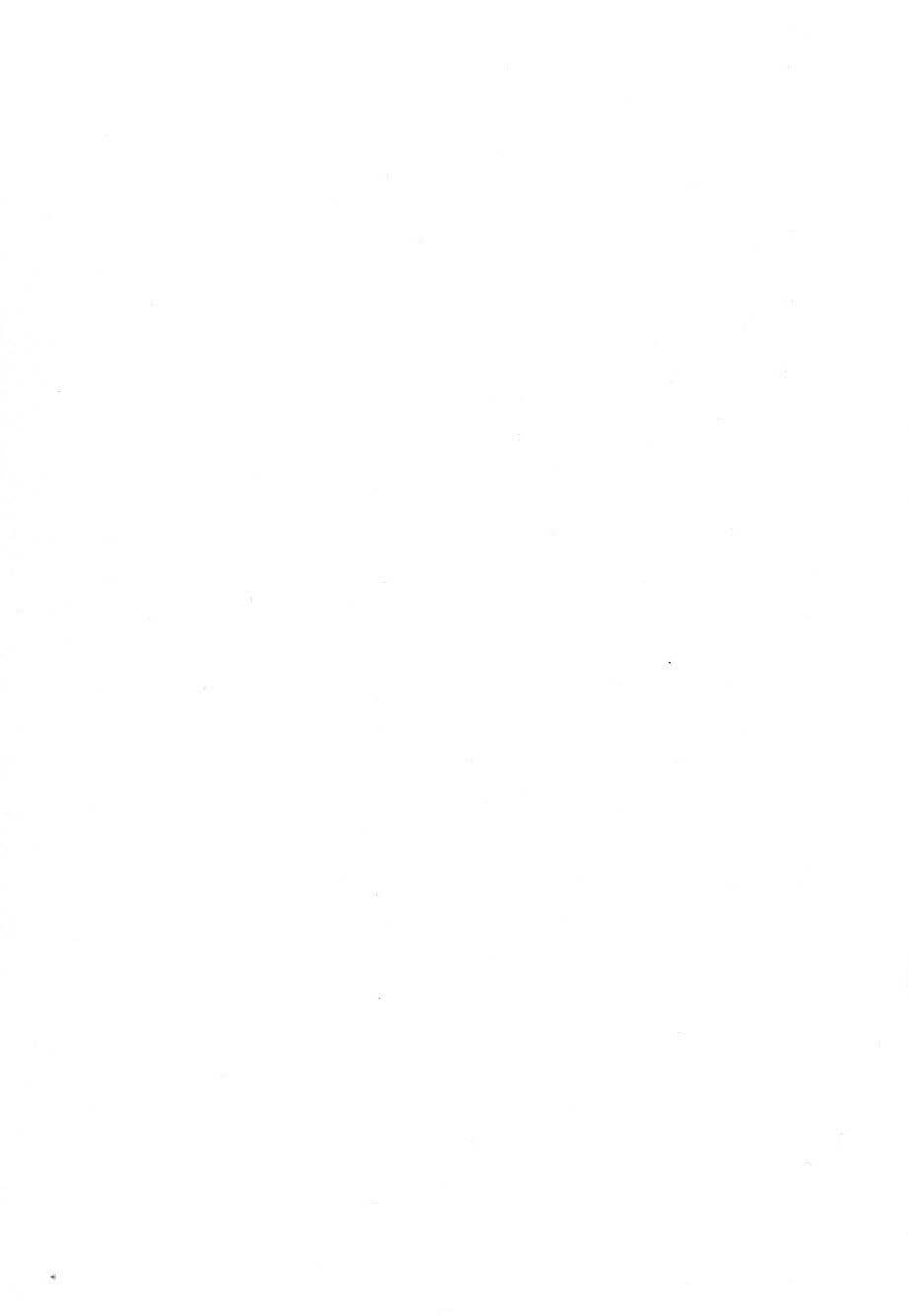


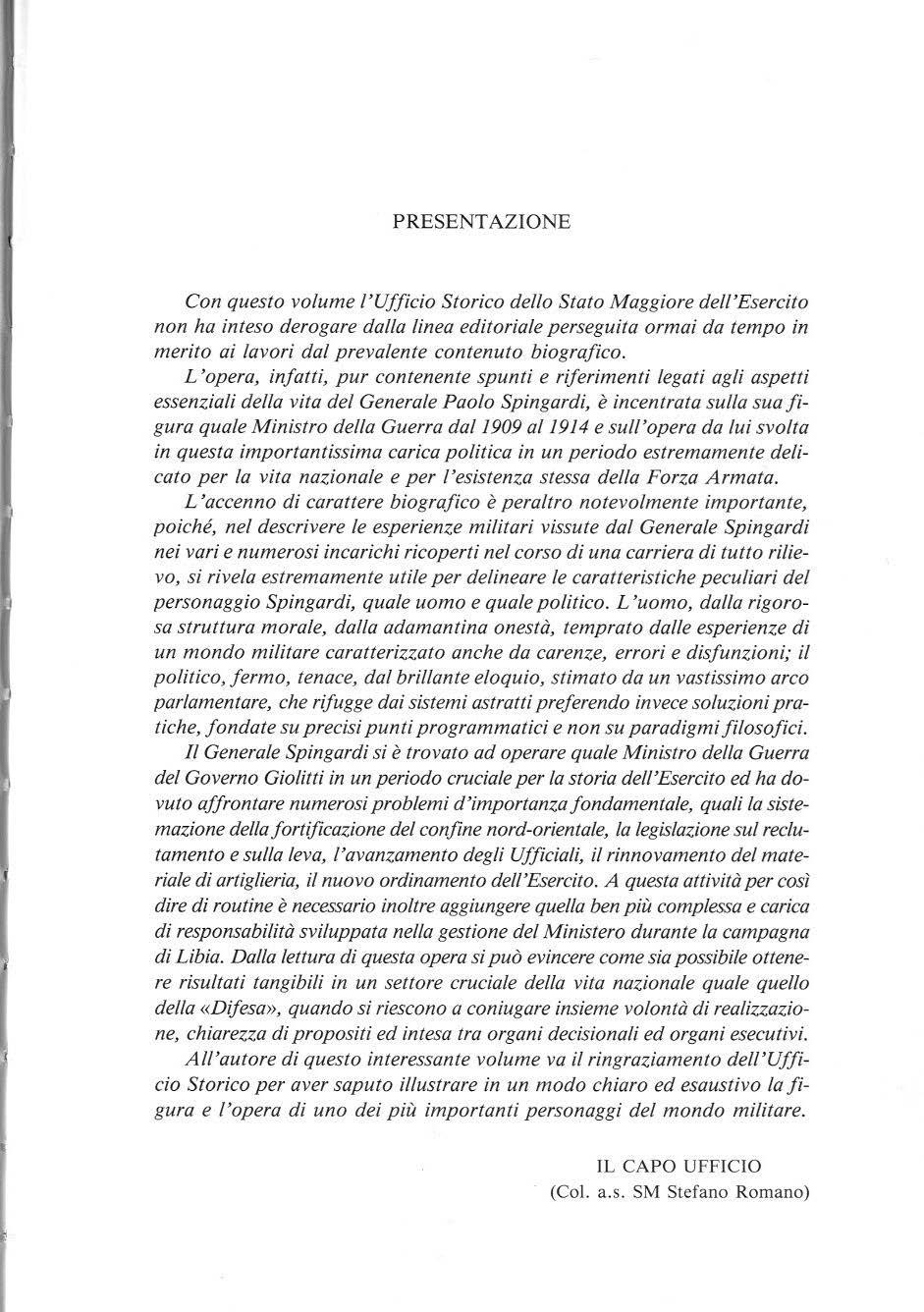


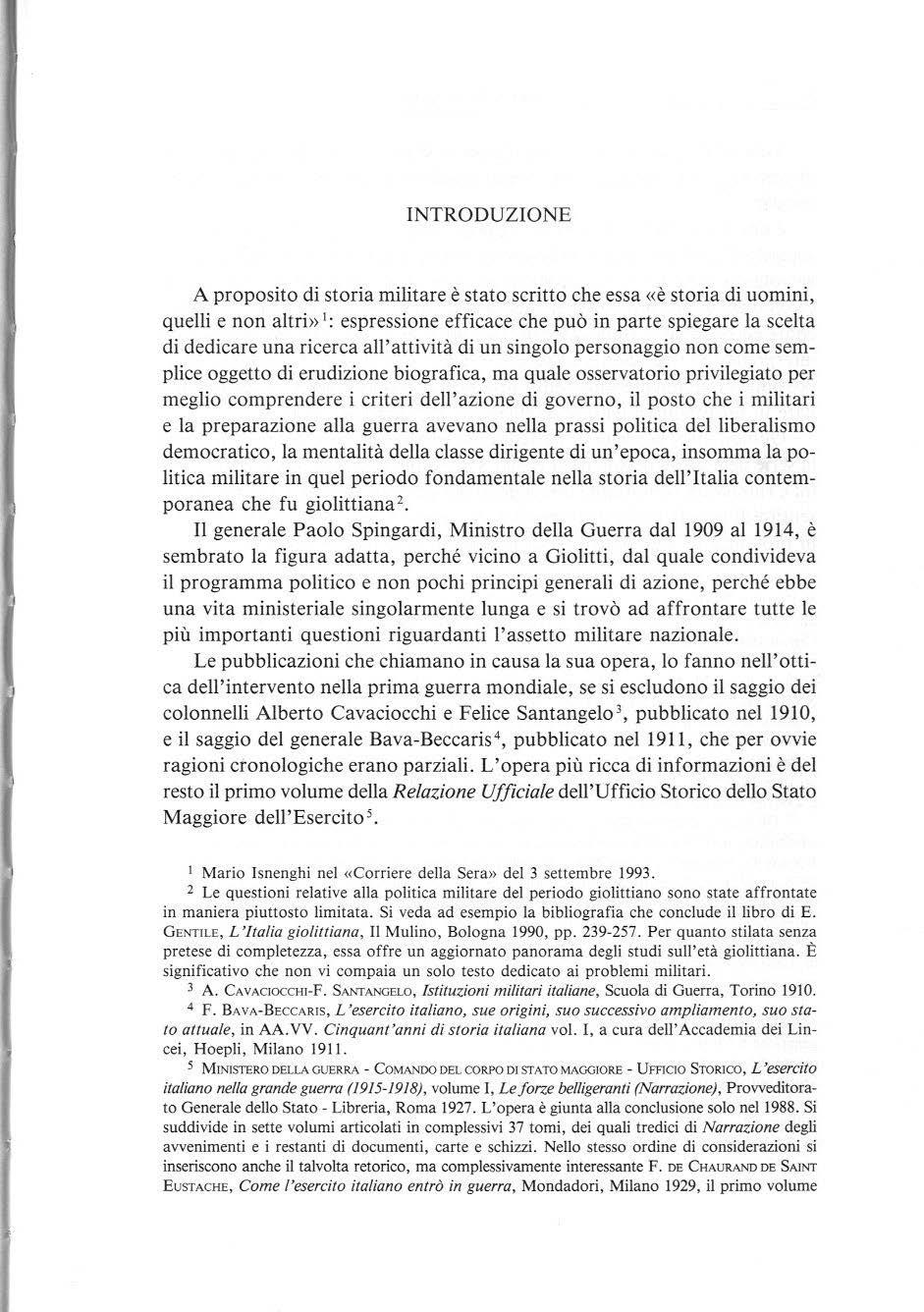
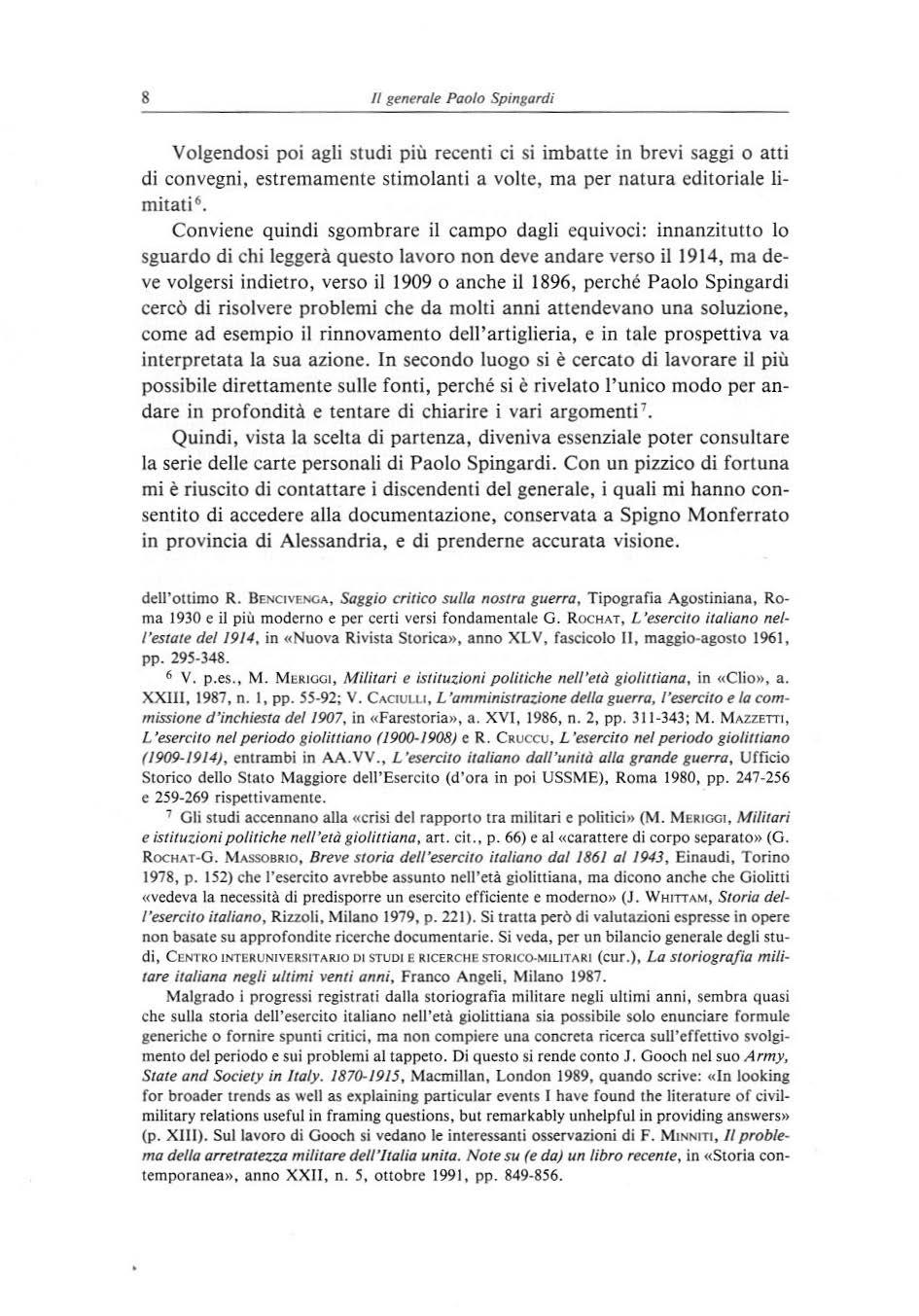

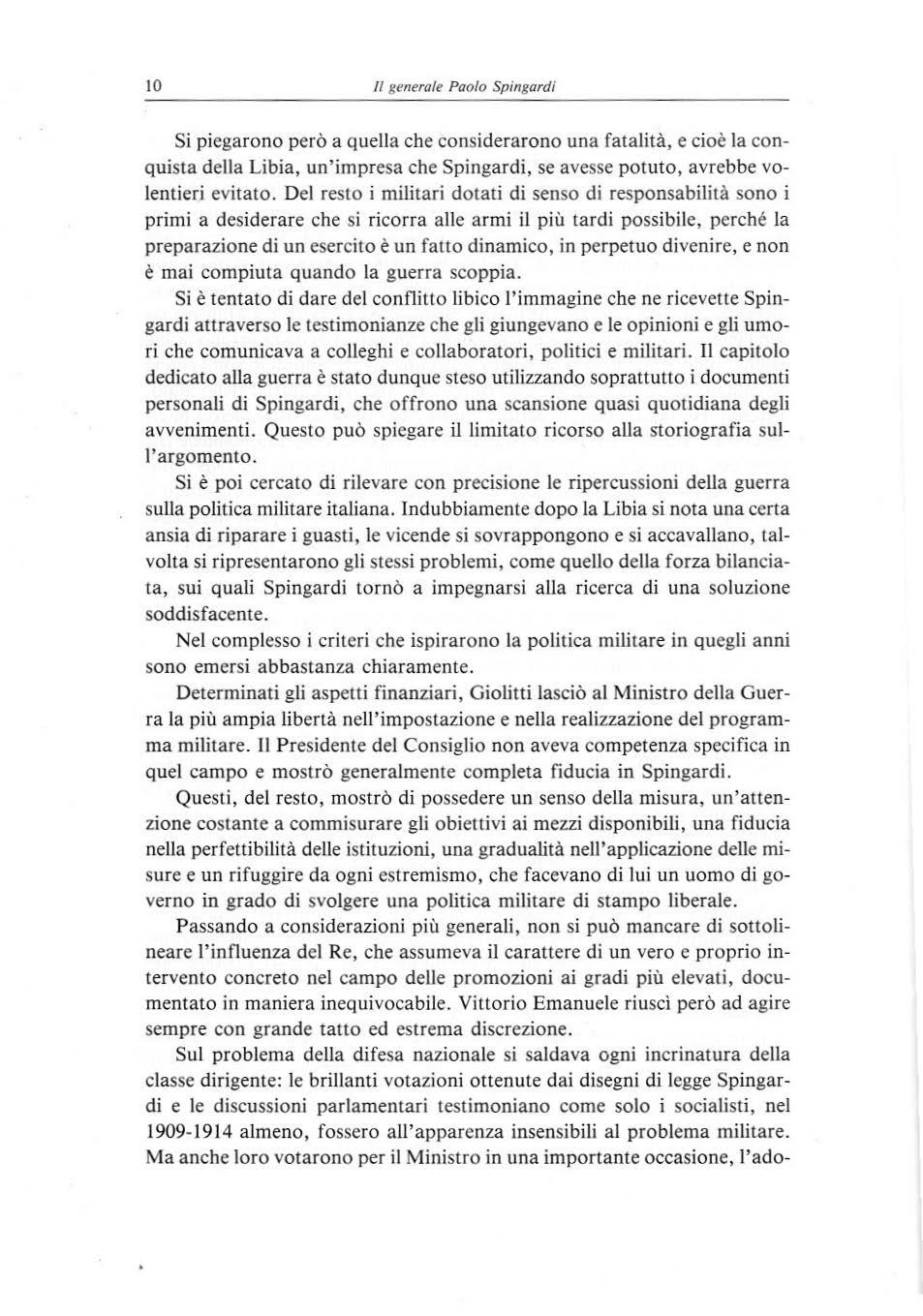
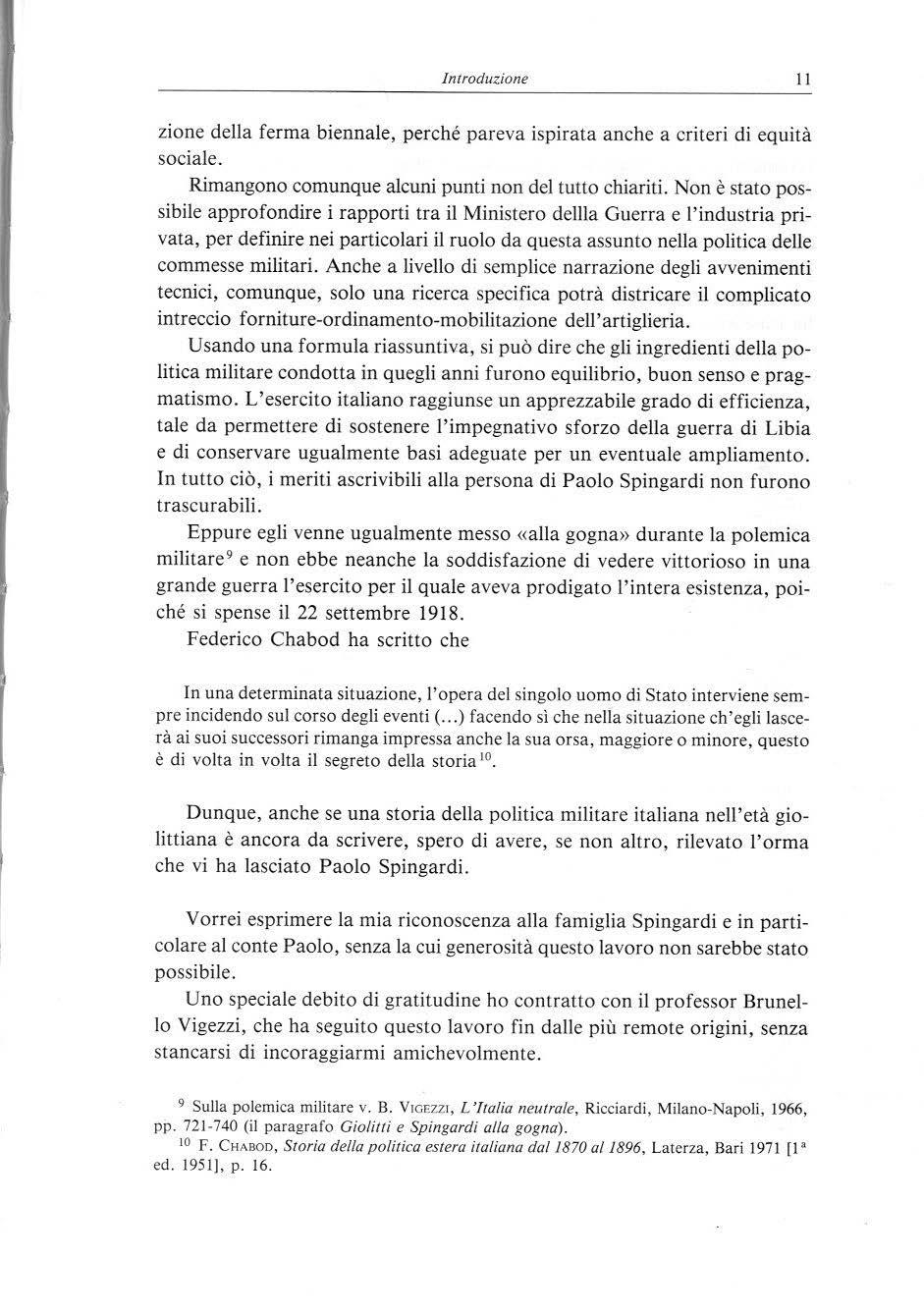
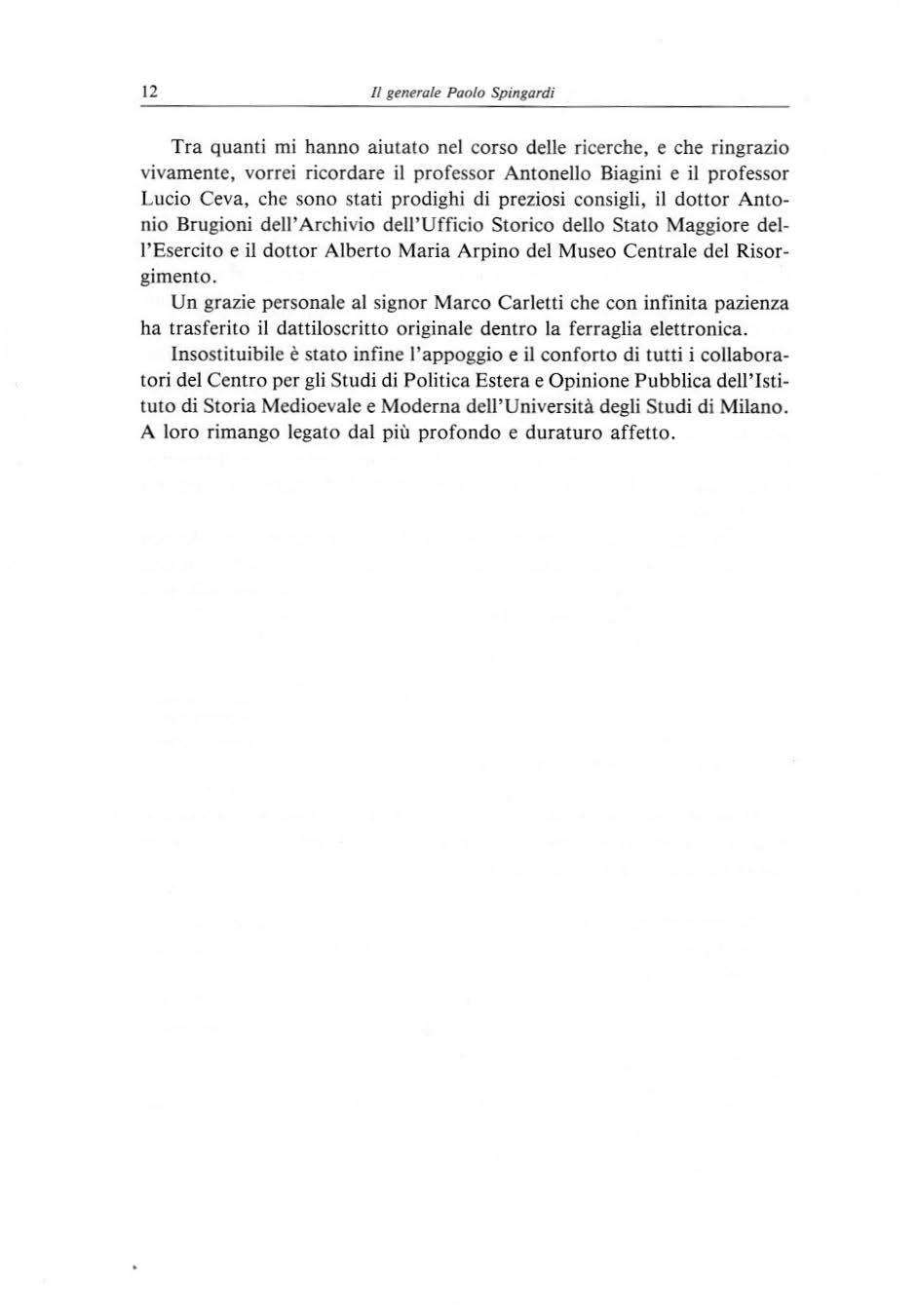
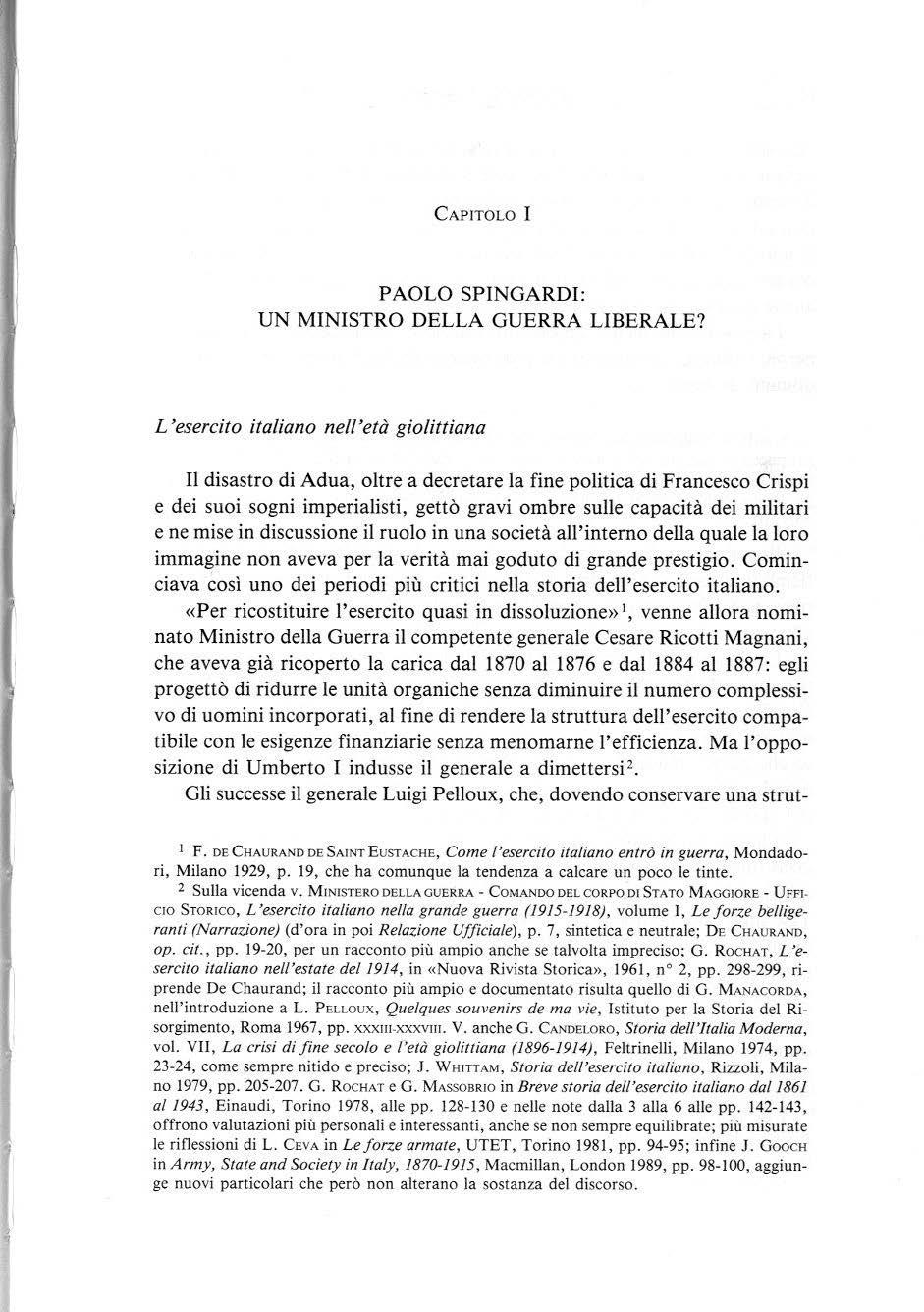
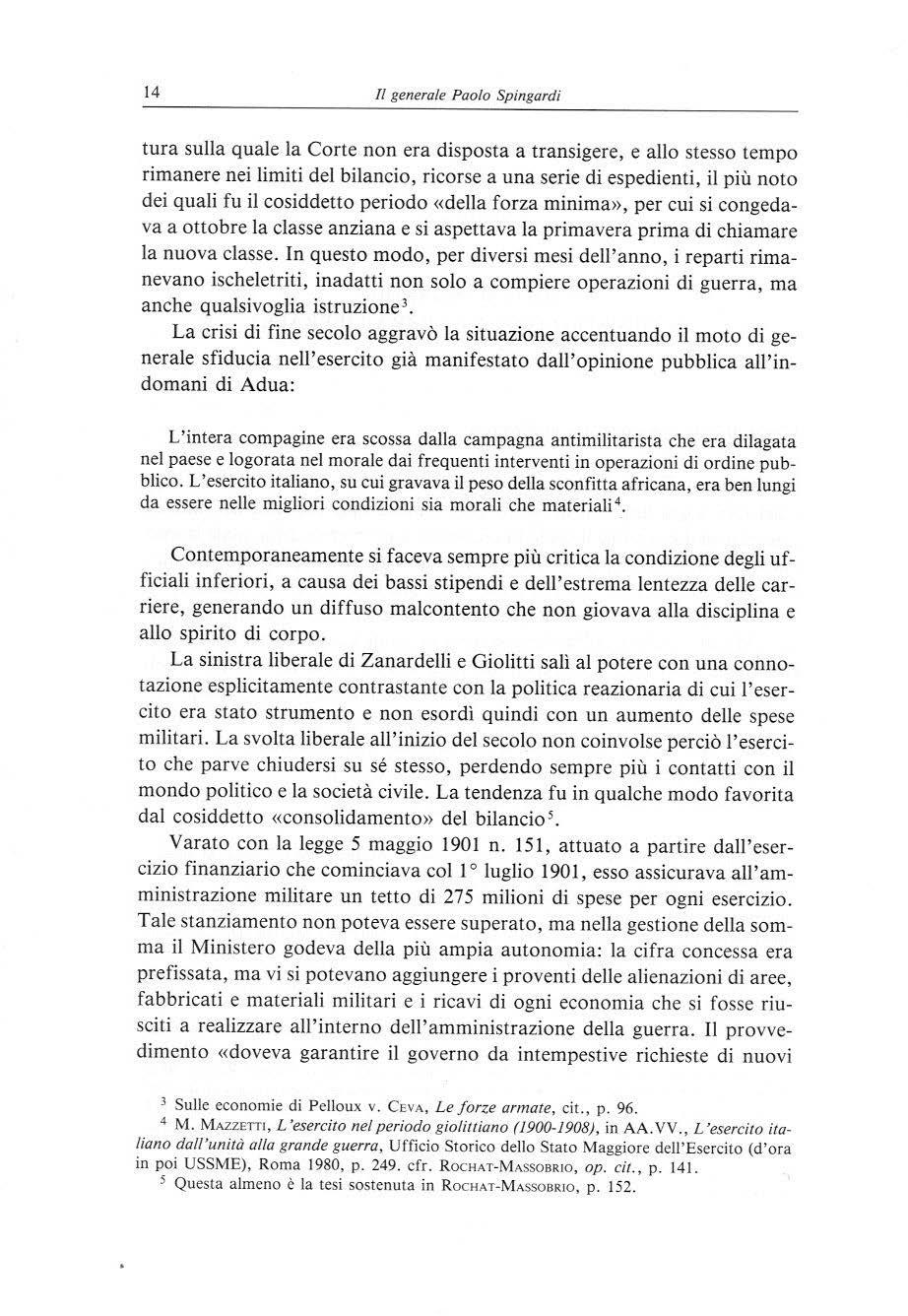
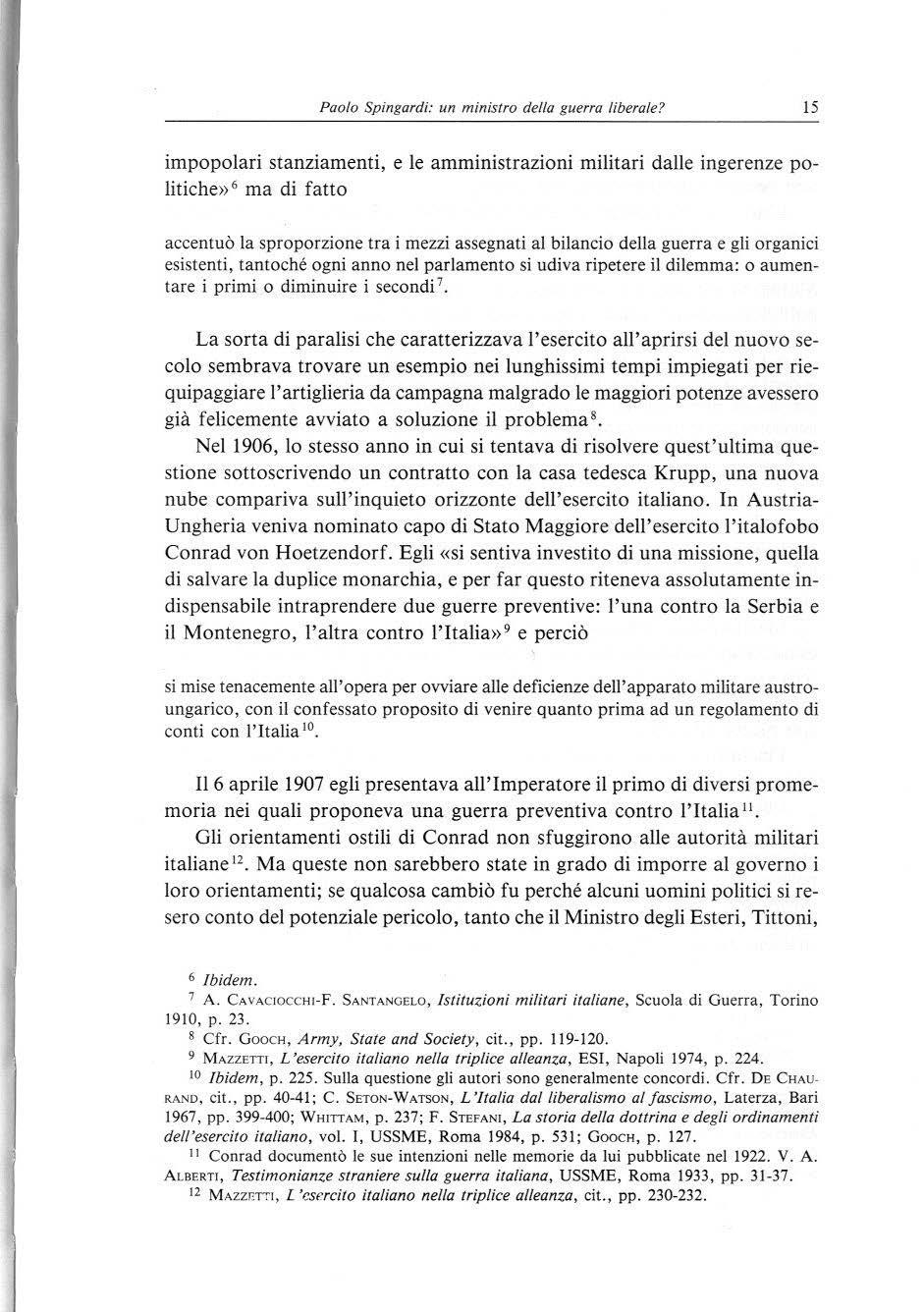

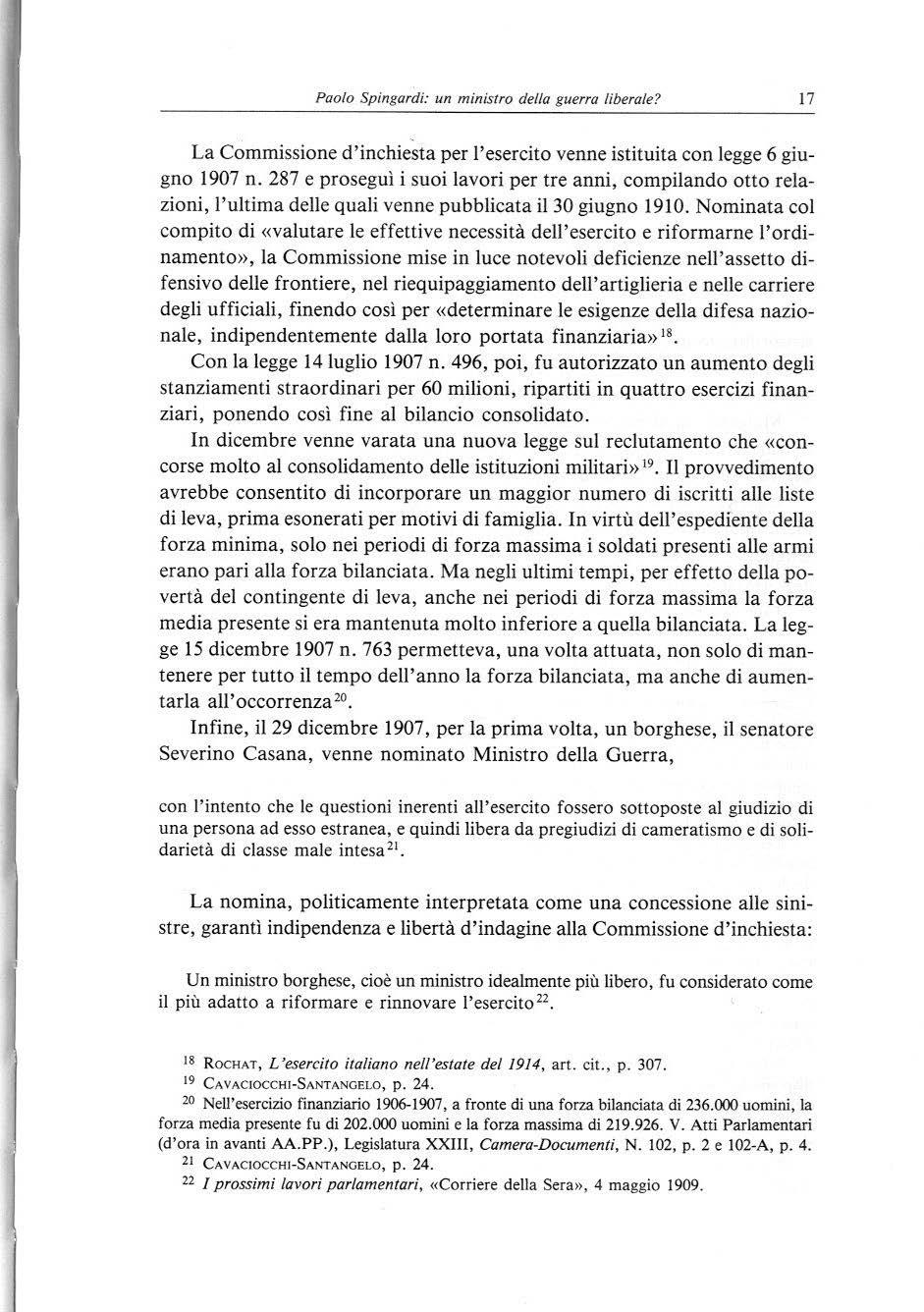
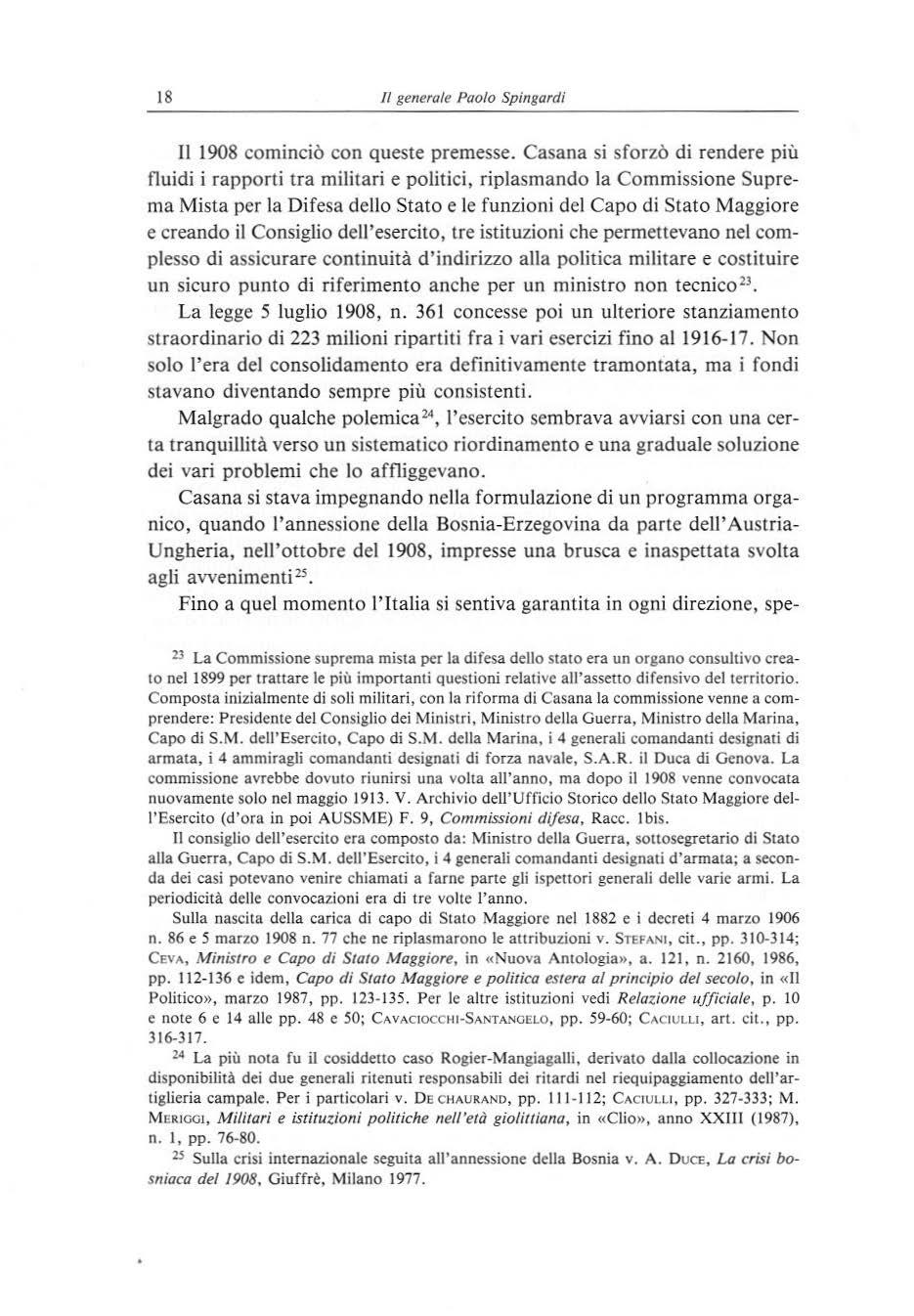
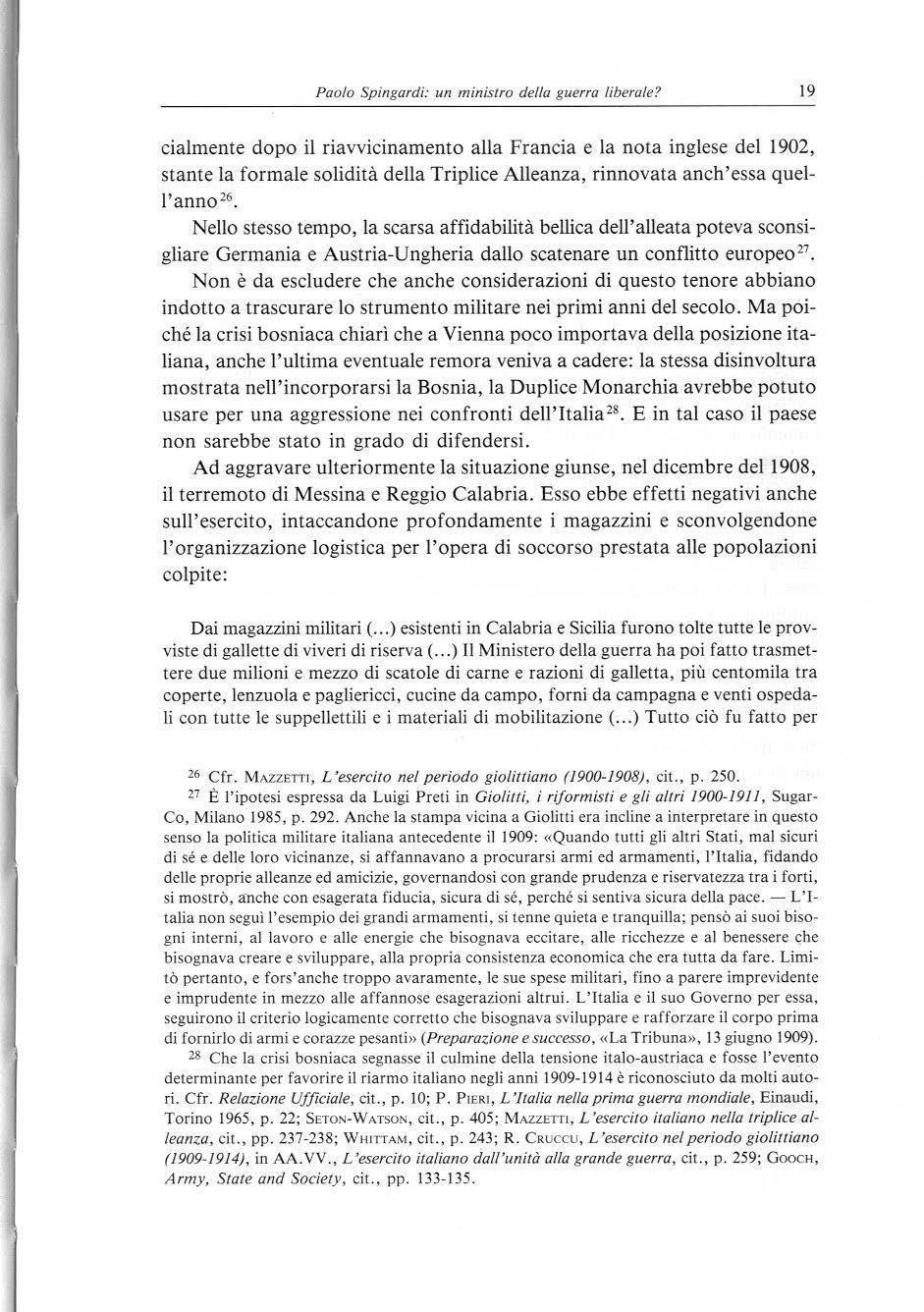
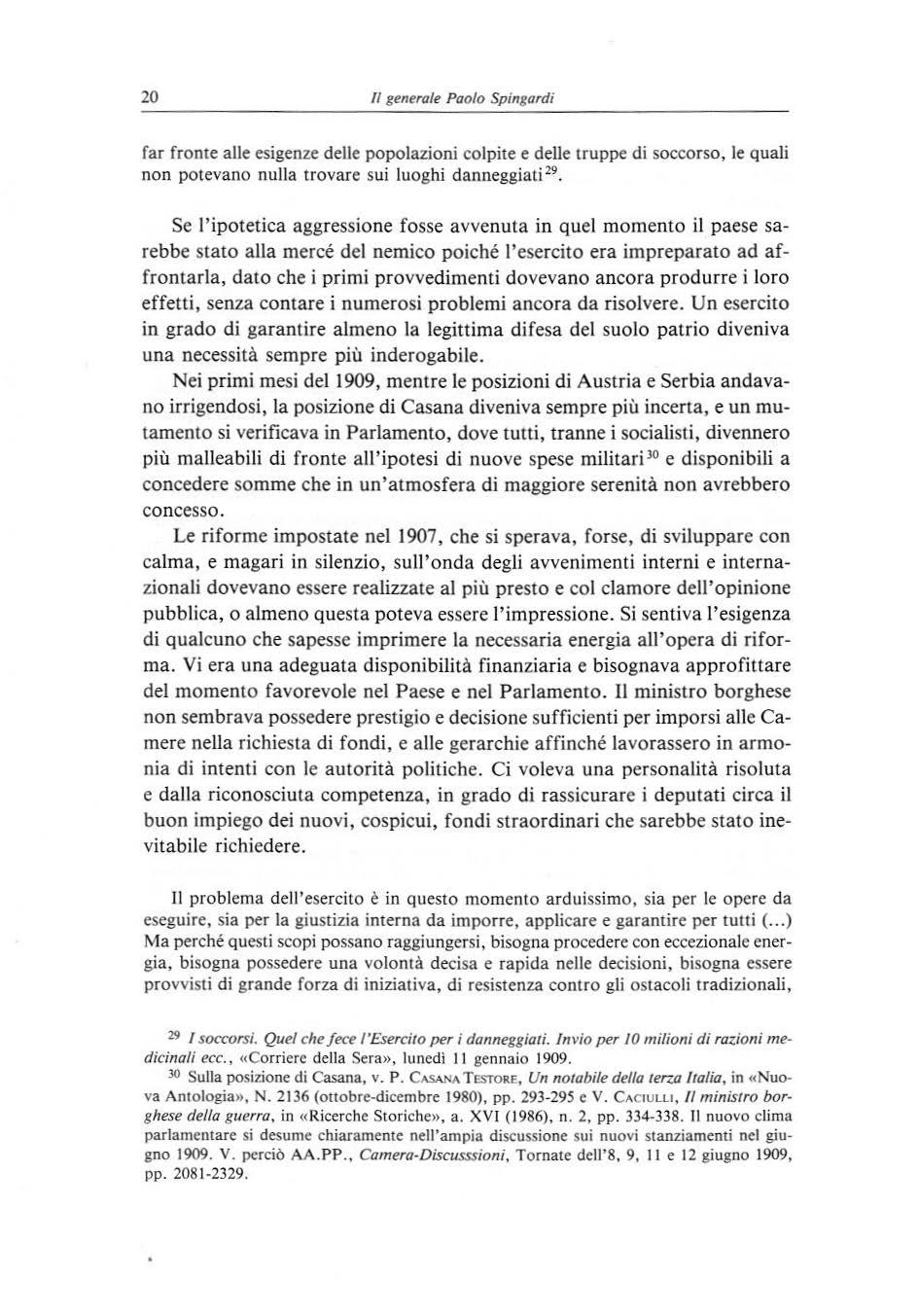
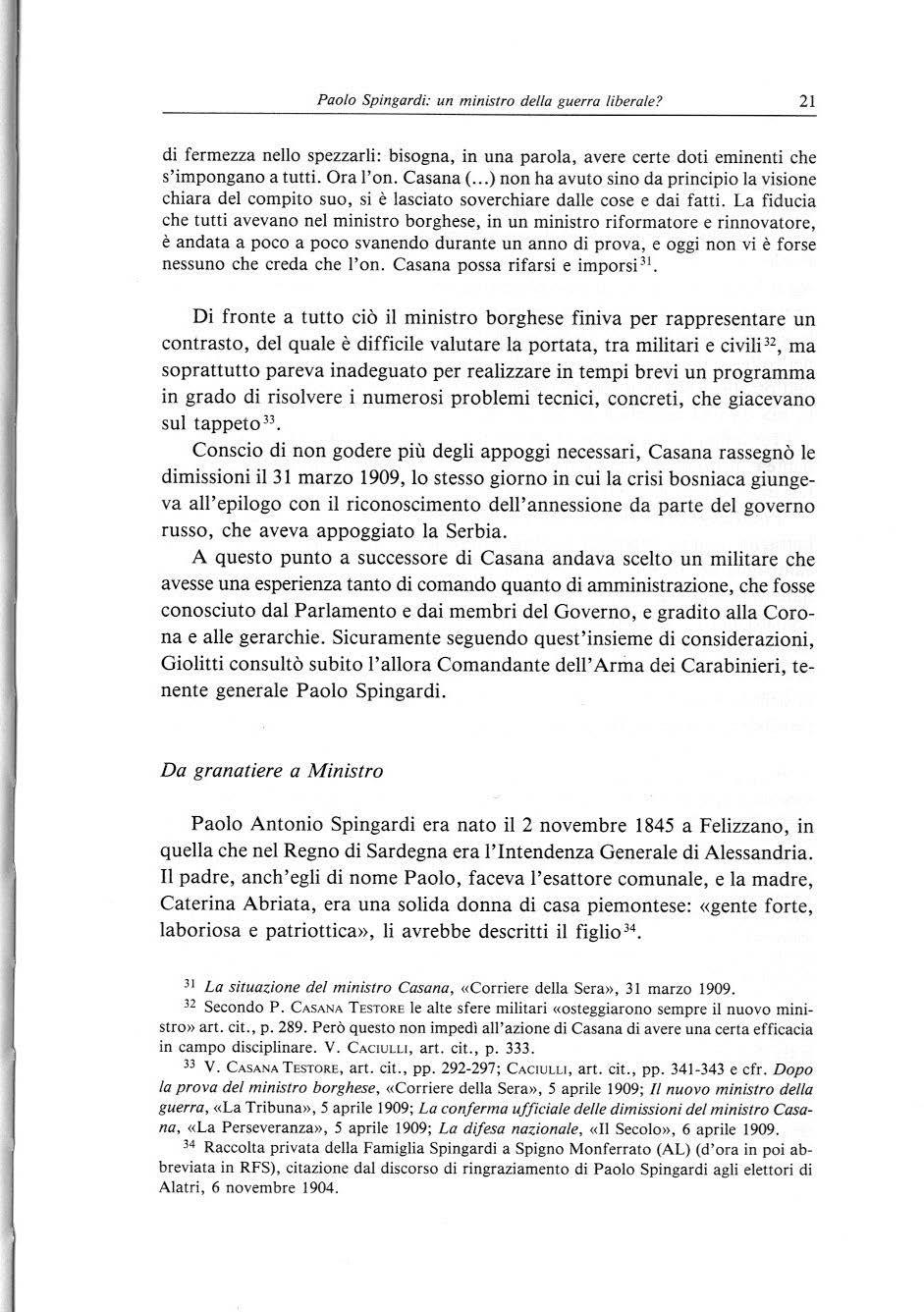
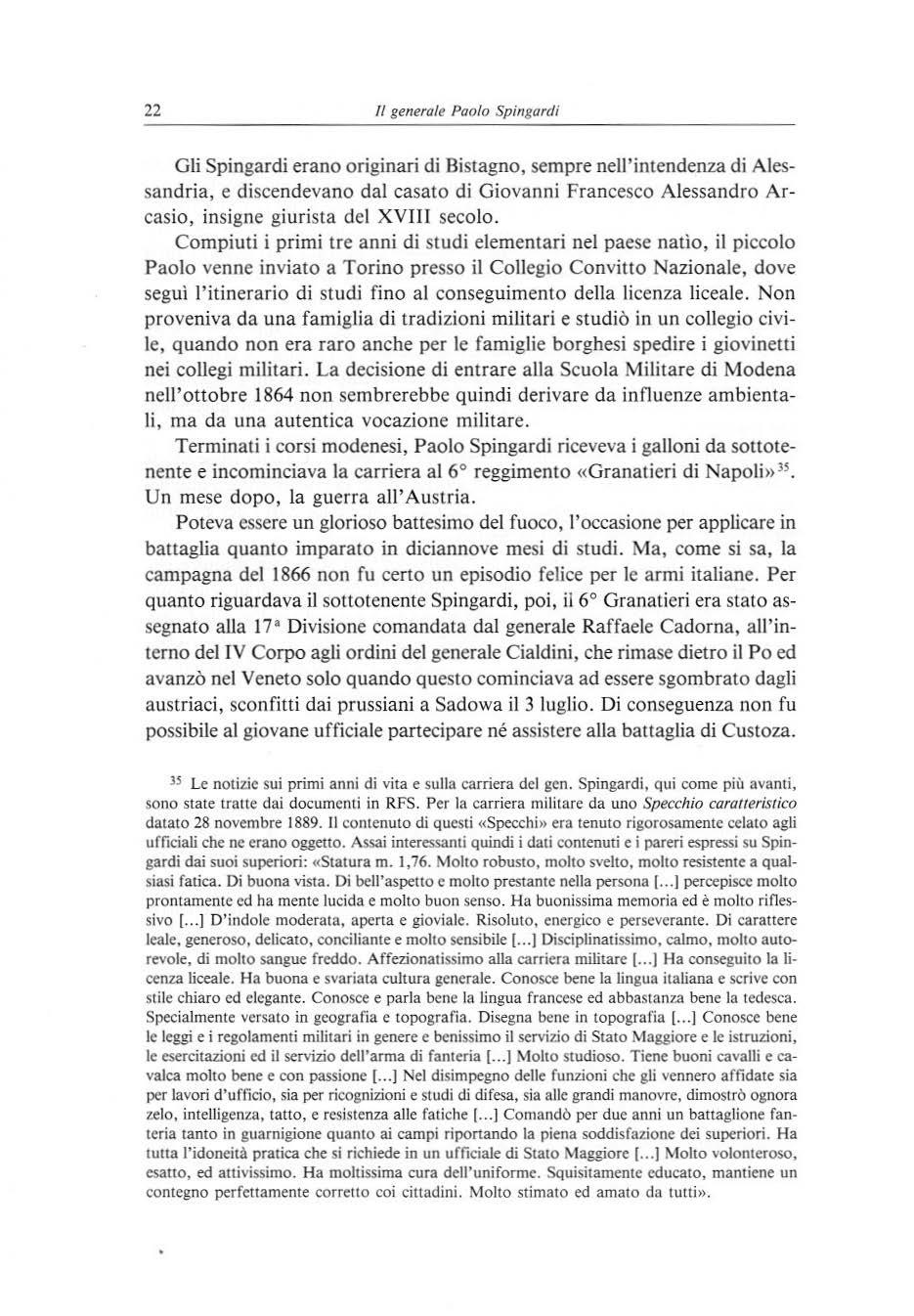
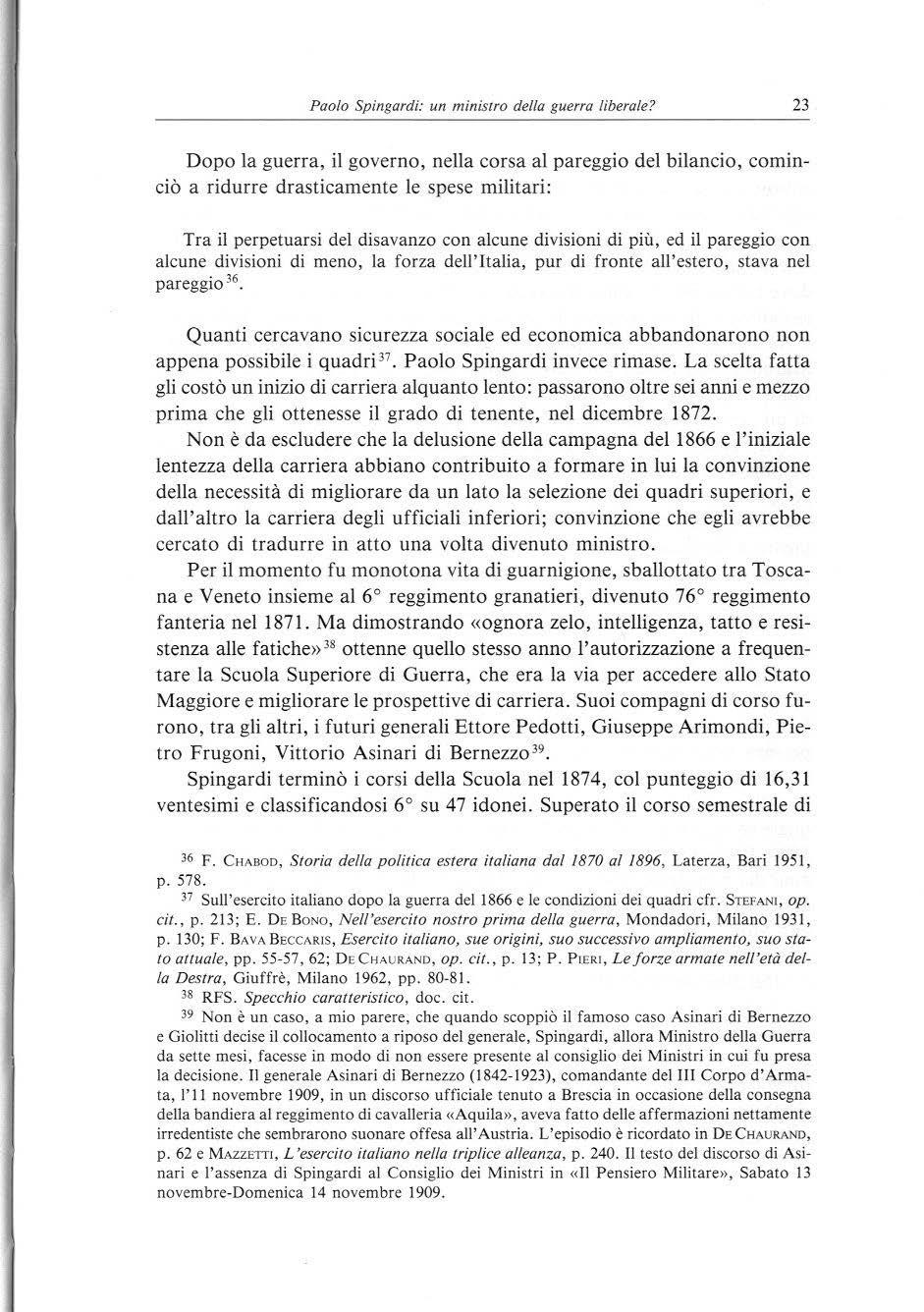

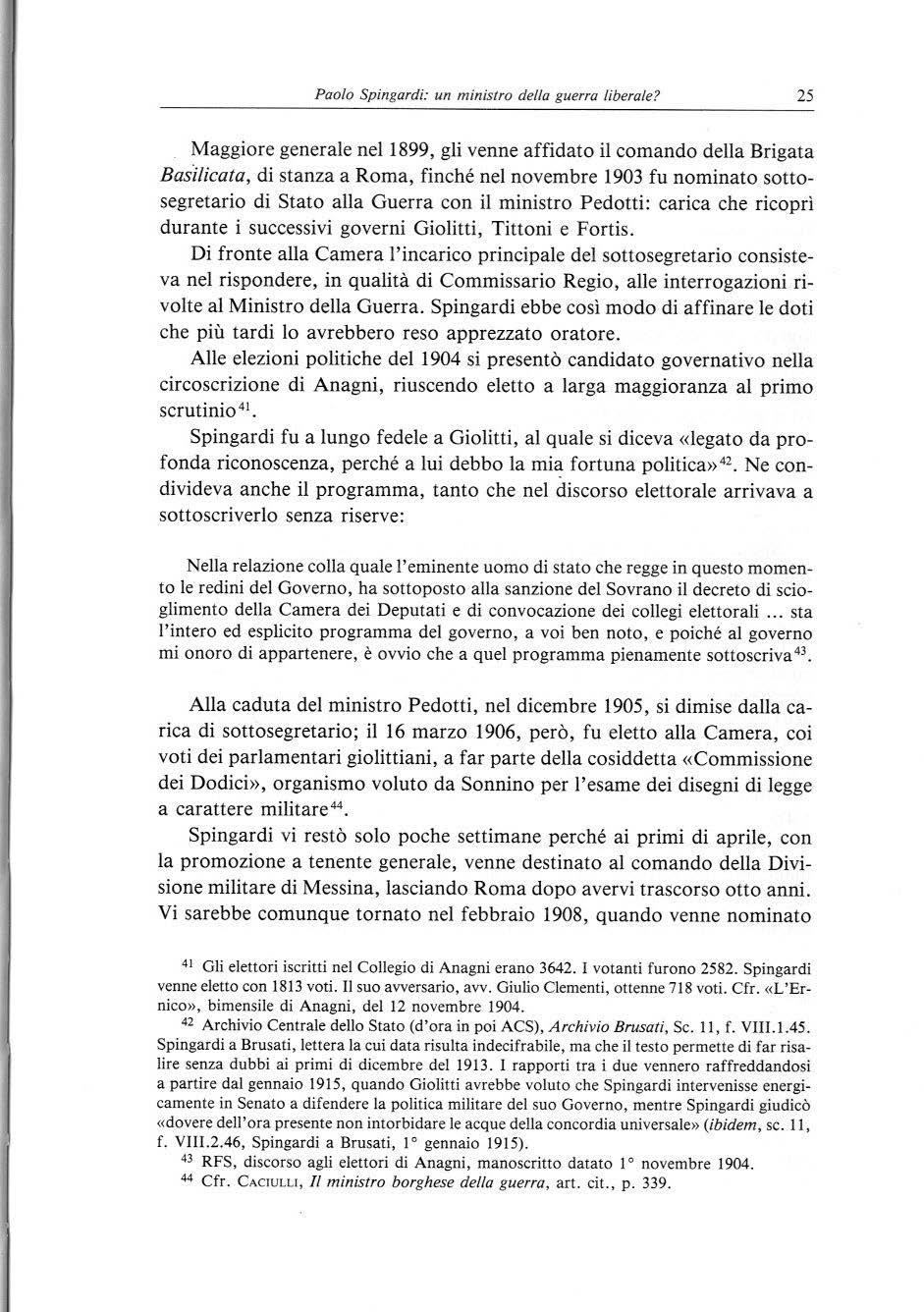
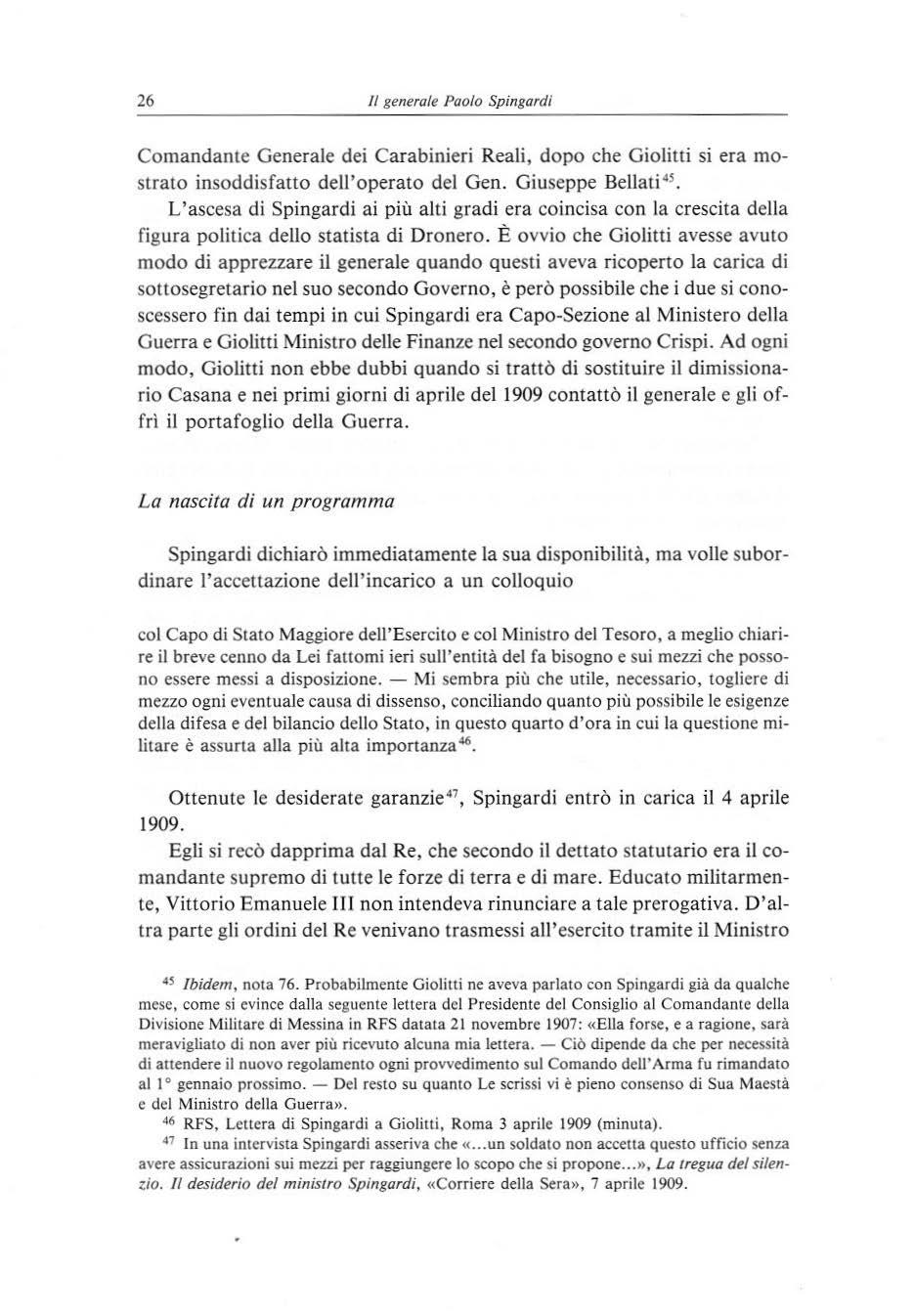
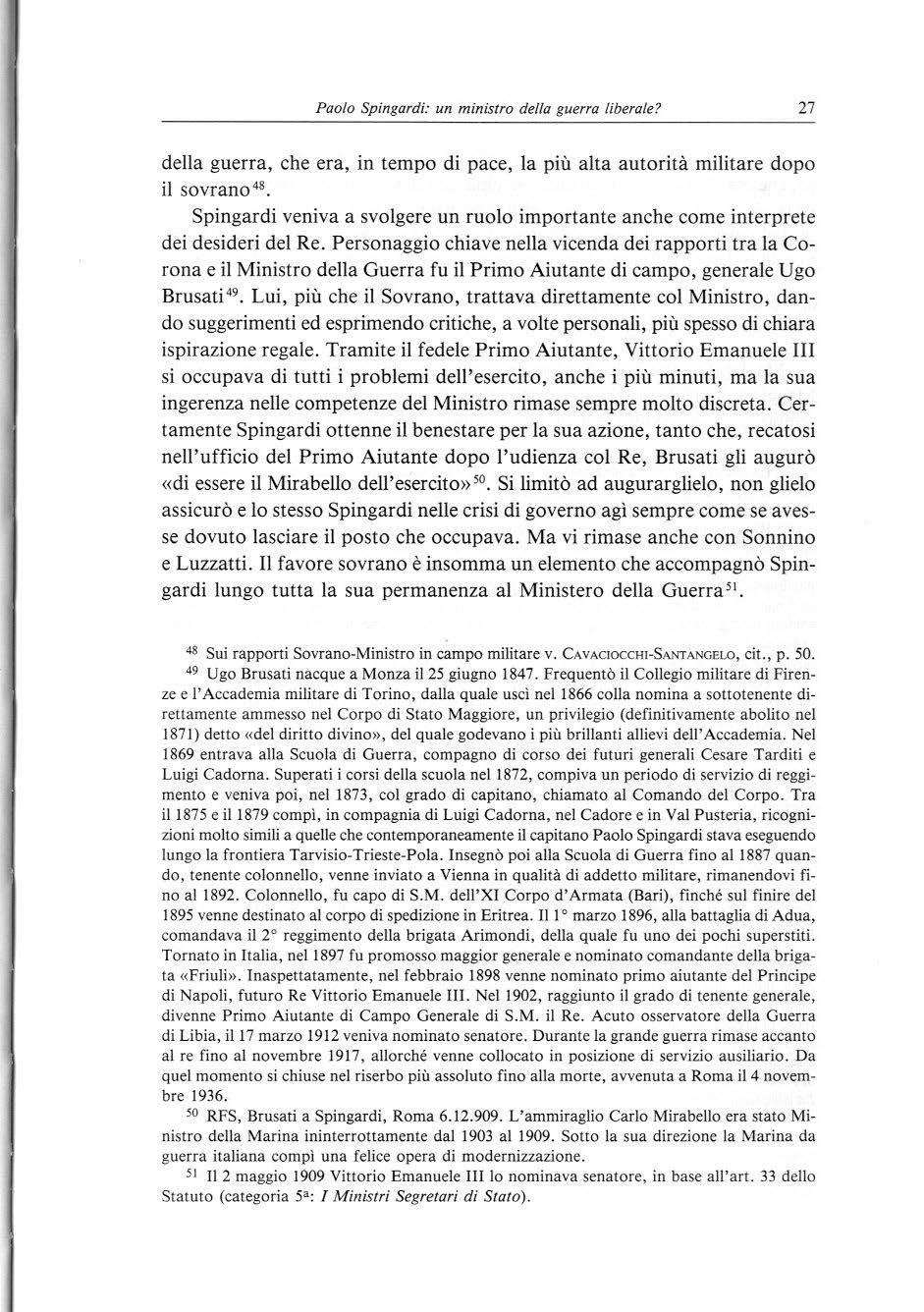

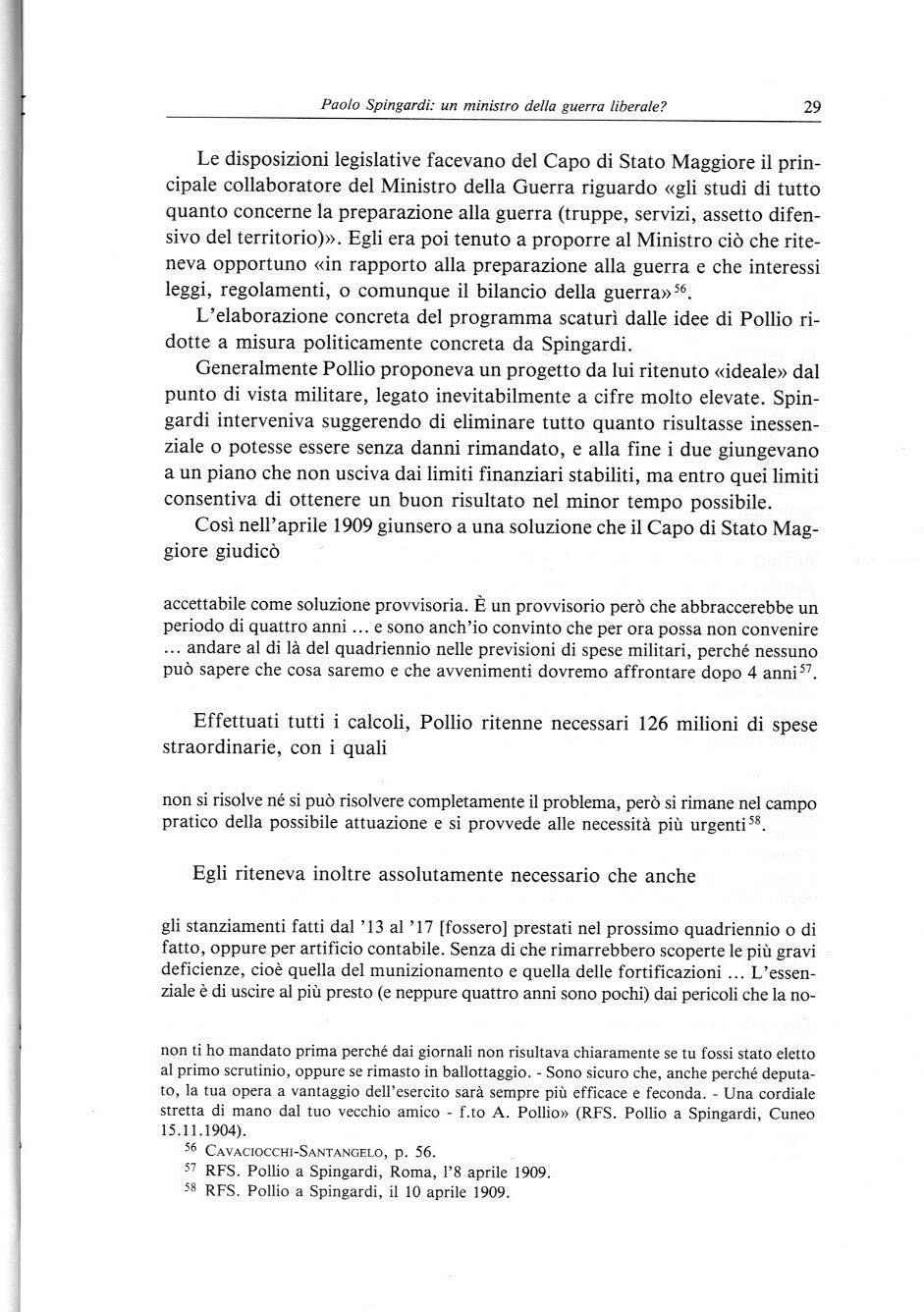
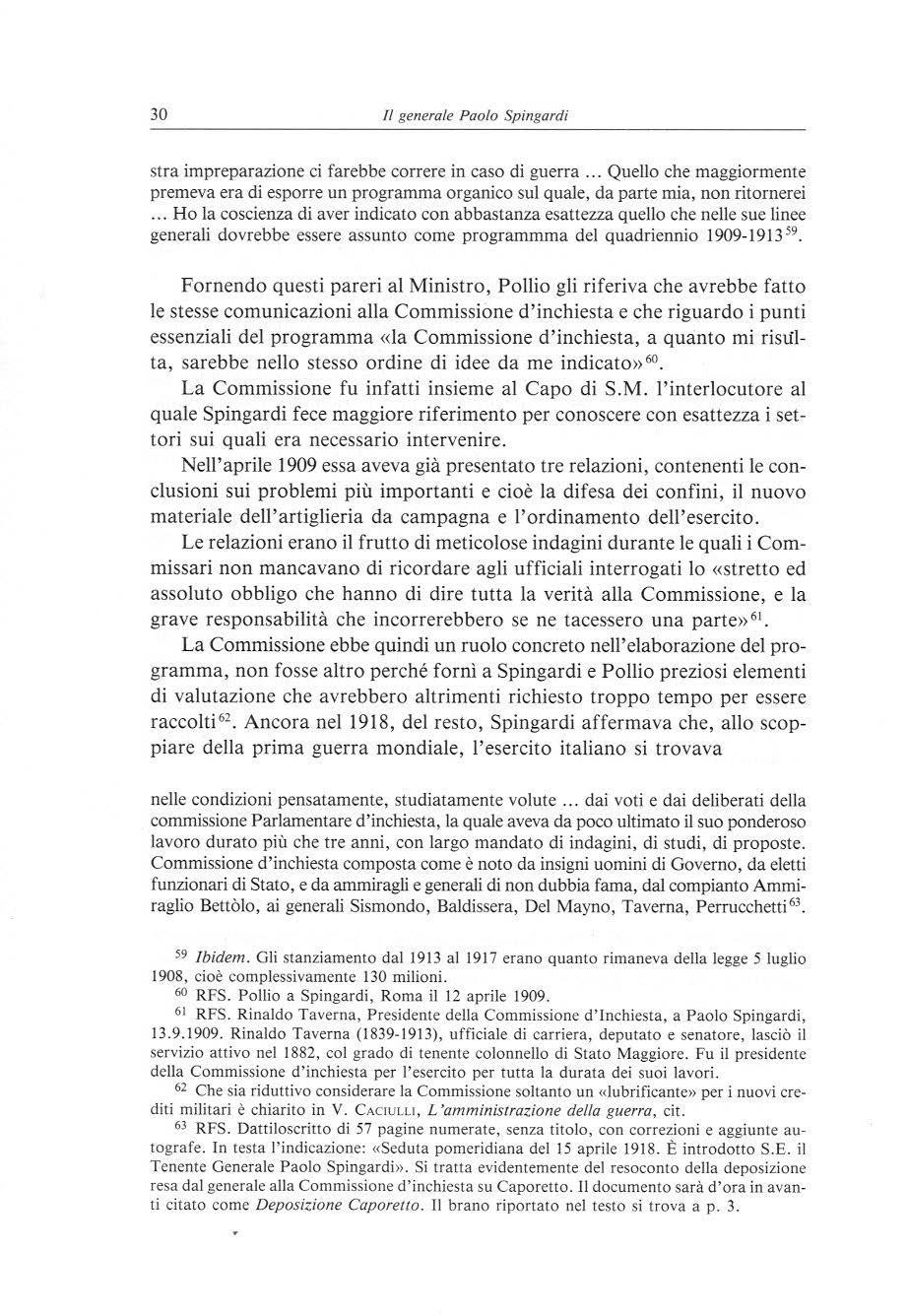
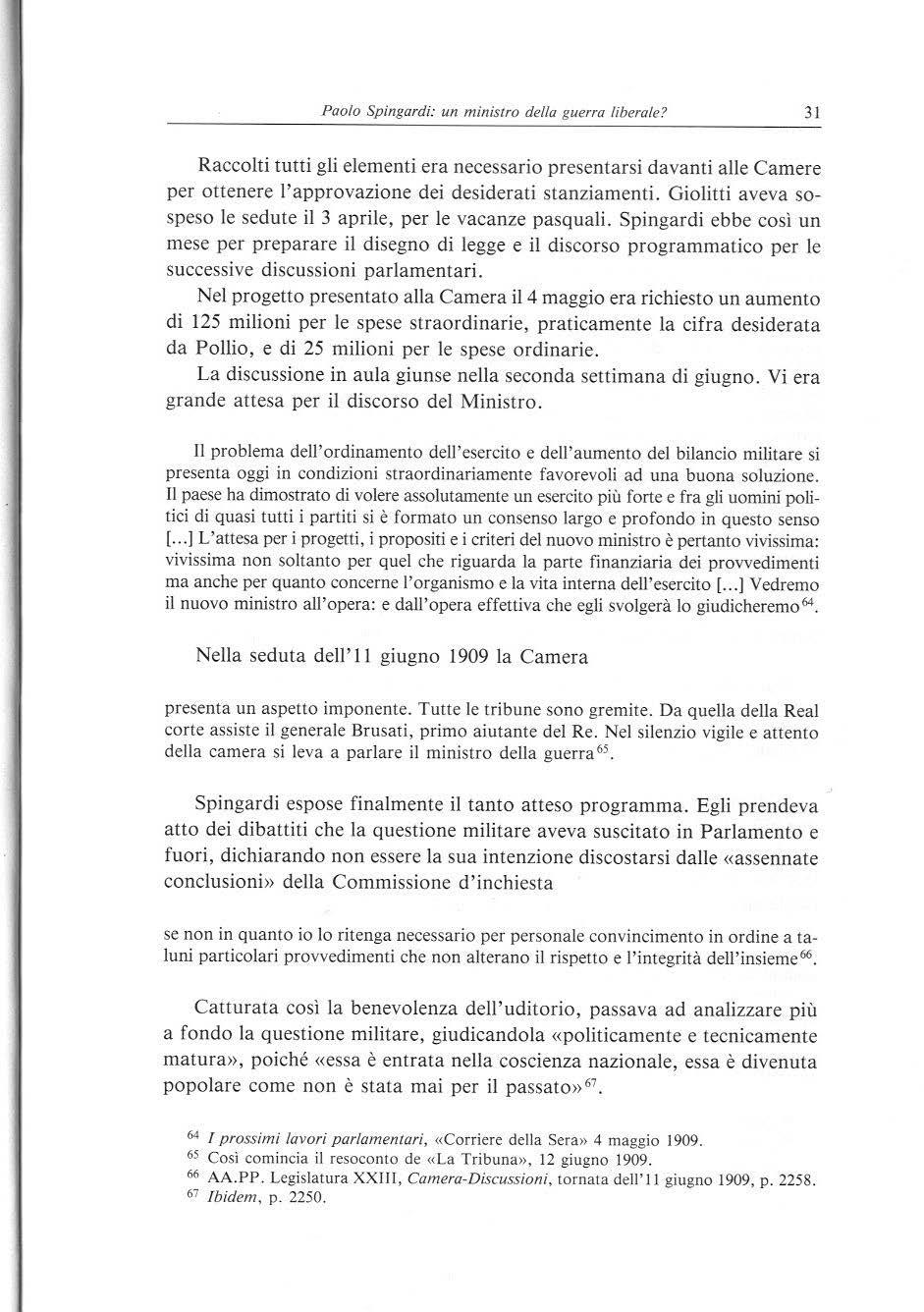
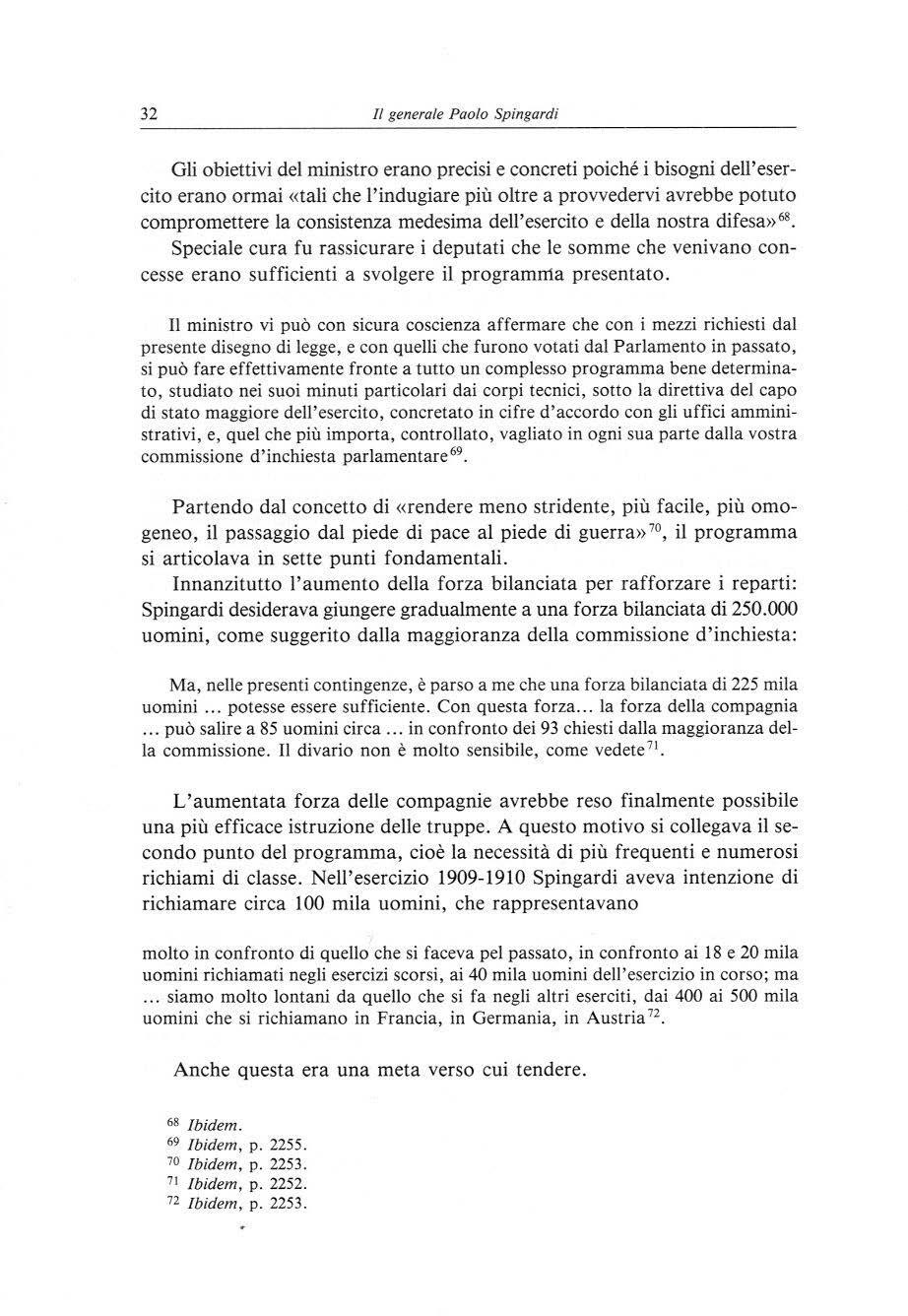
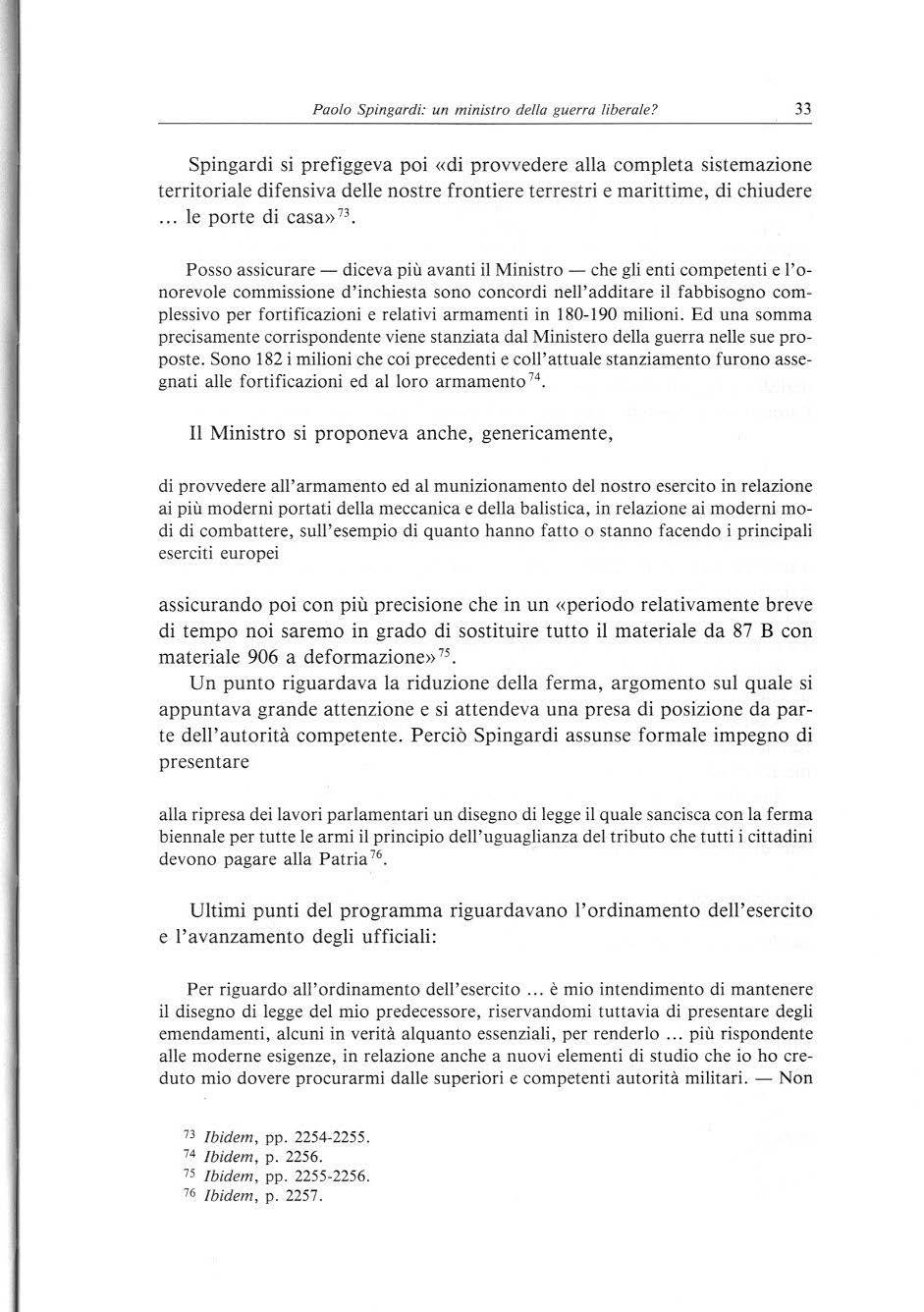
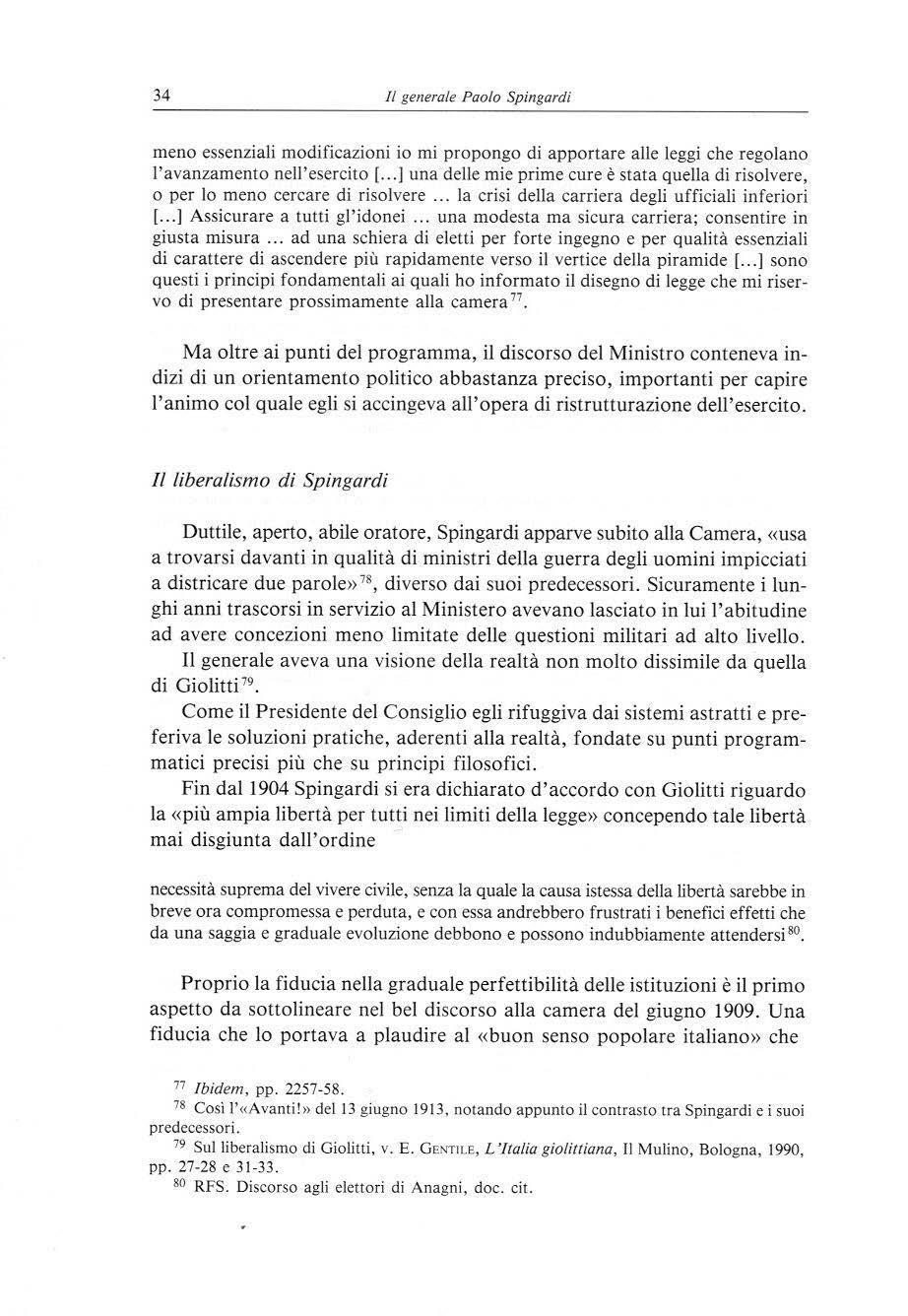
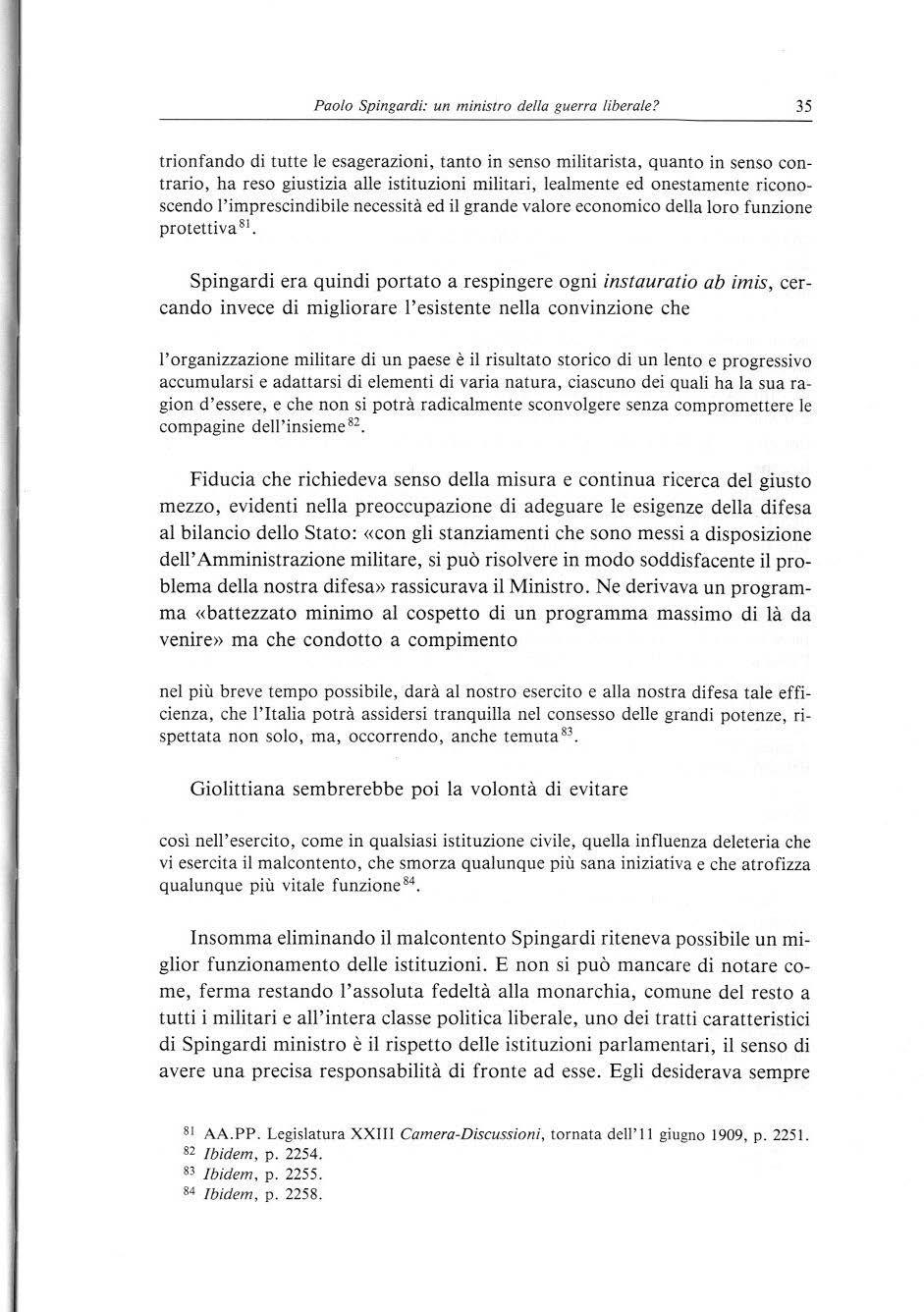
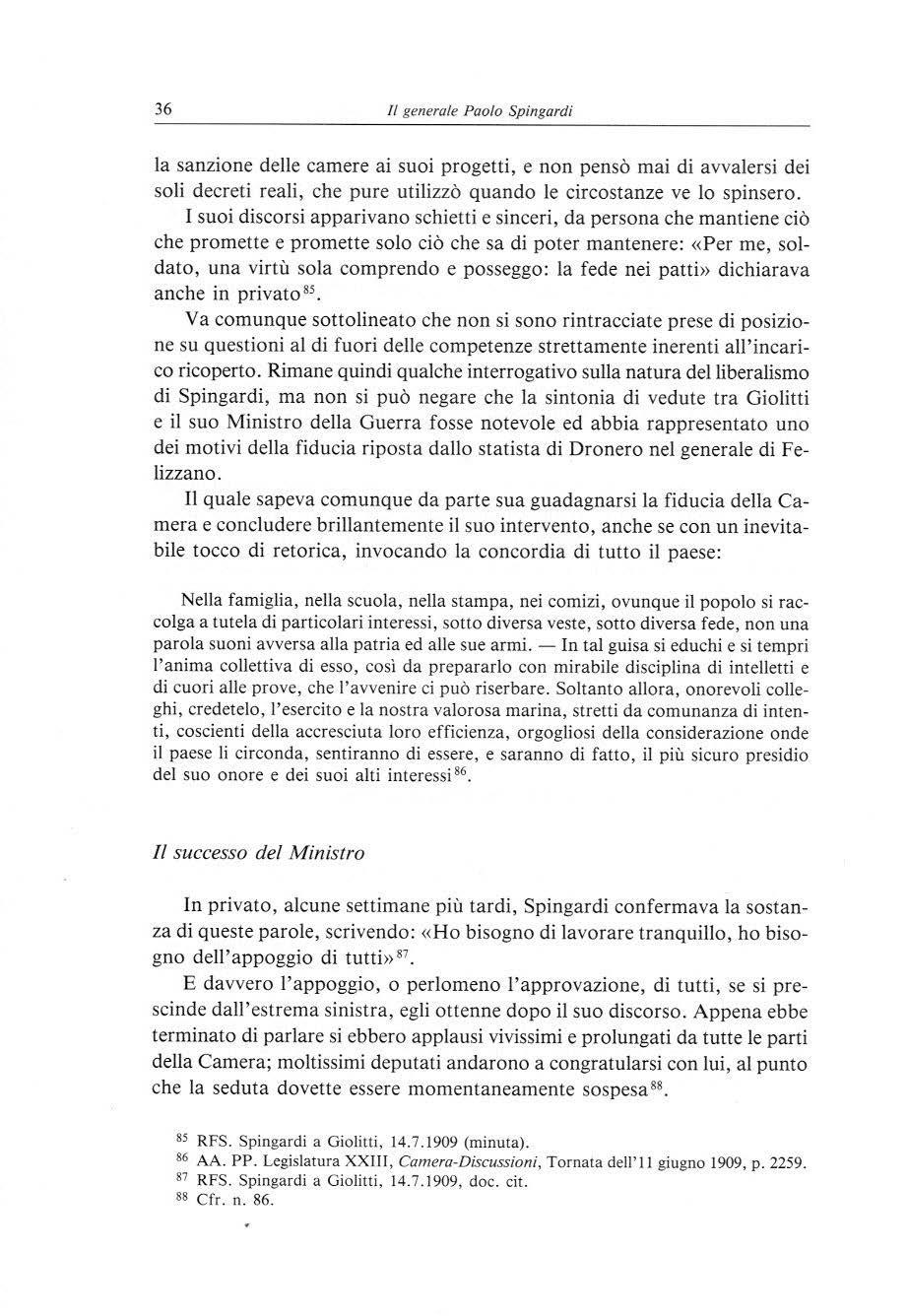
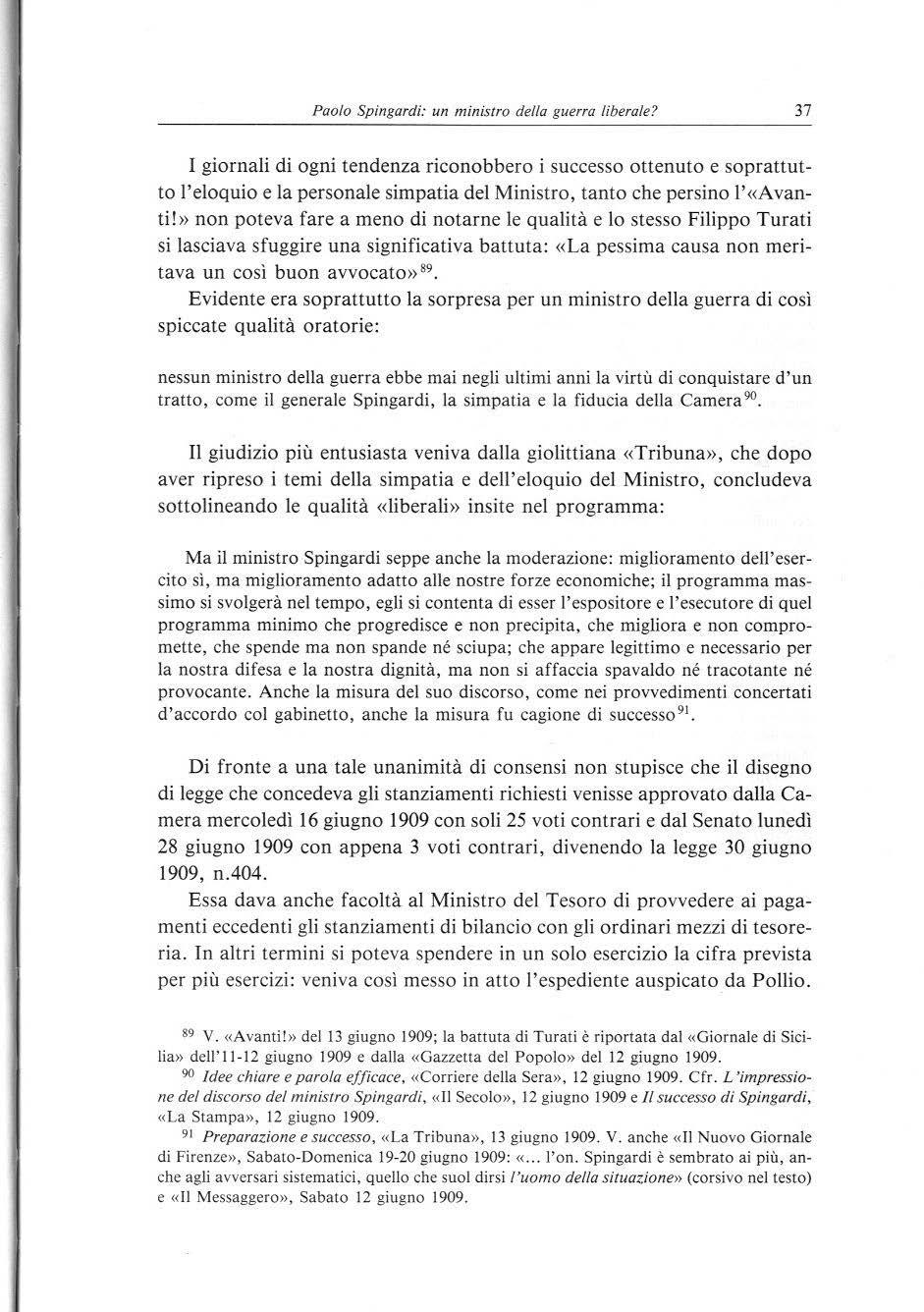

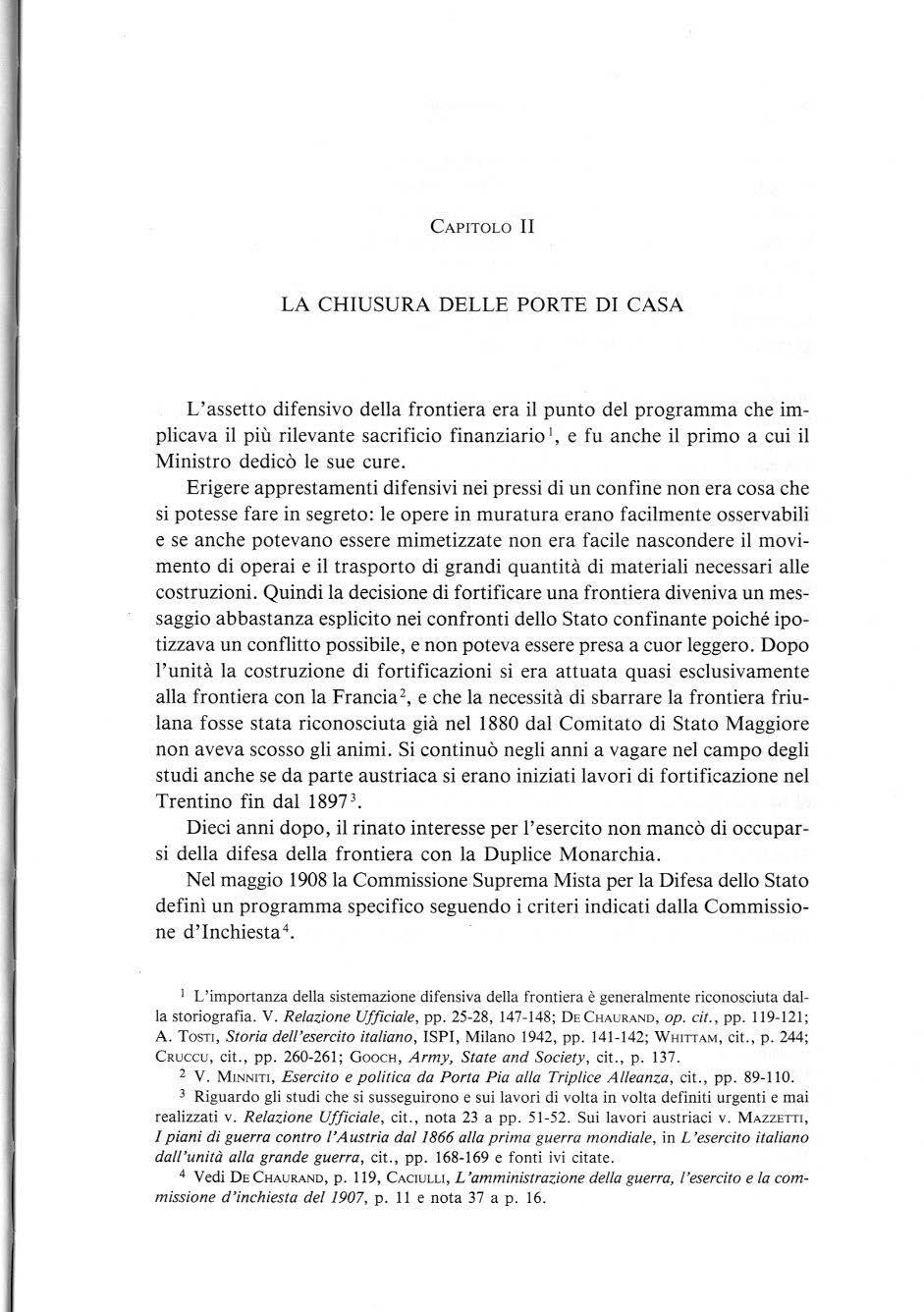
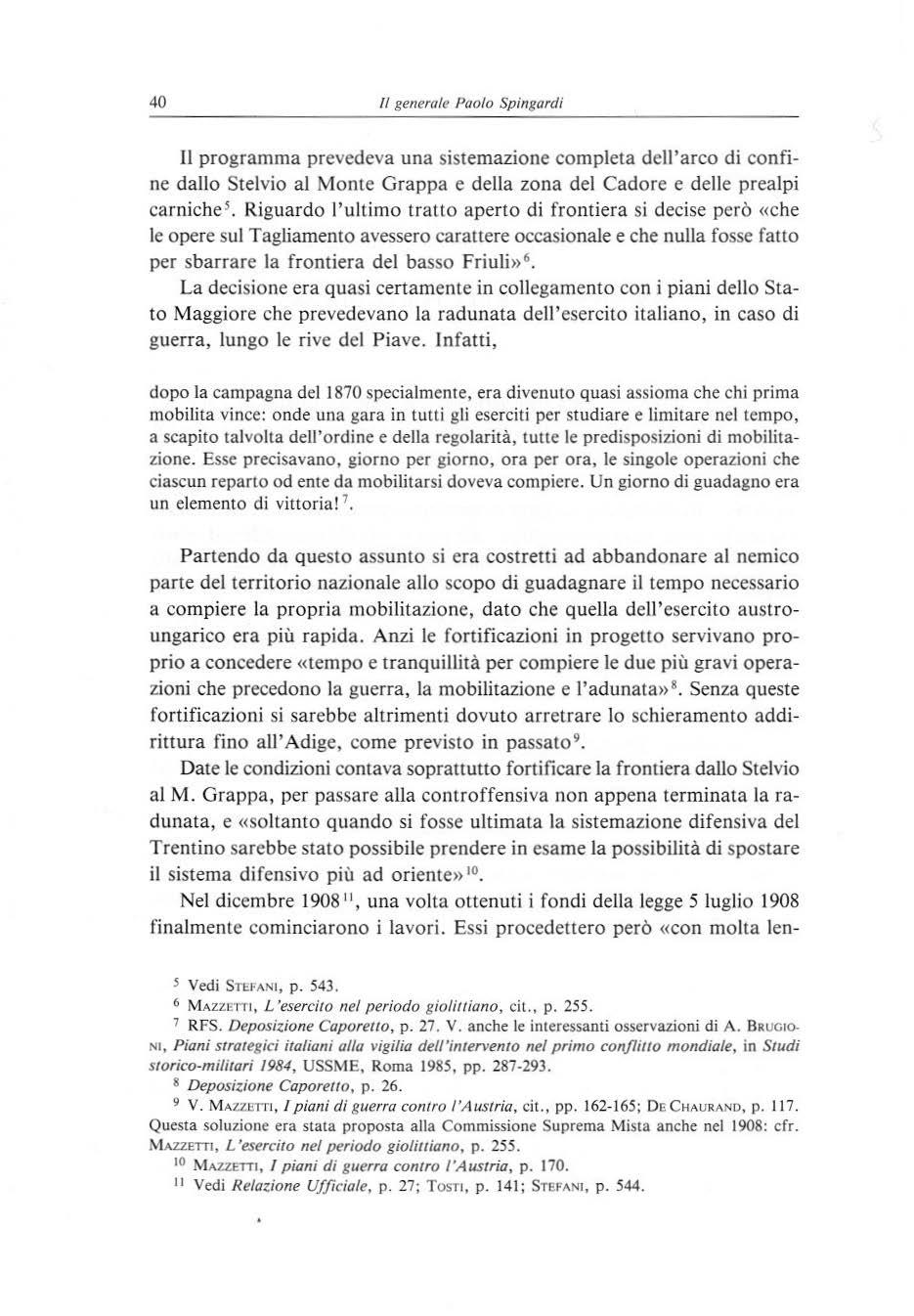
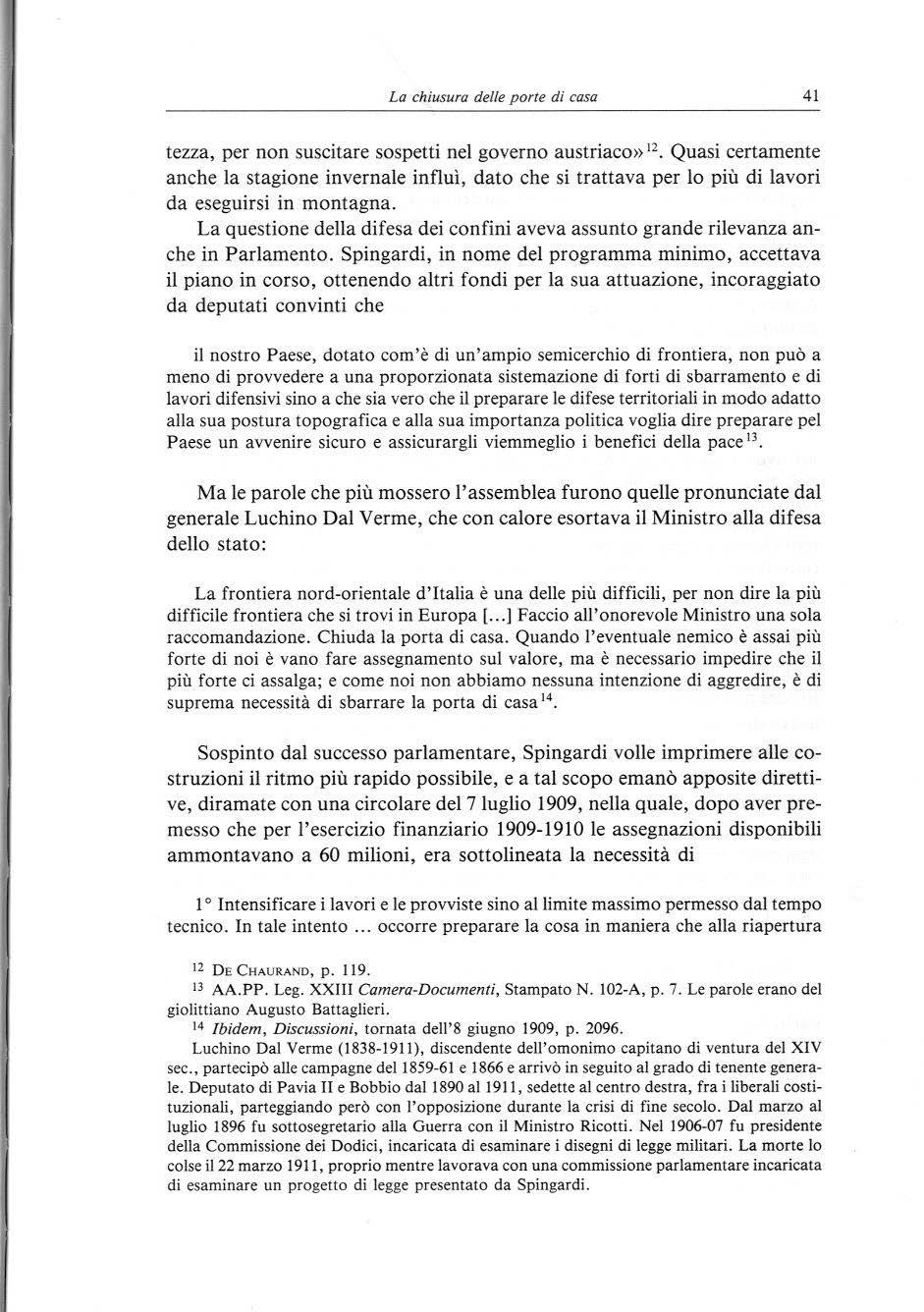
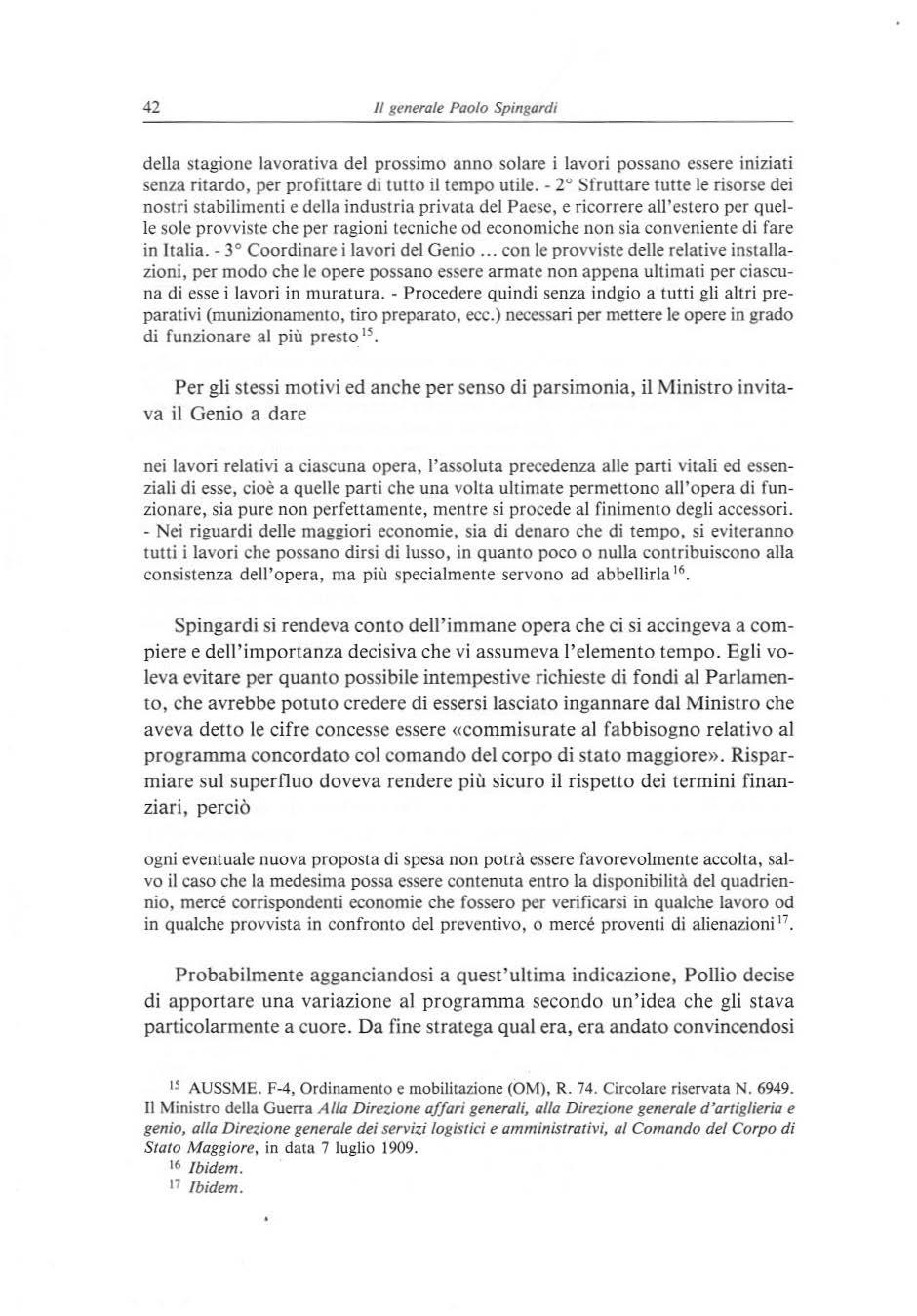
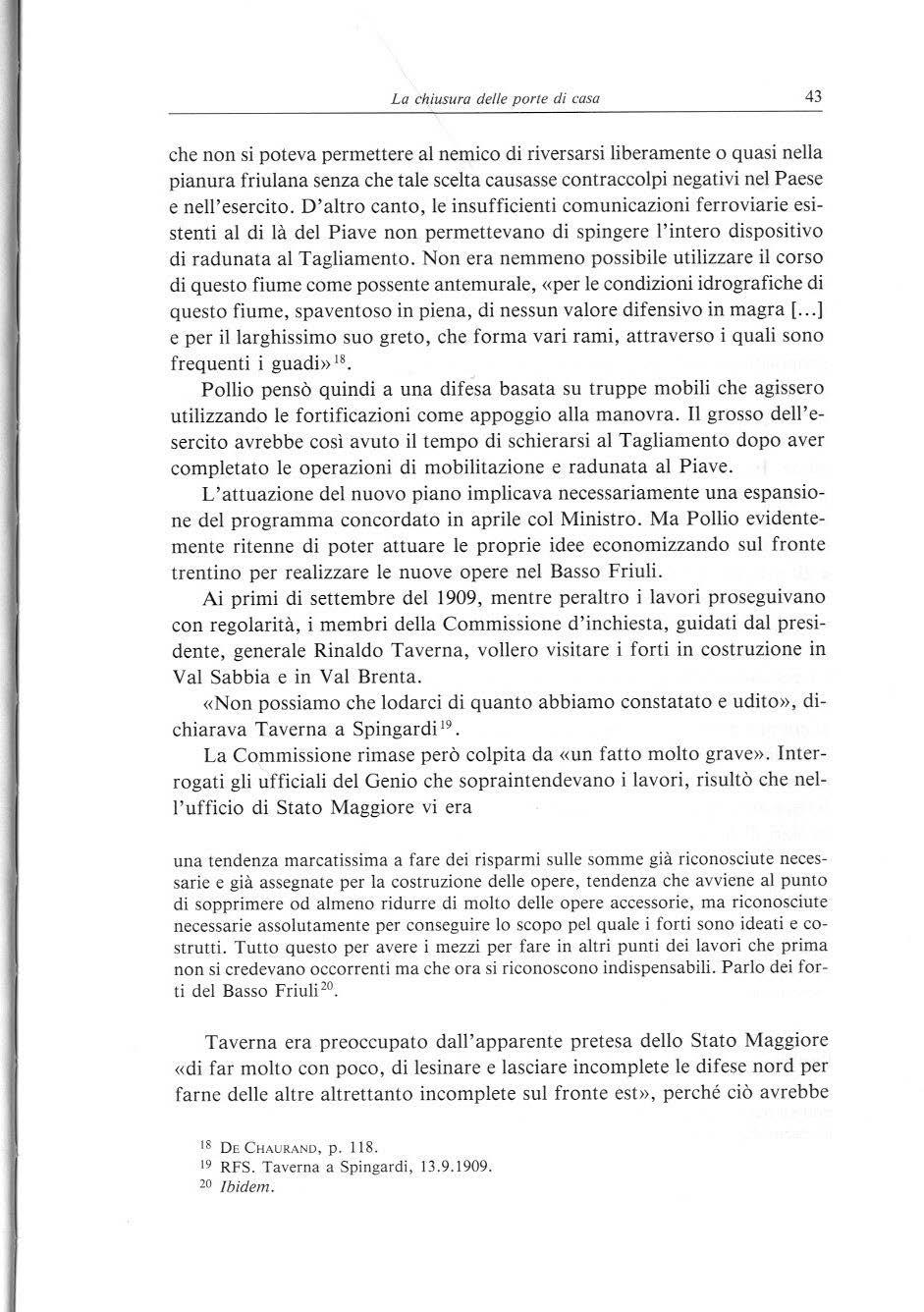
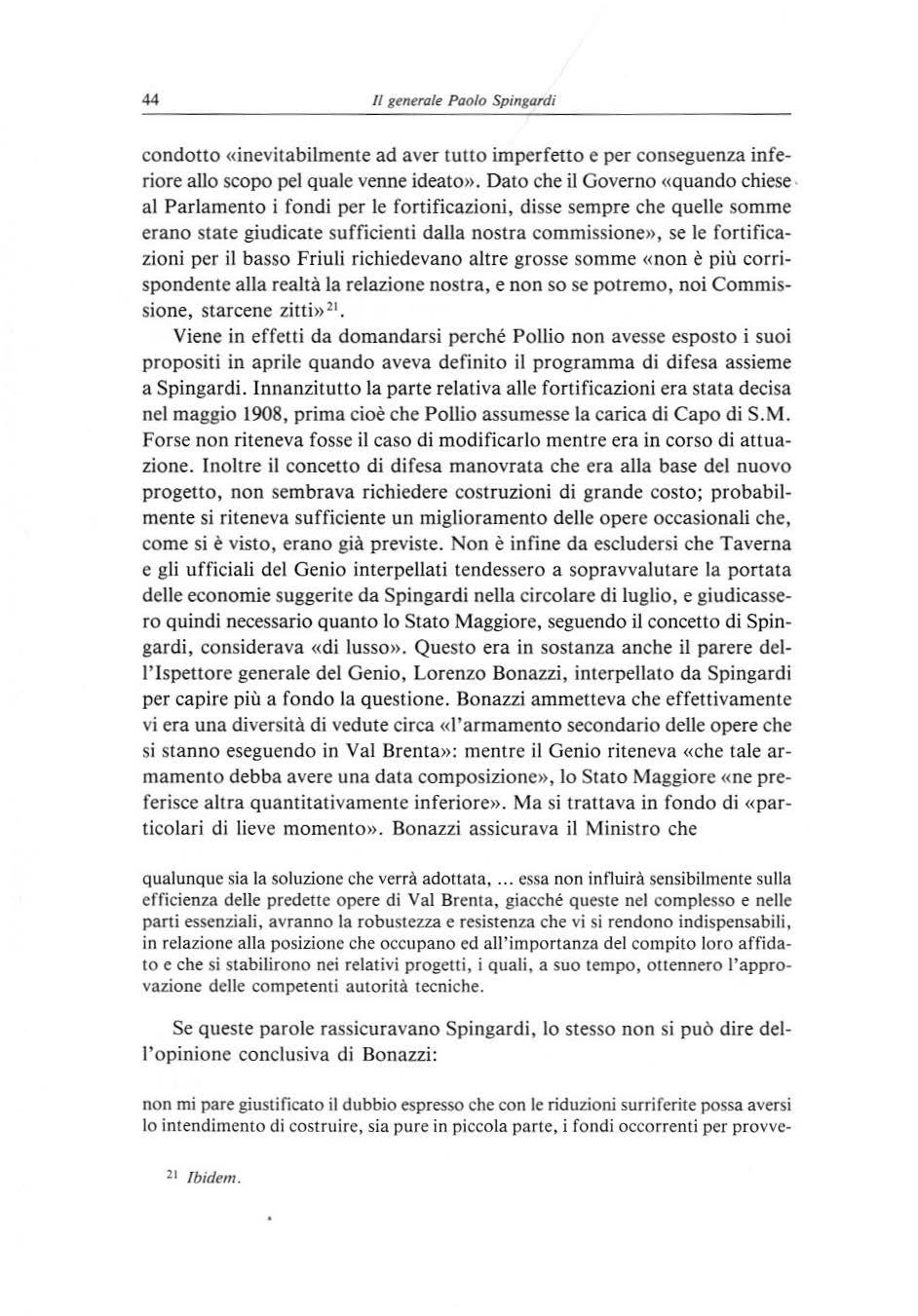
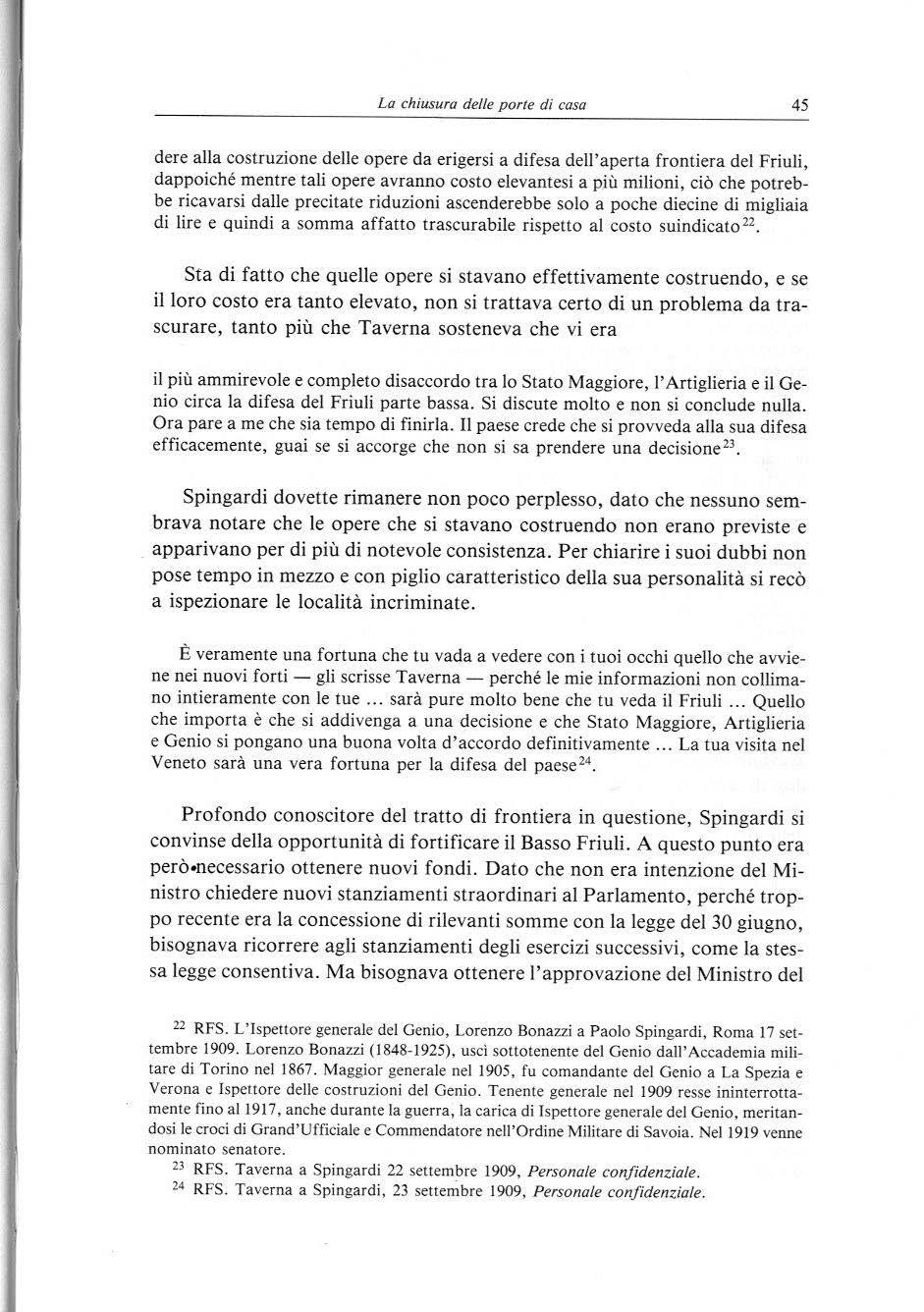
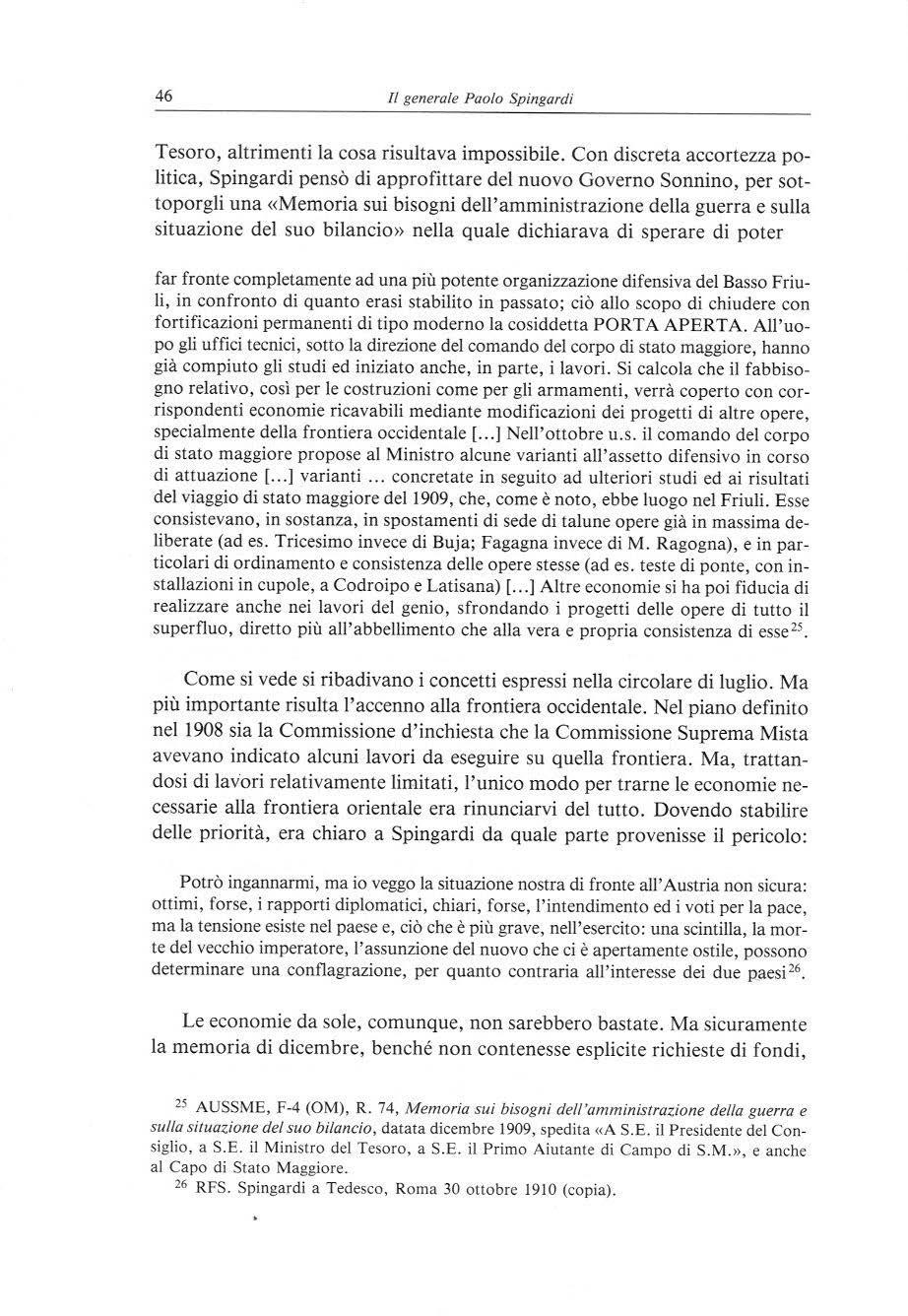
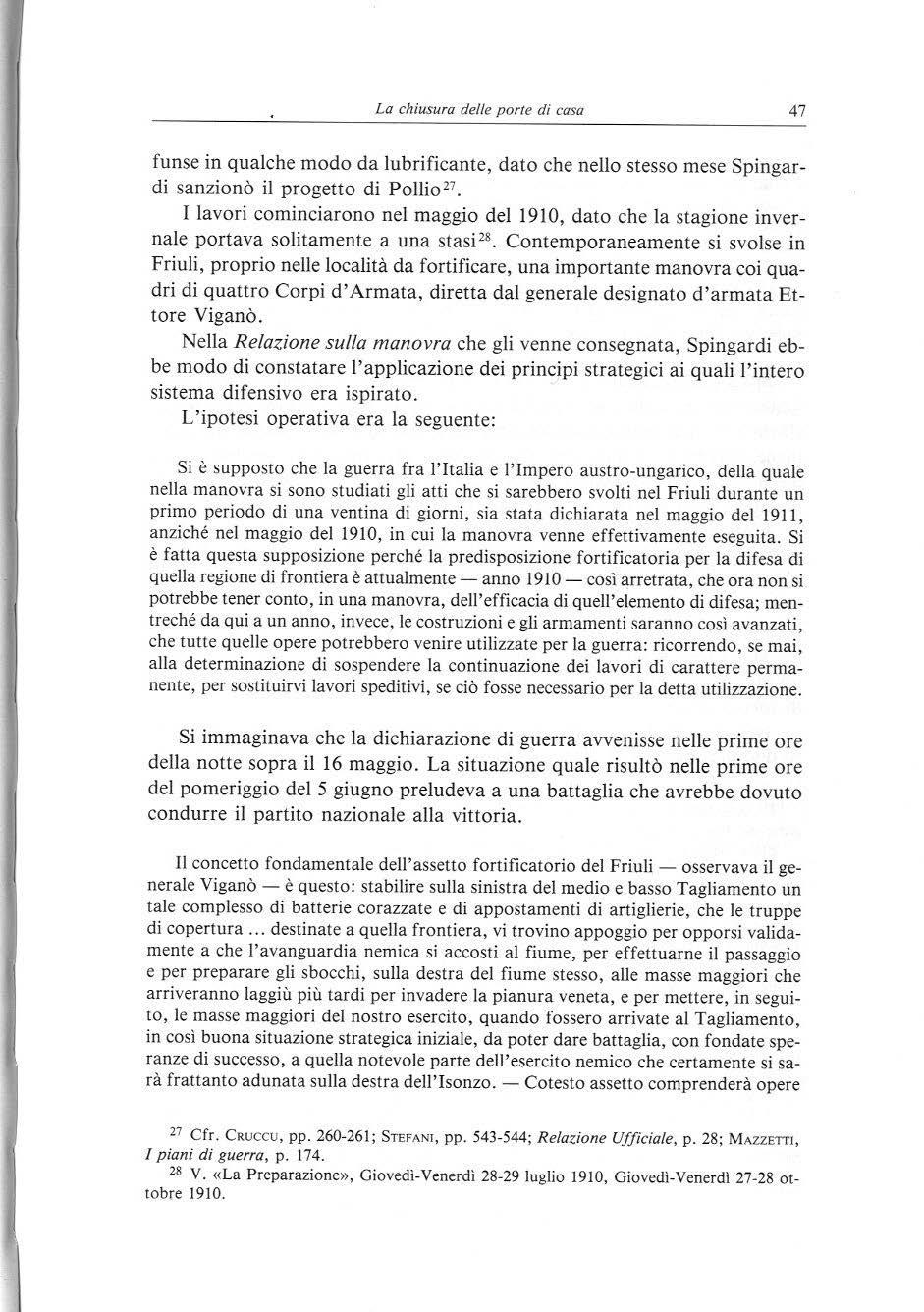
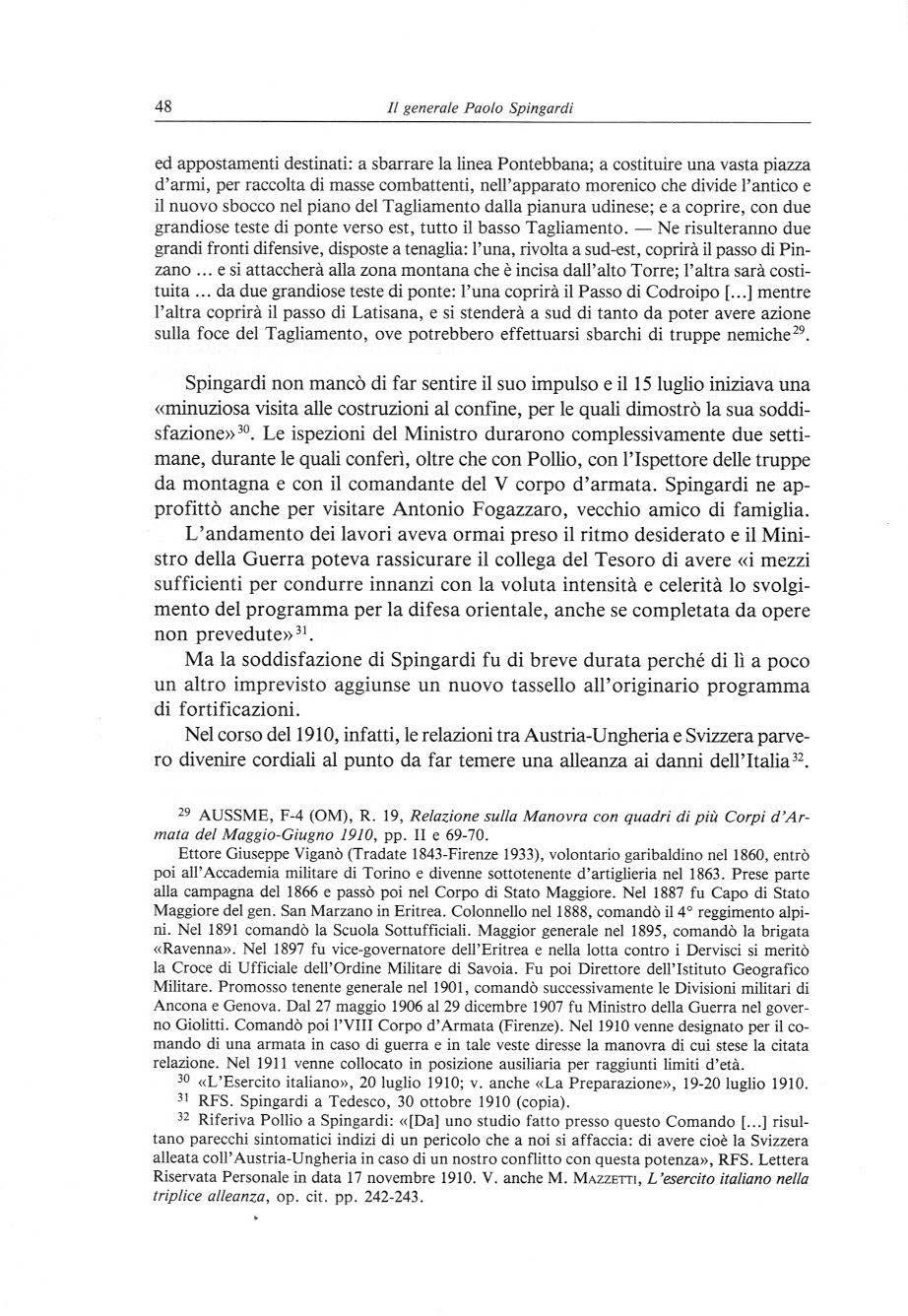
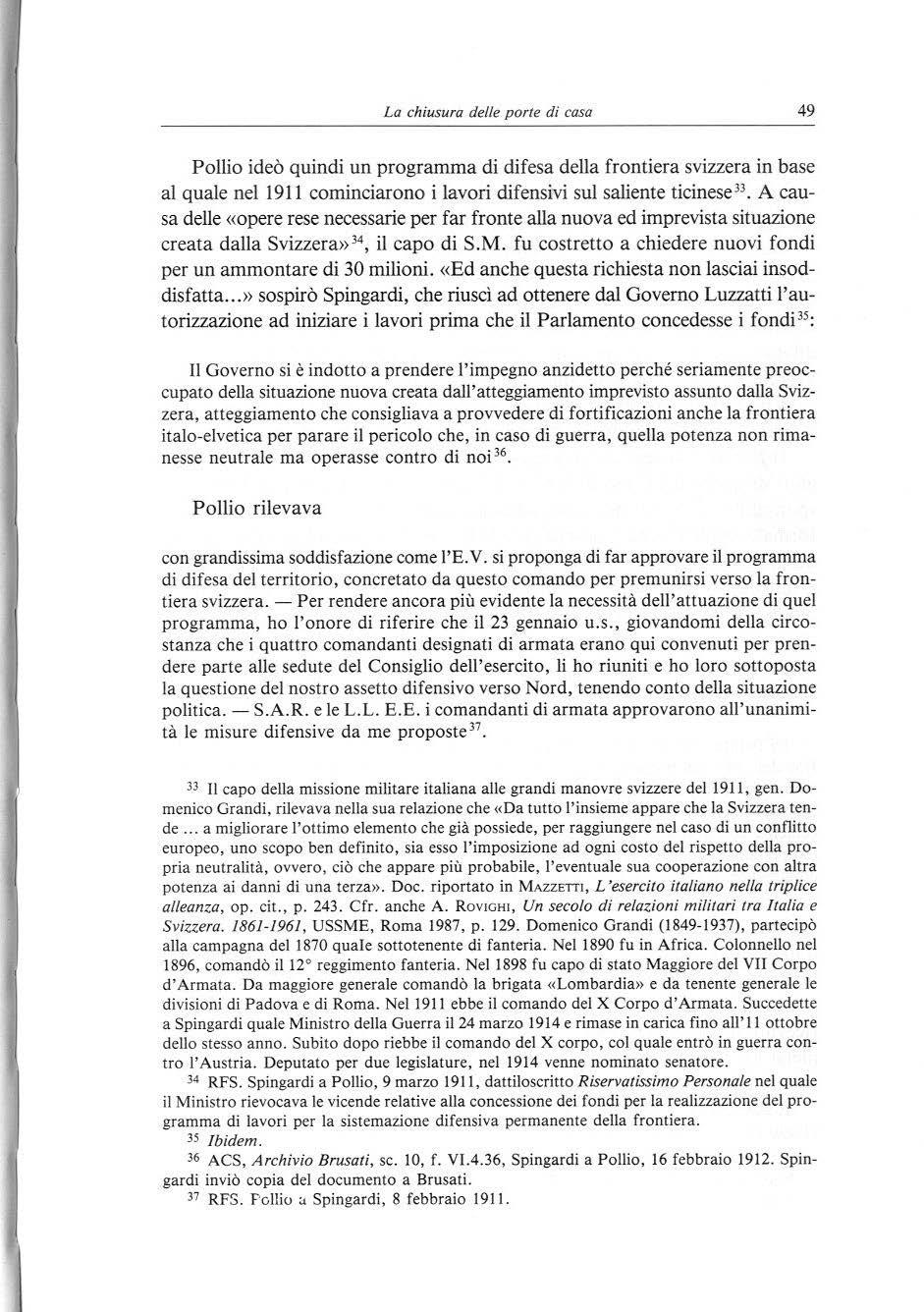
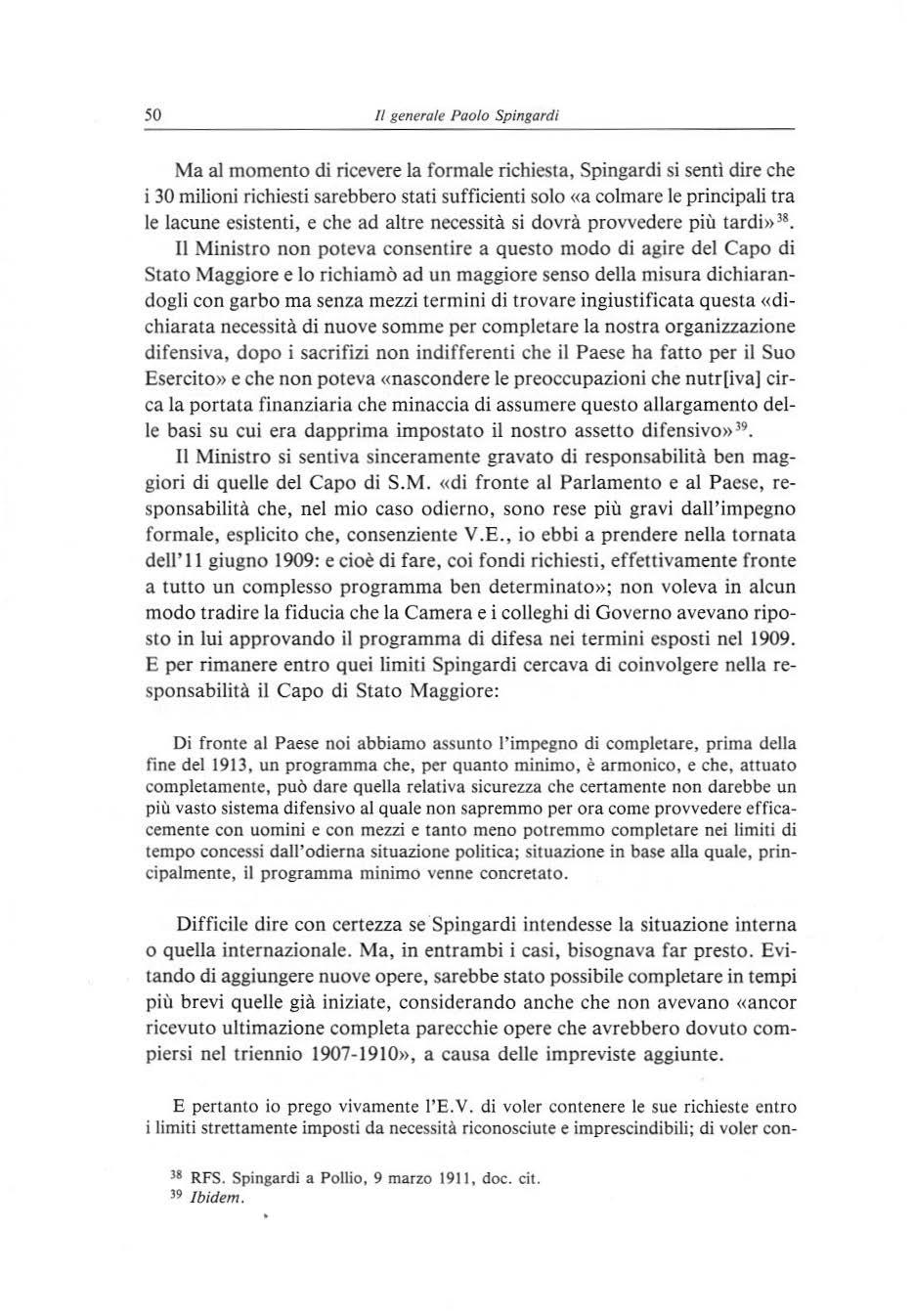
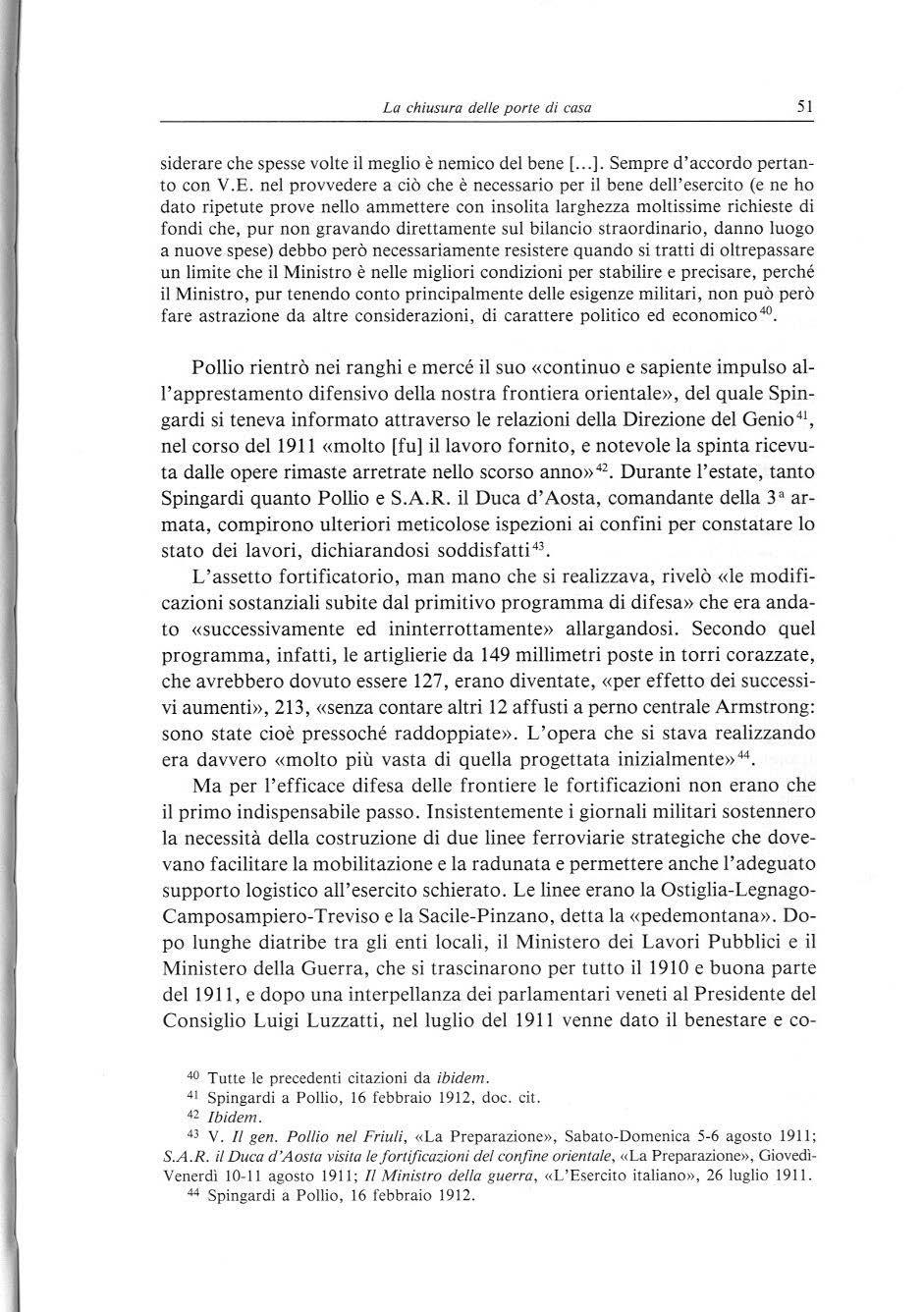
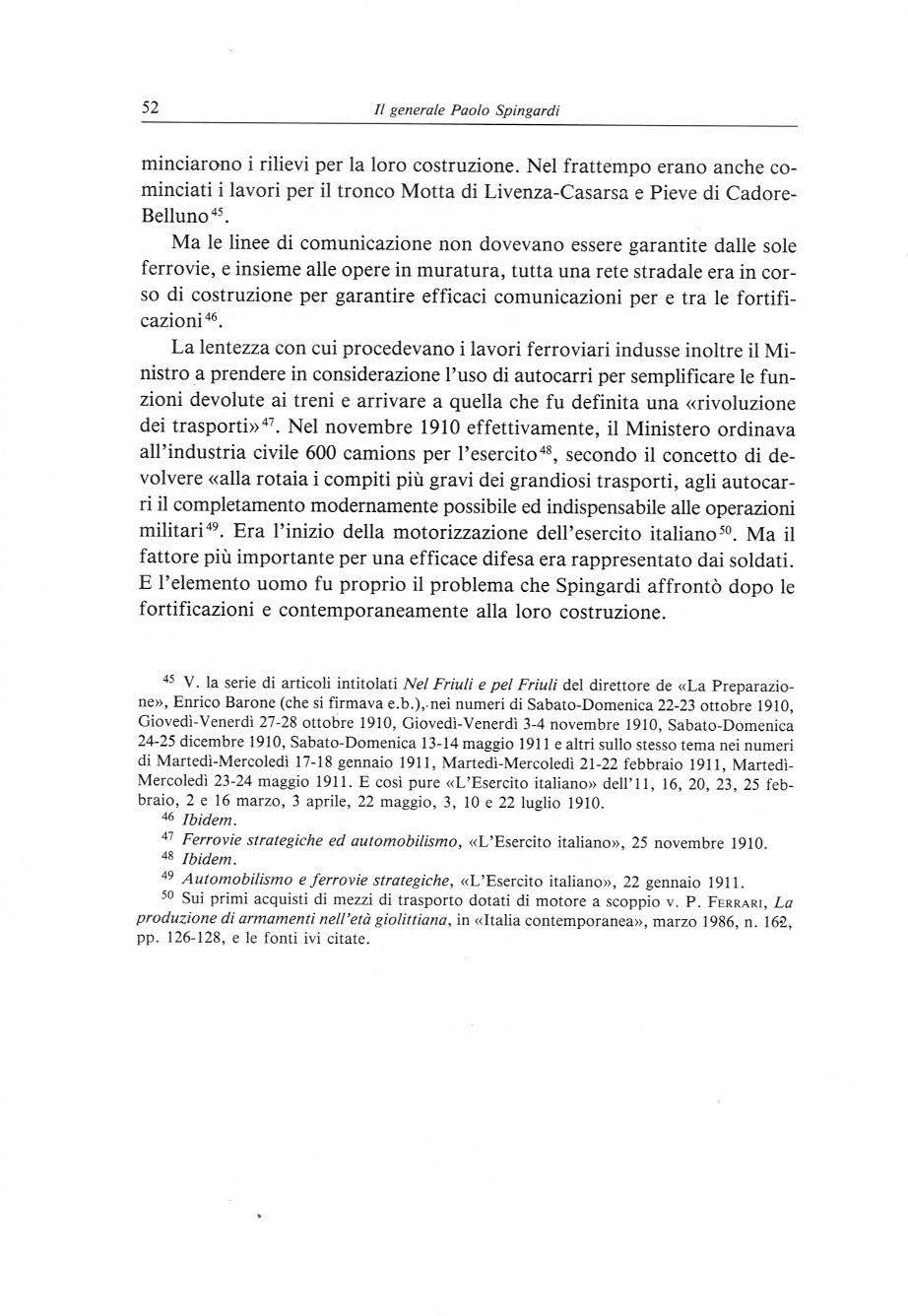
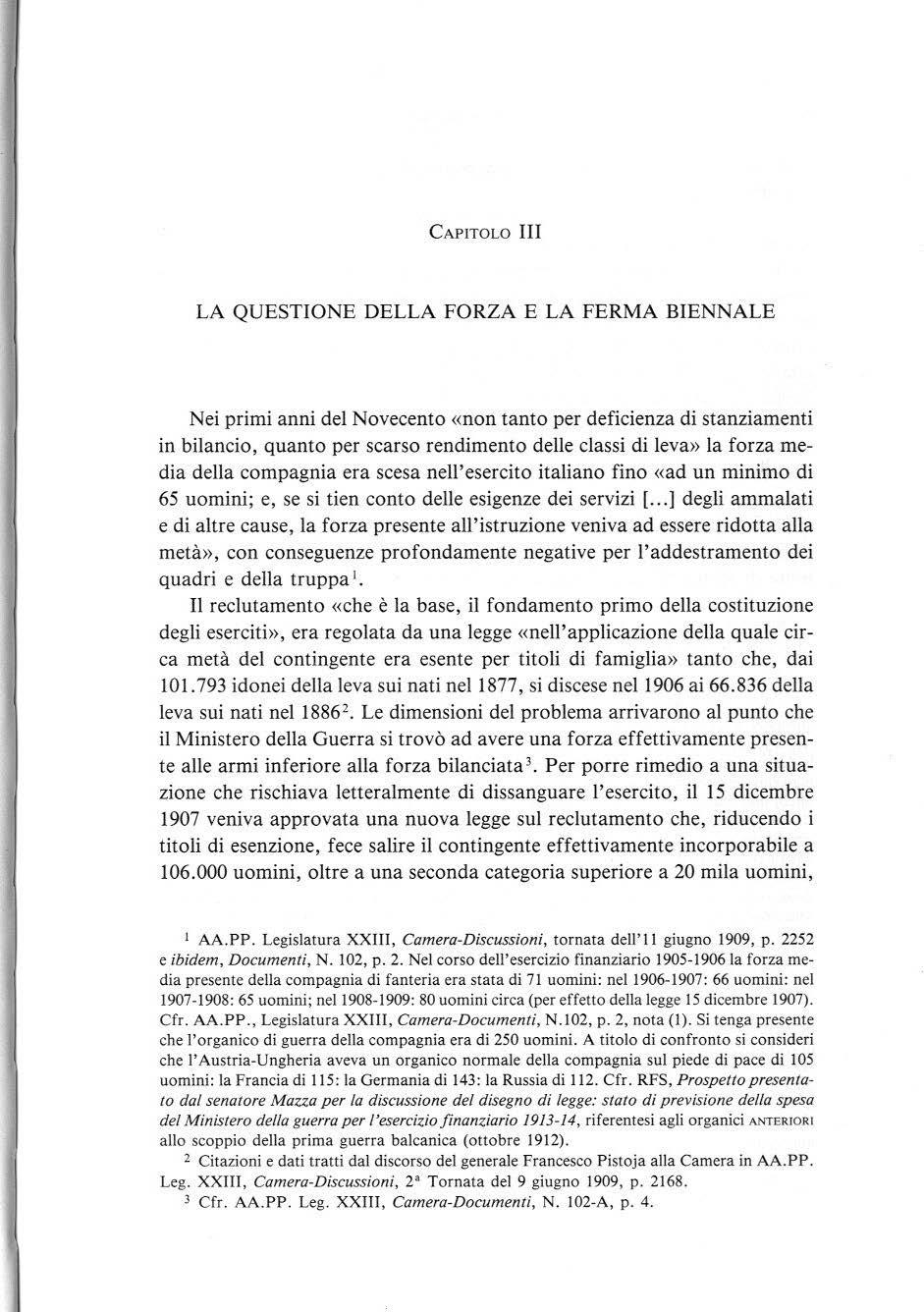
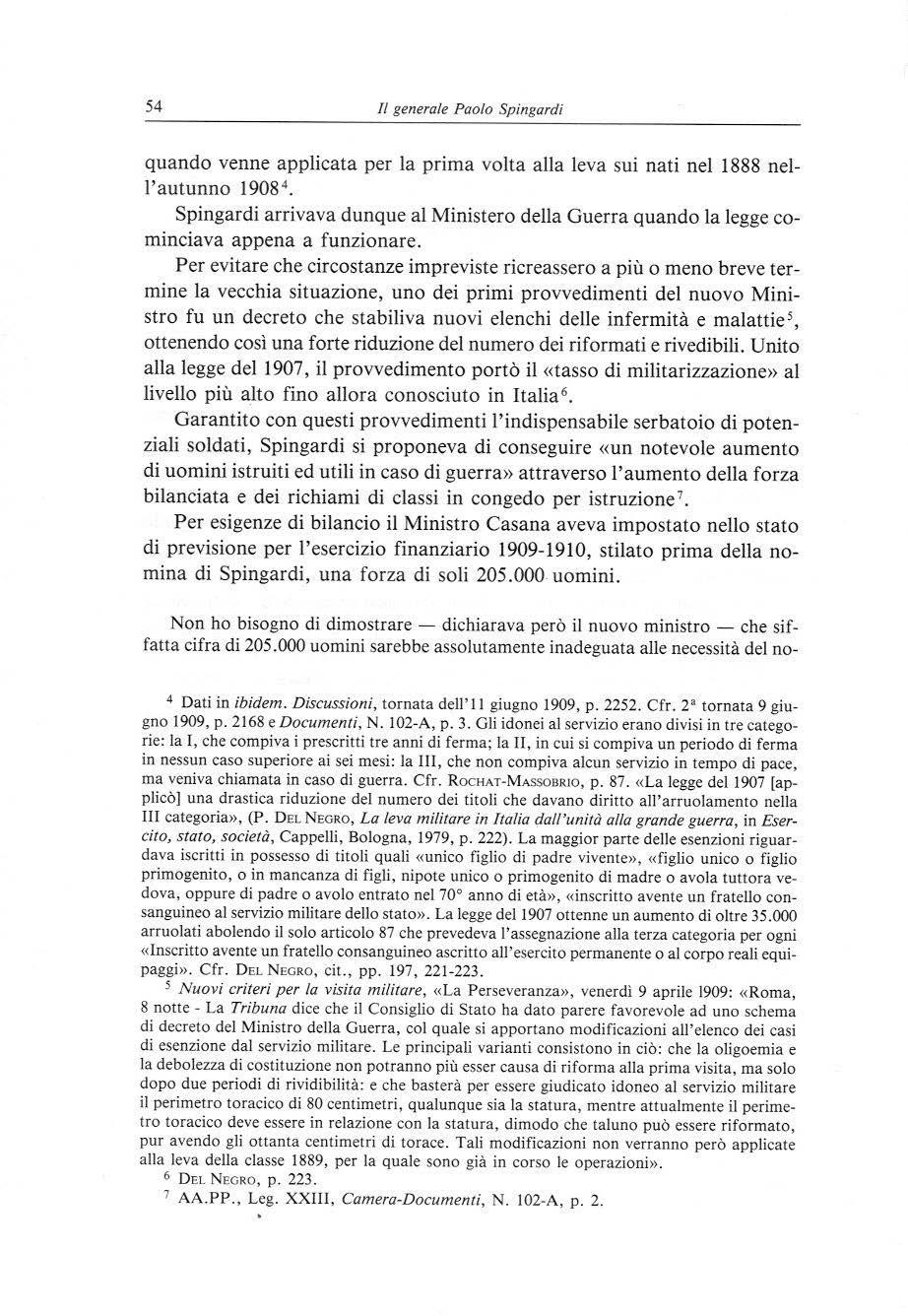
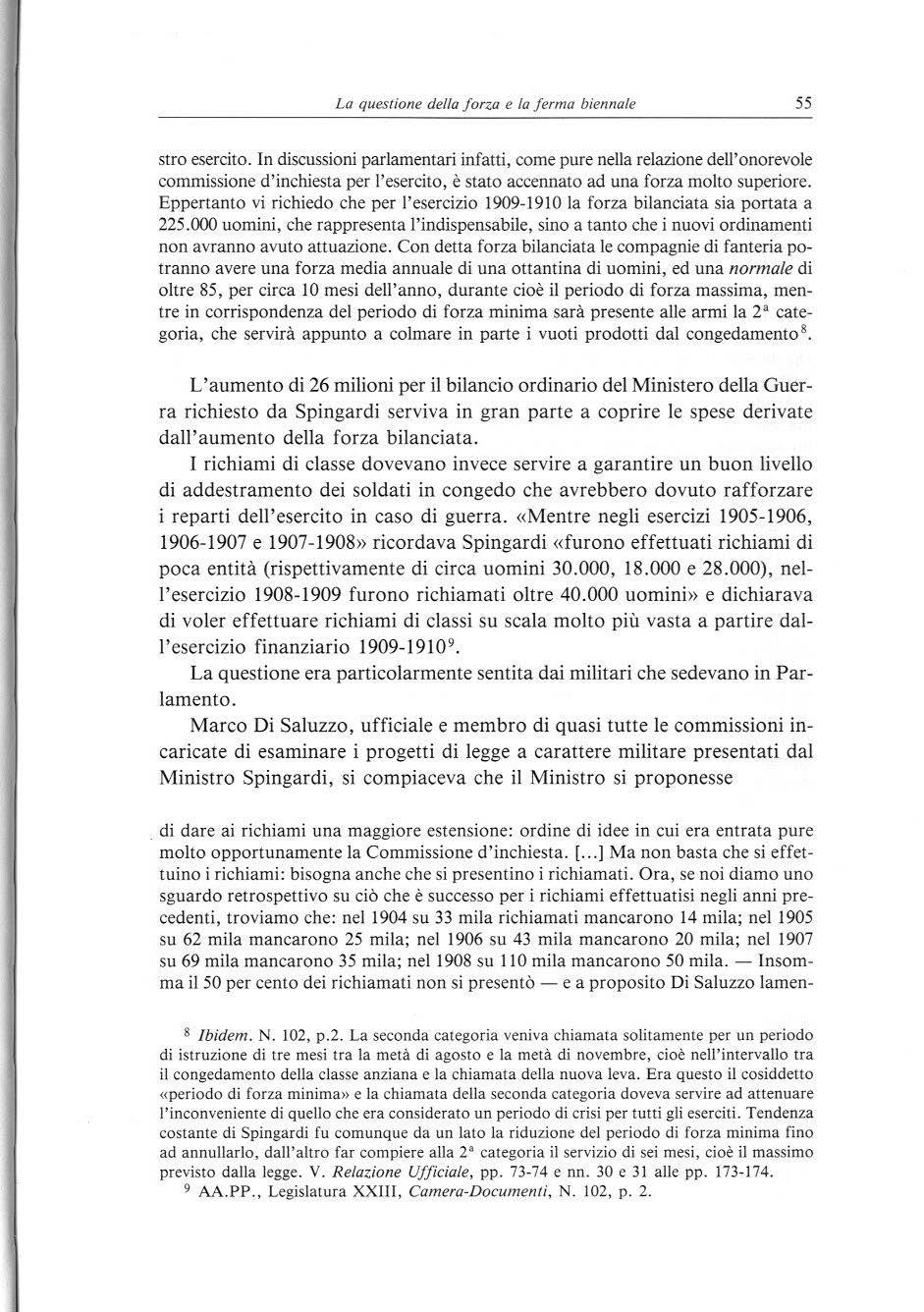
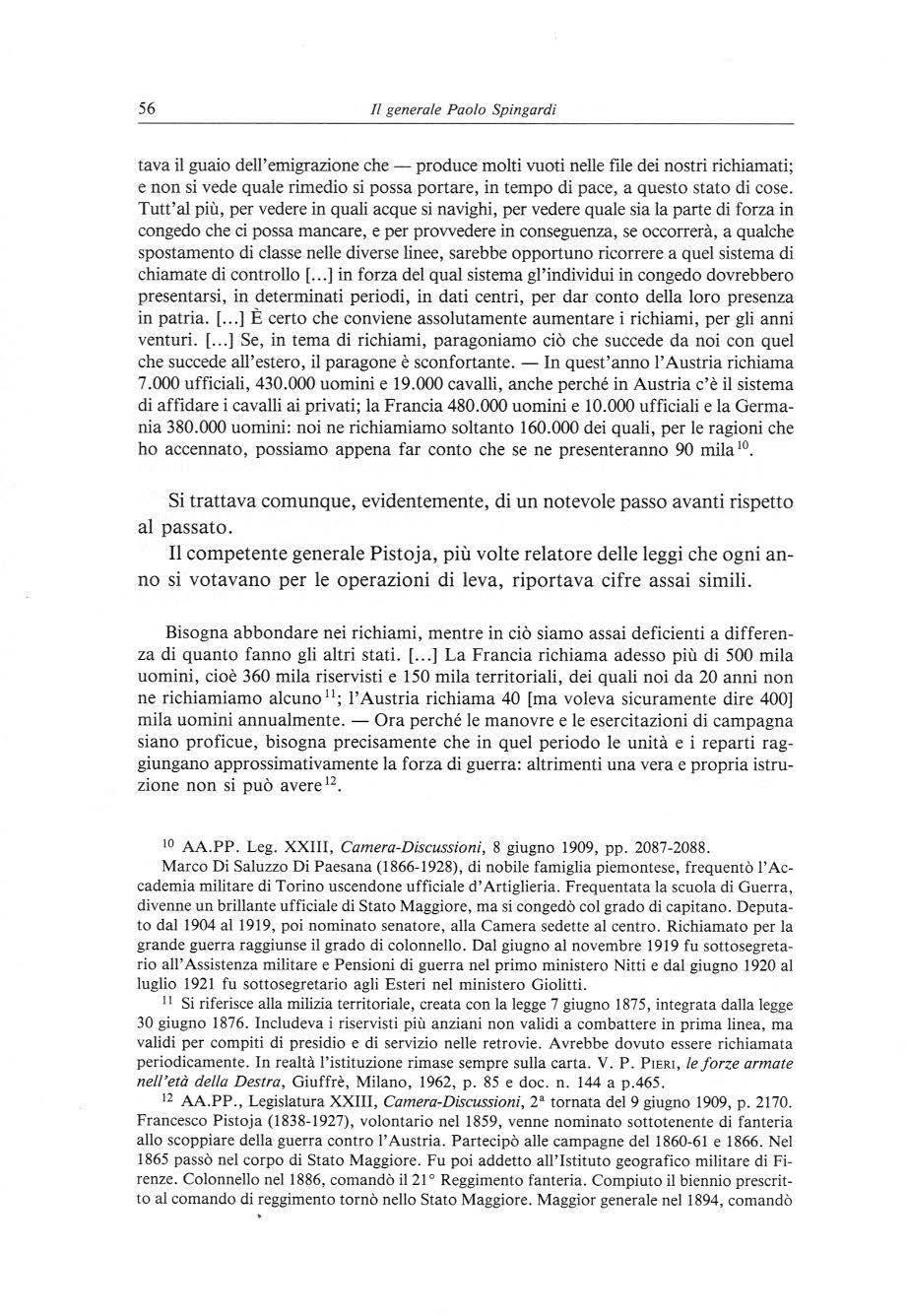
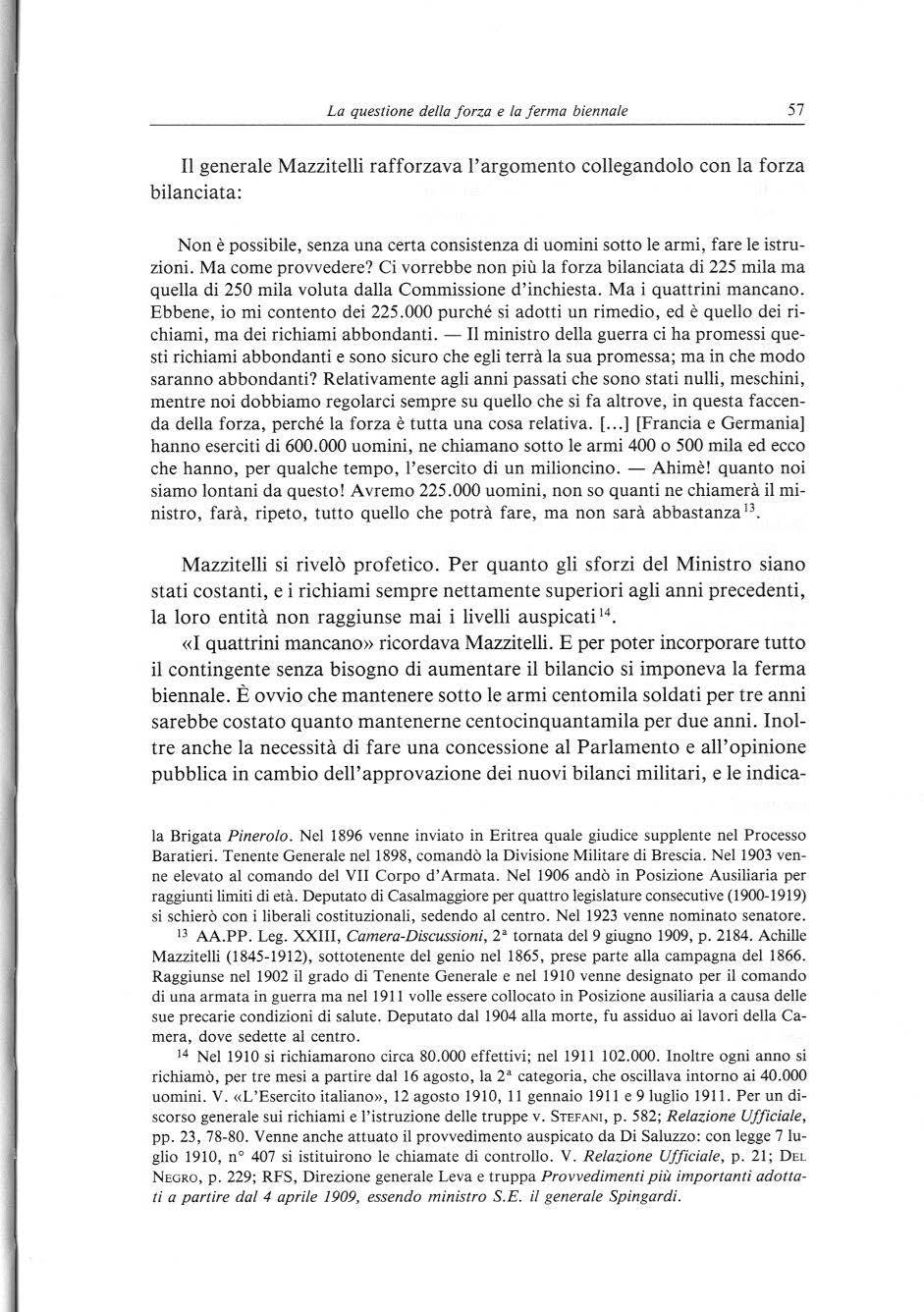
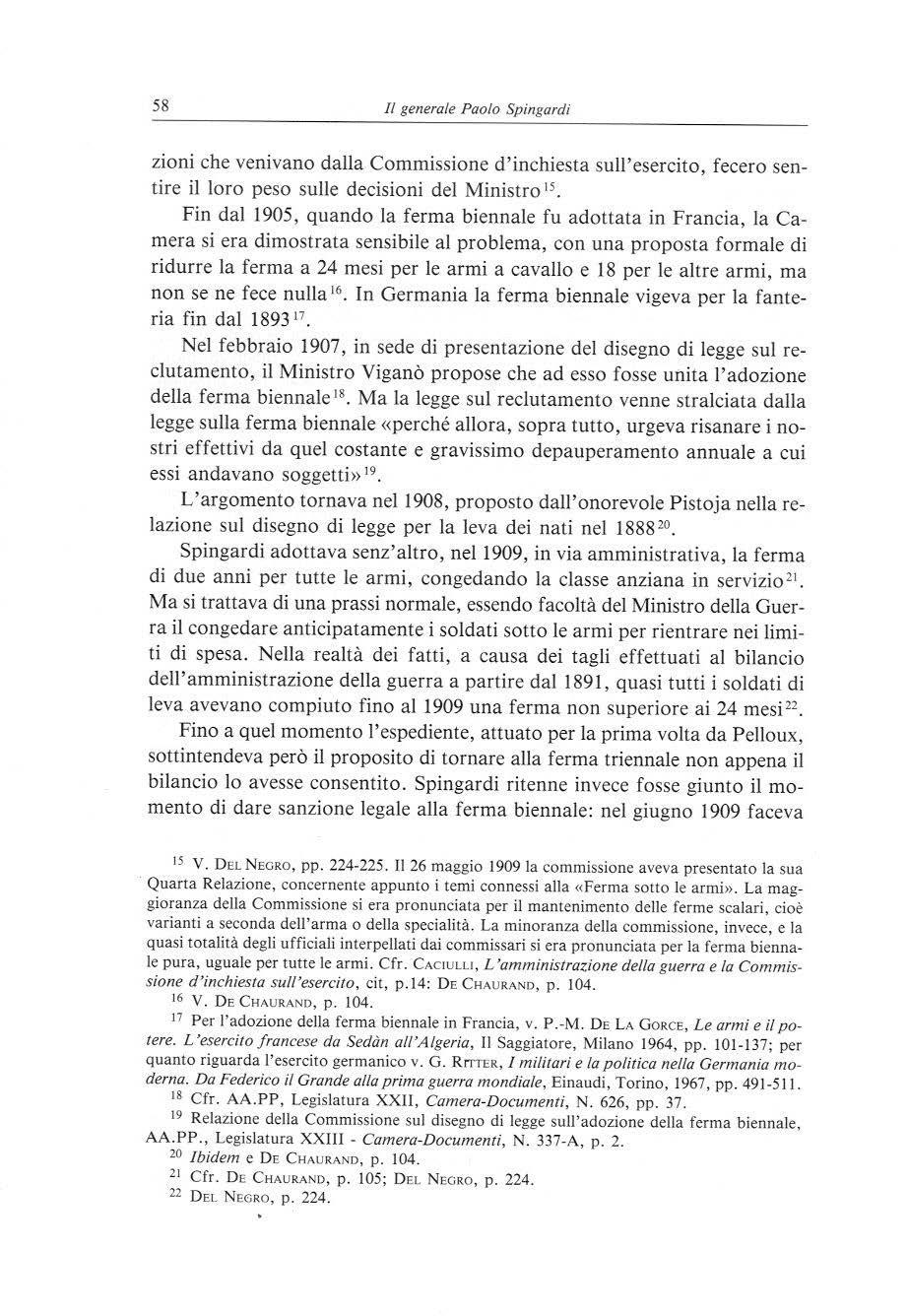
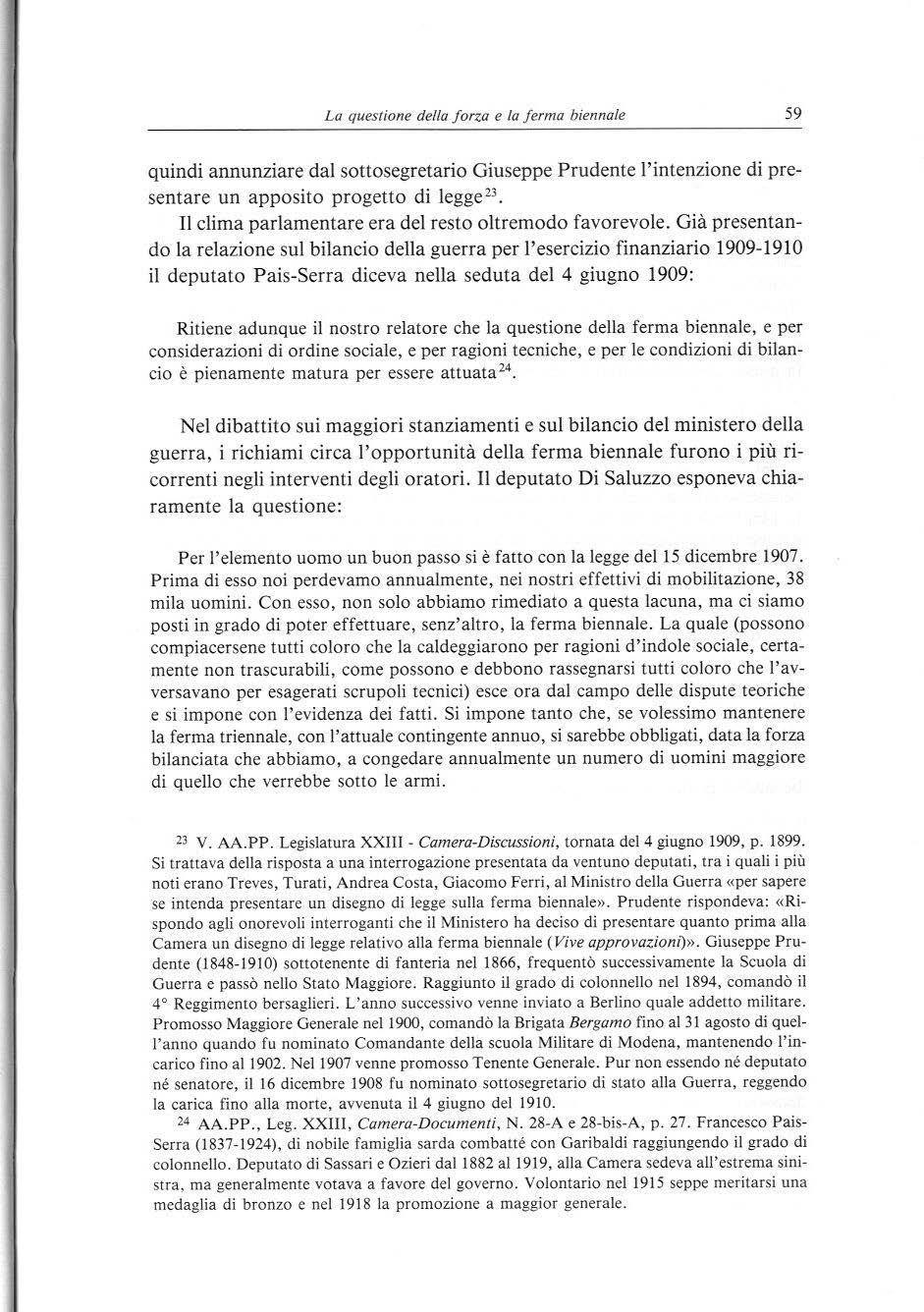
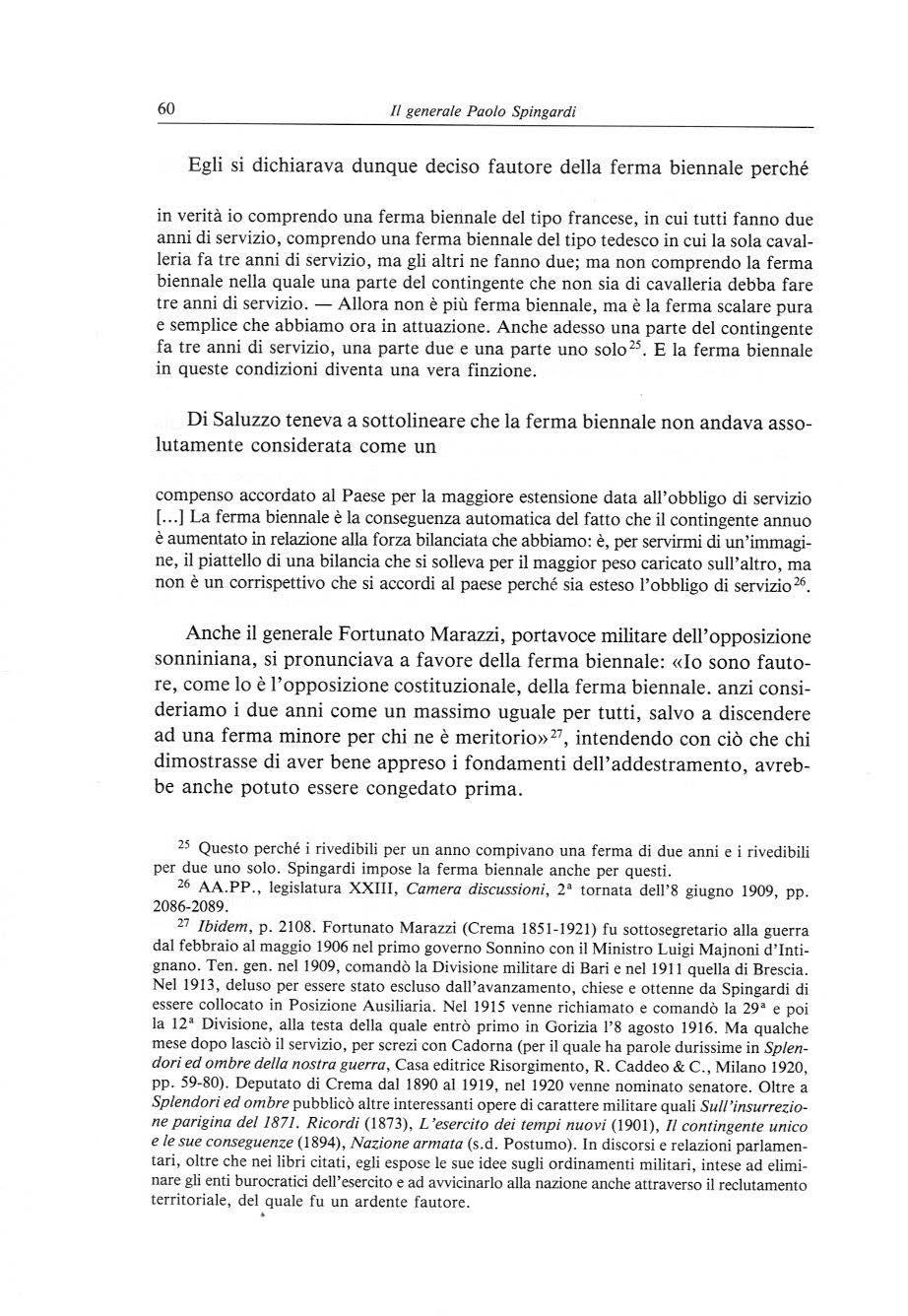
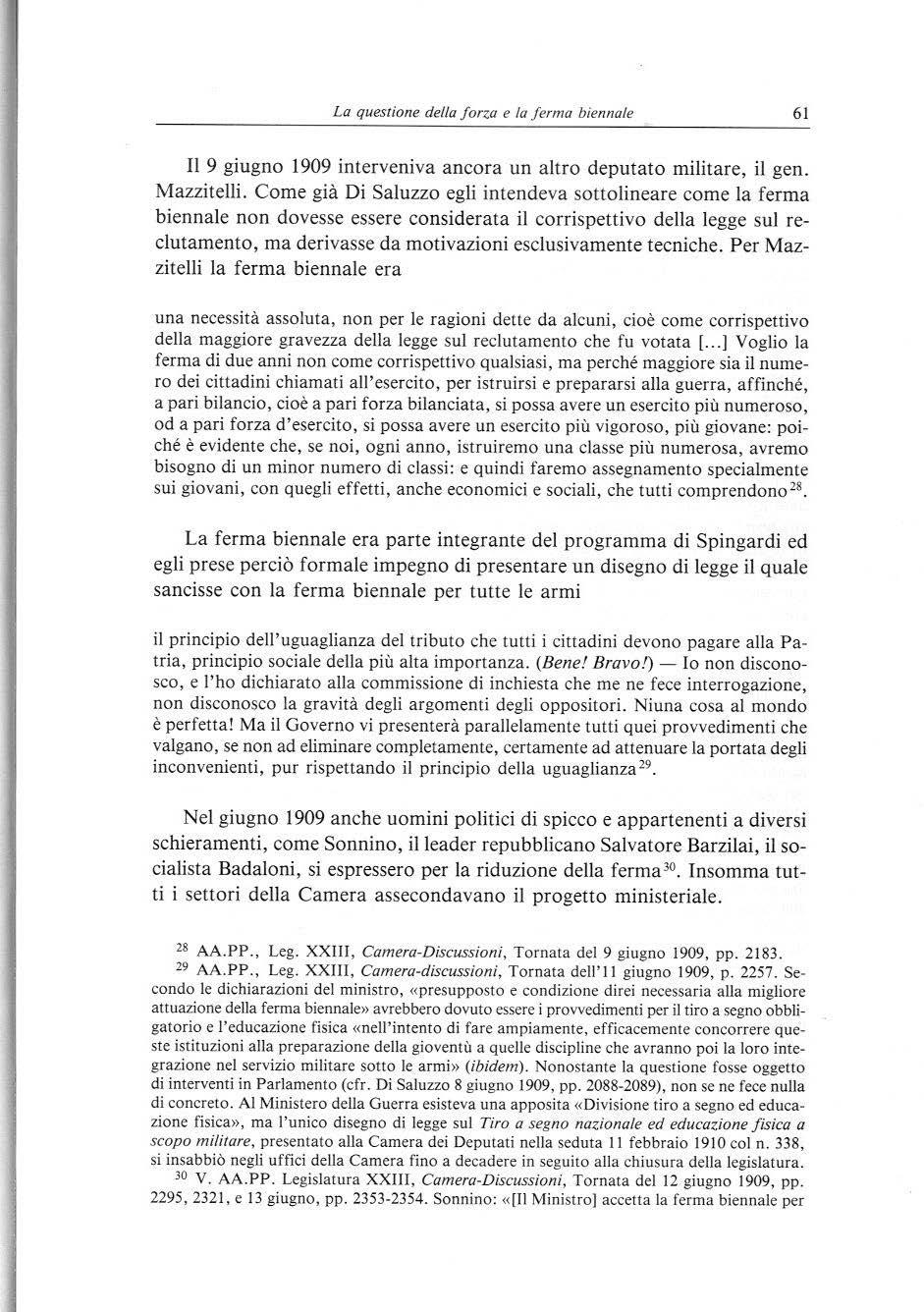
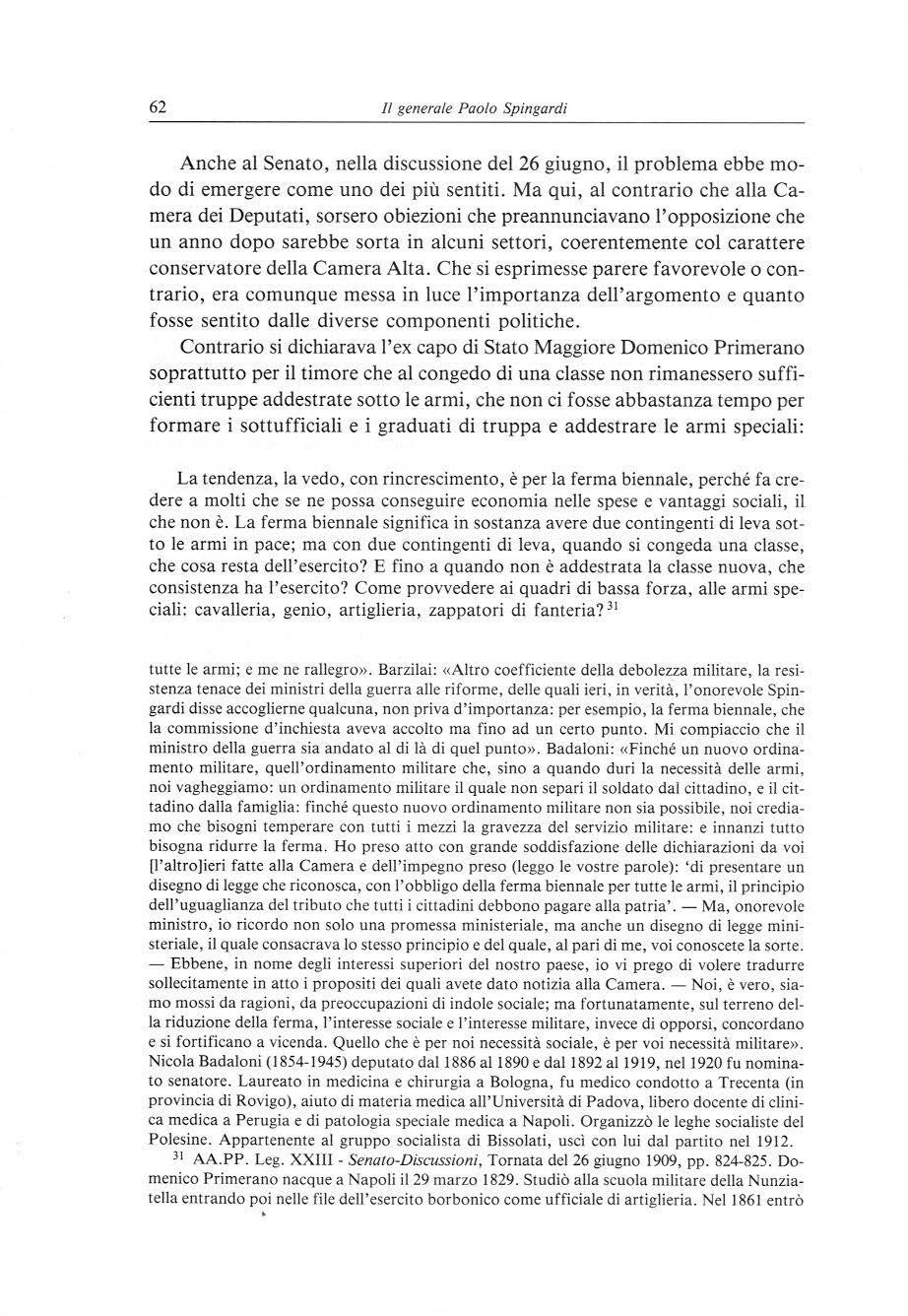

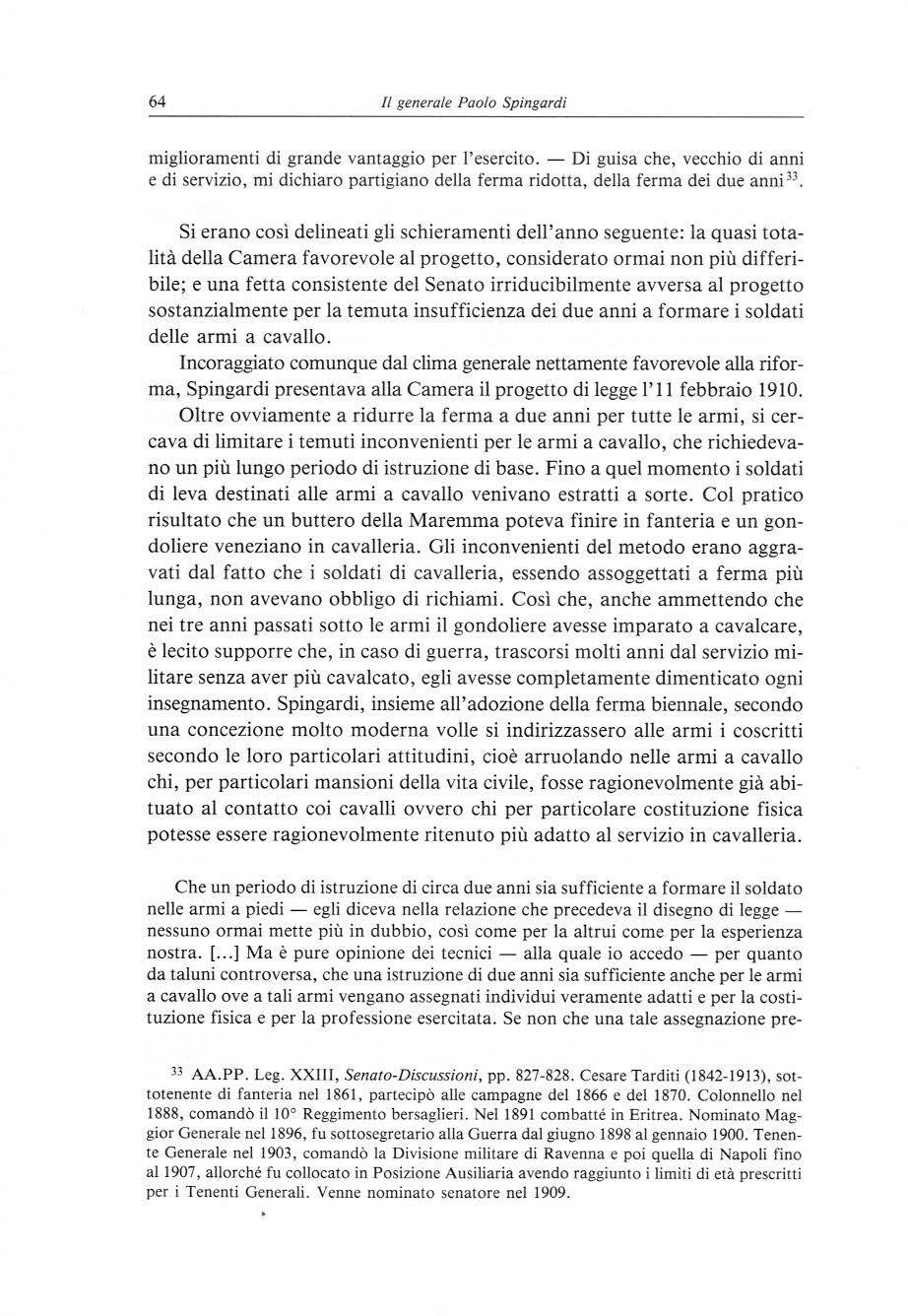
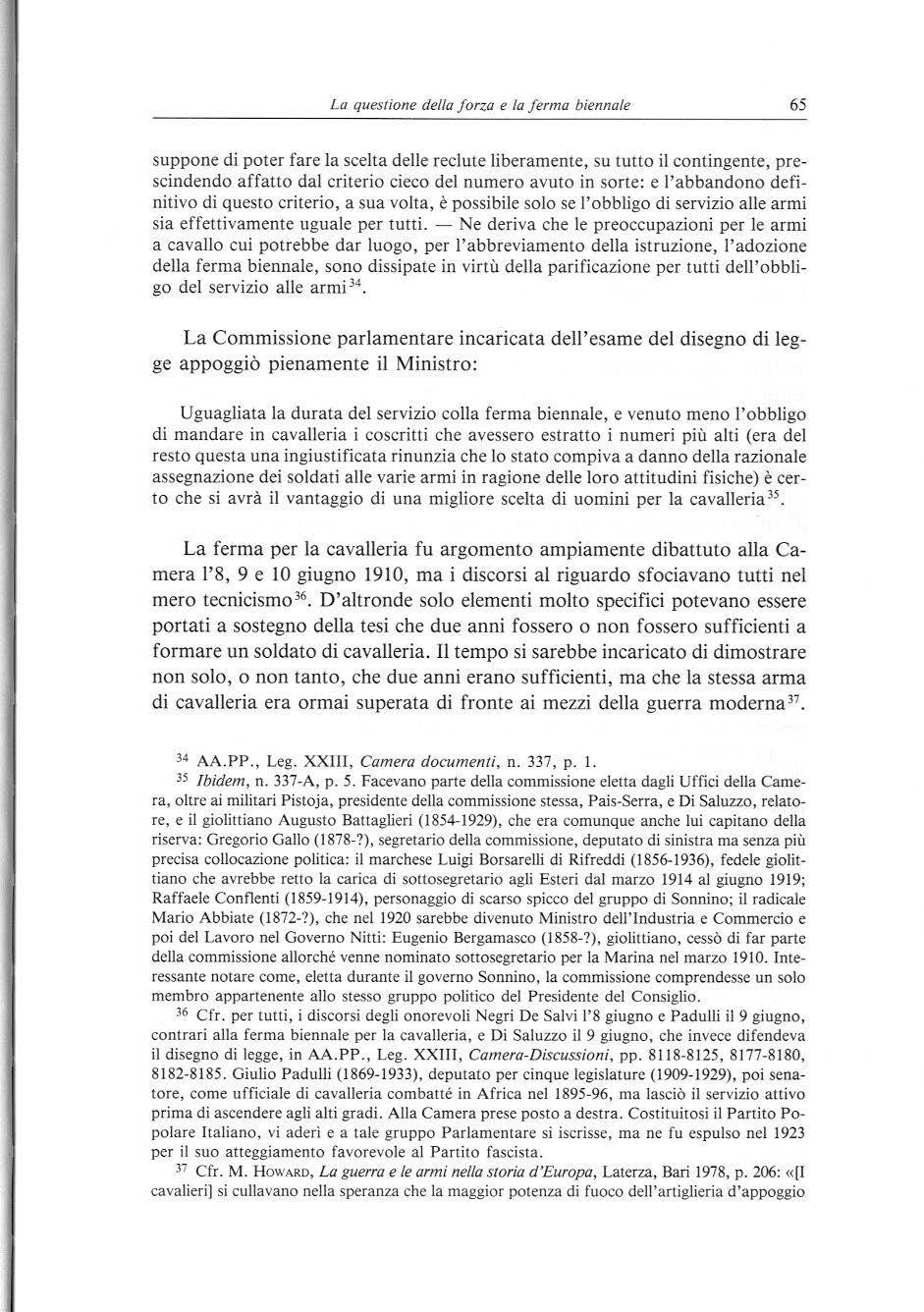 Il generale Paolo Spi'!gardi
Il generale Paolo Spi'!gardi
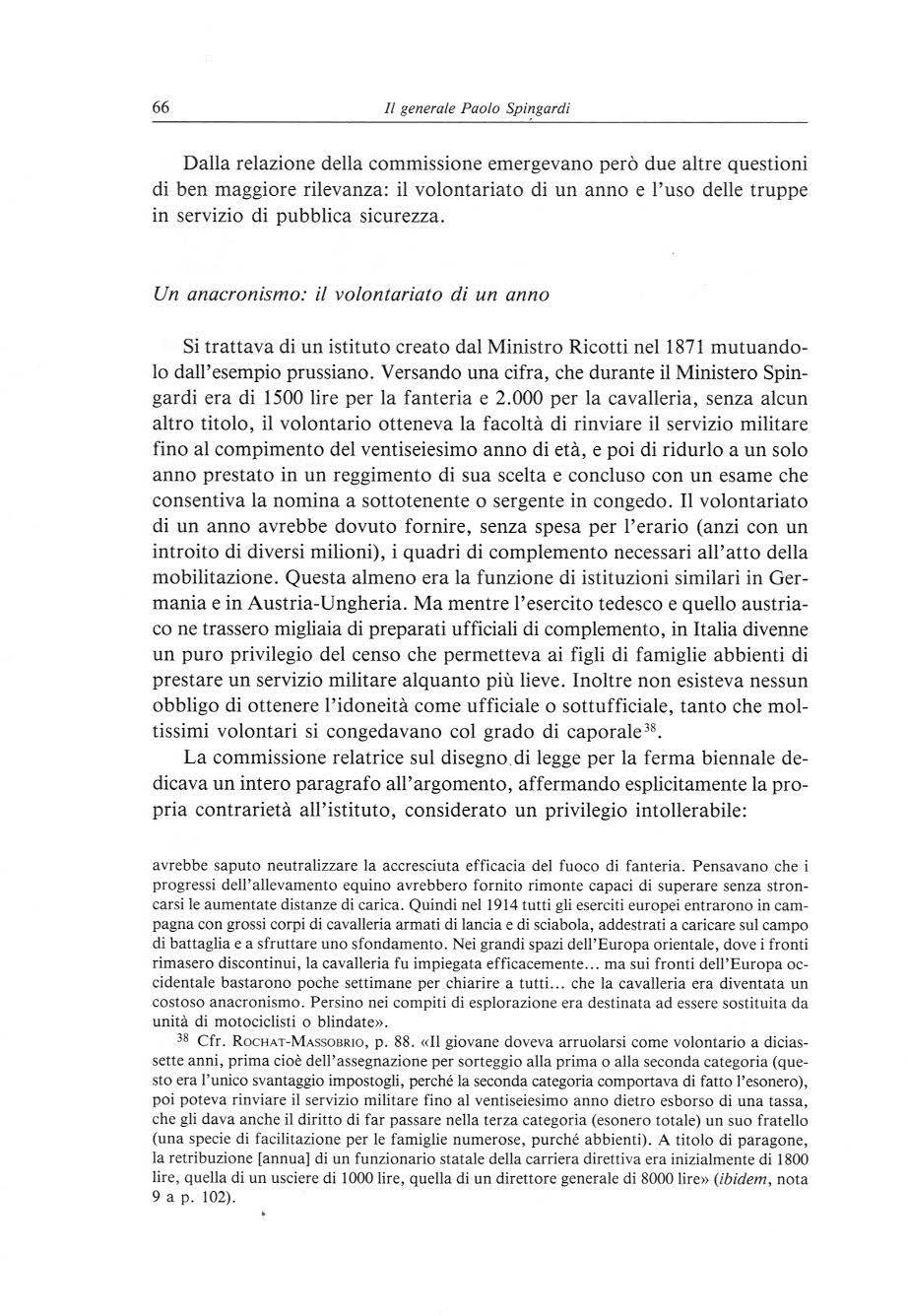
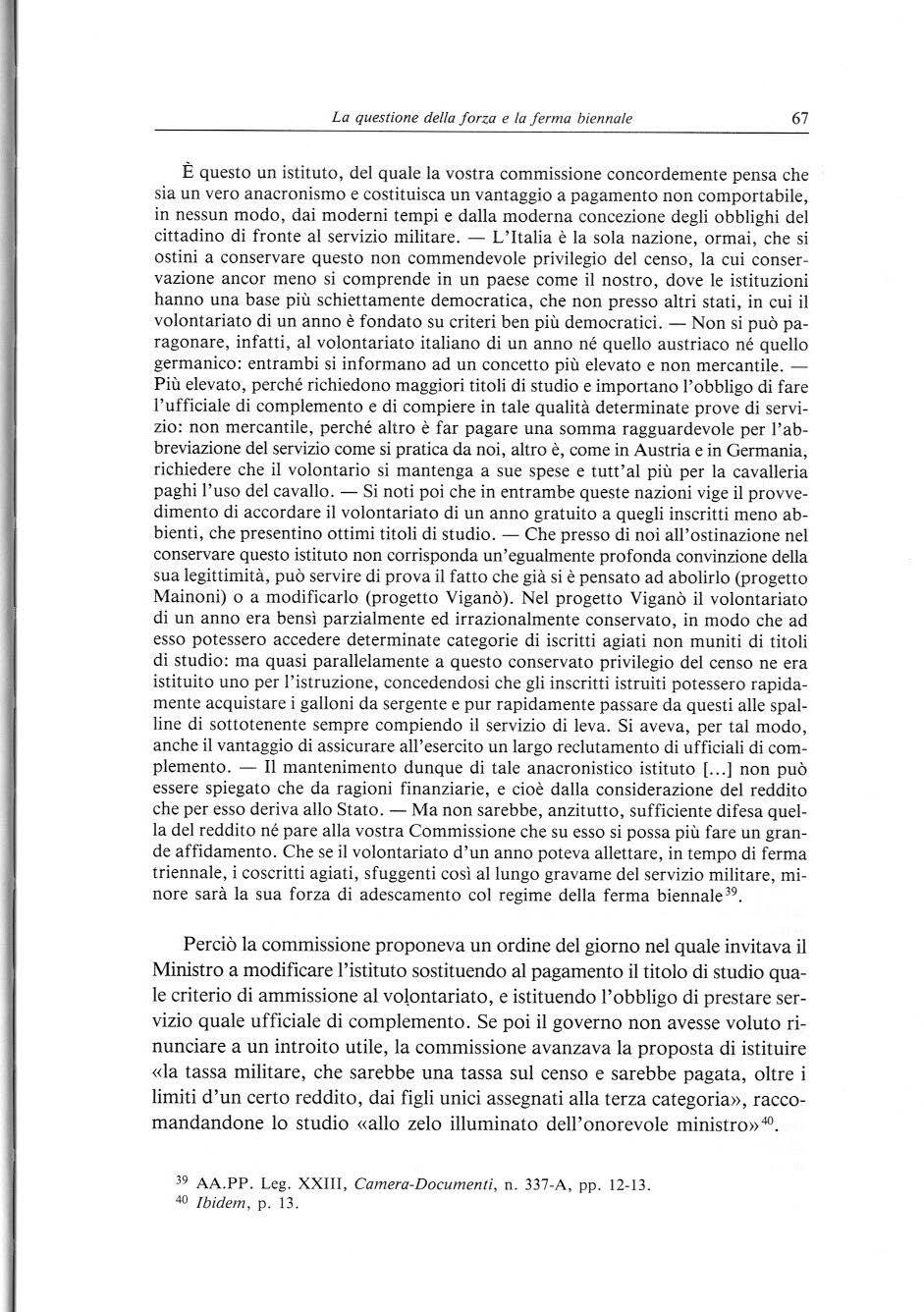
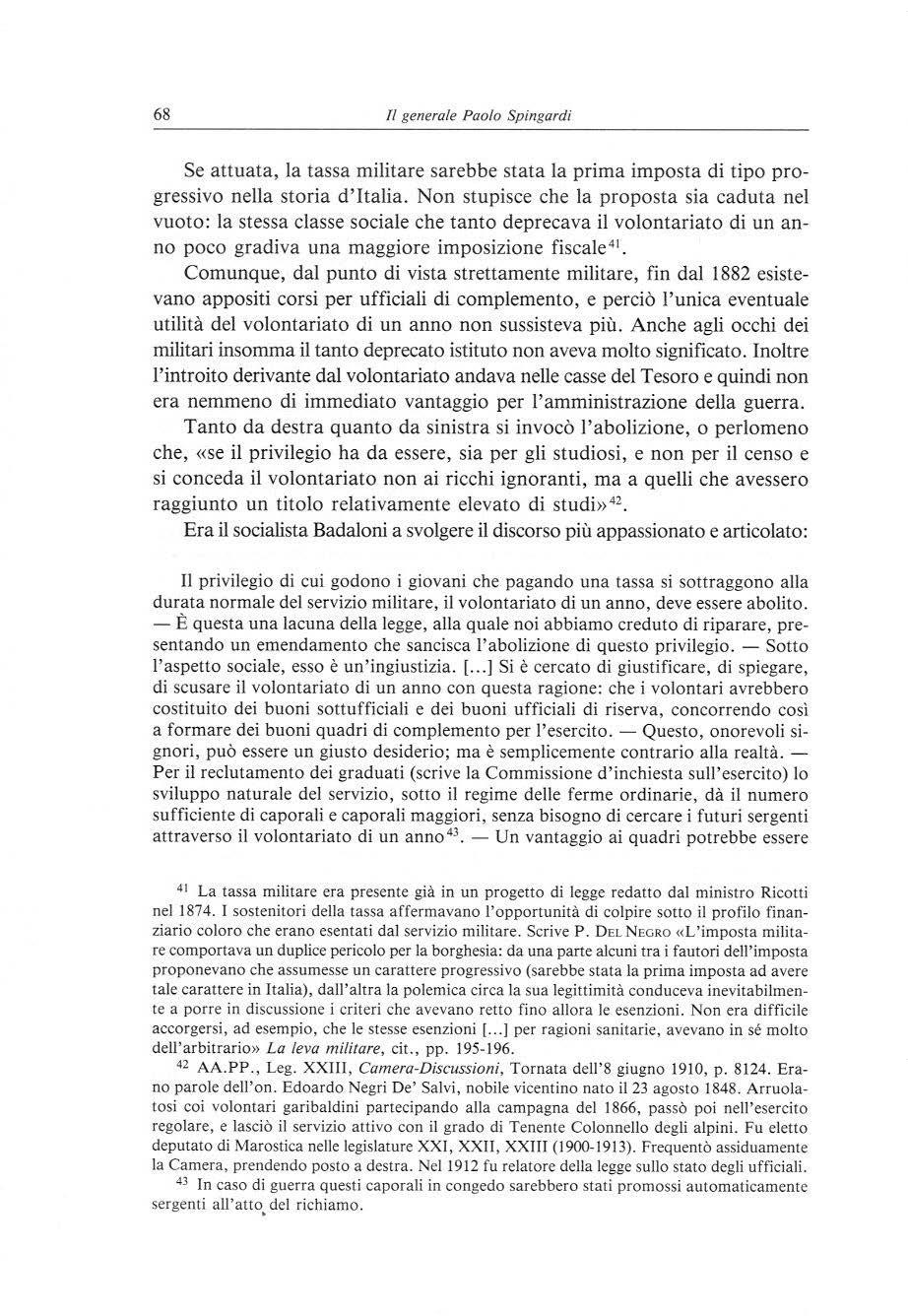
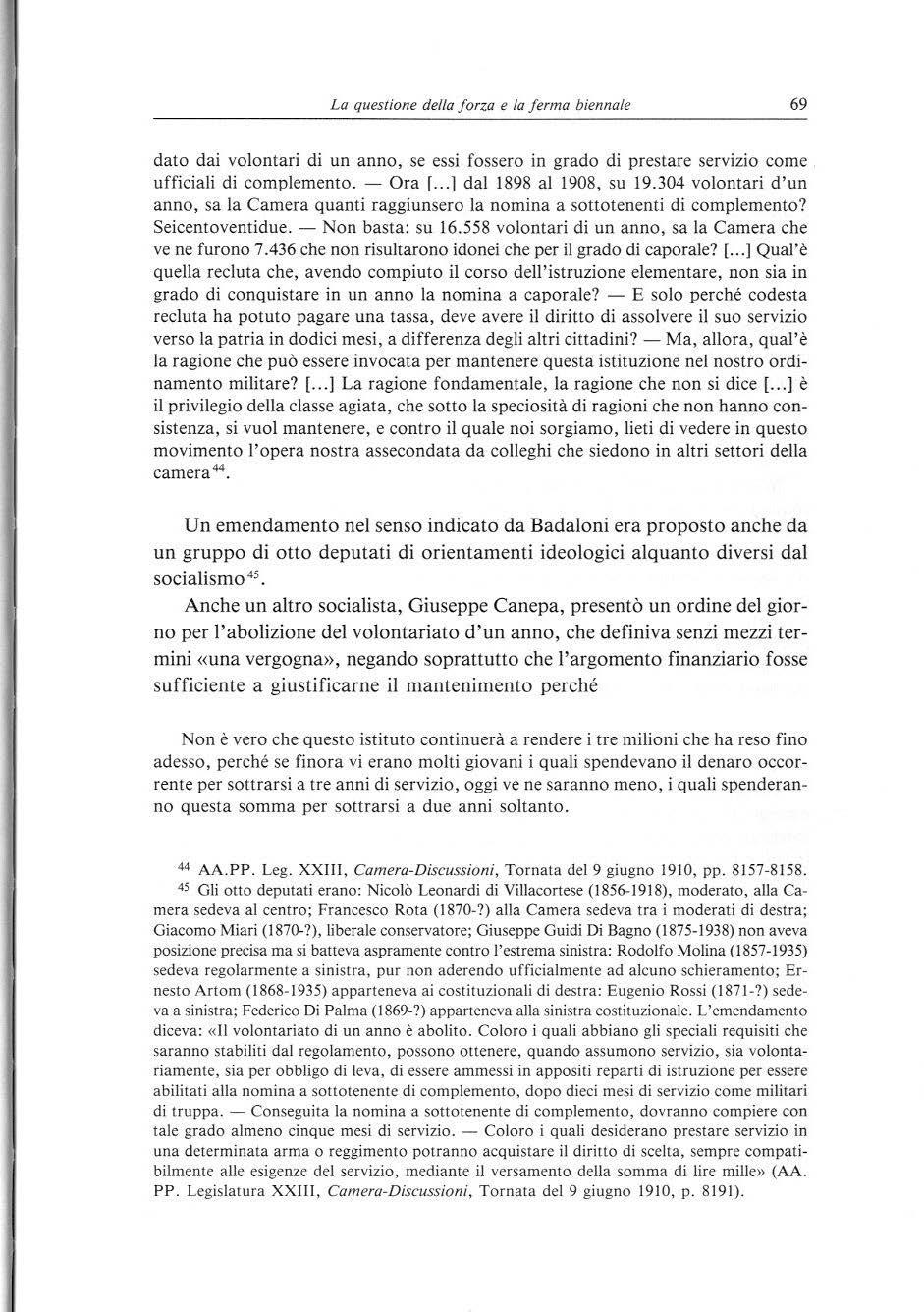
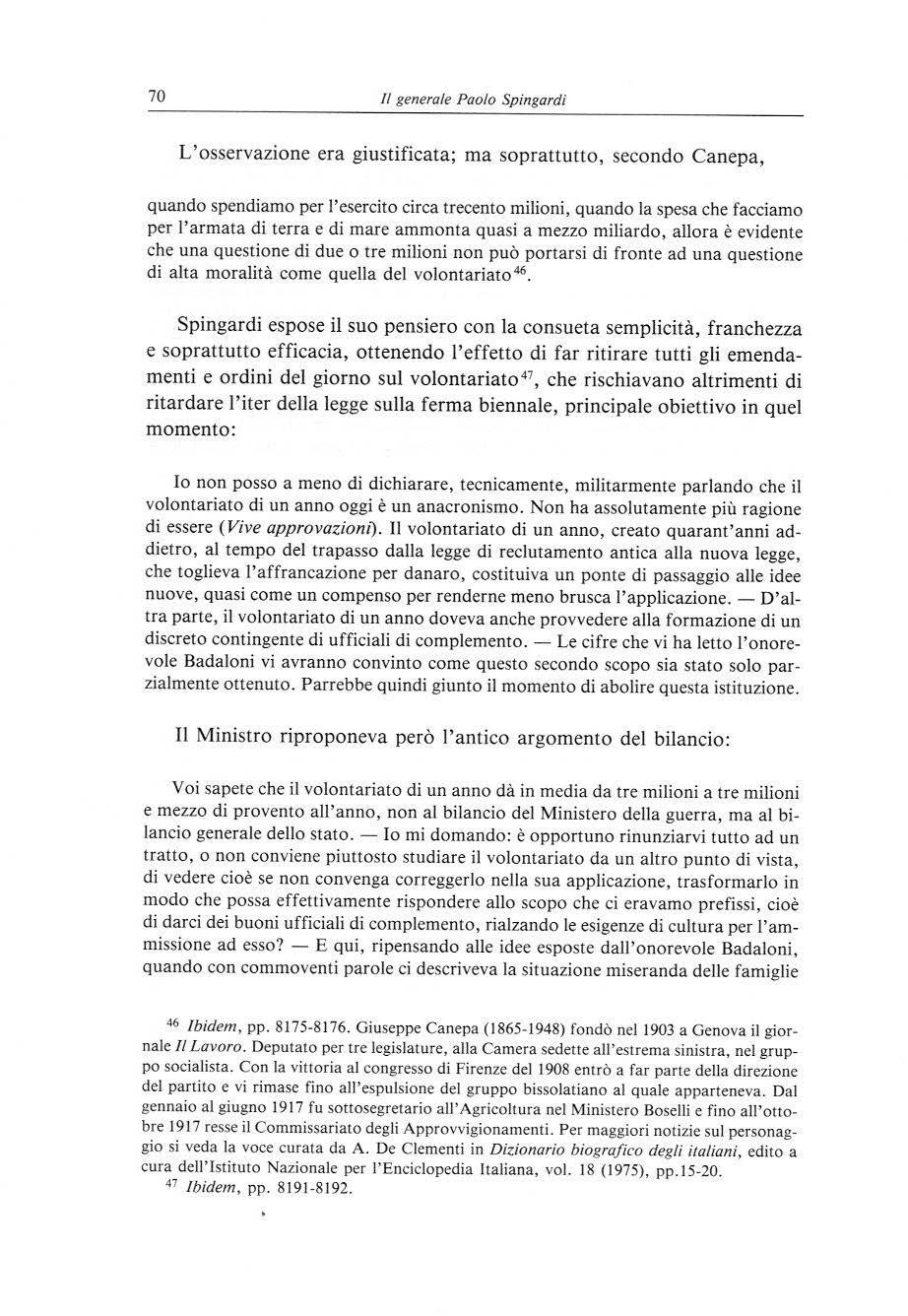
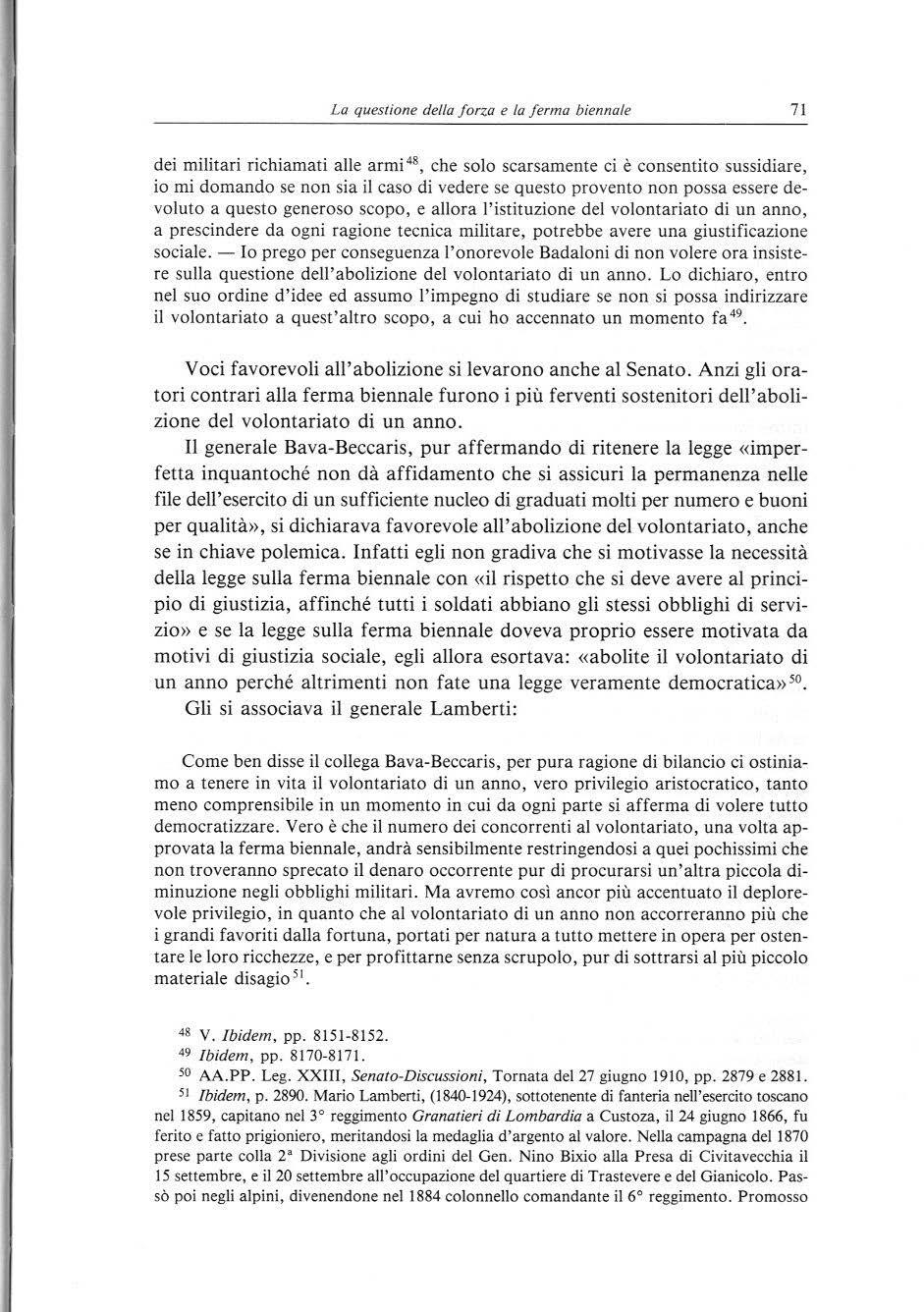
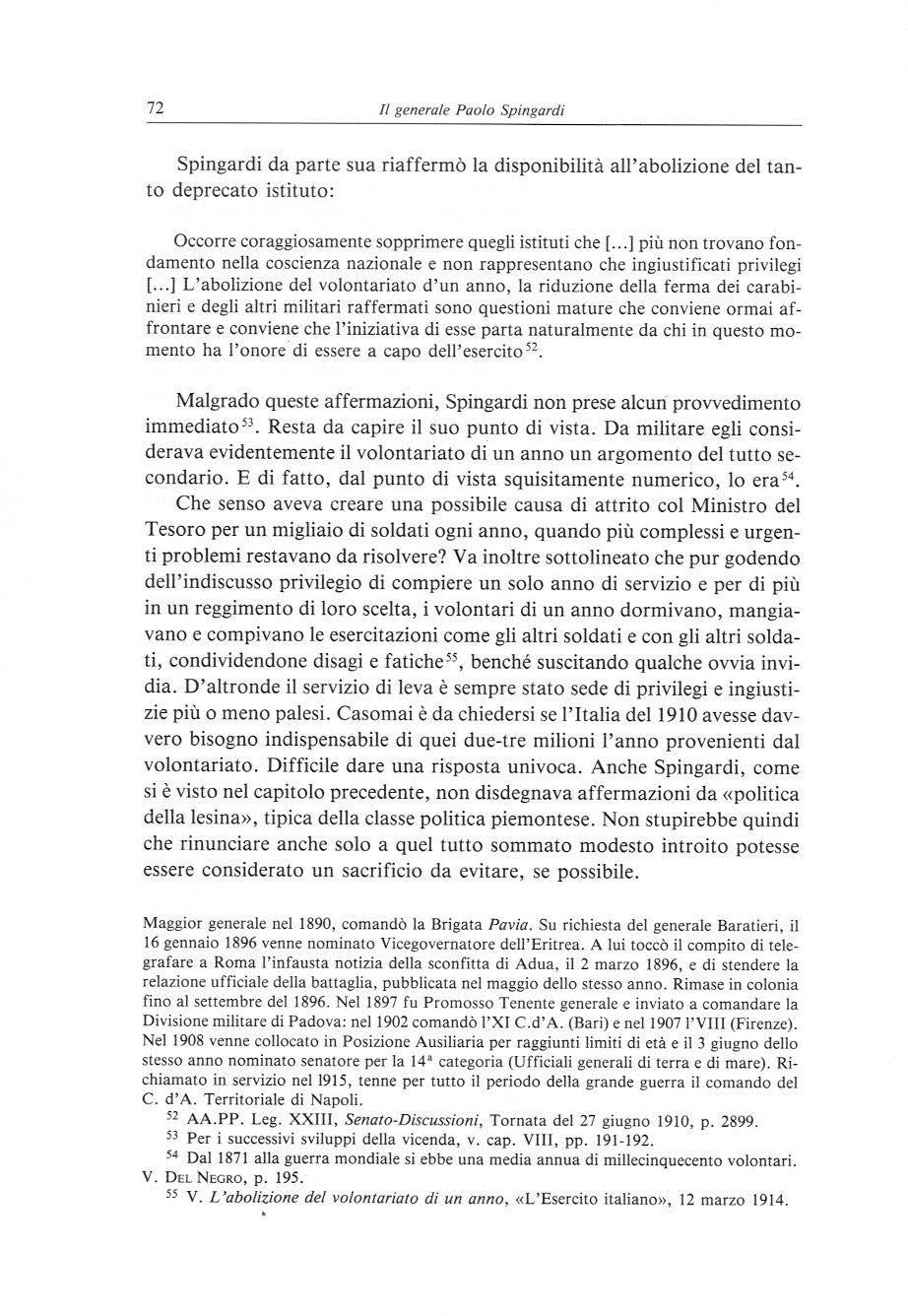
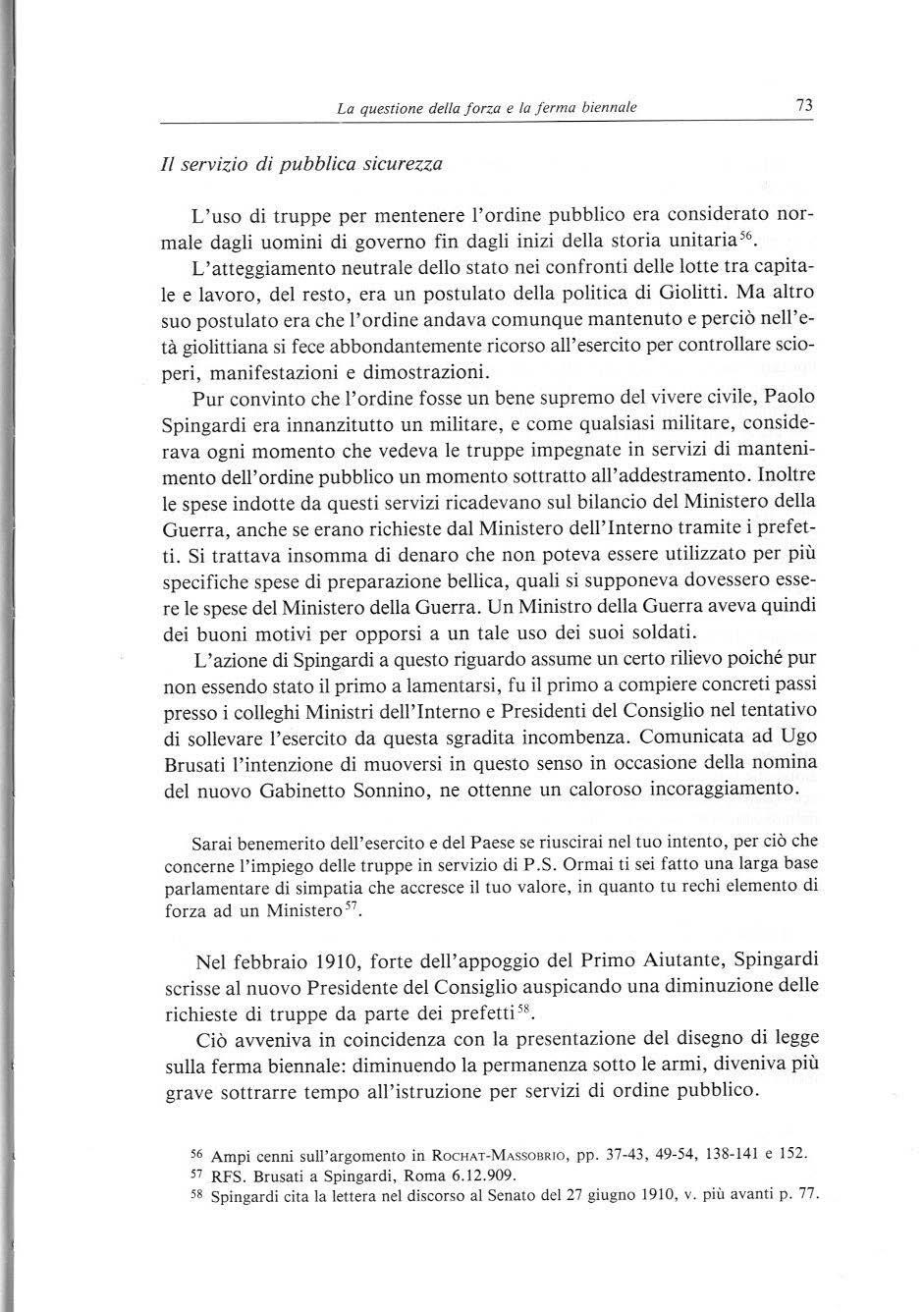

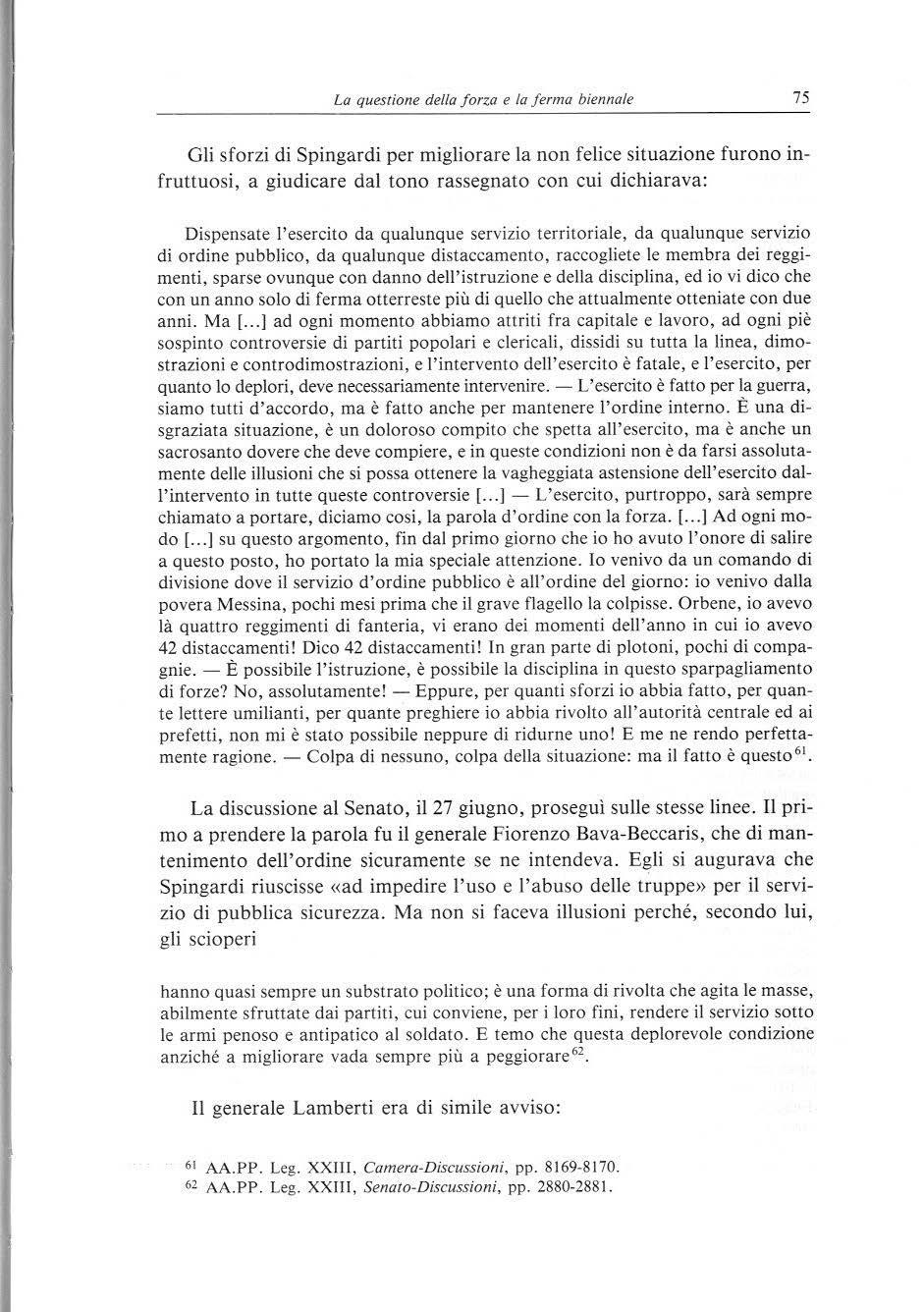
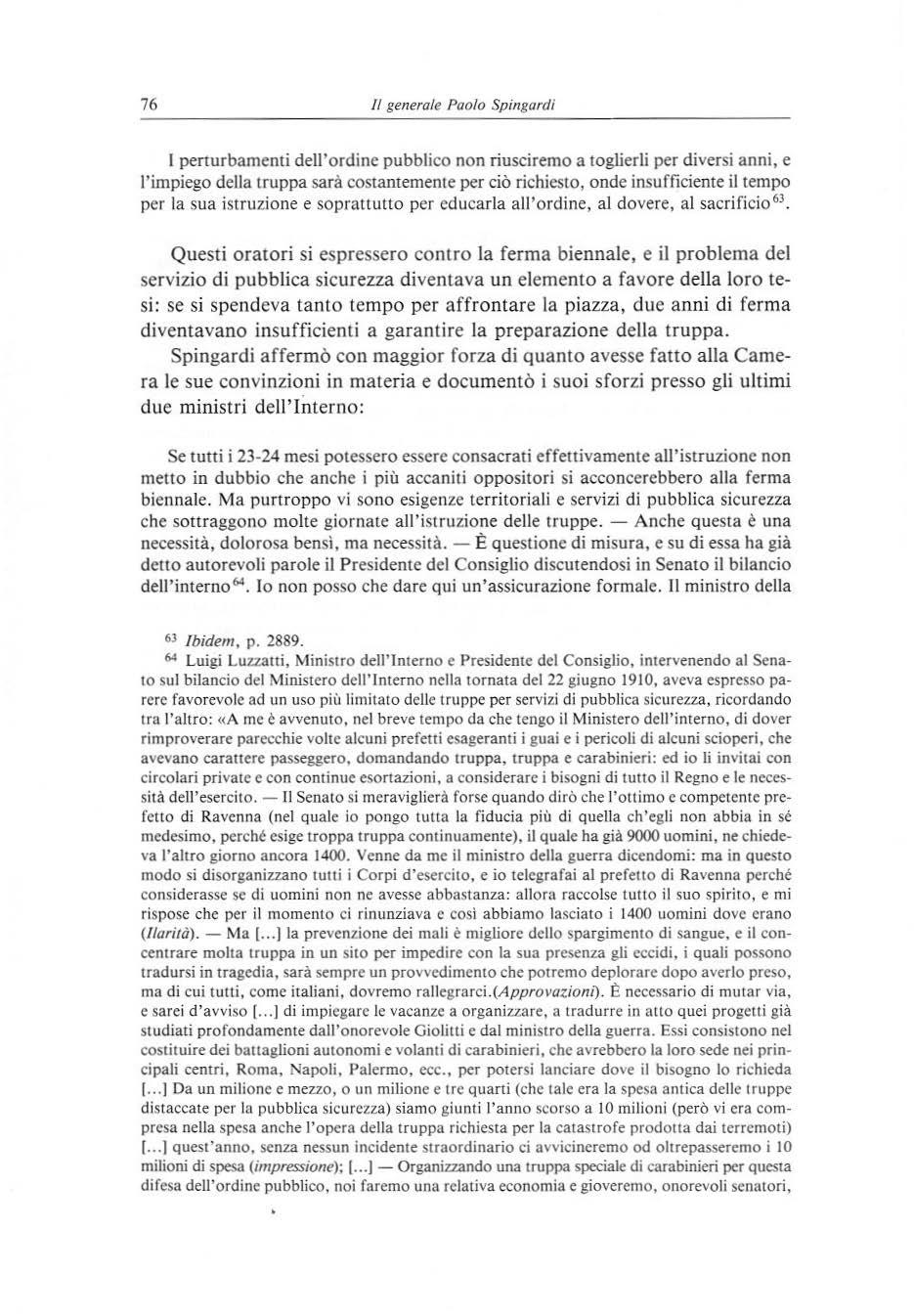
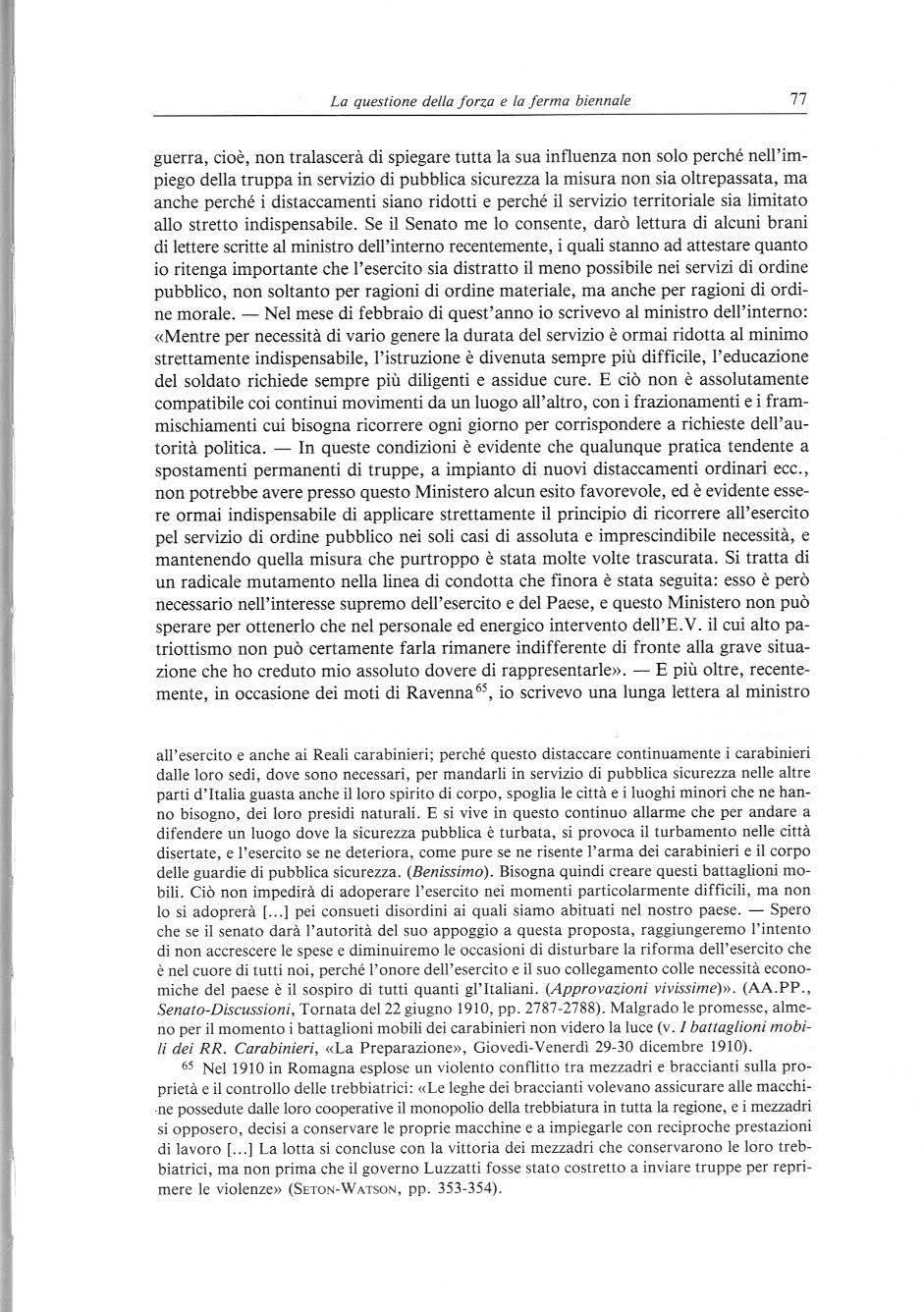
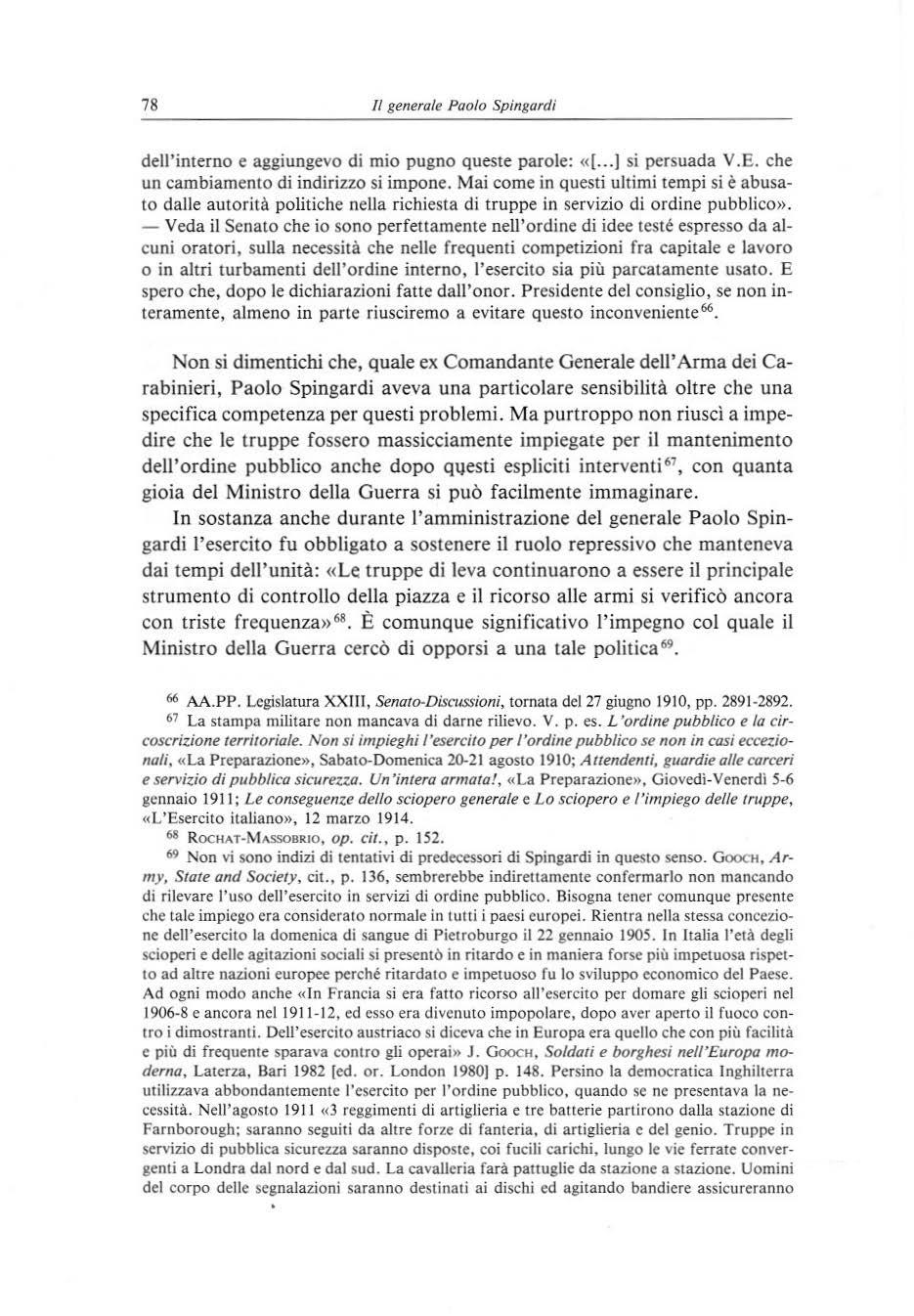
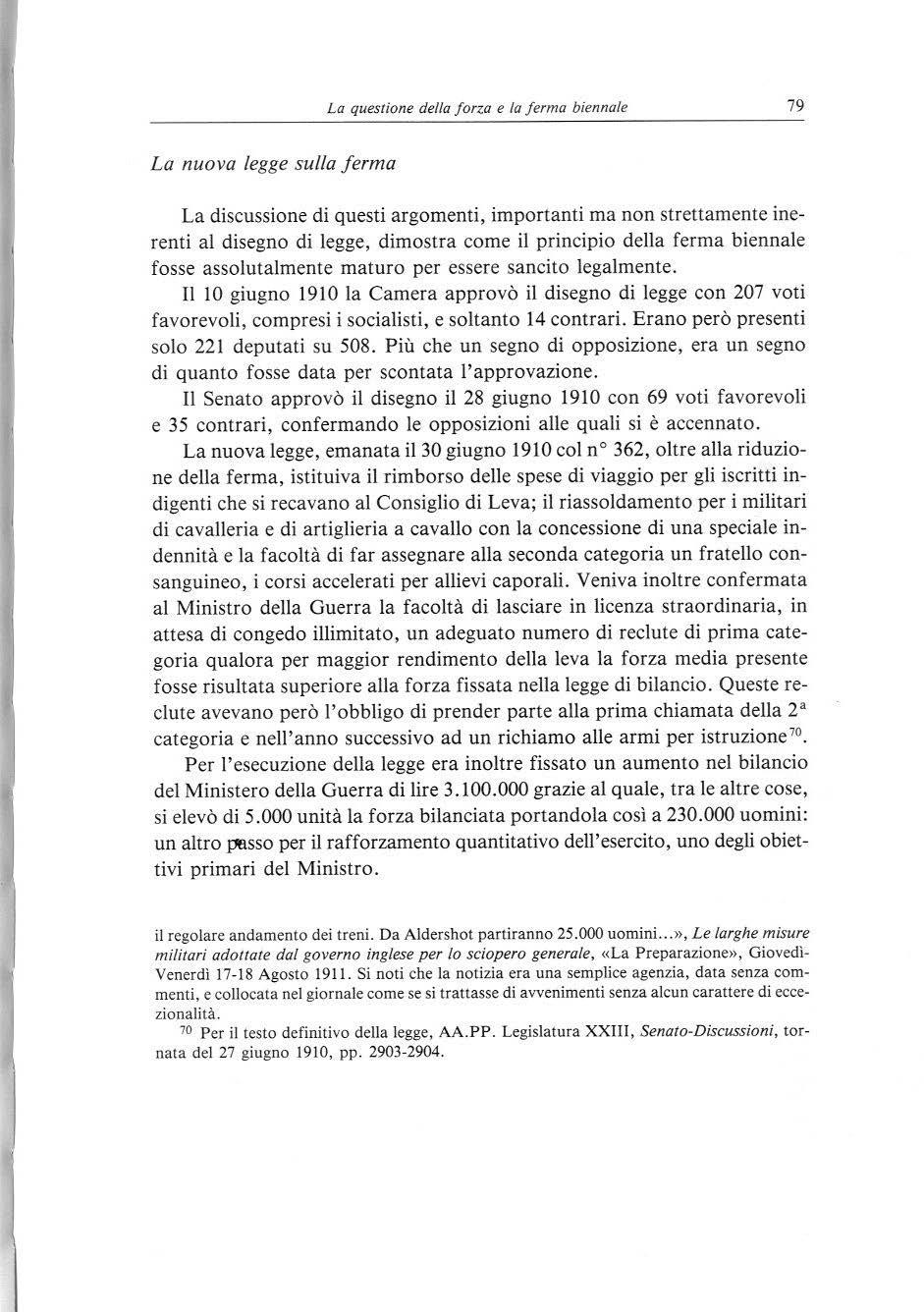

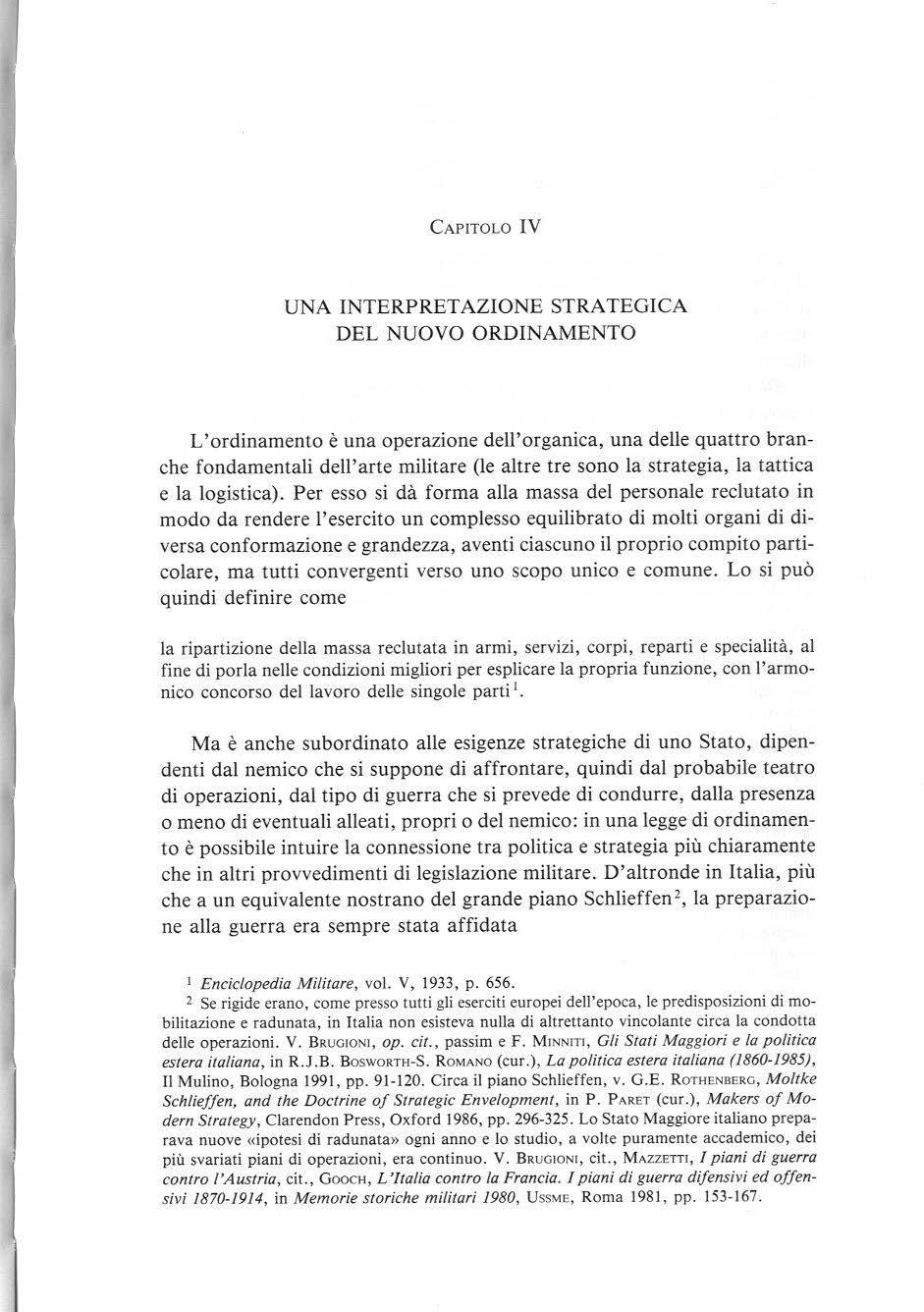
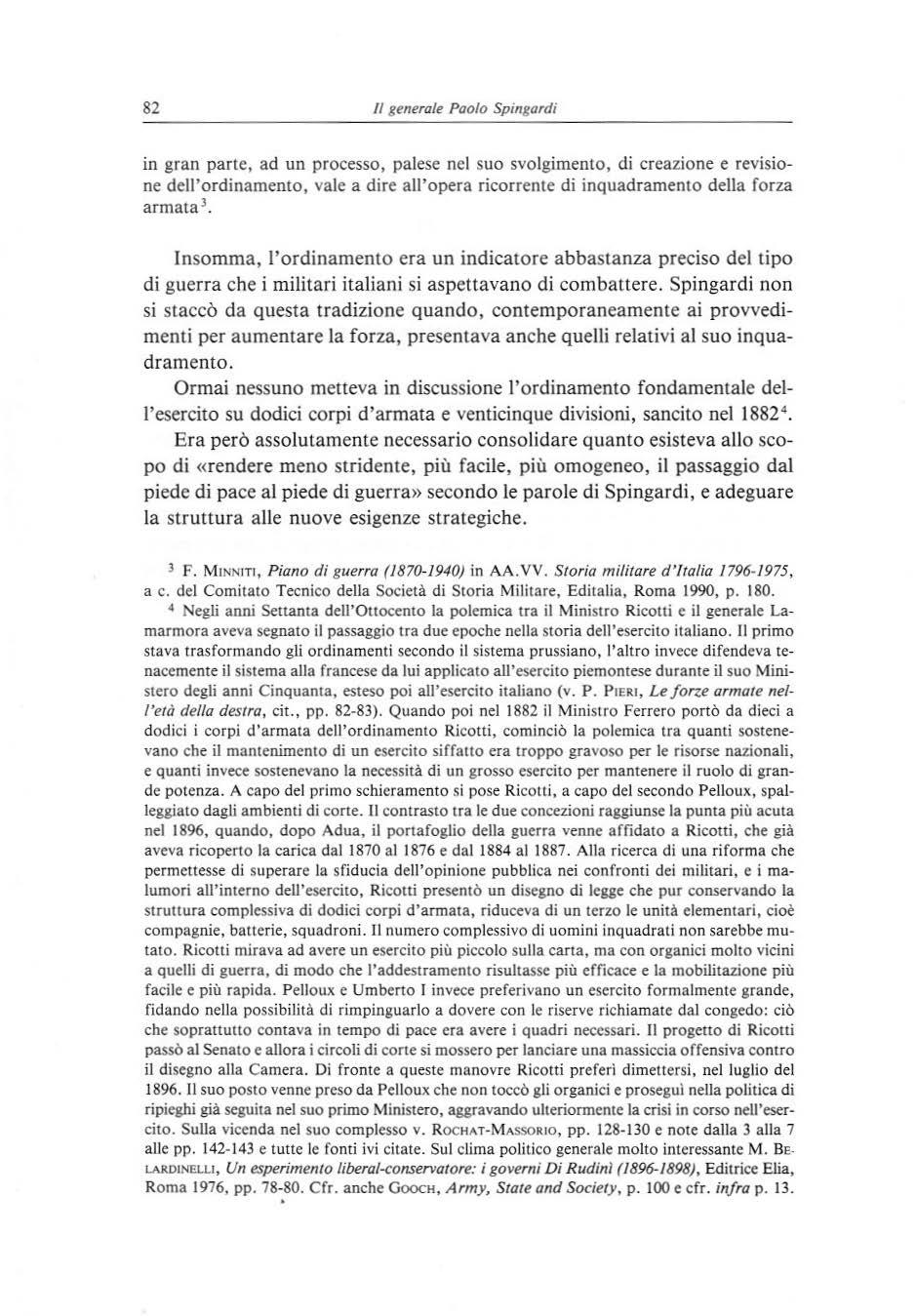
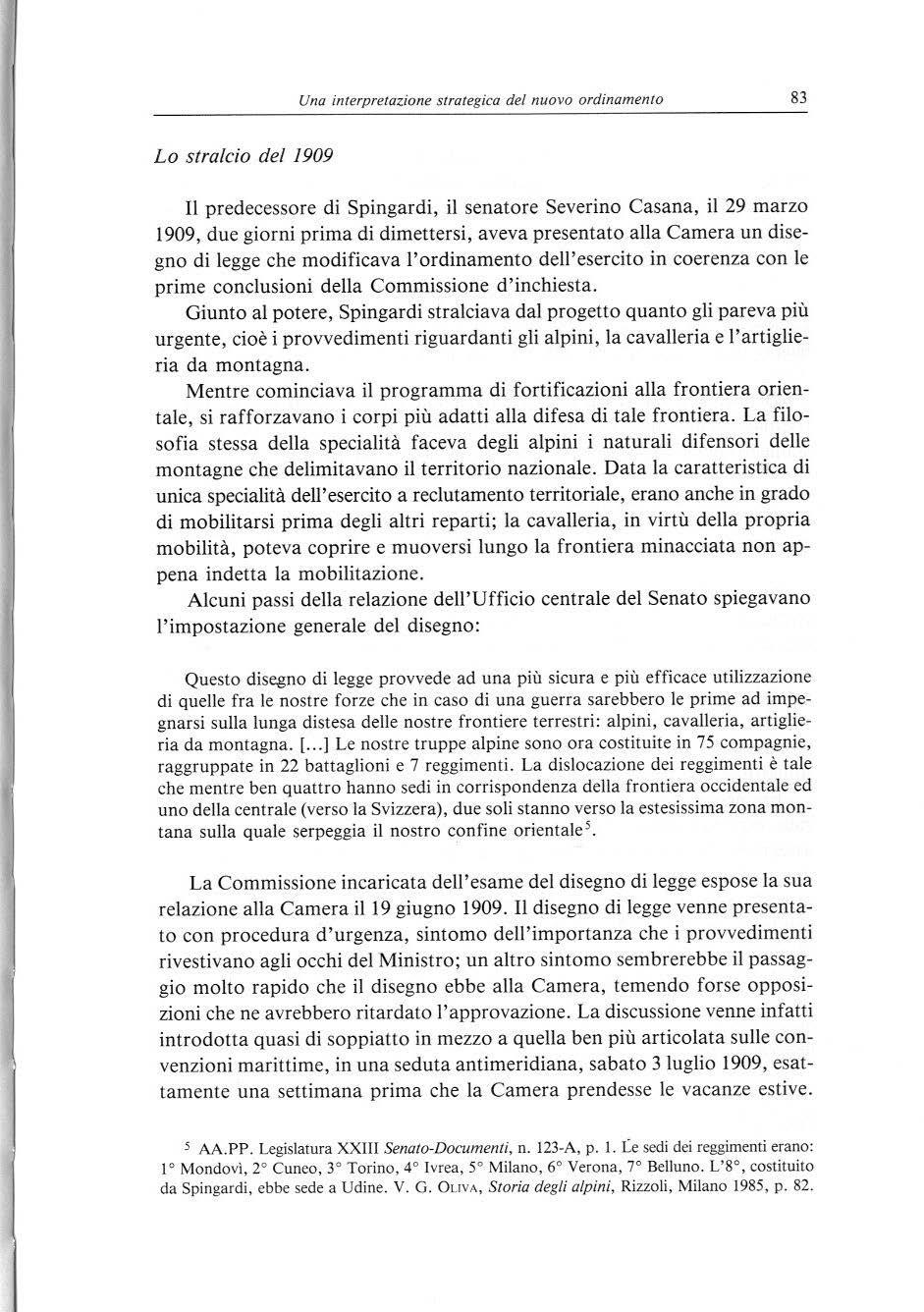
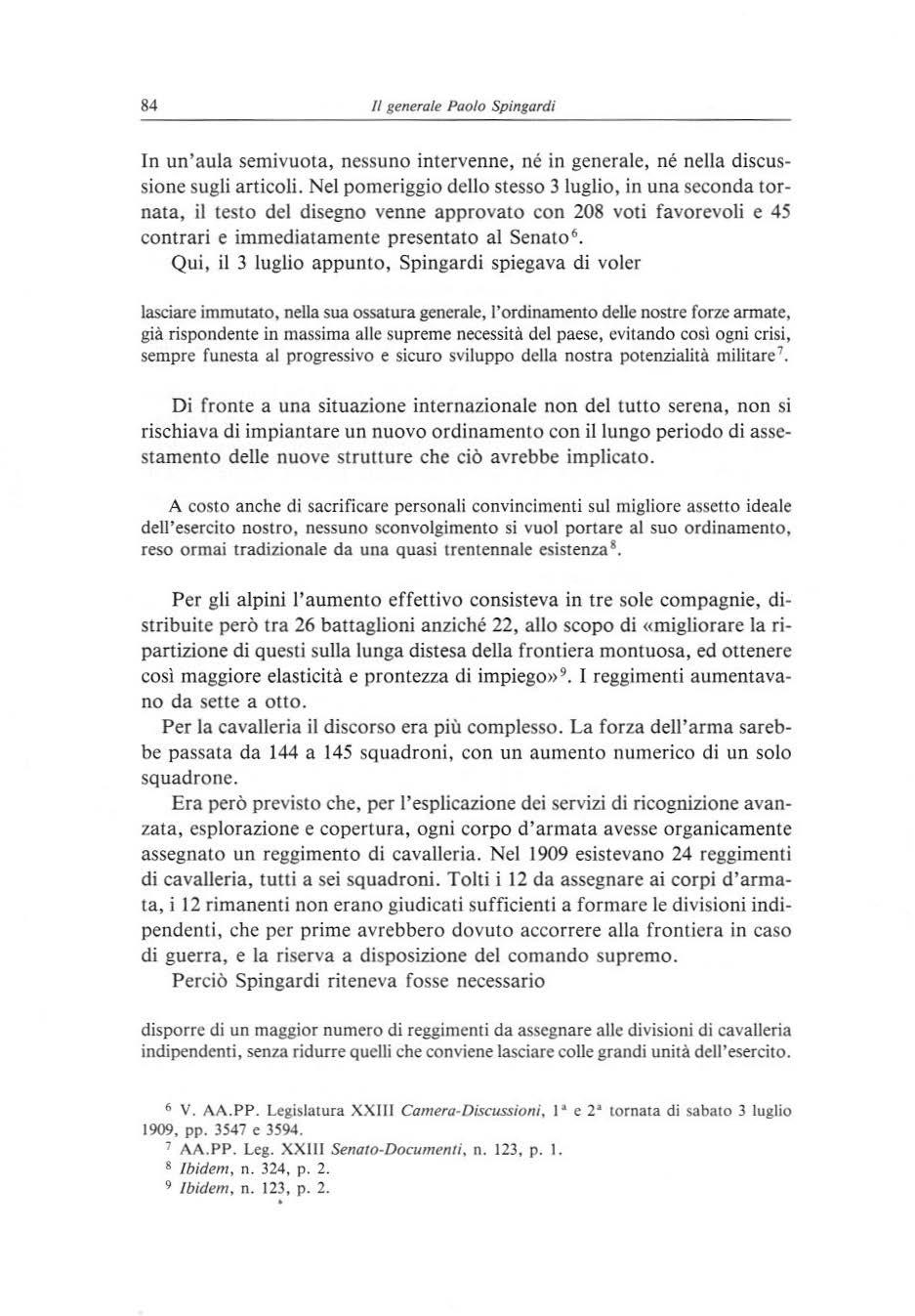
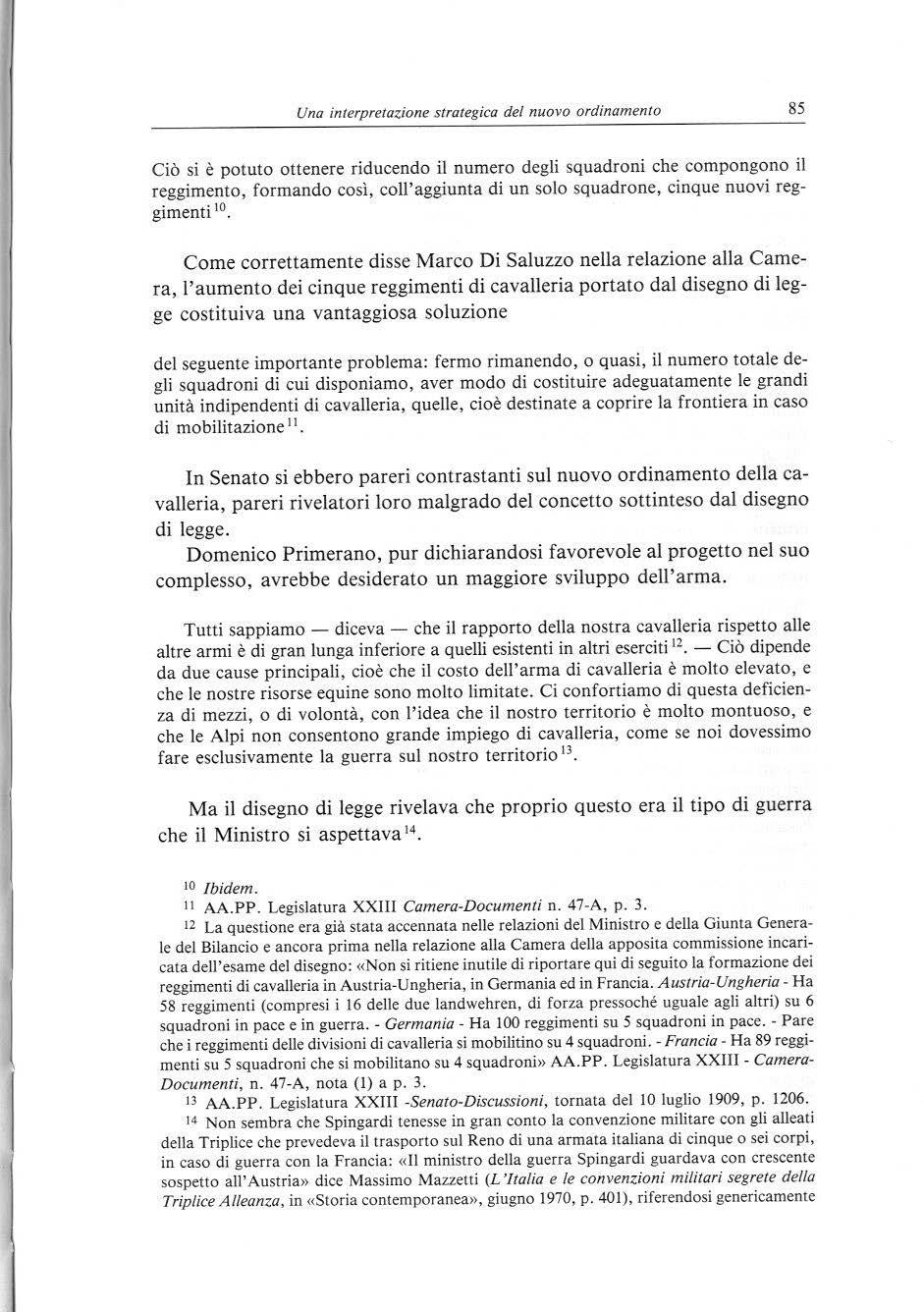
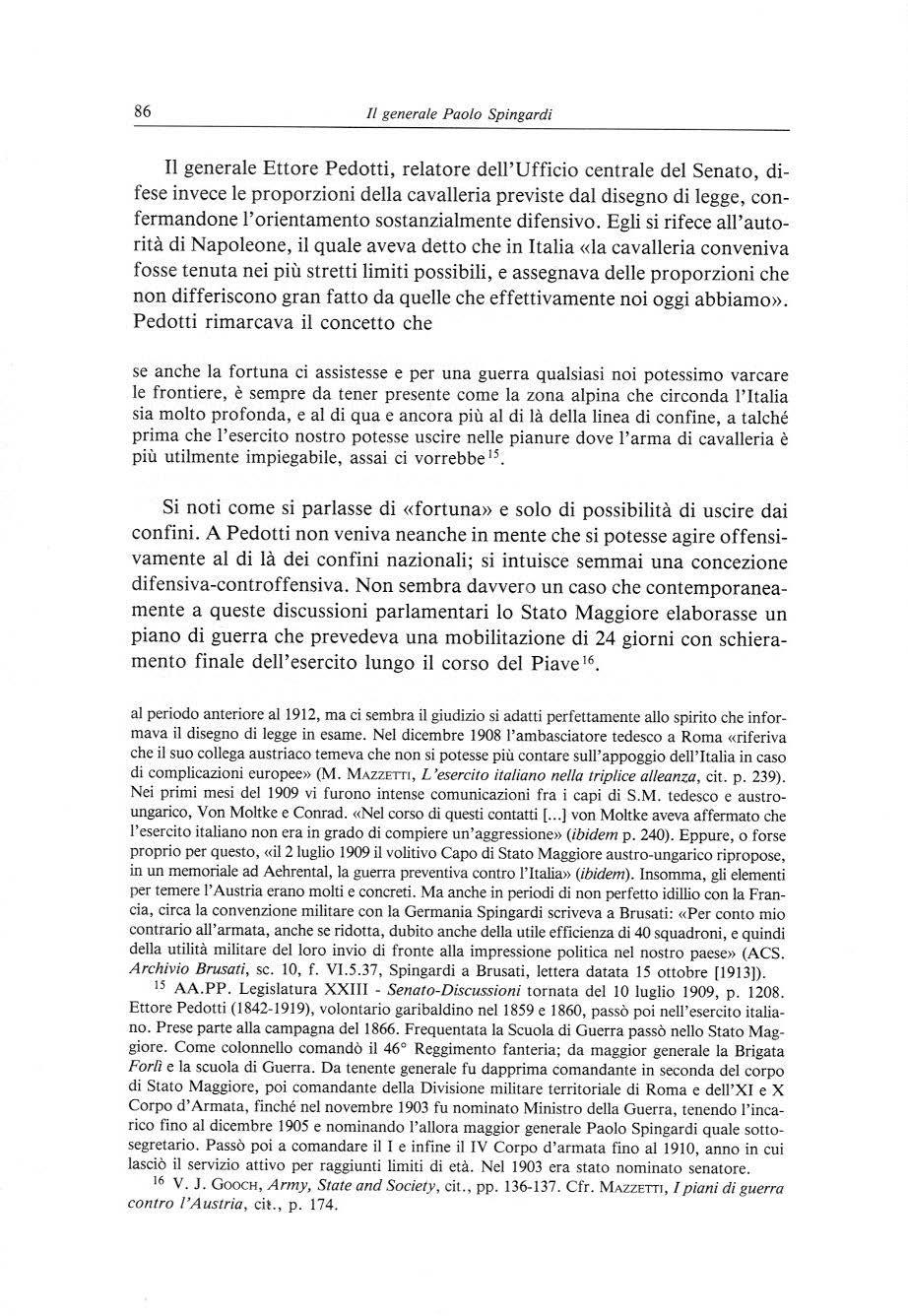
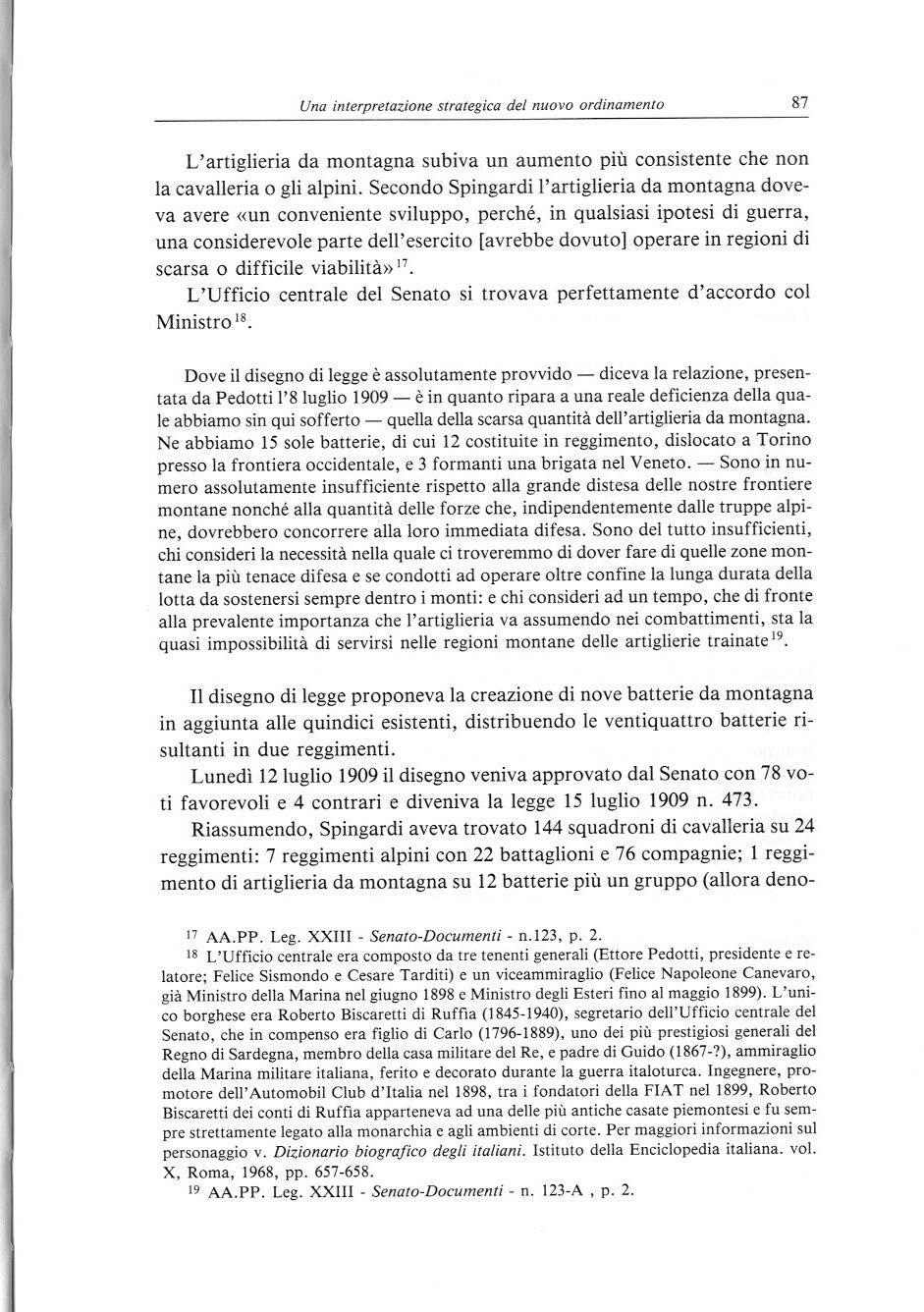
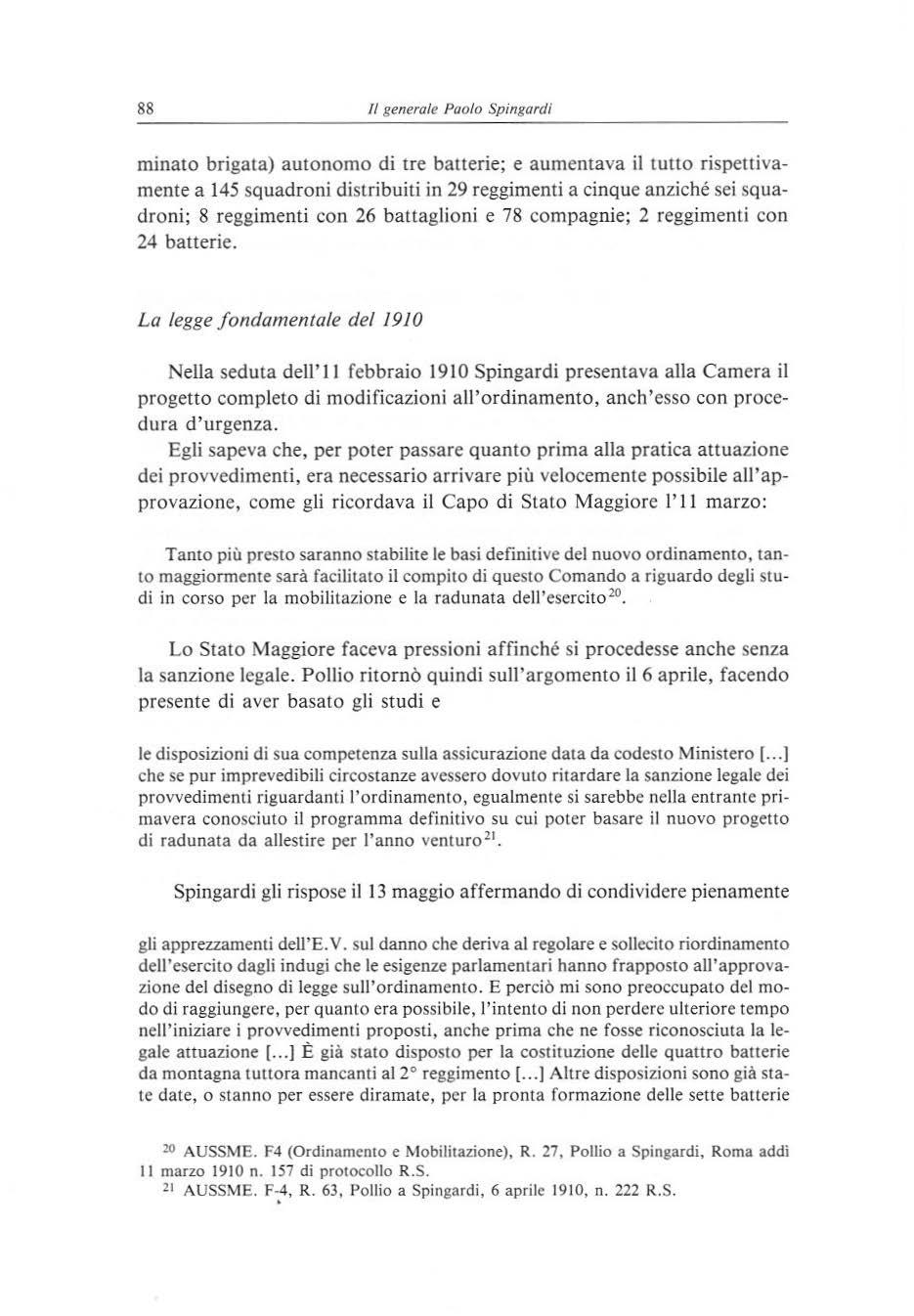
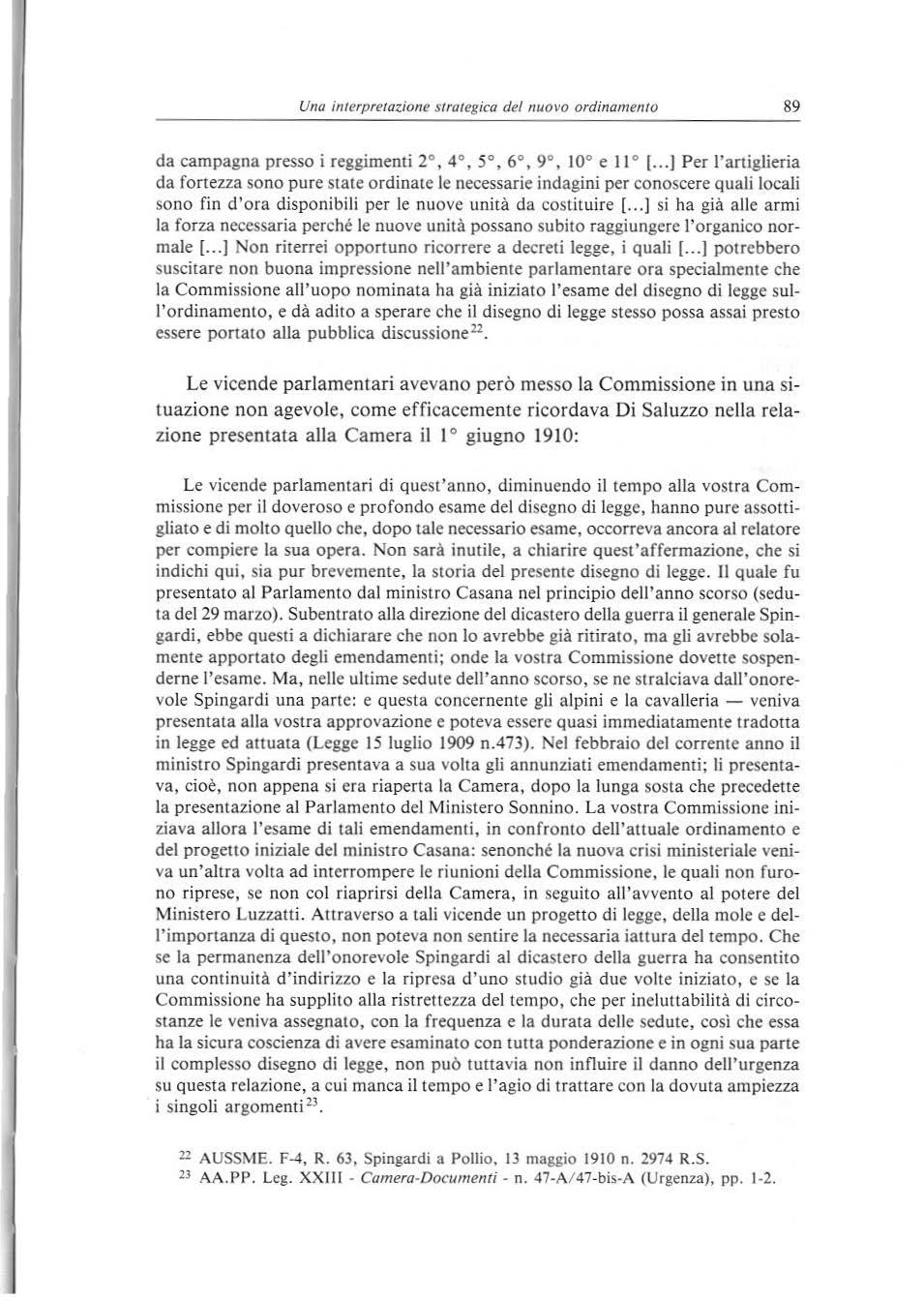
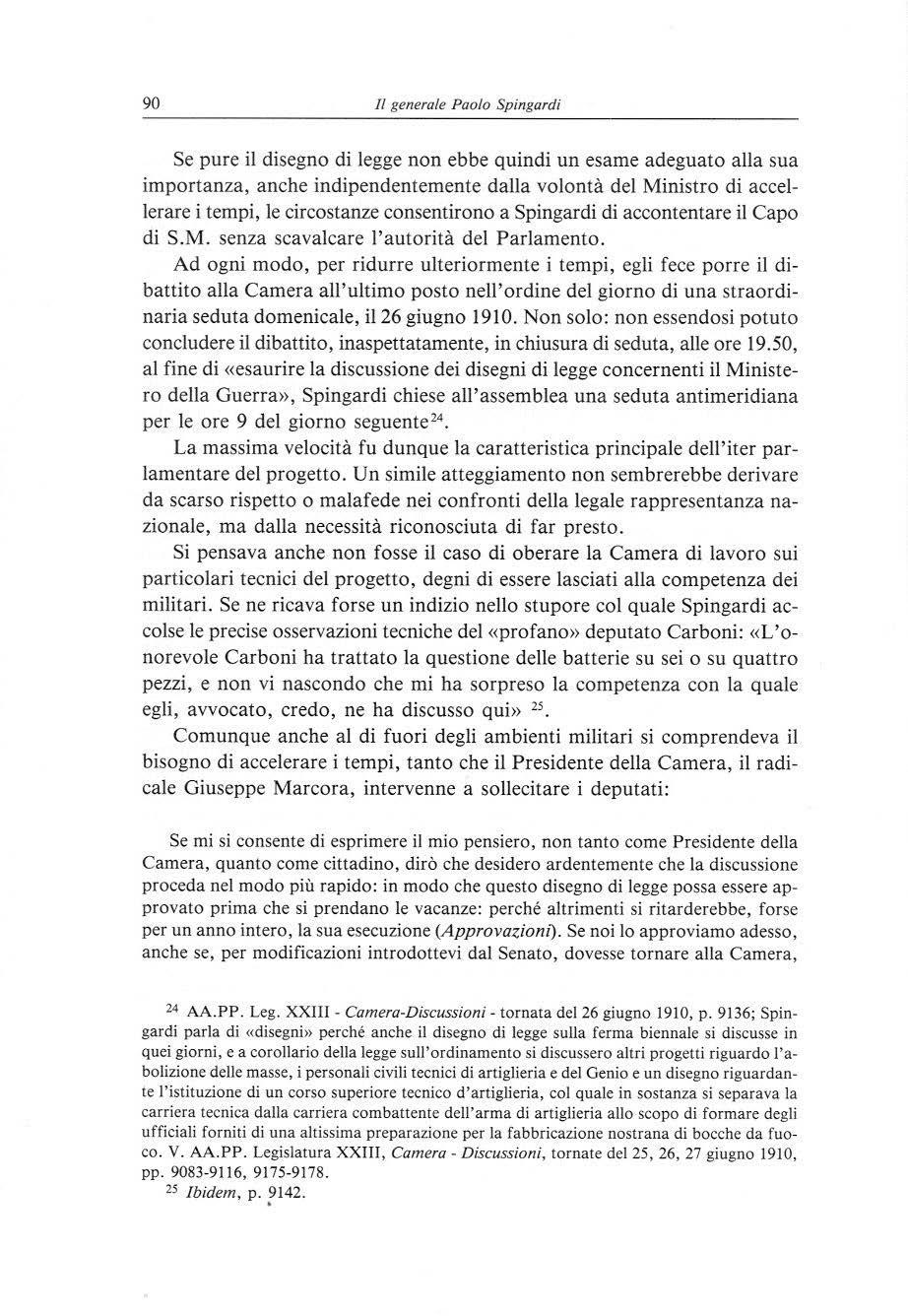
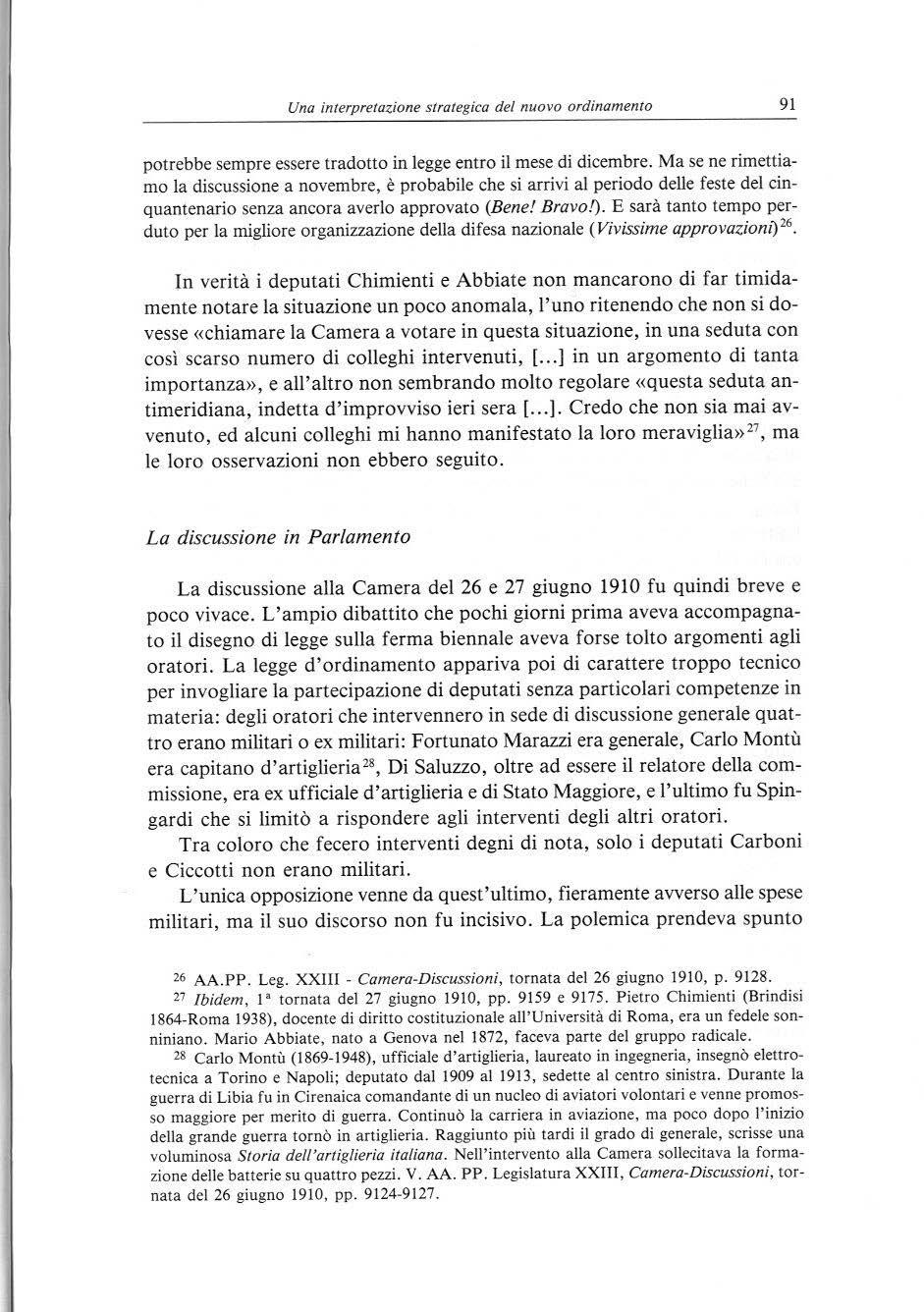
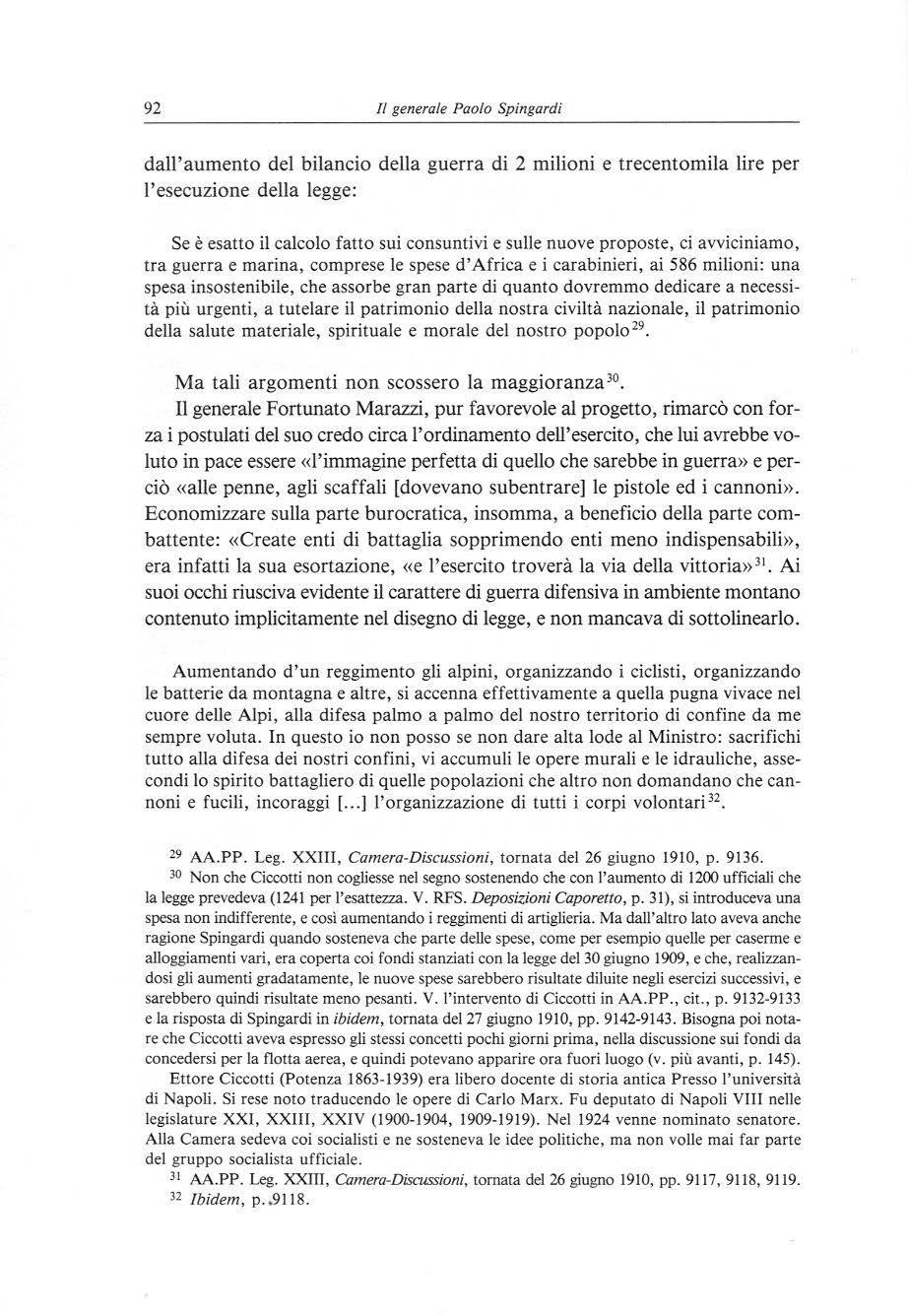

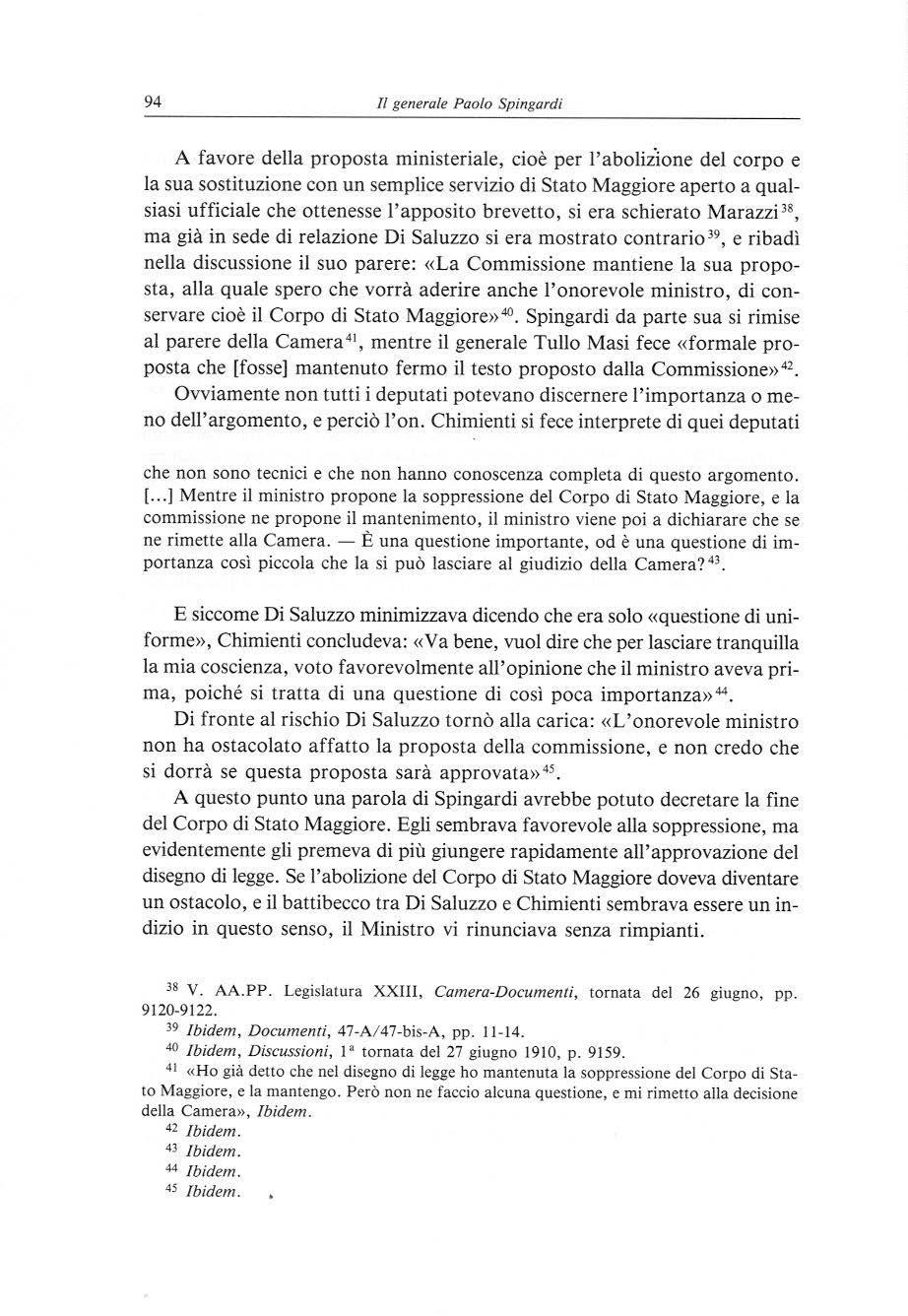
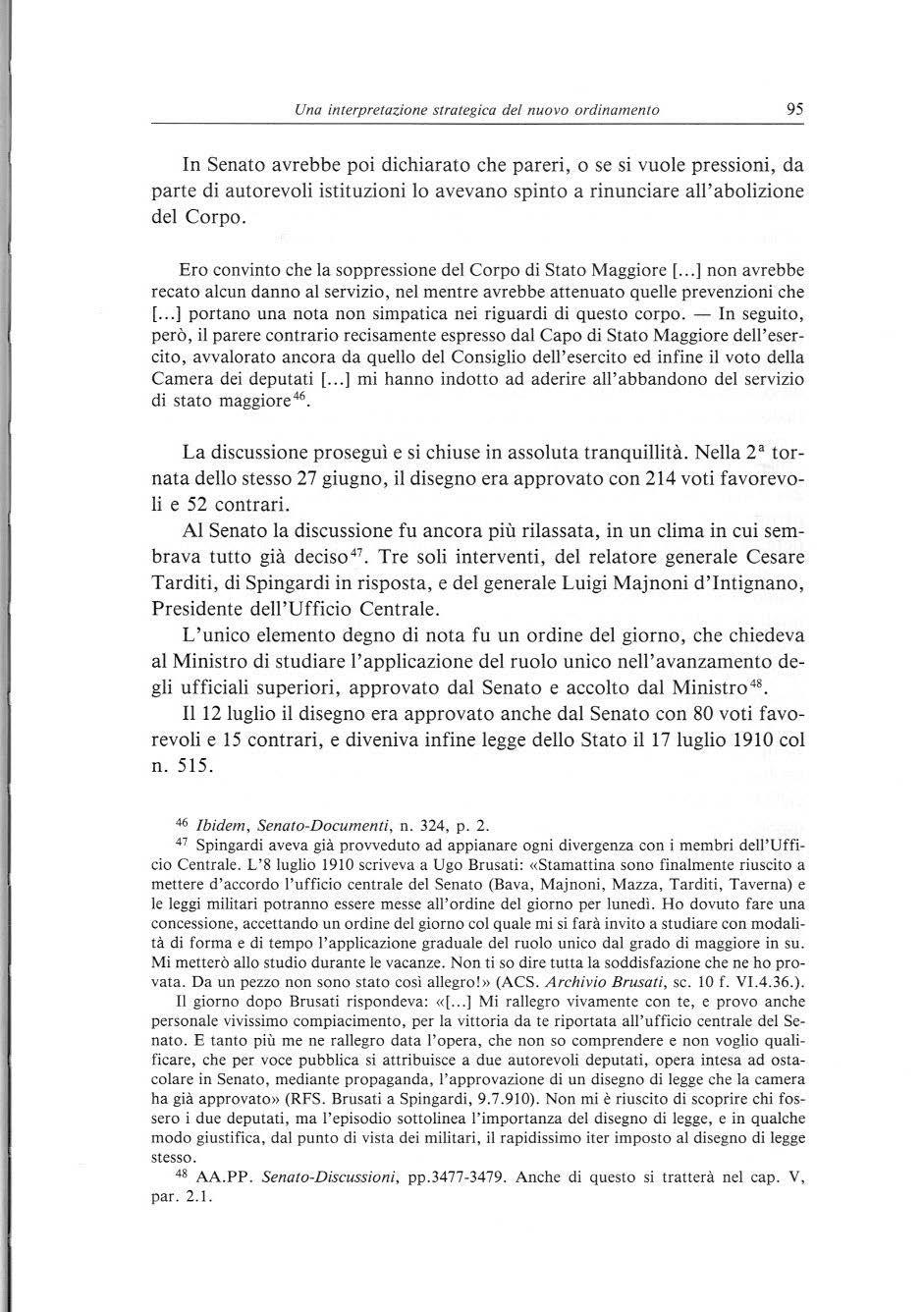
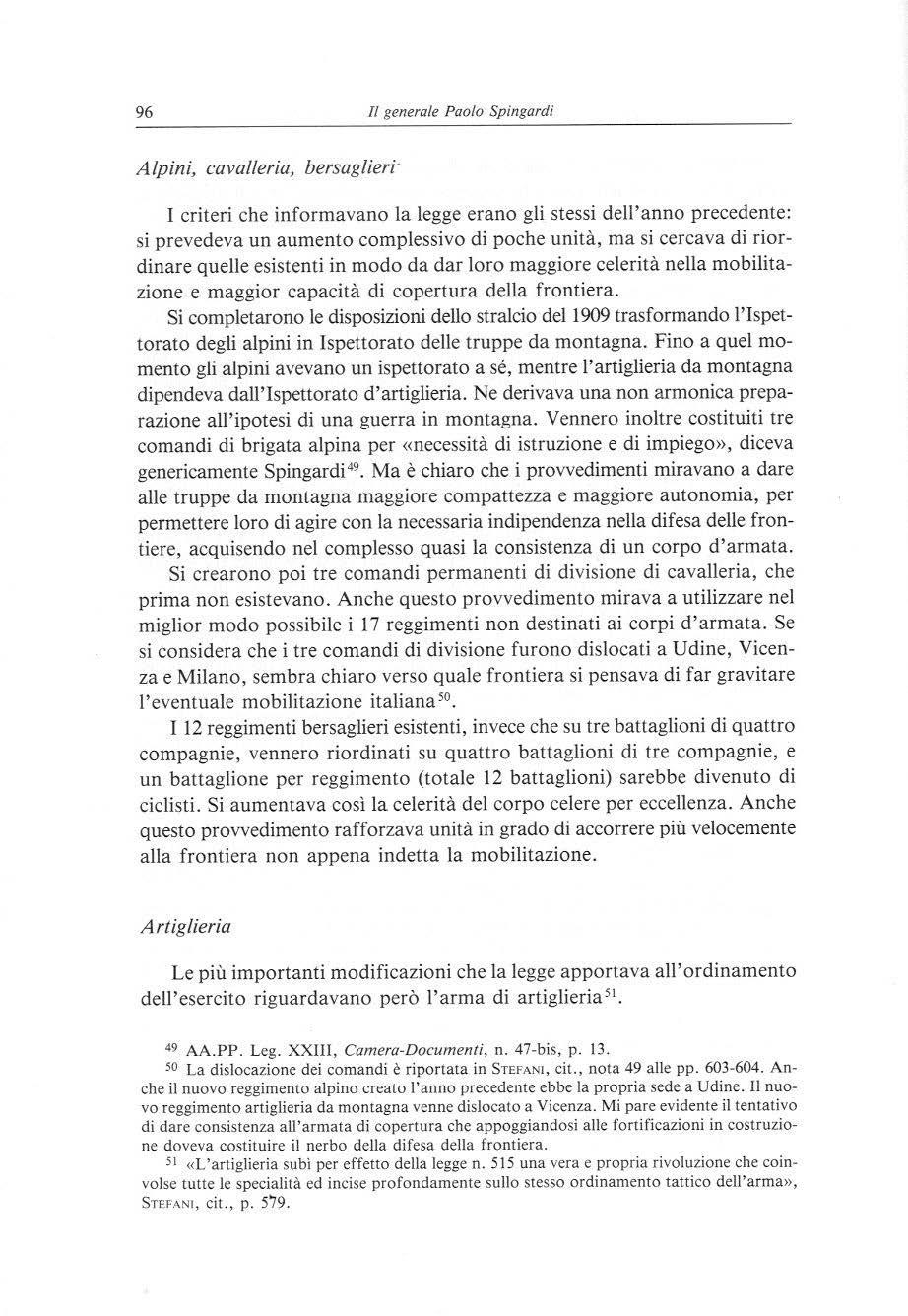
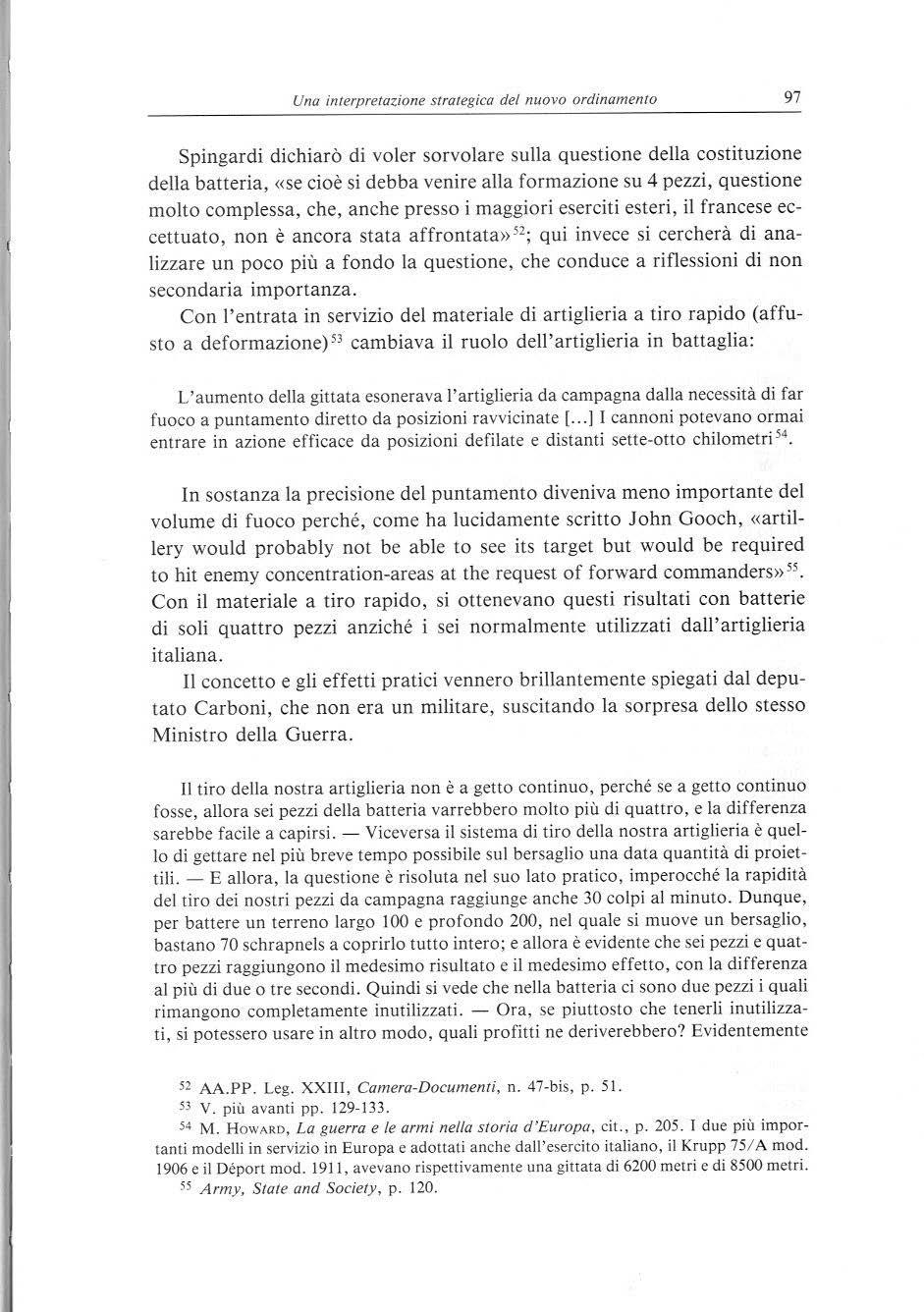
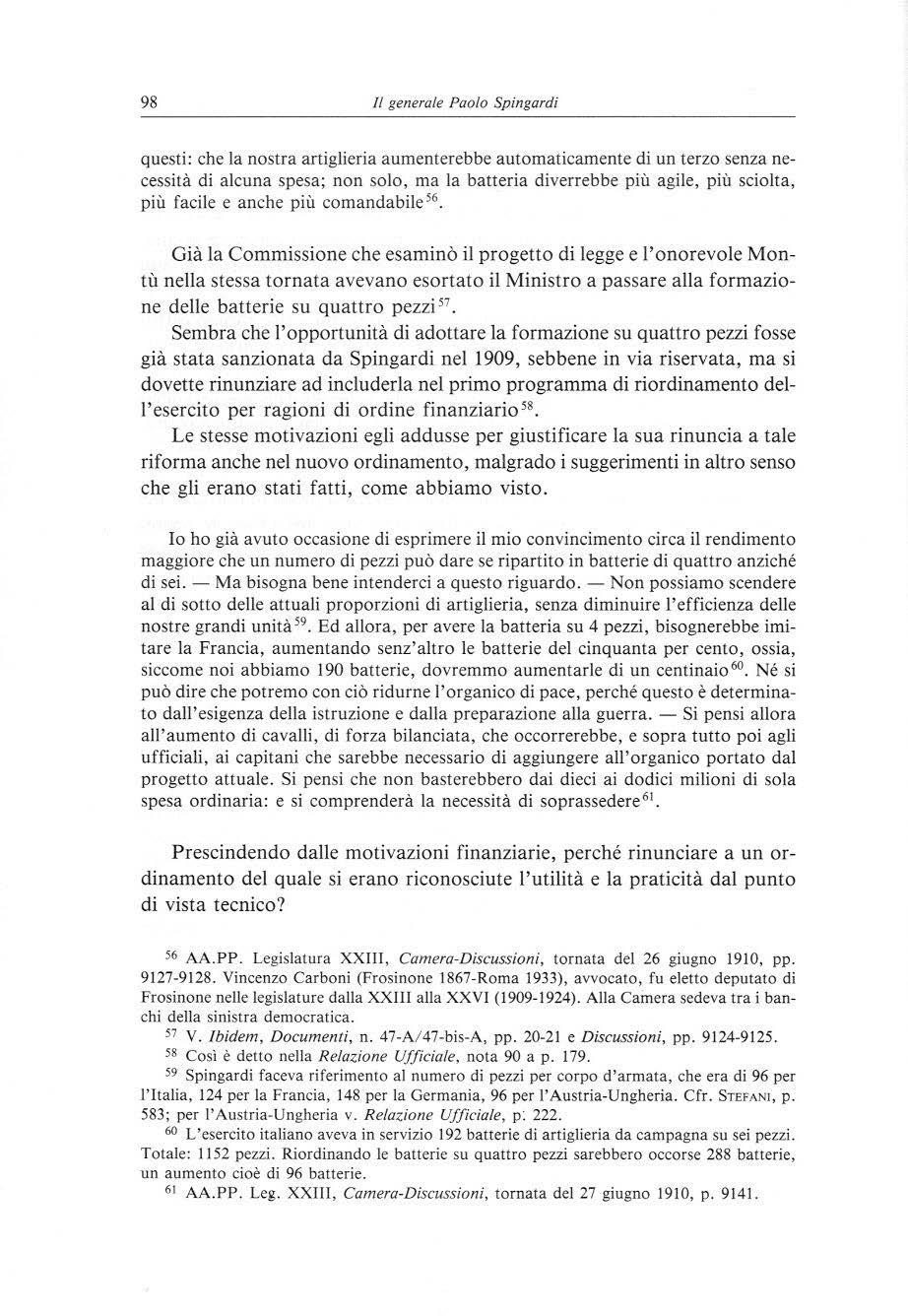
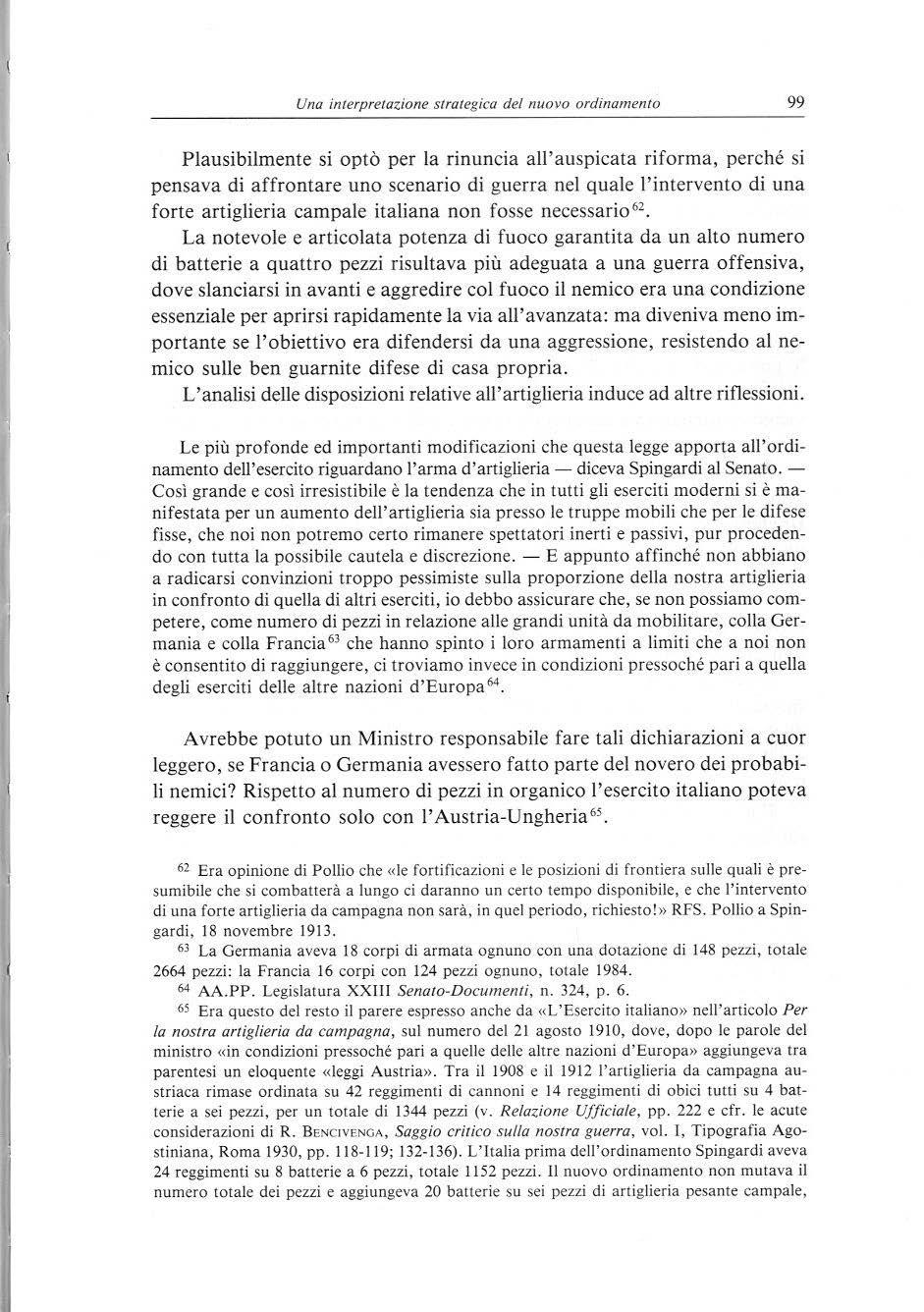
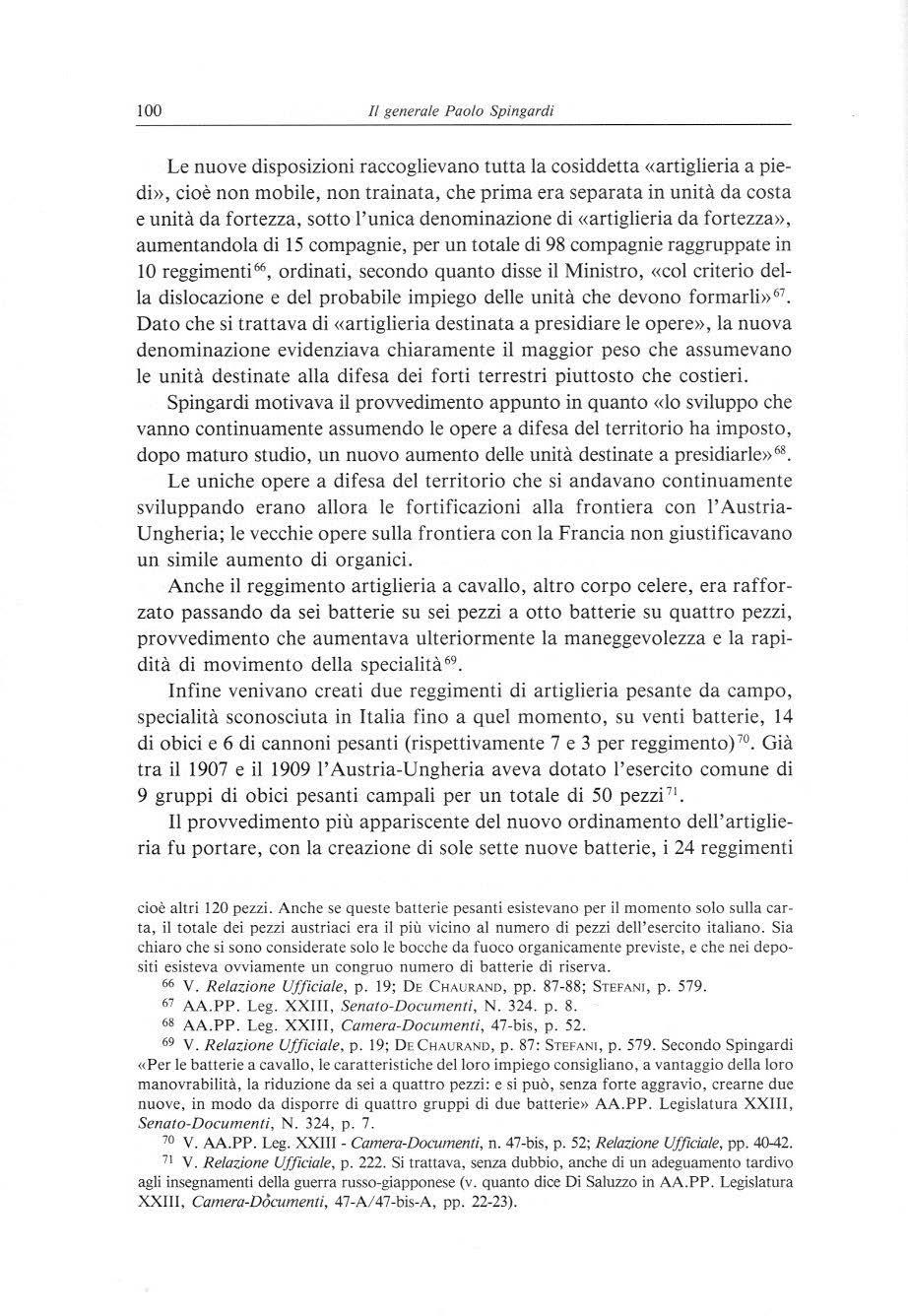
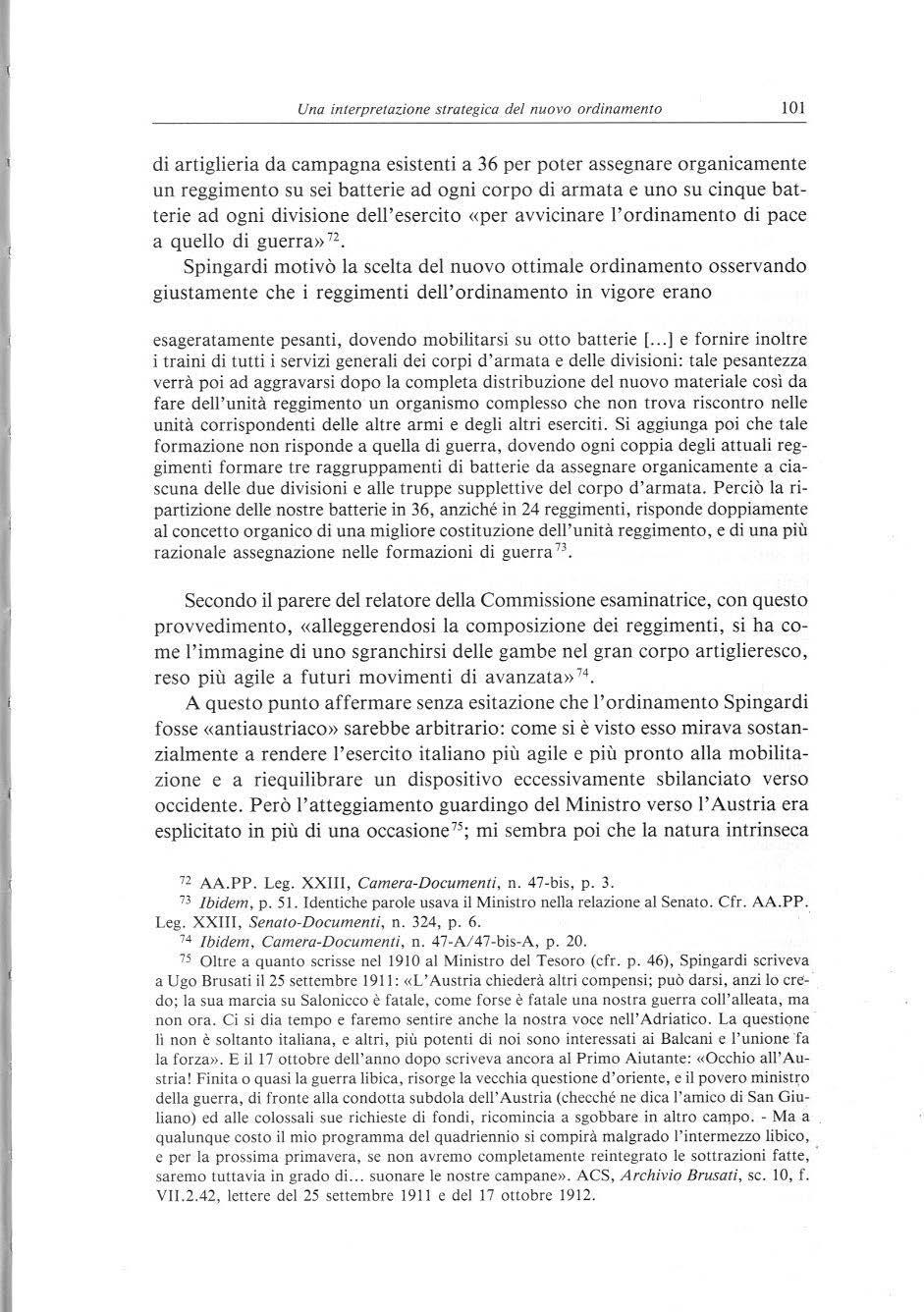
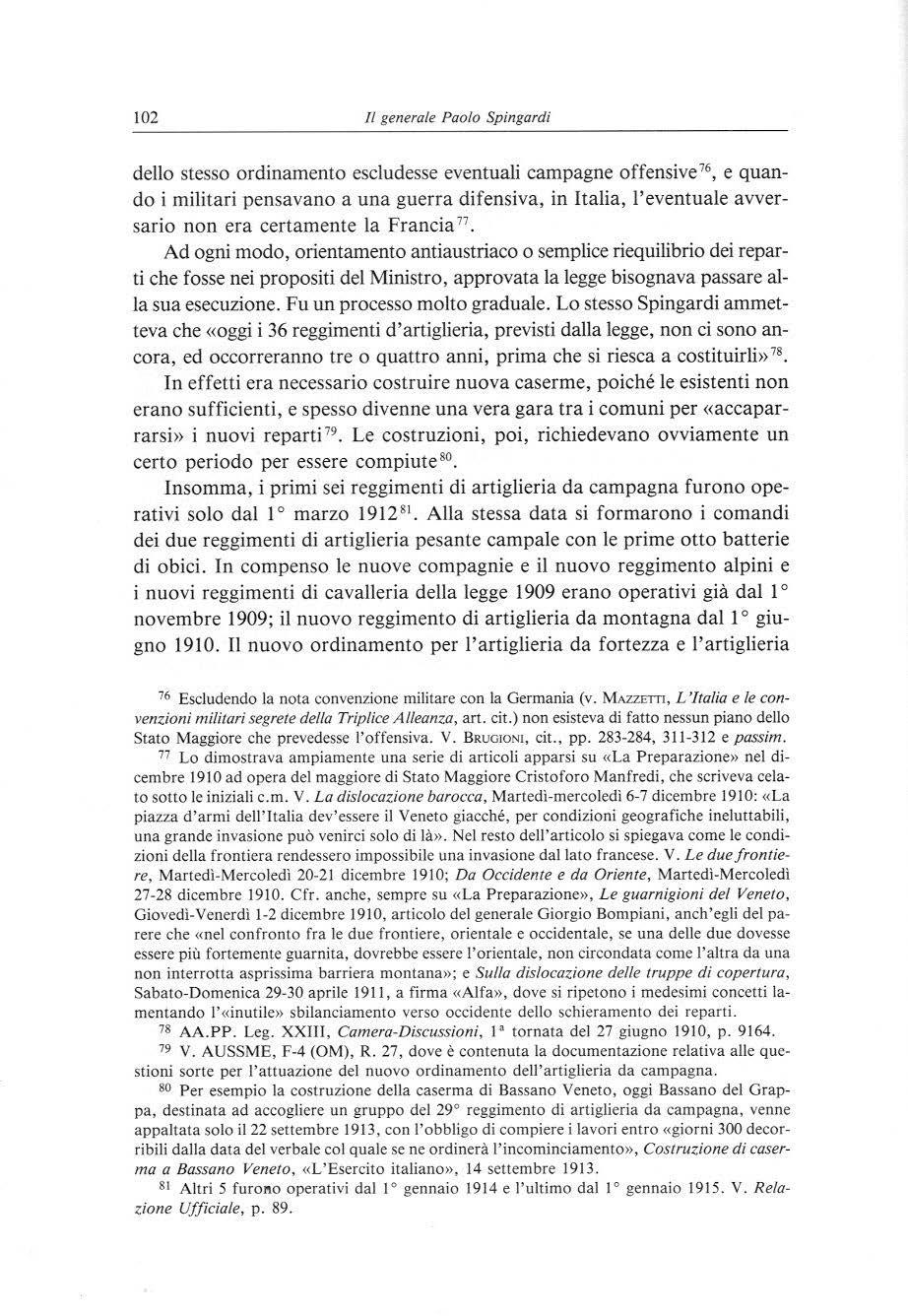
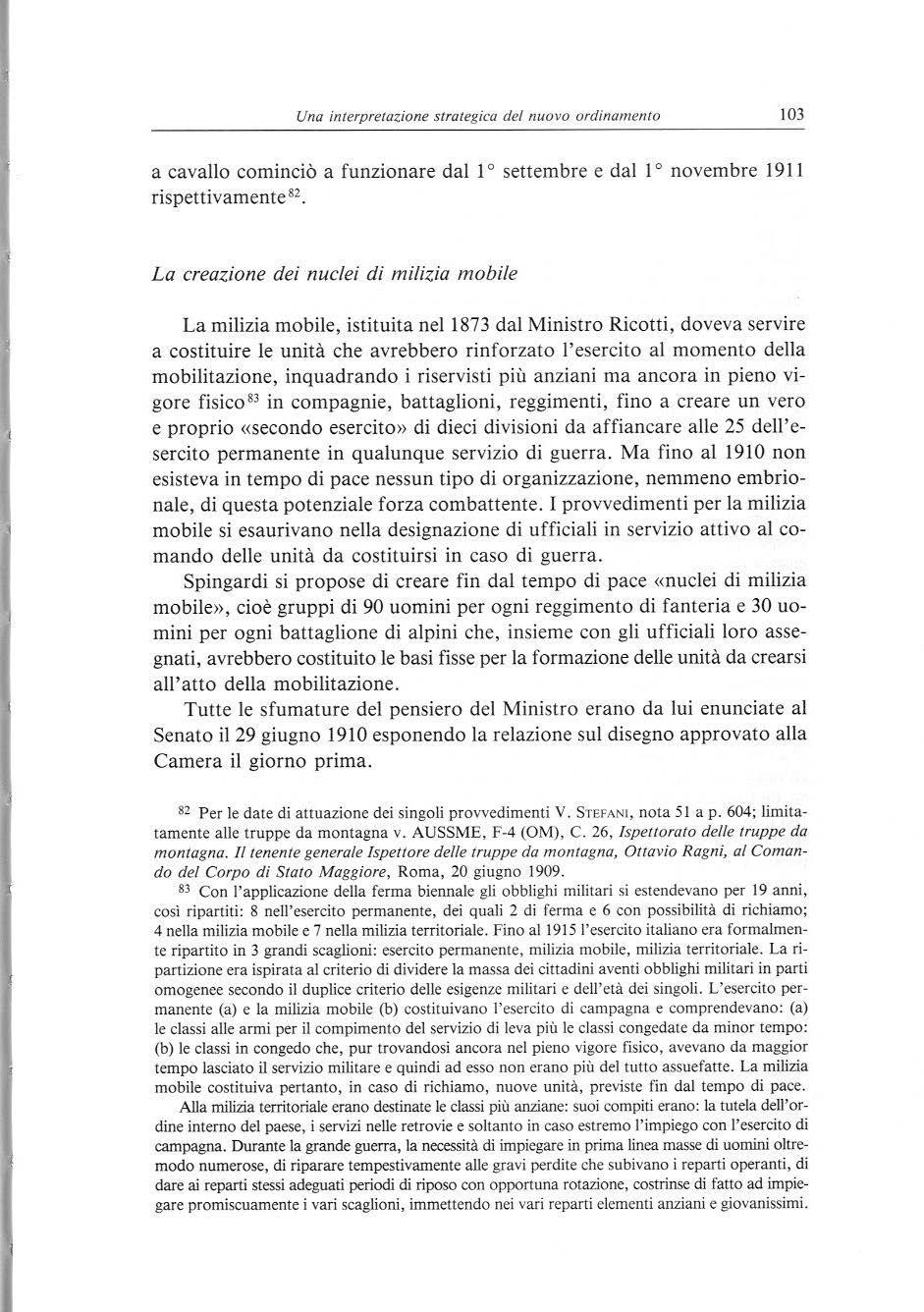
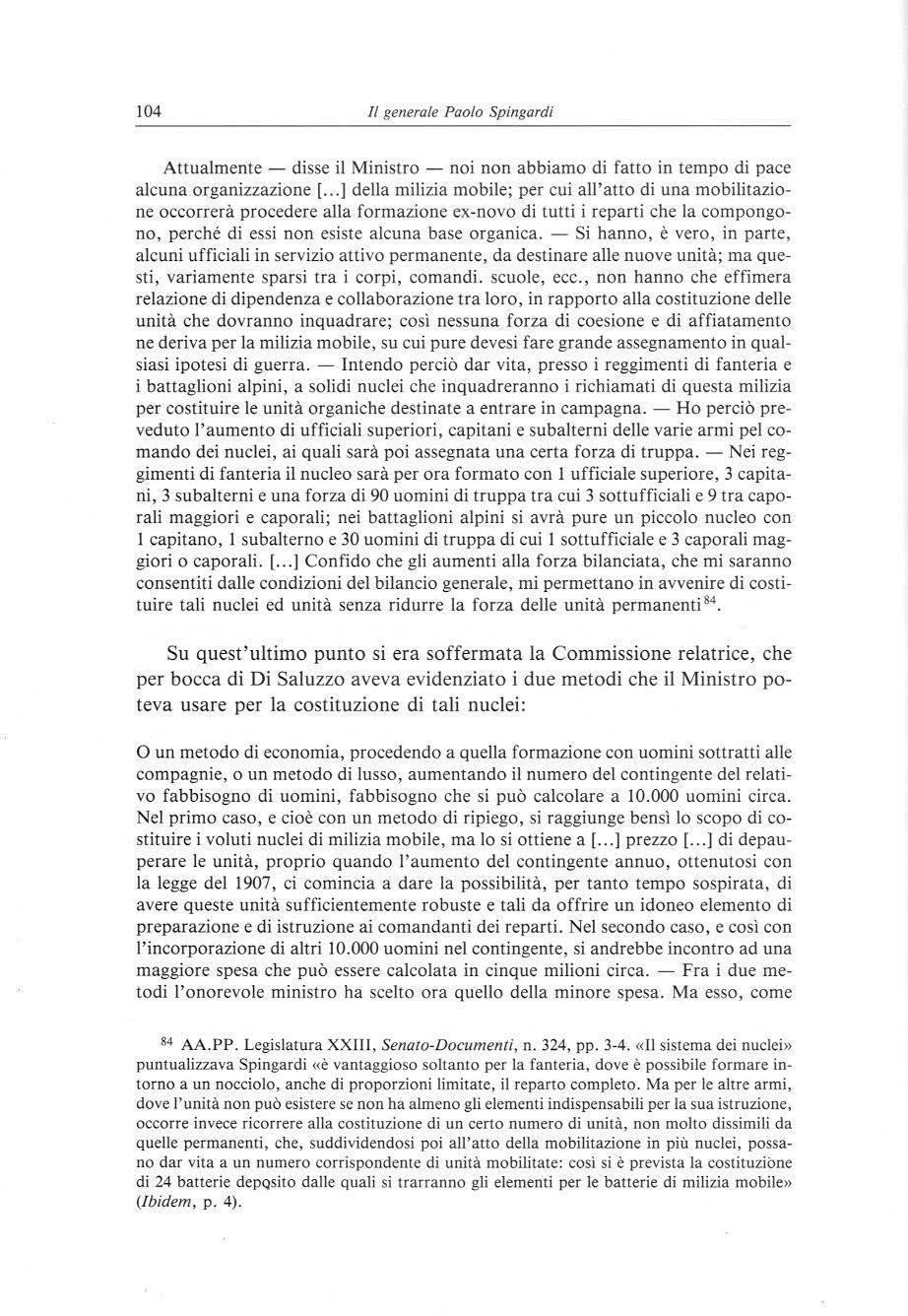
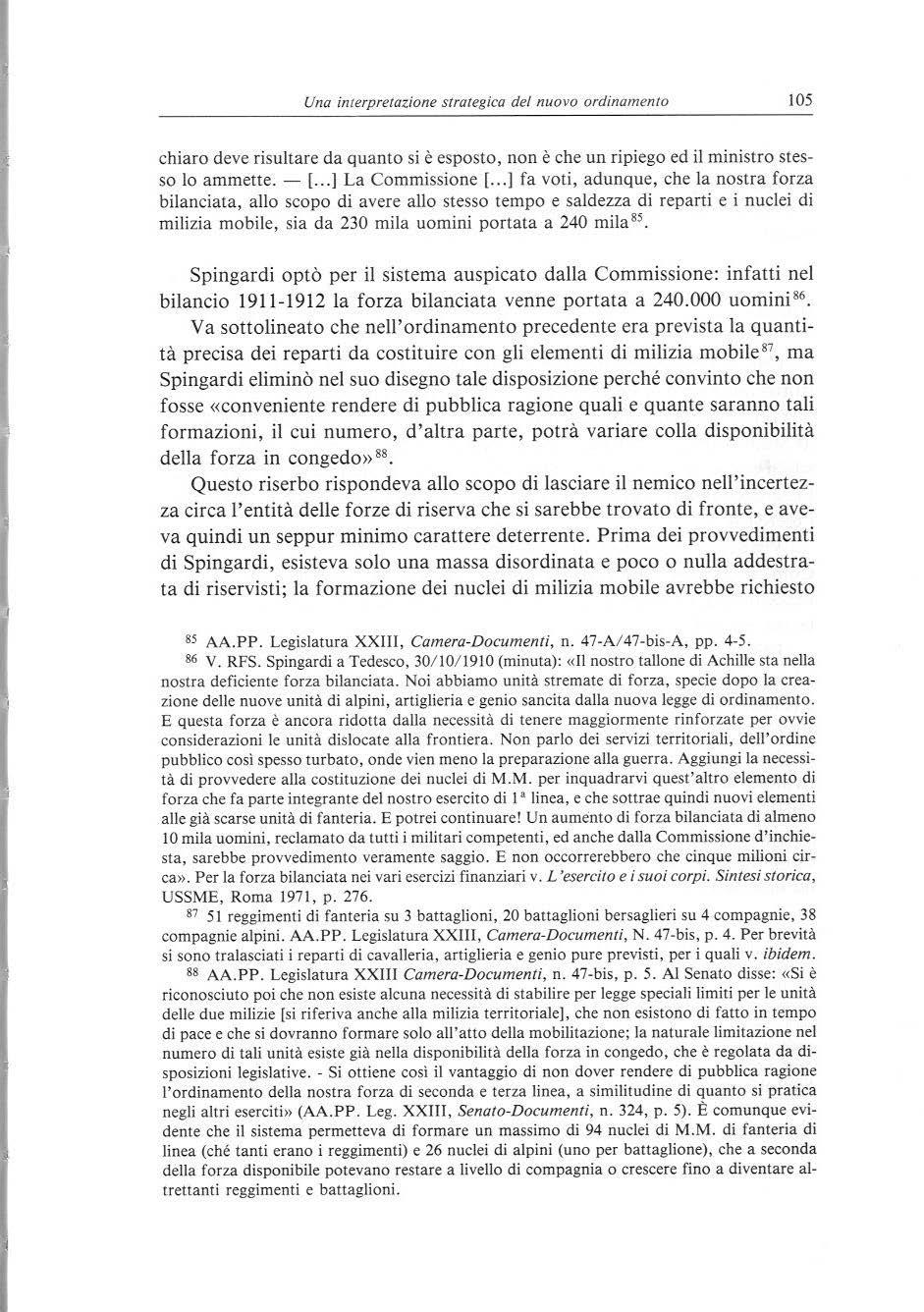
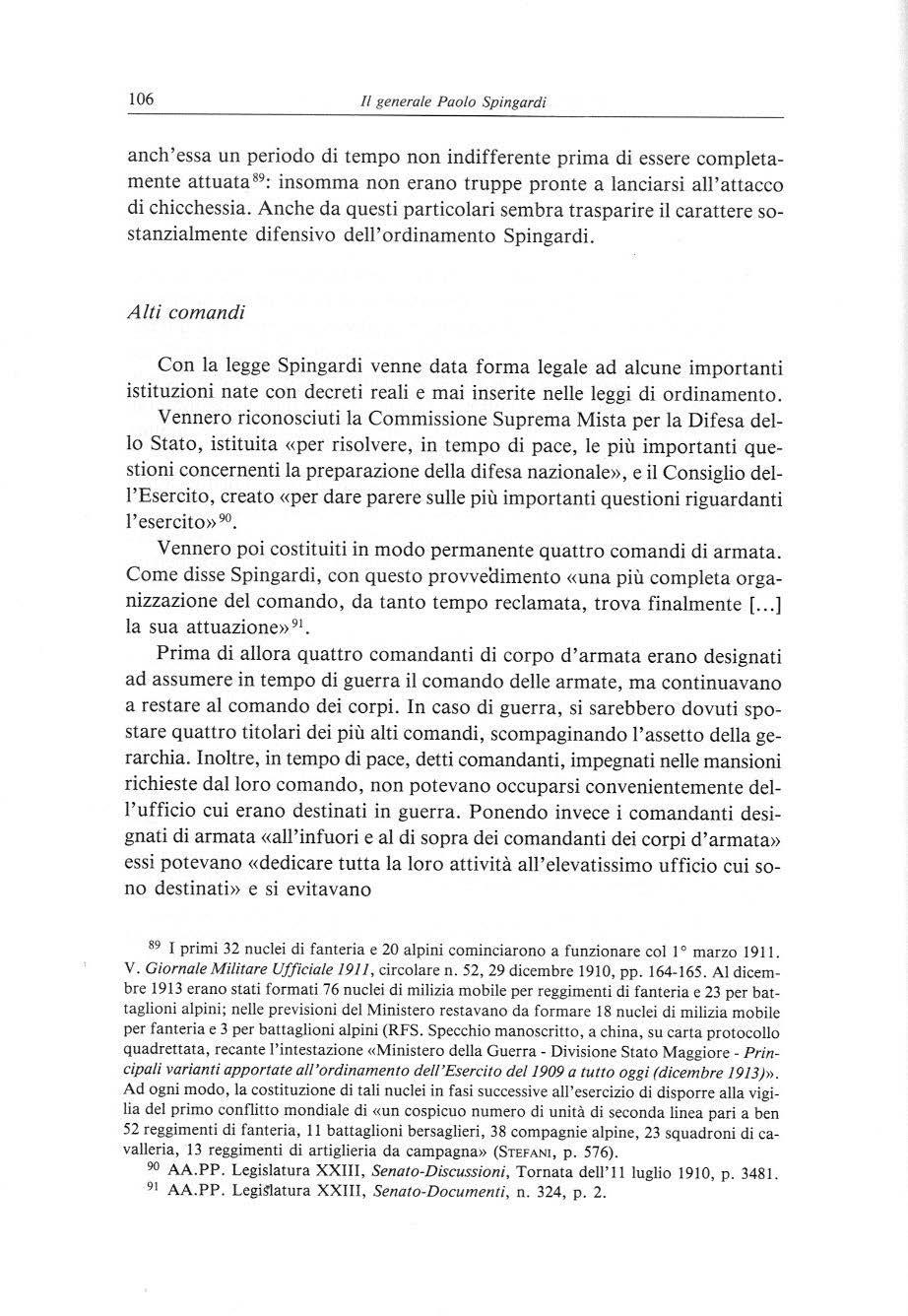
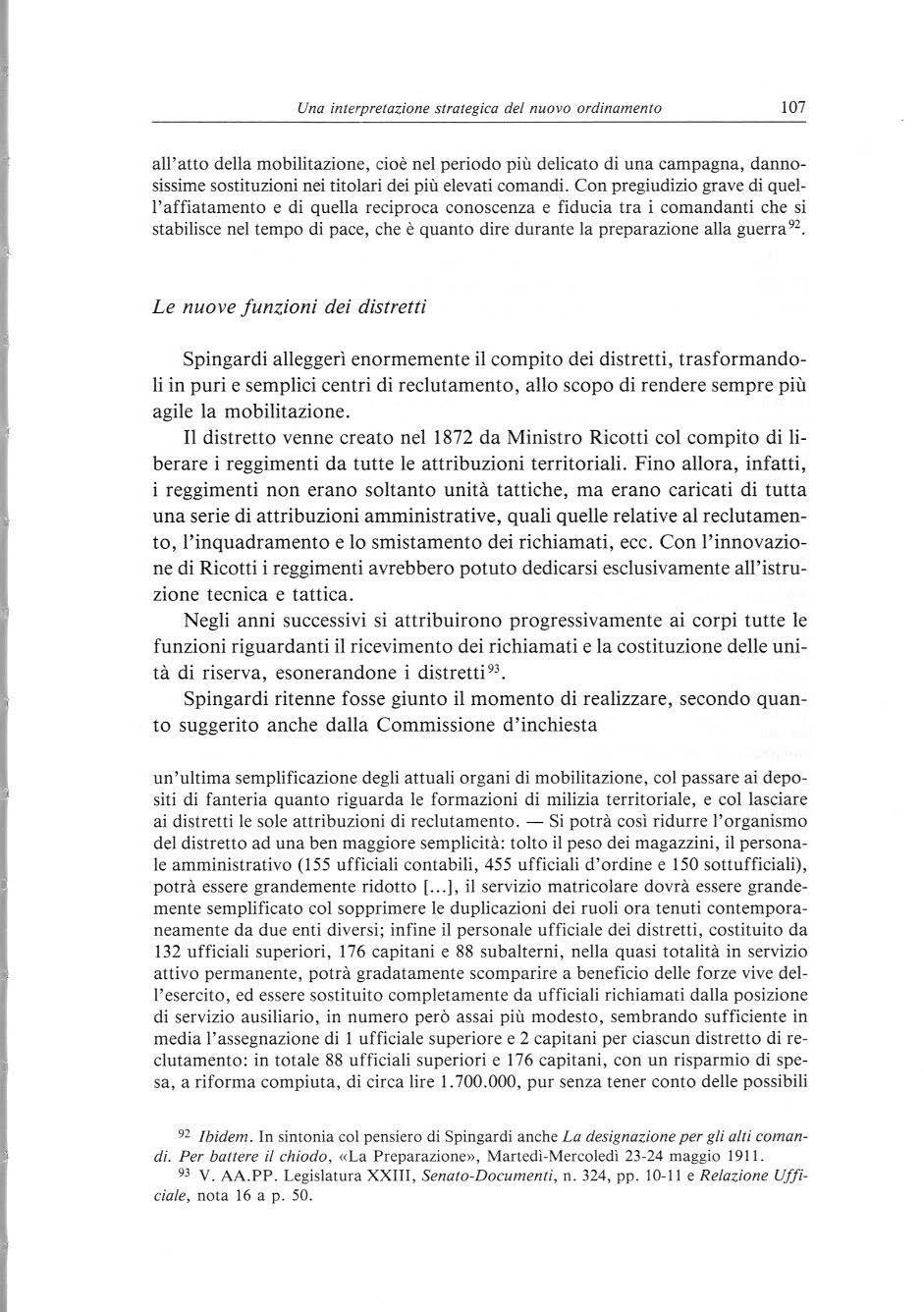
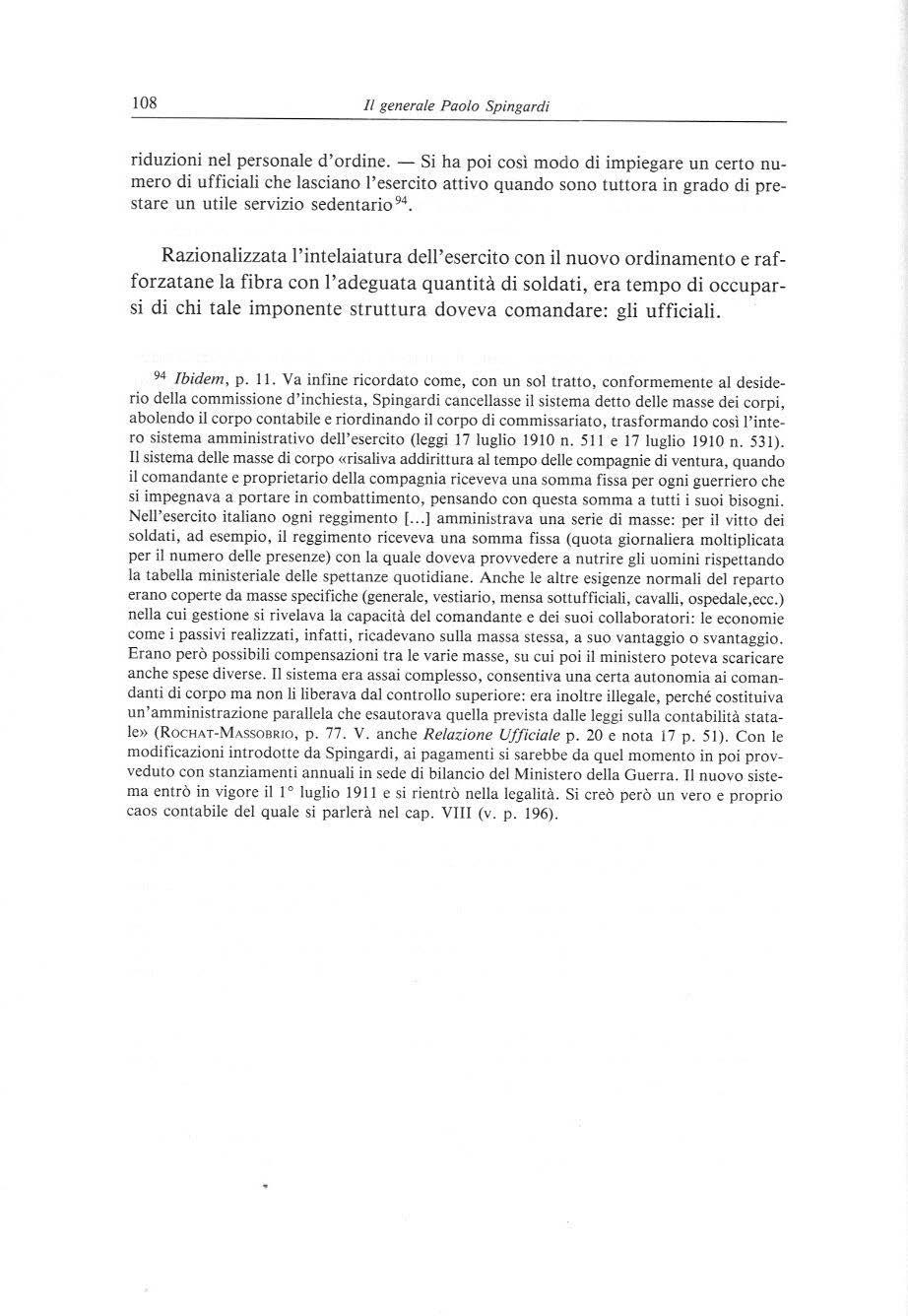
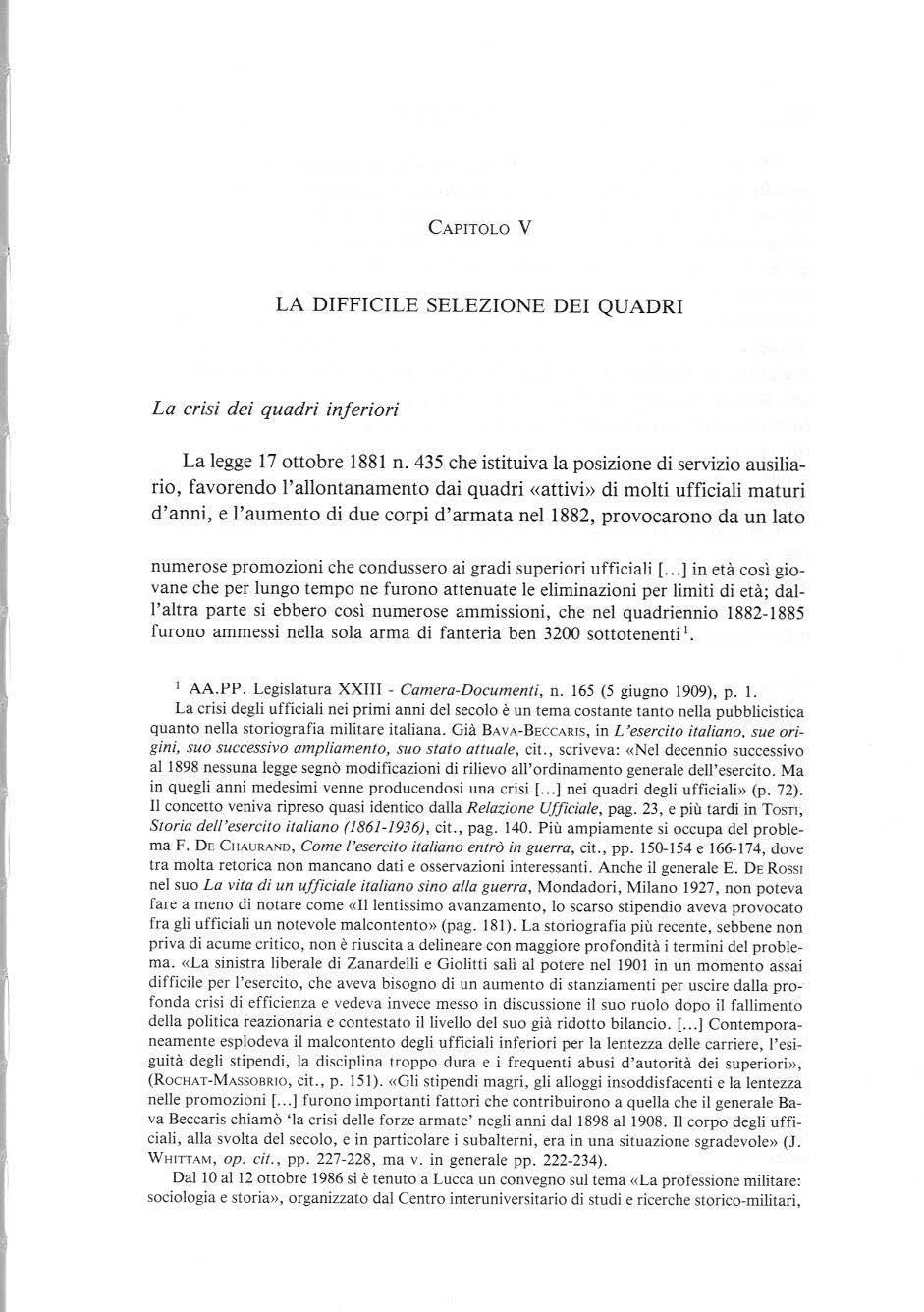
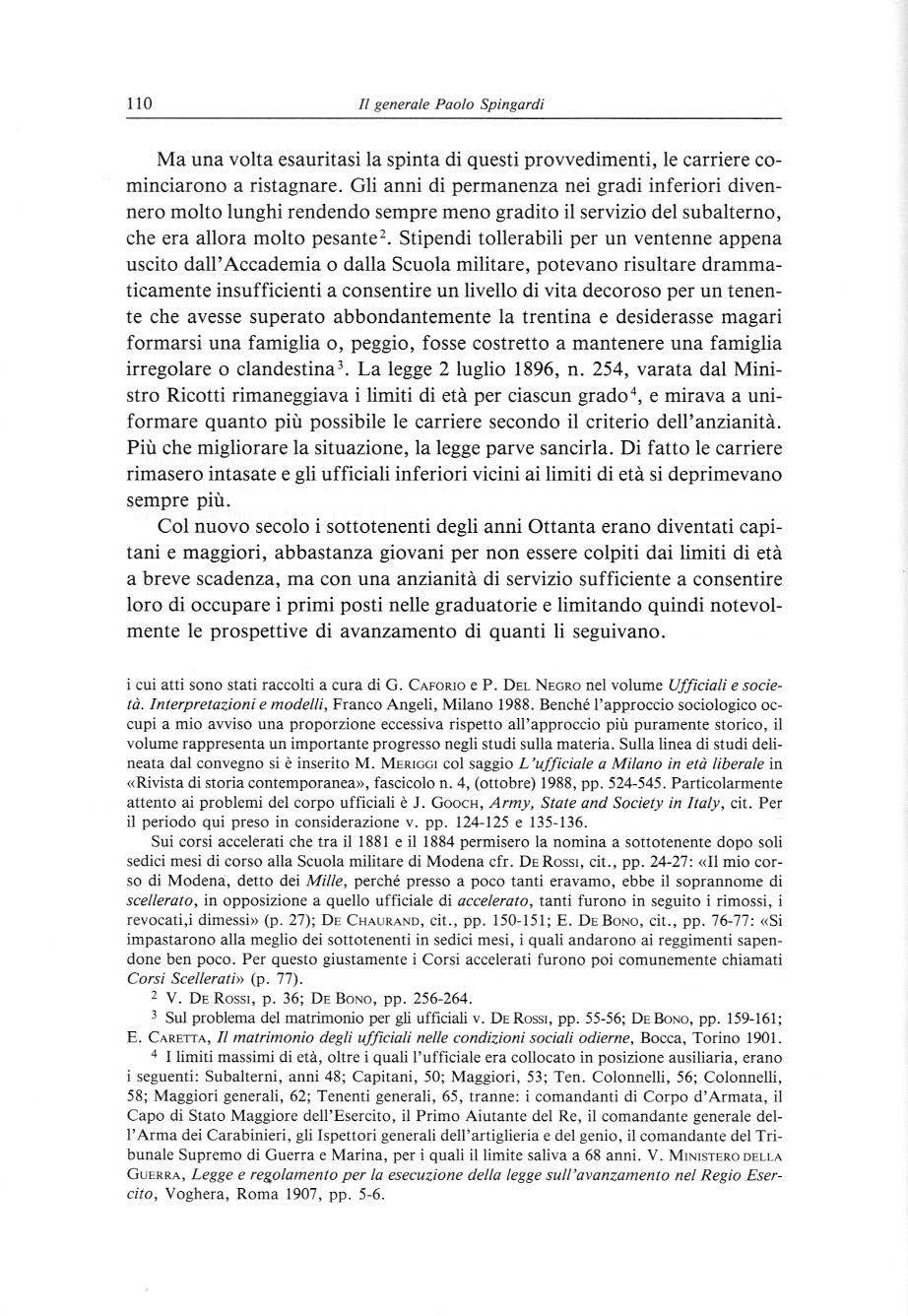
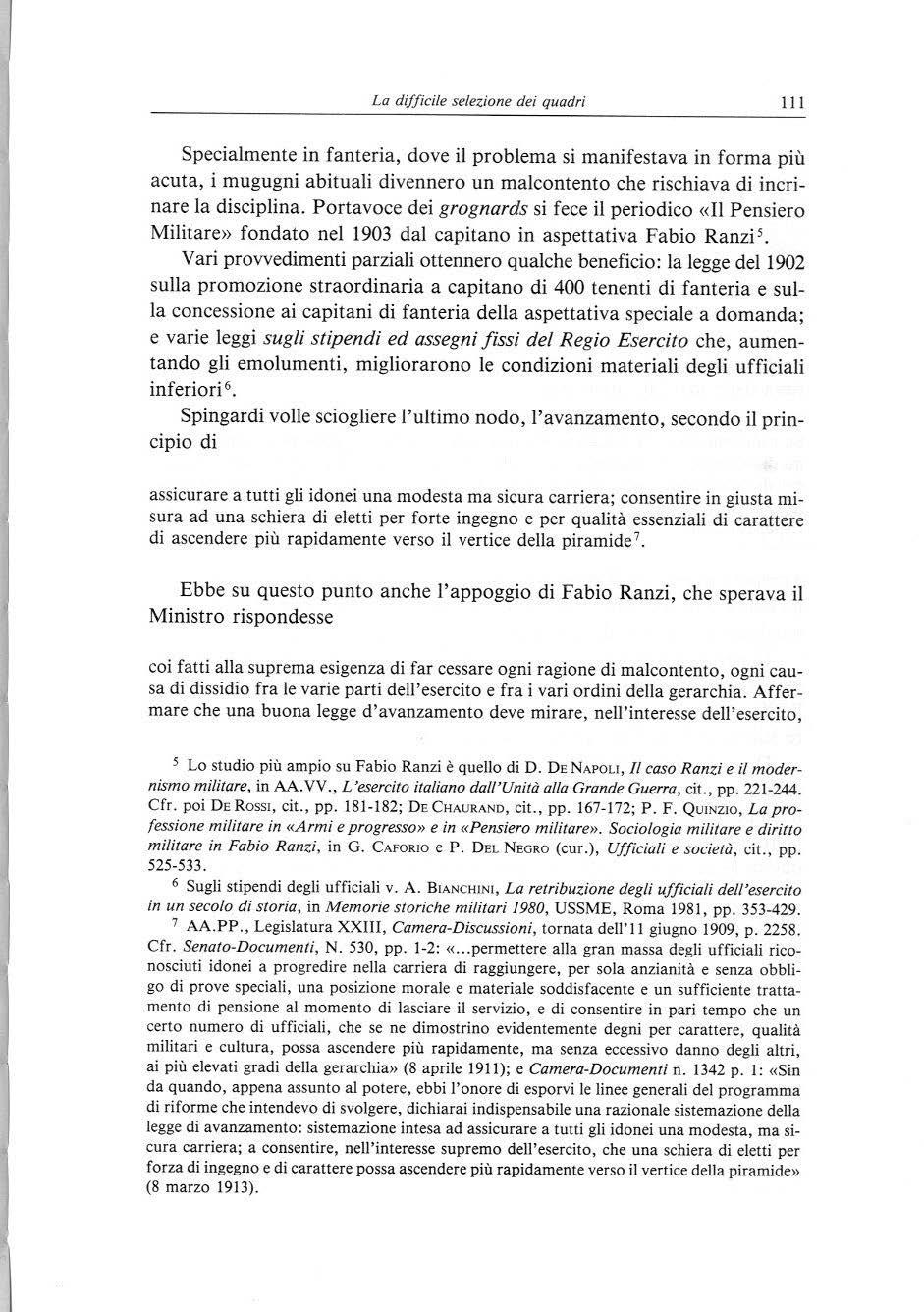
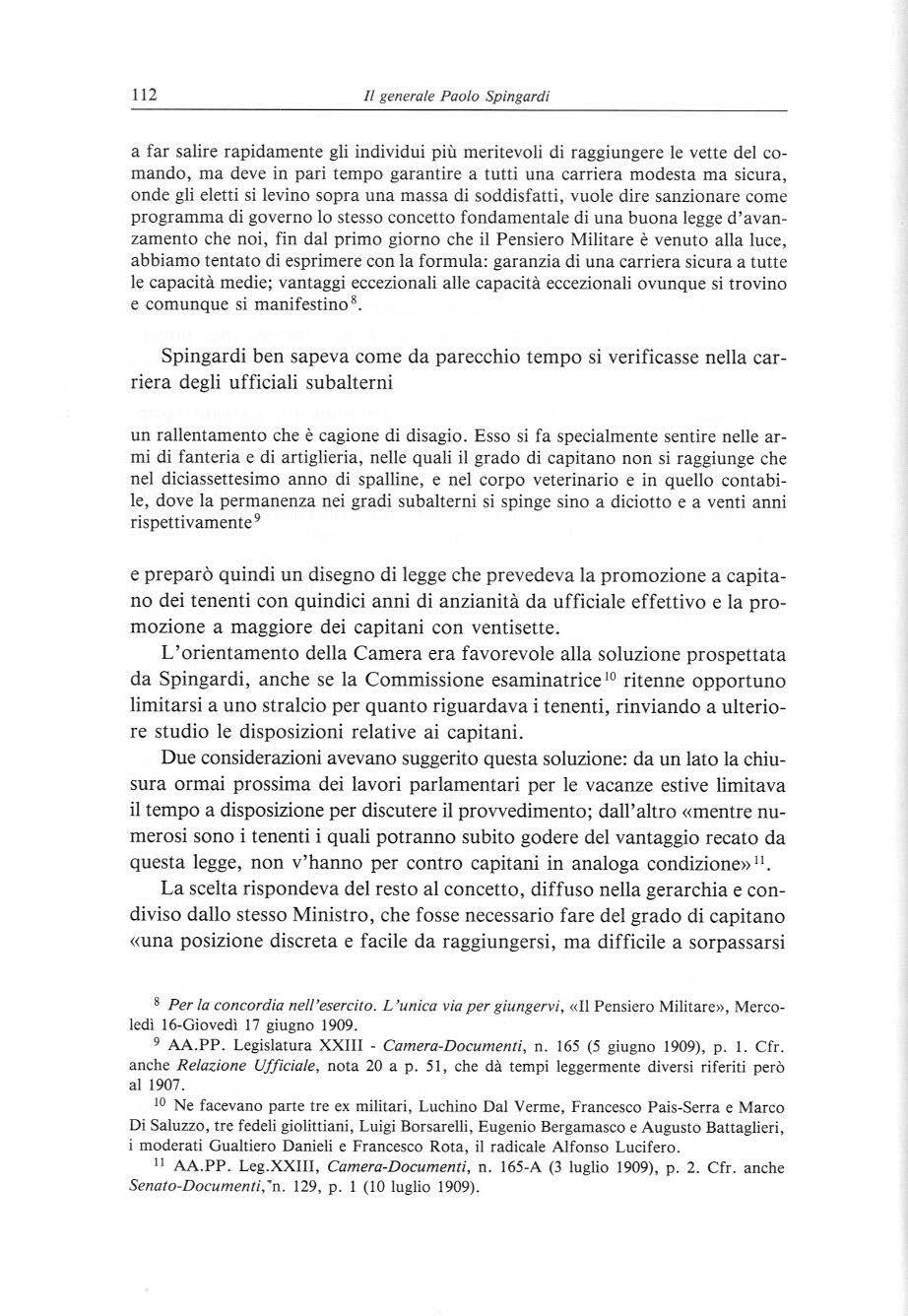
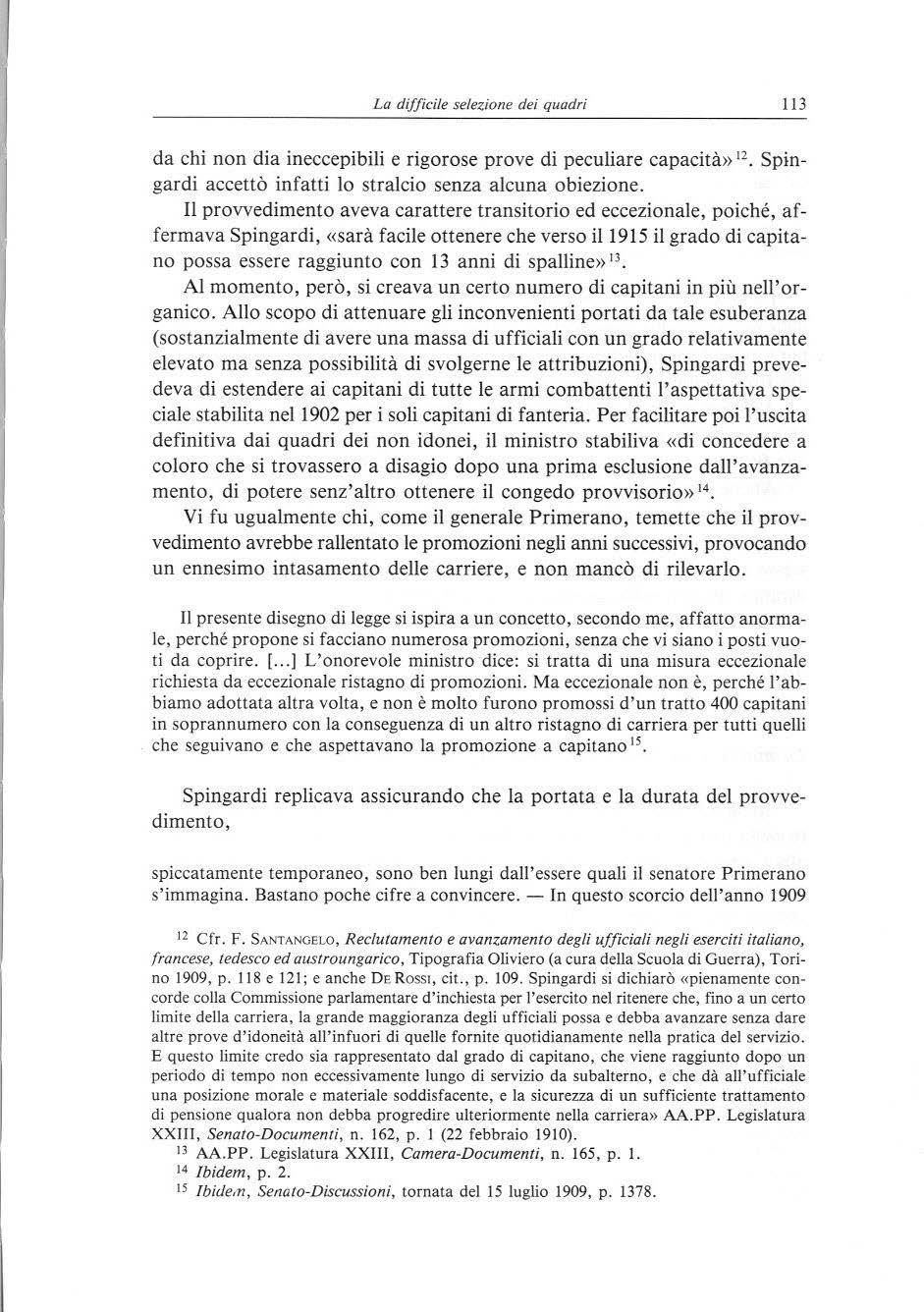
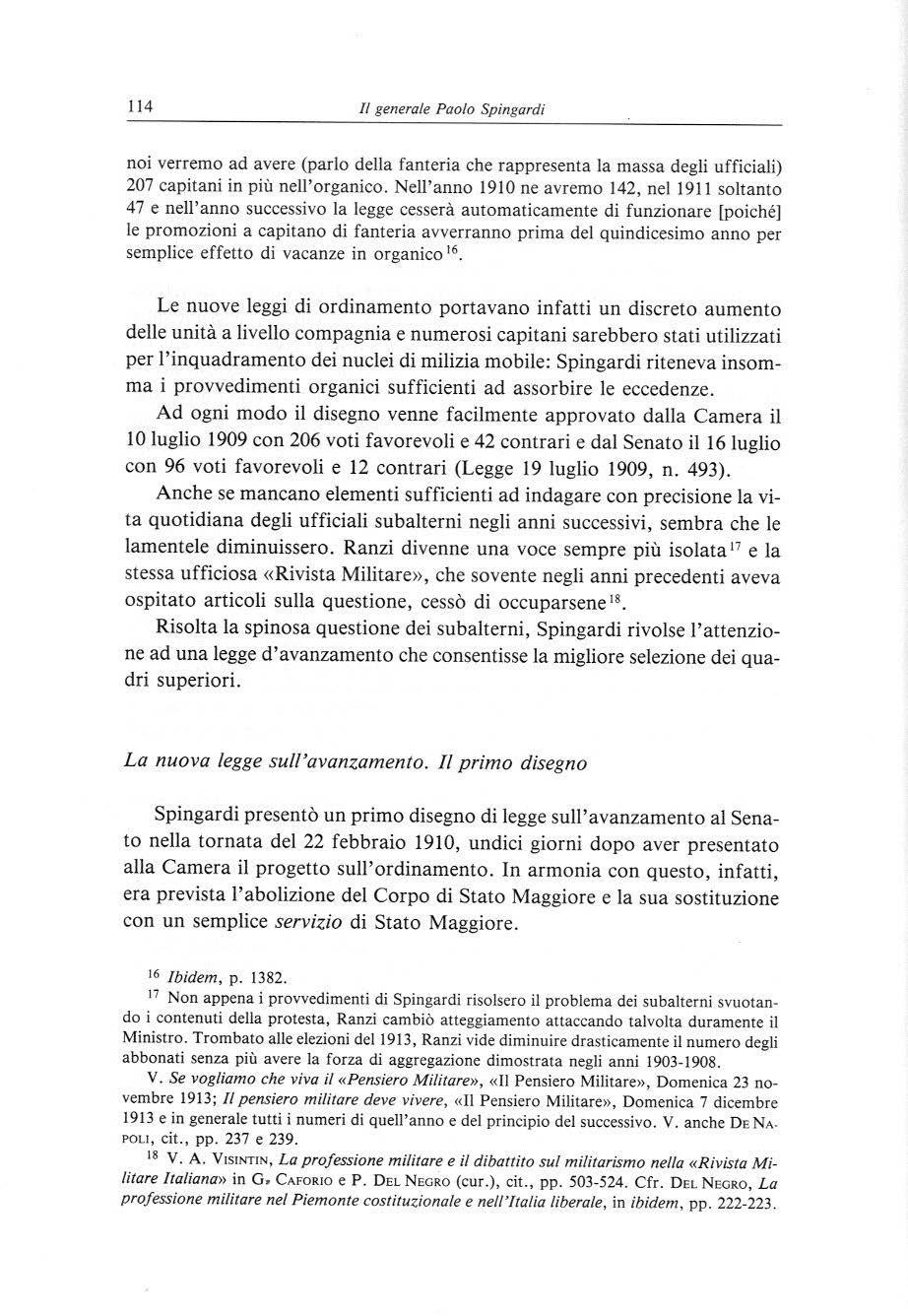
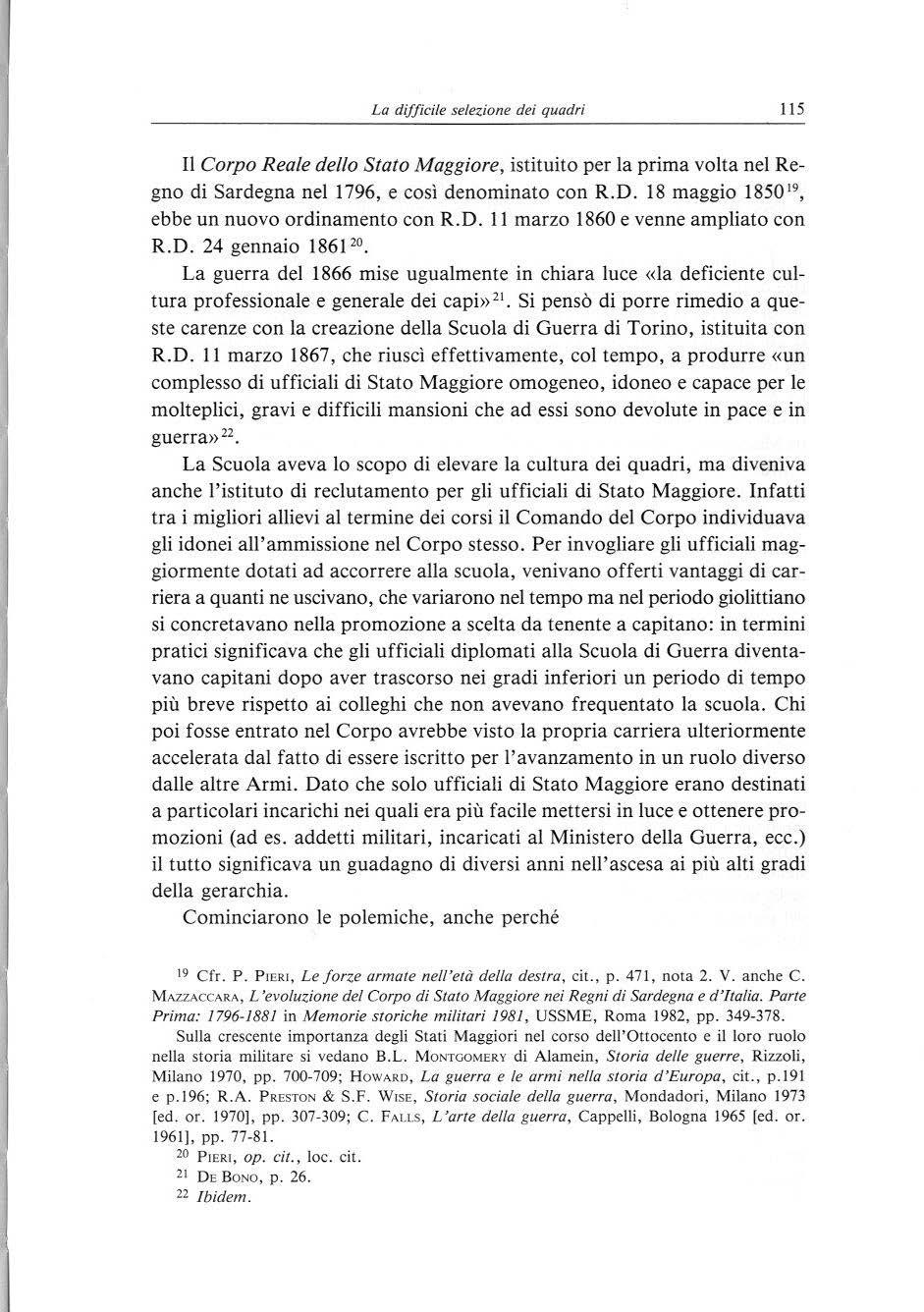
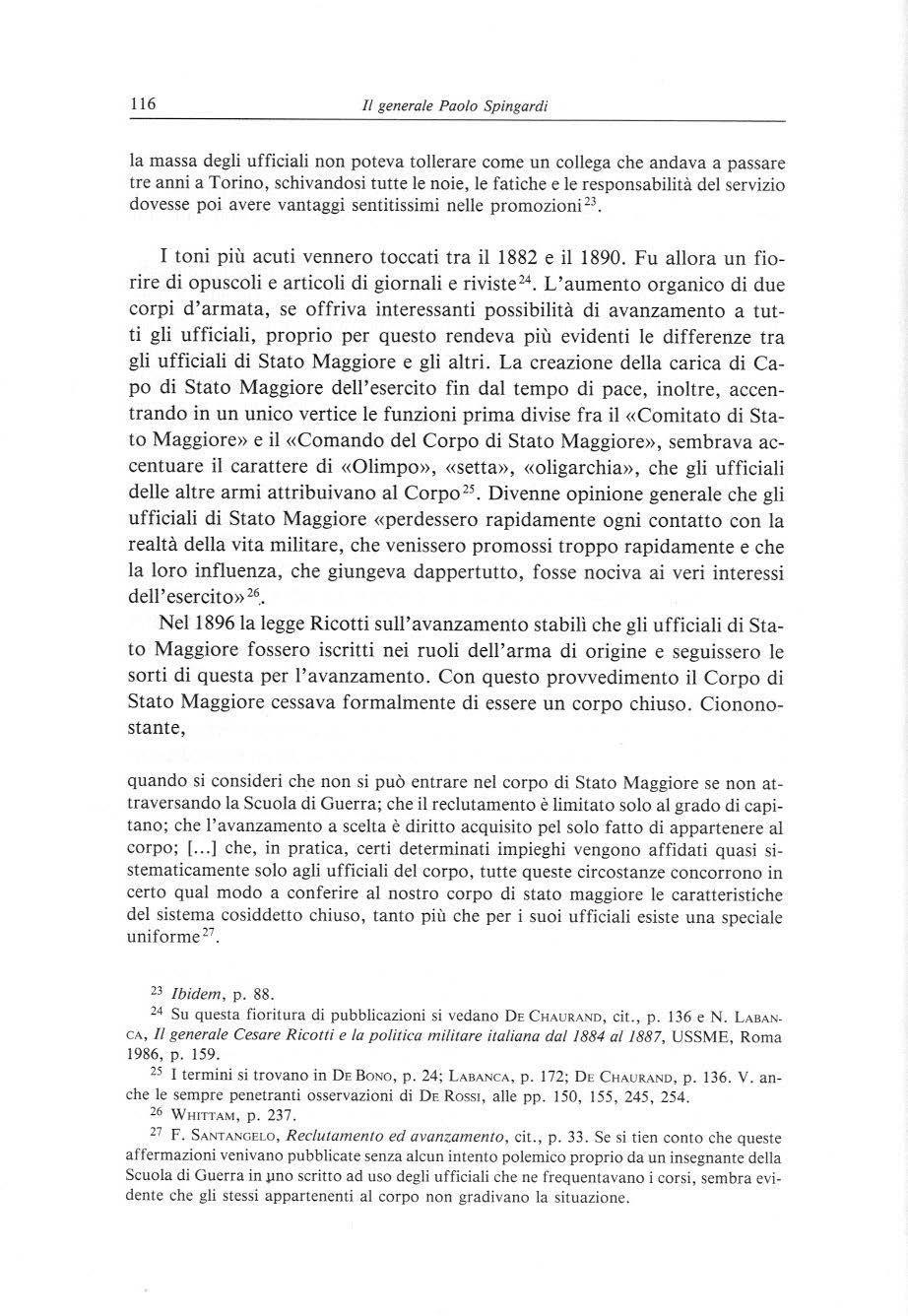
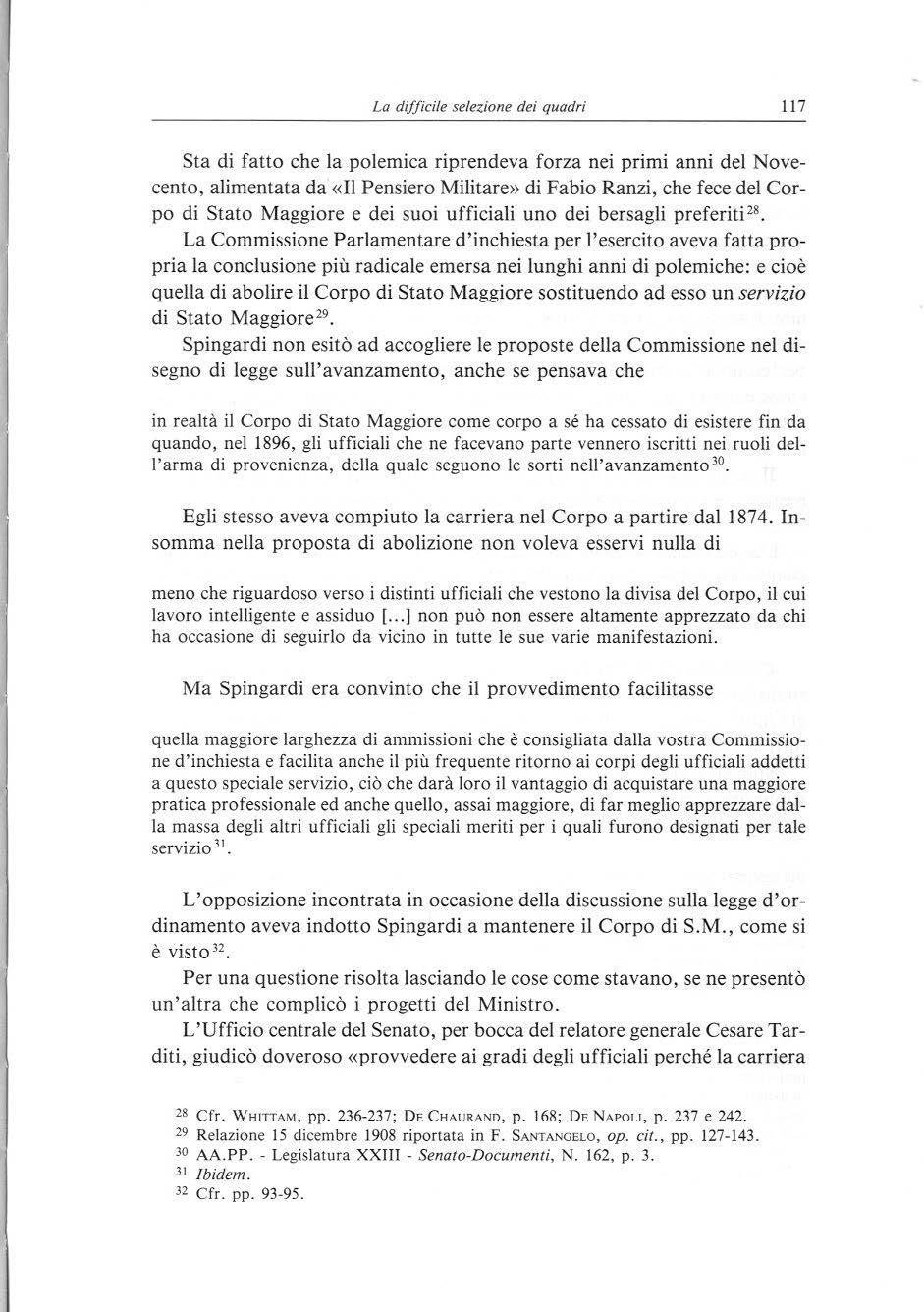
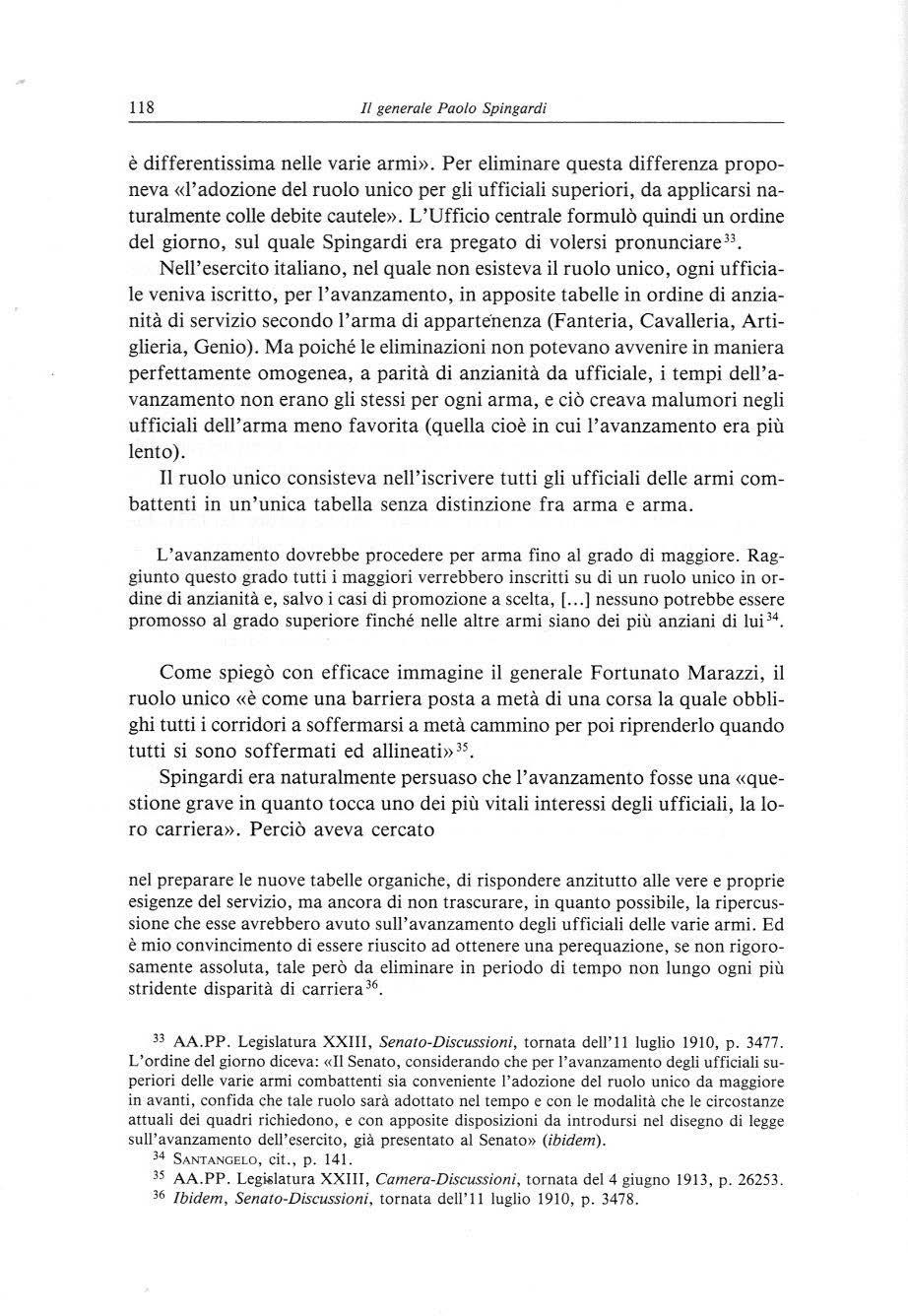
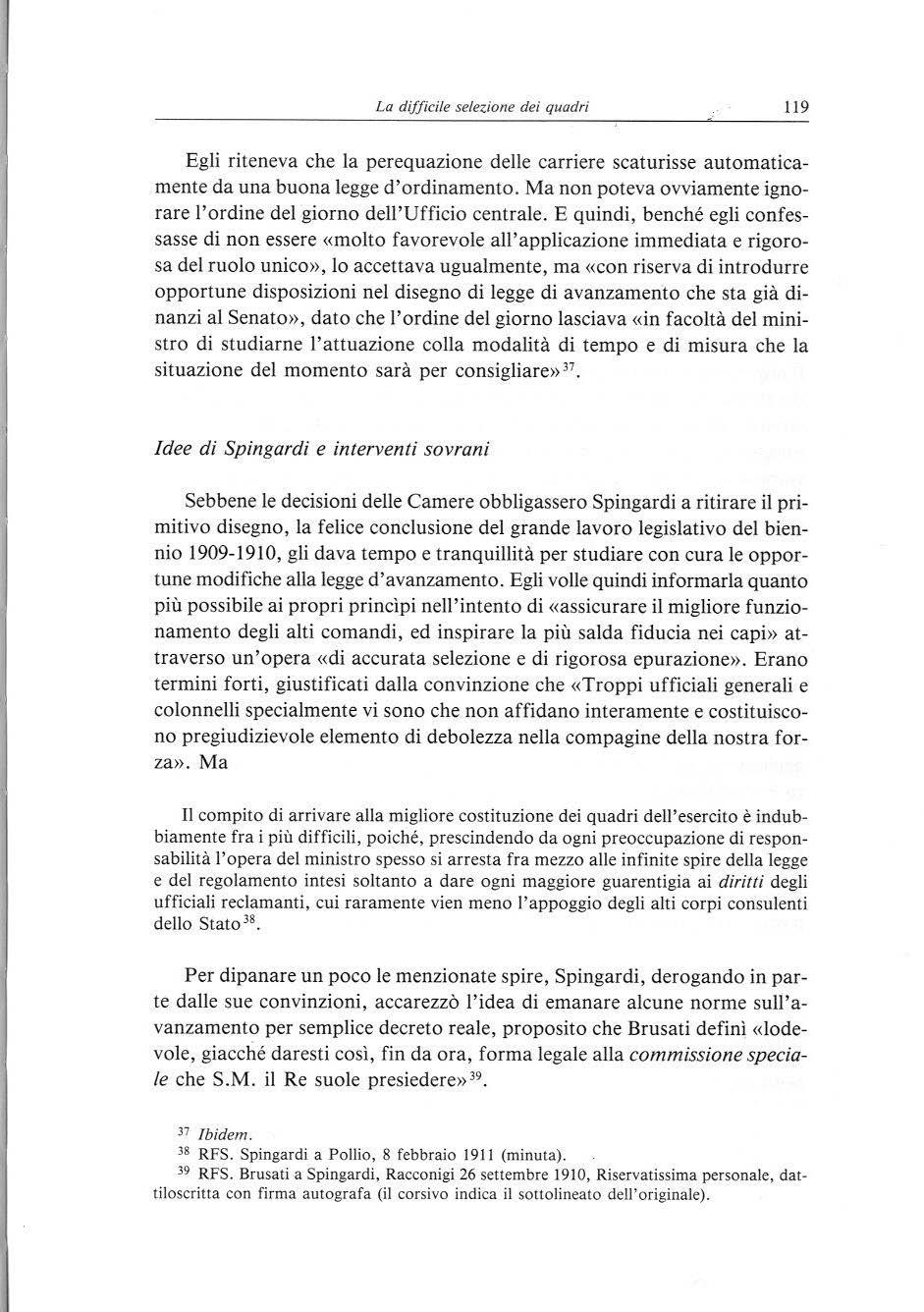
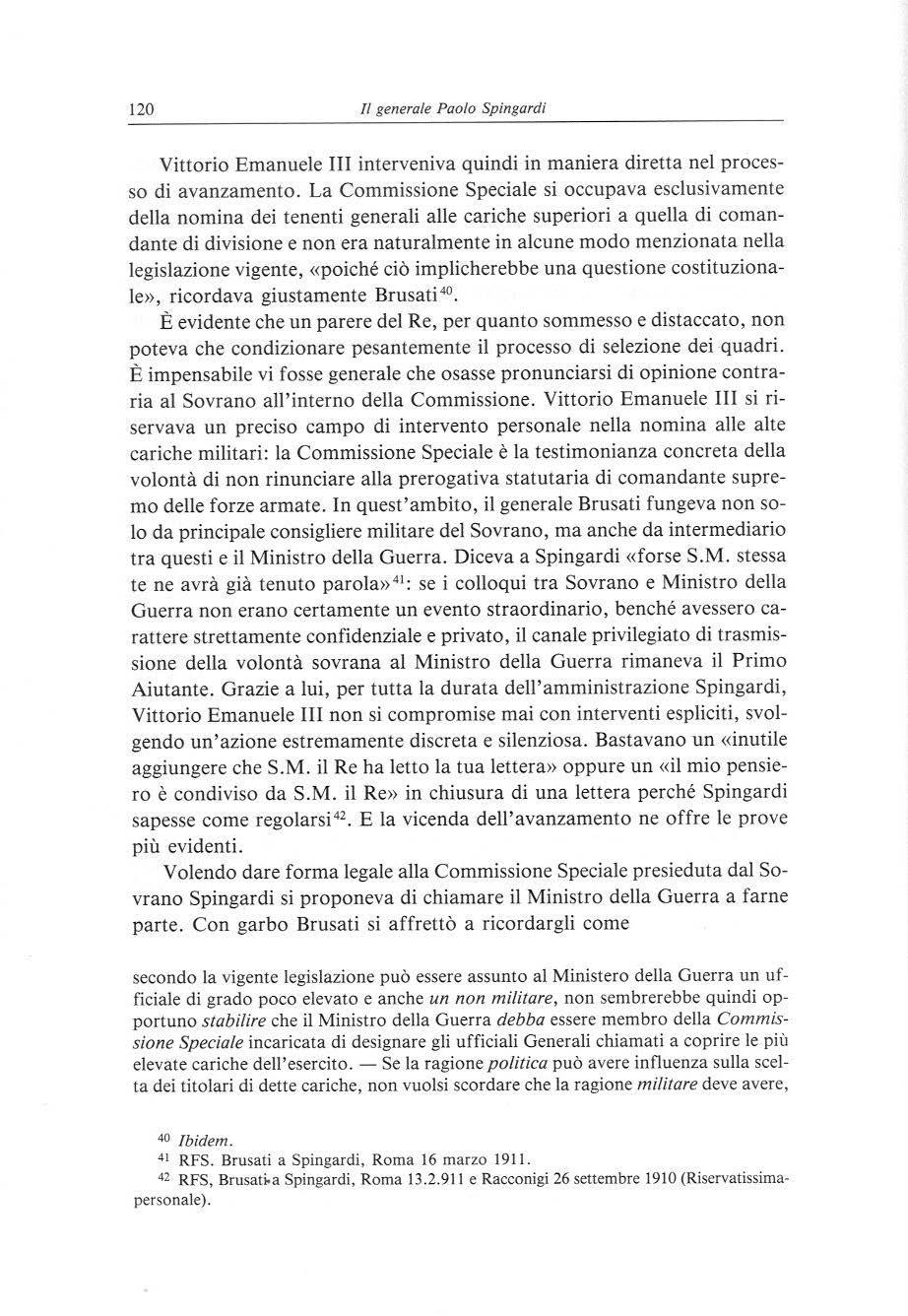
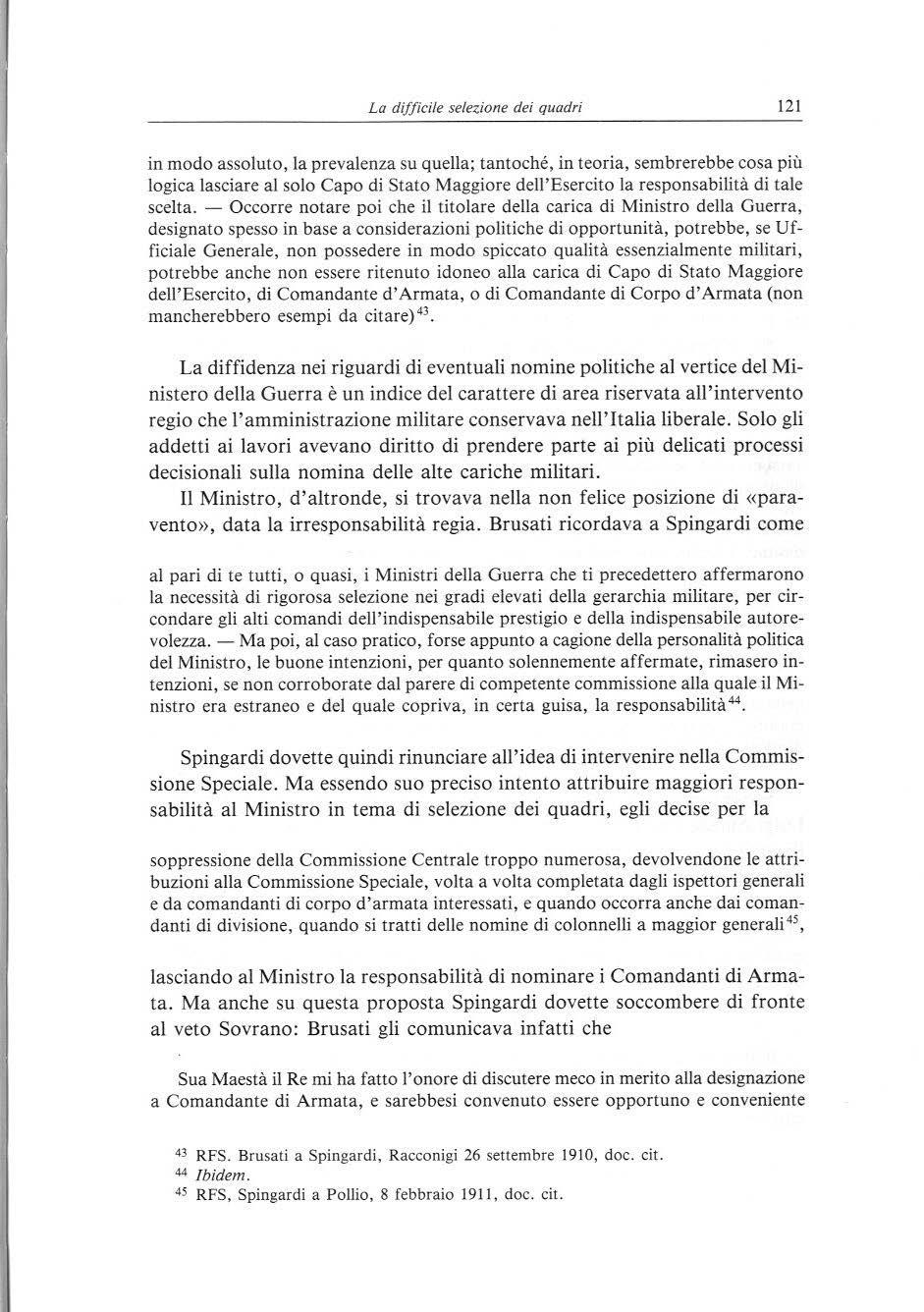
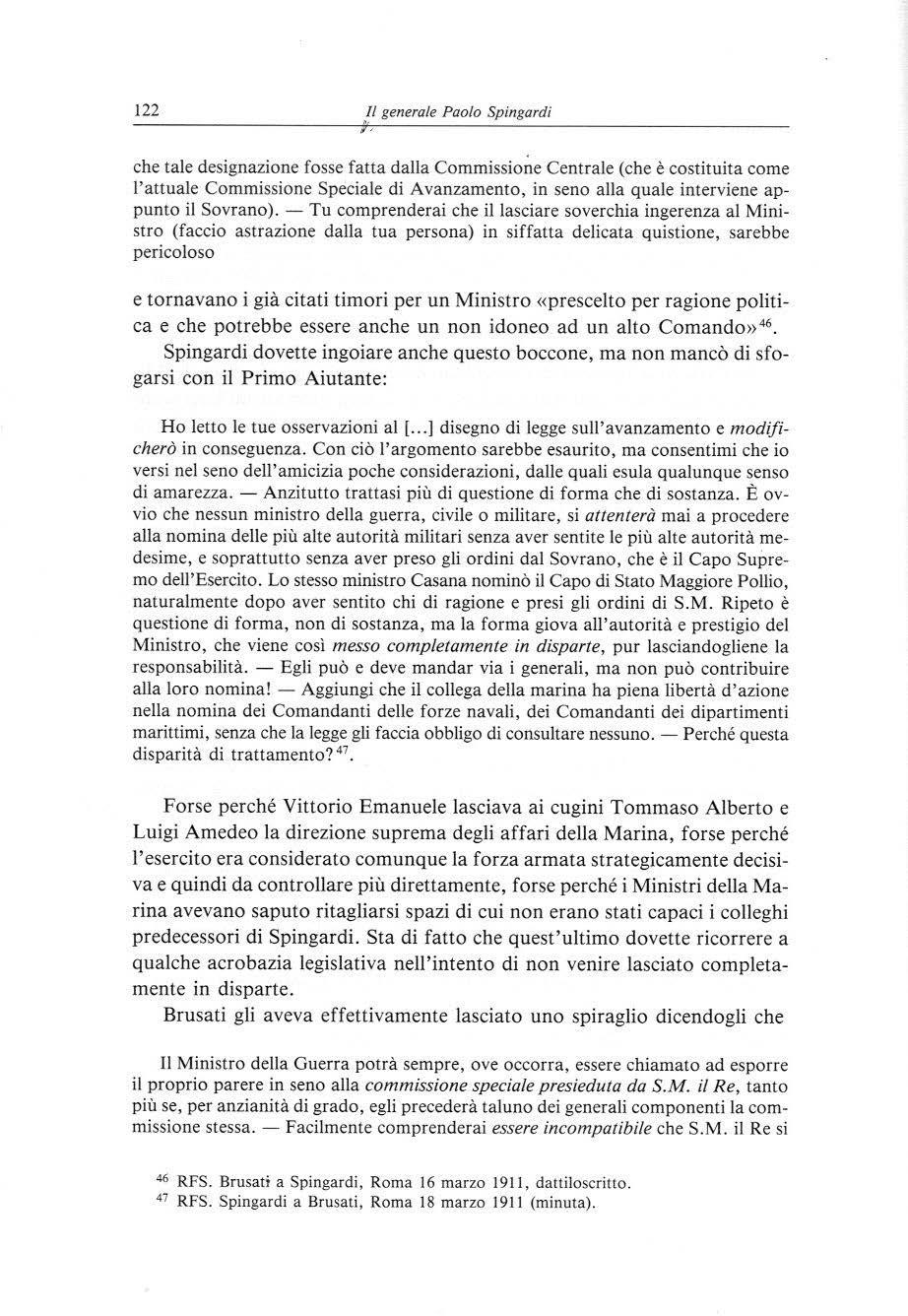
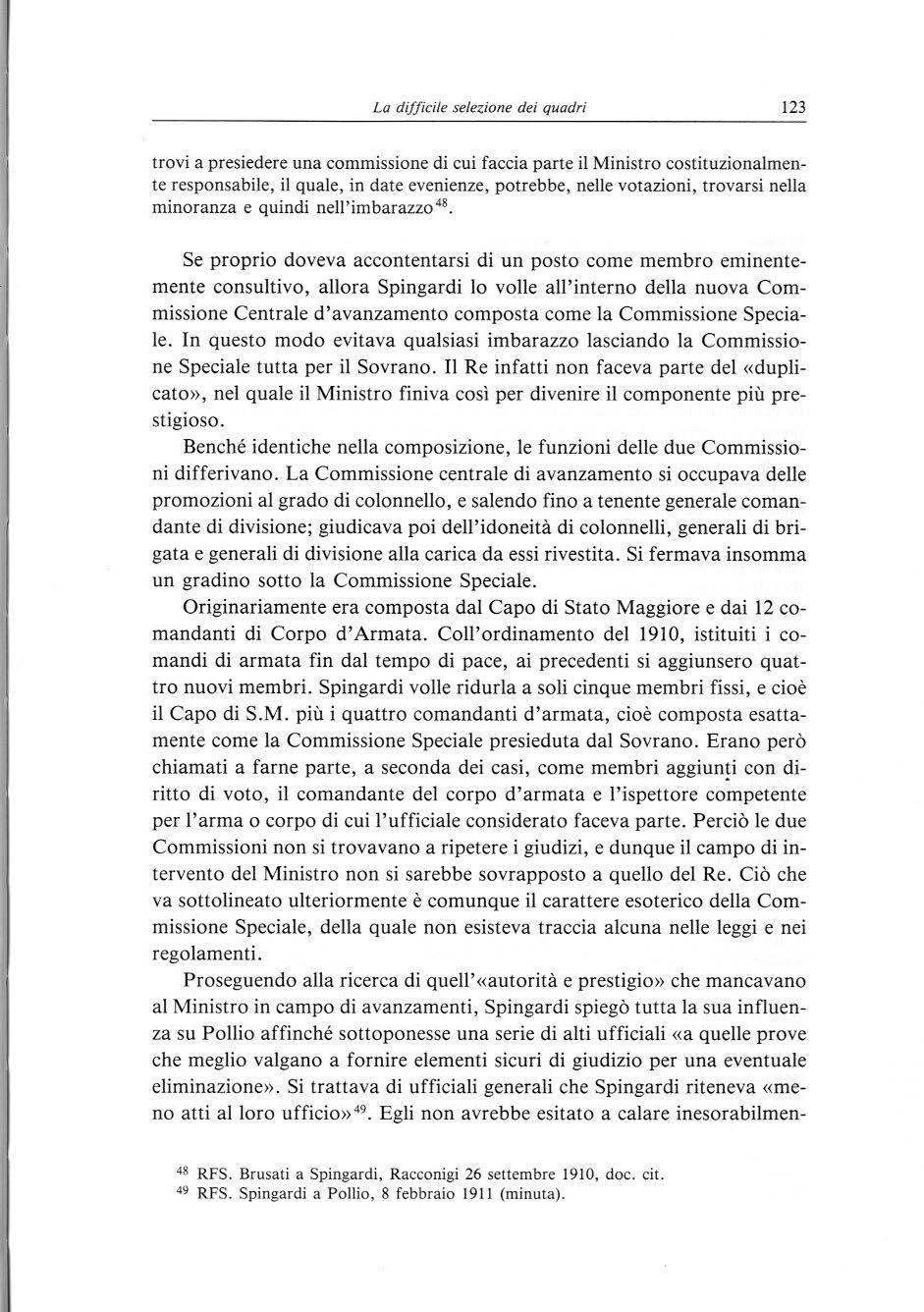
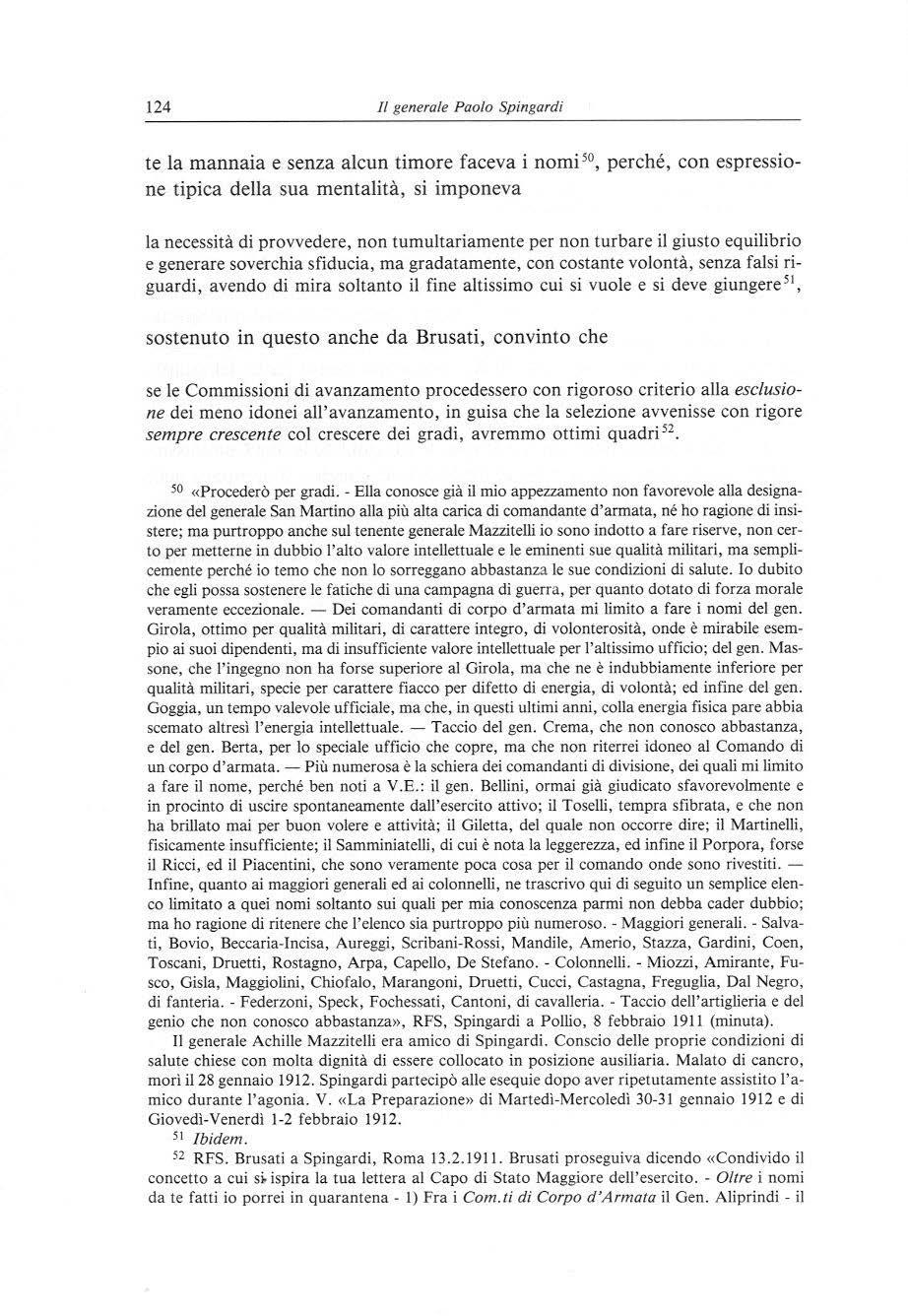
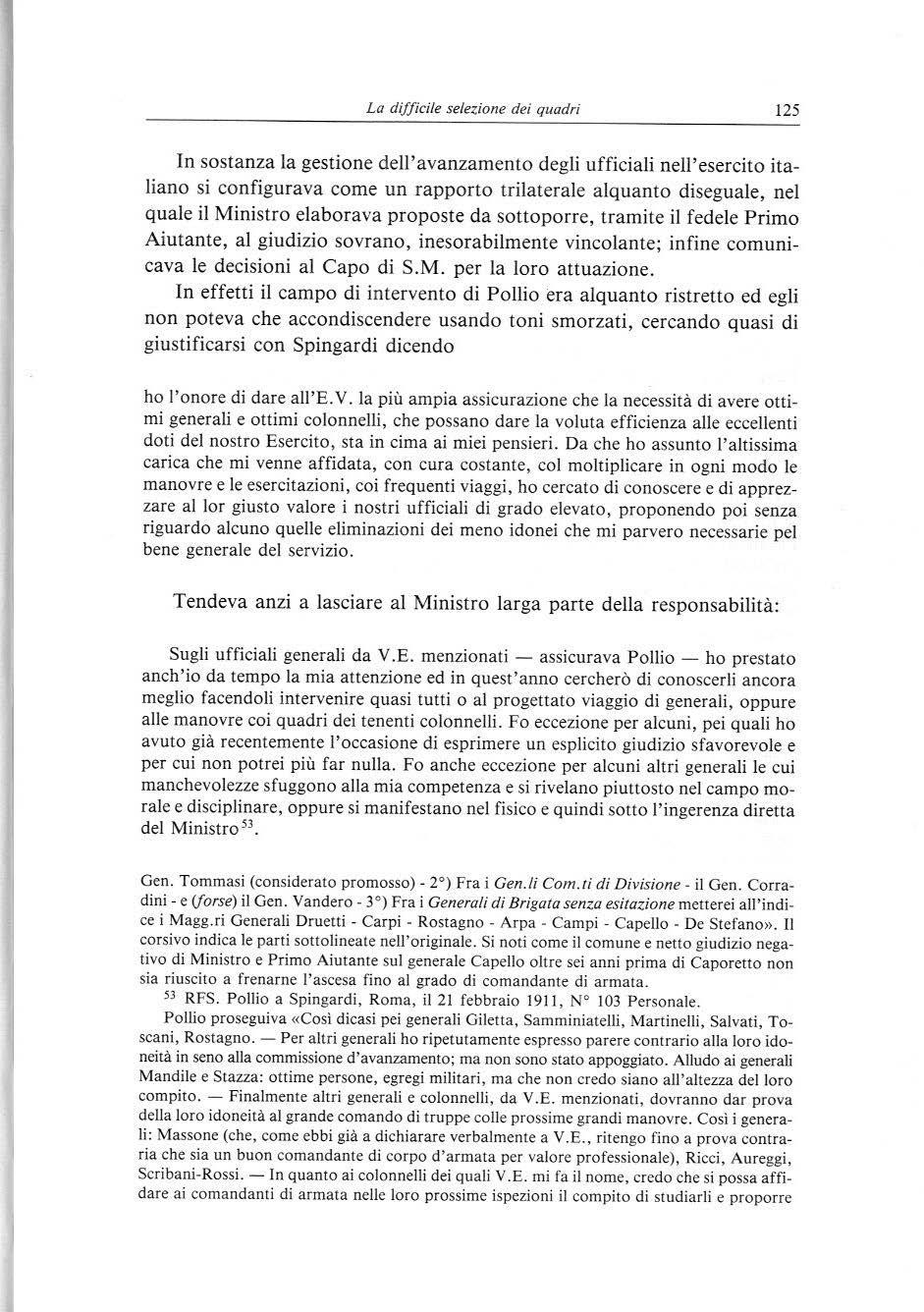
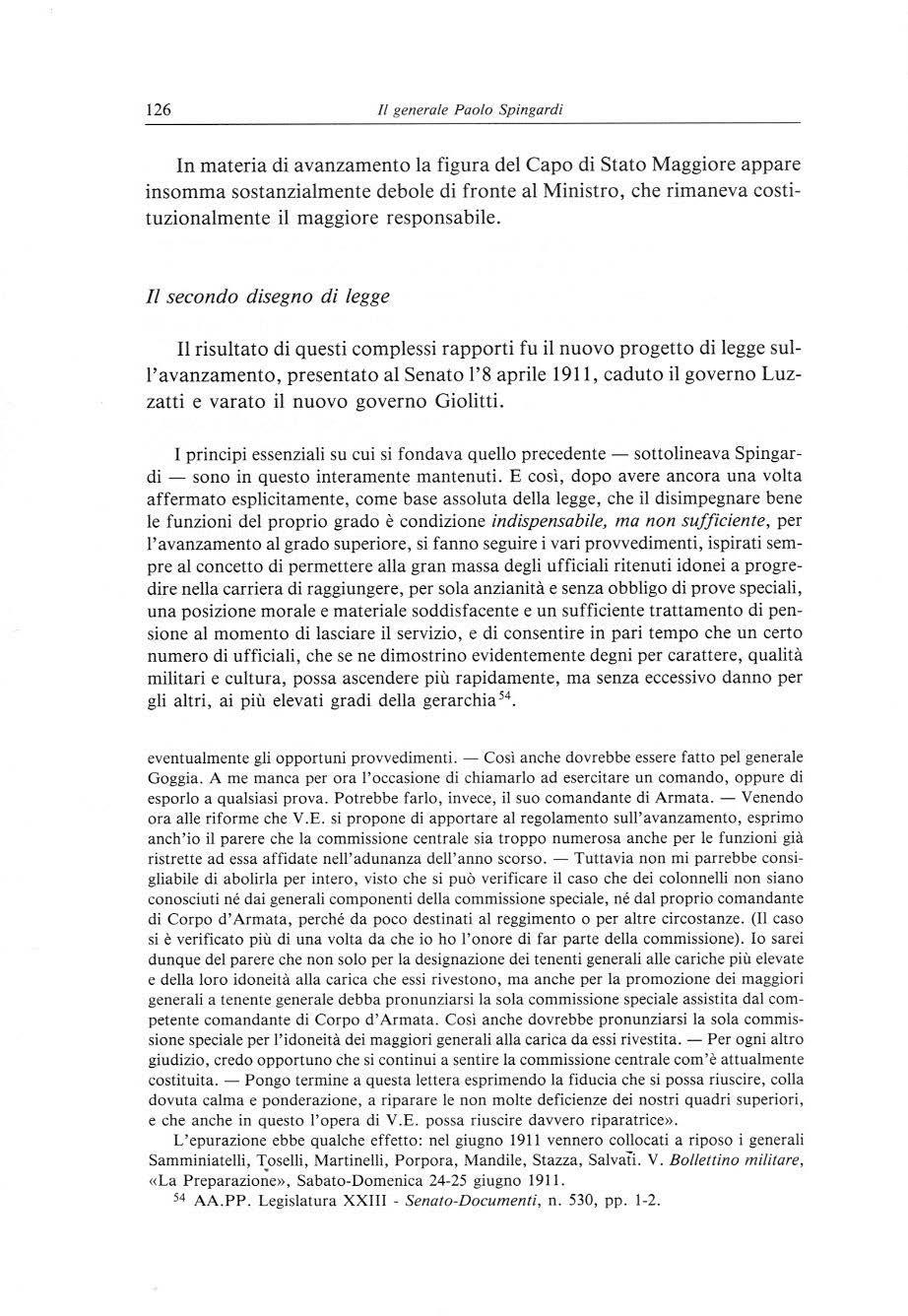
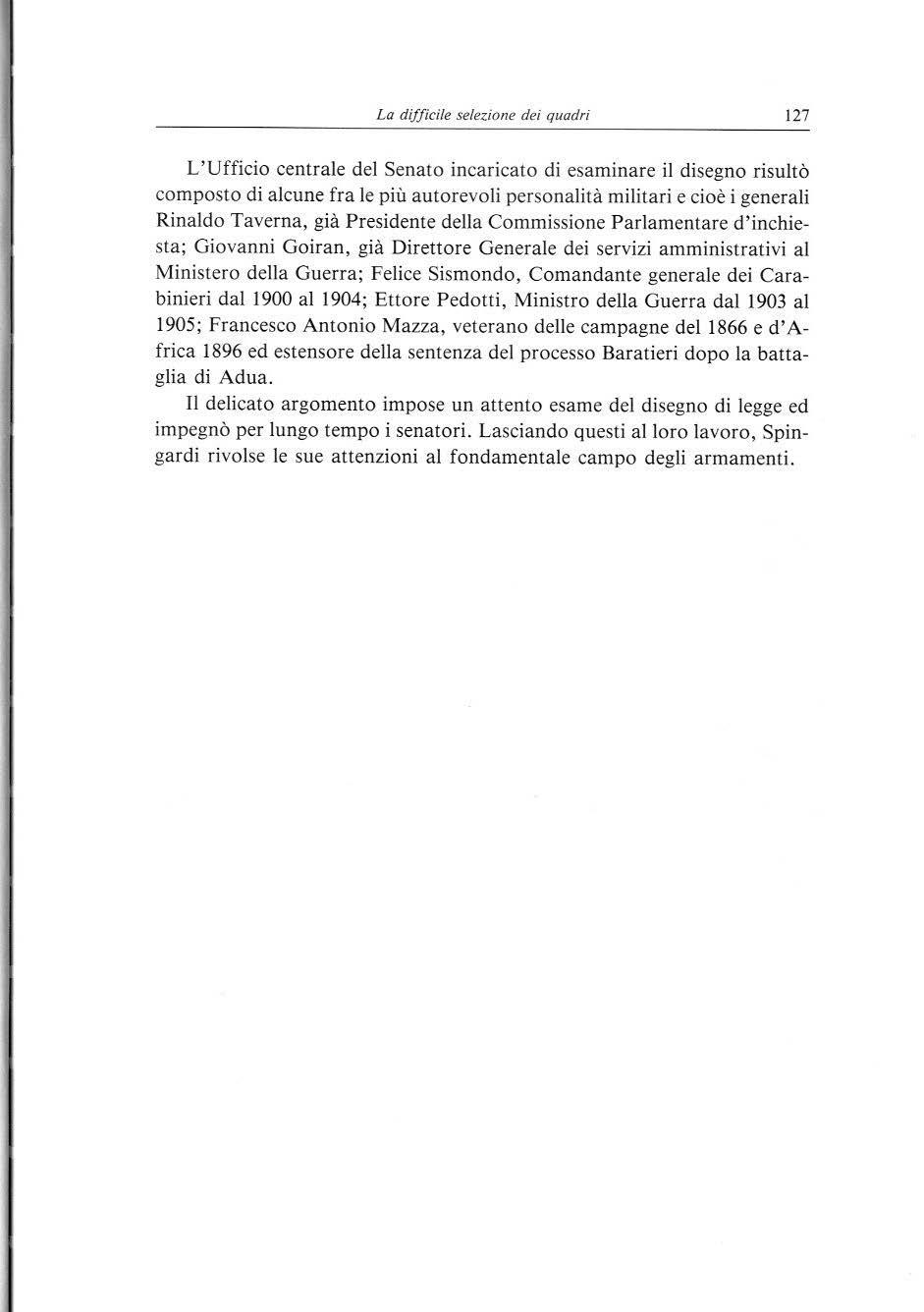


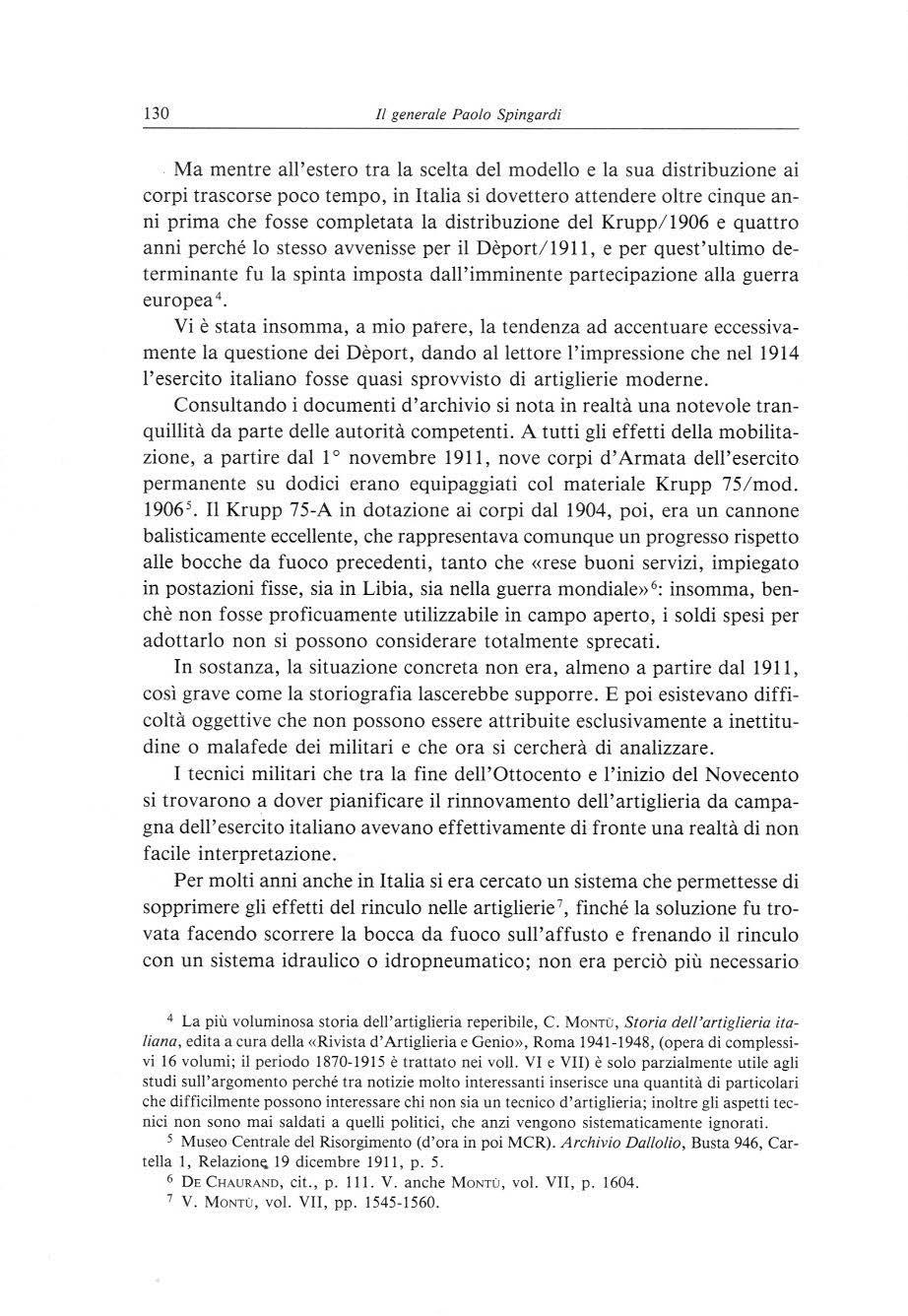
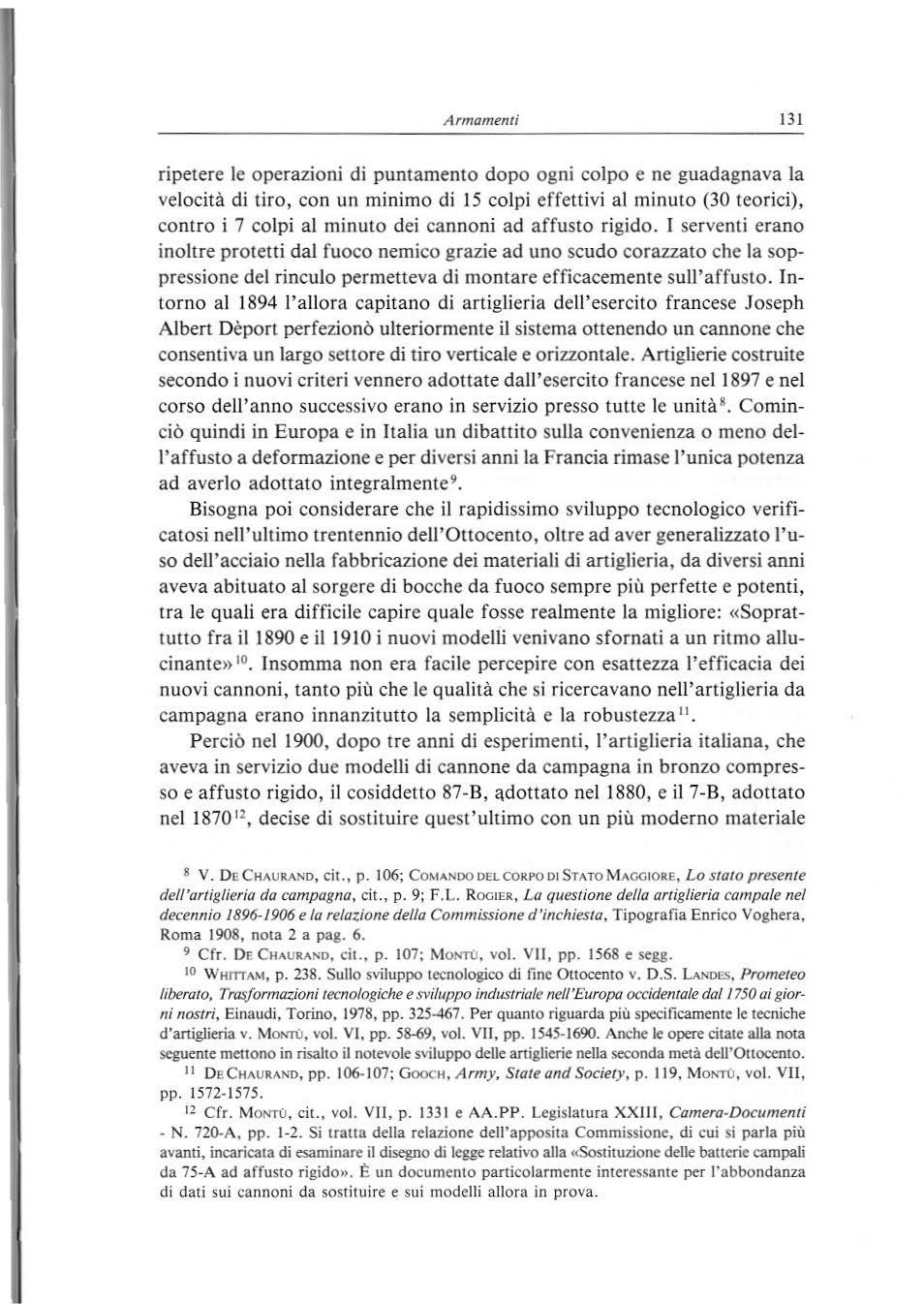
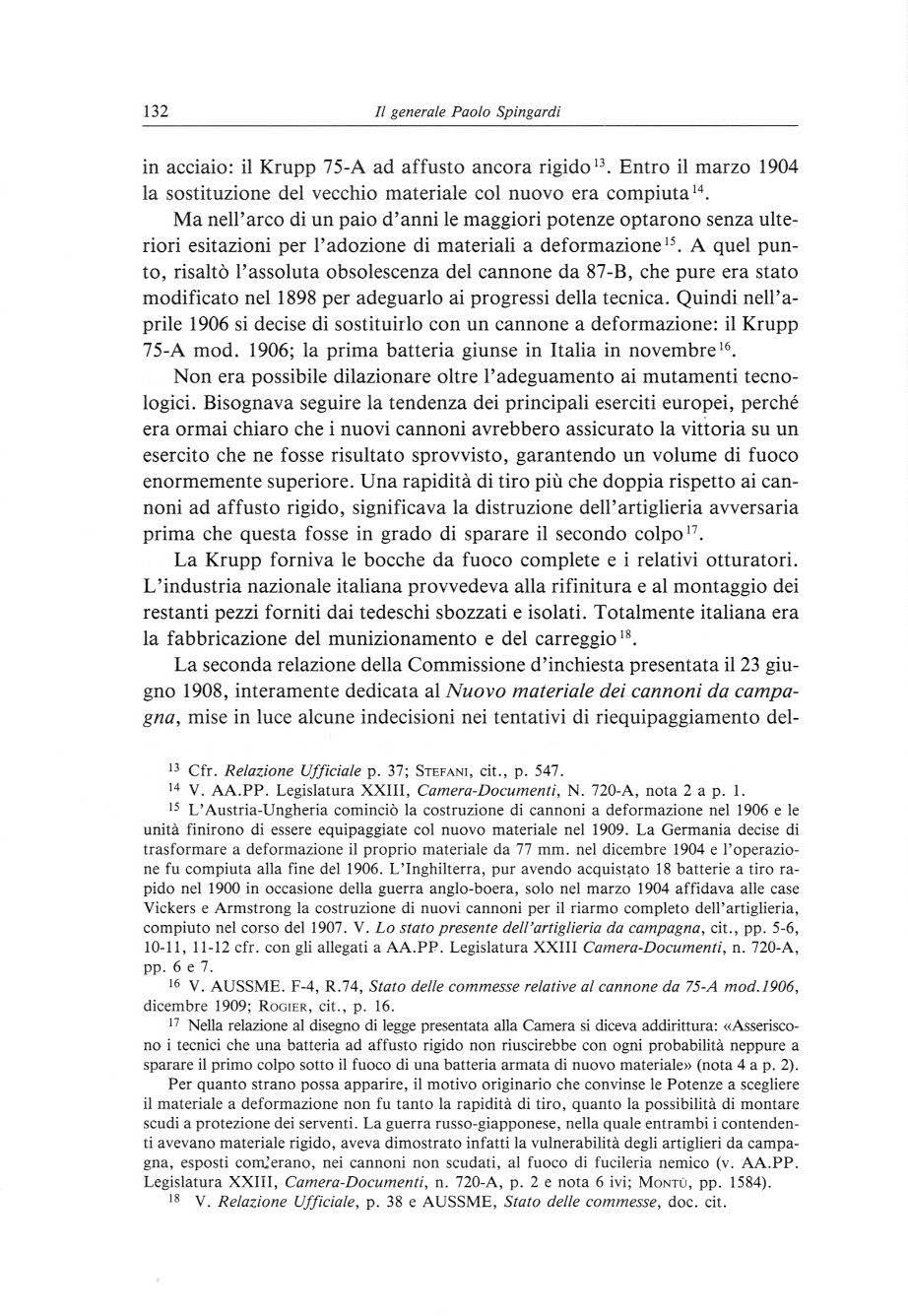
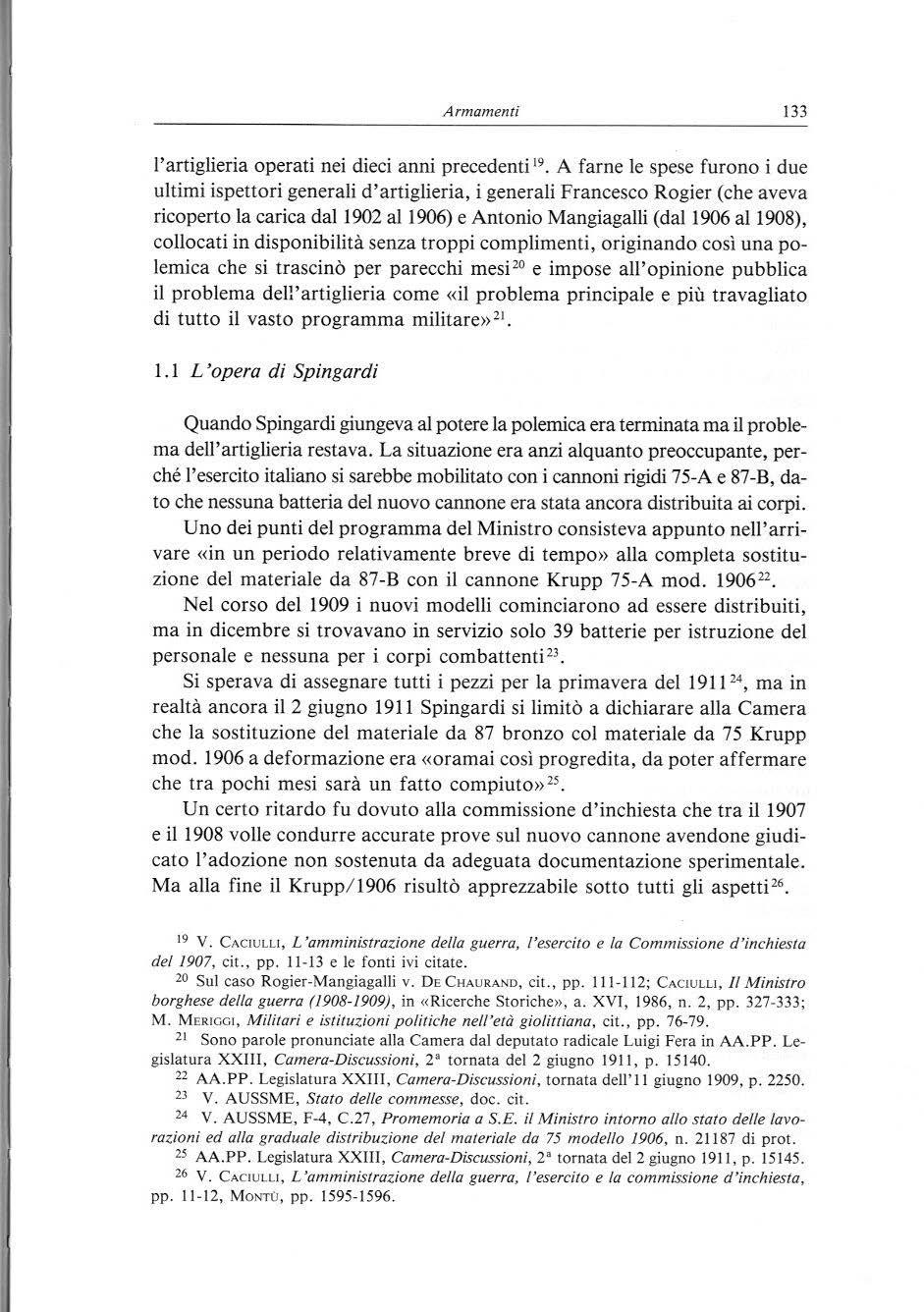
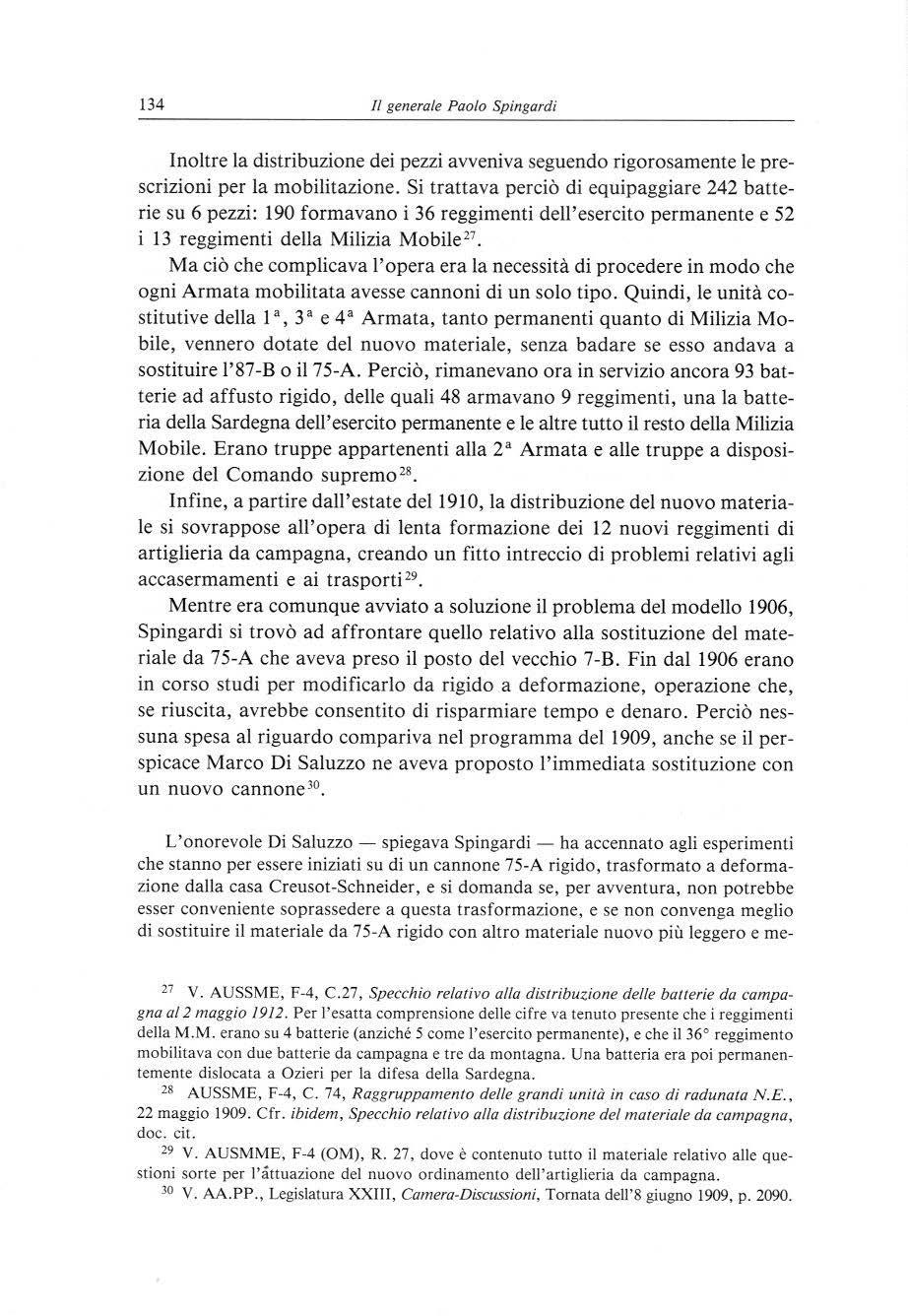
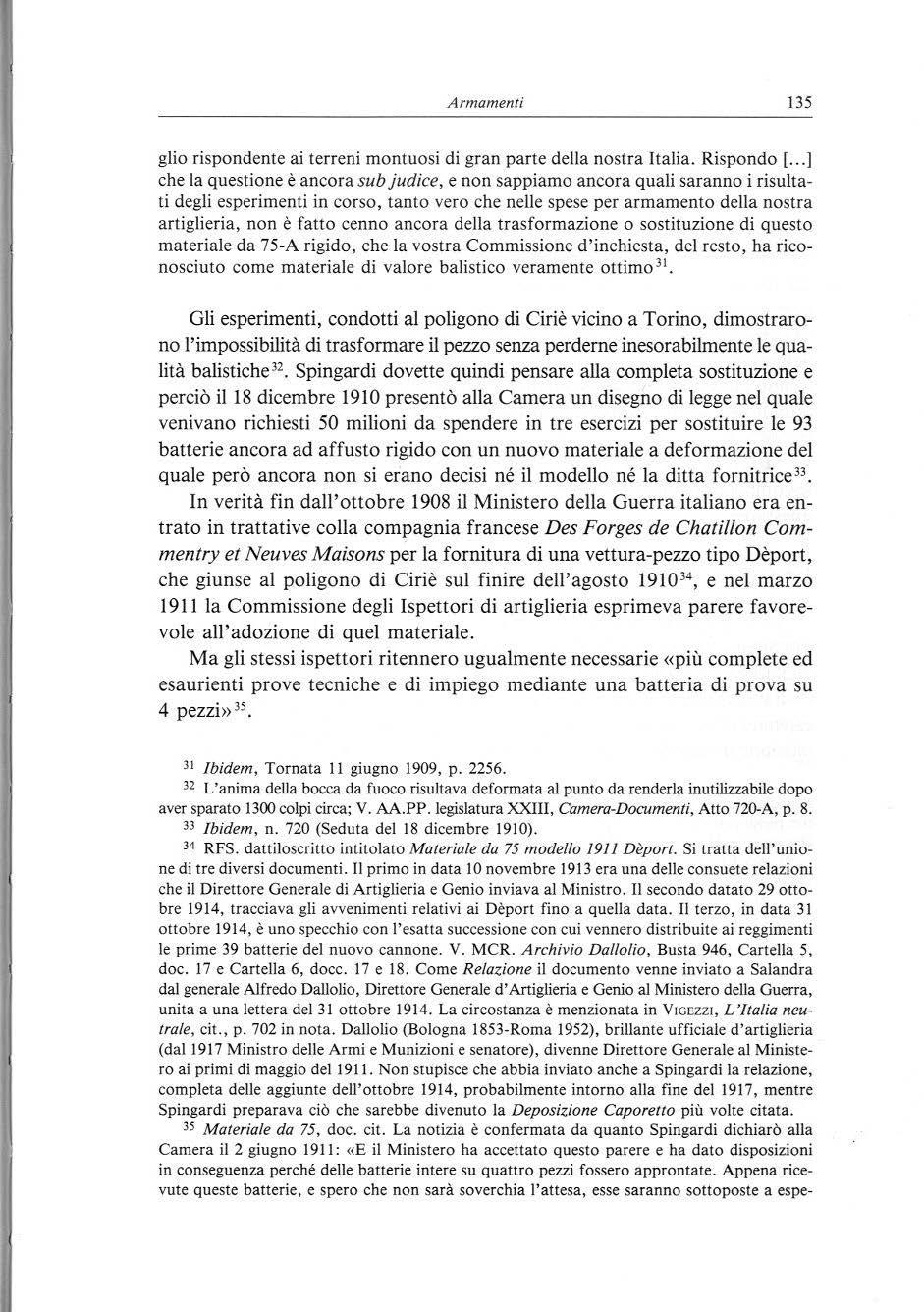
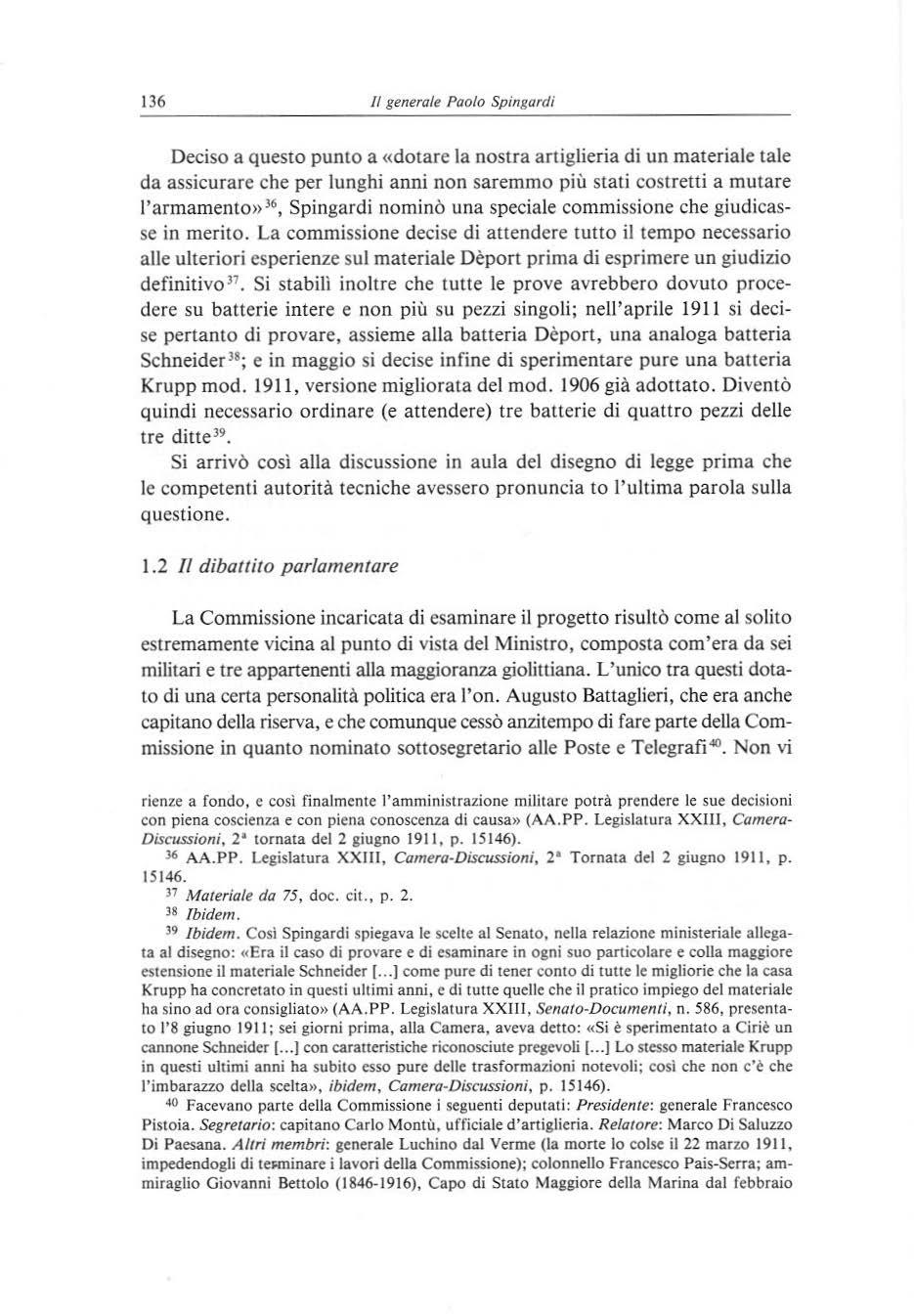
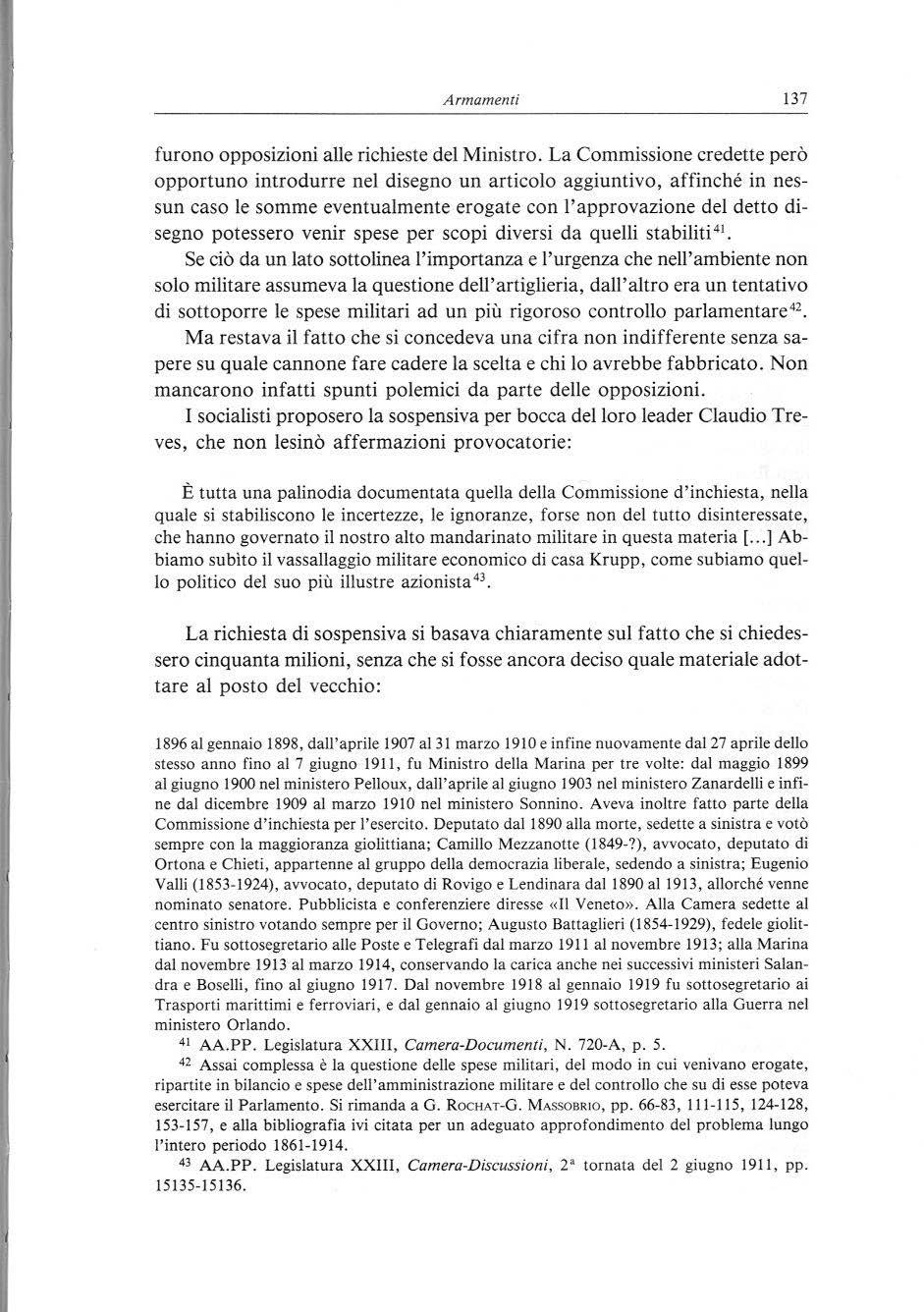
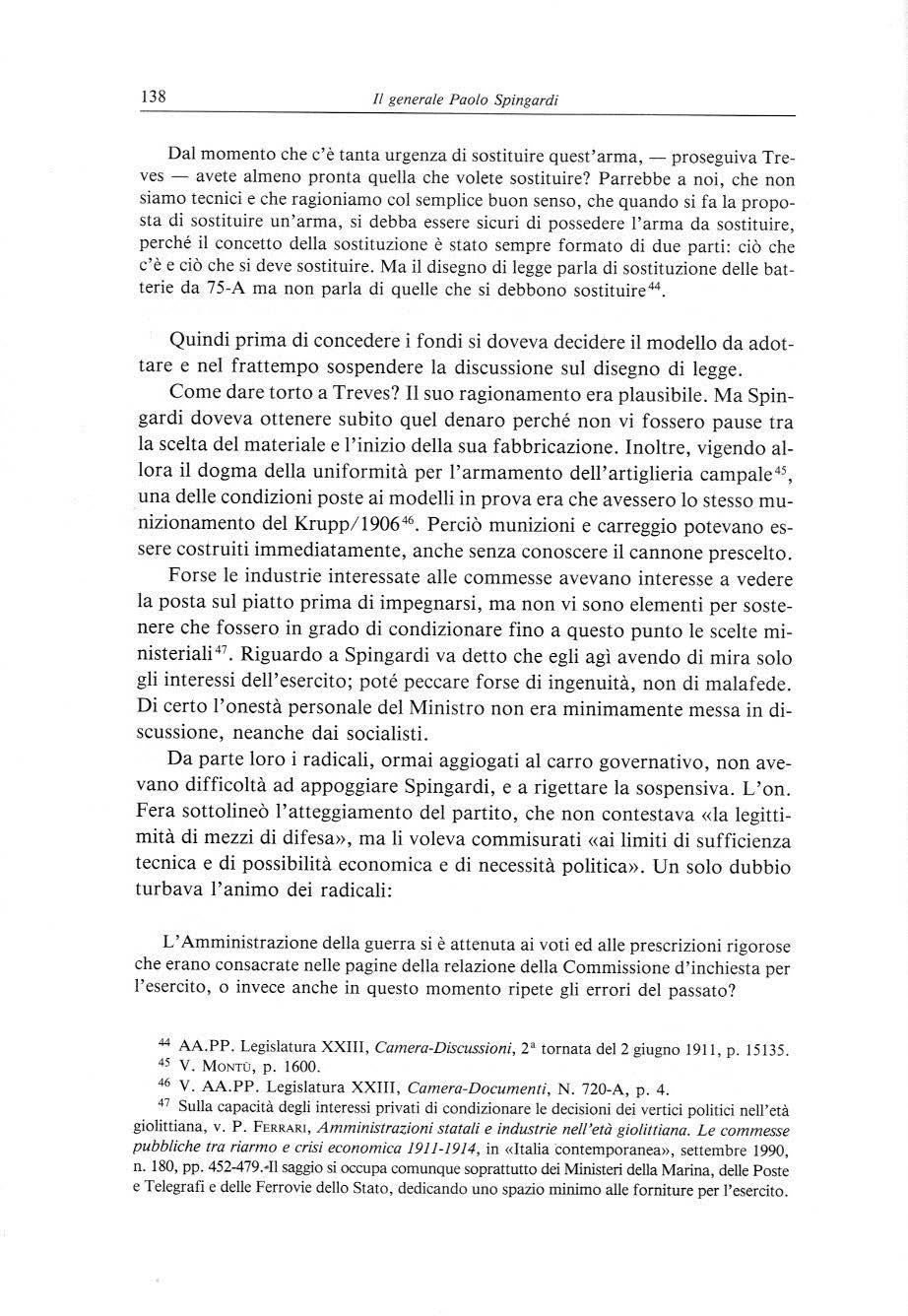
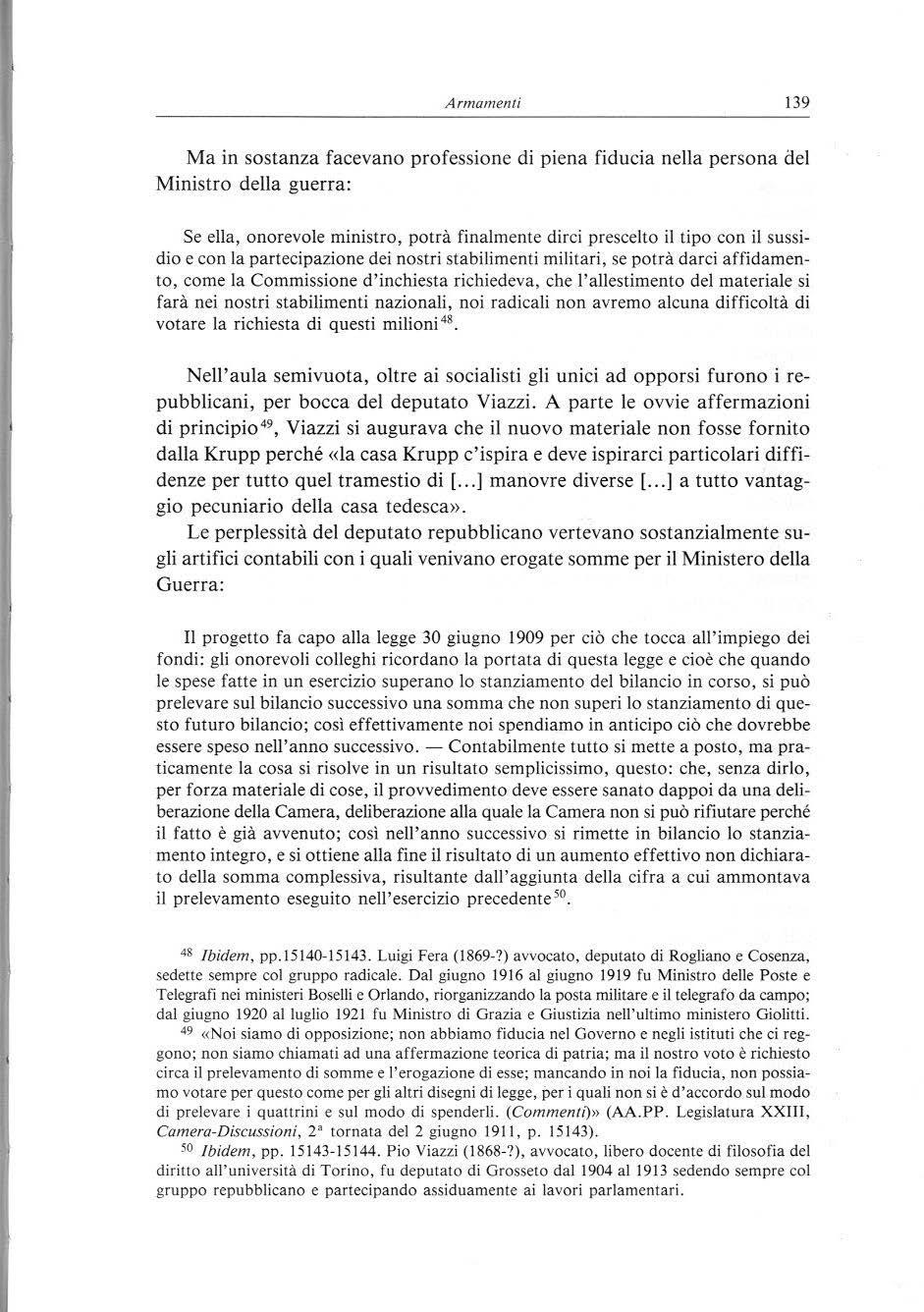
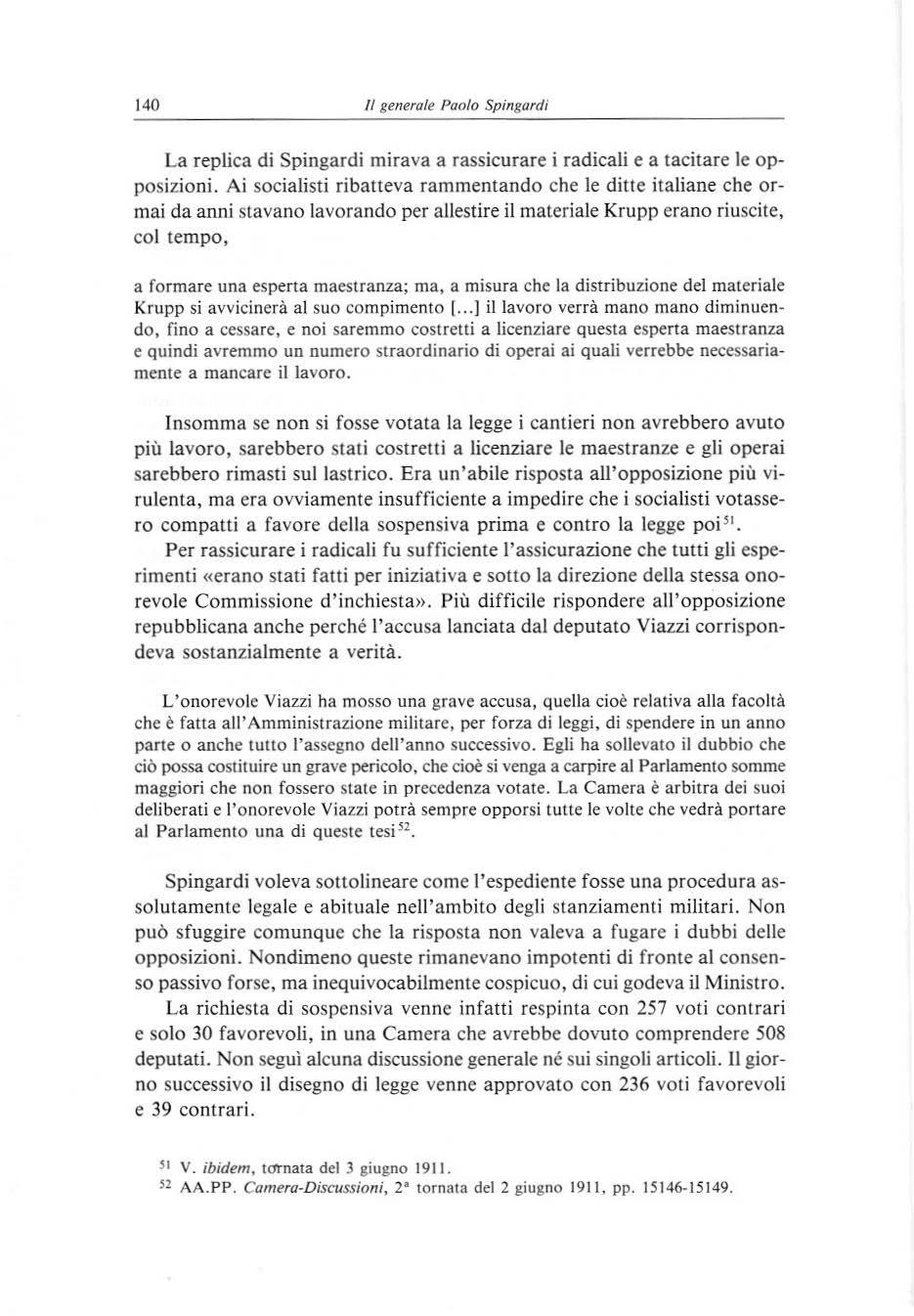
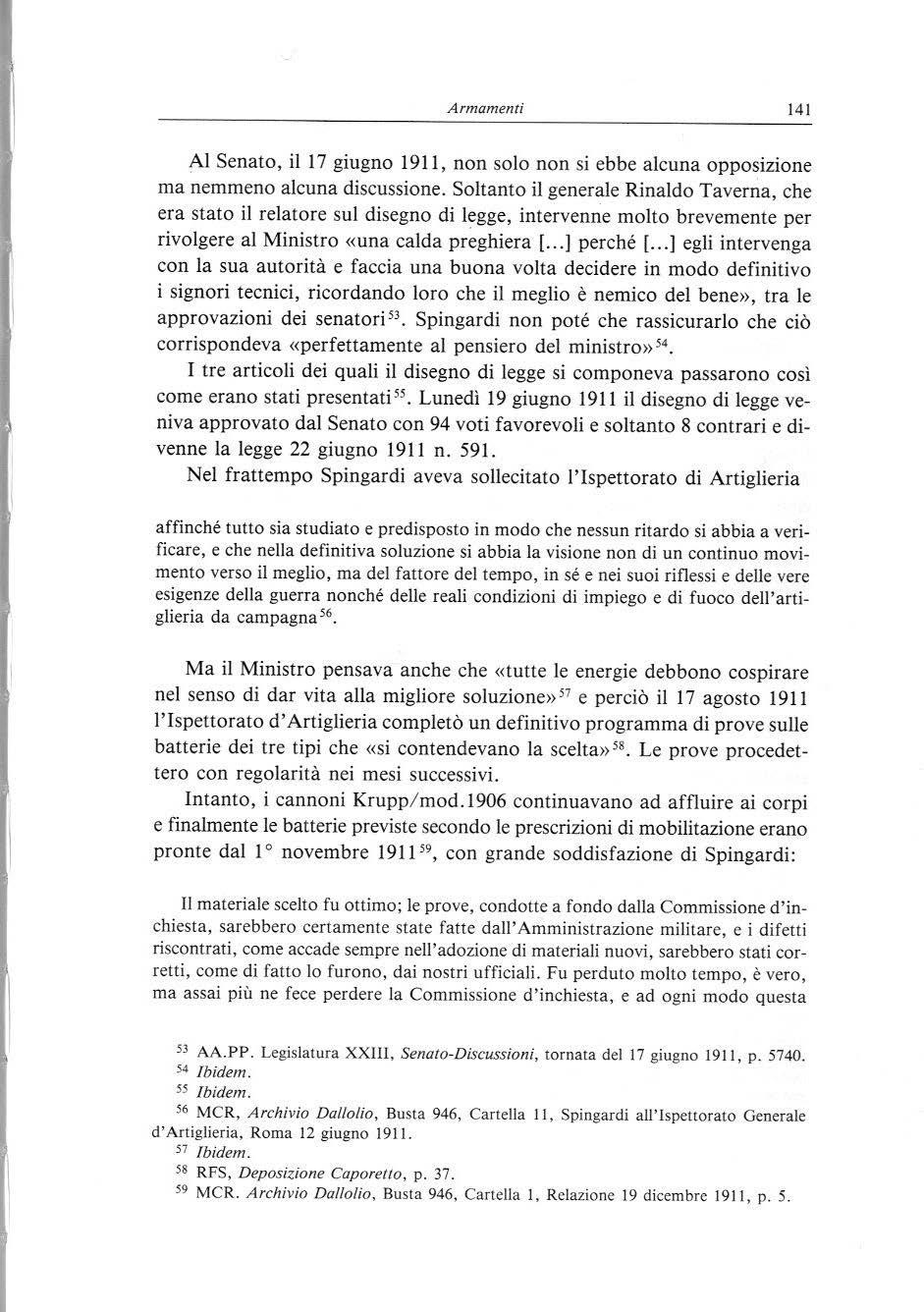

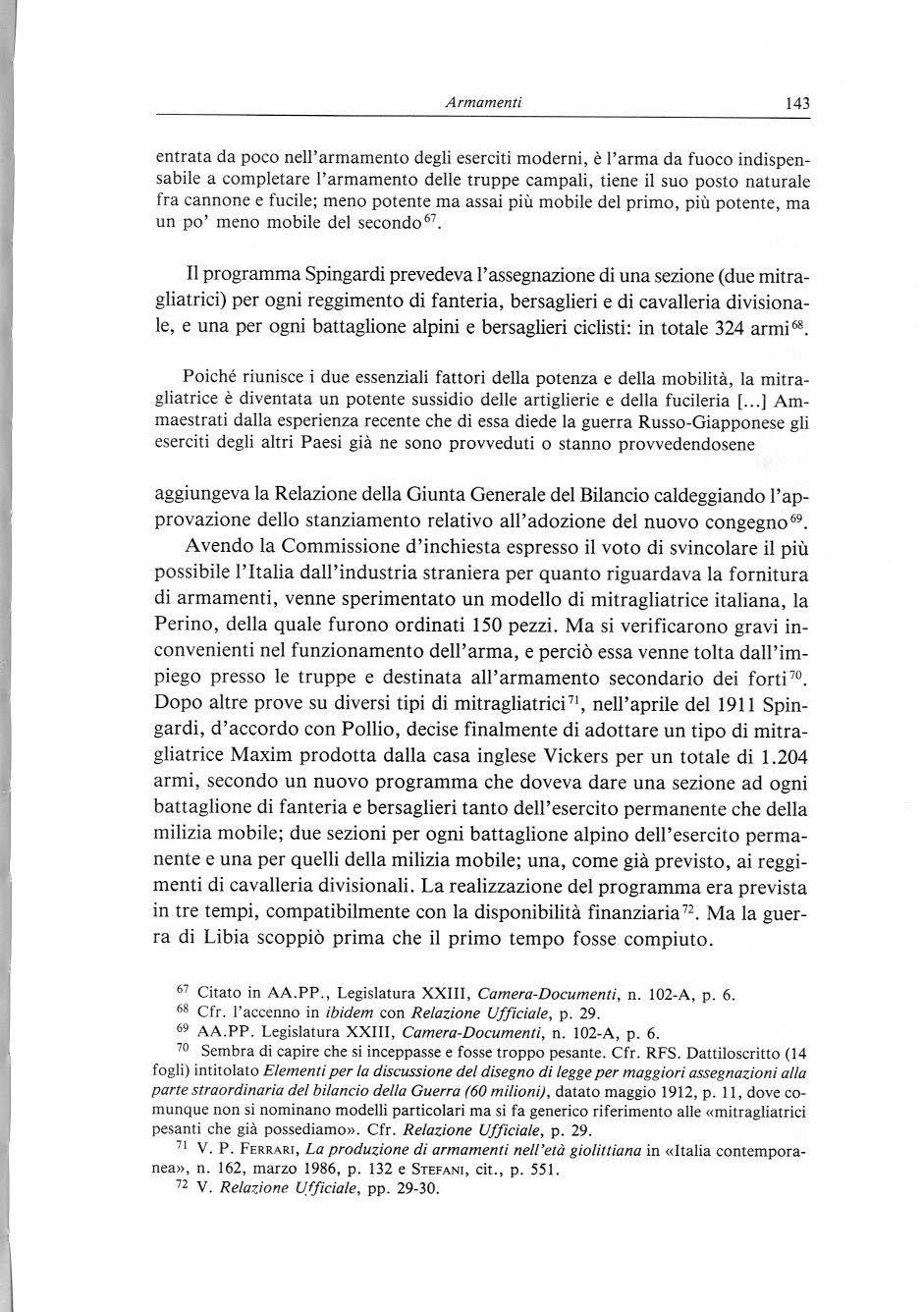
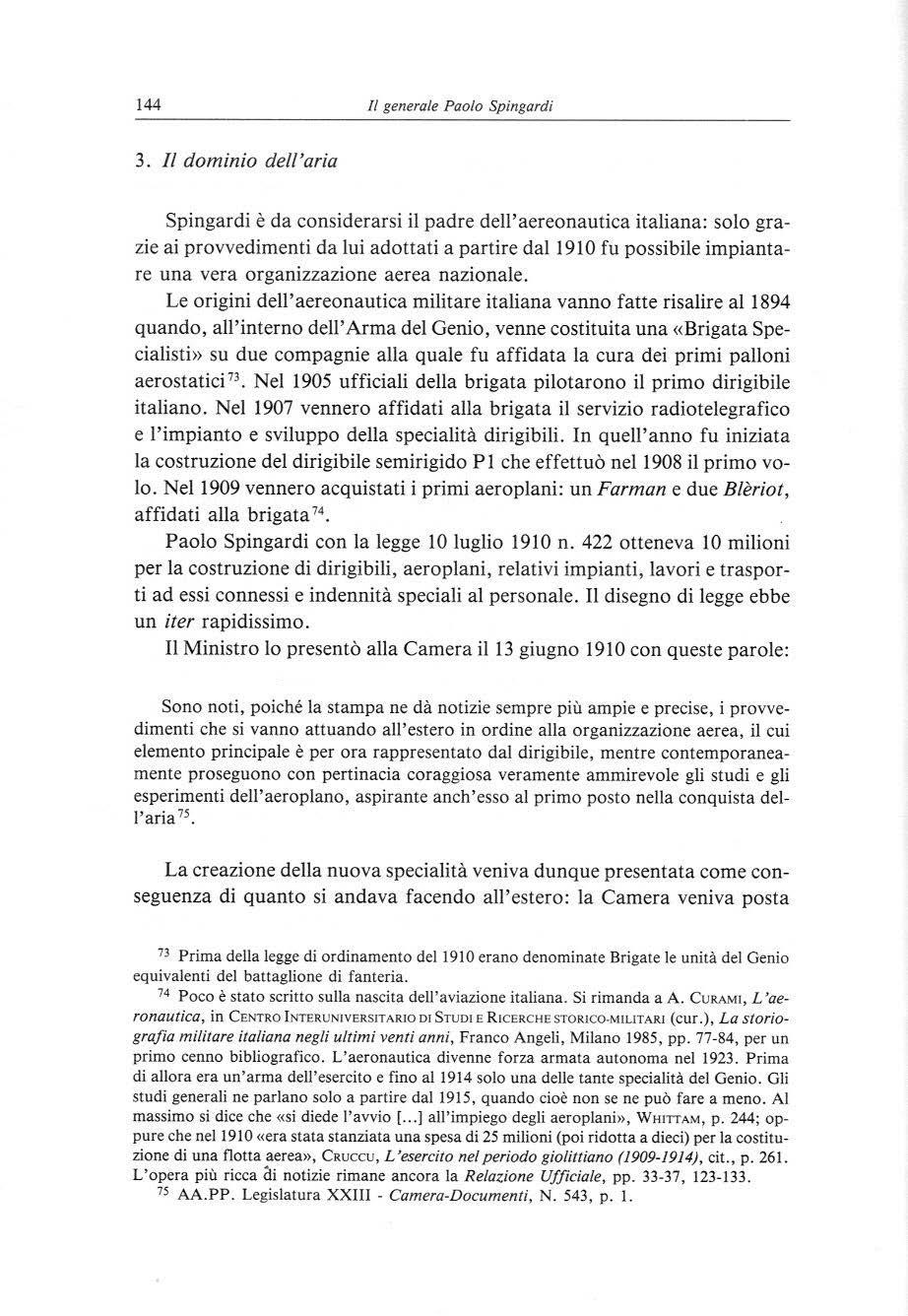
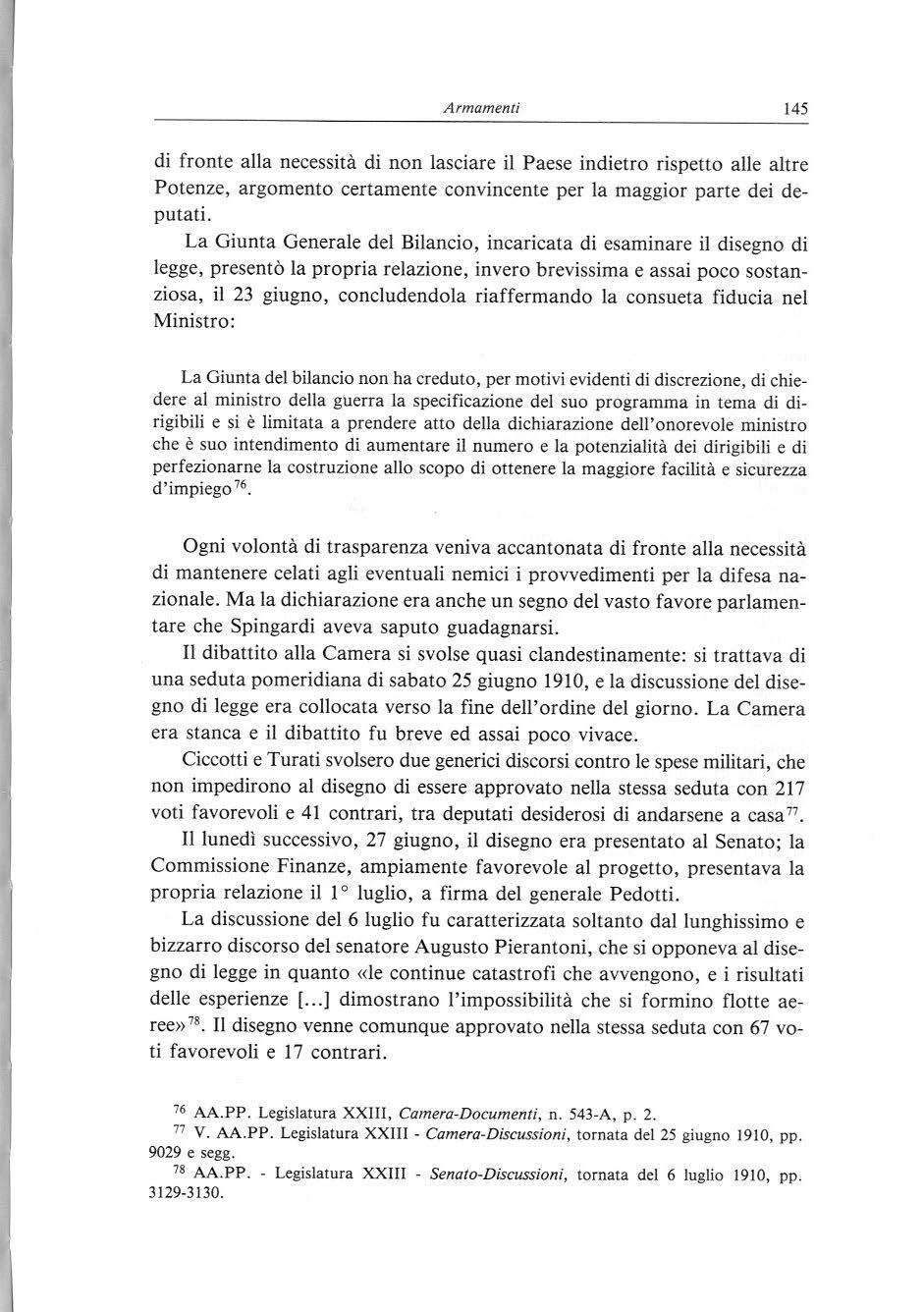
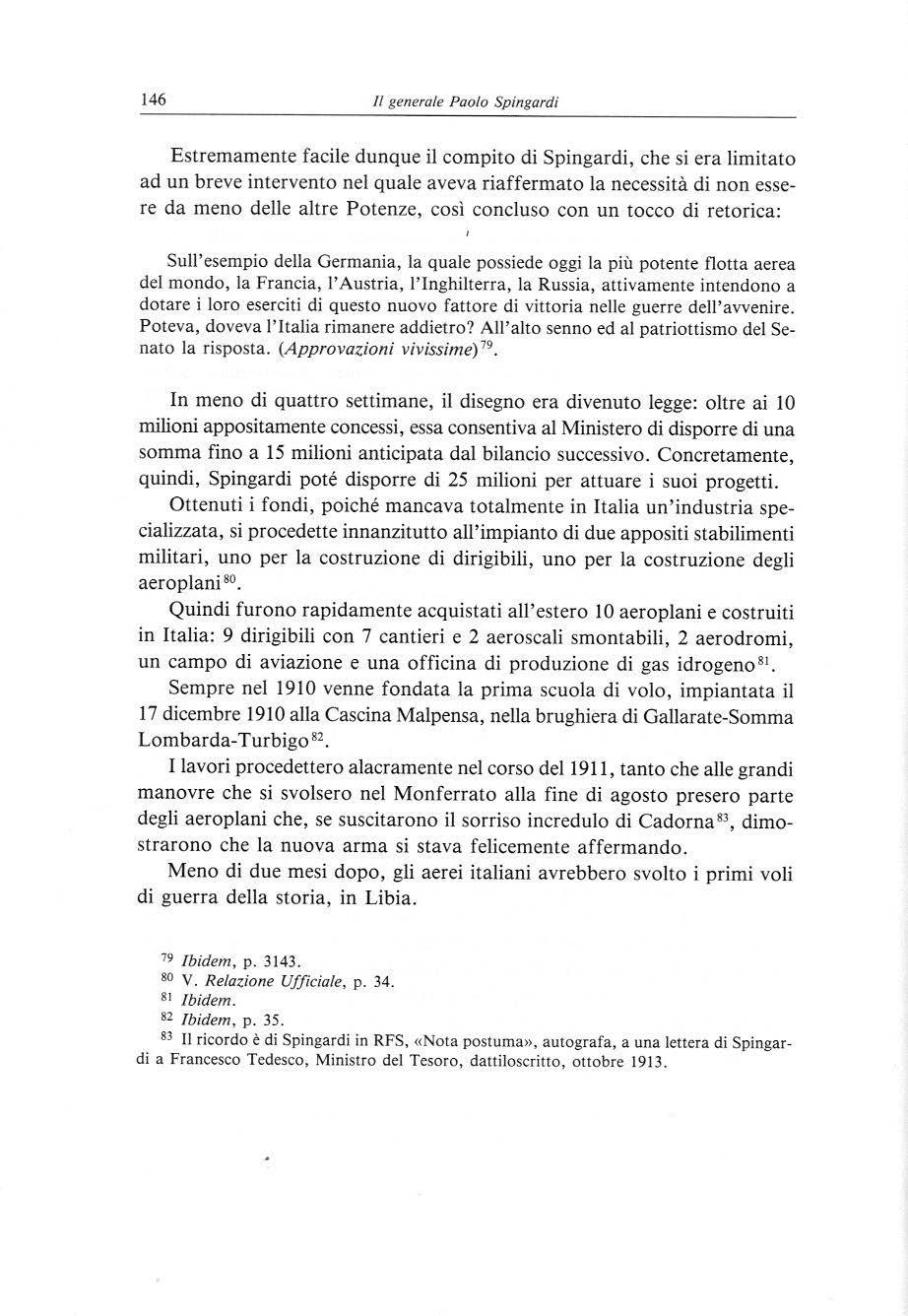
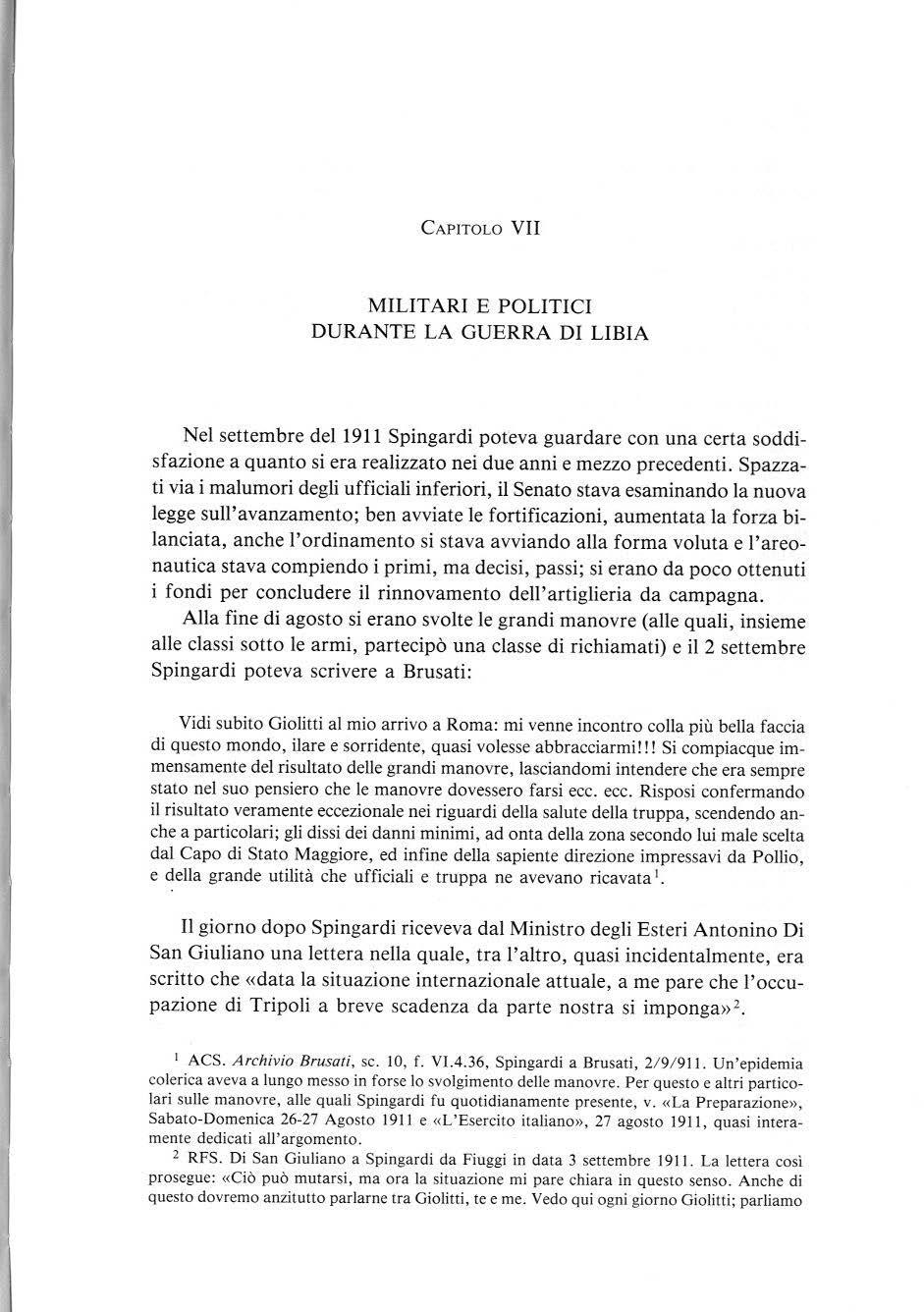
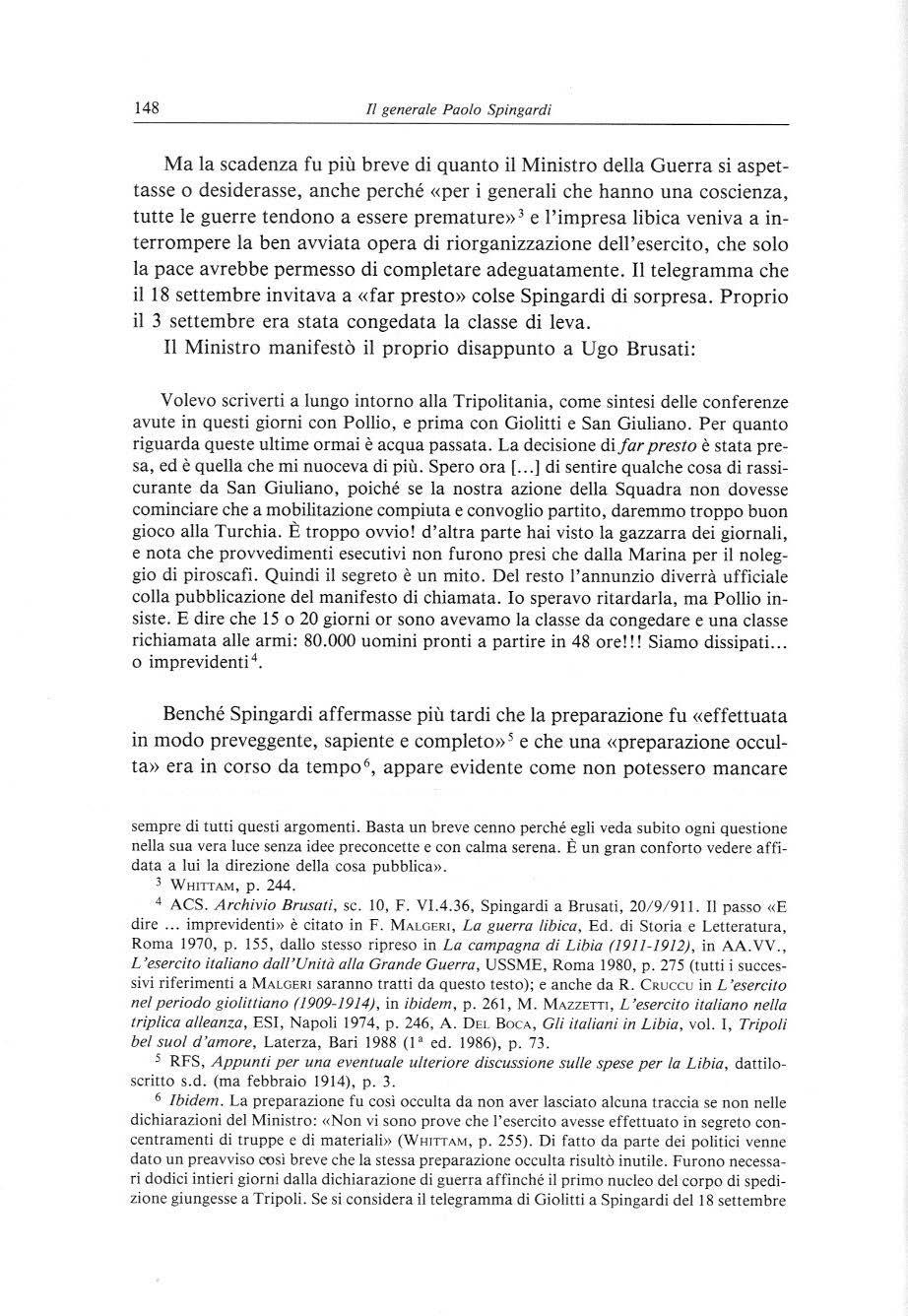

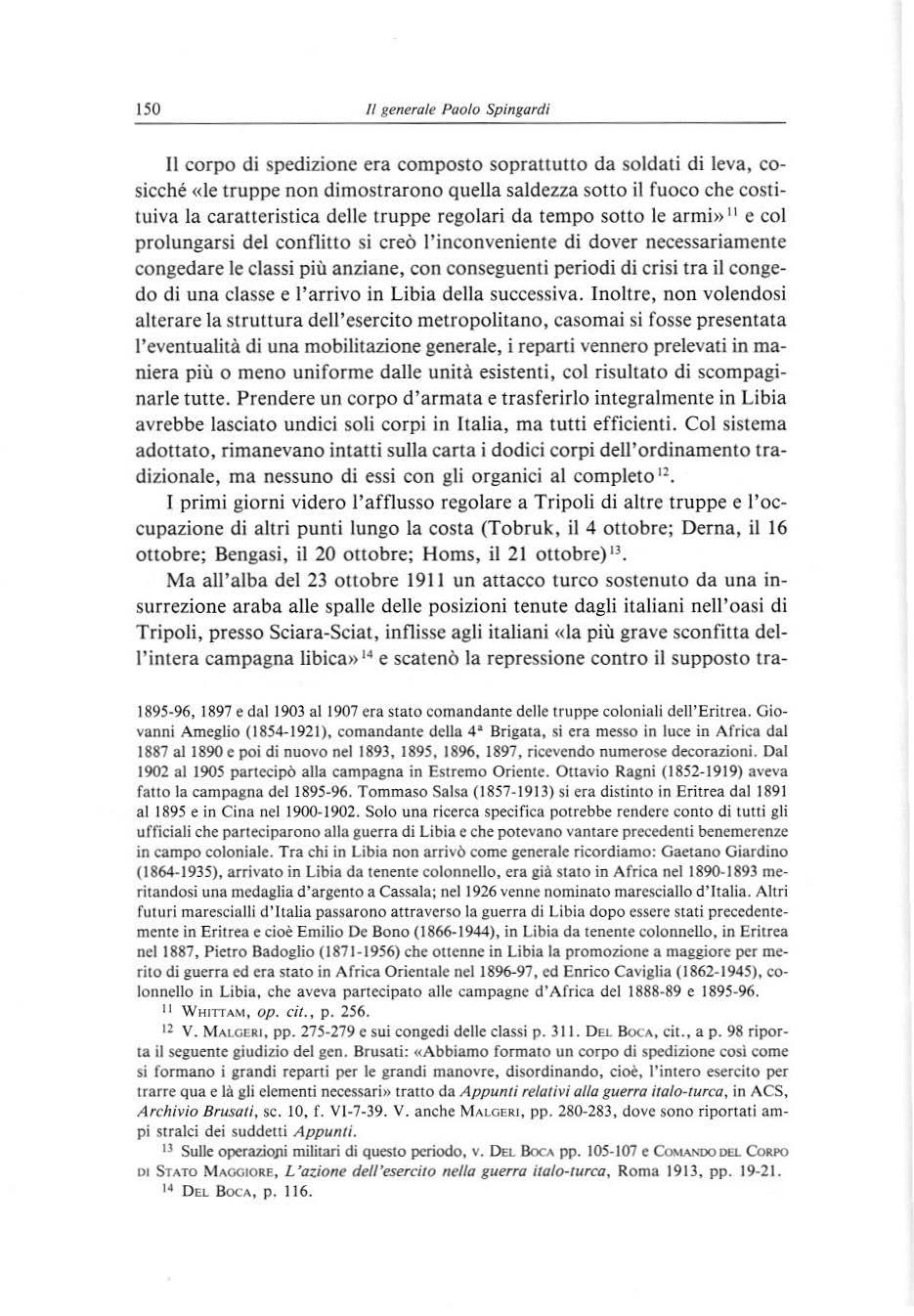
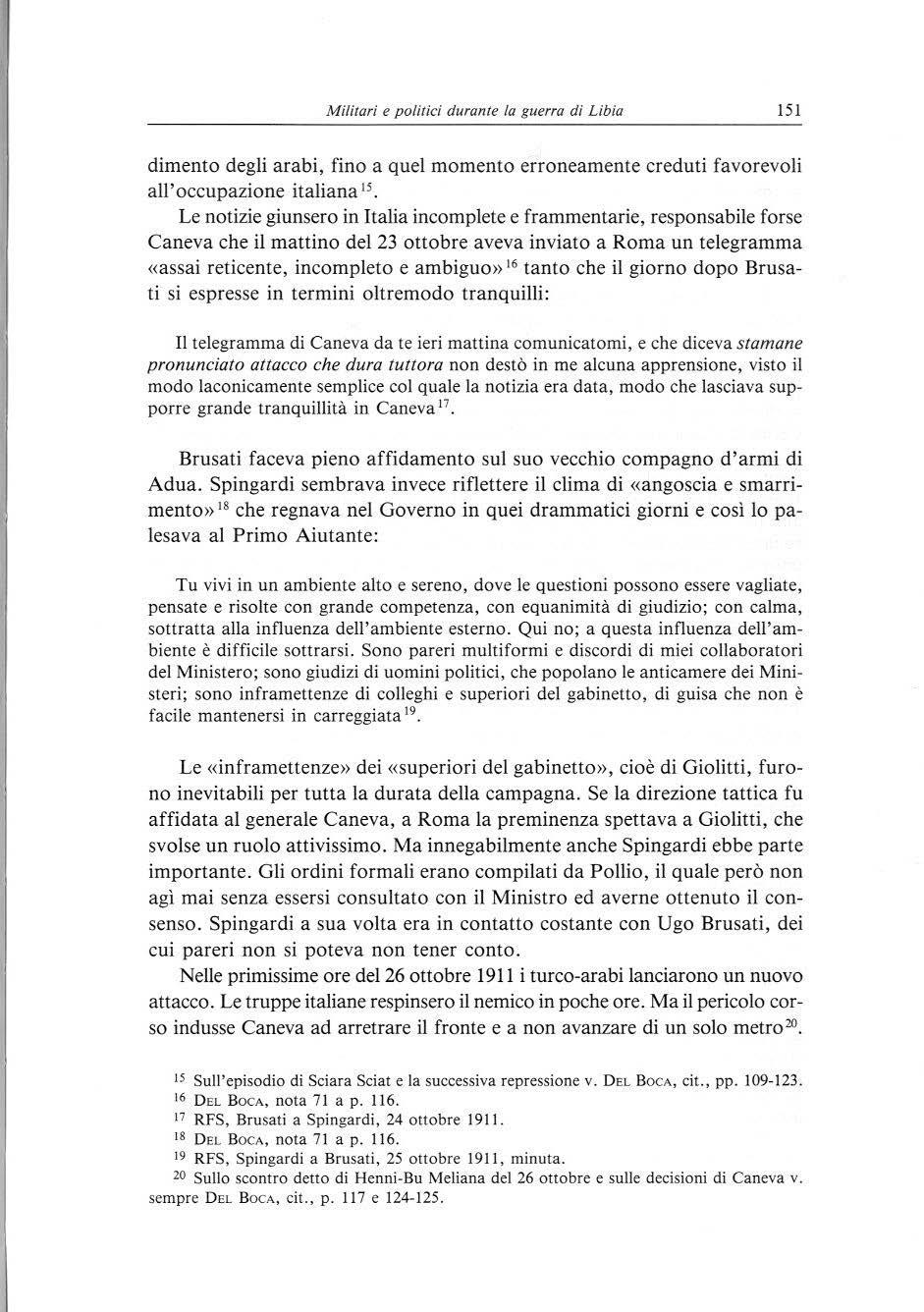
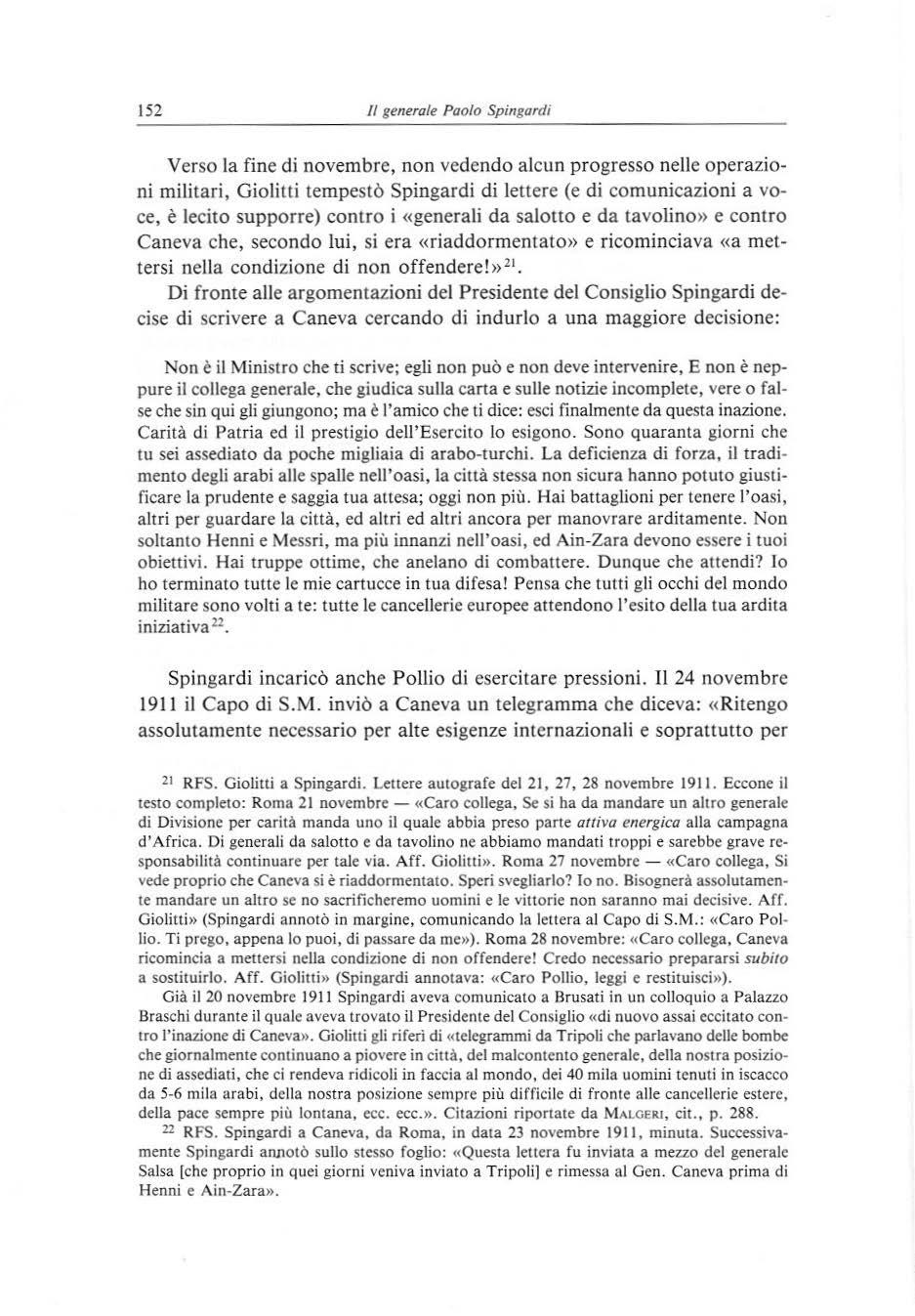
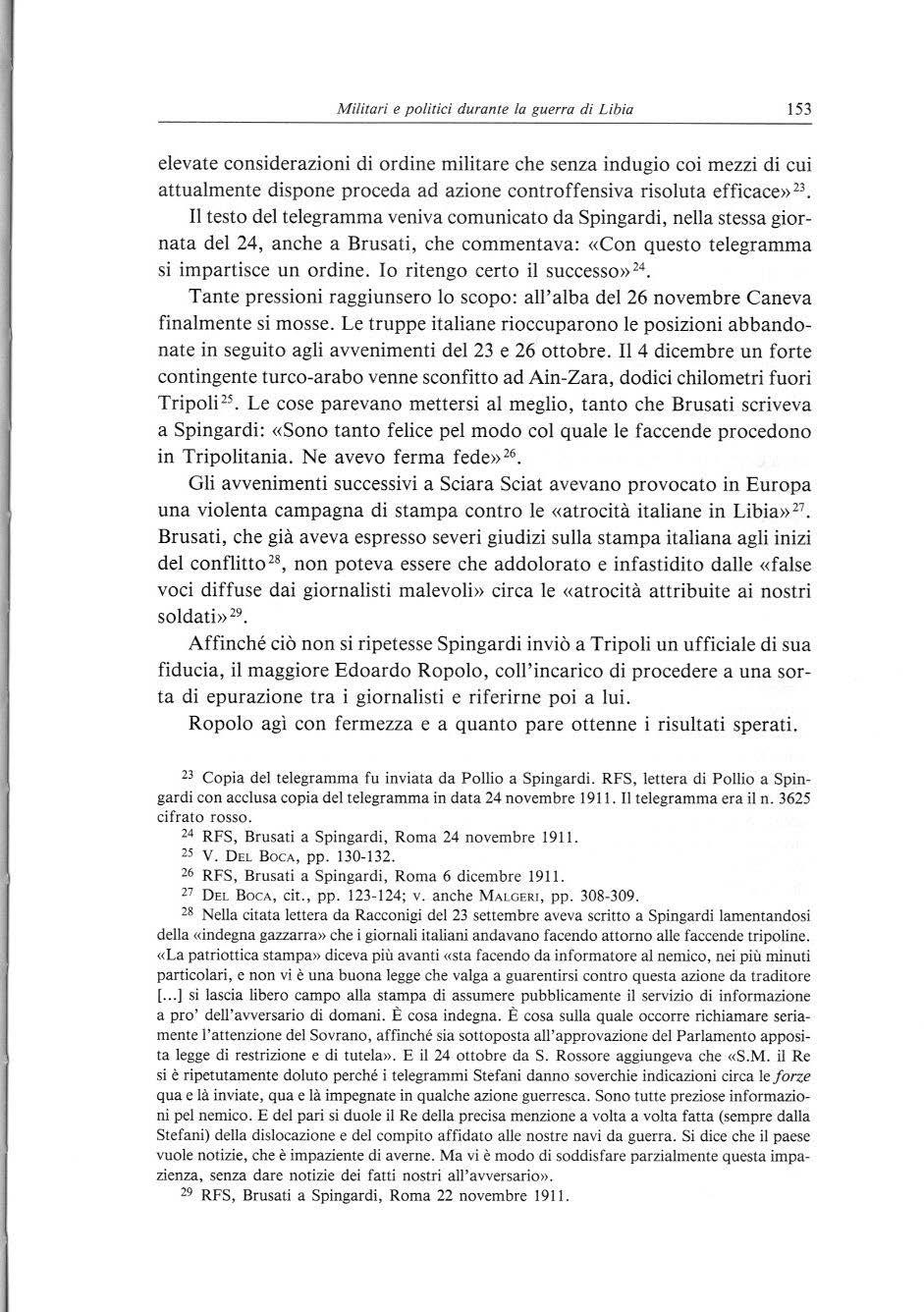
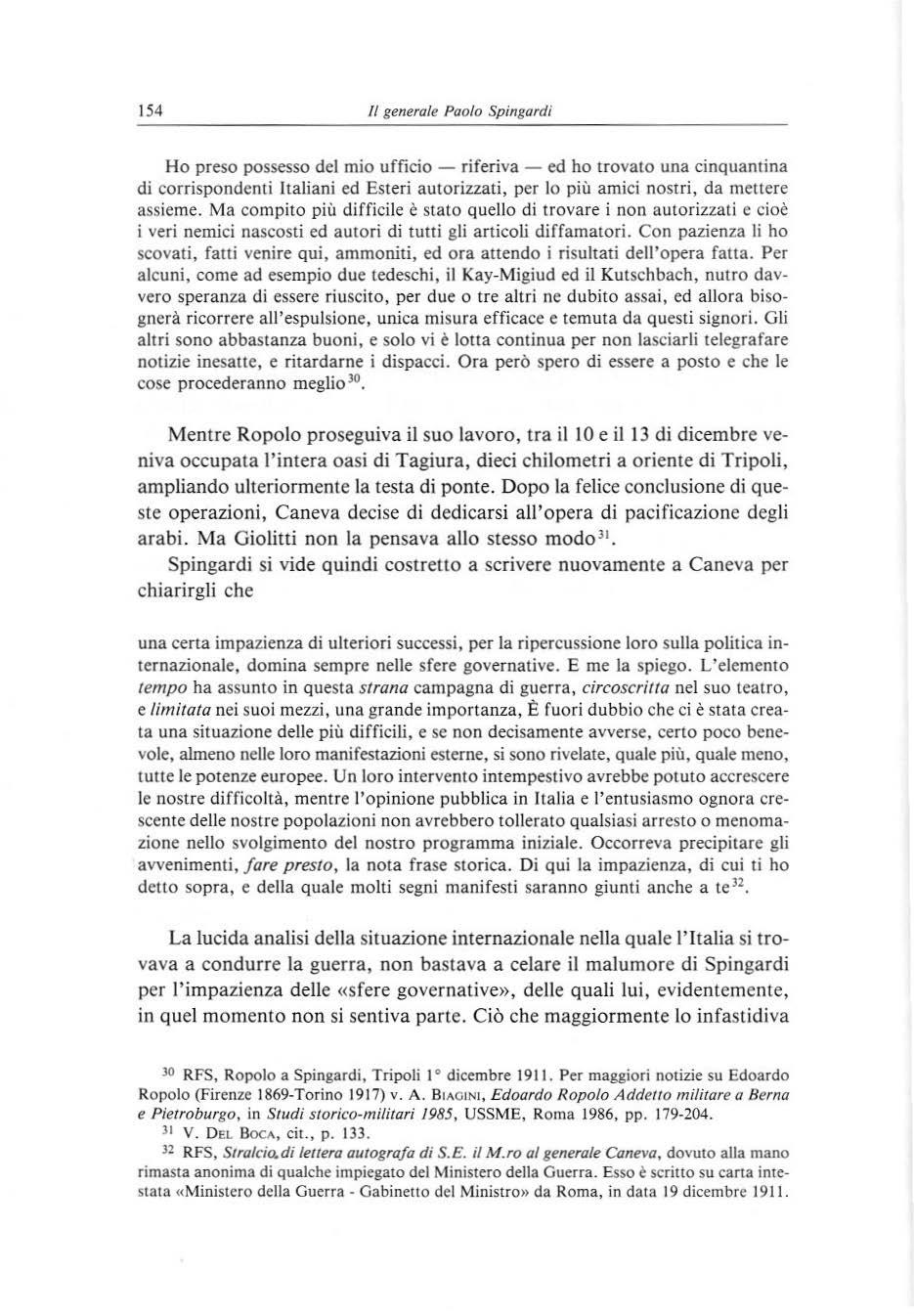

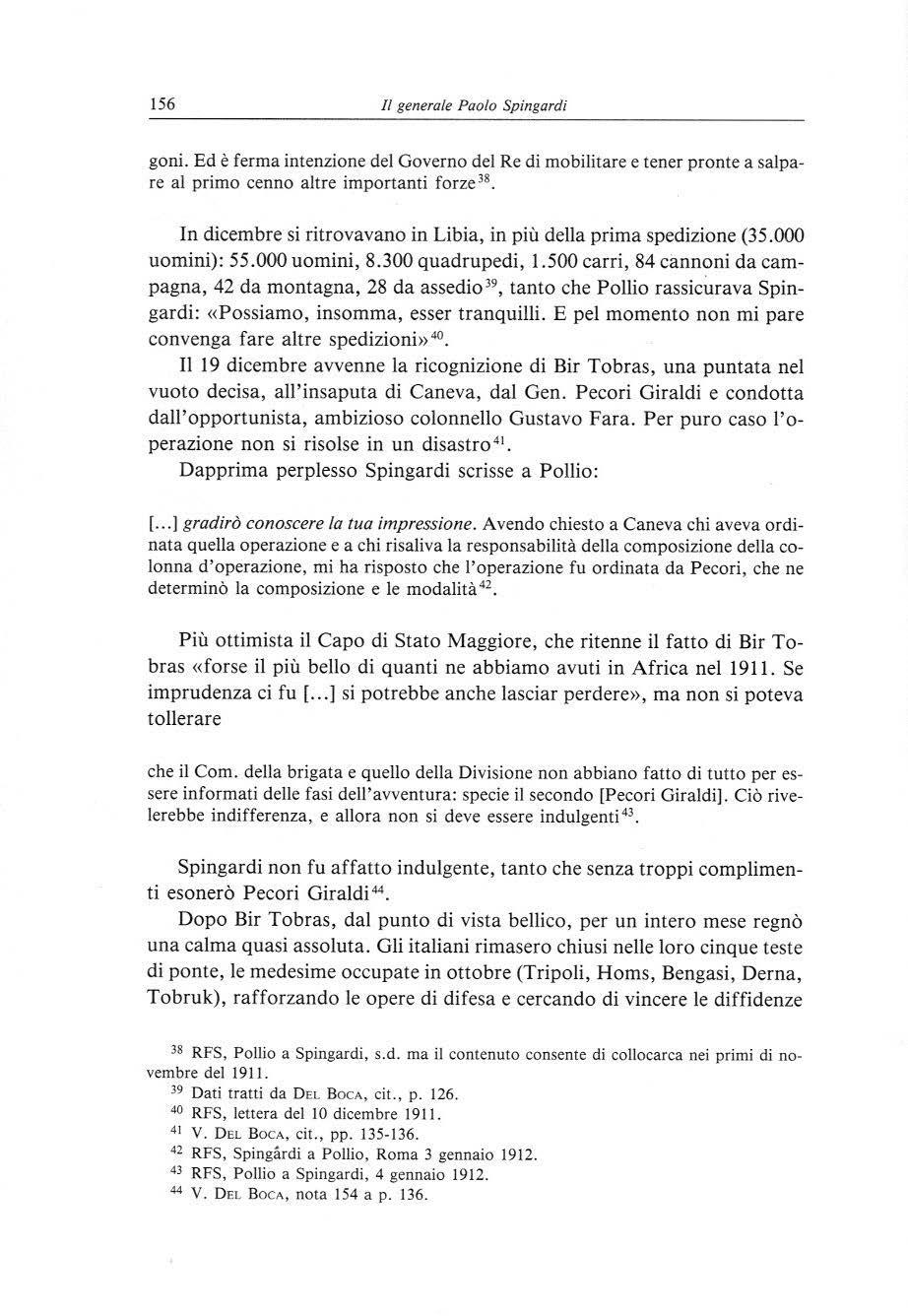
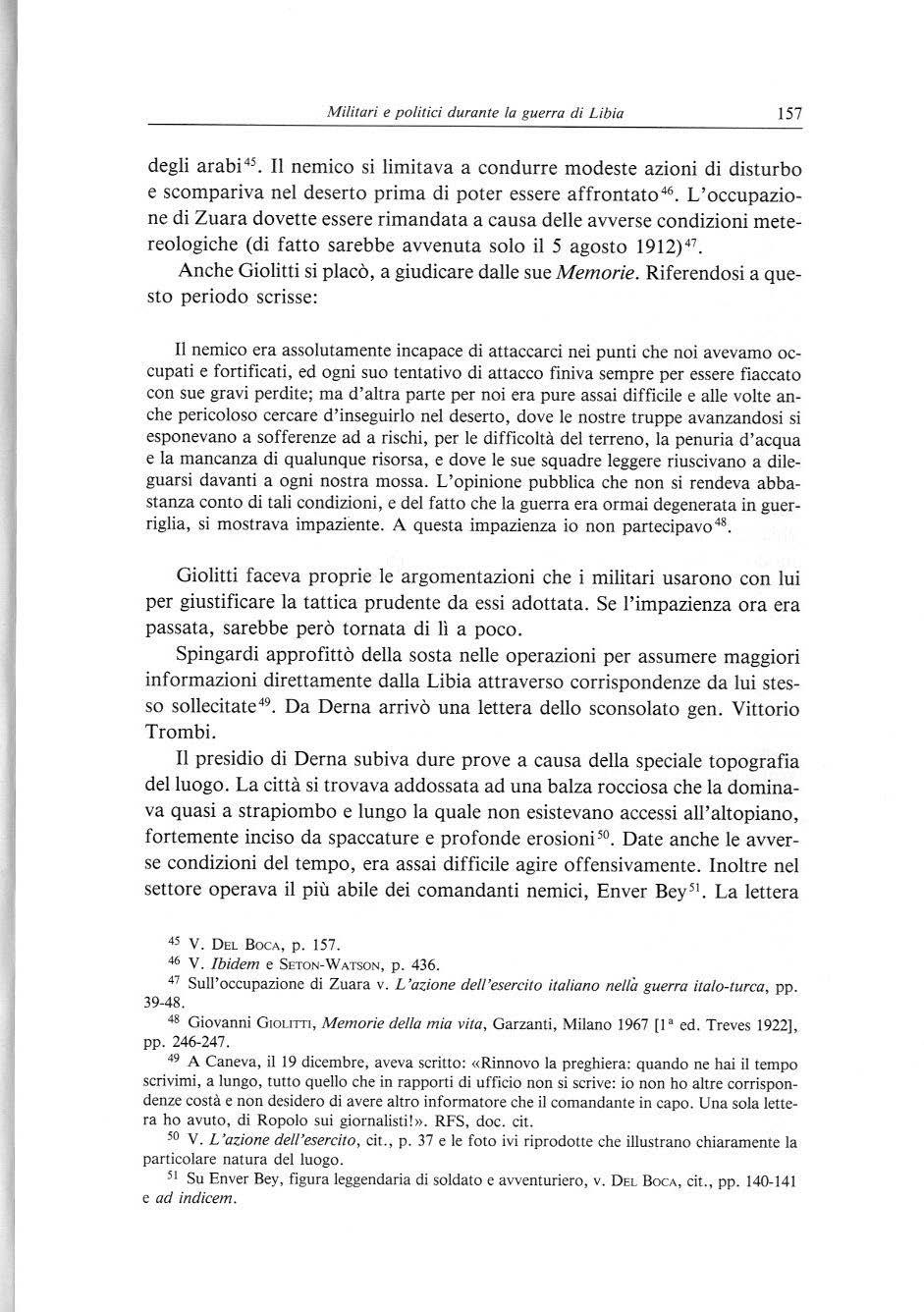
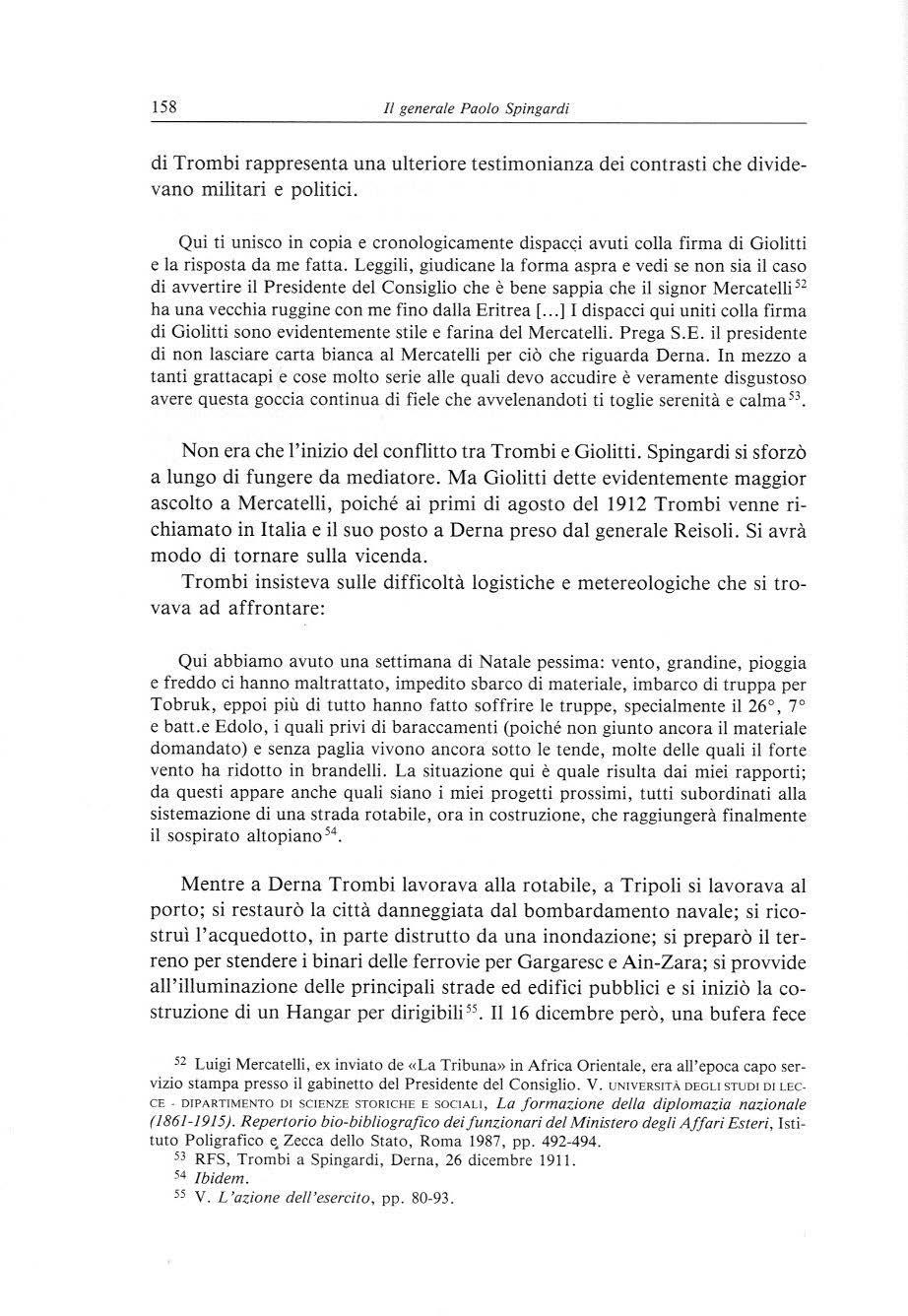
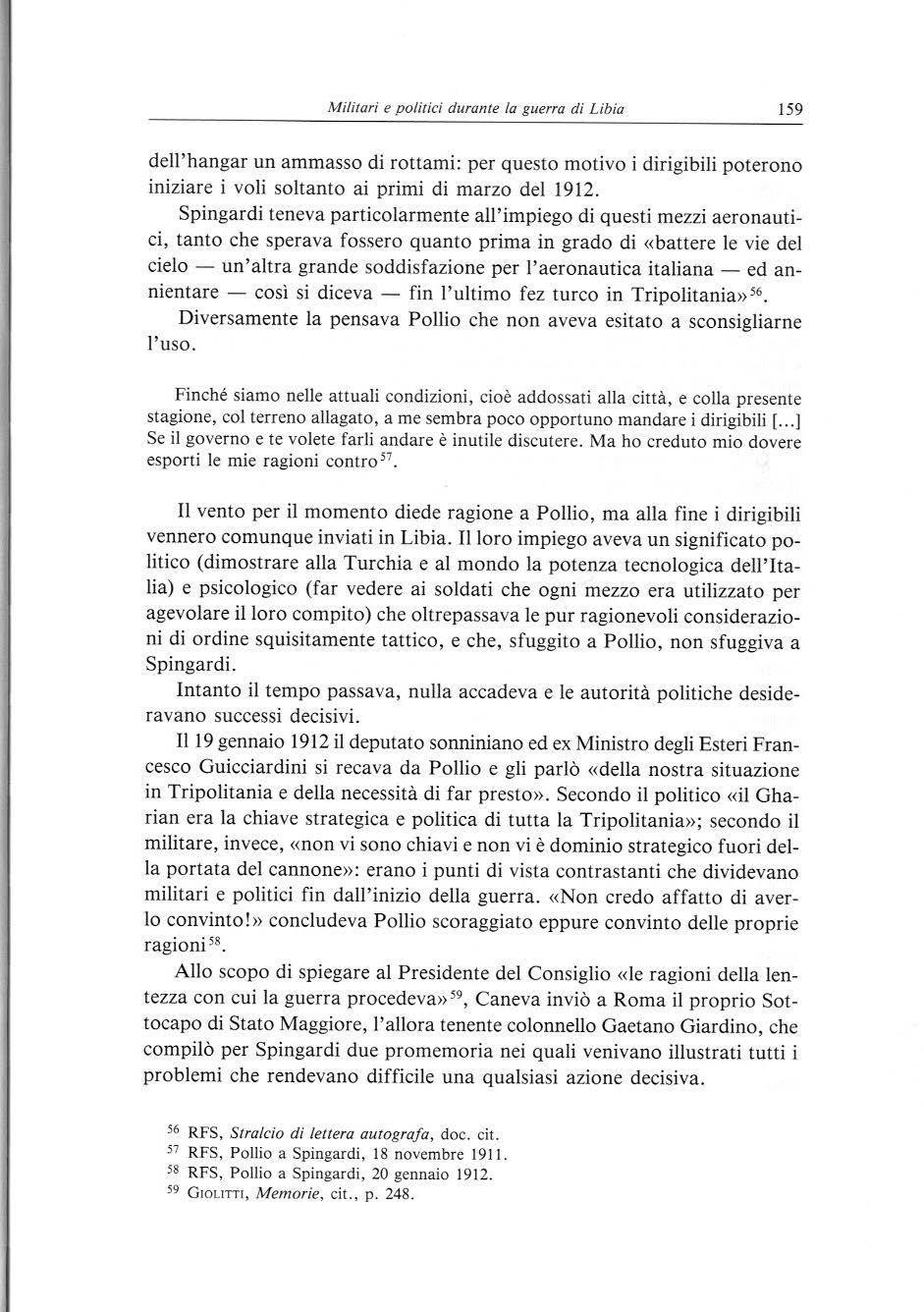 generale Paolo Spingardi
generale Paolo Spingardi
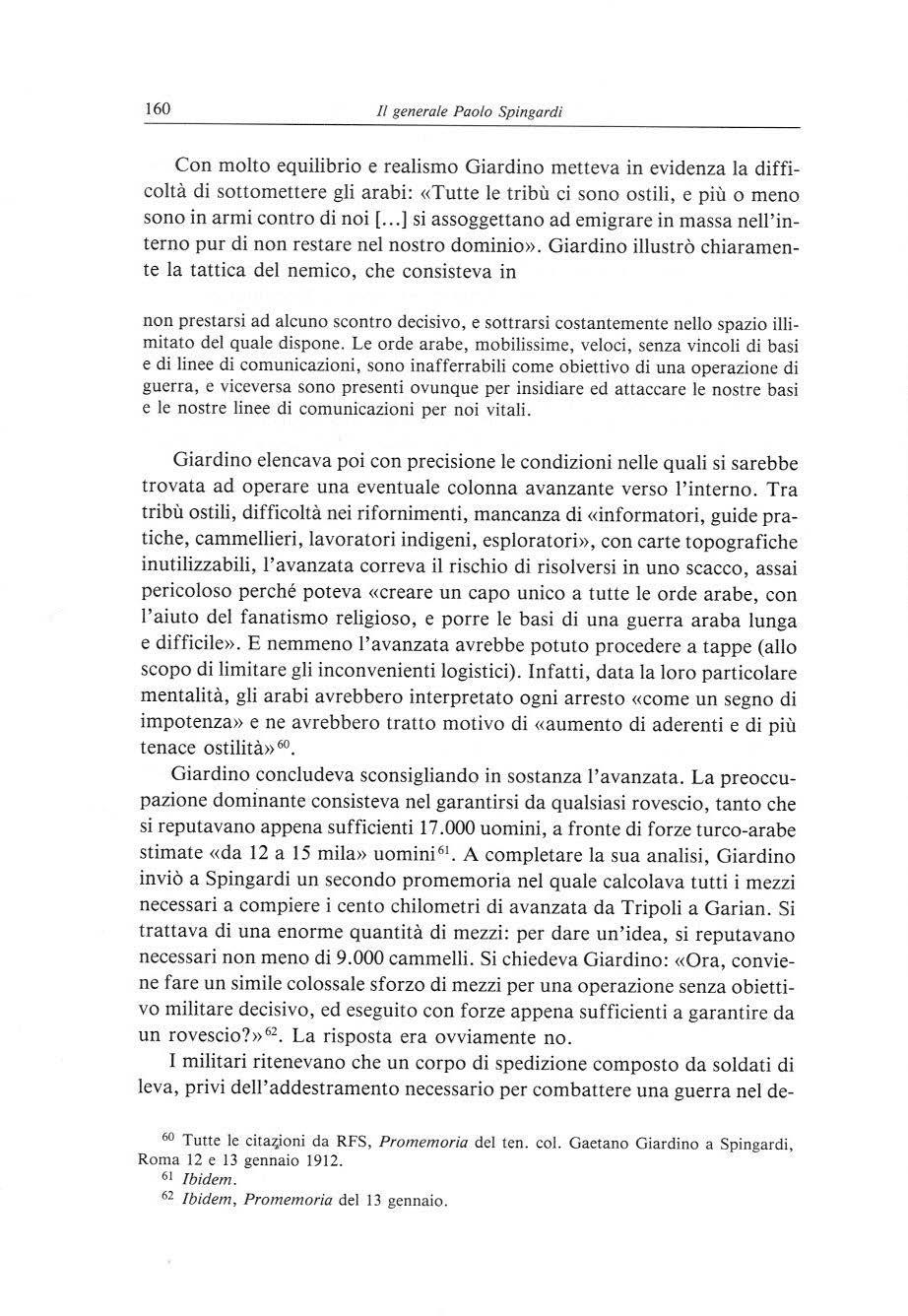
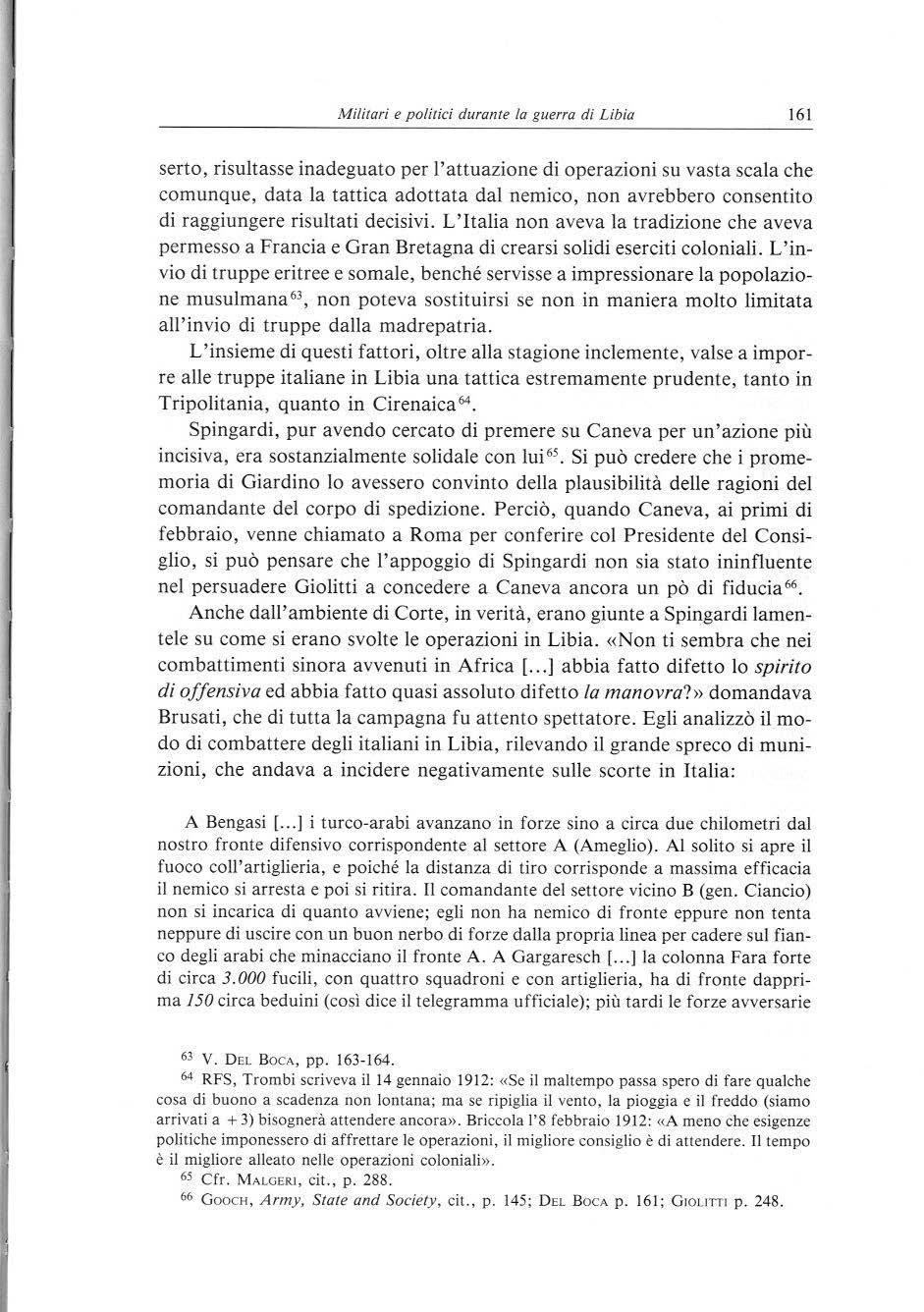
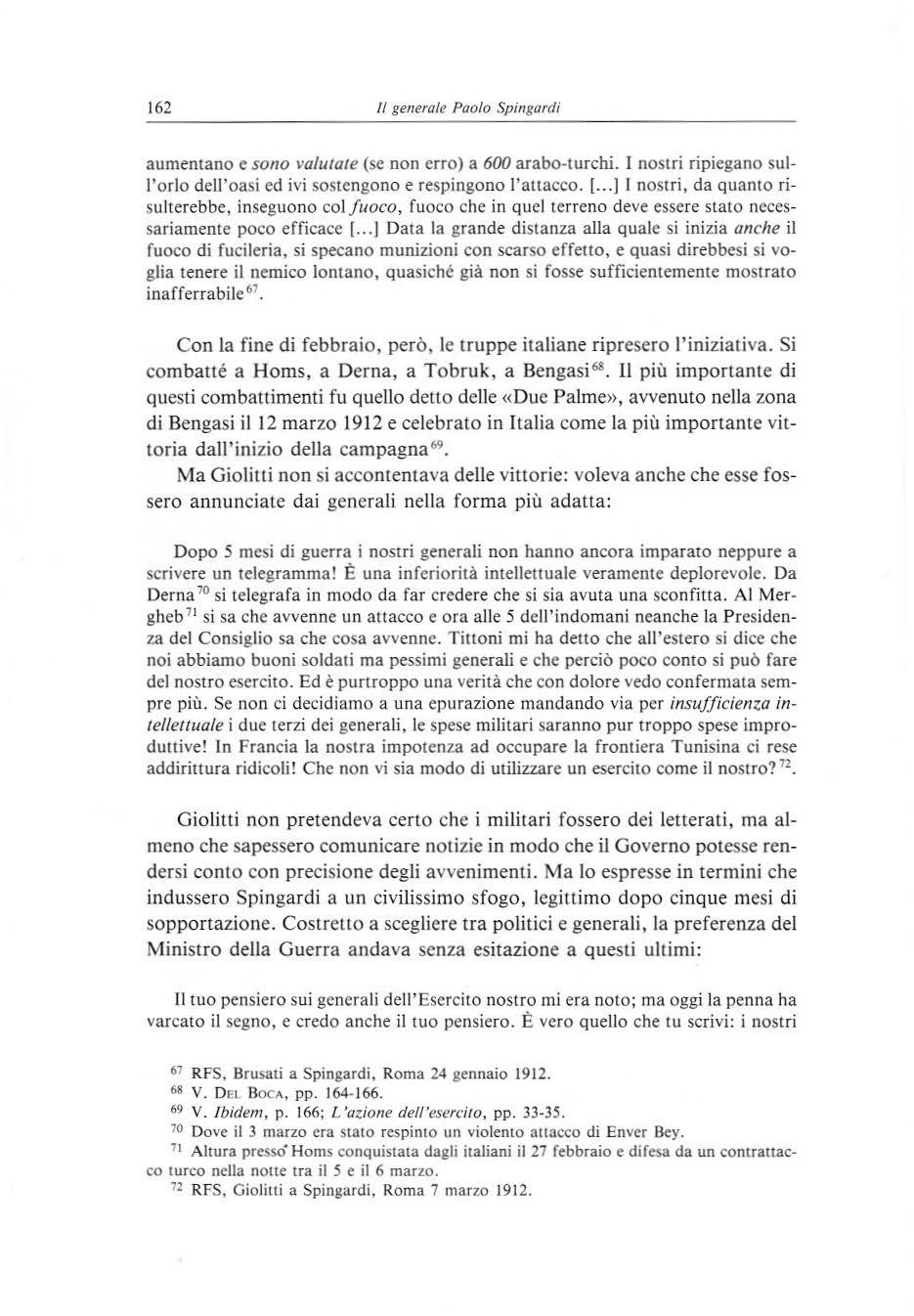
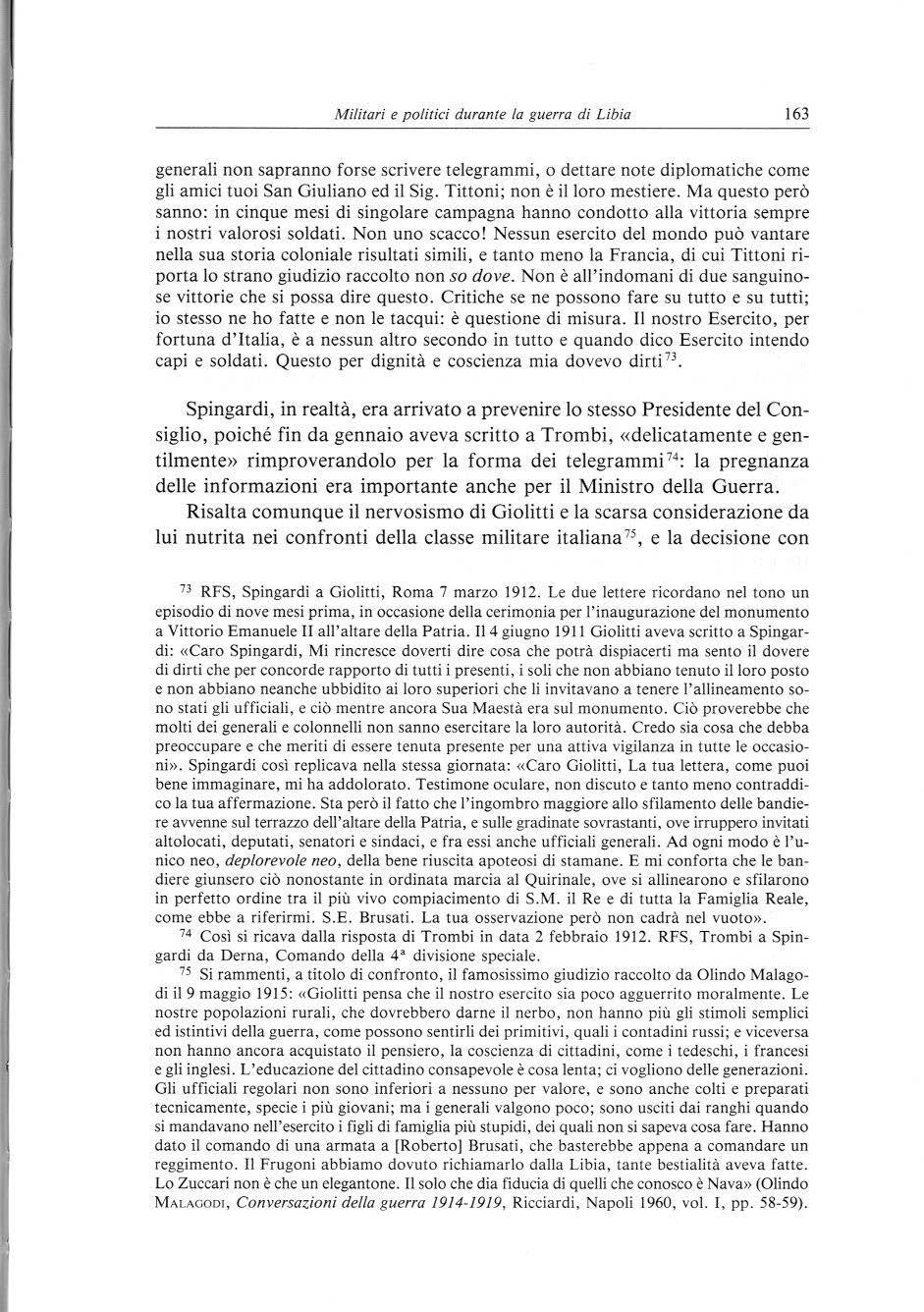
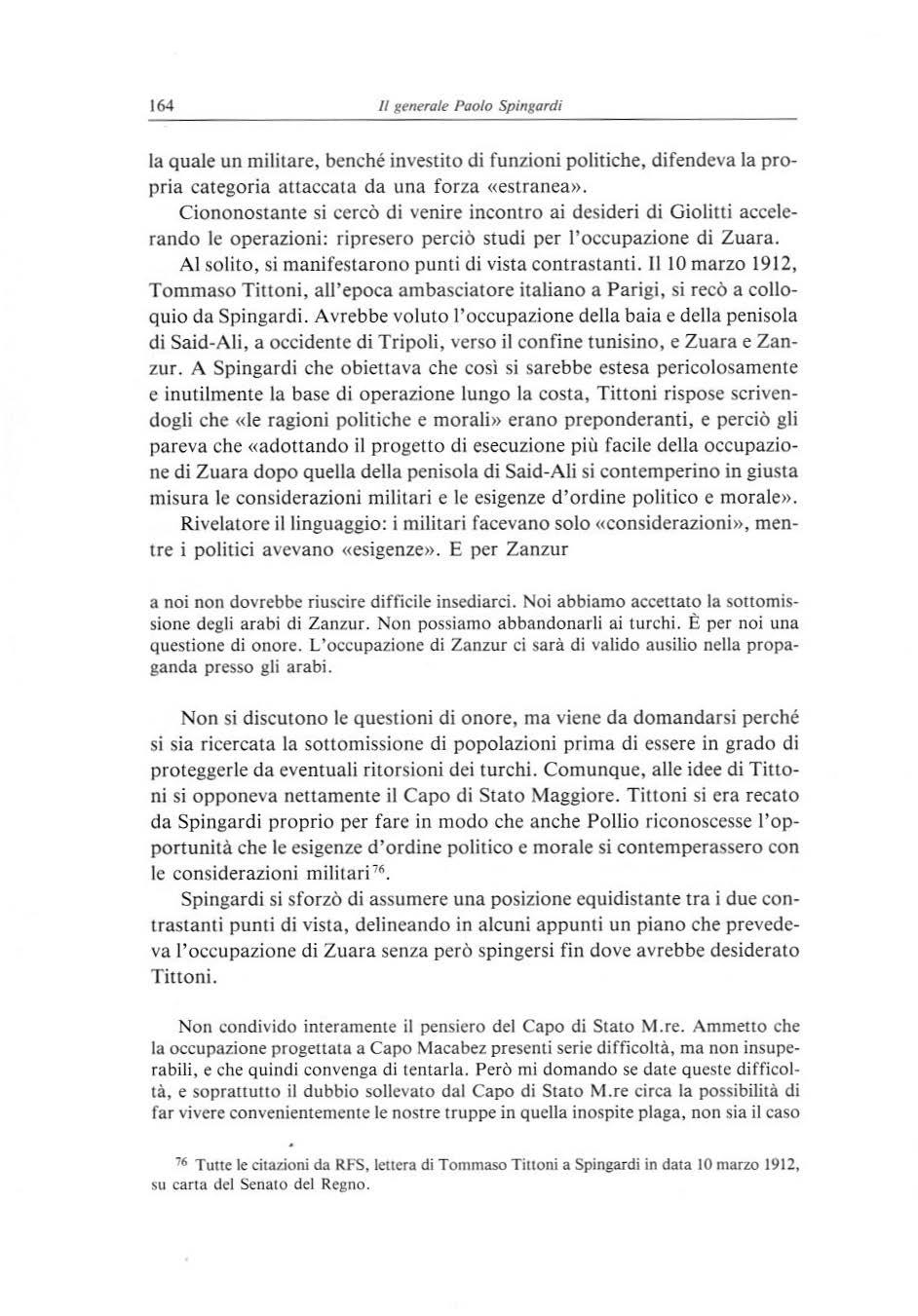
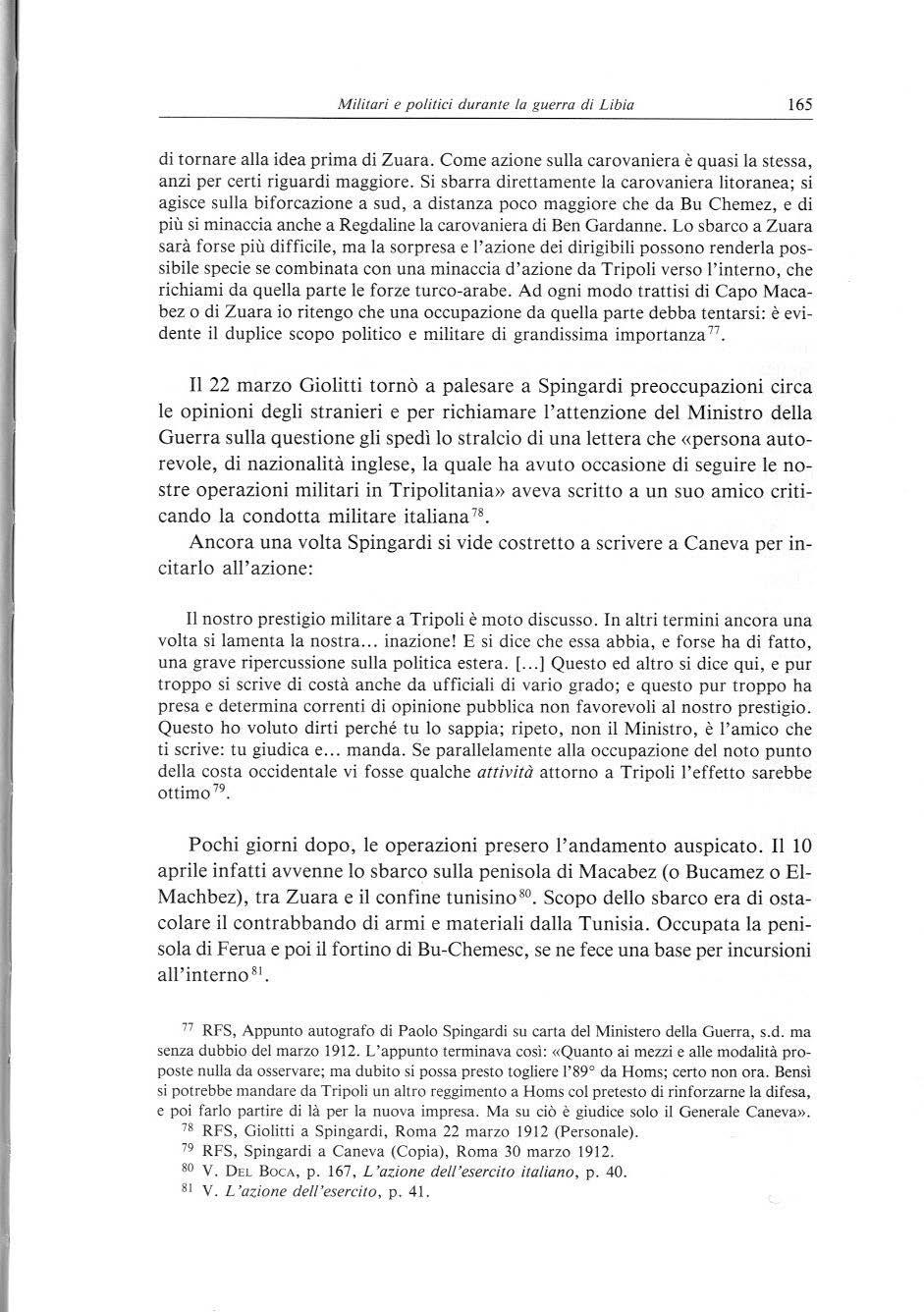
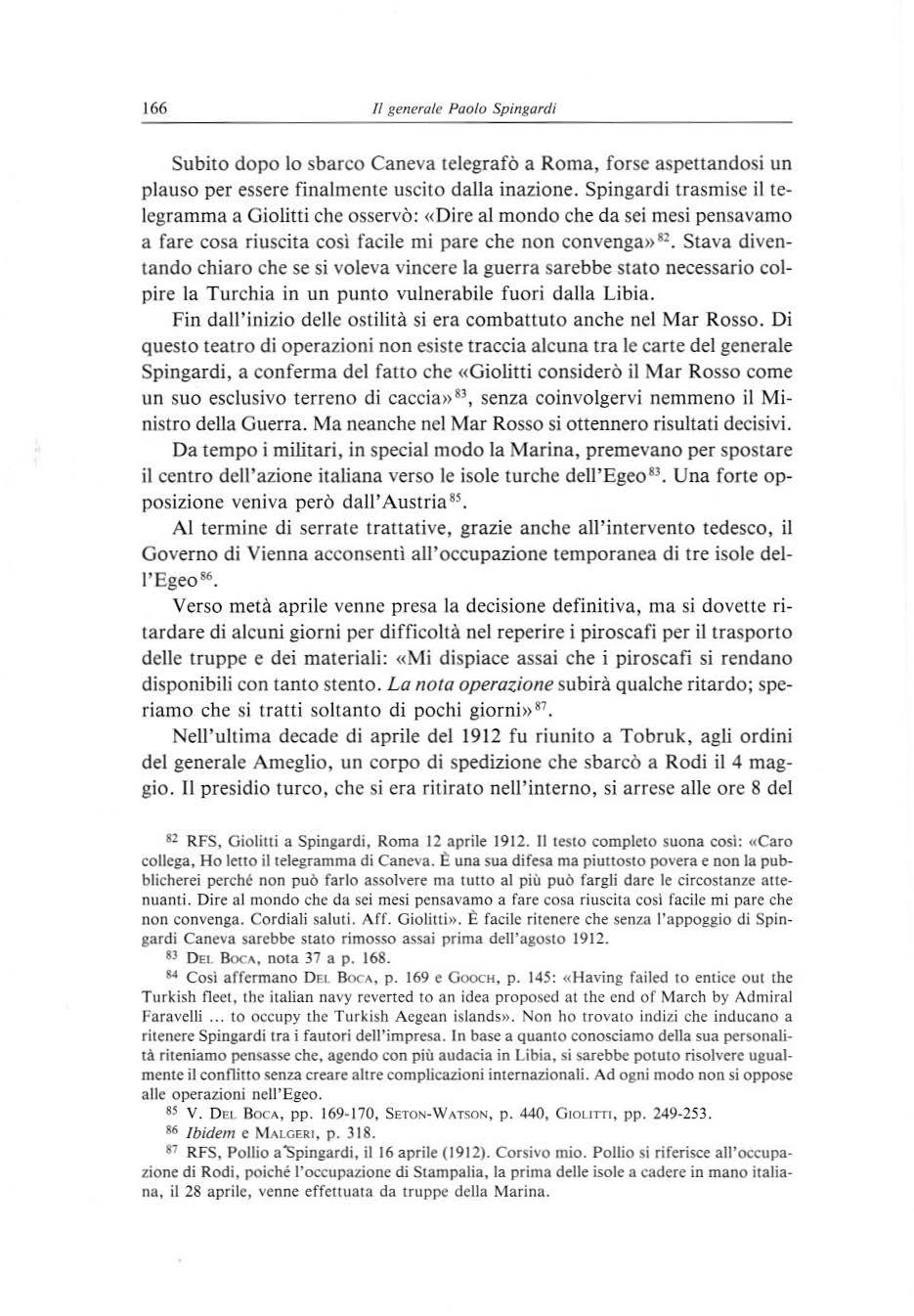
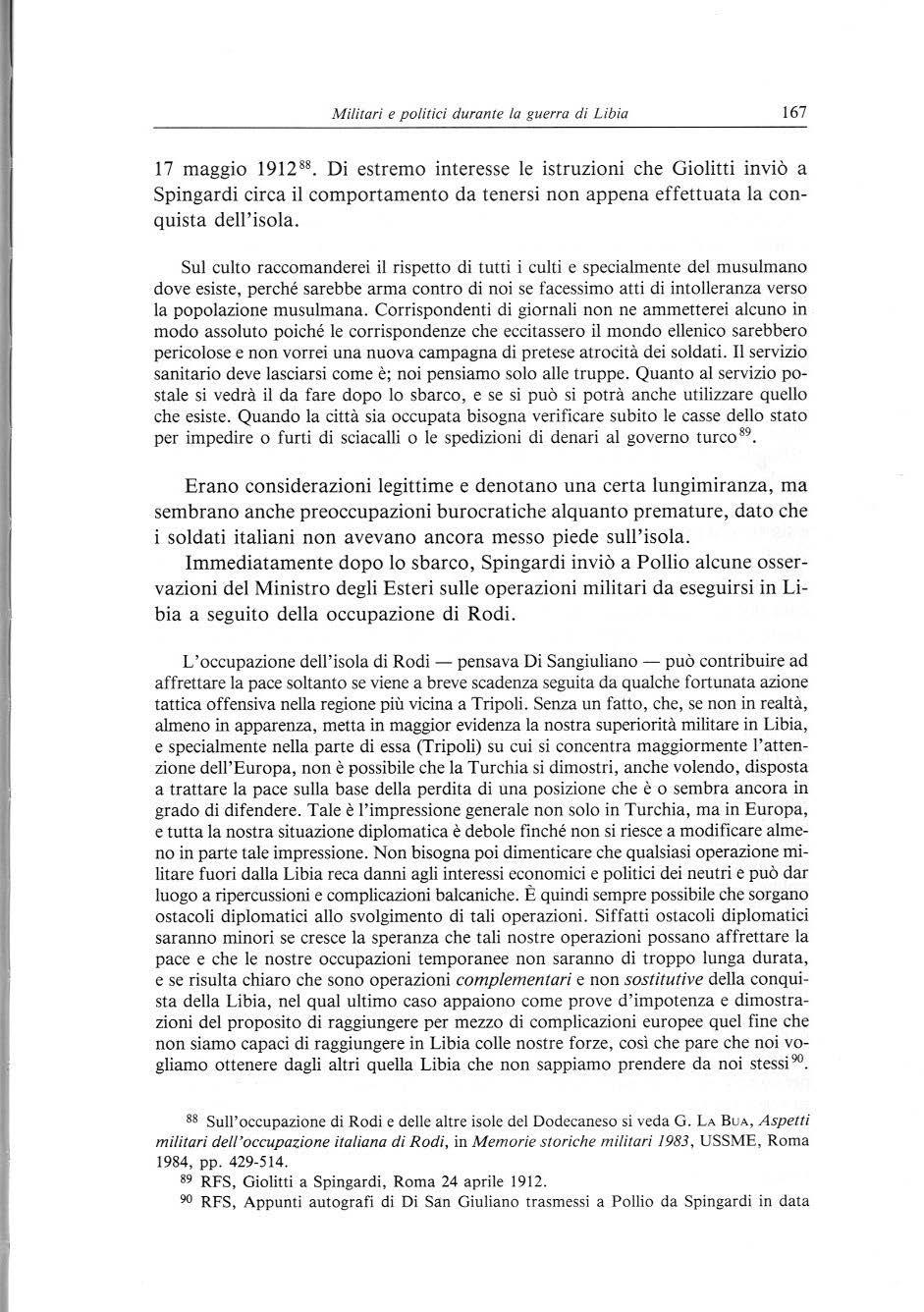
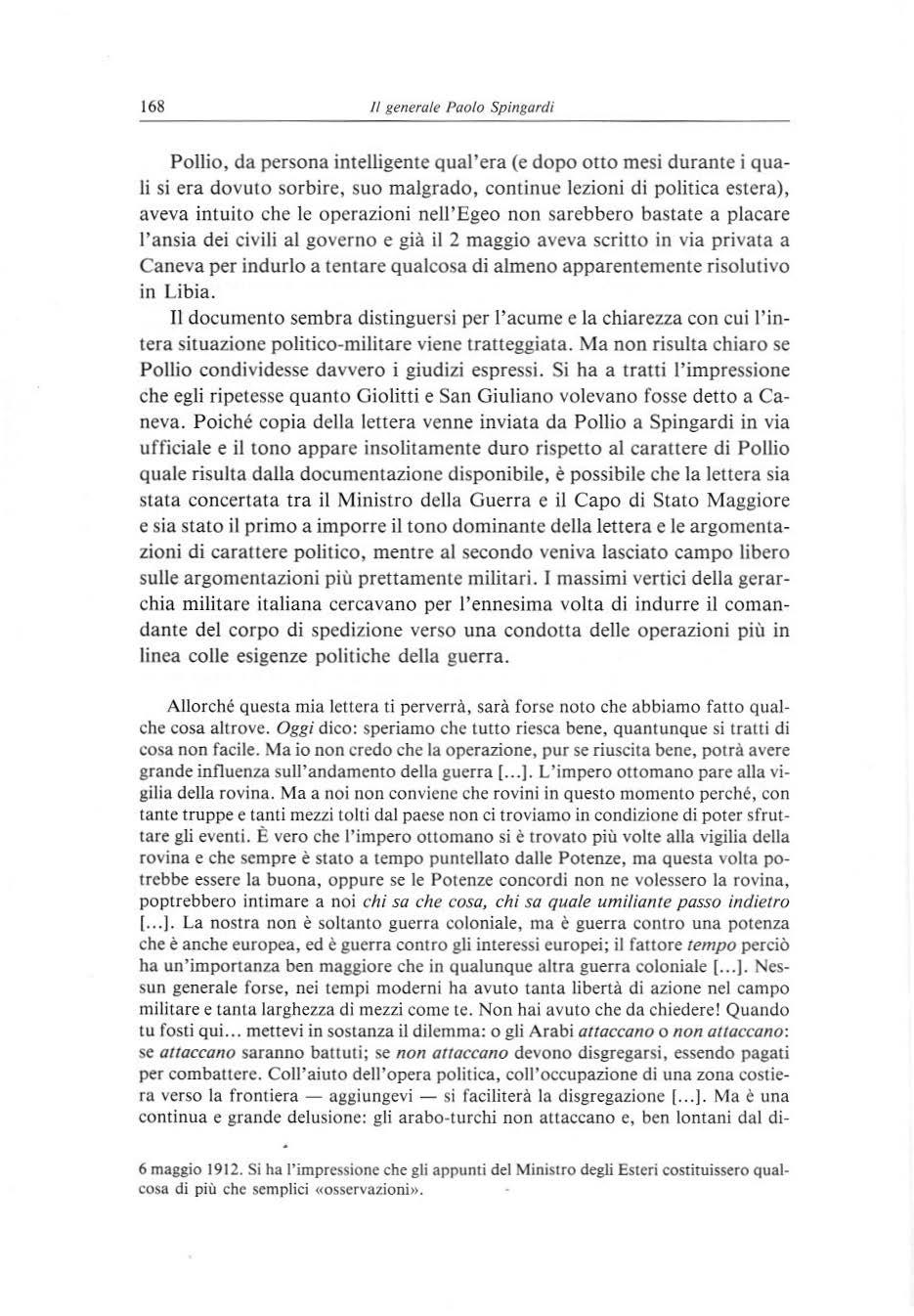
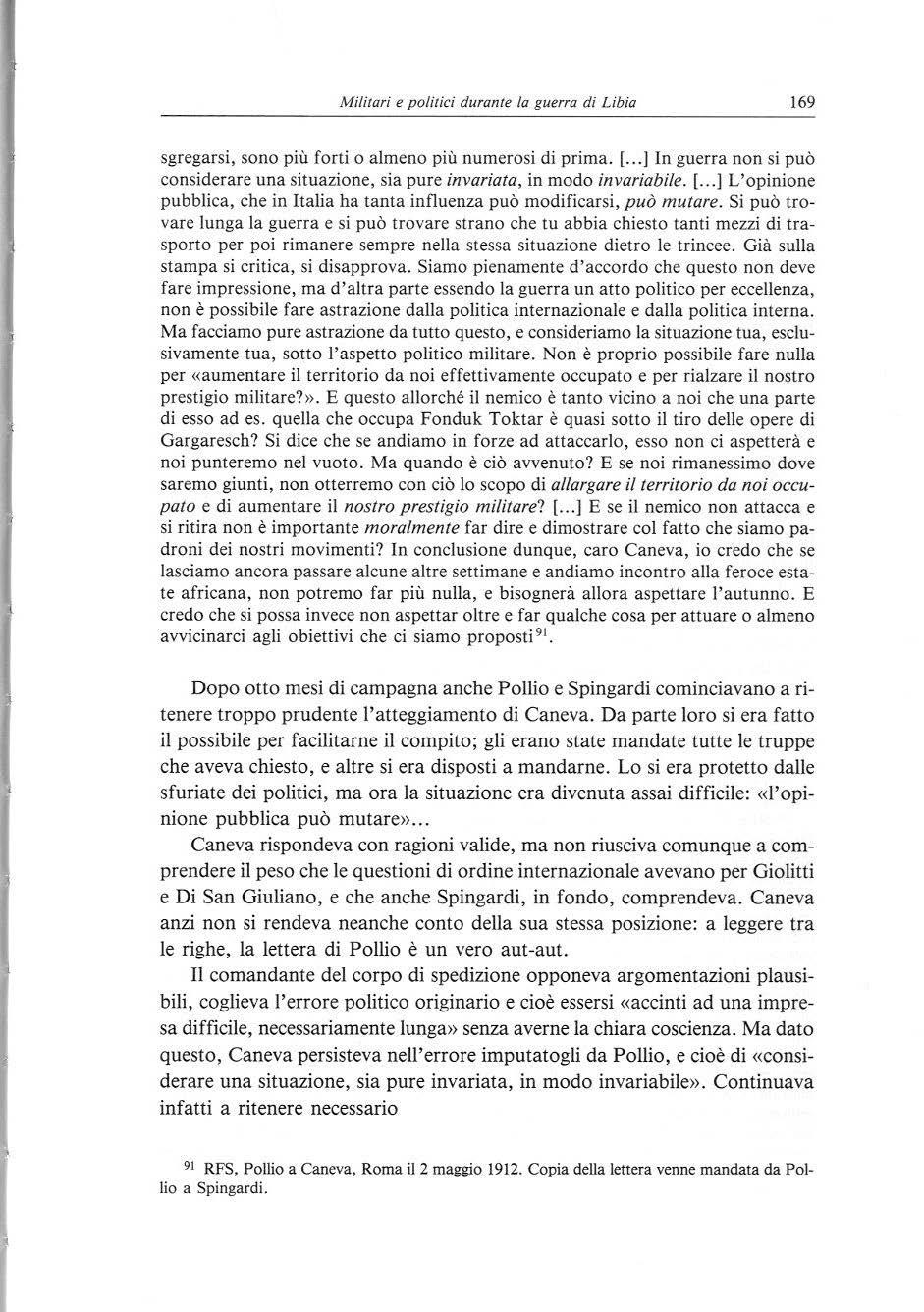
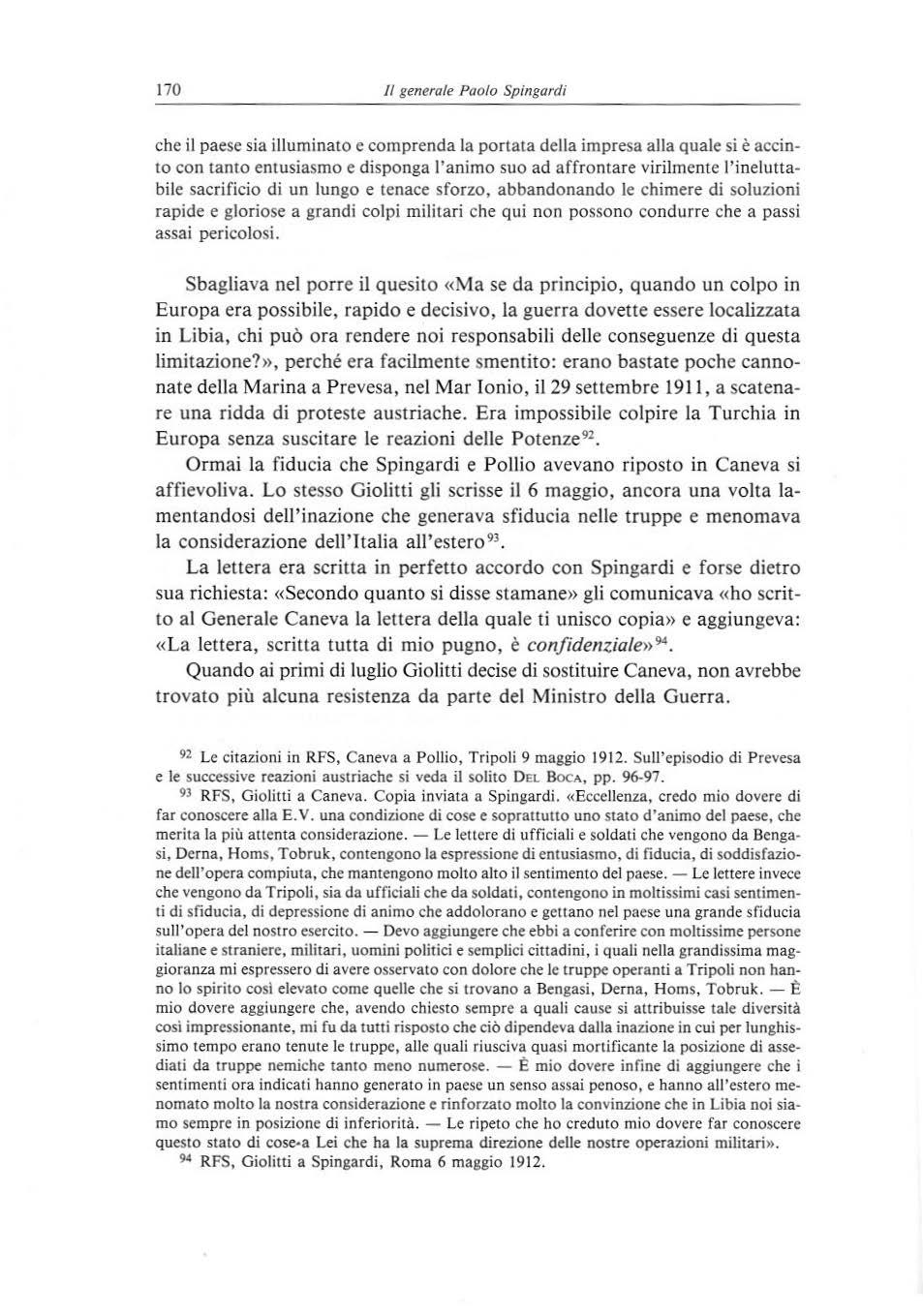

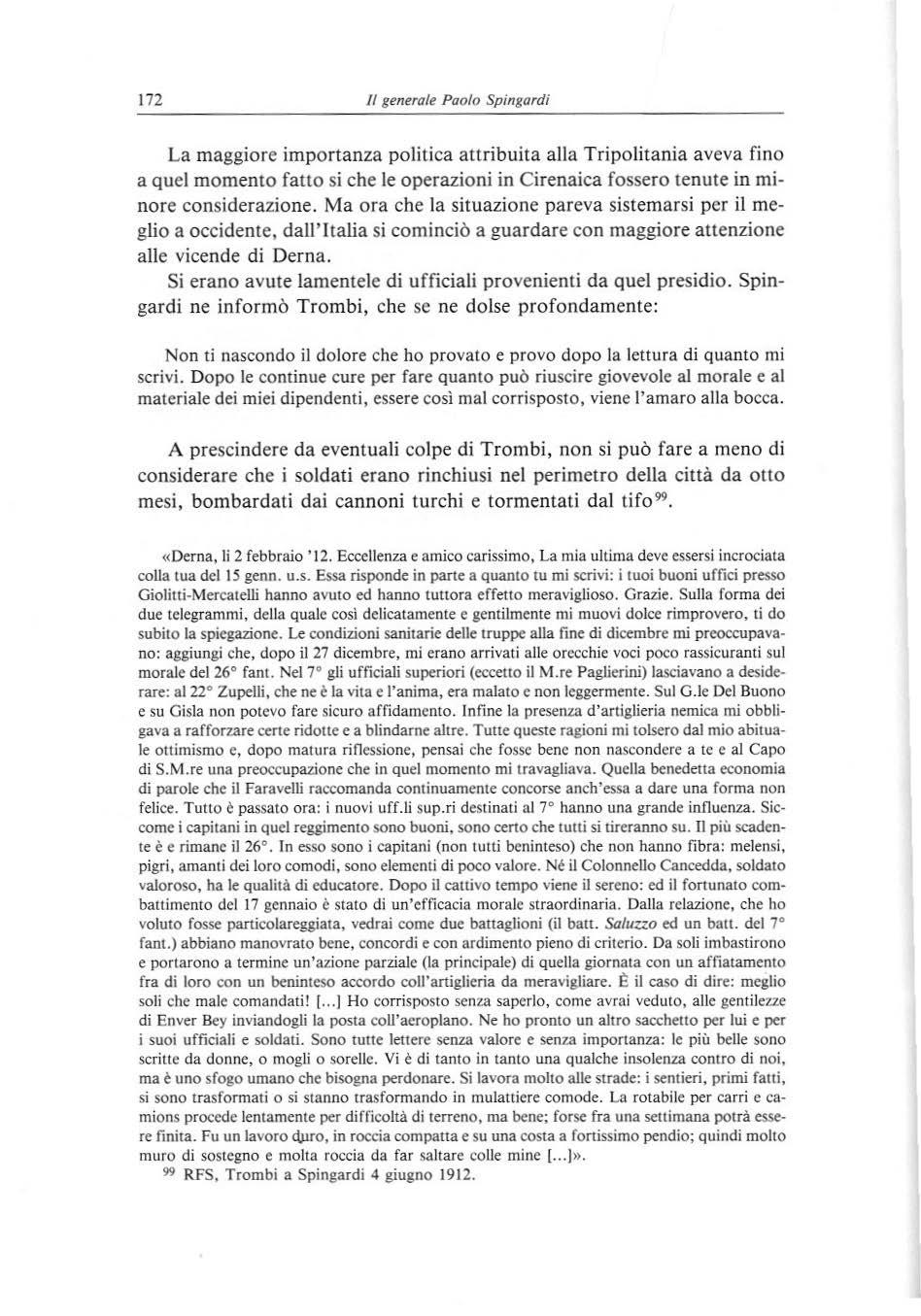
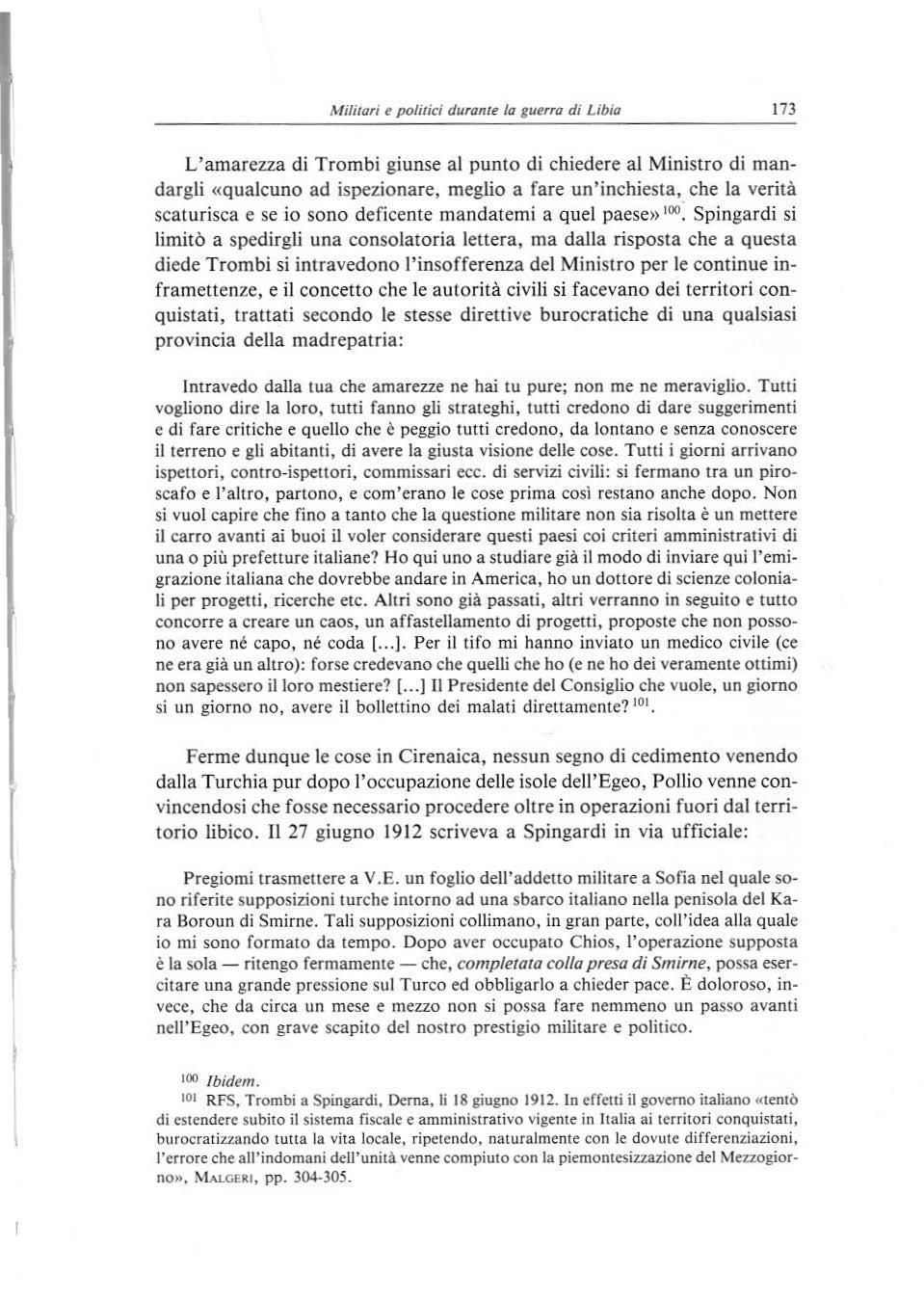
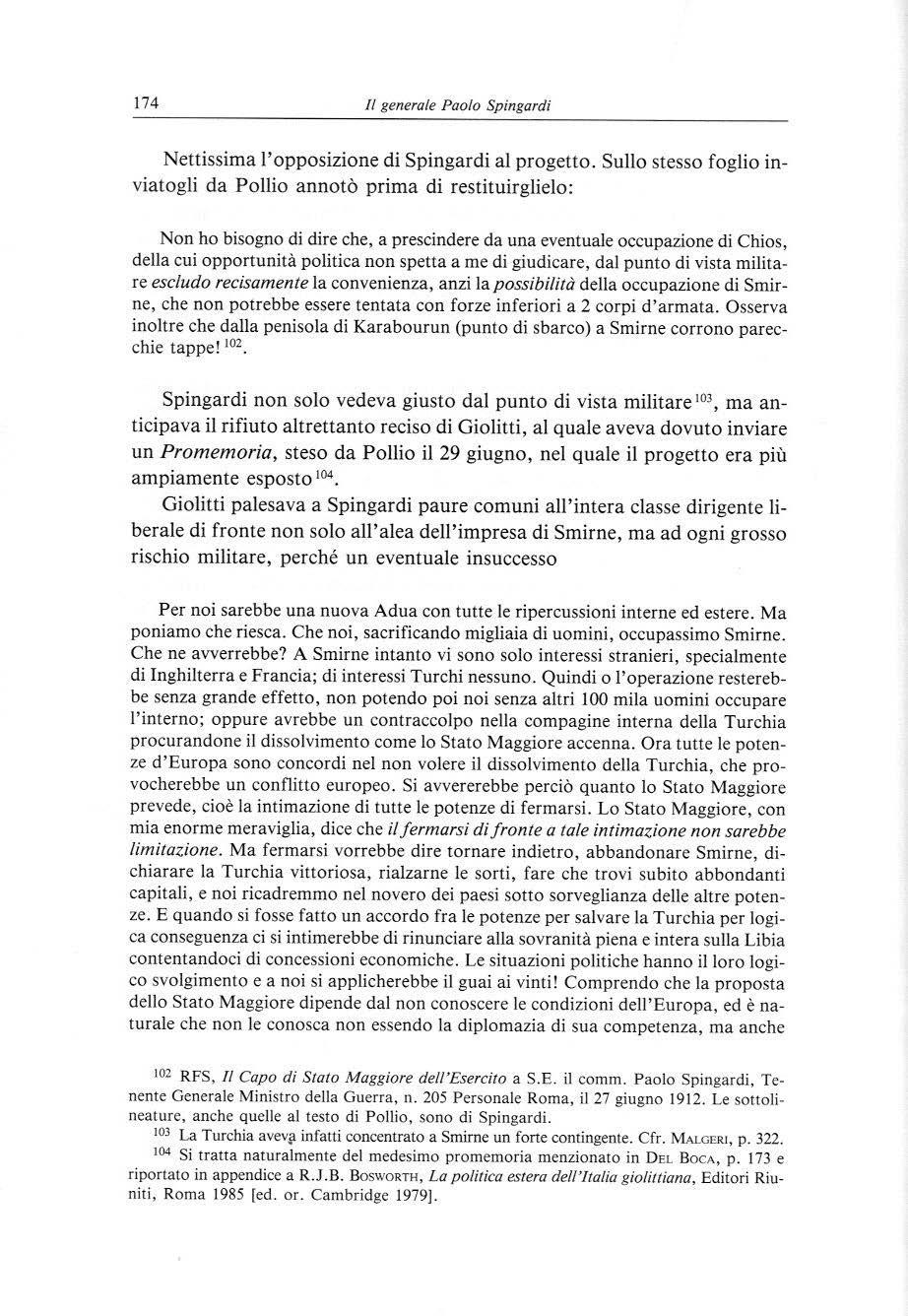
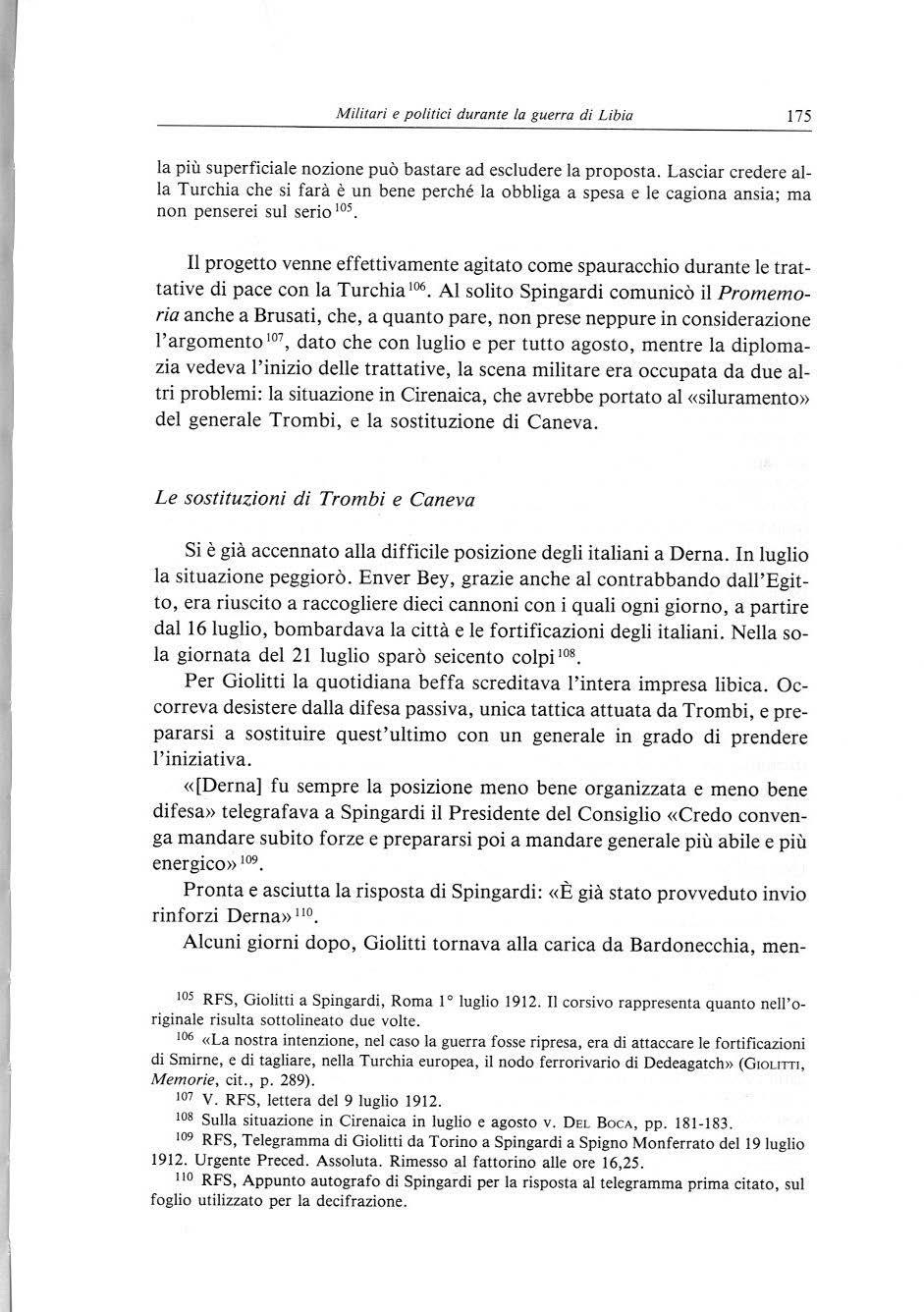
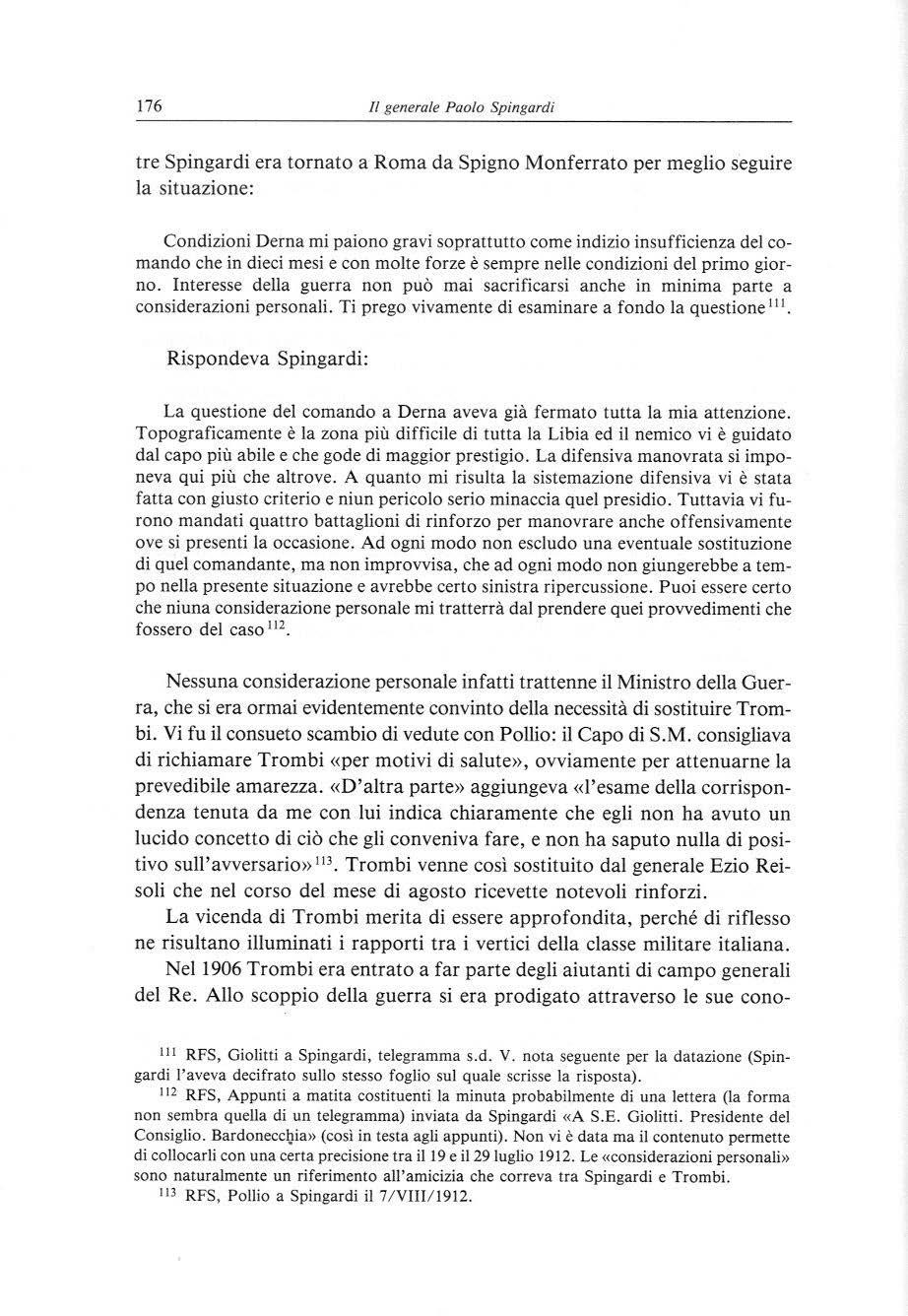
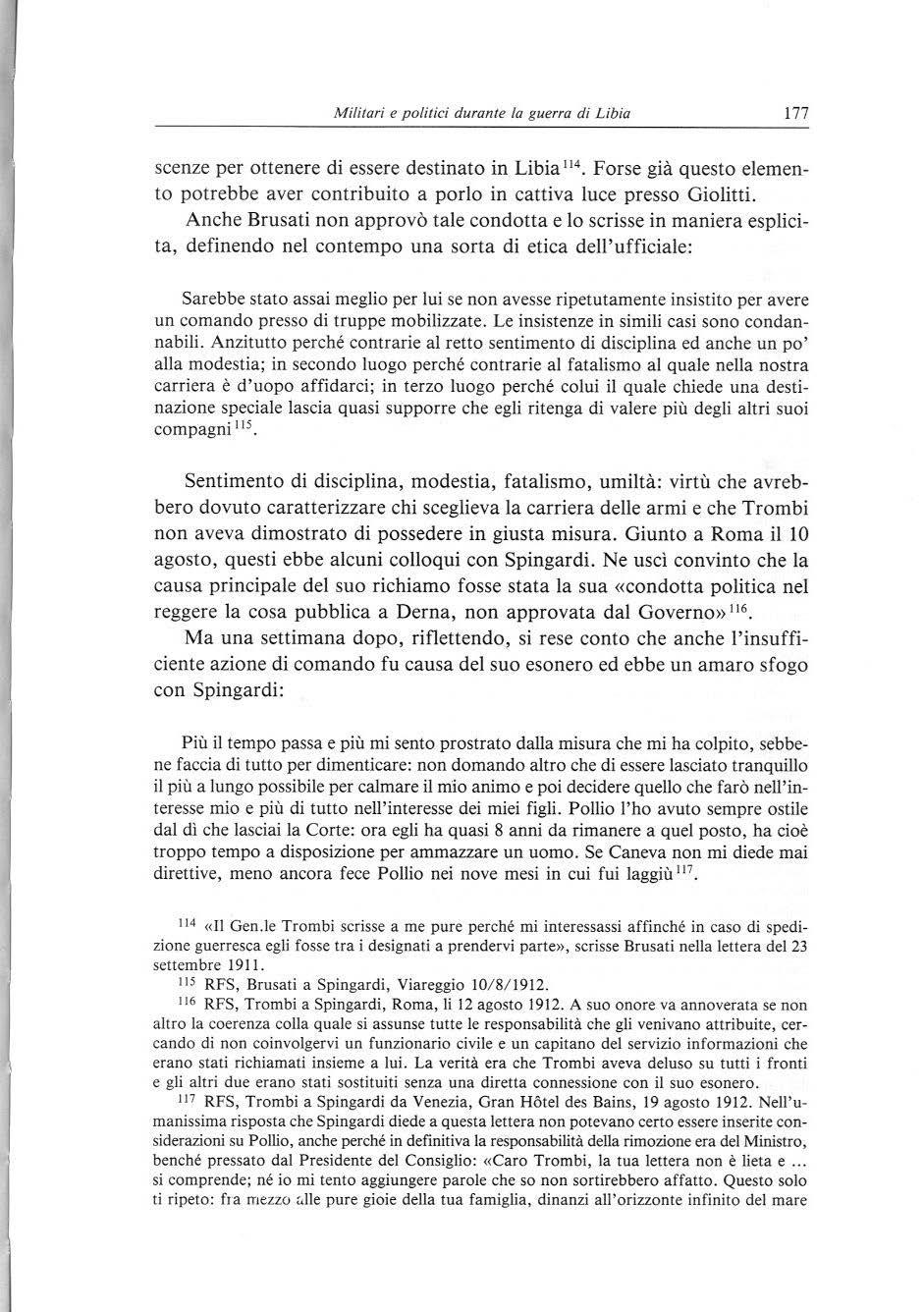
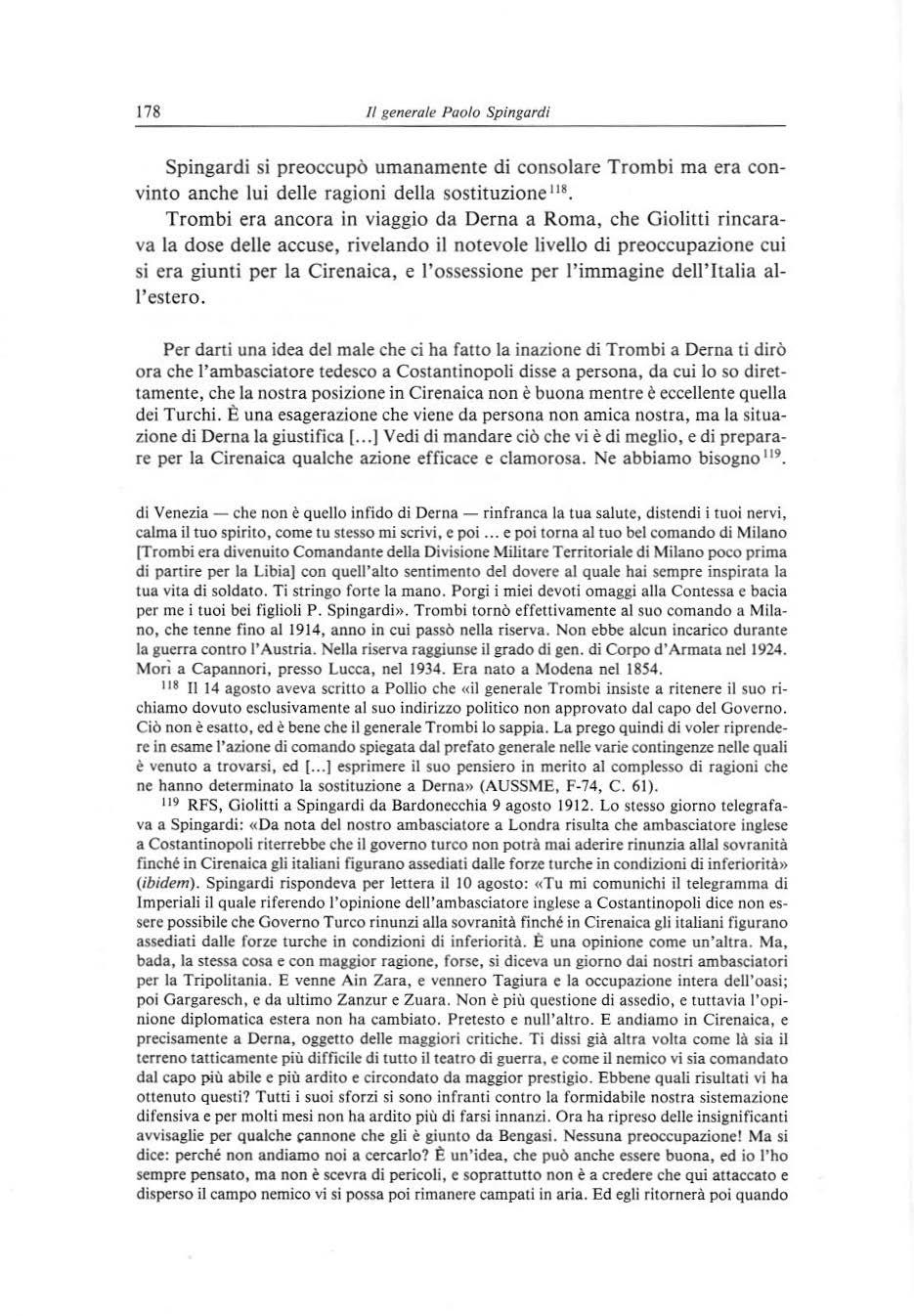
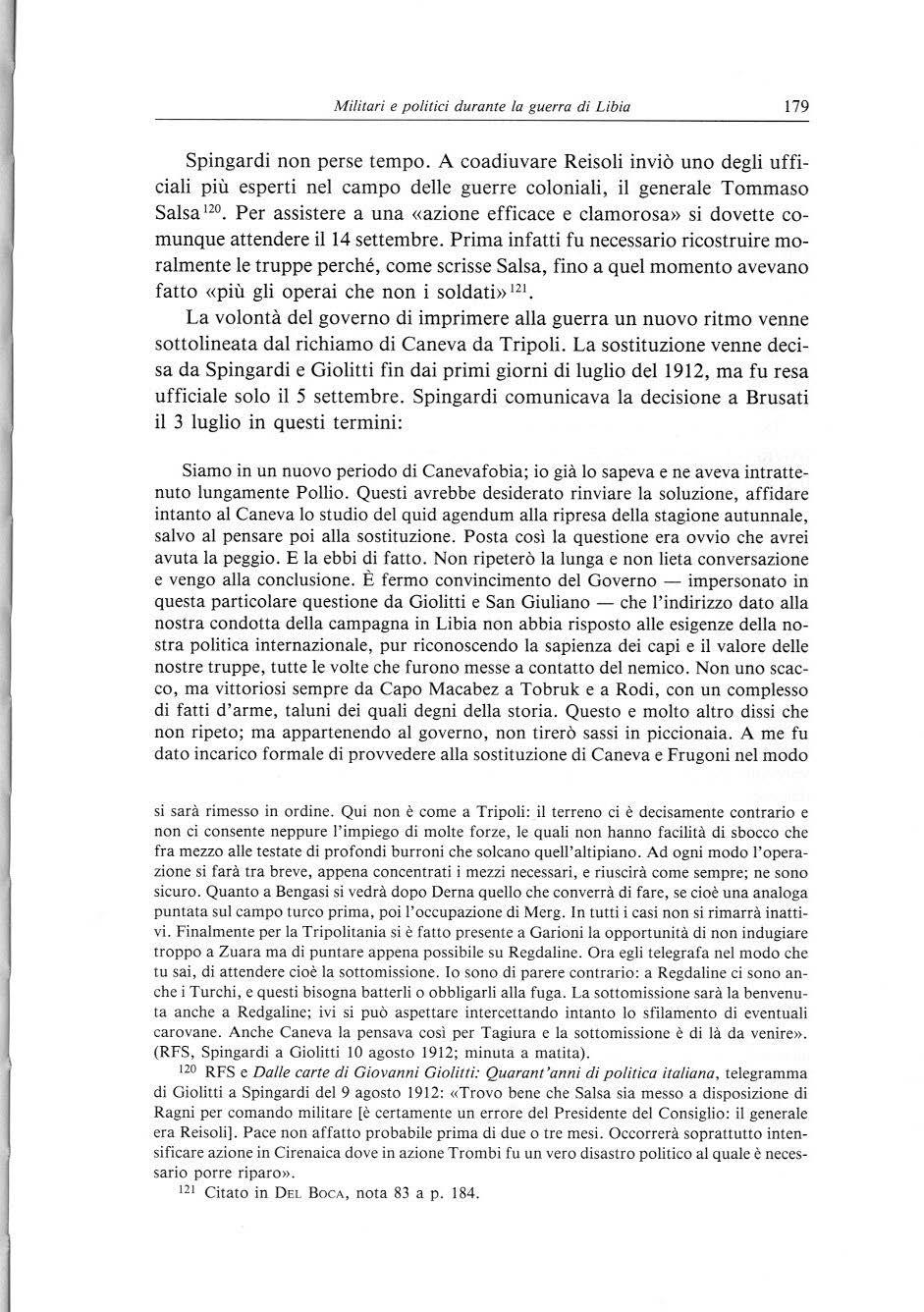
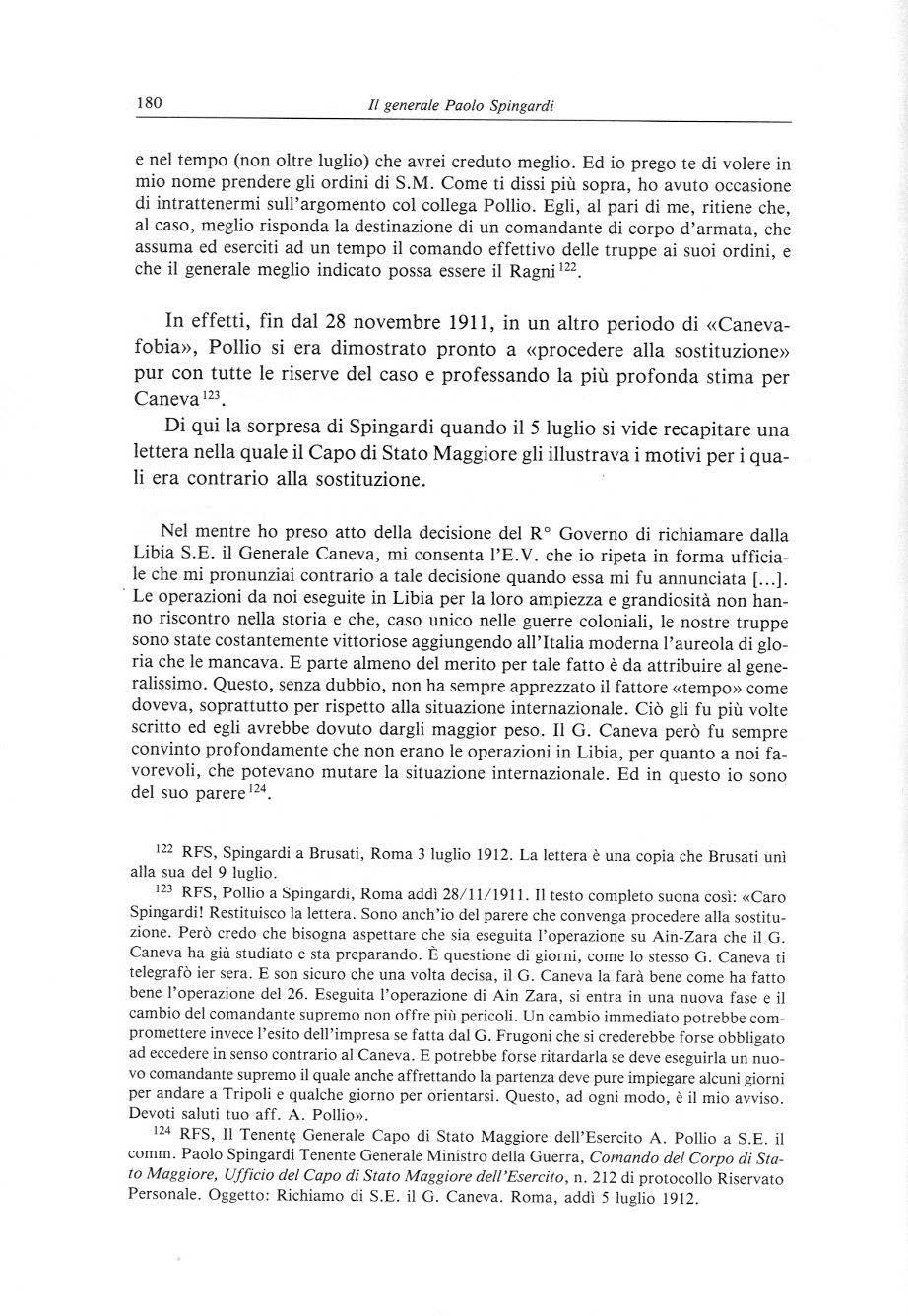
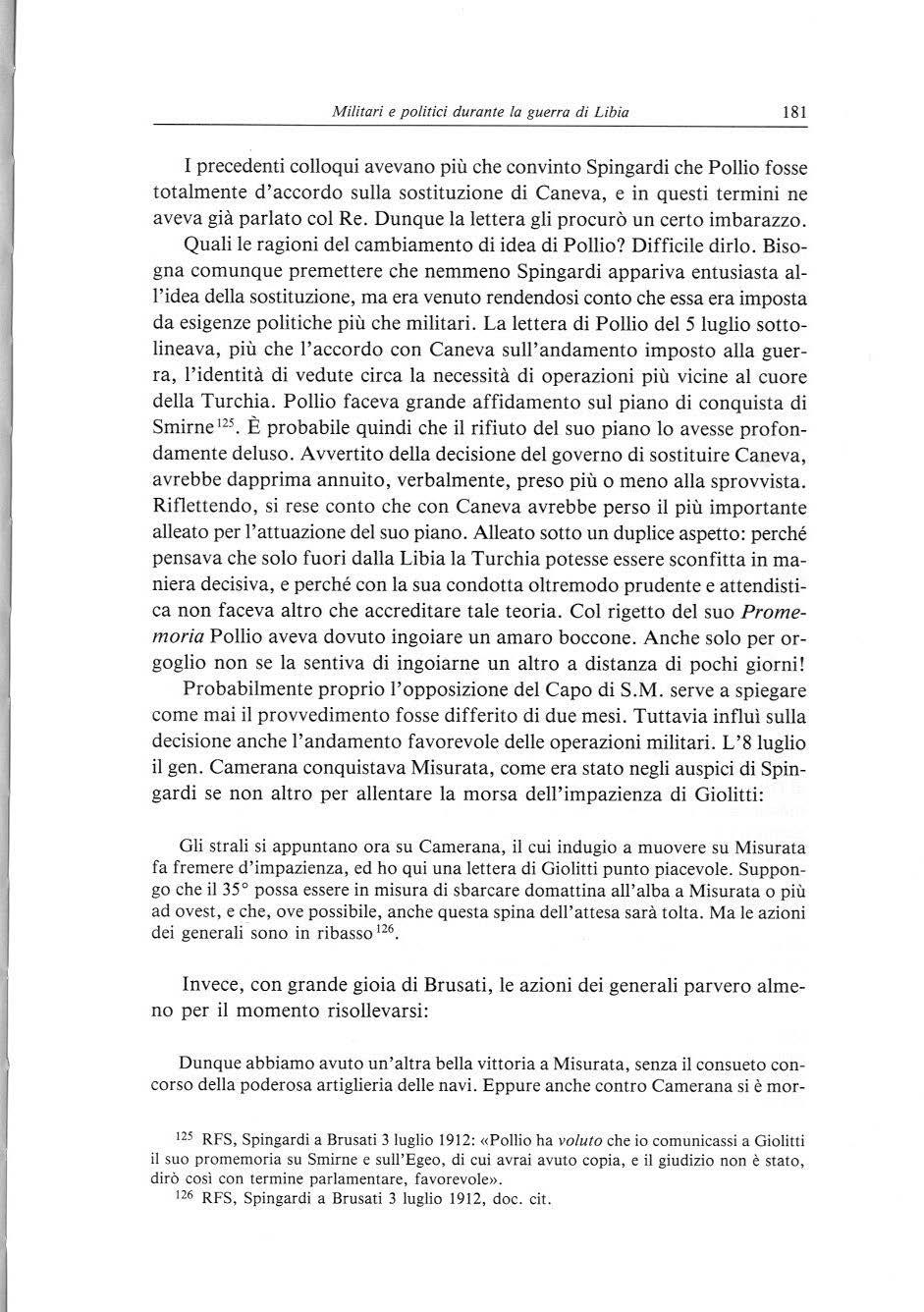
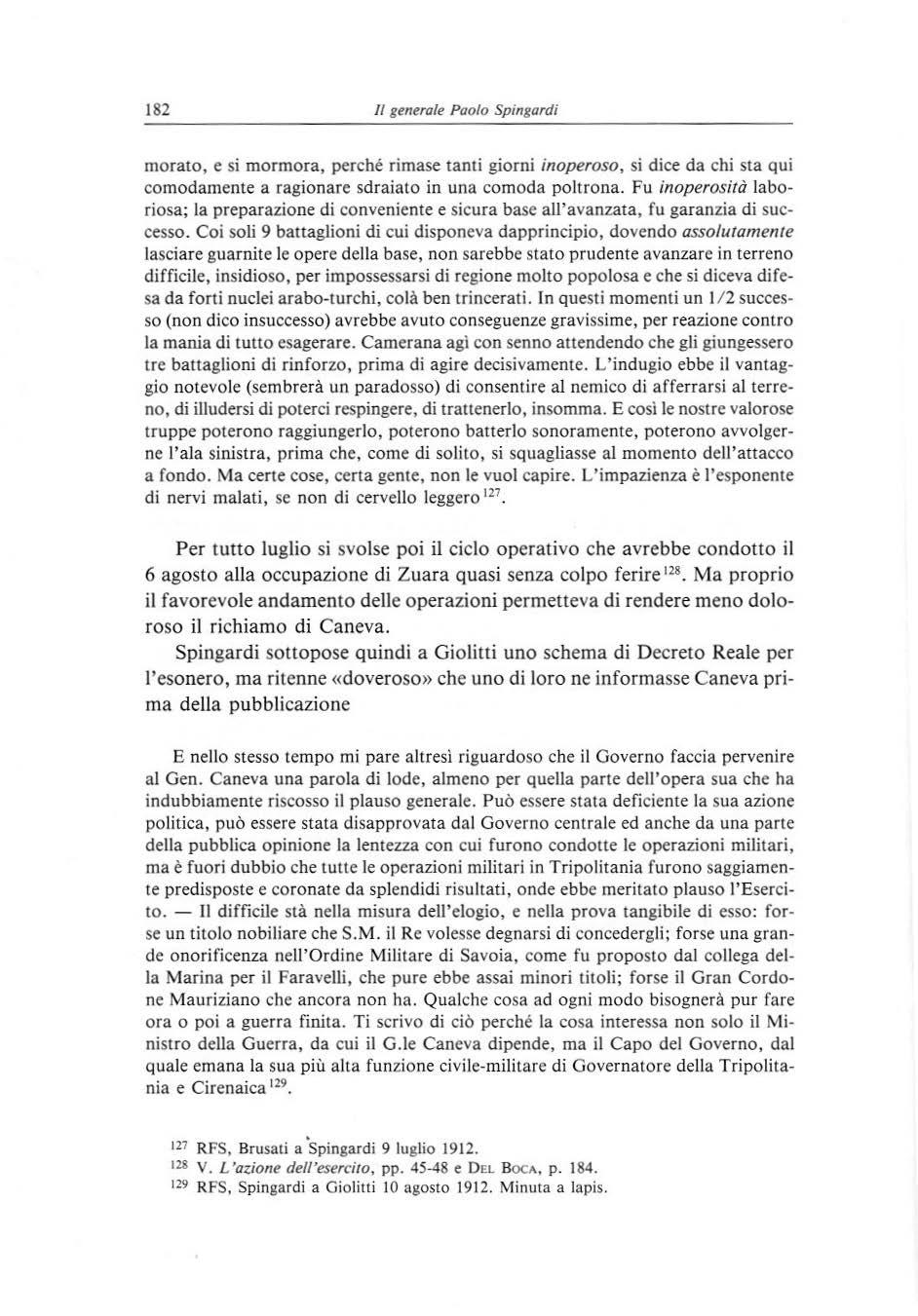
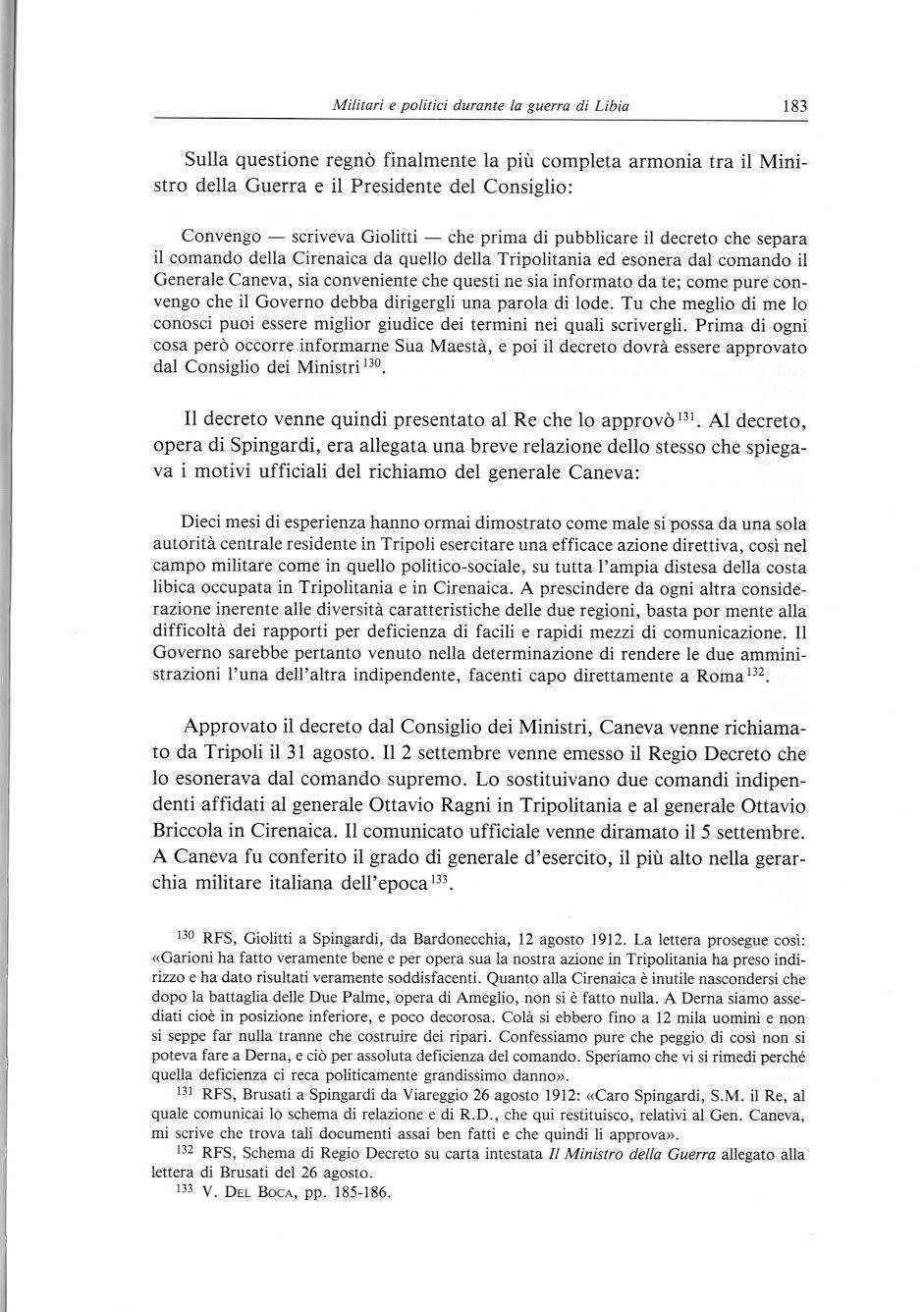
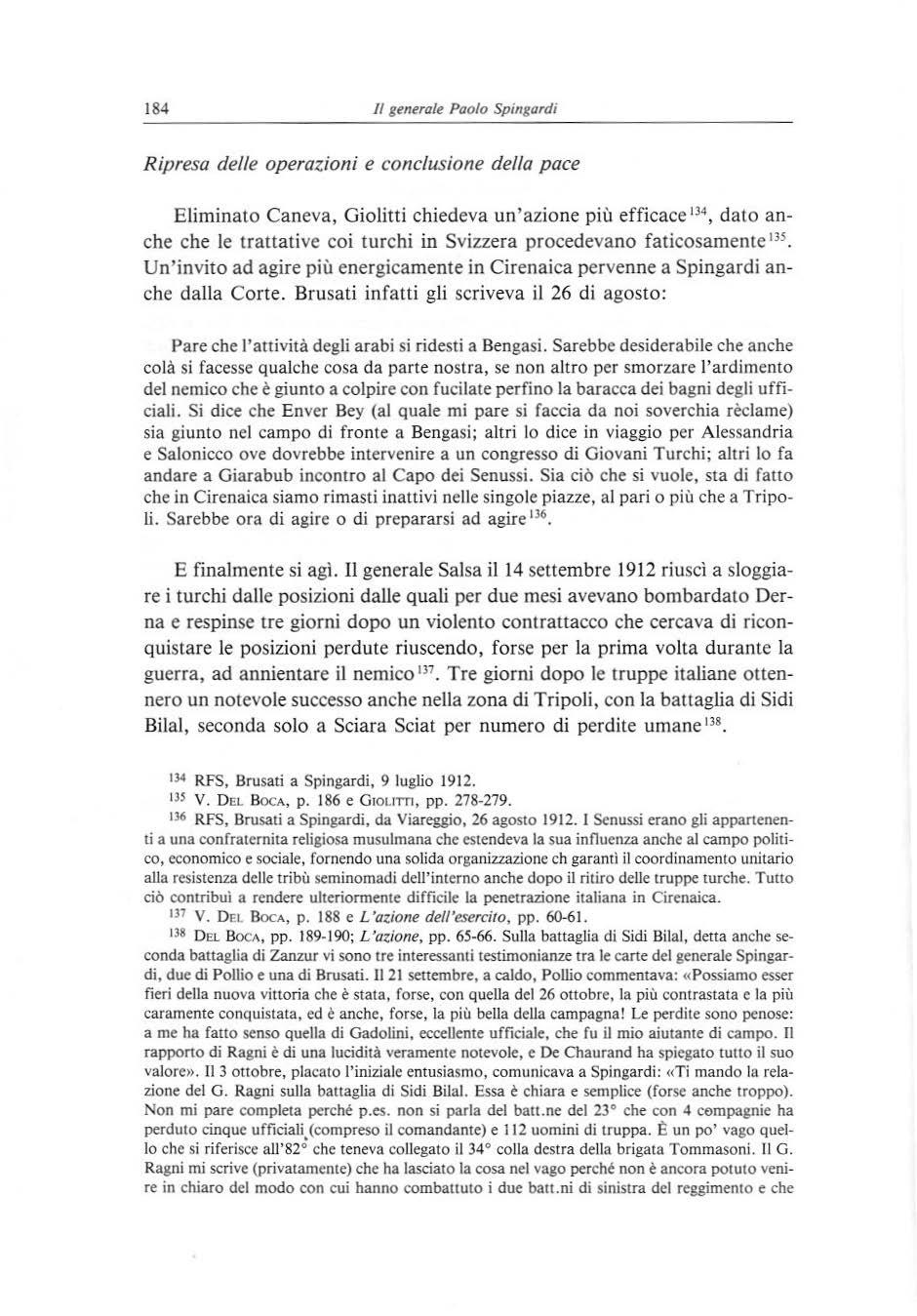
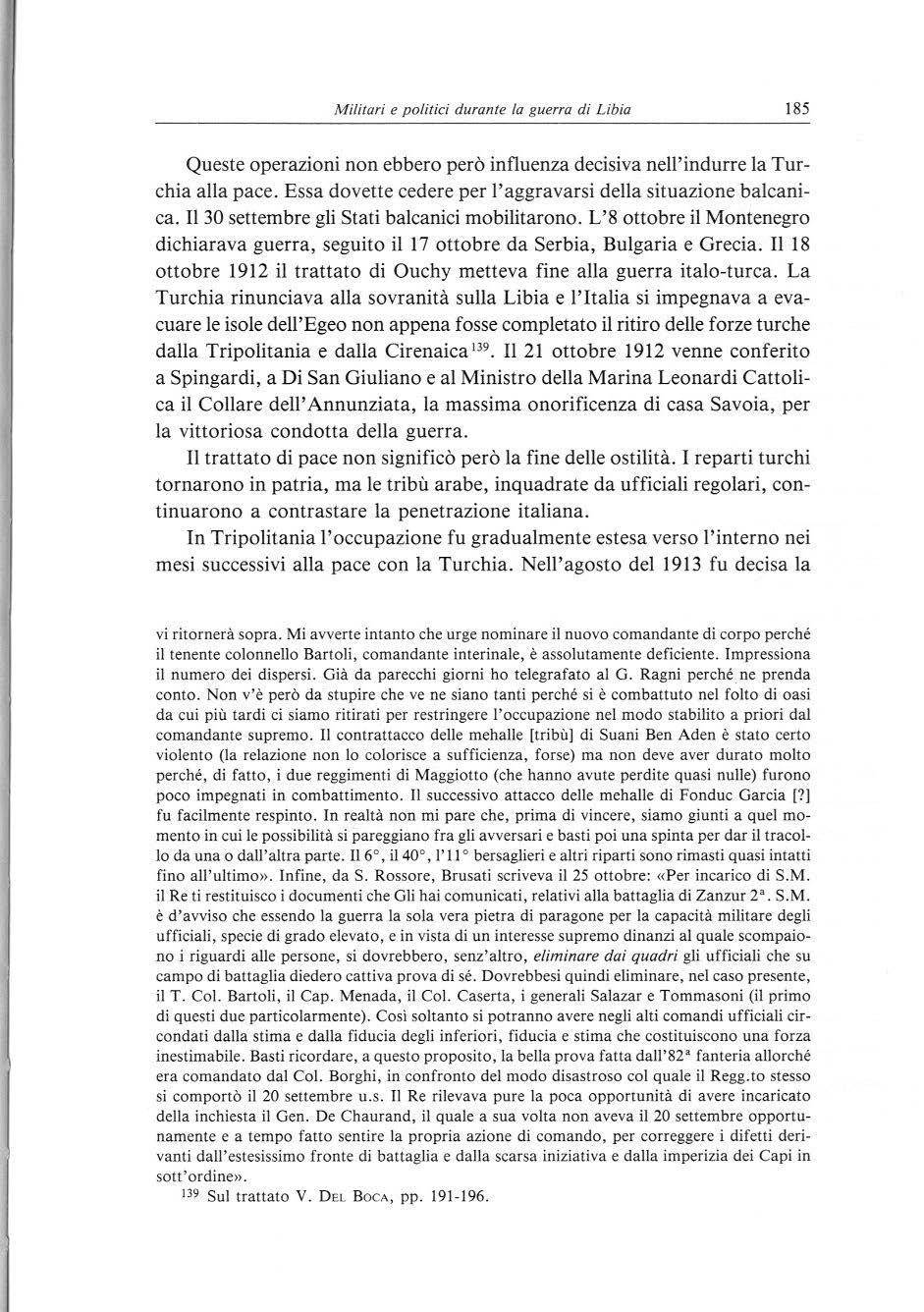

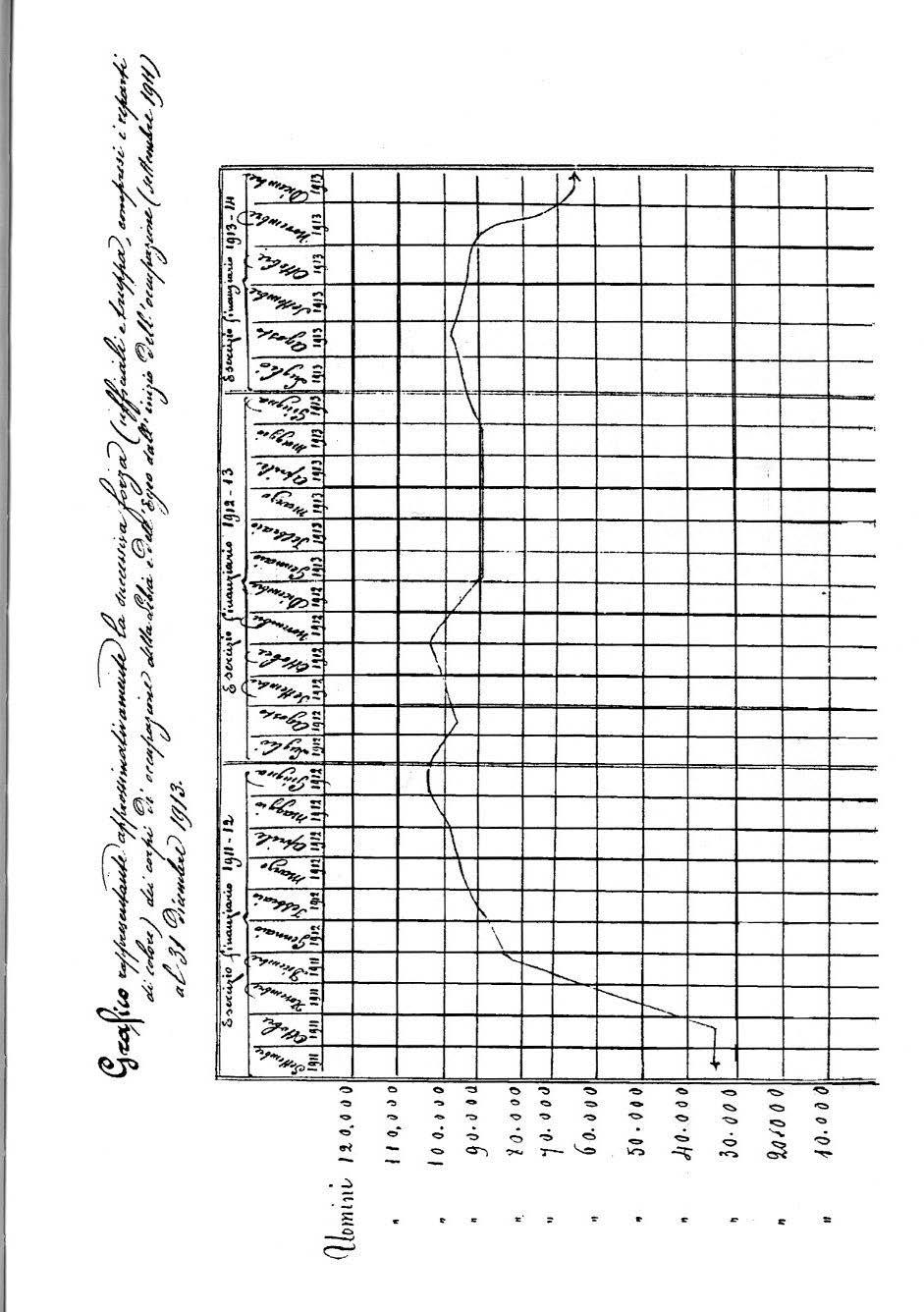

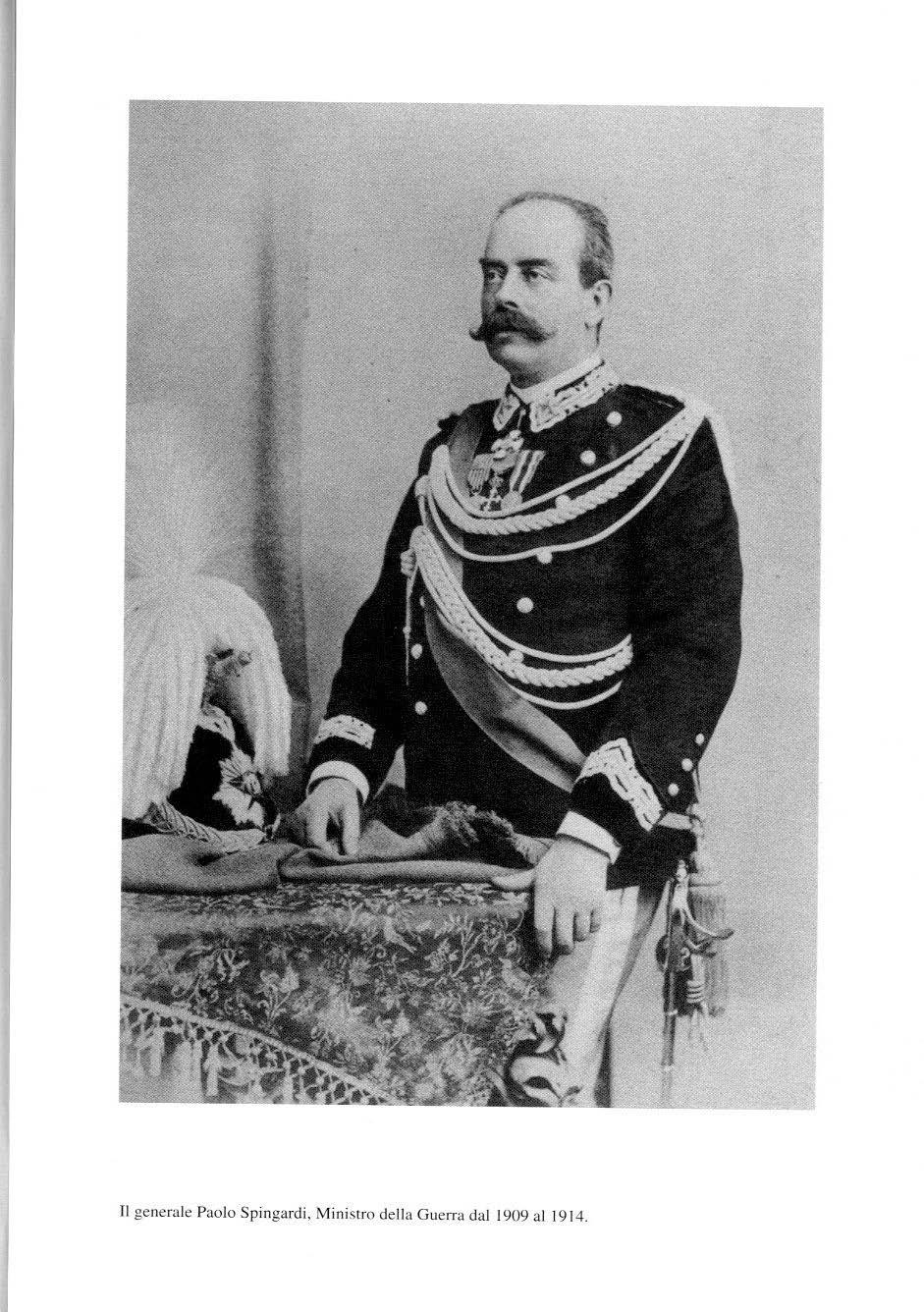 Il generale Paolo Sp inga rdi, M inist ro della Guerra dal 1909 al I 914.
Il generale Paolo Sp inga rdi, M inist ro della Guerra dal 1909 al I 914.
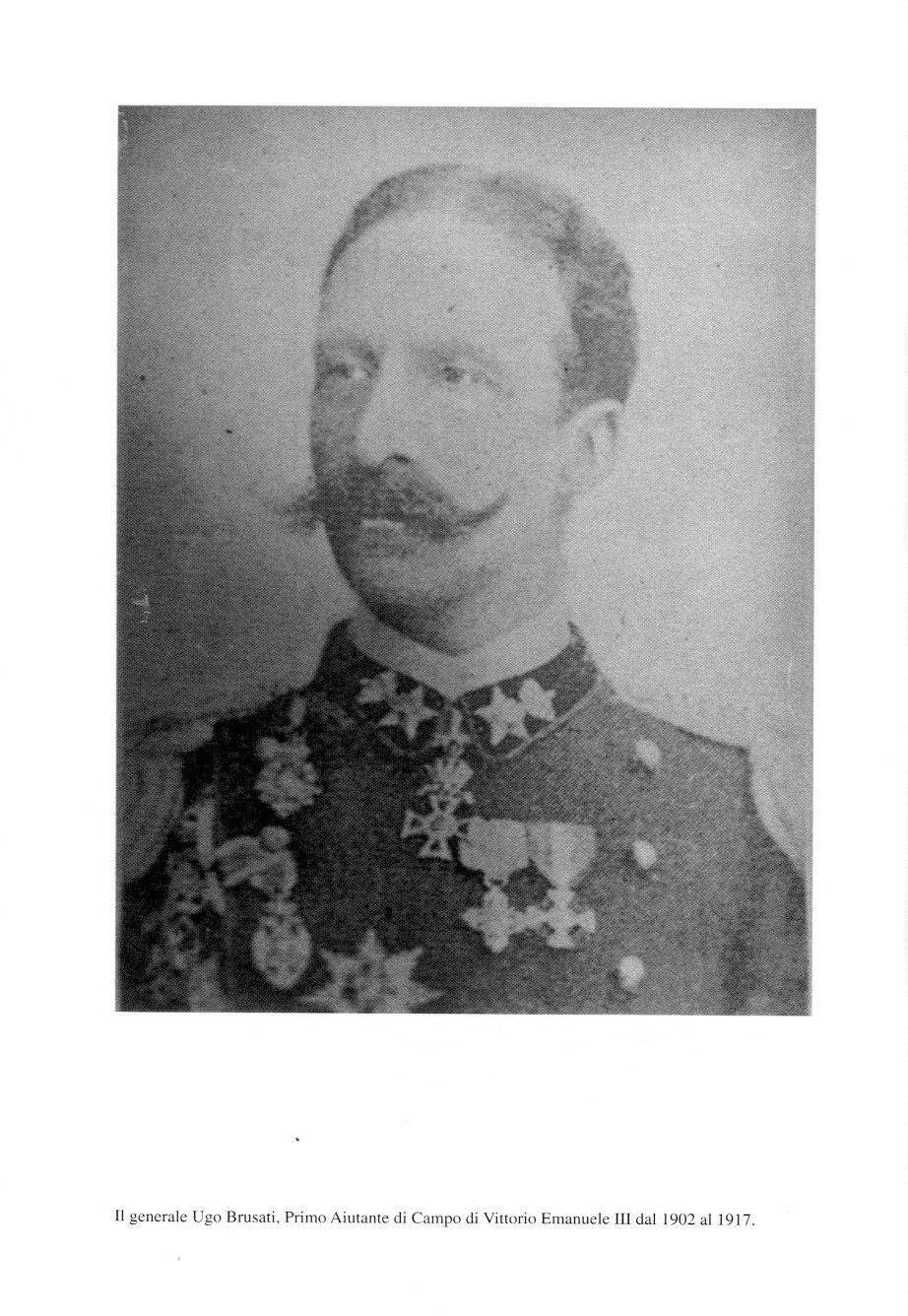
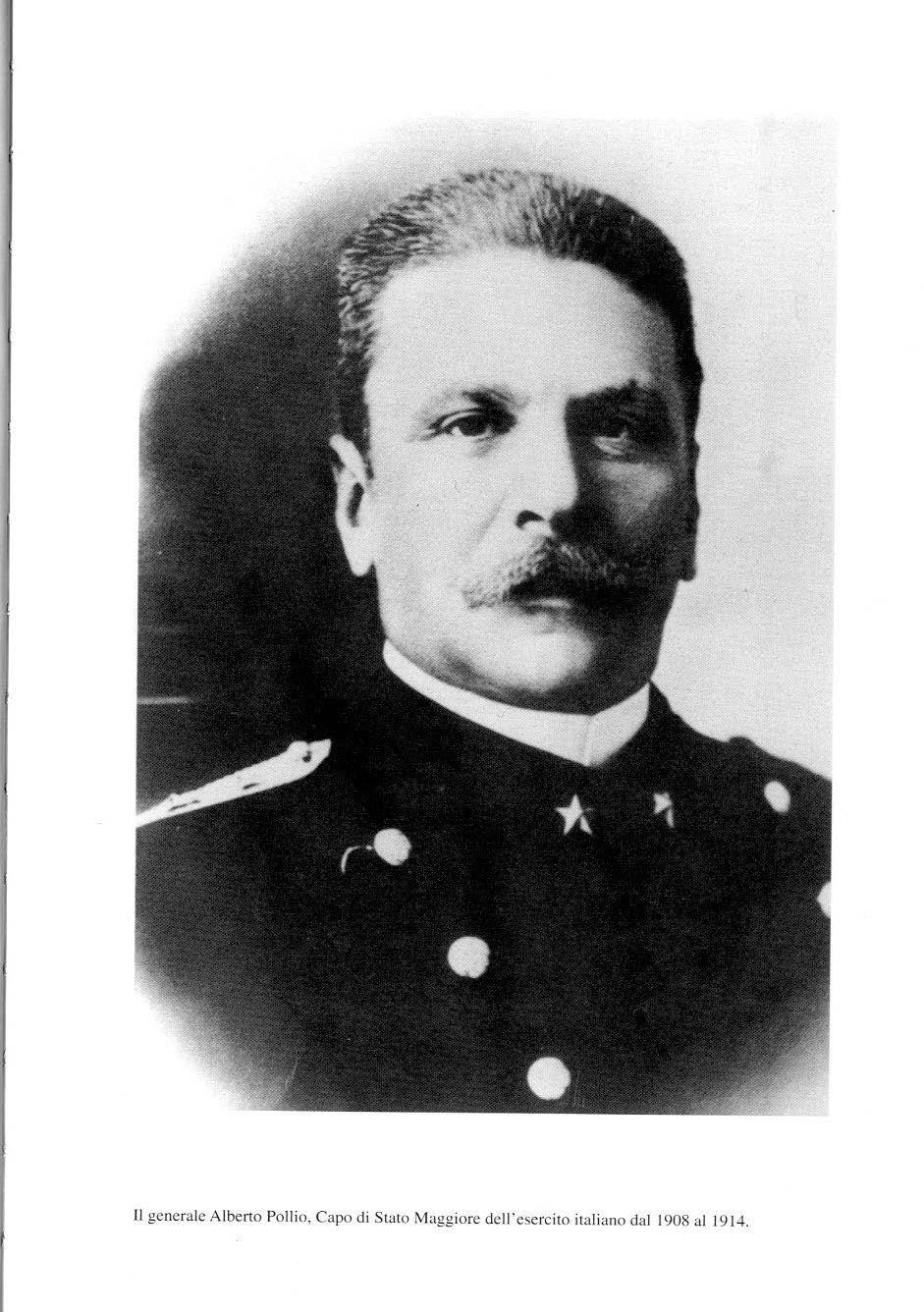 li genera le A lberto Poll io, Capo di Stato Magg iore dell'eserci w ital iano dal 1908 a l 1914.
li genera le A lberto Poll io, Capo di Stato Magg iore dell'eserci w ital iano dal 1908 a l 1914.
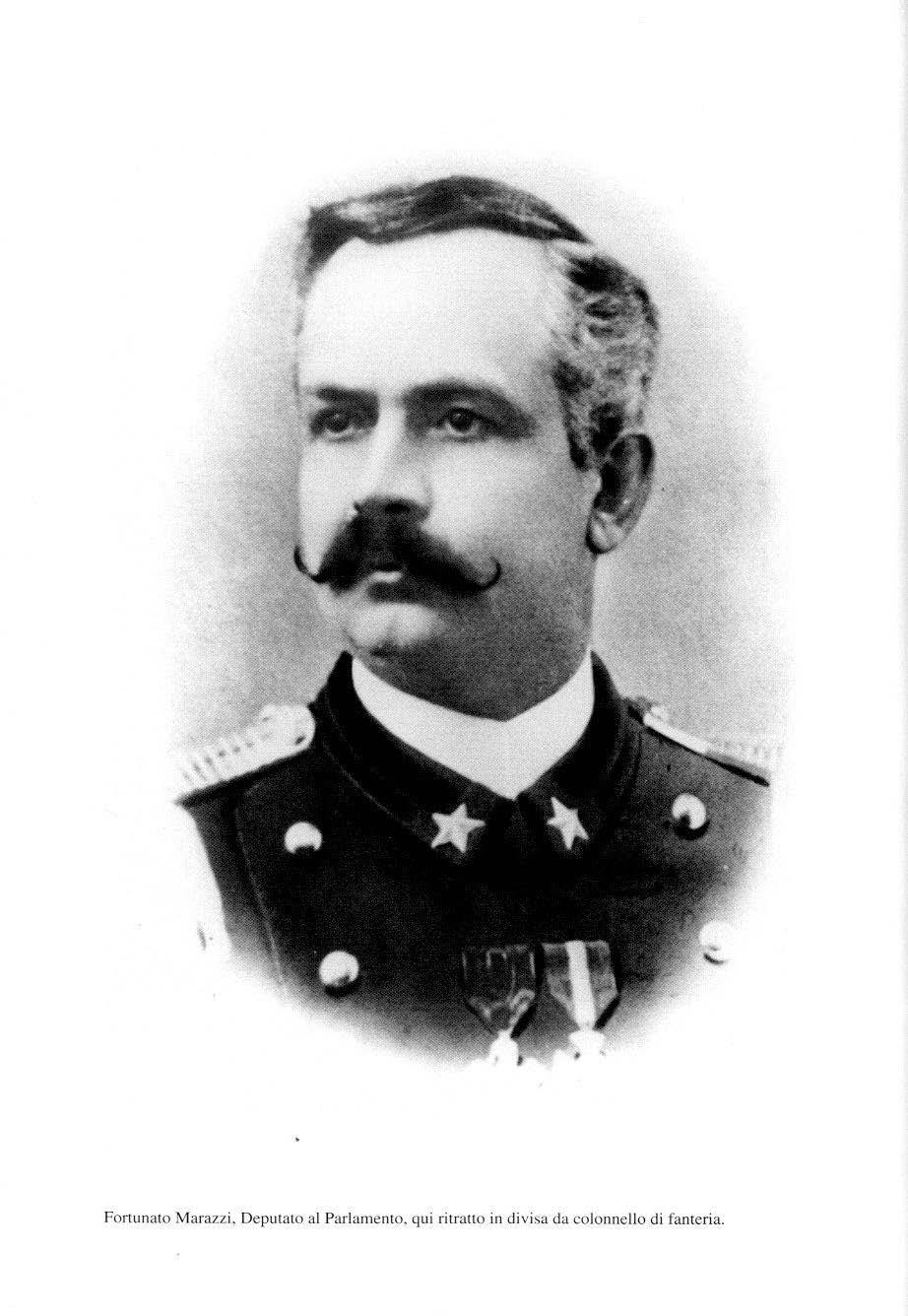 Fortunato Marazzi , De putalo al Par lamento. qui ritrailo in div is a da colonnello di fanteria.
Fortunato Marazzi , De putalo al Par lamento. qui ritrailo in div is a da colonnello di fanteria.
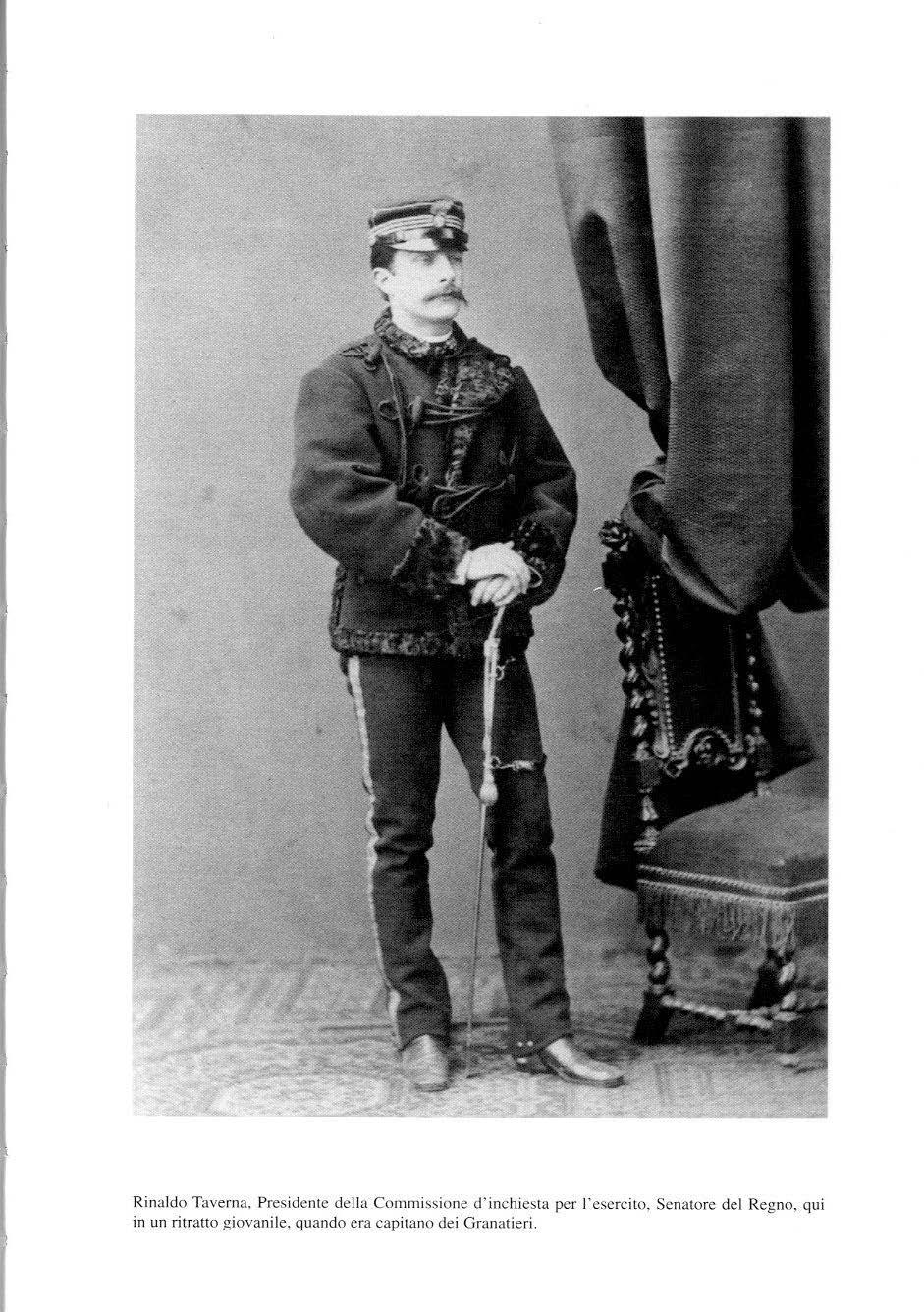 Rin al d o Taverna. Pres i dente dell a Comm i ssione d'inchi es ta per l'eserci tO , Senatore del Regno, qui in un ritratto giovan ile. qu an d o era cap it ano dei Granatieri
Rin al d o Taverna. Pres i dente dell a Comm i ssione d'inchi es ta per l'eserci tO , Senatore del Regno, qui in un ritratto giovan ile. qu an d o era cap it ano dei Granatieri
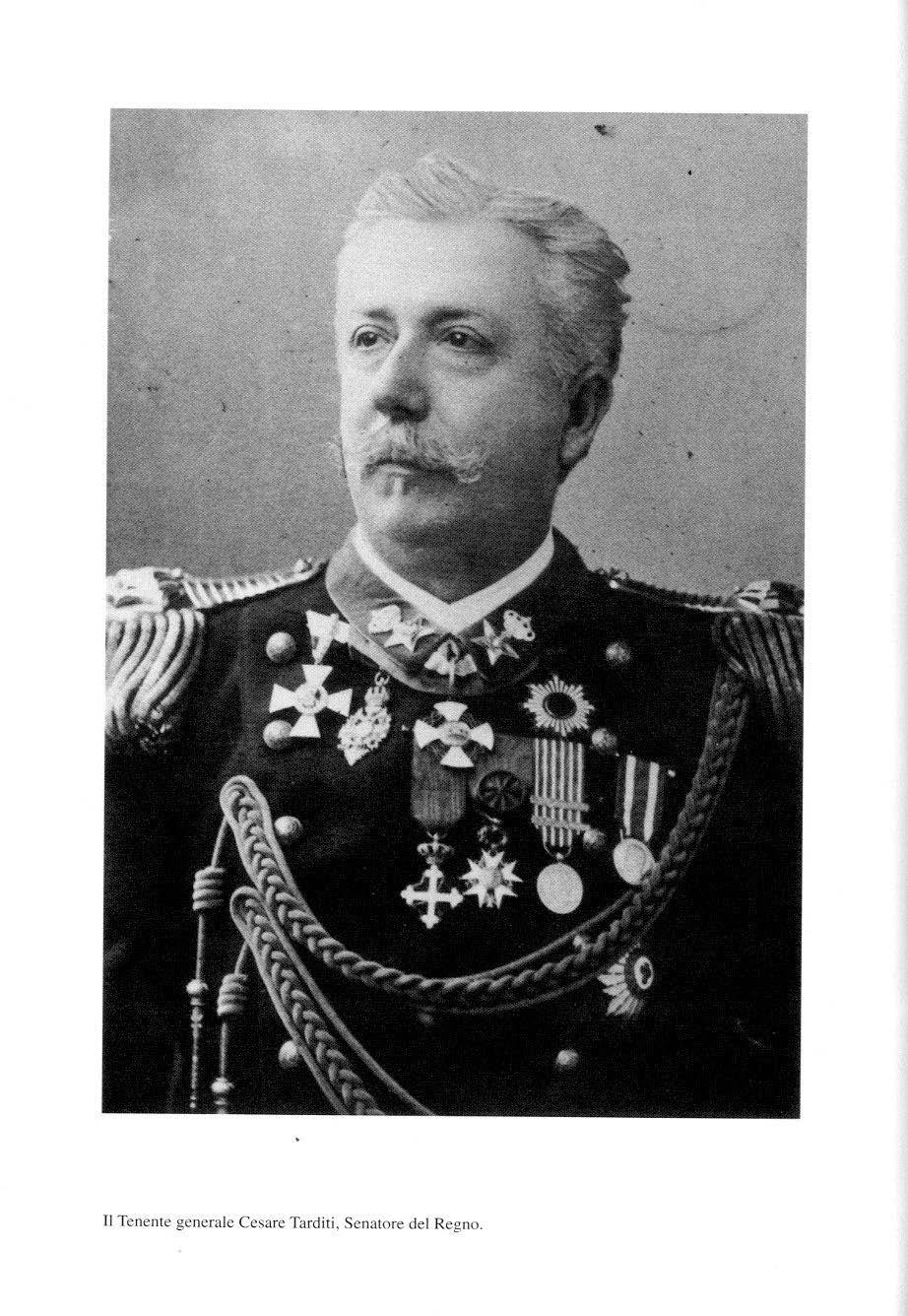 TI Teneme generale Cesa re Tarditi, Senatore del Regno.
TI Teneme generale Cesa re Tarditi, Senatore del Regno.
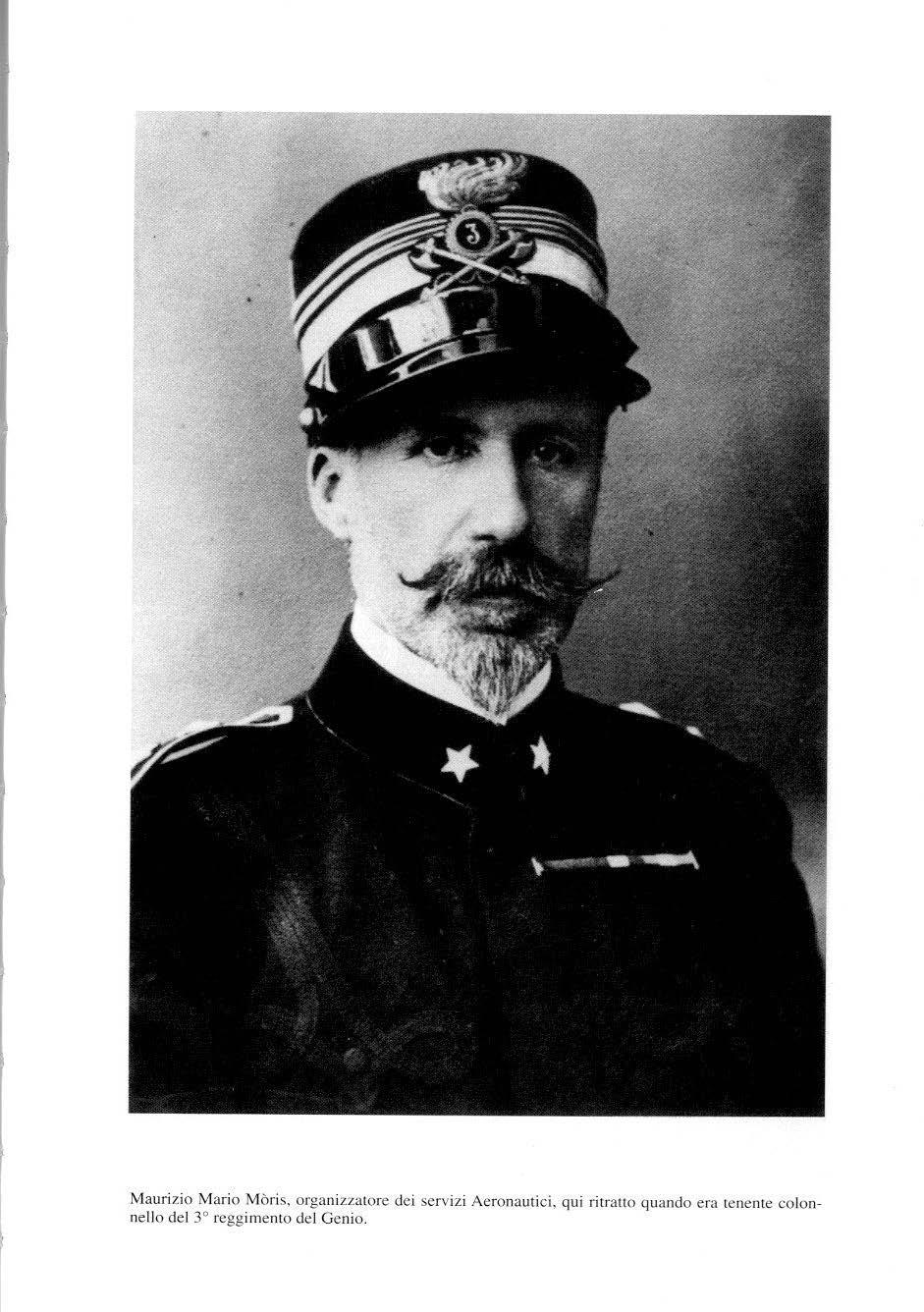 Mauri zio Mario Mòri s, organ i zzatore dei serviz i Aeronautici, qui ritrauo quando era tenente co l onnel l o del 3 ° regg i mento del Gen io.
Mauri zio Mario Mòri s, organ i zzatore dei serviz i Aeronautici, qui ritrauo quando era tenente co l onnel l o del 3 ° regg i mento del Gen io.
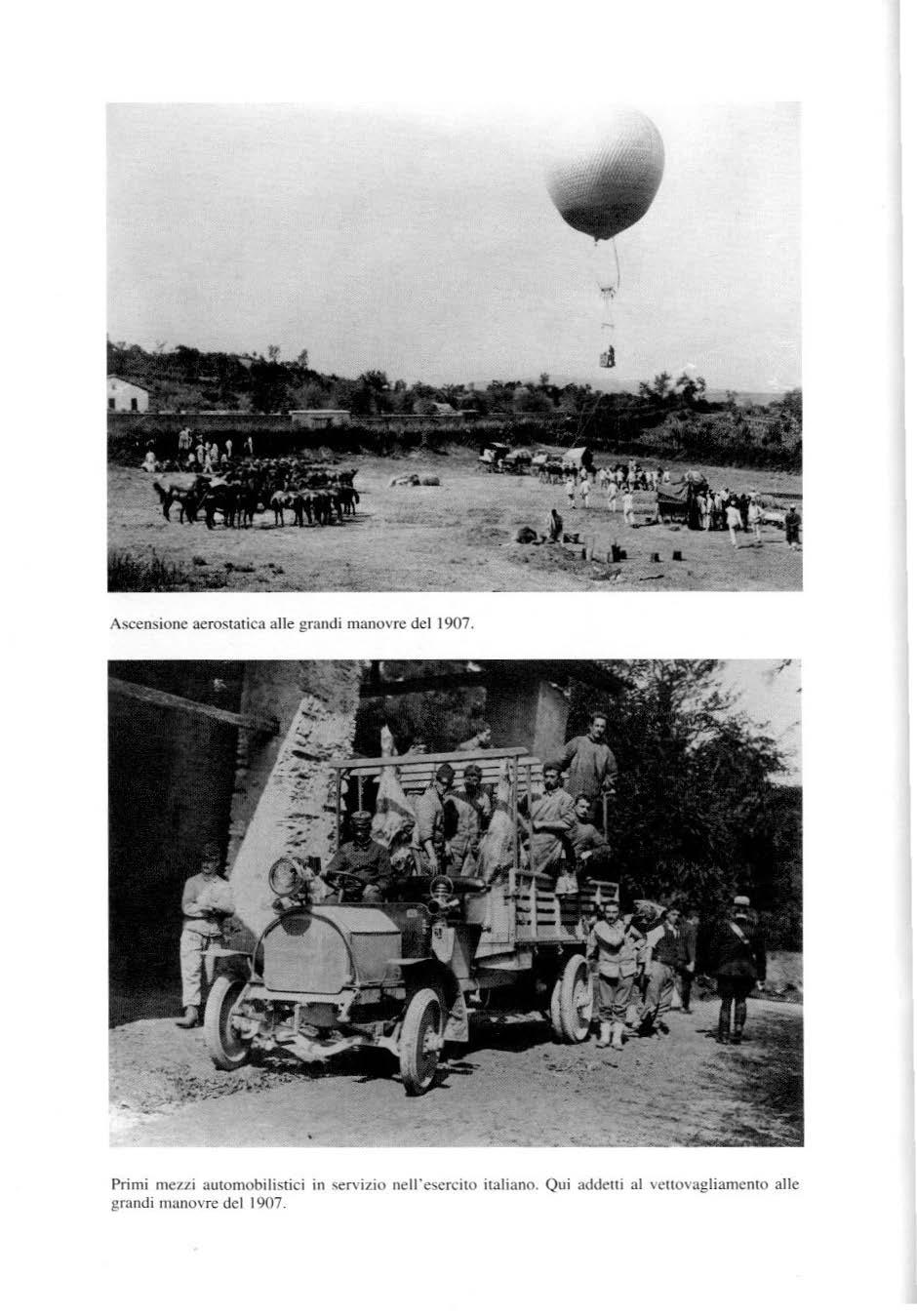 Ascensione aerostatica alle grandi manovre del 1907.
Primi meui automobilistici in ~ervizio nell'esercito italiano. Qui addeui al vettovagliamento alle grand i manovre del I907.
Ascensione aerostatica alle grandi manovre del 1907.
Primi meui automobilistici in ~ervizio nell'esercito italiano. Qui addeui al vettovagliamento alle grand i manovre del I907.

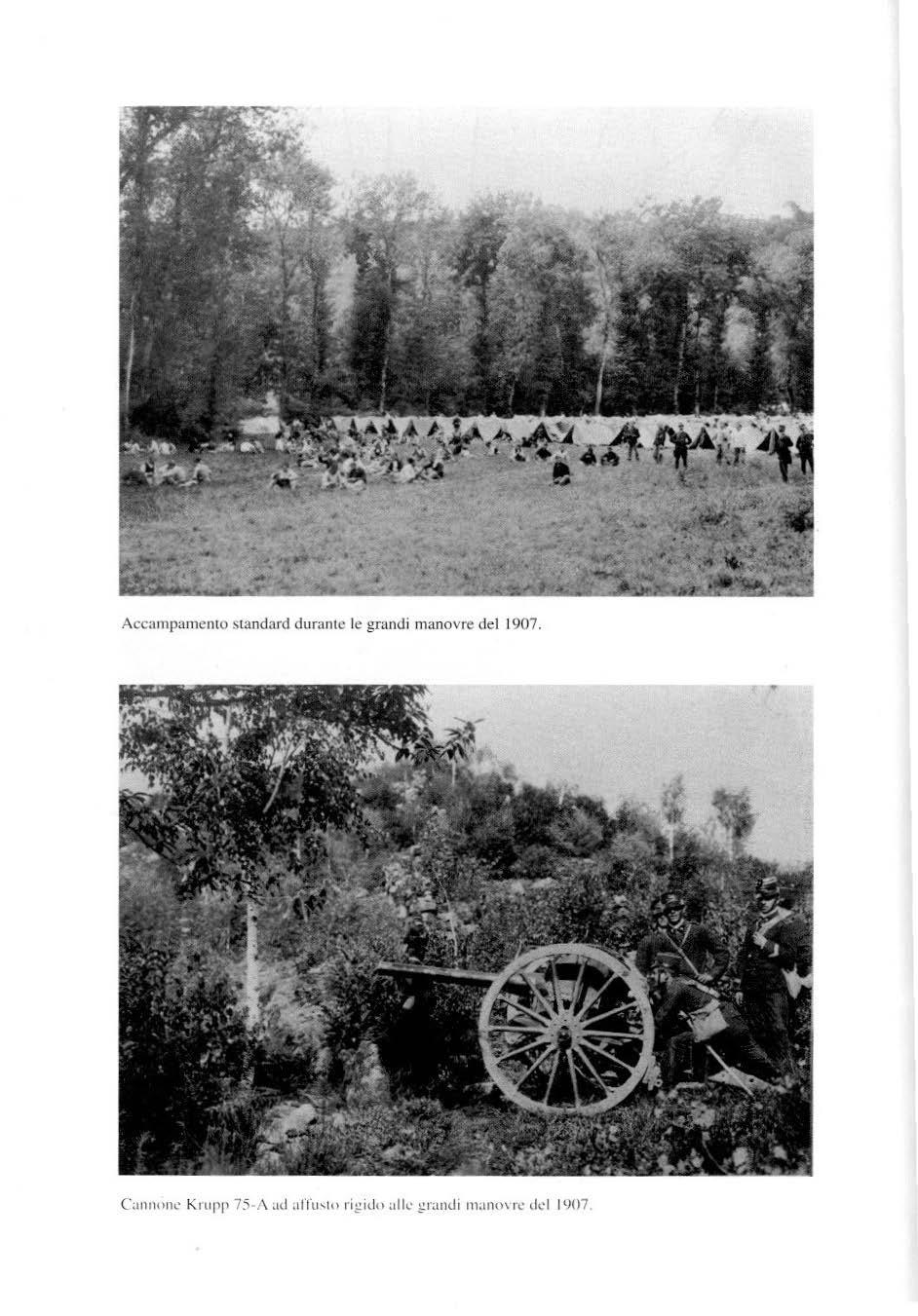
 Pezzo a de formaz i one K r upp da 75-A modell o 1906 al l e grand i manovre del 19 I l.
Pezzo a de formaz i one K r upp da 75-A modell o 1906 al l e grand i manovre del 19 I l.
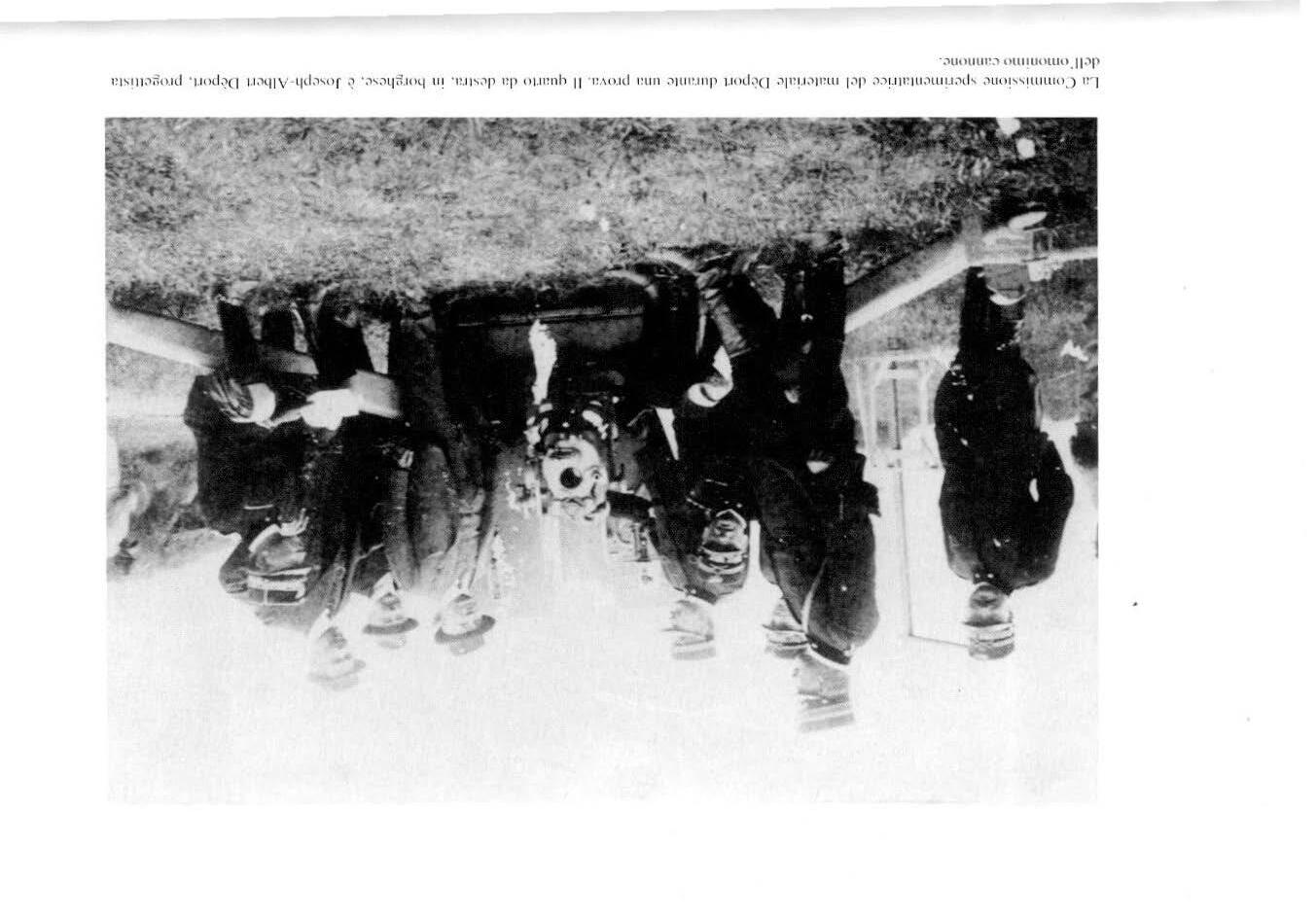
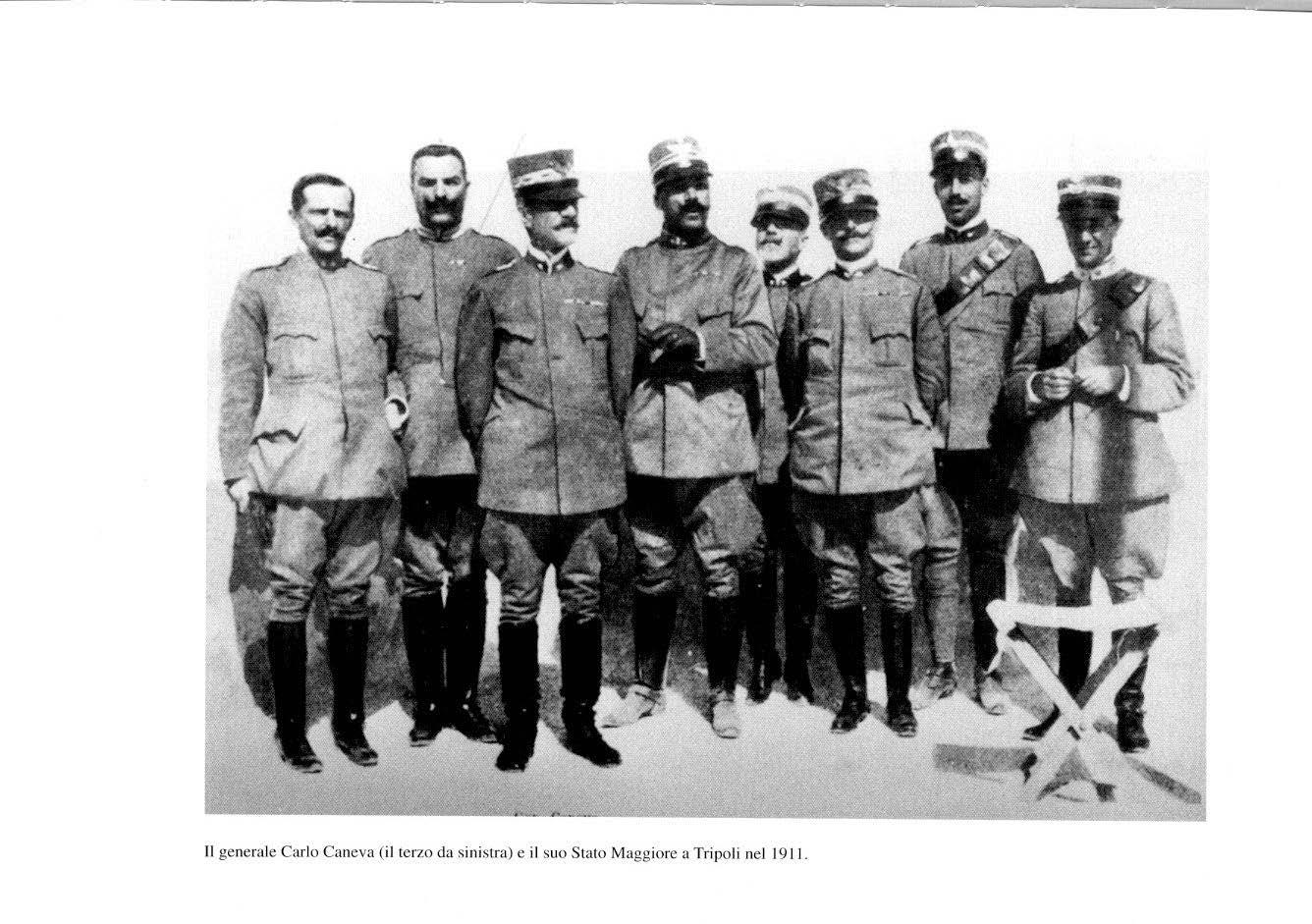 Il gene ra le Car lo Caneva (i l te rzo da s ini srra ) e il s uo Stato Maggio re a Tri p ol i ne l 19 I I.
Il gene ra le Car lo Caneva (i l te rzo da s ini srra ) e il s uo Stato Maggio re a Tri p ol i ne l 19 I I.
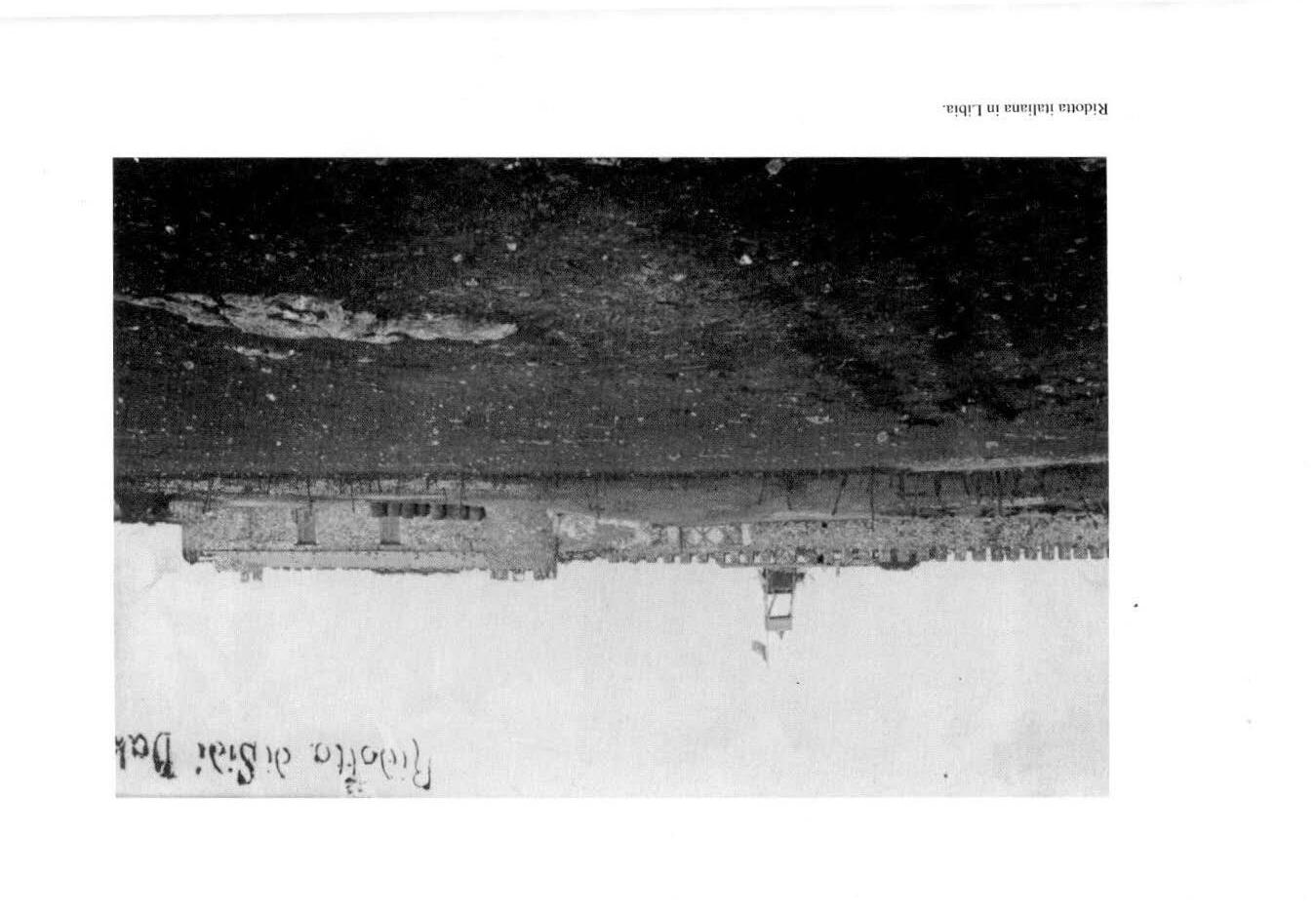
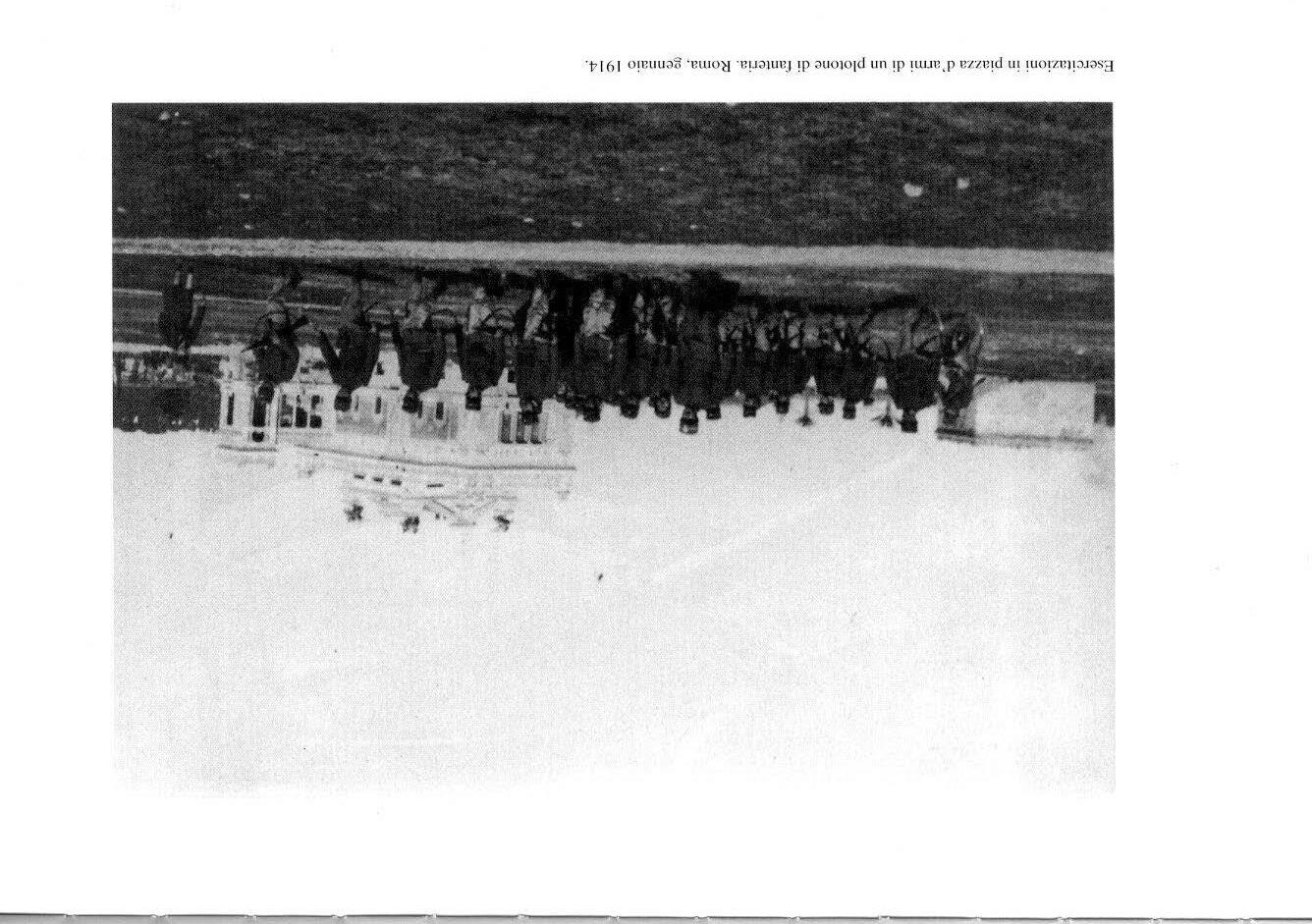
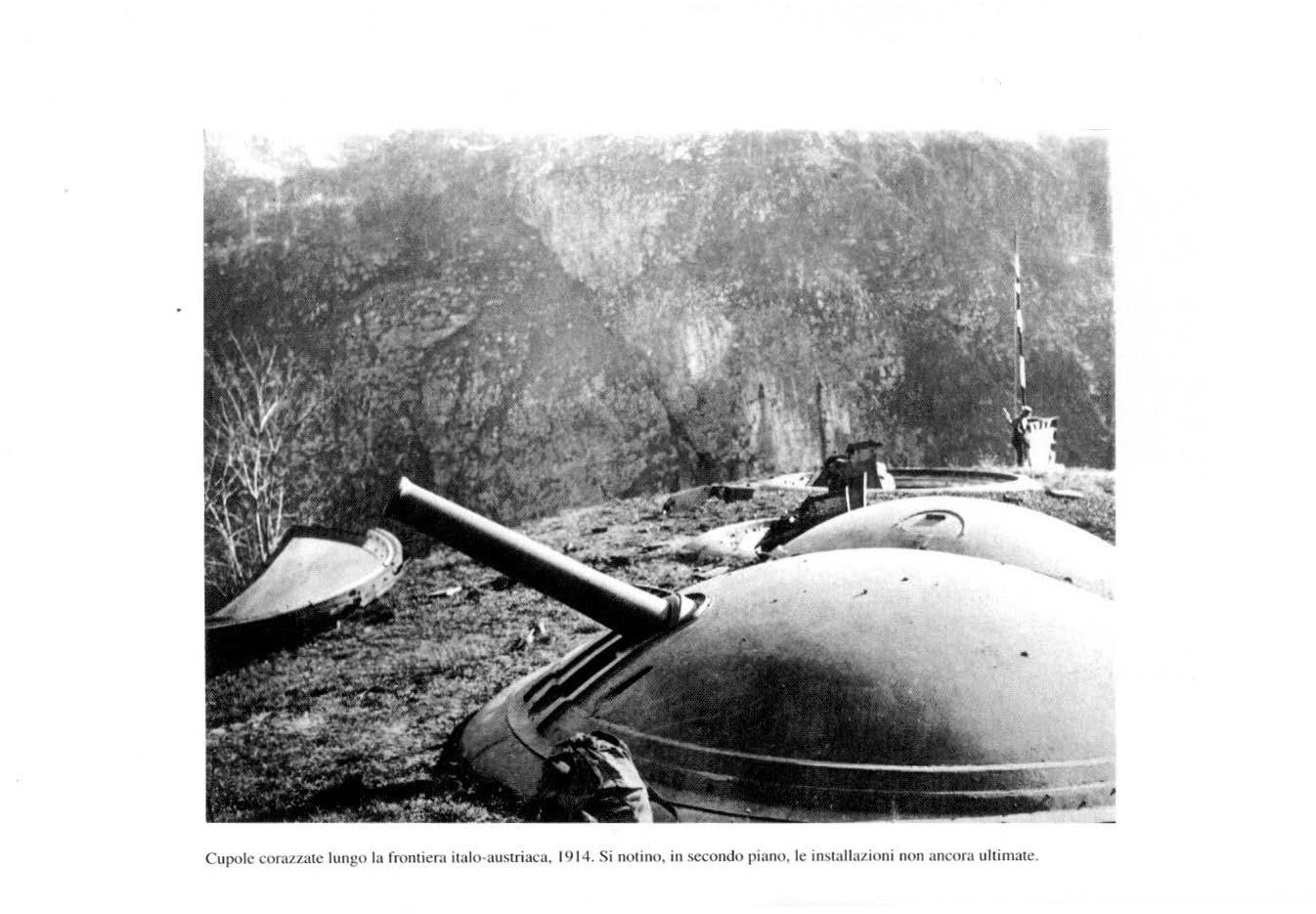 Cupol e corazzate lun go la fronti era i tal o -austriaca. 19 14. Si notin o. in seco nd o piano, l e installaJCioni non ancora ultimate.
Cupol e corazzate lun go la fronti era i tal o -austriaca. 19 14. Si notin o. in seco nd o piano, l e installaJCioni non ancora ultimate.