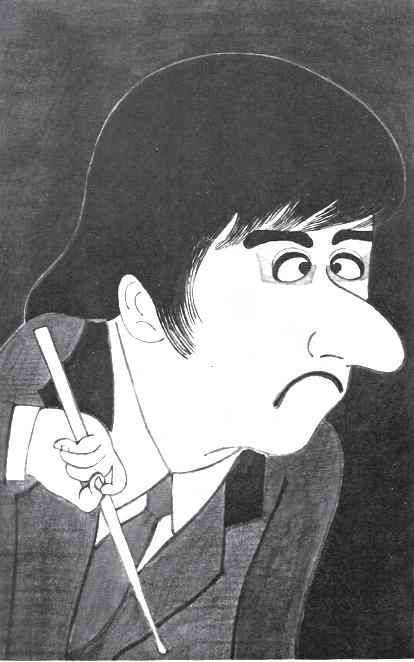Fabiana Andreani
Verbi deittici di moto in italiano e giapponese: due diverse rappresentazioni del movimento e della soggettività a confronto
Quando si legge un’opera in lingua originale, una sensazione comune è quella di sentirsi disorientati di fronte al testo: sebbene i personaggi siano i medesimi della versione tradotta, spesso i toni delle discussioni, le descrizioni degli stati d’animo, lo scorrere del tempo così come il ritmo delle vicende possono apparire dotati di un’espressività irriconoscibile e a tratti persino innaturale. Questo contributo trae il suo spunto originario proprio da questa comune e apparentemente banale esperienza, ed ha lo scopo di mostrare come, parafrasando le parole di Coseriu,1 “le lingue parlino delle stesse cose ma non dicano le stesse cose”. Ovverosia, nel caso specifico di italiano e giapponese, come esse non facciano uso delle stesse strategie per esprimere un medesimo contenuto. Si cercherà infine di mostrare come tali scelte influenzino la visione ed interpretazione dello spazio.2 1 Si veda Eugenio Coseriu, “Les universaux linguistiques (et les autres)”, in Luigi Heilmann, (a cura di) Proceedings of the Eleventh International Congress of Linguists, Il Mulino, Bologna 1974, pp. 47-73. Nell’articolo sono esposte le differenze che intercorrono fra significato, designazione e senso; dove il primo indica il significato di lingua, cioè il valore che una data parola ha all’interno del sistema lessicale della lingua a cui appartiene; la seconda indica invece la realtà extra-linguistica a cui una data parola fa riferimento; e infine il terzo consiste nel contenuto semantico del testo, cioè appunto nel senso che il testo comunica. Secondo Coseriu quindi non è possibile tradurre da una lingua a un’altra il significato, dal momento che questo è legato in maniera vincolante al sistema linguistico di cui una data parola fa parte; ciò che invece bisogna fare è comprendere la designazione di un dato termine e da lì ricercare nella lingua in cui stiamo traducendo il termine corrispondente che ha identica designazione di quello tradotto. 2 Si veda Dan I. Slobin, “From ‘thought and language’ to ‘thinking to speaking’, in John J. Gumperz & Stephen C. Levinson (a cura di), Rethinking linguistic relativity, Cambridge University Press, Cambridge 1997, pp. 70-96. Leonard Talmy, “The relation of grammar to cognition”, in Brygida Rudzka-Ostyn (a cura di), Topics in cognitive linguistics, John Benjamins, Amsterdam 1988, pp. 165-205. Talmy Givón, “Definiteness and Referentiality” in John H., Greenberg, C. A. Ferguson & E. A. Moravcsik (a cura di), Universal of human language, Stanford University Press, Stanford 1988, vol.4 Syntax, pp. 291-330. Come hanno fatto notare Slobin, Givón e Talmy, in ogni lingua esistono modi privilegiati per descrivere gli eventi e, in tal senso le scelte dei traduttori “are strongly influenced by the typologies of the source and target languages.” (Givòn, “Definiteness and Referentiality”, cit. p. 2, poiché, oltre che rispondere ad esigenze puramente stilistiche devono essere orientate a rendere il testo quanto più naturale per un lettore madrelingua.