

·nit •..,!<' 1o nm·eml>rc 191 H:
l'cirri\ o tlllllolo C n lo dd <,Jccicttorpcclinil'rr
\li <Id< <• m n (l bordo il Hc l'Cl il Gt'lì DiM



·nit •..,!<' 1o nm·eml>rc 191 H:
l'cirri\ o tlllllolo C n lo dd <,Jccicttorpcclinil'rr
\li <Id< <• m n (l bordo il Hc l'Cl il Gt'lì DiM
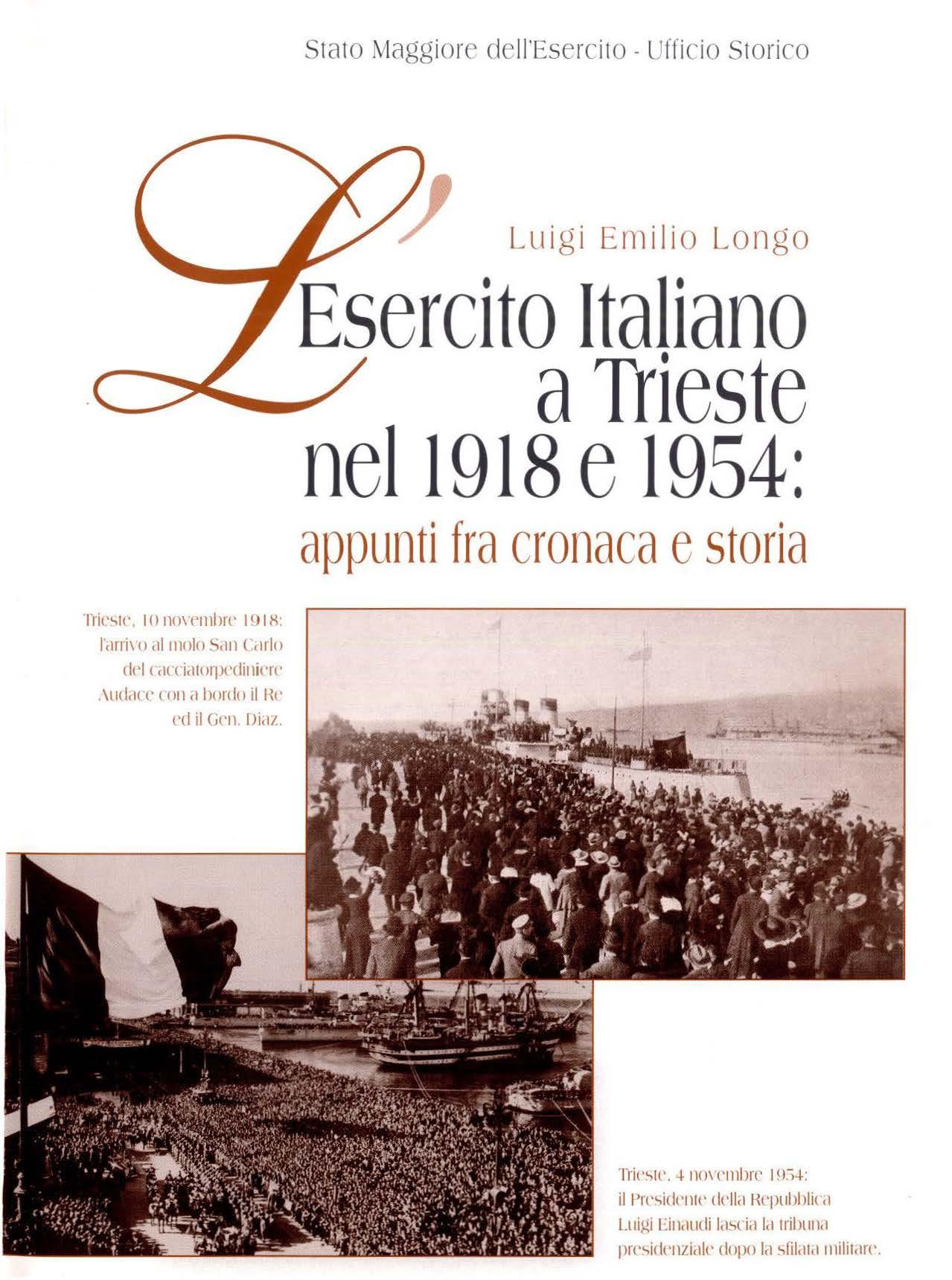
tutti i dirilli riservati. Vietata anche fa riproduzione parziale senza au torizzazione © Ufficio StOrico SME - Roma

' Italia del XXI secolo ha ben ragione di essere orgogliosa del proprio Esercito che sta dando, sia nel Paese che all'estero, quell'immagine di efficienza che rappresenta al meglio tutta la comunità nazionale.
Gli uomini dell'Esercito, infatti, insieme ai commilitoni delle altre Forz e Armare, esprimono la loro opera tività ben oltre il territorio nazionale, impegnati in missioni definite sì "di pace " ma connotate comunque da notevo le rischio c tensione psico -fisica. In questi scenari i nostri militari mettono in gioco nel modo migliore le capacità individuali e la predisposizione, lutta iralica, ad un'armonica integrazione nel contesto collettivo. Dori , queste, ancora più esaltate dalle situazioni reali, spesso ad elevato livello di potenziale emergenza, con tempi molto brevi di reazione c con poéhissimi margini di errore consentiti.
La Festa dell'Esercito riveste perciò, oggi più che mai, un carattere che non è solo celebrativo ma racchiude in sé un particolare significato: accanto alla rievocazion e degli avvenimenti in chiave storica , stimol a riflessione e condivisione su aspetti di imm ediata e futura attualità.
L a storia dcJ nostro P aese offre infin it i spun t i per individuare le città destinate ad ospitare, di anno in anno, la Festa del l'Ese rcito, consentendo di collegarle in un percorso ideale che armonizzi la tradizione con il vivere presente. In questa ottica l'importante evento si celebra quest 'anno a Trieste, che nella sua suggestiva cornice racchiude magnificamente profondi valori: la città di Trieste ha infatti
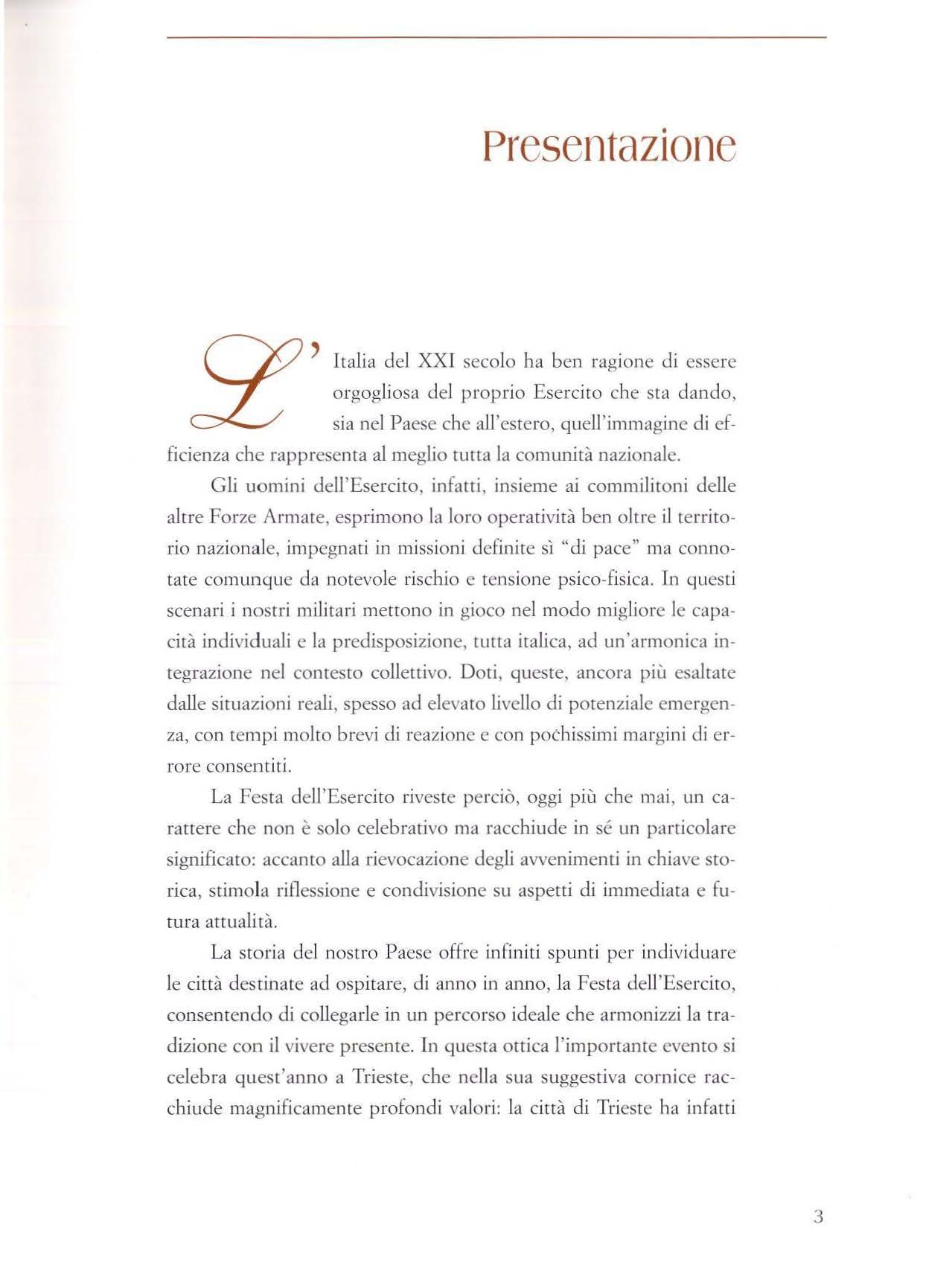
esaltato la sua tradizione storica, particolarmente ricca di avvenimenti, innestandovi in maniera [elice contributi di progressiva innovaz10ne.
Trieste riecheggia in sé, in ogni suo dove, le r isonanze lontane e pur tanto vicine della "passione adriatica", quello stato d'animo così vibrante che caratterizzò tanti "grigioverdi" che ad esso si abbeverarono tra ill915 e ill918. Ma Trieste sprigiona anche quel sentimento di forte consapevolezza di custode dei confini patrii da cui discende un atteggiamento di costante v igilanza.
L'Esercito Italiano ha vissuto 141 anni di vicende svoltesi in scenari, luoghi e situazioni diverse, ma mai come a Trieste ha trovato la sua vera ragion d'essere in termini di impegno ideale e concreto insieme. A queste pagine il compito di perpetuarnc il ricordo, tra cronaca e storia.

ra la città di Trieste e l'Esercito c'è sempre stato un rapporto particolare, un legame affettivo che il trascorrere del tempo, anziché attenuare , ha mantenuto vivo nella reciproca sintonia spirituale. Qualcosa di arcano, di romanticamente suggestivo, ha infatti portato sempre il nome di Trieste ad evocare l'immagine dell'Esercito e altrettanto istintivamente la Forza Armata si è identificata in quel nome , quasi che esso rappresentasse la sintesi di tante vicende che ne hanno scandito la storia .
È per questo che, in occasione di una Festa che celebra l'Esercito proprio a Trieste, l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore ha voluto uscire momentaneamente dal solco storico-rievocativo che caratterizza la sua produzione ed ha deciso di dar vita alla presente pubblicazione.
Una deliberata eccezione al normale modello storiografico, quindi , per sottolineare la peculiarità dell'intimo rapporto emozionale esistente fra l'Esercito e la Città di San Giusto. Un rapporto nato nel novembre 1918 sotto forma di una passione ardente, riesplosa con maggiore intensità 36 anni dopo, ancora più sofferta nelle sue premesse e maceratasi nel dolore di una l unga attesa.
Le pagine che seguono, così come specificato nel titolo, sono degli "appunti" che si collocano fra la cronaca e la storia, attraverso i quali si è inteso descrivere gli eventi cittadini con l'atmosfera che li ha permeati , con l"' anima" di Trieste, cercando di coglierne l'essenza anche attraverso quegli aspetti connessi con la pittoricità delle im-

magini e con l e rappresentazioni che ne d erivano Così il 1918 è stato fatto rivivere attraverso una sintesi descrittiva di alcune spigolature di "triestinità" e, accanto ai presupposti politici e strategico-tattici che portarono a Vittorio Veneto c quindi a Trieste, anche dell'arrivo dci primi reparti italiani . Analogamente, con la rievocazione delle trattative diplomatiche protrattesi dal 1945 al 1954, quest'ultimo decisivo anno è stato ritratto attraverso le trepidanti ore dell'attesa e della definitiva riunione alla Madrepatria, piene di tanti episodi piccoJi c grandi, seriosi e fu t ili, più o meno significativi ma comunque tutti espressione di un'unica, "grande emo)} zzone .
 Col. Massimo Multari
Col. Massimo Multari
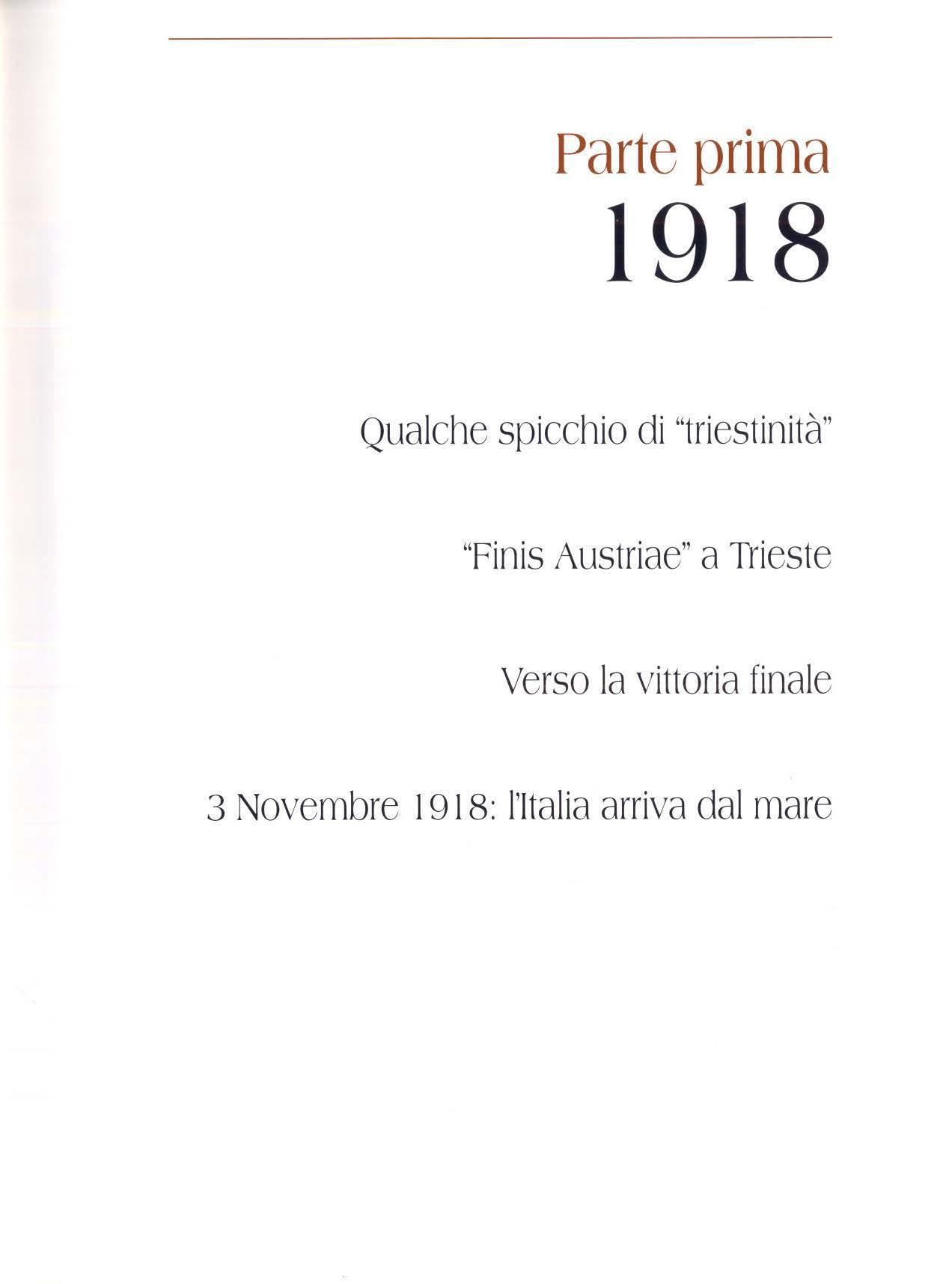
3 Novembre 1918: l'Italia arriva dal mare

OH \l POCLI \CLJ \'111\fl
\"01. \TE C'O ' l. \l'O\ O \ Y'W. \1\TICIII \EliSI IT\UCl :
'\E ' H \1 :o-01. CilE..;\\ I'I·.TR0"\10 1\II'OHI'OR \
\ ' 01. \Tr Ili :- \"\ Glt STO " 0\ H\ l R0\1 \"\l ltli> E RI !
S \LI T\TE "11· 1. GOLFO ( ; Il :-TI 'iO POLI.

CE\1\1 \DI·: L' ISTRI \.E Il \ h!WE POHTO 1•: IL LEO'i DI \HICCI \:
:-- \Ll T\ n : Il DI\ T\ Hl'iO Il E 1 : H>RI \
Pl'\ IlO\ l 1'01. \l TE\IPI l O:-lT\1\ \ HO\l \ 1'. \ C: E:-- \Hl' '
POI PIH.S:HI L'l R'\ \ 0\ F \1\C:OR TH \' lll E l'O l'OLI
\l\ CU \ RD \ \H \WO DE 1: \liTI E t> E L\ t.I.Oill \.
Il\ F\CCI \\LO STH \\IIEH UIE o\R\1 \TO \C C \\1f'\SI
SC 'l. \O'iTIW Sl 01.. <. \ \T\TI-. : lT\1.1 \ . IT\LJ \. lT\1.1 \ !
C\ROl CC I

((Le lanterne dal bordo catramato delle barche si sfaldano in tante lamine d'oro -che dondolano. E non c'è !una, ma sopra i pinastri di M ira mare un piccolo brivido di conchiglia, e !a città pare l'ostrica polposa nella conca di madreperla serrata tra i due tendini bianchi."
versi di Giacomo Comandin i sembrano esprimere, più compiutamente di altri, quella b e ll ezza soffusamente malinconica che connotava la Trieste fra gli ultimi decenni dell800 ed i primi dcll900. Bell a, romantica c pragmatica ins ieme, quella Trieste, ch'era ricca e modesta, molta sostanza e poca parvenza. I suoi magazzini scminascosti straboccavano di merci, le gru idrauliche del vecchio "Punto Franco " non avevano braccia sufficienti per scaricare dai piroscafi nei vagoni c negli hangars sacchi, balle e cassette; nei disadorni locali del Tergesteo si contrattavano affari con i mercanti di ogni parte del mondo; i cantieri impostavano silenziosamente navi che dovevano destare l'ammirazione di tutti i paesi navigatori, i capitani di lungo corso si preparavano a sostenere difficili gare ed a vincere ambiti premi sugli oceani; le società assicuratrici tesse vano alacri una fitta rete di interessi in tutta Europa e l ' Oriente; il teatro lirico allestiva senza grancassa spettacoli degni dei maggiori centri europei, la culru ra si affinava negli studi tappezzati di vo lumi di alcuni intell ettuali schivi e solitari; un pittore come Bolaffio dipin geva sconosciuto in una soffitta, un poeta come Saba stava molte ore del giorno dietro il banco della sua piccola libreria antiquaria , un romanz iere come Svevo curava la sua azienda industriale di colori so ttomarini.
Era la Trieste del Ginnasio Comunale D ante Alighieri, il vivaio della classe intellettuale dirigent e del la città, nato nel 1863 e che

avrebbe sempre rappresentato una pietra miliare nella sua struttura culturale.
Ed e ra la Trieste delle sue donne, con quella loro bellezza sciolta che senza essere morbida e ra calda, e sobria senza esse re arida, quegli occhi marini in carnagione rosea o quella cera bruciata sorto lo sguardo umido, impersonificata al meglio nella Lina Ji Trieste e una donna del Canzoniere di a ba, nell'Angiolina di Senilità, nell' Augusta e nella Carla della Coscienza di Zeno, nell'Edda Marty di Un anno di scuola
Donne di un temperamento particolare, non infia cchito né dal confessionale né dai timori trascendenti, che l'a ccostava piuttosto alla materia li tà, una materialità sana e vibrante. La "sartorel a" e l a "sessolota" rappresentavano un tempo due figure sola ri della vita triestina: univano i quartieri plebei a quelli borghesi, il porto al sobborgo, l'artigiano all'artista ed i l ricco commerciante al facchino. La loro stagione fiorente era il carnevale, con le mascherette dei grandi balli popolareschi, dei cosiddetti "cassoni"; perché il to-

no della vita triestina era dato in gran parte dalla mancanza di vere barriere fra popolo e borghesi.
E poi c'erano l e g ite domenicali sul Carso, a quell 'epoca ancora terra natural e, poco o quasi p er nulla modificata dalla mano d e ll ' uomo. Qualch e ca mpo di patate nelle sue doline, qualch e frutteto e qualche v igna intorno ai suoi rari villaggi, qualche chiesa in cima ai poggi più dolci; per il resto era selvagg io, lande di pi etra con ciuffi di ginepro, monti rivestiti di pinete, d'intricati faggeti, di piccole querce contorte. Valli silenziose e deserte, le stagioni decise, il clima rigido, la flora molto simile a quell a d e ll 'a lta montagna.
La gita su l Carso di domenica era per molte famigli e triestine un'abitudine. Tre quarti d'ora di como da salita e si era su. Poi istituirono il "t ram di Opicina ", e in venti minuti si poteva ra ggiungere l'altopiano. Ma tutte le strade che portavano ai vali chi, que lla di Contovello, quella di Tri estenico, la cala Santa, la strada di Banne , quella della Vede tta Alice, quella di Monte Spacc ato, di Basovizza erano battute la domenica da allegre comitive tra le quali non era raro vedere qualche padre col figlioletto a cavalcioni su ll e sp alle. E' pur vero ch e la maggior parte di queste comitive, raggiunto il ciglio s'avviava a poco lontane mete gastronom iche , le famose osterie campagnol e

Oppure si andava, più semp li cemente, a passeggiare a San Giusto Narr a la leggenda che Giu sto fosse un triestino autentico. un giovanottone ancora così giovane che le donne del popolo, quando guardavano l a sua immagine in Du omo dipinta da Be n e d et t o Carpaccio, dicevano fra loro ({Eljera un bel mulo" . Il giovane soffrì il martirio che m eg li o accendeva la fantasia dci triestini: fu annegato in mare. Ferito , mazzolato, sanguinante, più lo buttavano in acqua c più Giusto veniva a ga ll a . Così i crudeli so ld ati romani do veuero legargli molte pietre al collo, e finalmenre con molti macigni del Carso addosso il pe rsonagg io sco mparve nelle acque. n giorno dopo la sa lma di Giusto , con tutt e le pietre intorn o al collo, si trovò a ga ll eggiare lungo una dell e rive della città, la riva di Grùmula. Così San G iu sto entrò nel martirologio portandovi come ins egna nobiliare i s uoi sassi.
Sare bb ero dovuto essere autentici macigni del Carso, maxegni, taglienti e aguzze pietracce di calcare tagliate alla diavola , così come vengono g iù a un colpo di mart e llo , sb il enche , lun g he e strette come lame. Ma purtroppo l 'a raldica sfugge alle leggi della verità. Il realismo dei grèbani del Carso, di quelle autentiche scaglie g rev i e storte di un bel co lo re argenteo che ferirono con i loro spigoli l e spa lle e il
volto di Giusto, trovò impermeabile la mente dei disegnatori di stemmi, ed il suo sasso (ridotta la corona di pietre ad una sola) fu stilizzato nella forma di un grosso ovoide, ornato di scannellature regolari, che lo faceva assomigliare indiscutibilmente ad un melone . Ed ecco là, in mezzo al piazzale di San Giusto, la colonna di pietra bianca dell ' Istria e r alabarda Ji ferro diventato nero nella pioggia e nel vento; ed in cima alla colonna , a reggere l'alabarda protervamente confitta a sfidare il mondo, c'è sempre lui , il melone , il sasso di San Giusto . I triestini più anziani, f orse, ricordano ancora un ritorne ll o che diceva cos]:
A Roma i g'ha San Pietro, a Ven ezia i g'ha elleon,per noi ghe xe San Giusto col vecio suo melon.


Ilo scoppio della guerra la città restò praticamente isolata ed assediata. L e sue speranze in un arrivo i mmediato delle truppe italian e liberatrici andarono deluse. Alla delusione si accompagnò un senso di sfiducia negli organi più vicini al governo eli Roma, dai yuali e ra venuto l'avvertimento confidenziale di provvedere al mantenimento dell'ot·dine pubblico nel breve tempo che sarebbe int e rcorso dalla partenza delle autorità austriache all'arrivo dei nostri soldati. TI Corpo dei vo lontar i organizzato per la bisogna sarebbe stato si costituito, ma tre anni e mezzo dopo.
Hanno sbagliato sicuramente strada, dicevano alcuni anziani, non riuscendo a rendersi conto del ritardo. Forse non se ne rendevano conto nemmeno le autorità luogotenenziali, che avevano preparato il necessario per la partenza con una sollecitudine tale da far pensare piuttosto ad una fuga. Invece restarono, e cominciò l'isolamento.
La mobilitazione c gli internamenti avevano spopolato la città. 11 dominio mil itare vi si insta llò con tutto il rigore elci suoi tribuna li, i viveri cominciarono a scarseggiare, e fu pr ima la carestia poi la fame, aggravata dalla "spagnola". T giorni si succedevano ai giorni, i mesi ai mesi , le stagioni alle stagioni, sempre più smorti c gr ig i. 11 tempo si era fermato al maggio 1915 e non passava più, e ra diventato un dolore fisico. Nessuno sapeva niente di preciso su ciò che accadeva fuori dei confini cittadini. oppresso Il Piccolo, gli italiani non avevano a disposizione che fl Lavoratore, e questo usciva spesso con le colonne falcidiate dalla censura. Almeno gli italiani internati nei campi di concentramento dell 'A ustria avevano la possib il i tà di l eggere nel giornale ungh e r ese !lz Est i bo ll ettini d eg li Allea ri.
Il 16 giugno 1915 era stato disposto lo sciog limento de ll a Lega Nazionale che, costituita nel 1891, aveva rappresentato l'espressione autentica e spesso clamorosa della realtà triest i na in tutte le sue
diverse componenti irredenrisre. Ne erano espressione anche le strofettc di una canzone dell'epoca:
" 1 o pol esser nostro amico chi contrario a noi ne mostm, questa lingua xe la nostra xe la lingua nazional. De sta lingua che parlcmo in dt/esa sua costante sentinela vigilante xe la Lega Nazionat'

La città era come una donna che, con la fantasia eccitata, guardasse due uomini combattere per il suo possesso. Il suo cuore apparteneva forse a coloro che per essa si erano mossi cd ora spargevano il loro sangue lottando accanitamente. Non si rifiutava, ad ogni modo, anche a coloro che, con lo stesso spirito di sacrificio c lo stesso valore, ne difendevano il possesso.
Amici e nemici. tutti avevano sempre davanti agli occhi il prezzo della vittoria: Trieste, la bella perla sul mare. Un gran numero di uomini versava il sangue davanti alle sue porte, e negli angoli più nascosti delle case echeggiava il rombo del cannone. Quando calava la notte, migliaia di persone sedevano sulle terrazze dei caffè della riva e guardavano verso l'altra estremità del golfo, dove il cielo era tutto un lampeggiare di esplosioni. Due giganti lottavano per Trieste, Punta Sdobba lanciava ton n e ll ate di ferro infuocatc contro l'Hermada e l' H ermada rispondeva alla Sdobba, menlre il Carso insaziabile divorava m ig li aia e migliaia di uomini.
L a cosa più bella era quella di alzarsi dal lavolo della vita per guardare in faccia la morte, affacciarsi ad un balcone c scrutare nella notte. L aggiù, dall'altra parte del golfo, lampeggiava il bombardamento, scoppiavano le granate. Migliaia di uomini se ne stavano distesi dietro foreste di filo spinato, rannicchiati nelle buche c nelle trincee, le bombe a mano in pugno, oppure avanzavano e mori,·ano sotto le raffiche delle mitragliatrici. Qui la morte non poteva nulla, era il paradiso, là l'inferno; in mezzo, un paio d'ore d'autocarro.
Questa era Trieste, quando ancora si combatteva per il suo possesso. Una dolce attrattiva, un desiderio tormentoso. Poi vennero
la dodicesima battaglia dell'Isonzo, Caporetto, ed il rombo del cannone si allontanò. Splendore e gloria le furono roltc, perché essa non era piLtla bella per i cui occhi gli uomini combauevano e morivano a decine di migliaia. Il suo sorriso scomparve.
l propagandisti dell'epoca grida\'ano, a chi vole\ a c non \ ' olcva sentire, che le armate austriache marciavano su Venezia e si accingevano ad occupare Milano. Era la fine. Non ci voleva che la salda fede dei patrioti italiani per resistere all'accoramento. L'atmosfera cittadina, già tanto pesante, si incupì maggiormente. Per gli italiani, fu rassicurante più tardi la circostanza che, passata Caporetto, sulle vicende del la guerra tornasse il silenzio. La speranza riaffiorava. Vari segni prcmonitori annunciavano che qualche cosa di nuovo stava maturando. Alla morte Ji Francesco Giuseppe, qualche barlume di luce cominciava a venire d'o ltre il sipario di ferro. I campi di internamento furono sciolti. l deputati italiani alla Camera di Vienna potevano far sentire la loro voce. l\;la nessuno era ancora in grado di valutare la portata e le conseguenze della mancata offensiva austriaca sull'altopiano di Asiago, sul Montello e sul Grappa, preludio al Piave ed a Vittorio Veneto. Quando se ne ebbe piena conoscenza, non vi furono più incertezze: era la vittoria. Ma occorreva superare gli ultimi ostacoli.

Il 30 ottobre 1918 Trieste insorse, così come il giorno precedente era insorta Fiume. Il Luogotenente fries -Kene, prima di abbandonare la città, aveva fatto un ultimo tentativo di resistenza, ordinando al presidio di Monfalcone di inviare a Trieste forze sufficienti per reprimere il movimento popolare. L'ordine giunse a destinaz ione, ma non fu eseguito.
Tntctnto da Trieste e da Fiume partivano diretti alla volta di Venezia i delegati dci Comitati cittadini, sorti per la circostanza, al fine di sollecitare l'invio della flotta italiana. Anche da Pola partiva Lm delegato. V'erano da attraversare i campi di mine disseminati lungo iJ percorso e non si avevano punti di orientamento. Si scorgevano aeroplani italiani sorvolare i natanti degli argonauti c fare cenni amichevoli.
A Venezia i delegati ebbero qualche noia. furono fermati e bendati, sospettando le autorità che si trattasse di un affare poco chiaro. Allorché si convinsero del contrario promisero l'intervento, e mantennero la parola. Il 3 novembre 1918 scendeva a terra il primo generale italiano, e ponendovi piede consacrava l'evento secondo il ri -
to militare, dichiarando che prendeva possesso della città in nome del Re d'Ttalia. La folla, che da giorni aveva abbandonato le case imbandierate per gremire le rive, dava sfogo alla propria passione nella misura in cui l'aveva contenuta e macerata per più di 40 mesi.
I giorni successivi testimoniarono che l'Italia portava, con la liberazione, h clemenza verso coloro che le erano stati avversari e ostili. Ed anche questo era nella tempra romantica di quella guerra. Il generale Petitti sciolse il Comitato di epurazione che si era costituito ed accolse il generale barone Margutti, aiutante di campo di Francesco Giuseppe, che si presentò a lui in tenuta di gala con le decorazioni austriache accanto a quella dei Santi Maurizio e Lazzaro. Il suo imperatore era morto, il suo esercito non esisteva più cd il barone Margutti, seguendo l 'es cm pio di altri notabili dell'aristocrazia austriaca regionale, sollecitò l'onore di entrare nella comun i tà ordinativa del Regno d 'I talia.

t iu"' to' :<Ì I I un 11'11111'1' 11,•1 h•to\' IH\>:<0 II H' oliu
l'l'li. flll' lllill'l' tl i 111 111• \,• 1'111'11\11'1'. di' li ' tll'tl i!to• -•li\'Ìd• • l' l iu q u•ra", pl ti iiii ÌIIII 1I\JI
l!''"ui tis11111 l' •lt'll ituwri:.:ia, o·:11·ali•·n• tlt•l ' '' 'l ' " " l ru, ol •• ll a h >rllll'il ,. •I•·Ì luno li pru l l'l li lrt' tll'l! li s birri " tl• llo · " l'i• \.!t": tll 11 1111':-dr, , <k ll ' un li tlt ' , •l•·l tli ' •n liiiL' ,. '' ••p•·ori•i .,.:, t' l' t' ,. , , Cùi' IO (l'il'la) l o•d ulli 11 11• d..r iuith·o. la l' "''" n oltl lurala , ., ,, ,.,,.,(,. Zi t u , 1""'' \ Uu glie l m o n e Il ,
""''''' s$ur•· ti i ,\ 11 ila. i11 II IIÌ\1111' a l olt•gtu• fi ;.: lio. " l 111 11'\'"' i d i · oli 1'111 111 "' v oli Hh u le nb ur g, Pt l 111 pri11111 ' llllirl i•·rl! ms l t ' ll gt' ll t'l'alt• tl e L u tlc ll tlo l'f, al u ra11 Hlllll tint ,.Ji, VO li Tit·pltz, •·n po- pi rn la sullm \Hli'ÌIIù ol PI vnules imo, t• •l a ll ' :o• r:d,hia lo «•·urli•·:•-p up .o lì v o n ll c ill c n tl n n d , 110 111'111', a l
tlìsi ll u ><o m:llt)!ia- il :din ll i p:-; l.:mHw v tm He t ze n do l'l , : d ht 1 i : ro · t11 agiara c o n t e Tizsu, n 1l l' a11i nw
:< lr:ozi:t l\1 pi io tl alla ral. li in in1pu\t'ufto 1'111• ol:ol tlul••n !< Ìil ho•ll•' l'"llfu rl ali ola ll a 1 ' (' 11 ><111':1, 111) 11 posstll lO
II :ISiallldo•n• l:olto it'l't• pa r: th il •• pt•r di la ai ptw lt i d t•' la pÌ:t ll l!""'' ,. :o i llt.>l l i dii' l ll' g i•> ÌSt'll llll
l n •s li tl t• ll' ' ' "''t'r:tn tl , •·:m•!!ll:t, p• r •lt•s id ••rill olt•ì 1" " ., 11 1i \' <'II J.!IIIIII ingo iati ol:tll n lt•rr:\ tli iu )h ll' : l 't) g 1u,,: , ('!l p•unp ' f uu.- lut> .
l\\' ll :t o•a llo·•lndo• d i :-< :-\1•·fa"'' 11\tiii:< Ìg ll oor Fu i d u lti 1 lu• l r. o "•'III'J "' dd dt•lunlol. h• oTil 11 n ;;o ltlll ll t'
ro••tliÌ I' II I. - :-<olio• oiÌ ;: I"' ' ' "'' t(i tho ll o• \'Ì .-: ik oli t•t JII<Io:,!li:tll/ 1 ìl •lì Turdd.t \' d il s uu L':u uh a-
-<o•inlul\' di ' l' 11 rt·llia ì• iii\ ' Ìialu 11 1 I\''111Ìt'1 11 :1 r:tpp1t'N 'IIl: trlu
t: l 'nou p t' Fnolt'hti & l '.
rieste, un'ostrica che gli italiani si erano accinti finalmente a prelibare nell'autunno del1918, nell'ambito della battaglia che sarebbe stata storiograficamente indicata come quella di Vittorio Veneto.
Nel quadro di questa battaglia, il piano generale italiano si prefiggeva la rottura del fronte avversario nel punto di sutura fra le sue due armate sul Piave, la 5 ", detta anche Armata delJ' I sonzo, e la 6", con l'intento di scindere in due tronconi le forze nemiche del settore partendo dal Montello e puntando su Vittorio Veneto, modesto centro urbano ma importante nodo di comunicazioni, aggirando così da Sud la 6" armata ed impedendone il ripiegamento. E ciò a prescindere dall'attacco sul Grappa delJa 4" Armata, portato con lo scopo diversivo di attirare in quel settore le riserve austro-ungariche ma che si sarebbe tramutato in una battaglia di tipo carsico, con perdite enormi, ammontanti ad 1/3 degli effettivj delle fanterie impiegate e corrispondenti a 2/3 delle perdite totali di tutta la battaglia di Vittorio Veneto.
La nostra offensiva sul Piave, iniziata il 26 ottobre, aveva incontrato le più grosse difficoltà non tanto nella contrapposizione nemica, pur presente ed efficace soprattutto nel tiro di interdizione delle artiglie rie ed in alcuni centri di resistenza accanita lungo la sponda orientale del fiume - come ad esempio nella piana di Sernaglia - quanto invece nell e condizioni di piena del fiume stesso che, in alcuni punti prescelti per il traghettamento, aveva travolto uomini, ponti, passerelJe e teleferic h e . Supera rolo comunque in più tratti, anche se in tempi diversi, iJ 2 9 ottobre Je teste dj ponte oltre Piave erano ri uni t e, e nell o stesso giorno aveva in izio l 'ult ima fase della battaglia, quella del completamento del successo attraverso la rottura p iena d el fron t e nemi c o. Nelle prime ore del mattino del30, una col onna celere cost ituita da reparti de ll 'V III Corpo d'Armata e del Corpo d'Armata d'Assalto, le due Grandi Unità entrambe comandare al momento dai genera le Grazio l i, faceva il suo ingresso a Vittorio Ve-

L'<: splnsiorK ' d i
t tn proir tti le eli ca lii Ho
cll ts tri aco
sull'mgin e elci
Pi ave clll 'ini zio
clcll tl l)a tt;:Jgli a eli
\ 'itt orio \ 'c rw to .
neto, con il che si realizzava la scissione in due tronconi delle armate nemiche dislocate in montagna.
Alla vigilia dell'ultima battaglia. il quadro riassuntivo degli opposti schieramenti era il seguente:
Ordin e di batta gli a dell e fo rze austr o-un ga riche
Comando Supremo:
Imperatore Carlo I d'Asburgo; capo di S.M.: generale Arz von Straussenburg; sottocapo di S.M.: generale von Waldstatten; p.lenipotenziario tedesco: generale von Cramon.
Gruppo armate del Tirolo (dallo Stelvio al fiume Brenta):
Comandante: colonnello generale arciduca Giuseppe d'Asburgo.
10/\ armata: feldmaresciallo von Krobatin (dallo SteJvio all'AsticoV, XX, XXI, XIV C. d'A. c riserve).
11 /\armata: colonnello generale conte von Scheuchenstuel (dail'Astico al Brenta- III, XIII, VI C. d'A. c riserve)

Gruppo di armate Boroevic (dal fiume Brenta all'Adriatico):
Comandante: feldmaresciallo Svetozar Boroevic von Bojna.
Gruppo Belluno (dal Brenta a Fener sul Piave):
Comandante: generale von Goglia (XXVI, I , XV C. d'A. e riserve).
6A armata: generale principe Schonburg -Hartenstein (da Fener alle Grave di PapadopoJi -II, XXIV C. d'A. e riserve);
51\ armata: colonnello generale Wenzel Wurm (da Papadopoli alle foci del Piave- XVI, IV, VII, XXIII, XXII C. d'A. eriserve) .
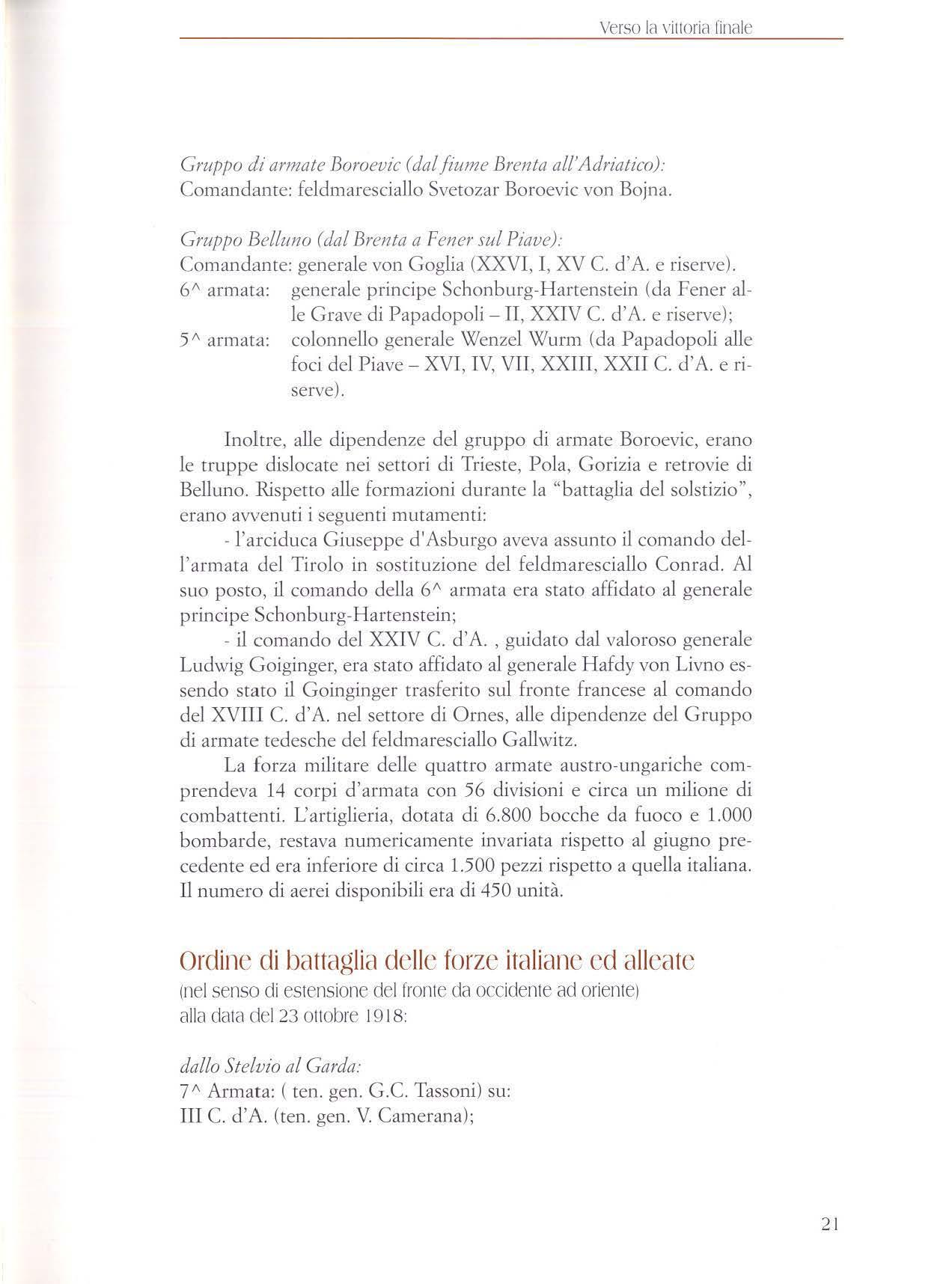
Inoltre, alle dipendenze del gruppo di armate Boroevic, erano le truppe dislocate nei settori di Trieste, Pola, Gorizia e retrovie di Belluno. Rispetto alle formazioni durante la "battaglia del solstizio", erano avvenuti i seguenti mutamenti:
- l'arciduca Giuseppe d'Asburgo aveva assunto il comando dell'armata del Tirolo in sostituzione del feldmaresciallo Conrad. Al suo posto, il comando della 61\ armata era stato affidato al generale principe Schonburg-Hartenstein;
- il comando del XXIV C. d'A. , guidato dal valoroso generale Ludwig Goiginger, era stato affidato al generale Hafdy von Livno essendo stato il Goinginger trasferito sul fronte francese al comando del XVIII C. d'A. nel settore di Ornes, alle dipendenze del Gruppo di armate tedesche deJ feldmaresciallo Gallwitz.
La forza militare delle quattro armate austro-ungariche comprendeva 14 corpi d'armata con 56 divisioni e circa un milione di combattenti. L'artiglieria, dotata di 6.800 bocche da fuoco e 1.000 bombarde, restava numericamente invariata rispetto al giugno precedente ed era inferiore di circa 1.500 pezzi rispetto a quella italiana. li num e ro di a erei disponibili era di 450 unità.
(nel senso di es tensione del fronte da occidente ad or iente)
alla data del 23 ot tobre 19 18:
dallo Stelvio al Garda:
71\ Armata: ( ten. gen. G .C. T assoni) su:
III C. d'A. (ten. gen. V Camerana);
XXV C. d 'A (t en. gen. E. Ravazza ); truppe suppletive d ' armata;
dal Garda a ft'A stico:
lA Armata: (ten . gen. G. Pecori Giraldi) su:
V C. d 'A . (ten . gen. G. Ghersi );
X C. d'A . (ten. gen. G. Cattan eo);
XXIX C. d' A. (ten . gen. V. De Albertis); truppe suppl e tive d ' armata:
Altopiano dei Sette Co muni:
6/\ Armata ( ten. gen. L. Montuori) su:
XII C. d 'A. (ten. gen . G. Pennella ) ;
XIII C. d'A. ( ten. gen. U. Sani) ;

XX C. d'A. (ten. gen. G. Ferrari ); truppe supple tive d 'a rmata;
dal Monte Grappa fino al Monte Pallone :
4/\ Armata ( ten. gen. G. Giardino ) su:
VI C. d 'A. (ten. ge n. S. Lombardi );
IX C. d'A. (ten. gen . E . De Bono );
XXX C. d 'A (te n. gen U. Montanari ); truppe suppletive d'armata:
dal Monte Pallone al ponte di Vidor:
12/\ Armata (ten. gen. J. C. Graziani) su :
I C. d ' A. (ten. gen. D. Etna);
XII C. d ' A. francese (ten . gen . J.C. Graziani); truppe suppletive d ' armata:
da Vidor al ponte della Priula:
8/\ Armata (ten. ge n. E. Caviglia) su:
VIII C. d'A. (ten. gen. A. Gandolfo);
XVIII C. d'A. (ten. gen. L. Basso);
XXII C. d'A. (ten. gen. G. Vaccari);
XXVII C. d'A. (ten. gen. A. Di Giorgio);
Corpo d'Armata d'Assalto (ten. gen. FS. Grazioli); truppe suppletive d ' armata;
dal ponte della Priula a Ponte di Piave:
I()A Armata (ten. gen. FR.L. Cavan) su:
XJ C. d'A. (ten. gen. G. Paolini);
XIV C. d'A. inglese (tcn. gcn. J. M. Babington); truppe suppletive d'armata;
da Ponte di Piave altnare:
31\ Armata (ten. gen. S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia -Aosta) su:
XVI C. d'A. (ten. gen. V. Alfieri );
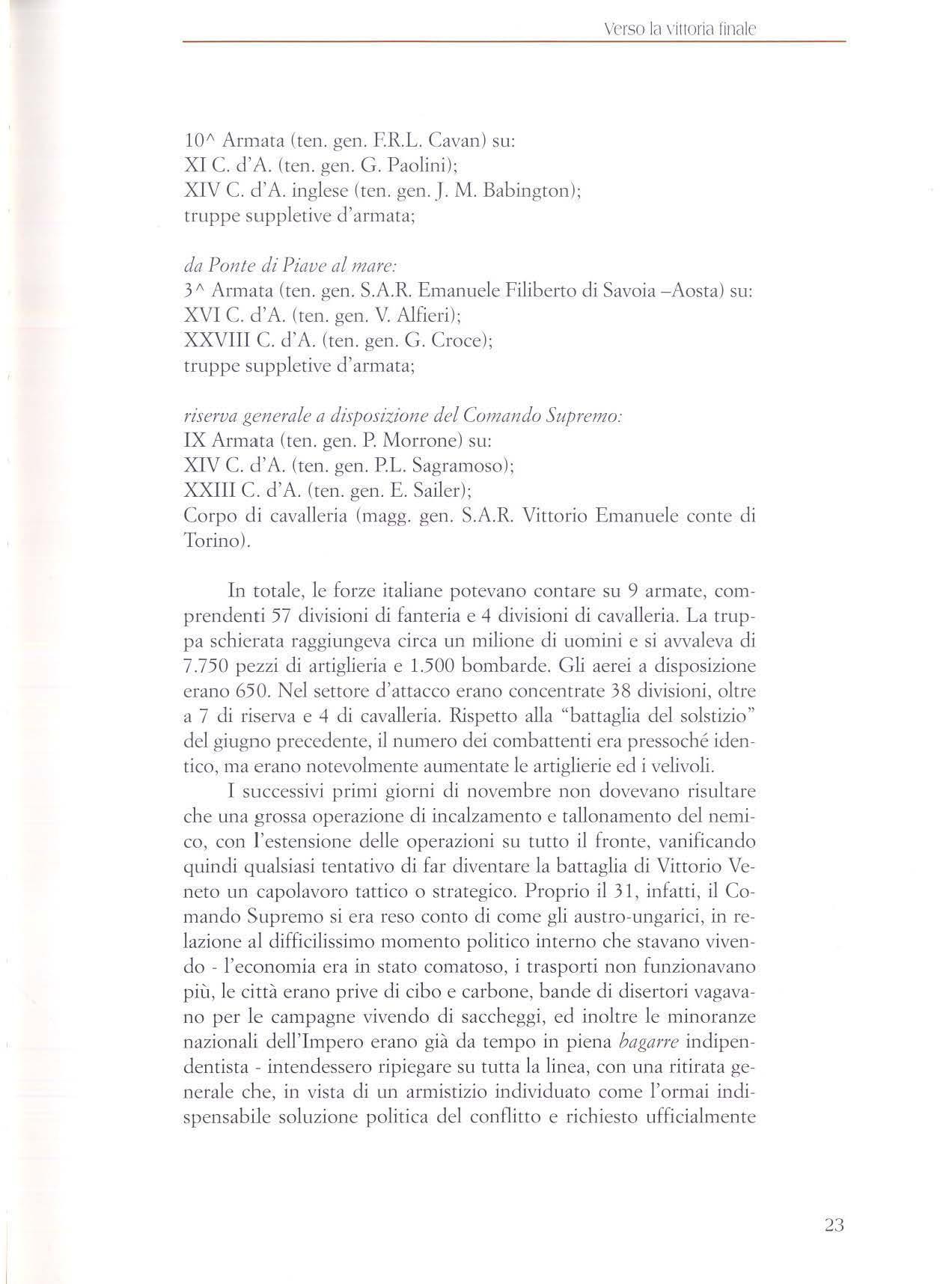
XXVIII C. d'A. (ten. gen. G. Croce); truppe supplctive d'armata;
riserva generale a disposizione del Comando Supremo:
IX Armata (ten. gen. P. Morrone) su:
XIV C. d'A. (ten. gen. P.L. Sagramoso);
XXII I C. d ' A. (ten. gen. E. Sailer); Corpo di cavalleria (magg. gen. S.A.R. Vittorio Emanuele conte di Torino).
In totale, le forze italiane potevano comare su 9 armate, comprendenti 57 divisioni di fanteria e 4 divisioni di cavalleria. La truppa schierata raggiungeva circa un milione di uomini e si avvaleva di 7.750 pezzi di artiglieria e 1.500 bombarde. Gli aerei a disposizione erano 650. Nel settore d'attacco erano concentrate 38 divisioni , oltre a 7 di riserva e 4 di cavalleria. Rispetto alla "battaglia del solstizio " del giugno precedente, il numero dei combattenti era pressoché identico, ma erano notevolmente awnentate le artiglierie ed i velivoli.
I successivi primi giorni di novembre non dovevano risultare che una grossa operazione di incalzamento c tallonamento del nemico, con J' estensione delle operazioni su tutto il fronte, vanificando quindi qualsiasi tentativo di far diventare la battaglia di Vittorio Veneto un capolavoro tattico o strategico. Proprio il 31, infatti , il Comando Supremo si era reso conto di come gli austro -ungarici, in relazione a l difficilissimo momento politico interno che stavano vivendo - l'economia era in stato comatoso, i trasporti non funzionavano più, le città erano prive di cibo e carbone, bande di disertori vagavano per le campagne vivendo di saccheggi, ed inoltre le minoranze naziona li dell'Impero erano già da tempo in piena bagarre indipendentista - intendessero ripiegare su tutta la linea, con una ritirata generale che, in vista di un armistizio individuato come l'ormai indjspensabile soluzione po.litica del conflitto e richiesto ufficialmente
HCj)élrlll di Cil\'iliiC'rid il<lli<mcl <li gu<H lo eli un fium<'
fin dal giorno 29 ottobre, potesse preservare, prima che fosse troppo tardi, l ' integrità delle loro armate e del loro territorio.
Bisognava, quindi, da parte italiana, farsi trovare al momento della cessazione del fuoco il più avanti possibile, onde legittimare rivendicazioni e richieste con un'occupazione territoriale militarmcnte conseguita, intento cui la controparte avrebbe cercato affannosamente di opporsi cominciando ad inviare sin dal 3 novembre, in vari settori del fronte , ufficiali parlamentari che chiedevano la cessazione delle ostilità, fingendo di ignorare che, se l'armistizio sarebbe stato firmato alle 15 dello stesso giorno (in realtà furono poi le 18), una clausola del protocollo imposto ai plenipotenziari austro-ungarici prevedeva che la cessazione del fuoco dovesse aver luogo 24 ore dopo, e cioè alle 15 del4 novembre. Si trattava, in ultima analisi, di lucrare il massimo interesse, ora, da quelle disposizioni e da quell'arricolazione delle forze con le quali, all 'inizio dell'offensiva, il Comando Supremo aveva inteso realizzare non più che una situazione mirante ad estendere il nostro controllo verso Est nella pianura veneta, e ad allargare l'area in nostro possesso così da garantire sicurezza e

buone prospettive di riuscita ad operazioni offensive che, per essere risolutive, si riteneva non potessero essere attuabili prima della primavera 1919.

Sulla base dell'evoluzione positiva delle operazioni - che aveva visto il suo acme nell'agosto aUorché le armate alleate avevano vibrato colpi improvvisi e veloci alle linee nemiche adottando un ' efficace tattica di attacco , grazie anche al primo impiego in massa della nuova arma rappresentata dai carri armati, che portava la pressione contro i loro punti deboli anziché quelli forti - gli esponenti politici francesi e britannici avevano iniziato una pressante azione su quelli italiani. In parte essa era condotta attraverso una sapiente enfatizzazione del fallimento dell'offensiva austriaca di metà giugno sul nostro fronte, attribuita al nostro pieno ed esclusivo merito, ed in parte attraverso esplicite minacce di ritorsione al tavolo della pace nei confronti del perdurare della nostra inazione proprio nel momento in cui loro stavano producendo il massimo sforzo.
il capo del governo Orlando ed il suo ministro degli esteri Sonnino erano ossessionati dalla paura che la pace potesse sorprendere l'Italia con le armate nemiche ancora in patria, come era successo a Custoza, e dopo la vittoriosa battaglia difensiva sul Piave di metà giugno avevano cominciato a loro volta a premere su Diaz e sul suo sottocapo di stato maggiore Badoglio affinché aderissero alle richiest e alleate e sfruttassero il successo gettandosi alle calcagna del nemico in ritirata, con buone probabilità di provocarne il crollo nel 1918. E qui il Comando Supremo italiano, attraverso la decisa opposizione dei suoi due massimi esponenti, aveva posto la seconda premessa fondamentale - dopo la prima, costitLÙta dall'arresto dell' offensiva nemica - per l'esito vittorioso della guerra , entrambe, nel loro insieme, molto più determinanti di quanto non Io sarebbero state le giornate di Vittorio Veneto .
Un sintetica analisi dei motivi di ciò mette in evidenza come l'attribuire ai nostri esclusivi meriti il successo della battaglia difensiva sul Piave non ci regalasse molto più di quanto ci competesse, perché in realtà i demeriti austriaci , che pur vi furono , non inficiavano la bontà della nostra conduzione operativa e, prima ancora, della predisposizione concettuale ed organizzativa della stessa.
L'ultima grande offensiva austro -ungarica sul nostro fronte, mirante a superare il Piave ed a metterei definitivamente fuori gioco, esprimeva la realizzazione da parte dello stato maggiore imperiale dell'antico sogno di un'operazione strategica combinata. Era un bel pro-
Ponte eli Pici\ c 01101) 1{' 1918: trinccrametlt i italit-mi ,<,ono \ 'isil)ili sulla ri\ 'él dcsrra del fiume.

LEse rei to llalic-mo n Trieste nel 1n18 e 1%4: <ìppunri fra cromGl c storici
getto, degno di un von Schlieffen, il geniale srratega capo dello stato maggiore tedesco dal1892 al1906, ed i pianificatori ne avevano curato con scrupo lo ogni aspetto, consapevoli di essere alle corde, tanto sul piano militare quanto ancor più su quello interno, e che questo avrebbe potuto rappresentare veramente l'u ltimo colpo di coda.
Il nemico intendeva condurre lo sforzo offensivo principale a ca va liere del Brenta in direzione di Padova, in modo da sfondare la nostra fronte montana ove essa era meno profonda, cioè in corri-
spondenza del Grappa, per poi giungere nel piano ed avvolgere tutto il nostro schieramento difensivo sul Piave. Contemporaneamente, sempre in pianura , avrebbe attaccato in dir ezione di Trevjso -Me -
stre ed avrebbe condotto energiche azioni diversive sul Tonale, nel settore delle Giudicarie ed in Val Lagarina, allo scopo di immobilizzare le riserve lasciando perplesso il Comando Supremo italiano sulla direzione dell'attacco più importante. Il Grappa rappresentava quindi il cardine della nostra difesa. La sua importanza era accresciuta da Ile difficoltà del nostro schieramento difensivo perché, mentre dalla parte nemica si presentava un versante ampio e di agevole percorso che facilitava l'attacco , dalla nostra parte rimaneva, alle spalle delle difese , un ripido versante verso la pianura, per cui le nostre posizioni mancavano della necessaria profondità a tergo. C'era una sola possibilità: resistere e contrattaccare.
Gli Austriaci, consapevoli del significato di "ultima spiaggia" che per loro rivestiva l'offensiva, l'avevano preparata a l meglio. Noi non eravamo stati da meno. Dopo le drammatiche vicende del novembre 1917, l'Esercito era stato sottoposto ad un'azione rapida ed energica di ricostruzione e riordinamento; se si valuta che esso , dopo Caporetto, aveva subito w1a riduzione di ben 800.000 combattenti effettivi, si può avere un'idea dello sforzo vera rnente notevole che era stato imposto alla nazione , alle industrie ed alla popolazione per riconferirgli la sua piena capacità operativa. Alle 50 divisioni nemiche attaccanti , ne opponevamo 44 , fra quelle schierate e quelle in riserva; deiHe 19 in quest'ultima posizione, 10 erano a diretta disposizione del Comando Supremo, che così si manteneva in condizioni di dirigere l'operazione.

Nello stesso tempo , si era costituita una riserva di 6.000 autocarri sui 31.000 dei quali l ' Esercito disponeva all'epoca, per lo spostamento rapido delle truppe nei settori minacciati (il secondo giorno dell'offensiva, ad esempio, la Brigata Sassari sarebbe arrivata in autocarro sino a 5 Km dalle prime linee sul Piave, e tre ore e mezzo dopo lo scar ico dai mezzi era già in azione). Su tutto il fronte schieravamo 7 .0 00 bocche da fuoco, contro le 7.500 austriache, di cui 5.000 tra l'Astico ed il mare, e 2.000 bombarde; ma il fattore importante era che l e nostre artiglierie mantenevano uno schieramento spiccatamente offensivo, dislocate il più avanti possibile in modo da poter battere proficuam ente in profondità le retrovie avversarie, le riserve ed i centri logistici.
I due sforzi principali, a cavali ere del Brenta e sui basso Piave, erano sratti condotti ad iniziare dal 15 giugno con forze pressoché equivalenti, ma il comando supremo imp eriale non aveva saputo effettuare quella indispensabile concentrazione degli sforzi là dove in-
tendeva ottenere il successo decisivo. E c'era anche un altro fanore che aveva giocato negativamente, impedendo agli austriaci di ripetere il successo del novembre precedente a Caporcrto: questa volta le div isioni tedesche, che in quell'occasione avevano pesato c come sulla bilancia dell'efficacia penetrativa, non c'erano, erano tornate sul fronte occidentale.
Il 19 aveva avuto inizio la controffensiva italiana, condotta con abbondanza di mezzi e determinazione fino al 24, allorché le nostre truppe si riarrestavano completamente sul Montello e su tutta la riva destra del Piave. La nuova linea sul fiume risulterà più corta di 8 Km e più lontana da Venezia di 6. Gli errori di conduzione austriaca non inficiavano assolutamente i meriti di quella itali ana . I n un documenro riservacissimo su ll e "Esperienze derivanti dai combattimenti del giugno 1918", prodotto dallo stato maggiore austro-ungarico, veniva testualmente affermato: le nostre truppe furono completamente disorientate e sconvolte dalla resistenze che incontrarono e dai combattimenti che dovettero sostenere nella zona intermedia /ortz/icata.
In effetti, in vista dell'offensiva, il Comando Supremo aveva reali zzato un'organizzazione difensiva in profondità sulla riva destra del Piave, artico lata su più linee susscgucntisi di un ti p o "elasti co" reso possibile da l terreno adiacente al fiume, ottemperante ad una disposizione di Cadorna risalente ai g iorni successivi a Caporetto e che costituiva uno tra i suoi non pochi meriti. La pianura, infatti, offriva un ambiente favorevole a questa organizzaz ione difensiva profonda sul retro delle prime linee. La fascia montana che a Nord cingeva la pianura, da una profondità massima di 14 Km si riduceva, in corrispondenza del Grappa, a meno di 5, per cui Io scardinamenro del fronte montano avrebbe posto in crisi tutto lo sc hi eramento in pianura. Per questo era stata spostata a Nord la riserva generale, e nel contempo s i era allestito uno schieramento strategico arretrato in pianura per parare un eventuale sfondamento nel settore del Pi ave.

Anche l'imp iego dell'artiglieria era una testimonianza che al Comando Supremo ci si era messi in linea con i tempi: il fuoco fu diretto ad inchiodare e distruggere le fanterie nem iche stùle loro stesse basi di partenza, a smantellare con metodo ponti e passerelle alle loro spalle, ad imp edire il consolidamento delle posizioni conquistate, evitandone così la rioccupazione a caro prezzo da parte delle nostre truppe.
La seconda premessa fondamentale per l 'es ito vittorioso della gue rra è da ricercare, come anticipare, dalla resistenza opposta da Dia z e Badoglio alle pressioni di Orland o affinché s i proseguisse su-
biro controffensivamente contro l'avversario in riLirata. Era un rifiuto che rispondeva ad una logica di carattere più tattico che strategico, alla base della qua le stavano considerazioni senza dubbio fondate.
i nsistere nella battaglia, infatti, avrebbe significato, nella situazione del momento, intraprendere una vera c propria operazione offensiva a l argo raggio che implicava anche il forzamento di una linea

f1uviale di grosso impegno, che già si era dimostrata un arduo ostacolo per il nemico benché si fosse diligentemente e lungamente preparato a superarla. Avrebbe dovuto fare immediato seguito l'attacco a posizioni d i fensive intatte - perché ta l i, in effetti, erano rimaste quelle sulla riva sinistra del Piave - ben organizzare, sufficientemente presidiate da truppe che, se pur scosse dal combattimento, sarebbero state sostenute da un notevole schieramento di artiglieria la cui gran massa era rimasta del tutto indenne, perché so lo un lim itato numero di batterie l eggere aveva attraversato il fiume per accompagna-
l.d popoldi.ÌOill' d..,..,j..,((• dll'entrcltd (!t'i prillli itdlidlli cl
\Ili orio\ t 'Ilclo
re le colonne d'attacco. Né d'altro canto sarebbe stato possibile il passaggio immediato di tutto il nostro schieramento, nelle sue varie componenti d'arma, tecniche e logistiche, da una configurazione prettamente difensiva ad una spiccatamente offensiva.

Ed , infine, non poteva essere sottovalutato l'aspetto psicologico: un eventuale, probabile insuccesso, pagato con forti perdite, e senza alcun consistente vantaggio territoriale, riecheggiante ciò che era awenuto nei tre anni di guerra sino ad allora combattuta, avrebbe potuto avere un impatto pericolosamente negativo sulla !abilità emotiva di un opinione pubblica per la quale il contenimento della minaccia dopo Caporetto , e per LÙtima la recente vittoriosa difesa sul Piave, avevano invece rappresentato una benefica e prowidenziale misura compensativa .
Diaz e Badoglio ebbero ragione nell'opporsi in quel momento ad Orlando, privilegiando la decisione , che del resto competeva loro del rutto legittimamente, di continuare a mettere a punto lo strumento al fine di conseguire la netta superiorità e di esercitarla nei termini topografici e temporali ritenuti assolutamente ganmti di successo. Per contro, Orlando ebbe ragione, quattro mesi dopo, di opporsi alle loro tergiversazioni allorché i medesimi dimostravano di non riuscire a cogliere il significato politico, e le conseguenti implicazioni militari , di tutta una serie di eventi che avevano un inconfondibile carattere di " indicatori" altamente eloquenti.
n 26 settembre, sul fronte occidentale , gli inglesi erano riusciti a sfondare la Linea Hindenburg, inducendo Ludendorff ad insistere per un armistizio immediato nel timore che lo sfondamento divenisse totale e definitivo; il 29 dello stesso mese la Bulgaria cedeva Je armi, sotto le spaliate dell ' Armata d'Oriente del generale francese Franchet d'Esperey sul fronte di Salonicco; il3 ottobre l'Ungheria proclamava Ja propria indipendenza, altrettanto stavano facendo le minoranze nazion a.U deJJ'Impero (Cechi, Croati, Sloveni), ed il giorno successivo la Germania chiedeva infine ufficialmente a Wilson di trattare l'armistizio su ll a base dei suoi famosi 14 punti. Ce n 'e ra abbastanza per una valutazione politica deglì avvenimenti ta le da indurre a passare il p iù rapidamente poss ib i le alle attuazioni di ordine militare, evitando di farsi trovare fuori gioco proprio nel momento in cu i i giochi venivano fatti . Orlando, in ques t a cir costanza, f u intransigente ed irremovibile, capace di una determinazione - arrivò persino a minacciare di destituire Diaz dall'incarico - che gli sarebbe poi invece venuta meno in seguito, durante le patetiche giornate di Versailles .

Fu questo che ci portò a Vittorio Veneto, e Vittorio Veneto fu Ja grossa operazione bancaria di riscossione di quegli interessi operativi le cui premesse erano state poste sempre sul Piave, si, ma nel giugno precedente. Lì avevamo vinto la nostra guerra.
Una vittoria sofferta, più dolente che trionfante, segnata dallo stillicidio penoso d eli ' abbrutimento della trincea e dall'incubo ansimante dell'assalto, con la sopravvivenza determinata da un dato meramente statistico, il non trovarsi sul percorso di una pallottola. Una vittoria alla quale guardare con commosso rispetto, ancor più e ancor prima che con orgogliosa baldanza. E costruita da una massa grigia d.i contadini con un fucile in mano al posto della zappa, che non avevano mai domandato perché la loro vita dovesse essere fatica né perché ora la dovessero lasciare sulle pendici del Vo dice o sull'altopiano d'Asiago.
''Bè si vede che anche questo è necessario'': così il fante di cui narra Guelfo Civinini, una conclusione nella quale c'era qualcosa di superiore, di estraneo al pensiero, il senso profondo di una legge misteriosa, il nitore di una necessità umana oscura che era qualcosa di ancor più profondo dello stesso dovere, una consapevolezza solida e pacata che non era nemmeno rassegnazione od almeno non solo quella, qualcosa che trascendeva le sue tante "ignoranze".
Lo stesso autore, inviato de Il Corriere della Sera, ne aveva dato nell'ottobre del 1916 una significativa immagine. il pregio del brano intitolato " I fanti" risiede nel tono del tutto anticonvenzionale che lo caratterizza, refrattario agli sdolcinati e pateticamente retorici srereotipi del combattente tipici dell'epoca.
Un eserc izio di verismo, pur nella godibilità letteraria dell'elaborato:

"Lo rivedrò sempre, ogni volta che penserò al soldato italiano. Sempre ricorderò la sua risposta umile e sublime. Era un soldato di fanteria qualunque, un povero buon diavolo di contadino meridionale, forse analfabeta. Non era più giovanissimo, e non aveva nessuna aria marziale. Non era un bel soldato, come ce ne son tantt: che si guardano passare e si dice con commosso orgoglio: ''Bei ragazzi.'" e li si immaginano nell'atteggiamento fiero dell'attacco alla baionetta. Quello no: era un fante piuttosto scalcinato, come si dice nel linguaggio di trincea.
Era uno dei tantz: una delle particelle umane in/inites-ime che /anno la grande massa esercito. Era quasi buffo, aveva un visto scarno e giallognolo, due grandi orecchie a sventola e la barba ne ra, non /atta da quindici giornz: a chiazze inegualz:· aveva una giubba striminzita,
delle brache le fasce legate con lo spago. Si era seduto su un sasso, con addosso tutto un carico di robe, sotto cui quasi scompariva : zaino, tascapane, coperta, mantellina, tela da tenda, gamella, elmetto, cartucciera. Era in/an gato fino alle orecchie. Da poco era arrivato col suo battaglione, un battaglione di rincalzo, che stava per andare su lla prima linea, un chilometro più dove si combatteva. Si sentiva lo strepito dei fucili e delle mitragliatricz> e tutto intorno tuonavano le artigliere da assordire . Il magro /ante se ne stava lz' sotto una pioggerella sottile, col fucile tra le gambe come un bastone, con quel suo vùo giallognolo che non diceva nulla, asciugandosi tratto tratto il viso con la manica e guardando dinanzi con lo sguardo assente.

Un ufficiale di artiglieria che in quel momento non aveva da /are gli si avvicinò. Mi aveva detto poco prima: ai o adoro questi veri eroi della guerra, i fanti Se non amassi tanto i miei cannoni vorrei essere ufficiale di fanteria per vivere con loro. A volte mi fermo con uno o con un altro e li interrogo. Non sono mai insignzficanti. Talora mi rispondono delle cose che non avevo mai pensato, che mi rivelano Fi talia, la grande vera I talia che noi non conosciamo; che mi portano ad immergermi nelle acque pro/onde dell'anima nazionale, della quale non vediamo e non consideriamo che le poche spume della superficie Bravi e buoni fanti! Dovremo ad essi la vittoria, a questi contadini italiani che hanno un fucile, e che muoiono senza neppure saper bene perché morendo, siamo compensati della perdùa della vita, dalla consapevolezza e dalla bellezza del nostro sacrificio. nella loro penombra spirituale, seguono soltanto chi li guida, e si sacrificano per un dovere oscuro di cui sentono la forza ma del quale non vedono la bellezza . Ci sono anche fra loro gli ma sono i sono L'eccezione. L a grande massa obbedz'sce al comando terribile senza discutere e senza domandare, con la stessa anima con la quale dicono a D io: Signore, /ate di noi quel che volete . . ... . . buoni fanti.' Bisognerebbe baciare dove passano" .
({Che cosa /ai qui?" domandò ora al soldato che si era alzato rimettendo a posto il suo carico con un colpo di spalla.
((San go col battaglione'', rispose il /ante ne l suo dia letto meridionale annacquato, storcendo un p o' il capo per indicare i suoi compagni.
((D i che brigata seir
ll /ante esùò un poco poi rispose qua si timidamente :
((Nun (o saccio".
"Come non lo sai? E chi è il tuo colonnello, lo sai?"
"Signornò. ''
"lt tuo maggiore?"
Il/ante scosse il capo, sconsolato.
"'11.7 • . )) l'fUll O SCICClO
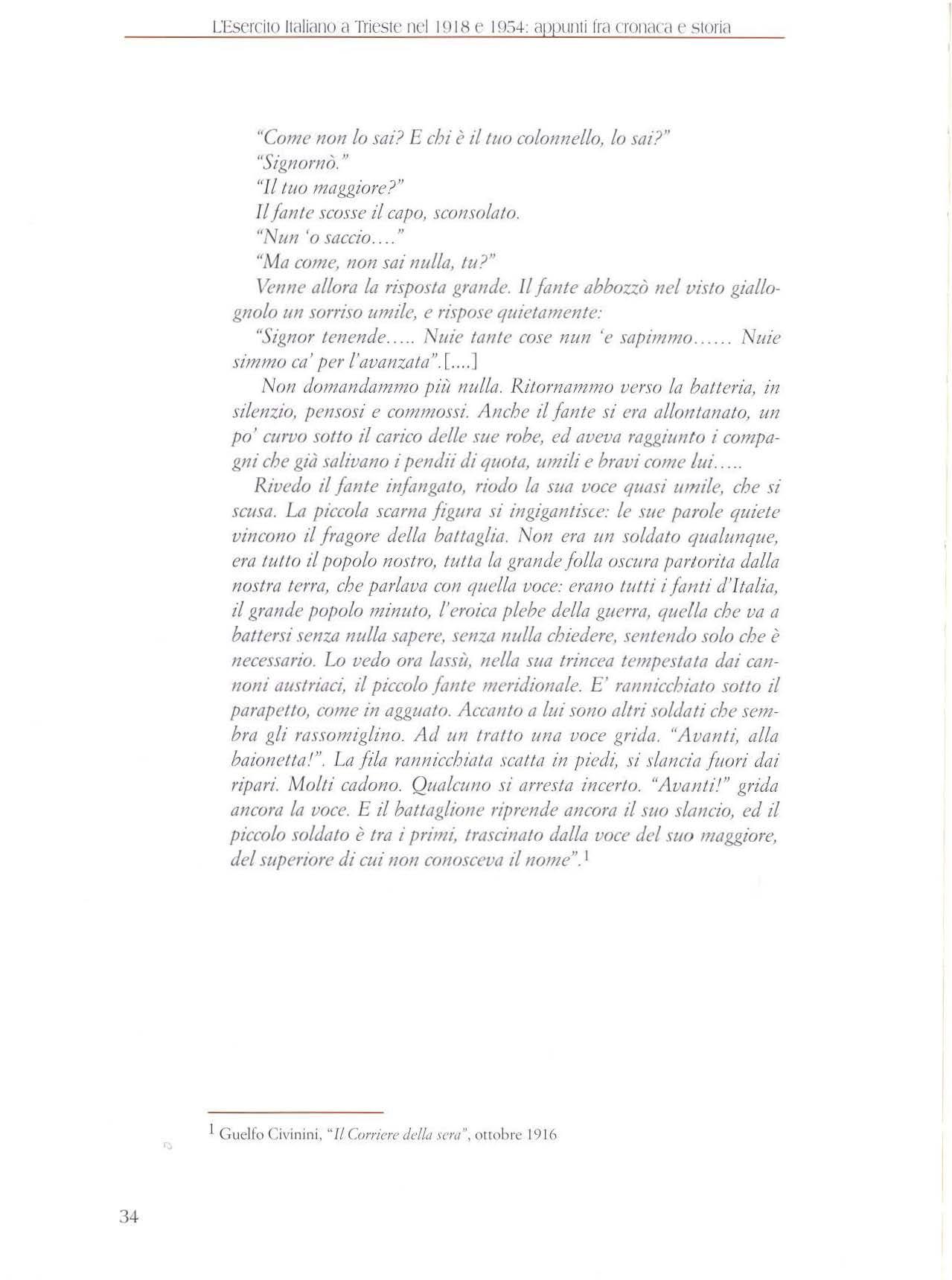
"Ma come, non sai nulla, tu?"
Venne allora la risposta grande. Il /ante abbozzò nel visto giallognolo un sorriso umile, e rispose quietamente:
"Signor tenende Nuie tante cose nun 'e sapimmo Nuie simmo ca' per l'avanzata".[ ]
Non domandammo più nulla. Ritornammo verso !a batteria, in silenzio, pensosi e commossi. Anche il /ante si era allontanato, un po' curvo sotto il carico delle sue robe, ed aveva raggiunto i compagni che gùì salivano i pendii di quota, umili e bravi come Lui .....
Rivedo il /ante in/angato, riodo la sua voce quasi umile, che si scusa. La piccola scarna figura si ingigantisce: !e sue parole quiete vincono il fragore della ba!taglia. Non era un soldato qualunque, era tutto il popolo nostro, tutta La grande folla oscura partorita dalla nostra terra, che parlava con quella voce: erano tutti ifanti d'Italia, il grande popolo minuto, l'eroica plebe della guerra, quella che va a battersi senza nulla sapere, senza nulla chiedere, sentendo solo che è necessario. Lo vedo ora lasszì, nella sua trincea tempesta/a dai cannoni il piccolo fante meridionale. E' rannicchùzto sotto il parapetto, come in agguato. Accanto a lui sono altri soldati che sembra gli rassomiglino. Ad un tratto una voce grida. alla baionetta!''. La fila rannicchia/a scatla in si slam;ia fuori dai ripari. Molti cadono. Q ualcuno si arresta incerto. "Avanti.'" grida ancora la voce. E il battaglione riprende ancora il suo slancio, ed il piccolo soldato è tra i primi, trascinato dalla voce del suo maggiore, del superiore di cui non conosceva il nome". 1
Bclflclglid di \'ili orio\ t ' Jlt'lo . o11ol>rc l q l H: P' Nd/Ì( Il l( ' di l>er- i <on mitrilgliclll i(< '.



l più brillante, dal plmto di vista cronachistico , tra i resoconti dello sbarco italiano a Trieste è certamente quello di Rino Al essi, del quale l ' autore ha lasciato traccia in un bel volume pubblicato trentasei anni or sono ,2 e del quale si è cercato di operare una sintesi che riesca a rifletterne, per quanto possibile, la freschezza e l'immediatezza letterarie.
Per i componenti della spedizione, compresi gli inviati speciali della stampa nazionale, l'imbarco sul cacciatorpediniere Audace era stato fissato per le 9.45 dalla riva degli Schiavoni. Su Venezia gravava ancora, a quell'ora, il silenzio umile e nebbioso di una notte senza vento. Immota l'acqua, ferme Je gondole affiancate agli attracchi , appena percettibile lo sciabordio dei lenti risucchi lungo le fondamenta degli antichi palazzi; non una voce, non una luce. Tutto, intorno, aveva un sentore arcano di cose perdute. Persino la maestosa mole della "Madonna della Salute " sembrava essersi fusa in una strato ancora più denso e più nero, quasi un'enorme vela ancorata nel punto dove il Canal Grande sfocia nell'aperta laguna e già prende le sembianze del mare.
Il luogo di riunione per J'attesa dell'imbarco era l ' hotel Danieli, ma già un'ora prima la decina di corrispondenti di guerra, giunti dai piLL opposti settori del fronte in movimento, si erano trovati al caffè Florian. C'erano Emanuele Baroni del Gazzettino, Arna ldo Fraccaroli de 11 Corriere della sera, Achille Benedetti de 1L Giornale d'Italia, Mario Sobrero de La Gazzetta del Popolo) Baccio Bacci de La Nazione di Firenze, Ermanno Amicucci de IL Mattino di Napoli, Gigi Michelotti de La Stampa, Antonio Baldini de La Tffustrazione Italiana, Gino Piva de IL Resto del Carlino, il celebre commediografo Sem Benelli e Rino Alessi, entrambi operanti per più di una testata.

Con loro, esponenti del mondo politico triestino, giunti da un paio di giorn i , con i segni di una gran d e tensione psico -fisica: lVlarco Samaja, membro del vecchio partito lib era l- mlziona le di Felice Venczian; Ugo Callini, uomo di fiducia di Valentino Fittoni, il leader del soc iali smo triestino che da Vicnna, dove era rimasto, aveva lanciato l'id ea velleitaria eli una repubblica istriana con Trieste capitale; Giuseppe Ferfolija, rappresentante s lavo di lingua it al iana. I tre avevano costituito il 30 ottobre, dopo l'insurrezione della città e la precipitosa fuga del luogotenente Fries - Kcne , un "Comitato di alure Pubbli ca". 1\lla l' organo che aveva in mano la città era il "Fascio azionale" nel quale figuravano i nomi dci più attivi patrioti italiani, dal podestà Alfonso Valerio al suo vic e Costantino Dor ia , da ilvio Benco a Vittorio Furlani, dall'on. Edoardo Gasser, deputato italiano alla Camera austriaca, allo storico Pietro Sticotti, dal chirurgo Amerigo d'Este ad Aldo F ort i , dal giurista istriano Nicola Li n der al letterato Marino de Szombathcly.
Tra i personaggi in questione s i intr ecc iavano rapide voci e no-
tizie. La più attendibile era che tutte le genti che popolavano il bacino danubiano erano in movimento. L'Imperatore Carlo offriva autonomie, indipendenze, un regolamento federativo degli Stati g i à soggetti alla sua corona, i sudditi venivano promoss i cittadini con l'imp egno del più assoluto rispetto delle loro libertà ed infine, un particolare ordinamento per Trieste. Ma dai Carpazi all ' Adriatico il rifiuto sarebbe stato unanim e Però Trumbic, firmatario dell'accor -

do di Roma per la disintegrazione della monarchia danubiana e che si considerava il Cavour della Iugoslavia, aveva già avanzato le proprie pretese su Trieste, prefigurando la città e tutta l'Istria come porto della nascente Iu goslavia. Prima di fuggire da Trieste, il luogotenente Fries -Kene aveva consegnato la flotta al comitato slavo, intendendo di pagare così un debito a coloro che lo avevano sempre aiutato, durante il suo governo, nella lotta nazionale contro gli italiani. Gli sloveni erano stati buoni e fedeli sudditi dell'Impero, domani lo sarebbero stati doppiamente di una grande Iugoslavia della quale già sognavano i confù1i all'Isonzo se non addirittura al Tagliamento.
A Trieste, alle prime notizie della disfatta milit are, la popolazione era insorta e le autorità municipali, con in testa il podestà Valerio, avevano costituito quel già menzionato "Comitato di Salute Pubblica" del quale erano entrati a far parte rappresentanti di tutte le correnti politiche e della minoranza slava. TI socialista nazionale Puecher, che aveva fondato da tempo una pubblicazione intitolata "La Lega delle Nazioni", sarebbe stato per l'immediata ammissione di Trieste all'Italia, in forza del diritto democratico di autodeterminazione dei popoli, mentre i socia li sti di Valentino Pittoni avrebbero auspicato una soluzione indipendentista. Il Comi t ato, secondo le ultime notizie, si sarebbe attribuito un solo compito, quello della difesa dell'ordine pubblico avvalendosi del Corpo municipale dei vigili urbani e dei vigili del fuoco. Prima del precipitoso congedo dalla città, il luogotenente aveva passato i poteri al Comitato. Ma la popolazione italiana era insorta , aveva invaso le caserme, assa l tato i magazzini militari, e si era armata diventando di fatto padrona della città senza piani prestabiliti, e senza attendere oltre aveva occupato e presidiato tutti i punti -chiave: il palazzo della Luogo t enenza, quello delle Poste, il Porro Vecchio e quello di Sant'Andrea, le due stazioni ferroviarie ed i cantieri, in pieno accordo con le forze operaie. Da allora erano passati quattro giorni e quattro notti. La popola zione aveva vissuto per le strade, si era raccolta sulle rive a spiare il mare, a sperare di vedere un pennacchio di fumo, la sagoma Ji una nave. Quando erano apparse nel cielo le sagome degli idrovolanti decollati dalla laguna di Grado, la gente appariva come impazzita: era il primo segno che le forze armate .italiane s.i erano messe in movimento e allora, alte, erano risuonate l e strofe dell'Inno a Trieste, un testo adattato da un autore anonimo alle note deli'Tnno a Tripoli bel suo! d'amore .. .) risalente agli anni della guerra italo-turca dell911:

[ ...... .] Popoli cbe avete in core la dolce della redenzzòn, destasi nel nuovo albore la madre Italia al rombo del cannun. Liberi l'Italia vuole i figli suoi che schiavi sono ancor. Sventoli, spiegato al sole, sul colle di San Giusto il tricolor. [ ....... ]
Dal l o novembre aveva poi visto la luc e un quotidiano italiano, La Nazione, improvvi sato alla gar ibaldina , senza mezzi, da Silvio Benco e da Giulio Cesari, che fungevano da direttori, c da alcuni vecchi redattori de Il Piccolo.

Le printr lince
itclliclll(' CId\ dl1 1Ì cl \l onftliCOilt'
\"ÌSIC <ldill' trincee
austro-ungd ri< l w fl ell'll cnn<t dd
TI 2 novembre, giorno precedente alla partcn.::a della spedizione da Venezia, era arrivato un grosso motoscafo d'alto mare con a bordo un nosrromo, un meccanico ed un marinaio c, soprattutto, la pianta della zona minata deJ porto di Trieste, dal castello di Miramarc alle dighe c da queste all'intero arco del vallone di rvluggia. lVlancando l'ausilio di quella carta, nessuna nave avrebbe potuto accostarsi alle rive triestine senza correre il rischio di saltare in aria. Ed il merito era di Frausin, l'anziano comandante della Capitaneria, un vero lupo di mare, patriota fra i patrioti. Un merito notevole, dal momento che tutto l'Alto Adriatico era disseminato di mine vaganti che in s idiav ano la n av igazio n e.
Ma il tempo stringeva. Abbandonare rapidamente le fumanti tazze di tè e di caffè, il gruppo dei partecipanti alla spedizione aveva cominciato ad avanzare verso quel tratto di riva predisposto per l'imbarco. In esso, sotto la pioggia campeggiava la massiccia figura de l generale Petitti di Loreto, dai capeJJi bianchi, dai folti baffi e con il pizzetro alla Vittorio Emanuele Il , con il braccio sinistro ricoperto da una l arga benda, frutto di un<t recente ferita riportata durante

un'ispezione in trincea, preposco a gu idar e lo sbarco nella città di an Giusto.
La formazione navale destinata all'operazione era costituita da quattro cacciatorpediniere. Il primo era l'Audace al comando del capitano di corvetta Starita, e su di esso presero imbarco il generale Petitli ed i giornalisti. Gli altri erano il Fabrizi, il Missori ed il La j'vfasa, tutte uni t à intitolate ai nomi di ufficiali garibaldini che avevano preso parte alle campagne del Risorgimemo.

Con il generale salirono a bordo 16 carabinieri destinati a presidiare la sede del Governatore a Trieste, e dietro a loro un ristretto gr uppo di personalità civili che da tempo collaboravano con incarichi fiduciari presso il Comando Supremo, capeggiate da Camillo
Ara, ultimo presidente dd partito italiano di Trieste cd esperto conoscitore della situazione politica ed economica delle terre adriatiche.
A breve distanza l'uno dall'altro, i quattro caccia si staccarono dalla riva. L'Audace era in testa ed all'altezza del traghetto di Sant'Elena appoggiava con rapida manovra a s ini stra, poi a destra, imboccava il canale fiancheggiato dai moli per accelerare infine la corsa ed entrare in mare aperto. La velocità di navigazione stab ilita dal Comando Marina era di 20 nodi.
La formazione navale stava puntando in direzione di Caorle quando improvvisamente le mitragliere di poppa dell'Audace aprirono il fuoco ce rcando di colpire alcune mine vagant i. Nel l'aria echeggia r ono colpi secchi e sibili. A fianco di Starita f in dalla partenza era andato a col locarsi un nostromo inviato dal vecchio Frausin; un uomo di mezza età, con la pelle bruciata dcii so le c dai salmastro che conosceva l'intera rete dei campi minati. Non vi era a ltro tratto che permettesse una navigazione presumihilmente sicura: si apriva all'altezza del caste llo di Miramare e si snodava lungo la sp lend ida costiera di Barcola. Gli altri caccia, ad un certo punto, non seguirono più il capo - squadr iglia, in quanto diretti verso località della costa tstnana.
Ancora qualche nodo e sulla linea dell'orizzonte si videro apparire tre lun ghi cortei di imbarcazioni senza alberi né fumaioli, trainati da piccoli va poretti lagunari. Si trattava di vecchie "m aone ", i cararteristici barconi a fondo piatto come zatte r e, che in la guna erano ad ibire al trasporto del carbone da Marghera alla Giudecca. Erano salpate Ja]la Marittima di Vene zia nelle prime ore del mattino e, attraversati i canali della città ancora addormentata, fra pallide luci az-
zurre, si erano spinte a l largo , scortate da navi e da idrovolanti che vo.lavano bassi sul mare. Trasportavano duemila fiamme cremisi, due battaglioni di bersaglieri, il X ed il XXXIX, che la sorte aveva prescelti per portare il saluto liberatore dell'Italia ai fedeli dell ' opposta sponda.

Il convoglio procedeva lento lungo la costa. Si faceva giorno , ma non spuntava il sole, e cielo e mare si fondevano in una tinta plumbeo-cinerina. Le ore stavano diventando lunghe, monotone, noiose. Una sottile pioggia cadeva ad intervalli. All'intorno filavano le navi vigilanti, e nel cielo rombavano i motori. Dalla tolda di un caccia il generale Coralli, comandante della 2" Brigata Bersaglieri , salutava sorridendo i suoi uomini. Dalla costa, oltre la Livenza, giungeva cupa .la voce del cannone accompagnata da vampe arancioni in lontananza: era la Terza Armata che incalzava il nemico vinto. l bersaglieri stavano silenziosi, con le scarpe slacciate ed il salvagente a fianco , come prescritto dalJa navigazione operativa.
Il convoglio proseguiva lento. Dopo undici ore si intravvide la penisola istriana. Più innanzi, gli anziani individuarono il Carso: la fronte si rabbuiava e cadeva sul volto un velo di dolore a] pensiero dei tanti compagni sepolti o dispersi lassù, fra quelle doline. Le reclute, curiose, si affollavano da un lato e le imbarcazioni si inclinavano sul fianco. L'Hermada che aveva vomitato fuoco come un vulcano ora taceva , e Duino le faceva da sentinella. Le migliaia di persone che percorrono ai giorni nostri la strada costiera che da Duino a Sistiana raggiunge Trieste non sanno, nella grande maggioranza, che questa fascia di terreno carsico in prossimità del mare fu teatro di vicende spaventose. In particolare, per il possesso di Duino si combatté con estremo accanimento. La larg a dorsale dell'Hermada, estendentesi verso quello che fu definito ('l'inferno di Doberdò", sbarrava come un VLÙcano in eruzione la via per Triest e. Chi occupava l'Hermada, avrebbe posseduto anche la città. Ne erano consapevol1 entrambi i contendenti, e quell'altura di 323 metri divenne una specie di incudine su cui furono sacrificate inter e divisioni. La visione dei battaglioni decimati che tornavano dalla battaglia faceva sorgere ne.U'animo un desiderio di pace ben p.iù forte e genuino di quello in voca to da tanti retori sentimentali od antimilitaristi. Soltanto chi era testimone di un simile spettacol o poteva comprendere e ricordare per sempre il calvario di quegli uomini e la loro orrenda tragedia. Verso le 15 si incominciò finalmente a vedere terra. Laggiù, in fondo al golfo di Panzano, si delineava un informe frastagliamento
di rovine grigie e spente: Monfalcone, il cui cantiere appariva come un cimitero di scheletri di ferro.
L'Audace rallentò la corsa. Si era entrati nel canale che si apriva libero tra la riva ed i campi di mine. Tra il porticciolo di Santa Croce e Grignano la costa appariva come uno spalto bruno , ricco di vegetazione , che scendeva a picco sul mare. Le famose bianche torri di Miramar e, cantate dal Carducci, spuntavano sulla cresta dd verde promontorio che nascondeva la mole del Castello. Erano ormai quasi le cinque. Ancora pochi minuti di navigazione, ed ecco il miracolo: Trieste è là in fondo, tutta grigia, nascosta entro una cortina di
vapori che la sera imminente ha reso più fitta. Riecheggiavano i ricordi di visite lontane, quando i piroscafi del Lloyd correvano veloci fra Trieste e le Bocche di Cattaro, partendo da quel molo San Carlo che era il cuore della vita marinara della città e che aveva avuto aneh' esso la propria storia.
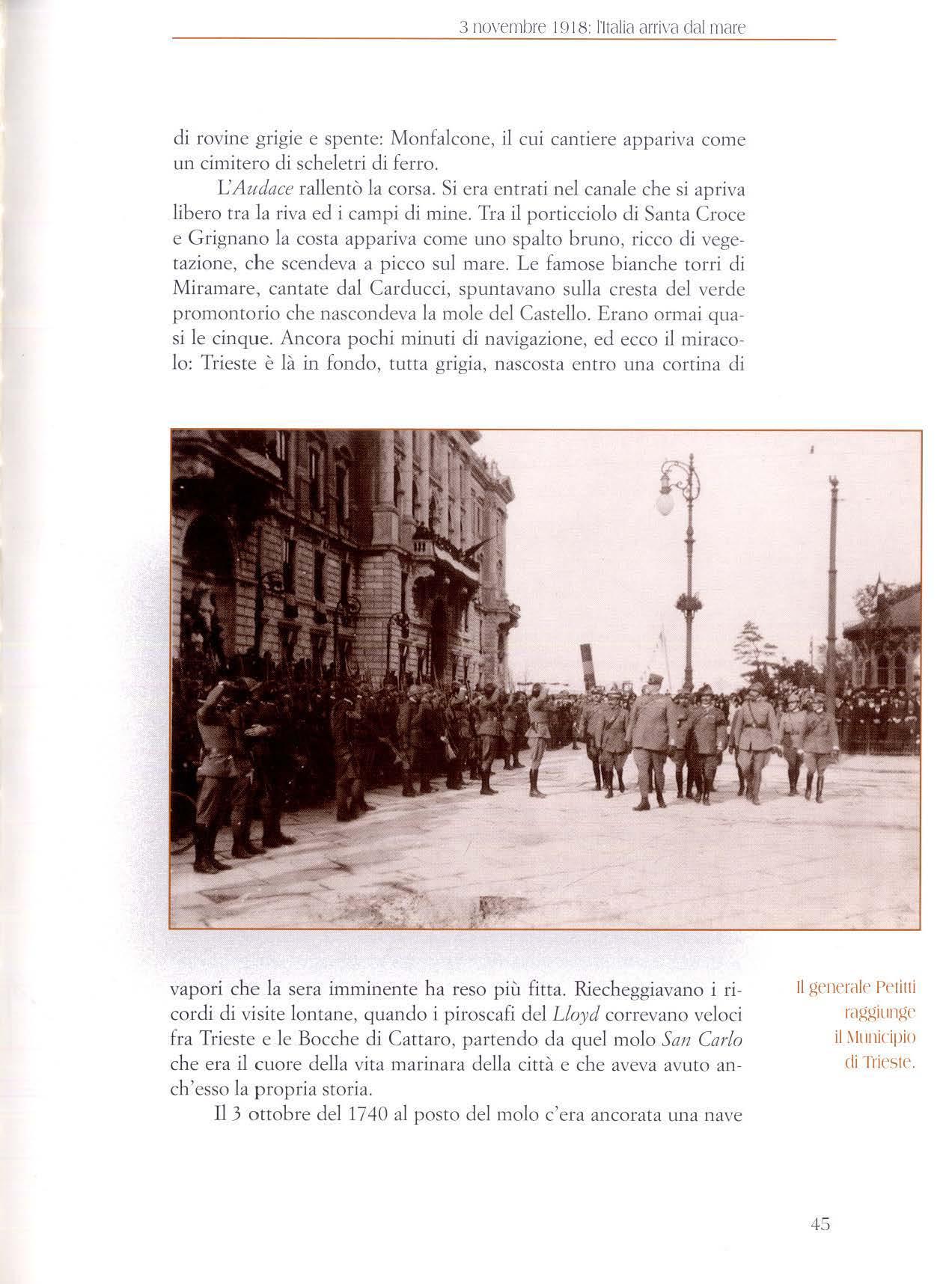
ll 3 ottobre del 17 40 al posto del molo c'era ancorata una nave
Il gC IH'I'éllt' Pl'lilli l'dggi ll l lgt' il 1icipio eli Tri<'SIC
da guerra con 70 cannoni recante sulle fiancate, a grandi lettere, il nome San Carlo. All'improvviso una falla si aprì nei fianchi della nave, che in breve sprofondò nonostante gli sforzi fatti per sah·arne almeno i cannoni. Furono fatti venire da Mantova esperti ufficiali di marina perché rccuperassero la nave, ma tutti i tentativi fallirono. Il fango tratteneva tenacemente la sua preda. In quell'epoca si discuteva sul modo di proteggere le navi ancorate al porto, che le violente raffiche della bora spesso sbattevano l'una contro l'altra. Sorse allora l'idea di utiliaare la carcassa della San Carlo come base di un nuovo molo. La costruzione durò orto anni, dal 1743 al 1751. Per lunghi anni il molo San Carlo sembrò osservare il precetto divino. Per se i giorni offriva, infatti, da mattina a sera, lo spettacolo della più intensa attività, piroscafi partivano cd arri\'avano in continuazione, i facchini faticavano a caricare od a scaricare le merci, marinai, viaggiatori e doganieri correvano, si urtavano affrettandosi fra il chiasso in mezzo a quel labirinto di casse, di barili, di bagagli. Alla domenica, invece, il quadro era diverso: una folle elegante faceva il giro del molo, pacatam e nte, chiacchierando. Come intermezzo, le squallide giornate d'inverno, durante le quali la bora urlava selvaggiamente ed i marosi spazzavano via i casotti della finanza e rovesciavano le colonne. Poi erct venuta la guerra: la miseria, b desolazione, con il solo conforto di una segreta speranza. Quatlro lunghi anni di attesa ma che alla folla, assiepata sul molo sotto la pioggia, erano sembrati meno lunghi degli ultimi due giorni.
Si attendeva l'Italia. E l'Italia sarebbe ve nuta sull'Jludace, chiudendo così la storia del molo San Carlo e dando inizio a quella del molo Audace.
Tornando al convoglio in navigazione, dopo tante ore la bella meta si svela d ' incanto. La città bianca si prepara all'offena e si avvicina. Dalle imbarcazioni si agitano selve di bandierine confuse con le piume degli elmetti. Un coro di gioia si sprigiona dal mare. Trieste si avvicina sempre più. Si vede già la folla accalcarsi sulla riva, ed un confuso agitarsi di braccia come onde oscure. Alle voci che provengono dal mare fa eco la voce del popolo accorso per abbracciare i soldati italiani, prossimi all'approdo. Ora l'esultanza esplode senza freno, come delirio, dal mare c dalla sponda.
Le rive, i moli, le finestre, i balconi, i tetti dei palazzi rigurgitano di popolo che agita bandiere tricolori. La notizia dell'arrivo delle nostre truppe ha mobilitato l'intera popolazione, tra i Magazzini Generali e la Lanterna Vecchia, ovunque ha potuto trovare uno spazio


lt Il llt llal lenzlose, la loro mi1eria per 8 8 8 8 8 l' ingrJrdlgt& dello ingltule domln iou ì. l/ l t.&Jia. t iene l Viene, aiola d'armi. Ma dove la fou a Il pe&uo u nto di di · e.rouala di Jittori a, eou l'ulivo dellB feaa agli inoooeoti o agli opproui, do n pa ce oella IJ)&uo po a•enle. Evvru l L& la pugnaeìlà è ribelUooe oontro perfid ia 'btlU u iora li& le uauoai , la Madre o.o · d' iaiqoi a loro aguniusgio oovra l più alta, Jif u a aoi 1 Il no•lro auott quaei doboli , i r i pu,oaeill a lorn uou a luo nop,la , udn dola, almile alle )hde11no ehe a rm1 ed ali dol geoio uwa oo, dtl DI'liri grudi au la pale d'all&re, oell a aoa a toria, che lo la uct ultrt eee1 bel la t rrndl a lo di di t ith luee l oombatuudo di aeeolo iD oulo.
l'.' Ma ptroh• f tofauare queat'ora, di· E be.atdetla aia, per qua ol<l Ofli l 'e.••• 010 ebo atrine otl oos uo ooore? eua eowp•o, la fona E • N oa di llOi dobbia mo ptrlare, ma aia l a ftoot.& della M&Jrt dell' alloro }41 ...., la Kad re aottra, l' Italia l & ' ebe po rg011o lo n•nre mao1 nd to ta ! ltl l&la l&rt nella 1 111 g u adtau, e di·
Adea oo enlrisblo noi .nrameote IMI e<>Q· MDII a lei 1 fo lc•raole dl glor ia ehioa- •ou io dtgh uomini, • da ,una n la fruta, ebbri di lf&lit14int per lrille rlta di car tlli, cl IDI&o.or, d
l prl wì tre ooo una Ja un l• • benz ino, co si un battesimo palrioUico nra u ut e Il qu arto 10 otrop lA uo). Tl u acco lto alla em ollo nan Le. rin dal eorunudA nlo de l vorlo cav iL>oo Il marinaio rn bacia to abbrar.eial<l Fl&u t lu ; & i pr11oì ort tadì ui ebe polt · do11tte 6rtu are rouumernoli rooo ut r col primo tore porcbè t uttr n wr• un tu logaaro ù' Ha ll a l'h O a Tt!u te , rl Ul a Ulro Gio · del roe&Saggete d' H>Ji a Poi lo ìnler· va oni Oe lu ea e Il •o ldato ihl iaoo Oi no rog sm111 o a lurrgu Otrrl, gli reeero geo rta rereo il pa lozto Ci oarrb cbo la torpediulora m&a · u -luoguteoen u irnperide. da Tri86\<, amrb a Ma pocb • • gli fece ••l sno lo >•nella, do re p•to uu moto· uoetro. ull• porh rlo iu lrioufo s oa ro co l • uu Uno &l palau o. morehratore. A V•n• : a uall a ••P • • nu deglt aneni onuli di Triuto e l'u· n Ueto anau.n al o nantiO po rtaiO dar dt Tr ru to Dalla f<UO>I 11 lentro egh pro. pro roeb dlmeal r&lloDl colotoJruime Ag· oua crb J"'Ch e paroto: giaoa• parlieob rr anUe OIJOr• t ioa t ello Fralellll La di \'eaeu mao_da 1 11 per Ja ot<apn rou do l al auo u lulo a. la popolu rone dr pa e cbo iOYocb der fr•ttlti, 114• Oomnr ma llt!!• Trrtile ••· 1aulle q u lì c...: iatO' di oalla poltr d,rrt eoncrunla alla lan11g ha l " b ana ! 11 ma11 ualo P$glrani rip artlfl ali at· Il metllgl(lo • da appl an•l ba d'l'llai \'t Quu '"'aldo 1 ul 111
l ibero. Attendeva dalle prime ore del mattino, ha sopportato la nebbia, sfidato l a p iogg ia, non h a toccato cibo, ha cantato, invoc<:\to l' Ita li a . Q u ando hanno v isto p rofilarsi la prua de ll 'Audace, le donne sono cadute in g in occ hi o, ch in andos i fino a baciare l a terra . D a ll 'a l to de ll 'anfi teat ro coronato dagli spa lt i de ll 'an t ico Castel lo a ll a basi lica d i San Gius to intere fa m iglie hanno lasc iato i loro quart ier i e sono scese a ll a r iva. Ne ll 'ari a ferma le grida, i canti Ji esu l tanza, le invoca · zioni, le esplosion i d i fe li cità, il delirio di tutto un popolo unito Ja una s t essa pass ione si f o ndeva in un alto, mister ioso coro che per la lontananza da cu i giungeva sembrava farsi inno c preghiera. Lenramente in co m incia\'a la manovra di attracco. Sul molo San Carlo in g ran parte sgombro si vedeva ora distintamente un comparto schieramenro militare. E ra un b attaglione di formazione improvvisato, compos t o eli so l da t i di varie armi di nazionalità boema Nel tratto di mo l o ve rso il q uale l'Audace avanzava si era intanto formato un g r uppo d i una cinquant ina di persone con a capo il podes t à Va lerio. Gli al tri erano i membri d el Comitato Naz iona le: ex consigl ier i e dep ut a ti de ll e disci oJt e r a ppresen t anze cittad ine, c h e cmgevano

L'a mplesso fr ate rno.
Noi abblllD O liri p&llltO il Ulfot.rdo
d•Ua aoatra Ht.a, uo1 abbi•uno r&if·
JlfOIO Il culmine dtl ooolro deatiao :
tutto il lou.uiL•Io•o woll'rire ebe oi di•do
Il pltUt.o 1 Jn l!ltreo& liiJera gioia cbf' coi d rtt eeompl· rlteo'o di t QPrfua tbe ai luuuooLl ul •••Irti c•ore al rnmo •mpl•·•• dei fr>t<lli. d'Itali a, l: quale Hah•! E qa•li fra•oUi!
Il ••tiro pl.!rtoe 4• lffl, Il pa drone auoa&O di baJOI'ItUa, dt uppl e dell• IUlt dlllf& ltl e&rtera, DCII
J'lflO dr lU fl fteiiUl CUI. 1EtDpo
af.o.W dalla uot o: toot ci a un moralo 'fit'i '!11•lu la a. ••11 di sa•rra t • 101:1 foOltodo fa.n ebe dimt a\'"'•lwo •ti<ht 11 d' l&.ala, un ) rua;aa11o, eol Titarero, con to afugio dtllo w•mme, con l& Ulitmstone del rnoc.umcntt, ron le froq-tatt' tH' aoilDt, fllOfUO pir RiOrJlO ei ICliUtiCU à lht lui, d11 po qo allro oun 1, " •fon4b l' llroca e tlt Jommo l'ltaha, l' a rratet h
i m.glal Il r di Trie- •t<, ai po b 4Jr fino • ien, quelli the uou ltanuo l'Ila) lll\puto, o fOluto upere, obe eooa Tri,.le. lerl l'ante u dutl1 e fo doeomoot.> eh oon al di;hoKg•: i l • arr1 li ololo il Lri colore 1 e data, il dl da S•n Ùllltto, L'arrivo del fra telli libera tori. La (l)lfll iruuulnta. lDDumPrtnlt: oaa ••Il• pisua d'lt.. h a , lbllt fUI atOii 1 ptlbllO IIUÌ ttth u-. • cl•i maa::auiat dtUa otoUo Itri parl<'tblt ••• coll4 lo ll•lhe1Jio d' ogsci.S> molML&., v-rcb• lt d•i tiorndi e le rhtHDIUDo Jalla 1\rf"ftltan facenoo «mr r' u1ere che l' ttHtt.o taoto u 1iou.oa ote ••r•t.tat.o dorna ,, ,·eant duun1e la gtornatta. L' niit-<l rtP•aliarrr , vruuuuoeiato J'arrifO dell a &p edr z.J(I Ilt': Halfan a. ptr la matt-ln3; uu ndfu t !'!i•l(riJUII\tL da Vtn,.Jia, avt 'fa arllUremiJ NOI • Il' t' r3 m&>u l m•re lr& • Tm-
tra un Jtnco velo dt n!.!'ltbia;
1 eaeriatorr.ldloier• fratho\4 uno ra«o, Egli fllal a l'lt.lh • the <lOruhalt• difubli eti; • •r pNd n o al molo per Ja roJea oDI d11 P"rQh opprtlll S. Carlo, Un ltaontt è• the daii'Aittlri•, e d1tt ebe a J'riule gll dirigt l' ormtggao doU• nave o:nm1ra- uuco-llòfaeelli •• n• o m ., •olootaglia, baeia •l a r o ebe vlMe rieufl!lrllo damoatil a d ll p,.iale•e dtl Co outalo lerra, Tnltl, a e • bo rdo non di ululo e oh• rlmallj;" oo • Il\ IOI'O tiHO»ione. 1littpo$ition• dir oao\·o O Herno J l pudutà Valerao talito a 11 generale a dell' .Audaeo , ebo cl porta il eomln· nowe dell' ea.rc•to 11J.ll•11o. d.att del d' O<Scu p io oe, geo•- L' a" Pueehor a nomo dii partito role Ù•r lo Ptt•ltl di Boroto, rirolge aoei\li11a e dallt elut• luoro•mi ..,.. al rentr•l• '' d.ltOr$0: lut & ttl g•oetAit ti libfru.ort l-ilt' , ,.no J.a ,-tot.a 11 r.h.• d:tla tua.nol.a ao •• att.J. fOil! l!! poff'!Yt- eon•..,. ;, • an ht:ho di 'tri• l it ali.iOO pl•r 11 C41U1p11»t:to rf•JI• d1tSO tnas.o obe LI p t taoLI " ,. vcatto M-..od•,, u!olo coauDou.c. della thtt la. '"'"' Jo..fJ,,I.&.&IODe .vna a o 1 ritti. u•cw•ta ftaltlh dtlle &!tu ture q9tlle lm•'*o ebe lode la<..,llabUe ba ..,...,tto idri • Ucbe e qotllt rro•bno (a;riAUsa). rratalll the le n d(!: ••,, .dull! l' •.r•t quJie -ci a 1' 111 Trll"tte tn q n Q uc& JJt;na (ttn)fl L l' m1• r._• 'fibra roUIWO 1tllt ao.'lrf t.rupv• ba laftLDIO dello ,., (l lb)Oft lo ..,..tt-j !'00 6ef!d- ODO 4e,:U HflrtJU p!à rortr d' Boro p• • ruere MHl J• tnu. plrQla, meuo 1n. fUJ&. (appt u,_a, t l n ate lo dlr4 p eu reitt) . J l K•u•ralo IID8rllll OOOIIDOU,, batte (Jn jng ltfO oalal.a in .roM; 1f g•• il P••d• oJ toolo ft poi proelJhoa cbo ntpnllllo
sciarpe e cocca rde tricolori. Non mancavano anche alcuni esponenti slavi del Comitaro di Salute Pubblica.
Le cime vennero finalmente gettare dalla tolda alla nva dove i marinai della Capitaneria di Porto assecondarono alacremente la manovra Ji attracco , Il brusio della folla lontana , che era g ià scemato , ora cessò come per incanto. Ciò che stava avvenendo non era più la scena di uno sbarco, ma la pre[igurazione di una catarsi.
Appena la passerella fu gettata, il generale Petitti la superò con passo sicuro ed agile, ed in pochi secondi fu a terra. Battè con forza il piede e nel silenzio dell'attesa, che aveva inchiodato la nereggiante massa umana su rutta l'ampiezza Jelle rive, la sua voce risuonò alta e solenne: "Prendo possesso di Trieste nel nome del Re d'Italia".
Ed il genera le ed il podestà si abb racciarono mentre 1a Co ll a mneggiava a l l ' Tta lia, Subito dopo si formò un corteo con in testa i due protagonisti principali. La meta era il palazzo dell'imperial-regia luogotenenza a circa duecento metri dal molo L'apparizione di Petitti sconvolse gli animi. La compostezza rispettata sino a quel momento andò in framumi. Non v'erano più di cinquanta metri da percorrere per arrivare al portico del palazzo, eJ il generale venne sollevato di
peso da robuste braccia di popolani. Tutti volevano toccarlo, abbracciarlo, baciarlo e la stessa sorte ebbero quanti facevano parte del corteo. Petitti arrivò finalmente sotto il portico. Là la marea si era fermata. I sedici carabinieri erano già ai loro posti. Sfilarono i membri dei Comitati. C'erano tutti, anche gli slavi capeggiati dal deputato Wilfan. Per questi non era l'Italia che prendeva possesso di Trieste ma l'Intesa. Sarebbero stati in breve disingannati da Petitti.
In un salone del palazzo , il neo -governatore prende la parola. Trieste è italiana, dice, ma non soltanto Trieste. L'Armata di Pecori
GiraJdi è alle porte di Trento che entro domani sarà anch'essa italiana. Ma la meta delle nostre truppe è mo lto più lontana: arriverà fin dove arriva il diritto italiano. Trieste è italiana, si, ma non è tutto; le nostre navi risalgono l'Adriatico, su] Carso l'esercito ha già sorpassato le linee che tenne vittoriosamente durante le dodici battaglie dell'Isonzo, Gorizia è liberata. La nostra bandiera giungerà sino a ll e Alpi Giulie, legittin1o confine del nostro Paes e.
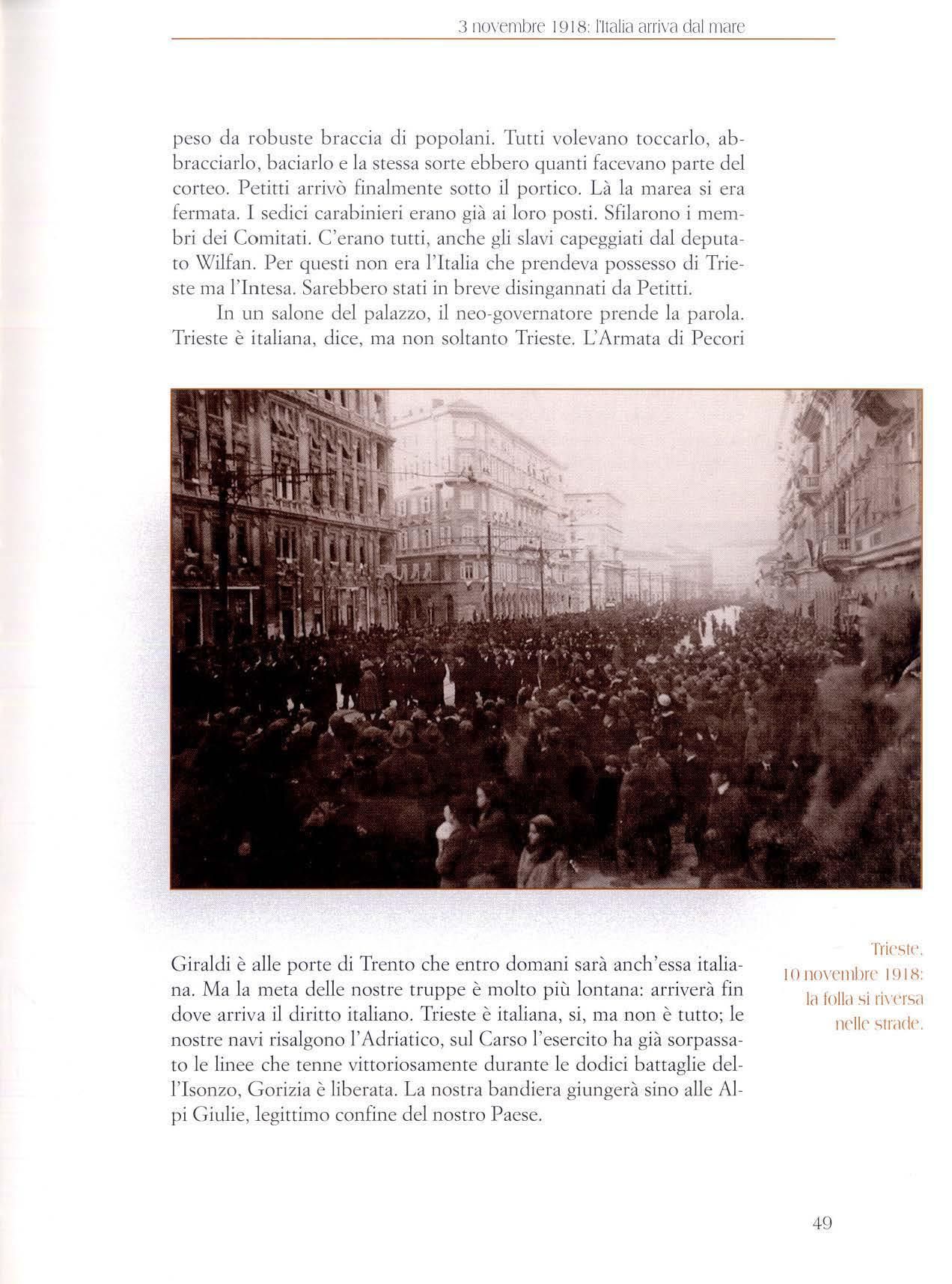
l o nm·ctnl>rc 1q l H: i l><'f'<.,dgli<'ri sfilclllO d Trie'->ll'
Il generale ha appena pronunciato le ultime parole che dalla riva e dalla piazza, dove la folla aveva invaso i boschetti cedui creati per proteggere il paJazzo dalla manifestazioni popolari, si leva un grido echeggiato da migliaia di bocche: "t bersaglieri.'".
La catena delle ''maone" venezian e, trainate dai vaporetti lagunari, con i bersaglieri al comando del generale Coralli era infatti anch'essa felicemente arrivata, e lo sbarco era avvenuto sul molo prospiceme l'edificio dell'Hotel Excelsior. I bersaglieri sbarcati dalle chiatte, dopo un tentativo di schieramento sulla riva, ruppero le fila c si dispersero nella fiumana. In breve tempo, i loro elmetti rimasero senza piumetti. Ogni ragazza triestina aveva una piuma infilata nei capelli a guisa di portafortuna. I soldati si mossero in colonna fra due siepi di popolo esultante, sorto una pioggia di fiori cd uno sbandierare di tricolori dai balconi (ma do\'e li aveva conservati Trieste,

tutti quei fiori e quelle bandiere italiane?), finché si giunse alla Caserma Grande, là dove era stato impiccato Oberdan, dove la moltitudine si accalcò e dove i bersaglieri avrebbero passato la notte.
La mattina del 4 novembre in Piazza Grande si schierarono i due battaglioni mentre di fronte, sul mare si intravedevano i profili delle navi. Nel centro della piazza stazionava una scorta di sei bersaglieri con la bandiera da issare sulla torre di San Giusto. Era il tricolore offerto dalle donne di Trieste, che l'avevano lavorato di nascosto, trepidami, durante la lw1ga attesa. La scorta d'onore alla bandiera era formata da un ufficiale, un sottufficiale ed un graduato del X Battaglione del 7 ° Reggimento Bersaglieri, e da analogo personale del XXXIX battaglione dell' 11 o Reggimento. Alfiere era il tenente Bordno.

Venne costituito nel 1852 con R.D. del19 marzo c nell'aprile del 1861 passò alle dipendenze del Comando Bersaglieri del 2° Corpo d'Armata. Il l o gennaio 1871 il battaglione veniva inquadrato nel 7° Reggimento Bersaglieri di nuova costituzione, a far parre del quale sarebbe rimasto fino allo scioglimento nel settembre 1943. Nel1975, nel quadro della ristrutturazione dell ' Esercito, il21 ottobre fu ricostituito il X Battaglione Bersaglieri Bezzecca per trasformazione del preesistente XXV Battaglione Bersaglieri, che ere ditò bandiera e tradizioni del 7 ° Reggimento.
li 19 oLtobre 1992 il battaglione venne soppresso e la bandiera ceduta ai 7° Reggimento Bersaglieri, che fu nel contempo ricostituito con l'incorporazione dell'XI Battaglione Caprera, che a sua volta, per ripristinare la discendenza tradizionale, dal l 8 aprile 1997 cambiò denominazione riportando in vita iJ X Battaglione Bezzecca.

Campagne di guerta: - 1855 - 1856 (Crimea); 1859 (2A guerra d'indipendenza; 1860 - 1861 (antib riganta ggio nel CentroMeridione); 1866 (3/\ guerra d'indipendenza); 1870 (presa di Roma ); 1915 - 1918 (1/\ guerra mondiale); 1939 (occ upazione dell'Alban i a); 1940 - 1943 (2/\ guerra mondiale ): Ricompense ed onorificenze: - l medaglia di bronzo al v.m. per la battaglia di San Martino (1859). Ila inoltre concorso all'assegnazione delle altre ricompense che fregiano la bandiera del r Reggimento Bersaglieri (l croce di cavaliere dell'Ordine Militare d' I talia- l medaglia d'oro al v.m.- l medaglia d'argento al v.m.l medaglia di bronzo al v.m.).
Fu costituito nell912 , con R.D . del27 giugno, nell'ambito dellll o Regg.imento Bersaglieri per sostituire il XV Battaglione dislocato in Cirenaica, con compiti di controllo territoriale (per questa ragione, venne anche indicato come XV Battaglione BIS).
Dopo aver preso parte alla prima guerra mondiale, nell919, a seguito della riorganizzazione del Corpo comportante lo sc ioglimento di tutti i reparti bersaglieri creati per l'esigenza bellica, venne anch'esso soppresso.
Il 10 novembre arrivarono anche il r e e il generale Diaz. Il re era giunto inaspettato , mentre la visita del generale Diaz era stata annunciata. La nave che doveva portare il Comandante Supremo era stata segnalata per le 11, per cui alle 10, allorché la Lanterna aveva seg n ato " n avi in vista", al molo non c'era che poca gente . Alm om ento al palazzo del Gove rnatore c'erano il podestà Val eria, il vic ep residente del Consiglio o n. Doria, l'on. Ara e pochi altri cittadini , tutti riuniti per recarsi ad incontrare il vincitore deJla batta glia di Vittorio Ve neto. Poco dopo la prima se gnalazione della Lanterna , ne era giunta un'altra: una delle navi batteva all'antenna lo stendardo rea le di Savoia. Il palazzo entrò subito in agitazione; si susseguirono ordini e disposizioni , ed in breve tempo tutto fu pronto per accogliere il sovrano.
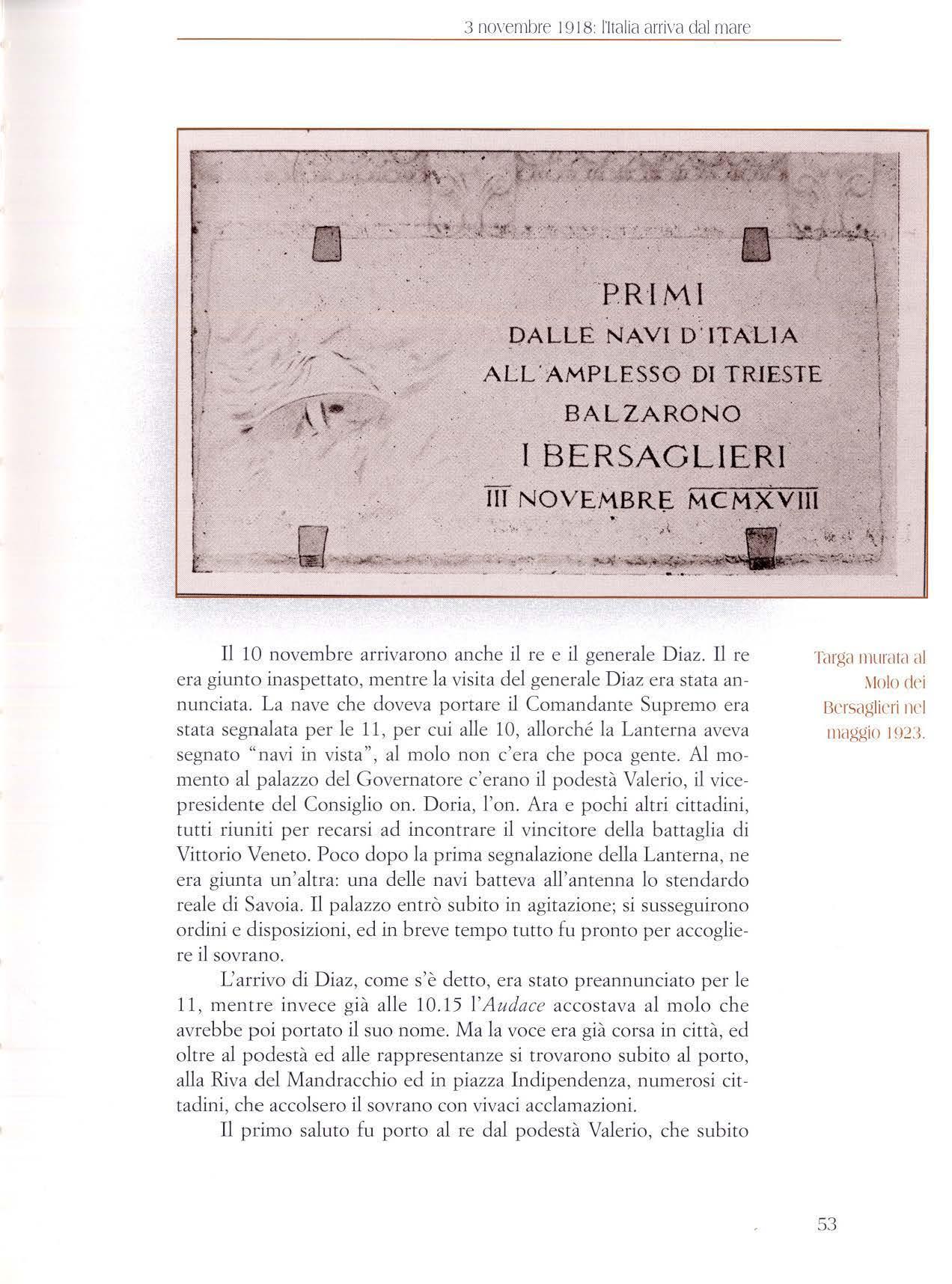
L'arri vo di Diaz , come s'è detto , era stato preannunciare per le 11, mentre invece già alle l 0.15 l'Audace accostava al molo che avr e bbe poi portato il suo nome . Ma la voce era già corsa in città , ed oltre al podestà ed alle rappresentanze si trovarono subito al porto, alla Riva del Mandracchio e d in piazza Indipendenza, numerosi cittadini, che accolsero il sovrano con vivaci acclamazioni.
Il primo saluto fu porto al re dal podestà Valeria, che subito
'!Mgél llllll'éltél CII lo cl ei 13crs<1glicri nel tlklgg io 1!>23
l () 110\ '('ll)hH' H li H: l'élll< '<,<l dell'd iTi \ o cll'i Hc di mo lo Sélll C uJo
scusò la modesta accoglienza imputandola alla mancata informazione ne i confronti dei cittadini. Ma il re non voleva giustificazioni: era st a to lu i stesso a non desiderare nessuna cerimonia di ricevimento, po i ché era venuto a Trieste, pellegrino de ll 'idea nazionale, solo per una visi ta sentimental e alla citlà che i nostri. soldati avevano portato nel g rembo del la famiglia italiana.
Ed il re salì, tra getti di fiori, in un 'automobile accanto aJ sindaco, con i general i Diaz e Cittadini sulla stessa vettura. Su altre automobi li seguivano i generali Petitti e Badoglio, il ministro della ReaJ Casa Matt io l i-Pasqualini, l'ammiraglio MarzoJo, comandante della d ifes a d i Venezia, ed a l tre persona lità mili t ari . il corteo, tra già fitte al i di popol o p laudente, attraversò la piazza Indipendenza e si recò a l M un icip io, dove il podestà pronunciò un discorso di saluto al qua l e il re r ispose con brevi parole. Seguirono le prescnrazioni e Vittorio E manuele II I , che era visibilmente soddisfatto di quella semplice cerimonia, strinse a tutti la mano rivolgendo la parola ad alcuni di ess i . frattanto l a folla che si era radunata sulla piazza acclamando al r e, ottenne che questi si presentasse al balcone. TI sovrano volle poi

vedere la tomba di San Giusto, e visitò rapidamente la basilica.
Uscito dalla chiesa, sempre tra la foUa che gli si pigiava intorno, il re si recò al Castello, dal cui torrione ammirò la bella veduta di Trieste che , disse , gli ricordava un po' Genova.
Chiese anche numerose informazioni sugli edifici ed i vari punti della città, facendo osservazioni sulla g randiosità di tal une strutture. Dalla caserma, attraverso le vie Carducci, San Giovanni, corso e piazza della Borsa , Vittorio Emanuele III fu condotto al palazzo del Governatore.
Al momento della partenza Trieste, nell'armonia festante della terra, del cielo e del suo mare, assurse ad una suprema bellezza. Tutta la città, che non era stata avvertita d e ll'arrivo , aveva saputo però che alle 12.30 il re aveva deciso di partire. Da tutti i quartieri affluirono cittadini , che si fusero sulla piazza, sulle riv e, sui moli in una folla densa, vorticosa, piena di felicità. Lo stato d'animo popolare sarebbe stato efficacemente esp res so dai versi in vernacolo di Flaminio
Cavedali:
Il generale Pclitti cìCcoglie il SO\Tntlo.


O re Vittorio, in questo tricolor che te vedi ondegiar libero al vento, ravisa ti el gran palpito del cuor del popolo che ti te ga redento:
Ravisa in questo simbolo de amor la fede che nei giorni de/tormento i spasimi calmava del dolor e a la /iama ghe dava l'alimento:
Ravisa in questa gente che saluda in ti el suo re e 'l suo liberator la stirpe che da Roma xe vignuda,·
e in sto soneto che no ga valor; una nota fra 'l popolo cressuda come eressi in un pra, fra l'erba, el /io r.....

ANTONIANI VITTORIO
BAlNELLA DANTE
BASSO FERR VC CIO
BEDNAWSKI ARMANDO
BELL VSCHI CARLO
BENVSSI BERNARDO
BERGfu\iAS ANTONIO
BLOTZ BRVNO
BONIVENTO CALLIAN O
BORDO::--l CARLO
BORGHELLO CARLO
BORRVSO ANTONIO
BORTOLVSSI PIETRO GALLIA::'\0
BROVEDANI AVRELIO
BRVNNER GVIDO
BVRI SERGIO
CALCINAR! GERMANO
CANTARVTTI MARCELLO
CARNIEL FABIO
CA R N IEL RICCARDO
CATTARVZZA ADRIANO
CAZZAG ON EMILIO
CEDOLI::--l VITTORJO
CESCA MENOTTI
CHARLET RENATO
CICVTTO ROMEO
CIMAROSTI CALLIANO
CLEMENTE LIVIO
COC ITO GVJDO
COLA VTTI GIVSEPPE DOMENICO
CORSI GVIDO
TRIESTINI CHE ALLA NE LLA GVERRA DI RE DI
COSTANTINI GINO
COZZI NAPOLEONE
DAVRANT BR VNO
DA VRANT G I OVA NNI
DAVRANT GUIDO
DEBEGNACH ATTILIO
DEL NEGRO ANTONIO
DE MARCHI EZIO
DE AMEDEO
DE PELLEGRfNI MARIO
DE RE DE RIN NICOLÒ
DE \'ALENTINI ANGELO ALFREDO
DE ZORZI VMBERTO
DIE::--lA VMBERTO
ELIA ENRICO
FABBRO MAR IO
FABRIS PIETRO
F ABRISSIN INNOCENTE

F ANTA RICCARDO
FERRARI L VCIANO
FRANZIN MARIO
GASPARD IS VMBERTO
GATTINONI GIVSEPPE
GEROMET ERMANNO
GIACICH EZIO
GIACOMELLI CARLO , GIANANTONI ISIDORO
GIOPPO MARIO
GRECO ANTONIO
HOFMANN MARlO
IENCO GIOVJ
IONA RVCCt
IVS LUIGI
KERS ARRIG<
KRALIEVI C H
KRVMPE AVR
LIEBMANN R.t
LIEBMAN N R. t
LORENZIN I C L VCA TE LLI C.
LVCCHINI Pll
LVNAZZI
LVZZATTO Pl
MA GRIS
GAL: MAGRIS R ICC
MAIONICA RE
MAIONICA R\
MALVTTA Al MAM OLO MARANZA NA MARANZA NA MARANZA NA
MARA SCVTTI
MARCON ETT I MARCOVICH
MARTINVZ ZI
MATVSSI C IV
MECCHIA CA!
MONT I
MORETTO N V MORTERRA P
•A T RIA DI E D E R O LA V I TA
MCMXV- MCMXV III
MORPVRGO GIACOMO
SIL VESTRI MARIO
RO
J MIRA NDO
lE L IO
DBER TO FU ACHILLE
DBERT O FU ENRIC O
:ES AR E
AR MEL O DI CARMELO
ET RO ETTORE
ILEO
:A R DO
/ GG ER O
SERT O
GIOVANNI l T ALO
RO MANO
ROMA NO
CARLO
CLEME NTE
LIO o ' \1B E RTO '.\ O LO
MVLLONI RO MANO
MVZZATI ANTONIO
NIGRIS ERNESTO
NORDIO AVRELIO
NORDI O FABI O
NO VELLI BR VNO
PADOA ALDO
PADOVAN
PASCOLATTI GV ID O
PELLARINI LVIGI
PETZ STELI O
Pl.\ZZA GI O R G I O
PI CC IOLA G I NO
PIC C IO LA VITT O RI O
PIRO! MARCELLO
PODER S AJ PIETR O
PO LONIO VGO
PRELZ
PRISTER MARC O
Q VADR ! NI VITT O RI O
REISS GIORGI O
RIMI N I FAB[Q
SALON MARIO
SAL VATORI SILVIO
SALVI GVIDO
:>CALIA NATALE DI SEBASTIANO
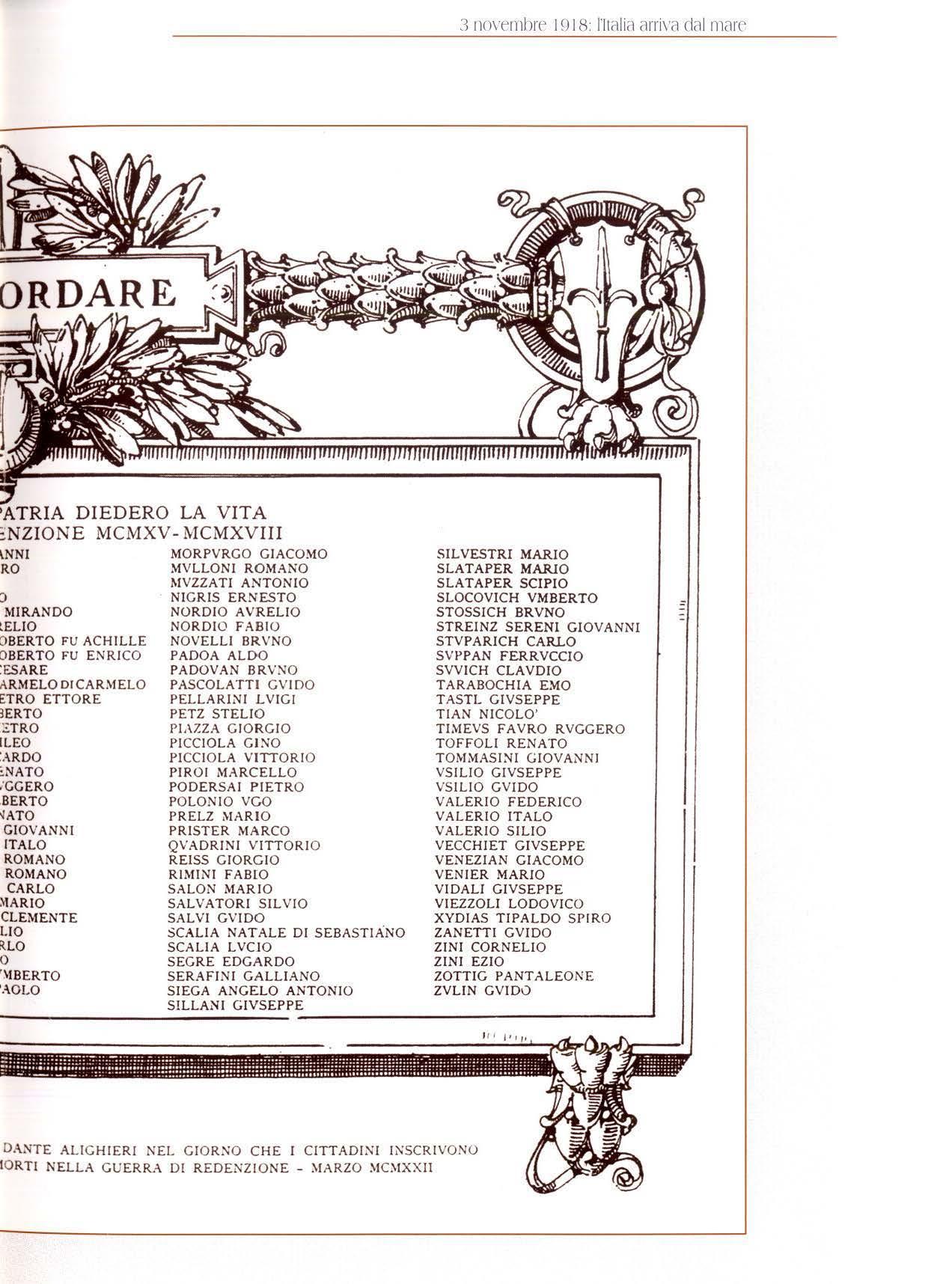
SCALIA LVCJO
SEG R E EDGARDO
SERAFI N I CALLIANO
SlEGA A NGE LO A N T ONIO
S!LLANI G I VS EP PE
SLATAPE R MARJ O
SLA T A PE R SCIP IO
SLOCOVIC H VMBE RTO
STOSSIC H BRVNO
STR E INZ SE RE NI GIOVANNI
STV P ARIC H CARLO
SVPPAN F ERRVCCIO
SVV ICH CL A VDIO
TARABOCHIA EMO
T ASTL GIVSE P PE
TIAN NICOLO'
TIME VS FAVRO RVGGER O
T O FFOLI RENATO
T O MMASINI GIOVA NN I
VSILIO GIVSEPPE VS ILIO GVIDO
VALERIO FEDERIC O
VALE R IO IT ALO
VALE R IO SILIO
VECCHIET G I VSEPPE
VENEZIAN GIACO MO
VEN I E R MA R IO
VI DA LI G I VSEP P E
VIEZZO LI LODOVICO
XYDI AS T IP ALDO SPIRO
ZA N E TT I GVIDO
ZINI CORNELIO
ZI N I EZ IO
ZOTTI G P ANTALEO N E
ZVLIN GVID0


26 ottobre 1954: "arrivano i nostri! "
L'Esercito a Trieste
dal I 9 18 ad oggi


e si es clud e Berlino, che dopo quasi quarant'anni dall a fine della guerra ancora ne stava sopportando le drammatiche conseguenze, nessun'altra città al mondo ebbe come Trieste, dopo il 1945 e per tanti anni, una sorte altrettanto infelice, un'esistenza altrettanto provvisoria ed una altrettanto pericolosa instabilità per ciò che concerneva il mantenimento della pace generale.
Il "peccato originale'' che provocò la condanna di Trieste a nove ann i di autentico purgatorio nel quale si bruciarono al fuoco dell'arresa amore e odio, speranze e delusioni ed in più di un 'occasione anche innocenti vite umane, risaliva al 1 ° maggio 1945, allorché le avanguardie del IX Korpus iugoslavo avevano occupato la città al grido di "Trst fe nas", - "Trieste è nostra" in sloveno, uno slogan con il quale i partigiani iugoslavi avrebbero tappezzato nei giorni successivi l'intera città - quando i primi reparti corazzati alleati già entravano nell'abitato e ne prendevano possesso.
Mentre le forze del generale neozelandese Freyberg rallentavano la marcia a causa di ripetuti e poco chiari ordini c contrordini, il V II Korpus iugos la vo, senza preoccuparsi di liberare il capoluogo del Quarnaro, convergeva da Fiume su Lubiana c da qui si dirigeva a marce forzare verso Trieste. Lo stesso fece il IX Korpus, che discese da Gorizia ed entrò a Trieste dall'altopiano.
E' necessario ed opportuno rievocare, sia pure sinteticamente, gli antefatti dell'intera questione.
Quando era ormai diffusa, all'interno dcll'Allied Forces Headquarters, l a sensazione di essere di fronte al col lasso finale tedesco, il generale Alexander aveva informato i Combined Chief'ì o/ Staff delia propria in tenzione di occupare quelle parti della Venezia Giulia imporranti per le operazioni militari e di stabilire in esse, e solta nto in esse, l'amm ini s tra zione militare alleata con il conco rso di personale
locale, italian o o iugoslavo, idoneo allo scopo Era, in altre parole, la traduzione in termini operativi del principio della " lin ea di demarcaz ione ". Il 27 aprile 1945 , in un messa gg io allo stato mag g iore imperial e, Alexand cr sottolineava ancora la necessità c he , n e ll e direttive d e i CCS, venisse stabilito con estrema precisione quanto la direttiva del Combi11ed Civil A//airs Committe e aveva la scia to in sospeso, e cioè le concrete modalit à con le quali porre in esse re il piano stabilito, cd in particolare la necessità di una scel ta esp li c ita a favore o contro l'eventuale uso della forza nei confront i dell'esercito iugoslavo.

Pur t enendo pr esente l'even tualità di una mancata co llaborazione iugoslav a ai progetti alleat i , la direttiva d e i CCS ad Alcxander, il 28 aprile 1945, continuava ad appellarsi al principio d e ll ' is tituzione del Go verno Militare Alleato in tutta la Ven ezia Giulia , ma precisava che i l buon funzionamento del piano dip e nd eva dalla co llaboraz ione con l ' Unione Sovi etica e che n e l frattempo lo si sarebbe dovuto porre in atto se le necessità militari lo avessero richiesto. Indubbiamente, la direttiva dei CCS non era in grado di fornire alcuna solu z ione definiti va agli int e rrogativi aperti; al contrario, la esplicita dichiarazione di non pot e r disporre d e ll 'elemento fondam e ntale di suppone (ovvero del consenso sovietico) e la su bordina zione alle n ecess ità militari, forniva di fatt o al Comandante Supremo Allearo dd Mediterraneo l'avallo a continuare nella pianificazion e g ià avviata e mirante a stab ilire un a sorta di linea di d emarcaz ion e .
Nel mezzo di un frenetico scambio di messaggi in cui l e direttive e rano superate dai fatti prima ancora di pervenire ai destinatari, il rapido sviluppo delle operazioni militari portav a gli iugosl av i, il 1o maggio 1945, a v incer e " la corsa per Trieste", a controllare cioè la maggior parte della Venezia Giulia fino all'Isonzo. Era però una vittoria sul filo dì lana, in quanto l'av anzata dell e unità dell3 ° Corpo , c h e e ntravano il 2 magg io e ricevevano la resa d e lla guarnigione tedesca, e soprattutto la d ecis ione presa il giorno successivo da A lexa nder di sp ingersi avanti evitando scontri aperti con gli iugoslavi c di occupare le aree di militare della Vene z ia Giulia , ovvero Triest e e le linee di comunica:done verso Nord, informandone Tito - provocavano una sovrapposiz ione di arce operative in una porzione della Venezia Giulia, mcnu·e ve ni vano profferìte reciproche accuse di mancata fedeltà agli impegni. Ad ogni modo , Alexand e r o rdina va di non proc e dere all ' istituzione del gove rno militare ad Est dell' I sonzo.
I n un tel eg ramma d e l 5 maggio, diretto a Mc Millan e d al Fo-
reign 0//ic e, l'ambasciatore inglese a Belgrado affermava che Ja propria analisi della situazione lo portava ad affermare come lo stato maggiore generale iugoslavo avesse in mano da solo l'iniziativa e tentasse di fornire una base militare quanto più forte possibile alle rivendicazioni politiche. Sul piano pratico , esso era preoccupato di liquidare l ' opposizione politica prima di ogni
possibile interferenza. Perciò compiva un notevole sforzo militare nel manten e r e a Trieste alcuni contingenti ed era , per contro, turbato ed irritato dalla presenza della divisione neozelandese. Aggiungeva, inoltre, di non ritenere che Tito sarebbe giunto agli estr emi n é che avrebbe provocato un incidente. Ma in un'atmosfera eli tensione locale qua l e era in atto in Istria , non poteva essere esclusa la possibilità di qualche combustione spontanea. L'unica azione che Tito aveva intrapreso , fino a quel momento, contro le truppe d'occupazione era stata l ' affermare che esse non potevano operare ad Est clell ' Isonzo , ma né lui né i comandati iugoslavi in loco avevano fatto finora qualcosa per dare effetto pratico a quest'ordine e, concludeva il diplomatico >era molto dubbio che lo avrebbero fatto.

In realtà, i dirigenti iugoslavi puntavano al controllo militare della Venezia Giulia come premessa a l controllo politico, ma con estrema cautela nell'imporlo, nel senso che al piano per costringere al silenzio le opposizion i locali non corrispondeva un altrettanto deciso e sicuro progetto di contenere la presenza militare alleata ad Est dell'Isonzo. Pertanto l'ambasciatore britannico a Belgrado Stevenson, e più esplicitamente Mc Millan , continuavano ad analizzare la situazione all a luce dell ' "esperienza greca". Effettivamente la strategia iugoslava, con il suo tentativo di estend e re e di consolidare il controllo militare facendo di esso la necessaria premessa per il con -
Il ll (lro lcl :\lc:-.:cmcler. CO llléllld!llll (' supremo allc<Jio dd \led il cmmro cluré.mtc gli ultimi llWSi (j('Jiél "2 11 G \ l. c ministro dcll(l clifcscl itlglcse del! 19:12 eli 1
trollo politico ricordava, sia pure in una situazione più circoscritta ma non per questo meno esp losiva, quella che nei mesi precedenti si era temuto avrebbe tentato il partito comunista greco.

Il richiamo all' "esperienza greca" era indice di come gli ambienti diplomatici in glesi si ponessero di fronte al problema della Venezia Giulia. Si trattava infatti di evitare che il controllo militare si assestasse diventando premessa c supporto al controllo politico. Veniva perciò privilegiato il piano dell'intervento militare, e ciò faceva escludere dall'orizzonte delle iniziative possibili una trattativa con l'Unione Sovietica. In ultima analisi, i diplomatici inglesi non vedevano nelle truppe iugoslav e presenti a Trieste la longa manus di questa, non ragionavano cioè in termini di espansione dcll'URSS attraverso i paesi satelliti, ovvero in termini di guerra fredda. Essi miravano invece, in ambito più circoscritto, a respingere il tentativo di imporre un'egemonia politica comunista agendo su quello che era il suo vettore principale, la presenza militare.
L'8 maggio a Belgrado, nel corso di un primo incontro con il generale Morgan, capo di stato maggiore Jell'AFHQ, Tito respingeva sia il carattere che il contenuto dell'accordo proposto. Egl i non accettava infatti un 'ipotesi di soluzione sul piano esclusivamente militare, mentre lanciava una controproposta che prevedeva una gestione militare congiunta accanto all'amministrazione civile iugoslava nella parte occidentale della Venezia Giulia, in quella parte cioè che Alexander aveva dichiarato di voler occupare. P er di più, era lo stesso Tito a spostare decisamente la questione, nell'incontro del giorno successivo con Morgan, dal piano militare a quello politico riaffermando il diritto del vincitore ad amministrare la zona contesa in quanto essa faceva parte delle rivendicazioni territoriali da presentare alla conferenza della pace. Si poneva pertanto il dilemma fra l'uso o meno della forza, una decisione che il comandante supremo del Mediterraneo demandava ai politici.
Con altrettanta urgenza si poneva per i dirigenti inglesi il problema di conoscere quali fossero nel concreto le intenzion i ame ricane, ferme all'enunciazione della direttiva dei CCS ad Alexander il28 aprile ed alla dichiarazione del presidente Truman che non sarebbero state impi ega te truppe americane contro l'esercito iugoslavo. Si delineava anzi la possibilità di una sospensione dei process i decisionali britannici finché non fosse stato chiarito l'atteggiamento statunitense, che si temeva diretto ad aprire la discussione con l'Unione Sovietica
11 6 maggio, un funzionario della divisione per gli affari dell'Europa mericlionale, Cavcndish Cannon , redigeva un memorandum nel quale, al di là delle ripercussioni det e rminate in Italia dalla situazione nella Venezia Giulia e della riaffermazione dei principi della Carta Atlantica, affermava come per gli USA non si trattava di p rendere posizione nella disputa tra Italia e Iugosla via o di esser e coinvolti nella politica interna balcanica, ma che il problema
era fondamentalmente quello di stabilire se stessero permettendo al governo sovietico Ji decidere, attraverso il suo satellite iugoslavo, quali Stati e confini istituire che fossero i più idonei alla futura poten z a sovietica nel teatro mediterraneo.
Fallito l ' incontro fra Morgan e Tito, dimostratasi ormai insostenibile la posizione americana sulla Venezia Giulia , diffusasi la percezione del rinsaldarsi di un controllo iugoslavo su Trieste, il IO maggio gli Stati Uniti indicavano in questi termini l'alternativa che si poneva loro, o ritirarsi completamente dal territorio , con tutte le conseguenze che ciò avrebbe comportato, o dar corso alla politica in atto minacciando l'uso delia forza onde assicurarsi il pieno ed esclusivo controllo di Trieste e Pola, i punti- chiave della regione.
L'atteggiamento americano nella crisi apertasi con la Iugoslavia era dunque indice della tensione ma anche dell'equilibrio, sia pure instabile, tra due modelli di formulazione dei rapporti con l'Unione Sovietica, fra due modi cioè di analizzare la politica estera russa , considerandola rispettivamente disponibile alla trattativa o sistematicamente mossa da obiettivi di espansione del comunismo, ossia fra

Skri<ll>in liclmilc)\'ic
111inislro df'gli esteri clclll'HSS per LUl decennio ( 19:39- l D-1-9)
due mo di eli r ispondere alle iniziative sovietiche, facilitando la ricerc a d i intese a li vello diplomatico oppure, alternativamente, assumend o a tteggi amenti a tti a comprovare volontà di resistenza e di front egg iamen t o .
A conclusione delle discussioni all'interno del Dipartimento di S t a t o, T r um a n comun ica va a Churchill l'intenzione di assumere una line a d i fe rmezza nei confronti della Iu gos lavia, mirante a garan tire il con t ro ll o s u Tr ieste e Po la , sulla lin ea di comunicazione attraverso G o ri z ia e Monf a lc one e su un'area sufficiente ad Est di questa linea tal e da p e r m ette re un ' idonea vigilan za amministrativa. In tal modo si r ip ro p on e va un all ine a me nto fra la posizione americana c quella ingle se.

Il 2 1 m agg io il gove rn o iu gos l avo e mett eva una nota con la q u a le ri p on deva in senso affe rmativo alle richi este g ià presentate da M o rg a n a T i to: ven iva cioè accettata l' a mministra z ione milit are all eat a ad Ove s t d ell a linea proposta da Morgan, a patto che una rappresema n za mil i t a re ed una p iccola missione riman essero in loco e che ven i se c on se r va t a l 'amminis trazion e civile iugoslava. Sul ca mbiam e nto di a tt e gg ia mento da parte iu gos lava pesò senza dubbio in mani e r a d e t e r m inan t e l ' a tteggiamento dell'Unione Sovietica , il c ui sil enz io r en d ev a m a nifesta la vo lont à, in questa fase, di non fare della Ve n ez ia G iu lia un argomento di trattati va con gli a lleati occidentali.
P e rta n t o, a segu ito della nota iugoslava del 21 magg io, la crisi v irtu al meme s i conclu d eva; per iniziativa di quel governo, infatti, la t r a n a riva si sp ostava tutta sul problema dell'amministrazione dell ' ar e a ad O ves t d e ll a linea di demarcazione, imp eg nandolo a gara ntire il m a nt e n ime n t o dei vari istituti di governo civile fra i quali il Consig lio d j L ib e r az io n e d i Trieste (CLT ), il tribunale del popolo ed un co r po di p oli z ia c itta dina denominato Guardia del popolo.
Ce r a , i n sos t anza , i l ten tati vo di chiudere del tutto i processi p os t i in atto d a p a r te dell'amministrazione civile e militare iu goslava a Tri es t e . E c iò esp l icitava anche l ' intenzione di defini re e chiudere tu rr i g l i aspett i d e ll a controversia con la Iugosla via, in modo che l 'e, ·e nr u al e p e r ma n e nza di un con t enz ioso in merito non a u mentasse ul te ri o r ment e l'on e re dei prob lemi che l'amministrazione alleata si a r e b b e trov a t a d i fronte, un onere già di per se stesso molto magg io re di q uello che era stato assunto nel territorio italiano.
L a bozz a d i accordo venne pres e ntata dagli ambasciatori ameri cano e d i nglese a l governo iugoslavo il 2 g iu g n o. Essa prevedeva p i e na a u t o r i tà al le at a nel territorio ad O ves t della lin ea di demarca-
zione, il ritiro di tutte le forze iugoslave all'infuori di una missione militare e di un distaccamento di 2.000 uomini, lo scioglimento dei contingenti non regolari, l'istituzione de l Governo Militare Alleato con l'eventua le utilizzazione dell'amminisu·azione civile costituita dagl i iugoslavi a discrezione del comandante supremo alleato, la restiruzione di tutti i cittadini italiani deportati alla data de l 193 9 e delle proprietà confiscate.
Il 9 giugno venne firmato l'accordo
di BelgraJo, ed il generale Morgan rimase n ella capitale iugoslava per defini r ne i particol ar i. L e discussioni roterono considerarsi concluse il 28 dello stesso mese. Ma le forze iugoslave avevano abbandonato Trieste già il giorno 12 Esse si ritirarono ad oriente dell a cosiddetta L inea Morgan. Il territorio ad occidente della linea fu lasciato ag l i ang loamericani, che ino ltre occuparono iJ porto di Pola .
G li iu goslavi erano rimasti a T rieste esattamente un mese e dodici giorni. li modo in cui l'avevano occupata sarebbe stato successivamente giudicato, da parte di autorevoli commentawri swrico-politici, il p i ù grave errore politico commesso da Tito nel corso della g uerra. e infatti nel 1945 gli iugoslavi avessero avuto il buon senso di occupa r e tutta l a Venezia Giulia meno la città d i Trieste, è forse probabile che l'avrebbero poi potuta ottenere alla conferenza della pace . Oppure, nel corso di successivi negoziat i, l' avrebbero realmente potuta t rasforma r e in un territorio libero assimilabile, in tempo p i ù o meno breve, dall a Iugos l avia . Con l 'occ upazione di Trieste, invece, essi non erano riuscir] nel so l ito gioco del fatto compiuto, si

ip Br m 1111 lll w di bdllctglid lìto).
dd < on..,iglio <• dt'llcl clrlld Hcpul>l>li< rl Fcdcr d le Popolclr<' di lltgo..,ld\ id CICli 110\'t'llliJrc l D+:l.
erano inimicati l'opinione pubblica di tutto il mondo occidentale ed avevano pregiudicato, invece di migliorarla, la loro posizione nelle trattative di pace e portato i triestini ad esasperare il risentimento verso di ess i d opo il comportamento tenuto nella città.
Ma d'altro ca nto , anche ammettendo che il maresciallo Tito , occupando Tri este nel modo che si è visto , avesse commesso quel grave errore che g li è stato attribuito, resta il fatto che gli an gloamericani, in seguito a quel colpo di test a, vennero presi in contropiede. Non che man casse ro loro le forze e la volontà sufficienti ad imporre agli occu panti di abbanelonare la "presa", ed e ra proprio quello che molti triestini in quel momento si attendevano da essi. Ma la quest ion e non era così semplice: c'era il pericolo di sco ntri armati, che avrebbero potuto provocare reazioni a catena e compromettere la situazione anche in campo int e rnazion a le. Non va dimenticato, in fatt i, che la I ugos lavia era una na z ione all eata, e che buona parte dell'opinion e pubblica occ ident ale aveva seguito con simpatia l'accanita resistenza opposta ai ted esch i dai partigiani di Tit o.
TI 9 giugno 1945 si ebbe a Bel grado la firma dell'accordo. Per effetto di esso, pertanto. il territorio della Ven ez ia Giulia qua le si es t endeva nel 1939 (owero l e quattr o province di Gorizia, Trieste, Fiume e dell'Istria) veniva diviso in due parti lungo la cosiddetta linea Morgan. La parte ad Est di essa, la Zona B , ricadeva sotto l'amministrazione militare iu gos lava, m entre quella ad O ves t, la Zona A, veniva sottoposta all'autorità del governo militare alleato. L'accordo eli Belgrado non ch iud eva però la trattativa fra angloamericani e iugoslavi, che pros eg uiva allo scopo eli rag giungere un accon.lo di caratt e re operativo; ed in tal e sede sarebbe maturata n e i comandi alle ati la consapevolezza che il dispositivo relativo ali' amministrazione d ella Zona A s i ri vel a va inad eg uato ai fini di un cont rollo a pieno titolo del territorio suddetto.
E' in qu esto quadro che vanno co llocate l e decisioni ra gg iunte a Pari g i sulla questione della Venezia Giulia. Di essa si era cominciato a discuter e all'inizio di maggio del 1946, po co dopo l 'a p e rtura della seconda sessione del Consiglio Jei m inistri degli est e ri. Nella seduta del 4 maggio, cias cu na dell e quattro del egaz ioni aveva difeso la proposta formulata dal proprio rappresentante in seno alla commi ss ione che aveva visitato la Vene z ia Giulia fra il marzo c l'aprile dello stesso anno: si andava dalla "lin ea Wilson ", che tagliava a metà l' l s tria , lasciand o la parte occ identale in territorio italiano, alla " linea sovietica" che correva per buona parte più ad O vest del confine na-

poleonico austro-ital iano del 1866. Nelle riunioni dei giorni successtvt, non SI nusciva a tro v are alcun accordo sulla proposta di un plebiscito nell'a rea con testa t a , né veniva accettato un invito di Molotov diretto a compensare le mutilazioni territoriaJi lungo la frontiera orientale con più favorevoli concessioni all'Italia in tema di co lonie e riparazioni. Eguale risultato nega-
tivo sortiva l'intenzione di Byrnes e Bevin di trovare un compromesso lungo la "linea francese" , che mantenesse in Italia quanto meno la parte nord-occidentale dell ' Istria.
Lo svanire della prospettiva Ji un accordo rilanciava, a Londra, un ' ipotesi già formulata dai rappresentanti inglesi , che prevedeva l'istituzione di uno Stato autonomo limitato ad Ovest della "linea sovietica" ed a Est della "linea francese" , non retto da forme di autogoverno ma da un organo dipendente dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU .
Pertanto, sulla proposta formulata da parte francese a titolo di soluzione provvisoria (l'internazionalizzazione cioè del territorio di Trieste) si registrava sin dall'inizio una disponibilità di fondo da parte americana ed inglese con un'unica precisazione che si colJegava ai progetti già elaborati: che non venissero previste forme di autogoverno o di controllo su base multilaterale, e che non si trasferissero ad un piccolo territorio gli stessi problemi che stavano avvelenando le relazioni fra le grandi potenze nel l oro controllo congiunto dei Paesi occupati.

n fatto che dopo la presentazione della proposta fossero state definite alcune questioni in sospeso apriva la via ad un accordo anche sulla questione di Trieste. NelJa seduta del 3 Juglio, infatti, veniva accolta la "linea francese" come tracciato di frontiera fra Italia e
llr-my Trunmn. presiclcnw degli Slclti l'ni li <léll 1 élprilc 19-+.:> eli 3 llO\Tillim' 19:>2.
Iugos lavia ed isrituito il Territorio Libero di Trieste (TLT) lungo la fascia costiera da Duino a Cittanova. L'inrernazionalizzazionc della part e della Venezia Giulia comprendente Trieste, il suo relroterra immediato c l'Isrria nord -occidentale era poco più che una formula, e restavano da definire le modalità concrete di funzionamento del sistema di governo previsto per la nuova ent ità terriLOriale.
T lavori preliminari per il Trattato di pace ebbero inizio a Londra Lll8 gennaio 1946, in un momento nel quale i rapporti tra URSS da una parte ed USA ed Inghilterra dall'altra erano particolarmente tesi. Tiro si sentiva forte come non mai. Furono fornite notizie in merito alla preparazione di un colpo di mano iugoslavo su Trieste qualora i ministri degli esteri riunjti a Londra non avessero accettato le richieste deJ governo di Belgrado. I n marzo i generali L ee e Morgan dichiararono pubblicamente che, in caso di un tentativo del genere, gli attaccanti sarebb e ro s t ati respinti con la forza delle armi. Gli americani sostenevano inoltre la tesi della creazione di un porto lib ero a Trieste cd a Fium e. TI confine tra Italia c I ugoslavia avrebbe dovuto seguire la linea etnica. Venne nominata una commissione quadripartita (USA, In ghi lterra, Francia ed URSS). Questa compì un'inchiesta piuttosto sommaria nella Venezia Giulia fra il 9 marzo e il25 aprile, che non contribuì a chiarire e tanto meno a modificare le idee dei componenti delle singole del egazi oni.
L e discu ss ioni per le trattative si trascinarono per tutto il 1946. Nella riunione del Consiglio dei ministri degli esteri a Pari gi dal 25 aprile al 26 maggio, Molotov continuò ad insistere per l' assegnazione di Trieste alla I ugoslavia, mentre su proposta dell'americano Byrnes si parlò per la prima volta di un plebiscito da tenere nella zona compresa tra la linea francese e quella americana. Ma sia questa proposta sia quella di Molotov, che suggeriva di estendere il plebiscito a tutta la Venezia Giu lia , sarebbero state resp int e .
Durante l 'intervallo tra le due sessioni delia Conferenza di Parigi (16 maggio- 15 giugno), si cominciò a ventilare l'idea della internazionalizzazione di Tri este, e la Iugoslavia fece subito sapere che non s i opponeva a quella del porto ma che non prendeva nemmeno in considerazione quella della città. Tiro, il 27 maggio, si recò a Mosca pe r chiedere a Stalin il pieno appoggio, che però non gli venne concesso. Fu anzi rimproverato dal dittatore soviet ico per l'intra n sigenza che continuava a dimostrare, quasi non s i rendesse conto che la slavizzazione di Trieste avrebbe potuto rivestir e il ruolo di detonatore per innescare una nuova guerra mondiale.

Fu così che il progetto dell'internazionalizzazione della città prese a guadagnare terreno. L'Italia, che durante tutto questo tempo era stata sempre presente ed attenta alle trattative ed aveva sempre sostenuto le proprie ragioni con i pacati ed equilibrati interventi di Alcide De Gasperi, avanzò ogn1 nserva possibile sull'attuazione di un simile progetto. Ma le tre
grandi potenze dell'Occidente si rendevano ormai troppo bene conto che esso avrebbe rappresentato il solo compromesso idoneo a bloccare le richieste jugo-russe, e si proponevano di non lasciare alternative: o così, o niente. Ed infatti Molotov, alla ripresa della Conferenza, s1 pronunciò favorevolmente sullo Stato libero, governato però alternativamente dall'Italia e dalla I ugoslavia. Proposta, questa, che venne anch'essa respinta, ma che tuttavia fu interpretata come una prima concessione sovietica.
Tra rifiuti, emendamenti, nuove proposte e controproposte si arrivò al3 luglio 1946, che va considerata come la data di nascita ufficiale del TLT. La soluzione comunque non soddisfò nessuno, tranne i francesi che l'avevano proposta e caldeggiata. Si giunse così alla Conferenza della Pace, ed il 28 settembre alla approvazione della linea francese - così era stato denominato il confine che avrebbe dovuto separare il TLT dalla I ugoslavia - differendo peraltro ogni altra decisione riguardante la struttura del Territorio stesso. li 9 ottobre vennero approvati anche gli articoli del Trattato di pace con l'Italia.
AIJa Conferenza di Parigi seguì la riunione del Consiglio dei ministri degli affari esteri a New York, che ebbe inizio il4 novembre 1946. Il 28 dello stesso mese i Quattro Grandi si accordarono sullo statuto, sul confine c sulle questioni militari , ma le cose tornarono a peggiorare per un ulteriore irrigidimento sovietico ci r ca il finanzia-

mento del TLT. Bene o male si arrivò al 12 dicembre, data nella quale turri i principali ostacoli vennero superati. La firma del Trattato ebbe luogo a Parigi il lO febbraio 1947, ed il 15 settembre esso entrò 1n v1gore.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale i rapporti tra Stati Uniti e l' I nghilterra relativamente all'area mediterranea avevano subito una modifica, nel senso di un progressivo disimpegno da parte britannica da quelli che erano stati sino allora considerati i tradiziona li interessi imperiali sull'area stessa. Se a partire dalla metà del 1944 era stata proprio la componente inglese a pilotare, s ia su l piano m il itare che su queUo politico-diplomatico, l'ini:t:iat iva alleata in Venez ia Giulia, alla fine del 1947 il rapporto fra i due partner occidentali risultava compless ivamente rovesciato.
Alla fine di quell'anno, da parte americana, venne prevista per la prima volta una relazione diretta fra la questione di Trieste e la po litica interna italiana, in altri termini la possibilità di un intervento statunitense in funzione anticomunista nell'imminenza delle elezioni po litiche italiane previste per l'aprile 19-l8. Se il loro esito non appariva scontato e le linee di condotta americana non avrebbero potuto essere cristallizzate fino a quel momenro, un obiettivo di fondo della politica degli USA appariva comunque fuori dubbio, ovvero l'intendimento di non vedere Trieste in mani iugoslave, intento che del resto continuava a essere condiviso anche a Londra.
Negli ultimi mesi del 1947 la situazione italiana veniva dcscrirta, a Washington, alla luce del più tipico contesto ideologico propr io del l a guerra fredda, e c ioè come i l teatro di una apoca littica prova di forza tra il comunismo c la democrazia. Ne ll a cons ideraz ione che obiettivo del PC I era il comp letamento assoggettamento del l'Italia al controllo sovietico e che tale eventualità avrebbe compromesso la sicm·czza americana nell'Europa occidentale e nel Mediterraneo (con r ipercussioni che si temeva potessero arrivare fino all'America latina ) il Dipartimento di Stato e lo stato maggiore americano definirono progressivamente una politica di pieno soslegno al governo capeggiato da Dc Gas peri, della quale si fece portavoce l'am b asciatore ame ri cano in Ita l ia Dunn. Essa privilegiò l'intervento di caratrere economico, preludio del futuro piano lVlarshall, in quanto era valutaz ione corrente, a ll 'interno del la diplomazia americana, che le diffico lt à attraversa t e dagli Sta t i dell'Europa occ identale nel p r ocesso d i r.icostruz ione econom ica fossero il più fert il e terreno d i co ltu ra del comunismo. Ma non vennero escluse altre iniz iative di carattere p iù

prettamente tattico, soprattutto dopo che il colpo di stato comunista del 24 febbraio in Cecoslovacchia aveva rafforzato i sostenitori di un più duro atteggiamento anticomunista.
Il 20 marzo 1948 veniva emesso un documento, la cosiddetta "nota tripartita", nella quale Stati Uniti, I nghilterra e Francia proponevano all'Un ione Sov .ietica di negoziare un pro -

toco ll o al trattato di pace con l'Italia che prevedesse la restituzione dd TLT alla sovranità italiana. Non si trattava, in realtà, di una proposta per un reale negoziato, ma di un'iniziativa a carattere tattico mirante ad attribuire alla Iugoslavia, e di conseguenza alla sua potenza internazionale sponsorizzatrice, l'Unione Sovietica appunto, la responsab ilità di aver impedito sino ad allora l'istituzione di un TLT realmente indipendente. Comunque, al di là della propria connotazione tattica, la "nota tripartita" creava una convergenza fra la dichiarazione di intenti da parte alleata e le aspirazioni italiane alla revisione del. trattato di pace, e veniva pertanto assunta dal governo di Roma come base della propria linea di condotta nei confronti della questione di Trieste.
li Territorio Libero non sarebbe stato in realtà mai attuato, e la mancata nomina del Governatore avrebbe prolungato l 'amm i nistrazione de ll a Zona A per altri sette anni.
Alla fine del giugno 1948 giLmgeva, nel complesso imprevista, la no tizia della spaccatura fra l'Unione Sovietica c la Iugoslavia . Da parte americana, la prima analisi dell'evento veniva compiuta con estrema tempes t ivi t à e non si mancava d i coglierne la portata. Per la prima vo l ta ne ll a storia, uno stato comunista affermava la propria indipendenza da lviosca; e pur senza nutrire alcuna aspetta6va circa una modifica del regime interno iugoslavo, il fondamentale, profon -
\\ 'in.., ton Cl1ltrcilill. Célj)O (!!'l gm·crno inglese cl<lll'otlolm ' 10:1 1 cl ll'aprile 1D:1 >
do significato della sfida di questo Paese veniva collegato ad una prospettiva di disintegrazion e di quello che fino ad allo ra era stato considerato come un blocco monolitico sotto l 'egemon ia dell'Unione Sovietica. L o stud io si concludeva raccomandando dn ev itare atteggiam ent i sia adulatori che troppo freddi nei confronti di Tito.
Era soprattutto dall'ambasciata americana a Belgrado che, all'inizio del 1949, provenivano l e indicazioni e le valutaz ioni che permettevano di riempire quel vuoto d i iniziative rimasto sost anzialmente invariato per tutta la seconda metà del 19-J 8 In uno studio del Policy Planning Sta// si ne gava che la disputa tra Tito e Sta iin fosse uno stratage mma adoperato a fini tortuosi dai soviet ic i, e si invitava a non cons id erare del tutto indifferente per gli Stati Uniti una caduta del regime iugoslavo , alla quale sarebbe succeduta una nuova dirigenza formata da esponenri più rappresentativi ed oricnrati verso l ' occ ideme.
D a tale presupposto, c recependo uno degli obiettivi del contenimento n e l senso della creazione di tensioni a ll 'interno del blocco comunista, lo studio iJlustrava la consideraz ion e di fondo dalla qual e partire per rifo rmulare la lin ea di co ndotta n e i confronti della Iu gosla via, ovvero il fatto che la crisi di questo P aese lasciava aperte solo du e alternative (Tito od uno strumento nella mani dcll'URSS) e che di conseguenza l'indebolimento di T it o avrebbe fatto il gioco della grande potenza orientale. Nel documento si sosteneva quindi con forza la necessità di un intervento economico immediato e non condizionato da contropartite politiche, capaci di minare la stab ilità del regim e iu gos la vo. Per fare Ji questo Stato un caso esemp lare e irripe t ibile (il riferimento riguardava la Cina), si a uspic ava che la politica americana si fondasse su clu e obiettivi: il sostegno econom ico come garanzia di indipend enza, e la non interferenza nei confronti del mocl ello di reg ime all ' inr erno de l Paese, escludendo, quindi, ogni ini z iati va che avesse potuto iod ebolirlo.
Nei mesi successivi venivano io gran parte ridimensio nat e l e aspettativ e di diffusione del titoismo su ampia scala e s i co nsolidava comunque l'obi e ttivo tend ente a mantenere a galla Tit o, sia pure con un procedere inizialmente molto cauto soprattutto per c iò che concerneva le climensioni del supporto econom ico. Simil e nel com plesso era anch e la posizione bri tannica.
Nella seco nda metà del 1949 s i precisavano anche l e implicazioni strategiche ad ampio raggio derivanti dalla nuova co ll ocazione iugoslava. Il Policy Planning Sta// formu lava un nuovo quadro di ri-

ferimento che sarebbe stato riproposto neg l i anni successivi rimanendo inalterato nella sostanza. Un successo sovietico nel distruggere il regime di Tito e nel sostituirlo con un governo fantoccio completamente asservito a Mosca avrebbe infatti , . rappresentato un Immediata minaccia alla sicurezza dell'Italia, della Grecia ed un grave capovolgimento della posizione com -

plessiva degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale.
Sebbene nel corso dell949 non venissero sciolte tutte le riserve circa l a stabilità del regime iugoslavo, i nuovi termini della pianificazione militare e la stessa valutazione politica dello scisma di Tito cominciavano comunque a modificare la funzione di Trieste come baluardo dell'Occidente nel quadro della strategia del contenimento. Nel settembre di quell ' anno lo s tato maggiore americano faceva notare come a causa del miglioramento nelle relazioni con la Iu goslavia la possibilità di incidenti internazionali a Trieste si fosse già notevolmente ridotta, e come fosse l ecito aspettarsi che diminuisse ulteriormente finché fossero persistite le differenze tra il regime di Tito e d il Cremlino, e sino a che il re gi me di Tito avesse avuto bisogno dell ' aiuto occidentale al fine di mantenersi al potere.
Il problema di Trieste tendeva perciò a non apparire più come un aspetto delle relazioni globali fra Est ed Ovest, a non essere più co ll ocato nel quadro dei progetti sovietici e delle risposte americane ad essi, e la presenza alleata nella Zona A tendeva a perdere quel carattere di test circa l'atteggiamento complessivo nei confronti dell'Unione Sovietica. L'orizzonte intorno a tale questione si restringeva progressivamente , e finiva per ridurre a quattro il numero deg li ìnterlocutori: Stati Uniti, Inghilt erra, Iugoslavia ed Italia.
Dagli ultimi mesi dell948, però, cominciò a farsi luce un nuo-
. \ JHllony EcJcn, ministro clcg li este ri Ìllglcsc del l l n.=; l (-lii9.S:t
vo p resup p os to nei r a p porti con le forze politiche locali. A differenza d i que lJ o f ino allor a in uso, che aveva raffigurato la realtà politica del p o s to ne i te rmin i di una compresenza, di un equil ibrio tra forze antagon is te , il nuovo p resup posto si fondava sulla consapevolezza che, in conseg u enza di un processo di rafforzamento prodotto dalla stessa po li t ica de l con ten imento c consolidam dalla dichiarazione triparrita e da lla c risi abb at tu t asi sul partito comunista locale dopo la rottura tra I ugo sla ù a e l 'Un ione Sovietica, l'insieme delle forze politiche e sociali ri chiam a ntes i all a so lu zione italiana della verrenza territoriale andava co n sider ato come l' e lemento di assoluta maggioranza a Trieste.
E' d a c iò che prese forma quella c h e è stata pressoché generalme nt e anch e se impropriamente definita come la politica filoitaliana del Gove rn o M il it a re Alleato, della quale il comandante, generale Ai r ey, era c o ns ide r a to il principale ispiratore ed artefice. In realtà, b en lungi dall 'ade r ire al le aspettative del governo italiano c pur rimanendo il Gove r no Militare Alleato un'entità separata rispetto alle fo rze poli t ich e i t a lia n e, e soprattutto estranea al clima politico c cult ur ale n e l qu ale ess e si collocavano, la politica di Aircy si fondò sul p re sup p osto d i un a p resenza largamente maggioritaria del le forze fil o i t al iane ed ope r ò spesso in modo da farla risaltare, come testimon ia n o le s ue pubb lic h e dichiarazioni a favore della restituzione del TLT all ' Ita l ia , espresse in modo da rendere chiaro il nuovo rapporto pr i, i lcg iar o con i g r uppi a questa favorevoli.

I no lt re, n e l settembre 1948, dopo che si erano già avvertite alcune so lleci t az ion i da p a rte del Forcign 0//ice, Airey decise di indire le el ez ioni lo c a li, e pu r non ignorando che i futuri consig Ji cri comun a l i s a reb bero st a t i p iù indip endenti c meno soggetti all'autorità del Governo Alleato. ciò non servì a mettere in discussione l'ob iett ivo con n esso a tale scelta: il fornire un riconoscimento reale, che pote\·a p ro ven i re soltanto da una consultazione elettorale, al carattere magg ior ira rio dei parti ti filoitaliani sulla scena politica locale.
L' a ttegg iament o nei confronti del gruppo etnico sloveno rifletteva d 'a lt ro c a nto l a volon t à di non fare alcunché capace di ritardare il p roce ss o d i r ima rginazione delle ferite recenti o di riap rire q u ell e vec c h ie , d i a tte n uare le tensioni persistenti a livello locale e di assume re un a funz io n e st a b il izzatricc secondo il dettame del Dipartimento d i S t a to E r a una prospeLtiva rapportabile alla rcimpostazione d e i ra ppo r t i f ra i q u a ttro interlocutori, p rei udenti all'avvio di un dialogo s u l pro b lem a di Tr ies te. D'altra parte il ruolo delle forze filoital iane q u a le in re rl oc u tore privilegiato poneva alle iniziative nella prc-
detta direzione un limite oltre il quale si sarebbe potuto correre il rischio di suscitare l'ostilità della stessa Italia ufficiale , il tutto in una situazione nella 4 uale , a causa del forte antagonismo esistente fra i gruppi etnici, ogni atto che avesse coinciso con i timori dell'uno sarebbe diventato immediatamente cedimento alle richieste dell'altro.
A partire dalla
seconda metà del 1949 la politica de ! governo militare alleato continuava nel complesso a seguire le linee di fondo precedentemente tracciate , ma tendeva nel contempo a cogliere, nel suo concreto sviluppo, certi esiti di fatto che dimostra vano la possibilità di raccordi con la ridefinizione della politica ang lo americana sulla questione di Trieste. Gli obiettivi di questa erano individuabili n e l fornire un periodo di distensione, contribuire alla riduzione di alcune delle lensioni che avevano reso i] problema di Trieste così esplosivo, concorrere al miglioramento di uno dei tradizionali punti critici dell'Europa sudorientale , togliere di m ezzo dalle relazioni fra Italia e Iu goslavia una questione altamente critica

Ma era evidente che si trattava di formulazioni piuttosto generiche, così come quella della prospettiva di una spartizione delle due Zone del TLT fra Italia e Iugoslavia , un 'eventualità manifestatasi in concomitanza con il riallincamento della Iu gos la via nei confronti dell'Occidente. Era del tutto concepibile che il governo iugoslavo avrebbe consentito alla restituzione di una gran parte del TLT all'Italia solo a patto che gli fosse stato consentito di mantenere sotto la sua piena sovranità la zona che amministrava al momento. Gli Stati
Uniti non potevano proporre o sostenere attivamente tale spartizione , ma avrebbero potuto accettarla qualora l'Italia, come pure l'Inghil terr a e la Francia, avessero dimostrato di aderirvi.
.\!( Ì( le dc Gdspcri. del co11sìglio ililli<mo d(11 rliccmlxc 19-t:J l D:J]
I n sos tanza, pu r nella disponibilità in linea di principio ad accettar e una so l uz ione d i compromesso, gli USA propendevano per un attegg ia m e n to d i imm o bilità c di astens io n e da ogni iniziativa volt a a favo ri re i l1 d ialogo fra l tali a e Iugoslavia. Ancora più esplicito era l' a tteggiament o d e l Foreign 0//ice britannico, che già verso la metà di a pr ile sempre del 1949 aveva dato mandato all'ambasciatore a Be lg ra do d i non ag ire da interm ediario in un'eventuale trattativa fra i d ue prcdert i P a es i.
Ta li a t tegg iamen ti testimoniavano il netto ridimensionamento c h e la q ues t io ne d i Tr ieste aveva subito dopo la rottura fra la Iugosl a via e l ' U n io n e Sovie tica ; essa perdeva qualsiasi ril ievo in relazione a i t e r m in i d el r apporto fra E st cd Ovest e diventava , per Stati Uniti e Ing hilt e r r a , un e lemento da riportare alla politica nei confronti dell'It a l ia e d ell a I ugos la via e da valutare in relazione alle ripercussioni che avreb b e p rodotto all'interno di queste nazioni. A tal proposito un e lememo d i p reci sazione del nuovo quadro di riferimento proveniva da l D ip a r t imento di Stato di Washington, che affermava come il c onsenso iu go sla vo ad una formu la che po t esse salvare la faccia a Tito e d avesse il suo s u pporto fosse l'e lemento indisp ensab ile ad ogni so l uz ione. Non si sarebbe potutO ad esempio prendere in esame ne pp u r e l a res t i w z i one della zona angloamericana ali ' I tali a senza l' a ccordo iugo s lavo, anche se i soviet ici fossero stati d'accordo. A ri bad i re il ca rattere di indispensabilità del consenso iugoslavo , \\'a s h ington es cludeva che si potesse raggiun gere una soluzione, p u r ri tenuta d i comp r omesso, attrave rso un'iniziativa unm laterale in qu anto il co mp romesso non poteva non fondarsi su l consenso i ugosl avo. Sta b il it a in q ues to modo la condizione imprescindib il e, l'altro element o d i r ife r imento, la "nota tripartita", assumeva la d imensione d i u n i mpegno da non smentire essendo ancora valide le ragioni di or d in e t att ico che a vevano indotto ad elaborarlo; un impe gno però la cu i att u az ione e ra del tutto incompatibile con la prernessa enunci at a . Un eventu al e a desione sovietica alla dichiarazion e del 20 marZ0 1948 a v re b b e p osto in fa t ti il Dipartimento di Stato in ovv ie d iff ico lt à ne ll 'ev it a re un'iniz i ati va osti l e a T ito. In u lt ima anali si il co nsenso iu gos lav o r appr ese nt ava un elemento d i orientamento de ll a pol it ic a an1e r ic a n a ment r e la "nota [ripartita" era inv ece legitt imata a gi oc a re un r uol o di f reno, di res istenza al movimento ne ll a direzione c a p ace di p o rr e te r m in e alla vcrtenza. F urono questi i cardini dell a p o li t i c a a me ric ana ed ingl ese dalla metà del l 949 alla metà del 19 5 1.

L'impostazione data al problema dal Dipartimento di Stato sanzionava di fatto un atteggiamento di assoluta immobilità da parte am e ricana, sebbene la distinzione fra obiettivi tattici e strategici rappresentass e la base sulla quale, attraverso progressivi aggiustam e nti, la vertenza di Trieste sarebbe g iunta a conclusione.
Il quadro descritto rimane v a so -
stanzialmente immutato fino ai primi mesi del 1951. L'attenzione delle diplomazie occidentali verso i contatti itala -iugoslavi, che continuavano a ritmo intermittente f ra g li ambasciatori dei due Paesi, ribadiva soltanto come asserzioni di disponibilità al negoziato e possibilità di a vviarlo concretamente fossero termini fra Joro molto distanti.
Nel corso del 1951 , peraltro , pur respingendo sistematicame nte le pressioni iugoslave tendenti a smuovere Stati Uniti ed Inghilterra dalla posi zion e di assoluta estraneità al dialogo fra le parti direttam ente interessate, l e due diplomazi e occidentali cominciavano a dimostrare di vo lersi spostare dalla linea di condotta fino allora seguita .

Nel ma rzo 1951 De Gasperi e Sforza , nel corso di una visita a Londra , suggerirono che venisse ribadita la dichiarazione tripartita sia in sostegno aJl e forze governative impegnate nella campagna per le elezioni amministrative e si a come base per il negoziato fra Italia e Iu goslav ia. La proposta veniva però solo parzialmente acco.lta: la dichiarazione tripartita veniva sl riaffermata nel comunicato diramato alla fine dei colloqui , ma ad essa s i accompagnava l ' auspicio per una sistemazione "per via conciliativa". Sia p ur e in termini alquanto ambigui, cominciava ad essere ridotta la va lenza frenante oppost a dall a "nota tripartita " per l'avvio di una trattativa bilaterale , considerata
Owight O;wicl Eiscnhm \'C'r prcsidclJie degli Stati L'niti ( 1o m<mdmo) dal 1052 al 10:16.
come lo strumento indispensabile di ogni soluzione.
L'iniziativa volta ad individuare nuovi elementi di riferimento per la politica angloamericana su ll a questione di Trieste sarebbe partita da Londra, cd avrebbe trovato il primo fattore di propulsione nell'avvicendamento governativo britannico dopo la sconfitta laburista nelle elezioni del195l. A ciò si univa la determinazione del nuo\'O ministro degli esteri Anthony Eden di porre termine agli impegni militari inglesi nella Zona A dopo che gli stati maggiori alleati avevano dichiarato di non aver obiezioni in tal senso, sia in conseguenza del fatto che l'accordo di assistenza militare collegava Ja Iugoslavia al sistema difensivo dell'Europa occidentale e sia, più in generale, perché stava cominciando ad attenuarsi il timore di un attacco sovietico in Europa.
Due ipotesi ,·enivano sommariamente delineate c sottoposte, a pa rti re dalla fine del 1951: l'individuazione di una "soluzione ideale", da prescnrare ad Italia e Iu goslavia, sulla base della spartizione delle due zone del Territorio Libero con lievi aggiustamenti di frontiera su entramb i i versanti o, in via alternativa, il ritiro angloamericano dalla Zona A. Quest'ultimo progetto incontrava notevole resistenza al Dipartimento di Stato, al cui interno si riteneva che una soluzione dc facto non fosse consentita dal trattato di pace proponendo, in alternativa, di rinviare la questione aU'ONU.

Al di là di questa difformità di giudizio, le due ipotesi, sia pure in maniera diversa, avrebbero avviato Stati Uniti ed I nghiltcrra a passare da spettatori passivi ad attori di primo piano nella soluzione de ll a vcrtcnza . C'era ancora un'iniziativa da attivare prima di procedere risolutamente lun go la nuova direzione: far riaprire il dialogo fra Italia c Iugoslavia al fine di ottenere la verifica Jefiniriva dell'impossibilità di un accordo bilaterale, che era la condizione necessaria pe r produrre un cambiamento nella linea di condotta inglese ed americana. D 'alt ra parte, la ricerca di tale verifica riapriva il vecchio scenario anziché porre le premesse per il nuovo.
Ma il 28 agosto 1953 l'agenzia giornalistica ]ugoprcss diramava una nota c he riportava la convim::ione di non poche persona l ità belgradesi sull a necessità di riprendere seriamente in esame l'atteggiamento iugoslavo in merito al problema triestino. Tale dichiarazione veniva interpretata da Pella, da poco nominato capo del governo italiano, come prova della volontà iugoslava di procedere all'anness ione formale della Zona B, eventualità alla quale egli contrapponeva la ferma intenzione di far entrare le truppe italiane nella Zona A. La
nota iugoslava rappresentava senza dubbio un elemento di pression e nella direzione tendente a risolvere la vertenza in via definitiva mediant e la spartizione del le due zone, o quanto meno a preparare il terreno ad essa. Di fronte a tale iniziativa la risposta del governo italiano fu rivolta , per converso , a sollecitare la restituzione della Zona A all' I talia a titolo di soluzione provvtsona.

La nota iugoslava e la risposta italiana erano pertanto espressione di due orientamenti sui quali i rispettivi governi si erano att estati. Per quanto riguardava la risposta di Pella, essa non rappresentava un pretesto, una mossa preordinata per forzare la mano agli americani ovvero una concessione alle destre, sulle quali il nuovo governo italiano , minoritario , era obbligato a far conto. Lo stesso spostamento di unità militari in prossimità della frontiera orientale italiana in risposta al concentramento di forze al confine ed alJe manovre in programma nel settore di Lubiana, rispondeva verosimilmente ad un obiettivo di mobilitazione interna in analogia a quanto avveniva in Iugoslavia. Nella prima decade di settembre la contrapposizione si irrigidiva: Tito rivendicava l 'intero TLT fatta eccezione per la città di Trieste da sottoporre ad uno statuto internazionale , e dal canto suo Pella proponeva un plebiscito nell'intero TLT.
La percezione, da parte americana ed inglese che le due iniziative non erano capaci d'altro che di inasprire il confronto fra I ta li a e Iu goslavia; l'immagine di un vicolo cieco nel quale i due interlocutori si erano cacciati; la preoccupazione di una minaccia alla sicurezza delle truppe americane a Trieste proveniente da forze militari non adeguatamente controllate dal governo italiano sul mode ll o dannunziano del 1919; le incertezze sulla reazione del governo italiano; tut -
Giuseppe
Célj)O Ciel go\ crno itùliano d<.lll'agosto del 1D;)3 <l quello elci 193+.
() nowmbrc 1<r1: in Piazz<l dell'L ni 1cl' cl'lmlitl
ro questo insieme di valutazioni e preoccupazioni faceva considerate e aurita, per lo meno a breve termine, la prospettiva di un accordo fra Italia c Iugoslavia e forniva lo stimolo alla diplomazia americana ed inglese a riavviare il processo arrestato prima delle elezioni del giugno 1953.
L'8 ottobre 1953, infatti, una nota bipartita faceva conoscere ai due governi direttamente interessati l' in tenzione di ritirare le truppe
alJeate dalla Zona A e di trasferire tale territorio all'amministrazione italiana, il che equivaleva di fatto ad affermare che, per quanto concerneva Stati Uniti ed In ghilterra, la vcrrenza e ra da considerarsi conclusa. Comun que Stati Uniti ed In ghi lt erra non avrebbero richieSLO al governo italiano né a quello iugoslavo di aderire formalmente a tale interpretazione . Qualora essi avessero manifestato in seguito il propos ito di awiare una trattativa bilaterale al fine eli modificare i confini , i governi americano e britannico non sa reb bero intervenuti a favore delJ'uno o dell'altro. Contemporaneamente il governo di Belgrado veniva portato a conoscenza che né l 'eve ntuale annessione

della Zona B né quella successiva della Zona A avrebbero suscitato proteste da parte alleata.
Il problema di Trieste veniva così a collocarsi esclusivamente nel quadro delle re lazioni itala-iugoslave. La decisione del1'8 ottobre evitava di prendere posizione nel merito della controversia fra soluzione provvisoria e soluzione definitiva. Ed era proprio tale circostanza ad impedire un rapido disimpegno angloamericano. Da un lat o, infatti, il governo italiano era legittimato a considerare come soluzione eli carattere provvisor io il passaggio della Zona A alla propria amministrazione, ed a presentare la nota bipartita come un riconoscimento implicito alla richiesta di "equiparazione"; dall' altro, però, ciò provocava un atteggiamento di assoluta resistenza da parte iugoslava. A Belgrado ed a Zagabria venivano prese d ' assalto le sedi di enti americani ed inglesi, ed il lO ottobre Tito affermava che l ' ingresso delle truppe italiane nella Zona A sarebbe stato considerato come un atto di aggressione nei confronti della Iu goslavia.
In termini immediati, quindi, la dichiarazione del.l'8 ottobre dava luogo ad un inasprimento della tensione fra Italia e I ugoslavia, associato ad un altro spostamento di unità militari ne]Ja seconda metà del mese. Ma a ll'ini zio di febbraio del1954, a seguito della disponibilità da parte del governo italiano ad una trattativa disgiunta in vista di una soluzione definitiva ed in virtù di un analogo atteggiamento da parte iugoslava , fu avviata a Londra una serie di conversazioni segrete fra tre delegati rappresentanti rispettivamente gli Stati Uniti, l ' In ghi lt erra e la Iugoslavia che si sarebbero protratti fino alla fine di maggio.
Le trattative successive, durate da giugno ad agosto del 1954, sembrarono concentrarsi dapprima su questioni secondarie, ed a tale riguardo l'ambasci atore italiano a Londra Erosi o riuscì a far cadere il progetto sull'autonomia ed a escludere impegni internazionali per l'istituzione a Trieste del "porto franco", riservando tale materia alla competenza della legislazione italiana. Ma le trattative

stesse sembrarono avviarsi verso un punto morto per quanto riguardava l a sistemazione territoriale; solo in settembre, peraltro, grazie all'intervento diretto di Eisenhower, fu possibile sb loccar e la situazione, per cui la Iu gos lavia ricevette una parte del settore sud-occidenta le della Zona A di estensione inferiore rispetto a quella concordata alla fine di maggio.
Il memorandum d'intesa, sig lato a Londra il 5 ottobre 1954, prevedeva la cessazione dei governi militari delle Zone A c B del TLT ed il passaggio di queste rispettivamente all'amministrazione italiana e iugoslava una volta apportate le modifiche territoriali concordate. Al memorandum era annesso a ltr esì un dettagliato statuto per la tutela delle minoranze etniche. In virtù del documento, che in sostanza dava la sanzione formale ad una decisione maturata un anno prima, due interlocutori, Stati Uniti cd Inghilterra, uscivano completamente di scena, mentre si apriva un nuovo capitolo nelle relazion i fra It alia e Iu goslavia, che sarebbe stato caratterizzato da una pro lungata "gestione della prowisorictà" culminata solo con gli accordi di Osimo dellO novembre dell975.

La data del 5 ottobre l 954 segnò per Trieste la vera fine della guerra. Questa, per i triestini, era durata esattamente 9 anni, cinque mesi e dieci g iorni di più che per il resto dell'T talia. Durante questo lungo periodo di tempo la città aveva vissuto molte giornate drammatiche, di cui le più intense furono quelle del 5 c 6 novembre 195 3, durante le quali nelle vie c nelle piazze si ebbero 6 morti e 77 feriti. Solo alle ore 12 e 16 minuti, dunque, del 5 ottobre 1954, con la firma del memorandum d'intesa, si pose termine ad una situazione così assurda e così pericolosamente tesa.
La cerimonia londinese, anziché al Foreign 0//ice, si svolse al Carlton House Gardens, nell'appartamento privato di Anthony Eden, momentaneamente indisposto. Nel salone dci ricevimenti della villa del ministro degH esteri inglese erano allineati, sull'ampio ripiano di un tavolo, i documenti dell'accordo stilati in quattro copie, quattro grandi fogli azzurri legati da altr ettanti nastri dello stesso color e. TI testo dei documenti era in in g lese, lin gua ufficiale usata n el corso delle trattative. Un quinto documento era cost ituit o da una carta geografica del TLT, di un metro quadrato di superficie, contenente le modifiche apportate alla linea di demarcazione tra la Zona
A e la Zona B. Il primo ad app orre la propria sigla in calce al documento d'intesa fu, secondo l'ordine alfabetico, l'ambasciatore italiano. Lo seguirono gl i altri: il sottosegretario aggiunto al Foreign 0/fi-
ce Harrison per l'Inghilterra, l'Alto Commissario americano a Vienna Thompson per gli Stati Uniti ed infine l'ambasciatore iugoslavo Velebit. Nello stesso ordine vennero siglate le quattro copie dello "statuto speciale", il documento che doveva regolare gli interessi delle minoranze italiane nei territori ceduti alla Iugoslavia.
Le manovre politiche che avevano condotto agli eventi descritti sarebbero state rese di pubblico dominio solo alcuni anni dopo in un volume di memorie di Eisenhower, dal quale risultava che, qualora la soluzione del problema triestino fosse stata ancora procrastinata , tutta una serie di questioni riguardanti la politica interna italiana ed anche alcune ancora più importanti, di carattere internazionale, sarebbero state seriamente compromesse. All'epoca dei fatti Eisenhower era stato eletto solo da poco alla carica di presidente degli Stati Uniti. Egli si era reso subito conto che il mantenimento dello statu qua in quel punto cruciale dell'Europa non avrebbe sicuramente giovato né al progressivo allentamento della tensione internazionale né alla propria politica personale. Aveva perciò deciso che uno
TfÌ('Sll' .J no\'l:ml)t'l' 1933 : lcl polizia ci\ ·ile i i
t mmifcstiJnti rifugintisi nelle-t Ci1il'Stl eli s. .\ ntonio nuo, o.

dei primi atti del suo mandato quadriennale sarebbe dovuto consistere nella definitiva composizione del problema triestino e nel ristabilimento di rapporti quanto più armonici fra Italia e Iugoslavia. Che il problema fosse effertivamente spinoso, lo avrebbero dimostrato poco dopo i primi atti del governo PeiJa, succeduta a quello di De Gasp er i, che si oppose energicamente alla ratifica del trattato della C.E.D. fino a quanto gli alleati non gli avessero dato precise assicurazioni circa la salvaguardia dei diritti italiani su Trieste. Fu come appiccare il fuoco ad una miccia. Gli italiani furono all'improwiso profondamente scossi dal rapido succedersi degli avvenimenti, senza riuscir e a rendersi pienamente conto che da un momento all'altro avrebbero potuto essere nuovamente coinvolti in una guerra . Tito, infatti, aveva interpretato - od aveva fatto finta di interpretare -gli intendimenti di P ella nel senso che egli si proponesse di occupare Trieste, ossia annettendola di fatto, se non di diritto, all'Italia. E per dimostrare che, dal proprio canto, la Iugoslavia non avrebbe assistito passivamente ad un'azione del genere, aveva ordinato una parziale mobilitazione. A sua volta Pella, in vista di un conflitto armato, aveva in viato truppe alla frontiera nord-orientale e navi da guerra nell'Alto Adriatico, notificando agli alleati che, a meno di non ottenere il loro sostegno, l'Italia sarebbe stata costretta ad uscire dalla NATO.
Seguirono settimane particolarmenLe intense. C'era sempre nell'aria una minaccia che la sc intilla desse fuoco alle polveri da un momento all'altro, e nessuno poteva imma ginare le cons eguenze che ne sarebbero potute derivare. E quando 1'8 ottobre fu annunciato che le truppe alleate si sarebbero ritirate dalla Zona A per essere sostituite da quelle italiane, Tito, che in pre cedenza aveva dato il proprio consenso ufficioso a questa soluzione, murò improvvisamente atteggiamento e dichiarò, questa volta ufficialmente, che se l'Italia fosse entrata nella Zona A avrebbe consid e rato questo atteggiamento come un atto di aggressione nei confronti della Iugoslavia e si sarebbe riservato di inviare a propria volta le sue truppe.

Sarebbero passati alcuni mesi prima che si ristabilisse una certa caJma, e fu allora, agli inizi del 1954, che Stati Uniti ed Inghilterra compresero finalmente ch e, per giungere alla risoluzion e definitiva del problema, sarebbe stato necessario per prima cosa mettere a contatto diretto le due parti in causa e guidarle con diplomazia ed intelligenza verso l'auspicabile accordo.
Nel mese di maggio del l 954 si pervenne a concorda re la base
del 1V1 emorandum , siglato da Harrison, Thompson e Velebit , ministri degli esteri rispettivamente di Stati Uniti, Inghilt e rra e Iugosla via, mentre per quanto riguardava il rappr ese ntante dell ' Italia , la sua non partecipazione era dovuta al fatto che per quanto ri g uardava le rettifiche territoriali si era convenuto di accettare quelle previste dalla nota dell'8 ottobre 1953 .
La felice conclusion e della vertenza sare bbe stata determinata, secondo quanto scrisse in seguito Eden nelle sue memorie, da un carico di grano americano offerto alla I ugoslavia che ne aveva urgente bisogno . L'entità del carico non sarebbe mai stata precisata, ma con esso .la Iugoslavia acquisì. anc h e qualcosa di più sul piano territoriale : la verde e lussureggiante Punta di Lazzaretto, all ' estremo Sud della Zona A, in cambio de ll a quale all'Ita lia venne concesso un <eg uale porzione di terreno sterile e roccioso a Nord.
Il 5 ottobre, finalmente, si giunse al termine del lungo contenzioso durato 9 anni: I talia e Iugoslavia trovarono l'intesa , sulla questione di Trieste , per un accordo accettabile da entrambe le parti.
L(l TC'Slèlta ciel giorncllt> eli Triestr elci 4 onoJ)t"C' 1934 cllll lLIIlCiémlt' lcl firn1(l clcii 'Clccorclo di Lonclw pre\·isto per il giorno SlllTCSSiVO.



quel martedì mattina l'entusiasmo esp los e letteralmente nella città giuliana, che apparve tutta ricoperta dal tricolore. Non è possibile valutare anche per approssimazione il numero delle bandiere che comparvero alle finestre ed ai balconi: si tenga solo conto che negli ultimi tre giorni 50.000 vessilli erano stati distribuiti gratuitamente dalla Lega Nazionale, che migliaia di altri furono cuciti in fretta nelle case c che i negozi ne avevano esaurito tutte le scorte in poche ore.
Come è stato ben descritto in un volume che rievoca dettagliatamente la cronaca di quelle giornate3, lo spettacolo di decine di migliaia di persone che cominciavano ad aprire ad una ad una le finestre per esporvi il tricolore fu di una bellezza tutta singolare. L'alba di quella mattina del 5 ottobre era piovosa, ed il riverbero della vegetazione carsica non raggiungeva la città, ma nonostante ciò essa aveva l'apparenza di una tavolozza.
Pressappoco alla stessa ora a Roma, al Quirinale, intorno al Presidente della Repubblica Luigi Einaudi si erano riuniti i ministri ed i rapp r esentanti della Giunta Comunale di Trieste con a capo il prosindaco Visintin. Dopo aver firmato il messaggio destinato alle popolazioni del TLT che tornavano all'amministrazione italiana, alle ore 13, allorché giunse da Londra la conferma della stipu la dell' accordo, il Presidente della Repubblica, levandolo dal cofano verde che lo conteneva e dopo averlo baciato, consegnò nella mani del prosindaco di Trieste un grande tricolore.
A Trieste, la ratifica dell'accordo londinese determinò la sospensione del respiro di centinaia di migliaia di cittadin i nell'attimo in cui, alle 14, salirono sui pennoni di piazza dell'Unità due grandi bandiere. Una di esse era ancora quella che era stata innalzata nel 1918, mentre l 'a ltra era stata confezionata appositamente per questo rito. Conren1poraneamente il tricolore comparve, per la prima volta dopo il 1945, su tutti gli edifici pubbli.ci, sulla Torre Civica e sul
campanile di San Giusto. Il simbolo nazionale ritornò così a spiegarsi al vento dopo undici anni di ostracismo al quale lo avevano condannato tre specie di occupanti. n giorno successivo segnò l'inizio di una serie di manifestazioni delle quali sarebbe stato difficile prevedere la durata. Ogni atto della rappresentazione si prolungava per un'intera giornata. Ogni mattina ed ogni sera, alia medesima ora, l'alza e l'ammaina bandiera in piazza dell'Unità davano il segnale del principio e della fine dell'azione, proprio come l'alzarsi e l'abbassarsi del sipario a teatro. Solo a tarda notte la città si addormentava. La duplice, quotidiana cerimonia davanti al Palazzo del Governo aveva in sé una suggestione coreografica rappresentata dal corteo di decine di automobili e di motorette imbandierate, stipate di cittadini, che seguivano ogni mattina ed ogni sera il carro attrezzi dei vig ili del fuoco preposto alia c erimo nia.
La sera del5 ottobre, nel corso di una conferenza stampa tenuta dal consigliere politico italiano ministro Fracassi, venne illustrato il testo dei protocolli firmati a Londra. n ministro disse di non sapere quando sarebbero arrivate Je truppe italiane in città, precisando solo che il t ermine minimo era di 21 giorni e quello massimo di 30, e di non conoscere ancora esattamente il tracciato della nuova linea di confine. Ma nel frattempo la popolazione della "zona minacciata", come ven iva definito il territorio che in base all'accordo sareb be dovuto passare alla Iugoslavia , attendeva ansiosamente di conoscere l a propria sorte e stava sul piede di partenza.
Durante la predetta conferenza stampa erano anche stati diramati gli inviti per la riunione programmata per il pomeriggio di mercoledì 6 al castello di Duino , dove il comandante militare alleato della Zona A, in procinto di lasciare l ' incarico, avrebbe ricevuto il generale italiano De Renzi designato ad assumere il comando militare di Trieste. Nella riunione si sarebbero anche definiti i preliminari relativi al passaggio dei poteri.
Il generale De Renzi , insieme ad altri sette ufficiali , entrò nella Zona A alle 14.50. Era il primo militare italiano che metteva ufficialmente pied e oltre il posto di blocco di Duino; altri ufficia li italiani, prima di lui e dopo il 1945, erano venuti a Trieste in varie occasioni, ma sempre e soltanto in qualità di invitati e raramente in uniforme. Il cielo era grigio e minacciava pioggia. Un leggero vento investiva dall'altopiano quella terra irrigata dalle acque del Timavo . E sarebbero stati proprio i profughi istriani di San Giovanni del Timavo a dare il primo benvenuto al rappresentante dell'esercito ita -

liano. Un picchetto d'onore formato da un plotone della Polizia Civile presentò le armi, ma la scena non ebbe nient e di marziale. Ad impedirlo, fu la folla di triestini che erano venuti a salutare il generale per conto loro ed a modo loro. on appena fu possibile, si formò il corteo delle automobili diretto al vicino castello di Duino. ul piccolo piazzale antistante l'ingresso, la fanfara del 2 ° battaglione dei Lancaster Fucìliers eseguì gli inni na z ionali italiano, inglese cd americano. Il generale De Renzi , al cui fianco e ra il col. Gaspari, capo di stato maggiore del V Corpo d ' Armata c suo aiutante in prima, passò in rassegna il picchetto d'onore del 351 o reggimento di fanteria statunitense.
Oltrepassata la soglia del castello , il cerimoniale da militare si tramutò in quasi mondano. Ci fu la protocollare stretta di mano con il generale Winterton, immortalata dai numerosi fotografi, alla quale seguì il ricevimento offerto ai rappresentanti della stampa. Poi le delegazioni italiana, inglese ed americana si ritirarono in una stanza per

la discussione dell'accordo. Le porte vennero sbarrate, e all'esterno si piazzarono gli uomini della Militar;• Police.
Della delegazione italiana facevano parte, oltre al generale De Renzi cd al col. Gaspari, il ministro Fracassi, il prefetto Vitelli, direttore superiore dell'amministrazione del Governo Militare Alleato, il ren. col. d'artiglieria Palla. designato quale capo di sraro maggiore del governatore, il ren. col. del genio Montiglio, suo vicecapo, poi il ten. col. del genio Pirrone, il maggiore di fanteria Casertano, il maggiore degli alpini Vendramin ed il capitano di artiglieria Cagiari. La delegazione alleata era formata dal generale Winterton, dal generale Dabney, dal consigliere poi itico inglese Broad, dal consigliere politico americano Sims, dal col. Porter, capo di stato maggiore delle truppe americane, dal col. Maynell, capo di stato maggiore delle truppe alleate della Zona A, dal ten. col. Lough, capo di stato maggior e d e ll'amministrazion e del G.M.A., dal ten. col. Russel, capo della segreteria politica del Comandante di Zona, dal direttore dell'ufficio informazioni alleato Dunham e dall'interprete ren. col. Sasso n.

Alle 17.30 il generale Dc Rcnzi ed il suo seguito ripartirono per Udine, dopo essersi accordati con i rappresentanti alleati sui punti essenziali del piano per il trasferimento all'Italia dei poter i nella Zona A e per l'ingresso delle forze armare italiane.
Da quello stesso giorno. cd anche in quelli successivi, la maggior parte delle truppe alleate rimase consegnata nelle caserme, intenta agli ultimi preparativi prima della partenza. Gli inglesi, particolarmente, osservavano strettamente la consegna. Sembrava fossero spariti dalla circolazione c certamente non partecipavano alla gioia dei triestini. Questo atteggiamento costituiva, in buona parte, il fnnto del comportamento tenuto dal generale Winterton fin da quando, il 19 marzo 1951 , aveva assunto il comando delle forze alleate del TLT succedendo al generale Aircy. Allorché. tre giorni dopo, il nuovo comandante ebbe il primo contatto con la stampa locale e con i giornalisti esteri e gli inviati speciali accreditati presso il G.M.A , sembrò non essere del tutto ins e nsibile alle istanze degli italiani e fece una dichiarazione nella quale, ri[erendosi alle proprie esperienze durante la prima guerra mondiale. espresse sentimenti di simpatia nei confronti della popolazione italiana, il che determinò il risentimento dei rappresentanti della stampa slovena che abbandonarono la sala. Ciò avrebbe determinato in lui, nell'intento eli dimostrare la propria imparzialità, la necessità di dar luogo ad una politica del di-
vide: cl impera, che avrebbe in seguito pn.wocato gli incrcsciosi e talvolta drammatici incidenti dei quali s'è detto.
' E1le aueggiamento lo avrebbe portato più di una volta a prendere pnwvedimenti non adeguati alla realtà della situazione. Esattamente un anno dopo il suo arrivo a Trieste, dopo i sanguinosi episoJi del marzo 1952, anziché adoperarsi per calmare gli spiriti accesi,

inasprì la popolazione triestina inJirizzando al direttore di pubblica sicurezza un messaggio nel quale esprimeva il proprio elogio per il moJo risoluto ed esemplare con il quale aveva affrontato i disordini.
Ciò <l\'eva fatto si che, forti Ji questo avallo, durame i nuovi incidenti Jel novembre 1953 le forze dell'orJine si sentissero autorizzate, quand'anche non spronate, a reprimerli in maniera ancor più violenta e brutale. Da quel momento, il generale \XIintcrton fu a Trieste l'uomo più odiato dalla popolazione italiana.
E' alla luce di questi fatti che si possono capire, anche se non
giustificare, i motivi per i quali Winterton, alla scadenza del suo mandato. preferì sottrarsi all'obbligo di congedarsi ufficialmente dalle nuove autorità civili e militari di Trieste, dopo che le truppe italiane avevano farro il loro ingresso in città
Alle 11 di quella mattina, infatti. Winterton avrebbe dovuto cedere i poteri al genera le De Renzi. Il generale inglese affermò che non aveva potuto presentarsi all'appuntamento con De Renzi per co lpa del maltempo, ma la scusa era puerile. L'ipotesi più verosimile era che egli temesse di esporsi ad una dimostrazione di scherno da parte della popolazione, che infatti nei giorni precedenti aveva fatto incerta nei negozi della c ittà di tutti i fischietti disponibili, senza dissimulare l'uso a l quale intendeva destinarli. Winterton sarebbe partito insalutato ospite, accompagnato da un uragano di fischi.
Con gli americani, invece, i rapporti erano stati improntati a reciproca simpatia sin dall 'ar rivo delle loro truppe ncl1945, nonostante il primo comandante militare della città, colonnello Bo\\'man, non avesse fatto molto per favorirla mantenendo un contegno non proprio amichevole verso la popolazione italiana. A differenza degli ing lesi gli americani, allorché venivano comandati in serviz io di ordine pubblico, prendevano la cosa con spirito sportivo ed esprimevano con parole e fatti la loro solidarietà ai triestini; per cui quando i loro reparti arrivavano sul terreno degli scontri, anziché ven ir fatti segno all'ostilità della folla erano inv ece calorosamente applauditi.
Venerdì 8 ottobre 1954, davanti al generale D abney comandante delle forze statunitensi, si mosse il primo di una colonna di cento camion Dodge, carichi di materiali, con destinazione Livorn o, su ciascuno dei quali oltre all'autista c'erano 24 uomini. Alle 8 del mattino il primo contingente di 250 soldati del presidio militare di Trieste aveva definitivamente abbandonato il TLT, dopo essersi congedato tra manifestazioni di simpatia ed affetto. L'indomani e nei giorni successivi sarebbero seguite le partenze di un secondo e di un terzo scaglione accasermati tra San Giovanni, Roiano e Prosecco.
Sempre in quello stesso giorno di venerdì 8, arrivarono ad Albaro Vescovà, v illa ggio attiguo alla lin ea di demarcazione tra la Zona A e la Zona B, alcuni autocarri dell'esercito americano che scaricarono una trentina di sedie destinate ai membri della comm issione mista incaricata di fissare la nuova linea di confine e formata da ufficiali americani, inglesi e iugoslavi. T co lloqui vennero interrotti alle 17.30 e sarebbero ripresi il giorno successivo, sabato 9, con questa novità: che la commissione mista, da triplice, sarebbe diventata quadruplice.

Ai lavori, infatti, potevano assistere anche due osservatori italiani, parrecipazione alla quale i delegati iugoslavi avevano inizialmente cercato di opporsi nonostante fosse stata prevista anche nel testo dell' accon..lo siglato a Londra.
La cronaca registrò inoltre il telegramma di risposta del presidente Einaudi al sindaco Barroli, che si era fatto interprete già dallo stesso giorno 5 dei sentimenti della popolazione (riestina ricongiunta a ll 'T tali a.
L'ing. Gianni B artoli, nel1954, era ormai da cinque anni sindaco della c i ttà. Nato a Rovigno d'Istria ncll900, aveva legato la propria sorte a quella di T rieste durante g li ultim i anni di guerra. Aveva fatto parte sin dall'inizio, per un certo periodo anche in veste di presid ente, del C.L.N., nel cui ambito rappresentava pure la Democraz ia Cristiana della quale era divenuto in seguito segretario provinciale. Nel maggio del 1945, durante l'occupazione iugoslava di Trieste, e r <l riuscito a so ttrarsi alla cattura da parte dci "ti tini", e dopo la
Jl COilllllicliO dctllcl popold!iotl<' eli ili< lllli lllililclli dllleri< ni cllld SlélZiOlll' fl'ITO\ 'iclficl <li TtiC'-.11'

creazione del TLT si era gettato anima e corpo nel! 'agone politico fondando il Comitato di difesa dell'italianità di Trieste, del quale sarebbe divenuto anche presidente, c collaborando attivamente all'Opera per i profughi giuliano-dalmati della quale avrebbe ricoperto la carica di consigliere amministrativo. Era stato nominato sindaco nel 19-+9.

Gianni Bartoli. durante gli "anni difficili" di Trieste. fu senza alcun dubbio un personaggio tipico. Nessuno più di lui avrebbe forse meritato di assumere e rccit<lrc la parte di protagonista di quelle storiche giornate dell'ottobre 195-+. Più che amministratore della città, infatti , eg li era stato in quegli anni il suo oratore ufriciale, uno dei più fervidi nel proclamarne in ogni occasione l'ita lian ità. Con i poteri di sindaco ridotti ai minimi termini, poiché ben poco avrebbe potuto decidere senza il consenso del Governo Militare Alleato, Bartali dedicò gran parte del proprio tempo alle cerimonie ufficiali di ogni genere, il che gli consenriva ogni volta di pronunciare un discorso che si trasformava progressivamcnre in un comizio ricco di fervidi, appassionati richiami all'Jtalia. Per quanto cercasse di controllarsi, in ognuno di questi frangenti Bartoli finiva sempre per commuoversi fino alle lacrime. ammantando la sua esposizione di un'intensa carica emotiva. Era stato per questo che l'umorismo popolare gli aveva affibbiato un nomignolo che non era sinonimo di scherno quanto invece di affettuosa, riconoscente arguzia: "Gianni Lacrima".
Su Gianni Bartoli sono stati pronunciati i giudizi piLJ disparati, nessuno dci quali, probabilmente, può essere considerato esatto. Il loro punto debole consiste nel fatto che sono stati pronunciati nel momento più difficile e confuso della storia di Trieste , quando le contese politiche intestine si andavano inasprendo ogni giorno di più dando luogo ad equivoci, malintesi c conflittualità. Amministrare per quasi otto anni una città soggetta ad un go\'crno mil i tare straniero significava già di per sé dover subordinare ogni delibera all'approvazione dell'autorità tutoria.
Un'autorità che si dimostrava intransigente, burocratica fino all' esasperazione, dispotica e, come se non fosse sufficiente, composta da uomini appartenenti a due popoli diversi e come tali esprimenti non una ma due mentalità spesso in contrasto fra loro e quasi sempre inconciliabili con quella della popolazione triestina. Quest'ultima, per di più, era a sua volta suddiv isa in tante correnti ideologiche per quanti erano i movin1enti politici che la rappresentavano.
n descritto scenario era articoJato su due blocchi principali, dei
quali uno - più numeroso ma non per questo più omogeneo - filoitaliano, mentre l'altro , meno cospicuo ma più compatto e combattivo oltre misura, antitaliano, entrambi molto più impegnati nel combattersi fra loro che non per il benessere della comunità.
In questo contesto, e pur essendo f uor di dubbio popolare, il sindaco era costretto tuttavia a difendersi su vari fron6, poiché proprio la su a popolarità suscitava invidie e gelosie.
Il dolow <l<'gli dl)itdnti Lot li: t drstit Jclld in hd'->t • dl l'd< cure lo d J)i:lSSciJ'( ' ciii il Il
Fu sua anche la decisione, in quel5 ottobre 1954, di far suonar tutte le campane che facevano parte del complesso di San Giusto. Fino a pochi giorni prima, erano nell'assoluta impossibilità di far udire la propria voce, essendo state rimosse poiché bisognava rinforzare i basamenti del campanile che l'enorme peso dei bronzi, con il trascorrere degli anni, aveva scavato e corroso. Erano cinque in tutto, in riga, sistemate una vicino all'altra in ordine di grandezza. La più piccola era state relegata all'interno; in mezzo tre di più recente fabbricazione friulana. Ultimo , affacciato alla grande arcata a tutto sesto , rivolto verso il mare, e LCampa n on.

l gim d Ili triestini , cglidllo nc ll \lt t('...,<l dcil'drti\'1 1 delle truppl'
Lo storico bronzo era orma i più che centenario , in quanto era stato fuso per la seconJa volta nel 1829, ec.l aveva salutato con il suo baritonale eJ intenso suono le date storiche più significative Jella città. D a molto tempo, ormai, non aveva avuto più occasione di farlo. Dal 194 3 in poi, e fino a quell'ottobre 1954, Tri este non aveva più registrato g io rni felici, neanche un anno prima, 1'8 ottobre 1953 , allorché Jopo l'annw1eio Jella nota bipartita si era salu tato troppo frettolosamente in I talia il suo rirorno alla madrepatria. Aveva suonato, si, un mese dopo, ma erano stati rintocchi mesti, con i quali il Campanon aveva accompagnato al cimitero le vitti me di quelle quattro sanguinose gio rnate di novembre.
Ora invece, per quanti sforzi si fossero fatti per rimetterlo in efficienza, non fu possibile aJoperarlo. Ma la sua voce non avrebbe potuto tac ere il g iorno in cui i soldati italiani avrebbero fatto il loro ingresso in città. Perché qu esto fosse possibile, fu deciso di sos penJere 1 lavori c Ji rimandare le gettate in cemento sui basamenti a dopo l'evento.


l 26 ottobre le truppe italiane entrarono in città, mentre il giorno prima reparti dell'esercito iugoslavo avevano occupato la striscia di territorio dell'ex
Zona A che il Memorandum di Londra aveva assegnato alla Repubblica Popolare Federativa degli Slavi del Sud.
Nei giorni precedenti erano stati sistemati in tre punti del territorio che stava per ridiventare italiano i nuovi posti di blocco, uno al bivio di Plavia, uno a Cerci ed uno a Lazzaretto , tutti e tre coUegati telefonicamente con la caserma della Polizia Civile di Muggia. Contemporaneamente era stata sgomberata la casermetta del vecchio posto di blocco di Albaro Vescovà. Per tutta la settimana era anche continuato 1'esodo di coloro che avevano deciso di rifugiarsi al di qua del nuovo confine: alla sera di sabato 23 ottobre, il numero degli abitanti dei paesi ceduti alla Iu goslavia che avevano abbandonato le loro case per rifugiarsi in Italia ammontava a 2. 741.
Sfuggì alla generale osservazione un fatto che era invece significativo: mentre all'alba di lunedì 25 le truppe iugoslave si attestavano sulla nuova linea di demarcazione, un sergente dell ' 81 o Reggimento Fanteria del Raggruppamento Trieste e tre soldati avevano sostituito i militari inglesi alla base del Lazzaretto, anche se in cima al pennone sul piazzale dei Gibraltar Barracks sventolava tuttora la bandiera britannica. Infatti, non si trattava ancora di una presa di possesso ufficiale da parte delle truppe italiane, ma di un semplice accorgimento per consentire agli ultimi soldati alleati di unirsi ai reparti in partenza.
A Trieste, mano a mano che diminuiva il numero degli uomini in uniforme inglese ed americana, aumentava nei cittadini l 'a ttesa per l'arrivo delle nostre truppe. La data era ormai nota: martedì 26. Al complesso dei reparti destinati ad occupare l 'ex Zona A era stata attribuita la denominazione di Raggruppamento Trieste; <Ùmeno uno di essi avrebbe potuto affacciarsi al posto di blocco di Duino solo dopo un'ora dall'aver ricevuto l'ordine di movimento. Si trattava di
\ o l t<' cld 2h ortohrr 1!l.:> k i primi nucl<·i di trupp<' irdliclnc \ ' dlrdllO il posto di 1>1()( < o di Duino .
un battaglion e dell'8° Bersaglieri , sta nziato provvisoriam ente presso la caserma "Franco Martelli " di Pord e none ma pronto co munque a trasfer irsi e ntro domenica 24 nella vecch ia residenza di Gradisca d'Isonzo. Il regg im ento era inquadrato nella Divisione "Ande" , ed era comandato dal co lonn ello Ricciardi. Il battaghone prescelto per costituire l'avanguardia dell'intero Ra ggruppamento era il V, agli ord ini del tenente co lonnello Federico.
Gli altri re parti del Ra ggr uppamento cominciarono ad affluire a Cervignano giovedì 21. Prima ad clrrivare in treno da Porlì fu una compa gn ia d c ll'82 ° Fanter ia, c h e s i sistemò nella caserma "Monte Pasubi o". Poi fu la volta del li bartaglione e della compagn ia armi d'a ccompag nam ento, alloggiate nella caserma "Monte Vodice" a Villa Vicentina, seguiti dalla compagnia pionieri e trasmissioni contemporaneamente alla qu a le giunse anche la compagnia comando. Tra venerdì 22 e sabato 23 sarebbe conlluito il resto degli effettiv i, parre a Palm a n ova c parte a Villa Vi cent ina. IJ generale di brigata Mario

Gianani, comandante dei reparti di fanteria della Divisione Trieste ed al quale era stato affidato temporaneamente anche il comando dell'omonimo Raggruppamento, era giunto a Cervignano la sera del21.

Per quanto riguardava il concentramento delle unità navali, questo avvenne nel porto di Venezia, dove stavano già attendendo l'ordine di salpare l'incrociatore Duca degli Abruzzi, con a bordo ben 45 marinai triestini, ed i cacciatorpedinieri, Granatiere, Artigliere e Grecale. Preposto a!Je operazioni di sbarco era l'ammiraglio Candido Bigliardi. Per il compito di scortare dal cielo le quattro unità della marina fu prescelta una squadriglia di aviogetti della 511'· Aerobrigata, di stanza ad Istrana.
La notizia ufficiale che il trapasso dei poteri sarebbe avvenuto martedì 26 ottobre fu comunicata sabato mattina 23 dal generale De Renzi nel corso di una conferenza stampa convocata nella caserma "Savorgnan" di Udine.
Tr ic..,lc .
2(ì olloiJrc l lrl lollél si al molo . \uclan' per sél lumrc le t1ni1i1 dcll;1 léli'Ìllll i ldli,lllé.l gitllll<' poro prilllél dtl \ ·cnczicl.
Dopo l'annuncio, la giornata di domenica 2--l a Triest e trascorse tranquilla. Al lunedì il cielo er a compl etamente coperto, pioveva; la grigia alba autunnale sembrava destinata ad agir e da freno all'impazienza che era n e ll'aria. Pr oprio quel g iorno si sarebbe verificato tm episodio significativo, avvenuto a Monfalcone tra una giovane sposa triestina ed un ufficiale dello stato maggiore della 2" Di vi s ione Navale d es tinata a raggiungere il giorno dopo Triest e al comando dell'ammiraglio Big liardi.
L'ufficiale, reduce da un via gg i o a Trieste, dove si era recato p er accordarsi c irca le operazioni di ormegg io delle quattro unità, passando in automobile a Monfalcon e vide improvvisamente a breve distanza dalla propria macchina una g iova ne coppia. Erano due sposi, appena usciti dalla chiesa dove era stato celebrato il rito nuziale. Lei , una ragaz za di poco più di vent'anni, slanciata e dai capelli castani , vestiva un vaporoso abito di tull e ed era al braccio d e ll'uomo che l'a veva portata all 'a ltar e . Entrambi erano diretti alla stazione in procinto di partire per il tradi z ionale viagg io di n ozze
U sopraggiungere di una macchina con un ufficiale d e lla Marina a bordo av eva fatto tr asa lire la sposa, alla qual e quasi d ' istinto venne l'idea di al z are la mano perché l'a uro si fermasse. Come questo avvenne e dallo sportello si affac c iò l 'ufficiale la g iova n e donna, con un certo impaccio ma con altrettanta spontan e ità, dich iarandosi trie stina chiese di poter affidare all'ufficiale, p e rch é fosse consegnato ai marinai italiani, un segno di fede e d'amore insieme. E nel dire ciò, aiutata da co lui che le s tava a fianco, tagliò a metà il velo bianco e lo porse all ' ufficiale insieme ad un bel ma zz o di ga rofani bianchi. "Sono nata a Trieste- disse - e non potrò essere nella mia città il giorno in cui i nostri soldati rimetteranno piede nella mia terra. Che questo pezzo di velo e questi fiori accompagnino con affetto l'ingreS!ìo a Tri este dei nostri marinai". Non aggiunse altro , c d i due sposi si allontanarono qu asi di corsa. Il velo ed i fiori, consegna ti all'ammiraglio Bigliardi, av rebbero accolto a Tri este i marinai del "Duca degli Abruzzi".

Quel martedì mattina del 26 ottobre non vi fu risveglio nella città che non aveva dormito. Neanche la pioggia, con la qual e la fort e bora, invorri can dola , conrinuava a gioca re a modo suo dalla mezzanotte in poi con punte ra gg jungenti spesso i 70 chilometri orari, riusciva ad att enuare la tensione generale.
Venne ufficialmente ri cos tituita l a Questura, il c ui primo provvedimento fu quello di soppr imere, s ia nel centro cittadino sia in p e -
rifcria, l "distretti, della Polizia Civile e di ripristinare i vecchi commissariati. Alle 9, lungo l'intero arco del nuovo confine con l a Iugoslavia, a partire da un paio di chilometri in linea d'area a Nord di San Giovanni del Timavo fino all'abitato di Lazzaretto incastrato nella piccola insenatura tra Punta Sottile e Punta Grossa, si erano at-
testati i reparti dell'Esercito, le cui avanguardie avevano preso ad avanzare all ' alba procedendo sotto la pioggia.
Le autocolonne preposte ad occupare l'ex Zona A erano quattro. In base al piano operativo una di esse non attraversò la città ma sfilò per prima attraverso la "Tarvisiana, passando per Sistiana e Villa Opicina, proseguendo poi sulla nuova strada di circonvallazione che in cima al monte Spaccato irrompeva improvvisamente fuori dall'altopiano.
So tt o u n cl pi oggia il lCCSSù J1 tl' Tri es te snlu ta il suo Esr. rcil o

La prima autocolonna proseguì per Montebello, scese a valle, passò rasente alle alte mura del cimitero di Sant'Anna, tagliò a sinistra subito prima dello !:>tadio eli San Sabba, poi ancora una volta a clcstra imboccanclo infine il rettilineo alberato che porta a Zaule; a Muggia fu dato l'alt, e le pattuglie vennero immediatamente fatte
proseguire per Vi lla D ecani, Lazzaretro cd Albaro Vescovà.
L a seconda autocolonna sino a Villa Opicina compì il medesimo percorso, poi scese direttamente verso la imboccanclo la grande camionabile che alla curva di faccanoni divcmava via Fabio Severo. L'obiettivo era la caserma eli via Rossetti per raggiungere la quale seguì l'itinerario di via clel Coroneo, piazza Oberdan, via Carclucci, viale D'Annunzio, viale dell'Ippodronw, via Rossetti. Anche la terza colonna si diresse verso la stessa caserma, ma vi arrivò percorrendo la litoranea, viale Nliramare, piazza clelia Stazione, via Ghega, piazza Oberclan, via Giustiniano, via Rismondo e via Rossetti. Queste due u ltime autocolonne ricevcnero lungo l'intero percorso un'accoglienza emusiasmante. Attraversarono il centro cl ella città fra le sette e le sette c trenta. Imboccavano una strada, e subito sopra eli esse le imposte si aprivano una dopo l'altra, produccnclo un effetto acustico clel tutto parricolare: al rumore uniforme prodotto clai motori a basso regime si sovrapponeva quello causato dalle persiane sbattute frctto losameme contro i muri de ll e case.
Piove\·a ancora intensamente, ma piovevano fitti anche i fiori.

La quarta autocolonna, infine, era quella che, guidata dal generale De Renzi, avrebbe don1to partecipare alle cerimonie predisposte in piazza dell'Unità per il trapasso dei poteri. L'itinerario previsto era il seguente: Duino , liroranea, viale 1\rliramare, piazza della Stazione, corso Cavour c piazza dell'Unirà. Quando verso le 1 l vi fosse arrivata, il reparto inglese prescelto per partecipare alla cerimonia sarebbe sceso da una nave e si sarebbe schierato su un lato della riva. fl reparto, costituito da 150 uomini tra ufficiali c soldati, era stato formato con i migliori elementi dd l o Battaglione del Loyal Regimeni c dcJ 2° Battaglione dci La11casbire Fusiliers, nonché dalla banda c dai tambur i del l o Battaglione del Loyal. Lo comandava il ten. col. F. H. Bowcn, comandante del battaglione dei Fusi!iers.
L'incontro tra il generale De Renzi ed i generali alleati Winterton e Dabney sarebbe dovuto avvenire all'I lo rei Excelsior intorno alle 11.15, ora nella quale anche i bersaglieri sarebbero stati schierati sulla riva 3 novembre. Nel preparare però qucsra parte del program-
aiue.
loo "'1U..
olmboll dd!Tnlf.a 4>Ua l'a. trla t<l!ll tMtlmdl.t<-ipllaa. ..-Janieed• u
di<! l'l!.llla Ila cwa-
...-..- ..
-cii -a. aaodlo<ldla'\.,....._,... Ilo
• ""''• • \ "111«141 v -· &1111 l lioll'IOC· ,.,._, P"dM. ""- ...,oaù -lo w ICZI""' ab!Mndoat • 111>'.....,u. TtdJJ DGl M........_ ""'"'"' loo o!nmmall<.bo d•U• _,... ••l!IAoo. era. .t4o 41 - ..u-J ""'
Ai_fratelli giuliani

w.r... li a.loiiB
--eli ,.,.. .,._..s, .u - Il "' Wlstnn. lftJIIe di - waWic.o..-e Ili _.,.. , dw loa _,.. mlo al» a,.-.nllll.. 1'- • c.&- ....,,...S.. - .---'... ,....... ..._ rnosur...-e t
........ .n...nau -f*ÌII Mll.t - aJOe aa,l.
•lnop (,n,...,. -n. cill.t IO '-"" dJ - c:ala&a n. ca dJ ...,.11a ...ttrna lNJ.
KIIIMtta. ,_ a. • ..u. da. l'b.. S" GMtr. (t•-ra.tUW t1 rt'l.f)l)
• wn 1\2& nu1. dfflW' a .,..o """"'"'lrr• rolpl Ili ,.,.. nll .., TMk. UIWI.a naiJn• u<a tcHo ri<oblcno IJQI""''OO lftJbii<O <fie ., lm'""'f'" "" lf' ar• .,, ,,..,_ 41 '""!&,pt.a <bi u , .. ...,g.. allll y..,.. "'".."' ""'• r
•n. rl<·wt.a. , "· "-· n. lrlllu14 dJ ..,...,. ,..,. •• pon..sc .._ -·--.-....
...... nflt's Sna&b UIJe....,.,.,., lui- alla pb. al c.:u... ,._ .-.- -
I'ISJ&à eli -
___
141 JOdk ,_ - sc..ta.
l'f:l"àt cllcbmoo "' rnldll cfalw.f: ........,..._ b lftl;.l
-t.o.
u oli·
pOI!. c:aedalo OINI 1.& Mlft>
u. ..- -·...., rln i- "'"''Jd c:<J" la c:Willà lt&SU.oa
u.Q • 4J P. o&cda. s.,u.. f lroklll dle .- _,. "" .....
t.U., ..,.. !An •1<1•• eaon, &a l&eQa la .,,.... drllt P"' ,.,......, '\rJ. 1.o\'Un , li o.al••• -
•• .....,,.,. """"'"'"'" ..,.,.. crr>< CW'J • di Trte.s.o
• ...tul,d'lmd'l'-' l Tri<Cie of Joa .-a. Tna.. _Jap. I"Mda ....a. - lllotnl oka. - -.arme. ...s-sc. IJ ,.,..u a.ltria ••ùmaatof1 ""C'CI ,...,. ... -,....... ""' ... .._,..di- lllllv ......,.,, '!....,..., <kl• do ad .s 141 d 0W-.Mr1 dJd...Ulfa t• .Ila k - D4ld ....., .m>tl. "u le ,.,,.,., At- II'Jiao Ilio!
107


ma non si era tenuto conto della carica di entusiasmo con la quale la folla avrebbe accolto le nostre truppe. L'autocolonna dei bersaglieri, infaui, arrivò a Barcola più o meno all'ora prevista ma fu a questo punto che cominciarono i problemi.
1\:on appena i primi auromezzi tentarono eli inserirsi a passo d'uomo in mezzo alla folla, questa li chiuse da ogni lato c li costrinse a fermarsi . Nessuno ed in nessun modo poté impedire quello che accadde. Non solo i bersaglieri non si opposero all'abbordaggio, ma in molti casi addiriuura aiutarono i cittadini ad issarsi sugli automezzi.
I n questo "assalto" gareggiarono con pari ardore giovani c non più giovani, e fra essi le ragane non facevano certo parte della minoranza. Quelle che restavano a terra si aggrappavano con le dita ai bordi dci mezzi o stringevano forte le mani ed i polsi dci bersaglieri. Avevano il capo coperto da cappucci, sciarpe, fouJards per proteggcrsi contro la pioggia, ma la maggior parte di essi furono barattati con i cappelli piumati od anche con una sola piuma strappata dai piumctti, dal momenro che i cappelli dei bersaglieri non erano sufficienti per accontentarle rutte.

Quando poi la colonna, ormai irrimediabilmcnte in ritardo, giunse all'altezza della stazione ferroviaria, anche le piume erano finite; restavano però le stellerre. Fu così che i bersaglieri, privati anche di quest'ultimo distintivo espressione della loro militarità, anziché qualche minuto prima delle li pervennero alla riva del molo Au dace quasi a mezzogiorno; qui , secondo iJ programma, avr e bbero dovuto scendere dagli automezzi, assumere la formazione prescritta e percorrere a passo di corsa, con la fanfara in testa, il tratto della riva fino all'Hotel Excelsior. Ma non solo non poterono scendere dai camion, pressati come erano dalla moltitudine, ma sarebbe stato anche inutile farlo perché ormai era troppo tardi. Nessuno infatti avrebbe potuto immaginare che la vettura del genera le e la colonna che la seguiva avrebbero impiegato più tempo a percorrere i tre chilometri da Barcola a piazza dell'Unità che non i vcnriquattro della litoranea da Duino a Barcola.
·L'unica cerimonia che avrebbe avuto un regolare svolgimento fu quella dell'alzabandiera in piazza dell'Unità, a mezzogiorno in punto. Ciò fu possibile perché i vigili del fuoco, preposti all ' incarico, erano schierati sul posto già da un paio d'ore. Quando le due grandi bandiere salirono sui pennoni, le campane di tutte l e chiese della città suonarono a distesa, sovrastate comunque dalla profonda, baritonal e , inconfondibile voce del Ca m panon. Alloro suono fecero eco
i fischi prolungati delle sirene delle fabbriche e delle imbarcazioni ancorate nel porto. Vi erano anche le quattro unirà della Marina arrivate da Venezia.
Il genera le De Renzi presenziò alla cer imonia dell'alzabandiera dal balcone del Palazzo della Pr efettura. La sua automobile, sfuggendo alla folla, era riuscita a pervenire in piazza dell'Unità poco dopo le 11, precedendo di quasi un'ora la co lonna dci bersaglieri. D e Renzi scese a stento dalla macchina. Erano con lui il prefetto Vitelli e il ministro Fracassi.
Avrebbero dovuto compiere più o meno una ventina di passi per raggiungere l 'ing resso del Palazzo , ma era veramente un problema. L e transenne messe in opera per mantenere sgombro uno stretto passaggio davanti aUa Prefettura erano state spauate v ia dalla ressa, nonostante i tentativi delle forze dell'ordine per opporsi all'impeto della folla.
A questa, del resto, non importava nulla delle manifestazioni ufficiali, non aveva voglia di ascoltare i discorsi o di assistere a parate, ma desiderava vedere da vicino i suoi soldati, coccolarli e cantare con loro. Per le cerimonie e per i discorsi ci sarebbe stato sempre tempo e De Renzi, generale o meno che fosse, era anche lui uno di quei soldati, il primo fra loro. Mancò poco che non lo rapissero.

A forza di gomiti, stringendo mani c cercando di resistere alle pacchc sulle spalle, riuscì tuttavia a raggiungere il palazzo c ad unirsi a ll e auto rit à c he lo stava no aspettando. Il sindaco Banoli lo affiancò su l balcone, c da quel consumato "comunicatore" che era, indicò dapprima co n la mano il generale D e R enzi che gli era a fianco, e subito dopo puntò l'indice su di sé, mostrando la fascia tricolore rappresentante l ' ins egna di sindaco italiano che ind ossava per la prima volta. La folla, nella piazza, andò in delirio.
D opo i discorsi del genera le e del s inda co, l'entusiasmo delle moltitudine cambiò obiettivo c si rivolse ai marinai delle unità navali. Una colonna di manifestanti, sempre cantando, defluì verso il molo della Stazione Marittima ed improvvisò una cordial e manifestazione, l'ultima, all'indirizzo delle truppe americane imbarcate su lla nave Genera! Haan in procinto di sciogliere gli ormeggi.
D opo mezzogiorno la pioggia ed anche la bora diminuirono d'intensità. In quel momento il genera le Winterton era in navigazione verso Malta, il generale Dabne y viaggiava in automobile verso Udine ed il Duca degli Abruzzi stava manovrando in rada per andare ad armegg i arsi al molo, mentre la bandiera donala alla c ittà da Ei-
naudi garriva sulla torre della Cattedrale c si levavano i vagiti di quella bambina che, nata nelle prime ore della mattinata , sarebbe stata battezzata con i nomi di Gabriella I talia.
La piaz za dell 'U nità, intanto, si andava lentamente svuotando. Centinaia di persone, però, continuavano ad attardarsi sulle rive e sui moli; per tutto il resto della giornata e per buona parte della notte avrebbero continuato a salire sui tre cacciatorpedinieri, fraternizzando con i marinai.

Per dare un'idea della foga con la quale vennero compiute le '' incursioni " a bordo delle tre navi da guerra, era sufficient e ]'e lenco degli oggetti abbandonati o perduti dai tri es tini in quella giornata di marted) solo sul Grecale: 6 paia di guanti, 14 ombrelli , 8 fra borse e cartelle, una cintura di cuoio, un ferro da st iro , una sporta piena di verdura e dì cibo. Più tardi, si venne a sapere che a circa 200 cappelli da bersagli e re erano stati completamente strappati i pium ett i e che decine di loro erano ino ltre rientrati in caserma senza il caratteristico copricapo. Queste, in sintesi, furono le "perdite" dichiaral e dall'Eserc ire durant e la pacifica occupazione di Trieste nell 'ottobre di 48 anni fa.
Frattanto altre centinaia di persone , oltre che in piazza dell'Unità, erano ancora radunate in piazza Goldoni, in piazza Perugino , in piazza Garibaldi ed in piazza Venezia dov e alcune band e eseguivano ininterrouamente inni nazionali e patriottici. DappertuttO si canrava. Anche i soldati che e rano rimasti nelle caserme ricevevano la loro parte di festeggiamenti: chiunqu e si trovasse a passarvi davanti, non mancava di fare una sosta, unendosi ai gruppi che già facevano circolo intorno aUc sentinelle o ressa davanti agli ingressi. Questi assembramenti durarono p er tutto il pom er igg io. La ge nte non si se ntiva di restare a casa, anche perché Je celebrazioni ufficiali non e rano ancora finite. Già per l e 16.30 era infatti prevista una nuova manifestazione: un corteo cominciò a formarsi in Foro Ulpiano, davanti al Palazzo di Giusti z ia , e con bandi e re in testa mosse per via Carducci diretto , attrav e rso piazza Goldoni ed i] Corso, nuovamente sulla piazza del Municipio sfavillante di luce , do ve un'ora più tardi sarebbe toccato anche al sindaco Ba rtoli di pronunciare il proprio discorso ufficiale. Pure le piazze adiacenti, come piazza della Borsa e piazza Verdi , nonché il tratto d e lla riva 3 novembre tra il palazzo d e lla Prefettura e quello del Lloyd Triestino, erano g remi te fino all ' inv e rosimile.
Venerdì 29 lasciarono Trieste il Grecale cd il Granatiere, diretti
a Malta p er partecipare a un'esercitazione NATO. li generale De Renzi, esaurito il proprio mandato , consegnò aJ prefetto i poteri civili ed al generale Gianani quelli militari e ripartì.
Il 31 ottobre fu la prima domenica di Trieste restituita all'Italia.
Verso sera giunse da Reggio Emilia un ' autoco lonna che consegnò al
un repmlo italiano sc l1icrato sul pi azza le Lli Sém Giusto.
sindaco Bartoli un prezioso cimelio: il primo tricolore fatto sventolare dai Costituenti della Repubblica Cisalpina il 7 gennaio 1797, quello al quale Giosuè Carducci aveva dedicato uno dei suoi più celebri inni. Arrivarono anche 47 corazzieri al comando del magg. Bruno

Tassoni, destinati a formare iJ 4 novembre la guardia d'onore per il Presidente della Repubblica .
Il primo giorno di novembre, lunedì, arrivarono anche gli alpini dell'So Reggimento ed i carristi del 5 ° Reggimento Lancieri di Novara. Ne l tardo pomeriggio del 3 novembre si commemorò il trenta-
seiesimo anniversario dello sbarco dei bersaglieri dall'Audace, una cerimonia alla quale intervennero rappresenranze di tutte le armi e specialità dell'esercito e molti cittadini. Più tardi, si festeggiò l'arrivo della nave scuola Amerigo con a bordo gU allievi dell'Accademia Navale di Livorno, e dell'incrociatore Montecuccoli, proveniente da Alessandria d'Egitto con i reduci di El Alamein. I canti e le acclamazioni della folla si alternavano ai colpi scanditi dagli arnesi usati dagli operai del Comune che stavano ultimando l'allestimento delle tribune dalle quali, l'indomani, il Presidente Einaudi avrebbe assistito alla grande parata.
I n serata arrivarono i gonfaloni del la capita le c di tutte le città decorate di medaglia d'oro, scortati dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito gen. Liuzzi che poi, con i generale De Renzi e Gianani, li avrebbe guidati sino a piazza dell'Unità dove ad attenderli era iJ sindaco Barroli. Complessivamente, nella sola giornata di mercoledì 3 novembre arrivarono a Trieste, con mezzi di vario genere, oltre 50.000 persone , tra le quali più di L.000 ex combattenti giunti espressamente dalla Sardegna. Nelle vie di Trieste, prima di allora, non si erano mai viste circolare tante automobili con targhe diverse; vi fu della gente che, non avendo trovato posw negli alberghi né altrove, trascorse l'ultima parte della notte rannicchiata sui sedili delle automobili.

I l giorno successivo, 4 novembre, anche il tempo fu dalla parte di Trieste: sole e cielo azzurro, nella tersa tranquillità dell'aria e del mare. Tra il molo Audace e la Stazione Marittima erano allineate le unità della Marina : il Duca degli il l'Artigliere, il Libra ed il Cassiopea, mentre al centro dello schieramento si profilava l'elegante sagoma dell'Amerzgo Vespucci. La folla si estendeva da piazza della Libertà fino al Campo M.arzio, per un tratto di oltre 6 chilometri. Alle 8.55 le artiglierie prodiere degli incrociatori spararono i prescritti 21 colpi di salve in onore del Presidente della Repubblica, che in quel momento stava scendendo dal treno alla Stazione Centrale accolto dal sindaco Bartoli, già suo allievo negli a n ni Vent i al Politecnico di Torino.
Mezz'ora dopo erano tutti in piazza dell'Unirà. Mentre i ministri e le autorità prendevano posto nelle tribune il Presidente Einaudi passò in rivista i reparti . Alle 9.50 il rosso gonfalone della città venne decorato di medaglia d'oro al valor militare, ed alle 9.52 i carabinierj motociclisti aprirono la sfilata, seguiti dalla "campagnola" del gen . Dc Renzi. Sfilarono 22 bandiere c stendardi, 6.200 uomini, 50 carr i
armati, 30 autoblindo, menrre in cielo sfrecciavano 24 aviogetti F84. Ma il momento culminante della parma s i sarebbe m' uto, naturalmente, allorché comparvero a passo di corsa i bersaglieri. sotto un
uragano di appJausi. Quando 1\ùtimo uomo Jell'ultimo reparto transitò <.lava n ti alla tribuna presidenziale, si vide Einaudi scuotere il capo sorridendo cd il Presidente del Consiglio Scelba manifestare anch'eg li un sorridente compiacimento, così come g li altri ospiti del palco

-+ IlO\ ('llli)rl' 19.3-+ : il C.1po dello Stato Luigi Ein<lufli clecor<l il gonfalone clell<l citt;l co n lcl mcdagliél croro eli \ '.111.
riservato alle autorità. Un uomo isolato ed in borghese, ve terano d e lla prima guerra mondiale, con il cappe llo da bersagliere fieramente piantato in testa, era sbucato improvvisamente da sotto la barriera di tra nscn ne che delimitavano il percorso, ed eludendo la sorveglianza si era messo a passo eli corsa nella scia dei bersaglieri e cercava con sforzo di tenerne il passo
Il programma della cerimonia non prevedeva discorsi del Capo dello Stato , a parte il proclama indiriz zato alle Forze Armat e nell'anniversario della Vittoria. Ma E inaudi avrebbe parlato anche lui , nel pomeriggio , dopo il conferimento della laur ea ad honorem in ec onomia e commercio nell 'Aula Magna dell ' univ e rsità. Dopo il lun go protocollo che precedette il confe rimento del diploma, il Presidente non poté esimersi dal ringraziare. E fu il suo primo ed unico discorso pronunciato qu e l g iorno: 357 parole in tutto , che componevano un breve e magistrale sagg io di elevato pensiero , int eso a proclamare l 'a utore come immeritev ole della distinzione che gli veniva resa ed es altante in vece gli uomini e l'istituto che gliela aveva voluta conferire, dci quali c del qual e mostrò di conosce re il valore e la sto ria.
La giornata eli Lui gi Einaudi si conclus e con la partecipazione al solenne Te Deum celebrato dal vescovo mon s . antin alle 18.30 nella Cattedrale. Il Presidente e la moglie, donna Ida, non riuscirono a trattenere le lacrime. Questo particolare, piCt che gli squilli d i tromba, il battere di tacchi e le streue di mano che all e 20 ne salutarono alla stazione la parte nza per Roma, rappresentarono il ve ro congedo dalla c inà, da Tri este ancora e finalmente italiana.


opo i Battaglioni Bersaglieri X e XXXIX, che nel 1918 avevano inaugurato la presenza militare italiana a Trieste, e superata la crisi connessa all'impresa dannunziana di Fiume tra il1919 e il 1920 , nel secondo semestre di quell'anno prese sede in città il Comando del V Corpo d'Armata che vi sarebbe rimasto sino agli eventi armistizial i del settembre 194 3 .
Per quanto riguarda la dimora del predetto Comando , essa fu sempre Villa Napoleone, generalmente meglio conosciuta con il nome di Villa Necker, una delle poche se non l'unica costruzione del tardo Settecento triestino che avesse validamente resistito alle insidie legate al trascorrere del tempo.
Dal 1854 al 1918 la villa era stata sede di comandi della Marina austro -ungarica, con funzioni prevalentemente logistiche , fatta eccezione per il periodo relativo alla prima guerra mondiale durante la quale assunse una configurazione operativa. Tra la fine del conflitto e l'agosto 1919, Ja villa ospitò comandi minori ed uffici vari dipendenti dal Governatorato della Venezia Giulia e dal Comando della 3 A Armata.
Dopo 1'8 settembre 1943, Villa Necker fu occupata dal Comando militare tedesco del presidio, dal quale dipendevano enti militari diversi, terrestri e marittimi, officine riparazioni, alloggi per il personale militare, ecc Il Comando della Difesa Territoriale italiano retto dal gen. Giovanni Esposito, trasformato inizialmente in "Ufficio Coordinamento per l'Ordine Pubblico" e, successivamente, in "Comando Militare Regionale italiano", eb be invece sede nel palazzo opposto a Vzlla Necker, in v ia dell'Università.
Fra il l o maggio ed il 13 gi ugno 1945 la struttura fu occupata da reparti vari di truppe e partigiani iugoslavi, che contribuirono in modo sostanziale a deteriorare quanto era rimasto ancora intatto dell'edificio e dell'annesso parco.
Dopo il ritiro delle truppe d e l maresciallo Tito e fin o a l ritorno d i quelle italiane , Villa Necker non fu sede di alcun comando, ma venne utilizzata come alloggiamento eli enti angloamericani. Alla fine di ottobre d e l 1954 vi era installatO un battaglione in glese REME (Royal Electrical M echanical Engineers), i cui uomini avrebb e ro completato, con la caratt e risti ca noncuranza e disinvoltura di tutte le truppe di occupazione , l'o pera di deterioram e nto in pr ece d e nza già ben avviat a.
Dal 1920, alle dipend enze del V Corpo d'Armata si sa rebbe ro alternati n elle rispe tti ve zone di com p e t enza, le seguenti Brigate:
1920 - 1921: Brigata "Ferrara";
1920 - 1926 : Brigat a "Sassart', trasformatasi dal 1926 al 1934 in XII Brigata di F anteria, dal 1935 al 1939 in Brigata di Fanteria "]ì'mavo" ed in fi n e dall 939 a119-13 in Divi sione "Sassari";
1923 - 1926: Brigata "Casale 11 •
Alcuni dci r epa rti di pende nti , anch 'ess i di guarnigione nello stesso territorio, furo no i seguenti :
1920- 1940: 151 o e 152 ° Rgt. Fanteria "Sassari";
1920- 1926: 12 ° R gt Fanteria "Casale";
1931 - 1939:23° Rgt. Artig lieria Campale;
1940- 1943: 34 o R gt. Artiglieria Campal e;
192 6-1930:5° G r. Artiglie ri a e/a;
1922- 1943:5° Rgpt. Gen io C.A. , poi 5 ° Rgt. Genio ;
193 0- 1943: 10 ° R gpt. Artiglieria GaF;

1920-1 943:5° Centro Automobilistico, poi 5 ° Rg r. Autieri .
n 15 ottobre 1954 , un a decina di g iorni p rim a del ritorno d e lla c ittà g iulian a all' Italia , venne costituito a Bolog na il R aggruppamento Trieste, compostO da Com ando, 82° Rgt. Fanteria " Torino", l Gruppo del 21 o R g t. Artiglieria Campale, Compagnia Genio Pi onieri, Compagnia Trasmissioni c R ep arti di Supporto. Sarebbe stato sciolto il 15 settembre 1955 e le unità dipendenti destinate in g r a n parte a lla Division e di Fanteria "Folgore'' .
A Tri este si formò il Comando Militar e di Zona ( 24 °), il quale avrebbe dato vita, iJ l o settembre 1962, al Comando Militare di Trieste D ivenuto dal l o dicembre 1968 Comando Truppe Tri este, l'e nte venne posto alle dipendenz e del 5° Corpo d 'A rmata ed esercitò fw1zioni di comando nei settori disciplinare, addestrat ivo ed ope rati vo per quanto ri gua rd ava le unità stanz iate n e l t e rritorio di competenza Con la ristrutturazione dell'ottobre 1975 assunse alle dip e ndenze
il 151 o Battaglione di Fanteria Motorizzato "Selle Comuni'', divenuto ncll992 151 ° Rgt. Fanteria ('Sassari", il14 ° Gruppo Artiglieria da Campagna "J'vfurge" e due battaglioni di fant e ria motorizzati in posiz ion e " quadro ".
Riprese la denominazione di Comando Militare di Tri este il l 0 nov e mbre 1986, e nella circostanza venne inquadrato nel Comando Regione Militare Nord-Est. Dal l o giugno 1989 assunse le funzioni di Comando Zona per la Regione Friuli - Venezia Giulia. Nell'ambito del riordinamento dell'Esercito , d a l 1992 e bb e alle dipendenze
il ricostituito l o Rgt. Fanteria Addestramento Recl ut e ''San Giusto" ed alcuni enti territoriali Da rilevare come, contemporaneamente ai reparti m e nzionati, ebbero sede in zona anche il Rgt. "Piemonte Cavalleria (2°)" dall956 e 1'8 ° Rgt. Artiglieria "Pasubio" dal1975 al 1995.
Il Comando Zona fu soppresso in data l o luglio 1986, ed il personale confluì nel Comando Militare R egionale Friuli- Venezia Giulia cost ituito nella stessa sede il giorno successivo. Il prederro Comando è stato sciolto il l o gennaio 2002 e riconfigurato come Comando R eclutamen to e Forze di Completamento R egionale "FriuliVenezia Giulia".
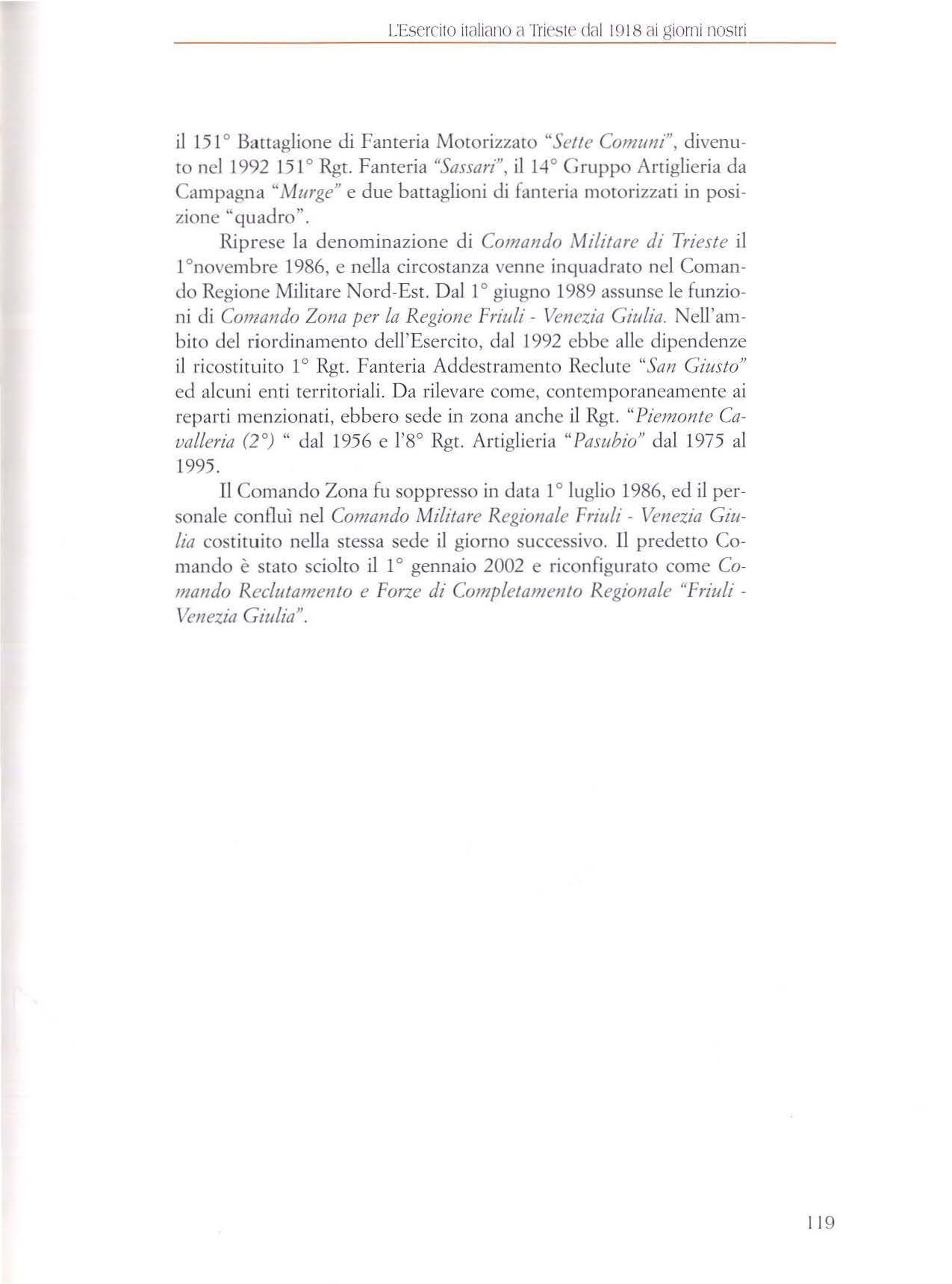

Tri<'<,IC. -+ nm ·emhrr 1D.)..J..: clopo JC> <mni. i bcrsdglicri ritorncmo a passo eli corlì<.1.


Presentazione
Introduzione
Parte prima: 1918
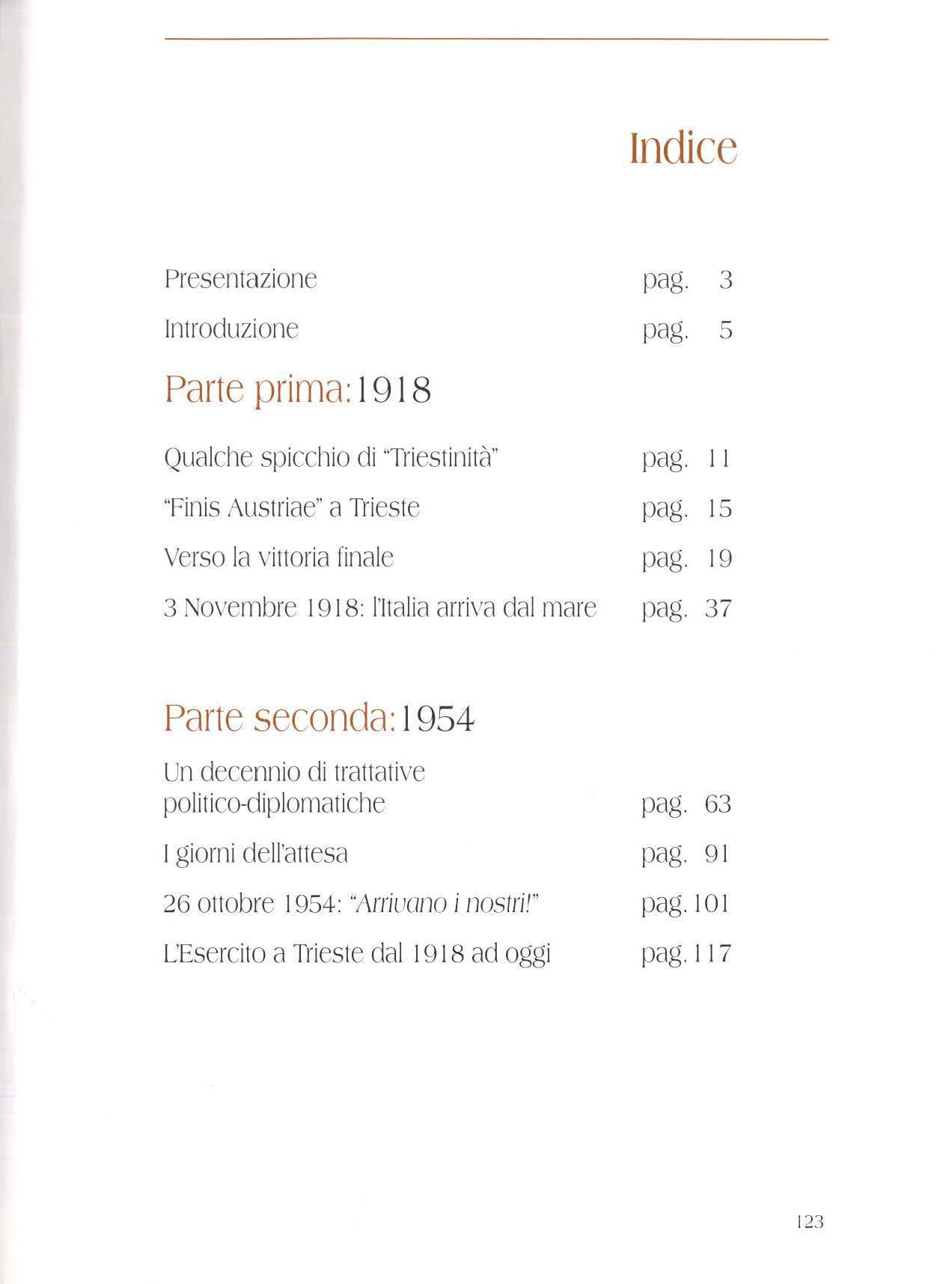
Qualche spicchio di "Triestinità "
"F inis Austriae" a Trieste
Verso la vittoria finale
3 Novembre 19 18: l'Italia arriva dal mare
Parte seconda: 1954
Un decennio di trattative politico-diplomatiche
1 giorni dell'attesa
26 ottobre 1954: "Arriuano i nostri! "
L'Esercito a Trieste dal 1918 ad oggi
pag. 3
pag. 5
pag. l l
pag. 15
pag. 19
pag. 37
pag. 63
pag. 91
pag.IOI
pag. 117