




















Sicurezza alimentare prima di ogni altra cosa.
Oggigiorno le micotossine infestano circa il 25% del mais raccolto, ponendo a rischio la salute di persone e animali. Anche l’impatto economico delle contaminazioni è molto alto.

Le innovazioni tecnologiche di Bühler possono ridurre la contaminazione da micotossine lungo l’intera catena del valore, garantendo elevati standard di sicurezza alimentare e conseguentemente, proteggendo la salute di consumatori ed animali d’allevamento.
Per maggiori informazioni www.buhlergroup.com

La n os t r a s o s tanza risie d e
n elle f o r m e at t r a v erso le qua li c i mo stri am o .
N oi offri am o qu el c h e si am o .
Se mp r e .
www.ocrim.com


www.paglierani.com

• NUOVO DESIGN DELLA TESTA
CON VENTILAZIONE DIFFERENZIATA E OTTIMIZZATA
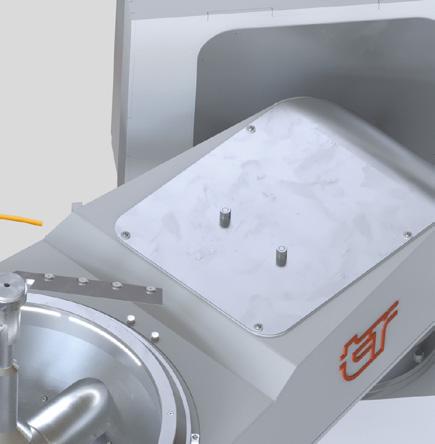

• MOTORE BRUSHLESS (SISTEMA BREVETTATO)

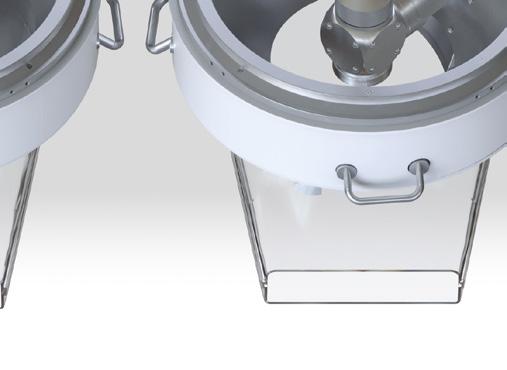


• DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI


• SCARICO PRODOTTO FRESCO (OPTIONAL)
• MASSIMA SEMPLICITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE
• TUTTO CON UN SOLO VENTILATORE!
Da più di trent’anni facciamo girare la testa ai nostri clienti.
LA RIVISTA ITALIANA PER L’INDUSTRIA MOLITORIA dal 1950
Associazione Industriali Mugnai d’Italia
Via Lovanio, 6 - 00198 Roma
DIRETTORE EDITORIALE
Andrea Valente
Presidente Italmopa
DIRETTORE RESPONSABILE
Claudio Vercellone
DIRETTORE TECNICO
Lorenzo Cavalli
Presidente Antim
COMITATO TECNICO EDITORIALE
Carlo Brera
Esperto in sicurezza alimentare
Marina Carcea
Ricercatrice per gli alimenti e la nutrizione, CREA - Roma
Giuseppe Maria Durazzo
Avvocato, esperto in diritto dell’alimentazione
Maurizio Monti
Miller’s Mastery - Tecniche di macinazione
Luigi Pelliccia
Responsabile Ufficio Studi, Mercato e Ufficio Stampa di Federalimentare
Giovanni Battista Quaglia
Tecnologie alimentari
COMITATO DI REDAZIONE
Piero Luigi Pianu
Tullio Pandolfi
Laura Pierandrei
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Alfredo Tesio
REDAZIONE
ufficiostampa@avenue-media.eu
Tel. +39 051 6564337
PUBBLICITÀ
expo@avenue-media.eu
Tel. 051 6564348 / +39 344 1300590
EDIZIONE, DIREZIONE, REDAZIONE, PUBBLICITÀ E AMMINISTRAZIONE
Edizioni Avenue media®
Viale Antonio Aldini, 222/4 - 40136 Bologna Tel. +39 051 6564311
STAMPA: MIG - Moderna Industrie Grafiche
Via dei Fornaciai, 4 - 40129 Bologna
RIVISTA FONDATA NEL 1950
Registrazione Tribunale di Bologna del 31 luglio 1992 n. 6129
Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 679/2016. L’informativa Privacy è disponibile sul sito di Avenue media www.avenue-media.eu alla pagina “Informativa Privacy Editoria” www.avenue-media.eu/informativa-privacy-editoria






Despite its efforts, including communication efforts, the milling industry continues to be held responsible for rising production prices. Actually, the profit margin is getting smaller and smaller. Moreover, the recent problems have only complicated a situation that was already quite difficult. Therefore, the scenario is unpredictable, so mental resilience is required to deal with situations that may arise at any time. Certainly, in the past few months tensions eased on agricultural and energy commodity prices, but it would be unwisely premature to believe that the crisis is over, when it could, instead, reappear with the same force in the medium term.
COSTI DI PRODUZIONE, IMPREVEDIBILITÀ DEL MERCATO E INFLAZIONE RENDONO SEMPRE PIÙ COMPLESSO LO SCENARIO
PRODUCTION COSTS, MARKET
UNPREDICTABILITY AND INFLATION MAKE THE SCENARIO INCREASINGLY COMPLEX
Èindubbio che l’anno appena conclusosi ha rappresentato, per il comparto alimentare in generale e per quello molitorio in particolare, un annus horribilis per quanto concerne l’esplosione dei costi di produzione. L’incremento delle quotazioni delle materie prime agricole, ma, più ancora dei costi energetici hanno rappresentato, nel primo semestre 2022, una sfida senza precedenti per la sopravvivenza di alcune Aziende dei nostri comparti, anche alla luce dell’obiettiva difficoltà a riversare, nella fase iniziale, seppur solo parzialmente, tali aumenti sugli attori a valle dell’Industria molitoria. La volontà della distribuzione di tutelare i consumi anche attraverso una moratoria dei listini è apparsa indubbiamente comprensibile e condivisibile in un’ottica sociale ma appariva, al contrario, deleteria per settori produttivi, quale quello molitorio, da sempre caratterizzati da margini di redditività che non consentono in alcun modo di assorbire, da soli piuttosto

che nel contesto dell’intera filiera, choc violenti e inattesi. Sarebbe stato doveroso, ancora una volta, riconoscere gli ingenti sforzi profusi dall’Industria per contenere l’inflazione. E invece, abbiamo, nuovamente, assistito al consueto balletto di dichiarazioni volte a convincere l’opinione pubblica e i policy maker che gli autonomi interventi delle singole industrie sui listini erano troppo spesso frutto di decisioni puramente speculative. Dichiarazioni che, fortunatamente, si sono successivamente affievolite, alla luce della generale presa di coscienza della situazione dei mercati, consentendo in tal modo all’Industria di trasformazione di uscire da una fase di preoccupante apnea.

Detto questo, le prospettive per il 2023 appaiono ancora incerte, per via di una evoluzione imprevedibile della situazione geopolitica. Il conflitto in Ucraina continua, e probabilmente continuerà, a rappresentare un fattore di forte instabilità per il quadro macroeconomico internazionale e italiano. Certamente, gli ultimi mesi hanno evidenziato un allentamento delle tensioni sulle quotazioni delle materie prime agricole e energetiche ma sarebbe incautamente prematuro ritenere superata una crisi che potrebbe, invece, riproporsi, con la stessa forza nel medio periodo. Il tasso di inflazione si mantiene in ogni modo, e non poteva risultare diversamente, su livelli particolarmente elevati e i tassi
di interesse nominali continuano a crescere creando in tal modo un humus fertile a una contrazione della domanda nazionale e internazionale. Una situazione potenzialmente delicata in particolare per quei Paesi, quale l’Italia, fortemente export oriented. Avremmo modo, senza alcun dubbio, di riparlarne.
Per quanto concerne l’andamento del settore alimentare, il 2023 potrebbe risultare un anno a due facce: nel primo semestre, è prevedibile una stagnazione della redditività dell’Industria con conseguente prudenza nelle politiche di investimento da un lato e una generale debolezza dei consumi dall’altro. Il secondo semestre potrebbe invece essere caratterizzato da un calmieramento dei prezzi allo scaffale e una ripresa, seppur contenuta dei consumi. Uno scenario, pertanto, abbastanza complesso e un po’ fosco, ma che, esperienza insegna, potrebbe essere ribaltato senza alcun preavviso.
 Andrea Valente
Andrea Valente





Il3 gennaio 2023 l’Ue ha autorizzato l’uso alimentare della polvere parzialmente sgrassata di grillo (Acheta domesticus). A breve, pertanto, in Europa pane, cracker, biscotti e snack, e altri prodotti alimentari, potranno avere tra gli ingredienti farina di grillo a elevato contenuto proteico. Il via libera europeo si riferisce alla sola società vietnamita Cricket One Co. Ltd, che aveva richiesto l’immissione del prodotto sul mercato. Per quanto riguarda i rischi relativi alle allergie, il grillo domestico può provocare reazioni nelle persone intolleranti ai crostacei, ai molluschi e agli acari della polvere. L’Efsa ha specificato che se il substrato con cui vengono alimentati gli insetti contiene ulteriori allergeni, questi ultimi possono risultare presenti nel nuovo alimento. Per questo motivo, gli alimenti contenenti polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus saranno adeguatamente etichettati.


Arriva dalle associazioni di categoria pugliesi (tra cui CIA-Agricoltori Italiani de La Capitanata), la proposta di inserire nel listino della Borsa Merci di Foggia la semola di grano duro italiano. La missiva ufficiale è del 10 gennaio scorso e nasce per sostenere il valore qualitativo di tale prodotto e dell’intera filiera per garantire un equo riconoscimento alle imprese cerealicole e di trasformazione del territorio de La Capitanata. L’iniziativa punta a fare da apripista per l’intero Paese anche in funzione del ruolo di “granaio d’Italia” che ha Foggia. “I costi per la produzione del grano duro - spiega Angelo Miano, presidente di CIA-Agricoltori Italiani de La Capitanata - sono lievitati a 1.200 euro/ha, a fronte di una produttività di circa 23,5 quintali per ettaro. Senza l’inserimento della semola nella Borsa Merci, tutta la filiera rischia di saltare perché affidata alla trattativa tra le parti che penalizza quelle più deboli a monte della filiera”.
Grani perenni e popolazioni evolutive aiutano i produttori ad abbattere i costi di produzione e ad adattarsi ai cambiamenti climatici nel rispetto della sostenibilità ambientale. È quanto emerge da due studi del programma Change-Up - Innovative Agro-Ecological Approaches to Achieving Resilience to Climate Change in Mediterranean Countries. “I grani perenni - afferma Laura Gazza, ricercatrice del Crea Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari di Montelibretti, Roma - non hanno bisogno di essere seminati annualmente perché si auto-rigenerano ogni autunno, ma hanno una dimensione dei semi e una resa inferiori a quelle dei grani moderni. Le popolazioni evolutive sono, invece, miscugli di grani differenti che sfruttano la variabilità genetica per adattarsi alle condizioni ambientali e offrire produzioni stabili nel tempo”. I grani perenni, peraltro, non necessitano di diserbo: essendo rustici, sono particolarmente resistenti agli attacchi fitopatologici.








Molini Pivetti è stata e sarà presente con le sue farine a due fiere internazionali: SIRHA 2023, il Salone di riferimento mondiale dei settori Food Service e ospitalità tenutosi all’Euroexpo di Lione dal 19 al 23 gennaio, e Gulfood 2023, la manifestazione fieristica di riferimento in Medio Oriente per l’industria alimentare e delle bevande, in programma presso il Dubai World Trade Centre dal 20 al 24 febbraio. A Lione Molini Pivetti ha promosso una serie di eventi dimostrativi dedicati alla pizza, mentre a Dubai l’azienda emiliana sarà presente con le linee di farine professionali dedicate alla pizzeria e alla pasta fresca. “L’investimento nella ricerca e sviluppo ha puntato a migliorare le nostre farine affinché siano perfette per lo specifico utilizzo” ha dichiarato la responsabile Marketing Tonia Sorrentino.

Sostituire i fertilizzanti chimici con microrganismi e batteri in grado di favorire la crescita delle piante anche nei periodi di stress idrico, migliorando le funzioni del suolo e la produzione agricola. È il risultato del progetto “Ortumannu”, condotto da ENEA, Università degli Studi di Cagliari, CRS4 e Mutah University (Giordania) che punta a contrastare l’impoverimento dei suoli e a promuovere una produzione agricola d’alta qualità, riducendo l’utilizzo di fertilizzanti, pesticidi e acqua. Il team di ricerca ha isolato e identificato dal suolo 40 ceppi di batteri che sono stati testati per la capacità di promuovere la crescita delle piante, fissare l’azoto, mobilizzare il fosforo, solubilizzare il potassio e produrre siderofori, cioè sostanze organiche in grado di influenzare l’accrescimento delle piante.


La Provincia di Trento ha istituito all’inizio dell’anno un marchio a tutela della qualità del pane fresco artigianale locale al fine di favorirne la riconoscibilità sul territorio provinciale. Fortemente voluto dall’Associazione Panificatori provinciale, il marchio “Pane Fresco” è rappresentato da un fiore stilizzato con varie gradazioni di marrone, il colore del pane. Il passo successivo sarà quello di incentivare la sua adozione presso negozi e Gdo che potranno apporlo su scaffali, sacchetti ed etichette. Possono richiedere l’uso del marchio “Pane Fresco”, le imprese che lo producono e commercializzano direttamente; le imprese che acquistano “Pane Fresco” da terzi e lo commercializzano al dettaglio; altri enti per finalità puramente promozionali e informative.



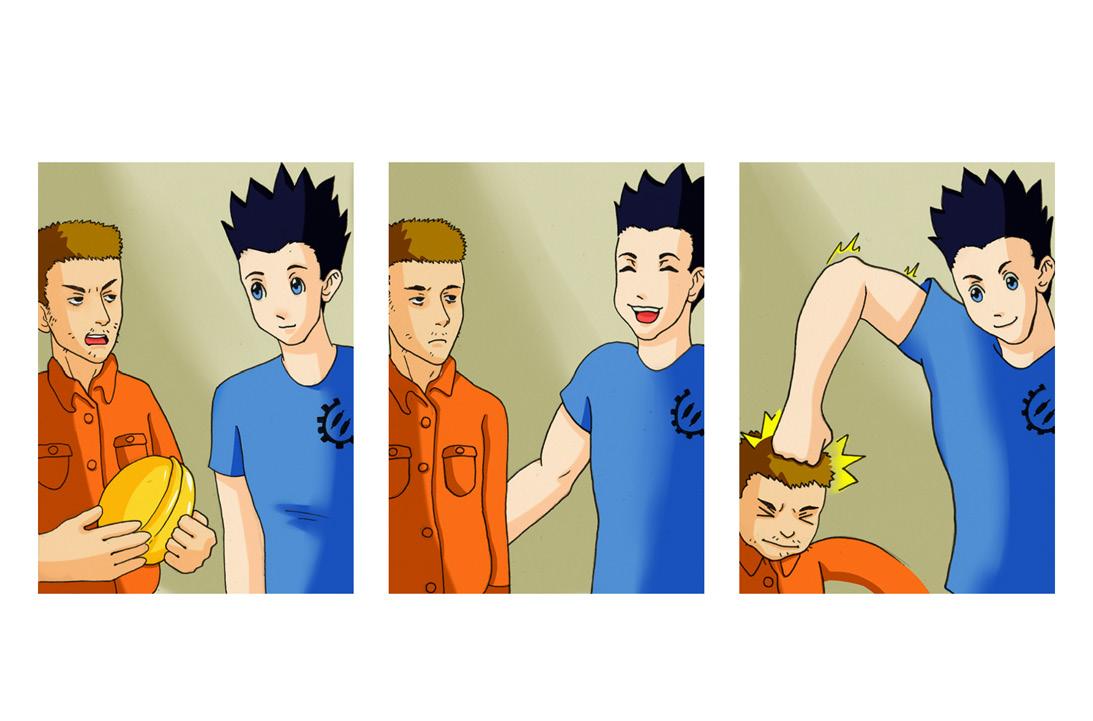
ASigep 2023, Agugiaro & Figna ha portato in vetrina “Le Sinfonie”, la linea di farine dedicata alla produzione artigianale in pasticceria, composta da nove referenze di farine di grano tenero e sei varianti di semilavorati delle migliori qualità, per soddisfare al meglio le esigenze nei diversi tipi di lavorazione che l’arte dolciaria prevede. La fiera è stata soprattutto l’occasione per esporre la nuova declinazione de “Le Sinfonie”: “Magistrale”, una farina elastica e duttile, che garantisce una fermentazione equilibrata durante tutte le ore di lievitazione, senza apportare tenacità agli impasti. Altra protagonista della proposta di Agugiaro & Figna a Sigep è stata la linea “Mia” di farine ottenute da macinazione integrata: un processo brevettato che associa due tipologie di molitura, quella più tradizionale a pietra con quella moderna a cilindri.

Aumentano le importazioni di cereali in Italia (+8%) così come le esportazioni (+9,9%), tuttavia il saldo rimane sempre in negativo. Lo rivela il report di Anacer relativo ai primi 10 mesi del 2022. Le esportazioni dall’Italia dei principali prodotti del settore nei primi dieci mesi del 2022, per contro, sono risultate in aumento sia nelle quantità di 374.000 t (+9,9%), sia nei valori di 1.276,3 milioni di euro (+37,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I movimenti valutari relativi all’import/export del settore cerealicolo hanno comportato nei primi dieci mesi del 2022, un esborso di valuta pari a 7.912,3 milioni di euro (5.521,8 nel 2021) e introiti per 4.700,3 milioni di euro (3.424,0 nel 2021). Pertanto il saldo valutario netto è pari a -3.212,0 milioni di euro, contro -2.097,8 milioni di euro nel 2021.


World News è la rassegna delle notizie dall’Europa e dal mondo sull’agroalimentare. Un punto di vista aggiornato e puntuale su quanto accade in sede comunitaria ed extra-comunitaria, per essere sempre informati sulle dinamiche internazionali in ambito politico, economico e scientifico. Brevi flash che possono risultare di interesse per la filiera - italiana ma non solo - della trasformazione dei cereali.






Laseduta dell’Usda dello scorso 12 gennaio potrebbe scatenare effetti negativi sul mercato europeo della farina e dei semi di soia importati dall’Argentina. “Se la produzione dal Brasile, è di poco aumentata a 153 milioni di tonnellate metriche - afferma Mario Boggini, esperto di mercati cerealicoli nazionali e internazionali -, quella dell’Argentina è parecchio al di sotto delle attese con 45,5 MMT. La conseguenza è che il mercato dei proteici si è scatenato. I riflessi negativi riguarderebbero specialmente l’Europa. La causa del calo di volumi è la siccità ma, se a febbraio dovesse finire l’effetto della Niña, quasi sicuramente pioverà. In caso contrario sarebbe un dramma per l’impennata dei prezzi, già alti, poiché l’Argentina è tra i principali esportatori in Europa di farina e semi di soia”. Tuttavia, già dalla seduta mercantile del 17 gennaio il mercato sta ridimensionando la reazione violenta avuta dopo i dati Usda.

FranceAgriMer, le previsioni per le esportazioni 2022/23 di grano tenero dalla Francia al di fuori dell’Unione europea sono salite a 10,6 milioni di tonnellate, il 21% in più rispetto allo scorso anno, su forte domanda dal Nord Africa. Il Paese, che è il più grande produttore di grano dell’Ue, a dicembre aveva spedito 10,3 milioni di tonnellate di grano, ben 300.000 tonnellate in più rispetto al mese precedente. Secondo Paul Le Bideau, vice capo dell’unità cereali di FranceAgriMer, la domanda è ancora significativa dal Maghreb, in particolare dal Marocco. La competitività del grano francese nei mercati del Nord Africa era stata aiutata dall’aumento dei costi per le forniture di spedizione dalla Russia, il più grande esportatore di grano del mondo.
Il porto egiziano di Damietta ha ricevuto la nave Oxana V proveniente dalla Russia con 42.000 tonnellate di grano a bordo per la Supply Commodities Authority. La nave alza bandiera panamense ed è lunga 186 metri e larga 31. Questo “sbarco” avviene come parte degli sforzi dell’Egitto per garantirsi la disponibilità di materie prime strategiche e soddisfare così le proprie esigenze di grano nonché per confermare la disponibilità di impianti portuali per ricevere navi cisterna. L’Egitto è stato il paese leader nell’importazione di grano russo durante il mese di gennaio, poiché ha ricevuto oltre 191.000 tonnellate, rispetto alle 103.000 tonnellate di un anno fa.
REALIZZAZIONE DI SILOS IN CALCESTRUZZO ARMATO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI FARINACEI









RIVESTIMENTI DI CELLE E SILOS CON RESINE EPOSSIDICHE CERTIFICATE PER IL CONTATTO CON ALIMENTI

RIVESTIMENTI DI PAVIMENTI CON RESINE MULTISTRATO E AUTOLIVELLANTI







TINTEGGIATURA SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE DI OPIFICI INDUSTRIALI

RINFORZI E MIGLIORAMENTI SISMICI MEDIANTE L’USO DI INTONACI ARMATI, NASTRI IN FRP E STIRATURE ARMATE
s.p. Andria-Trani km 1,500 Andria (BT) t 0883.251661











info@pi-sa.it www.pi-sa.it












riferisce che prezzi più alti e migliori condizioni atmosferiche potrebbero aiutare la produzione di grano in India, consentendole di favorire gli agricoltori nel piantare varietà ad alto rendimento in una zona più ampia. Va ricordato che l’India ha subito una storica ondata di caldo l’anno scorso in un momento cruciale per lo sviluppo del grano che ne ha rallentato la produzione. L’aumento di questa nel 2023, per quel che riguarda il frumento, potrebbe incoraggiare l’India a prendere in considerazione l’abolizione del divieto di esportazione dei prodotti di base e contribuire ad alleviare le preoccupazioni per l’inflazione costantemente elevata dei prezzi dei prodotti alimentari.






L’AUTOSUFFICIENZA DEL GRANO

appena trascorso, lo Zimbabwe (paese senza sbocco sul mare) ha realizzato il suo più grande raccolto di grano (375.000 tonnellate), rendendosi così autosufficiente. Il raccolto del 2022 è stato superiore del 13% rispetto all’anno precedente, superando un record di mezzo secolo fa. La superficie coltivata a grano è aumentata del 10% e, soprattutto, lo Stato ha istituito una politica di distribuzione di fertilizzanti e di acquisto di colture attraverso un ente pubblico, il Grain Marketing Board, che ha conquistato gli agricoltori. Di conseguenza, lo Zimbabwe non ha più bisogno di importare grano per soddisfare il proprio fabbisogno, risparmiando fino a 300 milioni di dollari in costi di importazione. Nell’attuale contesto in cui i paesi africani soffrono per l’assenza o il costo elevato del grano russo e ucraino, lo Zimbabwe si distingue per la sua politica proattiva.
NOVITÀ! TELAI IN ALLUMINIO PER OGNI MODELLO DI PLANSICHTER



Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 305 del 31/12/2022
è stato pubblicato il Decreto 22 dicembre 2022, recante modifica del decreto 13 gennaio 2011. Le modifiche del DM dello scorso dicembre riguardano in particolare l’allegato 2 di quello del 2020, sulle contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da acido fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale.
Tale allegato, introdotto dal decreto 10 luglio 2020, n. 7264, risulta modificato come segue:


a) nei punti 2 e 3 la data del “31 dicembre 2022” è sostituita da “31 dicembre 2025”;
b) nell’ultima frase la data del “31 dicembre 2022” è sostituita da “31 dicembre 2025”.
I termini di cui all’allegato 2, punti 2 e 3 del DM 13 gennaio 2011, n. 309, già oggetto di proroga con quello del 10 luglio 2020, n. 7264, sono quindi ulteriormente prorogati in attesa dei risultati del progetto di ricerca “Sistemia del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni accidentali o volontarie - BIOFOSF-CUBE” finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell’acido fosfonico nei tessuti vegetali e di altri aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici e finanziato dal Mipaaf in data 29 aprile 2022. Il decreto è entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

IlMinistero della Salute ha di recente pubblicato sul proprio sito web il rapporto contenente i dati del “Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti relativi all’anno 2020”. Il rapporto riassume il sistema italiano dei controlli dei residui di pesticidi in alimenti, la programmazione del controllo ufficiale, l’organizzazione dei controlli, il sistema di verifica, ai sensi del Reg. Ue n. 625/2017, la trasmissione dei risultati dei controlli ufficiali.
Nel capitolo 7 sono contenute le elaborazioni dei risultati dei controlli dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per l’anno 2020, per quanto riguarda in particolare campionamenti, residui complessivi, su alcuni prodotti quali i cereali, alcuni prodotti trasformati, quali olio e vino, baby food, prodotti di origine biologica e alcuni alimenti di origine animale.
I campionamenti sono stati effettuati sia sul territorio nazionale, dalle Autorità sanitarie locali, sia all’importazione dai posti di controllo alle frontiere del Ministero della Salute. Relativamente ai risultati, dal rapporto si evince che nel corso dell’an-









no 2020, sono stati analizzati complessivamente 8200 campioni di alimenti per verificare la presenza di residui di prodotti fitosanitari. Di questi soltanto 76 sono risultati superiori ai limiti massimi consentiti dalla normativa vigente, con una percentuale di irregolarità pari allo 1%. Nel gruppo cereali sono state rilevate solo 7 (lo 0,6%) non conformità, mentre l’81,9% dei campioni è risultato privo di residui rilevabili. Per i cereali i campioni che presentano residui, in tutti quelli analizzati - nel complesso sono stati 1202 (1172 sul territorio nazionale e 30 nei controlli
all’importazione) - sono in percentuale inferiore rispetto ai campioni senza residui dei due anni precedenti. Per quanto riguarda i prodotti biologici, tra i 388 campioni nel complesso analizzati, di cui 107 di cereali, il 91,5% non presenta residui, mentre l’8% presenta residui nei limiti di cui al Regolamento CE n, 396/2005 e smi. Complessivamente quindi, come per gli scorsi anni, i risultati dei controlli ufficiali italiani continuano a essere in linea con quelli rilevati negli altri Paesi dell’Unione Europea e indicano un elevato livello di protezione del consumatore.

Seguendo un iter ormai ampiamente consolidato per la regolamentazione dei contaminanti nei prodotti alimentari, è stata da alcuni anni avviata in ambito europeo una riflessione sul nickel in vista della messa a punto di una sua regolamentazione nel quadro del Reg (Ue) n. 1881/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Il nickel è un metallo, che appartiene alla categoria dei metalli pesanti, diffuso in tantissimi elementi in natura, tra cui molti alimenti, sia di origine animale sia vegetale, in acqua e in molti oggetti di uso comune. La principale fonte di esposizione al nickel è il consumo per via orale, poiché esso è presente come elemento contaminante. Tale metallo è tra i primi responsabili di reazioni allergiche da contatto.
Nel febbraio del 2015 la European Food Safety Authority (Efsa) ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute umana associati al nickel presente nei prodotti alimentari, in particolare nei vegetali, ma anche nell’acqua potabile. L’Efsa ha stabilito un livello di sicurezza, noto come dose giornaliera tollerabile (DGT), di 2,8 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo. Sulla base dei correnti livelli di esposizione medi ed elevati, gli esperti dell’Efsa hanno concluso che l’attuale esposizione alimentare cronica al nickel è motivo di preoccupazione per la popolazione in genere.

Il parere del 2015 è stato integrato/modificato da un successivo parere scientifico della stessa Efsa risalente al 2020. La Commissione Europea ha chiesto a questa di aggiornare il suo precedente per tener conto dei nuovi dati, della guida aggiornata sulla dose di riferimento (BMD) e delle nuove informazioni scientifiche disponibili. Per calcolare l’esposizione alimentare cronica e acuta sono stati utilizzati più di 47.000 risultati analitici sulla presenza di nickel. L’esposizione alimentare cronica al 95° percentile, ovvero nella maggioranza della popolazione, è risultata inferiore alla dose tollerabile giornaliera (TDI) negli adolescenti e in tutti i gruppi di età adulta, ma in genere superava la TDI nei bambini piccoli e in altri bambini, e anche nei neonati. I valori del margine di esposizione (MOE) alimentare acuta media e per il 95° percentile rappresentano un problema di salute per gli individui sensibilizzati al nickel.
Sulla base del parere dell’Efsa la Commissione europea ha adottato nel luglio 2016 una Raccomandazione (2016/1111) sul monitoraggio dei livelli di nickel in alcuni alimenti. In applicazione della Raccomandazione gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, hanno svolto un’attività di monitoraggio della presenza di nickel negli alimenti nel 2016, 2017 e 2018. Il monitoraggio si è incentrato su cereali, prodotti a base di cereali, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti per bambini, alimenti a fini medici speciali destinati in modo specifico ai lattanti e ai bambini ecc. Gli Stati membri hanno inoltre effettuato un’attività di monitoraggio della presenza di Nickel anche nei mangimi.
Di recente, tenendo in considerazione l’ampio lavoro di preparazione svolto, la DG Sante della Commissione europea ha pubblicato un progetto di regolamento sul nickel in alcuni prodotti alimentari e ne ha discusso durante l’ultimo gruppo di lavoro sui contaminanti dello scorso anno. Secondo informazioni pervenute, nel corso del GdL la DG Sante ha illustrato il parere dell’Efsa da cui risulta che il valore limite tossicologico per l’esposizione cronica al nickel può essere superato per un certo numero di gruppi di età. Alcuni prodotti
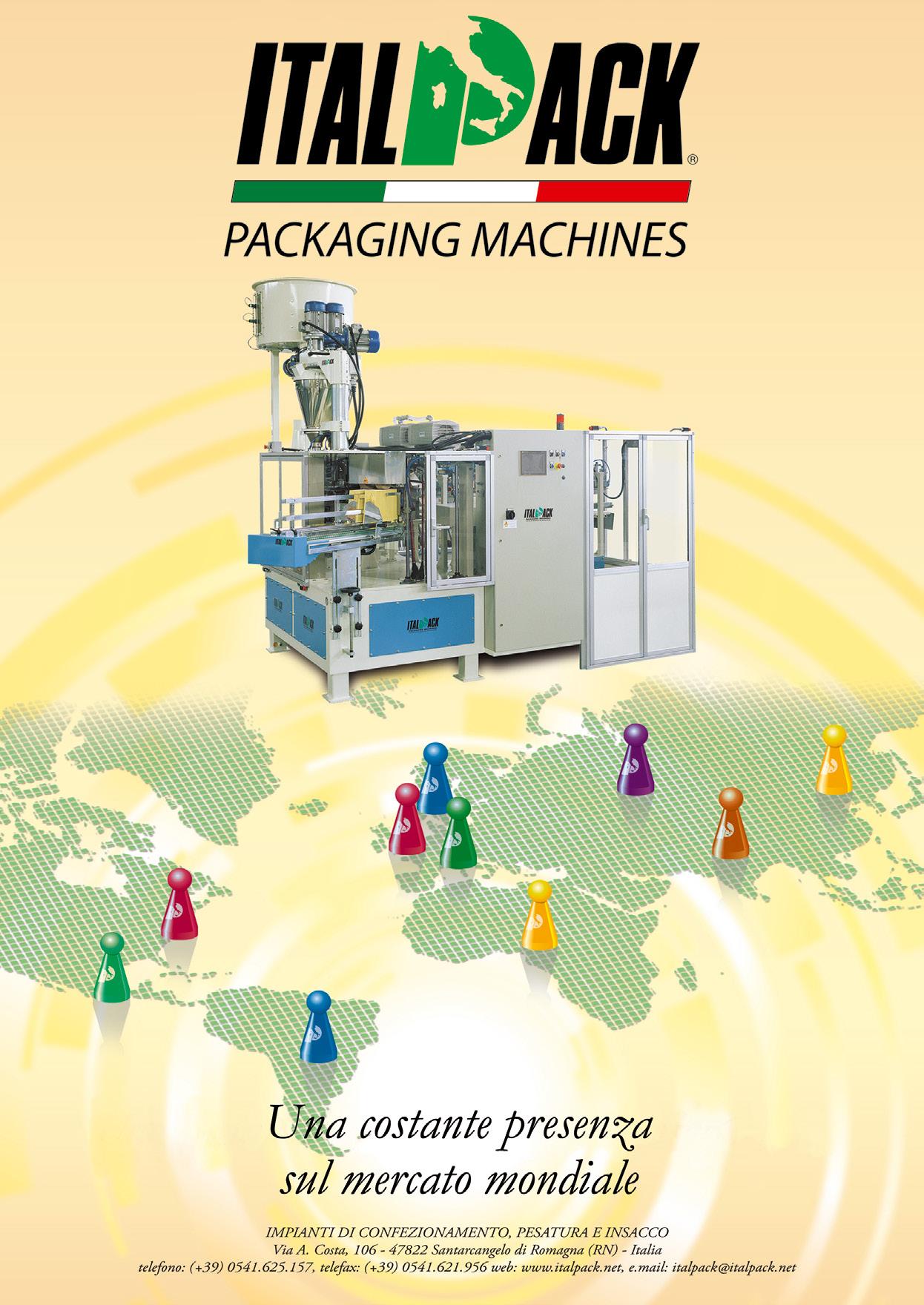
alimentari sono particolarmente rilevanti nell’esposizione al nickel, pertanto, potrebbero non essere richiesti limiti massimi per tutti i prodotti.
I rappresentanti degli Stati membri dell’Ue si sono confrontati con i rappresentanti della DG Sante, in particolare sul fatto che innanzitutto i limiti massimi (ML) debbano essere individuati per ampie categorie di prodotti o per prodotti specifici. Sempre in seno al GdL, uno Stato membro ha indicato che gli ML sono ora proposti principalmente per prodotti di largo consumo, mentre alcuni prodotti specifici mostrano livelli più elevati, ma sono disponibili pochi dati al riguardo. La DG Sante ha proposto un approccio prudente per quanto riguarda i prodotti per i quali sono disponibili pochi dati: inizialmente i limiti massimi possono essere fissati in termini più ampi e possono sempre essere abbassati in futuro. A quanti risulta, un altro Stato membro ha indicato che potrebbero esistere differenze geografiche nella quantità di nickel negli alimenti, ragion per cui sarebbe preferibile che fossero fissati limiti massimi per le categorie di prodotti generali, per i prodotti destinati in particolare ai bambini.
Un altro Stato membro si è chiesto se sia necessario proporre limiti massimi per tutti i gruppi di prodotti contenuti nella proposta della Commissione. Dopo aver riesaminato il parere dell’Efsa, solo i possibili rischi sembrano riguardare i bambini piccoli men-
tre negli adulti, le reazioni di ipersensibilità desterebbero preoccupazione solo negli individui sensibili al nickel. La priorità dovrebbe essere inizialmente sugli alimenti specifici per neonati e bambini piccoli.
La DG Sante ha risposto che la proposta di regolamento prevede la fissazione di limiti massimi di nickel per i maggiori contributori all’esposizione e che questi prodotti sono rilevanti anche per l’esposizione dei bambini. Attualmente sono disponibili dati sufficienti per la maggior parte di questi prodotti, quindi è possibile proporre la fissazione di limiti massimi.

Nel caso dei cereali, l’attuale proposta prevede limiti massimi solo per la materia prima. La DG Sante ha indicato che i fattori di trasformazione devono essere applicati nel caso di prodotti a base di cereali preparati e trasformati. La (nuova) raccomandazione di monitorare il nickel viene ampliata per includere una serie di gruppi di prodotti (tra cui tè, cioccolato e cereali per la colazione) per i quali sono necessari più dati e che contribuiscono in modo importante all’esposizione. La DG Sante ha indicato che è sua intenzione organizzare una consultazione delle parti interessate nel 2023. L’esame della proposta di regolamento procederà in ambito ai Gruppi di lavoro dei contaminanti composti dei rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri.
a cura di Tullio Pandolfi

I VALORI AFFIDABILI, ESATTAMENTE COME IL NOSTRO SENSORE RADAR. THE 6X ®. ORA DISPONIBILE!





Da oltre 60 anni abbiamo in mente una cosa sola: rendere sempre più precisi i valori di misura. I valori umani sono però sempre al centro del nostro lavoro e questo ha ispirato la realizzazione del nuovo sensore di livello radar, il migliore in assoluto: il VEGAPULS 6X.
VEGA. HOME OF VALUES. www.vega.com/radar
2023
will not benefit as much as 2022 from the wake effect of growth in the first part of the year. Overall, 2023 will be worse, with weak and anonymous figures. The article analyses the current European and Italian economic situation that is still affected by inflation and a slump in domestic food sales in volume, not sufficiently offset by the increasing pace of exports. However, some positive signs come from the milling sector, which reached an export level of 472.5 million over 10 months, with a robust +32.5% over the same period last year.

Il 2023 non usufruirà come il 2022 dell’effetto scia di una crescita messa a segno nella prima parte dell’anno. Nel complesso, sarà un anno peggiore, con numeri deboli e anonimi. In questa chiave, le recenti misure di elevazione del tasso di sconto a contrasto dell’inflazione europea, varate dalla BCE sulla scia delle analoghe misure adottate oltre Atlantico dalla FED, non risultano esenti da critiche. La congiuntura comunitaria è profondamente diversa, nei suoi punti deboli, da quella americana, a cominciare dalla pressione sui costi e dalla minore competitività e solidità del sistema produttivo Ue legate ai prezzi dell’energia, rispetto al sistema americano, notoriamente autonomo ed esportatore sotto questo profilo, e dal peso schiacciante sui bilanci pubblici delle misure di contenimento di tali costi varati per famiglie e


imprese. In altre parole, le misure della BCE appaiono in qualche modo rigide e prive di creatività per una inflazione “da offerta” come quella comunitaria. Tanto più, alla luce della necessità di non penalizzare gli investimenti diretti a ridurre le attuali vulnerabilità produttive europee. E alla luce, altresì, della annunciata riduzione progressiva, nel corso del 2023,
di uno strumento strategico per il sostegno finanziario allo sviluppo di sistema, come il “quantitative easing”.

alcuni parametri sono in funzione del singolo mese e per altri in funzione dei periodi, secondo la rispettiva, migliore rappresentatività
elaborazione Federalimentare su dati Istat
Intanto, l’Istat ha diffuso gli indici dei prezzi di dicembre. Ne emerge un lieve rallentamento del passo tendenziale dell’inflazione, che scende al +11,6%, dopo il +11,8% registrato a novembre e a ottobre. Il rallentamento nazionale fa eco timidamente a: quello registrato dall’inflazione della Germania, scesa a dicembre al +8,6%, dopo il +10,0% di novembre; quello della Francia, scesa a dicembre al +5,9%, dopo il +6,2% di novembre; quello della Spagna, che si è fermata a dicembre sul +5,6%, dopo il +6,7% di novembre. L’Italia, fra i grandi paesi comunitari, rimane perciò il più esposto sul fronte dell’inflazione e il più pigro nella tendenza al rientro. I beni energetici, i beni alimentari “non lavorati” e i servizi relativi ai trasporti hanno rallentato la corsa a dicembre. Al contrario, hanno accelerato ancora proprio i beni alimentari “lavorati”, e poi i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e i servizi relativi alle comunicazioni. Va sottolineata quindi la perdurante tensione dei prezzi dell’alimentare trasformato. La quale, peraltro, non deve meravigliare considerato che, a monte, i prezzi alla produzione dell’industria alimentare hanno raggiunto a ottobre, secondo gli ultimi dati disponibili, il picco tendenziale del +17,1%.

In “media” d’anno, l’inflazione nazionale registra così un +8,1%. È l’aumento più vistoso dal 1985, quando essa segnò il +9,2%.

I segnali provenienti dalla produzione, dalle vendite interne e dall’export indicano, negli ultimi mesi dell’anno, chiari profili di appesantimento della congiuntura alimentare e, conseguentemente, una “velocità di uscita” verso il 2023 piatta e involutiva. In particolare, la crisi delle vendite alimentari interne in volume, non riequilibrata a sufficienza dal passo espansivo dell’export, sta contraddicendo le tradizioni anticicliche del settore e ha cominciato a impattare sul livello di attività delle imprese. Nello scorso mese di novembre l’industria alimentare ha registrato infatti, a parità di giornate di calendario, un calo di produzione del -3,9% sullo stesso mese 2021, che replica sostanzialmente il -4,0% di ottobre e fa seguito al +0,3% di settembre e il +4,0% di agosto. Il trend progressivo sugli 11 mesi della produzione di settore si è abbassato così al +1,5%, dopo il +2,1% dei 10 mesi, il +2,9% e il +3,4% dei progressivi immediatamente precedenti, delineando, come prima accennato, indubbi profili involutivi. Il molitorio ha fatto peggio del “food and beverage” complessivo: ha segnato infatti un calo vistoso di produzione del -10,8% nel confronto novembre 2022/21, che appesantisce e porta al -1,5% il confronto progressivo sugli 11 mesi 2022/21. Il fenome-
no si riflette anche sul valore aggiunto richiesto da un mercato sempre più orientato al risparmio. In linea generale lo dimostra, se si vuole in modo semplicistico ma attendibile, il -4,1% accusato sui primi 11 mesi dell’anno dalla produzione del segmento dei “piatti preparati”, dopo il robusto aumento a due cifre del 2021 e i

buoni tassi di sviluppo degli anni pre-pandemia. Il mese di novembre, comunque, si caratterizza essenzialmente per un’ulteriore, forte erosione delle vendite alimentari. Il confronto tendenziale col novembre 2021 registra infatti un +6,6% in valore e, soprattutto, un -6,3% in volume. L’appesantimento del mese porta il passo progressivo delle vendite alimentari sui primi 11 mesi 2022/21 su tendenziali del +4,5% in valore e del -4,0% in volume. Un calo in volume così marcato è davvero senza precedenti recenti.
Nel singolo mese di novembre il differenziale fra i trend in valore e in volume delle vendite alimentari segna così 12,9 punti, vicinissimo ai 12,8 punti indicati dall’Istat come passo dell’inflazione alimentare del mese. È un tasso, quest’ultimo, superiore all’inflazione parallela (+11,8%). Non è un caso perciò se esso impatta negativamente sulle vendite alimentari in valore, e soprattutto in volume, assai più di quanto avviene nel perimetro non alimentare. Le vendite di questo perimetro fanno affiorare infatti, a novembre, variazioni tendenziali del +2,9% in valore e del -1,8% in volume. Nel mese, quindi, l’effetto prezzi in questo ambito rimane nettamente meno pronunciato rispetto all’alimentare. L’eredità dei mesi precedenti mantiene così, per il non alimentare, segni espansivi nel confronto sugli 11 mesi 2022/21, con variazioni del +4,8% in valore e del +2,5% in volume. Infine, il bilancio complessivo
CALO PRODUTTIVO DEL -10,8% PER IL MOLITORIO RISPETTO AL NOVEMBRE 2022/21


delle vendite totali del Paese registra sugli 11 mesi un tendenziale del +4,7% in valore e una erosione del -0,3% in volume, emblematica comunque della crisi montante e diffusa dei consumi.
Sul fronte delle esportazioni, va detto subito che le prospettive economiche internazionali sono molto deboli. Per il Pil Usa sono di un +0,2% nel 2023, mentre quelle Ue indicano un +0,5%. Il Pil del gigante Cina dovrebbe chiudere il 2022 con un +3,0%, limando nettamente le precedenti stime del +4,5%. Le stesse prospettive italiane indicano nel 2023 una crescita del Pil pari al +0,4%, dopo il +3,9% toccato nel 2022, in gran parte grazie alla forte spinta inerziale maturata nella prima parte dell’anno. Comunque, il Pil mondiale 2022, secondo le più recenti valutazioni del Fondo Monetario Internazionale, dovrebbe aver superato per la prima volta la quota di 100mila miliardi di dollari, con un +3,1% sul 2021. A fronte di una crescita media del +2,7% negli ultimi 10 anni, il FMI prevede altresì che nel 2023 la crescita in termini reali diminuirà nettamente, per attestarsi sul +1,3%. In questo quadro, il commercio mondiale, dopo aver toccato nel 2022 un tasso espansivo del +4,3%, profila nel 2023 previsioni molto incerte e in ogni caso volte nettamente al ribasso, col rischio di totale piattezza o quasi. Va aggiunto che l’esperienza degli ultimi lustri in-
segna che lo sviluppo mondiale è bene intonato quando il tasso di crescita del commercio del pianeta fa da traino ed è circa doppio rispetto a quello del Pil. Nel 2022 esso lo ha superato a fatica, mentre nel 2023 i due tassi potrebbero finire sostanzialmente con l’equivalersi su livelli decisamente marginali. I più recenti tassi specifici sui primi 10 mesi 2022 dell’export dell’industria alimentare indicano variazioni del +19,7% in valore e del +4,8% in volume sullo stesso periodo 2021. Essi generano un apprezzamento unitario di 14,9 punti, ma cominciano ad appiattirsi, soprattutto in volume, in chiusura d’anno, sottraendo progressivamente al settore l’unica stampella espansiva di cui ha potuto godere negli ultimi mesi.
Lo stesso sostegno recato dal mercato Usa alle esportazioni della nostra industria alimentare, va valutato attentamente e senza trionfalismi. Esso infatti in valuta ha segnato sui 10 mesi un +18,7%, sicuramente apprezzabile, ma assai più contenuto rispetto al parallelo +33,9% raggiunto, nel periodo, dall’export totale del Paese su questo mercato.

Il molitorio infine è stato performante. Ha raggiunto infatti una quota export sui 10 mesi di 472,5 milioni, con un robusto +32,5% sullo stesso periodo dell’anno precedente. In quantità, l’export di comparto ha sfiorato in parallelo la quota 511mila tonnellate, con un +6,2%. Quest’ultimo è il delta più sincero: non è drogato infatti dal surriscaldamento costi prezzi che nel comparto è stato molto elevato. I primi 5 sbocchi del molitorio su gennaio-ottobre sono stati infine, nell’ordine: Germania, Francia, Usa, Spagna e Regno Unito, con un netto distacco rispetto agli altri e con variazioni in valore oscillanti tra il +47,9% della Germania e il +22,0% della Francia.
 Pelliccia
Pelliccia
As to food law, a reminder of 2022 with a reflection on 2023 outlines some open and undefined crises. Let’s take the mustard allergen and other undesired elements that can be found in certain flour products, as well as plant protection treatment residues on imported products. Sometimes, the rules have been interpreted differently according to the States, or are not supported by effective or reasonably expensive control methods, or have created distortions between different product categories. So, wherever the solution has not yet been found, somehow the problem seems to be set aside, while operators still have to deal with it.
Un promemoria sul 2022 con una riflessione sul 2023 del diritto alimentare vede alcune crisi aperte e non definite. Penso a quella dell’allergene senape e altri indesiderati presenti in taluni sfarinati, a taluni residui di trattamenti fitosanitari su prodotti importati, come l’ETO e 2CE, ma anche ai casi della curcuma, degli idrossiantraceni che, al di là delle loro specificità, hanno mostrato l’affanno di un legislatore che ha scritto discipline problematiche per chi doveva applicare tali regole. Talvolta, le norme hanno trovato interpretazioni diverse ne-
gli Stati, o non sono supportate da metodi di controllo efficaci o ragionevolmente costosi o hanno creato distorsioni tra diverse categorie di prodotto (ad esempio tra alimento di uso corrente e integratore) e laddove la soluzione non è stata ancora trovata, in qualche maniera il problema sembra accantonato da parte del decisore, mentre ancora gli operatori debbono affrontarlo.

La Comunicazione della Commissione in tema di sicurezza alimentare (2022/C 355/01) ha sancito la tendenza di quella Istituzione a creare diritto attraverso la forma dell’aiuto all’interpretazione delle norme (evidentemente non troppo ben scritte), mentre la Corte di Giustizia, forse perché non interpellata puntualmente da taluni giudici nazionali, non mi sembra abbia regolato questioni fondamentali nella nostra materia. Anche il sistema unionale Solvit non ha fornito risposte importanti, in materia alimentare negli ultimi anni. Eppure che a livello italiano diverse norme possano sollevare forti dubbi di compatibilità col diritto Ue a me pare evidente. Da quella sul made in Italy, interpretata non tenendo conto della disciplina Ue sull’informazione ed etichettatura degli alimenti e men che meno del Regolamento sull’origine doganale, a quel-


Quando la ricerca ti porta oltre ciò che esiste, alla scoperta di nuove soluzioni e al raggiungimento di importanti traguardi. La nuova tecnologia per la pasta corta con i suoi originali trovati brevettati è, ancora una volta, la sintesi delle nostre capacità e della nostra specializzazione per garantire la massima valorizzazione della materia prima, la facilità di conduzione, il risparmio energetico e servizi di valore.
Fava, da sempre con voi, in una vita dedicata alla pasta.

OTTIMO RAPPORTO COSTO-RENDIMENTO
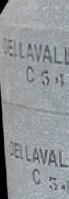

PIÙ EFFICIENZA
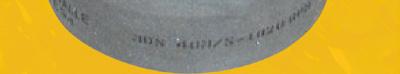
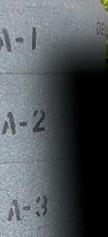
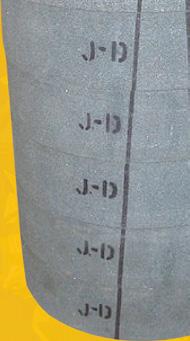
• Bilanciate singolarmente




• Ridotti tempi di montaggio

• Maggior elasticità, consumo uniforme e quindi risparmio energetico

• Fino a 1% in meno di chicchi rotti
PIÙ DURATA
• Resistenza all’usura tre volte superiore degli abrasivi in commercio
MENO COSTI

• 80% di risparmio rispetto alle mole diamantate in commercio

• Ridotti costi di manutenzione
CERTIFICAZIONE DI ALIMENTARIETÀ
SCOPRI


MOLE

le sull’origine (specialmente per grano e latte), così come talune letture “nazionali” relative ai cosiddetti “sup” (le plastiche a uso unico), o quel legiferare nazionale, italiano e di molti altri paesi, in te-

ma di etichettatura ambientale che sembra privo della ben che più minima armonizzazione unionale. Tutti ambiti che danno l’idea di come l’integrazione normativa quale processo europeo sia stata di fatto accantonata e che gli stessi Stati membri la reclamino principalmente per far fronte a proprie difficoltà. Tendenza disgregativa che, a mio avviso, solo apparentemente soddisfa le visioni di sostenibilità di ipotetici modelli di autonomia alimentare. Detto con lo spirito del giurista
del settore, la battaglia su un prodotto alimentare simbolo nazionale rischia di distrarre da una situazione più importante, ma complessa. Troverei auspicabile una vera e propria cabina di regia nazionale, che già potrebbe trovare un’azione prodromica nel migliore coordinamento delle Amministrazioni competenti, con lo scopo sia della tutela economica sia geopolitica delle produzioni mangimistiche e alimentari. Questioni di principio, si potrebbe dire, se non fosse un problema quotidiano quello degli operatori di confrontarsi con decine di maniere diverse di porre l’etichettatura ambientale sugli imballaggi, o se gli stessi non dovessero rispondere a criteri differenti nell’indicare l’origine di un ingrediente o valutare rischi di non conformità secondo il Paese di destinazione dell’alimento od occuparsi di conformità di ingredienti e imballaggi fabbricati da terzi fuori dal territorio nazionale o dovessero tener conto di criteri di conformità differenziati a seconda del punto di entrata nell’Ue.

Se l’Ue non dà sempre il buon esempio, le difficoltà a coordinare e armonizzare le attività di controllo sul territorio nazionale







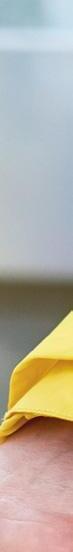












non mancano, così come talune interpretazioni autocefale da parte delle articolazioni territoriali dei servizi in materia alimentare; gli esempi possono essere molti e riguardano singoli uffici delle varie amministrazioni: capitanerie di porto, ufficiali fitosanitari, uffici veterinari, o dell’igiene alimentare, del controllo ufficiale ecc. Si dirà che l’Italia delle molteplicità è fatta così da sempre; che non possiamo chiedere lo stesso rispetto delle norme igienicosanitarie al banchetto in mezzo alla strada o alla grande azienda, o che è ben più fattibile tenere sotto controllo e sanzionare una grande azienda che produce alimenti in Italia piuttosto che solo li importi. Come ad accettare che ci siano piani legali diversi: salvo che, a me pare, tali situazioni percepite non abbiano presupposti normativi. Eppure, dal punto di vista europeo, nulla vieta che possano coesistere anche in materia igienico sanitaria e d’informazione del consumatore diritti e doveri diversificati. Se pensiamo che le stesse regole legali si debbono applicare, per esem-
pio, al supermercato che consegna a domicilio, alla multinazionale che fa lo stesso servizio, al rider che, anch’esso multinazionale, consegna la pizza o al fornaio che lascia un sacchetto di pane all’uscio di un vicino bisognoso, credo che emergano l’abnormità e l’inadeguatezza dell’impianto normativo e di quello del controllo. Il 2022 si è concluso con una serie di non
conformità per la listeria e diverse aflatossine. Se per la listeria, la rinnovata attenzione dovrebbe per lo meno riconsegnare il messaggio dell’importanza della cottura dei cibi laddove prevista, per talune aflatossine il rischio è quello di ricercarle al fondo della filiera, invece che concentrare le risorse per bloccare l’introduzione di ingredienti non conformi. E la stes-



sa logica si potrebbe applicare a diverse situazioni a rischio di non conformità e di allerte sui prodotti pluringrediente. Il rischio economico e legale, come in tanti altri casi, dovrebbe essere riportato a monte della filiera, senza esclusioni preconcette della produzione primaria, evitando una corsa a ritroso a seguito di controlli poco mirati a valle che finiscono per interessare, quasi a random, operatori che poco o nulla sanno o possono sul controllo delle materie prime.
Il 2023 non sarà l’anno dell’etichettatura frontale col superamento del NutriScore e del Nutrinform battery in una fusione, auspicabilmente armoniosa, di concetti e forme diverse. I profili nutrizionali, anch’essi annunziati, a prescindere dagli alti scopi che dovrebbero attuare, rischieranno di fare riemergere un sistema che discrimini tra cibi e modelli nutrizionali buoni e cattivi che tanto sono consoni alla filosofia normativa contemporanea improntata a un’opera educativa, ma che molto hanno perso della neutralità rispetto alla libera scelta dei consumatori e a quella dei produttori; quindi sarà da vigilare che i profili nutrizionali non diventino l’evoluzione più articolata e matura del me-

todo proprio del NutriScore. Forse torneremo a parlare con più attenzione di novel food (e non solo di insetti alimentari), del ruolo che la ricerca scientifica applicata agli alimenti può portare, ma sovente rimane nelle maglie di una normativa complessa e di dubbia applicazione e incerta applicabilità. Dalle colture cellulari alle sostanze alimentari caratterizzate dall’RNA, ai nuovi metodi di produzione, di purificazione, di estrazione ecc. le novità che premono sono molte e il fatto di non valutarle per difficoltà anche degli apparati di consulenza e di controllo ufficiale non può che bloccare sviluppi in parte interessanti o lasciarne filtrare l’introduzione sul mercato in maniera poco chiara. Ritengo auspicabile un profondo aggiornamento normativo in tema di integrazione alimentare materia in cui l’Italia è tra i grandi soggetti industriali, ma che corre il rischio legato alla fragilità delle regole
attuali e ai contrapposti interessi all’interno dell’Ue. Ed è ancora tutta da attivare una riflessione giuridica e di tutela dei diritti in relazione alla procedura di controesame e controperizia prevista dal Decreto Legislativo 2021/27 e per quanto riguarda l’art. 70 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in relazione al nuovo meccanismo di estinzione delle pene per molti reati alimentari.
Attendo con interesse la normativa europea sugli enzimi. Se la chiarezza in materia credo sia auspicabile, così come un puntuale controllo di sicurezza di quei componenti alimentari di frequente e non dichiarato impiego, la novella porrà notevoli problemi relativamente ai controlli di conformità d’uso degli enzimi, col rischio più che concreto della creazione di una potente nuova norma con una problematica attività di verifica della sua corretta applicazione nei prodotti intermedi e in quelli finiti. L’auspicio (non costa nulla) è che, nel rispetto della legalità, chi scrive le norme si impegni sempre più a confrontarsi con i vari esperti per migliorare la tecnica normativa e quindi possa essere maggiormente apprezzato ciò che si concretizzi per il cittadino in un atto cogente.
Giuseppe Maria Durazzoal Parlamento Ue European Agri-food industry: the state of play in the EU Parliament

Severaltopics emerged during the 12th edition of the Comagri Report, the annual meeting dedicated to sharing the work done by the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development. Held on the 20th of December at the European
Parliament headquarters in Rome under the coordination of MP Paolo De Castro, the event was also attended by MP Francesco Lollobrigida, Minister for Agriculture, Food Sovereignty and Forestry of Italy. The topics discussed included the slowing down of the European
Green Deal and moving away from the European goal of carbon neutrality by 2050, as well as the difficulties in approving some measures of the Farm to Fork strategy related to agricultural profitability, such as the reduction of pesticides and industrial emissions.
GREEN DEAL, FITOFARMACI, EMISSIONI INDUSTRIALI E TESTO UNICO SULLA

QUALITÀ: ALCUNI DEI TEMI AFFRONTATI AL COMAGRI REPORT 2022
GREEN DEAL, PLANT PROTECTION PRODUCTS, INDUSTRIAL EMISSIONS AND THE CONSOLIDATED TEXT ON QUALITY: SOME OF THE TOPICS ADDRESSED AT THE COMAGRI REPORT 2022
Diverse sono state le tematiche emerse nel corso della dodicesima edizione del Comagri Report, l’incontro annuale dedicato alla condivisione del lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo. Tenutosi lo scorso 20 dicembre, presso la sede del Parlamento europeo a Roma sotto il coordinamento dell’Onorevole Paolo De Castro, l’evento ha visto anche la presenza del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Onorevole Francesco Lollobrigida. Tra i temi affrontati, si segnalano il rallentamento del Green Deal europeo per via della grave crisi economica, il conseguente allontanamento dell’obiettivo europeo della carbon neutrality al 2050, nonché le inevitabili difficoltà di approvare alcuni provvedimenti della strategia Farm to Fork legati alla redditività agricola, quali quelli sugli abbattimenti dei fitofarmaci e delle emissioni industriali. Ancora, si è discusso della partenza del primo Testo Unico europeo sulla qualità dedicato ai prodotti a denominazione di origine, il
quale potrebbe vedere la luce già entro la fine del 2023.
La prima riforma “green” che sembra destinata a slittare oltre i tempi prestabiliti dalla rigida scaletta della Commissione europea, è quella del regolamento sui fitofarmaci. Come noto, la bozza in discussione è nata con l’obiettivo di abbattere del 50% l’uso della chimica in agricoltura entro il 2030. Una soglia temporale che oggi appare quasi impossibile da rispettare. La Commissione europea ha accolto, infatti, nelle votazioni dello scorso dicembre, la richiesta dell’europarlamento, su proposta di 17 ministri europei dell’Agricoltura, tra cui l’Italia, di sottoporre la riforma a una seconda valutazione d’impatto che tenga conto, diversamente dalla prima, anche degli effetti del conflitto russo-ucraino sul settore agricolo. “Non possono non tenersi in considerazione - ha spiegato l’Onorevole De Castro - le grandi difficoltà economiche che
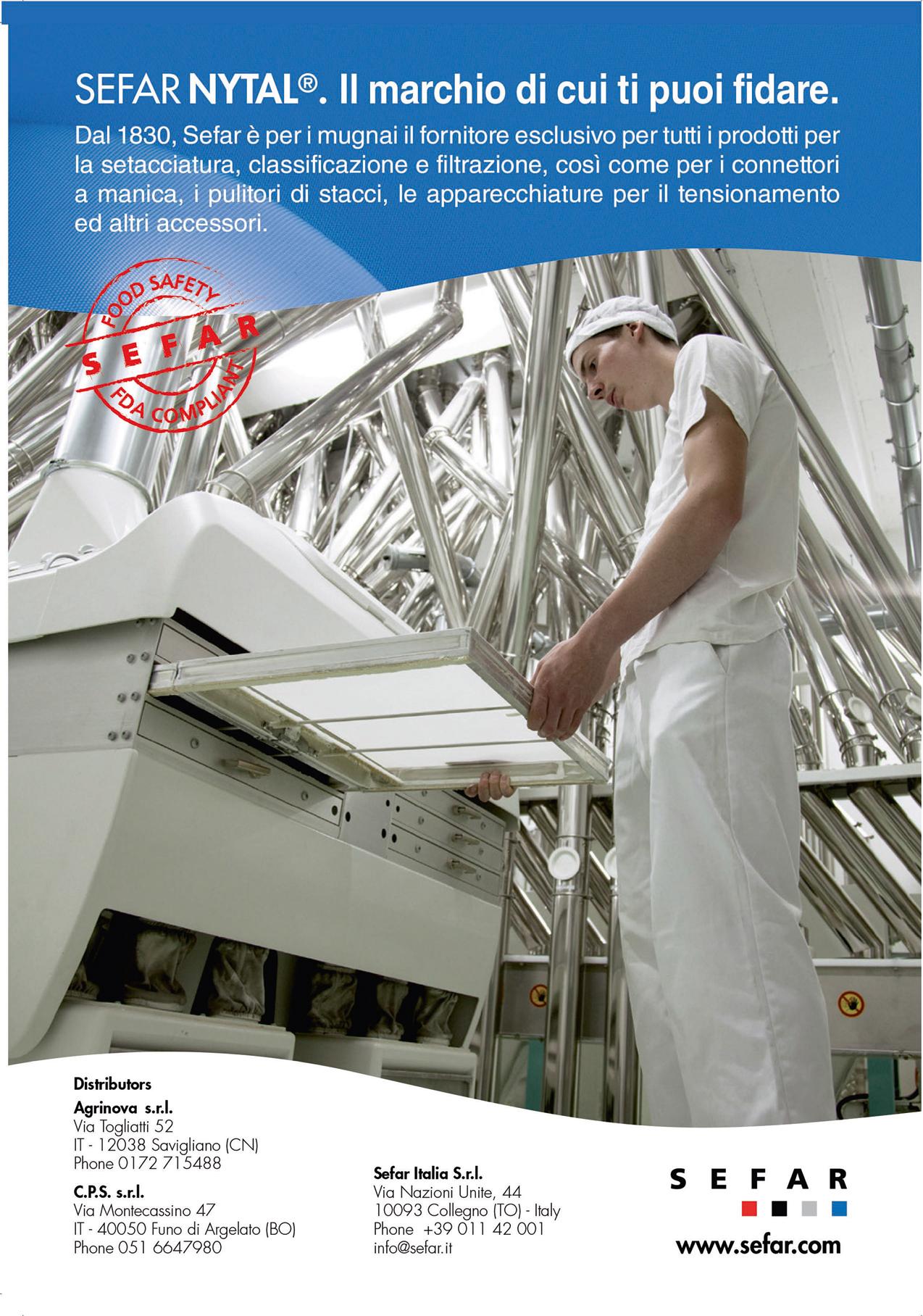
il settore agroalimentare europeo sta affrontando a causa del drammatico incremento dei costi dell’energia e delle materie prime che erodono all’osso i margini di guadagno delle aziende agricole. Questa situazione arriva a sfiorare il paradosso se si considera che nel 2022, la domanda di made in Italy agroalimentare è cresciuta mentre, per contro, in questo stesso anno, molte aziende del settore faranno fatica a chiudere i propri bilanci in positivo”. Il nuovo regolamento sui fitofarmaci è uno di quei provvedimenti della Farm to Fork considerati nevralgici nell’impianto del Green Deal, insieme, fra gli altri, alla bozza per una nuova direttiva sulle emissioni industriali, il cui iter legislativo è anch’esso fonte di preoccupazioni per i parlamentari europei. “Sono due provvedimenti che generano grande apprensione - ha proseguito De Castro -. Per quanto riguarda il regolamento sui fitofarmaci, posto che è indiscusso che tutti vogliamo ridurre la chimica in agricoltura, il problema principale deriva dal fatto che non esistono, a oggi, soluzioni alternative per sostenere la produttività, e quindi il reddito, degli agricoltori. Come se non bastasse, nella prima valutazione d’impatto della Commissione, depositata la scorsa estate, all’Italia viene chiesto di ridurre l’uso dei fitofarmaci del 62%, ben 12 punti percentuali al di sopra dell’obiettivo medio europeo, con la motivazione che nel nostro Paese se ne usano di più rispetto ad altri: circa 6 chili per ettaro rispetto ai 2-3 degli Stati nord europei. Un confronto che non ha senso; non si possono paragona-

re sistemi produttivi diversi. Noi usiamo più fitofarmaci e, si noti bene, in un’ottica di progressiva riduzione che non ci è stata riconosciuta, perché dobbiamo combattere quotidianamente con le fitopatologie in aumento anche a causa del cambiamento climatico che è più accelerato nell’area del bacino mediterraneo. È ovvio che in un Paese del nord Europa dedito alla selvicoltura o all’allevamento, questi problemi siano meno sentiti. Non possiamo chiedere ai nostri agricoltori di fare un tuffo nel vuoto, smettendo di usare la chimica senza che, sul mercato, siano disponibili delle alternative concrete per potere continuare a produrre”.
La seconda valutazione di impatto della Commissione europea, è attesa per l’estate 2023. Una data ritenuta troppo tardiva rispetto alle tempistiche stabilite dalla tabella di marcia del Green Deal, dal momento che l’attuale legislatura europea terminerà a maggio 2024 e che, entro dicembre 2023, s’interromperà l’attività legislativa con la conseguenza che tutti i
provvedimenti in sospeso slitteranno alle votazioni della prossima legislatura. Tra questi, anche quello per l’armonizzazione delle etichette nutrizionali e della battaglia portata avanti dall’Italia contro il Nutriscore già bocciato dall’Antitrust. “Abbiamo vinto una battaglia - ha precisato De Castro - ma non la guerra”.
La matassa da dipanare nella disciplina sui fertilizzanti viene resa ancora più intricata e genera un’ulteriore pressione sull’attività della Commissione, anche a causa del forte aumento dei prezzi che hanno subito i fertilizzanti dopo la guerra russo-ucraina che si attesta intorno al +80%. Negli ultimi giorni di dicembre, proprio a proposito della carenza di fertilizzanti - di cui la Russia è il primo produttore ed esportatore mondiale - la Commissione europea ha presentato agli Stati membri una serie di misure tra cui spicca l’uso dei 500 milioni di euro destinati alla riserva anticrisi della Pac. La mancanza di fertilizzanti genera incertezze sulle potenzialità di resa in tutta Europa, dove gli analisti francesi di Strategie Grains prevedono un calo complessivo delle semine a frumento tenero a 21,67 milioni di ettari contro i 21,78 dell’anno scorso. Una stima che avvalora il dato italiano. Dall’assemblea di Confagricoltura dello scorso 15 dicembre, peraltro, il presidente Massimiliano Giansanti ha proposto l’istituzione di fondo unico europeo per l’acquisto centralizzato dei fertilizzanti, che potrebbe garantire un maggior potere contrattuale agli acquirenti calmierando i prezzi e, in secondo luogo, assicurare una più equilibrata distribuzione geografica dei prodotti. Per ridurre il fabbisogno dall’estero di cereali, gli agricoltori italiani sono pronti a coltivare un milione di ettari più, anche grazie all’ampliamento governativo dei terreni agricoli coltivati e alla sospensione dell’obbligo di rotazione. Obiettivo, ridurre il deficit nazionale che, per il grano duro, è del 35% e, per quello tenero, del 62%. Per questo sono previsti, per le prossime semine, investimenti in crescita a doppia cifra, tra l’8 e il 10%. Una risposta importante a fronte della riduzione della produzione cerealicola globale (-2%) che vede l’Europa esposta con un calo dei volumi
Utilizzata nel settore molitorio per il passaggio del prodotto (semola, farina etc.) viene realizzata in acciaio inox aisi 304 BA sp. 10-12/10 elettrosaldata e saldata a tig con trattamento di lucidatura esterna, nei diametri 105-120-150200-250-300 mm e nei vari componenti quali tubi, settori, settori girevoli, valvole, giunzioni.

Utilizzati nel settore Molitorio e Generico Industriale, vengono realizzati in Acciaio
Zincato Gr.ra Z200 o a richiesta in Acciaio
Inox aisi 304 2b nei spessori 6-8-10-12/10 nei vari Diametri e dimensioni sia per i prodotti standard Seven che per le richieste personalizzate da parte del Cliente.
Used in the Milling and General Industrial fields. Made from Z200 basis weight galvanised steel or, on request, AISI 304 2b stainless steel with thicknesses of 6-8-10-12/10 and various diameters and sizes for both standard Seven products and for customised productions.

Used in the milling sector to convey the product (durum wheat flour, ), these items are made of 10-12/10 gauge 304 BA grade stainless steel, electrically and TIG welded and polished externally; available in 105-120-150-200-250-300 mm diameters and a range of components including tubes, fixed segments and rotatable segments, valves, splices.


del 7,3%, di oltre cinque punti percentuali sopra la media e l’Ucraina con riduzioni fino al 40%. Fattore determinante dato che il Paese colpito dalla guerra ha in attivo un accordo con Russia e Turchia, sotto l’egida dell’Onu, per il transito marittimo dei carichi di grano via Mar Nero grazie allo sblocco dei principali porti lì presenti.
La relazione dell’attività del Parlamento europeo è stata commentata anche dal Ministro Francesco Lollobrigida. “Ci vuole più Italia in Europa - ha affermato -. Siamo molto critici sul ruolo di quest’ultima nel recente periodo poiché, per il modo in cui questa Unione è impostata, dà adito, di fatto, alla concorrenza sleale tra gli stessi Paesi membri. Se le normative sono le stesse per tutti, c’è da chiedersi come mai, nel giro di pochi anni la Germania sia diventata la prima potenza europea e l’Italia, da quarta potenza che era nel 1991, si trova, oggi, economicamente in ginocchio. Crediamo all’Europa come senso di appartenenza ma un sistema che punta a diventare più competitivo deve tenere a mente anche l’elemento di competitività dell’Italia. In merito al nuovo regolamento sui fitofarmaci, per esempio, è chiaro che se non si hanno delle soluzioni alternative alla chimica per combattere gli agenti patogeni in aumento, significherà avere meno prodotto agricolo. E se manca prodotto, bisogne-
rà prenderlo da qualche parte per soddisfare la richiesta del mercato, magari da chi non rispetta gli standard che ci siamo dati. Ed è qui che si crea l’humus per la concorrenza sleale alle nostre aziende”. Secondo Lollobrigida, la posizione italiana è allineata al 90% con quella della Francia dove, a dicembre, è rispuntata una nuova bozza di decreto anti-plastica, avallata dalla Corte Costituzionale del Paese d’Oltralpe, che aggiorna la lista dei prodotti esclusi dal bando europeo e segna un ulteriore dietrofront di Parigi, in tema di imballaggi spinto anche dalla necessità di agevolare lo smaltimento degli stock. Anche sul tema imballaggi e plastica, l’Europa sembra traballare lungo il percorso delineato, secondo quanto riferito da De Castro. “Per quanto riguarda il regolamento sul packaging - ha sottolineato - si parla di spostare la destinazione finale del prodotto sostituendo la parola ‘riciclo’ con ‘riuso’ delle confezioni, che è cosa ben diversa. Tuttavia, il problema principale resterà comunque quello di continuare a garantire la sicurezza alimentare”.
Il secondo provvedimento nevralgico nell’impianto del Green Deal che desta preoccupazione al Parlamento europeo, perché rischia di saltare, è la direttiva sulle emissioni industriali. Su questo punto, lo stesso De Castro ha ribadito che: “non si può equiparare l’inquinamento dell’industria a quello degli allevamenti zootecnici. Nel primo caso le emissioni si disperdono nell’atmosfera nel giro di un millennio circa, nel secondo in meno di dieci anni. Le emissioni da attività zootecniche andrebbero regolamentate in modo diverso”. A sostegno di queste argomentazioni, il Ministro Lollobrigida ha citato uno studio di Assosuini che dimostra come, durante il lockdown ci sia stata una significativa riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera nonostante le attività zootecniche siano andate avanti per soddisfare al fabbisogno alimentare del Paese. La riduzione, per Assosuini, è stata determinata da un abbattimento della circolazione del traffico e della produzione industriale. Il Ministro ha anche annunciato: “Lavoreremo sulla forestazione anche con l’allargamento del registro dei terreni agricoli per dimostrare all’Europa che si è sbagliata per tanto tempo poiché sta pagando un prezzo troppo caro per non produrre come potrebbe o per la dismissione di alcune produzioni. Bisogna impedire questo processo perché non si tutela l’ambiente smettendo di coltivare. Anzi, lo si devasta

TECHNOBINS ha acquisito la rappresentanza in esclusiva per l’Italia di SIMEZA (primaria azienda spagnola per la costruzione di sili ondulati, con sede a Saragozza). Con questa operazione TECHNOBINS è diventata l’unica azienda sul mercato italiano a poter realizzare tutti i tipi di silos metallici per lo stoccaggio di materia prima in grani.





La professionalità di TECHNOBINS consentirà di proporre il prodotto più adatto per ogni esigenza.

se pensiamo ai gravi problemi di dissesto idrogeologico che ne sono derivati. Certamente, va affrontata la questione di ridurre le emissioni, ma va fatto rimanendo ancorati a quei principi che definiscano cosa conviene e cosa, invece, devasta l’ambiente. Dopo la dismissione della grande industria adesso stiamo competendo sul mercato con la qualità delle nostre produzioni agroalimentari. Non possiamo lasciare che venga svilita a vantaggio delle grandi multinazionali che non fanno altro che abbassare il valore aggiunto e monopolizzare il mercato, portando grandi risorse in mano a pochi. Il nostro nemico principale è la standardizzazione dei prodotti e per contrastarla agiremo su diversi livelli comunicativi”.
Dalle attività del Parlamento si annunciano anche due sviluppi positivi. Il primo riguarda il nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche per il quale l’organo legislativo Ue sta lavorando con oltre seicento emendamenti al fine di arrivare a un testo di compromesso sulla proposta della Commissione. L’auspicio è di avere una posizione definitiva anche del Consiglio, e quindi chiudere l’iter legislativo del primo Testo Unico europeo sulla Qualità, entro il 2023, sotto la presidenza spagnola. “Si tratta di un provvedimento - ha detto De Castro - molto atteso dagli operatori e nell’interesse dei consumatori, che va ad aggiornare un sistema che in Italia muove un giro d’affari di circa 20 miliardi di euro. Su questo tema, ci sono 122 proposte della Commissione dentro le quali si affrontano prodotti molto importanti per il nostro Paese come il prosecco o l’aceto balsamico. Abbiamo tutto l’interesse a mettere una pietra tombale ai vari tentativi di evocazione, altrimenti detto ‘Italian sounding’ che colpiscono questa eccellenza italiana”.
L’altra nota positiva riguarda il nuovo regolamento sulla promozione di cui, la Commissione con gli Stati membri ne ha approvato il programma per il 2023. Si tratta di un passo importante perché la proposta è rimasta ferma presso il Collegio dei Commissari europei per tanti mesi dal momento che alcuni Stati Membri volevano escludere dal programma alcuni

prodotti per noi strategici come il vino o la carne. Su questo punto l’europarlamentare Salvatore De Meo, relatore del regolamento, ha sottolineato una sorta di “disallineamento temporale con il provvedimento sulle Ig: materialmente non è ancora disponibile, speriamo che il Collegio dei commissari ce lo sottoponga con la pubblicazione nel nuovo anno”. “Questo nuovo impianto normativo - ha specificato De Castro - metterà ordine a un settore che a partire dagli anni Novanta ha visto aumentare notevolmente il numero dei prodotti Dop, Igp e Stg, rendendo necessario un aggiornamento e una semplificazione delle procedure e mettendo i Consorzi di tutela nelle migliori condizioni per difendere le nostre eccellenze da evocazioni e tentativi di imitazione, purtroppo sempre più diffusi”. Una posizione condivisa dal Ministro Lollobrigida che ha osservato come in questa fase “il ruolo dell’Italia nell’Ue è sotto attacco, per problemi circoscritti e individuali, non solo per i casi di corruzione, ma anche per tutto ciò che riguarda la qualità, che va difesa a livello di Sistema Paese”. Dal canto suo, l’europarlamentare Camilla Laureti ha osservato l’importanza del programma
di educazione alimentare “Frutta e latte nelle scuole”, per il quale, ha detto: “gli Stati membri per ora sono riusciti a spendere solo il 10% delle risorse finanziarie a disposizione”.
Tra i temi affrontati durante l’incontro, anche lo stato di applicazione della direttiva 633/2019 contro le pratiche commerciali sleali recepita in Italia con D. Lgs n. 198/2021. “A giorni pubblicheremo i dettagli nella relazione annuale - ha anticipato il Capo dipartimento dell’Icqrf, Felice Assenza -. A un anno dall’applicazione, abbiamo fatto più controlli di quanti non ne abbia fatti negli ultimi dieci anni l’ente precedentemente preposto che era l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Le nostre indagini si sono concluse con l’irrogazione di sanzioni a carico dei retailer nel 10-15% dei controlli, con previsioni di incremento delle irregolarità accertate nel 2023 anche per via un piano di rinforzo del personale preposto all’Icqrf, appena decretato da Ministero”. Intanto, entrerà in vigore nel 2023 il Piano strategico della Pac che Angelo Frascarelli, presidente di Ismea, ha definito multi-obiettivo, con un budget per l’Italia di circa 7,3 miliardi l’anno, fino al 2027. “È una Pac più selettiva - ha detto Frascarelli - che premia la produttività e la qualità a invarianza di fondi rispetto ai prezzi correnti, in confronto alla precedente programmazione”.
La Redazione
ANCHE LE FARINE PIÙ “INNOVATIVE”

NON POSSONO PRESCINDERE DALLE CARATTERISTICHE INTRINSECHE DELLE MATERIE PRIME
EVEN THE MOST “INNOVATIVE” FLOURS CANNOT DISREGARD THE INTRINSIC CHARACTERISTICS OF RAW MATERIALS
Inthis article, the author takes a brief look at flours and their ingredients. At present, many mills are actually looking for new products to meet the demands of professionals and nonprofessionals who are increasingly attentive to the use of high-quality processed products in terms of aromatic bouquets, semi- and wholemeal flours that can support them in the production of highhydration and long-processing products. In short, the flour market is rapidly changing. However, it would be wrong to think that certain products are “better” than others because of their structure.

Si narra che tutto iniziò grazie a un chicco di grano che un nostro antenato trovò, annusò e schiacciò tra i denti per assaggiarlo. Mille anni dopo in Egitto a seguito di un’inondazione del Nilo vennero sommerse le scorte di farina. Le favorevoli condizioni ambientali e le colture batteriche naturali presenti nell’ambiente stesso dettero luogo a una reazione chimica: la “fermentazione”. Per salvare le scorte di farina bagnata si provò a rimescolarla con altra asciutta e in questo modo si venne a conoscenza della lievitazione tramite fermentazione spontanea. Con l’introduzione del forno con camera di combustione separata da quella di cottura si ebbe la rivoluzione in termini di cottura. Gli Ebrei non avendo a disposizione il lievito crearono un pane privo di lievitazione. I Romani adottarono i procedimenti di panificazione degli Egizi e furono i primi a utilizzare un mezzo meccanico per impastare gli ingredienti.
In Grecia si preferiva aggiungere alla pasta di riporto del succo d’uva per rendere il pane ancora più prelibato. In realtà, si racconta che già nel III secolo a.C. i Greci fossero divenuti maestri nella panificazione, con la produzione di ben 70 tipi di pane. I semi, per la produzione della farina, venivano dapprima separati dalle spighe mietute e successivamente tostati e frantumati grazie all’ausilio di due pietre. La farina bianca, a causa dei molteplici processi di lavorazione, aveva un alto valore commerciale e solo i benestanti potevano permettersela. Più era bianca e maggiore era il suo pregio, assumendo il ruolo di simbolo del rango sociale e del-


la ricchezza di una persona. Con il motore a vapore si iniziò a inventare metodi e macchinari sempre diversi, per la produzione di farine di vario tipo e in larga scala. Nel XIX secolo, poi, nacquero realizzazioni uniche e rivoluzionarie. Furono introdotti i rulli d’acciaio che frantumavano e polverizzavano i semi, migliorandone così la raffinazione, e il sistema delle molle che separava meglio la crusca e il germe.
Nelle industrie moderne, il grano subisce diverse lavorazioni. I semi vengono puliti, finemente macinati, polverizzati e setacciati per separarli dalla crusca e rendere la farina più fine. Il germe viene asportato per permettere una più lunga conservazione della farina. Esso verrà usato successivamente o trasformato in olio. Oggi, nel mondo, la coltivazione del frumento è la più estesa e la più importante. Come noto, il frumento è il cereale più utilizzato nell’alimentazione umana e rappresenta un’ottima fonte energetica e una discreta fonte di proteine, sali minerali, vitamine e fibre. È largamente coltivato per via della sua adattabilità ai vari tipi di terreno e di clima. Se il grano tenero si è diffuso nelle aree fresche temperate e piovose, il grano duro si è sviluppato e adattato nei climi caldo-aridi del Mediterraneo grazie alla maggiore resistenza alla siccità. Nel primo la cariosside si presenta alla frattura bianca e sfarinabile e fornisce farine adatte alla panificazione, mentre la cariosside di grano duro si presenta alla frattura di colore ambrato e a spigo-
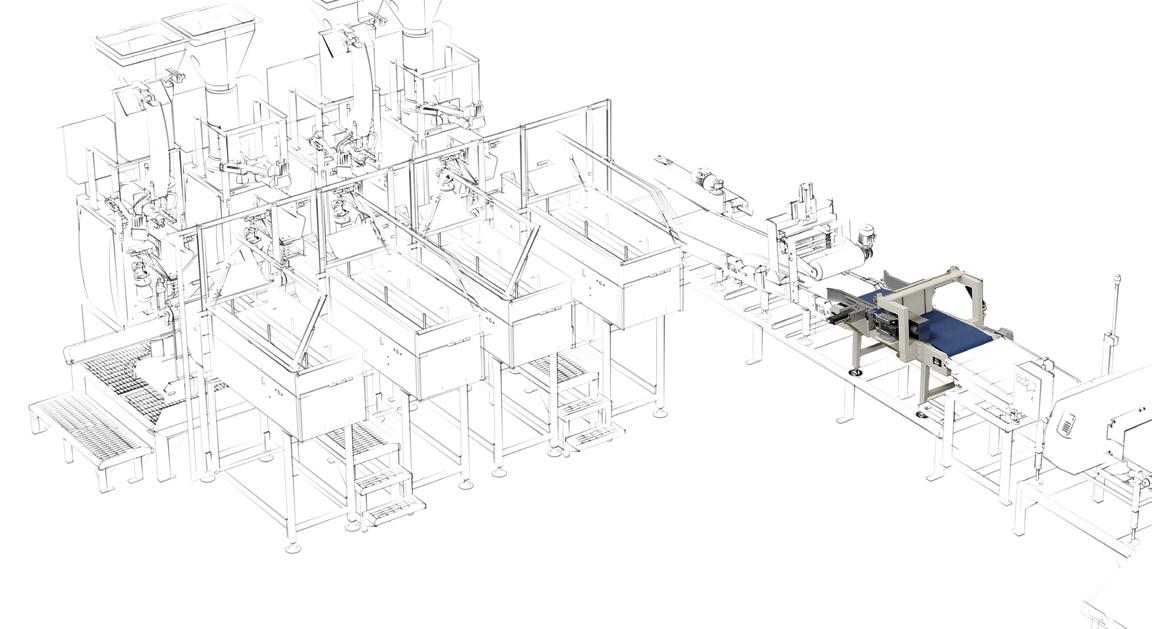


li vivi e fornisce la semola utilizzata nella produzione di pasta. La parte corticale della cariosside di frumento, nota anche come crusca, ha una funzione prevalentemente protettiva ed è ricca di fibre cellulosiche, pentosani, ceneri (sali minerali) e composti bioattivi. L’endosperma è composto dallo strato aleuronico e dall’endosperma vero e proprio. Lo strato aleuronico è formato da uno strato di cellule in cui sono immagazzinati proteine ad alto valore biologico, vitamine, sali minerali, enzimi e lipidi. La maggior parte della cariosside è occupata dall’endosperma, costituito da granuli di amido immersi in una matrice proteica. Il contenuto in proteine diminuisce dalla periferia verso l’interno, non solo come quantità, ma anche come qualità. La forma e la dimensione dei granuli di amido sono caratteristici per ogni cereale. L’embrione è ricco di proteine e lipidi (acidi grassi essenziali) e vitamine (in particolare vitamina E) ed è rivestito da uno strato epiteliale detto scutello, che fornisce sostanze nutritive utili allo sviluppo della futura pianta durante la germinazione. L’embrione viene di solito eliminato durante la macinazione per la presenza di grassi che, ossidandosi, limiterebbero la conservazione della farina.


Come noto, uno dei cereali più antichi al mondo è il farro, e dal latino “far” prende vita la parola “farina”. I mulini sono da sempre alla ricerca di nuove varietà genetiche per rispondere a esigenze ambientali
e qualitative come la produttività, la resistenza alle malattie e agli stress ambientali. La prima fase è la selezione dei grani tra italiani ed esteri, perché oggi non si riesce a soddisfare la richiesta di grano e tramite accordi europei si acquistano grani da molte parti del mondo, con caratteristiche diverse tra loro. In tal senso, importanti sono gli agenti atmosferici, che influiscono sulla crescita e sulle caratteristiche della materia prima. Con l’arrivo al molino, ancora oggi il primo controllo è quello visivo: si prende una campiona-
tura del carico e si controlla se non siano presenti tanti grani rotti, corpi estrani in percentuali alte, per poi passare al controllo del peso specifico e all’analisi a livello qualitativo. Alcuni molini sono dotati di determinate attrezzature per il controllo dei chicchi di grano, si tratta di selezionatrici ottiche che verificano che il singolo chicco non contenga elementi nocivi per la salute del consumatore finale. Una volta che il grano è pronto alla prepulitura da corpi estranei (pietre, erbacce), nella fase successiva verranno macinate delle campionature per determinare le varie qualità reologiche che determineranno il comportamento delle farine durante le fasi di lavorazione. La macinazione del grano, come noto, può avvenire o per schiacciamento (tipicamente la macinazione a pietra) o per estrazione (macinazione a cilindri). La macinazione a cilindri semplifica la separazione delle parti cruscali, in quanto nei vari passaggi si “sbuccia” il chicco di grano per estrarre la sacca di endosperma interna. In questo modo, nel processo di molitura, si ottiene un numero di granuli intorno al 4/10% per le farine 0/00 di amidi danneggiati e, quindi, più facilmente attaccata dagli enzimi diastatici. Questo porta ad avere una farina che, durante il processo di maturazione dell’impasto svilupperà una quantità di zuccheri maggiore messi a disposizione dei lieviti e dei processi in cui sono coinvolti. Un tempo, per ottenere le farine, si usava il buratto, uno strumento nato nel 1909 per opera di un mugnaio, caratterizzato da una struttura tubolare lunga a sezione esagonale, ricoperta da strati di tela forata di varia tessitura. Posto all’u-









scita della macina a pietra, faceva passare al suo interno la farina in uscita, ottenendone una più raffinata e un’altra più grezza che invece usciva dalla fine del buratto. La farina è costituita essenzialmente dall’endosperma amidaceo e può contenere delle impurità in grado variabile a seconda della categoria merceologica alla quale appartiene (D.P.R. n. 41 del 5 marzo 2013). Infatti, gli sfarinati possono essere suddivisi in cinque tipologie, di seguito riportate in ordine decrescente di raffinatezza: 00, 0, 1, 2 e integrali. Le farine integrali contengono l’endosperma amidaceo, il germe e i tegumenti della granella e per questo hanno un maggior valore nutrizionale rispetto a quelle raffinate. Le proteine del frumento possono essere suddivise in quattro classi in base alla loro solubilità in solventi diversi: albumine (solubili in acqua), globuline (solubili in soluzioni di cloruro di sodio), gliadine (solubili in soluzioni di etanolo 70% (v/v)) e glutenine (solubili in soluzioni di acido acetico) (Osborne, 1924). Albumine e globuline sono essenzialmente proteine enzimatiche, ricche in amminoacidi essenziali, localizzate nell’embrione e nell’aleurone. Gliadine e globuline, invece, fungono da proteine di riserva e sono collocate nell’endosperma (Belitz et al., 2009). Oggi possiamo trovare alcune tipologie che nascono dal grano tenero: la 0, 00, tipo 1, tipo 2, integrale. Durante il processo molitorio in primis viene separata la crusca e il germe di grano, quest’ultimo limita la shelf life delle farine, alcuni molini hanno scelto la strada di aggiungerlo in una fase successiva in quantità minori, come anche alcune parti cruscali vengono inserite in una fase successiva per realizzare le semi integrali, per donare una spinta in più sotto i profili aromatici finali all’interno degli impasti. Ovviamente ci sono altri processi che possono donare un sapore finale ai nostri prodotti, come ad esempio una corretta fermentazione, una gestione delle temperature dove enzimi, lieviti e batteri riescano a lavorare al meglio. La distinzione tra le diverse farine viene rappresentata dalla percentuale massima di ceneri al suo interno: come noto, si parte dalla classica 00 con una percentuale massima di ceneri dello 0,55%, passando alla farina 0 con un massimo di ceneri dello 0.65%, successivamente si passa alle farine se-
mi integrali. Nella categoria delle farine semi integrali è possibile trovare la farina di tipo 1 con un quantitativo massimo di ceneri del 0,80%, in fine la farina di tipo 2 con una % massimo di ceneri dello 0,95%. Vengono classificate come farine integrali le farine con una percentuale di ceneri massima tra 1,3/1,7%.
La maggior parte dei molini è da sempre predisposta alla ricerca di nuovi prodotti per soddisfare la richiesta dei professionisti e degli amatoriali sempre più attenti nell’impiego di lavorati di alta qualità sotto il profilo dei bouquet aromatici, di farine semi integrali e integrali che possano supportarli nel realizzare prodotti ad alta idratazione e a lunghe lavorazioni. Negli ultimi anni sono aumentati i prodotti con alte idratazioni e lunghe lievitazioni; un po’ per moda, un po’ per un messaggio errato dei vari social, dove si pensa che più il prodotto sarà idratato più esso sarà digeribile. A oggi una parte di mercato pensa che una farina 0 sia meno salutare di una farina tipo 1 o tipo 2, senza un riscontro scientifico, ma solo per la differenza di ceneri (sali minerali) all’interno di esse. Ovviamente è chiaro che si sta parlando di una percentuale minima tra le farine citate, senza dimenticare poi che entrambe le farine sono molto simili come percentuale di glutine. È possibi-
le trovare farine con caratteristiche simili tra loro come il W (indice di forza della farina), il P/L (indice di tenacità/estensibilità) e altri fattori, con unica differenza del quantitativo di sali minerali. Perciò una farina 0 o una tipo 2 potranno avere caratteristiche simili, la differenza si potrà notare durante i processi di lavorazione. Alcune farine presentano delle parti cruscali a foglia larga che si possono cogliere a occhio nudo. Esse potrebbero avere problemi durante le fasi di puntata degli impasti andando così a compromettere la struttura del glutine; viceversa si possono reperire farine con delle parti cruscali fini per non compromettere la struttura finale degli impasti.
Negli ultimi mesi, sono sopraggiunte consulenze da parte di clienti che erano alla ricerca di farine semi integrali perché nutrivano la convinzione che si potessero ottenere dei prodotti più digeribili: informazione errata. Al massimo si potrebbero ottenere prodotti più completi a livello di profumi e sapori.
 Andrea Aimar
Andrea Aimar

What is the situation of Italian water resources? What are the proposals to solve the increasingly frequent problem of droughty summers and winters? Based on the statements by associations and consortia, the author analyses the topic, highlighting critical issues and mentioning both potential and current projects. Among the latter is the so-called “Piano Laghetti” promoted by the Italian Association of Water and Land Reclamation Consortia (Anbi), which aims at creating about 10,000 artificial reservoirs along the peninsula using landfill and collecting rainwater for irrigation purposes and the production of green energy. The plan also includes the so-called “river contracts”, which represent an alternative tool for the integrated and systemic management of water basins.
Le nevicate di gennaio potrebbero salvare l’Italia dalla grave siccità paventata dopo l’esperienza del 2022. Quello che preoccupa gli esperti, oltre alla crisi idrica che colpisce tutti i principali bacini italiani, è anche il moltiplicarsi di eventi estremi. Secondo l’European Severe Weather Database (Eswd) siamo su una media di oltre cinque al giorno. La mancanza di infrastrutture per la raccolta delle acque piovane e la carenza idrica nei principali bacini e fiumi della Penisola, mette
in crisi le produzioni cerealicole. Molti di questi sono ben al di sotto della loro portata media con possibili e nefaste conseguenze per la prossima campagna agricola. Se nel 2022 si sono raccolti, lungo tutta la penisola, dal 10 al 30% in meno dei volumi di frumento, nel 2023 la situazione potrebbe non migliorare, nonostante le nevicate, stanti le condizioni di progressiva perdita di portata dei fiumi e di pesante assottigliamento delle risorse di falda, secondo quanto riportato dal Cnr in
un comunicato del 12 gennaio scorso. Per ovviare a questi problemi, l’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica (Anbi) ha messo in campo, all’inizio dell’estate scorsa, il cosiddetto “Piano Laghetti”. Esso punta alla costruzione di circa 10mila invasi artificiali lungo la Penisola per raccogliere le acque piovane che saranno sfruttate sia per scopi irrigui sia per la produzione di energia verde. Contemporaneamente sta decollando l’attività del Tavolo nazionale dei contratti fiume, costituito
nel 2007 e coordinato dall’architetto Massimo Bastiani. Questi accordi, che vedono nelle Autorità di bacino distrettuali la controparte, rappresentano uno strumento alternativo per la gestione integrata e sistemica dei bacini idrici. Gestione che viene realizzata attraverso intese e azioni specifiche attivate tra i vari utilizzatori di acqua (agricoltori, aziende ecc.) che operano lungo l’intero corso dei fiumi. Recentemente, poi, il Tavolo nazionale ha ottenuto anche un supporto finanziario da par-

te dell’Europa, con l’inserimento di questi strumenti di gestione nell’accordo di partenariato, previsto per il prossimo luglio, tra Italia e Commissione europea.
La siccità e quindi la produttività dei campi, incidono inevitabilmente sull’andamento del mercato. Il quadro, all’inizio dell’anno, si presenta ricco di luci e ombre. Secondo i dati Ismea, tra la metà di dicem-
bre 2022 e i primi dieci giorni di gennaio 2023, i prezzi del frumento duro fino nazionale sono stati stabili nelle borse merci di Roma, Bari, Milano e Bologna, in calo invece a Foggia e Altamura. Contemporaneamente, secondo i dati sulle importazioni dell’Italia, riportati dall’Ufficio Studi della Borsa merci telematica italiana (Bmti) a fine dicembre 2022, “L’attuale annata continua a registrare un deficit di arrivi di grano duro extracomunitario. Dal primo luglio le importazioni

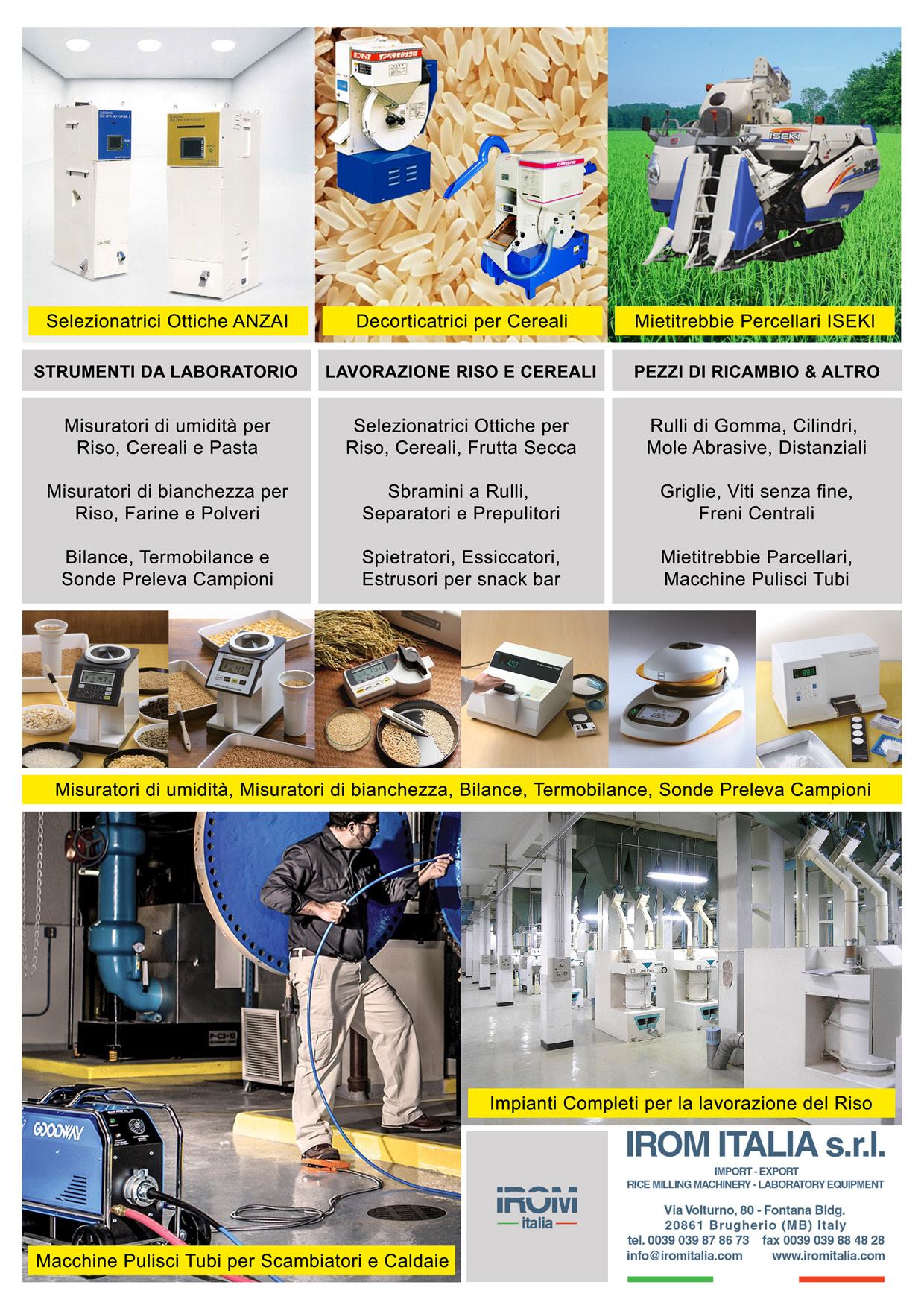
sono state di fatto dimezzate (-48%, pari a 291mila tonnellate) rispetto allo stesso periodo dell’annata precedente a fronte però di acquisti nominali di 598mila tonnellate (il doppio) di cui 400mila provenienti solo dal Canada. Questa differenza può esser spiegata, secondo la Bmti, dal fatto che molto del grano duro comprato nel Paese nordamericano da o per acquirenti italiani, viene riesportato. Tale deficit di import di grano duro in Italia non è sinora servito a rianimare i prezzi del prodotto nazionale che registrano riduzioni importanti. Una situazione che si sviluppa in un contesto in cui, secondo le proiezioni dell’associazione europea Coceral relative a metà dicembre, si registra una sostanziale stabilità delle superfici seminate: 1,3 milioni di ettari pari al -1,1% rispetto al 2022.
Per la Bmti, i prezzi dei principali cereali nazionali hanno mostrato ulteriori cali all’inizio di dicembre, rivelando un rallentamento a ridosso delle festività natalizie quando i listini sono tornati più stabili. I mercati sono apparsi comunque deboli, condizionati, nel caso del grano tenero e del mais, dalla disponibilità di merce estera. Nonostante la fase di calo, i prezzi di mais e grano tenero hanno chiuso il 2022 in crescita rispetto all’anno precedente (+17,7% per il mais, +7,1% per il grano tenero). Negativa la variazione per il grano duro in discesa di quasi il 10% rispetto ai prezzi record di fine 2021. Nella seduta dell’Associazione meridionale cerealisti di Altamura del 23 dicembre 2022, il grano duro canadese di prima qualità ha registrato un calo di 5 euro sul 16 dicembre precedente, attestandosi a 474 euro alla tonnellata sui minimi e 477 euro sui massimi. In sostanza, questo cereale ha perso 72 euro dal 29 luglio dell’anno appena concluso.
In questo contesto economico, l’andamento climatico dell’inverno in corso gioca un ruolo nevralgico. Secondo i dati dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche del Paese, aggiornato al 23 dicembre scorso, la siccità nel Nord Italia ha ormai caratteristiche endemiche che suscitano grandi preoccupazioni. È ormai acclarata una netta differenza tra la situazione idrica nell’Italia centro-meridionale, dove abbondanti
piogge hanno rivitalizzato i corpi d’acqua superficiali. Nelle aree settentrionali, nonostante le recenti precipitazioni, fiumi e bacini sono in grande sofferenza.
Tutti i grandi invasi del nord sono vicini ai minimi di capacità: il lago d’Iseo, ad esempio, è sceso al 24,3% (un anno fa era al 61,4%), mentre il Garda, sceso al di sotto del 33%, è a un terzo, mentre a dicembre 2021 era al 78,6%.
Preoccupa la portata del fiume Po che, in Piemonte, resta stabile sui drammatici valori del 2021. In questa Regione rimane sempre grave anche la situazione degli altri fiumi, che registrano quasi tutti una decrescita con un’unica eccezione per il Tanaro, che supera di poco i valori del 2021 comunque considerato un anno molto critico.
“La situazione del Po sta diventando critica - dichiara Massimo Gargano, direttore Anbi -. Se nel 2022 aveva una portata di 470,87 m3 al secondo, il 10 gennaio 2023 era scesa a 394,7 m3. L’Adige, in Veneto, mantiene la stessa situazione del 2022. Decisamente diversa è la condizione dei corpi idrici del centro e sud del Paese che tendenzialmente garantiscono un sufficiente approvvigionamento di acqua. Qui sono in decrescita l’Ombrone, unico fiume toscano con andamento negativo, il Garigliano e il Sele in Campania. Nelle
Marche, i livelli dei fiumi restano sostanzialmente stabili. In Umbria, per le piogge, il lago Trasimeno, si è alzato di 20 cm riducendo così il divario dalla soglia critica, fissata a -12 cm. Il Tevere si mantiene a un livello idrometrico superiore ai due metri. La controtendenza del sud Italia sul tema siccità, è data anche dagli investimenti della Cassa del Mezzogiorno che hanno infrastrutturato le aree che hanno retto i colpi della siccità. Anche per questo, nessun problema si registra in Sardegna che pure è, tra le regioni del sud Italia, la più siccitosa”.
Lo scorso 10 gennaio è stato siglato l’accordo di finanziamento del Pnrr dal Ministero dell’Ambiente ad Aipo per il progetto di “Rinaturazione del Po”. Tuttavia la situazione del bacino rimane ancora drammatica proprio a causa di una mancanza di coordinamento dei prelievi d’acqua da parte degli stakeholder da monte (Piemonte e Lombardia) a valle (Emilia-Romagna e Veneto). Oggi i prelievi sono gestiti dalle concessioni regionali, ma in tempi di grave siccità come questi servirebbe una visione d’insieme che tenga conto di una distribuzione concertata a livello interregionale e che sia proporzionale, per le varie aree, in base alla disponibilità di acqua.
Intanto, la sigla dell’intesa dà inizio alla fase operativa per la realizzazione dei numerosi interventi lungo tutta l’asta del Grande Fiume. Prossimo passaggio, la mappa capillare delle opere nelle diverse province del bacino interessate dai lavori. La quota

di finanziamento anticipato su cui si potrà contare è di 357 milioni di euro. Il piano d’azione - redatto dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in tandem con lo staff tecnico di Aipo - è sostenuto dall’Unione europea grazie al Next Generation EU.
Esso punta a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche, dopo oltre cinquant’anni di eccessiva pressione su acque e consumo di suolo oltre a escavazioni nel letto del fiume. L’obiettivo è quello di passare da un modello economico e sociale basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse ambientali a uno che, invece, impieghi, protegga e valorizza il capitale naturale, ponendolo alla base del modello di sviluppo. “Ci sono degli elementi che dovrebbero essere presi in considerazione in questa fase di grave siccità e che riguardano la gestione del Po - spiega Paola Zanetti, codirettrice tecnica del consorzio Emilia centrale competente per la gestione e manutenzione dei bacini -. Si pensi ad esempio al fatto che per il mais, che è una delle principali colture della nostra area con circa 3mila ettari (18% delle superfici), un quarto della produzione viene utilizzata come biomassa, ma a oggi non esistono delle evidenze scientifiche sul fatto che la resa energetica green derivata dalla biomassa di mais (coltura idrovora), giustifichi il grande impiego di acqua ed energia soprattutto per pomparla e distribuirla. Stessa riflessione andrebbe fatta, ad esempio, sui prati stabili coltivati a foraggere. Rappresentano il 40% dei campi che serviamo ma la quota di acqua che assorbono è sproporzionata: 48% del totale.

In questa stagione, fra l’altro, stiamo registrando un aumento delle coltivazioni di grano tenero dalla riconversione di quelle a mais, perché non ha bisogno di irrigazioni dato che si approvvigiona dalla falda superficiale.
L’attuale situazione del Po è legata anche alle sorti dei grandi laghi, in particolare il lago Maggiore, e alla carenza di manto nevoso sulle Alpi che sembrerebbe comunque mitigata dalle recenti nevicate. Comunque, in questi giorni abbiamo iniziato a prepararci per le irrigazioni della stagione calda che prevediamo saranno anticipate di un mese (già da giugno), per l’aumento delle temperature”. Tra gli strascichi della passata estate siccitosa che incidono sui consorzi di bonifica che operano lungo il corso del Po, c’è quello di dovere rimediare ai danni subiti dalle pompe idrovore quando hanno lavorato molto intensamente e su livelli bassi del fiume, con la conseguenza che aspirando acqua sabbia e fango, si sono usurate anzitempo e necessitano di essere riparate.
“La mancanza di una visione sistemica dell’uso dell’acqua del Po - precisa Zanetti - fa mancare l’acqua nelle zone a valle del fiume, per esempio il basso Veneto o Ferrara, nelle province situate sul delta del bacino. Qui, gli operatori di quei terreni devono anche misurarsi con la penetrazione dell’acqua salina nell’entroterra (anche fino a 20 km) a causa della mancanza di portata. E anche gli affluenti non stanno meglio. Per questo stiamo pensando a nuove tecnologie per efficientare l’uso della risorsa idrica soprattutto in periodi come questi in cui la portata è al di sotto delle ordinarie medie mensili”.

Nella Pianura Padana i bacini dell’Enza e del Secchia, che soffrono cronicamente di mancanza d’acqua per la loro posizione orografica.
Secondo Anbi, non si placa la grave crisi idrica registrata da mesi, neanche sul territorio piacentino con i volumi idrici trattenuti nelle dighe di Molato e Mignano inferiori alla media, così come le portate di fiumi e torrenti.
La situazione è tale, che il presidente del Consorzio di bonifica di Piacenza, Luigi Bisi, raccomanda alle imprese agricole: “La massima prudenza nella programmazione dei piani colturali, soprattutto se sprovvisti
• Dati statistici e andamento settore molitorio;
• Elenco dei Molini a frumento tenero e frumento duro operanti in Italia, suddivisi per regioni;
• Elenco delle associazioni italiane, comunitarie ed estere del settore cerealicolo e molitorio.
Per maggiori informazioni sui contenuti del volume: www.avenuemedia.eu nella Sezione Editoria - Libri
M o DA l ITÀ DI ACqu I s To:
• Online sul sito www.avenuemedia.eu nella sezione Editoria - libri.
• Compilando e inviando a dir@avenue-media.eu il seguente coupon.
28,00 €
Cedola di acquisto "annuario Di MoLini D'iTaLia - X Edizione"

❏ Versamento con carta di credito (dati criptati) dal sito www.avenuemedia.eu - libri
❏ Bonifico bancario intestato ad Avenue media srl, Viale Aldini Antonio 222/4, 40136 Bologna.
Banca d’appoggio: Banca Popolare Emilia Romagna Ag. 7 Bologna, IBAN: IT15V0538702406000000437531
❏ Versamento su ccp n. 18182402 intestato ad Avenue media srl, Viale Aldini Antonio 222/4, 40136 Bologna. Si allega il bollettino di ricevuta:
❏ in busta chiusa ❏ con spedizione via fax al n. 051.6564332
Importo: Euro 29,50 (volume 28,00 Euro + spedizione Italia 1,50 Euro)
Causale: Acquisto e spese di spedizione 1 copia “ANNUARIO DI MOLINI D’ITALIA - X Edizione”
Il libro va spedito a (scrivere in stampatello):
Nome
Cognome
Azienda

Codice fiscale/P. Iva (obbligatorio) Via N°
CAP Città Prov. Tel. Email
LEGGE PRIVACY - Tutti i dati rilasciati verranno raccolti e trattati (in modalità manuale ed informatica) nel rispetto del D.lgs 196/03 anche per l’eventuale invio di materiale informativo e/o promozionale. I dati non verranno diffusi a soggetti esterni ad eccezione di istituti bancari, società di recapito corrispondenza, aziende da noi incaricate per la gestione dei servizi. È suo diritto chiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento: Avenue media srl, Viale Aldini Antonio 222/4, 40136 Bologna. Può trovare il testo integrale della legge con l’enunciazione di tutti i Suoi diritti (titolo II) sul sito www.avenuemedia.eu al link Legge privacy.
Laguida peradeguare
alla transizione ecologica




Prodotti e tecniche innovativi Paolo Ranalli
Come rendere sostenibile la filiera agroalimentare?
In questo volume l’Autore affronta il tema del momento: la transizione dei sistemi agricoli verso nuovi modelli produttivi.

Vengono esposti concetti come biodiversità , ecosistema , farming e definiti gli strumenti per la valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale. Un richiamo è anche alle nuove frontiere dell’agricoltura, al suo futuro smart e al cibo che verrà.

Il filo “verde” che attraversa e lega le scelte future delle aziende agricole si chiama innovazione. Declinata su misura d’uomo e dell’ambiente.
Per maggiori informazioni sui contenuti del volume:

www.avenuemedia.eu nella Sezione Editoria – Libri


€ 32,00
• Online sul sito www.avenuemedia.eu nella Sezione Editoria - Libri. Pagamento con carta di credito o bonifico bancario
• Compilando e inviando a dir@avenue-media.eu il seguente coupon





















Cedola di acquisto “Transizione ecologica in agricoltura” Edizioni Avenue media®

Recapiti per la spedizione
Nome e Cognome o Ragione Sociale dell’Azienda .......................................................................................................................................................... Via
Dati per la fatturazione
Nome e Cognome o Ragione Sociale dell’Azienda .......................................................................................................................................................... P.IVA o Codice Fiscale ...............................................................................................................
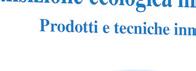


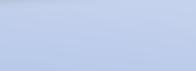

Bonifico bancario intestato a Avenue media - Viale Aldini 222/4, 40136 Bologna Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. n° 7, via Lame - Bologna - Iban: IT15V0538702406000000437531
Causale: Acquisto e spese di spedizione 1 copia “Transizione ecologica in agricoltura” Importo: Euro 33,50 (volume 32,00 Euro / spedizione Italia 1,50 Euro)
laproduzioneagricola
di fonti alternative come pozzi o vasche aziendali.” Negli invasi dell’alta val Tidone (Molato) e di Vernasca (Mignano) mancano complessivamente 3,8 mln di m3 d’acqua, rispetto alla media degli ultimi dieci anni, nonostante tra il 2021 e 2022 non siano state effettuate le procedure di svaso. La portata del fiume Po si è attestata sotto al minimo storico mensile e in deficit sono anche il fiume Trebbia, il torrente Nure e le falde acquifere.
“Di fronte a questa fase anomala e preoccupante, è importante che si inizino a concertare le soluzioni più adeguate per aumentare la resilienza dei territori, nel caso in cui la situazione idrica non andasse migliorando” indica Francesco Vincenzi, Presidente dell’Anbi. “La disponibilità d’acqua per l’irrigazione - aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - non condiziona solo l’agricoltura, ma l’economia agroalimentare del territorio: pomodoro e mais sono il volano dell’economia primaria piacentina. Per questo diventa prioritario aumentare la capacità di stoccare acqua, quando arriva, per distribuirla, quando serve.
La preoccupazione sulla risorsa idrica in Emilia-Romagna è data anche dal fatto che in questa Regione si produce un terzo dei volumi cerealicoli nazionali, prevalentemente grano tenero. Il 9 gennaio, a causa dell’assenza di precipitazioni, la vicepresidente della Regione con delega all’ambiente, Irene Priolo, ha convocato un incontro di aggiornamento della cabina di regia sulla criticità idrica (con aggiornamento previsto a febbraio in un incon-
tro con gli enti locali), attivata con la dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale, lo scorso 4 luglio e prorogata fino al 31 dicembre 2023.
“Occorre fare quanto prima - ha detto Priolo - una seria valutazione sui provvedimenti necessari per non farci trovare impreparati nella prossima stagione estiva, con un focus particolare sulla Romagna e sulla diga di Ridracoli”.
Con le risorse assegnate dal Governo per far fronte all’emergenza siccità 2022, in Emilia-Romagna sono già stati conclusi o sono in corso, 13 dei 58 interventi programmati per complessivi 8,7 milioni di euro. Pronti a partire altri 21 per un costo di 1,8 milioni di euro. Oltre alla situazione dei fiumi, poi, c’è da analizzare i livelli delle falde che, al 10 gennaio 2023, risultano in generale più bassi dappertutto rispetto a gennaio 2022, a eccezione del conoide Trebbia-Luretta nel piacentino. Particolare attenzione è riservata alla situazione del conoide del fiume Reno e del Marecchia. Per quanto riguarda gli invasi, il Suviana registra un riempimento al 75% (-25%); Ridracoli al 65% circa (-35% ma in ripresa); Brugneto (59%; -41%), Mignano 33% (-67%) e Molato appena al 3% (-97%).
Il cosiddetto “Piano Laghetti”, presentato da Anbi insieme a Coldiretti la scorsa estate, per la realizzazione in Italia di 10mila invasi artificiali entro il 2030, utilizzando terra di riporto, ha l’obiettivo di raccogliere le acque piovane e sfruttarle sia per scopi irrigui sia per la produzione di energia verde fotovoltaica e idroelettrica.

“Oggi riusciamo a recuperare solo l’11% di questa risorsa ma puntiamo a triplicare con il Piano Laghetti entro il 2030 - spiega Massimo Gargano, direttore di Anbi -. Dei 10mila progetti, 245 sono già cantierabili per un valore di 3,5 miliardi di euro. Non potranno certo essere risolutivi, ma contribuiranno a ridurre il pericolo siccità, che solo quest’anno ha comportato circa 6 miliardi di euro di danni per l’economia agricola italiana. Con l’aumento della capacità di accumulo, potremo arrivare a fornire acqua irrigua a circa mezzo milione di ettari in più. Un dato importante anche in considerazione dello sblocco Pac di ulteriori 200mila ettari per uso agricolo”. Il Piano Laghetti prevede, inoltre, di usare gli invasi artificiali anche per la produzione di energia verde finalizzata all’autosufficienza energetica per l’attività di pompaggio.
“In questo senso - precisa Gargano - rispondiamo agli obiettivi del Pniec, il Piano integrato per l’energia e il clima e agli obiettivi di Agenda 2023 dell’Onu. Contemporaneamente, grazie a questi interventi, abbiamo in programma di ridurre la bolletta che pagano le imprese e i cittadini”.
Dei progetti già cantierabili, 40 sono ubicati in Emilia Romagna per un incremento di capacità complessiva, pari a oltre 102 milioni di m3, garantendo irrigazione a più di 68mila ettari in più di campagna. Vi saranno installati 57 impianti fotovoltaici galleggianti (con una potenzialità di oltre 9,4 milioni di Kw/anno) e la realizzazione di 12 centrali idroelettriche per una produzione stimata annua di oltre 930mila kWh”. Parimenti sta decollando l’attività del Tavolo nazionale dei contratti fiume, costituito nel 2007 e coordinato dall’architetto Massimo Bastiani. I contratti fiume, che vedono nelle Autorità di bacino distrettuali la controparte dell’accordo, rappresentano uno strumento alternativo per la gestione integrata e sistemica dei bacini idrici. Gestione
che viene realizzata attraverso accordi e azioni specifici, attivati tra i vari utilizzatori dell’acqua (agricoltori o aziende), che operano lungo l’intero corso dei fiumi, da monte a valle. Dopo una partenza in sordina, quindici anni fa, il Tavolo nazionale dei contratti fiume ha finalmente ottenuto, nel 2022, per la prima volta, un supporto finanziario da parte dell’Europa con l’inserimento di questi strumenti di gestione nell’accordo di partenariato, previsto per il prossimo luglio, tra Italia e Commissione europea che garantirà l’accesso di questi strumenti contrattuali pubblico-privato alle risorse previste per i fondi strutturali. “Lo strumento - spiega Bastiani - permette di garantire prelievi e rilasci monitorati e strutturati in un piano di visione generale attraverso una sorta di network tra gli stakeholder, evitando sperequazioni e disparità di attingimento tra chi sta a monte e chi a valle. Le principali criticità da superare in questa direzione, sono, ad esempio, i pozzi abusivi, i prelievi non controllati da parte degli agricoltori e l’eccessivo utilizzo dei fiumi per la produzione di energia idroelettrica”.


Tra gli ultimi contratti fiume conclusi tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ci sono il Patto dell’Arno che è il primo contratto fiume che è stato siglato tra tutti gli stakeholder operanti da monte a valle del corso d’acqua con l’affidamento della parte esecutiva, in deroga alla competenza dell’autorità di bacino distrettuale, ai relativi consorzi di bonifica. Diventa sempre più fondamentale iniziare a ragiona-
re in termini di distretto idrografico. L’altro contratto fiume, arrivato a fine 2022, è quello della media valle del Po. Dal 2007 a oggi sono stati chiusi 61 contratti fiume in 15 regioni. Con il supporto finanziario europeo, essi potranno decollare ulteriormente e le Regioni interessate potranno inserirli nei loro programmi operativi.
MODALITÀ DI ACQUISTO:
• Online su www.moliniditalia.it
ORGANO UFFICIALE ITALMOPA ANTIM
THE ITALIAN MAGAZINE FOR THE MILLING INDUSTRY
THE ITALIAN MAGAZINE FOR THE MILLING INDUSTRY



LA RIVISTA ITALIANA PER L’INDUSTRIA MOLITORIA

RIVISTA ITALIANA PER L’ INDUSTRIA MOLITORIA
betterworld
Bühlerdisponediun’ampiaretedi assistenzatecnicaedassistenza post-venditainItalia,specializzata nellamanutenzionedimacchinariper l’industriamolitoria,mangimistica, dellapanificazione,dellaselezione ottica,dellalavorazionedelcacaoe dellaproduzionedipasta.Inostriespertisaprannofornirle servizidiassistenza,contrattidi manutenzioneprogrammata,parti diricambiooriginali,revisionerullie stacci,retrofitdimacchineobsolete, consulenzaemoltoaltro.Cicontatti perqualunqueinformazione:service.italy@.buhlergroup.com
gli imprenditori, gli operatori e i tecnici della prima e seconda trasformazione dei cereali

gli esperti della panificazione e del dolce
i costruttori di macchine e impianti
✓ i ricercatori ✓ i tecnici di laboratorio
• Compilando inviando a dir@avenue-media.eu il seguente coupon
(12 numeri)
Proprietario: Italmopa
Abbonamento Italia € 45,00 Abbonamento estero € 96,00
Versamento con carta di credito (dati criptati) dal sito www.avenuemedia.eu - riviste di settore
Bonifico bancario intestato ad Avenue media srl, Viale Aldini Antonio 222/4, 40136 Bologna. Banca d’appoggio: Banca Popolare Emilia Romagna Ag. 7 Bologna, IBAN: IT15V0538702406000000437531
Versamento su ccp n. 18182402 intestato ad Avenue media srl, Viale Aldini Antonio 222/4, 40136 Bologna.
Si allega il bollettino di ricevuta con specificata la causale di versamento: in busta chiusa spedizione via fax al n. 051.6564332
La rivista va spedita a (scrivere in stampatello):
Nome
Codice fiscale/P. Iva (obbligatorio)
CAP Città
E-mail per ottenere la password che consente di accedere alla rivista online (si suggerisce di inserire quella personale)
LEGGE PRIVACY - Tutti i dati rilasciati verranno raccolti e trattati (in modalità manuale ed informatica) nel rispetto del D.lgs 196/03 anche per l’eventuale invio di materiale informativo e/o promozionale. I dati non verranno diffusi a soggetti esterni ad eccezione di istituti bancari, società di recapito corrispondenza, aziende da noi incaricate per la gestione dei servizi. È Suo diritto chiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento: Avenue media srl, Viale Aldini Antonio 222/4, 40136 Bologna. Può trovare il testo integrale della legge con l’enunciazione di tutti i Suoi diritti (titolo II) sul sito www.avenuemedia.eu al link Legge privacy.
Luanda (Angola) - Qualche mese fa è stato collaudato l’impianto molitorio “green field” da 350 T/24h a tenero per Sanabel, con la piena soddisfazione del cliente e del team di Ocrim. Un impianto dotato di tecnologia di ultima generazione, per soddisfare le necessità del cliente legate alla sicurezza alimentare e al risparmio energetico.

Il team di Ocrim ha tenuto conto di alcune specifiche, richieste dal cliente, per un’ottimizzazione generale dell’impianto. Una progettazione intelligente e macchine all’avanguardia, per questo impianto che è completo di silo farine da 420 tons e stoccaggio per sottoprodotti da 150 tons, il tutto gestito da un sistema di automazione, targato sempre Ocrim, studiato e

realizzato per semplificare le attività del molino. Il direttore vendite di Ocrim, Fabrizio Baccinelli, sostiene che “in Africa lo sviluppo economico sta crescendo e l’Angola sta diventando un importante punto di riferimento per l’intero continente, grazie a industrie virtuose come Sanabel Group, ma anche tante altre che hanno la forza e la lungimiranza di investire e potenziare il proprio business non solo per questioni autoreferenziali, ma anche per il bene collettivo della comunità. Noi di Ocrim siamo felici di essere diventati loro partner e di contribuire a questa ascesa economica che ha un impatto positivo anche da un punto di vista prettamente sociale”. Hassan Nourredin, amministratore delegato di Sanabel Group, dal canto suo, si ritiene molto soddisfatto di avere scelto Ocrim per questo progetto e ha affermato: “È la prima volta che ci affidiamo a Ocrim. Abbiamo sempre sentito parlare della azienda cremonese come una delle più affidabili al mondo e devo dire che il risultato ha superato le aspettative. Ocrim è un partner attento, innovativo e puntuale. E, con nostra positiva sorpresa, i tempi di consegna sono stati pienamente rispettati, nonostante le complessità del periodo pandemico. Noi di Sanabel lo abbiamo apprezzato molto”.


La 44esima edizione del Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, organizzato da IEG - Italian Exhibition Group insieme alla triennale AB Tech, ha prodotto cinque giornate all’insegna della concretezza, dell’incontro dei saperi e dell’alta formazione, dense di affari e networking, all’interno di un panorama di offerta solido e innovativo, pronto ad assecondare ulteriore sviluppo.
È stato un Sigep della ritrovata fiducia, con le imprese che hanno riscoperto il valore delle relazioni e l’entusiasmo nel presentare le innovazioni prodotte nell’ultimo biennio vissuto fra tante difficoltà. Un Sigep che ha espresso un’energia positiva percepibile in tutto il quartiere fieristico riminese, sold out con oltre 1.000 imprese su 28 padiglioni, per 130.000 mq di expo. Un settore connotato da forte dinamismo, innovazione e propensione all’export. I visitatori esteri sono arrivati a Rimini da 155 Paesi. Per quanto riguarda le provenienze: 77% Europa con Germania, Spagna, Grecia, Francia e Gran Bretagna ai primi
posti; 12% Asia e Medio Oriente con prevalenza da Israele, Libano, India, Corea e i Paesi dell’Area del Golfo; 7% Americhe con Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile e Argentina ai primi posti e il 4% dall’Africa, in primis da Marocco, Algeria Egitto, Libia e Nigeria.
Sigep 2023 ha quindi segnato il pieno ritorno alla sua dimensione di salone leader mondiale per la gelateria artigianale e fra i primissimi per gli altri comparti dell’arte bianca e del caffè. Insieme ai dati numerici, è soprattutto la soddisfazione generale degli espositori e dei visitatori a decretarne il successo.
In fiera erano rappresentati i settori Gelato, Pastry, Choco, Coffee e Bakery, quest’ultima filiera potenziata grazie alla contemporaneità con AB Tech Expo.

Sigep e AB Tech hanno attirato l’attenzione dei media italiani e internazionali che hanno prodotto un’audience pari a 439 milioni di contatti lordi. 655 gli accrediti in sala stampa, dei quali 70 esteri.
La 45esima edizione di Sigep è in programma dal 20 al 24 gennaio 2024 alla Fiera di Rimini. Ma prima, Sigep, la piattaforma della community del foodservice dolce e del modo italiano di viverlo, si appresta a un nuovo, ambizioso appuntamento: Sigep China. Si terrà dal 10 al 12 maggio 2023 e sarà organizzato da EAGLE, società interamente controllata da IEG, in partnership con Fiera di Colonia, allo Shenzhen World Exhibition e Convention Center in contemporanea con Anufood China.

20/24 febbraio 2023 DUBAI (EAU)
GULFOOD
Salone internazionale dell’industria alimentare e delle bevande www.gulfood.com
29/30 marzo 2023 PARMA
CIBUS CONNECT
Mostra convegno per l’industria alimentare www.cibus.it
14/18 marzo 2023 NEW DELHI (INDIA)
AAHAR
Fiera Internazionle dell’Alimentazione e dell’Ospitalità www.indiatradefair.com/aahardelhi/
28/30 marzo 2023 LAS VEGAS (USA)
SIAL AMERICA
Salone Internazionale del Food & Beverage www.sialamerica.com
17/19 aprile 2023 AMSTERDAM (OLANDA)
FOOD ALLERGY FORUM
Convegno sulle allergie alimentari
www.foodallergyforum.org
17/21 aprile 2023 MINNEAPOLIS (USA) CONFERENZA ANNUALE IAOM
Distretto Nord America
www.iaom.org
23/25 aprile 2023 COLONIA (GERMANIA)
PROSWEETS E ISM
Saloni internazionali delle tecnologie per l’industria dolciaria e degli snack www.prosweets.com
4/10 maggio 2023
DÜSSELDORF (GERMANIA)
INTERPACK
Salone internazionale del packaging
www.interpack.com
8/11 maggio 2023 MILANO
TUTTOFOOD
Salone internazionale dell’industria agroalimentare www.tuttofood.it
23/25 maggio 2023 PARMA
SPS ITALIA
Salone dell’automazione e delle soluzioni digitali www.spsitalia.it







