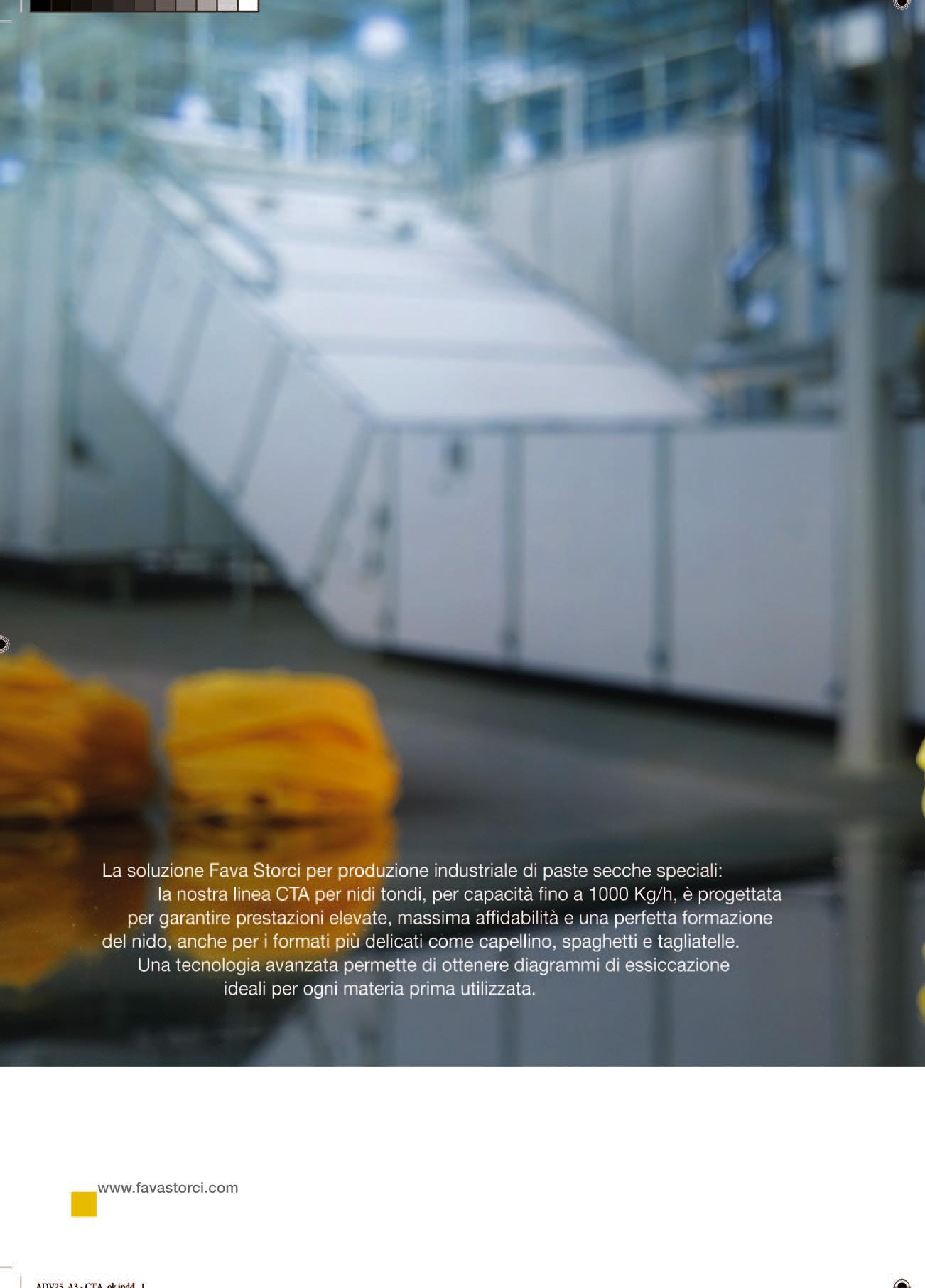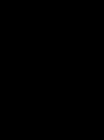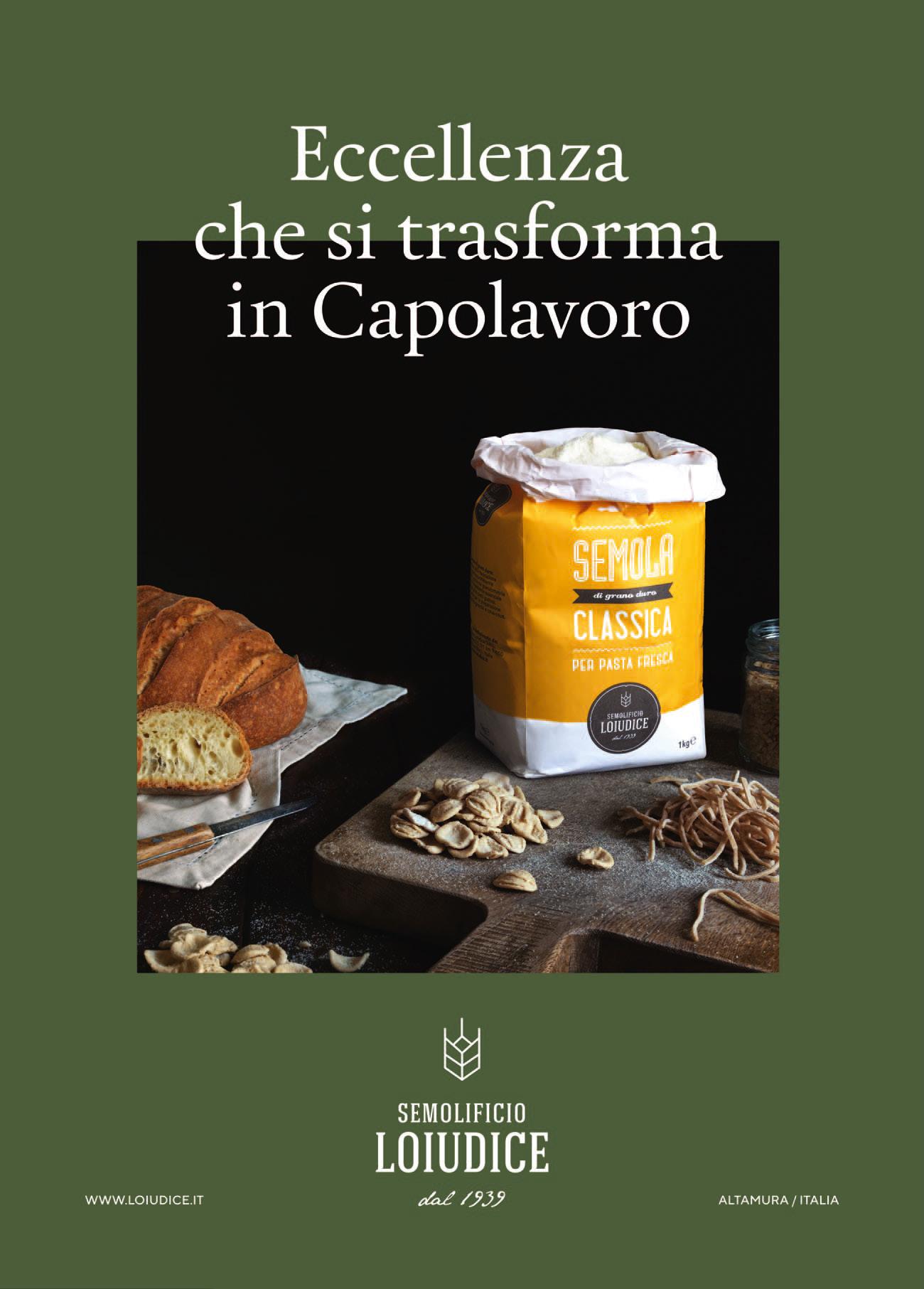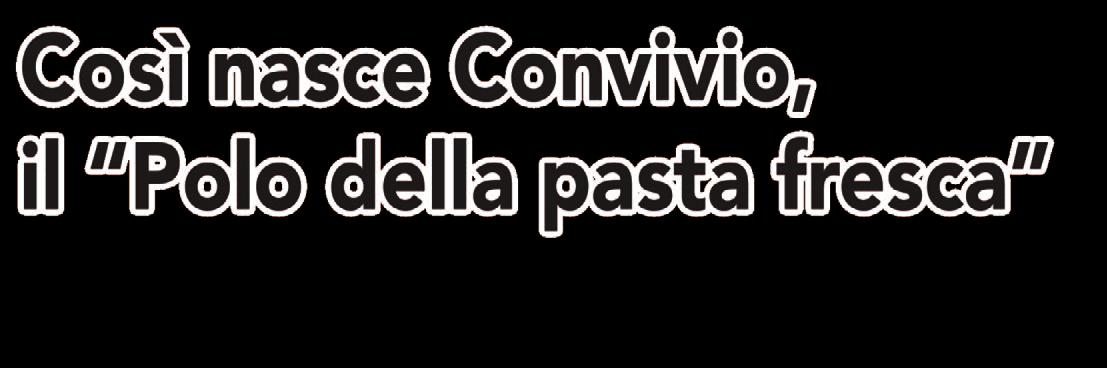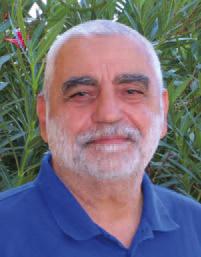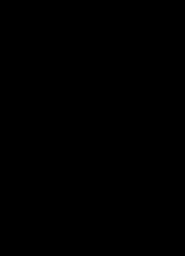Preservare e promuovere la pasta fresca fatta a mano
Ecco il Campionato che trasforma
il primato italiano in patrimonio culturale
Il Campionato della Pasta Fatta a Mano nasce nel 2024, da una idea della BTL Prod., come la prima e unica competizione ufficiale interamente dedicata all’arte della pasta fresca. In Italia, ogni regione custodisce un formato tradizionale, spesso diverso da provincia a provincia e, in certi casi, da comune a comune. È un universo infinito di forme, condimenti, rituali familiari e comunitari che fanno della pasta fresca un patrimonio identitario del nostro Paese. Il Campionato ha deciso di trasformare questo patrimonio in una sfida appassionante, mettendo al centro due elementi semplici e straordinari: la pasta e le mani. Ne è nato un evento che non si limita a decretare un vincitore, ma diventa un’occasione di incontro tra chef, osti, cuochi, massaie, food blogger, influencer, giornalisti e appassionati. Tutti uniti dalla stessa passione: confrontarsi “a colpi di mattarello e impasti”, celebrando tradizione, creatività e convivialità.
Fin dall’esordio, il Campionato ha potuto contare sul sostegno di partner di rilievo: su tutti il Consorzio Edamus, non un semplice partner ma vero coproduttore del format dalla sua prima edizione. E ancora, Consorzio Ricrea, Fondazione Vincenzo Agnesi, In Cibum Scuola di Alta Formazione Gastronomica, Zwilling, Ballarini, Molini Pizzuti, Ordine dei Dietisti di Salerno. A questi si sono aggiunti chef stellati, giornalisti ed esperti del settore, che hanno contribuito a dare autorevolezza e visibilità all’iniziativa.
Il legame con l’industria pastaria e con le istituzioni è parte integrante del progetto. La collaborazione con consorzi, fondazioni e scuole di cucina rappresenta un ponte tra tradizione, formazione e innovazione. Il Campionato vuole infatti essere non solo una gara, ma anche una piattaforma di networking che unisce produttori, chef, istituzioni, scuole e aziende.
a cura della Redazione

Tale competizione si pone una missione chiara: preservare e promuovere la pasta fresca fatta a mano come patrimonio culturale, artigianale e gastronomico italiano. Per il 2026 gli obiettivi sono ambiziosi: crescita del format, rendendo l’evento un appuntamento fisso e riconosciuto del calendario gastronomico nazionale, valorizzando sempre più la figura dell’artigiano della pasta soprattutto dal punto di vista professionale. Internazionalizzazione, con la possibilità di aprire le porte ancor di più a concorrenti esteri e raccontare la tradizione italiana oltre confine. (nella precedente edizione ci sono stati concorrenti da tutta Italia e anche dalla Spagna, con richieste anche da fuori Europa). Coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso istituti alberghieri e scuole di cucina. Sostenibilità, con attenzione alla filiera corta, al recupero alimentare e alla valorizzazione del territorio. L’edizione 2026 prevede un tour di selezioni nei capoluoghi italiani, riservato alla categoria dei Professionisti: titolari e collaboratori di ristoranti, bistrot, laboratori di pasta fresca, trattorie, agriturismi, hotel, ma anche consulenti, docenti di corsi e chef privati. Parallelamente è prevista
la categoria amanti, aperta a tutti gli appassionati che desiderano mettersi in gioco che invece gareggeranno solo nella fase finale. Ogni piatto verrà valutato da giurie diverse: per i professionisti, chef stellati, giornalisti, nutrizionisti ed esperti; per gli amatori, una giuria composta da chef, blogger e operatori del settore. I criteri di valutazione riguarderanno impasto, gusto, aspetto e equilibrio nutrizionale, con schede tecniche dedicate. La finalissima si terrà all’interno del DMED - Salone della Dieta Mediterranea, evento che mette al centro lo stile mediterraneo attraverso show-cooking, masterclass, talk e incontri con istituzioni e aziende provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo.
Il Campionato della Pasta Fatta a Mano vanta un primato unico: nessuna competizione ufficiale di questo tipo era mai stata organizzata prima, né in Italia né all’estero. Un evento che, in pochi anni, punta a diventare non solo un concorso gastronomico, ma una vetrina culturale e identitaria, capace di raccontare l’Italia della pasta fresca al mondo intero.
La Redazione
Dazi pasta, Emilia Romagna chiede al Governo una trattativa con gli Usa
Per l’Emilia-Romagna l’export di pasta e prodotti da forno negli Usa vale oltre 118 milioni di euro. “L’ipotesi di un dazio aggiuntivo antidumping del 91,74%, che colpirebbe 13 marchi italiani produttori di pasta che esportano negli Stati Uniti, e andrebbe ad aggiungersi a quello del 15% su tutti i prodotti europei, si configura come l’ennesima misura punitiva verso le produzioni alimentari italiane. Se il provvedimento dovesse essere confermato, a partire dal 1° gennaio 2026, le tariffe doganali complessive salirebbero al 107%, un tasso che, di fatto, renderebbe davvero complesso proseguire l’esportazione. È necessario che il Governo si attivi immediatamente, a partire dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e da quello degli Affari Esteri, per cercare un accordo politico con l’amministrazione americana”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura e Rapporti con la Ue, Alessio Mammi.
Rummo lancia Maxima ad Anuga 2025
Ad Anuga 2025, Rummo ha lanciato Maxima, una linea di prodotti altoproteici con 21% di proteine da piselli verdi e 100% naturale.
L’azienda mira a offrire un’alternativa alla pasta tradizionale, mantenendo un elevato contenuto proteico. Il prodotto ha riscosso successo tra distributori e partner del pastificio campano, che ha ormai consolidato la sua leadership in Francia e ottenuto risultati positivi in Svizzera e nei paesi nordici. Le vendite stanno crescendo anche in mercati più lontani come Sudamerica e Stati Uniti. Impegnata sul fronte della qualità, Rummo punta sempre più a un posizionamento premium.
Voiello lancia due nuovi formati di pasta
La pasta di qualità cambia forma con Voiello, che porta sugli scaffali due novità assolute destinate a conquistare gli amanti della buona tavola: il Paccariello Capriccioso e lo Spaghettone Innamorato. Due nuovi formati dal design innovativo, pensati per trasformare ogni piatto in un’esperienza creativa e sorprendente. La voglia di sperimentare è sempre più centrale nella cucina italiana: secondo una ricerca AstraRicerche per Voiello, quasi il 75% degli italiani considera fondamentale “inventare, provare e non fermarsi alla solita idea”, mentre oltre il 74% sarebbe pronto a provare un nuovo formato se proposto dal proprio brand di fiducia. Proprio per rispondere a questa curiosità crescente, Voiello ha deciso di innovare partendo da ciò che gli italiani amano di più: la forma della pasta, uno dei principali driver d’acquisto per oltre il 55% dei consumatori.
Pasta La Lanterna compie 70 anni
L’azienda ha celebrato il suo settantesimo compleanno, con dipendenti e clienti, in un appuntamento che oltre a ripercorrerne la storia, è stato occasione per presentare i progetti che segnano il futuro. Tra questi c’è il lancio degli Imbutini di Ozzano, pasta dal design originale ideata da Flavia Valentini e già riconosciuta come Prodotto De.Co. del Comune di Bologna, che entra a far parte della Gourmet Collection La Lanterna. Farà il suo debutto anche Pastiz, il nuovo prodotto nato dalla collaborazione con Nicola Paiato, pasticciere Apei founder de Le Follie di Ferrara: un guscio di pasta frolla che custodisce un cuore salato firmato La Lanterna, pensato come cibo da passeggio pratico e innovativo. Infine, è stato svelato il progetto solidale La Pasta della Vita realizzato insieme all’associazione A-ROSE ODV che, attraverso i Cappellacci di Zucca, destinerà parte del ricavato alla ricerca oncologica.
Agrilevante, l’accordo di filiera per la tutela del grano pugliese
Un nuovo accordo di filiera tra agricoltori, pastai e grande distribuzione per difendere il grano pugliese e i suoi derivati. Un’intesa capace di affrontare questioni che mettono a rischio la produzione: aumento dei costi, crollo dei prezzi e concorrenza estera. È quanto annunciato nel corso di Agrilevante a Bari, dove i protagonisti del mondo del grano hanno deciso di “costruire un modello di filiera più forte, trasparente e innovativo”, fanno sapere attraverso Coldiretti Puglia pastai, agricoltori ed esponenti della distribuzione. I nodi, secondo Coldiretti, sono chiari e vanno dalla necessità di “aumentare fino a 40 milioni di euro il sostegno del ministero ai contratti di filiera pluriennali” a maggiori investimenti in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla transizione tecnologica.
Grano duro, Ismea certifica la crisi
Resta al centro del dibattito la questione delle quotazioni del frumento duro, con le associazioni professioni agricole sempre in prima linea nel difendere un’eccellenza tra le produzioni del settore primario italiano. Il fattore deflagrante è stata l’avvenuta pubblicazione, particolarmente attesa, del report Ismea sui costi medi di produzione del frumento duro, che ha confermato le preoccupazioni del mondo agricolo. Lo studio ha infatti evidenziato che nel 2025 in Puglia, Sicilia e Basilicata, nonostante un incremento delle produzioni con rese unitarie di 3,68 t/ha, ovvero con un prezzo medio tra l’1 luglio e il 22 settembre scorsi di 295,5 euro/t, il costo medio di produzione è stato di 1.170 euro/ha, con un differenziale tra prezzi e costi pari al 7%, il che significa, trattandosi di una media, che per molte aziende la crisi è difficilmente sostenibile.
Novità in casa Rodolfi Mansueto: ecco i sughi pronti
In arrivo sugli scaffali entro fine anno, “I Sughi di Casa Rodolfi” rappresentano una mossa strategica per affermarsi in un mercato, quello dei sughi pronti a base pomodoro, in costante crescita. Con i prodotti della sua nuova linea, Rodolfi Mansueto compie un passo in linea con le richieste dei consumatori, che hanno poco tempo da trascorrere ai fornelli, ma non rinunciano a una buona pasta. Al contempo, il brand mantiene i propri tratti distintivi: materia prima italiana e sapori autentici di casa, che con i nuovi Sughi di Casa Rodolfi sono finalmente alla portata di tutti. Ogni ricetta nasce da ingredienti semplici e genuini, scelti con cura e lavorati per esaltarne il gusto.
Commodity Agrifood 2026: 300 operatori all’edizione annuale dell’evento
Si è tenuta il 2 Ottobre la XIV edizione di Commodity Agrifood, l’evento di Unione Italiana Food e Areté - The Agri-food Intelligence Company dedicato ai mercati delle commodity agroindustriali. Ad aprire l’evento, quest’anno nuovamente in versione “live”, dopo i saluti di Mario Piccialuti, direttore UnionFood, e di Enrica Gentile, CEO di Areté, una ricca tavola rotonda con esponenti di primo piano della filiera agrifood italiana ed europea: Carlo Alberto Buttarelli, Presidente Federdistribuzione, Riccardo Felicetti, vicepresidente UIF e Presidente dell’omonimo pastificio, Patrick Pagani, Direttore COPA-COGECA, Giovanni Tamburini, Presidente CEFSAssociazione Europea Industria Saccarifera, insieme a Mauro Bruni, presidente di Areté.
Un quadro eterogeneo, con diversi distretti in crescita e altri in calo
La ricca e variegata tradizione agro-alimentare italiana ha portato alla formazione di numerose realtà locali caratterizzate dalla presenza di prodotti tipici. Allo scopo di rappresentare queste realtà locali, Intesa Sanpaolo ha identificato oltre 50 distretti agro-alimentari, ovvero zone geografiche specializzate nella coltivazione e nella trasformazione di prodotti agricoli e alimentari. Questi distretti sono caratterizzati da una buona propensione all’export e risultano distribuiti lungo tutto lo Stivale.
La Redazione
Dopo il record segnato a fine 2024 a quota 28,7 miliardi di euro (+7,1% rispetto al 2023), l’export dei distretti agro-alimentari continua a crescere anche nel primo trimestre del 2025, sfiorando i 7,2 miliardi (+1,2% tendenziale a prezzi correnti).
Dietro questo risultato si nascondono tuttavia andamenti molto eterogenei da parte dei distretti monitorati.
Come stanno le filiere?
Il contributo maggiore alla crescita nel primo trimestre del 2025 viene dalla filiera agricola, che arriva a toccare quasi 1,3 miliardi di euro di esportazioni (+11,5%). Protagonista assoluto il distretto dell’Ortofrutta romagnola, con un boom del 34,3%; ottimi risultati anche per le Mele dell’Alto Adige (+19,2%), in recupero la Nocciola e frutta piemontese (+24%), dopo il calo del 2024. In lieve regresso invece la fi-
di Rosa Maria Vitulano - Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo
liera vitivinicola (-2,7%), dopo il buon risultato del 2024 (+4%). Sono soprattutto i due distretti principali a registrare arretramenti importanti: quello dei Vini di Langhe, Roero e Monferrato chiude il primo trimestre a quota 415 milioni di euro, - 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, andamento analogo per i Vini del Veronese (-8,2%). Secondo le elaborazioni dell’UIV (Unione Italiana Vini) i consumi di vino sono in calo in tutti i principali mercati di sbocco, soprattutto per i vini “premium” e i rossi più strutturati. La corsa pre-dazi ha spinto il commercio internazionale nei mesi precedenti, ma a partire dal primo trimestre del 2025 si sta assistendo a un riallineamento tra “spedito” e “consumato”. Nel complesso, la filiera vitivinicola esporta verso il mercato americano oltre un quarto del totale.
Pasta, dolci, conserve e salumi
La filiera della pasta e dolci registra un arretramento nei primi tre mesi dell’anno e chiude il pe-
Tabella 1
Le esportazioni dei distretti agro-alimentari monitorati da Intesa Sanpaolo per filiera Esportazioni(milionidieuro)Peso%Differenza(milionidieuro)Variazione%tendenziale 20241trim2025202420241trim202520241trim2025
Pasta e dolci 5.0281.095,517,6366-687,8-5,8 Agricoli 4.1331.289,614,41851334,711,5
Conserve 3.142784,311,0106-573,5-6,8
Carne e salumi 2.719696,49,3136415,36,3
Lattiero-caseario 2.531670,98,8146796,113,3
Olio 1.955445,45,5567-7240,9-13,9
Caffè 1.581457,86,8137809,521,1
Riso 758203,52,6-13-8-1,7-3,7
Prodotti ittici 12230,80,412010,81,5
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Arretramento per filiera pasta e dolci
riodo con esportazioni di poco superiori al miliardo (-5,8%) dopo il record del 2024 (5 miliardi; +7,8%). Anche per questa filiera, sono due i distretti a trascinare verso il basso il risultato finale: i Dolci di Alba e Cuneo, che arretrano per ben 99 milioni (-21% tendenziale), e il comparto pasta e dolci dell’Alimentare di Avellino (-11,5%).
Va in controtendenza invece l’altro distretto campano, l’Alimentare napoletano, che per il comparto pasta e dolci recupera la chiusura negativa del
Figura 1
2024 (-4,5%) con un balzo del 37% nel primo trimestre del 2025. Positivi tutti gli altri distretti della filiera, in particolare il comparto pasta e dolci dell’Alimentare di Parma (+1,8%) e i Dolci e pasta veronesi (+4,1%); stabili il comparto pasta e dolci dell’Olio e pasta del barese (-0,03%) e la Pasta di Fara (+0,2%), quest’ultimo nonostante l’arretramento sul mercato statunitense (-12,5%). Il distretto della pasta abruzzese è tra quelli della filiera maggiormente esposti verso gli Usa, con un peso del mercato americano del 30% sul totale. In contrazione anche la filiera delle conserve: -6,8% nel primo trimestre del 2025, a causa soprattutto
Le esportazioni dei distretti della pasta e dei dolci monitorati da Intesa Sanpaolo (milioni di euro)
dell’evoluzione negativa delle Conserve di Nocera, che arretra del 14%. Il comparto conserve dell’Alimentare napoletano segna anch’esso una contrazione del 10,6%, la performance negativa non pregiudica tuttavia il risultato complessivo del distretto partenopeo, che nel combinato disposto con il comparto pasta e dolci si assesta a 209 milioni nel primo trimestre del 2025 (+7,7%).
Positive le dinamiche degli altri distretti della filiera: si distinguono in particolare le Marmellate e succhi del Trentino Alto-Adige (+11,1%) e il comparto conserve dell’Alimentare di Avellino (+11,6%), che però non riesce a compensare l’arretramento del comparto pasta e dolci e lascia in terreno negativo il risultato complessivo del distretto (-5,1%).
Ottimi risultati invece per le filiere zootecniche. Per le carni e salumi (+6,3%), si registrano incrementi diffusi per quasi tutti i distretti; spiccano in particolare i Salumi del Modenese (+13,4%). Nel complesso, per la filiera il mercato statunitense pesa l’8% circa, con punte del 35% per i Salumi di Reggio Emilia, distretto che si mantiene in territorio positivo (+1,9%). Altro distretto particolarmente esposto è quello del Prosciutto e altre carni conservate di Udine (+1,8%) con valori di export piuttosto contenuti, ma che ne destina circa un terzo al mercato statunitense. Anche le Carni e Salumi di Cremona e Mantova avanzano del 12,8%; in lieve arretramento i Salumi di Parma (-3,2%).
Gli altri distretti
In progresso tutti i distretti del lattiero-caseario: il distretto parmense realizza 25 milioni in più (+23,6%); accelerano le vendite estere per il Lattiero-caseario sardo (+25%), distretto maggiormente esposto verso il mercato americano con un 75% del totale; si spinge sempre più lontano anche la Mozzarella di bufala campana (+12,4%) soprattutto in Giappone (+38%), Cina (+5,6%) e Stati Uniti (+63%). La produzione di latte in Italia, dopo il +1,9% registrato nel 2024 (dati Agea), ha registrato una contrazione dell’1% nel primo quadrimestre 2025, in linea con tutti i principali paesi produttori europei, e ciò sta mantenendo
Figura 2
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
elevato sia il prezzo del latte alla stalla sia quelli dei principali formaggi Dop.
Germania primo partner commerciale per i prodotti dei distretti agro-alimentari
La filiera dell’olio invece registra una fisiologica battuta d’arresto (-13,9%) dopo il boom del 2024 (+40,9%). L’Olio toscano (-17,2%) perde terreno soprattutto verso gli Stati Uniti (-13,9%) e verso la Francia (-44,5%), l’Olio umbro (-5,2%) arretra sul mercato francese (-31,9%) e su quello polacco (-34,6%); il comparto oleario dell’Olio e pasta del barese (4,1%) subisce un calo soprattutto sul mercato tedesco (31,6%) e statunitense (12,2%). La filiera dei distretti dell’olio complessivamente risulta esposta, per oltre un terzo sul totale verso il mercato Usa; il distretto dell’Olio toscano è quello maggiormente interessato (40%).
Crescite a due cifre per la filiera del caffè (+21%). Il Caffè, confetterie e cioccolato torinese segna un +21,7% tendenziale nel primo trimestre del
2025; il Caffè e confetterie del napoletano (+18,4%) registra ottimi risultati negli Stati Uniti (+119%); il Caffè di Trieste (+21%) raddoppia le esportazioni in Germania (+108%).
Per la filiera del riso, si accentua il trend negativo del 2024 (-1,7%) e chiude il primo trimestre con esportazioni in contrazione del 3,7%: il Riso di Vercelli cala dal 3,3% mentre il Riso di Pavia arretra del 4,2%. Secondo l’Ente Risi nazionale, la filiera italiana ed europea risulta penalizzata dall’aumento dell’import di riso extra-Ue, in particolare da parte di paesi meno avanzati, che beneficiano di accessi preferenziali senza l’applicazione di tariffe. Positiva infine l’evoluzione del distretto dell’Ittico del Polesine e Veneziano (+1,5%), grazie al raddoppio delle vendite in Spagna.
I principali sbocchi dell’export nazionale
La Germania si conferma primo partner commerciale per i prodotti dei distretti agro-alimentari anche nel primo trimestre del 2025 (+6,2% tendenziale), seguita dagli Stati Uniti (+7%) che sorpassano la Francia (-0,1%); al quarto posto il Regno Unito (-8,3%). La crescita dei flussi verso il mercato Usa non sembra legata a eventuali politiche di approvvigionamento anticipato, in quanto tassi di crescita sostenuti si sono registrati in tutti i trimestri dello scorso anno. Il quadro è comunque eterogeneo, con diversi distretti in crescita (anche rilevante) e altri in calo; non è quindi da escludere che per alcune aree distrettuali ci possa essere stato anche un effetto anticipazione. Le produzioni agro-alimentari italiane vendute negli Usa inoltre potrebbero essere potenzialmente meno sensibili alle variazioni di prezzo rispetto a quelle dei nostri competitors: si tratta, infatti, di prodotti di nicchia, spesso legati al territorio e certificati DOP/IGP, molto apprezzate da una clientela ad alto reddito. L’evoluzione nei prossimi mesi continuerà a essere condizionata dal clima di incertezza che caratterizza il contesto geo-politico internazionale. La ricerca di nuovi partner commerciali resta una strategia molto valida di diversificazione del rischio derivante dall’entrata in vigore di dazi più pesanti.
Rosa Maria Vitulano
Luca Maurizio Duranti, managing partner e amministratore delegato di Alkemia illustra a “Pasta&Pastai” la struttura del progetto
Dall’iniziativa di Alkemia SGR, con un coinvestimento di Banca Ifis, nasce Convivio: holding delle eccellenze food dedicata a pasta fresca e piatti pronti. In totale, sono 5 le realtà aggregate: Valsugana Sapori (Trentino), Parmachef (Emilia-Romagna), Casanova Food con il brand Pasta di Venezia e Pastificio Cecchin (Veneto) e Poggiolini (Toscana). Alcune di queste vantano linee dedicate agli operatori professionali del fuoricasa. L’obiettivo è quello di rispondere alle necessità del mercato creando un player industriale nel settore food, capace di consolidare le migliori tradizioni regionali italiane e posizionarsi nel tempo come protagonista a livello internazionale. Luca Maurizio Duranti, managing partner e amministratore delegato di Alkemia illustra a “Pasta&Pastai” la struttura del progetto.
L’operazione del “Polo della pasta fresca” parte da Food Excellence. Come nasce questo fondo, come si sviluppa e che finalità possiede?
L’operazione del “Polo della pasta fresca” è un progetto di build-up nel settore della pasta fresca e dei piatti pronti freschi, promosso e gestito da Alkemia SGR Spa attraverso il fondo Alkemia Food Excel-
lence I. L’idea nasce dalla constatazione che il settore della pasta fresca e dei piatti pronti in Italia è altamente frammentato, composto da una moltitudine di operatori locali e società familiari che, nonostante producano eccellenze, sono spesso limitate nella crescita. Il mercato di riferimento è “sizeable”, con un valore di oltre € 2,7 miliardi nel 2023, in co-
La Redazione
di Lorenzo Bellei Mussini - Pasta&Pastai publishing coordinator



stante crescita e con una domanda crescente di prodotti genuini, facili da preparare e “sani” come i prodotti senza glutine e senza lattosio. Il progetto si svilupperà in tre fasi. La prima, che si è perfezionata ad agosto di quest’anno dopo un percorso durato oltre un anno, ha visto l’aggregazione di cinque aziende target strategicamente situate nel centronord-est Italia che ha permesso di aggregare un gruppo di aziende che nel 2025 svilupperà un fatturato di circa € 30 milioni in specialità regionali di eccellenza, con una marginalità significativa. La seconda fase, già in corso, prevede l’aggregazione di ulteriori 3-5 aziende italiane (in parte già selezionate), al fine di ampliare ulteriormente il portafoglio prodotti con altre specialità regionali, consolidare la presenza su categorie strategiche ed estendere la copertura geografica in regioni chiave come Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. Al termine di questa fase, i ricavi complessivi del gruppo sono stimati superiori a € 70 milioni. La terza fa-
se si concentrerà sull’integrazione commerciale, industriale e organizzativa delle aziende acquisite, e sullo sviluppo internazionale, prioritariamente nei mercati europei. Alkemia, con una dotazione iniziale di € 20 milioni (hard cap a € 50 milioni), ha
Luca Maurizio Duranti, managing partner e amministratore delegato di Alkemia
I soci venditori hanno reinvestito nel progetto
realizzato le acquisizioni attraverso Convivio Spa. Questa fungerà da capogruppo, accentrando le funzioni chiave e sarà guidata da Giovanni Panzeri, manager con una lunga esperienza nel settore della distribuzione organizzata. Da sottolineare che i soci venditori delle aziende acquisite hanno reinvestito significativamente nel progetto di aggregazione, acquisendo una partecipazione di minoranza significativa in Convivio, e nominando propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione della medesima. Ogni imprenditore ha mantenuto però le responsabilità di gestione della propria azienda. Le finalità del progetto di aggregazione sono:
• costruire un leader italiano nel settore della pasta fresca e della gastronomia di alta gamma;
• creare un portafoglio prodotti diversificato e distintivo, che valorizzi le specialità regionali;
• servire efficacemente i canali Gdo (Modern Trade), HoReCa e Normal Trade, sia a livello nazionale che internazionale;
• generare sinergie produttive e commerciali (ad esempio, attraverso il cross-selling e un assortimento più ampio);
• aumentare l’efficienza e ridurre i costi tramite economie di scala e la centralizzazione delle funzioni chiave (acquisti, logistica, programmazione della produzione);
• sostenere investimenti in produzione, marketing, comunicazione e nella struttura commerciale;
• accompagnare il passaggio generazionale per le imprese familiari coinvolte;
• impegnarsi attivamente nella sostenibilità, con attenzione alla filiera di fornitura e alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance);
• generare ritorni attrattivi per gli investitori attraverso la crescita dimensionale del gruppo, il mantenimento di un’elevata profittabilità.
Chi sono i player del Polo e che ruolo ricoprono all’interno dello stesso?
Come anticipato, la prima fase del progetto ha visto coinvolte cinque aziende italiane di successo, complementari per prodotti e clientela. Queste aziende sono state selezionate per la loro alta qualità artigianale, know-how produttivo, caratterizzazione regionale e solida redditività. Si tratta della trentina Valsugana Sapori, fondata nel 2006 e punto di riferimento nazionale per le specialità regionali, quali canederli, spatzle e gnocchi. Poggiolini, nata nel 1972, che offre un’ampia gamma di prodotti di pasta fresca tipicamente toscana, inclusi pici, tagliatelle, maltagliati, tortelli e ravioli. Parmachef, fondata negli anni ‘80 a Parma, che è diventata leader nella produzione e confezionamento di piatti pronti freschi, grazie a tecniche di cottura innovative. La veneta Casanova Food, nata nel 2013, che si distingue per la sua specializzazione in prodotti di pasta
Per far parte del progetto di build-up
occorre avere dei requisiti specifici
fresca senza glutine e senza lattosio, offrendo soluzioni uniche per creatività e gusto. Infine, Fratelli Cecchin anch’essa veneta, nata alla fine degli anni ‘90, riferimento nel mondo delle crespelle e di prodotti tipici veneti come bigoli e fagottini ripieni. Collettivamente, queste aziende contribuiranno a creare un portafoglio prodotti ampio e diversificato, arricchito da specialità regionali e risposte a nicchie di mercato (come il “senza glutine”). Questo consentirà al gruppo di offrire una gamma che coniuga qualità, tradizione e i valori del territorio italiano.
Per accedere al Polo occorrerà avere dei requisiti o potranno accedere anche quelle piccole e medie imprese locali di pasta fresca?
Sebbene il progetto si rivolga a operatori locali e familiari, per far parte del progetto di build-up occorre avere dei requisiti specifici. Alkemia, infatti intende selezionare aziende che, nonostante le loro dimensioni contenute e le sfide tipiche delle Pmi italiane, presentano caratteristiche distintive, quali:
• prodotti di alta qualità e forte caratterizzazione regionale;
• specializzazione, anche in segmenti di nicchia in crescita come i prodotti senza glutine e senza lattosio;
• solide performance storiche e una buona crescita;
• alta marginalità e basso indebitamento finanziario;
• capacità produttiva non satura;
• ove possibile una presenza sui mercati esteri;
• la volontà dei soci venditori di cedere il 100% del capitale e di reinvestire una parte significativa dei proventi nel progetto, garantendo la continuità gestionale.
Visibilità di un settore, nonché ampliamentoauspicabile - di produttività e commercializzazione (anche all’estero) saranno affiancati da un’attenta comunicazione a tutela della filiera della pasta?
Sì, la visibilità del settore e l’espansione commerciale saranno supportate da una strategia di comunicazione che include anche la tutela della filiera e l’attenzione



alla sostenibilità. Convivio prevede investimenti specifici in marketing e comunicazione. È prevista la creazione di un marchio ombrello di gruppo, la definizione di una brand identity distintiva e lo sviluppo di un piano di comunicazione coordinato. Queste iniziative mirano a valorizzare i prodotti, sostenere le vendite e implementare attività promozionali sul trade (per esempio volantini, merchandising). Convivio si impegna attivamente per la sostenibilità, mostrando una particolare sensibilità verso la filiera di fornitura e le tematiche ESG (Environmental, Social, Governance). Convivio avrà la responsabilità di gestire i progetti legati alla sostenibilità e di allineare le certificazioni delle aziende. L’ottimizzazione della logistica e dei trasporti, resa possibile dalle maggiori dimensioni del gruppo, comporterà anche benefici ambientali (ESG). La strategia commerciale è poi focalizzata sulla valorizzazione del prodotto di qualità. Il know-how di processo, l’attenzione alle filiere locali e la capacità produttiva del gruppo permetteranno di offrire una gamma di prodotti che coniuga qualità, tradizione e i valori del territorio.
Il Polo ha in progetto anche delle aperture a nuovi settori di mercato, come ad esempio i prodotti “free from”?
Assolutamente sì. I prodotti “free from” (senza glutine e senza lattosio) sono un settore di mercato
strategico e in crescita su cui il Polo intende focalizzarsi. Casanova Food è una eccellenza nella produzione di pasta fresca senza glutine e senza lattosio e rappresenta un punto di forza per il gruppo. Convivio ha anche in progetto la creazione di nuove linee di prodotto per soddisfare le esigenze del mercato, quali ad esempio le polpette vegetali, i ravioli con ripieni gourmet e pasta fresca con farine alternative.
A fronte dell’attuale inflazione alimentare e dei costi delle materie prime, il Polo può rappresentare un modello virtuoso in termini anche di sostenibilità economica?
Sì, Convivio è strutturato per essere un modello virtuoso in termini di sostenibilità economica, specialmente in un contesto di inflazione alimentare e aumento dei costi delle materie prime, grazie a diverse strategie: sinergie di costo ed economie di scala. La prima riguarda la centralizzazione attesa degli acquisti che consentirà di ottimizzare il rapporto con i fornitori del gruppo e abilitare le conseguenti sinergie di costo. La seconda verte sul coordinamento della produzione e sulla crescita attesa dei volumi e consentirà di beneficiare delle economie di scala legate all’efficienza operativa.
Lorenzo Bellei Mussini
Un progetto nato per valorizzare la produzione cerealicola marchigiana, in particolare quella del frumento duro
Nella regione Marche massivamente si coltiva il frumento. Tenero, da sempre per la produzione di pane, ma anche duro - da cinquant’anni - per la semola della pasta. Quest’ultimo si coltiva grazie a un agronomo-genetista marchigiano (nato a Castelferretti nel 1926) che nel secondo dopoguerra fu incaricato nell’ambito dell’Enea di migliorare geneticamente quella che allora era una coltura praticata solo nel sud Italia: aveva un fusto molto alto, era poco produttiva e spesso arrivava a maturazione in forma striminzita. Le prove e le sperimentazioni degli anni ’60 erano condotte in Puglia, Sicilia, Lazio, Abruzzo, Toscana. Nelle Marche i campi sperimentali erano nell’azienda di famiglia del genetista, a Camerata Picena. Diversi i genotipi incrociati (Castelfusano,
Catelporziano, Cappelli…) fino a ottenere la varietà iscritta al Registro varietale nel 1974 con il nome di “Creso” che fu protagonista della “rivoluzione verde”. In cinquant’anni il duro marchigiano ha surclassato il tenero e così la Regione è il terzo areale tipico per il frumento a grano duro, mentre le caratteristiche della granella prodotta sono un riferimento qualitativo per l’intera produzione nazionale. Nello scorso ottobre - al Cassero di Camerata Picenaagricoltori e assessorato regionale hanno avviato il procedimento per il riconoscimento del Distretto del Cibo detto “Gran_de’Marca - frumenti marchigiani”. In occasione del cinquantenario della principale coltura regionale è doveroso portare a conoscenza dei consumatori che un quarto della pasta che ogni giorno si porta in tavola può essere fatta con frumen-
di Marino Mosconi - agricoltore



to marchigiano, che la qualità marchigiana è sinonimo di sicurezza alimentare libera da agenti inquinanti. Le quasi 500.000 tonnellate di granella marchigiana diventano circa tre milioni di chili di pasta alimentare, circa il 25% del consumo nazionale annuo. Il riconoscimento del Distretto “Gran_de’Marca” è la chiave per assicurare la provenienza della materia prima della pasta alimentare italiana, materia prima coltivata secondo un disciplinare condiviso e certificata da analisi di istituti terzi. In questi giorni si stanno contando i protagonisti agricoltori che credono nella filiera che traccia il percorso dal seme allo scaffale. La pasta di semola di grano duro come normata dalla legislazione italiana è la principale fonte alimentare della “Dieta mediterranea” e gli italiani che la preferiscono hanno diritto di riconoscere la provenienza del frumento che ne è l’unica componente, conoscere la provenienza significa riconoscere il territorio di origine, la cura del ciclo biologico in campo, la trasformazione molito-
ria e la pastificazione. Camerata Picena è la “porta” di questo Distretto marchigiano del cibo, porta che si apre sulle colline anconetane, maceratesi e fermane dove la brezza dell’Adriatico conferisce al frumento caratteristiche organolettiche e sanitarie non riproducibili in altre aree del pianeta.
1967: le premesse
Al XIV Convegno della Società Italiana di Genetica Agraria, nell’aprile 1970, fu ricevuta la Pubblicazione n. 252 del Laboratorio per le Applicazioni in Agricoltura del Cnen “[…] Le premesse che ci spinsero a tentare la diffusione di alcune linee di frumento duro ottenute mediante l’uso di agenti mutageni al di fuori delle aree tipiche di questa coltura, poggiavano principalmente sul fatto che il clima e, soprattutto, i terreni argillosi e freschi delle Marche potessero evitare a questa coltura la principale avversità rappresentata dai pericoli della stretta. Tale fenomeno è provocato comunemente da eccessivo

caldo arido e da terreno con scarse riserve idriche, condizioni che spesso si verificano nelle regioni dell’Italia meridionale e insulare. Tali pericoli si verificano più spesso su colture di frumento duro che su quelle di frumento tenero poiché in genere i frumenti duri hanno semi più grossi e che maturano in un tempo più lungo, quando con l’inizio dell’estate le piogge sono sempre più rare e le temperature giornaliere sono in rapido aumento. I risultati favorevoli ottenuti nel primo triennio di prove (C. Mosconi, 1967) hanno spinto il Laboratorio del Cnen ad approfondire le esperienze intraprese”. “C. Mosconi” è Carlo Mosconi, marchigiano di Castelferretti, agronomo-genetista che nel 1974 insieme ad Alessandro Bozzini per il Cnen registrò la nuova varietà “Creso” di frumento duro.
Il frumento grano duro nelle Marche, dall’innovazione alla tradizione
A sud di Bologna l’agricoltura italiana è poco competitiva nelle colture Cof (cereali, oleaginose, foraggere) ma il grano duro - specialmente in Puglia/Basilicata, Sicilia e Marche - è ritenuto “coltura tipica”. Il settore ha davanti due problemi: uno interno, la sua efficienza ed efficacia; uno esterno, le regole del gioco. Quando pensiamo al duro non dobbiamo dimenticare il tenero perché il mondo del
pane è in rivoluzione. L’aggregazione, la logistica, la limpidezza delle borse merci, la produttività sono temi che deve affrontare e risolvere il produttore in prima persona senza troppo delegare a chi non rappresenta i suoi interessi ma le regole del gioco riguardano tutti: produttore di materia prima, intermediari di trasformazione, consumatore, società. Non privilegiare la produzione agricola interna è come favorire la delocalizzazione industriale: ne abbiamo esempi vicini.
A metà degli anni sessanta, il consumo di pasta alimentare aveva iniziato a crescere in tutti gli strati della popolazione, l’esodo dalle campagne aveva ridotto la produzione casalinga e favorito quella “compra” - com’era definita quella che si acquistava allora anche sfusa - la pasta “compra” era fatta industrialmente e il frumento duro era - ed è - la materia prima d’eccellenza; il consumo cresceva ma le zone di coltivazione del sud spesso davano raccolti insufficienti alla richiesta dell’industria di trasformazione. In quegli anni l’allora Cnen - oggi Enea - (Comitato Nazionale Energia Nucleare) con il suo Laboratorio per le Applicazioni in Agricoltura si occupava anche di ricerca genetica e si pose l’obiettivo del miglioramento del frumento duro; si sperimentarono anche alcune “mutanti” di frumento duro nelle Marche. “Il frumento duro, alla fine


degli anni Sessanta, era presente nella regione (Marche) su poche decine di ettari a scopo sperimentale” (R. Ceccarelli, Grano, pane e riso nella Marca di Ancona, 2001). Quegli esperimenti erano nelle colline di Camerata Picena.
Lo storico Riccardo Ceccarelli ha ricordato - con adeguati riferimenti bibliografici - che le Marche, specialmente nell’area centrale lungo le valli del Misa, dell’Esino e del Chienti, sono state considerate dal Cinquecento all’Ottocento il “granaio dello Stato Pontificio” mentre nei primi anni del Novecento il granturco e il frumento (tenero) si coltivavano quasi ovunque, anche se “i prodotti bastano appena ai bisogni locali”. Il tessuto tipicamente mezzadrile del primo ‘900 si è evoluto senza stravolgimenti nel secondo dopoguerra con la rivoluzione industriale che ha chiamato lavoro nei centri più grandi della costa e con la rivoluzione verde che ha dato forma a una nuova agricoltura, non più di sola sussistenza ma anche produttiva e commerciale specializzandosi nei diversi settori.
La testimonianza del professor Alessandro Bozzini (Cnen-Enea) ha descritto il percorso che lo ha portato al Creso, dall’incontro con D’Amato e Borlaug, con i frumenti messicani resistenti alle ruggini e l’introduzione del nanismo fino agli incroci con il Castelporziano e i successivi con il Cappelli. Fino
agli anni ’60 tutte le varietà di grano duro erano caratterizzate da una taglia molto alta, 140-180 cm, che le rendeva fortemente soggette agli allettamenti, cioè al ripiegamento della pianta fino a terra, che arrecava gravissimi danni alla coltura, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Per superare tale problema, che non consentiva di adottare alcuna innovazione (l’uso dei fertilizzanti azotati aumentava notevolmente il rischio di allettamento), si erano ricercate possibili fonti genetiche di bassa taglia nelle varie collezioni mondiali, oppure tentato di abbassare la taglia delle singole varietà incrociandole con quelle di grano tenero ma con una riduzione della qualità pastificatoria. Con la mutagenesi fu possibile selezionare molti mutanti a taglia bassa e con caratteristiche agronomiche assai positive. Alcuni furono iscritti nel Registro Nazionale delle Varietà: Castelfusano e Castelporziano, entrambi selezionati tra i mutanti del Cappelli. Essi rappresentano le prime varietà di grano duro a taglia significativamente ridotta a essere coltivati ed erano resistenti all’allettamento e consentivano anche di applicare con successo le concimazioni azotate. Furono i primi grani duri a essere coltivati anche nei terreni fertili.
Per migliorare le caratteristiche dei mutanti e per trasferire i “caratteri mutati” in nuove varietà, fu realizzato un ampio programma di incroci, con successive selezioni genetiche per caratteristiche di interesse agronomico (resistenza all’allettamento, precocità, resistenza alle malattie, produttività) e per caratteristiche qualitative della granella (peso ettolitrico, proteine, capacita pastificatoria). La ricerca di allora ha portato frutto; anche oggi la ricerca genetica è chiamata ad affrontare problemi. Nel 2013 il frumento duro marchigiano è stato pari al 16% della produzione nazionale, occupando il solo 12% della superficie, dimostrando la spiccata specializzazione regionale.
Complessivamente le aziende rilevate che coltivano duro sono poco più di 16 mila, un quarto di queste dispongono di meno di 3 ha e rappresentano il 4% della sau; solo un quinto dispongono di almeno 20 ha e rappresentano il 64% della sau. A fronte di una superficie coltivata (136 mila ha nel 2013) da 16 mila aziende risulta una media aziendale di 8 ha a frumento duro, dato dal quale si può presumere una superficie totale dell’azienda “media” pari a 16 ha
(frumento al 50% in rotazione con proteoleaginose). Gli areali dove la presenza del frumento duro è maggiore sono le medio-basse valli del Misa, dell’Esino e del Chienti.
È la coltivazione più diffusa nelle Marche grazie al suo ottimo adattamento alle peculiarità del territorio: le caratteristiche qualitative delle produzioni sono mediamente elevate rispetto alla media nazionale, purtroppo la produzione è ancora troppo indifferenziata rispetto a quella di altre regioni quindi povera soprattutto per quelle aziende di piccola dimensione che non hanno alternative al seminativo asciutto; la domanda mondiale è prevista in crescita con buone prospettive anche per i cereali minori ma esige un consolidamento della filiera che appare attualmente debole soprattutto nella fase di prima (molini) e seconda (pastifici) trasformazione locale.
Il Creso: un esempio di innovazione nel sistema agroalimentare
Tra le nuove linee selezionate apparve subito emergere la linea FB55, con piante basse e vigorose, spighe molto fertili, resistente alle malattie e in particolare alle ruggini. Fu iscritta con il nome Creso. Selezionata nei laboratori per le applicazioni in agricoltura del Cnen da un incrocio fra un grano mutante (B144) radio indotto dal Cappelli e una linea del Centro Internacional de Mejoramento de Maize & Trigo, si rivelò ben presto di grande interesse
agronomico e industriale per l’elevata produttività in campo e la buona qualità di pastificazione. Iscritta nel 1974 nel Registro Nazionale delle varietà di grano duro, in pochi anni diventò la varietà più coltivata in Italia (già nel 1982 rappresentava il 60% della semente di grano duro certificata) facendo raddoppiare la produzione italiana di grano duro a parità di superficie. La varietà incontrò subito il favore degli agricoltori più preparati che, impiegando moderne tecniche agronomiche di coltivazione, raggiunsero in Italia centrale produzioni uguali o superiori a quelle del frumento tenero. L’agricoltore fu favorevolmente impressionato dall’aspetto della granella di Creso, dalla adattabilità di tale varietà e dalla positiva risposta ad ogni miglioramento della tecnica colturale. Le industrie di trasformazione (mugnai e pastai) accettarono e apprezzarono la qualità tecnologica del prodotto che risultò assai elevata sia per le caratteristiche genetiche sia per le migliorate tecniche colturali.
Il Creso si diffuse rapidamente in tutta l’Italia Centrale (Lazio, Toscana e Marche in particolare), nelle zone Adriatiche del Nord a clima non rigidamente continentale e nel Mezzogiorno. Secondo i dati Istat, la superficie coltivata a Creso è passata da poche decine di ettari nel 1973 a 77.000 ettari nel 1976, a oltre 400.000 ha nel 1982. Nel 1983 il Creso era coltivato su 31.573 ha in Toscana, 81.782 ha nelle Marche, 38.754 in Puglia, 22.900 ha in Basilicata,
60.000 ha in Sicilia. Il Creso, varietà iscritta nel 1974, raggiunse nel 1984 il 58,3% di tutto il seme certificato di grano duro in Italia.
L’utilizzo della varietà Creso, accompagnato da una sempre più appropriata tecnica colturale, ha significato per l’agricoltore evidenti benefici economici e un incremento della produzione nazionale di duro - realizzato grazie alle caratteristiche di maggior produttività del Creso rispetto alle varietà preesistenti - dalle 60 mila ton. del 1976 alle 370 mila del 1984. Il Creso ha sostituito il grano tenero in molte aree del centro nord e in particolare nelle Marche ridimensionando il grosso deficit dell’Italia per tale prodotto. Se tale varietà è avvantaggiata dall’ adozione di moderne tecniche agronomiche, si può altresì aggiungere che essa ha agito come veicolo di promozione tecnologica (e non solo) presso le aziende agrarie, le Società sementiere e le industrie di trasformazione. Questo frumento rappresenta il frutto di una intima connessione tra ricerca scientifica e produttori agricoli e l’innovazione si è realizzata per merito delle ricerche in un centro di alto livello scientifico. La varietà Creso è stata determinante per una vera e propria rivoluzione cerealicola in Italia. Ha fatto crescere tutta la coltura del grano duro: da sinonimo di povertà economica, agronomica, varietale, quella del grano duro è diventata una coltura ad alta tecnologia: seme certificato, tecniche agronomiche accurate; l’industria molitoria e quella pastaria sono diventate le prime del mondo.
La pasta di solo grano duro è rimasta un prodotto tipico, anzi si è affermata come piatto tipico italiano; senza la ricerca e l’innovazione, sarebbe rimasta una peculiarità sconosciuta ai più (è giusto tenere riservato in una nicchia un prodotto di qualità apprezzabile da tutti?). Il Creso ha dimostrato che an-
che i prodotti tipici si avvalgono con successo del contributo della ricerca e dell’innovazione. Anche oggi all’agricoltura italiana si richiede di soddisfare le esigenze alimentari primarie, di accontentare le sempre crescenti e diversificate aspettative del moderno consumatore quindi di adottare le più avanzate tecnologie garantendo la sostenibilità ambientale non rinunciando a essere competitiva sul mercato internazionale. A chi opera in agricoltura il consumatore moderno chiede una responsabilità specifica riguardo alla fornitura di cibo sano con qualità in quantità, adatto alle sue moderne esigenze. Questo possono fare l’agricoltura e l’industria insieme anche se più recentemente l’agricoltura pare solo usata quale immagine bucolica per ammaliare il consumatore distraendolo da una buona e doverosa ricerca di prodotto salubre, sano, sostenibile, semplicemente.
Questo è il distretto del frumento duro
Nella collina litoranea tra Falconara Marittima e Camerata Picena prese avvio la coltivazione del “duro” alla fine degli anni ’60 del 900, un “epicentro” tra Jesi e Macerata, un territorio storico quello della “antica Marca Anconitana”, un possibile distretto rurale vocato ai frumenti. Un marchio pensato per l’occasione “Gran_de’Marca” può così identificare il frumento marchigiano e stimolare un progetto cui hanno promesso di lavorare una banca locale, una società partner di fiducia dei coltivatori e istituzioni che hanno ricordato, osservato e proposto un futuro all’agricoltura marchigiana tutta, chiamando gli agricoltori ad “attivarsi”.
Nel 1981 si sono coltivati 214.000 ha di frumento (144 tenero + 70 duro) in sole 7 campagne il duro da zero arrivò ad un terzo della superficie destinata ai frumenti (oggi da 214 a 135 un calo del 37% con rapporti diversi: tenero meno di 18, duro quasi 120) Il duro ha mosso i suoi primi passi qui, in agro di Camerata Picena, in continue sperimentazioni fin dagli anni ’60 e da qui si prospetta di identificare l’areale tipico, prima nei 5 comuni dell’Unione poi fino a tutta l’Antica Marca Anconitana. In 50 anni il duro qui ha dato molte soddisfazioni agli agricoltori e anche ai pastifici, da qui è partita anche l’avventura di quella che è diventata l’azienda “sementiera” più importante d’Italia. Qui - in questa Regione - il “seminativo” rappresenta quasi l’80% della superficie


coltivata e circa il 30% della PLV. La percentuale di seminativo sulla Sau è la più alta d’Italia (Toscana 63%, Puglia 53%, Sicilia 49%, Abruzzo 40%). Anche l’incidenza della Pac sul reddito dell’agricoltore (Frascarelli, T.V. 34/18) risulta superiore alla media italiana: 44,1% contro 28,3% (Toscana 34,05; Puglia 41,0%; Sicilia 32,4%; Abruzzo 20,8%); questo significa che il titolo Pac - praticamente uniforme a livello nazionale - è una componente importante per le agricolture povere e meno determinante per quelle ricche (Trentino 11,6%; Alto Adige 11,9%; Friuli V.G. 14,6%; Lombardia 16,7%).
Solo una coltura sostiene economicamente il seminativo marchigiano da 50 anni: il frumento a grano duro (introdotto nel 1974) che ha fatto rientrare la regione tra le “tradizionali” dandole il diritto al premio accoppiato. All’epoca della lira il premio al duro superava il milione di lire (grazie a Giulio Leopardi Dittaiuti, marchigiano anche lui). Quei 120.000 ha di frumento a grano duro marchigiani producono circa 600.000 ton di granaglie che, nel 2014/2015 valevano 240 mln/euro (400 euro/ton) e oggi solo 180 mln/euro, praticamente solo tre quarti, eppure da quelle 600.000 ton si ricavano 400 mln di kg di pasta che vale non meno di 800 mln di euro.
Il riconoscimento del “Gran_de’Marca”
Dal 2008 - con la prima Conferenza sul tema - si è individuata l’opportunità e la necessità di valorizzare la produzione marchigiana di frumento duro
per la pasta alimentare; da allora si è consapevoli che la Regione Marche rappresenta il terzo distretto italiano per la coltivazione del “duro” dopo quello “Apulo-Lucano” e quello di “Trinacria”. Ecco che il Distretto “Gran_de’Marca”, oggi riconosciuto da Regione Marche, raccontato nelle sue motivazioni storiche ed economiche, da qui deve rappresentare il progetto per i prossimi 50 anni di agricoltura. Tale riconoscimento è la chiave per assicurare la provenienza della materia prima della pasta alimentare italiana, materia prima coltivata secondo un disciplinare condiviso e certificata da analisi di istituti terzi con una filiera che evidenzia il percorso dal seme al piatto.
Conoscere la provenienza significa identificare il territorio di origine, la cura del ciclo biologico in campo, la trasformazione molitoria e la pastificazione. Le 500.000 ton che annualmente si producono nella regione Marche - grazie ai progetti infrastrutturali realizzabili con le provvidenze comunitarie riservate ai distretti riconosciuti - potrebbero/dovrebbero essere molite interamente in territorio marchigiano. Le semole che ne derivano potrebbero/dovrebbero essere distinte e non confuse tra le altre. Le paste alimentari - derivate da frumento marchigiano - potrebbero/dovrebbero avere il bollino identificativo “Gran_de’Marca” e potrebbero/dovrebbero essere preferite dal consumatore.
Marino Mosconi
Sabato 27 settembre 2025 si è svolta ad Altamura la Giornata Tecnica dell’Antim
In prima fila tutto il nuovo Consiglio Antim, il presidente Cavalli Lorenzo, il vicepresidente Massimo Zorzetto, il tesoriere Gerardo Calvello, il segretario Gobbo Radamez, insieme ai nuovi consiglieri Andrea Colombo, Luigi Iorio e Stefano Mazzini, per una giornata tecnica all’insegna di un tema molto sentito, anche per via della questione dazi.
Gli interventi
Dopo i saluti inziali del presidente, si è subito passati alle relazioni, la prima delle quali di Carmine Ricciardi di Bühler che ha parlato di “Processi di pastificazione: dalle semole alla pasta di qualità”. La lavorazione della pasta può strutturarsi in più modi, ancorché il processo
più comune sia la produzione di pasta secca di grano duro senza ingredienti aggiuntivi. Ricciardi passa in rassegne quella che sono le paste alternative, realizzate con materia prime diverse rispetto alla semola di grano duro, ovvero mais, riso, sorgo, miglio, avena ecc. successivamente, mostra un semplice diagramma di flusso della produzione di pasta secca di grano duro con i tre processi di miscelazione, estrusione ed essiccazione. L’argomento presentato si concentra sulla fase di miscelazione, in cui la semola, che generalmente ha una granulometria compresa tra 100 e 500 µm, viene miscelata con acqua, in genere fino a raggiungere un contenuto totale di acqua del 31%. Vengono poi passate in rassegna diverse tecniche di misce -
a cura della Redazione
lazione che possono variare notevolmente in termini di tempo di permanenza della miscela acqua/semola. I processi di miscelazione tradizionali, di lunga durata, possono arrivare fino a 20 minuti, mentre alcune tecniche di miscelazione moderne e rapide non richiedono più di 30 secondi. Tuttavia, l’obiettivo della fase di miscelazione è la formazione di una semola uniformemente plastificata.
La seconda relazione è stata a cura di Marco Galli di Ocrim, dal titolo “La produzione di semola in un mercato dinamico”. Ora, produrre qualsiasi genere da commercializzare richiede di avere chiaro che le specifiche del prodotto sono definite dall’utilizzatore finale. Questo vuol dire che gli impianti devono essere il più flessibile possibile sia nella produzione sia nell’uso della materia prima con lo scopo di cogliere le opportunità che il mercato offre, sapendo che la richiesta è sempre più personaliz -
zata e questa sarà la tendenza futura. Parlare oggi di gestione dei frumenti, continua Galli, non è solo parlare di diagrammi e/o macchine: un tema di grande importanza che è sempre più impattante per la gestione industriale ottimale è la miscelazione dei grani, intesa come mezzo per garantire costanza del prodotto finito nel tempo. Si tratta di un aspetto fondamentale in qualsiasi linea di produzione, con risvolti economici importanti poiché permette di cogliere le opportunità di mercato sull’acquisto del frumento e il suo utilizzo nelle differenti produzioni. L’ideale sarebbe avere una miscela che si basi sull’ottenimento di una costanza qualitativa rispetto a una quantitativa. Come Ocrim si sono quindi domandati come garantire la costanza qualitativa nel tempo. E la loro risposta è stata il “QTM”
Un tema importante è la miscelazione dei grani
Quattro i pilastri strategici che sostengono qualità e sostenibilità
(Quality Target Mixing), un principio di miscela che integra i sistemi di dosaggio con il rilevamento in linea delle proteine, ovvero un sistema dinamico che gestisce i dosatori ponderali in funzione delle letture in “Real Time” del contenuto proteico della miscela e che, in variazioni rispetto al set-point, tramite un sistema integrato di supervisione varia il dosaggio dei singoli frumenti per correggere qualitativamente la miscela.
La parola è poi passata a Luigi Iorio, Saverio La Volpe e Stefano Rossi di Barilla che hanno riflettuto su sostenibilità e sviluppo tecnologico
del processo, parola d’ordine per un’azienda efficiente. Il loro focus è stato su quelli che sono i quattro pilastri strategici che sostengono qualità e sostenibilità: ricerca e sviluppo, specialmente per i nuovi strumenti di misura, per la validazione dei processi, per i diagrammi di macinazione; gli impianti, con la scelta dei macchinari, l’efficienza degli stessi e le corrette manutenzioni; le persone e la loro sicurezza, il loro benessere, la loro formazione e crescita; il controllo, di sicurezza e qualità, del processo e delle performance. Quindi sono passati a trattare le leve di miglioramento per un equilibrio della tecnologia di macinazione.
Gli altri speech e la presentazione del Molino Barilla di Altamura
Spazio come sempre per gli sponsor, alcuni dei quali hanno avuto la possibilità di esporre una relazione. Come Enrico Bagarollo di Newpharm che ha parlato delle novità aziendali: nelle metodologie primarie e integrative alla protezione cereali nelle fasi dello stoccaggio. E ancora, Paolo Guerra di Evoluzione Servizi che ha affrontato le nuove metodologie per il trattamento conservativo dei cereali e derivati con atmosfera modificata.
L’impianto Barilla di Altamura
Al termine di queste due relazioni, Francesco Piemontese plant director del Molino di Altamura del Gruppo Barilla ha illustrato ai presenti l’impianto che è stato poi visitato nel pomeriggio della medesima giornata. Un molino, quello pugliese, che unisce tradizione e innovazione: l’arte del saper fare si sposa con l’avanguardia, per dare vita a una materia prima di qualità.
Riconoscimenti
Al convegno ha partecipato l’I.T.S. Academy Agribusiness School con la presenza di docenti, alunni e tutor nonché la Presidente dei “Giovani Italmopa” Clelia Loiudice. Prima della chiusura

del Convegno, il Presidente Cavalli a nome del Consiglio Direttivo, ha ricordato che il prossimo dicembre l’Antim festeggerà i suoi 35 anni di nascita e per l’occasione non poteva non consegnare due pubblici riconoscimenti a due persone che in maniera diversa hanno e stanno contribuendo al successo sempre più crescente dell’Associazione. La prima targa è stata data al Dott. Claudio Vercellone - Ceo Avenue Media con la seguente motivazione: “Con profonda gratitudine per la professionalità, la passione e la cura con cui avete reso i nostri eventi un’esperienza indimenticabile. Il vostro impegno e la vostra dedizione sono stati fondamentali per il successo di ogni iniziativa”. La seconda targa è stata consegnata alla Dott.ssa Anna Lucia Dell’Acqua - storica commercialista Antimcon la seguente motivazione: “Per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata, che hanno contribuito in modo significativo al successo e la crescita dell’Antim”. Il Presidente ha peraltro voluto sottolineare all’intera Assemblea che la dottoressa ha svolto e svolge in forma gratuita la sua attività per l’Associazione.
Il prossimo dicembre l’Antim festeggerà i suoi 35 anni
Marco Galli di Ocrim
Da sinistra, Claudio Vercellone, Ceo di Avenue media e Anna Lucia Dell’Acqua, storica commercialista Antim
L’informazione professionale specializzata per: - l’industria pastaria - i pastifici artigianali - i laboratori - i costruttori di macchinari - i tecnici alimentari - i fornitori di materie prime