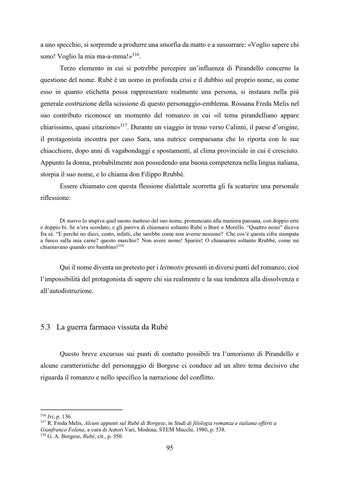a uno specchio, si sorprende a produrre una smorfia da matto e a sussurrare: «Voglio sapere chi sono! Voglio la mia ma-a-mma!»316. Terzo elemento in cui si potrebbe percepire un’influenza di Pirandello concerne la questione del nome. Rubè è un uomo in profonda crisi e il dubbio sul proprio nome, su come esso in quanto etichetta possa rappresentare realmente una persona, si instaura nella più generale costruzione della scissione di questo personaggio-emblema. Rossana Freda Melis nel suo contributo riconosce un momento del romanzo in cui «il tema pirandelliano appare chiarissimo, quasi citazione»317. Durante un viaggio in treno verso Calinni, il paese d’origine, il protagonista incontra per caso Sara, una nutrice compaesana che lo riporta con le sue chiacchiere, dopo anni di vagabondaggi e spostamenti, al clima provinciale in cui è cresciuto. Appunto la donna, probabilmente non possedendo una buona competenza nella lingua italiana, storpia il suo nome, e lo chiama don Filippo Rrubbè. Essere chiamato con questa flessione dialettale scorretta gli fa scaturire una personale riflessione:
Di nuovo lo stupiva quel suono inatteso del suo nome, pronunciato alla maniera paesana, con doppio erre e doppio bi. Se n’era scordato, e gli pareva di chiamarsi soltanto Rubè o Burè o Morello. “Quattro nomi” diceva fra sé. “E perché no dieci, cento, infatti, che sarebbe come non averne nessuno? Che cos’è questa cifra stampata a fuoco sulla mia carne? questo marchio? Non avere nome! Sparire! O chiamarmi soltanto Rrubbè, come mi chiamavano quando ero bambino!318
Qui il nome diventa un pretesto per i leitmotiv presenti in diversi punti del romanzo, cioè l’impossibilità del protagonista di sapere chi sia realmente e la sua tendenza alla dissolvenza e all’autodistruzione.
5.3 La guerra farmaco vissuta da Rubè Questo breve excursus sui punti di contatto possibili tra l’umorismo di Pirandello e alcune caratteristiche del personaggio di Borgese ci conduce ad un altro tema decisivo che riguarda il romanzo e nello specifico la narrazione del conflitto.
316
Ivi, p. 136. R. Freda Melis, Alcuni appunti sul Rubè di Borgese, in Studi di filologia romanza e italiana offerti a Gianfranco Folena, a cura di Autori Vari, Modena, STEM Mucchi, 1980, p. 538. 318 G. A. Borgese, Rubè, cit., p. 350.
317
95