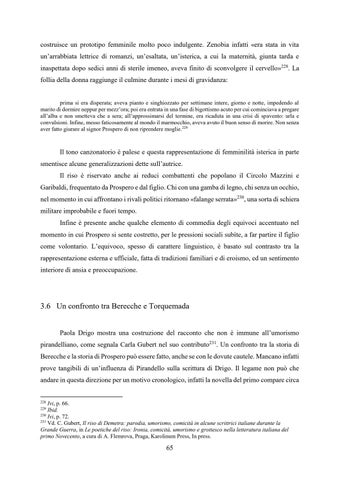costruisce un prototipo femminile molto poco indulgente. Zenobia infatti «era stata in vita un’arrabbiata lettrice di romanzi, un’esaltata, un’isterica, a cui la maternità, giunta tarda e inaspettata dopo sedici anni di sterile imeneo, aveva finito di sconvolgere il cervello»228. La follia della donna raggiunge il culmine durante i mesi di gravidanza:
prima si era disperata; aveva pianto e singhiozzato per settimane intere, giorno e notte, impedendo al marito di dormire neppur per mezz’ora; poi era entrata in una fase di bigottismo acuto per cui cominciava a pregare all’alba e non smetteva che a sera; all’approssimarsi del termine, era ricaduta in una crisi di spavento: urla e convulsioni. Infine, messo faticosamente al mondo il marmocchio, aveva avuto il buon senso di morire. Non senza aver fatto giurare al signor Prospero di non riprendere moglie. 229
Il tono canzonatorio è palese e questa rappresentazione di femminilità isterica in parte smentisce alcune generalizzazioni dette sull’autrice. Il riso è riservato anche ai reduci combattenti che popolano il Circolo Mazzini e Garibaldi, frequentato da Prospero e dal figlio. Chi con una gamba di legno, chi senza un occhio, nel momento in cui affrontano i rivali politici ritornano «falange serrata»230, una sorta di schiera militare improbabile e fuori tempo. Infine è presente anche qualche elemento di commedia degli equivoci accentuato nel momento in cui Prospero si sente costretto, per le pressioni sociali subìte, a far partire il figlio come volontario. L’equivoco, spesso di carattere linguistico, è basato sul contrasto tra la rappresentazione esterna e ufficiale, fatta di tradizioni familiari e di eroismo, ed un sentimento interiore di ansia e preoccupazione.
3.6 Un confronto tra Berecche e Torquemada Paola Drigo mostra una costruzione del racconto che non è immune all’umorismo pirandelliano, come segnala Carla Gubert nel suo contributo231. Un confronto tra la storia di Berecche e la storia di Prospero può essere fatto, anche se con le dovute cautele. Mancano infatti prove tangibili di un’influenza di Pirandello sulla scrittura di Drigo. Il legame non può che andare in questa direzione per un motivo cronologico, infatti la novella del primo compare circa
228
Ivi, p. 66. Ibid. 230 Ivi, p. 72. 231 Vd. C. Gubert, Il riso di Demetra: parodia, umorismo, comicità in alcune scrittrici italiane durante la Grande Guerra, in Le poetiche del riso: Ironia, comicità, umorismo e grottesco nella letteratura italiana del primo Novecento, a cura di A. Flemrova, Praga, Karolinum Press, In press. 229
65