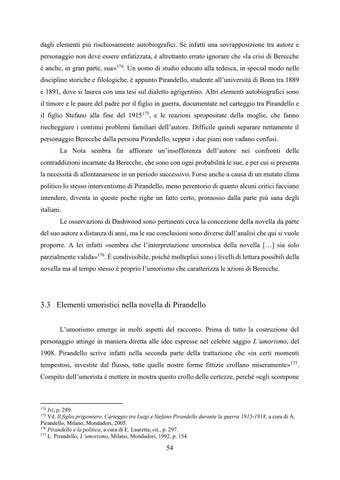dagli elementi più rischiosamente autobiografici. Se infatti una sovrapposizione tra autore e personaggio non deve essere enfatizzata, è altrettanto errato ignorare che «la crisi di Berecche è anche, in gran parte, sua»174. Un uomo di studio educato alla tedesca, in special modo nelle discipline storiche e filologiche, è appunto Pirandello, studente all’università di Bonn tra 1889 e 1891, dove si laurea con una tesi sul dialetto agrigentino. Altri elementi autobiografici sono il timore e le paure del padre per il figlio in guerra, documentate nel carteggio tra Pirandello e il figlio Stefano alla fine del 1915175, e le reazioni spropositate della moglie, che fanno riecheggiare i continui problemi familiari dell’autore. Difficile quindi separare nettamente il personaggio Berecche dalla persona Pirandello, seppur i due piani non vadano confusi. La Nota sembra far affiorare un’insofferenza dell’autore nei confronti delle contraddizioni incarnate da Berecche, che sono con ogni probabilità le sue, e per cui si presenta la necessità di allontanarsene in un periodo successivo. Forse anche a causa di un mutato clima politico lo stesso interventismo di Pirandello, meno perentorio di quanto alcuni critici facciano intendere, diventa in queste poche righe un fatto certo, promosso dalla parte più sana degli italiani. Le osservazioni di Dashwood sono pertinenti circa la concezione della novella da parte del suo autore a distanza di anni, ma le sue conclusioni sono diverse dall’analisi che qui si vuole proporre. A lei infatti «sembra che l’interpretazione umoristica della novella […] sia solo parzialmente valida»176. È condivisibile, poiché molteplici sono i livelli di lettura possibili della novella ma al tempo stesso è proprio l’umorismo che caratterizza le azioni di Berecche.
3.3 Elementi umoristici nella novella di Pirandello L’umorismo emerge in molti aspetti del racconto. Prima di tutto la costruzione del personaggio attinge in maniera diretta alle idee espresse nel celebre saggio L’umorismo, del 1908. Pirandello scrive infatti nella seconda parte della trattazione che «in certi momenti tempestosi, investite dal flusso, tutte quelle nostre forme fittizie crollano miseramente»177. Compito dell’umorista è mettere in mostra questo crollo delle certezze, perché «egli scompone
174
Ivi, p. 289. Vd. Il figlio prigioniero. Carteggio tra Luigi e Stefano Pirandello durante la guerra 1915-1918, a cura di A. Pirandello, Milano, Mondadori, 2005. 176 Pirandello e la politica, a cura di E. Lauretta, cit., p. 297. 177 L. Pirandello, L’umorismo, Milano, Mondadori, 1992, p. 154. 175
54