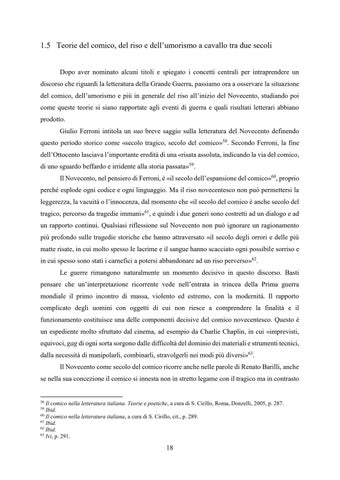1.5 Teorie del comico, del riso e dell’umorismo a cavallo tra due secoli Dopo aver nominato alcuni titoli e spiegato i concetti centrali per intraprendere un discorso che riguardi la letteratura della Grande Guerra, passiamo ora a osservare la situazione del comico, dell’umorismo e più in generale del riso all’inizio del Novecento, studiando poi come queste teorie si siano rapportate agli eventi di guerra e quali risultati letterari abbiano prodotto. Giulio Ferroni intitola un suo breve saggio sulla letteratura del Novecento definendo questo periodo storico come «secolo tragico, secolo del comico»58. Secondo Ferroni, la fine dell’Ottocento lasciava l’importante eredità di una «risata assoluta, indicando la via del comico, di uno sguardo beffardo e irridente alla storia passata»59. Il Novecento, nel pensiero di Ferroni, è «il secolo dell’espansione del comico»60, proprio perché esplode ogni codice e ogni linguaggio. Ma il riso novecentesco non può permettersi la leggerezza, la vacuità o l’innocenza, dal momento che «il secolo del comico è anche secolo del tragico, percorso da tragedie immani»61, e quindi i due generi sono costretti ad un dialogo e ad un rapporto continui. Qualsiasi riflessione sul Novecento non può ignorare un ragionamento più profondo sulle tragedie storiche che hanno attraversato «il secolo degli orrori e delle più matte risate, in cui molto spesso le lacrime e il sangue hanno scacciato ogni possibile sorriso e in cui spesso sono stati i carnefici a potersi abbandonare ad un riso perverso»62. Le guerre rimangono naturalmente un momento decisivo in questo discorso. Basti pensare che un’interpretazione ricorrente vede nell’entrata in trincea della Prima guerra mondiale il primo incontro di massa, violento ed estremo, con la modernità. Il rapporto complicato degli uomini con oggetti di cui non riesce a comprendere la finalità e il funzionamento costituisce una delle componenti decisive del comico novecentesco. Questo è un espediente molto sfruttato dal cinema, ad esempio da Charlie Chaplin, in cui «imprevisti, equivoci, gag di ogni sorta sorgono dalle difficoltà del dominio dei materiali e strumenti tecnici, dalla necessità di manipolarli, combinarli, stravolgerli nei modi più diversi»63. Il Novecento come secolo del comico ricorre anche nelle parole di Renato Barilli, anche se nella sua concezione il comico si innesta non in stretto legame con il tragico ma in contrasto
58
Il comico nella letteratura italiana. Teorie e poetiche, a cura di S. Cirillo, Roma, Donzelli, 2005, p. 287. Ibid. 60 Il comico nella letteratura italiana, a cura di S. Cirillo, cit., p. 289. 61 Ibid. 62 Ibid. 63 Ivi, p. 291. 59
18