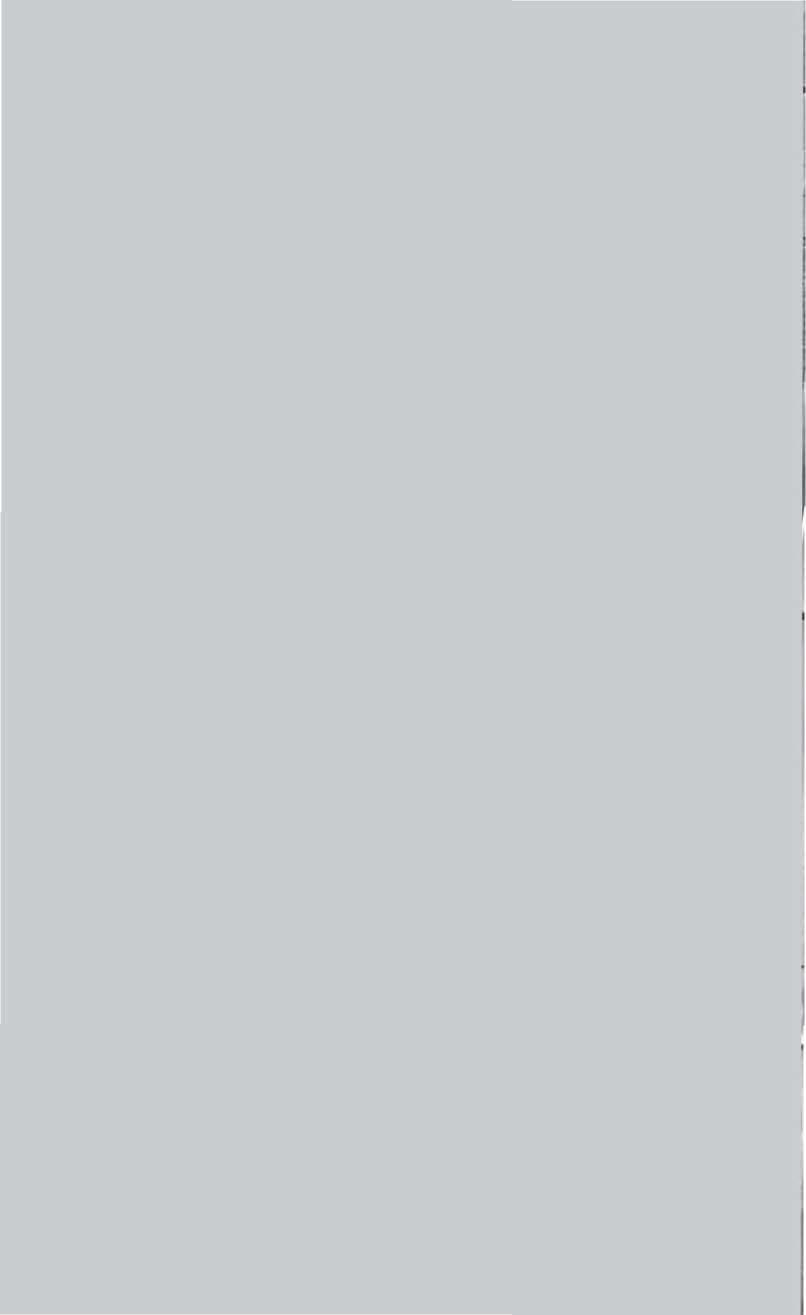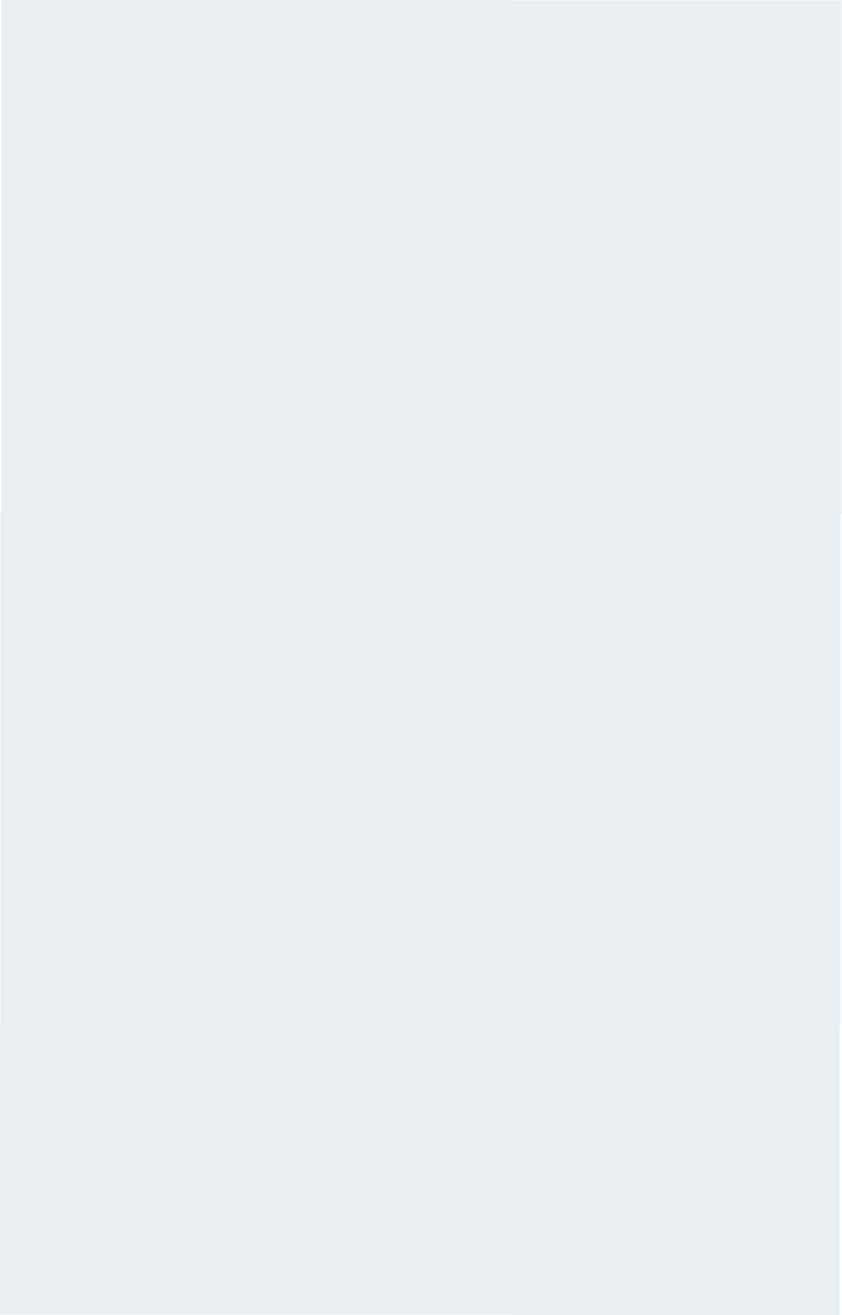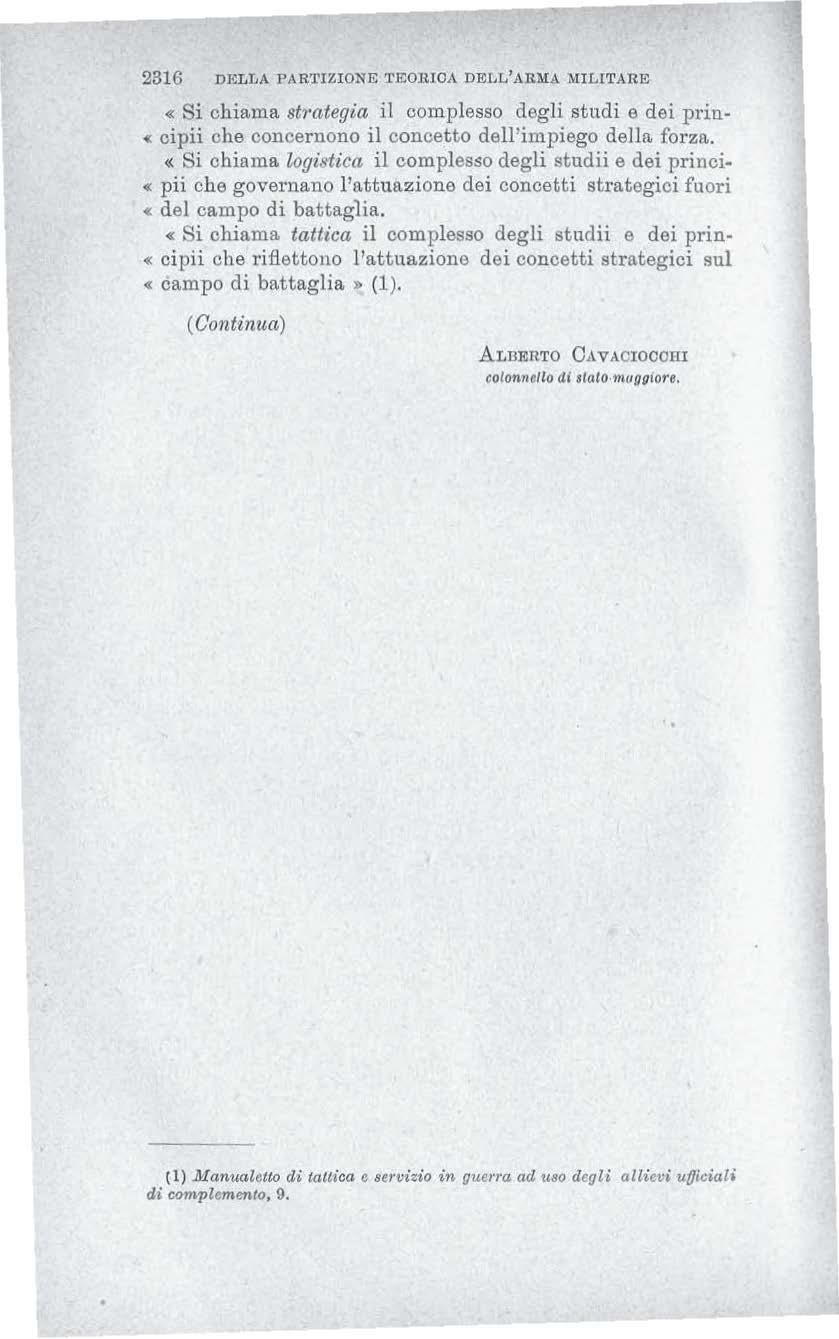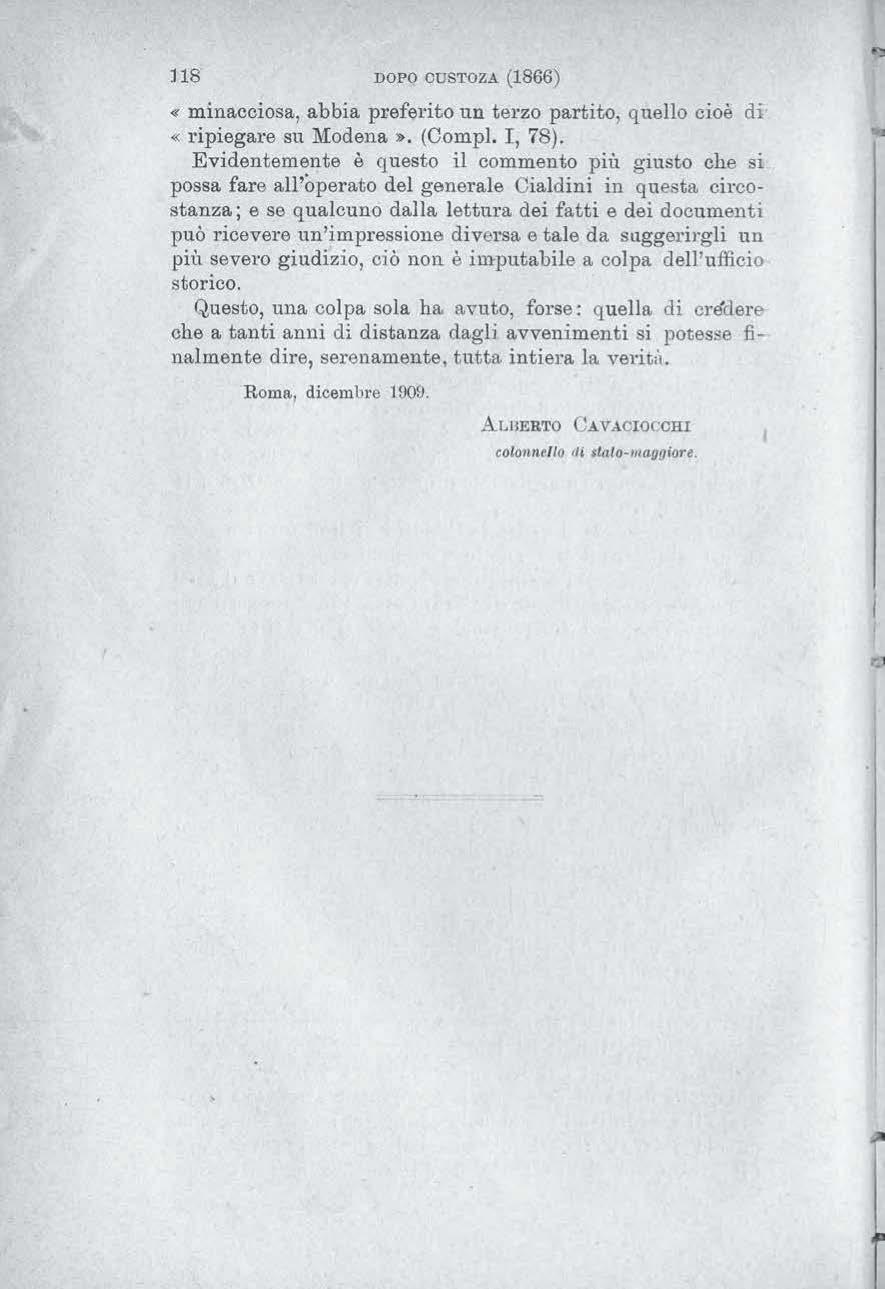A r t i c o l i P u b b l i c a t i d a l 1 9 0 7 a l 1 9 1 2 : a l l o r a C o l o n n e l l o d i S t a t o M a g g i o r e e p o i C o m a n d a n t e d e l 6 0 ° R G T F a n t e r i a .
ALBERTOCAVACIOCCHI
L e p r i m e g e s t a d i G a r i b a l d i i n I t a l i a
L a C i r c o s c r i z i o n e m i l i t a r e t e r r i t o r i a l e
L a d e f i n i z i o n e d e l l a d i s c i p l i n a
D e l l a p a r t i z i o n e t e o r i c a d e l l ' a r t e m i l i t a r e ( I e I I p a r t e )
R e l a z i o n e s u l c o n g r e s s o s t o r i c o i n t e r n a z i o n a l e d i S a r a g o z z a
D o p o C u s t o z z a - 1 8 6 6 ( R i s p o s t a a l g e n . B . O r e r o
S u i m e t o d i d i s c h e r m a p e r l ' E s e r c i t o
N o t e s u l l a F a n t e r i a ( I e I I p a r t e )

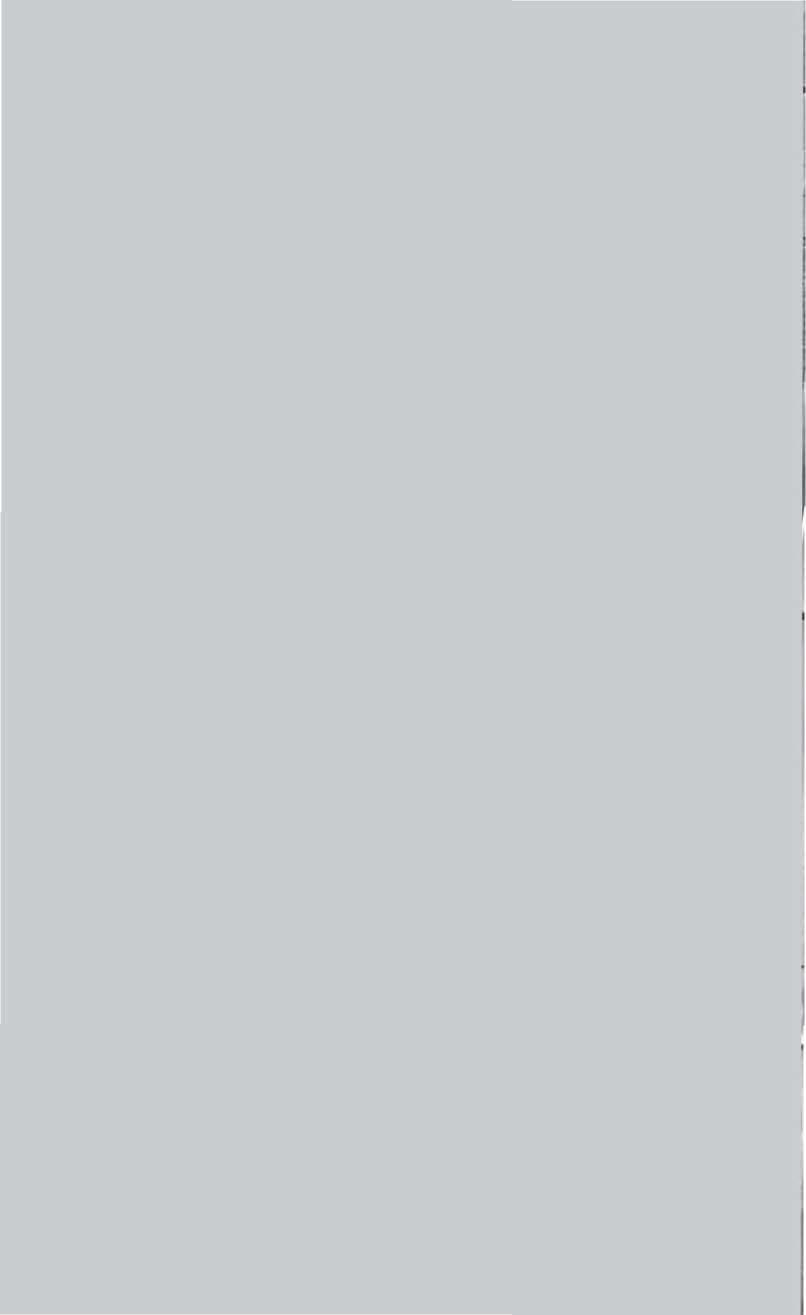
LE PI\UI EGESTA DI GA RI8ALDI INITAL I1 \
(',OIDlllCillOl'H•l'C tlcgn::uncntc Oiuseplle occorrel'(•bbe scl'ivt'ruc i11tern, ht storia•. Esistono, è vero, numerosi ra.ccouti della sua. vita o di episodi eli questa; ma da nN;suno mess i si può dire rhe n.p'Pain.no nella. vera lnce i iatti, poichò, indiprlllL<•ntementC' dali t' che vi Ai no t ano, talvolta i racconti stessi t'bbC'ro uno scopo pununC'nte apologetico, tn.l'allrd. t'bbC'ro un intN1to Op}lOl'IIO, qmltsi scmpl'O poi g li nntoti non seppero sottrarsi n. sen.timf'nti pn.rtirol:tl'i, o guardarono le cosCI da tlll punt.o di vistn, uuilnterftle.
La, Rtorin, non può rsscre scritta nhc coi documenti. Il docurnrnlo Atolico r:1ppresrnta Rempre un pt'nsiero od nn In t t o, c·bc !n o tu c.rccluto; il co nfron to <li molLi tlocmmrnti r icost.nlilSCC l'ambiente. nel quale i ll<>nsicri matmnrono c cl i fa t ti nccacldero, e dà. l'iliovo ai l)rott'tlgoni!;ti dr l qun <lro, disegnantloue lo sfondo.
Dai c\o('umenti Rn.1 1ora.rmo fnor i , ò VN'O, lllll'ttn ro qtt<•lle a (\tli rnrnnwnte può xot t <'lthmque rac<'h OJWra ma q u cll <• pai'Rioni npp1n irathto a l lei tor<' c.omP cose c·he (m·ono, non <'Olll(l c·osc chP sono, c gli renclera.ntLO anzi viva l'imTnn.ginl' delln. olw offre o,rgomrnLo al capitolo distol'ia, c·ousidN'a1 o.
Lot.ta continua fu a.11punlo l:t vitn, <li Chnihnldi: mn.gnanima. lotta. l>Cr alla q un le dobbiamo la patria,. l•} poichè col <l:w mo<lo di tnwdAI'<' con esattezza le [usi di (lUesta si erige nIla memorirHli Lui il monumento più bPllo o più dura.tmo
<:lt'Egli si lllt'riti, lutti quc•lli ehc posl'!ono debbono contribuit·vi c fr·a. i primi l'rscrcito. iniziare r.onlribnto c n servire di eccitamento c•ù
<>sempio, vn,lga, oggi, nel centrRimo a.univers;l.l'io tlclla. nasC'ita. dell'Eroe (t luglio 1807). una. ;rr·ie d i ùoc·umenti, concernenti le snr prime gesta in Italia (1) .

Sic·come peraltro tali docmuenti, sia per le ln,cune che presen1ano, ;;i a l)Cr l'indole loro, nou haRt.ano n. ricostruil·c gli tt.vvenimenti che corsero tra l'arrivo Ili Gl\ribalùi a Xizza. e il suo ri-
(l 1 clocnmenti qui fanno pnrte di nna. raccoltn. completa di tlocmnrnti, concernonti ,t.:li avvenimouti del l S ,lH, di ctù si sto.
LI\ puh!Jlioazione :\ cnrn. clell'nfllaio storico ùello Analogo ll\voro sta. apparecchianclo per lo :\ltre campagne della i.ndipondenzn. itn.lia.na.
1053
6i - li\. .
1054: LE l?RIMID GESTA DI C·ARIBAl,OI IN ITA.LIA torno in Lif.ru.ria dopo l'impn•sa. di }Jomzzone, sarù llenl! anzitutto rias-;umere bre,emente. sc•c·oudo ht VNsioue piu prohahilt', i fatti, ai quali i documenti :o:ervir debbono d'illustrazione.
Sul principio del 1818 Garibaldi, avuto !'<'lltorc in ..\lontend<'o delle rifornw couc('sse da Pio TX t> cl el eli fron<l•t che :-;p i m ìu vatrift ,, decide <l i r i tmire 111\ -pugno doi migliori <' velegp;ia.t'P per l'Italitl. ::::.iu dall'ottobre 1817 egli aveva offerto n l pontefi('(• il proprio braccio e la propria spatla. (1 ); ma, non avutane ri:-;po,;ta, si faceva Ot'u JH'<•Ceùt>t'<' da Giac·omo Medici, il quale oltre I>Pt' incitlw<• alht guetT<L le provhwh• llOll anc·ora solleva.te in per tll<'zzo dt•l Onrt·razzi pt·oponeva. nl grandu<·u di Toscana di <l<'stinan• Garibaldi :li comando lh·ll(' tl'lllllJP (2).
Jntnnt.o il 15 fl JlriiP l 81H il brigantino << Hpern nza >> l p;t da 1\[out.<•vicl<•o, rec·n.nclo il dmw c• HCf!sun1ucluc l inc•pt·ln lc> coste ch>lh\ approtlando u- Pota, l snllt• Hpa.gn.uol<•, In sitnazion.<' <qlp:tl'l' c·amhiata: l'<'>l<'I'C:ifo J)Ìt'lltOIIt<•sP HÌ l> lllliiO .. di TJOtnh:lnlia, e ai M()('.COtNi Yt'· l nnti d'u. ltt'<' varti tl' l talht :<•ti ;:. in 1!;\lN'l':t, eont.ro l ' Anioltl'iac:o!
Chuibaldi, non pin può tomare in patria<' sbarC'ar<• )lihcralll<'ntt• a Xizzn il !!1 ùi giugno , poichl> c•.on<i<llllla a mori<', prontuH'i:Lta. rouLro Ili lni nt•l l. conw di,;t•l'tOI'l' t' rib<'llP. <•
C\llt1C•f'llnt n (3). Il 28 l> n, ONlOVHj ivi t't-di si t nn ttit•nt· q nnlC'lH· m o, i do c·on. volo n turi la. pict•olu c•olonna <·otulotta Nl dalle• antorita militari. 11 luglio il t.t<'ll<'l'<llc! parl<' pPr il <m m po. <L JH't•nth•t·Yi ore li ai eh• l H1•, "viì1 larcli l:L snn. C'Olomm Hi n. illilano.
Circ•a In fath al n• (\n·lo ,\}))p!'{() Ìl\ noverlwlla, llOit r.onoseono docnmenti ufficiali; occorre dunque rimettc•rsi alle• varie momorie ehP ,tw tmttano ( 1). D;t NPill hra potcrsi 'r.h'c•gli [m il :3 c il l luglio u.l qnartic·r venemlt• di Uovcrlwlla (' si VJ'l''lClltÒ ÌllllllNiiata.nH'HtC' al Hc, c•ltC' ' lo a<·<·olse molto cortl•s<•meme <' si moslrò al fatto ùdl(• j!('· nell'America; ma nulla Hi cotwhins<', ]Wn:hè il Ht• lo rimandi. rl>i mittisLl'i, uUc!!audo h• uornw Il Pin(')li a.ttribui: (
(Ì) W . \1.\RIO. - « Ln. viti\ di Garibalcli », 13.
(2) l'M;ISI. - « Vita <lol gen. Giacomo lleclioi », 18.
(3) nello « Memorie autobiogratioho », dico che giunse u. Nizzu VOl'SO il 23 eli giugno 1848. Il ptilllo clocumonto dcllQ. serie permetto eli lisan.ro con pl'ooisiono CJHOsta data :\l 21 di giul(no.
( ·1) 1'1:->1!1.1 l. «Storia militare nel Piomouto», 111, 526. - OTTClLIXI. « Ln rivoluzione lombarda. del 18-18 o 18 19 », 292. - Gt"EKZO:-ol. " Gnriba:di », l ,225. - PAStxr. « Vilt\ del genomi p GiMomo Modici », 22. GA RIBALo: «Memorie twtobiogrnliche », 191.

* * *
LE PRHlE GESTA DI GARIBALDI IS ITAI,IA 1055
:->t·<· <:iù ali ahituale simulaziOne dol Re; il Gner:r.oni c lo Ga!'iiJalùi acl inei>Olutezza. <'a. ùiffic1Pnza delle armi POl)Olari 1.' clegl i uomini l'ivoluzionari: il Pa.;;ini che la -parola clcl Rt• non fu clai ministri; sta di tatto che Garibaldi dovè recarsi a 'l'orino. o ve, n dc t ta ùclln vV.Murio e d<'l Guerzoni, fn d nl Ricci. 111inistro tlell'int<'ruO, consigli:lto a partir<' p<'r Yt'nezia per rendPrvi ntili Rervir.i <lOill<' Mr.-aro. Otfeso. dn, Tor·ino cort't' t\llorn a "\filano (15 luglio), <<S<'nza t•in:-;c•.ire, <'t!li di<'<', a.d oLtC'uere <li s('rdre il mio pat•st• HOlto 1tessun Infi1w. ittC<Ll'Ìtlftf.o da.l govemo provviso1·io lombardo <li tuire> una legiont• eli volo n ta.l'i a Bc>rgn m o. <li part.ir·t• d:\ -'mano lanc:ia il :-;t•t.ntcnt <' pr oc·lnm a:

<< Alla giovt•nt ìt!
« T,n gllt'l'I'U in:rrossa; i annwntauo: la patria ha hi-
<s ti i \ ' O i.
« C'hi ''indirizza rttwst t' pnrok lm C\Ollt hnttnto JH'l' 011orare il
< no1111· it.tli:wo. c·omc> pol<•nt. in lidi l'tranit•ri; 1\ :H·<:Ol'I'O
<c c·on 1111 di CIOtnpnp;ni cht 'Inntc•vich·o p<'l' aiutare•
< atwh'c•gli ln nosll':l p:ttrin., c rnorit·(' Hl\ tt•rrn it;llintw. ggli
• ft•tlt• in \oi: voll'lc•. o giovani. an•dn in
«.\C<'OITdl', onrwt>nt,ratcwl intumo n nw. L'lta.lia lm hisog-no
<<di dic•d. di \'t>n1itnila \olotttari: da tnttP le• parti
IIIIJllHIIt i pilt sit'lc• <'... alle• ,\lpi! 'lustriumo all'Italia c• all'Eu-
< • I'Clp<l c· l w \ oglia1no \ritw c n• c> villt'l'l'{'ll10. ' <• G. <: \THH u ,n r. •>
nl'll(' ll<' lntVH;.dialo ll:tlht fl'l>bl'l ' Jll't'Sa !l H.OYP!'lH'Jl<t, (ì:trilHtltli latc.oglic• <'irca. :JOOO volontari. C'ltc nttomo al nucleo clei venuti <l IL\m<•ric·a ÌOl'llla IlO h• h[liO'II(' i ta l i a /ICI. Il ao luglio ('a 13t•rga mo; tlnl comitato di <lifesn tli 'liluno, di l'P'\(' t'Cito i n .• pt>l' Jll'<'lltll'l' pari c• a lltl gramh· h: t taglin t'he :oita Jl<'l' t·omhattut:t Jll'I'Si>O la c·.ittà. P:n tito cln Br>rgaltlo il l. si :b J><'l'UOlLtrC' a '[t'rate; mn. alb 'ista di liallltuP in clireziolll' di :'llil:mo. riprend1• la m:u·('ia e n l mattino clc•l .'5 è a )[onza. Qui la :wtizia ch•lla c· cl elia CH pitolazione, ]JOrt n. le u:tll l' t orme• di fup.g-i ( ÌYÌj ([li i lt• JH i llW ÙCfPY.ÌOlli. La c:olonn:L, gi1mg-c• il 6 a, ('omo: J\lazzini l"ac·Polllpagtta, ma Ila. l'omo pass;l in S\·izzera, dn molti snoi atlc•l't•nLi, ('lù•ttiYi o supposi i.
t COl'JlO aust.riaeo è sull(' tra<' ti i<' della colonnn. Questa sol!lta. il i a S. Fc•rmo. 1'8 t' il 9 in Yar<'sc>, il lO pa-;sa il ' J'irino a 8esto < c• si [ermo. n I \ 'Olontnl'i, da :3000, ::;ono 'titl()tti a 1300. Il nc·mico ]Htrtecipa a Garibaldi la. F<OS}wnsiont• d'armi ed l'gli 1:\ fa rbpc·thre. pur tton nYendo intenzione di
1056 LE PRIME GESTA DI GARmALDI IN ITALIA acconciarvisi; ma il 1:3 a.gosto, avuto notizia dell'a.I·mistizio Sala sco, il generale ;rompe gl'indugi. La. sera. del 13 coi suoi è ad Arona. ove requisisco i due vapori Verbano e San O lo, pan•c:c.hi barcotli, viveri e <l<Ltl<ni; con questi mezzi il14 attraversa il la.go :\fngg'iore e sbarra a Luino, sul territorio lombardo.
Qui comincia l'impresa, che ha per epilogo il combattimPuto <li Morazzone (1). In Luino. la schiera è gi:\ l'idotta ad 800 uomini. n 15, l)l'ÌtnO scouLro vit torioso }>l'CS:->0 la Becraccia (TJttino ); il 17, per Ghirl:1 <' Vnlgn.nmt, Garibald i enLnt in Vares<'

Al generalo D'Aspre, comandan.to d<•l II corpo d'urlllnta <mR11·inco, Rpetta riRtttbilire 1!1. tra Bergnmo <' il htgo '\[aggiore; dispone all'uopo ùi cinqu<' lwign.te, 15 à 20 lllila uomini. Il 22 agosto queste forze sotlO in misura. di <•OnYt>rp;l•rr su Varr.,.e, ove si ùitigon.o il 23; una. bl'iga1a vi<>ne pemltro dir<'tta n. 01ivio per cl1i1ulerr ai Ga.l'ibaldini •·it i•·n.ta verso la t-;vi?:zrm.
Ou,t'ihaldi nott aspcLLn. che il •wmico lo :L<:Cet'<lhi; il ripiPg:b An ArciRate, laRCÌfbndo u, I•ldtuto un. dh;L<WC;bmeuto, (!Omandaio fhb (litwomo
Gli ordini eh•l D'Aspre per il 2-l l<'ndono a chiudere ai 'olo•ttnl'i ogni sca.m}lO, si:L Yerso Se:sto ('a.lt•lul<•. :sia ' ' er::;o la l':ivizz<·ra: una brigata ò di (alto ;bV\iala verso nn<t pe1· O:n ira te sn TJuino, c le a.ltro risJwLtiva.mentc <b Vat'<'H<', Induno e Yiggii1 : Il <l<'ltl inn.io tli volottlal'i, cd w iorma il disLitecutmenLo MNlici, n:;Halit.o it 2 l pl'CFiSO lto<l<'I'O (2), tien i l'l'l l IL va,)Ot'OSfl.Wente a.ltl<'ll li co e llOHCiia ripara. in Hviz;wm; Hn.rihald i col grosso, prot<•t to dn, qru•.,.lo <·ombat1inwnto, per Vnlganna, Rando eCu' io, gimll<lo a1tol'llo a. Ca.mpo <l<•i Fiori e coste:rgiando di Yat·es<', JWI' Gavi m te marda Yut•ese, alle sp:\1\c tl<'gli <bvvcrsari clw lo <'<'t'· cano tra i monti; il a, Morar.zonc. ltt que::;t.o giro, tnt Rancio e Ca:ssauo ln, uolouua incouLm lu. hrign.La 1\Ifmrm·; <lol>O \)!'(•ve combattimento, Garibaldi si ril••'at• e lascia pass:trc il nemiM; questo proc:ecle sn 1Juino, credendo el w i voloutnl'i sbarrargliene In, mentre il cammino H' rso il ùi
11 25 il D'Aspre, ct•edcnclo per notizil' ttvlLte che Garibaldi ad chh1mn.. iu rinforzo Be!!Llt hrig-u.ta e comhiua, un movimento convcl'g<'nLo di quattro lHign,t,c tra Brebbio, t' 'reruatc, mentre le t l'e ùue sostano n e o il 26, • giungendo con la. brigatn. Schwarzenbcrg n,d 0:-<matc, è informu,to che i G <U'ibaldini si trovano invect- tra )Iorazzouc c Galliate.
( l ) I fatti qui riassunM sono più minutamente nart·ati dal
• Gli :H'veuitnenti snilitn.rt clt•llSlS--!9 >>,III, 52;:)-:532.
(2) Circa le dl\te <li questi movitncnti, ai uott\UO discordanze fm i vnri testi.. Il Pa.siui, per pone per il <li Rocloro o •li Viggiù m dttta. del 23. '
'
Ania subito le trUl)Pe <"he ùa sottomano cou movimento accPrchiaute in quella direzione e alle 7 pom. il generale giunto a .l\Ia.lnu.te, sa finalmenL(' che Garibaldi è in ì\Iorazzoue. N(' verso sem, l'attacco inaspettato, che qnasi mimcolosnm<?ute Garibaldi rit•see a respingere; P('l'Ò il villaggio è posto in liammc tlnllP cannonate e ln piccola, srhiel'a è drconùa1a ùal n<•mieo clw a.:-rpett.n il pc t' rinnova,J' C1'assa.Ho . :\la alle l l di not1l·, p('l' uu viottolo trm.;elll'a t o dalla vigilanza. aus1riara, In piccola rolonna sfugge ancora. una volta al soverchinnte nemioo, e a piCicoli gTitJlPi raggiunge il c·ouline svizzero . OaJ·ihaldi, alfrauto dalla fatica. n dalla febbre, è il27 a Luwmo, di <lon•, ttttnwerso ln Franeia, ritormlo <t Nizza il lO sett<.'mbre, * * *

eo:-ù in e croHologicam<'nLc i 1'11.L1i, ceco i ùocunwnti.
Dal {Jfll!enw {frnei'lrlr dcUa tli JYizza al presiclmit' del dci ÙH'to·ieatv clel portajo{llio della ff'IU:tl'lt. Torino.
Nii'J:m, 2:.! giugiLO 18..1:8. lt>ri veri-lo w ore \IJUlil'i antime1·iùiatH'. in questo porto (;.ittst•pp<' Garibaldi. iuun bastimento« l'Esperanza>> han<1 irm ttmc1·iMrut, di <•n i Jt<' Hgmn, il ('OTll<Ulda n t t•; oondnt•<•va. scM> tma COll lpa.gitia, di uomini, la ruaggiot· pal'Le ltaliani eh(' timpatriano.
Rinoom<' Bg-li è nativo (.li qnt•sta dtln, <'<l il suo :w•iyo em n.t1Nlo (' dcsiciN'lLl.O Ùa }liti d'tffi llH'st•, l'l.Ì mdllllÒ 3>lJJOI'tO UUèì. <tlUl>Utilà di person<' per vctl<•rlo e sN·olni dPll'ilomo in pnll'ia. <' del ntlorc col qunlf' nl(>ritato il gr:Hlo di generale.
l<•J'i si n:nò <lft me n ore quat.lt'o J)Omcridianc, JH'l' sentire se nnlla si opponeva nllu, di lui pPt'UHtnenr.lt. ilt patl'hl> Ri lto al giomo 2(i volgent(' nw:::w. t>poca. in rui iutendt>va vartire alla. volta di Ot•non\, vcr quindi r<•<:ar::;i n.l <'<Lmpo in J,ombardi:t., e colla suacom pagniu,eomba,Ltt'l'<' per l'intli]>cndeJtZ<L d 'ILalin.; (' uu L<•mpo il d'un per la sua, <·ompagoia, 1><'1' qtwsti quattro o cinque giorni. Jc, rispo:>i d1e non bi frapponcvu. alrlln ostacolo alla sua permanenza, anr.i che dopo lll\ di lJI'OCCdentc direttamente da :\fontcvidco, alcuni l!iorni di riposo in seno della. famiglia etl in mezzo ai 8UOi concittadini; e nhe: in quanto alla. com}ll<Jrllia,,l'avTci fatta alloggiare in uu piano de l quat·Licre ili S. Domenico, come la feci <li fatto alloggiare. n avvts<l>i prudent.c accedere e facilitare il ùi Ltù desiderio stante le maniiestazioui di gioin della popol<Lzione, e tanto più perchè il di Lui arrivo da.nùo
LE PRIME Q.ESTA DI GABillALDI IN ITALIA 1057
luogo a parlare di t•s,;o. i partiti prr l'alfare del giornalt• dt•ll'•E•·O•> tron1uo motivo eli t•on.tettere la loro agitazione., eù è probabile olw si conciliano (sic).
Heputo conv<'niPnte, ùi rendcrn<• informata, V . E. d i quanto xopra, prr 110rma, c•ù ho l'onore di riunovarle i sensi del mio clistintissimo
(.lrch. eli Stflto - Torino). 1-'o:-> :-;
Dal n. 88 rlel (IÌOI'1tale di Jlila,w <<Il 22 Xizzn, 21 giugno Uìl!>.
Il generalo Onrii.Ht.ldi arrivò }L con 85 uomini dt>lh snn il loro uniforme è a,sai b<'llo (blow;r t•on moRt r<• Yerdi, pantaloni bianchi); essi sono armatt e manoyrano por eccellenza; Oi;.-"i xono uomini sct•lti che po:;; ' ouo SN'Yire Ili nucleo per formare uu eccellente - Ho veduto il gon<•rale Garibaldi, elle gotlc per.t:etta ... l•;gli disHt· in llUù hlico, appt•n:t di 11011 ossore t•opubhlicn.no, ma itu li nno t' Jlront,o a vNsa.re l 'ultiu:ut. p;o<'.<'i<L ùel sno :o;u.ngnn J)('] re o JH't' l'Italia. -Volontari d'ogni p!H'll' si presentano ver H<':.wirlo.
Val fJOI'fi'IW dd l" di l'iN. Iii Cirnova al di !JI'll'l'tl t' IIW,.;,,,,, 'l'ori 1111.
Gl'nova , 29 ginp;tw ISlS.
Pro<'('drnt<> tl.t \i;,z:li giuugcnt <tu<•st:l maLtin:l! in 0PilO\'U , Pl'l' la via di lliiH'l'. Garibaldi c·ott u. 150 C'irwli 'olontari diretti per la Lomh:U'(lia, i quali wtlll<'I'O alloggiati lt>lla cax<'rllla tli Lt•onnnlo.

I o ne informo quindi Y. E. ad ovpor!Uil<l! di r .ei llOI'IlHI, l'ÌH<'I'V<11HIOilli di .l:atk poi nonosecre il giorno in emi paÙimnno <hl. qneHL!t dLtà
H o ft·a.Uauto l'onore di rinnovut•Lt• i R<'llsi del mio <listi11tis· ximo ossequio.
(.lrC'h. eli Statr>- Tori'llo). Hmas.
Dal !JOI'fi'IW della cli!•ig . di Genova eli guerra t' 1/lltl'ina. 'l'orino.
Genova, 30 giugno J 8 lH. • .
Facendo l'eguito al mio foglio in t1ah11 ùi ieri 11. 3163, mi dò l 'onori.' d'informar<' l'T;;. Y . che la colonmt ùi Garibaldi è (·ompo· sta <'ome vic:ne in marg-ine indicato. Oli uffiziali banno E'ò'\}>Ol'>to trovar;:;i privi atfatto di denaro pe t· la. loro xnssistenza, e]>l><'rciò. iu attesa che sh11 loro [atto un assegnamento paghe, eonvivono ù a un fruttore a ragguag li o di lire 45 l)et caduno al mc/ie
1058 LE P.B.DtE GESTA Dl GARlBAI.D I IS ITALIA
ll.ltlss'ufficiali t•;-;olùati sono all'orùiuario colla truppa dellmt -
ta,,!!lione tli riserv<t del 16° reggimen.to. c la civic·a a.mruinistmzione Lli Genova. loro Homminist.,m una ra.zione ù i vino r11l giorno .
1<::-;seudo prob<tbile ehe il generu,l<• <hn ibaldi, co ll a, l'Jnn, l<•gione, si solfermi pN alc-.nu tempo a, onde rcclnt:unenU, io prt'go perciò V. R di farmi conosten• le di Lei determinazioni, l'i a (·irca. lo pendio degli ufficiali. sia intorno alla. l>aga. ve:-;tiario, e mantenimento della bassa. forza.
Ilo frt\ttullto l'onorl' di rinnov<m' n. V. E. i sPn:-;i <h•l mio diisRimo lt1wr::;.
ln.notttzione in nuo·rri ne. - L:t colottn<b (hl>ribrLldi, !tmwnzia,t.n, dal minist<'ro interni ùi 60 intlividtli <\irra,, è inv<•<·<• di n. 11)5 l'in·a., fta. i quali n. 17 uffiziali di diverso Q'tado. nora non si i.' pot nto <Wt'l'l' l:1 sit.nar. ion<1 unmeri<-a. (A rch. di Ntnto- 'Polino).
Dal !J01WIW tlclla eli Genot•u o l •ministro di guerra, r
1 ° 18 18.
F:tc·enùo al mio foglio in di ieri n. miro
I'Ìl·o 1li t rastut>UN<' qui a \ r K Jo o ot·iginal<' nominativo degli ntnziali <' <' nnnt<'ric\O cl!•lla tl'uppa, C:OiliJlOUClltC ht ll'J.!ÌOI\l' dtl', r iohi<•i-ìL:l. fa.LLn mi cl<'l g<'llCJ'ttlc ho dispo--to :tcriò sin no loro
S0111l11ÌUÌStt'!lt i g li Ogg<'ili UCCC'SI'\!tl'Ì di C!tllC'ellerhb, Ull!1 c.ln. la m hurro con gli 300 rul·c:hi!ti ùi P l nwstole pure> ùi legno. per c·ni starò n.tt<'ndPnclo le direzioni 1li Y. g, in
Preg-iomi di rinuo'·•wlt• i Ht'nsi tlt-1 mio tlistiutl.<j"imo
OHSC'(jlllO ( f b·ch. eli Stato- Torino).
St a to nnm c rl c o degli indi vidui de lla legione ltn.llaun.
f. RADO CoGNOIIK e No11e
8
GR AllO CooNOlll o No'IB
l Ufficiali Garibaldi Giuseppe. 1l Ufficiali Leggiero G
2 Id . Anzani .1!'1·ancesco. 16 I d. R iglii n i Cnrlo.
B Id . Luigi. lG Id. R izzo Tomaso.
4 Id Lnmbe 1· t i Giovanni 17 Id. Paggi Natale.
6 Id. Angelo 18 Id. Luigi.
() Id . Maroc etti Gins . 19 Id. Coce li Luigi.
7 Id. Sacchi Gaeta no. 20 I d Maggi Alberto.
8 Id. Ramorino Paolo. 21 Id. .llissaglie Luigi.
9 Id. Parodi Tomaso. 22 I d . Medici Giacomo.

10 Id. Rodi Carlo. 123 I d Aurigoni Felice.
11 Id. Buono Ignazio. !24 Medico Ca.sas Giuliano.
12 Id. Ameo P ietro 1145 Legionari
1!3 Id . Peralta. Bernardino . l
1...1:: PRDIE GESTA DI GARI.B.\I,DI ITALIA 1059
l
.,
e
E
"'
;,-
"'
...
1060 LE l'RIME GESTA DI GARIBALDI IN IT AL1A
Sono in tnt1io ufficiali n. 17 , serger1 ti n. 6 . medici 1 , e logional'i n.l45.- Totale generale n. 169. (A1·ch. di Btato- Torino).
G. GARIB .\LDI.
D al governo c1ella d'ivis. di Genova al •ministro di e1narina. Torino.
G<mova, 2 luglio 18-18.
La colontm Garibaldi, siccome io n,yeva l 'onore d'infor.mare l'E. V giunta qui numerosa di 155 individui, con1prrsi 17 1l.ffizia,li, invec<' di 60, fa recl u tam<'ll.LO o si trova al giorno ù 'oggi :t 170 inùiviùui, non compresi li 17 ul:'tlziali.
11 general<' con lettem d'oggi mi 11revicne che st.n.va -part,ire <li sua llerson.a pE>l campo, onde prendere gli or· dini del Re, lo r.cbè tonde in.certo il tempo ohe si fermeratlrlo 111 Genova. qnesti volontari. Non avendo ish·uziou.i a. tal riguardo, io mi volgo all'E. V con preghiera. Ili voknni dir e:
1 o se il genera le Gal'ibaldi abbi n, beo l Là d i f a r·e reclutnment1., senza l 'asse nto, mmLi il cornm iss<tri o di g uerra.;
2° St' 1\<'l caso ch e an.cot·n. qui s i fe rm ar:;se qualclw tempo, cleblJa co rtt,inua.ro acl NlSCI'C in il batbglioul" eli rist'l'Vu dc1lu 0 reggimento eli fn.nLeria, la va.rianLc sun m1 mericn. situazione ;
3° St' dehba in Une essN·c ùcl pr·('s iùio. Ed iu at.Lcsa degli orù iu.i di codesto miniRtero a t,alr iguatùo . Ilo l'onorA di rinnovnt·o all'E. Y . it mio (li sti nti:;simo oss('quio . (A ·rch. iU Stato- 'l'orino).
Dal1n·iniste,.o di e mm·i·na al uovemato!'e di Genova.
Torino, 3 lug1io 1.8.i:S.
Con snc lettere del 30 tU giugno scorso, a 2 di luglio volgente n. 3182 e 3216, V. S I. dell:1 forza delia colorma Garibaldi, m'infoJ·ma 'dellc fatte per la stenza della medesima e mi domanda dctcrmiua zioni sulla paga, vestiar io , e mantcnim('nto ç_ella bassa forza; !'<(l il suddetto Oaril>aldi possa recluta.re senza l'a«::< ent o, nanti il 4ommissa.rio di gnena; $e tale colo nna possa contimtare in press o iJ battaglione di riserv.a del 16° reggimento di fantel'ia; se debha, considerata come corpo del presi aio éli Genova. in forza di qual e diSl)Osizioue del governo sia quest.a colonna instilìuita ed apptovatn., nè ad ogni modo facendo la med e.<;ima parte dell'armata. io non posso far determin:1zione al01lna, nè considerarla alLTimenti che qnal corpo di volontari non attinenti all'esercito.

K on pertnnto a.ppl'O>O la di.::;posiziono che Y. S. r. mi seri ve di a,ver f.atta per le1 tanto ucgli uffiziali, "qun.nlo dei basH'uffiziali e soldati, e le fo, ])eT quanto ùl'l me ùipE>ntlc, fn,coltà a Mnf,inuare le sLNlsC\ d isposizioni, in fino tt che il mini:-;tcm degli affari in terni, a emi 1'-lcrivo, mi cl ia, m ag-gi01·i 1aggun,gli intorno a (!U<'l'lto corpo . di c·ni la provenienza. p,·cll. l1i Stufo- Torino).
Dol di guerra e ·marimr al ·ministero dt•yli i11terni.
3 l ug li o 18·18 .
n governo di G<>nOVl\ tiCl'ÌVe CSSCJ' (•Olà una colonna Oariba.ldi forte eli 155 uomini P 17 uffiziali di ya.rio grsdo; non M'ere l!li ufficiali onùc vi ve l'e. cd esser<> stati m<>ssi dozzin:t ùa nn trattorE> a L •15 al mc•s1• pcr c•iasenno, finrltè loro sia fa.tto un assegna.mento di t'H:St>re poi la bnssn. forza statél. irt sus· sistcnza. pr<'RSO il lmltagliout• ùi tlcl 10° t·eggimC\nfo di fanteria, Lo stesso gOV<'l'l\l'tiOI'<. ' · sr.l'iV<'1 in n.ltra, Hnccex-.iva, I,•Lf ,( •J'Cì• , che tale Ylt. r<'cluta.ndo in Genova. Nl è om frJl·t<• di 170 uomini; a.vvis:.t ùal O:trihaldi rn.ggnaglialo dl<' queHti JH>l' gli Ol'clini cl<'l H<>, il <·he n ·ruh• int•t•rto lWt quanto t<> mpo lit eolonnn. st;nà in Oc•nova c <l<'t<.'rminazioni ittLOl'ltO (' Hll'li'!iSi(•nzn. rna; I:IC ùC'hba <'Oil'lidrt'IW8i qual <·o r po tlc•l vresidio; i'!C ai>IJin. lét<·olti\ '" far rccl n t.c •. l gnont il mini>;lt>t'O rlclla d1t. th i, c }H'l" or<lin<• di chi, q tolonna sia, Hlata. inslilui t a, C'! ti ne n bbin no m i nati gli u(Tiziali, doudc j)l'OYC'Ilga, cd i:t \LI tìl ,ti qu:.tlC t"OllH'IIÌt'llZa O palio, ('sistn in Gl'tV>Ya.

Acl ogni modo, L:tl<• non <'li"lltlflo pttrtc dP il 't>Ht't'niLo, U mini:-.Lero dolb gue r·m nou poLr't'hlw illg<•rir:,i n<>l ht m<•d<•Himu, nò quindi prov vNlct·e ::ùl<> !Hl<' vaglt<' cd alla. sua come non ]n'OY\' <•ùr a_!!li altri Yolonta.ri molti che prendono parte alla guerra a t tua le.
il miuistro di stato p<•r gli n ffnri <li gnNm C1 marina., n<•l desiùt•rio di E'Yital'<' ogni <•aw;n, a <liso t'clini, hn app r·ov<Lf,o, P<'l' qun..nlo dn hti clip('nch•, )(• \lisposi-
7.ioni che sonoHi fn.Liu por la su-.fi i '!il•nza di <·olonna, ed ...
n.utorizzn.L o ::1 continuarle per iutahiO. fmchè S. E. i1nHtrchese
TI ieri, ministro ::;cgrptario di stato JH'l' f!li affari df'll'intt•rno. a cui pr('gia,<si ùi rivolgersi. sia.-:i c·ompiac·iuto di maggiori informazioni iutomo alla mrdrsima, ed abbia significato qun.li pron7 edimenLi in via <li polizia stimi di fare.
LE PRIME GESTA DI GA R IBALDI IN ITALIA 1061
(.·ircll. di Hto/o- :rortno).
l ltll gm•er·no prM;visorio ili Lornbardict
11l ministi'O di guena emaTina.
)filano, H ln glio 1R18.
E:;s{'ndo a :Milano, lihero d'impegni antecedenti. il pt•otle sig. Ginsepp<> Garibaldi., difensore di :Yiontevideo, lo scrivente govel'no !';i affrettò di offrit·gli nn grado nt'll'e,;N'cito lombardo, affiuchè il suo valore e la sn a ne siano senza, indugio -vantag!l"iO della, ,QTan l'aus<b com llll•' · AvE>ndo egli accettata. l'offerta, il governo l'ba nomin<110
P.O<>to eli generalP tli brigata, €' vi inCR.l'ica. di imm ediata uwn.tc i1 suo regolare brevetto.
ANET ,LI )[ORONI. (Arth. r?i i'! lato di JI il(.(-no- Oa1·t.eìltt 102).
l milbi8/ero c/.i lomhcmlo ol signm· lltaggior {tenera.le Oaribalili.
15 lu glio .
no l'onore tl'ann.unzia,J'(' a Y. H. J. dHl il !!OVI.'l'llO f'(·Utrilllt', con d<'(IJ'CLO in. ùHta ili icl'i to ho nominMo tnal)·giMe
<1<'11 'cH<'l'<·ito Iom ba.rtlo.
Xell'n.tLO tli l'itw!trioo godo ùi ))arH•<·iparle 1:b p i r• Henl i soddisfazione di q mi n il·;tcto. wr inleri1n, de/. por/afovlio f40BRERO.
(A )'(·lt. rli 8ta to rli 1!1 ilanr, - o,utella 102).
Dal ?niniWJI'o lli lo·mbardo ltllo 8tato nta[Jgiore gene)'((te.
15 luglio
Il miniRtero dà avviso allo stato maggioi'<• che il sig. Oarib<dùi vem•e uomitwto maggiore dell'esercito lombardo.

L'inoaricctto, pet interi'11?t 1 del portafoglio SOBltERO.
(Arl'h. di Statò rli .JIUa?uJ- Cartelle' 102).
Pror;lam.a lU Garibalclì agl'Ittt.Uettti.
Berg-amo, 3 agosto 1848.
I ta.lia.ui!
Quando Roma aveva i barbari alle pol'te, più nnmerosi delle spiche dei suoi campi e resi terribili dalla vittoria, Roma mandava le sue legioni in Spagna ed in Africa,, e le bceva. sfilare alb vista degli rLssediant i in segno di
1Qt.)2 LE PRIME GESTA Dl G A RIJ3ALD1 IN ITALU
I l
LE l'RHIE GESTA DI QARJDALDI IN ITALIA 1063
Quando l<> città lombarde, st,,mche d i tra loro. o ùi KOJ)portnre le iu(ami aught>rie degl'imperatOl'Ì teùt>schi (ehe si all<'tt>ano <tll'una pN' comlmttcr<' o ma,uometterc l'aJ1t'tt) :,;'act•org<'V<1liO dC'lle insidie di qu<'i Hlldi ci pa.tlroni, alzavano un grido di llttÌOlll'o (l di fnttC'llanza, lascia.V<lUO l'aratro e giuntY<lllO in Pontida tli nou vivct· servi, com<' re1.ti!i in LC'gtla· no l<· ncl'nntl<j d<•ll>nrbaro.
E oggi clH' un es<'rcito italiano sta a troutt> di'l nemico, <·hc il grido tll•ll'iutiera penisola è di voler<• eutant•ipnrsi, oggi che inJi llitP iìOllO l<> risot·r;e, di cui lthbonùH il nos1.ro Lo: n<'ll:t l't>tl'Of!mt.t·clin il PiemoutP, gtll't'l'i('ro e i<plt•udiùo d'anlor<•, acc·ot· t'<'Utlo nlln vo<"e tl'ltalia; la Liglll'ia, lwlla. tl'c>nt11sial'1mo, t·icca di ineHtw!'ihili mezzi, alzat,n, in Roma, c h1. 'l'oseaun, t·hc t:wto di'i martiri han gia :-;parso per la Aanta causa t• dl<' 1·ipit•ne ù'indidhil<• anlot·c• non d <tul>autlOm'l'atmo lH'I' <'t'l'LO; m· voi. l)O]lOli bPlli<:osi <lcl Berp;amasM, non rh;pontlN'ek alla.
ù' l talh.l, sarete nwuo clei tn·otli di eli Brcsclill, che domani c·ttn!('t'antto l'inno della viLtot·ia c• Mlt·isc•tLtto!
u hbandouialllo, JH'r Dio, i gnerr iet•i 11IH' c•om bè\t.Lono per lu, sa.nLn. o nomnnc•; non ('<llla :-;ul c:apo la vurola di'l mor·c•ntc•, calpestato dall' . \nstl·o. Kov,·cniLrvi c·h<' i popoli< lw dirt'n<lono non <ladouo. Hovvc•nitrvi <liH' ric•.atl\Jt,i Hrrvi degli antichi (.imnni, n.ou vi rrli(,(>l'a!Ul.O olw lagl'imc·, s(' pure Yi lnsc·c•''nnno la vita.
Ounnla.Le, per J)io, <li llmnhini, c:lw aspct.t.n.ao tltL voi l't>siRlt•uz:t tl<>i liberi, vosLrc doJttw, a11<• vosln• Oh Dio! non Yi c•opl'ite Ilei mantello di pio m ho o dc• l mant<.'llo d'lnfamiu. ra,zza bel ht, vl'i vilc•gin hll dal l 'rea,{,Ol'l'.
Chi vi dirip:e parol:L rt>tlucc• d<t lontane> contrati<', è> v('· unto coi suoi compagni per otTrivi la, vita, 1><'1' se]lpellirsi c·on qnest i valorosi h1. vol)ira, t<.•ÌTa, che t'tlblmndoniLI'ltt agli drl

Oh, spero sl, r;pero clw la. m;<L paro1a, bcncbi' debole. stll'à a.Rf'oltata: che i gc>uerosi <.l<•lla OiU!1, ùrl Borghi, dc•lle V:1llatet> dei :i'lonLi L'ipctrmnno l 'eco tlclht croc·ia.ltL italiltmt, dello sterminio st L'<tniero; ognuno, cercando attorno di sè, incontrerà un'arma, uu f<·rro JH'r difendere 1:1. bella terra , eh<' lo ha. nutrito e cresciuto.
Bc>rgamo Rlt l'à il Pont ida della generazione presente <' Dio vi ron.durrà a Lc>gna.no .
L a b<tndiera. dc•lla legione italiana di j.\'lonteviùeo e di Sant'An· t.onio liVCntohl. sulla di Bergamo cù intorno ad essa vi a:-;petta il vostJ'O o.
(A l'Ch. di Ht((tO di JI ila no- rat'tclla
•
•
GA&IBALDf.
Giuseppe Gcuibaldi a sua madre.
Bergamo, 4 agosto 1907 .
.. )L'ldre.
Oggi ritorno a Milano eon 2.500 uomini, ove cretlo trovil-li il Ro coll'esercito. I o credo che i Tedeschi non andranno l)iù nvauLi. <l forse la Provvi<leuza li ha mandati sì avanti per liberaroonc. Dio ci proteggel'à e ci guiderà alla vittoria. Ebbi un po' di terzana, ma sono sette giorni che non ò tornata e ho riprC'so l'appetito, sto benone. Bisogna che ilJJOpolo non si e che non ascolti lA. voce dei tt-nditori e dci codardi. causa santn. del popolo italiano non pup perite. Un bacio ad .Anuita,, ai bimbi. I miei saluti a Gustavo, a, Com·t. Angusto, Galli, Pipiu. DisdPri, a tutti gli amici. Addio, sto.to o amate il ..
vostro G. G \Rrn .u,nr.
(CAMOZZL, Be?'{JU?M e Oariùnllli, G).
Ordino del giomo <li Gal'ilJ<tlcli alla legione italicma. Merate. 4 agosto 1818.
J,ol!io nari. il c·annoue tuona- il punto in cni siamo ò pericome iu posiziono di essere l:lglh1ti fuol'i, e poi il giorno di domani ci promette un (•!un po di l>a ttaglht degno di voi.
Atlnnquo vi eh ied o ancora unn. no t te di sacr ili zio - progrmlinm o In marcia. l'indipendenza
G. GAltlBAWl.
(X mmN.B::J, JiJpislohwio di G Oa,·ibaldi, 1. 18)
GittsepJJe Gal'ibalcli (tl generale G1·ìffini. Como. 6 agosto 1848.

AvrotP udito a quest'ora la. capitolazione di Carlo Alberto, l'evacuazione della città di .Jlilano dallo truppe e l'altro nuovo. T·utto qm• sto non ha cho fare con noi. !;a guel'l'a italiana contro continun , finchèvi sono llOmiui che sanno o vogliono farla..
I o souo dnuque dociso di fan• il mio dovere. che voi ttividet·etc gli stessi t'vi esorto quindi ad o.vvicinar,•i alle mie con le altre farze. L'Italia tarà questa volta, veramente da sè. Credetemi. generale.
(.XDlENES. op cit. id. id.)
Vostro dev. ed aff.
G. GARffi.!LDI.
106·1 LE PRIME GESTA DI GARIDALDI IN ITALIA
lluW[JfJion• rornand{lll{<' ill0 battnglio·ne di'l Li0 l't'fi[J jalltl'l'ia aL capo di stato maggiotP della l a divisiollt'. Galliate.

Oleggio, 12 agosto 18t8 .
Gim;ta. gli ordini ri cev uti, ap1lcna g iunto in Ole gg io stamant> v-crxo 1<' J.. distaecai una compagnia p<'r alla volta di Rorj.l:O Ticino, astenendomi eli distacNtrne altra per occupa to dal Oarib:"tlcli colle Rtt<' tr npp c Vennero pure Rl:thiliti. i vosti al pol'to d'Oleggio e d a qu<>llo di Castc•lnovn.t<', <' ognuno vemu.•ro da,J<• le istruzioni OPJ)Ql'l.une colht consogrtn. ricevuta. da codesto atato maggior<' .
..\i cltte porLi di Oleggio c Oastt' lnovatc mi non <'SR<'l'e stabilita. vermm slazion<' ùi ca r ahinic•ri rcnli pel sen·izio dei
Si s nvpone llO LOrc g it·ovn.gn,rc ]Wl tJH<>.St' LI'<' Sl) Ì(' d rl lH'Illieo; siuora. nu ll a posso a:i'lovc•rare; 11'\A. le e gli ugeuti di polizia sono prevenuti e sot•\·egliano.
Illmt.lagliono venne lbC(Juat'tierato n<'llomtlc 14iiì appnrlì'IH'Illc alla <:ompagn ì a, di Gesù, la conwnn.le s i presta. con zelo cd ogni buon vol<'l'<' pPl}lronto e facile
no l'onore di raffC'r'l1l lbt'JU i con di!;t,in. to
• Dr YrLT,\P \LLE'rTo. (.lrch. sfato IIW!Jg. 1:ol. 60, pay. 31i).
l l COI/UtndmtiC l(l Ja dii'Ì!/ÌOill' u7 capo c1rllo Mato I!W[J[IÌOI'f !JWII'alt·.
A /(18,'/WUll'ill.
('c:mmo, li 13 ago-;fo 18Ht
Orule essere <lt'l'tO flh<· tlivb;iorH' sotto i miei orclini, chc> llictro l'ullimo ortliue genenr:t ... d<'ll't1.t'tnatn,, l> in pos ì ziou<' sn l ' l 'icino, a1lcmpia. c>sa.ttanwut<' allo scopo pe r mti Yi è stata lasf'iaht, pregherei V. I. a. volcrmi fa\ orire alctmi schiarimenti.
l . l tJort.i 1ml Ticino n. Bol'go 'l'icino e 011st<'llt>tto essendo importnnti ad osservar,;i per sape>re qua.li monnwnti fa il nemico al di là del Tieino YCl'tiO Somma. <li.:;taccai un lt Oleggio che desse 1lei posti nei vari xi ti anzich•tti. Om a, 0astelletto vi è il generalo Ga1·ibalcli con h1 stm trnJ>va; desidNerei sn.pere se <tuesto genPrale l1a tla continuarE:' a st:tr Il o se va, a. raggiungere gli altri corpi lombanli; nel caxo che i;lia, che mpporti d evo avere con lui.
, .
.. •• :CIC PRD[E Gll:STA DI GARIBALDI IN ITALIA 1QG5
2. Tra::>metto a ll a S. Y. copia dell.'l con8egna che, rtou avendo ordini precisi, diedi ai posti elle oeonpano i porti, pregaudolo a volermi dire se la aJ>prova; e l 'avverto nel temJ)O stesso che' ad alcuni di questi -p orti mancano i ca.rabinieri per br In polizia•.
3. I due reggimenti Piemonte real e e Aosta cavallC'ria. il pr imo del qua.l i faceva già. parte eli questa d ivisione. essendo stanziato a Vigevano trammezzo alla linea che occupo attualmentt>, desidererei sapere se facc iano l)ario della clivisione c se si pos:-;a.. il ca.so occorrC'udo . impiegare q ualcho squadrone per facilita.re la, corrispondenza su nna lint>a così estesa; in caso contrario. preghC1'ei l a S. V. I a voler fa,r un distn.ccam<'nto ùi <'tL· rn binicri a cavallo eh<' fare questo serv izio .
4. Tl 24 de ll o s<:orso mese (Fie non erro) partl il 3° battaglione 13° reggimento, dil'ctto su Cremona in accomJ)llgn.amcnto cl<'i pri(!Jonie1·i di Somma Ca.m1)agna . Questo f>n,t.t n,glione tntt'om n.l pregberci la, S. V. l. a volermi diro dov<' si tt•ovn, e conw potrei hn·c per ottencrc• a la, divisione. ·
5. DmanLC> ht cn.mpugna. cbl>i l 11ogo sovcnt(l d'os:.;crv:tn• che la lll<t.ll<\nll7.lù di prat iea d0l sap<'r Lirlne il fnoil<• rt•Htlf' irmLilt' tnoco e ai u nn, ben in Ccl'iorità sni 'C<'Sl)<'<:ialmt'nto i cae('htto!'i; m i pare l'larcbhe qtH.'Hto n.rmiHtizio si l':ìl'C' <t d ivi:.;iouc' lltl!l!
scuola di Liro; ond<' st• 1:11 H. Y. J. nort mi l'lnri ve nulla in c.ontmriu, ìtpproiltictò di'li<• lnn<h> clw :wvicinano le uostrl' l)QI'iziolli JWr far·e timn• a.l bel'sn.gli.o g l i nomini dt'lhr btrgate PiemonL<' c Pincrolo . <' proetn·ct·ò questa R<·noht Ri faccia nc•l modo il più utile• c l w :'<al'IÌ possihik

G. V. H. I. H(• mi Y<'llflOltO moiLt' domande di piccoli 11crmes::;i p<•r l'iulN'no, f!ll (Jhe proporzioni l<' dt>vo <H'· nonlnre.
7. Cl1icderc•i ancora'" V. S. T. RC voles::;c indi carmi se v i :LlHIOru. o no la, pololta. dell'a,rmn,ta. Interpretando l'ordine gcnern.h• t-lell'a,TtlHI.ta; che. dC'Rtina qneÙÌ vi::;ione DI star Rlll r_rÌClHO in posizione fn.ccndo OCCUlJ!tl'e i porti da piccoli pof.\ti, piazzn.i i c1uuttro reggimenti a. OaUiatc, Tn'cate, Cerano e Cas:.;o lunovo, due> battaglioni, ehc l'i cam biano ogrli cd oceHl>llinO i vorti Ù<'Hil'a., tt Zl•rholò, Cn,va <' S . .i\Iartino Sk.conHuio, l'a ltro a.Jla sinistra, Ol egg io, Borgo Trecate c Cat->telleLto. In questa gniJ:;a ho !'cm · pre dieci bt'Lttaglioni alla mano per qualunque movimento .fo:.;IWmi orùiuatò; in questi villa.ggi l'aria, è sana eh(> sttl ba:-<l.'lO TiC\ino; e i esse;ntlo J'iunili, l'istruzione è diretta.
1066 LE l?:RIME O EST A D I GAEUBA LO I l.TALIA
Il c·apitano della. · mi tl'<h<lllette In qni unita do· manda e:!IP rarromarHlo raldanwttte alla l'\. Y. I., a:-;sictmll '<' <lell a Yl·!'ità clell'espo:;t.o.
\Ii vcrmettn che auc·h<' qni h· rarc o mandi le ricompensi' l'lti<·· le due· brigate• negli ultimi c:omhattimenl i c· i rimpiazza·
nwn1 i c·lw fW<'\'O l'onon' tli c·ltiNletlc JWr la briga hL Pi cmont e. ht prep;o i l'\C'll8i dc%1 mia vii• alta Htima e pari c·onsich•raziouc•.
l •' f:Im DO D I ::-:\ ,\'O I\.
(. l rch. :-.(filo 11/a[ffl· rol. 18, flaff. 75!l).
Dal fllll'l'l'ltr• ddl11 di .Yol'tll'" o/ rli !fllt'l'rrt l' moriurr. 'l'ori?! O. :XO\'<li'H. <WOs10 ll:\18.
'l i trovo 11<'1 cal-lO eli \'ar pn•sc•nl1• a Y. E. Clht· i•. ac·N1nfountu a f'a:-;tc•llctto :<oprn 'l'iC'ino la comandata dal J!<'llE't'ah• On· ri hn h li. di J :w o c· i rea uomini, e·on art iglic•ria c• C'è\\'allc·ria.
QltPsto c·m·1•o, a quanto :sembra non si trov<1 addetto nd :11c• tma divisioll<' <lc•ll'PsPw·ito, e d il j.tl'lH't':dt• l-111 1 luogo eli· :-posizioni arhitmri<'. ric·hit>ù<'tlllo viY<'l'Ì rei nltr<' somministr·lllZ<·.
\PII. in t <'n•ssP del h rc•J!olarit u dC' liC' c·os<· r ciP! huou orci i Hc· m·l pnPsc• cln l1ti oc•t·ttpnto, ttlì fon. pt' c'glLrholli voiPrmi indic·nrc• l'OllH' clC'hl10 <'OtHIIll'llli ll('Ì l':t}l)lOl'(Ì Ciii' ]lOI'::';n t'Sl-1('1' llt•l l'USO d';t\'1'1' C'CIII lui. c passo intanto :di'onore• eli Jll'01t""il:nk i :o.c•nst dPl 111io clisi in t o Os"i•'ctl1io.
( IJ·rh. di 8[11(0- 'l'orino). TJI!Ofl. !JI''II. lf0HFB:\W>.
lf Nt'f/l'l'fario c·omtl/1·11/1 di

111 !flil'l'rttctl ort • cii
Cm;lellt•Uo 'l'il'ino. H :J·gosto li'\.
11 .'''<'tWralt• ( ••uih,tldi, ('}H• l' tnnlto ahhntluto c• sc·orato c·d 1111 po' amtHalato. t> co:.;i. puro dilllt•ill' molto n 1mtlfwc·. scbbc•nt• iu to11do se mhri huon uomo.
( 'o m nn C!tH' pt>rò t nn t o frd c• snclai. Jll'l' ac·c·ont l'Il itt cwth stl:l l'inhesta l'ti in :<omminiHtrarc• alloggio. m<'zzi cli !ollls>listPmm " di traHporto aHa sua (J'liJIIJa, elw l'itl ora non la minima \ ' ('s· o JH'PpOtl.'nza ad nlcuno. trann<' cli qualcht> im· pmdt•nle. ùi f(IL<'lli C'lw np11 r;olfril'l.' nt> lc· n \l l e trupJH' lornhardc•, o ct•rean.o p i u f tosto di <'l'llorqtH'rt• du· di :--o\·· vcnirt' agli iltf<•lici.
"Le• truppe <li lui. che al suo fm-:-e a,.;c·c•tHl<•Ya!w a :.? mila nomini. ora TN;i.tlnano. per le freqtwnti dhwndnni. a C'i1 ea 1100. I.'Otnpr<'s:l l'nfficinlit:\ molto unnwro..:a.
T, l!: PRI?.Lill OE'l'rA DI GAIU'BALùl IX 11'A L,IA 10G7
-
Detta truppa, sebbene comp osta di elementi eterogenei, ossia di -persone di ogni nazione e maniera, sinora non si sa che abbia c:ommessn. cattiva azione, avendo molta stima e t imore del suo generale che , sebbene sempre ritirato e quasi invisibile, procura di far mantenere tutta la disciplina possibile.
All'istante fa. richiesta di fargli allestire dei carri. per la p;:Lr· ten.za, e mi confida segretamente volersi dirigere verso la Svizzera
IIo l'onore cl'esscre coll a ma .ggiore stima devotissimo servitoro.
(Are'h. stato magu. 18, pag. 747) . OAPPELLt.

Procùnna à1: Onribnldi a,gl' TtaUani.
Dio e il popolo. Itali.ani!
in. ?l'filano dal 1)01)0lo e cla.' snoi a. duce cl'nomini, la cui meta non. è HUro che t'indipendenza italiamL, io non posso conf.ornuwmi alle umilin.n t i convenzioni ratillcate dal Re eli Sanlegna, con lo st1·anioro ùominatorc del mio paese.
Se il R<' di Sanlep:na ha, una rorona, che conserva a Corztt di çofpe o di viltà, io ot1 i miei com1mgni non vogliamo eousorvaro con. infamin. la, vit.a; rwn voglir11mo, senza courpil'l'C il noSfiJCl'iflzio, abbanùonan' la sorte della nostra !'m.cra tcrr·a al ludibrio di chi 1tL soggioga c la te. Un. im1)eto solo di comba.t.timento gaglia.rclo, un vensiCJ'O ttnanimc ci valse la sa.nta, vi· rile inclipentlonza gustammo. sclJbe.ne pochi, i migliori, l'a.vess<>ro gufiJdap;natn, O(l uniti J)OSCitl tra i l'<'r iug;a.uuo, la vedessero scomptwRa 1\fa ora che il pl:'nsiero, sciolto l'iniquo freno al la sua diffuse pel' tutte lo m eu ti quella suprema verità, elle suona sterminio ùeì Hmnni , ora che l'opera., iu1ìuiti elementi ra..O:orzata, si. può cooJ•dinaro, c la preRtano già numerosi corpi, emo,ncipa,ti cl:a.gli interessi regali; ora. che sono smaschern,ti etnei traditori cille pigliarono le redini della rivoluziono J)er anuichilèÌrla; ora. che sono uote le rn,gioui clell'eccidio a Goito, delle mitraglie, ùelle febbri a, l\IantovfL, dei proài R.omani e Tos(\ani e del le codarcle ca.pito1aarmi, il popolo non vuole più iiiganui. Egli ha concepita la sovrana sua potenza, la provò e vuole conservarla a prezzo della -vita; ed io etli miei compagni, che ne ebbimo fiducioso mandato, che accogliemmo qual dono il più pre.zioso che potesse a noi largire il Supremo, noi YOgllamo corrispondergli come ne spetta. Noi vagheremo sulla tena., che è nostra, non ad osservare indifferenti la tracotanza dei traditori, nè le straniere depredazioni, ma per
1068 LE Gl!:STA DI GARIBALDI Ili!
ITALIA.
l J l l 1
LE PRIME GESTA DI GARIDALDI lX ITALIA 1069
dare alla inl'clioe e tlelwm. tra p a tt·in, l'tùtimo re:::piro.
combattendo senza tregua <'da leoni la guerra santa, la, guerra ùell'inclipt•ntlcnzèt italiana (l).

t'astellc>tto, agosto 18-18.
( . 1n·h. stato ?1W,ff!/· ool. :.18, pag. 11L:)). G \RIBALTI!.
Il conwnd/fufe tld 1-!0 l'f!J{Jitnento fantcrin
(1/ l'Il/IO <lelf11 IIW!f(JÙH'I liflla Ja 0erano.
1-! o 184.8.
111o ba t tn!.!'liOn<' da. tlict1P i ,vari ti nell'i:;truziotw. ntl rccc;r,iom• di. <tnello di Castelletto. doq• LrOYÒ un posto tl<•llt> truppe di Garibaltli. \i chw porti d'OIP:,rgio e C'aa112 nou vi 1•r:mo aucom stabiliti li earnhinieri. Lo no l'cm-l<' nl monwnto.
· Tutto il :;('l'vizio pt·ocwclP ron regolarità c si compiono le istru· ;doni d P Il n t l'ltppn..
Invio la Ril uaziotw dr l giorno vari pPr la forza, !l!•l mio l'<'!!'gi111Pllto. pct·smtso che il 13 mi farà nltl'(•ttanlo.
\'eng-ono Lmllo tn1tto riun,<'ndosi al r.o1110 dci drn)lprlli; ma vi von·<>hh<' J><'l' var1r cl<'i <lnt·n,l)iHieri rC'uli o <lclll' 11\ltoritù mag· gior t'igort> o vigilanza p<'t' i'nr li individui disp<•r:si.
Ho l'onore di cìr•l mio distinto ri>qwtto.
( lr<·h. stato nwgy. 1·ol 00, /)a!]· lO:i). D \'lUNO.
t l) Qnosto non b inedito, 08Houclo riportMo por intoro dn.l PA·
!'IN L Mlln. «Vita dol gou. Wnc•omo 1\II'Jdi<'i », dtd GUJ·atZONJ, noi Vito. di Oarilmldi »o dn.n.ltri. Ln do l tmtlimonto di Cnrlo Alhorto obbo o l lom, fnorl cloll'iomonto, maggior credito di qnollo oho oggi si JIO!isn.aupporro o cuocnc•ntanemu61lto vi prt•l!tl\rono fudo, uon 11oltanto lo f1Jllo llompro oili orNiuliti\, mn.tmclw nl dCII volgnro Non pub dunque il liugunggio eU Gl\riht\ldi in questo mou1onto occollio· nalo; 1\ltt·o volto 1\ncom ogli cliKnbbifliri\, t:lll)I'HmHlo l' impttl8o gonoroso doll'ttnhuo, nlit ust'rìt. altro pm·olo otl altro. furmn. <.:osl uo l 1860, n Vittorio Emo.nuolo l [ ohe coroborl\. <li trttttouerlo (11\NI!o.ro lo 1.1trotto dopo li bo· ln Sioilia, c•gH ri s porulon\ con lo. s oguouto fli bou nltro tenore:
«Siro!
«A :\faesti\ è notn. l'alti\ stimo. o l'amore obo vi porto; mn.l:l. pro ·
« sonto concliziono in non mi ooucorlo <l'nbùidirvi, como s11>rebbo mio
« rlesiderio.
« Cbiarno.to dtti popoli mi nstonni 6no o. quando mi ftt
«so ora, iu onta di tutto lo clliam:\to olto mi nrrivano, vorrei
« meno :li ruioi doveri o motterei in pericolo la santi\ oo.nSt\ doll' Italia.
« PP.t'mottA-to quindi, SirO\ ohe questa Yoltn vi disub bidisca ApJlcno. avrò
« nl mio assunto liberando i 1>opol i da un giogo 1\bOl'l'ito, do-
« porri) la mio. spada ai VoRtri piedi o Vi nùbidirò fino line de' mioi
«giorni.
<('l'ono <lel Faro, lO n.gosto lSGO.
«GARIBALDI >', cXmExE,;, Epistolario di G. I, 122).
Dal ?ninistero della g·w;rra al govrmo cleUa divisione ài Novara.
'l'orino, H ap:osto l 8 ·18. Riscontrando al foglio di. V. S. I. delli 18 volgente, n. l 332, ho l'onore di accennarle che la legione. comandata. dal g<'ncralc Garibaldi. deve ricevere gli ordini genera!<' 0livieri, comn.nùanle delle truppe lombarde; e· colgo frattanto qneRta per rinnoYare a V. S. I. gli atMsLaLi ecr, . (l). (A1·ch. t7i Stato- 'Co1·ino).

J>at gm•c1'1UJ della àitisione eli Xovar<r ,. al capo dello· stato 11W!JfJÌ01'C generale. AleSiiiHUlria.
N ovara, li lo 18 l8. 11i<'cvo al momento, ore 8 Y:! d i Rrnt, le d ne l eLt cre <;Ilo ho l'onoH• di courpi<'garr nlln. S. V. l. per lo Ella vedrà, le mo:sse, gli atti violenti c le dimostrazioni d<•l generale Ga , ribn,lùi, ehc da sul Tidno (ove doveva Rtarsene, ed promesso per letter·a alle mi<' rimostranzr di [rrmarsi tranquillo) si rondussc collatrnppn. <'duo pt>zzi di nr t i gliel'in. in Arona., contltw<'nclo t.r·e ostaggi di dct to lnogo di On:->t(\llcLto, o come m<•glio appu,re dalla letter·a eli qn<'l soWi.n,l rn<lNtL<' di polizin..
l\lcntre sp<'<.lisco In, pr<'sente pcl' istaf'fetta, ne potgo pure con mezzo avv iso n S. A. R. il <hH'll. di Genova in C<>rano, prr quelle instau tanco provvidenze <:lH' vcclr:\ <'OilV<'uieuti a.l cospetto d<'l sig. comtmdante L'armata nuRtl'ia.cn, pcl caso t<'ntasse qualche colpo sulln, mNlcsima non osLu.nto ln tregua.
Ho l'onore di raffc rmn.rmi con pl't'tlh;tinto os!l<'.qnio, di V. fi.l. devot isRimo obbedientissimo s<>rvitoro
D'ORFgNQO.
P. S.- Uni:;co pure una lettera. cld diPallnnza., con preghiera dh<>Rlituzione, dalla quale l:icorgesi il timore d'un colpo di mano del sig. Garibaldi l:i U quella tesoreria.
(l) Nel!:\« Vitn. del generale Giacomo Mr.dioi ,, scritta d :fitapita.no GIO -
VANNI P ASINI, n. png. 17 si legge: « Nb eli poggio a Garibaldi potevt\
« pitare in Piemonte; la. popola-zione l 'n.cooll!e freddamente o 11on sospetto
«o ore dopo il 11uo arrivo gli fn dal governo snbn.lpino intimato di
« sciogliere Ja sua bn.ndn ... e di ago mb rare il territorio piemontese. A tn.le
« intimn.zione ed insnltn.nto qualifica, smcssn. ogni modcrn:r.iono, 11piegò
« quello. bandiera Dio o popolo ecc.». « Como appn.re dai doomnonti, questa
« a!l'orm..'l.zione, fatttl certamente in buona fede, non hn fondamonto di YO« riti\}>. (Not11 dell'ufficio atorico'.
1070 LE l'RIME GESTA. DI GARIBALDI ITALIA
ì
PRDLE GE";TA DI (;AUIDALDI ITALIA 1071
Snta cletl'ufficio r'icet·elltt'.- V> ore 8 aut. :::Ìl)Cc1ilo immediatamente il caY. OliviC'r·i a Cerano.contr'ordini ùiS. :\f.
(-lrch. stuto magg. 1•ol. 18. pau 727).
DaL conumilo militare èlcUa c:ittù di ArO?w al gooernalotr tlrlla ione eli li"OV(t?'a.
AroPa, ill-1 agost<' 1818.
Ho l'onore tli far rapporto all'E. Y. che que.-;ta manc giunse in c:odc>sta città il generai<> Garibaldi c•olla. sua clw ammont<'t'i\. torse a. 1300 uomini, e ciò S<'nza alcun avviso d'uffirio, llNtnehe lo formali là volut<' dai per la domandn,, a. <[lwsto colll<tndo milit.nrr, in. 'Città. 1l m<><l<'sirno hn. pone n l por'to, co11 ordino di non htsoiltt'<' nir<' :t qnet-;1 n, gli irltlivitlni cl<'lht ilpond!b o-pposta.
Di t.:mto informando l 'g. V. ne• la, prego di. COtn]H\l'tit·mi li Rnoi ordini, nt•l NtHO dovf''lf'<' il sullod:tto generale Rog:rior'tllttc in Ar·ona.
ric·onfrrmurlr uli rtU i dt>lt·irt•t·eot<' mio (.b·,•h. Slt1t11 nWff!l· t•ol. 1)1({1. 729). Dr
Tl sntlointmdn;t" di poli-:ia al ant•r1·natore della rli N.ovm·rt. :UL, ..,..
Aronn., addì H HH8.
Il corpo Garihn.ld i i n t elle Llo si p n tò Of!l!i i n q1wsta l'ittà ove, :t]lp<'tUt :rimi t o, Hcqnr:-11 rò barche ed l lntt 1<•lli a vnpor<' lJPI' t rasportar<' la "nn. lntppn. luddovc vrn:\ <la lni d<'::;t i-
lui lm pme due twzzi c sebbenf' fnc1·in, eredPr<' diretto in IsvÌZZI'l':t, si ritiene invece che voglia uno Hharco e per ll'lllare la sorte tlclle at·mi in q ll<'lle contrade contro gli ria•}i.
Prim a, tli partire da o pol:!e in ist.ato <li arresto trP ind ividui tli Castellétto, cioò · i dUl' fmLelli Minolla, c cc>\'LO Bar· hel'is, pcrchè partigia.ui, <:onw mi si disse, tlell' AnsLrit'lt, c S<' li comlusl3e con lui non si saprcbhe c1ual fine.
I n questo punto mi si a!lsicnm dH• Garibaldi colpì questa ciLtà. d'un;t Mntl'ibuzione di L. 10 miht, di 20 sacchi riso e 10 ù'a.venn..

N el ciò portare alla cogni1iot;e <li V. E. ho l'onore di attestarle gli :Jtti !lC'l massimo mio o:o;seqnio.
Drll'E. \.
(Arcl1. maff{f. I!Ol. 17. pag. 731). Tosr.
LE
I?RIMm GESTA DI GARIBALDI IN ITALIA
Dal f/Ol'CI'Ilo dl'll« dil'isùnw Ili al cupo deUo IIW!J!fiore yenerale .
• t! r( I'ÙI.
X o vara, l-1 ago;; lo 18!8. DaJ cav. r,oppi, consigliere' della l'('gia intPndrnr.a , di 11uesla città. ilwari.cato di um1. mh;sion<' speciàlr, l's"<'tHlomi Ntata comlmicmta la seg1.wntc lettem Ù<tl c'ommtale di Castellello :t lni indirizz:tta. tt'i reco di spNlit·hL per copia couiornw alla S. V. 1. nffinchè Ello,, <'i'IX<'ndo infol'mata delle dd Rig. Garihalcli (\ tlelht tntpprt che ticnt• n, suoi orclini, vop;liu degnarsi di indil•ttrmi qual<• sia l:t di lni intenzione :1. qm•sto riguardo e quali norme io dchh<t in giarrbò io Un qtti ignot•o qual<' sia la Yt'mtlosi?.iouecl<'lla:;ndclPtt:t IC'gione riRpctLivamcnlc alti'HLO d• ' ll'ttrmal!t <'soLto gli m·clini di qmtlc gcnc'l'ltle ùi ùivisione <'HHa tli1·ct 1· 11Hc>n1.<• 'li Lt·ovi. IIo l'onore di rinnovnrh• i st>nsi drlln, distiuta, consicl<'t';tziont• t' de frrrnr.a.

(AI'th magy. rol. 18, pay. 71i)).
fl ('Onto nclco/lc a 1° /J(!/l(f,lf{ÌO'IIof' rlcl 1 1° I'C'fJUilnl!/110 jml/l'l'iU fil cupo drllo Jl(ato JIUI[J[JÌOI'C della 1• dil'isimu · .
f't ra iw.
li H ;\gosto l H lR.
'Xulh'b ùi nuovo ai poHti rwll<' 24 ore. sln.mancrPt!ato a. visHat·c• il uistace:trnt•uto Ji Bor:.ro 'l'icino, <'hhi a Hlli})erc positivamcnt il gNwralt• <iadbahli a v t·VH ttt>lla. rwttt• a hba ndonato Cas(t>ll<>tto Ti<·ino verso .\rona. e M ' t'o nondut'('Udo <trre'!lttti li Barlwl'is Jrmocenzo, t·npilano uelhl. m ilizin. romwmle; Minelht Pnmccs r o, 1rnPntc itlrn. P .'lrinolla, Oiovan.nisottoteuentcidm; qunlc s ia. tlt>ll<11·o u.n·eslo Hi ignora.
rnifOrinallciOIUÌ (lUÌUÙÌ ai Jll'Lllli Ol'clini J'i<:l'VUti. fo partire Ull<l> rompagnia ]>t'l' occnvare <'ast<>lletto 'ricino. in lnO!!O della legione Oarihalcli.
(.1lrch. sta tu 111agg. vol. (JO, 1Jaf!. 380). nr VJLLAPAJ.LB 'I'TO.
n capita/IO Stli[JIT ctl {/CIIfl'lllC' Otrribalili.
Gastd lt•tt o
Resto C'al<'ntl <• , 11 a).!o:Sto {!) 18-18.
Il eapitano comandante dt•i l. H. trup]lC iu Sesto C'aleude. si fa premura di uotiziarh-.. , si:,r. :.r<•ueralc. C'IH• dieh'O l'apporto a\·nto 11:\ una pa.ttuglia. yicino alh rip<t dì Pr·t"m:t-lùo
1072
LJ<.:
PRIME GESTA DI GARIBALDI ITALIA 1073
si ;wu.uzò uu nulllero cousideH•vole de' suoi dipendenti armati, l'itiensi nella lYtn·a intenzione tli requisirvi quattro harclle grandi ivi ancomte, i quali. però sono retrocessi all'avvicinarsi della pattugli<t <lietro ordine il'un suo ufficiale, elle dal la. ripa. piemontese a.ssictLrò essere arbit.raria intrapresa della truppa, fWnr.a ordine
Ritenendo la comunicazione non Ria libera che pl'r la via netta del porto a, Sesto Calende c ciò solamente per i signori ufficiali, ed itbitanti U1uitro!l, porge preghieJ'a, per· c.h è il sig. generale voglia compiacentemente dispone, che uou Ri ahbiano a l'innovare simili hlConvenicnti, che poTterebbero il scioglimento 1 l ellc contratte stipulazioni.

(A ?'eh. stato nw.gg. 'VOl. GO, va.g . 393). ST,\.GER.
TI <·onw?ldanlf la b11 diviN ion e a./ capo dello maggiore gencra (P J1les.9aincll·ia.
Oera.no, Ìi 11 agosto 18•18.
11 1i fo prf'm ura. di rifcri r·e <t V t:\ I. clt(• dalle iuformn,zioni 11t'('R<' (1nesVoggi ufficiali arnst riaci al potttc sul TiciLto, lL marr1-lCiallo Bitdl'lzky lasniò :Milano con nn corpo d'al'ntatn,, andan<lo a soLLomrtt(IJ'(' Brescia<' Bergamo a,ncora in 1\l'i viene pnr·(' ffhiJto l'il>l)lJOrLo or ont che lasciò colla, RlHl· gc rttt• (l[H'ILelletto, l'Mattùosi verso Arona; al.WCHtò quali tr<' utricia.li ùc l ht guardi.<t nos1Tl'a. Questa banda spandt• i1 terrore itt qnelhq)opolazioni esa,rebbe qnulchc s e verissimo pl'ovvt•dimento n, sno riguardo .
Gmdiscu. lt1. S. V. I. i seni-li d elht mia piì't à>Ha sl'imu c pertctta, COJ1$ÌclOm7.ÌO Il C.
(.tb·ch. stato 'IIU.C{fU · vol. 18, ]W g. 553). FEitDINANDO DI SAVOIA.
_., n consi{! li ere il' V ittm·io ZoJJ?J i a· H. A. R. i t dawa, di Geno'va,. Arona 1 15 18J8, (ore 5 <.lcl nu1iLtino).
OLtonuto il }litgamcnto dcUa eontrihttzione, che imponeva <'L quesLa nella Honu1u11 di lhe 7 mi.hh, più 20 ::;acchl di riso, 1286 l'azioni di p<tne cou 3 sacchi di salpava il sig. Caribaldi con tutti i slloi,da Arona, seuza elle lasciasse ad alcuno ove tivolgcvasi. Da. alcnnc sfuggite a qnalcllP iudividtlO di quella comit i va di briganti, più elle legione di guerrieri, temesi gravemente che le scen-e di Arona siano .state rinnovate a Palhmz;1 eù a I ntra; nulla però mi fu dato di sapere in propoRito di positivo . Fra alcuni momenti io pr oseguirò il mio yia.ggio. per Palhmza; intanto io mi reco a doverosa premura, a
s<'comht dell'onoreYole inrarico <ht Y .•\. lt. ieri sera <tllìdatomi, <li r<•nùerla. di tanto di intesa,. scbbt-ne non occorra. provVN \im cnto alC11llO ll<'l' di Lei l?a.rtc n.llo stnto in cui l e eOH('.

Quivi temesi ciH' il sig. Ga:rihaldi llOH>Ut· fra, alctuli giorni ri<•ompal'ir<>; io uol (·r<>do, in]H'rciocchè troppo benC' conol'<<'O qual premio mr!'ita la inianu• smt rondoti.a; ma OYC' YC'raruentC' utcl'"'ll' ritot·no, io incarico tutl<' quest<• autorità tli Rtnre bene all't·rta. per l'<'tHl<'l'lte it"Lform:tto CL11l' 1 corpo del rral<• <'Hl't'dLo stanzht.to a queHkll città più vl0Ìlllù 1 Oltl[lll'ÌCCVCl'(' ([Ht•Ì H0('('01'SÌ che <1<•1 <·n so, l' rhc daJ quurLiPr dell'am1ata v<•rrehlleru Kt a.bilit i. lo rredo all'atto inutile' di IC'nél'l' ùist•OJ:,;o a Y .A. n. ll<·lla. hrutnl<• dC'l Garibaldi in \rona <•d itt <'astelletto sopra Ti<·ino; non debbo per<) t a<·t>rlf' che a in fa t t i !'i tesero lui <·onclu.-4>.t' ]ll'Ìgionit•ri tt'C individui di ('a!;tcf'llt•tlo, C'ht• potnlo lH'· ttC'LI'<Wl' la i'lllfl, inLC'nziott<' a loro riguardo; <dw r·cq nisì t nt.ti i Yapm·i non HOhtnwn f.(•, ma l<' lmt•chc C' hn .t'Mtd :ùtWora. elH• tt·ovc) ud !Wl\0 di. lll \llla l'OH C(Ut'lli c•)t(• Xl'('() lni C'OI1.dUSX<' da ( 'u,. st(ll\(•tto.
J)a CJUC'Sti hl'<.'\ i \' .•\. TI. JHIU farsi \lll.idNt c·lti sia il fa.lll()s() tllllll}lioru•. c•hp abbandonava lt• t'Ì\'<' li<>lL\m<•ric·n lll'l' ><'· uir·p a <'ombaUt•r·t• JH'l' la. lihel·Là it:1liannt
C'ogli del pitt pl'ofondo rispt•tLo ho l'onore tli r•ass<'g rmrmi di vor-;1,t'}LAltczzn l'P:llc\ umiUssimo ll<•vofiskimo ctl
X(' l' vitOJ'(' , Prc7l. st(lfo llillf/!1· rol. GO. pa[f. aH;;). Yl'rTORIO Y-oPJ>I.
l l1wttoi·ntcn<lcntr di polizia c1i .Arontr ul ffOI'I nwton· di Xot•ara
.\rona, 15 ago:;lo 1818.
A le une orP- vrim<t e lw :zi in ('.i Ltà. il gC'H<'r'n h• (hrihnlcli col suo noq>O, vi si }}l'Cscnla \ 'll• H•JWlw l'avvo ca.io Hro.!Ierio; note come sono lt' t en<l<•uzc politic·h<' di quest'ultimo. si lfatta c:oineidctua c la <·irc•o1-;ta.nza ali 'arri\·o in .ll·ona ti d Gm·iha.l<li si era posto il RroJl'erio in rl'ht;r.iorw con f'N;O, mi tuW<Lttero molti Rospetti; pnro (sic) h<>n bcnc ht t\Ol'<<t; dovetti conos<:<•t'<' r.he 1\('ssun concerto vi CT'a l'ra quelli sovr:t inLNvrnuto, e chc non co vano nem m c no. Seppi altr<>sl che V<' n uta costl dc l Brof. f<•rio non aveva a.lLro Rcopo, ecc<>tto que llo di accoml>a,gnar<> bt smt concubina, la Zanner, coi figli di <1nesta a Lucarno, <• c·hc l'abboccamento, che l'avvoeato Brofferio ebbe col Garibaldi. consistette per perorar<> la. causa Ù(>Ì ir·atelli :.\Iinella. e BarbE>rLc;; anzi seppi che quesl 'ultjruo fu poi rilasciato e in smt wce a.l'l'<'Rtato 1.m tal Gucnzio di Castelletto, che fu llOi coi 1\lirwlla, imb arcato .
107-! LE PRDif; GESTA DI GARlB.\LDI IN ITALIA
LF: l'RDIE GESTA DI GARJJ3ALD1 IN ITAL I A 1075
tua.ttillll, alht punta tlel giot·no. li battelli<' 11<b\ igli
< t uali stava il col'po Oaribaldi, f.nron o vh;ti navjgal'c nelle vicinanze di Lui no it1 ditez ione de lla Svizzera . Era corsa. voce che; ieri in fa,<·.cia, a, Belgirate, Ù<tribaldi avesse posto a contribuzione anche qu<>l comune di 3 a l mila; ma questo llOU restò comprovato dalle informazioni che mi sono procurate .
La <:ontribuzioue poi <l'.à.rona pnga.ta a, Garibaldi ronsisl<' in li t'<' 7 mila, 20 sac·chi <li riso e 2 di av<>ua•.
dci ln'Ltte ll i c navigl i, che forma.vano po,rt(l spedi:dono Gait ilm ld i, sin qui, <dt(' HO Jto ore J2 Yz, reLrocesso.
Ifo l'onore di a.1,1estl\.l'<' a V. Jj}. gli a t t i del massimo rixpctlo ed Di V. K (. 1tch çtalo ntll!fff· vol. 60, Jltlff· lOl). Tosr.
l l rrtpo !lrllo stato 1rW[f!Jiore urnemlc tll f'OIIHUUlft'l'ttr (1rUa 111 l1i!Ji.Sione.
aùùl. 15 ngo:-;to 1818, (Or<' 8 nnt.).
1 1<'ntre Rhwa aspettando li OJ'tlitti per rispondrt'l' alla
IPit<'ra eli Y. A. H. tl<>i 13 corrente, stanott<• c·osh\ per sfafl\'tta l':mnunzio tl<>lla mar cia <lel c·orpo Garibaldi su
C' C; hC' costui o.ddU(l<'VH, SCCO ùn, t'nst(\IIPtto Lt•e OSL:tggi, (' lllÌilltc· c; i }wn, di fare t,o l tP ùi viver i c di dcna.ri. [ l governatore di Novara, ll C' I dare di M ' <'l'JH'resopariN1ipcl'A.V. bit o a S. m i l m ordinato di ri volgc1·mi a LC'i quale comandanl<· la 4... divisione <lell'esereito, onlle « nel « pitL breve tcrmirw, ClOU <'llergichc non disgiunl<' da, << mh.nu·e di prudenza, si ponga un f.prmine a siffn.HidisoJ•dini >>. Sped isco impertartto a. V. A. H. lu. }Jrcsentc per m('zzo drl sig. e;w. Olivicr i , nLnzia lo u.udetto a. quN:;t.o sta.L o Vignva.uo, ha già pr·ovviHto per l'inv io n.CN·n.uo di In• squadroni eli .\osln cavallerhL. 11 ne pone inoltre n. dii'\pOsizione di V. A. R. In, restante parte di detta brigata cava.Ueria, qualora credessi' O}>porttmo di chiamare appo di sè altri squadrotti. L a colonrm <li spcllizion<', ùi truppf' miste tla. V. .A. credute uco<'Hl:!arie, sarà dir·et,ta :Ld Ar·ona,e indi on• possa csfìer<.' i l Garibitldi co L t :ma tru:p]m.
gli :-;i intima l'c l'ord ine di reLrodarp il ma l tolto, lasciare in liberi à le anestate e di reearsi per fa strada e tappe da Y ('rt'ell i , deposito general(' dci corpi roll<'gati, a cui il HP diede ricon•t'O nei suoi stati. Qualom egli opponesse S. iutendc che sia ridotto all'obhetlienza co ll a forza, in quttl caso si avrebbe riguardo alle diversf' categorie d ell a legione, cioè ai graduatl <' a quelli che nol 80no; a

1076 . ' l,.E PRIME GESTA DI GARIBALDI Di ITALIA coloro che desiderano rimpatriare ed n. quelli invece che iuten· ùouo proseguir la gnena, sottomettendosi però alli ordini 1li legittimi capi. NatmalUleute coloro che cJùetlerebbcro di lo potranno faro, ma disarmati, le at·mi. essendo prima fatto riti· ra.l'e da V A .
La preRentc incumbeuza è assieme delicata c non scevra di difficoltà e <.li quaJclH' pericolo; ma la prontezza dell e dh"!l)ONizioui, la l oro efficacia e l'energ ia in chi dirigerà la spedizione,ll.l' assicureranno i.l buon esito.
n orw. Olivieri rec(mdosi ÙOJ)O a N ovant, vi sarà lator e di qnelle (lisposizion.i o JHtl'tecipazioui che l'A. V. divitierà di dare a quel ìiig. governatore.
Ho l'onore cti.vorgere a, Y. A,, R. gli <t.W ucl massimo mio os-
SALASCO.
N . B. niuottn, all'obhec.lil'nzfl o la Garibaldi, Ral'à Ùl' r1e che pe r ora rimanga un l.m,tLaglionf.> a presi.d io di Arona, il darà il 1.lista.ccamcnto a Castelletto 'l.'icino. Se il caso di arresto del Oa1·ibalui, S . lH. intende che <tbhia luop:oc sia. cottc1ott.o n.el C<l·stello ùi 1)er esservi giudicato.
(Arch. stato nwgg. vol. ()9, 2>ag . .t105).
Ocr L !/OI!M'no del.la divisione di N ova1·a a l capo clello stato 1ntt{f!Jiot'e ge-neraLe.
Alesswnàd(l.
Novnra., li 15
U:o .l'ono1 e di n V. R. l. copia, di del sig. in· trntlenLc di Palhtnzà, relMiva <tllc mosse o fazioni de l gcDI'Ntlt· Garibaldi, ricevut:L vochi momenti sono.
S. A. R,. il clucn. di Genova ehbe sott'occltio la lettera c vi appose la noUt autogntia, 1>m·c apparente drLlla, Sl.tOcitata. copia .
l::ìorivo al ministero di gnern.1o di contol'mità c sped isco la presente pet· istatf'etht urgente1
ilo l'onore di riproicssarmi cogli aLti del più distinto ossequio, di Y S I.
(Aroh. stato magg. vol. 18, 1)ag. 819) . D'OltFENGO.

L'i-nten.cìento c'li PaUanza al gorerno della r11visiO?ì·C à1:
Novwra .
Pal)anza , 15 18-18.
ilo spedito una persona, c1i mia contìdenza per e&1Jlorare limoYimenti del generale Garibaldi; que ll o. oggi Ri recava nel comune diLuvino, situato s1ùla spondalombar<la. ecli vi trovava la t.rnppa
del (:hwibaltli coi due battelli a vapore sequestrati, costoùiti da un cù:apvello dì annati, e mi riferiva che a l corpo del Garibaldi si erano unite due colonne, l'una. e l 'altra. lombarda. e che la. forza tof.}tle. gli ortlini. ùelmedesim.o, poteva a.scen.derP :.l, 3 mila, e più uomini; che aù una <li 7 in 8 miglia era accampato un corpo <li Austriaci ùi. 4 m il a uomini, e che cm prosttn com ba ttimcnto.
TI sequestro dei tlue mi fa presumere che qna.ntlo la Lt'Ul>"PH di Ga.J'i baldi ·f.ossc oostr·ctta di reLrocederc, efìì:iariÌJrenderC'bbe la v.ia, del lago e votrcbbc }Jortarsi sulla sporuln, Fno degli uffìciali, jntel'l'ogato ùallo esplora.torc sullo scopo deUn, i'pe<l izJone d tll'MlLl' l'armistizio, rispose Nsserc intenzion<' ùcl loro capo di fa1· l a gnern\, p<>r loro conto, non csseuùo vincocM i nl pa Lti.
E HCl soggit u\g(.lre a.lht S. V. L che mi risulte:t'cl>he eho il (htril.>ald i avrebbe condo tw scco quai prigionieri cluc individui, deHomiuati li fratelli l\ l i ne ll a <li. CnstolletLo 'l'icino, ho l'ouorr di l'ipl'oi:essarmi. co l l) i ù pl'O:tondo rh·;petto Ù('V01 i:;simo c obblig;.Lt iss iuto :-;crvitore DUPlMH.
Nota il!i B. A R. a clUélt eli Gen0/,1((.- Jc suis t'Il. C(' 11)0 !11 ('!11, n Al'Oil.<Lj j'<tVlH'ClHI (jllt' htl'l' ROÌL' doif avoir lnl.tLu un norpH ùe4 à 500 fait t'u!ii ll cr 1('13 rn·is(mI I ii.'I's. Je V<LÌ!-1 H• J)0\11' i adlCL' C{tH', parln,nf, aU COITillHtll· d a.nt du norp atttl·idlirn:;, il tw prPnn<' p<lS ccci pOlli' une infraction de l 'armiHLi<:c.
(Arrlt. tlla,qy. 18, p a!f.' 821). PblltniNANDO DI HA
Dal ffOVCI'IW detl(! ili vis-ione <li N ouara al Oll])O (leUt> 11talo ma{/(Jiore t(e{l'(W?!/atu . .A.lesswndt·in.
OV<l>l 'a, il 15 a.gmltO 1818 .
In aggiunta a ll a l.cttera che e-bbi L'onore d'i n via,re ieri ùJlaS. V L
T;t•ne compiego ùirc.Ltami dal 1:-1ig. sindacQ tli .ò.J'OU<\, per far i11ionna.zioni che Le d iedi riguardo a.l geuer•ale Oari bal(li c la sua legione.
Preg'iomi Tipeterle i l:!Cnsi del mio distiubi::!simo ossequio. h' (Arch stato mag!J vol. 18, 825). D'ORFENGO.
Il dri Al'ona al yover.natore della. divisione d·i K · il 15 a.t{osto 1848.
Ieri di buon mat'tiuo giunse in questa città ttltta la colonna del sig . generale Gariba ldi da esso lni comandata in persona . <> c·on ùuc pezzi di artiglieria; Ilrima :sua cnra fu il sequ.estTo di

LE l'Rl.\IE GESTA DI GARIBA.Ll>I IN l'l'ALU 1077
lQ78 LE PRIME GESTA DI GARIBALDI :m ITALIA
tutte l e ba•I'Che, tauto del sito, che di q nelle giunte coi concorrenti al mercu.to, e se<1uestrò pure i due ba ttelli a va1Jorc. Ingiunse aJla cid.ca amm inistrazione l a c:ontribuzione di 10 mila :franchi e la provvista i m mediata ùi 1286 razioni di pane, di 20 sacchi di ri:so. e tli 10 ùi a.vcna . Qllesta in1provvi1<a apJ)arizion<" di forza, di tutto 1mnto arma.ta in nn paese inerme, pose l'amministrazione nella dura necessit:\ di assecondare lo domande, auzicllè avventma.re la l)Opolazione a lla violenza milita.re; e si limitò solo a pregal'e il sig generale percM tllOderasst> l e sue domande, in un momento tli emigl'azione ùei bcnestan1,i e di già lu np:lri sa<:l'itìci drl nnmicipioperlcsussistcnzP delle milizie dello st tLLo.

IIu. quin(li potuLo ottent>re ln. l'i<lu?,ionc a sole 7000 lire della, drl denaro, etl a so li 3 <h•ll'ave tt<t, le 128(1 razior1i di vaae ed i 20 eli riso, che dovuto rcquisit'C llai negozianti,<" pt·endere tL prestanza il tlPHaro dai privati.
T/amminisLt·a.zione oivimt ignora. :;c detto gencra.lc operò di eoncel'to co l governo <li S. 1)(. cll in Lal enso oso che il ratto SbOl'RO ;,ml'à ri conosciuto; lll<L R<' diVCl'H<"LlnClltC tosse, avrehbc vm· a.rtolH' In. ra,g-iotlC di exs<'r cl:tl gov<'mo 1,utclato pc! Clbf.iO venif!sc ri<louwm.la t a, la suddeLtfll doma.nda, che notL -poi rcuhC' più auompirc; c s<H'ehhe cosl cspost<l a tlci ùispi}Le<'t'Ì per <'ui iSl lusinga, che V. avvif;el'à n, quctmez:;'li e lle J)O SS<tno j)Orltt a l <·o· perto d'ult.criorc tloman<l<l.
rL pr·efato sig. gcnorn.le <.lèt qucst,a, coi dttc vnvol'i o 1.ant<· altl'e barche a,ll'in;.;i\ <lcl ht_go co r1 tuttn, hL s1Ut l<'gione, ht Hll<t direzione; ma si crede gcnent1 mente ehc l'i Lo.i·1ti in btCVt'.
A l qual fine io rinnovo all'E. V., in nome dcll'amminiHtrazion<', le più v i v-e mir i stanze, onde si <legni compart iT<'. i provvedimenti che crederà pilt :->i cur i por tutelare questa )ìOpolazionc da. ulL<'l·iori i{Ue ricbieste, quando 'lueste non essere ùal governo poi riconosciuto ed tLpprovate.
rro l'onore di riproteRlarm i· co l nHtf>:-;imo ossrquio e v('nerazione
Pel .s·inilaco il f. f.
PATTONI.
P. S. -All'istante vengo ùi aJ)PL'endcre intlirettamentc ohe il Garibaldi ha lasciato traspira;r e che la sua intenzione è eli portarsi colla sua colonna a Luvino e Laveno, territorio lombardo , coll'intenzione di provare l a sorte dell e armi cout1·o gli .t:\J.lstl'iaci.
Forse questo non sarà che una :.;upposizione , ma mi creùo tuttora in dovere ùi rendernela intesa.
(A1·ch. sta/o magg. r;ol. 18, pag. 827).
D'OitFENGO.
.Dal comando militare di'ila l'iltù di Arona a1 {/Oilttmat.ore delia divisione di Novara.
Al'Oll<t, i1 15 agor;to 18 18. s<:>guito al mio foglio di i<'ri 11. 107 in conto ù<>l geUf'ntl Oarihalùi, dE>bbo informare la E. Y. dw il predetto è partito da C[lll'sta eittà lo giorno colla snn truppa alle or<' 5 pom. serwntlosi dci du1• va.pori il Yerbano <:>d Carlo, con dit•d altri hat'P.oni. tirn.ti rimorchio; gli furono somministrat<>, n ltuanto I IIÌ si di!-ìSO, da quN1t';nnminis1,razione razioni fli viveri, ed una ll01111ll<t <li d<>ll<tro. sua non la, voleva lw;e.iar conosc•er<>, che allorqU<LlHlo sarcblwsi tro' uto in via.
l'l'(•tcndesi C'bf' <•j.di a \' esse nut<>nzionc di portarsi ''l'l'SO PalI mz tt clllntm per (arsi somministntre altre rar.ioni r <l<>nm·o, quiudi poi sb<trcm·c• a bnviuo sponda opposta, Uht pt••·ò uiLima t>sR<'l'C srlllpl'l' in snpposizionC'. Partendo cln ('alll·<'liC'11o NOpl'U. ' l'iciuO fCC:<' iLI'l'('Hlflil'l' t t'C' individui nh e ÙÌCCVHt <LVVI'I'i<IÌ <·anNa itn.tiann, dut• d<'' deYono <'HHI'l'l' <'<'l'ti fmtl'lli Barheris, l'altro non n<> conosc·o il nome.

PPndente l(> poche <'l'<' C'Il<' la s\Hidet tu tmpva qui ft•t·mossi non dil•dr luogo a lagnanze. rt sig. a'". Brofl<•rio potr<•blw <l:u·c• rnag· giori indicazioni, poi<'hè trov<WaHi c·ol Oaribalcli in collcHtuio la ma,t tina d<·l suo univo.
P1·egiorni int,lLttt.o rinnovart• n li' gli :ttt.i d<• l ri V!'rc•nt.<> mio 014"<'(JIIÌO.
(Arcl!. stato lllrtf/fl· l'O[. 18, J>Uf/· Dt l3J.: S'I'\(;J'\(), di Armw rtl f/Ot'l 'nwtorc di Xot•nm.
A1·onn, l::i agosto voce i1t qut>sLu, citt.tì, nlw l'a.nuf\tta, comanùala thll sig. gl'nora](• Gl'iffini, che ora re<lll<'<' da. Hi.'('RCIÌU. Hn ll p, mon· lagnt• superiori n, BC'rgamo, f;ia ]J<.>t' di:-;ccndere f;Up<:>riormt'nlc a.l la.go :\laggiore, e quindi ]Wl' questa via portarsi nello Rtato e fa,r per Arott<l..
Se mai avesse Y. E. couoset•rà. quanto sia necrHsario spC'dirc> ::;ul lu.ogo tlclef,!ati e provv<•<Lil.ori, onde tll\ pasche dicesi 8 alli 10 m il :t uomini solùuti, uoncl lè a JH'IlRftre per le <'Ù a, quant'altro occoua..
Jo non dubiLo, che ht del governo vrov,•Nl<'rà , J)cr t<·mpo. a:ffinchè ogni non manch i, mentre, già abbattuto qu<'sto paese ùa altri non potrebbe assolutamente esse't'<' in grado di fare ulteriori sagrifìzi.
Jn tale buona fiduoia, ho l'onorC' di ùil'lni col mas><irno Ol'lsc>quio d<'lla S . Y. I. nmilll;):!imo obbedientissimo servitotl' (Arch. stato magg. t•ol. 18, pug. 831). BOTTELLI.
LE PRIME GESTA DI GARJn,\LDI I.X ITALIA 1079
Il p'l'imo 'ltf!iciale presso il eU [JU.errtt f' 11lal'·ina al catJo dello stato magr1io1·e genel'a.11'

acltlì.16 agosto 1848.
Dietro ai I'<òpporti comunicati dal min istero tlell'hltemo t'Ù altri ricevuti da.l governo delta divisionE' di Novara. ed a l comandante del corpo dei cara,bin ieri reali, qucRto ministC'ro 8lato informato:
Che il Oal'ibaldi coll a snn leg-ione, sta.uziatflt iu CastelleLto sul 'rici11o, ove doveva , stn.rxene ed a.v('vn. anzi. JH'Otnesso }Hl!' l C'ttern. dopo le faLLegli da,l govet·no ui Novara di tl'anqnillo. si. r(•cò il tlll'ttt ino (lol l t correntt· eolla. sua Lruppu. (1300 11omini circa) e (.h t o pezzi d ':t t·tiglieria in Arona, coudur.cndo seco, nè xi xa a. qua l fme, ti'<' di Caxtcll.ett.o, cioè i chw fratelli .Jlfin.e1.7(t <> ccrt o Bm·beris, pere h è vartighmi, comr s i disse, ùell'Austt·irli
C' he colà,giunto, sua prima. cura. ru ùi rit('nl:'re le bn rcltc oh e s t,n.· vano fl ,ncontte in quella enda non che qu<'l le pl'O \'e nienti dalla. spon.ch11 lornlmrda, poi non pcrme1teuùo ln. partenza di nessuna ùi ree<.\ 1)111' nwttcl'<' a. sua diApol"iizionc i duo 11i ror.;cu.fl , uno (l(li qua.li <Ì('positò i tl'e HndtleLti
l' h P imponeva. a ll n. eittà, di Arowv un di 10 lir<•, di 1286 razioni di van<·, di 20 d i.l'il:lo LO ùia,vcna; la Mntl'ibuzio tlc tlictro alle pl·eglliere del fu 1·idottn e in lire 7 miln, 3 f!O.Ciohi di avena rd il ri111nn e utt> llC'l quant ita .tivo l'tchiesl o; ·
Che così se ne htscia.n(lo gravi apprC'nsioni in. q11t>lla po·polazioae twl s uo riLoruo, c h e dagli 11ni si (,rmeva. dov(>r ced<;>l'(l fra. hrev<>, me11lr<> da. a lt r i 1·d supponeva. <'.ho voleRsc fa.r uno sbnrco a ed a Luino ver coutimutro le ostilità contro
Come io ebbi ier i hò di queste co;;e, io ho Rcritto cele remente t<tn Lo a l sig . f. f. di govcrna.Lorl' della; di visione eli N q11anLo al s ignor l LLo gotenentc genera te ce1v. OliviPri, com andante generale délle trup})e lofl'!ba.rde rinuite nei regi stati, pregauùo di far k occorrenti disposizioni acciò il Garibaldi non più, sua. tnt'P})a, rientt·are uùi reg i stati; cd ILO l'onol't' d'infornunne V . S . L , ::;ia, ver opportuna :sua. intelligenza, sia anehe a,f. fuJ.c h è Le viaccia, ove S . l\L cosl lo stimi. di notizìare di qua nto sovra S. E . il feld-maresciallo oomanùaute in ca.vo d elle a.nstriache, ond e all'E. "V. sia noto che daU'aggressionl', che potrebbe succedere p er varte del Garibaldi. il Piemonte non dovrà per nulla compl'OlllesRO
1080 LE PRIME GESTA DI GARElALDI IN lTALIA
..
LID l'lotPfEl DI GAUlBàLDI IN ITALIA 1081
ValeuJomi di quest'occasione, pregiomi di rinnovare <l Y. i seusi del mio distinto ossequio.
(Arch. stato 1nagg. vol. 6, pa.g. :33.1) . i'lfENA13REA.
n com.a11dcmte della· J_l\ ditlisione al NIJW àtllO Stato tnCl{NjÌOtC generale A les;s(ttHlria.
Cet>ano, il lG <l!gosto 1848.

Quanùo ))('l' mezzo ùcl mw. O!iv ieri riccveLti g-li ordini Tel a·· tivi n.l On.ribaldi, foce l'onore di darmi. io gi}\ <la divorse oro TieevuLo l'a\'viso ch'css.o g-Ciuern.lE- <Wevn. la,sciato il territorio sttrdo; non<linl<'UO, COl'l'cndo voce ch'ei civotonHwc, fcei pa.rt,irc ill.t0 reggimento con h<tt· teria o ùtLC squadl'oni cava.ll<n·ia pcw .Aronu..
1\fi recai io stt>xso ad Al'OllfL c trov<t.i 1ittttl' le iufm·nt<t· zioni datemi priHHl ; pcwò tutti (•.oncordare a 1lirc dte la truppa del genm·n,le cm tlh-sciplin<l!ta t' ch'<>gli aveva, dC't Lo clw, rt meno d'una, nc•ocssità al-lf;o l nta, noa surebiJe vii'11ornat.o Kt tl noRLro Lcni'tol·io. Correndo voc<' ttC'l pacs<> eh' !Dg-l i u uinl), <:Ile è t.mllu, sLnt<la <.li Luganor t' Cliò Vt'l' dare ht mauo a GrHUni chr erra, da. quanto m·edeRi, l·ntllt• <li<'Lto Bel'· gamo e cerc<lt venire colla Ll'UlJlla Rul nosLt·o territorio, e scmlmtndomi clw, so qucst:L era l n, snn. intenzione, n vr(•hbc co!l V('· nuto al gov<•mo dc•l Hc, non potentlolo <l!pl)oggi<ne dircthLmettte, a.Jmono ta.eit.nmeutc p:iacchè il corpo di Gr i ffini che forse cos1 si era ardito c tlisoiplimtto, g-li ·fc<·i serivero dal m io eu.po di sLu.to nutggiorr nomr, oudP Aa !)<.>I'P lo sue i11tenzioni e signillcanùogli in pal'i tempo l'ordine d'auda,re <t V'et·cc•Ui..
J\fcntre ciù faceva, venne spa1·sa la voce che Ùi..'lperso 1Ul eorpo di 500 Anst .rittci c tn,tti Jnosche1Mtrc i llrigiouieri. rensa;ndo el te un fa.Mo <:osì commcsHo tlll una truppa ohc fino a.llont aveva apvareutemenLc fatto pa,rt e dell'armata del Ue, attirerebbe (ua,Lche gra.vc t·ichiamo o forse (]_tmlcltc dimostrazione armata pe1' parte <l egli A mltl'iaci, onde prevenire quanto pot.rebbe distl.lThare le trattative, reca tomi a Ca:;;tellctto Rpeùii ;t Som111a il colonnello onde il generale oomandante le truppe imperiali che avevo riceVtltO ordine tli por fine disordini commessi da Garibaldi; che non p o tev o ciò t'lire, non cssendo,;più esso slù nostro territorio, m a che qualnuqne <'l!ggressione da esso fatta doveva e&sererigna.rclata come fatta da una t;mppa. eli fuorusciti; infatti eravamo pronti a punirli severamente, qualora ci capitassero per le mani.
1082 LE PRtME GKSTA DI GARTDALDI IN ITALIA
l'i.spoile che ne aHebbe fatto rappot·to al maresciallo, il <tuule cerf,ameute avrebbe apprezzato qncsL<' ragioni , perteLtamente con c hi a.veva da fare .
L a rLc:;posta del getwrale Garibal cli mi giunse solo i;tamanc•: r:t-
gione per cui tardai <t fare questo rapporto. Esso ùi<'e non poi C'l' l ui ed i suoi compagni tteconsentirc alla pace col-lumi co drlla }w-

tria nostra; e sinmo disposti a cont.i?ttwre la g1terra contro il 111'miro cmmme, in Lombarllia o dovunqut• sia pùì. conveniente. AYC'I\ÙO nel tempo sLt>i:!!;O ricevuto che il suo corl)O, :weampato tra Luino c U<•I· mignago, e fo r·Lc om di più di ebbe uno scontt·o corttro 400 A nstl'i:wi, <·hc lo aLt:t<'<'l1t'OtlO, nel quale ebbe 6 morti e H {t'riti; ('}l(' c"so riticnt' tntt'ont i va.pori c i bar<•otl.i, per rit it•at·si in caso fosse minaccia,to da forze superiori <• dimostrò l'intt'nzionc eli mettt're contribuzioni in I ntn1. <' Pallauza; faccio pn.rt ire iuuneuia.ta,mc.mLc.• il L3° reggi mento eon la mezza batLcrht de ll a 4a batter ia di }H•r A t'OM, oude il H o 1lOrtn.l'!ii Il. Pa.llanza (' r nt.m. il t,enbl. di ritorn.a t·c· territorio, ìipcro si 1'0tr:1 qu<>stu ma pen-;o non sia in II•Hzionc del Re .si vndu, u, cercarlo sul tcnitorio lomhnrùo, tauto sarebbe OlH'raziOJw ùilllaYetulo c.•gli c.• I'Omlot to sponda del htgo qualSi tutti i haLtclli eh<' pot t't•bl>c•t·o t t•asporlatll> (,l 'll])JH1.
Ili tutto il rc.•Kto dc.• ll :t litlea. V('l'HCJ Pavia, ttotl ùo ll<.'!isllll:ò meriti ;tttc.•nzionc; sembnt i rl\ clc.•s<·hi vi abbiat\0 11oea {ot·za, avendo un corpo cl'anuata cotwc.•ntmto da :t ' Iagt>u1a. Hi couicrma la, nuova <'be il m:uc.•sdallo abbht iu p<'t'S OJHl Mllùotto iu duo dci snoi c1iuquc <·ot•pi d\wmata. 1,<• truppe am.;tt'iachc, chC' ora abb iamo al oon.Hue ogni g-iorn.o so'LL'o<w.hio, sono, l a. C!.Wa.llc.>riu.spccial mPnLe, clireì yiù in mt.Lti vo e lu1 la uostm; d i eotto patito molto e perso rnolLi uomini dalla {atica. Non giorno clw qtmlohe ttfllcin .! e non dica clw sono stau<·hi <l<>lla, g-nena c ardcutcm('n1c' la, 1>:11'(>. lt'attnO generrlimt'tìl<• grandi elogi dd h\ bravura dei 110"\tri soldati. Abbiamo molti ammalati; molti uomiu.i mancano di cappotto c difficilmente si può oLtenerne ùn.i (((o posi Li; se si ha l'ioomiuci!trc la guerra credo, i m porLautissimo l'azicncl!t eli guenn. pensass<> a l modo di acc<:'lcmrc que ll e l)l'OvvisL(>; pPrchè, :w gran i neon ve niente si }JOt in luglio far l a, gncna. l'lenza cappotto, ciò a. questa stagione non. è più llossibile.
Le popolazioni di queste fronti(•rc iietnbrano, malgrado il loro <'Ontinuo contatto coi Lombardi, desiderose di pace e b<'n disposte pel governo. Le guardie civi.ol10 hanno buoua. figum e c bi0(lono armi, ru:;sicul'a.ndo che se ne sa.prebbero t'!crvirt•. I disordini di Ga.rihnldi t.olg-on l 'illnsionp alht maggior p:1t'te di quelli
/
\
PRIME GESTA DI GARIBALDI lN ITALIA 1083
che erano esaltati per i volonLo.ri e le loro prodezze; e su r1uel p11nto .mi parve ieri osservare Lm cambiamento.
Qnanto alla divisione, sarebbe bene da. desiderare le truppe potessero presto riprendere le loro stanze di Galliate e Trecate. J..lCrchè stanno molto male nei paesi ove ora sono i due regg i menti di Pilu•ro lo.
Prima di terminare queslo rappor t o, ho l'onore eli farle i miei ringraziamenti -pel grazioso r iscontro alle mie domancle, che ricevetti ieri; ed ho l'onore di assicurarla. dci sen,'-\i della mia, più alta co nsiùerazio ne.
(Arch. stato magg. 'VO(. 18, 71ag. 877). FERDINAXDODIKAVOIA.
JJal comwndo generale dei cw·abin-ieri ?·eaU al ministro ili e rnm·i:lt<t.
rl'orino, 16 18l8.
l<'gionc c h e con rnia. l'elazion.e ùi ieri n. 712 avl.'vO l'ouor<' <Il a.l l'E. V. esser giurd.a i t\ A1·ona. dopo di HVC'l' una contribuzion,o c.l i llrC 7 mila, gia.<:chè quella, <Jiviea nmminh;Lraoiouo lf' osserva va O)!SCt'e imJ)Ossibìlc di som.miu i:-;tnwlé una maggioro somma., non elle di venf,i sa.cehi di riso. dicci di o 1386 rar,ion.i ùi pa.ne, sa lpò da fltlella mtla. circa lt• or·e 8 'ful)Oll1C'l'idianc dello HtCSl:>O giOJ'llO .l4 uel COI'l'enLe in due piros,cafi c CJ.Uantc ba.rchB potN·ono bastare. ht dit·(•zioue di Pallanza, ma po i Ri seppe ch'ora. dirotta. <1. T1uino . (L ombardia).
L'ingegnere T:htrbo t•i, !HTesta.to tla qul.'l la lt>gionc, in HO· guif.o a caldo istanze di a lcune persone, c ùataluni VlLOlKi<ttHho Ul('diatl te ranzo ne, \remte fu,tto rila.t;oiarc d.u.l ca.po, g<'ncmle Garibaldi; i fra.tell i Minella l)Oi, in compa.gnic1. di un ta.J Gnenzi Bcrtano, come gli ti a. Oa:-;telle'Lto T ici no, a.rresLat,o in quel dì a.u Arona, furono tr·a Lti coli 1ci, scnza<Jhè nuJla abbia giovaLa l'intcrcessiouea loro vro Brofferio, il quale, trovandosi ivi eli pal:lsaggio vcr la Svizzera, ebbe col predetto Unribalili tul colloquio, che in sulle prime destò qualche I:!OspeLto.
La ci.LLà d'Arona . per u,dempirc <:t.ll'imvostalc contribuzione fra. lln'onJ., come erale fu di ricorre1'e all'im· prestito eli lire 6 mila dal monastero delle Salesiane, e di mille liro da quella ))arrocchia.

Prego l'E v. tli gradire gli atti del mio rispetto.
(A1 ch. eli Stato - LOVERA colonmello comandante in 2a
l>al della itivisionr. di N o vara al ca1w clel l o stato ·maggiore fje'"ti!C?'alf. .Alesswndria.
Novara, ill6 agosto 1848.
Facendo seguito alla mbt di ieri u 1356 ù.o l'onore di COil1}JÌ<'· ftare copia di. lettera, del sig. sindaco di pure in daML di ièJ' i, -pervmrutami alla Rera., dovo la l><Htcn za <le l coniere, colla. tlnale m i significa vocifcrarsi in quella città la.l1ossibilo calata, del g('ncrale Griffi n i colla sua 1.rnppa (tht 8 o] O mi l a, uomin i ) dallo montagne suvcriori a. Bergamo, l'!U']JeriormeuLe allago :i\Iaggiorc•, per qn ind Lreca,rsi n el r. torritol'io pa.ssamlo perla oiLtà suddetta.

Le mosse del generale Ga1·ibaldi snl htgo JWCdctto verso la. Svizzel'a coincidendo con tale vocifera zione, mi tengono in sospetto ùi qualche inLrlli.genza tra i <lne coman.tln. r1Li per un col po di m<1no, ve1· cui ne por s i R. A. H. il tlnca. di Genova fino <la if'ri f!<'I'U., e co ll'o(ticrno cot,.icrc scrivo ben anche altrtini· !-lter•o di gue>I'I'U. o mari nn..
Ho l'ortot·e di professa.l'o n. ll 'R V . gli aLti del pilt lJl'ofondo J'i . spclto . Di V. H. J. (A.rch mugg. 1! 0{. 18, 1iCtff· 875). l>'On.PT>JNGO.
[f, C(l po sto lo 'IIW{J,(jiore ,generale at {JOV ematOI'f' ai };"0Va1'(t.
r i.i:'lt , a.ddl 17 agosto 18·18, (ore 5 pom . ).
Ilo l'Ì<'·<•vuto sta.. notL c le favoritemi con111nicazioni id t lorno n.ll o mo1-1se di Garib:tlùi Nl il19 o 20 al 'ricino ciel 0011lO tli
5 mila twmini del g<'neru.lo Giacomo Dumn.do . come p:lio m• 110 f1t.1to cenno per mezzo del di guena COl:!tlmamla.to d:Lll'i11tPndcn.tc gHnorn.Je d'armala.
fucerLH, pm•ò S.l\f. sulle mosse del Ga,rihal di, mi fece testè ehi ama.rr com<' infra cioè (sic):
Di J'(>llùer<' avvertita V. B di H})edire immediatamente un 11ffizia ,le, <lttto a b(>ne dt>U(> iuctmtbeuzc, a reca1·e umt l ettera. di U('i al Aig. gencral<> au;.;tl'iaco che comautlcrà a Buffalora o <t Somma, in cui Ella, dichiari:
1° Che il Gn.ribalùi non?>, come neanche la sm'lt truppa, al servizio di S. M. ohe se questi ha, violando il tenitorio, infranta la. convenzione, U'c<tso colpisce esso Ga.ribaWi, voichè sotto l'osservanzl;\. della medesima egli godeva protezione nello stato nostro, protezione a cui ha con ciò volontariamente rinunciato;
zoChe sì tosto si ebbe contezza dei progetti del Garibaldi. H i spedirono ordini alla 4a divisione per dirigere truppe da. qual i h·np'{lc arrivarono poco dopo la pa,rtcnr.a precipitosa d el
108:1 LE PB.l:ME GESTA DI GARIBALDI lTAUA.
LE PRDlE GES'l'A DI (YARCDALDI IN lTALlA 1085

eorpo Gnriualdi. I n.sommn.protest;ue d<'rorosamcnte, ma lcalnwn.La, che dal governo si. opera. ciò cùe si deve, e se vi è stato in· tonYenieltte, va nttribuito a indh itluo o c·orpo, che si era. come b<>n lo sa. ·c S . , sot.totne8SO a S . .i\L ma che poi non si en1 preso pNtxiero eli manten<'re la. tlaia. fellc.
È inutile che io lliit agginugn. alla B. Y . che pra.tica. come El1:1 è (legli e di qn<'Hi di codesta. S]l<'('ie. sa1Jrà dichiarare il pt'u.o;ie•·o clel gov<'rno nei limiti con-ven i enti. ehe se G:u·ibaldi i è diretto nella e non ha in vaso il t l'l'l'itorio ora, ht, pratica non sarebbe c>d allom ue ll a swt pcnsrrù se dc•bba n.vere effrU o o no. Pregola, sig. di gradire, ecc ...
:N. B. - Se V. K. I. gi utlichet·à del ca"o di Ia 1·c l'umbaRciata di c·ui nella. prese n t e, a tempo con interess<Wl<'llto ht e ho glicnt• verrà l:tbt1 ft, on.tlo a. S . (Arrh. stato nL((!I!J· twl. 59. z>tt!J. ·121).
Tl .yinrlaco Ili CCttvnolliO a u· (u l'ltUanza.
Cnnnohio, 16 1818.
f 1wi fl<'l'llt all l' OJ'<' 10 Vénttc qui r.ondoLto, tln. divcrs;i d<'lln colonna. Garihaldi, tm loro compagno, JWt' nonw Béno li'raneesco, stato h'l'lltV<'lll<'nte iC'rito i n una coscht dallo sc·ont ro nvnl .o An<rf ,r•in.ni in. lJtlino, avvenuto h•ri <'On 1lt'N'l l iE'rn. tli f,tl'lo fu <la noi l':tceolto. <' IL<'J>Ilsitalo IWI rko,<•ro di S]H'CI;tlc, ci0\1' Vli si pr(':;1;t l'O Jl J)C)I'1111lll .. -
<d V<'Ugono f da ('a n.n ero s<•Ltc> ( 'roati ferii i , fa il i
Jll'igiorti<•ri dal Clnribalcli <' c·olà dir<•tti J>l'l' <·urati; Jll'l' non trovar"i ivi ]H'<•,.idio eli <·hinu·ghi e medi<'inali, qtt<'l !'ig.
!'Ìillhtco li dil psse rpli.
\oi gli abbiamo pnr<• :u•c·olti <' JH'l' VPI'Ìiit'are 'W an•"sc•ro armi, e gli d<•po!iti in nnn Cl\lll<'ra sicmra, dov(• gli si l'<'ll«lono qnPgli ufTizi clw
:)entiamo cll<' li cltte hatt(•lli a va por<' c·oll'alt•·o naviglio l'l'quisito si trovano tutt'ora tu•lla. md:b di r... udno a (lil;posizioll(' drl
Gnrlba l tl i , il qtw.le ieri nvn'bb(' avuto uuo sconlro con utut C'Olonna. di 500 am;IJ'i ( ci . c·on5 morti p<>T' parte. 7
fc>riti e 17 i t a li an i, ess•)ndo rimasti pure pri gionieri al Lri 215 AnstriaC' i , rh c l'li mise•·o bo1 do ti 'uno dei vapol'i. Dei 1 'i ferit i
italiani, uno è il soprannollliuato: altro si clite trovu. :-; i in ('an•'Pro c 15 furono ricowntti dalla RlÌntol'<l Laura So!rro l\Iant(•g-azza.
n<'lla. di lPi casa. di su ll rh fuw tli quPsto hor!!o Yetw'l c'antlPl'O.
- ANX<l 1.11
:)ALASC'O.
Ora :.i ùiee elle> il generale Garilmlùi. lasciando la difese nei ùintortti tU Lmino, ::;iasi recato a Lngano per in1/:I'Ot-l"larla d'altri Loml>n.nli. che eonti11ui qnakhe fuoco d'avamposto al di là di Ln>ino.
n ;;ig. sindaco di Cannero mi xmive di ten<•r<' qud Croati a dixposizioue del getwralc Garibaldi. lo Cl'eùo però che uon si }IOsconsiderare eome prigionieri uostro territotio. a,ttt>xo l':l.rmh;tizio conchiuso col R<•.

Lntmtto si pre!'ILauo lo1'0 li uec€'H>mri l-'Occorsi coll<' dovute Cfl!lled attenderò sollec·ito orùint• di \. I. :mlll.' loro ulteriori diRposizioni, non varenùo n<•mmcno giuxto che de h bano oon.t inuare a, rimanere a caric·o di qne!-;to
è lH'Ce.'iiMt.t·io ·un conLiltuo 's<'rvizio <l<•lln, 11azio: uale, il quah• riesci.' tt·oppo alla sola milizia ordinaria. H(•mb.ra.mi c:hc• sarcbbo il eli Tielri.edt•re il Hr>rvizio coll<•ttho drll:t rb;erva; anche SO\T:t di c·iò attc•uùe1·ò }(• di L(li istrnzio1ti.
La ùc•lla in Lut.Lom comlml.tc•nle non. Tmò a nwno di recare inquiet udinC' llPgli animi i nol'tri ahiLn,nLi; giova però 11pcnur chr il r. goveJ'tLo JH't•se le clt•bit.<• mi .... m·<· lH'r far rispettare la. twutmlilà di'l nostro tl'rrito!'io. al· m c> no f\ nchò <lnrcri\. l'armistizio.
Sell'ntt<•sa di prou1r instruzioni ho l'cmorc ...
(Ar<'h. stato nrugg.1•ol. lR, prcfJ. %5).
l l sindaco di Omt •ru·ro all' eli Pullanza.
< 'ann<'I'O. il H> agol'to lR 18.
lUi trovo ttPII<' c•it·c·ostanze <li la H. \ r . 1. eh t• Stllltt Rpondn. OV<' si dic e n fJU\ ino, r<'gtto lombardo, 1lirim })etto a, questo nomnne si t il gcneml<• Oa,J•i lmld i eol suo esercito. che <lie<'lli cort.'ltan• di t mila nomini, ed il giorno 15 con. diedel'o tlUa bnitn.glia. coi Tc•cleschi, dove• cll<' vi Vlwi f('l·iti ddl'eli<'l'<:ito Gll.rihalùi. <'di questi tU' vennero tradotti ancora in qtlesLo comm1e, dove oh e non. fl(LCsti si l'ica•vrre e trattar<• a llOI'Ill:L della oircolare n. 50 d<>l 10 :tA'Osto <'01'1'. dit•ttmata da.l miui.st.ero d i gu('rra., oppure Re u.hbinno a tmtLarxi in modo specia.le e
Si agginmJ;<' che ORI!i 80UO pure qui r-;ba.rca.t.i 8 f\olda1 .i. uno italhu10, c gli alh·i 7 croati. tnt tife1·iti; questi ultimi furouo tmSlllt>flsi al comune di Cannobio, ovr csist<' uno con tlllmc•ro :mfficieut(• di medici e spc•ziali. Il suddetto itnliano fu ricov<.>rato iu qucRto comunt>, tlove gli Hi presta, a LHolo d'umanità, ogni
Tn un pa.lazzo di ra.gion.e dPila famiglia l\[antegazza. dirim · JH'tto al castello di Cannero. venne poi impl'O\'\'isatn nua specie
... 1086 LE PRIME GESTA 01 G.\RlBALDl
L'\ 11.'ALIA
u; P.RHtt: GESTA DI GARlDALDJ IN ITALIA 1087 di nuovo dove st<tnno mecolti :sotto cura medica e t"hirurgi(::\ molti soldati feriti della. lt•gione Ouribaldi, che ricowm,rouo qui ieri Sl'l'a dopo il combat1imento di Luino.
Ora pot<>ndosi rinnovare il eomba,Ltimt•nto ed approdo a queRta sponda di floldat i italiani o tedeschi, fet'iti o tng-gitivi, si rac<•omantht a q1testa antotità sup(•riot'e il sot,toscritto sinclaro, ottde voglia comphte('l's i ù'impart ,irc imnH•tliatamente l t> opporl une h;trnzioni in proposito per norma di cluest 'ufficio locale.
Ilo l'onore
(.tlrl'11. !!lato UWfffl· vol. 18. 1Jtrg. 961). C\RONE.
il t·apita1w lurttrllo a NI{)O?'t' <<il Verbano •) 111 si ffllor i. rl iretlo1·r della età di navi fJIIZiont· ,qu[ la ffO. Gcrmiguago, li 10 18 ·18.
Approfitto del fortuna1o passaggio di una lHtrra ùi ('muwro p('lr f:trlC> noti?.il', c ck ll c d<'llttf-ltWcliziorw. l<'l'i lt> or<' 5pom. suC('('RSC un a.11à<'<·o per pnrtt• degli AuAf l'iac.i :mila. l<'gion<', la RLav n ccnmpata f,ra la nasa d<'ll:l. Cri v1•lli ti l'albergo della, liNlctwc·in. li fnoco fn da amho lt- pari i: ma, dopo ch·t·a me1.z'orn di c·omba11.im<'nt o, g li ùov<'f ,ft>J'O <l('dl•re alllL SIIIH'l'Ìo t•it,ù dt>lln l<•gione <' dat·si alla fuga , lal'ciauùo vrigioniN·i. R o 10 morti, <' eit·ca. lo ft>riU Questo H<'Ontr·o può avere h• gravi con,;t>gm•nz<•; noi si!LlllO in critiNL posiziotw per· non din• ll<'rinoloHiHsimn,, >41' i rinforzi :wxt t•he artn<'rauuo a vranuo, cont'ì_) natura l<'. tl.,i JH'Z?.i d 'n.rLigliNia, l)Oi('.h?> H g<'Mmlc Ga.!'ilm.ldi f<'co meHcrP :L hordo un <:<Jnnonc JH'I' ogni pirosca.fo, ond<' sc•mJH'<' hL l<'gione, c·om<' Hi 1.' es<>guiLo, infn.tti, di gi:\ it•!'i p<'r ottenet'<' il pn•s<1opo. Poichè, ftppen<L il gent1rale <:redè O!)l>OrLuno di avan?.arc• li due battt•lli al Nolo nostro apparire, gli Austriaci si d i edero nIla fuga, a.v N le looi scoperto pronta mente·, e8semlo che i l V<'llll<' ;t deciclersi Rullo ])OsLal<'.
Del giomo c·h<' io :-;arò in libertà non dirgli<'lo. Ieri wn;o mezzo giomo il fi;<'Mra. lc mi fece donHLmlarc, -per ùi.nni ulwlwll'attual<' sua.posiziotw non lJOl('va., c·.on suo dispiac·ere, cl(•l giorno in emi mi avrebh<' in lib<'rtà; nlw li UO!'\tri bat1(•11i era.no iutliiipensa.hili HÌ Ruoi piani, e oiJc per intanto uon }lO· assolutamente lasdarmi liberf{ Assicurandomi. dit>tro le osscrva?.loni che io gli l'c-ci snlti i mprgui d(•ll:l coi governi, ehe non mi a.vrebbe trattennto un'ora di piit di quaulo gli cm fece metten> un presidio l·mi due pirOH<'.afi con un uffiClin.le snpcr ior o il quale dirig<' lÌ> nost.re moss<>, e mi dichin,rò ROl<'nuemente eh 'io era a. sua. di.-;posizione . c che i ma.cehiui,;ti uon poteva.uo in vt>run modo sortire dal battello. A me solo l'd a Yi-

smara, :-lllll<l> mia pa rola d'onoro d'c:-;:ser prottti ad ogni cl•n no, ha permesso di. mettere piedi a iel'l'n, <l urante il giorno; con l n1 t o questo mi accoglie con somma gentilezza. cd <tifa hilità, ed usò li termini più <lolci; in q,ucRto modo c hi t'la. quando, e come 1ìninì, e presentandosi altri mezzi le farò pN'VE'nire altl'(' nuove.
I hn,t .t.(' Ui finora lHumo nulla malgmdo li sfoni <mi son soggetti ])Cl' il grn.n convoglio che Jumno Ù<t ('.OH· durre; si può fltt·e un movimento senza avere i l'imol'chi a.tt;wcati; di piit oggi il convoglio si cresciuto col rE-galo che m i h n. fatto O:wibaldi dei 23 pribrionieri, la. cui :Jorte ... Dio solo può <'onoscct·e, e che io non l)OI:lSO prev<'tltwe che <1<•11<' 11iù mis<'rahili.
Io a.Lt èttdo tutto quanto, a seconda. d<> ll e circo:-;tattze, credo m•cess:nio u,l benessere <](•i bottelli: ho fn,lto ripamt'<' la. sa-In. cl('l Verbano, onde non soffm trop}>O <·olla, scosRa del eannon<'. ma. clubito un poco che poHs l\. t<lor ritorno liC'l\z;t Yarl n; i<'l·i dopo il io mi mottcvu tliso]wa., d1•l pont<' di };uino , ed il B. Carlo 1'\,l d i tmt.to. mn.ttina il Oariualùi, J)U.l'l<mdo di hnoniHHitua om sullt• tratwi(' dt>i Tt>deschi in direzione di Yarese, mi lm. ordinato eli metlNnti in rada. qui a. Germignaga; sa. <lmtl li ntt<'tHlP. Iddio ht mandi lmonn.. Devoti-;simo obblig:ttiHsimo S<'rd!ot't!
(A roh . .vtalo vol . 18, JW!f· 925) . PON7.0Kl.
di Pullan:u «l goNrnatm·e tlrlla diri11ilmr di
Pallauza., J7 a)!;osto 18 18.
:Mi :lo -pn•mm·a di dan' n.U'R. V. in comuui(:a.:l.iont• i du<> fogliricevuti, l'nuo dal situht.co del comune di Ca.nuohio, c l'n,ltro d;t quello di Ca.tmero, dai rbultn.:
Esserr seg-uito uu combattimento tm gli Aust l'i:w.i e la. GarihuMii il giorno l o andante: <W<' t'e ctuest 'ultimo preseelti li comuni [tttzitletti pet· l';tt•e llll deposit.o ttc' suo i feriti e <lei prigionieri feriti;
T en<'re sempre :t su:l. tlisposiziotw due battelli a Yaport>, di modo clte restano tutt'a.tiatto intt•rt·otte le <•omunicazioui Ili quest,i pat•si per Milano, Torino c Nova.m , <' gli ft.ltri vicini al litora l0. '
I comuni di e Cannero, la città d'Intm e quest:1. di Pall:.u1za sono es}JOstc cd iu esse, per caso ùi diHiatta., la trnppa anzidetta. potrebbe rieoYerarsi; }J<'l' il c·he io i1011 f'red€'rei inopportuno l'invio in drtta. locnlità. tli fo1•ti distaceH.mcuti ùi tmppa
Le comunicazioni lltli O;t.nnobio e du. Canllero flllO a. Pallu,uz:l. sono as."ai difficili per vh di terra, t'non sarebht:'ro fors e pratica-

1088 LE PRIME
GESTA DI GARlB \LDI DI ITALIA
LI!J PRIME GESTA Dl GARIBALDI IN !TALlA 1089
bili C'lll· per la fanteria; poi per la via del lago, coll'uso delle barrhC', può giuugervi senza ùi:fficoltà
.Aniva in que::;lo momento al mio ufficio certo sig. Bottazr.i, ufficlin.le piemonl,eso a;pplioa.to a.lla colonua Garibaldi dal cessato gOV('l'JlO JH'OYVisorio di Milano in qualità di colonnello cnpo di stato maggiore. ieri detta legione dopo av<'r conos(liute le intenzioni del suo Nl-po, pale:,;o.1o nel vroolama qui uniLo, r ritoma a. Novara )>et' riprendere Hcrvizio sott.o gli m:ditti eli l-t il nostro dilettissimo Il suddetto sig. BoHazzl allega (•h e la t1•upp:\ Garibaldi somma. a millecinquN·<•nto uomini. .X !'lr·agguagliar<' di quanto sona all'B. Y. ho l'onor·c (.l rch. stato magg. vol. 18, 7Jag . 903). DuraMI.
Da7 ffOt'CI'?UJ della dit•i11ioue di Not•M'll a/ <'0}!0 dello 11W!f!JiOte [/C?Ierrt/l' .A
Nova.ra, 17 a.gosLo 1818.
Com piego una rrlazior1e <h•l ca.piln.no dei battelli a vapore di sul ma.ggior·p seqnel-!trn.ti thtl Hil!. gen<'mle Gndhaldi. th1l Hig. in1,end<•nto di d'Arona, dAlla q\Htl<> vedrà 1:1. posizionr loro c le mosse ciel sig. g:en<>ra,lc Garibaltli. che h:t dotato il ter-ritorio lombardo cd fazioni no gli Aust ri!Lci.
Ho l'onor·c tli l'ipr·oLesLarmi, coi scnHi del mn.RAimo rispc(,to di Y. R. J. (..lrrh. stato IIICI[/{1· t•ol. 18, ]W!J. 923).
L'iniNI!lPt1l6 della provincilt di PaUanza al t·omal/lilantc deUa •lll divi8'iont'.
Pallnnza. li 17 1818.
Ef;s<'tHlo informato che all'A. ·-r. R. ern. affidato il comando (lel COI'}JO d'esercito tli sul Tic ino durante l'armistizio . mi prendo la. lihet·tà ùi ra.gguaglinl'la. dell'andamento della trut>pa eli Garibaldi . la quale, il giorno 1-1 corrcnt<', lastiava \t·ona 1><'1' n, Luino paesl' lombanlo.
:Mi fo pt•rciò ))l't•mnra di dn,rc· a ll ' A. V. R. in comurùcazionc li ùuc fogli J•icevut.i.l'tmo dal Riudaco ù<'l comune di Cannero, l'altro da quello del comune di C'annobib, situati sl questo che quello sull'C'si rrma frontiera YCl'$0 la Hvizzera e d:li quali fogli risnlt !1:
Essere seguito uu comba.ttill1ento p:li Aust1·iaci e la trnppn, di detto Garibaldi il giorno 15 andan.te; prescclti li comuni anzidetti ver f<'l.re un deposito dei !SUOi fel'iti. e de' prigionieri ferili;

Ten<>re s<>mpre a snn. llispol'lizione i <lue b<tLteUi a 'apore <tppart<'lwnti alla. Hociet à 1li uu.vigazione, ht di emi sede• t> Htabilit<t in restano tlltt'affatto intt•rrotte le c·omuuica,zioni di q_ut'l'lLi paesi per Milano, 'forino t• Novarn,, c gli altri paesi vicini alliLorale.
Già e·olle m it- relazioni in data delli H, 15 e l ti vohwntc nwsl• ho tt>uuto il govcrua.ton• di Novara iu[ormato tli tutto quanto, chiedendo elw l'li provv('tlessc )Wl' la. l'ìi<'nrezz<\• di quest(• l)Opohtzion.i, ghwchè tktto Garibaldi iu poss(.':-so dei due battc:'ili <L va-pore può giung<'re n.H'ttnp<'lll'l:lhL ed imporre c·orltribuzioni Hugli a hi1 fmti, si eco m<' fetw ill l in Arona..
Sinorn non ristlitandomi che il j!OYI'l'llO ahhia date• disposi· zioui eli I'IOrta 111. propol'lito, lw Cll',•dnLo d(•l mio 1Lovere <li porr<> 1'V.R. il Vl'J'O Htuto dd lo <:o:o;C'.JWr'snaso C'lw a.YJ'à. più ;tmpio poh•t'<' per· tutelar'<' qut-sta 1'1·outic•m conLro iltiLomo arm:'llto ù<>l <:n.J'ih;tldi.
I I'Oilluni di (';uuwhio c CaruiPro, nonl'hè lt• l'il H\ di <' lntrn, C'sposti, cd in <'!';si. in raso di ht In, tl'lll)lHL <tnzid<··t.ta l)OlrC'hbe per· il ehe io tLon Cl'(\d<•r<•i inopportuno l 'iltvio in <l<•tt.e loeali L:\ tli !orti <UHt :wmml'nt i Il i t ntppa.
Le comunim1zioni <hlJ c t'ann.ero Hino a Pu,lhtu?.a l-lO IlO dillic•.ili ]lt>r la. v in òi 1C'rrn., e nOI t sa.rcblH•ro for."<' pratiea.bili dir ]>Cl' ma, ]>OÌ per la ÙC'l coli 'uso dell<l l><tl'Ch<' pnò senza, difficolL:l..
.drl'iva in. qtwsto mom<•nto al mio nfli<liO ('(•r'to sig. Bot tazr.i. 11ffioialn ;tpplieato c·olonna. Garibaldi dal t(•Sl!alo governo provvisol'io di 1\[i\a,uo in qualit>a <li. colonnello c;tpo dt-llo stn.io 11\ltggior<•. ggli a.hhandonò ieri llrHa. h•gionc dopo avere <:ouosciute le intenziotù ùel Rito tapo palC'satc tll'l proclama, qui unito,<' t•itorna. Nov:wn 1)er l'ipJ'end<'r<• servizio j!li ordini di S. :.\L no:;h·o a.matiRsimo sovl'ano.
n t>IHid<'ttO Bottazzi alfcrm<t (;hp la truppa ùel Gnribalùi SOtnllHt a l nOO 110lllini.
:sreU'a V<'r l'onot'C di rn.j!guaglinr eli quanto sovm l'A. Y. R. Ilo <•zia.ndio l'alto onore di protestarmi co' sensi di profonLli!'lsimo rispetto, e llc ll n. lllftfiRim ft venera.zioue e cl uh biùi<'lt?.a. ùell'. \. V. l-t. • (Ar('h. St«to iiÌagg. t•ol. 60, pag. 4 L9). Dl'PRA:o;.
Il colMI!nello à1•t genio militare, uddrtto aUo stccto ?IW!J{Jioi'e, al colonnello le tn1ppe acl Al'mw.
Pn.llanza, 17 agosto 18-18, <tlle tli ma.ttina.
lTnisco qui inchiuso copia di due lettere ùei l'liJida.ci di <'annohio e Cannero; la cosa si fn \U'j!'ente e vi ci vole imme<liato provvedimento per la protezione delle nostre comune. Primo t>

l 090 LE l'RDlP! GESTA DI GARIBAL.Ol lN l'l' \LU
Llli l'RDI:E GESTA Ul (.tAJUDALDI DI l1'AL1A 10fll
c·he ùuranle la so-;pen,.;ione d'armi è a. compromt>ttero'li al rice·
Vf're prigionieri e t('riti austria.c• i; RN·,ondo, uon. è ch<' le eo· nnme siano caric·n te ùi spc.se per un a>vcnttuit•re; }>C'l' impedire :t questi inconvenienti ci volc• la forz:t e subito, onde }11'1'/!0 la S. Y. ùi mandare una copia di <tnest:t mia a. S. A. n. il ùuca tli Oeuova, tM'Ciò sappia. tdlc ai Rnoi m·dini. che nn certo cap. Boltar.zi, ritira.to da1l'armata R:tnht, è• ghmto la no1.tt> pa.ssa.tn, ad prov<'nien t.c dal eu. m po G<tribaldi c·he rw faCI'\'a. lo Dl<\tHiai to-.tanwnt<' :t (' lllU\.llÙO l'a.vrò i ntPHO, f.:tl'Ò l>!Ll'tt' :tlht' :-\. delht n•htZÌOl\l'
.\.>n·rto la Y. R. C'hl• si tiene a Stre-;a. harelH' pt•r· tmsportarl'
1000 <' piCt n,OJnitti, st' fn.
Hc il tempo l'<tHsse c·onc•i•,.;so, sa1·ei partito SI'<',OlHlo l'intetlig(11tza Jl('r i no; JlCl'Ò, IW il lago si tranquilla, non irtÙIII!:t'ro n JlOrtarm i colà.
f),\ }lC'l'SOlli' si sa C\hC il UaTihaldi è sempre alla snn pC'lsiziollt' in \'istn :tJ.!li • .
Pt'(•giomi pt·o f rt it'l t• i :·H'Hl'li il t•lla pre<listi n la m ia consid<'l'll ziont>. (. 1l'f•ll. M(lfn IUIIffY· rnl. GO, JW!I· 115). HoL \lWIJI.
Il rololll/ltllo drl f/l' nio, (ldr1rrto ttl/11 11WffffÙJI'1'1 al CO/IUHHlUttle ft• (I'U]J}I l' (1(/ .li'O'i/11.
Pnlln 17 <tJ.!Ost o 18, (or·p 2 pom ).
'\li (o premura di far <'OtlOse<'re nlla •·. Y. I. tutto c·iò clw <ln l sig. <'ftpit.:tno di poi. <·olonnPllo al Hervizio 1h•l J.!owrno provvi-;odo di :\1 ila,no.
D isse nllc il d'avanti il'ri inc·omitwiò alh• 3 !·:! porn. <' !ìnì lm'ora. e mezza dovo. non erano clH' <llmLtro di linea, l'!l ntHù lli 'l'iroh·Hi; hL perùit111 dci comauù:tti tli Gariholdi dai 14, di h'P morti o 30 feriLi; l' dice c·ltc tlon•vano l'sscre di più, ma non lo puotea l'irur:Lr<•.
I>opo i l combattiment.o, il Garibaldi diede fuori nn pro<'l<tmn, di (•ni l'invio nna ropin,, Pd è }H'r code:;to Htampalo <·he il <·olonnello BoLtazzi lmwiò il eampo. profittando dell'occal'iou<• rhf il Gal'ibaldi incnmmi11ava l;t sua. tT'Uppa fnori di f;nino per lo !>tra,· dalP elw eondure in Svizzera; dice JWrò che la colonn:t Garibaldi non pnol esser<' di 11iù di 1000, ]l<'rchè molti vi sono dil'ertati, Pd i snoi ..lmcri<'ani. clw saranno ;-;ouo sopra i ,·apori t> battelli a. f'lli':H'C' i raunoni, ed il bagaglio elle lu-,;(·iò n, b01·<lo.
Il proclama è cluaro 'e<l è rept1bhlicn, eli<' Yolr, o1Hlr non vi d :mùE>rehbe più indugio t\ i m1•zzi più sp<'dienti 1w1·

riacquistare i nostri vapm·i e batteUi <'he sequestrò ad Arona, particolarmente che ehi ha i vapori r.omanda il lago.
llli pregio della stit;}a della S. V. I.
(A1·oh. stato 1nagg. 60, pag . 427) . f30LAROL!.
IL oo1nanàante àeZ 14° 1'egg. fanteria comandante la 4a divisionè. Oerano .
.Arona, 17 agosto 1848.

Tosto ricevuto l 'avviso eli V. A. R. ho disposto pet' la di parte della mia truppa per Pa.llanza. Allt' ore 6, terminato il rancio, partiva il mio 2° battaglione con tre pezzi d'artiglieria, con ordine che, dOJìO breve riposo !l> Stresa, alle 3 domani partisse per Palla nza. A mezzanotte sarà da aUre tre compagnie del 3° battaglioM al di San Vitale, onde evitare l'agglomerazione di truppe in Stresa. l'icovcro, con apparenza di nuova piogght. '
Intanto av<>vo scritto a Sohwoli r>er prevt•nil'lo ù pregarlo per ]c occot•rcnti disposir.ioni come più praLico del paese, accenna ndogli ht c oNlottn. a tenere i.n che Garibalcli colla sua tTUppa s'avv irina sse a qtwlli pne:.;i.
Ho pur scritto all3° :per la sLraùa eli rilevare i miei posLi eli Oleggio, Pot'to Ticino e CasLellet,to, '[Wl' ricompone il mio 1° bat· taglionc . .ALLendo quests, nott,c ill3°, ello qui rimarrà coll'artigliol'ia. Alle 6 Yz ho spedito un plico all'A V. R. od uno al go· vernatot'<> di Novara, di Ct'li mi si iacovft pt·omma per parto <lcll'iutcntlcnLe ùi Pallauza.
.Anzicltò fare un l'iassuuto di vm:i mggn!'l!gli l'icovnti dal ba· rone Solfl.roli, credo più chial'O eu opport.uno di mandargUeli tLtLLi })01' averne più precisa conosceuza, tLtttochè non racchiu· dano oost' di grave importanza, ad eccezione del proclama clw fn ca.t1sa che i.l nominato colonnello 'Bottazr.i abbandonava il oo1·po eU Garibaldi. D Bottazzi è ora a Pallanza; scdssi verchè mi fosse avviato con scorta, onde farlo pa.ssare all'A. V. R. Mi vieo rifc· rito che la compagnia Manara s'avvii da li'Ionzaverso Gallamtc, ove furono comandate provviste. Vi è clli. vuol vedere in ciò un tentativo di congiunzione con Garil1aldi; i.o credo a V('CC che se· gua l'itinerario ppescritto dagli Austriaci. Domani avrò su ciò qualche ragguagilo .
Dicesi che Garibaldi abbia licenziato i Tagazzi arruolati in :Nfllano, inç a,paci per la guerra; infatti al mo1uento mc ne fu condotto uno, che ripetè precisamente quanto già sisasull'attacro del 15 coi 'l'edeschl: parla che nel corpo vi è molta diserzione 1 pel'chè lascia ignorare le sue intenzioni, c quindi mancano <li viveri.
1092 LE l'lUME GESTA DI GARffiALDI IN ITALIA
..
LE l'lUME GESTA DI GAIUDALDI IX ITALIA 1003
Anzichè lasc:i:nlo amare a ca:-:a a Gillarat<·. l ' ho provvi::;orhmf'nte ai carabinieri.
Oggi 1mo Ù<'l miei giiì cattivo sogget1 o, preHo dn.l vi.no in umL osteria o v<• alten·ava, feN• r<>sistenza acl un mio tenente, cagiQIUHLùogli una ferita alla mano. Sirc:omc mi pre· nwrebbe ni (lare Ull prPghrrci l'j_, \. R. tli voler ordinare all'uùitOJ'<' di gn<'na in Novara ùi. tos1o qui rr<'arsi. per proeeùere in vta portando H<'CO il coùiN• di c·ni sono privo.
Nella 1ìdll(·in. olw 1<' mi<' di:;poKizioni siano nel scuso tlelle intrnzioni tlPll'A. Y. n.(' che l e ('0Sf' buona rins<·i1a, ho intnnt<' l'alto onore ùi protestarle li aHi del mio profondo osl'lequio.
(. lrch 11/llfJfl· vol. 60, JUX!f· 131 ). D nn\ 'iO.
Ual qua'l'ticr [JCIWI'« le 1n·incipalo nl (Jovema .to1'() <li N'ot•ara.
Al<'sfmtulria, J 7 agos1 o 1818.
Xella nottr 1·iof' it>ri HEJra a ore l l hol'iccvulo per staff<'Lfa.non moli o celere sm-.. h·tt era d<>i J 5 11. 19!1 1 <·.oll'ac·dtiwmvi del dispaccio clt•ll'inlt•udenl<' di Pallnnza, n. V.:-;.
Uerlamcnte> lP moss<' drl (hwilwl<li Hon <li gmn monH•nto JWl' h• (\Ollflcgneuze t\ t<'lllf'l':·d, mu Lu.,•ispons:Lhilit.3, 11(' eadc lui stesso. lnLu.nto la vr<•ll.rnr.<L di H. A. lt. il dttca di Genova <·o n fot'Zili, mcnLrc confort :L la popolazione, }W ile il snùdrtlo nella. o di abbanclon:tr<' :1JTatto la t<'rl'? eh<' gli oiTPriva ricovero<' ]HOl<'zionc, o di arPcltaJ'li rc<'<UHlot;i a Yerrf•lli, ove non potr:t pi(l sr age\'Olnwnlc muovere o compromrlt<'t'(' il paese rispcLto ollc ci osHet·va..
C'osa. di r1gmmlo c da avvertire <LI vrescnte si è che il Onriualdr (•ercasl':le di oonginugersi al sig. DLwmdo, c così rinniti H in 'i mila uomirli di mol<'sl:nc :Ml un tl'mpo e l'<•Kll'<'llltli <l<'stra del corpo austJ·i:H·o in confine. rol cantone di Lugano ('ridno) e formando no'\tra sini<;tra. a loro talento, punto prendersi pemne1o delle nostre delli assunti impegni etc. etc.
l11 tale sLa.t.o di COl<C io credo che d vonà, molla <·a.utcla nell'::unmetterc su l territorio regio il corpo Durando, anzi ciò fare . }H'r metà ad un giomo di ùistaur.a. Rotto ])l'Ptesto dc' viveri. ma in Rom ma per dividerli. ossE>rYarli e far RÌ che senza incouveuieuti Riano arrivati a YcrcelJi. convE'gno generale delle lrU]1pc, confederate o uo.
:Ma questo governo 4"ouc;r1<'l'Ù con S A. R. il comandante della 4"' div[Hiou<.> tuL1 e qt1estc ('ose) aRsicme purG al Rìg . luogo· tPnente gen. c,w. Olivieri: JIOÌ('hr ij- distnnza non se ne può ben

1094 LE PRUIE GESTA DJ GARIDALDJ lN lTALià giudicare, e l e sit.ua.zion i vaJ'ia.no dal ll1lllto in <mi si è scriLto costà prima di poterne a,'\"'et·e jl Tiscontl'o dal I'Onumùo genetale. (An·h. .stato vol 2, ]Ja{f 671).
Il p1·imo presso ii m.ini stero cìi e al caJlO deUo b'tato ttnagg·iore {!e.ttemle. A le.ssand1·ia.

Torh,o, addl J8 1818.
Da l e ùall'intentlenzn, generale <li :Nova.m questo miHistero ha r i cevuto . r elat iv:1mente al Gn.rihalùi ed a,lht sua l egiono, ltli.N:im'i ragguagli i qnl\li, oltr:e a ll a conferma di qmmto ven n o p:i à partedpa to alla S V. I. col <lisparcio cl el 16 con<-ntn 11. 1065,1, rccano qna.nto in ap}Jl'CS!'>O: j
j)t'l'SOUll> ùi c.onutl(>nr.a. l.rpedi.ta cblll' in tc nll entc 11i Pallanzn pc1· i mov:mcn.t.i cl<'l Gn,ril>alcli, s i recavrt il lo cotrcntc 1wl r.omun<' di Luino, sull a sponda l om barda, cd ivi tt·ovava hl. tr upp a del Oaribalùi roi baLtcJli l'l· vapore scq nc· trftti, cllstoùit.i d;;t, utl d t·u.ppell o di ..nmnti. A Lruppa Ri rmttO rinn.iL e (llle ro lonnc>, l'nn:.J r l'altra l ombar da,, c la iorza 1oLa1<> soLto gli Ol'dini del Oatihu.l<li poteva, uscc>nùcJ'C a :3 mila uomin i<' più. 1\tl un a <li 7 iu 8 ll1iglia, }'\.Ccampn.to un uo r·po d' .Austr itLc:i eli il nomini cd <'m prossimn Utl f'Om bn,ttimruto.
11 !lN{U<'str o 1lei cl ne va po ri I(lCI' J>l'Nmm<'l.'O all'N;p lorator<' cl te qua.ndo l a tl'tq>va clcl Gariha1di foHsL' a rcL t•occde.re e:;!';n, ripretlderehbP hL 1lrl l ago e potrl:'lJbe l)Ortttr;;i sulla sponda. U no deg;li uffiria,li, iatt'ITOj!ali dall'esploratore f! ullo st·opo spt' 1 l izionr ùurante l 'fnmi!'>1.izio, rispose CSf';cre in tenzi oni' del tor o <'·<\p o di 1'1\r la. gn0rra prr loro c;on t o noTI essendo vi11oo lati da a lcun i
R. .A . .R. il clu<'a di O<>nova., a :'ll.'gu ito d<'gli o,vvts • ricevuti 1lal go vetno di N ova r n , part.ito 1!1 nott.<> con un co mp cLente nurucro eli f u,nti (3 000) ed a l cuni ])czzi d'a rtiglirrh\, per recm·si in Aroua onde pl'ovvedere alla s icur ezza di quelle riviere, poco dopo il s11o giungere in questa. città, vetliva. informato che il Gariba ldi • a,vess<' preso terra s ull a lomba.rda in di Lu ino c co là <1vesse batLutò gli Austriaci, ùopo aver fatto fucil a re t r e individui c-he I'CC O aveva in ostaggio, di cui s ono i fr-atelli Mi· nella agenti del marchese Visconti di Mila.no.
Questo fatto veune annunzmto da S A R. il du ca di Genova al sig. governator e di Novara., parteci}Ja.ndog li ad un tempo che andrwa. a parthe da Arona per Castelletto sopra Ti cin o , onùe far sapere al sign or comandante delle truppe austriache iu qnei eli nt o rni che, agenùo il o;ig . Gal'ibaldi in ù i pendentrmente dal regi.o
<'sPrrit o. il fatto :--no uon avei'S<' ,f,, consi<lt•ra.J·,-i come una •iola· zione ·ùt>llo stipulato a.nui:stizio.
Intaul o che mi perwngono quest<' notizie ti)!nardo alla lf'gionc Oaribal<li, io ricrvo altro mpt>Ol'{o in chtla dello c·orren te d al RÌ/o! 1'. f. di governa tor t> ùc•lht divi-:wtH' tli N 0\'flra, .n<'l qual<', ti[N'<'tHIOl'Ì a uotizie ri<·.t•vut<> dal sin.dat'o di Arona. mi partf'cipa.
:-;parsa. VO(lt.' in ta h' t'h e la t rnppa. <.·om1tndala dal gt•· twmh• Gl'iffi.ui (8 o 10 miht nomini), e:lw ora, rNince lln, Ht·escilt, Ya,ga sulle monlagnt' sn]wriori a, HC'rg:<Ullll. sta per disc·endcre sutwl'iormrntc• o,l lai!O
t• quindi }l('l' qul':sla Yht portarsi nt•i r<.•gi st.ati, fne<•n<lo ]lllHl·utggio per Aronn.
lo :d t•s.c;o c·he le mosse dPl een('rHI<' Chuibalùi sul lago J>l'Nlt•tlo. c:oincidt•tulo C'OH tnlc• vol'ii'N'itziotw, lo lt'ngouo in soxpC'tto di q1tnlc•.lt<' intPIIigc'nzn !l'a i tl1w CtOlll<tntbmti lH'l' 1111 c•o lpo di mano. ondt• ue hn. fin tlnlla :'ìem d<·ll5 c·orrPntt', po1·to a\ viHo a.< '<•rano A. R il due·a <li C(>novn. fo llli lllil'Ctfo di f<11' 1\0ilS!l [H'YOi<' Jn di queslC ('OX(', HC'· l'io. ordini tli S. le piai'C•ia <li l<' j)J'Oll((> miSUl'(' d1<• si stinwrù d i ado t t are Hl l'i gll:\ nlo, fcl.rt>ndomi ral'iro d i inl'ol'ma dn rhc• il sintlac·o di Arona lt1t tliJ·ptto Il' piiL caltl<' iH'lt:mzn dal govt'l'llO pt·cn vrdn a prC'st•t'\U.l'e CJIH•l p:ws<' ùa :::iffalt<> gh\ oli t'<.'lllodo pt•rssmn t o p<>r gli rmt rl'iori pa-;-
Gradisc·a, sif.('. gc•twt·nlt•, i c;cusi clt•l mio distinto os-;<>quio.
(A/dt. stctto mrt[ffl. vc•l. G, 1)(/ff. 565).
:i.\!GNt.BRBA.
D11f !f"t·cnw della dil•h;iont • eli Soram ul capo dello 11tato nwr;yiol't' {JI'IH:I'ale • J lr.<1sandrict.
Xovarn, il 18 agosto 1818. no 1'01101'<' di I'Ollll)Ì<.'!.!;:II'(' ('Opia di Utl pl'OC'lanm ÙC'l g't'll('J':llc• Garibaldi. datato tla. :-.ul 'l'it'ino ill3 an<lautr. t' ric·evuto ier i 1-iera. dovo 111! JHM' lenza ùl•l conit'r<.'; com piego JHtt '(' ropia di l<>tt<>ra. di:'l sig. inlencleult' di c di d11C altre dc• i l'ig:not i di Cannohio e C'aonero dallo stc•s-;o inollt•a.temi. t'('latin• alle fazioni guenc•scbe Ile• l stulclcUo <'npitano contro )(> t l'llpJ)e s1ù territorio lombardo, c colgo il favorevole incontro JH'l' aYt>l't' l'onore di alla S. Y. gli atti del pitl dh;tinto
{AI'ch .. lllri{J{J. rol. LS. ptlfl. 959). G. R. SPIXOLA
• f.f. di l'apodi stato magyiot'e.

LE
DI
L'l
PRDlE CE'iTA
GARU3AT..Dl
IT\I,IA 1095
Jf capit(tno << Yrrbano>>
af sig . Reilaelli, rliretlo1'e della società ({'i navig((zionr sul {a!J().

Da bordo del V"rrbano , in raùa n. ::\Iacagno li 18 agosto 1818, (ore 7 Yz mattin:1). · lel'i :;era \Cr:-;o le nove ore ricev<'va il rivèrito di !toi foglio t.lcl 17. TI gPnerale COlla }><ll'tt• tlt•JI(' Slle truppe <'l'a acquarIÌ<'l'l1tO JU Luino, c questa matt.ina, <l'int.E>Jligenza col c:1.pitano HiHso conutndn n t(\ l n, s]1Nlir.ionc dei nost.ri piroscafi, aveva de<' iso eli re>carm i ]W N; 'lo ùel sig. P:<' ll <'l'nlc pE'r eseguire le <li T1ei i1-'lruziolli, quando n il g<'llt'lale speiliva a bor<lo uu nffida.le cou dii<' ordinanze, porlnn<lo nn :11 d<>tto sig. c·a-pitano Rb:so. <'OI quale lo an t'Il(' egli colla tmppa c·h(' :lY<',·n coli\ THll'th a (S('llza indic:att• dnve), lasciando ltll piNolo presidio a con m1 nfficial<> sup<'l'iorc qnal suo rnpprescntfl-nte, che conL:wf.L sulla di lui fermezza J>Cr COH!!C l'VItl'O il convoglio dci ph'oRrafi, c· hC' it1tn.u to P ou <l i l>enRm'c a tutte> quellt> provvigioni uecesRnric al mnntcn.imento d <'l ! a t l'nppa . (' <·he opexa):lsC <l'intc•lligenzà tol Hno rapprcsrnl:ml(', laqciato ('SlH'essamenlt• in JJnino. Dietro partenza <li Oaribalcli, io mi J'ivolj!evo a Hignori nfil<'inli superiod. c·C'rnHnica.ntlo loro ln di lei Mtc>rn., non !'lenza lll(lltC'r loro s.oL1'occh io lllLtc qu!.'llt• ci ,·cosl!tnr.c• c· ho erNl cva p itt n. LLc tl ct•snadrl'li ùi ht«(lia.rmi in lihcrtù, a.lmcno ton nn ha tl<>llo. Essi m di riHponderlo che e1·ano più che mai d't>sSI'I' ,•ansa di tanti incagli e disordini, dw Jl(•rò il Jlcnsi<>rc di socc·m·t·crela. 1>atria p re' il l<>va natmal mente' HU d'ogni cosa; che tl'nltrondt> la posiziotH' <lt•lla colonna è lnl<' non potere assolutamt> n L<> pdva,rl:J> di quPst.o m<>zzo certo c Hi<mro di rit ir ata iu caso eli. un diRaRtro; c: h er il ttso iarl e a n cltr \Hl battello lo toglìer(' il (,u tto, <.'ssendo i m possibile ùi lasciare con 1111 sol vapore t ulto il <•onvoglio; c1w fitHtlmcnte dal d h;pa.ccdo del sig. genE>rale ]>Otevasi argomentare che le coRe voll{cvano a l H.• ne . che colla truppa. per l'interno n<• vii:' ne <'hiaro che da un mowt•uto all'altro i ha.ttcl!i saranno rilasciati, c el le poco ten rpo in qu(•sbt in.eertczza., l)<'n:h{l il gen<>m l c ùon p u ò a.llont n.uarsi n OOH<L dnllago, a:vcllllo lascia lo alln. 0ustodia Ù('i virosMfi il convoglio dell e mun izioni, cariaj!gi e cannoni che :thbiaruo S<'ll11H'e a bordo; e cOttC'.hiudeva no C'O l replicarm i le parole di Garibaldi, che le bo già scri11 o nel mio foglio del1G corrente:« chealpriHJO momento possibile i battelli messi in libertà » 1 autorizzandomi intanto ad assicurat·la. che potendo <ru esta spedizione un felici.' risultato.
t nt t.1 emn lh•l g<•nerale di com pensare l'impresa di tutti quei
lO!JG LE I'IH.\IE GESTA DI ITALIA
LE f'RU!E GES'IA DI GARTBALOI 1T.\Ll \ 1097
.Innni. clw le s1trauuo dnllc sne diSllOsiziotti. Questa mattina alle ore\ 4. mi ve11iva dn (o or <l i ne cl i scaltlarr il \ ' crha tto ])er Ma.uagno s\qJcrwl·c, o-ve mi trovo in quf'sto momento, nel ùi visamento di <::.tl'i<',:l>l'e tutto il sn,lc che trova in deposito, affin<> di poterno proYn•tlere il -paesr tU Luino e adiarenz<'. alfatto sprovvisti ]ll'l' la. dimor<\ tl<'lla lrgionc. Finora però uott so qual direziorw si prrnderù, nYendo hu;riato il :-;. Carlo a :\lnC'ap;no inferiot·e; ILil<'l r, hc ò certo che app<'na. cariea.to il sale ci rrnh<'rcmo altrove. QnPst.a,, mio mtro Reùaelli, è ht mht l)Osizionc rehtti va alln, legione; un caso tli. it>l'i mi ba, messo poi in nn cerio qnnl1-woncerto. potC\n.do ieri mattina, per Mnsa d'nn. pervm·:o;issimo 1t•mpo, con1inuarr in ancoraggio :-;ulle t'ive ùi Luino, i o p<>rsuadeYa. il I'OIIl<HHlant<> <1:tpitano His:-;o (c•spcrto marinaio) tli ptH'tarsi in sicuro nel tli :\[nca.gno, llN' non resttne i acl un ineviL;tbill' tlbmstro n LuLLo il con. Oomunioa.tn. lltwsta neccRHiLà al gt•JH'l'<tlc.', ni oh e mo tU d iHtHll'l'e conte ta·<•tle\'a ]!C'l' la sicmrezzn, dc•l convoglio, <• c\uto cmlirt<' a,l ('a ,rlo di segnirmi, mi all'accenni\oto H('llO. Dopo \ln'om drta rhc si f'l'll fatto mo' imcnto, vt•nh·:L al mio bordo ilmatl'llotto
(11ic) Diaggio ad avvisarmi Oh<' il \ ismara•. tosto giunto <·ol H. Om·lo a :.\In.catgno, prendeva 11 :wvia.tosi a :.\ln.r.agno suprl'iore nologgiu v:L UIHt bm·mt, fltCC'!ldosi llfasporL<tt'<l <b Cannobio. ilw:wicanùolo di n. rctulm·mi <•dot.to di qtwHL<L sun. improvvisa va.rtc•nzn ,, n.ppoggiantlola , a. moli vi di. salute•. Da Ca.unt•ro poi mi Hrriv<>v:l. lo inclttHO high<"t tto. In <lnl'-.t o modo io J'<'i!lM·:tcolS. C\n·lo abbandona.to ai Il'<' nm1ellotti Nl nlla. t.ruppa r,he vi stanzia. Pt•u-.anùo che sarc•hhr :-;Lato inulil<' mnudnrc a pregare SLahilini, n{l potendo a. last'hH'<' quel batt<lllo in Lèl.lo n.hl.mndono; nell'iltLI'I'<'HHt' dl'll'itnpl'<'S<t ho ALima.to prndenro e <li :t malgrado tl'nno sLt·a.ordinario vc>uto. UIU\. h:trctt n. Cannobio al timonieri.' (\wlo ilwitandolo a l'<'O<trsi pronta.menl<• a borùo ùcl H. Ca l'lo. <'Ù alht l-lC'nt verso le ;) ore arrivava in Macaguo. Qttcsto <'l'n l'uni<'<> provvedimento ]lossibile <tlln. C\il'<:t>stanz,., e spero tli anre la di l<"i approvazimw. Io non voglio g-iuclioare ht eoruloLta. del sig. Vismara; mi -pn.re però che nou è questo il moùo tli tmtlare : io r.redo e sono cert.il!simo che la su:t :-;uluto uou era bnon:h cd era. · n.nzi già un giorno che non mangiava.; ed avendo 1111<1. legittima causa., perchè non trattare <'on po' ph1 ùi <lrlkatl:'zza? a lei)ìgurare la sorpresa dei eapi della legione. cui dovetti necessariamente <:omunicare.l'<wvcnuto, "del sospetto nel quale st.anno adesso. Forst' non tanto di me, ma in siugolar modo ven;o clei. peL' i qun.U sono st<tti dat.i ordini. rigorosissimi alle ::;cuHnelle; e l e che l)<'r qn<mto finora

non possa a meno d1e dir beue drl modo civile e con c·ui ci hanno tra.l t.:tto, n.on vi è però da ...

Ga.ribalùi l'iN•VtltO dell'arrivo truppa che ora, l1'ovasi rostl; anzi qui eone vo<·e tra, gli uillcin.ti rlw c·onw.ndata dal duca di Genova. Tn qnrsto momento, C\hc sto pet; <:hiudere la prescntt>. mi si orùiua la partt>nza per Lo<·tn uo. la:-;C'iaudo i barc·oni su questa rin1 <·olln 1lovuta s<orta; non so an· fiOra il motivo, il q naie mi st•n ira JH'l' continuare la prl'sente le ore 8).
1\I::t.gadiuo, or' <' L2.
Yerlt>ndorni or<liua!u part<'nza lH'l' ritomarc n.l\lac·:tgno, l'i· pr<>ndo hq>t>ttna pc·r Mntinuare In.. n•lazion<>. Lo seopo d<'lla gi! a. n !Jocaruo e Maga1lino t'l'<lrehl.Livn. al sale <li <li c•ui le ho parh1to 'tni sovm; non ne couosM JH'rò le e.ire.ost:tll7.<'. Lt• rt\C'· eonterò intn.nto olw poto Htl Pssl•rd di gmn t<WOI'<' tmu. t.al 1msseggiat.n. pt•r In, no:-;tra lilwrazion<', u;tmeno d<•l Vt'rbano, gi:wclrr, ;'lb:wcat o a, J;o<·fnno C'o l <·:Lpil.ano Rit>so, nn uffi · dnl<· Nl un. n\t,r·o <'Ìvilr interessato rwtl'u n·ar<' ùcl $:11<•, tutti di<'tro dPI P\'<'rletto c·omarHhmte fummo 1osto nn c·onsiglien• di st:'tto, sig. lJ. Husca. c dnl c·ommic:,ario di govc•t·no. i quali, scam h iah• alc•ntu•]Htl'Olc, c• i in" it m·ono a recare·i all'uffi(lio. li ou pit:tno HhlsO, p t't'SO sospctlo di CJ.tl<'I'>Lo il t vito, cd approtl Li arulo <l ' nn lllOm<:'nlo tdw i due magist,r·a,t.i s'<lran.o alql1:tnlo da rwi al· di<l<'ndo a,l rPsto <iella. <:oru pagtùn, di a.nchtr<• p t i l'<' nvnrtti, mi JW<'St' JWl' nrt lmtt·<:io cl'irnpt·ov,·iso <• mi fee<' tor·uur<> in· dic•tr·o, <liceudonri <•.lw bisoj!nava dw toma"si c·on lui a h01·do. <' pPtl!'trando foll:l Hi l'UJ!f!Ìlutst• il <:auotto, <'tl in un Yolo fu m mo 3 bot·ùo. Ht>ppi 110i che si t m !l:\\ n di sequPsl rar·ci tut! i ]Wl' ]lOtere rimeL(Cl't' il pnhbli(l() drl battello, (IÌl> c:ltc mi già. <letto prima anohe il nornmissario di gov('J'rtO, fa· C<'ndomi eh<; ncll'iut.eres"l<' o dd puhblico ]Wnsavn. di SN[li<'Str:nci. comitwiando me <'Il il ca· pitano Risso; il qual(• di:o;corso fu <LU<'llo eh<' oceasionò l'invito nll'uffi('io di t ntti rwi. cl el cb c fors.- a \'\'Ct'tito il ca.pjtano Hi..,so, il mi fa,tto ati voce, la d<'t<•rminazione di. rit.omar(' cor1 un colpo di HOq>rPsa me e lui Rtd Yerhn.no; re:-;ta.mmo a,rwot·a più di tm'onll nelle acqut> di L,o(mrno, aU'anr om salpata, OtHlt> il reAto tlt•li:L conred a. bordo, la via di Ma.gadiuo, <lo ve il ca.pita.no Risso voleva spedite una, a. LuJrano, ci siamo I'ÌlllPiNi sul ritomo d<'lla nostra stazione, do\e giungemmo fra mezz'ora circa .•\ttendo <'olà a chind<'l'<' la preseutt> qualora. vi I.TovaH:si nuove disposizioni per ragg-ua.gliarnela.
1098 LE PIUME GE!::>T\ DI 0 ,\RIB.\LOI !X ITALIA
•
lJC• ùi<;pO$izioni chC> qui si trova,uo sono ùi ritormtr(' alla noxtra pri111a ])Osizionc d i in.feri ol'C, \Wl' cui liOIL ho nu ll 'a,Jtl'o da aggiuugN'(' per ora. lo sono più elle slauco di questa vita; egli è da lun<'<lt, primo giorno del no:'!tro c·hc uou toeco il leLt.o, ed <t.nu lte in q uell)oco tlormiT·e clw si fa n.l\a, bell1t nwglio sono ad ogni monwrtlo svt'gliato ùa. ordini e movimenU, c·.h<' 1-1i ric·P\'OtlO t' si deYono fare. clw lNmini. prr<'hè n.è io. nf' i rnaochhliHllb possht.mo duml'ia Rcmprt•. e speriamo brru•. :::iopmvvenen d o qualche cof-la ùi l'ill'van.t(', l<• ne serivt>rò, cd ilo iulanto il bc•rH· eli rivcril'la. DcvoLissimo :-;<•n·o 11. Pox r. 1.
IJa.prrio\cllt,r l e R<tr:\ oonr:;egnata bm·mt a H<'i n•mi, '< ui c·omo d'a('(:ordo <:OITh;pondern mila.nl'si lir<' 2 1
T,n, presrntP vcmw alt<• Ort' 10 ]>Omel'idiane <1<·1 giomo lR 1RJ8.
(Arch. 1ilalo rnllflfl· 110L. HO, tWfl. tu:i).
If cupo dello mag{liorr UI'IICTalt• a{, l!Ointmdantr delltt 1• dit•illiol!r.
CeJ·a no.
Alt•ssanùria, adùt 18 agosto 1818, (ore 'i nnt.)

!(•l'i <L noll.t• il luogot e l LNl..L<' (li "Lu.Lo cn,v. J\vogndro, ill\·iato da V . .\. IL mi porg-cv;t sua lcH<'l'a dci lH d:t ('p rano. <We\a fat.to ritomo. In dipendeuza dell<' notiziP cito Y . .A. l t riccvc•va ddh• mosse òrl Oal'ibaldi r stu.to o l ( imo il P<'ll'iÌCl'O d i fare <Wlti1Z:l•T<' \111 Ut<tg!-(ÌOl' 1\\1111Cl'O di l.nlp1J11• IL Sù<t · glioni da fntm. a Ca..;telletto sopm Tidno, c non dubito <·lwsisa.ntnno dati li Ol'flini al <lonuLndant<' inl<•rinalc.la hriga.ta di Pirw· ro lo, poièlièl il genentl<' ll[auno Ì' malato n 'T'oriuo, li oppor! uni ordini, dico, ]Wr ben guidarli acl ogni ewnienza, ritenuto dw se il corpo d(>gli insorti r·itonut indie t ro 'uol rssct'<' i Mmuni <lir1•Lii a VPrerlli, coloro r.hc ciò d<'1iiùcr:.tno cd il Oarihn Idi posto in <ll'l'<•sto ili ( 'asa,lc> (Castello) in nspt'l· tativa di t·omc wmw già JH't•s<·ritto <la S. :\I.
Qtwllo che vi em tcrnPn• in liOdPsti monli si è la congitrn· • z iotw ùei Ml'pi genera i Durando, Grilli ni. <1 di deLLo Oal'iha. llli; il primo ha se<·-o 5000; il secondo non sono certo. Hl<t valutaudolo
a. 1000, cb<> aggiuntò ai 3000 dc>l Garibaldi Rat'<•bhero, cos1 cougitml.i, 12.00 0 uomin.i i nei t'Cct (J)
(lJ Che qu esta riun ione fosse 11elle mire di Garibaldi è ripctutnmeote a.fformato anche nella« Vita del generale Giacomo Medici » dal PASI:SI il quale fa ri.sn.lire l'intenzione al 25 luglio e documenta In. cosa citn.r:do lettere scr1tto n Durando, 1\[auo.ra, Griffini, o 'l'hn.nbe r g (Nota dell'ufficio
LE PHHHi OESTA
DI GARTDALOJ lN l'l'ALIA 1099
)fa<·agno $Uperiorc· (ore l llOmeriùiunc.>).
•
È hen.c;ì Yero che rorpi di cotal natura , privi di <'antll<'ria e di artiglieria, non c·o:stiluisrouo una divisione; }>N' dif<'tto di suHs isteuz a <' eli comando ass olllto presto si S})erpel'al JO; nw avrcbbet·o })OilliO el'lsere int<>si fare un impeto forte e an·N·are ILuulche grave incaglio alla piena N;ec·uzione di tutti li artic·oli d <•ll'armisL izio, elle nssai ci 1>remono, poichè sono a 1700 Piemont<.'si, artiglieria,, za]lJHl!tori e ( rup'J)a ùi lin,.a, Nl un mMel'iale d'artiglieria e ùi munizioni tanto piu da stimat-:i, (!h<• nou siamo in grado di surroga.re, ii<' pet· mnla. Y<>nturn wui,; . S<·ro pordut.i o t.l'atLrnut,i.
It•ri R. M. mi ordinava, che, ]><>r mrzzo di shdTetta e!' i<'re. io iln lo stes:so govNnaton• t li -o va r:t a seri" <'t'c al sig. g<'lle· t·alt• coma ndanLt' l<' tnq>po imperiali :L Somma,, nel S<' llso stesso <li ciò c he V . .A. !{. :wct>nunv1t per mezzo del envo di sta.to maggiote delln. division<'. Ella mi annunzia d'avPrli già fa t t i partire ([acentlo ore di tale lt•tt<'l'a un u ffidalc dello Htn lo di Novam) <' co11 c•iò io mi lusingo oh<• il nomic·o sarà ]>ic•namentc• tlt•lla l'l't titudim• <' dei st•nHi d'onorc• nhe gOY<'l'nano l'operar<• della l'egia, armata, (:ho <ttul.n.to mnggiOl'lll<'llL!'
(Jracli1.issinH• mi sono le noU:de che V. A. R. Hi comphwque agginngt'l'<' al Hopranwntovato suo di"pat·c·io intorno alldorzc• nem Hulln parte d<>l Ml'SO d!>l sul\ (l condizioni di quPllc Lrllll))<' c<l il loro SlJ iJ'it o.
Il li) arri v:wa costà il sig.. \ il domani eia un inviato strao•·dinario francego ì\Ir. Boi;; le C'omtc. ll lG l'ip:trtiV<l!no n.mbeduc•, cos\ eziandio fac·ova rilorno a 'l'ol'ino il c·on1 e Revrl <'011 m di c·.ompoiT<' uu minist <'l'O, <lirt'i qna::;i un goYerno, di r.ni .è sonuno, il hil;oguo.
è mt'glio inHttlnt<' dopo 1\vpplic:azioue di mignMI<' illG.
11 LO o 20 le tl'uppC' del g<m<>rale Oin,r.omo Durando, <tlwlle slt•Hs<' che custodirono dnraut<' la, campagna i vassi dello Rtelvio, 'l'onall' <' del Cnffaro, vareheranuo il Ticino per recarsi n. Vrl'tlclli, adunata gcne •·ale dei c·cwpi con (Nl<•rati.
l o scris!'li pcrchè iu tltw colon n<• ad un giorno d'intervallo ciPtte 1ruvpe si foH presentate; llHL non so n c·erlo d'c>-:scr ascoltalo, nome scm1lrc è accaduto l a campa.gua con s\ fatti corpi;

dE> Ir rsto è u11 omaggio alla veri Là,, che il <l etto genmalc Dm·nn.do snccedettc, in quel comando della dife;;iL dci passi che scendono dal 'rirolo su Bt·escia, Bergamo c• Lecco, allo mezzo svizzero mandi, assai. me glio condusse le cose ed io debbo a;;siòÌ eur...omiare il modo col quale si t<'nne in rehLzione col eomando gencrah• dell'armata e seppe mant<'ncrvi la disciplina, sciogliendo il batta· glionc della Morte (An fossi) e s; m ili comunisti e l'epubblirani.
Tl o l'onore tli vorgere a V. A. R.. gli att i del mio ossequi o. (Ar<'ll. magg. t•ol. 59, pafJ. :127).
HAL.\l-<('0
• J100 J,fi: PR.Hm Cl JllS1'A l); UA RIRA Ll)l IN ITALIA
•
Il f'I(JHJ dl'/{o 11/ato IIWfJUiOrt' !Jl'1tf'ra/e al com11ndarbfl' della l•
18 agosto 1818 , (or<> 9 mattino).

R. M., ch'io ho avuto l'onore di vetlerc <LI momen.to. l'apPrato da\._\.)[' inearic;t di prc•snivcriP: nlw il Ga,·ibal<li t•ou i 11011 tlebbonsi nostre tl'UJlPC inseguin•. oc·c·OI'l't'ndo, nltt·c• illimit<> ùclJo stato, RÌ ,-rrrso Lombardh1•. <:hl' nella C'ltc sarcbbP h<'llC' l'iprrnderp i hat tc•lli ll vapot·c• c•d i hal'(·oni. sc• approda.no alla, l'lJIOIHllL l'<'gÌ<L tlOit c·IH' far l'iJnc·tLC'n• in libc•t'là li dii P ostaggi a< 'al'tcllc·t lo, sn<lditi dc•l H c•.
1-i. ;'IL sJqlpOIW (I]Je V. A. H. <'HS<'IH io eli J ' il ,ot'ILO a CNa.JtO, c• \'1:-;La l'assc•nr.1l clel gc•net·al.\fanno, il •.dg_ colonnello Damiano "' rà il comando <leli n. hrig<LI a; a nwpo c·lu•, la stwdiziom· c•ompoxtn dc•lle varit• anni c·onu• colonna. mobiiP c• di]H'Ildt>nll' da u1m sJH•c .ictlt• opemr.JOII<', lo ahhia lìc!Mo ad un g-<.'111'miP. t• <'Ol'\Ì lu ;;t·dtn. Hia, <'<Ldula sul <·uv. Ht•s. il Kolo n Ila cii\ isionc>.
Nt•ll'uH c·aso, c·onw nt•ll'alt,1·o, (JII\'H ii nlli!'ia.li sli]H'J'i(>Ii HClll in gl':nlo di disim1wgnar<' ht•nC' qut•sto sphtc·c•\ olc• alfa n•.
Il l< p dt•si<lem cdu1, n Lo ill·it.it·o d t• l <htl'ihu Idi in sp<>r·ptomto il suo c·orpo, \ ·. •\. ric·hiami a ( ' t•r ·auo il 1Wrho clc•llc• sn<> fot·ze, hHwianclo al monw11 t o un ha tta ,.rl ionc· 11 d In t •·a. <' Palhlllza, <'d altro ad .\rona.
l n qn<•stc• lc><•;tlitn s:u•;umo piu tnrd i 1lt't t i hattag-lioni l'llllTO/.!"UlÌ
tla <pwlli ch•llu 2" divit-;iOIH' eli d fL JH'I'nch•1·si Novan1, lll<t l'ot·din<• apposi lo \ 'Prrà n suo ll'mpo <lato. int n nt,o a V. A. li 1ni('i cm:s<'(!lli. ( L/·r·/1. .'i/11(0 ltiU!J!J· l'O{. 50, J)CI!J. 1:)1 ).
J)a[ fJIH'PI'tW del/11 di NoMra (Il f'II/)O di'Ilo Hialo ltlctff!li"''l' !Jfllemlt• • t kssMHlria.
:\0\'a!'<l, li-ì ngoxto 18 tR.
:\li rc•co a dO\'I'l'o:sa pl ' C'llllll'a tli far c·ons<'t'l'<' alla \. L in l'\'ai$ione di mi significa n nonw di :\I. eol pn·:rialo foglio di ieri. ore 5 pom .. c1he .• \. IL il cluea di (i enova ila n:andato il :,;ig-. eolOllll<'llo La :t Mag <•nta tlal sig. gc•nemle Hallt•r. per romunic·.aq!li g li Ot'cliJti di M. J'igu a rdo n.\ Oal'ihaldi. astNwndo:-;i 1lal parola dei prigionil'ri <' feriti austt·iad, elw t•t·ano sl<11ti rimessi sttl noiilt•o lNritol'io. oom<· a.n1 te YPdra Y. R l. dalle <·art<· unil<' alla mi a <l'og-gi n. 1981. "lJe<litcle per istaffot.la ae<·t·lPrat<l, al nH•zzodì; cireostanr.n diffic·il1•
70- A:'i:-10 Lll
LE PRI.UE li EST.-\ DI GARJB-\LOJ J:S ITAI,JA 1101
e t·omproml.'tlente. c·IH• S. A.. H. CTCd<• lt•ner occ:ultfL il più hil<·. fìnchè tH' abhi:l istruziorw viù pt·c·c·is<' 1mlmodo ùi t·cgolar:>i.
<'Ile il gcnc•rale ;wsLt'htco e;.;sf.'rc• pienanwnte JHirsuaso, <·hp l> Cl' par•lt• del governo 1101'\Lro si r opetaLo colla JlUlHHima lc•altù.
l debiti c·oncerti ;.;i sono pn•si col ;.;ig. Olivieri, c·ome c·olla prelodn t H A. IL c:hr <>h bi stalll<Lll<' l'onor·<• di inchinn,re. appunto ywi c·oncert i ;.;nùdet ti. <' sono1-1i p m da te· l l'oppor! n ne dirc•zioni al si)!. cololllwllo Dantiano. t·hc• trovasi in \rona eol suo n•ggillll.'lt(O, a fine di V<'<lf'f(' H(' HiH JHli"Hi!JiJp di lll'l'lntaÙNC il gt•· rtct·nk nunlJ)<lo ad <'lltral'<' n<.>l r. t.c•t·t•iLOl'io <·olia, Ll'llpj)a di\ isn in du<• alla distanza tli nn l'ntut dall'altra. lH'I' p;;;.;cn• imm:1ntinl'nl <' <lit•t•lt<•. lHll ' t' dh hw, a \ t•rc<'lli :-;otto i d<•l ;.;ig. g<•n. Olivicri.
:41w<lis<·o nll'istant<• il vic·t•-ndit or<• di gll<'t'ra (nnic-o in <tn<•i-;ta tlh il tulitore iu <'Ol\J!t•do) ati \rOtta, ll'ot·diuc•
H. il duca di (l<•nov:t, lH't'lli'O<·<'d<•rt• <·on <·Plel'ita I"OlH';t
1111<1 immhol'dinaziotw ('oln
t 'olgo ((ll<'Hia JH'I' \. :-\. l. a 'oler promuo\' Pn• gli 11llìlli affini'IH' sia dt·l'ltinato in ([ll<'l'il<t <Livisiottt• qualCihe lldit.or·<• di lWl di!.;iJilJWI-!:110 dei pml· t•dimenti, oht• lll:tllll' il nunwt·o tlellt• trllpp<• in c•s:m stanziai<•, sono frNptenti.
Il() I'OtiOI'I' 1li t·ipmft•:;s;u·l• nll:t \. l. ;!li atti clPI più distinto OHI'I\'IjliÌO.
(.1!'('1/. H(ll/0 lnUff!l· 1'ol. 1R, )111ff !Hl7).
/Jal l'Oli/In/do !Jnlt'l'll/1 1lri l'llmldnii'I'Ì l'l'li/i f:tl ll/litbi8l1'11 Ili fJIWI'/'CI l' marin11.
' l'odno, l!lago:-;Lo IHIR.
l lo l'onm p di tntsnwtlc•rC' all ' \. t·opia d'un 11<'1 g<'lll'l'ale Gu.I'Ìlmltli, HL·Il Lo dil'l\tliO pN mezzo tl<'lla nc•i pac•si della Lotn Lnng:o il littor:tlf' del la go :\htggiot•t•.
Pt·<'goln di \'Olt>r a:tl!ratlir<' gli al ti dt•lmio ris1wt lo \.
A nnotuzionr a lapi11. - 1\Ja.ndn.re una . c•.opia tlC'I Jll'Oelama al quartier pt·in<'ipale pt•r ;.;na norma. (rlrch. di, 'lato- 'l'orino).
!l nmwndante dl'lla ·l • a l capo dr/lo sllllo ?rWg{fiorr rtrncr(l[t·.
('emno, li 19 agoRio 18J8.
Ho L'onore di dfcrir<' alla S. I. eh<' iPri maLtimt S. E. il vNnatore ùi Novara mi richiPH<' <li mantlarP tm uflic·iale a <:t•rtifìca,J'e il tenente mart•Rc:iallo auALriaco. <'.omatHln,n l.<' l (' t.rnl)llf'

LE
1102
PRIMI!: Ot::STA Dl GAlUDALDI IN ITALIA
fronte della 1• di \'isionc: eh t• il Rt• disapprovava altamente le mosse di

Benchè come già ebbi l'ottorc di rifcrirlc, inviato <t !'Iom ma mand<lti nuovn,mente il m io Celpo di stato mag-giore dà l conte di IIaller, c·lw px·otestò sapere chP il Re avea in tutto ciò ag-ito colla massime'\! lealtà. La commi11sione fu fatta a voce, non a V<'tH1omi il govematorc di Sovara trasmesso all'ttn<t lettera JWL gem•rale aust1·i:wo; a quest'ultimo p<'rò, dietro sua ricbiestn, il t·olonnello La :Jf<ll'lllOI':t diede copin di qtwgli tit\Oli ti<'II'Ot' diut•, Lt'a.smessomi d<t V. S. l. <"'J rigm'Lrùo di Garibaldi. c• lw potea nsi n10sl mrc sellza fltlenn itwon vcnicnle. PJH'tm ricevuti i suoi tlispact•i , t't•catimi dal NW. Avogadro <' rigtHU'dant.i Dmando. mi n•t·ai in persona a Xovant onde inh•udt•rnli t•ol goY<'I'natorc N1 il gPnt•ralc Olivieri.
mtrOV<li c·ht• l't'agli !\Letto ordinato, 1\011 HO ùa ((U<lll• tli dut• autori lì\, gia<·c·ll?> stt quc•::;Lo non Cl'UllO <1\l('('Ot'tlo, di 'snt'l' il ' l'iuino c <limorn a Ol<'g-gio c:on la sua colomut; loro non c:o11veniv<t Lt•nc•rt• tn.l Lrnppe'l> nlla fronlicra <'sii nata in modo a n•ndcn• per m t't:\ l:t mia divi· sionc inut ill• st• 'i <'m da agin•; c·lw qnt'sta Pra d'alft'Otlllt> c·ontraria al dispacc·io :-;('J'ittomi dalla.·.\. J. :\li dissC'I'O n ' ' ''cbhcro pro\' t'< l n t o a lE> IlO l'l' d Pgli or d in i. Esscndo d Hl dispac· do di Y. l. rucH\Ontamlalo di I·I'IH'I' o<whio a c1iò c·lu• il r:orpo di nnrundo non poLcsse nnirc• n, qltl'llo <li (hwilml<li, proposi n.gli anzideW tcnPnli gencrn.li di portare· <ht Novam, dn e lmLta.glioni Borgo ){aJtct•o, oudt> a qualunque c•vt>nto ai <·ot·pi che passano il 'l'ic·ino la "lt·ndn. <.lrlla. montagna.<' di avanz;u·c• da l'erano n Oallialt• il 1 t'<'gginwnlo <Iella mht <li visione·. il A'<'tteralt• Oli \'irri m i asl'!ie11l'ò, lt• tl'li ppe lo m bardc• d ip<'mleudo da lui, tosto tcwcavano il1molo pic·monLc•sc csl'!o I'ÌI-lpottdernc.
<' llOil pn.r<•nùop:li nc•ec•si-ìlwio <tlonn movimento di t,ruppa, mi limiLai a. mand1wc• il battagliotw 3 ° dc•l 13°, giunLo da . Pi a<'t'nza, a. mgg-iung<'r<' il Huo reggimento.
Riferisco tut.to ciò alla S. Y. l. oml<• Happia per part<• mia ho fatto quanto da me dipetl<h'\"ll JH't' lll<'ltermi in obbt•dicnz:t ai stwi ordini.
Non avenclo ltllt'ora alrnn ra.pport o d.a . quelle rwrti, pcnHo non vi lìi:t nulla, di nnovo.
Graùisra, la, vrrgo, i ><enHi della mht più alta stima. e pari con-
'B'EROL.'A.."'IDO DI SAVOIA. (.lr(·/1. Silllo liWf/{1· rol. 18. pay. 1021).
I,E PRI ME GESTA DI GARIBALDI IN ITALIA 1103
Il comandante clel-!0 J'('gghnento (IL cmnandant.e della 4" divi&ùm 1•.
r'e1'(11W •
. \ ron<L . 19 ng-ost;o 18 18.
Oggi l'icevo tante mezze notizie, per cui attentl<•vo u narral'lt• qua lel! c eosa, di principale; C\ hè c:rm lo, vo ies:; i Lu Lto tH1rrare a J l'A. V. 11. futin·i ver farle uuu confusion<': provt•rò però a. rias · sumerlc, anchc nella persuasione c·ht• la ronfiùt•nza che dt•gna:-;r onorarmi suvp lir'à. a ll e ln.cunt'.
;\li viNI acc·c•nmtto rhc Garibaldi si rceava. c-onw si è> n:c<tto. a Lcnwvo con <tncsto utHL c:ol eor·po di m, JH'ovcnic•ntc ùa ?\Ionza. I n v in i q u<•;;ltt scorsa no t lP un piecltetto di en,vallpda c·o11 un nffic:ialc• n pr<•ntlcr l.'infonuazioue. t•d a.lritomo mi contava r h t• il col'po s'avviava, eon buon orùi1w <' hnon spir·ito in Piemonte. c·onlltnùalo (Jsl/olutamt•11il' da D urando.
Dall<• in[onnn,zioni JH'l'Ò pn•st• scn1hnt elw unn p;u·tc, dict•si di rnila., sinsi s1:H·.c•aln c• din•l.tn verso <ia.J'i!Jaldi d1L Gallu.ml.t•; ma , nontw 1-1011 ter·lo. I .'utnc•ialt• mi <lis:w c·he domani li do vmnno at.t.acc•nn• in l'orz:t Oa. r ib;tl di; ne ho Lof.lto thtLO <1 a stcsst> all'<•rta in caso di <·oi nlJ)Ot'i <·he Lutl'om hn, tlil-lpOnihili. ;\fi vien dt•tlo l'lw la <·olorwa Oriffini r l'icntra ta in Kvizzet·n, dov'l> ;l l a,zzini t>d un t\OilliL:tl o J)I'Ovvisol'io lomb;u·clo, c·lw a1·ma <·ull'intl·nclinwnlo di l't'l'arsi c·on OaJ•ihaldi.
Il bat'01W Bohtroli h:t disposto nn ntio baLtn.gliotH' <tù I n tnt con dtw p<•zzi d'arliglit'ria; <Wl't'hlw, ronH• è intrnzioH<' dell':l<'<'·hittHf\. IC'llera, volo n l;\ tli mandar l'orz<' '<'l'so Cannobio; io pl't'O srriHI-Ii ieri a l NW. F'<• cl Nic•,i, l' lw sc•guil.n, <·.o lOt u w, t1i noll <t n chu· o lt 1'<' Tntra p<•r· non spnrpig-lhll' lt• forze• c·lu• non potr<'i aunH•ntnl't'; <•d arwhe CL'PÙO impolitieo eli tt•oppo Oarihaldi.
t H' vada ' ' <'rso 1:\J a 110i h<tHl :t; Lroppo Ì' alH'Orn JH'l' hli l'opinione puhhli<'a, pt>r c·ui ei vuole• prnd<•Hzn.
Il o ricwvnto 01't li n<• cla l govc•t·ua1,() 1't' di Novara, eli raecoman· clare a Dtll'lHHlo di c•nlrare twl nost r o territorio a d imczz:Lte ('O· lonne; l'ordin<' t'l'H ùi iN·i: non l'ho r·it\evnto nhe oggi a mczzogioruoj proent't'1'Ò di n,<lcmpicrvi l>l'l' eiò c lt p, rignanht l'<tvvia· 1l1C'Ill0 Vt'l'HO Y<'l'('<'liÌ.
Dm'i:tntlo b('l\!'lcmbnt manlierw onlin<• nella sua colonna e sJwro buona fc•de.
Hr.usi A. R. la fretta t li c· o n tanti r lw 111 i tra t! <'ngotlo <l01l vagllll not izi(•, come di c·.om l e varie I <•Mere.r i <'cvnLP senza fargliene nn sunto; non ho il t<•mpo H<•nza di troppo ritnr · da,rnele la. spedizione tlt•lle a!Lrc car·tc pre:;crittemi qtti ac('hius<•.
ilo l'onore di protest.an• all'A. V. H. l i >ì<'Mi del mio profondo Ol-ISCquio.
(Ar<·h. stato magg . vol. 6 0 , pag. 1135).

1104: LE P RDIE GESTA DI GARIBALDI IN ITALr \
D..UUANO.
1/. primo uflìoiul!' J>'reQso il ministero ài guen·a l ' m1o·ina
Yll I'I!JIO <.leUo stati) m.aggiore generale. A le.ç&!lllclria.
' l' orino. aùdl 20 1848.
D<t ' reN•n li l'H pvorti rigual'ÙO a li<• mosse ed ali<· opera zioui dt-1 generale Oal'ibaldi colla sun truppa :;ul territorio lombardo, intomo ai qua,\i M<•tlo superilno di t>ntrarein.maggio1·i dcLLagli, pPI'nhè d<'vt' T•}lht nvC'r ricevuto dalle autoritfl, l<' tllf'tl<•simc comnni<·a,zioni, io l' il<•YO <'i w il predetto. n sl•p;nito ù<'l primo (10111 battiuwnto Phlw Austriac·i. mattdò nclk tomuni <lt•l lago ali'uni prigionit>ri e fl•riti. i <tuali fnrono 1'ic·ow1·at i<' cumli.
Hirronw ili fa n<•<'Pssal'ia una dt•lilwrazionc in pt•opoxilo. imp<'t'<Wc·hè tali individui non possono dal govPrno di H.l\:f. <'On:;id<wn-ti conw p r·ig-ioniNi di gtH'I' t'n,, Cc1•it,i duwtnLP l'nrmiìll i zio t' Ù<l 1,t•npp<' non riconosoiul <' da H. .ì\1. io pn•go \'. H. l. d i \' ol<•r toHlo i sovrani ot·tliui JH'I' <luellt• dt•tt•rmiHazioni <'h<• saranno t'H\'\·isat<• opporlllll<' c· di fnrment• c·onos<'Pl'f' ilrito.
Dall ' uHimo mpporlo <L<•l goY<'t'llO <li l'iìlulln t'Il<' il g-et1Pralc· DumtHio <·ou 5000 ttomiui (\'•w pnssan• qucsL'oggi il 'l'ieino p<'r n•<':m;i ltd l <> HHt'ò tnu· tenuto a lht H. V. I. l"<' }H'l' ti i cpwsl o miniìll<•ro vot ·s·i\ <·on JWI'tn Il l'il L<'ll<'l'lll i a,nl'l H• JJn.rleC'ipt• cl<•llt> disposizioni p l '<'"<' a t al truppa. Chaùisc·a, sig. le prott>sl<' dd distinto mio (Arcl1. xt11to tltllf/!1· r ol. G. ptty. Iii O). .\lt::-ìAHRE.\.
/Jtll comM1clo [Jf'IWra{c• clf'i l'lcmbh1ieri l'etili tr/ 111 in istro d i f/111'1'1'11 e marina.
'l'orino, 20 agosto !R-!8.
Sei mattin o dc•l 18 c·oi'L'entl' il <·npitano «>Ù il c·omntesso dei ùtw piro)lcafi, rlw il Garibaldi S<'Cluestrò pe1' uso <l<'ll:.t sua truppa e tnl.tom riliNlC p1•esso di sto l'lotto la di mt ùt·apprllo dt>i suoi, pet'vennPt'O a e T'itormti'<' in A r feriti della truppa Garibaldi sono Lnn:;pottati a, ( 1ftlutcro, cd i pl'igionieri faW ueUa fazione tt>sl.è seguita,, v<>ngono <liret.ti a Cannohio. !eri mattina a Bor1ro Ticino un <'Orpo di truppa, forte di 3500 uollliui, comandato dal g<•nerale Giacomo Durando e lliretto VerC'<>Ili, onde unirsi alla divisione Olivieri cui è tl<'stiuaLo di far parte.
Si osservano Crontie1·a lotnbi't>rda alcru1i movimcuLi nella t ruppa, austl'iac·n. di cui un corpo di 3 mila nella sl(•ssa mattina

Lb:
PRIME GESTA DI GAR I BALDI IS ITALIA 1105
1106 l.JE PRIME GESTA DI GARIBALDI IN ITALIA
ùi ieri si di1;tcse lqngo h1 sponda del 'l'icino in prospet to di Turbigo, Lonn.te, Robiglietto e Cuggiono, anzi in quest'ultima po ·
!':izione vennero colloeaLi dicci pezzi d'artiglieria.
Ho l'onore di riunovnt'<' nll'E . Y. gli alli 1lel mio ri,.,peLto. (Arch. di Stato- 1'orino). T.; OVERA.

Il ('()'111 (11/(ltt Il te aèlla .J a d it'i si mil' al capo (lt>llo xtato ltWffUiore genera/t• .
A l l'!l/ICI l! dl'i a.
Dal qun.rLil·r g-ctlerale di l\mwo, li agosto J8.
Torno in questo monwnto da Arona <' Pal\a uza. ove l'ni a V<'· cl ere la Pinerolo. <' mi a riferir\ e c· l w <·ot-re Yocr, ('he p<\1'(' ionùa.ta. Chwihaldi fosse ieri H Ynt'('S(' t' vi rosse t.ac cato .A11sl.rhwi ClOU. m;s<•riscono l'ii
Hcmtissero aneom l<! fucil<d<'. vn .pori c•he tutt'o ritiene non :weì\ cht> c·irca 50 nomini c clue c:nnnoni. Teri tcnta.rono. in nn pot·to della Hvizzern, gli ahilauti arn·stamt• uno. ma non giun Ht'ro a t<•mpo. Di ed i onliur i'\Ì <l\'<•vn nno,·e l't't'l<' (:h(' Co:-;se lon(,a no c In gu;wclia clri due vnpol'i non il bn.Lt:tgli01W clu• n lnlm lll<tnda!ii'IC un dista.c·cn.· meuto itt hm·c•h(> già a <·.iò prepat·aL<' n tentare di J'Ì]H'<'Jl<lert> i Yapori. Pt•t•gai il cololllll'llo Holaroli lli rarc·oglit>t't' LP infonnazioni c tlecid<'l'<' sul xito si clov<>a. o no, t.Pntat<' qn(ll colpo di mano . ..\ vea ot·dinn.t o a l co lotuH •llo D;unia.no di non pot•Lnt•c• Lt·upp<l a.l di Là di lnt m pct' non dividc•t'<• troppo Il' HUC forz<': ma, l'inl<'tHI<•ntt> della provincia, rirhie:·w. i<•ri sera. c·on la n la im<istenza, allPgaudo un artic·olo delle leggi detto seorso :Hl ottobre, il tòm;ul<lnntt• t'Il il colonnt>11o Kolaroli di tllrLtere :3o0 nomitli a, Rtut di:-;po!>izion(' pet· pot·Lal'li Cannno bio , () lte <L rn in, in:-lttpnt a v i :Hledt:ouo. O m
C'hC ciò l> fa.tto, brnchè posizione 1li questi uomini sin arri· l'lehiata, non mi sembrò don•rli far ritintrP. perchè forse farehl>P (•attivo C'lft>Lto nel pacst'. Del:iiùerCL'l'i lll't 'o informato ).le ventmcnte l'inLctHlenLc h:t il tliritto <li 1liHporre delle truppe. essendo :t rwora esse fonn<tLt• in tliviHioni tli guet·t' }li . 11 passaggio dc•lht truppa Durando H'Pif("tLua lmnquillamc'nle cd osservai che -paiono più ùiH<'iplina ed nl'ia di soldati dl:'lle altn• truppe 1om barde. Dicesi cht> Griffiui Kia (•o l corpo in :->vizzera. Tut t.i i nlipporti c le in formazioni, <'l t<' ho potuto racf:ogliere s ulla linea clel 'l'icino, si rwcordan.o <lire che a l\Iihtno vi sorto 3000 uomuti, pochi sm ll n. litH'a f1€'l 'I'ir.iuo <'che l'm·nuLfn. si conc·entra tra Pallanza. c rJodi, OYe il marrsciallo il suo qna1•tier gen{'rale.
GESTA DI GAR!lDAT,DJ IN I TALIA 1107
, Le civiche<' le popolazioni <LCllP spO lltlc del hLgo sembrano diS]lOstc all' ordin e; ma molti!".simi .;\lilanesi !".ono collitw d'I ntr;l P Pallnnza. Yi predicano repubblica e tengono relaziotli con che è nel canton Ticino alla testa di nn com i Lato , r.la e hn, titolo di govern o provvisorio delln, Lo m b<u-clin,, <' con Oari baldi, ch e inl'orm ano di.'li <! nostre mosso <>d al fJnn le tlr tntr a off t'OllO <'ssi somme Bt>nchè tutto ciò non parti<'olarnH•nte dei mit'i a[ari. che qncfìtP uozioni ] ;n potevano interessare. Gradis<>a, J; a, pr(•go, i :wn.-;i tlcll:a particolare min. :o; lim a e pari r.onl-! id<'ra.ziònc. 'tJ M l ' ,,';'llll '' +J. ' (" tnh. magg. vol. 1R, JWff 103o). F'ERDTNANUO

Dal quarlirr gc ttel'alt• JII'Ìitf'i[}((lè al rommulcmtr clrlltt l' ('erano .
A l <'Hs:t ntlt•i n, li 20 no J'Ì('('VIl(O le ùut• \p1((•rc (•h(' v. A. R. fcec 1'01101'(' di dit·i!!t'l'lll i it•ri 1!) corretti<' <' m i u !fretto
'l'n1to dò <'iw Y. A. IL di éOllC<'l'lo !'ol gowruatoa·p eli Xovat·:l. lta op <' t'n,t.o in l'igun.t·do ul i-l i g. ge tw t·ah> c·.omamlanl<' il ea.m po :t HomHHh in 1li lH'IH ti<• li< • lll OHHt' ve d cl G1\· rihaldi, Ila itwontmto l'appt·ovaziOJW di H. :u. c JH'I' nH'?.:t.O di l<•tl><'l'\'t'l\utami lH'I' la vin, ùi Phtt·(•n:m dal g<•ll<'l'<tl<• d<:' ho ritt•va.to l'iH' Rad<>t?.ky tton dnl>it:w1t punto d<'ll' in tcnzionl' dd Ht• e d<>l suo gov<•nw di <' fnt· i C:O l l tl hi 11 !-ìi, <' lH't'Ln nto con.H id <•ntnl qu<.>l l e sono r<>alm<•ut<•, intntpi'<'S<' purtic·olal'i, HOll già tli eol'))l o miliz i<' rt•golari, ma di nnarrltisti <' t'imili. <'lllH'I'<'iò mal<• loro tosto o l!U'<li.
( 11'<•11. 8/a to ?tW!fff· IIOl. 2,JUI{f· U8!)). H \LASC'O.
Il t·olrnuwllo del m •Mo, allde ll o allo mU{!ftiore, al cO?t l llllll((llfc drlhr divisione.
P !\llanza, !31 agoHlO 18!8.
In :-;cguito n.l tlcsitlt•t•io <'S pr e;;so llli da. v. A. n. di essere inl'Olm ata tll'll'andamenio dt•ll<· co s<·, Ilo l ' onore di J'<lHS<>gnare a lln.
. \. Y. <·hc a xcconda dcllt• r<>plicat<• futtl' ùal Hinda<::o di Callllohio a ttne.sto intendente (' p<•t· via, della ùomauùa fattami ùut> volte dall'ill.mo :;1g coman<lante questa. città. mi HOtt cr eduto in <lo vere, sta.nto l l\ im]> e rios iL à delle c irc:o sta uze. di aderire a ll e ùomanù<• st uld <'ttt•, inviando a Canno bio una forzu ùi 350 uomini di quei s t anziati aù Inlt·a. sotto il <•ouiando del pii1 anziano. ed alla d isposizione del sig. intendente,
LE PRI:ME
1108 LE PRIME GESTA 01 GARIBALDI IN ITALIA il quale partì. asl'ie.me ai medesimi. che ginnRcro alla loro tlC'..,tiua?.ione il 20 le 2 del mattino gt>mm venm incontro <' ut•nc acco lti da quem n,bibwti.
T>c•,•o poi riierire a Y. A. R. eh<' almonH•n.to della partenza della :sudùetta (ht lntt·a. una. barca fn vetlu i da II<L :->ponda c alla voli a eli Luino: da qmtnto mi vie n l' sup em clir etL<b ad <WverLit·c• il Garibalcli del movinwuto delht 1rnppa, c• ('iò chl' mi (•onfetma in tale opinione. si è clw a.Ua utattina ciel giorno suddetto, verso le ore 5, il Chtribaldi (ert• ritiran• <hb ::\lacagno i ÙJI<', haLtc•lli a va,por'f', ove nl sicuro d'ogni int.c•mveric•. per <tvvial'li a Luino, OH giunti. aumentò fino a 300 nomini di'Ili cotl1J>OSLO prim:Hii so li LO, l'acpnclo 'olger<· le bo<:c·he ù<'i cannoni <'Onlro lJuino.
))a no i<> ]ll't'Vc'llll LC\111 i q uesL:-> ma W n a, :-wppi l w Oarilmld i da Vai'<'S<' si ritirc'l ver,.;o Luino, fa<·c•nùorw clalln 1ma g-c•ntc• oc·c·n· pat·c• le• al Ltu•c•.
'li venrw fattu stama ttc•, prt· parte• di cptc•sto ill.mo COl lhtll · dante• (in sc•g-uito a dom<ltllht, del intc•ttclentc•, <t,ppoggiata <la nn a.tto <·Otl!iOhtl'<' dd c•onw tH' di ( ':mnohio), una lHIO\' a , t•iohi cdi altri 1.30 uomini, c·on UllJH'Zr.o <·hc• slanlt• 1:• dt•llc· t,r·nppc• in CftH•sLi ùinLorni m·c•dci mio dover<' non atl<·r·ird, (' tra:>rncttt•rc• n.\' .•\. H. la di ric·l1ic•Hta c l'atto nonsolnr<'. dt•gtti clarf! tlu(•lli ordini clw CJ'Nic>n\
c:on nuien t i.
l/ill.mo :-;ig. intcnùc•nte vi<'lt<' in quc•sto llHHll<'nto ù'infm·· uHnmi, thc• l 'i ll.mo sij!. eontc HotTO!ll('i venne• dai lui , ondr partc•c•iparli c•ssrrli stata r·iclti<'sla dal Garihalcli nna !'Ommu cli clenaro; ;ti <'llC c•sHcndosi Lo sLCHHO rifiutnLo, e Lt•merHio pc•r·cdò d'llll:l qualc·he l'llppresaglia, implorcrC'hhc la protc•ziOll(' uri
gOV('I'lJO ]H' I' l(' Slll' Ìl)OI('.
Ho l'onor<' di umiliar c· a \' . ..\. t:. i scusi dc•l mio )n·o[onclo l'Ì·
(. 1rdt. .•;lato mautl· l'o l. Go, JW!f· 189). Ror, \ROl , r.
[t Ct./;}litano del V erbu no » nl sig. R('(iaelli, direttori' drlla .<;ocidà di 1un·iyazion1' 7tt[JO. lhtl VcJ•hano, in mtla, di TJuitw, 21 ago!'to 1818, (ort• 10 V:! aut.).
JJa mia va ùiventanclo tutti i giorni più uiffi· c:ile <'scabrosa . Finora ho nulla ricC'vuto dal generalC> Garibttldi. in risposta , alla mia con la quale gli conutnica\a l'ultima di lei lctt<>ra. Il generai<> con la sua truppa nmza verso Como; ma h1tti i giorui manda dhpacci a questo cç>nlandante. Ol'(liuantlogli m ovim enti <' posizioni da <'R<'g11irsi dai battellì. l <•ri sera per ordine \ ' ennero rila))c·iati in liùertà i d n<' fratelli :\finelln. La

l
notlt• s<•or:s<11 pas:-<ò in .Jiaeagno infc1·iort> con Lutti d ne i battelli qut'sta mattina :> giorno <·ol \('rba.no l'i marcinva a :Jlaeal!no "11JWl'ÌOI'e pt>t riprt•nderc la vendita dt>l Verso le n si salpa \'a uav ig:tnclo 1\ l agadino }Wl' in<:ontmrc una ban:a tli truv1w i t a l hM l<' (disarm:tt<•) provt'nienti dali n Hvizzcm, le quali (l ilO) din•lte a rinforzare Oal'ibaldi; ritrovatala il sasso di Pino. In prend<'n\1110 a rimorc·hio condtH'Plldola a T,uino, thl do'<' :Ll genera i!'. I o che v t• rHo sera, ri1 onwt'<'lllO <t .l'I l a· ra1-mo snperion•, dove a bhimno lasdat o l' soldati <•d il ban'O Il<' alla ]H'OYvi::ta ùi lt•l!ua per h• mncéhim•. Dalle notizi<•. eht• qui ricniamo. il gon•rno sardo 'a prendt>tHio mhmt'<' th•l tntto n st.ili alla t•olonnn, <' HJ.H'cinlnwntt• vct• lii>Pnlrr i h:\1 !l'li i: t' sn <JIH' · st.o vi Il:\ molLo a Oli or·uiuidi Onri bn l di sono <'11<• in tH's· sun modo si Ù<'hha darf' 111otivi alla xpon<ln <li lagn.:uuw: che ht dei batl<'lli non es<'guiH<·a l<> su<• operazioni t• 1\0n pt'()VVI'dH 11 1 HI\OÌ UÌJ.!Ogni C'h<' :mJ Ja HflOiltl<l IOJIII>ftl'dH. pl'r<) l<• Lru PP<' pi<•motll <•si l'iH\CHHf'l'O <lt>l lc mofiH<' ùit·c•LLI' ver·so i hnttelli. il <·om:mdant<· hn ordini assoluti di resisLPl'<' c• di la fol'im c·on In fnnm. F'ors<• l'ii JH'Pparano t t' isti fai t i. l!'orst• il il ali;tuo va ad 1-ipar·so da mano i t a linrm: l> io no n voj!lin; ma CiOllllliHJlH' sì nH•t.tn.no l t• oOH<'. io sono i .ranquillo <' dt•c·iHo; pNfìno c· lw un nss<• dl'l hallt•llo io rcs1<•rù a l m io poxto. (Wl'<· h(' uon 111 i t't•nd<•t·ò rua i i rl<l!'gno d i q twlla :stima <• di qHt•lln <·lw mi diHIO/'\It'ò la sodl'ln nt>l l 'aflldar·mì i suoi hntL<'Ili. l o ln, Jll't•go it d:Lt' n li quu lc:ht• t•hwon.tl'o CIOit•iLorno tl t• l llH'HSO, a se l'i V t't'm i qnalclw <·osa a lllio solli<•vo. Ho no do leu t i si m o d<·l suo }>O t'O huon Hl a re• <li salu t c•. m n HJl<'l'O c-111' sa 1'<\ urla N1sa CfTillll'l'H. ro HLO ht•llÌHHÌlllO lllltlgratln i disagi d<•lla vita. Ch<' 11011 mi HpO!!;l io <la oLt.o dot ·:n<•nùo pcwlt<' ore rH'IIa not .tP, pl'l' i <:O n(.illlli lllO' iiiH'J\( ,j <'h<> t-10110 t'OlllHlldfl(i. ()lH.'Hltll llO((p poi illllÌ · lauN!l' Yittor<>. c•ht• (a le Hlll \ c•rhnuo di timonil:'rc•. ì• slnl o ns1-mliLo da fl'l>hre, <' lt·mo C'l w d<>bba a nel nn• a ca,.a; l' eosl nuo t'PsLerò da JH'l ' nw i'iOlo, abh<utdouato LnLt,<• lP l><'l'HO n<' 1li m in <·oniiùenzn. l t' HKO l o l'iut piazzerò c· o n un mattPlotto. t•d il c·omarulantt· lH'Itl'it>l'à a darmi llUO di'i suoi uomini ver far [uoco ete.
(A1·rh. stato nW[J!J. vol. liO,
Il mpu dello ,'flato IIWff!Jiorr yenemlt al comanclan/t' della 1a dit•isio ·ne. (" erwno.
addì 21 ag-osto 181ft
•·. "'l. ha inteso con vivo inl<>H'RsanH'nto le notizi<• diYerse qhr
Y .•\ . H. mi porgeva col !o\llO fogli.o dei 20 eorrente.

LE PlUME GESTA ])I GARI'BAl,DI lN" ITALIA l1U9
L. PONZONI.
1110
LE PRIME GESTA ni GARIBALDI IN ITALIA
TI Re non crede che si asi a t t l'ilmita. la facoltà ad un interHl<'ll te di immmifìchiarsi nella disvosizione dello, truppa, mas:'\im e poi qtwlla. corni' attualnwnLc. su l pi<'tle ùi

V.\. Y. quindi richhtmcrà a Pallanzn il clistacc·amento ...tato btto l'lll C:tnnobio, toslo d1c sappia,si eonw Hiasi il corpo (]i Gnri baldi.
\l )J>tova a<;;;ai il Ht• l'itlea1n spNliziom• per ricmprrart• l'uno d<•' \' a pori c• c·rNlE' c·hc• pos:-;a giovare al huon eRito l'opera drl sig. httt'Ottt' eo louncllo
H. M. lHL J>nn· w:ulita. la, notir.ia, c·hr il c·orpo dc•! geucrn.l<> Dllrnndo. ilJWirno di qualc·hc rii-.'1Hll'clo dopo la ùivisiouc> lomb:u·tla. lm attravrr·:-mto rcgol:trme>ntr il connrw, facendo cli as1mi
<'Olll ]>III':•Ul..
Hc• il ;;ig. <lt'iffini si l>rC'sent<•r'lÌ. l'arà uopo c•gli c•d i suoi, poic·hì' c·omc c·apo eli volonta r i ha. sc•r' ilo c·on r.t•lo c·on l'arrnaLn, <?ll Ìl tll ltimo c:or1w c:om:uu tuntc n, Brc•scin, t,anto :,;i a dopc•rò c ft•c•c•, c·h<' mis<• in io<a,lvo il colonnt>llo c·uv. C'IH• n •c·nlosi in qn<>lla dUà pt•r· palc·xan i ir.io, YC'nne da una banda. eli similt> Mmposir.iout• di qtwlln noL<L eli ntt.omin,to, st rm Lo c· Dio so lo :-m. cmm. sa.rl'hbc Hlll',I'Psso, sC'nr.a 1';111tm·c•vole
C' JH't'tltl ;H'<' intc>l'\' <'nziotw clrl C:t'iffini.
Xulln ùi nuo,·o nc•llt• nltn• tlhi)o\ioni dl'll 'c:-;(• rdto. l'cl i umlali n. sccnHt.rl\ di nunll•t·o. Dirò rno1Lo 11 fan• an<•or·u. l)l'Ìilln dì t'HS('l'(' in t•Olllplt•(() )Wl' Cll(t'lll'l' in ('l},mpa,gua. poidtè> st• Ili già illlJH'l'ft•Han1<•nte in ht'Pvr si i' ritloLLi n.II 'PstrC'li10, <:ome• pu1· troppo -vitlcs i in I\1U' clt> Jl o
Fa\'orL"<·a Y. A. fnr palese allt• autoritù eli Pallnnza clw li noHtri <'roati f<•riti non ponno <:oul'!id<.'t';tl'si prigionieri di gu<•na, c tH•t·r·iò, su bi t.o gup, ri (,i, santn no c·.oruwgn.a.Li a llu , fro ntic•r:r. c:Otl fogli di via.• iu <'ni coust<>rà della loro pro, <•nit•nr.;l.
Ilo l'onor·<· di ripett•t'<' a . •\. R g-li :ttti clPl mio e ùc•vozio1w.
(. 1r('/t. lliato t1Wff!f. l'Ol. i)!), pag. •t :3o). :-)ALAf'IC'O.
/Jul romaullo ffl'nel'alt· ilei cctl'abinieri l'l' ali <ll m'iniHim ili ffi((JJ'I'tt l' 11wrinu.
'l'orino. 22 1818.
l distarc·anwnti di truppa che si trontvano a Hc•sto ('alC'nde , evacuarono, p i l•gn.udo V<' l 'HO Galla l'a tc per unirsi in massa con tutti altri rhc trovavansi nei vicini. Questo movimento si attribuisce alli' mos."c che va facendo la lrgione Garib::tldi nC'i clirtt orni di Varese.'
In st.'gnito a lla, partenza da :-3C'Hlo di d l't! a il 20 ne drrivò l'incouvrnientP c,Jw rolà non Ri \OicY:UlO più ricevere
Lfl: PiHMfl: GESTA DI GARIBALDI lN ITALIA 1111
l>l'igioni eri ùi guerra. cll<' si c.>rano fatti partire da, Arona.. Avvenne put'e c:h<' quella 1!1larclia nazionale, elle accompagnava il s<>nza l'intervento dC'i reali <'arabin.ieri. nel reklituit·si :-;nl liton1-le non n•nne riconoRéinta dalla rPgia truppa cliC si trovn,va Hl porto di Caslc•lletto, nè l r ru di ;trmata. La non eùb<' però altra C'ouseguenz;l.

Trov:tnclmd i11 Al'O nn. un u tnc:htlc dc• Ho Filato maggion• divisiou<' ùi Xo\' a.ra, delrgato a tale uopo, quel c·omandantc di st11ziom• a seco lni il Sc·sto p<>r veder<' s<' vi sia c·hi ù<•hba ric·c>vc•n• i venit•nti onde• <'vilnn• nltc•t·ìori inc·onvC'u iNrti.
'l'omunùo :d Gu .J'ibal<li, debho sogg iuHgc• rc• ehr 1 di lui ;UT<'· stati frnt<'lli di Castelletto. a dal ba tt.c•llo in ArOLHl, ra<·,c·.ontando i loro ptl Litnct\Li. \'i <'LilCOt;\ il Zon<·a, clt'tlo Burlan. A l Juino lW<Lncstnwa il Onrihahli un ma· WLr.zellO di tmlc•, dn c:tn s i calc·.ol:t llOSSIL :wc•t·c l'ÌIJ'<tLlo c•it·ca HO mila lirc• n,w.;t l'iaclw.
1\far.zini trovm;i a clO\ c• re<"luta ll<'l' <'onto clt'l (hu·ihalelt c• do v c• st n, pt'c•cliHl)OIH'UtlO li IL provvisorio Iom IHI. l 'clo repubbli c·nno. Il dm·a Utta c•tl alt• c· fanlig-Lic pot<>nl i eli si vnoiC' ahhia no llH'HHO in giro ne• ' •·c•gi st.a Li molLi cmissal'i, incn,J'Ì('a ti d i indurre lc· truppe lo111 harcl<' a non i1ttc•marc• nl'l Pit•n1ontc• P eli pt'O<:lll'<tl'c' ùi fuggin• lP loro H l'lUi n•t·so la. :-ivizzC'l'll, ovp a di1igc•nzn clc•l pn•Ciitato clu c.a sara.nno ronvc•nevol· nwttLc• ac;colti. I, a lli'(Pziouc• eli molti vo l outnri c l<· diserzioni c·hC' Hc•guono in gmn ll\lllH'l'O l'm i Lombtu·di itwcH'pOI'ltli V'<'l'l'C'hbc•t'O all'np]lOggio di tal<• supposiziotw.
Ho l 'onore di t•ipt ·oLcl'\t,n•·p all'g. V. gli aW dc•l mio l'ir-;pett.o. ( lrrlt. di Ntato- 'fori11o). Lou:ru.
/)(1//'intt.mdl I!Zlt drlla lil'ot•inf'iu di l'allau za olln r. 81' ffl'eft' rilt eli {11'1' !!Ti (lffuri dl'll'inlemo .
• P n Il <Htza, UHS.
è Hln to rìt'erilo cdlC, cl'orcJitw Hll}>m·ior<', fOJ'Zlt :trm <1la, thL rich icsta 1wr dift>nd<>r<• il borgo c• cl il mandanwnto cl i Cannobio oottLro k SèOJT('t'Ìc cl<'l <·ondotLic•t'O Garibaldi, doveva abbandonare qm•lle loc·alità. Il mio (lOV<'l'<' mi impone l'obbligo di protesta l'c con l t'O tll lo 111 isnra. j.!iarc·hè quPll<' con t nt!l<' Ho no lt• pilt esposte all'invasione dl'lla rolonna Oaribaldi, si lt ltziMa l'!ull;b vieina lo m ba.nla. Il govc•mo, eoll'assumersi ht tutela di qut•sta. proviuc·ia mandanùovi una, fOl'Zfll militare illl1JOnentc, nou può la:-;C'iare in balia, ad mut trupp<t di nn-cn1nrieri un mandalll<'nto clrlla popol(l.zione di 9 mib ahihtnti, la quale si{> SC'mpr<' dimost n1 a fl'ezionata ai nostri reggi tori, "o!!giaC'<' con H•
1112 LE .PRIME GESTA DI GAIUBALDl IX ITALIA

qualunqne altra ai ùeUo ha diritto alh\J prott>zione ehe ogni buon governo deve alli' per:;onc• ed alle proprietà. Qua.lc proteziom• l'icutnmentf' l'autori ti\ politic·a non è in tli o ve i roma,ntlanti militari ric·nsinsi di prest:n•vi l 'aiuto delle• toro roru•; non c;;scnùo suffic·irut<' l'oJH'Ja della milizia. nctzilmnle, HIHovvi;;ta d'armi, p('} manLc•ni mc•nto pnbbUc·a, e s i ourrr,za. ('J'Nlo di ::M'Cl 't• JH'll ;; mia t·c•lazionc in ùaUt del 20 C'OI'I't•nt c• eviùenL<'mc·nL<• llo,•c•rsi <·onsiùerare il Chnihald1 quale• ribelle alle l<•ggoi d <'ilo stato. IH'I' l'SS<'l'Hi fatto lcc·ito di c·ontnlt•llere atti di vioiNtza in din•rsc• loc·aliLà. c• rh<'essPndo rwlh•nttrilnt?.ioui clelrautol'il:\ eli polizht eli hl \ila t• lt> :-.o:-;l<tl\zP cl<•i dtt:tdirti c·onti'O l'hiunquP vot'rl'l> hc• t·c•c·;Hvi noc·tmwn t o, io c•n1 autorizzato. a IIOI'Ill:t cl<>ll ' nr·t. 13 br' <'Vt• tto dic•t•nllm.o 18-11. (li ric·hic•di'L'<' lunqll<' forza a.rnJata 1wr tutt'hl n'il horg-o ùi Cannohio.
•\li ree.
(.t 1'(·/1. stato 111«!1!1 · vol. nO, !Jflff· l(i l). D l' I'H Ul.
J)ul golli'I'IW dC'Ilu diriNiow· di 1\.oram al ?nÌUÌNII' I'() rli ff/111'/'U (' IIWI'Ì/111.
vara . :.?:.? H:,!Osto l H 18.
L:, truppa !\Otto gli ordini dt>ll!<'llc>ral<• Dumndo H\'('IHio Y:U' · <·at o il ' l'iduo in d H<' c·olonnc•, <"Il<' niHI'C•iarono. lln;l sop1·a t•l'a.tl'l\ , su Rorgo 'l'i<•ino.llllli'illl}l av\'Ì Ol-lRÌ a Vc•rc·c•lli, c·onw JHII'(• l' alLnt, p<'l' I'ÌliHmen• n dispoHizioiH' d1•l g<'nerall! OliviPI 'Ì.
Orn, d nl qual'tit>J' g"t'llt'l'<tl<• i 11 •\ n.d t'Ì}t vic rw dato l'or·<li rw a rtll<'HL'u l l,ilno <li IH'I 'C· ll è> Hhl!no ta.li Lrupp<• (• onc• c•nl,mLc in q1wsta oiltà; Lalc tl<•t.C I'tn iunzimw è> p1cna di pc•rieo l i. l pr•oposil i <ll·iminosi. tenuti dulla t mppa contro H. il H<• noH( l' O sij.!llOL'I'. non sPLtza ('S t <'l'li:\ l'l' i11 l<'n zio n i g[uistrc <' fa vorc•voJi all'illtpr<'sa d<'i g-enrn1k ( lnribaldi, tol quale sarehh(' disposta di mi spingono a la presente all' lt \'. lH'l' islaffc•(la, onde c·nld:un<.'nt<' pregarla, HP ?> tut t'om in lt•Htpo, Ili imp<'ùirl' l'invio t1 qtwlla tiLlà di ta,le miUzia prr togliNla cl n Ila i'l'ontiera, dO V<' le• n·lrtzioni clei i e d t• Ile fazioni sono p i i'l frN{lH'lll i e cl incc>ntivc a, qualche grave di so rdin<>.
gg l i è> poi ta1tto più nc<'l'Hsa1·io <li non avvicin<H<' la soldateI'!Ud detta alle frouticL'P lomlnlr<l(•, in quanto clw mi sono tro· ntto nella c·it('ostauza urgt•utt• di Ol'dinare che i due c·onvoJ.di di prigionit•ri austriaci. clw Nano di• etli sopra da Gattinara, siano im·cce. oggi l'uno c• domani l'altro. dirC'tti da Roma·
gnano a quella città, J)er('h(> t•s!-<<••ulo Sesto Calende stato <'Ya · dalle truppe at1."tr1adH· ed aggira.ndoRi non lontano ('O· !orma Gariba.Jdi. eranHi al pnl-lsan• d('ll' nltimo drappello,
•
IN ITALIA 1113
iel'i.mauif<•statetln quegli abitanti dech>e int<•nzioni di malmenare
1 prigionieri etl al l'O I!a.r li nelle acqtH' dd htgo.

<'iò stantt•, l'E.\'. converrà me<'O ùe1\a n<•<·essità di las<·iandn V<•reelli lP milizie DlU'antlo, <' d<.>ll'urg:enza d'impat·tire ùir<•ltallH'Il t<> daJht stesKa g. V. gli or d i n i OC' correnti per p:uadagnat· l empo al gt•tu•rall' Olivit•ri col meno d• l ro l'onort• etc. (Arch .• ruagg. !>OI. 18. pa[J. 1195).
TI minis/l'o tli [flll't'l'tl (Il t·omtotcla,til' la mista (Olil•iai).
'roril•o. 22
Posteriormente n <pumto io st·riVl'\' <l T <·ou mio tliO d'oggi n. lOOiì::i sulla, din•zion<• a Xovat'<l onlinahl dal quart iN gt•n<•l'ulP del eo t•po di lru pp<.L Dn1·ando, t•sS<'IHlo l tl i IH'I'V\'IInta. P"" istaff<•Ua la h•tt<•l':l, clw qui 1mita JWI't·opht Ll· I'Oill\lllÌI'O, del di Xov;mt. m•lla qunll' t•sponl' di molto J)('SO su ltn, in<.'Oitvt•nÌt'l\Zll dPihh llH'IltOV!tll1 ll<•sLillaZiOIH', ÌO llll 11·oyo twlla nc•ccossihì (aggiungen<lo t·osì alln R. \ · l. nuova inC'IIIIllwnza a ctul.'ll<' lmlt<• da c·ui i' ut luahtH•IIt<.' Of·c·upal<l) di pt·egarla, di all'uvvhtnwnto a Novara dpl\p p r·c·d<'Lt.o t I'IIJIJ>t•. riuwt l<'ndo in lil.'l'anu•ul<• alla di L<•i pt·ntll'nza <' sng:tcilù il dispot'l'l' nc•l mig-liOI' modo di tnl .f<t la truppa c·osta sott.o li di },pi orcJini. I'U<'.('!lÙO sl c·IH' lll'i lu Oghi piÙ pt'()sSÌtlll :tllfL ri'OHbÌN'lt \C'IIIHtiW liPslinnti li mililat·i <·he uwl'itall<) mag1.dor <'Onfitlc•III.H, llll'llt.n• lP lt'IIJ)lJ<', IH'ILP quali ltOtl :-:i ha troppa lidtu·in, saranno iiiV<'<'·I' tPtlltl(• IH'i lltOghi, OV(' 1J0SS0ll0 Sl'llZa ÌI\(\OIIVC't1i(•ld t• :-1('1'(' lt>llll(t' in in quauto l)Oi agli in<lividni di I'Ìj)I'O· valo t\OllL<•gno e eontrari ni prineipii th•l g-ovC'l'IIO monHI't·hit•o ('Os1,Ì( IIZÌOlllllt•, dovmnno ass())UlHilll'tLlt• Vl'ltÌI'(' ('H]llllsi, !1dOpt'· mnclo all'uopo l'ausilio tiPi buoni <' lolleYoli indi\ idui 1><'1' lill<'r·n.n.;i tloi lH'l'ltiC'iosi; l' l'icon'l'tHio <•ziantlio. qualora J•}lla non abhia [ol'zn, milil!tt't• suffi<d<>nl<• a, disposizione, JH'I' <W<'l'IH'. a H. ;\ . H. il chwa eli <lt•uova. eonHmdnntE' tlt•lla l• ùivisionl' a ('<•rnno. t'onfi<lanclo IWIIa I'Oilecita wopt•nsionc> Ili J. pE:'l' ilt'('g'ÌO
:.-wrvizio a,ffi n<·h è lP acce n nn t r d i·l'Ì<'·E'Vn 110 p ree· iso <'H<'I!Hirnc>ttto, mi onoro<'<'<'.
(.-1 n·h I1Wf/fl· voi:() fJaff· (i Il). \.
TI t•omtoHlantr del/11 1" dit'i8itnu· ul t'llflo drl/o ·mug[jiiJrl' fft ' llel'lllr drll'armato.
C ' erano. li 23 agosto 18
)ipll'ctc{'usru·e a Y. H. l. del suo Coglio 21 ho l'onon• tl'a-ssiemarlacht• farò rtunnto si potràoullt> vuntualllH'Ill<• gli or·,liui in esso c.ont<•tmti.
LE GES'l'A
GARiBALDI
DI
A
•
:Sulla so ùi nuovo qnanto alle una ,•oee HJHH'fi<L c h e venga. a rinforz;n lo il g-enentle MonLecucC\oli c·on 10 battaglioni.
Quanto al generalt· Garibal<li, le ultiuw mosH<' sono eht· rell·c)<• esse da , verso Luvino. J,e sul' Lrnp]W i'lOUO <tlunental<' i due (mtf'lli ;\[in('\la, lLI'l'esta.ti snl noHtro tenilorio (< ' lLstellct lo); t' HH'lllr<' si manti<'n<· a Hll<':-ì<' clellc• tc·ne lombarde, O\ t' si Lrovar, c vend<'tHlo prN;o nei tn<lj.!ùzzini nnstrhwi, diede c11· <iÌll<' <·ht• i Y<\pori <•la non ùwl'ssero nulla sul tf.'.rri t orio sardo. !'11!' pol<•ss<' esst•r<• <li r·<•c·riminazioni. Pare c:lw i 'r<'d<•s<· lli ,mosLrundogli poc•;t ror'?.lt, volt•i-!sero al,tirarlo nc•lht n•tt•; ma lui, da· è al c·l'rto umno ardito <'d HI'\'Orto. rN;pinS<' c·on. van l agg-io i loro pi<·<·oli c·orpi, scn;m lasc-iar:-;i altirar·p. :\fandù, mi sc·t·ivono, nn a.vviso nl f't)l ll<• Bon·onH•o. <li matuhtt·J:{Ii ùn llt> ii-!olc llllrL :-;omuta. non so quale.

J<'r i il 'l'i<·ino a ('astPilt>l lo :!50 u')mini c·ou tlu<' pPzzi
HoN:a d'Auro<' mareiando d<b truppa ordinata. l <'l'i pme Borm u. Olc•ggio, mcnl.re t't'a sol t o l<• nl'llli pt•t· partir<' IH'I' Yen·plli. !Ùlllllltllliun <•d alenni, in vl'<H' di il IClt'O c•,;tpO l' I n bandit•J'a, JH'<'l'll'l'll l a sl t·ada di \ ro11a. dkt•!Hio 'oh•l'si unir<' ;l Garilmltli; ma l'l'allO JlOI'hi <• mr p:tr<• nn t:a-;o clu non Ili P l lt•rc·i i!llportnnza. ('rt•do non pi Ìl tCiltfl l 't• di !'Ì )ll'<'tl([(•l't' i Va pOI' i , lH'I'\dH\ 111 <'tl t l'('l'ìÌ )ll'('(mnW<\-ILO hat·coni IH'l' traHr·:-;an• il lag-o (<·o!;a <'lw non si può fan• di'l tutto in SN'n•to), d:1 l nt.m tu• ;n' hmrono (la!'ibaltli, C'lt<' rinforzò la g uardht. d i c1ssi <:o n ordì Il l' d i se• <'l'l'. IlO aLta<·c•at i; CJ't• do non :-;i a intcnziorw di'l Re far Hpargc•n• il ::magli<' il alhLno . da<' al C'f.'I'IO l!lll'SÌO <'011t(•J'(•hbt>.
Q• mnt:o ai pt·igiouic l'i LetlN;oh i feriLi, l'nvcvo p: i i\. [a Hi l t o siano g-uariti man<lc•rò d :t l :;rcn<•ml<' (]i d h L'lione• ausLri:u·o <· 111<' ne t'arò fart' ril't•vuln.
I eri m aLLi nn, lllHL RL<tll't•Lta dc•lminis(.pro mi ortlimwa ùi 8 Jl!'· d in• a 'l'orino il c·olonrL<'IIo Della ..\farmorn; lo fc<·i part ir•c• Rubito. <'ome t•n•tlo, non lung<t la sua za, lo fat·c•io rimpiazzar'<' dnJ più <lll?.iaHO tleg-U ufli<·iaJj di questo flLuLo Gradhwn. la prt>go, i spusi ùc•lla mia lH'dt•tta c• pari ('01\:-;idcnt zio ne.
P. N.- Qucstn. mattin<t Pit•tuontc ha <·omincinto la sc·uola di t iro, clH• darà, spt•ro, buoni ri:-;111 taLi; la :-;cuola ali battaglione pure ht•nc; quanto a Pinerolo, twi o v'è phL?.zaLo non v i è un palmo di terra da fare istruzioni eli mau<'ggio tl'artn i c• scu ol a eli p<>lotl.one. H o l'onore <li rac(·onmnùmk il la.Lore tlelln. prcsen!P C'orna· ]Wr»ona <'lw <lnmute guena viùi Rovent<• <'
• !114 Llt P.RlME
GESTA DI GARIDALDI I:-1 ITALIA
mostra inteUigt•nza. c· oraggio e molta devozione per la italiana; ora riparte per andare a Yent•zia.
(il?·oh. Sfttto nW{fff· Vol. 18, 1Jafj. li u5) .
fl ('UfJ/1 fle/ln StCLtO !/(mera1e ul ('OIIItWt111nte dl'lla 1'' dil'i8ione.
C't l'Il/Ili •
.L\I<'ssaudrht. aùùì agosto 1818. (ore 12 nwl'id.).

:-)tamattt' 110 <1\' uto l'onore tli a 1:1. U. il ntpporlo elll' \' .'\.dirigeva <t qlH'sto eomando il 23 (\(•1 COl't't-nlt'.
Il H.e ha int1•so soddis:faziont' (•]tp l'ist.rHzione uc•lla , ht•ig;tta di Pi{•montc è pPr In hl'iJ.!Itta Pinero lo vic•tte spinta Jll'l' quanto li aUuali alloggiamenti di qut'l c·orpo lo )H'l'lll('(touo. Yisto che Oaribnldi sla vi<·ino ai suoi tmsporti. Nl lln altlnentnt:tla guardia s\IÌ vapori, io rredo ottimo il diYisanll'nto di non nelle rwquc• fuo!'i <lei donunio n·gio per nomhat.tc•J'<' qu<'· Rl<\ g<•nL<', eh<' JWl' om lo n Lo Hof\Lro l'd ha ltlht liherLù.li uuciHno<:enti l'l':LI.clli
N<•ll'w;cÌl' dall'ordinanza, il R<• mi ha ronsegn:11a l';wc·hiusn le• l l<'ra, c·on ordi H<' far h a pihn '<' p<·•· \ ia, :1 c·<·el<•rala. l mp<•rtanto assil'llW!ll pl'l'S(>IlL<• dil'iJ.!O il tutto a \ \. H. per apposita :;tall't•tla, t' l'oppol'lunit.t per l'ÌJH'Ic•l'l<' gli :i.lti <lcl nlio <1!-ll'l<'quio.
(.Jrch. 8/alo iiH!ff!f· 1111[,, 59. 'JIItff· l!l:i). HAT n\l-:lt' O.
]Ju/ ffli/'1'1'1/0 dellu di Nono·tt
11l I'IIJW di'Ilo stato IIW!I!fÌOrt' !Jeneralf• Alts.wmdria.
:\ovar:t. it 2:5 nj.!osto 1818.
'L'msiueuo a\'.:-;, T. c·opia di lc•ttern tlc·l sig. c.onHtttdnniP tl<•lln, pt·ovincilt di Palhtnza, <' tlelht citt,;\ di 1\rOl\<1• riflelLt-nt.i, In priJUa le fazioni del!,!elwra.lc Oul'ibalùi, la sN:omla lp mosse ùcl <:apitano Ba1·hara colla gnltmigiont• della I{,oN·u d'Anfo e tt•rztlt la rt'la. zioue dl.'ll'iutt>ndt'nlt• di Pallanza. rc•latiYa pme al gent·•·nlt• Uarth:lldi. •
Ho l'onore ùi rinnO\' are a Y. H. J. J.!li atti ùel mio clh1!into o:-:SC!'J.uio.
(Arch. stato magg. l)ag. 12:H).
Dal comando generale dci t·ro·tlbinieri al minislto di gu<·n·rr t' marina.
'forino. 25 agosto
ll generale Garibaldi entrato co' suoi iti Yate!:!e (Lombardia) co:,;Lrinse quegli abitanti ad una <·ontribuzioue di 60 mihL lire auio!l<riache, e con lll:mifel:!to iul!innst• n Lutti li circouvidni co-
LE PRIME GESTA DI GAUmALDI IN ITALIA 1115
llltllti. di mettl\J'e (ra quattro ore disposizione delle• stw truppe• tutti li c·avalli e le armi di f'Ui polessrro essPre J)l'O\'\'isli. pc•mt., p t• i eonl,ra cld\a. m ili tar<>. Fmttan to 1olsc in oxtaggio setu• per,.,oue dt'lle più ragguatdevoli. di c·Hi dntpose·i a 1\tatc•libc•ntte nwdian t c· la r a nzonf• di 14 milalh·c•. Il mattino ù<'l 23, in nn:t ddlc sconeri<', impose al pic·eolo villaggio di L,n·cno la di altri' 10 mila lit•t•, oltre• ;td tm:t quanfità di sn,le, l'fì. t'Ìlla, c•tl HiLi<'ne sc•tnprc• l i <luc• pir·osrafi l'd ha dalo ot•ùirll.' al cl!·appello lli gmnclin di difenderli sino all'c•xl t·rnto, qnantlo lt• lruptw s<'Ll'd<' C;l•t·c·as>wro di loglierli.
fA\ colon Pa di Garih;lldi trovasi tuttora Hullc• eollitw f1·n \ \t rese•. L11itlo c• !Jtt\'1'110. Lt• g ittlli!OilO giomalnH•nL<' di'i rinforzi, i quali \ c•ncbht•t•o giù ora falli a,.;<'l'lHI\'l'l' a,i l mila unmini; <' si allxirur·a c·hr altri volontari svii'.ZI'I'i <' Iom bardi, aslloldati da l dtt<·a di :vt iiHno, v<'ITanno fn1. tHwn 1H I alht nJOd<• :-dm n. <'H) non d imello m o\! i nlli zia li italia n i c• pohu·l'hi d i ('s-.a vunno via du l.n,Jnui l'lÌ suppout• 11011 loutnno lo "doglim<'nlo tli tnl<' tntppa, tunto piìt c·ht• il Oarihaldi. a VN't• di umitaltl'si Il:' popoluzioni, s<' lr t'l'Il<\<' IWV<'l'sc• c·ollt• di lui sOlJC'I'· c·hit>ric. '\Pila ll<'nl clt•l 1111 NH'pO di li mi111 A m; t l'iac:i. st•guil o cln 1111 alt m, oc·mtpò Y!li'C'sc• .•\ Clnllantl<• <' RomliH1 sono 1infor zn.li li prPsidi.
l1n c·OHtp:tgnia eli volonlnt•i ùnl t·apiluno B:tl'hara. c·IH• 1tddl 23 giullgt•vu a. da Hoe('.fl, d'A n l'o c·on 01' · clin<• cli tlllit·:;i alla di\ •isionc· Dnmndo. In domanc• invc><·c• di 1'(':-IH<' r.o1 d tH' rwzzi d ·,wtìglic•r·i<t t li tm i (l mtud !111 V l'l'l'IO •\ llj.!.'t'l'lt, pc•t· t·aggittng!'l'<' Garibaldi. Il c·omatulantf' la l'iLbì d' ,\roHa. loxtochl' il H<'PP<', lli<UHlù dal Barhnra un ulnzialc • lomharrlo. t·o11 missiont• d ' indtu·lo a l' <'(l'O<'t•dc>r<> !'d a l'<'lldet•;;i <'o' );tlO i n.l lorO dOVI'I'('j fili tJilÌ Hl' IH' l l o l'onOI'l' di g, V. aLti ck l mio t·ispeLLo. (.11'1·11. di N/alo- Tori Ilo). Lon; n \.
/l ('0 liW Il da 1111' /11 /H'fil' i 11 ('i Il (l i p a {iftnZ(( r1l !fOIJI'maiMI' di'ila rli ,\ ·ovara.
Pallauza.. :Zii
l n con li 11un.zionc tll•llt• p l'CM< h•.n ti m i t• t'eia zioni, ho 1' o n ore di rit'Prirc all'E. Y. clw ieri \l'L'SO h• 1 pomeridiane AustriiH'i piomba.rono su La,vruo, oncltl da qu<·l luogo il gc ueralt· Oa!'ibaldi, che• l'occupa va c stù quale tne1 te va cotttrihnzioni.

Dalla <tuasi rr:-;islenza, c:hc questi oppo:-;c si f;l c·erta inthlziOIH' che il llUIIIN'O dpgli AusLl'iaci rossi' assai ma.g-1-dore di <pwllo di Garibaldi.
li combattimento durò pochi isL<lnLi e fu a. vista dei tlH<' li·
lllo u; PRDIE GESTA 01 GARIBALDI l'l'ALIA
mitroiì l)aesi Pa.llanza cù lutra., cl1e sono posti vicini (' dirimpetto a Laveno.
Gli Austriaei cliJ•e::;::;ero 1-1: a 16 colpi di Munone V<bl)Ore. dove era.Ai rifugiata la, poca. gon.te che aveva ;,;eco Oaribaldi . il qual<', :scambiati due o tre colpi, 14i ritirò iuoffeso vers o T-'nino, o w . h a il 1-ltlO quHrticr genera le.

Creùesi clw da luogo accaù()rc uno scontro, Ps· co là raccolta tutta, la forza ùel lùi, c ltc da -pitt giomi Ri sta. tli prepa1•ativi ve1· tieE'ver<.> il
P. S. In q_nesto illta,ntc t>i venne a la. voc<• che eone (1he gli \ Ltstriaci ;tb biauo occupa,t1o Luino. (iJ1'f•h stato VOL. 18, pt.tg. 1233). J!BLLIZZE'I"l'f.
I l.sot.to-intendentl' ll1 A 1·ona «·l govM·nttlorc eU N ovcm1.
2:1 1848.
l t•r i i drtC' ba LI.<' Il i H il Verha.no <•<l i ( ' a1 ·lo, K<l<l\H'SLra ti
<.In, Oat'ihaldl, trOY!Wanl-li Luin.o <' l'n.lLJ'oa TJtbvcncJ
t' VCl'HO le { p0111Gt'id i<tl\0 la, colon ('. OlltHild:1ln, dal RIH ldCLt,o
V<' HIl<' vivarurn t<• ll Ltaeca.Lu. in <(tlC'IIc vicittu.nze dall'annata
i.L ll i4riUJcm Ia, 1t lO mila, nomi ai <;il'<\<\, per <·.ni, dop<) utt vivo cnHnoneggictmcnto . <lovf'Lkro i bat. t c•lli r ip a.. wt·so M i no.
ALo une or·<· dopo t'a.Lt.o. <lot <llln.lo t ton con,oscono ·i Ll<'itag li ]JORitivi, com]Ja.riva iu Angora. nmt <\ol.onnfl, di volontari :wenti cluc pezzi d '!wUgli<•ti<t; dovt>a. enLml'fl nei rt>gi ma invece• c<'n:<'J tli eougitmgersi. èOH quella. di Uai'Ì· bn ldi; nell' r nH•rgentc• cl<'l co t n b<tLii mc11to q U<'11a. t.rovn vasi a C'èt· dta.gictLI'. (' llOH Si R311H'eh!)(' littom C!llUtl l)it'Oi'IÌOill' <tbhiit p'I'Ci'O. Vindi vidno elH• t'N\Ò qni lrt twtizia. c ; hr }1.(\Callut.o parte ùi Va.tCH(' lo seon1ro; 11i emi ;L V. E. <· on mio fog lio (l<'l 22 Il. 377, è 1111 1lell a lb ergo tlelln ::>tclk'lo in di Cit i non mi si din• il nolll('. c•he non sia stato t1·oppo vmitil\1'0 nel suo mecont.o. :\ri glodo et<-. ( .-lroh. stai<! '/ll(tfJU· lìol. 18, pag. 1237).
1l 0011W?tda ltle d' .liro n(( «l governatore di ..Yovara.
N ovara, il 25 <1gosto 18M3.
Devo informare V. R. T. che la eompagnia. tlelle guide del Ti· rolo, comandata dal Barba ra, di cui mi si Na. a.nnunzia.to l'aJTivo da Rocc;:l 1l'Jinfo per questa ciLtà., g iunt a li 23 a.
LE PRIME GESTA or GARIBAJ,pi fij ITALIA
1117
7 t - LU.
Hesto Calende, il mattino sussegt1ente prese la via di ..\ngem pt•t· u nir!-d a ll a, truppa ldi. ll motivo dato dal comandante ht medesima si è che dal Gariballli venne Rpcdito un distaccamento ùi tl'llppa. vers;o Se"! to che tla, riò l1• sue gtlid<' non vol osl:lero t rll ·· gittare. da parte . ma unirsi al Garibaldi , ch'egli avendo <lut' cannoni di ca libr o, per nou ]lerdl'rli. pur dovuto s<'gnir<• la sm1 trnppa.
Il piet!O de l gen<•rale lhu·and o, a l qua l comarulant<• ùi dt'tlt' guid(• era. diretto, <' eh<' Lrovn,val-!i in quPilo <lirettomi in dal<\ di iel'i l'altro dall'm. V. pelmezzo dei <:anthinieri reali per tn·gen tt•, ve 1me t o;;Lo fa,l1 o tottN'l' d n Il\ Ca.l :'nd<letLo capitano Barham, esigendone la riN•vntn In quali' porta la dt•.l 23 antl. all<• ore G di st>ra l' ;;pit>/4<Wa in tnpo ehe la detta truppa. di gnidt> non l'{ia <·hl' ]WL' ric•ntrar<• al c:ollfinl', lll'H T\OillH'l' dirigel'HÌ ilt Hta.ti.
I> i tanto informando l'E. V. IH'l' di l<•i nornut, ho l'onore t> l <'. (ilrf'/1. stato lntlff!/· 'l!l/ 1. 18, 123!>). Bt•:HTJ\C1NO .
li?'. t·om 111Ì8.çario di 110liz'ia 11ùttendrnza !/M1J' rtr/ e (li ?l·ol!ltl'(( a{ !JOI' I' I'IWillrl' di il'ot'llt'fl, li agosto 18-JH.
EHI'{t'JHiomi i<•ri n•<·n.to a Cai!lellt'l t o ' l'ic·inn ]Wl tli!lillllH'g'lW di un incil.t'ico lla <trwsto sig. intc•tHl<'lll<' p:Nwntle, c• di lù av<'ndo t mgillthto n S<'sto Calende, )Wl' deonos(·t>n• qual ronùl\lll<'nlo a.vl' r polt'fiS<' la Hpa r:;a.si clcll'u,nivo di molt a, tru pp a in quel borgo, rinvl'ttni uua colonna am;triac•a, forte• di mila uomilti c·irc·a, l'nnu•r.a e ru,vn ll el'i<\, l a Htcssu c·onu1 rula t n cla nn gl•nc• •·ale; < ' mi fu assicurato che twlla s<.'ra dov<.•a gilmgervi nu <1orpo di altri 3 mih1 uomini, c si. cr ede ohe tal corpo sia ad inHc'guit't' Garibaldi, si nei dintor1ti tli
Po co prima dt•l mio al'l'i vo in Oa!\Lelle t.to, enwi giunto il capitano, comandante la. Rorc·a. d'Anfo (aUua lmcnt<' iu fol'za. dt'll' a.t·mistizio eeduLa !tii 'A u stl'iaco), con parte delta. truppa chl' con due <·annoni d::J 16 e due c·arri di mmt.izioni, CLtut l<· artiglieria <' m unizioni ritrovai a,lla. in. Borgo 'J'icino ùircUi a questa Clittà, tlOV(' devono giungocn• oggi. Il c·a.pitano c:oma.nùa.ute il detto distac<·amento ::wevu in contmte ù c• ll e diflì colLà per il suo pallsag-gio in. qul•sti rt>gistati, p<.'r partt• del gen<'ml(' auRtr iac•o a Sesto Oaleude, per motivo c he il giorno ::tnLcceùentc• aveva avuto nn abboccamento Garibaldi.
D a <'erto Guarnascheri Giova.nai di Hnoui, d. i vussagg-io p<>r (tucstn città, il qmtle racc,' a parte della colonna, di Garibaldi, da.

1118 L.J<; PRIME OI GARIB
AL DI IN I TALIA
esso lui lasciata il 23 a.ndante nelle vicinauze di Valtravaglia, mi è stato assicurato il predetto Garibaldi aveva sotto gli ordini 350 circa ù'uomiui; rra i quali si con.tauo molti giovani appnrtenenti allo famiglie più distinte di }filano c altrove.
:YEl,l fal'tni un dovere di rassegnare all'E. V. le predette nozioni i r1 obheùienza alli ordini verbali avutimi, lro l'onore etc.
(A?·ch. stato magg. ·vot 18, ?Jag. l 279) . DEAl\rnRosrs.
Il comandante il J 4° al contwnclante deZZa àiv ·isione. Oerano.
'Palla.nza, 26 agosto 1848.
Le Mse Garib•\llli non Hcmbran.o andargli molto a eon forza Aust,riaci s11 vari -p1.mti ove si t·enev!b, ntl vcntte, n qne l che dicesi, ovnnqu<> sconftt,t,o ed obbligato t1i prcr1dcr la montu,gna, mentrP dal ht spi::l.ggia i vapori slll nofltr·o estremo confine nolla
rt 2° ba,t,taglione, ello in gntn parte Uannobio, gl i tien d'occhio r spero che non vcr·ranno molestate le l)Opola.zioni del re.
lA) qni aoclrinsn. copia di :-;piega tUHì}ti cltiaramentc le VAJl'ÌC' 111 ORS('.
qnest.a m<tnl:' !tllc Ot'O 11 cbh<' <'Hcguimertto la :-;cntenza di lllOJ'L(• co rttr·o il Ro l clMo Hm·ghesc di quosio t·cggimonLo. Intervenivano llne lmLtagliorti . 1° t' 2°; cosn, l)J:O Mtlè con ordine . ..:\Ile oro 8 giur1gcva. da. Borgoman.Cl'O il 1° bai,Laglione, la cui [or·za l) t'es(ln.te in sol dal .i cnt di 150 uomini. Vennoro tosto ripartiti JH'lle vat·ie r.ompagnio e domani li uffteiali e bassttffichtli ripartiranno por il deposito, ionnnt'l' il 2• hat,taglionc di J·iSI•rva..
Non si tm:sctU'a nè la. prop1'ictà , nè l'istrnzione, n\Ontre si a.' LctHlono gli oggetti pl'I' riformare la tenuta,. ' Ho l'onore di pl'ote:;;tare a.Il'A. V. R. ti Hensi profondo mio (A I'Ch. stato 1•ol. 60, pctff· 555). D Al'ICIANO.

Ilsincl<wo di Oannobio all'intendente di Pctllcmza.
Ca;nnobio, 25 agosLo 1848.
Lo scontro, di <mi le l:lCl'il:lsi i<'r sera, avvenne fra un corpo eli tre mille Austriaci e dugento armati élclln, colonna Garibaldi, i quaU non potetono valérsi di altri 600 volontari che stavano con loro. ])ernhè non avevano ancora potuto Dopo una ostinata resistenza.. sopraffatti d:il nn mero i volontari dovettero ritirarsi, ]l art<• per tena e par1·c coi vapori, c stanotte pernottarono a Ma,ragno, d'onde però dovettero sgombrare stamane per
LI!: PRIME GESTA DI GARlBALDI lN ITALIA 1119
l'avvicinarsi ù:i un corpo di cir·ca 500 Austriaci, che oeruparono pure i due picco li comtmi di 1\ia(·agtlo. Stamattin a, i val)Ori ave. vano ancorato neHe acque svizzere, ma torse per rispetto neutralità elevetica ftuono costretti <li ritornare inùi('i,ro, ecl (H'èl< si vedono auoOl'!\ti poco pnngi <la 1 conmne (li S. ultimo JXWI'\e delin. nostra frontiera 1-larda.
n maggiore nhe fiUCsto battaglione trasportò gli a · v.amposti, che pl'im<ù si 1,euevn,no vf'rso On,nnero, quella dir<>zioue. Vogliamo sperare che mcreè avvctlut't' ÙLQ.posizioni c la forza militare di cil'cfl, 3M uomini chr qui rimane, c;arcmo difesi ùa og·ni la qual<' a vreblJc cel'ta mc.ntc fWuto lno go senza, l'energica !:!piegata. da V. f-:.. I. ])Cl' Lutelare an · (;lle questo pacH<'. nh<' N·a. Appunto il più <•sposto <' l'11uico aperto aù ritintta , ftrnHtta.
l V<t1l01'Ì 1 quautntlqUC CaW HCg'llO a, moJt,i COll)i ùi ClLllllOHC, ùt'vono a-ver sofferto as),la. i l)Oco; u.l momento cu.dchi d i molLa, g-cntt>, ma ttOll IHmno piit l';morel1io. Ki dic.c che il p;encrrtl(l Gat ib al.di si sull<' mon(.agn<' JW esso ma, l'li duhita <lh<', < l a l nnm<'l'O, dt•bl>a l'i Lirars i in
A 'Bc lli nzona <Wrivò it>l'i il gt'nl'rn l<> Ol'iffini COl1110CJlli uffichtli, avrmlo la sna fCl'l11P7.Z;;t, della, Hvizzera Jt<'l ma nt<>ncr<' ht l)ropria lll'nt mlitfi, togli<• la pro l>ahilit.h di nlLI'i trnl.:.ttivi, comc{non lal'eia. sprr:tnr.a di aloun Htwc·p:o;so al g<'ttera l<• ù::wihaldi.
(A 1)/0[Itf. 1111l 60, 'Jiafl· :157). A vv. nrov,INOr..l.
li éli yucwra t' mttrinct at 1Xt1JO deUo stato maggiore generale. A
'J'orino, !Hldì 27 agosto 184.8 .

La r<:'gi<t set.rr<'teria. di sLfLLo vcr p:! i a.J!ari intenti fece conoscere a questo ministeJ'O una l'l1J>JJl'C8enta,nr.;.lJ dell' intendente. <lella provincht di Pa1lanz11, circtt llJ ù i non pl'ivare. per le adùoite ragio1ti 1 il borgo c mandamcn.io di Cannobio di pre· 1;iilio
Onde Y. S. l. }Jossa meglio VPt1ere quanto v i è mi Co debito ùi comunicarlo COl)il'lt stessa lettem delPintcJl(len.te -predetto.
Pcuimenti ravviso <li mio spccia.lc <.lovere <l'in'l'orwarla eh e alla lll·efata regia segreteria di atato per gU a.:ffari interni ho osservato come nelle contingenze mal competerebbe alle operazioni ùell'esereito il manteneTe varzia li distaccamenti di truppa isolati, epperò, qualunque fosse l'orùine che emanasse da.l qlHt.rticr gencrn,le l)J'inoipale, pel' disporne si dovesse ott<.'mperarvi tosto;.
1120 LE .PBJ'AtE GESTA DI G.I.RlBAL!J! l'l'ALIA
LK PRnfb: GESTA JH OARIBALDf U ITALIA 1121
t•ss<•t't' dunque OYYio il la pt:efata regia l'>egreteria ùelln prrsen1t> uin·ostanza per prontamt'nte attivare l'orditHun<•nto tlt'lla gnnrtlia moLile nélla provinc·ia di J>allauz;t ed altre. )l"<•ll'an.!l'P l'onol'<' di raggmtgliu.rla tli quanLo sopnt JH'l' l«:> clielle S<w.auno utili ttl cnxo, l<• nggiungm•ei. la. di volrrmi s<HHlH'e tenel'e informn.to ( ii q u.ahmq11e cambiamento di SLallr-11 di truppa che V<'Hga, MHlil ord inato, 1>01' uornht di questo minist<•ro; e pt·cgiomi tt<'l trmpo i'{ t Cl'lSO ti n no· \llrlt• J.{li <ltti ll('ll'osscquio mio
( . 1l'l'h . .V/llfll mag[J. I'Ol. (i, }lllff· 7i7). D .\HOIOf!D \.
/Jol touuuldo {/f nftllll' dt•i l'amùinicti l'l'ali (l[ di !fiii'I'NI r m(lrina.
'l'o1·ino, 28 agosto 1

l 1t' uot.izi<> <J l H•llo I'Ì<'l'VliL<' iNi <•d iui.OI'IlO alla eolouna Clari lmlcli HOIIO alqnauto uomt• quelli' rtt<leonLalr
div<•rHc- pt>l'l'lOUe cd in dill'l'I'Pitli luoglti, xi eontratldi<·ono.
pui>lttl t n via indmt•t• l'lu• la :·wm tlt•l :.! ·Llr l.rtl))IW aul'lli'Ìa(IIH•
o<·utqmrono TJuino <' La\' t•llo 1·o1t una J'orr,a tli i iu 5 111ila umuini. \1 loro anivo i clur piros<·alì !i'nllonlanarono du qtL<'IIt• KJHHHl<•
tl<'llago. tagliando lr gonH•n(• dt•i han·oni c·he Yi l.'rano ulft•t 'l'<tli. ontlt• non impettiti PII ohhligat i a rimort'11iarli. l1i 'l't•dps!'lli
l!li ft•c·ho tlit•tro alcmw <·antwnal<•; non <·on;;ta. pt•ro <·hc nP risul).'el giol'llo snt'<'l·ssi\·o 25 stavano :UH'OI':tli
11(•11(• aeqllt' svir,r,(•J'C, llHt ])Ili'(' elw ]Wl' rispeLto a.U:t U<•utrnlit.i\. fosHPI'o <·o:-;(,l"<•t.t i a slll]Jttrr, P d :111 i 20 Hi ., t.ro va vano :ttWOL'itl i pOt\o l ung i oomntte di R. Hurlo1nnt<'O, uWmo paeH<' th•Lia l'ront iPra. Hat•cla \l'l'SO il <·onfin<· lieitH'sl' \ qunnlo p;tt'<'Va i dur vapol'i <'· l'allo <-:lt ' Ì<·hi <li JH'rl'IOUr.
Il <l<•lla colouna <:ari haiti i tro' il 2!) :-.nllt• c·ollitH' tli Yn.rt•st•. nll;t tli forsc• Il' <' da l'nlt•ndt•. (' nwnlr<• i 'l'eùeschi <.'Yac·tuu·ono tla qlu•sto luogo per dis!Pnth•r:.;i lungo il littoral<> tino ad ]spra. il <:arihatdi prol:ìtLò del monwnto di ta,l<• mo' imento per 1-\{>t>dil <' ordin<• a t-:>esto, onde Hi sero lr<• buoi, prO\' VCclt•n• farina <' d ne botti tU vino; m n, i><HHI v i :;opt'aggiuu){rv:Luo a Il!' i 2 m iln. AustTiaoi elle Hi i nqJOH·
i:iNIHHtl'OII O dL (!lLCI:Ite
I l !W Hi dice'' <l! iu Arona che h11 colonna del Garib<tldi dov<'a'ìi lrovan• }L n1<1l partito. p eto h t• <LCC!CL'<lhiaLa <la imponNtti fo1·ze LP· de:;c·lw.
La compagnia del noi o capitano Barbara. apparlPuent<•
eolonna ùPl generale Giacomo Duntudo, l'iuscJ- ad unirsi per là · maggiot· pa.rte alht d<'l Gn .ribaldi; ma qu<>.._ti i:;le!>so in dns."c il capi.tano 'Barbara a rPtrocPdere nei regi :;;tali con i tlnc
L.F. PRIME GES'l'A DI GARlDAI..Dl IN ITALIA
cannotti che con<lncevH, !:!eco, pm·clli' gli sarebbero sct·viti d ' int ba.ra.zzo, n.è avea cavalli !lu.fficienti da, Lral-lcinarli nelle montagnl'. Temendo anzi che poh•ssero dai TedeRc·hi , cou.-,igliò al capitano Barbara di :lù<lurre d'aver<' sbagliato stmda ingannato dalle guide, onde non loro prigioniero coi <:annoni t> con gli L10mini oh<' serviva-no a, i mc<lositn i. di fatti il capita,uo Ba,l' · bara, r-;orpt'<'so dai 'l't•dc:-;c·hi. ma il JH 'I'le... lo gli vnlx<• <'d ottenn<• clat g<'Ll<'t'a lP llei nH•d<•si m i eli pott•t'<' il 'l'id no (.' giunger<• a Caslell<'tto, d'ond<• xi c gi•ms<' ic•J'i 27 coi <·annoni a );o. vara.
11 24 n,nivava a Bollinzona il Ot'iJJìni <:m't poehi ufli · ci ali, :wcmlo RcioHI\ la K\Ho colo tlna. Qtwsta i dava, H d Tutm il 26.
no l ' onore di , ._ d<>l mio ri:-;pctto.
(A rl'h. eli Stctlo- 'l 'o rino). Lo VERA.
Oa/, M ma nt lo ilt• i l'Il b-ini el" i l'l'ltl.i a l 111 i d i ff1tel'l'll r marin(l. ' l'o rino, 2!) aJ!O->to 1848.
D;t ]nu'ti<·olari no1.i;,i1• ric•t•vntc dnl <'OIIl<lltdantc• tli ndla divisione ùi Novu.ra, dsultet·c•hiH' <·.ILe il Onrilmldi sa;rcbhe fcl'ito <MI HIL lmwcio t· 1111 111\<L nlltrLO rw ll ' u l timo xc:ontro avnlo ton [.(li .t\m;tl'Ìa<'i, <' dw urto dei suui ufficiali ru il 26 trasportMo a Yaml Pombht Tidn.o) f<•rito irt un:• c·o· xcia da urt <'Olpo ùi 'Xello giorno 2<>, Jll'l'SiiO 8(•:-;to UaiNtd<', vt•tute Ìll.CettllÌ!Ltn. una dcLl:b Lt\ Bn.tlia; llln, non xi H:li xc lH'l' JHII ' ll' tl<'gli AusLI'itLd o d<'lln. (hwihalùi.
Ilo l'o rtO!'<' di rinnonll'<' all'E. atti d<•l lllio di stinto I'Ì · spetto.
(A rrh. di Stato- ' l'orino). LOVKRA.
Il conuwrlmtte I' Cff[J irnento a l t·otlumdcwte della t n di v·isimtl'.
Ct'J'(tnO.
Pallauza. 29 agosto 18 48.

Teri clallp l atlc 5 pont. il vapore il Verbano si l:e t'llHIVH in facC'ia ù' e wrso terra lltt<•
L'ufficia,Je che erasi tosto portato ai pl'zzi. ricevett<' li uomini della har<·a e fattili a.rrestare, Ycnivano cou· dotti nel vicino corpo ùi guardia.
Scorgt'nùo che alcune barchettc> del paese volevano o -poic'vano pot'LU.t'::;i verso il vapore, ne iull)e(liva: i.l ùistar.co dn,lla spiag· gia , ed alcutù giovaaù del paese volendo insistere eontJ'O l'orùitH' d:tto, li a,vvC'rtì che avt·ebbe fatto u:-;:n la. forza ùall!' :-;enti11elle, e per la loro pertina.<'P itH;L'itt>nza li fe('(? nrrestarE'.
C'iò arretò qualche Hussurro tt<'l paese, sì che tosto ne pervenne notizia in Pallanza ,,\l'intendente e al barone Solat·oli. che imme.diata.mon.te me tl.e diedero avviso.
Ri di tosto porbrsi ad Intra vet•pr<>ndereeS<lLtn co· gnizione di cosa.
t 'o là ginnLi Hi trovò eh t• un<11iJH'cie di <tltrmziont• si Htùl'ufficiale d\wtiglicria, pt•r l'a1Tcsto cb e fWt'va fatto overart•, notlchè per aver t•iteuuto <tucUi discesi ùnlla har<·lwtta clel \:tpore, adducendo che prinht di ::;cend<'re av<''' atto chiesto se dò em pt>rlllN!AO.
TAl barulleLta. con letwva quattro J><'l'HOHe: dtw hot·glJ<>si <' due l>areaiuoli. Rsaminati i tlue borghesi, tli('hhnnrono essersi imhat•mtLi dnl confine per <•sser sul nostt·o liLt.ot•nle, <' par<•ndo eh<' non :w<>ssero inLc•ttzioni OHt.ili, l'int<'ndc•HL<· giudicò C'he pol<•vauo C$S('t' vosti in libertà P<'l' !'('('<\l'Xi OVl' VOI(•vnno. l dtte ba.l'CJaiuoli, uno g<•novc!w <ht più anni al H<'guito tlc•l Oal'ihn. ldi, l'clltro <ltl, ll<HJO dicbia.t'Ht'O tto 11011 vo ler a.lfro dte far incetta d'tm po' eli vino t' ritornar1WJll' al vnpot·c; ogtti eOR<l. fu IO!'
i. qun ,t Lro borgll(>l-(i, an·<·Ht,u,t .i lH'I' l'ìnHist<•nza ùi im hnt·c·;trsi contro il di vi<• Lo. Hi d lll'Ò molta faLic•n a wovar lot·o, {Ll padJ•e d'tmo di Nl al Hig. Hiuthwo. t'lw tlen• ohheùit•nw alli ordini <lei bziothLt'i, <'h<• <·oxì si può OV C't'a t'<' nei tl 'urj!<'llza; Yi J\ll'ouo parolt•, v;tri, lll'Ol<'Ht,e, mu a ll a. iltH' la Ht' tlllm) <'almarsi, i furon o i in lilwrt.à, <'d ognuno Hi HC'pat·ò.
l ht Lutto (JII<'I:ILO Ht•mprC' piu eonvinto olto a<l l nt'rasipal'leggiatonGadhuldi c (')tt• di've avpt·vi dt'gli aderenti.
Notl Hi l'!:t OV<' sia <lari baldi t· la lt•uppn; quc•i s!'t•snro dal va.por<' ùic·ltiat·arono di nou
Vuolsi eh<' 1'\ht stato disperRo uclle montagtw dai o che Garibaldi R!cs ·o sia ferito; <·ose cert<· però non xi sanno; rmJ. :s(•, questo !ltil Lo spt'l'<t d i a V l.'l' p rei-ILO la rc:-;Lituzionp dei vapori.
(Arc1t. stato ma{f!l· 11ol. 60. Jla!J. 58]).

DAl\JI \NO.
0a{ {'0'/na.ttdo gwnera{l' dd CU1'U/J'in ,ieri 1'1'llli al di gw'1Ta (' marina.
30 agoHlo
Da una l('LtC'ra. del c·apitano di uno dei batlelli a, vapore del . lago in data. clel 2i C'èHleute, risulta c·he non aveasi da. alcnui giorni nessuna notizia ùel Garibalùi, dalla ttlttppa cht• tt·ova ,vasi a bordo di detto battello; tn.lcùè il ca;pita.no Rizzo, p t'<'-
LE PRIME OIDSTA DI GARIB ALDI IN ITALIA
1123
1121 LI!.: PRIME GI>:STA DI GA Rl.BALDI IN ITALIA. posto al <·onwwlo di qucll<t spe<li una staffetta 1>er utf':r.zo di nna bar('<l, la quale tu' istn a Belgit·ate e (' quin1li alla sponda lombarda, che costeggiò a certa distanza. nt'llo st·opo. si prcsunw. di facilitare l'imbarco a Ganbalùi, o tntto alnu•no il mezzo <li l ' ice,·crc li ordini.

'Pt'(> dl.'i :-;noi giunst•ro In :-;era del 27 ;td ..uoua. e molli d<'i loro c·ompagni plll' l' in Olèggio li 28 successiYO. t·otwordi t ul ti nello a;.:st•rirc dw il loro gencntle e l'aiutante tli campo d<· Yono rifugiai i in Hdzr.rnt allor1'11(• si s('Ol'S<' l'impossibilita Ili loUnrc c·ontru lr (Ol'Y.t' impotwnt i oppoi\tc ùalli _\w:triat·.i; <' grnn parl<> di cLU<'gli Genovesi, th•IJ<· lol'o at·mi, <'ht• di<•ono g<'tla1 <' ondt' non <-'"s<•rtw impacriati tt(• Jl a [uga, sono itlt<•nr.inunti di ripah·inr<'.
1128 I>H ,rLl da N'ovn.nt 1111 dt'lll>}>Cllo tli 23 uffizinli <' :l2 1 bnsli'll 1'ficht.li <' soldf1t.i t.mwuni, n<ld<•Lti nl corpo di'l A'<'llCJ'a ,J<' Dnrfmdo. c:hht.nutt i in ' I'OH<m,na d a l IOI'o Hovmno. g i umw in Novat·a,, pl't' I'Ìil l ftnt'l'Vi, i l l 0 lntLLaglionc di'i c:uc·C'iatoJ'i lo 111 hat·di, uoumncla t.o dn l colon twllo Cav<t.f.( no la, HHsicntt• a chw <li <l<'lHli'\iiO di'l eot·vo di'l g<'mmtlc Dman<lo, formanti itt 1111 crlltttlro ùi 20 nffìeinli c• 600 <'soldati, pro,c•nh•nti dalla Hvi:r.r.t.>m.
Jlo l'<morl' eli l'iprofpsfarc> ali ' K \. gli alli di'l mio risp('t to. (.l t'l'h. di Nlafo 'l'orino). LO\'EitA.
lf t'tJmmtduntt· dd l:J l'l'f/!fiiiiC11fool rmtWIIflttnlt' della .J ('cruno.
'so un. li :u t n l818.
lnl'onno c·un tutto tu Y. \ . IL C'il<.' lt> ore!> ancorat•ono in C(ll(':-;to porto i chw \ ':tpoi'Ì, sotto f,!li ordini clel sig. Luig-i J>ouzoui. c:omatlllant<· clrl V<•t:lmuo.
Ilmcd('simo t'lt)libmo \ ' C't\ltc> pl'ima di\ mt• per ùontanùHnni sc• potevft a ppt•odarc•: p<'llll<'sKO <·l w n on Phhi ù ifficoltù. di dm·c•, dopo clH' tui dic<l<• l<• s<•J.;tH•nti infot·ma.:.doni:
l 0 non <WN honlo, della colonna Uat·ihnldi, <•d anr.i nti tl isxt' elw Pt'a tw :o;b<U't\llti, tu.tti i sol dati rc:;hlui de.ll a colonun. Gn.riba. l<li, lll<òltl' a. Locnmo;
2 ° <•Il \.• <lopo ta le :-;lwrno i vap ori fnrono messi in lihe t·tà c l'<.>carono a P a.ll:ln:r.a, ov<' ( u t'O ito vi;.:iL<òLP l<' macchine flalla Mlllmisxio n <' cii vapod, eu rmt.ori.r.r.ati n fare le so lite e:ors<>, eominciando da domani a1la nnn. pomeridiana.
L o ste;.:so comandattle ùel Verbano, juterroga.to da me ovc ,.i Lrovass<' il Gat·ibal<li, mi nou. saperlo di poHitivo, solo avt•r· sentito eliserc in Hvizz<•ra, ùa do,·e si creùevapartito per Genova. lui crc>de lt'aVN:mntlo la l <'ra.ncia: i n ultimo mi soggiunge ri-
cevuto una lettem in tla1 ,n tlel 29 agosto, ma non si conosce d:1 dove ùata.ta; nt' ho prt'sa copia cbr eornpiego a Y \. R. LLttto che mi sembri di nhnHL importanza,.

11 Verbano eomineia le f'!Ue corse do tiiHiti allcon•ponwrilliaut• t•l'altJ'O restt'rà q11:1 autorato. Ovc Y .•\. H. avesse <L'talcll(l c·osa in contrario, le lt'pli<'o YOlermi rilast•i:ll'<' di'gli ordini prima Ili quest'a ora.
Mi pr<•gio con c·iò <l<>ll'onorp di lribltt ari<· gli umili sen.-d d<'l pin tlovuto ossequimlO l'ispetLo.
(:1 roh. stato marf!l· 1•ol. 00, 1)(tfJ. n!H>). P \1M.
Il gf'nn·ull Uarilwl<li al ('llJ!Ìitow dell'nba1111.
29 agosto l :4ig. capitnuo dt•l \ <•rhano,
\'i nH'COillando llSI'llll di C:OllLillliHI'\' 1 l'H'I' Hl (:t l llÌ giorni ;tll(\Cll'fl,, ad t!S<'gnit·c• gli or d in i <'ltr v'ha, alli da t i il t\Ottlll>lldnn t<' Hi<·1·io, Ropm d t'i quali pot r<•h• <·hiNI('rt• voi <tn:mto piìt 'i a g -
!.!I':Hla <·he 10 snrù in do' <'1'<' tl'<•s:uuliJ' i pi<•nanwnt<•. Yi saluto. - •
(Arr·h. stato 11/llff!l· t•o/. t\0, Jlllff. UOI). O. (L\Hill\t.nr.
Il ('Omandantt • l'arma rlr•i r•rrraùinil'l'i rt •ali nl'/.la d'il'i.viont• di Xollnra govl'l'llcJ/ort • di Nol'<f!'a.
).cl\ :tl'a. l settemhrc• lrllK
l Pri l ' altro t m va vusi di pa:ssng-gio in Aro t w, pron•ttit•nl<' da Il a Kvizzera, il sig. a v\'. BroiTC'rio; tlu ,l Ilo q nio <tvuLo c·.on llll suo coHflde ttle, (IOnstlt c·h<' il Garibaldi, JH'I' hL HIUl• i mpl 'PH!l , riposrwa 1-\Uli'UlllOU(' alla 1-i\U\ ('Oionna di ([UJ'il<' di ])m•ando (' C1riJlini, di<>tro intelligen:r.a anl'lw axsiPm<', ma t' hP pPr <'ircosta.nze fortuite• non <>ssendosi la lll<'d<•sima pot.uto <'IIPtltuue e ridotto a poc·hi uomini, e fc>bhriC'itanle ('gli stesso. a' c• t· gituli<·ato prndc·nt<• di ritimr:si a Lng-ano; c• i<'t'i tlovc·,-a rN·arsi ll<'lla che O('(atpa a, Lo oarno una lntLL<•twLa clel su<ldc•l t.o sig·. avv. Brolft•t·io, coll'in(,('nzione d i ntdunat·vi t utta. g('nt p <:hé gli sarchlw !-ltHM> possil>ile.ver segttitare in Loml><Lr<lia le c:ontro gli ù nl:'t..riaci.
Hhmlterebbc JHII'<' <.:hc il giro vizios•> fntio dal gencrn.lt• Gl'iifitti (cni però alcun<• persone d'alto r<mgo prestano lr miJ!liori int<'nzioni Yerso il HP. cui quartier generale egli r<•cossi ieri. passando per questa città) cioè 11i p:'t.sRare per la Svizzl'ra per V<>ll it·p nei regi non mirano ad nltro ehe allo di unirsi n Oariha.Ldi; ma clte per non (>Ssergli RLa to permesso di pa:-;sare il .
' LE PRlllE
DI
GESTA
GAB.IDALDI IN ITALIA 1125
confi1te ;wnutto, siaa i perciò detennin<Lto di J ' ientrare inPiemon, t e. Xon lal-! ciò però la llhLggior pAl'L<' di quella legione d'ofl\·irsi. inerme al Oarihalùi. che la rifiutò per mancanza d'armi da dist!'ihu.irsele.
Affn,tto divergenti le opinioni Hu l conto del]lrecitato GJif. fLui, molte persone tencu(lolo ver attacc•H Lo n.\la èansa dr l H<· e del govemo coatituilionnJe, mentr<• altri, ira cui parecrhi d!'' I'IUOi 11ffic•iali, lo dipingono rome partitante cl<•l Kistema rcpubblieano. sup]>onrndogli l'intenzione di proelamado in Lomhanlin c nei n•gi Ktali, qnalom, effcttwm· dosi ilprogl.'tto di conginuzioue alle le gion i di Dnntndo c Garibaldi, 1'01-l!<NO l'ÌUS(.)iti :ul <W<'l'C il t-JO]H'H VV('lltO.

Non d<•ggio pretermct t<'r<' di fa,r<• OKS<'l vare a.lla }<}. Y,. quanto ùi duhhioso ahbia.no l<' git<' eontinm• drl l'lig. ''' '. Brotferio in. momNtt.i nel\a Kvizilera, sol t o il prt>testo di vede t'e l'anzi· <letta :mu. trn LLcnn!,:\, (''lH<' tHio ben no t.i i suoi principi i, <'d essendo fott<>tll('ILI<' avva.lo r oLi i soHpctLi s ul HUO co nto da ll e sm• rel azioni in qnrl JHINlC. <' segnatanH'nle ro l fa.ttHll'iO ì\faz?.ini, l'lt<' da qualc·he t c• nt po risirùe a Lu guno .
•\ltro C"IH' IIH't'ila. in q urst i t<•mpi tli ft•rnl<'n.tazion<', I11LL:t l 'al t<•nzionc dt•l govc' J'UO, Hi è il nominato <'<'l'llUHChi tln ) l i· la.no, g ii\ c•sLc•n so t·c dc•\ gio t·nal t• dc•ll'opc•l'aio, s ia pc• ll t\ i Lt>ntte con· J'<•t'<'ll1.1' a\ 11!C eol Oarihaldi, sht p<'l' i f1·equenti andh·ivicni eh<' ft\ nei r<•gi stati, constando <·hc> lniH'<Ii Kc·orso, 18 I'IC':Hluto agosto, sbarc·ù acl ln tra ton altro i1ulh iduo sc·onosdnlo, nella stessa giomata pi'<'He lct via dc•\ l nl(o, mettLl'<' l'gli sersi d i1'<' [,t o 'l'or i no.
! eri s<'l':\ vPrso le or<' Il ghmsc· a. <'uHtclleUo s11l ' l'icino, provcnicn(P da KC'sto ( 'alc•ndr. 'utluogotencnte :tul'\lri:wo. latore di un plic·o tlil·etto ùal suo g(•lu•ntlc al sij!. c·onuuulanlt> il distac·cnmento di t.ntppa picnlonL<'H(', stan..:ia.ta su quella sponda del1'i· ci no, it qual<• ri ehit>Kt' l'a nn<l • pella Hj)(•dizione con ordinanza<'· ;t\ su o c·oruaJul:tnt<> d el ba Lll1!!1ionc in Oleggio.
Li sudclc•tt i due uffizin li <•onferi rono qualche tempo e t.utto riò c·hc ha potuto capil·e il brigadiere dl.'lla Rtazione di ( ':tl'ltclletto, fu chE' tntltava.si di R<tpert' ovr trova vasi il qua.rtier f.wnerale pii1 dcino, c·ioì" tlu<'IIO tli S. A. R.. il ùucn eli (:cuova. , c• elte il tenente :tust-riaco db;KC sottovotJ<' a quell o !lPlll.' nosh·c tnq>]l<': dob · bi(lmo abbcoulonarr .l! i lmw.
:Xcll'av<'rP l'onon di la.tllo riferir!' nli"E. Y. ho pme quello di riproft'..,s;u·mi con i s<'nsi di profoudo l'isprtto.
1.lr<·h 9tato nwgg. ·t•ol. 18. pag. J 171). l )l;; ( 'IlOLE .
1126 t.E PRD!E GESTA DI GARIBAI..Dl I:-< ITALIA
JJal q11wrtùr generale pri?HYitpale al tninist,.o 1'er gli affcwi esteri.
AlC&r-;anllria, li 2 settembre 1848. Ho l'onol'e di tra.smettere a V. E. copia d'una lettera che ricevetti quest'oggi da.lluogoteuente generale cav. IIess, quartier mastro generale ùell'esercito austriaco, ailìMhè Ella a.bbia cognizione delle re lazioni in cui ci trovi::..mo con esso. lui e provegga secondo giudichel'à conveniente intorno ai richiami che va facendo sull'aggressione ùel Garibaldi, il quale però, 1La. quanto corre qui voce, deve c;ssersi l'itirato con tuttili E;uoi nel territorio Debbo ancol'a Lratteuere V. ]i). sulla necessità che si :·wnte in 'l\Jilano di avere. urt impiegaLo (Juahtn<JUC del regio governo. o <1l1c i ncornbenr.ato qua.lcho consol e estero per la :.lpcdiziono ùi l)assall01'ti persone (lir<>tL<' agli l'<'gi c JWr l'a.:lsh;l,em:a di cu i potrcl>bc!'o (li f:;. M. alloro arrivo o durante il lol'o soggiomo i r1 quella città. V liJ. rn.vvL..,('rà fac il mente l'intvortatJza di sodùisiarc a tal<• noc·er-:sità, laonùe st>nza im;isLcl'<' maggiormente mi pt'egio etc. ,

(A l'eh. stato -magg. vol .• 2, tJag. 781 ).
Oal govemo della di1l iS'Ì()nt> di al <·api) clello maggim·e genemle. A lesscmclria.
Nov;-wn , li 2 18"1-8. Uo l'onore di 0om piego,re tttt ra.gguaglio conHttldante l' arma <lei carabiniet'i teali iu questa clivisione in ùMn, ùi ieri, r icevuto alla sera., concernente il cousn,puto si{!;. Oal'ibalùi, llal q uale. si raccoglie che la Kpèranza <lt>li 'inn>rcsa dal met1esimo i niziata contro Sltll'uuìone alla sua colomta di. quelle di Durando o Gdffini, ciò che non s i n.si 'J)Ot11Lo effettuar<>, p rr i01·tuite circostanze, e l'a.n<lare c venire e le relazioni coi suddcLLi del ben noto avv. Broffcrio, come pul'e la comparsa e le clirezioni di certo Ccrnuschi, milanNlc, dPHtò gmvi soRpetti di men(> repubblicane.
Il signor inte11dente di P:-1llauza, con. lettera, ui ieri rn i c h e nella serat del 31 scorso a.gosto :1pprodarono r,olà li due battelli a vapore, lasciati in libertà dal Garibaldi, e vrevia verificazione fatta medesimi da quella commissione di sorveglianza, proseguu:ono ta corsa a ll a volta, ù.i Atona. e che riptcuùerà, l'interrotto suo co1'SO ill:lerv izio posta le; .ag-giunge che H1 milizia Ga,· 1'ibaldi è tutta ùispersa, e cbe da qua,nto diceB i abbia, r-gli preso· la via di Genova.
Glol'io J'iprofessarmi con gli. atti del ben d istinto ossequio.
(Arch. stato rnagg . ·vol . 18, pag. D' 0RFENGO.
LE PRIME GESTA DI GARIBALDI l'l'A l,I.à, 1127
Torino .
TI 111i11istm di guerra e marino ul I'OIIUmitante dellll J a diri.vicme. Crrano.
'l'ol'i uo, n,ddt -l seitem bre 18 L8.
Il'a t Lo c·hr po rgo Y. A. IL d il' l i r1ti J><'l' tnt.to eiò ulre si (• c·ompiaei.uta di noWicmrrnl con di Cog lio <klli <mdant.e lllOLi vi c·lu• no nsi gll ar ono il ri<; hiamo a ùt>l b::tttaglion r ckst in:tto a Cannero e Uauuo hio, non posHo uht• apphmùb·e n l tuanif0sln.lo di vb;nmen t.o ùi rorwc·nlrar·c il più possibile l<• truppe tl<>ll:l Ili \ÌHÌOn<' da Lei rorua r}<htla, ri• ('hhtnla rttlo la bJ·igatu Pi r•erolo <' hr t a h:\lterht di battaglia a G a lliate c 'I'r'N·ntc•. e <'iùp<·i sa\'Ìssimi J'itlrssi t101l'l\ . \'. nrll'intNrsse li l'l sc•nizio l' d<•lla tnr ppn nwcll'si n w.
La dispc>sir.ione d'invio tli tnqlJH' irt Noval'a, ùi cui Blla mi fa plll'OI:l, /:> ('011Kt'A\ll'liZHt dc•l hiHog nu <•Jtp KÌ fCC<' ::;enLirC' dopo il HUG -
c• pduto JH'r pm·t <• <LPllu tn rppn J>ur un do, com'<>bbi post·ia l'orwr<' di mggrUtJ.diarnr Y .• \. lt ht> quali' lnq>p<r rit;evt•Hc• ordirw di c·ont·Pnt r·an;i i n '1'rino,1wr· C'ltÌ mi viPn r•ifl'l'ilo llal J.\'OVl't' llO di Nova m l'i H' c· o m iHC'ic•r·à i l :iliO :1 v \ hrrtll'll t.o ri parW Hlllt•ntc• i n t.t·c• l'ol onr u· di nomini c·it•t·a.
l n ltttanto al rontcnmo a tc·n<•t·:;i in \'l'l':iO 1<' trnppr D mando od altre• drlla divisiotll' mista, vuoi c•s..;('l'l' liUCllo <li una
J'i-.c•r•vtl t <'zzn. ond<' non mmwh i no tut t i li (')w clc•bhonsi nsm'<' a IH'l'sotw, per· lo piu l'si ranl't' uHi <lcllc truppe diHt'Ì plin:tll' c• goVPl' tta\ ,(• r<>t•olat'lllrlll<': <'pperò Km'ù sc• mpr ·e <l a. proc·m:ll·si eli cvitat'r <' il (lout..atto Lt•n. f,I'UJll><'
c> cpw li P l o rnh<tnle , 1H'OCu r·:wdo c·.ltt' :t oiò si riesoa O('.(IUJ)ftnùolo
l't'P q lH'rt l Pmt•nte cll an ti v<'ll<'rt do \ p <luindi. tl<'l c•aso c:lw nomnwf ta tw qna lche disorùitw, illtrttt>di:rtantPlll<' JH'O<'Pcll't'l' al di:-;nrmanwnlo ùei co lp evo li, assog-:,:t•llarli al meritato enstigo. O\ V<'I'O farli al <·nnfìrt<'. ontlr tol!liere al!li nllri i rtc<'llli\'O a ll a \li onot•o intanto della }H'<'S<' Jll<' occa!Sionc Jlet· offrir·c alla.\. \ ". l'omag-gio cl('} mio distintissimo ossrqnio .
T/intendente della JJI't;l'incict ài PetUcmza al ro mtcmla nt(' di'l/a Ja

P a lla tt:t. ;l, atldì 6 seLt.cmbl'<' l 8 l8
•\ll t>:t.za Reale.
t' rrdo di'l mio do n·n• d'infot'lll<\l'C Y. A. R. che le tmppt' :tu· slri<tche. giunte sttll a spouda lombarda del )Ia,ggiore per <·ornhattere la colonna Garibaldi. non si ritirate U('tl'int('t·no dopo la distruzione di detta c·olonnn., occupando aucor<lo i c·orntmi
112fi LE PRDIE GESTI\ DJ G ARIBALDI IX ITALIA
(A 1'('/t. HIII[O IIW[J[J. l'O{. 5!} , flll!f.
JhH OR'IUJ) \.
d i L:weno, Àllgt•J'a e Re:,;t·o C'a.lendl', JWimi dt•lht frontiera elopo ht traver:m dPilago; ciò c h e fn presumere che non l'itirf"lntlosi

Nu ll a lin ea d r l ' l' icino , pOI:lsa no avr.n• l 'intenz io ne la. spoueht sa.rùa fhlito
Ilo l'onore eli ron l'w u,.:i clPl piit profoudo t o
<li Y .•\.. R
(.lrrlt. Ht11lo 11/llf/ff. rol. 60, JWff· GJ9). Dl PR.\S.
fl <·omamlantt /11 t •l a l I'IIJ!O dt1llo stato IIIU!f!fio·re f/1'111'1'(1 / t·. Jl/ t'liNIIIIdl'ill.
t '<'l'ano. s<'ttl'mln·<' 1818.
); t• li l'ic·c·' ul:t n Y. H. T. dc• l suo foglio n. 111 i fo l a dt>hila pr<'llllll'll ril'erirl<' l 'adn.t lanwnto clri han·oni p t>r tm sporto d 'a l'!iglic•J'in, di end i11 t'sso H i tratta. fn tatto n ll on· hè, lWt'IHlo io rie·.pv ut o d a l en.po dello :<.Llt to mag-giore• dPII'm·lnl\la
l 'ol'( lil t<' ùi por t il l'C' d<'lil' ll'lllJJH' dc• li n. eli v isiotll' fìOt.lo i rni<'i 01' · dini C pl'Oh'l!j!e't'(' la H}) OIU[<\, dc•l ('01111'0 l<' ÌIIC'Ill'HiOilÌ
eli Oarib a ldi. muiidni 11H'7.Z:l hattt>ria dc•lln ta d i battaglia <·ol l!'" n lnlr a l' P allitu?.a. tnlplJP t•o;sptuln a Intr a c· Pnllan?.a , l'inl<'tlllc•nl<' <l<'lla pt'oviuC'ia l'OlltatHlc) C'lt«' :-.i mandn l-!sl' un h aL t:tglion t• c•on qua.l<•llt• IH'7.'l.O d'!u·ti )! li l'r'in. a t ': tllll <'l'O p ( 'a,nnohio, nomnni ld l l' pnr<'Vtl.llO pitt I'H poHLi nlic• g-li n.lt l'i; 11011 <'HKt•ndovi l'll t·ndc• p<'l' eonclurvi artigli<•l'Ìl' P t'orditi <' dt•l qu:nlim• gc•nc•ra le ù i pro t C'l!gt'l't' cpwsl i paPJoli t h·lla rei n JH'eci so, il e·olonuC'llo Holal'Oli a tar allt tirc• tllll' roni })<'l' pot!'r all'uopo tmsport:n·e· due• pPzzi eli c·nnnmu• :-.11 1 sito più m itta.('('in t o. OradiAca la H. V. T. i lll'lla 111ia piìt distint a ima l'pari <'OllHid!'rrtZll)ll('.
(.lrf·ll. Ntato?JHlflfl· 1•ol. 18, pa!J.Hì 35).
Dti-'\VOtA.
Dal fJfll't'/'110 gcntrale tlt •lla di Xizzu ul ministro di yuerm t' nwrilw.
\ir.r.a. !l
V. li uofo gn<' JTig li <•t o (hwibfddi vi<•tH' di in H. lJOl' l'llZO d<•l Vrwo. C'd avendomi h!Mo inleqw ll nn• avrC'b lJC' JlOt .uto lihcrlmentP porlmsi in io riKp o nd<'Ya non <l'l'l'(' a di lui riguardo alcun orùin<' superiOJe , <'solo HapNuc qnanto c·rn stato in l' rrto iu un art iC'olo elelh1 Gazzetta pinnontese.
I o mi ascriyo p<'rhtnto nffìcio di tanto pal'l('<'Ì·
pa.r<' l'li V . E. <'011 preghiera di yoler mi cs:-;cre C(lrtc<;c di sprria.LP clir rziottC' non <;e Hzn. r· ltr· <l<nilHtlùi
LF. PRDII': GESl'A DI G.\RIBAI,Dl IX IT-\LI.\. 1129
1130
DI
IN ITALIA godendo eli moltll POl>Olarità in questo paes<'., sua, patria . e ma.g::;ime ft·a, la numet·o:;a classe degli uomini eli mare, io non saprei se il tifhtLo (li ammetterlo possa. dar luo go a maggiori disordini che la dì. lui ammiss ion e, <'Onstandomi già che molte persone sonosi recate <t v.isitarlo e qui comi n cht a destarsi qualch<' inqlUE'tndine.
Ho l'onort> <li riprotel'lta.rle i Reusi. del mio ossequ i o.
(AI"ch. ili StcLtO- 'l1 otino). DE SOXNAZ
Da.L com.(.milo generale il ei ca1'alJinie1'i 1·eali o l ministro di guertct e ?narina.
'l'orino, J 2 l8il8.
Nella del lO a tl cl:tnt(•, V<'l'f'O lf' Ol'<' 7 lh, giu ns e ntllla, riUà <li NizzA. il generale Oa.ri bu.hli. G iunto a St. Laurent {P t·anoia.) sorisse nll'!ignor gov<>t naLol'e di Nizza p<'r conoscel'l'H\.' non vi fo,c:;se opvosiz ionc <1,1 <li lui ingtesl:lo tl(),i regi Rtat,i. Il govcrna.to t'(l pl·oscr isse a i '<%\l'abinit>ri di gua,rdia a l del Va.ro di nonlal:!oia,rl o P<'lt<'l ra.re H<' nor1 m uni Lo ùi recapiti, cd a.l triml'nti di Ri no a lrì c<•v(>re dei suo i ot<l ini.l l Gm·iba.ldi sn qu<• s ta noLlnc<vziom• rC'trocc•ù ctte a Hl.. };au r·ent. ù'ontlo gli ftL rntLo :fMoiLà. ùi giuncr<'l'C n N i r,;,a, un'ont dopo.
Si ùi<:e nff(•Ho da giomi <li grav<' :t:cbbl'e, c (•he il 1Ptto.
Ho l'onor<' ùì r•iproi'N;Lm'(' V . gli aLti del mio ri:-<p<'t t.o. (Aroh. <li StGito - 'l'orino).
fl, <·omandwnte tnititar'c provincia di l;;. Remo ttt go verno delta provhwia di 1-.Tizzn (L).
San nemo, 28 settembr e 184R.
!\'li fnc(•io cfl.tioo di con Otle.rtziahul.'nte informa:t:e l 'E. V. che il g iorno 26 andante mer:>e fl. Lcun c J)erRone mi parteciparono esser giunto pe1· il <' Oniere di Nizza , nn gc.nentle con molte de col·azioni , P c lw dcsitleravn padarmi; lo al la l)I'Ìtlla credetti abe fosse V. <'mi recai tosto all'n.lbergo él(> Ji a Palma., dove• il medesimo aveva (sic); ma. qual fu l a mia HOrpresn. allorchè riconobbi essere il così detto generale Ga riba1rli, ch e ma,i eli fA>rmi chi amare, ma che ta le vrovenzione fn solo officiosità <Lell 'oste!;sa. rhp mi fatto partecipare l'arrivo di dett.o ])ersormgg io!
(l) Annessa. t\ lette-ra del governato:re di Nizza. a.l ministro di guerra e mal·ina., in d a.ta. 29 settembre 1848, n. 6515 - Ufficio Polizia..

LE PRIME GESTA
GARIBALDI
Trov<Li all'albergo, a com p l ime n tar E:' il Garibaldi, il m :Borea. il s ignor ronte Rovt>t•izio r<'gio sindaco. avv. l\fn>;sabò c Amelio, il signor Sartot11'1 <·apit<tuo dE'l porto. maggior ùi piazza Boglioni, e molte n.lll'e lH'.Cr;o tw d(•IJe pi\t p t onunc.intc 1wr il nuovo orcli.n<> di c·o-;e; vi er;t p\UC il ' 'i ce-ronl'ol<.> di h·anl'ia. Nl il cav. ..1.\ug<>lo viec-consolt• di Spagna, t11l<'sL'ultimo amicissimo c·ol GnriiJaldi, <>n tram bi uomini eli marr, il qualc• [ree tanto eh<> lo tmtt<>mw due in questu c• lo ft>C'!' allOf.!· in <'asa HHa•.

In tale fra t tc>mpo si la voc·<> p<'t' In citti\ d<'ll'an ivo clt•l Ouribnldi, c·h<' si radutH'I tosto nna f<>lla di ]Wt'sonc awnti all'.tlbet•go snddetto, gridando pi\1 volte: << OnJ'ihaldi
Qu ei'! li si f\ffarc·ii> al halcotw t> li ringraziò; indi si 1 t.><'ò a eh• l di J.1ui amico c·av. Pc•Hante <' sempre (\Ott l'ac·c·ompa.gnamento clt•lle pcri{Oil<' cht• Hi trovammo all'allH'rgo, ol(,rc In folla clt•l le pNsottc c•hc• Hi tl·ovavano nt'lla, slt :.uln, t•epli(!<U\tlo l<' eli : « \ ' i va Garibaldi, Pio IX, l ' inùiJWtHlcm:u, italiana. •>.
(:}iunto alla porta d('lla c:a-;n. del Pc•xant<•. io bo pnHlenlt•mentt• pt'<'}!O commiato <lal Oat'ihaldi l'mi t'itit'floi; t' ù'allcmt in poi non l'ho piì'l vedute,, Ho twn) c·lw <l'orclrtw ci<'! Hignor HiHdneo g li fn :-;omrninistmta una gtun·clia d'onot'l' eli un l militi. Cflllth• il tl eLt o Olwilmldi lnL t.c•nnLo t.utt.a ttot .Lc•; all'indonHuiÌ gli fu poi solo xomminiHlrato \tl\1\ .'Wiltilw lla. , \llt • Ol't' () dC'lln m <i<'ll i gli fl•t'<'l'O, la b:tndu ci vie·a eli q tH'sl a t·i Il a. un n, Ht'r<>nttta, av<'ndo in quplla <H·c·.af)ionc> il Oarih:\,Jcli di tluovo p:tr· lato al pnbhli<·o, c• moltiiHclin'· g t•ithtva: \ ' ivn Oal'ihaldi. \ "iva Pio l X, Vivn. <'ari o .1\1 h<'rlo N·c·. Il l1t Lll1 tH• re\ da qnnnl o mi fu riferito, nou sttc<·edettc• a,leu n diHol'<i i Il(' d i sorta.
IC'ri poi li ufTìC'iali tl<>ll!'l milizia c·ontunnlc•, il dic>dero un pt·a ttzo nll'a lh t>t'g<' clt'lht J>nlma al O:wibn.ltli, qnotizzandoxi un tanto radnno, e da qnanlo ho inlt''<O H · <lit·c•, oggi llevc partin• pel corri<•re alln, volt:t di Genovn.
Tanto mi m·t•do in dovere di t'it'c• t•it·t• V. on<l<' Eli:\ Hia n l fatto di quanto <Jui rbhl' hwj!o all'at't'iYO <lt'l Garih·11di, <' ml'ntn• pt•t>giomi cor.
(A 1'('11. di ilfnto - Toriuo).
Bel orn nn hl'ev(' commrnto. ** *
C'R.\ \'ERI.
11 26 <l'agosto in tra il delle• Jì:unnw rh<' eire onda no la.11ic•rol a, Yalorosi\ -;c.lli<>m qua!'i una << », !òlvauis<·<> una prim<t \'Olta il lunga.mC'nte e tt.rtlentf'm('nt<' da CaribahJi. ili (•!),('('i;1,1'f\ da,U' r L,tlia (t l 'ab orrii o nit•ro •>: allo ::!lesso modo rbP il tf'u tali vo li<>t n meni<> ('o m; n da t o tll'l mat·r.o dalle armi llOflOl:wi l' fll'OllPI!uito poi ron 'arin 101 tunct
LE E'RULE GESTA DI (iARIBALDl IN lTA tJA 1131
1ln.llf' a1 mi regie, era, tr on cato il 4 agosto miseramente a l\Tilano, J)<'ì' l'incn.pacità, ù ei .r.rmdoWeri, per l a d efezione a1lea.ti c p<'l' la. mancanza d'unione c'li t.ntti gl ' It a liani in una la. rede e in una sola Sp<'ranr.a .
Ge:u·ibn.l<li, l'ni. il 'seu:1 im euto della c·oncor<lia. nnima.va , gi.uni:ìe non fu ascol tato . non fu ma era c•he c: osì f'osso 1 1H'l' fol'r.a delle cose e dell'ambiente .

Garib;1 lcli, nel 1848, non p iù, è wro, nno per gi'It.a li a.n i, ehè anr. i nel 18-1.6 era. sta.t::L in Ha.lin. un;t pnhh li ca sottoArrir.ione pe1 offritgli una . d'onore (l); DUl q1H'stn. non (Wcva rnrcollo, uegli stat.i :::ardi, c he 757 a dPrcnti c in mo l Li em il dubbio rhc le gef!tn. accadute in <tu cl lon tano pae:-;r foF;'3el'O state , co nw S1)CS:40 HI1(\C<'dC', iu g ig!ln1;it<> dalltll fa.ntn>; i a n<>l l 'a.1.tnwe1\'fLH' l ' \tl:tnUeo.
Si noti aneo rn rhc n.dht ru.o(loltn. drlla piemontese tk l J 8 l8 una rolt,, sola. s i ne, m i nn Oal'ibaldi: c niò per ,w•contat<' 1<' eontrib nzio ni impostl' agli nh il nn.Li ùi Aronn .. L rh i'n'<ldcz?.:a co11 h1, qnalc il R(' ac(:O l!o\t' il rNLuee dtbll'.Anltwic<L dlll lqne il s<'ntimento della nìaggiol'anza, drlla povola?.:iou<> pi emontese. :-;t" nLim<'nto ch e n,pparc ft'Ntn<mt<'m<' ltte anc he tllti clonu' ll <mti l' ip ortat i, nC' i quali)(, :M 1tor i tà eomnnnJi si llC'II<' J'<'quis izioni <l domAJndl'bno ]lro'Lr r.iOlL(' <lont r o CV<' ll.f,nn li ritorni d<'l gtw ni g li cro. V'è LnlffwhL anr h c f}lltl•lohc l'ftl'<t [,meda ùi 1';1 · voregght m cttto pcl' l u, pie <:olfL se hi<'l' <L c ill'ino cl u C\c 1 lll<l· poc:o oltrP i eonfltt i (l cl ]Jl n.tonismo.
J.,a. m<nl.<·an?.:a di do tatlll<'ldi n.on di mcLLNe in c hi Mo il mot.ivo lH' l' <m i Oaribnldi. H<'l co ll oquio di non ottc> tm e <li il })<l('H<' << fo!Ott() LWHHLlll Lito lo >> . ( ' ht> l'osa. <: llÌ('·
ClH' cos<tgli V<'ll tH' 1:illuta.to'? i\ g- itHli C<Lrr tln l proclamll, d e l2 7 l ug-lio, C H()OO IHL O <lllHlltO :') Ì J)UÒ H l'gU Ìl'(' <hti V<tl'Ì t> d al la eg- li vol<'V<I• or·g-ani :4za.r<• un I'OI'te COl'j)O <l i vo lontari. p('r MmbaLtel '<' r.o 11 fi tM.l.clo ù (>ll'cser('.i t o reg-io. Orno, in ht gli.o, I. 'Nìpcrimento ùei vo lonLa.r i ct·a già, stato tatto ed in massima vartc era :tnlliLo. I doctLment.i c i rapporti couccrnenti l 'intem campagna l'anno f f' cl" d Pllll c·!Jttiv<t 1wova mente iatta, 1nu· ponendo i1t ltt cr le lode vo li ccce:cio n_i. Più r ht> la di.ffidenz<L co n t ro un ex-cond an u ato morte dovottP quindi poter e la. sfitlucia in una in.. che avPva. d ato sino a.llor a cosl ma.g ri risultati. E l'avparecehio dei Yolon.Lm·i, clt<' <:osa Em l)o:ssibil e che il govcmo san lo desR<' fl Gar ib a lùi quel comauùo di corp i regoh,ni, c lw invano egli a,veva. pdma <lal go vcmo pontificio e ùa quello toscano '? :i!l prob::vbile che questa ipote8i non sia. stata nemmeno nel
1132 LE PRIME GESTA Dl I T ALIA
(l ) Rivista. del risorgimento, I, 321.
l-'lUMI•! CH,S'rA I H 'lARfD.t\LPJ. I N J<r,\LlA lli3G
t·oii<Htnio d i HoYerhelln: e OJ!I!i i JW>llt•ri. tonos<"cndo '<·:·nIIH'Ille ehi fossr '' il noto gnt>nigliem •> od il (< con»a})uto Oarih<tldi », aVl'<•h lwro JH'< •I'rriLo òi ' ' ''di'l'l' In i ul posto !l ol (10111<· di nou si può ll<'IDtn• f'lw allora una simHt• p1·oposta p n r:-;a una hnt'IPtta.
quanto poi all'impossih;titù tli s Pn in· la «so Lto u••ssull l ii o lo », i fn.Ui non la. ronl'<• rn mno, voi<"llè da l 10 a l a'ost o Il' tru ppt• 1l t> l gi'IICI'al<• Gari l mId i sono <'UIL'-'Ìtl<'r:t t" C"'lllle p a rll' clcll<· l'orz<· :t :.,:n;n·dia IIPl 'l'idno t• il c·apo tlPllo magJ,!iore
UÌl·lli<tt'a <•hp I')(H(' th•hhOilO N!B<'I'I' ll·j)IJHl'l.t·
JWnli ali<• lruppt> lomhanle t· dip<'IHlenli d al geJH'l'<lle Oli vi<>J'i.
D<•l l't•sto . anl'lw a \lilaltd Oal'ihalùi non lron1 l'appogj!io drt•
<I.V I'I'I>I}l' l'i\ll'mto; il J!OVI'l'ltO Jll'()\ VÌS() l'iO lo hensJ, filH', ùi <·ustiluir•t- una. a Bt•q,!UJllo; lll!t, pur<' pl'l' lt•
IIH'IIt• d<·l Sohr·t•J'O. non gli fac·ililò ìl t·ompitu t' mal<• lo prO\' id<>
d'aJJII: P di H•sliurio. E di fatto t'h<• :1 lui non 1'11 <tt•c·orclntn rnag;gion• t ·OJtsidPmziout• di <·hn I!<HI <•ss<•. pPl' c·scmpio, il ' lll'iiTiui. il qu:dt•. HY<'ndolo pn•t·<•dulo udl':tzion<• t•d lnd<'\ollllPIII<· <·onfporl'tto, t•ra <Wt·ap:tt'J.tbl la litllu·in dt•t•li si<'HHi t·npi d<•ll\•st'l'l·it.o
L':111Jhi<•u!t· t' iluJOtllt'JJio JHIIl t•t·ano dunqtll' tJ·oppo l'avon•\oli aii'ÌIIl}ll't'Sll; ('l'Osi sl:tllt!O \(• C'OI'il', JIIIÌ> f())'S(' l'l 'l'<! l' llll'l'tt\ ÌgJin \:1 diflld<•llz:t d<•llt• nutorilft militari t• politi<dH• verso (Jarihaldi!
Il JII'OI'lHJJJll poi tlc•l a.g:o:-;lo di've• ll<'l'<'ssl1l'Ìliii1Pil( c• t:ll' l or·o lo :o;l<•sso pffpl(o dtc urL panno H)?.ilalo innnn:!.i ati ,m loro t• rih:ulir·c• ogni :->tll'b t li sOsJil'l ti.\ ha <li t>ilt. La rh;olnziouC> c•:-;tn•lll<l di (J ari hal d i t' pt·<•stt ir LIIH molll!'JLio, in oni l a Hlllt sc hic•ra ,. c'onsid<•J·ata ('01111' J>lll'lf' d!'IJ't•s('J'l'ilo l'(•giO: J'afto Sl'llllll'Hi dtiiHillt' tliiH ' iolazimw di'i ]la l t i <· c·nm <' t a h· 1\ c·ou l ra rio all' ouor m i li t a n•. H<'ll7.a <'Oill:u·p <'ht• JHLù olfrin· :t l l'.\mdrin {ll't•tt•stn di mii1JH'I'<•
J'a, J'Illi:s(izio. I'Oit (uLtl• )(• l:nta li C li P Il<' hPJ'o al l.>t('llWIII<'. il qual(' slu nu•dkandu 1<• ft·rill' <' appun•<·c·hin ndosi a uuo,·a loti a.
Qli <'Si.(' gl': l V i t'ii'COH1 •l\.JlZ(' HO IlO IL li ('l w CO llllliLJO VOllO !H:.tggioJ'tii<'JJI<• il J'<•. i mini:-;ti'Ì <'il <·apodi :sl;do maggiore• d<•ll'<•s<•rc·i lo, <' IHUO\OIIO a stleguo il duc:a tli <:<'110\'U. eulll:tlHlantt• cth iH iOll(' l'H; l' la gu;u·tlht del Ticino. ggJi <•h ielle di fatto il l l agosto(< ptOV\rc dillJPiltO >),l'il lr• ril'('V<' ÌHc·;u·ic·odi prO\ ,·edct•t• ac·tbè « twl pii1 br<' v<• ll'rmiut•, con ziuni <·tteq!irdtt• HO!\ disg-intttc du mi::;urt• di prudPIIzn, si ponga tut (,pr•minc a ,.;iffatti di Hol'din i •>, C\on L\·wvcl'L<'nzn, eh(' <• l'ilH'l! mbrnza (' ùelil'a la (' non ui diflicolt:'l l' di qua l c·he pE'rito lo >), :\la Il' disposi?.ioui d'animo gi<H HIH' duc·a (l) si nmno rnpi-
(1 ) Ferdint\mlo di Savoit\ era nato nel 1822.
B .\:'oNO Lll

thuul:'ntP mo<JiflNmdo: il 16 riferisce ehe h\ Ltnppa garibaldina i• disc·iplinnta rd N pone l'avvi<Jo c11e, qualora non C\Olll· Jli'C'UWtt:t il t o Ù<'ll'arrui,:;tizio, lf• f<Ì lasci rare. a proprio l i<' ]H'rirolo , ciò r lw vnolr, in territorio 'Ricevuto poi <hll Hnln.sro l'ordinecli proc·Ltt'ltl't>tli riprendc•t·<'ih;t1lt•llirtvn.ll0l'<' 1>cl i hareoni, allo s<·opo <li ri tn•i\itinar<' l'int<>notto poxtalr :-;nl lago, il :-;i ac:c·ittA"<' a wevnntn• la :;pcdizionc; ma vi ri ttttn(• iu, il t'<' ahhi;l appt·ova.to <1lw "i lt>nli di ri pi:•lianw 111111, JH't'<'hf. sn]lt•ndo <•ss<>r<' i ,·,tpori \'i!!ilati. ,:;pa.rgP J'Pl?IH• iln.\i:tuo· P rtdhl lt •t,tl'ru (·.l11• rifel'hH'I' int<>n· d:ì lHll'<• notizi<' eli improutat<> ad t•vid<•nt<' sim -
path1 t• 'l'w.::i c·nrnpiar·PtHl nl'i dtt• i 'l'edl'st•hi non ahhiano potuto
<• ntlir•;trlo t\011:1 >> i\ Jn il fatto pill r lJlH'IòtO:
('}tp il]HOC'I:llmt di ('a1<1t>JlPHO, lltt'I1[1'C' I'OllllllllOVI' lt' Ìlt
),ottordin<•, 11<'1 tnlto indill'<•n•n1i il du<'a <li Geno\a <'il
1'<• f 'a,l'lo Albel'to. tant.oc:hi' il IO st•t LC'tnhn· Ot>tiha.ldi, :td on1<t
1•lw il g-owrno av<':o;!o\C prima divisnLo d'imprigioJu1rlo :L ( ':H;M<' <' so ti 0\)0rlO a gitHli;do, è O [orna n• liheranH•ttte <l '\ izza.
! 11 I•OJnp l<>sRo, fJiti'St<t, pl'imn, i m pt·esa di Onrihaltli [u trn. l1• tlttlll(l fmt unatr. poic·hè non :o;<ll'[,) a lcun l'isnltnto l'ffiCul't', l>OsP imbarazw il go\ c•rnc sardo t• molto l :tUo ci 'nlle da attt h<' lP lH'l' evitnro l'ciTnlìÌOlW di t·itt:tdino.
T/alba <l<•llit ..m nont>rn arwora, "Jlnntat:l : nno vì RaC'riilc·i, llltO\'(' tli'IUSioni l'i VOit'Vl\1\0. )) a parto piOitlOilit•..;t•. SOlt:\.nto lo Hfot·zo di s pern.to c:he con clu sso a, \ovn.nL poLova :tntmonir<' clw alt t'a nnionp, all r a pre]mt·nziorw mol'ale t• umt.Nink, :senno p oli tiro (quello drl c·onit• tli C:nour). altro spirito di (qnl'llo di re Vi ' tnrio oneonPvn.no p o r ri<lM'O patri a agl'Italiani. Da p:11 te di Oaribaldi. non <•c r·to mauca., u la d<'lla rw<·(•:-;..;ità I'Ont'ordia ,. 1lel :-mrl'iiìcio <lHtlc opinioni purt.ieolal'i por il ben;) c\Otnnu<', tanto uiJe cln. qneeto punto <.Ja1a lo in!\u.uahilt• Lra lui e 1\lazzini (l); ma era nei'C'5Snl'in una più n eH n. yi-:io ne •lei mezzi e l'occct. siorto di frtt'lli moglio couoHcere ù agi 'Ita li l'II Jti. Ci vo leva, iu a ltr e• parole, l'epi ca difesa di Homa (' la. non meno c•pka l'itirnia rlol 1849. Di fatto il generale Alfonso L a :Mat·mora, dte si a Genova. nel !-ìC lt ombr e tli quell'anno, a l D abo nnid a.: << H o visitato Garibaldi; h a bella fisionomia, 1t11 far ror.zo, nm l'm ne o; s<>mpre più mi <:lw in buone mani se nt' poteva trar parti Lo •>; e pochi !riomi dopo (< Oaribf\l<li non uomo (\OlliUlll'; h\ fisionomia, eomunque rozzn. è> molto e.spres;,;in1. P ar la poco l' bene: ha molta pcuelrazione; R<'lllPl'f' p i tr mi elw è- g itta Lo nel parLi to repubblicn.no pt•r
(1} GARIBALDI. - « Memorie nutobiobrrafìolle 1 9·1.

113:! LI•: l'H DIE G I·:STA DI OA RlBA LDl IN I T .A LI .A
LE PRI\IE (';f!:gTA Dl GARID \ LD! I TA.LL\ 113;)
hu t tersi c lWl'ehè i snoi erano rifitttati. iSr lo (\l'<•ùo o l' a t·evubhlicano d i principio . Fu g-rnvc er I'Ot'e non sel'Vil'I-Jl'n<•.
Oc•,(\OJTellÙo 1111:1 n uova guerra, è 11o mo da, impiega r e (1 ) >>.
Qneslo gindizio, wonunz ia.to 11t>l 18 l 9 dal che fn tli sta1o mn.ggion· del duca di Gc•nova. u.cquistn tanto 111agviore importanr.a. se :'i pOLt IIH'ntc ehe due anni dopo <' pr<>tisament<> il :!0 18:>1 Xitto Bi x io seri V<'YH a GNOlamo .Remorino, n p1·opoRiLo ùi una polcmi<1a tra Gnribahli o
Pisar:mr: <- Qmloli sono i fn,tti elw \·ogliouo mostl'itt'c•.i pN·eh(l
<< lMloriamo un d i (lOUvcnr.iOH<' ? Ri amo al tem p o degl' i -
<• l<'aUi c·i 'ogliono r non c·iarl<•. Oaribaldi pnò avere <h'll <'
« huone qualitn. lll!l quelle ùi nn gClll' I'Hl<.> non <'Cirto. l'hi ama il proprio p:w,;c• (]p,<' pensarci dn<> volt<· prima <li c·onhihuir·<·
« i nna lzn n• f•t•rt<· ripu tazioni. 1'111• la oria non <·ouos<.:<•r:ì
« <'lH' JlCl' j mali t•lt(• Il(' •> (2).
f primi )ms,;i kOllll Sl' 111p1't• diffieili 1 gli osl<Hloli LlLllLo piu j!l'll\ i qunnt .o più aJ f,:t <'la. tllèla: nri tà, t.ltl' lt.ll<'ht• in qn<•stn, nil•coHinnza i f;lf li <' rl.H• il somnlo <l!'i poet,i rinnla
1·o"l mira lliltn<•nll• nel Yt>r:.o. rit·on'l'tHlo il anuiypr..;:ll'io agoi'(O {:3):
IJII. libertt\ non ù fanciulla
Dn poco I'amc;
?l:fnl·chosa ella non ò cho in danza sc·occhi
.01\' tondeggianti memb1·i agil diletto.
Il cui busto offre il seno ed off'ron gli occhi
' L'remuli il letto;
Dum vit·ago ell'ò, dure dotnnndo.
Di pl'l'igli e d'amor pmovo famose;
!n mozzo al sangue della sua ghirlanda Ct·escon le rose
.\t.ngn-ro
C\ v H'IOCOHI
cniOIIIIClto di Ilo lo moqqfore
( l l L. CHtALA, ""Alfonso Lnmni·morn, commemorazione» . - Sron:zn, « Gàr i baldi in 'l'oscann ».

(2) Arch. della r. 11nivors. <li Genovtt, Carto d i Nino Bixio.
(3) CARocccr, Pooeio, 409.

I1A ClllCOSCRIZlONE niiLITARE TEIU\ITORIALE
sTOJUCO.- .\ routaf to imnwdia.to <lPllc• trnp1w stc'l!nno i coma1uli tetri/oria/i n ogmm.o dei qua li «peLLn l u gitnil'!dir.ione "u ll r truppe c• s11i "itml!ti i.n li mìtttte porzioni tlrl territorio dPllo Ht< t to, nwdi1mtc ht cil·roH('riziMIC tcl'ritnriatc.
Il fr}tzionatnrnlo geml'C'hiC'o dPl tt•nitorio qunlP l> ogg iùì presso tutti :.rli i. rio(> con una . rert a, roniRpondenzn. fra le grandi ltnilù t <•rt·i!ol'inli del t<'llt ] \0 di pn,c·r c•](' nnità mo hili d<'l t<•mlw ù i l! Il t'l'l'H, P n•la.t ivn mentr t·ecrnl<', perchè '<Ol'fH' r si 8v iltt]>pò i n !'loltnn t o do1)0 le gnrrt·c• napol<'O· Nl c•hbP la primn originr in Yrro P c·hp nn'origine pi ù antica può t•:-scrr rinf t'U.C'c·iatn nc•llc> instit n:doni di nonut, e non soltanto nella «ro lonia •), ma :\IH·lw 1wl faLlo c·lw . xia lr l'<'· e-ioni in cui t•ra d iv hm l'H <l li n. sia le pro vi ndr i. m pa1·utorir (con· pr<'!or·ian(l <' pt'ONnnlori<'). c•o ,o.; t.iLninmo nna cirr.mwrir.ionr acl un L<•mpo <' milifar·t•, almeno fiN·ondo dò dt<' o.;i 1mò argui t'(' dalle p o<'Ile l r:.lNli(• rimastt• l\(li do<·mru•n! i. \ loro volta i barbari, \Hl l' non a vendo una V(lt'a c• 1wopr·ia t•ir<·o:..c:l'izionc• LP l'· rilorialc. <·on gli I'SPt'<•iti di nnttltl't\llt'l'O HOnat.n piìt PIH' po" fd h ile In, ltH'O <'O 1n pngitm, !\Clopo di l<iourt•zz:t, ti no a. eh!' la ùomiml ,zio ttP non parv<' loro p ni, qnando1'o<·· r•upn1.inun l'\ Ì lu s itt i!Ò tli pt•rm uwntl' l' il popolo sfr:miPI'o not'<\Ò el i <'Onfundersi <·ol nazionale•. la. sovnutitì\ longohnl'da in lt alia, la HU\Tanil à l'ranc·n nlf rovi'. vollt•t·o Ol(tghd r·at tlt'l' militari nel paese <·on cnnlf t ere• vur 1-lCll lJ>r'<' mohilt>, le quali rompi<'l'· sero aU.r·cxl tttLL<• lr altrt' funzioni p;t•n<•t·ali d P Ilo Slal o: l' furono i dtt cat i. A rotnp(.'t'\\ queHt.o or·g:tn(•simo sopra' Vl'llll<' l'impero con il feuùalrsimo, prr cui il territorio nrltlò Hminuzzato HPnzn. JH'ec•isP regole, P solo <·on ln monarchia, in partieolar lliOùo con. la ft·ances<', ftt dato ri.lomarc• a,d un ordiunmertto tenitotinlc• vero e proprio. :i\1a HO Il fu qncsLO Ili\ Ol'Ù in.aJU('IltO h:t:-;n.to i c·ri · fer ì odiemi , tanto (\lte le Atcsse sc>ùiei divisioni t.Pniloriali nelle qua li fn la Fran<'ia eia lJui g i X.Y l nel 17j(i 1 più C'h<' sen Ìl'(' a sc·opo militare, "ervi.vano a poli t ic·o. i (\Omaucla.nti di divisione rrano più che allt·o goVPmatori (•.i\·ili t' 111ilit.:wi, e ne.<;snna conisponcleuza ' ''N'a l'ra l a. <l ivision<' tc•ni tot ialP <'l 'o m o· nim a uni.Là di I!U<'rra.• ht qnule. del n•sfo: fn <-rl•n ta P"l' l a })l'im a volLa solo llE'l1793.
La. circoscrizione militare odierna sorsl' dulH[lH' vitt l:u•ùi cd in Pt·usl:iia, essenzialnwlltt per il ricordo elle tloYevn

1635
163(i LA OIRCOSCRIZlOXE TERRITORI \I.'E rimasto degli eserciti fntuc<•:-;i di otc-upazionP : t> non fu dw l'applicazione concreta di un'idea tlw ave\a germog-liato nel eerV<'llo di "X apoleone T t> rh<> egl i non pot?> mettert- in pratic-a. pe r I!Hlnl'Anr.a di tempo e di opportunit.t (1).

<' ONSrDERAZIONI \.E"NBitJ\U Rl'L HR I{ \RCniCO DJ•j], 'I' I<:RRITORIO . - ;si' II C' ('01 \dizioui di fatto Odi<'l"I'U', IWS!10110 11011 <' in dubbio cl1e l'hlC'al<> di liiH\ c·ircoscrizimu· militart• territot•i:t le (luello in. t•ui fo-;se rispettata al massimo ::_rr;ulo hl <' l'onlill:lll\1'1\(0 di pile-t' Si lltY\riciuass(• 1[\1:\lltO piil fo'ls!• pol'sihile a quello di ttll<'tTa. :\fa {> e\idente a ltresì rh<> solo 1111 tl•rritorio perfettamen!t• e C'-'SO "tesso potrt•hl><• permetter<• di t·onsctntin• uu simile itlealt•: 1•d atu·or;l non snn•bh<' sullì<'it•n.tt• interna. nHt o<'<'OtTcrt•hht eh<' i tliversi contìni dt'l nwdc>simo sfato r:-tpprt'"<'ntasst•ro }Wl' ('sso nn ngnal di min:M'c·ia.
Ili JIÌlÌ l:t 1AtTitol'in lp deve tetwr c·onlo t li un :t folln di di vnri o or<litw ,dip<'ndenti d:l rirrol'l!lllz<• po liti ehc•, dalla rete sfm cl a lt• t' ft•rro\'iaria, dagli ost:u·oli geogm flc·i. dalla rircosc·J'iziont• nnuninistrntiva: siC'C·ht• non st pnò imnn mo<l<'llo, hnono JWI ogni raso e }ll't ogni p:wst> . possono invec·t• rit·prc•an· ah·um• rondizioni g<• twntli l' eli lll:t,sitna <·ni ne('("-;s:ni o -;otld i sfn l"l'.
La •·irc·o-.rrizio m· milita n• lNri l o ti al<> <li m t Jl:H•st• altro non t • l'lw ln ripmtiziotw dpliPITitorin naziona le in frazioni, c·m
I"ÌHpOnd en t i ai VHri j.!l'lHlini dt•lht }oj 1)0ÌC']H' g<•·
I'<Ht'l lin trC' muti, il di sc-i ]!linare, ill<'l.l\ic•o c• l'ammilli Hintl i v o, c· h c non lo:t>l1l ]l1"<' HO tl1o fusi tra loro, e riguar d :t lrupJl< ' <' s i\f'\ i:d val"i pt>r nnnu•ro t• qunlit:ì <·non st>Ulp t '<• uniformc•na•nlt• cli st t·ihuiti su tutto il lrtTitorio, lH' clt•riv:t una 'arieta rin·n sc•rizioni. t•he mirnno a clin•rsi e tlifferi.scouo pnn',Jll'r rapnrti<·olari, da pat-s<' a pae:w. I n linea getwra le si lHl<'l soltanto aii'Prmart> c:he ilpiìt perfetto fmzionamento .!!erarchit•o tlel lt•tTitorio sarà quello dw tra h . • c·irco-.crizioui mnggiori e qtwlle minori serbt>r:\ tali proporzioni. C'lw l P relazioni rispetti\ c eorrispontl tmo Rlla st•mplit·ità t> siano eYitall quegli inc·rol"i di a l tri buz ioni e di ùipe>ndrnz<', pei quali può andar<• smarrita
HP t t,a definizione tloll<· 1'('8ponsnhili t à.
l n altre parole, xi tlov•·à CO it<'Cd('t'P che il terreno eserdti, sull;t d h; t ribn ziout> delle h·nppP <• dt>i sen izie sui loro raggruppamenti. qtwlla 11aturale infiueuza <·ui si di'YI.' nect•&Oaria.mente sottost.trt•: ma si donnnno rispettare in pa.ri tt·mpo i princ•ipi cht• st•n·ono 1li
( l) l o avev3-lungamente il progetto di ripartire la Fr&n cia in venti o venticinque distretti militari, che avrebbero costttuito nltr ettaute armate L..1s « )!émorial de St. H élène », \-1, 323.
LA OffiCO SOIUZlONE MILITARE TERRITORI ALE 1637
h;h-;e aù hnoua costiLnzione della. g'l'l'U.rch ia, sonza l'im aucre vi11colati Ila. preconc<>iti di 1-1immetria o cl'a lt1·o g<>nero rhe impedirebber o il pedetto atlaLtarnento all'ambient<·. Per esempio. sarà vauo il discuter<> tt•oricamente st• sia prefcribUt• il piede mohile od ilpiNle ùi gnarnigion<'; sa1·à itwcc·(' più pratiro il wcler<', !'HSO pPr c•.al'lo, quale tlei chH' :'listcmi d c•hhn, es1:1er e mtt.nralmeuLP e com<' si po::;s;t, lH'll'applicr\tzion.e, ric:avnrP d n,l c:ui siamo vincohtti i trntt.i migliori.
È ovvio cbc non è pos-;ihile che frazione th•lla (·in·<lserizione 1-(('Ucralt•, t'òrri-;pmHh•utc• ad m1 ('omando di c·cH·po eli arma,t;, , o di clivision(•, eomh;wi perfPttlllllf'Hte con ogui d !'lle a.Jt l 'ti t:iJ·c·osca·izioni o Ill' c•on l!H'<'tll ln t\l t ntulwro ÌllL(Il'O; ta,· Inn o l'('t'l'zioui sono uc•cc•s:.:at·ie; quello <'11<· import,\ i· di c•vilnt'l' lP t•c·c·c'zioni nou t• di l<•ncr pn·scllll' c•he la t•in·osri·iziouc• d<'ve ed esseuzialuwntc• ai bis ogni del tc•tlii>O di pa.e<'.
h l Italia, Hl l R97, ht cdrc•oHerh:iom• milit::vrc· t cm·itor·hth· t·i· lll<tsC' fissa La P<' t' 11sta In. t·cgoln sa nei t n, dal <l i· ritto amJniuislmtivo c·hc• • una ragiom• tl'<·xscre uutmwnw e in (< ti ipellÙ<'ll te.• non votl'à a mmett <'t" i pc•r ll<'s'ltllla ti t'l le· · 1• zioui (P !Ti (o r ia li (l). <'o n In l<'gl-(<' g;i llJ!IlO '07 si dt•t'tii-(Ò invc•c·c d n, quc•Ht.o JH'ittc ipì o, ciH• lu, c:ireosc•.riziotu• 111 ili turo l Pl'l'iLorial<• llov<•sso èHH<'l'C d<•tt1 t'm i un tu pc•t· cloca·pLo t·pn.lc•. Ad ngni tuuclo t•osì f<teemlo si l' scm]n·e nel c·;t mpo dt•lla ro stituzionc•, P<'l't'hè lo slnlttlo (urt. 71) pn•sc·rin• solt.attto: (< r,c• « inslitnzioni c·umuuali <' provinr.iali c• la t'irc·ost•rizionc• dt•i ro <• munì c clelle JWOvit1dc souo l'l'golate clnlln l<•ggc •> • \. nc·lw fm lo c:ircosrriziotti poli tic·.! w, n.mn 1iniHt·m t Ì\' <' c• 1-!;Ì utlizhL· r·ic• <· qm.Jit• ntilit;u•i ::;art•hlH' drsitlembilc• la perìt•t!H c·otTispontlf'nza. in modo uhc entro il l<>nitor·io di ogni tlh•isiotw fos"l<' com · preso un JUttnc•ro intl•ro tli pr()yinc:ie ('clL•nlro das<JUH't i srn·Ld puhhlir.i fos:-wt·o eon c•ritl'ri a.naloglti cliHtr·ihuiti. Siamo lotttanì
J n, idt>alt>. <( Ln, quist .ion<' ue lle eirt•oscrir.ioni dc•i "letvi zi <<pubblici (o forttlamenlalc. prt·ohè clulln sua soluziom• dipeudc "l'impianto n•golarc Lli tutti gli ordini ammittistnttivi. L.t catL"a

« p1 inw c·onfusiom· l'h t• rc•gna nei nostri ordini anltllini -.;tr·1 ·
«ti vi si devt• ripE:'tere appunto tlalln munc·anza di tum rnzionnle
« c:irco scrizio ttc tcrriLorialt· ùcl regno. ' l'utti, o quasi tnili, i ser-
'' vizi llanno il loro speciale territorio l' le• rirroscriziotli rdative
« K'inc'l'O<'iano l' si acca> alluno tra di lMo •> I'Pr c•·wmpio, il miristero dellt' fluanzc• ha diviso il lcnilorio dc·I l'l'l-(110 in ben ln•dici cit·c·oKc'rizioni cl ivprsc•, non eoiN·itlt•Hli.
( l ) Btl!CI'l'0 1 t Istituzioni tli ùiritto militare , ?a.
' 2) M11RCUt:T1't 1 Nuova , anno n, n. 21, }Ing. 104 - Mi NO 1.11.
In Italia, ira i criteri seguiti nel fissare la circoscrizione militare tcnitoriale, vi fu bensì anche quello di discostarsi il merto possibile datla circoscrizione in modo che IWl territorio di ciascuna divisione o almeno d'o gni corpo d 'armata fosse compreso un numero intero di provincie; ma lo scopo uou potè, per altr'i mot.ivi., exsere interament(.' La. ùifficolta di adatL.<tmcnto dipende dal ratto cbt' la vigente ne amminist.rati' a ancora quella delle anticl1e provincie quali eKistevano prima, che fosse compiuta l'unità italiana. Lo di tradizione e di particolarismo. aiutalo dalla burocrazia coru;enat.rice, impedisce che sia, mutato uno Rlato di cose, che ct'rt,amenl c non più ai di una buona amcivile.
TJA OllH.'OHORIZ!Oi'\g pgn !:L SERYTZIO T'i
T'I'\LL\ 1·: TC OM\'< DI DI CORPO D\RM\T-\EDIDf\'1
!HONE- ln Halia 'i n. o 12 com Hl li di corpo <l'armata t erri t oriali c 25 comandi di division<' territoriale.
r n Germania vi !\ono 22 territori di corpo <l'armata (numerati
<la I u XlX e 1. II, l ii buvaresi; il c·orpo della IIO!l ha l<•rrit.ot·io). I comandi tli non i':OUO <·omandi terl'iloriali.
l n ,\ ustrh1· e vi sono 13 m·u1di lt•nitorhli di c· oq)o d'armnta.]wr·l'eil<'t'<·ito eomuue e 10 comandi di dhi.-.ione o di dieli Lrmdwchr; (!\lt'Sti nllimi, in 11011 luulllO al· <'tma r<'lazionc col <•.omnud o terrilorinlt• dell'c•:.;ercito t'Onuu\c.
In Fnuwia vi HOI\o 20 eli c·orpo d'armata (c·ompreso il "X l X ù' Algc•ria <'d e... duHo il XXI, <·orpo <'olouinl<' R<'nza ter l'itorio speciale•). piit la autonoma di Tunisi. .\ c·it·t·oKt'r·iziOill' va ]lOi <tu<'lla dei govemi dr t• <li Uon.c: a queste autorità tenitoriali, non dovr c•blwro, secondo h11 Jegge del 1873, esserv-<'nc• In pratÌ<'a :H·<"aùc• <liYersament<.', come si dirà ft·a poco.
l u nè il comando di corpo nè quello di ùivi..o.;iorw hanuo attribuzioni territoriali; per quc-;te xono istituite• 12 gra ndi cireoscrizioni e il tenitorio dei cosacchi tlel Don. tm (•ni sono ripartiti i 27 corpi ù'nrmala allhri in 2 nt'l Ca.ncaso, 2 m•l T1Lrk estn.n e n el T.ran-;caspio) a i 2 corpi d'armal:\ di cavalleria.
In Svizzera, sebbene l'esercito sia ordinato su 1 corpi d'aL·mata ed 8 divisioni. in tempo di pace L'\ cirCO$Crizione I><"r il servizio generalo comprende solo 8 circondari di diviSione.
lJimitandosi agli esempi citati, più cbe bastt>voli allo si vetle che dappertuLto, eccetto che iu Italia., vi. è. od avrebbe dovuto esservi, una sola. autorità avente attribuzioni terntoriali di generale, cioè avente sotto la propria. gittriqdiziotu' tnt-

1638 LA
MILITARE TERRITORULE
Le h• truppe e t.utti i servizi compresi nella cerchia di un dato tt>rritorio. L 'Austr ia - Ungh<'ria nemmeno costituisce utl'ccce· zionc, perchè l'esercito comutw e la L and"Tehr sono complcta,menl<' separati. salvo, in Allsf,ria, In dipendenza dci comandi di div. di Lw. dai comandi di corpo d'a ,rmata dell'esercito eomnnc.

l n Frnncia , secondo l<• ggu 2 1 l11glio J 873, il collln.tulo del torritol'iO apparteneva solLlm t,o al !!:Cncra.l<> comanùa.ute di eorpo d 'arnH't.tn.; rw. risnltavn, di e(> il D cbt p erricrrc, una troppo gnHtdc n.ltlucnztt di questioni miuul<• dtL r isolvem allo stato maggiore cl<•l corpu d'at·ma.ta, e per· i gt.•n<•t·ali di divisione e di llll nochTo da Lutlt• lo questioni di mobilitazione.
P <'l' rinwdhtn• a incottv<'tl.i<'tlle, l'art. 18 della lt•ggt• dt'i cpmùri (5 gcmulio 1 875) confidò ai generati di divisione<' di hri· gala l 'es erdzio del comando t<nTitorialc, soLto l'autorità cl<•l coIIHilltlanll• di corpo <l'tlt'ma.ta.; tale <·omando vicn loro conf<'l'ito uwdìnnte dctcl'lllinar.iotw miuist<•t·ialt•. Di mn.ss inw., ogni geno· nt.IC' eli o eli di osorciLa il conlftndo l<w· t·iLot'ialt• di qtmi.Ll'o o dtHl HttdclivìHioni di rcgiotw, dovp si Lt·o· vano l'ipat'titi i quattro o dnt• l't'gginH.> ttti della clivisimH• o clella hl'igah1.; se questi roggitJH•nti distaccati fuol'i d<'lla t't'· gionc, ilmini::;tt·o dt>lla gnl' t'l':t lH' <·<mlilhl il f•omauùo a f.!C'ru•rati di <·uvall<•t·ia o d ' nrtig lict·ia resicll.'nti IU'l tt•nitorio corrispond<'tll<'.
l JC' t ruppt' l'E'Siù<m ti JtC:'i l<'J'I'itori li a i goYt'J'IIÌ di P a· l'igi t'di l,iont> f\Ono J>OHtc soLto l'autor·ità. dei gov<'rnntori milil!wi dal punto di vh;ta del s<•t•vir.io di pr<'sidio e della disciplitUL g<•· twr·al<•; ma diJwuùono d ai loro c·outnndnnli di corpo tl'at mat;u,, sot.to ilmpporLo doll'istrnziotw, d l'Ila di!iciplinn. int<.•t'tt:t1 dt1l tHW· ROJHLlo <' <Jell'omminii:!Lra?.ionc• (l).
Hi V(\dt' d UJH]UO eomc in ll' r• an<• in il xist.c·ma vigente Hia il ft•uLt,o di una c·ontradùir.iouc l<' gal<>; in l invece dcrivn, dallo l'pit'ito di ll'a.dizione. il qual(• f<'<'<' Hì rho dai comandi di di]HU'·
1inwnto <'di divisione Hat·do, dopo il breve periodo ùci <·.mnandi di provincia, nel 1873 i comandi ll<'rali l' <li d h isioue, che di V<'Jtlarono ]>OÌ comandi di r.orpo di. visione ncll877.
ed Italia sotc hanno tltutqne 1:\J pluralità, dci g1•an.tli conHtndi wrri Loriali. Corrispo JLtlc csK:t a.ù una neccssiLì\.1 Si JHlÒ su biLo rislJOtlderc di no, !l'esemp io (li alL1'i grandi eserciti, qttali il tedesco e l'a.ul'!tr·o·ungal'ico. 'È esqa. A domanda si ccrclwn\ di ris1>ontlcrc con l'esame obbiettivo ddla qne>ltione.
Lo attribuzioni dei nostri comandi ili corpo d'armata<' di di· vili ione sono fissate rispetLiVè\lllente dai capitoli I e II del t't'go·
( l) Dr:l.t\PRRI!JERRE, « L 'arroée fmnçaise, organisation », n, 1:>.
Tn\ CIRCOSOIUZIONE mLl'I'ARE 'l'J!:RRl'l'OR IALE l(l39
lti4Q !.A
mLlTARE l'ERRlTORI \LE lamento per il:>ervizio territorialt>. È (acile dalla lettma d i <•ssi che la distinziout> dei tom p iti non è punto netta. anzi in talune vi è 1)Crfetla ann.lo/.{ia; ciò mtturaluwnte pro<luce la Rovrap posizione dei poteri, la. moltiplicazion<' ùel laxoro e ùel <·onlrollo. la <·onfusione delle respon.-;nhilità c qualche YOita atLriLi non n.e<·t•Hs<ni; tli più la moltiplirazione ùellaxoro prodm·t> anche l'cif<•tlo di ric-hiedete utt doppio personale, <'lte ntl<•nda allt> sle. se itu•ombcnz<' presso l'uno e l'altro comando.

l/import anz<l dt•lla q t ton almiuist ro ùdhl 1-{UI.'t· n\ g-enerale P<>lloux, <·h<• ii n dttl 189:3 foce studinre ùa una. commis;;iono 1m ttuovo n•golanwntu inspim t o da uu prin<·ipio ('di ('UÌ furonO daJ 'i\10 SI!('('('SS0r(' diramate l(• hOZZ(' di :-;{;\111
Jl<l. Secomlo questo J'<•w>lantt•nto , i <·onuuttli di eli visione :wrt•hlwro perdnto ogni tarn t t l'l'l' trnir·or·iah•. rimanendo questo c·oHc·rn tt·ato uelsolo c·omando di rorpo d'<trmata. X el fnnzionamt•ntu clt•l HPni:do ;;al'(•hhr stata in tu l nHHlo intwdotta una notcYolt• l'it'lll· p l i!ìc:aziollc'; il prn;onalc• ù<'l c·mnnn<lo th•lla, diviHion<' di fantPria :t\n•blw potuto riclollo al minimo.<' lo "lato lll:tl!gion· ncldt•tto al nu•dl'simo nwr piit fr<•qtwnti <·ontatti c·on la truppa. tnan s ioni piì1 »trc•Ua tnc•ntc· OJH'ralh<· c ntagl-{iOt' t<•ntpo tla <lt>dieat·<' al proprio pcrf<•zionanwnto intc•ll<'ttualc <' tN·ni<•o. t"nqunlc·he aunw11to <li per:>ollnlc• san•hlw stato lH'l' <:cmtro tH'C't'"-"lll'io pr<'sso i l'Olll:llttli di c•orpo ll'at•unth\; ltlit ivi sarPhh<' stat(} pussibilr sC\ind<•n• l' ullic•io in ÙH<' p:n·ti distinte, l'uun il comanclo <'OIIH' uuit:t <ln mobilittu·si inl!Uì't-ra.l'altra il c·omurulu t'OIIH' c•ntc• h•tTitoriah•, la l'una d<>l c·apo.l'aiLm <lei soLLoC'upo di stuto llWl!g io rr, c·on prentll'nzu di Htlìd:tli ùi s t.ttlo tlllll-{gior<' rwlla primu, di uffidali applic·nti nella H<•c·uuda ln lul modo si :-;;ll'<•hl>ero ottenuti. nnt·he JH'I' lo shto ma!!· giore del l'orpo ù vantaggi :mn loghi a qul'lli <H't't't f n•• ti JWI' le divi:·lioni, c1 stn,ta, altrc'SL pre<lispoiit a, in moti() Jl<'tto <'razionai<'. la del conHIIH io in du e parti. l'uu: mohilt•. l'a ltra fissa, all'atto t lella mobilitazi01w. analowun<•ntt • a. quanto aC'C'ade, ]J('t' <'scmpio, itl 11ì'lltl('Ìa ed in. (: t•mHntia . •\lt rn grauùi"'"imo stato quello ùi ric·hieù<'l'l', in <·a · o;o di rnoiJilitazionr. minor p er:-;onalc (>!'l' il xer\ izio nei <·muan · tli lol'l'itm·iali, perchc bastato pl'OV>C<h're <L do<lic·i ,.o . mandi, qtwlli di C'Orpo d'armata, iuv<'<'<' <'ltf' a tr<·nlaseLl<'
2:3) quanti sareiJhcro c·ou l'aggiuuta di 'entic•in<LllC ùh·bioni. il \·anl:tggiO piit rilevanlt' ùerh ('J'ehhc ùallu ntagl-{iOt st'lll · vlicit,à con ht ctua1e votrel>lwro essere t'l'gola.ti i rapporti 1-{c't'aJ·chici. Invcro Ol-{gidt In plUTalità delle.dipendenz<· :-;i può din· l'ili' costilui:;ca regola per tutte le armi. tranne l'lw per la fnntt·ria di linea. T t·omandi eli gruppo a lpino, di brigata di cavall('li 1li artiglieria <' ù el gen io dipendono da tanti comandi di
quanti sono i territori ùiV<'l'lii in corpi o i dil)Cndcnti h anno stanza. s<•nza contal'c la special e dipendenza dagl'ispettori. Horvolaudo sulle con."illN·azioni che può suggerire l'l'same di d:lscnn <'àl';O particolare, si può dire cl1e abolendo H territorio <livh;ionalc si 1>otrebbero togliere tutti gl 'incroci derivanti d a i dh;taccamcnLi di una divisione·. dislocati uC'l1,(f'nitorio di un'altr'lL si potrcl>btl dC'f1nirt> mel:!liO lu, situazione di Laluui eoru anùi eli brigata od (•quivalenti. lHllll'nùoli o compl<•tamen t (l alla diJH•ntl<>nza di nn solo <·omando di o alla dipenclenza ùir<>Llll t'<l esdul'h n dol comando di corpo d ' anna t n. Pe r fi s::Hll '<l lo id ee con un pio, nl' l L<'lTitorio drl J corpo di lr l'l'ln?.ioni ))OtwhbNO eSSCl'(' Hl<l h il il e CQF\Ì: il corpo d'ar' IIH\l<l eotnl H'Pndc•rrhb<• 2 divisioni, l gruppo alpino. l bri gata di c·a' allerin r l rupp e non CiaH<'tma diyision e <·Olll]ll'(lrtùer<>hl><' hrigatr d i fanteria <' l l'<'l-{g-imento cl'ttrtiglirrin d a cn,mpagna; il gmppo al pirw 2 r egg. al pini , l roggim o r\Lo bt•r·sag-licri e il t'(lgg im ento art .ig li c l'i a, da montngnn.. "Le lt·uppe non ind ivisional<• (urliglirria. eia for·tezz:t. 111 i natori. ferm\iC'ri ) for·uwrrbb<•ro ln·ignta con corpi rrsidenti in altri lerrilori di c·or·po d'armata mn non dovr ·ehbcro dip<'rtdC'n' clnl coHulnù a nl<' di c·orpo d 'arnw l n, rhe per <tuartto conc<•r n<• ilser·vizio di IH'N;i<lio ed in ]mrlc ht rnobiliLn.z ionl' , rint<tn<•nùo p<• r· l1t! to il alla <lip<•ntl<•nzn dt •i rispcl.Li vi is)wt (o l'i.

'l'ornando n l prngetto t li n• gola m l'n (.o sul servizio l c•rritOI'ial<>,
c· h<· dal l in ]>Oi r inws<' dinw11 li<•n t o negli :H·<·l dvi del ntini stt'ro, non sono ben 11ot.i i motivi JH'l' <·ui esso non l'l>be .fort,una. e qu<'llo e dito nrl 1905, s i :lf l<mno anc<mt antiehi criltwi. For:-w lo SJ)il'Ìto cli tmdizioll('; f 01At' il timon• c·he L'<>sh•nsiom• trrTitoriale di taluni comandi l'oss(' troppo vn'lta per t'S':iere spezzata in parti minori i forS<' tnlurw mend<> Ìll('' itabili nel rNligc>rc un n •golameu to su rnwv<> bmd, 111<'ndc che influirono Kttl giudizio c·o rn pl ess ivo i eo ma.ndn n ti di eorpo dtiamat.i n <Lar·c ùel Lavol'O: forse anc·ltr In ritrosia di taluno a d ac·cresce r·<· d'un tratto l<• proprir atll'ibnzioni c n•sponsabililà
JH'c,rnLivo espt•t·irnento; for:-<t' e<lt'sseuzialuwnte il ramhiameuto ed altrr mula:r.ioni nel pen;onaiC', eomb inat<• con più m geuL i tu•cc•ssiLà. derivanti dn.lla. gmwra ù'AI'ricu, contribuirono a Rèppellir·o nt'gli archivi il progetlo om ricor · <lato. Ji'ors'ane he vi c on tribui il parere eontrario di parN•chi romand an t i di divisione, cb<' vide r o in q uri progetto una di minutio cupitis. Ad ogni modo, il ratto stesso c·h<' q\lesto progetto lta eaislito, l' import a nza reale cl c ll n. question<•, c·he s i 1Hlò consideran• come semplicemente sop iLH , HHL non l/esempio della -n'ranc·ia elice poco a, fa\'ore della pluralità dei <·omaudi. t> il paese doYe la mala pianta dt'lla bu-
t.A MlLITAlU:
1641
1642 LA CffiCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE rocrar.ia lH\ , più radki; e rivif\te franceAi ricon(' assaf Rpe:-;;;o la lagnanr.a clw gli ufficiali degli o;tati maggiori siano Rofl'ocati dalle incombenr.e burocratiche. Il motivo addotto di non tlisin.teressare lalmtP autorità dagli aJlparec<:lli della mobilita.r.ione nemmeno ba valore; in l talia, i comandi di hrigata non sono enti territoriali, eppure hanno, nelle questioni di mobilitazione.>, la <lc.>bitn. iuge• cuz:L Qtwlla doHa mobilitazione invem U Ila CÌl'CORCrir.ionc Rpeciale <:ber in (!lWlla geuentle e Che può. anzi dev<'. !-mssisterc.> senza <'IH' le autorità <'lte v i provvedono nbbiano tutte le man.Hioni rhc spettano ai grundi <·omandi territoriali.

Qunnto 1>oi ;tll'imJwùi•·e l'<w< •entrumen1o di <tUl'Htioni minu11· al comaudo di <'OI"J>O d'nnnata, il coJt.-.istt•n•hlw nni<-a 111cnto nel definire in modo (\hinto e nrtto l<' attribuzioni di ogni gra<liuu dt•lla gerarc·hia, mediant<• una h e tùntesa ripartizio1w d elle l'<'Sponsahilità, !t eomiurim'<' <lni gmclini più facendo, si limiteranno le alt l'ihnzioni dei !!t'ad i :o;UJH'I'iuri a 1•iò d è di IOl'o vrra spettamm" og-1tnn.o 1wrà un'ada! t.a Hfcm di ati ività .
.A titolo d'elu•mpio, c·oHvit•np <'itare l'm·tlinauwnto leùcs t•u. l vi <·iusclllt <'.om:uuhuttt' d i rorpo tl 'a rma h\ prt•,.dt>ch· a11t• manu vt•e, t ruzimu.• t a nlla 1Jf'<'1Hli':Hr.imte• n ll:t gu<•na d t• Ile· t r11ppr dip<•ndcnti; ha l 'alta din•7.ion<> del 1wrvizio di 1 v<.>rciò dipendono din•ttanwntc· tln lui. al pari dci C'omaudanti di divi..,ione, i gov<•rni miLitari <" i c·onw1uli di fortt•zza. Tnultn· h;t d ircttu !!inrisò i r. io n<•, e<'<'<•tt o C'Il<' p<•r la pn rtc riHt'T\':1 t a agli i.-;JH'It.ori, 11 flì.<:iu li <' sulle ti11 PJl<' JHIIl indiYisiona h•; l ll'O n l 'tlt·. mediante l'intendenza, ai 'a l'i Ht•t·vizi, 1issa, d 'a<'con lo <'111\ l<• an· torit:L civili, lo mi:;un• riguardanti il rec:lutanwnto, lo t hiamute per istruzione (<·ompl'c.>si ullìdali in <·ongedo). hl tnohili · t.:tziono e il mantenimento dell'ordine }nthblko; m•i Ntsi può auclw dispoue di tTUJlP<' di altl'i <·orpi .d'a rm:rta <'IH' si tmvino stù suo terr·itorio. <·ontinnano pero n J'lllHLUt•n•, rwr malmentc, alla clip<'tl<leuza d<•i ri.-.,)H'ttivi comandanti di C'<lrpu d i armata.
Il <·oq>o tl'armaht> l'Omprende, normalment<•. dtw dh+-ioni di fanteria, e lrupp<' non inùivisionale.
La divisione di fanteria comprende due o t n• brig-at<' di fant<·ria., uua brigata di eavall<'rht c una brigata di due reggimenti eli artigli<'l·ia da campagna. Le truppe non <·ompr<•ndono, iu via normale: l battaglione cacciatori. l di artiglieria a piedi, l battaglione pionieri e 1 ba ttagliont• trenu. Il comand<tnte di dhrision<> è soltauto <·omandante ili tt'Ul>Pa: )lresicde alle manovre di tutte le truppe dip<•nden.t'; dirige ltma,no'\.TC annuali ili divisione e a. quell<' di hrigata: lw
giurisdizion e solo sug-li ufficiali dei riparti dipendenti; prescrive le inchieste da farsi dai tribunali d'onore (consigli ùi disciplina) e sopra.intende alla giustizia militare secondo le norme sta.b ilit e per que.c:;to spec ia l e Non vi so no nè coma.néli eli artiglieria, nò comautli del geuio che abb iano coi romandi di corpo d'armata rapporti analoghi a quelli es isten ti i n I ta1la, l)ffi'Cbè l'art iglierìa, da crtmpagua è tutta coml)resa nelle divisioni o non dipende da nessun 'a ltra autorità, me11trc l'artiglieria ùa fortezza e le truppe tecniche. hanno una gerarchia separata con limitati rapporti coi comandi territoriali. J servizi poi sono nettamentP separati ùalle truppe . I comandj ùi corpo ù'arma1,a, con l'estenùelie loro attribuzioni, allegger iscono il lavot'O del miniAtcro e del gabiuctto miliLaro e permettor10 uu. hu·go dN·entramento delle attribuzioni che in a l trL paesi sono <li esclusi ·m comdel potere centrale; ma ciò rt<'mmcmo coudnce ad un sovercl1io accentramento di ufl'ari a l comando tlel co r·po tl 'armahl , pcrchè anche le mir10ri auiorit:\ b !\nuo facolt:\ estese elw conL1·ibuiscono a lla, divh;ione c.lcllavoro. il comanda nt e ùi bt• igaia il serv izio inLPt no n l 'ist ruzionc dei rcgp;iruenti ù ipenclenti, vigìl11 a r.he sin.no pr<'ROULi alle tutLi i milite11'i non di rc g:olar e licenv.a.; coadiuv a t o da uu l'lmziouario dell 'inlenùen za I n. t('ntrl tHlci r egistri, la gestione dei viV(Iri c il sel'Vizio <l c>gli 11ffiei.; c.lcll<· ope.raz.ioni di reC'lutamenlo (P<'l' l e quali soltanto è organo il' T'I'ilol'i alc ) (lcgl'i u, pparec<' hi ùi mol>ilitazion.e cù estondc Ja prowi a so r·veglianza a i distretti \li Nl ai mnl<'tinli ll 'al'mamento e di equipagg iatuento .

U comandante di regp:imeuio è t'CSt)onsahilr <I ella ist.l'u?.io tw , d e ll a o del t'cg-gimertto, riparLis co le nuove lo\'e le varie unità., fissa lr d elJHWSOHalc, regola le operazioni di congechtmento . Come capo . educatore c r apprese nt ante del corpo degli ufficiali, decide df'll'u,<"Mttazione d ei giovan i che si prcscnt:tno a l rt'ggimen to co m e aspi.rauti uffi ciali (Fahnenjun7wr), sott o}JOHe n,l voto ufficiali l' accettazione d e i nuovi promossi, redige le note canttte r·L-;ticltr' di ·tutti gli ufficiali dip endenti, dirige le ine.J1ieAto ùel tribunale d 'onore reggimentale. Oltre ad 1m tl.iutante (tcneutc in 1°) inearicato della rellazionr e della diramazione degli or< Uni, mo'bilitaziou e e d ell a tenuta ùei tmni <li se-.:·vir.io, è addetto ctl comando del reggimento un 1.1ffi cial e super ior e (Offizim· beim cui son o affidati special i inc ati<'.hi soprattutto per l 'istruzione ùegli ufficiali, senza che perciò venga punlo menomatfL l a responsabilità del comandante.
Tutto ciò che riguarda l'amministrazion e , l 'eqnipaggiamenlll e l 'armamento è eli spetta.nr.a diretta il ei c omandanti di reggi-
LA M.ILI'.rARE :J.'.ERRITORLALE 1643
mento; Luttavia i cotllanùanti di bTigata e di divisione hanno ohbligo di vigilare a eh<' non ,.;i commettano abusi e Nono responsabili ddh• twgligenze dl•i loro dipen<le•nli. Particolarmente i comandi eli hrigata c·urano :-cverameutt• rhe tutti [!li uffiriali. i sol· tu:ffichtli e• i 1-iOldati, nt•lla mi-;m·a rispc•ttivamcnte conoscal\0 pil•uamentc i propri doveri e li c·ompinno ('-;altamente: e dellt" infrazioni rileva 1<'. rome plll'e di ogni uffieiale l'Uperior<'.
<Il qualt• 't'Ilf..!;<lllO uwuo lt• necessari<' enNgie morali e• fisiche <'lo Zt'lO in Sl'l'\'Ìzio <l<'YOIHI ÌlllJl1('(1Ìilt<lllH'Ilh' fare l';tppOrlo sOttO la propria
l'on Ol'din<' tli gahitwllo del 111 clit•t•mùtr l85S, l'imperatore· Gugli<'llllo l <"hiarint l\111'01' nwglio i Jli'Opt•i intendinwn.ti c··
<<Ogni c·omandant t• 1li :-;ingoio ri11:lrto. <\ partir<• dal com:m·
<· ùanLt• di e·ompagnia. :-;qnatlrone o hnth•rill. i' anzitnl t o
<<sa bile ch•llu n•gohtlll<'llbll't\ i:;trnzion<' del proprio reparto<' llevt•
<< quiudi limita to il meno 1Wlla "<·('\t n dt'i nwzzi.
<< p<'r<·hr In libertà di sc·c•lta U!'f!i<:.ura <' proli t lo quali
<-sono Yoluti dalla su]wriori
« J c·onullulanti di e di h1·igata di b:tttt'l'ic hanno
<• de•llp ;-;ÌnJ!oll• <·ompagnie c battc•ri<> quclht sor
<• \' t'glinnr.u direttiva c·ht• la. loro rc'"JIOII"aùilillì, cs((•1:m a lntlt i
<• l'ltUlÌ tll'l l'('l'VÌZÌO. l'('!Hlt• IIC'Cl'SSUl'ÌU; llHl UOll tl<'bbOllO l')IÌ!l·
,, l!l'l'si oltrl' qnanto r t•i<·hit•sto da fal"r intf'rpt·etazioni dd n·
<• o eia omis..;ioni.
<• l e·ont:mclanli eli po ...sono dare :-;oltanto lt· normr
<• {{<'llt'ntli JH'l' In rt'gohu·t· istntzione d<'i singoli hatla:,tlioni, bri ·
<• gnh• di hul tcrit•, o sqmtdroni: ma atwh'e"lsi non d<'bhono Rpin·
« ger<· la propria iu g<'rrnza oltre 1<• false• inte•rprt.>tazioni oll omi"·
«;-;ioni prima ucreunat<'.
<• 'l'n ti i i e·oumndnnf i d<•i singoli I'Cparli l'Ono l't'"pons:tbili l'lw i
<< regohtllll'tt!i di el'l'rc·izi r le• i:-;tru:zioni approvnt<' eon r. dec•rf>to
<• no :-;lr<>ttalll C;' Hl c i, d H• :rti nffi<'in li in xerdziu
<< le• e·ompagnic, sctuadroni c• l<' hattet•it.> sia.no impil.' j!ati
<<in modo <'lw iRtruendo la truppa perfezionino ::.è e clu
<• nelle• ixtruzioui <li specie e nell'allenamento abhia l :l mas
<• sima <·ma della ::salute della trnppa. Inoltre dt•vr sevc>ra
<• 111ente• cut·me che, l>tll' l'irhiedendo da ognuno ilmni>"imo sfor1.o
<<congiunto a zelo <·onservali il lit•to animc'
<• e l'amon• al serYizio e• o:rnuuo rif!ttardi la strt'tta ossernlll7.l
« dt.>i propri do,·eri c·nmt• un punto d'onorl'. La trascuranza eli
<< questi princ·ipi nuoct• al Nt•n-izio. X eres::;aria rou..;egncnzn di.' l·
<< l'int.emp<'stivo intervento del SUJWriore nella sfera d 'a tt.ività

<<dell'inferiore è quella eli arrecar<> itnp<'dimento ;uvere rbe sod·
« disfazione e lieto animo. di rPndere impossibili la tanto nece<:-
164:4 lu\ CIRCOSCRIZIOSE lllLI'l'AHE TEllRlTOJUAI,F
f<-n'IIHt:'.ione del carnt1l'l'C c lo th•ll'indivi1lualità «e fiualmt'nlt· di far sì <"ltt• i :-.uprriori Hlt•x'!i caùano uPII'lm ilate<• ralità ed in luogo di ahilitar:;i pi<'ghi Sltperiol'i l't•:-. t in o al "punto in <"ni l'i tro>avauo rwllow nltimo illl]liego.
,, {'omhat l<'rt• energi<"amcnte qtwstu malt• è il primo dovf'rc <• ùei geuera li. quer;;ti lluHno. rispetto ali 'ist t·u ;,iotw m i n n tu d cltn. (<truppa, a iMi lmzioni ann lo g-he <t 4 ucllP loro spot t n n li l tt•ll'a.m• mini<;t.raziont• int<'rnn. 1wlln lll'gli ,tfrari l'utH·Nnenti ,. gli ttffidnli <IPi corpi dipt•ndt•nti. Se in qut•..,fl• fac·c·crult• t's"i " t'Oittl'ollano <' soltanto l:ì intt•r·, eugono. do\ t> s'a<·· « t•orgono cht• illor·o inf<•rior·<· immediato 11011 adcrnpia ai propri
« dO Vl'r'i. <' l ' in tt'l'vento sin richiesto dall'in"'nilirientP iufluenza

.. pl'N\Onalt• ù<•ll'inferion· < ' dt>l in modo
• an:\logo l''l'li dt•hùono <·omportar:;i Jignurdo <lll'i'ltt'll?.imw. l n
" q uesti non do\ t•atuw però pr<•nd<'l'l' il tl .. J,·unum-
" tl au t<' d i ha t.t o di nH•nto <•d ord inn r't' !-ìU•Rsi il di loi'O r-;pctta n'l.H ; <•s!!i do vraruto in vt'C<' c•ll(l i
pr·opri inf L•r·iot·iJ C'iasenno tH'lla lH'opri:t l'lt'<•r·n t li ati h iflt, Hi rl•-
• i prirtt'Ìpi HO\ l'll('('('lllla(Ì. c•ltt• l'él'!alta OI'S<'l'\UUZlt
• tl<•l regolanll'uto assiruri la Yolnta ttnifonnità, C'lt<' l<' UJH'l'll.-
« zioni JH'it lC'ipali Riano ruzionalntt>ntt• ri pa1·t il<• fnt i vaJ'i d<•l-
« l' Ut\llO (1 )(l O!)l'l'ft.zioni !H'I'Oilil:t.l'iC vi HÌ!lllO opporl.U llltlt i('Jtle in-
« tr t'<'ah'tLc. ( 'untpito ùci W'llt•rnli pc!· qHPst .o ri-:pl·Lto
(• <·an• il uHt o momt•nto m•l qttale <' d'intc•r·, t•nirr .
«affine di non J>l'l'lllCtlt'I'<' 1111 nt•ll'istt·nzioru• tiPII<•tr·upp<•.
• l <·oman<lunti di NII'JHI d'annata <' di divisiorH• dt•hhouo l'ivolg<We tu t tu h1 l()J'O Htt pnnto t•d l o ordino
«ino l tre rht> nrllr nolt• dt•i t· om:Htd<lnf,i di t'<'gg i -
• lllt•nLo RÌll l-.plic·iltmlt'lll<• clit'hiarato :w t'HNi pOK"'<'J.tj.(:IILO il dono
• 1li snv<>n• islrnirl' un tl<'l ltlodo dando • <o sl garanzia di pOI<'r <:op rirc in avvenir<• atwhc· il « rwrale. l n modo analogo Hi drvl' nellt• no t t' l'flru.ttt•-
" cl<•i N>mnndanti di <'di hri.gaLa <' dt'l.tli iHpct-
« tol'i, H<' <'"'Hi <'Sl'l'<:itiuo il t'OIIl<HIIlo d<•lh• truppe• in modo <la uon 41 ittt rnlcinrr l'oprra dei loro in ft•riori. <la pr·om uoverc lo w i lnppo 4 d l'lla loro iniziatiYa <'d incli\'itlnalità, da il matcl'ttÙ<' (<c· hno1w vo lontù. umore a.l:wr,·ir.io e li eto ani111o c• , iu<< vec•c di pNcl<•rHi itt mittu:'.i<', :< i perfezionino, in modo d:1 m<:ri,, tar<> i comnndi clt•ll'<•svrcito.
« D ue ]mnti lo ritengo ancora nrc<::-:sario tU toC<·u r·t•: l<• i"pe« zio ni per parte• dei genernli <: l'aumt•nto H<'mprt'J>iìt <'l'<'"l<'<•nt<> «de l fra superiori t'd inferiori. P er dò Chl' r igtu11'tht l (' • ixp ezioni , io Lrovo piennmrnte giusto <'.h t• nell'atto eli assume.t'<' (( il comando il novo titolart• srt•nda u<•llt> prim<' fino • al minimo particolarl'. JWl' JlrOClll'i1l':d al più possibile
1,,\ CJRCOSCIUZIOXE :mJ.ITJ.IH.; 'I'KRIU'fORIAI.Io: 16J;)
<1 cognizione deHc singole persone e dello stato delle truppe: in <<seguito, soltanto c1uan clo egli abbia un determinalo motivo per <<farlo, sarno no opportune le i:spczioni estese fìuo a l particolarl'.

<<Per ciò chr lo scriver(', Io richiamo anzitutto all'os<< servanza. ù<•ll'anlica massima che per le facc·ende abituali. << quando i" po:;;sihile V<'rhale, non si dt•ve tratt:ue1>er i<< scritto e <'lw Oj!Hi c:utegj!io rm i <"oman<lanti di rc:rJ.:inwnto l'tl « i loro in.f<•riori n•sideuti nclluOI!O -.te&;o è proibito • ·
I n Fratu•ia, il rorpo d';umata <'omprende normalmente due o tre diviRioni di fantcrill, mut hl'igata di cavall<'t'Ìit c uu.'\.
d 'artiglirtin. da <·ampagna. uno Hquadroue del tr<•rw. Al<· uni l'Otpi d'armata <·ompn·utlono anrlw una diviRtone di <·avallrrin; fra i vari corpi sono poi Yar i amenh• rip artite le altn• trnppe (<·ac<:iatori, llrtiglit•ria a piedi, genio). f fWt'VÌZÌ !\OliO l'<'golat i }>Cl' COI'!JO d'arm:tta. llt•:tggntl>Pam<'nto tlcll<' tr<' armi in tt•utpo di pace rum eominrcrchlw, ii<'<'onùo l n, lc:rgt• pl'imit iva, di ot·<linamcnto, dre uel corpo d'!WIIHl.ta; prn.ticamcut<• eomincia p i 11 in ])tt"lH<l ••\'endo i comandaut i di divifdoue anc·lw il roman<lo di una "ltHldivisimw regionalt• <•<l in <pwsta compiti :umlog-hi <'- qtwlli dt•l emnando di <'orpo tl'arma t a. \ ':l l t> per l 'l•s<•t'<·it o frnnrt•se la stt•ssa uss(>l'\':t • 7.ÌOUC (atta pl'l' 11' inslihazioni italhUH'.
T co:.n"IH IH FOR'I'EZZ \.- ' l 'm i <·umaudi di l'ort<•ua <•sh tt•uti iu I talia <' qtwlli di altl'i pat•si vi sono sen"ihili diht•r<'t\7.1'. Per· lirssni'O le idN• , s i n)llfroutino i eonmndi di fMt<>zza tC'clt•st·hi l' frauces;i t'OH t[IH'lli italiani. Ki \'C' tlrà c•hr urll'impt•"n lcclr">CO \t} (Jl'io <:ipn)i forfi'ZZI' hallUO un t'Ollllllld:tlltC <:Ol grado tli gt•ueral<•: il quale a \'l'l\ poi il uclo cl<•lla fort<>zza in gn<'n:t; atl es"'o addetto un <·olorwt•llo capo di stato maggiore, <'tlll uno o ]IÌÙ ufficiali di "tato ma:rgiore , ollrr :ul ulli<·iali di ar·t iglit•ri:t t' che f!anwno, in <m!lo tli mobilitn:dorw, i t•omnndnnti tli artiglh·· ria o d<>l dt•lht fortezz:L . ..:.\nalo garuentc 1)<'1' i JH'itu•.ipali s<>rvizi. Ri l•·at hL dunqu<' di ottimo. il qual<• -;lmlin <'propou<' iu lf·mpo di ptH'<· quanto t·on<·(•t'llt> la pr<•ptmtzion<' a dift•sa c· il miglioram<'ufo clt>lla fortczza c nel tempo stcs-;o tH' <•ma la buon a c·on"lcnaziouc. Yi è insomma accenb-anH'nlo di <lirezimw e di responsabilità, pm· esst>nùo gl i ufficiali ù'arti!!li<'ritt e del genio, per la, parte pmameut<• t N·nica del sPrvizio. alla. diJWildenza <.!eli<• risp('ttivl.' f-lnpcriori autorità.
J u Fr au<"i:L vi sono pure govrmi militati e com:u,cli <.li grup11i di jortrzza. I primi sono instituiti ]Jil ' t che altro per ragione politica allo sc·o]>O di <'''ilare, sopmtntto nella capita le, eh e un generale possa dL.. porrl' pil'namente eli tuUt' l e forze del prc,;idio; gli altri sono inyec·e <'t'(•ati per ragione militare e banno composizione <l hbastanza Himilc n, quella, degli a.nalol!:bi comandi tt'cl(>Stlhi, per <tuauto r.onccnt<' l'artiglieria e il gonio, mentre il c•omando
1646 J,A ClRCOSCRIZJONE
llTLlTARE TERRITORIALE
MILITARll: TERRlTORI.ALI!: 164 7 fortezza è spesso a.ssunto da un general e ili divisione o di bvigata.

In H alia., o il comando della forte1,za è assunto in tempo di pace dal comandante di ùivi sione il quale all'atto della mobilitazione lo cede ad altri, oppure è assunto in pace ed in guetca. dallo str..sso ufficinle cbe ne è com;mdante appositarnenLe desigoàto fin dal tempo eli pace, ed a ll ora si tnttta iu molti casi di ufficiali del perRonale delle fortezze (ossia di i nsufficienLe capacit à, neU'impiego taLtico c tecnico della propria e di menom ata attit ud ine al :;ervizio nelle armi di artiglieria o genio) , con limitate o modeste mansioni in tempo di pace, non aventi a.lla, loro diiJendenza gli ufficiali d'artiglieria e del gou·io che sar anno poi addotti aJlfdortezzain caso di. mobilitazione. Ed anche nella pre}Hltl'f.t:?;iouc dcUn. difesa h anno pa.r Le secondaria, percllè gli st udì di a]Jpa.rcccll io o eli mif.!'lioramonto sono <'SRNlziaJm eute faLLi du.U<' ùil'ozi.oni di m: Liglicrin. o del f!Onio, sotto il cont rollo <lei rispettivi c:oman.ùi, e co l corLcorso (l co l contro llo ùci conutnùi ùi e ùi corpo d'at·mata; il tra.Ltamonto delle quist..ioni rouccJ' lH.•uL i una fOI'· tezza riehi.cclo nn lu ngo C;.wteggio o la rinniono dello commi ss ioni di difesa (i em i membri 111\\Lano 'fr•cqncntemeu te), invece <'11<' competenza t1i una, Rola c pcrmancnto an l ori r·c&pon sahilo de ll o, '[ortczzu, in pa.c:c od in l!trerr:tt. , Vesilltenza d'i d no comn,udi sovntpposi i aventi mansioni torr iiOt·ia li .l'a anche sì. oh o ontmm bi abhia.no biflogno di organi eonsultivi teonioi ùi grado diverso, dai comancli d 'artiglieria e de l genio (' dallc 't'ispeliLive o :;ottotlirezioui. 11 lavoro parallelo cu i Hi accounu.to p rodu<•e 1111 git·o vir.ioso; per s9·pr·a un<b cln L}t questione, il comando d i di v i si ono it\lerpell}l. la. dirrzionc ùcl genio, e a, il comando del corpo d'armata il corua ndo <l ol gonio ; m:\ queRto clli ede ancora il parere drlla dir ezione, è po i lo &tesso già d ato al comando ùo ll n, divisione; siccl1è dopo un lungo C<trtcgg io si al risultato ohe lo stesso parere fa capo per due ùivei'se vie al med es im o com ando . Se invece il comando di eli vis ione fosse scarieato da queste attl'ibuz ioni, non avrebbe bisogno ili organi tecni ci; e nemmeno ne avrebbe bisogn o il com:t n d o del corpo di armat a, se a11.a sua dipendenza v i fossero i comandi di che coordinassero e raggruppassero il l avoro che ora è fatto per vie pM' a1lele, se non divergenti.
CONCLUSIO NE.- L a circoscr izione militare te rritoriale p el' i.1 servizio generale, qun,le è or a in Italia, non è quella che meglio risponde ad un semplice e ben ordina t o funzioua.mento del coma ndo. Senza entral'e nei particolari rehttivi a cias01m'arma c a
LA OfRCOSClUZION.E
r:iasetm servizio, si può cli.re opportuno concentrare, di anzitutto nel solo romand<' di corpo d'nrmata le att:ribnzio n i t<>rl'itoriali crimlo1e gent>rale, disting:ne!)tlo poi nettamente• fra lP minori autori quelle a>enti C'ara tter<' mobile da que11 t> aventi carattere stahi1t>, le trnppe dai r la!';c·ianùo alle divisioni unicamente carfLLterr mobile. La ùistinzion<' delle truppe dai srr,rizi fonthl>mentah• e dt>:,idt•raùile sotto tnHi i riguardi, C'ome e(lmplem('uto (lella riforma accennata, indipE:'mlenLCnl<'nte d<l • qua.lsiasi aHro pro,·vedimento accossorio .
Per tut.tP queste considerazioni. chi esum.as::.e il progetto del 1893 c ne concretasse 1111a edi?>ione rivccluhl e corretta, farrhbe ccrtamcnit• overa di grande 11t.ilit·à per l'esPrC'ito.

1640 LA MIJ,ITARI•:
TERRITORIALE
'l'ot·iuo. 1006.
AJ..ngR1'0 ÙAV\CIOCCRJ •
..

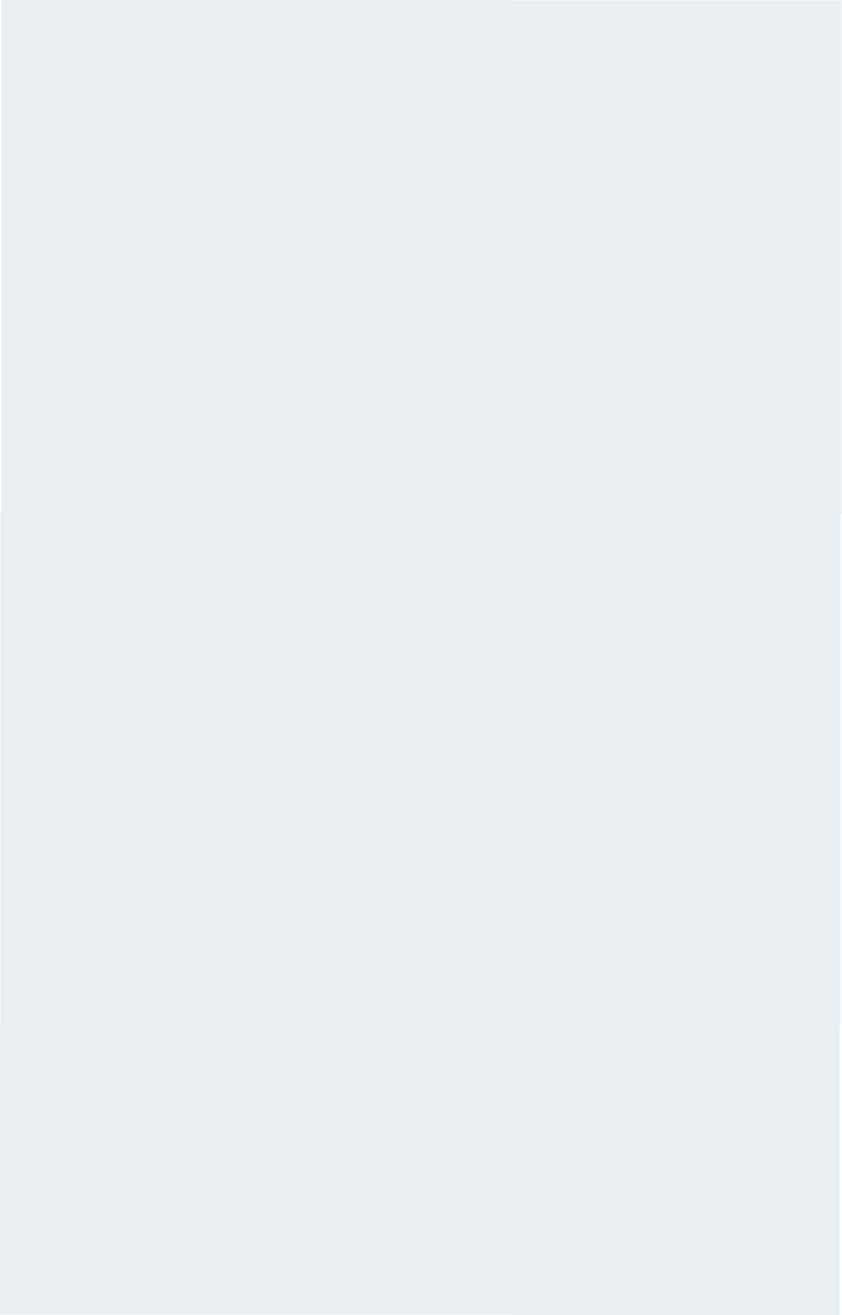
PEI\ LA DE FINIZIO NE DEJJLA DISCIPIJINA
È noto cClme la parola. «disciplina"' non avesse in altri tempi il significato che oggi più comunemente le viene attribuito e che piuttosto fosse adoperata. ad indicare un ramo o l'altro dello sc ibile, a seconda. dell'aggettivo che l'accompagnava: per esempio, le discipline ma.tematiche, le filoso· fiche, le militari e via dicendo. Tanto è vero che i Tjatini chiama vano c l'iCverità •, q nella che più tardi si usò di chiamare disciplina; in ta l caso, però, c disciplina • poteva tradursi per c regola. •·
Ad ogni modo, 4ualnnqne sia stata la fortuua di questa parola., essa fu costantemente adoperata nei regolamenti per le truppe sarde e passò, col regolamento del 30 ottobre 18:>U, nell'uso di quello che fn poco dopo proclamato c regio eHet;cito italiano •·
ti t·egolamento pe1· le truppe di fanteria in data 18 ngosto 1840 non conteneva nna vera. definizione della disciplina; diceva peraltro ( art. 10) : c Non bavvi disciplina senza la
c stretta osservanza de' doveri militari, e senza la respon::;a-
c bilità. e l'obbellienza prescritta nell'ordine gerarchico della
c milizia • : Ìln-ece quello del 30 ottobre 18:>!1, nella premessa, dichia.ra.va.: c .. .le attribuzioni e i do-
« veri di ciascnn membro della militar gerarchiA. vogliono es-
c sere definiti con regole certe ed inviolabili. Nell'osser-
« vanza di queste regole consiste la disciplina militare "'·
Il regolamento del l dicembre 1872 ripeteva. nella premessa la. definizione di quello del185D; ma all'art. 2 davlt una seronda definizione alquanto diversa dalla prima:« La

c disciplina militare consiste nell'abito di adempire tutti i
c doveri inerenti allo stato militare •.
T ancredi l!"'ogliani, allora capitano, il quale fu 'in quel tempo incaricato di dare nuova forma al regolamento di disciplina, credette utile anche spiegare nel modo che segue il concetto su cui basò quella. definizione.
« L'abito di adempire tutte le obbligazioni inerenti allo
c stato militare la di.çciplina milita1·e »
Si dice l'abito, per distinguere l'adernphnento attuale, che si può avere per cause estrinseche ed accidentali - (l'autorità personale di un generale, l'imminenza di un peri-
Hl
•
colo ecc.)- dall'adempimento abituale, che si fa per l'apprendimento acquistato col lungo uso di adempire questi doveri, e nel quale propriamente consiste la disciplina, come suona la voce, che significa im;egnarnento e metonimiapprendimento, .w:ienza, arte. Or come l'i m parare intellettivo di una. cognizione speculati\"a. non consiste nelr.werla inte,a unn. volta, ma s'tnell'averltt. appresa in moclo do. ritrovarcela sempre presente alla mente quando ci fa di bisogno; così l'imparare un dovc•re non consiste nel comprenderlo intellet.tivamente, ma sì nell'f'lsegnirlo praticamente; e questa esecltzione •leve constare ùi una serie di atti, devo ciot'· eHsere un abito. E dicesi abito, non abilttdin('; perch•\ ahifo è h\ ripetizione di quest'atti primitivamente ri tlesst\ e meditata, perciò meritoria, perciò virtù: l'abitudine t> la ripetizione materiale, inconscia di Hè medesima • (J ). Pur tenendo conto tli 'lueste considerazioni, può riil dubbio sull'oppot·tnniltl di avere introdotto, nel lJledesimo testo: dne definizioni dello. me(lesima. cosa 6 predi quella principalissima do. cui s'intitola il libro; ma in fonrlo si può convenire che le tlne definizioni non erauo contraù<littorie, nHI. equivalenti, con la sola differemr,A. che l'una era oggt)ttiva, l'altra soggettiva, riguardauio la prima la !lisciplinn. in sè stessa, e la :;econda. ln'\Ct-e il soggetto cui dovevasi applicar€'. E si può senz'altro conchiudere che delle due dcfinizioui era certamente migliore prima, appunto perchè uggettiYa, e quindi invariabile (2): avvertendo che il difetto rilevato dal Fogliani e consistente nel riferirsi l'o:;servanza delle regole dello stato militare all'(ldempimento attuale, piut.to,;t.o che a quello abituale, poteYa facilmente esser tolto coll'aggiungere al sostantivo c os;;ervanza • l'aggettivo c costante » TJa disciplina sarebbe stata così definita. c l'osservanza costante delle regole sullò stato « militare », oppure a11che e meglio <t l'adempimento co• c stante e volonteroso dei doveri propri del militare •. ultima. edizione (1H07) ùel regolamento di disciplina
è ripetuta, a pagina 1, la definizione oggettiva contenuta ne lprecedente; ma a pagina 7 essa dh-enta c l'abitudine

« di adempire tutti questi doveri, di adempirli esattamente. c coscienziosamente, cioè non per timore di pena o speranza -« dì ma per intima persuasione della. loro intrin -
( l ) - nu ovo regolamen to di disciplina». " Riv. mil. italiana •, gennaio 1873, png. 159-160.
(2) Soggettivamente considerata, lu disc ipl ina può essere, a çolta a Yolta, dovere, diritto o •il'tìJ.
J.L2 PER I,A D EFL''HZIOXE DI•:LLA DISCIPLINA
-« seca. necessità » . Ora, per quanto il signi.D.cato possa essere attenuato dalla spiegazione"che segue la parola sta di fatto che questa parola è stata. sostitÙita a quella di abito, jnnegabilmente assai più opportuna pe r i motivi addotti dallo stesso autore di questa specie di definizione.
A pagina l si trova pure scritto : .- La d isciplina s'infonde «in tempo di pace, e si mantiene salda in tempo di guerra, «mercè il diligente, costante abito di osservarne i precetti». Si sostituisca qui, alla parola « disciplina », la definizione datane a pag. 7, e si veda che razza. di discorso ne salta fuori. E ciò prova due cose: che non è propria la definizione, e che l'ultimo periodo citato voleva forse dire un'altra cosa: «Che « la disciplina occorre sia salda sopratutto in guerra e che per raggiungere questo fine è ne cessario sia infusa con l'esercizio del tempo di pace».

Videant con.·mles.
Roma1 19 dicembre 1D07.
PER LA DEFINIZIONE DELLA D I SCfPLINA 143
A.LDERTO Ù.A. \"ACIOOOl!l.

DF.LLA PARilZIONE TEORICA DELL'ARTE MILITARE
' r rattare della partizione teorica dell'arte militare potrà parere a taluni, oggi, una supe1·fiuità, dappoichè :fin dai primi passi nella carriera milltare l'aspirante ufficiale impara a conoscere definizioni, le quali sono per lui ciò che i ferri de l mestiere sono per l'artigiano. Strategia, tattica, Iogistica, organièa, sono oramai considerati come vocaboli tmdizionali noti a tutti e costituiscono da molti anni la bMe dei programmi d'insegnamento negl'instituti militari; siechè si temo che le mutazioni, che si volessero introdun-e nella terminologia ora usata, turberebbero abitudini inveterate e sarebbero agli studiosi più d'imbarazzo che d'aiuto. I conservatori più tenaci giungono sino al punto di negare l ' utilit.n della su questo argomento.
Ji1ppure in realtù. non è cosi. Coloro che avversano, in nome della tradizione, ogni mutamento, non sanno che il nostro frasario militare è poco comprensibile fuori del nostro paese e dimenticano probabilmente quale sia la vera tradizione classica italiana, donde sia venuta a noi la partbdone comunemente acoottata in Italia, quali e quanto disparate siano le opinioni dei più rinomati scrittori italiani ed esteri, antichi e recenti; qnalo infine sia l'evoluzione per cui siamo giunti alle condizioni odierne. Coloro che, in nome della tt·adizione, prerlicauo l'immobilità negando il diritt.o f\. progredire, non banno forse mai pitl rivolto, con in· tento critico, il pensiero a quanto, sui banchi della. scuola, venne loro inseguaéo, adagiandoRi nella beata indolenza Idi chi giura in rerbo magù:tri i mentre invece è noto che la maggior parte dei progressi scientifici è dovuta ad uomini, ebe discepoli ribelli oggi, diventarono i ca.piscuola dell'indomani.
Qnanto poi all'utilità eli una discussione su questo argomento, essa apparirà evidente quando si pensi che parti?.ione teorica di cui trattasi ò la base dei programmi. di studio e che cla essa dipende la concezione pratica che il giovane ufficiale acquista de' propri doveri, in quanto concerne il proprio ulteriore perfezionamento intellettuale.
Ed ora, un po' di storia. Gli scrittori più antichi non si affannarono intorno al problema della partizione teorica dell'arte militare. Nei vocabolari greci troviamo le parole st1·a·

2301
:r *
*
Hi -ANNO LOI. •
tegma, esercito, .strategomai, servir nell'esercito, 8trategia, co· mando dell'esercito, comandante, tactike, l'arte della guerra; nei vocaboli. latini troviamo l;trategeurn, luogo ove i soldati si radunavano, st·1·ategitt7 territorio su cui il pre· fetta aveva giurisdizione i dal che si vede, insieme con la poca corrispondenza tra il significato attribuito alle medesime parole dai Greci, dai Romani e dai moderni, la nessuna preoccupazione di sottili distinzioni in un fatto CO:iÌ oomJ>lesso come la guerra.

Le prime definizioni vengono assai più tardi. Il risorgere della letteratura militare, speute.si con la caduta dell'impero romano, si nccom pagna. in Italia al rinascimento generale de1le arti e delle scienze, che fu conseguenza degli studi compiuti dagli eruèiti sulle nntiche memorie, rimesse alla lnce nel quattrocento e d i vu lgate poi per mezzo della stampa. Tra i primi il :Jiachiavelli, nei sopra. Livio, investigò le cause della libertà e della prosperità di Roma, e nel libro sull'a rte della guerra tentò di ridestare le antiche instituzioni romane; e, come il Maclliavolli, altri scrHLori Ai occuparono d'arto mililare, fra cui il Garimberto, il Busca. il Forni, i l Moutecuccoli, il Palmi ori, per non citare che i principali. Tn Francia emersoro principalmen1.e il Puységur, il "F'euq uières, il Ji'olard, il maresciallo di Sassonia o il Gni· bort; iu Austria il principe di Ligne; ma qua!:òi tutti questi scrittoti, tanto italiani, quanto stl'auiori, nel trattare dell'arte militare non si curarono di .farne una partizione teo· rica cb e ne agevolasse lo studio m<>todico i i più tmttaron.o prom.iscuamente di apparecchio o d'impiego delle forze, ba· dando più ai ftttti quali si presentavano o.lla loro mente e alla successioue loro nel tempo che ad un ordine astratto d'importanza o ad un rnggruppamento della materia secondo un indice scientifico; molti si occuparono di una parte limitata dell'arte militare e accesero dispute sopra un campo ristretto, come, per esempio , quello dell'ordine li· neare e dell'o1·dinl' nella maggior parte dei casi poi, parlarono clell'arte militare senza definirla. eccezione il Forni ed ill\:J:ontecnccoli, ciascuno dei quali dette materia, che costituisce l'arte militare, la partizione ragionata che qui appresso si legge i ma conviene notare che il .l\Iontecuccoli parlò piuttosto di gue1·ra che cl'a1·te mil#m·e, sebbene eg li abbia. ùetto nella. prefazione:
« Videa dell'arte è misura e l'tw> f. maestro delle cose da c farBi; qumdi è che ... si porranno 1u primo luogo, giusta il c concetto dei matematici, i principi e quelle maggiori proc posizioni sulle quah, come sopra stabili basi, l'intelletto
• 2302 DELLA J>ARTIZlONE TEORICA Mif,lTARE
m:LLA PAB.TIZlONlì: TEORICA DELL'ARTE MILITARE 2308
• Millogizzando sicuramente s'appoggia; in secondo luogo « recheranuosi avanti, come proposizioni minori, le pratiche « di essi aforismi ».
Quanto al Maohiavelli, si può considerare come definizione e partizione dall'arto militare questo passo dellib1·o I della gue1·1·a (anno 160G) :
« Ad ordinare un esercito, bisogna trovare gli uomini, « armarli, ordinarli e uei piccoli e grossi ordini esercitarli, w: alloggiarli, e al nimico dipoi, o stando o camminando, ra.p4 presentarli. In queste cose consiste tutta l'industria. della « guerra campale, che è la più necessaria e la. più ono« \'ata (l) .
ll marchese Filippo Forni (Hi40), in un trattato per uso <lei lo milizie pontificie (2), partisce la materia che forma oggetto dell'arte militare nel modo che appare dal sehema:

8 .g
Scelta. Comparti· mento
capi. l dci eoldnti. l
ldolio tru p pc n p i odi. delle truppe 1\ cnvnllo. dei quartieri.
oaor.cizio dci soldo. Li. i! l per mo.rcinro. Diaciplino. ot·dmo.nzo . • . . . ..... per combo.ttoro. ·a
fl
leggi militnri.
·a l
1 del combnttoro in montagna.. l Fazioni l doll'attnccar piazzo. 1della dello piazze
l opportunitt\. del sito. ,S il nomico . . 1 opporttmità del tempo. \ Opportunità dolli opportuni organi. del combnttorlo. clol ritirttrsi da. esso.
Il hlontecuccoli (16G8) ve (3 ) ; (( T,Ja guerra è un'azione d'eserciti offeudentisi in ogni c guisa, il ctù fine si è la vittoria.
(l) Opero di )hcuuvEr.r.l, L. I- Dell'arte <lclla !J!Urra, 3 i9
(2) FORNI.- Nuovo 8tabilimcnto di milizia in servi::io dell'Italia.
(3) - Aforismi dcll'w·te bellica.
r
:!• "' "'
/]
l
« La guerr a è interna od esterna; offensiva o d ifensiva; « marittima o terrestre, rispetto alle persone , al modo ed al « l u ogo diverso .
«La v i ttoria si consegu:isce per mezzo dell' a ppa? ecchio, « della dispo&izione e dell'operazione.
« In ci asched u no di tutt i tre questi membri si hanno
c: vantaggi o disavvantaggi, che sono qualità naturali o ac« quistate, di tempo, di luogo, d'a1·mi o d'altro, che g iovano
c: o nuociono a sormontare il nemico.
« L' appm ·eccltio si fa d'uomini, cl'Mtiglieria, di munizioni, « di bagagli o e d i dan aro.
c: La disposizione si ragguaglia alle forze, al paese, al di-
c: segno che si ha di offendere, di diteudere o di soccor-
« re l'e (l) .
c: L'ope,·azione s'eseguisce con risoluzione, con segrete z za, • f( con ce l erità, marciando, alloggiando, o com battendo :. .
Nell'epoca napoloonica e in quella di poco ltt pr ecedette, q nella che il l\Iontecuccoli chiamo. va diHposizione e il F orni oppo1·tunità incominciò a chiamarsi .'lt?·ategia (2), mentre si disse tattica quella ohe i due scrittori 110minati chiamarono rispettivamente ope,·azione o {a::ioni , sebbene, specie riguardo al Montecuccoli, la conispondenza non fosse perfetta . Qllalctmo anche detite alla strategia il nome di grande e f't'a q nesti va pa.rbico l armeute citato il Guibert (1772), il quale così rag ionava:
c: Agli occhi della maggior parte doi m ilitari, la tattica
« non è che un ramo della guerra: ai miei, essa è la base
« di questo. scienza, anzi è la scienza stessa Bi;;ogna di-
« videro l tatLica. in due parti: l'una elementare e limi-
« tata, l'altra complessa. e subJ i mo. La second11 è, propria-
« mente parlando, la scienza dei generali.. .. essa è tutto, in « una. parola, per chè è l'arte di f are operare le truppe e
(l) Il capitolo che tra.tttl della diRposizione dà norme generali per formulMe il piano d'opomziono e per l' impiego dolht forze; sonn norme tnt.· ticho e strategiche o.d un tempo.
(2) Nella. Jflnciclopédie méthodiquc del 188 7 (Art ruilita iro, tomo IIJ) non si trovo. la pnrolu stratéqie o l'espressione taotique gbtérale ò consido ratl\ equivalente a. quella. di art cle lrs uucrre Nel st,pplément de l 17 9 7 ò la distinzione fra strategia o tattica; iv i si parla di una 8Ciencc 11tratégique, che è la. scion1.a. sublime che dove avE'ro un generale o di oui l a non ò cho una pat·to. più rooonto vocabolario mar ino o militare del Guglielmotti la do· finiziono de llo. strutegio. e della. to.ttioa appa.re non nleno confusa che nell 'antica enciclopedia. sopra ricordata. L'tma e l'altra sono denominate oro. scienza. ed oro. arto; l a str ategio. cornp r endo anche quella. che comunemente dices i tattica e la tattica. s i p uò scambiare con l'ordinamento. c La. tattica. è nr to di composi'l.iono nt1mer ica, come l o. str ategia ò scienza di mo· v imento t r ionfante 1.

2304 DEL T>A PARTIZIONE TEORTOA DE L L'A R TE MlLITARE
•
DELLA PARTIZIONE TEORICA DELL'ARTE MILITARE 2305
< perchè tutte le a l tre parti non sono che cose secondarie,
< le quali, senza di essa, non avrebbero scopo o sarebbero
c soltanto cagione d'imbarazzo. Appunto su questa seconda
c parte (detta, nel seguito dell'opera, grande tattica) abbrac-
c ciata sotto questo vasto aspetto, non esisto alcuno scritto
c dogmatico; alcuni autori ne hanno trattato uno o due
c rami..".. giammai il nesso indispensabile cho hanno tutti
c fra loro .... tutte prove d'ignoranza e della rarità delle
c grandi vedute (l} :..
Dopo la sua prima fortunata campagna, l'arciduca Carlo
dedicò agli ufficiali dell'esercito austriaco un libro eli precetti militari, nel quale sono enunciate nuove definizioni.

c La strategia » egli dice « è la scienza della guerra: essa
c abbozza i disegni, concepisce e dete1·mina lo svolgimento
c delle imprese guetTesche eù è, propriamente parlando, la « scienza dei generali in capo. La tattica è l'qrte della guerra:
c essa insegna il modo in cui i grandi debbono es-
c ser messi ad eil'etto. Quest'art.o è indispensabile a.d ogni
« comandante di corpo » (2).
Il generala Jomini, che tradusse e pubblicò nel18-!7 q uest'opcra dell'arcidnco., fa a questo definizioni il seguente commento:
< La distinzione fatta ùa.ll' A. per definire ùue rami ùi « una medesima scienza oi sembra nn po' troppo sottile.
« Perchè non dire che la strategia è l'arte di dirigere le «proprie masse sul punto deoie>ivo e la tattictt quella d'impegnarvele? »
Napoleone, tanto nella sua voluminosa corrispondonzu., quanto nelle memorie dettate da Sant'Elena, raramenLe adopera le parole IJtrategia e tattica, preferendo pa.dare genericamante di gtterl'tt e dando allo stesso vocabolo tatticlt un si gnificato pure generico, equivalente a. modo d·i e quinch applicabile a qualunque azione umana, e non soltanto a quelle guerresche. La parola che s'incomincia a trovart- negli scritti del Jomini, non ricorre mai in nessun modo, nò come sostantivo, nè come aggettivo, negli scritti napoleonici .
Col Clausewitz e col Jomini si affermano duo scuole diverse: l'una si attiene alla partizione già adottata e che molto non si discosta da quella. degli scritt01·i classici italiani, l'altra si atteggia ad innovatnce e disegna un nuovo quadro Di entrambi gli autori è utile citare il testo.
(l) GtnBERT.- E1111ai général de la guerre..
(2) AnoiOtTCA CAJl.LO. - dtlla strategia.
n Olausewitz (1832), le opere del quale, come è noto, sono postume, non avendo egli creduto, mentre era in vita, che i p r opri scritti avessero raggiunto quel grado di perfezione cui egli avrebbe asp i rato, dice :

« Far la guerra è lottare . . . . la lotta è il solo atto e:ffic cace della complessa attività che in senso lato prende il « nome di guerra....
« Obbligato a lottare, l'uomo cercò di pro cacciarsi il vane taggio per mezzo di invenzioni .... e le prime di que« ste, le armi, creò ed imparò ad adoperare seguendo lana« tura e le necessità della lotta, e subendone le leggi .•..
« L'attivith. che crea l e armi e ne iusegna il maneggio, ch e c presiede cioè alla preparazione alla guetTa, è ben divers a c da quelJa che dirige la guerra ... la lotta si esplica anch e
« senz'armi. "
« Benchè la preparazione e l'esecuzione della gue r ra siano
« l egate da nna mutua azione e reazione - la gnena sugge-
« rlscenuovi mezzi e questi modificano la. forma della guerra
« - tuttavia la guerra ò i u sè un'attività affntto speciale,
c perch ò ò contrassegnata da. una circostanza che le è affatto
« propria: il pe1·icolo, cui soggetti i combattenti e che
« manca completamente alle attività che l a preparano . . ...
c: La distinzione è importa.ntis!'lima e non. ve ne sono altre
« a l trettanto e fU caci per distingn ere le due d i verse attività .
«Si ricordi come perflone molto abili nell'una si siano di -
« mostrati di nua pedanteria dannosa nell'altra, come la
« forza armata sia u n mozzo già. predisposto che si può ado -
« perare bene, conoscendo solamente i modi del suo impiego
c e gli effetti che ne conseguono.
«Adunque l'arte della gnarra in senso ristretto (l(?·iegs-
« kttnst ), poi chè impiega nella lotta i mezzi che si h anno
« a disposizione immediata, n on potrebbe esser meglio de -
« signata che co l nome di arte di condmTo la gnerra , Krieg -
« (u lmtng; mentre i n senso pit\ esteso essa abbraccia ancora
« tutte quelle attivit:\ c h e hanno por fine l a guerra e pa.l'ti-
« co l a.rmente quelle che, rispetto alla creazione de ll a fo r za
« armata, ne assicurano il recl u tamento, l 'armamento, l'equi-
« paggiamento e l'istruzione.
« Per p oter etabi l ire una teoria veramente pratica, è as-
« solutamente necessario distingnere quelle dna categorie di
< att i vità. È facile in ver o comprendere che qualunque teoria
c: di arte militare, che incominciasse a determinare un modo
« unico di apparecchiare e d'impiega r e l e forze armate, sa-
« rebbe applicabile soltanto ne ll e circostanze i n cui l e forze
« esistenti potessero precisamente essere apparecchiate od
« i mpiegate i n q u el modo.
2b06 DELLA PARTIZIONE TEORICA
DELL'ARTE MTLITARE
DELLA PARTIZIONE TEORICA DELL'ARTE mLirARE 2307

Se si vuole invece stabilire una teoria che sorva alla
« pluralità dei e non sia del t.utto inapplicabile in qua l-
« cuno di essi, bisogna fondarla tan(,o sui mezzi comuni di «guerra, quanto sui più essenziali risultati cui essi pos -
• sono condurre.
«La. condotta della guerra abbraccia adunque la prepara-
« zione e la condotta del combattimento; e se quest'ultimo
«consistesse in un'azione unica, non vi sarebbe alctm fon·
« damento pet· una più l:l!mpi.a partizione fra. le at.bività che
« vi concorroHo; ma ..... po;0h ò la lotta si compone invece
" di un numero variabile di azioni isolate e circoscritte, che
«sì chiamano .combattimenti o che costituis00uo di per sè
.. nuovi elementi, ne derivano logicamente due ordini di at-
« ti vità assoltttn.moute distinte, la tc,ttica e la .9tJ·ateoia, la
._ prima. dello quali predispone e dirige l'azione del combat-
« timento, mentre seconda coorcli11a i combattimeuti in
« modo da conseguire il fine ulLimo della guerra.
« La distinzion e fra tattica e strategia è ora di uso co-
"' mune, di guisa che, se nza roud orsi chiammenlo ragione
c clel motivo di essa, ognuno sa abbastanza csn.ttamente a
• quale ùelle due l\7.Ìon_i debba riferirsi un det e rminato atto,
., preso isolatamente. E certo obe 1:10, nell'uso, tt\le pa.rti ·
« zione è cosl ciecamente seguita, dove twe1·o nn serio fon-
c damento; o noi, nella ricerca di questo, fummo appunto
« gl\idati dnll'nHo della. maggiomuza, e non consicleriamo le
«altre distinzioni adoperate da. si1lgoli scrittori, ma che non
« hanno mai potuto diventare di uso comune, p erchè arbi-
• trarie e non derivate dalla natura stessa del le cose. Se-
« condo la 11ostrn. distinzione, la tattica. ò la dottrina che in-
« segna acl Ùlìpie(Jcwe le (ol'ze nel e la strategia
« quella che acl impiegare i combattimenti pe1· conse-
« ynire lo scopo clella guen·a
« 'Preciseremo in seguito il congegno di combattimento iso-
« lato o indipendente, cioè quale sia la sua unità: per ora
• accenniamo soltanto che rispetto allo spazio, cioè fra com-
« batti:rtl.enti contemporanei, l'unità si estende quanto il co-
« mando personale, mentre rispetto al tempo. cioè fra combat-
« timenti che si soguono a breve intervallo, l'unità si p r olunga
« fino allo scioglimento della. crisi che ogni combattimento
<1: determina. per sè stesso.
«I casi dubbi - quando, per esempio, più combattimenti
« isolati potessero considerarsi parte di uno solo - non con-
« dannano la nostra divisione, poichè qualunque fonomeno
« della vita reale presenta differenze grad uali. Tuttavia si deve
« ammettere che vi sono operazioni le qnali, considerate sotto
« m1 certo ap p artengono tanto alla tattica quanto
« alla strategia., come sarebbero talune posizioni così estese da
« assomigliare a. schieramenti di corpi isolati, talvolta le di-
c: sposizioni preliminari per il passaggio di un fiume ecc. ecc.
c Dividiamo l'arte militare in tattica e strategia, tenendo
< conto soltanto dell'impiego delle forze, poichè le molte 11.ltre
« attività che contribuiscono agli atti guerreschi, avvicinan-
« dosi più o meno allo.. tatcica ealla strategia, sono estran ee
«a quell'impiego: sono le ai.tività che hanno per fine il ma n-
« lìeuimento e la conservazione delle forze. Si comprende fa-
« ci lmente che, se occorre ree luta re ed istruire le truppe prima
« d'impiegarle, è assolutamente necessario provvedere ai loro
« bisogni durante l'impiego; e si comprende che tutti i prov-
« vedi menti necessari devono rigorosamente essere considerati
« q ualo preparazione alla lotta, ma solo in q nanto essi si av-
« vioinano molto all'i m piego forze o si alternano costan-
« te monte con questo durante lo svo l gersi della guerra. Sic-
« come il primo c ompito di ogni teoria è di separare fra loro
«gli eterogenei, si ba. duuque un motivo di 3eparare, come
« si fa per tutte le attività che preparano l'esercito, anche
• q nelle occorrenti a.l mantenimento delle truppe dalla con-
« dottn propriamente eletta dell a guena, vale a dire dall' arl.e
« della guorra considerata. nel suo stretto significato; neAstmo
« penserebbe, infatti, a ritener parte della condotta della c guerra tutta la l unga litania dci rli vettovagliamento
« e di amm i nistrazione, poicbb, pur essendo in reciproca re·
« lar.ioue di cause ed effetti con l 'impiego delle bruppe, essi "ne sono essenzialmente diversi, (1).
Il Clausewil;z prosegue distinguendo le attività cho si identificano con la lotta :)tessa e quelle che mirano escluMivamente alla conservazione delle forze; osserva che le marci e, gli accantonamenti e gli accampamenti fanno parte delle p rime, poichè contemplano atti che lasciano sempre presupporre l'idea del combattimento, mentre al contrario i servizi delle sussistenze e di il rifornimento delle armi e dell'equipaggiamento sono attività che si occupano soltanto de ll a conservazione de ll e forze. L a marcia par ticolarmente, astrazione fa.tta dal combattimento, è un mezzo strategico e non soltanto un obbietto d ella strategia; ma siccome le truppe che l a eseguiscono devono in ogni istante essere in g rado di poter combattere, l a. sua esec u zione va soggetta alle leggi della tattica non meno che a quelle della strategia. Qu est a , de l r esto, anche a 1l01·quanuo si propone come scopo

2308 D.Elf, f., A ('AR'rJZIONE 'l'EORlOA AULITARE
(l
) 0 LAUSEVI1'Z.- V om Kriegt, libro II, cap. I.
plinoipale la conservazione dello strumento che deve adoperar e, non esce dal proprio campo, che è quello d'impiegare l e forze; le attività part1colari che a ciò mirano, l 'uso speciale dei mezzi a ciò destinati escono dal campo della pura arte militare, perchè le conoscenze tecniche e le abilità necessarie debbono nell'esercito quando si insegna alle truppe a combattere.
Il Cl ausewitz n cl udo: « Emerge dalle considerazioni -< esposte che le attività alla guerra si dividono c in due grandi rami, quelle che preparano l'azione e quelle " che si esplicano nella guerra stessa; partizione alla quale « deve piegarsi anche la teoria.
«Le conoscenze e le abilità necessarie alla preparazione si c occupano di creare, istruire e mantenere le forze armate, c qualunque sia \.1 nome generico sotto il quale si vogliano « comprendere: vi appartengono 1' artiglieria, l'arte della «fortificazione, la cosicletta tattica elementare, tntta l'or« p;auizzaziona e l'amministrazione della forza armata e si« mili. La teoria della guerra, che si occupa dell'impiego dei « mezzi così apprestati per i suoi scopi abbisogna soltanto
«dei risultat.i ùi quello attiviL}i., o precisameute del.la cono-

« scenza delle qualità. priucipali dei mezzi adoperati .
c Questa chiamiamo noi m·te della guer,·a, nello stretto si-
« gniDcato, oppure teoria della condotta della gtterra, oppure
« teo1·ia sull'impiego dette (o1·ze a.l·mate (1), dtJnominazioni che
c indicano una stessa. cosa. Essa tratterà dunque del com·
« battimento solo per quanto è la lotta propriamente detta,
«e delle maroie, degli accampamenti e degli accantonamenti
« come di stati particolari che a' identi.fìca.no piu o meno col
« combat.timento. Non conside1·erà affatto il ma.utemmento
« delle trnppe come una attività che le appartenga, ma si
c dei suoi risultati nello stesso modo in cui (lovrà
'((considerare i risultati ui altre circostanze di fatto.
« L'arte della. guerra, così limitata, si suddivide in tattica
..: e strategia: la prima. si occupa delle modalità. di ogni sin -
« go1o combattimento, la seconda dell' del combatti-
« mento . Entrambe cons i derano le marcia, gli accampamenti
« e gli accantonamenti so l tanto in relazione al combatti -
c mento, atti elementari che diventano tattici o strategici
« secondo che si riferiscono alle modalità o all'importanza
« del com battimento.
« Molti fra i lettori potranno trovare inutile o superflua
« tale accurata distinzione fra la tattica e la strategia, due
DELLA
TEORICA
2809
PA.RTIZIONE
DJJ:LL1ARTb: r.tiLlT.A.Rm
(l) Theoric dea Kriegfuhrens, Theorie des der Streitkrajte
« cose tanto vicine l' tmn all'altra nel campo dell' azionet
« perohè essa non esercita alcuna influenza immediata sulla
« condotta della gnel'l'a: sarebbe di certo un gran pedante chi cercasse sul campo di battaglia gli effetti immediati di
c tale distinzione teorica .
« :tlfa. poichè il primo dove1·e di ogni teoria è di chiarire e
« di coordinare i concetti e la loro rappresentazione, spesso
« confusi e anche tra loro, non si può sperare
« di poter procedere, con faoilih\ e chiarezza, nel suo svo1-
« gimento a.Uorchè manca la. certezza di aver collocato illet-
« tore nel voluto punto di vista e quando manca l'accordo
c sui nomi da adoperare e sul concetto <•h e q neslii ra.ppre-
« sentano. La taf,ticn. e la strategia, bencbè siano attività es-
« sen:t.ia1mento diverse, hanno molti addentellati nello spn.zio
«e nel tempo e le loro leggi ed i loro reciproci rapporti non
«possono fttcilmente essere pensati e compresi senza preci-
« sarne il conl'et.to con tutta la possibile el3attezza
c Il non ammottere quel dovere del metodo significa c'be
c si rinunzia a qualunque considera.zioue teorica, oppure che
c non si è mai osservato come la mancanza di una tale ana-
« lisi preliminare sui concetti confusi condnca a conolnsioni
« fn.ntastiche, a generalità. vnote di senso, como quelle ohe
« tanto frequentemente si ò di udire e di leg-
« gere » (1).
11 generale Jomini (1837), dott1·inario per eccellenza., così si esprime:

« T/arte <lella. guerra, qualo si concepisce generalmente, si «divide in cinque rami puramente militari..... ma v'à uno.
«parte essenziale di questa scienza che, male a proposito,
« è stata finora esclusa: ta politica della gwm·a.
« Rebbene qne'lta abbia più particolare attinenza con la « scienza dell'uomo di Stato ch e con quella del gùerriero, c dacchè si è immaginato di sepa1·are la toga dalla spada.,
« tuttavia non si può disconoscMe rhe essa è inutile a un « generale in sottordine, è in vece indispensabile a qualunque "generale comandante in capo di un esercito ... ..
« Per queste considerazioni, sembra che l' al' te
« si componga realmente di sei parti ben distinte:
c la prima è la politica della gtte1'1'a ;
« la seconda è la .Ytrategia, o l'arte di ben dirigere le
« masse sul teatro della guerra, sia per l'invasione di un c territorio estero, sia. per la difesa del territorio nazionale;
« la terza. è l a grande tattica. delle battaglie e dei com« battimenti;
(l) CLAUSEWr:rz. - Op. cit.
2310 DELLA PARTIZIONE TEORICA DEJ,L'.ARTE
1\rlLITARI!:
quarta è la logù;tica, o l'applicazione pratica rli
c muovere gli eserciti;
<< la quinta è l' a?·te dell' ingegne1·e, l' attacco e la difesa
« tlelZe (01·tezze ;
« la sesta è la tattica spicciolOt (de détail)
« Vi si potrebbe anche aggiungere la filosofia o la pa1·te
« mo'l'ate della guerra; ma sembra più conveniente riunirla
« in un solo tronco con la politica.
«Noi ci proponiamo di analizzare le principali combina« zioni delle prime quattro parti, non avendo punto lo scopo c di trattare della tattica spicciola, nè dell'arte dell' inge« gnere, che forma scienza a parte.
« Ber essere un buon ufficiale di fanteria., di cavalleria e « ù'arbiglieria è inutile conoscere tutte queste parti uguale mente beM; ma per diventare genemle od ufficiale di stato· « maggiore di merito, questa cognizione è indispellsa« bile..... » (l ) ·
La dottrina dello Jomini fu introdotta in Italia allorchè con l'instituzione della scuola di guerra si dette Ull nuovo indhizzo e un nuovo impulso agli studi militari. Il Ricci prima, il Marselli poi, e così i loro successori fino al1900, divulgarono quella teoria più o me110 modificata e concorsero a farne la base dei programmi d 'insegnamento delle scuole militari, sebbene pochi anni prima dell'opera del Ricèi fosse apparsa qnella del Deoristoforis, il quale si era mantenuto fedele alla dottrina del Olawsewitz e dei suoi predecessori, dando dell'arte militare la seguente partizione:
« Se lo scopo della guerra è la vittoria e questa, è
« dalla massa più forte, la st1·ategia, che sceglie il luogo più
« conveniente alla lotta, sarà: l ' a1·te di condw·1•e i·n massa
« t'ese1·cito non combattente sut punto decisivo. La tattica in-
« vece, la quale manovra le truppe dell'offesa a fine
.: di urtare la linea del nemico nel pòsto più conveniente,
« sarà : t' a1·te di cond-zwre in massa t' ese1·cito combattente sul
« punto decisivo » (2).
Agostino Ricci (1863) dice :

«Non -vi ha forse un'altra disciplina in cui regni minor
« accordo fra. gli scrittori quanto nell'arte militare ... non
« tanto nei dettagli ... bensì nelle questioni generali ... va l e a
« dire nel modo di stabilire le basi sulle quali si fonda, nel
<fissare i limiti della materia... nel deterniinru:e la sua defi-
« nizione...
( l ) JO!IIINJ.- Précis de l'art de la guel'n, 29.
(2) Dm CarSTOFORIS. - Ohe. cosa sia la guerra, 11.
DEL f. A PA:&TlZIONE TEORICA DELL' An.TE MTLI'l'.A.RE 2311
In fatto di arte militare non si tratta più oggidì di creare, « ma solamente di ordinare, poichè anche le idee più nuove
« (non quelle relaLive alle questioni tecniche), o che almeno
« sono tenute per tali, con un po' di pazienza. si scoprono fa« cilmente rivangando i tanti scritti che tralitano della ma.-
< teria, anche talora in quelli più nascosti dalla polvere delle
« biblioteche militari.
c :Ma se la materia abbonda, manca da noi di altrettanto « la forma, un buon sistema generale che la com« prenda, manca in una sola parola l'unità nell'insegnamento
« officiale, ciò cbo è bou diverso dall'esl:lere del tutto igno-
« l'ata ...
«L'arte militw·e, considerata nel campo scientifico, è la « esposizione dei pl'incipii coi quali si devono o,·gan'izzare e far « agil·e le w·rnate moderne (l); nel campo della pratica poi c non è altro che l'applicazione di essi... ne consegno nna uac turn.le divisione del sno insogname11to come scienza in rlue « parti distinte: studio dei principii sull'organizzazione delle « tl.l'mtLto, dei principii sull'impiego delle armate in gucna ... ».
Per procedere alle ulteriori suddivisioni il Ricci adopera. il cri te rio del maresciallo 1\rarmont : • On decou v1·e tm p1·incipe en considérant bien te but et en che1•chant ensuite le meil< leu1· riiO!Jen de l'atteindre ».
« Scopo della orgauizzazione uùlitare di un paese (ol·ga<1( niw) ò quello di creare con gli elementi di forzu. da esso
4 possednt,i dei mez;,i d'azione che possano bastat·o alla tu-
« tela della sna esistenza, contro gli attacchi dai nemici
« esterni e..l interni. Gli elemeutì dt forza, rnoyens potw at-
« teind1•e te bnt, sono: il personale, il materiale, il terreno:
«il primo agisce; il secondo completa. l'azione; il terzo à il « teatro di essa; quindi tre rami distinti dell'orgt\uica che
• '>Ì scindono in altri secondaxi:
c a) re lati vi al personale, cio(• reclutamento, istruzione in-
« tellettual o (scuole), istruzione morale (codice penale, regola-
« mento disciplinare, ricompense), tecnica (tattica delle varie a1:mi), azione colletti va (ordinamento tattico dei
« grandi corpi, gerarchie e comando), amministrazione (prove vedere e render conto);
« b) relativi al ma.terialo, cioè tutti quei mezzi estrin-
« seci all'uomo mediante i quali si mantiene, si sviluppa, si
(l) ll Rtccr dice d'aver tolta questo. definizione dal mo.rescia.llo MA.R(Eaprit dell inatitutions militaircs), cioè : L' ensemble. ck8 oonnaissaMe8 néccssaires pour organiser et oonctuire une masse à'hommes atmées. Alle connaissatJCC8 so:otitul i principii.

2312 DELLA PAUTIZIO::-:E TEORlCA DELL'AR'J.E
MILITARE
AR1'lll 'M I L I TAltlt 2313
modifica o si aumenta. la sua forza fisica-materiale stabile : caserme e altri fabbricati militari (architettura mi-
« litare), p1azze forti (fortificazioni permanenti.), fonderie,
« officine, ecc. (metallurgia, balistica, pirotecnica, mecca-
« nica, ecc .) i materiale mobile (cioè-, sommariamente, arma -
« mento, munizionamento, equipaggiamento, sussistenze, ri -
« monte, mezzi di trasporto, ponti, tel egra-fi, aerostati, ecc. );
« c) relativi al terreno, forme esterne: conoscerle (geo-
« desia, topografia), riprodurle (l\artograna), risorse del ter -
« r eno (statistica militare); circoscrizione militare; difesa

« territoriale degli Stati (piazze forti, comunicazioni). Alla
c conoscenza dei due elementi, materiale e terreno, contri-
« buisoono in larga misura le scienze matematiche e naturali .
«Per insegnare l'i m piego delle armato già organizzate
c non si segue pii1 la partizione derivante dai tre olementi
« personale, materiale e terreno 1 perchè le armate formano
« già un solo st1·uroonto, bonsi il criterio della successione
« delle azioni: p1·elimina1·i, ossia politico-mili-
« tari; operazioni, ossia impiego delle forze per ottenere un
« tlato scopo; o conclnsione, meditmte la quale si rendono
« duraturi per un dato Rpazio di t em po i risultati ottenuti
«con le armi Ciascuno di questi periodi dr. luogo ad u11a
« serie di atti disLinti, i quali vogliouo essere condotti con
« l a scorta c.li princil?ii, il cui studio ò il soggetto della se-
« conda parte dell'arte militare •
« I yrelimina1·i comprendono: la politica della guerra, se si
«vuole all'arte militare propriamente doHa, ma che
« ne informa affatto lo spiri Lo; lo studio del teatro di guerra militare ) ; la mobilitu;r.ione.
« Le operazioni comprendono: i concetti 'delle grandi ope-
« razioni (strategia); .l'esecuzione dei concetti (logistica);
« l'urto delle armate cioè le battaglie (gran tattica,) i opera-
« zioni tli dettaglio (operazioni secondarie o di guerra mi-
c n uta) i operaz10ni speciali (passaggi di fiumi, assedi, im-
« barchi, diversioni, ecc.) i e condotta morale della guerra
«(psicologia mihtare) cioè lo studio e l'impiego di quell'ele-
« mento morale che sempre il soldato porta. seco e da cui
« dipende in cosi grande mii'>ura il di una campagna.
«La conclusione comprende: la diplomazia militare e la « politica finale della guerra, le quali, benchè non parti in-
« tegran t.i dell'arte militare, specie quest'ultima, sono ad essa
« immensamente attinenti e meritano di essere anche per poco
« considerate in un insegnamento completo • (1).
( l) Rtoox.- Dell'insegnamento d ell'arte militare, 13, 14, 34 o 39.
1'EORIOA.
•
Quanto precede è compendiato in una tavola sinottica, che costituisce l'indice dell'altra opera del generale Jticci: In·
troduzione allo delr arte militare (18GB
Nicoh1. Marselli (1875) scri•e:

La prima condizione affinchè una scienza esista e che
• essa delinei nettamente il proprio contenuto, i proprii li-
,, miti... Nella pace apparecchiasi la guerra... còmpito che
, spetta al ministro della guerra.; quello di adoperare l'eser-
"' cito in guerra, al generale che lo comanda; entrambi se-
« con.daH in pace e in guerra. da tntte le autorita che eia
• dipendono ... La guerra consiste nei conflitti armati e nei
c movimenti che a produrli...
« L'istruzione teorica, ossia la scienza della guerra, è, nel
« suo più largo senso, lo studio di tutte le funzioni militari .
« Bssa dividflsi seooudo le funzioni in nna parte che riguarda
« l'apparecchio od organica e iu un'altra. che riguarda l'azione
.c o della guerra in senso ristretto.
« L'o1'ganica è scienza generale dell' organa.mento della po-
c tenza. militare ùi uno Stato; abbraccia tutto il meccanh;mo
" della. potenza militare, ne oveln. i nessi , e comprende
c parti, alcuno delle quali ricevono in essa. un pieno svt-
• luppo; altre lo ricevono in tutte le particolari discipline
c militari... tali sono Pamminù;trazione militare, la. legisZ<t ·
"zione militare,l'artigliel'ia come tecnologia ossia. studio delle
• armi e del relativo materiale, la fortificazione, come sdenza
« del costrnire fortezze, la topografia, come arte del rilevare
• il terreno e di leggere le carte che lo rappresentano ... e vi
c potrebbe trovar posto la pedagogia militare L'orgau i ca
« definisce queste p arti, fa. vedere a <Iua.le scopo provvedono
• nel complesso del lavoro organico, le funzioni n cui si rife-
• riscono, le colloca al proprio posto, lo coonliua
• in luce i nesst e di ciascuna assegna alcuni princi pii fon-
• da.mentali ...
• I.Ja della guerra, nel senso stretto, cioè degli studi
« che- riguardano l 'azione, comprende: la J>Olitic(l della guerrct,
.. siccome quella che assegna lo scopo generale ed i lin1iti
• delle operazioni militari: la sb ·ategia. che precisa lo scopo
c particolare o militare e fa il piano direttore; la logistica
« che si occupa delle disposizioni di marcia per eseguire il strategico e giungere all'urto, cioè alla tattica.
c Vartigliel'ia rientra. in scena come una delle tre armi com·
« battenti, e la fortificazione come trincee da battaglia e la·
c vori campali: cioè rientrano entrambe come elementi della
< tattica, ma, come guen·a delle fortezze, riconquistano una
< posizione più autonoma. La geografia militare si aggiunge
c come studio della natura relativamente all'azione militare.
• 231-.1 DELLA
TEORICA DELL'ARTE )[lLITARE
« E )A. sto1·ia della. guerra? Anch'essa è clat:isificata come -« una delle militari; ma essa è. nel tempo stesso un
c tutto, poichfl comprende l'azione nello spazio e nel tempo eli
c tutti !Jli eze,nenti milttari p1·eparc,ti netta pace » (1).
Il generale Mazzitelli (1879) ripete la definizione del Marselli (2).
Il generale Corticelli (1900) scrive:

« L. Scienza ecl w·te ·militare. Il complesso delle cogni-
« zioni necessarie per condurre e fA.r combattf\re
c gli el:!erciti costituisce la scienza L' a1·te militm·e ò
« la Hcienza in atto, Ol:!sia l'applicazione dei dettami di esl:!a
« ai easi concreti di guerra.
« La blcienza m i l itare si pnò d i v id ere nei segllenti rami:
« l che si occnpa della raccolta e della pro-
« disposizione dei mezzi di aziono, coordinandoli nel mi -
« glior modo perchè se ne possa fare il più efficace impiego;
« 2° lct logistica, ohe ha per oggetto il mantenimento
c dell'eHorcito in la sna sicnrezza o il compi-
c mento dei movimenti Mcessari affine di presentare al ne·
« mico le truppe nelle m1gliori condizioni. per combattere;
« 13° la tatticct, che insegna a combattere per il raggiun·
c gimento dello scopo flnale, la vittoda.
« Vorganica abiJracnia. cosi tuttlt l'opera di preparazione
c alla guerra, mentre la logistica e la. tattica si occupano della
« condotta ed azione degli esel·citi sul teatro di guerra e di
« fronte al nemico.
« 4 ° Nello sopraccennate dottrine costituenti la scienza
« militare non abl>iELmo di proposito incluso ht st1 ·ategia, in·
« quantochè essa non è materia da professarsi in apposito
« cor:io o da apprendersi in particolari trattati o libri. La
.,. strategia è la l:llntesi della scienza militare, od in altri
« termini è la. risultante degli a!.t,i organici, logistici e tR.t-
« tici, coi quali si svolge ogni campao;na. Atti strategici non
«si danno: vi è bensì un pensiero strategico, che dapprima
« presiede all'opera della. prepa.mzione, e quindi determina
« ed informa la condotta delle operazioni, indirizzandole al
« raggiungimento di un dato obbiettivo militare, o militare
«e politico ad un tempo» (3)
Il tenente colonnello Domenico G uerrini, costretto dalla tirannia di nn programma a rispettare la trinità stabilita dai precedenti seri t tori, seri ve:
(l) MARSELLI. -La uuerra e la Bllll storia, 50-53 (3U oùizione).
(2) MAZZlTELLT.- ilrlll militare, 17.
(3) CORTICELLI. - 1'-lt.muale militare, l.
DELLA PARTIZION.E TKORIOA DELL'ARTE
MILITARE 2316
« Si chiama strategia il complesso degli studi e dei prin« cipii che concernono il concetto dell'impiego della forza.
« Si chiama logistica il complesso degli studii e dei princi« pii che governano l'attuazione dei concetti strategici ftt ori « del campo di battaglia.
« Si chiama tattica il complesso degli studii e dei prin« cipii che riflettono l'attuazione dei concetti strategici sul « campo di battaglia » (l).
{t) eli tattica e servizio in guc l'l'a acl t i BO degli a lliet•i uOicia li eli complemento, 9.
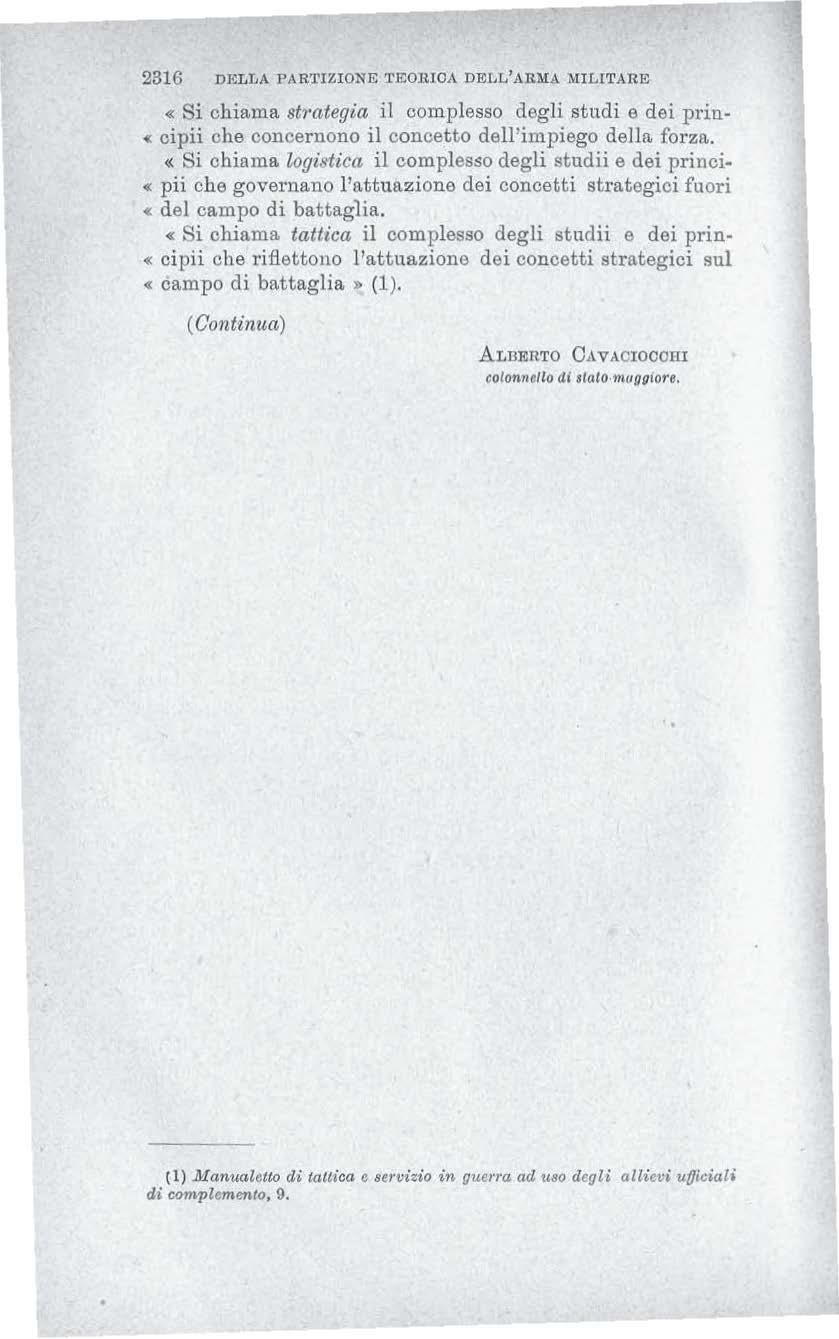
2316 PARTIZIONE
TlllOltJOA DELL'ARMA MILITARE
ALBERTO CA VA OIOOOUI colonnello di ..

DELLA PARTIZIONE TEORICA DELL'ARTE MILITARE

(ContilltUlZÌOJ" t /In,, Xl, pa!l. !311)
Re così poco concordi si palesano le opinioni dei vari scri ttori sulla partizione teorica dell'arte militare in genere: non meno discordi sono quelle sul sigmfìcato e sni limi t i della logistica in pa.rticohu·e. Di questo argomento tra tta. in modo ampio ed esauriente uno scritto del generale Luig i Zuccari (190G), stampa.to ad uso degli ufiiciali della sc uo la di guerra; qui si riassumono pertanto più brevemente i punti principali dell'argomento, aggiungendovi qual ch e considerazione a conferma.
Il generale J omini scrive:
«È la logi.vtica unicamente una scienza di cose minu te?
« oppure è, al contrario, nna scienza generale, che formi u na
« dello parti più essenziali dell'arto della gt1erra; oppure
« iufìue non sarebbe che uu'espressione consl\crala dall ' us o,
« per designare vagamente i liver1:1i rami del servizio di st.ato-
« .maggiore, vale a. dire i Yari modi di applicare allo op ern.-
« zio n i effetti ve lo com binnzioni speculative
« Queste ciomftn<le parranno singolari a coloro che credon o
« form.J.moute che non vi sia più nulla da dire sulla guerra
« e che ::>i ha. torto a cercare nuove definizioni, quando tutto
c sembra loro ben definito. Io invece, persuaso che dall e
« bnone definizioni dPriva la chiarezza delle concezioni, con-
« fesso che sono q nasi imbarazzato a. le accenna te
« questioui, apparentomento cosi semplici.
c Nelle prime edizioni di quest'opera, seguendo l'esempio
c di molti militari ho la. fra i particolari
« d'esecuzioue del servizio di stato-maggiore, che forman o
« oggetto del regolamento per il servizio in guerra. e di qual-
« che istruzione speciale per il corpo dei quartier-mastri.
« Questa opinione era il risultato dei pregiudizi consacrati
«dal tempo; la parola logistù;a deriva, come è noto, da.
« quello di major-général de (tradotta in tedesco con
«quella di qum·tie1•rnei.ste1·), specie di ufficiali che avevano
«una volta la funzione di alloggiare o accampare le truppe,
« di dirigere le colonne, di collocarle sul terreno . .A ciò si
"'limitava tutta la logistica, la quale, come si vede, com-
« prendeva tuttavia la castrametazione ordinana. Ma con
240G
***
c la maniera di far la guerra senza accampamenti, i
c movim enti diventarono più com plìcati e le att r ibuzioni
« dell o stato-maggiore più esteso. n capo di stato-maggiore
«fu incal'icato di trasmettere sui punti più lontani del tea-
c tro della guen-t\ il peusie1·o- del generali::;simo e di pro -
« curare a questo tutti i documenti per basarvi le sue ope-
« razio ni. Associato alle combinazioni di lui, chiamato a
« parteciparle, spiegarle ecl ancue a son•egliame resecnzione
« nel loro complesso come nei minimi ptnticolari, le sue
c funzioni s1 este::;ero nece::;sa.riamente a tutte lo opera zie 11 i
« rli nna campagna..
« D'allora n poi la s ro ienza. d'un capo di stato-maggi(•re dovetLe abbracciare anche tutte le varie parti dell'arte
« della guerrn. e se tal ;;cienza è q uelln. che si denomi llll logibasterebbero appena le due opere dell'arciduca Cado,
" i '\"Oluminosi trattat1 d • l Gttibert, del Laroche-Aymon, del

.- Bousmard e del marchese dì 'l'ernay per abbozzare il corso
• in completo d'una logistica, si m ile, poichè questa non sa-
« rebbe meno che la scienza dell'applicazione di t11tt.e le
.: scienze militari.
cc Da quando precede sembra l'Ìsnltare naturalmente che
< l 'antica logistic:.\ nou potrebbe più bastare per
« la degli e che le funzioni attuali
« òi questo corpo dovrebbero ancora essere formulato, pl\rte
« i n un corpo di dottrine, parte in dispus1zi0ni regola.men -
« tari. :J(a nn complesso soddisfacente non esiste ancora in
« nessun posto.
« Ammesso che l'antica logistica non fosse che una scienza
« di cose m mute per regolare la roaterinlità delle marci e;
c a.mmess -> che le funzioni dello stato-maggiore abbracuino
« oggt le combinazioni più elevate della bisognerò.
4. anche ntnmettere che la logistJCa. uou e più che una parti-
« cell a dell11. scienza degli stati-m aggiori , oppure che bisogna.
< dare ad essa un altro sviluppo e farne una scienza nuova,
.r. che non solamente quella degli stati-maggiori, ma
< anche quella dei gen(lrali in capo »
A conferma ùi ciò, il Jomini enumera di poi i punti prin -
cipali che dovrà comprendere (diciotto) e nei quali è rac-
c h iuso quanto concerne l'impiego e la conservazione della forza; indi soggiunge:
« Esaminando questa "'asta nomenclatura, che si potrebbe
< ancora accrescere eli parecchi articoli minuziosi, ognuno
c protesterà che tutti questi doveri sono tanto que ll i del
c g eneralissimo, q uantu quelli dello stato-maggiore : è questa
< una verità che noi abbiamo testè proclamata, ma è pure
DELLA TEORICA OELL 'ARTE
lllLITARE 2407
c inconrestabile che precisamente affincbè il generale in capo
« possa dedicare tutte le proprie cure alla suprema direzione
« delle operazioni, gli è stato assegnato un capo rii stato-
• maggiore incaricato dei parncolari d'esecuzione: sicchè «tutte le loro attribuzioni sono neces>'ariamente comnni ecl «è rovinoso per l'esercito qut\ndo que:te autontà cessano «di non fame che una sola. Ciò accade tnttana. fin troppo « frequentemente. anzitutto perchè i generali sono uomini « e qnindi ne hanno tutti i difetti, poi perchò non mancano .: nell'esercito interess1 e pretese in rivalitil coi capi di stato< maggiore • (1).
Il D' A.yala così definisce la logi::.tica:
c J,a logistica (cui potrebbo.>i fot-,;;e dare il nome di
c tegin anlmini.-.;/,·ath·o) !'econ.lo il Bardin !:l la scienzn rlel
c rag10namento e del calcolo, la quale, rischiarl\ta dai clati
c della statisti<·a, costituisce ltt. parte specnla.tiva e razionale
c militare: è la •alutazione del campo della guerra,
« il rrlifronto de' disegni approvati, la del 1'o,.;to delle
c fortificazioni, insomma il ramo intellettuale dell'arto,. (2 )
Il generale IHeci cosi parla della logistica:
« Havvi , oltre alla razion1llc concezione di un piano di
c operazioni strategiche, qualche cosa di ben importante: n
c è. in una parola, la. sua e:;ecm-.ione, i cui difetti pogsono
« ma.ndure a rua.le o rendere quanto meuo inutili le piit belle
• • concezionì stra.tegiche. Da qui emerge l'ufficio della loyi-
4. ramo d'arto militare di competenza speoiale degli
« stati-maggiori delle annate.
« Cosi dicendo; non intendo già che la. cura. dell'esecu·
« zione di un piano d'operazioni strategiche sia. estranea ai
« doveri del geuerale che ne ha la e che lo ha.
c formato; ma tengo a Rtabilire due •crità importanti, le «quali sono:
« l ' essere due cose beu distinte la formazione di nn
< piano e la sua esecuzione, ri chiedendo esse delle doti
« aò un Cf'rto punto ,tfl"atto di..er:;e:
« essersi introdotti appunto erl ampliati gli stati-ma.g-
c giori 11elle armate moderne per s<·aricare il generale che
« ne ha il comando d'una parte della sua respou:'la bilità. la
« qtHde, quando materialmente gli fosse las ciata intera. fini·
.c: per essere superiore alle di lui forze.
4 :.\Ia qui cade in acconcio una domanda: dove fìnic:cono i
« doveri del generale e incominciano quelli del sno stato-
11) Jo:v:un. - Préci11 de l'art di'l la qunrt. 14:>.
(2) M.\RtA.>.rO D'AV.U..o\.- Bibliografia militare italiana po.g. XXI.

DELLA P \RTJZJO);E TEORlCA DELL'ARTE
llfLlTARE
PA.Rl'IZIOXE TEORICA D ELI.; .\RTE MILITARE 2409
c maggiore? domanda alla quale non si può darfl una risposta
c assol u ta. poichè la questione è essenzialmente questione di
c: per::;onahtà, tutto dipendendo cla.l cs.ra.ttere e dall'att i tu -
c: dine eli colui che esercita. il comando...
c :4tucliando l&. cosa astrattamente si può ben stabilire e
c sino a un certo punto precisare q mdi siano i doveri de ll a
c e quah quelli della sf1•ategia; ma in pratica i l
c generale non sarà solame11te la personalità stmtegica, come
c: i l sno capo di stato-maggiore non rappresenterà solo la
c: per,;onalità logistica, queste rlne funzioni si compeuetre-
c r anuo a vicenda, talora anche ma nell'opi·
c nione però e anche nel fatto, il peso delle disposizioni eRe-
c enti \'6 ricadrà sul capo di stato-maggiore, come q ut>llo.delle
c concezioni stra.tegicbe san\. devoluto a chi esercita il co-
-< mando ( 1}
l l generale Ricci qui ud1 gli uffizi della logistica non meno nmpliamente eli q tmnto avesse fatto il generale
J omi111, 11oggiungendo che c un n!Ticio importante che cncle
bt•ne nel dominio della logistica, che è quanto dire
...
c nello funzioni degli ufliciali eli stato-maggiore, ti la diplo-
c u/f/Zict militare • {2 )
Lo autore altrove dice dtA la logi:;tica è « l't\ttna-
« zione dei concetti iltrategici col mezzo delle ma.rcie, disio -
• caziom, passaggi di osta.col i tolTi toriali, ecc. • {'3) e in una
istrn-ume •mll' insegnamento alla .9cuol(t supe1·iore eli gw•>'l'a ineùita, aggiunge che -c la logistica ba uel campo
c Hlratcgico L'ufficio stesso bt\ la tattica sn l campo di
« hattnglia -..
J l generale i seri ve:
" La strategia ha per obbietto il disegno delle operazioni
c militari; la logìstica, le disposizioni concernenti l'alterna
c Yicf'nrla di moto e di riposo delle truppe: la tattica, i modi
c rli combattere. La prima f1\ il piano generale; la
c lo eseguisce nel campo della tras lazione; la terza, in quello
« rlell'nrto. La prima. indica la direzione in cui deve spiu-
c il grave; la secondo. ne calcola tutte le resistenze
c lungo il viaggio; Ja terza assegna le leggi dello scontro
«con altro grave. La logistico. è, pertanto, int.imamente e
« prossimamente legata. alla. strategta; è il veicolo pel' e ni il
« del generale arri n\ all'azione tattica delle truppe.
« forma il còmpito più speciale dello stato-maggiore, (l) Rrccr. lnJrodu::ione allo 1tudio Il' arte milit{Jre, 242.

(2) RICCI. - Id. id., 356.
(
3) RLCCI. - Dell'iM egnamen!o dell'arte militare, 7 2.
1
rleputato a fare in un esercito l'oflicio rli nervi eouduttori
« Jel pensiero dal cervello alle membra Il che non vnol dire
• ehe soltanto il capo di stato-maggiore debba occuparsi delle
• modalit<ì logistiche. Se ne occupa a n che chi comanda in
<< capo, benanche chi eseguisce gli ordini. I.,a ste«<:a e1a.bo-
« razione del pia.uo di guena. si fa. attraverso uno studio at-
• tento dell e posdibilità logistiche, senza di che es:;o potrebbe
« !!vanire come sogno fantastico . E si fa pru·e con la previ ·
« sione delle possibilità tattiche. Onde il piano non esce, e
« non deve uscire, dalla. mente del generale come abbozzo
« indeterm-inato o vago, ma come ben delineata figura cui il
« capo di stato-maggiore colorisce ed i comandanti delle
« tmppe incarnano nell'azione. Come potrebbe il generale
« prescrivere la direzione dei mo,·imenti, seuza aver prima
« esaminato se esistano le strade per dar passaggio ad una
« ùata di truppe in un detenninato tempo? Unl\
« eoncrelastrategia f. per sè stessa log1stica suprt>ma o grande
« ehe s i vogha. Per tnl ragione noi vediamo parecchi autod,
« massime ledescbi, restring or:n a disLmguere ·nella seienzn
« della guerra. solamente la strategia. dnlla t.a.ttica e con):;i-
« derare la or ne1la prima, come sceltn. delle strade
« da. percorrere, ed or nella seconda, come particolari clispo-
« sizioni di mar01e e di riposi per andare n combattere. Per
« sta. bi l ire uno. maggior gradazi one nelle idee ci siamo in-
« dotti a seguire l'uso prevahm in altri scrittori, o distiu-
« gniamo l'ordito generale o strategico, che è opera di chi
« co1uanda,, tlalle disposizioni particolari o logisticho che ri·
«g uardano tl <'apodi stato-maggiore, sebbene po:;:;ano \'emr
.- dettate dalla meute stessa che concepisce . Che :;iffatta di-
« stinzione non sia artificiale si tocca con mano quando l'i
«st udio. attentament.e la C'oo·ispondenza di Xapoleone. Voi
« trovato in prima alc uni documenti che contengono il con-
« cetto, anche l'orditura fondamentale delle operazioni da
« eseguire, e poi tlua. sequela cl i lettere ti genera li, a. i capi

« <lei va1·i servizi, in cui con molte particohtrnà si prt:'scri-
« vono le norme per attnare il piano strategico. Uno :-;tesso
« uomo può fare l'uno e l'altro, come spesso fece
c come fa il Moltke che nel {alto è insiem e stratego e capo
« di stato-maggiore; ma ciò non toglie che sieno att.i di-
« stinti per una maggiore o minor dose di generalità. Re
« non che la distinzione è indeterminata. e la sepa.rnzione
non esiste. Un capo di stato-maggiore è l"ombr a. del gene-
« rale , e le due personalità debbono compenetrarsi a ncenda
« t3 fo rm arne una sola, che chiameremo direttit:a. Il gene-
c rale può avere una mente sjntetica e feconda di grandi
2-J:JQ
DffiLLA TEORICA DELL' ARl'r: lflLITARE
« idee, l addov e il suo capo di stato-maggi ore dev'essere u omo
«an ali t i co e d'ordine, come dicesi. Quegl i darà a questo una su cui lavorare; questi, nel porsi all'opera, vedrà. sa l tar
c fu or i le difficoltà dell'operazione; ed allora, di comune ac-
• conlo, elaboreranno quel piano concreto, che comprenderà
« il con cetto o motivo strategico e la forma l ogistica ; con-
« cetto e for m a che sono indisso l ubilmen t e sposat i , sì c h e
« quell o senza questa è vana larva, questa senza quello un
c cor po ino r ganico ...
c N ella logistica. come in ogni umana cosa, bavvi una re-
<( gi one superiore ed una inferiore ; havvi cioò un'alta ed n na
c basi-la logistica, direttiva la pr i ma, esecutiva la seconda.
c è costituita dalle disposizioni del comando dell'e-
< se r cito o almeno d'una di quelle parti (armate) opern.nti con
c. n na certa indipendenza, espresso in ordini cho vengono co -
« m nnico.ti ai comandanti di armata o di corpo d'a r mata;
«questa, dall'esecuzione d i tali ordini, che fa tanto pi\'1
m innhL quanto piil si disceucle per la scala gerarchica. Re
c l' alti\ Jogistica è q nella direttiva, perchè non sarà alta l a
• logistica di un comandante di corpo di armata, che marci
« Ìlòolato? E di fatto non saremmo alieni dal chiamarla t.al e,
« se il corpo d'armata maroiassl'l iRo lato por conseg uire tm
c proprio scopo strategico. In tnl cuso il corpo equ ivarrebbe ad unn piccola armata Rtrategica . se il C'orpo fa parte
,-dell'armata, come accade ordiuario.mente, allora osso marcia secondo una direzione e secondo nua o più prescrit... tegli du l comando dell'armata, nl qna.le, a sua volta, ven· indicate Jo.l supremo com:mdo dell'esen·Uo; ed in tal caso solamente le disposizioni di questo hanno d r itto ad

« essere conside r ate come alta logistica. Questa, come si è
c detto, è il necessario complemento del concetto ;;trategico;
c e però non è in:oeparabile. Con:;isteudo la sna funzione nello
c -; ceglie,•e le linee di marcia e ut" l dare le sul ge -
c nere delle marcia, in conformità. del fine strategico, è er-
e r onco parlare di alta logistica qnando non aRiste indipen -
« denza strategica. L'alta. logistica, nelle recenti campagne,
c ha costituito i l còmpito del ge n. v. 1\l:oHke...
« Dobbiamo noi dichiarare che anche ne ll n. log istica infe -
c r iore, ha.,·vi ragiotle a di-;tingnero una parte diretti va. da
< una esecutiva?
c Or dinariamente ci facciamo l'idea. che lo. logistica si
« arrel:iti con la strategia. al limite esterno di un campo di
« battaglia. Noi possiamo ammettere c h e l a logistic a com -
< prenda gli atti fuori del combattimento, come n dire l' ac-
< cantonamento, la marcia, l'act-ampamento, senza che ciò ne
DEJ,t.
TEORJU.\
A
DELL'ARTE 2411
« debba condurre all' iùea. che essa non varchi pnnto la sogha
« del campo di battaglia. e quindi la logistica non è solo
« strategica, ma anche tattica. Codesto fu vero sempre, ed è più che mai, attesa ]n. grande estensione degli odierni
« oam p i, su cui manovrano grandi masse i n ordine non li-
« neare e saldato. I campi di battaglia si allargano in guisa
« da rendere piit vera la defìniz10ne della gNmde tattica come
« strategia del campo di battaglia...
«Per mostrare sempre più quante cose vivano in uua,
« che le menti non usate a. riflettere credono essere a.utouo-
« mica, a:vvertiremo che la l ogistica, se a prima nsta. paro
« che non esca da altri visceri che da quelh della strategia,
c iu realtà. ò nelle sue disposizioni determinata da fattori
• non solo hlrategici, ma anche tn.ttici ed amministrativi ...
c essa obbedisce pure ad esigenze... in somma esigenze to·
« pografì.che, demogmfiohe, fisiologiche, econo-
« miche, sociali... Per sì fatte ragioni la logistica, sebbene
c prenda uorma dalla strategia, che è la Slll\ anima inform a-
« trice, dalla tattica che lo scopo, pure,
« dalle st.reLt.e dell'tma e dell'altra, riesce a costituirsi ('on
« una sua autonomia, come a 1·te e però come ...
« Prima di l!'eclerico In. Joghticn, come arte, esisteva tlp-
« !lena... (:Ou Federico e più cou };apolcone si fa adulta, cioè,
«C'Ome nrte diviene occupaztonc difficile e complessa. che ri-
« chiede ingegno spec•iale, come sctPnza comincia. a far ca-
« polino col proprio nome nei trattati diclnttici ...
c l .a logistica, es:;e nd o la f0rmn determinaLa e partirolare
« del concetto elevo conformorsi a' principi doli o.
« stmtegia, i quali, alla lor volta, discendono dalla supremo.
«necessità della guerra: vincere la. battaglia. Per conseguire
c tale scopo è necessario accumulare sul campo della. pogua
« nna somma di forze superiore a. quella. dell'inimico: il d1c,
« nel dominio dei rapporti numerici, non si pnò ottenere :.e
« non marciando in guisa che le frazioni dell'esercito
« t:ano riunirs1 meglio di quello che possano le frazioni de!·
« nemico ... È un supremo roucetto logistico ... il
« princip10 dominante la logisticn. > (l)

Il generale Corsi, in un ordine generale per la :wuola ùi guena (inedito) esprime sulla. Loyistica la. seguente opinione:
« Sotto q nesto tj tolo convenzionale si comprende nel corso
«eli questa. scuola, oltre quella parte dell'arte militare cui
« suol darsi comunemente tal nome, a.uchc il serv izio di
<stato-maggi ore e quello d'intendenza in guen·a. La ma te-
2112 DELLA PARTIZIOSE TEOHICA DELL',\RTF: MILITARE
(l) M.UlSELU.- La (ll( trra e la '"a storia, n, 1:>9-173 (34 edizione).
lH:LL.\. .P.AllTIZfOXE T.EO:B.lCA. D.ELL' ARTE MILITARE 2413
c ria è dunque divisa in tre parti. Gli allievi ne han no già
« qualche idea quando ne incominciano lo studio, per effetto
c degli studi anteriori d'organica., tattica. strategia, storia.
c e geografia. militare. l\Ia. qui si attingono cognizioni p re-
c cise, del massimo valore singolarmente per quelli che sa" rann o poi chiamati a far servizio di stato-maggiore . Qui
..: pure, come per l'organica, è mettere a disposi" zione dei discepoli nn sommario dei dati ùi f1\tto e tabelle
• e modelli litografati o stampati, per non perdere tempo in
c de ttatura e compilazioni in cni il profitto sarebbe minore
.: asRa i del lavoro.
c È indispensabile il pitl stretto accordo con l'orga.nic·a. e
c con la tattica... Del resto questa i struzione è di natura sua
c in sommo grado pratica (l ) "·
I l generalo :Moreno, premessa la definizione della Jogistica. qual e fu p i ìt tarùi t\ccettata dal generale Cortioelli, soggiung e:

c Col nome di mezzi logistici, o .w·tizi, intendiamo distin ·
c guere quegli organi dell'e!'lerciLo rhe hanno la
c fm1zionu di soddh;fare i materiali bisogni delle truppe in «campagna.. Questi bh;ogni sono molteplici e prosso i cli-
ct versi eserciti non I:!Ol\0 sempre t>gualmente raggruppati , nò < p er e modo egnalmente !loddisfatti. In generale, «pe r ogni beu definito ed importante bisogno delle truppe
«: h avvi uno speciale serv i zio che funziona. con nn modo or-
c ga.uico proprio e con un proprio pE>rsonale, aln1eno il quale,
• rispetto all'impiego, ha uua. pMticolare gemrrhin.
c Xel loro prooe.,.so i si ì>volgono in tre fasi ben
c distinte:
c fètw! organica, raccoglie e ordina sin dal tempo di pace
..c le rÌtiOl':!e d'ogni natura. del paese;
« f'ctHe logistica (tmminùJtrativlt, fa perveuiro sino a con-
c tatto delle truppe opN·anti le risorse provenic>nti Jall'in -
c terno clel paese, o incettate sul teatro d'operazione;
c d'attuazione, soddisfa. direttamente i bisogni delle
-oc truppe secondo la. destinazione ùi cias cun servizio.
« Lo scopo prinoipal issimo dello operaz i oni logistiche è
« dalla logistica conseguito quando le truppe Hi presentano
" a combattere il nemico nel momento e nel luogo più op-
< portnno, nella direzione più conveniente, nella. più com -
• pleta sicurezza, con la. maggiore possibile conoscenza delle
« condizioni del nemico, nel massimo numero, perfettamente
« fornite di quanto loro occorre, e nella migliore disposi-
(l) Consr. - Della irtm:iow, anno lS.,.J t:ii - \NW Llll.
DJ.;LLA PABT I Z I ONE TEORICA MILITARE
" zione per l'immediato impiego nel combattimento. La
< l ogistica. perciò non può vi vere separatamente dngh altri
< rami della scienza. militare, ne estranea si può mantenere
« a ll e considerazioni d'indole strategica, organica e tattica,
« po i chè anzi aù esse insp i randosi e su di esse influendo,
< concon-e a costituire il tutto armonico ed inseparabile,
« ch e t- appunto la. scienza. militare, di cui solamente il hi-
« sogno espositivo didattico consiglia Ja. separata conside-
« ra zione di parti .
c Ciò spiega perchè vi siano alcune ope r azioni, le quo.li,
c per l a loro funzione rispondendo atl un tempo a considerazioni proprie della logistico. e a considerazioni a questa
« estranee, devono trovar posto tra. le operazioni logi .. ti che.
< henchè non no possono completamente giustificare l'indole
• t>sclusi va.
« Per e<::empio: il passaggio di f01·za. di un tiumo è
« 1mzitutto operazioue tattica per la moclalit:'t del suo svol-
« gimento, ma nello stesso tempo è opemzione tecnica poi
« mezz i cho impiega., ed è operazione logistica. per lo scopo
« pr ecipuo t\ cni ruira, la tra.slazione dAlle truppe da uu
<< punto ad un altro, a l cui conseguimento concorrono i modi
« tattici e i mezzi tecnici. Ne derivn che dello :.;te:;so og-
« getto 1rat.teranuo la tattica, la tecnica., e la.
« ognuno. bensì dal suo punto eli vista t!pecialc 1 ma ognuna
« senza. poter trascurare le esigenze delle altre, tutte seu:r.a
« pot.el' trascurare il modo organico eli es$ere delle truppe.
4' &tesso può dirili del le avanguardie, degli avamposti,
c delle avanscoperte, di quelle operaz10ni cioè che, senza
« u.vcre per scopo dirt>tto il combattimento, devono tt!ner:;i
« pronte a.d impiegare que:lto mezzo per C'Onseguire lo scopo
« logistico; può dirilj a.nzi (li tn.tte le operazioni che piit
• propri;\mente si dicono logistiche, perchè iufi ne anche
• queste non mirano che a preparare l'ttzione tattica, ai
« bisogni de ll a. quale devono perciò soddisfare. .
« l ;e operazioni logistiche possono in diverso modo essere
« classificate. Questo manuale, che nou mira ad una rigo-

« rosa classificazione. ne trattet·il. nell'ordine che
« torna. alla. semplicità de ll 'esposizione. Di (atto il manuale
<r comp r ende netta Operazioni logistiche gli a;·go-
« rnenti: marcie, in lontananza e in vicinanza. del nemico
« - stazioni, accantonamenti e accampamenti- avamposti
« -avanscoperte - passaggio delle linee fluviali, in lon·
« tananza. e in vicinanza del .nemico - passaggio delle zone
« montane - e neU(t catego1·ia Mezzi logistici compi'ende.
24:14
DF.T.LA TEORICA DELL'ARTE MILITARE 2416
c i serdzi d'intendenza, anche ogni sorta di trasporti in ferrovia a sul mare • (1).
Il Guerrini così definisce i compiti della logistica:
c L e operazioni effettive fuori del campo di battaglia si
c ridu cono essenzialmente a dell'esercito, e delle
c sue frazioni.
< P erciò la logistica si occupa essenzia lm ente delle marce
c studiando il modo di nel minor tempo possibile,
c t:ol meno possibile di disagio e di pericolo .
c Tra. due marce, l'esercito, o le sue frazioni, devono so-
c stare, pel riposo o per obbedire a concetti strategici;
« quindi la logistica studia. le stazioni perchè r iescano quanto
c più si può comode e sicure.
c Iu marcia o in !)tazione, l'esercito consnma. vettovaglie,
« Yestiario, ecc., iu combattimento consuma personale e ma-
c terinle: occorre tlunq ue provvedere alla sostitnzione di
c: tutto quello che mnn mano si consuma, epperò la logistica
c ,tuùia ed attua i l'iftJrnimenti.
« Durante le operazioni, una parte de l persona le e del
c mat erhde dell'esercito si ritluco tempor&D<'I\mente inutile
c (l'c r ili, ammalati, nrmi rotte, ecc.): inoltre, cadono in po·
< tere doll'eserçito uomini e materiale del nemico; tutto
« questo personale e questo materiale imbarazzante, peri -
c colo:so, o semplicemente inutile, deve essere allontanato·
c t'pperò la. logistica ne cnra. lo sgomb1·o.
c Inoltre la logistica. provvede al sodisfacimonto di molti
« altri biRogni, come la. cura dei malati e feriti Jeggieri
« (servizio sanitario o servizio veterina1·io)1 le comunicazioni
-« (servizio postale e servizio to1egrnfico), ecc. •· (2) l\Ientre l'uso consacr.wa cosi in ltalia la. pnrtizione dello. materia che torma oggetto dell'arte militare secondo il metodo dello Jomini per successiva evoluzione modificato, ·all'estero era seguito un indirizzo diverso, come appare dalla seguente tabellina. in ctti sono descritto le materie che in alcuni degli istituti superiori d'Europa mirano allo insegnamento della preparazione e della condotta de lla guerra.
(l) :\foR&""o.- Manuale dt louiatica, 30 c 222.
( 2 ) Jfanualttto di fallica e servizio ecc., 10. Si noti t.>hc lo steo'I!O Gueninì, no' suoi studi non adoporu mai. porchù nou ne p1 ov a nonò utilità, il vo<'ttbolo lo{Ji.fltica.

PA IIII'I
École su pèr ro> de guerre (t !lOI)
T attica applicata (divisa in 3 cattedre).
Sto r ia militar<', atrate· giae tattica generale. {llanca quale cattedra a
Mobilitazio n e.
Servizio ùi stnto-magg.
Amrninist t•azione. TaLLiou mwa le.
(:\l t\DCa)
Tattica.
( 1900)
Storia militare e stra · t<'gia. Guerra d'Msedio.
Serviz io di stato giore (ope r azioni).
Servizio el i stato - mal!:giore (amministr.).
(Manca quale cattndrn a Rè)
Coslìtuzionl' ùegli e8C."rciti.
Tattica.
Cl9il3)
Storia militè.re.
Guerra ù'BMt"dio.
Scrvi7JO di stn,o-mRg· giore. Guerra marittima.
Passate cosi in rassegna lo opinioni dci più autorevoli scrittori sulla part.izione teorica. dell'arte militare in genere, e sulla. logistica in ispecie, è agevole scorget'lle lo non piccole divergenze, le quali, insieme con la differenza di metodo e'liste n te di fatto tra. le scuole militari italiane e le principali estere, offrono argomento di meditazione e induoouo uatumlmeuto a. sottoporre opinioni e fatti alla. critica serena od obbietti va. che guidi ricerca <le l meglio: tica <:he ò n n diritto ed un bi.soguo <lell'uomo, mo. che duve rivolger:;i unicamente alle t.eorie e non ai loro autori, serbando la dovuta riverenza. per uomini benemeriti dell'n rto militare quali il Clausewit.z, lo Jomini, il Ricci, il l\!arselli ecc. e tenendo il debito conto dello condizioni di tempo. di stndi, di preparazione, di ambieute frammezzo alle quu.li le varie teorie ebbero vita..
Ciò premesso, conviene ordinatamente, comiuciaudo dallo Jomini, che primo si distacca da.Ua tradizione cl assica ita liana.
La partizione de llo J omini che altro l'enunciazione d i alcuni part i colari aspetti sotto i quali può es,et·e considerata. l'arte della guerra, ne ll a dottrina che 11e e nelle sue manifestazioni . .Manca. perciò l'unità. ili criterio nella partizioue, e gli elementi che ne derivano non sono, come a. filo di logica della stessa SlJecie, ma. di genere diverso . Così nel dist.inguere la politica della gueJTa dalla st? ategia, l o Jomini enumera, secondo il suo concetto,

2416 DET,LA TEOlUCA DELL'ARTE MILITARE
* *"'
due t'unzioni di una stessa persona, il generale in capo; distingu endo poi la logistica dalla !ftrategia e do.ll'arte dell'ingegnere, distingue funzioni di personali eli geuere diverso, essendo, nel suo concetto, la strategia funzione dei generali, la log i stica. degli stati-maggiori e- l'attacco e la difesa delle fortez ;r.e degli ingegneri: infine distinguendo la g1·ande tattica dalla tattica sptcciola, fa nna distinzione basata su ll a gerarl' hia, ossia non più sulla diversità dei personali, ma sulla snddi,·isione di uno stes..;o personale ( l ) E in questa partiz ione generale lo .Jomini parla solo dell'impiego della forza e ne dimentiCll. l'appm·ecchio. Riservando ogni apprezzamen to sul resto , si può :fin d'o r a osservare che nemmeno è suili cientemente giustificato il fare delJa politi ca della guen·a un ramo staccato dell'arte mi l itare, per due motivi principali. Anzitutto, la politica interviene nelle cose mililiari non soltanto col dare speciale carattere alla prepnmzione ed assegnanùo lo scopo finale da raggiung el'e quando venuto il mom ento di ricorre re a.i mezzi apparecchiati per la guerra; ma. durante lo s-çoJgimento delle operazioni guerresche inter-çoien e ancora mutando o modificando lo scopo finale, influisce tsugli alleati e sui neutri, e da ultimo determina le condizioni tli pace. Essa peraltro rimane !>Gmpre n,lla. dipendenza diretta. degli stessi poteri che ln.. reggono in tempo di paco, oggi piit cho nei tempi passati, data la cosr.ituzione attua l o dell e società. civil i .
In :>econdo luogo, se il comandante in capo, pur non av endo h1. politica a propria dispostzione come mezzo diretto, ne subisce l'in Hnenza, questa si estende non solo alla direzione generale delle operazioni, ma pesa a nche sui par· ti eolari, fino al sistema. di alloggiamento e di requisizione e al sen·izio di scoperta e d'informazioni; è dunque un elemen to d 'i nteresse generale, di c ui va. tenuto conto in ogni conting enza pratica o n on può essere da solo ed astrattamento considerato.
Xemmeno è fondato il fare dell'art e dell' in[Jegne,·e, in <pianto concerne l'attacco e la difesa delle fortezze, un ramo a parte, mentre essa. è collegatlli cosi strettamente con tutti gli altri rami, specia lmeate con la strategia e con lo. tatti ca: è evidente che questa separazione è ancora frutto della. tradizione e rimonta al tempo in cui dell'arte dell'ingegnere si considerava. solo la pa.rte
{l) La partizione oho fa lo Jomini si può paragona re n quella cheto.luno facesse della popolazione di una regione, suddividendo g li ab itanti di un in maschj o femmine, quelli di un altro in ricchi e poveri, quelli di un terzo in bruni e biondi. e via di cendo.

DELLA PARTIZIOXE TEORICA DELL' AR'fE :mi.tTARE 2·!17
La partizione fatta dallo Jomiui si può dnnque dire difettosa anche senza sottoporla a più sottile analisi, perchè incompleta e basata su criteri divisori non omogenei, e perchè talune distinzioni non sono sufficientemente fondate.
L'uso di criteri non omogenei per rispetto alla natura della cosa che si considera si riscontra anche nella partizione del Ricci, che deriva direttamente da quella dello Jomini. D Ricci non tenne conto di quanto v'era d'inorgnuico nel lavoro fatto dallo .Jomini, e procedendo sulla stessa. via esagerò nel fissare i criteri di partizioM, nello spingerne l'uso fino alle estreme conseguenze : fece così un lavoro di cristallizzazione, una putizio110 metafisica. Egli adottò molteplici criteri di'risori: la :successione delle az10ni guerresche nel tempo (preliminari, ope1·azioni, conclusione), la ùi"ç'isione della forza ne' suoi (personale, materiale, terreno), la distinzione delle operazioni nelle due fesi di concetto c di esecuzione (strategia, lop;istica), ecc. Ne derivò una partizioue artificiosa e poco adatta agli scopi didattici ni quali mira"a.
Il Ricci seppe precisare meglio, secondo il proprio concetto, il valore dei termilti strategia e e mettere in evidenza. l'importanza dolla condotta mo:ale della guerra. (già. accennata dallo Jomini)1 cbiaman Jola cologia militltre.

Gli difetti notati nelle partizioni dello Jomini e del H.koi si trovano in quella del Mar;;elli, che a quella del Ricci somigha.ntissima. Egli sul nlore de1le ragioni che avevano guidatogli scrittori precede-nti nelleloro definizioni è dubbioso: il dubbio traspare e\·idente dai quesiti che muove a sè stesso e cui risponde sEmza convinzione. LtL partizione che egli accettn. non è altro che la fedele esprAs· sione di quanto era nell'uso e nell'insegnamento niliciale ed è ricca di contraddizioni, le quali appaiono evidenti nelle pagine che trattano della logistico..
La partiziono del Corticelli è una derivazione logica delle precedenti, spinta all'esagerazione di avere abolito la stra· tegia, il cui posto naturale git\ nella stessa definizione del Mnrs elli era stato usurpato dalla logistica..
Infine, cou la partizioue p1·oposta. dal Guerrini, c la oppo· ... sizione fra concetto ed esecuzione, applicata dal generale c Ricci a distinguere la strategia dalla Jogis tica., fu este;;o. «forse per amore di semplicità e di simmetria, a precisare il compito della. tattica rispetto alla strategia.
« La logistica. assume esclusivamente l'aspetto di impiego « della forza come suggeriva il Marselli, ma viene
2418 DELLA PARTJZIONE TEORIC \ DELL'AR'l'E MILtrARE
escluse. da l campo tattico: la tattica. di-çenta. subordinata
c della strategia, mentre ha. in sè un r1nalche cosa di ben
c distinto e di affatto indipendente da tutti gli altri rami
c della guerra; la strategia, bench& confinata. nel concetto
c puro come per l'autore precedente, diventa una premessa
c nece ssaria alle altre due parti:. (1 )
Alla par tizione usata. dal Clausewitz, simile a quella usata clall'Arciduca. Carlo e dagli scrittor i italiani dal Maal Decristoforis (osservando la. sostanza più che i vocabol i , presiede, diversamente che in quella dello Jomini
e nelle sue derivate, ruuità di criterio, data dal pericolo, il quale coufer1sce un carattere particolare alle successiYe operaz ioni. Si ottiene cosi la. distinzione fondamentale Lra la preparaziOni' e la. condotta della gllerra (stabilimento ed i mpiegu secondo il Forni); e poichè quest'ultima consta. di combat.timenti che vanno fra loro coordinati ad uno scopo finale , o che costituiscono azioni isolato e circoscritte da cui deri,-a. ogni volta una nuova Rituazione, ecco uascerne le due attività. diver:>e della tattica e della. (fazioni ed opporlunitiì secondo il Forni), d i cui l'una rigtumla pa.rti<·olarmente il combattimento, l'altra il coorùiuamento dei vari combattimenti. Ed anche 11\ questa sucldinsioue il criterio di base è sempre il pericolo, perchè il combattimento rappresenta appunto jJ momenLo di maggior pericolo.
li Clausewitx adunque, ponendo in luce il carattere di sovrana. indipendenza del combattimento ne l complesso de ll'atti v i tti. guerresca e assumendolo come criterio d ivisore, ha risp ettato, con acume di filosofo e cura d i artista, l'unità. della materia; ma riconoscendo l'esistenza eli una categoria di operazioni, che non sono nè stmtegiche, utl tattiche, e di un 'altra categoria di operazioni comuni alla strategia ed alla tat.t ica, non ha tracciato ueppur 1ni, a malgmdo dei criteri razionali e semplici adottati, nna. classificazione assolutamente chiara. e distinta.
P oichè l'indeterminatezza che rimane nella partizioue del Clausewitz potrebbe far dubitare che a toglierla dovesse concorrere un IJ.Uid mediunt fra. la sir(ltegia e l a tattica, qua l e nel concetto del H.icci e dei suoi seguaci avrebbe dovuto es:-;ere la logistica, conviene fare ancora su qnesto argomento alcune particolari considerazioni, tenendo per base le opinioni varie espresse in proposito.

DELLA P.\RTTZIONE TEORICA DELL'ARTE MILlTARE 2419
**.;:
(l) ZvccARt - Rifluioni sulla logi8tica. 17.
DELLA I"ABTIZI ONE TEORlCA DELL'ARTE lULITABE
Lo Jomini afferma che la logù;tica era materia nota nei tempi precedenti i suoi: v'è eli fatto la nebulosa definizione del Ba.rdin e il von Ilar legg nota come logistù:a si dicesse il semplice calcolo del tempo occorrente per una marcia: cosa invero troppo limitata per formare oggetto di dottrina. speciale (l). Lo stesso Jomini, del resto, esprime, nel principio della sua trattazione, qualche dubbio che lascia insoluto, a meno che non debba intendersi ch'egli, traducendo e stampando nel 18 W l'opera delrarcidnca Carlo sui principi delh\ strategia, nella q unle di logistica non si disCOlTe, abbia inteso di correggere, divulgando la dottrina. di un piit illustre maestro, Popera. propria (2). In questa L\., come abbacinato dalla parola logù;tica, costruì un edificio basato sulle attribuzioni clegl i !>ta.ti-maggi01·i; a. tal fine fece una lunga. enumerazione di tutti gli argomenti che la logistica a>rebbe dovuto comprendere, entrando in minuti particolari; e :;olo al termine di essa capi di essere caduto in un equivoco (clmcttn se 1·écriera qtte tou devoiriS Hont aufanl (/u (jtte rNt.c de l'état·majo1·) e di avere abbo:r.zato l'indice di unlt scienza propria tanto degli stati-maggiori, quanto dei generali.
L'equivoco permano ed aumenta. negli sc1·iltori posteriori; così il Ricci stabilisce esl'lere la logistica ramo dell'arte 1llilitare di compl'tenr.a <legli stlttÌ·mnggiori ed anche dei generali, ma conclude dividendo rigidamente concetto da esecuzione, fa.ceuùo corrispondere alla faso di concetto un determinato ramo dell'arte m ilita.rc, cioè la strategia, alla fase di esecnzitme nn altro ramo, cioò ln. logistica, e consid<:'ra.ndo i due rami come competenza di dut:l diverse categorie di sone (geuernli e L'e!:mme delle pagine scritte dal ) [ arselli sulla logistica. mostra che· anch'egli non si seppe liberare dall'equivoco originn.le, pur tentando ùi correggere rerrore della netta separazione della personalità. de l generu.Je da qnella del c&.po di stato-maggiore. Adottando le idee del Ricci senza esserne interamente convinto e cercando di smu::;sarne gli angoh,
(l) Anche dell!l parola IO!JÌ8tica è assai incerta. Se si ,·ol ess(· risalire a i GrC'ci, vi si troverl'lboo il /.Qcoldr, ,•orrispondente al furiere d'alloggiamento : e nllortl dov r ebbe dir11i c non logi•tica. I n alcuni libri di matematiche dei secoli xvr c xvrr s'indica con lorr·.ftica l'aritmetica e con logistica l'algebra, da louismoll, calcolo.
(2) Nell'avvertenza che prende In traduzione dell'opera dell'Arcidu ca Carlo, si lottge: • Les rnilitaires de tous Ics pays sauront grò à l'aut· ur " du Tl·aité dea urartds opération8 dc leur offrir la tradu• tion d'un OU'Lil-'e • plus complet que le sien..... ».

2·:120
egli giunse ad altre erronee distinzioni, come quelle di una alta e di una ba.s!:a logistica, direttiva la prima, esoc uti va la secon da . L'errore si scorge considerando che in ogni attività guerre sca. concetto ed esecuzione si fondono in un tutto armoni co : in altre parole, ogni comando concepisco ed eseguisce, poichi, eseguisce ri-.petto al precedente e concepisce ris!Jetto al susseguente: e ciò è vero in tutti i gradini della gerarchia. a partire dal generale in capo cl1e compie il mandato nili.datogli dal paese e come conseguenza di e-sso concepis ce il piano di guerra. Se poi ci si addentra nell'interno di un comando (generale e stato-maggiore), si vede che l'opera di concezione, la. quale si traduce nell'ordine trasmesso ad un comando sottoposto, si esplica in due fasi, eli cui l a prim a, e di competenza dello stato-maggiore, consist o nella ricerca di quegli elementi o daLi di fatto, 1mi quali il generale baserà poi la propria concezione definitiva, cotTispondente alla seconda fase. Il concetto del Ricci, se importanza. per fissare la. responsabilità dello !!Lato-mo.ggior e ri,p etto a l generale, no11 ne ha alcuna per fissare la responsabilità del gene r ale verso i suoi superiori od inferiori. Tn realt ù, il concetto, il modo in eui è cong,•gnato l 'esercito, ò la somma algebrica. delle azioni dei vari comandi, a ognuno dci quali spetta. di una parte del coneehto dell'aut orità. fino ai gregari ai quali spetta la SC\mplic e esecuzione, per q 11anto nemmeno sta da esclmlcre nello stesso soldato unn funzione di concetto. Co11cetto ed esecuzion e sono dunque, concludbndo, indissolubilmente uniti nell'azione guerresca ed il voJerli dividere ò <·osa che sfugge dal campo dell'atti\ ità pratica.
Tu tto ciò dovette comprendrro il Corsi, che nella breve inedit a ser i t tura assegna alla parola l ogistù·a un significato conn•nzionale. come ramo d'insegnamento professionale, facend ole comprendere la logist ica comnnemente detta, il servizio di stato-maggiore e il servizio d'intendenza in gnarra, e raccomandanàone il pitl strPtto accordo con l'organica e con l a tattica: il che corrisponde ancora ad una concessione all'u so scolastico, unita alla. riconosciuta. necessihi di moderare e limitare il campo, che per forza delle precedent i definizi oni alla logistica era stato assegnato . ln altri ter min i, fatta eccezione dalla. parola, il Corsi ci riporta alle concl usioni de l Clausewitz, cosicchè si può ancho stretta dei conti riconoscere non essere quella parola necessa ri a, poichè senza aggiungere chiarezza alla distinzione dell 'autore tedesco, può essere causa di confusione, come nell' ultima definizione del Corticelli, nella. quale la. logistica. prende il

DELLA PARTiziOXE 1'EORIOA DELL'ARTE 2121
posto della strategia. La logistica. non può aspirare a formar& trinità con la strategia e con la. tattica, poichè se a queste è possibilo, salvo gli addentellati inevitabili, assegnar e un significato abbastanza precit>o, la logistica invece è parola che l'abi tudine ha re so eccessivamente antonomastica e che, come altre molte, non è solo un traslato, ma nasconde mancanza di contenuto interiore e conduce quindi a gravi errori, o per lo meno ad indeterminatezze. Questo pensiero appa.re evidente, ogniq ual volta si eviti di adoperare l'agget· tivo logistico e vi si sostituisca una indicazione più concreta od anche nulla (1).
Non si può disconoscere l'utilità., anzi la uecessitù di dividere in parti, a scopo !lida.ttico, l'arte militare, come "i fa d'ogni altro corpo di dottrina: negare qnosta verità equivarrebbe ad impedirll lo studio o vano il progresso, non dell'arte, ma dei mezzi che soccorrono l'arte. Occorre porò che la ptwtizione fatta bene, altrimenti l'errore nel divirlere la materia si traduce in co.tt.ivi programmi e in infecondo frutto dell' insegnnmento.
Una dulle per cui la partizione dello Jomini: dP.l Ricci e del l\Iarselli1 non mf>.no che quella dell'arcidu cn. Carlo ed altre dolio stesso genero. non rispon,tono piena· mente allo scopo, sta nella confusione fatta tra. xcienza od arte, o meglio nella pretesa di dar carattere scientifico a. quella che è e non può esser*" rdtro che (IJ•te. Ammessa, per brovitù, como dimostrata questa proposizione; ammesso pure che ogni arte, per quanto degna di tal nome, è soggrtta a. principi e regole chr non si possono impunementP violar e: ma cho nemmeno si pos:;ono con certezza matematica defi-

(l) d'uso l'Olllune pt\J•!ut·c di •·ir·ugnizioni t\ >JCopo logitttiru, di dilli· coltà logi81iche, c. na di endu.
Si OI!Servi quunto più si r eud& l'id••a pal'ltmdo di ric ognizioni a. scopo <ti sosti\ o di morcia, di ditli<-nltà. dipendenti ragioni di vettovaglio.meuto, di climtl, di 11tnl(le. t:· ·c., a "e<·onda del C•tsi L ' ).(· goltivo loyistica o (• vago, o costituisco un ploonasma. Ba><ti ricordnre cho nell'anno scolastico 1905-0u pot6 l'inSC'I(Ilanto di al11t scuola di guerra svolgere l'intero corso Konza nect•sgitÌL tli mai udopcrarl' qul"!ta parola, nè t·omo sostantivo, nò corne aggettivo (tranne che nel titolo dol corso); che l'ufficio Htorico l'ha completamento banditu dal proprio vocabolario; o che allorchò il generale Zuccl\l'i chiese. con una di refol'enàum, la dofillizione della logistit·a a tntti gli allie\·i della s<'uola di guorra, ne ebbe risposte così vario e dispnrato da ribndire la <'OllVinzione che quella parola fosse la cons1>gutmza di un equi,·oco.
2422 Dto;LLA PàRTIZIO::-."E TEORICA DEL!..'
"'• •
ARTE
nire e limit are, sovratutto quando si tratta della parte riservata ai più alti comandi ; considerato poi che il g r ado di certezza aumenta quando si debbono indicare le funzioni di ogni ruota di quel complesso meccanismo che è l'esercito, e che la liber tà :l'aziono che va lasciata ad ogo.i organo diminuisce yja na che si discende dall'alto verso il basso, dall'artista all'arttgiano come direbbe il principe di Ligne; si conferma da u n lato « la necessità di comporre principi e regole in un «corpo di dottrina» (Clausewitz), le quali, pur essendo basate anche sulla nozione di scienze posith·e, non conferiscono carattere di scienza al complesso; dall'altro l' opportunità di tener conto in questa composizione della germ·chia, come quella che meglio d'ogni altro criterio risponde a.lla. ua tura. della. cosa che si considera: l' e.c;ercito. in rapporto questi concett.i con i maggiori raggrup pamenti dell'attività guerr esca.: JJrepara?·e l'ese1'c'Ìto (costituzione di pace, mobilitazione, costituzione di guerra); adunar e l'e>1ercito su,/ teab·o d'ope1·azione (trasporti per terra. e per mare) i impiegare l' (marcia, sosta., loro sicul'(>zza, com ba. t timento) i ma ntenue l' eRercito in C((,mpagna (servizi prosso l'esercito e al suo seguito\ si può riassumere la partiziono naturale, a scopo didattico, clolla materia nel seguente schema, dove di fronte alla natura della cosa sono indicate le corrispondenti attivit:'t:
ESEIICI l'O
C• d' l ••man 1 o statr-magg. ( .FI\l\teria . . . . .
Cavnllerin Artiglieria. . . . . .
Onlinament<>, n. e l più nmpio signifi<"ato di quosta pnrolo. (l).
Sorvizi.
IM I' II': GO
8 cl l marcio l loru eicu-:;; aostt• l rozza S a l Combatt imenti e nts· ::l -o d" !;o ••....
Amrninislraziono. - Con.qervnzionEI della
Con questa pa.rtizione , che si basa sull'esempio autorevole dei vecchi maestri italiani (Machiavellì, Forni, Montecuccolil, si evitano le distinzioni non abbastanza nette di st1·ategia e di tattica, e quella inutile ed anzi scolasti camente

( l ) Secondo la definizione del Gu;;tieln1otti, ordintJmento 11ignifico • mot ·
• l ere a suo posto stabilmente secondo n \l mero, qualità. dotazrooe. mul.istri, coniorwe al piano organico : epperò comprende anche lo stabihra gli obblight militari, che improprinmentu dico>ii reclutamento.
DELL.\ PA.RTIZIO!\E TEORICÀ DELL ' ARTE MILITARE 2433
•
dannosa di logistica, pur offrendo modo d'inquadrare tutta Ja. materia che forma argomento di studio professionale con unità di cri terio e d'indirizzo.
Tutto ciò non esclude che astrattamente si possano anche definire la :strategia e la tattica secondo li Olausewitz, sia pure a titolo di !lemplice erudizione, per chè que.sti vocaboli non tolgono chiar ezza al discorso, laddove siano adoperati con parsim<lllia e in senso mo l to generico: ma quel che importa massimamente è l'educare la giovenhi a rifuggire dal vnniloq uio, ad usare precisione di linguaggio ed a seguire, nell'apprendimento dell'arte militare, un indirizzo pratico.

2124 DELLA PAUTIZIOYE TEORICA
DELL:ARTE MILITARE
AI.BERTO CAV.\C'IOCCRI colmmtlln di ,,,Jio 11111Uf!iorf.


RKLAZIOU SUL COSGRESSO STOR ICO HTERJAZIOULK DI SARAGOZZA
Nel mese di ottobre di quest'anno la città di Saragozza volle, con solenni festeggiamenti, celebra re il centesimo anniversario de' suoi famosi assedi: episodi gloriosi della guerra d'indipendenza di Spagna in cui il popolo e l'esercito, validamente aiutati dagl' lnglesi e dai Portoghesi, riuscirono a l'invasione francese e a conservare l'integrità nazionale.
Il parlamento spaguuolo decise, ed il Re sanzionò, che per l' occasione fosse indetto nella città un congresso storico, al quale fu dato carattere internazionale. I lavori del congresso dovevano essenzialmente porre in rilievo e documentare gli avvenimenti della guerra d'indipendenza in general e e degli assedi di Saragozza in particolare, nonchè le relazioni fra la storia. europea e quelle della Spagna e del Portogallo dal 1807 al 1816.

Perciò il congresso venne ordinato in varie sezioni corrispondenti ai diversi scopi, cioè:
I. Storia politlca della penisola iberica (1807-l Rlf>);
II. Storia militare;
III. Storia interna;
IV. Relazioni con l& storia delle nazioni straniere;
V. Studi a proposito dell'assedio di Saragozza;
VI. Bibliografia, memorie, biografie, corrispondenze, materiali inediti .
Il governo spagnuolo invitò ufficialmente i governi esteri
a. mandare delegati propri, e l'invito venne accettato dall'impero cinese, dagli Stati Uniti dell'America del Nord, dai regni d'Italia, di Portogallo e di Svezia., i quali mandarono ciascuno uno o più delegati (1).
(l)=====;==
Stati
China .. Stati Uniti Id. Id. Id. Id, Id. Id. Id.
Italia Id. Portogallo.
Gli
:'\ o mi
Contfiziooe
:\Jr. Liju Juan . l
Leonard Wood.
C. F. Goodri<'h • Georgo 'to.yl de Langorne
Henry Rosaman Lang .
A. C. Coolidgo . . . .
Mr. Theodoro Davis Boal
Frederic L. Chapin . . l
Clarence S. Hay
Alberto C'avnciocchi
Giulio del Bono . .
.Abel Acncio de Ahneida
Segretario di legazione. Maggior generale. Ammiraglio. Capitano. Capitano di fregata. Professore. Professore. Segretario dolio. ' deleg. Segr. part. di Mr. A. C. Coolidgos. Colonnello. Capitano. Colonnello.
687
Botelho.
Svezia 1 Mr. Arthur Stillo 1 Professore
l!niti: mandarono r"ppresentanza così numerosa per ntto di eunpatu11 e d1 rinnovata amicizia vet·so la Spagna.
..
REI,AZIO:-<E SUL STORICO
Erano rappre!'lentate inoltt·e le università inglese di Oxford (l), la francese di Bordeaux {2) universitil spagnuole.
Presero finalmente parte al congresr:;o molti professori d'università, parecchi ufficiali dell'eserCito spagnuoJo, ecc.
Il 14 di ottobre fu tenuta la seduta inaugurale nell'aula magna dell'università di medicina e di scieuze di Saragozza. Presiedeva, quale rappresentante del Re e del governo, il ministro della guerra Don Femando Primo de Riveira marchese d' Estella. lo stesso che aveva comandato le forze spagnuole alle Filippine; ar:;sistevano i delegati dei vari governi e delle università, i rappresentanti della deputazione provinciale e della giunta comunale, il capitano generale della 5a regione, vari ufficiali di ogni grado e molto pubblico.
Il primo segretario del congresso, sig. Aluè, diede lettura di una breve relazicne sui lavori compiuti dalla com· missione organizzatrice, pose in rilieYO la importanza del congresso medesimo e ringraziò i delegati esteri e nazionali per il contributo dei lavori presentati .

Il rappresentante del comune di Saragozza, in sostituzione dell'alcalde ammalato, salutò in nome della cit.tà il rappresentante del governo, i delegati stranieri e tutti i congressisti . .Parlarono poscia il sig. Ybarra , presidente effetti vo,
13 i delegati esteri a nome del governo rispettivo in questo ordine: delegato della Cina, delegato degli Stati Uniti, delegato dell'Italia, delegat,o del Portogallo, delegato della Rvezia.
Il primo delegato d' Ita.lia pronunziò le parole seguenti :
« Quale rappresentante del governo di S. M. il Re d'Italia,
« porto il più cordiale saluto alla nobile terra di Spagna
« ed al suo Angusto Sovrano, al valoroso esen.nto amico,
« alla imnw1·tale ed eroica città di Saragozza, agli organiz-
« zatori di questo congresso storico internazionale e a tutti
« coloro che d'ogni paese, anehe dalla lontana America e dalla
« lontana Cina, sono qui convenuti a commemorare il glo-
« rioso assedio.
« Alla patria di PalRfox spero riuscirà particolarmente
« gradito q nello clella patria di Cristoforo Colombo, poichè
« il popolo italiano ed il popolo spagnuolo, affini per ori-
« gine, per razza, per costumi, per lingua, per tradizioni,
« hanno e0muni i sentimenti e pari l'entusiasmo nell'arom i-
(l) Sig. Charles Oman, professore nella università di Oxford.
(2) Sig. Marion, professore nell'università di Bordeaux.
688
« rare gli atti di 'valore che non onorano soltanto la na.zione « cui l'eroe appartiene, ma ononmo tutta l'umanità.
« In nome dunque di quel sentimento generoso che qui "' unisce tutti i presenti in un solo pensiero di ammirazione, << io esprimo l'augurio che i lavori del congresso raggiun« gano lo scopo di elevare, a,.i prodi di ogni nazione che ba« gnarono coll6ro sangue i campi della penisola, un monu« mento di ricordi scri'tti, più bello, più grande, più duraturo «che qualsiasi monumento di marmo o di bronzo».
I n seguito pronunziarono brevi discorsi i rappresentanti delle università di Oxford e di Bordeanx, il rettore ·dell'università di Madrid e finalmente il ministro della guerra, il quale con frasi brevi ed espressive rammentò i legami della propria famiglia con Saragozza, che annoverava il padre del ministro tra i suoi difensori
Poscia in nome del Re e governo dichiarò aperto il congresso .
Il 15 di ottobre furono ordinate effettivamente le sezioni e cominciarono i lavori.
A presiedere la seconda fu destinato per quel giorno il "prof. Oman dell'università di . Oxford e nominato segretario il secondo delegato italiano capitano Del Bono.
Aperta l'adunanza il presidente, dopo aver salutato gli intel·venuti, concedette la parola al primo delegato italiano colonnello Cavaciocchi, il quale aveva in preMdenza inviati i lavorl. seguenti, compilati e raccolti per èura dell'ufficio storico del comando del corpo di stato-maggiore:
I. Vicende delle truppe napoletane facenti parte del corpo d'osservazione dei Pirenei orientali durante la campagna dell'anno 1808 nella Catalogna.

II. Diario storico delle truppe italiane in !spagna nell'anno 1811.
III. Diario storico delle truppe italiane in !spagna nell'anno 1813 (1).
Il colonnello Cavaciocchi nel presentare i la"\l'ori stessi, pronunciò le parole seguenti:
« Nessun altro congresso storico, più di questo indetto « per commemorare l 'assedio di Saragozza, poteva a buon « diritto dirsi internazion ale e convocare i rappresentanti -e: di così numerose nazioni. Fra ql}-este, l'Italia, la quale « mandò numerose schiere a combattere nella penisola ibe< rica tra gli anni 1807 e 1813.
<.I> L e notizie conMrnenti le truppe napoletane el'ano state raccolte e capitano Guido De Mayo; quelle concernenti le truppe del regno ttahco dal capitano Aristide Arzan o
&4- ANNO LIV ,
DI SARAGOZZA 689
'
«La maggior parte di queste truppe combattè, è vero, a
« lato delle forze napoleoniche o fusa con esse, contro gli
« Spagnuoliima nemmeno va .dimenticata una legione siculo<< calabrese, costituita a cura di lord Bentink con truppe del «re Ferdinando di Napoli ed emigrati calabresi in Sicilia, la
« quale sbarcò a Cartagena e fu quindi avviata in Catalogna
« ad operare d'accordo con le forze insurrezionali e britanni-
« ehe Ne parla il Napier nella storia della guerra penin« snlare.
« Delle truppe italiane che militarono in Spagna contro
<< gli Spagnuoli occorre distinguere quelle che costituirono
<< intere divisioni (e furono le napoletane e le cisalpine), da
« que lle che fornirono solo il contingente a corpi frau<< ces1.
« I documenti che non in gran copia, stante la brevità del « tempo disponibile tra l'invito al congresso e la convocazione
« di questo, furono potuti trarre dagli archivi di stato di N a-
« poli e di Milano, riguardano le prime, cioè le divisioni del « regno di Napoli e quelle del regno italicoi quanto alle se-
<! conde, cioè ai corpi francesi formati con contingenti ita-
« liani, è necessario ricorrere agli archi vi di Parigi. Di questi •
« corpi si possono particolarmente ricordare:
« il3l 0 leggiero, formato nell799 da Valdesi e reclutato poi con Piemontesi ;
« il 32° leggiero, formato nel 1805 con Liguri, Romani

« e Napoletani i
« il 113° di fanteria, formato nel 1808 con Toscani;
« il 21 o dragoni, formato nel 1.801 con Piemontesi;
« il 26° cacciatori a cavallo, formato nel 1801 con Pie-
« montesi;
« il 28o cacciatori a cavallo, formato nel 1808 con Toscani.
« Nel1808 il 31" leggiero e il 21° dragoni la campa-
« gna con J unot i il 31o leggi ero prese anzi parte al primo a t -
« tacco contro Sa.ragozza, condotto dal generale Lefèvre -
« Desnouettes (v'era eottotenente Eusebio Bava, il generale
« piemontese del1848) . Il 26° cha.sseu1 s raggiunse più tardi,
« combattè gloriosamente contro gl'Inglesi a Rolica (Porto-
« gallo) ed a Vimeiro, ove protesse la ritirata di Junot, bat-
« tuto da W ellington. Il 21° dragoni ·passò poi al corpo di
« Soult ed ebbe parte alla presa di Burgos. Il 113° fanteria,
« del corpo Mortier, rimase jn Aragona. An che il 115" fante-
« ria, che il 10 febbraio 1809 ebbe parte principalissima
« nell'espugnazione del convento di S. Francesco, q_ui in Sa-
690 RELAZIONE
SUL CONGRESSO STORICO
ragozza, era, secondo il Vacani, i n massima parte compo-
«,sto d'Italiani (1).
« Nello stesso anno 1809, dopo presa la Corogna, il 31o leg·
<!: giero rimase a presidiarla; quindi passato al co r po di
« Soult, si trovò all'assalto di Oporto e si segnalò poi a Ta-
·« lavera de la Reyna insieme col 21° dragoni; quest'u l timo
«combattè anche ad Ocaiia.
« All'assedio di Tarragona, diretto dal Gouvion St. Cyr, "presero parte il 113° fanteria ed il 28" chassewrs; questo
« combattè pure a Medelina.
« Nel1810 il 31° leggiero e il 26° 'Chasseurs combatterono
« ad Arapiles e quest'ultimo ebbe parte alla presa di Ciudad
« Rodrig o. '
c. Infine nel 1813, il 21° dragoni combattè a Vittoria con-
-« tro \Vellington.
«Di quanto fecero gl'Italiani riuniti organicamente in
c divisioni non occorre io m'indugi a parlare; tanto più che
« la storia, appunto per questo motivo, è più facile da trae-
c ciare . Basterà che io ricordi i nomi dei principali coman·
c danti, che fQl'ono Lechi, Pino, 1\Iazzucchelli, Severoli e
« P alo m bini.
« Oggi, a cento anni di distanza, ricordando le passate
« lotte senza rancore, si può trovare strano che gl'Italiani
c i quali erano persuasi di combattere a favore della pro·
« pria libertà, combattessero contro la indipendenza spa.-
« gnuola; ma è necessario considerare che essi pensavano
« di sostenere il nuovo regime, figlio della rivoluzione fran-
« cese da Napoleone, contro il vecchio re·
« gime, rappresentato dai nemici di lui, e non si accorgevano
.- della stonatura. Del resto, negli ultimi anni la guerra
« nella penisola iberica era divenuta assai impopolare tra i
« contingenti italici, sopratutto napoletani, tantochò le di-
« serzioni erano numerosissime.
« Per gl'Italiani il concorso alla. guerra di Spagna ha sin-
• golare importanza, non tanto per la causa più o meno
< per la quale essi combatterono, o per il risultato
« finale della campagna, quanto per il fatto che essi, ba-
« gnando del loro sangue i campi eli battaglia della peni·
« sola come quelli di tutti gli altri luoghi dove si decisero
(l) VACANI. - Storia della campagna cùgli Italiani in Spagna, vol. II, pag. 24

. Negli archivi di stato italiani non vi sono prove al riguardo ; tutta-
V"_!&. il llò0 fosso tra i reggimenti schiettamente francesi, non
81 può m modo assoluto escludere la veridicità di tale affermazione, poiché
le :r:eolute italiane erano generalmente ripartite fra molti reggimenti, che vanavano d'anno in anno.
INTERNAZIONALE DI SARAGOZZA 691
SUL CONGRE&SO STORICO
«le sorti del gran Corso, impararono a conoscersi e ad ape prezzarsi nel nome d'Italia.. E questo dovè pensare lo stesso c esule di S . Elena, allorchè dettò la profezia che l'Italia
c avrebbe un giorno formato indubbiamente una o-rande c nazione, con Roma capitale. o
c Se nel periodo napoleonico le truppe italiane si trova« rono generalmente cont1·o le spagnuole, in altre occasioni, « immediatamente prima e dopo, si trovarono invece le une « a fianco delle altre.
c: Nel 1793, Tolone fu assediata dalle truppe repubblican'e « francesi. La difesero I nglesi, Spagnuoli, Napoletani e Piec montesi, col sussidio delle rispettive flotte (rappresen« tava la flotta del re di Sardegna la fregata S. Vittorio).

c Senza esporre tutte le vicende di questo assedio, che finì
« con la vittoria. dei Francesi, ne rammenterò soltanto un
« episodio. In un rapporto scritto dopo il fatto d'arme del
c: 1° ottobre, nel quale gli alleati s'impadronirono d i due pie-.
« cole ridotte, costruite dai Francesi sotto il forte Faraone,
« il -brigadiere generale lord Malgrave elogia le truppe che
c combatterono e specialmente le sarde' e le napoletane.
« Elogia il generale Gravina e il brigadiere generale Pi-
« g11atelli e « le sergent Moreno de la marine espa.gno1e
c: qui, suivi de trois braves soldats du meme corps avec ·
« un coura.ge et une adresse sans égal tra.ça la ligne sur
« laquelle devaient marcher les colonnes a droite, et cela à
« la portée d'un coup de pistolet à la fa.ce de la garde a-
« vancée de l'ennemi (l).
« Più tardi, nel 1835, furono inviate dalla. Francia in soc.
«corso del governo spagnuolo contro i Carlisti ·alcune le·
« gioni straniere che combatterono in Biscaglia. Il 5° bat-
« taglione della l legione era composto d'Italiani.
« Oggi, nel commemorare l'eroica difesa della città c im-
« mortale •, tutti qnesti ricordi si affollano naturalmente
« dinnanzi alla nostra. immaginazione e l'Italia rinata è lieta
«di salutare qui, insieme con gli Spagnuoli che seppero
« conservare la propria indipendenza, anche gli alleati d'un
c giorno, riuniti con fraterno cameratismo ad illustrare il
c valore dei combattenti che furono, e ad onorare i caduti
« d'ambo le parti. Passata la bufera che !JUrifica il cielo,
« questo appare più azzurro e più limpido, promettitore di
« un avvenire fecondo di pace e di prosperità ».
Per maggior chiarezza della presente e8posizione giova ora dare qualche cenno più particolareggiato sugli st udi e
G92
RELAZIONE
(l) Archivio di stato di Torino, soz. 1", mazzo 11° (imprese militari). L•,ttcl'e. del lt10gotencnte colonnello de Revel.
-sui documenti presentati dai delegati italiani in nome dell'ufficio storico.
Il primo di essi narra le vicende delle truppe napolitane ,facenti parte del corpo d'osservazione dei Pirenei durante la campagna -del 1808 in Catalogna. Occorre rammentare che sul :finire del 1807, mentre il corpo d'armata francese ·di Junot e quelli di Dupont e di Moncey penetravano rispettivamente in Portogallo ed in Spagna, Napoleone concentrò una forte a Bajona ed un altro nucleo nel Rossiglion e, ai quali dette il nome di esercito d'osse1·vazione dei Pirenei orientali. Posti agli ordini del generale Duhesme, questi corpi comprendevano truppe francesi ed italiane: le prime agli ordini dei generali Chabran, Bessières e Schwarz, le seconde - riunite in una sola di visione di circa 6000 uomini e 800 CA.\alli - agli ordini del generale conte Giuseppe Lechi da Brescia.
La divisione italiana era stata formata, per ordine dell'imperatore, con truppe del regno d'Italia e del regno di Napoli. Queste si componevano del l o di linea sotto il comando del colonnello Pégot e del 2• reggimento cac·ciatori a cavallo sotto il comando del colonnello Zenardi.
Nel febbraio del 1808 la divisione italiana entrò in Catalogna ed andò a presidiate Barcellona ed i forti citconvicini. Durante l'anno compi un servizio di colonne mobili dirette contro gl'insorti spagnuoli, che occasionò parecchi scontri narrati diffusamente nella memoria presentata .

Questa si basa principalmente su tre documenti trQvati nell'archivio di stato di N a poli, (l} cioè:
(l) Vennero consultate inoltre le opero seguenti: GouviON-S,t.mT - Giornale delle operazioni militari nella Catalogna durante glb anni 1808 e 180fl.
Nal'IETL - Storia della guerra ddla e d el m ezzogiorno della :Francia dal l807 al 1814.
:MATHlEU Dt1lllAS - Cenno sugli avvenimenti militari sulle campagne dal 1799 al 1814 (campagM del 1808). Torno ventesimo.
NApOLEONE. - militare di Napoleone (note sottoscritte dal generale Bertrand e destinate al generale Savary).
DoN CAVALLERO. - Di/esa di Sw·agozza o relazione dei due assedi sostenuti da codesw città nel 1808 e 1809.
A. ZANOLI. - Bulla milizia ci8alpina-·italìana: cenni stot·ici statistici. dal 1796 al 1814.
C. VaCANI. - Storia delle campagne e degU, assedi degli Italiani in !spagna dal 1808 al 1813.
CoLLINGwooo. -Corrispondenza con Sitr Hew Dalrymple (comandante delle forze inglesi in Portogallo).
ALPRONSE DE BEAUOHAMl'. - Btoria della guet·ra di Spagna e di Por4ogallo durante gli anni 1807-1813.
JoRN JONES. - -Note e commentari.
Ll!l.ll'ÈVRE. - Giomale delle operc&Zioni. ·
INTERNAZIONALE DI S.ARAGOZZA 693
l' Un rapporto del generale Duhesme a S. M. il Re delle Due Sicilia, datato 11 gennaio 1809, da Barcellona e riferentesi alle operazioni militari mandate a compimento dal corpo d'armata dei Pirenei orientali durante l'anno 180&,
2" Un cenno generico (in a:coompagnamento allo stesso) al valore dimostrato dagl i ufficiali e dalle truppe e due gimenti napoletani, che facevano parte d9l corpo d'armata surriferito, nei ripetuti sçontri cui parteciparono. A esso tengono dietro le specificate proposte d'avanzamento pe1· meriti dì guerra, concernenti i l colonnello Zenardi del 2° cacciatori a cavallo, il colonnello Pégot del l 0 reggiment<:> di linea napolitano ed i capi battaglione d'Ambrosia e d'Aquino dello stesso corpo;
3° Il rapporto del colonnello Guglielmo Pégot del l o reggimento di linea napolitano sulle operazioni del corpo d'armata dei Pirenei orientali.
Questi rapporti, confrontati con le narrazioni di fonte più svariata, cioè italiane, fra.ncesi e spagnuole, vengono confermati con esattezza in tutte le loro parti sin nei più minuti particolari ed essendo compilati da Francesi non dànno motivo a temere che esaltino oltre misura le gesta dei reparti napolitani posti ai loro ordini.
Il rapporto compilato dal colonnello Pégot offre, come-ènaturale, maggior copia di particolari, relativamente alla partecipazione del suo l o di linea napolitauo alla campagna del 1808 in Catalogna, di quella rinvenuta nella relazione redatta al tempo stesso dal generale Duhesme; ma i due rapporti, controllandosi vicendevolmente, concordano appieno nel riconoscere gli ottimi servigi prestati da quel valoroso corpo, salito in breve tempo ad alto grado di estimazione presso i più vecchi e famosi napoleo- .. nico. Infine le successive proposte d'avanzamento pei principali comandanti uapolitani, contenute nella lettera colla quale il generale Duhesme accompagnava la trasmissione

a. S. M. il Re delle Due Sicilie (l) del rapporto circa le
CABANES. - Guerra di Catalogna; parte prilna.
THIÉBAULT- - Spedizione del Portogallo.
HEw DALl.\Yllf.E'LE. - Corrispondenza riguardante le opemz.ioni militari ru-l Port.ogallo durante il 1808.
F:t."RRARELLt- Il generale D'AmbroBioDE LAUGIER. - Fasti e vicende dei popoli italiani d<ll 1808 al lSlS.
A. L. - Lettere a"gli Italiani in Catalogna.
LrssoNI. - Fatti storico-militari 1800-1813.
TUROTTI. - St.oria delle armi italiane dal 1796 al 1814
TR:ffiCBERA. - Degli. archivi napoletatti.
(l) In realtà, Gia.cchino Mura.t regnava soltanto in pot·chè in Sicilia. era.si rifugiato il Borbone. Ma il rapporto era indirizzato al re delle Due Sicilia.
694
RELAZIONE SUl, CONGRESSO STORICO
operazioni del corpo d'armata dei Pirenei orientali, sono conferme ineccepibili della valorosa condotta dei due reggimenti napolitani addettigli nella éampagna tlel 1808 i n Catalogna. E però i termini altamente lusinghieri, adoperati all'indirizzo dell'opera del colonnello Zenardi, comandante il 2" reggimento cacciatori a cavallo napolitani, ridon.dano a lustro dell'intiero corpo ai suoi ordini, e suppliscono in parte alla mancanza, per tale reggimento, di un rapporto analogo a quello redatto dal coJonnello Pègot pel l o di linea. Del resto tutti gli stori ci militari più autorevoli, che impresero a narrare i fasti delle truppe italiane nelle guerre di Spagna, particolarmente il Vacani e lo Zanoli, sono unanimi nel riconoscere la bella prova fatta dai contingenti dell'esercito delle Due Sicilie (l).
Nel settembre dello stesso anno 1808 fu apparecchiata una seconda divi sione i taliana agli ordini del generale Pino, la quale fece parte del VII corpo francese generale Gouvion Saint Cyr. Questo corpo, dopo presa la fortezza · di Rosas, ruppe l'investimento di Barcellona ed entrò nella città; e nel successivo anno 1809, rinforzato dalla divisione. Lechi, assediò e prese Gerona. Durante queste operazioni il Saint-Cyr fu sostituito dall'A.ugerau.
Nel 1810 le due d i visioni italiane, molto stremate di forze, furono fuse in una sola divisione al comando del generale Mazzucchelli, poi del generale Severoli, quindi del genera l e Pino ed infine del generale Fontana. La divisione assediò e prese Hostalrich e compì altre operazioni minori. Entro l'anno, l' A.ugerau fn sostituito dal Macdonald.
Il sMondo dei lavori presentati contiene il diario delle operazioni della divisione italiana operante in Catalogna ed A.ragona, dal novembre 1810 al dicembre 1811, ma è manchevole dei mesi di giugno e di settembre.

L e truppe italiane durante questo periodo fecero parte, sino a tutto il di marzo, dell'armata di Catalogna (maresciallo Macdonald) e con essa operarono, prima verso il basso Ebro per aiut.are l'armata d'Aragona (maresciallo Suchet) all'espugnazione di Tortosa, poi verso Tarragona, per tentarne, senza risultato, la presa.
r(l) In tem po utile prima. dello. chiusura del congresso furono inviati a Saragozza altri importanti documenti rintracciati nell'archivio di Stato di NapolL Essi saranno perciò compresi nella pubblicazion e cui attende la commissione organizzatrice de l c ongresso. .
INTERNAZIONALE J).I SARAGOZZA 695
STORICO
Napoleone tolse, verso la :fine di marzo: al maresciallo Macdonald Fincarico di espugnare T arragona e lo affidò al maresciallo Suchet, cosicchè la divisione italiana passò alla dipendenza di quest'ultimo e con l'armata di lui strinse d'assedio la fortezza, la quale cadde il 28 di giugno.
Nel luglio e nell'agosto la divisione venne divisa: la brigata Bala.thier, agli ordini diretti del divisionario Peyri, si trasferì prima a Saragozza, poscia operò verso i confini di Valenza, it;J. unione alle divisioni francesi Harispe e Montmarie, contro i corpi spa.gnuoli di Villacampa e di Campillo; :finalmente il 20 di agosto passò l'Ebro versu Lerida e Igualada; la brigata Palombini tornò subito in Catalogna lJer difendere il Montserrat e il 23 d'agosto s'avviò verso Figueras per dar mano al corpo di Macdonald nell'espugnazione di questa -città.
Caduta Figueras prima dell'arrivo della brigata Palom· bini, le truppe italiane furono nuovamente, nella prima quindicina di settembre , riunite all'armata del maresciallo Suchet. Il 17 del mese istesso il Peyri tornò in Italia e il comando della divisione fu assunto dal generale Palombini.
Nella seconda metà di settembre l'armata di Suchet, e con essa la divisione italiana, penetrò nella regione di Valenza e campeggiò dapprima s otto Sagunto tentandone l'assalto di viva forza. Non essendo questo riuscito, l'armata pose l'assedio alla fortezza.
Nell'ottobre, un corpo misto d'Italiani e Francesi condotti dal g enerale Palombini mo sse in soccorso di Teruel , minacciato dalle truppe di Obispo; ma essendosi questo ritirato, tornò indietro a tempo per prender parte alla ba ttaglia di Sagnnto (25 ottobre). Caduta questa fortezza (26 ottObre), Suchet assediò Valenza, la quale dopo una resistenz a gloriosa si arrese onorevolmente il H gennaio 1812.
Caduta Valenza, le due divisioni italiane vennero nel181 2 mandate in a proteggere le ietrovie, trovandosi in tal modo impigliate in continui combattimenti.
Il terzo dei lavori presentati comprende il diario delle operazioni della divisione italiana durante il1813. Sui primi di tale anno, la divisione italiana comandata dal gen!')rale Palombini, che stazionava nei dintorni di Madrid, ebbe ordine di trasferirsi in Biscaglia per aiutarvi il corpo d'operazione frane;ese, e di liberare, attraversando la vec chia Castiglia, la ]jnea di comunicazione dell'esercito del centro con la Francia dalle incursioni delle truppe spagnuole, soccorrendo pure di viveri i presid i stretti dal nemico. La

RELAZIONE SUL CONGRESSO
Jl
sione per Segovia, Valladolid e Burgos giunse in febbraio nella Bureba, dove, dal 9 al12, sostenne vari combattimenti, l'ultimo dei quali, vittorioso, le permise di procedere verso l'obbiettivo che le era stato fissato.
Giunse così a Bilbao il 22 di febbraio e ne rafforzò la difesa.
Nella seconda quindicina di marzo venne diretta all'attacco di Oa.stro,·attacco ohe andò fallito, tanto per la tenacia dei difensori, quanto per la man cata preparazione del comandante generale francese .
Nell'aprile gl'Italiani percorsero i monti di Biscaglia e di Guipus coa, combattendo contro i battaglioni spagnuo li il 2 a Guernica, il 5 a Narvanis, il9 ad Ayscotia: ma le minaccie degli Spagnoli su Bilbao li costrinsero a retrocedere in soccorso d ella città. ·
Nei primi giorni di maggio la di visione venne ridotta ad una brigata, della guale assuns e il comando il generale S .t Paul. Nel mese istesso concorse all'assedio regolare di Castro, che cadde il giorno 12. . ·
Durante il resto del mese di maggio e nel giugno prese cura dello stato difensivo di Castro e di Bilbao e fece frequenti sortite contro i battaglioni spagnuoli .
La mala piega delle operazioni francesi nella regione ob· bligò gl'Italiani a sgombrare Bilbao il 20 di giugno, dirigendosi a Durando e pos cia a \"ergara. Di qui protessero, in retroguardia, la ritirata dell'eser cito francese sulla destra della Bidassoa.
Alla ripresa delle operazioni, dirette dal maresciallo Soult, la brigata italiana passò a far parte della divisione di riser\a comandata dal generale Vilatte e rimase, dall'agosto al novembre, nei pressi di Orogne e di Serres, a. coprire gli sbocchi della Navan·a, erigendo ridotti di difesa a cavallo . della grande strada di Bajona fra S. Jean de IJ\lZ e il forte di Socoa.

Nella slconda. quindicina di novembre, per le sconfitte patite dall'armata, la brigata iniziò la ritirata nel territorio francese e, congiungendosi con le altre truppe italiane provenienti dai Pirenei, volse verso Grenoble, dove giunse alla fine dell'anno. Rientrò poscia in Halia.
Nello stesso giorno 15 ottobre, dopo che ebbe parlato il colonnello Cavacioccbi suìla memoria e sui documenti di cui si è fatto cenno, il presidente prof. Oman diede lettura d'un lavoro inedito e molto interessante intitolato : Dia1·ìo -di si1· Oharles r mtghan in Spagna, 1808.
IXTl':RNAZ!OXALE Dt SARAGOZZA 697
·
SUL CO::iGRESSO STORICO
Nei giorni successivi fLtrono presentate e lette nella 2a sezione altre memorie, interessanti la storia militare di questo periodo: di esse vanno rilevate le seguenti:
1° Collezione di docMmenti dell'ese1·cito {1·ancese dal 1808 al180!J, del sig. Gregorio Garcia Arista;
2• Si1· Chm·les Doyle e il suo piano eli socC01'80 a Sa1·ayozzc6, del sig. :Mariano de Pano y Ruata ;
3° Etude su1" les gzeen·es d' Espagne del commandant Bagès;
4° Elogio clel rnm·esciallo Suchet, del prof. Marion ;
5° La penisola ibe1ica cvntro Napoleone. essenziali e ce1tni gene1·ali sul movimento. Sue conseguenze im,necliate pm·· il P01·togaUo, del colonnello porto-ghese A. bel Bo t elho;
6° Stndio biog1·a(ico e critico sop1•a D. Fernando Gm·cia y "ltléin, del sig. Zapia; '
La cavalle1·ia spagnuola nella gum·ra d'indipendenza, del sig. Eliseo Lanz;
8 ' Napoleone e la gub·ra nella penisola, del colonnello del genio Bonus;
9° La gum·ra dell'indipendenza, come fattoJ•e del p?·ogresso, del colonnello di fanteria Emanuele Diaz;
10" Assedio di Sa'ragozza, del generale La Sala.
Questi lavori, ad eccezione dei tre primi, ebbero più che· altro carattere di conferenze o di studi tratti da libri già esistenti, e soltanto i tre primi valsero essenzia l mente a porre in luce documenti inediti.
Conviene altresì ricordare due pubblicazioni fatte nell'occasione del congresso e cioè:
La condesa de Btweta y a Regente, del sig. Mariano De Pano y Ruata (storia aneddotica condotta su documenti inediti);
Sitio de Zaragoza, di F. R. Laudeyra y F . Galiay (versione e critica della relazione francese dal generale Rogniat).
Il giorno 20 ottobre venne dennitivamente chfuso il congresso con cerimoniale analogo a quello usato per la seduta. inaugurale.
Dopo che il segretario ebbe brevemente riassunto i lavori compiuti, parlarono il rappresentante della città, i delegati delle varie nazioni, i rappreséntanti delle università e finalmente il b!memerito presidente effettivo sig. Yba.rra .
Il primo delegato ita l iano, a suo turno, ricordò che l'Italia aveva anch'essa, come la Spagna, dovuto conquistare la propria indipendenza a prezzo di sangue; mise in rilievo le analogie tra la difesa di Saragozza del 1808-09 e la difesa

• 698 RELAZIONE
di Roma. del 1849, tra l'eroe popolare spa.gnuolo, Pala.fox, e l'eroe popolare italiano, Garibaldi; e soggiunse:

«Ma non soltanto questi ricordi e questi pensieri io porto «con me dalla nobile e tanto ospitale terra di Spagna; il «azzurro d' Italia mi ricorderà pure il bel cielo di Spagna, <la leggiadria delle donue italiane mi ricorderà la bellezzar «la grazia., la gentilezza delle doune spagnuole.
< Ond'è che affollandosi queste rimembranze nella mia. « mente, uno solo sarà il mio sentimento; ed il mio pensiero «volerà sempre riconoscente dalla città eterna, Roma, alla.. « città irnmo1·tale, Saragozza :. .
Roma, 7 novembre 1908.
INTERNAZIONALE DI SAR.AGOZZA 699'
A.cnu:nTo C,\vAcroccm. colonnrllo.

DOPO CUSTOZA (1866)

(Risposta al !Jtnerale B. 0H"Eno)
Sotto il titolo: Dopo il generale Orero pubblica nel fascicolo del dicembre l !l()!) della Nuova Antologia uno studio critico sulla recente opera dell'ufficio storico del comando del corpo di stato-maggiore, intitolata: Complemento• alla sto1·ia della campagna del J81j{j, venendo alla conclusjone che essa « non è, per quanto riguat·da. il primo volume, che un commento acl wmm Delpltini della battaglia di Custoza •·
Un'affermazione così assoluta e così acerba non può essere lasciata senza adeguata risposta; in questa peraltro chi scrive, persuaso che meglio valgano le buone ragioni, non aJoprerà. frasi e pttrole poco abituali nelle polemiche cortesi, come quelle che ha adoperato il suo contraddittore, non solo nella Yuova Antulogi(l, ma anche nell' R.çercifo itaUano del 22 dicemb1·e.
Lo scritto del generale Orero tende dinlostrare che il generale Cialdini, nel dare l a sera del :25 giugno 1866 il contrordine di passare il Po e prendendo la di ri t. i rare il IV corpo su Modena, nou disn bbid ì al coruaurlo supremo: che da C} nanto ha esposto l'U. S. non si può ricavare la certe:eza che il telegramma, attribuiti) prima al ge11erale La Marmora, poi al Re: Disastro ilnpa,·allile, coprite la c·apitale, nou sia stato spedito mai ; che H generale Cialdini, passando il Po, sarebbe andato incontro quasi certamente ad una sconfitta; che, infine, non già la. ritirata dell'armata del .Mincio fu decisa per effetto del monmento retrogrado del IV corpo, ma avvenne l'inverso.
f)i tratta, evidentemente, iu parte di questioni di apprezzamento, in parte di questioni di fatto. :Riguarclo alle prime, l'ufficio storico può solamente rispondere degli apprezzamenti che ha veramente fatti, non di quelli che posson!)
essergli attribuiti, anche se scaturiscono natura li dalle circostanze di fatto logicamente es p oste, riguardo alle seconde. l'uiìicio storico non può che rimettersi a quanto risulta, sia dalla relazione ufficiale, sia dai nuovi documenti pubblicati nel recente lavoro, il quale non è, come il titolo stesso dice, che un semplice I'Omplemento alla relazione stessa: complemento non solo utile, ma necessario, poichè di taluni documenti importantissimi nella re1azione nou era stato fatt ocenno alc uno.
]Il l
Da quanto si sta per dire, il lett01·e vedrà che rigual·do:l.ll'a,ere il generale Cialdini disubbidito o no, l'u1licio storico si è limitato ad i documenti, senza venire ad una conclus10ne esplicita; che riguardo al telegramma: Diù·1·epa1·abile ecc. ritiene l'ufficio storico d1 aver pienamente ra.ggiunto la pro"V"a dell' che circn. il disastro cui sarebbe andato incoutro il Cialdini pas,!mdo il J>o, la questione h :sh"ta post.a diversamente da «·ome l'intendeva l 'ufficio storico; che infine non può essere assolutamente posto iu dubbio che l'ufficio storil'o abbia affermato Ja verità. d1cendo che In ritimta dell'armata del l\lincio diJlE"Se da quella dPI IY corpo, trattandosi di uu dato di fatto indiscutibile.
Entrando oet1z'a.ltro nel vivo dell'rtrgomPnto. eon verrà. ,;gombrare anzitutto il terren" du.lle questirmi acce!lsori<-.
11 critico, parlando dt>i due ,·olmni che l'Ompougouo l'opera, d ice che se c la. raccolta dei documenti coutenuti uel secondo
4 volume, spoglia. com'è d'ogni upprezzamento personale e .. a.ccom pagna.ta Ho lo eia. qualche nota spiE>gativa, può rea)mente.... fornire gli ti di un gi ttclizio i m parziale,
..: non così può del primo volnme ,., Il secondo ''a dunque messo ::;cnz'altro fnori causa, e :-;oltant.o si può osse-rvare
'('be il non è esatto òioP che ..: es::;o è unt\ Aemplice rilccolta di documenti noti integt-al· • meute o nella loro pr.rte più importante -.., l>ta di fatto che inve<:e purecclti documenti importanti ed inediti. Ed 11011 t·egge l'appunto che siano stati omessi a lcuni dOl'Utnenti già ed i r. i dal Chiala, poichè in una nota. alla yJremessa QOno ricordate tutte Jc più i m portanti pnbblica:Gioni iu guisa che il lettore "R dovP. trovare ciò che non è pubblicato una seconda
Un'altra eosa occorre dire. L'opera fu scritta. per ordine e oecondo le istruzioni di S. E. il generale :-:inietta, prima. 1h lasciare l'nfficio volle leggere, ed a.pprovò, il primo volume, come poi il suo successore l'Ì vide ed approvò il secondo. Se dunque l'u{llcio storico tols<> dal libro" C'ustoza " l'a.n(>ddotCI riflettente il generale come cl(lfo di fatto ciel la. cui a.utenti.citA. non aveva, e non lur. motivo d.i dubitare, e lo gliò d'ogui commento per rimauere scrupolosamente obbiettivo, rimangono compl(>tamente indipenùenti dall'opera delstorico l'opinione personale che S E. il generale Pollio .aveva allorchè scrisse il libro, come quella che potrebbe avere

ltJ8 DOPO OUSTOZA (1866)
$'* •
i
oggi. dopo che nnovi documenti banno gettato maggior luce sulla questione.
Ciò unicamente per la verità, non già perchè il capo dell'ufficio storico, dinanzi alla. critica, meuomamente rifugga. nall'accettare piena ed intf'ra. la respousabJ!ità. del proprio lavoro.
Passa.nJo ai punti principali, il critico dice che pitl che allo scopo dichiarato neJla p1·entt'8.wt, il hbro si direbbe scritto a sostegno eli una tesi i cui due punti principali sono:
c 1 che tll\·er:.e sart>bbero state le sorti della c se il generale La Marmora aoçesse ascoltato i snggerimenti «del R":
c 2" che la :;itnazione dell'esercito si sarebbe ,•addrizzata.
• :>e Cialdini avesse obbedito all'ordine inviatogli dal Re:..
Sul primo puuto il crit,ico si t·imette ai da.ti di fatto, tra 1 quali noli cert pnò le test1mouianze del generale H.o,·ere e del duca Sforza·C'esarini; nè rl'altra parte l'ufHcio storico ha apprezzamenti propri, avendo semplicemente riportato pareri fli person11ggi a.ntorevoli. fru l'tli principalmente quello del generale Govonf'.
Sul secondo punto invece il f•rit.ico maggio1·mente si ap· pet biasimare lo studio •lell'uffie)o storiuo. Ma. questo ha espresso 1'11.pprezzamento che gli viene impntato?
A. pag. ti2 del volume I, dopo aver dimostrato che al chiudersi della giornata del 2! giugno il Re • aveva in mente
.. rlell'olfensiva. ,., aggiunge: c ;\Ia a rendere vano que-
« sto proposito gagliardo del He, che &Vl'ebbe 1'1\ddrizzato la c situaziono a malgrado rlelJ'inazione del generale
• DPlla. Rocca e degli E'l1'ori commessi dal Dma.ndo e dal
.. Cerale .tll'inlzto della giorua.tn, concorrt)vano om la. disnb-
c bidieuzn. del Sirtori, lo del L11 Marmora. e la « titubanza del Cialdini: anzi d l q nest'nltimo, non del La c 1\[armom o Jel Re. è il primo telegramma che doveva, con c la parola. « di11astm " • snscita.re a Firenze così grave com-
c. mozione ».
Essendo tjnesta una delle frasi maggiormente incriminate, vale la pena di riporta.rla per intiero; e da essa appare subito che non gi;\ il del Po da. parte di Uialdini, ma. il concetto generale di ripigliare l'offensiva. era q nello che po· tera ,·ruldl'izza,·e la .silttazione; ossia il procedere tli Cialdini oltre il Po combinato con la ript·esa. offensiva dell'àrmata del ::\lincio, rtuale appunto era Of'l pensiero del .Re V)ttorio Ema-

DOVO CUSTOZ.\ 11S66)
' *"' "'
nuele subito dopo la battaglia {doc. 41: 4.4) e quale. secondo varie te,.,timonianze autorevoli, era. da. ritenersi possibile (do65, 66, 67); e che un complesso di cir,:osta.nze, non nna sola, conl:Orsero a manùa.rlo a vuoto. Procedendo. il critico rile..-a parecchie accuM t'ht> l'utlicio ..;torico pa mosso al generale Cialdini. Ora nell'opera di cu1 trattasi non si sono mai formulate acctt8t', ma fatte semplici osservazioni molto moderate o elevati taluni dubln, all'unico scopo di rendere agevole la critica storica, dalla quale c;olra.nto lo studio,;o può trarre qualche ammaestramento. E cosi, per Gl'!empio, non già si è detto che l'a11ticipazione nel pas.::are il Po ordiullta rlal Re (doc. 41) •· non recava iucom·e« nient1 e non poteva in alcuu modo dir"l f'ot:ino.wt • come il critico 1·iferisce, ma in si ò detto: « non semhra. che ::Ja« rt•bbc stata nssolntl:lmeute impossibilE' •: formtt 1lnbitativa che Ruona ben diversamente e che non eRclude punto la possibilità. che il cambiare improvvisamente gli ordini impartiti per un'operazione cosi clelicata arrecasse iuconvPnienti. No11 tratta, dunque, di dimenticanza. di cose di ordine ele-mPnt.aro da parte dPll'ufiicio stonco, come il critico suppone. Vero è elle 11arebbe stato, allora. necessario rinuuciare a talune prt>ca.uzioni, intese ad ingannare ed elnclerne la vtgilanzr.: ma m·a.mai, come e accennato a. pag. liO rlel volume l, queste misttre pit\ non orauo imlispensahili. Elssenclo il nemico giil volto in altra di1·ozione.

ll critico trova. ... trano dicn. che "iCCIJUle nel ,..ecoudo telegmmma. del He (doc. H) non si parlava più eli passagdel Po, quest'ordine non dovessE> ''ome ab1·ogato, ed osserva che a vt>ndo il He ri,.e,·nto J,\ risposta di Cialdini (doc. e couoi'cendone ilpan•re, era logtco :s'inten,]esl'le precisa.mente l'opposto. Certo il secondo telegramma Je] lte poteva essere più esplicito: ma poichè il generale Cialdini avevn nella risposta. dichiarato di pas,;are il Pn il 25 giugno e non aveva ricevuto contrordine, sembra invece logico ritenere che permanesse l'ordine di il fiume. '\e cosi non fosse, il Re non avrebbe Mtccessi..-a.ml:'nte telegrafato al generale: Credo com·errebbe aspettasse tm giorno a
...: passare il Po ,. (doc. n2) ed a.ncora: «l\!i dica cosa ella. fa, sa
•< si l'ente di resistere qutllche giorno nella posizione che preu« cleri passato il Po ') (cloc. 62 E siccomo> quest'ultimo tPiegramma ha la data del 25 giugno, ore 18. 30, è chtaro che, per lo meno, uou v'era ancora in questo momento consonanza d'idee fra. il comando supremo e ti generale Cialdini.
Y ero è che al gran quartiere generale regnava molta confusione d'idee, si da produrre tutti q nei tentennament i
110 UOPO C'OSTOZ-\ ] 866)
che dai documenti appariscono chiari; ma dì questi il Cialdini non ebhe notizia che dopo Ol'dinata la l'itirata, e quindi essi non poterono infinire sulle sue decisioni. Certamente il passare il Po da. solo, senza che L'armata del Mincio si accingesse, a riprendere l'offensiva, sarebbe stato un atto molto arma rufficio storico non ha mai affermato che così dovesse essere fatto e softanto ha detto, a p1·oposito della sup· posizione assurda che l'arciduca Alberto volesse sbucare dai Distretti, che in questo t;aso nella peggiore ipotesi il generale Cialdini e l'arcidnea Alberto si sarebbero scontrati alriuCirca a fo1·ze pari (sulla destra del P o); e che qualora il Cialdiui aves,;e invece il passAggio , occupando le posizioni intorno a Trecenta secondo il previsto, le condizioni tattiche in c:ni si sarebbero p1·eseutate all'attacco le forze dell'arciduca :;arebbero state, a cagione della difficoltà di spiegamento, tutt'altro che tali da. lasciar sperare agli Au"triaci. sta. pure superiori in numero, sicura vittoria.
Questi e non altri sono i conce t t i espressi da pag. 71 a pag. 7i, commentando i dtscorsi tenuti a Bondeno, prima cioè che il generale Cialdini i l primo telegramma del TJa Marmora. sulla bt\litaglia (doc. ..J7).

Posta. la questione in questi termini, cadono nattlralmente Lutti gli a.ppunt.i che il criti<·o muove all'ufficio storico, atl'opinione ehe il Cialdini dovesse N.a solo prol'edere ofFensiva.mente oltre il Po.
I ragionamenti, o meglio, i documenti collega.ti da un tenue filo di uenll.zione logica dell'ufficio storico, sPgnono parallelamente i fatti che si svolgono presso il gran quartiet·e gene1·ale e presso quello del IV corpo; sicchè uon si poAsono scindere senza. cagionare errate interpretazioni. E solo a questa stregua si può esamina.re il presunto piano dell'ar··iduca Alberto.
Quel che dice la relazioue ufficiale austriaca è riportato nel vol. T a pag. 72, nè occorre ripeterlo. Il critico, al1a che per una marcia fra Po e Adige non vi sono disponibili che tre strade, come strada ordinaria. la ferrovia. risponde avergli l'arciduca Alberto detto, vari anni dopo la battaglia. che egli avrebbe fatto marciare le truppe anche per la sinistra dell'Adige, moltiplicando cosi le colonne, e che la ferrovia sarebbe stata usufrnita come ta l e, non come strada ordinaria.
Si pnò obbiettare che le colonne dirette per la sinistra del fiume avrebbero allungato il cammino e che i trasporti
DOPO OUSTOZà (1866) 111
***
per fenovia, se utili per percorrere grandi distanze, più uo.LI. per brevi trat.ti, sopratutto se la linea è esposta alle offese nemiche, come sarebbe avvenuto attorno al 26 giugno 1866. Si p<1trebbe anche domandare se il materiale fossepronto o quanto tempo sarebbe occorso per apparecchiarlo, e via !licendo; ed osservare che Ja di visione delle forze austriache :in due nuclei a cavallo dell'Adige sarebbe stata per esse pe1·icolosa, sempre conto che la ritirata da l Mincio ordinata per il 2:) era stata disdetta, 11ella spe ranz a di un concorso del IV t;Orpo dal basso P o . « Facevasi molto

« assegnamento suJl'effetto che dovevano prodnrre sul ne« m:ico le operazioni del Cialdini sul basso Po. e cominci avasi a sperare di poterue trarre presto profìtto >> (Relazionf" ufL [!, 35). Ora è c hiaro che se Cialdini si fosse avanza to stùla sinistra del Po e !"armata anstriaca gli fosse mos>l a incontro, e n el frattempo dal Mincio l'armata principale italiana fosse sboccata s11l fiauc:o dell 'attaccante, l'ar ciduc a Alberto si s.webbe trovato a mal partito. 1Queste considerazioni il Oomple111ento non espoue, perch è sono evidenti t. perchè già sono espresse ne1la relazione ufficiale: ma so ne la chiara dimostrazione che l' uffi c io stori co non ha fatt e ora osservazioni avventat e.
Sembra :;;trano pe1·altto ché il critico della .lnfo tor;ilt, il qnalo presta così Giaca t'e (le alle affermazioni di uno straniero, avente nn,tnral<" interesse a lasciar credere che egl i in condizioni di s t: onfiggt>re, dopo Custoza, il IV corp o, sia invece tanto restio ad arrendersi all'evidenza, l 1uando Ai tratta di cosa ben documentata. e riifettente il comand o supremo italiano.
T/ufficio storico ha dimostrato (Complemento, I, 70-71 che il telegramma attribuito prima al La :i.\Iarmora., poi al Re, col quale si diceva al Qjaldinì: irreparabileCop1·ite la capitale, i· pura leggenda, e ne ha fornito la negativa e positiva. La prova negativa nel fatto, che non se ne trova traccia nel carteggio, nemmeno fra le carte lasciat e rlal Cialdini: la prova positiva dipende da questo, che i t elegrammi esistenti del Re dimostrano aver egli avuto costantemente, ancora il 26 giug110 dopo decisa la ritirata, il pensiero opposto (doc. 75 ) ; di più i particola.ri forniti sul convegno di 'Bondeno danno anche la spiegazione del modo come potè nascere la leggenda, oltre a dimostrare che se il generale Cialdini avesse realmente ricevuto l'ordine di tornare indietro, non avrebbe ritenuto necessario di udire, sia. p111'e p1•o fanna, il pensiero d ei propri dipendenti circa, l'opportunità d'insistere nel passaggio del Po. Quasi ciò non bastasse, c'è ancora il telegramma col quale il generale Cial-
112 DOPO COSTOZ.à
..
dini st scusa. di avere egli usato la parola disaxtro. mi c sono servito parola dù<a.<?tro attJ·ibuitelo telegrammi S. bi. che c: :;enza darmi precise informazioni mi hanno sgomenntv• • (doc. 74). Xon dunque perC'hè il Re avesse questi\ parola, ma solo perchè non date precise informaziot i, ·lerivò quello sgomeuGo al Cialdini che gli fece considerare la battngha. come disastro. ostante tutto dò, il critico non divide la. sicurPzza. .Iell'utlìcio c: ben sapendo come la mancanza. dt coe· c renza di nn atto uon basta. per escluderlo • (1). Or bene, sul significato che potrebbero avere queste pa· role, si può domandare al critico quali pa.rolo o quali egli avrebbe adoperato, se una supposizione simile fatta per un atto concernente il generale Cialdim.

Il critico cade pure in riguar.lo al di Bondeno. c Anzitutto •, egli dice, c notiamo easere erront•u. c l'importanza che nel libro delPufficio storico vien data al « convegno d i Bondeno • ecc. Ora l'uflkio storico nou ha voluto nè accrescon•, nè diminuire, l'importanza <h quel con'\"'egnu: ha '\"'Oluto dire quello che realmente fu, non secondo una sola versione, ma secondo tutte le ra<·colte fra il 189-t e il 1893 dai quattro divisionari, in quel tempo ancora viventi: generali Chiabrera, Oa.dornn, l\!e?.za· capo e .Ri<:otti Per conseguenza la versione d eli 'ufficio 'ltorico nnn pwì essere en·onea, come i frammenti pubblicati delle varie testimonianze dimostr<\no, e comP app:tri· rebbe so qneste fossr.ro pnbblica.te integJ'almente. Ripa.rlare d i questo convegno era opportuno, percbà la relazione ufriciale. nel t<'s to che t'n appro,·a.to da. l Cialdini, parla. d i m n· ,iglio e uon di ,.,1pporto e dice cho i generali con,-en 1Li < furono concordi ecc. c (Il e :;(}}tanto la noterella ('be precede il II volnme, apposta in seguito n protesta del ge· nerale Clldorna, dico che non t'n un vero e proprio ma un :-.emplice ''af>po,·lt> (2 l.
(l) 11 t•ritico uc11uucuo t•&elnd•• un ntto di
d••l Uialdini. il q un lo nvrobbo potuto tnl<""Ìfl t lei tdegranuni ri•·cvuti. lo non ci c1·edo e pt·nso <.' he, S>' gt•ncrosità v1 iu. questa fu dn pnrto del Re. nl quak, &Mohbo rit1scito furiiA di tLUontana.ro dt\lltL proprio. poreona ogni ne· ··nsa pnbblicundo i tele;:;t·nmmi dùl 24. Inv••c)O, siccome q li<'Hti fu-rono tenuti "''greti. <'iò Il\ valorò lu lestg<'nd•• che così c per al Re. - A C.
(!!) Xellt· O.••trt:a:iQ,.: J.l Cialdir1i nlkl stQrÌfl della campagtvt del 186h d•\ lui fatto <topo letto il mano,.critto della rt•lazione ufficinlo (luglio 18i2). ><i legsro: MdiuA venne nò fu sospeso primtL dclln delibPrnzioue pfesa dal consiglio di guerra tennto a Bondeno. Anzi
• il posRaggio del Po non (n controman.lttto cho a tardiHRÌmo. sera. nella sperat\Ul <.'he un quo.lch5• nnovo tele:.tmmmu meno sconfortAnte avNbbn
• permesso di eseguirlo Ciò pro,·a. ira l'ultro, chf' il generale Cialdini a,e,·a in mente di av,r t•!nuto un di crterrn, sebbene tale non ios."C purso ai suoi dipcn•ll1uti. ·
• • POPO CCSTUZ-' (186!>\ 113
IS- L''·
Trascut·ando altre o:,s E! lYtrtioui dt minor conto, ma. nou meglio fondate, c'è un punto sul <tua.le conviene fermare un ta.nlino l'attenzione.
Dice il critico ··he la divisioue non si :-baudò durante il combattimento, perchè il suo comandantP la ntrasse prima che l'usse sm·rmssato il limite mass1ruo di resil:lteuzn. che sullu hase delle perdHe subite egli calcola. del , ; e clw )>Cl' il generale Cialdini. non potendo t'ilte assegnamento sn un coefficiente maggiore, evitanclo d'impegnar" t·isparmiò al paese una seconda :-iiCUl'tl S('OIItit!a.

ione ri \' e:,l e t.al graNità che non si può pas1<an sotto silemdo, sia fltll'l' come accademi<:a. ::>ta di fa.t .to dte il Cialdtni non potè avere noti?.ia di q uest 1 dat.i alloruhè decisa 1l1 l'i tirarsi: 11\a pure li avesse avuti. t'nr torto al ->no alto i ntelletto tl suppnrlo c·apa1·e di nn simile ragwnalllento. He il gen. Govone ritrasse la !l• div1sioneprimacbe !Wes:sP subito maggiori perditl' 1 c1ò 11011 accadòe per esaurimento materialE>. di quell<' truppe, t'hc pur e dtginne si erano dimovalorose•: ma poi' l'impressione morale, dipendente dal Y<'dere c hA 'lualn n q H ult erwre sforzo srtrebbe SI a.to vano, mancando soct·orsi A scar:seggianòo le mnnizioni. mentre il Della H.occn rÌlllHHPHI mattivo a V11la.frauca. Che la prepara.,ionc militare nou stata corrispon· dente all' ù noto eò ,·, a.uche hre\·emeniP. accennato dalla relazione utlicia.le (l, 7-8); uè Ili. nuova opera dell'ufficio slorico com p l et amen t e ne tace, poichè rif'erit;ce sn q ue:;to pw1tO il parere nello stesso generale Cialdiui (doc l.J:6); ma è pur noto che lP lil'cnse lli poca sohdita, lanciate o Ila truppa con sO\'erchia leggerezztt subito dopo la battaglia, furono poi riconosciute inginste. Otò d11.lle relazioni del generale .:\larmorn. che lealmente attenua l'errore (l el primo gindiilio e ricou nsce il valort\ del :-.ollat o 1tahano, q ua.le fn dimost,rato riai fa.t.ti e fu riconosciuto 1lallo stesso avversano
1n tuttf.' le battaglie, spe<:ialmente in q sfortnfiàt.e. succede sulla. Jinea. di fuoco una selE-zione, per l'UÌ i più timidi se ne ritraggono, lascumrlo soli i più animos1: succedt'. cioè, quello che Garibaldi, <·on frase incisiva, <·hiamava la separazione del loglio dal grll.no. Dipende poi es,;euzialmente dai capi il non impensierir:,\ del troppo loglio, ma basarsi essenzialmente sul grano. Ciò fece il colonnello Boni a.t·
114
tomo a 'Monte Tone: ciò fecero i valorosi avanzi della 1a di visione, disputando cosi lungamente al nemico, anche dopo che erano rotti i vincoli organici, il terreno a n01;d eli Vento .
Per conseguenza, a fatti compiuti, ogni ragionamento, basato sopra una presunta poca solidità de ll e tr u ppe, in questo caso concreto manca di fondamento.

Ma anche ragionando i n astrat to e in linea generale, la capacità di res1stenza di una truppa dipende da tante circo-;tanze variabili: che è avvenuto tl caso non raro di truppe ..;olidi:-sime che, dopo aver dato prove supreme di valore, si sono sbandate improvvisamente, da timor panico, per nn falso allarme ( 1) , e di allre ritenute poco solide cht> in ..·ondtzioni particolari hanno fatto ottima prova; sicchè è assmdo voler pesare a prio1·i sulla bilancia e riassumere in una c:ifra il valore di un reparto di t;ruppa. Il comandante che vol<'!>Se far ciò sarebbe siomamente votato alla sconfH,tn..
11 l·ritico ragiona pure intorno alla frase u:mta nel Comple111€1llo ecc ( T 162 laddove ::;i dice e:>sere del Cialdini il primo telegramma • che dove\'n con la parola s\v;citare a. c Firenze cosi grave cootmo7.ione •. Egli uega che la. popola.ZÙIIll' eli Firenze potestie commuovere per un telegrammA. dirett.o al ministro, a lui 80io. Ora. poichè l'U. H. nou ha punto parlato eli popolazione o ha riportato il telegramma int t>grahneut.e, chinro che esso allndeva al go1Jerno di nou alla popolazioni!-. Che poi quel telegramma non fosHe stato preceÙltLO o accompagnato da altri più gravi, appare dal flltto a l!'irenze, nella giornata del 24, non furono spediti che due telegrammi. uno dal La. Marmora (doc. 43 ), l'altro da.l Cialdini (doc. -!G), e che il primo è molto meno graYe del se<:Onflo.
$ ...,
Ma l'ultimo argomento '>volto dal critico è quello che per lo conseguenze che ne derivarono, se non per il conto che ne fa il critico, rivtlste maggiore im p ortanza. Egh nega, con ragionamenti, ma senza prove, che la ritirata delParma.ta del Mincio sia stata determinata dalla mossa retrograda del Cialdini. Ora. l'esposizione dei fatti, documentata éOm'f. dalla relazione ufficiale e dal complemento, non lascia alcun dubbio su questo punto. Il critico cita., è vero, il telegramma del 25 giugno. annunciante al Cialdini nn cQilOYimento indietro (doc. Z>3) senza ricordare che esso giunse
DOPO CUSTOZA (1866) lli>
* ."'
quando il movimento era già. iniziato e tacendo che la ritirata dell'annata principale, ordinata per il 25. fu poi disdetta, mentre gli orJini dati al Cialdini tende"'ano a trattenerlo sui basso Po. Questo è un dato di fatto e non un apprezzamento, ed P. strano che il critico, il quale nega all' nfficìo storico il diritto di fare apprezzamenti, gli domandi a questo puuto di giudicare se .il nialdini abbia fatto bene o male a non passare il Po (2 .

1\fa per dimostrare che l'ufficio storico non ha seguito alcun preconcetto ed ha studiato g l i avvenimenti con la ma-<sima obbiettività. basti ricordare che già la relazionP ntliciale t II. 3;) , dopo riportato il telegramma col quale il La )!armora pregava caldamente il Cialdini lli non abbandonare il Po, sogginnge: Poco dopo h' 'lte;;so generale La Marmora ebbe notic zia che il IY corpo era giil. in marcia :m l\Iodena . .l!"n riso« l uto d'intraprendere nella sera stessa la ritirata, comandata «e poi disdetta il dì prima.».
Qui il critico potrebbe obbiettare che anche la relazione ullicia.le, finita eli stn.mpare nel 18$'15, è opera delFutlicio storico, e coinvolgere nel biasimo gli scrittori prese.nti e qnelli pas-<ati. Riesce dunque i-.truttiva nn po' di storia.
Dopochè Jl mini:itro della guerra. Bertolè Yiale :>i fu imp••gnato dinanzi alli\ cn.me.ra dt'i deputati. per snllt'cita.zione del generale La. Marmora, a far sonvere la relazione- della tunata. campagna, cou lettera. del 25 novembre X. n:Jn:; pregò il generale Cialdini <l'inviargli tutti quegli ulteriori ragguagli o documenti ch'egli credesse c convenienti, per • porre sotto Ja più vera e com p l eta luce i fatti da na.rrat-si. c al che forse più che tutto varrebbe meglio nna sommaria c ragione di essi
{l) Un Ìtltto similo ndln scconrln di "'agre.m.
(2) X('Jl'E,ucito ito.lirw.o tlcl :!:! tlic('mbr>'. il critico cho l'owcro
r<l<!l.l impo&-.ìbile d••i •:nlcri rld comundo supremo è un 1111 rito rli pir} del generale Ci.\ldim (l , , pul'chè « per lt1 palt•"' tlii<'Orditl t'Si-t<·nte
« trt\ romnnd>\nte in c11po <' cupn di stato-mAggioro · per din•r:;cen7.e ed
« uttr it i mnnifo11tatisi t•u il enpo di t<tato m11gjlior.> 1.' i dipendenti comun-
« dunti dci primi tre ,·orpi d'nri!Hit!l, un nuovo 11tto niTen.'livo dal ::\lincio u non twrebbt} avuto SttfficJOnti pl·obahilitfl. rli succes:;o por ritontumc h• '' provu ». Sorvolt1ndo fili qmwto •1pproz7Alnento 111olto d;scntihilo, specie quanrlo si tt·atti di unu doppia offerlSÌVA dal ::\lincio e cloll l'o. di ft\tto c ho gli attriti frn il gonoru lo• L11 ::\[>\rmorn c i DI'Ila. Roccn e Cnednari non assun'lero il c:muttorn di vere disuhbiclienze. {'h" il eont«tno del generale Pillnull fu porictto in n!mi circostilnzn e eho• le dimiasioni del ge· nemle La )farmora du capo di stat{)--maggiore dell'e-Prcito, da cui clip4>"e crisi del comando <'Ofll fnn"•tu per le ulteriori opera1ioni, fu detenninata unicamente dall' inatte:<n ritimt.. del IV corpo dal Po • in. a troppr a comundare. Al Re che voi prt!ndiate il comando... r> telegrafa il Lu )f,trlllnra nl Cialdini il :!G giorno (doc. 72.
116 DOPO CTSTOZA l
'\66
U generale Cialdini, con lettera N. 3D3 da Pisa in data 9 dicembre 18GB, rifiutò di aderire alla preghiera del ministro, adducendo. fra le altre, le seguenti ragioui:

«Le mie idee nou preva.lse1·o e neppure oggi tl:overebbero «favorevole accoglienza .... Preferisco tacere, anzichè rim.et.. t.ere la difesa delle mie couTinzioni militari a persone che .. lungi dal dividerle le oppugnano pienamente. Occorrendo saprò difenderle io ;;tesso.
« ch'io rimasi meravigliato quando vidi ch'Ella assumeYa l'impegno di pubblicare la storia della campagna ... del18Gti, dopo la disgraziata polemica dell'estate sco1·sa. La c storia dei disastri o degli riesce llelicata molto e " spinosissima e credo difficile che quella del '66 non conduca nuove polemiche, non solle•i dissapot·i piit gravi. l\iorti «noi, qualsiasi scrittore potri1 giudicare a suo talento i generali c.;he ebbero nn comando impot·tante nel '()G (U. :-;.XII « ris. li lli2) ».
Per conseguenza il geuet·uJe si Limitò a t.rasmettere al ministero il dtario delle ope1·azioni.
La relazione della campagna fu scritta tra il18ti8 e il L8li\l e fn opera principalmente di Carlo Corsi, l 'insigne scrittore t• storico. ncordato con venerazione da Lutti q uauti lo c.;onob bero o lo ebbero maesh'o. Il lavoro, llcntpolosameute e obbiett.ivll.mente redatto, Yenne sottoposto all'ttpprov:azione dei generali La Della H.occa, ùialdiai ed altri.
Il generale Cialdini, restituendo il manoscritto iu dat,a :H luglio l87:l, trasmise una nota abbastanza, lunga di osservazioni, delle quali il Corsi tenne conto modificando, o ve occorreva, la relazione: ma. J l Cialdini nulla obbiettò al citato passo del II volume. Questo fu tuttavia pu uhlicato solo dopo la morte del generale. probabilmente per rispetto alla sua volontà: e dall8W: ad oggi sono trascon-:i altri quindici anni, durante i qnali anche il critico ha taciuto. Certamente egli vensò allora, e forse adesso ha dimenticato, che chi volesse ne-gare Ja veridicità. della relazione uHìciale contraddirebbe lo stesso Cialdini.
L'ufficio storico invece, con la receute pubblicazione, non fa che conTaHdare l'affermazione già. contenuta nella relazione ufficiale; lungi, dal lanciare accu8e contro U generale Cialdini, conclurle: « E evidente l'infl.ueuza della mancanza c di quella nnità di comando, per la quale tanto aveva. pero< rato il Cialdini all'inizio della campagna : mancanza alla « q nale si deve se il Cialdini, posto neLPalteruati va di passare " il Po oppnre di rimanet\Ì semplicemente in attitudine
DOl'O CUSTOZA (1866) 117
minacciosa, abbia preferito un terzo partito, quello cioè di « ripiegare su Modena:. (Comp i. I, 78 ).
Evidentemente è questo il commento più gmsto che si possa fare all'operato del generale Cialdini in questa circostanza.; e se qualcuno dalla lettura dei fatti e dei documenti può ricevere un'impressione diversa e taJe da suggerirgli un più severo giudizio, c:iò no11 è imputabile a colpa dell'ufficio storico.
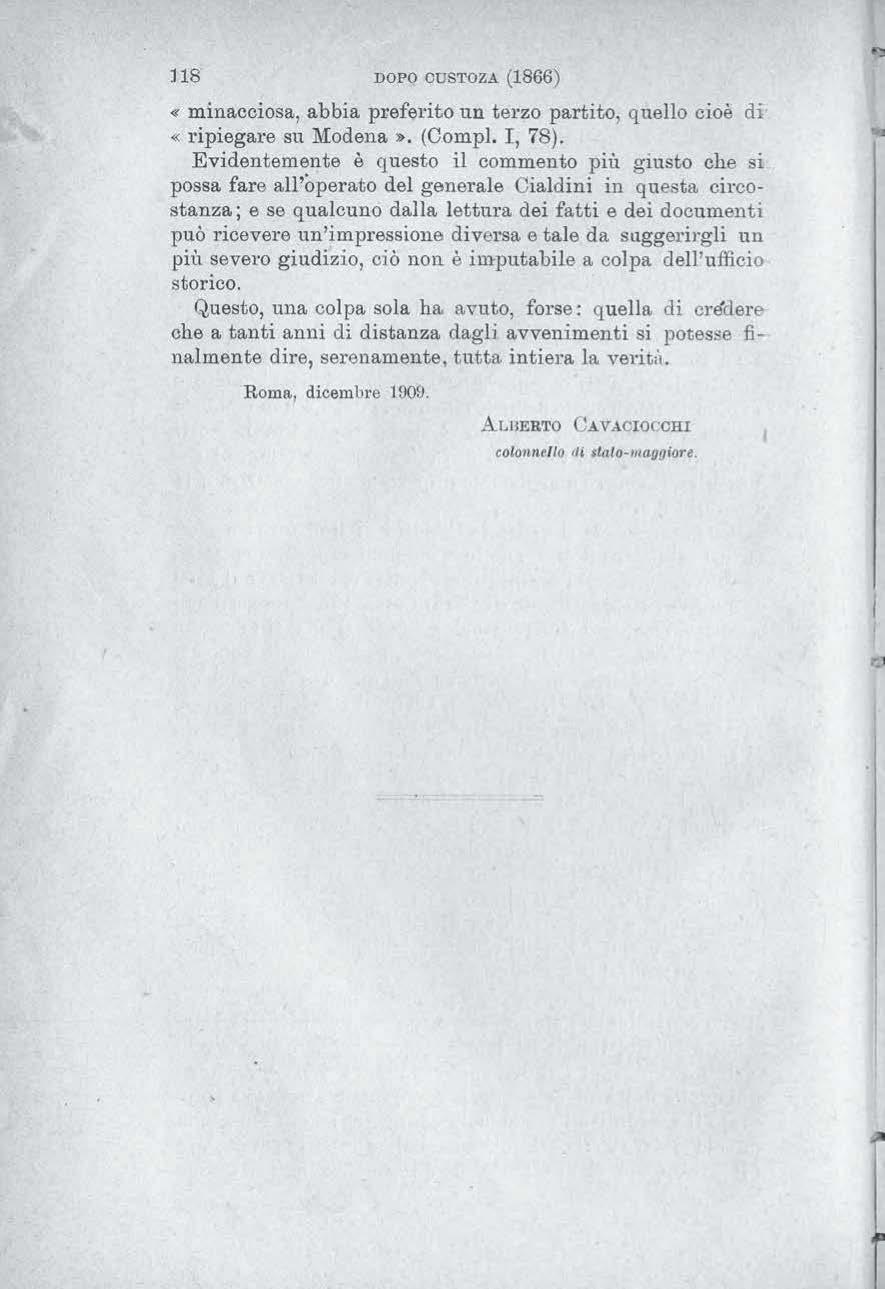
Questo, una colpa sola ha. avuto, forse: quella di cre"der e che a tanti anni di distanza dagH avvenimenti si finalmente dire, serenamente, tutta intiera la veritit.
Roma., dicembre 1900.
118 DOPO OUSTOZA
(1866)
t: l
A.LuEBTO C.A.vAciot ·oru cololllttllo Ili rtato-111agoiore.


SU I mETODI DI SCIIElUIA PER L'ESEI\OI'l'O
Nell'esercito nost.ro, dal 1874 ad oggi, si sono avute Jue diverse scuole di scherma, basate sn metodi radicalmente diversi: quella che si fuse poi COli l'EnricheLti e rimase in vigore fino al 1884; quella Parise, che fu instau· rata nel medesimo anno ed é tuttora in vigore

Recentemente però i maestri Pecora.ro e Pessina hanno proposto che il metodo di scherma per la sciabola fosse modificato secondo le norme cla ess i dettate i.n un nuovo trattat.o; o poichè il ministero della guerra., pur facendo riserve circa l'adozione definitiva del trattato medesimo per quanto ne rifletteva la forma, ha delibentto d i sperimentarne la sostanza presso la scuo l a magistra le di scherma, sembra utile di rilevare la portata delle modifioazioni proposte e defi11ire il carattere che avrebbe d'ora inHanzi l'iHsognamento della scherma nelJ'eserci.to qualora l'esperimento riesci.sse feli· ocmonte (1) '
Anzi tutto è bene ri potere cosa che non sarà mai dett.a a sazietà.: l'esercizio della scherma, come quollo che rassomi· glia acl un giuoco e ne tien deslo al pari l'interesse, è t r a gli esercizi ginnastici qu ello che meg l io si p1·est1L a conservare a lungo la elasticità El vigo1·in. delle membra e che può essere praticato anche nell'età matura., e va considerato prin· oipalmente come esercizio ginnastico e solo secondariamente come un'eventuale preparazione al duello. poi il dire, come il Campolieti nella militar!', che non concona. a dare, al pari dell'abilità nel tiro con arma cla. fuoco, maggior confidenza nelle proprie forze; chi si sente agile o forte n capa,ce di ben maneggiare un'arma biauoa. sarà sempt·e meglio disposto di un altro ad affrontare la lotta a corpo a corpo, che può esse1.·e frequente anche nelle guerre odierne; senza conta r e c h e la prat ica i nsegna che
(l) 11 presente nrticolo git't era. stato scritto. allorquando vide la lnce uu nuo,·o di Ferdinnndo :.\Ia:;iollo, intitolato; fA, di 8tia/!o/a. Osservazioni sul trattato dei maestri Pccoraro t Siccomo il omPstro "i\fa.s io ll o non fa cho t·ipHtere in g •·a.n parte coHo detto no i suoi prot·odonti così brevi noto ed aggiunte sono atolo sufficiouti o far cho questo articolo ancbe nl nuovo opuscolo.
611
un buon tiratore di spada e di sciabola è pure uu buon tiratore di pistola, qnaud'anche non adoperi quest'arma che una volta all'anno. E questo il risultato di un'osservazione sperimentale.
Di più la scherma di sciabola è particolarmente importante come preparazione degli istruttori che debbono ÌllSegnare ai soldati di cavalleria il maneggio di quest'arma da. cavallo.
Oo11fermata l'importanza che ha l'esercizio della scherma e l'opportunità conseguente di mautenerla in onore nell'eSf'rcito, ne deriva logicamente la necessità che il metodo sia buono: sicchè dei vari metodi è utile ricordare le principali caratteristiche.

Il sistema aveva, pet' la spada, ripudiata l'arma tratlizionale italiana, adottando un fioretto simile al frt\11· cese, ma due dita più lungo, munito di c:ooeia invece che di anelli E" in cui la martingnle france:;e e1·a sostituita da un auello metallico. Ma voleuc.lv fondere la scuola italiana o la frA.noese ue aveva accomuua.to piì1 pregi cho difetti: prescrivendo d1e i movimenti d i ca vu.zione a vel'isero 1m ne i pale perno nell'omer0, invece ello nel pugno o nelle di tu, a\8\R rinunciato alla finezza e all'(jlasLicità propri tlol giuoco francese·. volendo c·he puruLe la. puntn rimanesse indirlzzn.ta al pet.to o al fia11co avversarlo, obbligava il pugno a contorcimenti d<mnosi, contravvenendo poi a quesLo criteno con l'abuso del giuoco volante (c ioè de1 cosi <.letti iufino, con l'a-fondo stabilito in modo, uhe do.l piede alla spalla smìst.ra, ptwsallÙO por l'anca, fosse una linea rotta e il gitiOcc.Uio deiltro fosHe !t piombo sulla. punta del piede destro, produceva una squilibrata inclinazione del corpo in a.vant,J, da cui era difficile il ritorno in guardia. Ne derivava che twll'assalto 1 due nYYt'r:;a.ri Cl'<\110 natnralmente tratti, dallo scorrere del piede siuislro e da l preponcleraxe del poso del corpo in ayauti, a serrare la misum, e un'assalto di fioretto si tramutava il piìt sovente in un antiestetico scambio di forconatè o di colpi di frusta (1).
(l) A di><cllrH·o del Rechwlli ,.n <letto •·he ('l·rli eomp():;o un tmttato per la soho•·ma cii puntu llO io pet·chò ne fn richiesto a c·ompl(;Jttlonto 1h•lln l"ll'tf' rimancnll•, l'itl'IW\·a Il\ pt·i.nl'ipale.
612 SUI METODI fii PJ.CR L'inSERC1TO
.. *
Analoghi difetti però si riscontravano anche nella scherma di sciabola, con la differenza cha qualche cosa di buono vi per quanto concerneva il portamento del ferro. Ma l'indirizzo che aveva preso la scuola di Milano era tale, che fatta eccezione di quei pochi valenti che avevano saputo sottrarsi all'andazzo comune e interpretare con sano criterrio le idee che il maestro fo1·se non aveva saputo esprimere, l o sche1:mire di sciabola era 1·idotto ad una specie di atletismo l nel quale i muscoli si irrigidivano con l'esercizio accessorio della clava, e, bandita ogni finezza di giuoco e di modi, le correzioni erano date a suono eli piattonate. L'insegnamento della scherma era diventato così tutt'altro che una scuola di cavalleria.

Si capisce qui udi che il metodo Redaelli, sia per difetti propri, sia per difetti dei discepoli, non potesse durare immutato a lungo: si videro infatti ben presto le spade del tradizionale modello italiano sostituire il fioretto ibrido1 denominato a piacere mezzo-italiano o mezzo-francese, e parecchi maestri combinare, tanto per la spada, como per la. sciabola, gl'insegnamenti del .Redaelli con quelli di altre scuole, sì da dimbtu.ire gl'inconvenienti lamentati, creando peraltro tanti metodi diversi, quanti erano gl'insegnanti.
Venne a buon punto nel 1&q2 indetto un concorso per nn uuovo acl uso dell'esercito; e la commissione, composta di persone fra le quali a lcune competentissim.e, prescelse il trattato di Ma.saniello Parise (1 ).
Questi ricondusse la. scherma di spada alla tradizione italiana quale si era conservata e a poco a poco perfezionata nel mezzogiorno d'Italia, componendo un trattato nel qnale era perfetto equilibrio tra. la sosLanza e la forma, dove lo spirito, ohe deve informare le azioni, era opportuna· mente messo in e-videnza, dove la scioltezza e l'eleganza erano sostituite alla rigidità e alla ma.terialità del precedente sistema. Basti paragonare il modo di fare il saluto dell'uno e dell'altro e ricordare quei g1·otteschi appeni (battute di pjede) del sistema Redaelli, che per certi maestri erano la base di tutto l'insegnamento!
)
St'I METODI DI SCHER!I1A PER L'IDSEROI'IO
613
(l
Della commissione. presiedltta. dal generale Angelirù, facevano parte. fra gli altri , i baroni .Anzaui o di San <1iUileppe e parecchi uffidali di <lavalle1·in.
Se Lo schermire di spada era dal Parise trattato con maestria indisuutibile, non erano altrettanti i pregi del suo sistema per lo suhermire di sciabola: qui le parb.te lroppo ravvicinate al corpo e per conseguenza. troppo largher c il fer1•o maneggiato principalmente di pugno col concorso dell'avambraccio invece che più solidamente portato, costituivano, rispetto al sistema pt·ecedente, motivj d'infm·iorità. compensati solo in parte dal più razionale portamento del corpo nelle posizioni di guaràict o di a-fondo.

Accadde perciò quello che doveva accadere: mentre la maggioranza degli schermilori abbracciò con entusiasmo H sistema per la spada, minor favore incoutrò il suo sistema per la. sciabola: ed anzi alcuni degli stessi maestri usciti dalla scuola di H.olna. si ingegnarono d'innestare, sui metodi appresi dal Pariso, quel che di buono avevano riconosciuto nell'a11tico metodo Redaelli o ne' suoi derivati.
Fra questi merita fpart.icola.re menzione il trattato cl i sohermn. d i spada e d i sciabo la d i FArdinando 1\fas iello.
Discorde dal suo maestro Redaelli pet· La forma. sia del In spada, sin. della sciabola, e perqual1·he particolare del giuoc:o, egli ha voluto rinnovarnf' e, a sno modo, perfoziona.rne il sistema, concorrendo così a mantenere viva quella scissione nell'arte italiana di schermire, che con la decadenza del reùaellismo sembrava ormai prossima alla fme e cui nou era, ad ogni modo, chiusa tma. via eli conciliazione.
Che 110n fol:jse di1licile il trovtl.re questa via appare logicamenr.e da. quanto è stato esposto fin qni: cho a fissare l'accordo non mancò, almeno da una parte, la buona volontà, dimostra il tentativo fatto circa da Parise. Egli radunò allora presso i l ha.rone di San G i tl:>eppe i prin· ci pali rappresentanti dei \Ori s1stemi e si dichiarò disposto ad introdurre nel proprio trattato alcune variallti, tali che KÌ potesse addivenire all'unificazione della scherma italio.na. A malgrado della sua condiscendenza, l'intransigenza d i ta.lun i mandò a monte Ja conciliazione.
Questo fatto dimostra pure che il compianto Parise riconosceva l'opportunità di migliorare la scherma di sciabola e se ne asteneva solo per non cedere ad dopo aver invano tentato Ja via dell 'accordo.
614 S\,; J D! SOllERMA PBR
La conclusiouo di fatto è questa: 80110 rimasti oggi agli antipodi i due :,Ìstemi Parise e :Masiello: il primo ha a proprio vantaggio ]a indiscutibile bontà del metodo di spada 7 seguito dalla grande maggioranza degli schermi tori italiani; il secondo ha per sè il vantaggio di taluue manchevolezza generaluHmte riconosciute dell'altro nel metodo di sciabola.
Potrebbe dunque riuscire interessante un confronto tra. i duo sistemi; ma poichè il metodo Parise è troppo noto nell'esercito o troppo diffm;o, perchè occorra tra.ttarne ampiamente, basterà invece n velare tal une caratteristiche do l metodo Masiello in contrapposto a quelle dell'altro.
Circa il metodo di spada potrei anche tralasciare eli occuparmone, poiohè pitL nessuno nell'esercito e pochissimi fuori seguono ta.l motorlo, e ce1·tament.e chi ha imparato il metodo Parise non lo abbaudona p i ù . Parlo per esperienza perchò ish'uito, quando nro giovane, col sistema Redaelli dapprima o poi eo' suoi derivati, quando ebbi la forLuna eli conoscorn Mn.sa.niello I'Elrise mi convinsi talmente de l la superiorità teo1·ictt e pratica dol sno sistt•ma, che mi d<>cisi, nou più giovane, a mutar via, acquistando 11ell'ctà. matura maggiore e correttezza di quella. che, per errot·e di metodo, io awssi potuto conseguire negli anni giovanili.
Hasterà in ogni modo ricordare che, come derivato del si· stema Hedaelli, il sistema di Ferdinando Masiollo ne conserva i principali difetti, pur avendo.> adottato una spada di moclello simile n. quella italiana del ;parise, sebbene meno razioualmento equilibrata. Ancora pii\ accentuato che nel :;Ìstema. Redaelli i• il difetto dell'a·fondo squilibrato in avanti, di cui dirò pitl ampiamente in seguito; oltre a ciò le pnrate sono difettose por il pret'oncetto che la punta debha rinHlllero rivolta vot·so la linea di offesa. Ill\1asiello spiega questo fatto cou le ragioni addotte dal Grisetti e dal Rossaroll:

« Acca.cle nelle parate, che per urtare con forza la sparla
« nemica, il pugno s] disvia per poco dalla Linea d'offesa.
« Dunque allora conviene sostituirvi la punta, che forma
« scudo al vostro petto, ect. » . Cjò significa, in altre parolo che se l'avverstlrio la nostra parata, noi dobbiamo far quest.a in modo che snccecla l'incontro: e allora sarebbe più semplice di insegnare a tirar sempre e a non parare mai, perchè il risultato sarebbe lo stesso sempre, a dispetto dell'a.·
SUl METODI DI SCHERMA PER L'ESERCITO G15 ** *
forisma: « toccare e uou c:>sere toccati • · Ma poichè n. ga.rau · tirsi dal pericolo insito nella parata del sistema Masiello s'insegua appunto l' oppoi:iizione , che ue neutralizza l'effet.to, chiari appflriscouo l 'inutilità di fare quauto egli consiglia e il dauno che si può ricevere dal fare una parata meno si· cura per la ricerca di nn vautaggio illusorio.
Piuttosto dunque che fare un carico a .Masauiello Parise di es.;ersi distaccato in questo punto dalle teorie del Rossaroll, glieue va fatto nn merito di più, poichè è proprio delle persone in lelligen ti i l sa persi distacca.rc dalla tru.ù izio ne quaudo questa è Ìll urto cou lo. logic·a. E che la pnnt(t possa fare llcnclo o illogico: mentre, per è im·ece natura!(·, nello sche rm ire cla tcm·ono, il provocare tma parata e risposta per applicare su questa un arresto al braccio lSCartaudo iudif'tro, poichè q ttest'nzioue, nou di scudo, ma th controffesa, conduce a rispettare l'aforisma foudameutale della or ora cibto .

A l tro difetto dello parate suggerì te dnl Masiello per la tn r za e per la secouda è tt nello di t'i l braccio completamente disteso, ot.teuou 1o cof;Ì un irngidtmeuto di m nsco l i clnn11oso e privanc l osi di que l lo. elasticità che solo }HlÒ essere ùa.ta da nn com·enie11te picgamento dei gomito. « IJa « fretta e la for:r.a so11o i nemici capitnli do ll a scherma • ( LJ.
E qui, sitt per le cavaziont 1 sia per le parate, occorre fa.re un'os"le-rvuzione genetica. l d<'trattori del sistema Pa.rise gli attribuiscono movimenti che il maostro llOll si è mai sognato d' i nsE:Ignare e to.uto meno di fare: (l uando rgli parla di movimcuto d1 pol::Jo, cpmlcutto s'immagina t·.he debba far rotare follement.e la. spada i 11 giro, descrivendo cou essa un cono e sventolamlo ht punta; i 11veco i movi · menti di polso, volnt.l dal trattato e inseguati pratica.meute cla lui (parlo sempre per esperion?Ja personale), sono per la massima parte semplici movimenti eli rotazionP attorno all'asso il quale poi, natnralmente e senza si elica. ogni volta, accompagna il polso quando ciò ouuorr e per un cambiamento di linea d'offesa. I n tal modo la cavazione riescC' strettissima e co:;i veloce, che 110n occorrono cronoscopi compiacenti per vedere che è assai più rapida di quella di spalla voluta dal 1\fasiello. Così pure
G16 SUl DI SOIJElOIA Pll;R L' El:ill:ROITO
(l) P\RISJ:. - TrattatQ dtllfl "l'Ilda, 31
nelle parate di contro, quando è detto che il pugno non si deve spostare dal centro d'operfl.zione, non si può fare astrtt· zione di quell eggiero movimento di che semp r e è necessar\o, specialmente se si allarga il movime11to di cavazione dell'avversario.
D el resto, nel 1882 il maestro 1Yiasiello si misurò a N apol i col maestro Parise: e trattandosi di capi-scuola i l risultato dell'assalto può avere un siguifìcato speciale. Or bene, il maestro Masiello fu battuto, con netta ed iudiscutibile superiorità, dal maestro Parise, e fu battuto anche da.l dilettante barone Anzani; più fortunato riusoi soltanto nell'assalto col ùi lettante Miceli. E vero che i l Masiello disse poi che ciò gli accadde per un malore a l ginocchio : ma che uno schermitore di vaglia si arrisch) a cimentarsi con forti schermitori della scuola avversa trovandosi in condizioni fisiche d'inferiorità, è da ingenuo il dirlo, più anco r a il farlo.

Il maestro l\'Iasiello ricorre al sussidio della geomet1·ia per dimostrare che la cavazione fatta eli spalla è più stretta di quella fatta di pugno, e si vale anche di una figura per mettere ìu evidenza che l'apertura clel cono, descritto propria lama attorno a ll a coccia del feno avversario, è maggiore se il vertice de l cono ò al polso cl1e all'omero: e questo sapevamcelo! Ma quello ch e pnre tutti sanno, é che il Masiello sembra di mentical·e, è che le cavazioni si funno ordinariamente attorno alla l ama e non attorno ttlla coccie., che quindi per uno spostamento così breve l a differenza di apertura del cono è impexcettibile; che per contro, l'agilità del polso e delle dita ò tanto maggiore di quella dell'omero, si che l a cavazione tiesce più ve l oce , come già si è detto, ed ha anche il vantaggio che il movimento di pugno non è veduto che a cose fatte, mentre il movimento della spalla si avverte assai tempo prima.
Sorvolando su al tri particolal'i, come quello che la parata di terza col pugno di quarta (Masiello) è assai meno efficace di quella col pugno di terza (Parise), la quale agevola particolarmente la risposta di cartoccio, si può rilevare che il trattato del Masie ll o non considera il filo sottomesso, azione che si pratica assai spesso durante l'assalto e che é particolarmente agevolata dai legamenti fatti come il trattato Masi ello consiglia; e ch'egli consiglia pure eli non esegui r e l e parate di contro che sulle finte dell'avversario. Quest'ultimo
SUI METODI Dl SCTIER:llA PER L'ESERCITO 617
consiglio, anche se riferito alle abitudini dell'avversario, è alquanto ameno: poichè è chiaro che una parata è o non è degna di questo nome e che nessuno si potrebbe arrischiare ad eseguirla se non fosse capace di parare anche un colpo vero. r./affermare che la parata di contro è inefficace contro la cavazione semplice è pure cervellotico: talnne parate di contro o di mezza contro (p. e. contro di. guarta e mezzacontro di mezzocerchio, ecc.) sono anzi pit\ facili che le pal'ate semplici per chi vi abbia il pugno esercitato e non inigidito dalla scuola del Masiello.

Sorvolando anche sulle osse1·vazioni poco serene che nel trattato l\Iasiello sono sparse a riguardo del trattato Pa.rise e che hanno tutto all'incirca lo stesso valore di quelle già confutate, merita il conto di rilevare che il Masiello ha in più del Parise il così detto coupé (da non confondere con quella vettura chiusa a due posti che chiamano (Jliam); od io non nego che quesLo colpo si possa eseguire, perchè specie sotto miilura qualche volta riesce :;poutaneo od efficace; ma non q ualc lo prescrive il Masiello, cioè eseguito facendo perno al gomito, o:;sia offrendo un facilissimo ber:-;aglio all'avversario, quando si tratti di schermire sul terreno . Dico questo, perchè ill\Iasiello l'ìOStiene el'ìsore il il suo metodo perfettamente adatto anche per il duello: il che non credo.
Ma insistere sulla spada sarebbe come sfondare una porta aperta: megho rlunq ne passare alla sciahola..
Poichè, come si è visto, i difetti principali del sistema Parise noi modo di impugnare e maneggiare il ferro, prima di trattare di questo argomento è bene esaurire quanto concerne l'atteggiamento ùcl co1·po indipcndentelnente da altra considerazione, tanto pitl che quello che vale per la sciabola, vale anche per la spada. {1).
Ri è già accennato che i metodi Masiello e Pa.rise differiscono fra l oro leggermente per la posizione di spiccatamente por quel la di a-fondo.
(l) Si IIB!I qui indifforentemo nlo la paroln spada o (ì01·etto, per iudicnro l' arma generalmente usata uul giuoco di sala ; orn l'tt• o sta per riserv tu·e a questa il nrme di fioretto, I><'r dare quello di apmla soltanto nll'arm a Jl\ duello.
61R SOl METODI DI SCHERMA PER L'ESERCITO
Nella guardia il 1\lasiello vuole il peso del corpo ugualmente xipartito su entrambe le gambe; (l) il Parise invece lo fa gravitare forse un pocp più indietro, sebbene esplicitamente non lo dica.
Certo è che i difetti che il Masiello attribnisce alla guardia cl el Parise non sussistono affatto; anzi, poichè il piede dest J·o, dovendo scorrere rapido innanzi e indietro, tanto piit facilmente ciò potrà fare, quanto meno sarà gravato, e tanto meno agevolmente potrà in tal caso l'avversario accorgersi che ai sta per partire a fondo, è da ritenersi, anche in questo particolare, preferibile il sistema Parise all'altro.
Quanto all'a-fondo, il .Masiello ricorre alla fisiologia e riporta i seguentt pareri del La.grange:

« Il dal:lsunto completo dej movimenti della scherma sta
« nel finto combattimento detto as.qalto. Tutte le grandi fasi
«dell'assalto si possono ridurre a tre: la guardia, l'attacco ll'<,·fondo] e la parata; la risposta non merita e<peciale
« menzione non essendo cl1e un attacco rapidamente succe-
« dente ad una parata.
.: Per mettend ht guardia, il tiratore, dritto, rialza la spalla
« siu istra per portare la più alta. della testa; abbassa
« al contra1·io ]a spalla per tenere la mano all'al·
« tezza. della mammella destre.; la testa è volta all'a v-
« vexsario, ma il corpo si presenta.nùoRi di !ian.co.
« Per tale disposizione, quando i l tiratore !l'inchina, il corpo
«si curva non allo innanzi, ma da nn lato, da quello dello
« avversario, da quello della mano che tiene la spada, e
« e tanto più egli s'inclina quanto piti è attento a scrn-
« tare l'avversario ourle sorprendere il momento di attaccarlo.
« Allora il tira.to1·e si rannicchia come un animale in ag-
« gnato, ed il corpo si curva. sempre pil1, innanzi di stendersi
« per lanciare la litoccata. In questo momento di posizione
« forzata, la colonna vertebrale snbisoe il maggior sforzo e
« cede da un lato (2).
c Nell'attacco [a fondo! il tiratore si distende, ossia il
< Lronco si porta in avanti violentomenta dalla
(l) Nel trattato del ::llosiello, le rnianre sono spesso dato in centimetri e in gradi, quasichò in so.ll\ di schor·ma. ai avesse a. portata il metro e il qlradranto Molto più pratico è invece misurare a dita, a palmi, a piedi, misure sempre disponibili o per eli pir:l costantemente in proporzione con ciasouno achormidore.
(2) Si noli elle nulla ùi lutto ciò suct'edo secondo il trutl ato l'arise.
SU1 MlJ:TODI 0( pgR 619
« parte dell'avversario onde toccarlo. In questo spostamento
« laterale, si può rassomigliare la colonna vertebrale ad una
« leva la cui estremità sia ca1·icata dal peso della testa e
« delle spalle, peso che si aggitmlle alla scossa del movi-
« mento di flessione per comprimere la parte laterale d f'i
« corpi del1e vertebre. Per tale compressione spesso ripetuta
« e violentemante, l'osso finisce per cede1·e nella metà che
« subisce la pressione, mentre l'altra metà serba lo spes-
« sore no1·male. La spina vertebrale, costituita dalle vertebre
«disposte una sull'altra, seguo nel suo Lutto questo cedi-
« mento e devia.
« Nella parata il corpo non lavorano so l tanto
« l'avambraccio e il pugno; ma il tiratore conserva sempt'P
« la posizione laterale della guardia, poichè il corpo deve
« essere pronto a dare all'istante la risposta.
« Così in tutte le fasi della scborma il corpo agisce e si
« affatica in una posizione, che forza il tronco ad inclit1arsi
«costantemente dalla parte che tiene l'arma» (pag. 10-ll del trattato Ma siello di sciabola).

E più innanzi,
« Dalla fisiologia sappiamo che, affinch•\ le parti tutt;e
« t"he concorrono a.ll'esf'cuzione di nn movimento vi ab-
« l>iano azioni. realmente utili, si richiede una tal quale eli-
« sciplina che attribuisce a. ciascuna di esse la funzione
« sna particolare; o che il fine per cui nna data regione
«del corpo indireHamente prende parte al lavoro, altro
« non ò tal volta che di fornire un punto d'appoggio ag .li
« arti che agiscono; in tal caso l'atto indiretto muscoloro
c è una necessità imposta da11a mobilità estrema delle ossa
« che costituiscono lo scbeletl'o.
c Infatti, bisogna sempre che una dello estremità del
« muscolo abbia un attacco fisso, a.ffinchò l'altra estremitit
« possa fare trazione efficace sull'osso cui si attacca. Più.
« è considerevole la. forza da consumare, e più urgente di-
« venta la necessità di fornire un punto d'appoggio im-
« mobile ai muscoli che devono agire, perchè questi si
« mettano in azione con tutta l'energia possibile. Quand o
« poi ii movimento consuma una forza importante, ri·
«chiede sempre, come innanzi è accennato, la rigidezz a
<< della co lonna vertebrale e del tronco eli cui essa forma
« l'asse.
620 SU l ME•rODl OI SOllElit:MA PlllR L' .ESERCITO
«Ma la rigidezza della colonna vertebrale non può ot-
« tenersi senza H lavoro dei muscoli, si attaccano alle
c vertebre, i quali, alla loro volta, hanno Vbisogno di altri
c punti d'appoggio per spiegare l a loro energia. Prescri-
« vere quindi l'asse del tronco perpendicolare al suolo si-
c gnifica volere: rigida. la. colonna vertebrale, per fornire
« un sicuro punto d'appoggio fondamentale ai movimenti
« energici della scherma; l'esercizio di una quantità di mu-
« scoli, che altrimenti non entrerebbero in azione; l'azione
« simmetrica di certi muscoli, la quale, consistendo nello
« effetto di forze eguali e contTarie impedisce il deviamento
« (scoliosi della spina verticale) <.la quella parte ve1·so la

« quale la forzerebbe una curvatura continuata; l'altezza
c delle spalle sullo stesso livello, per impedire la forma-
c zione consistente nell'abbassamento di una eli esse, il quale «abbassamento Hi riscontra in tutti quei tiratori che si «valgono di un diverso atteggiamonto » (pag. 31-32).
Chi legge queste premesse, logicamente Ri aHpetterebbe che la posizione dell'a-fondo fosse descritta presso a poco cosi: Vibrare il colpo "tendendo nello stesso tempo la gamba sinishra, senza punto muovere da terra la pianta del piede e spingendo il piè dritto innanzi, senza strisciare, ma. rasentando il t.e rreno per la lunghezza di circa un piede, in guisa che il ginocchio resti perpenùicolare al calcagno . [ n questa il piè destro e il formeranno una linea, alla quale il tronco sarà q na:;i perpendicolare.
Invece, il maestro Masiello deHcl'h'e l'a·f'ondo in questo altro modo, afl sai diverso da quello ora citato e tl'att(l dal Pari:{e: c Dalla posizione di guardia si premerà. fortemente
« il piede sinistro al si contrarranno maggiormente-
« i muscoli dell'arto inferiore sinistro, affincbè esso scat -
« tando come molla spi11ga in avanti tutto il corpo; il piede
" destro rasentando il suolo s arà portato avanti sulla diret-
« trice per la metà dello spazio compreso fra i piedi e
« verrà battuto a terra vivamente; il piede sinistro dovra
« rìmanore fisso al suo posto; il peso del corpo donà gra-
« vitare quas i interamente sulla gamba. destra. In tale po-
« sizione il pugno e l e spalle dovranno formare una linea
« retta; il tronco e l'arto inferiore sinistro una diagonale ;
« la gamba destra dovrà. essere perpendicolare al suolo; il
« tronco dovrà formare colla coscia destra un angolo di
SUI liETODI DI SCHERMA PER L'ESERCITO
621
40 - ANXO LV1.
« circa 90 gradi; la coscia destra con la gamba un angolo di circa 110 gradi:..
Accorgendosi peraltro che tra le premesse e la. conclusione non corre troppo liscia la logica, cosi egli cerca di giustificare la contraddizione:
« Infatti impariamo dalla fisiologia che, nei diversi eser« cizi del oorpo1 la colonna vertebrale talvolta è combi-
« nata col movimento quale contrappeso a. rista.bilù:e «l'equilibrio compromesso dallo spostamento del centro di « gravità, e talvolta concorre coi movimenti degli arti, non «più per ragione d'equilibrio, ma per necessità di un ate lieggiamento particolare, favorevole a.ll'esecuzione della-
« voro ; (lbe in tuLti i casi dove lo ò energico, il « tronco prende parte ai movimeuti degli a.rti, i muscoli
« del bacino vengono in aiuto degli arti inferiori, quelli
« delle spalle sus({idia.no gli arti superiot·i, ed al moto di
« tutti partecipano i muscoli della colonna vertebrale e
« delle coste, perohè molti hn.nno punti d'inserzione sugli
« omoplati, sugli omeri, sul bacino, sul femore. Quanto pitt
« è violento lo sforzo e ta.uto più completa deve essere la
« combinazione e la partecipazione di tutti i muscoli del
" oo1·po a.l lavoro di un gruppo musoola1'e principale, per «fornire a questo una. grande manifestazione del NllO ef-
« fetbo utile. Così, volendo prodnrre una spinta viole11f a. colla
« mano, ciò clìe, dire, avviene in fu,tfi i colt>i della
« .<;olte?•ma e maggio1·mente in qu,elli più efficaci (puntate), dovranno i muscoli del tronco aiutare a. rafforzare l'azione
c degli a.rti superio1·i, e la col onna, per farsj parbocipe del
« movimento nel modo più efficace, dovrà flettersi da. una
« parte affine di metter:li nell'llsse del bt·accio, porchè questa
« direzione sarà più favorevole di una direzione angolare
« per sostenere, con tutta la del tronco, il movi-
._ mento eseguito dagli estensori del
«E non solamente l'inclinazione del tronco giova, per le
« suespresse ragioni di distanza e di meccanismo organico,

« all'efficacia dell'offesa, ma anche, a parer nostro e con
« grande utilità, a quella della difesa.. Non tutti i colpi
« infatti riescono al bersaglio, ma più spesso, anzi, da un
« colpo fallito il tiratore devo tornare alla parata della ri-
« sposta.. Ora, quantunque le regole della buona scherma
4. impongano di parare tornando in guardia, avviene di fro-
622 SUI METODI .01 SCHERMA PER L'ESERCITO
-« quante che la r isposta è così celere, che lascia appena il
c: tempo di muovere il braccio per deviarla; allora lo scher-
< mitore pal'a dalla posizione1 ,di a-fondo, ma il bersaglio
c: ch'egli presenta è talmente r i dotto dall'inclinazione del c busto, che basta un piccolissimo movimento del braccio
c: per compensare alla velocità dell'offesa temuta. Svolgen· dosi &opra una diagonale, u n a parte di esso (quella in-
c feriore) viene allontanata, e quella che si avanza (la parte
c: superiore) è protetta dal braccio (sic), mentre tutto il detto
• bersaglio (1), poi, viene compreso fra due punti vicinissimi
< fra loro (anca e spalla), che per la loro prossimità ne per-
« mettono la più facile difesa.
< :Ma facciamo puré il caso in cui alla buona legge del
« 1·itorno in guardia veuga ottemperato: potremo forse noi
« dire che questo avviene più sollecito quando il tronco si «trovi sulla perpendicolare al suolo'? No certamente, poichè
< per tornare in guardia dal nostro a - fondo, tutto il lavoro si
« riduce ad imprimere un movimento di rotazione, intorno
c: alle anche, alla parte superiore del corpo, il quale mentre
<riprende la posizione verticale, acquista, per la massa, una
c tal forza viva, da trasportare spontaneamente la gamba
« destra nell11t posizione di guflirdia, ed impiegSJ quindi evi-
« dentemente a oompiet·si un tempo assai minore di quello
< in cui, uon potendo Hcosbarsi in senlilo inverso, deve rice-
< vere moto dai muscoli della gamba stessa.
c Iu ogni modo 11011 importerebbe dichiararlo, giacchè la < pratica lo dimostra: non principalmente dal pronto ritorno
« in guardia, éhe pttre è necessario e voluto pe1· la ripresa
c: dell'offesa, viene procurata la valida difesa, ma dai movi-
< menti del braccio, i quali si compiono in ogni caso prima
< che si compia il ritorno, perchè piu limitati perciò più ve· « loci e quindi piu atti a contrapporsi efficacemente ai mo« vimenti veloci dell'offensore » (Masiello, pag. 66-68).
Ora non è ohi non veda la fallacia di queste argomentazioni e le contraddizioni in cui cade jl Masiello. Anzi tutto egli non s'accorge, ne' suoi entusiasmi per il Lagt·ange, che questi non è schermi tora e che anzi i suoi ragionamenti con-

SUI ME7'0DI DI SCHERMA PER L 1ESER01TO 623
(11 Si el'ige cosi a sistema. il cercare di sottrarre &i colpi a.vversa;ri un bersaglio convenzionale, quasiohè non siano temibili i colpi al viso o al braccio.
durrebbero a sconsigliare la scherma, perchè esercizio fisico dissimmetrico. In ogni modo, o la ragione fisiologica, che dice dannosa l'inclinazione del corpo da una parte sola, è giu sta, e allora va rispettata semp1·e tanto nella gua1·dia, quanto nell'a-fondo; oppure non ha valore, e allora è perfettamente inutile fare sfoggio di :fisiologia ma] digerita. La poca competenza schermistica del fisiologo Lagrange si appalesa chiaramente laddove egli paragona i colpi della scherma e maggiormente quelli più efficaci (puntate) al lavoro che fa il corpo per produrre « una s pinta violenta della mano », quas1 che invece di vibrare una pnntata, si trattasse di far forza alle ruote di un carro per spingerlo avanti. Quanto agli effetti dannosi (secondo lui) della scherma, li fa derivare appunto dallo 3forzo dissimmetrico degli arti e dell'incli11azione della spina dorsale: la quale inclinazione i n vece, col sistema. Parise, è quasi eliminata, dovendo il tronco rimanere yua.•n verticale. Si noti che il maestro 1\l[asiollo, polemizzando, trascura questo quasi, che corrisponde ad una leggiera inclinazione del busto innanzi.
Ma lasciando correre la fisiologia e rimanendo nel puro campo della scherma, si osserva, per riguardo alla facilità di parata, non osse r o punto vero che l'inclinazione del busto innanzi renda più difficile all'avversario di colpire, poichè anzi il viso rimane più vicino all'avversario e ohi fa più piccolo ò più facilmente domina.to e può essere colpito fiuo sul dor"o; che é stupefacente udir parlare di un riparo offerto dal braccio; che infine in tal posizione squilibrata si è tratti a chiudere la misura per l'i m possibilità. di tenor fermo il piede sinistro, e il ritorno in guardia è più diffìcile e richiede più fatica di quel che accada quando il tronco rimane quasi verticale.
Qllest'ultimo punto, poichè il Masiello afforma il contrario, merHa di essere illustrato. J uclinando alternativamente, com'egli vuole, il busto avanti nell'andare a fondo e indietro nel tornare in guardia, il centro di gravità del corpo subisce prima un abbassamento e poi un sollevamento per opera di muscoli che allacciano il bacino alla spina e lo spostamento del centro suddetto è tanto maggiore, quanto maggiore è l'inclinazione del busto. Siccome poi il peso del corpo viene a gravare quasi tutto sulla gamba destra, ne viene che per tornare in guardia occorre prima

624 SUI DI SCHERMA PER L'ESERCITO
•
S'Cl METODI Dl
SCHERMA PER L 1ESER01TO 625
Tialzare il busto e poi ritirare indietro la gamba. In complesso, il lavoro meccanico è assai maggiore che nell'a-fondo eseguito col metodo Parise, dove l 'abbassamento e il risollevamento del centro di gravità sono unicamente dovuti all'effetto dell'allungo, il peso del corpo rimane più equamente ripartito sulle due gambe e basta il ripiegamento della gamba sinistra per tornare senza sforzo ed elegantemente in guardia. Si aggiunga che in questo modo più facilmente s'impedisce lo scorrimento del piede sinistro e che col busto quasi verticale le parltte riescono agevoli dall'afondo come nella posizione di guardia e si può anche rispondere dall'a-fondo.
Il maestro Masiello sostiene uhe l'a-fondo eseguito col suo sistema è di ao a 50 centimetri più lungo che quello col sistema Parise e a tal uopo presenta ai lettori, nel recento opuscolo, alcune fìgure schematicho che non co1·· rispon<lono pnnto alla reaHà. Anzitutto, queste fìgtu-e rap presentano uomini aventi le braccia attaccate al collo e le gambe attaccate al coccige, ossia l'autore prescinde dalla posizione delle spallo e ùelle anche, posizione che ha, in questo cfi.So, -particolare importanza. In secondo luogo egli attribuisce al sistema Parise un a-fondo immagil1ario, invece eli prendere come base quello disegnato nel suo trattato, o meglio ancora quello cha si trova.·a pag. 56 del trattato dei maestri l'eco raro e Pessina ricavato da una.'fotografia. Paragonauùo questa figura con q nella contenuLa nel trattato di sciabola del Masiello, dopo averle ridotte entrambe alla medesima scala e aù ogual proporzione di membL·a, come qui si è fatto, si vedono a colpo d'occhio molte coRe.
Si vede prima di tutto quale delle due posizio1ù sia più equilibrata, più esLetica e meglio rispondente ai dettati della fisiologia, così unilateralmente invocata da Ferdinando Masiello: risulta poi evidente che la. lunghezza dell'a -fondo ò almeno ugua l e nei due sistemi (e praticamente si prova che è anche più lungo l'a-fondo del 1Pa.rise); e la ragione si trova nel fatto che il vantaggio ottenuto dal Masiello inclinando il busto è compensato dallo svantaggio dell'inclinazione della. spalla destra e del sollevamento dell'anca sinistra.. La prima. accorcia la stoccata, perchè le due spalle non p0ssono più essere sulla stessa linea del pugno e per

,
conseguenza si ha una spezzata invece di una linea retta.; il secondo accorcia pure la stoccata, perchè impedisce di spingere innanzi tutto il corpo, e per conseguenza. anche il pugno di quel tratto che corre tra l'anca sinistra sollevata e ritratta e la stessa abbassata a pari dell'anca destra. Si
noti che nell' ultima edizione del trattato di sciabola il maestro Masiello ha tolto la prescrizione, esisteute uella edi· zione precedente, che le due spalle e il pugno dovessero essere sulla stessa linea; e ciò ò naturale, poiohè la figura indica che la spalla sinistra (· notevolmente più alta della. destra e che il pugno, per rispettax·e quella prescrizione, avrebbe dovuto trovarsi del ginocchio. In ogni modo l'aver prima stabilito ua.a. simile prescrizione e l'averla poi tolta per necessità, dimostra che la. rinuncia non può essere che dannosa, o per lo ,,meno che le cognizioni anatomiche del maestro Masiello erano alquanto annebbiate allorquando pensava che la spina dorsale potesse essere in-

626 SUl METODI DI SOlil!:RMA PER L'ESERCITO
A runùo Siit&nt.\ .\fa•i•ll•l A sistomft. E>arlse.
•
clinata fortemente i nnanzi, pur mantenendo le spalle oriz· zontali.
n maestro M.as i ello va sofisticando sulla misura di un un piede, oltre la larghezza. della guardia, stabilito Mme lunghezza dell'a-fondo nel trattato Parise, e su quella di sei decimi della statura )?referita da lui; io rispondo che è puerile con siderare simi l i misure come tassative, sia perchè da uomo a uomo variano le proporzioni del co1·po, sia perchè l'a-fondo va commisurato alla distanza dal bersaglio, non potendo la misura essere sempre precisamente quella regolamentare.

Infine, il Masiello prescrive di batte1·e vivamente iJ piede destro a terra nell'a -fondo. Perchè? Io so che talvo l ta, por cercando rli fare diversamente, per la mala abitudine coutrattain ormai remoti involontariamente faccio quello ch'egli prescrive....e subito me ne pento, per il dolore che provo a l calcagno. Ma quello che particolarmente dev'essere grazioso e pratico è l'a-fondo col piede sinistro, fatto battendo nello stesso tempo il piede destro (così. lo vuole i l Masi ello).
Ciò mi ricorda 1.111 certo ìstruttore che, qnando io ero al· lievo clell'Accademia militare, impaperandosi nell'insegnare il del pezzo da montagna ad avanca1·ica, diceva: «Il numero uno fa un passo avantj con la gamba destra e un indietro con la gamba. sinistra». Povero numero uno !
L'erroneo atteggiamento dell'a.-fondo, comune alla spada ed alla sciabola, e proprio del sistema Masiello, è, a mio avviso, cosi fondamentale e grave dif'etto, che basterebbe da so l o a far mettere da parte il trattato: l cosiochè non sarebbe possibile nemmeno ammettere, in via conciliativa, che rimanesse in vigore il sistema Pal'ise per il fioretto e fosse adottato queUo Masiello per la sciabola.
Senonchè altri difetti presentia il metodo Masiello anche per il modo di maneggiare il ferro. Anche qui i molti movimenti de l braccio devono avere per perno pJ.:incipale l'articolazione scapolo-omerale, la mano deve sempre stringere l'impugnatura con fo r za, e l'infelice matematica è di nuovo chiamata in ballo a sostenere l'assurdo. Per esempio, il Masiello ripete l a barzell etta che la sciabola è una Leva di
SUI METODI DI PER L'ESERCITO 627
terzo genere (1) e consideratala ferma ed appoggiata al ferro avversario stabilisce l'uguaglianza dei prodotti delle forze per i rispettivi bracci ll.i leva per ricavarne la conclusione che il minor dispendio di forza per ottenere una data pressione sul ferro avversario si ha quando la è esercitata dalla spalla piuttosto che dal gomito o dal pugno. Ognuno che non sia affatto digiuno di meccanica vede che qui il Masiello ha impostato un problema di dinamica come se fosse un problema di statica: che si prescinde in tutto questo dalla velocità, che nell'urto conta àl quadrato; !lÌ dimentica che la velocità angolare, a parità di spazio percorso e di tempo impiegato a percorrerlo, è tanto maggiore quanto minore è il raggio, e per conseguenza maggiore se si fa perno al polso piuttosto che a.lla spalla. Il Masiello poi non considera che a far si che ava-mbraccio e ferro formino un sistema rigido, occorre la fot·za della mano : nè che il massimo di violenza del colpo si ha quando si sommino le velocità angolari dovute alle tre articolazioni del braccio.
Per conseguenza il JUasiello, qualora avesse voluto dimostrare che il maneggiare la scia ho la essenzialmente di pugno non consenbe di dirigere sicuramente i colpi di taglio e di tenere saldo il ferro per correre alla parato., avrebbe dovuto lasciar dormire la matematica, buona soltanto per chi la sappia adoperare, e dire che, a malg1·ado dei vantaggi eh.e pnò presentM·e lo sche1·mire di pugno, quell'unico inconveniente pllÒ esser tale da render opportuna la ricerca di nn altro metodo.

Di un altro metodo, ma non del suo : chè alle men<le già accennate vnnno aggiunte l'eccessiva 1·igidità del braccio nelle parate e la larghezza. dei movimenti di molinello. Tnlune parate anzi parano poco: per esempio, la prima, fatta con la sciabola sul prolungamento del braccio disteso, è facilmente delusa dal tra.versone di montante i e dalla parata di prima la risposta alla te::;ta, eseguita. piegando il braccio fin che il pugno sia all'altezza. della fronte, è troppo larga (e ller
(l) ]\·a le lut·une del tra.tlo.to Pecoraro-Pcssina, il m. MasieUo nota che manca. un capitolo che tratti della sc iabola c considerata come leva». Si potrebbe rispondere che, coroe sarebbe pre!eribile una manovelle• ; od anche, per analogia, osservare che noi t ro.ttato Mo.siello si ometto di trattare della sciabola « coneidot·ata. como Mla.brodo ll, visto cho il più rooonte modello di quell BI'IDI\ consigLiato dal maestro ho. appunto una coccin. foracchiata in modo da poter ;;ervire anche a quell'uso.
628 !>Ul METODI DI SOHEBM.A PF:E L'ESEROrrO
conseguenza lenta ed esposta a un'uscita in tempo), mentre si può eseguire benissimo combinando il movimento dell'àvambraccio e del pugno e conservando la perfetta padronanza del ferro, spostando legged.ssimamente il pngno dal suo wro di operazione.
Altro errore del Masi ello, che trovo spigolando a caso, è quello di affermare che la sola azione di controtempo che si possa eseguire con la sciabola è il colpo al braccio sul tempo dell'avversario. O il parare a rispondere sopra un'uscita in tempo non è forse nn controtempo?
Così pure le battute sono dal Masiello insegnato in un modo solo, mentre ve ue possono essere di varie specie.
Questi pochi accenni 1 fatti a titolo d'esempio, sono sufficienti a dimostrare che il trattato del maestro non solo è difettoso per il metodo, ma è anche incompleto, come meglio apparo cOtlfrontandolo col trattato Pecoraro-Pessina: difetto, quest'ultimo, comune anche al trattato Parise, il quale peraltro aveva dato, volnta.mente, alla sciabola miuore importanza e minor e sviluppo che al fioretto .
Si viene cosi a discorrere del trattato di scherma per la seiabola da poco pubblicato dai maestri Salvatore Pecoraro o Oado Per.sina.
Questo trattato è, per la sostanza, frutto della lunga espe· rienza di due rinomatissimi suhermitori; ma forse una soverchia. premma ne fece trascur:1re troppo la forma, su questa principalmente si appuntarono gli strali dei critici. Dinanzi alle censure gli antori uè si inalberarono, nè si scoraggirono: da persone di spirito presero nota degli appnnti loro mossi laddove pareva che avessero qualche fondamento e promisero una seconda edizione riveduta e corretta, nella quale peraltro avrebbet·o mantenuto quanto di fondamentale era nella prima.

E mentre il ministero, udico il parere di una commissione, approvava che il loro metodo fosse approvato iu via d'esperimento presso la scuola magistrale, ossi completavano i loro
pubblicando un t1·attato per la scherma di spada (giuoco da terreno) corrispondente al nuovo tipo di spada regolamentare. Di questo sarà. detto più innanzi: qui basti accennare che nella premessa a questo trattato, i maestri .Pessina e Pecoraro, dichiarandosi convinti fautori del me-
SUI METODI DI SCBERMA PER L'ESERCITO 629
*•...
::;tndi
todo di schermire col :fioretto stabilito da colui che fu per lunghi anni il loro direttora, soltanto poche aggiunte vi ritennero opportune: aggiunte di poco conto se si considera che il metodo è in vigore da ventisai anni e che la perfezione umana non giunge al segno da produrre di primo getto un lavoro eternamente inalterabile. E nemmeno è arrischiato il dire che il trattato di sciabola Pecoraro-Pessina contiene quelle modifica.zioni, uhe il Parise sarebbe stato disposto ad accettare, pur di addivenire all'unificazione della scherma italiana, e che egli stesso forse si sarebbe deciso a proporre, se il cielo gli avesse dato vita. Lo prova il tatt o che nell'istruzione por le sciabolate da cavallo egli aveva già adottato un sistema non perfettamente corrispondente a quello indicato nel suo tt·attato.
Questo premesse lasciano chiaramente divodere che il nuovo metodo ò precisamente quello che gli schermitori invocavano; nn metodo, cioò, nel quale i grandissimi pregi del Pat·ise por la scherma di spada sono accomnuat.i nd un sistema alquanto diverso di maneggiare la sciabola, pm· conservando dol primo l'eleganza, l'elasticità, la corret;tezzn, la llttttlralezza eli movimenti e 1·ipudianclo quello eccesso di forza e qnolla rigidità che sono i nemici capittdi della scherma.
Infatt.i, la llcia.bola t\ impugnata. e maneggiata in moùo da. poter porto.ro il ferro con sicurezza. e velocità, valendosi di tutto le tnticolazioni di Clll madre natura lu\. fornito l'uomo, ma in minima pa1te di quella dell'omero, come quella. che fa perdere in elasticità e in rapidità. quanto essa può fornire di forza: il giuoco ò arricchito di tutto ciò che per essere l'arma adoperabile di punta è analogo al giuoco ùi spada; clai va.rt metodi esist.enti,. tanto dal Paris o, quanto dal Reda.elli e da' suoi dori va ti, è tratto quanto in essi vi era di buono e di pratico; principalmente, po1, nessun esclusivismo ha mosso gli autori, che si sono sforzati di dare• al giuoco tutta quella variotù., tutta. quella adattabilità ad ogni genere di avversario, che raralllente si trova negli altri trattati, in molt.i dei quali più si cura il meccanismo cho l a. finezza dell'ano. Per esempio, il Pessina e il Pecorara con· siderano quattro varietà di battute, laddov e ill\Iasiello ne considera una sola: ora è evidente che l'avere un a. certa larghezza di scelta consente allo schermitore di

630 SUI ME'l'ODI DI PER L'ESEROlTO
rare questa alle tendenze dell'avversario e di più, obbligando a studiare la scelta, affina il tatto, l'occhio e la pl·ontezza di deCisione, ossia la scelta del tempo, alla qual cosa sopratutto gli autori attribuiscono la massima impo1·· tanza.
Anche trattato ha scagliato i propri fulmini Ferdinando Masiello, pubblicando il citato opuscolo. Molti appunti riguardano la forma, e d1 ciò si è già detto: soltanto si potrebbe ripetere al critico l'evangelico avvertimento : 4:' Chi di voì è senza peccato, lanci la prima pie.« tra». E anche per qttesto basti un esempio. 'rrattando della divisione del bersaglio, scrive nel proprio trattato il Masi ello: Essendo lo schermitore in perfetta guardia, colla
« spada sulla linea d'offesa, immagil1iamo che sia tirato
« dalla linea direttl'ice un piano perpendicolare alla stessa, «il quale conseguentemenLe passerà per l'asse del braccio
« o della lama dello schermidore... Di primo accl1ito, chi sa che la linea d'offesa e la linea direttrice sono parallele, sa pure che Llll piano come quello che indica l'autore non si può ti?·are; leggendo il seguito, si capisce che si tratta di un piauo verticale passante per la linea d'offesa e quindi parallelo alla linea direttrice; ma non c'ò modo di scusare questo sproposito, né come un errore di stampa, nò come una svista, perohè è costantemente ripett1to per la spada e per la sciabola, anche nella più 1·ecente edizione. Dunque:
« .J[edice, ctwa te ! »
Anche per la sostanza, il .Masiello biasima naturalmente l 'aver conservatp l'a-fondo del Parise, e pM·t1colarmente non ritiene opportune oerte azioni, che il Pessina e il Peooraro consigliano. Fra queste i :fili sottomessi, le parate di contro, le parate di cont1·o in senso opposto, l e azioni circolate.

Sarà <l.u estione di opiuione o di gusto: ma quando queste azioni si vedono praticamente ed efficacemente eseguite nella lezione e nell'assalto, non sì capisce come si possano negare. Al più si potrà consigliare di non abusarne, quando ciò possa riuscir e pericoloso; ma dall'uso moderato alla soppressione assoluta, ci corre! Anche il così dotto COUlJé di spada è pericoloso, eppure il Masiel lo lo ammette !
Ma facciamo un esempio. Contro un avversario che dall' invito di quarta sopra una finta di punta pari tel'za e mezza contro di prima, non riesce naturalissima, con la
...
SUI METODI DI SCHERMA P.ER L 1ESERCI'f0 631
sciabola, l a doppia finta circolata? E questo è un caso co· munissimo, e gli esempi si possono moltiplicare a volontà..
Nell'opuscolo., col quale 1l Masiello biasima acerbamente il trattato Peooraro-Pessiua, accenna alla commissione (di cui io facevo parte) la quale ne ha approvato la sostanza e dice di dissentirne. Egli peraltro dichiara di non aver biasimato mai il modo p1·atico col quale i rlue maestri accennati hanno schermito, ma il testo del trattato, non corrispondente con la pratica.
Ora qnalohe cosa di simile ha detto anche la commis· sione, encomiando la sostanza, dimostrata praticamente in sala di scherma, e facendo risorvtt. sulla forma: ma da questo a credere che esponendo chiaramente ed e::;attamente quanto gli auton praticamente fanno, essi c debbano passare con « armi e bagaglio senza i l minimo sforzo » nel campo delle idee e delle teorie del Masiello, m.olto ci corl'e.
Invero, paragonando l a scherma di sciabola che Pessina e Pecoraro fauno molto beue, pur non avendola saputa ugualmente bene descrivere, con quella che :Masiello descrive senza che abbia da to uguali prove di saperla fare, io non t rovo concordanza Basterebbo la differenza dell'a-fondo; ma altre rilevantissime ne ho notate e chiunque pnò nota.rle parago11ando semplicemente l o :figure dei ùno testi: e meglio si rileveranno, quando verrò alla luoP l'edizione riveduta e corretta del trattato tanto PPr conseguenza sorge il dilemma: O H modo pratico di schermi re dei due maestri è il buono, e allora essi, la. commissione e il maestro 1\fasiello sono tntti d'accordo, ma quest'ultimo è in contraddizione col testo dol proprio trattato; oppure il trattato di Masiello è il btlono, e allora non può esser buono il modo pratico di schermire di Pecoraro e di Pessina.

Non rimane adunque chP sollevarsi al disopra dell e beghe personali ed attendere il termine dell'esperimento iniziato, nonchè la seconda edizione da questi ultimi maestri promessa; dopo di che 1' insegnamento della scherma nell'e· sercito si potrà dire quasi definitivamente sistemato.
Quasi? Alla sistemazione definitiva dovrà. concorrere, come si è detto, anche il nuovo trattato per la scherma di spada da terreno. Già. nel 1904 Uasaniello Parise aveva pnbbli-
632 SUI METODI 1U SCHERMA PER L 1ESEROITO
**a::
cato, a questo scopo, un'appendice al testo ufficiale; ma il giuoco era adattato alla spada allora in uso per l'esercito, la quale lasciava alquanto scoperta la mano e presentava lo svantaggio di. avere la lama troppo :fles sibile per poter consentire un giuoco di precisione ai bersagli avanzati. Da11904 in poi anelò diventando d'uso sempre più generale un altro genere di spada, che, pur conservando il vette trasversale come caratterisliica dell'odierna spada italiana, era munita di una coccia capace di garantire completamente il pugno, e una lama meno flessibile, ma pur sempre leggiera.

A. trovare nna soluzione .ma di questo problema pensava precisamente Parise in quei giomi, in cui immaturamente la morte l o co lse. Egli vagheggiava un'impugnatura. che fornisse ad un tempo i vantaggi propri di quella italiana e di quella f1·anoese, con lama a sezione triangolare come quella che non dirsi esclusivamente francese, perohè già usata in armi italiane fino dal secolo xvx.
L'idea non potè, sventuratamente, essere concretata; certo è, in ogni modo, che s i hanno ora vari modelli di spada, più o meno simili fra loro, che garantiscono bene il pugno e la cui lama ò quasi rjgida.; tale è il modello ormai divenuto regolamontare.
Ma. a. conturbare le aure schormistiche, già agitate dalle precedenti controve1·sie, è testè venuta anche in Italia la clispnta tra i (l01·etti8ti e gli spadi&ti. Dicouo questi che il modo di schermird è unico, che il fioretto è una parvenza. di arma, non un'arma vera; che non vi deve essere alcuna convenzione negli assalti, affinchè questi rispecchino il duello. Rispondono quelli che i pl'incipì che reggono l'arte della scherma .,ono bensì unici, ma che ne può variare l'applicav.ione a seconda dei lim iti del bersaglio; che limitare il bersaglio è utile, perchè altrimenti il giuoco, ristrotto ai bersagli avanzati, perdo di attrattiva e sopra tutto rinuncia al beneficio che si ottiene con la ginnastica dell'af'onclo; che sul terreno c'è la punta, e in sala non c'è, sicchè occorre una convenzione a sostituirla, ladclove la coscienza dell o schermitore non basti; che l 'esercitarsi continuamente con la. lama rigida non cou,;ente di vibrare con la. voluta. decisione i colpi al petto senza pericolo; che il ferro troppo pesante stR.nca la mano e ilTigidisce il braccio; che infine
SUI h!ETOIH Dl SCHERMA. PER L'ESERClTO 633
uno spadista puro potrà diventare u.n toccatm·e, ma non sarà. mai uuo sche1·mito1·e nel vero senso della parola.
È questa u.na di quelle questioni, che non si risolvono che col tempo. La FederaQlione schermistioa italia.na, per attenersi allo stato di fatto attuale e mantenersi al disopra di ogni discussione partigiana, ha nettamente distinto il giuoco di sala da quello da terreno, accogliendo nel proprio grembo spa.disti e -fiorettisti. E allo metodo è giusto che si attenga l'insegnamento ufficiale della scherma, pre· parando maestri che siano capaci di segnalarsi in qualsiasi campo.

E quaRto pare aia l'indirizzo che seguirà - ed a ragione - la nostra scuola magistrale di scherma e di educazione :fisica, tenendo ferme le ottime basi fondamentali :fissate da. Masaniello Paris e, senza peraltro rinunziare a quel costante e progressivo perfezionamento, cui è nella natura umana di mirare senza posa.
Viterbo, 6 gennaio 1911.
634 SUI METODI DI SCHERMA PER L'ESERCITO
,
Ar,nERTO O..l VAOIOCOHI colonnello commula11te il 60' ,·egglmenlo (o.tttcr·la.


NOTE SULLA FAN1'ERIA.
LA SPECIE. - c La. fanteria. è il nerbo dell'esercito • ; per conseguenza non saranno mai troppe lo cure dedicate a. cl uest'arma, a.ffinchò essa corrisponda. per valore intrinseco all'importanza. che per forza delle cose essa ha. nell' insieme dell'organismo militare.
A giudicare dai nomi, vi sono quasi in tutti gli eserciti varie specie di fanteria. In Italia, come è noto, la fanteria genericamente eletta comprende la fa:nteria di i be,·xaglieri e gli alpini; oltre a ciò, della fanteria di linea. due reggimenti sono di graMtieri, e i bersaglieri forniscono alcuni bn.tta.glioui eli
Ri può osservare come sarebbe più chiaro sostituire alla denominazione (untl'ria di li m•" q nella di fucilieri, poichò allora si eviterebbe qualunque equivoco c si sarebbe sempre certi che, dicendo fanteria, si a.llndorebbe indistintamente a. gl'anatieri, fucilieri, bersaglieri ed 11.lpini. Si aggiunga. cho l'attributo di linea non ha. più, da oltre un Recolo, significato alcuno.
Dare alla fanteria di linea. l'appellativo di fucilil'l'Ì nem · sarebbe nna novità; esso era anzi in origine prero· gativa della gloriosa brigata Aosta Vero è che eli fuciliéri fn a.ncl1e detto in altri tempi un reparto dove erA.no raccolti i peggiori soggetti dell'esercito piemontese; ma a questa sLregua nemmeno si sarebbe dovuto rievocare, per i volontari garibaldini del 1859, il nome di Cacciatm·i di'l/e Alpl, ricordando che questo nome già avevano assunto le bande del brigante Violino (1796): bande che dapp r ima operarono a. danno dei Francesi e poi, comprate, mutarono bandiera e al servizio della repubblica.
« I Romani » 1 osserva Napoleone I, «avevano due specie c di fanteria: la. prima, armata. alla. leggiera, era munita • a· nu' 8.l'ID8. da gitto j la. seconda, pesantemente armata, c portava una corta spu.da. Dopo l'invenzione della polvere , s;- L'''·

893
« si conservarono ancora. due specie di fanteria: gli archi-
c bugieri, che erano armati alla. leggiera e destinati ad espio-
c rare e a molestare il nemico i i picchi eri, che tenevano
c: luogo dei pesantemente a1·mati. Dopo centocinquant'anni
c: dacchè Vauban fece sparire da tutti gli eserciti d'Europa
« le l ancie· e le picche, sostituendo a queste il fucile con
« baionetta, tutta. la fanlìeria fu armata alla leggiera e de-
« stinata tanto ad esplorare, quanto a cont.enere il nemico;
« non ci fu più, così, che una sola specie di fanteria; e se
« si ebbe per ogni battaglione una compagnia di cacciatori,
«ciò fu per far simmetda cnn la. compagnia granatieri e
« perchè in un batt11.gliono di nove compagnie una sola
«compagnia scelta (cl' élite ) non sembrava. sufficiente ( l). Se
c: 1' imperatore Napoleo11e creò compagnie di volteggia tori
-c armate con fucili da dragone, ciò fece unicamente per
« sostituirle alle compagnie di cacciatori e l o compose d1

« uomini alti meno t1i 5 piedi (mef..ri 1,G7) per sfruttare i
« coscritti di sLa.tura variabile da quattro piedi e dieci po l-
« lici a cinque piedi (l ,Gl· l ,G7) i quali fino allora erano
« sta t i esenti ... ; e fu un modo efficace d i sUmolare l '.omu-
« !azione quello di mettere a confronto i pigmei e i gi-
« ga.nti. Se ci fossero stn.ti nel suo esercito uomini di di-
« verso colore, egli a.vrebbo composto compagnie di neri e
« d i bia.nclll ; per lo stesso moti vo: i n un paese in cui ci
«fossero dei cic l opi e dei gobbi, si trarrebbe
« buon partito da compagnie composte di cic l op i e da altre
«composte di gobbi. ·
« Nel 1789, l'esercito francese comprendeva reggimenti
« di linea. e battaglioni cacciatori: i cacciatori delle Ce-
« venne, del Vi vara.is, delle Alpi, della Corsica, doi Pirenei,
c che all'atto della rivoluzione formarono mezze-brigate di
c fanteria leggiera.; ma non vi fu punto la pretesa di avere
« due fanterie differenti, poichè esse era.uo ednca.te, istruite
« e armate allo stesso modo; soltanto i battagHoni di cao ·
• « oiatori erano reclutati fra g li uomini dei paesi di mon ·
{l) Ai tempi di Na.poloono, i granatieri in Francia orano scolti secondo il criterio della statnrn; prima d'allora. invece la. compagnia raccogli e va i migliori soldati do l battaglione: usanza. che il runresciollo di Sassonia biasima anche percbò « on veut des grenadiors partout; ot.
• s'il y a quatre chots à fes!lcr, so sont. !es granadicrs qu'on domnnde c et .. on les fait tuer mal ò. propos ». (Mu réverieB, 31).
x 894
NOTE SULLA F.A:l<TERIA
-< tagna e tra i figli dei guardacaccia, il che li rendeva più
c adatti ad essere impiegati ait confini delle Alpi e dei Pi-
-e renei, o se si trovavano ad essere impiegati negli eserciti
c di settentrione, ad essere distaccati di preferenza per at·
c rampicarsi su una altura e per frugare una foresta; questi
.c uomini però, quando si trovavano in linea in un giorno
.: di battaglia, tenevano molto bene il posto di un batta-
< glione di linea, poichè a ve vano la stessa istruzione, lo
.c stesso armamento, la stessa educazione.
c I governi levano spesso, in tempo di guerra, co1·pi ire regolari, cui danno il nome di corpi franchi o di legioni,
c reclutati fra i disertori esteri o formati d'individui aventi
.c uno spirito od un'opinione particolare; ma oiò non costi-
c tuisce due specie di fanteria. Non ce n'è e non può esse1'·
c cene che 1tna. Se gli imitatoll:i servil:i (les singes) dell'an-
c tichità. vogliono imitare i Romani, non già. debbono creare
c fanti leggieri, ma fanti pesantemente armati o battaglioni
c armati di spada, perchè tutta la fanteria d'Europa fa il
c servizio di t.ruppe Jeggiere :. (1).
La poca opportunità di a\"ere due specie di fanteria, cioè due fantel'ie a:rmate e a.ddest;rate di-versamente, apparve pure da parte tedesca nella campagna del 1866 e fu dichiarata esplicitamente dal maresciallo Moltke nella « Memoria in-

c dirizzata a S. M. il Re di Prussia il 25 luglio 1868:. (2).
Le prescrizioni regolamentari per l'addestramento dei cacciatori, vigenti da lunghi anni, erano ancora, durante
la. detta campagna, basate sui criteri seguenti:
.. Il mos chetto corto essendo ,per costruzione un'arma di difesa atta a produrre il massimo effetto solo se adoperata
c con calma, un'energica offensiva da parte dei cacciatori
c deve considerarsi come cosa eccezionale (3)
« Se inoltre si tien Mnto che il combattimento in ordine
c sparso rappresenta pei cacciatori il sistema normale di «combattere, si dovrà ritenere che il combattimento a fondo
c in campo aperto non è una forma adatta alle qualità ca-
c ratteristiche della loro arma da fuoco. È invece molto
(l) :UoNTJIOLON. - Mém.oirea d e Napolé<m., I, 239·241.
(2) ÀIOL'l'KE. - Taktisch e t md strategische AufsiUze, 144 146.
(3) Il tiro del moschetto era più preciso che quello del fucile, ma la carica era più lenta per la. necessità del forzamento ad ogni colpo.
l ' NOTE SULLA FANTERIA 81!5
NOTE SULLA FANTERIA
« opportuno l'impiego del fuoco col moschetto dei caccia-
« tori iu quei punti ove è difficile, per parte del nemico, l'as-
« salto con l 'a rma bianca, cioè dove il terreno è rotto e nelle
« locali tà che offrono naturale protezione e la cui conser-
« vazione è importante e può essere garantita dalla supe-
c riorit.à del fuoco; nelle trincee durante una ritirata e in
« generale in quei te rreni che permettono alla destrezza e
c alla circospezione del cacciatore di sfruttare tutti i vantaggi oi.Terti da una località.
«Basandosi su questi principì che regolano il loro impiego
c nel co!llbattimento, i cacciatori giustificheranno il loro
« titolo di a1'ma speciale se eviteranno il modo di combat-
« tere della fanteria e si manterranno fedeli alle massime
« che crearono la fama di questo corpo speciale.... Per il
« servizio di sicurezza, durante le marcia e l e soste, 1' im-
« piego dei cacciatori è particolarmente raccomandato:
«a) Ìtl ierreno eminentemente boscoso e montuoso;
«
b) per mantenere occupati nella cerchia degli avan-
« posti tal uni punti particolarmente importanti;
c
c) pl'r compiere ardibe imprese, in terreno adatto sui
«fianchi e a tergo (1) .
Il Moltko- osserva che raramente si presentò durante l a campagna del 186G l'occasione cl' impiegare i cacciatori seco ndo lo norme regolamentari; che non v'ò ragione, dato il valore che ha l'offensiva, di addestrare un'arma speciale per scopi pnramente difensivi; che data la scarsità dei cacciatori Ji professione (un CJ. uinto del totale in un battaglione di cacciatori sul piode di guerra, mobilitato con 12 classi), meglio sarebbe riunire tutti i cacciatori in un solo reggimento, da denominare c reggimento cacciatori della < Guardia • e coi battaglioni cacciatori rimanenti costituire i reggimenti di fanteria ancora mancanti nel piano orga-
(l) L6 nOI'lllO por l'impiego dci cnociato ri o più o.noora qnelle per l' impic-j;(o dei bersaglieri all'atto dell!t loro orenzione assomigl iano a quello cho il maresciallo di Sassonio. suggo· riva per i fanti nrmati. al tempo in cui quo11ti soli erano armati di schioppo e i fanti pr>!<tlntemente armati portavano la pio<'a (.11<'8 réceriu, 31 ), Napoleone ammettevo che pochi uomini per compagnia fossero armati di carabina a più lento caricamento, mn di maggior git· tata: oppuro che no fossero IUtnktte compagnie di borghesi de:;tinati arimanere dietro gli spalti d i unn fortezza.. (Corre8 pondancc militaire dc Napoléon 1", X, pag. 324).

896
, nico generale, o almeno, se queste p r oposte n on f ossero "accettate, dare ai cacciatori lo stesso fucile della fante ri a c e introdurr e nel loro addestramento tattico l'ord i ne chi uso, .c. il fuoco a salve e l'attacco alla. baionetta:. .
Prima ancora che il Moltke avesse dedotto da una cam · pagna di guerra il difettoso ordinamento dei battaglioni di Jliger, ..llessandro La Marmora aveva notato, fin dal 1836, gl'inconvenienti della < carabina scanalata, sol'arma usi< tata sinora da questa specie di truppa; [i] quali inconve« nienti, consistendo principalmente nella lentezza de l ca« ricare e nel poco mezzo di difesa all'arma ' bianca., non c danno abbastanza confidenza al soldato per compromet« tersi corpo a corpo :. ; sicchè, nel proporre la formazione della prima compagnia bersaglieri, propose pure l'adozione di un'arma migliore e nello stesso tempo antepose al com· pito difensivo un compito offensivo. Vero è che il compito difensivo dei bersagli eri fu simile a quello dei cacciatori; ma. lo scopo generico fu quello di avere <un corpo di ben c addestrati bersaglieri, singolarmente in paese montuoso, c impedito ed opportuno alla guerra minuta » 1 quale era appunto il carattere della massima parte degli Stati sardi (l) e più particolarmente fu assegnato loro il compito di « sec condare con la precisione del tiro ogni operazione princ cipale » av\"ertendo che «essendo di natura ad accompa.« gnare le spedizioni tanto della truppa di linea che della • leggiera, e prendendo ogni volta posizione, i bersaglieri c non si devono adunque considerare come una truppa leg· te giara, ma piuttosto come una specie di artiglieri a a pie" cola portata e di grande mobilità. :. (2)

Nel fare questa proposta, certamente il La Marmora si inspirò al ricordo dei cacciato1·i ca1·abinie1·i Canale, creati da Vittorio Amedeo ill con editto del 28 ottobre 1792, la -cui divisa ricorda molto quella dei bersag l ieri e il cui fon<latore, conte Malaba.ila di Canale, appartenne allo stesso Teggimento cui fu assegnato da sottotenente i l La Marmora. I cacciatori dovevano essere arr uolati senza riguardo alla sta· tura, a questa sola condizione ": « Con ciò sieno robusti ed
(l) R. decreto 18 giugno 1836.
( 2 ) Proposi.;ione per a formazione di tma co mpagnia di ber.>aglieri e modello di uno sohioppo per loro uso
NOTE SULLA FANTERIA 897
808
NOTE SULLA FANTERIA
« atti al ser'71ZlO per cui sono destinati, che esige fatica.
« e sveltezza non ordinaria • (1).
Così nacquero i bersaglieri, i quali tuttora. si conservano ecl a ragione, benchè non esistano pit1 in massima parte i . motivi che ne snggerirono la fondazione ed anzi il solo motivo tuttora esistente, quello cioè di avere truppa par· ticolarmente adatta alla montagna, abbia dato origine ad un altro corpo speciale: quello degli alpini, creato nel 1873. Non v'è dubbio che sarebbe stato possibile evitare la costituzione di un corpo nuovo, richiamando i bersaglieri, al meno in parte, •alla loro origine; ma non è altrettanto certo che ciò sarebbe stato utile all'esercito. Per convincersene basta tener presenti i ricordi ora citati, dai quali appare chiaramonte che non vi può essere· che una sola specie eli fanteria, o che so anche una parte della fanteria potrà avere attitndini speciali, come nol caso degli alpini, il fondamento doll' istruzione e dell'impiego non può essere che uno per tutta la. fanteria. Por contro sono utili tutte quelle differenze che rialzano lo spirito ed eccitano l'emuJa.zioue: esempio caratteristico le compagnie di volteggiatori e di granatieri dell'epoca napoleonica, per non ripetere quella paraùos.:;ale dei c iclopi e dei g obbi Porciò non è affatto anormale ohe i bersaglieri conservino il nome loro, sEfubone non abbiano più quella particolare precisiono di tiro, che ebbero all'inizio, allo stesso modo che nesst1no pensa di cambiar nome ai granatieri, col pretesto che da molto tempo non lanciano più granate; mentre le tradizioni gloriose degli uni e degli altri o lo spirito di corpo che li anima sono un preziosissimo 'Patrimonio eli forza mora l e. Enunciare a proposito do i bersaglieri il d n h bio d'Amleto, perdendosi nella vana ricerca di uno spocialo impiego del corpo in caso di guerra (2), equivale a. rinnegare l'esperienza. del passato e a volersi illudere cho gente e. piccli possa essere qua l che cosa di diverso dalla I bersa-
(l) Donom. - L e{Jgi, provvidenze c mani / e8ti, XX VITI, 324, - Il La. l\lnrmora. non ricercò la novit à del nome, poichò altri corpi di bcrartglirri erano già esistit.i. l bersaglieri s uoi furono peraltro più simili ai cn ct:'ia· tori carabiniel'i su menzionati cho ad altri tipi di bersaglieri più somiglianti ai Jii.gor prussiani: basti ogsorvln·e che osai ebbero la. baionetta e gli nitrì la daga o il coltello da cnccia.
(2) '!lfENARJNT. ll dil emnw ri'A.mlrto pe i ber8a!llitr i - Rit•ist« militare italiana, aprilo g iugno 1904.

glieri non sono, non debbono, non possono essere altro che fanteria scelta.: ma. è già questo un altissimo onore, che impone agli ufficiali dei bersaglieri il dovere di curare con tutte le loro forze che i fatti corrispondano al nome.
Non può, del resto, recare meraviglia che un concetto
così semplice abbia stentato a prevalere nella pratica, se si pensi che Alfonso La. Marmora nel 18G!) scriveva: « Uti-
« lissimi sono i nostri bersaglieri e checchè ne dica il ge -
c nerale Trochn e dir possano altri generali pari a lui, spero
« sAranno nell'attuale proporzione conservati. Io stesso
c ho introdotto, e non me ne dolgo, che la nostra fanteria
c di linea sappia., occorrendo, combattere in ordine spa.r'lo.
« i\[a con tutto ciò dichiaro che voler fare di tutta ln. no-
c stra. fa.ntEt.ria altrettanti ber;;aglieri è un errore che ci po-
c trebbe costar caro Appu11to perchò abbiamo ottimi bat-
c taglioui bersaglieri, impareggiabili massime per preparare
«e completare i combattimenti, la. nostra fanteria di li nN\
c ùovrebbe es:sero più solida o più comp11.tta delle altrt'. Ora.
c lltnto piit che, colla celerità delle armi a ret.rocarica, l'or-
c tliHe chiuso ha ripreso quella maggiore c:he
c nveva prOV\'Ìsorinmente ceduto all'ordine aperto, dmante
c il brove periodo delle armi di precisione a tiro lento :. (l).
E quel che è ancora più strano, il generale Alfonso La 11[armora. insisteva aJtcora in quc:;te idee nel 1871 (2) clopo la della. guerra frauco-prn'lsiann ,\ questo proposito riesce part)co1a.rmonte

rievocare quanto il generalo Carlo Corsi rammenta. circa. le discussioni e le impreso;ioni che i bersaglieri suscitarono al tempo della loro origine: ·
c Nella. primavera del 184:1:, sul cadore d'un dì piovoso,
c io giungevo a 'l'orino venendo da Alosstmdria . La pes1tnte
c vettura che mi insieme ad una dozzina. d'altre
c persone, svoltando sulla piazza della. Gran :Madre di Dio,
« infilava rapidamente il ponte di Po; quando l'occhio mio
c curioso in mezzo a tante cose per me nuovissime si fermò
c :sopra una strana figura d'nomo nero, che stava. piantata
c proprio E sull'uscire del ponte. Un, cappellaccio a larga
« messo a sghimbescio, un mantelletto serrato al collo
..,
NOTE SULI,A 899
(l} alla swria. dd la campagna ckl lSGG in Imlia, II, G7. l2) ALFOXSO LA - Qrllltlro discorRi, 97
« e stranamente corto, calzoni di foggia militare, e cii sotto
« al mantello la estremità d'tmo schioppo o la punta di un
«fodero d'arme. Cappello e mantello grondavano acqua.

«Appena ebbi tempo di guardarlo; era già buio e la ctu-
« rozza andava di galoppo. Non vidi in quel nero nè viso
« nè mani; e non so quale idea mi passasse pel ma
«rammento ohe mi trovai in vena di buon umore. E stavo
« per chiedere che cosa fosse quella bizzarra figura, quando
« uno dei miei compagni di viaggio esclamò, additando a p-
« pnnto quella specie di gnomo: Il p01;ero bersaglim·e! ];"u
«la prima volta che udii pxonunciare questo nome; e dav-
« vero la impressione fattami a primo aspetto dal prim is-
« simo che vidi degli uomini cui quelnomo appellava non
«fu ammirativa!
Vidi poi pe1· le vie di Torino altri di quei soldati, se1tza
« quollo strano ma1ttelletto, col pennacobio sV'olazzante, in
« fa.rsotto succinto, svelti, vivaci, risoluti. Mi furono dette
., di loro mirabili cose: che erano capaci di fare tre chilo-
c metri di corsa in venti miunti, e poi scavalcar
« inerpicarsi pe1· groppi e balzi, saltar fossi e siepi, e poi
« Lirttre a segno a colpo sicuro a sette od ottocento pas!li.
« Bouchè allora non avessi idee nette in fatto di milizia,
• e forse appunto a motivo di qut?olla mia ignoranza, tutto
c ciò mi seppe di ciarlataneria, c non osai dar torto a coloro, forestieri e piemontesi, Ctli quella divisa pareva strava·
c gante e e quella gente piuttosto una baucla di
« guerriglieri che un corpo eH soldati.
c Uua. mattina, in una. stra.da là dietro piazza Vittorio
c Emanuele, udii uu infernale disaccordo òi ·stridule trom·
« bette e vidi sfllarmi dinanzi in un minuto quattrocento
« di quei diavoli turchiui. Andavano a passo speditissimo,
« qt,asi a slanci, curvi sotto il peso d1 enormi zaini, colle
«carabine in bilancia. Tutto quello scnro, quei neri pen·
« nacchi svolazzanti, quello stridore di trombe e quel passo
c precipitoso avevano un certo che di tempesta da scuoLer
« i nervi e infhtmmare il cervello. Ma uno di quei canuti
« avanzi della Moscova, le cni parole mi sembravano re-
c sponsi d'oracolo, mi 1 freddò da bambini!
« Qztel La .!Jfal"mo?·a è uno u.n .!Jioloclt che si
« pasce di sangue umano. I suoi be1·saglieri non se1·vono acl
« attl"o che ad empi1·e gli ospedali, i cirnite1·i. Quel passo! ...
noo NOTE SULLA FANTERIA
c: quei saltt! Povera gioventù! pove1·u Piemonte! Infatti si «diceva che le ernie e le polmoniti fossero molto frequenti
c: in quel corpo.
« Li rividi nell'autunno sulle lande di S. Maurizio stor< meggiare sparsi e tirare a segno . Erano davvero svelti e c corridori e tiravano a meravig l ia. Ma da nn Iato il vecchio
« oracolo diceva: j]fetteteli in faccia ad uno di co« razzieri francesi o di ttsseri austr iaci o ad un battaglione
« di Goddarn o di K(tise1·lich qu,esti balle?·ini ...! e dall'altro
«parecchi giovani militari bronto lavano: Qualunqne corpo
« di fante? ·ia può {a1·e lo stesso; purchè lo si voglia.
c Intanto gli spregiudicati dicevano: i bersaglieri non «sono una nuova specie di fanteria, ma sibbene un saggio
« ùi ciò che potrebbe essere la fanteria tutta tra pochi anni;
« sono la prima forma d'un concetto che mira ad un ra-
< dicale mutamento delle armi e della tattica di tutta la
« milizia a piedi. I gonzi vanno in estasi ammirando da
« una parte questi nuovi espedienti di guerra cosi leggi eri
«e dalPaltra gli antichi ta.nto solidi e gravi, e si compiac-
e ciono dello !'ltato reciso che li separa. Ma a guardar bene
«a. fondo, la. questione è assai più grande e molto diversa.

« Abbiamo a confronto due sistemi tattici, il vecchio che
c sol finire dell'epoca uapoleonica cominciava già a lasciare
« qualche cosa da desiderare, ed uno nuovo in prova. La
« guerra dirà qua le sia il migliore dei due; ed allora con·
« velTà tenersi a quello e lasciare l'altro. Nella fanteria
c non può e>servi ragionevole distinzione, tranne quella
c: sola tra la scelta e la ordinaria A tali discorsi coloro
« che avevano i dieci e più anni di servizio e i mo l tissimi
« che da loro pigliavano l'imbeccata crollavano la t esta. in
« atto di scheruevole compassione, preparati a difendere
c: sino agli estremi, quando lo vedessero seriamente minac -
c: ciato, ogni briciolo del vecchio sistema, cadendo il quale p areva loro dovesse cadere il mondo. Solito effetto del -
c l'abitudin e! :. (1) .
Le fanterie scelte esistono, del resto, in tutti i principali eserciti ; ma. nel calcolarne la. proporzione rispetto all a fanteria di lin ea, non bisogna dimenticare che in a l cu ni eserciti vi sono grandi unità di truppe scelte (il corpo di
NOTE SULLA FANTERIA 901
(l) CoRSI . - Tlclllicinque anni in Italia, I , 42-44.
armata della guardia in Germania e in Russia, la divisione della guardia nel Giappone); senza di che si corre il rischio di cadere in affermazioni inesatte, come quella contenuta nella relazione del 23 maggio 1896, la quale accompagnava la presentazione al Senato del progetto Ricotti pel ri01·dinamento dell'esercito ( l )
Contro le fanterie scelte e precisamente allo scopo di di· minuire il numero dei nostri bersaglieri, si ossot·va da taJuui che la loro esistenza è nociva alla fanteria di linea e si paragonano all'edera cche abbarbicandosi alla gran quercia c: delle forze nazionali ne assorbe i succhi migliori :. ( 2) Ora ciò è pura. esagerazione, fìnchè lo cose rimangono noi. limiti presenti; in fatto di assegnazione rlel personale quello che interassa. di più è che gli uomini adatti alla fanteria non siano presi, senza sufficiente motivo, da altre armi; ma se fra tutti quelli assegnati alla fanteria gli individui aventi speciali requisiti saranno riuniti in reggimenti a parte, ciò potrà riuscire di vantaggio piuttosto che di danno, come chiaramonte dimostrauo le parole di Napoleone. Ad evitare poi auuho il pil1 lontano pericolo che la fanteritt di linea accolga individui di scMto, il provvedimento più opportuno consisterebbe nell'allargare sempre più la base <lei recluta· mento, in modo da poter fare una più larga selezione fisictt del contingente incorporato.
La. fanteria ciclista, recente istituzione, è certamente un'anna speciale, perchè si sPrve di un mezzo eli locomozione rliverso da quello fanteria onliuaria; mA. se i ci· clist,i, in ragione della loro mobilità. snlle strade, possono avere compiti particolari che non potrebbero essere disimpegnati dai fanti a pieùi, devono per altro essere in grado di compo1·tarsi como la migliore del l e fanterie noi casi in cui non possano valersi della bicicletta eù anzi portarla sulle spalle e combattere: e ciò forse in condiz ioni eccezio· nalmente difficili, porchè lontani dall'appoggio delle altre truppe. Ad ogni modo, anche la trasformazione parziale ùei ber:!laglieri in ciclisti non implica che si debba distruggeme
(l) Secondo quella rotazione, la. proporzione t1·a lo fanterie sco lto e quello Ji linef.\ StH·obbe dj 1/5 per I'Ita.Ua; l lO per l' !\ustria-lJnghoria, di l / lO circa per Il.\ Francia {osoluse le truppe di Algerin), eli 1 ' 33 por la Ger· marua, di l 9 circa per la Russia.
(2) ;\[AR ,\ZZI. - L' Nurcito dei tclllpi 275.

--
902 NOTE SUJ,LA FANTERIA
l a parte rimanente, la quale sarà sempre l a plU numerosa e l a più aoiatta. a conservare le glorioie tradizioni, che i l corpo creò marciando e combattendo unicamente a piedi .
Q nanto agli alpini, è superfluo spender parole pe r dimost r a r el' uti lità di avere truppe specialmente addestrate alla. guerra di montagna: desta anzi meraviglia che, allorc·hé fu creata. in Italia nel 1873 la. prima. compagnia alpina, l'idea sia par:>a. nuova. e originale, mentre già in Italia i cacci a tori Canale e i ber saglieri avevano avuto il medesimo scopo, in già esi:'te'ç'ano i tiratori tirolesi e fin dal 1780 il principe di Lign e nei Prt'}ugés militaires patroc i nava. nn maggiore svil uppo di questa istituzione, vo l euclo che ci fossero nell 'e· sercito degli al'l·ampicatori I!JrimpettrR), dei nuotatori e dei questi t1ltimi addestrati a portare celermente or· dini e notizie, servizio cui meglio si prestavan o gli éclaireurs a cavallo ideati da Napoleone I e che ora potrebbe anche essere ben disimpegnato dai ciclisti. Va rico r dato che i Russi, nella guerra contro il Giappone, avevano appunto a sussidio della fantoria reparti di esploratori a cn ,·allo.

T/essere gli alpini particolarmente a.dtlestrnti allA. guena. d i non devE\ per altro generare esclusivismo; allo stesso modo che a fianco degJi alpini si troveranno in montagna altre truppe e lutti dovmnno opemre armonif•amente, cosi anche gli alpini pol;ranno cluamat.i a combattere fuori delln zona al pino.. A.nzi il loro motto tradizionale: J..Yon .<1i !, che è una felice espt·essione di gagli ardo spirito militare, va interpretato semplicemente in senso tattico, nel senso cioè che ogni teparto alpino sarà capu,ce di tener e acl oltranza la posizione affidat.agli, sia e!-lsa suile
A lpi, sull'Appennino, sulle ambe d'Africa o in p ianura, n on mai in strategico, setfSO cioè di dover assicurare lo sbarramento dei valichi al pini contro un'invasione stra· niera, perchè allora si cadrebbe in quell'assurdo dissemi· namento di forze che corrisponde alla puramente passiva gnen-a di cordone .
fiiova infine ricordare che anche oggi i cacciatori d i tal cini esel'citi esteri non co r rispondono sempre ai nostri be rs aglieri e ai nost.ri alpini, pur essendo scelte; e ciò specialmente per diversità di reclutamento. Per esempio, i Jiige r tede:.chi sono scelti per metà circa fra quelli che s i
, .... NOTE SULLA FANTERtA 903
dedicano alla carriera forestale e per l'altra meta fra lll· ,dividui che spiccano per agilità (non per robustezza).
In taluni eserciti, quasi a sostituire l'artiglieria reggimentale dell'epoca napoleonica, furono creati reparti di mitragliatrici, di cui torna acconcio parlare a proposito della fanteria, sia perchè la non è che un fucile a tiro 1·apidissimo, sia perchè in taluni eserciti tali reparti formano organicamente parte dell'arma di fanteria. Le batterie o le sezioni di mitragliatrici ricordano le batte?·ie di amusettes che il maresciallo di Sassonia prevedeva di formare quelle d'ogni centuria per reggimento {il reggimento essendo di 4 centurie) e per legione (la legione essendo di 4 reggimenti) (J.11es 1'éve1 ies, 38). Più ancora ricordano le amusette.s i cannoncini preconizzati dal Langlois e dal Reichenau.
Le mitragliatrici però non hanno dappertutto eguale assegnazione ed eguali compiti: il loro ordinamento è pure assai vario e non sono state con uniformità di criterio jntrodotte in tutti gli eserciti. D el resto, p or esempio, i Tedeschi hanno reparti di mitragliatri c i e non hanno compagnie di ciclisti; dimostrano anzi poca simpatia. pe1· il largo impiego dei ciclisti, temendo quasi di fornire a molti il mezzo di a.llontanar::i dal com battimento sotto pretes ti aventi l'apparenza della legalità.
Del nurne1•o della fanteria è supet'fln.o discorrere, perchè essa ha n a turalmente negli eserciti odierni la prevalenza numerica ed anzi essa stessa serve ordinariamente di unità di misura per ragguagliarvi le altre armi (1)

LA RII'ARTIZlONE 'l'ERRITORIALE. - Il frazionamento gerarchico della massa, mentre deriva da necessità tattiche per il tempo di guerra, ri sponde a necessità disciplinari, amministrative e di addestramento in tempo di pace. Il conesatto di quel che siano la brigata, il reggimento e le unità minori si avrà dunque soltanto accoppiando la.
(l) « L'infanterie d ' une armée étant représentée par un, la. cavalerie -« sera un quart ; l' artillerie un huitième; les troupes du génie un qua« rantième; Ies équipages militaires un trenti ème ; ce qui fera treize « trentièmes; :mais il auffi.t que la. ca.va.lerie so i t le cinquième de l'J.nfante-« ries de l'éta.t , à cause du pays des rnontagnes. - MoNTBOLON, Mé-« moires de Napotéon, I, 230 ».
SULLA FANTERIA
nozione della loro reale composizione con quella delle funzioni dP-i rispettivi comandanti. Queste funzioni hanno dunque grandi$Sima importanza in guerra e in pace; mentre però in guerra l'ordine gerarchico naturale non può essere turbato che per circostanze speciali e straordins.rie, iu tempo di pace esso è subordinato alla distl·ibuzione delle truppe sul tenitorio dello stato.

In Italia, non tutti i corpi d'armata e tutte le divisioni hanno la precisa quota di fanteria che loro spetterebbe in simmetrica ripartizione; un corpo d'armata è privo di berila· glieri e un altro ne ha due reggimenti; gli alpini sono variamente distribuiti fra i corpi d'armata di confine; ma l'anomalia più saliente concerne tre brigate di fanteria: quella il cui comando a sede in Nocera ed i cui reggimenti sono rispettivamemte a Nocera ed a Potenza, ossia 11el territorio di due differenti COl'pi d'armata: quella il cui CO· mando ha sede jn Catanzal'o, mentre i reggimenti sono a Catanzaro e Lecce; e quella il cui comando ha sede lt H.oma, mentre i reggimenti sono a Civitavecchia ed a Viterbo, ossia nel temtorio ùi differenti.
Per queste brigate, il caso è !l.nalogo a quello che si riscontra nelle brigate al pine e nei raggruppamenti superiori al reggimento delle armi di cavalleria, di art.iglioria. e del g<mio.
In vero le brigate al pine, cosi come sono COt)LituiLe, si tro· vano tutte a cavallo del territ<>rio di almeno due divisioni e due a del territorio di due corpi d'armata. Ne risulta per il comandante della brigata una moltiplicità di dipendenze, poichè i comandanti di brigata, ollre a dipendere personalmente dal comandante di corpo d'armata nel cui territorio risiedono e tecnicamente dall'ispettore delle truppe da. montagna, dipendono, per i corpi sottoposti, dai comandanti di divisione nel cui territorio i corpi stessi o i loro distaccamenti hanno sto.nza. La couseguenl!>a è questa: per quanto di disciplina f!ia unico per tutto l'esercito, pure il !!UO modo di applicazione può es· sere a seconda delle persone a cui compete curarna il ri:>petto; ed anzi è questa una delìe funzioni in cui la personalità dei comandanti può maggiormente spiccare, giac· chè esistono infinite vie che guidano al medesimo scopo.
Potrà dunque accadere, in mezzo alla. naturale varietà di
..... NOTE SUI.LA. F'A:STERIA
metodi, che uno stesso comandante di bri'gata si trovi nell'occasione di applicare, in casi uguali, due pesi e due misure, a seconda che un reggimento o parte di e§so si tl·ovi nell'una che nell'altra divisione, nell'uno piutto'f!to che nell'altro corp'o d'armata: cosa la quale non giova al prestigio del grado, perchè la diversità di apprezzamento, ammissibile e naturale in persone di v erse, non si può con-cepire in una stessa persona.
Questa moltiplicità di dipendenze cui è soggetto un comandante di ' brigata alpina sarebbe in parte eliminata il giorno in cui il solo comando di corpo d'armata conservasse carattere territoriale ; poi eh è in tal caso, quando il comandante di brigata fosse, coi rispettivi reggimenti agli <H·dini diretti del comandante di corpo d ' armata ' o agli ordini di un solo comandante di divisione, dipenderebbe da una persona sola. Per i d'armata poi, nei quali non si trovasse che un solo reggimento, sarebbe preferibile il conservarlo autonomo piuttosto che porlo alla dipendenza di un comandante di brigata avente stanza in un altro .corpo d'armata.
L'essere ognuno dei reggimenti dei bersaglieri posto in tempo di pace alla dipendenza di un comando di brigata di linea è un esempio dell'applicazione del c1·iterio che l'ordinamento del tempo di pace deve anzitutto corrispondere alle opportunità del tempo di pace.
LA BttiGATA m IL REGGIMENTO .- Venendo ·a considerare più particolarmente l'intima costituzione della fanteria, è tuttora utile seguire il filo della dot.trina napoleonica.
L'unità superiore al battaglione ha. oggi il nome di ?·eggimento. Nel p1·ogetto formulato a Sant'Elena, Napoleone I aveva disegnato di denominarla b?·igatct, rimanendo soppressa l'unità comprendente d.ue reggimenti e conispondente alllodierno nome, quale era esistita durante le campagne na· poleoniche.
« La brigata sarrà composta di tre battaglioni e coman-
« data dal colonnello brigadiere con tre aiutanti di campo,
« cioè un capitano in l 01 incaricato del servizio di stato ·mag-
« gioré, un c.apitano in 2° proveniente dalla cavalleria, in-« caricato del comando degli esploratori, e un tenente. '

-'
SULW.
NOTE
FANTERIA.
c: Un sergente per battaglione sarà addetto allo stato·
c maggiore per le scritture e le traduzioni.
c: Il colonnello brigadiere a'•rà una. guardia composta di
c: no-çe esploratori, fra i quali un tenente, un maresciallo
c d'alloggio e un brigadiere, i quali saranno addetti alla
c: sua persona e gli faranno servizi d'ordinanza. Gli aiutanti
c di campo porteranno sul proprio cavallo i sacchetti di
c viveri: saranno armati di una. sciabola e di uu paio di
c pistole, che appiedando, porteranno indosso; avranno a
c tracolla una borraccia. ed un astuccio contenente un ca-
« uoèchiale, la carta l'occon-ente per scrivere e
c la tesa (misura metric-a ).
c Per il servizio di polizia la brigata avrà un drappello
c ùi gendarmeria, composto di un maresciallo, un brigadiere
c e tre gendarmi.
c La brigata risulteJ.•tì composta di 2898 uomini di fan·
c teria, 126 di cavalleria, 36 cannonieri che serviranno 3
c pezzi da 3 libbre, 72 soldati del treno che condurranno
c 1·1.1: muli o cavalli da basto, 18 macellai che condurranno
c ùa 150 a 200 bestie bovine o l'equivalente in altri ani·
« mali ; totale. 3159 uomini e 310 cavalli da sella appar-
e tenenti allo stato -maggiore, agli esploratori e al treno
c d'artiglieria.
c lJa brigata non avrà. con sè nessuna vettura, eccetto i
c: pezzi d'artiglieria e un carro·fucina di battaglione tirat,o
• da1 cavalli; gli altri duo carri-fucina dei battaglioni SR.·
c rauno col grosso bagaglio • (1 )
Benchè Napoleone ne avesse divisata la soppreRsione, pnre la brigata., quale esiste oggidi nella maggior parte degli eser·
·citi, è un'eredità. del passato, tramandata a noi attraverso all't·poca napoleonica. Quale ne sia l'organico è noto; che
· essa abbia come principale difetto quello di eRsere in guerra un'unità binaria, è pure noto; basterà quindi, per completarne la conoscenza, prendere in esame ]e funzioni del coman · dante di brigata in tempo di pace.
Il capo VI del nostro regolamento di disciplina (edi'zione 1907) tratta. particolarmente dei doveri del comandante di briga ta. Dopo a-çerne fissata la dipendenza, il regolamento dice:

c: Il comandante di brigata ha per ufficio di esercitare
(l) M é moire., de :NapoUo n, 231.
SULLA FANTERIA 907
NOTE SULLi FANTERIA
« una continua ed immediata vigilanza sull'istruzione, sulla
« disciplina, sull'amministrazione e sul buon andamento in
« genere d'ogni servizio dei reggimenti della bri gata affidata
« al suo comando . Deve essere oggetto delle sue costant-i cure
« ogni particolare del funzionamento dei reggimenti per
4. poter sovv4'lnire col proprio consiglio i comandanti dei reg-
« gimenti ed anche, se occorra, intervenire a correggere di·
« rettamente le negligenze e gli abusi, a 1;iparare gl'incon-
« venienti e le irregolarità, ad imprimere vigore e buona
« direzione in ogni ramo del servizio, attenendosi però a
« quanto prescrive il n. 93 del regolamento, cioè lasciando a
« ciascuno l'autorità e la libertà d'azione che gli competono
« e che determinano il grado della sua responsabilità, ecc.
« Egli deve stndiarsi di conoscere individualmente gli uf« iìoiali della bdgata, specialmente gli ufficiali superiori e «i capitani; e tutte le volte che gli si offre l'occasione deve
« portare il contributo della propria esperienza e del proprio « sapere per accrescerne la coltura profess ionale».

È chiaro che por quan t o il regolamento si sforzi di separare le attribuzioni del comandante di brigata da quelle del comandante di reggiment·o, esse rimangono pnr sempre molto simili, forse perchè il regolaUlenbo non ha insistito abbastanza sopra un che ogni cosa sia fatta a l tempo debito : la prescrizione di esercitare la vilanza a tempo debito, invece che continua ed imlìMdiata, sar e bbe stata sufficiente a scindere nettll.inente le responsabHità. Così prescrivono, per esempio, i regolamenti tedeschi.
È, del resto, criterio c-ostante dei Tedeschi quello di ripartire le responsa.bilitt\ anche nel- tempo, e di collocare le varie autorità gerarchiche a tale distanza fra loro, che nes· suna possa appoggiarsi su q_uella inferiore o superiore, o sulle laterali, par reggersi in pi,edi, per modo ch e chi non sa reggersi per propria virtt\ è indubbiamente destinato a cadere.
Il reggimento in Itll.li!ll. comprende, di massima, tre battaglioni: fanno eccezione due reggimenti alpini che sono di quattro. In altri eserciti vi sono reggimenti di quattro e di due battaglioni.
Sebbene la cosa sia discutibile, alcuni ritengono troppo pesante il reggimento di quattro battaglioni, salvo casi speciali: e il reggimento di due battag!ioni deriva generalmente da una misura transitoria.
"
908
Il capo VII del regolamento di disciplina. tratta. dei do· veri dei comandanti di corpo e specifica ampiamente quali es..;i siano, tanto sotto il rispetto della disciplina, quanto sotto quello dell'istruzione e dell'educazione; le attribuzioni amministrative sono nel regolamento di disciplina sologene· ric·amente accennate e a. completarle provvede il regolamento di amministrazione e di contabilità.

A mettere in luce lo spirito del regolamento basta notare, cla nn punto di vista generale, che esso prescrive chiaramente che l'istruzione e l'educazione della truppa va dal comandante di corpo lasciata agl'istruttori naturali, che sono i comandanti di battaglione e di compagnia, astenendosi
c dall'intromettersi ad esercitn.re esso le attribuzioni parti-
• colnri dei vari gradi, per riserba\'e tutto il suo tempo, la.
c sua operosità e la sua liho1·b\. di giudizio ad i11vigilare e c migliorare sempre ph\ l'andamento generale del servizio » t n. 211) e ponendo invece particolare e continua diuc nelFistruzione degli ufficiali, come pure ,·nole il regolamento d'istruzione, il quale altresì ohe si debba giudicare del hworo d'ognuno dai risultati.
Tra le particolari attribuzioni del comandante di reggimento, principalissima. è quella. di porre cia!->cuno nelle condizi oni più favorevoli per adempiere ai propri <loveri, tenendo per guida il giudizio proprio ed ilrl"golamento. Ha, quin.li, speciale importanza e merita d'essere sottoposta a speciali analisi l'operazioue, prevista dal u 213 del regolamento di clisciplina) con le parole: • RiparLisce le reclute c tnt. le diverse compagnie in guisa che, subordina.tamente « alle varie esigenze del set'vizio, riesca eguale presso ognuna.
c di esse il numero degli uomini più intelligenti e di mag-
c giore istruzione •.
Le informazioni che può ave1·e un comandante di reggimento sulle reclute che stanno per giungere dai vari distretti ri guardano essenzialmente i seguenti punti:
l luogo di nascita.
2 ar.ni di ferma, a qualità professionali,
4 • grado d1 coltura,
5 qualità. morali,
6" qualità fisica.
Xon tutte queste indicazioni hanno per altro uguale grado
XO'fE
SULLA F.,!\TERL\
58 - AIIXO LVU.
NOTE SOLJ,A. FANTERIA
di certezza ; di esse poi talune hanno importanza principale, altre importanza seconda1·ia.
Il dist1·etto eli pt•ovenienza e gli anni di (e1·rna sono dati di fatto, che non si possono trascurare nell'assegnazione delle reclute ai vari reparti. Il mescolare tra le varie compagni& glì uomini dei vari distretti e pel comandante del reggimento un obbligo dipendente dal sistema. di reclutameHto vigente presso di noi; il tener conto degli anni di ferma è pure una necessità, per ragioni ovvie. Potranno solo variare le modalità seguite per tener conto di questi elementi.
Le qttalitlt p1•o(essionali hanno ptu·e grande importanza, specialmente per talune armi e specialità (sovra tutto per l'artiglieria e per il genio); limi.tandooi qui a considerare il caso della fanteria, l'importanza di questo elemento vien e limitata e dallo scopo che si vuo l e conseguire, e dalla maggiore o minore attendibilità. dell'informazione avtlta s11 ciascun individuo. Queste due considerazioni consigliano di 110n ricercare distinzioni troppo sottili, clte non sarebbero pratiche , e di attenersi invece a distinzioni abbastanza genet·iche, da rendere difficili o di poco rilievo gli errori.
Gioverù. anzj qui ricordare quanto prescrive il n Ul del regolamento d'istruzione (edizione 1907): «Nell'interesse del < servizio, è pure necessario promuovere l'istruzione di quei <so l dati e caporali, i quali abbiano le qualità. militari per « consegnire rispettivamente il grado di caporale e di ca· < pora1 maggiore, ma difettino delle cognizioni che per tali gradi sono necessarie ".

Ancora più. incerte sono le qttaUtà -mo1·ati, pe.rchè su di esse il comandante di reggimento ha solo le indicazioni che ricava dalle fedine penali o dai rapporti delle autorità politiche, quando giungono in tempo, e costituiscono di solito una base di giudizio assai fallace.
Converrà essenzialmente tener d'occhiq i rei di furto qualificato, distinguendoli dai rei di furti campestri, e quelli designati come sovvers1v1; questi ultimi, di massima, si dimostrano poco pericolosi e sono spesso ottimi soldati (1).
(l) La giustizia distributiva vorrebbe che anche questi fosse1 o ripartiti fra le compagnie; altre considerazioni indurrebbero piuttosto a separarlì pel' gruppi, assegnando ad una compagnia tutti quelli che banno magagne dello stesso genere.
Il 910
\ engono infine le qualità fisiche; ma anche riguardo a queste, è difficile avere una giusta idea complessiva del valore di ciascun individuo; basta, per convincersene, notare i ragguardevoli cambiamenti che fauno taluni dopo qualche mese che sono alle armi. Anche la misura toracica non dà un criterio esatto, perchè andrebbe combinata con altri ele· menti: e soltanto la statura può essere presa in considera· zione, per l'inconveniente che può derivare dal mettere accanto, in uno stesso reparto, individui molto alti e molto piccoli.
Le informazioni concernenti i punti indicati possono essere fornite da ciascun ufficiale, inviato a prendere le re· clute in un distretto, mediante una tabella conforme al seguente modello, nel quale è tenuto conto contemporaneamente delle suddivisioni naturali che emergono dalla situazione degli individui nella vita civile e di quelle altre che occorrerà di per gli interessi derivanti dalla vita militare: suddivisioni, come si vede, abbastanza larghe, da trascurare quelle sfumature che sono facilmente causa di errore.

)IOTE SULLÀ FANTERIA 911
•

NOrrE SU LLA FAN'rERIA
All'ufficiale inviato a prendere le reclute occorre prescri\'ere che le inforn azioni giungano al corpo almeno 24 ore prima dell'arrivo del drappello.
Di tutte le informllzioui così mccolte bisognerà dunque tener conto. coordinandole al criterio dal regolamento; criterio che più genericamente risponde allo scopo di trarre dai :-ingoli 1·eparti il rendimento pando o l grado il della l'C\aponsabilit.<\ uei comandanti di compagnia.
Il mezzo piit semplirc, per soddisfare nello stesso tempo n que:;to criL••rio e al principio di giustizia, me;;colnre }1' redut.e, \alf'ndo-..i dei criteri l)iù o meno sicuri innanzi enumerati, in modo dn ottenere una ma!lsa, omogenea la. quale. divisa. fra dodici compagnie, forni!o;ca dodici porzioni n Yenti tui:te i p1·egi e i i di tetti Xon :-.i pot rù. ottenerfl mai, è vero. n nn perfetta ug uaglinnzn: bisognerà perciò !'ontentarsi eli una equivul('nzu, quale s i può ricavare da una mNlia. Mn ncn basteril •.:l e le compagnie si equivalgano all'inizio; occorrerà che tplesta. eqnh·aleuza sia mantenuta nel corso tlell'auno o clw comanflante di con::pagn1a colga i frutt1, buoni o cattivi, che avrà seminato. Oltre dnnqne a fnr sì che ogni eompagnia ubbia iu sè tutti gli elementi necessari per "\'Ì\'e r e di vita propria, occorrerà che essa conser't'i una forr.a app r ossimativamente ugnale a quella delle altre compagnie e che uello stes!'O tempo tutt1, soldati, graduati e cariche speci al i, nascano e muoiano nella stessa compagnia: solo così facendo si pot r à addossare al comandante· di compagnia tutta la respon;;:abilità che gli spetta. 11 passaggi o di uomini da una compagnia all'altra è pernicioso ed n. ra gione il regolamento prescri \e di astenersene senza asso· 85- .\:-.xo LYil

1337
! l • ;. l
luta necessità ;, p,aveggiamento del deve q nindi essere fatto principalmente con l'assegnazione delle reclute e secondtu·iamente con lo sottrazioni di personale che le vicende del servizio via via richiedono.
Ciò premesso, &i può dare qualche suggerimento snl modo di praticamente procedere all'assegnazione.
Jl criLorio della st,atum è il solo che richieda nn procedimento diverso dagli altri criteri, perchè è il solo pet· cui non conviene la moscoJanza. uniforme, ma piuttosto nn raggruppamento scalare. Inve1·o, la statura varia ordinariamente dal minimo regolamentare di metri 1,6:5 ad un mas. si m o di 1, 78.
Ora non è dannoso che in una massa come quella di un reggimento si t,rovino simili differenze, mA. dannoso che queste diff<'renze raccolte nella bre\'G cerchio. di una eompagni11. OHrechè l'ft,giOJli mOl'A.li, ntgioui materiali consigliano di separare gli estremi. Nella marcia è tli fastidio la diwrsa cadenza. dl passo ùel vicino: so quindi Haratn!O raccolti in gruppi diversi gli individui dal passo l uugo e q n eli i dal pnsso corto, ognuno in comodità, menLre la. velocità della colonnn rimarrà costante, pel'ohè di esHtt sono rcspousabili gli uflir.iali.
T1 non aver nella medesima compagnia individui di staturo assfl,i di verse favorisco an eh e H servizio del corredo e del vestiario, p<>!' il minor numero di taglie cho accorreranno a ciascnna compagnia e per la facilità degli scambi.
Infine una dist .inzioue all'antica. 11apoloonica di grmuttieri e di luugi dall'essere 110civa., t.• vantaggiosa, perchè favorisce l'emulazione. preJ'eribile, diceva Napoleone, in nn battaglione di sei compagnie averne una c di granatieri, composta dei più begli nomini, e

c l'altra di volLeggia.tori, composta. dei piit piccoli, perchè
« ciò fornisce il maggio1· stimolo di emulazione che esista
«.fra gli uomini. La differenza fisica è forst' pii1 grande che
« ln. differenza dei costumi; gli nomini alti disprezzano i
« piccoli o i piccoli vogliono far vedere, con la loro audacia
<< e con la loro bravura, che disprezzttno gli alti (t)
V'ha di pit't: "'m messo che tutto debba. nascere e morire nella compagnia, è utile ovitaro di mettere uu caporale
(l) <Jorre8pondence de Napoléon I, XXI, png. 425.
1838 NOTE SULLA li'ANTERIA
·
piccolino a capo di gente più alta di lui; e lo stesso vale pei sottufficiali, ed in certa misura. anche per gli ufficiali Gli uomini, è vero, non si misurano a spanne; ma questo proverbio è nato tra le persone intelligenti ed è moneta fuori corso in mezzo a gente ordinariamente rozza, sulla quale il maggior prestigio si esercita mediante la prestanza fisica.
Si potrebbe opporre, all'adozione del sistema fin qui esposto, che qualcosa di simile esi:,tè in Piemonte secondo l'ordinamento del Villamarina dal 1831 al 184:D e si stimò poi opportuno di abbandonarlo. Si legge infa.tli nella s/o)·ÙJ. della Ao.11ta, dei colonnelli Fabris e Zanelli (pag. 26226:3\:
c Granatieri, cacciatori, fucilieri costituivano una special..,
c gerarchi a: i cnpitani dei grann.tieri dovevano, giusta le
c di:;po:oizioni dei regolamenti, scegliere i loro uomini su
c tutto il reggimento frn individui di cui fosse stato per alcuni anni di servizio riconosciuto il coraggio e la buona

c !'Ondotta, interrogando sulla scelta. i primi e i migliori
c della compagnia; st>nonchè <ìel coraggio non potevans1
«avere molte prove in tempo eli pace, e tenevasi invece
« molto conto del la :stal ura. Conforme al loro mandato sul
c campo 1ii battaglia, i cacciatori erano scelti fra gli uomini
« che a robustezzt\ accoppias3ero agilitt\ di membra. e di spi-
e rito: il testo formava i fucilieri, massa d'uomini depau-
« perata dei migliori elementi, costituita quasi dal rifiuto
• dei granatieri e dei cacciatori, plebe del reggimento. L'e-
c mulazione, che volevasi con tale ordinamento destare e
c tener viYa nel cuore dei soldati, aveva per lo più la sua
« espre,.;sione nello scherno: ai granatieri appioppavasi il
c nomignolo di plancia-a-pan, quasi co11 la. loro statura non
c fossero buoni ad altro che ad nfferrare co' denti il pane,
c che so]e,·a tenersi sulle assi sovrapposte a capo del letto:
« la missione de' cacciatori nel com battimento, quel loro
c correre di qua e di là, per cercare il nemico e approfit-
c tare degli accidenti del terreno, aveva valso loro il titolo di-
c spregia.tivo di rat·da·comod: i fucilieri erano addirittura
c considerati come un cataplasma applicato alle gambe de'
«granatieri, moventesi con cadenza severamente uniforme
« sul selciato delle città.. e a uelle de' cacciatori, correnti
« agili e presti per monti e per piani. e furono senz'altr(l
NOTE SULLA FANTERIA 1339
1340
NOTE SULLA FANTERIA
« denominati papi·n. I ncensurabi l i per contegno, pe r uni-
« forme e per attitudine ma.novriera nella piazza d'armi e
« nelle parate, i granatieri erano l'orgoglio dei colonnelli;
«il comando delle loro compagnie era ambito compenso a i
« capitani più anziani e più. prestanti della persona e me-
« g l io forniti di q nalità militari; ma gnai se, in vece J01·o,
« marciava in testa del reggimento il battaglione caccia-
« tori ! Allora quelli spregiati rat-da ·co mocl mettevano in
« opera tutta ltt forza dei loro gan-e t ti, per costringe r e i
, granatieri a trar fu01·i la lingua., e se uno di questi ri-
« maneva addietro, un coro di risa schernitl'ici si levava
« lungo tutta la colonna, e alla vondetta doi cacciatori
«aggiungevasi quella dogli spregiati papin. QueBte diff(\ ·
« renze però non andavano oltre la superficie: grauatwri,
« cacciatori, fucilieri erano come rami Ji versi innestati in
« un tronco comune -..
Appare du. questa descri;r.ioue quanto la spinta della emuper eiretto de l sh;tema, poteute, e :Je plll'e sono messi in rilieYo gl'inconvenienti dovt1ti alla esa.gorl.\zione dello spirito di battaglione, è anche vero che l'assl'gn(l.zioue come si propone oggi è fatta diversamente da quella di ttllora o per uonseguenM e\•Ìhl. la maggior parte dei difetti allora esistenti. Inoltre non va dimeuLica.to che spetttt agli ufficiali anche il dare nn giusto indirizzo allo spirito di corpo e conciliare l'emula;r. i ono col rispetto recip r oco. De l resto, il metodo qui proposto fu già attuato, presso il •J.• reggiment.o, dal tenente generale %uccari che ne fu colonnello attorno al 1899, e vige ora il G0° reggimento di fanteria, dove se no sono tutti i vantaggi t>euza che l'littsi manifestttto al cun inconveniente.
Il fare praticamente la mescola n za delle reclute per distretto, anni di ferma, professioni o quahb't intellettuali, combinandola col raggruppamento scalare secondo la sta· ttna, non sn.rebbe facile e for:se possibile, senza il sussidio eli un metodo grafico oho l'endesse l'operazione puramente meccanwa.
Serve a ta l uopo u na ta b ella rassomigli ante ad una tavola pitagorica, nella quale le colonne verticali corrispondono alle varie stature, g r adatamente crescenti di centimetro in centimetro a partire dal minimo di metri 1 ,55, e le colonne orizzontali corrispondono alle dodici compagnie

del reggimento disposte in ordine numerico. Si otterranno così casellei i numeri, che saranLo segnati, indicheranno quanti individui aventi una dE-terminata statura sono assegnati ad una determinata compagnia.

Per compiere la preparazione della tabella converrà determinare quale sia la statura che divide in due parti numericamente eguali il contigente assegnato al reggimeuto (media. geometrica). La lltA.tura minima è eli metri 1,55, la mn:;sima sarebbe normalmente di 1,76, ma può ancbe essrre oltrepas,;ata, quando il ùa destinare ai granatieri risulti esuberante, ed anche per circostanze speciali .. Hiccome di ma:ssima sono assegnati alla fanteria di linea gli uomini di statura inferiore a metri l,G5, il termine medio sarà pii1 rav,·icinato nl limite minimo che a quello massimoi si snppongn che nel caso pratjco sia risultato appunto 1 ,65. Converrà allora, per avere n11a certa elasticità, fissare un gruppo tli statme prossime alla media, per •Jsempio tre, da serbare c·omuni a tutte le compngnie, poi tracciare t limiti tra cui de,·ono essere comprese le stature tli ogni siugola. compa.guia in tnono cha ad ognuna \'enga tL corrispondere 1111 numero eli se non uguale, almeno ('«JUi\'alente. in ragione della diversa densità colonne Yerticali. eYideuto che mantenendo le assognazioni, rignardo alla. l:ltat ura, entro i limi ti determi uati M n tale sistema grafico, si otterrà compaguie e nei hattaglioni una tne lia. di statnra scalarE>, iu modo che i pm alti del 1° battaglione risulteranno ancora un po' più alti dei pilt bassi ùel 3".
Yalga d'esempio pratico In seguente tabella, clente all'asst>gnazione di una clas-=e di reclute nel GO" teg· gimento di fanteria.
l l 1 l SULLA FANTERIA 1341
5 Il l ,
1
1
. j j
... 8 o 1 1 : 1 1 1 r-,'i: ': u c.> ::; ;;;: u"'=:< rJ t• 'tG ! u l nl s i ' l 61 t J t l t l t 1-1- 1 l l l l l l l l l l 53 tll ja,l ol 1l G "l sl t4J-I-153 ! l j l l l i .s1 'l 4[ sj 3/ H 31 tsl -148 l ,, l
o (/} o l l ta. 9 u l- l 4 . 3l 4 1- 1- l - l- -l l j : l t• a.rl 41 ul u l 41 31 21 41 J l t 1- 1-1,., l 5'1 l I O rt3 l b j tsj 3 l - 6 l t l t ; -l- - - l l _i l 1 31 u . tsl ; j s jn[ t l-! - l t l-l - .- 1 11 l l l l ul H[331 51 3 : 'l tol 2 tsl-1-l u l 58[ u; G[ si al uj tal uj-1-158 l 49 15,3$ 1 51 Ii i 3l t tll 'l !71- 1- '9 z 1::1 .... >
6' 1 l l l l 3 . 18 !2 l 4 l 8 l t t l ( l - l t l - l- l - l l l l l l 50j ol 41a 31 ul 41 t6j 1-1 so 7' 1 l l l l l t - 1-1-1- 1 l l l l H 3Sj 41 51 31 31 Uj 3 ti , -l - i 8' [ l l l l l l 3 l 43 l 9 l tt l 3 l 2 l l t l l l - l - l. - l l l 1iG _ 3 4 r.l 4: 2 ul a H> , •l-1 9'1 l l l l l l 3 t 3 i 9' H l 4 l t l ! l l l t 1-1- 1- . - l l l l 46i t ! 31[ ' sj 3 t[ tt ' t 61 - [46 s• wl l l l l l l l l «Tft l-7-] 9 ;131 1 1 t r- l t l - l - l l 1 t9[3sl !Il 6 1 51 il nl tJt91-l •154 w j l l l l ! l l 1 5 6: 61Ui i l513l t 3f t l t l t l -l 3[ 61 tol '/ toJ 3[ nl -1 - 153 l l l l l l l l l l l 'l 'i ' l 6l jstl_ 'l ti f- I- ' 51 l t 8 1 3t l j30 16l j 43149 , 66148 l 3 :; j j3o t6j 91 91 u l s j_9_1 4T:t 1 1loo t 1!9tluoj s!j59j57Jul wj47] t961 tj t 1 oo t

S T A T U RE Con l re nna DI S TR E TTI
T
...
···r·.......,r·"...
"
.... <:P .... t-:>
c 2 '" :::: "' ..,
!!? Ili l_' l l
_
.J _- J.l c "" . ... . ... . ., , . ...1... . ... . .... ... ....l .... ., ..
.... ... ....
r,.
. ., o • , , 12 ,
.
...
Oltre a questa. 0perazione preparato.::ia, il comandante del reggimento ne donà fare un'altra: trovare i numeri R,, di reclute con ferma di un anno e di due anni da assegnare a. compagnia. A. tal uopo egli richiede alle compagnie il numero ..J, di anziani cui spetterà il congedo dopo un anno e siccome ogni compagnia dovrà per· d ere ad ogni congedamento un ugual numero di uomini, i numeri R,, R, risulteranno dalla relazione:
R, +A,== C, n, == c. dove C, e c. sono costanti, fra le quali eone pure la relazione
o,-+- o, = o numero che eguale per tutte le compagnie.

Evidentemente, Ot è ugnalo al numero totale delle reclute diviso per 12; C, si ha dividendo per il numero di reclute e di anziani cui spetteril. il congedn.mento fra un anno; conoscendo C', e C, deducC'InO R, e R, Con ciò sarà stabilito quanti coscritti di uno data ferma dovrà dcevere ciascmlo. compagnia: e le cifre co1·rispondenti potranno subito scritte nelle colonne vet•ticali dei totali, nello stesso modo che nelle colonne orizzont-•tli dei totali potranno essere scritti i numeri degli individui, ascritti nd una determiforma e aventi una ònt.a. sla.tura.
Fatto questo lavoro preparatorio, prima ancora che ogni singolo drappello di reclute giunga al corpo, potrà esser fatta. l'assegnazione di <>sse allo compagnie, sulla base delle informazioni mandate dall'nilìoiale manda.to a. ricevede.
Distretto per distretto, le reclute verranno ripartite in dodici gruppi, con la sola avvertenza che per riguardo alla statura rimangano entro i limiti segnati dal grafico e che riguardo agli altri requisiti siano equa.mènte distribuite. Naturalmente con-çerrà cominciare la ripartizione dai nn· meri più piccoli perchè poi cogl'individui comuni, corrispondenti ai nnmeri più grossi, riescirà più facile colmare le differenze; bisognerà tener presente altresi obe gl'individui sui quali i comandanti di compagnia. potranno fare più probabile assegnamento per tra.rne i graduati e le cariche spe· ciali, potranno essere normalmente- comprelli tra. quelli con ferma più lunga A che qualora nella. forza delle compagnie • dovesse pur sempre rimanere qualche piccola differenza,
SOTE Sl'LI,.\ J.'.\l\TERIA 1343
sarebbe bene favorire le compagnie estreme, quelle c1oe dove trovansi i più alti e 1 più bassi, poichè appunto in qnesti sono più :4·equenti i casi di rif01'ma
Questo sistema rispetta tutte le prescrizioni del regolamento e nello stesso tempo conci)ia tutte le necessità cl1e occorre tener di mira, e nemmeno impedisce t:he, oltre ai criteri indicati come principali, si. tenga donto anche di criteri secondari e speciali, come que1li di non separare troppo gl'isolani, di usare particolari avvertenze circa i pregiudicati, di ravvicinare i congiunti e gli omonimi, e via dicendo.
Potrà accadete, anzi sarà il caso più frequente, che i l'UO· lini dei vari distretti non giungano abbastanza in tempo per fare il compuLo della medi"" geometrica delle come occorre per tracciare la tabella. Ma in questo caso potrà se1·viro la media negli anni precedenti.
Tutto ciò che si è detto s.in qui rignal:da la compagnia sul pieclo Ji petce; ma è chiaro che analoghe considerazioni valgono a11ehe per la uompagnia. sul piede di guerra e che perciò lo stesso lavoro che si fa per la forza alle armi rloVl'ebbe osser fatto ver lo. forza ia congedo, sui rnol.ini òi mo· bilitazione. I n quealio caso la giust,a riese:e anche più facile, perchè basta tener t onLo dei graclu!\.ti e delle carioh e speciali q nali effettivamente sono e ripal'tire il perS011ale fra le GOmpagnie in egual misura, avvertendo di rimànere entro i limiti di statura fissati per ciascuna.

.Per l'assegnazione clegli uomini di 2" categoria può invece bastare il criterio puro e semplice della statura,.
Non basta però la cura posta nell'assegnazione per ass.ila retta costituzione dei reparti: occorre anche altt·ettantA. cura nel conservarlo.
Se delle reclute sarà stata fatta bene, :;e duranbe l'anno le sottrazioni di uomini dal servizio ordinario, per fornire attendenti, rinforzi alle compagnie di sanità e di sussistenza, pìantoni ai comandi e simili, sah\. fatta con norme fisse e tenendo la massima che ciascun battaglione debba bastare a se stesso, non potranno accadere disparità da rendere necessarie intempestive pereqtHtzioni.
Vi possono bensì essere motivi di va.riazioni nella forza delle compagnie indipendenti dalla. volontà del comandante•
1344 NOTE SULLA. .FANTE.RIA.
d1 re,;gimento: ma nemmeno queste debbono indurre a fare spostamenti. Il solo t'atto che può rendere iu parte infruttuosi tutti gli :sforzi del comandante del reggimento e de' dipendenti è quello dei congedi anticipati; e questo ci spiega. il perchè que:sto provvedimento sia tanto roviuoso per la compagine dell'esercito, che si erli. fin pensato di vietarlo per legge.
A l ogni modo è necessario ehe tutto ciò che concerne assegnazione e mO\'Ìmenti di personale sia retto da crite1·i costanti, nello stabilire i qunli e nella fermezza di farli ossen·are, rimane implicata la responsabilità del co· mandante: respon:sabilitit che a torto si crede ùa tal uni che e!':sere delegata, in simili faccende, all'aiutante maggiore, 11 quale altro non è, e non deve essere, ehe 11 segretario clel·comaudante.
Può nascere il Jnbbio ehe a mettere in pratico. i m·iLori siano d'ostacolo ttt.lune prescrizioui del regola.TJleuto sull'avanzamento od anche necessiLà speciali di servizi•'· Ran\ pertanto utile esaminare attentamente &.nt·he q nel> t O lato della. q uestionc.
11 numero 19 del J•egolaml'llto d. ùtn,zione conforma il principio, già stabilito dnl regolamento di tliHcipliua, che il comandante del corpo non Ol'Llina. passaggi th u nicin.J i e graduati da un battaglione ad un altro o da nua compagnia ad un'altra che ecco:&ionalmento ed allora che ciò sia richiesto rere di xerrizio.

D'altra. parte i l * 31 d el regol a111entu sull' at·anza mento stabilisee che le promozioni a caporale ed a caporal maggio1·e siano fatte sul quadro del corpo i sic· eh è in certi casi taluni passaggi da. compagnia a compagnia. possono sembrare indipendenti dalla. volontà del co· mandante del reggimento (l).
( l ) Il regola111e11lO c eli nl n 19 proscriva:
« J passaggi di ufll('iali o grarluati da uno ud altro l'Optulo, cho il rego·
• lamento di disciplina. militnro consente in varo necessità di servizio,
c nuocciono sempre all'offi,.aco interessamento dei oomondanti por l'edu·
• cazione e l'istruzione doi loro repnr ti. Perciò sono da <;tuanto più
• Ili possa
• Il regolamento sull'at·an:amotto re!Jio escrrit:> prescrivo invece al
§ 31 :
• L'avanzamento ai gradi di truppa, eccetto quello di maresciallo,
• è regolato sulla base del ruolo di anzianità dei rispettivi graduati ed
c aspiranti caporali. a
Il § 48 stabilisoo: c La iscrizione dei militari di truppa, dichiarati me-
« ritevoli di promozionE', nei quadri d'avanzamento è fatta, per grado e
, NOTE St ' LLA F.ANT.I!RlA 1345
Non è possibile logicamente dubitare che fra i due regolamen!ii siasi voluto stabilire una contraddizione; e poichè questa. esisterebbe, se l'uno e l'altro dovessero essere interpretati alla lettera, si deve piuttosto ricercarne lo spirito ed a questo attenersi. Ora lo spirito del regolamento snll'avanzamento sta nel priucipio che 110n si ·commettano ingiustizie e non si creino malumori tt•a i gradnati eli uno stesso reggimento con brusche spereqnazioni; questo eluuque dovrà soprattutto essere tenuto eli mira nell'applicare le massime sancite dai regolamenti d'istruzione e di avanzamento. E il conciliare l'uno e l'altro non è impossibile, purchè si seguano ta.lune avve1·tenze.

Auzitutto, un mozzo di pareggiamento si ha nelle sottruztOni eli personale cl,o debbono di tanto in tanto essere fatte alle compa.gnie per mantenere a numero , gli maggiori di reggimento e di battaglione o par servizi t'nori del corpo; Lutti q nesti spostameuti, se fatti con criterio opportuno, concorrono a concedere al sistema nua corta. elasticiLà.
In secondo ll10go, converrà nou eccedere nella formazione dei quadri d'uvanzamento, preferendo di fare: quando occorra, quadri su ppletivi.
In terzo luogo, facendo lo promozioni non 1dla spicciolata, ma a gruppi, riesco più facile ri!òpettare, inineme col quadro d'avanzamento, la massima di lasciare cinscuno alla propria compagnia. Lo stol!SO regolamento cl'ammlni.Ytrazione, con lo stabilire (in M'monia col 13 del 1·egolamento .snll'lwanzamento) che lo promuzioni negli uomini di trnppa, la nomine ai diversi impieghi ed alle cariche speciali ed i passaggi da una ad altra compagnia avvengano normalmente alla fine d'ogni mese, ammette cbe nel .ripianaro l'organico vi sia un certo margine di tempo. Di più è snf-
« por ordine d'anz ianità. sonza d igtinzione della spocio.liLà. ùoll'impiogo o dolio. t'arica che coprono, o por i quo.li sono cle,.igno.t.i. Pot• lo promo" zioni ai gradi di caporalo .... lo. iscrizione nei quadri di nvo.nzament<>
« è fatta in base al punto di chlssi6cazioue, 1\Ssegnato dallo commissioni « di avanzamento, come ò dotto al § 46. »
E il § 46 dice;
• Por i militari dichiarati idonei al grado di caporale
c le commissioni assegnano un punto di classificazione, che deve servir& c di base per stabilro la loro anzianità relativa al nuovo grado •·
Il § 13 prescrive che le promo,ioni nei gradi di trllppa di massimo. si facciano ogni mose.
1346 NOTE SULLA FaNTERIA
ficiente che le tabelle graduali e nume1·iche di formazione siano, nei riguardi amministrath·i: rispettate nel loro com· ple;;so; e potrà così accadere che vi sia differenza d'organico tra compagnia e compagnia, cou minor danno di quello che apportano i passaggi da. compagnia a compagnia.
Potrà accadere, con questo sistema, che i graduati delle varie compagnie rimangano diversamente gravati dai vari servizi, in ragione della diversità del loro numero. A questo inconveniente, che avviene solo quando il servizio è dato per compagrua, è facile O\·viare ordinando il servizio per battaglione.

Può anche accadere che in certi distaccamenti di com· pagnia sia un organico der i va n te dalle particolarità <li servizio, per il q•1a.le ogni è creato. In questi casi, il numero dei graduai i ò vincolato a q nello delle sentinelle, oppure alla varietà dei com p i ti in caso d'allarme in certi forti di sbanamonto od altre analoghe necessità.
Quando ciò accade, ne deriYa. uno sbilancio di forza nel battaglione che fornisce il personale in più alla compagnia a danno dt•lle t\ltre compagnie; d11.nno tanto più grave, quanto maggiore il tempo pel quale dura. In questo caso le recidi rJI'ado previste dai regolamenti consentiranno tli utilmente di capor11li e di semplici so l dn.ti por le funzioni di caporal mn.ggiore e di caporale; veci di grado ohe sa.ra utile, per considerazioni disciplinari, fissnre COli ordine del giorno, sebbeno il codice penale militare (·10, 122-133) riconosc11. l'autorità del grado effettivo in chiunque sia stato comunque designato, anche tem pora.ncamen te, a · farne le >eci, come rileva. dall'espressione Mtpe1'Ì01'e in grado o nel comando. Questa el:ipressione nella sua. generalità. corrisponde perfettamente, del resto, al principio sancito dalla legge, cbe il grado è distinto dall'impiego.
Da. quanto precede appa r e dunque che, mediante la buona volontà e soprattutto con la fermezza nel resistere agli incitamenti che non mancheranno da varie parti affincbè sia no fatte eccezioni al principio fondamon tale che ogni compagnia prov'\"eda. a se stesHa, si potrà, il più delle volte, seguire la via. più innanzi tracciata e rispettare, almeno nello spirito, tutti i regolamenti, anche se nella lettera apparentemente non concordino.
, NOTE !:>OLLA l!'A::-."TERIA 1347
'
Il regolamento d'istruzione (ediz. 2\ 1907) dà per l' impiego clol tempo (orari e Teparti delle istruzioni) norme chiare e rispondenti t·dlo scopo di lasciare ad ognun o una. precisa sfera el i attività. Volere determinare in modo meno generico la parte che spetta ad ognuno sarebbe tupare la sana. iniziativa. e togliere a ciascuno la pos!':ibilità di adoperare nol miglior moùo i mezzi propri e quelli altrui. Al comandante del reggimento rimane però aneora.largo margine per l A. propria atLività nell'intero:sso <lel servizio

Fra. gli altri punti \'a particolartneute considerato i l modo di regolare il !)ervizio, secondo le norme stabi l i Le in propo,ito dal regolamento ài servizio interno (eù iz. 1909).
Il numero 76 di queobto regolamento dice: « Le maggio-
« rità <li reggimento, le maggioritò. di battaglione e gli uffici
« d i compagnia tengono i reg istri per i vari servizi cb e
c loro 11potLa di comancla1·o. Gli ufficiali e i graduati vi
« sono inscntti per grado e per anzianitt\; i soldati inveco
«nello ordino coll\e sulle tabelle ùi ripartizione dello
« compagnie.
c 'rutti i servizi sono di massima comandati cominciando « rlai primi isrrìtti :., secondo criteri che lo stesso regolamento specifica e che si riassumono tutti in (tnnllodell'eqnith.
La c;jtata prescrizioHo non sign ifica punto che, pe r esempio, l'niìieiale od ai viveri dabbtt essere comandato per lnrno di anzianitì1. reggimentale, senza riguardo ad altn' necessità; nulla impedisce cho nncho questo ed altri servizi siano ç.omandnti per battaglione, salvo rispettare l'eqttità. mantene ttdo i vo,ri battaglioni in coud iz io11i pari. L'interesse clell'istrnzione consigl i a anzi di seguire il cri terio di comandare d'ispezioue od ai vi veri gli ufficiali del battaglione che foruisce le guardie e gli altri servizi territoriali, lasciando disponibili per l'istruzione gli a.lt.,1:i ufftciali. In questo modo basta che la maggiorità di reggimento regoli il turuo fra i battaglioni; il comando eli batLag l ione poi regolerà i l turno fra gli nffioia.li dipen d enti nel modo meglio r i spondente alle necessità del serv i zio.
S'intende che per far ciò occorre che non vi siano squilibri di personale tra battaglione e battaglione, sì da produrre maggiore aggravio all'uno piuttosto che all'altro.
L'el asticità nel fissare i turni di servizio, cosi consentita da l rego l ament o d i servizio interno, non è per altr o con-
1348 NOTE SvLLA FAXTERJA
'
cessa nel fissare i turni dei . distaccamenti dal regolamento per il servizio territoriale, il quale stabilisce regole fisse e tassative i.n modo che il tt1rno rimane automaticamente determinato. Ora è chiaro che se questo provvedimento ha il pregio di assicurare la stretta osservanza dell'equità, considerata dal solo punto di vista degli inte r essi individuali, ha per contro il difetto di non corrispondere sempre ugualmente all'interesse del servizio, il quale richiederf'bbe che anche il turno di distaccamento fosse regolato in guisa da pareggiare i vantaggi e gl'inconvenienti d1e ai vari reparti possono derivare dall'esistenza dei distaccamenti medesimi. ·
IL E LA COli.PAONu. - « Il battaglione »1 dettaYa il prjgioniero ùi S. Elena, « deve bastare a sè stesso; « sarà dunque ordinato in 1nodo da poter provvedere al c proprio mant.enimento e combattere; S!lrà fornito di sarti,
c di cappe llai, di calzolai, di armaiuolì e di artificieri per «provvede re al vestiario e all'armamento; ùi macellai e di «fornai per apparecchiare i viveri; sarà fornito di cavale lerin, di ca.unoni, di cartuccia, d'ingegneri e eli attrezzi,
c di medici, di ambulanze e eli mezzi di tn.spol'to, per poter
« combatte re. Sarà l'orte eli 1050 uomini. eli cui 18 del lo
c stato maggiore, 12 cannonieri, J 2 esploratori a cavallo, 30
c soldati nel treno e !H.8 uomini di fanteria, divisi in sei
«compagnie, ognuna di li5S. Ogni compagnia avrà una se« zi one di granatieri e una di vo!Leggiatori.
« I 12 canno11ieri saranno agli ordini dell'aiutante cane noniere , del capo artificiere ((Jlwde arti(icie1· ) e del sotto
« capo arm aiuolo (sous-garde a1·mw·ie1·) e serviranno un
c pezzo da H li.bbre(l), attaccato a due cavalli e avente due
c da basto carico di ventiquattro .cartocci a palla o
c a. granata da 3 Fra i 30 soldati del t.reno, G saranno ma· « cellai, 24 condurrauuo 48 muli o cavalli da basto del bat« taglione (o GO asini) e saranno agli ordini dei furieri, 4
(l) Secondo il J.Camwle di met1·ologia di AYOELO 1\Lu!Tl:KI. l'equivalenza. di alcuni pesi e misure dell'epoca napoleonica era la soguonte: libbra 16 oncie = chilogrammi 0,489506 ; oncia = chilogrammi 0,30594 ; = metri 2,000000; piede = 12 pollici, = metri 0,333333; pollice = metri 0,027'778.

:NOTE SULLA FA)lTJ<lBIA
dells bestie da soma saranno cariche di bagngli degli uffìciali, 8 di cartuccia, G delle ambulanze e 30 dei viveri (1).
« Gli esploratori saranno tratti dai volteggiatori e mon1( tati su cavalli di 1 piedi e 5-G pollici (metri 1,48-1,61),
« cbe saranno bardati con la massima semplicità; saranno «armati di l ancia, sciabola moschetto e di due pi stole ed
.: equipaggiati come la fanteria, non n.vendo che gli speroni «in più e una piccola valigia im·ece dello zaino.
« ) G8 sottnffioiali, capol'nli e soldati di 111 e 2'' c lasse di «ogni compagnia (2) saranno esercitati in uno dei quindici
« mestieri JO carradore; 2 carpentiere-falegname; a· carpentiere-bottaio; 4 " carpentiere-calafato; 5° fabbro;
« 6° fabbro-chiodaro; 7° fabbro-armajolo ; 8 ' maniscalco;
c 9, fucinatore: 10" sellaio; 11 ' cordaio; muratore, H3 G
« sarto i 11• calzolaio; 15' artificiere; fra essi il comandante
«del battaglione, sn propot;ta de ll' aiutante Fti la-
« ''ori, sceglierà ogm anno un mastro in ciascuno di questi
« me:;tieri: questi mastri avrnnno un giorna-
« liaro in mgione del lavoro compiuto, da dai
c for1di c1e1Pamministrazione per del consiglio.
« 'l'tttti gli indivni dc•l bn.Ltngliono devono impiegaro la «giornata, a lt\vorare per l' llqttipaggia.mento, l'armamento,
«i viveri, gli ed in generalo per Lutti i bi -
c sogni dell'tunministrazione del battaglione il quale deve
«a. tutto provvedere per me-zzo ùei propri operai.
c T so!dati di l• ellwso hn.uno due soldi di soprassoldo,
c quelli di 2" classe un soldo. I soldati di l" e 2" clnsso
« samuno divisi in tre parti: 1" cannouied, zappaLori, pontieri. I primi sono specialmente esercitati nel servizio
«c'l'artiglieria; i secondi nei lavori c'li zapP,a., nei lavori di « fortificazione campale e nei còmpiti che spettano ai fLtuti
« nell'u.ttacco e nella difesa delle fortezze e dello posizioni;
«gli ultimi nella costt·uzione ùi ponti di barche, nel traino,
( l) Alcuna di queste ideo non sono origì.1ali òi Napoleone I. ma rimontnno nl maresciallo di Sassonia, il quulo nVtl\"11 nnche proposto C'ho ogni reoturin {184 u01uini) fosse munita di un'amusette ùi sua invon7.iona. specie di g rosso sohioppo o di p iccolo cannone lanciante palio dì mezza libbra ( liie« r€verics, 20). Anrho il principe di Ligno proponeva uno strano model lo consistente in un doppio wosso schioppo con baionetta, in cavalcato su di un affusto ad una sola ruota, ma con larga coda, capace di mantenere in equilibrio il sist ema (Fm'ntaisifs militaire1, 39).
(2) r so lda t i eruno divisi in tre cla ssi.

1350 NOTil: SULt.A FANTERIA
c nella manovra delle barche e nel nuoto: a questo scopo
c sannno provvisti di una cintura di cuoio divisa in otto .
« Ogni anno i due soldati cannonieri più intelligenti di (( ciascuna compagnia saranno riuniti per un mese in una
c scuola d'artiglieria, i due zappatori più intelligenti in una
c e i due migliori p ontieri su un gran fiume e vi
« saranno più specialmente istruiti ed esercitati da ufficiali
« di artiglieria, del genio e della marina » (1 )

Va tenuto presente che qui è considerato il battaglione
s ul piede di guerxa; per avere idea di quello che avrebbe po·
t uto essere sul piede di pace, occorre riferirsi ad altri scritti
n apoleonici, secondo i quali la forza di pace avrebbe doYnto essere la metà di quella di guerra.
Se a tutto ciò si aggiunge che in altra occasione Napo· leone scritto: <È necessario che l'amministrazione • n ei reggimenti resti separata per battaglione» ( Oo1·1· . mil., 1005), l>i avrà un'idea esatta di ciò che fossero, nella sua ment e, il hatt11glione e la compagnia E ciò è interessante, perch è il pensiero napoleonico, nelle linee generali e mutanrlo solo qualche particolare. ancora oggi può servire di guirla e perchè in esso si trova trMcia di vtnie istituzioni che ora sono scomparse dall'esercito francese, ma sopravvi"Vono in altri eserciti .
.:\f o lti provvedimenti suggerit i allora noll sarebbero, evidentemeut.e, più necessari oggidì, sia per la esistenza di taln ne specialità, sia perchè con le armi odierne gli artificie ri e gli armaiuoli sarebbero inutili, gli esploratori a cava llo potrebbero essere sostituiti da esploratori ciclisti e l'a rtiglieria reggimenta.]e sarebLe un anacronismo; ma sta eli fatto che il criterio napoleonico ha presieduto all'ordina· mento del servizio delle munizioni e di quello sanitario ed in parte anche a quello degli zappatori. Torna anzi oppor· t uno qui il ricordare che nel progetto Ricotti del1896 per il riordinamento dell'esercito italiano era prevista Ja costit uzione di speciali plotoni di porta-feriti, di zappatori e di c iclisti all'infuori dell'organico delle compagnie: plotoni in numero di uno per reggimento di fanteria in tempo di pace, ma destinati a diventare uno per battaglione sul piede di guerra.
, NOTE SULLA .FANTERIA 1351
(l) Oorr. mi l de Napoléon l, X, 320, 321.
Quanto al numero delle compagnie che cost i tuiscono un battaglione, il sistema pi'ù generalmente usato oggi in Europa è quello del battaglione di 4 compagnie: in alcuni eserciti però il battaglione ha normalmPnte 8 compagnie (esercito britannico): in altri vi sono battaglioni di G com. pagnie (battaglioni chassew ·s des Alpes) ecl in altri soltanto di i-1 (esercito portoghese). Anche in It•dia, de1 resto, alcuni battaglioni alpini e. tli recente, tutti i batt.aglioni bersaglieri httnno solo n compagnie. Il battaglione di 4 compagnie, della forza complessiva di 1000 uomini in gnona, è q nello che, ment ro consente di comandato in campagna, permette che la compagnia abbia ancora lntl piede di pace una sufficiente forza e risponda alla massimn eeonomia di quatlri.
Uirca la fon•..a clelia compagnia sul piede di guerra, non manMno scrit .tori, i t!na.li reputano cho la cifra di 200 uomini sia esagerata; anzi alcnni vorrebbero che fosse ridotta a meno della metà. Si può rispondere che tal cosa sarebbe util•' 'in due oasi: se potesse mantenere invariato il totale clegli nomiui, aumentando il numero delle compagnia o in pro i>OJ'l'lione doli n. forza. minore eli oppuro se :si potesse fare degli uomini una !!celLa tale, che i meno buoui e i meno animosi rimatlf':,;'!cro a casa. Il primo prov\'edi· mento urta contro ragioni di finanza pen·hè importn mnggiot·e spesa di il secondo contro ragioni di possihilitìt, perchè la selel'.ione dci pii1 e òei me110 animosi non può es :-<1'1'1' fatta che dumnte il combattimento. Idea analoga e!.-òprimeva. il 1\fachia.Yelli di<'ondo che eli :ZO giovani di bella prN;enl'.a che si c ogni uomo confesserà, come
«ci sia minor Gl'l'Ore torli tuLti per armndi ed esercitarli,
<< non potendo aa.pere quale di loro ·sia migliore, e riserbarsi
« a far poi più cedo deletto, quando nel praticarli coll'eser-
c cil'.ÌO si conoscessero quelli di più spirito e di più vita • (l ).
Oirca. la. forza della compagn.ia sul piede di pace, uella rehtl'.ioae dell'ufficio centrale del senato circa il progetLo di legge sul riordinamento dell'esercito presentato dal Ricotti
nel 1896, si legge: « La solidità. e la compattezza delle

c truppe provengono in gran parte dalla conoscenza, dal·
c l'affiatamento e dalla reciproca fiducia dei capi con ì loro
1352 NOTE SULLA
( l) )fACHL\VEf,LI - Opere (Libro r, dell arti' dr/la !J!ICrra), 352.
« suba.lterni e df'lgli uomini di truppa fra di loro . Una volta
c tale coesione si otteneva colle lunghe ferme: ora che queste
« non sono più possibili : non vi e altro modo di oonsegui rl e
c che con gli organici gro::;si in .tempo di pace ...
«Con una grossa compagnia... il capitano, istruendola,
c educandola sempre da sè, ne assume tutta la responsa-
« bilità, sapendo pu1·e che dai risultati dell'istruzione sarà
« giudicatb; entrano quindi in gio co i motivi C\he fanno
c agire gli uomini, il s e ntimenw del dovere, l'amor proprio,
c l'emulazione. Inoltre àvendo mezzo, con i grossi orga -
c nici, di dare agli ufficiali la responsabilità reale de1l'istrn« zione e della educazione del loro 1·iparto, si accresce in «loro lo spirito d'intrapre s a e s'iustilla l ' abito ad affron« t.arne la responsabilità».
La stessa relazione ricorda che le compagnie bavaresi avevano un organico di pace inferiore alle prussiane e trova un nesso tra questo fatto ed il contegno non sufficientemente energico delle truppe bavaresi a. \Vorth ed a Coulmiers, in paragone di quello tenuto iù tutti i combattimenti dalle truppe prussiane.
Inoltre a provare quale sia la differenza. di avere a combattere truppe piit o meno solide, dta i seguenti fatti:
« lJ'esercito tedesco, nelle prime ciuque settimane della
c cam p<tgnu del ebhe sul teat r o della guerra nn a
« considerevole supe,·ioritià numerica sull'esercito imperia le
c francese, eppure perJette in <}Ue] periodo di tempo circa

·c 80.000 uomini . In tutto il rimanente della durata della
« guena 1 ('irca ci n q ne mesi ), in cui si trovò pre a lot-
« tare con notevole inferiorità di numero contro le armate
« improHisa.te della repubblica, non ebbe in tutto che
« 50.000 uomini circa fuori di combattimento » .
«Il generale Werder, uel ge-nnaio 1871 1 resistette per tre
« giomi sulla Lisaine all'urto di forze immensamente su-
« periori alle proprie e perdette in tutto 1800 uomini, non
« più di quello che un solo reggimento prussiauo, i l fan-
« teria, aveva perduto in ttn'ora di tempo alla battaglia de l
« 16' agosto 1870.
c Cosi pure le perdite dell'armata del principe Federico
« Carlo a Le .Mans non furono che di 3600 uomini, cioè la
c metà di quelle che il solo m corpo aveva s ubito a lla
« battaglia di Mars-la Tour
1!6- ANNO L\11
NOTE SULIJA F.ANTERJA 1353
Queste considerazioni storiche peccano evideutemente ùi semplicismo. L'andamènto di una battaglia e le perdite dei combattenti dipendono da tante circostanze complesse, che rarame11 te si può con certezza dire se vi sia stata una causa decisi va e quale sia stata. C+li avvenimenti del 1870-71 ci dicono soltanto che truppe solide come le tedesche possono vincere truppe improvvisate come quelle della repubbli<!a del 4 settembre, anche se inferiori di uumero, ma non dieono nulla di piì.t, nè ci danno un indice di proporziono ehe st possa applicare ad altri oasi. Ciò non toglie che le idee contenute nella relazione abbiano importanza indipen· dentement.e dalla più o meno stretta relazione di rd effetti che possano aver fra loro i fatti storici citati. È strano peraltro che trattando dolla. coesione nei rcpu·Li mobili&ati, la suddllltn relazione laccia dell'influenza cl1e su di essa esercita il fatto clte quelli cho hauJJO HN'VÌLo in te.mpo di pace in nu reggimento, toruino a servire nello stesso reggimento anzi nella compagnia, in tempo di guerm. Qursirt <.:Ondizione ha ancora maggiore importanza clollA. forza <le.lla compagnia in tempo di pace o il lrascurarlu costituisce forse l'inconveniente grave dell'appmeccltio m i li tare ital inno.

Non pnò perc1.ltro nege.ro cho con l'adozione della ferma biennale la forza delle compn.gnie nf>i reggimenti di fanloria non rinfonmii sia riilttllnLa, almeno noi primi anni clell'npplicazione delln legge, troppo scarsa. Inconveniente gravi$simo ò l'avé1' riservato ai riveùibili il privilegio d i rimanere nlle armi uu anno solo, pol\'hè in tal modo circa un terzo del contingente assegna,to alla. fanteria, invece di 22 o 23 mPsi, preRta servizio appcna 10 od 11, o la ferma biennale unica soltanto, in pratica, u.Jlo stato eli dosid<'rlo. Ridotta a così minimi termini la classe ttnziana, ne deriva ehe dopo il congedamonto non v'ò più soldato anziano che non abbia almeno una carica speciale, siccb.è ]n, nozione <lel .se·rnpUc1' Roldato ùi fanteria si perde fìno al momento in eui non termina l'ist.rutione della nuova lent: ed anche nIl ora le isliruzioni speciali distraggono troppa gente dalle istruzioni generali.
Qualunque sia in ogni lllo-1o la forza di pace dolla compagnia, disponibile per il servizio e per le istruzioni, è opportnuo ricordare che il dire che soltanto le grosse com-
SULLA FANTERTA
pagnie dànno solidità e compattezza è affermazione troppo assoluta, al pari di quella che la responsabilità del comandante di compagnia si perda col diminuire dell a forza. Da che cosa invece dipenda, soprattutto, il rispett o del prin- ) cipio della responsabilità si è visto trattando dell'assegnC z ione e dei movimenti del e si può riassumer e dicendo che in fatto di sbalzi numerici della forza inte· ressa for;;e meno aver presenti gli uomini per un tempo maggiore o minore, che il poter fare per dato tempo assegnamento sicuro sop r a la massima parte del personale.
Il comandante di compagnia può in questo caso preparare i graduati, designare le cariche speciali, tenere uomini di riserva per colmare le lacune impreviste, può in una parola, prevedere le necessità future e tenersi in misura da provvedervi . .All'ufficiale poi che si lagna di aver disponibili per l'istruzione soltanto una diecina di uomini, si pot.rà sempre rispondere domandandogli se egli sia ben certo che ciascuno di quei dieci uomini non abbia più individualmente nnlla da imparare e iu molLi casi gli s) farà . toccar con mano quanto lavoro, anche per quei dieci uomiui, gli resti ancora da fare e cou1e, per certe co>Je, siano preferibili i riparti piccoli ai riparti grossi. 8i può anzi affermare cun sicurezza. che coloro, i quali oggi cercano di lA. loro pigrizia con la pochezza della. forza1 si lagnerebbero ugualmente Ùl..lmani, se avessero costantemente la compagnia :m un piecle p1·ossimo a quello di e con maggior fondamento di ragione, perchè, per l'istr uzione della truppa., la troppa forza finisce per essel'e d'ingombro ; e per l'istruzione degli ufficiali è sufficiente che la forza sia massima solo pel' breve tempo, il che si ottiene con richiami dal congedo dul'ante le manovre où anche nel modo eccezionalme nte previsto da l rego l amento, po· nenclo insieme diversi reparti per formarne uno solo di forza maggiore. In quest'ultimo caso non bisogna dimenticare che le unità organiche vanno sempr e rispettate anc h e nella fusione loro per formare un'unità di manovra; p. es., se di due battaglioni si formerà. uno solo, converrà che le compagnie due a due per formarne una e che in og ni compagnia provvisoria gli elementi delle compagnie originarie rimangano distinti fra loro e soggetti ai propri ufficiali e graduati .

::.IO'.rE SULL.!. FANTERIA 1355
NOTE SULLA FANTERIA
Questi provvedimenti mirano appunto a lasciar integra ai comandanti di battaglioue e di compagnia la responsabilità che loro spetta, giusta le prescrizioni dei capi IX e XIX del di disciplina,
« Il comandante di battaglione risponde al comandante
« del corpo clell'istruzione, della disciplina e dell'ammini-
c straziono delle truppe ohe comantla. come pure della loro
« condotta e del loro contegno in genere. Hoprnintendeudo
« all'istruzione delle compagnie per quanto è necessn.rio ad
« !lssicurarsi che il proprio hattaglioue riesea perfettamente
c istruito in ogni del servizio, lascia ai comandanti
« di compagnia suoi dipendenti la ll.('Cessarit'L libertà di ((azione per concerne e l'amministrare le
« proprie compagnie ed invigila perchè si attengano co-
« stttntemenLe allo spirito dei regolamentt ed agli ordini
« superiori. Hispond o d' ogni particolare istrnzione che il c comandante eli corpo c redesse bf·no affidargli • (1).
ln questo parole llel regolamento, n.ssai meglio oh<' dove tratta dei doveri del comt\lHlaute eli brigata, è spiogn,to il modo di flel superiore verRo l'inferiore, evitando sia le iutromissioni fuori eli lampo, n,nche se fatte a fìn di bene, sia le frequenti riobioste fatte ùnll'inferioro su g m1.nto devf' fare, tutte cose nocive e come tali proclamalt' dd regolamento. Soltanto la parola è forse su· por/lua, perchè potrebbe essere ronle interproLata e perchè l'opPra dei comandn.nti di bnttaglionn e di compagnia si può svolgere benissimo in modo distinto, :>eu7.a imlebite ingerenze, soltant.o CJ naado l'li tengR. conto di Ull elemento importantissimo: il tempo. Facendo le cose a tempo debito, con la do-.uta successione, ginrlicanclo l'opera dei dipendenti <lai. ri.Sllltati, le rispetti ve attribuziOlli si districano naturalmente e si osserva ]a prescrizione de l 1·eg.· d'ist1·uz. e serv. int. (n. 4):

La gradazione gerarchica dev'essere rispettata nell'istru« zione come in tutte le altre funzioni dell' ordine milic tnre •·
Nella stessa assegnazione delle reclute, dove può a. prima vista sembrare che vi sia, per parte del comandante di
(l) Il nuovo regolamento di amministrnziono e di contabilità doi corpi assogna al battaglione importanti compiti. Sarebbe immt\ turo parltJ.rne prima di un periodo d i esperimento.
1356
r eggimento, il salto del gradino gerarchico co r rispondente al comando del battaglione, ciò in realtà non è, perchè il principio che ogni compagnia possa fare da se implica particolarmente e prima di ogni altra cosa. Ja responsabilità del comandante eli compagnia e perciò occorre che a lui siano assegnati direttamente dal comanùante di regg i mento i mezzi opportuni. La responsabilità del comandante del battaglione verrà dopo, sia per invigilare che ogni comandante di compagnia faccia il proprio dovere, sia nel pro-çveJere che a sua volta il battaglione viva di 'rita. propria, senza nulla dover richiedero agli altri battaglioni.

La libertà d'azione in ogni grado non >a per altro int esa come libe1·tù eli far male, ma soltanto come lilwrttÌ di fa r be n e, salvo prediligero un metodo piuttosto che un altro . Inte r pretata cosi, la parola cox-fantemente usata da.l regolamentu è razionale e l'opera del superiore cosi intesa non può mai intralciare l 'opera dell'inferiore.
N on bisogna peraltro dimenticare che a coadiuvare il <:apitano sono destinati i subalterni e i graduati clelia compag n ia e che il cnpi t ano ùeve \'a.lersene secondo l' attitutline di ognuno. riguardi a grado où anzianità .
Dei dow'ri tli uguuno dice abbastanza i l 1·egolamento : il i tiOl tumc i oli c i caporali eli squadra e di cont n bi l itù. tanto meglio ri:.>po11derauno a quanto richiede il s u perio r e, quanto maggiore snrà l'autorità che ad essi Harà datn. di acquistare dimostra.ndo di goder piena la fiducia ùel capitano.
Agli ufficiali subnlterni va fatta. una particolare raccomandazione: da essi molto dipende il huon andamento di un corpo, perchè essi rappre:sentano le gio>ani energie che sono l a speranza an·enire e in essi deve esse1·e accolto quel fuoco sacro, deve vibrare tutta. quella poesia della vita milita re, che fa dell'ufficiale un apostolo e non un mestier ante.
P articolarmente debhono i suùalterni anziani dare i l buon e invigilare i p1·imi passi dei giovani sottoteneuti , cui un cattivo indirizzo dato all'inizio della carr iera può riuscire fatale. Le osservazioni amorevoli de i compagni valgono tah·olta assai più che gli ammonimenti e i castighi dei superiori: l'intervento opportuno del col-
NOTE SULLA l'ANTRRlA 135 7
1358 SULLA FANTERIA
lega anziano può spesso evitare inconvenienti e dispiaceri g1·avi.
E la stessa avvertenza vale anche, in àobita proporzione, per i sottuffi.ciali.

Quanto ai doveri del comandante di compagnia, tutte le prescrizioni dei varii regolamenti ne fanno il principale educatore ed istruttore della tn1ppa: funzione importante e delicata quant'altra mai e che richiede « lungo studio o lungo amore ».
Viterbo, 1()11.
ALBERTO CA\ AOIOCCHI colo•mdlo (OIIItlltdant t Il GO• l'r!J!Iim.-nlo (ankrin
•