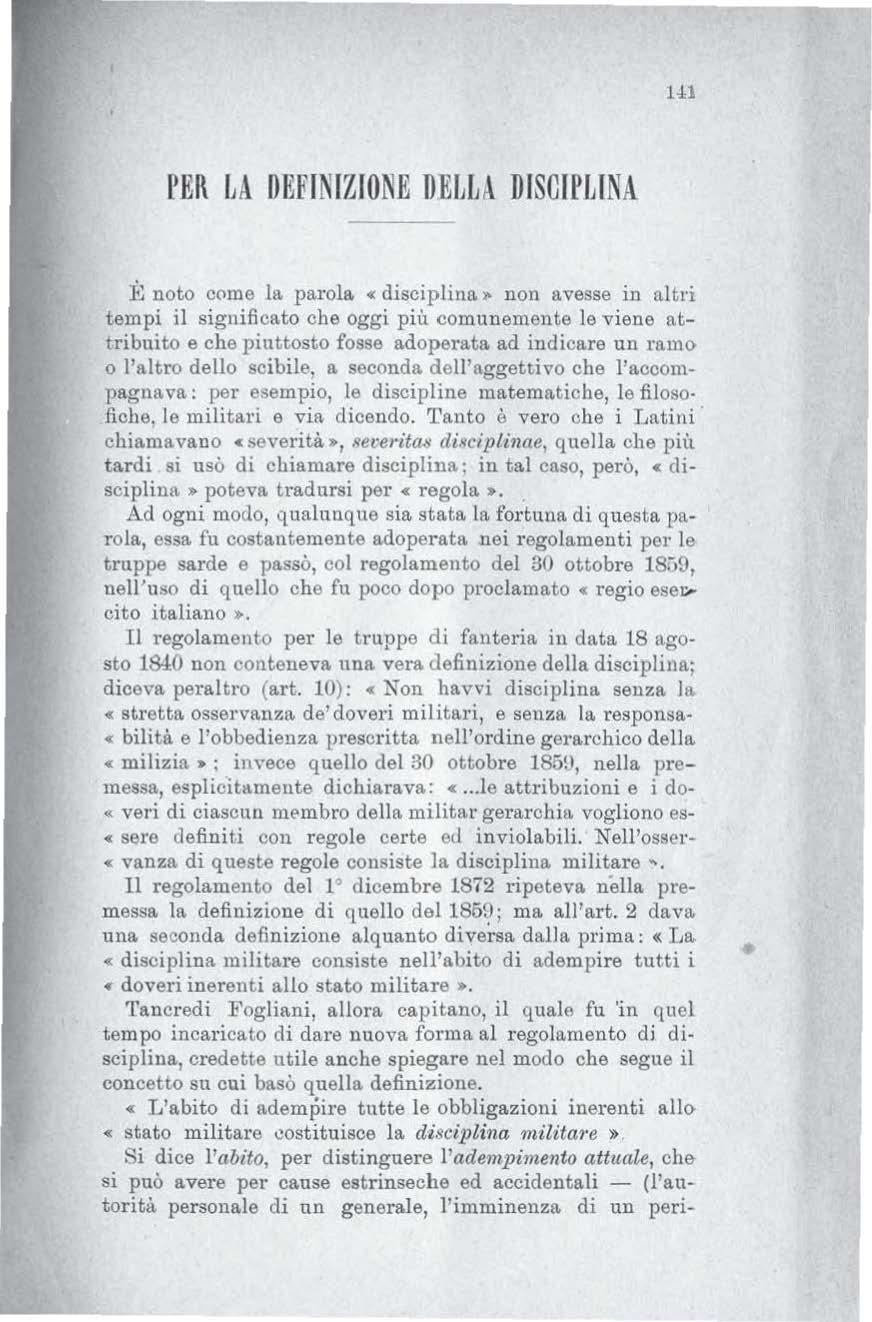
3 minute read
PEI\ LA DE FINIZIO NE DEJJLA DISCIPIJINA
È noto cClme la parola. «disciplina"' non avesse in altri tempi il significato che oggi più comunemente le viene attribuito e che piuttosto fosse adoperata. ad indicare un ramo o l'altro dello sc ibile, a seconda. dell'aggettivo che l'accompagnava: per esempio, le discipline ma.tematiche, le filoso· fiche, le militari e via dicendo. Tanto è vero che i Tjatini chiama vano c l'iCverità •, q nella che più tardi si usò di chiamare disciplina; in ta l caso, però, c disciplina • poteva tradursi per c regola. •·
Ad ogni modo, 4ualnnqne sia stata la fortuua di questa parola., essa fu costantemente adoperata nei regolamenti per le truppe sarde e passò, col regolamento del 30 ottobre 18:>U, nell'uso di quello che fn poco dopo proclamato c regio eHet;cito italiano •· ti t·egolamento pe1· le truppe di fanteria in data 18 ngosto 1840 non conteneva nna vera. definizione della disciplina; diceva peraltro ( art. 10) : c Non bavvi disciplina senza la c stretta osservanza de' doveri militari, e senza la respon::;a- c bilità. e l'obbellienza prescritta nell'ordine gerarchico della c milizia • : Ìln-ece quello del 30 ottobre 18:>!1, nella premessa, dichia.ra.va.: c .. .le attribuzioni e i do-
Advertisement
« veri di ciascnn membro della militar gerarchiA. vogliono es- c sere definiti con regole certe ed inviolabili. Nell'osser-
« vanza di queste regole consiste la disciplina militare "'·
Il regolamento del l dicembre 1872 ripeteva. nella premessa la. definizione di quello del185D; ma all'art. 2 davlt una seronda definizione alquanto diversa dalla prima:« La c disciplina militare consiste nell'abito di adempire tutti i c doveri inerenti allo stato militare •.
T ancredi l!"'ogliani, allora capitano, il quale fu 'in quel tempo incaricato di dare nuova forma al regolamento di disciplina, credette utile anche spiegare nel modo che segue il concetto su cui basò quella. definizione.
« L'abito di adempire tutte le obbligazioni inerenti allo c stato militare la di.çciplina milita1·e »
Si dice l'abito, per distinguere l'adernphnento attuale, che si può avere per cause estrinseche ed accidentali - (l'autorità personale di un generale, l'imminenza di un peri- colo ecc.)- dall'adempimento abituale, che si fa per l'apprendimento acquistato col lungo uso di adempire questi doveri, e nel quale propriamente consiste la disciplina, come suona la voce, che significa im;egnarnento e metonimiapprendimento, .w:ienza, arte. Or come l'i m parare intellettivo di una. cognizione speculati\"a. non consiste nelr.werla inte,a unn. volta, ma s'tnell'averltt. appresa in moclo do. ritrovarcela sempre presente alla mente quando ci fa di bisogno; così l'imparare un dovc•re non consiste nel comprenderlo intellet.tivamente, ma sì nell'f'lsegnirlo praticamente; e questa esecltzione •leve constare ùi una serie di atti, devo ciot'· eHsere un abito. E dicesi abito, non abilttdin('; perch•\ ahifo è h\ ripetizione di quest'atti primitivamente ri tlesst\ e meditata, perciò meritoria, perciò virtù: l'abitudine t> la ripetizione materiale, inconscia di Hè medesima • (J ). Pur tenendo conto tli 'lueste considerazioni, può riil dubbio sull'oppot·tnniltl di avere introdotto, nel lJledesimo testo: dne definizioni dello. me(lesima. cosa 6 predi quella principalissima do. cui s'intitola il libro; ma in fonrlo si può convenire che le tlne definizioni non erauo contraù<littorie, nHI. equivalenti, con la sola differemr,A. che l'una era oggt)ttiva, l'altra soggettiva, riguardauio la prima la !lisciplinn. in sè stessa, e la :;econda. ln'\Ct-e il soggetto cui dovevasi applicar€'. E si può senz'altro conchiudere che delle due dcfinizioui era certamente migliore prima, appunto perchè uggettiYa, e quindi invariabile (2): avvertendo che il difetto rilevato dal Fogliani e consistente nel riferirsi l'o:;servanza delle regole dello stato militare all'(ldempimento attuale, piut.to,;t.o che a quello abituale, poteYa facilmente esser tolto coll'aggiungere al sostantivo c os;;ervanza • l'aggettivo c costante » TJa disciplina sarebbe stata così definita. c l'osservanza costante delle regole sullò stato « militare », oppure a11che e meglio <t l'adempimento co• c stante e volonteroso dei doveri propri del militare •. ultima. edizione (1H07) ùel regolamento di disciplina è ripetuta, a pagina 1, la definizione oggettiva contenuta ne lprecedente; ma a pagina 7 essa dh-enta c l'abitudine
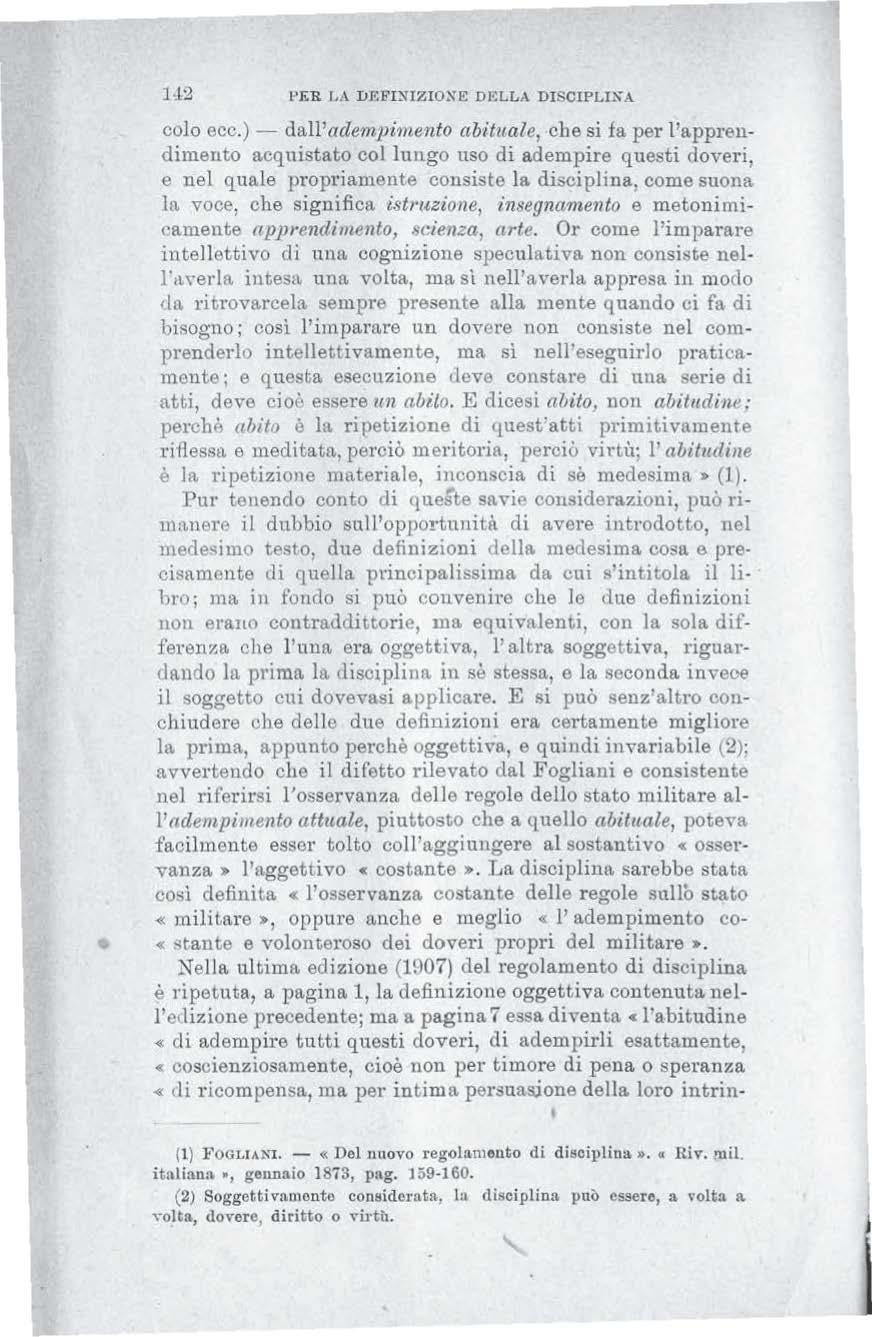
« di adempire tutti questi doveri, di adempirli esattamente. c coscienziosamente, cioè non per timore di pena o speranza -« dì ma per intima persuasione della. loro intrin -
( l ) - nu ovo regolamen to di disciplina». " Riv. mil. italiana •, gennaio 1873, png. 159-160.
(2) Soggettivamente considerata, lu disc ipl ina può essere, a çolta a Yolta, dovere, diritto o •il'tìJ.
-« seca. necessità » . Ora, per quanto il signi.D.cato possa essere attenuato dalla spiegazione"che segue la parola sta di fatto che questa parola è stata. sostitÙita a quella di abito, jnnegabilmente assai più opportuna pe r i motivi addotti dallo stesso autore di questa specie di definizione.
A pagina l si trova pure scritto : .- La d isciplina s'infonde «in tempo di pace, e si mantiene salda in tempo di guerra, «mercè il diligente, costante abito di osservarne i precetti». Si sostituisca qui, alla parola « disciplina », la definizione datane a pag. 7, e si veda che razza. di discorso ne salta fuori. E ciò prova due cose: che non è propria la definizione, e che l'ultimo periodo citato voleva forse dire un'altra cosa: «Che « la disciplina occorre sia salda sopratutto in guerra e che per raggiungere questo fine è ne cessario sia infusa con l'esercizio del tempo di pace».
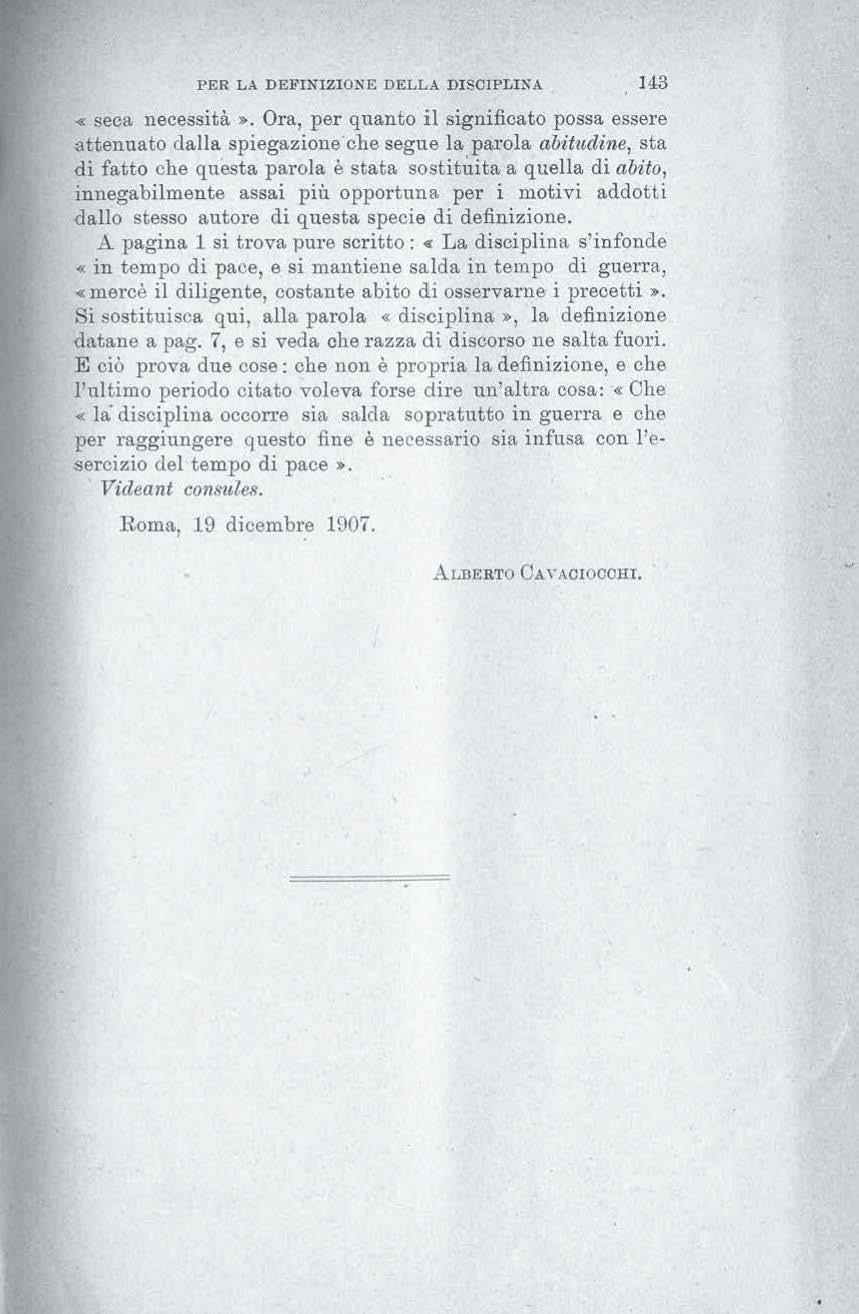
Videant con.·mles.
Roma1 19 dicembre 1D07.










