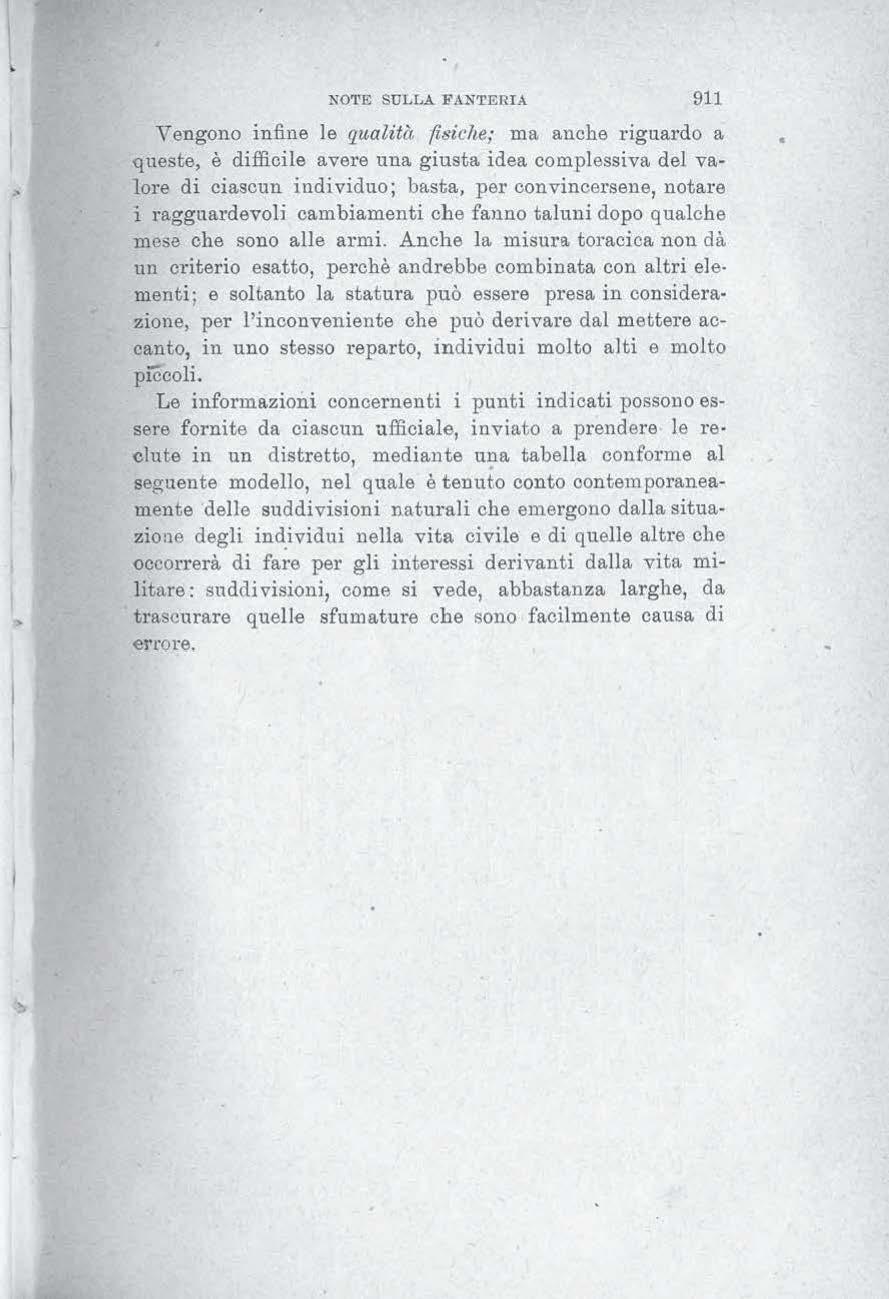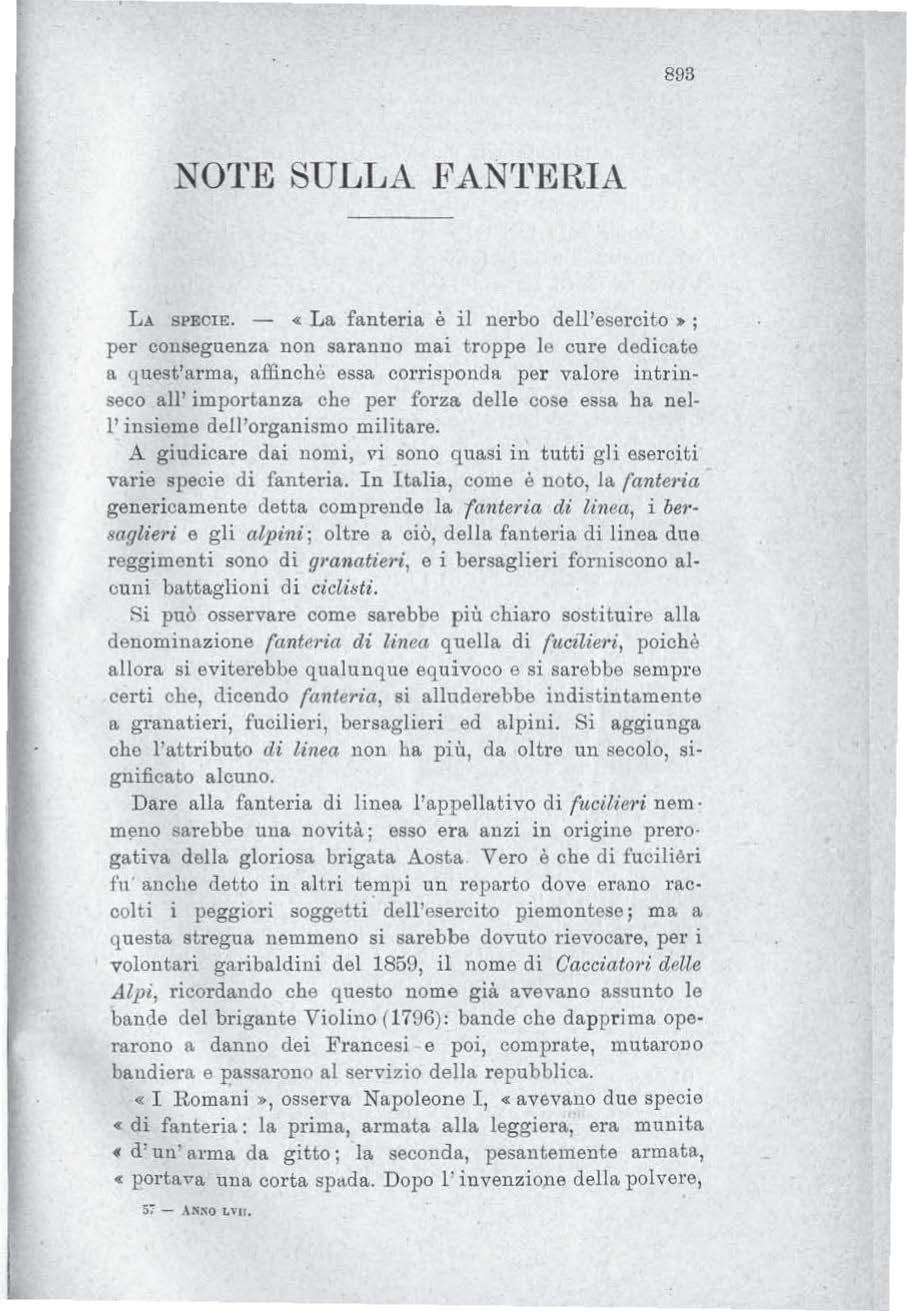
29 minute read
NOTE SULLA FAN1'ERIA.
LA SPECIE. - c La. fanteria. è il nerbo dell'esercito • ; per conseguenza non saranno mai troppe lo cure dedicate a. cl uest'arma, a.ffinchò essa corrisponda. per valore intrinseco all'importanza. che per forza delle cose essa ha. nell' insieme dell'organismo militare.
A giudicare dai nomi, vi sono quasi in tutti gli eserciti varie specie di fanteria. In Italia, come è noto, la fanteria genericamente eletta comprende la fa:nteria di i be,·xaglieri e gli alpini; oltre a ciò, della fanteria di linea. due reggimenti sono di graMtieri, e i bersaglieri forniscono alcuni bn.tta.glioui eli
Advertisement
Ri può osservare come sarebbe più chiaro sostituire alla denominazione (untl'ria di li m•" q nella di fucilieri, poichò allora si eviterebbe qualunque equivoco c si sarebbe sempre certi che, dicendo fanteria, si a.llndorebbe indistintamente a. gl'anatieri, fucilieri, bersaglieri ed 11.lpini. Si aggiunga. cho l'attributo di linea non ha. più, da oltre un Recolo, significato alcuno.
Dare alla fanteria di linea. l'appellativo di fucilil'l'Ì nem · sarebbe nna novità; esso era anzi in origine prero· gativa della gloriosa brigata Aosta Vero è che eli fuciliéri fn a.ncl1e detto in altri tempi un reparto dove erA.no raccolti i peggiori soggetti dell'esercito piemontese; ma a questa sLregua nemmeno si sarebbe dovuto rievocare, per i volontari garibaldini del 1859, il nome di Cacciatm·i di'l/e Alpl, ricordando che questo nome già avevano assunto le bande del brigante Violino (1796): bande che dapp r ima operarono a. danno dei Francesi e poi, comprate, mutarono bandiera e al servizio della repubblica.
« I Romani » 1 osserva Napoleone I, «avevano due specie c di fanteria: la. prima, armata. alla. leggiera, era munita • a· nu' 8.l'ID8. da gitto j la. seconda, pesantemente armata, c portava una corta spu.da. Dopo l'invenzione della polvere , s;- L'''·
« si conservarono ancora. due specie di fanteria: gli archi- c bugieri, che erano armati alla. leggiera e destinati ad espio- c rare e a molestare il nemico i i picchi eri, che tenevano c: luogo dei pesantemente a1·mati. Dopo centocinquant'anni c: dacchè Vauban fece sparire da tutti gli eserciti d'Europa
« le l ancie· e le picche, sostituendo a queste il fucile con
« baionetta, tutta. la fanlìeria fu armata alla leggiera e de-
« stinata tanto ad esplorare, quanto a cont.enere il nemico;
« non ci fu più, così, che una sola specie di fanteria; e se
« si ebbe per ogni battaglione una compagnia di cacciatori,
«ciò fu per far simmetda cnn la. compagnia granatieri e
« perchè in un batt11.gliono di nove compagnie una sola
«compagnia scelta (cl' élite ) non sembrava. sufficiente ( l). Se c: 1' imperatore Napoleo11e creò compagnie di volteggia tori
-c armate con fucili da dragone, ciò fece unicamente per
« sostituirle alle compagnie di cacciatori e l o compose d1

« uomini alti meno t1i 5 piedi (mef..ri 1,G7) per sfruttare i
« coscritti di sLa.tura variabile da quattro piedi e dieci po l-
« lici a cinque piedi (l ,Gl· l ,G7) i quali fino allora erano
« sta t i esenti ... ; e fu un modo efficace d i sUmolare l '.omu-
« !azione quello di mettere a confronto i pigmei e i gi-
« ga.nti. Se ci fossero stn.ti nel suo esercito uomini di di-
« verso colore, egli a.vrebbo composto compagnie di neri e
« d i bia.nclll ; per lo stesso moti vo: i n un paese in cui ci
«fossero dei cic l opi e dei gobbi, si trarrebbe
« buon partito da compagnie composte di cic l op i e da altre
«composte di gobbi. ·
« Nel 1789, l'esercito francese comprendeva reggimenti
« di linea. e battaglioni cacciatori: i cacciatori delle Ce-
« venne, del Vi vara.is, delle Alpi, della Corsica, doi Pirenei, c che all'atto della rivoluzione formarono mezze-brigate di c fanteria leggiera.; ma non vi fu punto la pretesa di avere
« due fanterie differenti, poichè esse era.uo ednca.te, istruite
« e armate allo stesso modo; soltanto i battagHoni di cao ·
• « oiatori erano reclutati fra g li uomini dei paesi di mon ·
{l) Ai tempi di Na.poloono, i granatieri in Francia orano scolti secondo il criterio della statnrn; prima d'allora. invece la. compagnia raccogli e va i migliori soldati do l battaglione: usanza. che il runresciollo di Sassonia biasima anche percbò « on veut des grenadiors partout; ot.
• s'il y a quatre chots à fes!lcr, so sont. !es granadicrs qu'on domnnde c et .. on les fait tuer mal ò. propos ». (Mu réverieB, 31).
-< tagna e tra i figli dei guardacaccia, il che li rendeva più c adatti ad essere impiegati ait confini delle Alpi e dei Pi-
-e renei, o se si trovavano ad essere impiegati negli eserciti c di settentrione, ad essere distaccati di preferenza per at· c rampicarsi su una altura e per frugare una foresta; questi
.c uomini però, quando si trovavano in linea in un giorno
.: di battaglia, tenevano molto bene il posto di un batta-
< glione di linea, poichè a ve vano la stessa istruzione, lo c I governi levano spesso, in tempo di guerra, co1·pi ire regolari, cui danno il nome di corpi franchi o di legioni, c reclutati fra i disertori esteri o formati d'individui aventi
.c stesso armamento, la stessa educazione.
.c uno spirito od un'opinione particolare; ma oiò non costi- c tuisce due specie di fanteria. Non ce n'è e non può esse1'· c cene che 1tna. Se gli imitatoll:i servil:i (les singes) dell'an- c tichità. vogliono imitare i Romani, non già. debbono creare c fanti leggieri, ma fanti pesantemente armati o battaglioni c armati di spada, perchè tutta la fanteria d'Europa fa il c servizio di t.ruppe Jeggiere :. (1).
La poca opportunità di a\"ere due specie di fanteria, cioè due fantel'ie a:rmate e a.ddest;rate di-versamente, apparve pure da parte tedesca nella campagna del 1866 e fu dichiarata esplicitamente dal maresciallo Moltke nella « Memoria in- c dirizzata a S. M. il Re di Prussia il 25 luglio 1868:. (2).
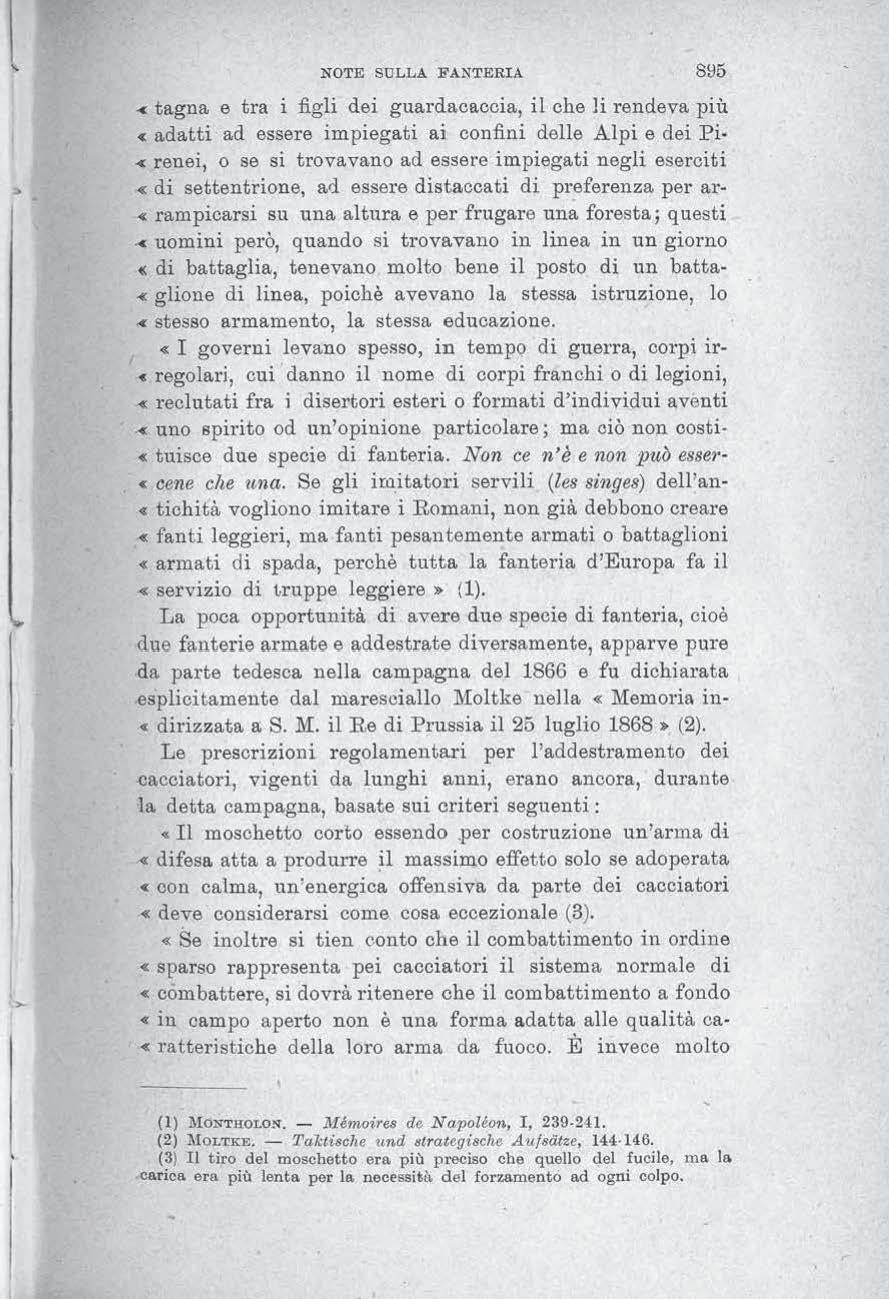
Le prescrizioni regolamentari per l'addestramento dei cacciatori, vigenti da lunghi anni, erano ancora, durante la. detta campagna, basate sui criteri seguenti:
.. Il mos chetto corto essendo ,per costruzione un'arma di difesa atta a produrre il massimo effetto solo se adoperata c con calma, un'energica offensiva da parte dei cacciatori c deve considerarsi come cosa eccezionale (3)
« Se inoltre si tien Mnto che il combattimento in ordine c sparso rappresenta pei cacciatori il sistema normale di «combattere, si dovrà ritenere che il combattimento a fondo c in campo aperto non è una forma adatta alle qualità ca- c ratteristiche della loro arma da fuoco. È invece molto
(l) :UoNTJIOLON. - Mém.oirea d e Napolé<m., I, 239·241.
(2) ÀIOL'l'KE. - Taktisch e t md strategische AufsiUze, 144 146.
(3) Il tiro del moschetto era più preciso che quello del fucile, ma la carica era più lenta per la. necessità del forzamento ad ogni colpo.
Note Sulla Fanteria
« opportuno l'impiego del fuoco col moschetto dei caccia-
« tori iu quei punti ove è difficile, per parte del nemico, l'as-
« salto con l 'a rma bianca, cioè dove il terreno è rotto e nelle
« locali tà che offrono naturale protezione e la cui conser-
« vazione è importante e può essere garantita dalla supe- c riorit.à del fuoco; nelle trincee durante una ritirata e in
« generale in quei te rreni che permettono alla destrezza e c alla circospezione del cacciatore di sfruttare tutti i vantaggi oi.Terti da una località.
«Basandosi su questi principì che regolano il loro impiego c nel co!llbattimento, i cacciatori giustificheranno il loro
« titolo di a1'ma speciale se eviteranno il modo di combat-
« tere della fanteria e si manterranno fedeli alle massime
« che crearono la fama di questo corpo speciale.... Per il
« servizio di sicurezza, durante le marcia e l e soste, 1' im-
« piego dei cacciatori è particolarmente raccomandato:
«a) Ìtl ierreno eminentemente boscoso e montuoso;
« b) per mantenere occupati nella cerchia degli avan-
« posti tal uni punti particolarmente importanti; c c) pl'r compiere ardibe imprese, in terreno adatto sui
«fianchi e a tergo (1) .
Il Moltko- osserva che raramente si presentò durante l a campagna del 186G l'occasione cl' impiegare i cacciatori seco ndo lo norme regolamentari; che non v'ò ragione, dato il valore che ha l'offensiva, di addestrare un'arma speciale per scopi pnramente difensivi; che data la scarsità dei cacciatori Ji professione (un CJ. uinto del totale in un battaglione di cacciatori sul piode di guerra, mobilitato con 12 classi), meglio sarebbe riunire tutti i cacciatori in un solo reggimento, da denominare c reggimento cacciatori della < Guardia • e coi battaglioni cacciatori rimanenti costituire i reggimenti di fanteria ancora mancanti nel piano orga-
(l) L6 nOI'lllO por l'impiego dci cnociato ri o più o.noora qnelle per l' impic-j;(o dei bersaglieri all'atto dell!t loro orenzione assomigl iano a quello cho il maresciallo di Sassonio. suggo· riva per i fanti nrmati. al tempo in cui quo11ti soli erano armati di schioppo e i fanti pr>!<tlntemente armati portavano la pio<'a (.11<'8 réceriu, 31 ), Napoleone ammettevo che pochi uomini per compagnia fossero armati di carabina a più lento caricamento, mn di maggior git· tata: oppuro che no fossero IUtnktte compagnie di borghesi de:;tinati arimanere dietro gli spalti d i unn fortezza.. (Corre8 pondancc militaire dc Napoléon 1", X, pag. 324).
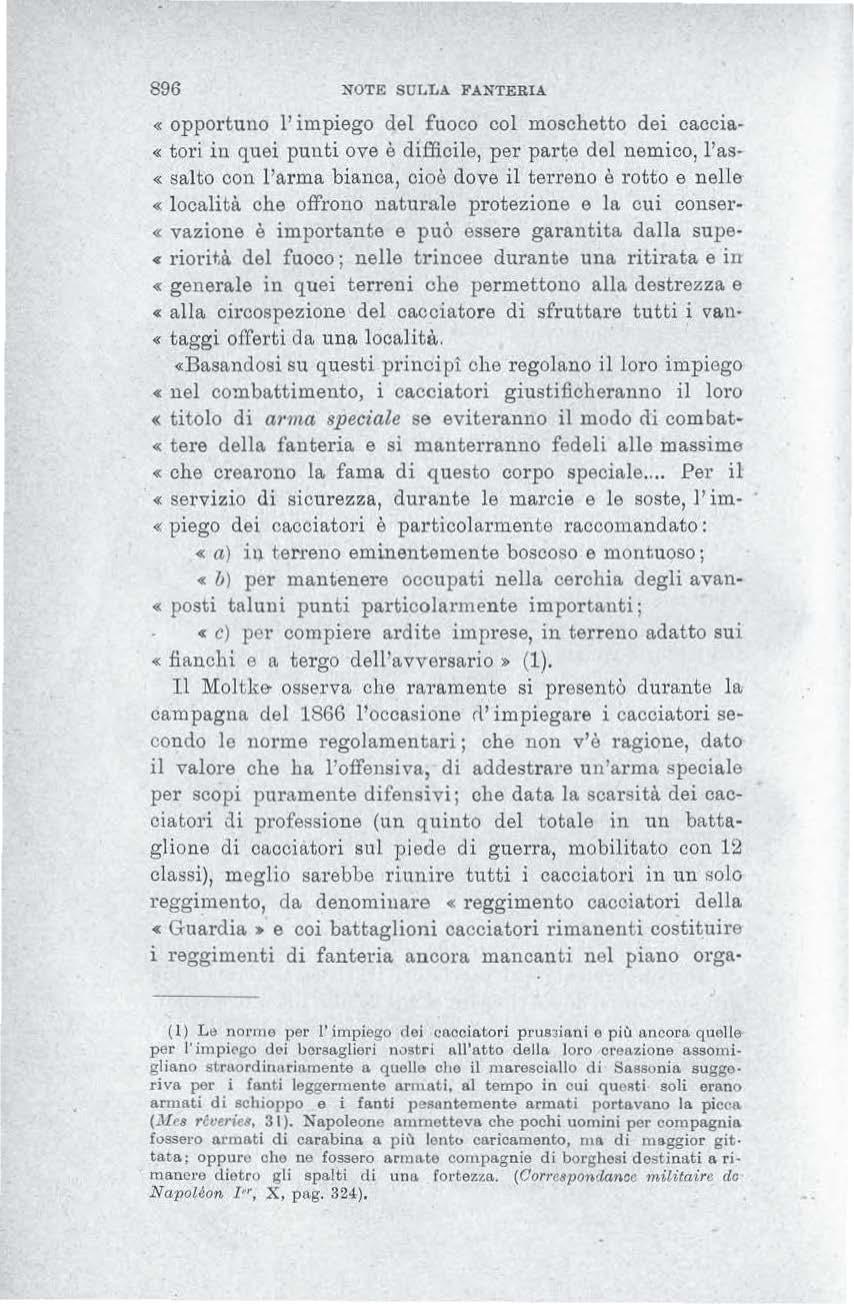
, nico generale, o almeno, se queste p r oposte n on f ossero "accettate, dare ai cacciatori lo stesso fucile della fante ri a c e introdurr e nel loro addestramento tattico l'ord i ne chi uso, .c. il fuoco a salve e l'attacco alla. baionetta:. .
Prima ancora che il Moltke avesse dedotto da una cam · pagna di guerra il difettoso ordinamento dei battaglioni di Jliger, ..llessandro La Marmora aveva notato, fin dal 1836, gl'inconvenienti della < carabina scanalata, sol'arma usi< tata sinora da questa specie di truppa; [i] quali inconve« nienti, consistendo principalmente nella lentezza de l ca« ricare e nel poco mezzo di difesa all'arma ' bianca., non c danno abbastanza confidenza al soldato per compromet« tersi corpo a corpo :. ; sicchè, nel proporre la formazione della prima compagnia bersaglieri, propose pure l'adozione di un'arma migliore e nello stesso tempo antepose al com· pito difensivo un compito offensivo. Vero è che il compito difensivo dei bersagli eri fu simile a quello dei cacciatori; ma. lo scopo generico fu quello di avere <un corpo di ben c addestrati bersaglieri, singolarmente in paese montuoso, c impedito ed opportuno alla guerra minuta » 1 quale era appunto il carattere della massima parte degli Stati sardi (l) e più particolarmente fu assegnato loro il compito di « sec condare con la precisione del tiro ogni operazione princ cipale » av\"ertendo che «essendo di natura ad accompa.« gnare le spedizioni tanto della truppa di linea che della • leggiera, e prendendo ogni volta posizione, i bersaglieri c non si devono adunque considerare come una truppa leg· te giara, ma piuttosto come una specie di artiglieri a a pie" cola portata e di grande mobilità. :. (2)
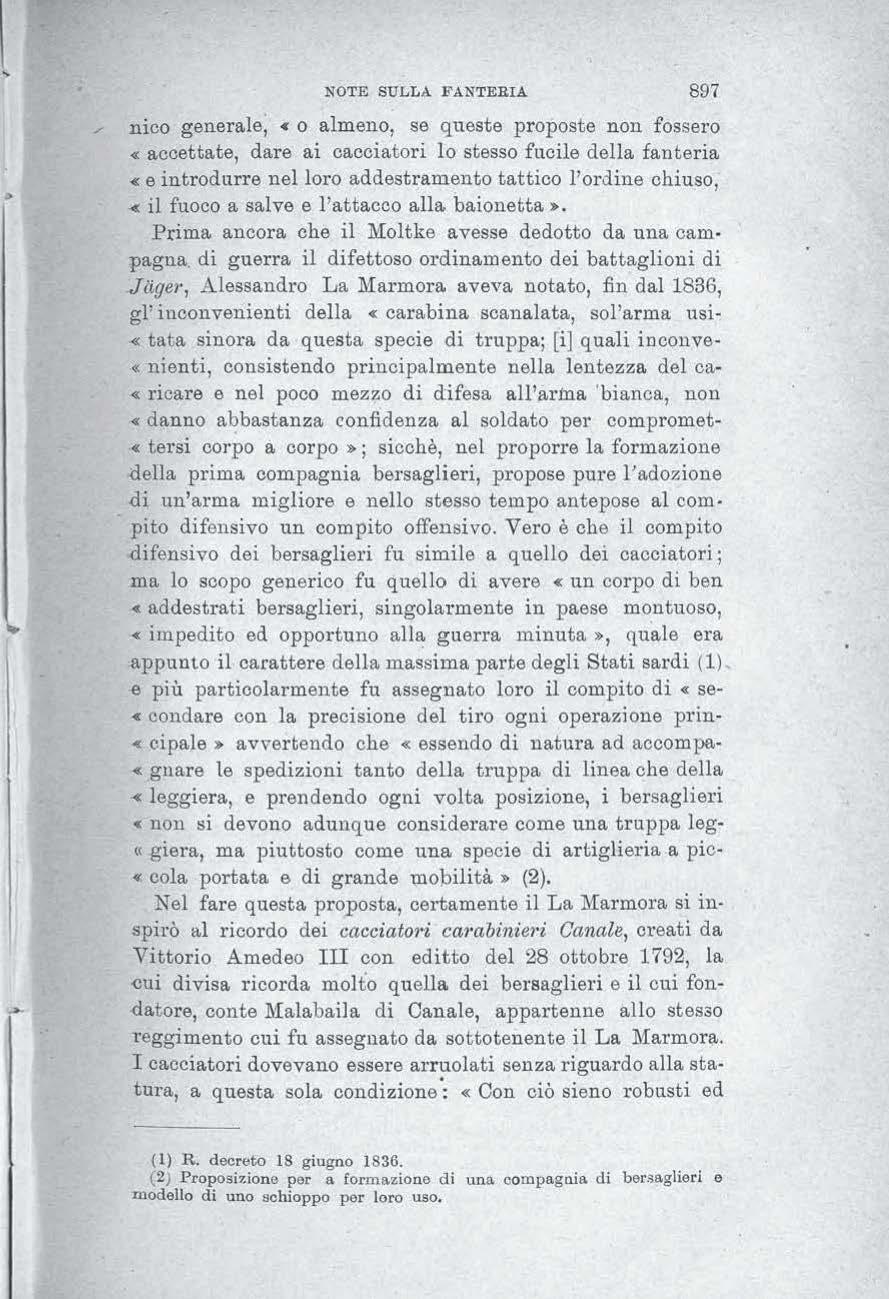
Nel fare questa proposta, certamente il La Marmora si inspirò al ricordo dei cacciato1·i ca1·abinie1·i Canale, creati da Vittorio Amedeo ill con editto del 28 ottobre 1792, la -cui divisa ricorda molto quella dei bersag l ieri e il cui fon<latore, conte Malaba.ila di Canale, appartenne allo stesso Teggimento cui fu assegnato da sottotenente i l La Marmora. I cacciatori dovevano essere arr uolati senza riguardo alla sta· tura, a questa sola condizione ": « Con ciò sieno robusti ed
(l) R. decreto 18 giugno 1836.
( 2 ) Proposi.;ione per a formazione di tma co mpagnia di ber.>aglieri e modello di uno sohioppo per loro uso
808
Note Sulla Fanteria
« atti al ser'71ZlO per cui sono destinati, che esige fatica.
« e sveltezza non ordinaria • (1).
Così nacquero i bersaglieri, i quali tuttora. si conservano ecl a ragione, benchè non esistano pit1 in massima parte i . motivi che ne snggerirono la fondazione ed anzi il solo motivo tuttora esistente, quello cioè di avere truppa par· ticolarmente adatta alla montagna, abbia dato origine ad un altro corpo speciale: quello degli alpini, creato nel 1873. Non v'è dubbio che sarebbe stato possibile evitare la costituzione di un corpo nuovo, richiamando i bersaglieri, al meno in parte, •alla loro origine; ma non è altrettanto certo che ciò sarebbe stato utile all'esercito. Per convincersene basta tener presenti i ricordi ora citati, dai quali appare chiaramonte che non vi può essere· che una sola specie eli fanteria, o che so anche una parte della fanteria potrà avere attitndini speciali, come nol caso degli alpini, il fondamento doll' istruzione e dell'impiego non può essere che uno per tutta la. fanteria. Por contro sono utili tutte quelle differenze che rialzano lo spirito ed eccitano l'emuJa.zioue: esempio caratteristico le compagnie di volteggiatori e di granatieri dell'epoca napoleonica, per non ripetere quella paraùos.:;ale dei c iclopi e dei g obbi Porciò non è affatto anormale ohe i bersaglieri conservino il nome loro, sEfubone non abbiano più quella particolare precisiono di tiro, che ebbero all'inizio, allo stesso modo che nesst1no pensa di cambiar nome ai granatieri, col pretesto che da molto tempo non lanciano più granate; mentre le tradizioni gloriose degli uni e degli altri o lo spirito di corpo che li anima sono un preziosissimo 'Patrimonio eli forza mora l e. Enunciare a proposito do i bersaglieri il d n h bio d'Amleto, perdendosi nella vana ricerca di uno spocialo impiego del corpo in caso di guerra (2), equivale a. rinnegare l'esperienza. del passato e a volersi illudere cho gente e. piccli possa essere qua l che cosa di diverso dalla I bersa- glieri non sono, non debbono, non possono essere altro che fanteria scelta.: ma. è già questo un altissimo onore, che impone agli ufficiali dei bersaglieri il dovere di curare con tutte le loro forze che i fatti corrispondano al nome.
(l) Donom. - L e{Jgi, provvidenze c mani / e8ti, XX VITI, 324, - Il La. l\lnrmora. non ricercò la novit à del nome, poichò altri corpi di bcrartglirri erano già esistit.i. l bersaglieri s uoi furono peraltro più simili ai cn ct:'ia· tori carabiniel'i su menzionati cho ad altri tipi di bersaglieri più somiglianti ai Jii.gor prussiani: basti ogsorvln·e che osai ebbero la. baionetta e gli nitrì la daga o il coltello da cnccia.
(2) '!lfENARJNT. ll dil emnw ri'A.mlrto pe i ber8a!llitr i - Rit•ist« militare italiana, aprilo g iugno 1904.
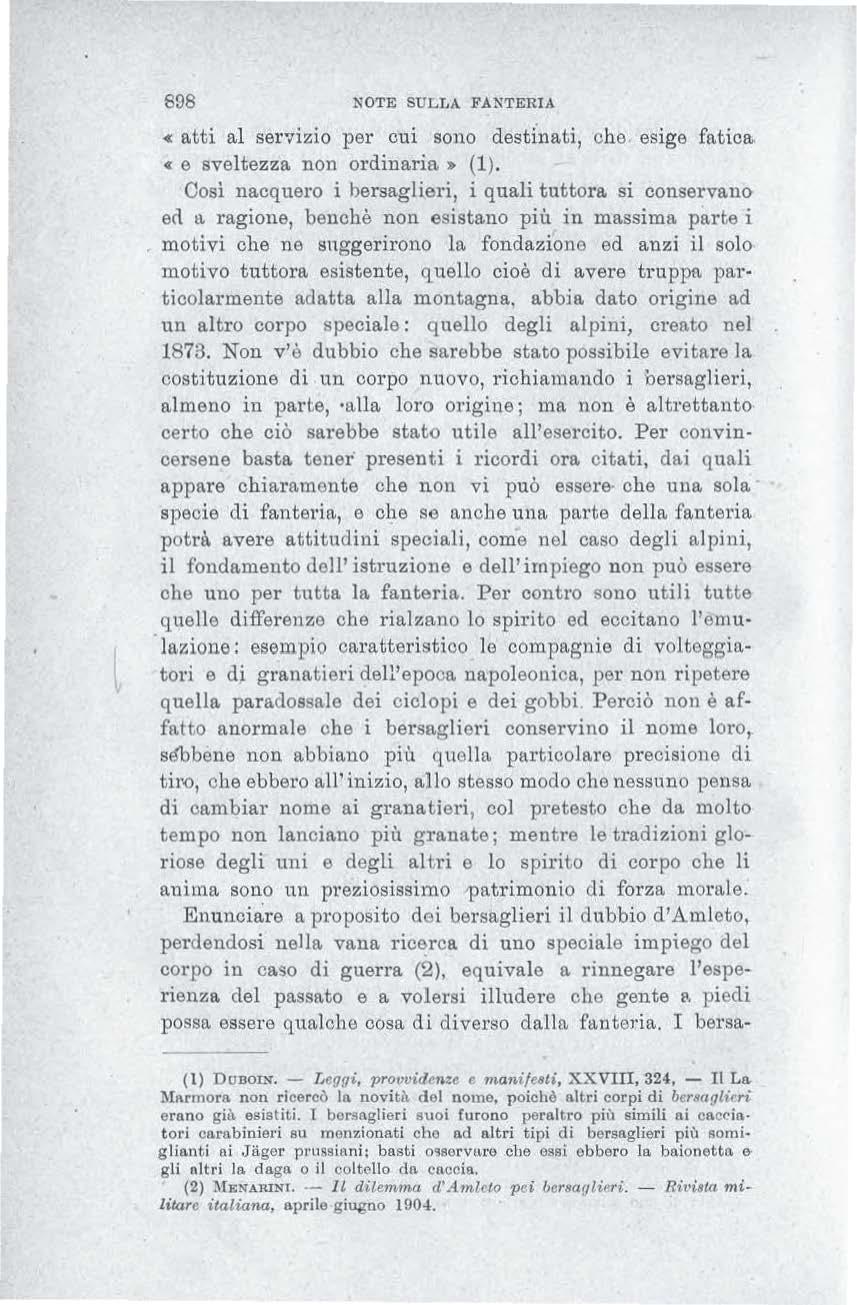
Non può, del resto, recare meraviglia che un concetto così semplice abbia stentato a prevalere nella pratica, se si pensi che Alfonso La. Marmora nel 18G!) scriveva: « Uti-
« lissimi sono i nostri bersaglieri e checchè ne dica il ge - c nerale Trochn e dir possano altri generali pari a lui, spero
« sAranno nell'attuale proporzione conservati. Io stesso c ho introdotto, e non me ne dolgo, che la nostra fanteria c di linea sappia., occorrendo, combattere in ordine spa.r'lo.
« i\[a con tutto ciò dichiaro che voler fare di tutta ln. no- c stra. fa.ntEt.ria altrettanti ber;;aglieri è un errore che ci po- c trebbe costar caro Appu11to perchò abbiamo ottimi bat- c taglioui bersaglieri, impareggiabili massime per preparare
«e completare i combattimenti, la. nostra fanteria di li nN\ c ùovrebbe es:sero più solida o più comp11.tta delle altrt'. Ora. c lltnto piit che, colla celerità delle armi a ret.rocarica, l'or- c tliHe chiuso ha ripreso quella maggiore c:he c nveva prOV\'Ìsorinmente ceduto all'ordine aperto, dmante c il brove periodo delle armi di precisione a tiro lento :. (l).
E quel che è ancora più strano, il generale Alfonso La 11[armora. insisteva aJtcora in quc:;te idee nel 1871 (2) clopo la della. guerra frauco-prn'lsiann ,\ questo proposito riesce part)co1a.rmonte rievocare quanto il generalo Carlo Corsi rammenta. circa. le discussioni e le impreso;ioni che i bersaglieri suscitarono al tempo della loro origine: · c Nella. primavera del 184:1:, sul cadore d'un dì piovoso, c io giungevo a 'l'orino venendo da Alosstmdria . La pes1tnte c vettura che mi insieme ad una dozzina. d'altre c persone, svoltando sulla piazza della. Gran :Madre di Dio,
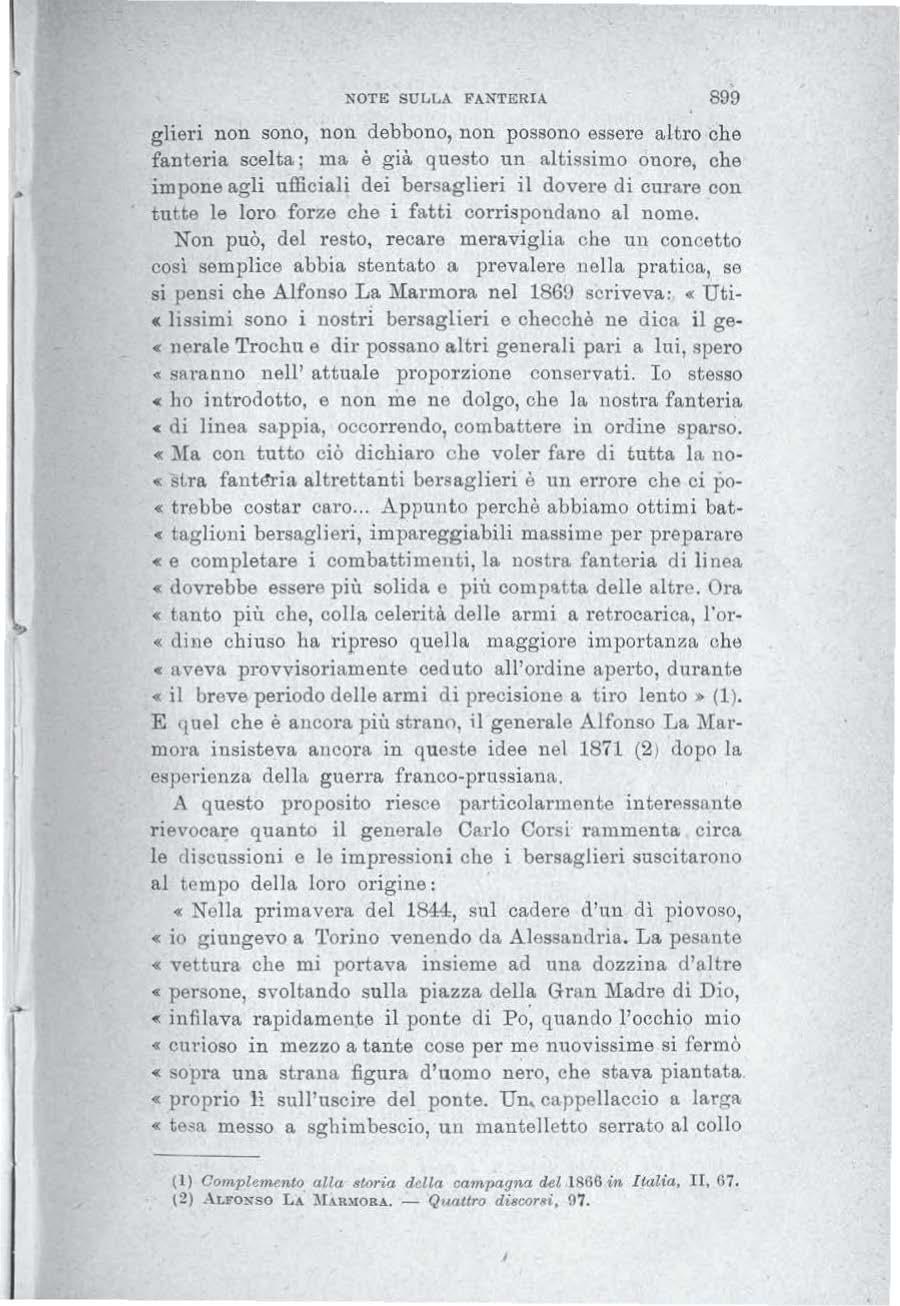
« infilava rapidamente il ponte di Po; quando l'occhio mio c curioso in mezzo a tante cose per me nuovissime si fermò c :sopra una strana figura d'nomo nero, che stava. piantata c proprio E sull'uscire del ponte. Un, cappellaccio a larga
« messo a sghimbescio, un mantelletto serrato al collo
« e stranamente corto, calzoni di foggia militare, e cii sotto
« al mantello la estremità d'tmo schioppo o la punta di un
«fodero d'arme. Cappello e mantello grondavano acqua.
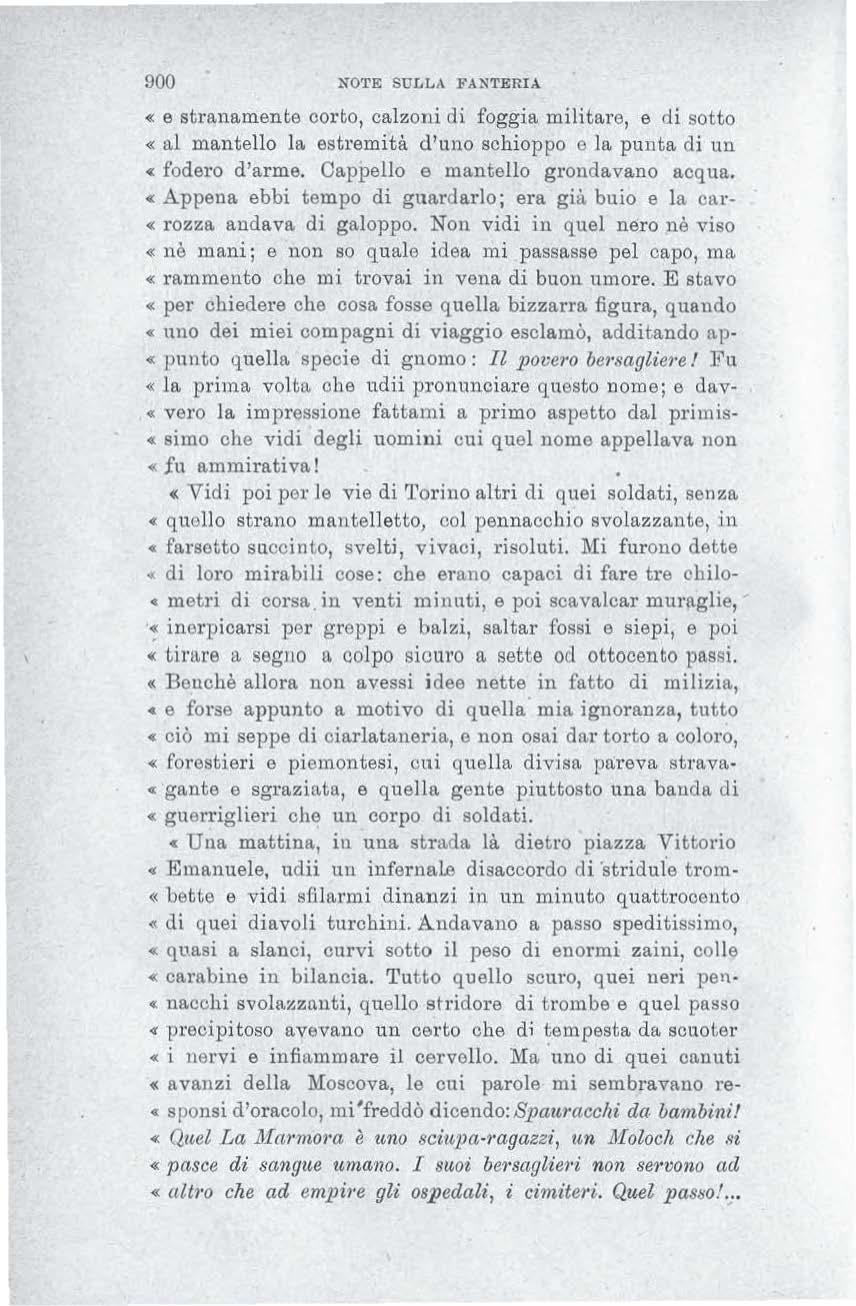
«Appena ebbi tempo di guardarlo; era già buio e la ctu-
« rozza andava di galoppo. Non vidi in quel nero nè viso
« nè mani; e non so quale idea mi passasse pel ma
«rammento ohe mi trovai in vena di buon umore. E stavo
« per chiedere che cosa fosse quella bizzarra figura, quando
« uno dei miei compagni di viaggio esclamò, additando a p-
« pnnto quella specie di gnomo: Il p01;ero bersaglim·e! ];"u
«la prima volta che udii pxonunciare questo nome; e dav-
« vero la impressione fattami a primo aspetto dal prim is-
« simo che vidi degli uomini cui quelnomo appellava non
«fu ammirativa!
Vidi poi pe1· le vie di Torino altri di quei soldati, se1tza
« quollo strano ma1ttelletto, col pennacobio sV'olazzante, in
« fa.rsotto succinto, svelti, vivaci, risoluti. Mi furono dette
., di loro mirabili cose: che erano capaci di fare tre chilo- c metri di corsa in venti miunti, e poi scavalcar
« inerpicarsi pe1· groppi e balzi, saltar fossi e siepi, e poi
« Lirttre a segno a colpo sicuro a sette od ottocento pas!li.
« Bouchè allora non avessi idee nette in fatto di milizia,
• e forse appunto a motivo di qut?olla mia ignoranza, tutto c ciò mi seppe di ciarlataneria, c non osai dar torto a coloro, forestieri e piemontesi, Ctli quella divisa pareva strava· c gante e e quella gente piuttosto una baucla di c Uua. mattina, in una. stra.da là dietro piazza Vittorio c Emanuele, udii uu infernale disaccordo òi ·stridule trom·
« guerriglieri che un corpo eH soldati.
« bette e vidi sfllarmi dinanzi in un minuto quattrocento
« di quei diavoli turchiui. Andavano a passo speditissimo,
« qt,asi a slanci, curvi sotto il peso d1 enormi zaini, colle
«carabine in bilancia. Tutto quello scnro, quei neri pen·
« nacchi svolazzanti, quello stridore di trombe e quel passo c precipitoso avevano un certo che di tempesta da scuoLer
« i nervi e infhtmmare il cervello. Ma uno di quei canuti
« avanzi della Moscova, le cni parole mi sembravano re- c sponsi d'oracolo, mi 1 freddò da bambini!
« Qztel La .!Jfal"mo?·a è uno u.n .!Jioloclt che si
« pasce di sangue umano. I suoi be1·saglieri non se1·vono acl c: quei saltt! Povera gioventù! pove1·u Piemonte! Infatti si «diceva che le ernie e le polmoniti fossero molto frequenti c: in quel corpo.
« attl"o che ad empi1·e gli ospedali, i cirnite1·i. Quel passo! ...
« Li rividi nell'autunno sulle lande di S. Maurizio stor< meggiare sparsi e tirare a segno . Erano davvero svelti e c corridori e tiravano a meravig l ia. Ma da nn Iato il vecchio
« oracolo diceva: j]fetteteli in faccia ad uno di co« razzieri francesi o di ttsseri austr iaci o ad un battaglione
« di Goddarn o di K(tise1·lich qu,esti balle?·ini ...! e dall'altro
«parecchi giovani militari bronto lavano: Qualunqne corpo c Intanto gli spregiudicati dicevano: i bersaglieri non «sono una nuova specie di fanteria, ma sibbene un saggio
« di fante? ·ia può {a1·e lo stesso; purchè lo si voglia.
« ùi ciò che potrebbe essere la fanteria tutta tra pochi anni;
« sono la prima forma d'un concetto che mira ad un ra-
< dicale mutamento delle armi e della tattica di tutta la
« milizia a piedi. I gonzi vanno in estasi ammirando da
« una parte questi nuovi espedienti di guerra cosi leggi eri
«e dalPaltra gli antichi ta.nto solidi e gravi, e si compiac- e ciono dello !'ltato reciso che li separa. Ma a guardar bene
«a. fondo, la. questione è assai più grande e molto diversa.
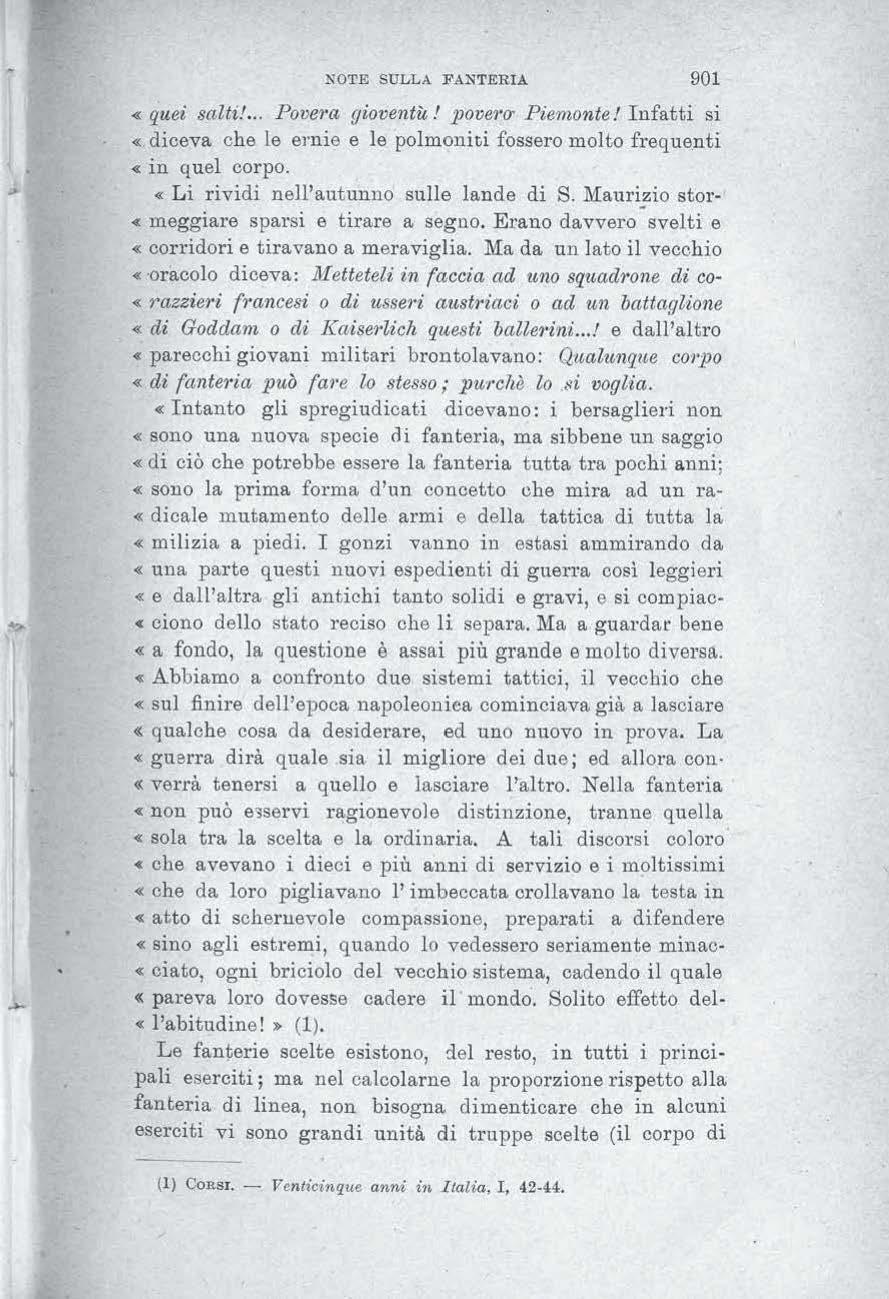
« Abbiamo a confronto due sistemi tattici, il vecchio che c sol finire dell'epoca uapoleonica cominciava già a lasciare
« qualche cosa da desiderare, ed uno nuovo in prova. La
« guerra dirà qua le sia il migliore dei due; ed allora con·
« velTà tenersi a quello e lasciare l'altro. Nella fanteria c non può e>servi ragionevole distinzione, tranne quella c: sola tra la scelta e la ordinaria A tali discorsi coloro
« che avevano i dieci e più anni di servizio e i mo l tissimi
« che da loro pigliavano l'imbeccata crollavano la t esta. in
« atto di scheruevole compassione, preparati a difendere c: sino agli estremi, quando lo vedessero seriamente minac - c: ciato, ogni briciolo del vecchio sistema, cadendo il quale p areva loro dovesse cadere il mondo. Solito effetto del - c l'abitudin e! :. (1) .
Le fanterie scelte esistono, del resto, in tutti i principali eserciti ; ma. nel calcolarne la. proporzione rispetto all a fanteria di lin ea, non bisogna dimenticare che in a l cu ni eserciti vi sono grandi unità di truppe scelte (il corpo di armata della guardia in Germania e in Russia, la divisione della guardia nel Giappone); senza di che si corre il rischio di cadere in affermazioni inesatte, come quella contenuta nella relazione del 23 maggio 1896, la quale accompagnava la presentazione al Senato del progetto Ricotti pel ri01·dinamento dell'esercito ( l )
Contro le fanterie scelte e precisamente allo scopo di di· minuire il numero dei nostri bersaglieri, si ossot·va da taJuui che la loro esistenza è nociva alla fanteria di linea e si paragonano all'edera cche abbarbicandosi alla gran quercia c: delle forze nazionali ne assorbe i succhi migliori :. ( 2) Ora ciò è pura. esagerazione, fìnchè lo cose rimangono noi. limiti presenti; in fatto di assegnazione rlel personale quello che interassa. di più è che gli uomini adatti alla fanteria non siano presi, senza sufficiente motivo, da altre armi; ma se fra tutti quelli assegnati alla fanteria gli individui aventi speciali requisiti saranno riuniti in reggimenti a parte, ciò potrà riuscire di vantaggio piuttosto che di danno, come chiaramonte dimostrauo le parole di Napoleone. Ad evitare poi auuho il pil1 lontano pericolo che la fanteritt di linea accolga individui di scMto, il provvedimento più opportuno consisterebbe nell'allargare sempre più la base <lei recluta· mento, in modo da poter fare una più larga selezione fisictt del contingente incorporato.
La. fanteria ciclista, recente istituzione, è certamente un'anna speciale, perchè si sPrve di un mezzo eli locomozione rliverso da quello fanteria onliuaria; mA. se i ci· clist,i, in ragione della loro mobilità. snlle strade, possono avere compiti particolari che non potrebbero essere disimpegnati dai fanti a pieùi, devono per altro essere in grado di compo1·tarsi como la migliore del l e fanterie noi casi in cui non possano valersi della bicicletta eù anzi portarla sulle spalle e combattere: e ciò forse in condiz ioni eccezio· nalmente difficili, porchè lontani dall'appoggio delle altre truppe. Ad ogni modo, anche la trasformazione parziale ùei ber:!laglieri in ciclisti non implica che si debba distruggeme l a parte rimanente, la quale sarà sempre l a plU numerosa e l a più aoiatta. a conservare le glorioie tradizioni, che i l corpo creò marciando e combattendo unicamente a piedi .
(l) Secondo quella rotazione, la. proporzione t1·a lo fanterie sco lto e quello Ji linef.\ StH·obbe dj 1/5 per I'Ita.Ua; l lO per l' !\ustria-lJnghoria, di l / lO circa per Il.\ Francia {osoluse le truppe di Algerin), eli 1 ' 33 por la Ger· marua, di l 9 circa per la Russia.
(2) ;\[AR ,\ZZI. - L' Nurcito dei tclllpi 275.
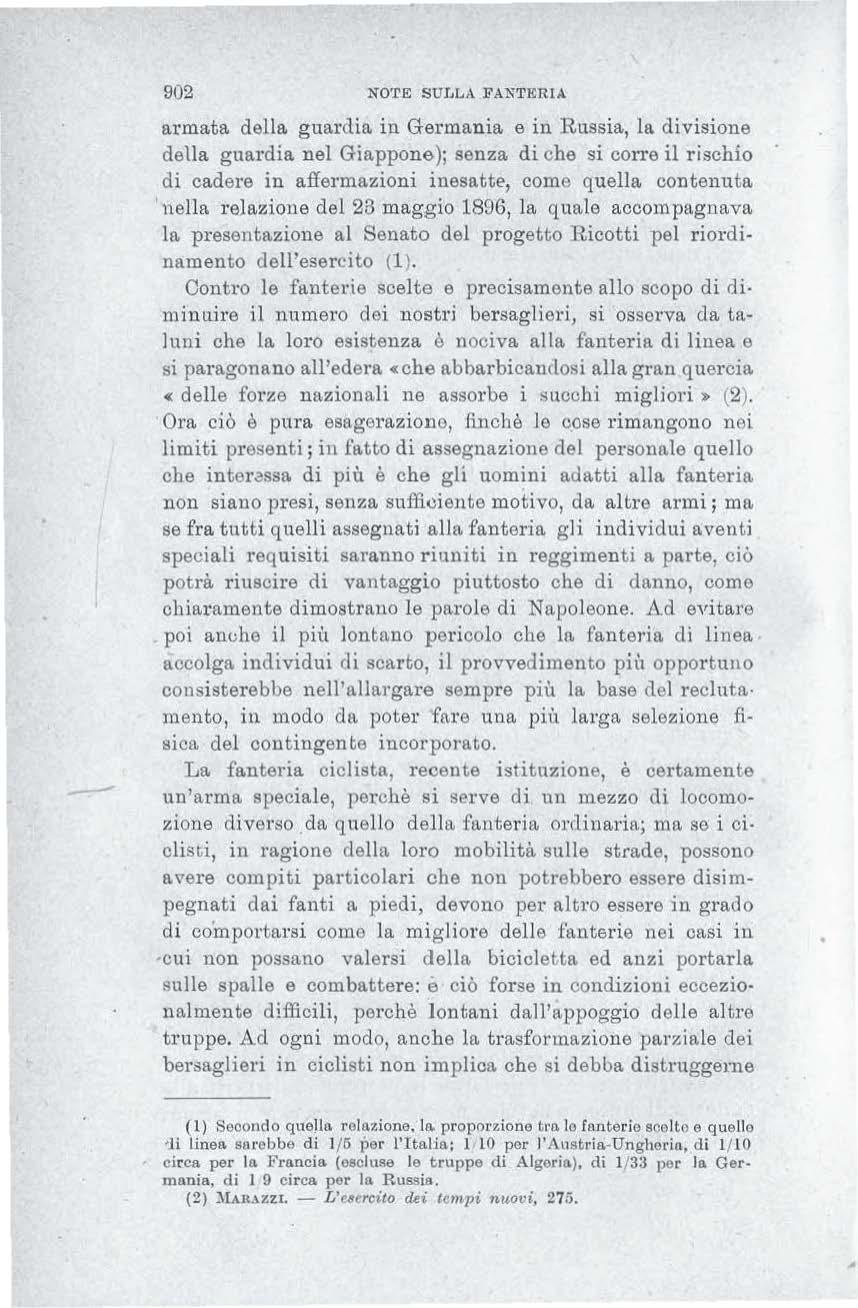
Q nanto agli alpini, è superfluo spender parole pe r dimost r a r el' uti lità di avere truppe specialmente addestrate alla. guerra di montagna: desta anzi meraviglia che, allorc·hé fu creata. in Italia nel 1873 la. prima. compagnia alpina, l'idea sia par:>a. nuova. e originale, mentre già in Italia i cacci a tori Canale e i ber saglieri avevano avuto il medesimo scopo, in già esi:'te'ç'ano i tiratori tirolesi e fin dal 1780 il principe di Lign e nei Prt'}ugés militaires patroc i nava. nn maggiore svil uppo di questa istituzione, vo l euclo che ci fossero nell 'e· sercito degli al'l·ampicatori I!JrimpettrR), dei nuotatori e dei questi t1ltimi addestrati a portare celermente or· dini e notizie, servizio cui meglio si prestavan o gli éclaireurs a cavallo ideati da Napoleone I e che ora potrebbe anche essere ben disimpegnato dai ciclisti. Va rico r dato che i Russi, nella guerra contro il Giappone, avevano appunto a sussidio della fantoria reparti di esploratori a cn ,·allo.
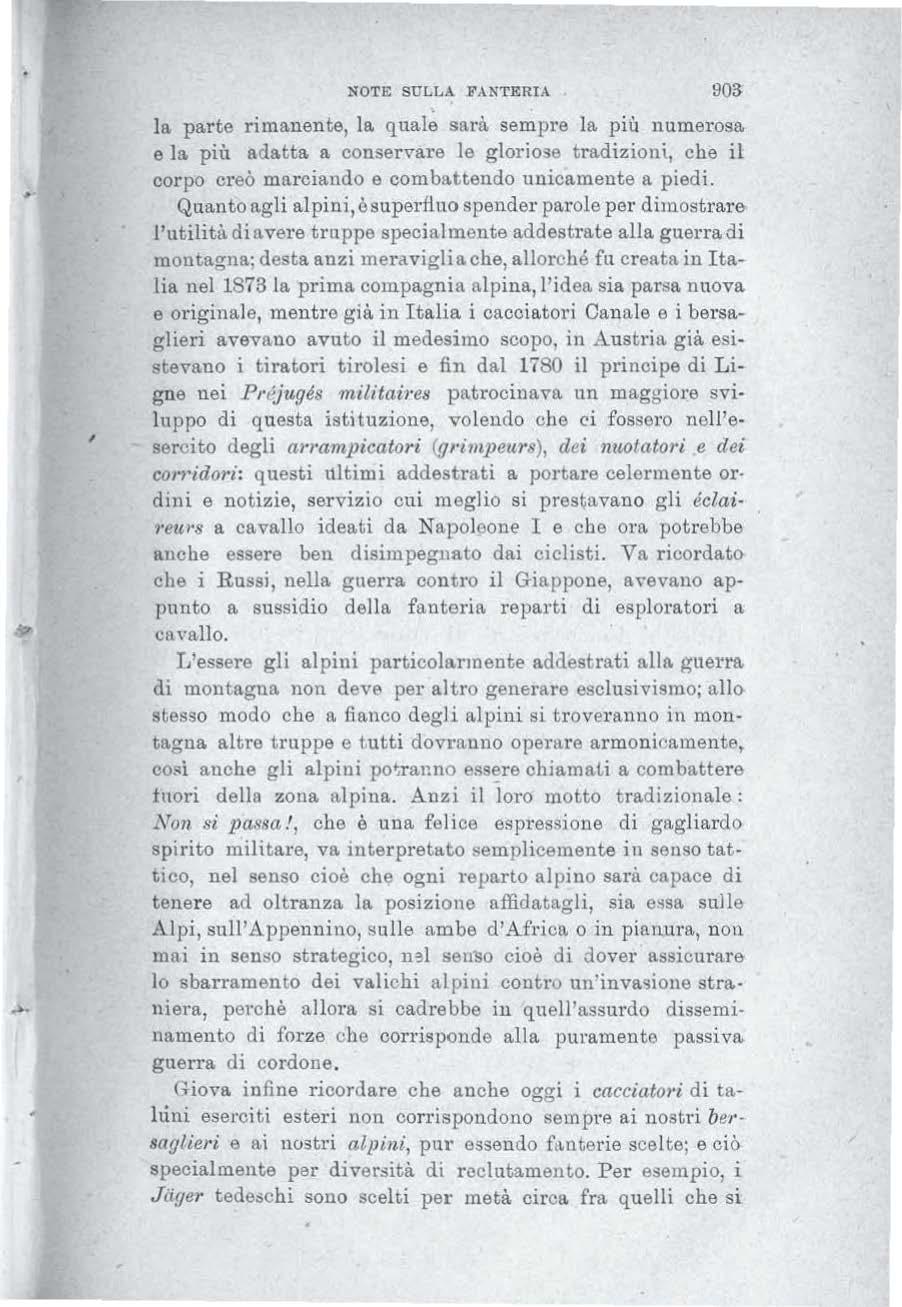
T/essere gli alpini particolarmente a.dtlestrnti allA. guena. d i non devE\ per altro generare esclusivismo; allo stesso modo che a fianco degJi alpini si troveranno in montagna altre truppe e lutti dovmnno opemre armonif•amente, cosi anche gli alpini pol;ranno cluamat.i a combattere fuori delln zona al pino.. A.nzi il loro motto tradizionale: J..Yon .<1i !, che è una felice espt·essione di gagli ardo spirito militare, va interpretato semplicemente in senso tattico, nel senso cioè che ogni teparto alpino sarà capu,ce di tener e acl oltranza la posizione affidat.agli, sia e!-lsa suile fiiova infine ricordare che anche oggi i cacciatori d i tal cini esel'citi esteri non co r rispondono sempre ai nostri be rs aglieri e ai nost.ri alpini, pur essendo scelte; e ciò specialmente per diversità di reclutamento. Per esempio, i Jiige r tede:.chi sono scelti per metà circa fra quelli che s i dedicano alla carriera forestale e per l'altra meta fra lll· ,dividui che spiccano per agilità (non per robustezza).
A lpi, sull'Appennino, sulle ambe d'Africa o in p ianura, n on mai in strategico, setfSO cioè di dover assicurare lo sbarramento dei valichi al pini contro un'invasione stra· niera, perchè allora si cadrebbe in quell'assurdo dissemi· namento di forze che corrisponde alla puramente passiva gnen-a di cordone .
In taluni eserciti, quasi a sostituire l'artiglieria reggimentale dell'epoca napoleonica, furono creati reparti di mitragliatrici, di cui torna acconcio parlare a proposito della fanteria, sia perchè la non è che un fucile a tiro 1·apidissimo, sia perchè in taluni eserciti tali reparti formano organicamente parte dell'arma di fanteria. Le batterie o le sezioni di mitragliatrici ricordano le batte?·ie di amusettes che il maresciallo di Sassonia prevedeva di formare quelle d'ogni centuria per reggimento {il reggimento essendo di 4 centurie) e per legione (la legione essendo di 4 reggimenti) (J.11es 1'éve1 ies, 38). Più ancora ricordano le amusette.s i cannoncini preconizzati dal Langlois e dal Reichenau.
Le mitragliatrici però non hanno dappertutto eguale assegnazione ed eguali compiti: il loro ordinamento è pure assai vario e non sono state con uniformità di criterio jntrodotte in tutti gli eserciti. D el resto, p or esempio, i Tedeschi hanno reparti di mitragliatri c i e non hanno compagnie di ciclisti; dimostrano anzi poca simpatia. pe1· il largo impiego dei ciclisti, temendo quasi di fornire a molti il mezzo di a.llontanar::i dal com battimento sotto pretes ti aventi l'apparenza della legalità.
Del nurne1•o della fanteria è supet'fln.o discorrere, perchè essa ha n a turalmente negli eserciti odierni la prevalenza numerica ed anzi essa stessa serve ordinariamente di unità di misura per ragguagliarvi le altre armi (1) nozione della loro reale composizione con quella delle funzioni dP-i rispettivi comandanti. Queste funzioni hanno dunque grandi$Sima importanza in guerra e in pace; mentre però in guerra l'ordine gerarchico naturale non può essere turbato che per circostanze speciali e straordins.rie, iu tempo di pace esso è subordinato alla distl·ibuzione delle truppe sul tenitorio dello stato.
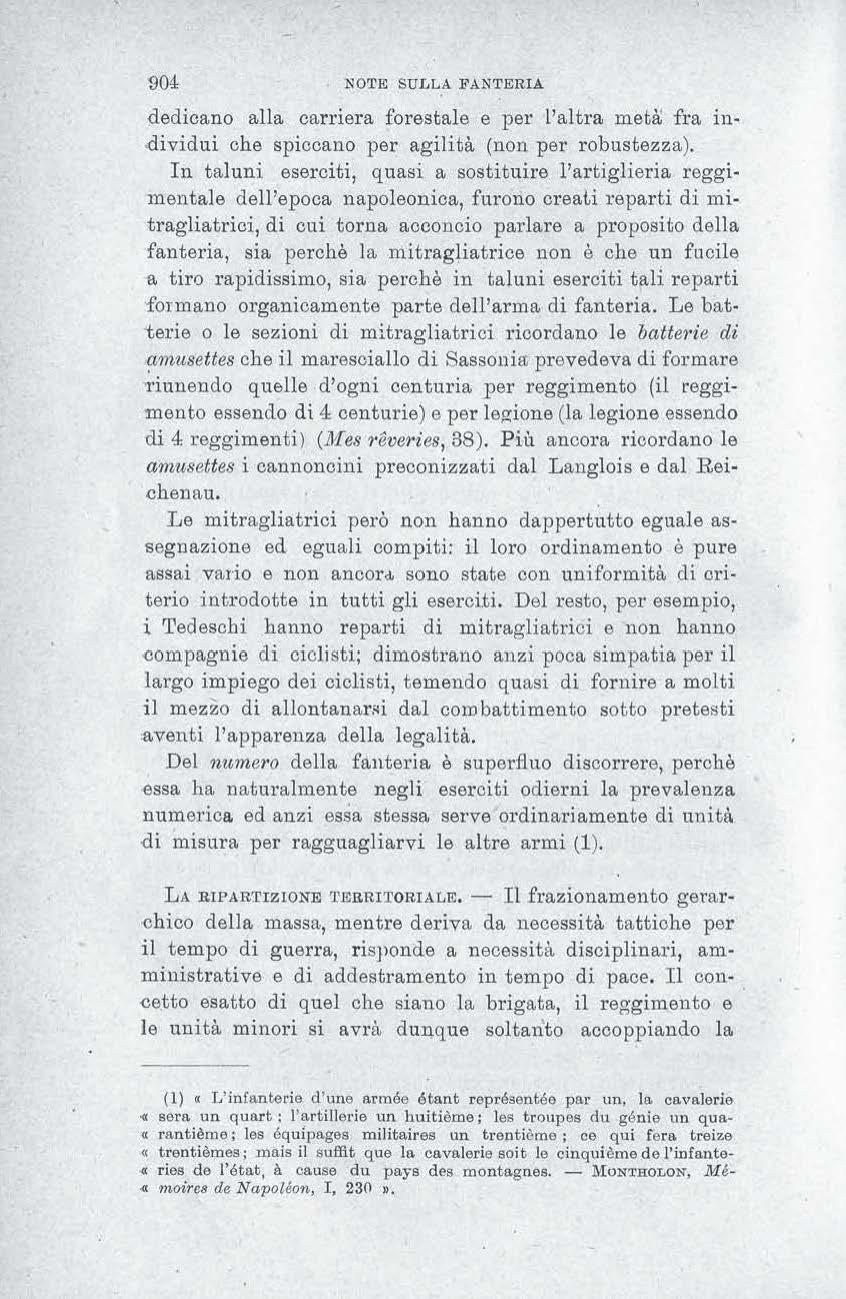
LA RII'ARTIZlONE 'l'ERRITORIALE. - Il frazionamento gerarchico della massa, mentre deriva da necessità tattiche per il tempo di guerra, ri sponde a necessità disciplinari, amministrative e di addestramento in tempo di pace. Il conesatto di quel che siano la brigata, il reggimento e le unità minori si avrà dunque soltanto accoppiando la.
(l) « L'infanterie d ' une armée étant représentée par un, la. cavalerie -« sera un quart ; l' artillerie un huitième; les troupes du génie un qua« rantième; Ies équipages militaires un trenti ème ; ce qui fera treize « trentièmes; :mais il auffi.t que la. ca.va.lerie so i t le cinquième de l'J.nfante-« ries de l'éta.t , à cause du pays des rnontagnes. - MoNTBOLON, Mé-« moires de Napotéon, I, 230 ».
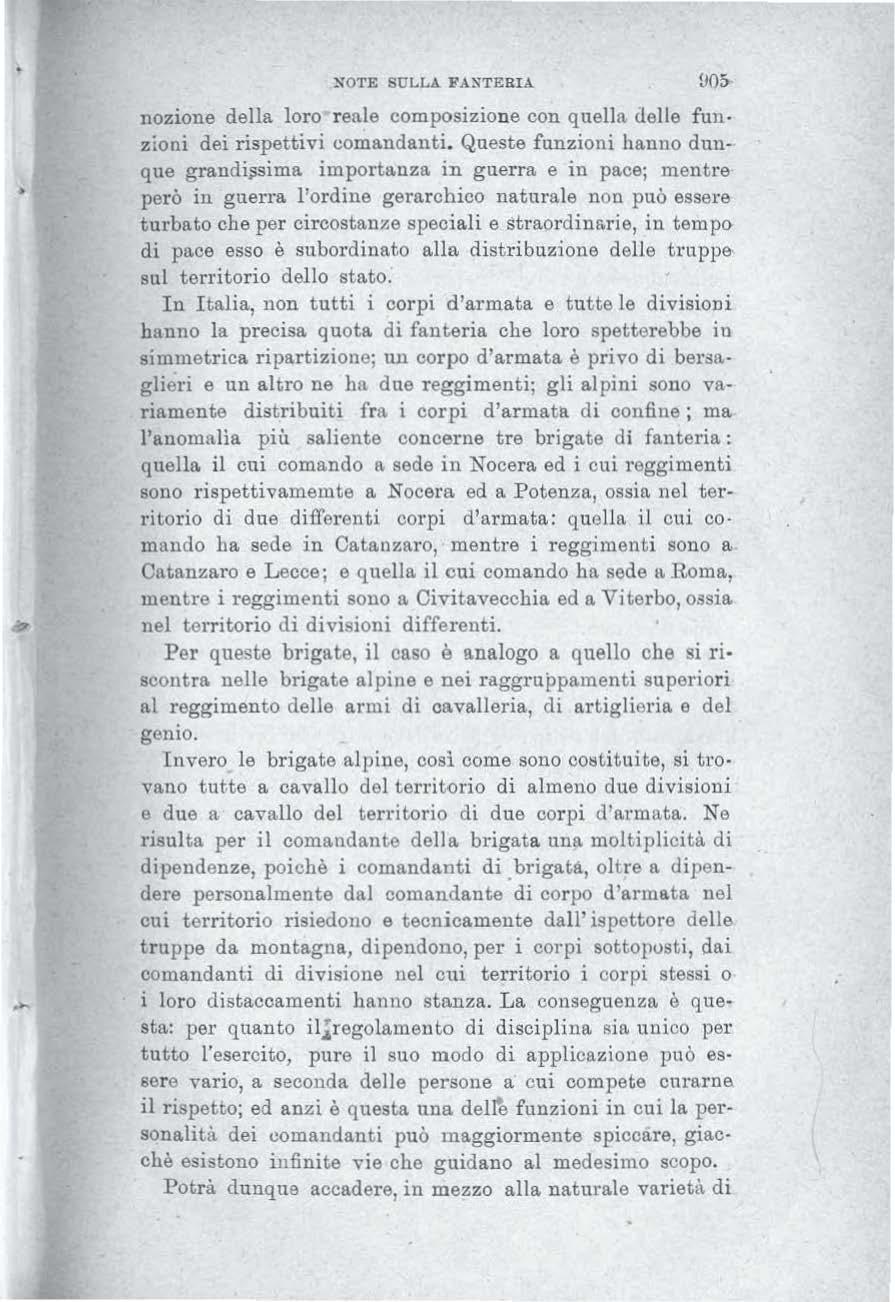
In Italia, non tutti i corpi d'armata e tutte le divisioni hanno la precisa quota di fanteria che loro spetterebbe in simmetrica ripartizione; un corpo d'armata è privo di berila· glieri e un altro ne ha due reggimenti; gli alpini sono variamente distribuiti fra i corpi d'armata di confine; ma l'anomalia più saliente concerne tre brigate di fanteria: quella il cui comando a sede in Nocera ed i cui reggimenti sono rispettivamemte a Nocera ed a Potenza, ossia 11el territorio di due differenti COl'pi d'armata: quella il cui CO· mando ha sede jn Catanzal'o, mentre i reggimenti sono a Catanzaro e Lecce; e quella il cui comando ha sede lt H.oma, mentre i reggimenti sono a Civitavecchia ed a Viterbo, ossia nel temtorio ùi differenti.
Per queste brigate, il caso è !l.nalogo a quello che si riscontra nelle brigate al pine e nei raggruppamenti superiori al reggimento delle armi di cavalleria, di art.iglioria. e del g<mio.
In vero le brigate al pine, cosi come sono COt)LituiLe, si tro· vano tutte a cavallo del territ<>rio di almeno due divisioni e due a del territorio di due corpi d'armata. Ne risulta per il comandante della brigata una moltiplicità di dipendenze, poichè i comandanti di brigata, ollre a dipendere personalmente dal comandante di corpo d'armata nel cui territorio risiedono e tecnicamente dall'ispettore delle truppe da. montagna, dipendono, per i corpi sottoposti, dai comandanti di divisione nel cui territorio i corpi stessi o i loro distaccamenti hanno sto.nza. La couseguenl!>a è questa: per quanto di disciplina f!ia unico per tutto l'esercito, pure il !!UO modo di applicazione può es· sere a seconda delle persone a cui compete curarna il ri:>petto; ed anzi è questa una delìe funzioni in cui la personalità dei comandanti può maggiormente spiccare, giac· chè esistono infinite vie che guidano al medesimo scopo.
Potrà dunque accadere, in mezzo alla. naturale varietà di metodi, che uno stesso comandante di bri'gata si trovi nell'occasione di applicare, in casi uguali, due pesi e due misure, a seconda che un reggimento o parte di e§so si tl·ovi nell'una che nell'altra divisione, nell'uno piutto'f!to che nell'altro corp'o d'armata: cosa la quale non giova al prestigio del grado, perchè la diversità di apprezzamento, ammissibile e naturale in persone di v erse, non si può con-cepire in una stessa persona.
Questa moltiplicità di dipendenze cui è soggetto un comandante di ' brigata alpina sarebbe in parte eliminata il giorno in cui il solo comando di corpo d'armata conservasse carattere territoriale ; poi eh è in tal caso, quando il comandante di brigata fosse, coi rispettivi reggimenti agli <H·dini diretti del comandante di corpo d ' armata ' o agli ordini di un solo comandante di divisione, dipenderebbe da una persona sola. Per i d'armata poi, nei quali non si trovasse che un solo reggimento, sarebbe preferibile il conservarlo autonomo piuttosto che porlo alla dipendenza di un comandante di brigata avente stanza in un altro .corpo d'armata.
L'essere ognuno dei reggimenti dei bersaglieri posto in tempo di pace alla dipendenza di un comando di brigata di linea è un esempio dell'applicazione del c1·iterio che l'ordinamento del tempo di pace deve anzitutto corrispondere alle opportunità del tempo di pace.
LA BttiGATA m IL REGGIMENTO .- Venendo ·a considerare più particolarmente l'intima costituzione della fanteria, è tuttora utile seguire il filo della dot.trina napoleonica.
L'unità superiore al battaglione ha. oggi il nome di ?·eggimento. Nel p1·ogetto formulato a Sant'Elena, Napoleone I aveva disegnato di denominarla b?·igatct, rimanendo soppressa l'unità comprendente d.ue reggimenti e conispondente alllodierno nome, quale era esistita durante le campagne na· poleoniche.
« La brigata sarrà composta di tre battaglioni e coman-
« data dal colonnello brigadiere con tre aiutanti di campo,
« cioè un capitano in l 01 incaricato del servizio di stato ·mag-
« gioré, un c.apitano in 2° proveniente dalla cavalleria, in-« caricato del comando degli esploratori, e un tenente. ' c: Un sergente per battaglione sarà addetto allo stato· c maggiore per le scritture e le traduzioni. c: Il colonnello brigadiere a'•rà una. guardia composta di c: no-çe esploratori, fra i quali un tenente, un maresciallo c d'alloggio e un brigadiere, i quali saranno addetti alla c: sua persona e gli faranno servizi d'ordinanza. Gli aiutanti c di campo porteranno sul proprio cavallo i sacchetti di c viveri: saranno armati di una. sciabola e di uu paio di c pistole, che appiedando, porteranno indosso; avranno a c tracolla una borraccia. ed un astuccio contenente un ca-
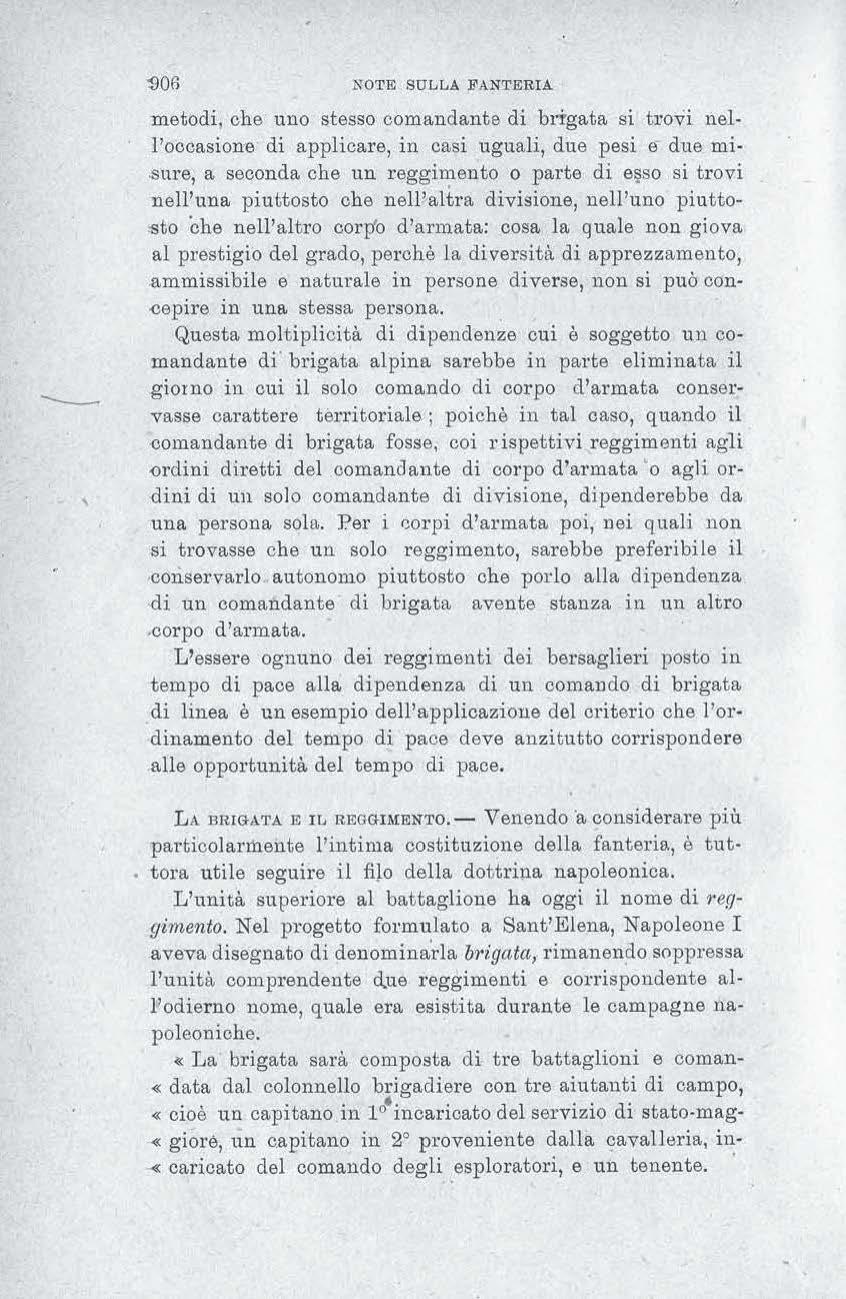
« uoèchiale, la carta l'occon-ente per scrivere e c la tesa (misura metric-a ). c Per il servizio di polizia la brigata avrà un drappello c ùi gendarmeria, composto di un maresciallo, un brigadiere c e tre gendarmi. c La brigata risulteJ.•tì composta di 2898 uomini di fan· c teria, 126 di cavalleria, 36 cannonieri che serviranno 3 c pezzi da 3 libbre, 72 soldati del treno che condurranno c 1·1.1: muli o cavalli da basto, 18 macellai che condurranno c ùa 150 a 200 bestie bovine o l'equivalente in altri ani·
« mali ; totale. 3159 uomini e 310 cavalli da sella appar- e tenenti allo stato -maggiore, agli esploratori e al treno c d'artiglieria. c lJa brigata non avrà. con sè nessuna vettura, eccetto i c: pezzi d'artiglieria e un carro·fucina di battaglione tirat,o
• da1 cavalli; gli altri duo carri-fucina dei battaglioni SR.· c rauno col grosso bagaglio • (1 )
Benchè Napoleone ne avesse divisata la soppreRsione, pnre la brigata., quale esiste oggidi nella maggior parte degli eser·
·citi, è un'eredità. del passato, tramandata a noi attraverso all't·poca napoleonica. Quale ne sia l'organico è noto; che
· essa abbia come principale difetto quello di eRsere in guerra un'unità binaria, è pure noto; basterà quindi, per completarne la conoscenza, prendere in esame ]e funzioni del coman · dante di brigata in tempo di pace.
Il capo VI del nostro regolamento di disciplina (edi'zione 1907) tratta. particolarmente dei doveri del comandante di briga ta. Dopo a-çerne fissata la dipendenza, il regolamento dice: c: Il comandante di brigata ha per ufficio di esercitare
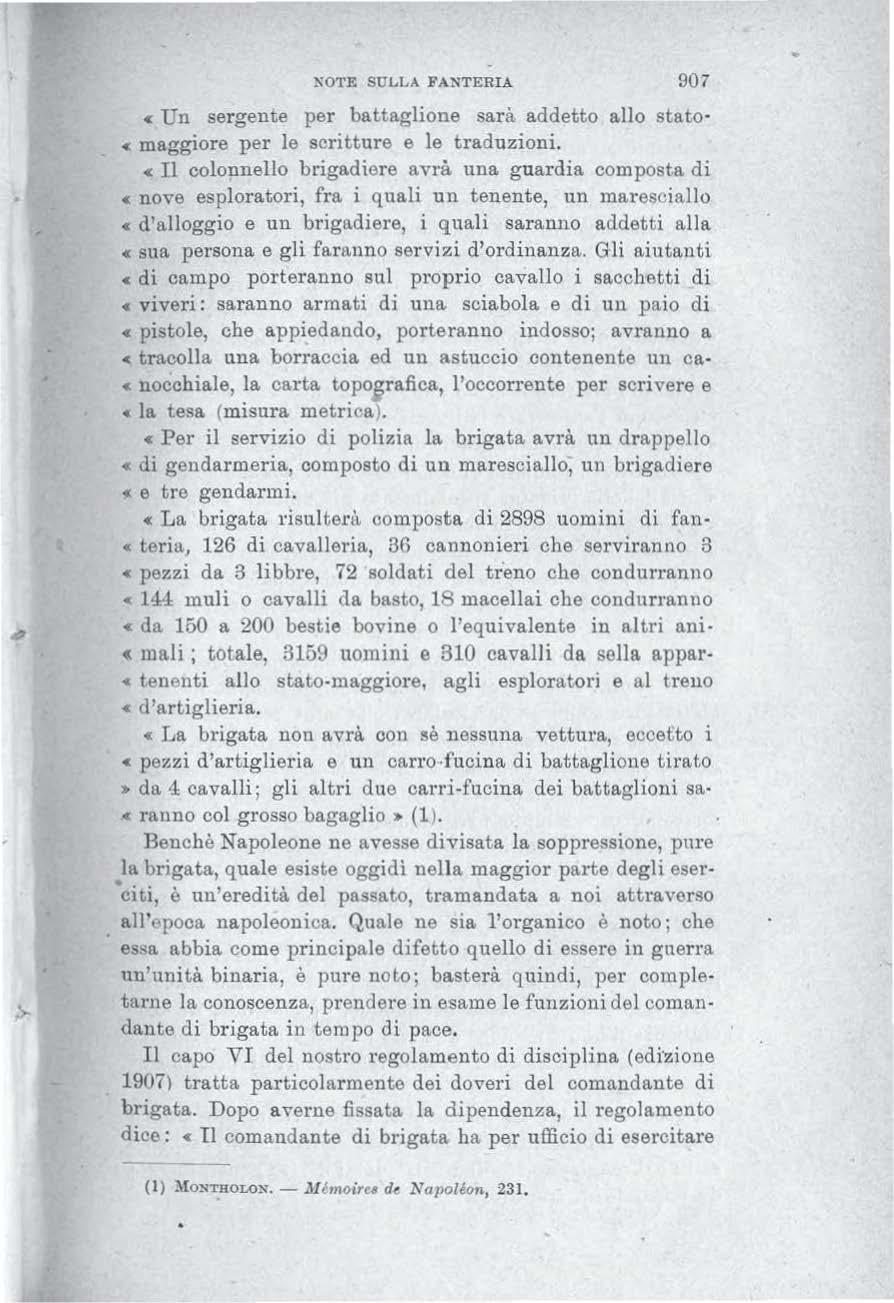
(l) M é moire., de :NapoUo n, 231.
NOTE SULLi FANTERIA
« una continua ed immediata vigilanza sull'istruzione, sulla
« disciplina, sull'amministrazione e sul buon andamento in
« genere d'ogni servizio dei reggimenti della bri gata affidata
« al suo comando . Deve essere oggetto delle sue costant-i cure
« ogni particolare del funzionamento dei reggimenti per
4. poter sovv4'lnire col proprio consiglio i comandanti dei reg-
« gimenti ed anche, se occorra, intervenire a correggere di·
« rettamente le negligenze e gli abusi, a 1;iparare gl'incon-
« venienti e le irregolarità, ad imprimere vigore e buona
« direzione in ogni ramo del servizio, attenendosi però a
« quanto prescrive il n. 93 del regolamento, cioè lasciando a
« ciascuno l'autorità e la libertà d'azione che gli competono
« e che determinano il grado della sua responsabilità, ecc.
« Egli deve stndiarsi di conoscere individualmente gli uf« iìoiali della bdgata, specialmente gli ufficiali superiori e «i capitani; e tutte le volte che gli si offre l'occasione deve
« portare il contributo della propria esperienza e del proprio « sapere per accrescerne la coltura profess ionale».
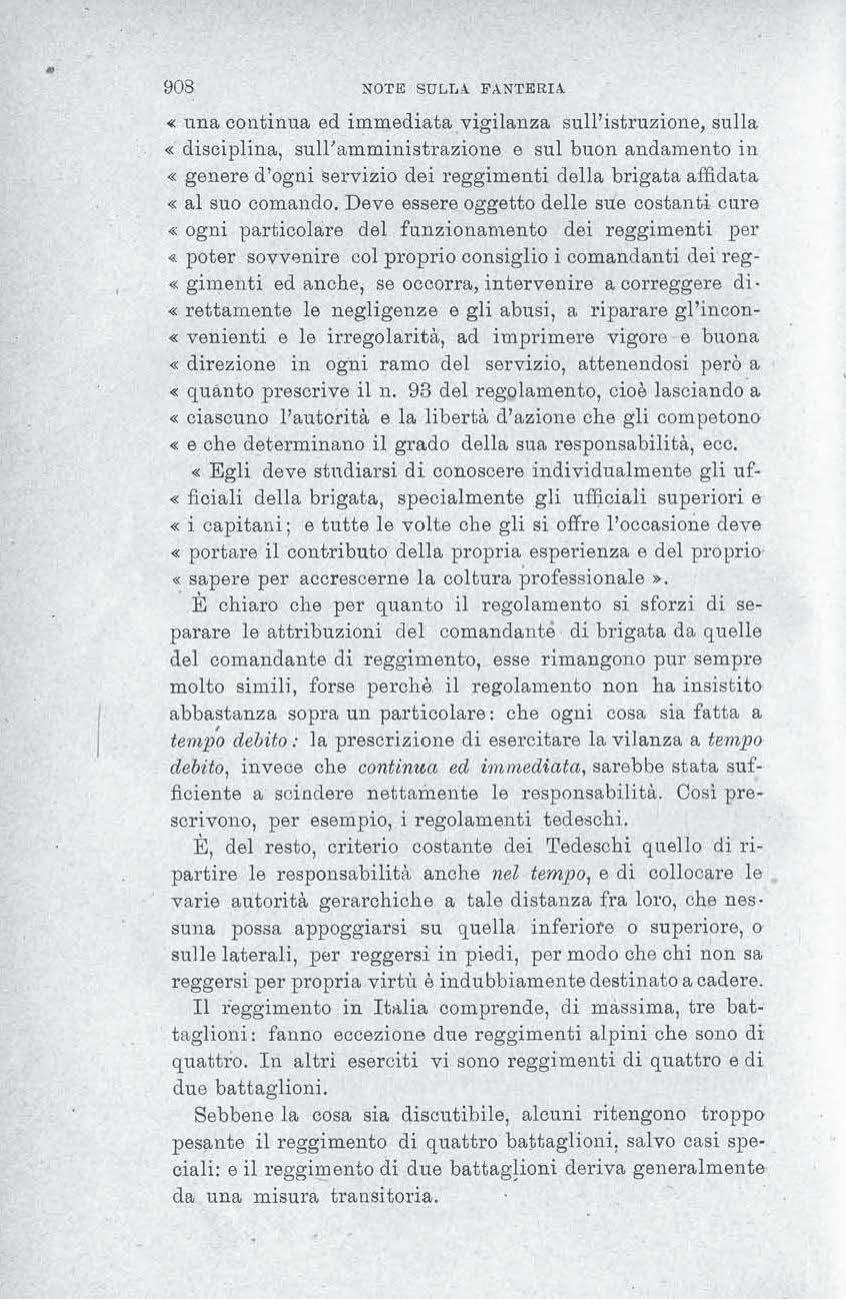
È chiaro che por quan t o il regolamento si sforzi di separare le attribuzioni del comandante di brigata da quelle del comandante di reggiment·o, esse rimangono pnr sempre molto simili, forse perchè il regolaUlenbo non ha insistito abbastanza sopra un che ogni cosa sia fatta a l tempo debito : la prescrizione di esercitare la vilanza a tempo debito, invece che continua ed imlìMdiata, sar e bbe stata sufficiente a scindere nettll.inente le responsabHità. Così prescrivono, per esempio, i regolamenti tedeschi.
È, del resto, criterio c-ostante dei Tedeschi quello di ripartire le responsa.bilitt\ anche nel- tempo, e di collocare le varie autorità gerarchiche a tale distanza fra loro, che nes· suna possa appoggiarsi su q_uella inferiore o superiore, o sulle laterali, par reggersi in pi,edi, per modo ch e chi non sa reggersi per propria virtt\ è indubbiamente destinato a cadere.
Il reggimento in Itll.li!ll. comprende, di massima, tre battaglioni: fanno eccezione due reggimenti alpini che sono di quattro. In altri eserciti vi sono reggimenti di quattro e di due battaglioni.
Sebbene la cosa sia discutibile, alcuni ritengono troppo pesante il reggimento di quattro battaglioni, salvo casi speciali: e il reggimento di due battag!ioni deriva generalmente da una misura transitoria.
Il capo VII del regolamento di disciplina. tratta. dei do· veri dei comandanti di corpo e specifica ampiamente quali es..;i siano, tanto sotto il rispetto della disciplina, quanto sotto quello dell'istruzione e dell'educazione; le attribuzioni amministrative sono nel regolamento di disciplina sologene· ric·amente accennate e a. completarle provvede il regolamento di amministrazione e di contabilità.
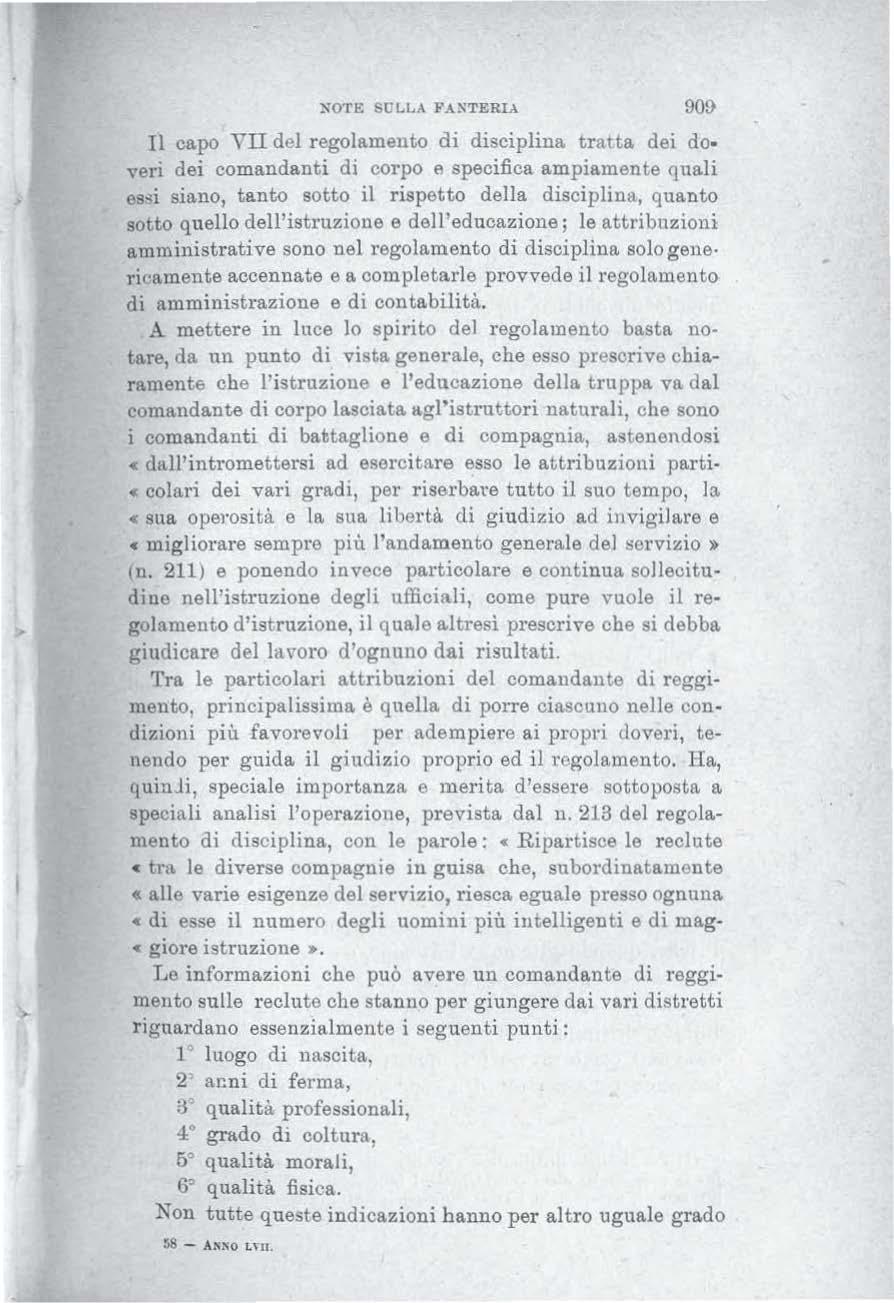
A mettere in luce lo spirito del regolamento basta notare, cla nn punto di vista generale, che esso prescrive chiaramente che l'istruzione e l'educazione della truppa va dal comandante di corpo lasciata agl'istruttori naturali, che sono i comandanti di battaglione e di compagnia, astenendosi c dall'intromettersi ad esercitn.re esso le attribuzioni parti- c sua operosità e la sua liho1·b\. di giudizio ad i11vigilare e c migliorare sempre ph\ l'andamento generale del servizio » t n. 211) e ponendo invece particolare e continua diuc nelFistruzione degli ufficiali, come pure ,·nole il regolamento d'istruzione, il quale altresì ohe si debba giudicare del hworo d'ognuno dai risultati. c di esse il numero degli uomini più intelligenti e di mag- c giore istruzione •.
• colnri dei vari gradi, per riserba\'e tutto il suo tempo, la.
Tra le particolari attribuzioni del comandante di reggimento, principalissima. è quella. di porre cia!->cuno nelle condizi oni più favorevoli per adempiere ai propri <loveri, tenendo per guida il giudizio proprio ed ilrl"golamento. Ha, quin.li, speciale importanza e merita d'essere sottoposta a speciali analisi l'operazioue, prevista dal u 213 del regolamento di clisciplina) con le parole: • RiparLisce le reclute c tnt. le diverse compagnie in guisa che, subordina.tamente « alle varie esigenze del set'vizio, riesca eguale presso ognuna.
Le informazioni che può ave1·e un comandante di reggimento sulle reclute che stanno per giungere dai vari distretti ri guardano essenzialmente i seguenti punti: l luogo di nascita.
2 ar.ni di ferma, a qualità professionali,
4 • grado d1 coltura,
5 qualità. morali,
6" qualità fisica.
Xon tutte queste indicazioni hanno per altro uguale grado
NOTE SOLJ,A. FANTERIA
di certezza ; di esse poi talune hanno importanza principale, altre importanza seconda1·ia.
Il dist1·etto eli pt•ovenienza e gli anni di (e1·rna sono dati di fatto, che non si possono trascurare nell'assegnazione delle reclute ai vari reparti. Il mescolare tra le varie compagni& glì uomini dei vari distretti e pel comandante del reggimento un obbligo dipendente dal sistema. di reclutameHto vigente presso di noi; il tener conto degli anni di ferma è pure una necessità, per ragioni ovvie. Potranno solo variare le modalità seguite per tener conto di questi elementi.
Le qttalitlt p1•o(essionali hanno ptu·e grande importanza, specialmente per talune armi e specialità (sovra tutto per l'artiglieria e per il genio); limi.tandooi qui a considerare il caso della fanteria, l'importanza di questo elemento vien e limitata e dallo scopo che si vuo l e conseguire, e dalla maggiore o minore attendibilità. dell'informazione avtlta s11 ciascun individuo. Queste due considerazioni consigliano di 110n ricercare distinzioni troppo sottili, clte non sarebbero pratiche , e di attenersi invece a distinzioni abbastanza genet·iche, da rendere difficili o di poco rilievo gli errori.
Gioverù. anzj qui ricordare quanto prescrive il n Ul del regolamento d'istruzione (edizione 1907): «Nell'interesse del < servizio, è pure necessario promuovere l'istruzione di quei <so l dati e caporali, i quali abbiano le qualità. militari per « consegnire rispettivamente il grado di caporale e di ca· < pora1 maggiore, ma difettino delle cognizioni che per tali gradi sono necessarie ".
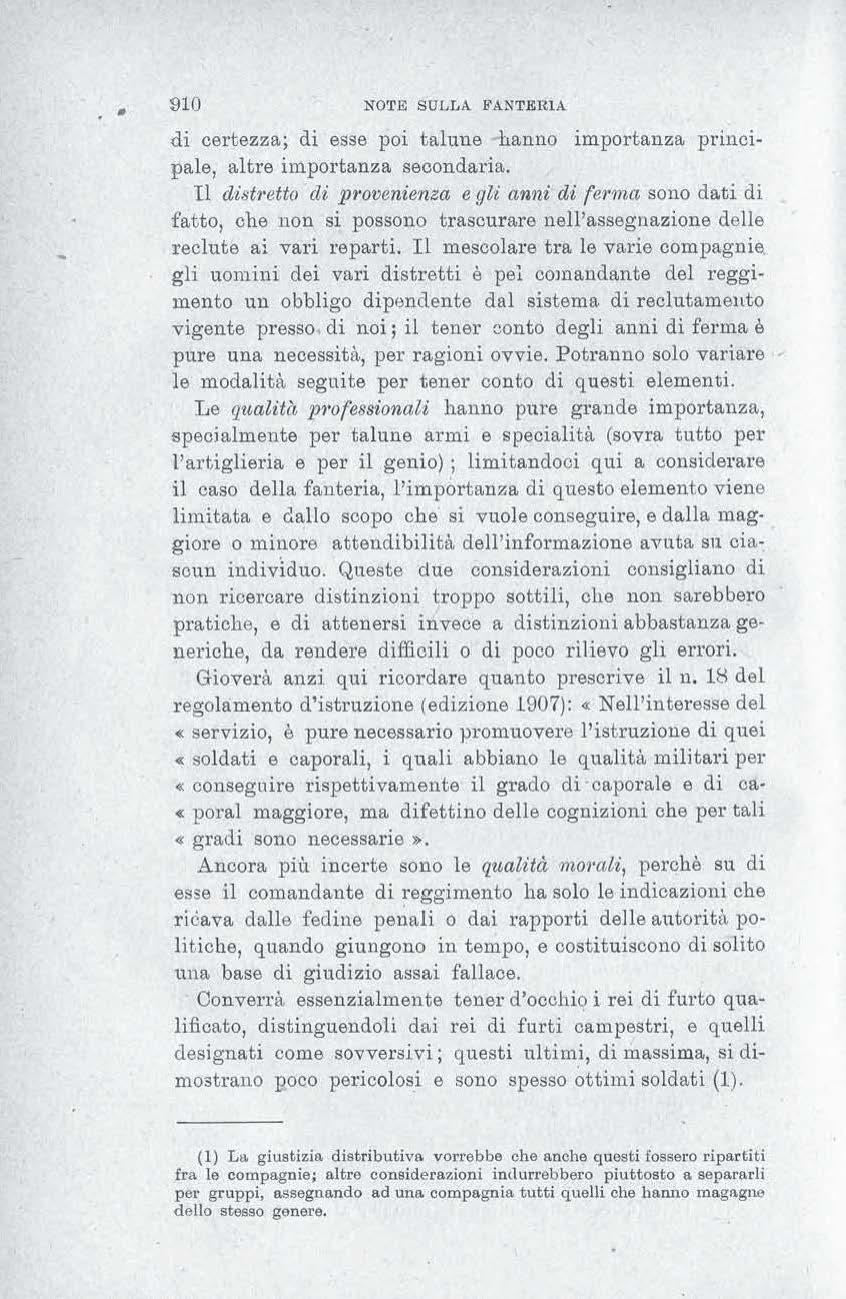
Ancora più. incerte sono le qttaUtà -mo1·ati, pe.rchè su di esse il comandante di reggimento ha solo le indicazioni che ricava dalle fedine penali o dai rapporti delle autorità politiche, quando giungono in tempo, e costituiscono di solito una base di giudizio assai fallace.
Converrà essenzialmente tener d'occhiq i rei di furto qualificato, distinguendoli dai rei di furti campestri, e quelli designati come sovvers1v1; questi ultimi, di massima, si dimostrano poco pericolosi e sono spesso ottimi soldati (1).
(l) La giustizia distributiva vorrebbe che anche questi fosse1 o ripartiti fra le compagnie; altre considerazioni indurrebbero piuttosto a separarlì pel' gruppi, assegnando ad una compagnia tutti quelli che banno magagne dello stesso genere.
\ engono infine le qualità fisiche; ma anche riguardo a queste, è difficile avere una giusta idea complessiva del valore di ciascun individuo; basta, per convincersene, notare i ragguardevoli cambiamenti che fauno taluni dopo qualche mese che sono alle armi. Anche la misura toracica non dà un criterio esatto, perchè andrebbe combinata con altri ele· menti: e soltanto la statura può essere presa in considera· zione, per l'inconveniente che può derivare dal mettere accanto, in uno stesso reparto, individui molto alti e molto piccoli.
Le informazioni concernenti i punti indicati possono essere fornite da ciascun ufficiale, inviato a prendere le re· clute in un distretto, mediante una tabella conforme al seguente modello, nel quale è tenuto conto contemporaneamente delle suddivisioni naturali che emergono dalla situazione degli individui nella vita civile e di quelle altre che occorrerà di per gli interessi derivanti dalla vita militare: suddivisioni, come si vede, abbastanza larghe, da trascurare quelle sfumature che sono facilmente causa di errore.