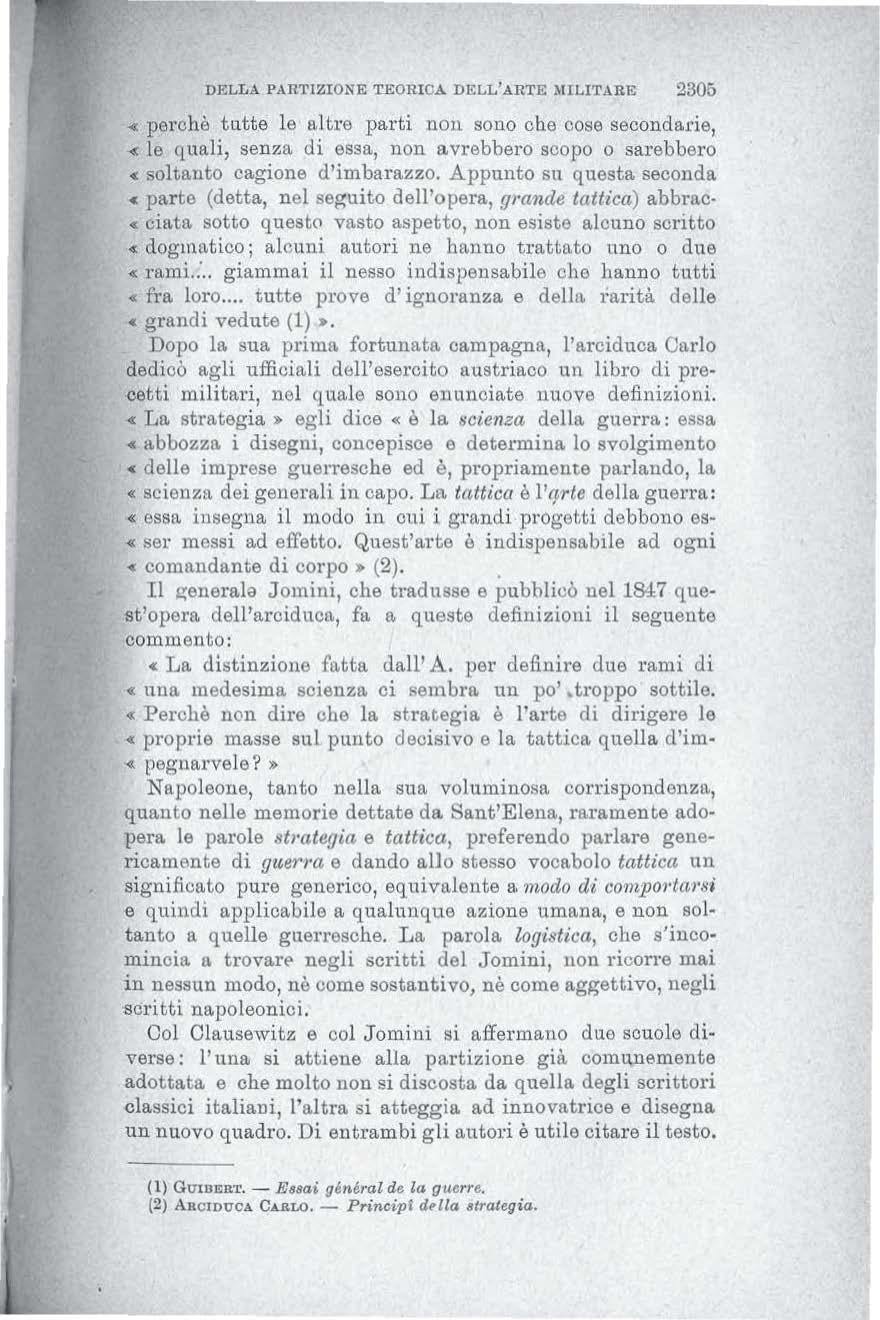
19 minute read
DELLA PARTIZIONE TEORICA DELL'ARTE MILITARE 2305
< perchè tutte le a l tre parti non sono che cose secondarie,
< le quali, senza di essa, non avrebbero scopo o sarebbero c soltanto cagione d'imbarazzo. Appunto su questa seconda c parte (detta, nel seguito dell'opera, grande tattica) abbrac- c ciata sotto questo vasto aspetto, non esisto alcuno scritto c dogmatico; alcuni autori ne hanno trattato uno o due c rami..".. giammai il nesso indispensabile cho hanno tutti c fra loro .... tutte prove d'ignoranza e della rarità delle c grandi vedute (l} :..
Advertisement
Dopo la sua prima fortunata campagna, l'arciduca Carlo dedicò agli ufficiali dell'esercito austriaco un libro eli precetti militari, nel quale sono enunciate nuove definizioni. c La strategia » egli dice « è la scienza della guerra: essa c abbozza i disegni, concepisce e dete1·mina lo svolgimento c delle imprese guetTesche eù è, propriamente parlando, la « scienza dei generali in capo. La tattica è l'qrte della guerra: c essa insegna il modo in cui i grandi debbono es- c ser messi ad eil'etto. Quest'art.o è indispensabile a.d ogni
« comandante di corpo » (2).
Il generala Jomini, che tradusse e pubblicò nel18-!7 q uest'opcra dell'arcidnco., fa a questo definizioni il seguente commento:
< La distinzione fatta ùa.ll' A. per definire ùue rami ùi « una medesima scienza oi sembra nn po' troppo sottile.
« Perchè non dire che la strategia è l'arte di dirigere le «proprie masse sul punto deoie>ivo e la tattictt quella d'impegnarvele? » n Olausewitz (1832), le opere del quale, come è noto, sono postume, non avendo egli creduto, mentre era in vita, che i p r opri scritti avessero raggiunto quel grado di perfezione cui egli avrebbe asp i rato, dice :
Napoleone, tanto nella sua voluminosa corrispondonzu., quanto nelle memorie dettate da Sant'Elena, raramenLe adopera le parole IJtrategia e tattica, preferendo pa.dare genericamante di gtterl'tt e dando allo stesso vocabolo tatticlt un si gnificato pure generico, equivalente a. modo d·i e quinch applicabile a qualunque azione umana, e non soltanto a quelle guerresche. La parola che s'incomincia a trovart- negli scritti del Jomini, non ricorre mai in nessun modo, nò come sostantivo, nè come aggettivo, negli scritti napoleonici .
Col Clausewitz e col Jomini si affermano duo scuole diverse: l'una si attiene alla partizione già adottata e che molto non si discosta da quella. degli scritt01·i classici italiani, l'altra si atteggia ad innovatnce e disegna un nuovo quadro Di entrambi gli autori è utile citare il testo.
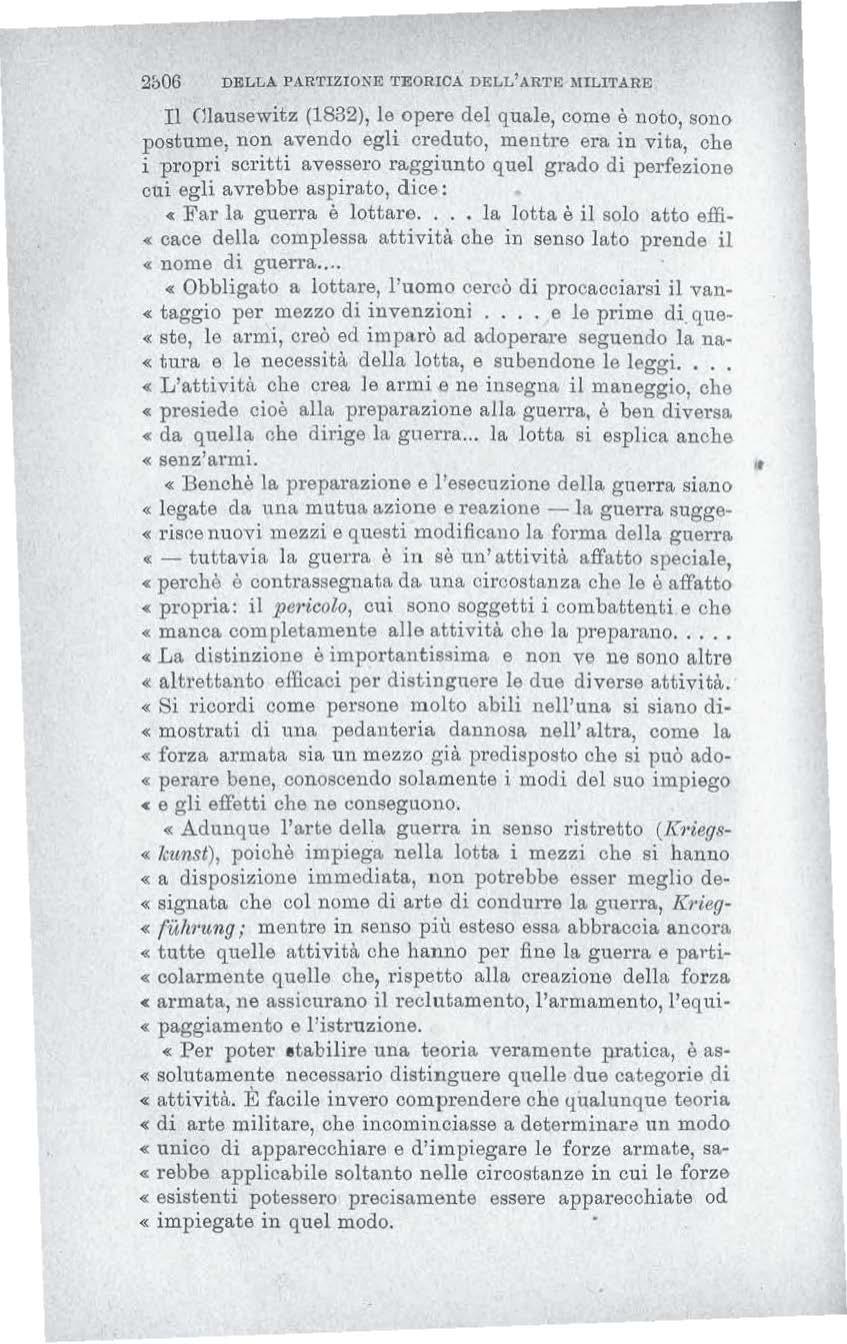
« Far la guerra è lottare . . . . la lotta è il solo atto e:ffic cace della complessa attività che in senso lato prende il « nome di guerra....
« Obbligato a lottare, l'uomo cercò di pro cacciarsi il vane taggio per mezzo di invenzioni .... e le prime di que« ste, le armi, creò ed imparò ad adoperare seguendo lana« tura e le necessità della lotta, e subendone le leggi .•..
« L'attivith. che crea l e armi e ne iusegna il maneggio, ch e c presiede cioè alla preparazione alla guetTa, è ben divers a c da quelJa che dirige la guerra ... la lotta si esplica anch e
« senz'armi. "
« Benchè la preparazione e l'esecuzione della gue r ra siano
« l egate da nna mutua azione e reazione - la gnena sugge-
« rlscenuovi mezzi e questi modificano la. forma della guerra
« - tuttavia la guerra ò i u sè un'attività affntto speciale, c perch ò ò contrassegnata da. una circostanza che le è affatto
« propria: il pe1·icolo, cui soggetti i combattenti e che c: La distinzione è importa.ntis!'lima e non. ve ne sono altre
« manca completamente alle attività che l a preparano . . ...
« a l trettanto e fU caci per distingn ere le due d i verse attività .
«Si ricordi come perflone molto abili nell'una si siano di -
« mostrati di nua pedanteria dannosa nell'altra, come la
« forza armata sia u n mozzo già. predisposto che si può ado -
« perare bene, conoscendo solamente i modi del suo impiego c e gli effetti che ne conseguono.
«Adunque l'arte della gnarra in senso ristretto (l(?·iegs-
« kttnst ), poi chè impiega nella lotta i mezzi che si h anno
« a disposizione immediata, n on potrebbe esser meglio de -
« signata che co l nome di arte di condmTo la gnerra , Krieg -
« (u lmtng; mentre i n senso pit\ esteso essa abbraccia ancora
« tutte quelle attivit:\ c h e hanno por fine l a guerra e pa.l'ti-
« co l a.rmente quelle che, rispetto alla creazione de ll a fo r za
« armata, ne assicurano il recl u tamento, l 'armamento, l'equi-
« paggiamento e l'istruzione.
« Per p oter etabi l ire una teoria veramente pratica, è as-
« solutamente necessario distingnere quelle dna categorie di
< att i vità. È facile in ver o comprendere che qualunque teoria c: di arte militare, che incominciasse a determinare un modo
« unico di apparecchiare e d'impiega r e l e forze armate, sa-
« rebbe applicabile soltanto ne ll e circostanze i n cui l e forze
« esistenti potessero precisamente essere apparecchiate od
« i mpiegate i n q u el modo.
DELLA PARTIZIONE TEORICA DELL'ARTE mLirARE 2307
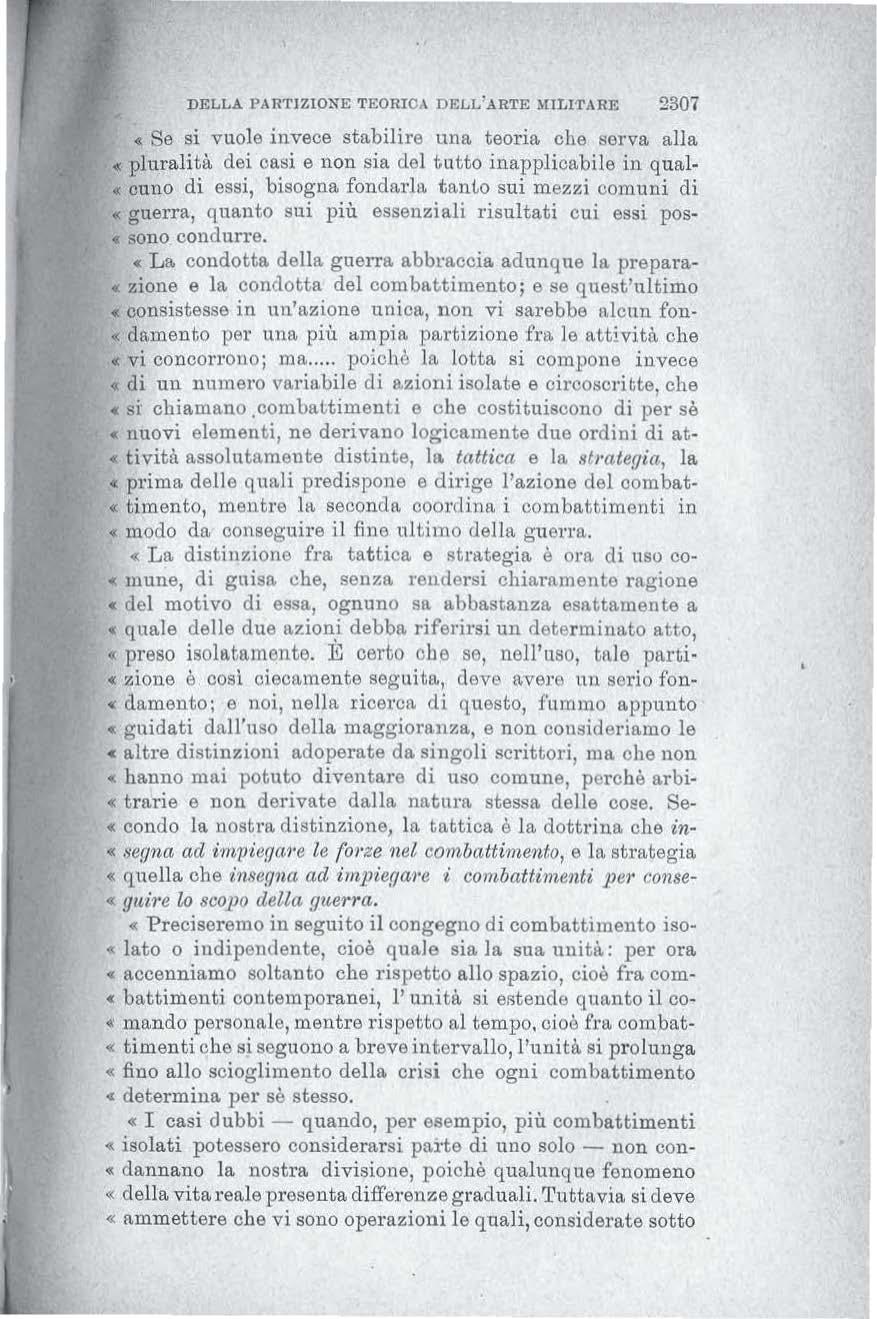
Se si vuole invece stabilire una teoria che sorva alla
« pluralità dei e non sia del t.utto inapplicabile in qua l-
« cuno di essi, bisogna fondarla tan(,o sui mezzi comuni di «guerra, quanto sui più essenziali risultati cui essi pos -
• sono condurre.
«La. condotta della guerra abbraccia adunque la prepara-
« zione e la condotta del combattimento; e se quest'ultimo
«consistesse in un'azione unica, non vi sarebbe alctm fon·
« damento pet· una più l:l!mpi.a partizione fra. le at.bività che
« vi concorroHo; ma ..... po;0h ò la lotta si compone invece
" di un numero variabile di azioni isolate e circoscritte, che
«sì chiamano .combattimenti o che costituis00uo di per sè
.. nuovi elementi, ne derivano logicamente due ordini di at-
« ti vità assoltttn.moute distinte, la tc,ttica e la .9tJ·ateoia, la
._ prima. dello quali predispone e dirige l'azione del combat-
« timento, mentre seconda coorcli11a i combattimeuti in
« modo da conseguire il fine ulLimo della guerra.
« La distinzion e fra tattica e strategia è ora di uso co-
"' mune, di guisa che, se nza roud orsi chiammenlo ragione c clel motivo di essa, ognuno sa abbastanza csn.ttamente a
• quale ùelle due l\7.Ìon_i debba riferirsi un det e rminato atto,
., preso isolatamente. E certo obe 1:10, nell'uso, tt\le pa.rti ·
« zione è cosl ciecamente seguita, dove twe1·o nn serio fon- c damento; o noi, nella ricerca di questo, fummo appunto
« gl\idati dnll'nHo della. maggiomuza, e non consicleriamo le
«altre distinzioni adoperate da. si1lgoli scrittori, ma che non
« hanno mai potuto diventare di uso comune, p erchè arbi-
• trarie e non derivate dalla natura stessa del le cose. Se-
« condo la 11ostrn. distinzione, la tattica. ò la dottrina che in-
« segna acl Ùlìpie(Jcwe le (ol'ze nel e la strategia
« quella che acl impiegare i combattimenti pe1· conse-
« ynire lo scopo clella guen·a
« 'Preciseremo in seguito il congegno di combattimento iso-
« lato o indipendente, cioè quale sia la sua unità: per ora
• accenniamo soltanto che rispetto allo spazio, cioè fra com-
« batti:rtl.enti contemporanei, l'unità si estende quanto il co-
« mando personale, mentre rispetto al tempo. cioè fra combat-
« timenti che si soguono a breve intervallo, l'unità si p r olunga
« fino allo scioglimento della. crisi che ogni combattimento
<1: determina. per sè stesso.
«I casi dubbi - quando, per esempio, più combattimenti
« isolati potessero considerarsi parte di uno solo - non con-
« dannano la nostra divisione, poichè qualunque fonomeno
« della vita reale presenta differenze grad uali. Tuttavia si deve
« ammettere che vi sono operazioni le qnali, considerate sotto
« m1 certo ap p artengono tanto alla tattica quanto
« alla strategia., come sarebbero talune posizioni così estese da
« assomigliare a. schieramenti di corpi isolati, talvolta le di- c: sposizioni preliminari per il passaggio di un fiume ecc. ecc. c Dividiamo l'arte militare in tattica e strategia, tenendo
< conto soltanto dell'impiego delle forze, poichè le molte 11.ltre
« attività che contribuiscono agli atti guerreschi, avvicinan-
« dosi più o meno allo.. tatcica ealla strategia, sono estran ee
«a quell'impiego: sono le ai.tività che hanno per fine il ma n-
« lìeuimento e la conservazione delle forze. Si comprende fa-
« ci lmente che, se occorre ree luta re ed istruire le truppe prima
« d'impiegarle, è assolutamente necessario provvedere ai loro
« bisogni durante l'impiego; e si comprende che tutti i prov-
« vedi menti necessari devono rigorosamente essere considerati
« q ualo preparazione alla lotta, ma solo in q nanto essi si av-
« vioinano molto all'i m piego forze o si alternano costan-
« te monte con questo durante lo svo l gersi della guerra. Sic-
« come il primo c ompito di ogni teoria è di separare fra loro
«gli eterogenei, si ba. duuque un motivo di 3eparare, come
« si fa per tutte le attività che preparano l'esercito, anche
• q nelle occorrenti a.l mantenimento delle truppe dalla con-
« dottn propriamente eletta dell a guena, vale a dire dall' arl.e
« della guorra considerata. nel suo stretto significato; neAstmo
« penserebbe, infatti, a ritener parte della condotta della c guerra tutta la l unga litania dci rli vettovagliamento
« e di amm i nistrazione, poicbb, pur essendo in reciproca re·
« lar.ioue di cause ed effetti con l 'impiego delle bruppe, essi "ne sono essenzialmente diversi, (1).
Il Clausewil;z prosegue distinguendo le attività cho si identificano con la lotta :)tessa e quelle che mirano escluMivamente alla conservazione delle forze; osserva che le marci e, gli accantonamenti e gli accampamenti fanno parte delle p rime, poichè contemplano atti che lasciano sempre presupporre l'idea del combattimento, mentre al contrario i servizi delle sussistenze e di il rifornimento delle armi e dell'equipaggiamento sono attività che si occupano soltanto de ll a conservazione de ll e forze. L a marcia par ticolarmente, astrazione fa.tta dal combattimento, è un mezzo strategico e non soltanto un obbietto d ella strategia; ma siccome le truppe che l a eseguiscono devono in ogni istante essere in g rado di poter combattere, l a. sua esec u zione va soggetta alle leggi della tattica non meno che a quelle della strategia. Qu est a , de l r esto, anche a 1l01·quanuo si propone come scopo plinoipale la conservazione dello strumento che deve adoperar e, non esce dal proprio campo, che è quello d'impiegare l e forze; le attività part1colari che a ciò mirano, l 'uso speciale dei mezzi a ciò destinati escono dal campo della pura arte militare, perchè le conoscenze tecniche e le abilità necessarie debbono nell'esercito quando si insegna alle truppe a combattere.
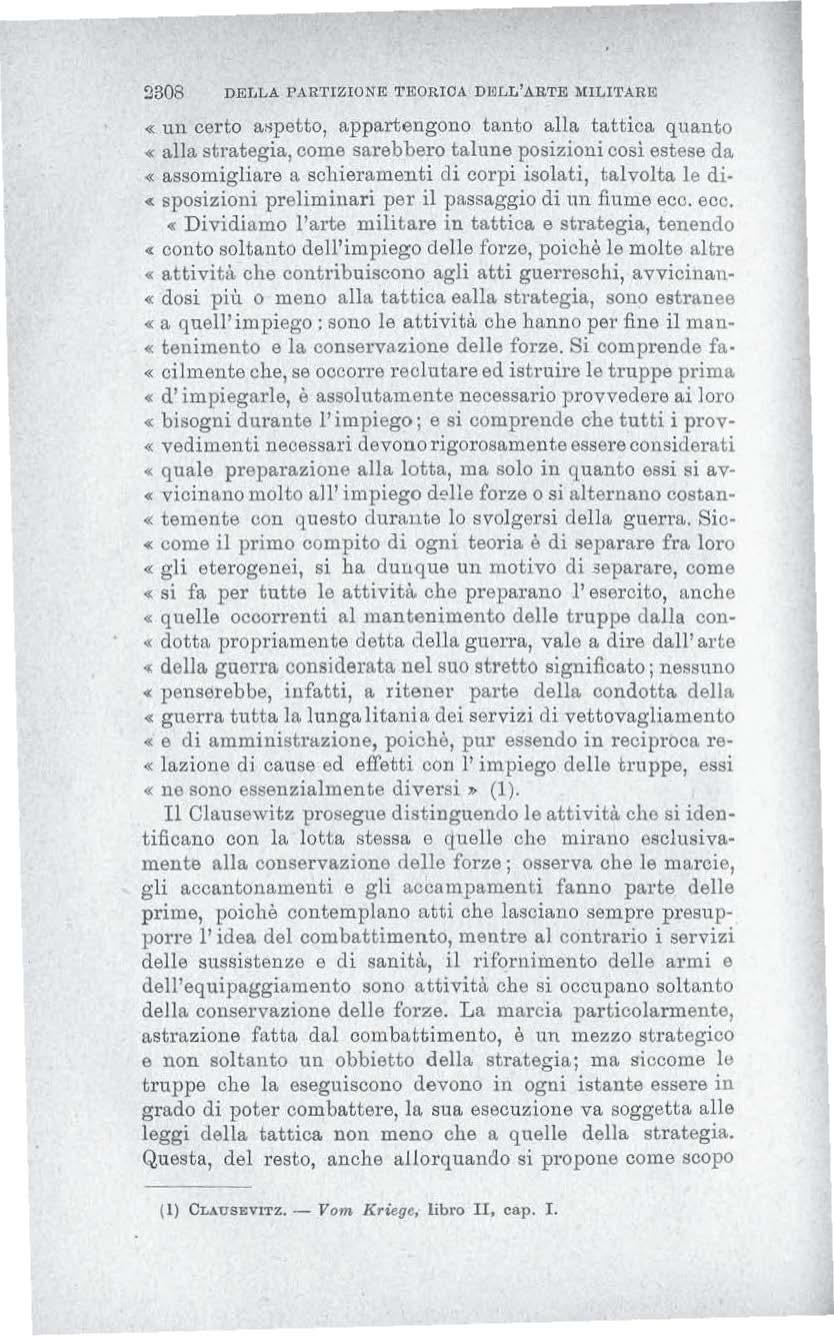
Il Cl ausewitz n cl udo: « Emerge dalle considerazioni -< esposte che le attività alla guerra si dividono c in due grandi rami, quelle che preparano l'azione e quelle " che si esplicano nella guerra stessa; partizione alla quale « deve piegarsi anche la teoria.
«Le conoscenze e le abilità necessarie alla preparazione si c occupano di creare, istruire e mantenere le forze armate, c qualunque sia \.1 nome generico sotto il quale si vogliano « comprendere: vi appartengono 1' artiglieria, l'arte della «fortificazione, la cosicletta tattica elementare, tntta l'or« p;auizzaziona e l'amministrazione della forza armata e si« mili. La teoria della guerra, che si occupa dell'impiego dei « mezzi così apprestati per i suoi scopi abbisogna soltanto
«dei risultat.i ùi quello attiviL}i., o precisameute del.la cono- c Questa chiamiamo noi m·te della guer,·a, nello stretto si-
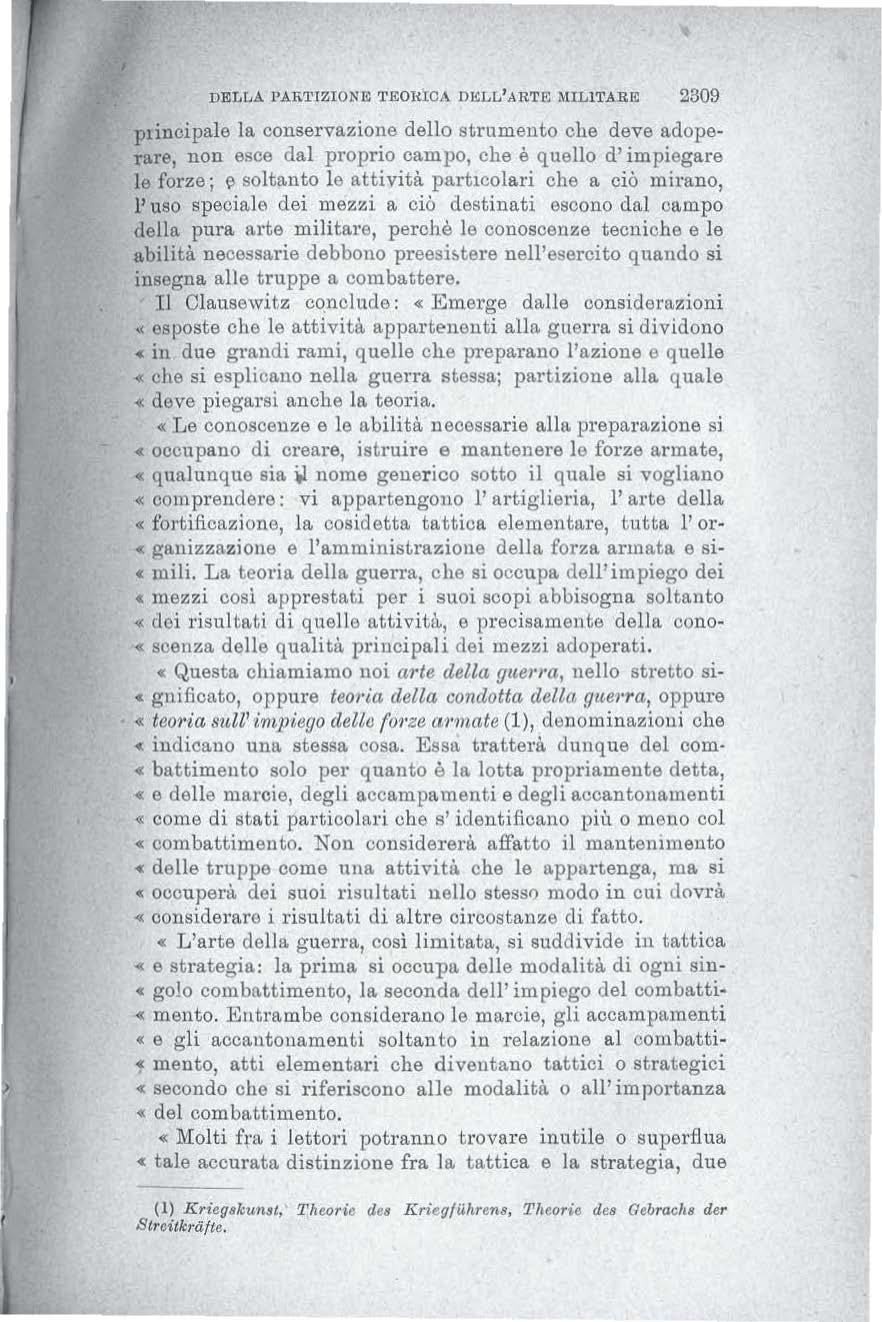
« scenza delle qualità. priucipali dei mezzi adoperati .
« gniDcato, oppure teoria della condotta della gtterra, oppure
« teo1·ia sull'impiego dette (o1·ze a.l·mate (1), dtJnominazioni che c indicano una stessa. cosa. Essa tratterà dunque del com·
« battimento solo per quanto è la lotta propriamente detta,
«e delle maroie, degli accampamenti e degli accantonamenti
« come di stati particolari che a' identi.fìca.no piu o meno col
« combat.timento. Non conside1·erà affatto il ma.utemmento
« delle trnppe come una attività che le appartenga, ma si c dei suoi risultati nello stesso modo in cui (lovrà
'((considerare i risultati ui altre circostanze di fatto.
« L'arte della. guerra, così limitata, si suddivide in tattica
..: e strategia: la prima. si occupa delle modalità. di ogni sin -
« go1o combattimento, la seconda dell' del combatti-
« mento . Entrambe cons i derano le marcia, gli accampamenti
« e gli accantonamenti so l tanto in relazione al combatti - c mento, atti elementari che diventano tattici o strategici
« secondo che si riferiscono alle modalità o all'importanza
« del com battimento.
« Molti fra i lettori potranno trovare inutile o superflua
« tale accurata distinzione fra la tattica e la strategia, due
« cose tanto vicine l' tmn all'altra nel campo dell' azionet
« perohè essa non esercita alcuna influenza immediata sulla
« condotta della gnel'l'a: sarebbe di certo un gran pedante chi cercasse sul campo di battaglia gli effetti immediati di c tale distinzione teorica .
« :tlfa. poichè il primo dove1·e di ogni teoria è di chiarire e
« di coordinare i concetti e la loro rappresentazione, spesso
« confusi e anche tra loro, non si può sperare
« di poter procedere, con faoilih\ e chiarezza, nel suo svo1-
« gimento a.Uorchè manca la. certezza di aver collocato illet-
« tore nel voluto punto di vista e quando manca l'accordo c sui nomi da adoperare e sul concetto <•h e q neslii ra.ppre-
« sentano. La taf,ticn. e la strategia, bencbè siano attività es-
« sen:t.ia1mento diverse, hanno molti addentellati nello spn.zio
«e nel tempo e le loro leggi ed i loro reciproci rapporti non
«possono fttcilmente essere pensati e compresi senza preci-
« sarne il conl'et.to con tutta la possibile el3attezza c Il non ammottere quel dovere del metodo significa c'be c si rinunzia a qualunque considera.zioue teorica, oppure che c non si è mai osservato come la mancanza di una tale ana-
« lisi preliminare sui concetti confusi condnca a conolnsioni
« fn.ntastiche, a generalità. vnote di senso, como quelle ohe
« tanto frequentemente si ò di udire e di leg-
« gere » (1).
11 generale Jomini (1837), dott1·inario per eccellenza., così si esprime:
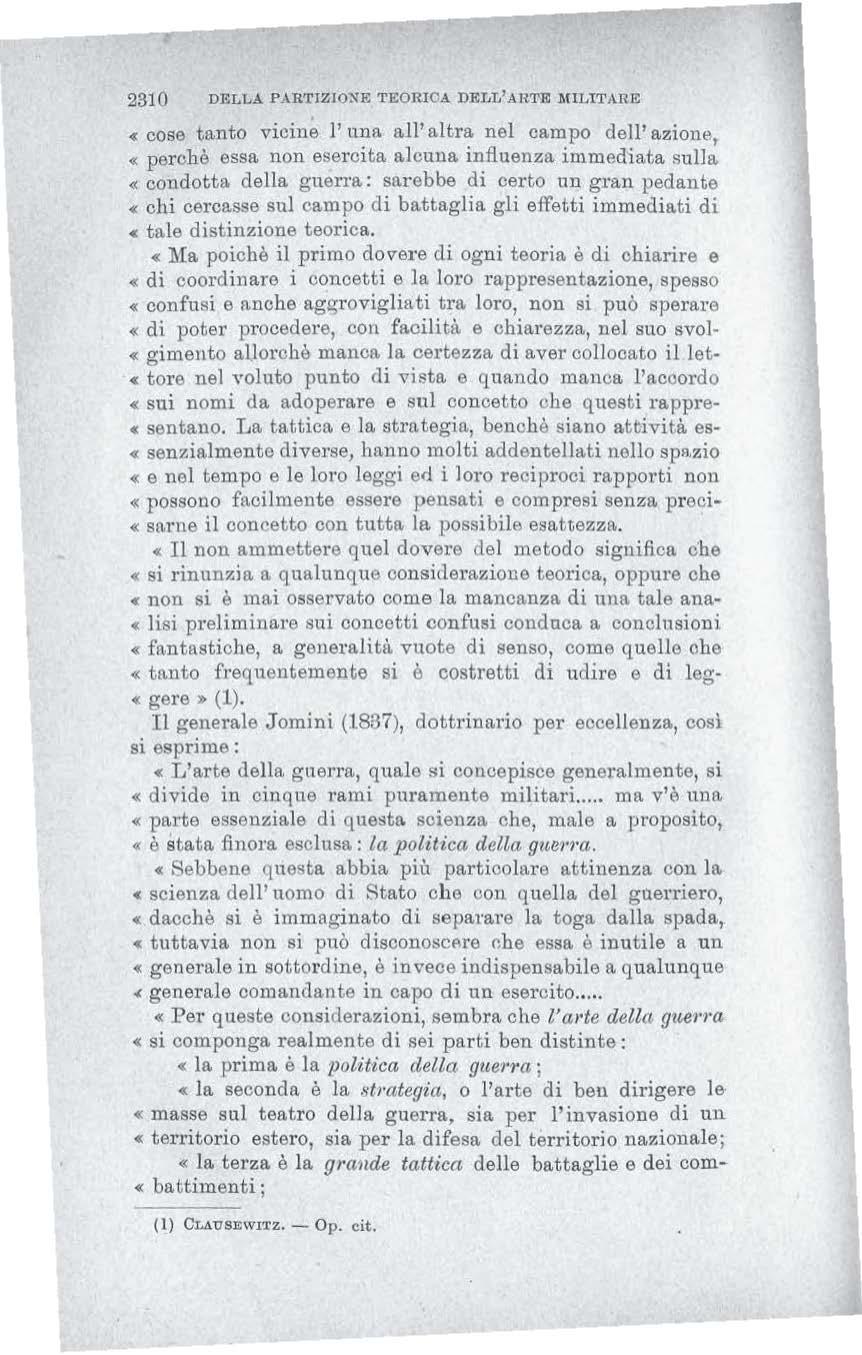
« T/arte <lella. guerra, qualo si concepisce generalmente, si «divide in cinque rami puramente militari..... ma v'à uno.
«parte essenziale di questa scienza che, male a proposito,
« è stata finora esclusa: ta politica della gwm·a.
« Rebbene qne'lta abbia più particolare attinenza con la « scienza dell'uomo di Stato ch e con quella del gùerriero, c dacchè si è immaginato di sepa1·are la toga dalla spada.,
« tuttavia non si può disconoscMe rhe essa è inutile a un « generale in sottordine, è in vece indispensabile a qualunque "generale comandante in capo di un esercito ... ..
« Per queste considerazioni, sembra che l' al' te
« si componga realmente di sei parti ben distinte: c la prima è la politica della gtte1'1'a ;
« la seconda è la .Ytrategia, o l'arte di ben dirigere le
« masse sul teatro della guerra, sia per l'invasione di un c territorio estero, sia. per la difesa del territorio nazionale;
« la terza. è l a grande tattica. delle battaglie e dei com« battimenti; quarta è la logù;tica, o l'applicazione pratica rli c muovere gli eserciti;
(l) CLAUSEWr:rz. - Op. cit.
<< la quinta è l' a?·te dell' ingegne1·e, l' attacco e la difesa
« tlelZe (01·tezze ;
« la sesta è la tattica spicciolOt (de détail)
« Vi si potrebbe anche aggiungere la filosofia o la pa1·te
« mo'l'ate della guerra; ma sembra più conveniente riunirla
« in un solo tronco con la politica.
«Noi ci proponiamo di analizzare le principali combina« zioni delle prime quattro parti, non avendo punto lo scopo c di trattare della tattica spicciola, nè dell'arte dell' inge« gnere, che forma scienza a parte.
« Ber essere un buon ufficiale di fanteria., di cavalleria e « ù'arbiglieria è inutile conoscere tutte queste parti uguale mente beM; ma per diventare genemle od ufficiale di stato· « maggiore di merito, questa cognizione è indispellsa« bile..... » (l ) ·
La dottrina dello Jomini fu introdotta in Italia allorchè con l'instituzione della scuola di guerra si dette Ull nuovo indhizzo e un nuovo impulso agli studi militari. Il Ricci prima, il Marselli poi, e così i loro successori fino al1900, divulgarono quella teoria più o me110 modificata e concorsero a farne la base dei programmi d 'insegnamento delle scuole militari, sebbene pochi anni prima dell'opera del Ricèi fosse apparsa qnella del Deoristoforis, il quale si era mantenuto fedele alla dottrina del Olawsewitz e dei suoi predecessori, dando dell'arte militare la seguente partizione:
« Se lo scopo della guerra è la vittoria e questa, è
« dalla massa più forte, la st1·ategia, che sceglie il luogo più
« conveniente alla lotta, sarà: l ' a1·te di condw·1•e i·n massa
« t'ese1·cito non combattente sut punto decisivo. La tattica in-
« vece, la quale manovra le truppe dell'offesa a fine
.: di urtare la linea del nemico nel pòsto più conveniente,
« sarà : t' a1·te di cond-zwre in massa t' ese1·cito combattente sul
« punto decisivo » (2).
Agostino Ricci (1863) dice :
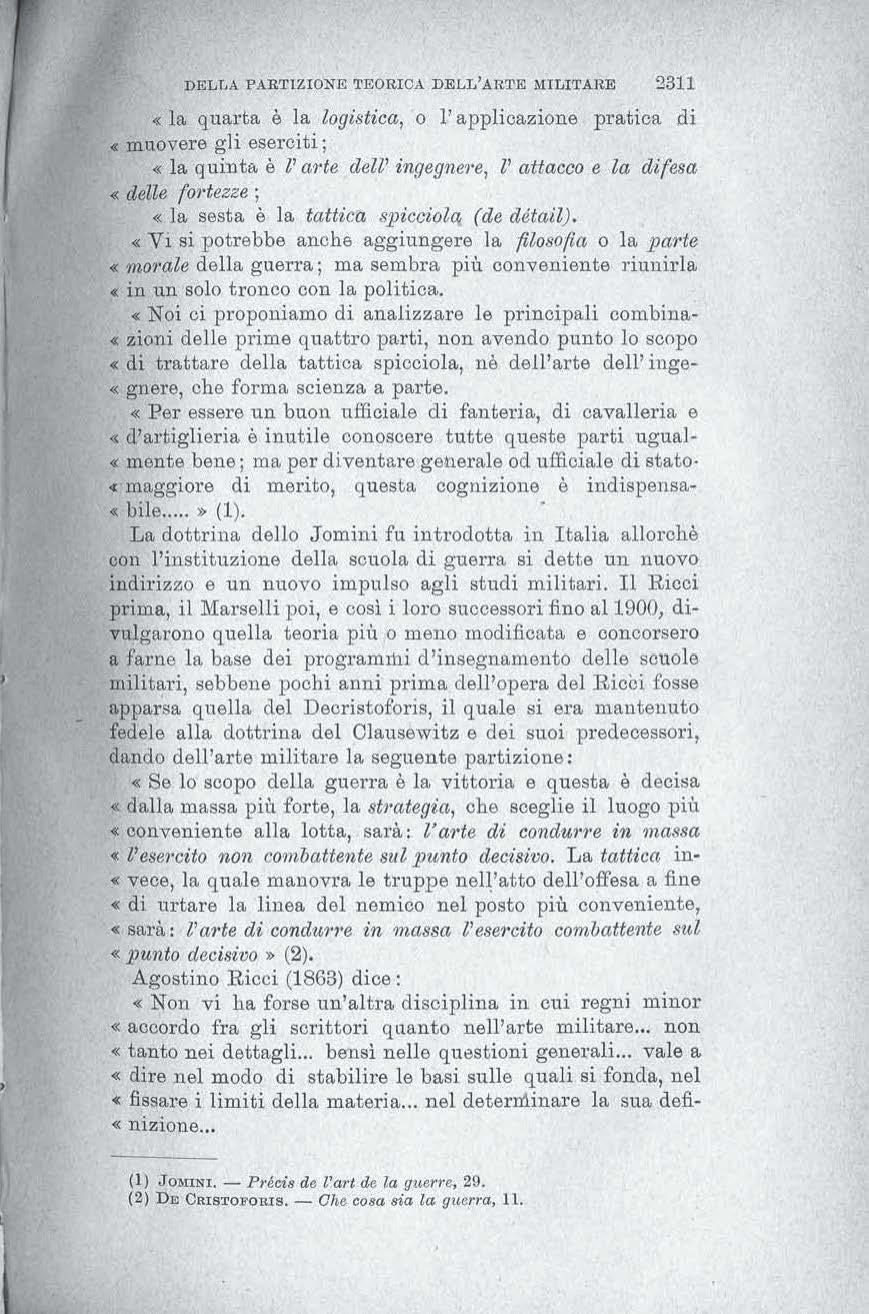
«Non -vi ha forse un'altra disciplina in cui regni minor
« accordo fra. gli scrittori quanto nell'arte militare ... non
« tanto nei dettagli ... bensì nelle questioni generali ... va l e a
« dire nel modo di stabilire le basi sulle quali si fonda, nel
<fissare i limiti della materia... nel deterniinru:e la sua defi-
« nizione...
( l ) JO!IIINJ.- Précis de l'art de la guel'n, 29.
(2) Dm CarSTOFORIS. - Ohe. cosa sia la guerra, 11.
In fatto di arte militare non si tratta più oggidì di creare, « ma solamente di ordinare, poichè anche le idee più nuove
« (non quelle relaLive alle questioni tecniche), o che almeno
« sono tenute per tali, con un po' di pazienza. si scoprono fa« cilmente rivangando i tanti scritti che tralitano della ma.-
< teria, anche talora in quelli più nascosti dalla polvere delle c :Ma se la materia abbonda, manca da noi di altrettanto « la forma, un buon sistema generale che la com« prenda, manca in una sola parola l'unità nell'insegnamento
« biblioteche militari.
« officiale, ciò cbo è bou diverso dall'esl:lere del tutto igno-
« l'ata ...
«L'arte militw·e, considerata nel campo scientifico, è la « esposizione dei pl'incipii coi quali si devono o,·gan'izzare e far « agil·e le w·rnate moderne (l); nel campo della pratica poi c non è altro che l'applicazione di essi... ne consegno nna uac turn.le divisione del sno insogname11to come scienza in rlue « parti distinte: studio dei principii sull'organizzazione delle « tl.l'mtLto, dei principii sull'impiego delle armate in gucna ... ».
Per procedere alle ulteriori suddivisioni il Ricci adopera. il cri te rio del maresciallo 1\rarmont : • On decou v1·e tm p1·incipe en considérant bien te but et en che1•chant ensuite le meil< leu1· riiO!Jen de l'atteindre ».
« Scopo della orgauizzazione uùlitare di un paese (ol·ga<1( niw) ò quello di creare con gli elementi di forzu. da esso
4 possednt,i dei mez;,i d'azione che possano bastat·o alla tu-
« tela della sna esistenza, contro gli attacchi dai nemici
« esterni e..l interni. Gli elemeutì dt forza, rnoyens potw at-
« teind1•e te bnt, sono: il personale, il materiale, il terreno:
«il primo agisce; il secondo completa. l'azione; il terzo à il « teatro di essa; quindi tre rami distinti dell'orgt\uica che
• '>Ì scindono in altri secondaxi: c a) re lati vi al personale, cio(• reclutamento, istruzione in-
« tellettual o (scuole), istruzione morale (codice penale, regola-
« mento disciplinare, ricompense), tecnica (tattica delle varie a1:mi), azione colletti va (ordinamento tattico dei
« grandi corpi, gerarchie e comando), amministrazione (prove vedere e render conto);
« b) relativi al ma.terialo, cioè tutti quei mezzi estrin-
« seci all'uomo mediante i quali si mantiene, si sviluppa, si
(l) ll Rtccr dice d'aver tolta questo. definizione dal mo.rescia.llo MA.R(Eaprit dell inatitutions militaircs), cioè : L' ensemble. ck8 oonnaissaMe8 néccssaires pour organiser et oonctuire une masse à'hommes atmées. Alle connaissatJCC8 so:otitul i principii.
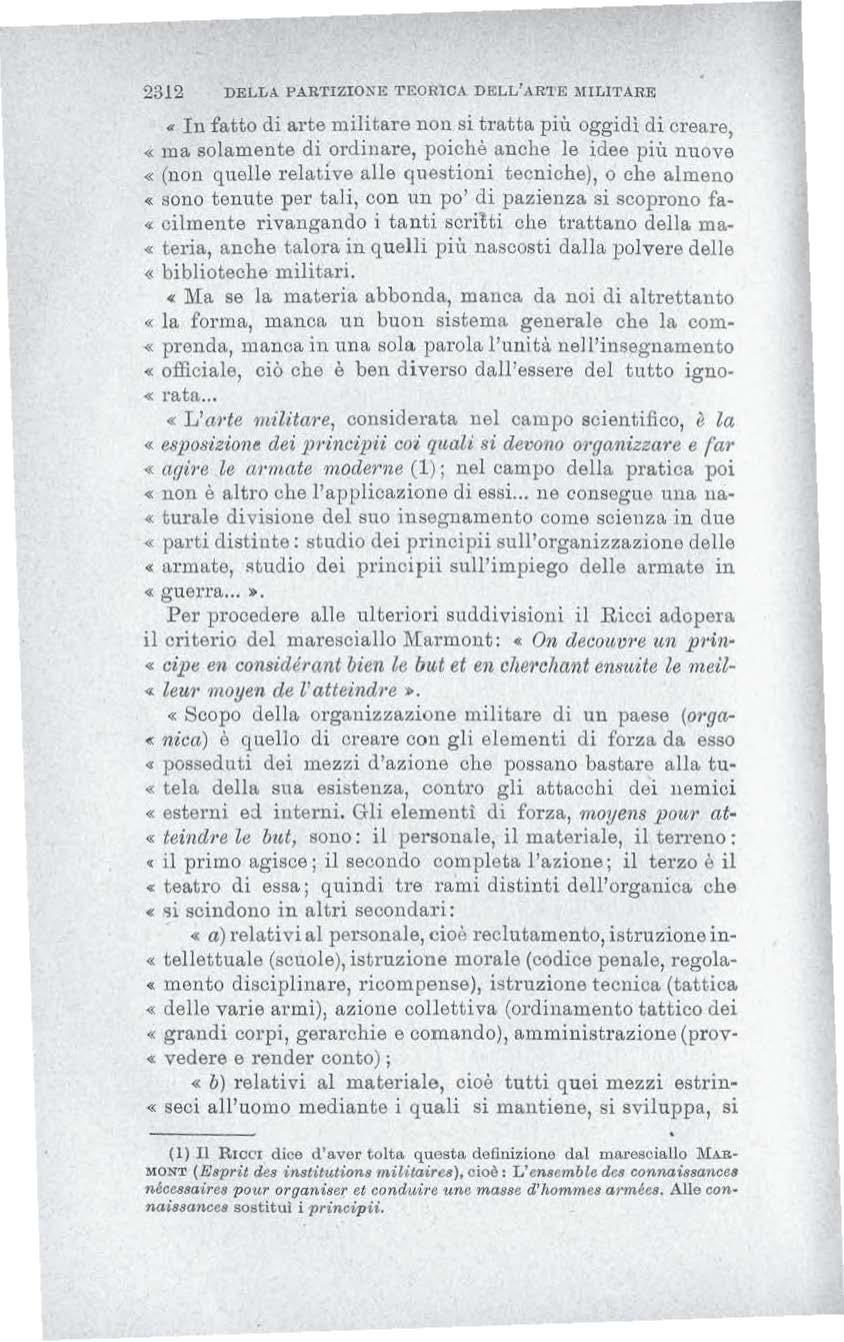
AR1'lll 'M I L I TAltlt 2313 modifica o si aumenta. la sua forza fisica-materiale stabile : caserme e altri fabbricati militari (architettura mi-
« litare), p1azze forti (fortificazioni permanenti.), fonderie,
« officine, ecc. (metallurgia, balistica, pirotecnica, mecca-
« nica, ecc .) i materiale mobile (cioè-, sommariamente, arma -
« mento, munizionamento, equipaggiamento, sussistenze, ri -
« monte, mezzi di trasporto, ponti, tel egra-fi, aerostati, ecc. );
« c) relativi al terreno, forme esterne: conoscerle (geo-
« desia, topografia), riprodurle (l\artograna), risorse del ter -
« r eno (statistica militare); circoscrizione militare; difesa
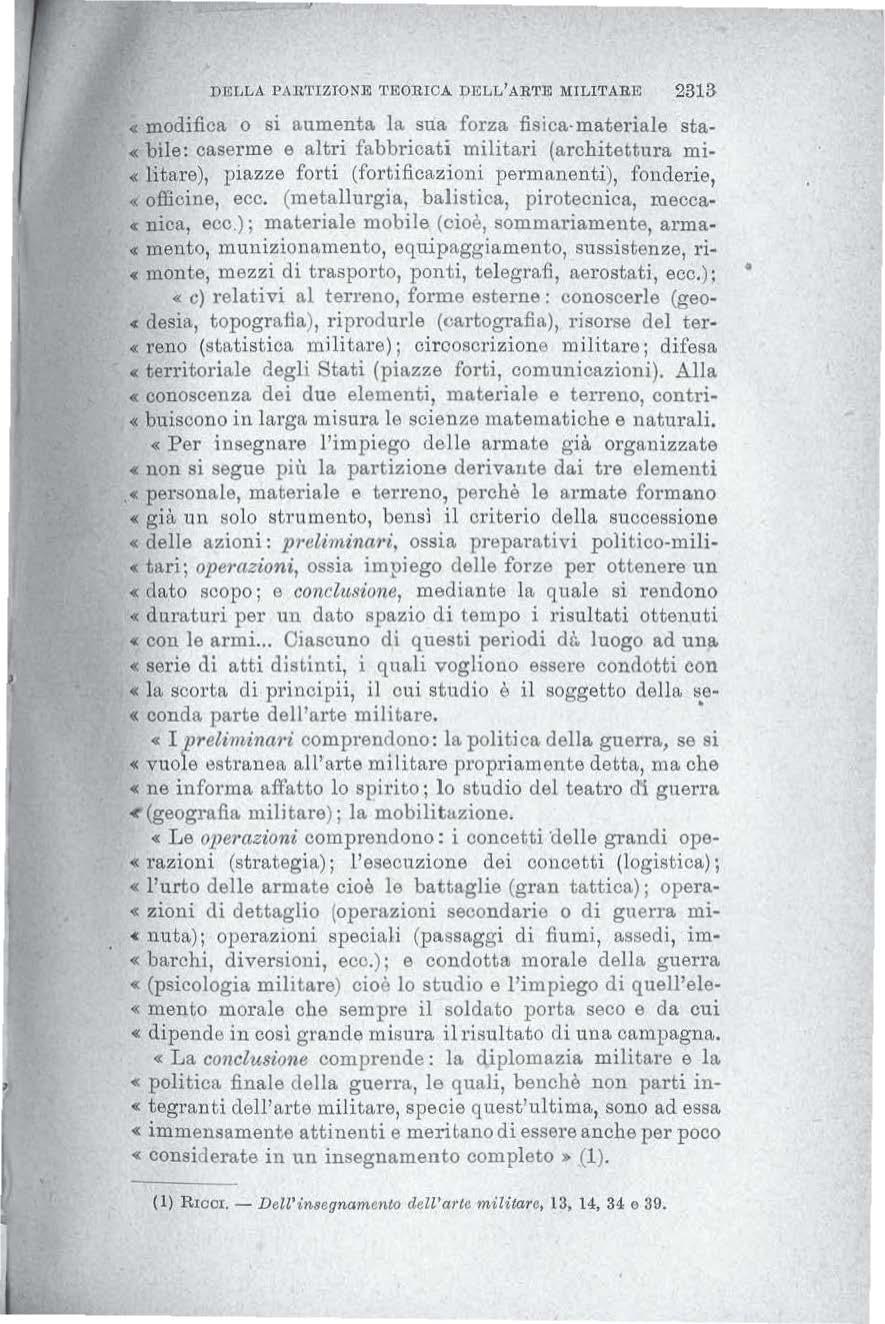
« territoriale degli Stati (piazze forti, comunicazioni). Alla c conoscenza dei due elementi, materiale e terreno, contri-
« buisoono in larga misura le scienze matematiche e naturali .
«Per insegnare l'i m piego delle armato già organizzate c non si segue pii1 la partizione derivante dai tre olementi
« personale, materiale e terreno 1 perchè le armate formano
« già un solo st1·uroonto, bonsi il criterio della successione
« delle azioni: p1·elimina1·i, ossia politico-mili-
« tari; operazioni, ossia impiego delle forze per ottenere un
« tlato scopo; o conclnsione, meditmte la quale si rendono
« duraturi per un dato Rpazio di t em po i risultati ottenuti
«con le armi Ciascuno di questi periodi dr. luogo ad u11a
« serie di atti disLinti, i quali vogliouo essere condotti con
« l a scorta c.li princil?ii, il cui studio ò il soggetto della se-
« conda parte dell'arte militare •
« I yrelimina1·i comprendono: la politica della guerra, se si
«vuole all'arte militare propriamente doHa, ma che
« ne informa affatto lo spiri Lo; lo studio del teatro di guerra militare ) ; la mobilitu;r.ione.
« Le operazioni comprendono: i concetti 'delle grandi ope-
« razioni (strategia); .l'esecuzione dei concetti (logistica);
« l'urto delle armate cioè le battaglie (gran tattica,) i opera-
« zioni tli dettaglio (operazioni secondarie o di guerra mi- c n uta) i operaz10ni speciali (passaggi di fiumi, assedi, im-
« barchi, diversioni, ecc.) i e condotta morale della guerra
«(psicologia mihtare) cioè lo studio e l'impiego di quell'ele-
« mento morale che sempre il soldato porta. seco e da cui
« dipende in cosi grande mii'>ura il di una campagna.
«La conclusione comprende: la diplomazia militare e la « politica finale della guerra, le quali, benchè non parti in-
« tegran t.i dell'arte militare, specie quest'ultima, sono ad essa
« immensamente attinenti e meritano di essere anche per poco
« considerate in un insegnamento completo • (1).
( l) Rtoox.- Dell'insegnamento d ell'arte militare, 13, 14, 34 o 39.
Quanto precede è compendiato in una tavola sinottica, che costituisce l'indice dell'altra opera del generale Jticci: In· troduzione allo delr arte militare (18GB
Nicoh1. Marselli (1875) scri•e:
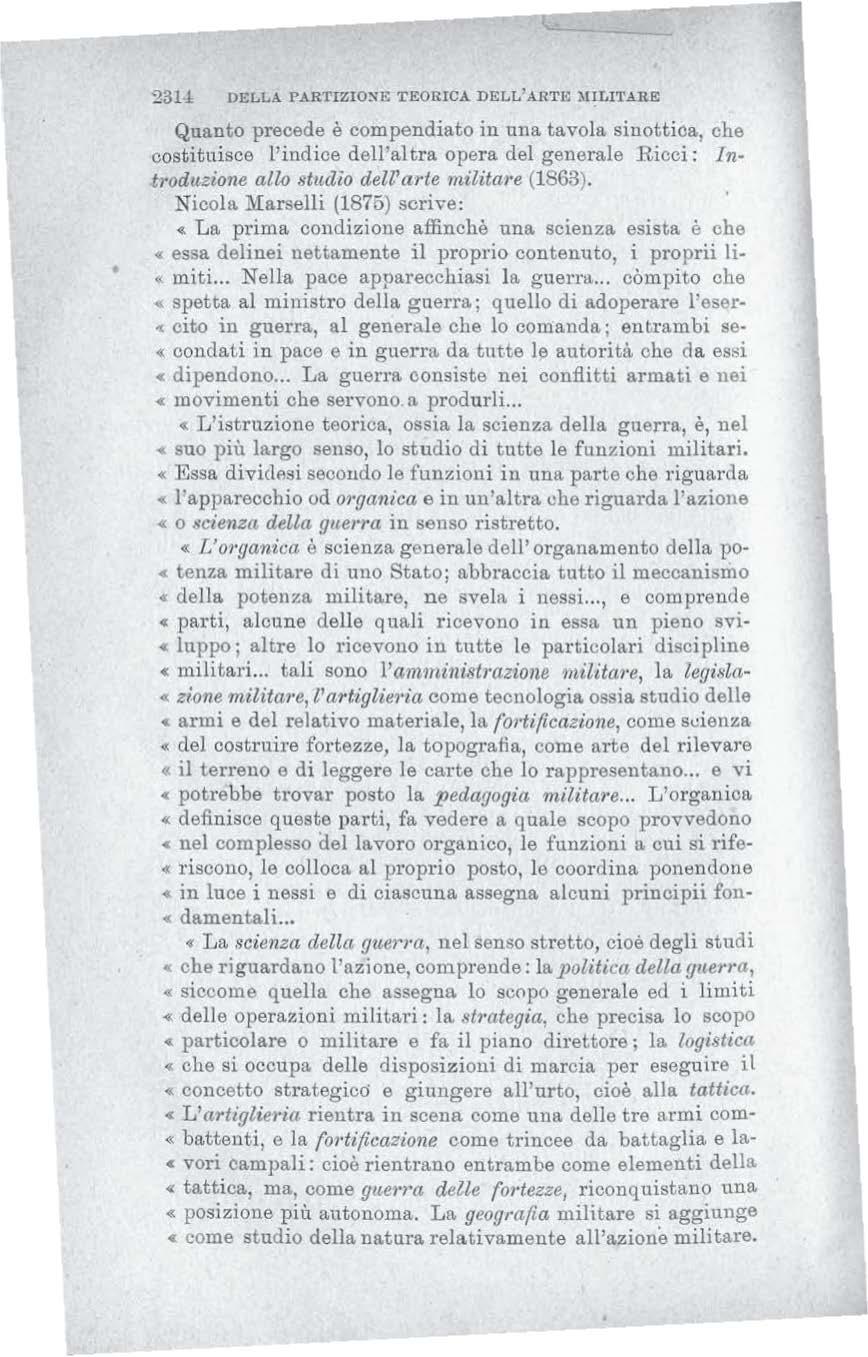
La prima condizione affinchè una scienza esista e che
• essa delinei nettamente il proprio contenuto, i proprii li-
,, miti... Nella pace apparecchiasi la guerra... còmpito che
, spetta al ministro della guerra.; quello di adoperare l'eser-
"' cito in guerra, al generale che lo comanda; entrambi se-
« con.daH in pace e in guerra. da tntte le autorita che eia
• dipendono ... La guerra consiste nei conflitti armati e nei c movimenti che a produrli...
« L'istruzione teorica, ossia la scienza della guerra, è, nel
« suo più largo senso, lo studio di tutte le funzioni militari .
« Bssa dividflsi seooudo le funzioni in nna parte che riguarda
« l'apparecchio od organica e iu un'altra. che riguarda l'azione
.c o della guerra in senso ristretto.
« L'o1'ganica è scienza generale dell' organa.mento della po- c tenza. militare ùi uno Stato; abbraccia tutto il meccanh;mo
" della. potenza militare, ne oveln. i nessi , e comprende c parti, alcuno delle quali ricevono in essa. un pieno svt-
• luppo; altre lo ricevono in tutte le particolari discipline c militari... tali sono Pamminù;trazione militare, la. legisZ<t ·
"zione militare,l'artigliel'ia come tecnologia ossia. studio delle
• armi e del relativo materiale, la fortificazione, come sdenza
« del costrnire fortezze, la topografia, come arte del rilevare
• il terreno e di leggere le carte che lo rappresentano ... e vi c potrebbe trovar posto la pedagogia militare L'orgau i ca
« definisce queste p arti, fa. vedere a <Iua.le scopo provvedono
• nel complesso del lavoro organico, le funzioni n cui si rife-
• riscono, le colloca al proprio posto, lo coonliua
• in luce i nesst e di ciascuna assegna alcuni princi pii fon-
• da.mentali ...
• I.Ja della guerra, nel senso stretto, cioè degli studi
« che- riguardano l 'azione, comprende: la J>Olitic(l della guerrct,
.. siccome quella che assegna lo scopo generale ed i lin1iti
• delle operazioni militari: la sb ·ategia. che precisa lo scopo c particolare o militare e fa il piano direttore; la logistica c Vartigliel'ia rientra. in scena come una delle tre armi com·
« che si occupa delle disposizioni di marcia per eseguire il strategico e giungere all'urto, cioè alla tattica.
« battenti, e la fortificazione come trincee da battaglia e la· c vori campali: cioè rientrano entrambe come elementi della
< tattica, ma, come guen·a delle fortezze, riconquistano una
< posizione più autonoma. La geografia militare si aggiunge c come studio della natura relativamente all'azione militare.
« E )A. sto1·ia della. guerra? Anch'essa è clat:isificata come -« una delle militari; ma essa è. nel tempo stesso un c tutto, poichfl comprende l'azione nello spazio e nel tempo eli c tutti !Jli eze,nenti milttari p1·eparc,ti netta pace » (1).
Il generale Mazzitelli (1879) ripete la definizione del Marselli (2).
Il generale Corticelli (1900) scrive:
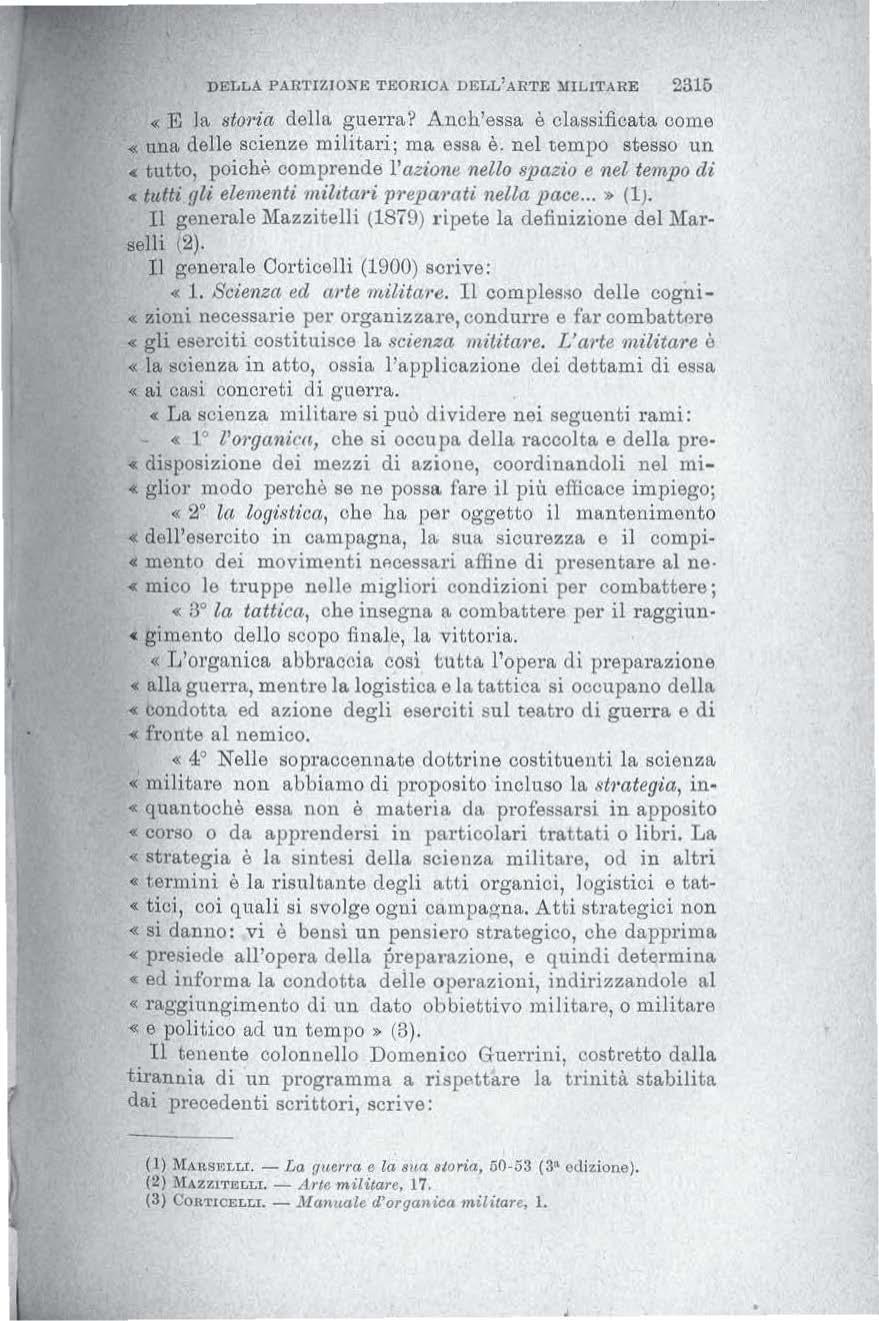
« L. Scienza ecl w·te ·militare. Il complesso delle cogni-
« zioni necessarie per condurre e fA.r combattf\re c gli el:!erciti costituisce la scienza L' a1·te militm·e ò
« la Hcienza in atto, Ol:!sia l'applicazione dei dettami di esl:!a
« ai easi concreti di guerra.
« La blcienza m i l itare si pnò d i v id ere nei segllenti rami:
« l che si occnpa della raccolta e della pro-
« disposizione dei mezzi di aziono, coordinandoli nel mi -
« glior modo perchè se ne possa fare il più efficace impiego;
« 2° lct logistica, ohe ha per oggetto il mantenimento c dell'eHorcito in la sna sicnrezza o il compi- c mento dei movimenti Mcessari affine di presentare al ne·
« mico le truppe nelle m1gliori condizioni. per combattere;
« 13° la tatticct, che insegna a combattere per il raggiun· c gimento dello scopo flnale, la vittoda.
« Vorganica abiJracnia. cosi tuttlt l'opera di preparazione c alla guerra, mentre la logistica e la. tattica si occupano della
« condotta ed azione degli esel·citi sul teatro di guerra e di
« fronte al nemico.
« 4 ° Nello sopraccennate dottrine costituenti la scienza
« militare non abl>iELmo di proposito incluso ht st1 ·ategia, in·
« quantochè essa non è materia da professarsi in apposito
« cor:io o da apprendersi in particolari trattati o libri. La
.,. strategia è la l:llntesi della scienza militare, od in altri
« termini è la. risultante degli a!.t,i organici, logistici e tR.t-
« tici, coi quali si svolge ogni campao;na. Atti strategici non
«si danno: vi è bensì un pensiero strategico, che dapprima
« presiede all'opera della. prepa.mzione, e quindi determina
« ed informa la condotta delle operazioni, indirizzandole al
« raggiungimento di un dato obbiettivo militare, o militare
«e politico ad un tempo» (3)
Il tenente colonnello Domenico G uerrini, costretto dalla tirannia di nn programma a rispettare la trinità stabilita dai precedenti seri t tori, seri ve:
(l) MARSELLI. -La uuerra e la Bllll storia, 50-53 (3U oùizione).
(2) MAZZlTELLT.- ilrlll militare, 17.
(3) CORTICELLI. - 1'-lt.muale militare, l.
« Si chiama strategia il complesso degli studi e dei prin« cipii che concernono il concetto dell'impiego della forza.
« Si chiama logistica il complesso degli studii e dei princi« pii che governano l'attuazione dei concetti strategici ftt ori « del campo di battaglia.
« Si chiama tattica il complesso degli studii e dei prin« cipii che riflettono l'attuazione dei concetti strategici sul « campo di battaglia » (l).
{t) eli tattica e servizio in guc l'l'a acl t i BO degli a lliet•i uOicia li eli complemento, 9.










