SARDONIA

Trentesimo anno/Trentième année Febbraio 2023 /Février2023
La Magia di Monte Furru
The Social Gallery
La Rinascita della Macrostoria
Proposta di Maurizio Onnis
Indirizzo d’Autore
Angelo Spada Maxia
Sas dies imprestadas
I Nuragici ed il primo vetro
Claudia Aru ed il decimo disco
Claudia Aru a Sa Scena
Nìvola monumento a Gramsci
Giuseppe Pettinau
Sa Stria
Su Stiddiu
Il 2022 di Annelise Atzori
Slow Food Gita in Sardegna
Katia Corda Silio Cinema

Roma New York - 1953 / 1964
Il miglior gelato sardo
Ristorante Is Femminas
Sebadas mucadores
Dominio Pubblico da Doyle a Escher
Emilio Lussu e le Leggi Razziali
Il sardo firmatario delle Leggi
Sulla vetta delle Incompiute
https://www.vimeo.com/groups/sardonia
https://www.facebook.com/sardoniaitalia
Foto robyanedda
Cagliari Je T’aime
Programma di creazione di Esposizioni e Manifestazioni Artistiche
nella città di Cagliari a cura di
Marie-Amélie Anquetil
Conservateur du Musée du Prieuré Directrice de la revue
“Ici, Là bas et Ailleurs”
Espace d’exposition
Centre d’Art
Ici, là bas et ailleurs
98 avenue de la République 93300 Aubervilliers
marieamelieanquetil@ gmail.com
https://vimeo.com/channels/ icilabasetailleurs
Vittorio E. Pisu
Fondateur et Président des associations
SARDONIA France
SARDONIA Italia
créée en 1993
domiciliée c/o
UNISVERS
Elena Cillocu via Ozieri 55 09127 Cagliari
vittorio.e.pisu@email.it
http://www.facebook.com/ sardonia italia
https://vimeo.com/groups/ sardonia
https://vimeo.com/channels/ cagliarijetaime
SARDONIA
Pubblicazione
dell’associazione omonima
Direttore della Pubblicazione
Vittorio E. Pisu
Redattrice Luisanna Napoli
Ange Gardien
Prof.ssa Dolores Mancosu
Maquette, Conception Graphique et Mise en Page
L’Expérience du Futur une production
UNISVERS
Commission Paritaire
ISSN en cours
Diffusion digitale
Durante tutto il mese di febbraio l’Arrubiu Art Gallery Cafè di Oristano Via Giuseppe Mazzini 88, galleria bar ormai nota ai nostri lettori, ci propone una mostra veramente interessante dove due artisti, un pittore ed un fotografo, ci propongono uno sguardo differente su certi aspetti del carnevale sardo in diversi paesi dell’Ogliastra e della Barbagia, senza dimenticare naturalmente la Sartiglia oristanese, vernissage il venerdì 3 febbraio 2023, mentre dal 4 al 12 febbraio la mostra “Collettiva di Fotografia” sarà visibile ad Iglesias all’Associazione Remo Branca in Via Roma 68, vernissage il sabato 4 a partire dalle ore 18.


Non potete mancare queste due manifestazioni nell’attesa di altre succulenti sorprese. VEP
Questo numero di febbraio vorrebbe continuare nell’entusiasmo, anche se mitigato da tanti inconvenienti sia personali che nazionali e fino agli internazionali che contaminano le nostre giornate, e trovare in tante realizzazioni umane degne di riconoscenza ed interesse l’energia e la volontà di continuare a credere che domani sarà certamente migliore di oggi.
Appunto accade di scoprire tante iniziative sia prossime e completamente sarde, sia lontane ma tali da apparirci come fraterne e capaci di rincuorarci e di spingerci a continuare nelle nostre iniziative che a volte ci possono apparire vane ed inutili.
Le manifestazioni artistiche che ci piace di citare, come The Social Gallery diretta da Jo Coda con il concorso di Roberta Vanali, oppure i successi di personalità come Annelise Atzori, artista a 360°, la cantante Claudia Aru arrivata al suo decimo disco e l’attrice e realizzatrice cinematografica Katia Corda che si illustra nelle produzioni sia personali che di altri realizzatori, senza dimenticare la scuola di musica di Ilaria Porceddu a Cagliari, ci confermano nelle nostre intuizioni, materializzate con la serie “Meglio una Donna” ma anche con la scommessa della “Collettiva di Fotografia” che ha convocato una quindicina di fotografi sia sardi che francesi per una mostra diventata itinerante.
Anche la mostra delle vedute linografiche di Cagliari, esposta alla Grotta Marcello fino alla fine di gennaio prende fine, mentre un’altra iniziativa, nata al momento dell’inaugurazione della galleria bar Gutzman a San Domenico a Cagliari, e suscitata da Mattia Enna con i suoi santini, ha accettato l’impegno producendo per il momento una dozzina di immagini della Santa Bella Bella Grassa Grassa di cui la prima fu esposta ad Iglesias nella manifestazione “L’Arte in Vetrina”.
Per il resto questo mese vi propone delle escursioni che vanno dalla storia e dal modo di considerarla e praticarla fino alla memoria delle infami leggi razziali ricordate all’occasione della Giornata della Memoria insieme alle deportazioni e lo sterminio genocidario praticato dai nazifascisti, dove si ritrova anche lo zampino di qualche sardo.
Fortunatamente Emilio Lussu ci riscatta da tale vergogna come il matematico di Villamassargia Angelo Spada Maxia, che non bisogna assolutamente dimenticare, ringraziando Dolores Mancosu di avercelo ricordato.
Per il resto ci piace proporvi qualche scoperta o riscoperta gastronomica che riceve le riconoscenze le più meritate sia in casa che all’estero.
Non dimentichiamo naturalmente le proposte politiche del sindaco di Villanova Forru che ci sembrano urgenti di sostenere mentre dobbiamo ancora una volta sottolineare alcuni aspetti particolarmente vergognosi dell’incuria e dell’incompetenza che spesso non arrivano a gestire correttamente il bene pubblico.
Sperando che queste situazioni diventino un lontano ricordo vi auguro di approfittare del carnevale sardo. Vittorio E. Pisu
LA MAGIA DI MONTE FURRU
La magia di Monte Furru e i suoi tesori nascosti: il gazebo in marmo e la casa degli spiriti. Monte Furru, nell’agro di Sassari, raggiungibile appena dopo via Baldedda, è uno scrigno di tesori nascosti e purtroppo dimenticati, divorati dal tempo e dalle intemperie.

In questi luoghi sono nate storie affascinanti e leggende, in cui è racchiusa la cultura di Sassari, specie dei secoli appena passati, vissuti da una società più semplice, ma profondamente crudele, divisa per classi.
In cima c’erano i pochi colti: avvocati, notai, professori, medici e ma-
gistrati, ma la ricchezza vera la possedevano i grandi proprietari agrari. In mezzo c’era la borghesia sassarese, talvolta illuminata, composta soprattutto da commercianti, la cui unica legge in genere era il profitto e non certo il potere o la cultura.
Infine, numeroso, il terzo stato: un esercito di braccianti, ortolani o agricoltori, spesso analfabeti, che eseguivano le mansioni più umili, e soprattutto faticose. Se si guarda con occhio attento i vecchi poderi di Monte Furru sono evidenti queste disparità: le ampie stanze per i padroni, i piccolissimi alloggi per domestici e mezzadri.
E quel gazebo ottocentesco di un vecchio casolare della zona (da tanti lustri tormentato dalle erbacce), elegantissimo e a pianta circolare, con splendide colonne in marmo, doveva essere uno sfizio dedicato a pochi eletti, un riparo estivo, dove si poteva pranzare con gli ospiti e volgere lo sguardo verso la bellissima valle.
Il volgo invece poteva solo riposare e fantasticare, nel poco tempo libero a disposizione, magari osservando i nobili gozzovigliare.
A Monte Furru, dove fiorirono queste dimore sfarzose, nacque anche la magia della Casa degli spiriti, quella delle mura appartenute a Don Cri-
stoforo Dequesada, marchese di San Saturnino, morto di vecchiaia a 80 anni, nel 1893.
Vari anni dopo la sua dipartita si narravano di canti e di strane voci provenienti da quelle pareti decadenti.
LA LEGGENDA DEGLI SPIRITIUn viandante un giorno tornava a Sassari.
Dalla zona di Logulentu s’inerpicava verso Monte Furru, che gli avrebbe spalancato le porte della città.
Era quasi buio e l’uomo vide un bagliore provenire dalla casa del marchese, udì anche voci gioiose, soprattutto femminili e ne fu irresistibilmente attratto.
Nella casa venne accolto come un re e poi invitato da una fanciulla a partecipare ad un grande girotondo.
All’inizio non sentiva la fatica, ma quel girotondo era sempre più vorticoso e veloce.
All’uomo, dopo l’estasi, girava la testa e le sue gambe divennero molli e pesanti, ammorbate da una stanchezza improvvisa che lo stava uccidendo.
Accanto a lui gli uomini e le donne che partecipavano al girotondo non sentivano la fatica e continuavano a sorridergli felici.
Con la forza della disperazione il viandante si sottrasse a quella presa mortale e scappò, correndo col cuore in gola.
(segue pagina 4)
3
Foto giovannideligios
(segue dalla pagina 3)
Poi ebbe il coraggio di voltarsi, ma dietro di lui non c’era nessuno, le luci erano sparite e i canti gioiosi non si udivano più: c’era solo silenzio, ombre e un vecchio rudere, la casa di Don Cristoforo. Solo in quel momento l’uomo si accorse di avere ballato con dei fantasmi, quelli che volevano ammazzarlo di fatica. Il viandante raccontò a tutti quella storia, che fece il giro della città. In molti gli credettero, altrettanti lo presero per matto.
Ma da quel giorno la casa del marchese Cristoforo Dequesada divenne per tutti la Casa degli spiriti. E lo era sino a qualche anno fa.
Ora, infatti, la leggenda magica è caduta nell’oblio e questa vecchia storia la ricordano soprattutto i più anziani. Il bellissimo gazebo (e il relativo appezzamento agricolo) è distante poche centinaia di metri dalla casa di Don Dequesada, quella dei fantasmi. Pur coperti dai rovi e dall’incuria dell’uomo, entrambi potrebbero essere valorizzati e riaccolti dalla storia, finalmente strappati dall’ingiusto anonimato a cui sono stati condannati decenni fa. Argentino Tellini.
Aggiungo che altri hanno scritto sull’argomento, che rispecchia in pieno tutti gli scritti.
Con affetto, il vostro. Giò Del Giò.
ROBERTA VANALI, CURATRICE DEGLI
EVENTI DI THE SOCIAL GALLERY, DESCRIVE QUESTA NUOVA REALTÀ
NATA A QUARTU
SANT’ELENA PER PROMUOVERE I
TEMI LEGATI ALLA
GIUSTIZIA SOCIALE
E ALLA LOTTA PER I PROPRI DIRITTI.
USANDO L’ARTE
COME BUSSOLA
progetto “The Social Gallery” nasce a Seattle da un’intuizione condivisa da Giovanni Coda, regista e fotografo, e Aurora Martin, direttrice del Social Justice Film Festival.
Idea di fondo?
La creazione di uno spazio polifunzionale legato ai temi della giustizia sociale, dei diritti violati, negati, perduti, il tutto filtrato attraverso una prospettiva artistica che si muove come un flusso di coscienza, senza confini né barriere.
La Social Gallery viene allestita a Quartu Sant’Elena, nella centrale via Eligio Porcu, contemporaneamente alla sua gemella Justice Gallery, in fase di allestimento a Seattle, con la quale sono previsti scambi culturali virtuali e fisici, nell’ottica di promuovere le istanze sociali.
LE INIZIATIVE DI THE SOCIAL GALLERY
Ho ricevuto l’incarico di curare gli eventi di The Social Gallery che hanno preso avvio con la mostra di Giorgio Russo, fotografo di scena di Coda da ben dodici anni, con una selezione di scatti tratti dalla trilogia di genere che contempla “Il rosa nudo”, “Bullied to death” e “La sposa nel vento” oltre a “Storia di una lacrima”, inno alla vita che affronta il tema dell’eutanasia, tratto dal libro di Piergiorgio Welby “Ocean Terminal”.
E proprio a Welby, che ha combattuto per anni contro l’accanimento terapeutico, abbiamo voluto dedicare il se-

IL
Foto giorgiorusso
condo evento con una selezione tra acquerelli, incisioni e una serie di elaborati digitali realizzati con Corel Drow quando la sua condizione fisica si aggrava ulteriormente.
GLI ARTISTI DI THE SOCIAL GALLERY

Con l’obiettivo di ricadute positive sul territorio si è deciso di valorizzare con una serie di progetti alcuni giovani artisti residenti a Quartu Sant’Elena, a iniziare da Davide Gratziu, la cui mostra di illustrazione DOUBLE è attualmente in corso.
Vedi il video https://vimeo.com/789420710
Al centro della sua ricerca ci sono una forte attenzione per la fragilità esistenziale, il tema dell’identità in continuo mutare e il superamento dei confini di genere ma soprattutto la soggettività della percezione di se stessi e degli altri.
A seguire, nel mese di febbraio, si terrà l’esposizione di Voci dal profondo di Matteo Piccioni, un percorso nella pittura che muove dal lato oscuro dell’esistenza umana e dove l’atto creativo diventa strumento di autoterapia, veicolo per analizzare con spietata ferocia i mali dell’anima. Il tutto si inserisce nella programmazione del V-art Festival Internazionale Immagine d’Autore “Exposition”, ideato e diretto da Giovanni Coda.
Roberta Vanali
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2023/01/the-social-gallery-progetto-artistico-sardo-ispirato-giustizia-sociale/
uando uscì per la prima volta, nel 1976, per i tipi di Einaudi, “Il formaggio e i vermi” di Carlo Ginzburg divenne subito un best-seller e negli anni successivi fu tradotto in venti lingue. Dalla sua aveva numerosi punti di forza: era innanzitutto scritto molto bene, si leggeva con piacere pur essendo il resoconto di una ricerca d’archivio che chiunque altro avrebbe trasformato in un pedante testo infarcito di note a piè di pagina; raccontava una storia affascinante, quella di un mugnaio friulano del Cinquecento che, a causa di letture disordinate, arrivò a costruirsi una propria cosmologia antitetica a quella ortodossa e finendo inesorabilmente bruciato dall’Inquisizione; era, infine (e soprattutto), un’opera-manifesto di un genere nuovo, quello della microstoria, che riusciva a rappresentare un’intera epoca (in questo caso, quello dell’ambigua religiosità popolare dell’età della Controriforma) a partire da uno studio di caso, e che sceglieva per questi casi non più “le gesta dei re” (come scriveva Ginzburg nella prefazione della sua opera) ma quelle degli ultimi, degli sconfitti, rimossi dalla memoria storica. La microstoria giungeva all’apice di un’autentica rivoluzione copernicana, inaugurata dalla scuola (segue pagina 6)
5
Q
(segue dalla pagina 5) storiografica francese delle Annales, la storica rivista fondata nel 1929 da Marc Bloch e Lucien Febvre, che a differenza degli “Annales” quasi omonimi di Tacito si fondava sul rifiuto della histoire événementielle, la storia esclusivamente politico-militare, per concentrarsi su quella economica e sociale.
Questa “nuova storia”, come la definì Jacques Le Goff, iniziò con l’analisi delle dinamiche profonde delle società nel loro evolversi storico; gradualmente, l’attenzione alla società spinse in seguito a prediligere una nuova unità d’analisi, quella della “cultura popolare”, con l’obiettivo di restituire voce a coloro che non apparivano mai nelle cronache e negli annali, se non quando iniziavano a costituire un problema, esattamente come il Menocchio di Ginzburg di cui nulla sapremmo se non fosse entrato in rotta di collisione con l’Inquisizione lasciando traccia di sé negli archivi processuali. Si trattava di scrivere la “storia dei marginali”, come la definì Jean-Claude Schmitt, i veri attori della storia: gli “anonimi muratori” che avevano innalzato le mura di Tebe, come scrisse Ginzburg riferendosi alle “Domande di un lettore operaio” di Bertold Brecht.
Se in una prima fase si provò a fare questo tipo di storia sulla base di dati
LA RINASCITA DELLA MACROSTORIA
quanto più possibile impersonali e quantitativi, esattamente con lo scopo di abbassare i riflettori delle singole personalità per puntarli verso le forze indistinte delle masse, gradualmente si capì che bisognava invece restituire contorni ai singoli “marginali”, ricostruirne le storie e usarle per meglio chiarire l’ecosistema di una determinata epoca, soprattutto il suo contesto socio-culturale popolare.
Questa seconda svolta si verificò, secondo Schmitt, dopo il 1968, in coincidenza con il movimento di contestazione che vide proprio i marginali diventare protagonisti.
Di qui una rinnovata attenzione a fonti quali registri notarili, schedari di polizia, atti comunali, attraverso cui riportare in vita storie dimenticate di uomini, donne, famiglie, villaggi ai margini della grande corrente della Storia.
Lavoro impegnativo, a cui solo poche grandi personalità riuscirono ad accostarsi con successo.
Storici di grande erudizione, spesso antropologi, in grado di padroneggiare più discipline e giungere a felici intuizioni a partire da pochi dati, o di far parlare fonti che ad altri non direbbero nulla.
Nacquero così capolavori come quello sul villaggio occitano di Montaillou durante la crociata contro gli albigesi di Emmanuel Le Roy Ladurie (1975), o “Il
 Foto herodote.net
Foto herodote.net
ritorno di Martin Guerre” di Natalie Zemon Davis (1982) sul caso di un impostore del Cinquecento in un villaggio dei Pirenei, o “La domenica di Bouvines” (1973) in cui Georges Duby ricostruiva la battaglia del 27 luglio 1214 tra le armate francesi di Filippo Augusto e quelle della coalizione imperiale guidata da Ottone IV.


Profondità d’analisi, quella richiesta per la microstoria, di cui certo non tutti gli storici sono dotati; cosicché (notava già Ginzburg in un bilancio scritto nel 1994 “Microstorie: due o tre cose che so di lei”) la microstoria più spesso si è trasformata in sinonimo di “micro-analisi”, scelta non per vera convinzione storiografica ma per comodità e, si potrebbe aggiungere, pigrizia, di quella vasta maggioranza di mestieranti della storia non in grado di affrontare i problemi con la stessa mole di conoscenze, cognizioni e multidisciplinarietà degli storici delle Annales e dei loro epigoni, e che pertanto hanno preferito scegliere micro-casi spesso di storia locale, con un ben definito e circoscritto insieme di fonti da analizzare (quasi sempre fondi archivistici), dai quali non trarre, come invece nell’originale microstoria, le necessarie generalizzazioni per gettar luce sulla cultura popolare dimenticata di una determinata epoca, ma semplici elenchi di fatti e notizie, così ricadendo nel peccato della storia
evenemenziale da cui la rivoluzione della “nuova storia” intendeva precisamente affrancarsi.

In questa deriva costantemente alimentata dai dipartimenti universitari di storia, soprattutto, ma non solo, in Europa, e specialmente in Italia, è naturale che opere ambiziosissime che invece dichiaratamente prendono le distanze da queste micro-analisi e intendono riportare in vita quel filone oggi dimenticato della “macrostoria” siano accolte, a fronte di enormi successi di pubblico, con velato scetticismo o palese repulsione.
Studi popolarissimi quanto controversi come “Sapiens” di Yuval Noah Harari (2011), “L’alba di tutto” di David Graeber e David Wengrow (2021), “Armi, acciaio e malattie” di Jared Diamond (1997), pur molto diversi per approccio filosofico e impostazione di fondo, condividono da un lato l’ambizione di scrivere nuove grandi “storia dell’umanità”, dall’altro le critiche di quanti ritengono un simile sforzo non solo inutile, ma sostanzialmente impossibile.
In ciò dimenticando però che proprio la “nuova storia” nasceva, agli inizi del Novecento, per tentare un’analoga impresa con armamentari concettuali nuovi rispetto a quelli che fino ad allora erano stati impiegati per scrivere le grandi opere (segue pagina 8)
7
(segue dalla pagina 7) di sintesi storica che rappresentavano i best-seller dei secoli passati, come il Declino e caduta dell’impero romano di Edward Gibbon (1776-1789), che a dispetto del nome si spingeva fino alle Crociate e alla caduta di Costantinopoli, la “Storia di Roma” di Theodor Mommsen (1854-1856), l’incompiuta “Storia universale” di Leopold von Ranke (1880-1886), fino alla monumentale storia comparata in dodici volumi di Arnold Toynbee (A Study of History, 1934-1961).

Qual era infatti il senso di un classico rivoluzionario come “Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II” di Fernand Braudel (1949), su cui torneremo più avanti, se non quello di evidenziare la “continuità nel tempo e nello spazio” della civiltà mediterranea?

A fondamento di questa ricerca, Braudel pose il concetto di longue durée, contrapposta al tempo breve definito “la più capricciosa, la più ingannevole delle durate”.
Se Braudel e gli storici che ne hanno condiviso l’approccio rivoluzionario oggi ci sembrano così distanti dagli autori di best-seller come Harari, ciò sta sicuramente nella diversa impostazione metodologica delle loro opere, ma anche nel fatto che non abbiamo ancora compreso fino in fondo il vero significato della macrostoria.
Questo termine è stato oggetto di una riflessione articolata da parte di due studiosi noti più come futurologi che come storici (esattamente come Yuval Harari è oggi maggiormente noto per le sue prospezioni nel futuro che per le sue analisi storiche, pur essendo in realtà uno storico di formazione e di professione): nel 1989 a un seminario all’Università delle Hawaii Johan Galtung e Sohail Inayatullah parlarono di “Macrostoria e macrostorici”, tema che confluì in seguito in un libro con lo stesso titolo (Macrohistory and Macrohistorians, 1997).
Galtung, sociologo di formazione, fondatore degli studi sulla pace, era stato il pionieristico promotore del primo Congresso mondiale sul futuro organizzato nel 1967 a Oslo con il titolo “Mankind 2000”, insieme al giornalista e pacifista Robert Jungk. Inayatullah, che allora stava completando il dottorato all’Università delle Hawaii, sarebbe diventato in seguito uno dei più stimati esponenti degli studi sul futuro, grazie a un metodo di analisi molto noto e applicato chiamato CLA, acronimo di Causal Layered Analysis (“analisi causalmente stratificata”).
Il metodo parte dall’obiettivo di immaginare futuri alternativi a quelli “egemonici” e predeterminati, a partire dalla decostruzione delle narrazioni dominanti nel presente; per farlo, Inayatullah individua quattro
 Foto wordpress.com
Foto wordpress.com
diversi livelli di analisi: la “litania”, cioè le narrazioni dominanti; le “cause”, che includono i fattori storici, economici, politici e culturali; la “struttura”, ossia il discorso sottostante che legittima la struttura; il “mito”, cioè il livello più profondo e stratificato, che con Jung potremmo definire l’insieme degli archetipi inconsci che definiscono una civiltà.
La sua importanza consiste, da un lato, nell’adottare come unità d’analisi la “civiltà”, intesa come una collettività storicamente e culturalmente omogenea, e dall’altro nella capacità di analizzare gli strati profondi della civiltà per individuare le “visioni del mondo” soggiacenti e operare per trasformarle.

Il CLA è in effetti la versione pratica e futuristica dell’interesse di Inayatullah per la macrostoria.
Nel suo libro firmato insieme a Galtung, la macrostoria viene definita come “lo studio delle storie dei sistemi sociali, lungo traiettorie separate, in cerca di schemi”.
La macrostoria è diacronica in quanto si focalizza sugli stadi della storia e sulle cause del cambiamento nel corso del tempo, in questo distinguendosi dallo studio di singole unità o macro-unità storiche in un lungo lasso di tempo, come nel caso di una storia dell’Italia o della Francia che si estende per diversi secoli, o anche dell’intera storia della civiltà umana dalla prei-
storia a oggi. La macrostoria cerca degli schemi, dei pattern: segue cioè un approccio “nomotetico”, in cerca di regolarità, di generalizzazioni, che Inayatullah non teme di definire vere e proprie “leggi”.
Vedremo più avanti perché proprio in quest’ultimo passaggio si situa il problema di fondo della macrostoria e il suo fraintendimento di fondo.
Macrohistory and Macrohistorians partiva da una domanda: perché c’è in giro così poca macrostoria?


Le risposte degli autori sono diverse.
Innanzitutto, lo abbiamo già accennato, perché è “intellettualmente difficile”: bisogna avere una solida conoscenza dei singoli casi che si vogliono analizzare, che spesso appartengono a epoche e aree geografiche molto diverse tra loro, in palese contraddizione con la tendenza alla iper-specializzazione degli storici, per i quali trattare di un periodo storico al di fuori della propria specializzazione assume i contorni di un reato di “sconfinamento”.
In secondo luogo perché bisogna avere un’indubbia capacità di riconoscere degli schemi, “dare senso a grandi quantità di dati”, il che implica da un lato una certa dimestichezza con gli approcci quantitativi (le teorie devono essere confrontate con i dati), dall’altro l’attitudine(segue pagina 10)
9
Foto cronachenuoresi.it
(segue dalla pagina 9) alle generalizzazioni, esplicitamente disincentivata all’interno dei circoli storiografici contemporanei.
Infine, perché di solito il macrostorico lavora con fonti secondarie anziché con fonti primarie, fatto che tende a dequalificarlo al ruolo di interprete anziché di storico vero e proprio, secondo la tendenza ormai invalsa a ridurre il lavoro dello storico a palombaro di fondi d’archivio.
Esattamente questi punti sono quelli su cui si basano le critiche ai più recenti autori di macrostoria sopra citati.
Nel caso di Harari, per esempio, lo storico di Oxford Steven Gunn ha scritto sul New Yorker che la sua capacità è stata quella di aver “scavalcato” la critica degli esperti attraverso “domande così grandi che nessuno può dire ‘questo pezzo secondo noi è sbagliato, questo pure’…

Nessuno è esperto sul significato di tutto, o della storia di chiunque, sul lungo periodo”.
“Sapiens”, così come i libri di Jared Diamond (vincitore del premio Pulitzer per la saggistica nel 1998), sono stati inoltre criticati perché si concentrano molto sulla preistoria e sui primi millenni della civiltà, pur non essendo gli autori né archeologi né antropologi.
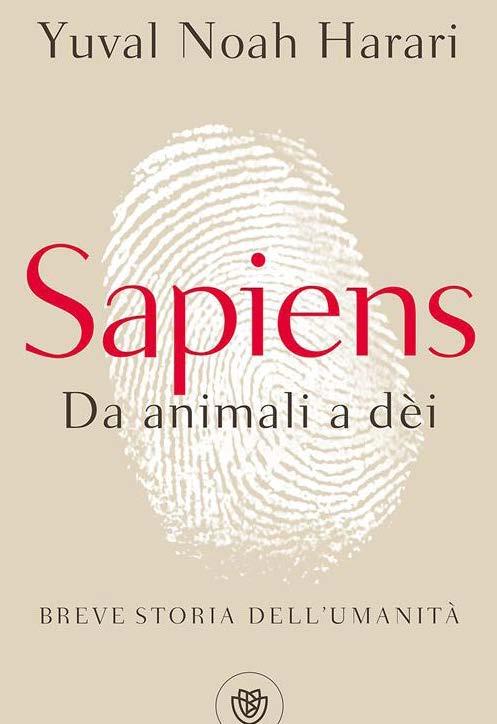
Nel caso di “L’alba di tutto”, gli autori sono invece rispettivamente un
antropologo (Graeber, prematuramente scomparso nel 20202) e un archeologo (Wengrow), con un background ideologico molto diverso dagli autori precedenti .
Graeber è stato un noto attivista di Occupy Wall Street e un intellettuale dichiaratamente anarchico.
Mentre Harari e Diamond sono stati accusati di “determinismo storico”, in quanto nei loro testi cercano di spiegare perché la storia dell’umanità non poteva che imboccare una e una sola traiettoria possibile, quella che di fatto ha imboccato, a causa principalmente di fattori biologici e geografici, Graeber e Wengrow nel loro libro presentano un’altra storia della civiltà, dove a lungo sono coesistite almeno due traiettorie possibili, di cui una sola è diventata dominante perché imboccata dall’Occidente, a danno di modelli sociali fondati sull’autogoverno se non persino sull’uguaglianza.
Così scrivono verso la fine del loro libro:
“«Non c’è modo di uscire dall’ordine costituito immaginario» scrive Yuval Noah Harari in “Sapiens”.
«Quando noi abbattiamo le mura della nostra prigione e corriamo verso la libertà, di fatto corriamo verso il cortile di ricreazione più ampio di una prigione più grande.» [Harari] non è l’unico ad arrivare a questa conclusione.
 Foto biologicalonlinedirectory
Foto biologicalonlinedirectory
Quasi tutti coloro che scrivono la storia su grande scala sembrano aver deciso che, come specie, siamo veramente bloccati, senza via di fuga dalle gabbie costituzionali che ci siamo costruiti.”
Per i due autori, invece, la nascita degli Stati e quindi di regimi verticistici fondati sulle disuguaglianze non sarebbe il frutto di una “necessità storica” derivante dalla rivoluzione agricola del Neolitico, ma un processo molto successivo e non inevitabile, come tale in futuro anche rovesciabile.
Le accuse loro avanzate sono state in questo caso di “utopismo” e di manipolazione dei fatti storici per interpretazioni orientate a offrire una particolare visione del presente.
Ciò che in realtà accomuna le critiche a tutti questi macrostorici è, più ancora dello sconfinamento disciplinare o degli errori evidenziati dagli specialisti in diverse parti delle loro opere, la tendenza a offrire grandi generalizzazioni valide per comprendere il presente e immaginare il futuro.
Harari non lo ha nascosto, tanto da aver fatto seguire a “Sapiens “un altro best-seller, “Homo Deus”, esplicitamente orientato a una discussione sui futuri possibili della civiltà umana.


Come spiegano Galtung e Inayatullah, essendo la macrostoria diacronica, ossia focalizzata sui cambia-
menti nel tempo, “il futuro vi è sempre implicato, e spesso senza alcuna promessa di progresso illimitato”.
In effetti, se guardiamo a queste opere ci rendiamo conto che in comune c’è la critica all’idea del progresso lineare.
Per esempio, “Collasso” di Jared Diamond (2004) ci mette di fronte al serio rischio che la civiltà tecnologica possa seguire le stesse traiettorie dei Maya o degli abitanti dell’Isola di Pasqua.
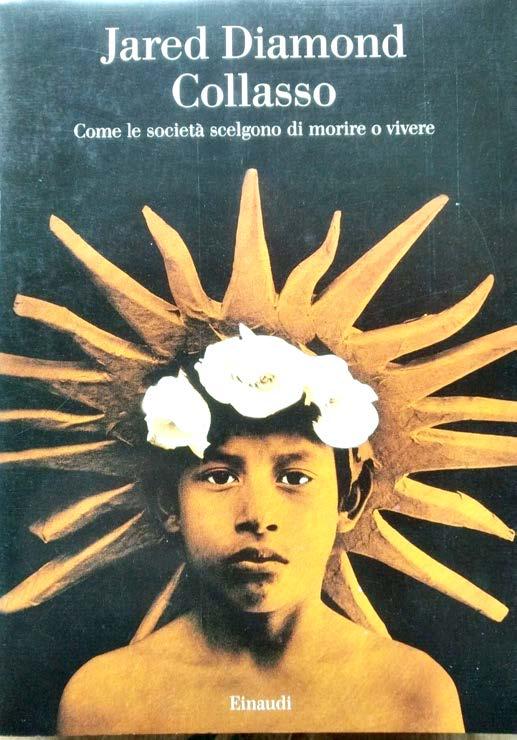
“Come conseguenza, il macrostorico non è in grado di promettere progresso illimitato.
Presto o tardi il declino arriverà, come predetto da una teoria ciclica”, leggiamo in Macrohistory and Macrohistorians.
Il concetto di ciclicità è uno degli aspetti centrali della macrostoria, nonché uno dei più criticati, a causa del rischio di determinismo storico a cui si associa.
Esso si basa sull’idea di “stati della storia”, che ha una lunga e illustre tradizione che risale perlomeno a Esiodo e alla sua successione di epoche storiche sempre più decadenti, dalla gloriosa Età dell’Oro a quella dell’Argento, fino all’Età del Bronzo e a quella del Ferro; metafora ripresa dall’apocalittica ebraica al tempo dei Maccabei, quando fu scritto il Libro di Daniele, la cui visione del succedersi di regni (segue pagina 12)
11
(segue dalla pagina 11) sempre più decadenti ha la forma di una statua dalla testa d’oro, petto e braccia d’argento, ventre e cosce di bronzo, gambe di ferro e piedi d’argilla. Più avanti il tema fu ripreso da Paolo Orosio nelle sue “Storie contro i pagani” (417-418), un racconto della storia del mondo dal Diluvio fino alla caduta di Roma, che si basava sulle tesi di Agostino espresse nella Città di Dio e proponeva una concezione della storia divisa in quattro imperi: babilonese, macedone, cartaginese e romano. Fu un libro dal successo enorme, l’unico testo latino conosciuto nel mondo islamico per mille anni e pertanto fonte primaria per Ibn Khaldun, uno dei primi macrostorici nel vero senso della parola, che nella sua “Introduzione alla storia universale”
(Muqaddima, 1377) presentò un’influente teoria della storia, in cui l’inesorabile declinare della ʿaṣabiyya, ossia dell’identità culturale di un determinato popolo, viene associato alla caduta ciclica delle dinastie: tutte, inevitabilmente, vedono con il passare delle generazioni declinare il loro nerbo e decadere nel lusso e nell’ozio, finché una nuova dinastia più forte non arriva a soppiantarle, in cicli di circa centoventi anni.


Ciclicità e decadenza da un lato, visione della storia come tendente al progresso e alla salvezza
universale dall’altro, furono i due grandi poli intorno a cui la storiografia medievale e pre-moderna oscillò per secoli.
L’Uomo è caduto a causa del peccato originale e vive in un mondo caduto, precisa Agostino, dunque, ogni progresso nelle civiltà umane non può essere che apparente; e tuttavia Dio si rivela nella storia, che può essere letta come orientata alla salvezza, non all’inesorabile collasso.
Ottone di Frisinga tentò di tenerne conto nella “Historia de duabus civitatibus” (1143-45) sviluppando in modo più moderno anche il concetto della translatio imperii, lo spostamento periodico del centro del potere, individuato in età medievale come uno dei motori della dinamica storica.

Tutti gli imperi seguono un analogo destino: nascita, apogeo, caduta; nascono in Oriente e si spostano progressivamente verso Occidente.
A questa ciclicità si contrappone però una dinamica lineare che è quella espressa dalla religione cristiana: “Noi dovremmo aspettarci che il mondo finisca presto, se non fosse sostenuto dalle preghiere e dalle azioni di uomini santi dei quali, per grazia di Dio, vi è ora grande quantità”.
Bisognerà aspettare Edward Gibbon per mettere in discussione le tesi di ispirazione agostiniana: il suo
Foto wikipedia.org
“Declino e caduta dell’Impero romano” attribuiva non solo alle invasioni barbariche, ma primariamente alla diffusione del cristianesimo e ai suoi effetti su quello che Ibn Khaldun avrebbe definito l’aṣabiyya dei romani (spirito marziale, espansionismo, grandeur) il ruolo determinante nella caduta dell’Impero. Frutto dell’anticlericalismo illuminista dell’epoca, l’opera di Gibbon contribuì nondimeno a superare definitivamente l’approccio religioso alla macrostoria e ad avviare gli studiosi successivi alla ricerca di nuovi processi universali.

Inesorabilmente, alla teoria della salvezza doveva sostituirsi la teoria del progresso intramondano; ma le teorie della ciclicità non vennero invece intaccate da questa trasformazione.
L’idea secondo cui le civiltà sono destinate al collasso risorse allorquando il forte utopismo illuministico prima e positivistico poi iniziò a declinare. Agli inizi del Novecento l’ambizione di cercare leggi deterministiche con cui interpretare le dinamiche storiche fu messa al servizio di sforzi per predire il futuro collasso della civiltà occidentale.

Esemplare da questo punto di vista fu “Il tramonto dell’Occidente” di Oswald Spengler (1881-1923), non a caso scritto e pubblicato all’indomani della Grande guerra e del collasso dei grandi imperi centra-

li, in cui l’autore si proponeva esplicitamente di “predire il destino di una civiltà e, propriamente, dell’unica civiltà che oggi stia realizzandosi sul nostro pianeta, la civiltà euro-occidentale e americana, nei suoi stadi futuri”.
Basandosi sull’analogia con le età dell’essere umano, Spengler traeva dalla sua “prognosi della storia” la convinzione che ogni civiltà abbia una sua nascita, una sua giovinezza e una sua senilità, essendo le civiltà “organismi viventi d’ordine superiore”.
Secondo questa morfologia della storia, la civiltà europeo-occidentale sarebbe, in analogia con il “tramonto del mondo antico”, entrata nella sua età senile, che si manifesterà nei primi secoli del presente millennio.
L’approccio di Spengler è comparatistico e lo studio delle civiltà del passato ha il preciso obiettivo di predire l’evoluzione futura della nostra civiltà, che si troverebbe in una fase simile a quella del tardo ellenismo, caratterizzata dal passaggio da un’anima “apollinea” a una “faustiana”, dove la piena consapevolezza dei propri mezzi conduce a una cultura dinamica fondata sul mito del progresso attraverso la costante trasformazione del mondo per mezzo della tecnica.
Il confronto tipico tra l’opera di Spengler e quella di (segue pagina 14)
13
(segue dalla pagina 13) Arnold Toynbee riflette da un lato lo scontro tra l’Europa continentale e l’Inghilterra che contraddistinse ancora tutta la prima metà del Novecento, i grandi paradigmi nietzschiani contrapposti al progressismo liberal di marca anglosassone. Ma Toynbee fa un passo avanti nel cercare di superare l’impostazione determinisitca della macrostoria.

Non ci riesce ancora, naturalmente, perché la sua opera si situa in una fase ancora immatura del discorso storiografico; ma nella sua critica alle “soluzioni deterministiche” nella parte dell’opera che tratta del crollo delle civiltà decostruisce le quattro ipotesi allora dominanti.
La prima, quella secondo cui il collasso dipenda da leggi fisiche, ispirata alla seconda legge della termodinamica che regola l’inesorabile crescita dell’entropia:
“È una delle perenni umane debolezze questa di ascrivere i propri insuccessi a forze del tutto indipendenti dal nostro controllo.
Questa manovra mentale seduce particolarmente gli spiriti sensitivi nei periodi di decadenza e di rovina; e nella decadenza e rovina della civiltà ellenica era un luogo comune di diverse scuole filosofiche quello di spiegare lo sfacelo sociale, da esse deplorato ma non riparabile, come il fortu-
ito e inevitabile effetto di un generale attacco di «senescenza cosmica»”.

La seconda ipotesi, quella di Spengler, secondo cui le civiltà, come gli organismi viventi, hanno una durata fissata da leggi biologiche, è ugualmente esclusa, “perché le civiltà appartengono a una specie di fenomeni che non è soggetta alle leggi della biologia” (e così finalmente si chiude il lungo percorso iniziato con Esiodo che compara le età della storia all’età dell’uomo).
La terza, che è sostanzialmente quella di Khaldun (che Toynbee non cita), per cui i crolli derivano dalla progressiva degenerazione dei ceti dominanti, è tacciata di razzismo.

La quarta, infine, cioè la teoria ciclica, è attribuita alla fascinazione per la ciclicità delle stagioni, ma non trova riscontri nella storia diacronica: “Il genere umano non è un Issione legato eternamente alla sua ruota né un Sisifo che sospinga eternamente il suo macigno alla vetta della stessa montagna e, impotente, lo veda ricadere al piano”.
Piuttosto, Toynbee individua come forze motrici del collasso le “pressioni esterne” e le “minoranze interne”: caso classico, ancora una volta, dell’Impero romano, eterno modello di ogni tentativo di individuare
Foto g.b.langetti/ixion
leggi storiche universali. In questo caso le pressioni esterne sono ovviamente quelle dei barbari, il “proletariato esterno” per usare la terminologia di Toynbee; mentre le minoranze interne sono rappresentate (secondo la tradizione inglese risalente a Gibbon) dai cristiani, definiti il “proletariato interno” dell’Impero. La tentazione, ovviamente, è quella di cercare analoghe forze nel presente (perlomeno nel tempo in cui scriveva Toynbee).

Di minoranze interne, riconosce l’autore, ce ne sono quante ne si vuole, dall’intellighenzia cosmopolita al proletariato urbano; entrambe sono oggetto di processi di reclutamento e assorbimento da parte dei ceti dominanti, ma nessuna di esse è stata in grado di dar vita a una nuova “chiesa universale”, sebbene forse in questo caso Toynbee abbia sottovalutato la forza dell’ideologia comunista, determinante per tutto il XX secolo.
Quanto al proletariato esterno, la grande profezia dell’autore inglese, scritta nel 1939, fu che la civiltà occidentale contemporanea fosse ormai talmente pervasiva da non avere più minacce al di fuori di sé, ma in grado nondimeno di generare “barbari interni”, che Toynbee indicava coerentemente nelle milizie fasciste e nazionalsocialiste.

Nel 1936 il fondatore della rivista “Annales”, Lucien Febvre, demoliva l’opera di Toynbee, accusato di “aver scritto una storia illusionistica, da prestigiatore, che fa sfilare le civiltà «come i quadri di un melodramma»”, per il quale la storia poteva riassumersi “nella risposta di un vecchio bibliotecario a uno scià agonizzante che in punto di morte voleva imparare tutta la storia: «Mio principe», gli disse il vecchio saggio «mio principe, gli uomini nascono, amano e muoiono»”.
“Economies – Sociétés –Civilisations” era il sottotitolo che Febvre e March Bloch avevano scelto per la loro rivista; sì, anche le civiltà, ma prima di loro le società, termini che non sono sinonimi perché “società” designa una struttura più profonda, a cui i nuovi storici intendevano rivolgersi.
L’obiettivo era quello di superare gli steccati disciplinari e servirsi dei nuovi sviluppi della sociologia e delle scienze economiche per dotare la ricerca storica di nuovi strumenti; ma veniva abbandonata l’ambizione, considerata illusoria, di estrapolare dalle vicende della storia leggi sempre valide con cui predire l’avvenire.
Vi si sostituiva una più matura concezione storiografica: la ricerca delle forze permanenti, impersonali e collettive, che producono il mutamento sociale (segue pagina 16)

15
(segue dallam pagina 15) nel corso delle epoche storiche, all’interno di un’ottica che Fernand Braudel (successore nel 1946 di Febvre alla direzione delle Annales) definirà longue durée. Non però una “storia immobile”, formula coniata dallo stesso Braudel e da Le Roy Ladurie; perché obiettivo della nuova storia, chiariva meglio Jacques Le Goff, è piuttosto quello di “spiegare meglio il cambiamento”. Era del resto, questo, un lascito di Marx, che nei suoi studi non era riuscito a individuare i meccanismi alla base del passaggio dal feudalesimo al capitalismo; gli storici ne avevano raccolto la sfida focalizzandosi sulle strutture socio-economiche, trasformate nella nuova unità d’analisi privilegiata.
Dunque, pur essendo esplicitamente idiografica, ossia orientata al particolare e rifuggente da pericolose generalizzazioni, questa “nuova storia” recuperava dalla macrostoria l’abbandono degli aspetti meramente evenemenziali, la focalizzazione sulle leggi del cambiamento storico, la prospettiva di lunga durata.
Se ne distingueva invece ancora per due elementi: l’attenzione (come si accennava all’inizio) al ruolo delle “masse”, alla “cultura popolare” anziché alle grandi dinastie e ai dominatori; e di conseguenza una rinnovata
attenzione alle fonti, anzi a nuove fonti, fino ad allora ignorate, con le quali riuscire a ricostruire le strutture sociali del passato.
Esemplare è l’opera già citata di Braudel “Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II”, nella quale il tema delle oscillazioni, delle ripetizioni e dei cicli è dominante e letto entro una cornice di dialettica tra “strutture” e “congiunture”, termini che scandiscono le prime due parti dell’opera (la terza è dedicata agli “avvenimenti”).


Le oscillazioni sono tipiche delle congiunture e come tali possono essere cicliche, mentre le strutture restano fisse; ma anche le strutture possono infine mutare e queste sono le trasformazioni irreversibili che conducono a nuove società, come nel passaggio marxiano dal feudalesimo al capitalismo.
Non c’è dunque una teoria ciclica della storia né una concezione lineare orientata al progresso permanente, ma queste due concezioni depurate dalla loro componente nomotetica sono comunque sussunte all’interno del discorso di Braudel: ci possono essere ciclicità, come del resto accadrà sempre più nell’epoca del capitalismo con le sue cicliche recessioni, ma ci possono essere anche trasformazioni strutturali, non però tendenti al miglioramento costante, alla salvezza universale o all’utopica società comunista immagina-
 Foto organon Filippo II
Foto organon Filippo II
ta da Marx.
Alle strutture socio-economiche, la “nuova storia” saprà in seguito aggiungere l’analisi della mentalità e dell’immaginario, andando a formare quelle componenti che Inayatullah ha riassunto nel suo metodo di analisi causale stratificata.
Passata tuttavia la grande stagione dei maestri e quella dei loro diretti discepoli, la nuova storia cede il passo a una microstoria sempre più “micro” nelle ambizioni e nelle unità d’analisi, in cui il rifiuto della generalizzazione non conduce più alle profonde riflessioni sulle peculiarità delle dinamiche storiche delle varie epoche ma al ritorno a una storia di “fatti” senza interpretazioni, di tessere sempre più piccole che non si è più in grado di ricomporre in mosaico, a causa delle distanze crescenti delle discipline e dal conseguente sospetto verso la lunga durata, che richiederebbe di abbandonare la confortevole veste dello specialista per azzardarsi in pericolosi sconfinamenti nell’altrui autorità.
A questa tendenza, come hanno risposto i nuovi macrostorici? A guardare le loro opere, sembrerebbe che la lezione della “nuova storia” sia stata dimenticata. E quasi certamente è così, perché spesso queste opere nascono con il preciso intento di superare la degenerazione della disciplina verso il “micro” e recuperare
gusto e ambizione per le generalizzazioni.
La conseguenza è il ritorno a uno sguardo tendente al determinismo che nuovamente cerca di cogliere leggi storiche con cui effettuare quella “prognosi” orientata al futuro che auspicava Spengler. Si pensi alla discussa opera di Peter Turchin, che ha recuperato gli studi di Ibn Khaldun e li ha posti alla base di una nuova disciplina, la “cliodinamica”, fondata sulla modellizzazione matematica dei processi sociali e applicata alla spiegazione dei processi ciclici di ascesa e cadute delle nazioni: “Historical Dynamics: Why States Rise and Fall” (2003), “War and Peace and War: The Rise and Fall of Empires” (2006), Secular Cycles (2009), “Ultrasociety” (2016), recentemente tradotto in italiano con un titolo grossolano (La scimmia armata, UTET 2022).

Turchin, che di formazione è un biologo, ha messo su con i suoi colleghi un approccio matematico che mescola macrosociologia storica, storia economica ed evoluzionismo culturale applicandolo all’analisi di sistemi complessi come le civiltà umane.


La sua è una scienza che, come tale, si pone il preciso intento di dedurre leggi che possano essere sottoposte al vaglio della verifica empirica.
Il modello è in grado di partire (segue pagina 18)
17
(segue dalla pagina 17) da princìpi primi di tipo deterministico per ricostruire in progressione lo sviluppo delle civiltà del passato fino ai giorni nostri, e ovviamente può essere usato per fare previsioni sul futuro.
Motore di queste dinamiche è la guerra, prodotta da gruppi sociali diversi in conflitto per le risorse, il prestigio e il potere: una forza definita da Turchin “creazione distruttiva”, che pur terribile ha portato a grandi sviluppi ma che infine potrebbe distruggere sé stessa facendoci approdare a un futuro senza guerre.
Su metodi e tesi similari si pone l’opera dello storico Walter Scheidel nel suo recente studio “Fuga dall’impero. La caduta di Roma e le origini della prosperità occidentale” (LUISS University Press, 2022).
Ancora una volta il punto di partenza è la caduta dell’Impero romano, ma questa volta l’obiettivo non è approfondire le sue motivazioni ed estrapolarne leggi generali, quanto cercare di capire perché, a partire da quel grandioso crollo, la civiltà occidentale e quelle del resto del mondo abbiano iniziato a divergere.

La tesi di fondo di Scheidel è che la caduta dell’Impero romano abbia messo fine a un esperimento unico nella storia (mai prima di allora e in seguito una così grande percentuale di popolazione di un’ampia area
geografica è stata sottoposta a un unico dominio) che però, crollando, ci ha reso un grande beneficio, perché ha avviato quel processo di sana competizione tra popoli e società che ha reso possibile la Grande divergenza, verificatasi a partire dalla Rivoluzione industriale, quando lo sviluppo economico dell’area occidentale dell’Eurasia ha iniziato a divergere marcatamente dall’area orientale.
La fine dell’Impero, dunque, sarebbe alla base delle trasformazioni radicali avvenute milletrecento anni più tardi. Roma fu una singolarità della storia, dovuta secondo Scheidel a una serie di fattori irripetibili, geografici innanzitutto (la centralità nel Mediterraneo), ma anche storici (la scomparsa dell’impero macedone), economici, tecnologici, ed è solo un bene che l’Impero non sia più tornato, perché laddove sono persistite forme di dominazione imperiale, come in Cina, alla lunga sono venute meno le forze propulsive dell’innovazione, prodotte dalla “frammentazione competitiva del potere”. Scheidel la chiama la “Grande Fuga”.
La parte più interessante del libro (per il resto non particolarmente originale né nelle premesse né nello svolgimento) è nelle sue motivazioni.
Docente di Storia antica alla Stanford University, Scheidel osserva che gli storici hanno abbandonato
 Foto wikipedia.org
Foto wikipedia.org
ogni interesse nella ricerca sulle cause della Grande divergenza, che invece “è importantissima per capire come il mondo sia diventato com’è”.
Una rapida scorsa ai background degli autori che se ne sono occupati mostra che “solo uno studioso su circa quaranta che si sono espressi sul tema viene da una specializzazione in storia”, mentre la maggioranza è composta da scienziati sociali ed economisti. In buona parte Scheidel attribuisce questo disinteresse al “passaggio dalla storia economica o dalla macro-storia alla storia culturale o alla micro storia”, che avrebbe tagliato fuori la comunità degli storici professionisti dall’impiego di metodologie innovative provenienti da altri campi con cui analizzare i processi di lunga durata.
E tuttavia, se la diagnosi è probabilmente corretta, la terapia non sempre lo è. Fuga dall’impero, esattamente come “La scimmia armata” di Turchin, propone teorie esplicitamente deterministiche e torna a valorizzare fattori come quelli ecologici e geografici per individuare le cause dei processi storici.
Non è, di per sé, un errore, perché rispetto al passato oggi disponiamo di molti più dati e teorie molto più sofisticate per analizzare, per esempio, l’influenza dei cambiamenti climatici sulle dinamiche delle civiltà, e l’integrazione con gli elementi provenienti

dalla paleontologia e dagli studi genetici sull’evoluzione ci consentono di estendere molto più in profondità nel passato gli studi di macrostoria, come accade nelle opere di Harari, Diamond, Graeber e Wengrow. Maurice Aymard, discepolo di Braudel, lo spiegava in un bilancio sul concetto di “lunga durata” a cinquant’anni (2008) dalla sua originaria proposta: “La storia non inizia più a Sumer. La rivoluzione scientifica dell’archeologia è in effetti venuta ad abolire la frontiera dell’invenzione della scrittura, che serviva a distinguere la storia dalla preistoria, e quella, spesso associata alla precedente, dell’opposizione tra «società fredde» e «società calde»: essa ha riavvicinato gli antropologi, gli archeologi e gli storici, che lavorano sia sull’Europa che sulle altre grandi aree geografiche e culturali del mondo.
E ha mobilitato numerose tecniche di analisi, di misura, di uso di modelli e di digitalizzazione, prendendole in prestito dalle scienze esatte.”
Di questo si deve tener conto, superando la naturale ritrosia degli storici per simili sconfinamenti disciplinari.
Un’opera come la “Storia notturna” (1989) di Carlo Ginzburg è stata pioniera di tale svolta, come ricorda giustamente Aymard. Ma il rischio che si corre è (segue pagina 20)

19
(segue dalla pagina 19) in questa rinnovata tentazione di sviluppare leggi universali con l’obiettivo di fare della storia una scienza empirica (Scheidel per esempio fa ampio ricorso ai “controfattuali” con l’obiettivo di sottoporre le sue teorie a verifica).
Se ne erano resi conti già Galtung e Inayatullah nel loro libro “Macrohistory and Macrohistorians”, scrivendo che il tentativo dei macrostorici di realizzare una scienza porta spesso a chiudere anziché a tenere aperta la ricerca storica, cercando risposte definitive che hanno l’effetto di cristallizzare il mondo in un blocco monolitico, sulla base della convinzione che le cose non potevano andare diversamente e che quindi non esistono alternative al presente in cui viviamo.

Le conseguenze sono evidenti: si ritorna a una “visione ferroviaria” della storia, come la definì il filosofo Bertrand de Jouvenel, critico nei confronti delle teorie della modernizzazione, per le quali tutte le società sono destinate a seguire le stesse traiettorie, e si toglie ogni spazio alle storie alternative, quelle dei marginali, tagliati fuori dalla grande corrente storica la cui riscoperta è invece utile a mostrarci come le cose potevano andare diversamente (di grande interesse, su questo fronte, i nuovi studi sulla Rivoluzione france-
se allargati allo studio dei movimenti di emancipazione dei neri e delle donne).

Fondamentale, inoltre (scrivono Galtung e Inayatullah) è “l’abilità di rimuovere il futuro dalle limitazioni della storia predeterminata e ciclica. Invece, [la macrostoria] dovrebbe creare la possibilità di una spirale, accettando la struttura, ma con la volontà di trasformare la sofferenza associata alla storia”. Abbiamo bisogno di macrostoria più che mai oggi per riuscire a superare la visione “patchwork” del mondo che la soffocante compartimentazione disciplinare ci consegna, in cui gli storici non sono più in grado di aiutarci a comprendere il mondo in cui viviamo e contribuiscono a rafforzare la sensazione di un presente incomprensibile, eterno, inesorabile.
Ci occorre tornare alla macrostoria perché la storia possa aiutarci a definire le traiettorie di futuro che intendiamo imboccare. Ma ci serve una macrostoria che abbandoni ogni tentazione di individuare presunte leggi deterministiche a torni invece a cercare tendenze.
Una tendenza non è una legge, anche se agisce su una scala di lungo periodo.
Le tendenze demografiche, per esempio, definiscono la struttura delle società in cui viviamo, ma non rispondono a leggi deterministiche; ancor di più, le ten-
Foto quadernid’altritempi.it
denze economiche (i cicli di accumulazione del capitale e di recessione) non rispondono a leggi di natura, ma sono la conseguenza delle strutture sociali.
L’attenzione a questa dialettica tra struttura e dinamiche, che si deve a Braudel, è andata persa con la deriva microstorica degli ultimi decenni, mentre i pochi autori che l’hanno portata avanti, come Immanuel Wallerstein, con le sue teorie del “sistema-mondo”, l’hanno fatto nell’alveo della sociologia, anziché in quello della storia, non senza subire la perdurante fascinazione delle spiegazioni puramente economistiche care alla scuola marxista.
Jacques Le Goff esprimeva anni fa la speranza “che la scienza storica sia ormai meglio in grado di evitare le tentazioni della filosofia della storia, di rinunciare alle seduzioni delle maiuscole (la Storia con una S maiuscola) e di definirsi in rapporto alla storia vissuta degli uomini”, invitando però gli storici a non cedere alla tentazione di operare una frattura epistemologica “rinunciando a essere senza frontiere e a flirtare con tutte le altre scienze dell’uomo” per ritagliarsi una propria nicchia.
Oggi ci troviamo invece a confrontarci esattamente con questo duplice rischio.
Maurice Aymard ha avanzato un’interessante proposta: poiché non possiamo fare a meno dei nuovi
strumenti che le hard science hanno messo a disposizione della ricerca storica, perché non guardare piuttosto a “quanto ci hanno offerto, nel corso degli ultimi decenni, le analisi della disseminazione, della biforcazione e del caos, della complessità o ancora l’analisi stocastica”?
Strumenti che sfuggono alla tentazione del determinismo, alla generalizzazione, alla ricerca di leggi di natura, e che al contrario “hanno in comune il fatto d’introdurre l’idea stessa di rottura e di cambiamento e di orientare le scienze sociali allo stesso tempo verso rappresentazioni non lineari del tempo e verso analisi delle società in termini di sistemi dinamici”. Seguendo questa proposta, si eviterà forse che la rinascita della macrostoria possa farci cadere negli stessi errori del passato e al tempo stesso aprire una seconda rivoluzione storiografica, di cui abbiamo più bisogno che mai per fare della storia uno strumento decisivo per la nostra ricerca di futuri alternativi alla gabbia del presente.
ROBERTO PAURA (1986) È
PRESIDENTE DELL’ITALIAN INSTITUTE FOR THE FUTURE, DIRETTORE DELLA RIVISTA “FUTURI” E VICEDIRETTORE DI “QUADERNI D’ALTRI TEMPI”. COLLABORA CON DIVERSE RIVISTE COME GIORNALISTA SCIENTIFICO E CULTURALE. IL SUO ULTIMO LIBRO È “OCCUPARE IL FUTURO. PREVEDERE, ANTICIPARE E TRASFORMARE IL MONDO DI DOMANI” (2022).


21
Maurizio Onnis ha scritto : “Ho una proposta. L’innesco è questo articolo, lungo e complesso, postato qualche giorno fa da Andrìa Pili e che adesso rilancio.
Io non sono uno storico, ma per mestiere mastico e rimastico continuamente la storia universale.
Nel tracciarla, sono quindi obbligato a chiedermi senza sosta quali siano i suoi snodi, quali strutture sostengano ogni civiltà, che cosa determini il passaggio da un’epoca all’altra.
E così via. Ora, la macrostoria (è raccontato bene qui sotto) non ha il compito di dettare auspici o, peggio, individuare “leggi”.
La sua missione è scovare linee di tendenza e ipotizzarne sviluppi futuri. Nessuno può negare che in tale campo, per ciò che riguarda la Sardegna, ci sia moltissimo da fare.
E la proposta è proprio questa.
Trovarsi e discutere di come uscire da un racconto storico della Sardegna specialistico e frammentato, per cominciare a considerare le nostre vicende globalmente. In altre parole, non più solo conoscere il nostro passato.
E nemmeno più solo valutare l’impatto del passato sul presente. Ma servirsi di tutto ciò per costruire un avvenire più consapevole.
So già quale potrebbe es-
DI MAURIZIO ONNIS

sere la principale obiezione: che la stessa storia della Sardegna e dei sardi va ancora per gran parte scavata e scritta.
È vero. Non mancano però oggi gli appigli, e le diverse competenze disciplinari, per passare a un abbozzo di macrostoria.
È un tentativo onorevole, che andrebbe solo a vantaggio di tutti noi.
È anche un tentativo estremamente ambizioso, ma per dire che è impossibile bisogna provarci.
P.S.: quasi nessuno degli studiosi dedicatisi alla macrostoria negli ultimi decenni è uno storico.
Il campo è perciò aperto a ogni contributo”.
Maurizio Onnis è Sindaco di Villanovaforru dal 2001. Consulente editoriale, ha viaggiato nei paesi in via di sviluppo e studiato antropologia e storia delle culture.
Nel 2013 è uscito per Piemme “Il fotografo di Auschwitz”, scritto con Luca Crippa e tradotto in Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Cina.
L’anno successivo, sempre per i tipi Piemme e sempre con Luca Crippa, viene pubblicato “L’archivista”. Considera la Shoah il nodo più intricato, doloroso e misterioso della storia occidentale recente e dedica a questo argomento studi approfonditi.
È anche autore di numerosi testi scolastici.
Foto saracollu
PROPOSTA
Indirizzo d’Autore è la nuova scuola di scrittura e musica di Ilaria Porceddu, un luogo dove imparare a conoscere e far crescere la propria identità artistica.


A partire dal songwriting, passando per la voce, il suono, gli arrangiamenti, fino ad un prodotto personale, professionale e unico.
La consapevolezza della propria capacità, e gli strumenti necessari per creare, conoscere e far parte del settore musicale/discografico, saranno approfonditi durante le lezioni individuali, le consulenze e le masterclass con cantautori, produttori, autori, discografici, esperti del diritto d’autore, giornalisti musicali e professionisti della canzone, organizzate nel corso dell’anno.Non importa a quale livello sei, l’obiettivo è creare. Ho deciso di aprire Indirizzo a Castello, nel cuore di Cagliari, per l’aria che si respira.
Dentro e fuori lo studio.
Si, il romanticismo del centro storico con tutta la sua magia ecc ecc ecc. In realtà ciò che sento è vita. Incasinata e reale, storica e popolare, antica nel suo essere contemporanea mentre guarda il futuro tenendosi forte alle mura del passato.
L’asettico qua non esiste.
E non mi importa la comodità di un parcheggio,
INDIRIZZ O D’AUTORE
mi importa che possiate arrivare dopo una camminata e sapere che qui potete respirare.
E poi, dopo aver scritto qualcosa, andare a brindare con una birra Quando ho immaginato indirizzo d’Autore avevo in mente un salotto. Un posto in cui mettersi comodi e raccontare. Un posto in cui ci si senta a casa nel cuore di Cagliari.
Ognuno di noi ha un mondo interiore e credo che la musica sia il modo più efficace per farlo venire alla luce.
Nel cuore di Cagliari si aprono le porte di Indirizzo d’Autore.
Ho avuto questa idea in pieno lockdown.
Ci sono voluti due anni di studio, confronti con professionisti e progettazione, perché l’idea diventasse un progetto reale.
Questo è stato selezionato e ha vinto un bando creativo per l’imprenditoria femminile.
E ora quello che era solo un disegno è diventato finalmente una bellissima realtà.
Tutto questo per dire che ciò che è importante ha bisogno di semina e cura, come per le canzoni, e tempo necessario per la costruzione di qualcosa che abbia un’identità e una prospettiva duratura.
Indirizzo d’Autore parte e ha una visione già chiara dei prossimi due anni.
(segue pagina 24)
23
Foto indirizzo d’autore
(segue dalla pagina 23)
Lezioni individuali, scrittura, consulenza, pre-produzioni, approfondimenti e masterclass con professionisti del settore (autori, compositori, sound engineers, giornalisti musicali, etichette discografiche, esperti di diritto d’autore), sono gli strumenti chiave per costruire la propria strada e diventare professionisti.
In questi anni ho incontrato tanti ragazzi che attraverso lo studio e il confronto ora considero artisti con un progetto solido e pronto a far parte del mondo musicale. Sono felice di aver creato finalmente un posto dove dar vita a tutto questo.
E’ finalmente online il sito di Indirizzo d’Autore.
Frugate, spulciate e scoprite tutte le info di questa nuova casa. Sono immensamente grata a chi ha dedicato tempo e amore a questo progetto.
SEO Pirates siete una meraviglia!
Ilaria
ANGELO MAXIA MATEMATICO

La disciplina della matematica, appellata regina delle scienze per la relazione di fondamentale rigore che sviluppa in ogni ramo e dottrina tecnica o scientifica, è un linguaggio - d’importanza pratica e teorica per la progressiva estensione di determinanti contributi applicativi in diversi settori - che ha segnato la civiltà e la storia di tutti i popoli.
Tra le figure dei matematici sardi brillano la personalità e il notevole valore di Antonio Fais (Ploaghe, 25 aprile 1841 – Sassari, 3 settembre 1925) che nell’attività scientifica, in sintonia con i maggiori matematici italiani e internazionali del periodo, si cimentò nell’algebra complementare, nel calcolo infinitesimale e la geometria differenziale delle curve e delle superfici, e quella di Angelo Maxia (Villamassargia, 12 febbraio 1910 – Roma, 29 novembre 1945), a cui dedichiamo la nota biografica.
Angelo Maxia, seguendo la naturale ed istintiva propensione verso la scienza dei numeri, consegue prima la maturità scientifica e nel 1934 la laurea con lode in Matematica all’Università di Cagliari; la tesi, sotto la guida dell’illustre professore Enea Bortolotti, riguarda la “geometria degli spazi anolonomi” e sviluppa uno studio avviato, solo da alcuni anni, dal matematico rumeno Gheorghe Vranceanu (Valea Hogii, 30 giugno
Foto unionesarda.it
Indirizzo d’Autore Via Alberto Lamarmora, 86, 09124 Cagliari Tel.:+39 371 577 9874 info@indirizzodautore.com www.indirizzodautore.com vedi il video https://youtu.be/ o8-01Lr5kv4
1900 – Bucarest, 27 aprile 1979).
Mentre frequenta il Corso per Allievi Ufficiali Artiglieri, a Lucca, è vittima di un grave incidente che gli causerà l’amputazione della gamba sinistra e conseguenti disturbi circolatori.
Con grande forza d’animo ed “estrema rassegnazione e serenità” coltiva gli studi e l’insegnamento.
Dopo una breve parentesi in un liceo classico cagliaritano, raggiunge il Bortolotti all’Università di Firenze dove, tra il 1937 e il 1942, opererà come assistente, libero docente e professore incaricato.

Il docente sardo è ormai meritoriamente riconosciuto, nel circuito accademico e nella comunità matematica, come massimo competente italiano “nel campo della geometria degli spazi a connessione” e alla scomparsa del suo maestro Enea Bortolotti viene chiamato da Enrico Bompiani all’Università di Roma, Bompiani scrisse : “I tre anni passati con Lui in comunanza di lavoro sono stati per me un vero gt»dimento. Il suo earattere mite si aeeompagnava ad una schietta fermezza nelle sue idee, la illimitata generosità del suo animo ad una indipendenza non comune di giudïzio.
Perfetta lealtà, integrità morale assoluta unita alla sua dottrina procuravana al MAXI A Taffettoo e la stima dei colleghi e dei giovani.
Egli è stato stroncato sul punto di raccogliere l’ambito
premio del suo lavoro: nella Geometria degli spazï a connessione, in cui dopo la scomparsa del suo Maestro era, forse in Italia il più competente, lascia risultati molto notevoli.
A Lui il nostro affettuoso ricordo, a]la famiglia lontana l’espressione della nostra condoglianza.”
La generosità d’animo e l’impegno civile di Angelo Maxia è testimoniato con l’operosa presenza nell’Istituto Matematico romano durante i bombardamenti americani del 1943; la partecipata resistenza ai tedeschi, a fianco dei cittadini in Piazza Colonna, e l’aiuto ai bambini dei quartieri Ostiense e Nomentano colpiti dai bombardamenti all’inizio del 1944.
Il professore di Villamassargia, pur nella fugacità della sua esistenza, ha prodotto numerosi articoli che documentano l’intensa attività scientifica e due basilari monografie: “Insieme convessi e orbiformi” (Studium Urbis Editrice, Roma, 1940) e “Studio proiettivo differenziale di un elemento cuspidale di specie superiore” (Edizioni Cremonese, Roma, A1947).
Diversi lavori del Maxia, dedicati alla geometria delle varietà anolonome, sono custoditi dall’Unione Matematica Italiana e tra gli Atti dell’Accademia

Nazionale dei Lincei tra i quali : “Sui lavori di Luigi Bianchi riguardanti la geometria degli spazi di Riemann”
Cristoforo Puddu
25
giorni della merla, gli ultimi 3 giorni di Gennaio considerati i più freddi dell’anno, sono anche quelli che stabiliranno come sarà la primavera a seguire.
Se il 29, 30 e 31 di Gennaio saranno freddi, la primavera arriverà presto e sarà mite, mentre se i giorni della merla saranno miti, la primavera sarà fredda.
Ma esistono anche altre credenze popolari, con cui in passato si pronosticava l’andamento del tempo, per i mesi a seguire.
Si dice che se il 2 febbraio, durante la giornata de Sa Candelora piove o soffia il vento, ci dovremo aspettare altri 40 giorni di brutto tempo.
Se invece non piove è segno che l’inverno è prossimo a concludersi.
Si osserva il clima anche durante i giorni dedicati a Sant’Antonio Abate, e a San Sebastiano per pronosticare l’andamento del tempo.
Le leggende legate ai giorni della merla sono diverse e variano da regione a regione, ma ne esiste una che è sicuramente la più diffusa conosciuta.
Secondo la leggenda una femmina di Merlo dal piumaggio bianco e candido come la neve, per ripararsi e proteggere i suoi piccoli dal freddo pungente dell’inverno, si rifugiò dentro un comignolo per 3 giorni, riemergendone il primo febbraio completamente nera per la fuliggine.
SAS DIES IMPRESTADAS
Sarebbe infatti questo il motivo per cui il merlo perse la colorazione bianca, diventando definitivamente e per sempre nero.
La leggenda dei giorni della merla, in Sardegna ha dei risvolti legati prevalentemente alla vita e ai costumi dei pastori. I giorni della merla in Sardegna diventano così “sas dies imprestadas”, che tradotto significa i giorni prestati.
La leggenda de sas dies imprestadas, narra di un pastore che, durante un inverno particolarmente mite e favorevole, anzichè essere grato per la buona sorte e l’ottimo pascolo che il mese di Gennaio aveva concesso, si vantò e addirittura si burlò del mese, perché essendo già il 29, era convinto che fosse ormai finito, in quanto a quei tempi, il mese di gennaio finiva il 29. Gennaio offeso e arrabbiato, decise di vendicarsi, e chiese a Febbraio, che allora aveva 30 giorni, 2 giorni in prestito per punire il pastorello.
Febbraio acconsentì, e Gennaio utilizzò i due giorni prestati, per scatenare tutta la sua furia sul pastore ingrato, mandando freddo e neve per sterminare il gregge.
Di tutto il gregge, solo una pecora che si era rifugiata sotto una pentola in rame si salvò, e il pastore caddè in rovina. www.notiziesarde.it/giorni-della-merla-sas-dies-imprestadas/

I
Foto notiziesarde.it
Sarebbero stati i sardi nuragici i primi a produrre il vetro primario nell’intero bacino del Mediterraneo nel 1700 avanti Cristo, almeno uno o due secoli prima degli abitanti di El Amarna, antica capitale dell’Egitto, ai quali era stata accreditata finora la prima creazione di questo materiale.
La scoperta è avvenuta nel 2021 nel sito archeologico del nuraghe “a corridoio” di Conca ‘e Sa Cresia (datato al radiocarbonio all’incirca 1700 a.C., inizio della civiltà nuragica), nella Giara di Siddi, in Marmilla. Autrice della ricerca è la geologa e archeologa Giusi Gradoli, libera professionista con dottorato di ricerca in tecnologie delle ceramiche preistoriche.

Recentemente è stata scoperta una parte del nuraghe che era rimasta nascosta da un crollo murario.
Sarebbe un’area artigianale, interna ed esterna, in cui sono stati recuperati tantissimi reperti, tra cui un crogiolo in frantumi per la fusione del vetro, e sono state trovate sparse un po’ ovunque tracce di scorie vetrose.
Un’analisi eseguita dal Dipartimento di scienze chimiche e geologiche dell’Università degli Studi di Cagliari ha confermato che si tratterebbe di vetro primario.
Il vetro è uno dei primi, rari e preziosi materiali conosciuti e utilizzati dalle antiche civiltà per la realiz-
NURAGICI ED IL PRIMO VETRO
zazione di vari utensili. Proprio la sua produzione sta regalando un primato eccezionale alla Sardegna e ai Nuragici, la fiorente civiltà che nacque e si sviluppò nell’Isola a partire dal 1800 a.C., in piena età del Bronzo, famosa per aver costruito migliaia di nuraghi disseminati un po’ in tutta la regione.
Non c’è mai stata una certezza assoluta di quando l’umanità abbia scoperto il vetro. Tuttavia, fino a questo momento, le scoperte archeologiche avevano sempre fatto propendere per l’attribuzione al popolo degli egizi delle prime produzioni artificiali di vetro, facendole risalire al 1500 a.C. Il vetro è composto principalmente di silice, la sostanza di cui è fatta la sabbia e che era presente in grandi quantità in Egitto e in Mesopotamia.
Fu un blocco di vetro ritrovato nel 1932 nel deserto libico a dare il via alle ricerche che portarono al riconoscimento della capacità degli egizi di lavorare il vetro, oltre alla ceramica.
Il dubbio iniziale se gli antichi egizi producessero direttamente il vetro o se invece lo importassero dal Vicino Oriente, per poi lavorarlo, fu fugato grazie agli scavi risalenti al 2007 e condotti da un gruppo di esperti guidati da Paul Nicholson dell’Università di Cardiff e da Caroline Jackson dell’Università di Sheffield. (segue pagina 28)
27
I
(segue dalla pagina 27) Nicholson era infatti a capo di un’equipe della “Egypt Exploration Society” che si occupava di studiare, già dal lontano 1983, il sito archeologico di Amarna, che si trova sulle rive del Nilo e che, fino ad oggi, è sempre stato ritenuto il luogo più antico del mondo per la produzione del vetro.
Il gruppo di archeologi aveva ricostruito e messo in funzione la fedele copia di una fornace risalente a 3000 anni fa e che ritenevano fosse utilizzata dagli egizi per produrre il vetro utilizzando la sabbia del luogo, ipotizzando inoltre che questa fornace facesse parte di una più vasta area industriale dove si ricorreva a processi di produzione di manufatti ad alte temperature.
Ipotesi confermata dal fatto che sempre in quel luogo furono rinvenuti attrezzi utilizzati per la lavorazione delle ceramiche.
“Non sapevamo con certezza se il vetro lavorato per produrre i manufatti finora rinvenuti nel sito fosse prodotto in loco o venisse importato”, aveva dichiarato Nicholson nel dicembre del 2007, ora credo sia evidente che artigiani esperti fossero in grado di produrlo autonomamente e che fossero anche coinvolti in altre industrie manifatturiere”.
A distanza di 14 anni dalla Sardegna sembra invece emergere una realtà
diversa, l’utilizzo di materiali vetrificati per la realizzazione di artefatti sembra risalire infatti ad un periodo ancora più antico.
È quanto scoperto durante gli scavi archeologici eseguiti a Siddi, un comune della provincia del sud Sardegna, nella regione della Marmilla, per recuperare il sito nuragico di “Sa Conca ‘e Sa Cresia”, un nuraghe complesso, nato come nuraghe a corridoio nel Bronzo Medio e poi ristrutturato come Tholos, come tomba a forma di cupola, nel Bronzo Recente.

Grazie al rinvenimento, proprio all’interno del sito, di un recipiente, di un crogiuolo per la fusione del vetro, la dottoressa Giusi Gradoli, geologa e archeologa, e Mauro Perra, direttore scientifico degli scavi, hanno annunciato che lì probabilmente c’era un sito di produzione primaria di vetro, forse il primo non solo in Sardegna, ma addirittura in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo perché risalente al 1700 a. C. Di conseguenza sembra che i Nuragici abbiano preceduto gli egizi nella produzione del vetro e che siano stati i primi al mondo.
“Qui c’era una produzione primaria di vetro nel 1700 prima di Cristo, spiega la dottoressa Gradoli ai microfoni di Videolina. Attualmente, i primi vetri conosciuti in Europa sono del Bronzo Recente, Bronzo Finale, e sono dell’Egitto, di Amarna e del nord dell’Egitto,
Foto shmag.it
datati 1600 – 1500 a.C.”
“Non ci aspettavamo niente di tutto questo, sostiene il direttore scientifico degli scavi, Mauro Perra, abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo incaricato la dottoressa Gradoli di fare delle analisi delle ceramiche e poi, a sorpresa, è venuta fuori questa grandissima scoperta”.
“
C’era uno strato vetroso, amorfo in questa ceramica che, precisa ancora la dottoressa Gradoli, dal punto di vista della tipologia, era completamente diversa da tutte le altre domestiche”.
Una scoperta che riveste un’enorme importanza, per la quale sono state disposte delle analisi chimiche dello strato amorfo rinvenuto nel vaso, eseguite dal Dipartimento di scienze chimiche e geologiche dell’Università degli Studi di Cagliari e che non hanno fatto altro che confermare quella che per gli studiosi era già da qualche giorno una certezza: i primi al mondo a produrre il vetro furono proprio i Nuragici in Sardegna.

anni. Sono passati 10 anni anni da quando decisi di intraprendere il mio percorso musicale da sola.
10 anni da quando decisi di non affidarmi a nessun agente, di non chiedere a nessuna etichetta, non iscrivermi alla Siae, vendermi i concerti da sola, non affidarmi a nessuna distribuzione.
E lo feci perché le condizioni erano sempre inaccettabili per me.
Quale fu il compromesso? Usare i social in maniera massiccia, accorciare la filiera, imparare a fare tutto.
In questi 10 anni sono successe una marea di cose, in stragrande maggioranza, bellissime. Ho venduto migliaia di cd, fatto concerti in lungo e in largo, stretto mani, conosciuto persone che poi sono diventati amici veri ( tanti).
Per carattere, festeggio tutto, non potevo non festeggiare questo traguardo. L’ho fatto con una cosa fuori moda: un vinile.
Si chiama 10, come gli anni che sono passati da quel giorno in cui mi buttai verso l’ignoto e contiene 10 brani, quelli più rappresentativi.
Raffaella Piras
Grande la soddisfazione espressa del sindaco di Siddi, Marco Pisanu, che ha dichiarato: “È una scoperta sensazionale, eccezionale, che non può che riempire di gioia e di orgoglio l’intera comunità siddese ma anche la Marmilla e tutta la Sardegna, ne siamo veramente orgogliosi”.
Ne ho registrato uno di nuovo, Lassaddu proi, e sono davvero soddisfatta perché si sente come canto adesso in tutte le sue sfumature, c’è Simone Sassu (segue pagina 30)
29
10
(segue della pagina 29) al pianoforte in tutta la sua bravura, lui che è arrivato a cambiare le cose e a darmi un suono nuovo, e c’è Sig Redeyef, Matteo Marongiu, colui che è sempre stato al mio fianco: un musicista straordinario, un arrangiatore raffinato, un amico. Spero di farvelo ascoltare presto.
Ci sono dei ringraziamenti fondamentali da fare:
a Claudia Baldus che, anche questa volta, ha fatto la foto giusta, quella che volevo, che per me è piena di significato ( un giorno, forse, ve la spiego).
A Maurizio Olla che ha impaginato il tutto in tempo record.
A MalaRadio MalaRadio, Cisco del mio cuore, che ha aggiustato i suoni, quanto bene che ti voglio!
A Maria Atzori che si è sbucciata tutta la parte burocratica e lo ha voluto quasi più di me.
Ma grazie a tutti voi che in 10 anni mi avete dato modo di esistere.
Apriranno il concerto i vincitori del mio contest di canto … e Asia.
I vinili sono già disponibili. Grazie.
Per prenotare, scrivete a questo numero:
+39 347 9389791
B Flat
domenica 12 marzo 2023
dalle 19
Via Del Pozzetto 9
Quartiere del Sole
09100 Cagliari
CLAUDIA ARU IL DECIMO DISCO
Claudia Aru (...) est una cantadora sarda. Cun sa scritura de cantzonis e mùsica e un’atividadi notàbbili de cuncertus tenit una carriera intensa chi at biu fintzas sa partecipatzioni a acuntessimentus in Osaka, Pechino e Shangai e sa collaboratzioni cun atrus artistas sardus de importu mannu.

Biografia
A pustis de si laureai in s’Universidadi de Bologna in stòria de s’Arti, at bìviu de su 2002 a su 2005 in Barcellona, innui at studiau mùsica in sa scola “Taller de Musics”.
A pustis, at bìviu in New York e in Roma e est torrada in Sardìnnia in su 2008, innui at fundau su progetu Bentesoi, cun Arrogalla, chi at pubblicau duus Album, Tripland e Folk You.
In su 2012 inghitzas sa carriera sua de solista pubblichendi s’album Aici cun s’eticheta Nootempo chi iat giai prodùsiu is album de is Bentesoi.
S’album bessit a pustis de su sìngulu omònimu e in paris cun un’atru sìngulu, Burdu bu.
Totus is testus de s’album funt scritus de issa etotu e sa mùsica est cumposta in collaboratzioni cun Marcello Pilleri chi sonat sa ghitarra e su banjo e cun Mat-
Foto agora
teo Marongiu a su contrabbassu.
In su 2013 bessit su segundu album, A giru a giru. In su 2015 bessit su sìngulu Su Tasinanta, sighiu de s’album Momoti, chi pigat su nòmini de sa criadura de fantasia de s’immaginàriu sardu e chi unas cantas pubblicatzionis ant definiu cummenti s’album de sa maduresa de s’artista.



In su mesi de ladàmini de su pròpiu annu, bincit su Prèmiu Andrea Parodi po sa mellus interpretatzioni. In su 2016 at cantau cun su grupu suu in Osaka, Giaponi, in un’acuntessimentu organizau de s’Istituto Italiano di Cultura.

S’ocasioni dd’at ispirau sa creatzioni de su vìdeu po sa cantzoni Oi mi scidu chitzi, bessiu in su 2017. Sèmpiri in su 2016 est stètia candidada a sa Targa Tenco. In su 2019 pubblicat s’album Aru, innui contat cun ironia e crìtica su mundu de provìntzia. In s’interis de sa Pandemia de COVID-19, cun s’impossibilidadi de fai cuncertus nous, abarrat ativa in lìnia publichendi su sìngulu “Arrò du Covid” e ghetendi s’idea de cumpartzi òperas de artistas sardus me is arretzas sotzialis cun s’hashtag #adottaunartistasardo comenti sinnu de solidariedadi in su momentu de dificultadi. wikipedia.org
Discografia

2008Tripland
cun is Bentesoi
2010Folk you!
cun is Bentesoi
2012Aici
2013A giru a giru
2015Momoti
2019Aru Sìngulus
2012Aici
2012Burdu Bu
2015Su Tasinanta

2016La canzone dell’estate

2017 -
Oi mi scidu chitzi
2019BHGAI
2020Arrò du Covid
2021T’agatu
31
ILciclo di Masterclass musicali organizzate da “Veni, vidi, cognovi”, realtà formativa con base nella Barbagia-Mandrolisai, di cui “Sa Scena” è media partner, si propone come opportunità unica per musicisti e artisti.
Otto gli appuntamenti in programma con docenti dai volti noti nella musica sarda e nazionale tra cui Carmelo Pipitone, dei Marta sui Tubi, Claudia Aru, Arrogalla, Gino Marielli, Maurizio Pretta, Alessandro Pili, Perry Frank e Quilo di Sa Razza.
Questo primo ciclo si terrà tra gennaio e giugno e ciascuna di esse prevede due giornate.
Lo scorso weekend del 14 e 15 gennaio, al Centro Polifunzionale di Sorgono, paese con più di mille abitanti, si è tenuta la Masterclass di canto moderno con la docente Claudia Aru.
Il seminario si è svolto in due giornate di otto ore ciascuna, durante le quali sono stati esplorati aspetti legati alla tecnica di esecuzione, alla respirazione e ai cambi di registro, nonché quelli più prettamente legati alla performance.
Nell’ambito della media partnership i redattori di Sa Scena incontreranno i docenti delle masterclass al termine di ciascuna per conoscere da vicino le loro impressioni a caldo sull’iniziativa di Veni, vidi, cognovi.
In occasione della Master-
CLAUDIA ARU A SA SCENA
class di canto moderno Laura Garau ha scambiato due parole con la docente Claudia Aru sull’incontro con gli studenti e sull’insegnamento, sulle scene musicali in città e nei piccoli centri e in particolare l’importanza che assumono le esperienze musicali in questi ultimi, grazie anche alla presenza delle scuole civiche.
Si ringraziano l’Associazione Brincamus, Giancarlo Palermo e Giorgia Cau, il centro Polifunzionale di Sorgono per averci ospitati e Claudia Aru per la disponibilità. Laura Garau
https://www.sascena.it/intervista-a-claudia-aru/ vedi il video https://youtu.be/xCf_ ReVzN3Y
Una donna bella è una donna felice.
Perché è più luminosa, più sorridente. Non perché è magra”.
E’ il bellissimo messaggio body positive lanciato dall’artista di Villacidro Claudia Aru.

“Non voler mostrare il proprio corpo è spia di una grande insicurezza, spesso cela traumi e brutte esperienze che vanno affrontate e curate.
E siccome ” sei grassa”, anche io me lo sono sentita dire dal mio “compagno”, so esattamente quanto faccia male.
E’ un dolore lacerante che può portare a conseguenze terribili. Per questo bisogna curarsi l’anima e abbracciarsi, ascoltarsi, accettarsi ( e mandare a cagare chi non ci rispetta).
Volersi bene, sì, di nuovo, parte tutto da qui”.
Foto vistanet
“Sempre più spesso mi accade di parlare con persone che non vanno al mare per non mostrare il proprio corpo, scrive la cantante sarda.
A preoccuparmi, c’è che chi rifiuta di fare il bagno al mare non siano solo adolescenti nel pieno della loro crisi esistenziale, ma anche donne mature e… uomini. E quindi non bastano i modelli di body positive… evidentemente c’è qualcosa di più profondo e serio che merita una riflessione.

Mi sono imbattuta qualche giorno fa, su una nuova sfida di TikTok chiamata “Boiler summer cup”.
Si tratta di una gara che consiste nel conquistare la ragazza più grassa e, di conseguenza, più “cessa” della discoteca, farla sentire bella e corteggiata, salvo poi sbeffeggiarla e umiliarla impietosamente”.
Ovviamente tutto deve essere rigorosamente ripreso e postato sul social.
Quindi c’è qualcosa di profondamente inquinato che va scardinato e combattuto.
Ma non parlo solo del bullismo, i cretini ci sono e ci saranno sempre.
Noi dobbiamo amarci di più, rispettarci di più, ascoltarci di più. Amiamoci, sempre, che siamo magri, grassi, alti, bassi, o quello che volete, la cosa importante è mettersi al centro della nostra vita, stare bene dentro.
Ps e fatevelo il bagno, che la gente in spiaggia ha cose più importanti da fare che guardare la vostra pancia.
Ci vediamo in spiaggia”.
www.cagliaripad.it/564763/ claudia-aru-una-donna-e-bellaperche-e-felice-non-perche-emagra/
La ricerca di Costantino Nivola (Orani 1911 - Long Island 1988) attraversa due continenti e una varietà di ambienti: dalla Milano razionalista fra le due guerre alla New York dell’Espressionismo astratto, dalla Parigi surrealista dei tardi anni Trenta a quel ritrovo di scultori da tutto il mondo che erano le cave della Versilia negli anni Settanta, dalla Berkeley della contestazione studentesca alla Roma degli anni di piombo, passando e ripassando per la Sardegna, luogo reale e mitico intorno al quale si era formata la sua visione di artista.
Il suo è stato un itinerario non lineare ma pieno di svolte e di ripensamenti, che lo ha portato a indossare di volta in volta i panni del grafico, del decoratore e creatore di allestimenti, del pittore, dello scultore e del designer, muovendo dalla scala minima del foglio di carta a quella monumentale dell’intervento architettonico.
Il Museo Nivola di Orani - oltre duecento opere dell’artista, tre padiglioni modernisti nel cuore della Barbagia immersi nel verde di un parco-giardino mediterraneo ai piedi del monte Gonare - è stato fondato nel 1995, ampliato nel 2012 e rinnovato a partire dal 2015 con un nuovo allestimento e il lancio di un programma di mostre temporanee.
A partire dall’itinerario nivoliano (segue pag. 34)
33
(segue dalla pagina 33) e in linea con una visione del contemporaneo come spazio ibrido in cui l’arte si intreccia con l’architettura, con il design e con l’attivismo, il Museo Nivola è un luogo aperto alle sperimentazioni in cui passato e presente dialogano, dove l’arte e la figura di Nivola diventano metafora e trigger di un modo nuovo di pensare la cultura.
Il Museo ospita una collezione permanente, articolata in sezioni che raccontano il percorso artistico di Nivola, a partire dal suo primo importante progetto americano: lo showroom Olivetti sulla 5th Avenue, realizzato con i BBPR, che lo lancia come “scultore per architetti”.
Il percorso espositivo presenta poi la sua attività di art director nelle redazioni di riviste americane come Interiors e Pencil points, e ce lo mostra nel giardino della casa di Long Island, dove sperimenta le tecniche del sand casting e del cement carving, che vedranno la piena maturità negli importanti incarichi americani dei college Morse e Stiles di Yale o per la facciata della Hartford’s Mutual.
Non mancano i progetti utopici per la Sardegna: quelli non realizzati come il monumento a Gramsci, gli esperimenti con la pittura e quelli con la luce e lo spazio, le terrecotte, e l’approdo della tarda maturità, con le Vedove e le Madri che costituiscono forse l’aspetto più iconico
NIVOLA MONUMENTO A GRAMSCI
e conosciuto dell’arte di Nivola.
La ricerca sullo spazio, lo porta negli anni Settanta a elaborare il tema delle “stanze” in disegni, dipinti e sculture.
Opere compiute più che modelli, le stanze rielaborano l’idea dello spazio al tempo stesso fisico e simbolico del monumento a Gramsci, sottraendolo dalla sfera dell’arte pubblica per reinterpretarlo in chiave privata ed esistenziale.
Semplici forme geometriche aperte sul lato frontale, le stanze hanno piccole finestre che lasciano entrare la luce modificando lo spazio.
Nel 1968 Nivola inizia a lavorare a un monumento dedicato ad Antonio Gramsci da realizzare a Ales, paese natale del politico e filosofo.
Per Nivola Gramsci era “il più grande dei Sardi”: nonostante le umili origini e i problemi fisici, si era elevato grazie all’impegno e alla grandezza del suo pensiero. Il monumento, disegnato con Richard Stein, evocava la prigione fascista di Gramsci e al tempo stesso la stanza della sua casa d’infanzia.
L’assenza del soffitto serviva da contrasto simbolico tra la situazione di costrizione fisica di Gramsci e la capacità universale del suo pensiero di espandersi all’infinito.
Nasceva il 22 gennaio 1891 Antonio Gramsci

Foto the vision.com
Ci ha lasciati Giuseppe Pettinau, uno dei grandi protagonisti negli anni Sessanta delle neoavanguardie artistiche in Sardegna.

Aveva insegnato a lungo al Liceo Artistico di Cagliari, dove ha istruito centinaia di studenti. Un altro protagonista dell’arte sarda lascia un profondo vuoto in città.
Giuseppe Pettinau nasce a Sardara (CA) nel 1943. Nei primi Anni Sessanta partecipa alla costituzione del “Gruppo di Iniziativa” impegnandosi con diverse mostre collettive.
In questo periodo la sua pittura è prevalentemente di tipo espressionista con richiami sia al cubismo picassiano che al surrealismo di Miró.
Dagli Anni Settanta ad oggi la sua ricerca si sposta verso esiti di carattere materico, con ambizioni narrative legate ad una più rigorosa strutturazione dello spazio. Nel 1991 è tra i fondatori del “Gruppo ‘91” di cui elabora il manifesto.
Nel 1992 vince il primo premio di pittura al “Festival Regionale delle Arti”.
E’ presente nella collezione d’Arte Contemporanea della Galleria Comunale di Cagliari.
Dal 1968 al 1985 e docente di Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico di Cagliari.
E’ autore di numerosi saggi critici su artisti sardi.
All’occasione della mostra “L’enigmatico alchimista” allo Spazio (In) visibile nel 2019, Roberta Vanali scriveva :
Il simbolo artistico - si dice - è un rimandare ad altro e, nello stesso tempo, un riunire.
Ma è un rimandare ad altro - diciamo noi - che non può in se sussistere senza rimando problematico a se stesso, alle complesse mediazioni interne cui è sottoposto per via di specifiche “formatività” in un determinato territorio eidetico di rappresentazione.
Artista difficilmente imbrigliabile nelle trame di una singola categoria, Giuseppe Pettinau imposta la sua poetica su simboli enigmatici e misterici, attraverso un percorso analitico dove tensione e pathos insistono sul gesto pittorico teso a rivelare i flussi della coscienza umana.
Impostata sulla materia pittorica, l’indagine meditativa lenta e metodica restituisce ambigui e inquietanti ectoplasmi che galleggiano tra grumi dell’informale e simboli alchemici attingendo ad un inconscio ancestrale derivante dalla profonda conoscenza di filosofia, poesia e mitologia.
Come un moderno Diogene, Giuseppe Pettinau cerca l’uomo. L’uomo piegato su sé stesso, avvolto dall’ombra che lo circonda e lo fa tra graffianti codici segnici intrisi di un’aura sacrale e solenne. (segue pagina 36)
35
GIUSEPPE PETTINAU
Foto paoloorsini
(segue dalla pagina 35)
In alcune sue manifestazioni la pittura informale è stata prodiga di lacerazioni poco dialettiche, di frammentazioni esasperate sino al crollo di un orizzonte razionale capace di controllarne le traiettorie vitalistiche. “Spero di aver contribuito, con la mia pittura, a rendere visibile tale conflitto”.
Negli anni Sessanta l’approccio pittorico dell’artista è di natura onirica, molto vicino alla trasfigurazione lirica della realtà di Paul Klee e al surrealismo di Mirò.

Un linguaggio descrittivo e simbolico di diversa provenienza semantica che si pone a metà tra astratto e figurativo. Sono tempi in cui è in atto un processo di svecchiamento culturale che vede gli artisti isolani uniti contro un folklorismo imperante ed un sistema oramai asfittico. Pettinau partecipa attivamente alla costituzione de Il Gruppo di Iniziativa e del Centro di Arti Visive attraverso un’incessante sperimentazione che è anche esperienza esistenziale e che negli anni Settanta lo conduce ad esiti più vicini all’espressionismo astratto che risente dell’influsso vorticoso del movimento artistico Co.Br.A.
Negli anni Ottanta il segno si fa più lineare e la gamma cromatica si riduce notevolmente.
Iniziano a comparire lacerti spessi e grumosi puntualmente graffiati o incisi e prende forma la serie delle Teste, monoli-
ti che alludono alla figura umana, una costante nella ricerca dell’artista che si protrarrà fino alla fine degli anni Novanta.
È nostro preciso convincimento che in quest’ultimo scorcio di secolo il settore delle arti visive sia caratterizzato da confusione linguistica alta, frutto di estrema inerzia.
Siamo cioè convinti che il Postmoderno abbia del tutto mancato, per amore dell’arbitrio, ciò che si era prefisso: d’essere espressione concreta di un radicale mutamento di rotta.
Si legge nell’incipit del Manifesto del Gruppo ’91 di cui Giuseppe Pettinau è stato artefice, nonché teorico, insieme ad Attilio Della Maria, Italo Medda, Italo Utzeri e Beppe Vargiu, e i cui dettami confluiscono nell’alveo della componente spazio-temporale che, privata del ruolo di forza propulsiva primaria, acquista un’importante profondità di senso.
Quello degli anni Novanta è il periodo più prolifico per la produzione artistica di Pettinau.
Alla rigorosa strutturazione dello spazio accosta un apparato simbolico più stratificato.
Il nero scompare e la superficie pittorica si accende. Il linguaggio si fa più introspettivo e la visionarietà più enigmatica.
Compaiono lettere, numeri, apparenti esseri unicellu-
Foto artribune
lari dall’evidente nucleo che si sostituiscono in parte all’ordine geometrico.
Il segno appena accennato diventa più marcato e aggressivo e i colori più cupi.
L’inevitabile trascorrere del tempo in cui l’uomo è vittima di un continuo mutamento è ora al centro dell’indagine concettuale dell’artista.
Negli anni del nuovo millennio ritorna alla tele di grandi dimensioni e per contro ai disegni di piccolo formato dove l’uso del colore è congeniale alla trasfigurazione lirica della realtà.
Realtà indagata nei suoi reconditi processi, tra i meandri più profondi dell’inconscio.
Nascono due distinte serie di disegni a china: una in un rigoroso bianco e nero dove pare riemergere l’automatismo del gesto; l’altra a colori più calcolata ma dall’atmosfera evocativa.
La mostra personale di Giuseppe Pettinau, ideata e curata dalla sottoscritta per Lo Spazio Invisibile, arriva dopo diversi anni in cui l’artista decide di partecipare solo marginalmente al dibattito artistico-culturale isolano. Con l’obiettivo di tracciare il percorso e attribuire il dovuto riconoscimento ad uno dei più grandi artisti storici del panorama isolano, sono state selezionate le opere più rappresentative dal 1968 al 2006 tra oli e disegni per un totale di un centinaio di lavori.
Artista di grande spessore intellettuale ed estrema sensibilità e raffinatezza, capace di svelare i mali dell’esistenza attraverso un processo di trasformazione dell’inconscio in immagini simboliche, Giuseppe Pettinau giunge al riconoscimento del sé mediante un percorso fatto di allegorie, metafore, immagini archetipiche, simboli spesso indecifrabili, codici occulti e figure antropomorfe che lo proiettano in un universo alchemico.
Universo dell’arte della percezione, capace di plasmare e trasformare la realtà per giungere alla sublimazione esistenziale. Territorio in cui l’artista è maestro.
Roberta Vanali Bibliografia
A.Negri (a cura di), La Collezione d’arte contemporanea della Galleria comunaledi Cagliari, Cagliari, Amilcare Pizzi 1983.G.Pellegrini, Per l’arte in Sardegna: Giuseppe Pettinau, Stampacolor, Cagliari 1989. G.Pettinau, Manifesto Gruppo 91, Cagliari 13 dicembre 1991. AA.VV.

Arte Duchamp: dal Moderno al Postmoderno , Arti Grafiche Pisano, Cagliari 2004.G. Pettinua, Sul Simbolo, in “Soliana” n. 3, Cagliari giugno 2008.W.Nazzari, Quel Centro al centro. Un posto in trincea, Grafiche Ghiani, Cagliari 2017.
https://www.academia. edu/39851251/GIUSEP -
PE_PETTINAU_Lenigmatico_alchimista
37
Foto artribune
iu Egidio era entrato in agonia alle sette di quella sera di primavera e alle otto se ne era andato, dando un respiro più lungo, come uno che sta per addormentarsi dopo un giorno di fatica. Mi aveva riconosciuto e aveva mormorato: “lassaimì andai, ka sou fendu finas e prigu”... lasciatemi andare ché do anche fastidio...mentre la cagnetta, che mai era entrata in casa, era comparsa nella stanza, si era messa dritta sulle zampette posteriori e, indisturbata, aveva lambito i piedi del padrone morente. Sentii la carotide muta, il polso assente e ascoltai il cuore silenzioso più per abitudine che per una reale necessità.
La breve agonia non aveva lasciato segni su suo volto che appariva sereno.
Uscii con Luigi all’aperto nella sera che ormai affondava nel buio...capita che il sole muoia quando muore un uomo.
La cagnetta bianca era accucciata per terra, uggiolò per un attimo, poi mise le zampe sul muso e si abbandonò; e fu allora che dall’angolo oscuro della casa, si levò il canto...de sa stria...no, non un canto, ma un pigolio lamentoso, ritmico e ossessivo, che spezzò il silenzio della campagna per dieci minuti: un lamento lungo che finiva in un singhiozzo strozzato, che poi cessò d’un trat-
S SA STRIA DI TONINO SERRA CONTU
to....per poi ricominciare, per due volte, e poi finire. Luigi volse lo sguardo in alto e mi precedette per un secondo: “commenti naranta is antigus”
Sa stria.
Era giunta sulla casa squassata dalla sventura per annunciare la potenza della morte sulla nostra fragile esistenza.
Luigi la riconobbe.
L’aveva sentita a dieci anni quando il padre era morto battendo la testa su un masso mentre correva per catturare una capra e sa stria era volata sulla loro casa per cantare la terribile notizia a una giovane madre e ai suoi quattro figli rimasti soli.
Sa stria...la strega...sa coga abile nel “cocere” le erbe... ha accompagnato fin dall’epoca romana i racconti e le superstizioni dei sardi: un’ambasciatrice che annunciava la morte posandosi sulla casa in lutto.
E’ il barbagianni...Tyto Alba per gli ornitologi...un mite uccello notturno cacciatore di topi e rane, dal bianco volto schiacciato e con occhi neri e buoni come quelli di un mendicante che ti chiede l’elemosina e non si offende se non lo guardi in faccia e non gli dai neppure un centesimo.
I sardi del nord credevano che fosse una strega in sembianze di uccello, che uccideva i bambini in culla succhiandone il sangue, ma nel contempo dalle sue
 Foto artribune
Foto artribune
penne bruciate si ricavava una pozione che curava l’itterizia.
Poteva anche provocarla l’itterizia con sa striadura: una strega vampiro che dava la vita e la morte e che volava...senza scopa...dopo essersi trasformata in uccello notturno ungendosi i talloni e le ascelle con un olio magico tratto dalla peonia...s’orrosa e’ cogas: lo stesso che nel santuario di Delfi usava l’oracolo per entrare in contatto con Apollo.
I sardi del Campidano credono invece che sa stria accompagni col suo canto “su carru de sa morti”, trainato da cavalli senza testa e guidato dalla morte vestita di bianco, che sferragliando corre il villaggio alla ricerca di chi si avventura di notte nelle strade.
A Ierzu, oltre che ambasciatrice di morte, sa stria conservava ancora la sinistra fama di strega capace di provocare una febbre altissima e mortale su chi era stato frastimau...”anku ti giùmpidi sa stria”...volando sul corpo addormentato dello sventurato.
Una febbre maligna che colpiva chi non dormiva sul dorso o con i piedi incrociati; e contro sa calgentura si poteva preparare solo una pozione antica: si misurava l’altezza e l’apertura delle braccia del malato con un filo di lana tratta da sa lissa del telaio, e se si aveva la fortuna che i diametri fossero disuguali, gli si faceva bere con acqua la cenere ottenuta bruciando il filo con
un pezzo di unghia e di abito del malato e con un suo capello.
Se guariva in pochi giorni sa meiga era riuscita, altrimenti il malcapitato moriva entro l’anno.
Mi permetto di dissentire da miei avi e dalle dietedde del vicinato.
A me piace pensare che sa stria non sia un sadico uccello che provoca la sventura, ma un aedo triste, un cortese visitatore che annuncia una tragedia consolando i vivi che piangono...come la folla di contadini che vennero a salutare siu Egidio sciamando nell’aia alla fine della giornata...”a ddu conosciri in celu”...”tenei passiensia”...o come sia Maria sofferente, dritta con fatica su due bastoni...”non ddi podia fai ammanku”...o come sia Dominiga, stretta nei suoi numerosi lutti...”Deus onat, Deus leat...”
E mi piace credere che questi esseri, questi elfi benigni che arricchiscono le nostre case e i nostri cuori, che abitano le foreste e le montagne e il cielo alto siano apportatori di pace e non di morte.
E che i loro amore disinteressato che ancora ci tributano dopo millenni di massacri, di sfruttamento, di sacrifici nelle nostre guerre feroci e nei nostri giochi crudeli, sia un dono immeritato che dovremmo invece guadagnarci ogni giorno. Questi esseri non hanno il senso della morte...che questo privilegio è riservato (segue pagina 40)

39
(segue dalla pagina 39) agli umani...ma sentono quella degli altri e i loro sensi sovrumani avvertono la solitudine, il senso dell’abbandono del padrone che muore; e quando sono soli tutto il loro amore immenso si trasforma in un dolore angoscioso parimenti senza confini e senza speranza...che spesso aiuta gli umani ma ignora gli animali.
Alcuni giorni fa ho visto un filmato in cui un cane era abbracciato alla tomba della padrona morta... non accucciato, ma con le zampe protese a circondare quel pezzo di marmo...e quando un guardia pietosamente cercò di sollevarlo, il cane si mise a singhiozzare, come un uomo che ha perso la madre, e si stringeva ancora di più a quella terra che conservava la sua unica ragione di vita. Il filmato dura trenta secondi...ma non lo consiglio a nessuno.
Quando siu Ligas morì, negli anni Trenta, a s’e Cuboni, nel crollo di una grotticella di tufo... de bruverinu...chè allora non esistevano detersivi e le pentole si nettavano con quella polvere abrasiva..il suo cane si accucciò sulla frana...ululò guaì uggiolò pianse e non mangiò ne’ bevve per sette giorni...e si lasciò morire, nonostante i contadini degli orti vicini facessero a gara per portargli da mangiare e bere.
Mia sorella grande lo ricorda ancora...”finiu fi-
niu” dalla sofferenza su quel cumulo di terra. Negli stessi anni Ierzu conobbe una storia speculare, che commosse tutti.
Era nevicato tutto il giorno e siu Pasquali Corgiolu si accorse che il sua asinello non era tornato. Volse il capo verso il cielo grigio e pensando che la bufera fosse passata lasciò la sua casa di Cresia de Susu e si avviò tra la neve alta verso Genna’e Figu. Lo trovarono il giorno dopo sotto un cumulo di neve, che era caduta in abbondanza, con accanto l’asinello che lo vegliava e che ogni tanto cercava di farlo rialzare spingendolo piano col muso.
Ci chiediamo con molta ipocrisia se meritiamo l’amore di questi esseri che spesso ci colmano di dolcezza nei momenti duri che la vita non ci risparmia.
È come chiederci se meritiamo una Padre celeste che ignora la nostra arroganza e la nostra assenza di umanità.
Certi che non li meritiamo...ma spero che possano perdonarci perché ogni giorno tentiamo d’avvicinarci...almeno un po’...alla loro primitiva, istintiva e sconvolgente capacità di trovare felicità e pace nello sguardo di un altro essere...
Lo so, è difficile fare questi tentativi...ma vale la pena di provarci.
Tonino Serra Contu

Foto toninoserracontu
SU STIDDIU
ACagliari, sotto Piazza D’Armi, in una grotta, si nasconde il lago di “Su Stiddiu”. È capitato tante volte di sentir parlare di reperti archeologici, risalenti all’epoca romana o addirittura più antichi, ma pochi sanno che sotto piazza D’Armi a Cagliari si trova un lago sotterraneo, giusto qualche metro sotto i nostri piedi. Ebbene sì, probabilmente conosciuto da tanti ma non visitato da tutti, il bacino d’acqua si trova esattamente sotto la piazza, nella Grotta de Su Stiddiu, “della goccia”, chiamata così per via del fenomeno di stillicidio ancora in corso. Situata a meno dieci
metri di profondità ed estesa fin sotto il carcere di Buoncammino è una grotta artificiale appartenente anch’essa alle segrete di Cagliari, fra camere e cunicoli scavati sotto il lastricato della città.
Le grotte, risalenti al periodo fenicio-punico e riutilizzate in seguito anche durante il Medioevo, venivano utilizzate per estrarre minerali e pietre calcaree, necessari per la costruzione di case, edifici e mura difensive.
Successivamente i cunicoli sono serviti a convogliare le acque della rete idrica cittadina in una grande vasca di contenimento creando così il lago sotterraneo, che
con la sua limpidezza, sembra quasi finto. Uno specchio d’acqua cristallina nel quale si riflettono le bianche pareti rocciose della grotta, che ha reso speleologi e visitatori spettatori di uno scenario incredibile, lontano dalla frenesia della città.

Oggi il livello dell’acqua è diminuito notevolmente, da quasi quattro metri di profondità a un metro e mezzo nel presente, portando alla luce nuovi ambienti utilizzati nei modi più svariati, prima come cava di estrazione mineraria, poi come deposito della fabbrica di birra “Ferrero-Barisonzo”, proprio come una sorta di frigorifero industriale.
Poi, circa ottant’anni dopo, cambiando ancora destinazione, diventò un rifugio antiaereo durante i bombardamenti del 1943, quando il Genio Civile incluse la grotta di “Su Stiddiu”, nella lunga lista di tunnel e cunicoli adibiti a riparo. L’unica entrata attualmente accessibile è quella di viale San Vincenzo, tramite una piccola porta di ferro comunicante con quello che è un paesaggio insolito, basti pensare che, camminando all’interno della grotta, a pochi metri dalla propria testa, è posto uno dei punti nevralgici più importanti del traffico automobilistico cittadino.
Per quanto concerne l’acqua e il suo impiego, gli scritti del canonico Giovanni Spano ci forniscono preziose informazioni. Fino al 1867, il capoluogo sardo era sprovvisto di un acquedotto cittadino. L’acqua ad uso domestico proveniva dunque dalle fontane sparse per la città, come quella legata al Pozzo di San Pancrazio. In tale contesto si inseriscono anche le acque cristalline della Grotta di Su Stiddiu.
Non stupisce infatti che queste garantissero l’approvvigionamento idrico di buona parte della città.
In prossimità della Seconda Guerra Mondiale, la sua destinazione d’uso cambiò drasticamente. (segue pagina 42)
41
Foto angelopili gruppo speleo aloefelice
(segue dalla pagina 41) Fu così che nel 1942 la grotta rientrò nel registro ufficiale dei luoghi sicuri in cui rifugiarsi dalle bombe.
L’interno, visitabile solo con la presenza di speleologi e esperti durante visite organizzate, presenta non solo il lago, ma ambienti enormi con un età storica risalente addirittura a 2500 anni fa, che col tempo sono stati in parte modificati artificialmente, come quando insieme alle altre grotte sotto Piazza D’armi, quella de Su Stiddiu venne tenuta sotto osservazione per il timore che i detenuti di Buoncammino, potessero evadere dal carcere, posto esattamente a pochi passi dalla grotta.
Per questo alcuni accessi ai cunicoli vennero in parte chiusi con grate di ferro o murati.
Più volte gli improvvisi crolli della vicina Grotta della Frana ne hanno compromesso la stabilità.
A ciò è da aggiungere la fragilità della sua copertura, minacciata dal via vai delle tante persone che transitano per la Piazza d’Armi.
Tale pericolo ha richiamato inevitabilmente l’interesse dell’amministrazione cittadina.
Per ovviare ad altri incidenti, questa ha decretato, nel 2014, la chiusura della Grotta della Frana e il suo reversibile riempimento con argille e resine.
La Grotta di Su Stiddiu è, dal canto suo, posta sotto vigili controlli.
2022 DI ANNELISE ATZORI
Si è concluso un anno colmo di successi e riconoscimenti per l’artista Annelise Atzori. Nata in Germania ma di origini sarde e residente a Sanluri Stato, Annelise Atzori è un’artista a 360° di fama internazionale. Pittrice, scultrice, grafica, poetessa, mosaicista, diplomata all’Accademia di Belle Arti, vanta esposizioni in tutto il mondo e migliaia di fan che la seguono con affetto.

Il 2022, un altro anno che ne ha sancito la fama con le diciotto mostre che hanno visto protagoniste le sue opere in giro per il mondo: da Dubai a Roma, da Londra a Barcellona, da Parigi a Venezia.
Tanti anche i premi, tra cui il Primo premio “Città sì” vinto a Berlino per la creatività e per la tutela del patrimonio artistico, il Gran premio per l’arte e la cultura vinto in occasione dell’Universal Expo di Dubai, la Palma d’oro per le arti visive vinto alla Biennale internazionale di Montecarlo e il Premio “Arte cavallo” vinto all’Ippodromo di Milano.
Il segreto del suo successo?
Cercare la diversità nelle piccole cose: «Io studio sempre il diverso, commenta Annelise.
Penso sempre all’innovazione, alla ricerca dell’inusuale e ogni volta che mi pare ci siano due cose che non hanno nulla a che fare con l’altra, allora mi piace
Foto giornalel’ora
IL
cercare un collegamento e ci trovo un senso. Quando faccio i mosaici, ad esempio, chiudo gli occhi, prendo un fascio di tegole e scelgo i colori, casualmente.
Le idee sono tutte nella mia testa e spesso bisticcio con gli attrezzi che utilizzo perché le idee sono infinite e vogliono tutte venir fuori».
Tra i premi e gli attestati collezionati, l’ultimo a Firenze, lo scorso 4 dicembre, in occasione di una sfilata tenutasi a Palazzo Borghese che ha visto tra i protagonisti 24 abiti di Annelise:
«Dentro Palazzo Borghese ho vissuto un giorno da sogno.
Ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della tessitura quando ero una bambina.
Non vivrei senza la mia arte, quando creo i miei abiti uso un occhio estetico, mi piace cercare modelli che mettano in risalto la bellezza del corpo femminile: trasporto la mia arte negli abiti».
Tanti anche gli appuntamenti e i progetti per quest’anno, in lavorazione una sceneggiatura “Cuore di bambola” che promette di far parlare di sé nei prossimi mesi.
La Gazzetta del Medio Campidano
https://www.lagazzettadelmediocampidano.it/sanluri-annelise-atzori-un-anno-di-opere-darte-in-giro-per-il-mondo/

Nuovo riconoscimento per la città di Iglesias e il suo territorio.
Dopo i dati rassicuranti del 2022 che hanno visto l’Iglesiente crescere in termini di attrattività turistica e di offerta culturale, la zona sud-occidentale dell’Isola è stata scelta da Slow Food Italia per “Slow Food Travel”, il percorso formativo dedicato alla promozione dell’enogastronomia locale e alla formazione degli addetti ai lavori, per dar vita a un’offerta turistica attenta al patrimonio delle comunità.
Gli incontri di approfondimento, orientati sugli assi del turismo sostenibile e dell’imprenditorialità, si sono tenuti lunedì 16 gennaio nei siti della grotta di Santa Barbara, Porto Flavia e il belvedere di Nebida, mentre la formazione ha avuto luogo nella giornata successiva presso l’Istituto alberghiero Ipia Galileo Ferraris di Iglesias.
Al termine dei seminari formativi e dei tavoli di lavoro nei quali si è discussa la promozione di un’offerta turistica in grado di presentare il territorio attraverso la lente di Slow Food, gli operatori aderenti hanno sottoscritto le linee guida che definiscono le caratteristiche dell’accoglienza proposta, del tipo di esperienze presentate e del marketing congiunto.
“Il turismo di qualità si costruisce mettendo in rete (segue pag. 44)
43
(segue dallam pagina 43) tutti gli attori, pubblici e privati, per creare la destinazione turistica, ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usa, ed è proprio nei periodi di bassa stagione turistica che bisogna impegnarsi maggiormente per ottenere poi il massimo risultato.
Siti minerari, scuola, ristoratori e albergatori devono procedere tutti uniti verso un unico obiettivo: creare sviluppo turistico sostenibile e lavoro stabile 365 giorni l’anno”.
Per Rossella Pisano, team leader del progetto di Slow Food Travel Sulcis Iglesiente e Cagliari: “Abbiamo voluto proporre un percorso emozionale, fatto di esperienza, buon cibo, cultura e bellezze naturali. Con l’obiettivo di promuovere una realtà molto importante come quella dell’Iglesiente, per fare sistema insieme ai produttori del territorio, agli operatori del settore e alle comunità locali.
Slow Food Travel vuole far vivere emozioni, educare i viaggiatori alla tutela della biodiversità alimentare e favorire la conoscenza di culture, identità e gastronomie locali, ma anche creare sinergie e stimolare incontri con le persone, custodi della natura e delle tradizioni dei territori”.
https://www.sardiniapost. it/cucina-e-cibo/slow-food-sceglie-iglesias-come-destinazione-enogastronomica-e-turistica/ https://www.slowfoodgodo.it/evento/sardegna-non-solo-mare/

FOOD GITA IN SARDEGNA
Quando si parla di Sardegna si pensa ad un mare bellissimo, ma noi vogliamo andare a scoprire la zona sud-occidentale dell’isola che è il Sulcis-Iglesiente (Meurreddìa-Igresiènti in sardo).
Questo territorio è sempre stato conosciuto per l’attività estrattiva di molti minerali nella zona di Iglesias e per quella riguardante l’estrazione del carbone nel Sulcis, delle cui numerose miniere carbonifere oggi nessuna è più operativa.
L’estrazione e la lavorazione dei minerali in Sardegna risale a tempi molto remoti a partire dalla preistoria; queste attività sono state poi portate avanti dai Romani in modo più organizzato sino ad epoche recenti.
Il nostro percorso inizierà a Cagliari dove trascorreremo tutto il weekend, visitando il centro storico con una guida ed anche alcune realtà produttive nei dintorni della città, come la salina Conti Vecchi (gestita dal FAI) ed i campi storici del cappero selargino.
Da lunedì ci sposteremo verso il centro dell’isola dove visiteremo un sito archeologico molto importante a Barumini ed entreremo poi nel territorio del Sulcis-Iglesiente, dove ci fermeremo alcuni giorni. Avremo modo di conoscere meglio l’ambiente e la storia dei luoghi, andando a visitare alcuni produttori (formaggi e sottoli locali), dei siti archeologici ed anche alcuni insedia-
Foto sowfood
SLOW
menti minerari che hanno fatto la storia e la cultura di questa zona per secoli.
Soggiorneremo due giorni a Buggerru, una piccola località sul mare.
Nei giorni successivi, ci sposteremo ancora più a sud continuando l’esplorazione del territorio con visite a luoghi storici, paesaggi da favola e visite a produttori e cantine della guida Slow Wine (in questa zona si produce un rosso importante, il Carignano del Sulcis). Soggiorneremo a Sant’Antioco e un giorno andremo anche all’ isola di San Pietro, a Carloforte, in occasione della Festa del “Girotonno” una manifestazione annuale per ricordare la pesca al tonno e l’esistenza di tonnare ancora operative sull’isola.

Nel programma sono state previste numerose soste gastronomiche presso osterie che sono segnalate dalla Guida Slow Food, ma abbiamo previsto anche alcune cene libere per lasciare ad ogni partecipante la possibilità di organizzarsi come meglio desidera. Il programma è stato impostato con una filosofia slow per lasciare anche qualche spazio libero per godere del paesaggio e del mare.
Durante il percorso avremo anche l’assistenza e la collaborazione della Condotta Slow Food di Cagliari, con la quale faremo anche una cena sociale nel corso del primo week end.
Precisazione:
Il programma che troverete qui di seguito è ancora indicativo per la scelta di alcune osterie e di alcuni produttori e potrebbe subire qualche modifica negli itinerari, considerando che stiamo ancora definendo alcuni dettagli nella logistica.
Anche il costo totale del viaggio è indicativo, ma non andrà oltre all’importo massimo indicato. Purtroppo, alcuni costi legati ai mezzi di trasporto interno sono ancora in corso di definizione.
Ci riserviamo comunque di aggiornare tutte le informazioni entro poche settimane.
Programma di massima
Sabato 27 maggio 2023
Partenza da Bologna –arrivo a Cagliari
Visita salina Conti Vecchi
Campi storici di capperi (Selargius )
Cena con condotta Cagliari ??
Pernottamento a Cagliari presso Hotel Italia
Domenica 28 maggio
Visita guidata del centro storico a piedi
Pomeriggio libero (spiaggia del Poetto)
Cena (con Condotta di Cagliari???)
Pernottamento Cagliari
Lunedì 29 maggio
Gergei (SU) – visita microcaseificio con pranzo Visita Su Nuraxi a Barumini
Pernottamento a Buggerru presso Hotel ‘904
Martedì 30 maggio (Fluminimaggiore)
(segue pagina 46)
45
Foto sowfood
(segue dalla pagina 45)
Visita tempio di Antas
Fluminese Formaggi
Pranzo a Gonnosfanadiga
Perle di Sardegna (sottoli)
Museo Etnografico Mulino ad acqua a Licheri
Pernottamento a Buggerru
Mercoledì 31 maggio
Visita miniera Porto Flavia Masua (Iglesias)
Miniera San Giovanni con grotta Santa Barbara
Pranzo a Gonnesa
Visita parco archeologico
monte Sirai (Carbonia)
Pernottamento a Sant’Antioco presso Hotel Moderno
Giovedì 1 giugno
Visita necropoli di Montessu (Villaperuccio)
Visita a cantina
Pranzo a Giba o a Nuxis
Spiaggia Porto Pino –Sant’Anna Arresi (pomeriggio)
Pernottamento a Sant’Antioco
Venerdì 2 giugno
Tragetto Calasetta – Carloforte
Festa del Girotonno
Museo civico a Carloforte
Pranzo in locale tipico
Rientro tardo pomeriggio col traghetto
Pernottamento a Sant’Antioco
Sabato 3 giugno
Solky Affumicati – Calasetta
Visita cantina
Pranzo a Calasetta
Pomeriggio libero (giro dell’isola o spiaggia)
Ritorno all’aeroporto di Cagliari e rientro a Bologna
vedi informazioni :
https://www.slowfoodgodo.it/evento/sardegna-non-solo-mare/
KATIA CORDA SILIO CINEMA
“Ieri sera presso la Sala Storica del Cinema Vittoria a Uta, è stato proiettato” Fragheterra”, con la regia di Katia Corda, anche se il tempo non è stato magnanimo, c’ era un pubblico molto attento, e ha seguito la trama con moltissimo interesse, bellissime location, che hanno dato ancora una volta la certezza che la nostra Sardegna, una volta che la visiti, ti lascia rapito e ammaliato dalla bellezza dalla semplicità e calore della gente.
Susanna Mallei.
IAttrice, regista e scrittrice barbaricina 51enne, Katia Corda è un vero e proprio vulcano di idee e di passione. Premiata e apprezzata in tutta la Sardegna, oggi parla con noi di arte, cinema, donne e progetti per il futuro. Conosciamola meglio.
Quando e come è nata la tua passione per la recitazione?

Credo di averla sempre avuta.
Sin da piccola imitavo tutti, professori, conoscenti, attori e vedevo che le persone si divertivano tanto! Allora ho pensato che sarebbe stato utile unire la passione alla formazione, ma non potevo permettermi dei corsi a Roma o un’accademia.
Ho dovuto quindi muovere i miei primi passi in un laboratorio teatrale della compagnia Fueddu e Gestu
Foto katiacordasilio
di Villasor, che ancora esiste. Là ho avuto la conferma che recitare sarebbe stato ciò che avrei fatto da grande.
Prima ho dovuto studiare e poi lavorare per crearmi una mia indipendenza e quindi permettermi, in età adulta, delle master class con i più grandi attori e registi italiani, da Pupi Avati e Verdone a Veronesi e tanti altri.
Quali ruoli hai interpretato e a quale ti senti più legata?
Sono molto eclettica e quindi ho interpretato vari ruoli, con caratteri completamente diversi.
Come Angheledda in “Bandidos e Balentes”, una ragazza che colpita dalla faida prende la situazione in mano, tipico del matriarcato, armando la mano del fratello per vendicarsi del torto subito.

Oppure Agostina nella commedia “A si biri” di Francesco Trudu, proprietaria di un’agenzia funebre che esce con la borsetta a forma di bara e si fa fare i cartelloni pubblicitari del suo negozio, con foto in pose da vamp accanto alle sue bare.
Poi ho interpretato Lucrezia, una pseudo contessa moderna, al quanto truffaldina, nella serie tv “Orlando e Carlotta” di Alberto Cocco, per non parlare poi della Dott.ssa Piscitelli, una psichiatra internista nel film “Side Effect (effetto collaterale)” di Antonio
Meloni scritto da Angelica La Sala.
Infine, Assunta nel mediometraggio “Fragheterra” ideato dal geniale Franco Mascia, dove mi sono occupata sia della regia che di interpretare appunto Assunta, una donna colta, materna e molto concreta.
Forse sono più incline ai ruoli drammatici…ma se mi dovesse chiamare Verdone, ti dico solo che sto chiudendo la valigia, perchè lo adoro!
Con “Bandidos e Balentes” hai vinto un prestigioso premio.
Raccontaci come è andata.

Bandidos e Balentes stava girando per i festival nazionali ed internazionali, vincendo numerosi premi, sempre come miglior film, miglior fotografia e miglior colonna sonora, poi un giorno mi arriva la candidatura come miglior attrice protagonista al Gulf Naples Film Festival, un festival internazionale.
Non credevo ai miei occhi! Tornare in Sardegna col premio tanto ambito come miglior attrice protagonista e miglior film è stata un’emozione indescrivibile.

Qualche settimana dopo, poi, mi arrivò anche la candidatura come miglior attrice protagonista al Film Fest International a Milano, un festival mondiale.
Mi sono ritrovata a Milano in una cerimonia con rappresentanti di tutto il mondo.(segue pagina 48)
47
(segue dalla pagina 547) Io ero in lizza con altre cinque attrici selezionate, su 400 film.
Non ho vinto il premio ma in quell’occasione abbiamo ricevuto il premio come miglior film straniero.

Insomma, il rientro in Sardegna è stato comunque colmo di orgoglio! Nel tuo ambiente, ti sei mai sentita discriminata o presa meno sul serio in quanto donna?
Più che in quanto donna, in quanto sarda. Quando provi a lavorare fuori, salta spesso fuori il “problema” dell’accento.
Se sei romana vai bene se parli in romanesco, se sei napoletana va bene perchè sei simpatica, se sei siciliana va bene perchè puoi fare film di genere… ma se sei sarda ti dicono che devi fare un corso di dizione.
Credo che il sardo non sia facilmente collocabile, perchè il popolo sardo, se ci pensi non è comico, non è drammatico, non è mafioso e quindi al sardo col suo accento cosa gli fai fare?
Allora ho studiato dizione, ma poi ci ho riflettuto a lungo e ho deciso di combattere affinché si rispetti anche il mio accento!
Cosa vuol dire, secondo te, essere femministi oggi?
Secondo me non dovrebbe più esistere nemmeno la parola femminista, perchè significherebbe aver raggiunto la parità
totale con l’uomo, soprattutto in ambito lavorativo.
È innegabile che ancora oggi la donna fatichi doppiamente per arrivare ai posti di rilievo riservati agli uomini.
Se poi con tanta fatica ci arrivi, o è perchè ti sei concessa, o perchè sei bella o sei figlia, moglie o parente di chicchessia…non perchè hai le capacità!

Ci sono tanti pregiudizi da scardinare.
Spesso rivendichi la tua volontà di non volerti sposare. Come mai?
Credo che tutto abbia un inizio ed una fine…diciamo che amo gli inizi, consapevole che la fine prima o poi debba arrivare!
Meglio quindi non firmare nessun contratto per stare con un uomo e vivere le storie d’amore per una libera scelta che si deve rinnovare ogni giorno.
Inoltre il matrimonio implica la convivenza ed io al massimo potrei sopportare di avere il mio compagno come dirimpettaio!
Credo che più si sta lontani e più ci siano possibilità che la storia duri.
Poi mai dire mai! Io non escludo nulla nella vita… Per una donna è più difficile farsi strada nel cinema?
Quali sono gli ostacoli e i pregiudizi che hai osservato?
Devo dire che come attrice, oltre alla questione rela-
 Foto katiacordasilio
Foto katiacordasilio
tiva all’accento, non ho subito pregiudizi rispetto agli attori uomini.
Fortunatamente nel cinema si può essere alti, bassi, belli, brutti, vecchi e giovani…è un’arte molto democratica!
Magari ora, che per la prima volta, mi cimento come regista per Fragheterra in un ruolo, quello della regia che è tipico maschile, potrebbe capitare che mi si guardi con un occhio diciamo…più attento! Quanta determinazione e quanto studio ci sono dietro ai risultati che puoi vantare oggi?
Determinazione tantissima!
Studio altrettanto, soprattutto la tecnica di Sanford Meisner, discepolo di Stanislavskij, che è la tecnica di recitazione più vicina a me ed a ciò che intendo per recitare…”vivere veramente una situazione immaginaria”: l’attore deve imparare ad ascoltare l’altro e soprattutto a non essere centrato su se stesso, ma sull’attore che sta lavorando con lui.
Non solo attrice ma anche sceneggiatrice, regista e… scrittrice! Cosa rappresenta per te l’arte? Che progetti hai per il futuro? Cosa non hai ancora ottenuto?
Ogni volta che penso a tutte queste cose, dico “bisogna che desideri qualcosa che non farò, perchè se realizzo tutto ciò che desidero, forse morirò ancora giovane…ho terminato il mio compito sulla terra!”
A parte le battute, per me senza l’arte la vita non avrebbe gusto!
Ne adoro ogni forma: pittura, scrittura, recitazione, canto, scultura. Sicuramente non so dipingere, scolpire e forse nemmeno cantare!
Spero di essere credibile nella recitazione e molto ironica nel mio scrivere, come nel mio libro pubblicato dalla Arduino Sacco Editore intitolato “E chi se li (s)Corda!”

dove in chiave ironica racconto vari episodi della mia vita che, nel momento in cui li ho vissuti, mi hanno fatto soffrire, compreso il naufragio sulla Concordia nel 2012, ma che poi sono stati esorcizzati dalla potenza dell’ironia.
Infatti, il fil rouge che lega questi aneddoti è il messaggio che “qualsiasi cosa di spiacevole ti accada, affrontala col sorriso…perchè riuscirai a superare tutto con più facilità”.
Cosa non ho ancora ottenuto? Essere scritturata per un ruolo in un film di Verdone o Ozpetek, ecco il mio desiderio più grande ora!

Di recente hai girato “Fragheterra”. Come è stato lavorare con Franco Mascia e come ti ha accolto la terra d’Ogliastra?

Girare con Franco Mascia è stato emozionante, perchè ad ogni scena, stavamo realizzando in immagine ciò che lui ha pensato nella sua grande testa!
(segue pagina 50)
49
(segue dalla pagina 49) Sono davvero orgogliosa di aver fatto parte del suo progetto, sia come attrice che come regista, ma soprattutto come amica! Lui ha una mente vulcanica, gli raccomando di dormire la notte, ma non c’è verso, la creatività che mette nei suoi splendidi murales, la trasferisce quando immagina delle storie da sceneggiare, come lo spot contro la violenza sulle donne ideato sempre da lui e intitolato “Neanche per finta” per la regia di Massimo Sulis, dove ho potuto recitare con Franco anche là, emozionandomi ad ogni ciak!
Che dire poi dell’Ogliastra? Una terra misteriosa, incantevole e selvaggia che mi è entrata nel cuore: sono stata accolta a braccia aperte e coccolata, spero di tornare presto.
Ci sono delle donne, nel campo del cinema e non solo, alle quali ti ispiri? A parte tutte le grandi attrici del cinema italiano del Neorealismo, io adoro Meryl Streep…un sogno potersi avvicinare a lei!
Per il resto vorrei sempre ispirarmi alle donne che hanno qualcosa di interessante da raccontare…
Michela Girardi
https://www.vistanet.it/ ogliastra/2021/05/12/ le-donne-che-ci-piacciono-lattrice-e-regista-katia-corda-lironia-ci-salvera-sempre-sul-set-enella-vita/
ROMA NEW YORK1953 / 1964 T
ra le varie rotte che nel Dopoguerra allacciavano Europa e Stati Uniti, ce n’è una particolarmente cara al mondo dell’arte: Roma-New York.
Negli anni Cinquanta, con il ritorno di artisti, scrittori e intellettuali dall’esilio e dai campi di prigionia, Roma emergeva come il centro di una nuova avanguardia.
Tutta italiana, slegata dall’influenza parigina che aveva in gran parte definito la prima metà del ventesimo secolo. New York, d’altra parte, brillava della luce del cambiamento, illuminava il resto del mondo con la promessa di un orizzonte nuovo. In un ménage che univa arte e società, il legame tra le due città ha assunto il sapore di un passaggio di consegne, o quantomeno di una contaminazione irreversibile. Roma, con l’eredità decadente, ma sempre affascinante, di una lunga tradizione classica, umanistica e barocca.
New York, oceano di libertà senza debiti pregressi, culla di novità anche in campo artistico, fautrice di un futuro ancora tutto da scrivere.
Così accadeva che, grazie a figure di raccordo come il gallerista triestino, ma di base a New York, Leo Castelli, artisti posti agli estremi dell’Atlantico si incontravano, di qua o di là, per lavoro, amo-
 Foto finestresull’arte
Foto finestresull’arte
re, amicizia. Insomma, per l’arte. Ma cosa avevano da offrirsi l’un l’altro? L’America, lanciata dal consumismo sulla via della Pop Art, trova in Italia una forma d’espressione più intimista, legata in particolare al gesto e alla materia, un Informale intriso di liricità antica.
L’Italia, anch’essa sospinta dal boom economico, è ammaliata dall’immediatezza dall’iconografia consumistica americana, tanto da incorporarla nell’estetica dominante al tempo: il nuovo realismo.
Il Nuovo mondo anelava dunque la cultura del Vecchio; il Vecchio mondo desiderava le trasformazioni del Nuovo.
Di questo rapporto cruciale si occupa in questi giorni la sede newyorkese di David Zwirner, a Chelsea, nella mostra Roma/New York, 1953-1964, curata da David Leiber e visitabile fino al 25 febbraio. Un racconto visivo di mondi ed estetiche intrecciate, come risulta evidente confrontando gli esiti artistici che i rispettivi autori hanno proposto. Nei lavori di artisti cresciuti con un’impronta neorealista (come Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Mimmo Rotella e Mario Schifano) si nota dalla metà degli anni Cinquanta in poi l’annessione di elementi tratti dalla sfera dei consumi o dalla

dimensione urbana di matrice americana. In particolare Schifano, che nel 1962 espone da Sidney Janis a New York nella storica mostra The New Realists, si fa portavoce di una pratica pittorica che accoglie frammenti di immagini, pubblicità e testi.
É la nascita della Pop
Art italiana, che si lascia sedurre dal fascino glitterato del consumismo d’oltreoceano ma è in grado di trasportarlo in una dimensione meno immediata, più stratificata, più ricca di implicazioni, più classica, più europea. Contaminazione inversa, invece, nel caso dell’Informale, corrente astratta caratterizzata da una ricerca sulla materia.
Sono figure come Afro Basaldella, Toti Scialoja, Alberto Burri e Piero Dorazio a portare a New York -(con le mostre nelle gallerie di Eleanor Ward, Catherine Viviano e Leo Castelli) i picchi sublimi di un movimento che a metà degli anni Sessanta andrà a perdere il suo mordente.
Allo stesso tempo, diversi artisti con sede a New York, come Philip Guston, Franz Kline, Willem de Kooning, Robert Rauschenberg, Salvatore Scarpitta e Cy Twombly esponevano a Roma, in particolare alla Galleria dell’Obelisco (segue pagina 52)
51
(segue dalla pagina 51) di Irene Brin e Gaspero del Corso e alla Galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis.
Un fitto intrecciarsi di personali e collettive che hanno determinato le rotte creative degli artisti in questione. E che Zwirner riprende, con una operazione curatoriale (e commerciale) volta a riaccendere prepotentemente i riflettori sui migliori esiti pittorici nostrani post-bellici in America (quindi sul mercato globale), accostandoli in modo da far ridondare rimandi e connessioni. Roma/New York, 1953-1964 si concentra infatti in particolare sugli artisti italiani, molti dei quali - tra cui Angeli, Perilli, Novelli - sono riconosciuti e acclamati in Italia, ma rimangono meno conosciuti negli Stati Uniti.
Ma anche autori pressoché sconosciuti come Luigi Boille, che però nel periodo considerato si è reso protagonista di importanti mostre, tra cui una al Guggenheim di New York accanto a Fontana, Castellani e Capogrossi.
Oppure Conrad Marca-Relli e la sua complessa pratica pittorica basata sul collage.
Nato da genitori immigrati italiani, Marca-Relli è stato un punto di contatto chiave tra le due comunità artistiche, mettendo in relazione mercanti e artisti e aiu-
tando a stabilire i rapporti che hanno reso questo periodo così importante, unico e forse irripetibile.
Difatti già nel 1964, l’anno in cui Rauschenberg vinse il Leone d’oro alla Biennale di Venezia, le comunicazioni iniziarono a farse più rade.
Roma perse la sua centralità nell’avanguardia artistica italiana, con Milano e Torino ad attrarre sempre più artisti e investimenti.
New York invece rimase lì, centro nevralgico del sistema dell’arte mondiale, ed è lì è ancora oggi, all’apice del sistema artistico internazionale.
E non dimentica quegli anni in cui, se si affacciava verso l’oceano, vedeva Roma.
Luca Zuccala
Giornalista, scrive di aste e fiere d’arte per il Corriere della Sera, è professore di giornalismo e mercato dell’arte per RCS Academy, tutte le domeniche tiene la rubrica sui mercati dell’arte per Rai Radio 1. Ossessivamente in giro per il mondo per mostre e fiere d’arte, si occupa da sempre di critica e mercato dell’arte, è vicedirettore di ArtsLife e vicedirettore del dipartimento culturale della fiera WopArt a Lugano.
https://www.finestresullarte.info/recensioni-mostre/recensione-mostra-roma-new-york-19531964-david-zwirner

Foto giosetta fioroni 1964
Incoronato più volte miglior maestro gelatiere d’Italia in varie competizioni, e numero uno in Sardegna per il Gambero Rosso, Fabrizio Fenu è apprezzato anche negli Stati Uniti da chef del calibro di Dan Barber.
Trasforma in gelati e sorbetti le eccellenze agroalimentari della sua Sardegna.
Non c’è erba o fiore che non abbia provato a “gelatizzare” con la sua innegabile abilità, si è messo alla prova anche con prodotti totemici sardi in apparenza difficili da trasformare in gelato, come capperi, cipolle, asparagi. formaggio pecorino, ricotta, bottarga, sempre con risultati allettanti.
Ha anticipato, insieme ad altri colleghi, il trend attuale del gelato per tutte le portate, del “gelato gastronomico” vincendo a Firenze il Firenze Gelato Festival nel 2014 proprio con un gelato al “Pecorino Fiore sardo Dop con pere caramellate al miele di Sulla”. Incoronato più volte miglior maestro gelatiere d’Italia in varie competizioni, Fabrizio è apprezzato da chef del calibro di Dan Barber, e ogni mese vola negli Stati Uniti dove a Boston segue la mensa aziendale di una company americana high tech che attribuisce grande valore al cibo preparato ai propri dipendenti e ospiti, in termini di qualità, sostenibilità delle materie prime, gusto e attenzione alla salute, e si avvale della sua col-
MIGLIORI GELATI SARDI
laborazione per gelateria.

Tra i suoi allievi ci sono anche gli studenti dell’MIT di Boston a cui ogni anno dà lezioni di gelato coinvolgendoli anche nella creazione di nuovi gusti.
Fenu non smette mai di sperimentare; la sua testardaggine e forza di volontà, tipicamente sarde, sono forse i suoi più grandi punti di forza, insieme alla collaborazione con sua moglie Maurizia, pastry chef, con cui ha aperto recentemente la gelateria-pasticceria I Fenu nell’ariosa ed elegante Piazza Galileo Galilei a Cagliari.
Attualmente il suo lavoro di ricerca lo sta portando a lavorare sulle piante selvatiche sarde tra cui la famosa Erba di San Giovanni o Iperico, una pianta officinale, che ha numerose proprietà, antisettiche, toniche, e che darebbe vita ad un gelato anche nutraceutico. I Fenu producono già gelati alla Senape selvatica, all’Acetosella, all’Elicriso, all’olio di Lentisco, piante officinali che oltre ad avere interessanti aromi e gusto sono anche virtualmente terapeutiche. Del resto, già i gelati alle mandorle sarde alle varietà locali di frutta contengono vitamine, oligoelementi ed altre sostanze che sono una panacea per l’organismo, specie d’estate quando le alte temperature provocano disidratazione e abbassano la temperatura sanguigna. (segue pagina 54)
53
I
Foto fenu
(segue dalla pagina 53)
Fabrizio e Maurizia hanno anche reso plastic free la loro gelateria-pasticceria, eliminando le vaschette di polistirolo, i cucchiaini di plastica, le bottigliette e tutta la plastica monouso, sostituita da oggetti ecologici.
“I Fenu” di Cagliari insieme a “Dolci Sfizi” di Macomer, ancora premiate dal Gambero Rosso, entrambe riconfermate nella guida “Gelaterie d’Italia 2023” con il massimo riconoscimento, i tre coni. Per Fabrizio Fenu, gelatiere artigiano che con sua moglie, la pasticciera Maurizia Bellu porta avanti il locale in piazza Galilei a Cagliari, è il settimo anno di fila.
I primi due era stato premiato per la gelateria di Marrubiu, di cui sono originari.
Fa invece centro per la quarta volta consecutiva Nicolò Vellino di Macomer. I due hanno entrambi aderito con numerosi colleghi sardi e italiani alla campagna “un gelato per l’Ucraina”, ideata da Emergency a sostegno della popolazione colpita dalla guerra.
Impegno «irrinunciabile» per Vellino, perché «l’ aspetto etico è importante quanto l’alta qualità dei prodotti».
Emozionato Fabrizio
Fenu per l’ennesima conferma: «Un’emozione pari a quella della prima volta, è molto più difficile confermarsi», afferma.
Due gelaterie “simili” per visione, quella di Cagliari
e quella di Macomer: prodotti di stagione e di alta qualità sostenibili e prevalentemente sardi. Tra i gusti de “I Dolci Sfizi” troviamo il torrone di Tonara e gli agrumi di Milis, ma anche fil’e ferru e s’aranzada.
I Fenu hanno creato tra i tanti “Ricotta di pecora scorza d’arancia, abbamele e mandorle tostate della Marmilla” e la novità il “Gelato gastronomico”, al pane con un mix di farina e segale integrali di San Gavino abbinato al gelato alla cipolla.

La Gelateria Artigianale Dolci Sfizi nasce dall’idea del suo titolare Nicolò Vellino di portare nel cuore della Sardegna le esperienze maturate durante gli anni trascorsi in giro per l’Europa. Dolci Sfizi ha come obiettivo la valorizzazione del territorio sardo e dei suoi prodotti. Il suo gelato ha guadagnato nel 2020 i 3 coni del gambero rosso e la menzione speciale al concorso internazionale “sherbeth” (cui ha partecipato con il gelato al torrone di Tonara). Dolci Sfizi non è solo gelato, ma anche pasticceria secca e cioccolateria. Nicolò Vellino ha maturato le sue conoscenze sul cioccolato negli anni trascorsi per lavoro e studio in Svizzera, dove ha acquisito l’attestato di Maître Chocolatier.
https://reportergourmet.com/140084/i-gelati-del-territorio-di-fabrizio-fenu-miglior-gelatiere-della-sardegna-per-il-gambero-rosso.html
www.sardiniaecommerce.it/it/shop/dolcisfizi/
Foto dolcisfizi
La spianata con il maialetto di Seulo, il prosciutto crudo di Villagrande da passeggio in cono, le polpette di pecora, i culurgiones fritti, su frigadori (il pane tipico) di Esterzili, la zuppa dei centenari.
Sono i prodotti tipici di tante piccole aziende della blue zone sarda che si potranno comprare e gustare come street food a Cagliari.
L’idea di Maria Carta, originaria di Seulo, chef e proprietaria di “Is femminas”, il ristorante premiato di recente nella guida 2023 del Gambero Rosso con ben due forchette.
Il “Blue zone store”, proprio davanti al ristorante Is femminas, mette in mostra tanti altri prodotti tipici degli interni montuosi della Barbagia e dell’Ogliastra: legumi, frutta secca, miele, vino.

È il cibo dei centenari, e non a caso Is femminas vuole essere la cucina del cibo sano e della longevità: “La mia terra d’origine mi ha ispirato l’idea di far assaggiare, a locali e turisti, i prodotti delle piccole aziende della blue zone che lavorano con la naturalezza degli ingredienti. Gli animali crescono allo stato brado, le marmellate contengono solo frutta e zucchero, non ci sono aggiunte né trasformazioni”.
Al centro il benessere delle persone.
E tra il gran caprino dei centenari, le marmellate di Pom-
IS FEMMINAS
pia, le salsicce e le birre artigianali, una colazione sarda e un aperitivo da strada, si invita anche a conoscere la storia dei paesi dell’interno sardo in cui si vive più a lungo e in salute. Is femminas ha aperto nel 2019. “Sono stati otto mesi di lavoro e due anni di lockdown, dove siamo andati avanti grazie alla voglia di fare le cose per bene: pasta fresca, cibo sano, con la voglia anche di sperimentare”.
Un esempio tra tutti: il gambero avvolto dal filindeu, uno degli assaggi principe del menù degustazione.
Maria Carta è nata e cresciuta a Seulo, poi ha lavorato a Roma per 23 anni.
In Sardegna è tornata otto anni fa, e dopo alcune esperienze, sempre nel mondo della ristorazione, ha deciso di fare il grande passo.
“In realtà la passione per la cucina è arrivata in seguito a una punizione”, confessa la chef.
“A 15 anni mi avevano bocciato a scuola e mio padre per un anno intero mi ha fatto cucinare con i prodotti dell’orto”.
Da lì la cucina è stata punto di partenza e di ritorno, con il cuore sempre a Seulo, paese di centenari: “Mia nonna ha 96 anni, mio nonno aveva 98 quando è morto, il fratello di mio nonno ha quasi 100 anni e ancora va all’orto e fa il miele”.
Un’altra particolarità della bottega è che conta 60 etichette di vini esclusivamente di cantine gestite da donne, proveniente da tutta Italia. (segue pagina 56)
55
(segue dalla pagina 55)
Infine, la visione: “Piano piano inseriremo anche i prodotti delle altre blue zone del mondo, conclude Carta.
E c’è una sorpresa: il gin giapponese”.
Il progetto è appena partito ma è già un unicum, non solo in Sardegna. “La cucina è il luogo designato alla conservazione delle tradizioni, poiché è anche il modo di preparare le pietanze che rivela le origini di un popolo”, si legge in un cartello all’entrata della bottega.
E presto la cucina di Maria Carta abbraccerà anche quella delle altre blue zone del mondo: Okinawa (Giappone), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Grecia), Loma Linda (California).
Laura Fois
Is Femminas
Via Napoli, 90/92
Telefono:
Tel.:340 8531608
isfemminas@gmail.com

www.facebook.com/isfemminas/ http://accademia1953.it/it/ristoranti/ristorante/60409-femminas
Le “Sebadas Mucadores” sono diventate un marchio registrato: l’arte della lavorazione sarda è pronta a sbarcare nel mercato nazionale e internazionale.
Un successo quello di Luca Floris, 50 anni, nuorese doc, dipendente di una azienda floreale per lavoro ma ben più conosciuto come uno dei più bravi maestri nella lavorazione delle specialità del centro Sardegna.
Da su filindeu ai culurgionis si diletta in cucina da anni grazie alla bravura e all’amore ereditate dalla mamma.
Un’arte quella che dal nuorese spopola non solo in tutta l’isola, bensì è conosciuta e apprezzata anche oltre mare.
Lavorazioni particolari, antichi segreti che si tramandano di generazione in generazione e che, di certo, non si possono trovare sui libri di cucina. Grazie ai social, le foto pubblicate da Floris delle prelibatezze da lui realizzate, senza volerlo e tanto meno esserne cosciente, sono diventate virali sino a richiamare l’attenzione dei grandi chef stellati e delle tv nazionali ed estere. Ed è così che, passo dopo passo, è arrivato al successo e la decisione di registrare presso la C.C.I.A.A. il marchio “Sebadas Mucadores” uno dei suoi capolavori.
Sebadas triangolari, decorate e al mirto. In omaggio all’ abito tradizionale di Nuoro. Si prepara con un impasto a base di semola e strutto, con un ripieno di formaggio di pecora fresco inacidito e scorza di limone , si frigge in abbondante olio bollente, appena dorata va tolta dal fuoco e cosparsa di miele.
 Valeria Putzolu
Valeria Putzolu
https://www.sufilindeunugoresu.it/ sebadas-mucadores/

Sebadas Mucadores da Luca Floris Ricetta e lavorazioni originali della Famiglia Floris
Foto lucillacienciarelli
Vedi il video vimeo.com/793472491
Poche cose sono certe come il passare inesorabile del tempo, ma questa è anche un’ottima notizia. Come a ogni scattare del nuovo anno, infatti, anche l’inizio del 2023 porta con sé un dono per i creativi di tutto il mondo: il copyright di una vasta raccolta di opere d’arte, letteratura, cinema e fotografia è decaduto, rendendole a tutti gli effetti di pubblico dominio e quindi condivisibili e riutilizzabili per qualunque scopo.
Per via delle diverse leggi sul copyright in tutto il mondo, però, non esiste un unico “dominio pubblico”: in Paesi come l’Italia (e il grosso dell’UE), il Regno Unito e la Russia si liberano idee e opere di persone decedute nel 1952, che fa corrispondere la durata del copyright alla vita dell’autore più 70 anni; in Paesi come la Nuova Zelanda, gran parte dell’Africa e dell’Asia, si liberano quest’anno le opere di persone decedute nel 1972 (cioè morte da 50 anni); e infine negli Stati Uniti, i più severi, si liberano le opere create o pubblicate nel 1927.
Vediamo ora alcuni (famosi) prodotti culturali che saranno finalmente accessibili a tutti.
1. IL DETECTIVE PIÙ FAMOSO DEL MONDO: SHERLOCK HOLMES
Ebbene sì, come opera letteraria del 1927, la raccolta di racconti Il libro dei casi di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle (Edimburgo, 1859 – Crowborough, 1930)

COME OGNI
è finalmente aperta e disponibile negli Stati Uniti. Questo significa via libera a rimaneggiamenti o adattamenti letterari e cinematografici, senza rischi né costi.
Il personaggio, che esordì nel romanzo “Uno studio in rosso” del 1887, è comparso in quattro libri e cinquantasei racconti, venendo poi ripreso in innumerevoli opere teatrali, cinematografiche e televisive, rappresentando con ogni probabilità la più celebre figura di investigatore della storia del giallo.
Anche il capolavoro di Virginia Woolf (Londra, 1882-Rodmell, 1941) del 1927 “Gita al faro”, anche tradotto “Al faro”, è diventato libero per l’uso pubblico oltreoceano senza bisogno di un permesso o un pagamento.
Il romanzo, che amplia e migliora la tradizione modernista primo-novecentesca, privilegia rispetto alla trama l’introspezione psicologica dei personaggi, distinguendosi come esempio eccelso del genere.
La storia, che coglie la famiglia Ramsay in vacanza sull’Isola di Skye alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, si svolge tutta nell’attesa, soprattutto del figlio piccolo della coppia, di una gita al faro.
(segue pagina 56)
(segue dalla pagina 55)
Giulia Giaume
Una gita ideale che, senza fare spoiler, cambierà completamente connotati diventando l’occasione
57
UNA VASTA RACCOLTA DI FILM, ROMANZI E OPERE D’ARTE
PRIMO DELL’ANNO,
È TOTALMENTE ACCESSIBILE ALL’USO PUBBLICO ECCONE UNA SELEZIONE
2. GITA AL FARO DI VIRGINIA WOOLF
con il passare degli anni di rivalutare le relazioni emotive tra i protagonisti. Aquistalo qui
https://www.amazon.it/ Al-faro-Virginia-Woolf/
3. LE OPERE DI M. C. ESCHER

Le opere di ispirazione matematica e logica del celere artista e grafico olandese Maurits Cornelis Escher (Leeuwarden, 1898 – Laren, 1972), come xilografie, litografie e mezzetinte, sono diventate libere nei Paesi con una legge del copyright che termina 50 dopo la fine della vita dell’autore.
Nonostante il grande interesse popolare attuale, Escher è stato per la maggior parte della sua vita trascurato dal mondo dell’arte, inclusi i nativi Paesi Bassi, diventando solo in un secondo momento sempre più apprezzato fino all’attuale celebrità globale.
4. LA PRIMA STORIA SU MISS MARPLE
Agatha Christie
Ancora una storia investigativa entra nel dominio pubblico degli Stati Uniti: il racconto “Il club del martedì sera”, tradotto anche come “Un’idea geniale”, di Agatha Christie (Torquay, 1890 – Winterbrook, 1976).
Questo libello, meno noto di altre opere dell’autrice, presenta il debutto sulla stampa della celebre detective dilettante Miss Marple. Pubblicato per la prima volta nel 1927 su The Royal Magazine, il racconto riguarda un gruppo di amici che si incon-
DOMINIO PUBBLICO DA DOYLE A ESCHER
trano ogni martedì per narrare a turno un mistero reale che gli altri tentano di risolvere.
5. METROPOLIS
Libero da copyright negli Stati Uniti è anche il capolavoro cinematografico “Metropolis”, film muto di fantascienza espressionista tedesco del 1927 diretto da Fritz Lang (Vienna, 1890 – Beverly Hills, 1976) e adattato da Thea von Harbou (Tauperlitz, 1888 – Berlino Ovest, 1954) e Lang stesso a partire dall’omonimo romanzo di von Harbou del 1925.
Parliamo di un film di fantascienza pionieristico ambientato in una futuristica distopia urbana, che segue i tentativi di Freder, il figlio del padrone della città, e Maria, figura di riferimento per i lavoratori, di superare il vasto abisso che separa le classi sociali e riunire i lavoratori contro Johann Fredersen, il capo della città. Nel 2001, questa pellicola è stata la prima a venire iscritta nel registro della Memoria del mondo dell’UNESCO.
6. GLI SCRITTI DI MARIA MONTESSORI
Sono passati 70 anni anche dalla morte di Maria Tecla Artemisia Montessori (Chiaravalle, 1870 – Noordwijk 1952), medica ed educatrice nota soprattutto per la filosofia dell’educazione che porta il suo nome e per i suoi scritti sulla pedagogia scientifica.
Laureatasi con lode alla scuola di medicina della Sapienza di Roma – una delle prime donne a frequentare la
Foto mauritscornelisescher
scuola di medicina in Italia – creò un metodo educativo che punta ad attivare gli interessi e le propensioni naturali dei bambini, coinvolgendoli personalmente, piuttosto che tramite metodi di insegnamento formali.
Il suo metodo è in uso oggi in molte scuole di tutto il mondo, e i suoi scritti di pedagogia e didattica sono altrettanto celebri e utilizzati.
Disponibile negli Stati Uniti è Amerika, il primo romanzo incompleto di Franz Kafka (Praga, 1883 – Kierling, 1924), scritto tra il 1911 e il 1914 e pubblicato postumo nel 1927.
Il romanzo nacque in origine come breve storia intitolata “Il fuochista”, incorporando molti dettagli delle esperienze dei suoi parenti emigrati negli States.
La storia descrive le bizzarre peregrinazioni del sedicenne immigrato europeo Karl Roßmann, costretto ad andare a New York per sfuggire allo scandalo della sua seduzione da parte di una domestica.
È più umoristico e realistico della maggior parte delle sue opere (eccezion fatta per l’ultimo capitolo), ma condivide il leitmotiv di un sistema oppressivo e intangibile che mette il protagonista in situazioni bizzarre. https://www.artribune.com/editoria/2023/01/dominio-pubblico-da-sherlock-holmes-a-escher-le-opere-appena-liberate-dal-copyright/
In questo articolo del 21 ottobre
1938 apparso su “Giustizia e libertà”, Emilio Lussu, con la proverbiale ironia che lo contraddistingueva, commenta con sarcasmo le teorie razziali del manifesto del luglio ’38 e le voci che davano il duce in persona deciso a relegare in Sardegna tutti gli ebrei italiani.

“Le Journal des Débats pubblica, tra il serio ed il faceto, uno scritto in cui si attribuisce a Mussolini il proposito di relegare in Sardegna tutti gli ebrei italiani.
Con i tempi che corrono, queste cose vanno prese sempre sul serio.
Come sardo, nato in Sardegna e rappresentante di sardi, io mi considererò direttamente interessato.
Il decalogo della razza bandisce non solo gli ebrei, ma anche i sardi dalla “razza italiana”. È quindi logico che il regime abbini la nostra sorte.
Il comandamento IV del decalogo dice: “La popolazione dell’Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra Penisola”.
Siccome la Sardegna non fa parte della Penisola ma è un’isola, l’affermazione suesposta non tocca i sardi né punto né poco.
Nel comandamento V è detto: (segue pagina 60)
59 Foto Metropolis © Archives New Zealand
7. IL ROMANZO INCOMPIUTO DI KAFKA
(segue dalla pagina 59)
“Per l’Italia nelle sue grandi linee la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa”.
Che si intende qui per Italia?
Italia peninsulare, come afferma il comandamento IV, oppure l’Italia in generale e quindi anche insulare?
Nel primo caso, ogni discussione è oziosa.
Nel secondo caso, la Sardegna è rimasta razzialmente quella che era mille anni fa: non ariana.
Secondo il decalogo, pertanto, i sardi non sono mai stati e non sono di razza ariana.
Questa conclusione, che è la conclusione logica ricavata dal manifesto razzistico, deve essere giudicata offensiva da quei pionieri della scienza antropologica ed etnografica che, essendo sardi di pura e incontaminata razza sarda, hanno redatto o firmato il documento scientificamente convinti di appartenere alla razza ariana.
È il caso del prof. L. Businco, firmatario del manifesto, e dei dottori Zonchello, Cao, Pintus, Maxia e Pirodda, i quali hanno dato pubblica adesione al manifesto, attraverso la lettura che il prof. Castaldi, direttore dell’Istituto di Anatomia
Umana Normale presso l’Università di Cagliari, ha inviata al ministero della Cultura Popolare.
E, se non faccio involontario errore, sono portato
EMILIO LUSSU E L E LEGGI RAZZIALI
a ritenere che lo stesso professor Castaldi abbia nelle vene tre quarti di sangue sardo e solo un quarto di sangue ariano.
Vero è che il comandamento IX del decalogo introduce e, nello stesso tempo, elimina un dubbio, quando dice: “Dei semiti, che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della Patria nulla in generale è rimasto”.
Come sarebbe a dire? E la Sardegna che è?

E i sardi che sono? Una volta posta la questione della razza, noi sardi vogliamo andare fino in fondo.
Noi non l’avremmo posta per primi, ma tant’è: poiché ci siamo, ci vogliamo stare.
È tempo che anche noi sardi ci proclamiamo francamente razzisti.
Dei semiti, in Sardegna è rimasto parecchio, e in generale e in particolare.
Noi ci teniamo e non molliamo d’un millimetro, dovessimo tutti farci misurare l’indice cefalico da una commissione speciale della Società delle Nazioni.
Noi abbiamo il diritto di chiamarci semitici, allo stesso modo con cui gli italiani della Penisola si dichiarano ariani.
Che fa il prof. Taramelli, diventato senatore del regno per meriti scientifici e fascisti?
Non parla?
Foto mosaico-cem.it
E che ha egli mai fatto, in quarant’anni, se non rigirarci, noi sardi, da tutte le parti e ritrovarci tutti semitici?

E che eravamo noi fino alla seconda guerra punica?
L’eroe nazionale sardo della resistenza a Roma, Amsicora, era un sardo-cartaginese, semitico al cento per cento.
Roma repubblicana e imperiale ci ha fatto a pezzi, proprio come fa adesso Roma fascista, ma noi restiamo sempre quello che siamo: semitici. Noi ci riconosciamo tutti fra di noi, in qualunque parte del mondo ci troviamo: a Roma, a Parigi o a New York.
Purchè, beninteso, non vi siano arabi o ebrei. Noi non conosciamo la noia, il cui nome non esiste neppure nella nostra lingua, talmente c’è rimasto profondo il ricordo del deserto, il cui orizzonte appaga pienamente lo sguardo e i sogni d’un solitario in Arabia o in Africa.
E basta una melopea cantata in Logudoro, a Bengasi o a Aden perché ci sentiamo tutti incantati e legati alla primitiva vita degli avi comuni.
E le migliaia di Nuraghe, monumenti di una gran civiltà sarda preistorica, che coronano ancora i punti strategici dell’isola, nemmeno il decalogo razzista potrebbe attribuirle ad ariani.
Chi erano i loro costruttori? Invasori scandinavi o guerrieri del Sud mediterraneo?
Civiltà ariana passi (anche gli ebrei italiani sono a civiltà ariana), ma non razza ariana.
Ohibò! Il solo nome ci irrita e può trascinarci ai più gravi eccessi.
Sulle nostre terre non sono passati né cimbri né teutoni, né germani né celti, né goti o visigoti, né longobardi né franchi, né normanni né tedeschi né austriaci.

Neppure greci, se non quelli dell’Impero bizantino, e solo burocrati che non avevano sufficiente fortuna per comprarsi una carica a Bisanzio.
E i Vandali vi han fatto un’apparizione fugace, senza neppure aver avuto il tempo di consumarvi un paio di sandali.
Pisani e genovesi, che hanno scorazzato per la Corsica in lungo e in largo, in Sardegna non hanno mai avuto fissa dimora, paghi di vendere le loro mercanzie sulla costa, senza confondersi con gli abitanti.
I pochi castelli pisani sembra fossero stati appositamente preparati da furieri d’alloggio aragonesi.
Aragonesi e spagnoli vi hanno vissuto da feudatari, son pochi armati, sempre paventando agguati e imboscate, importando tutto dalla madre-patria, uomini e spose.
In due secoli di vita comune con il Piemonte e (segue pagina 62)
61
(segue dalla pagina 61) con l’Italia ariani, sono stati celebrati in Sardegna matrimoni misti meno di quanto se ne possano combinare in un anno a Torino o a Genova.
Noi siamo rimasti semitici.
Basta un nonnulla per commuoversi semiticamente, e far parlare in noi la voce del sangue.
Il racconto della distruzione di Cartagine ci stringe il cuore come la notizia di un disastro familiare recente.
E non v’è un sardo dabbene che, leggendo Virgilio, non si intenerisca per la dolce bontà con cui la nostra Didone, semitica, accolse ospitale quel furfante e vagabondo di Enea, ariano.
E non senta odio per l’avventuriero fedifrago che, abbandonata la generosa regina, ebbe dagli dei non pene ma premi.
I figli di Enea compensano bene i doni della pia regina…
Noi reclamiamo rispetto per i nostri padri e per il nostro sangue.
Fino al decalogo razzistico del luglio scorso, di scienziati che abbiano messo in dubbio la nostra origine semitica, ve ne è stato uno solo: il prof. Lidio Cipriani, docente di Antropologia all’Università di Firenze.

Egli ha sostenuto la nostra origine mongolica. I sardi altro non sarebbero che i resti di un popolo mongolico, disperso da invasori implacabili, e di
cui non si trovano tracce, oltre che in Sardegna, che in una parte staccata del Giappone del Nord.
La distanza è un po’ forte, come ognuno può controllare sulla carta geografica.
Speravamo che il prof. Cipriani correggesse le sue congetture e c’imparentasse con i cinesi, chè di giapponesi non vogliamo sentire parlare; ma quando lo abbiamo visto, improvvisamente, in testa ai firmatari del decalogo razzistico, ci son sorti nuovi dubbi sull’essenza della sua autorità scientifica.
Possiamo pertanto considerare chiuso il breve incidente mongolico e ritenerci ancora semitici puri.
Così stando le cose, è troppo giusto che gli ebrei italiani vengano a finire in Sardegna: essi sono i nostri più prossimi congiunti.
Per conto nostro, noi non sentiamo che pura gioia. Essi saranno accolti da fratelli.
La famiglia semitica uscirà rafforzata da questa nuova fusione. Semitici con semitici, ariani con ariani.
Mussolini va lodato per tale iniziativa.
Anche perché rivela, verso noi sardi, un mutato atteggiamento.
Nel 1930, davanti a un giornalista e uomo politico francese che gli aveva fatto visita, pronunziò parole e propositi ostili contro l’isola fascisticamente malfida, e affermò che avrebbe distrutto la nostra razza, colo-
 Foto wikipedia
Foto wikipedia
nizzandoci con migliaia di famiglie importate da altre regioni d’Italia. Egli mantenne la parola e popolò le bonifiche sarde di migliaia di romagnoli e di emiliani.

Ma, a difesa della razza sarda, vigilavano impavide le zanzare, di pura razza semitica.
L’immigrazione ariana è stata devastata dalla malaria e ora non ne rimane in piedi che qualche raro esemplare superstite.
Con gli ebrei, sarà un’altra questione.
Essi saranno i benvenuti per noi e per le zanzare fedeli, le quali saranno, con loro, miti e discrete come lo sono con noi.
Sardi ed ebrei ci intenderemo in un attimo. Come c’eravamo intesi
con gli ebrei che l’imperatore Tiberio aveva relegato nell’isola e che Filippo II di Spagna scacciò in massa. Quello fu un gran lutto per noi.
Ben vengano ora, aumentati di numero. Che razza magnifica uscirà dall’incrocio dei due rami!
Per quanto federalista e autonomista, io sono per la fusione dei sardi e degli ebrei.
In Sardegna, niente patti federali.
I matrimoni misti si faranno spontanei e la Sardegna sarà messa in comune.
E quando saremo ben cementati, chiederemo che ci sia concesso il diritto di disporre della nostra
sorte.
L’Europa non vorrà negare a noi quanto è stato accordato ai Sudeti. Una Repubblica Sarda indipendente sarà la consacrazione di questo nuovo stato di fatto. Il presidente, almeno il primo, mi pare giusto debba essere un sardo, ma il vice-presidente dovrà essere un ebreo. Modigliani può contare sul nostro appoggio che gli sarà dato lealmente. Penso che dovremmo respingere la garanzia delle grandi potenze mediterranee e svilupparci e difenderci da noi stessi. Se gli ebrei d’Europa e d’America vorranno accordarci la decima parte di quanto hanno speso in Palestina, è certo che la
Sardegna diventerà, in cinquant’anni, una delle regioni più ricche e deliziose del mondo, la cui cultura non avrà riscontro che in poche nazioni avanzate.
Ciò non toglie che i nostri rapporti non possano essere buoni, inizialmente anche con l’Italia ariana; ma da pari a pari.
Vi sarà uno scambio di prodotti, e noi potremo, data la ricchezza delle nostre saline, rifornire l’Italia ariana, specie di sale, chè ne ha tanto bisogno.
Naturalmente, non accoglieremo tutti gli ebrei italiani.
Ve ne sono parecchi che, per noi, valgono gli ariani autentici.
Il prof. Del Vecchio, per esempio, noi non lo vogliamo.
E vi saranno parecchi ariani di razza italiana che noi terremo a fare semitici onorari.
Problemi tutti che risolveremo presto e facilmente.
V’è la questione del re-imperatore che, come si sa, ha fatto la sua fortuna come re di Sardegna.
Si ha l’impressione che il decalogo razzistico sia stato compilato anche per lui.
Non esiste infatti nessuna famiglia, in Italia, meno italiana di quella reale; essa non appartiene più alla razza italiana pura. Di origine gallica, i matrimoni misti l’hanno corrotta a tal punto che (segue pagina 64)
63
(segue dalla pagina 63) il sangue straniero vi è in predominio palese.
E il principe ereditario, figlio di una montenegrina, è sposato con una belga-tedesca; una principessa con un tedesco, e un’altra con uno slavo-bulgaro.
Ariani ma non italiani. La futura repubblica sarda sarà magnanime anche col re di Sardegna. Lo accolse l’isola, fuggiasco dall’invasione giacobina, lo accoglierà ancora una volta, profugo dal dominio ariano-italico.
L’isola dell’Asinara gli sarà concessa in usufrutto fino all’ultimo dei suoi discendenti. E potrà tenervi corte, liberamente, a suo piacere.
Ci sia concesso ora dare uno sguardo all’avvenire, sì ricco di promesse, in mezzo a tanti disastri presenti.
Noi vediamo già gli ebreo-sardi dominare il Mediterraneo: una talassocrazia di scelta razza semitica, sui solchi delle vele fenicee.
Dopo Mosè, Giosuè, e i Maccabei, gli ebrei non conobbero glorie militari. Ma la Sardegna è una stirpe guerriera.
Dalla fusione scaturirà un popolo scientificamente audace, che non avrà nulla da invidiare ai figli di Romolo e ai granatieri di Pomerania.
Sarà l’ora dei Vichinghi del Sud.
Sarà l’ora dell’arrembaggio.
E verrà la resa dei conti.
La razza ariana-italica avrà parecchie gatte da pelare con noi.
Dalla Sardegna partirà la crociata per la riconquista dell’Italia perduta.
E sarà una crociata con la croce. Cristo era ebreo, e la critica storica non dà per certo che fossero ebrei i suoi persecutori.
Giuda pare fosse un levantino, ariano dunque, fuggito in Palestina per debiti.
Chi trascinò Cristo al patibolo non fu re Erode, semitico, ma il proconsole romano, ariano.
Erode comandava in Galilea, come oggi il bey comanda Tunisi.
Il destino pose fino ad allora l’antagonismo, che è universale, fra Cesare ariano e Cristo semitico. Questo è il senso dell’opposizione fra razza ariana e razza semitica.

Nel conflitto, chiusi gli occhi su inezie e quisquilie, noi siamo per Cristo.
Crociata con la croce dunque.
Croce solida e dritta, non ritorta come lo scorpione della croce gammata. Croce, impugnata come una spada.
E giù botte da orbo”.
Emilio Lussu
Foto lastampa
Il 15 luglio 1938 dieci scienziati italiani, Lino Businco (sardo, nato a Cagliari e in ruolo in città fino al 1937), Lidio Cipriani, Arturo Donaggio, Leone Franzi, Guido Landra, Nicola Pende, Marcello Ricci, Franco Savorgnan, Sabato Visco ed Edoardo Zavattari, firmarono il Manifesto della Razza.
Il documento diede il via alle persecuzioni razziali nel nostro Paese, soprattutto contro gli ebrei e giustificò poi in seguito, nel settembre dello stesso anno, la promulgazione delle Leggi razziali volute dal Partito Fascista di Benito Mussolini.

Il documento prova con basi non scientifiche a ribadire prima di tutto il concetto di razza, di per sé non attribuibile all’uomo, e a dimostrare la superiorità di quella presunta ariana propria del popolo italiano. Ciò che venne sottoscritto nel documento fu di fatto un contenuto privo di basi scientifiche, volto addirittura a dimostrare una certa originalità del razzismo italiano rispetto a quello tedesco.
I nomi degli scienziati firmatari sono rimasti a lungo nell’ombra ma, come ricorda l’Ansa, nel 2005 lo scrittore e giornalista Franco Cuomo, scomparso nel 2007, scrisse il saggio “I dieci” dove approfondì la vicenda, facendo emergere dettagli ancora più inquietanti.
Cuomo, infatti, si sofferma sulla storia dei 10 scienziati, sottolineando come in effetti nessuno di loro pagò mai per ciò che aveva sottoscritto e dopo la guerra vennero reintrodotti nei loro ruoli. Lino Businco, un sardo tra i firmatari delle leggi razziali
Tra questi dieci, come detto sopra anche un cagliaritano, Lino Businco. Come riporta un articolo del Manifesto Sardo, Businco pubblicò in quello stesso anno un articolo “scientifico” dal titolo emblematico “Sardegna Ariana”, che inseriva i sardi tra i popoli di “razza” ariana.
«I Sardi, argomentava Businco, vanno considerati come un gruppo purissimo di quegli ariani mediterranei che trovano la migliore espressione entro la razza italiana. Non potevano appartenere a opachi aggruppamenti razziali africani quegli uomini i cui antenati avevano dato origine alla luminosa civiltà dei Nuraghi.
Tra i protosardi e la popolazione attuale vi era una singolare continuità di caratteri che attestava una mirabile conservazione del sangue attraverso i millenni».
https://www.vistanet. it/cagliari/2023/01/27/
lo-sapevate-tra-i-firmatari-del-manifesto-dellarazza-del-1938-cera-anche-un-sardo-rep-1/
65
IL
SARDO FIRMATARIO DELLE LEGGI
embra strano immaginare la Sardegna, celebrata per il suo mare, come sede di sport invernali.
Eppure nell’isola, che è un vero e proprio continente in miniatura, non mancano le vette innevate.
Spettacolari, come l’immagine che offrono in questi giorni, dove le luci dell’alba sembrano accendere la neve sul Bruncuspina, la seconda cima più alta della Sardegna. È qualcosa di unico a queste latitudini, poter indossare gli scarponi e scivolare sugli sci o sullo snowboard ad appena 25 chilometri di distanza da quel mare che, nelle giornate serene, appare all’orizzonte.

Ho scritto “è” e non “sarebbe”, perché ho avuto l’opportunità di farlo, qualche tempo fa.
Allora, a Bruncuspina, era ancora in funzione il vecchio ski-lift realizzato nel 1973 e rimasto in funzione fino al 2016.
Ma qui finisce il bello della nostra isola e inizia la vergogna di una delle tante incompiute.
Questa di Bruncuspina non è la peggiore, ma è certamente la più alta: raggiunge i 1.803 metri della stazione a monte della seggiovia, completata nel 2019, mai entrata in funzione.
É incredibile ripercorrere la storia di quest’impianto.
Il cosiddetto Piano Neve, che avrebbe dovuto ga-
SULLA VETTA DELLE INCOMPIUTE
rantire una svolta turistica al territorio, era parte di un “Programma integrato d’area” approvato dalla Regione nel lontano 1996.
È però solo dodici anni dopo, nel 2008, che la Regione approvò il finanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione della seggiovia e delle infrastrutture al suo servizio.
Ma occorrono altri nove anni perché il Comune di Fonni, nel 2017, approvi il Progetto esecutivo e perché la società piemontese CCM Finotello inizi a realizzare la seggiovia sul pendio settentrionale del Bruncuspina, per completarla nel 2019.
Si tratta di una seggiovia biposto, in grado di trasportare fino a 1000 persone all’ora dai 1568 metri della stazione a valle ai 1803 metri di quella a monte. Da allora sono trascorsi altri quattro anni e quella seggiovia non ha ancora trasportato un solo turista in vetta.
Nessuno sciatore è sceso da uno fra i 93 sedili, dei quali è dotata la seggiovia, per affrontare una delle due discese che partono dalla cima di Bruncuspina. La seggiovia é ancora desolatamente chiusa e abbandonata.
Le scuse sono varie: manca il collaudo dell’impianto, non è stato ancora realizzato il rifugio per accogliere i turisti, la strada per arrivare a Bruncuspina non è
Foto www.bruncuspina.com
S
percorribile quando nevica...
Ora la sindaca di Fonni si accorge che occorrono almeno 250.000 euro all’anno di spese per garantire il funzionamento dell’impianto, perché lo conferma il Piano di gestione che il comune aveva commissionato in occasione dell’inizio dei lavori.
É sempre la solita storia, si hanno idee poche e confuse.
L’unica certezza è che si devono spendere i soldi pubblici, se poi vengono sprecati, perché manca la programmazione e dei budget sostenibili, non fa nulla. Sono trascorsi ventisei anni da quando venne delineato il fantomatico Piano Neve.
Oggi la neve, diventata nel frattempo sempre più rara, ci sarebbe pure in abbondanza.
Ma non possono esserci gli sciatori. Eppure sarebbe semplice cercare ispirazione, copiare dagli altri.
Oltre la neve, sfruttare la location e i suoi paesaggi anche nelle altre stagioni.
Trekking, mountain bike, magari una pista di slittino su rotaia.
Semplicemente trascorrere una giornata in vetta. Le possibilità ci sarebbero a volerlo.
Siamo bravissimi a sprecare in ogni occasione la fortuna di vivere in un continente in miniatura, unico e
straordinario.
Ci dobbiamo invece limitare a sognare, osservando l’immagine da favola offertaci da una webcam.
L’ennesima incompiuta. La più elevata della Sardegna, a 1800 metri sul Gennargentu.
Enrico Napoleone
Il Bruncu Spina, con i suoi 1.829 metri è la seconda vetta più elevata della Sardegna dopo punta La Marmora.
Si trova nel massiccio del Gennargentu, in provincia di Nuoro, nel territorio amministrativo dei comuni di Villagrande Strisaili e Desulo.
La porzione territoriale in capo al comune di Villagrande Strisaili è stata concessa in enfiteusi perpetua al comune di Fonni.
Sulla cima della montagna si trovava un osservatorio astronomico, attualmente ridotto allo stato di rudere.
Il toponimo in sardo può essere tradotto con l’espressione in lingua italiana “cima del cardo”.
Tale denominazione è riconducibile alla presenza, sulla montagna, di specie erbacee appartenenti alla famiglia della Asteraceae. Secondo altri (Massimo Pittau - Toponimi della Sardegna meridionale) il toponimo significa “cima della spina” e fa riferimento alla Prunus prostrata che vi vegeta.
Foto dalla webcam offerta da:
www.bruncuspina.com

67








 Foto herodote.net
Foto herodote.net





 Foto wordpress.com
Foto wordpress.com




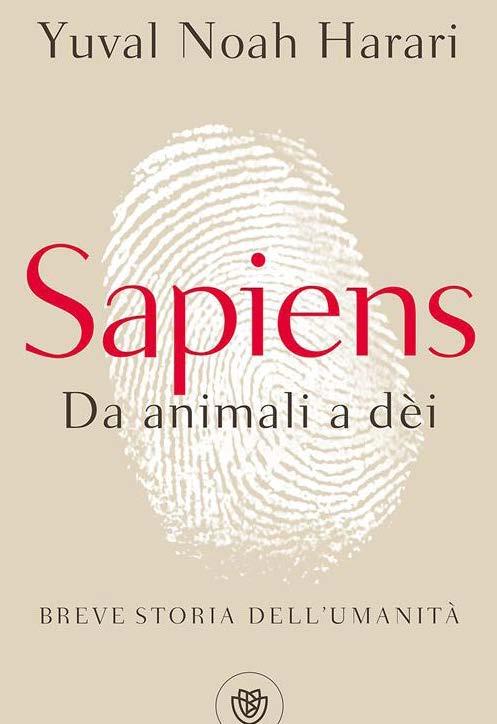
 Foto biologicalonlinedirectory
Foto biologicalonlinedirectory


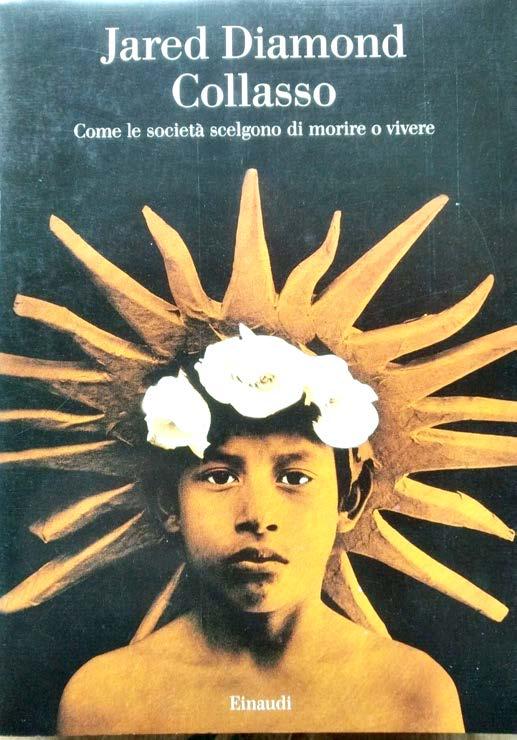














 Foto organon Filippo II
Foto organon Filippo II




 Foto wikipedia.org
Foto wikipedia.org






























 Foto artribune
Foto artribune













 Foto katiacordasilio
Foto katiacordasilio



 Foto finestresull’arte
Foto finestresull’arte






 Valeria Putzolu
Valeria Putzolu








 Foto wikipedia
Foto wikipedia




