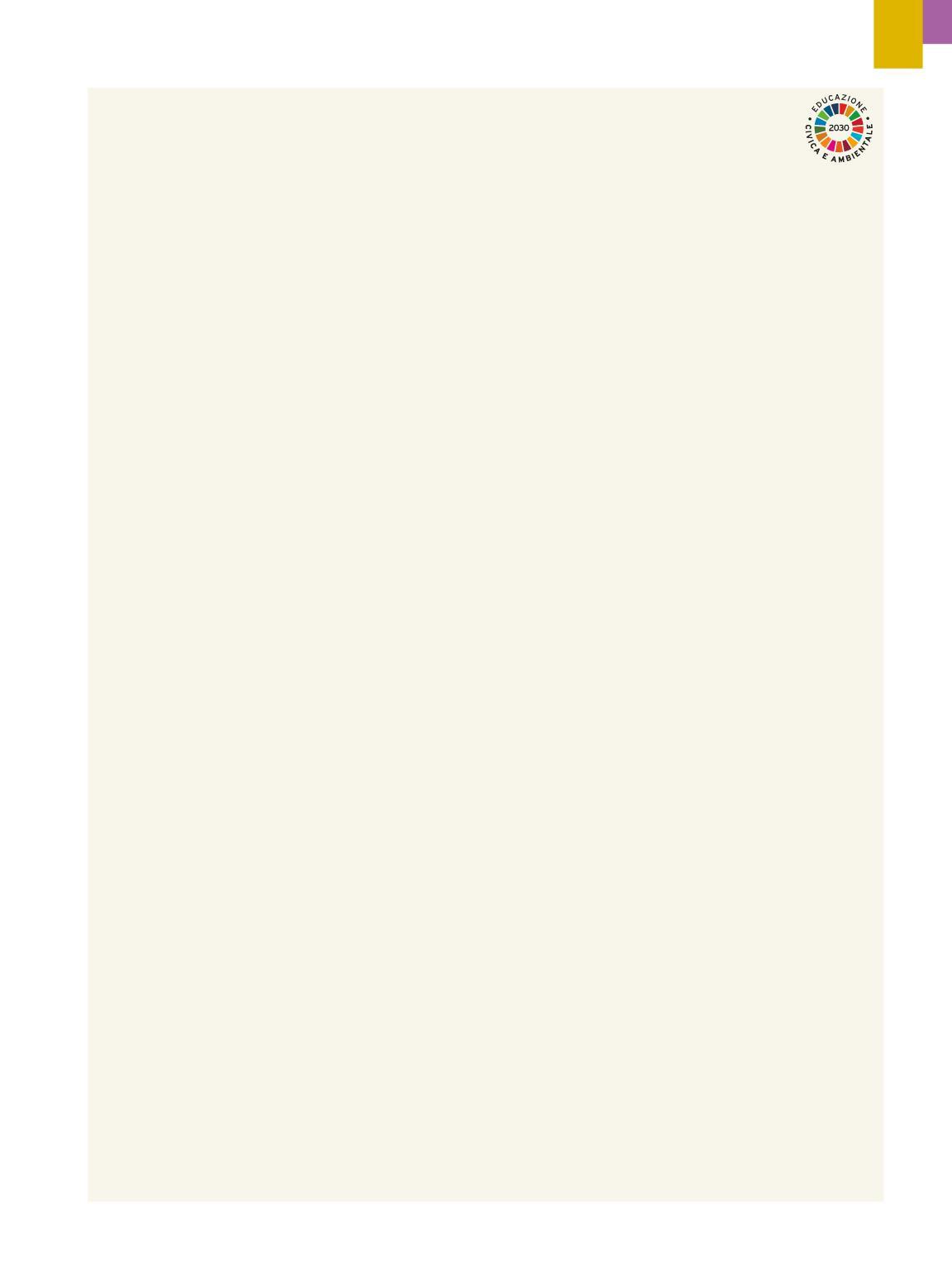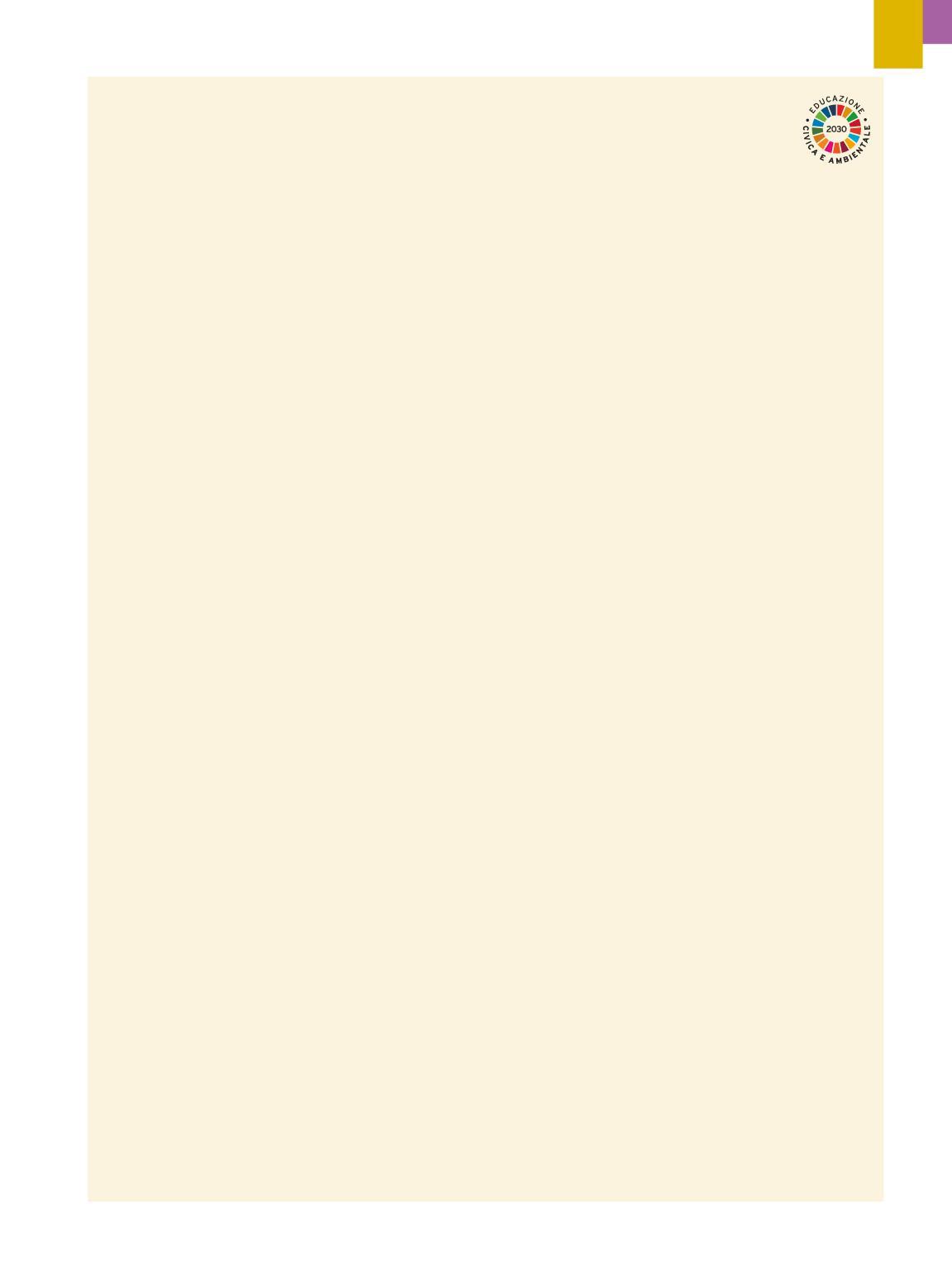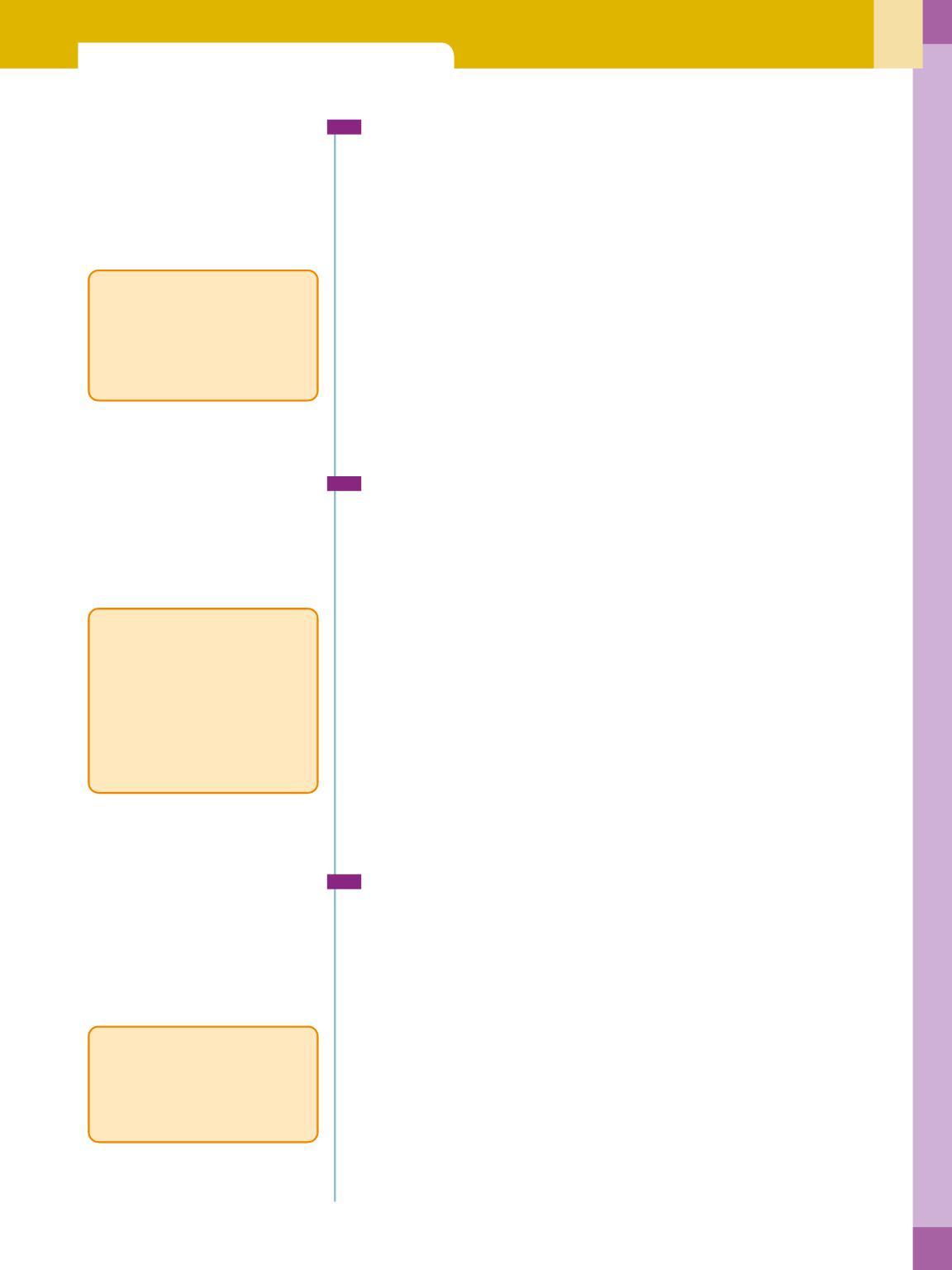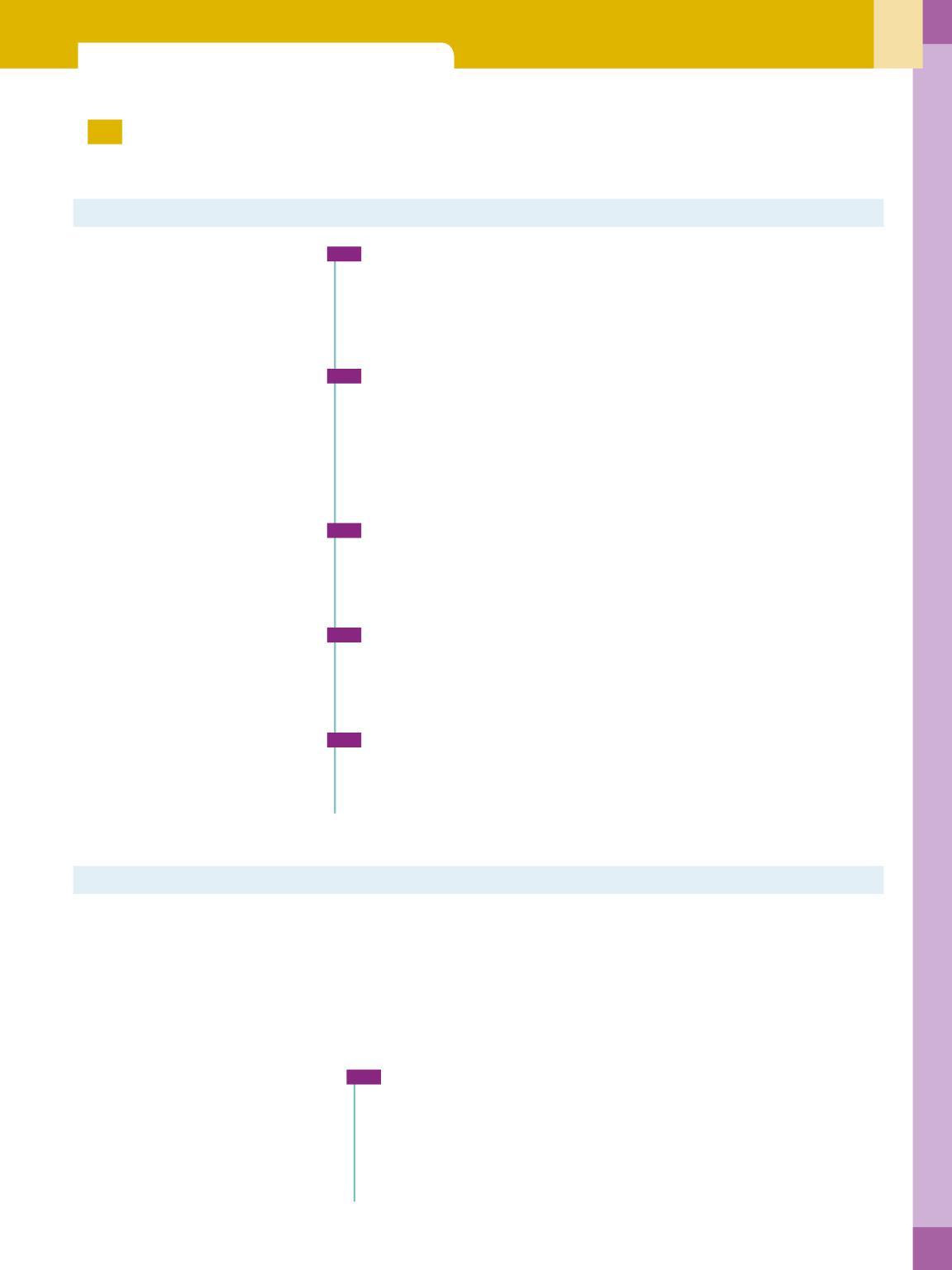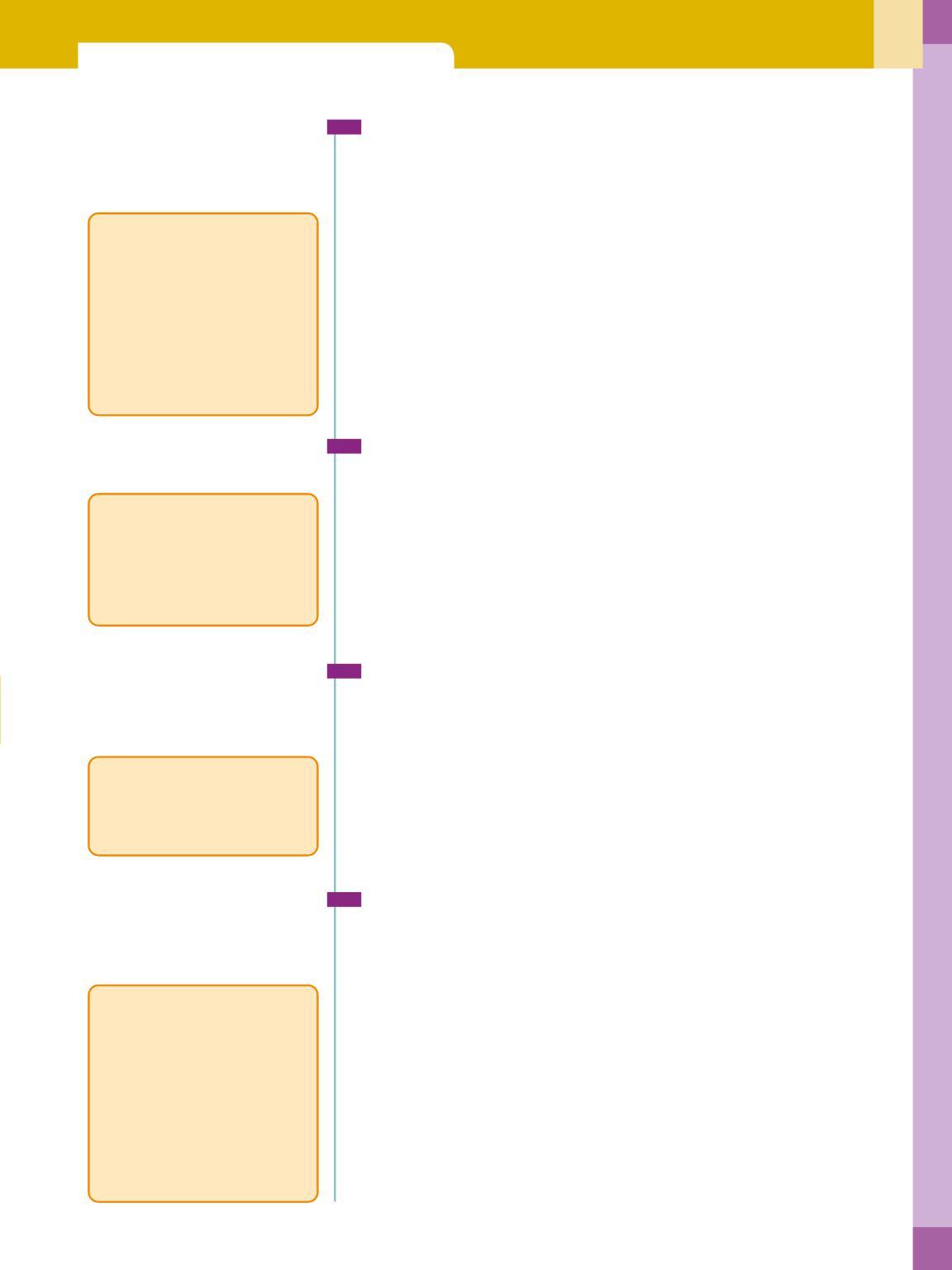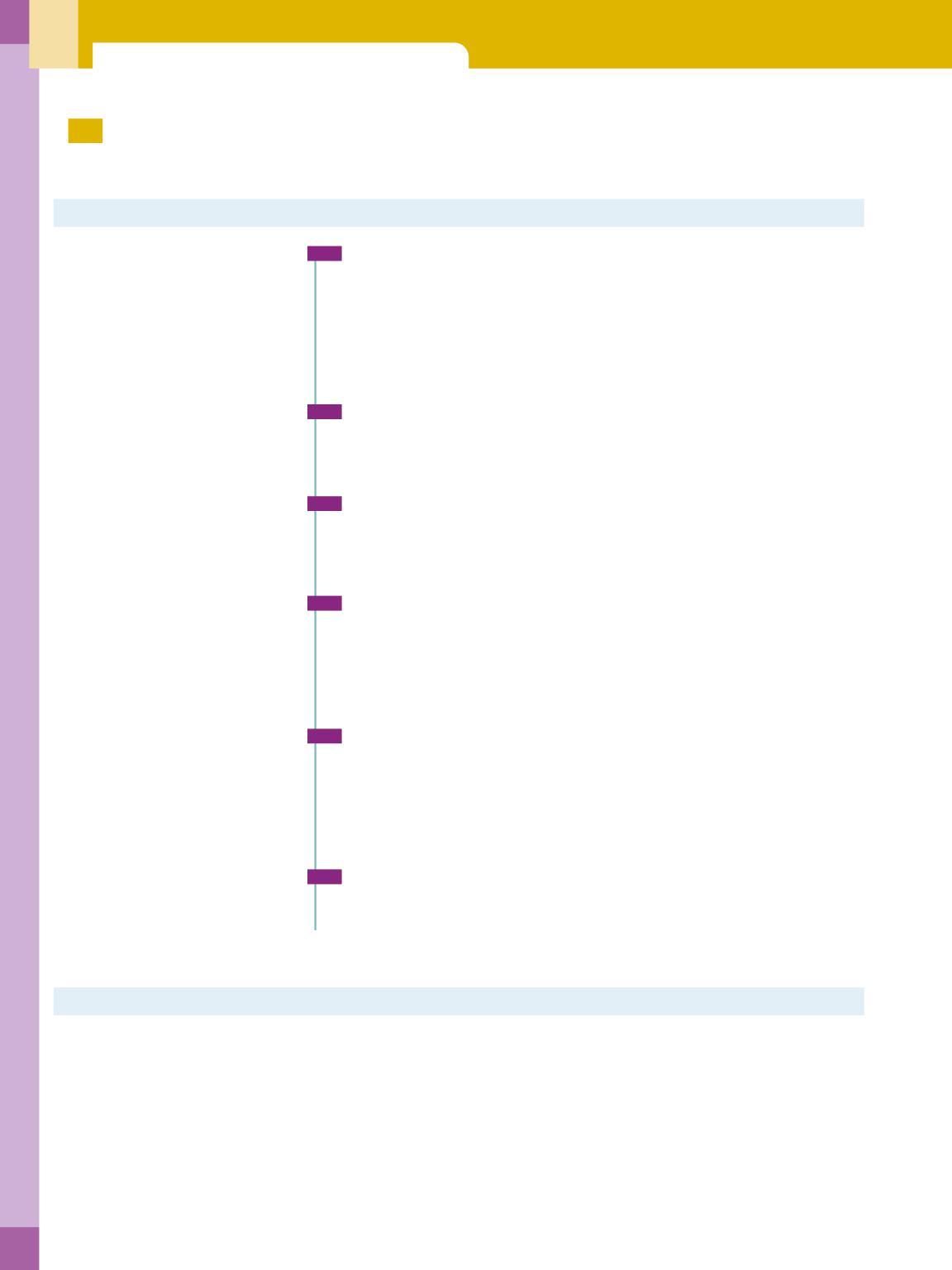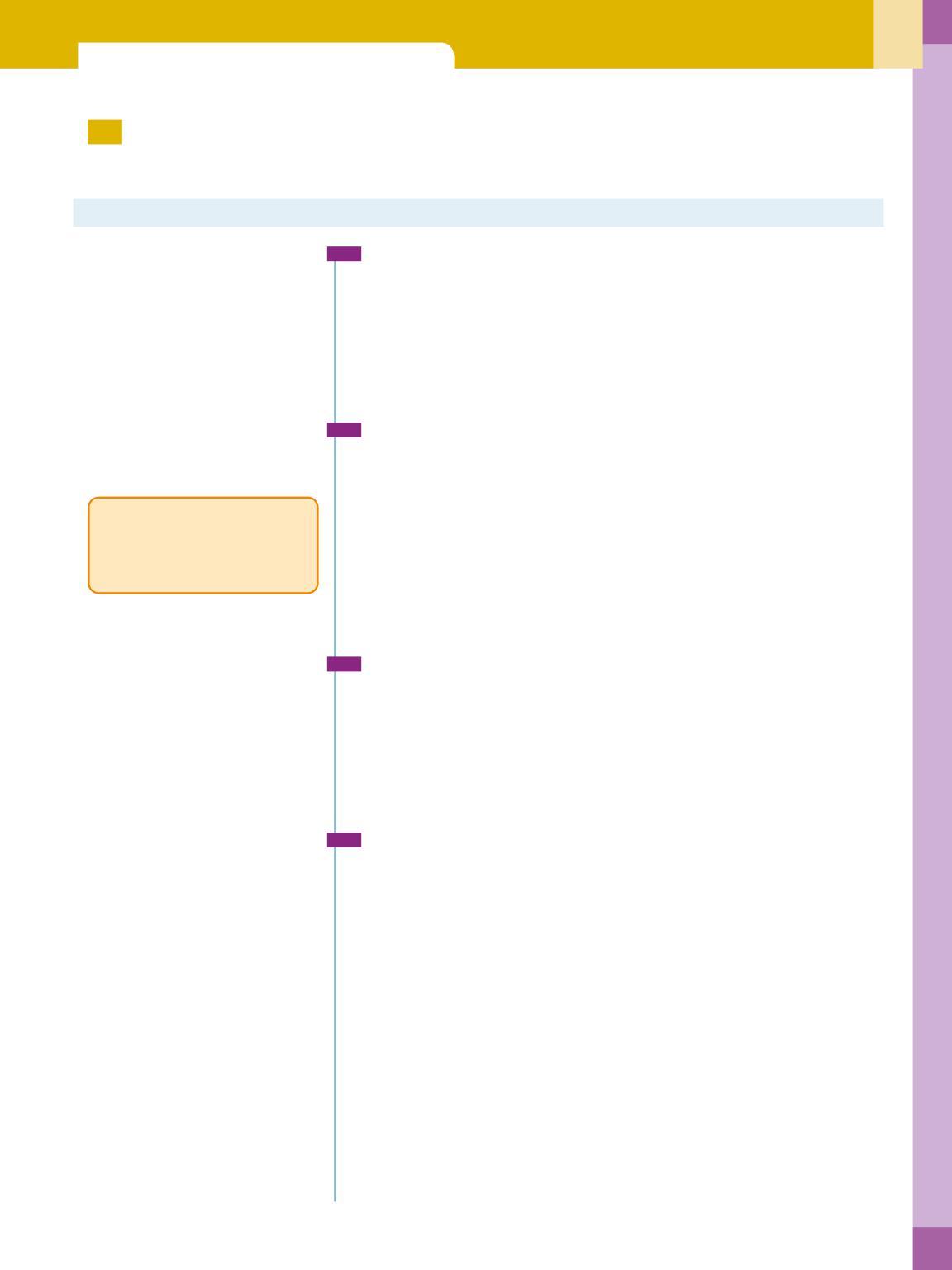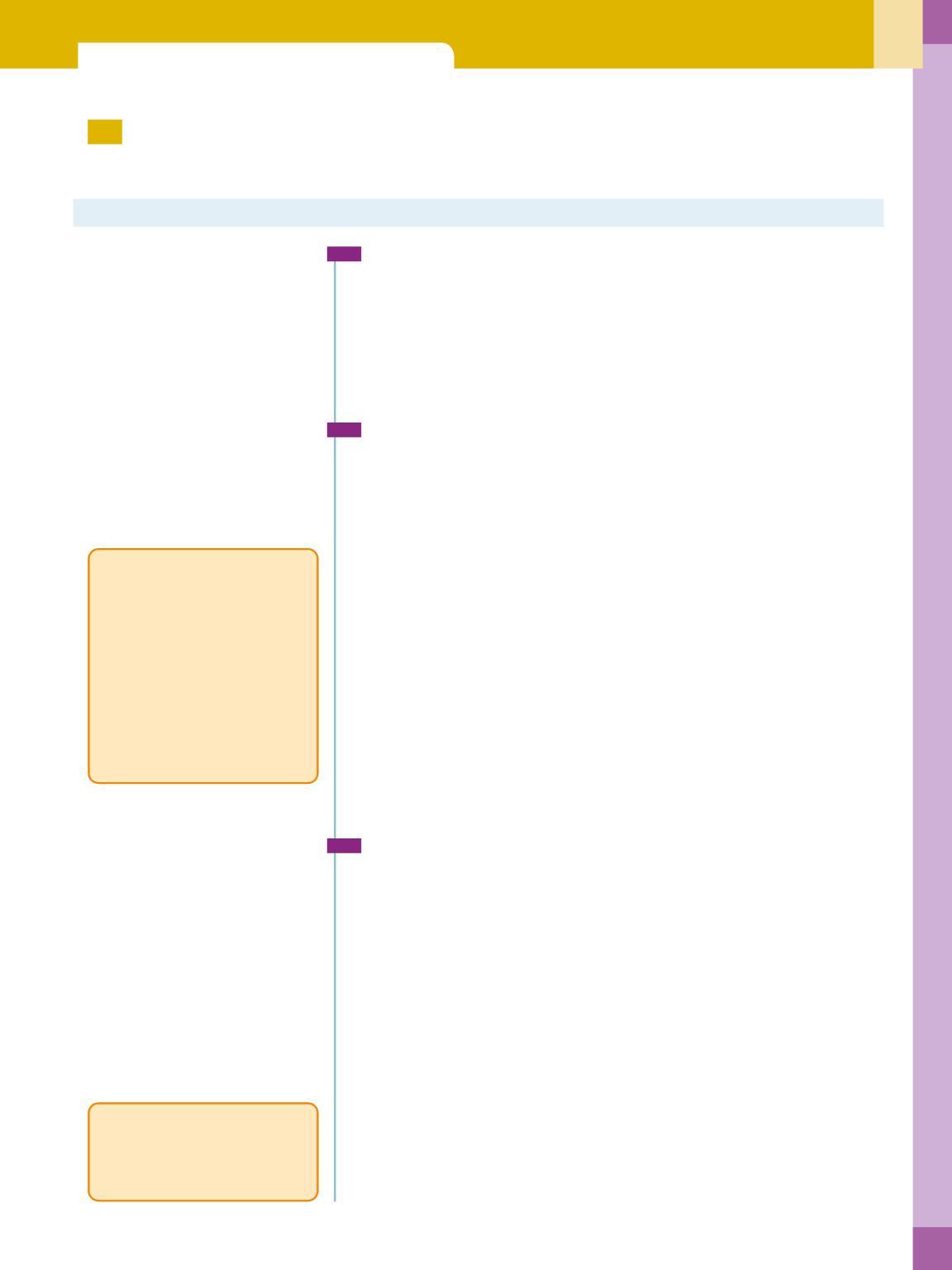2.4 La ricerca del lavoro
Il lavoro subordinato La definizione della subordinazione Un rapporto di lavoro subordinato o dipendente si costituisce con la stipulazione, tra un lavoratore e un datore di lavoro, di un contratto di lavoro subordinato (articolo 2094 c.c.). Il contratto di lavoro subordinato è quello con cui una parte (lavoratore) si obbliga, in cambio di una retribuzione, a svolgere il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’altra parte
(datore di lavoro). Si svolge soprattutto all’interno di un’impresa in quanto è il modo attraverso cui un imprenditore si procura la forza lavoro necessaria (insieme alla natura, al capitale e all’organizzazione) per l’attività diretta alla produzione e/o allo scambio di beni o di servizi. Un datore di lavoro, però, può essere anche un altro soggetto, privato o pubblico, diverso da un imprenditore.
Le caratteristiche del lavoro subordinato I caratteri distintivi del lavoro subordinato all’interno di un’impresa sono: • la collaborazione nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa; • la subordinazione del lavoratore verso il datore di lavoro, in quanto il lavoratore è obbligato a osservare le direttive organizzative e le disposizioni tecnico-pratiche emanate dal datore di lavoro e dai suoi superiori nella gerarchia dell’impresa. Per esempio, un lavoratore dipendente deve rispettare l’orario di lavoro e gli ordini di servizio relativi alle modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa. L’obbligazione del lavoratore verso il
datore di lavoro è un’obbligazione di mezzi, e non di risultato, in quanto il lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività, ma non è responsabile del risultato della sua attività. Il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato anche dal fatto che di solito il datore di lavoro si assume: • il rischio economico, cioè di non riuscire a coprire con i ricavi i costi di produzione e, quindi, di operare in perdita; ● il rischio giuridico, cioè di non riuscire a pagare i debiti verso i terzi e di essere responsabile per gli eventuali danni causati ai terzi dai lavoratori.
I diritti del lavoratore Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso: pertanto il diritto fondamentale che viene riconosciuto al lavoratore, in cambio della sua attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro, è costituito
dal diritto alla retribuzione. Al riguardo è da rilevare però che, in alcuni casi particolari previsti dalla legge o dai contratti collettivi, il lavoratore ha diritto a una retribuzione anche in mancanza dello svolgimento attuale di una prestazione lavorativa.
Il diritto alla retribuzione Secondo il primo comma dell’articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto a ricevere una retribuzione che deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente per assicurare un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, cioè ai familiari a suo carico. Dalla disposizione costituzionale emerge in modo evidente che la retribuzione non svolge soltanto una funzione economica in senso stretto, come mezzo di sostentamento ma anche una funzione sociale in senso più ampio, come reddito che può garantire la libertà e la dignità del lavoratore e dei membri della sua famiglia. La retribuzione spettante a un lavoratore, che viene distinta tradizionalmente in salario (quando si riferisce agli operai) o stipendio (quando riguarda gli impiegati e gli altri dipendenti), deve essere indicata, in relazione alla categoria e alla qualifica del lavoratore, nel contratto individuale di assunzione. Di regola la retribuzione viene determinata facendo riferimento alla retribuzione prevista, per quella categoria e per quella qualifica, dal contratto collettivo del settore nel quale rientra l’impresa o a cui si riferisce l’attività svolta. Considerata la retribuzione “sufficiente”, a norma del primo comma dell’articolo 36 della Costituzione, non può essere derogata in senso peggiorativo nei contratti individuali (cosiddetti minimi contrattuali). Il contratto individuale di lavoro, però, può derogare in senso migliorativo rispetto alla con-
trattazione collettiva e prevedere per un lavoratore una retribuzione maggiore rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori di quella categoria e con quella qualifica (cosiddetti superminimi contrattuali). In base alla legge, la retribuzione spettante a un lavoratore può essere (articolo 2099 c.c.): • una retribuzione a tempo, che è la modalità più diffusa, stabilita in proporzione alla durata dell’attività lavorativa (cioè un tanto all’ora, al giorno, alla settimana o al mese) a prescindere dal risultato dell’attività del lavoratore; • una retribuzione a cottimo o a provvigione, fissata in relazione al rendimento dell’attività lavorativa (cioè un tanto per ogni unità prodotta o, se l’attività del lavoratore consiste nella promozione e/o nella conclusione di affari per conto del datore di lavoro, un tanto per ogni affare promosso o concluso). Il cottimo a sua volta può essere: – un cottimo puro, quando la retribuzione dipende esclusivamente dalla produttività del lavoratore (e quindi il lavoratore che non produce nulla, per qualsiasi causa, non ha diritto ad alcuna retribuzione); – un cottimo misto, quando la retribuzione è costituita da una parte fissa che viene integrata da un sovrappiù per ogni unità o per ogni affare in più rispetto a un certo quantitativo minimo stabilito nel contratto di lavoro. Per esempio, una sarta a domicilio viene pagata quattro euro per ogni riparazione effettuata (cottimo
119