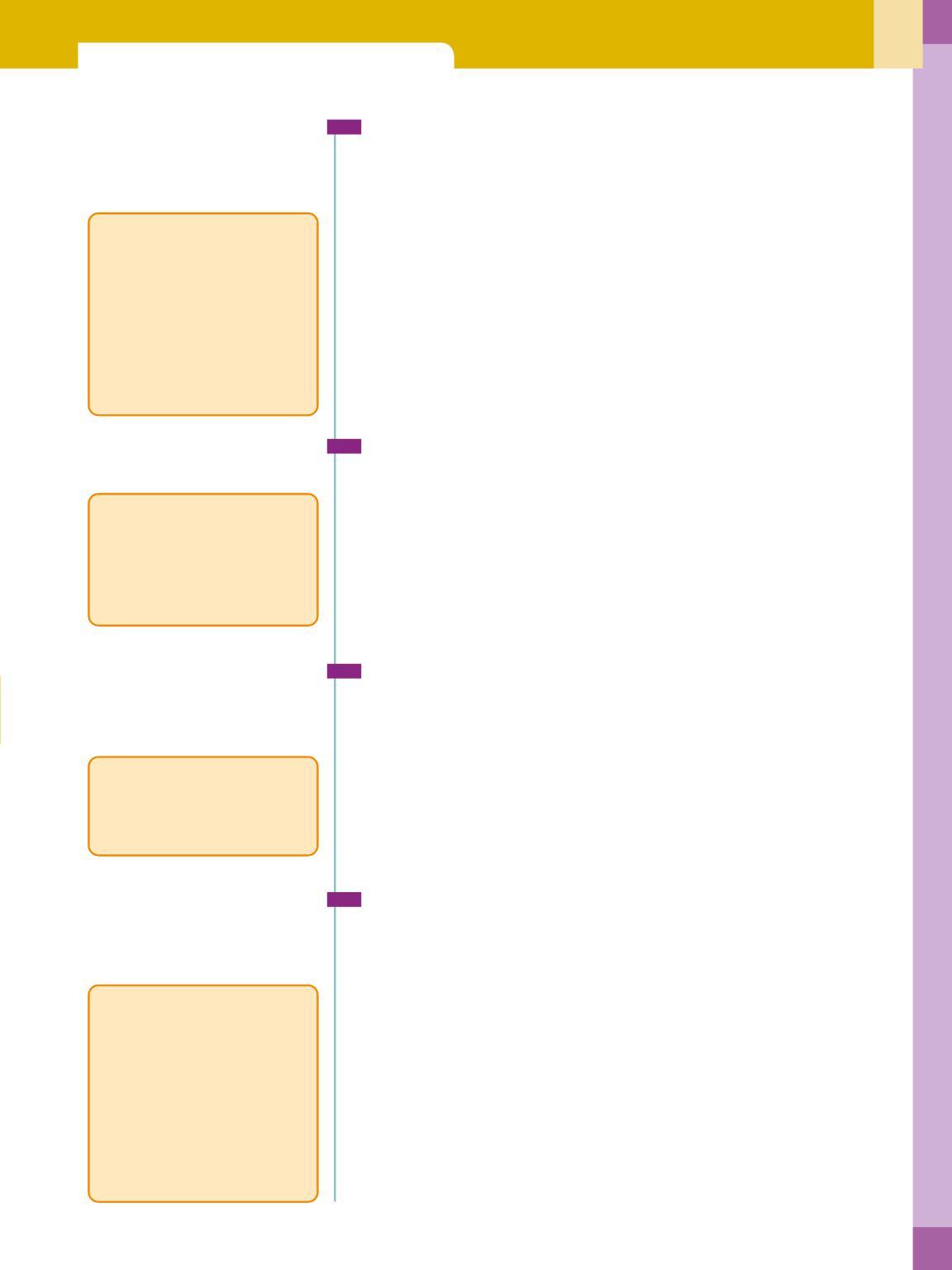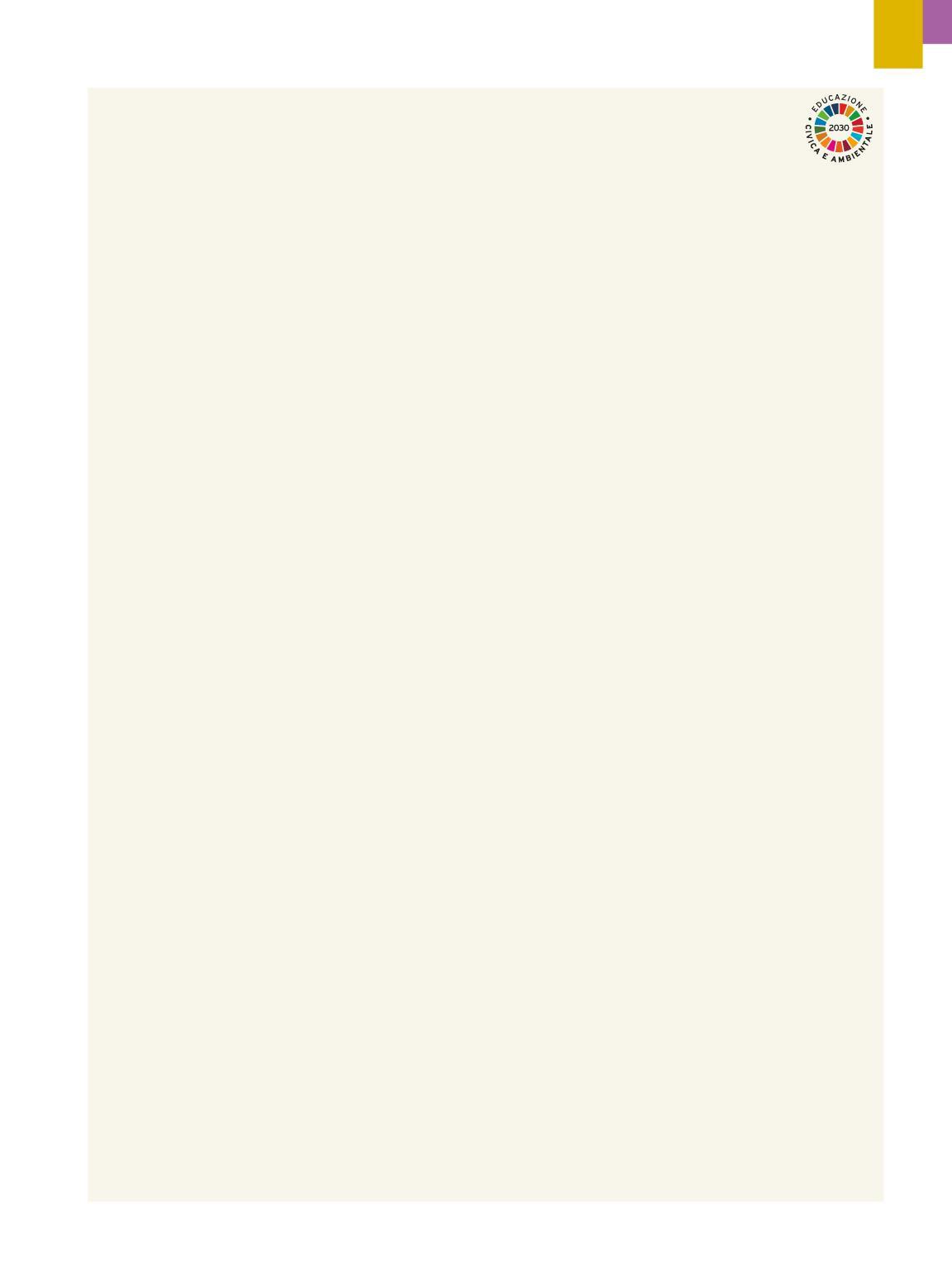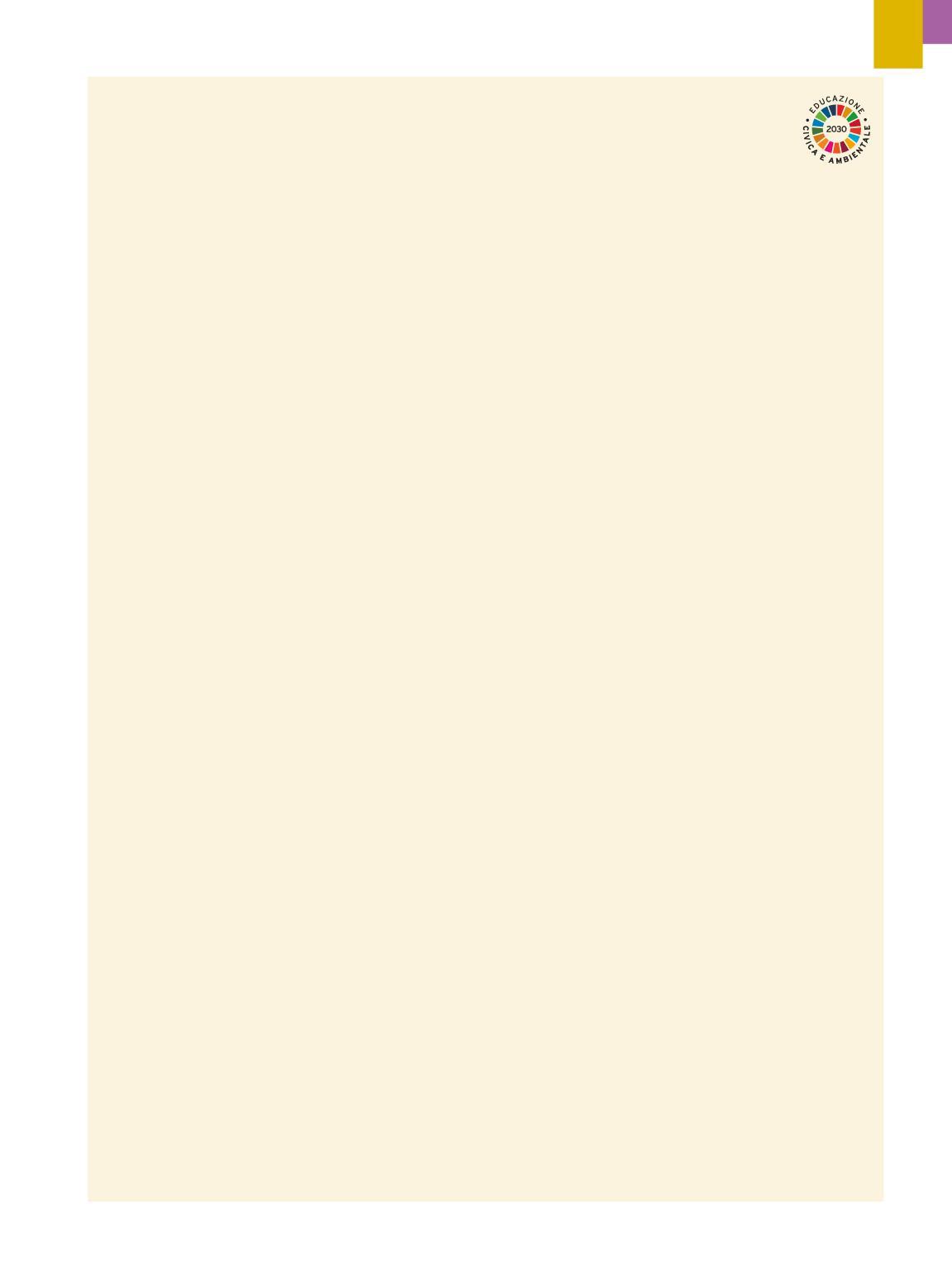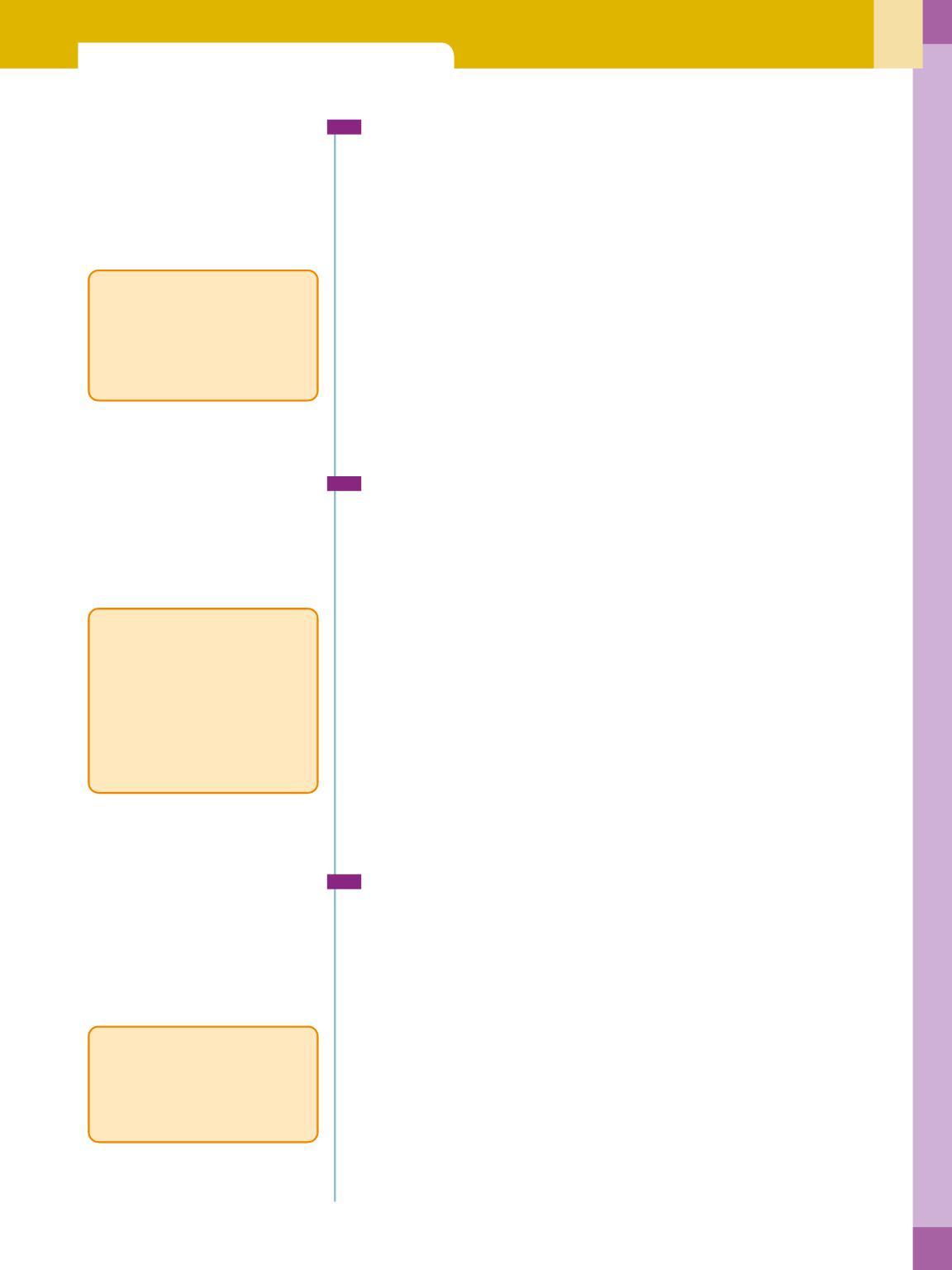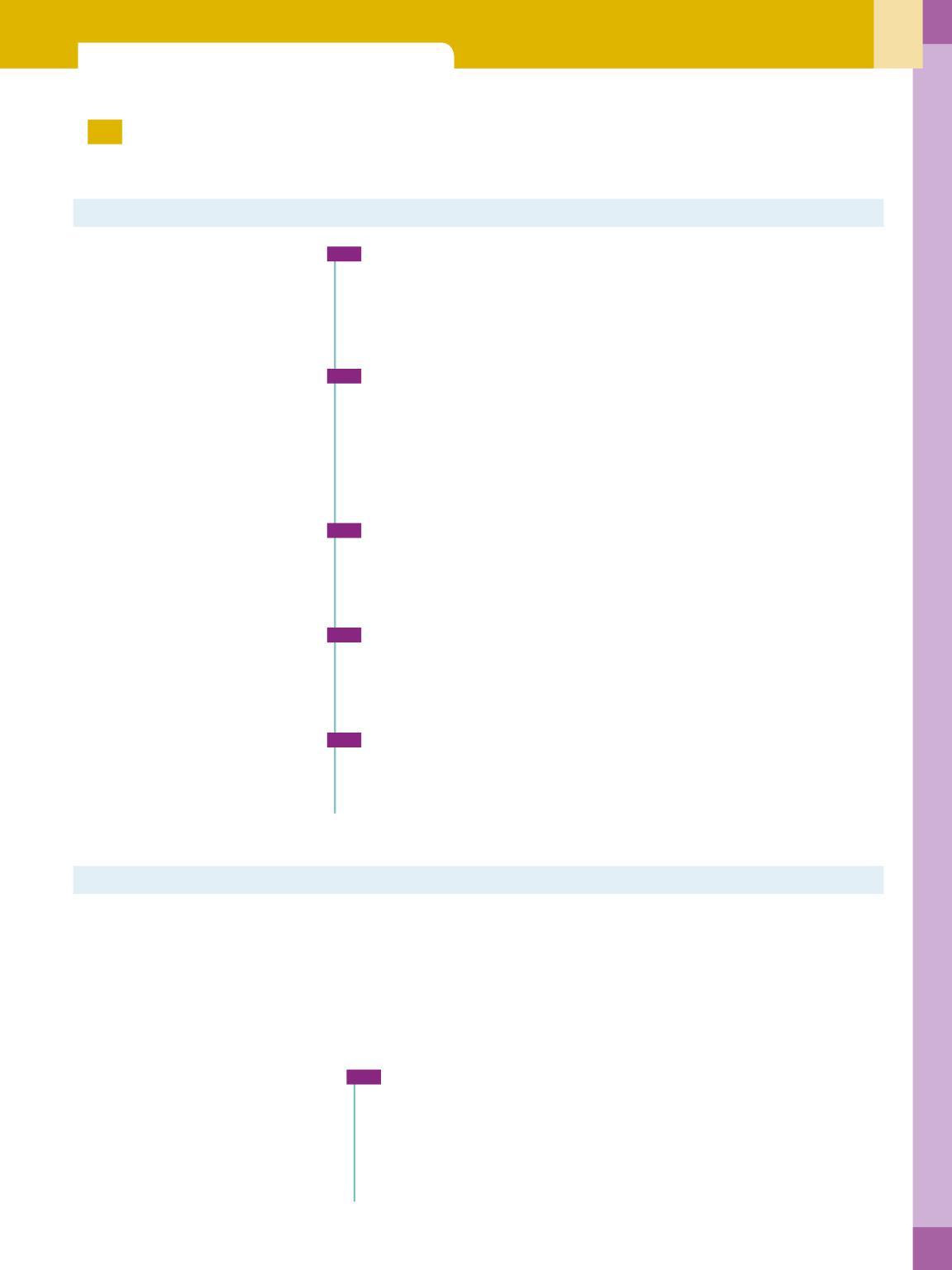9 minute read
laboratorio di metodo. verso l’esame tipologia a
Comprensione e analisi [Elaborato unitario]
Il brano riporta il dialogo tra il capitano Bellodi e i familiari e soci di Salvatore Colasberna, piccolo imprenditore edile che è stato ucciso, presumibilmente per non essersi piegato alla mafia. Le ricostruzioni del capitano, incaricato di svolgere le indagini sull’omicidio, partono dalle cinque lettere anonime ricevute, in cui vengono fornite diverse informazioni sulla morte di Colasberna, che però gli sembrano non credibili e motivate solo dal desiderio di depistarlo. Il capitano smonta le versioni contenute nelle lettere e ritiene invece che «la traccia buona» sia un’altra: il lavoro della vittima nel settore edile e la “protezione” data alle aziende da associazioni illecite, cioè dalla mafia, in cambio di denaro. Bellodi non ha prove, ma sostiene di conoscere il modo di operare di una di queste associazioni, che fornisce alle ditte informazioni preziose e vari tipi di supporto, e che agisce con ritorsioni anche violente ai danni di chi non accetta il suo “aiuto”. Bellodi offre ai Colasberna e ai loro soci la possibilità di comprendere fra le righe il significato della sua ricostruzione («voi mi capite»), ma la loro posizione resta sempre la stessa, evasiva e ben determinata a non fornire alcuna collaborazione alle indagini, anzi decisa, inizialmente, ad avvallare le ipotesi inconsistenti avanzate dalle lettere anonime. Quando però il capitano introduce la questione degli appalti gestiti dai mafiosi, familiari e soci negano fermamente questa possibilità («Non può essere») e infine dichiarano di non sapere nulla di queste cose e di non averne mai sentito parlare, facendo emergere il loro atteggiamento omertoso. Anche se è chiaro che le associazioni di cui parla sono mafiose, il capitano Bellodi non cita esplicitamente la mafia, ma vi allude con giri di parole, facendo riferimenti generici a «ditte appaltatrici», dedite a vari tipi di traffici e composte da «gente che non dorme mai», persone costantemente impegnate ad agire nell’ombra che forniscono vari servizi (supporto, informazioni, controllo) agendo come una «associazione», cioè con una precisa forma di organizzazione che estorce denaro in cambio di “protezione”. Il capitano allude anche a episodi di intimidazione messi in atto da queste associazioni mafiose che, per convincere le aziende a pagare il “pizzo”, ricorrono a minacce e atti di violenza. Di fronte a queste allusioni del capitano, Giuseppe Colasberna, unico interlocutore di Bellodi, cerca di parlare il meno possibile. Le sue risposte sono brevi, secche ed evasive. La comunicazione è affidata soprattutto alla mimica, fatta dagli sguardi e dai gesti che esprimono l’omertà e la coesione dei familiari e soci dell’ucciso. Essi, infatti, prima di rispondere si guardano tra di loro, come per consultarsi sull’atteggiamento da tenere. Quando Giuseppe Colasberna dichiara di non sapere nulla dei fatti malavitosi esposti dal capitano, familiari e soci annuiscono «con facce stralunate», per sottolineare l’assurdità delle informazioni ricevute, rispetto alle quali sono ben intenzionati a fingersi stupiti e totalmente estranei. Nell’ultima riga è sempre la mimica a chiarire la loro posizione omertosa di approvazione alle parole di Giuseppe Colasberna, che ribadisce: «non le ho mai sentite queste cose». Per cercare di far parlare i familiari e i soci dell’ucciso, il capitano procede per gradi, evitando di svelare subito quello che sa in modo da capire le reazioni dei suoi interlocutori. Quando presenta le diverse ipotesi emerse dalle lettere anonime, concede loro degli appigli per far emergere la loro posizione («Può essere» dice Giuseppe Colasberna), ma subito dopo le confuta, dimostrando la loro inconsistenza («Non può essere» risponde il capitano). Quindi introduce l’argomento che gli interessa veramente, anche in questo caso senza parlare direttamente di mafia. Porta infatti il discorso sulle ditte appaltatrici e sul loro comportamento estorsivo, suscitando l’immediata reazione di Giuseppe Colasberna, che nega fermamente non solo il loro possibile coinvolgimento nell’omicidio, ma persino la loro esistenza. Con frasi come «Non può essere», «Di queste cose non sappiamo niente», «non le ho mai sentite queste cose», familiari e soci prendono le distanze da quanto sostiene il capitano, che invece cerca in tutti i modi di coinvolgerli per infrangere il loro muro di omertà: «Voi, a quanto pare, siete dei testardi», «voi mi capite», «voi capite». Talora si dimostra accondiscendente con loro («Lo dico anch’io», «Può darsi»… «può darsi»), ma poi mantiene ferma la sua posizione: «Sì che può essere», dice, quando il Colasberna nega che il lavoro edile e gli appalti abbiano a che fare con l’omicidio. Dall’agitazione dei convenuti, che davanti alle insinuazioni ostentano «facce stralunate», il capitano capisce di aver colto nel segno. La sua è quindi una strategia retorica che mira non tanto a persuadere i suoi interlocutori, quanto a coglierli in fallo e a farli cadere in contraddizione, per smascherare il loro comportamento omertoso e convincerli a dire ciò che effettivamente sanno.
2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?
3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.
4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare la protezione della mafia?
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? Per alludere alla mafia Bellodi usa giri di parole. Parla infatti di «ditte appaltatrici» dedite a vari tipi di traffici e composte da «gente che non dorme mai», persone costantemente impegnate ad agire nell’ombra che forniscono vari servizi (supporto, informazioni, controllo) agendo come una «associazione», cioè con una precisa forma di organizzazione che estorce denaro in cambio di “protezione”. Chi non si piega a questa dinamica malavitosa è costretto con la violenza a sottostare o a uscire definitivamente di scena con la morte. Il linguaggio di Giuseppe Colasberna, unico interlocutore di Bellodi, è estremamente conciso. Le sue risposte sono brevi, secche ed evasive. La comunicazione è affidata soprattutto alla mimica, fatta dagli sguardi e dai gesti che esprimono l’omertà e la coesione dei familiari e soci dell’ucciso. Essi, infatti, prima di rispondere, si guardano tra di loro, come per consultarsi sull’atteggiamento da tenere. Quando Giuseppe Colasberna dichiara di non sapere nulla dei fatti malavitosi esposti dal capitano, familiari e soci annuiscono «con facce stralunate», per sottolineare l’assurdità delle informazioni ricevute, rispetto alle quali sono ben intenzionati a fingersi stupiti e totalmente estranei. Nell’ultima riga è sempre la mimica a chiarire la loro posizione omertosa di approvazione alle parole di Giuseppe Colasberna, che ribadisce: «non le ho mai sentite queste cose». Probabilmente il capitano allude a episodi di intimidazione messi in atto dalle associazioni mafiose, che per convincere le aziende a pagare il “pizzo” in cambio di “protezione”, ricorrono a minacce e atti di violenza.

Per cercare di far parlare i familiari e i soci dell’ucciso, il capitano procede per gradi, evitando di svelare subito quello che sa in modo da capire le reazioni dei suoi interlocutori. Prima presenta le diverse ipotesi emerse dalle lettere anonime, concedendo loro degli appigli per far emergere la loro posizione («Può essere» dice Giuseppe Colasberna), ma subito dopo le confuta, dimostrando la loro inconsistenza («Non può essere» risponde il capitano). Quindi introduce l’argomento che gli interessa, anche in questo caso senza parlare direttamente di mafia. Porta infatti il discorso sulle ditte appaltatrici e sul loro comportamento estorsivo, suscitando l’immediata reazione di Giuseppe Colasberna, che nega fermamente non solo il loro possibile coinvolgimento nell’omicidio, ma persino la loro esistenza. Con frasi come «Non può essere», «Di queste cose non sappiamo niente», «non le ho mai sentite queste cose», familiari e soci prendono le distanze da quanto sostiene il capitano, che invece cerca tutti i modi per coinvolgerli e infrangere il loro muro di omertà: «Voi, a quanto pare, siete dei testardi», «voi mi capite», «voi capite». Talora si dimostra accondiscendente con loro («Lo dico anch’io», «Può darsi»… «può darsi»), ma poi mantiene ferma la sua posizione: «Sì che può essere», dice, quando il Colasberna nega che il lavoro edile e gli appalti abbiano a che fare con l’omicidio. Dall’agitazione dei convenuti («facce stralunate») il capitano capisce di aver colto nel segno. La sua è quindi una strategia retorica che mira non tanto a persuadere i suoi interlocutori, quanto a coglierli in fallo e a farli cadere in contraddizione, per smascherare il loro comportamento omertoso e convincerli a dire quello che effettivamente sanno.
Interpretazione

Il brano è un efficace affresco del diffuso atteggiamento omertoso tenuto nei confronti della mafia, il cui potere intimidatorio arriva all’omicidio e a ogni genere di minaccia e aggressione. Anche di fronte alla morte di un loro parente e collega, i familiari e i soci di Calasberna, la vittima dell’omicidio di stampo mafioso su cui il capitano Bellodi sta svolgendo le indagini, non intendono dire nulla di quello che sanno, un po’ per paura e un po’ per un diffuso e quasi proverbiale atteggiamento reticente di fronte ai fatti di mafia. Il capitano si dimostra molto abile nel cercare di farli parlare, smontando i tentativi di depistaggio arrivati con lettere anonime, che i familiari e i soci dell’ucciso tendono invece ad avallare nel timore che emerga la verità e che i mafiosi pensino che a denunciarli siano stati loro. Dalle domande del capitano emerge anche la descrizione dei traffici malavitosi che stanno dietro agli appalti dei lavori edili, e del sistema mafioso basato sul “pizzo”, con cui si offre “protezione” in cambio di denaro. Da recenti fatti di cronaca si capisce che questo tipo di pressioni criminali non sono sparite e che anzi si sono propagate in molte aree dell’Italia e dell’Europa, espandendosi a partire dalle zone in cui un tempo erano radicate, come la Sicilia, terra in cui Leonardo Sciascia è nato e che conosceva bene. Quello della criminalità organizzata, d’altro canto, è ormai un fenomeno conosciuto anche al di là dei confini siciliani, non solo per via delle notizie di cronaca, ma anche grazie a un vero e proprio filone letterario e cinematografico che cerca di denunciare i molti abusi e le atrocità commesse da Cosa Nostra, raccontandone storie di fantasia, ma verosimili, che provano a rendere l’idea di cosa significhi essere un siciliano, circondato da meccanismi e personaggi che dalla mafia sono più o meno indirettamente controllati, come accade nelle indagini del commissario Salvo Montalbano, protagonista di una fortunata serie di romanzi polizieschi di Andrea Camilleri, poi riadattati anche per la televisione. Ma alla finzione si aggiungono gli episodi reali e i personaggi storici più significativi ricostruiti nelle fiction Rai dedicate a Falcone e Borsellino, nel documentario sulla vicenda del generale Dalla Chiesa, nei film su don Peppino Puglisi e Peppino Impastato e sulla storia del pentito Tommaso Buscetta. Non è certo facile avere il coraggio di denunciare le intimidazioni della mafia, se il prezzo da pagare è la perdita delle proprie attività o addirittura la morte. Alcuni lo hanno fatto e in molti casi hanno pagato duramente quello che si può definire un atto di eroismo. È però vero che se non si abbatte il muro di omertà e di connivenze che salvaguardano i mafiosi, non si riuscirà mai a sconfiggerli e a ridare una vita normale a vaste aree del paese, la cui economia è paralizzata dalla “piovra”, metafora utilizzata dal cinema per descrivere la pervasività delle associazioni criminali in tutti gli aspetti della società.
(Lavoro svolto da uno studente del V anno)