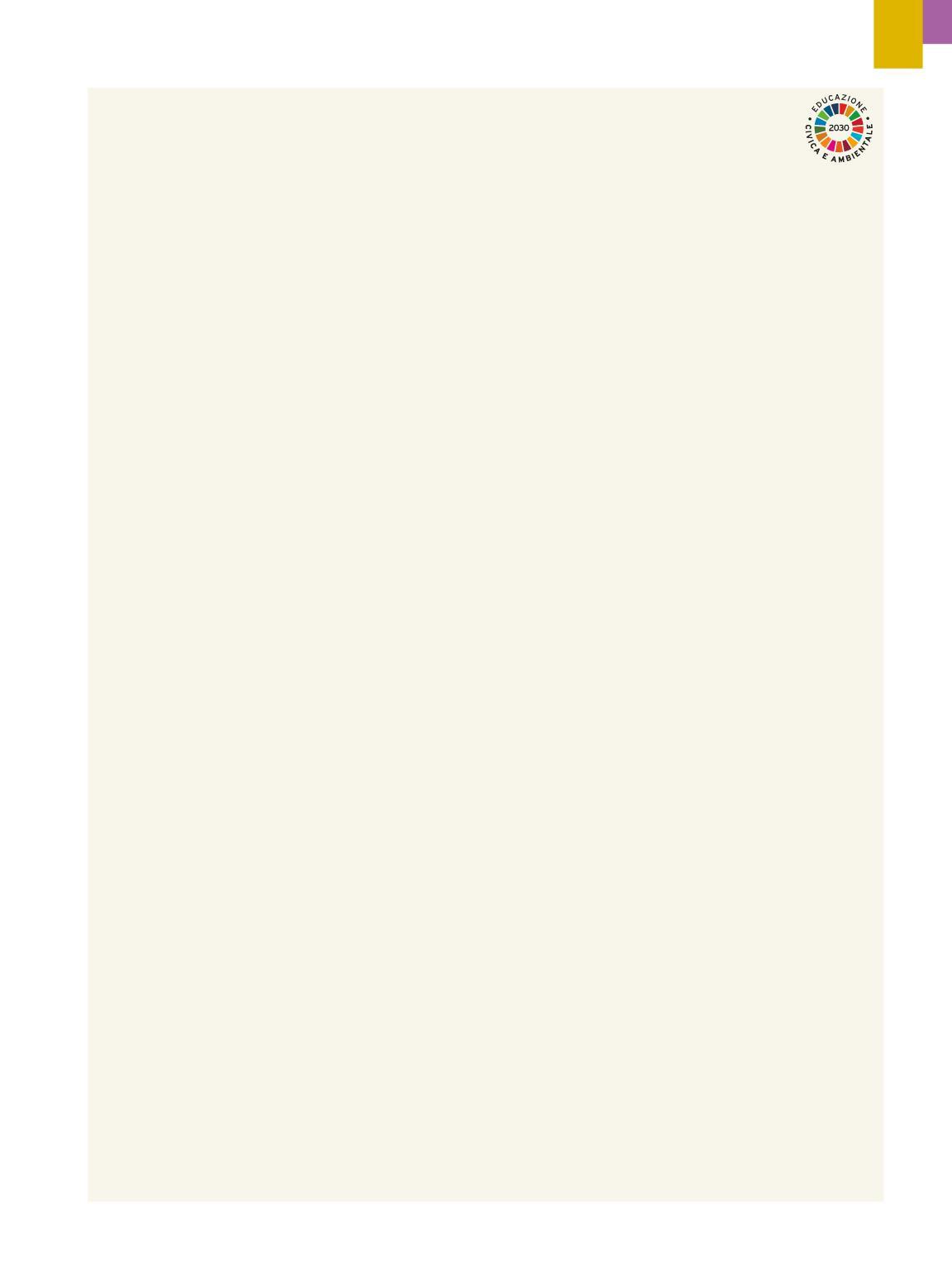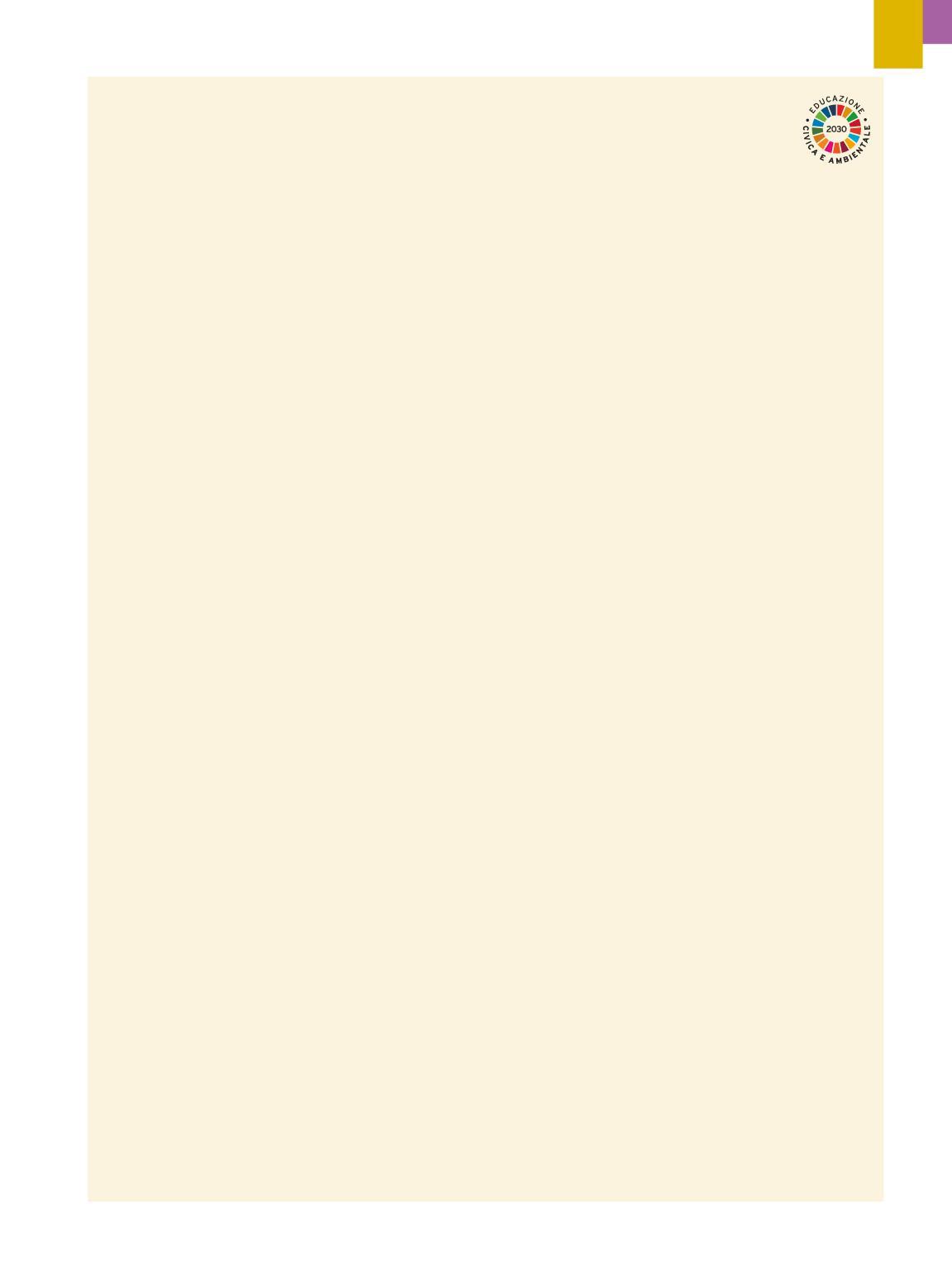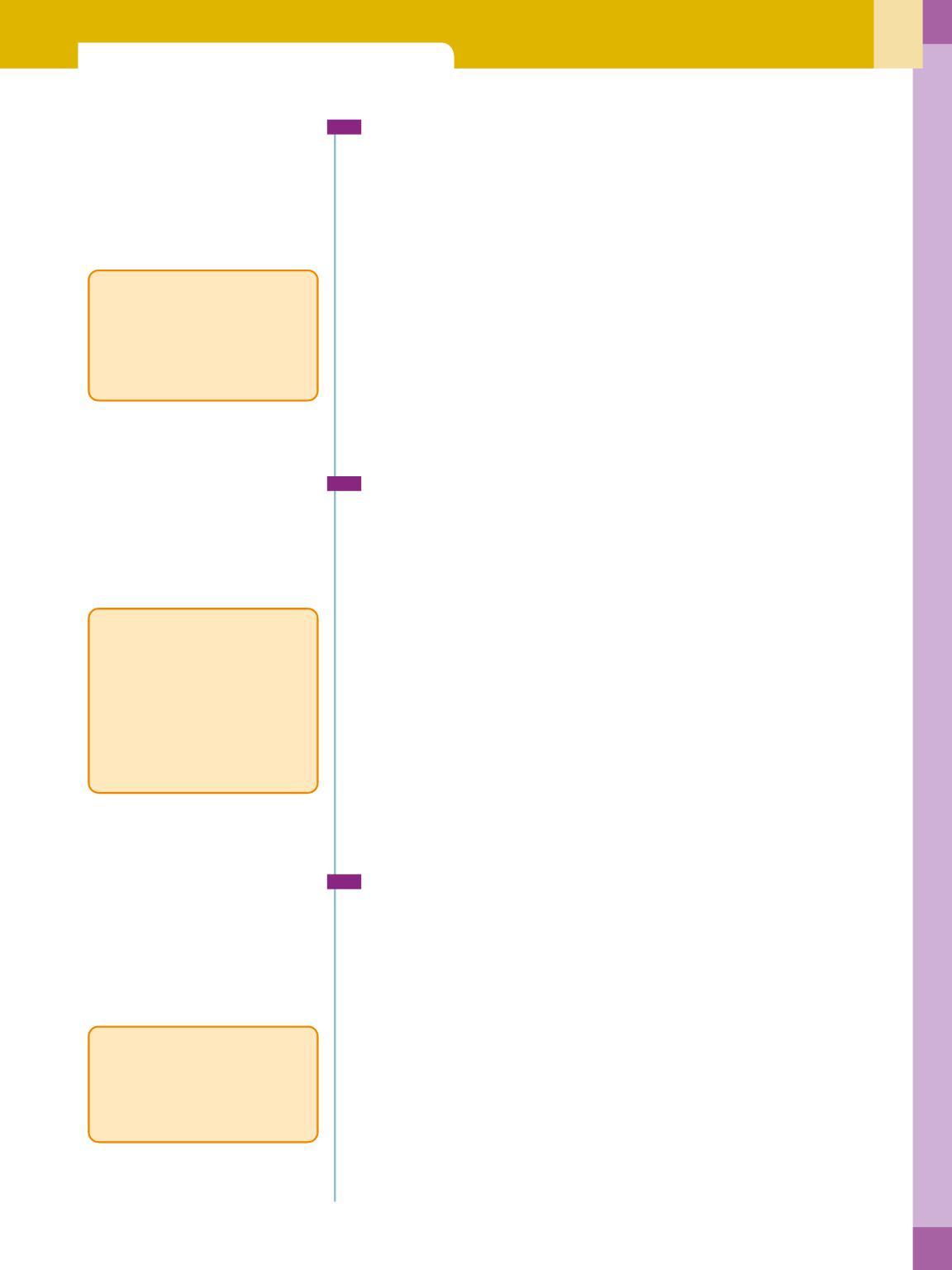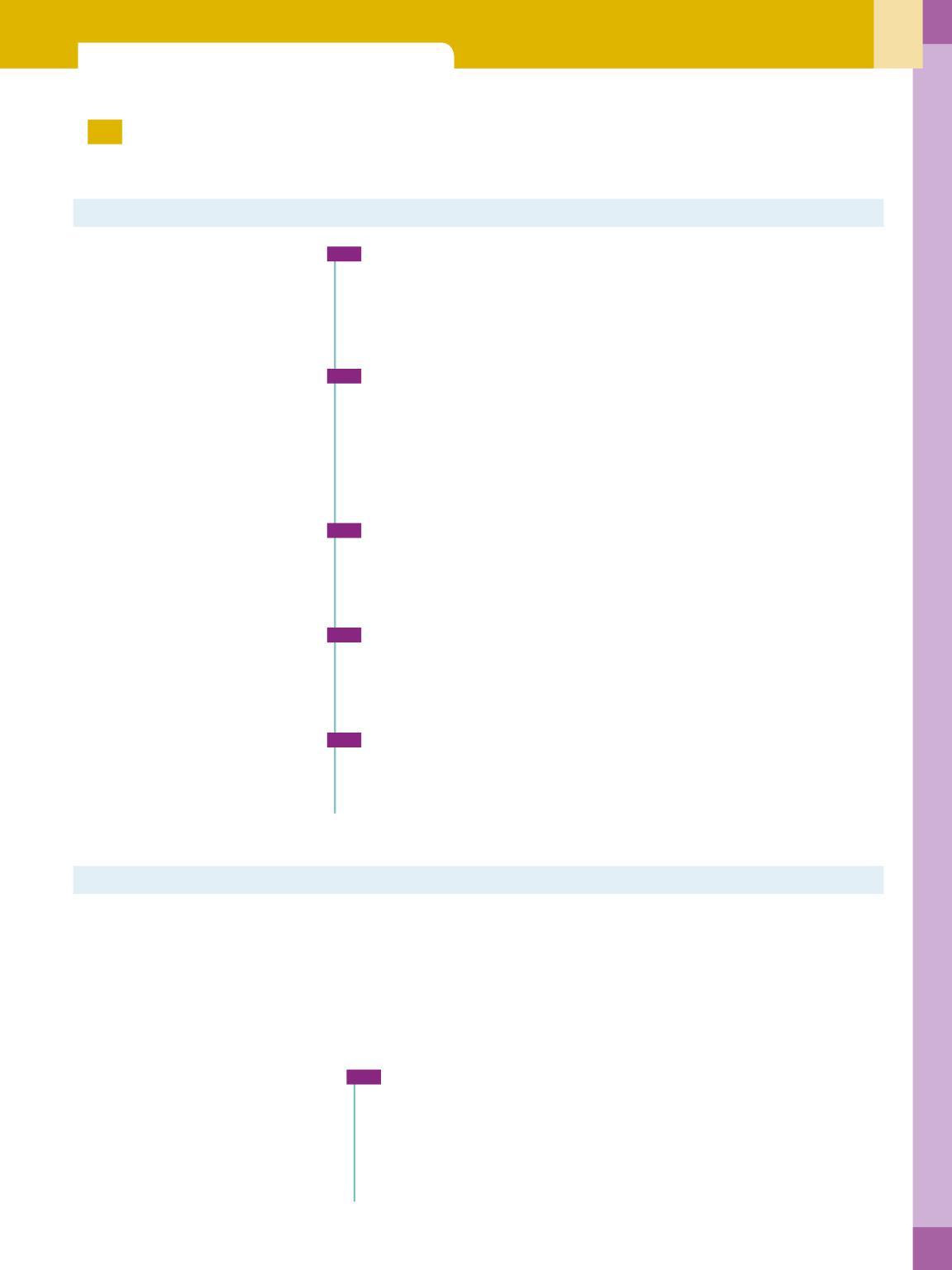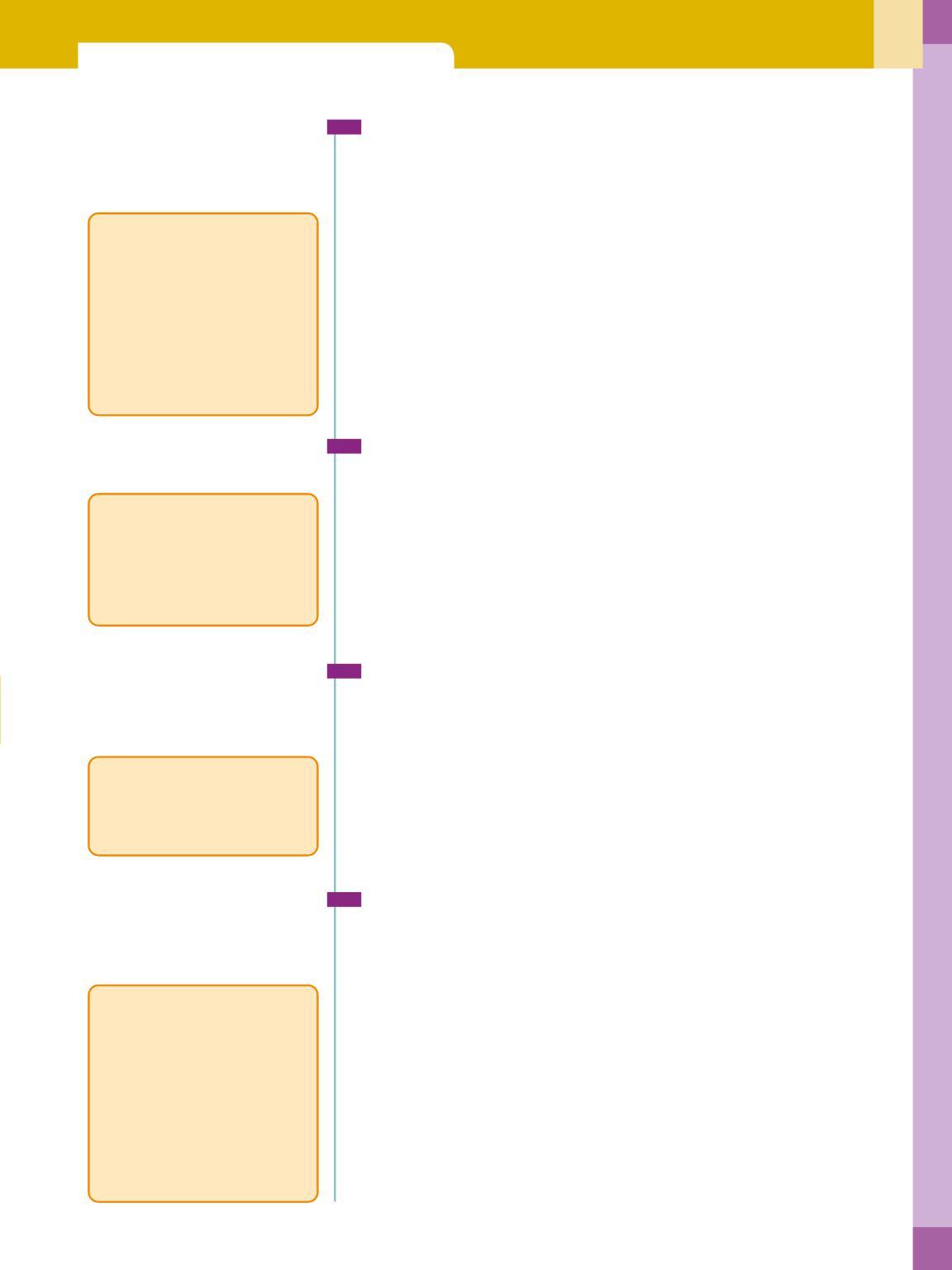3 minute read
laboratorio di metodo. verso l’esame tipologia a
6. Analizza il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. Dal punto di vista metrico la lirica presenta i caratteri emblematici della poetica ungarettiana. I versi, liberi e di lunghezza variabile (con alternanza di bisillabi, settenari, endecasillabi…), sono frammentati da frequenti pause, spazi bianchi di silenzio che isolano le parole enfatizzando la loro forza evocativa. A dar loro maggiore risonanza concorrono anche la mancanza di punteggiatura, il linguaggio semplice e le figure metriche e retoriche: i numerosi enjambement (vv. 10-11; 16-17; 19-20; 2526), le metafore (per es. “rincorro le nuvole”, v. 12), le analogie (“gocciole di stelle”, v. 23).
Comprensione e analisi [Elaborato unitario]
Già dal titolo si comprende che il principale tema della poesia è la rinascita fisica e spirituale alla vita che giunge dopo la dolorosa esperienza vissuta dal poeta nel corso della prima guerra mondiale. A questo tema si intreccia quello del ricordo, sia della sofferenza patita nella vita in trincea, sia del sentimento di comunione con i suoi compagni di battaglia, sia della vita normale, che gli eventi bellici e gli orrori della guerra gli avevano fatto dimenticare. Un’altra tematica presente nella poesia è quella religiosa, che si esprime con la domanda “Ma Dio cos’è?” posta dal poeta a nome di tutta l’umanità, un’umanità talmente dolente e terrorizzata (“creatura/atterrita”) che di fronte agli orrori della guerra giunge a dubitare dell’esistenza di Dio. Come potrebbe infatti Dio, essere supremo perfettissimo, tollerare che gli uomini patiscano tanta sofferenza e crudeltà? Una risposta viene dalla percezione di Dio come “natura”, nella quale la creatura piccola e insignificante che è l’uomo trova la pace, il conforto e l’energia necessaria a superare l’angoscia e recuperare il senso della vita. I «risvegli», cui allude l’autore, possono essere individuali e collettivi. Il risveglio individuale è quello che sente il poeta quando torna alla vita dopo gli orrori della guerra, quando il contatto con le cose semplici della quotidianità lo aiuta a superare il suo stato di angoscia e paura. È questo il risveglio del poeta, dell’io-lirico, che sembra ricordare tutta la sua vita “profonda e lontana”, rivivendola con un percorso di distacco dal presente e di ricerca interiore che lo fa entrare in contatto con le questioni fondamentali dell’esistenza: che cos’è la vita, che cos’è la morte, che cos’è Dio? I risvegli collettivi riguardano, invece, la presa di coscienza che Ungaretti auspica per tutta l’umanità, che dovrebbe trarre dalla brutalità della guerra la forza per riuscire a evitarla, anteponendo la dolcezza della vita e della natura alla tragicità dei conflitti. E ai conflitti si riferisce tutto il senso della lirica, come si desume dalla precisazione del luogo e della data (Mariano il 29 giugno 1916), con la quale Ungaretti vuole contestualizzare chiaramente la poesia per aiutarci a comprenderla. Mariano è un comune del Friuli che si trovava nelle retrovie durante la prima guerra mondiale. Emergono quindi fin da subito il riferimento alla guerra, il senso di angoscia per le distruzioni cui ha assistito, per gli amici morti, per le “vite perse” che percorrono tutta la poesia, associati però al bisogno essenziale di ritornare alla vita consueta. Per esprimere questa tensione alla rinascita, Ungaretti si serve della metrica riconducibile alla sua poetica. I versi, liberi e di lunghezza variabile (con alternanza di bisillabi, settenari, endecasillabi…), sono frammentati da frequenti pause, spazi bianchi di silenzio che isolano le parole enfatizzando la loro forza evocativa. A dar loro maggiore risonanza concorrono anche la mancanza di punteggiatura, il linguaggio semplice e le figure metriche e retoriche: i numerosi enjambement (vv. 10-11; 16-17; 19-20; 25-26), le metafore (per es. “rincorro le nuvole”, v. 12), le analogie (“gocciole di stelle”, v. 23).