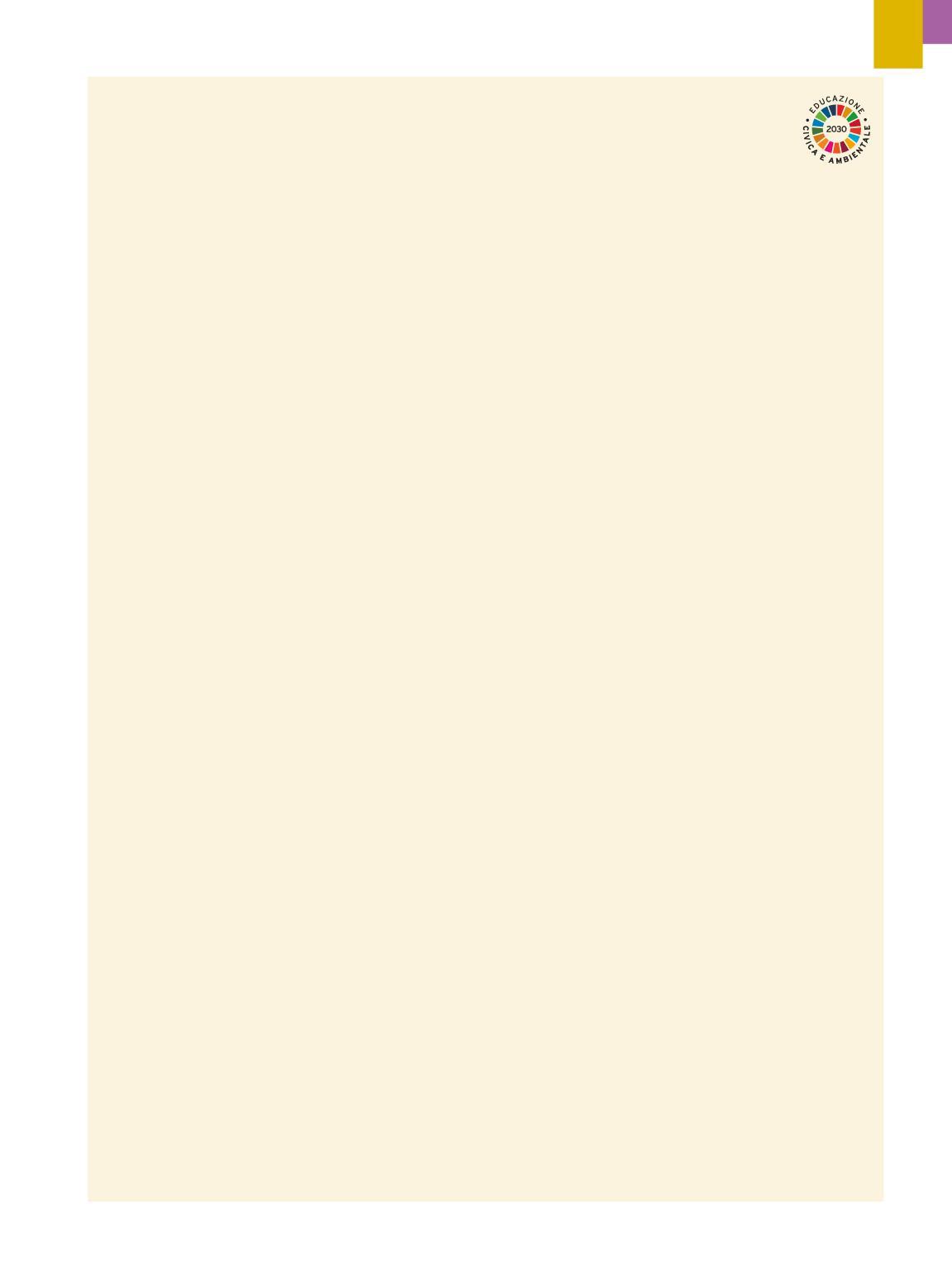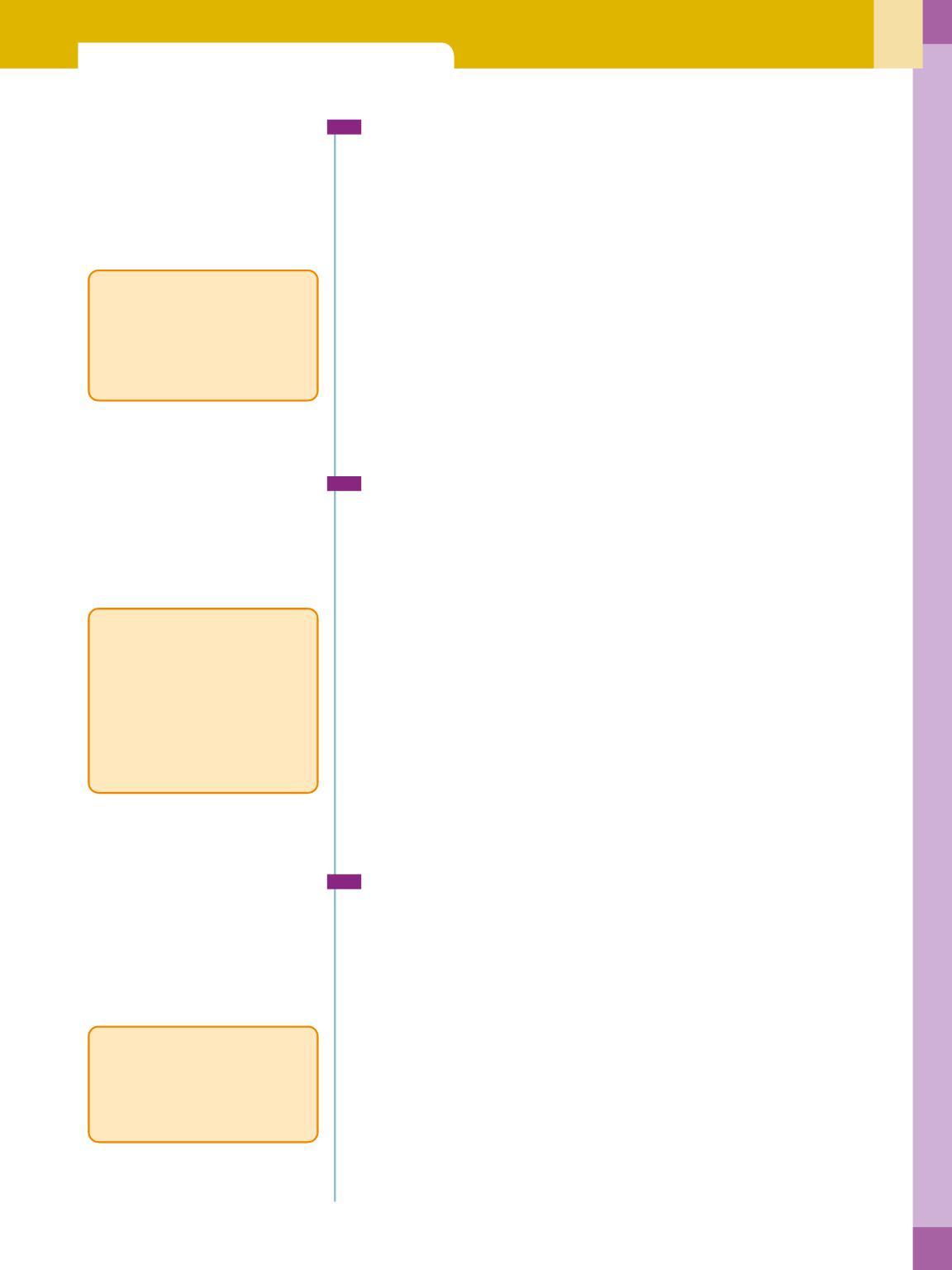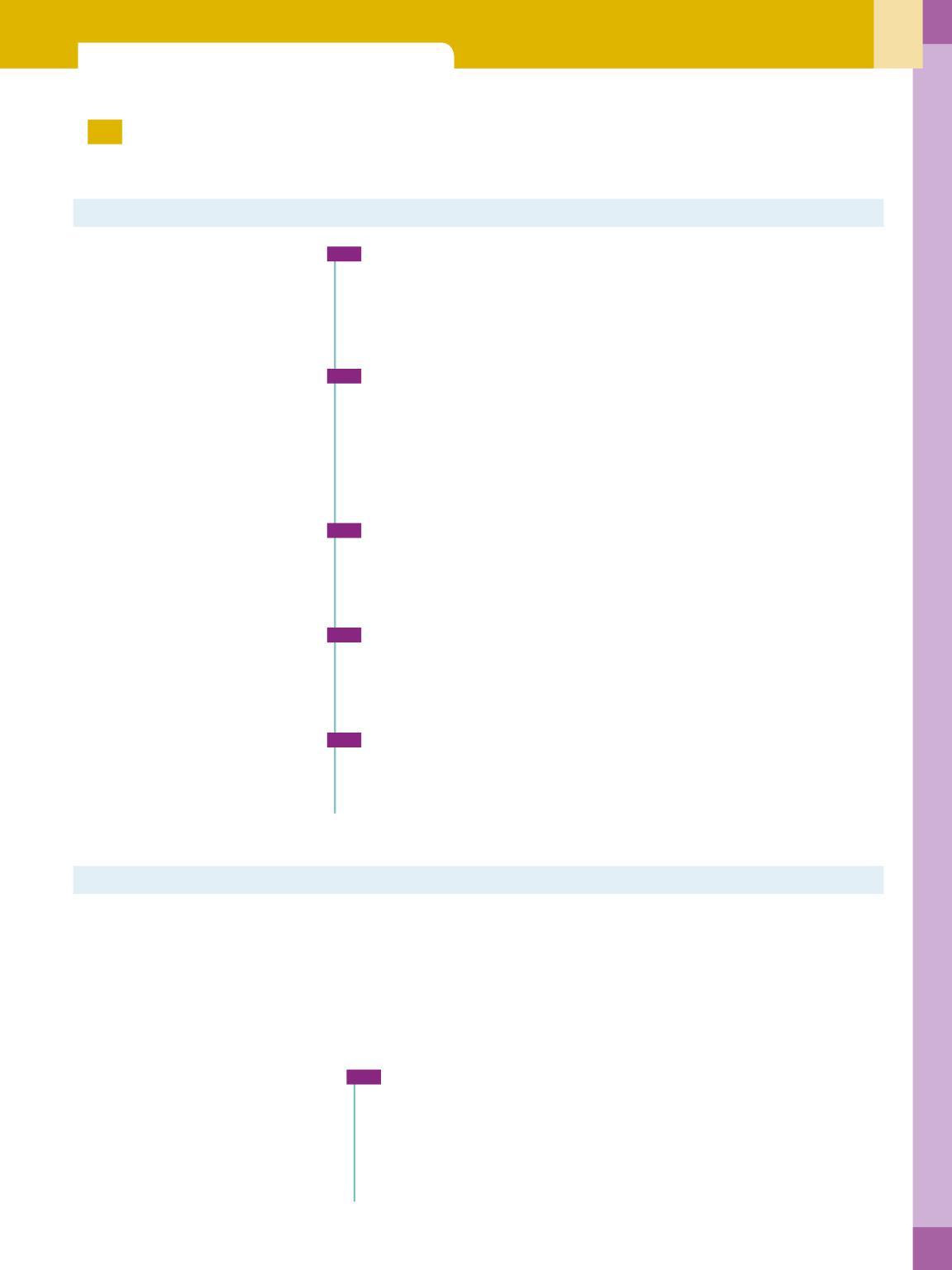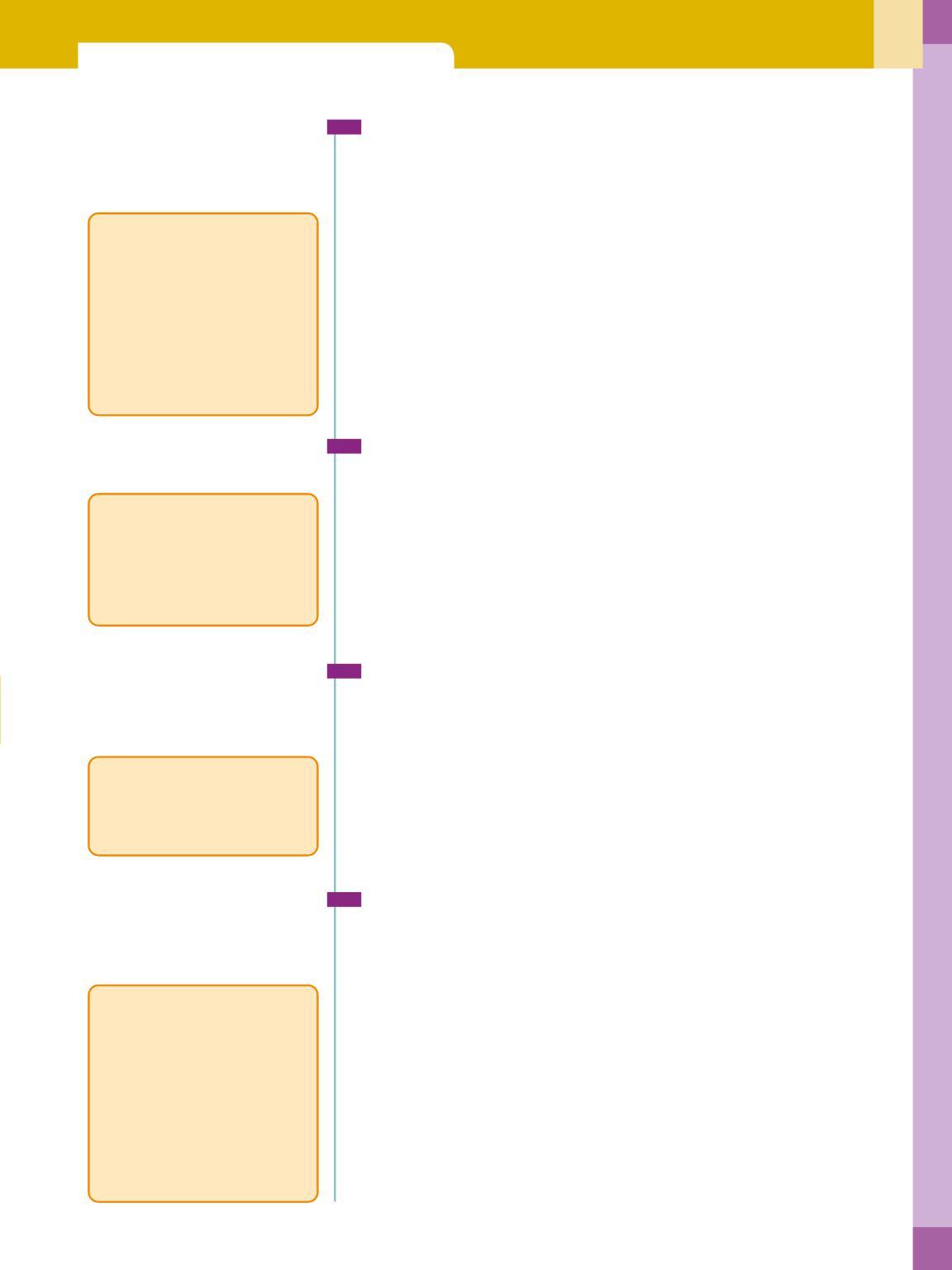8 minute read
Il lavoro subordinato
La definizione della subordinazione
Un rapporto di lavoro subordinato o dipendente si costituisce con la stipulazione, tra un lavoratore e un datore di lavoro, di un contratto di lavoro subordinato (articolo 2094 c.c.). Il contratto di lavoro subordinato è quello con cui una parte (lavoratore) si obbliga, in cambio di una retribuzione, a svolgere il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’altra parte (datore di lavoro). Si svolge soprattutto all’interno di un’impresa in quanto è il modo attraverso cui un imprenditore si procura la forza lavoro necessaria (insieme alla natura, al capitale e all’organizzazione) per l’attività diretta alla produzione e/o allo scambio di beni o di servizi. Un datore di lavoro, però, può essere anche un altro soggetto, privato o pubblico, diverso da un imprenditore.
Le caratteristiche del lavoro subordinato
I caratteri distintivi del lavoro subordinato all’interno di un’impresa sono: • la collaborazione nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa; • la subordinazione del lavoratore verso il datore di lavoro, in quanto il lavoratore è obbligato a osservare le direttive organizzative e le disposizioni tecnico-pratiche emanate dal datore di lavoro e dai suoi superiori nella gerarchia dell’impresa. Per esempio, un lavoratore dipendente deve rispettare l’orario di lavoro e gli ordini di servizio relativi alle modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa. L’obbligazione del lavoratore verso il datore di lavoro è un’obbligazione di mezzi, e non di risultato, in quanto il lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività, ma non è responsabile del risultato della sua attività. Il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato anche dal fatto che di solito il datore di lavoro si assume: • il rischio economico, cioè di non riuscire a coprire con i ricavi i costi di produzione e, quindi, di operare in perdita; ● il rischio giuridico, cioè di non riuscire a pagare i debiti verso i terzi e di essere responsabile per gli eventuali danni causati ai terzi dai lavoratori.
I diritti del lavoratore
Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso: pertanto il diritto fondamentale che viene riconosciuto al lavoratore, in cambio della sua attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro, è costituito
Il diritto alla retribuzione
Secondo il primo comma dell’articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto a ricevere una retribuzione che deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente per assicurare un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, cioè ai familiari a suo carico. Dalla disposizione costituzionale emerge in modo evidente che la retribuzione non svolge soltanto una funzione economica in senso stretto, come mezzo di sostentamento ma anche una funzione sociale in senso più ampio, come reddito che può garantire la libertà e la dignità del lavoratore e dei membri della sua famiglia. La retribuzione spettante a un lavoratore, che viene distinta tradizionalmente in salario (quando si riferisce agli operai) o stipendio (quando riguarda gli impiegati e gli altri dipendenti), deve essere indicata, in relazione alla categoria e alla qualifica del lavoratore, nel contratto individuale di assunzione. Di regola la retribuzione viene determinata facendo riferimento alla retribuzione prevista, per quella categoria e per quella qualifica, dal contratto collettivo del settore nel quale rientra l’impresa o a cui si riferisce l’attività svolta. Considerata la retribuzione “sufficiente”, a norma del primo comma dell’articolo 36 della Costituzione, non può essere derogata in senso peggiorativo nei contratti individuali (cosiddetti minimi contrattuali). Il contratto individuale di lavoro, però, può derogare in senso migliorativo rispetto alla contrattazione collettiva e prevedere per un lavoratore una retribuzione maggiore rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori di quella categoria e con quella qualifica (cosiddetti superminimi contrattuali). In base alla legge, la retribuzione spettante a un lavoratore può essere (articolo 2099 c.c.): • una retribuzione a tempo, che è la modalità più diffusa, stabilita in proporzione alla durata dell’attività lavorativa (cioè un tanto all’ora, al giorno, alla settimana o al mese) a prescindere dal risultato dell’attività del lavoratore; • una retribuzione a cottimo o a provvigione, fissata in relazione al rendimento dell’attività lavorativa (cioè un tanto per ogni unità prodotta o, se l’attività del lavoratore consiste nella promozione e/o nella conclusione di affari per conto del datore di lavoro, un tanto per ogni affare promosso o concluso). Il cottimo a sua volta può essere: – un cottimo puro, quando la retribuzione dipende esclusivamente dalla produttività del lavoratore (e quindi il lavoratore che non produce nulla, per qualsiasi causa, non ha diritto ad alcuna retribuzione); – un cottimo misto, quando la retribuzione è costituita da una parte fissa che viene integrata da un sovrappiù per ogni unità o per ogni affare in più rispetto a un certo quantitativo minimo stabilito nel contratto di lavoro. Per esempio, una sarta a domicilio viene pagata quattro euro per ogni riparazione effettuata (cottimo
dal diritto alla retribuzione. Al riguardo è da rilevare però che, in alcuni casi particolari previsti dalla legge o dai contratti collettivi, il lavoratore ha diritto a una retribuzione anche in mancanza dello svolgimento attuale di una prestazione lavorativa.
puro) oppure una centralinista di un call center viene pagata dieci euro all’ora più cinquanta centesimi oltre il decimo contatto in un’ora (cottimo misto). Di solito i sindacati tendono a ostacolare o comunque a limitare il ricorso al cottimo, in quanto è ritenuto più “usurante” per il lavoratore (che è spinto a lavorare di più per avere un reddito maggiore) e anche più rischioso. Nella retribuzione a tempo, infatti, il rischio dell’eventuale impossibilità del lavoro per una causa non imputabile alle parti rimane a carico del datore di lavoro (che deve comunque pagare il salario o lo stipendio al lavoratore), mentre nella retribuzione a cottimo tale rischio passa a carico del lavoratore (che, se non è in grado di produrre, non ha diritto al pagamento del salario o dello stipendio). Altre forme di retribuzione meno diffuse, sono: • la partecipazione agli utili, che ricorre quando come corrispettivo della sua prestazione lavorativa al lavoratore viene riconosciuta una quota degli eventuali utili netti dell’impresa; • le prestazioni in natura, che consistono in beni o servizi concessi in modo gratuito o semigratuito a un dipendente (cosiddetti benefici aziendali o fringe benefits). La retribuzione non è costituita soltanto dal salario o stipendio in senso stretto, ma è formata anche dai seguenti elementi (cosiddetta onnicomprensività della retribuzione): • la paga base o minimo contrattuale, che è determinata dai contratti collettivi in relazione alle diverse categorie e qualifiche professionali, e i cosiddetti scatti di anzianità, che sono gli incrementi periodici della retribuzione (di solito biennali o triennali) collegati al numero di anni di lavoro; • l’indennità di contingenza; • le altre maggiorazioni o integrazioni di carattere accessorio, previste dalla legge e dai contratti collettivi. Oltre alla retribuzione, al lavoratore sono riconosciuti altri diritti economici, come il diritto alle ferie annuali retribuite, il diritto al riposo settimanale, il diritto alla maggiorazione per il lavoro straordinario o festivo ecc., e alcuni diritti non patrimoniali, come il diritto al rispetto della sua libertà e della sua dignità, il diritto di potere manifestare liberamente il proprio pensiero, il diritto alla sicurezza e alla salute ecc.

Gli obblighi del lavoratore
Dal contratto di lavoro subordinato derivano anche alcuni obblighi a carico del lavoratore. Il principale è lo svolgimento della prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. Da quest’obbligo ne derivano altri, che non hanno un carattere autonomo ma sono accessori o strumentali rispetto all’esatta esecuzione dell’attività lavorativa da parte del lavoratore: l’obbligo di diligenza: l’obbligo di obbedienza; l’obbligo di fedeltà; l’obbligo di riservatezza. Un lavoratore ha l’obbligo di diligenza in quanto, nello svolgimento della sua prestazione lavorativa, deve osservare la diligenza (cioè l’attenzione, la cura e la precisione) che è richiesta dalla natura dell’attività esercitata e dall’interesse dell’impresa (articolo 2104 comma 2, cc.). Per esempio, la diligenza che deve impiegare un contabile incaricato della tenuta della contabilità di un’impresa è diversa da quella di una centralinista incaricata di ricevere le telefonate dei fornitori e dei clienti. Un lavoratore subordinato ha anche l’obbligo di obbedienza, in quanto deve osservare le disposizioni relative alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa impartite dall’imprenditore oppure dai suoi collaboratori, dai quali il lavoratore dipende sotto il profilo gerarchico all’interno dell’organizzazione dell’impresa (art. 2104. c. 2 c.c.). L’obbligo è strettamente connaturato alla nozione stessa di lavoro subordinato, nel quale il prestatore di lavoro svolge la sua attività “sotto la direzione” del datore di lavoro che, quindi, può anche emanare ordini (di carattere direttivo, organizzativo o disciplinare) per regolare lo svolgimento della sua attività lavorativa. Un lavoratore dipendente deve rispettare il divieto di concorrenza, in quanto non può svolgere un’attività concorrente con quella dell’imprenditore, per conto proprio o di terzi, anche al di fuori del suo orario di lavoro (cosiddetto obbligo di fedeltà). Infine un lavoratore non può rivelare segreti aziendali, cioè notizie riservate riguardanti l’organizzazione e i metodi di produzione dell’impresa (cosiddetto obbligo di riservatezza; articolo 2105 c.c.). L’eventuale violazione degli obblighi posti a suo carico da parte di un lavoratore può dare luogo a responsabilità disciplinare o a responsabilità contrattuale per l’inadempimento della prestazione lavorativa. Il potere disciplinare del datore di lavoro ha il proprio fondamento giuridico nel fatto che il lavoratore svolge la sua attività “alle dipendenze” del datore.
L’irrinunciabilità dei diritti
I diritti che sono riconosciuti a un lavoratore dalla legge o dai contratti collettivi in considerazione della condizione di inferiorità economica e sociale rispetto al datore di lavoro, sono qualificati espressamente come diritti indisponibili o irrinunciabili. Pertanto sono considerate invalide le eventuali: • rinunce, cioè gli atti unilaterali con i quali il lavoratore dichiara di non volere più esercitare il proprio diritto; • transazioni, cioè gli accordi con i quali il lavoratore e il datore di lavoro prevengono o pongono fine a una lite rinunciando in tutto o in parte alle rispettive pretese. Per esempio, è invalida la rinuncia di un lavoratore alle ferie o la transazione con la quale il lavoratore rinuncia al versamento dei contributi in cambio di una somma di denaro. L’impugnazione di una rinuncia o di una transazione compiuta da un lavoratore deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi decorrenti (art. 2113 c.c.): • dalla conclusione del rapporto di lavoro, se l’atto di disposizione è stato compiuto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro; • dal momento in cui è stata compiuta, se l’atto di disposizione è avvenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.