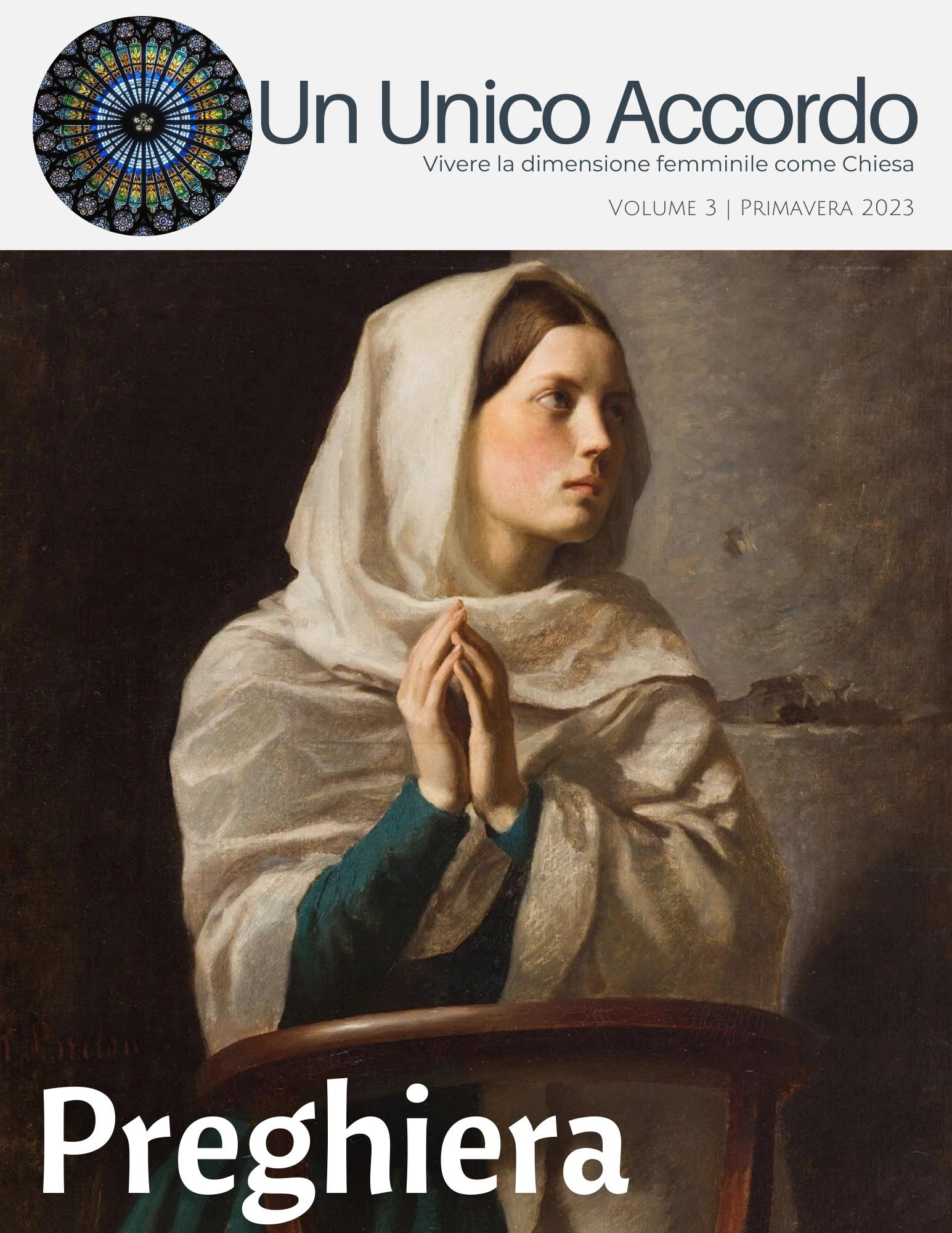
CONTENUTO
EDITORIALE
Lucinda M. Vardey
IL “PADRE NOSTRO’ IN ARAMAICO
Craig E. Morrison O.Carm
L’INTERVISTA DI MAGDALA
Emily VanBerkum e suor Jo Robson OCD.
LECTIO DIVINA INCARNATA
Monica McArdle
IL POTERE DELLA PREGHIERA
John Dalla Costa
CONVERSARE CON DIO
Lucinda M. Vardey
PREGARE IN COMUNIONE
Kimberley Morton
www.magdalacolloquy.org
Un Unico Accordo Preghiera Volume 3, Numero 2 Primavera 2023
1
Editoriale
Il catechismo raggruppa la preghiera in tre espressioni: vocale, meditativa e contemplativa. La nostra preghiera vocale più comune e importante è naturalmente la preghiera del Signore, il Padre nostro. Craig Morrison ci fornisce alcune informazioni essenziali su questa preghiera, pronunciata originariamente da Gesù nella sua lingua, l’aramaico.
La preghiera meditativa (o mentale) implica la riflessione sulla Parola di Dio. Una più completa esperienza delle Scritture può avvenire utilizzando non solo la mente ma anche il corpo. Monica McArdle mostra una via pratica per questo incontro nel suo articolo “Lectio Divina Incarnata.”
La carmelitana suor Jo Robson, intervistata da Magdala, condivide le intuizioni e i consigli di Santa Teresa d’Avila, una delle guide più significative della Chiesa sulla preghiera contemplativa. L’intento della preghiera contemplativa è quello di sviluppare un’intima amicizia con Gesù. Questo proposito di intima amicizia divina ha costituito per molte donne sante il fondamento della loro vita di preghiera. Kimberley Morton presenta tre sante con cui ha fatto amicizia e che l’hanno aiutata a fare amicizia con Gesù.
Le mistiche femminili, che hanno scritto delle esperienze delle loro anime nelle conversazioni con Dio, restituiscono molta sapienza acquisita nella contemplazione. Abbiamo riassunto alcuni dei contenuti di questo aspetto dialogico presente nella preghiera contemplativa della beghina medievale Margherita Porete, della cistercense sassone Mechtild di Magdeburgo e di Santa Caterina da Siena.
Lucinda M.

Vardey Caporedattrice
“La preghiera ha solo l’apparenza di un atto linguistico ... Fondamentalmente è una posizione, una collocazione di sé.”
www.magdalacolloquy.org 2
Patricia Hampl (citata in Wise Women).
Craig E. Morrison O.Carm è professore di Lingue aramaiche e siriache presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma. Ha scritto per “The Catholic Biblical Quarterly,” “The Bible Today,” “The Word Among Us” e “Give Us This Day,” oltre che per altre riviste scientifiche. La sua ricerca attuale si concentra sull’edizione critica della Bibbia ebraica, la Biblia Hebraica Quinta. Occasionalmente, conduce ritiri presso il Mount Carmel Spiritual Centre di Niagara Falls.
Il “Padre nostro” in aramaico
 Craig E. Morrison O.Carm
Craig E. Morrison O.Carm

IL MONDO ARAMAICO DI GESÙ
Nella scena conclusiva di Jesus Christ Superstar, Giuda interroga Gesù sul perché sia apparso “in un tempo così strano.” Parte della stranezza del tempo di Gesù era rappresentato dal crocevia linguistico in cui viveva. Predicava in aramaico, ma nel breve lasso di tempo intercorso tra la sua predicazione e la comparsa dei Vangeli scritti (40 anni), il suo messaggio fu tradotto in greco.
La città natale di Gesù, Nazareth, in Galilea, nel nord di Israele, era probabilmente un villaggio monolingue di lingua aramaica. Forse c’erano alcune attività amministrative in greco, ma la lingua del mercato di Nazareth era l’aramaico. Anche la città più sviluppata di Sepphoris (6 km a nord-ovest di Nazareth)—il centro amministrativo della regione della Galilea ai tempi di Gesù—era una città prevalentemente di lingua aramaica, anche se la popolazione potrebbe aver avuto una maggiore esposizione al greco rispetto alla gente di Nazareth.
I VANGELI ARAMAICI
Non sono giunti a noi vangeli in aramaico. I vangeli aramaici che possediamo sono traduzioni del III-V secolo dei vangeli greci. È possibile che sia esistito un vangelo originale in aramaico, dal momento che il messaggio evangelico si è diffuso a ovest di Gerusalemme in greco e a est di Gerusalemme in aramaico. Ma questi manoscritti originali in aramaico sono andati perduti, lasciando agli studiosi solo il sogno che un giorno possano essere ritrovati.
Spesso mi viene chiesto se Gesù parlasse greco. La risposta è semplice: se l’avesse fatto, a chi l’avrebbe parlato? Al di fuori di Gerusalemme, il greco era parlato pochissimo dalla popolazione ebraica. Così, quando Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare, pronunciò la preghiera che conosciamo come “Padre nostro” nella lingua che aveva imparato da Maria e Giuseppe, l’aramaico.
3
www.magdalacolloquy.org
L’aramaico di Gesù fa capolino periodicamente nei vangeli greci e questi “aramaismi” sono conservati nelle nostre traduzioni italiane. Il momento più significativo si ha quando, in Marco 15,34, Gesù, prossimo alla morte, grida in preghiera il primo versetto del Salmo 22: “ Eloi, Eloi, lemà sabactani?” “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Il significato di questa supplica deve essere lasciato per un’altra volta, ma rivela che Gesù ha pregato i Salmi non nel loro originale ebraico, ma nel suo nativo aramaico). Ci sono altri momenti significativi in cui Gesù parla la sua lingua nei vangeli greci. Alla figlia morta di Giairo dice: “Talita kum” “alzati ragazza” (Marco 5:41). In Marco 7:11 Gesù pronuncia la parola “Korbàn,” che l’evangelista greco traduce con “un’offerta a Dio,” poiché il suo pubblico non avrebbe capito l’aramaico. Gesù apre le orecchie di un uomo sordo con la parola “Effatà” (Marco 7:34). Maria Maddalena si rivolge a Gesù risorto con “Rabbunì” (Giovanni 20:16) e Gesù si riferisce a Dio come “Abba! Padre!” (Marco 14:36). Anche l’“Amen” che pronunciamo nella liturgia riflette una pronuncia aramaica.
‘IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO’
Il “Padre nostro” contiene alcune espressioni molto impegnative, difficili da trasporre in italiano. Tra queste c’è “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” (Matteo 6:11). Le traduzioni italiane mettono una nota di accento sulla parola “quotidiano” (greco: epiousios). Nella traduzione aramaica di questo versetto greco leggiamo “Dacci oggi, il pane di cui abbiamo bisogno” (letteralmente “il pane della nostra necessità”), scopriamo dunque come i primi cristiani di lingua aramaica interpretavano questa frase. Ma cosa voleva dire Gesù? Forse alludeva alla manna del deserto, apparsa per la prima volta in Esodo16 per nutrire gli antichi schiavi israeliti appena fuggiti dall’Egitto e affamati. O forse questa espressione è un’allusione a tutti i pasti (la parola “pane” in aramaico ha spesso un senso più ampio di “pasto”) nei Vangeli, compresa l’Ultima Cena. O forse non ne conosciamo il significato preciso. Come scrive Sant’Efrem, le interpretazioni di alcuni versetti biblici possono essere diverse come i volti dei loro interpreti. Queste sfide ci ricordano che stiamo recitando un’antica preghiera che è stata pronunciata per la prima volta a una comunità ebraica nei dintorni della Galilea, in un tempo e in un luogo molto diversi dai nostri.
‘IN TENTAZIONE’
Negli ultimi anni si è assistito a un crescente dibattito sulla traduzione della frase “Non ci indurre in tentazione” (Matteo 6:13). In superficie questa supplica sembra un po’ sconcertante. Perché Dio dovrebbe indurci in tentazione? Possiamo farlo benissimo da soli. Non abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Per evitare questa confusione, Papa Francesco preferisce la traduzione “Non abbandonarci alla tentazione.” Una possibile soluzione per comprendere questa frase sconcertante si trova nella sua traduzione aramaica.
Il problema qui non è la frase “Non ci indurre.” Ci sono pochi dubbi sul suo significato in greco o in aramaico. La difficoltà sta nella parola “tentazione.” La parola greca che sta alla base della parola “tentazione” è peirasmon. Ma questa parola greca ha due significati, “tentazione” e “prova.” La Vulgata la interpretava con “temptationem,” da cui deriva la preferenza italiana per “tentazione.” Ma se consideriamo le traduzioni in aramaico dei vangeli greci, scopriamo che il greco peirasmon fu tradotto nel III secolo con la parola aramaica nesyuna, che significa
www.magdalacolloquy.org
4
“prova.” Così, i cristiani di lingua aramaica interpretarono la frase nel senso di “non portarci alla prova” o, più liberamente, “non metterci alla prova.” Sullo sfondo di questa frase potrebbe esserci il primo versetto di Genesi 22, “Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo,” che apre la storia nota come “Il sacrificio di Isacco.” Quando diciamo a Dio: “Non metterci alla prova,” ricordiamo a Dio che non abbiamo la forza d’animo di Abramo. Dio ha potuto mettere alla prova Abramo e Abramo si è dimostrato fedele. Ma noi potremmo benissimo fallire e quindi preghiamo “non metterci alla prova.”
La maggior parte della preghiera del “Padre nostro” ha un significato chiaro, anche se profondo. Mi sono concentrato sulle due righe più complicate della preghiera per aiutarci ad apprezzare la profondità dei loro significati all’interno del mondo aramaico ebraico di Gesù, in modo che noi, nonostante la nostra conoscenza limitata di quel mondo, possiamo avere una comprensione più ricca della “preghiera che Gesù ci ha insegnato.”
L’intervista di Magdala
Emily VanBerkum e suor Jo Robson OCD.
Suor Jo Robson OCD è membro della comunità carmelitana di Ware, in Inghilterra, dal 2000. Ha un interesse particolare per gli scritti e l’insegnamento di Santa Teresa d’Avila e ha pubblicato articoli su questo tema in diverse riviste di natura spirituale e accademica. Attualmente è coordinatrice del programma di formazione iniziale per le sorelle carmelitane nel Regno Unito e fa parte del team editoriale della rivista “Mount Carmel.”
Emily VanBerkum è redattrice associata di Un Unico Accordo. Per maggiori informazioni su di lei si rimanda al sito web.

Emily VanBerkum Può parlarci della sua comunità religiosa di Ware, in Inghilterra, e della struttura quotidiana della sua vita di preghiera?
Jo Robson Siamo una comunità carmelitana contemplativa di 11 suore e incentriamo la nostra vita sulla preghiera. La struttura della nostra giornata si basa su due tipi di preghiera: la preghiera solitaria e quella silenziosa (quando ci alziamo al mattino e di nuovo alla sera). Completiamo poi queste con le preghiere della Chiesa: la Liturgia delle Ore e, naturalmente, la Messa. Cerchiamo di bilanciare le nostre attività e i nostri doveri quotidiani con questi diversi tipi di preghiera.

5
www.magdalacolloquy.org
EVB La spiritualità carmelitana ha contribuito molto alla Chiesa. In che modo Santa Teresa, in particolare, ha influenzato la comprensione dei diversi aspetti della preghiera?

JR Ovviamente Santa Teresa è una sorta di maestra di preghiera e una figura enorme nella tradizione cristiana. È un grande privilegio vivere la vita che lei ha concepito per noi. Penso che il messaggio di Santa Teresa sulla preghiera si riduca a insegnamenti molto semplici. Che la preghiera è per tutti e, soprattutto, che la preghiera interiore è per tutti. Lei stessa viveva nel XVI secolo, quando la Chiesa era molto in apprensione nei confronti dei laici—soprattutto delle donne laiche— che si impegnavano nella preghiera interiore o mentale, per cui ci si limitava a recitare le preghiere vocali, il rosario, a partecipare alla Messa e a ricevere i sacramenti. Si riteneva che tutto ciò che andasse oltre potesse portare fuori strada. Nel frattempo, Teresa stava vivendo delle esperienze straordinarie nella sua vita di preghiera, che riconosceva provenire da Dio ed essere per tutti. Questo intraprendere la grande avventura della preghiera era il modo per incontrare e trovare Dio. E in tale intuizione, Teresa arrivò a de-mistificare la preghiera, vedendo che qualsiasi tipo di preghiera interiore ha a che vedere con lo sviluppo dell’amicizia con Cristo. E se questo tipo di preghiera favorisce questa amicizia, allora è buona e può essere praticata. La missione di Teresa era quella di rendere la preghiera accessibile.
L’altra intuizione rivoluzionaria che ha avuto è che il tipo di preghiera in cui ci impegniamo tutti, come suore, sacerdoti e laici - quella della contemplazione - non riguarda noi stessi, ma è al servizio della Chiesa e del mondo. Quindi, quando entriamo in una vita monastica carmelitana, lo facciamo per questo motivo. È un tipo di preghiera che guarda verso l’esterno.
EVB Coltivare la preghiera interiore stando in comunità è certamente un’intuizione importante. Quali benefici vede in questa vita di preghiera interiore, in particolare nel valore del silenzio?
JR Il silenzio è qualcosa con cui lottiamo - in un certo senso, è un bene, perché è qualcosa con cui anche il mondo lotta. Ci si aspetta che la vita monastica sia piena di silenzio e che si viva in un idillio tranquillo, ma posso dire che in un monastero c’è molto rumore quando molte monache chiacchierano! Teresa insegnava che la vita ordinaria è il luogo in cui troviamo Dio. Non voleva che la nostra vita monastica fosse considerata una rarità, ma che lavorassimo, mangiassimo insieme e facessimo le cose che la gente comune deve fare. È qui che incontriamo Dio, non in ideali astratti o in un deserto. Questo è parte del dono di Teresa alla Chiesa, che la vita normale è il luogo in cui si trova Dio.
EVB C’è qualcosa di così bello e accessibile in quello che dici, nel fatto che Dio si trovi nel quotidiano. E sulla nostra grande sfida nel mondo, quella di sentirci a nostro agio nel silenzio. Questo ci può fornire una mappa per “l’orazione di quiete” di Santa Teresa?
JR La terminologia può essere fuorviante. Quando Teresa parla di questa “orazione di quiete,”
www.magdalacolloquy.org
6
in realtà non si tratta del silenzio in quanto tale. Si concentra su una sorta di silenzio interiore. Una delle cose che Teresa conosceva bene, dopo anni e anni di esperienza nel tentativo di pregare da sola, è l’enorme sforzo che comporta. Dobbiamo impegnarci a concentrare la nostra mente, il nostro cuore e la nostra attenzione su Dio. Teresa conosceva questa lotta, sapeva che le prime fasi della preghiera riguardano lo sforzo umano di cercare di fermare la mente, di smettere di distrarsi nella preghiera. Ciò che è incoraggiante nella comprensione della preghiera da parte di Teresa è che tutti gli sforzi compiuti da noi stessi per arrivare a uno stadio di quiete nella preghiera sono, di per sé, preghiera. Perseverando nella preghiera, Dio si fa carico del processo. Dio interviene e dice che non riuscirai mai a raggiungere questo obiettivo da solo, devi lasciarmi entrare! “L’orazione di quiete” è quando ci viene concesso un livello di immobilità e di tranquillità, in cui le distrazioni si dissipano e scopriamo che il nostro cuore si è fissato su Dio. Può accadere solo per un breve momento, o alla fine di un’ora di preghiera, quando Dio interviene e ci dà quello che Teresa chiama “il dono soprannaturale della preghiera.” Dobbiamo dare a Dio lo spazio per lavorare.
EVB C’è qualcosa di così umano nella nostra tendenza ad aspettare quei momenti di “epifania” da parte di Dio come preghiera, invece di coltivare una vita di preghiera per arrivare a quei momenti! Ritiene che questa dinamica di dare a Dio lo spazio per lavorare sia una delle maggiori sfide oggi nello sviluppo della preghiera, specialmente per coloro che vivono nel mondo?
JR È certamente vero che questa è una delle sfide più grandi. Teresa e coloro che l’hanno preceduta conoscevano questi ostacoli alla preghiera. Non è che la natura umana abbia subito un cambiamento radicale in 500 anni! I problemi esistono oggi come prima. Dobbiamo staccarci dal rumore e dal trambusto del mondo e rischiare che, quando ci si siede in silenzio, ci si confronti con chi si è veramente. Teresa parla molto di questo bisogno di conoscenza di sé, della lotta per fissare il proprio cuore su Dio. Sottolinea che abbiamo bisogno di vederci in comunione. Non siamo soli nella preghiera. Le persone che porto in preghiera, le persone con cui sono solidale nella preghiera, quelle per cui intercedo, sono in comunione con le nostre preghiere. Le nostre sfide di oggi sono influenzate dal nostro comportamento sociale: la necessità di spegnere i nostri telefoni e i nostri messaggi su whatsapp. Anche se non sono così specifiche, queste difficoltà a distaccarsi sono perenni nel comportamento umano.
EVB Anche noi possiamo sentirci intimiditi quando approfondiamo la nostra vita di preghiera. Sapere che queste sfide sono sempre esistite e si sono presentate sotto diverse forme, può certamente essere di consolazione. Ha qualche ultima parola di saggezza sull’approfondimento della vita di preghiera?
JR Santa Teresa direbbe che non appena si desidera iniziare a pregare, si è già fatto un lungo cammino. Gran parte del lavoro è stato fatto con questo desiderio, poi si tratta di avere il coraggio e la fiducia di lasciare entrare Dio e di affidare il processo a Dio. Perché Dio aspetta ogni persona. C’è una relazione meravigliosa da vivere. Perché non provarci?
www.magdalacolloquy.org 7
Monica McArdle si graè laureata all’Università di Durham, nel Regno Unito, con una laurea e un certificato post-laurea in chimica, ma non ha mai insegnato a tempo pieno a scuola, scegliendo invece di unirsi alla Comunità cattolica di Sion per l’evangelizzazione, lavorando nelle scuole e nelle parrocchie di tutto il Regno Unito. Il suo ministero, per la maggior parte, ha comportato l’esplorazione dell’uso del teatro, del mimo, della danza e del linguaggio dei segni come modalità di comunicazione per far sperimentare il Vangelo cristiano nella vita degli altri. Questo l’ha portata, dopo 20 anni di missione attiva, a completare un master in Somatic Movement and Dance Education (SMDE) presso la University of Central Lancashire, dove ha studiato la preghiera incarnata per la tesi del Master, anche se in un contesto laico. Ha poi completato un Master presso l’Università di Chester e ora è al quinto anno di studi di dottorato part-time presso l’Università di Roehampton, nel Regno Unito.

Lectio Divina incarnata
Monica McArdle
Leggendo il Salmo 63 si può notare come questo sia disseminato di verbi, praticamente uno in ogni riga. Inizia con “O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia,” poi c’è il banchetto, l’esultanza e l’afferrarsi. La preghiera in questo salmo non è certo passiva, ma pienamente viva e partecipativa, a dimostrazione che la preghiera coinvolge tutto il corpo. Guardo con gli occhi, lodo con le labbra, alzo le mani e mi sdraio sul letto per ricordare e riflettere. Allo stesso modo, Dio assume un ruolo attivo: all’ombra delle ali di Dio posso gioire; Dio riempie la mia anima come un banchetto; la mano destra di Dio mi tiene saldo. Forse questo è uno dei motivi per cui il Commentario Biblico Jerome afferma che “forse nessun altro salmo esprime in modo così vivido l’intima relazione d’amore tra Dio e il suo fedele.” Ciò che dimostra è che la fisicità è una parte importante della preghiera.
Questa percezione costituisce il cuore della mia ricerca di dottorato sul ruolo del corpo nella preghiera cristiana, con particolare attenzione alla lectio divina . L’interesse è nato dalle mie esperienze come membro di un’équipe missionaria cattolica che lavorava nelle parrocchie e nelle scuole, principalmente nel Regno Unito. Il mio ministero prevedeva l’uso del teatro, del mimo, della danza e del linguaggio dei segni come modalità di comunicazione per portare un’esperienza del Vangelo nella vita degli altri. Grazie a questo lavoro ho visto persone raggiungere un senso più olistico di se stesse e una consapevolezza più fondata di Dio.
Queste esperienze mi hanno portato all’Educazione al Movimento Somatico (SME), che è uno studio del sé dalla prospettiva della propria esperienza vissuta, che comprende le dimensioni del corpo, della psiche e dello spirito. Una premessa fondamentale per la “consapevolezza somatica” è la comprensione che il corpo, o “soma,” è un insieme integrato, piuttosto che un conglomerato differenziato di categorie di mente, anima, spirito o anatomia.1 La proposta somatica è che attraverso l’uso del movimento, del suono, del respiro, del tatto e dell’immaginazione si sviluppi la capacità di notare ciò che potrebbe emergere attraverso le sensazioni corporee. È un mezzo per scoprire e percepire uno spettro di conoscenze che portiamo dentro di noi: infatti, come spiega la danzatrice e filosofa Maxine Sheets-Johnstone nel suo libro The Primacy of Movement [Il primato del movimento] , l’azione dei nostri
www.magdalacolloquy.org
8
“corpi tattili-cinestetici sono porte epistemologiche.” La conoscenza soggettiva può essere acquisita prestando attenzione all’interazione degli aspetti fisici, mentali, emotivi ed estetici/ spirituali della nostra esperienza vissuta.
La Lectio divina è una forma di preghiera cristiana di lunga data che si basa su un impegno dinamico con la Bibbia. Nel loro libro Lectio Divina: Contemplative Awakening and Awareness [Lectio Divina: Risveglio e consapevolezza contemplativi] le direttrici spirituali benedettine Christine Valters Paintner e suor Lucy Wynkoop la descrivono come “un invito ad ascoltare profondamente la voce di Dio nelle Scritture e poi a permettere a ciò che ascoltiamo di plasmare il nostro modo di essere nel mondo”. Il monaco certosino del XII secolo, Guigo II, ha articolato la lectio divina in quattro fasi, o “pioli della scala:” lectio (lettura) , meditatio (meditazione) , oratio (preghiera) e contemplatio (contemplazione). Nella mia ricerca ho abbinato queste quattro componenti della lectio divina: lettura, meditazione, preghiera, contemplazione, con i quattro attributi somatici chiave di grounding, ossa, respiro e movimento.
Fasi della Lectio Divina
lectio (lettura), una prima conoscenza di un testo sacro;
meditatio (meditazione), un periodo di riflessione prolungata sulle sue parole;
oratio (preghiera), una risposta attiva a Dio;
I punti focali della consapevolezza somatica
Grounding: sostegno, tenuta, riorientamento, testimonianza.
Ossa: senso di sé, connessione, forza, presenza.
Respiro: forza vitale, che porta di movimento a un’integrazione bidirezionale.
contemplatio (contemplazione), la presenza del Divino.
Movimento: attualizzazione, espressione, personalizzazione.
Qui di seguito sono riportate le linee guida per integrare la pratica e l’esperienza.
LECTIO
La prima fase prevede la lettura ad alta voce del brano. Per questo, siamo incoraggiati a prendere coscienza del terreno sotto di noi, lasciando che la pienezza del nostro peso scenda con la forza di gravità. L’obiettivo è diventare consapevoli del fondamento di sostegno e presenza che ci accompagna costantemente, anche quando non ci pensiamo. Il grounding, in questo contesto, si riferisce alla connessione che ogni persona ha con la terra, creando un senso di radicamento ed equilibrio.2 Si dice che una relazione attiva con la terra sviluppi “la capacità di percepire e di vivere nel ‘qui e ora.’” “Il grounding può aiutare una persona a essere più presente all’esperienza della preghiera e quindi ad andare oltre la semplice articolazione delle parole.
9
www.magdalacolloquy.org
MEDITATIO
Poi il brano viene letto una seconda volta, per ascoltare profondamente una parola o una frase che richiama l’attenzione. Poi riflettiamo su questa parola mentre percepiamo ed esploriamo la forma dello scheletro che è in noi. La danzatrice e psicoterapeuta Linda Hartley scrive del come localizzare e tracciare le ossa e gli spazi articolari possa “risvegliare l’esperienza vivente.” L’iterazione della frase, come le ossa del corpo, sono tracciate e percepite e forniscono un chiaro percorso per la meditazione.
ORATIO
Il brano viene letto una terza volta, riflettendo sul modo in cui Dio parla attraverso il brano. Che cosa dice la Scrittura sul nostro rapporto con Dio e sul nostro rapporto con il mondo? Il movimento del respiro porta un senso di espansione tra l’inspirazione e un senso di contrazione nell’espirazione. Le domande da porsi sono: “Che cosa ricevo da queste parole?” e “Che cosa sono invitato a rinunciare, a lasciar andare?” In questa fase non si tratta di praticare tecniche di respirazione, ma piuttosto di permettere alla consapevolezza del ritmo e della forma del respiro di diventare un veicolo di relazione nella preghiera.
CONTEMPLATIO
Il brano viene letto una quarta volta, mentre ora riflettiamo sulla risposta che Dio ci invita a dare attraverso questa parola. A questo punto, il corpo è più in sintonia con le esperienze percepite del terreno, del peso, delle ossa e del respiro, e quindi la nostra consapevolezza è risvegliata a qualsiasi seme di movimento che si agita all’interno. La sensazione percepita può essere lieve, ma è importante, perché quando la esprimiamo fisicamente, si manifesta la nostra risposta alla preghiera. Se vogliamo, possiamo amplificare il movimento: senza forzare nulla, ma lasciando che la preghiera fluisca, senza sforzarsi di trovare parole o significato, semplicemente essendo e muovendosi come si è in questo momento di preghiera. Non c’è bisogno di considerare in questa preghiera se si sta “facendo bene,” perché tutte le esperienze di movimento sono intrinsecamente autentiche, avvengono solo nel momento presente e, quindi, sono aspetti preziosi della preghiera.
La lectio divina incarnata offre una porta d’accesso alla rivelazione della verità. A volte siamo sorpresi da ciò che riceviamo, altre volte siamo toccati dall’inaspettato. E così, torniamo al Salmo 63, con la sua pletora di verbi e di impegno attivo per ricordarci che, proprio come il nostro corpo è in costante movimento—dal respiro ai battiti del cuore e alle sinapsi nervose che si attivano—anche la nostra preghiera, la nostra comunicazione, la nostra connessione con Dio devono essere in movimento.
Note 1 Secondo la definizione dell’ISMETA (Associazione Internazionale di Educazione e Terapia del Movimento Somatico).
2 Il grounding svolge un ruolo significativo nella Danza Movimento Terapia, come discusso in questi articoli di P Tord & I. Brauninger (2015) Grounding: Theoretical application and practice in Dance Movement Therapy e B. Meekums (2002) Dance movement therapy. Terapie creative nella pratica.
www.magdalacolloquy.org
10

www.magdalacolloquy.org 11
“Il corpo è il miglior direttore spirituale.” Vilma Seelaus OCD.
Il potere della preghiera
È come se le acque immaginate da Ezechiele scorressero come parole. Un rivolo dal Tempio che scroscia in un ruscello profondo fino alle caviglie. Lode e lamentazioni, con desolazione e gloria pronunciate e cantate giorno dopo giorno fino a far scorrere un fiume profondo fino alle ginocchia e limpido e splendente.
Le parole si combinano nei secoli innumerevoli voci aggiungono i loro canti partecipando a un’ondata e contribuendo ad essa rendendo le acque di molti cubiti distanti dall’altare all’altezza del fianco.
Fin dai tempi antichi le preghiere della Chiesa sono state le preghiere pronunciate da Gesù: i salmi che ha beatificato e compiutoconsacrando l’abbandono sulla croce. Pregare incessantemente come raccomandava San Paolo la Chiesa ha cercato di rendere santo il tempo e ogni ora sacra con la sua Liturgia delle Ore.
Pregato per millenni il fiume di parole è diventato così ampio e profondo da essere impraticabile. Eppure quella ampiezza del Mississippi e quella portata d’acqua del Rio delle Amazzoni sostenevano come previsto da Ezechiele una ricca crescita e una ricchezza incalcolabile
www.magdalacolloquy.org

12
lungo il loro vagabondaggio secolare.
Credete nel potere della preghiera?
Se sì
allora non può che essere che il mondo così com’è con benedizioni e bellezze, con rischi e tentazioni è stato creato (almeno in parte) dal fiume di preghiere, largo come un lago e profondo un miglio offerto per secoli da sacerdoti, suore, monaci e donne e uomini santi.
Credete nel potere della preghiera?
Se sì
allora non possiamo non riconoscere un deficit crescente e attuale una siccità di parole da parte di conventi ormai silenziosi e monasteri sempre più vuoti.
Per essere chiari: Dio non ha bisogno delle nostre preghiere, noi sì. Tutta l’umanità e la nostra storia futura hanno bisogno come sempre del torrente di preghiere quotidiane per guarire e perdonare ciò che va storto e mettere a frutto le nostre più alte possibilità in realtà concrete.
Abbiamo bisogno di recuperare la Liturgia delle Ore perdere noi stessi de-centrando l’egocentrismo trovare la libertà nella nostra totale dipendenza da Dio.
Abbiamo bisogno di reimparare la Liturgia delle Ore per rifornire il serbatoio delle preghiere invocando la grazia rifornire le acque che saziano la sete di giustizia e di pace.
John Dalla Costa
13
www.magdalacolloquy.org
Conversare con Dio
Lucinda M. Vardey
Lucinda M. Vardey è la caporedattrice di Un unico accordo. Per maggiori informazioni su di lei, si rimanda la sito web

Nel mettere insieme un libro di preghiere di donne ho citato le parole di un’amica che ha detto che “la preghiera è una conversazione che ci sostiene.” Mi ha fornito così una delle sintesi migliori sul concetto di preghiera, inteso non solo come incontro con Dio, ma come relazione. Una conversazione che sostiene non può essere un monologo, ma solo un dialogo. E, come in ogni conversazione di significato e sostanza, richiede una completa onestà, offrendo la possibilità di condividere desideri e aneliti, ma anche lamenti, dubbi e confusione. Richiede anche di sviluppare la capacità di aspettare, di ascoltare e di riconoscere la voce di Dio quando Dio parla. Bisogna avere fiducia nel fatto che la sapienza, l’amore e la cura di Dio sono pronti a essere rivelati nel modo in cui Dio decide che tutto avvenga, e nei tempi che Dio stesso ha stabilito. E, infine, deve esserci una sete di intimità e di unità.
In quanto attività dialogica, la preghiera come conversazione non è ampiamente riconosciuta, spiegata o registrata, probabilmente perché è più che altro una preghiera femminile. Tuttavia, ci sono tre donne che ci hanno fornito alcuni esempi significativi: la beghina francese Margherita Porete (1250-1310), la cistercense sassone Mechthild di Magdeburgo (1210-1297) e la terziaria domenicana e dottore della Chiesa Santa Caterina da Siena (1347-1380). I loro scritti assumono forme diverse, ma condividono temi molto simili. Ciò che
tutti trasmettono è lo sforzo di arrivare alla verità nei loro modi specifici. Nel suo Trattato sull’amore di Dio , San Francesco di Sales scrisse che la preghiera e la teologia mistica, a cui queste donne contribuirono, “non è altro che una conversazione in cui l’anima si intrattiene amorosamente con Dio riguardo alla sua amabilissima bontà per unirsi e accompagnarsi a lui.” 1 Lo scopo di questo amoroso scambio non è solo quello di essere amati da Dio, ma, come ha spiegato Mary E. Giles, quello di essere in un “vedersi relazionale” dove “la conoscenza non può essere acquisita indipendentemente dall’esperienza delle profondità dell’amore.” 2
Imparare dalle Scritture richiedeva anche che le donne rendessero vive le Scritture stesse attraverso esperienze uniche, a seconda del livello del loro impegno nella preghiera. Registrando le loro esperienze, queste tre donne hanno dato un contributo che avrebbe influenzato gli insegnamenti dei santi e delle sante dei secoli successivi.
Margherita Porete inizia il suo Lo specchio delle anime semplici con un dialogo tra l’Amore e l’Anima, che si trasforma rapidamente in un dialogo a tre con l’introduzione della Ragione che, naturalmente, è messa in difficoltà dal contenuto del loro discorso. Poi si aggiungono anche Dio e la Chiesa. A un certo punto, Porete osserva che la schiavitù deriva dal fare tutto a partire “dalla ragione e dalla paura, mentre la vera libertà può venire solo dal fare le cose per fede e per amore”. Il suo
www.magdalacolloquy.org

14
libro traccia il progresso della conversazione, dove introduce una scala di perfezione, una metafora che Caterina usa anche nel suo Dialogo. Porete ha un capitolo sulla “Notte oscura” che sviluppa un concetto introdotto all’epoca dagli studiosi francesi Tommaso da San Vittore e Guglielmo da Saint-Thierry. Spiega che la “verità” nella relazione divina non si trova in ciò che la gente dice di Dio rispetto a ciò che Dio è, e ciò che Dio è non può essere detto.

Mechthild di Magdeburgo definisce la preghiera come un mezzo per trasformare il cuore. Scrive che essa rende “mite un cuore amareggiato, gioioso un cuore triste, saggio un cuore stolto, audace un cuore timido, forte un cuore debole, chiaro un cuore cieco, ardente un cuore freddo. Attrae Dio che è grande in un cuore che è piccolo, spinge l’anima affamata verso la pienezza di Dio.” 3
Scrive The Flowing Light of the Godhead [La luce fluente della Divinità] (una raccolta di visioni, rivelazioni, pensieri e lettere) “dal cuore e dalla bocca di Dio” tra il 1250-1264. Chiede a Dio perché ha creato l’anima e la risposta è: “Per la necessità dell’amore”, spiegando che “Dio ha tutte le cose buone a sufficienza, tranne il rapporto con l’anima; di questo Dio non è mai sazio”. La preghiera di Mechthild assume la forma di uno sguardo su Dio, mentre Dio e l’anima dialogano. Come per Margherita Porete, altri aspetti entrano nella conversazione, tra cui la “comprensione”. Alla fine di questi dialoghi, ogni donna arriva a sperimentare l’unità con la Trinità. Mechtild scrive:
Signore Gesù Cristo, Tu sei il mio corpo! Signore Spirito Santo, Tu sei il mio respiro! Signore Santa Trinità, Tu sei il mio unico rifugio e la mia Pace eterna.” 4
San Bernardo di Chiaravalle insegnava che il contemplativo deve trarre dal rapporto con Dio forza e alimento per le altre anime e ciò è testimoniato dalla complessa opera di Santa Caterina da Siena intitolata semplicemente Il dialogo.
IL DIALOGO
Mentre i libri di Margherita Porete e di Mechthild di Magdeburgo sono caratterizzati da una dialettica tra allegorie, la struttura di Caterina è composta da domande rivolte a Dio e dalle risposte di Dio. Nel corso della stesura (che si presume sia durata circa un anno) la scrittrice acquisisce la conoscenza e la comprensione della verità, dell’amore per Dio e per il prossimo, dell’operato della Divina Provvidenza, del ponte (o scala) sul corpo di Cristo come via verso la verità, dei cinque tipi di lacrime che corrispondono agli stadi dell’anima, delle rivelazioni del “cuore sacramentale” (il corpo mistico della Santa Chiesa) e dell’obbedienza all’esempio di Gesù. La traduttrice inglese del Dialogo, Suzanne Noffke O.P., descrive l’intero libro come “un grande arazzo a cui Caterina contribuisce punto per punto, fino a quando non è soddisfatta di aver comunicato tutto ciò che ha imparato riguardo alla via di Dio.” Non è tanto un trattato da leggere quanto una conversazione in cui entrare.”
“Signore e Padre celeste, Tu sei il mio cuore!
L’ingresso nel discorso di Caterina ci apre ai particolari della sua relazione con Dio, nonché alla sapienza e all’insegnamento morale che Dio le rivela. Dio si rivolge a lei in momenti diversi come “figlia carissima,” “figlia gentile,” “figlia amata” e “figlia dolcissima,” e identifica Dio stesso come “il fuoco che purifica l’anima.” Riguardo alla pratica della preghiera, Dio
www.magdalacolloquy.org 15
avverte che se l’intero scopo della preghiera vocale si basa sulla recita di molte parole— una “moltitudine di salmi” e “un gran numero di Padrenostro”—essa non piacerà a Dio né porterà molto frutto.5 Dio ammonisce che non è consigliabile nemmeno abbandonare la preghiera vocale per quella mentale: “Una persona deve camminare passo dopo passo,”perché l’anima è “imperfetta prima di essere perfetta,” quindi anche la sua preghiera è imperfetta.6 Dio raccomanda che la preghiera vocale e mentale includa la concentrazione sull’amore di Dio e sulla sua misericordia per il peccato, consentendo una maggiore conoscenza di sé. E quando una persona che prega “sente il suo spirito pronto per la mia visita,” Dio dice che “deve abbandonare la preghiera vocale.” 7
Dio riassume che la preghiera perfetta è come la “madre” dell’anima e si raggiunge “non con molte parole, ma con l’amorevole desiderio,”8 e questa preghiera include il fare del bene al prossimo con “parole o azioni,”spiegando che la “carità amorevole” è “preghiera continua.” 9

Caterina offre preghiere di comprensione e di gratitudine nel corso del suo testo, per la sapienza acquisita e in ringraziamento della guida di Dio. Il Dio che parla a Caterina ha una voce chiara, ferma e diretta. Dio vuole che un’anima speri solo in Dio e non in se stessa, che non serva due padroni, affermando che il mondo “non ha nulla in comune con me, né io con lui.”10 Dio aggiunge: “E poiché nessuno di voi è stabile in questa vita, ma cambia continuamente fino a raggiungere il suo stato stabile finale, io provvedo costantemente a ciò di cui avete bisogno in ogni momento.”11
Dio assicura a Caterina che Dio “condisce ogni cosa,” imponendole di considerare ogni cosa con riverenza “la disgrazia come la consolazione,” perché “qualsiasi cosa io faccia per provvedere al corpo è fatta per il
bene dell’anima, per farla crescere nella luce della fede, per far sì che confidi in me e rinunci a confidare in se stessa, e per farle vedere e conoscere che io sono chi sono e che posso e voglio e so come assisterla nel suo bisogno e salvarla.” 12
Nella preghiera finale Santa Caterina si rivolge alla Trinità come luce, come mare che nutre l’anima “perché quando guardo in questo specchio (d’acqua) tenendolo in mano con amore, esso mostra me stessa, come tua creazione, in te, e tu in me attraverso l’unione che hai realizzato della Divinità con la nostra umanità.” 13
Note
1 San Francesco di Sales, Treatise of Divine Love [Trattato sull’amore di Dio], traduzione a cura del Rev. Henry Benedict Mackey OSB (Ill, Rockford, Tan Books, 1997) p. 233.
2 Citata in The Flowering of the Soul: A Book of Prayers by Women, a cura di Lucinda Vardey (NY, Ballantine, 1999), p. 358.
3 Mechthild di Magdeburgo, The Flowing Light of the Godhead [La luce fluente della Divinità], traduzione di Lucy Menzies (CT, Martino Pub. 2012), p. 136.
4 ivi p. 132.
5 Caterina da Siena, The Dialogue [Il dialogo], tradotto da Suzanne Noffke OP (NY, Mahwah, Paulist Press, 1980), p. 124.
6 ibid
www.magdalacolloquy.org
16
7 ivi, p. 126. 8 ibid 9 ivi, p. 172. 10 ivi, p. 281. 11 ivi, p. 282. 12 ivi, p. 293.
13 ivi, p. 336.
Kimberley Morton vive e lavora a Toronto. Ha lavorato nel marketing, nella pubblicità e nello sviluppo aziendale. Parrocchiana di lunga data presso la parrocchia cattolica di San Basilio, è stata coinvolta in vari ministeri, tra cui il servizio ai senzatetto nel programma “Fuori dal freddo” e l’accompagnamento di coloro che si stanno convertendo al cattolicesimo nel Rito dell’iniziazione cattolica per adulti. Ha inoltre fatto parte del Consiglio parrocchiale; è membro fondatore del Consiglio di Magdala e membro della comunità laica delle Donne Contemplative di Sant’Anna.

Pregare in comunione
Kimberley Morton
Margaret
Nella mia vita di protestante mi è stato insegnato a credere che i santi fossero in competizione con Dio per le nostre preghiere e la gloria; quindi non hanno mai avuto un ruolo nella mia vita o nella mia fede. Da quando sono diventata cattolica, mi si è rivelato un nuovo “gruppo di amici” nei santi. Ora capisco che essi non sottraggono in alcun modo la gloria a Dio; anzi, è vero il contrario. La gloria di Dio viene magnificata attraverso la loro vita, le loro parole e i loro sacrifici.
La mia conversione alla Chiesa è avvenuta molto rapidamente nell’estate del 2013. Avevo una nuova relazione con un uomo meraviglioso che amavo profondamente e avevo deciso di iniziare a frequentare la Messa con lui (di mia iniziativa e con molta curiosità). Stavo prendendo coscienza della realtà della “grazia di Dio” e molto presto mi sono ritrovata a dire “sì” a un altro tipo di relazione: una relazione con Gesù. Non soddisfatta delle preghiere di routine, volevo equilibrare il mio bisogno di preghiera strutturata con il mio desiderio di dialogo con Dio.
Sono diventata ossessionata dalla storia della donna al pozzo e dal suo invito a relazionarsi con Gesù attraverso l’acqua viva “...una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14). La sua vita e la sua esperienza mi hanno davvero parlato e ho sentito un’affinità non solo con la sua sofferenza e il suo isolamento, ma anche con la sua immediata conversione. Questo mi ha introdotta alle grandi donne della Bibbia e alle sante. Pensavo di poter trovare la mia storia in evoluzione nella loro vita e nel loro esempio, e grazie alla loro sofferenza e sapienza trasformarmi in modo che la mia conversione fosse “portata a termine.”
Naturalmente non è stato così facile. La conversione non è un momento unico e non è mai un prodotto finito una volta per tutte: che sia una conversione alla fede cattolica o dal suo
www.magdalacolloquy.org 17
“In quella realtà che conosciamo come Comunione dei Santi, queste persone esistono in relazione con noi. Traiamo da loro un’eredità viva....”
Carney OSF.
interno, richiede che io dia tutto quello che posso in ogni momento in cui sono invitato da Cristo a farlo.
Mi conforta leggere dei santi, scoprire i loro percorsi verso la completa unione con Dio e gli ostacoli insormontabili che ognuno di loro ha affrontato. Hanno vissuto vite a cui posso aspirare. Nelle parole di Santa Madre Teresa di Calcutta, “Io posso fare tutto ciò che voi non potete, voi potete fare ciò che io non posso; insieme possiamo fare grandi cose.”
È una gioia essere nutriti dal profondo amore dei santi per Gesù. Le donne che seguono le loro storie mi illustrano in modo nuovo le verità del Vangelo.
La Ven. Nano Nagle, nata in Irlanda nel 1718, mi ha dimostrato che nulla è impossibile con la grazia e la guida di Dio. Ha vissuto i tempi tumultuosi in cui i cattolici locali si sollevavano contro le forze anticattoliche dell’Inghilterra, rischiando la vita per servire le giovani ragazze che desideravano un’educazione cattolica. Nata in una famiglia di proprietari terrieri, dovette ricorrere all’accattonaggio notturno nei bassifondi, ma non fu mai tentata di rinunciare a fare del bene.
Tutta la sua vita di servizio - Nagle fondò un ordine religioso e una società missionaria laica, oltre alle sue scuole per l’educazione dei poveri dei quartieri poveri - fu piena di difficoltà e, quando fu vicina alla morte, disse a un amico: “Penso che l’Onnipotente mi ha dato la salute per affrontare ogni piccola fatica; e se non ne facessi uso al suo servizio, potrebbe presto privarmene.” 1
Quando mi sono avvicinata alla mia cresima nella Chiesa cattolica nel 2015, ho riflettuto su quale nome di santa prendere. Volevo trovare una santa con la quale potessi sentire una vera parentela, una donna forte, piena di grazia e di amore per Dio e di desiderio di carità e di verità. Ho trovato questa persona in Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce.
Nata nel 1891 da una famiglia ebrea osservante, Edith fu un’educatrice e la prima donna a conseguire un dottorato in Fenomenologia, un ramo della filosofia. Fu attratta dalla fede cattolica grazie a numerosi incontri con cattolici e alla lettura dell’autobiografia di Santa Teresa d’Avila. Dopo aver insegnato in una scuola domenicana, fu ordinata suora carmelitana nel 1933. Edith aveva un profondo senso di responsabilità nei confronti degli altri e delle verità della croce, come indica il suo nome religioso. Credeva che “quando si cerca la verità, si cerca Dio, che lo si sappia o no.” 2


Edith e sua sorella Rosa, anch’essa convertita, furono catturate dalla Gestapo in Olanda e imprigionate nel campo di Westerbork, prima di essere inviate ad Auschwitz dove lei e la sorella morirono. I sopravvissuti al campo hanno testimoniato che Edith assistette molte donne e bambini e tutti coloro che la accompagnarono sul treno merci per la Polonia. Edith credeva nella dignità delle donne e nel vivere il loro genio femminile.
“Un santo,”ha scritto la mistica e scrittrice inglese Evelyn Underhill, è colui che ha avuto “un contatto estremamente meraviglioso con il mistero dell’Universo, una vita di infinite possibilità.” Diceva anche che i
www.magdalacolloquy.org
18
santi forniscono “gli strumenti di un amore dinamico,” un amore che viene purificato dall’interesse personale e reso più perfetto “a un costo tremendo per se stessi e con un effetto tremendo. ”Sta a noi fare uso dell’amore dinamico, “un motore per lavorare con Dio.”
AMICI SPIRITUALI
I santi mi aiutano a trovare un equilibrio nella vita di preghiera. Come dare, come ricevere e come ascoltare. “Uno dei temi della spiritualità femminile nella nostra epoca,” scrive Ronda Chervin nel suo libro Treasury of Women Saints [Tesoro di donne sante] , “è il bisogno degli uomini del ministero di spiritualità delle donne, anche quando gli uomini si sono consacrati a Dio nella vita religiosa. I carismi speciali delle donne sono complementari a quelli degli uomini e non possono essere semplicemente sostituiti da un’amicizia tra persone dello stesso sesso.” Mi viene in mente la nobildonna romana del III secolo, la Beata Jacopa de Settesoli, che divenne amica intima di San Francesco d’Assisi, con il quale si fermava regolarmente a Roma. Le regalò un agnellino che la seguiva ogni giorno a Messa e rimaneva al suo fianco mentre pregava. Era particolarmente affezionato alle torte speciali che lei gli cucinava. Mentre stava morendo ad Assisi, San Francesco la chiamò perché andasse da lui e gli portasse i panni per la sua sepoltura. Lei aveva già intuito che ne aveva bisogno e venne comunque, arrivando dopo la sua morte. Questa amicizia dimostra che anche gli uomini più santi hanno bisogno del conforto e delle cure delle donne.
Jacopa cercò di farsi guidare da Francesco su come essere caritatevole, ma ricevette molto di più. Fu probabilmente l’unica donna, dopo Santa Chiara, con cui egli sviluppò un rapporto stretto. Quando Francesco accolse “sorella morte,” accolse anche “frate” Jacoba, come la chiamava, per essere l’unica donna presente tra i suoi fratelli in lutto nel monastero.

L’autrice suor Chiara Lainati ha scritto: “E’ proprio prerogativa dei santi, come degli artisti di capolavori immortali, essere vivi in ogni epoca e parlare sempre il linguaggio del presente.” Le vite dei santi sono essenziali per guidarci alla santità; essendo in relazione con loro, abbracciando la loro amicizia, ci sforziamo di diventare una cosa sola con loro nel corpo mistico di Cristo, lasciandoci guidare dagli esempi delle loro virtù. Possiamo essere rafforzati dalla loro fermezza, chiedendo il loro aiuto e, soprattutto, unendoci a loro nel servizio di Gesù, facendo la nostra parte nei passi verso la piena comunione.
Note
1 Boniface Hanley, ‘For the Poor Alone, The Anthonian (Patterson, N.J.: St. Anthony’s Guild, 1984), pp. 3-29.
2 https://carmelitesofboston.org/history/ourcarmelite-saints/st-teresa-benedicta-of-the-crossedith-stein/
Ven. Catherine De Hueck Doherty (O Jesus).
www.magdalacolloquy.org 19
“Una moltitudine di parole non soddisfa l’anima, ma solo una vita santa, un cuore puro.”
Un Unico Accordo
O Dio, nostro Creatore, Tu, che ci hai fatto a Tua immagine, donaci la grazia di essere accolti nel cuore della Tua Chiesa.
R: In un unico accordo, preghiamo.
Gesù, nostro Salvatore, Tu, che hai ricevuto l’amore delle donne e degli uomini, cura ciò che ci divide, e benedici ciò che ci unisce.
R: In un unico accordo, preghiamo.
Spirito Santo, nostro Consolatore, Tu, che guidi il nostro lavoro, provvedi per noi, come noi ti chiediamo di provvedere per il bene di tutti.

R: In un unico accordo, preghiamo.
Maria, madre di Dio, prega per noi.
San Giuseppe, resta accanto a noi.
Divina Sapienza, illuminaci.
R: In un unico accordo, preghiamo.
Amen.
20
www.magdalacolloquy.org
Accogliamo i vostri commenti e le vostre riflessioni (o feedback) e considereremo la possibilità di condividerli nelle prossime edizioni o sul nostro sito web. Se volete contribuire, si prega di inviare a editor@magdalacolloquy.org
Se non siete ancora abbonati, potete farlo in qualsiasi momento gratuitamente grazie al generoso sostegno dei Padri Basiliani della Congregazione di San Basilio.
Basta visitare il nostro sito web www.magdalacolloquy.org dove potrete anche leggere i precedenti numeri della nostra rivista ed essere informati sui nostri progetti e le nostre attività.
La rivista Un unico accordo viene pubblicata in italiano, inglese e francese. Per accedere alle versioni nelle altre lingue si prega di visitare il nostro sito web.
With One Accord (Un unico accordo), musica originale composta dal Dr. John Paul Farahat per l’intervista di Magdala ed eseguita da Emily VanBerkum e John Paul Farahat.
Immagini presenti in questo numero:
Copertina: “Giovane donna in preghiera in chiesa” di Jules Breton (1827-1906).
Pagina 2 “Una discepola” di John Everett Millais (1829-1896).
Pagina 3 Particolare di un’antica icona bizantina.
Pagina 11 “Giovane monaca in preghiera “ di Sergei Gribkov (1852).
Pagina 12 “Il fiume Tignana” foto di John Dalla Costa.
Pagine 14-16 Margherita Porete” (artisti sconosciuti); copertina del libro di Mechtild di Magdeburgo dall’edizione della Paulist Press; “Santa Caterina da Siena che scrive” di Rutillo di Lorenzo Manetti (1630).
Pagine 18-19 Ven. Nano Nagle (artista sconosciuto); “Frate Jacopa,” particolare di un dipinto raffigurante il “transito” di San Francesco ad Assisi di Domenico Bruschi (1840-1910).
www.magdalacolloquy.org 21
In questo numero
Copyright © 2023 Parrocchia di San Basilio, Toronto, Canada
Per contattare la redazione scrivere a: editor@magdalacolloquy.org
ISSN 2563-7940
EDITORE
Morgan V. Rice CSB.
CAPOREDATTRICE
Lucinda M. Vardey
REDATTORE ASSOCIATO
Emily VanBerkum
TRADUTTRICE ITALIANA
Elana Buia Rutt
COORDINATORE DI PRODUZIONE
Michael Pirri
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI PROGETTO
Margaret D’Elia
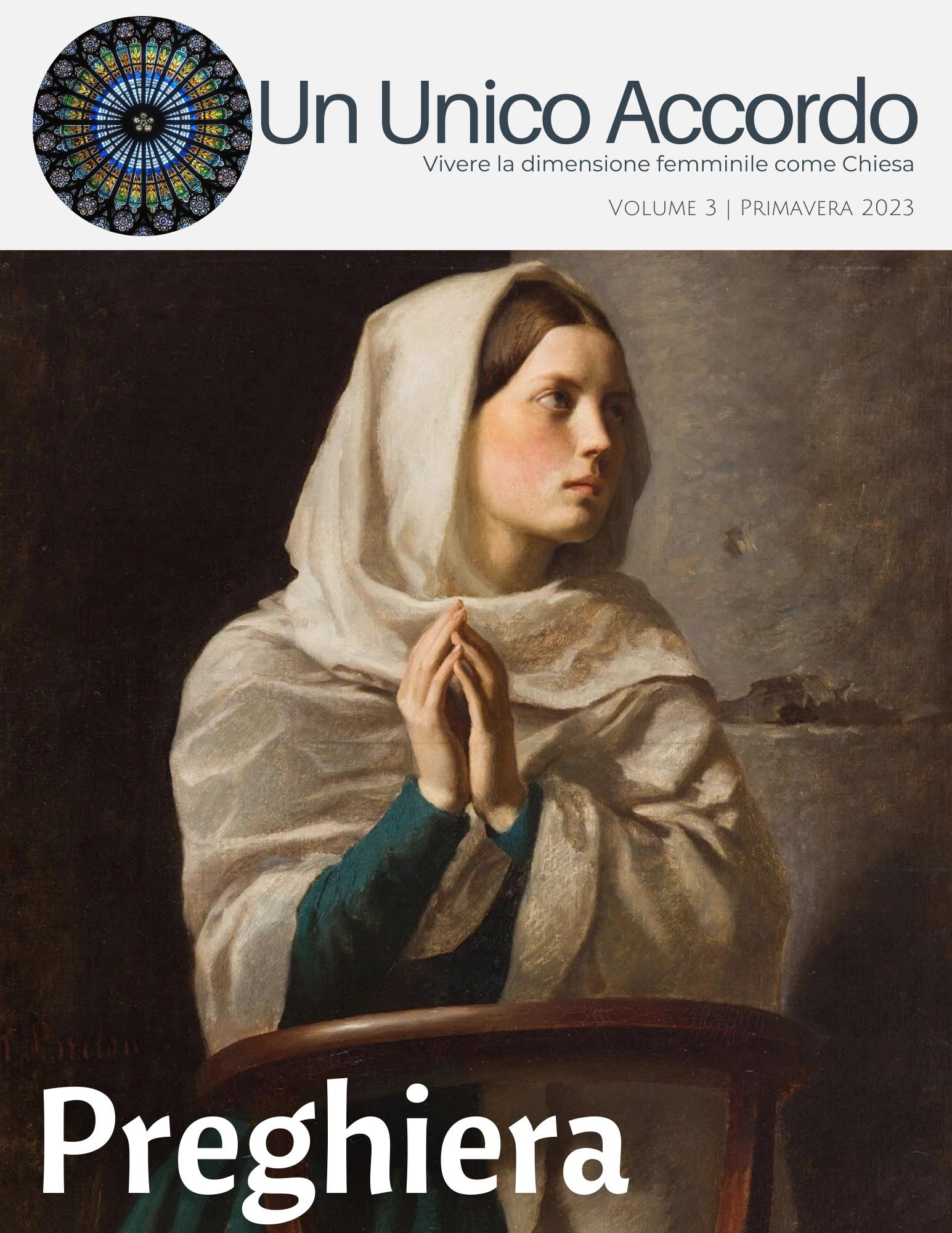


 Craig E. Morrison O.Carm
Craig E. Morrison O.Carm















