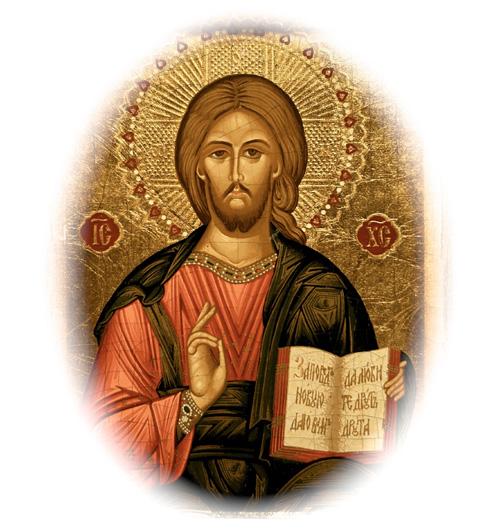
5 minute read
Editoriale
Il catechismo raggruppa la preghiera in tre espressioni: vocale, meditativa e contemplativa. La nostra preghiera vocale più comune e importante è naturalmente la preghiera del Signore, il Padre nostro. Craig Morrison ci fornisce alcune informazioni essenziali su questa preghiera, pronunciata originariamente da Gesù nella sua lingua, l’aramaico.
La preghiera meditativa (o mentale) implica la riflessione sulla Parola di Dio. Una più completa esperienza delle Scritture può avvenire utilizzando non solo la mente ma anche il corpo. Monica McArdle mostra una via pratica per questo incontro nel suo articolo “Lectio Divina Incarnata.”
La carmelitana suor Jo Robson, intervistata da Magdala, condivide le intuizioni e i consigli di Santa Teresa d’Avila, una delle guide più significative della Chiesa sulla preghiera contemplativa. L’intento della preghiera contemplativa è quello di sviluppare un’intima amicizia con Gesù. Questo proposito di intima amicizia divina ha costituito per molte donne sante il fondamento della loro vita di preghiera. Kimberley Morton presenta tre sante con cui ha fatto amicizia e che l’hanno aiutata a fare amicizia con Gesù.
Le mistiche femminili, che hanno scritto delle esperienze delle loro anime nelle conversazioni con Dio, restituiscono molta sapienza acquisita nella contemplazione. Abbiamo riassunto alcuni dei contenuti di questo aspetto dialogico presente nella preghiera contemplativa della beghina medievale Margherita Porete, della cistercense sassone Mechtild di Magdeburgo e di Santa Caterina da Siena.
Lucinda M.

Craig E. Morrison O.Carm è professore di Lingue aramaiche e siriache presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma. Ha scritto per “The Catholic Biblical Quarterly,” “The Bible Today,” “The Word Among Us” e “Give Us This Day,” oltre che per altre riviste scientifiche. La sua ricerca attuale si concentra sull’edizione critica della Bibbia ebraica, la Biblia Hebraica Quinta. Occasionalmente, conduce ritiri presso il Mount Carmel Spiritual Centre di Niagara Falls.
Il “Padre nostro” in aramaico
Craig E. Morrison O.Carm

Il Mondo Aramaico Di Ges
Nella scena conclusiva di Jesus Christ Superstar, Giuda interroga Gesù sul perché sia apparso “in un tempo così strano.” Parte della stranezza del tempo di Gesù era rappresentato dal crocevia linguistico in cui viveva. Predicava in aramaico, ma nel breve lasso di tempo intercorso tra la sua predicazione e la comparsa dei Vangeli scritti (40 anni), il suo messaggio fu tradotto in greco.
La città natale di Gesù, Nazareth, in Galilea, nel nord di Israele, era probabilmente un villaggio monolingue di lingua aramaica. Forse c’erano alcune attività amministrative in greco, ma la lingua del mercato di Nazareth era l’aramaico. Anche la città più sviluppata di Sepphoris (6 km a nord-ovest di Nazareth)—il centro amministrativo della regione della Galilea ai tempi di Gesù—era una città prevalentemente di lingua aramaica, anche se la popolazione potrebbe aver avuto una maggiore esposizione al greco rispetto alla gente di Nazareth.
I Vangeli Aramaici
Non sono giunti a noi vangeli in aramaico. I vangeli aramaici che possediamo sono traduzioni del III-V secolo dei vangeli greci. È possibile che sia esistito un vangelo originale in aramaico, dal momento che il messaggio evangelico si è diffuso a ovest di Gerusalemme in greco e a est di Gerusalemme in aramaico. Ma questi manoscritti originali in aramaico sono andati perduti, lasciando agli studiosi solo il sogno che un giorno possano essere ritrovati.
Spesso mi viene chiesto se Gesù parlasse greco. La risposta è semplice: se l’avesse fatto, a chi l’avrebbe parlato? Al di fuori di Gerusalemme, il greco era parlato pochissimo dalla popolazione ebraica. Così, quando Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare, pronunciò la preghiera che conosciamo come “Padre nostro” nella lingua che aveva imparato da Maria e Giuseppe, l’aramaico.
L’aramaico di Gesù fa capolino periodicamente nei vangeli greci e questi “aramaismi” sono conservati nelle nostre traduzioni italiane. Il momento più significativo si ha quando, in Marco 15,34, Gesù, prossimo alla morte, grida in preghiera il primo versetto del Salmo 22: “ Eloi, Eloi, lemà sabactani?” “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Il significato di questa supplica deve essere lasciato per un’altra volta, ma rivela che Gesù ha pregato i Salmi non nel loro originale ebraico, ma nel suo nativo aramaico). Ci sono altri momenti significativi in cui Gesù parla la sua lingua nei vangeli greci. Alla figlia morta di Giairo dice: “Talita kum” “alzati ragazza” (Marco 5:41). In Marco 7:11 Gesù pronuncia la parola “Korbàn,” che l’evangelista greco traduce con “un’offerta a Dio,” poiché il suo pubblico non avrebbe capito l’aramaico. Gesù apre le orecchie di un uomo sordo con la parola “Effatà” (Marco 7:34). Maria Maddalena si rivolge a Gesù risorto con “Rabbunì” (Giovanni 20:16) e Gesù si riferisce a Dio come “Abba! Padre!” (Marco 14:36). Anche l’“Amen” che pronunciamo nella liturgia riflette una pronuncia aramaica.
‘IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO’
Il “Padre nostro” contiene alcune espressioni molto impegnative, difficili da trasporre in italiano. Tra queste c’è “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” (Matteo 6:11). Le traduzioni italiane mettono una nota di accento sulla parola “quotidiano” (greco: epiousios). Nella traduzione aramaica di questo versetto greco leggiamo “Dacci oggi, il pane di cui abbiamo bisogno” (letteralmente “il pane della nostra necessità”), scopriamo dunque come i primi cristiani di lingua aramaica interpretavano questa frase. Ma cosa voleva dire Gesù? Forse alludeva alla manna del deserto, apparsa per la prima volta in Esodo16 per nutrire gli antichi schiavi israeliti appena fuggiti dall’Egitto e affamati. O forse questa espressione è un’allusione a tutti i pasti (la parola “pane” in aramaico ha spesso un senso più ampio di “pasto”) nei Vangeli, compresa l’Ultima Cena. O forse non ne conosciamo il significato preciso. Come scrive Sant’Efrem, le interpretazioni di alcuni versetti biblici possono essere diverse come i volti dei loro interpreti. Queste sfide ci ricordano che stiamo recitando un’antica preghiera che è stata pronunciata per la prima volta a una comunità ebraica nei dintorni della Galilea, in un tempo e in un luogo molto diversi dai nostri.
‘IN TENTAZIONE’
Negli ultimi anni si è assistito a un crescente dibattito sulla traduzione della frase “Non ci indurre in tentazione” (Matteo 6:13). In superficie questa supplica sembra un po’ sconcertante. Perché Dio dovrebbe indurci in tentazione? Possiamo farlo benissimo da soli. Non abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Per evitare questa confusione, Papa Francesco preferisce la traduzione “Non abbandonarci alla tentazione.” Una possibile soluzione per comprendere questa frase sconcertante si trova nella sua traduzione aramaica.
Il problema qui non è la frase “Non ci indurre.” Ci sono pochi dubbi sul suo significato in greco o in aramaico. La difficoltà sta nella parola “tentazione.” La parola greca che sta alla base della parola “tentazione” è peirasmon. Ma questa parola greca ha due significati, “tentazione” e “prova.” La Vulgata la interpretava con “temptationem,” da cui deriva la preferenza italiana per “tentazione.” Ma se consideriamo le traduzioni in aramaico dei vangeli greci, scopriamo che il greco peirasmon fu tradotto nel III secolo con la parola aramaica nesyuna, che significa www.magdalacolloquy.org
“prova.” Così, i cristiani di lingua aramaica interpretarono la frase nel senso di “non portarci alla prova” o, più liberamente, “non metterci alla prova.” Sullo sfondo di questa frase potrebbe esserci il primo versetto di Genesi 22, “Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo,” che apre la storia nota come “Il sacrificio di Isacco.” Quando diciamo a Dio: “Non metterci alla prova,” ricordiamo a Dio che non abbiamo la forza d’animo di Abramo. Dio ha potuto mettere alla prova Abramo e Abramo si è dimostrato fedele. Ma noi potremmo benissimo fallire e quindi preghiamo “non metterci alla prova.”
La maggior parte della preghiera del “Padre nostro” ha un significato chiaro, anche se profondo. Mi sono concentrato sulle due righe più complicate della preghiera per aiutarci ad apprezzare la profondità dei loro significati all’interno del mondo aramaico ebraico di Gesù, in modo che noi, nonostante la nostra conoscenza limitata di quel mondo, possiamo avere una comprensione più ricca della “preghiera che Gesù ci ha insegnato.”





