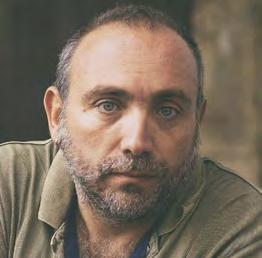
5 minute read
3. Immergersi nel Mediterraneo di Leonardo Palmisano pag
Terza sfida: immergersi nel Mediterraneo
— di Leonardo Palmisano
Advertisement
dirigente d’impresa, scrittore, direttore artistico di LegalItria
Essere cervelli pugliesi significa essere dentro un solo grande cervello che è il Mediterraneo. La Puglia è un avamposto di un sistema formale ed informale di accoglienza. Per questo sono nati o fioriti intellettuali e pensatori che hanno innovato un’idea di Mediterraneo allo stesso tempo pacifica e dialettica —
La dimensione mediterranea innerva i miei ultimi (come Mediterranea, uscito ad agosto scorso per il mio editore, Fandango) e i miei prossimi lavori da autore, perché sostengo da tempo la necessità di far ruotare un’idea di cultura e di acco-
glienza meridionale intorno all’asse mediterraneo. La cronaca mal costruita da troppi media racconta un Mediterraneo di sola morte, mentre la vita che arriva viene cancellata dalle pagine di giornale. Noi mediterranei, anche noi pugliesi è ovvio, da tre decenni accogliamo, diamo ospitalità, consentiamo a centinaia di migliaia di migranti di approdare, di attraversarci, di restare, se lo vogliono.
Non è la popolazione meridionale a respingere, ma politiche furiose, che nulla hanno a che vedere con l’umanità che alberga da millenni sulle coste del nostro mare.
La Puglia dunque è pregna di questa umanità, anche se a volte stenta a riconoscerla o a tradurla in politiche (imbrigliata in una normativa nazionale sui e contro i migranti che si chiama Legge Bossi-Fini). La Puglia è, a mio avviso, un avamposto di un sistema formale ed informale di accoglienza. Per questo in Puglia sono nati o fioriti intellettuali e pensatori che hanno innovato un’idea pacifica e dialettica insieme di Mediterraneo. Su tutti gli altri, Alessandro Leogrande e Franco Cassano. Precedentemente, Tommaso Fiore. Il mancato auto-riconoscimento popolare di questo essere accoglienti fa il paio con un eccessivo autocompiacimento della politica, che si appende spesso la medaglia della bontà con gli altri. La politica ha peso, eccome, ma solo perché i pugliesi e le pugliesi hanno scelto di non sottostare alla ruvida legge dell’esclusione. Posso dirlo più di tanti perché mi sono cimentato nel frequentare i luoghi e le parole degli esclusi: i ghetti, le baraccopoli, i campi. L’ho fatto
in prima persona e l’ho fatto fare, dacché presiedo un’impresa, la società cooperativa Radici Future Produzioni, che ha avviato inchieste, progetti lettura contro le mafie, gestione di biblioteche e progetti di motivazione sociale e pubblica volti a riconoscere i bisogni degli altri come modo di essere e a favorire una risposta istituzionale pronta, efficace, onesta e materna.
Lo facciamo quando progettiamo il riuso dei beni confiscati alla mafia, per esempio, rispondendo a bandi dell’Agenzia della Coesione o di Fondazione Con il Sud aiutando tanti comuni pugliesi — come Se non fossimo pugliesi e Manduria, Mesagne, Trig- immersi nella nostra unicità giano — a individuare indi- meridiana non avremmo la rizzi puntuali nel dare sen- propensione all’accoglienza che so a questi spazi un tempo abbiamo (malgrado la politica) in mano al crimine organizzato, alle tante o troppe mafie pugliesi. Lo facciamo quando predisponiamo la lettura di quasi quindicimila testi contro le mafie in LegalItria, progetto di lettura che copre circa cinquanta comuni, alcune case circondariali, molti centri famiglia e centri per minori a rischio. Lo facciamo quando progettiamo funzioni economiche e sociali dentro spazi pubblico/privati, come a Sammichele di Bari dove stiamo ideando, in raccordo con il Politecnico di Bari e con l’amministrazione comunale, un cervello per l’agricoltura innovativa nel Mediterraneo: un agrihub, il primo di que-
sto genere al Sud. Lo facciamo quando gestiamo una biblioteca comunale, a Erchie, nella quale abbiamo incardinato il primo centro pubblico di documentazione sulle mafie intestato a Peppino Impastato e convenzionato con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi. Lo facciamo quando gestiamo una biblioteca sui Monti Dauni, a San Marco la Catola. Posto incredibilmente bello e suggestivo, abbarbicato su queste alture tutte da scoprire. Lo facciamo quando proviamo a fermare il consumo di sostanze stupefacenti portando musica tra i giovani con giovani artisti, itinerando nei loro stili e linguaggi. Stiamo facendo questo a Massafra, per esempio, rispondendo a un’esigenza avvertita da un’amministrazione attenta a contenere devianza e dipendenza tra gli adolescenti. Lo facciamo, infine, quando vinciamo un bando della Regione Puglia per promuovere il Terzo settore pugliese in Lussemburgo, dove insistono imprese che non si sono mai confrontate con i bisogni sociali, ma che vogliono essere aiutate, che vogliono un modello di riferimento.
Cosa c’entra tutto questo con il Mediterraneo? Se non fossimo pugliesi, se non fossimo così dentro questa differenziata unicità meridiana, non faremmo tutto questo. Essere cervelli pugliesi, perché questo siamo, è essere dentro un solo grande cervello che è il Mediterraneo. Non possiamo né vogliamo prescindere da questo pensatoio involontario. Vogliamo estendere questa mediterraneità nostra oltre il confine stesso del mare. Stiamo cercando di raggiungere i luoghi del riscat-
to più vicini: la Palestina, la Siria, l’Iran, il Kurdistan, l’Armenia… Territori contesi da autocrati, sovrani assoluti e altri assolutisti.
La nostra idea di Mediterraneo è di apertura. Ci inscriviamo in una delle due tendenze che hanno contraddistinto la storia politica ed economica del bacino: l’apertura (Venezia), la chiusura (i fascismi guerreggianti dell’età moderna). Il nostro modello è esplorativo. Le cose che mettiamo in cantiere non ci fanno fermare un attimo. Estendiamo la rete dei nostri rapporti. Intessiamo relazioni con altre imprese. Personalmente mi sento vicino a Marco Polo, capace di estrarre valore intellettuale dai suoi pellegrinaggi commerciali. Era un pioniere dell’antropologia sociale, dell’etnografia di incontri che Marc Augé (un altro mediterraneo) ha formalizzato come disciplina. Ed era, Marco Polo, un mediterraneo, un uomo della costa adriatica, abituato a guarda a sud-est, come tutti noi che qui nasciamo e che qui abbiamo deciso di fermarci o di tornare: di vivere. Se penso ai miei soci, invece, alcuni definiscono le cose come fece Braudel proprio con il Mediterraneo. Altri, donne soprattutto, si accaniscono nella lotta intellettuale alla mafia, come solo noi mediterranei, che le mafie le abbiamo partorite, sappiamo fare: come Peppino Impastato, come Pippo Fava, come Giancarlo Siani. Ecco, in sintesi, cosa mi fa dire di appartenere totalmente al solo mare che unisce e divide sempre chi lo abita da chi lo attraversa.












