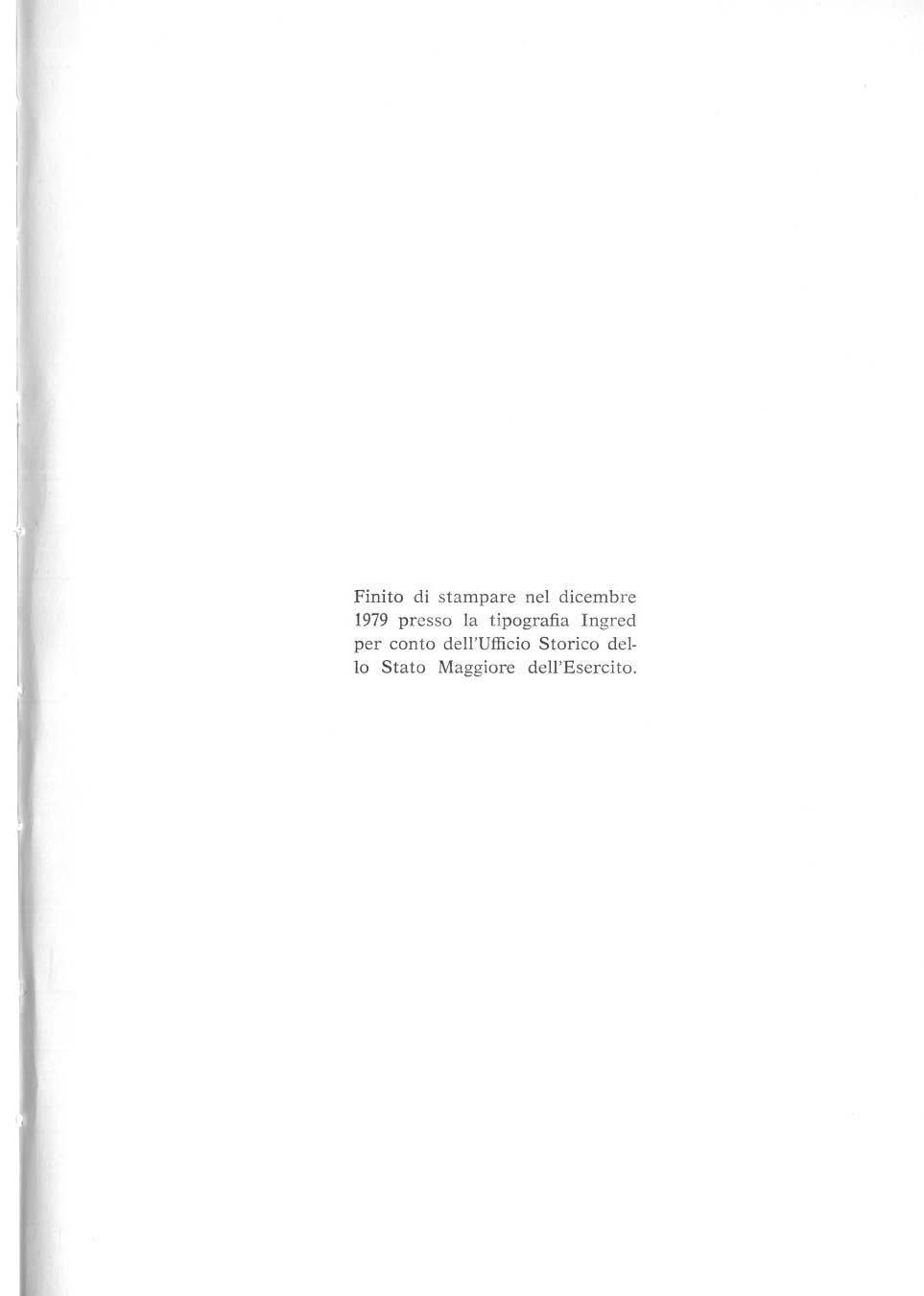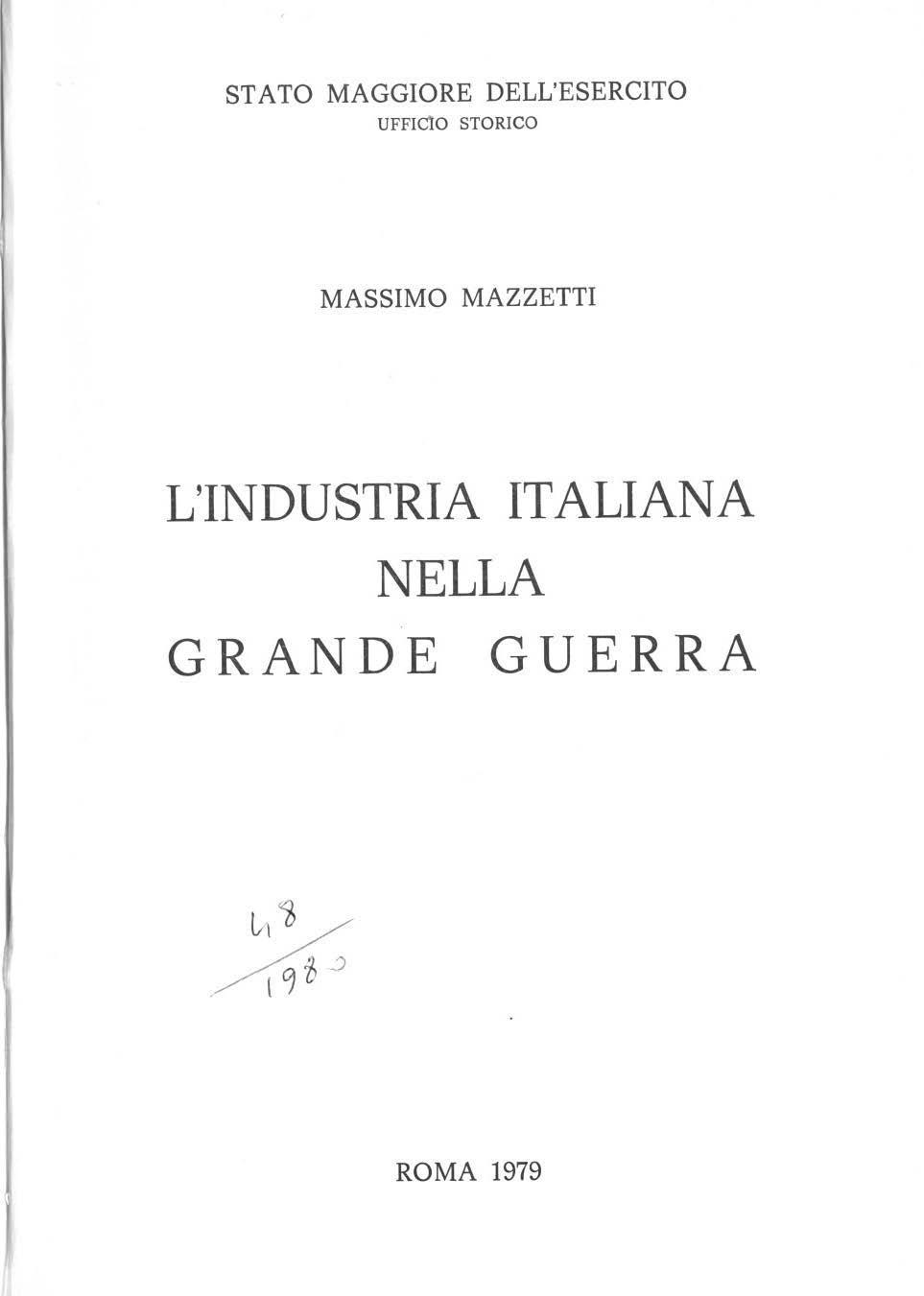

Il primo confl.itto mondiale mani/estò presto il suo vero volto di guerra di logoramento e quindi di materiali.
L'Italia dovette affrontare le nuove esigenze quasi all'improvviso, come del resto gli altri belligeranti, senza però disporre di un'industria pesante dalle strutture consolidate da tempo.
Ciononostante, negli anni di guerra, il nost ro Paese riuscì a produrre 2,5 milioni di fucili, 37.000 mitragliatrici, 16.000 pezzi d'artiglieria, 40.000 autocarri, 12.000 aerei, 12.000 carri ferroviari, 160.000 tonnellate di naviglio.
Lo sforzo gigamesco per reali zzare la mobilitazione industriale, l'approvvigionamento delle materie prime, la necessaria struttura di pianificazione economica e di controllo, fu effettuato con il contributo determinante dell'Esercito, basti pensare all'infaticabile opera organizzatrice del Gen. Alfredo Dallolio.
L'Ufficio Storico è pertanto lieto di pubblicare il presente volume quale documentato contributo ad un esame più amplio ed approfondito della prima guerra mondiale anche sotto l'aspetto produttivo.
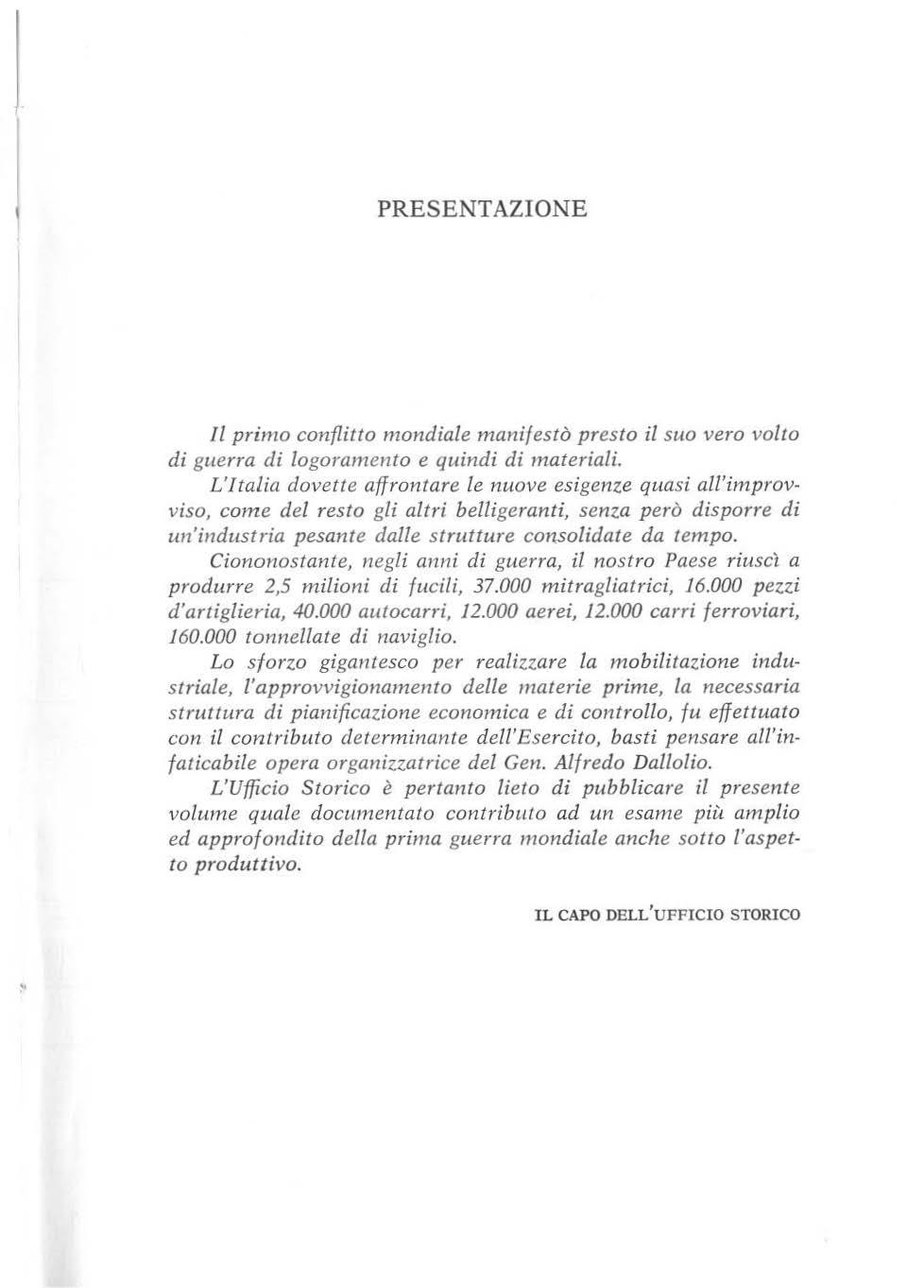 IL CAPO DELL'UFFICIO STORICO
IL CAPO DELL'UFFICIO STORICO

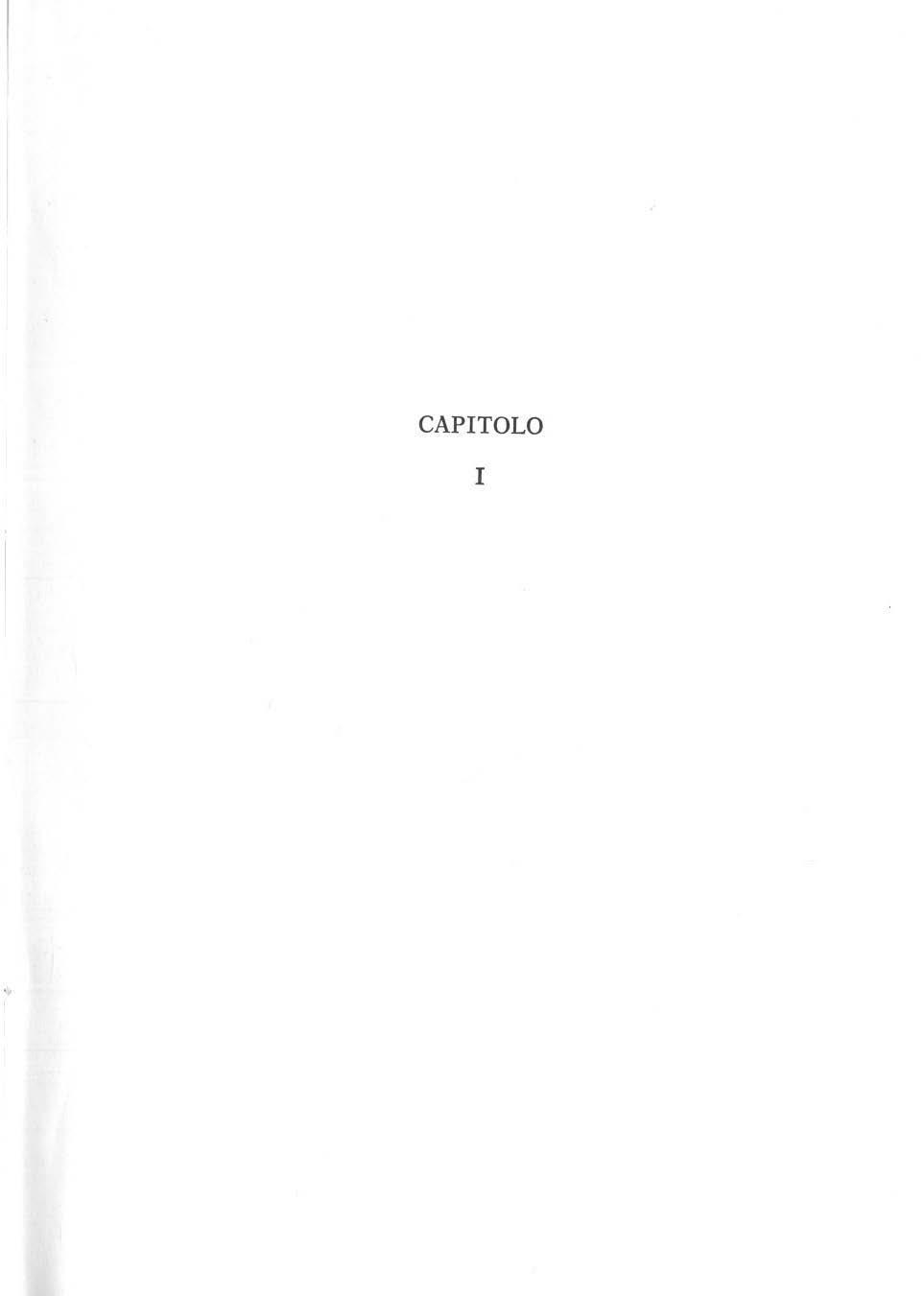

All'inizio del XX secolo la produzione dei materiali bellici per le forze armate avveniva in Italia in modo singolarissimo. Mentre i materiali d'armamento necessari all'esercito erano prodotti quasi esclusivamente da stabilimenti militari, la marina ricorreva in larga misura a ditte private. Le ragioni di questa diversità di orientamenli vanno ricercate in una pluralità di circostanze. Per quanto atteneva gli armamenti navali una potente spinta all'utilizzazione dell'industria privata derivò senza dubbio dalla rapidità con cui i cantieri privati approntavano il naviglio, mentre negli arsenali di Stato le unità rischiavano di invecchiare prima ancora che si potesse vararle ( cosa che talvolta ebbe a verificarsi). D'altra parte fornire commesse all'industria cantieristica italiana costitutiva, agli occhi dei governanti, un mezzo per sostenere un seltore di grande importanza per l'intera economia del Paese. Diversa era la situazione degli armamenti terrestri che, in primo luoiz;o, non avevano subito il rapidissimo sviluppo tecnico che aveva caratterizzato le costruzioni militari marittime nella seconda metà dell'ot tocento, e, secondariamente, erano molto meno complessi. A quell'epoca « sconosciuti erano infatti i mezzi chimici, ancora nell'infanzia i mezzi aerei; la fanteria aveva come arma principale il fucile; la massa dell'artiglieria era costituita da cannoni da campagna di calibro unico; la quasi totalità dei trasporti per via ordinaria era a trazione animale; i mezzi per le trasmissioni erano limitati quasi esclusivamente al telegrafo» (1). Del semplice armamento base non era peraltro indispensabile produrre grandi quantità in breve tempo; si poteva, poco per volta, costituirne convenienti scorte. Si contava, infatti, di combattere un even luale conflitto in gran parte attingendo alle riserve preparate fin dal tempo di pace. In quel periodo infatti « lo spettro di una guerra di lunga durata sembrava oramai dileguato dopo i magnifici esempi delle campagne prussiane del 1866 e del 1870, e, pur avvertendosi una tendenza marcata di tutte le nazioni verso un aumento considerevole degli eserciti in armi, non si riteneva che

la entità delle masse messe in campo avrebbe potuto, in una eventuale guerra europea, costituire ostacolo ad una rapida e pronta decisione del conflitto. Perciò, pur non disconoscendo le difficoltà di alimentare e rifornire una massa così ingente di uomini, si presupponeva che la brevità di durata delle operazioni avrebbe potentemente contribuito ad alleviarle » (2).
I n base a queste considerazioni era pressocché opinione generale che, in caso di guerra, i rifornimenti « sarebbero stati favoriti dalla semplicità d'armamento, mentre la loro entità sarebbe stata automaticamente limitata dal carattere di movimento, che la guerra avrebbe assunto. Le vere preoccupazioni si concentravano su quelli che erano ancora i rifornimenti tradizionali degli eserciti in campo, e cioè su quelli che si rivolgevano alla soddisfazione dei bisogni materiali del soldato (essenzialmente viveri) » (3) .
Per tutte queste ragioni in Italia si era preferito contare per l'armamento dell'esercito sull'opera degli stabilimenti militari invece di promuovere ex novo la costituzione di un'industria privata degli armamenti terrestri. Tuttavia, già nel 1906, in occasione dell'adozione del nuovo pezzo da campagna a deformazione, la constatata insufficienza degli stabilimenti militari italiani fece sì che buona parte della lavorazione del nuovo materiale fosse attuata presso la ditta ideatrice del cannone, la tedesca Krupp. Frattanto, stimolate dalla corsa agli armamenti e da alcuni successi nella vendita di naviglio militare a nazioni estere, le industrie italiane specializzate nella produzione di artiglierie navali ampliarono i propri impianti. Ciò rese possibile, nel 1911, in occasione di un ulteriore rinnovo del materiale da campagna con l'introduzione del cannone da 75/27 Déport, la costituzione di un consorzio per la produzione dei nuovi pezzi. Il consorzio raggruppava, per la costruzione dei vari materiali (dai pezzi veri e propri al munizionamento), 27 tra le maggiori imprese italiane metalmeccaniche. Si trattava della prima grossa commessa di materiale bellico a favore dell'esercito ed è comprensibile quindi che non tutto filasse liscio e che i materiali finissero per essere consegnati con un certo ritardo. Nonostante tutto ciò, però, l'esperienza di questo consorzio doveva dimostrarsi utile negli anni seguenti. I nfatti, con la guerra italo-turca, iniziava un periodo di tensioni internazionali, che si sarebbe concluso con lo scoppio della guerra mondiale. Nel corso dell'impresa libica, esattamente il 18 gennaio 1912, era stata istituita una « Commissione consultiva per gli approvvigionamenti dello Stato » allo scopo di coordinare le richieste dei singoli ministeri ed in qualche modo

programmare lo sforzo industriale necessario per fronteggiarle. La Commissione non riuscì, però, per vari motivi, a svolgere praticamente i compiti che le erano stati demandati, l'iniziativa fu quindi lasciata alle singole amministrazioni. Per quanto atteneva agli armamenti alJo scoppio della grande guerra, dopo la dichiarazione di neutralità dell'Italia nell'agosto del 1914, le ipotesi di un intervento a fianco della Triplice Alleanza persero consistenza; conseguentemente i problemi navali passarono in seconda linea (l'Intesa disponeva già del dominio del mare) mentre acquistò grande importanza la preparazione dell'esercito. Perciò fu praticamente la « Direzione Generale di Artiglieria e Genio» presso il Ministero della guerra, che si interessò principalmente dell'apprestamento dei materiali bellici. Fortunatamente per il Paese a capo di quest'ente era un ufficiale di eccezionali capacità, che avrà un ruolo di grandissima importanza nella conduzione dello sforzo industriale dell'Italia in guerra : il generale Alfredo Dallolio. La preparazione bellica italiana si svolse tra non lievi difficoltà di ordine finanziario: infatti nei primi giorni dell'agosto 1914, Da1lolio e il generale Tettoni (direttore generale dei Servizi Logistici) si recarono, per ordine del Ministro della guerra Grandi, dal Ministro del tesoro Rubini per esporgli le necessità dell'esercito; ottennero una risposta sostanzialmente negativa alle loro richieste, a causa della grave situazione finanziaria del Paese ( 4 ). In effetti a tutto il 13 ottobre 1914 le somme assegnate a carico del capitolo « spese per la guerra » per i « servizi di artiglieria » ammontavano a 54.000.000.000 di lire. Dopo la sostituzione di Grandi con il generale Zuppelli la situazione migliorò, ma di poco, visto che fra il 17 e il 27 ottobre Dallolio dové ridurre le sue richieste da 277.424.000 lire a 90 milioni (5). In effetti a tutto il 25 maggio 1915 furono stanziate per l'armamento dell'esercito 273.883.450 lire ( 6 ) e tutto ciò mentre le potenze con cui ci si intendeva misurare stavano spendendo miliardi in armamenti. Per valutare la comprensione con cui la burocrazia dei ministeri finanziari seguiva la preparazione militare italiana basterà rilevare come, ancora il 5 aprile 1915 , la Giunta del Bilancio chiedeva al Ministero della guerra se non fosse possibile realizzare qualche economia, sulle cifre precedentemente stanziate, in cons iderazione degli ingenti stanziamenti straordinari degli ultimi mesi! (7)
In questa situazione è comprensibile come i margini di manovra del Dallolio, in teoria amplissimi ( 8 ), fossero in pratica molto modesti. La non facile condizione in cui si trovava a dover operare il direttore dei servizi di artiglieria non fu, almeno al momento, compresa dal generale Cadorna il quale già 1'8 dicembre

1914, con lettera numero 3675, sollecitava il Ministero della guerra a ricorrere all'industria privata per accrescere la produzione bellica ( 9 ). Qualche tempo dopo il Capo di Stato Maggiore riprese questo problema in due lettere, rispettivamente del 23 e del 26 febbraio 1915, nell'ultima delle quali suggeriva di attuare una vera e propria mobilitazione industriale (1°).
Il 28 di quello stesso mese, in un lungo promemoria al Ministro (preparato probabilmente in previsione dell'incontro che Zuppelli ebbe quello stesso giorno con Cadorna) il Dallolio, dopo aver sottolineato come le dotazioni stabilite fossero state notevolmente ampliate, richiamò l'attenzione del Ministro sul problema finanziario per poi illustrare quanto era stato fatto per potenziare l'opera degli stabilimenti militari e per assicurarsi la collaborazione dell'industria privata in caso di mobilitazione. Dopo di ciò il documento affronta il problema vitale delle materie prime sottolineando le particolari caratteristiche dell'industria italiana: « Disgraziatamente in Italia la preparazione industriale tecnica non è all'altezza delle grandi industrie d'Oltr'Alpe meravigliosamente organizzate , possenti, esiste invece un'industria metallurgica fittizia, giacché mancano le relative materie prime. Vivono è vero alcune industrie meccaniche perché hanno per principale cliente lo Stato, ma appena mancano il carbone , il rame, il nikel, l'antimonio, il nitrato, il ferro manganese, il cromo etc. tutto s'arresta per fare delle dolorose constatazioni » ( 11 ). Alla luce di queste considerazioni il Dallolio aveva provveduto a rifornire di materie prime gli stabilimenti militari ponendoli in condizioni di lavorare per tutto il 1915 senza dover ricorrer.e alle« scorte intangibili ». Quanto alle imprese private l'azione della c, Direzione d'Artiglieria e Genio » si era per lo più limitata a delle intese in vista di un'eventuale mobilitazione. Riguardo a questa eventualità il Dallolio sottolinea due esigenze : quella di garantirsi la quasi totalità della produzione di acciaio nazionale e quella di lasciare, in caso di guerra, gli operai specializzati agli stabilimenti impegnati nella produzione b e llica Nel complesso l'azione del capo della « Direzione di Artiglieria e Genio » era conforme alle esigenze del momento, tenuto conto delle limitate disponibilità finanziarie. Tale sostanzialmente dové essere anche il parere del generale Cadorna che scrivendo il 4 marzo lodava « l'oculata previdenza e la solerte attività» dimostrata dal Ministero nell'approntamento dei materiali. Il Capo di Stato Maggiore richiamava però l'attenzione del Ministro sulla necessità di approntare convenienti scorte in previsione di una campagna di « lunga durata» (1 2 ). A proposito di questa lettera, in un appunto del 15 mar-

zo per il Ministro, il Dallolio, dopo essersi richiamato a quanto già aveva esposto nella relazione del 28 febbraio, poneva nuovamente il problema del personale, concludendo: « Ma per non sbagliare la soluzione occorre accordare tutti i mezzi, per non trovarsi neUe condizioni di varare le macchine e non avere le intelligenze che devono guidarle » (13 ). Il problema del personale specializzato era indubbiamente vitale e le pressioni del Dallolio non rimasero senza esito. I nfatti, come ricorda il Franchini: « La Direzione generale di Artiglieria e Genio assunse l'iniziativa della risoluzione; mentre le altre Direzioni Generali della guerra, il Comando del Corpo di Stato Maggiore ed il Ministero della marina, si associarono, la Direzione Generale leva e truppa annuì, intravedendo peraltro nella concessione di uomini per gli stabilimenti, soltanto una pericolosa sottrazione di combattenti. Venne nominata all'uopo una Commissione per studiare il problema ed essa, tra opposizioni e difficoltà, riuscì a concretare il provvedimento disciplinante l'istituto delle "esonerazioni temporanee" (R.D. 29/4/1915 n. 561) dal servizio effettivo sotto le armi, dei militari richiamati, col quale si ]asciavano gli operai specializzati agli stabilimenti privati che provvedevano materiali o lavoro per l'Esercito o l'Armata. Si rivolse subito dopo il lavoro alla compilazione del Regolamento di applicazione d el sopracitato decreto, e, con circolare del 2 maggio 1915, furono diramati gli ordini ai Comandi di Corpo d'armata» (1 4 ). •
Con queste disposizioni si stabiliva un complesso sistema che prevedeva, per alcune categorie, la « dispensa » dal richiamo alle armi, per altre « l'esonero temporaneo».
La « dispensa» era già prevista dalle leggi sul reclutamento per la marina (R.D. 16/12/1888 n. 5860) e per l'esercito (R.D. 24/12/1911 n. 1497). Le disposizioni in proposito furono precisate ed ampliate (1 5 ) cosicché allo scoppio della guerra mondiale la « dispensa» si applicava alle seguenti categorie:

a) membri di altri Corpi armati dello Stato;
b) addetti agli uffici e agli stabilimenti militari;
c) dipendenti delle ferrovie , delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
d) impiegati dei Ministeri, delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle Assemblee legislative e professionisti di interesse pubblico (notai, m inistri del culto, etc.);
e) personale della Croce Rossa e di altri enti sanitari;
f) equipaggi di navi mercantili al servizio dello Stato.
Per alcune di queste categorie di persone l'esenzione non era peraltro automatica, cioè doveva essere dimostrato che la lo-
ro opera era necessaria al proseguimento del servizio. In origine la « dispensa » veniva concessa anche a « personale di imprese e stabilimenti di proprietà privata che interessano l'esercito e l'armata»; con l'entrata in vigore delle disposizioni relative agli esoneri temporanei questa parte fu soppressa. Ciò non deve sorprendere poiché il provvedimento era in relazione con le carattenstiche proprie delle due figure giuridiche; infatti la «dispensa» aveva caratteristica di stabilità ed offriva scarse possibilità di controllo una volta effettuata la concessione (16 ). Il nuovo istituto dell'esonero temporaneo, invece, proprio per la sua caratteristica di provvisorietà, permetteva alle autorità militari un maggior controllo e la possibilità di effettuare i richiami una volta che fossero venute meno le ragioni che avevano giustificato l'esonero.
Da questa caratteristica di maggiore elasticità della nuova figura giuridica, oltre che dall'imperioso sviluppo delle necessità economiche del Paese sottoposto all'enorme sforzo della guerra, conseguì che, mentre le « dispense», dopo quelle effettuate all'atto della mobilitazione, non furono molto numerose, gli « esoneri temporanei » ebbero un grande ed imprevisto sviluppo. Le « esonerazioni tempor anee» erano concesse, in un primo tempo, in base all'art. 3 del R.D. 29/4/1915 n. 561, solamente da commissioni locali che, all'atto della mobilitazione, data la loro recentissima costituzione, non poterono efficacemente entrare in funzione. D'altronde, non era stata ancora definita l'organizzazione che avrebbe diretto lo sforzo industriale del P aese in guerra. Infatti, soltanto con il R.D. 26/6/1915 n. 992, veniva concessa facoltà al Governo di « imporre e fare eseguire le opere occorrenti per aumentare la potenzialità di quegli stabilimenti dell'industria privata la cui produzione fosse, in tutto o in parte, ritenuta necessaria per gli acquisti e i rifornimenti riguardanti le Amministrazioni della Guerra e della Marina» (art. 2). Inoltre veniva concessa facoltà di « dichiarare soggetto alla giurisdizione militare, in tutto o in parte, il personale degli stabilimenti che producono materiali per l'Esercito e per l'Armata, ogni qualvolta ciò occorra per assicurare la continuità e lo sviluppo della produzione richiesta dalle esigenze della guerra» (art. 8) I due decreti, 29/4 e 26/6/1915, costituirono la base di quella che verrà poi chiamata « Mobilitazione Industriale», i cui organi direttivi ebbero una prima sistemazione con il R.D. 9/7/1915 n. 1065 che istituiva il« Comitato Supremo per i rifornimenti delle armi e delle munizioni » ed il « Sottosegretariato per le armi e le munizioni » presso il Ministero della guerra. Venivano messe alle dipendenze del Sottose-

gretariato la « Direzione Generale di Artiglieria e Genio » e l' « Ispettorato generale delle costruzioni di Artiglieria » dell'esercito, ma non la« Direzione Generale d'Artiglieria e d'Armamento» del Ministero della marina. Con ciò si creava una situazione anomala secondo la quale il Sottosegretariato doveva provvedere ai bisogni della Marina senza avere la possibilità di un controllo tecnico dell'ente incaricato di fissarli, il che provocherà in seguito non pochi attriti.

Il gen. Dallolio veniva nominato il 9 luglio Sottosegretario per le armi e le munizioni. Il nuovo Sottosegretario non perse tempo: già il primo agosto aveva approntato un promemoria dal titolo « Organizzazione industriale per risolvere il problema del munizionamento» ( 17 ) che costituì lo schema base della Mobilitazione Industriale che fu sancita da li a poco con la pubblicazione del decreto luogotenenziale del 22/8/1915 n. 1277 che approvava il regolamento. In base a questo furono costituiti il Comitato Centrale di Mobilitazione industriale che iniziò a funzionare il 12 settembre di quell'anno ( 18 ), e sette comitati regionali (attivati tra settembre ed ottobre) (19 ). La caratteristica più notevolte di questi ultimi era data dal fatto che erano composti, oltre che da funzionari cd esperti, anche da rappresentanti degli industriali e degli operai, anche se con voto soltanto consultivo. Ai comitati regionali erano demandate funzioni di consulenza e controllo riguardo al personale degli stabilimenti «ausiliari», nonché giurisdizionali nei conflitti di lavoro del personale degli stessi stabilimenti. Le caratteristiche degli stabilimenti « ausiliari » fu. rono così efficacemente descritte dall'Einaudi: « Se il Ministro della guerra, persuaso che uno stabilimento privato o un suo reparto era atto, per i suoi impianti e macchinari, a produrre materiale necessario per i rifornimenti bellici, lo dichiarava « ausiliare »; tutto il personale, dai gestori ai proprietari, ai dirigenti, agli impiegati amministrativi e contabili, ai capi tecnici e agli operai, passava sotto la giurisdizione militare » ( 20 ). Lo stabilimento dichiarato « ausiliare » veniva posto sotto il controllo delle autorità militari e del comitato regionale territorialmente competente, mentre il personale godeva dell'esonero. Per la ripartizione delle commesse le ditte fecero capo a vari enti capigruppo militari o civili che tenevano continuamente al corrente il Sottosegretariato delle lavorazioni in corso (21 ).
Nonostante la grande solerzia del Dallolio il meccanismo della « Mobilitazione Industriale » stentò a mettersi in moto. Ciò è da imputarsi ad una lunga serie di motivi: in primo luogo le disponibilità finanziarie che, nonostante la dichiarazione di guerra, re-
starono alquanto modeste, costringendo talvolta il Sottosegretariato ad assumere impegni non ancora coperti da opportuni stanziamenti ( 22 ). La modesta disponibilità dei mezzi finanziari non poteva non influire negativamente sugli orientamenti degli industriali, in genere alquanto prevenuti contro il regime di imperio creato dalla guerra ed orientati ad ottenere consistenti commesse prima di operare le trasformazioni necessarie perché i loro stabilimenti potessero intraprendere le nuove lavorazioni. Vi erano, è vero, delle eccezioni, come quella di Perrone, proprietario dell'Ansaldo: questi non solo soddisfece tutte le richieste rivoltegli, ma si agitava continuamente per proporre nuove soluzioni e fare accettare nuovi materiali ( 23 ), non esitando a questo scopo a ricorrere a tutti i mezzi ( 24 ). Questi sistemi non potevano non allarmare Dallolio che in una lettera al Comando Supremo, il 3 agosto 1915, sosteneva che il tentativo del Perrone {< di volersi creare una situazione privilegiata tipo Krupp, Schneider, Skoda non è da approvarsi, tanto più conoscendo i metodi per i quali ha inclinazione » ( 25).
Tuttavia l'attivismo del proprietario dell'Ansaldo o il diuturno lavoro degli stabilimenti militari non era certo in grado di riparare alle carenze dell'industria, assolutamente impreparata ad affrontare i problemi connessi con la produzione bellica. In effetti, era impossibile improvvisare una grande industria degli armamenti, non soltanto per le peculiari caratteristiche degli impianti, ma anche e soprattutto per le specifiche competenze tecniche del personale. Fu quindi indispensabile che dirigenti e maestranze si misurassero con i problemi peculiari delle nuove lavorazioni compiendo anch'essi il loro « apprendistato di guerra», meno crudele certo di quello dei combattenti che sperimentavano sulla propria pelle sistemi di lotta non prima conosciuti, ma non per questo meno impegnativo.
Che gli aspetti organizzativi e tecnici avessero un'importanza capitale è dimostrato proprio dai dati sulle fabbricazioni di guerra durante il primo anno del conflitto. In effetti l'unica produzione di armi di un qualche rilievo fu quella dei pezzi da campagna, che si poté giovare della precedente esperienza fatta dal Consorzio per il 75/27 modello 11.
Tra il 24 maggio 1915 ed il 30 giugno 1916 furono infatti prodotti ben 1567 cannoni, nello stesso periodo furono inviati al fronte 1233 pezzi di medio calibro dei quali però la maggior parte, 850, era costituita da vecchi cannoni tolti alle fortezze per cui i pezzi nuovi furono solo 383;per i maggiori calibri le nuove armi furono 53; in quanto alle artiglierie pesanti campali la loro

produzione fu di 164 bocche da fuoco, ma anche qui si trattava in gran parte di mezzi di ripiego: i pezzi da 102 della Marina trasformati ingegnosamente dall'Ansaldo in autocannoni (26 ). Anche la produzione di proiettili fu modesta: 4.458.598 colpi completi nel 1915, meno di un quarto di quanto verrà prodotto l'anno seguente ( 27 ). Solo nel 1916 lo sforzo bellico del Paese raggiunse un livello, per qualificazione del personale e per ampiezza e continuità dei lavori, tale da permettere una prima organica stesura di un programma di armamento. Questo piano veniva definito di intesa tra il Sottosegretariato armi e munizioni ed il Comando Supremo, cercando di contemperare le esigenze belliche con la potenzialità degli impianti e le disponibilità di materie prime; da ciò derivò necessariamente che i programmi furono modificati col mutarsi delle situazioni. Ecco infatti un quadro riassuntivo dei piani relativi alla costruzione delle artiglierie, definiti durante tutto l'arco della guerra:
Tabella 1
Questi dati forniscono un quadro orientativo dell'evolversi dell'armamento italiano durante la guerra a seconda delle particolari esigenze del momento; essi testimoniano anche il progressivo potenziamento dell'industria bellica italiana, sebbene le cifre indicate nei programmi non corrispondono sempre ai materiali effettivamente ultimati (per esempio i pezzi prodotti tra il 1° lu!!lio 1916 ed il 30 giugno 1917 furono 3662 e non 4660 come nel programma n. 4) ( 29 ). L'aumentata produzione fu anche conseguenza dell'aumento delle disponibilità .finanziarie che raggiunsero in breve cifre notevoli. Ecco i dati delle spese di guerra in milioni di lire per i servizi del settore degli armamenti :

Alla fìne del 1916 la prima grande prova che ia guerra aveva imposto alle strutture finanziarie ed economiche italiane era stata superata: si era creata quasi dal nulla una potente organizzazione i ndustriale che era riuscita a far fronte alle enormi richieste dell'esercito. Appena ottenuto questo risultato si profilava però un'altra prova ancora più impegnativa, causata dalla modestia delle risorse nazionali in quanto a materie prime e dalla guerra sottomarina illimitata che falcidiava grandemente le importazioni. Questa situazione portò ad un maggior intervento dello Stato nell'economia. Dapprima, nel tentativo di far fronte alla crisi delle fonti energetiche, fu costituito, nel gennaio 1917, il Comitato per i combustibili nazionali a cui si aggiunse nel febbraio di quello stesso anno il Commissariato generale per l'approvvigionamento e la distribuzione dei carboni, che aveva il compito di importare e ripartire la principale fonte di energia dell'epoca. Poiché la crisi dei trasporti marittimi causava gravissimi problemi alimentari (si pensi che la principale voce delle importazioni italiane era appunto costituita dal grano) si provvide a costituire, nel giugno 1917, il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari con il compito di organizzare e gestire il reperimento e la distribuzione dei viveri . Contemporaneamente si ampliavano i provvedimenti miranti ad intensificare la produzione agricola con una serie di decreti relativi al credito agrario, alla coltivazione delle terre abbandonate, al controllo sulla produzione ed il commercio dei concimi. Successivamente, il 14 febbraio 1918, si provvide a dar vita all'organizzazione della « Mobilitazione agraria» affermando così l'intervento diretto dello Stato anche nella produzione agricola. Si affiancarono quindi alla « Mobilitazione Industriale » tutta una serie di strutture create per far fronte non solo ai bisogni dell'eser cito, ma per soddisfare anche le esigenze della popolazione civile in

un momento in cui, per molteplici cause, le materie prime ed alcuni prodotti fondamentali si andavano rarefacendo.
Frattanto la struttura della « Mobilitazione I ndustriale» veniva ampliata e precisata con tutta una serie di Decreti Luogotenenziali ( 12 ottobre 1916 n. 1747, 15 marzo 19 17 n. 570, 5 luglio 191 7 n. 1093 e 9 settembre 1917 n. 1512) . I n base a questi provvedimenti i comitati regionali furono portati a undici con sede rispettivamente a Torino per il Piemonte; a Milano per la Lombardia; a Genova per la Liguria; a Venezia per il Veneto; a Bologna per l'Emilia; a Firenze per la Toscana; a Roma per Lazio, Marche, Abruzzo ed Umbria; a Napoli per Campania, Calabria ed il circondario di Lagonegro; a Bari per Puglie e Basilicata escluso il circondario di Lagonegro; a Palermo per la Sicilia; a Cagliari per la Sardegna. Erano anche ampliate le rappresentanze dei tecnici, degli operai e degli industriali nei singoli comitati e, col decreto del 5 luglio 1917, veniva loro delegata inoltre la sorveglianza disciplinare degli stabilimenti. Contemporaneamente alla ristrutturazione e all'ampliamento dei comitati regionali anche il Comitato Centrale venne allargato. Queste trasformazioni vennero favorite dal fatto che, col Regio Decreto 16 giugno 1917 n. 980, fu istituito il Ministero per le armi e le munizioni a cui passarono tutte le attribuzioni del precedente Sottosegretariato. Il nuovo ente fu diretto dal gen. Dallolio che ebbe per sottosegretari dapprima il generale Vittorio Alfieri (fino al 9 ottobre 1917) e successivamente l'on. Paolo Bignami.

Il Ministero si articolava in quattro settori: Servizi generali, Servizi di mobilitazione industriale, Servizio tecnico armi e munizioni, Servizio amministrativo, e tre direzioni generali: di Artiglieria, del Genio e di Aeronautica, impiegando il seguente personale:
La creazione di quest'organismo, decisamente imponente in un'epoca in cui l'organizzazione dello Stato non era ancora vitti-
ma dell'elefantiasi burocratica, era conseguenza del fatto che una parte estremamente rilevante dell'industria italiana era stata via via impegnata nello sforzo bellico e, anche se non produceva direttamente anni, era posta sotto il controllo dell'organizzazione creata dal generale Dallolio. I nfatti gli stabilimenti ausiliari, che alla fine del 1915 erano solamente 221, divennero 797 al 30 giugno del 1916, 998 il 31 dicembre di quello stesso anno, 1463 il 30 gmgno successivo, 1708 alla fine del 1917 e, al termine del conflitto, erano divenuti 1976.

Oltre a queste imprese esisteva una miriade di stabilimenti minori, troppo piccoli per essere dichiarati ausiliari, « nella quasi totalità impegnati nella produzione di proiettili di piccolo e medio calibro», come ebbe a dichiarare il generale Dallolio nel corso di una seduta del Conùtato Centrale della M.I.. Dai dati raccolti risulta che il numero di questi stabilimenti oscillò nel corso della guerra tra le 1.000 e le 1.200 unità ( 32 ). Anche queste industrie minori riuscirono, almeno in parte, ad ottenere il particolare regime di favore concesso alle imprese «ausiliari», compreso l'esonero di parte del personale. Gli stabilimenti dichiarati « ausiliari » si ripartivano tra i vari settori industriali nelle seguenti proporzioni:
Per quanto riguarda la situazione alla fine del conflitto, un'altra fonte riferisce i seguenti dati circa gli stabilimenti ausiliari alla data del 31 dicembre 1918: industrie estrattive del sottosuolo (comprendenti miniere e cave di ogni genere): 292; imprese di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura,
prendenti industrie del legno, dei cereali, imprese conserviere, industrie delle spoglie animali e della carta): 228; industrie metallurgiche e siderurgiche: 204; industrie delle costruzioni metalliche e meccaniche: 558; industrie della lavorazione dei mine-rali non metallici e dell'edilizia (comprendenti fra l'altro le raffinerie di zolfo e petrolio): 126; industrie della lavorazione ed utilizzazione delle fibre tessili: 75; industrie chimiche ed elettrochimiche ( comprendenti anche le imprese che fabbricavano gli esplosivi): 442; industrie e servizi di bisogno collettivo (imprese di trasporti, telefoni, telegrafi., cavi, consorzi idrovori, centrali elettriche): 135 ( 34 ). I dati relativi al numero degli stabilimenti industriali dichiarati ausiliari non si riferivano ovviamente solo a stabilimenti già esistenti, ma anche ad imprese nuove sorte nei settori più produttivi nel corso del conflitto; la loro ripartizione comunque testimonia una concentrazione industriale già preesistente alla guerra e che le necessità belliche accentuavano inevitabilmente.
Sembrerebbe, in base ad un'osservazione sommaria dei dati, che la situazione delle altre regioni italiane, rispetto a quelle del triangolo industriale, sia migliorata nel corso della guerra; in realtà questo apparente miglioramento è dovuto alla progressiva estensione dell'ausiliarietà a nuovi tipi di imprese. Caratteristico è il caso della Sicilia, passata, fra il finire del 1916 e gli inizi del 1917, da 24 a ben 135 industrie mobilitate per l'estensione del regime di ausiliarietà alle miniere. È da tener presente, anche a questo proposito, che su 292 industrie estrattive esistenti alla fine della guerra, solo 53 erano in Lombardia, Piemonte e Liguria, mentre in queste tre regioni vi erano 170 stabilimenti siderurgici su 204 e 409 imprese meccaniche su 558. In quanto alla capacità di espansione, i dati più significativi sono senza dubbio

offerti dalla comparazione dei dati del 1917, quando l'ausiliarietà era praticamente estesa a tutti i tipi di industria, con quelli del 1918. Ebbene, delle 454 industrie dichiarate ausiliarie in questo periodo ( si tratta in grandissima parte o di nuovi stabilimenti o di imprese la cui importanza era molto aumentata nel corso del conflitto) ben 238 erano all'interno del triangolo industriale.

Questi dati si riferiscono al solo numero delle imprese; per quanto riguardava la « qualità » della concentrazione industriale, bisogna considerare che « in Piemonte 203 società ( su 244) denunciavano nel periodo bellico, utili di 61.634.000 lire, su un capitale nominale di 445.800.000 lire; in Lombardia 596 società (su 783) su 1.845.100.000 lire di capitale nominale rivelano utili netti di 148.622.000 lire; in Liguria 183 società {su 226) con un capitale di 662.700.000 lire accusavano 78.365.000 lire di utili netti » ( 36 )
La concentrazione reale di investimenti e di profitti doveva essere ancora maggiore, visto che lo Stato riscuoteva il 60% delle imposte, sui sovrapprofitti di guerra, nelle sole tre provincie di Genova, Milano e Torino. Questa concentrazione imponente per numero e per dimensioni delle iniziative industriali in Piemonte, Liguria e Lombardia, poneva anche gravi ed impellenti problemi per quanto riguardava la disponibilità della mano d'opera. Come si ricorderà, il problema del personale era stato risolto prima con l'introduzione della dispensa e successivamente con la creazione dell'<< esonero»; le due figure giuridiche differivano tra loro sostanzialmente per il carattere di maggiore stabilità della prima. In base a ciò, le autorità militari riservavano la dispensa alle persone che avevano uno stabile rapporto con lo Stato o con enti pubblici ( operai degli stabilimenti militari, ferrovieri, dipendenti degli enti locali etc.) mentre concedevano l'esonero a quelle persone la cui collaborazione avrebbe potuto anche, ad un dato momento, non rendersi più necessaria al fronte interno divenendo quindi disponibili per essere inviate nella zona di combattimento. Inoltre la stessa provvisorietà dell'esonero costituiva un potente strumento per garantire la collaborazione allo sforzo bellico d egli operai.
Nonostante questo carattere e nonostante il fatto che nell'ultimo anno di guerra si verificasse una contrazione della produzione globale e un rallentamento nella fabbricazione di alcuni prodotti a vantaggio di altri, il numero delle esenzioni invece di contrarsi andò aumentando; ciò dipese da una molteplice serie di fattori quali il forte incremento dell'esonero concesso per i bisogni dell'agricoltura, la difficoltà di trasferire da uno stabilimento all'altro, e soprattutto da un luogo all'altro, gli operai eso-
nerati, la necessità, nonostante la saltuarietà degli arrivi delle materie prime, di mano d'opera sufficiente a poter riprendere a pieno ritmo la produzione. Frattanto, nel corso del conflitto, si era palesata la necessità, in conseguenza dello sviluppo dei settori industriali connessi con la produzione di guerra, « di ricercare altre maestranze già pratiche, le quali occorrevano per accrescere numericamente la mano d'opera bellica. Per sopperire a questa deficienza di mano d'opera, si provvide subito a ricercare ovunque operai borghesi a mezzo degli uffici del lavoro e degli enti interessati al collocamento della mano d'opera» ( 37 ). Non essendo sufficienti gli operai così reclutati, « sorse la necessità di ricercare presso i corpi e i reparti militari individui che, nella loro vita civile, avessero esercitato determinati mestieri di operaio, ma che non erano stati ammessi all'esonerazione, alcuni perché non conosciuti dagli industriali, altri perché, appartenendo a classi di leva, non si trovavano nelle condizioni volute per ottenere l'esonero» (38 ). Nacquero così i reparti dei militari-operai; « essi, quantunque assegnati agli stabilimenti, dovevano vestire la divisa e dormire in caserma; erano sottoposti a tutti i doveri dei militari in servizio presso i corpi, poiché erano considerati, a simiglianza dei militari di truppa addetti agli stabilimenti militari, quali militari "comandati". Si chiamarono perciò "militari-operai comandati" » ( 39 ). Con lo svilupparsi delle operazioni crebbe anche la richiesta di mano d'opera per le industrie belliche. Le autorità militari si trovarono di fronte al duplice problema di aumentare il numero degli effettivi dell'esercito mobilitato e contemporaneamente assicurare l'aumento della produzione. Si cercò quindi di contenere il numero degli operai impegnati nella produzione interna, incrementando da un lato la specializzazione dei singoli, e dall'altro dando priorità agli impianti più produttivi. Per conseguire il primo risultato furono costituite scuole di tornitori militari a Torino, Milano, Genova, Modena, Roma, Napoli e Palermo, e una scuola fonditori a Genova; a queste scuole veniva ammesso personale militare ritenuto inabile alle fatiche di guerra che, alla fine del corso, veniva distribuito tra i vari stabilimenti dai singoli comitati. Per quello che riguardava la necessità di dare priorità alle aziende più produttive, la Mobilitazione Industriale, dopo vari accertamenti, si convinse della necessità di concentrare le maestranze negli stabilimenti meglio organizzati (40 ). Siccome, però, il trasferimento del personale borghese da uno stabilimento all'altro incontrava ostacoli, si preferì, invece di aumentare il numero degli esoneri, di accrescere quello degli operai militari. Quindi, « quando una officina produceva poco, in re-

lazione alle maestranze (specie militari) per cause non eliminabili in un avvenire prossimo, gli organi centrali non esitavano, date le necessità del momento, ad utilizzare meglio la maestranza , e specialmente quella che più facilmente poteva spostarsi: la maestranza militare» (41 ). L'aumento però degli operai militari creava un'altra serie di problemi per il loro accasermamento ed inquadramento. « Si pensò allora di non "incorporare" quei nuovi chiamati, di mestiere operaio, la cui opera fosse ritenuta assolutamente necessaria ed indispensabile agli stabilimenti di produzione bellica presso i quali si trovavano a lavorare prima della loro chiamata alle armi. Furono p erciò date speciali disposizioni per la loro "immatricolazione"; e, poiché venivano a trovarsi a più completa disposizione delle necessità di lavoro degli stabilimenti, furono denominati "militari operai a disposizione"» (42 ). Poiché questa posizione permetteva alle autorità militari di poter pienamente disporre della mano d'opera, senza sovraffollare ulteriormente le caserme, fu concesso a molti operai comandati di passare a << disposizione »; ciò implicava il vestire l'abito civile e di passare le ore libere dal lavoro in famiglia. Il numero degli esonerati e operai militari (sia comandati che a disposizione), nei vari periodi del conflitto, risulta dalla Tab. 6.
Questi dati si riferiscono alle esenzioni rilasciate dalle Commissioni locali e dai Comitati regionali di Mobilitazione Industriale. Anche l' Ufficio militare di sorveglianza presso il Commissariato generale per i combustibili nazionali era abilitato a rilasciare esoneri. Data, però, la modesta entità dell'attività dell'industria italiana nel settore, il numero di questi esoneri fu molto limitato; infatti al termine delle ostilità non raggiungeva le 10.000 unità ( 44 ).
Non tutti gli esonerati e gli operai militari erano impegnati nell'industria; infatti col 1917 era stata iniziata, in forma massiccia, anche la concessione di esoneri e di personale militare per i bisogni dell'agricoltura. L'incidenza di queste concessioni sul totale del personale avente obblighi militari ed assegnato alle industrie risulta dalla Tab 7.
Il personale non destinato alle attività agricole era, per la quasi totalità, addetto al settore industriale come risulta dai dati relativi alla sua ripartizione , al 30 settembre 19 18. (Tab. 8)
Come si desume da questi dati, oltre 400.000 uomini erano impegnati nelle attività industriali vere e proprie e meno di 40.000 nel settore terziario. Il grosso delle attività industriali era comunque costituito da stabilimenti (ausiliari e minori) che lavoravano nei rifornimenti di armi e munizioni, il cui personale risulta dalla Tab. 9.

Ripartizione delle esenzioni in Totale delle Data esonerati militari operai esenzioni comandati a disposiz.


In conclusione, se si considerano i 15.550 operai militari comandati presso gli stabilimenti militari veri e propri, la cifra totale degli esentati a vario titolo addetti all'industria bellica vera e propria sale a 358.050 contro i 163.090 esonerati per le esigenze dell'agricoltura ed i circa 92.000 necessari alle imprese inerenti « i servizi pubblici e l'economia nazionale» ( 48 )
Come si vede, anche per quanto si riferiva alla mano d'opera, lo sforzo maggiore fu compiuto, né poteva esser e altrimenti, n el campo dell'industria, più strettamente lagata alle esigenze militari.
(1) C. ROSTAGNO: Lo sforzo industriale dell' Italia 11ella recente guerra, in • Rivista d'Artiglieria e Genio•, dicembre 1926, p. 2076.
(2) ibidem p 2075.
(3) ibidem p. 2076.
(4) Archivio del Museo Centrale del Risorgimento Roma (A.M .C.R.): Carte Dallo/io , busta (b.) 949, fascicolo (f.) I • provvedimenti per l 'esercito (guerra 1915-1918) •
(5) ibidem.
(6) ibidem
(7) A.M.C.R. Carte Dal/olio, b. 946 f. 7. Ecco il testo dell'interessante documento:
« L'Onorevole Giunta del Bilancio s ul disegno di legge a. 289 riflettente lo stato dì previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1915-1916 ha formulato il seguente quesito: "Si desidera conoscere se, in conseguenza degli approvvigionamenti e dei lavori eseguiti nell'esercizio in corso, coi fondi straordinari messi a disposizione del Ministero della Guerra in vista dell'attuale situazione internazionale, non s ia possibile prevedere qualche riduzione nelle spese straordinarie per l'esercito già autorizzate per gli esercizi avvenire dalle leggi in vigore". Si pregano gli uffici a i quali è diretta la presente circolare di fare d'urgenza sull'argomento, ciascuno per quanto riflette i servizi che rientrano nella propria competenza, le comunicazioni che stimeranno del caso a questo Segretariato, per metterlo in grado di preparare e sottoporre alla superiore approvazione la risposta da darsi all'Onorevole Giunta con la maggiore possibile sollecitudine Il Sottosegretario di Stato Elia •.
(8) Vedj allegato n. 14.
(9) cfr. E. FAI.DELLA: La grande guerra, Milano 1965, voi. I, p. 27.
(10) cfr. ibidem p. 28 e l'allegato n. 1.

(11) Vedi allegato n. I.
(12) A.M.C.R Carte Dallolio b. 949 f. 8.
(13) ibidem.
(14) V. FRANCHINI: «La mobilitazio11e industriale dell'Italia i11 guerra•, Roma 1932, p. 78.
(15) Per la Marina R.D. 16 maggio 1889; R.D. 10 a prile 1890; R.D. Il giugno 1893; R.D. 11 agosto 1894; R.D. 27 giugno 1897; Legge 1 febbra io 1900 n. 26; R.D. 27 novembre 1904; R.D. 29 aprile 1915 n. 561; per l'Esercito: R.D. 15 aprile J9ll n. 374; R.D. 17 maggio 1914 n. 548; R D. 29 aprile 1915 n. 561; R.D. 13 magg10 1915 n. 707; R.D 18 maggio 1915 n. 668; e dal D.M. 22 maggio 1915 stabilente le modalità di applicazione.
(16) Comitato p er la mobilitazione civile: • Le varie forme d i esenzione dal servizio effettivo sotto le armi in Italia durante la guerra mondiale • (1915-1918), Roma 1933, pp. 37-39.
(17) Vedi allegato n. 3
(18) cfr. V. FRANCHnn: op. cit.: p . 80.
(19) I "Comitati Regionali • avevano le seguenti sedi: Torino per il Piemonte; Milano per la Lombardia; Genova per la Liguria; Bologna per l' Emilia ed il Veneto; Roma per l'Italia centrale e la Sardegna; Napoli per l'Italia meridionale; Palermo per la Sicilia.
(20) L. EINAUDI: • La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana•, Bari 1933, p. 102.
(21) Vedi allegato n. 2.
(22) A.M.C.R. Carte Dallo/io b. 949 f. l • I provvedimenti per l'esercito •, cit.
(23) Sulla versatile attività dell'Ansaldo vedi gli allegati n. 3 e 4.
(24) Vedi allegato n. 5.
(25) cfr. allegato n. 6. La lettera per quanto firmata da Zuppelli è chiaramente del Dallolio. E' caratteristico della personalità dell'allora Sottosegretario alle armi e munizioni il fatto che egli riesca a valutar~ con sostanziale equaoimità Perrone, riconoscendogli difetti, ma anche pregi, nonostante che le prove dei contrasti che ebbe con lui appaiano in quasi ogni cartella del suo ar chivio.
(26) cfr. Ministero della Guerra: L'esercito italiano nella Grande Guerra (1915-1918), Roma d.v. (citato da qui innanzi come Relazione Ufficiale Italiana R.U.I.) voi. IV, torno I ter allegati 2, 3, 4 e 5.
(27) A.M.C.R. Carte Dallolio b. 944 f. 27. Dati sul munizionamento inviati a S.E. Salandra e C. Montù: Storia dell'artiglieria italiana, Roma d.v. voi. X, p. 559.
(28) Tutta la documentazione sui programmi di costruzione delle artiglierie è contenuta in A.M.C.R. Carte Dallolio b. 952.
(29) cfr. R.U.l. voi. lV tomo i ter allegati 2, 3, 4 e 5. Va considerato però che parte del materiale indicato fu ultimato in seguito sen1..a essere perciò inserito nei programmi successivi: vedi avvertenza al programma n. 7.
(30) F. ZUGARO: li costo della guerra italiana, Roma 1921, p. 19.
(31) A.M.C.R. Carte Dallo/io b. 960 f. 5 La ripartizione dei vari servizi era la seguente: Servizi Generali: ufficio invenzioni, servizio delle missioni all'estero, servizio trasporti A. e M., servizio automobilistico, ufficio comunicazioni statistiche interalleate; Servizi di Mobilitazione Industriale; Comitato Centrale della M.I. e uffici dipendenti, servizi esonerazioni temporanee, ufficio storiogr:ifico della M.I.; Servizio Tecnico A. e M. che comprendeva servizi per ogni tipo di materiale bellico oltre ad un servizio collaudi ed a un « servizio approvvigionamento materiali metallici • con vari uffici; il Servizio Amministrativo A. e M. comprendeva gli uffici: finanze, acquisti, commerciale, proventi e requisizioni. A.M.C R Carte Dallo/io b. 960 f. 6.
(32) Questi stabilimenti erano 1181 il 26 novembre 1916 (cfr. allegato U) 1200 il 28 febbraio 1917 (A.C.S. Ministero Armi e Munizioni b. 42) 1078 il l giugno 1917 (A.M.C.R. Carte Dallolio b. 948 f. 24). E' probabile che nell'ultimo anno di guerra, in considerazìone della carenza deJle materie prime, il numero di questi stabilimenti si sia ulteriormente ridotto.
(33) Alla data del 30 giugno 1917 gli stabilimenti indicati come varii comprendevano 26 imprese alimentari, 16 industrie del legno e della latta, 27 stabilimenti della carta e tipografico, 6 ditte produttrici di cotoni idrofili e medicinali, 2 oleifici e saponerie, 14 industrie della gomma, dei cavi elettrici e della telefonia, 42 fra imprese agricole, di frigoriferi, del ghiaccio, dei vetri. I dati sono desunti da: Ministero della Guerra, Sol· tosegretariato per le Armi e Munizioni, Elenco degli stabilimenti dichiarati « ausiliari • a tutto il 30 giugno 1916, Roma 1916 Ministero della Guerra, Sottosegretariato per le Armi e Munizioni, Elenco dei;li sta bilimenti dichiarati • ausilìari • dal 1 luglio al 31 dicembre 1916, Roma 1917, Ministero delle Arrni e Munizioni, Elenco degli stabilimenti di chiarati «ausiliari• a tutto il 30 giugno 1917, Roma 1917.
(34) cfr. Comitato di Mobilitazione Civile: I Comitati Regionali di Mobilita zione industriale (1915·1918), Roma s.d. pp. 119-121.

(35) Per le fonti vedere le note 32 e 33. Sul finire del 1917, come si è già detto, il Comitato Veneto Emiliano fu diviso in due, quello dell'Italia cen trale in tre (Sardegna, Toscana ed un terzo Comitato per il Lazio, il .Molise, l'Abruzzo, l'Umbria e le Marche) e quello dell'Italia meridionale nei due Comitati di Napoli e Bari. Abbiamo lasciato la ripartizione precedente per facilitare la comparazione.
(36) R. RoMEO: Breve storia della grande industria in Italia, Bologna 1967, p. 121.
(37) Comitato per la Mobilitazione Ci\'ile: Le varie forme di esenzio ni, cit. p. 113.
(38) ibidem p. 114.
(39) ibidem p. 124.
(40) V. FRANCHJ~t: Dì alcu11i element i relativi alla maggiore utilizzazione delle maestranze durante il periodo bellico, Milano 1928, pp. 17 ss
(41) ibid em pp. 27-28.
(42) Comitato per la Mobilitazione Civile: Le varie forme di esenzioni, cit. pp. 124-125 .
(43) ibidem p. 438.
(44) cfr V. FRA~CHINI: La ,nobilitazione , op. cit. p. 142.
( 45) A. SERPlERI: La guerra e le classi rurali iralìane, Bari 1930, p. 64 ed anche Comitato per la Mobilitazione Civile: Le varie forme di esenzione, op. cit. p. 438.
(46) cfr. A. SERPIERI: op. cit. p. 68.
(47) cfr. Ministero della Guerra: Alcuni dati sulla prima guerra mondiale, Roma 1935, p. 27; A.M.C.R. Ca rte Dallolio b. 948 f. 24; A.C S. Ministero Armi e Munfaioni b. 42. Va segnalato che sovente viene conhlso il personale addetto alla produzione delle Armi e Munizioni con la totalità degli operai partecipanti in \'ario modo allo sforzo bellico del Paese. Cfr. V. FRANCHINI: op. cit. p. 144·145. In realtà, come si evince dallo stesso autore (pag. 135), bisogna considerare anche le imprese addette ai servizi pubblicì ed interessanti l'economia nazionale.
(48) Nel calcolo si sono considerati anche i circa 10.000 esoneri concessi dal Com· missariato Generale per i combustibili nazionali.
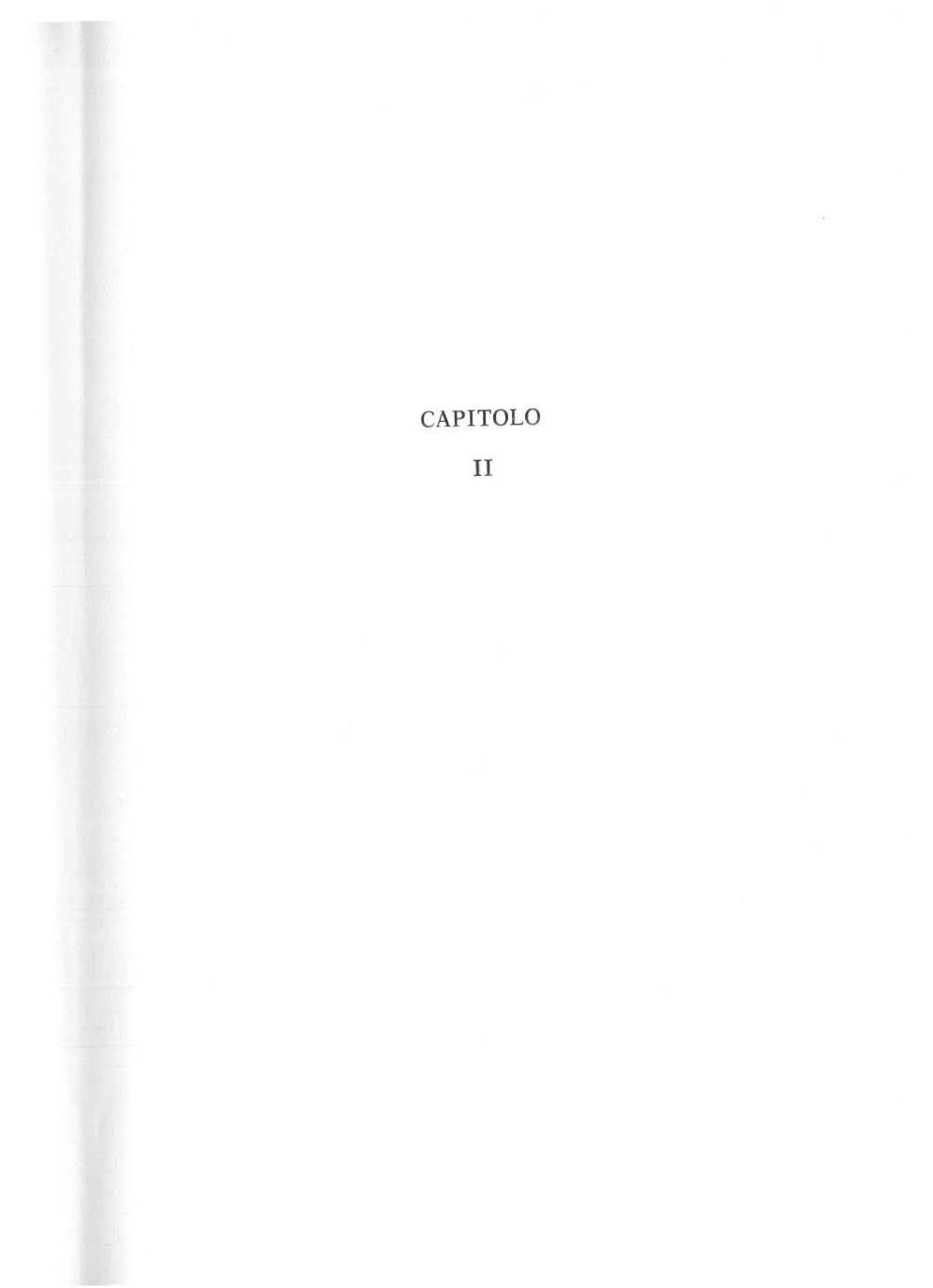
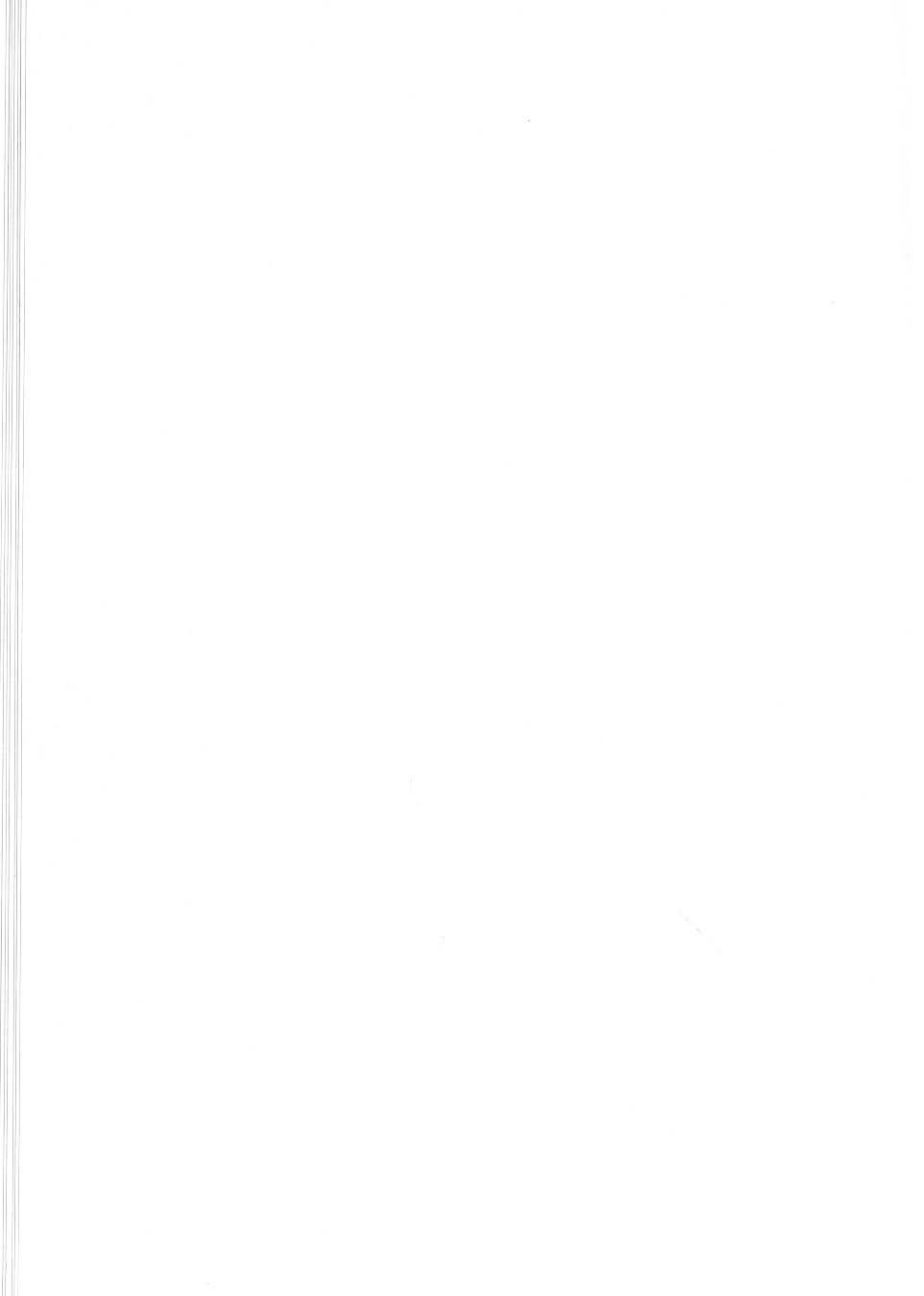
Come si ricorderà, all'inizio della sua opera, il gen. Dallolio aveva espresso qualche preoccupazione circa la possibilità di impiegare in pieno e sviluppare le potenzialità industriali del Paese, poiché tutto dipendeva dalla possibilità di importare le materie prime di cui l'Italia era sprovvista. Nel corso del conflitto le preoccupazioni dell'organizzatore della Mobilitazione Industriale non dovevano rivelarsi senza fondamento. A tal proposito basta osservare l'andamento delle importazioni e de lle esportazioni negli anni della guerra:
Tabella 1
Questi dati dimostrano crudamente da un lato la crescente difficoltà incontrata dall'Italia nel procurarsi quanto occorreva alla conduzione della guerra ed ai bisogni della sua popolazione, dall'altro come il Paese, impegnato in un supremo sforzo per la sopravvivenza, non fosse più in grado di ridurre, con l'esportazione dei propri prodotti, il disavanzo della bilancia dei pagamenti.
Il rapidissimo aumento del valore delle importazioni dal1'estero negli anni della guerra era conseguenza di un complesso di fattori che meritano un ulteriore esame. Prima del conflitto la grande maggioranza (i tre quarti) delle merci importate od esportate dall'Italia viaggiavano via mare. A questo traffico l'armamento italiano partecipava fornendo circa il 50% del naviglio ne-

cessario. Con lo scoppio della guerra la situazione si alterò progressivamente a svantaggio dell'Italia; infatti i Paesi centro-europei, che costituivano il principale mercato di scambio per via di terra, si chiusero, prima in parte, ed infine, dopo la dichiarazione di guerra alla Germania, completamente. Per questo fu necessario rifornirsi quasi totalmente via mare. Oltre a ciò Russia e Romania, tradizionali mercati di approvvigionamento del ·grano, che costituiva la principale merce importata, erano inaccessibili per la chiusura dello stretto dei Dardanelli . In conseguenza di ciò e delle particolari condizioni create dalla guerra nei mercati europei, fu necessario ricercare oltre oceano il grano e gran parte delle materie prime essenziali. I percorsi divennero quindi più lunghi facendo lievitare i costi e rendendo ancor più insufficiente il già modesto tonnellaggio italiano. Negli anni del conflitto il tonnellaggio delle merci sbarcate in Italia subì considerevoli riduzioni, come risulta dalla Tab. 2.
Da questi dati risulta che le importazioni italiane mantennero una media mensile quasi costante nel primo periodo della guerra ( 1.365.966 di tonnellate in media nel primo semestre del 1915, 1.345.463 in quello successivo, 1.349.900 nei primi sei mesi del 1916), cominciarono a decrescere sul finire del 1916, scese-

ro ad una media di 893.259 tonnellate al mese nel 1917, precipitarono a 789.406 tonn. mensili all'inizio del 1918 e solo negli ultimi sei mesi di quell'anno risalirono ad una media di 978.989 tonnellate.
In definitiva, delle 52.970.729 tonnellate importate in Italia nel corso della guerra, il 30,71 % giunse nel 1915, il 29,02% nel 1916, il 20,24% nel 1917, il 20,03% nel 1918. Il Governo Italiano cercò di far front e alla crisi determinata dal costante ridursi delle importazioni con varie misure, la principale delle quali fu la requisizione, prima parziale (negli anni 1915-1916), poi totale (anni 1917-1918), d el naviglio commerciale nazionale. Il naviglio requisito, compresi i piroscafi germanici ed austriaci sequestrati, comprendeva 113 unità il 31 dicembre 1915, 340 il 30 novembre 1916, 345 il 30 giugno 1917, 306 il 30 dicembre 1917, 298 il 30 giugno 1918 ( 3). Come risulta da questi dati, dopo l'attuazione pressoché totale delle disposizioni di requisizione nei primi mesi del 1917, il numero delle unità disponibili va sempre più riducendosi. Ciò, come la contrazione delle importazioni, è da mettersi in relazione diretta con l'inizio dell'offensiva sottomarina germanica. Nell'ottobre del 1916 infatti: « sebbene 32 navi inglesi, assalite da sommergibili, riuscissero a respingere l'assalitore, fossero salvate e fuggissero , la distruzione totale del tonnellaggio inglese sommava a 176.000 tonn., perdita eccedente di 30.000 tonn. quella avuta nell'agosto 1915 che fino ad ora era stato il mese più nero della guerra. Gli alleati persero 74.000 tonn. e le perdite neutrali sommarono a 85 navi, per 102.500 tonn. eccedendo di 40 navi e di 25.000 tonn. qualsiasi massimo precedente» ( 4 ).
Gli effetti dell'offensiva sottomarina non mancarono di farsi sentire anche in Italia. Infatti, il carbone inglese, che nel luglio 1914 veniva comprato a Genova a 30 lire alla tonnellata, era già salito a f. 86 alla fine del maggio 1915 raggiungendo le 190 lire nel gennaio 1916 ( 5 ). Dopo quella data i prezzi si erano in qualche modo stabilizzati; ad ottobre 1916 oscillavano infatti tra le 190 e le 200 lire, da quella data però « passarono a 195-200 nelle prime tre settimane di novembre, e 210 nell'ultima, a 230-235 nella prima di dicembre, chiudendo l'anno a lire 300-310 » ( 6 ).
Il rapidissimo aumento dei prezzi era causato, da un lato dall'elevarsi dei noli e dei premi di assicurazione (7), dall'altro dalla diminuita disponibilità della merce, sia a causa degli affondamenti, sia a causa della minore quantità di naviglio impiegato nei trasporti con l'Italia.
Nel luglio del 1914 il tonnellaggio mercantile mondiale era così ripartito:

Com e risulta chiaramente da questi dati, la posizione inglese era di assoluta preminenza tra le marine alleate; da ciò conseguiva necessariamente che i trasporti italiani e francesi dipendessero in gran parte dalla disponibilità del naviglio britannico, il quale, per effetto dell'aumentata attività sottomarina germanica ed in seguito alla decisione tedesca di considerare dal 1° febbraio 1917 « zona di guerra» il mare attorno alle isole britanniche, era in primo luogo impegnato ad assicurare i rifornimenti alla madrepatria. Né vi era la possibilità di sopperire al diminuito impiego di unità inglesi con nuovo naviglio italiano, perché « tanto in Francia come in Italia le costruzioni navali erano quasi arrestate. Al 31 dicembre 1916 il tonnellaggio francese ed italiano dimostrava una diminuzione fortissima e non vi era speranza che ulteriori perdite potessero essere rimpiazzate » ( 9 ). In effetti la quantità del naviglio italiano perduto nel corso della guerra fu notevole:

Tabella 4
Causa
Per eventi b ellici
A questo salasso non poteva certamente far fronte l'aumento delle unità della marina mercantile italiana, il quale nello stesso periodo fu il seguente:
Questi complessi fattori determinarono una situazione per cui, benché Ja quantità delle merci importate in Italia si contraesse sempre più, la bilancia dei pagamenti italiani registrava passivi crescenti.

Tutto ciò avveniva non tanto per l'aumentato prezzo delle merci all'origine, quando per il vertiginoso aumento dei noli e delle assicurazioni marittime. Questa situazione gravò pesantemente sullo sviluppo dell'organizzazione industriale italiana nel corso del conflitto, perché influì gravemente sulla possibilità di disporre delle necessarie fonti di energia.
Scrisse infatti l'Einaudi: « Purtroppo la guerra sottomarina riduce alla metà l'importazione di quella che era stata la fonte principale di forza per l'industria italiana: da una media di 10,5 milioni di tonnellate negli anni dal 1911 al 1913 l'importazione del carbone scende a 9,8 nel 1914, al 8,4 nel 1915 cd 8,07 nel 1916, a 5,04 nel 1917 ed a 5,8 nel 1918. Scarsissimo fu l'aiuto porto dalla coltivazione dei giacimenti di lignite, sebbene lo scavo annuo da 608 mila tonnellate nel quinquennio antebellico pregredisse a 953 nel 1915, a 1306 mila nel 1916, a 1722 mila nel 1917 ed a 2171 mila nel 1918. Ma l'uso ne fu limitato quasi in tutto al riscaldamento ed alla cucina. Persino nel gennaio del 1918, quando il carbone straniero maggiormente scarseggiava, le ferrovie dello stato non ne consumarono più di 25.000 tonnellate » (1 2 ).
Nel tentativo di porre rimedio alla insufficienza delle fonti di energia, causata dalla mancanza del carbone, si diede il massimo impulso alla produzione di energia elettrica:
Tabella 6
Ma il pur notevolissimo sforzo, mirante a ricavare il massimo dagli impianti idroe lettrici, non poteva certo sopperire alle necessità dell'industria, per cui fu necessario, negli ultimi due anni di guerra, costituire un Commissariato generale per i carboni, il quale provvide a di s tribuire i combustibili secondo un rigido ordine di precedenza, per cui la r ipartizione del minerale avvenne secondo le proporzioni seguenti:
Tabella 7
Media 1909-1913
Media 1915-1918
Data la limitatezza delle font i di energia, si era forzatamente scelto di tralasciare le esigenze di tutte le imprese industriali non direttamen te connesse con lo sforzo bellico.
Questa decision e aveva avuto al momento effetti limitati sul mercato interno, poich é la domanda veniva in qualche modo soddisfatta e la situazione permetteva il riassorbimento della mano d'opera rimasta momentaneamente disoccupata in altre attiv ità industriali. Sul mercato internazionale provocava, però, la contrazione dell e esportazioni, determinando il rapi do aumento dello squilibrio della bilancia dei pagamenti.
La limitata disponibilità de l carbone influì anche sulla mi-

nore o maggiore attività degli stabilimenti ausiliari, a seconda del loro grado di importanza agli effetti del tremendo sforzo bellico che il Paese stava affrontando.

Le imprese estrattive non ricevettero un grande sviluppo in seguito allo scoppio della conflagrazione mondiale; anzi, « nel periodo dal 1914-15, nonostante l'aumento dei prezzi dei metalli, dovuto allo stato bellico, la produzione mineraria diminuì, rispetto alfa precedente, a cagione della scarsezza della mano d'opera e della difficoltà dei trasporti. Nel primo anno di guerra le minjere att ive, e che riuscirono produttive, furono 619 con 41.065 operai; quelle attive, ma che non riuscirono produttive, furono 488 con 1709 operai; la produzione della cave fu di 9593 cave di cui 6939 permanenti, 2654 temporanee con un totale di 50.000 operai » (1 5 ).
Con la concessione dell'ausiliarictà agli stabilimenti ed i conseguenti esoneri, e mediante un massiccio intervento dello Stato, la situazione migliorò, ma non in tulti i settori, come risulta dai dati della produzione mineraria negli anni di guerra: Tabella 8
Come si vede, la produzione mineraria italiana ebbe negli anni della guerra un andamento molto differenziato da settore a settore e ciò dipese, oltre che da fattori inerenti la produzione, anche da altri elementi, quali la maggiore possibilità di impor-
tare il minerale (come nel caso del rame) (1 7) e soprattutto l'utilità dei vari metalli per far fronte ai bisogni creati dalla guerra. La brusca contrazione nella produzione di zinco è, ad esempio, da ricercarsi nel fatto che, essendo il metallo in gran parte esportato, si preferì con trarne la produzione per sviluppare altri settori più strettamente collegati con la situazione bellica.
Il vertiginoso aumento della produzione dei combustibili foss ili è da mettersi in relazione con l'estrema carenza di fonti di energia, per cui, nonostante la qualità scadente del carbone estratto da 39 miniere di lignite e 25 torbiere esistenti prima della guerra, « il numero salì, sotto la spinta delle provvidenze statali, a 223 e 149 » ( 18 ).

La brusca caduta che la produzione del minerale ferroso subisce ne l 1918 sembra contravvenire a questa logica, tanto più che non è composta da un aumento delle importazioni dei metalli, le quali, anzi, passano da 1.220.368 tonnellate nel 1917 a 915.567 nel 1918. Il calo si verifica, anche in percentuale, da 11,4% a 8,6% ( 19 ).
Ques ta situazione diviene comprensibile qualora si consideri che in una guerra di materiali, come era appunto il primo conflitto mondiale, il problema non è tanto quello di rifornire il combattente di armi, quanto di munizioni, il cui consumo è enorme. Erano le munzioni che assorbivano la maggior parte della produzione d'acciaio ( 20 ).
Dopo Caporetto e la ritirata al Piave, l'esercito italiano assunse un atteggiamento difensivo che ridusse sensibilmente il consumo di munizioni. Oltre a ciò bisogna considerare che, essendosi accumulato negli anni precedenti un numero ingentissimo di proiettili che non si erano potuti caricare, fu possibile contrarre la produzione de i colpi vuoti incrementando invece il numero dei colpi completati:
Questi dati spiegano esaurientemente perch é nel 191 8 non ci si preoccupasse eccessivamente di incrementare l'estrazione del minerale ferroso.
Le considerazioni svolte per l'industria mineraria sono valide in gran parte anche per le imprese siderurgiche, la cui produzione in quegli anni fu la seguente:

Come si vede anche la ghisa e l'acciaio seguono (né poteva essere altrimenti) la parabola tracciata dall'estrazione dei minerali ferrosi. « D'altra parte, le accresciute difficoltà di importazione del minerale bloccarono ogni ulteriore espansione dei grandi impianti per la produzione di ghisa d'altoforno, e spinsero invece ad un febbrile ampliamento di quelli destinati alla lavorazione del rottame, e alla creazione di tutta una serie di nuove ed imprese in questo settore, con un accrescimento della capacità produttiva assai superiore all'effettivo incremento della produzione consentito dalla disponibilità di materie prime e di mano d'opera addestrata, e con una base economica evidentemente legata solo ell'eccezionale livello raggiunto dai prezzi durante la guerra. Un effetto diretto d el conflitto sulla industria siderurgica, poi, fu anche lo sviluppo assunto dalla produzione delle ferroleghe e specialmente dalla elettrosiderurgia sotto lo stimolo della necessità di supplire alla deficienza di combustibile: sicché la produzione di ghisa al forno elettrico balzava da 2.300 tonnellate nel 1914 a 61.900 tonnellate nel 1918 » (23 )
Le imprese meccaniche ebbero un amplissimo sviluppo nel corso del primo conflitto mondiale e, per quanto, come rileva il Franchini (24 ), sia difficile tracciare un bilancio complessivo « mancando sull'argomento statistiche ufficiali e data la enorme eterogeneità dei materiali», si tenterà egualmente di tracciare un quadro che sia, almeno per le produzioni più importanti, il più completo possibile.
Senza dubbio, il primo posto tra le industrie belliche spet-
ta alle imprese che si occupavano della fabbricazione di munizioni. Si consideri infatti che i consumi per i soli proiettili d'artiglieria furono i seguenti:
Si tratta complessivamente di 47.087.397 colpi sparati nel corso della guerra cui sono da aggiungere 15.804.000 colpi di piccolo calibro, 5.070.730 proiettili di medio calibro, 303.219 colpi di grosso calibro esistenti nei depositi e presso le truppe al momento dell'armistizio (25 ). Oltre a questo materiale completo, bisogna ricordare l'esistenza, presso i depositi al momento dell'armistizio, di alcuni milioni di colpi finiti-vuoti (cioè senza cariche) considerando i qupli il totale dei proiettili prodotti in Italia nel corso della 1a guerra mondiale raggiunge e supera i 70 milioni ( 26 ). Alla costruzione di questo munizionamento, come del resto all'intera produzione bellica, contribuirono in varia misura stabilimenti sia privati che militari.
In questa sede ci riferiamo ai dati complessivi della produzione, riservandoci di trattare più oltre dello specifico contributo dato dagli stabilimenti dipendenti dal Ministero della guerra.

P er l'approntamento di tutto questo materiale furono impiegati nel corso della guerra 2.099.000 tonnellate di metalli e precisamente:
Tabella 12
1.667.000 tonnellate di acciaio
280.000 tonnellate di ghisa acciaiosa
131.000 tonnellate di ghisa
21.000 tonnellate di rame (27)
Per valutare a pieno l'importanza della produzione dei proiettili d'artiglieria, nel quadro della produzione nazionale durante la prima guerra mondiale, è necessario tener presente la disponibilità di acciaio, ghisa e ferro in quegli anni:
Questi dati se ci permettono di apprezzare l'enorme sforzo compiuto dall'industria italiana per la fabbricazione di munizioni nel corso della prima guerra mondiale (infatti per il solo munizionamento d'artiglieria fu impiegato poco meno di un quarto, cioè 2.078.000 tonnellate su 9.276.000, di tutto il materiale ferroso disponibile), d'altro canto però, quegli stessi dati testimoniano la scarsa autonomia dell'industria meccanica italiana, che dipendeva per quasi un terzo della sua produzione dalle importazioni dall'estero. Ciò non mancò di avere conseguenze anche sul ritmo di produzione dei proiettili d'artiglieria. « Da un mese all'altro gli scarti sono assai sensibili » scrisse il colonnello Geloso « tanto nel quantitativo complessivo dei singoli mesi come nelle medie giornaliere relative, le variazioni sono certamente dovute in gran parte alla irregolarità del traffico marittimo che, a cagione della guerra sottomarina, non faceva affluire in modo costante le materie prime ed i semilavorati; ed infatti tali variazioni sono in realtà evidenti e gli scarti sono più violenti durante l'epoca in cui l'intensificarsi della campagna dei sottomarini contro il traffico marittimo rese, per qualche tempo, assai aleatori e della massima irregolarità tutti i rifornimenti » ( 29 ).
Il Geloso suffraga queste sue affermazioni con un esame della produzione d i munizioni francese ed inglese che risultano, nel 1917, molto più costanti di quella italiana, la quale per i piccoli calibri va « da un massimo giornaliero di 84.100 colpi completi allestiti nel febbraio, ad un minimo di 14.500 nell'ottobre: lo sbalzo "minimo" percentuale fra un mese ed il successivo è ben del 28%. Appare chiaramente, da questo confronto, che cosa significhino una preesistente buona organizzazione industriale ed il possesso delle materie prime indispensabili per la fabbricazione degli ordigni di guerra; a questi due elementi, ed insieme al fatto che dei rifornimenti erano padroni i Franco-I nglesi (i quali perciò, dovendo prima, com'è naturale, provvedere al proprio fabbisogno, li m i suravano a noi nella quantità a loro non necessaria

più che in quella a noi indispensabile), devesi se l'Italia, nelle produzioni industriali di guerra, anche dopo essere arrivata ad una ottima organizzazione capace di alto e costante rendimento, dovette sempre soggiacere ad una grande irregolarità di produzione; e non soltanto per i proiettili d'artiglieria» ( 30 ).
Nonostante queste difficoltà, anche nel settore delle armi portatili fu possibile assicurare, per tutto il corso della guerra, un munizionamento sufficiente . All'inizio del conflitto la situazione in questo campo era tutt'altro che pari al bisogno; i tre stabilimenti impiegati erano infatti in grado di fornire un solo colpo al giorno a tutti i fucili 91 esistenti, mentre producevano complessivamente solo 28.000 colpi per i fucili 70/87 della milizia territoriale.
Nel luglio del 1915 la produzione mensile era già salita a 60 milioni di colpi e sul finire dell'anno fu ulteriormente aumentata. « Così, malgrado le difficoltà per procurarsi le materie prime, dal 1916 in poi la produzione di cartucce risultò sufficiente per il rifornimento di tutti i fucili e di tutte le mitragliatrici in senrizio, anche nel caso di qualsiasi eventuale più elevato consumo, e ciò tanto più perché il fuoco di fucileria erasi ridotto di molto ed il consumo di cartucce era prevalentemente fatto dalla mitragliatrice » ( 31 ).
Nel corso del conflitto furono complessivamente prodotti
3.616 milioni di proiettili per armi portatili ( 32.). Parimenti soddisfacente fu la produzione di bombe a mano che da 5.000 al giorno nel 1915 crebbe fino a 45.000 nel 1918 raggiungendo, nel corso del conflitto, un totale di 22.360.000 bombe prodotte (33 ).
Di meno facile risoluzione si dimostrò il problema di provvedere al munizionamento delle bombarde; la produzione giornaliera aveva, sul finire del 1916, faticosamente raggiunto le 2.300 unità, livello fortemente inferiore alle richieste del Comando Supremo che fu quindi costretto a diminuire le dotazioni e imporre limitazioni ai consumi. Solo nel 1918 per la riduzione dell'impiego di quest'arma, la produzione dei proiettili per bombarda raggiunse un livello sufficiente ( 34 ).

Notevole fu anche la produzione di munizioni per l'aviazione: nel 1918, l'anno in cui la nuova arma ebbe una grande espansione, furono prodotte 417.000 bombe e granate, 490.000 colpi per cannoncini, 5 milioni di pallottole B.T.S. e 660.000 perforanti per mitragliatrici (35 ).
Furono inoltre costruite, per i bisogni della marina 62.247 tonnellate di munizionamento: 13.994 torpedini e 674 siluri ( 36 ).
Per avere un'idea complessiva della capacità produttiva rag-
giunta, nonostante tutte le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, dall'industria italiana nel munizionamento, è necessario esaminare il programma per il primo semestre del 1919 fissato, in base alle richieste del Comando Supremo e alle possibilità industriali del Paese, agli inizi dell'ottobre del 1918. « Secondo tale programma la produzione colpi-finiti-vuoti è complessivamente preventivata in 16.231.000 corrispondenti ad una media (per i 180 giorni) di 90.150 proiettili giornalieri. Nel numero dianzi accennato sono compresi anche i piccolissimi calibri (57-42 40V-37/25-25), esclusa però la produzione delle granate da 37 Fant. delle quali è preventivato un allestimento complessivo di 7.500.000 corrispondenti ad una media di 41.500 al giorno» ( 37 ).
Per quanto si riferiva alla fabbricazione dei proiettili da bombarde il programma prevedeva le seguenti medie mensili:
Dai dati appare chiara, nell'ultima fase della guerra, la maggiore importanza data all'impiego del mortaio da fanteria (Stokes) rispetto a quello della bombarda. Era inoltre prevista la costruzione al mese di 1.500.000 petardi offensivi più 50.000 bombe a mano SIPE e circa 20.000 bombe da fucile al giorno (39 ).

In quanto alle armi portatili il programma prevedeva l'allestimento mensile di:
15
mod. 91 :95
910/915
"
L'enorme lavoro necessario alla produzione di una così imponente massa di materiali fu reso possibile, non solo dal pieno sfruttamento del macchinario esistente, ma anche dal grande ampliamento del numero degli impianti dell'industria meccanica,. « L'importazione di macchine utensili dall'estero, che era stata di 13.611 tonnellate nel 1907, nel 1917 raggiungeva le 22.488 tonnellate: massimo assoluto, che non verrà più superato fino alla seconda guerra mondiale, e a cui occorre aggiungere le 14.000 tonnellate di macchine utensili prodotte in quell'anno dall'industria nazionale» (41 ).
Il potenziamento della struttura industriale permise anche il rapido sviluppo dell'industria degli armamenti. Si è già fatto cenno alla lentezza ed ai ritardi con cui, tra il 1911 ed il 1914, l'industria italiana provvide alla costruzione di poche centinaia di cannoni di piccolo calibro (354 alla fine del dicembre 1914) (42 ), nel corso della grande guerra furono invece costruiti ben 16.000 pezzi di tutti i calibri a cui bisogna aggiungere circa 7.000 bombarde e lanciabombe; a queste cifre bisogna sommare i 2.664 pezzi allestiti per la Marina. La produzione delle armi automatiche, partendo praticamente da zero, raggiunse il totale di 37.029 mitragliatrici di vario calibro per il solo esercito. Ciò ridusse il concorso degli alleati, in questo settore in cui la potenzialità produttiva italiana era all'inizio pressocché inesistente, alla fornitura di circa 7.000 armi.

Per quanto si riferisce ai fucili, all'atto della mobilitazione si palesarono alcune carenze per l'insufficienza delle dotazioni di armi moderne; la situazione migliorò verso la fine dell'anno, ma l'arrivo di nuove reclute fece sì che nel febbraio del 1916 si manifestasse una deficienza di 113.000 fucili 91; ciò avvenne proprio mentre la cessione di 400.000 vecchi, ma sempre impiegabili, fucili 70/87 alla Russia riduceva Ja disponibilità di armi di riserva. La situazione migliorò lentamente nel corso degli ultimi mesi di quell'anno. « Negli anni successivi al 1916, la produzione nazionale fu tale per cui non si ebbe alcuna preoccupazione per la formazione quasi continua di nuovi reparti di fanteria e per il loro armamento » ( 43 ).
La grande capacità produttiva raggiunta dall'industria italiana degli armamenti fu messa in risalto dagH avvenimenti che seguirono la rotta di Caporetto.
Nell'ottobre del 1917, all'inizio della battaglia, l'artiglieria italiana disponeva di 7.138 pezzi di ogni tipo; al termine del ripiegamento la situazione era la seguente:
Per sopperire alle gravissime carenze, l'esercito italiano poté disporre all'inizio solo di quella parte dei 1994 pezzi, costruiti tra il 1° luglio ed il 30 novembre 1917, che era stata tenuta di riserva. La famosa storia dei 600 cannoni da 105 costruiti in più dall'Ansaldo non è che una leggenda (44 ). Di fronte alla gravità della situazione gli imprenditori e le maestranze delle industrie belliche diedero prova di un notevole spirito patriottico (45) permettendo l'approntamento, il 12 dicembre, di un programma di emergenza secondo il quale, sospesa per qualche tempo la produzione dei proiettili d'artiglieria di piccolo calibro in considerazione dell'elevato numero di proiettili scarichi disponibili, e concentrata ogni risorsa nella produzione delle bocche da fuoco, fu possibile approntare, per la fine di aprile, altre 471 batterie nuove, più 682 pezzi di riserva.
Nel maggio poi furono prodotte ben 352 batterie complete per cui la produzione complessiva nei sei mesi considerati superò i 4 .000 pezz i.
« A t u tto aprile 1918, ossia dopo 6 mesi dalla data del nostro ripiegamento sul Piave, tutte le perdite in materiale d'artiglieria erano colmate» ( 46 ).

Per avere un'idea complessiva dei risultati raggiunti nel campo degli armamenti dall'Italia nel corso del primo conflitto mondiale basta comparare la disponibilità di armi all'inizio ed alla fine del conflitto:
Tabella 17
Fucili mod. 91
Fucili 70/87
Fucili a u tomatici
Moschetti mod. 91
Non meno eloquenti i dati relativi alla produzione di armi per l'esercito italiano ( aviazione esclusa) : Tabella 18
Per quello che riguarda la potenzialità raggiunta dall'industria italiana nel campo degli armamenti, essa è chiaramente illustrata dal programma per il primo semestre del 1919 che prevedeva l'allestimento del seguente materiale d'artiglieria: Tabella 19
Importante anche il programma di costruzione delle bombarde e dei mortai che richiedeva una produzione mensile di 2 bombarde da 400, 4 da 320, 80 da 240, 100 da 58 ed 800 mortai da fanteria (Stokes); oltre a ciò era stata finalmente prevista la consegna all'esercito italiano di 1400 carri armati tipo Renault, la cui produzione affidata principalmente alla FIAT, sarebbe dovuta avvenire al ritmo seguente:

Notevole anche la prevista produzione mensile di armi portatili calcolata in:
Tabella 21
Fucili 91 completi
Moschetti mod. 91 completi
Pistole automatiche
Pistole a rotazione
Mitragliatrici 914 Fiat
Mitragliatrici leggere SIA Moschetti mitragliatori

Va precisato che, per quanto si riferiva al1e mitragliatrici Fiat, i responsabili della Mobilitazione Industriale non ritenevano le ditte appaltatrici in grado di rispettare gli impegni assunti. Si sarebbe trattato comunque di una produzione insufficiente, tanto che era prevista la richiesta di 1200 mitragliatrici Vilkers al Governo inglese e di 800 Lewis a quello americano ( 49 ).
Nel corso della guerra l'industria automobilistica conobbe un periodo di grande espansione. Le previsioni relative all'impiego dei mezzi automobilistici, anche le più audaci, furono superate dalla realtà; infatti la pratica delle operazioni rivelò che il nuovo mezzo aveva possibilità quasi illimitate.
Per rendersi conto dell'importanza dell'autotrasporto militare bastano le cifre che testimoniano lo sviluppo del servizio automobilistico nel corso della guerra :
Si tenga presente che questi dati si riferiscono al solo esercito operante e non tengono conto del personale e del materiale assegnato in territorio per servizi vari ( commissioni di requisizione, motoaratura ecc.). Si trattava di servizi che all'inizio del
conflitto o non esistevano o non impiegavano automezzi e che alla fine della guerra impegnavano 20.000 uomini con circa 12.000 autoveicoli ( 51 ).
Alla creazione di questo imponente servizio l'industria italiana contribuì fornendo, nel corso della guerra, i seguenti materiali:
Tabella 23
Autovetture
Autoambulanze, autobus ed autobotti
Autocarri
Carri rimorchio
Carrozzerie per autocarri ed autovetture
Motocicli
Ganci di traino per rimorchi Fusti per benzina
Oltre a ciò il servizio automobilistico militare impiegò 938.750 pneumatici ed effettuò acquisti di parti di ricambio per 128 milioni di lire ( 53 ).
L'industria automobilistica italiana ottenne in quegli anni successi anche nel campo internazionale, come dimostrano i dati delle importazioni ed esportazioni di automezzi negli anni della guerra:
Poiché per i primi due anni gli autocarri sono compresi nel numero delle autovetture, è difficile fare un computo preciso. P er gli anni successivi, cessata completamente l'importazione degli autocarri dall'estero, l'industria italiana poté, in questo settore, affermarsi anche a livello internazionale finché le esigenze interne non divennero assolutamente prevalenti (si consideri che, tra l'ottobre 1917 e i primi di novembre 1918, il numero degli auto-

carri dei servizi automobilistici dell'esercito aumentò di 11.000 unità nonostante le perdite causate dalla ritirata al Piave). Nel settore delle autovetture la concorrenza estera fu pienamente sconfitta; soltanto nel campo dei motocicli le fabbriche estere, soprattutto quelle inglesi, continuarono a tenere un indiscusso primato.
Nonostante i grandi progressi realizzati nel corso della guerra dall'industria automobilistica italiana, furono, senza alcun dubbio, le imprese aeronautiche quelle che ricevettero il maggior impulso dal conflitto. Le ditte costruttrici di velivoli passarono da quattro nel 1914 a otto nel 1915 per divenire undici l'anno successivo, ventuno nel 1917, e per raggiungere il numero di ventisette nel 1918. La produzione di aerei si accrebbe anch'essa proporzionalmente: 382 aerei nel 1915, 1255 nel 1916, 3.861 nel 1917 ed infine 6.523 nel 1918, per un totale complessivo di 12.021 velivoli. Sviluppo analogo ebbero le fabbriche che si occupavano di produrre le eliche: tre ditte nel 1915, undici nel 1916, trentuno nel 1917, sessantadue nel 1918, con una produzione di 1.700 eliche nel primo anno di guerra, 7.585 nel 1917 e 30.498 nel 1918. Estremamente significativi sono poi i dati relativi alla produzione dei motori di aviazione:
« Un'idea abbastanza precisa dell'impulso assunto dall'industria aeronautica durante la guerra è fornita dalla constatazione che, nel solo anno 1918, furono prodotti il 53% dei velivoli, il 61 % dei motori e il 76,5% di eliche isolate di tutta la produzione del periodo bellico. All'armistizio rimasero in sospeso (e fu. rono poi annullate) commesse per altri 15.592 apparecchi e 26.111 motori» ( 55 ).

Al termine del conflitto il servizio aeronautico disponeva di 1.055 apparecchi alla fronte e di 1.600 nelle scuole, di 7 dirigibili, 1.200 apparati R.T., 3.468 mitragliatrici per aerei, 2.069 cannoncini e pistole mitragliatrici, 515.240 bombe di vario tipo ( 56 ).
L'enorme sviluppo dell'industria aeronautica nell'ultimo an-
no di guerra fu reso possibile dalla concentrazione degli sforzi e dei mezzi in questo settore, riducendo, come già si è detto, altre produzioni. Si manifestava anche in ciò l'azione di stimolo e al contempo di controllo della Mobilitazione Industriale.
L'industria meccanica italiana provvide anche all'allestimento dei « mezzi tecnici ausiliari» per l'esercito, che comprendevano una svariatissima qualità di articoli di cui elenchiamo qui solamente i più notevoli per quantità:
Tabella 26
Filo spinato
Paletti di ferro per reticolato
Ferri a doppio T
Lamiere dei vari tipi
Elementi curvi di trincea
Filo d'acciaio
Fune metallica
Reti metalliche varie
Tubi di ferro e di acciaio
bulloni, chiodi e viti
Tutto questo materiale, ad eccezione del filo spinato per cui si dovette ricorrere per il 58% del fabbisogno all'importazione dagli Stati Uniti, fu prodotto dall'industria italiana che provvide anche alla fornitura di 3.000.000 di badili e a quella di 3.000.000 tra picconi e gravine ( 57 ).

Negli anni della guerra la produzione di materiale ferroviario subì invece un forte rallentamento. Si preferì infatti sfruttare al massimo il materiale esistente e impiegare le industrie e i capitali nelle lavorazioni necessarie allo sforzo bellico. La produzione del materiale rotabile ferroviario fu in quegli anni la seguente:
Tabella 27
La carenza di nuove costruzioni non mancò di far sentire il suo peso e rese più difficili e faticosi i trasporti. « Numericamente le FF.SS. entrarono in guerra con 5.047 locomotive e ne escono con 5.207. Il materiale è tuttavia invecchiato, l'età media della locomotiva a vapore FF.SS. è salita dai 14½ anni del 1914 a 16 anni nel 1918. Il materiale dà, col durare della guerra, malgrado le sforzate cure di manutenzione, un evidente accenno di stanchezza al termine della stessa » ( 59 )

Venne invece fortemente sviluppata, partendo praticamente da zero , la produzione di materiale per ferrovie a scartamento ridotto Décauville .
Nel 1917 era in servizio un'ampia rete che permise in quell'anno il trasporto di 888.977 tonnellate con l'impiego di ben 156.145 treni, per un percorso medio di 11 ,2 Km. In seguito al ripiegamento al Piave, si dovette abbandonare gran parte della linea.
Sulle posizioni raggiunte fu però costituita un'altra rete con nuovo materiale. Attraverso queste reti furono trasportate nel corso del 1918, 715.713 tonnellate di materiali con l'impiego di 127 .333 treni con percorsi medi di 9,2 Km. Alla fine del conflitto le linee a scartamento ridotto approntate dagli Italiani avevano raggiunto un'estensione complessiva di 800 chilometri ed avevano richiesto la posa complessiva di 3.000 chilometri di binario (60 ).
Queste linee ferrate in miniatura erano servHe da 300 locomotive e da ben 10.000 veicoli (esclusi i carrelli per il trasporto della terra) (61 ).
L'industria cantieristica italiana, nonostante l'estrema necessità di disporre di un gran numero di navi, non fu particolarmente potenziata, come risulta dai dati relativi alle costruzioni navali:
Benché il diminuito rapporto tra il numero delle unità e il tonnellaggio dimostri che ci si stava orientando verso la produzione di unità di lungo corso, lo scarto tra il naviglio varato durante la guerra e quello sceso in mare negli ultimi quattro anni di pace è molto modesto. Si tratta infatti di 39.479 tonnellate di più, che, rispetto alla necessità di naviglio determinatasi nel corso della guerra, sono irrilevanti. A determinare questa situazione non fu certo la capacità degli impianti, ma oltre alla carenza delle materie prime, vi fu il fatto che l'attrezzatura cantieristica fu molto impegnata per effettuare riparazioni di naviglio nazionale ed alleato. I dati seguenti si riferiscono ai giorni di permanenza in cantiere delle navi in riparazione:
Anche le industrie dell'ottica e della meccanica di precisione potenziarono considerevolmente la loro produzione in seguito alle commesse militari.
Considerando il panorama dello sviluppo complessivo delle industrie meccaniche italiane nel corso della prima guerra mondiale, non si può che convenire con quanto ha scritto il Romeo: « Si può dire veramente che solo con la guerra l'Italia abbia visto il nascere di una industria meccanica di dimensioni adeguate all'apparato produttivo nazionale, e anzi, eccedente in larga misura i bisogni della produzione di pace» (64 ).
Oltre alle industrie siderurgiche e meccaniche, anche l'industria chimica conseguì, negli anni della guerra, un forte sviluppo. E necessario tener presente che fino allo scoppio del conflitto il mercato italiano era in questo settore dominato dall'industria tedesca. Negli anni della guerra quindi le imprese chimiche italiane si trovarono in una particolare situazione di favore per svilupparsi; tuttavia, per le carenze delle materie prime, fu necessario anche in questo campo contrarre alcune produzioni per poterne sviluppare altre. « Ridotto il consumo di sapone per usi civili e quello dei concimi chimici, la produzione d ei perfostati

cadde da 925.000 tonnellate nel 1914 a 432.000 nel 1918, e quella della calciocianamide da 15.500 tonnellate nel 1914 a 7.000 nel 1918; e si dovette invece fronteggiare la larghissima domanda di esplosivi e dei relativi elementi, accrescere la produzione di medicinali, moltiplicare quella dell'idrogeno e dell'ossigeno (il quale ultimo passava da 712.500 mc. prodotti nel 1914 a 2.960.000 mc. nel 1918) » (65 ). Nonostante il concentramento degli sforzi nel settore degli esplosivi la carenza di materie prime incise pesantemente sulla capacità produttiva delle industrie italiane del settore. Per quanto riguarda gli esplosivi da lancio « di fronte a un fabbisogno mensile di balistite che mediamente fu di poco inferiore alle 3.000 tonnellate, la produzione nazionale non raggiunse neppure le 2.000 tonnellate» {66 ). « P er l'esattezza, la capacità produttiva degli stabilimenti italiani assommava a 1.750 tonnellate mensili; tali risultati costituivano però la potenzialità massima visto che "in genere" non furono neppure raggiunti » ( 67 ). « Per sopperire alla carenza di materie prime si dovette ricorrere largamente all'aiuto degli alleati». « Il problema della cellulosa fu da noi risolto con importazione, essenzialmente dall'America, di cascami di cotone e di linters (fibre corte di cotone) » ( 68 ).
Notevoli difficoltà presentò anche« l'approvvigionamento delle altre materie prime organiche necessarie alla fabbricazione degli esplosivi appartenenti alla serie degli idrocarburi aromatici (prodotti dalla distillazione del carbon fossile) e comprendenti inoltre la glicerina e l'acetone» (69 ). Minori difficoltà incontrò invece l'approvvigionamento degli acidi. « Per la nostra forte disponibilità di piriti di zolfo, fu possibile preparare acido solforico in gran copia sia col vecchio processo delle camere di piombo, sia col processo più recente di sintesi dell'anidride carbonica» (1°).
Riguardo all'acido nitrico si riuscì più che a quadruplicarne la produzione ( 71 ). Infatti, « la produzione bellica mensile media di acido n itrico è stata di oltre 70.000 quintali in confronto ai 15 .000 antebellici » (7 2 ).
La carenza delle altre materie prime necessarie all'approntamento delle cariche fu però tale che non permise, per un lungo tempo, che la capacità di caricamento dei proiettili eguagliasse quella di produzione e nello stesso 1918, quando la situazione era decisamente migliorata, con un fabbisogno previsto di 3.850 tonnellate mensili « l'industria nazionale e il rifornimento dall'estero di esplosivi vari poterono provvedere a circa 3.600 tonnellate di esplosivo lasciando insoddisfatta la residua domanda di 250 tonnellate » (7 3 ).
Per gli esplosivi di scoppio, nonostante si fossero introdotti

esplosivi al nitrato di ammonio, ai clorati e perclorati in sostituzione del tritolo, la cui produzione abbisognava di materiali in gran parte importati, non si poté sopperire con la produzione nazionale alle necessità della guerra. Infatti nel 1918, su una richiesta di 6.600 tonnellate mensili di esplosivo, l'industria italiana fu in grado di produrne solamente 2.900 in media. Si dovette quindi ridurre il programma di costruzione dei proiettili d'artiglieria e contemporaneamente ricorrere all'importazione dai Paes i alleati. La produzione totale degli esplosivi ( di lancio e di scoppio) effettuata in Italia negli ultimi anni di guerra è illustrata dalla seguente: Tabella 30
Se si considera che dal gennaio 1917 al giugno 191 8 la pr~ duzione era pressocché raddoppiata, non si potrà fare a meno di constatare quanto sia stato grande lo sforzo dell'industria italiana nel settore. Tuttavia bisogna rilevare che, nonostante i risultati raggiunti, si era ben lontani dal soddisfare le richieste del Comando Supremo che assommavano nel 1918 a 10.250 tonnellate di esplosivo mensili. I programmi di munizionamento furono, forzatamente, ridotti; nonostante ciò si dovette ricorrere massicciamente alle importazioni di esplosivi dall'estero. Per avere un'idea dell'importanza di questi aiuti ottenuti dagli alleati, si consideri che nel 1918 poco meno della metà dell'esplosivo di scoppio impiegato in Italia era stato importato ( 75 ).
Per quanto riguarda gli aggressivi chimici, ne furono prodotti in Italia complessivamente 13.000 tonnellate, in gran parte cloro e fosgene, benché nell'ultimo anno di guerra l'esercito italiano disponesse di granate all'iprite. Questa era di provenienza francese per la quasi totalità, poich é la produzione su larga scala di questo gas iniziò in Italia solo poco prima dell'armistizio. Oltre al cloro ed al fosgene, l 'industria italiana produsse anche piccole quantità di gas lacrimogeno (76 ).

Successi ben maggiori furono fortunatamente conseguiti dall'industria ch imica italiana nel campo dei medicinali, settore in precedenza controllato dall'industria germanica e in cui si riuscì a far fronte, sia pure non senza sforzo, alle richieste provenienti dal Paese e dall'esercito. Per quel che riguarda l'industria della gomma, si è in precedenza fatto cenno a ll a notevolissima quantità di pneumatici acquistati nel corso della guerra dall'amministrazione militare.
Tali commesse non esaurirono tuttavia le capacità produttive dell'indus t ria italiana, nonostante questa dipendesse totalmente dall'importazione per quanto riguarda le materie prime:
Tabella 31
La contrazione delle esportazioni di pneumatici dopo il primo anno di guerra, nonostante il progressivo aumento delle importazioni di gomma greggia, è da mettersi in relazione con l'aumento della domanda interna, cosa di cui ci si rende facilmente conto se si considerano le cifre relative al progressivo aumento della motorizzazione militare.
Per quanto riguarda le industrie conciarie e delle ca lzature, esse dipendevano per gran parte delle materie prime provenienti dall'estero; la produzione delle calzature, che al giugno 1915 era di 395.000 paia al mese, fu portata nel settembre 1916 a 810.000. Nonostante questo aumento, fu necessario importare grossi quantitativi di scarpe già pronte per coprire una richiesta m ensile che era circa di un milione di paia ( 78 ).
Il commercio con l'estero in questo settore, in quegli anni, è contraddistinto da grosse importazioni sia di materie prime che di prodotti finiti ; eccone i dati alla tab. 32.
Dai dati risulta come, sia pure lentamente e con l'utilizzazione di una grande quantità di materia prima di importazione, l'industria italiana delle calzature si avviasse a fronteggiare il fabbisogno nazionale; infatti l'importazione di scarpe già confezio-

Anno Pelli gregge e salate Pelli conciate Paia di scarpe importaz. esportaz. importaz. importaz.
nate, dopo la massima espansione raggiunta nel 1916, tende a contrarsi rapidamente, per il progresso conseguito dalla industria italiana nel settore.

L'indu stria cotoniera si trovava, allo scoppio della guerra, in una crisi di sovrapproduzione. Le condizioni particolari create dal conflitto d eterminarono la risoluzione di questa crisi. Si verificò infatti una contrazione dell'importazione di tessuti e filati esteri cd un forte in cremento dei consumi interni. « Questo consumo fece assorbire rapidamente gli stoks accumulati e sollecitò la produzione che, specialmente nei primi due anni di guerra, si riaccese anche per il fatto che le importazioni di materia prima si potevano effettuare senza eccessiva difficoltà » ( 80 ).
L'industria cotoniera fu anch'essa vittima della guerra sottomarina illimitata intrapresa dalla Germania, come risulta dai seguenti dati:
Come si vede, con il 1917 le importazioni , e quindi la produzione, si contraggono. Degno di nota è il fatto che sebbene la produzione di quell'anno fosse scesa al di sotto della media prebellica, gli utili dichiarati dalle industrie del settore furono del 12,77 % mentre quelli del 1914 erano stati dello 0,94 % ( 82 ).
Questo fatto non deve sorprendere; infatti le commesse militari, che per il solo vestiario furono pari al 16% della intera produzione del periodo, avevano fatto aumentare la domanda provocando un aumento dei prezzi.
Anche nel settore laniero vi fu una notevole espansione « stimolata dalla domanda interna quasi triplicata, ma allargatasi anche all'esportazione » ( 83 ).

Tuttavia l'industria laniera, come quella del cotone, dipendeva in gran parte dalle importazioni per le materie prime; la produzione nazionale di lana grezza era infatti paurosamente insufficiente. Si pensi che« nel 1917, mentre il fabbisogno era stato preventivato in circa 500.000 quintali, di cui 340 000 per l'esercito e 160.000 per la popolazione civile, la produzione di lana lavata si contenne in quintali 68.000 e nel 1918 per quintali 55.000 » ( 84 ).
Fu quindi necessario ricorrere all'importazione di lana greggia e di semilavorati nella misura seguente: Tabella 34
La produzione di tessuti di lana come quelli di cotone subì una riduzione in seguito all'offensiva sottomarina germanica, come è evidenziato dai dati sull'esportazione e l'importazione dei panni di lana:
Il crollo delle esportazioni fu conseguenza dell'emanazione di norme che vietavano di espo rtare tessuti di lana. Nonostante questo provvedimento la situazione produttiva si aggravò ulteriormente. « Negli ultimi mesi del 1917 le difficoltà dei trasporti e delle importazioni, nonché la limitazione della forza motrice agli stabilimenti industriali, ridussero, per esempio, la produzione dell'industria laniera ad un terzo di quanto era necessario ai rifornimenti. Nel maggio 1918 erano inattivi decine di stab ilimenti, molti dei quali importanti, per mancanza di materie prime, ferme nei porti di sbarco per deficienza di mezzi di scarico e di trasporto. Nel luglio 1918 la crisi dei rifornimenti di vestiario, specie degli oggetti di panno e di tela, venne ad accentuarsi; le cause principali erano sempre: la deficienza di materia prima, le difficoltà dei trasporti, e, per alcuni generi, la scarsa efficienza di impianti e di mano d'opera nelle industrie » ( 87 ).

Nonostante ciò, « l'industria nazionale soddisfece quasi completamente alle richieste dell'ese rcito dal punto di vista quantitativo» ( 88 ). Le imprese italiane non si limitarono a questo ma approfittarono della guerra per colmare lo svantaggio che le separava dalle industrie estere dello stesso setlore. Infatti, mentre precedentemente alla guerra l'Italia dipendeva quasi completamente dall'estero per i tessuti pettinati, nel corso del conflitto l'industria italiana si pose in grado di fornire all'esercito ben 45.830.000 metri di questi tessuti ( 89 ).
Gli jutifici trassero grande vantaggio dalla guerra fornendo con facilità , data la larga disponibilità nazionale d elle materie prime, i 271 milioni di sacchi a terra e i 56.303 mq. di tela juta richiesti dall'amministrazione militare (90 )
Le cose non andavano però altrettanto bene nel settore dell'industria serica, nel quale « la guerra aggravava la crisi della trattura , dove le bacinelle si ridussero del 20 % e la produzione di seta greggia da 4.479 tonnellate nel 1914 precipitò a 2.134 tonn ellate nel 1919, nonostante qualche progresso nella tessitura e nella tintoria, dovuto, quest'ultimo alle nov ità prodottesi nell'industria chimica nazionale » (91 ).
Una delle novità realizzate dalle imprese chimiche italiane era s tata la creazione di fibre sintetiche che avevano preso il nome di « seta artificiale»; la produzione su vasta scala dei nuovi filati non aveva potuto fare a meno di danneggiare le tradizionali attività seriche.
L'industria dei materiali da costruzione non ebbe un grande sviluppo negli anni del conflitto. La carenza di mano d'opera arrestò quasi del tutto l'industria edilizia. Nello stesso periodo la
richiesta di materiali da costruzione da parte dell'esercito fu la seguente:
Mattoni
Cemento a lenta presa
)) a presa rapida
Calce idraulica e comune
50.000.000
1.579.900 quintali
754.000
786.000 )) )) (92)
Questa modesta domanda non poteva certo da sola incentivare la produzione, visto che la capacità produttiva nazionale era di 10 milioni di quintali annui di cemento, mentre quella della calce si aggirava intorno ai 14 milioni di quintali ( 93 ).

La domanda provocata dalle esigenze militari fece aumentare tuttavia la produzione di altri materiali da costruzione. Furono richieste dalle necessità dell'esercito 1.935.200 mq. di Eternit e 6.815.450 mq . di cartone incatramato; in qualche caso, come per il feltro catramato, di cui furono impiegati 1.360.400 mq., nell'insufficienza della produzione nazionale, si dovette ricorrere all'importazione. Ebbe anche enorme espansione, nel corso della guerra, l'industria del legno: per le sole necessità dell'esercito occorsero 2 225.500 metri cubi di legname da costruzione e 11.000.000 di metri cubi di legna da ardere ( 94 ).
Anche sul mercato interno per la diminuita disponibilità di carbone, la legna da ardere fu largamente impiegata. L'aumentata richiesta di legname si tradusse, purtroppo, in ampi e non sempre razionali disboscamenti e ciò, anche se non immediatamente, non avrebbe mancato di avere un'influenza negativa sul patrimonio boschivo e sulla sistemazione idrologica del Paese.
Considerando complessi vamente lo sforzo bellico italiano esso appare senza dubbio notevolissimo; tuttavia per valutarlo a pieno è indispensabile raffrontarlo a quello degli altri Paesi belligeranti. L'esame della tab . 37 consente di comparare la produzione degli armamenti per l'esercito francese e italiano.
Come si vede l'Italia appare nettamente surclassata. Non sarà male però ricordare che la produzione di guerra francese iniziò un anno prima rispetto a quella italiana, che la Francia disponeva già prima della guerra di una grande industria degli armamenti, infine va rilevato questo elemento fondamentale: che la potenzialità industriale francese anteguerra era ben altra in
confronto a quella italiana. Bisogna considerare infatti che, nel biennio precedente al conilitto, la media della produzione di ghisa in Francia era di 4.600.000 tonnellate contro le 400 .000 italiane e ch e nello stesso periodo si producevano oltral pe 3.500.000 tonnellate d'acciaio contro le 900.000 dell'Italia ( 96 ). Considerando questi punti di partenza e le difficoltà per l'approvvigionamento delle materie prime si comprende quanto, nel complesso, sia stato notevole lo sforzo industriale italiano nel cor so della prima guerra mondiale.
(l) Cfr. R. ROMBO: Breve storia della grattde industria i1t Italia, Bologna 1967, p . 237. dati sono in milioni di lire.

(2) Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari: Dati e notizie relative alla situai.ione e all'impiego del tonnellaggio naziouale ed estero sorto il co11trollo italiano ed al traffico marilltmo di importazione. (Citato da qui innanzi come Dari e notizie), Roma 1919, tabelle 7-9.
(3) C. ROSTAGNO: Lo sforzo i,idustriale dell'Italia cit., marzo 1927, p. 381.
(4) B. FAYU!: Il traffi co maritrimo, Roma 1931, voi. II, p. 345.
(5) cfr. L. EINAUDI: La questione del carbone ed il porto di Genova, in • 11 Corriere della Sera• del 12 1.1916.
(6) L. ErNAtiD1: La condorta economica, cit., p. 149.
(7) Secondo calcoli dell'Einaudi, già sul primo aumento i noli ed i premi assicu· rativi avevano influito per ben 75 lire su 160 L. Enu\11>1: La questione del carbone, cit .,
(8) J.A SALlEl: Il controllo i11tcralleato del traffico marircimo, Torino 1938, p. 8.
(9) C.E. FAYLB: op clt.: p. 372.
(10) Dati e notìzle cit.: tabella I. Le perdite si riferiscono al periodo 31 dicembre 1914, 1 luglio 1919.
(11) Ibidem.
(12) L. E1muo1: La condotta economica, cit.: 81.
( 13) Cfr. R. ROMEO: op. cit., p. 234. I dati sono in milioni di KWh
(14) L Enuuor: La condotta eco nomica, op. cit., p. 153.
(15) V. FRANCHJNI : La Mobilita zione , cìt., p. 189.
( 16) I dati, espressi in tonnellate, sono desunti da V. FRANClllNI in La mobilitatlo· ne , cit., p. 190 e da R ROMEO: op. cit., p. 217 ss
(17) Cfr. V FRANCHINl: La Mobilitazione , op. cit., pp 193-195.
(18) L EINAUDI: La co11do11a economica, cit. , p 155.
( 19) Dati e 1101itie, cit., pp. 13-15.
(20) Si consideri che secondo i dati di fabbricazione dell'epoca erano necessari 9,8 Kg. di acciaio per la costruzione di un proiettile di piccolo calibro, 45,3 Kg. per un colpo di medio calibro e 255 Kg. per uno di grosso calibro. Cfr. C Gel.OSO: Produzione, rifornimento e consumo di munizioni per artiglieria durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, in « Rivista d'Artiglieria e Genio•, marzo-aprile 1918, p. 7 dell'estratto.
(21) Ibidem, p. IO.
(22) Cfr. V. FRANCHINI: La Mobilitazione , cit. , p. 196 e R. ROMEO: op. cit., p. 227.
(23) R. ROMEO: op. cii., pp. 117-118.
(24) V. F'RAKCHINJ: La Mobilitazione ...• cit., p. 197.
(25) C. Gaoso: art. cit., p. 30-31.
(26) Ministero della Guerra: I rifornimenri dell 'eserci to mobilitato durante la guerra alla fronte italiana, (1915-1918), Roma 1924, p. 238.
(27) c. GELOSO: art. cit., p. 21.
(28) Cfr V. FRANCHINI: op. cir., p. 193. I dati sono in migliaia di tonnellate.
(29) C. Gm.oso: art. cit., p. 13.
(30) C. Gm.oso: art. cit., pp. 14-15.
(31) C. MoNTtl: Storia dell'artiglieria italiana, Roma 1934-1955, voi. XI, pp. 643-644.
(32) Ibidem, voi. X, p. 558.
(33) Ibidem.
(34) Ibidem, voi. XI, pp. 647-650.
(35) R. ABATE: Storia dell'aeronautica italiana , Milano 1974, p. 139.

(36) C. Mo~Tù: op. cit., voi. XI. pp. 681-682.
(37) A.C.S. Ministero Armi e Munitioni b. 16. Promemoria in data 10.10.1918, dell'Ufficio dati e statistiche: « Programmi d'armamento per il 1919 •.
(38) Ibidem.
(39) Ibidem. Vedi anche l'allegato alla lettera 335 R.V. dell'Ispettore Superiore Tecnico in data 1 ottobre 1918.
(40) ibidem. « Programmi d'armamento per il 1919 •, cit..
(41) R. Ro~mo: op. cit., p. 119
(42) R.U.I. voi. I (narrazione), p. 89
(43) I dati relativi alla produzione delle armi sono desunti da C. MoNTù: op. cit., voi. X, pp. 556-558 e voi. XI, pp. 640-642 e 680.
(44) La leggenda dei 600 cannoni diffusa dagli autori vicini all'Ansaldo ed ai Ferrone viene, purtroppo, accettata pressocché da tutti. la realtà dalle carte Dallolio risulta chiaramente che tulio il materiale prodot10 dall'Ansaldo era stato in precedenza regolarmente commissionato. Le particolari condizioni di commozione nazionale del novembre 1917 permisero un lavoro particolarmente intenso (vedi allegato n. 7) nulla di più. Gli unici pezzi prodotti in eccedenza rispetto alle ordinazioni furono gli obici da 105 che però risultarono un fallimento. Fu probabilmente per ottenere che il Ministero si addossasse la totalità del costo di questo fallimento che il 3 gennaio 1918 Perrone scrisse a Dallolio per avvertirlo che non avrebbe più potuto costruire nuovi pezzi senza nuove commesse come sosteneva di aver fatto fino ad allora. Il Presidente dell'Ansaldo aggiunse poi: « Gli uffici tecnici dipendenti da V .E. possono facilmente, quando lo vogliono, controllare l'esattezza di queste nostre affermazioni; basterà che contino i cannoni in lavorazione nelle nostre officine per constatare che il loro numero supera quello dei cannoni ordinatici •. Era un invito temerario con un uomo come Dallolio che Perrone avrebbe dovuto conoscere meglio. Infatti il 20 iennaio, rispondendo alla leltera del 3 e ad una successiva offerta, il Ministro comunicò l'es110 della indagine in base alla quale gli unici materiali costruiti in eccedenza sulle commesse erano appunto gU obici da 105. (Per tutta la vicenda vedi gli allegati: 8, 9, 10).
(45) vedi allegato n. 7.
(46) c. MONTll: op. cit., voi. Xl, p. 637.
(47) Ministero della Guerra: Alcuni dati sulla prima guerra mondiale 1915-1918, Roma 1935, p 29. Le cifre comprendono sia i materiali presso le truppe, sia quelli conservati nei magazzini.
(4S) Minlstero della Guerra: / rifornimenti , cit p. 238.
( 49) A.C.S. Ministero Armi e Munizioni b. 16, lettera e promemoria citati.
(50) A. P uGNANI: Storia della motorizzazione militare italiana, Torino 1951, p. 245.
(51) Ibidem.
(52) Si noti che su 43.390 autoveicoli ben 37.019 furono fomìti dalla FTAT. Cfr. A. PUGNANI: op. cit., p. 244.
(53) Ibidem: pp. 246-248.
(54) Cfr. c. ROSSAGNO: arr. cir., gennaio 1927, p. 49.
(55) R. ABATE: op. cit., p. 138. Da questa opera sono ricavati anche i dati relativi alla produzione aeronautica.
(56) Ministero della Guerra: I rifornimenti, cit., pp. 263-265. Le armi elencate sono in più di quell.e costruite per conto dell'esercito i cui dati sono stati forniti in precedenza.
(57) c. ROSTAGNO: art. cii., rebbralo 1927, p. 247.
(58) Cfr. R. ROMEO: op cii., p. 229.
(59) P. LAINO: Le ferrovie italiane nella guerra italiana 1915-1918, Roma 1928, p. 87.
(60) Ibidem: pp. 100, 105.
(61) Ministero della Guerra: I rifornimenti, cit., p 254.
(62) Cfr. R. Ro>.tllO: op. cit., p. 228.
(63) C. MoSTù: op. cii., vol. XI, p. 680.
(64) R. ROMEO: op. cii., p. 119.
(65) Ibidem: p. 120
(66) C. Moi.'Ttl: op. cii., voi. Xli, p 347.
(67) C. PlrrRA 01 CACCUlu: T.'industria degli esplosivi in Italia durante la guerra e la loro Lllilizza zione nel dopoguerra, in • Rivista di Artiglieria e Genio•, settembre 1923, p. 216.
(68) c. MONTt/: op. cit., voi. XII, p. 347.
(69) V. FRAscm.'-1: La Mobilitazione, cir., p. 214.
(70) C. Moi.--rù: op. cit., voi. XII, p. 247.
(71) V. FRAXCffiNI: op. cii., p. 214.

(72) c. Pl!TRA DI CACCVRI: art. cit., luglio-agosto 1923, p. 119.
(73) V. FR.U,CHINI: op. cii., p. 214.
(74) C. Pl!TRA DI CACCI.JlU: art. cit., settembre 1923, p. 247.
(75) Cfr. C. MoNTCl: op. cit., voi. X, p. 562.
(76) 1bidem: voi. XI, pp. 636-641.
(77) I dati sono io migliaia cli quintali e sono tratti da C. RosTAGNO: art. cit., febbraio 1927, p. 280.
(78) Camera dei Deputati: Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta per le spese di guerra, Roma 1923, (citata d'ora innanzi come Commìssione Parlamentare), voi. II, p. 557.
.
(79) I dati sono io migliaia cli tonnellate e sono desunti da C. MoSTù: op. cii., ~ol. Xi, p. 728.
(80) V. FRANCIJJ!\L: La mol,ititazione , cit., p. 217.
(81) I dati sono in migliaia di quintali. Cfr. C. ROSTAGNO: op. cii., febbraio 1927, p. 268. Vi era una minima esportazione di cotone in bioccoli ed una piccola importa· ziooe di filati entrambe di scarsissimo rilie\'o.
(82) R. ROMEO: op. cit., p. 116.
(83) Ibidem, p. 120.
(84) V. FRA.NCHINI: La mobilitatione, cit., p. 220.
(85) I dati sono in migliaia cli quintali. Cfr. C. ROSTAGso: op. cit., febbraio 1927, p. 270.
(86) Cfr. ibidem, p. 271. I dati sono in quintali.
(87) Mlolstero della Guerra: Statistica dello sforzo militare italiano nella guerra mo11diale: I servizi logistici, a cura di F. Zugaro e R. Ratiglia, Roma 1929, pp. 278-279.
(88) V. FltANCRJNI: op. cit., p. 223.
(89) Cfr. c. ROSTAGNO: op. cii., febbraio 1927, pp. 271-273.
(90) Ibid em, p. 275.
(91) R. Ro~lEO: op. cit., p. 120.
(92) V. FRA.,,;CJum: op. cit., p. 224.
(93) Ibidem, p. 225.
(94) Cfr. c. MoNTCl: Op. cii., voi. XI, p. 729.
(95) I dati relativi alla produzione di armi italiane sono riassunti dalle pagine precedenti, queUi francesi provengono dalla nota Idee generali sulle fabbricaz.iom di guerra in Francia e sui loro rapporti cou la nawra della guerra, pubblicata dalla • Rivista d'Artiglieria e Genio • nel m:irzo del 1923, pp. 134-138.
(96) R. ROMEO: op. cit., pp. 115-116.
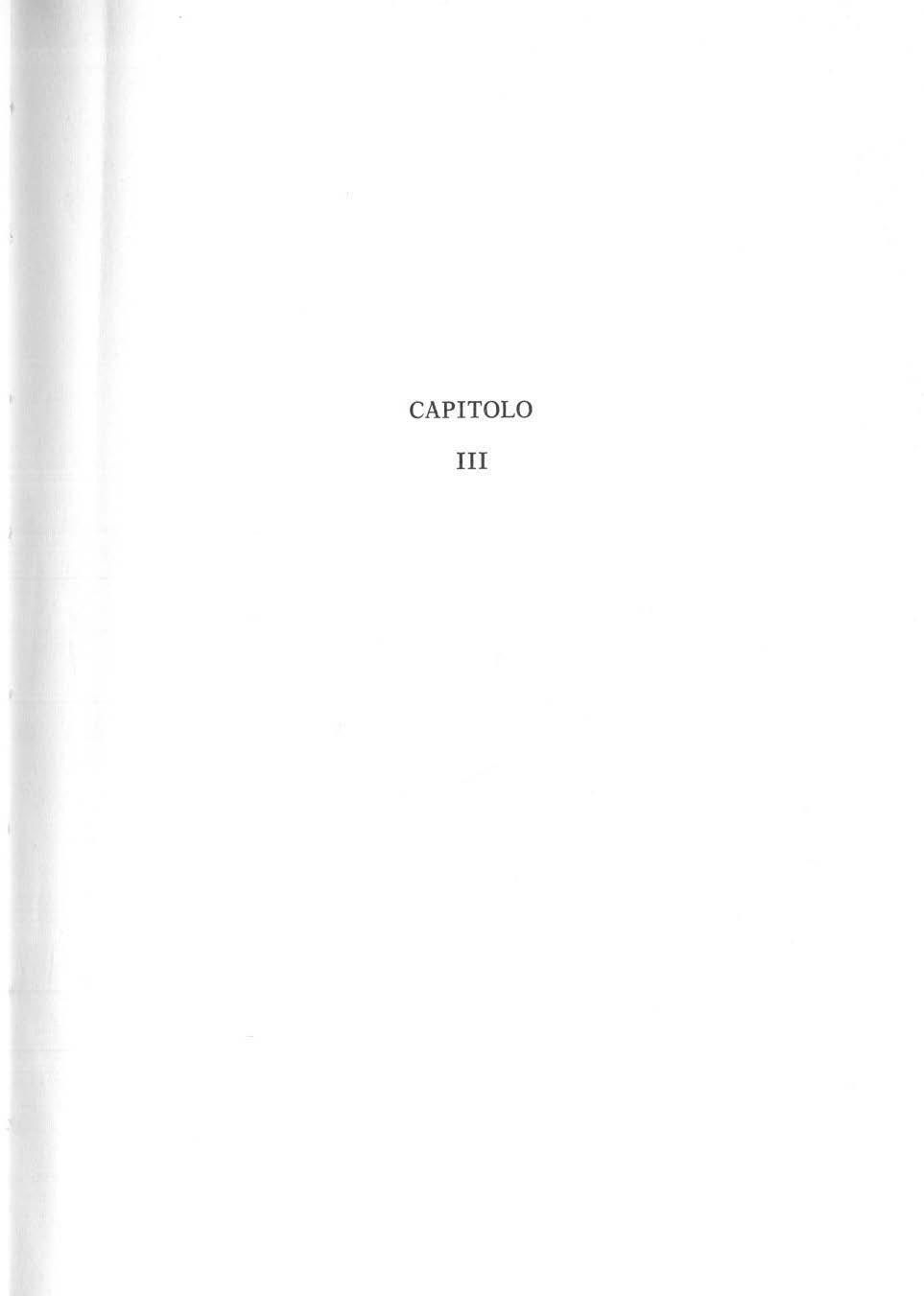
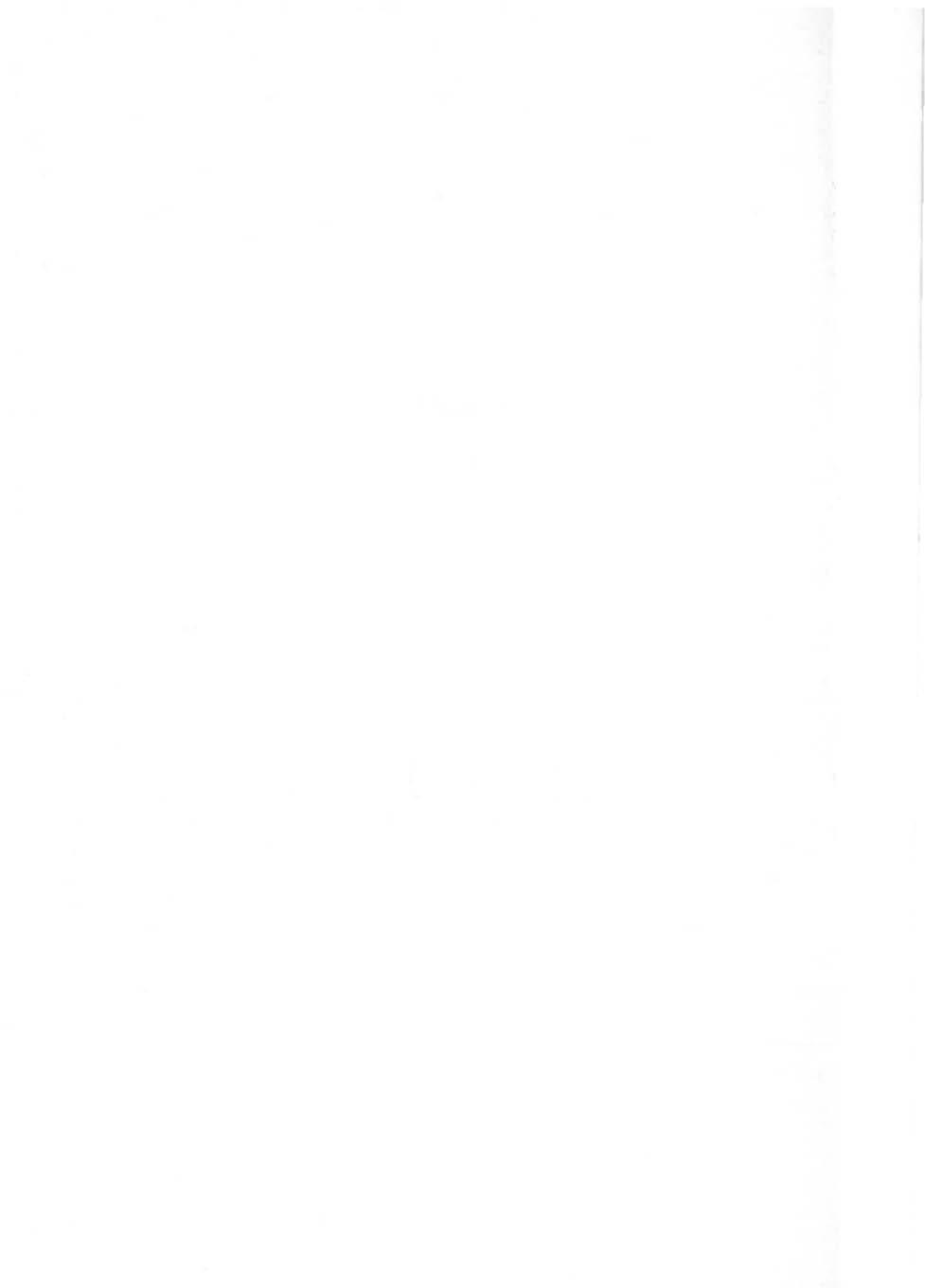
L'Italia, come altre nazioni europee, possedeva già prima dello scoppio del conflitto una vasta gamma di stabilimenti militari. Questa situazione non derivava soltanto dal perpetuarsi di vecchie strutture in buona parte risalenti al periodo pre-unitario, ma rispondeva anche a considerazioni di estrema attualità. Si riteneva, infatti, non senza qualche fondamento, che sarebbe occorso un certo tempo prima che tecnici e maestranze dell'industria privata acquistassero l'esperienza necessaria alla produzione dei vari e complessi materiali necessari all'esercito. Bisogna considerare, come già abbiamo accennato, che dopo il 1870 si era andata formando in tutti gli Stati Maggiori europei la convinzione che un'eventuale guerra continentale sarebbe stata di rapidissima risoluzione.
All'epoca della guerra russo-giapponese non vi era commentatore che, dopo aver oservato l'andamento delle manovre dei contendenti su vasti spazi, non si sentisse in dovere di precisare come, in caso di un conflitto europeo, la celerità delle operazioni sarebbe stata di gran lunga maggiore in considerazione della migliore rete stradale, della grande ampiezza dei trasporti ferroviari , della maggiore disponibilità di artiglierie. Tutto ciò avrebbe dovuto rendere gli scontri più rapidi e decisivi. Si sarebbe trattato, in definitiva, di una guerra combattuta in gran parte dall'esercito peQ:nanente contando soprattutto sulla disponibilità dei materiali di mobilitazione tempestivamente aumentati dall'incessante lavoro degli stabilimenti militari. In realtà proprio l'impiego strategico delle ferrovie e la grande disponibilità di artiglierie ed armi automatiche, uniti alla mobilitazione di milioni di uomini, favorì le azioni difensive e la stabilizzazione dei fronti. Infatti, il trasporto ferroviario permise al difensore di spostare truppe nei punti minacciati rintuzzando le offensive dell'attaccante le cui truppe avanzanti, muovendosi a piedi, erano molto più lente di quelle che viaggiavano in ferrovia. L'aumentata capa-

cità distruttiva delle armi facilitò il compito della difesa permettendo di arrestare col fuoco il movimento avversario . La mobilitazione di grandi masse permise al difensore di disporre sempre di riserve sufficienti e infine fece sì che il fronte di battaglia venisse s aturato rendendo impossibile qualsiasi manovra avvolgente.
La realtà della guerra, così diversa dalle previsioni, costrinse tutti gli Stati che vi presero parte a compiere un enorme sforzo impiegando tutto il proprio potenziale industriale. Ovviamente gli stabilimenti militari furono i primi ad essere impegnati nella produzione.
Il gruppo più importante degli impianti militari italiani interessati alle costruzioni belliche fu, senza dubbio, quello delle costruzioni d'artiglieria. Il numero degli stabilim enti, già alquanto esteso, non aumentò nel corso del conflitto, ma gli impianti stessi conobbero un grande ampliamento e la produzione fu enormemente aumentata. Fu infatti fabbricata dagli enti militari, la totalità dei fucili e moschetti 91 (officina di Roma 244.377 fucili, fabbrica di Brescia 534.000 mosch etti più 5.131.000 parti di fucile, ed il resto dalla fabbrica di Terni); furono ricalibrati
709.768 fucili 70/87 (officina di Roma); anche gran parte delle mitragliatrici italiane furono costruite dagli stabilimenti militari (24.879 dalla fabbrica di Brescia), notevole fu anche il contributo neJla costruzione, ma soprattutto nell'allestimento e completamento, dei pezzi d'artiglieria (officina di Torino, arsenali di Torino e di Napoli, direzioni d'artiglieria di Torino, Piacenza, Venezia, Genova, Roma). L'organi zzazione militare provvide anche alla costruzione di una quanti tà notevolissima di affusti e di altri materiali d'artiglieria (1). Per quanto riguarda il munizionamento i laboratori pirotecnici di Capua e Bologna provvidero a gran parte del munizionamento per le armi leggere; infatti per il solo fucile 91, la capacità produttiva giornaliera complessiva era di 2.450.000 cartucce complete. Nella fabbricazione delle spolette dei proiettili, delle cariche di lancio e di scoppio, anche se non così ril evante come per le armi leggere, l' attività degli stabilimenti militari fu notevolissima; oltre a ciò furono costruiti materiali di ogni genere . :E. da segnalare a tal proposito l'attività del laboratorio di precisione di Roma c he produceva anche per l'industria privata. Oltre alla produzione di materiali nuovi, va considerato che questi stabilimenti riparavano una quantità enorme di materiali danneggiati.
L'organizzazione delle costruzioni d'artiglier ia ebbe nel corso della guerra una notevolissima espansione; nel 1914 infatti

gli stabilimenti avevano un personale di complessivi 10.280 tra ufficiali addetti, impiegati ed operai. Nell'ottobre del 1918 la situazione del personale era invece la seguente:
Complessivamente quindi il personale degli stabilimenti d'artiglieria raggiungeva le 61.551 unità. Si era verificato, rispetto l'anteguerra, un aumento di oltre il 600% del personale imp egnato, con un incremento che non trova riscontro nelle imprese industriali private. Riguardo alla composizione delle maestranze operaie si conoscono i dati relativi all'occupazione femminile:

I dati si riferiscono ai mesi di agosto degli anni conside rati.
Come si vede l'incremento della mano d'opera femminile fu, percentualmente, molto superio re ( oltre il 1000%) a quello complessivo delle maestranze. Il che è ovvio in relazione alla carenza della mano d'opera maschile, creata dalla particolare situazione bellica.

Oltre che degli stabilimenti d'artiglieria bisogna tener conto, parlando dell'industria militare, dell'officina di costruzioni del genio di Pavia e di quella del battaglione specialisti del genio di Roma. L'officina di costruzioni di Pavia, nel periodo prebellico, costruiva artifìzi e attrezzi per minatori, equipaggi da ponte e carreggi del Genio. Nel corso del conflitto questo stabilimento produsse o mantenne in efficienza circa il 30% di tutto il materiale del genio occorrente in zona di guerra ( 4 ). Le officine del battaglione specialisti di Roma furono impegnate dapprima nella produzione di aerostati e, successivamente, in quella di materiali per gli aeroplani. Allo scopo di poter sopperire in breve tempo a svariate lavorazioni, vennero costituite, nel 1918, a Castenaso, presso Bologna, officine del genio alla diretta dipendenza dell'Intendenza Generale. Questi stabilimenti tra l'altro provvidero, in brevissimo tempo, alla costruzione dei 10 chilometri di ponte di tipo speciale occorrenti per l'offensiva finale italiana ( 5 ). Inoltre, col progresso della radiotelegrafia, si fece sentire la necessità di disporre di uno stabilimento specializzato; sorse quindi, a fianco del preesistente Istituto Radiotelegrafico Militare, l'Officina Costruzioni r.t. Questi stabilimenti nel comples so impiegavano circa 3.000 persone tra operai militari, borghesi e donne ( 6 ).
Oltre a questi enti, bisogna tener presente l'esistenza delle officine di riparazione di materiali del genio, costituite una per
ogni armata, oltre a quella dell'Intendenza Generale. Questi impianti non si preoccupavano soltanto di mantenere in efficienza le dotazioni, ma costruivano anche baracche, barche, apparecchi da ponte, carreggio vario ed anche altri materiali (7).

Il Servizio Automobilistico militare che, come abbiamo visto, ebbe un grande sviluppo nel corso del conflitto, disponeva di una propria organizzazione di officine di riparazioni.
Per le piccole riparazioni vi erano gli autoparchi che, al termine del conflitto, erano 9 ed impiegavano 4.000 operai-militari, la cui opera è illustrata dai dati seguenti :
Tabella 3 Anni
Vi erano anche 7 parchi trattrici con deposito laboratorio che impi e gavano 1.000 operai ( 9 ).
Per le grandi riparazioni, quelle cioè che necessitavano di oltre 75 giorni di lavoro, il Servizio Automobilistico disponeva di un deposit o centrale con sei stabilimenti di riparazione che impiegavano 3.300 operai, in gran parte militari, e che, nel corso della guerra, ripararono i seguenti materiali:
(10)
Non meno importante fu, nel corso della guerra, l'opera degli stabilimenti de l servizio di vettogliamento. Prima del conflitto erano in funzione: 26 panifici, 12 molini, 3 gallettifici, 2 stabilimenti per la produzione di conserve alimentari; 27 magazzini di distribuzione viveri; vi erano inoltre altri 26 panifici militari, chiusi ma predisposti ad entrare in funzione in caso di mobilitazione ( 11 ). La capacità di produzione giornaliera massima di questi impianti era la seguente: i panifici militari in funzione potevano produrre 764.440 razioni, quelli chiusi 446.480.
I mulini potevano macinare 3.370 quintali e i gallettifici confezionavano 535 quintali di gallette da 200 grammi (1 2 ).
« Durante la guerra nulla fu fatto per aumentare la capacità produttiva dei molini, la quale pertanto fu insufficiente per i crescenti bisogni militari. Tale insufficienza sarebbe stata ancora più forte se al posto del grano non si fosse importato dal1'estero, in quantità cospicua, lo sfarinato. Ad ogni modo si dovette ricorrere largamente al concorso di molini privati, adottando prudenziali misure per evitare qualsiasi sostituzione o adulterazione del grano durante la macinazione » (13 ). I mulini militari maciranono durante la guerra 3.765.464 quintali di grano, 73.850 di segala, 80.665 di orzo, 261.807. di riso, 13.603 di granone e 998 di fave ( 14 ). Nonostante si trattasse, nel complesso, di quantità notevoli non erano assolutam ente sufficienti, fu quindi l'industria privata a fornire la maggior parte (circa 1'80%) della farina occorrente ai bisogni dell'esercito ( 15 ).
Nel corso del conflitto furono prodotti in Italia 4.960.250.000 razioni di pane la cui produzione era stata così ripartita:

stabilimenti militari 4.542.774.000
impianti privati 417.476.000
Gli stabilimenti privati impegnati nella produzione di pane per l'esercito furono riforniti dall'amministrazione militare di circa i 2/3 della farina occorrente (16 ). La maggior parte delle razioni fu prodotta in zona di guerra dai forni da campo delle truppe e dai panifìici delle retrovie quali quelli di Edolo, Ala, Vicenza, Marostica, Mestre, Belluno, Palmanova, P ortogruaro, Latisana, Cervignano, Udine. La produzione dei panifici militari territoriali fu invece la seguente:
Tabella 4 Anni
1.006.831.000 (17)
Per quanto si riferisce alla produzione di gallette, i gallettifici di Torino, di Camigliano Ligure e di Foligno, già esistenti allo scoppio della guerra, si dimostrarono ben presto insufficienti, per cui fu necessario devolvere ai panifici militari anche la produzione di gallette. A questo scopo furono ampliati gli impianti o, come nel caso di Roma, furono affittati stabilimenti privati.
Anche così aumentata la capacità produttiva degli stabilimenti non riuscì a far fronte alle richieste e pertanto si fece ricorso, anche in questo campo, all'industria privata ( 18 ).

Nel corso del conflitto furono prodotti in Italia oltre 970.000 quintali di gallette di cui: in stabilimenti militari in stabilimenti privati
740.000 quintali
230.000 quintali ( 19 )
In quanto alla mano d'opera, fu impiegato nei mulini, panifici, gallettifìci militanti il seguente personale:
5
Nell'ultimo anno di guerra l'amministrazione militare requisì undici impianti per la produzione e lavorazione dei vini, trasformandoli in stabilimenti vinicoli militari che « ricevevano il vino di varie qualità e gradazione alcolica, acquistato o requisito dalle commissioni militari, per eseguire il taglio, allo scopo di ottenere un tipo unico del prescritto grado alcoolico (10%) » ( 21 ).
Questi impianti furono poi restituiti ai proprietari tra il 1919 ed il 1920 (22 ).
All'inizio del conflitto l'esercito italiano, se disponeva di una vasta rete di impianti per la lavorazione di cereali, non aveva, a differenza dei maggiori eserciti europei, nessuna possibilità di disporre di frigoriferi per la conservazione della carne congelata; pertanto « si dovette provvedere nei primi mesi della guerra al servizio carneo per le truppe mobilitate, con bovini nazionali che venivano concentrati in appositi parchi, sistema questo quanto mai costoso e deleterio per il profondo logorio del nostro patrimonio zootecnico » (23 ).
Si cercò, in un primo tempo, di servirsi degli impianti privati che risultarono insufficienti alle necessità militari. Fu decisa allora la costruzione di una serie di « frigoriferi militari» precisamente
Nel 1917 l'esercito ottenne la cessione, da parte della Marina, di due stabilimenti frigoriferi l'uno a Taranto, con una capacità di 1.000 tonnellate di carne, e l'altro a Venezia per 600 tonnellate ( 24 ). Con queste costruzioni, che supplivano alle carenze degli impianti privati, fu possibile disporre, nel 1918, di uno spazio frigorifero di mc. 60.000, sufficiente per 20.000 tonnellate di carne ( 25 ). L'amministrazione militare italiana, se all'inizio del conflitto non disponeva di impianti per la conservazione della carne congelata, aveva però predisposto efficacemente per la produzione della carne in scatola che, assieme allla galletta, costituì la classica razione viveri di riserva dell'esercito italiano. All'inizio del 1915 infatti era stato ultimato il grande stabilimento di Scanzano nei pressi di Foligno che, assieme a quello già esistente a Casaralta (Bologna), fornì la maggior parte della carne in conserva prodotta in Italia per i bisogni dell'esercito ( 26 ) A questi due stabilimenti si unì nel 1917 quello minore di Alghero di nuova costruzione. Questi impianti, che effettuavano il ciclo completo di lavorazione, dalla confezione delle scatolette alla spedizione del prodotto finito, raggiunsero livelli produttivi veramente notevoli, come dimostra il numero di scatolette prodotto negli anni della guerra:
Tabella 6
La produzione degli stabilimenti militari è senza dubbio d egna di nota, visto che su 245.481.230 scatolette di carne prodotte in Italia nel periodo 1915-1917 ( 28 ), 176.926.849 erano state prodotte da loro e solamente 68.454.381 dall'industria privata.

Gli stabilimenti militari produssero anche 799 838 flaconi di brodo concentrato pari a 14.400.000 razioni di brodo, 682.537.785 razioni di condimento in conserva, infine lo stabilimento di Casaralta preparò 184.700 lingue di bue e 12.300 lingue di suino (29 ).
« Quanto alla forza di lavoro, Casaralta si è servito, in media di 1.500 militari e 300 donne; Scanzano, che alla sua apertura im-
piegava 415 militari e 7 borghesi, ne impiegava rispettivamente 1.150 e 12 a cominciare dal luglio sino a tutto il maggio successivo (1916). Il 12 giugno di quest'anno, a seguito di un ordine di intensificazione della produzione, lo stabilimento ricevette un rinforzo di 600 militari. Il 13 ottobre dello stesso anno la maestranza borghese (donne) saliva a 402 e alla fine del mese a 692; i militari venivano contemporaneamente ridotti da 1920 a 1846 » ( 30 ). Sensibilmente inferiore era invece il numero delle maestranze del piccolo stabilimento di Alghero.
Il servizio di vestiario ed equipaggiamento dell'esercito italiano disponeva, all'inizio della guerra, dei seguenti impianti: 4 magazzini centrali vestiario ed equipaggiamento: un opificio vestiario ed equipaggiamento; 40 magazzini casermaggio di cui 27 principali e 13 succursali ( 31 ).
I magazzini centrali vestiario ed equipaggiamento erano organi di raccolta e di rifornimento ai depositi della rispettiva circoscrizione territoriale; avevano un organico di alcuni ufficiali, 70 operai di ruolo ed alcuni avventizi.
All'atto della mobilitazione i magazzini furono trasformati in stabilimenti di riserva viveri ed equipaggiamento con il compito di rifornire le unità territoriali e i reparti mobilitati oltre che dei viveri e del vestiario anche dei materiali di servizio generale e di cucina, della cancelleria, degli stampati ecc. La ripartizione degli oneri fu così stabilita: lo stabilimento di Torino doveva rifornire i depositi centrali di due armate, quello di Verona doveva essere a disposizione della Intendenza Generale, quello di Napoli doveva restare a disposizione del Ministero, mentre lo stabilimento di Firenze e quelli di nuova costituzione di Milano e di Alessandria dovevano rifornire ciascuno il deposito centrale di un'armata. Fu inoltre costituito a Roma un deposito di riserva vestiario ed equipaggiamento. Per far fronte a queste esigenze, organici ed impianti furono convenientemente ampliati ( 32 ).
A differenza di quanto avvenne in altri settori dell'industria militare, in cui si provvide ai bisogni di guerra con ampliamenti degli impianti esistenti, nel settore dell'approntamento del vestiario si procedette alla costruzione di numerosi nuovi stabilimenti. In effetti, prima della guerra esisteva il solo opificio militare di Torino che provvedeva alla fabbricazione di manufatti di vestiario, di equipaggiamento e di scarpe ( con una produzione massima giornaliera di 1.000 paia) e con una maestranza di 270 operai. Nel corso della guerra la capacità produttiva fu enormemente aumentata; allo stabilimento fu inoltre assegnato il com-

pito di recuperare calzature, zalill e tascapani fuori uso sgombrati dal fronte. In conseguenza dell'aumentato lavoro il numero degli operai fu portato a 500 unità in media. Per il servizio di riattamento dei materiali di vestiario e di equipaggiamento fu costituito un nuovo grande opificio vestiario ed equipaggiamento a Milano il quale, in un secondo tempo, provvide anche, oltre che al riattamento degli oggetti di vestiario, alla lavorazione di oggetti di lamiera e di ferro (borracce, gavette, marmitte, casse di cottura ecc.) .
Data la sempre crescente mole di lavoro fu necessario aggregare all'opificio laboratori privati con una maestranza complessiva di 28.000 addetti. « Una idea della mole del lavoro svolto dal detto opificio può trarsi da alcune cifre relative all'anno 1917: carri ferroviari ricevuti 4.214, carri ferroviari spediti 3.507, movimento di autocarri e carri ordinari 18.280, oggetti riattati: cappotti 294.806, mutande 419.254, pantaloni 195.285, gavette 565.197; oggetti confezionati: berretti 1.354.447, corregge di pantaloni in tela 1.122.183, sacchetti diversi 630.210 » ( 33 ). Per il riattamento del vestiario e dell'equipaggiamento furono inoltre costituiti numerosi opifici minori. L'opificio di Borgo Panigale (Bologna), sorto dalla trasformazione di un piccolo stabilimento per la disinfezione dei materiali ospedalieri, aveva una capacità di disinfezione e di riattamento di capi di vestiario di 250 quintali al giorno ed impiegava 650 operai tra civili (in gran parte donne) e militari.
L'opificio di Torre Annunziata (Napoli), il quale oltre che al riattamento dei materiali fu incaricato di confezionare oggetti di vestiario ed equipaggiamento, raggiunse una produzione giornaliera di 60 quintali di materiali disinfettati e 20 quintali di materiali lavati, riattando al contempo 500 capi di vestiario e 4.000 sacchi e impiegando 340 operai.
L'opificio di Modena fu incaricato dapprima di riattare calzature, zaini e tascapani, successivamente ebbe anche il compito di approntare i materiali di cuoio occorrenti ai laboratori della zona di guerra per la riparazione delle calzature. Oltre a ciò fu incaricato della costruzione di materiali nuovi ed infine anche della produzione di spazzole.

L'opificio dell'Aquila fu invece incaricato di fabbricare scarpe; impiegava 200 operai fra borghesi e militari ed aveva una capacità produttiva di 1.000 paia di scarpe al giorno.
L'opificio di Caserta aveva lo stesso personale e la stessa capacità di produzione di quello de L'Aquila, fu addetto però anche al riattamento di materiale sgombrato dalla zona di guerra
e riparò oltre 200.000 paia di scarpe, 150.000 tascapani e 35.000 zaini.
L'opificio di Firenze, sorto come sartoria, fu successivamente trasformato in calzaturificio con personale e capacità produttiva simile a quella degli stabilimenti di Caserta e de L'Aquila.
L'opificio di Pontedera (Pisa) con una maestranza di 320 operai provvide al riattamento di 70.000 quintali di zaini, scarpe e tascapani sgombrati dal fronte.
Oltre a questi stabilimenti bisogna ricordare l 'opificio militare laniero di Biella, istituito nel 1917 e chiuso nel 1919, che disponeva di ben dieci reparti specializzati.

Tutti questi impianti erano in territorio; nella zona di guerra « presso ogni armata furono gradualmente istituiti laboratori di recupero con stazioni di disinfezione, con il compito di eseguire il riattamento degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento, delle calzature ed anche delle pelliccerie. Da t i i mezzi n ecessariamente limitati di cui i detti laboratori potevano disporre, i materiali che richiedevano trasformazioni o riparazioni di maggiori entità erano fatti sgombrare sugli opifici militari territoriali » ( 34 ).
Al momento dell'armistizio erano in funzione 17 di questi stabilimenti.
Non si può concludere la panoramica delle industrie militari senza fare un cenno alla Farmacia Centrale Militare che concorse validamente, con l'industria farmaceutica nazionale, all'approntamento dei mezzi sanitari occorrenti. Il « Laboratorio militare siero antitetanico» di Bologna produsse tra il maggio 1915 ed il novembre 1918 1.120.539 fiale ( 35 ).
Considerando gli impianti industriali dipendenti dal Ministero della guerra nel loro insieme, non si può fare a meno di notare che si trattava di un complesso notevole sia per il numero e le dimensioni degli stabilimenti, sia per il personale impiegato ( dalle 120.000 alle 130.000 persone) sia per i livelli produttivi raggiunti. Tutto ciò fu però reso possibile dal fatto che l'organizzazione industriale militare partiva da una consistente base pre-bellica. L'esistenza di una rete così ampia di stabilimenti militari dimostra la scarsa integrazione esistente prima del conflitto tra strutture militari ed organizzazione industriale nazionale. Questa sfasatura fu causa non ultima della impreparazione dell'industria italiana a soddisfare le esigenze belliche. Oltre a ciò, se l'esistenza di un grosso apparato di stabilimenti militari testimonia il distacco e la reciproca sfiducia tra gli ambienti dell'industria privata e quelli militari all'inizio del conflitto, l'espan-
dersi di questa struttura con ritmi celerissimi che non trovavano riscontro nelle imprese civili, denuncia che, nonostante la mobilitazione industriale, la diffidenza dei militari nei confronti degli imprenditori civili era ben desta ed operante. Il quadro delle attività industriali militari non sarebbe però completo se non si considerasse il servizio del genio civile dell'esercito mobilitato. Il regolamento dei servizi in guerra, in vigore nel 1915, nella seconda parte in cui trattava dei servizi, accennava, assai sbrigativamente, tra l'altro, al servizio della manutenzione stradale a tergo dell'esercito mobilitato. In base a quanto stabiliva il R.D. 1° dicembre 1912 n° 1462 tale servizio avrebbe dovuto essere disimpegnato da funzionari del Genio Civile appositamente mobilitati. I lavori che venivano affidati a tale organo erano quelli di manutenzione ed ampliamento della rete stradale e di riattamento e costruzione di ponti. Al principio del 1915 furono iniziati gli studi per l'ampliamento della rete stradale del probabile teatro di operazione. Nell'aprile si diede inizio ad alcuni lavori, per il modesto importo di 450.000 lire, che non poterono essere ultimati prima dell'inizio del conflitto (36 ). All'atto della mobilitazione si rilevò tutta l'insufficienza dei provvedimenti posti in opera e si dovette pagare il fio degli scarsissimi collegamenti esistenti tra il Ministero della guerra e quello dei lavori pubblici. Questa mancanza di contatti aveva fatto sì che sorgesse un grosso malinteso. « Lo Stato Maggiore dell'esercito, nel prevedere e nel proporre l'opera del genio civile a tergo dell'Esercito, aveva, forse, immaginato che esso vi giungesse munito di propri mezzi, di operai, di attrezzi, di cariaggio, di macchine stradali ecc. Il Ministero dei lavori pubblici, invece, riteneva di dover dare soltanto il personale tecnico per la costituzione delle Direzioni: né poteva ritenere diversamente: sia perché ogni spesa occorrente alla guerra era di pertinenza del Ministero della guerra; sia perché, come è noto, il genio civile non era, come non è ancora, costituito per l'esecuzione dei lavori con mezzi propri» ( 37 ). In realtà il regolamento prevedeva l'impiego, quali organi esecutivi del Genio Civile mobilitato, di « quelli esistenti fino dal tempo di pace per la manutenzione delle strade nazionali, provinciali e comw1ali, il cui personale, funzionari ed agenti subalterni, che agisce nella zona delle operazioni, in guerra passa alla dipendenza dell'intendenza dell'armata rispettiva». In pratica, i funzionari del Genio Civile mobilitati, avrebbero dovuto servirsi, come organi esecutivi, degli uffici tecnici comunali e provinciali pre-esistenti. In realtà la direzione del Genio Civile poté avvalersi di questi organismi « assai raramente, stipulando però con le de-

putazioni provinciali e con i comuni interessati, speciali convenzioni con le quali l'amministrazione militare si assumeva le spese straordinarie. Ma in genere gli organi provinciali e comunali erano rimasti atrofizzati dalla guerra » ( 38 ).
Anche se la cooperazione degli uffici tecnici degli enti locali, fosse stata piena ed entusiastica, essa sarebbe rimasta comunque insufficiente. Considerando le disposizioni del Regolamento di servizio in guerra, il generale Guido Liuzzi osservò: << :È evidente che l' "ameno volumetto" non poteva lontanamente prevedere l'enorme tormento cui dovettero sottostare tutte le strade; ma a me pare che sarebbe bastato di considerare un pò l'impiego dei mezzi automobilistici, ch'esso medesimo stabiliva e l'impiego di un parco d'assedio d'artiglieria e del genio, sia pure del tipo prebellico, per capire che il servizio così com'era previsto no potevasi ritenere sufficientemente organizzato» ( 39 ).
In definitiva, l'imprevidenza e la mancanza di coordinamento degli enti interessati all'organizzazione, posero la situazione del Genio Civile presso le truppe mobilitate, in una difficile posizione all'inizio delle operazioni belliche, per alleviare la quale non si poteva ricorrere alla requisizione in loco com e prevedeva il regolamento. Infatti « tale requisizione in sito fu praticamente impossibile, in quanto tutto ciò che poteva occorrere era già stato requisito localmente, per scopi strettamente militari durante il periodo immediatamente precedente alla guerra e durante la mobilitazione; né risultò pratico e possibile rivolgersi alle imprese locali, ché i vari e successivi tentativi fatti in proposito ne dimostrarono fin dal principio l'inefficacia, poiché gli stessi mezzi che non trovavano sul sito le Direzioni, non potevano trovare neanche le imprese, che già ne erano state private dalle requisizioni anteriori e a provvedersene fuori trovavano ostacoli ben più gravi per i trasporti ferroviari, tutti, naturalmente, impegnati in servizio dell'Esercito » ( 40). Fu pertanto necessaria una serie di interventi dell'amministrazione militare per mettere il Genio Civile, al seguito delle truppe, in condizione di svolgere i compiti che gli erano stati affidati. Si provvide quindi ad integrare il personale con ufficiali di complemento o di milizia territoriale laureati in ingegneria. Per i lavori si impiegarono reparti di milizia territoriale, contemporaneamente si iniziò a ricercare tra i mobilitati, il personale specializzato per assolvere determinati compiti. Le intendenze delle armate provvidero ai più urgenti bisogni di materiali. Il problema maggiore fu quindi costituito dalla carenza dei mezzi di trasporto « Si tentò, da prima, di

organizzare alcune squadre di carri borghesi, ma risultò essere difficoltà troppo grave anzitutto il provvedersene, quindi il loro mantenimento per il foraggio, infine la loro circolazione in zona di guerra. Onde, in generale, risultò indispensabile, che carri, quadrupedi e camions automobili fossero forniti dall'autorità militare, e cioè dalle Intendenze d'armata.

Pel trasporto della ghiaia o pietrisco occorse provvedere, da prima con carriole, con carrette a mano e perfino con squadre di donne, che le trasportavano dai ghiaieti o dalle cave, a schiena, nei gerli, ai depositi che si andavano costituendo lungo le strade. Non occorre illustrare come ciò risultasse, oltre che immensamente dispendioso, assolutamente inadeguato al bisogno per la lentezza e per l'eccesso di operai occorrenti, mentre questi sarebbero stati assai meglio utilizzati per tutti gli altri lavori, ove necessitavano anche in gran numero. Finalmente, dopo continue insistenze dell'Ispettorato e delle Direzioni del Genio Civile d'armata, le varie Intendenze si convinsero della necessità di provvedere il carreggio, ma il numero e l'organizzazione di questo fu sempre inadeguato al bisogno» (41 ). Superate, sia pure faticosamente, le prime difficoltà, il servizio prese a funzionare alacremente; si impose però ben presto il problema di reclutare personale civile su vasta scala per far fronte ai lavori resi necessari dall'aumento continuo del traffico.
La formazione di una vasta maestranza alle dipendenze degli organi del Genio Civile mobilitato si rendeva necessaria anche perché le centurie lavoratori, che si erano incominciate a costituire con personale della milizia territoriale, operavano anche alle dipendenze dei comandi dell'arma del genio e quindi la disponibilità di questo personale era alquanto precaria. Infatti, i lavori affidati al Genio Civile mobilitato erano lavori di 2° linea, vi era quindi la tendenza, non del tutto ingiustificata del resto, nei comandi che disponevano dell'utilizzazione del personale, di dare la precedenza ai lavori di P linea affidati al genio militare. Pertanto, il 28 dicembre 1915, l'ufficio affari civili del Comando Supremo inviava a tut6 i Prefetti del Regno la circolare n. 24328 che stabiliva le « norme regolatrici del servizio relativo al reclutamento della mano d'opera per i lavori militari in zona di guerra » ed una copia del contratto base Questi documenti ci permettono di stabilire qual'era il trattamento riservato alla mano d'opera dipendente dal servizio del Genio Civile. Gli operai dovevano avere un'età compresa tra i 17 e i 60 anni, eccezionalmente erano accettati fanciulli tra i 15 e 17 anni purché fossero accompagnati da un parente ed il loro numero non superasse il 10% dei
singoli gruppi. Coloro che venivano reclutati si impegnavano a lavorare da 6 a 12 ore di tutti i giorni della settimana, dovevano restare sul luogo del lavoro per tutto il periodo del contratto e portare con sé alcuni indumenti e stoviglie. Questo personale veniva trasportato dai luoghi di reclutamento in zona di guerra a cura dell'amministrazione militare, che provvedeva al vitto e all'alloggio per tutto il periodo dei lavori. Al personale veniva assicurata anche una percentuale della paga per i giorni di inattività dovuti a forza maggiore (intemperie, ordini superiori, malattia) pari rispettivamente al 30%, 50% e 50% su una giornata lavorativa di sei ore. Tutte le maestranze venivano assicurate contro gli infortuni sul lavoro nonché contro i rischi di guerra. I salari venivano fissati nel modo seguente:
Fanciulli L. 0,10-0,20 all'ora
Operai non qualificati (manovali, braccianti) » 0,30-0,40 »
Operai qualificati (fabbri, minatori, carpentieri) » O,40-0,SO »
Capi squadra » 0,60-1 »
Questi salari orari potranno sembrare non disprezzabili se si considera che il salario medio orario di un manovale della Fiat era nel 1915 di L. 0,43 ( 42 ), tuttavia bisogna tener presente che le condizioni di lavoro erano alquanto diverse perché l'attività del personale del Genio Civile era soggetta ad una molteplice serie di interruzioni per cui in zona di guerra « le mercedi giornaliere furono, all'inizio di L. 1,50 a L. 2,00 per i ragazzi, di L. 2 a L. 2,50 per le donne, di L. 3,50 a L. 4,50 per gli uomini» ( 43 ). I capi squadra poi percepivano dalle 5 alle 10 Jire al giorno a seconda delle attitudini.

Si trattava di paghe modeste a cui però bisogna aggiungere che « per gli operai venuti in zona di guerra dall'interno del paese, si provvedeva direttamente all'alloggio e si somministrava ad essi la razfone viveri del soldato, ciò che equivaleva ad una spesa in più, oltre alla mercede, di circa L. 2 al giorno» (44 ).
In definitiva il salario, per quanto modesto, restava per le maestranze completamente disponibile, ciò facilitò indubbiamente il successo della campagna di reclutamento. Infatti il segretario generale dell'ufficio affari civili del Comando Supremo, nella circolare 37053 del 7 giugno 1916 ai comandi del Genio, poteva annunziare che dal mese di gennaio a tutto l'aprile erano stati reclutati 126.154 operai abolendo quasi completamente gli intermediari privati che in precedenza effettuavano il 75% dei reclutamenti. Nonostante il successo dell'operazione, esisteva a quella data una forte richiesta di personale ( circa 22.000 unità).
La carenza di mano d'opera fece sì che il 13 agosto si disponesse che il periodo minimo di lavoro previsto dal contratto fosse portato da 60 a 90 giorni. La preoccupazione di fornire il maggior numero di operai possibile fece si che sì verificassero nei reclutamenti una serie di inconvenienti che il Segretario generale segnalò nella circolare 56917 del 16 agosto 1917, ai Prefetti del Regno: « arrivo di operai pregiudicati, ammalati, mutilati e non più atti a proficuo lavoro; di fanciulli in numero considerevole e molti di età inferiore ai 15 anni compiuti, vecchi di oltre sessant'anni, persone che mai furono operai e costoro in parte compresi e in parte non compresi negli elenchi».
Questa situazione impose una serie di provvedimenti di vigilanza e di controllo. D'altra parte la carenza di mano d'opera, che il buon esito dei reclutamenti non riusciva a diminuire poiché buona parte del personale non rinnovava il contratto alla scadenza, provocò un fenomeno particolare, segnalato dal segretariato generale con la circolare 78518 del 5 ottobre 1916 diretta alle direzioni del Genio. Sovente i cantieri, nel tentativo di assicurarsi una maestranza stabile, aumentavano le paghe al disopra dei minimi stabiliti, il che finiva per comportare un trasferimento di mano d'opera da alcuni cantieri ad altri.

D'altro canto, non tutti i cantieri offrivano le stesse condizioni di lavoro e era inevitabile che il maggior disagio o rischio venisse maggiormente retribuito . Per mettere un po' d'ordine in questa situazione, il segretariato generale indicò il 29 novembre cinque tipi diversi di zone di lavoro:
1) vicino all'abitato e in condizioni non disagiate;
2) in media montagna e lontano dall'abitato, disagiate per i ricoveri;
3) disagiate per lavori e ricoveri (malariche o di alta montagna);
4) non disagiate, ma soggette al tiro d'artiglieria avversaria;
5) disagiate e soggette al tiro d'artiglieria.
Queste cinque ripartizioni dovevano costituire ognuna una sottoclasse dei gruppi di salario prefissati, comportando ciascuna un diverso trattamento economico ( di cui, sia pure sotto il pretesto di rilevarne l'entità, si indicavano i limiti) all'interno delle varie categorie di operai.
D'altra parte, la sempre crescente richiesta di manodopera fece sì che il 31 dicembre si stabilissero le norme per il « reclutamento di operai per lavori militari nel Comune di dimora ».
A questi lavori potevano essere adibiti non soltanto gli operai
con le caratteristiche già indicate in precedenza, ma anche le donne tra i 17 e i 50 anni e ragazzi tra i 13 ed i 15 anni.
I salari previsti erano i seguenti:
Capi squadra da L. 0,55 a L. 0,70
Operai qualificati » » 0,40 » » 0,55
Operai non qualificati » » 0,30 » » 0,45
Donne e fanciulli (fino a 17 anni) » » 0,20 » » 0,35
La carenza di personale induceva infine il segretariato generale a stabilire, con la circolare 110457 dell'll gennaio 1917, le norme relative al reclutamento di maestranze femminili anche fuori della zona di operazioni. Tali disposizioni prevedevano tra l'altro il divieto di assunzione per le donne in gravidanza, il divieto di impiegare le maestranze femminili in zone battute dal fuoco nemico; l'orario massimo di lavoro previsto era di 10 ore, il salario doveva essere compreso tra i 25 e i 40 centesimi l'ora. Queste disposizioni venivano a regolare una situazione di fatto, poiché le maestranze femminili locali erano, come si è visto, impiegate fin dall'inizio del conflitto. Poiché la carenza di mano d'opera continuava a farsi sentire, con le norme emanate il 31 maggio 1917, si giunse ad estendere il limite massimo d'età per gli operai destinati a lavorare nel comune di residenza, al 65° anno.
Le campagne per il reclutamento del personale per il servizio del Genio Civile non ottennero, nel 1917, il successo che avevano conseguito nel 1916, e ciò è facilmente comprensibile ove si consideri che i nuovi richiami alle armi avevano ridotto il numero della mano d'opera disponibile ed al contempo accresciuto le necessità dell'agricoltura. Il reclutamento ebbe nel biennio l'andamento di cui alla successiva tab. 7.
Questi dati non forniscono però il quadro esatto della situazione del personale; infatti, i rinnovi dei contratti non erano infrequenti, per cui gli operai impiegati nei lavori dal 1915 all'ottobre del 1917 furono in media 140.000 (46 ).

Questo personale disponeva nel 1917 del seguente materiale: 3.600 carri da trasporto, 85 km. di binario Decauvilles, 728 carrelli Decauvilles, 923 botti d'inaffiamento, 4 sfangatrici, 616 spartineve, 107 compressori, 70 frantoi, 18 perforatrici, 5 escavatori, 3 locomotive stradali con rimorchio, 150.000 attrezzi vari ( 47 ).
Buona parte di questo materiale andò perduto nella ritirata dell'ottobre-novembre 1917 e si dovettero superare notevoli difficoltà per il suo ripristino ( 48 ). Il disastro di Caporetto implicò anche una brusca e notevole riduzione della mano d'opera a disposizione del servizio del Genio Civile sia per le vicende del-
la rotta, sia per gli ulteriori richiami e revisioni del personale precedentemente considerato inabile, la media degli operai impiegabili s i ridusse a 100.000 unità ( 49 ).

Benché i salari fossero stati aumentati portandoli ad un massimo di 4,50 lire per le donne, di 6 lire per gli uomini ( 50 ), si trattava di aumenti estremamente modesti dato che non avevano per nulla seguito l'incremento subito dai salari industriali che nel frattempo erano più che raddoppiati . È certo inoltre che la distribuzione gratuita della razione di tabacco spettante ai militari o la vendita di oggetti di vestiario a prezzi convenienti disposta nel maggio del 1917 a favore degli operai che lavoravano per il Genio Civile, non potevano essere elementi sufficienti a favorire le operazioni di reclutamento. Alla carenza di personale si cercò di ovviare impiegando, nei lavori, ove era possibile, reparti di prigionieri di guerra ( 51 ).
Il principale compito del servizio del Genio Civile mobilitato fu sempre quello della manutenzione, del riattamento ed eventualmente del potenziamento della rete stradale a tergo dell'esercito operante. Per far fronte a que~to compito « le singole Direzioni del Genio Civile d'armata furono divise in Sezioni, a capo di eia-
scuna delle quali fu posto un ingegnere d i classe. Le Sezioni, poi , a loro volta, furono suddivise in reparti, ad ognuno dei quali fu preposto un geometra del Genio Civile, oppure, in alcune località e Direzioni, un tenente di complemento del Genio militare passato in aiuto al Genio Civile. Come criterio generale fu adottato quello di assegnare ad ogni sezione dai 300 ai 500 chilometri di strade in manutenzione e dai 40 ai 60 chilometri ad ogni reparto, riducendo tale assegnazione quando ad una sezione o reparto era assegnato anche il compito di curare notevoli sistemazioni o nuove costruzioni , aumentandola se le strade in manutenzione richiedevano una cura limitata. In qualche caso fu trovato anche conveniente costruire speciali sezioni di lavoro, destinate ad occuparsi esclusivamente delle costruzioni di maggiore importanza. Centurie di cantonieri furono distribuite fra le varie Sezioni. Alla dipendenza immediata delle Direzioni furono assegnati ufficiali d'ordine per il servizio di protocollo, di archivio e per quello contabile, quando questo non fu disimpegnato da ufficiali ragionieri, e militari scritturali » ( 52 ).

Per la sola manutenzione della rete stradale fu necessario impiegare una media di 3 o 4 uomini ogni ch ilometro. « Per la scarsità progressivamente crescente della mano d'opera maschile e valida, in conseguenza dei successivi richiami alle armi, si provò l'impiego della mano d'opera femminile, che corrispose assai bene alla cura del buon governo delle strade, ove, più che grande sforzo, si richiede pazienza ed attenzione » ( 53 ). Per avere un'idea dell'ampiezza e dell'importanza di questo servizio basta pensare che la manutenzione della zona delle retrovie si esercitava su circa 10.000 chilometri di strade ed impegnava 40.000 operai al giorno nei periodi normali e 50.000 nel periodo di sgombero delle nevi ( 54 ). Nonostante che la mano d'opera disponibile fosse sempre inferiore alla richiesta delle Direzioni, furono affidati al Genio Civile numerosissimi altri compiti oltre alla manutenzione della rete stradale, compiti di cui il Gen. Guido Liuzzi fornì un dettagliato elenco: « opere di consolidamento, amp liamento, rettifica, finimento, ripristino in seguito a frane, nuove costruzioni di strade, rinforzi e allargamenti di ponti, nuove costruzioni di ponti, sgombro neve, linee décauvilles, nuovo tronco ferroviario a scartamento ridotto, impianto ospedali in baracche, acquedotti, spiazzi per artiglierie, traverse di abitati, baraccamenti, cimiteri, fognature, idranti da incendio» ( 55 ).
Nel corso della guerra furono costruite, in zona di operazioni, strade camionabili per 3.200 km., carr arecce per 1.200 km., mulattiere per 1.000 km ( 56 ). Tali nuove costruzioni furono
effettuate per la maggior parte dal Genio Civile, il quale provvide anche al rinforzo di 380 ponti cd alla costruzione di 130 ponti nuovi per la lunghezza complessiva di ml. 4.000 (57 ).
Buona parte delle 40.000 baracche mobili inviate in zona di guerra furono montate dal Genio Civile come gran parte delle baracche fisse. Anche per quanto riguarda la costruzione di acquedotti il contributo del Genio Civile fu notevole; infatti esso costruì la maggior parte dei 530 km. di acquedotti ch e rifornivano le armate schierate nel 1918 t ra il Garda e il mare (58 ). Come si vede l'opera svolta dal Genio Civile mobilitato ne l corso del conflitto fu, nel complesso, senza dubbio imponente.
(1) Per questi e per gli altri dati qui riportati vedi: Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, Da.ti statistici dell'attivitt} degli stabilimenti e direzio11i d'artiglieria. durante il periodo bellico, luglio 1914 - ottobre 1918, Roma 1922.
(2) Ibidem. Per quanto riguarda i dati del Laboratorio pirotecnico e della Direzione d'Artiglieria di Bologna bisogna tener presente che come ufficiali ed impiegati vengono indicati rispettivamente 81 e 80 persone senza ulteriore specificazione di categoria.
(3) Cfr. Comitato per la Mobilitazione civile. Il co111ributo delle maestranze femmi11i/i all'opera. dì allestimento dei materia.Ii bellici (1915-1918), Milano s.d. p. 54.
(4) Cfr. C MONTù: op. cit., voi. XI, pp. 609 - 610, 665
(5) Ministero della guerra: I rifornimemi cii., p. 79.
(6) Questi dati sono ricavati per sottrazione. Infatti dalle cifre fornite in: Comitato per la Mobilitazione Ci\'ile, /I co11tributo delle ma.estra.nze femminili , cii., p. 55, si desume che gli addetti alle officine militari fossero in complesso 64.300 (42.300 uomini e 22.000 donne). Sottraendo da questa cifra gli addetti agli stabilimenti d'artiglieria, si ricava approssimativamente il numero degli operai degli stabilimenti del Genio.
(7) Cfr. C. MONTù : op. cii., voi. Xl, pag. 665.
(8) Ministero della guerra: I rifomimemi, cit ., p. 261.
(9) Ibidem, p. 262.
(10) Ibidem, p. 261.
(11) Ministero della Guerra: I serviti logistici, cit., pp. 56, 129.
(12) Ibidem, pp. 123; 129, 132.
(13) Ibidem, p. 123.
(14) Ibidem, p. 126.
(16) Ibidem, p. 127.
(17) Ibidem, p. 131.
(18) Cfr. G. ZINCALI: /I rifornimento di viveri dell'esercito italiano in R. Bachi L'alimen1azìo11 e e la. politica. annonaria. in Italia, Bari 1926, pp. S72, 577 e 578.
(19) Ministero della Guerra: I servizi logistici, cit., p. 134.
(20) G. Z!NGALJ: op. cit., p. 134.
(21) Ministero della Guerra: I serviti logistici, cit., p. 209.
(22) Ibidem, p. 210.
(23) Ibidem, p. 161.
(24) Ibidem, pp. 162·163, e G. ZINCALI: Op. cii., p. 607.

(25) Ministero della Guerra: / serviti logistici, cii., p. 163.
(26) Va rilevato che nel corso del conOiuo furono importati 232.777 quintali di carne in scatola. Cfr. G. ZINCAI.I: op. cit., p. 628.
(27) G. ZINCALI: op. cii., p. 622.
(28) Cfr. A. Puioocm: L 'indust ria zootecnica considerata in rapporto all'era presente e al dopo-guerra, Torino 1918, p. 18.
(29) Cfr. G. ZINCALI: op. cit .• pp. 623-626.
(30) Ibidem, p. 627.
(31) Ministero della Guerra: I servizi logistici, op. cit., p. 56.
(32) Ibidem, pp. 280-281.
(33) Ibidem, p. 283.
(34) Ibidem, p. 286.
(35) Minislcro della Guerra: l rifornimenti, op. ci t., p. 250.
(36) Ministero dei Lavori Pubblici: l'opera del Ge11io Civile nella guerra mondiale 1915-1918, Roma 1922, pp. 3-4.
(37) Ibid em, pp. 5-6.
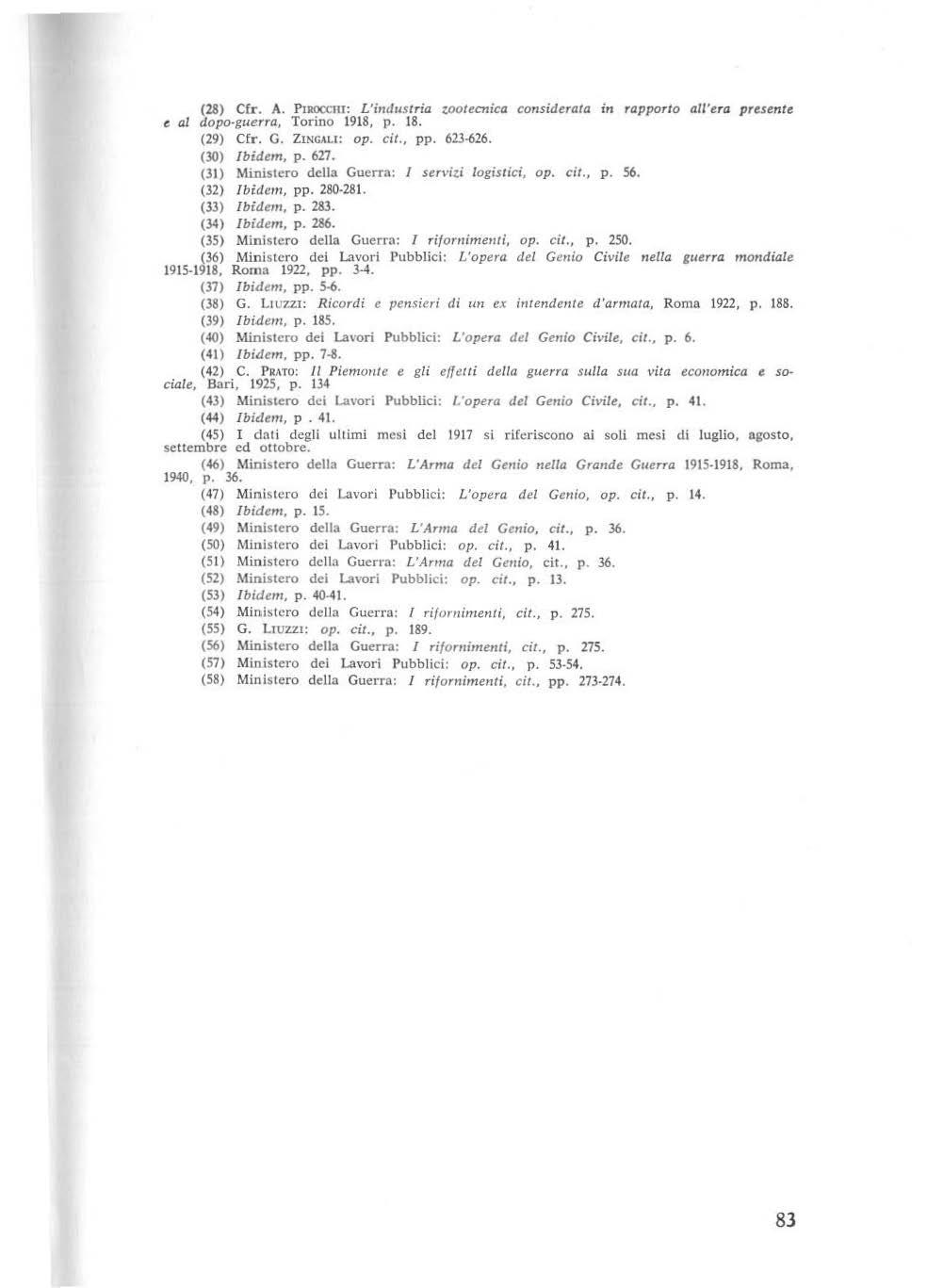
(38) G. L1u1.z1: Ricordi e pensieri di rm ex inrendente d'armata, Roma 1922, p. 188.
(39) Ibid em, p. 185.
(40) Ministero dei Lavori Pubblici: L'opera del Genio Civile, cii., p. 6.
(41) Ibid em, pp. 7-8.
(42) C. PRATO: li Piemo11te e gli effet ti della guerra sulla sua vita eco11omica e sociale, Bari, 1925, p. 134
(43) Mini~tero dei l.a\'Ori Pubblici: !.'opera del Genio Civile, cit., p. 41.
(44) Ibidem, p 41.
(45) I dali degli ultimi mesi del 1917 si ri(eriscooo ai soli mesi di luglio, agosto, settembre ed ouobre.
(46) Minhtcro della Guerra: L'Arma del Genio nella Grande Guerra 1915-1918, Roma, 1940, p. 36.
(47) Mini~tcro dei Lavori Pubblici: l'op era del Genio, op. cit., p. 14.
( 48) Ibidem, p. 15
(49) Ministero della Guerra: L' Arma del Genio, cit., p. 36.
(50) Ministero dei Lavori Pubblici: op. cit., p, 41.
(51) Ministero della Guerra: L'Arma del Genio, cit., p. 36.
(52) Ministero dei Lavori Pubblici: op. cit., p. 13.
(53) Ibidem, p. 40-41.
(54) Minis tero della Guerra: I rifornimenti, cii., p 275.
(55) G. Lruu1: op. cit., p. 189.
(56) l\tinislero della Guerra: I rifornimenti, cir., p. 275.
(57) Minis tero dei Lavori Pubblici: op. cii., p. 53-54.
(58) Ministero della Guerra: I rifornimenti, cit., pp. 273-274.
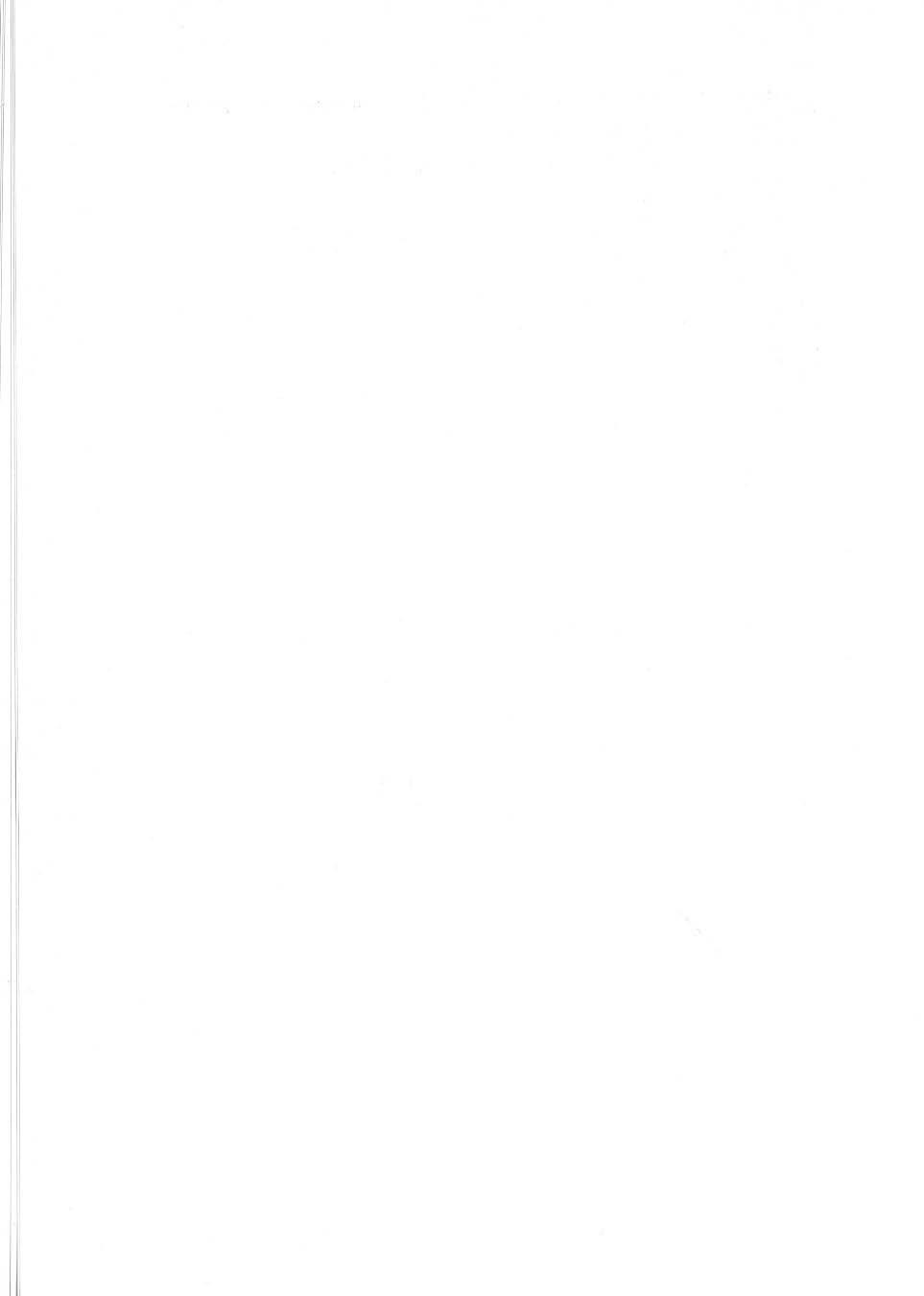
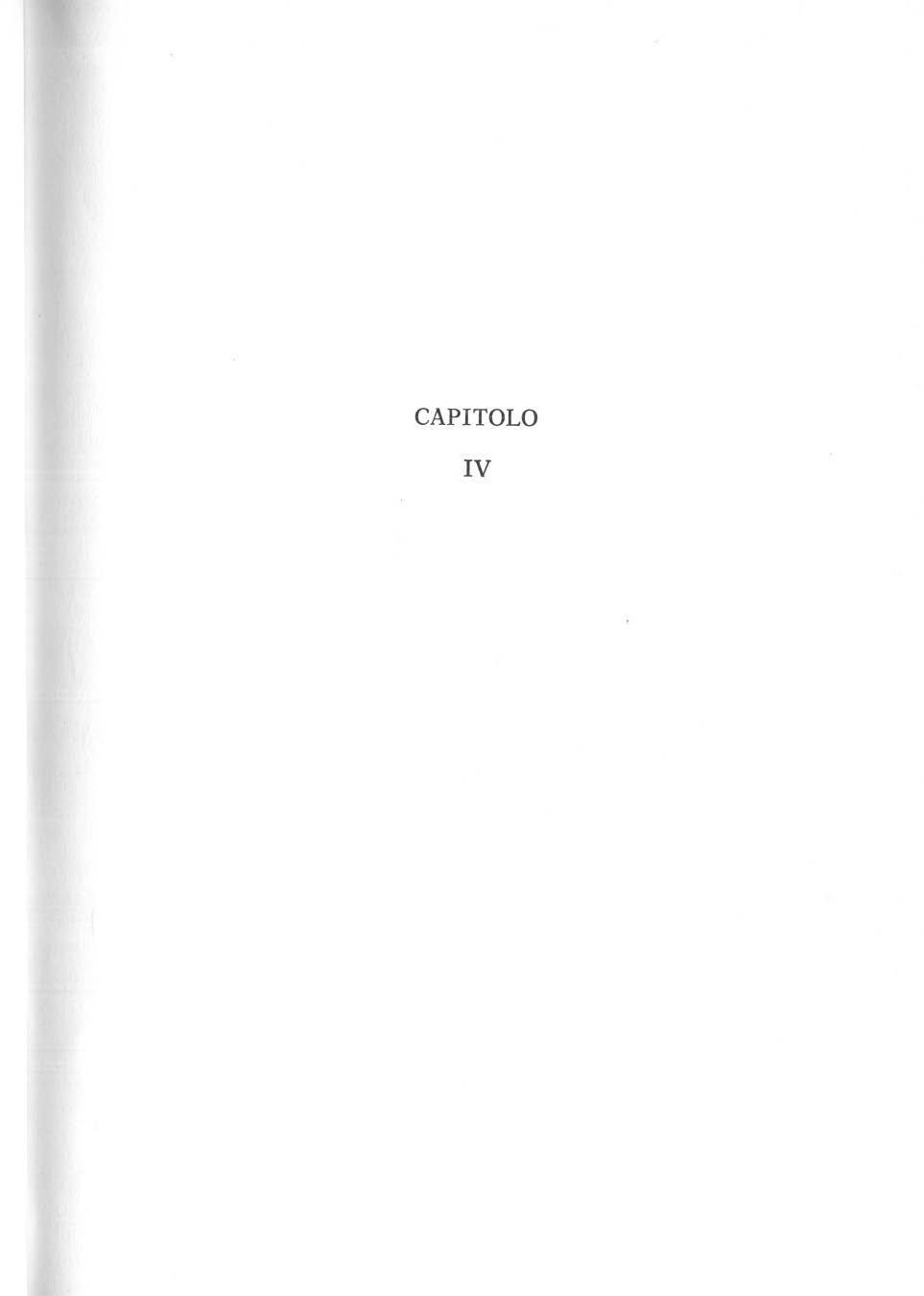
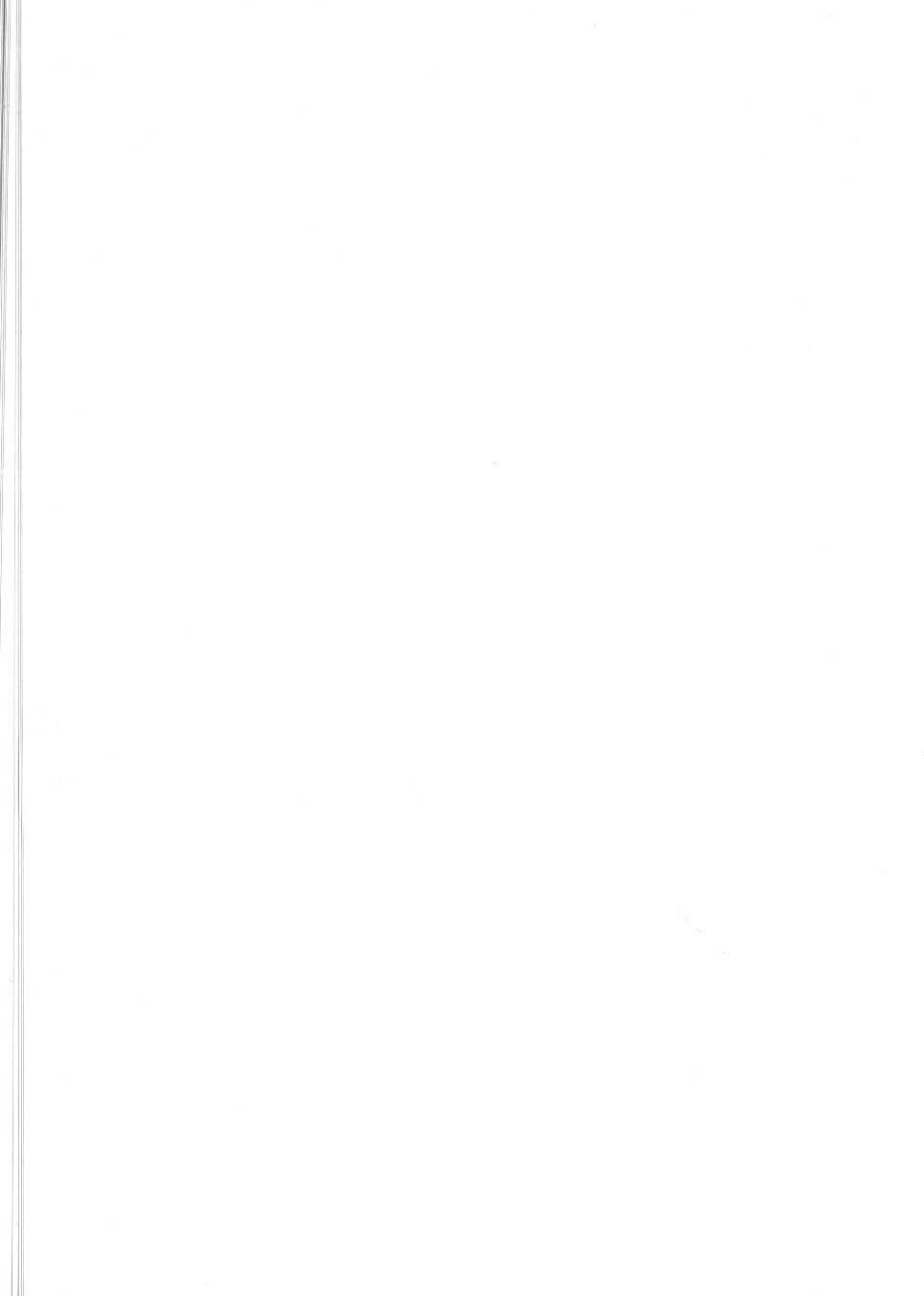
Come si evince dai fatti che abbiamo esaminato nel primo capitolo, la complessa struttura di controllo e di pianificazione economica realizzata in Italia durante la prima guerra mondiale, non fu organizzata a seguito di precedenti studi, ma venne creata pezzo per pezzo sotto la spinta delle circostanze. Il regime che ne derivò lasciava ben poco spazio all'attività sia dei datori di lavoro che dei lavoratori; non sarà quindi inutile esaminare l'atteggiamento che questi gruppi sociali assunsero nei confronti della Mobilitazione Industriale. L'entrata in vigore della regolamentazione relativa alla militarizzazione degli stabilimenti impegnati nella produzione bellica preoccupò, né poteva essere altrimenti, gli operai poiché, come riferì il generale Dallolio nel corso di una riunione del Comitato Centrale della Mobilitazione Industriale: « Le masse lavoratrici vi intravedevano il simbolo del ferreo rigorismo militare » (1). In effetti le maestranze non potevano certo apprendere con eccessivo entus iasmo le notizie di essere sottoposte ai rigori del codice penale militare , tanto più che in un primo periodo l'orientamento prevalente nei tribunali militari fu quello di applicare le disposizioni secondo criteri di estremo rigore (2). D'altra parte, però, ]a nuova rigida disciplina trovava un corrispettivo negli esoneri concessi agli operai aventi obblighi militari e nella garanzia che, finché durava lo sforzo bellico, il lavoro sarebbe stato loro assicurato. Le maggiori preoccupazioni riguardavano però le libertà sindacali; la valutazione che le organizzazioni operaie davano della situazione può essere desunta da una relazione tenuta al Congresso Nazionale della FIOM nel 1918, in cui si affermava che gli organismi della Mobilitazione Industriale « sorsero con lo scopo principale di disciplinare la mano d'opera e di risolvere i problemi del lavoro evitando gli scioperi ne1le officine mobilitate; gli operai non possono più licenziarsi dagli stabilimenti ausiliari, senza il

consenso dei Comitati regionali di mobilitazione; anche se non hanno obblighi di leva sono considerati come dei militari; alle punizioni normali si aggiungono altre che possono venire distribuite dagli ufficiali addetti alla sorveglianza degli stabilimenti; possono fare della prigione, il licenziamento per punizione vuol dire il boicottaggio dell'operaio licenziato; la libertà di sciopero è soppressa» (3) . Il quadro qui tracciato pecca di qualche esagerazione; infatti l'operaio se non poteva licenziarsi, non poteva neppure essere licenziato senza il consenso dei Comitati Regionali, come d'altronde se la preoccupazione degli scioperi, come già dicemmo, era presente agli organizzatori della Mobilitazione I ndustriale, è fuor di dubbio che lo scopo istitutivo del nuovo ente consistesse nell'organizzazione della produzione per la guerra, nel cui quadro vanno valutate le limitazioni del diritto di sciopero. :E. comunque evidente ch e la situazione venutasi a creare con lo scoppio del confli tto era tale da preoccupare grandemente i dirigenti sindacali; infatti la legislazione eccezionale avrebbe potuto costituire un punto di partenza per un tentativo mirante a liquidare le organizzazioni operaie con misure repressive.
Le autorità militari preposte alla mobilitazione industriale batterono invece tutt'altra s trada . Si legge infatti nella relazione con cui il Ministro della guerra presentò il Regolamento della Mobilitazione Industriale: « Militarizzando il personale bisognava assicurargli un equo trattamento, salvaguardarlo da eventuale sfruttamento e permettergli di far valere le sue giuste ragioni, nell'interesse stesso della produzione. Poiché ove il personale è scontento anche la militarizzazione perde efficacia e non basta ad aumentare la produzione. D'altra parte bisognava escludere assolutamente la possibilità d'interrompere il lavoro degli stabilimenti. La questione fu risol ta concedendo alle maestranze, come pure per conto loro agli industriali, di ricorrere ai Comitati Regionali che fun gono da amichevoli compositori. Mancando l'accordo, i Comitati emettono ordinanze provvisoriamente esecutive, salvo il ricorso al Comitato centrale che decide inappellabilmente com'è chiaramente disciplinato dagli art. 7 e 10 >> ( 4 ) Dei Comitati Regionali facevano parte, oltre ad un ufficiale generale o ammiraglio che li presiedeva e ad alcuni t ecnici, in ugual numero i rappresentanti degli operai e d egli industriali, sia pure con voto consultivo.
All'inizio questo meccanismo per risolvere le vertenze incontrò qualche difficoltà; ricordò a tal proposito di gen. Dallolio: « All'entrata in vigore di tale disposizione, fu notata come una incertezza ed una indecisione forse di aspettativa, per aro-

bo le parti interessate. Gli industriali temevano che un consesso formato anche con la rappresentanza di membri operai tendesse a concedere eccessivi miglioramenti economici, anche per quella naturale contrarietà a permettere che altri esaminasse questioni interne delle aziende; la massa operaia riteneva al contrario che un Ente, sia pure costituito essenzialmente da elementi borghesi, risentisse troppo dell'Autorità militare da cui dipende, e come tale si mostrasse meno accessibile alle richieste, anche giustificate, di benefici .finanziari.
Sorpassato facilmente il primo periodo di avviamento, quando, sia da parte delle Direzioni degli stabilimenti sia delle maestranze, fu effettivamente constatato come questo collegio arbitrale delle mercedi operaie, nell'emettere le proprie sentenze, s'ispirava a giusti ed obiettivi sensi di equità e di giustizia, affluirono le domande di miglioramenti, e le vertenze, tutte debitamente esaminate, vagliate, furono risolte con reciproca soddisfazione delle parti interessate.
Si può oggi affermare che la massima parte di tali controversie fu amichevolmente composta coll'intervento dei Comitati regionali ~> ( 5 ).
Tutto ciò non avvenne a caso: infatti il generale Dallolio, per tutto il tempo in cui fu a capo della Mobilitazione Industriale, condusse una politica che aveva come obiettivo il recupero delle masse operaie all'union sacrée della nazione in guerra. Questo atteggiamento dipendeva, sia dall'ovvia considerazione che la collaborazione degli operai era un fattore importantissimo per il rapido approntamento dei materiali bellici, sia dal profondo convincimento di Dallolio che la grande maggioranza degli operai non fosse disfattista. Il Ministero delle armi e munizioni era convinto che il proletariato industriale, per quanto largamente ostile alla guerra, non avrebbe, nella sua grandissima maggioranza, fatto nulla che potesse portare l'Italia alla sconfitta. Partendo da questi convincimenti, il generale Dallolio, non solo condusse un'azione mirante ad appianare il più possibile i contrasti tra imprenditori e lavoratori , ma cercò di valorizzare in ogni modo il grande contributo dato dalle maestranze operaie allo sforzo bellico del Paese non esitando a difenderle efficacemente dall'accusa di « imboscamento » avanzata da più parti. « Il presupposto implicito di molte delle osservazioni » dichiarò il generale alla commissione d'inchiesta per il disastro di Caporetto « è che la condizione dell'operaio, appunto perché quas i sempre esente da risch i, sia già una condizione di favore fatta all'individuo . Ora, la cosa cambia aspetto se guardata da un punto di vista più ge-

nerale e più elevato. Il punto di partenza deve essere che la guerra moderna, nella sua formidabile complessità, richiede bensì che molti cittadini affrontino la morte; ma esige pure che gli altri compiano lavori sussidiari e complementari; del tutto indispensabili, meno rischiosi, e questi altri, nell'interesse stesso del paese, dovranno naturalmente essere coloro che a questi lavori ed a questi uffici sono i più adatti. Non deve dunque essere interpretato a sfavore dei non combattenti il fatto, accessorio, che essi non corrono rischio; la necess ità vuole che sia così; e quando i non combattenti hanno fatto tutto ciò che il paese ha loro chiesto, essi non hanno meritato meno dei loro compagni combattenti ... Per la stessa via, si giungerebbe pure a concludere a sfavore dei meriti, rispetto al paese, dei comandanti di eserciti, i quali, appunto perché debbono comandare, sono indubbiamente meno esposti alla morte dei semplici soldati. Ne può darsi importanza al fatto, del quale è stata molto esagerata la frequenza, che nella folla di coloro ai quali il paese ha ordinato di servirlo nelle officine, qualche individuo si sia infiltrato per fini scorretti; si tratta infatti di casi rari, dai quali non sarebbe equo trarre conseguenze generali >> ( 6).
Qualche tempo prima, parlando al Senato nella seduta segreta del 6 luglio del 1917, il generale Dallolio aveva energicamente difeso il diritto degli operai ad una buona retribuzione affermando: « Se l'operaio avente obbligo di leva e che lavora in uno stabilimento percepisce una paga superiore a quella del soldato, non si deve dimenticare, oltre le condizioni di ambiente nelle quali egli è obbligato a vivere, che egli deve provvedere completamente a sé e per la famiglia, e che coloro che tuttora sono negli stabilimenti, in qualità di comandati, in divisa militare, sono soggetti ad una ritenuta d el 15 % su ciò che percepiscono, ritenuta a favore dello Stato per controbilanciare le spese di equipaggiamento, accasermamento ecc.

Si aggiunga inoltre che tutti coloro che, chiamati alle armi, si trovano o vengono a trovarsi adibiti ad aziende, officine o stabilimenti di Stato, di altre pubbliche amministrazioni o private, ausiliari o no, sia perché esonerati, sia perché al momento della chiamata vi furono lasciati come comandati a disposizione, sia perché in seguito assegnativi nelle loro qualità stesse in cui precedentemente lavoravano, sono soggetti ad una imposta, la così d etta imposta sui militari non combattenti, stabilita col Decreto 1525 del 9 novembre 1916, imposta che è proporzionale al salario che le dette maestranze percepiscono.
Il soldato invece , oltre alla paga che percepisce alla mano,
è provvisto di tutto quanto occorre alla sua esistenza, vitto, vestiario, alloggio, tabacco, e per di più la sua famiglia percepisce un sussidio e sommando ciò che il soldato costa allo Stato per sé e per i sussidi, si vedrà che la cifra non è così lontana da quella che percepisce un operaio negli stabilimenti, poiché anche sulla questione delle paghe degli stabilimenti non è giusto lasciar credere che esse siano quelle favolose che si tenta di [ar credere. La grande massa degli operai ha paghe che si aggirano dalle 4 alle 6-7 lire al giorno, se ci sono degli operai che percepiscono delle paghe superiori, questo è dovuto o ad un'eccezionale loro attività, che è giusto sia premiata, che permette loro di guadagnare col cottimo e quindi con una produzione intensificata, che è quanto occorre in questi momenti di avere, oppure sono adibiti a lavorazioni specialissime o investiti di mansioni per le quaU una ]oro maggiore retribuzione può essere giustificata » (7).

Come si vede il Ministro delle armi e mw1izioni non aveva esitato a spingere tanto in là la sua difesa da equiparare quasi la condizione economica dei soldati a] fronte con quella degli operai nelle officine omettendo, per sostenere la sua tesi, un piccolo particolare, cioè che la maggior parte dei lavoratori a bassa retribuzione era costituita da donne. Il Ministro non si limitò a sostenere la legittimità e la giustizia delle alte retribuzioni operaie; nel suo discorso affrontò anche tm altro tema che era stato oggetto, nei mesi precedenti, di una vivace campagna di stampa: que1lo degli sciali e degli eccessi a cui si sarebbero abbandonati durante le ore di riposo gli operai. A tal proposito il Dallolio disse: « circa l'appunto che si fa al1e maestranze aventi obblighi militari, esonerate o comandate negli stabilimenti, di abbandonarsi durante i giorni festivi ad eccessi, si deve osservare che essendo essi in tutto e per tutto ambientati colla massa operaia, questa e specialmente quando ad essa si debba chiedere uno sforzo continuativo ed intenso, ha diritto per legge ad una giornata di riposo sulle sette, e questa giornata di riposo è tanto più doveroso il concederla in quanto ché è nell'interesse stesso della produzione che essa deve essere concessa. Tanto è vero che la pratica ha dimostrato che il lavoro festivo, che in certi periodi si è dovuto imporre, non ha dato quel rendimento che invece dava la maestranza che possa godere sia del prescritto riposo settimanale. Non si dimentichi infine che questa maestranza entra al mattino presto nell'officina e vi esce a tarda ora, e ciò ininterrottamente per tutta la settimana » ( 8 ).
Il generale Dallolio nella sua difesa degli operai era andato più in là di quanto avesse mai osato fare la stampa socialista che,
replicando alla campagna dei giornali intervetist:ii, aveva più che altro negato gli « eccessi » e la prodigalità dei lavoratori dell'industria bellica. Il Ministro delle armi e munizioni affermò invece, senza mezzi termini, che il riposo festivo era necessario e che se gli operai consumavano nelle ore libere qualche bicchiere di vino se lo erano ampiamente meritato. Certamente il generale Dallolio, l'uomo che aveva saputo organizzare in breve tempo l'industria italiana per la guerra, non poteva essere tacciato di disfattismo e di conseguenza poteva permettersi affermazioni che, fatte da altri, avrebbero provocato le più vivaci reazioni. In verità queste dichiarazioni erano, almeno in parte, in contrasto con il tentativo di creare nel paese un clima di austerità e di risparmio, intrapreso, tra gli altri, dallo stesso Ministro delle armi e munizioni. Il fatto che il Dallolio si sia indotto a farle testimonia quanto fosse, a suo giudizio, importante respingere gli attacchi che verranno mossi alle maestranze degli stabilimenti bellici.
L'azione di tutela portata avanti dal Ministro delle armi e munizioni nei confronti degli operai, non aveva lo scopo di cercare di staccarli dalle loro organizzazioni sindacali, tendeva invece ad ottenere anche la collaborazione di quest'ultime. Quest'obbiettivo, che costituisce una delle caratteristiche più notevoli della politica del Dallolio, fu perseguito non solo conferendo una larga partecipazione, nei Comitati di mobilitazione industriale, ai rappresentanti dei sindacati operai, ma anche delegando importanti decisioni a commissioni miste in cui le organizzazioni dei lavoratori erano largamente rappresentate ( 9 ). La scelta di questa politica derivava dalla profonda convinzione del Ministro per le armi e munizioni della legittimità e dell'opportunità dell'azione sindacale come dimostrano le sue direttive al generale Eugenio Caputo dopo i fatti di Torino dell'agosto 1917: « Le istruzioni da me date con Dispaccio 4938 del 26/8/1917 non lasciano alcun dubbio che in ogni caso le disposizioni disciplinari circa gli operai debbono sempre essere applicate in modo da non colpire mai innocenti, e in ogni modo colla coscienza di un dovere, e mai colla impulsività di un provvedimento di rappresaglia. Da molte parti si segnalano che continuano revoche di esoneri per sola rappresaglia, operai firmatari memoriali appartenenti Commissioni Torinesi. Ora pure dichiarando zone di guerra le tre province di Torino-Alessandria-Genova non si è inteso affatto di togliere la libertà di riunione per motivi economicitutt'altro -.
Le disposizioni che mirano a togliere qualunque inciampo o

ritardo alla continuità del lavoro debbono garantire al personale militarizzato un equo trattamento salvaguardante da eventuali sfruttamenti e permettergli di far valere le sue giuste ragioni nell'interesse stesso della produzione. Imperocché come saviamente ha rilevato nella sua relazione S.E. il Ministro della guerra, ove il personale è scontento anche la militarizzazione perde efficacia e non basta ad aumentare la produzione ( Circolare 28 ottobre 1915 pag. 40 - Volumetto relativo alla Mobilitazione Industriale).

Prego far chiamare operaio Colombina appartenente al Comitato Centrale Mobilitazione onde avere indicazioni, nomi e fatti provati, affinché sempre e in ogni circostanza disciplina e giustizia siano congiunte. Il Ministro Dallolio » ( 10 ).
Per quanto concerne l'atteggiamento dei sindacati operai nei confronti della Mobilitazione Industriale si ricorderà che all'inizio vi erano - al loro interno - grosse preoccupazioni e perplessità nei confronti dei nuovi organismi. Soprattutto nel più grande tra i sindacati operai, la C.G.L., si nutrivano forti timori che la nuova regolamentazione servisse in realtà principalmente a strangolare le libertà sindacali. Indubbiamente Gino Castagno diceva la verità quando affermò che « la mobilitazione industriale non fu cercata ma subita » ( 11 ). Tuttavia, constatato che non vi era alcuna intenzione liberticida, l'atteggiamento dei dirigenti sindacali della stessa C.G .L. si modificò e la collaborazione divenne sempre più intensa e fattiva. Per comprendere a pieno questo atteggiamento è necessario considerare che negli anni che avevano proceduto il conflitto, la C.G.L. si era trovata in serie difficoltà. L'espulsione dei riformisti di destra, il passaggio del P.S.I. sotto il controllo dei massimalisti e la costituzione dell'U.S.I. da parte dei sindacalisti rivoluzionari, avevano determinato una situazione per cui la C.G.L. aveva dovuto affrontare i primi accenni di ristrutturazione della organizzazione industriale italiana in una situazione di particolare debolezza, ciò sia per la mancanza di coordinamento per l'azione del partito e sia per le iniziative dei sindacalisti rivoluzionari che non mancarono di metterla in difficoltà. Paradossalmente lo scoppio del conflitto aveva tratto, in qualche modo, l'organizzazione sindacale riformista fuori della crisi in cui si dibatteva. Infatti, mentre la ristrutturazione degli impianti era rinviata in seguito alle commesse belliche, i sindacalisti, per l'atteggiamento assunto, non rappresentavano più un concorrente capace di creare gravi imbarazzi. I noltre, la speciale situazione creata dal conflitto diminuiva la possibile azione ed incidenza del P.S.I. permettendo alla C.G.L. di muo-
versi m piena autonomia, senza troppo preoccuparsi della copertura del partito. In questa contingenza la Mobilitazione Industriale, passate le prime paure, dové apparire ai dirigenti riformisti come la grande occasione, non solo per mantenere in piedi l'organizzazione durante il periodo bellico, ma anche per assumere un nuovo ruolo in qualche modo «ufficiale» e pressocché alla pari con gli industriali. Una possibilità concreta dunque non soltanto per portare avanti « l'ordinaria amministrazione >> sindacale, ma anche per accresce re l'in1portanza e l'influenza d e l sindacato specie nelle piccole e medie industrie dove la sua presenza era stata in genere, fino ad allora, molto debole.
In definitiva la politica del Dallolio e l'atteggiamento della C.G.L. determinarono una situazione che fu riassunta da Bruno Buozzi, nel corso di una seduta plenaria del Comitato Centrale della M.I. con le seguenti parole:

« In nessun paese belligerante d'Europa la Mobilitazione Industriale è stata accettata dagli operai con la stessa serenità con la quale l'hanno accettata gli operai italiani, e ciò acquista tanto maggior valore se si considera che, fino al momento dell'entrata in guerra, il nostro paese ha avuto discussioni politiche talora vivaci » (1 2 ).
All'inizio, anche da parte degli industriali l'accoglienza alla nuova struttura della Mobilitazione Industriale non fu buona come ebbe a dire il generale Dallolio; le direzioni degli stabilimenti vedevano in essa un'ingerenza intollerabile nel campo delle loro specifiche attribuzioni ( 13 ).
Anche in questo caso la politica adottata dal Dallolio fece ben presto modificare l'atteggiamento degli imprenditori. Infatti il capo della Mobilitazione Industriale deside rava la collaborazione degli industriali non meno di quanto desiderasse quella degli operai. Egli era scettico sulla opportunità di ricorrere alle requisizioni pure previste dalla legge: « poiché sono convinto che non si arriverà mai a questo estremo. La requisizione avverrebbe quando gli industriali si rifiutassero di fare e produrre di buona voglia quanto fosse loro richiesto dal governo. Coi poteri conferitigli, il governo assumerebbe allora l'amministrazione e la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento, sostituendosi all'industriale. Ora non c'è da illudersi. Per necessità di leggi contabili, o per inevitabili congegni burocratici, il governo è fatalmente un industriale più lento e forse anche meno efficace dei privati, cosicché nelle sue mani la produzione, invece di aumentare, probabilmente diminuirebbe e sarebbe più costosa. Si conseguirebbe così, in un primo periodo, un risultato dia-
metralmente opposto a quello desiderato. Per questi motivi, e certo del patriottismo degli industriali e degli operai, non ho disciplinato le requisizioni, né le imposizioni d'opera da parte del governo . Ove occorresse si potrà farlo rapidamente» (14 ). Non ci fu bisogno di ricorrere a misure estreme; gli industriali non appena si accorsero che le autorità militari non intendevano ricorrere alla facoltà loro concessa dal decreto d el 26 giugno 1915 di stabilire d'imperio i prezzi dei materiali commissionati all'industria, collaborarono di buon grado. « La dichiarazione di ausiliarietà, vista con sospetto quando sulle prime vi si addivenne d'imperio e si temevano ingerenze dello stato nella gestione interna delle imprese, divenne presto ambitissima» (15 ).
La militarizzazione era deside rata sia dai proprietari sia dalle maestranze degli stabilimenti per diversi motivi. Gli industriali, con la dichiarazione di ausiliarietà, si assicuravano m olteplici vantaggi, il principale dei quali era senza dubbio la certezza di poter contare sulle commesse militari fino alla fine del conflitto; acquisivano inoltre la sicurezza di poter far fronte agli impegni poichè era stabilito un trattamento preferenziale e prioritario, per le industrie mobilitate, nell'assegnazione delle materie prime, mentre la concessione degli esoneri garantiva la disponibilità di maestranze qualificate la cui continuità di lavoro era assicurata dalla militarizzazione. In pratica, con la dichiarazione di « ausiliarità » si eliminava la quasi totalità dei rischi che l'imprenditore deve affrontare in condizioni normali. Notevoli erano anche i vantaggi che le maestranze conseguivano in seguito ad una simile dichiarazione; infatti, oltre all'agognatissimo esonero, bisogna considerare la non licenziabilità senza l'autorizzazione dei Comitati Regionali e, man mano che l'organizzazione della Mobilitazione Industriale si andava strutturando, un deciso miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e una maggior cura per le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro . Tutto ciò aveva un notevole peso soprattutto nelle piccole industrie dove le condizioni di lavoro erano sovente precarie e il movimento sindacale quasi inesistente.
All'atto pratico poi i Comitati Regionali si dimostrarono discretamente efficienti nel regolare le controversie tra datori di lavoro ed operai come risulta dalla tabella di pagina seguente.
Da questi dati risulta che, dopo il primo periodo che potremmo chiamare sperimentale, si fece ampio ricorso alla mediazione dei Comitati e se l'elevato numero delle vertenze negli ultimi due anni testimonia la necessità di rapidi adeguamenti dei salari

Tabella 1
Anni Componimenti ottenuti con l'intervento: Ordinanze del di deleg. del C.R. del Comitato Reg.
al costo della vita, l'alto numero delle conciliaznoni avvenute testimonia l'efficacia dell'azione equitativa dei Comitati; ciò risulta anche dal confronto del numero delle ordinanze emesse in quegli anni dai Comitati Regionali e dal Comitato Centrale presso il quale era possibile ricorrere in seconda istanza:
Tabella 2
Il fatto che su 1.406 vertenze solo 192 fossero state risolte in modo tale da indurre una delle parti a ricorrere presso gli organi centrali della Mobilitazione Industriale, testimonia l'efficacia dell'azione svolta dai Comitati Regionali.
Indubbiamente l'essere riusciti a comporre oltre 1'85% delle vertenze, in un modo che fosse accettato dalle parti, dimostra anche l'eccezionalità della situazione. Infatti questa reciproca buona disposizione tra industriali ed operai non era soto portata dal clima particolare creato dalla guerra. L'Abrate attesta che il segretario della lega industriale piemontese, Gino Olivetti, « spingeva gli imprenditori a concedere il possibile senza costringere gli operai all'arbitrato dei comitati di mobilitazione e occorre dire che era ascoltato» (1 8 ).
Tutta questa condiscendenza era giustificata dal fatto che le amministrazioni militari non facevano difficoltà a trasferire il costo degli aumenti salariali concessi, sul prezzo delle fortniture (1 9 ). In definitiva la buona volontà degli industriali era derivata dal fat-

to che non costava loro un gran sacrificio concedere aumenti salariali, tant'è che, in genere, le vertenze sottoposte all'arbitrato dei Comitati Regionali e del Comitato Centrale si riferiscono, più che ad aumenti di salario in senso stretto, ad altri miglioramenti il cui valore economico o la cui portata nel t empo era più difficilmente valutabile o quantificabile.
Per comprendere a pieno gli effetti della situazione creata dalla guerra e dal particolare regime della Mobilitazione Industriale, basterà osservare le statistiche dei conflitti di lavoro in quel periodo:
Anche i dati relativi alle serrate sono quanto mai significativi:
Gli stabilimenti in cui si verificarono le serrate non erano certo quelli mobilitati, per cui la riduzione del numero delle serrate nel periodo del conflitto sta a testimoniare la particolare atmosfera di « pace sociale » realizzatasi in quegli anni.
Per quanto riguarda le industrie mobilitate, le giornate perdute per astensione dal lavoro dal 1° gennaio al 31 ottobre 1918 furono 356.855 ( 21 ) dal che si deduce che se, nel corso della guerra la conflittualità sindacale diminuì, ciò fu dovuto solo in parte al regime eccezionale cui furono sottoposti gli stabilimenti ausiliari

i quali, almeno per il 1918, contribuirono massicciamente ad elevare il totale delle giornate di lavoro perdute. In definitiva era la particolare situazione creata dal conflitto, che favoriva lo sviluppo industriale in assenza o quasi di concorrenza estesa, a ridurre grandemente i conflitti di lavoro.
La scelta delle autorità militari di non lesinare sui prezzi quando si trattava di aumenti salariali non era avvenuta a caso. Ciò infatti rientrava nella politica del generale Dallolio mirante non solo a rendere possibile la piena collaborazione degli industriali allo sforzo bellico, ma anche, e soprattutto, il recupero delle masse operaie all'unione sacra della nazione in guerra. Questa politica veniva articolata su due livelli: da un lato non si ostacolavano gli aumenti salariali che anzi, entro certi limiti, venivano favoriti, mentre si provvedeva, inoltre, ad imporre l'osservanza alle aziende delle norme igieniche e sanitarie e si dedicava notevole cura alla prevenzione degli infortunii sul lavoro, dall'altra veniva svolta una massiccia propaganda per far sentire gli operai non solo partecipi, ma anch'essi protagonisti dello sforzo bellico del paese. Questa propaganda ottenne un notevole successo tra gli imprenditori e le maestranze degli stabilimenti mobilitati, poiché controbbatteva le affermazioni che sovente affioravano nella stampa, specie di quella più accesamente interventista, per cui gli industriali apparivano come speculatori e gli operai come imboscati; gli uni e gli altri traenti vantaggi della situazione creatasi col conflitto. Queste affermazioni rispondevano ad una mentalità largamente diffusa nell'opinione pubblica e soprattutto nei combattenti; per cui la propaganda della Mobilitazione Industriale, tendente a valorizzare lo sforzo compiuto da imprenditori ed operai per la vittoria, non poteva che trovare una favorevole accoglienza dagli uni e dagli altri. Il far propria l'ampollosa qualifica di « combattente del fronte interno» poteva senza dubbio servire in questa situazione agli operai a sentirsi meno diversi dai combattenti veri, come la convinzione della validità ed indispensabilità della loro attività consentiva agli industriali di non sentire troppo il disagio di una situazione, che proprio a causa della guerra, permetteva loro di accumulare grossi profitti senza correre rischi. Non che un certo disagio non fosse egualmente avvertito. Infatti nella riunione del 16 dicembre 1916 della Commissione per il « risparmio operaio » presso il Comitato Centrale della M.I. Buozzi non esitò a dichiarare che non bisognava chiedere l'aiuto dello Stato per l'assicurazione operaia perché « in questo momento gli operai e gli industriali metallurgici sono considerati dei privilegiati

e quindi chiedere al governo dei contributi gli sembra problematico» ( 22 ). Fu, comunque, una delle principali preoccupazioni dei responsabili della Mobilitazione Industriale attenuare questo disagio. Il generale Dallolio, rivolgendosi al Presidente del Consiglio, nella riunione del 26 novembre, cui già abbiamo fatto ripetutamente cenno, concluse dicendo: « Gli industriali e gli operai hanno accennato ad una specie di marasma grigio che li turba; nulla ci deve turbare in questo momento . Industriali ed operai hanno fatto e continueranno a fare il loro dovere. Ma venga da Voi la parola che li incoraggi ad andare avanti fiduciosi e senza preoccupazione; la domando per gli industriali e per gli operai d'Italia e fino alla vittoria»! ( 23 )
Questa presa di posizione era perfettamente conforme alla politica seguita dal capo della Mobilitazione Industriale. Il generale Dallolio, come Sottosegretario prima e come Ministro poi, affermò sempre (abbiamo visto come) la propria fiducia nel patriottismo delle masse operaie, adoperandosi in ogni modo per valorizzare il contributo dato da queste al paese in guerra. Ciò se nel clima di intolleranza creatasi nel « fronte interno», poteva rendere meno difficile la posizione degli operai esonerati, finiva per coinvolgerli, sempre più strettamente, nel sostegno dello sforzo bellico nazionale . Un'analoga politica, nelle grandi linee, fu seguita dai responsabili della Mobilitazione Industriale anche per quanto riguardava il movimento sindacale . Infatti, la partecipazione ai Comitati Regionali dei rappresentanti operai su un piede di parità con quelli degli industriali, costituì indubbiamente un elemento di valorizzazione dell'organizzazione sindacale, anche per il crisma di legalità e di ufficialità che dava alla rappresentanza operaia. Questo fatto ebbe indubbiamente un grosso valore nelle zone in cui l'organizzazione sindacale era debole e nelle medie e piccole aziende, in cui, sovente, non aveva radici molto solide. Non ci deve quindi stupire se nella stessa relazione di Mario Guarnieri, al congresso della F I OM del 1918 in cui, come si ricorderà, si erano manifestate forti preoccupazioni sui motivi che avevano indotto le autorità a costituire la « Mobilitazione Industriale», si può leggere il seguente riconoscimento:
« I comitati di mobilitazione hanno fatto fare agli industriali e agli operai un buon passo . Nei paesi industrialmente e sindacalmente più progrediti hanno trascinato anche quei pochi industriali che ancora si rifiutavano di trattare coi propri operai, a considerare le loro richieste e a spiegare le ragioni degli eventuali rifiuti ad accoglierle . Lo stesso contatto tra rappresentanti operai ed industriali ha servito a dare a noi una più profonda

conoscenza delle ragioni che gli industriali adducono a sostegno dei loro interessi, ci ha abituati a considerare più seriamente il problema della gestione dei mezzi di produzione e ha infine abituato gli industriali a non valutare più il lavoro come un elemento secondario e trascurabile della produzione» (24 ).
La soddisfazione per l'importanza del ruolo assunto all'interno dei comitati di mobilitazione da parte del sindacato, fu chiaramente espressa, nel corso di una riunione speciale del Comitato Centrale della Mobilitazione Industriale, da Bruno Buozzi il quale non esitò ad affermare: « Gli operai riconoscono che nella Mobilitazione Industriale è stata loro data quella rappresentanza che desideravano, rappresentanza che è stata tenuta nella maggior considerazione sia dai membri industriali che da quelli civili » (25). Questa situazione permetteva al sindacato di svolgere un'azione che aveva un'importanza senza precedenti; è quindi spiegabile la sostanziale difesa che molti anni dopo Gino Castagno, un altro dirigente sindacale, fece dell'organizzazione della Mobilitazione Industriale: « A guerra finita, si poté, forse, dire che, senza di essa, gli operai avrebbero guadagnato di più, particolarmente la categoria dei metallurgici che avrebbe potuto far giocare sul piano economico l'effetto dell'enorme richiesta di mano d'opera negli stabilimenti del settore, per le esigenze della produzione bellica. Ma i dirigenti sindacali si preoccuparono allora più della difesa del movimento nel suo complesso, che non degli interessi economici immediati della categoria » ( 26 ). Nella situazione creatasi la « difesa del movimento nel suo complesso » poteva essere realizzata soltanto attraverso il potenziamento dei Comitati di mobilitazione e l'allargamento dell'influenza di questi. Su questa strada non esitarono a porsi i dirigenti sindacali.
Si legge infatti nel verbale della riunione su accennata, che Buozzi « coglie l'occasione della presenza del Ministro dell'Interno per accennare come, da qualche settimana, si prendano dei provvedimenti gravi verso operai di stabilimenti, tenendo conto delle loro tendenze politiche. Tali operai vengono allontanti dagli stabilimenti ed egli non trova che ciò sia giusto, né opportuno. Comprende che l'autorità politica non può rinunciare alle sue prerogative, né può lasciare alla Mobilitazione Industriale il solo diritto di giudicare; chiede però che non si cerchi di fare il possibile, onde tra Autorità politica e Comitati Regionali, si proceda sempre d'accordo quando debbano prendersi provvedimenti a carico di operai appartenenti a stabilimenti ausiliari. Il Comitato Regionale è il solo responsabile della produzione e del regolare andamento degli stabilimenti dipendenti e quindi non si può e non si

deve ammettere che altri enti fomentino il malcontento negli stabilimenti stessi» (27 ).
Ma la valorizzazione del ruolo delle strutture della mobilitazione industriale comportava fatalmente, per i dirigenti sindacali, un sempre maggiore inserimento in essi e quindi una sempre maggiore partecipazione allo sforzo bellico del paese. La forza delle cose spingeva inesorabilmente i dirigenti sindacali verso queste posizioni. Infatti, se non volevano rinunciare allo svolgimento dei loro compiti, dovevano necessariamente entrare a far parte dei Comitati della Mobilitazione Industriale, ed una volta entrativi, non potevano fare a meno di prendere parte attiva alla preparazione bellica. Questa situazione fece fra l'altro sì che si approfondisse la frattura tra la dirigenza della CGL e la maggioranza del P.S.I. che era ferocemente avversa a qualsiasi « compromissione» patriottica per il conflitto in corso. In genere si fa risalire l'atteggiamento più ben disposto verso le esigenze del paese in guerra assunto dai dirigenti sindacali, dagli amministratori socialisti e dal gruppo parlamentare, al loro riformismo contrapposto al massimalismo della direzione del P.S.I. Ciò è indubbiamente vero ma non spiega completamente il fenomeno In realtà vi sono anche altri elementi che bisogna considerare. Infatti se per la sua struttura burocratico-organizzativa, il Partito Socialista poté isolarsi dal resto del paese, cercando di mantenere in vita le proprie sezioni in attesa che la bufera passasse, non altrettanto poterono fare gli altri gruppi, i quali, specie i dirigenti della CGL e gli amministratori degli enti locali, avendo responsabilità pubbliche e dovendo agire necessariamente all'interno della situazione che si era venuta a determinare, non poterono non risentire del « clima » in cui viveva l'Italia.
Avrebbero dovuto o rinunziare a qualsiasia attività, e conseguentemente venire sostituiti o emarginati, o collaborare di fatto allo sforzo bellico del paese. P er i dirigenti sindacali la scelta era quasi obbligata anche se essa era pienamente conforme ai loro convincimenti riformistici. I diversi orientamenti del sindacato e del partito socialista nei confronti dello sforzo bellico del paese non mancarono di avere ripercussioni sulle stesse strutture organizzative delle associazioni
Il P.S.I. conobbe negli anni del conflitto un costante calo organizzativo passando da 58.326 iscritti nel 1914 a 41.974 del 1915, precipitando poi a 29.426 nel 1916, calando quindi a 27.918 nel 1917 per scendere ancora a circa 24.000 alla data del XV° Congresso nel 1918 ( 28 ). Secondo una pubblicazione ufficiale del P.S.I. ciò era quasi completamente da imputarsi ai richiami. « Non c'è

dubbio» si leggeva nel documento « che oltre il 60% dei nostri iscritti sia sotto le armi e perciò la diminuzione delle tessere e delle Sezioni è conseguenza dei richiami alle armi e dello stato di guerra in cui si trovano ben 12 province » ( 29 ).
In effetti la contrazione del numero degli iscritti aveva probabilmente cause più profonde che non il semplice reclutamento o l'estensione della zona d'operazione. Va infatti segnalato che la riduzione del numero degli iscritti si accompagnò ad una rapida contrazione del numero delle sezioni che da 1.843 nel 1914 scesero a 1.518 nel 1915 per precipitare a 1.221 nel 1916 e diminuire ancora a 1.159 nel 1917 ( 30 ). Né il calo si arrestò a queste cifre: infatti, nel congresso del 1918 parteciparono allo votazioni conclusive i rappresentanti di 19.027 iscritti divisi in 658 sezioni il che fa pensare che sul totale complessivo di 24.000 iscritti le sezioni non dovessero essere più di un migliaio.
Un primo esame sembrerebbe confermare la tesi che questa brusca riduzione delle strutture organizzative del P .S.I. sia causata dai richiami alle armi, infatti le province sedi di grandi concentramenti industriali sono tra quelle che reggono meglio la crisi organizzativa del partito (Milano da 65 sezioni nel 1914 a 56 nel 1917, Genova da 39 a 30, Torino da 56 a 42) il che si spiegherebbe con il fatto che il proletariato industriale invece di essere inviato al fronte fu impegnato nella produzione b ellica. Ad un esame più approfondito appare però una realtà ben diversa: infatti le province che contavano nel 1914 più di 50 sezioni avevano, con la sola eccezione, per altro spiegabile, di Forlì, retto bene alla prova anche se si trattava di province agricole in cui la mobilitazione generale era stata pienamente eseguita: Alessandria da 93 sezioni nel 1914 a 77 nel 1917, Bologna da 70 a 49, Firenze da 86 a 60, Forlì da 82 a 37, Novara da 155 a 125, Pavia da 67 a 50, Ravenna 78 a 49, Reggio Emilia da 107 a 91 (31 ).
I n queste province la percentuale di contrazione del numero delle sezioni fu fortemente inferiore a quella nazionale. Il crollo non era avvenuto nelle zone, agricole o industriali che fossero, dove la penetrazione socialista era notevole, bensì in quelle in cui l'organizzazione era debole soprattutto nel centro-sud. Alla luce di questi fatti si deve concludere che la crisi organizzativa del P.S.I. negli anni della guerra, molto più che ai richiami alle armi, è da imputarsi al clima politico creatosi nel fronte interno. Infatti, là dove il partito era numeroso e disponeva di solide tradizioni affrontò meglio la dura prova, mentre invece dove era debole e dove non esistevano altri gruppi tendenzialmente pacifisti ( come nel Mezzogiorno dove i cattolici facevano in gran parte

mostra dei loro sentimenti patriottici ed i giolittiani erano scomparsi, almeno ufficialmente, da tempo) fu isolato e vide frantumarsi la sua debole struttura.
In conclusione, la crisi organizzativa del P .S.I. nel corso della grande guerra, fu in gran parte conseguenza della posizione assunta dal partito che lo isolava dal resto del paese e rendeva difficile ogni sua azione propagandistica. La situazione organizzativa della CGL era in quegli stessi anni alquanto diversa. Da 320.858 iscritti nel 1914 la confederazione era scesa a 233.963 nel 1915; aveva toccato la punta più bassa nel 1916 con 201.291 iscritti, era risalita a 237.560 nel 1917, aveva infine raggiunto i 249.057 aderenti nel 1918 ( 32 ).
Per comprendere il senso di questi spostamenti è necessario valutare l'andamento delle iscrizioni delle federazioni di mestiere più rappresentative:

Si tratta dei dati relativi ad alcune tra le più importanti e significative organizzazioni di categoria da cui risulta, da un lato il progressivo contrarsi del numero degli iscritti nei settori non coinvolti nella produzione di guerra, in seguito principalmente ai richiami alle armi, dall'altro il vertiginoso aumento delle adesioni dei lavoratori dei settori interessati alla produzione per le forze armate.
In questo contesto si comprende sia la prima contrazione del numero degli iscritti, sia il successivo lento incremento. Incremento, giova sottolinearlo, che fu reso possibile dalla politica adottata dai dirigenti sindacali nei confronti della « Mobilitazione Industriale » e quindi del paese in guerra.
Nel complesso si assisté quindi al realizzarsi di una situazione che vedeva da un lato un partito socialista, emarginato dal clima di intolleranza creato dalla guerra, rinchiudersi nelle sempre meno numerose sezioni per radicalizzare l'intransigenza degli iscritti superstiti, dall'altro un'organizzazione sindacale che,
fortemente coinvolta nello sforzo bellico del paese, vedeva costantemente aumentare i propri aderenti.
Il successo della Confederazione Generale del Lavoro non poteva che rafforzare i convincimenti riformisti nutriti dalla grande maggioranza dei suoi dirigenti e questo, nella particolare contingenza determinatasi, non poteva che allontanarli dai loro compagni di partito.

D'altro canto, la scelta « collaborazionistica » della CGL la mise in condizione di operare attivamente, assieme alle altre organizzazioni sindacali, in favore degli operai deUe industrie mobilitate, ottenendo notevoli risultati nel migliorarne le condizioni di lavoro. All'inizio la sorveglianza disciplinare negli stabilimenti era affidata ai comandi di divisione, il ché non mancò di provocare qualche inconveniente e, benché a ciò si fosse posto riparo ( 33 ), fu ritenuto opportuno trasferire il controllo ed il coordinamento della sorveglianza degli stabilimenti ai Comitati Regionali di Mobilitazione Industriale. Questo servizio dapprima si svolgeva nelle sole imprese mobilitate, dal dicembre del 1916 fu esteso a tutte quelle che avevano operai militari o esonerati. « La sorveglianza si estendeva negli stabilimenti ausiliari e requisiti , a tutto il personale di ruolo amministrativo, tecnico ed operaio sia maschile che femminile; nelle aziende non ausiliarie, al solo personale militare (esonerati, comandati, a disposizione) » ( 34 ).
Oltre a ciò, con il D.Lt. del 5 novembre 1916 n. 1684 furono emanate nuove norme penali e disciplinari per gli stabilimenti adibiti alla produzione bellica. La nuova normativa mitigava le disposizioni del codice penale militare, alle cui norme, fino a quel momento, erano state sottoposte le maestranze. I sindacalisti, che si erano attivamente adoperati per ottenere che gli stabilimenti fossero sottoposti a norme meno rigide di quelle del codice penale militare di guerra, insistettero ulteriormente per ottenere ch e si avesse particolare riguardo nei confronti delle maestranze minorili e femminili impegnate nella produzione bellica ( 35) ottenendo ulteriori agevolazioni (D.Lt. 16 marzo 1917 n. 570). Nel 1917 poi una serie di disposizioni legislative (D.L. 29 aprile 1917 n. 670 e D.L. 24 luglio 1917) estese a tutte le imprese impegnate nello sforzo bellico l'obbligo, già in vigore per gli operai dipendenti dal Comando Supremo di guerra e per quelli degli stabilimenti militari, dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza. Si trattava di un provvedimento significativo dato che, come ha ricordato il Melograni, numerosi settori tra i più importanti fra quelli impegnati nella mobilitazione industriale, ne erano in precedenza esclusi. Del pari significativo era il fatto che il
provvedimento era stato studiato e fissato, nelle sue grandi linee, da una commissione mista operai-imprenditori appositamente nominata dal Ministro delle armi e munizioni ( 36 ).
Con il D.Lt. del 15 marzo 1917 n. 570 veniva istituito il servizio di vigilanza igienico-sanitaria presso il Ministero delle armi e mwlizioni. In sede locale il nuovo sen1izio era organizzato e regolato dai Comitati Regionali. Con le nuove disposizioni, non solo si vincolavano gli industriali ad osservare le necessarie disposizioni contro gli infortuni e per la tutela igienico-sanitaria deJle maestranze, ma si faceva obbligo agli stessi operai di servirsene. Tutto ciò contribuì notevolmente al miglioramento delle condizioni di lavoro anche se il numero degli incidenti sul lavoro si mantenne alto, nonostante le più accurate disposizioni antinfortunistiche, in seguito ai forti aumenti di personale non qualificato. Oltre a tutti i provvedimenti che abbiamo citato bisogna segnalare che, nel corso della guerra (benché talvolta, in considerazione di particolari necessità, grandi offensive, rotta di Caporetto ecc., si lavorasse anche fino a 14 ore al giorno negli stabilimenti) andò affermandosi una tendenza favorevole alla graduale riduzione del normale orario di lavoro; ecco, ad esempio i dati relativi alla Fiat:
Tracciando un bilancio degli anni della guerra nel corso del V Congresso Nazionale della federazione degli operai metallurgici tenutosi a Roma alla fine del 1918, Bruno Buozzi poté, a ragione, vantare una serie di notevoli successi ottenuti quali: il contenimento dell'orario massimo di lavoro entro le dieci ore giornaliere; gli aumenti per le ore di straordinario; l'equiparazione dei cottimi tra uomini e donne; l'iscrizione degli operai degli stabilimenti ausiliari alla Cassa Nazionale di Previdenza ( 38 ).

In conclusione non si può certo dire che la decisione della C.G.L. di collaborare con le autorità militari non riuscisse a conseguire notevoli vantaggi a favore della classe operaia.
Chiarita la posizione dell'organizzazione sindacale negli an-
ni del conflitto, resta da esaminare l'orientamento assunto dalle masse operaie nei confronti della guerra. Non vi è alcun dubbio che la quasi totalità degli operai fosse ostile alla guerra; rimane da chiarire se questa ostilità, una volta scoppiato il conflitto, sia stata così forte da far desiderare la pace anche a prezzo della sconfitta. Nel corso della guerra vi furono due grosse agitazioni popolari per porre termine al conflitto, che coinvolsero due grandi città industriali: le dimostrazioni di Milano nel maggio del 1917 e la sommossa di Torino nell'agosto di quell'anno, vale quindi la pena di esaminare questi due avvenimenti più dettagliatamente. Le dimostrazioni di Milano nacquero in seguito ad agitazioni sindacali iniziate nella provincia. Si legge infatti in un documento dell'ufficio riservato di pubblica sicurezza: « Il 24 aprile scorso cominciò a Gallarate l'agitazione degli operai tessili che estese in tutto il Circondario nonché a quello di Monza ed alla stessa Milano con manifestazioni pubbliche di carattere apertamente antibellico » ( 39 ). In questa situazione la corrente rivoluzionaria del partito socialista decise di fare un tentativo per trasformare l'agitazione in una vera e propria sommossa e costringere il partito a prenderne la direzione. Turati, in una lettera alla Kuliscioff, così descrisse i progetti dei massimalisti: « Figurati che il piano per il 1° Maggio era questo: si erano fatte conferenze fuori Milano, preparativi per chiamare alla Casa del Popolo tutto l'elemento sovversivo dei Comuni vicini , probabilmente anche peggiore di quello milanese: si era deciso di far così uscire la folla dalla Casa del Popolo per la dimostrazione ... proibita dal decreto luogotenenziale e dall'Autorità: io dovevo essere l'oratore e l'unico oratore perché l'adunata fosse permessa: a me non si disse nulla, anzi, quando , dopo parlato col Questore andai da Fortichiari per accertarmi che non vi fosse intenzione di corteo o d'altro - mi si rispose che nessuno vi pensava ... Molta roba combinata di nascosto nel Comitato, nei rioni e nella piccola propaganda. Aggiungi le decine di migliaia di manifestini . Per cui, in sostanza, si fecero tre truffe: al P artito, che non fu interrogato e non deliberò, a me, che dovevo essere la bandiera per coprire tutta questa roba; e all'Autorità a cui io avevo, in certo modo, garantito che, se si lasciava - come fu lasciata - ampia libertà al Comizio, p r ivato di nome, pubblico in realtà, non sarebbe seguito nulla nelle strade ... Un partito serio avrebbe riprovato energicamente questa triplice slealtà; tanto più che tutti dovevano sentire il pericolo che questi sistemi presentano dappertutto e non nella sola Milano » ( 40 ). Il lavoro dei massimalisti non andò sprecato: infatti il 1° Maggio a Milano circa 4.000 dimostranti,

in gran parte donne e ragazzi, mscenarono una manifestazione che impegnò lungamente le forze dell'ordine.
Le agitazioni si protrassero nei giorni successivi. Tuttavia gli avvenimenti non procedettero come la frazione rivoluzionaria del P.S.I. milanese aveva sperato; le manifestazioni « hanno sapore di jacquerie », nota Turati « con la differenza che sono sopratutto le donne, che però sono furie. Vogliono far cessare la guerra subito: rivogliono i loro uomini: ce l'hanno con Milano, che volle la guerra e che ora porta via loro tutto, grano, lardo, riso - riso sopratutto: che in campagna non si trova più e costa 1,70 al chilo -e vogliono far la pelle ai signori, fra i quali - beninteso - siamo anche noi, tanto che si sospettava di una dimostrazione rurale contro il Municipio. C'è forse lo zampino dei preti, e si spandono - come nella peste del Manzoni - le notizie più strambe, che il Municipio tiene nascosto il riso per affamare i contadini e così di seguito. Contro gli operai del bracciale, che fanno le munizioni , sono furibonde » ( 41 ).
La massa dei manifestanti era quindi costituita da donne ve nute dalla campagna le quali non intendevano fare causa comune con gli operai « imboscati » nelle fabbriche. Ciò comprometteva grandemente i programmi dei rivoluzionari, sia perché diveniva impossibile amalgamare gli operai e le contadine, sia perché queste fratture rendevano il movimento praticamente incontrollabile.
Mentre la frangia rivoluzionaria del partito socialista non riusciva a prendere la direzione dei manifestanti, i riformisti, capeggiati da Turati, si erano riavuti dalla sorpresa ed agivano energicamente per impedire che il partito fosse coinvolto in iniziative che giudicavano destinate al fallimento. In questo frangente emerse nuovamente la frattura tra le due anime del socialismo e le organizzazioni che le rappresentavano.
Infatti, mentre la C.G.L. e il Comune cercavano di por fine alle agitazioni, le strutture del partito cercavano con ogni mezzo di « allargare il movimento» (42 ). Nonostante che i tumulti continuassero , il 4 maggio i rivoluzionari che non erano riusciti a prendere il controllo delle agitazioni, non riuscirono nemmeno a contenere la pressione dei riformisti per cui, nella riunione congiunta dei rappresentanti della C.G.L. e del P .S.I., fu presa la decisione « di astenersi da qualsiasi partecipazione al movimento attuale, ritenendolo pel momento, inopportuno e privo dell'assenso della massa proletaria» ( 43 ).
La riunione della direzione del partito quattro giorni dopo sanzionò, sia pure non senza contrasti, la vittoria dei mode-

rati (41 ). Il tentativo della frazione rivoluzionaria o «rigida», come veniva chiamata, del P.S .I. di servirs i delle agitazioni lombarde per trascinare l'intero partito sulle proprie posizioni, falll quindi completamente. Ciò avvenne non tanto per l'azione moderatrice svolta da Turati, dal sindaco di Milano, dai dirigenti sindacali, quanto perché non s i verificarono le condizioni necessarie per « l'allargamento del movimento».

Infatti non si poterono integrare i dimostranti venuti dalla campagna con gli operai della città, né, a differenza di quanto era avvenuto in Russia, i r eparti impegnati nel servizio di ordine pubblico dimostrarono in alcun modo di voler fare causa comune con i manifestanti. I «rigidi» sapevano fin troppo bene che Turati ed i suoi amici si sarebbero opposti ad ogni tentativo rivoluzionario ed avevano puntato sulle manifestazioni per travolgere la loro resistenza: solo dopo il fallimento del tentativo compiuto dai rivoluzionari di estendere ed egemonizzare le dimostrazioni, fu possibile per i riformisti avere la meglio.
Il Prefetto di Milano riferendo al Ministero dell'Interno che i dirigenti socialisti avevano sconfessato le agitazioni, rilevò « ch e essi, malgrado le loro buone intenzioni, erano travolti dagli elementi più spinti » ( 45 ).
In effetti la situazione andò normalizzandosi perché le agitazioni non furono, come si è detto, tali da permettere ai « rigidi» di « allargare il movimento» come avrebbero desiderato. I riformisti, per prevenire il ripetersi di analoghi episodi, riuscirono a far votare nella riunione congiunta della direzione del P.S .I., della C.G.L. e del gruppo parlamentare, tenutasi 1'8 maggio, un ordine del giorno in cui tra l 'altro si invitavano « le organizzazioni e i singoli a non assumere iniziative isolate e frammentarie, le quali potrebbero compromettere quella forza politica che, indubbiamente, al Partito socialista è venuta dal suo atteggiamento di fronte a lla guerra e che varrà, al momento opportuno, a realizzare quel programma politico e social e che il Partito socialista si appresta a difendere str enuamente » ( 46 ). Scrivendo però qualche giorno dopo alla Kuliscioff, Turati si d ichiarava scettico sull'efficacia che un simile appello avrebbe potuto avere sugli estremis ti ( 47 ). Gli avvenimenti di Torino, di lì a qualche mese, diedero ragione alle previsioni del capo dei riformisti. Nel valutare la sommossa avvenuta a Torino nell 'agosto del 1917 non bisogna però credere che la responsabilità sia da attribuirsi unicamente all'azione della frazione dei « rigidi» del P.S .I., anche se questo gruppo s i era mosso da tempo verso obiettivi di tipo insurrezionale. Infatti come riporta lo Spriano:
« Ora è Francesco Barberis (27 maggio) che pare pronunci la frase, restata poi famosa: "nei prossimi comizi gli operai dovranno intervenire non con delle scatole di cerini in tasca ma con buone rivoltelle per attaccare la forza pubblica". Ora è Rabezzana, che affermerebbe: " non bisogna perdere più tempo e lavorare attivamente per una insurrezione generale, impadronendosi delle bombe, che si fabbricano in grande quantità in tante officine di Torino, per adoperarle contro i soldati" » ( 48 ) Nonostante ciò è indubbio che le sommosse che coinvolgono le grandi città con decine di morti e centinaia di feriti e di arrestati, non nascono unicamente dalla predicazione rivoluzionaria di un piccolo gruppo di agitatori, per quanto questi possono essere abili e tenaci. Per comprendere pienamente gli avvenimenti dell'agosto 1917, bisognerà considerare la particolare situazione della città di Torino. Il comm. Fe1Taris, funzionario della direzione generale di Pubblica Sicurezza inviatovi appositamente nell'estate del 1917, riferiva nel suo rapporto: « In Torino, l'opinione pubblica fu sempre, in tutte le classi, generalmente avversa alla attuale nostra guerra, e tale si mantenne. :È ben naturale, adunque, che ivi più che altrove, trovi il terreno atto a germogliare il seme della pace, anche se prematura » ( 49 ).
In effetti in città giocavano un grosso ruolo i giolittiani che disponevano anche di un grande quotidiano, (< La Stampa», e parimenti importanti erano i cattolici e i socialisti. Alla luce di queste considerazioni si comprende facilmente come la guerra fosse in sostanza respinta dalla città in blocco. Oltre a ciò bisogna considerare le particolari caratteristiche del proletario torinese. Si trattava di una classe operaia di origine recente, in gran parte immigrata dalla campagna, quindi scarsamente integrata con la città ed estremamente instabile. A questi fattori vanno aggiunti, per l'agosto del 1917, altri elementi tra i quali ebbe grande importanza la carenza di pane che iniziò a manifestarsi nei primi giorni di agosto ( 50 ), e che, per la scarsa comprensione delle autorità centrali, continuò a trascinarsi per settimane; oltre a ciò bisogna considerare che il 13 agosto si svolgeva a Torino una grossa manifestazione in favore della delegazione del Governo provvisorio russo. I delegati russi erano quasi tutti avversari della fazione bolscevica, ma i (( rigidi » con una traduzione (< assai libera » ( 51 ) delle parole dei russi e con l'appoggio dei compagni « sparsi tra la folla di 40.000 persone, riuscirono a trasformare la cerimonia in una manifestazione contro la guerra, inneggiando a Lenin e alla rivoluzione » ( 52 ). In quello stesso giorno Giolitti uscì dal silenzio che si era imposto negli ultimi anni per tenere

un memorabile discorso al consiglio provinciale di Cuneo in cui tra l'altro, definì la guerra in corso « la più grave catastrofe dopo il diluvio universale».
Due giorni dopo, il 15, fu pubblicata la famosa nota pontificia che accennava all' "inutile strage". Le ripercussioni che ebbero questi fatti sulla cittadinanza torinese sono facilmente immaginabili: la città era ormai un barile di polvere prnnto ad esplodere. Il 22 mancò il pane, cominciò così un'agitazione che si trasformò b en presto in rivolta armata. Gli scontri si potrassero fino al 26 e costarono la vita a 1 ufficiale, a 2 soldati, a 2 operai esonerati ed a 36 borghesi (di cui 3 donne), i feriti furono 152 e precisamente 2 ufficiali, 10 soldati, 4 carabinieri, 1 commissario di P.S., 22 guardie di città, 2 militi della croce verde; 11 operai esonerati e 100 borghesi. Furono arrestate circa 900 persone delle quali 822 furono rinviate a giudizio (53 ). Bisogna considerar e che i feriti tra i dimostranti furono probabilmente molti di più di quelli ufficialmente accertati e che i morti sarebbero stati molto più numerosi se le autorità militari non avessero fatto togliere colpi dai nastri delle mitragliatrici dei reparti impegnati p e r impedire che sparassero a raffica (54 )
Se le cause che determinarono la sommossa di Torino furono complesse, più semplici appaiono i motivi del suo fallimento che non fu dovuto, per la particolare situazione cittadina cui facemmo cenno, all'ostilità delle classi medie, poiché i moti furono caratterizzati « dalla neutralità degli strati intermedi, spesso benevola verso i proletari insorti» ( 55 ). L'insuccesso va invece attribuito a due precise circostanze: l'insurrezione, per il clima particolare e per le circostanze in cui era esplosa, non era facilmente estensibile. In quel momento, nelle altre grandi città non vi erano problemi alimentari e gli orientamenti dei ceti medi non erano quelli della metropoli piemontese. Infatti, quando il prefetto di Torino, nel tentativo di introdurre il tesseramento per il pane nella provincia, senza far aumentare la tensione, aveva chiesto il 12 agosto ai suoi colleghi di Genova e Milano di adottare contemporaneamente un analogo provvedimento, ne aveva ottenuto un rifiuto perché il problema alimentare in quel momento era un fatto esclusivamente torinese ( 56 ). Inoltre 12 giorni dopo, i dirigenti socialisti, anche quelli dall'ala rivoluzionaria, dovevano constatare che, data la situazione generale e le caratteristiche del movimento, questo non era «esportabile» fuori da Torino. Racconta infatti Gino Castagno: « Constatata l'impossibilità di estendere il movimento di massa, che rimaneva isolato e disorientato, senza sbocco e senza difesa, e che fatalmente

dava già segni di stanchezza, un gruppo di compagni, con Buozzi , Serrati, Barberis, e alcuni deputati e consiglieri comunali torinesi, decise di lanciare un manifesto agli operai per invitarli a desistere» ( 57 ). L'altro elemento, del pari determinante per l'insuccesso dei moti, fu l'atteggiamento della truppa che, a differenza di quanto era avvenuto in Russia, non fraternizzò con gli insorti, ma represse la rivolta, nonostante che negli ultimi tempi fosse stata svolta una notevole propaganda a favore della fraternizzazione e che gli appelli in questo senso si ripetessero costantemente.
A comprendere questo fenomeno potrà giovare un brano del rapporto dell'ispettore generale di P.S . d'Alessandro inviato appositamente a Torino dopo la sommossa: « In caso di disordini le autorità militari ritengono di poter fare affidamento sulla truppa di fanteria, cavalleria e artiglieria, mentre desta qualche timore l'atteggiamento che potranno prendere i soldati del genio, che, come si sa, appartengono in massima parte alle categorie di operai meccanici » ( 58 ) È significativo che soltanto i soldati, che avevano un rapporto di identità sostanziale con i possibili rivoltosi, destassero qualche preoccupazione, mentre gli altri militari, di estrazione contadina o artigiana, davano pieno affidamento ai comandi. Il fatto di non essere molto popolari tra i fanticontadini non era ignoto ai dirigenti socialisti: Scalarini, il disegnatore dell'Avanti! disse ad un amico, cinque mesi prima di Caporetto: « I soldati siciliani, sardi e calabresi sono monarchici per la pelle, essi sparerebbero contro di noi socialisti con la medesima facilità e con la medesima voluttà con la quale sparano sugli austriaci, e noi dobbiamo quindi fare fra loro un'opera di persuasione e di propaganda, cercando di attirarli nella nostra orbita » ( 59 ). Questo atteggiamento ostile ai socialisti dei fanti contadini era solo un portato della fedeltà dinastica? Ciò appare in verità poco credibile. Ci sembra assai più probabile che quest'atteggiamento fosse anche in buona parte conseguenza del sordo rancore provato dal combattente contro l'imboscato, da chi riceveva cinquanta centesimi per esporre la propria vita ogni giorno, nei confronti di chi guadagnava buone paghe al sicuro. « Politici e militari si preoccupavano» ha scritto Piero Melograni « che il proletariato volesse "fare come in Russia" ma in realtà una delle più notevoli differenze tra la situazione italiana e quella russa si trovò proprio nel fatto che in Italia, durante la guerra, la contrapposizione tra città e campagna non fu mai superata, e "i fanti contadini" provavano un odio crescente nei confronti degli "operai imboscati". A Pietrogrado i

tumulti del febbraio si trasformarono in "rivoluzione" quando la guarnigione si schierò dalla parte dei dimostranti. A Torino, viceversa, durante i moti dell'agosto, i soldati spararono contro i dimostranti» (60 ). In definitiva anche a Torino si ripresentò, in altra forma, la frattura che aveva provocato l'insuccesso delle manifestazioni milanesi. Infatti nella metropoli lombarda non era stato possibile amalgamare le donne del contado con gli operai della città ed a Torino la frattura fanti-contadini ed operai-imboscati aveva giocato w1 ruo]o determinante.
Da questa analisi emerge che nelle agitazioni del 1917 ebbe parte notevole la corrente rivoluzionaria del P.S.I., l'azione della quale non sarebbe stata comunque sufficiente a provocare le manifestazioni e la rivolta senza gravi ed obiettive situazioni di disagio. Infatti sia in Lombardia che in Piemonte, lo scoppio delle agitazioni non fu p r eordinato e solo i n un secondo momento i « rigidi » cercarono di controllare ed estendere il movimento. Peraltro, l'unica manifestazione propriamente operaia fu la rivolta di Torino, che per particolare situazione politica della città, per le caratteristiche degli operai che ne furono protagonisti, per le specialissime circostanze in cui si verificò, non può, da sola, costituire una prova dell'orientamento del proletariato industriale italiano durante la prima guerra mondiale.

Purtroppo manca uno studio sull'ordine pubblico in Italia durante la Grande Guerra che permetterebbe di valutare, con maggior precisione, gli orientamenti delle masse operaie nel corso del conflitto; tuttavia esiste un approfondito lavoro su i « Moti popolari in Emilia-Romagna e Toscana ( 1915-1917) » che può fornire utilissime indicazioni sia per la sua completezza sia per la «rappresentatività» delle zone esaminate. Infatti nelle due regioni erano stati eletti nel 1913 ben 19 dei 42 deputati che avevano costituito il Gruppo Parlamentare Socialista. Il successo elettorale era poggiato su una solida base organizzativa, infatti nel 1914, su le 1.843 sezioni che componevano il P.S.I., ben 668 erano toscane e emiliane. Di conseguenza, trattandosi di due regioni con un'opinione pubblica fortemente orien tata a sinistra ed in cui la presenza delle organizzazioni socialiste era fortissima, gli orientamenti delle masse operaie acquistavano in questo contesto, un'importanza che trascendeva la situazione locale.
Dallo studio citato (61 ) emerge che tutte le agitazioni operaie, non aventi un esplicito ed immediato movente economico, furono sempre determinate dalle agitazioni delle donne venute dalla campagna che impedirono agli operai di iniziare o continuare il lavoro. Così avvenne a Firenze, a Bologna, e a Reggio Emilia nel
dicembre del 1916, a Pistoia nel marzo dell'anno successivo, a Bologna in aprile, a Lucca a Prato e a Firenze nel luglio del 1917 (62 ). L'agitazione più caratteristica avviene a Modena nel maggio del 1917.
« Si tratta di un grosso sciopero in cui la spinta da parte del proletariato agricolo è una delle componenti maggiori. Il 16 maggio del 1917 il prefetto riferisce che il 14 "contadine dintorni di Modena iniziarono città manifestazione pro-pace. Si astennero lavoro sigarie locale manifattura e qualche centinaio operai altri stabilimenti, complessivamente 2.000 circa. Intervento arma Carabinieri portò all'arresto di 140 persone. Fra le quali Bombacci Nicola fiduciario del P.S.U. e segretario locale della Camera del Lavoro. Dalle 13 alle 14 cessò la circolazione dei trams, vennero rotti alcuni vetri dei finestrini delle vetture. Ieri sera vicinanze proiettificio Sacca intervenne reparto allievi ufficiali Cavalleria per caricare dimostranti". L'agitazione si protrae il 15, il 16 e comincia a "morire" il 17, quando solo le sigarie e 1.000 operai del proiettificio continuano lo sciopero.
Il primo telespresso, che abbiamo visto, rischia di portarci sulla strada sbagliata. Il nome di Bombacci, che ha partecipato evidentemente alla dimostrazione, non può non saltare agli occhi. Si tratta nientemeno che del vice-segretario del partito, noto per essere uno dei socialisti più "rivoluzionari". Per di più è il segretario della Camera del Lavoro di Modena; l'organizzatore, si pensa, non può essere che lui. Ma i rapporti seguenti cominciano a far vacillare questa ipotesi. Si viene infatti a sapere: 1) che lo sciopero al proiettificio militare è cominciato perché un picchetto di dimostranti (non operai dello stabilimento) aveva sbarrato il ponte di accesso allo stabilimento stesso, impedendo in tal modo agli operai di entrare; 2) che la mattina del 15 tutti gli operai, militarizzati e non militarizzati si sono presentati allo stabilimento, ma che, verso le 10, le dimostranti "si dirigevano verso lo stabilimento per invitare gli operai ad associarsi alla manifestazione"; 3) che il 17 per quanto l'agitazione sia cessata, la maggior parte degli operai "non rientra negli stabilimenti per tema di rappresaglie"; 4) che Bombacci dal carcere, invia al prefetto un biglietto in cui promette "di mantenere calma l'opinione pubblica" se non ci saranno "manifestazioni patriottiche" » ( 63 ). In definitiva, anche in questo caso l'azione delle contadine ha un ruolo determinante nell'iniziare e mantenere in vita l'agitazione, mentre quello degli operai degli stabilimenti è del tutto passivo. Gli stessi dirigenti socialisti, anche quelli, come in que-

sto caso, dell'ala più estremista, si preoccupano più di gestire che di promuovere le agitazioni.
Dal complesso degli avvenimenti appare chiaro che le tensioni maggiori non si sviluppano nelle città ma nelle campagne, da dove le agitazioni prendono il via prevalentemente per iniziativa delle contadine.
« Le ragioni che inducono le donne a far scioperare gli operai degli stabilimenti ausiliari sono fondamentalmente due: 1) negli stabilimenti ausiliari si lavora per la guerra: si producono proiettili, obici, fucili, scarpe militari, vestiti militari, zaini, ecc .; se gli stabilimenti si fermano, pensano le donne, si fermerà anche la guerra: l'operaio "militarizzato" non scioperando tradisce i desideri e le speranze della sua classe; 2) gli operai che lavorano negli stabilimenti ausiliari, inoltre, sono dei privilegiati, in primo luogo perché guadagnano di più degli operai delle industrie non convertite a scopo bellico e molto di più dei contadini; in secondo luogo perché l'esonero agli operai viene concesso con maggior larghezza che ai contadini. L'operaio militarizzato, oltre che un traditore degli interessi di classe, diventa, agli occhi dei contadini, un "imboscato"» ( 64 ).
Le agitazioni contro la guerra, in un ambiente estremamente significativo quale quello tosco-emiliano, ripropongono tutto il problema dei rapporti tra città e campagna già emerso, sia pure in forma diversa, nelle agitazioni milanesi e nei moti di Torino. Ciò rende necessarie alcune considerazioni sulla ripartizione del carico della guerra tra i vari gruppi sociali in cui era divisa la società Italiana.
Nel quadriennio precedente lo scoppio della guerra la ripartizione del prodotto lordo privato, fra i vari rami di attività, fu percentualmente la seguente : agricoltura 44,6%, industria 25,0%, settore terziario 30,4%. La guerra non poteva non sconvolgere questi equilibri per cui, nel quadriennio successivo, le percentuali furono le seguenti: agricoltura 44,2% industria 30,25% attività terziarie 25,55 % . Si ebbe quindi, negli anni della guerra in percentuale, una lieve contrazione del prodotto delle attività agricole (-0,4%) un fortissimo incremento delle attività industriali ( +5,25%) e una notevolissima contrazione della percentuale del settore terziario (-4,85% ). Da questi dati risulta chiaro che fu soprattutto la piccola borghesia a sopportare il peso della ristrutturazione del sistema economico imposto dal conflitto (come è noto le attività del settore terziario sono in genere quelle caratteristiche dei ceti medi). Tuttavia la piccola borghesia era il gruppo sociale che aveva più di ogni altro sostenuto l'intervento e che,

in ogni caso, si riconosceva pienamente nell'ordinamento vigente. Questo fatto faceva sì, che nonostante i notevoli sacrifici, non solo economici, questo ceto sociale si dimostrasse per tutto il conflitto sostanzialmente unito nel sostenere lo sforzo bellico del paese.
Come si è visto, la contrazione della percentuale del valore del prodotto dell'agricoltura subì negli anni del conflitto una modesta contrazione (- 0,4%). Tuttavia bi sogna considerare che il disagio nelle campagne, nel corso della guerra, non era solo quello di natura economica; furono infatti i contadini a sopportare materialmente il maggior peso del conflitto .

Il Serpieri calcolò che fossero stati richiamati alle armi circa 2.600 000 contadini (65 ) per cui le condizioni di lavoro nelle campagne divennero molto pesanti. « I richiami alle armi nella misura esposta avrebbero diminuito gli uomini adulti da milioni 4,80 a 2,20 - le unità lavoratrici da milioni 7,66 a 5,06 - le unità consumatrici da milioni 14,46 a milioni 11,86. Su ciascuna unità lavoratrice gravavano, prima della guerra, circa 1,9 unità consumatrici, durante la guerra, hanno gravato .fino a 2,35. In altri termini le unità consumatrici passive gravanti su ciascuna unità lavoratrice si sono elevate da 0,9 a 1,35 » ( 66 ) Poiché la produzione agricola subì nel corso del conflitto una lieve contrazione valutabile attorno al 10%, è evidente che per mantenere una simile produzione la manodopera agricola, non avente obblighi militari, fu sottoposta ad un super lavoro .
I maggiori sforzi, cui furono costrette a sottoporsi le contadine, non furono senza gravi conseguenze se s i considera l'aumento percentua le dei nati morti negli ultimi anni di guerra (67 ).
Oltre a ciò bisogna considerare che i contadini costituivano il nerbo della fanteria: l'arma maggiormente esposta e che ebbe le pit1 gravi perdite. I nfatti, benché i reparti di fanteria comprendessero il 67% dei mobilitati, appartenevano a quest'arma
1'87% dei caduti ed il 77% dei ferit i ( 68 ). Questo fatto non poteva non incidere profondamente sullo stato d'animo dei congiunti dei richiamati.
I contadini, a differenza della piccola borghesia urbana e rurale, erano stati completamente estranei al dibattito per l 'intervento, coinvolti in una guerra che non avevano voluto e le cui finalità non comprendevano, desideravano logicamente che il conflitto avesse termine nel più breve tempo possibile. Ciò è vero soprattutto per le donne sottoposte sia alla tensione dominante della preoccupazione per la sorte dei loro uom in i, sia agli effetti della fatica per l'aumentato lavoro
A modificare gli orientamenti delle masse contadine non contribuì certo la politica del Governo che tendeva a « mantenere bassi i prezzi dei prodotti agricoli per evitare l'aumento troppo rapido del costo della vita e, quindi, il malumore degli abitanti delle città specialmente dei lavoratori » ( 69 ).
Indubbiamente la società agricola poteva essere, a differenza della città, supercompressa senza che si verificassero moti tali da costituire un effettivo pericolo. Infatti, mentre in città un qualsiasi avvenimento può produrre facilmente una serie di reazioni a catena e trasformarsi in un fenomeno di massa, in campagna le reazioni sono molto più lente e gli assembramenti molto meno frequenti. Non a caso le manifestazioni contro la guerra si verificarono in genere quando le contadine si riunirono per riscuotere il sussidio governativo alle famiglie dei richiamati. Per di più le campagne erano generalmente meno politicizzate della città e comunque, per effetto delle reiterate chiamate alle armi, popolate quindi quasi esclusivamente di donne, vecchi e ragazzi. Tutto ciò faceva si che le agitazioni contro la guerra, per quanto violente, fossero destinate ad esaurirsi rapidamente. Se si considera, perciò, il problema dal solo punto di vista dell'ordine pubblico, nel fronte interno la politica scelta dal Governo era giustificata anche se « il continuo travaso di ricchezza della campagna verso la città convinse sempre più le masse contadine che la guerra era stata fatta ad esclusivo vantaggio della città» (70 ).
Alla luce di questa considerazione, potrebbe sembrare che questa politica fosse stata scelta anche perché aumentava la frattura già esistente tra fanti-contadini ed operai-imboscati; questo aspetto della questione sfuggì invece completamente ai governanti italiani, come del pari sfuggì l'effetto dirompente che avrebbero potuto avere, come infatti ebbero, le notizie del malcontento e dei disagi dei ceti rurali sul morale dei combattenti che, come si ricorderà, erano in gran parte fanti-contadini.
Questo complesso di fatti e di situazioni fece sì che, per gli ultimi mesi del 1916 e per quasi tutto il 1917, le campagne italiane fossero in fermento e che si svolgessero una nutrita serie di agitazioni contro la guerra (71 ). Queste manifestazioni, per quanto violente, erano di brevissima durata e interessavano, in genere, piccole zone, per cui non incisero quasi per nulla sugli orientamenti generali sia del Governo che delle forze politiche, anzi passarono tanto inosservate che solo recentemente sono state « riscoperte» dagli storici. Per le agitazioni operaie, al contrario, si è esagerato la rappresentatività dei moti torinesi e delle agitazioni di Milano. Come si è visto, in realtà la sommossa di Torino

va inquadrata in una particolare situazione locale e messa in relazione con una tale serie di specialissime circostanze che ne fanno un caso a sé. Riguardo alle manifestazioni milanesi esse furono determinate, oltre che dall'iniziativa della frazione rivoluzionaria del P.S.I., dallo stato d'animo delle contadine, come avvenne del resto in tutti gli scioperi contro la guerra avvenuti in altre città. In conseguenza di ciò, non ci sembra sostenibile la tesi di un'effervescenza rivoluzionaria tra le masse operaie italiane negli ultimi anni della guerra; anzi, dai dati disponibili, sembrerebbe nel complesso perfettamente giustificata la citata affermazione di Buozzi al Comitato Centrale della M.I. secondo cui gli operai italiani avevano accettato con grande serenità la riorganizzazione imposta dalle necessità del conflitto. Ciò fu indubbiamente reso possibile dalla politica adottata dai responsabili della M.I., politica che, in pratica, perpetuava, in forma più organica, l'alleanza operai-industriali che aveva caratterizzato almeno una parte del1'età giolittiana. Certo, per conseguire questa politica fu necessario sottoporre a duri sacrifici altri ceti sociali, creando, come osservò l'Einaudi, squilibri i cui effetti avrebbero inciso lungamente sulla intera società italiana. C'è tuttavia da domandarsi se una politica diversa avrebbe potuto conseguire i medesimi risultati. L'Einaudi affermò che « se lo Stato, sorretto dalla consapevole concorde volontà della nazione, si fosse ristretto a sottoporre a dura disciplina coercitiva industriali ed operai addetti alla produzione delle cose direttamente necessarie all'esercito in campo, quegli errori non sarebbero stati capaci di originare sconvolgimenti sociali » ( 72 ). Pur volendo prescindere -dall'importantissimo e fondamentale fatto che una « consapevole concorde volontà della nazione » non esisteva, non si può fare a meno di rilevare come un'organizzazione coercitiva, quale quella proposta da E inaudi, avrebbe, forse, retto alla resistenza passiva degli industriali e resistito all'urto delle agitazioni operaie, ma certo non avrebbe potuto creare quel clima di collaborazione che permise, nonostante notevolissime difficoltà, di far fronte alle richieste dell'esercito operante. La prova della validità delle scelte dei dirigenti della Mobilitazione I ndustriale si ebbe all'indomani della sconfitta di Caporetto . A questo proposito ha scritto Paolo Spriano: « Siamo forse di fronte a un'ondata profonda di patriottismo che scuota il partito socialista, i suoi quadri , i suoi adepti, le masse che ad esso si ispirano? L'affermazione non risponderebbe al vero » ( 73 ) In realtà, almeno per quanto riguarda le masse operaie degli stabilimenti ausiliari, si tratta di una affermazione tutt'altro che peregrina . Secondo lo Spriano i moti d'ago-

sto a Torino iniziarono allorché gli operai della Diatto-Frejus e della Proiettili non vollero riprendere il lavoro (7 4 ). Non sarà quindi senza significato leggere l'ordine del giorno votato dalle maestranze di quest'ultima azienda dopo Caporetto: « Gli operai degli Stabilimenti della Società Italiana per la fabbricazione dei proiettili in Torino, consci della gravità del momento, riaffermando il supremo dovere nella concordia che sola può dare ali'esercito la forza di ricacciare il secolare nemico al di là delle violate frontiere, esprimono ferma e immutabile la loro solidarietà coi fratelli che combattono al fronte per la salvezza del Paese, la loro volontà di proseguire con rinnovata energia nell'adempimento del loro dovere, la loro fede nella vittoria finale che non può, non deve mancare; e perché Torino possa fraternamente ospitare i profughi delle regioni ove il barbaro nemico tenta spargere onta, rovina e morte, deliberano di partecipare alla sottoscrizione cittadina, destinando una giornata del loro lavoro, certi che alla loro iniziativa aderirà compatta tutta la maestranza delle industrie torinesi» (7 5 ) Né questo era un caso isolato: dopo la sconfitta il generale Dallolio aveva rivolto un appello agli operai italiani per l'intensificazione della produzione. Le prime risposte a quest'appello, tutte approssimativamente del tenore del documento sopra riportato, occuparono un intero numero speciale del «Bollettino» della M.I. preceduti da una breve premessa in cui si diceva tra altro: « Fino ad oggi (fine novembre 1917) si calcola che più di quattrocentomila operai abbiano risposto all'appello; le offerte in denaro oltrepassano di molto i due milioni, oltre l'importo, non esattamente precisabile, di molt e diecine di migliaia di giornate di lavoro, cedute a beneficio dei profughi; ma le risposte e l e offerte continuano diuturnamente a giungere » (76 ). Ed infatti il « Bollettino » riportò ancora , per alcuni numeri, lunghissimi elenchi di sottoscrittori. Questi fatti chiariscono perché i dirigenti sindacali non esitassero, in questa circostanza, ad assumere atteggiamenti filo patriottici; era infatti evidente che questi erano condivisi da gran parte della base operaia. Per quanto riguarda il Partito socialista, il discorso è indubbiamente diverso: abbiamo visto come questo, a differenza del sindacato, si fosse ripiegato in se stesso riducendo i contatti con l'esterno: contemporaneamente gli orientamenti della base si erano radicalizzati, eppure nonostante che questo processo fosse già molto avanzato, le vicende seguite dalla rotta scossero profondamente la base ed il vertice del P.S.I. Lo testimonia uno dei protagonisti non certo incline alle sollecitazioni patriottiche, Amadeo Bordiga: « Mentre i veri italiani facevano

(molto platonicamente) argine coi loro petti alle "orde" austriache molti di noi militanti del partito correvano a Roma per far argine al tradimento dei nostri deputati, e ne potemmo scongiurare la piena effettuazione col trattenerli quasi .fisicamente sulla via del Quirinale, ove, si disse, Turati si era già vestito per andare (se in giacca o meno, questo non ci fregava per nulla). Senza fare i soliti nomi può avere eloquenza un episodio. Un buon compagno della sinistra... giunse trafelato alla Direzione del partito, dove un gruppo della Federazione giovanile esorta e scongiura il bravo Lazzari a tenere duro: quello fresco di notizie di sala-stampa ansima; pare che li fermino sul Piave senza arretrare di più! Noi avevamo in testa a fermare il partito sulla via della disfatta di classe e lo guardammo sbalorditi: in lui parlava già il complesso della difesa della P atria e delle bandierine tricolori sulla carta topografica» ( 77 ). Si trattava di un « complesso » alquanto diffuso nel P.S.I. tant'è che sotto la « ventata di paura e di nazionalismo del periodo di Caporetto, con la formidabile pressione politica e ideologica del momento e le numerose manifestazioni di patriottismo provenienti non solo dai capi riformisti del GPS e della C.G.d.L. ma anche da amministrazioni locali e organizzazioni socialiste periferiche » ( 78 ), si deterrninò, per contraccolpo, un'avvicinamento tra la direzione e la frazione di sinistra . Questo avvicinamento praticamente portò però solo a una deplorazione dei « collaborazionisti » e ciò probabilmente, non solo in ossequio al mito dell'unità del partito, ma anche perché, in quelle circostanze, non vi era la sicurezza che un confronto diretto si concludesse vittoriosamente.
In conclusione, posti di fronte allo spettro della disfatta, i dirigenti sindacali, in piena sintonia con la propria base, non esitarono a manifestare la volontà di collaborare con lo sforzo bellico del Pase. Si trattava, per la verità, per gli uni e per gli altri, di esternare una situazione di fatto esistente da tempo. Sul momento ciò non mancò di fare molta impressione e di influenzare notevolmente l'atteggiamento dello stesso partito socialista, la dirigenza del quale però, sia pure in maniera non troppo energica, riaffermò la propria volontà di « non aderire», e riuscì nei mesi successivi, a riportare sulle proprie posizioni la grande maggioranza del partito.
L'atteggiamento della C.G.L. fu invece alquanto diverso fino alla fine del conflitto e ciò anche perché il clima di reazione patriottica creatosi a seguito del disastro di Caporetto si conservò a lungo tra le maestranze degli stabilimenti impegnati nel-

lo sforzo bellico, come dimostrano i dati sulla partecipazione degli operai alla sottoscrizione del V0 prestito nazionale:
I dati, aggiornati a tutto aprile 1918, forniscono un totale complessivo di 86.563.750 lire: cifra notevolissima specie se si considera che questa raccolta di fondi era avvenuta dopo due precedenti sottoscrizioni l'una a favore dei profughi, cui facemmo già cenno, l'altra a beneficio dei combattenti.

In definitiva l'atteggiamento« collaborazionista» della C.G.L. era in parte anche conseguenza dell'orientamento di fondo di vasti strati del proletariato industriale.
(1) Vedi allegato 12.
(2) Cfr. G. NAPPI MODONA: Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922, Bari 1969, p. 199.
(3) M. GUARNll!Rt: La Mobilitazione Industriale, Torino, 1919,
(4) Comitato di Mobilitazione Civile: I Comitati Regionali, cit., pp. 85-86.
(5) Vedi allegato 12.
(6) Cfr. Relazione della Commissione d'inchiesta istituita dal R.D. 10 gennaio 1918 n. 35. Dall'Isonzo al Piave, 24 ottobre· 9 novembre 1917 (da ora innanzi citata come Relazione Caporetto, Roma 1919, voi. li, pp. 411-412.
(7) A.C.S. Ministero Armi e Munizioni b. 42. Difronte alle _Prese di posìzione del Dallolio appare davvero incredibile che vi s ia chi sostenga che gli • sproloqui sugli alti salari • operai durante la prima guerra mondiale abbiano avuto nel Comitato Centrale
di Mobilitazione Industriale • uno dei loro maggiori responsabili•. Cfr. La relazione di A. Camarda aJ convegno di studi « Operai e contadin.i nella Grande Guerra • Vittorio Veneto 14-16 dicembre 1978.
(8) A.C.S. Ministero Armi e Munizioni b. 42.
(9) Vedi allegati no. 13 e 14
(10) A.M.C.R. Carte Dallolw b. 948 f. 25.
(11) G. CASTAGNO: Bruno Buozzi, Milano 1955, p. 31.
(12) Vedi allegato n. 12.
(13) Ibidem.
(14) Commissione Parlame,itare, cit., voi. li, p. 111.
(15) L. EtNAUoI: La condotta economica, cii., p. 103.
(16) I dati sono desunti da E. Ra>llNn: Notizie sull'attività dei comitati di mob. lnd. nella composizione e risoluzwne di vertenze economiche e da Notizie sull'attività dei Comitali di mobilitazione industriale e delle commissioni di concUiazione nella composizione e risoluzione di vertenze economiche, entrambi in « Bollettino del Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale•, rispettivamente aprile 1918, pp. 118 e novembre-dicembre 1918, p. 385.
(17) Ibidem. Tra i dati delle ordinanze emesse nel 1917, sono stati conteggiati 6 ricorsi che alla fine dell 'anno risultavano ancora pendenti, analogamente è stato fatto nel 1918 per i 9 ricorsi non ancora decisi alla fine di quell'anno.
(18) M. ABRAm: La lotta s indacale nell'industrializzazione in Italia 1906-1926, Milano 1967, pp. 177-178.
(19) Ibidem, p, 179,
(20) Cfr. G. PRATO: op. cit., p. 144.
(21) Comitato per la Mobilitazione Civile: La sorveglianza disciplinare sul personale degli stabilimenti produttori di material e bellico durante la grande guerra (1915-1918), Roma 1930, p. BI.
(22) Vedi allegato o. 14.
(23) Vedi allegato n. 12
(24) M. GUARNll;IU: op. cit., pp. 15-16.
(25) Vedi allegato o. 12.
(26) C. CWAGNO: op. cit., pag. 31-32. A questo p roposito vedi anche C. CARnCLIA: Rinaldo Rigola e il sindacalismo riformista in Italia, Milano 1976, pp. 110 ss.

(27) Vedi allegato o. 12.
(28) Per i dati cfr. P.S.J. Relazione amministrativa a1111i 1914-15/16-17, Roma 1917, p. 4 e Il P.S.I. nei suoi congressi a cura di F. Pedone, Milano 1963, p. 17.
(29) P.S.l. Relazione amministrativa, cit., p. 4.
(30) Cfr. Ibidem, pp. 33 ss.
(31) Ibidem.
(32) Cfr. La Confederazione Generale del Lavoro negli atti, nei documenti nei congressi 1906-1926, a cura di L. Marchetti, Milano 1962, pp. 419-421.
(33) Nella riunione del 26 novembre 1916 il Generale Dallolio dichiarava a tal J?rOposito « La facile invadenza nel campo delle altrui competenze, originate forse dalla inesatta interpretazione delle disposiz.iom vi.genti, provocò, agli inizi, qualche isolata protesta; ma il richiamo energico, ed alcune severe punizioni, valsero a ricondurre la funzione dell'organismo sulla giusta e ben delineata sua via ». Vedi allegato n. 12.
(34) Comitato di Mobilitazione Civile: I Comitati Regionali, cit ., p. 65.
(35) A.C.S. Ministero Armi e Mu11izio11i b 121. Promemoria Buozzi-Rigola in data 30 settembre 1916.
(36) Vedi allegati on. 13 e 14.
(37) Cfr. G. PRATO: Il Piemonte, cit., p. 133. Sull'orientamento dei Comitati Regionali della M.J. a favore di un • uso prudente delle energie•, vedi Comitati di Mobilitazione Civile: I Comitati Regionali, cit., p. 16.
(38) BRUNO Buoz21: L'opera della Federazione Metallurgica dal 1910 al 1918, Torino 1918, pp. 3-40.
(39) Cfr. R. On FEUCB: Ordine pubblico e orientamenti delle masse popolari italiane nella prima metd del 1917, in • Rivista storica del socialismo•, n. 20, p. 481.
(40) Cfr. Ibidem, p. 475.
(41) Ibidem, p. 472.
(42) Ibidem, pp. 474-475.
( 43) Ibidem, p, 502.
(44) Cfr. L. AM.JlROsou: Né aderire né sabotare, Milano 1961, pp. 197-199.
(45) Cfr. R. DE FELJCB: art. cit., p. 481.
(46) Cfr. L. AMBROSOU: op. cit., p. 180.
(47) Cfr. R. DE F01.1c1,: art. cit., p. 476.
(48) P. SPRlANO: Storia di Torino operaia e socialista. Da De Amicis a Gramsci, Torino 1972, p. 399.
(49) Cfr A. MONTICONE: li socialismo torinese e i fatti dell'agosto 1917, in • Rassegna storica del Risorgimento•, gennaio-marzo 1958, p. 66.
(50) E. Vmmwors: La sommossa di Torino del 1917 e l'approvvigionamento del gro.no, Roma 1925, p. 3 1 ss.
(51) P. SPRIANO: op. cit., p. 412.
(52) c. SBTON • WATSON: Storia d'Italia dal 1870 al 1925, Bari 1967, p . 544.
(53) I dati sono tratti da un appunto del generale Albricci, risalente al periodo in cui fu Ministro della guerra, conservato nel Museo del Risorgimento di Milano. Archivio guerra cartella 120 Le cifre in questione sono state controllate ed integrate con quelle fornite da P. SPRIANO, op. cit., pp. 432 n e 433. Si veda anche G. CARCANO: Cronaca di una rivolta, Torino 1977, pp. 91-96.
(54) Cfr. A. GAITI: Caporetto, dal diarìo di guerra inedito, Bologna 1964, pp. 432-433.
(55) R. DEL CAlwA: Proletari senza rivoluzione, Milano 1970, vol. II, p. 36.
(56) E. V ERDINOrs: Op. cit., p. 39.
(57) G. CASTAGNO: Op. cit., p. 35 .
(58) Cfr. P. SPRlA.'10: op. cii. , p. 448.

(59) Cfr. Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Ufficio Storico, L'esercito italiano nella Grande Guerra 1915-1918, voi. IV, tomo 3°, p. 656.
(60) P. MELocRA.-a: Storia politica della Grande Guerra 1915-1918, Bari 1969, pp. 359-360.
(61) N. Dr STEFANO: Moti popolari in Emilia Romagna e Tcscana (1915-1917), in • Rivista storica del socialismo•, n. 32 , pp. 191 ss.
(62) Ibidem , pp. 204-205 e 211-213.
(63) Ibidem, p. 205.
(64) Ibidem, p 206.
(65) A. SERPIERI: op. cit., p. 50.
(66) Tbidem.
(67) Cfr. M. MORTARA: La sal ut e pubblica in Italia durante e dopo la guerra, Bari 1925, p. 467.
(68) A. BRONZUOLI: XXIV maggio, in « Bollettino dell'ufficio storico•, 1934, n. 2, p. 402.
(69) S.B. CLOucu: Storia dell'economia italiana dal 1961 ad oggi, Bologna 1963, p. 249.
(70) c. s,rrON-WATSON: op. cit., p. 542.
(71) Oltre allo studio della De Stefano più volte citato, vedi anche R. DE Fm.IcE art. cit.. L. PRJm: Lotte agrarie nella Valle padana, Torino 1955, pp. 340-350, A. CARACCIOLO: TI movimento contadino nel Lazio (1970-1922), Roma, 1952, pp. 149-162, e P. MELOGRANI: op. cit., pp. 329-334.
(72) L. EINAUDI: La condo/fa economica, cit., pp. 129-130.
(73) P. SPRIANO: op. cit., p. 451.
(74) Ibidem, p. 417.
(75) Cfr. • Bollettino del Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale •, Supplemento al n. 4 dell'ottobre 1917, p. 2.
(76) I bidem.
(77) Anonimo (ma A. Bordiga): Storia della sinistra comw,ista 1912-1919, Milano 1973, pp. 113-114.
(78) L. CORTESI: li P.S.I. dalla • Settimana rossa• al congresso nazionale del 1918, in • Rivista storica del socialismo•. n 32, pp. XXXV-XXXVI.
(79) A M.C.R. Carte Dallo/io b. 958, fascicolo • Sottoscrizione degli stabilimenti militari e ausiliari al V• prestito nazionale •
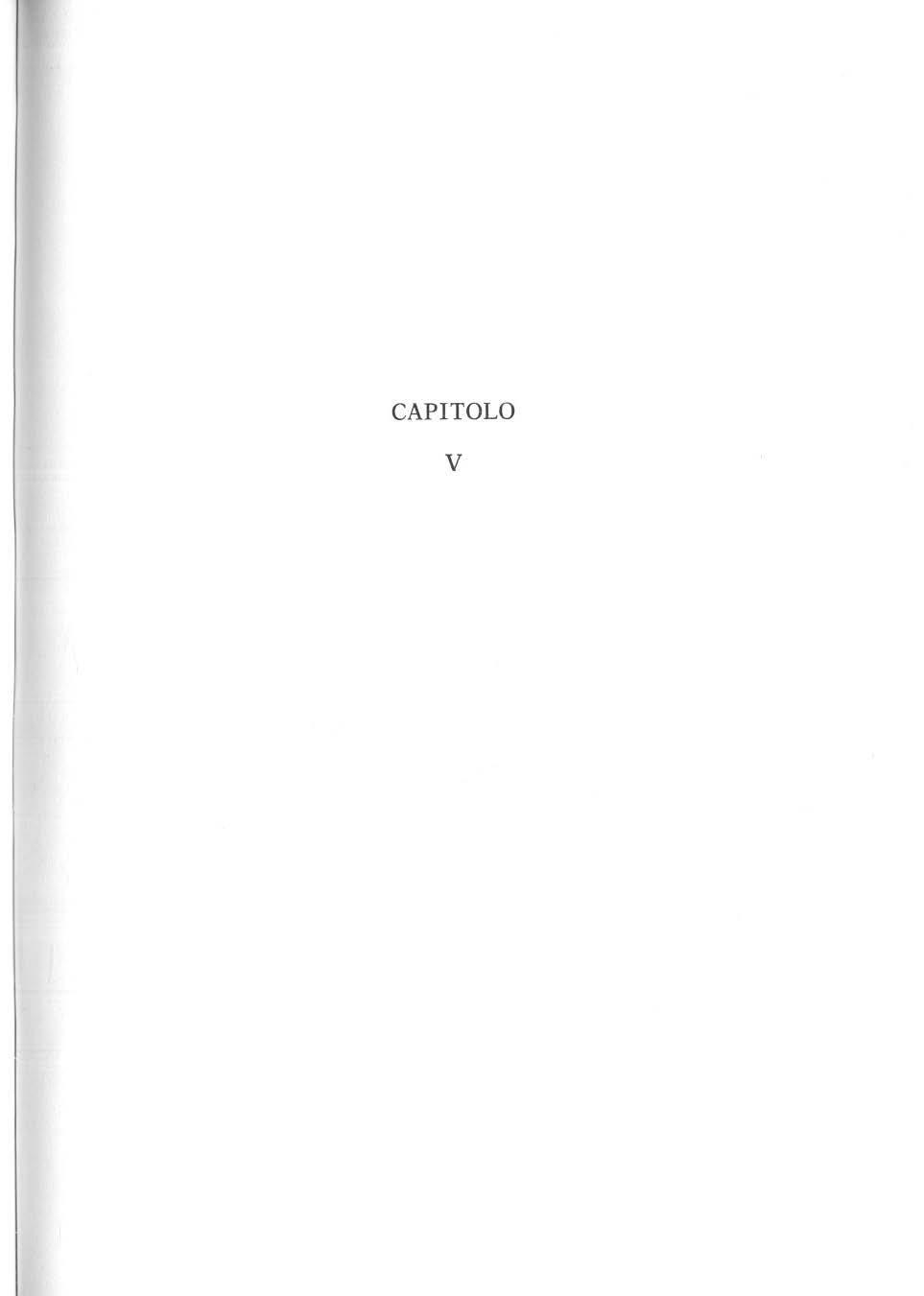
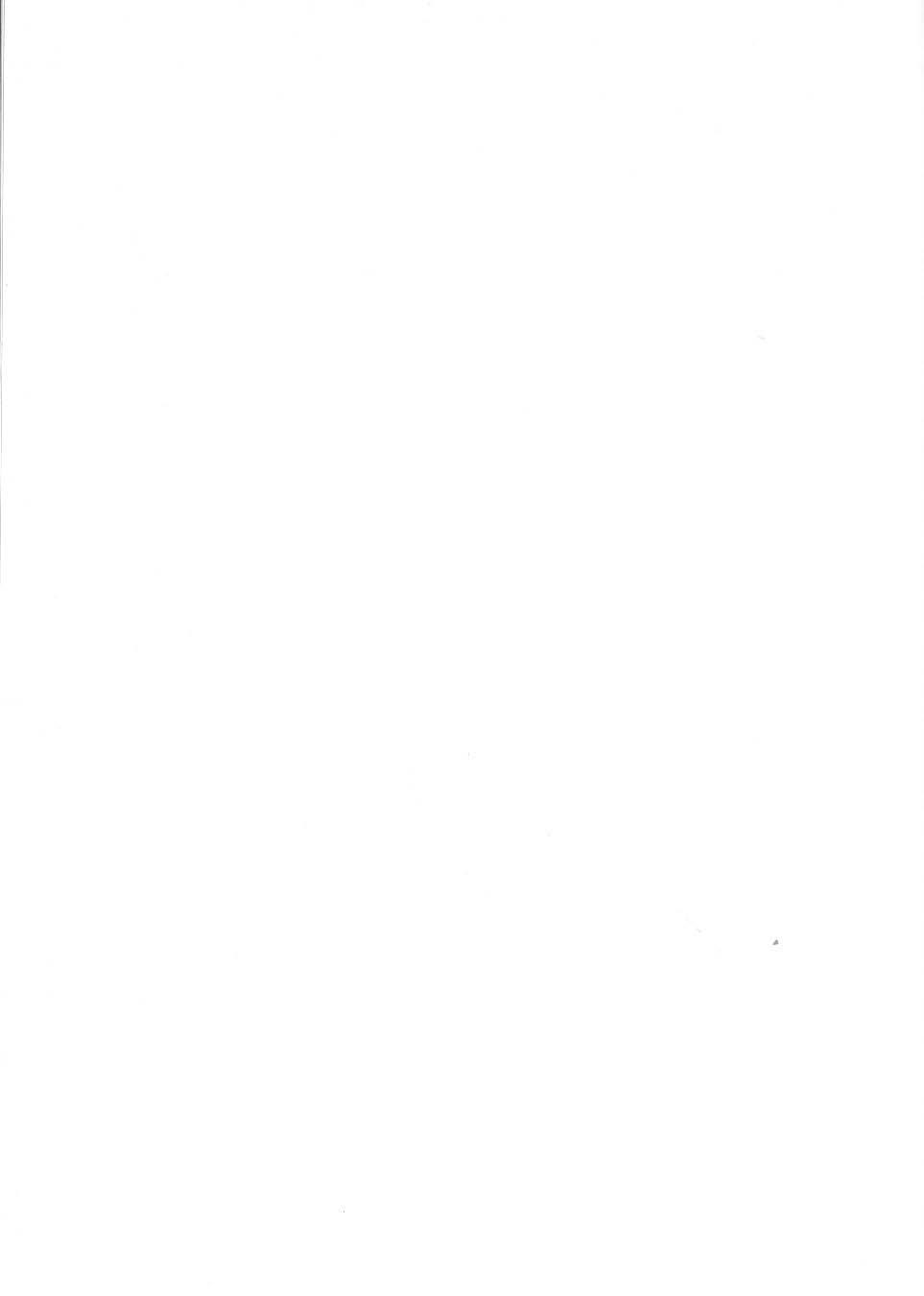
I profitti realizzati dagli imprenditori industriali nel corso della prima guerra mondiale furono oggetto di annose polemiche. Sembrava infatti enorme che alcuni lucrassero ingenti somme di danaro, proprio mentre il paese era impegnato in una durissima prova. Ciò attirò sugli industriali il poco benevolo aggettivo di « pescecani » ed il sospetto di ogni genere di malversazioni. In realtà, la Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra rilevò numerosi casi di speculazione e numerose irregolarità commesse dagli industriali. Sovente i materiali ottenuti a prezzo di calmiere per le forniture militari venivano sostituiti con materiali di scarto e rivenduti sul mercato libero a prezzi altissimi, come ad esempio avvenne per i cuoi prelevati a basso prezzo presso le concerie, per essere poi rivenduti illecitamente ma vantaggiosamente, mentre venivano impiegati, nella fabbricazione di calzature per l'esercito, cuoi di scarto. Nonostante le sanzioni previste dalla legge « il commercio, lucrosissimo, continuò diminuendo di intensità solo quando si pensò a rendere nominativi i buoni per poter controllare quale fosse il negoziante che ritirasse il cuoiame. In tal modo la frode fu diminuita, non impedita, perché il traffico si esercitò sul cuoiame ritirato dalle concerie e non direttamente con la cessione del buono» (1). In altri casi, materiali approntati per una amministrazione venivano rivenduti ad un'altra, se quest 'ul tima pagava prezzi più elevati. Il caso più clamoroso in questo senso è costituito dalla Società Ansaldo che « avendo già un contratto di forniture colla Regia Marina per cannoni da 381/40 al prezzo unitario di L. 410.800 e avendo riscosso le prime rate di pagamento e verificatasi la necessità da parte dell'Amministrazione delle Armi e Munizioni di avere cannoni d el genere, ad insaputa della Marina, concludeva un altro contratto con le Armi e Munizioni di cui erano oggetto gli stessi cannoni della Marina, dei quali s i operava il trapasso alle Armi e Munizioni, ma ad un prezzo unita-

rio molto superiore e cioè a L. 2.100.000 percependo l'anticipo del 50% » ( 2).
Vi furono anche casi di imprese sorte quasi esclusivamente per permettere al personale, quanto mai eterogeneo e raccogliticcio, di fruire deJl'esonero (3) Comunque il caso più frequente di frode nelle forniture militari era costituito dal tentativo, sovente riuscito, di vendere materiale con caratteristiche inferiori a quelle richieste. Ciò era possibile anche per la situazione in cui si effettuavano le commesse militari, poiché, in considerazione della eccezionalità della situazione, una serie di decreti avevano autorizzato a derogare dalle norme della contabilità generale delJo Stato per le forniture di guerra. Sotto la spinta della necessità e dell'urgenza di provvedere alle necessità dell'esercito si ebbero tutta una serie di contratti in forma estremamente semplificata, a proposito dei quali la Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra così si espresse: « Questa massa di contratti irregolari dell'Amministrazione centrale costituiscono oggi il contenuto di ben 10.501 cartelle di documenti, ordinativi, fatture, che durante la guerra non furono oggetto di alcuna registrazione contabile, e che ora soltanto ed in minima parte è stata sottoposta ad un esame analitico » ( 4 ). Passato il primo momento e stabilizzata la produzione su livelli accettabili allo scopo di mettere ordine in questa situazione e impedire che, passando attraverso i Comitati Regionali in cui gli industriali erano rappresentati, potessero ottenere prezzi di favore, fu costituita, all'inizio del 1917, una Commissione consultiva per la revisione dei prezzi, commissione che si mise alacremente al lavoro svolgendo un'attiva opera di controllo e ottenendo, in poco tempo, riduzioni dei prezzi concordati in precedenza per oltre 300 milioni ( 5 ). « Non è quindi a meravigliarsi» si legge nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra « che essa abbia suscitato opposizioni e tentativi di sfuggire alla sua azione, tentativi solo qualche volta riusciti, mentre nel complesso essa raggiunse lo scopo » ( 6 ). In effetti, il malumore contro la Mobilitazione Industriale, manifestato nella riunione della Confindustria del 6 luglio 1917, derivava in buona parte dagli aumentati controlli delle autorità centrali sui contratti concl usi in periferia (7).
La procedura adottata per la stipulazione dei contratti, e l'assenza per un lungo periodo di qualsiasi forma di controllo, sono importanti non solo per i vantaggi che gli industriali riuscivano a trarre facendo leva sulla necessità del momento o sulla scarsa capacità di trattare dei militari addetti, ma anche per tut-

ta una serie di collusioni che si verificarono tra funzionari della Mobilitazione Industriale e le imprese private. La relazione della Commissione di inchiesta sulle spese di guerra enumera una serie di casi in cui ciò avvenne ( 8 ). Questa situazione era conseguenza del fatto che, per creare dal nulla l'organizzazione della Mobilitazione Industriale, si era dovuto per forza ricorrere al1'opera di ufficiali che avevano da tempo lasciato il servizio per occuparsi dell'industria privata e di personale civile pratico dell'attività industriale, e quindi, come osserva Alberto Caracciolo, « era ben difficile, senza dubbio, trovare tecnici competenti e in pari tempo indipendenti da interessi privati» ( 9 ).
Questi inconvenienti, che erano inevitabili, non intaccavano certo la validità della struttura della Mobilitazione Industriale nel complesso, come implicitamente riconobbe la Commissione Parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra che, nella sua ultima riunione, votò all'unanimità il seguente ordine del giorno:
« La Commissione Parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra, dopo aver partitamente e scrupolosamente esaminate le singole gestioni dell'amministrazione delle armi e munizioni alla quale fu preposto durante la guerra il generale Alfredo Dallolio, reputa suo preciso ed altissimo dovere indicare il nome di lui alla gratitudine ed alla ammirazione nazionale; perché in quella sua urgente, immensa, difficile opera, non solo seppe far tutto ciò che si poteva per apprestare le armi alla difesa, alla riscossa, alla trionfale vittoria, ma, con esemplare illibatezza e con appassionata diligenza, procurò che il denaro pubblico non andasse malamente disperso; e invita il Governo a considerare se non sia da rendere onore e premio adeguati a uno degli uomini, che, con senno e probità incomparabili, efficacemente contribuirono alle sorti gloriose della Patria » ( 10 ).
Oltre alfa frode ed alla corruzione, vi erano modi legali con cui le industrie potevano aumentare i loro profitti. Poiché la materia prima era fornita dallo Stato a prezzo estremamente vantaggioso per le forniture militari, i privati potevano, con un'attenta selezione del materiale ed una ripartizione dello stesso tra varie lavorazioni consimili, economizzare gran parte della mate· ria prima a loro vantaggio. La Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra segnalò a questo proposito, esempi illuminanti. Poteva darsi infatti il caso che lo stesso industriale riuscisse « ad ottenere da tre distinte Amministrazioni dello Stato, ad insaputa forse l'una dell'altra, 650 tonnellate di vergella per fabbricare 300 tonnellate di cavi di diversa resistenza: sicché, pur calcolando un massimo di calo effettivo anche di 20 ton-

nellate, come avanzo di lavorazione, rimanevano ben 280 tonnellate di vergella che poteva impiegare o per altre forniture militari o per il suo commercio privato, nel quale si noti, la vergella, pagata in media dallo stesso industriale allo Stato a L. 1,50 al chilogrammo, era salita a prezzi anche 10 volte superiori » ( 11 ).
Anche maggiori erano le quantità di materiali che rimanevano disponibili al privato come puri e semplici avanzi di lavorazione. Scrisse a questo proposito l'Einaudi: « Soprattutto rispetto ai metalli ricchi, ottone , bronzo, rame, alluminio ecc. il problema dei residui di lavorazione presentò particolare importanza. Forniti dall'amministrazione a titolo di vendita, quei materiali rimanevano di proprietà del fornitore, proprietà apparente, poiché l'importo ne era detratto, per addebito, dall'ammontare complessivo del prezzo convenuto. I residui soggetti a requisizione, avrebbero dovuto essere restituiti, al medesimo prezzo di addebito: ma per difficoltà di trasporti e resistenze dei fabbricanti, la restituzione non avveniva quasi mai. Rilevantissimi erano i residui» (1 2 ). Abbiamo in precedenza accennato al fatto che nel corso della guerra fu r ono impiegate, per la sola costruzione di proiettili, ben 2.099.000 tonnellate di metallo. La quantità del solo acciaio occorrente per la costruzione dei vari proiettili risultava in media la seguente: Kg. 9,8 per i piccoli calibri, Kg. 45,3 per i medi calibri e Kg. 255 per i grossi calibri. Si noti che un colpo completo, comprendente quindi anche la carica e parte di altri metalli oltre all'acciaio, aveva i seguenti pesi medi: Kg. 5,5 per i piccoli calibri, 32 per i medi calibri e 200 per i grossi calibri (1 3 ). Si potrà facilmente comprendere perciò come i residui di lavorazione dell'acciaio, fossero, in questo settore, ingentissimi e ciò spiega il verificarsi per talune parti del proiettile il fenomeno segnalato dall'Einaudi: « Laddove dal 1916 al 1918 i prezzi degli altri manufatti erano in continuo aumento, solo i prezzi d elle spolette scemarono notevolmente, nonostante l'aumento dei prezzi della materia prima, della mano d'opera e delle spese generali, per la concorrenza ad accaparrarsi una così vantaggiosa lavorazione» ( 14 ). Per quanto il caso delle spolette fosse un caso limite, (richiedevano infatti una quantità di materia prima circa tre volte superiore al peso del prodotto finito) i residui di produzione per la costruzione dei proiettili d'artiglieria furono in ogni caso ingentissimi.
Alla luce di questi fatti non può certo sorprendere che i profitti della società industriali crescessero rapidamente negli anni della guerra. « I profitti medi dichiarati dalle anonime» scrive il Romeo « che erano del 4,26% alla vigilia del conflitto, balza-

no nel 1917 al 7,75% e ancor più significativi gli incrementi nei settori più direttamente impegnati nella produzione bellica. Così i profitti siderurgici salgono dal 6,30% al 16,55; quelli dell'industria automobilistica dall'8,20 al 30,51 % ; gli utili dei fabbricanti di pellami e calzature dal 9,31 al 30,51%; quelli dei lanieri dal 5,10 al 18,74%; quelli dei cotonieri, che ancora alla vigilia del conflitto si dibattevano in una gravissima crisi, dallo 0,94 % al 12,77% quelli dei chimici dallo 0,02 al 15,39%; quelli dell'industria della gomma dallo 8,57 al 14,95% » ( 15 ).
I profitti dichiarati dalle società sono sempre al di sotto del vero; s i deve ritenere però che questo fenomeno di occultamento si sia accentuato durante il primo conflitto mondiale e ciò non solo perché l'altezza confiscatrice d elle aliquote dell'imposta sui sopraprofitti di guerra spingeva in tal senso, ma anche perché i controlli non potevano funzionare efficacemente in un momento tanto eccezionale. Inoltre, una parte dei profitti come ad esempio quelli rilevantissimi derivati dall'impiego dei residui di lavorazione, sfuggivano per loro natura, a qualsiasi controllo. Conseguentemente non si può non convenire con il Caracciolo, quando rileva che i profitti dichiarati dalle società industriali nel corso della guerra furono « notoriamente molto al disotto del vero » ( 18 ). Va inoltre precisato che la ripartizione degli utili non avvenne in proporzioni eguali tra le varie imprese. Infatti, Augusto Graziani, sulla base dei dati dell'imposta sui sopraprofitti di guerra, rilevò che le imprese con un milione ed oltre di extraprofitti avevano ottenuto un saggio annuo di r endimento pari a circa il 34% del cap itale (1 7 ). Questo significava che le imprese maggiori, in grado di ammodernare ed ampliare agevolmente gli impianti, avevano potuto godere, per l'eccezionale situazione creata dalla guerra, di una rendita del produttore di straordinaria entità. Anche i salari operai, come i profitti industriali, furono oggetto di furibonde polemiche già nel corso della guerra. Infatti da parte della stampa interventista « si grida allo scandalo delle retribuzioni altissime, della dissipazione operaia, quasi fossimo di fronte ad un fenomeno "di profittatori di guerra" che abbia un'ampiezza di massa» ( 18 ).
In realtà la situazione era molto più complessa di quanto credevano gli interventisti; infatti gli aumentati consumi da parte degli operai potevano essere effetto, non solo dei maggiori salari, quanto dell'aumentata occupazione provocata dalla guerra. In quanto ai salari, già nel 1919, Riccardo Bachi rilevava che non esistevano dati complessivi per valutare l'andamento dei salari operai durante gli anni del conflitto ( 19 ).

In mancanza di enti che provvedessero alla raccolta ed alla analisi dei dati complessivi nazionali, è quindi necessario, per valutare la retribuzione delle maestranze operaie nel corso della grande guerra, servirsi di dati e studi parziali.
Nell'ottobre del 1918 il prof. Enrico Redenti pubblicò i dati relativi alle industrie mobilitate, quelle cioè dichiarate ausiliarie allo sforzo bellico e sottoposte a particolari controlli. Secondo questi dati il salario medio del personale maschile ( uomini e ragazzi) impegnato nell'industria bellica salì da 3,90 nel 1914 a quasi 9 lire al giorno nel 1917 ( 20 ).
Tale aumento va ovviamente commisurato con le variazioni dei prezzi al consumo i cui indici, negli anni della guerra, subirono le seguenti variazioni:
Sulla base di questi parametri si può riportare l'esito della ricerca del Redenti al valore reale delle retribuzioni: Tabella
Secondo questi dati si sarebbe verificato quindi un aumento non solo nominale, ma anche reale dei salari degli operai addetti alle industrie ausiliarie, l'aumento delle retribuzioni avrebbe cioè superato quello del costo della vita raggiungendo aumenti oscillanti tra il 14 ed il 21 % delle paghe prebelliche .
Questa conclusione sembra contraddetta dai dati relativi agli aumenti salariali verificatisi alla Fiat in questo stesso periodo.

(Tab.2)
In base a questi dati si sarebbe invece verificata, tra il 1913 ed il 1917, una piccola contrazione dei salari reali. Un'indicazione analoga si ricava anche dall'andamento dei salari delle industrie tessili laniere del biellese nello stesso periodo. (Tab. 3)
A rendere apparentemente ancor più contraddittorio il quadro, contribuiscono i dati raccolti dal « Comitato per la Mobilitazione Industriale» secondo i quali, nel 1917, le paghe degli operai meccanici a Torino raggiungevano quasi le 11 lire al giorno c2s).
Ciò porterebbe a concludere che le piccole e medie industrie pagassero salari più elevati del colosso torinese della meccanica che si trovava per di più in una fase di grande espansione. Questo fatto, in verità, appare poco credibile visto che le retribuzioni prebelliche della Fiat erano considerevolmente più alte della media nazionale delle industrie «mobilitate» (6,19 lire contro 3,90); comunque necessita una spiegazione.
Nel 1921 l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni sul Lavoro rese noti i dati relativi ai salari medi di buona parte degli operai infortunati negli anni del conflitto ( 26 ). Benché i dati raccolti da11a Cassa Nazionale Infortuni fossero già stati sottoposti a più di una critica, (27 ) si ritenne dai più che un campionamento così vasto fornisse un indice quanto mai attendibile per determinare il livello dei salari reali ( 28 ).
La successiva elaborazione dei parametri del costo della vita da parte dell'ISTAT permette oggi di individuare con esattezza i valori reali dei salari indicati dalla Cassa Nazionale Infortuni.
(Tab.4)

Tabella 4
Oltre a queste elaborazioni, bisogna segnalare la ricerca fatta da Giustino Madia sui salari degli anni di guerra. Tale ricerca era il risultato di personali raffronti e indagini. di rilievi raccolti direttamente alle fonti ( 29 ), e perveniva a risultati diversi da quelli conseguiti dalla Cassa Nazionale Infortuni:
5
Secondo il prof. Mario Balestrieri del Gabinetto di Statistica della Università di Padova, il Madia avrebbe però commessi vari errori statistici, rettificati i quali risulterebbero i dati seguenti:
Tabella 6

Nonostante che questi dati non siano privi di interesse, senza alcun dubbio sono le cifre fornite dalla Cassa Nazionale Infortuni quelle che hanno goduto anche recentemente del maggior credito tra gli studiosi ( 32 ).
Tali cifre sono state, però sottoposte a svariate critiche fin dagli anni della prima guerra mondiale, critiche che il Melograni riassume nei seguenti punti:
«
a) riguardano le retribuzioni medie giornaliere accertate in sede di definizione di infortunio, e si riferiscono pertanto ai soli infortunati, non alla generalità degli operai assicurati;
b) in secondo luogo, durante la guerra, non esisteva alcuna INAIL (istituto che oggi assicura obbligatoriamente "tutti" i settori dell'industria) ma la cassa nazionale infortuni sul lavoro , dalla quale erano escluse fra l'altro: le industrie tessili, le metallurgiche, le minerarie e le marittime, ecc. facenti capo infatti ad enti assicurativi diversi;
c) il salario accertato in sede di definizione di infortunio era solitamente quello denunciato dai datori di lavoro, ai fini della determinazione del premio assicurativo; la stessa relazione della Cassa, pubblicando i dati, dichiarò che non tutti i datori di lavoro avevano incluso nelle denuncie l'indennità caro viveri di recente istituzione, in modo che - per alcuni anni - le medie indicate nella tabella erano risultate inferiori ai salari effettivamente percepiti dai lavoratori infortunati;
d) è probabile, inoltre, che i dati della Cassa non tenessero sufficientemente conto delle parti mobili delle retribuzioni (i cottimi, per esempio), così frequenti nel settore delle lavorazioni industriali; è certo che essi non tennero conto delle modificazioni contrattuali di carattere normativo, le quali avevano conseguenze economiche profonde, ma difficilmente quantificabili (si pensi alla riduzione degli orari, alla introduzione dei nuovi metodi di calcolo per cottimi e superminimi, alle maggiorazioni per le ore straordinarie, alle variazioni di ferie e di festività, alle nuove qualificazioni categoriali ecc.);
e) infine, i dati pubblicati dalla Cassa costituivano la media aritmetica delle rilevazioni operaie tanto nelle regioni settentrionali ( dove i salari erano più alti), quanto delle regioni meridionali; tanto nella grande città, quanto nei borghi » ( 38 ). Si tratta di obiezioni non prive di fondamento, le quali a loro volta debbono essere sottoposte ad un esame critico. Le osservazioni a) ed e) si riferiscono sostanzialmente al fatto che i dati furono raccolti in maniera asistematica: ciò è indubbiamente vero ed influisce sulla piena attendibilità di questa rilevazione; va pe-

rò considerato che per dati complessivi molto numerosi, come quelli in questione, si attua una sorta di compensazione per cui i margini di errore divengono molto modesti, d'altra parte l'obiezione a) può essere valida solo dove si ammetteva una forte immissione tra gli assicurati di personale a bassa retribuzione ed addetto ai lavori pesanti (e quindi più soggetto ad eventuali incidenti). L'obiezione b) circoscrive più che altro la portata dei dati raccolti dall'Istituto nazionale per le Assicurazioni; bisogna però considerare che, nel corso della guerra, la sfera di competenza della Cassa Nazionale Infortuni fu enormemente ampliata. Infine, riguardo alle obiezioni c) e d) esse, se dimostrano che i dati raccolti non tengono conto di tutti gli accrescimenti dei salari operai avvenuti nel corso del conflitto, non sono tali da modificare i risultati di fondo dell 'inchiesta, cioè, anche tenendo questi fattori nel debito conto, è innegabile che, in base ai dati raccolti dalla Cassa Nazionale Infortuni, si sarebbe verificata una contrazione dei salari reali dei lavoratori nel corso della guerra, sia pure molto più modesta di quella risultante dai calcoli della Cassa stessa.
In definitiva, non ci sembra che le obiezioni del Melograni bastino a giustificare la conclusione a cui perviene: « La nostra tesi è quella di un aumento dei salari reali per una parte almeno del proletariato industriale e di una sostanziale stabilità per un'altra parte di esso, con periodici «aggiustamenti» di continuo elevarsi del costo della vita» ( 34 ).

Per suffragare questa tesi il Melograni si serve tuttavia di considerazioni quanto mai interessanti: egli nota infatti che: « Il vistoso aumento della produzione e dei profitti incitava più gli operai ad insistere nelle loro rivendicazioni economiche, ma consigliava i datori di lavoro ad accoglierle per non compromettere la produzione. Questi ultimi sapevano fra l'altro, come ha ricordato J'Abrate, che "le amministrazioni militari (spesso i loro maggiori clienti) non discutevano sui prezzi delle forniture quando gli elementi di costo potevano, come nel caso di quello del lavoro, essere dimostrati".
La dinamica della Mobilitazione Industriale stimolava sia l'aumento della produzione, sia l'aumento delle retribuzioni. Il personale addetto agli stabilimenti "militarizzati" era assoggettato alla giurisdizione militare e ad una disciplina formalmente molto rigida che vietava, fra l'altro, di ricorrere allo sciopero . Ma di fatto sarebbe stato impossibile assicurare il buon andamento della produzione ricorrendo ad una applicazione continua delle misure coercitive. Ne ll'atmosfera di "finanza facile" determina-
tasi durante la guerra poté spesso accadere che gli stessi ufficiali preposti alla sorveglianza degli stabilimenti destinati alle produzioni di guerra, svolgessero di fatto un'opera di mediazione tra gli operai ed i datori di lavoro, tra questi ultimi e le amministrazioni militari, facilitando aumenti di mercedi e di prezzi pur di evitare che negli stabilimenti a loro affidati scoppiassero incidenti suscettibili di far diminuire la produzione».
Dopo aver accennato all'attiva partecipazione degli esponenti sindacali all'azione dei Comitati di M.I. il Melograni riporta, a testimonianza degli orientamenti del Governo, una dichiarazione del gen. Dallolio: (< Non deve tacersi che a guidare il governo nelle linee generali della sua condotta verso le maestranze operaie non furono estranee preoccupazioni di natura anche politica.

Qualche cosa è trapelata in Paese del tenace, intenso lavorio fatto dai nemici, direttamente o indirettamente, presso le maestranze operaie; ebbene, malgrado questo, le maestranze operaie italiane hanno mantenuto la più grande tranquillità e differenza di quello che è accaduto in taluni paesi alleati .
Ma è indubitato che le maestranze avrebbero tenuto un contegno ben diverso se il governo non avesse sempre cercato di eliminare tutte le ragioni giuste di agitazione : è stata appunto la convinzione delle masse, che il governo si era messo per questa via e che intendeva rimanervi, che ha potentemente contribuito a rendere sterili le manovre degli agitatori » ( 35 ).
La politica governativa, insomma, curò coscientemente l'aumento della produzione e la tranquillità delle mase operaie: due obiettivi che erano strettamente legati fra loro. Quanto al terzo risultato di quella politica: la frattura tra fanti-contadini ed (< operai imboscati» riteniamo che esso fosse raggiunto inconsapevolmente: finora, in ogni caso, non abbiamo trovato alcun documento atto a dimostrare che la classe politica italiana fosse in grado di concepire un disegno strategico così geniale.
Il relativo benessere mantenuto o raggiunto da vasti strati popolari durante la guerra è indirettamente confermato dal fatto che i consumi privati non diminuirono ed anzi, in qualche misura, aumentarono rispetto al periodo prebellico .
I consumi privati pro-capite a prezzi 1938 variarono come dalla seguente tabella:
Tali dati risultano tanto più istruttivi se raffrontati con quelli della seconda guerra mondiale, durante la quale i consumi privati pro-capite, non soltanto diminuirono rispetto al livello prebellico, ma diventarono presto inferiori, in cifre assolute, ai consumi dei cittadini italiani riscontrati durante la precedente guerra. Anche la seguente tabella è infatti calcolata a prezzi 1938:
-
-
( 54)
Durante la seconda guerra mondiale la popolazione civile sopportò sacrifici economici e non economici (i bombardamenti aerei, per esempio, il passaggio del fronte attraverso la penisola ecc.) che non trovarono paragone con i sacrifici assai minori sopportati durante la prima guerra mondiale nel corso della quale, pertanto, la diversità di condizioni tra il soldato e il cittadino fu assai più netta.
I dati sopra riferiti, relativi al periodo 1914-18, riguardano tuttavia il cittadino medio senza fare distinzioni tra le diverse classi sociali. Un esame più minuzioso del consumo medio procapite dimostra tuttavia un incremento dei consumi popolari, vale a dire dei consumi primari e in particolar modo di quelli alimentari, come risulta dalla seguente tabeUa calcolata a prezzi

1938:
Gli economisti hanno generalmente sottolineato l'impoverimento dei ceti medi borghesi verificatosi durante gli anni della guerra, e dovrebbe quindi essere attribuito complessivamente ad
essi non un incremento dei consumi, ma un decremento degli stessi. I nuovi ricchi furono numericamente scarsi e non poterono influire in maniera sensibile sui consumi primari. Una parte dei contadini furono in grado di consumare più che nell'anteguerra, ma, secondo l'opinione del Serpieri, preferirono orientarsi verso maggiori risparmi, più che verso maggiori consumi. Einaudi ritenne viceversa che i ceti rurali partecipassero, in certa misura, all'incremento dei consumi, ma tenne a sottolineare che accanto ad essi « mantennero e crebbero i consumi le classi le quali nelle città e nelle zone industriali diedero più direttamente opera alla guerra: operai degli stabilimenti ausiliari od assimilati, artigiani mutatisi in piccoli industriali e coloro che si erano improvvisati commercianti e mediatori ».
Ci sembra inoltre assai sintomatico che l'unica rilevazione fino ad oggi conosciuta sui bilanci delle famigli e operaie negli anni della guerra, avvalori in maniera molto precisa la nostra tesi di un aumento dei consumi del ceto operaio cittadino. Nel dopoguerra ,infatti, la Società Umanitaria di Milano rese pubblici i risultati di una inchiesta compiuta da Angelo Pugliese sui bilanci di alcune famiglie operaie milanesi fra il 1913 e il 1917. Il Pugliese aveva esaminato i bilanci di 51 famiglie nel luglio
1913, di 28 famiglie nel marzo 1916, e infìne di 47 famiglie nel febbraio 1917. I consumi di queste famiglie erano notevolmente cresciuti nel 1917 rispetto al 1914 ed il 1916. Il Somogyi ripubblicando pochi anni or sono tali risultati, li giudicò « impressionanti » anche perché le famiglie sottoposte all'inchiesta non erano state scelte fra quelle particolarmente disagiate. Le differenze tra i tre periodi gli apparvero ancora più singolari dopo aver eseguito un confronto tra le famiglie di più ricca alimentazione: le famiglie che superavano le 3000 calorie giornaliere per ogni individuo erano 13 su 51 nel 1913, 6 su 28 nel 1916, e 22 su 47 nel 1917. Erano passate insomma dal 25,5% al 21,4% del campione considerato per salire infine, proprio nel 1917, al 46,8%.

Il fenomeno delle migliorate condizioni economiche delle famiglie dipese anche da un aumento dell'occupazione: infatti, grazie anche al maggior impiego della manodopera femminile, accadde spessissimo che una famiglia operaia contasse due, tre, quattro unità lavoratrici ( 36 ).
La considerazione del Melograni sono senza dubbio valide e fondate, tuttavia esse rilevano un fenomeno: quello del migliorato tenore di vita della classe operaia, senza fornirne alcuna spiegazione di come ciò si sia potuto verificare. In verità il mi-
glioramento del tenore di vita del proletariato industriale negli anni della guerra mondiale è rilevabile anche da ulteriori elementi oltre a quelli elencati dal Me lograni. Infatti un Presidente del Consiglio dell'epoca, Paolo Boselli, prendendo la parola il 26 novembre 1916 in una riunione del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale rilevava: « I salari sono largamente accresciuti; non c r edo che tutto il guadagno si versi in prodigalità inopportune; non lo credo perché i risparmi nelle Casse crescono, perché i pegni esulano dai Monti di Pietà, perché l 'acquisto di buoni del tesoro di piccolo taglio è abbastanza forte; tutto ciò significa risparmio » ( 37 ).
Tuttavia, quest'ulteriore elemento, se suffraga le tesi del Melograni relative ad un aumento della disponibilità finanziaria dei lavoratori dell'industria, non fornisce elementi sul come ciò sia stato possibile. D'altro canto, poiché, per i motivi che abbiamo precedentemente elencati, i dati raccolti dall'Istituto Nazionale per le Assicurazioni sul lavoro non possono essere completamente svalutati, rimane il problema di verificare se e come siano conciliabili i dati dell'Istituto con l'aume nto del tenore di vita della classe operaia verificatosi nel corso della guerra. A tal proposito non sarà inutile considerare il numero degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza negli anni del conflitto.
Il Decreto Luogotenenzia le del 9 settembre 1915 n. 1396 stabiliva il diritto al trattamento infortunistico per gli operai che lavoravano in zona di guerra per conto dell'amministrazione militare (art. 1); il decreto prevedeva inoltre che gli operai militari che lavoravano in stabilimenti dell'esercito o della marina, anche fuori del teatro di operazioni, potessero, in caso d'infortunio, scegliere tra il trattamento previsto « dalla legge infortuni e quello delle leggi sulle pensioni ed assegni militari » (art. 3). Con c iò il trattamento previdenziale era esteso agli op erai del Genio Civile in zona di guerra e degli stabilimenti militari nelle retrovie. Come si ricorderà, in questo periodo sia l'organizzazione del Genio Civile sia quella industriale militare erano in grande espansione.
La presenza di operai militari negli stabilimenti in cui a termini della legge del 1904, era obb ligatoria l'iscrizione alla Cassa Nazionale infortuni, creava il problema della disparità di trattamento esistente tra loro e gli operai civili. A questa situazione pose rimedio il Decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916 n. 594, che estendeva anche agli operai militari addetti a ques to tipo di stabilimenti privati, l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza. Un altro decreto del 3 dicembre 1916, n. 1773, estese l 'assicu-

razione ai prigionieri di guerra addetti ai lavori indicati dalla legge 31 gennaio 1904 n. 51 sulle assicurazioni. Infine il D.Lt. 29 aprile 1917 n. 670 stabilì l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza di tutti gli operai addetti agli stabilimenti ausiliari. Il provvedimento aveva lo scopo di costringere, tra l'altro, gli operai dell'industria bellica, che percepivano alti salari, ad un risparmio forzato in vista della situazione che si sarebbe venuta a creare nell'immediato dopoguerra. L'art. 7 della legge prevedeva infatti la costituzione, con parte delle quote, di « un fondo per la disoccupazione involontaria a favore degli operai degli stabilimenti ausiliari che rimanessero disoccupati dopo la fine della guerra». Il provvedimento incontrò, nella fase applicativa una serie di difficoltà. Scrive a questo proposito l'Abrate: « Così si verificava che, mentre l'operaia di un'azienda cotoniera il cui guadagno non superava nel 1917 le tre lire giornaliere, era parificata o quasi, agli effetti del contributo, ad un meccanico che ne guadagnava trenta: altri lavoratori, non appartenenti a fabbriche ausilarie, che percepivano anch'essi alti salari, erano del tutto esclusi dal provvedimento. Altri pasticci nascevano a causa del passaggio di maestranze da stabilimenti ausiliari ad altri che tali non erano e viceversa; insomma, un disordine pari alla pretesa del Ministero delle Armi e munizioni di legiferare in materia di assicurazioni sociali base » (38 ). Per la verità la « pretesa » legislativa del Ministero era stata minima, visto che le caratteristiche del provvedimento erano state decise da una commissione mista imprenditori-operai (39 ); peraltro gli inconvenienti non ebbero quella rilevanza che attribuisce loro l'Abrate e furono in breve eliminati. I nfatti il Decreto Luogotenenziale del 24 luglio 1917 n. 1185, con cui l'obbligo dell'assicurazione veniva esteso ai lavoratori stranieri, provvide a graduare meglio la ripartizione delle quote per i salari inferiori alle 5 lire giornaliere.
Comunque, in applicazione del decreto del 29 aprile 1917, fu. rono immessi, in un sol colpo, a fruire del trattamento assicurativo, tutti gli operai degli stabilimenti ausiliari.

Da questo esame de1la composizione degli assicurati alla Cassa di Previdenza nel corso della guerra, risulta che, per le sempre nuove immissioni di categorie di aventi diritto, i dati degli anni di guerra non sono comparabili con quelli anteguerra poiché le basi non sono omogenee.
Indicazioni non meno significative possono derivare da un esame delle retribuzioni dei gruppi che, via via, furono ammessi a godere dell'assicurazione.
In quanto agli operai del Genio Civile in zona di guerra, dei
loro salari si è già parlato; essi peraltro, come si è detto, non subivano aumenti altrettanto rapidi come quelli degli operai industriali e, anche se godevano di alcune previdenze, ( cibo ed alloggio gratuiti, vestiti a basso prezzo) queste non risultavano dai salari.
Per quanto riguarda i militari operai invece il discorso è più complesso: infatti il loro trattamento era diverso se lavoravano negli stabilimenti dell'esercito od in quelli privati. Nel primo caso, se i militari erano di leva, venivano retribuiti con la « mercede del picchetto» (un soldo l'ora!) più il soldo militare, più eventualmente il cottimo e lo straordinario. Se invece i militari operai erano « già militarmente istruiti» veniva loro attribuita, secondo la tabella « F », la paga annessa al regolamento degli operai civili del Ministero della guerra invece della « mercede di picchetto »; dovevano però versare al reparto la quota per il vitto e restituire il soldo. A tutti l'amministrazione militare forniva vitto e alloggio, non veniva però concesso il sussidio previsto per le famiglie dei chiamati alle armi (40 ). Per quanto riguarda poi i militari operai comandati o a disposizione presso le industrie private , il generale Dallolio, riferendo alla Commissione d'inchiesta su Caporetto, sostenne che si era riservato loro lo stesso trattamento degli operai borghesi poiché
« nella mentalità rudimentale sì, ma non sprovvista del senso della giustizia, dell'operaio, quando due persone compiono nell'officina lo stesso lavoro, essi sono due operai, i quali vanno trattati allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che uno dei due abbia obblighi militari » ( 41 ). In realtà le dichiarazioni del Ministro delle armi e munizioni possono essere considerate come affermazioni programmatiche, poiché la situazione effettiva era ben diversa. Lo Spriana nota infatti che, dal particolare status dei militari operai derivarono « alcune sperequazioni contro cui lotteranno , senza molto successo, i rappresentanti sindacali» ( 42 ). In effetti, la buona disposizione delle autorità militari e l'azione dei dirigenti sindacali, peraltro non particolarmente risoluta, ottennero in questo settore risultati modesti. Si legge infatti nella relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra: « I Comitati regionali appare siansi adoperati per impedire ogni sfruttamento della mano d'opera militare da parte delle Ditte. Quello di Torino, per esempio giunse gradualmente a far rispettare almeno i minimi stabiliti. Ma poiché diventarono sproporzionati alle sempre crescenti esigenze della vita, per non aver provveduto il Ministero ad una revisione di questi minimi, venne a verificarsi anche il ca-

so che per l'insufficiente retribuzione, congiunta alla perdita del sussidio governativo alla famiglia, degli operai militari chiesero di rientrare al proprio corpo» ( 43 ). Coloro che fecero domanda per rientrare ai reparti dovevano essere militari del Genio per i quali i rischi di guerra erano molto modesti, tuttavia questo fatto è sintomatico di una grave situazione di disagio, per comprendere la quale è necessario esaminare più dettagliatamente il trattamento economico dei militari operai. Quelli comandati fruivano di due diversi trattamenti: in Piemonte, Liguria e Lombardia fruivano, almeno in teoria, della paga degli operai borghesi più, eventualmente, del cottimo e dello straordinario; dovevano però rimborsare allo Stato circa il 15 % della paga più il soldo e il vitto, quindi praticamente ricevano dall'amministrazione militare solo vestiario e alloggio. In complesso un trattamento modesto poiché, come segnala la Relazione dianzi citata, si trattava in realtà della paga minima per le varie qualifiche che gli operai militari percepivano, decurtata per di più dalle competenze dovute allo Stato . La situazione degli operai militari comandati nelle altre regioni era ancora peggiore: infatti questi dovevano rimborsare allo Stato la differenza tra la loro paga e quella stabilita dalla tabella « F » già citata. Succedeva, in pratica, che il loro salario era commisurato dagli industriali a quello previsto dalla tabella « F », che era già modestissimo allo inizio delle ostilità, e che fu aumentato del 30% soltanto dal Decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918 n. 444. Le indennità concesse negli anni del conflitto al personale civile del Ministero della Guerra avevano permesso agli operai borghesi degli stabilimenti militari di far fronte in qualche modo all'aumento del costo della vita, anche se il loro salario restava ampiamente inferiore a quello dei lavoratori dell'industria privata. I militari operai invece si trovarono in una posizione ben più critica, sia perché alcune di queste indennità non spettavano ai militari di truppa, sia perché sovente le indennità non venivano addirittura prese in considerazione dai datori di lavoro privati Non deve quindi sorprendere se qualcuno, che aveva una famiglia numerosa, preferì rinunciare al salario per far pervenire ai suoi cari il modesto sussidio governativo che alla fine della guerra ammontava a 85 centesimi al giorno per Ja moglie, i genitori e i fratelli, a 45 centesimi per ogni figlio. Anche la situazione dei militari operai a disposizione era tutt'altro che ottimale, perché, se a questi spettava la paga degli operai borghesi, in pratica, anche in questo caso, si trattava quasi sempre dei minimi salariali ( 44 ). Concludendo, le retribuzioni degli operai militari, sia comanda-

ti che a disposizione, furono, nel corso del conflitto, sensibilmente inferiori a quelle delle altre maestranze: ciò dipese da una serie di fattori quali l'assoluta mancanza di un qualche autonomo peso contrattuale degli operai militari; il modesto impegno dei sindacati nella difesa dei loro interessi e la tendenza prevalente tra le massime autorità militari (e non solo tra quelle) a non creare troppe grosse sperequazioni t ra i combattenti e quelli che venivano considerati dei privilegiati perché sottratti ai rischi della guerra.

Nell'ambiente militare il generale Dallolio era in realtà un isolato nel suo tentativo di non creare forti differenze tra il trattamento economico degli operai e degli operai militari , la quasi totalità degli altri ufficiali era infatti molto più preoccupata di non creare eccessive sperequazioni tra i combattenti e i militari operai.
Nel corso della guerra la manodopera minorile e femminile fu largamente impiegata e come già abbiamo visto, al termine del conflitto, nelle sole industrie dedite alla costruzione di armi e munizioni si contavano 258.000 fra donne e ragazzi. Quanto alla loro ripartizione tra i vari tipi d'industria, una statistica dell'agosto 1918 fornisce le seguenti percentuali:
Nonostante ch e la richiesta fosse, nel corso d el confl itto, fortemente aumentata, l'offerta di manodopera femminile si mantenne abbastanza elevata e ciò incise notevolmen te sulla retribu-
zione che non aumentò con la stessa rapidità e con la stessa proporzione con cui crebbero i salari degli operai A questo proposito basti pensare che sul finire del 1916 una commissione mista operai-imprenditori, appositamente nominata dal generale Dollolio, pervenne alla conclusione che per la manodopera femminile, nella determinazione di nuove tariffe, si prendesse come base la paga giornaliera di 2,50 lire ( 46 ).

La necessità spinse un numero crescente di donne e fanciulle, appartenenti a famiglie artigiane, della piccola borghesia, o contadine ( quasi esclusivamente di braccianti) a cercare un lavoro che potesse sopperire in qualche modo alle necessità della famiglia compromesse dal richiamo alle armi dell'uomo di casa. Oltre a ciò si ricorse largamente all'impiego della manodopera minorile sia maschile che femminile. Per valutare l'ampiezza di questo fenomeno bisogna considerare i dati relativi alla composizione del personale delle industrie laniere nel 1918:
Indubbiamente il caso dell'industria laniera costituisce il caso limite dell'impiego della manodopera femminile e minorile, e ciò spiega come e perché il salario medio giornaliero abbia avuto, negli stabilimenti tessili lanieri, un modesto incremento nel corso del conflitto.
Oltre agli operai del Genio Civile mobilitato, agli operai militari e alla manodopera femminile, erano assicurati, presso la la Cas sa di Previdenza, anche i libici, i prigionieri militari e i detenuti, che lavoravano presso gli stabilimenti ausiliari. I libici veniva arruolati dal 1916 con un contratto base che assicurava una base minima di 3,50 lire (una lira della paga veniva inviata alla famiglia per gli operai sposati) in più diritto all'alloggio ed una somma quale premio d'ingaggio (48 ).
Si trattava di un salario modesto che, però, in considerazione del particolare tipo di vita condotto dai libici e delle agevolazioni per l'acquisto di viveri e di vestiario, permise a qualcuno di loro di risparmiare qualche soldo. Per quanto le paghe giornaliere dei libici subissero, nell'ultimo anno di guerra, qualche miglioria esse rimasero sensibilmente al disotto dei salari corrisposti agli operai italiani che avevano le stesse mansioni. Il trat-
tamento economico dei prigionieri di guerra e dei detenuti addetti al lavoro negli stabilimenti era ancora più modesto.
In conclusione una valutazione analitica dei salari operai dichiarati alla Cassa di Previdenza dimostra che, nel corso della guerra, si vennero a formare, all'interno delle maestranze addette agli stabilimenti, diverse categorie di retribuzioni a seconda di particolari condizioni di taluni gruppi di lavoratori.
Per valutare l'ampiezza del fenomeno, gioverà ricordare che dei 1.224.500 operai addetti, al termine del conflitto, alle industrie più strettamente legate con la produzione bellica, 703.000 pari al 57,41 % erano operai maschi esonerati o senza obblighi di leva, la cui retribuzione era proporzionata alla realtà di questo tipo di manodopera, mentre 521.500, pari al 42,59 % era costituito da operai militari, prigionieri, libici e donne. Categorie queste che, o per la particolare condizione o per la larga disponibilità, (ad es. la manodopera femminile) venivano retribuite in maniera minore.
Questa diversità di trattamento risulta chiaramente anche da documenti dell'epoca. Infatti la relazione del 1917 della sezione torinese della Federazione Italiana Operai Metailurgici « nel commentare le medie salariali relative agli anni 1916 e 1917 affermava che esse erano aumentate di poco per effetto dell'avvenuta immissione nelle officine di un gran numero di operai non specializzati e che i loro minimi salariali avevano sortito l'effetto di ribassare la media reale delle paghe nominali "per le maestranze impiegate prima della guerra" » ( 49 ).

Riguardo poi alla diversa incidenza di questi due gruppi di lavoratori nelle rilevazioni statistiche della Cassa di Previdenza, gioverà ricordare che tali rilevazioni erano formulate sulla base delle denunzie d'infortunio. A tale proposito è indispensabile valutare non solo la frequenza degli infortuni, ma anche cercare di individuare quali categorie erano le più colpite. All'inizio del 1918 veniva pubblicato sul « Bollettino » del Comitato Centrale della Mobilitazione Industriale un articolo sul problema degli infortuni sul lavoro, in cui, tra l'altro, si leggeva: « Il danno è aumentato in modo notevole per il ricordato peggioramento della manodopera».
Infatti dai dati forniti dalla Cassa di Previdenza, su un campione di 450.000 operai addetti all'industria bellica, gli infortuni erano saliti da 167 per 1.000 operai assicurati nel 1916, a circa 335 per 1.000 secondo i dati di una statistica parziale del 1917. La frequenza degli incidenti era stata più intensa laddove vi era stato il maggior incremento di manodopera, ad esempio, la Lom-
bardia, nel 1917, aveva 110.000 operai nelle industrie considerate, con una media di infortuni di 375 per ogni 1.000 operai.

Significativa anche la ripartizione di questi infortuni tra i vari tipi dell'industria lombarda: « dal 110 per le aziende elettriche al 145 per le chimiche ed esplosivi, al 190 per l'industria aviatoria, al 225 per le estrattive ed edilizie, al 283 per le metallurgiche, al 310 per i proiettifici al 460 per le fabbriche di automobili, motori a scoppio ecc. » ( 50 ).
Come si vede la percentuale degli infortuni era influenzata, oltre che, ovviamente, dalla particolare pericolosità di alcune lavorazioni rispetto alle altre, dal più o meno rapido incremento che alcune lavorazioni avevano ricevuto dalle commesse belliche. Non meno significative le notizie relative agli esiti dell'infortunio: « morti scesi progressivamente da 0,78 per 1.000 unità assicurate nel 1900 a 0,46 nel 1916; inabilità permanente invece aumentata da 3,20 a 8,92 nello stesso periodo di tempo, nel quale i valori per l'inabilità temporanea passarono da 73,73 a 116,29 nel 1916 » La statistica parziale del 1917 forniva invece i seguenti valori: 317,6 per l'invalidità temporanea, 17,3 per la permanente e 0,3 per la morte ogni 1.000 assicurati ( 51 ).
Come si vede le misure generali di prevenzione contro gli infortuni erano riuscite a far decrescere progressivamente il numero degli incidenti mortali, mentre era aumentato fortemente il numero delle invalidità temporanee, e, purtroppo, anche di quelle permanenti. Ciò era evidente conseguenza dell'inesperienza di molti nuovi addetti all'industria. Per far fronte a questa situazione la Mobilitazione Industriale lanciò nel 1917 una campagna antinfortunistica ed intensificò e rese sistematica la sorveglianza degli stabilimenti per far osservare le misure di prevenzione degli infortuni.
Nel corso del 1918 tale azione dové produrre il risultato di ridurre fortemente la percentuale degli infortunati. Sta il fatto comunque che, per quanto riguarda gli stabilimenti ausiliari, dal 1° gennaio del 1918 al 31 ottobre dello stesso anno furono perdute, per infortuni, 1.665.728 giornate lavorative , un dato relativamente modesto se si considera che il numero delle maestranze degli stabilimenti ausiliari in quell'anno era fortemente aumentato (52 ). La maggiore osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni non poteva però impedire che si verificassero proprio quegli incidenti dovuti all'inesperienza degli operai. Ed i lavoratori meno pratici ed esperti erano appunto, come abbiamo visto, quelli delle categorie sotto-retribuite.
In definitiva, la storia dei dati della Cassa Nazionale infor-
tuni può essere così ricostruita: nel 1915 l'iscrizione degli operai del Genio Civile mobilitati e quella dei militari addetti agli stabilimenti dell'esercito, determina una prima immissione tra gli iscri t ti alla Cassa di un notevole numero di assicurati a bassa retribuzione. Si noti che ciò avvenne contemporaneamente al richiamo alle armi di una parte degli assicurati «normali». Questa situazione, alterando le caratteristiche complessive degli assicurati, fa si che si determini una prima lieve contrazione del salario reale della media degli assicurati.

Questa diminuzione diviene più sensibile l'anno successivo allorché, a compensare gli effetti dei nuovi richiami alle anni, concorrono l'ampliarsi dell'industria privata e sopratutto il grande sviluppo assunto dal Genio Civile mobilitato e dagli stabilimenti militari il cui ritmo di espansione era, come abbiamo constatato, molto superiore a quello degli analoghi impianti civili. Oltre a ciò, ad abbassare i valori medi retributivi, contribuì senza dubbio potentemente, l'estensione dell'obbligo dell'assicurazione a gli operai-militari ed ai prigionieri di guerra che lavoravano negli stabilimenti per cui era prevista l'assicurazione. Nel 1917 si ebbe poi l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Nazionale Infortuni di tutti i lavoratori degli stabilimenti ausiliari, mentre cresceva il numero degli operai militari, delle donne e dei prigionieri in essi impiegati.
Ciò provocò una nuova contrazione del salario medio perché, in primo luogo, la maestranza a scarsa retribuzione era proprio la meno esperta ed anche perché militari e prigionieri erano addetti ai lavori più pesanti e più faticosi in cui quindi la percentuale degli incidenti era maggiore. Nel 1918 si verificò una ulteriore espansione del numero de lle maestranze d eJl'industria mobilitata, espansione, che, si badi bene, venne attuata soprattutto con manodopera femminile, militare, libica ecc. a basso salario. Si ebbe inoltre l'intensificazione della sorveglianza delle norme antinfortunistiche cosicché la maggioranza degli infortuni fu causata da inesperienza e quindi coinvolse quasi esclusivamente i lavoratori a bassa retribuzione . In sostanza i dati della Cassa Nazionale Infortuni sono la conseguenza a) del grande e progressivo aumento, verificatosi lungo tutto il corso della guerra, del numero degli assicurati; b) del continuo crescere, all'interno, del numero degli assicurati stessi, della quantità e della p ercentuale d ei lavoratori a bassa retribuzione; c) delle circostanze per cui operai militari, del Genio Civile mobilitato, prigionieri e libici, erano in genere adibiti ai lavori più pesanti e faticosi; d) del fatto che il progressivo aumento delle disposizioni antinfortunistiche e la
creazione di un efficiente strumento di controllo per la loro osservanza, attuandosi con efficienza sul finire del 1917, fece si che gli incidenti si riducessero, ma che la percentuale di quelli dovuti ad inesperienza si accrescesse ulteriormente. Tutto ciò porta a concludere che il rapido crescere delle retribuzioni registrato dai dati della Cassa Nazionale Infortuni negli anni 1919 e 1920, fosse dovuto, più che all'aumento della conflittualità, al fatto che, con la smobilitazione nel 1919, le categorie degli operai a bassa retribuzione fossero venute a sparire.
L'esame che abbiamo condotto sulle varie fasce retributive degli operai addetti all'industria bellica ci può permettere di chiarire il piccolo mistero della retribuzione degli operai della Fiat.
Come si ricorderà, dal confronto dei dati delle rilevazioni del Redenti con quelli dei salari giornalieri degli operai della Fiat, risulta che nel 1917, la paga media di un operaio meccanico nella zona del Comitato regionale piemontese, era di L. 10,74 mentre quello di un lavoratore della Fiat era di 9,81. Appare invero poco credibile che il colosso della meccanica offrisse retribuzioni medie inferiori a quelle delle altre industrie. Si rileverà a questo proposito che, mentre i dati Fiat si riferivano al totale delle maestranze, i dati del Redenti si riferivano invece al solo personale maschile; ciò ha indubbiamente il suo peso . Tuttavia, come abbiamo in precedenza visto, la percentuale delle donne impiegate nelle industrie meccaniche era alquanto modesta e non certo tale, da sola, da provocare una differenza di quasi una lira. P er comprendere questa differenza bisogna considerare la presenza degli operai militari; si potrà osservare a questo proposito che non è detto che i dati raccolti dal Redenti non siano influenzati dalla presenza nell'industrie, oggetto dalla sua rilevazione statistica, di manodopera militare. Il problema principale non è però costituito dalla presenza o meno di operai militari tra il personale oggetto delle due diverse rilevazioni (per quanto nel caso della statistica del Redenti ciò sia tutt'altro che certo) quanto della diversa incidenza di questo personale, poiché è sicuro che gli operai militari venivano preferibilmente assegnati, per ovvi motivi di produttività, alle grosse industrie, ed i libici e i prigionieri esclusivamente a queste. Come si ricorderà questo personale era in massima parte addetto a lavori pesanti e di manovalanza. Un esame più dettagliato delle retribuzioni degli operai delle Fiat, negli anni del conflitto, permetterà di individuare, sia pure per difetto, l'incidenza dei lavoratori a bassa retribuzione sulla formazione del salario medio.
I dati completi delle retribuzioni giornaliere nella grande

industria torinese, per il periodo che ci interessa, furono i seguenti:
Tra il 1914 cd il 1918 i salari dei cottimisti aumentarono di 7,38 lire pari al 104% della paga del 1914, quelli dei percentualisti L. 6,85 pari al 118 %, quelli dei manovali di 3,15 lire pari al 81 %. Benché indubbiamente vi fossero operai militari anche tra le due prime categorie è indubbio che la maggior parte del personale militarizzato era costituita da manovali; ecco quindi spiegato il perché dei modesti aumenti di questa categoria sia in assoluto che in percentuale. A questo riguardo sono estremamente significativi anche i dati d ell'immediato dopoguerra. Infatti , nel 1919 la retribuzione dei cottimisti aumenta del 19,7% quella dei percentualisti del 26,4 % e quella dei manovali del 34,7%. Ancora più indicativi i dati del 1920, cioè a smobilitazione ultimata. I n quest'anno gli aumenti furono del 33,6% dei cottimisti, del 35,5% per i perccntualis ti e del 90,9% dei manovali. Incrementi che in una situazione in cui, per la smobilitazione, non scarseggiava certo la manodopera non qualificata per i lavori di fatica, possono essere spiegati solo se si considera che i dati sono alterati dalla presenza, negli anni della guerra, di lavoratori a basso salario. Quindi gli aumenti della retribuzione media dei manovali appaiono nel corso d el conflitto minori di quelli che furono in realtà quelli degli operai civili, mentre nel dopoguerra si verificarono aumenti sproporzionati che in realtà sono anch'essi apparenti e che non sono altro che la conseguenza dell'eliminazione della manodopera a bassa retribuzione dagli stabilimenti.
Concludendo il nostro esame dei salari operai nel corso della prima guerra mondiale non possiamo far a meno di riconoscere che l'intuizione del Melograni circa l'aumento dei salari reali di una parte della manodopera industriale era esatta. Questa parte peraltro era costituita, in maggioranza, dal proletariato industriale poiché « i lavoratori di guerra » a bassa retribu-

zione erano in buona parte contadini ed artigiani. Anche la grande disponibilità di personale femminile, che permise una grande estensione della occupazione in questo settore senza che si esaurisse la disponibilità di manodopera (e che quindi questa divenisse cara come quella maschile), fu dovuta alla sempre maggiore disponibilità di donne e fanciulle delle famiglie artigiane o della piccolissima borghesia, ma soprattutto del contado.
Il Gini ha ascritto tra i risultati positivi delle esperienze della guerra per l'industria italiana il fatto che una parte cospicua di uomini e donne di origine contadina avessero fatto una sia pure rudimentale esperienza di lavoro in fabbrica ( 54 ).
Si trattò di un apprendistato pagato il più delle volte con la sottoretribuzione anche se, date le particolari circostanze in cui ciò avvenne, comportava almeno, per gli uomini, il privilegio di sottrarsi ai rischi della guerra guerreggiata. Va rilevato inoltre che di questa esperienza l'organizzazione industriale italiana non poté giovarsi molto perché queste maestranze furono, per la quasi totalità, espulse dalle fabbriche durante la riconversione che fece seguito al conflitto. Infatti gli addetti all'industria che nel 1911 erano 3.091.160 dieci anni dopo erano 3.182.797 con una piccola flessione sulla percentuale totale della popolazione attiva dal 19,0% al 18,4%. Per quanto riguarda poi l'occupazione femminile, tanto estesasi nel corso della guerra, la flessione fu ancora più netta; le addette all'industria passarono infatti da 1.382.864 nel 1911 a 1.218.347 nel 1921, mentre la percentuale scendeva da 8,4 a 6,9. Per quanto sia certo che sulla riduzione della manodopera femminile abbia influito la contrazione del lavoro artigianale, è però indubitale che la causa maggiore della flessione fosse la riconversione industriale, tant'è che la riduzione maggiore (dal 10,2 all'8,6) si verificò proprio nel nord industrializzato.
(1) Commissione Parlamentare, cit., voi. I, p. 429.
(2) Ibidem, voi. Il, p. 54.
(3) Ibidem, voi. Il, p. 115.
(4) Ibidem, voi. Il, p. 77.
(5) Ibidem, voi. II, p. 83.
(6) Ibidem, voi. Il, p. 82.
(7) In una rela:,,ione presentata in quell'occasione si legge che l'organismo della Mobilitazione Industriale • concepito con criteri di sveltezza e di equità, lentamente si va trasformando in un ente burocratico. in cui 1'impero della circolare, del regolamento, dell'ordine cli servizio, veniva a sovrapporsi a quella che doveva essere la principale guida dei comitati di mobiLitazione: il buon senso pratico nell'applicare le direttive necessariamente generiche impartite dal centro, l'adattabilità rapida alle necessità industriali del luogo e del momento•, « Bollettino della Lega Industriale•, anno Xl (1917), numero unico p. 6 ss.
(8) Commissione Parlamentare, cit., voi. T, pp. 305-306, voi. II, pp. 35, 48, 49, 55, 64, 72, 74.

(9) A CARAOCTOLO: La formazione dell'Italia ind11striale, Bari 1974, p. 187.
(10) Commissione Parlam enta re, cit., voi. II, p. 99.
(11) Ibidem, voi. Il, p. 95.
(12) L E1m1,1>1: La condotta economica, cit., pp. 128-129.
(13) Cfr. C. GELOSO: art. cit ., p. 7.
(14) L. ErNA\/1)1: L acondotta economica, cit., p . 129
(15) R Roi.im: op. cit., pp. 115-116.
(16) A. CARAOCIOLO: La formazione dell'Italia industriate, cit., p. 196.
(17) A. GRAZ1AN1: Lo sfo rzo economico dell'Italia in gue rra, Trieste 1919, p. 58.
(18) P. SPRJANO: op. cit., p. 3n.
( 19) R. BACHI: L'Italia economica nel 1918, Città di Castello 1919, p. 186
(20) E. REDl!NTI': Studi e notizie s ui salar i n elle industrie • mobilitate •, in • Bo llettino del Comitato Ccntrole dj Mobilitazione Industriale•, ottobre 1918, pp. 338-349.
(21) Istituto Centrale di tatistica: Sommario di statistiche storiche dell'Italia 1861-1965, Roma 1968, p 109
(22) E. Rrol!Nn: op. cit., p. 349.
(23) Cfr. G. PRATO: Il Piemonte, cit., p. 132.
( 24) I bidem , p. 133.
(25) E. REDllNTT: op. cit., p, 340.
( 26) I dati si riferivano infatti a 76.496 assistiti per il 1913 , 90.465 per il 1914. 94.920 per il 191 5. 101.098 per il 1916, 105.275 per il 1917, 78.284 per il 1918, 74.348 per il 1919, 92.U7 per Il 1920. Cfr. C. VISMARA: I salari degli operai nelle statistiche della Cassa Nazionale Infor tuni, in • Rassegna della previdenza sociale•. novembre 1921 , p. 86
(27) G. B AI.El.LA: Salari, costo delta vita ed indenni/li. caroviveri, in • Rivista delle società commerciali •, ottobre 1918.
(28) Oltre al c ita to articolo di C. Vismara vedi: G. TAGLIACARNE: Le variazioni dei salari reali nel!li ultimi anni, in e Rivi,ta bancaria•, agosto 1923 G. C1N1: Sul livello dei salari reali del dopo guerra in Italia in confronto al loro livello prebellico, in • Rhista di politica economica •. aprile 1923.
(29) G. MADIA: L'aumen to dei snJari dal 1914 al 1921, nel • Giornale degli economisti •, ottobre e novembre 1921 , p. 390.
(30) I salari reali sono calcolati in base ai coefficienti ru moltipJica7Jonc all'Istituto Centrale di Statistica: Il ,•alorc della lira dal 1861 al 1965, Roma 1966.
(31) Cfr C. Grnt: Sul liv ello dei salari reali , cit tavola XLV.
(32) Vedi A. FOSSATI: IA,'Oro e r,rodutione in Italia, Torino 1951 , pp. 567-569. C. VAN'I\ITRLI: Occupai.ione e salari dal 1981 al 1961. in e L'economia italiana dal 1861 al 1961, a cura di A Fanfa ni, MUano 1961 pp 560-596.
(33) P MELOGRANI: op. cìt. , pp. 36 1-362
(34) Ibidem, p. 362.
(35) Il brano della dichiarar.ione del generale Dallolio contenuto in R elation e Capo retto. voi. II, p 412 Il corsivo è nostro.
(36) P MELOcltANI: op. cit., pp. 363-369.
(37) Vedi allegato n. 12.
(38) M. A.BRATB: op. cii. , p . 173.
(39) Il 17 agosto 1917 era stata decisa la costiturionc di una comm1ss1one paritetica mista industriali-operai pr esieduta da un rappresentante del Sottosegretario alle armi e munizioni, per affrontare alcuni problt'mi sollevati dai rappresentanti sindacali. Nella prima seduta , il 6 settembre, il Comm. Orlando propose di m ettere a llo studio • una forma ru previdenza che, basandosi sulla larqbe7.7,a delle attuali pa$e, volga a salvaguardare gli operoi dalle conseguenze dei probabili minimi guadagni temibili per l'avvenire•. Tale proposta fu accettata e formulata come ro.ccomandazione. Successivamente nella seduta del 19 settembre, la Commissione propose che la proposta Orlando fosse sturuata da una commissione mista operai e datori di lavoro. TI Sottoseirretariato diede incarico di studiare la cosa alla commissione P.ià costituita, c he prese allora il nome di e Commissione per il risparmio opera io• N ella riunione del 16 dicembre 1917 f1.lrono esaminati due pro11ctti di assicura1ione presentnti d a due rappresentanti operai Ancillotti e Buozzi. La commissione scartando il prcj!etto minimo di Buou'i si pronunciò a fayore di quello dell'Ancillotti che costitul la base del decreto d el 29 aprile. Vedi allegati nn. 13 e 14.
(40) Cfr. Comitato per la Mobilitazione Civile: Le Wtrie forme di esenzione, cit., pp. 440-441.
(41 ) Relazione Ca poretto, voi. II, p. 412
(42) P SPRTANO, op. c it., p. 346.
(43) Commissione Parlame,1tare, cit., voi. II , p. 126

(44) Per le notizie sui shtemi di retribuzione degli operai militari cfr. Comitato per la Mobilitazione Ch·ile: Le varie fo rme di esenzione, cii., pp , 440-441.
(45) Com itato per la Mobilitazione Civile: li co ntributo delle maestranze femminili all'opera di allestimento di materiali bellici, cir., p. 57.
(46) Vedi allegato n. 13.
(47) Ministero della Guerra: / serv izi l ogis tici, ci t. , p. 278.
(48) V FRANClmn: La mobilitazio11e indu striale, cit., pp. 147-148.
( 49) B. BEZZA: li sindacato di massa tra riorganhzazione capùalistica e fascismo, in La FIOM dalle o rigini al fascismo 1901-1924, a cura di M. Antonioli e B. Bcaa. Dari 1978, p. 101.
(50) L C.o\RO'ZZr: li problema sociale dell'infortunio sul lavoro, in e Bollettino del Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale •, febbraio-marzo 1918, p. 98.
(51) Ibidem.
(52) Comitato per la Mobilitazione Civile: La sorveglianza disciplinare sul personale degli stabilimenti, c,t., p . 131.
(53) Cfr. G . PRATO: Il Piemo nte, cit., p. 132.
(54) C. GINI: Problemi sociologici della guerra, Bologna 1921 , pp. 203 ss.

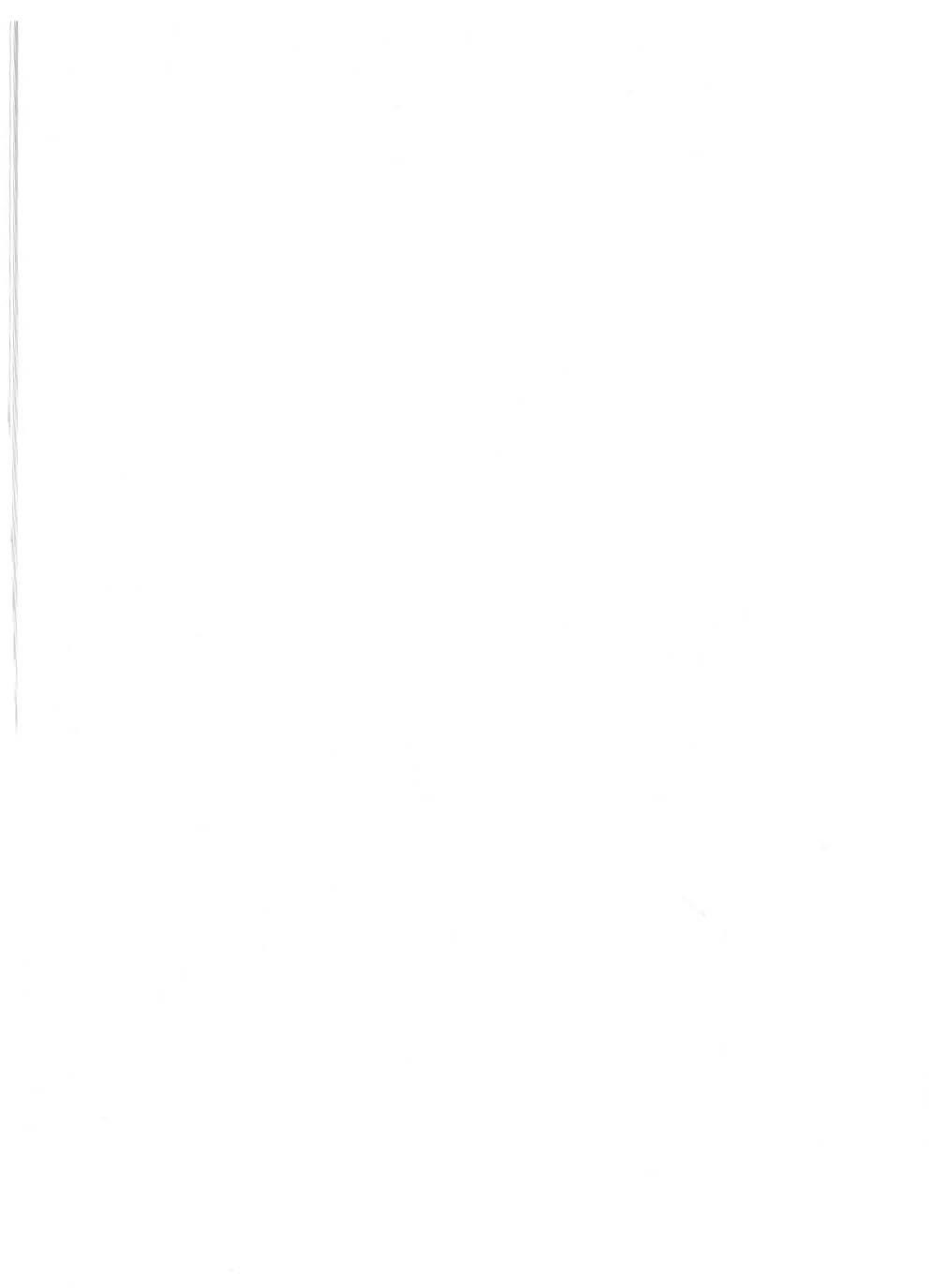
Lo scoppio della guerra sembrò porre fine all'annosa polemica tra liberisti e protezionisti sancendo la vittoria di questi ultimi. Sulla scia di questo successo e sotto l'incalzare delle necessità belliche, studiosi e giornalisti andarono oltre la primitiva affermazione dell'imprescindibilità del potenziamento dell'industria pesante italiana. « Il motivo dell'indipendenza dalla Germania, nella chimica come nelle industrie dei metalli, si univa spesso a quello dei compiti della guida economica di uno Stato moderno. Via via che la guerra si inoltrava si assisteva, d'altronde, a un tale sviluppo di produzioni già avviate e di creazione di rami nuovi di fabbricazione, che era difficile anche ai liberisti più rigorosi chiedere un ritorno al passato o negare l'utilità di tale apparato in circostanze come quelle di guerra » (1). I nfatti i più abili tra i liberisti non negavano più la necessità dell'intervento statale, preoccupandosi invece di circoscriverne la sfera d'azione. Così l'Einaudi, che, nel dicembre del 1916, chiedeva che i materiali militari navali e terrestri fossero costruiti unicamente da aziende controllate dallo Stato. Questo controllo doveva però avvenire senza alterare la struttura privatistica dell'impresa, secondo un sistema che anticipava le attuali industrie a partecipazione statale. Lo Stato avrebbe dovuto poi astenersi dall'ingerirsi nel resto dell'economia (2) .
Questa proposta, di chiaro contenuto limitativo, non poté esser presa in considerazione poiché in pratica, sotto la spinta delle imperiose necessità della produzione bellica, l'ingerenza dello Stato neH'economia non fece che accrescersi negli anni del conflitto. Questo intervento non corrispose ad un piano preordinato, né fu la conseguenza di ponderate scelte della classe politica. I dirigenti italiani avevano in gran parte un'esperienza di governo risalente all'età giolittiana, un'epoca in cui i problemi venivano in genere risolti attraverso mediazioni tra le forze in campo, senza perseguire un chiaro e definito disegno politico.

D'altra parte la totale divisione tra le sfere di competenza dei politici e d ei militari, non giocava certo a favore di una valida azione di direzione politica dello sforzo bellico. Per queste ragioni la classe dirigente, sia perché sprovvista delle conoscenze tecniche necessarie sia perché incapace di esprimere una propria organica linea politica nel settore, preferì abdicare nelle mani dei tecnici. Fu quindi il generale Dallolio, con la collaborazione di tecnici militari e civili, che organizzò e diress e lo sforzo industriale del paese. Questa soluzione, se si dimostrò efficace nei tempi brevi, era purtroppo destinata a mostrare la corda a l termine del conflitto poiché, fatalmente, la classe dirigente politica si sentiva estranea all'organizzazione creata dal Dallolio, la quale, in definitiva, divenne fatalmente, per i politici, uno strumento temporaneo di cui bisognava sbarazzarsi appena la situazione lo consentisse.
In ultima analisi fu Alfredo Dallolio a tracciare le linee direttrici della politica industriale del paese nel corso della guerra, e ciò, tutto sommato, fu senza dubbio un bene poiché il genera le, superando molteplici ostilità, seppe creare un clima di collaborazione tra industria e pubblica amministrazione e tra imprenditori e maestranze che non aveva precedenti nella storia italiana. Ciò era dovuto alla decisione di largheggiare nelle commesse e nei salari facendo in definitiva pagare al resto dd Paese l'espansione industriale e d il miglioramento delle condizioni di vita d elle masse operaie . Tutto questo non fu indubbiamente senza conseguenza per quanto concerneva la stabilità finanzi aria dell'Italia, tuttavja bisogna chiedersi se una linea politica alternativa, quella proposta dall'Einaudi consistente in « sottoporre a dura disciplina coercitiva industriali ed operai » ( 3 ), avrebbe consentito di raggiungere gli stessi risultati. Il generale Rodolfo Bianchi d'Espinosa che, come membro della Segreteria di Cadorna fu anche addetto ai rapporti con la « Mobilitazione Indus triale», ha scritto: « sono in grado di affermare che la sapiente e tenace opera di vigilanza, d'incitamento e di geniale organizzazione (e ripieghi) sviluppata dal generale Dallolio fu addirittura sbalorditiva» ( 4 ).

E f uor di dubbio però che l'azione de ll'organizzatore della Mobilitazione Industriale fu resa possibile dal clima di collaborazione che il generale Dallolio aveva saputo creare. Sarebbe stata concepibile una simile atmosfera se, invece di venire incontro alle richieste degli industriali e degli operai, li si fossero sottoposti a « dura disciplina coercitiva»? E lecito dubitarne.
La classe politica, se non seppe e non volle dirigere la politica economica del Paese in guerra, non seppe del pari formula-
re una chiara e coerente linea di politica interna. Le indicazioni che pervenivano dagli ambienti militari erano su questo punto tutt'altro che univoche: infatti a differenza di Dallolio, il generale Cadorna, chiedeva con insistenza al Governo energici provvedimenti contro i « disfattisti » ed i gruppi politici ostili alla guerra. Questo atteggiamento derivava dal fatto che il Capo di Stato Maggiore non si preoccupava che della sicurezza delle retrovie dell'esercito operante, mentre il Ministro delle armi e munizioni era interessato principalmente all'efficienza della stuttura industriale del Paese.
Gli orientamenti del Cadorna e del Dallolio divergevano sostanzialmente perché ciascuno privilegiava il compito che gli era affidato, ma ciò non avrebbe impedito certo al Governo di sviluppare una coerente ed organica linea politica poiché si trattava di pareri di tecnici che vedevano inevitabilmente solo alcuni aspetti del problema, mentre la valutazione complessiva spettava naturalmente alle autorità politiche.
Nonostante ciò, mancò una coerente ed incisiva azione di governo nei confronti del problema dell'ordine pubblico. Vittorio Emanuele Orlando, che, come Ministro dell'Interno prima e come Presidente del Consiglio poi, ebbe per un lungo periodo le maggiori responsabilità in questo campo, si oppose alle misure repressive proposte dal Cadorna, cercò di assicurare il regolare rifornimento dei principali prodotti alimentari alle grandi città e tenne rapporti, per interposta persona, con il gruppo parlamentare socialista. Si trattava indubbiamente di un abbozzo di linea politica che fu però portato avanti senza risolutezza e con molteplici tentennamenti. Più di una circostanza fa infatti pensare che gli obiettivi di Orlando fossero alquanto modesti: prevenire disordini e mantenere un minimo di rapporti con i deputati socialisti. Si trattava insomma di una politica che nasceva più dell'esigenza di garantirsi un qualche spazio di manovra parlamentare, anche nei confronti dei socialisti, che dal proposito di coinvolgere l'opposizione nello sforzo bellico del Paese. Infatti Orlando non approfittò della situazione creatasi dopo Caporetto per tentare di coinvolgere stabilmente nella politica di « union sacrée » tutto o in parte il partito socialista, cosa che, in quel momento, sarebbe stata tutt'altro che difficile. In definitiva, anche ad Orlando
mancò la visione del problema della politica interna nel suo complesso o, quantomeno, non ebbe la risolutezza e l'energia necessarie per portare avanti fino alle logiche conseguenze la sua azione politica, la quale appare, in conseguenza, più che come il frutto di un programma organico, come un tentativo di garanti-

re l'ordine pubblico alla meno peggio e di assicurarsi in qualche modo i contatti con il gruppo parlamentare del P.S .I.

In una situazione caratterizzata dall'assenza di una valida iniziativa governativa, gli orientamenti degli operai e degli industriali acquistano un'importanza ancora maggiore, sia per quanto riguarda l'ordine pubblico, sia per quanto s i riferisce a l funzionamento e lo sviluppo della Mobilitazione Industriale.
Circa i problemi relativi all'ordine pubblico, gli orientamenti delle masse operaie non costituirono, come abbiamo visto innanzi, un serio problema nel corso del primo conflitto mondiale. Più complesso il discorso relativo alla Mobilitazione Industriale. Come si ricorderà, dopo un primo periodo di perplessità, industriali ed operai accettarono di buon grado di inserirsi nel1'organizzazione creata dal Dallolio; ciò era dovuto alla particolarissima situazione nata dalla guerra che, annullando qualsiasi rapporto fra costi e ricavi, aveva fatto si che profitti e salari potessero espandersi senza contrasto; al termine del conflitto la cessazione delle commesse militari avrebbe determinato inevitabilmente una ben differente congiuntw·a. L'organizzazione della Mobilitazione Industriale avrebbe potuto sopravvivere anche in simili condizioni o doveva limitare la propria azione al periodo bellico vero e proprio? Era questa una domanda a cui industriali ed operai dovevano comunque rispondere. L'atteggiamento del Dallolio riguardo a questo problema era delineato abbastanza chiaramente; infatti nella più volte citata riunione plenaria del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale del 26 novembre 1916, egli rilevava la necessità « importante ed urgente di preparare, fin d'ora, un vero e proprio piano di Mobilitazione Industriale, che permetteva di trasformare l'industria del regime di guerra a quello di pace, senza scosse brusche e pericolose, ma gradatamente e razionalmente così da facilitare anche, alle diverse classi operaie, un assestamento delle loro condizioni morali ed economiche, profondamente turbate dalla guerra». Il generale vagheggiava una Mobilitazione Industriale del periodo di pace che poteva continuare « con opportune modifiche, allargamenti e addentellati agli altri organi dello Stato interessati all'arduo problema; le tradizioni di questa istituzione che ha dimostrato i grandi tangibili vantaggi che si possono ottenere da un'intima, quotidiana collaborazione dei rappresentanti delle Amministrazioni Governative, con le forze vive e produttive del Paese, industriali ed operaie» ( 5 ). Secondo il generale Dallolio non era il caso che si definissero, fin da quel momento, le caratteristiche strutturali della Mobilitazione Industriale di pace. Infatti , nella
seduta del 17 dicembre di quello stesso 1916 della Commissione mista che doveva esaminare il nuovo regolamento della M.I., il capitano Enrico Toniolo, parlando (praticamente) a nome del Sottosegretariato, sostenne il « concetto che preparare fin da oggi una Mobilitazione I ndustriale civile era troppo presto; però siccome il lavoro preparatorio per quello che si dovrà fare dopo la guerra non bisogna farlo a pace conclusa, ma anticipatamente, predisponendolo fin d'ora, esso dovrebbe essere espletato dallo stesso ente oggi esistente il quale già conosce quello che oggi si fa e cosa conviene studiare per l'avvenire. Con questo si eviterebbe appunto un'azione slegata e senza coesione fra le diverse iniziative che vanno ovunque sorgendo. L'organismo attuale si è dimostrato utile e quindi è bene aggregare ad esso altri elementi i quali possono portare il sussidio della loro competenza nel trattare questioni di diversa natura. Preparare fin da ora uno schema di mobilitazione civile è prematuro, ma siccome il periodo di guerra e quello delle trattative di pace non sarà certo breve, si potrà, durante questo periodo, fare un ottimo lavoro di preparazione e raccogliere quel materiale che potrà essere utilissimo» ( 6 ).
Si voleva in pratica che non fosse definita alcuna struttura alternativa alla M.I. ed, al contempo, si rafforzava quest'ultima chiamando a collaborare i ministeri interessati alla risoluzione dei problemi post-bellici. Quest'orientamento celava probabilmente la tendenza dell'allora Sottosegretariato per le armi e munizioni a far si che fosse incaricata la stessa struttura della Mobilitazione Industriale di risolvere i problemi del dopoguerra. Infatti, una volta che la struttura fosse stata convenientemente ampliata, chi avrebbe sentito il bisogno di crearne un'altra exnovo? In quanto ai programmi del Dallolio e dei suoi collaboratori, per la riorganizzazione della vita economica del Paese al termine del conflitto, ben poco si sa. Tuttavia, in quello stesso 1916, Enrico Toniolo diede alle stampe un breve studio sulla Mobilitazione Industriale in Italia in cui, dopo aver accennato all'opera svolta dagli altri paesi belligeranti per prepararsi ad affrontare i problemi del dopoguerra, si delineava, sia pure sommariamente, una possibile linea di sviluppo della organizzazione creata in Italia. « Ora per la Mobilitazione Industriale di pace è necessario che il concorso degli industriali delle diverse industrie sia raggruppato e coordinato in una specie di ente consultivo discipli.natore, il cui obiettivo dovrebbe principalmente essere questo: avviare gradatamente tutte le industrie che oggi lavorano per la guerra, a ridivenire industrie di pace, ma più forti, meglio organizzate, con una giusta razionale suddivisione dei campi di

lavoro fra le varie industrie, le quali, in tal guisa, raggiungerebbero progressivamente quella specializzazione che è il più grande elemento di forza e di impero, perché evita alle industrie identiche ed affini di abbandonarsi fra loro a concorrenza eccessiva e dannosa, mentre invece la specializzazione ne assicurerebbe la prosperità sia prossima che lontana ». Ciò non poteva avvenire che per mezzo dell'intervento statale e con l'adozione di una politica doganale protezionistica che il Toniolo suffragava con il parere di economisti che, dopo aver sostenuto il libero scambio, si erano convertiti, con la guerra, al protezionismo. L'efficacia di una simile politica era però, in qualche modo, dipendente da un'altra serie di importanti provvedimenti: « I giornali hanno già esposto un grandioso programma di opere pubbliche, stradali, ferroviarie, idrauliche da eseguirsi dopo la guerra e per una più rapida messa in valore delle risorse naturali d el nostro paese. È stato anzi formulato un progetto per la espropriazione di tutte le terre incolte, espropriazione non pensata ora, ma vagheggiata da lunghissimi anni, anche da eminenti e illuminati conservatori.

Ciò dimostra p ertanto che il concetto di un grandioso compito che spetta a tutti dopo la guerra, è profondamente sentito, per quanto forse ancora senza contorni precisi » (7).
In definitiva, il programma proposto dal Toniolo può essere così riassunto: alcune industrie specializzate, appositamente selezionate, produrranno, con l'appoggio dello Stato, per l'esportazione, mentre una politica protezionistica riparerà le altre dall' invadenza della concorrenza estera ed un grandioso programma di opere pubbliche favorirà le comunicazioni interne, aumenterà il potenziale nazionale di energia idroelettrica, diminuendo la dipendenza dell'Italia dall'estero e permettendo all'industria di attuare, quasi senza scosse, ]a riconversione. Le opere pubblich e e la riforma agraria avrebbero inoltre permesso l'assorbimento dei congedati dall'esercito e dei licenziati dall'industria di gu erra.
Si trattava di un programma grandioso, ma non privo di coerenza che il Toniolo, segretario del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale, non avrebbe potuto dare alle stampe senza il consenso dei suoi superiori ( 8 ).
In un simile contesto acquistavano senza dubbio una grande importanza gli orientamenti degli operai, degli industriali e della classe politica nei confronti di una possibile sopravvivenza dell a Mobilitazione Industriale per il periodo post-bellico.
Benché una commissione mista, di cui facevano parte alcuni tra i più cospicui industriali e i maggiori esponenti de1le organizzazioni operaie, avesse riconosciuto, in una riunione tenu-
tasi a Roma il 19 settembre 1916, « che non si possa a priori scartare l'idea della Mobilitazione Industriale anche pel dopo guerra, visti gli indiscutibili vantaggi ch'essa ha recato nel periodo di preparazione della guerra e visto il suo ottimo funzionamento » ( 9 ), tuttavia, già nella riunione del 17 dicembre della stessa Commissione, il Buozzi « ritornando sulla discussione d'ordine generale, richiama l'attenzione sull'affermazione che la Mobilitazione Industriale deve durare tre mesi dopo la guerra; egli dice che, finita la guerra, comincerà la smobilitazione delle truppe e quindi non trova perché gli operai dovrebbero continuare a rimanere mobilitati. Il Decreto sulla Mobilitazione Industriale, inoltre è stato fatto in seguito alla facoltà dei pieni poteri accordati al Governo, che è limitata al periodo della guerra e quindi tutti i Decreti decadranno col termine della guerra a meno che non siano trasformati in legge. Ritiene quindi che non sia il caso di stabilire che la Mobilitazione continuerà ancora tre mesi dopo la guerra » ( 10 ).

Questo atteggiamento contrario all'attività, anche di un solo giorno dopo il termine del conflitto, dell'organizzazione creata da Dallolio verrà sostanziato di tutta una serie di ragioni, dallo stesso Buozzi al congresso della FIOM del novembre 1918. Egli sosteneva che quando lo Stato non avesse più commesse e materie prime da dare « ogni industriale reclamerà ed otterrà giustamente completa libertà d'azione» per cui sarebbero rimasti mobilitati soltanto gli operai, « ciò che è poco e troppo ad un tempo! » Il ragionamento del dirigente sindacale, che sottintendeva l'evidente preoccupazione che il protrarsi nel dopoguerra della Mobilitazione Industriale potesse risolversi in una forma di controllo delle masse operaie, si basava però su premesse evidentemente errate. Infatti , che cosa era la struttura creata dal Dallolio se non uno strumento per la ripartizione delle materie prime e delle commesse statali tra le varie industrie? Negarle un simile compito non significava in pratica negarne l'esistenza stessa? D'altra parte la conclusione della guerra non implicava automaticamente il termine delle commesse statali; se infatti si fosse posto mano all'ampliamento e al riordino della rete ferroviaria ed al rinnovo, tanto necessario, del parco vetture; alla costruzione di nuove centrali idroelettriche, al riordino della rete stradale ormai insufficiente, alla ricostruzione della marina mercantile tanto duramente provata dal conflitto, come si vagheggiava negli ambienti della Mobilitazione I ndustriale, un massiccio intervento statale sarebbe stato più che giustificato.
Era però un simile intervento che i dirigenti sindacali tenta-
rono di eludere. Infatti, nella citata relazione, Buozzi si esprimeva decisamente contro l'arbitrato obbligatorio che riteneva lesivo alla libertà d'organizzazione e di sciopero e del pari respingeva qualsiasi proposta che tendesse a porre limitazioni legislative all'emigrazione. Per quanto si riferiva al problema delle leggi doganali, il segretario della FIOM non esitava a schierarsi contro il protezionismo nonostante la promessa di alti salari avanzata dai sostenitori di una simile politica, « Il proletariato non abboccherà » affermava recisamente « Noi siamo libero-scambisti » (11).
L'atteggiamento di Buozzi potrebbe lasciare perplessi se messo in relazione col fatto che una politica libero-scambista avrebbe inevitabilmente provocato il crollo di alcune iniziative sorte o sviluppatesi con la guerra, rendendo disoccupati migliaia di operai. Per comprendere la posizione del segretario della FIOM bisogna considerare però che, a parte l'evidente convinzione che il regime liberista fosse il più adatto a garantire un sano sviluppo industriale, il sindacato dei metalmeccanici si era grandemente rafforzato negli anni della guerra. Buozzi poteva quindi ragionevolmente prevedere che la sua organizzazione, di fronte agli inevitabili conflitti sindacali, impliciti nella scelta libero scambista, non solo avrebbe retto, ma si sarebbe ulteriormente rafforzata e potenziata.
Partendo da queste considerazioni era chiaro che qualsiasi arbitrato abbligatorio, come quello operato dalla Mobilitazione Industriale, diveniva implicitamente uno strumento per contenere l'espansione dell'attività sindacale e la stessa disoccupazione di migliaia di lavoratori il prezzo necessario e inevitabile da pagare, non solo per garantire la sanità del sistema economico, ma anche e soprattutto per assicurare lo sviluppo delle organizzazioni di classe.
Se la posizione della più importante organizzazione sindacale sul destino della Mobilitazfone Industriale era chiara ed univoca, non altrettanto può dirsi per gli orientamenti degli industriali. Per valutare questi orientamenti è necessario tener presente le grandi trasformazioni che la guerra aveva operato nella struttura economica del paese e in quella industriale in particolare. Nel 1914 il prodotto lordo delle attività industriali era stato di 4.653 milioni pari al 25% dell'intero prodotto privato lordo nazionale, nel 1918 aveva invece raggiunti i 16.774 milioni ed il 30,6%; questa colossale espansione era stata resa possibile dal trasferimento di capitali e di personale dagli altri settori in quello industriale (segnatamente dalle attività terziarie che avevano

concorso con il 32 % alla formazione del reddito nazionale nel 1914, mentre nel 1918 erano discese al 21,4%!).
All'interno dello stesso settore industriale la guerra aveva provocato un nuovo spostamento di capitali e di manodopera dalle imprese non interessate alla produzione bellica a quelle « mobilitate » Indubbiamente le condizioni eccezionali in cui operavano le industrie, specie dopo la crisi delle materie prime verificatesi in seguito all'estensione della guerra sottomarina, fecero si che anche nei settori interessati alle commesse militari, si creassero dei processi di concentrazione. Tale fenomeno è sufficientemente illustrato dai seguenti dati relativi al movimento delle società ordinarie per

Anche se la somma totale dei nuovi investimenti appare un po' gonfiata, da questi dati risulta che, negli ultimi anni del conflitto, si ebbe un aumento del numero delle grandi e medie aziende. Tale incremento fu però quasi sicuramente pagato con la rovina di molte piccole aziende e con la scomparsa di gran parte dell'artigianato.
In definitiva, l'economia di guerra aveva rafforzato enormemente le grandi industrie, moltiplicato le medie, ridotto le piccole e danneggiate grandemente le industrie artigiane.
Il processo d'accelerazione provocato dalla Mobilitazione Industriale, se aveva fortemente accentuato la dequalificazione, già avviata in precedenza, delle maestranze operaie sostituendo al vecchio tipo di lavoratore fortemente professionalizzato un nuovo tipo di operaio che potremmo chiamare « di linea», per il rafforzamento contemporaneo della media e grande industria, non era riuscito a produrre concentrazioni industriali tali da potersi automaticamente imporre a tutto il settore. Conseguentemente, la forte presenza della media ed anche della piccola industria condizionava in modo notevole gli orientamenti del mondo industriale. Nel valutare gli orientamenti degli imprenditori non si potrà prescindere da questa situazione di fatto.
All'inizio della guerra quasi soltanto il segretario della Lega degli industriali torinesi Gino Olivetti « si mostrava preoccupato per l'eccessiva compenetrazione di interessi fra gli organi statali e ambienti economici privati » (1 3 ).
Nel 1917 l'atteggiamento degli industriali mutò; infatti nel luglio di quell'anno all'assemblea della Confindustria veniva presentata, dalla presidenza, una relazione che, pur riconoscendo l'insostituibilità della Mobilitazione I ndustriale, non esitava a formulare forti riserve sulle caratteristiche organizzative che questa aveva assunto: « Quest'organismo che era stato concepito con criteri pratici di sveltezza e di equità, lentamente si va trasformando in un ente burocratico, in cui l'impero della circolare, del regolamento, dell'ordine di servizio, viene a sovrapporsi a quella che doveva essere la principale guida dei comitati di mobilitazione: il buon senso pratico nell'applicare le direttive necessariamente generiche impartite dal centro, l'adattabilità rapida alle necessità industriali del luogo e del momento» (14 ). Indubbiamente la burocratizzazione era un male deprecabile anche se difficilmente evitabile e senz'altro comprometteva l'elasticità degl i organismi della M.I. ritardando la conclusione dei processi produttivi. Vi è da chiedersi però se le proteste degli industriali non fossero in realtà causate dalle misure adottate per tutelare gli interessi dell'erario.

Infatti, nei primi anni del conflitto, l'organizzazione della Mobilitazione Industriale, posta di fronte al problema di realizzare produzioni per qualità e quantità senza precedenti nella storia del Paese, si dov'é inevitabilmente preoccupare più dei risultati che dei costi.
Era stato si, fin dallo scoppio della guerra, costituito un « Ufficio Tecnico » che tra i suoi varii compiti aveva anche quello di effettuare un controllo sui costi dei manufatti ( 15 ); tuttavia la preoccupazione di sopperire nel più breve tempo possibile alle necessità dell'esercito e la stessa mole del lavoro affidato a questo ufficio resero molto problematica quest'opera di controllo.
« Trascorsi i mesi di guerra del 1915 e giunti alla fine del 1916 buona parte dell'industria di guerra in paese era nata e sufficientemente sviluppata, l'organismo della Mobilitazione Industriale erasi convenientemente esteso ed aveva presi ampi contatti colle industrie belliche, cosicché sembrò giunto il momento di poter più rigorosamente vagliare i prezzi dei manufatti e procedere a sensibili riduzioni di prezzi» ( 16 ). A questo scopo si decise di affiancare all'Uffì.cio Tecnico una « Commissione Consultiva e di revisione dei contratti di forniture di guerra » con il compito di esaminare tutti i contratti eccedenti il milione di lire. La Commissione, operante di fatto fin dal gennaio 1917 e legalizzata con un decreto del Ministro della guerra del 1° marzo di quello stesso anno, operò con criteri di grande rigore come dimostrano le cifre relative alla sua attività:
Oltre a ciò il Sottosegretariato A.M. dispose che i prezzi stabiliti dalla Commissione fossero presi per base all'Ufficio Tecnico anche per i contratti inferiori ad un milione quando i manufatti da acquistare fossero « analoghi, identici o similari » a quelli valutati dalla Commissione.
Questi provvedimenti non furono i soli; infatti, all'inizio del 1917, fu anche organizzato un vero e proprio « Servizio amministrativo » per le A. e M. e a dirigere questo nuovo ufficio fu chia-

mato, nell'agosto di quello stesso anno, il tenente generale Ernesto Gardini « noto per il suo rigorismo e la sua rettitudine», il quale, pur agendo fra notevoli difficoltà, riuscì in breve a rendere operante il suo ufficio in molteplici direzioni.

L'azione del nuovo servizio ebbe infatti « ad esplicarsi in modo efficace e immediato innanzi tutto nell'accertamento di alcuno dei più tipici abusi ed errori commessi a danno dell'Amministrazione in occasione di alcune forniture ... Ma più ampio oggetto di indagine, di riorganizzazione e di interesse .finanziario per l'Amministrazione, offrì al nuovo servizio l'ampia materia dei recuperi, tanto in contanti che in materie prime, fino a quel momento, come si disse, quasi completamente trascurata» ( 18 ).
Questi avvenimenti chiariscono il fatto che le proteste degli industriali non erano provocate solo dalla « burocratizzazione » della M.I. Queste proteste erano destinate ad aumentare in seguito, in parte p er l'effettivo processo di burocratizzazione, ma soprattutto per l'aumento dei controlli. Infatti alla fine del 1917 l'Ufficio Tecnico era stato riorganizzato ed aveva assunto il nome di « Servizio Commesse Artiglieria» il cui nuovo capo, il capace colonnello Cortese, curò particolarmente la costituzione ed il funzionamento di un « Ufficio prezzi ». All'inizio del 1918 poi, a seguito dell'aumentato controllo deJlo stato sull'approvigionamento delle materie prime, a fianco del « Servizio Commesse Artiglieria» fu costituito w1 « Servizio Centrale Acquisti », con a capo l'energico ingegner Sinigaglia, che, con poteri di controllo e di intervento molto ampi, si interessò di tutti quei materiali che non rientravano nella specifica competenza del « Servizio Commesse » (19 ).
Indubbiamente il rallentamento, causato dagli aumentati controlli e dagli intralci burocratici relativi ai pagamenti, creò problemi agli industriali; va però ricordato che questi erano gravi soprattutto per la piccola industria con un giro di affari modesto e con un credito limitato. Per la grande industria indubbiamente i problemi erano minori anche in considerazione del fatto che gli anticipi « di rego la assommavano ad importi rilevanti » ( 20 ). Comunque, il 28 ottobre 1918, furono emanate disposizioni che consentivano di aumentare le commesse in corso e che facilitavano i pagamenti. Se il coro di proteste contro « la burocratizzazione » della Mobilitazione Industriale aveva visti uniti grandi, piccoli e medi imprenditori, non si deve per questo credere che tra loro non vi fossero divergenze sostanziali. Infatti la piccola e media industria reclamava una politica protezionistica, mentre le grandi imprese, soprattutto quelle meccaniche, erano in genere risolu-
tamente liberiste. Ciò non deve sorprendere poiché gli industriali piccoli e medi si rendevano conto che le loro imprese create e fortemente ampliate nel corso della guerra, che operavano talvolta in settori in cui in precedenza l'Italia era stata completamente dipendente dall'estero, non potevano, da un giorno all'altro, essere esposte alla concorrenza straniera pena la rovina. Per loro, quindi, la protezione doganale era, almeno per il periodo della riconversione. una questione di vita o di morte.
Per questi motivi i rappresentanti della media e piccola industria erano, in genere, disposti ad accettare, in cambio di una legislazione protezionistica, la logica conseguenza di una politica di intervento statale, cioè il controllo pubblico dell'economia attraverso la sopravvivenza della Mobilitazione Industriale in tempo di pace (21 ). L'atteggiamento dei rappresentanti della grande industria era completamente diverso: interamente ostile e decisamente favorevole alla politica di basse barriere doganali.

I capitani d'industria ritenevano che l'inten,ento statale fosse accettabile soltanto in momenti eccezionali; assolutamente dannoso in condizioni normali, come dannoso era ritenuto il regime protezionista che manteneva in vita imprese anti-economiche mentre limitava la capacità di espansione delle industrie meglio organizzate. Le grandi imprese non si preoccupavano molto della concorrenza estera, avevano in gran parte rinnovato gli impianti nel corso della guerra e si ritenevano in grado, una volta che la situazione del commercio internazionale fosse tornata normale, di reggere il confronto con le imprese straniere, non nutrivano neppure soverchie preoccupazioni circa l'inevitabile aumento delle tensioni sociali che la linea politica da loro scelta implicava necessariamente. Probabilmente ritenevano che la massa degli operai delle piccole e medie imprese, condannate al fallimento, andando a raggiungere la manodopera che si sarebbe resa disponibile con la smobilitazione, avrebbe costretto i dirigenti sindacali ad essere« ragionevoli». D'altra parte le grandi industrie erano in grado di accettare nuovi aggiustamenti salariali senza troppe preoccupazioni.
In definitiva, un eventuale crollo di piccole e medie imprese avrehbe sgombrato il campo alle grandi aziende costituendo al contempo una riserva di manodopera i cui migliori elementi potevano essere facilmente acquisiti con l'offerta di alte paghe e la cui massa avrebbe indotto i sindacalisti a non tirare troppo la corda . Il teorico di una simile politica fu Gino Olivetti, non a caso destinato a divenire segretario della Confindustria.
Il pensiero dell'Olivetti si trovava, sia pure con motivazioni
diverse, in pergetta sintonia con quello di Buozzi, come ha rilevato l'Abrate (22 ).
Ciò non deve sorprendere: sia l'uno che l'altro rappresentavano gruppi usciti estremamente rafforzati dalla guerra, erano convinti della propria forza e sicuri che, in caso di scontro, avrebbero superato la prova.
Scrive l'Abrate che « i frutti di questo non voluto, ma forse non inconsapevole consentire di due tra i più alti dirigenti delle organizzazioni imprenditoriali ed operaia italiana, su quelle ch e essi ritenevano le questioni più importanti del dopoguerra, furono assai scarsi, praticamente nulli» ( 23 ).

E. questo un giudizio che non ci sentiamo di condividere appieno poiché l'urto concomitante della grande industria e della maggiore organizzazione sindacale ottenne almeno un primo risultato: quello di liquidare la Mobilitazione Industriale.
Gli esponenti della grande industria e gli organizzatori sindacali rappresentavano senza dubbio due grandi forze in ascesa, certamente non rappresentavano però la totalità dei gruppi sociali del Paese, e soprattutto, gli interessi di queste forze erano difficilmente conciliabili con quelli della piccola industria e di quanti in essa lavoravano.
Se infatti sindacalisti e grandi industriali ritenevano, (e da qui la loro alleanza di fatto contro ogni controllo statale), ch e un eventuale conflitto si sarebbe comunque concluso con il proprio rafforzamento, ciò sarebbe avvenuto inevitabilmente a spese della media e piccola industria e degli operai non sindacalizzati, se non a scapito degli altri settori economici come era avvenuto durante la grande guerra. Gli interessi della media e piccola industria però erano meritevoli di protezione dal punto di vista dell'ordinamento statale quanto quelli delle grandi imprese. D'alt ra parte, la classe dirigente italiana dell'epoca non era parti colarmente legata alla grossa industria; avrebbe quindi dovuto sentire la necessità di conservare e rafforzare quegli strumenti come la Mobilitazione Industriale che potevano servire alla contemperazione delle varie esigenze evitando gli squilibri economici e garantendo la pace sociale. Certo, un'eventuale organizzazione della Mobilitazione Industriale di pace non avrebbe potuto operare nello specialissimo clima in cui aveva operato l'ente realizzato dal generale Dallolio nel corso della guerra. Bisogna infatti considerare che la tranquillità negli stabilimenti era stata assicurata, oltre che dagli alti salari, anche dalla possibilità, da parte delle autorità militari,, di revocare gli esoneri e di spedire al fronte gli operai riottosi e indisciplinati. Questa situazione al tempo stesso di coazione e di
privilegio, di cui sia gli operai che l'opinione pubblica erano ben consci, non era ripetibile al termine del conflitto. Per quanto si migliorassero orari e condizioni di lavoro, era inevitabile che, nonostante tutta la buona volontà mediatrice spiegata da un nuovo ente, si apriva una stagione di notevoli rivendicazioni salariali con conseguenti astensioni dal lavoro. Comunque fosse organizzata la Mobilitazione Industriale di pace non avrebbe potuto impedire una massiccia serie di scioperi. La nuova struttura avrebbe potuto però limitarne il numero e facilitare le trattative tra le parti in causa.
Nota il Melograni che nel 1919 « fu solo in autunno che ebbe luogo un mutamento nelle relazioni fra imprenditori e maestranze, con la :fine di quel clima piuttosto "euforico" che aveva fino ad allora contrassegnato i rapporti di lavoro » ( 24 ).

Certamente le buone relazioni tra datori di lavoro e lavoratori non avrebbero potuto mantenersi molto a lungo, tuttavia è fuor di dubbio che se la Mobilitazione Industriale avesse continuato a svolgere la sua opera, la tensione tra industriali ed operai sarebbe cresciuta molto più lentamente. Infatti, la sopravvivenza dell'organizzazione creata dal Dallolio unita ad un piano di investimenti pubblici, come quello che era stato vagheggiato negli ambienti del Ministero delle Armi e Munizioni, avrebbe probabilmente permesso che la riconversione avvenisse senza brusche scosse e sotto il controllo pubblico. Si trattava è vero di continuare a far pagare, attraverso le commesse statali, la sopravvivenza delle industrie create dalla guerra a tutta la collettività nazionale. Durante il conflitto, come abbiamo visto, anche i più accaniti liberisti non avevano potuto fare a meno di convenire sulla necessità che il Paese disponesse di una propria industria pesante, al termine della guerra però questi orientamenti erano completamente scomparsi e i liberisti avevano ripreso le loro vecchie lamentazioni contro le industrie «parassitarie» che avrebbero dovuto essere messe a morte per garantire un sano sistema economico. Intanto però le industrie, costruite non senza sacrifici nel corso del conflitto, esistevano; il distruggerle non avrebbe comportato per l'intero Paese un danno maggiore di quello costituito dal sacrificio da affrontare per mantenerle in vita durante il periodo della riconversione?
È fuor di dubbio che il mantenimento delle piccole e medie imprese, create nel corso della guerra, fosse nell'interesse della economia del Paese; del resto anche il principio della « sanità» del sistema economico è alquanto relativo poiché è indiscutibile che, oltre alla capacità imprenditoriale ed all'efficienza dell'orga-
nizzazione aziendale, influiscono, in modo determinante, sulla vita e sulla morte delle imprese, le condizioni economiche generali in cui sono chiamate ad operare. t:: indubitabile che abbandonare iniziative industriali, sorte con capitali modesti, alla concorrenza delle grandi imprese e dell'industria straniera, compresa quella dei paesi vinti, senza favorire in alcun modo il loro inserimento nelle produzioni di pace, significava votarne la maggioranza a certa rovina; e ciò indipendentemente dell'abilità degli imprenditori e delle maestranze e dalla stessa struttura organizzativa dell'impresa. Era del pari interesse dello Stato che la riconversion e non si tramutasse in un tracollo per l'industria pesante e che non si verificassero regressi in quelle che erano le industrie d'avanguardia dell'epoca. Si doveva cioè tutelare ad esempio lo sviluppo dell'industria chimica che, libera dalla concorrenza germanica, aveva potuto prendere finalmente quota, ed agevolare lo sviluppo dell'industria delle radiotelecomunicazioni che aveva cominciato a muovere timidamente i suoi primi passi negli anni del conflitto. Poiché le conoscenze tecnologiche e lo stesso sviluppo della ricerca teorica sono fortemente influenzate dalla potenzialità dei vari settori industriali, è fuori di dubbio che sostenere le industrie d'avanguardia significava tra l'altro cercare di impedire che si creasse una grossa sfasatura tra la t ecno logia del Paese e quella dei maggiori stati mondiali. Tutto ciò non aveva grande importanza agli occhi dei liberisti, se Luigi Einaudi scriveva ancora nel 1933 che tra le eredità della guerra erano stati inutili « i cantieri navali, gli stabilimenti dell'industria pesante, e quelli dell'industria chimica, i quali anzi lasciarono un'eredità pericolosa la quale non potrà essere liquidata per decenni» ( 25 ). A parte la questione dei cantieri navali il cui numero non aumentò nel corso della guerra, ma a seguito di questa, per l'acquisizione dei cantieri giuliani ed istriani; le affermazioni dell'Einaudi possono far sorridere in considerazione dello sviluppo che ha assunto oggi l'industria chimica e quando è sotto gli occhi di tutti il prezzo che i paesi dell'America latina hanno dovuto pagare per non aver saputo, o potuto, crearsi una propria industria pesante. Certamente ciò non appariva altrettanto evidente alla fine d el primo conflitto mondiale quando i rapporti tra indipendenza economico-industriale ed autonomia politica sembravano discorsi di guerra, superati, spazzati via, dalla pace perpetua garantita dalla istituenda Società delle Nazioni.
Tuttavia la conclusione del conflitto non aveva posto fine alla rivalità nazionali, né aveva fatto venir meno la situazione eccezionale in cui si trovava ad operare l'industria italiana. Come

si ricorderà, il maggior problema che l'Italia si trovò ad affrontare nel corso della guerra fu, senza dubbio, quello del rifornimento di carbone. Dalla disponibilità di carbone praticamente dipendeva la continuazione dello sforzo bellico italiano. Con la fine del conflitto, dalla disponibilità di carbone dipendeva in buona parte la possibilità dell'industria italiana di tornare ad essere competitiva sui mercati esteri. Nell'ult imo periodo della guerra il traffico marittimo alleato era di fatto posto sotto il controllo dell'Inghilterra ed i dirigenti inglesi non avevano alcuna intenzione di favorire lo sviluppo industriale dei propri alleati al termine d el conflitto. Così, quando nel luglio del 1919, terminò l'accordo per il trasporto del carbone dal canale di Bristol a Genova al prezzo calmierato di 47,6 scellini la tonnellata, il costo del trasporto p r ese a salire e alla fine dell'anno oscillava tra i 70 e i 77,6 scellini la tonnellata. Nel 1920 l'immissione sul mercato dei noli dei tre milioni e mezzo di tonnellate di naviglio mercantile varate nel 1919 dagli Stati Uniti, cominciò a fare sentire il suo peso e da 65-70 scellini il costo del trasporto di una tonnellata di carbone dal canale di Bristol a Genova scese a 37,6 a luglio e a 22,6 a settembre; in conseguenza dei nuovi vari nel 1921, il costo del trasporto si ridusse ulteriormente oscillando tra i 18 e 20 scellini ( 26 ).
Come si vede la situazione si normalizzò molto lentamente e ciò non poté non influire negativamente sulla riorganizzazione industriale dell'Italia e sulla capacità dei prodotti italiani di essere competitivi sui mercati esteri. Infatti, anche nei primi anni del dopoguerra, la bilancia dei pagamenti registra fortissimi <lisavanzi:
Tabella 3
La situazione di eccezione non era dunque terminata; ora le dotte disquisizioni dei liberisti potevano essere valide soltanto nel caso che le condizioni del mercato internazionale si fossero normalizzate. Fino a che ciò non si fosse realizzato era evidente che bisognava procedere con mezzi eccezionali. Conseguentemente, prescindendo dall'opportunità o meno, una volta che le

condizioni del mercato internazionale si fossero normalizzate, di smantellare una struttura come quella della Mobilitazione I ndustriale, è fuor di dubbio che uno strumento di controllo e pianificazione, come era appunto la M.I. si imponeva se si voleva superare, senza gravi scosse, il difficile periodo post-bellico.
Bisogna considerare, tuttavia, che al termine del conflitto, predominava in tutti gli strati sociali il convincimento che la situazione si sarebbe normalizzata da lì a breve tempo. Questo convincimento non giustifica che in parte i responsabili della politica economica del Governo italiano, ai quali non erano certo ignote le divergenze di vedute tra le potenze alleate e l'Italia, divergenze che sarebbero aumentate durante la discussione dei trattati di pace. D'altronde, uno dei maggiori requisiti di una buona classe dirigente è la capacità di compiere esatte previsioni per poter validamente orientare l 'azione del governo. La classe politica italiana, non solo mancava di una simile capacità di analisi, ma non aveva alcuna simpatia per l'organizzazione creata dal Dallolio.
Nei primi anni della guerra il Parlamento e la classe dirigente politica, probabilmente anche in conseguenza degli avvenimenti del maggio 1915, non avevano quasi svolto nessuna azione di direzione dello sforzo bellico del paese per cui la conduzione delle operazioni e l'organizzazione dell'economia di guerra era stata devoluta ai militari ed ai tecnici. Tutto ciò fece si che i politici, specie alcuni degli ex neutralisti, guardassero alla Mobilitazione Industriale come ad una creatura a loro estranea, ad un prodotto della guerra che doveva necessariamente aver termine con essa. Pesava probabilmente sull'atteggiamento dei politici la preoccupazione che, mantenendo in vita la Mobilitazione I ndustriale, i militari che l'avevano creata avrebbero finito con l'avere un forte peso nella economia, e quindi nella politica, della nazione. Si trattava però di una preoccupazione infondata visto che il generale Dallolio, « che solo conosceva e aveva segnato in un suo particolare taccuino tutti i dati dei fabbisogni e tutte le notizie stat istiche delle varie produzioni e solo ne poteva misurare e regolare la intensità e la necessità » ( 28 ), e che aveva saputo, con la sua politica, acquistare presso gli imprenditori e le maestranze un prestigio altissimo come dimostrarono le risposte al suo appello dopo Caporetto, lasciò, senza neppure abbozzare una protesta, il Ministero delle armi e munizioni nel maggio del 1918, ufficialmente per uno scandalo relativo ad alcuni contratti, in realtà per la guerra spietata che gli aveva fatto il Ministro del tesoro Francesco Saverio Nitti ( 29 ).

L'atteggiamento del generale Dallolio in questa circostanza è tanto più rimarchevole in quanto non gli si poteva rimproverare alcuna irregolarità. La decisione della classe politica di escludere l'organizzazione creata dal Dallolio, dallo studio dei problemi del dopoguerra, apparve evidente dopo la sostituzione del generale; infatti, invece di un ampliamento delle strutture già esistenti integrandole con i rappresentanti dei ministeri competenti, come voleva Dallolio , si costituì la famosa commissione per i problemi del dopoguerra, organismo pletorico in cui l'elemento tecnico passava in seconda linea rispetto alla componente politica. Si trattò di un organismo di utilità molto modesta, ma la cui creazione dimostrava la ferma volontà della classe dirigente politica di ridurre l'influenza dei tecnici e di non servirsi delle strutture della Mobilitazione Indus triale la quale, alla fine del conflitto, risultò essere una grande macchina di cui nessuno voleva più servirsi. La grande industria e le organizzazioni sindacali erano ostili a qualsiasi forma di controllo e di intervento statale, la classe politica non sentiva in alcun modo la necessità di un simile controllo, anzi il Ministro del tesoro dell'epoca, on. Nitti, non esitava ad affermare la necessità « che lo Stato tolga tutte le barriere inutili interne e svincoli la produzione, dia all'industria sicurezza e stabilità; quanto fu creato per necessità di guerra, deve scomparire con la guerra; tutti gli uffici devono essere ridotti in breve tempo a ciò che erano prima della guerra; presto e coraggiosamente bisogna sopprimere tutto ciò che è superfluo come dannoso; eliminare il più sollecitamente possibile quanto è stato prodotto da un'economia transitoria e perturbatrice». Commentando queste dichiarazioni s ul Corriere d ella Sera del 15 gennaio 1919, Luigi Einaudi scriveva: « bisogna abolire uffici e commissioni; mandare a casa impiegati e commissari ... Non basta essere più larghi di permessi di fare, di trasportare, di importare, di esportare. Bisogna rinunciare a dare i permessi; bisogna lasciare che ognuno faccia, trasporti ed esporti senza permessi, senza visti, senza bolli , senza inchinarsi a destra e a sinistra, senza fare viaggi a Roma... Non abolire i vincoli vorrebbe dire ridurre industriali ed operai a uno stato servile, vorrebbe dire immi serire la produzione della ricchezza, quando è più vivo il bisogno di accrescerla ». Il congresso della FIOM svoltasi nel novembre del 1918 a R om a e quello degli indus triali tenutosi nel gennaio del 1919 a Bergamo, dimostrarono che imprenditori e sindacati si muovevano sostanzialmente sulla stessa linea. Ebbe così inizio quella che lo stesso Einaudi chiamerà « rivolta contro il collettivismo bellico »,

si pose cioè bravamente mano a demolire quelle che venivano chiamate « bardature di guerra» nell'economia del paese.

I « demolitori » non si fermarono a considerare se la situazione internazionale era tale da permettere la sopravvivenza di un'economia non protetta e se le cosidette «bardature» potessero, almeno in parte, essere di una qualche utilità. L'ingenua convinzione che bastasse tornare alla situazione precedente per porre fine alle conseguenze della guerra ed il dogma liberista furono più forti di qualsiasi altra considerazione.
Si iniziò così la demolizione della Mobilitazione Industriale dando contemporaneamente il via alla più colossale speculazione di tutta la guerra: la svendita dei cosiddetti « residuati bellici ».
Sotto la pressione del Ministero del Tesoro, che reclamava sollecitamente recuperi, materie prime, prodotti finiti, semilavorati, furono svenduti in gran copia. Per giustificare questa incredibile prassi uno dei funzionari che parteciparono a questa alienazione in massa dichiarò alla Commissione d'inchiesta per le spese di guerra: « Anzitutto la compilazione degli inventari avrebbe richiesto moltissimi mesi e spese ingentissime per rimozione e pesatura dei materiali, ed ogni inventario non avrebbe in definitiva registrato che i materiali sfuggiti in così lungo tempo alla distruzione e alle giornaliere inevitabili sottrazioni, che si comprende quanto fossero facili, dato che detti depositi erano in aperta campagna; il Ministero della Guerra avrebbe a sua volta impiegato moltissimi mesi per la determinazione ad esso richiesta, ed infine l'organo unico destinato alla determinazione dei prezzi avrebbe dovuto determinare i prezzi dei singoli materiali da vendere senza una cognizione sufficiente del materiale di cui si trattava, il quale non poteva essere sufficientemente descritto in un inventario. Un ordinamento di questa fatta avrebbe comunque richiesto moltissimi mesi, e intanto l'industria nazionale avrebbe atteso invano, durante tutto questo tempo, i materiali di cui aveva bisogno per mantenere attive le officine e occupate le maestranze, e il Tesoro avrebbe atteso lungamente quei versamenti ch e sollecitava con tanta insistenza per i bisogni di cassa» ( 30 ).
La Commissione non riteru1e, giustamente, sufficienti queste giustificazioni: esse, non di meno, sono s ignificative della mentalità che predominava tra i liquidatori dei cosidetti «residuati».
Negli esercizi .finanziari post-bellici i « proventi dalla alienazione di materiali residuati della guerra e di navi radiate dal Regio naviglio» raggiunsero le somme sotto indicate:
Come si vede, pur trattandosi di somme rilevanti, i << proventi» non erano certo tali da consentire il pareggio del bilancio, ne è pensabile che il Ministro del tesoro avesse, nell'orgia di carta stampata di quegli anni, proprio bisogno di questi proventi. I n realtà tutta l'operazione fu caratterizzata dall'ingenua speranza che bastasse liquidare gli apprestamenti di guerra per por fine agli effetti della stessa. Così materiali di ogni genere, accumulati con grande sacrificio negli anni precedenti, furono svenduti a prezz i molto inferiori al loro valore. Dai numerosissimi enti, che si succedettero senza soluzione di continuità e senza un programma razionale nel compito di alienare i cosidetti residuati, furono venduti a infimo prezzo materiali necessari ai bisogni di mobilitazione del1'esercito che, negli anni successivi, si dovettero riordinare alle industrie oppure ricomprare dagli speculatori a prezzi di gran lunga superiori. Ciò avvenne perché nella frenesia di << normalizzare » si impedì al Ministero della Guerra di trattenere per sè i materiali che riteneva utili. :È fuor di dubbio che se la vendita dei « residuati » f~sse avvenuta con meno fretta i proventi sarebbero stati infinitamente maggiori.
:e. evidente inoltre che, se le materie prime disponibili nei magazzini dello Stato in copia notevole al termine del conflitto, invece di essere alienate a prezzi irrisori, fossero state destinate alle industrie per attuare il grande programma di opere pubbliche che il segretario del Comitato centrale della Mobilitazione Industriale aveva indicato nel 1916, non si sarebbe verificato alcun disastro finanziario.
La classe dirigente non nutriva però alcun desiderio di perpetuare ]a politica di intervento statale nel settore industriale come negli altri rami dell'economia. Cosicché alla fine del 1919, quando fu ormai chiaro a tutti che la normalizzazione era rin-

viata a data indefinibile, di fronte al minaccioso aumento delle tensioni sociali, il Governo si trovò privo di qualsiasi strumento d'intervento.
Per colmo d'ironia fu proprio Nitti, il paladino della politica della normalizazzione a tutti i costi, a dover ripristinare nell'aprile del 1920 il razionamento del pane e di altri generi alimentari.
La crisi colpl particolarmente il settore industriale ; non solo le piccole e medie imprese, ma anche le grandi aziende vennero duramente provate. La produzione del settore siderurgicico scese da 992.529 tonnellate d'acciaio e 313.576 di ghisa nel 1918, rispettivamente a 731.823 e 239.710 nel 1919, a 773.761 e 88.072 nel 1920 ed a 700.433 e 61.381 nel 1921 ( 32 ), ed anche le grandi industrie meccaniche, senza dubbio meno esposte, subirono gravi colpi: la Fiat ridusse la propria produzione di autovetture da 14.835 a 10.320 ( 33 ). Per far fronte a questa congiuntura le grandi imprese si appoggiarono sempre più alle banche che furono coinvolte nel dissesto economico.
Difronte all'insorgere della crisi l'atteggiamento della classe dirigente politica fu privo di energia e di coerenza.
Infatti, da un lato , sotto la pressione dell'opinione pubblica che reclamava provvedimenti contro gli speculatori di guerra, venivano presi provved imenti come l'imposta straordinaria sul patrimonio, l'avocazione totale allo Stato dei sovrapprofitti di guerra, la nominatività dei titoli. « Quali che fossero le ragioni morali e di giustizia sociale che avevano ispirato quei provvedimenti, essi contribuirono ad accrescere le difficoltà dell'industria» (34 ).
DaJl'altro lato si cercava di venire incontro alle grandi imprese in difficoltà promuovendo consorzi bancari e autorizzando anticipazioni da parte della Banca d'Italia.

Anche nei confronti della crisi dei rifornimenti alimentari l'azione del Governo non fu delle più abili. Si preferì infatti spendere somme ingentissime per acquistare derrate alimentari da rivendere sotto costo a prezzo di calmiere invece di utilizzare le stesse somme in investimenti produttivi ch e, mantenendo alti i livelli dell'occupazione e dei salari, avrebbero consegu ito, almeno in parte, gli stessi risultati, permettendo inoltre la realizzazione di nuove infrastrutture. Ciò non sembri eccessivo, infatti le spese a fondo perduto per gli approvvigionamenti e i consumi aumentarono a 4.700 milioni nel bilancio 1920-21 e a 8.600 milioni in quello 1921-22 ( 35 ).
Tuttavia, a parte la pressione dell'opinione pubblica, che
teneva ovviamente al mantenimento del sistema del calmiere, c'è da chiedersi se una decisa politica di intervento statale sarebbe stata possibile una volta che si erano smantellati tutti gli strumenti di pianificazione e controllo di cui il Governo disponeva al ter mine del conflitto.
In conclusione la crisi post-bellica avrebbe potuto essere affrontata e risolta in tempi più brevi e con minore perdita di ricchezza, se non fosse prevalsa la funesta illusione che gli effetti della guerra fossero cancellabili con un semplice tratto di penna e se, quindi, la classe dirigente politica avesse saputo resistere alle concomitanti pressioni della grande industria e delle organizzazioni sindacali, mantenendo in vita, sia pure per qualche anno ancora, la struttura della Mobilitazione Industriale, e sostituendo le commesse militari con investimenti destinati al potenziamento delle infrastrutture del Paese. Ciò avrebbe permesso di controllare la riconversione e limitare gli effetti della crisi. Effetti che, giova ricordarlo, compromisero seriamente in molti settori industriali i risultati conseguiti con l'e norme sforzo attuatosi nel corso del conflitto.
Purtroppo, però, le spinte particolaristiche e l'illusione che, con la fine della guerra, si sarebbe subito tornati alla normalità prevalsero. Questo fatto contribuì poderosamente allo scatenarsi, alla fine del 1919, di una crisi le cui conseguenze politiche sarebbero state ben maggiori delle stesse gravissime conseguenze economiche.
In definitiva, gli sconvolgimenti che subì l'economia italiana negli anni immediatamente seguenti il primo conflitto mondiale non furono solo conseguenza diretta delle condizioni create dalla guerra, ma anche e soprattutto dal « modo » di affrontare i problemi del dopoguerra scelto dalla classe politica, che, al termine del conflitto, disponeva di tutti gli strumenti necessari per controllare e dirigere l'attività industriale del paese nel difficile periodo dii transizione. La prosecuzione di una politica di intervento statale nel settore industriale, che favorisse con commesse per costruzioni ferroviarie, impianti idroelettrici ecc. il processo di riconversione, non avrebbe inciso sul bilancio molto di più di quanto fecero i successivi e tardivi provvedimenti adottati negli anni seguenti per fronteggiare, in qualche modo, la crisi post-bellica. La Mobilitazione Industriale rimase quindi in buona parte un'occasione perduta per sviluppare e razionalizzare l'industria italiana; il cedimento della classe dirigente difronte alle spinte particolaristiche era inevitabilmente foriero di successivi gravissimi cedimenti.

(1) A CARACCIOLO: La formazione dell'Italia industriale, cit. , p 171.
(2) CfT. Ibidem, p. 173.
(3) L. EINAUDI: La condotta economica, cit., p. 129.
(4) R. BlANCm D'ESPINOSA: Ricordi, riflessioni di un vecchio generale, Milano 1963, pp. 235-236.
(5) Vedi allegato n. 13.
(6) A.C.S. Ministero Armi e Munizioni, b. 42, verbale della riunione 17 dicembre della Commissione per il • risparmio operaio •, p. 5.
(7) E. TONIOLO: La mobilitazione industriale in Italia, Milano 1916, pp. 31-38.
(8) Che il generale Dallolio non fosse estraneo allo scritto del Toniolo è provato anche dal fatto che in alcuni punti questo riproduce quasi letteralmente la relazione fatta dal sottosegretario al Comiato Centrale della M.I. del 26.11.1916.
(9) Vedi allegato n. 11.
(10) A.C.S. Ministero Armi e Munizioni. Verbale della seduta del 17 dicembre della Commissione per il • risparmio operaio •, p. 6-7.
(11) Per le affermat.foai di Buozzi sul problema della M.I. B. Buo22.I: L'opera della Federazione metallurgica dal 1910 al 1918, cit., p. 18 ss.
(12) Banca Commerciale Italiana: Cenni statistici sul movimento economico dell'fta lia anno XII, Milano 1920, p 145.
(13) V. CASTRONOVO: Giovanni Agnelli, Torino 1971, p. 102.
(14) Problemi operai e sociali della guerra e del dopoguerra, in • Bollettino della Lega Industriale•, anno IX (1917), numero unico, p. 6 ss.
(15) Vedi allegato a. 14
(16) Ibidem.
(17) Commissione Parlamentare, cit., voi. II, p. S3.
(18) Ibidem , voi. II, p. 89.
(19) Vedi allegato n. 14.
(20) Commissione Parlamentare, cit., voi. li, p. 20.
(21) Una posizione analoga a quella dei piccoli e anche gli esp0aenti degli agrari che temevano di venire industria tanto rafforzatasi nel corso del coauitto. Cfr. tenden ze dell'associazione padronale durante la • Gra11de settembre-dicembre 1977, pp. 816 ss.
(22) M ABRATI!, op. cit., pp. 181-188
(23) Ibidem, p. 186.
(24) P. Mm.ooRAN1: Op. cit , p. 557.
medi industriali avevano assunto schiacciati anch'essi dalla grande F. PlvA: Mobilitazione agraria e Guerra•, in « Quaderni Storici•,
(25) L. EINAUDI: La condotta economica, cit., p. 390.
(26) I dati relativi al costo dei trasp0rti sono desunti dalle annate 1919, 1920 e 1921 della citata opera R. BAcm: L'Italia economica, rispettivamente alle pp. 218, 249, 249.
(27) Cfr. R ROMEO: op. cit., p. 237.
(28) Commissione Parlamentare, cit., voi. lI. p. 86.
(29) II GaUioari io un, peraltro pregevole, saggio su Dallolio sostiene che la campagna contro il Minis tro delle armi e muni1.ioni fu orchestrata dai fratelli Perrone. Per quanto è fuor di dubbio che i due industriali non amassero molto Dallolio, il ridurre la vicenda ad una faida dei Perrone, significa, in pratica, attribuire a Nitti la parte del sicario il che è indubbiamente eccessivo. In realtà il Ministro del tesoro aveva elaborato un disegno politico per il dopoguerra che s i basava essenzialmente sull'accordo dei maggiori gruppi industriali e delle organizzazioni operaie; un quadro in cui non vi era posto per la Mobilitazione Industriale per distruggere la quale era indispensabile allontanarne il fondatore. Sull 'intera vicenda cfr. V. GAU.INARI: /I generale Alfredo Dallolio nella prima guerra mondiale, in • Memorie storiche militari•, t9n, pp. 139-141 , e A. MONTICONE: Nitti e la Grande Guerra, Milano 1961, pp. 214 ss.
(30) Cfr. Commissione Parlamentare, cit., voi. II, p. 780

(31) Minfatero delle Finanze: li bilancio dello Stato dal 1913-14 at 1929-30 e la finan za fascista a tutto l'anno VIT, Roma 1931, pp 96, 210, 211, 224.
(32) Cfr. R. ROMEO: op. cii., p. 227.
(33) Ibidem, p. 127.
(34) Ibidem, p. 128.
(35) Ministero delle Finanze: op. cit., p. 312
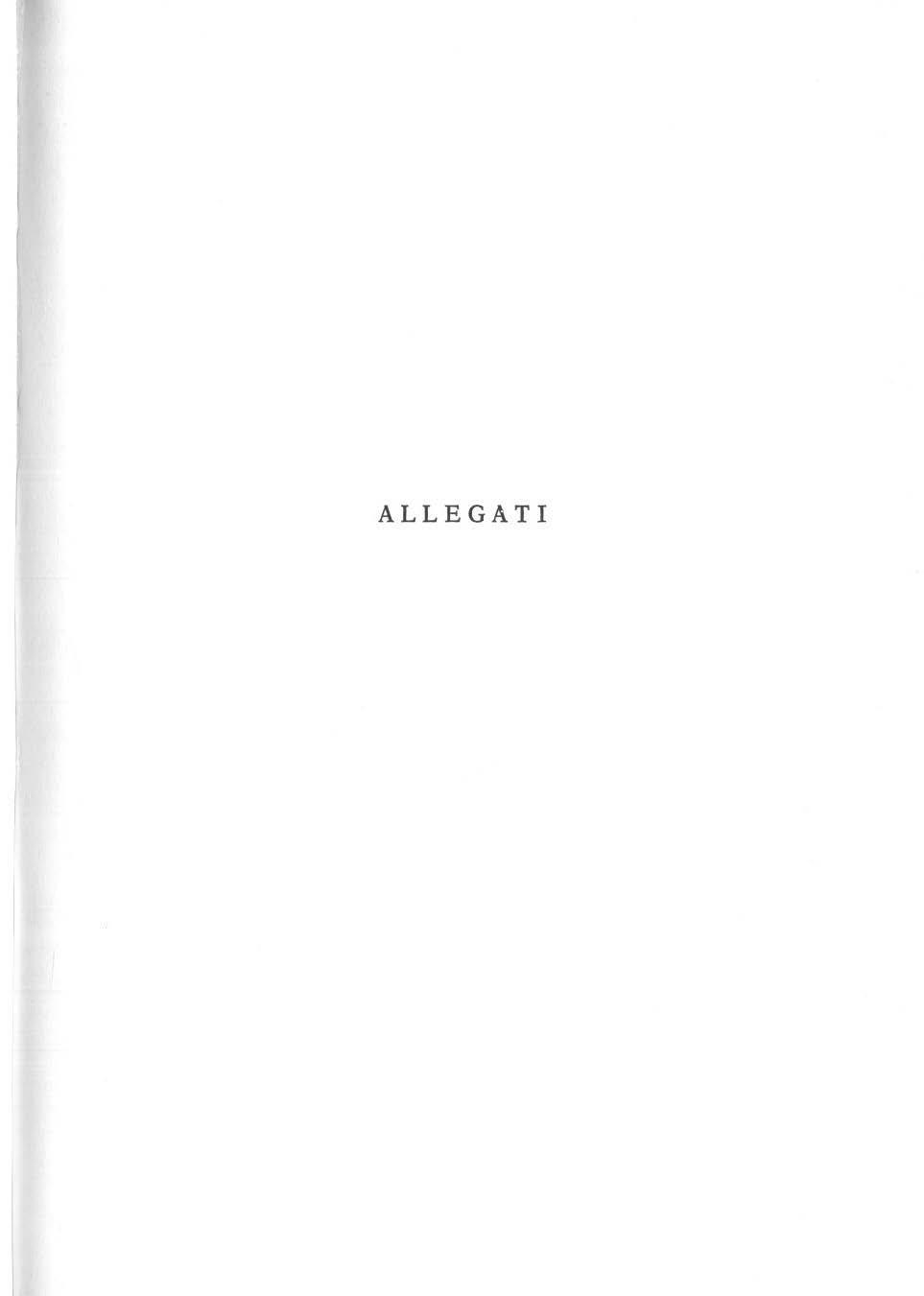
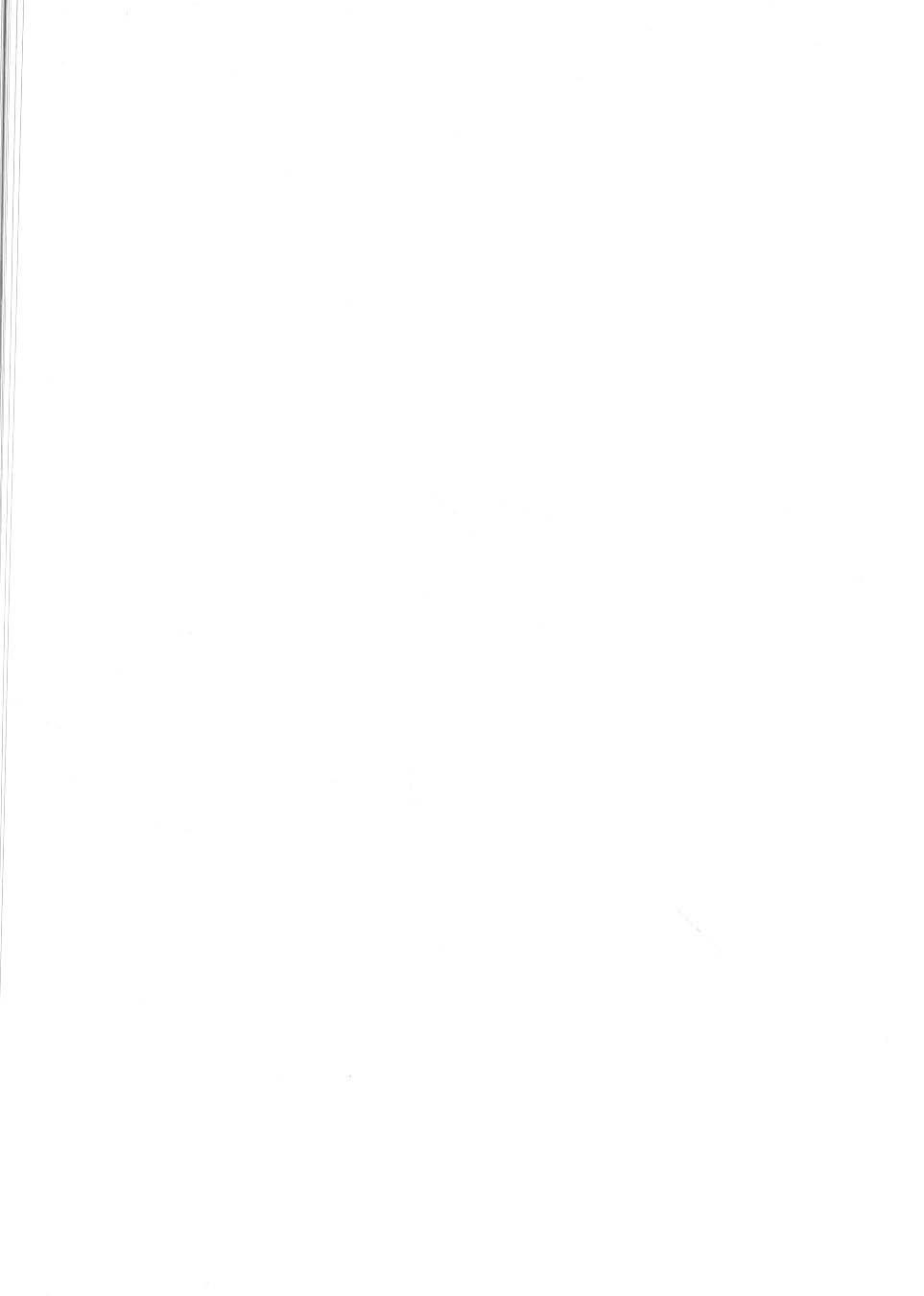
Documenti:
1) A M.C R. Carte Dallo/io, b 951, f. 1.
2) Ibid em, b. 951 f. 2.
3) A.U.S.S.M.E Ordinamento e Mobilitazione, b. 397 bis.
4) A.M.C.R. Carte Dallo/io, b. 959, f. 3.
5) Ibidem, b. 959, {. 4.
6) Ibidem, b. 959 f. 8.
7) Ibidem, b. 959, f. 3.
8) Ibidem, b. 950, f. 17.
9) Ibidem.
10) Ibidem.
11) Ibidem.
12) A.C.S. Ministero Anni e Munizioni, b. 42.
13) A.C.S. Archivio Primo Aiutante di Campo Generale di S.M. il Re, Sezione Speciale, b. 26.
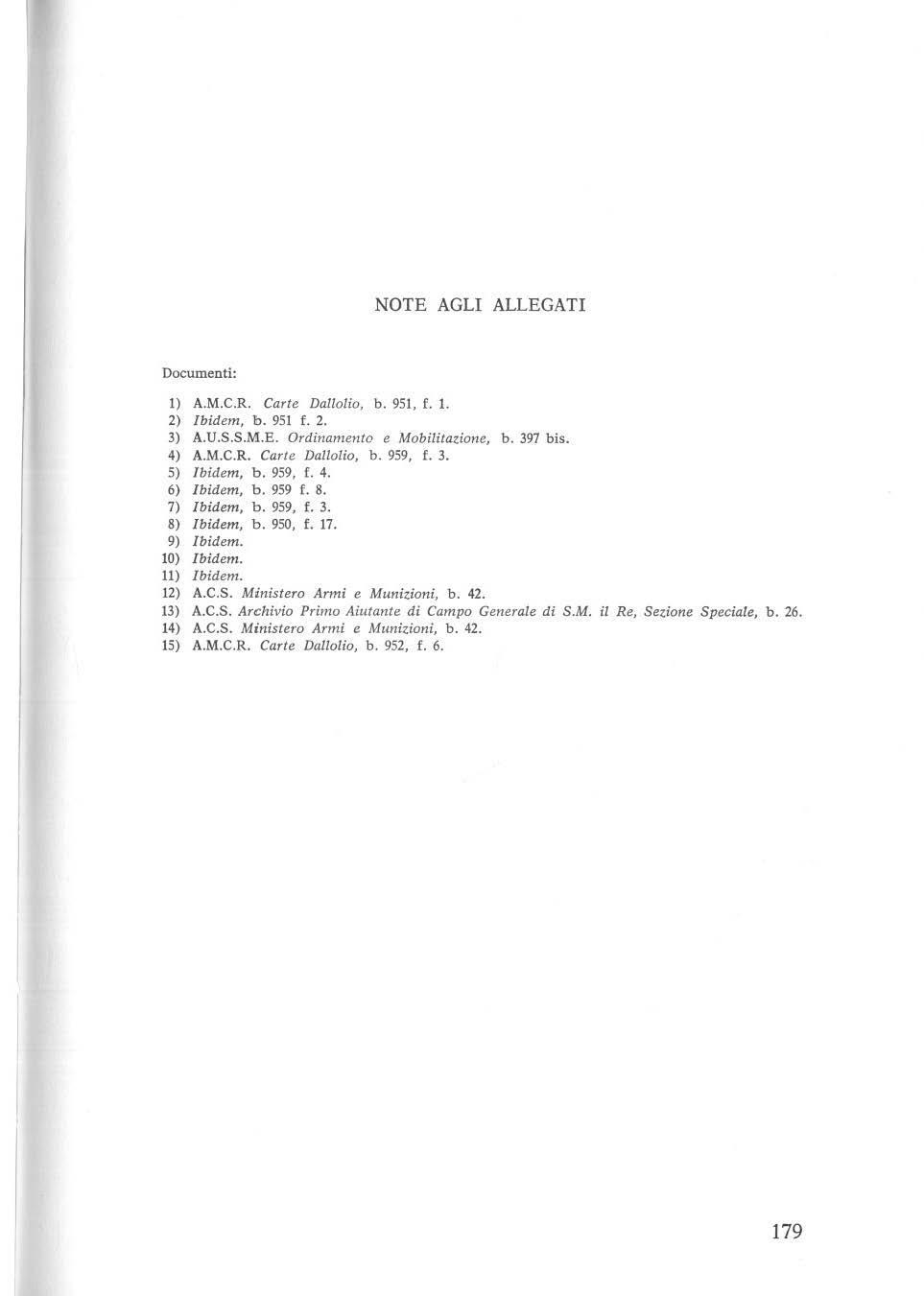
14) A.C.S. Ministero Armi e Munizioni, b. 42.
15) A.M.C.R. Carte Dallo/io, b. 952, f. 6.
OGGETTO: Munizionamento dell'Esercito. P rovvedimenti per intensificare la produzione.
Nel foglio n. 234 R. S. del 23 febbraio del Comando del corpo di stato maggiore diretto al Ministero della Guerra - Segretariato generale Di· visione stato maggiore - si legge:

ANCHE DA NOI NON SI TRASCURI ESPEDIENTE ALCUNO PER lNTENS lfJCARE IL CONCORSO DEGLI STABIL IM ENTI PRIVATI NELLA PROVVISTA DI MATERIALI PER L'ARMAMENTO ED IL MUNIZJO.
NAMENTO DEL NOSTRO ESERCITO TANTO NEL MOMENTO PRESEN· TE DI PREPARAZIONE, QUANTO NEL CASO DI MOBILITAZIONE.
Questa Direzione generale ba ferma convinz:one di nulla aver lasciato d'intentato, nel limite del possibile perché attraversando periodi cli crisi l'artiglieria ne uscisse con lode e con vantaggio, e quindi crede suo dovere riassumere all'E.V. tuttociò che si è fatto e si sta facendo per quanto riguarda il munizionamento, l'armamento e la rinnovazione del materiale da campagna e da montagna. In altra r elazione s i parlerà d elle cartucce e dei fucili, dei moschetti e delle pistole.
Il concetto di valersi dell'industria privata come aiuto e complemento dell'industria militare di Stato è stato sempre propugnato dal Ministero, SENZA RINUNZIARE ALLE TUTELE E ALLE GARANZIE CHE DI FIANCO E DT FRONTE ALL' INDUSTRIA PRIVATA PUO' OFFRIRE UNO STABILIMENTO MILITARE QUANDO SIA SERVITO DA UNA BUONA MAESTRANZA, EDUCATA CON CRITERIO VERAMENTE PRATICO E MILITARE.
Ecco ciò che sempre si è detto - scritto - ripetuto.
Quando sul finire del luglio 1914 si attuavano speciali disposizioni in vista degli avvenimenti politici che precipitavano, la situazione del munizionamento e dell'armamento era quella prescritta dal programma del quadriennio 1909-913 con quelle riserve in più risultanti dalla relazione R/ ma da me prese ntata in data 14 maggio 1914. Le successive ordinazioni sino al 30 otlobre per rinforzare il munizionam en to e provvedere a future eventualità risultano degli specchi n. 1 e n. 2 - ai quali ritengo far seguire le necessarie osservazioni.
1°) -I 450.000 colpi da 75 m• 906 rappresen tano 300 colpi per pezzo per cui da 1.200 (avendosi in più delle dotazioni il munizionamento dei magazzini di Z.A. - Dispaccio 21924 del 13 agosto diretto al Comando del corpo di stato maggiore) si arriva a 1.500 colpi per p ezzo (Dispaccio 35670 del 6 novembre 1914 diretto la Comando del corpo - Allegato n. 3) coll'aumento inclicato dei magazzini di Z.A.
2°) - Sin dal 6 agosto 1914 nella commessa la proporzione delle ;granate è portata ad 1/3, quantunque le proposte e le considerazioni
circa LA PROPORZIONE FRA LE GRANATE E GLI SHRAPNELS NEL MUNIZIONAMENTO DELLE BATTERIE DA CAMPAGNA siano state chieste al Comando del corpo di stato maggiore in data 26 ottobre 1914 col Dispaccio n. 1626.
3°) - Giova considerare come in conseguenza del nuovo programma circa i provvedimenti per l'Esercito l'aumento del munizionamento era stabilito in 200 colpi per l'artiglieria da campagna e 600 colpi per quella da montagna e 300 colpi per gli obici da 149 A, invece collo specchio n. 2 si era aumentata di 300 COLPI LA RISERVA PER OGNI PEZZO DA 75 MOD.
906-911
» DI PIU' DI 600 COLPI LA RISERVA PER OGNI PEZZO DA 65 MONT.
Per gli obici da 149 A il 19 ottobre si aumentava DI 300 COLPI LA RISERVA - COME ERA STABILITO.
4°) - Le commesse sono state date successivamente dall'agosto all'attobre precedendo molte volte le assegnazioni dei fondi per avviare le maestranze e riunire in antecedenza le materie prime, perché nei mesi di agosto e settembre le difficoltà di carattere industriale furono enormi sotto i riguardi tecnici e finanziari.
L'E.V. non può a meno di ricordare la relazione da me presentata in data 20 ottobre 1914 nella quale pur facendo tutte le riduzioni possibili al noto programma si arrivava a L. 152.115.000 così concludendo : NATURALMENTE SI CHIEDE DI AVERE FACOLTA' DI POTERE IMPEGNARE ANCHE TUTTA LA SOMMA DI L. 152.115.000 ASSICURANDO PERO' CHE SI STARA' NEI CONFINI DI QUANTO PRATICAMENTE ED EFFICACEMENTE SI PUO' RAGGIUNGERE, PREOCCUPANDOSI DEL FATTORE TEMPO IN SE E NEI SUOI RIFLESSI E DELLA MAGGIORE GARANZIA SULLA BONTA' DEI PRODOTTI IN UNA COLLA CONVENIENZA ECONOMICA.

E quando in vista delle nuove esigenze finanziarie dovetti cercare di apportare tutte le possibili riduzioni arrivando a soli 90.000.000 cosl concludevo (relazione 1633 del 27 ottobre 1914):
CONSCIO DELLA GRAVITA' DEI DOVERI E DELLE RESPONSABILITA' CHE INCOMBONO AL MINISTERO NELL'ORA CHE VOLGE, NATURALMENTE SI SONO DOVUTE FARE DELLE RIDUZIONI, TENENDO PRESENTE LA GRANDE NECESSITA' DI MANTENERE INTEGRA LA DIGNITA' FINANZIARIA DELLA NAZIONE.
E l 'E.V. osservando lo specchio n. 2 può rilevare che molte commesse erano già date il t• e 17 ottobre pel munizionamento da 75 camp. e da 65mont. quando ancora i 90 milioni non erano stati assegnati, e lo stesso si faceva per 150 colpi per pezzo per gli obici da 149 A. Ciò per dimostrare che la Direzione generale d'artiglieria precedette gli eventi, affrontando qualunque responsabilità.
In data 16 novembre si avvertiva il Comando del corpo di stato mag. giore sulla situazione del munizionamento (specchio n. 2) ma non perciò si arrestavano i provvedimenti per costituire nuove riserve, come risulta dallo specchio n. 4 che riflette i colpi completi, e n. 5 che riflette gli elementi di colpo, e prima del 30 giugno altre commesse e altri completamenti ci saranno. Naturalmente con tre polverifici che possono darci quasi 300 T. di balistite al mese, in caso di mobilitazione si fa presto ad avere 150.000 cariche di balistite in placche. Ma per ora conviene far calcolo solo sul denaro materiale.
Si consideri che alla metà di febbraio corr. la Divisione artiglieria aveva date commesse per 147.553.470 nelle quall il munizionamento d 'artiglieria entrava per L. 58.268.626 ciò che dimostra come si sia tenuto conto del grande consumo di munizioni, e deUa facilità di sprecare i colpi permessa dalla rapidità del tiro.
Premesso ciò vediamo quanto si è fatto per gli Stabilimenti militari
E PER INTENSIFICARE IL CONCORSO DEGLI STABILIMENTI PR/.
VATI NELLA PROVVISTA DI MATERIALI PER L'ARMAMENTO ED IL
MUNIZIONAMENTO DEL NOSTRO ESERCITO.
Riguardo agli Stabi limenti militari si è sempre raccomandato loro che le conclusioni fossero la risultante di questi tre termini bontà prodotto, tempo il più breve possibile, esigenze economiche e sin dai primi giorni si è provveduto a rafforzare le riserve intangibili coll'acquisto delle materie prime necessarie, assegnando successivamente 6 milioni circa, e mettendo ora gli Stabilimenti in grado di potere lavorare sino al 31 dicembre 1915 senza ricorrere alla riserva stessa perché BISOGNA CHE MERCI, ARMI, SERVIZI CI SIANO NEL PAESE E SI CONTINUINO
A PRODURRE QUALORA LA GUERRA SI DOV ESSE SVOLGERE. A ciascun Stabilimento militare si è sempre raccomandato, per quanto riguarda l'allestimento dei proietti, di servirsi dell'industria privata come completamento o rinforzo, in caso di mobilitazione, mentre già ora largamente ce ne serviamo.
Ma prima di tutto occorreva pensare all'acciaio, e le pratiche furono fatte coll'IIva colle Ferriere Lombarde colle Ferriere Piemontesi perché
NECESS ITA' NOSTRI MUNIZIONA.i.\1ENTI RICHIEDONO ASSOLUTAMENTE TUTTA LA LORO PRODUZIONE ACCIAIO SIA AD ESSI CONSACRATA SENZA RESTRIZIONI e mentre l'Ilva con tutte le sue varie Società affllli rispondevano come risulta dalle lettere annesse (allegato 6) le due Ferrerie cofermavano le maggiori assicurazioni.
FABBRICA D'ARMI DI BRESCIA - All'atto della mobilitazione può essere in grado di allestire giornalmente 220 granate con 13 ore lavorative e 440 con lavoro continuo. Ordin ato l'acquisto dalla Ditla Breda di 13.000 bossolì con facoltà di raddoppiare la commessa per potere immediatamente iniziare lavorazione senza pregiudizio massimo aumento progressivo produzione moschetti.
FABBRICA D'ARMI DI TERNI - Lo stesso per 300 granate. Ordinato l'acquisto dalla Ditta Breda di 30.000 bossoli con facoltà di prenderne altrettanti.
ARSENALE DI NAPOLI - Ricevendo dall'industria gli elementi (bossoli . tappi ogiva . diaframmi) completamente ultimati, può fare l'applìcazione e la lavorazione delle corone, il caricamento con pallette e la composizione del proietto sl da produrre 500 shrnpnels al giorno con orario di 12 ore ed 800 con orario continuato. Si è ordinato subito una riserva di 15.000 elementi per potere appena ricevuto l'ordine iniziare la lavorazione degli shrapnels tutto perdisponendo. Nel contratto si è messa la facoltà di ordinanroe altri 15.000. La fornitura sarà fatta dalla Ditta Armstrong.
OFFICINA DI GENOVA - Affinché possa p0rtare l'efficienza della propria produzione a 500 proietti al giorno cumulativamente pei calibri da 75 e 65 m/m occorrevano macchine per l'importo di L. 85.000 che sono state subito accordate.

Inoltre eliminando le seguenti Società ,perché esistevano con esse speciali accordi) Società Proiettili . Metallurgica Bresciana · Franchi Griffin .
Officine già F.lli Diatto . Industrie Metallurgiche . Officine Michele AnsaldiOfficine di Netro Rapid Italo Ginevrine Fratelli Bertoldo Westinghouse di Torino Armstrong di Pozzuoli, si è invitata la Offici na di Genova a prendere accordi con altre Società in modo che se mai al primo cenno si
possano ottenere sicuramente almeno 1000 proietti al giorno (compresi quelli dell'Officina stessa). E mentre si ritiene che colle attività e colle energie di un gruppo di Società che potrebbero per esempio essere la Società Alfa - le Officinedi Caluso. il Tecnomasio · le Ditte Thomson Houston Stigler Langen & Wolf si potrebbe an-ivare a 1500 proietti al giorno, non si è mancato di invitare la predetta officina a prendere immediati provvedimenti al riguardo.
OFFICINA DI TORINO - Può arrivare ad una produzione giornaliera di 800 shrapnels e 900 granate ricevendo daH'industria privata una parte degli elementi. Si è raccomandato di acquistare nuovo macchinario se occorre, e dare preventivamente le ordinazìoni necessarie in modo che ìa produzione - se mai - sia assicurata. Inoltre si è ordinato di mettere a contributo nuove Società private invece delle note Ditte (Proiettili, Rapid, Netro, Ansaldo, Breda, Metallurgica, Westinghouse) invitandone diverse altre, (Stunz, Fonderia del Pignone, Langen & Wolf, Officine Meccaniche ing. Lesio & C., Mattarelli ecc.).
Nel Dispaccio 428 del 7 febbraio 1915 diretto a S.E. il Capo di Stato Maggiore si leggeva: E AL PRIMO GIORNO DELLA MOBILITAZIONE L'E.V. AVRA' LE PIU' PRECISE E MINUTE INDICAZIONI CIRCA LE CARTUCCE IN PIU' DELLE DOTAZIONI E DI QUANTO FU STABILITO NELL'APPLICARE IL NOTO PROGAMMA... ciò non si riferiva alle riserve di armi e di munizioni per le quali era più che LEGITTIMO IL SUO VIVO DESIDERIO DI AVERE A TALE RIGUARDO INFORMAZIONI PERIODICHE E SICURE E PRECISE, SENZA DOVERE ATTENDERE PER AVERLE IL PRIMO GIORNO DI MOBILITAZIONE, ma bensì a trattative di indole riservatissima che erano in corso le quali per ragioni note all'E.V. non poterono essere portate a compimento.
In fatto di Ditte private MESSE A CONTRIBUTO CONTEMPORANEAMENTE PER UNA SOLA FORNITURA, parmi che l'Italia abbia preceduto ed Austria e Francia - il materiale da 75 mod. 1911 insegni -. E sin dal 1912 il Ministero rispondeva alle critiche e alle interrogazioni: PER SVILUPPARE IL VALORE COLLETTIVO VOLENDOCI SVINCOLARE DALL'ESTERO SI DOVEVA FAR NASCERE ED ACCRESCERE IL VALORE DEGLI ELEMENTI INDIVIDUALI E CREARE SORGENTI DI FORZA MILITARE TECNICA RAGGRUPPANDO GLI INDUSTRIALI ITALIANI. E SI AGGIUNGEVA: SE COME RITIENSI E COME CONCORDI SONO LE AFFERMAZIONI DEI COMPETENTI, IL MATERIALE SARA' BEN COSTRUITO SI AVRA' LA SODDISFAZIONE DI AVERE ORGANIZZATE E SVILUPPATE IN ITALIA DELLE FORZE DURATURE CHE RITROVEREMO SEMPRE PRONTE IL GIORNO DEL BISOGNO.

ACCIAIERIE DI TERNI - Interessato il Comm. Orlando a lasciare nulla d'intentato perché le aziende nelle quali è magna-pars (Acciaierie di Terni. Vickers-Terni) si adoperino per quanto riguarda i proietti di piccolo calibro, sviluppando la massima potenzialità con tre sole condizioni produrre molto . bene - economicamente. Il Comm. Orlando mi ba assicurato che farà di tutto per r.ispondere all'appello, per quanto sino ad ora nessuna delle due Società abbia fatto proietti di piccolo calibro. Anche recentemente avendo la Legazione di Grecia per mezzo del Ministro degli Affari Esteri chiesto di potere ordinare agli Orlando grosse munizioni di carabina e si è risposto affermativamente purché si mettano presto in condizione di produrre proietti di piccolo calibro.
METALLURGICA BRESCIANA - Può dare giornalmente 2000 proietti da 65 e 75 m/m sia granate e sbrapnels completamente finiti; si riserva di fare ulteriori comunicazioni riguardo alla collaborazione di altre Ditte,
dichiara di dare sempre LA PRECEDENZA ALLE COMMESSE DEI MINISTERI DELLA GUERRA E DELLA MARINA E QUALORA POI DOVESSE ESSERVI LA MOBILITAZIONE TUTTA L'INTERA NOSTRA PRODUZIONE SARA' RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE MILITARE LAVO. RANDO COLLA MASSIMA INTENSITA' POSSIBILE.
GRUPPO INDUSTRIALE PIEMONTESE - ...SECONDO GLI ACCORDI VERBALI INTERVENUTI COLLA S.V. ILL/ MA LE CONFERMO COLLA PRESENTE CHE SE MAI DOVESSE AVER LUOGO LA MOBILITAZIONE AD UN SEMPLICE AVVISO DELLA S.V. TUTTA LA PRODUZIONE DELLE DITTE SEGUENTI: OFFICINE GIA' FRATELLI DIATTO • PROIETTILI· INDUSTRIIE METALLURGICHE • OFFICINE MICHELE ANSALDI • OFFICINE DI NETRO. RAPID - ITALO GINEVRINA • FRATELLI BERTOLDO · WESTINGHOUSE Dl TORINO. PER QUANTO RIGUARDA LA FABBRICAZIONE DI PROIETTILI , CASSONI, CARREGGIO ECC. LAVORANDO COL MASSIMO D' INTENSITA' RESTA AD INTERA ED ESCLUSIVA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA. Ecco quanto dichiara.
La potenzialità complessiva giornaliera delle Officine è per ora da 4000 a 4500 proiettili di piccolo calibro e da 600 a 700 di medio calibro, ma si spera d 'aumentarla coll'arrivo di una pressa idraulica.
LA SOCIETA' BREDA può produrre circa 1000 proietti al giorno - è però impegnata per la Marina e per la Guerra sino a tutto Luglio - spera presto di aumentare la produzione. Assicura chf' tutti i lavori assunti o da assumere saranno per le Amministrazioni militari.
LA SOCIETA' FRANCHI GRIFFIN è nelle stesse condizioni circa gli impegni, può produrre come la Breda.
Le materie prime sono un fattore di capitale importanza rispetto agli elementi più appariscenti della organizzazione dell'Esercito. Disgraziatamente in Italia la preparazione industriale tecnica non è all'altezza delle grandi industrie d'oltr'alpe meravigliosamente organizzate, possenti, e s iste invece un'industria metallurgica fittizia, giacché mancano le relative materie prime. Vivono è vero alcune industrie meccaniche perché hanno per principale cliente Io Stato, ma appena mancano il carbone, il rame, il nikel, l'antimonio, il nitrato, il ferro manganese, il cromo ecc. tutto s'arresta per far delle dolorose contestazioni.
Non è il caso che io riferisca all'E.V. ciò che già è a sua conoscenza, né tutte le difficoltà incontrate. Noto solo che si era anche pensato di mandare in America un ufficiale superiore accompapnato da un capotecnico per fare acquisti diretti, ma per diverse ragioni si è contromandat,a tale decisione, e che in tutti i modi da mesi si lavora perc hé non solo gli Stabilimenti militari ma anche quelli privati abbiano k materie prime necessarie.
Fortunatamente il concetto stabilito dalla Circolare 505 giornale militare 1913 di avere UNA RISERVA INTANGIBJLE DI MATERIALI PRESSO LE DIREZIONI E GLI STABILIMENTI DI ARTIGLIERIA PEI BISOGNI IMPREVEDUTI ED URGENTI, è stato ar•plica to largamen te e come. tutte le lavorazioni hanno proceduto colla massima regolarità e senza inconvenienti per la mano d'opera pel 1914, cosl procederanno pel 1915giacché tutti gli Stabilimenti militari debbono avere entro il primo quadrimestre 1915 tutte le materie prime per le lavorazioni sino al 31 dicembre 191 5 senza toccare le riserve intangibili. Naturalmente al 31 luglio 1915 le riserve intangibili, che prima ascendevano al 31 luglio 1914 a più di 8 milioni, saranno quasi raddoppiate.

Per ovviare al grave inconveniente della crisi del rame si è anche proposto al Ministero del Tesoro di fare anticipare dagli lstitu6 cli emissione alla Metallurgica Italiana, alle Trafilerie e alla Società Corradini le somme necessarie per costituire forti depositi di rame che funzionerebbero di riserva ed ai quali fosse possibile attingere nei periodi cli momentanea e prolungata mancanza di normali approvvigionamenti.
Le Banche sarebbero garantite in capitale ed interessi dal deposito stesso cli rame, nonché dalle industrie contranenti per le eventuali differenze cli prezzo e cli oneri.
Si apetta la risposta. Giornalmente però occorre telegrafare al Ministero degli Esteri pel libero transito del rame, come a Genova perché la sosta non oltrepassi il limite dell'onesto, perché se sono lunghe le pratiche per fare arrivare il rame a Genova più lunghe sono quelle per farlo arrivare a destinazione, e intanto i ritardi si moltiplicano.
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI MECCANICI ED AFFINI - ESENZIONE DAL SERVIZIO MILITARE DEGLI OPERAI SPECIALIZZATI IN DETERMINATI LAVORI CHE SI FANNO NELL'INTERESSE DELLA DIFESA NAZIONALE.
Tale Associazione ha offerto i suoi servigi per preordinare una organizzazione dell'industria meccanica in servizio del Dicastero della guerra nel caso di mobilitazione. Si stanno studiando ed esaminando le proposte fatte in un con quelle che riguardano la mobilitazione degli Stabilimenti che lavorano a scopi militari. Inoltre si ritiene opportuno stabilire quali siano gli operai specializzati la cui opera debba considerarsi indispensabile pel compimento di alcuni determinati lavori, e che non possono essere sottratti agli Stabilimenti senza avere ritardi nelle provviste delle forniture di vero interesse guerresco.
E' innegabile che dopo la guerra ci sarà un prodigioso risveglio dell'industria. Deve l'Italia assistere passivamente agli sforzi che tutti gli Stati vorranno e dovranno fare per mettere in valore ciò che la guerra ha distrutto?
Recentemente.in un colloquio avuto col rappresentante del Gruppo Piemontese e col Signor Devies, si è parlato di un concorso maggiore del capitale Francese e della maggiore collaborazione della mano d'opera Italiana nell'immane lavoro di ricostituzione mentn:, oggi imperversa la demolizione e le trattative sono bene avviate. Ciò che è s•tato fatto da AnsaldoSchneider in proporzioni molto limitate può e deve domani essere fatto con maggiore sforzo e più efficaci risultati. L'essenziale è non essere mai né sorpresi né rimorchiati.
CONCLUSIONE - Mentre in passato si calcolava in caso di mobilitazione su una produzione mensile cli 100 colpi per pezzo da campagna e montagna, oggi si può calcolare in caso di guerra su quella di 100 colpi per pezzo nel primo mese e 300 nel secondo e successivi, e su 100 colpi per pezzo per obice da 149 invece di 50. Però dal 31 maggio 1915 si può calcolare sui 200 colpi per pezzo da campagna e 100 per obice campale.


Il concetto che è stato di guida sempre nella produzione del materiale da guerra è il seguente: BISOGNA CHE MERCI, ARMI, SERVIZI, CI SIANO NEL PAESE E SI CONTINUINO A PRODURRE QUALORA LA GUERRA SI DOVESSE SVOLGERE. A ciascuno dei nostri S tabilimenti si è sempre raccomandato di servirsi della industria privata come complemento o rinforzo dell'indusstria militare di Stato.
Gli Stabilimenti militari poco per volta si sono portati al massimo del loro sviluppo e della loro produzione tant'è che la Fabbrica d'armi di Terni che nel 1911 faceva 640 fucili al mese ora ne fa 15.000, e la Fabbrica d'arnù; di Brescia che faceva 600 moschetti ora ne fa 7000; il Laboratorio pirotecnico di Bologna che prima produceva al giorno 250.000 cartucce ora arriva a produrne 750.000 e a umen terà ancora, lo Stabilimento del BardaIone che prima produceva circa 90.00 cartucce al giorno ora n e produrrà 900.000
Poi si è pensato all'acciaio e le pratiche furono fatte coll'Ilva, colle Ferriere Lombarde, colle Ferriere Pie montesi, perché NECESSITA' NOSTRI MUNIZIONAMENTI RICHIEDONO ASSOLUTAMENTE TUTTA LA LORO PRODUZIONE ACCIAIO SIA AD ESSI CONSACRATA SENZA RESTRIZIONI. Le Società dianzi nominate confermavano le maggiori assicurazioni.
L'organizzazione della industria privata per la fabbricazione delle munizioni ebbe due periodi.
1°) PERIODO - Per ottenere all'atto della mobilit azione un'efficace rendimento dall'industria privata era necessario aiutarla opportunamente, spingerla all'acquisto e all'impianto delle necessarie macchine, cercare in alcuni casi che a spese d'altri fornisse la mano ù'opera, e vincolasse le maggiori difficoltà per organizzare la fabbricazione - in una parola preparazione e organizzazione.
2°) PERIODO - Stabilire su solide b:isi la produzione delle munizioni mobilitando poco per volta tutte le risorse industriali del paese integrando tre ternùni: bontà prodotto . tempo il più breve possibile - esigenze economiche. La ripartizione della fabbricazione fu sta bilita per mezzo di Capi-gruppo militari e civili i quali inquadravano officine meccaniche
di diversa specie ed importanza e indicavano la eventuale capacità di produzione e H genere di fabbricazione.
CAPI-GRUPPO sono i seguenti:
- Maggiore Generale PARODI, Direttore off. costruz. Torino
- Maggiore Generale GARDINI, Direttore Fabb. armi Terni
- Maggiore Generale CASELLA, Direttore Arsenale Napoli
- Colonnello d'art. MARTIN!, Direttore Lab. Pìrot. Bologna
- Colonnello d'art. MASCIA, Direttore Fabb. armi Brescia
- Colonnello d'art. STAMPECCHIA, Direttore Off. costruz. Genova
- Comm. Ingegnere FERRARIS Dante, che è alla testa del gruppo industriale piemontese per i materiali di artiglieria
- Comm. Ingegnere ORLANDO Luigi, Amministratore delegato della Metallurgica Italiana
- Comm. STUCCHI, della Società Stucchi e C.
- Ing. STIGLER, della Società Stigler
- Ing. Tedes<:hi, della Società Langen & Wolf i quali riuniscono 12 Società.
- Il Direttore della Società Meccanica Lombarda di Monza.
- Il Direttore della Società Robinetteria Macchi di Milano, funzionano da Capi-gruppo per Ja produzione delle spolette a percussione.
Inoltre l'Ing. Ferraris ha riunito 25 Società, il Colonnello Stampecchia 72 Società ed officine diverse ecc.
L'Ing. Luigi Orlando riunisce alla sua Società, la Società Metallurgica Corradini di Napoli, e le Trafilerie e Laminatoi di metalli di Milano che sino a tutto il 30 giugno 1916 hanno tutta la loro produzione vincolata alla Aroinistrazione rrùlitare essenzialmente per quanto riguarda le materie prime pei Laboratori Pirotecnici.
Così si è incoraggiata l'industria del Paese nella produzione del materiale che occorre all'Esercito e si è raggiunta progressivamente una produzione rrùgl iore e più economica.
I Capi gruppo corrispondono direttamente col Ministero al quale inviano il 10 - 20 - 30 del mese la situazione dei !ovari in corso.
Materie prime - Per quanto riguarda le materie prime naturalmente il Ministero, come sempre ha fatto, cerca di facilitare le provviste là dove sono le sorgenti cui attingere in alcuni casi fa distribuire tali materie alle singole officine in armonia colle ordinazioni che devono eseguire.
Perciò fu costituito un deposito di materie prime presso alcuni Stabilimenti rinforzando anche le riserve intangibili che questi devono avere a disposizione del Ministero.
Le riserve intangibili sono costituite dalle necessarie materie prime per mettere in grado gli Stabilimenti di potere lavorare dai 9 ai 10 mesi senza fare alcun acquisto.
COMMISSIONE SUPERIORE DI COLLAUDO - Sotto la Presidenza dell'Ispettore delle Costruzioni deve controllart' e far controllare tutti i collaudi relativi alle munizioni e fuochi da guerra, vis,itando Officine, Laboratori, Fabbriche e seguendo passo passo le singole lavorazioni.

COMMISSIONE PER L'INCREMENTO DEGLI ESPLOSIVI - Avrà lo scopo di studiare tutto quanto riguarda l'incremento degli esplosivi e vedere tutto quanto è possibile fare per riunire le materie prime necessarie per migliorare i procedimenti di fabbricazione, per strenuamente contribuire al dovere di produrre senza posa le maggiori quantità.
ESONERAZIONE DEGLI OPERAI - Col. R. Decreto 29 aprile 1915 si fissavano nuove norme per l'esonerazione temporanea dalla chiamata alle armi del personale evente obbligo al serv,izio militare addetto agli Stabilimenti privati che allestiscono materiali per conto del R. Esercito e della R. Marina o forniscono materie prime partendo dalla RICONOSCIUTA NECESSITA' OD INSOSTITUIBILITA' DEI MILITARI STESSI NELLE FUNZIONI CHE DISIMPEGNANO PRESSO GLI STABILIMENTI O LE IMPRESE.

Con Decreto Luogotenenziale del 17 giugno corrente n. 817 si s tabilivano speoiali norme relative alle esenzioni temporanee di militari richiamati dal congedo militare ascritti alla milizia territoriale i quali da un mese almeno prestano l'opera propria in qualità di direttori, capitccnici cd operai specializzati presso aziende proprie dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o private, limitate ai casi in cui DALL'ASSENZA DEI MILITARI POSSA DERIVARE LA TOTALE CESSAZIONE DEL FUNZIONA.
MENTO DELL'AZIENDA, STABILIMENTO OD IMPRESA OVVERO UNA
GRAVE PERTURBAZIONE AL NORMALE FUNZIONAMENTO STESSO.
In tutte le Commissioni Superiori che riguardano collaudi esplosivi esonerazioni degli operai entrano anche come membri civili tutte quelle personalità le quali nel campo industriale pei loro studi per la loro cultura tecnica sono più specialmente indicati e che hanno chiesto di potere dare l'opera loro nell'interesse del Paese.
Come pei Capi gruppo, e cosl per le Commissioni si sono cercati degli uomini pratici, spicciativi, che siano sul posto e abbiano conoscenza delle condizioni locali e dell'abilità tecnica dei produttori -e sappiano coordinare i metodi mighlori per raggiungere il risultato voluto - LA MOBILITAZIONE INDUSTRIALE.
CARTUCCE - Fra il Laboratorio pirotecnico di Bologna e quello di Capua e lo Stabilimento Bardalone della Metallurgica Italiana si arriverà a 72.000.000 al mese, e si seguiterà ancora ad aumentare.
FUCILI E MOSCHETTI MOD. 91 - Si può calcolare su 15.000 fucili mod. 91 e su 8.000 moschetti mod. 91. E' in vista l'impianto di una nuova fabbrica di fucili mod. 91 che dovrà funzionare col 1• gennaio 1916.
PROIETTILI - Tutte le ordinazioni sono date sino al 30 giugno 1916 e sino ad ora le commesse raggiungono le cifre che risultano nell'apposito specchio che si unisce alla presente relazione.
Roma , 27 giugno 191 5
IL DIRETTORE GENERALE f.to Dallolio
Dopo due soli mesi di guerra, si è constatato anche in Italia, come il problema della fabbricazione delle munizioni deve essere affrontato subito e rJsolto con larghezza di mezzi e di vedute, aEontanandosi quando occorre, dalle consuetudinarie forme contrattuali, dalle solite rigide norme amministrative.
Ciò potrà essere fatto tanto più tranquillamente oggi, inquantoche mai come in que sto caso il fine giustifica i mezzi e sopratutto mai prima d 'ora si è avuta occasione di constatare uno slancio cosl generoso e patriottico di ogni classe, intellettuale, industria k o commerciale per m ettersi a dis pos izione del Governo e collaborare con lui alla risoluzione di questo vasto problema di così vitale importanza per la difesa e l'avve nir e del nos tro paese.
Fra tanto fiorire di proposte, fra tante generose esibizioni d'opere o di persone, non sarà difficile al governo di poter scegliere degli ottimi elementi di collaborazione, che per posizione sociale, competenza tecnica e competenza amministrativa sappiano e poss ano garantire lo stato del r e· golare e migliore svolgimento del programa di lavoro che occorre sollecitamente eseguire.

Deve essere quindi scopo primo del S.S.A .M . studiare e creare più enti di collaborazione che lo aiutino a raggiungere coll'intendimento e mezzi pratici la meta prefissa, investendoli dell'autorità necessaria per disciplinare e coordinare le energie industriali del paese, lasciando loro, con le respons abilità dell'operato, anche una larga iniziativa, ,indispe nsabile in un paese come il nostro, ove eccezion fatta per la grande industria, la maggioranza delle industrie meccaniche è frazionata in stabilimenti di potenzialità media ed anche del tutto limitata, attrezzati in modo diverso, retti e guidati con criter.i, mezzi ed abitudini àive rse a seconda delle regioni nelle quali si trovano e delle fabbricazioni alle quali sono più specialmente destinate.
La serietà di questi enti di collaborazione, la loro competenza ed il fervore patriottico che metterano nell'assolvere il loro mandato, nonché il continuo contatto di affiatamento del S.S.A.M. permetteranno, non è da dubitarne, per questa volta ed io questo caso speciale, di non attenersi così strettamente a quelle garanzie e a quellè cautele amministrative e statal.i con le quali sono, in tempi normali, regolati i rapporti fra i fornitori e le pubbliche amministrazioni.
Lo schema dell'intera organizzazione industriale che deve concorrere alla risoluzione del problema del munizionamento può essere sinteticamente rappresentato come l'unita tabella neJla quale oltre alle parole ARMI e MUNIZIONI, si è aggiunto anche quella dei materiali, poiché in una guerra come quella che si sta svolgendo, e che per le previdenze che si devono adottare, non hanno minore importanza delle armi e munizioni
gli strumenti da lavoro o i materiali dei quali vanno largamente e sollecitamente provvedute le truppe operanti e sopratutto le 105 compagnie del Genio di nuova costituzione alle quali oltre tutti i lavori di rafforza_ mento di posizioni, lavori stradali, di ponti, fcr,ovie ecc. è affidato il compito non meno urgente ed importante di provi,edere in tempo agli alloggiamenti cd a tutti quegli altri innumerevoli servizi che sono indispensabili per assicurare all'esercito il modo migliore per sopportare l'inc lemente stagione che, in molte zone del teatro delle operazioni, è imminente.
Alla fabbricazione di tali strumenti e alla provvista di questi materiali l'industria privata può portare un aiuto grandissimo, perché esso sia efficace ed il più disciplinato, si ritiene conveniente .includerlo nel programma generale abbozzato nella presente relazione.
Ciò premesso ecco la tabella di cui è fatte cenno più sopra:
Armi
lMaterie l prime Fabbri-
Materie prime
Stabilimenti militari
Grande industria
Grandi Stab. Metallurgici
Grande industria pei greggi alla minore ind.
Acquisti all'estero
Approvvigio.. namento
Proietti
Fabbrica-
ITrattati- ) ve dir. (
zione 1 · tv~r~~: rette l
Materie prime Spolette
Fabbricazione
Materie prime Accessori
jFabbricazione
Stabilimenti militari
Grande industria
Media e piccola industria nazionale coordinata e rappresentata dai comitati regionali
Esplosivi \ Fabbrica)
II Materiali
Materie prime Trattative dirette con Fabbricazione ( le grandi industrie
Stabilimenti militari
Industrie private
Le trattative dirette che il S.S.A.M. ha e continuerà ad avere coi grandi fornitori di materie prime, con gli stabilimenti militari e con la grande industria, rimarrano invariate e non saranno che condotte parallelamente alle altre trattative indirette interessanti l'industria privata in modo da

armonizzare i bisogni e le esigenze di questa con i bisogni e le esigenze maggiori.
Così pure il ramo esplosivi continuerà a svolgere il suo programma coi mezzi e nella forma seguiti fino ad ora.
I campi, invece, nei quali l'industria privata può dare un concorso attivissimo e prezioso sono quelli dei PROIETTILI - SPOLETTE - ACCESSORI (pallette di shrapnels, bossoli, granate a mano ecc.) e MATERIALI.
Parte di questi ultimi sono e saranno forniti dalle officine di costruzione di Pavia la quale dovrà funzionare anche come punto di raccolta ed incremento dei materiali forniti dall'industria privata.
Il modo migliore per organizzare l'industria privata e trarre da esso H massimo rendimento in opere e prodotti finiti è appunto quello di creare quegli enti di collaborazione in aiuto al governo e di cui si è fatto cenno in principio, enti che per la loro formazione e la loro dislocazione si chiameranno COMITATI REGIONALI A.M.E.
Il numero e la composizione di essi saranno evidentemente proporzionali alla importanza industriale della regione:: relativa e si ritiene, per il momento, che sia sufficiente crearne nuove così ripartiti:
1°) Com. reg. PIEMONTE per le provincie del Piemonte;
2°) Com. reg. LOMBARDO per le provincie della Lombardia;
3°) Com. reg. LIGURE per le provincie della Liguria;
4°) Com. reg. VENETO-FRIULANO per le prov del Veneto e dell'Emilia;
5°) Com. reg. TOSCANO per le provincie della Toscana, Umbria e Marche;
6°) Com. reg. ROMANO per le provincie del Lazio, Abruzzi, Sardegna;

7°) Com. reg. NAPOLETANO per le prov. della Campania, Basilicata, Calabria;
8°) Com. reg. PUGLIESE per le provincie delle Puglie e Molise;
9°) Com. reg. SICILIANO per le provincie della Sicilia.
La sede del Comitato regionale sarà o nel capoluogo della regione per i comitati riguardanti una sola regione, o nella città capoluogo della regione più industriale per quelli comprendenti più regioni.
Il comitato avrà a capo il presidente della camera di commercio della città sede del comitato stesso, od altra personalità industr.iale designata dal governo, e sarà costituito da un certo numero di Consig1ieri (non più di otto, non meno di quattro oltre il presidente, a seconda della importanza industriale della regione) scelti tra le persone del luogo che non siano o possano essere fornitori, ma anche per censo, posizione e competenza tecnica e sopratutto pratica industriale e commerciale, presentino i migliori requisiti e possano assumere verso il governo normalmente e materialmente la responsabilità dell'impresa che sono chiamati a dirigere.
Per la scelta di questi consiglìeri i presidenti delle varie camere di commercio sottoporranno al governo entro un brevissimo limite di tempo, da stabilirsi, una lista di candidati .in numero doppio dei nominandi, compilata nel consiglio e l'accordo del Prefetto locale.
Il S.S.A.M. si riserva poi di scegliere tra le liste presentate i nomi di coloro che riterrà più adatti allo scopo, salvo domandare delle nuove liste se i nomi p resen tati non bastassero per la scelta
Il Comitato Regionale così costituito avrà nei suoi rapporti col governo per le forniture in parola, ed in rappresentanza di tutti gli stabilimenti industiiali aderenti della rispettiva circoscrizione, attribuzioni e
responsabilità analoghe a quelle che hanno i Consigli d ' amministrazione di una Società industriale, limitatamente però all'assunzione degli ordinativi, alle consegne di essi, alle provviste di materie prime per quanto fornite dal Governo, ed ai rapporti fra i i vari stabilimenti dipendenti.
I comitati regionali cureranno prima di ogni altra cosa a fondare e coordinare i vari gruppi e le varie Jniziative che fossero sorte in luogo fino ad oggi, e che le industrie del loro Circondario che desiderano concorrere a forniture di munizioni e materiali si raggrup pino in consorzi di forma Cooperativa su di una base comune che si indicherà e analoga a quella della Cooperativa proiettili di Milano.
Ciascuna azienda però nel suo andamento interno continuerà ad avere piena e completa libertà d'azione, salvo nella qi.:estione della mano d'opera per le quali il governo provvederà ad emanare opportune disposizioni, zd evitare illecite sottrazioni e d accaparramenti ed u na dannosa concorrenza, nonché p er restituire alle fabbriche gli operai invalidi mobilitati.
Stabiliti i fabbisogni, il Governo li dpartirà ai vari Comitati regionali in misura proporzionale alla loro potenzialità industriale e le ordinazioni saranno passate allo stesso prezzo e condizfoni per tutti contemplando due forme distinte di contratti, per completa fornitura dell'oggetto comprendente materie prime e lavorazione o per la sola lavorazione quando il Governo provveda a dare la materia prima od il pezzo greggio.
Il Comitato nell'assumere l'impegno per ·il prezzo e per le condizioni compilerà anche il reparto delle consegne che preferisce di mantenere, cd a stimolare l'osservanza di esse il Governo, in più d el prezzo stipulato, corrisponderà un premio da stabilirsi di volta in volta per quelle partite consegnate oltre il previsto di un determinato periodo.
Cosl pure se per circostanze varie ed impreviste un Comitato non può essere in grado di mantenere gli impegni presi, ad evitare o eliminare penalità gli è lasciata facoltà di farsi completare la differenza con la produzione di un altro Comitato il quale, dopo la consegna deUa propria rata, possa incaricarsene; per questa parte di forrutura il Comitato richiedente dovrà concedere al comitato fornitore, un benefic io del So/o .

Il S.S.A.M. sia per un controllo sull'opera dei Comitati regionali sia per condividerne la responsabilità provvederà a convocare in seduta plenaria al Ministero due volte al mese tutti i Presidenti dei Comitati, i Direttori di quegli stabilimenti coi quali le trattative dirette nonché i direttori degli stabilimenti incaricati di provvedere le materie prime o gregge, per una disposizione bisettiminale sulla situazione, per una relazione sui lavori eseguiti o da eseguire, per uno scambio reciproco di idee s u questioni varie che sorgessero, in una parola per affiatare e accordare tutti gli elementi produttori in modo da assicurare la regolarità e la continuità di tutti i rifornimenti e di tutte le lavorazioni prese figureranno in apposito verbale.
I Presidenti ed i Consiglieri dei Comitati r egiona li presteranno l'opera loro disinteressatamente, ed a coloro fra i corivocati che non hanno passaggio gratuito sulle ferrovie o biglietti di abbonamento, il S.S.A.M. gli rimborserà le spese di trasporto; verranno pure rimborsate ai Comitati Regionali le spese vive di amministrazione, postali, ecc. che incontreranno per l'esecuzione del loro mandato.
I Comitati regionali hanno ampia facoltà di farsi aiutare in luogo e nelle varie località della loro giurisdizione d:t tutti que i volonterosi che si offriranno e che riterranno atti allo scopo, ferma però res tando, nei riguardi del Governo, solo la loro personale responsabilità.
Su informazioni e garanzia del Comitato regionale il S.S.A.M. concederà a que lle ditte fornitrici che ne facessero domanda degli anticipi fino alla concorrente di un terzo dell'ammontare della fornitura loro aggiudicata.
192
Circa l'organizzazione materiale del lavoro affidato ai Comitati, i dati ed elementi che dovranno procurare subito e fornire in seguito, le norme e gli avvertimenti che dovranno seguire sarà fatto cenno in altra relazione di carattere più dettagliato ed esecutivo.

A fianco di ciascun comitato regionale iì S.S.A.M. provvederà a mettere una commissione permanente di Collaudo costituita da apposito e sufficiente personale tecnico militare e munita di tutti gli occorrenti poteri c delle serie di calibri e strumenti che le potranno occon-ere, per facilitare il funzionamento e sopratutto per risolvere presto il problema degli apparecchi di controllo sono in corso studi per ridurli ad un minimo indispensabile, senza contare che si potrà eventualmente ricorrere anche all'uso di automobili o di camions coi quali la Commissione di collaudo ed i relativi strumenti possono rapidamente portarsi da una fabbrica all'altra per eseguirvi i necessari collaudi, seguendo un programma ed un itinerario preventivamente stabiliti.
Così pure i Comitati regionali segnaleranno ed appoggeranno tutte quelle Ditte che più particolarmente fossero atte ad intraprendere la costruzfone di macchine utensili, torni, presse, ecc. e potranno altresì utilmente prestare l'opera loro pel reclutamento dl studenti da mandare alle scuole industriali che saranno adibiti alla preparazione di buoni tornitori e ripartire equamente questi ultimi a corsi finiti, fra gli Stabilimenti che ne segnalino il bisogno, in modo che anche questo importante fattore di successo procede armonicamente con tutti gli altri.
Dallolio
G. DRG /65
OGGETTO : Mater iale 105 campale - Affus ti 210 - Mortai 250Lancia bombe e cannoni antiaerei.
ECCELLE NZA, in relazione a quanto l'E.V. ebbe a richiederci nel merito della consegna, quale la nostra Società potrà osservare per i mortaj da 260, gli affusti da 210 cd il materiale da 105 campale pesante, ci pregiamo comunicare all'E.V. che è nostro intendimento presentare al collaudo in Officina
- gli 8 mortai da 260 come appresso:
2 entro il Giugno p.v
2 entro il L uglio p.v.
2 entro l'Agosto p.v.
2 entro il Settembre p.v.
- gli 11 affusti da 210:
1 entro il Maggio corrente
2 entro il Giugno p.v.
4 entro il Luglio p.v.
4 entro l'Agosto p.v.

-i 4 cannoni costituenti la prima batteria da 105 campale, come in appresso:
il primo cannone entro il Luglio p.v. i restanti 3 successivamente
Era nostro intendimento di anticipare i termini di consegna di tutti questi materiali, ma le successive chiamate alle armi ci hanno distolto e ci dis tolgono tuttora molto del nostro personale, e d'a ltra parte è da considerarsi che per i mortaj è un vero colpo di mano quello che viene fatto dalla nostra Società, in quanto che i lavori vennero iniziati appena nel principio del corrente anno e senza neppure essere in possesso di tutti i disegni relativi, siccome solo il 20 Aprile e.a. ci pervennero gli ultimi di essi.
Riguardo ai rimanenti 20 cannoni da 105, che - di nostra iniziativa - abbiamo messo in costruzione, non possiamo sin d'ora stabilire i termini di consegna, causa gli impegni assunti di fronte all'On. Amministrazione della Marina e d a to che il macchinario di c ui disponiamo è in gran parte impegnato in d ipendenza dei lavori relativi ai mortaj da 260 e 210 sovraccennati, nonché pei 152/45 che dobbiamo provvedere alla Re-
gia Marina, forniture queste che spingiamo cm la maggiore alacrità possibile, lavorando ininterrottamente giorno e nette.
Al riguardo ci riserbiamo di essere precisi prossimamente Nell'intento di far cosa grata all'On. Amministrazione della Guerra, noi ci permettiamo formulare una proposta che riteniamo - nelle presenti contingenze - meritevole della maggior attenzione:
La nostra Società ha in lavorazione n. 60 cannoni da 102/35 per la Regia Marina, destinati all'armamento dei Cacciatorpediniere in corso di costruzione, ed avendo noi - con notevole ar.ticipo sulle consegne stabilite - già provveduto all'armamento dei ca<"datorpediniere in corso di allestimento, proporremmo di approntare n. 2G dei suddetti cannoni da 102/35 opportunamente sistemati da poter essere utilizzati dal R. Esercito, entro breve termine - tre mesi circa - iniziardo la consegna del primo entro un mese dall'accettazione e benestare della nostra proposta.
Tale sistemazione potrebbe - ove il Ministero della Guerra ritenesse di prendere in considerazione la nostra proposta - da noi essere studiata, col precipuo intento di renderne facile il traf,porto e l'impiego di detti cannoni mediante gli ordinari camions militari.
Mentre ci riserviamo di rimettere un progetto di sistemazione - che crediamo bene r iuscito, accludiamo alla presente un prospetto dei dati balistici delrarma la quale alle prove ha dato risultati brillanti, sia come prec-isione, sia come rapidità di tiro, 20 colpi al minuto, ed il cui vero valore deriva dalla possibilità di una gittata da 10 a 12 kilometri.
Per rendere possibile la soluzione proposta, noi saremmo disposti ad assicurare alla Regia Marina l' approntamento in tempo debito dei cannoni da 102/35 strettamente necessari per l'armamento d ei Cacciatorpediniere in corso di costruzione, alla condizione che da parte della Medesima ci venga accordata una proroga per quanto riflette la fornitura di materiali non assolutamente urgenti.

I termini per la consegna di tutti i cannoni sopraccennati, presuppongono che le nostre Officine possano essere mantenute in tutta efficienza.
Abbiamo inoltre l'onore di informare l'E.V. che stiamo anche costruendo due tipi di lancia-bombe, uno dei quali è pressoché ultimato; un cannone antiaereo da 76/17 da installarsi sovra automobile, uno da 76/45 navale antiaereo, nonché uno da 102/35 navale pure antiaereo che installeremo senz'altro su automobile.
Questi tre cannoni verranno adibiti alla difesa dei nostri Stabilimenti.
Per il cannone da 76/17 antiaereo, abbiamo usufruito di un cannone da sbarco tipo SCHNEIDER di cui la Regia Marina ne possiede 92 esemplari, alcuni dei quali potrebbero eventualmer,te essere rapidamente installati sopra automobili muniti di affusto speciale antiaereo a linea di mira indipendente di nostra creazione.
Nella fiducia che !'E.V. sarà per accordare benevolo accoglimento alla presente, ci onoriamo raffermarci con ossequio.
Devotissimi S.A.I. GIO. ANSALDO & C. IL PRESIDENTE30.DGR-314
OOGETTO: Necessità di provvedimenti per facilitare lo svolgimento della vita industriale della Società.

Alla E.V. che conosce la nostra attività e spirito d'iniziativa, e la straordinaria potenza dei mezzi di produzione dei quali disponiamo, l'una e l'altra cosa essendo abbondantemente dimostrate, a prescindere da quanto facciamo e facemmo per la R. Marina, daJb solerzia e rapidità con le quali abbiamo approntati gli affusti per mortai da 305, 280 e 210, nonché i mortai ed affusti da 260, rivolgiamo fiduciosi le considerazioni seguenti perché siano adottati provvedimenti indispen sabili per la nostra vita industriale.
La nostra Società ha messo in costruzione, in aggiunta ai lavori indicati, le automobili blindate, i lanciabombe d,L 50 e 75 m/m, alcuni potenti cannoni da assedio da 152 mm. il primo dei quali sarà pronto entro pochi giorni, numerose batterie di cannoni campali pesanti da 105 e cannoni da 102 su automobili il cui acquisto, in seguito all'atto brillante delle prove, il Ministero si è accinto a regol are definitivamente.
Attendiamo ora con la massima alacrità ad impiantare ed organizzare:
Una fabbrica di proietti che sarà la più grande d ' I talia.
Una fabbrica di bossoli, spolette cd inneschi.
Una fabbrica di bombe scoppianti e di be:mbe a gas asfissiante.
E' in corso l'ingrandimento di tutti i reparti dell 'Acciaieria e dello Stabilimento di Costruzione d'Artiglieria, affinché la produzione dei cannoni sia notevolmente accresciuta
Abbiamo acquistato centinaia e centinaia di macchine d'ogni sorta, torni, bareni, rigatrici ecc. perché sia possibile l'estrinsecazione di un gran programma.
Sempre di nostra iniziativa facciamo un impianto per il rìtubamento dei cannoni, impianto indubbiamente destinato a rendere grandi servizi.
Insieme con la Società Dinamite Nobel di Avagliana, eseguiamo a Fossano un grande impianto per il caricamento di proietti e di bombe.
Abbiamo in corso di attuazione altre inizi,•tive importanti, senza parlare di quella importantissima, delle lamiere imperforabili per scudi da fanteria ed artiglieria ecc. che abbiamo già fornito in grande quantità.
T uttavia fino a tutt'oggi noi non abbiamo potuto incassare che piccolissime somme, ond'è che io mi permetto d'invocare da V. E. un provvedimento adeguato ad agevolare l'adempimento del nostro programma, il quale non solo è grandioso e senza precedenti nell'industria nazionale,
ma risponde indubbiamente a necessità impre~cindibili nelle attuali circostanze della guerra.
Sarebbe necessario di addivenire al più presto alla stipulazione del contratto di fornitura delle batterie da 102 e 105 la cui urgenza è <limo. strata anche dal fatto che la costruzione è avviatissima e che abbiamo da tempo ordinate per esse più di 500 automobili, facendo pure delle anticipazioni alle Ditte che le costruiscono Se sarà necessario di apportare varianti a queste batterie, le faremo di buon accordo con le Autorità competenti, ma noi non possiamo più continuare come ora a sostenere l'onere sia degli impianti sfa del materiale in costruzione, la cui quantità e mole tutte le commissioni che visitarono i nostri St,•bilimenti ebbero modo cli accertare, senza ricevere l'aiuto dei compensi contrattuali.
Non peranco abbiamo incassato la prima rata della ordinazione di 240 cannoni da 75, sebbene la lavorazione di es~i sia in pieno svolgimento.
Ancora non si è addivenuti alla firma del contratto per i cannoni da 75 da montagna, sul cui prezzo fuvvi un così lungo dibatti to.
Anche l'importante questione della fornitura di 160.000 proietti da 102 e 105 conviene che sia discussa, giacché per eseguirla in breve termine di tempo, ci abbisogna fare, e facciamo, un impianto d'importanza colossale; ma è ovvia la necessità che la nostra Società abbia di fronte agli oneri che sostiene ben altro e più preciso affidamento di quello che ha avuto finora.

Questo stato di cose anormale, il quale crea gravi imbarazzi finanziari alla nostra Società, che nondimeno ha mostrato di avere tante e tante utili iniziative, occorre che sia risolto con sollecitudine, la qual cosa sarà conseguita qualora a V.E. piaccia di ordinare che gli uffici dipendenti divengano senz'altro indugio alla stipulazione dei contratti e di esigere che siano subito dopo immediatamente applicati.
Noi non possiamo sopportare più a lungo un peso d'impegni che si cifrano a circa 40 milioni, ed io nutro fiducia che V.E. ben compreso della importanza di quanto mi sono onorato di esporLe, vorrà impartire le disposizioni che rispettosamente domando. Per la qual cosa porgo a V.E. i miei ringraziamenti anticipati, insieme con i sensi della mia profonda osservanza.
Della Eccellenza Vostra DevotissimoSocietà Anonima Italiana GIO ANSALDO & C. I L PRESIDENT E f.to Pio Perrone
N. 2619/ S. di protocollo. Riservatissimo . Confidenziale.
OGGETTO: Comm. Ferrone.
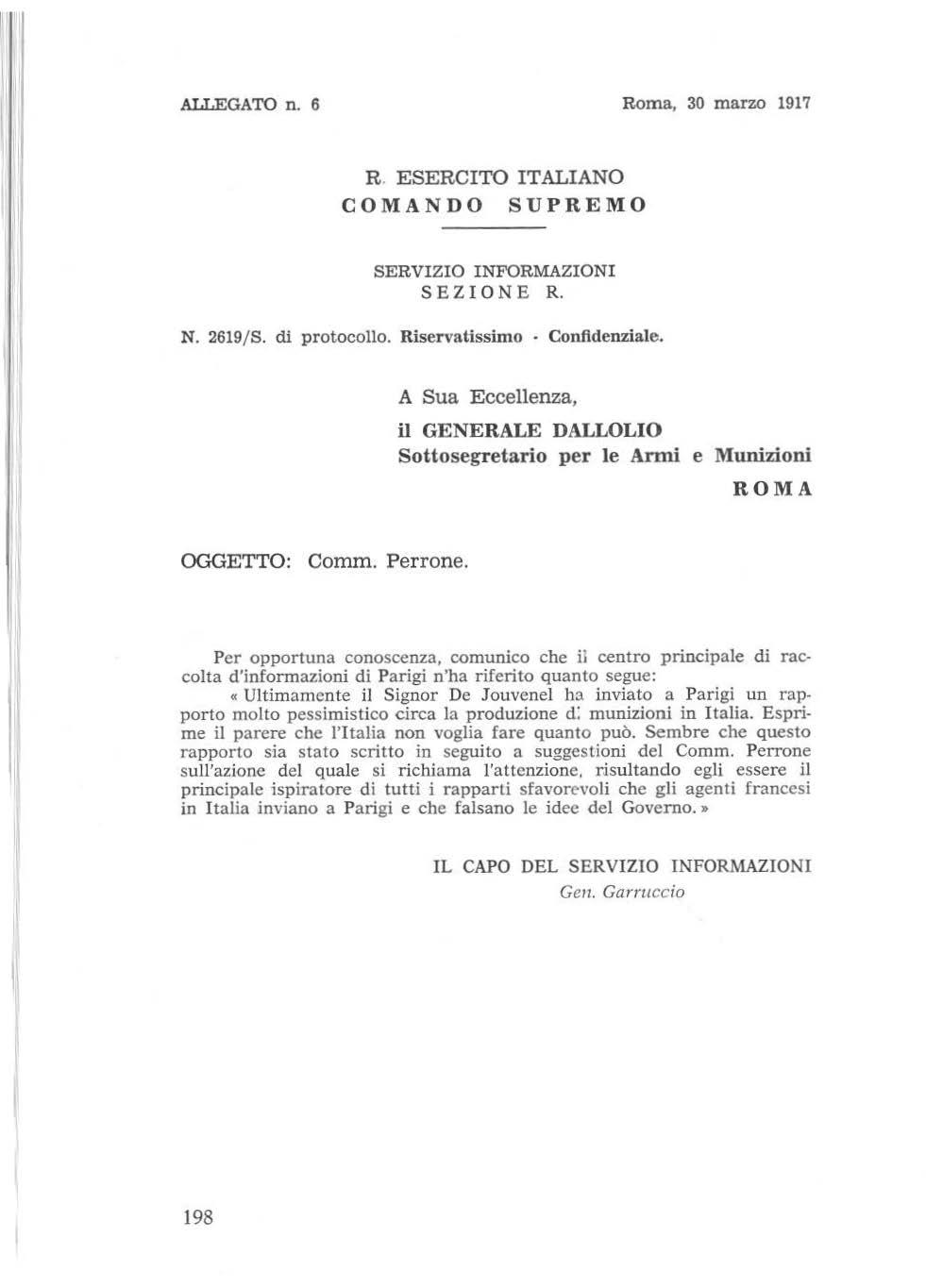
Per opportuna conoscenza, comunico che il centro principale di raccolta d'informazioni di Parigi n'ha riferito quanto segue:
« Ultimamente il Signor De Jouvenel ha inviato a Parigi un rapporto molto pessimistico circa la produzione d: munizioni in Italia. Esprime il parere che l'Italia non voglia fare quanto può. Sembre che questo rapporto sia stato scritto in segui to a suggestioni del Comm. Perrone sull'az ione del quale si richiama l'attenzione, risultando egli essere il principale ispiratore di tutti i rapparti sfavorevoli che gli agenti francesi in Italia inviano a Parigi e che falsano le idee del Governo. »
N. 3316

Al COMANDO SUPREMO · Uff. Tecn.
OGGETTO: Ditta Ansaldo & C.
La Ditta Ansaldo e C. ha adottato un sistema che è quello di mandare dei promemoria a quattro o cinque alte autorità compresa Casa Reale per uno stesso argomento - dopo avere parlato negli uffici del Ministero, tanto per dars i la maggiore importanza, per cui il Ministero mentre sta provvedendo riceve da tutti i lati raccomandazioni, comunicazioni, preghiere, invi ti - e l'argomento è sempre lo stesso - spesse volte già esaurito.
Il sistema del Comm. Perrone se fosse seguito dagli Orlando, Pecori, Ferraris ecc. porterebbe ad inconvenienti gravissimi sui quali non è il caso d'insistere, essendo più che sufficiente l'accenno - inoltre il tentativo di volersi creare una situazione privilegiata tipo Krupp, Schneider, Skoda non è da approvarsi tanto più conoscendo i metodi pei quali ha inclinazioni. Assicuro l'E.V. che per qualunque informazione il Ministero si farà un dovere di rispondere immediatamente e dettagliatamente ma prega vivamente perché il Comm. Perrone sia invitato a corrispondere solo col Ministero per argomenti che riguardano il Ministero stesso, e a non dilagare le sue corrispondenze. Per esempio circa le mitragliatrici mod. 1911 leggere, il Comm. P errone sapeva benissimo che non ce ne erano disponibili, tuttavia ne ha parlato, ha scritto al Ministero, ed ha fatto arrivare da diversi lati la stessa corrispondenza per avere sempre la stessa risposta. La questione dell'ex polverificio di Fossano fu subito risolta - si disse al Comando del Corpo di Armata di Alessandria di autorizzare i rappre. sentanti della Nobel di visitare l'ex polverificio di Fossano e di indicare loro ciò che si poteva cedere. Su1 posto, vedranno e riferiranno. Ma certamente arriverà anche dal Presidente del Consiglio una lettera del Comm. Perrone che torna a parlare dell'ex polverificio di Fossano ... L'industriale che ha tante ardite iniziative e promette di dare all'Italia stabilimenti di primissimo ordine deve però seguire la via normale e non tendere alla diseguaglianza nei rapporti d'ufficio.
Roma,
SOCIETA' ANONIMA
OGGETTO: Produzione di artiglierie.
Con lettera n. 33.P/271 del 30 Ottobre u.s. ebbi il pregio di informare la E.V. che il nostro Stabilimento di Artiglieria avrebbe consegnato, dal 26 di detto mese a tutto il 30 corrente, non meno di 470 bocche da fuoco campali di vario calibro e fatto il possibile per raggiungere la cifra di CINQUECENTO.
Sono lieto ed orgoglioso di poter significare alla E.V., che grazie allo zelo di tutto il personale ed al lavoro alacre ed indefesso delle maestranze, la suddetta cifra di CINQUECENTO bocche da fuoco sarà certamente raggiunta.
Mi tengo sicuro che V.E. apprenderà con legittimo compiacimento la notizia di questo sforzo, che sarà non solo mantenuto, ma superato se avremo un aumento di operai nella misura chiesta.
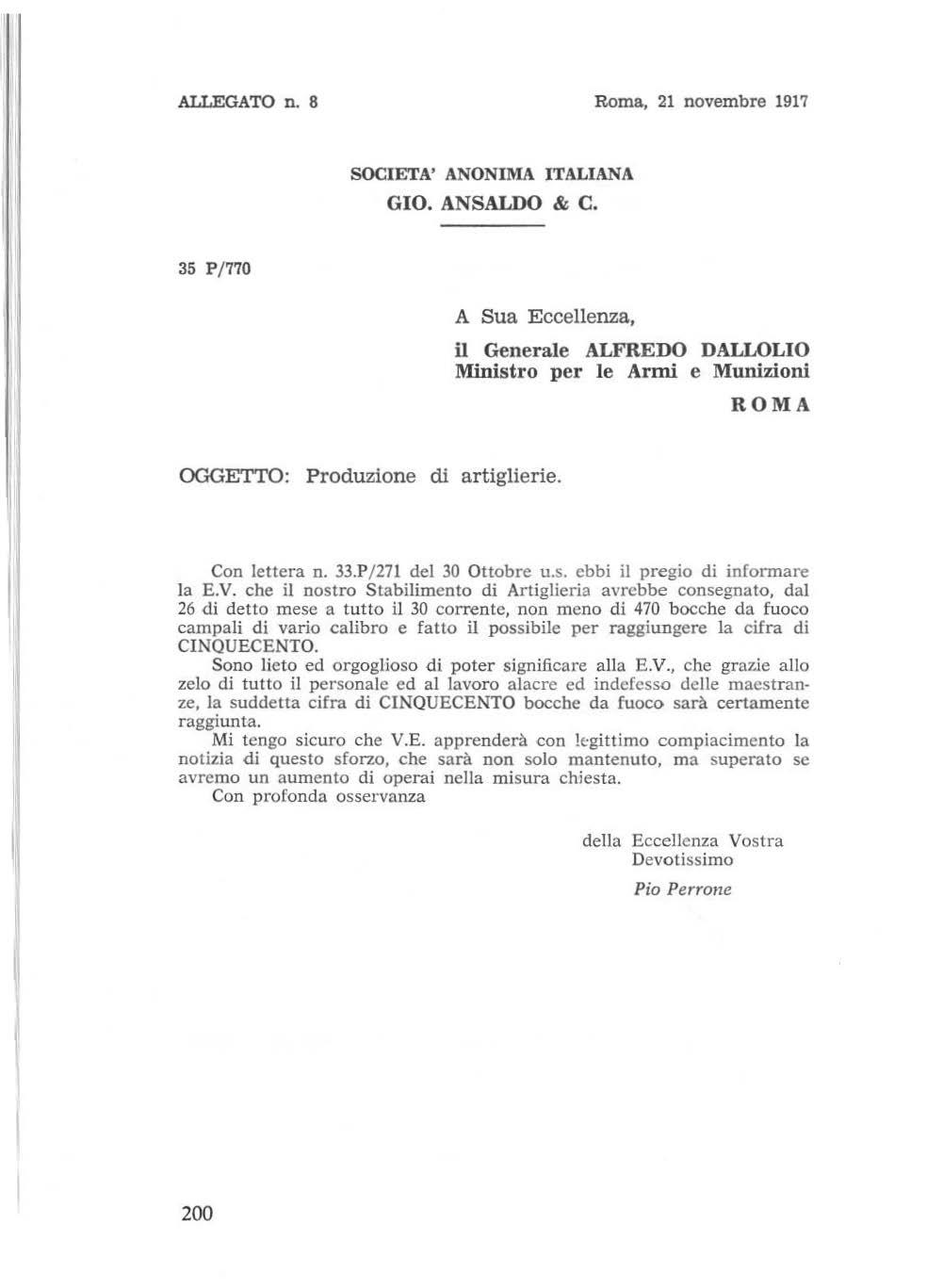
della Eccellenza Vostra Devotiss imo
Pio Perron e
200
PERSONALE RISERVATA
38/P.
IL GENERALE ALFREDO DALLOLIO
Ministro per le Armi e Munizioni ROMA
OGGETTO: Circa la produzione delle artiglierie.
Come é noto perfettamente a V E il metodo da noi finora seguito per la produzione delle artiglierie, e cioé di procedere alla costruzione di esse senza attendere le successive ordinazioni relatiYe, che m aturera nno a mano a mano, ci ha permesso di rispondere sempre con sollecitudine alle richieste di V.E.: cosl, per esempio - ultimo e recente esempio - noi potremo consegnare in questo mese di gennaio un considerevole numero di batterie da 105 appartenenti all'ultima ordinazione, il cui contratto è stato approvato appena in questi giorni; laddove, se avessimo atteso la conferma precisa della commessa prima di metterle in costruzione, non avremmo potuto iniziare le consegne prima del dice mbre di quest'anno. Avviene però, ora, nel ciclo delle lavorazioni inerenti alle arvi.glierie, che le acciaierie hanno non solo raggiunto, ma anche oltrepassato, la produzione degli elementi necessari a comporre tutti i cannoni ordinatici da V.E., cannoni che si trovano già nei diversi stadi successivi e che sarnnno ultimati e consegnati, nella quasi totalità, entro il primo semestre di quest'anno. Ma la nostra Società non può continuare nel sistema finora seguito e metter mano per proprio conto alla costruzione di nuove artiglierie, - oltre quelle, in più delle commesse, che sono avviate in certo numero, per i seguenti motivi:
1°) - Difficoltà finanziarie;
2°) - Eventualità della pace, nel quale caso rimarrebbe alla Società l'onere e la responsabilità della sua iniziativa.
Gli Uffici tecnici dipendenti a V.E. possono facilmente, quando lo vogliono, controllare l'esattezza di queste no~tre affermazioni; basterà che contino i cannoni in lavorazione nelle nostre officine per con s tatare che il loro numero supera quello dei canoni ordinatici, compresi quelli contemplati nei contratti stipulati in questi giorni.
D'altra parte, mentre non possiamo assumerci ancora il rischio di mettere in costruzione d elle artiglierie per conto nostro, ci corre l'obbligo di fare presente a V.E. che data l'attuale situazione dei lavori, qualora

in un momento dato occorressero al R. Esercito nuove bocche da fuoco, esso non potrebbe averle che molti mesi dopo l'ordinazione; a meno che un preciso provvedimento di V.E. non venga ad ordinarci di proseguire nelle lavorazioni, integrando di propria iniziativa, come ha fatto tante altre volte, i programmi mancati dal Comando Supremo.

Ed al riguardo oso pure richiamare l'attenzione di V.E. sopra un argomento di eccezionale gravità, cioé sulla riduzione della produzione dei proietti ordinata jn questi ultimi tempi dagli Uffici competenti del Dicastero delle Armi e Munizioni per la ragione che gli Uffici Tecnici del Comando Supremo domandano un quantitativo di proietti assai minore di quello che il Dicastero stesso provvede.
A parte la circostanza che V.E. ha molte e molte volte rilevato i gravi errori, di concetto e di previdenza degli Uffici Tecnici del Comando Supremo; quello, ad esempio, che ricordo per la profonda impressione che produsse nell'animo mio, di aver chiesto, in principio della guerra soltanto sei batterie da 105 (e V.E. ne fu tanto sorpreso che ordinò 60 di tali batterie, che poi risultarono ancora insufficienti al bisogno) è da notare che la quantità di proietti necessaria a logorare una sola volta tutte le bocche da fuoco da 105 (cannoni ed obici) in servizio ed in costruzione, non è inferiore a 10 milioni, come risulta da un calcolo semplicissimo in base al numero dei colpi che ciascuna di esse può sparare prima di essere erosa.
Ora, sta in fatto che mentre di tali proietti ne esistono due o tre milioni al massimo, gli Uffici Tecnici del Comando Supremo riducono ancora l'entità delle loro richieste. Ciò posto, devesi logicamente presumere che sia in corso un grave errore nel calcolare il fabbisogno delle munizioni e l'entità delle relative riserve, oppure quando ciò si escluda, che si stiano fabbricando troppe bocche da fuoco, nel quale caso converrebbe sospendere la produzione delle artiglierie e dedicare ad altre, più urgenti, l'attività che si spende per esse. Prego V.E. di gradire i sensi della mia profonda osservanza.
SOCIETA' ANONIMA ITALIANA GIO. ANSALDO & C.
Il Presidente f.to illeggibile
SOCIETA' ANONIMA ITALIANA
GIO. ANSALDO & C.
39/P. 195
Ill.mo Sig.
GENERALE DE ANGELIS
Ministero Armi e Munizioni
OGGETTO: Produzione che potremo riservare al R. Esercito nel secondo semestre del 1918 ripartita secondo i calibri.

Mi onoro di indicare qui appresso la produzione delle artiglierie, ripartita secondo i diversi calibri, che potremmo riservare al R. Esercizio per il secondo semestre dell'anno in corso:
CANNONI DA 70
Possiamo comodamente assicurare la consegna di cannoni di tale calibro entro l'anno.
Dovendo consegnare a termine di contratto . resta una disponibilità pel secondo semestre 1918 di cannoni da 70.
CANNONI DA 75
Possiamo assicurare la consegna di bocche da fuoco da 75 entro il 1918.
Dovendo consegnare a saldo di precedenti contratti resta una disponibilità pel secondo semestre 1918 di cannoni da 75.
CANNONI DA 76/45
N. 1.000
N. 200
N. 800
N. 1.600
N. 684
N. 916
Possiamo assicurare la consegna di
N. 200 bocche da fuoco da 76/45 tenuto conto degli impegni assunti verso il R. Esercito e verso la R. Marina a tutt'oggi resta una disponibilità per il secondo semestre 1918 di
N. 80 complessi da 76/45.
OBICI DA 105
Possiamo assicurare la consegna di . N. 100 batterie obici da 105. Tenuto conto delle batterie precedentemente ordinate resta una disponibilità pel secondo semestre 1918 di N. 75 batterie obici da 105.
Possiamo assicurare entro l'anno la con,;egna di batterie da 105. Tenuto conto delle . che restano a consegnare, res t a una disponibilità per il secondo semestre 1918 di batterie da 105.

OBICI DA 149
200
100
100
Possiamo assicurare entro l'anno la costruzione di . N. 200 batterie contribuendo per sole 500 bocche da fuoco (le rimanenti 300 dovrebbero essere fornite dall'amministrazione militare). Tenuto conto delle batterie già ordinate, resta una disponibilità per il secondo semestre 1918 di . N. 90 batterie di obici da 149.
La produzione dell'anno corrente è assorbita dalle commesse già date.
CANNONI DA 152/45
P ossiamo assicurare entro l'anno la produzione d i . N. 48 complessi da 152/45. Tenut o conto dei 16 complessi che restano a consegnare al R. Esercito, vi ha luogo a considerare una disponibilità di N. 32 complessi da 152/45.
Più ancora calcoliamo di poter dare n. 122 bocche da fuoco assortite prevalentemente da 105.
RIASSUMENDO: potremmo impegnarci a fornire per l'anno corrente oltre i materiali già commessi, almeno:
N. 800 cannoni da 70
» 916 cannoni da 75
» 80 canno ni da 76/45
» 300 obici da 105
» 400 cannoni da 105
,. 360 obici da 149
)> 32 cannoni da 152/4:>
)> 122 bocche da fuoco isolate assortite
complessivamente N. 3.000 complessi.
Con profondo ossequio
Dev.rno F.to illeggibil e
N. 328283
Risposta ai fogli 38 P 310 in data 3 corr. 39 P 195 in data 15 corr.
Piazza Colonna 366
e per conoscenza
ALLA SOCIETA' GIOVANNI ANSALDO & C. SAMPIERDARENA
OGGETTO: Produzione di artiglierie e nuove commesse.
In risposta ai fogli sopra indicati, questo Ministero notifica quanto segue per quanto concerne la produzione delle artiglierie esposta in modo particolareggiato nel foglio del 15 corrente (N. 39 P 195):

1°) CANNONI DA 70 MONTAGNA
AJJa data del 1° corrente risultano ancora da allestire 206 cannoni per i quali rimangono da fucinare 135 elementi.
Come già venne notificato non si daranno ulteriori commesse della predetta bocca da fuoco.
2°) CANNONI DA 75/906
Alla data del 1° corrente risultano ancora da allestire 584 cannoni, per i quali vennero già tutti fucinati gli elementi con un'aliquota di 70 in più delle attuali commesse.
Verrà data in questi giorni una nuova commessa di 500 cannoni.
3°) CANNONI DA 76/45 E RELATIVE INSTALLAZIONI
Alla data del 1° corrente risultano ancora da allestire 97 cannoni da 76/45 con 73 installazioni.
Verrà data in questi giorni una nuova commessa di 40 complessi, commessa da esaurirsi entro il prossimo settembre.
4°) OBICI DA 105
Si attenderanno i risultati delle prove definitive del nuovo materiale da 105 e se - come non dubitasi -i risultatL saranno pienamente soddisfacenti verrà data una nuova commessa di altre 50 batterie.
Per queste ultime 200 bocche da fuoco risultano già fucinati 180 elementi.
5°) CANNON I DA 105
Alla data del 1° corrente risultano ancora da allestire 654 cannoni con 416 affusti ed i rimanenti materiali per 70 batterie. Per le 654 bocche da fuoco sono ancora da fucinare tutti gli elementi unitamente a 263 elementi delle precedenti.
Verrà data in questi giorni una nuova commessa di trenta batterie.
6°) OBICI DA 149 CAMP.
Alla data del 1° corrente risultano da allestire ancora 379 obici con 368 affusti e rimanenti materiali per 70 batterie Per i 379 obici rimangono ancora da fucinare solo 50 serie di elementi.
Come venne ripetutamente notificato è assolutamente necessario che venga notevolmente aumentata la produzione degli obici così da raggiungere il numero di 60 obici al mese.
Verrà data in questi giorni una nuova cr,mmessa di trenta batterie ed una commessa di 200 serie di elementi per obici da 149 camp da mettere a disposizione di questo Ministero nel periodo dal marzo a tutto giugno e.a.
7°) CANNONI DA 149 A
Alla data del 1° corrente risultano ancora da allestire 164 cannoni per i quali sono ancora da fucinare 126 serie di elementi. Tale rimanenza di cannoni assorbirà la produzione di codesta Società fino alla fine dell'anno in corso.
Verrà data commessa in questi giorni di n. 100 serie di elementi per cannoni da 149 A. da esaurirsi nel periodo da marzo a tutto giugno c. a. Le 100 serie saranno tenute a disposizione di questo Ministero.
8°) CANNONI DA 152/45
Rimangono ancora da allestire aJla data del 1° corrente 17 cannoni da 152/ 45 e 9 installazioni.

Verrà data in questi giorni una nuova commessa di 20 complessi da 152/45.
9'>) MORTAI DA 260 SA.
Alla data del 1° corrente rimangono da allestire 60 mortai da 260 S.A. con 74 installazioni. Più 4 mortai da 260 S. Non verranno date ulteriori commesse di dette bocche da fuoco .
100) MORTAI DA 210 AD ORECCH IONI
Verrà data in questi giorni una nuova commessa di 100 mortai da 210 ad orecchioni da esaurirsi nel periodo giugno ottobre del corrente anno.
Con le lavorazioni per l'esaurimento delle commesse in corso e con le nuove commesse viene coperta per talune bocche da fuoco la produzione per l'intero anno in corso e per le bocche da fuoco rimanenti fino ad oltre il terzo trimestre del corrente anno.
Le commesse accennate di 300 serie di elementi per obici e cannoni da 149 renderanno possibile un aumento di produzione di queste bocche da fuoco nel terzo trimestre del corrente annc in più della produzione che sarà data dagli Stabilimenti di codesta Società permettendo, in pari tempo, di aumentare la produzione delle Acciaierie Ansaldo.
Pregasi accusare ricevuta.
Verbale della Seduta del 26 novembre 1916, ore 10,30, tenuta nella Biblioteca del Ministero della Guerra.

Sono presenti:
S. E. l'On. Prof. Paolo Bonelli, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato Supremo delle Armi e delle Munizioni.
S. E. il Generale Paolo Morrone, Ministro della Guerra, Membro del Comitato Supremo delle Armi e delle Munizioni.
S. E. il Vice-Ammiraglio Camillo Corsi, Ministro della Marina, Membro del Comitato Supremo delle Armi e delle Munizioni.
S. E. il Generale Alfredo Dallolio, Sottosegretario di Stato per le Armi e Munizioni, Membro con voto consultivo del Comitato Supremo delle Armi e delle Munizioni, Presidente del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.
S. E. l'On. Prof. Vittorio Emanuele Orlando, Ministro dell'Interno.
S. E. l'On. Leonida Bissolati Bergamaschi, Ministro di Stato.
S. E. il Generale Vittorio Alfieri, Sottosegretario di Stato per la Guerra.
S. E. l'On. Prof. Ugo Ancona, Sottosegretario di Stato per i Trasporti, Ex membro del Comitato Centrale per la Mobilizione Industriale
Il Vice-Ammiraglio Giulio Bertolini, Membro del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.
Il Generale Alfeo Clavarino, Membro del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.
Il Generale Morra di Lavriano Conte Roberto, Senatore del Regno, Membro del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.
Il Comm. Erasmo Piaggio, Senatore del Regno, Membro del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale
L'On. Dottor Angiolo Cabrini, Deputato al Parlamento, Membro del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.
Il.Grand'Uff. Avv. Pio Carbonelli, Consigliere di Stato, Membro del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.
Il Grand'Uff. Federico Brofferio, Direttore Generale del Tesoro, Membro del Comitato Centrale per la Mobilitazione Tndu striale
Il Comm. Ing. Prof. Cesare S.aldini, Mebro del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.
Il Prof. Ing. Ugo Bordoni, Ex membro del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.
Il Capitano Toniolo Cav. Enrico, Segretario del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.
Per il Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale di Torino:
Il Generale Morelli cli Popolo Comm. Alberto, Presidente.
Il Comm. Bonelli Ing. Enrico, Membro Civile.
Il Comm. Ferraris Iog. Dante, Rappresentante industriale.
Il Signor Colombino Emilio, Rappresentante operaio.
Il Tenente Fano Prof. Gino, Segretario.
Per il Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale di Milano:
Il Generale Sardegna Comm. Carlo, Pres idente.
Il Senatore Esterle Ing. Carlo, Membro Civile.
Il Comm. Pontiggia Ing. Luigi, Membro Civile.
Il Senatore Salmoiragh:i Ing Angelo, Rappresentante industriale.
Il Signor Buozzi Bruno, Rappresentante operaio.
Il Tenente Garbagni Ing. Mario, Segretario.
Per il Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale di Genova:
Il Contrammiraglio Coltelletti Comm. Giuseppe Ettore, Presidente.
L'On. Marchese Reggio Ing. Giacomo, Membro Civile.
Il Cav. Moresco Ing. Bartolomeo Francesco, Rappresentante industriale.
Il Signor Ancillotti Ferruccio, Rappresentante operaio.
Il Maggiore Bozzo Ing. Edoardo, Segretario.
Per il Comitato Regionale di Mobilitazione Industirale di Bologna:
Il Generale Piana Comm. Ettore Luigi, Presidente.
Il Senatore Tanari Marchese Giuseppe, Membro Civile.
Il Marchese Ferrere de Gubernatis Ing. Emanuele, Rappr. industriale.
Il Signor Frizzola Luigi, Rappresentante operaio.
Il Capitano Morselli Ing. Goffredo, Segretario.
Per il Comitato Regionale di Mobiltiazione Industriale di Roma:

Il Contrammiraglio Fiordelisi Comm. Donato, Presidente.
L'On. Molina Ing. Rodolfo, Membro Civile.
Il Comm. Perrone Pio,Rappresentante industriale.
Il Signor Gerardi Alberto, Rapresentante operaio.
Il Capitano Fiorentini Ing Filippo, Segretario.
Per il Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale di Napoli:
Il Contrammiraglio Borrello Comm. Edoardo, Presidente.
Il ·Conun. Masoni Iog. Ulderi.co, Membro Civile.
Il Conte Pecari GiraJdi Ing. Alessandro, Rappresentante industriale.
Il Signor Longobardi Giuseppe, Rappresentante operaio.
II Capitano Matetri Ing. Luigi, Segretario.
Per il Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale di Palermo:
Il Generale Di Blas i Comm. Raffaele, Presidente.
Il Comm. Ovazza Prof. Elia, Membro Civile.
Il Comm. Ducrot Vittorio, Rappresentante industriale.
Il Signor Di Giovanni Pasquale, Rappresentante operaio.
Il Capitano Salibra Avv. Vincenzo, Segretario.
Assistono alla seduta anche:
Il Comm. lng. Rkcardo Bianchi, Capo dell'Ufficio Approvvigionamenti Materiali metallici del Sottosegretariato per le Armi e Munizioni.
Gli Ufficiali del Gabinetto di S . E. il Generale Dallolio:
Ten. Colonnello Mazzoni Cav. Mario e CapHano Cauda. Gli Ufficiali dell'Ufficio Segreteria del Comitato Centrale per la Mobilìtazione Industriale:
Tenente Maggiorani Ing. Cav. Augusto. Tenente Scheggi Ing. Alessandro. Sottotenente Grugnola Avv . Renzo.
Anno scusato la propria assenza:
S. E. l'On. Barone Sidney Sonnino,Ministro degli Esteri, Membro del Comitato Supremo delle Armi e delle Munizioni, per imprescindibili impegni.
S . E. l'On. Paolo Carcano, Ministro del Tesoro, Membro del Comitato Supremo delle Armi e Munizioni, in missione all'estero.
Prende fa parola S. E. il Generale Dallolio il quale così esordisce:
Eccellenze, Signori,
La Mobilitazione Industriale Italiana che in passato era cinta di veli, ebbe a Milano, da S. E. il Presidente del Consiglio, un tributo di cordiale generosità e riconoscimento profondo. Oggi l'intervento di S. E. Boselli, dei membri del Comitato Supremo delle Armi e delle Munizioni e di amici specialissimi, non dell'ultima ora, costituisce un motivo di maggiore incoraggiamento al lavoro, con la speranza di aumentare la fiducia nella pubblica attesa. Dò a tutti gli intervenuti il benvenuto e, mentre mi accingo a dare lettura della relazione, ripeto quanto è detto nella chiusa della prefazione del nostro Regolamento: « per il presente e per l'avvenire compie opera sacra alla Patria chi alla Mobilitazione Industriale dà il tributo delle sue maggiori energie ».
Provvedimenti legislativi per la mobilitazione industriale.
Il Regio Decreto 26 giugno 1915, n. 993, integrato dal Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277, con la relazione che lo precede, costituiscono gli elementi sui quali venne fondato l'istituto della Mobilitazione Industriale, l'organo cui fu affidato il compito di organizzare, regolare e disciplinare tra loro, tenendole unite e volte ad uno stesso fine , quello della massima produzione di materiale bellico, le energie attive, industriali ed operaie del Paese.
Lo sviluppo rapido di una quantità di industrie nuove, l'ingrandimento o la trasformazione di impianti esistenti, l'accrescimento repentino delle masse operaie, e la creazione di nuove maestranze, la grande diversità

delle condizioni industriali delle varie R egioni d'Italia, la differenza di abitudini, di cultura e di attitudini nelle popolazioni, esigevano un organismo « semplice, decentrato e sollecito, con organi esecutivi locali, atti ad agire rapidamente, in contatto diretto cogli uomini, colle cose e con le c.,uestioni da risolvere», che agisse con la maggiore possibile uniformità in tutto il Paese, ricevendo istruzioni generali e concetti direttivi da un centro unico, che fosse sotto l'influenza immediata del Governo, e che infine assicurasse agli operai « sia civili che militari un equo trattamento, e la facoltà di ricorso, ove si credessero lesi nei loro diritti, senza però ammettere la menoma interruzione di lavoro ».
Ad un anno e mezzo di distanza dalla sua fondazione , si può dire che la Mobilitazione Industriale in Italia, per l'oper:t attiva ed intelligente dei Comitati Regionali, coordinata de integrata da quelle del Comitato Centrale, ha pienamente risposto ai fini che il Governo si proponeva, ed alle necessità nelle quali si è venuto a trovare il nostro Paese, necessità in moltissimi casi ben diverse da quelle presentatesi ad altre Nazioni.
Malgrado la maggioranza delle nostre industrie, ancor giovani, non avesse potuto svilupparsi e consolidarsi in passalo, come si era verificato all'estero, malgrado la scarsità di alcune materie prime fondamentali, malgrado la limitazione dei mezzi di trasporto, specialmente marittimi, l'industria italiana in brevissimo volger di mesi ha dato prove così bri.1lanti di intraprendenza, di genialità e di forza, da destare il più che legittimo orgoglio in noi stessi, e la ammirazione delle Nazioni nostre alleate
Contributo dell'Italia alla c ausa degli Alleati.
Il contributo che l'Italia porta in tal modo alla causa comune, contro il comune nemico, non è solo quello, importantissimo, delle azioni militari affidate al nostro valoroso esercito combattente, ma anche quello che l'esercito lavorante nelle officine dà oggi, e potrà dare in avvenire, permettendo l'invio ad alcuni dei n-0stri alleati, di materiali bellici di varia ed importante natura.

Quest'ultima forma di aiuto ha poi una speciale importanza, non solo immediata, inquantocbé gli strumenti ed i materiali di guerra italiani costituiscono il più sicuro ed apprezzato modo di aprire i mercati futuri, di quelle stesse nazioni, ai prodotti di pace che le nostre officine saranno domani chiamate a produrre.
I risultati ottenuti nel campo dell'organizzazione produttiva sono certamente dei più confortevoli e costituiscono la migliore garanzia che ben altro ed ancor più, saremo in grado d i fare, nel corso dei prossimi mesi, quando ci vengano assicurate quelle materie prime di cui abbiamo bisogno, in più di quelle che produciamo noi ed il cui incremento, oltre certi determinati limiti, non si può, oggi, assolutamente ottenere.
Il cammino percorso, se da un lato ci può e ci deve soddisfare, dall'altro ci deve spronare a tendere ancora ed in misura sempre maggiore tutte le nosti-e forze, tutte le nostre energie morali e materiali, per uno sforzo produttivo ancora maggiore.
A tutt'oggi, oltre i 66 stabilimenti militari impieganti 21.645 operai e 12.474 operaie, abbiamo 932 stabilimenti dichiarati « ausiliari» con una massa di ben 399.955 lavoratori, fra i quali circa 55.253 donne. Degli stabilimenti « ausiliari » 91 sono dediti alla produzione di materiali metallici, mentre 489 sono dediti a lavorazioni meccaniche, in massima parte bocche da fuoco, proiettili, bombe da bombarde, bombe a mano, cartucce da fucile, materiale da aviazione ed a u tomobilistico, ecc. I rimanenti stabili-
menti « ausiliari », in numero di 352, comprendono le fabbriche di esplosivi, quelle di prodotti chimici, industrie minerarie ed estrattive, cd industrie varie.

A questi si aggiungano ben 1.181 stabilimenti meccanici minori, non ausiliari, sparsi in ogni regione d'Italia, nella quasi totalità impiegati alla produzione di proiettili di piccolo e medio calibro, con una massa totale di 34.866 operai, dei quali 4.597 donne.
I n totale quindi possiamo dire che, direttamente od indirettamente interessanti il munizionamento, e l'armamento, abbiamo oggi circa 2.179 stabilimenti, con un esercito di 396.616 operai e di 72.324 donne, i quali ininterrottamente e disciplina tamente, nel fronte in1erno, in tegrano l'opera dei loro fratelli combattenti, cui forniscono in misura sempre più abbondante, e con sempre crescente perfezione, strumenti di offesa e di difesa.
La produzione raggiunta.
Il frutto del lavoro di questo colossale e bene organizzato esercito di industriali ed operai è costituito dalla produzione mensile di centinaia di cannoni di piccolo, medio e grosso calibro, di centinaia di bombarde d'ogni tipo, di mil ioni di proiettili di tutti i calibri, di decine di migliaia di fucili, di molti milioni di cartucce, di centinaia di migliaia di bombe da sparo ed a mano, di parecchie centinaia di camions, di qualche migliaio di tonnellate di esplosivi di vari tipi, e di mille e mille altri materiali d'artiglieria e del genio, delle più svariate qualità. Rimorchiatori, barche da ponte, paletti da reticolati e corde spinose, lamiere per blindamenti e coperture, scudi portatili, elmetti, carreggio d'ogni genere, strumenti da lavoro, apparecchi elettrici, telegrafici, telefonici, proiettori, apparecchi d 'ottica della più scrupolosa esattezza, finimenti e bardature speciali pel trasporto e l'impiego d'ogni materiale, aerostati, dirigibili, aeroplani con tutti gli annessi meccanismi per servizi accessori, natanti, motoscafi, sottomarini, siluri, torpedini, siluranti e naviglio di guerra, quanto insomma di più potente e di più perfezionato producono la meccanica, la chimica, la fisica e tutte le altre scienze che possiamo affermare essere oggi completamente utilizzate e mobilitate per la difesa e la grandezza del Paese, è frutto dell'ingegno e del lavoro italiano, e rappr esenta lo sforzo di centinaia di migliaia di braccia lavoratrici, e di migliaia di menti organizzatric i industriali, che opportunamente raggruppate e coordinate dalla Mobilitazione Industriale, hanno messo m valore la potenzialità produttiva del nostro Paese, sviluppando in noi una coscienza industriale e delle attitudini tecniche che non sono certo seconde a quelle di altri popoli e di altre nazioni.
Per le necessità dell'oggi e per la posizione futura dell'Italia nelle competizioni internazionali, nei campi del commercio e del lavoro, sarà questo uno dei grandi vantaggi apportatici dalla guerra, e sarà uno dei maggiori vanti della Mobilitazione Industriale l'avervi contribuito.
L'increm ento continuo di questa organizzazione, che viene abbracciando ogni giorno sempre nuove officine e sempre nuove iniziative, il favore crescente che essa incontra sia nella classe industriale che in quella operaia, per l'agilità e la spigliatezza dei suoi organi, la rapidità e la praticità dei suoi provvedimenti, l'equità delle sue deliberazioni in materia economica, il piede di eguaglianza e la serenità d'ambiente entro il quale si sono potuti sensibilmente migliorare, con reciproco vantaggio, i rapporti fra capitale e lavoro, han fatto sì che i Comitati di Mobilitazione Industriale si siano andati sempre più allargando e perfezionando anche nella costi-
tuzione dei singoli Uffici specializzati, nei quali danno tutto il loro contributo di intelligenza e di attività, elementi preziosi civili e militari, scelti, anche questi ultimi, con rigorosi criteri di attitudine e competenza tecnica.

Il Comitato Centrale è lieto di approfittare di questa occasione per tributare a questi preziosi collaboratori un sentito elogio ed un vivo ringraziamento, per l'opera silenziosa, ma feconda di risultati, fino ad oggi prestata, certo che essi trarranno dai risultati ottenuti, argomento per nuove conquiste e nuove affermazioni nell'interesse del Paese.
Varie forme di iniziative indus triali. Macchine utensili. Controllo siderurgico. Industrie elettriche.
Fra le varie e più importanti iniziative affidate alla Mobilitazione Industriale e da questa felicemente condotte a termine, oltre al compito principale della organizzazione della produzione, è doveroso accennare al valido contributo da essa apportato all'incremento della fabbricazione delle macchine utensili; all'accertamento tecnico rigoroso sui mezzi di produzione delle nostre industrie siderurgiche, che ha permesso la compilazione esatta di un quadro completo dei provvedimenti presi e da prendere per aumentare, come fu fatto, la produzione dell'acciaio; l'inchiesta eseguita su tutte le Società elettriche, con compilazione dei grafici delle reti di distribuzione, primo lavoro completo :n questo campo, che, oltre permettere lo studio, su elementi positivi, di eventuali allacciamenti fra le singole Società produttrici, per un mutuo sussidio in caso di deficienza di forza o di incidenti, permette anche di studiare, come si sta facendo, una serie di provvedimenti atti alla migliore e più completa utilizzazione dell'energia elettrica.
Servizio rottami. Servizio trasporti. Combustibili liquidi. Mano d'opera militare. Servizio esonerazioni.
L'organ izzazione del servizio ·raccolta, acqu1~to, distribuzione dei rottami metallici esistenti in paese, sottraendo questa materia prima di capitale importanza per le acciaierie, alle manovre accaparratrici degli speculatori; la regolarizzazione dei trasporti ferroviari interessanti gli stabilimenti ausiliari, per mezzo di un vero ufficio di assegnazione vagoni, istituito d'accordo con le Commissioni Militari di Linea; la distribuzione razionale e controllata dei combustibili liquidi, ed essenzialmente della benzina, alle industrie del munizionamento; il reclutamento e la distribune della mano d'opera militare, tratta dai depositi territoriali; l'ufficio delicatissimo delle esonerazioni per tutto il personale minitare degli stabilimenti ausiliari e di quelli non ausiliari, ma comunque interessanti il munizionamento
Con tutti questi organi, i Comitati R egionali hanno fedelmente ed esaurientemente assolto il mandato loro affidato dall'art. 5 del Regolamento sulla Mobilitazione I ndustriale, quello cioé di agevolare « efficacemente i rapporti fra gli stabilimenti ed i servizi militari da un Iato, e gli stabilimenti ausiliari dall'altro affiché l'opera cumulativa riesca vieppiù feconda per la produzione e l'approvvigionamento dei materiali da guerra ».
La mobilitazione industriale nel campo economico.
Nel campo d e ll'economia e del disciplinamento delle masse operaie, la Mobilitazione Industriale ha compiuto opera non meno utile nell'interesse generale del Paese, ed in quello particolare delle masse lavoratrici.
L'art. 6 del Regolamento sulla Mobilitazione Industriale, dispone che tutte le controversie economiche che possono sorgere fra industriali e maestranze d i stabilimenti dichiarati «ausiliari», debbano essere imme-
diatamente deferite ai Comitati Regionali di mobilitazione industriale.
All'entrata in vigore di tale disposizione, fu notata come una incertezza ed una indecisione forse di aspettativa, per ambo le parti interessate.
Gli industriali temevano che un consesso formato anche con la rappresentanza di membri operai tendesse a concedere eccessivi miglioramenti economici, anche per quella naturale :;c,ntrarietà a permettere che altri esaminasse questioni interne delle aziende; la massa operaia riteneva al contrario che un Ente, sia pure costituito essenzialmente da elementi borghesi, risentisse troppo dell'Autorità militare da cui dipende, e come tale si mostrasse meno accessibile alle richieste anche giustificate di benefici finanziari.
Sorpassato facilmente il primo periodo d'avviamento, quando, sia per parte delle Direzioni degli stabilimenti che delle maestranze, fu effettivamente constatato come questo collegio arbitrale delle mercedi operaie, nell'emettere le proprie sentenze, s'ispirava u giusti ed obiettivi sensi di equità e di giustizia, affluirono le domande di miglioramenti e le vertenze, tutte debitamente esaminate, vagliate, furono risolte con reciproca soddisfazione delle parti interessate

Si può oggi affermare che la massima parte di tali controversie fu amichevolmente composta coll'intervento dei Comitati regionali.
Soltanto in casi rarissimi, e dopo aver espletate tutte le opere di conciliazione, essi s'indussero ad emettere le ordinanze, contro le quali soltanto per 13 controversie fu prodotto ricorso al Comitato Centrale.
Di tali vertenze bavvenne attualmente un considerevole numero per le quali i Comitati debbono ancora emettere il loro giudizio; ma si può ormai assicurare che i principali stabilimenti ausiliari hanno visto regolate e fissate le mercedi operaie dai Comitati regionali di Mobilitazione Industriale.
Criteri seguiti nei componimenti.
Furono seguite due diverse forme per deliberare sugli aumenti di paga; la prima, quella di un miglioramento percentuale a seconda delle diverse categorie di operai e più specialmente a seconda dei loro guadagni giornaEieri, paga ordinaria, straordinaria e cottimo compresi. La seconda, quella oggi maggiormente adottata, -:oncedendo un'indennità giornaliera per caro-viveri, o come altri la chiama, un soprassoldo di guerra, variabile da 30 a 60 centesimi a seconda delle mercedi percepite dalle diverse categorie di maestranze.
Vertenze economiche risolte.
Le vertenze economiche risolte per l'amichevole interposizione dei Comitati Regionali, ammontano fino ad oggi a 130.
Quelle risolte con lodi arbitrali, senza she essi originassero ricorsi, furono in numero di 19.
Quelle risolte con ordinanza dei Comitati Regionali, alla quale segul ricorso di una o di tutte e due le parti intere10sate, e quindi con conseguente ordinanza del Comitato Centrale, furono in numero di 13.
In totale, la massa operaia che beneficiò dei miglioramenti economici conseguiti, sia per amichevole intervento o per mezzo di lodi emessi dai Comitati Regionali, è riferibile a numero 161 stabilimenti ausiliari, per un complesso di 137.268 individui
Il problema dei cottimi.
A complemento di questa parte economico-lavorativa, riflettente le maestranze appartenenti agli stabilimenti ausiliari, devesi 1icordare che una Commissione, appositamente nominata dal Comitato Centrale per la
Mobilitazione Industriale, con rappresentanza paritetica di elementi industriali ed operai, ebbe di recente a studiare la grave e complessa questione dei cottimi per gli stabilimenti che interessano il munizionamento.
La precitata Commissione ha concordato e tracciato delle considerazioni generali e delle direttive di massima, pienamente approvate dal Comitato Centrale di Mobilitazione I ndustriale, il quale, nel portarle a conoscenza dei dipendenti Comitati Regionali, ha stabilito che, nell'esame di questioni simi,li, essi vi si attengano e vi si unformino.

La sorveglianza disciplinare.
Per quanto ha attinenza alla disciplina delle masse operaie, ed alla sorveglianza sugli stabilimenti ausiliari, il servizio può dirsi ormai soddisfacentemente avviato.
L'art. 22 del Regolamento sulla Mobilitazione Industriale stabilisce che alla sorveglianza disciplinare del personale appartenente a stabilimenti dichiarati ausiliari, deve essere preposto un Ufficiale o, in difetto, il Comandante della locale Stazione dei RR. CC.
L'art. 15 dello stesso Regolamento stabili~ce che tutto il personale apartenente agli stabilimenti ausiliari è soggetto alla giurisdizione militare. Con disposizioni ministeriali successive, si stabiliva che a tutti gli individui facenti parte di stabilimenti dichiarati ausiliari, comunque soggetti ad obblighi di leva, fossero applicabili i rigori punitivi del Regolamento di disciplina per l'Esercito.
Su questi cardini fondamentali si è andato gradualmente impostando tutto il servizio di sorveglianza disciplinare, oggi assurto a sì considerevole importanza.
Codice penale per l e maestranze militarizzate.
La pratica ormai acquisita in più che un anno di suo funzionamento, la voce concorde delle Autorità Militari preposte a tale Ufficio, e dei Comitati Regionali di Mobilitazione Industriale, che tanto da vicino seguono ed accompagnano la vita ascensionale delle nostre officine di guerra, avevano suggerita la necessità di completare quella nuova e non ben delineata legislazione, con un Codice Penale che, opportunamente temperando e mitigando le rigide sanzioni contemplate nel Codice Penale per l'Esercito, dovesse applicarsi a tutto il personale sottoposto a quella speciale forma di militarizzazione.
Tale Codice, vivamente invocato anche dai Tribunali Militari per fa. cilitare e sollecitare il loro arduo compito, già approvato dal Consiglio dei Ministri e firmato da S. A. R. il Luogotenente del Re, verrà in questi giorni pubblicato.
Demarcate nettamente, attraverso ripetute circolari del Sottosegretariato Armi e Munizioni, il compito dei preposti alla funzione disciplinare degli stabilimenti ausiliari, giustamente sot·traendo dalla loro competenza tutte le questioni che rivestivano carattere tecnico od economico, può oggi fermamente asserirsi che i Comandi di Divisione, rivestiti di tale delicatissima mansione, rispondono egregiamente alle aspettative riposte.
La facile invadenza nel campo delle altrui competenze, originata forse dalla inesatta interpretazione delle disposizioni vigenti, provocò agli inizi, qualche isolata protesta; ma il richiamo energico, ed alcune severe punizioni, valsero a ricondurre la funzione dell'organismo sulla giusta e ben delineata sua via.
Certo la imposta presenza dell'Autorità Militare in ambienti dove fino allora rinfrenati svolgevansi i conflitti fra capitale e lavoro, fu mal giudicata e compresa.
Le masse lavoratrici vi intravedevano il simbolo del ferreo rigorismo
militare; le direzioni degli stabilimenti l'ingerenza intollerante nel campo delle loro esclusive attribuzioni.
E legittimo motivo di soddisfazione veder oggi confermata e richiesta da ambo le parti interessate la presenza di quella Autorità che niente altro prelende se non la garanzia che tutti sian protesi nel più intenso sforzo, indispensabile per corrispondere alle infinite e vitali esigenze del nostro Esercito in guerra.
Per formarsi un preciso concetto dei benefici conseguiti con il contributo del servizio di sorveglianza disciplinare, basterebbe esaminare e consultare le relazioni mensili ed i dati statistici compilati con ben inteso fervore dalle competenti Autorità Militari.
Assenze e p unizioni.
Si rileva da quei grafici riassuntivi, che la percentuale media delle assenze di tutte le masse operaie mobilitate è venuta gradualmente diminuendo, fino a ridursi al limite minimo possibile. Ciò ha tanto maggiore importanza quando si pensi che assenza equivale a mancata produzione.
Si rileva dagli stessi grafici, che le punizioni, i licenziamenti ed i deferimenti ai Tribunali Militari, tendono sensibilmente a diminuire.
Ciò anche significa che quell'esercito delle officine è andato ormai adattandosi ed uniformandosi a tutti i vincoli ed a tutte le restrizioni imposte con la più ben intesa disciplina.
Certo, il compito più importante dell'istituto di sorveglianza disciplinare è quello di prevenire in tempo ogni movimento od agitazione di masse operaie, nel precipuo scopo della continuità di lavoro e di produzione.

Anche tale mansione fu lodevolmente assolta. Ne è prova il fatto che, tolti alcuni sporadici, incomposti moti, immediatamente repressi con l'energico intervento dell'Autorità Militare o per l'amichevole interposizione dei Comitati Regionali (se la vertenza rivestiva carattere economico), non si ha fino ad oggi a registrare nessun vero, serio inconveniente.
Devesi aggiungere che l'organismo, sapientemente preparato, potrebbe domani rispondere, nella non •augurabile eventualità di agitazioni più vaste e pericolose
Personale addetto alla sorveglianza.
T anto si è Tiusciti ad ottenere con 363 ufficiali, scelti tra gli inabili alle fatiche di guerra, alla riserva, o nelle classi anziane della milizia territoriale, e con 46 sottufficiali dei RR. CC.
E si pensi che sono oggi 932 gli stabilimenti ausiliari, con una massa operaia che si avvicina al mezzo milione.
Per la sorveglianza esterna di quegli stabilimenti, che per le loro speciali condizioni o lavorazioni, richiesero la necessità di speciali tutele, fu provveduto con l'assegnazione di drappelli di truppa, che vi prestano servizio continuo o saltuario, a seconda della diversa importanza.
Sono circa 5.500 militari di truppa e non più che assolvono tale incarico per tutte le fabbriche di esplosivi, per tutte le aziende elettriche, per tutte le acciaierie e per quegli altri principalissimi stabilimenti per cui è dovere del Paese proteggere l'incolumità degli impianti.
Sorveglianza s ulle officine non ausiliarie.
Per tutte le officine od aziende non ausiliarie, ove è necessario praticare una speciale vigilanza nei riguardi di tutti i militari esonerati, lasciati a disposizione e comandati ad esse appartenenti, è stato di recente costituito un apposito ufficio militare in Milano, che deve servire di esperimento e d i prova, per ben precisare le mansioni di tutti gli altri uffici
consimili che il Comitato Centrale di Mobilitazlone Industriale ha in animo di istituire presso gli altri Comandi di Divisione, od almeno presso i più importanti.
Tale provvedimento si impone, oltreché per trarre il maggior rendimento lavorativo da quelle maestranze, per non perpetuare uno stato di disuguaglianza e di sperequazione nei riguardi delle s tesse categorie di operai, appartenenti invece a stabilimenti ausiliari

Personale straniero impiegato negli stabilimenti.
Nel chiudere questa esposizione di carattere disciplinare, si esprime l'augurio che venga presto approvato dai competenti Dicasteri, il Decreto già da tempo sottoposto al loro esame, e che risponde ad assolute improrogabili esigenze; il Decreto che disciplina la presenza di sudditi stranieri negli stabilimenti, la cui produzione interessa l'esercito e l'armata, meglio assicurandone il loro regolare funzionamento e circondandoli di quelle cautele che sono richieste dalla loro importantissima e delicata funzione
Maestranze. Istruzione professionale.
Anche nel campo delle maestranze e dell'istruzione professionale, la Mobilitazione Industriale ha avuto modo di ese1citare l'opera sua feconda di buoni risultati.
Scuole tornitori per militari inabili alle fatiche di guerra.
Nei primi mesi del corrente anno, il Sottosegretariato ritenne opportuno di contribuire più attivamente alla soluzione del grave problema della mano d'opera per gli stabilimenti addetti al munizionamento, promuovendo od incoraggiando l'istituzione di Scuole di Torneria per i militari inabili alle fatiche di guerra. In poco tempo entrarono così in fun. zione, successivamente, le Scuole militari di Roma, Genova, Milano, Modena, Torino, Napoli e Palermo; e molte altre, istituite in vari luoghi od ampliatesi per iniziativa di Enti locali, furono aiutate in vario modo ed a più riprese. Le spese d'impianto delle varie Scuole Militari furono sostenute dal Sottosegretariato; alle spese di esercizio si fa fronte con i regolari e cospicui contributi degli industriali, ai quali vengono poi proporzionalmente assegnati gli allievi delle Scuole.
S copo iniziale delle Scuole Militari, fu quello di preparare uno dei tipi di maestranza del quale era allora più forte la richiesta; degli operai, cioè, capaci di rendersi immediatamente utili in lavorazioni in serie di tipo semplice (quali, a d esempio, quelle relative alla fabbricazione dei proiettili di piccolo e medio calibro), compiute sotto la guida di operai provetti, a i quali restasse affidata la preparazione degli utensili e la rettifica periodica del macchinario.
Le sette Scuole di Torneria posseggono oggi in complesso circa 350 macchine utensili, delle quali 300 torni; la produzione totale sino ad oggi è stata di circa 5.000 allievi, dei quali 1.330 nel mese di ottobre scorso, corrispondenti ad una media di circa 4 tornitori per macchina-mese, cioè a circa 120 ore di effettivo lavoro d'officina per allievo.
È stata però preoccupazione costante del Sottosegretariato, che queste Scuole, lungi dal cristallizzarsi in determinate finalità, si mantenessero in contatto con la vita industriale e fossero pronte a modificare il loro funzionamento, se questo fosse appar so utile per soddisfare i bisogni della regione.
Ora, dal complesso delle notizie più recenti sullo stato della questione della manodopera, appare che mentre in molte regioni è scemata la ri-
chiesta del tipo di maestranza sopraricordato, anche per l'impiego crescente della manodopera feminile e giovanile, va diventando sempre più sentita la deficienza di operai meglio addestrati di quanto non possa ottenersi in un centinaio di ore di effettivo lavoro. È perciò che varie Scuole, per iniziativa prop:ria o per suggerimenti del Sottosegretariato, stanno gradatamente trasformando il loro funzionamento, nel senso di istmire ancora, e per un periodo di durata notevolmente maggiore, i migliori allievi dei corsi attualmente in funzione; ed è da presumere che il minor gettito mensile di queste Scuole, sarà ampiamente compensato dalla migliore qualità di una parte della manodopera fornita alle industrie, sopratutto se, mediante intese con le industrie della regione, verrà effettuato, nei limiti del possibile, una specie di collocamento virtuale degli allievi all'inizio dei corsi; ciò che permetterebbe, volta per volta, di specializzare convenientemente l 'is truzione complementare, in b ase ai reali bisogni della regione.
Dallo stesso ordine di idee è stata altresì i!,pirata una lodevole iniziativa del Comitato Regionale di Genova, quella di istituire una sezione Fonditori, la quale ha già licenziato circa 180 allievi.
Infine, per proporzionare i mezzi di istruzione ai bisogni ancora grandissimi della regione, è attualmente in via di esecuzione un considerevole ampliamento della Scuola di Milano che renderà possibile, senza alterare il gettito normale, l'aggiunta della sezione femminile e l'istruzione complementare dei militari che hanno dimostrato maggiori attitudini.
Fin dall'agosto del 1915, il Comitato Centrale di Mobilitazione I ndustriale, prevedendo le condizioni nelle quali, a breve scadenza, sarebbe venuta a trovarsi l'industria nei riguardi della manodopera (sia per effetto delle chiamate alle armi che dell'ampliamento progressi vo delle officine), invitava i Comitati Regionali a fare attiva propaganda p erché negli stabilimenti ausiliari fosse fatta la più larga parte possibile alle maestranze femminili. L'argomento fu oggetto di ripetute circolari, nelle quali furono lumeggiati da diversi punti di vista gli scopi che si proponeva ed i mezzi da impiegare per ottenere l'intento, vincendo le difficoltà reali ed i molti pregiudizi di ogni genere che esistevano in proposito nel nostro Paese.
Nell'agosto scorso, giudicando venuto il momento, veniva fatto un primo passo decisivo,prescriv en do che a determinate scadenze, gli stabilimenti nei quali si facevano certe determinate lavorazioni (essenzialmente tutte quelle relative alla fabbricazione dei proiettili fino al calibro di 87 mm.) dovessero avere raggiunto certe assegnate percentuali di manodopera femminile; e cioè le percentuali (comprendendo imieme donne e ragazzi) del 50% al 31 ottobre e dell'80% al 31 dicembre.
Preoccupandosi inoltre della tutela e dell'igiene (morale e materiale) delle nuove maestranze, il Comitato Centrale, invitava, nel settembre, i Comitati Regionali ad invigilare affinché fossero osservate nelle officine quelle cautele e quelle norme volute dalle disposizioni legislative, ed iniziava pratiche col Ministero di Industria, Commercio e Lavoro, per intensificare la sorveglianza delle condizioni di lavoro negli stabilimenti, col concorso del personale richiamato alle armi, appartenente all'Ufficio del Lavoro.
Comincia.no adesso a giungere dai vari Comitati le prime comunicazioni sul lavoro da essi compiuto e sulla situazione, al 31 ottobre, degli stabi,limenti dipendenti. P er quanto tutt'ora incomplete, essendo stata l'azione dei Comitati inceppata dal gran lavoro relativo alla chiamata della classe 1897, ed al richiamo di classi anziane, tuttavia le notizie pervenute sino ad ora sono sufficienti per illuminare, nelle sue grandi linee, lo stato attuale della questione dell' impiego delle maestranze femminili e giovanili, e per segna-

lare all'attenzione del Comitato Centrale alcuni problemi; la cui importanza è già notevole e crescerà indubbiamente in avvenire.
Percentuali di manodopera f emminile e giovanile al 31 ottobre nelle varie regioni d'Italia.
Le differenze nello sviluppo industriale delle varie regioni d'Italia, giustificano, in gran parte, i risultati diversi ottenuti dai diversi Comitati, malgrado la grande attività che ovunque essi hanno spiegato e lo zelo dimostrato nel vincere le difficoltà, veramente grandi, di ogni genere. Non è ancora possibile fare una statistica precisa; ma è ormai assodato che la percentuale del 50% prescritta per il 31 ottobre dalla circolare ricordata, è stata sensibilmente superata in Lombardia; seguono a poca distanza il Piemonte e la Liguria e poi, sempre in ordine decrescente, l' Emilia ed il Veneto, l'Italia Centrale e Meridionale e finalmente la Sicilia, nella quale la percentuale è ancora del 35%. Per ogni regione, queste percentuali risultano non da una uniforme introduzione di manodopera femminile e giovanile, ma piuttosto da una compensazione fra le percentuali molto elevate già raggiunte in alcuni stabilimenti e quelle basse che t utt'ora si verificano in altri. È tipico, ad esempio, il caso che si verifica a Milano, per i due grandi stabilimenti Romeo e Borletti; nel primo la percentuale è ancora del 20% circa, mentre nel secondo è superiore al 70%.
Tenuto conto dell'importanza delle maestranze delle varie regioni, si può asserire che al 31 ottobre alle lavorazioni previste dalla circolare dell'agosto scorso, era adibito, come media generale, non meno del 40% di manodopera femminile e giovanile. Negli stabilimenti grandi e medi il numero dei ragazzi era generalmente molto piccolo di fronte a quello delle donne; la proporzione cambiava alquanto, e per ovvie ragioni, negli stabilimenti di piccola e piccolissima importanza.
In generale la manodopera occorrente è stata trovata sul posto, sicché sono attualmente rari i casi nei quali si è dovuto provocare o favorire l'immigrazione.
Risultati tecnici dati dall'impiego della mano d'opera femminile.
I risultati sono stati ovunque ottimi nei riguardi sia della qualità che della quantità della produzione; in alcuni casi, anzi, superiori in complesso a quelli forniti anteriormente dalle maestranze maschili, come risulta da varie dichiarazioni di direzioni, di stabilimenti, sia dall'alta che daJla bassa Italia.
Naturalmente l'introduzione della manodopera femminile non può farsi, salvo rari casi, sostituendo la donna all' uomo nella condotta delle macchine utensili ; occorre invece adattare la lavorazione al nuovo tipo di manodopera, variando opportunamente sia l'attrezzatura delle macchine, sia, a nche, la suddivisione delle lavorazioni ed i servizi di manovalanza. E la necessità che queste modificazioni non turbino troppo il regime di produzione, spiega perché fino ad ora certi stabilimenti non abbiano potuto procedere all'assunzione graduale di maestranza femminile che con relativa lentezza.
Osservazioni di carattere economico e disciplinare.
T ende attualmente a general izzarsi, specie nell'alta Italia, il sistema raccomandato di recente anche dalla Commissione dei cottimi, di retribuire la manodopera femminile con gli stessi cottimi praticati con la manodopera maschile, a parità di lavorazioni e con equivalenza di mezzi; pur rimanendo alquanto inferiori le paghe orarie. Non sono rari, attual mente, i casi di donne aven ti retribuzioni superiori alle sette lire al giorno

Ad ogni modo, il Comitato Centrale ha raccomandato costantemente ai Comitati Regionali di Mobilitazione Industriale di vegliaTe affinché, tenuto conto delle condizioni locali, risulti equo il trattamento economico fatto alle donne e di intervenire con •aweduta energia per reprimere ogni accertato abuso ed ogni evidente tentativo di sfruttamento del lavoro femminile.
L'esperienza ha dimostrato, in tutte le regioni d'Italia, che i timori relativi a possibili inconvenienti, di carattere morale, del lavoro femminile, erano di gran lunga esagerati. Le cautele prescritte dalle vigenti disposizioni legislative, ed alcune precauzioni semplici, quali quella, ad esempio, di evitare l'ingresso e l'uscita contemporanea di uomini e donne si sono dimostrati sufficienti. In alcuni luoghi si riscontra persino, e senza inconvenienti, il lavoro contemporaneo di uomini e donne alla stessa macchina.
Viene invece segnalata da varie parti, specie da quelle dove, la sostituzione è più avanzata, la difficoltà di mantenere la disciplina nelle maestranze femminili e giovanili con l'arma delle multe; la sola di cui oggi dispongono praticamente le direzioni degli stabilimenti. La questione è assai importante e sarà sottoposta al più attento esame da parte del Comitato Centrale.
Impiego della. manodopera femminile in lavorazioni diverse da quelle per le qua.li tale impiego è obbligatorio.
I Comitati Regionali non hanno tralasciato di far propaganda, e con buon esito, per l'imp iego della manodopera femminile in lavorazioni ed in industrie diverse da quelle considerate nella circolare, più volte citata, dell'agosto scorso.
La maestranza femminile è attualmente utilizzata i,n larghis sima misura, e con risultati insperati, nella fabbricazione dei proiettili da 105 (Ansaldo), 149 (Stigler, Ligure Proiettili ) e persino per talune lavorazioni dei proiettili da 260 (Tosi); è impiegata nella fabbricazione delle artiglierie (Artiglierie Ansaldo), ,nella lavorazione, compresa la saldatura autogena, delle bombe Batignolles; nella lavorazione di prodotti chimici ed esplosivi, ed in una infinità di altre industrie ausiliarie. Si può ormai affermare in generale, come provato dall'esperienza, che son ben poche le lavorazioni industriali alle quali, variando opportunamente le attrezzature e le condizioni di lavoro, non sia possibile adibire la donna con ottimi risultati.
I rapporti dei Comitati Regionali dell'Italia Meridionale e della Sicilia, manodopera femminile, contribuiscono validamente a facilitare l'opera di propaganda presso gli industriali che i Comitati stanno proseguendo con alacrità; mentre, d'altro lato, molti pregiudizi vanno scomparendo difronte alla realtà delle cose.

I rapporti dei Comitati Regionali dell'Italia Meridionale e della Sicilia, sono unanimi nel constatare che la prima battaglia, contro la pregiudiziale di massima che si opponeva .all'impiego della donna nell',industria, è ormai vinta. Non v'ha dubbio quindi, che sarà molto notevole l'aumento, nei prossimi mesi, dell'esercito di oltre 72.000 donne che sono oggi addette a lavorazioni relative al munizionamento. L'aumento sarà indubbiamente facilitato dalla circostanza che in queste settimane sono entrate o stanno per entrare in funzione, a fianco delle scuole per militari inabili alle fatiche di guerra, quattro scuole femminili di torneria a Napoli, Genova, Milano e Bologna, oltre varie scuole sorte per iniziativa privata. Fra queste ultime, merita speciale menzione quella che il Comitato Nazionale di Munionamento, già benemerito per l'attiva opera di propaganda fatta ,specie nell'Italia Centrale, a favore della manodopera femminile, ha istituito a Roma da oltre due mesi, conseguendo ottimi risultati nell'addestrare le allieve alla lavorazione di proiettili di piccolo calibro.
Molti stabilimenti dovranno naturalmente continuare ed intensificare la
trasformazione delle loro attrezzature per rendere possibile il raggiungimento delle elevate percentuali prescritte; e per accelerare, ove sia necessario, la sostituzione, i Comitati Regionali non esiteranno, appoggiandosi al parere delle Commissioni di Collaudo, ad agire con avveduta energia, ritirando gradatamente il personale militare dagli stabilimenti.
Non è però da nascondere che in moltisimi centri industriali di piccola importanza, l'ottenimento di alte percentuali di manodopera femminile sarà ostacolato fortemente dall'alta proporzione oggi esistente di maestranza non avente obblighi militari. Nei centri di maggiore entità, si potrà porre riparo a tal inconveniente procurando che una parte di questa maestranza borghese vada in altri stabilimenti della stessa città e venga adibita a lavorazioni più pesanti o più difficili; ma in molti luoghi questo sarà impossibile, ove non si voglia concretare qualche provvedimento che, pur tenendo qualche conto dei diritti individuali, consenta lo spostamento delle maestranze borghesi in nome degli interessi supremi del Paese.
Ad ogni modo, si profila sin d'ora l'oppo1"tunità di est endere, in equa misura, l'obbligatorietà dell'impiego della manodopera femminile anche a varie altre lavorazioni, per le quali onnai l'esperienza non è più da fare; sarà questo un ulteriore passo verso l'attuazione completa del programma che ad ogni lavorazione, ad ogni uflìcio, venga adibita una persona capace, ma non più capace del necessario, e verso la completa messa in valore delle energie lavorative del Paese.
E per evitare infine, che anche da noi possa, in progresso di tempo, verificarsi in misura notevole il doloroso e preoccupante fenomeno deJJo sfibramento progressivo delle masse operaie (e specie delle maestranze femminili e giovanili, poco o punto allenate alla vita d'officina), converrà che i Comitati Regionali vigilino attentamente affinché l'intensificazione del lavoro non sia disgiunta - e può non esserlo - dall'osservanza di tutte quelle norme e di quelle cautele che valgono ad assicurare la salute dell'operaio, e quindi la continuità della produzione. Si segnalano in particolar modo due tendenze poco opportune, alle quali converrà cedere solo per gravi motivi, quella di allungare eccessivamente gli orari di lavoro senza concedere, in compenso, un sufficiente riposo intermedio, e quella di ridurre la durata del riposo settimanale.
Impiego dei militari in guerra negli stabilimenti ausiliari.
Già da qualche tempo non ba mancato d'attirare l'attenzione del Sottosegretariato anche l'importante questiO'Ile dei militari mutilati in guerra, sia per l'evidente opportunità di facilitare in ogni modo la sistemazione economica di questi valorosi, sia per utilizzare il non disprezzabile contributo di lavoro che i mutilati, convenientemente rieducati, possono ancora dare.
Per ottenere risultati concreti, occorre da un lato fare opera di propaganda presso gl'industriali, convincendoli che deve essere considerato come un titolo d'onore per gli stabilimenti l'avere qualche mutilato fra gli operai; dall'altro, e con l'aiuto dei benemeriti sanitari che si occupano della rieducazione, è necessario vincere le riluttanze che, per un complesso di ragioni, si incontrano molto di frequente fra gli stessi mutilati. E poiché è assai vivo fra questi ultimi il giusto desiderio di tornare presso le proprie famiglie, converrà tenerne il più gran conto nel fare le proposte di collocamento; e converrà altresì procurare che la rieducazione dei mutilati avvenga tenendo presenti le possibili occupationi che potranno offrire le industrie del paese d'origine.
Si tratta dunque di un'azione lunga e molto complessa, che si inizia ora, e nella quale i Comitati Regionali, anziché sovrapporre la loro opera a que lla di altri Enti sorti da tempo con intenti affini, dovranno piuttosto spronare e coordinare le varie iniziative.

Risultati molto importanti non è ancora possibile che si siano avuti. Tuttavia il collocamento dei mutilati è già cominciato, grazie al favore ,incontrato, specie nell'alta Italia, presso gl'industriali. Per iniziativa del Comitato cli Milano, sta sorgendo a Gorla, a fianco del Rifugio F.inzi, una scuola cli addestramento dei mutilati ad industrie meccaniche; ed a Torino verrà utilizzata allo stesso scopo, per iniziativa del locale Comitato e della Commiss,ione di Collaudo, qualche macchina della Scuola Militare di Torneria. Il Comitato di Roma è entrato in relazione con la Federazione Nazionale dei Comitati di Assistenza dei Mutilati, e rapporti analoghi si sono stabiliti anche altrove, per cura degli altri Comitati.

Le difficoltà di vario genere che sin d'ora si intravedono, non sono né poche né lievi (e fra esse va segnalata l'attuale scarsità di arti artificiali e, in genere, cli apparecchi ortopedici); ma non v'ha dubbio che esse saTanno superate, per quanto sia umanamente possibile, dallo zelo e dall'attività di quanti si interessano alla sorte dei nostri valorosi.
L'opera avvenire della mobilitazione industriale.
Riassunta in tal modo l'opera svolta da!la Mobilitazione Industriale a tutto oggi, e volgendo uno sguardo all'avvenire immediato e mediato delle nostre industrie, non è difficile intravedere fin d'ora quale altra vastissima ed importantissima serie di compiti e di iniziative possano essere ancora riserbate a questa istituzione.
Pur continuando l'azione sua nel campo affidato per la guerra e durante la guerra, la Mobilitazione Industriale potrà perfezionare sempre più il funzionamento del complesso organismo industriale dell'intera Nazione, servendo allo Stato come organo cli competente consulenza tecnica nella distribuzione delle varie lavorazioni, tenendo conto, per ciascuna di esse, delle caratteristiche degli stabilimenti più particolarmente adatti ad eseguirle. Si raggiungerà in tal modo il duplice risultato di avviare gratamente le varie industrie, specie quelle nuove sorte affrettatamente, ad una sempre IIHgliore specializzazione, e di conseguire anche dei sensibili vantaggi nel costo di produzione dei manufatti.
I bisogni del futuro.
D'altro canto non va dimenticato che mentre si preparano e si svolgono le vittorie militari, è pure urgente preparare e svolgere le vittorie economiche, che sole possono metterci ,in grado di sopportare le conseguenze del dopo guerra. Si pensi alle distruzioni che saranno avvenute e che converrà risarcire presso le Nazioni maggiormente colpite dal flagello; alle opere di civiltà pacifica rimaste interrotte dall'uragano che da più di due anni sconvolge il mondo; si rifletta alla situazione privilegiata nella quale si trova e si verrà a trovare l'Italia dopo la vittoria finale, ed alla necessità di assicurare alle sue industrie, potentemente accresciute ed ottimamente allenate, un congruo lavoro per l'interno e per l'estero, con una bene intesa e bene organizzata esportazione.
Non si perda di vista l'assoluta necessità di valorizzare tutte le risorse naturali del ,nostro Paese, in modo che la disoccupazione sia ridotta al minimo possibile e per trarre dal seno della nostra terra quanto più si possa, per dare incremento al nostro benessere, e l'altra necessità non meno importante ed urgente di preparare fin d'ora un vero e proprio piano di mobilitazione Industriale che permetta d: trasformare le industrie dal regime di guerra a quello di pace, senza scosse brusche e pericolose, ma gradatamente e razionalmente, cosl da facilitare anche alle diverse classi operaie, un assestamento delle loro condizioni morali ed economiche, profondamente turbate dalla guerra.
La mobilitazione industriale per la pace.
A tutto questo complesso vastissimo di provvedimenti, essenziali per l'avvenire economico e la grandezza del nostro Paese, la Mobilitazione Industriale « di guerra » potrà portare il prezioso contributo dell'esperienza acquisita, dell'organismo creato e del materiale raccolto, preludiando a quella Mobilitazione Industriale di domani per la transizione al « periodo di pace», che potrà continuare almeno per un certo tempo, e con opportune momfichc, a llargamenti ed addentellati agli altri organi dello Stato interessati nell'arduo problema, le tradizioni di questa istituzione che ha dimostrato i grandi, tangibili vantaggi che si possono ottenere da un'intima, quotimana collaborazione dei rappresentanti delle Amministrazioni Governative con le forze vive e produttive del Pr.ese, industriali ed operaie. Esclusa, con tal forma di collaborazione o,mai conosciuta ed apprezzata, l'idea di un'invas ione dei pubblici poteri nei campi riserbati all'iniziativa privata, verrebbe invece affidata alla Mobilitazione Industriale l'esplicazione delle più alte funzioni coordinatrici e direttrici dello Stato, tra i vari rami di attività nazionale, col supremo scopo della grandezza avvenire dell'Italia nostra .

Il Generale Dallolio dà poi la parola ai rappresentanti dei diversi Comitati Regionali, pregando il Preside nte di ciascuno di essi di esporre, sia personalmente sia a mezzo di uno dei membri, quanto obbiettivamente e serenamente ritiene opportuno, in base a quanto è esposto nella relazione, per integrare il lavoro dalla Mobilitazione Industriale.
Per il Comitato Piemontese pre nde la parola il Comm. Ferraris, il quale dice come non avrebbe osato di parlare in una autorevole riunione, perché temeva che l'amarezza di cui è pieno l'animo suo, per uno stato di cose che si sta creando intorno alle indu'3tri e per opera di una parte della stampa, non gli avrebbe forse permesso di contenere le sue parole nei limiti imposti dalla presenza d e lle LL. EE. Ma poiché S. E. il Generale Dallolio ha invitato i diversi Comitati ad esprimere i propri desideri, prende la parola e lo fa tanto p iù volentieri, in quanto sente il dovere di rivolgere, a nome degli industriali, un vivo ringraziamento al Capo della Mobilitazione Industriale, per l e frasi di incoraggiamento da Lui pronunciate. E tali parole torneranno tanto più gradite in quanto che, proprio in questo momento, l'animo degli industriali è depresso dall'atmosfera grigia di sospetto e di denigrazione nella quale si tenta m .avvolgerli. Operai ed industriali ritengono di aver fatto tutto il loro dovere e mai la loro collaboraz ione fu così intima come in questo periodo tragico della vita nazionale. Se qualcuno di essi è venuto meno al ;:iroprio dovere, lo si punisca, ma non ricada la colpa di pochi su tutta una categoria di lavoratori indefessi ed onesti. Industriali ed operai non intendono di sollevare alcuna difficoltà per Lutti i contributi che S. E. il Generale Dallolio giustamente ritiene che è loro dovere di dare, ma essi hanno bisogno di sapere che godono ancora di tutta la Sua fiducia, hanno bisogno di una parola che suoni approvazione a quanto hanno finora fatto e li .inciti a compiere lo sforzo finale necessario per la vittoria.
Il Generale Sardegna, Presidente del Corrutato Lombardo, prende a sua volta la parola. Non ha che da lodare l'attività e lo slancio degli industriali lombardi a favore della Mobilitazione Industriale. Energie che prima non si conoscevano e che gli stessi industriali non credevano di possedere, si sono viste sorgere per creare nuove industrie di ogni genere, anche estranee alla Difesa nazionale. Gli industriali si sono dimostrati molto soddisfatti dell'istituzione del Comitato Regionale e dimostrano di avervi fiducia e di ricorrervi per consigli ed aiuti. Le maestranze in principio erano invece poco favorevoli; temevano che in tale Comitato si favorissero gli industriali anziché gli operai. Dopo, a poco a poco, si sono abituate a presentare le loro vertenze al Comitato Regionale, il quale ne
ha oramai risolto più di 70, e quasi tutte all'amichevole, con sole 3 o 4 ordinanze, delle quali solo due hanno dato luogo a ,ricorso al Comitato Centrale da parte degli industriali.
Questo risultato è tanto più notevole inquantoché le maestranze di Milano e dintorni si sono quasi quintuplicate con importazione di elementi di tutte le regioni d'Italia, specie tra le avventizie.

Per quanto ha tratto con la manodopera femminile si è fatta la massima propaganda e può affermare con piacere che anche il Comitato di Assistenza Civile ha dato un efficace contributo; si hanno una gra,nde quantità di donne iscritte e che si provvede ad impiegare nei vari stabilimenti ove la percentuale ha raggiunto il 54%. Nota come sia invece un pò più scarso, per varie ragioni, l'affluire dei giovani studenti, molti dei quali, approfittando della facoltà loro concessa di arruolarsi volontari, anche se diciassettenni, preferiscono andare alla fronte.
Cede quindi la parola al Senatore Esterle, il quale opina che la questione della manodopera femm1nile abbia bisogno delle mass-ime cure, specialmente per quanto riguarda gli eccessivi orari di lavoro.
Deve poi osservare Ie condizioni disagevoli in cui si trova l'industria dei trasporti locali che non fu dichiarata « ausiliaria » e che quindi manca sempre più della manodopera necessaria mentre la poca rimasta dà delle frequenti noie. Chiede che le industrie dei trasporti locali usufruiscano di un provvedimento che, se non può essere quello dell'ausiliarietà, ad esso si avvicini.
Esprime poi il voto che le industrie elettriche siano considerate nel loro vero valore.
Dichiara che la sola industria che è stata preparata alla guerra, prima della guerra, è l'industria elettrica. Nessuno ha aumentato il prezw dell'energia elettrica se non in funzione degli aumenti avuti, in alcuni casi, per l'alto prezzo del carbone necessario. Tiene quindi a che tale industria sia tenuta nella giusta considerazione che le spetta.
Il Generale Dallolio, lo assicura che il giorno della vittoria, mentre si plaudirà ai soldati gloriosi, uguale plauso il paese tributerà pure agli operai ed agli industriali tutti che vi avranno contribuito con l'opera loro.
Prende quindi in seguito la parola il Generale Piana, Presidente del Comitato Veneto Emiliano per dichiarare che non ha nulla da aggiungere a quanto esposto dal Generale Sardegna, inquantoché le condizioni della zona di sua giurisdizione sono analoghe a quella della Lombardia.
Segue a lui il Marchese De Gubernatis, dello stesso Comitato, accennando brevemente ai due argomenti delle industrie eleuriche, per le quali dice che sono in corso impianti notevoli che daranno un grande contributo di energia, ed a quello dell'industria dei trasporti per la quale accenna alle gravi difficoltà entro le quali si svolge.
Per il Comitato dell'Italia Centrale parla l'Onorevole Molina. Per suo conto dopo aver udito con grande soddisfazione la relazione di S. E. il Generale Dallolio, così completa, non avrebbe altro da aggiungere. Ringrazia per le nobilissime parole che Egli ha rivolto all'opera dei Comitati. Tutti coloro che vi appartengono hanno assunto il delicato e difficile mandato che loro veniva affidato dal Governo, con piena coscienza della sua importanza e delle gravi responsabilità che ~sso portava con sé. L'opera ha trovato largo consenso ovunque, ed è stata facilitata dagli industriali e dagli operai che hanno dato una mirabile prova di disciplina, attività e produttività. In una dozzina di vertenze sorte tra industriali ed operai, può dire che tutte furono risolte per la grande accondiscendenza dimostrata da entrambe le parti. In due soli casi, infatti, si sono avute ordinanze, ma anche in questi non perché vi fosse disaccordo fra industriali ed operai, ma perché ragioni speciali di quelle due determi,nate e partico-
lari industrie, esigevano che un'ordinanza sanzionasse quanto veniva stabilito. Passa quindi a trattare della questione dei trasporti e dice che la produzione dei materiali da guerra ha assoluto bisogno di rapidi trasporti. Per questo si rivolge a S. E. Ancona presente, quale Sottosegretario di Stato per i Trasporti, notando come oltre la produzione dei materiali da guerra ocorre anche quella dei materiali rotabili se si vuole che la prima si svolga fino a raggiungere i risultati desiderati.
Passando alla questione dell'energia elettrica, afferma che nell'Italia Centrale esistono ancora meravigliose forze naturali da trasformarsi in tale energia, ma la scarsità della manodopera non rende possibile per ora l'integrale utilizzazione. A Larderello, ad esempio, si hanno 10.000 H.P. e se ne utilizzano solo 2.500. A fianco dell'ese-'cito che si batte al fronte, ci deve essere quello che lavora e che dia i mezzi per combattere. T utti lavorano con coscienza e con entusiasmo ed hanno fiducia di contribuire all'immancabile vittoria, e per questo occorre in modo assoluto evitare di considerare gli operai come degli imboscati.
Questa manodopera è assolutamente necessaria e rivolge speciale raccomandazione al Governo per la ,risoluzione del problema. La manodopera femminile può sostituire quella maschile, ma non in tutte le industrie e specialmente in quella elettrica; per questa industria la donna non è adatta, specie perché il lavoro deve svolgersi continuamente in piedi, e per le scosse continue che il lavoro stesso origina.
Riferendosi alle ultime parole della relazione di S. E. Dallolio relative alla Mobilitazione Industriale, che in questo momento rende così grandi servigi, riconosce ed afferma che tale istituzione ha anche un grande significato per il dopo guerra. Ricorda come in Roma, in questo stesso giorno, presso l'Associazione Comerciale Romana, siano convocate varie Associazioni Industriali e Commerciali federate per ~rattare il problema del dopo guerra al quale si riallaccia la Mobilitazione Industriale.
Prega il Presidente del Consiglio ed i Ministri presenti di voler onorare quel convegno della loro presenza, anche per pochi istanti. Ciò varrà a dimostrare la fusione perfetta tra l'azione Ji Governo e quella dei cittadini, nello studio e nella risoluzione del grave problema.
Per il Comitato di Napoli prende quindi la parola l'Ammiraglio Borrello.

Egli dichiara come l'Italia Meridionale si sia trovata difronte a gravi difficoltà per lo sviluppo delle industrie interessanti il muniziooamento, inquantoché in tale regione esse non esistevano o quasi. P erò con la buona volontà degli industriali e con l 'intellige;:iza propria dell'operaio meridionale a poco per volta si sono sviluppate molte lavorazioni fino allora sconosciute. Anche l'adozione della manodopera femminile ha dato dei risultati soddisfacenti; pregiudizi esistenti feoero si che le difficoltà fossero gravi, poiché da principio nessuna donna voleva dedicarsi al lavoro nelle officine, ma lo sforzo del Comitato e l'opera costante di persuasione e di convincimento esplicata, ha portato per effetto che oggi le domande delle donne sono numerose e giornalmente nuove reclute di questo esercito di lavoratrici entrano a far parte degli stabilimenti, con evidente soddisfazione degli industriali stessi.
Le lavorazioni che si svolgono nell'Italia Meridionale non riguardano solo il munizionamento, ma anche l'armamento e molte e diverse sono quelle che interessano l'equipaggiamento dell'esercito.
Relativamente all'energia elettrica, comunica che è stata assorbita tutta quella che esisteva ed ora si sta lavorando per aumentarla, per alimentare le nuove industrie che stanno sorgendo, in special modo quella dei forni elettrici.
La Scuola tornitori ha fatto tutto quanto era possibile per fornire i suoi allievi alle varie officine, ma gli industriali hanno fatto noto che pre-
ferivano elementi più perfezionati nel mestiere, e quindi si è provveduto ad allungare i corsi perché si potessero licenziare degli individui più addestrati al lavoro.

Il prof. Ovazza, del Comitato Siculo - dichiara come in Sicilia sia stato fatto tutto il possibile per rispondere all'appello del Governo. Capitali cospicui sono stati impiegati per impianti notevoli, nuove officine sono state costruite ex-novo; si sono create maestranze numerose e si è persino ottenuto largo concorso di donne nelle industrie dei proiettili. :e addolorato però di dovere constatare come p: rte di questo lavoro e di questi sforzi siano stati qualche volta frustrati per mancanza di materiale che non sempre è stato regolarmente. Come conseguenza di ciò si nota una certa disponibilità di allievi tornitori licenziati dalla scuola e di donne, iscritte, ma non ancora collocate.
Nota come il Cantiere Navale di Palermo abbia occupato uno solo dei cinque scali che possiede ed anche questo, per una nave che vi si costruisce per iniziativa privata. Si raccomanda vivamente perché sia provveduto affinché non manchi il materiale, e che si tengano nella dovuta considerazione anche le industrie nuove di questa generosa regione che con tanto slancio contribuisce alla grandezza della Patria col sacrificio dei suoi migliori figli, e con l'impianto di stabilimenti che possono essere di valido ausilio al munizionamento.
Il Genera le Dallolio. - Lo rassicura che con sentimento di altissima italianità si provvederà certamente a che la Sicilia abbia lavoro, in modo che dia quello che può dare per le armi e le munizioni. Tutti cercano e cercheranno di fare il possibile affinché industriali ed operai possano produrre, non avendo altra visione che l'italianità pura, altro concetto che l'industria italiana lavori italianamente. Quindi la,.orerà la Sicilia come qualsiasi altra Regione d'Italia; tutti debbono avere ed avranno la stessa gloria e gli stessi dolori. Anche questa volta assicura che si è d'accordo, esercito e marina, per far lavorare e date lavoro ovunque.
L'On. Reggio, del Comitato di Genova, esprime tutta la soddisfazione sua e degli altri colleghi del Comitato per aver lavorato e lavorare sotto la guida di S. E. il Generale Dallolio, il quale ha dato ala Mobilitazione Industriale tutta la sua intelligenza ed attività. Egli crede che non ultima soddisfazione del Capo della Mobilitazione Industriale sarà quella di aver riunito nei Comitati Regionali le rappresentanze degli industriali e degli operai, p erché da questo affiatamento e da questa collaborazione è uscito un risultato di grande importanza, il quale crede sarà ancor più notevole in avvenire per i benefici effetti che ne risentiranno le industrie italiane. Egli deve fare due osservazioni. La manodopera sia conservata per quanto è possibile agli stabilimenti; l'equa distribuzione fra coloro che debbono combattere e coloro che debbono produrre i mezzi è questione assai grave, ma ha fiducia che si saprà trovare il modo di riconoscere egualmente il merito di colui che combatte al fronte, come quello di chi lavora alacramente nelle officine.
La questione dei trasporti è anche di eccezionale gravità; sarà assai difficile trovare per essa una completa soluzione. Crede che si debbano tener presenti anzitutto le necessità dei trasporti militari, per l'approvvigionamento ed il munizionamento dell'esercito, ma, come in ogni lavoro, si deve avere presente anche qui il concetto di raggiungere col minimo mezzo il massimo risultato, in modo che possa rimanere anche una parte dei trasporti per la vita economica del paese, che è necessario, in questo momento, venga mantenuta viva, perché è fattore importantissimo pel conseguimento della vittoria.
Coglie l'occasione per mandare, a nome di Genova, un saluto a S. E. Boselli, che quella città considera come suo cittadino, e che oggi con la sua presenza consacra l'opera della Mobilitazione Industriale, ideata e
guidata da S. E. Dallolio, ed alla quale tutti coloro che vi appartengono, danno e daranno le migliori forze ed energie.
Il Generale Dallolio. - Prega un rappresentante degli operai di prendere la parola, lieto di ricordare ancora una volta, come nella Mobilitazione Industriale non esistano né oligarchie né plebi; ma siano tutti sullo stesso piede, industriali ed operai.
Il Signor Buozzi, rappresentante operaio <lei Comitato di Milano, aderisce all'invito rivoltogli da S. E. Dallolio e parla anche a nome di tutti i colleghi presenti. Gli operai riconoscono ..;he nella Mobilitazione Industriale è stata data loro quella rappresentanza che desideravano, rappresentanza che è stata tenuta nella migliore considerazione sia dai membri industriali che da quelli civili. A nome dei colleghi si permette di fare alcune raccomandazioni. È stato annunciato che è allo studio un nuovo regolamento nei riguardi delle donne e dei ragazzi, che si dimostrano generalmente un pò più insofferenti alla disciplina. Non ha bisogno di insistere per far rilevare come si tratti di materia molto delicata, che va esaminata con speciali cautele ,e considerazioni. Le donne ed i ragazzi non sono abituati a lavorare negli stabilimenti e segnatamente in quelli del munizionamento, per cui pensa che se uscisse un regolamento con norme rigide, si correbbe il rischio di allontanare le donne dagli stabilimenti stessi anziché facilitarne l'arruolamento, per la qual cosa tanta propaganda si è fatta e si sta facendo. Ad esse ed ai ragazzi deve essere concessa una libertà maggiore di quella che viene concessa agli uomini. Le donne dopo poche settimane che sono io officina, sentono molto il peso del lavoro, che debbono eseguire per la massima parte in piedi. Ritiene che ogni norma avente carattere militare debba essere esclusa. Non esclude che si possa adibire la donna anche alla lavorazione dei grossi calibri, ma sopratutto io questo caso occorre agire molto cauti poiché essa si stanca molto prima e con facilità assai maggiore dell'uomo; se quindi si pensasse ad impiegare in certa misura questo tipo di maestranza in simili lavorazioni, non curandosi di addestrarvi invece gli uomini, si correbbe il rischio di giungere al punto in cui le donne per la stanchezza eccessiva non potrebbero continuare ad eseguirle e non si avrebbero in quel momento, con facilità i corrispondenti uomini per sostiuirle. Come conseguenza immediata si avrebbe quindi u n arresto o una diminuzione nella produzione di quei tipi di proiettili di così alto interesse. S. E. Dallolio ha annunciato che a giorni uscirà il nuovo Codice penale riguardante gli operai appartenenti agli stabilimenti ausiliari. Per quanto si è letto sui giornali, sembra che anche questo sia ancora troppo grave. Occorre sempre tener presente, che l'Officina non può assolutamente considerarsi come una caserma, bisogna considerare che nell'officina i rapporti fra superiore ed inferiore sono essenzialmente economici, e quindi di natura tale che alle volte possono far perdere la serenità nelle discussioni che possono avvenire fra superiori ed inferiori. Quando fu fatto il Codice penale militare nessuno poteva prevedere la guerra di oggi, né che una guerra avrebbe portato alla militarizzazione di tutti gli operai. Il Governo ha già riconosciuto che doveva modificarlo e quindi occorre temperarlo in modo tale che le disposizioni siano ispirate dal concetto già esposto, che fa differenziare grandemente un'officina da una caserma.
Egli afferma che in nessun paese belligerante d'Europa la Mobilitazione Industriale è stata accettata dagli operai con la serenità con la quale l'hanno accettata gli operai italiani, e ciò acquista tanto maggior valore se si considera che fino al momento dell'entrata in guerra il nostro paese ha avuto discussioni politiche talvolta vivaci. Coglie l'occasione della presenza del Ministro dell'Interno, per accennare come da qualche settimana si prendano dei provvedimenti gravi verso operai di stabilimenti tenendo conto delle loro tendenze politiche. Tali operai vengono allontanati

dagli stabilimenti ed egli non trova che ciò sia giusto, né opportuno. Comprende che l'autorità politica non può rinunciare alle sue prerogative, né può lasciare alla Mobilitazione Industriale il solo diritto di giudicare; chiede però che si cerchi di fare il possibile, onde fra autorità politica e Comitati Regionali si proceda sempre d'accordo quando debbano prendersi provvedimenti a carico di operai appartenenti a stabilimenti ausiliari. Il Comitato Regionale è il solo responsabile della produzione e del regolare andamento degli stabilimenti dipendenti e quindi non si può né si deve ammettere che altri enti fomentino il malcontento negli stabilimenti stessi.
Il Signor Frizzola, rappresentante operaio del Comitato Veneto Emiliano chiede la parola augurandosi che il nuovo Codice penale cui fu fatto cenno nella relazione di S. E. Dallolio venga promulgato al più presto possibile al fine di mitigare le gravi pene stabilite dal Codice Penale Militare, e formula nel contempo l'augurio che insieme a questo nuovo Codice, si faccia un atto di giustizia riparatrice a favore di coloro che ebbero inflitte pene gravissime in seguito a sentenze emesse in base al Codice fino ad! ora vigente.
Riprende quindi la parola il Generale Dallolio, rivolgendosi al Presidente del Consiglio:
Eccellenza Boselli! ... ho presentato la relazione sulla Mobilitazione Industriale, abbiamo ascoltato la parola dei diversi Comitati Regionali e degli operai. Il mio compito è finito e la parola cedo a Voi, ma non la cedo se prima non faccio un appello al cuore del grande Italiano che siede al posto di Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli industriali e gli operai hanno accennato ad una specie di marasma grigio che li turba; nulla ci deve turbare in questo momento. Industriali ed operai hanno fatto e continueranno a fare il loro dovere, ma venga da Voi la parola che li incoraggi ad andare avanti fiduciosi e senza preoccupazione; la domando per gli industriali e per gli operai d'Italia e fino alla vittoria!

Sua Eccellenza Boselli, risponde a tutti gli oratori col seguente discorso: Io non conosco alcun marasma grigio che in questo momento turbi il nostro paese o l'animo nostro. Io so che tutti coloro che lavorano per la vittoria della Patria, o combattendo sulle terre e sui mari, o promuovendo l'attività delle industrie, o dando la vita e la forza delle loro mani alla produzione che giova alla vittoria, tutti costoro risplendono della medesima luce davanti all'animo della Nazione risorta, davanti alla riconoscenza che la storia italiana tributerà a coloro che in questo momento, o combattendo sui campi o lavorando nelle officine, ne preparano egualmente la liberazione compiuta e la gloria nel nome della civiltà. Il Generale Dallolio ha raccolto nella sua parola tanta vibrazione e tanta commozione per l'opera che egli ha creato, che noi sentiamo ad un tempo il suo cuore di soldato ed il polso vittorioso del creatore della Mobilitazione Industriale. Sentiamo, nella sua orazione, il grido della guerra, e si trasfonde in noi la convinzione nella vittoria presente e la convinzione nell'avvenire del nostro Paese.
Le industrie italiane banno fatto miracoli, né saprei di qual parola di maggiore fiducia abbiano esse bisogno, perché la fiducia cui aspirano è nei risultati dell'opera loro, ed esse dimostrano con tanta prontezza ed attività di essere capaci, da un Jstante all'altro, di dare nuove creazioni di lavoro alla Patria nostra che per verità non occorre parola di Governo perché esse debbano proseguire gagliarde e fidenti nel loro cammino.
Le maestranze furono e sono mirabili. Non so, non posso rispondere agli oratori operai che hanno parlato testè: a me pare che in nessun provvedimento preso nelle officine un operaio sia stato considerato diversamente dagli altri. Saranno state considerate la maggiore o minore abilità, e le varie condizioni del lavoro, ma credo di poter assicurare, in nome dell'autorità politica e rniJitare, che non è nel pensiero di alcuno di in-
trodurre nella disciplina di operai appartenenti a stabilimenti ausiliari, una qualsiasi pregiudiziale, per ciò che si pensa o si faccia fuori dell'officina. I nostri operai hanno dimostrato immediatamente le qualità di abilità e di genio che sono proprie del popolo italiano. E qui mi cade in acconcio di dire una parola intorno ai salari. I salari sono largamente accresciuti; non credo che tutto il guadagno si versi in prodigalità inopportune; non lo credo perché i risparmi nelle Casse crescono, perché i pegni esulano dai Monti di Pietà, perché l'acquisto di buoni del tesoro di piccolo taglio è abbastanza forte tuttociò significa risparmio. Non vi è dubbio però che fino ad ora troppa parte di questo risparmio è stato speso in lusso e prodigalità. Comprendo che a ciò è facilmente indotto chi non non avendo goduto di certi beni riservati solo ad altre classi, sente il bisogno di largheggiare per la prima volta in questi consumi; e però non condannato, ma dico che è tempo che gli operai più coscienti diano esempio e facciano opera di persuasione perché, pensando all'avvenire, una maggior somma sia data al risparmio.
Parlo per affetto agli operai; parlo così perché desidero che essi raccolgano e conservino i mezzi per sostenersi Jn una maggiore altezza morale ed economica quando i salari entreranno -in una via decrescente.
Ho inteso parlare di trasporti. Le questioni dei trasporti sono due: una quella prospettata dal Senatore Esterle, la quale riguarda i trasporti locali, cioè le comunicazioni locali tra le officine ed il luogo di partenza delle maestranze o della materia manufatta, e tra il luogo di arrivo delle materie prime e le officine; si desidera e si ritiene necessario che ,il personale adoperato in questi trasporti venga considerato come personale ausiliario. Si ritiene quindi che l'industria locale dei trasporti debba essere un'industria ausiliaria, e tale questione il generale Dallolio studierà con la consueta sua competenza. L'altra questione, più larga e complessa, è quella dei trasporti in generale. Purtroppo tutta la nostra produzione e quella della Mobilitazione Industriale, soffrono molto per la difficoltà dei trasporti marittimi. Le insidie inaudite contro i diritti delle genti e contro il senso di umanità, con le quali i nostri nemici riempiono continuamente i mari di inerrabili disastri, rendono assai difficile trovare trasporti marittimi. Quanto ai terrestri, so che il Ministero dei Trasporti fa ogni opera per attivarli il più sollecitamente possibile, e son certo che l'onorevole Ancona, qui presente, opererà diligentemente, con la competenza che ha sempre addimostrato, per rispondere ai bisogni della Mobilitazione Industriale.
Da questa scarsità di trasporti, marittimi specialmente, dipendono !in gran parte diminuzioni di lavoro che si verificano in Sicilia, e delle quali con tanta efficacia ci ha parlato il rappresentante del Comitato Siculo. Molto ho inteso dire del lavoro delle donne. E. un lavoro non ancora abbastanza esteso nei nostri stabilimenti; perché p er esso si richiedono spesso attitudini speciali che le donne non possiedono. Può darsi che nelle industrie e lettriche o dei trasporti non sia molto acconcio, ma non bisogna fermarsi alle prime prove, specie per l'industria elettrica. L'industria dell'energia elettrica occorre esplicarla con ogni mezzo nel nostro paese; può darsi che esista l'energia, e manchi la manodopera per utilizzarla; si tratta però di casi eccezionali. Occorre in tutta Italia produrre ad ogni costo, energia elettrica che sostituisca il carbone che ci manca, ed a questo oggetto il Governo va provvedendo nel modo più efficace
Sono convinto che il lavoro delle donne si svolgerà in ogni parte d'Italia. E. naturale che si sia svolto prima in Lombardia e nel Piemonte, perché da secoli in quelle regioni le donne sono impiegate nell'industria della seta, il che costituisce la tradizione al lavoro della donna. Essendo poi in quei paesi l'industria meravigliosamente svi luppata, larga è la possibilità d'impiego; ma ho inteso con piacere che anche nelle provincie meridionali il lavoro delle donne si va estendendo in un modo considerevole e son cer-

to che la donna meridionale, quando entrerà nelle officine, sarà una lavoratrice impareggiabile, poiché nei lavori dell'agricoltura, ha dimostrato, e dimostra, qualità veramente eccezionali. Credo perciò che il lavoro delle donne debba intensificarsi, non costretto, però, fra disposizioni troppo rigide: non bisogna introdurre nell'officina rigori tali che allontanino le donne, anziché incitarle ad entrarvi. Facilitare il concorso del lavoro femminile equivale ,in certo modo ad accrescere la forza virile della produzione italiana. È un argamento cui, con molto merito, il generale Dallolio, ha dato le sue speciali cure e per il quale non dubito che gli industriali diverranno efficaci contributori.
Certamente la Mobilitazione Industriale, ora rivolta ai bisogni della guerra, è di grande preparazione per l'avvenire industriale del nostro paese, che deve prepararsi alla indipendenza ed autonomia industriale. Amici dei popoli con cui siamo fraternamente legati ,lavoreremo concordi e co.. operatori con essi, ma ciascun popolo deve avere la propria forza, la propria indipendenza industriale. Gli ,industriali preparandosi all'avvenire, dovranno dalla produzione attuale trarre utili insegnamenti. Innanzi tutto occorrerà che cerchino, dove meglio ciascuna officina può, per località ed attitudini, di specializzarsi, perché non dovrebbe verificarsi nell'avvenire l'inconveniente che gli stabilimenti volessero far di tutto. In secondo luogo occorrerà disciplinare bene l'ingegno industriale e converrà provvedere non solo a produrre ottimamente, ma a produrre con economia, perchè occorre tener presente che la Nazione che voleva invade re tutti i mercati del mondo, li invadeva sopratutto pel basso costo dei suoi prodotti. Quindi noi dobbiamo preparci a questa futura lotta, con la specializzazione bene intesa e rivolta all'economia del costo di produzione.
Mi unisco al saluto che l'on. Molina invia alla riunione che oggi si tiene presso l'Associazione Commerciale Romana fra i promotori delle Società industriali ed esercenti, intesa ad esaminare ciò che dopo la pace si deve preparare. Mando ad essi il saluto di tutti i colleghi, nella fiducia che ciascuno cli noi, se gli sarà possibile, interverrà al convegno al quale ci si invita.

Mentre ringrazio del saluto che l'on. Reggio mi manca a nome di Genova, lo ricambio pensando che in Genova ferve una grande parte della vita industriale del nostro paese, e pensarlo che dal mare di Genova va il saluto di tutta l'Italia all'altro mare che attende il saluto delle vittorie italiane, va a tutti quei mari dove si combatte dagli italiani, e dagli alleati degli italiani, per la vittoria della libertà.
Al saluto che ricambio a Genova aggiungo, a nome del Governo, il più caloroso saluto a tutti i rappresentanti dei Comitati regionali di tutta Italia qui convenuti, a tutti gli industriali d'Italia che danno opera alla Mobilitazione Industriale, a tutti gli operai d'Italia che operano per la Patria in questo esercito di lavoratori. La guerra dei nostri soldati è, ne siamo certi, una guerra che ci assicurerà la vittoria; fornite a questi soldati le armi, forti come l'animo loro, e la vittoria sarà completa e prossima e più che mai fulgida e gloriosa!
Il Signor Ancillotti, membro operaio del Comitato Ligure, chiede la parola per fare una raccomandazione. Tutto quello che è stato detto in questa riunione è bene che .Io sappia tutta l'Italia e quindi tutta quella parte che si può comunicare, senza naturalmente quella che può essere conveniente tenere segreta, desidererebbe venisse data, attraverso alla stampa, in conoscenza al pubblico, perché questi sapesse quali sono gli sforzi di chi dirige la Mobilitazione Industriale. Poiché ha la parola e propone di attirare l'attenzione della pubblica opinione sulla Mobilitazione Industriale, vuol ricordare all'opinione pubblica stessa che siamo alla vigilia di un'altra offensiva, ancora più intensa di quella che il nostro valoroso esercito ha respinto nei monti del Trentino, e quindi nel ricordare che noi
siamo alla vigilia di una nuova cruenta battaglia diciamo anche che non abbiamo nessun dubbio sul valore del nostro esercito, un rappresentante fulgido del quale abbiamo qui tra noi nella persona di Sua Eccellenza Bissolati, ma aggiungiamo e diciamo ai combattenti lavoratori del fronte interno che, se sarà necessario un grande sforzo, per poter dare tutte le armi che saranno per occorrere ,essi debbono essere pronti, e lo saranno, a darle con la miglior lena, la miglior disciplina.
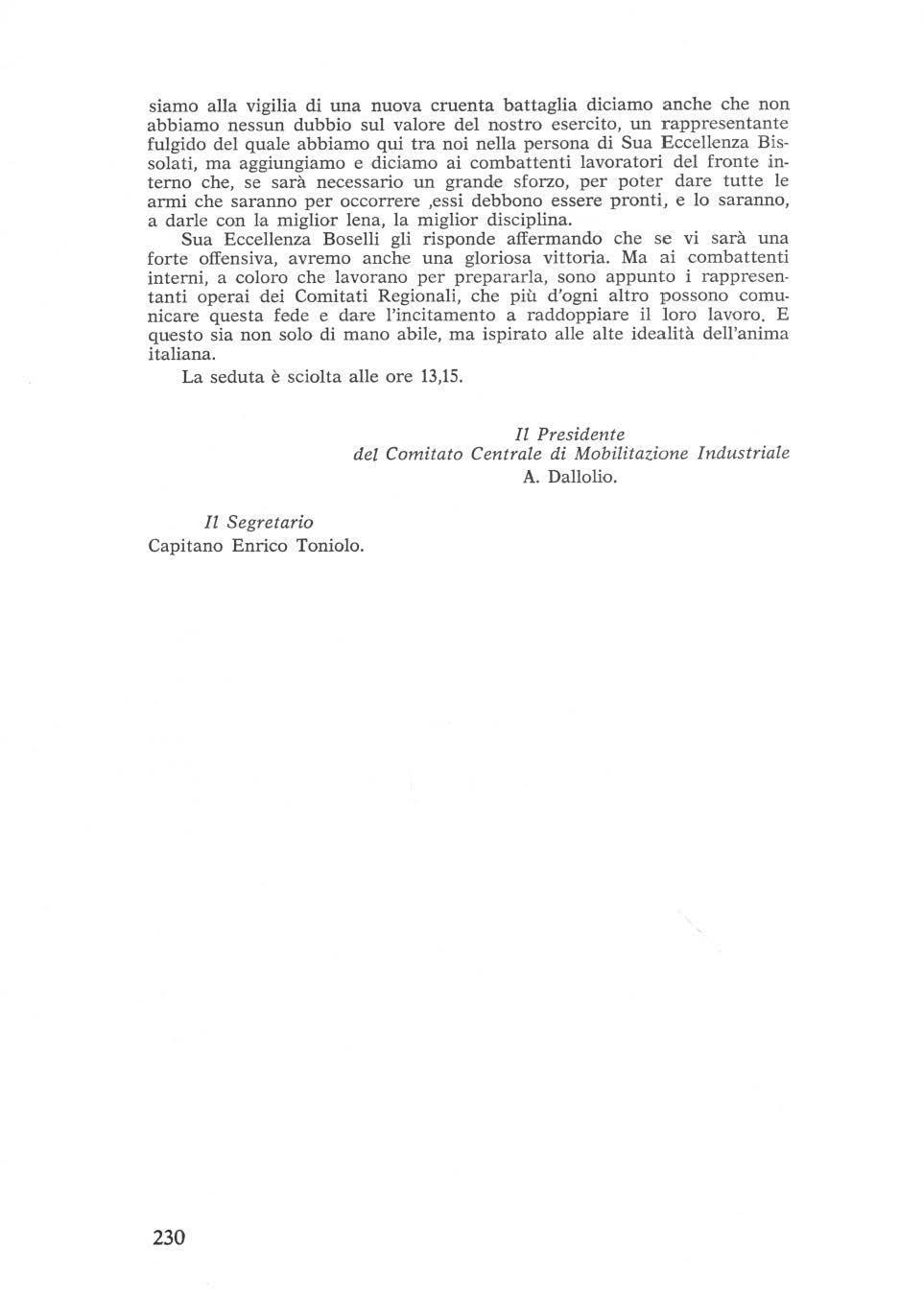
Sua Eccellenza Boselli gli risponde affermando che se vi sarà una forte offensiva, avremo anche una gloriosa vittoria. Ma ai combattenti interni, a coloro che lavorano per prepararla, sono appunto i rappresentanti operai dei Comitati Regionali, che più d'ogni altro possono comunicare questa fede e dare l'incitamento a raddoppiare il loro lavoro. E questo sia non solo di mano abile, ma ispirato alle alte idealità dell'anima italiana.
La seduta è sciolta alle ore 13,15.
Il Segretario Capitano Enrico Toniolo.
Il Presidente del Comitato Centrale di Mobilitazione IndustrialeIl Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale, nella sua Seduta del 17 Agosto 1916, ebbe a deferire ad una speciale Commissione l'esame e la risoluzione, in via consultiva, delle questioni sollevate in un Memoriale dei Rappresentanti Operai dei Comitati Regionali di Mobilitazione, ed in altro, della Unione Sindacale Milanese.

La Commissione venne costituita come segue:
Per gli Industriali i Signori:
Fera Comm. Cesare Genova.
Breda Comm. Ernesto - Milano.
Orlando Comm. Giuseppe - Roma.
Perrone Comm. Pio - Roma.
Ferraris Comm. Dante . Torino.
ed in rappresentanza degli Operai i Signori:
Buozzi Bruno - Comitato Regionale, Milano.
Colombino Emilio - Comitato Region<ale, Torino. Ancilotti Ferruccio . Comitato Regio,1ale, Genova.
Di Dio Guido - Comitato Regionale, Roma.
Sinigaglia Carlo Comit,ato Regionale, Napoli.
Con la lettera del 21 Agosto 1916 l'E.V. dav:1 allo scrivente, Ing. Cesare Saldini, l'onorevole incarico di presiedere tale Commissione, lasciandogli facoltà di indire le sedute, ch'essa avrebbe dovuto tenere vuoi presso il Sottosegretadato Anni e Munizioni in Roma, vuoi anche a Milano presso il Comitato Regionale di Mobilitazione, richiedendo in tale caso uno degli Ufficiali del Comitato a fungere da Segretario.
In pieno accordo col Sottosegretariato e col cortese concorso di questo, furono diramati gli inviti ai singoli Commissari, indicendo la prima Seduta per il 6 Settembre alle ore 15, presso il Comitato Regionale di Milano, seduta che in fatto ebbe luogo coll'intervento di tutti i Commissari, meno il Commendatore Perrone, il quale ebbe a scusare la sua assenza causata da motivi di salute.
NEL MEMORIALE DEI RAPPRESENTANTI OPERAI DEI COMITATI REGIONALI, SI CHIEDE:
1. - Che per la parte disciplinare siano richiamati gli Ufficiali preposti a tale servizio, a voler tenere in maggior considerazione la Circolare 24 Ot-
tobre ed 8 Novembre 1915 e le norme disciplinari stabilite dal Comitato Centrale di M. I. nella Seduta del Gennaio 1916.
2. - Che il trattamento degli operai militari sia ancora migliorato, quantunque si riconosca che molto già sia stato fatto.
3. - Che sia tolto agli Industriali il diritto di segnare sul libretto di paga il motivo per cui l'operaio venne licenziato - e sia - nel caso di mancanze - accelerata la procedura, affinché non avvenga che la condanna, magari di pochi giorni, non risulti in fatto aggravata da una punizione preventiva di durata molto maggiore.
4. - Che gli esoneri possano essere tolti, in caso di mancanza disciplinari, soltanto dai Comitati stessi che li hanno concessi.
5. - E come richieste di carattere economico, si crede giunto il momento di stabilire che i prezzi di cottimo in corso debbano rimanere invariati fino a quando gli Stabilimenti restaDo ausiliari, salvo che non si apportino variazioni ai sistemi di lavorazione. E si pensa poi che per i cottimi nuovi debba intervenire discussione fra le Parti - ed in caso di disaccordo, debbano intervenire i Comitati Regionali di Mobilitazione.
L' Unione Sindacale Milanese - dal canto suo - chiedeva che nel Comitato Regionale Lombardo si facesse posto anche agli aderenti dell'Unione; e desiderava anch'essa che le tariffe di cottimo non potessero essere diminuite per nessun motivo, e che i cambiamenti nel macchinario o nell'attrezzatura non dovessero essere fatti senza l'approvazione dei Comitati Regionali; e desiderava infine che i Militari comandati a lavorare presso gli Stabilimenti percepissero la paga oraria da essi goduta prima di essere richiamati sotto le armi e risultante dal libretto paga, noocbè gli stessi cottimi e percentuali degli operai borghesi, salvo la trattenuta di Stato. Presa conoscenza di tali documenti, la Commissione ha iniziato la discussione dei singoli punti, così come appare dagli allegati verbali.
Circa l'aumento dei Rappresentanti Operai, in seno ai Comitati, si ebbe solo da prendere atto che la richiesta è già stata soddisfatta dal Comitato Centrale con sua recente decisione portata a conoscenza degli interessati.
Circa alla parte disciplinare, di cui è cenno nel ricordato Memoriale degli Operai, ed ai commenti fatti al riguardo in seno alla Commissione dai Signori Buozzi, Colombino, Ancillotti e Di Dio, si ha solo da ricordare che il Sotto-Segretariato Armi e Munizioni ha già diramato ai Comandi di Divisione le necessarie disposizioni intese a vietare eventuali inframettenze da parte degli Uffici di sorveglianza disciplinare, intendendo il Sotto-Segretariato che siano anzitutto rispettate le discipline regolamentari già vigenti nei singoli stabilimenti.

Il Comitato Centrale, in una sua prossima riunione - potrà riprendere in esame - occorrendo - l'argomento per meglio precisare e coordinare le disposizioni già date.
Circa alla sospensione degli esoneri ed alla maggior sollecitudine pro. cedurale per le mancanze s i è riconosciuta la giustezza delle ragioni esposte e se ne raccomanda l'accoglimento.
Circa ai cottimi, dopo ampia, esauriente discussione, alla quale presero parte tutti i Commissari, industriali ed operai, venne di pieno accordo accolto il concetto che le tariffe di cottimo debbano rimanere inalterate per quelle lavorazioni che hanno raggiunto il regime di produzione, e che all'operaio si debba corrispondere tutta la percentuale di cottimo senza Umitazione alcuna.
E parimenti - di pieno accordo - si è acconsentito che, per le lavorazioni nuove, per la introduzione di macchinario nuovo, o per l'impiego di materiali aventi caratteristiche diverse da quelle in uso, le tariffe dei cottimi pos sano essere variate durante il periodo di apprestamento degli impianti o di tirocinio preparatorio della mano d'opera, avuto riguardo, così come fanno già gli industriali maggiori, a che non ne venga soverchio disagio, per quanto transitorio, agli operai. Ad ogni modo, sia quando viene raggiunto il nuovo regime di produzione, od anche quando nasce un dissidio per cottimi già esistenti, le nuove tariffe dovranno essere stabilite di comune accordo fra la maestranza ed i datori di lavoro, ed in difetto, deferite al giudizio del Comitato Regionale, sentite, all'occorrenza, delle persone specialmente competenti.
Per g li operai specialisti (attrezzisti, tracciatori, elettrotecnici, sellai, manovratori di gru ed altri) che integrano il lavoro degli altri lavoratori si dovrà corrispondere una percentuale fissa od una percentuale proporzionale al medio cottimo raggiunto dagli operai nei reparti che essi servono, e ciò per interessare anche gli specialisti, com'è giusto, nei cottimi di lavoro ed all'aumento della produzione.
Per la mano d'opera non quafificata o semiqualificata, dovrà stabilirsi un minimo di paga corrispondente alla paga mmima corrisposta alla maestranza della località nella quale si trova lo stabilimento. Nel caso di dissidio la decisione è rimessa al Comitato Regionale.
Per il lavoro femminile non si è caduti d'accordo quanto alla determinazione di un minimo di paga giornaliera e si è invece accettato unanimemente che il lavoro femminile venga retribwto col medesimo cottimo del lavoro maschile, quando si tratti di lavoraz ioni analoghe e che si svolgano con identicità od equivalenza di mezzi.
Dovendosi però studiare delle tariffe per le n uove lavorazioni di guerra, si prenderà come base, nella determinazione delle nuove tariffe, la paga giornaliera di lire 2,50.
Ed infine, come espressione di voto, ed a proposta Orlando, si è deliberato di proporre e favorire lo studio di una forma di previdenza che, basandosi sulla larghezza delle attuali paghe, valga a salvaguardare gli operai dalle conseguenze dei probabili minimi guadagni temibili per l'avvenire. * * *
Nella seconda seduta tenuta il 19 Settembre in Roma presso il Comitato Centrale di Mobilitazione si è approvato il verbale d ella prima seduta e si è intrapresa la discussione su taluni punti o nuovi o che non erano stati considerati nel precedente convegno. Su questi punti non sono intervenute formali decisioni e tutto al più sono stati pronunciati dei voti, come ad esempio:
1) Che la proposta Orlando di un accantonamento di parte della paga a scopo di previdenza per tempi meno favorevoli sia assai delicata e che la sua eventuale realizzazione debba essere studiata da una Commissione mista di operai e di datori di lavoro.
2) Che non si possa a priori scartare l'idea della mobilitazione industriale anche pel dopo guerra, visti gli indiscutibili vantaggi ch'essa ha recato nel periodo di preparazione della guerra e visto il suo ottimo funzionamento.
3) Che si affermi il principio di una percentuale di compenso spettante al lavoro straordinario ed a quello notturno, senza per ora definire la entità.

4) Che nel periodo di assestamento di nuovi lavori quindi di nuovi cottimi si corrisponda alla maestranza un compenso che potrà essere equamente deliberato dai Comitati Regionali. Agli stessi Comitati dovrà essere deferita la decisione nei casi di cottimi pei quali non sia intervenuto accordo. * * *
Eccole riassunte, IUus. Generale, in brevi parole le conclusioni alle quali la Commissione mista è addivenuta. I verbali allegati danno più viva e più diffusa la fisionomia dei dibattiti che hanno avuto luogo Consenta per ultimo che io metta in rilievo alcune risultanze caratteristiche della discussione ed anzitutto constati, che tanto da parte degli Industriali che degli Operai fu manifestato un virn e sentito e logio, insieme ad una grande fiducia, per la ideazione della Mobilitazione I ndustriale, per le norme regolamentari che l'hanno tanto efficacemente e modernamente disciplinata; per la praticità degli organismi esecutivi. E consenta ancora ch'io le faccia noto il grande compiacimento provato per la serenità mirabile, la inappuntabile correttezza e la grande competenza che hanno sempre regnato nella discussione di argomenti tanto importanti come quello ad esempio dei cottimi di lavoro.
Col maggior ossequio
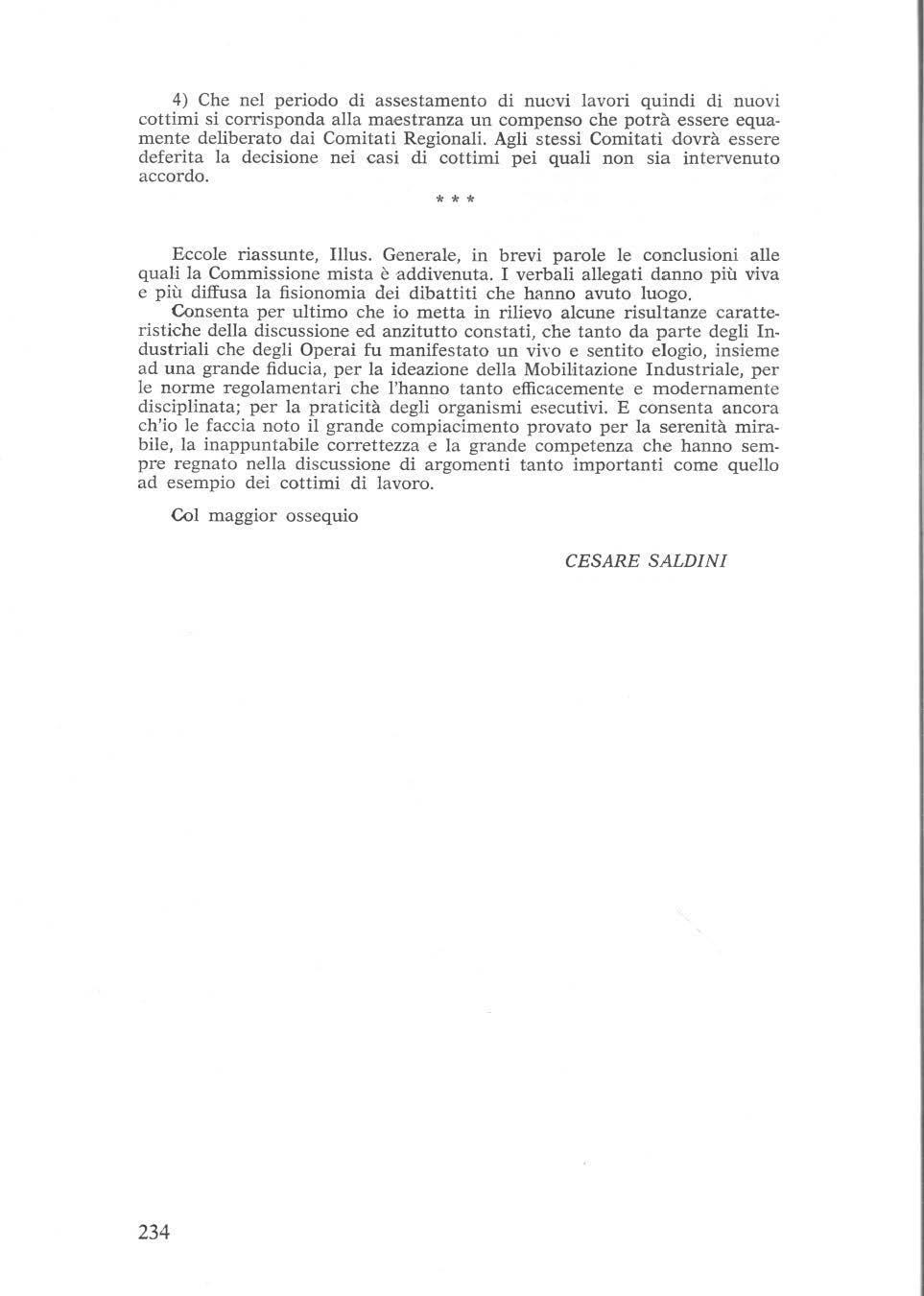
Verbale delle sedute tenutesi il giorno 16 dicembre 1916 nella sede del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.

Ore 10
Sono presenti:
Il Comm. Saldini Prof. Ing Cesare - Presidente
Il Comm. Ernesto Breda - Membro industriale
Il Comm. Dante Ferraris »
Il Comm. Fera Ing. Cesare »
Il Comm. Pio Perrone »
Il Comm. Giuseppe Orlando »
Il Signor Buozzi - Membro operaio
Il Signor Colombina »
Il Signor Ancillotti »
Il Signor Di Dio »
Il Signor Sinigaglia »
Fungono da Segretari, il Capitano Toniolo Cav. Enrico, del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale, ed il Tenente Garbagni Ing. Mario, del Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale di Milano.
Il PRESIDENTE fa noto che la Commissione, oltre il problema del risparmio operaio, dovrà discutere anche sugli argomenti da lui esposti nella precedente seduta risultanti dal verbale della seduta stessa e comunicati ai diversi commissari nella lettera di invito per la riunione odierna.
Il PRESIDENTE invita quindi a dar lettura dei verbali delle sedute precedenti.
Il Capitano TONIOLO legge i verbali.
Il PRESIDENTE, mentre si congratula per la esatta compilazione dei verbali stessi, apre la discussione sui medesimi.
Il Comm. FERA desider.a che sia modificato là dove parla dell'Uva e più precisamente quando il Comm. Perrone dice relativamente al monopolio che si potrebbe creare a questa Società, colla tesi della specializzazione.
Dopo breve discussione alla quale partecipano il Comm. Perrone, il Comm. Orlando, ed il Comm. Ferraris, chiarendo il concetto che il Comrn. Perrone voleva metter in evidenza e che si riferiva all'industria siderurgica in genere e non alla Società Ilva particolarmente, viene stabilito di sostitutire alla parola « Ilva » la dicitura « industria siderurgica».
Il Comm. Fera fa inoltre notare che non è esatto affermare che l'industria siderurgica sia quelle che maggiormente si presta alla costituzione dei trusts, e questa sua affermazione ha avuto anche la sua dimostrazione in Germania. I trusts sono molto più facili per gli alcools per
gli zuccheri, per i concimi, poiché i prodotti di queste industrie sono unici e semplici, mentre l'industria siderurgica si riferisce ad un grande numero di prodotti.
Il PRESIDENTE annuncia quindi che deve essere ripresa la discussione sul risparmio operaio e la apre intorno alle proposte fatte dai iliversi commissari. Poiché però tali proposte sono una conseguenza dell'idea lanciata dal Comm. Orlando, assente nelle precedenti sedute, dà a questi la parola.
Il Comm. ORLANDO dichiara che la sua fu una proposta fatta senza preliminari; dai verbali testé letti ha rilevato come essa, nella sua forma integrale, non sia stata approvata e quindi ritiene che debba essere nuovamente studiata e discussa. Certo egli crede fermamente, che nel momento attuale occorra fare una proposta di pronta attuazione e di limitati confini, perché se si divaga nel campo della soluzione delle questioni relative alla previdenza operaia e della disoccupazione, questo è così vasto che la Commissione non potrebbe essere in grado di venire ad una pratica de. cisione. Egli propone quindi di discutere e concretare qualche cosa in merito alla sua primitiva idea.
II PRESIDENTE osserva che la discussione in merito alla grave questione è già stata iniziata e quindi occorre sentire i pareri dei diversi commissari sulla proposta Orlando.
Avviene quindi una breve discussione circa le iniziative presi da altri Enti su quanto è oggetto di studio presso la Commissione, esprimendo l'augurio che la Mobilitazione Industrial e, venga interpellata quando si tratti di deliberare o decretare in materia economica che interessa direttamente industriali e maestranze dedite al munizionamento
Il Signor ANCILLOTTI espone quindi le sue idee in merito alla forma di previdenza che egli ritiene la più pratica e migliore per risolvere la disoccupazione nel periodo che passerà dalla fine della guerra all'assestamento delle industrie al regime di pace. Egli prende come base la proposta Orlando; trattenere agli operai qualche cosa di quello. che guadagnano. Egli fa notare subito che vi sono diverse categorie di operai che sono compresi nella Mobilitazione Industriale. Vi sono delle categorie che hanno interesse a che si formi questo fondo di previdenza, mentre vi sono altre categorie che non la riten-anno necessaria perché son convinte che non avranno bisogno di nulla. Tra queste ad esempio, si avrà la categoria degli operai appartenenti all'industria navale oggi essi guadagnano meno che per il passato e dì quanto guadagneranno in avvenire. Inoltre tale categoria, guadagna meno di quella addetta ai proiettifici che ha invece minori capacità tecniche e che sarà quella più colpita nel periodo che succederà alla guerra. Un'altra categoria sarà quella degli operai addetti a servizi pubblici, che difficilmente si assoggetterebbe a pagare una quota, avendo la sicurezza che non soffrirà della disoccupazione e che quindi pagherebbe solo per il vantaggio di altre categorie Occorre quindi tener presente l'interesse di tutti, non essendo possibile addivenire ad un provvedimento pratico adottando vari temperamenti.
Egli propone qtùndi per tutti l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza per una quota minima; poi una trattenuta a tutti, a seconda dell'entità del salario, che dovrebbe essere messa in un libretto individuale nel quale durante il periodo di guerra, si andrebbe così ad accumulare un fondo alla costituzione del quale dovrebbero anche contribuire anche gli industriali in misura eguale. Ad esempio se si stabilisse, a seconda dei salari, che ogni operaio deve versar mensilmente 1, 2 o 3 lire, egli proporrebbe che, in media, gli industriali versassero 2 lire, anche per far sì che essi non contribuissero maggiormente per quegli operai che hanno paghe più alte, e quindi minor bisogno degli altri. Come principio quindi, egual contributo degl ioperai e degli industriali. La Cassa Nazionale di Previ-

denza, che potrebbe farsi amministratrice cli questo fondo, fatta la pace, agli operai che rimarranno disoccupati restituirà gradualmente il capitale versato. Il Governo potrebbe eventualmente intervenire dando un sussidio alla Cassa Nazionale di Previdenza, onde questa potesse a sua volta, meglio sussidiare i disoccupati. Per gli operai che ,resteranno occupati la Cassa Nazionale di Previdenza passerebbe quanto da loro accumulato nel libretto individuale al rispettivo libretto pensioni. Si approfitterebbe in tal modo di questa occasione per risolvere, almeno in parte, la questione delle pensioni, poiché vi si troverebbero iscritti 300 o 400 mila operai e sarebbe questo un primo passo non indifferente.
A questo suo ragionamento egli sa che si fanno molto obbiezioni, ma fa notare subito che occorre tener presente come la Commissione, su tale grave problema, tratta gli interessi di operai, organizzati e non, ragionevoli ed irragionevoli, e quindi per facilitare l'attuazione di un provvedimento occorre dire a tutti che se si chiede loro un sacrificio lo si fa nel loro esclusivo interesse, poiché non si costringe nessuno a pagare per conto di un altro, ma che tutti avranno beneficio.

Con tale ragionamento sarà meno facile incontrare degli ostacoli; egli è fautore dell'imposizione coatta della quale non si nasconde le difficoltà, ma è convinto che prospettando la cosa così come da lui esposta se difficoltà si incontreranno non saranno gravi e potranno facilmente superarsi.
Egli è d'accordo col collega Buozzi circa la risoluzione del problema attraverso quello dell'assicurazione, della disoccupazione, ma oggi si deve risolvere una questione di carattere transitorio, perché se si volesse discutere della complessa questione della disoccupazione, nei riguardi di tutti i lavoratori, bisognerebbe farlo in condizioni di fatto assai diverse dalle attuali. Oggi non si può preventivare la disoccupazione per le diverse categorie d'operai. Anche nel campo metallurgico non si può prevedere nulla dipenderà dalle sorti della guerra e dalle previdenze che adotterà il Governo per le industrie, se cioè le metterà in grado di continuare ad intensamente lavorare e svilupparsi oppure se invece alcune si troveranno in cattive condizioni. Nulla è possibile prevedere e quindi occorre addivenire ad un provvedimento transitorio, mentre se si ba in idea di fare una cassa di soccorso per il dopo guerra crede che la sua proposta possa essere più accettabile di quella dei suoi colleghi operai. Con essa se dopo la guerra non sì avrà disoccupazione ,non si sarà perduto nulla, ma si saranno fatti assicurare 3/400 mila lavoratori alla Cassa N azionale per le pensioni della vecchiaia. Il Comm. ORLANDO desidera fare una raccomandazione e cioè che la discussione sia fatta e porti ad una deliberazione, ma al di sopra di qualsiasi movente politico. Egli ultimamente ha dovuto con dispiacere constatare invece l 'opera a lui contraria fatta da qualcuno dei membri operai presenti nella Commissione, sia presso le sue maestranze di Livorno che presso quelle di Spezia. Gli stessi fenomeni si sono verificati fra quelle maestranze e cioè, in questo grave momento, il rifiuto di lavorare nelle ore straordinarie. Deve dichiarare che deve lodare il collega Ancillotti, il quale come Membro del Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale di Genova, fece opera veramente conciliativa e portò alla soluzione della vertenza. Gli spiace invece che il collega Buozzi abbia agitato a Livorno le sue classi lavoratrici, forse perché sorpreso nella sua buona fede da un memoriale presentato dagli operai e che non rispecchiava le loro vere condizioni. Avrebbe gradito che il Signor Buozzi si fosse recato da lui come membro del Comitato Regionale di Milano.
Il Signor BUOZZI r isponde che è spiacente di quanto affermato dal Comm. Orlando e che nessuna ragione politica lo spinse nel difendere gli interessi degli operai di Livorno. Occorre che il Comm. Orlando consideri che egli è segretario di federazioni metallurgiche e che tale carica non è cessata per lui in quanto fa parte della Mobilitazione Industriale. Ad ogni
modo ritiene che egli non avrebbe potuto presentarsi al Comm. Orlando che come segretario di una federazione operaia e quindi forse non sarebbe stato ricevuto.
Il Comm. ORLANDO conferma che in questo momento bisogna prescindere da qualunque preconcetto o visione politica, mentre purtroppo ogni tanto la politica fa capolino. Gli industriali non sono federati e, in questo momento, anche gli operai debbono dimenticarsi di esserlo.
I membri operai sono stati scelti dal Governo perché persone intelligenti, ragionevoli e che hanno una grande ascendente sulle masse operaie; quindi essi non devono portare dei preconcetti o dei programmi di federazioni; si fiil'irebbe per non intendersi più. Nella Commissione sono tutti colleghi e quindi bisogna abbandonare la politica.

Il Comm. FERRARIS dissente dalle idee del Comm. Orlando in tema di trattative di questioni operaie, perché a Torino ove si è adottato un sistema diverso, cioè di federare anche gli industriali (Lega Industriale che conta oltre 300 soci) in tutte le trattative i componenti sono stati molto facili. Si augma che questi contatti continui fra membri industriali ed operai, creati dalla Mobilitazione Industriale facilitino sempre più il lavoro fra federazione e federazione. Per quanto riguarda l'accusa fatta dal Comm. Orlando, egli deve dichiarare che la Federazione Metallurgica di Torino spontaneamente, aderendo all'invito degli industriali, ha rinunciato, per il periodo di guerra, ai riposi che erano stabiliti.
Il Comm. BREDA vuole esprimere il suo rammarico per i fatti esposti dal Comm. Orlando e dal Buozzi, e che credeva non avessero a verificarsi su argomenti di paghe e retribuzioni. Siamo tutti militarizzati e quindi non debbono nascere queste discussioni che lasciano sempre uno strascico spiacevole sia per la materia che trattano, sia per il processo che devesi seguire per tali questioni onde risolverle. Bisognerebbe trovare la strada per evitare tutte queste questioni. Egli crede che i Comitati Regionali dovrebbero coordinare i loro giudizi in materia di controversie economiche in modo che possa stabilirsi per ogni località e per ogni industria il limite delle retribuzioni. Egli dichiara di aver trasmesso al Comitato di Milano l'elenco delle competenze che egli paga a tutte le categorie di operai, pregandolo di vedere se queste erano in armonia con quelle che venivano corrisposte altrove.
Il Comm. ORLANDO afferma che questo è molto difficile poiché le retribuzioni sono in diretto rapporto con l'abilità dell'operaio e del lavoro che produce.
Il ,Comm. FERRARIS trova ottima la proposta Breda se fosse raggiung-ibile da parte di tutti i Comitati Regionali, ma ,incontra troppe difficoltà oltre quella fatta presente dal Comm. Orlando. I Comitati stessi sono poi così oberati di lavoro c he sarebbe assai difficile. potessero raggiungere l'intento o avvicinarsi ad esso. Insiste d'altra parte nel far rilevare come a Torino non si ebbero che tre o quattro ordinanze mentre la maggior parte delle controversie furono risolte all'amichevole, in quanto intervenne l'accordo fra federazione industriale e federazione operaia.
Il Comm. Orlando fa osservare come l'industria Torinese sia tutta affatto speciale e particolarmente versata nella fabbricazione dei proiettili e delle automobili. Inoltre l'industria Torinese ha avuto l'esportazione che l'ha rinforzata e fatta prosperare. Le industrie Torinesi quindi hanno largheggiato con gli operai, perché lo potevano, ma hanno pur fatto il danno degli operai. Lo hanno fatto perché lo hanno potuto avendo il monopolio dell'esportazione e quindi potevano con grande facilità risolvere le questioni economiche.
Il Comm. FERRARIS osserva che a Torino si hanno molte altre industrie e non solo quelle accennate dal Comm. Orlando; le industrie Torinesi hanno saputo divenir fiorenti anche in tempi non buoni, e questo
l'affiatamento che hanno sempre avuto con le loro maestranze. Non si deve prendere fa Fiat come esponente delle industrie di Torino, poiché ve ne sono molte altre e molto importanti, come quelle tessili, quelle del materiale Ferroviario ecc.
Il PRESIDENTE interviene perché desidera che termini questa discussione che non rientra affatto nei limiti del mandato che ha fatto riunire la Commissione. Prega quindi i Commissari di non insistere oltre, mentre dopo le spiegazioni avvenute potranno con calma ed obbiettività come sempre,discutere sui temi sui quali sono stati chiamati a deliberare.
Il Signo BUOZZI desidera ancora far osservare che la Mobilitazione Industriale ha limitato la libertà degli operai, in quanto non possono scioperare, ma non ha impedito che essi possono presentare dei memoriali quando lo credono opportuno. Egli afferma che la controversia ha inizio quando l'accordo non si sia ottenuto all'amichevole fra industriale e maestranze.
Il Comm ORLANDO afferma che non ha mai escluso di trattare cogli operai e che questo è stato invece sempre suo principio.
Il Signor ANCILLOTTI dice che ha piacere sentire il Comro. Orlando compiacersi della sua opera conciliatrice esercitata, e deve dichiarare che l'opera da lui fatta nel caso delle maestranze della Vickers Terni è quella che egli ha fatto presso tutti gli stabilimenti ausiliari della Liguria. Egli constata con piacere che mentre nei primi giorni della Mobilita. zione Industriale pochi erano gli industriali con i quali si poteva trattare, oggi le questioni con tutti vengono risolte da lui e dal suo collega Benato; anche in questi uJtimi giorni ha conseguito una conciliazione negli Stabilimenti Odero. La questione più importante che chiedono gli industriali è quella delle ore straordinarie ed egli ha sempre detto che gli operai hanno l'obbligo di lavorare. Il collega Buozzi ha affermato la stessa cosa. Se il Comm. Orlando ha trovato che egli ha fatto opera conciliativa, questo è dovuto al fatto che egli da 15 anni si trova nelle organizzazioni operaie ed in mezzo alle maestranze, quindi è divenuto conciliante in quanto comprende perfettamente fin dove le classi lavoratrici possono ottenere e fin dove gli industriali possono cedere, stante l'ora tarda, 12,45, la seduta viene tolta e rinviata alle ore 15,30.
Il PRESIDENTE apre la discussione sulle proposte ANCILLOTTI.
Il Comm. Ferraris dichiara di aver posto molta auenzione alle proposte del collega Ancillotti poiché gli parvero subito le più pratiche e tali da portare all'accordo fra le due parti. Però prima di entrare nella discussione, desidera far osservare come l'Ancillotti non abbia fatto parola dell'eventuale disoccupazione, e del modo col quale a questa si dovrebbe rimediare, per coloro ai quali oggi si deve pensare prima di tutti e cioè agli operai che ritorneranno dalla fronte.

Il signor ANCILLOTTI dice di aver pensato anche a questi ed avrebbe in animo di proporre che gli industriali versassero egualmente la quota per questi operai mentre all'interessato dovrebbe sostituirsi il Governo; del resto non crede che si tratti di molti individui.
Il Comm. FERRARIS oserva che non saranno però pochi poiché nelle prime chiamate alle armi non si ammisero esonerazioni; molti quindi andarono alla fronte e benché se ne ottenne poi il rinvio di alcuno, pure ancora parecchi vi si trovano tutt'ora.
Il PRESIDENTE dice che è bene tenere presente un Decreto Luogotenenziale che stabilisce il concorso del Governo per quelli che sono alla fronte p er non far perdere loro nessun diritto.
Il Comm. FERRARIS pure ammettendo che gli industriali corrispondono alle famiglie di questi operai una parte del loro salario, afferma che questo può bastare soltanto ed a stento al sostentamento della famiglia.
Il Signor ANCILLOTTI dichiara che appunto nella sua relazione, che
poi leggerà, ha previsto questo e quindi opina che il Governo debba pagare la quota all'interessato.
Il Comm. ORLANDO afferma anche per per gli operai che sono alla fronte tutti gli industriali passano un compenso alle famiglie, al quale va aggiunto quello che le famiglie stesse hanno dal Governo, per modo che tale sussidio complessivo corrisponde in genere alla paga nominale. Quando questi operai torneranno dalla fronte, essi banno acquistato il diritto di preferenza sugli altri nuovi ammessi e riprenderanno il loro posto. Ora caricare agli industriali tutti i compensi di coloro che sono tuttora alla fronte, ai quali si garantisce il posto e si corrisponde già un compenso, gli sembra sia tropo gravoso.
Conviene nel progetto Ancillotti, ma crede che occorr-erebbe apportarvi qualche variante; vorrebbe ad esempio fare un libretto a numero. La stessa forma che l'Ancillotti propone è stata studiata ed attuata dieci anni fa dalla Società di Terni, senza nessun frutto, ciò che denota la poca educazione industriale dei nostri operai e come sia nostro obbligo di educarli . Egli d'accordo con l'allora On. Bissolati, studiò la cosa e difatti la Società di Terni per tutti i suoi operai paga oltre che la quota minima un contributo annuo di incoraggiamento di lire sei ed un contributo di premio uguale ai versamenti che l'operaio dovrebbe fare durante l 'anno, entro certi limiti e con date modalità Come risultato di questo si ha che sopra quattromila operai forse una dozzina hanno compreso lo spirito della cosa e versano ancora oggi qualche cosa durante l'anno. Ciò malgrado egli afferma di associarsi alla proposta Ancillotti perché trova necessario che bisogna insistere per convincere gli operai al risparmio ed educarli industrialmente. Rinuncia pertanto alla sua primitiva idea di un libretto di cassa di risparmio e conviene che sia bene prendere accordi colla Cassa Nazionale di Previdenza anche per vedere che venga sulle somme accumulate corrisposto un adeguato interesse. Occorrerà anche accordarsi perché .l'industriale, se fa questo sacrificio, abbia anche il diritto di assicurarsi la continuità della sua manodopera.
Il PRESIDENTE dichiara che anche a lui e accaduto presso a poco lo stesso fatto cui ha accennato il Comm. Or lando, per una a zienda alla quale egli è particolarmente interessato e nella quale sono impiegate molte donne. Si sono fatti dei sacrifici notevolissimi assicurando tutte le donne; ebbene quasi nessuna ha ritirato il proprio libretto. Ciononpertanto anche egli è d'avviso che occore insistere onde a poco a poco gli operai si convincano; è un dovere che si ha di fare tutto il fattibile, se non altro a scopo educativo.
Il Comm. FERRARIS rispondendo al Comm. Orlando osserva che è ben vero che gli operai che torneranno dalla fronte hanno diritto di ritornare ai posti che hanno lasciato, ma bisogna anche prevedere che molte officine dove essi prima lavoravano, forse non avranno lavoro sufficiente per impiegarli quando torneranno dalla fronte. Circa la previdenza non vi è alcun dubbio che essa debba essere coattiva e non volontaria perché sia quanto esposto dai Comm . Orlando e Saldini, sia l'esperienza anche da lui personalmente fatta hanno dimostrato che occorre imporre all'operaio di risparmiare. Si è poi riscont rato che mentre per gli operai il provvedimento da lui escogitato non detta alcun frutto, per gli impiegati invece dette i risultati che si speravano. La non riuscita però è anche dovuta anche all'instabilità degli operai nelle officine; ,tal volta per la natura stessa delle industrie che in certi determinati periodi dell'anno hanno bisogno di un maggiore e minor numero di operai.
Il PRESIDENTE invita il Signor Ancillotti a leggere la sua relazione.
Il Signor ANCILLOTTI legge quanto segue: Dovendo profittare delle circostanze attuali per provvedere alla costi-

tuzione di un fondo di previdenza per il dopo guerra, il sottoscritto si permette osservare:
Tenuto presente che un provvedimento generale inteso a risolvere per sempre il problema dell'assicurazione sociale contro la disoccupazione non è oggi possibile appunto perché attraversiamo un periodo transitorio e perché oggi non si può stabilire quale sarà nel suo complesso il movimento industriale Italiano dopo la guerra.
Ricordato conseguentemente che ogni provvedimento in ordine alla disoccupazione resta oggi limitato agli operai degli stabilimenti ausiliari nonché considerato in rapporto alla odierna intensificazione del lavoro ed alla possibilità, dopo la guerra, di un transitorio e parziale arresto dell'attività degli stessi stabilimenti, nota:
Fra gli stabilimenti oggi dichiarati ausiliari vi sono inclusi:
Cantieri Navali - Stabilimenti Siderurgici - Servizi Pubblici - (Aziende Elettriche e Gas) Offici ne Ferroviarie - nonché una parte di stabilimenti meccanici i quali prima della guerra erano adibiti a lavorazioni quali: Locomotive Ferrovarie, Automotrici Elettriche Ferroviarie, Carrozzoni per linee tramviarie elettriche, ecc . lavorazioni che per essere state sospese dovranno essere riprese con la maggiore intensità non appena ritornati alla situazione normale. Ora gli operai degli stab ilimenti citati comprendono benissimo che per il dopo guerra la disoccupazione li colpirà né punto né poco e quindi poco volentieri accetterebbero il pagamento obbligatorio di una quota per la Cassa di Previdenza contro la disoccupazione, utilissima quest'ultima invece gli operai dei proiettifici e in genere di quelle altre industrie di guerra che per non esigere una eccessiva capacità tecnica dal personale hanno consentito un rapido e forte aumento della manodopera.
Convinto però, il sottoscritto, della necessità di un provvedimento che sia eguale per tutti, pur potendo essere diverso nelle finalità, propone:
1) Iscrizione di tutti gli operai degli stabilimenti ausiliari alla Cassa Nazionale di Previdenza (Ramo contribu ti riservati) per il minimo della quota e cioè L. 0,50 al mese.
2) A tutti gli operai, a seconda del loro guadagno medio giornaliero dovrebbe eserc fatta una trattenuta mercé la quale verrà aperto un libretto di risparmio individuale sul quale verrebbero segnate anche le quote stabilite per gli altri operai venissero stabilite quote di L. 1, L. 2, L. 3, la quota degli industriali dovrebbe essere di L. 2 per tutti.

Gli operai potrebbero essere divisi in tre ed anche in quattro categorie a seconda delle quali verrebbe fissata l'entità della trattenuta sul salario e cioè :
Fino al guadagno medio giornaliero di L. 3 L. 1 mensile
)) )) )) )) )) da L. 3 a L. 5 )) 2 )) » )} )) )) )) da L. 5 a L. 8 )) 3 )) Oltre il guadagno medio giornaliero di L. 8 )) 4 ))
L'Amministrazione di questo fondo dovrebbe essere delegata alla Cassa Nazionale di Previdenza la quale offre le maggiori garanzie nell'interesse comune. Dopo la guerra agli operai che rimanessero disoccupati la Cassa dovrebbe restitutire ratealmente il fondo individuale accumulato. Non è da escludere che t rattandosi di sussidio a disoccupati il Governo possa fare a favore dei detti operai quanto oggi fa a favore dei soci delle esistenti Casse contro la disoccupazione.
Per gli operai che non resteranno disoccupati, ent ro un anno dalla fine della guerra, la Cassa Naziona le verserà la soma accumulata nel libretto d'iscrizione contro l'invalidità e vecchiaia.
Con ciò si sarà fatto un passo pratico verso l'avviamento delle assicurazioni sociali e contro la disoccupazione e contro la vecchiaia, problemi
la cui soluzione definitiva è da augurarsi il governo attui dopo la guerra. Nel tempo stesso avremo colpito nel minimo possibile la suscettibilità degli operai per questa forma coatta di assicurazione in quanto a tutti avremo assicurato un reale vantaggio individuale.
Si osserverà che il progetto, per quanto riguarda i sussidi per la invalidità e vecchiaia non favorisce i vecchi operai anziani i quali dalla loro tardiva iscrizione alla Cassa di Previdenza ritrarranno nessuno o pochi vantaggi. Anzitutto con la iscrizione al ramo Contributo riservato le somme pagate ritorneranno ai possibili eredi. Ma, è questo è il più importante, a tempo opportuno industriali, governo, comuni, potranno attuare speciali provvedimenti. Dicendo anche i Comuni, citerò l'esempio di Genova dove la Civica Amministrazione (su proposta del sottoscritto) fin dal 1912 versa un contributo di L. 4 a 12 annue a favore degli iscritti alla Cassa di P revidenza e che hanno pagato la quota annuale, e il contributo, nei limiti di cui sopra, è assegnato in maggior misura a secondo della maggiore età che aveva l'operaio al momento della sua iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza. II provvedimento ebbe tale partito risultato che se per il primo anno per soddisfare all'impegno preso bastarono L. 30.000 nel secondo anno ne occorsero L. 40.000 e nel terzo 50.000.
Resta da provvedere per gli operai che già facevano parte degli stabilimenti ora ausiliari e che attualmente si trovano tuttora alla fronte. Si potrebbe provvedere alla iscrizione dei detti operai lasciando al Governo di pagare quelle quote che non può pagare l'interessato. Ma del resto si tratta di un numero relativamente piccolo date le avvenute esonerazioni dal servizio militare.

Il Signor BUOZZI osserva che la Commissione è stata chiamata a discutere per il dopo guerra, quindi non può entrare in un campo generale il quale fatalmente, richiamerebbe l'intervento di altri enti.
Della Commissione fanno parte rappresentanti industriali ed operai degli stabilimenti ausiliari, quindi a lui sembra che si debba tener presente di deliberare in relazione al mandato avuto. Siccome pensa che le deliberazioni dovranno essere seguite da un decreto Luogotenenziale, si deve tener presente di venire in un campo pratico. La questione più importante per il dopo guerra è quella della disoccupazione per le ragioni già dette nelle sedute precedenti. Per queste considerazioni crede che il progetto Ancillotti debba essere esaminato con molta circospezione perché non gli sembra che risolva la questione. Afferma che egli tratta la questione da un punto di vista nazionale mentre l'Ancillotti gli che la veda un pò troppo da un punto di vista cittadino. Egli non crede che subito dopo la guerra si possano utilizzare tutti gli operai che attualmente sono negli stabilimenti, per fare altre lavorazioni che non siano quelle d!ella guerra. Effettivamente ci sarà qualche categoria di operai che non avrà disoccupa. zione, ma in compenso ve ne saranno altre che ne avranno molta. Egli trova che se ci saranno dei lavoratori che non temono la disoccupazione è egualmente giusto che lavorando ora e poi contribuiscano ora e dopo la guerra a favore di coloro che saranno invece disoccupati; è un concetto di alto valore sociale. Combatte il risparmio e non sente di potervesi mai associare, quindi ritiene che la cosa migliore sia quella di affrontare senz'altro la questione della disoccupazione. In questo momento è perplesso di chiedere l'aiuto dello Stato in questo momento gli operai e gli industriali metallurgici sono considerati dei privilegiati e quindi chiedere al governo dei contributi gli sembra problematico; ritiene che sarebbe bene fare ogni sforzo per fare da sé senza disturbare nessuno. Se questo esperimento volontario andrà bene potrà essere un incoraggiamento per l'opera futura dello Stato. Egli ha fatto un piccolo studio circa il funzionamento di alcune casse di disoccupazione che esistono in Italia, a Torino e Milano, occupandosi anche della Federazione dei Lavoratori del Libro. Questa ha
il 95% degli iscritti che sono assicurati. Parla quindi della Società Umanitaria di Milano la quale col versamento di 10,15 o venti centesimi settimanali, corrisponde un sussidio di L. 0,50, 1, o 1,50 al giorno; l'Umanitaria inoltre adottando il sistema di Gand aggiunge altri 50 centesimi al giorno.
L'Umanitaria nel 1914 aveva iscritti 14.764 soci; di questi nell'anno sono stati disoccupati 3.210; ogni disoccupato è stato disoccupato 37 giorni nell'anno in quanto le giornate totali di disoccupazione ammontano a 120.144. Ogni socio quindi ha dovuto 8 giorni e 2/10 di disoccupazione nell'anno.
Il 1914 occorre considerare che è stato normale nel 1° semestre mentre nel 2° semestre si è avuto un periodo di apprensione e di sospensione di parecchie industrie. Eppure nelle industrie metallurgiche la disoccupazione si è verificata in quell'anno in ragione di tre giorni per ogni associato.
A Torino, l'Associazione metallurgica fa pagare, come a Milano 10,15 e 20 centesimi; nel 1911 si sono avute una giornata e 3/10 di disoccupazione per ogni socio, nel 1912 1,25, nel 1913, 1,72, nel 1914, 2 nel 1915 1/2. La Federazione dei Lavoratori del Libro ha subito nel periodo della guerra la più grave crisi; questa fa pagare 30 centesimi alla settimana e corrisponde un sussidio di L. 2 al giorno.
Tale Federazione ha avuto una media di 13 giornate di disoccupazione per oggi socio. È bene però considerare specialmente tre mesi del 1914 perché i dati di essi possono dare una guida per gli eventuali progetti che si vorranno studia-re. In quei mesi fa la classe tipografica la più colpita. I metallurgici non passeranno certamente una tale crisi perché una parte degli attuali operai torneranno ai loro primitivi mestieri od alle campagne dopo la guerra; di conseguenza una parte del personale disoccupato avrà la sua nuova occupazione.

Nei mesi sopradetti si ebbero questi risultati: luglio una giornata, agosto due giornate e settembre due giornate e 8/10 che corrispondono all'incirca a 33 giornate di disoccupazione per socio e per anno
Si ammetta quindi che attualmente gli operai degli stabilimenti ausiliari ammontano a 500 mila e che appena finita la guerra se ne trovino disoccupati 100 mila e per un periodo di tre mesi; vediamo quale somma occorrerebbe per sussidiare con due lire gli uomini, 1, 1,50 le donne, e L. 1 i ragazzi. Cinquecentomila operai fanno all'incirca un miliardo e mezzo di ore di lavoro a ll'anno e quindi in un anno, contribuendo con un centesimo all'ora, verrebbero a dare quindici milioni. Se al centesimo all'ora degli operai si aggiunge un eguale contributo degli industriali si otterranno altri quindici milioni e quindi complessivamente 30 milioni. Si potrebbe forse non fare pagare contributo agli operai che hanno una mercede fino a lire 5 al giorno e che sono circa la metà, onde si avrebbe in tal caso una somma complessiva di 22 milioni e mezzo all'incirca. Nella ipotesi quindi dei 100 mila disoccupati calcolando in media un sussidio di 1,50 per 90 giorni, si verrebbe a distribuire una somma di circa 14 milioni. Rimarrebbero quindi 6/7 milioni che potrebbero servire per l'iscrizione di tutti gli operai alla cassa pensioni. Anche se la disoccupazione sarà maggiore di quella preveduta si avrà sempre un certo margine; quindi si ragg iungerebbe lo scopo facendo pagare relativamente poco a tutti.
Una tale risoluzione del problema non gli sembra troppo difficile, mentre forse resterebbe anche un margine per poter sussidiare anche gli operai che si trovano tuttora alla fronte e che potranno dimostrare di aver lavorato sino alla loro chiamata alle armi presso stabilimenti ausiliari.
Questo in linee generali il progetto; rimane ad intendersi sul modo di amministrare questi fondi e distribuirli. E qui dichiara subito che è disposto a dare tutte le formali assicuraz ioni che in nessun modo gli enti che li, amministreranno potranno celare della casse elettorali. A Milano esiste l'Umanitaria e potrebbe essere incaricata di tale funzione a Torino e
Brescia ci si potrà intendere direttamente cogli industriali, o fare dei consorzi fra industriali ed operai, o con i Comuni, o con gli Uffici del Lavoro.

La trattenuta sarà facilmente effettuata per mezzo di un Decreto Luogotenenziale, per stabilire e determinare gli organi amministrativi ci sarà tempo come ce ne sarà per la costituzione degli Uffici che dovranno amministrare e degli Uffici di collocamento per mettere a posto i disoccupati.
Il Comm. Orlando osserva che il progetto svolto dal Buozzi è improntato a principi di umanità e di collettivismo che non entrano ancora nella mente dei nostri operai. Non sa immaginare come si potrà fare a togliere ad un operaio un contributo che poi non gli resta inscritto di sua proprietà.
Il Signor BUOZZI replica che si tratta di un centesimo ora per gli operai e di un centesimo ora per gli industriali e che potrebbero eventualmente escludersi tutti quelli che percepiscono una paga inferiore alle 5 lire al giorno.
Il Comm. ORLANDO non crede che entreranno delle idee del Buozzi, finché non sarà svolta una grande azione di educazione del cuore e della coscienza degli operai. Crede più attuabile il sistema Ancillotti perché con quello un operaio fa un sacrificio, ma sa che ritroverà il frutto dello stesso.
Il Signor COLOMBINO osserva che con la proposta Ancillotti l'operaio pagherebbe mensilmente L. 3 e l'industriale L. 2 quindi complessivamente L. 60 in un anno, e con tale misero contributo non crede che si ri· solverebbe nulla, <tenuto conto che tutti riavrebbero il proprio. Le 60 lire che l'Ancillotti garantirebbe non possono bastare all'operaio che per tre o quattro settimane, mentre che la proposta Buozzi, pur facendo pagare fra operaio ed industriale la stessa somma di L. 60 annuale, si garanti· scono all'operaio disoccupato 180 lire che possono servire al sostentamento di tre mesi. :E: il criterio della collettività e della solidarietà umana che si deve affermare, non quello dell'egoismo. Si deve imporre, se gli operai non volessero sottostarvi così come si è fatto per la Mobilitazione Industriale la quale è stata applicata non certamente andando a chiedere prima a questo o quell'operaio il suo parere. Coloro che lavorano e conti. nueranno a lavorare anche dopo guerra senza risentire della disoccupazione è sacrosanto doveve colpirli e farli pagare anche per coloro che saranno disoccupati Le due proposte si equivalgono, ma il concetto informativo dell'individualità egli non può accettarlo. Si deve imporre questo contributo ed a tal uopo ricorda che Luzzatti, il creatore della previdenza in Italia ebbe a dire che la previdenza facoltativa è fallita e che ci vuole la forma coattiva. Il timore che le masse respingano il progetto Buozzi egli non lo vede; egli vive continuamente in mezzo ad esse e si impegna di andarlo a sostenere, a divulgare sostenendo l'idea della collettività. Del resto in Francia, in Inghilterra ed in Germania è il concetto della collettività che predomina e che ha dato ottimi risultati.
Il Signor ANCILLOTTI premette che se ci è un uomo che quando si tratta di tutelare l'interesse delle masse si mette magari anche attraverso la corrente delle masse stesse, è lui e non ha quindi bisogno di incitamenti. Il suo progetto non è un decreto di legge e può quindi subire tutte le modifiche che si riterranno opportune. Occorre tener sempre presente il modo di pensare degli operai delle diverse regioni ed ora che si fa un atto ardito, perché è la prima volta che si fa un passo verso la trattenuta dei salari, egli ritiene che bisogna farlo in modo da urtare il meno possibile la suscettibilità Egli osserva che due mesi or sono i suoi colleghi membri operai avevano altra opinione perché discutendo della disoccupazione con l'On. Cabrini espressero l'idea che occorreva preoccuparsi più della vecchiaia che della disoccupazione. Allora egli disse che per la Lombardia ed il Piemonte la questione era anche più importante forse che per la Ligu-
ria e si disse che lo Stato avrebbe dovuto eventualmente provvedervi. Oggi il Buozzi dice che non si deve neppur chiedere quel contributo, ma egli osserva che se domani si avranno 100 mila operai disoccupati e si avrà un sussidio anche dal Governo di altri 50 centesimi, non è poca nobilità accettare questo sussidio. Quando egli parla della duplice forma di assicurazione non si riferisce soltanto alla Liguria, ma a tutta l'Italia metallurgica. Non crede che nelle industrie metallurgiche vi sarà della disoccupazione perché oggi pur producendo di più come tonnellaggio hanno un minor numero di operai dato la proponderanza della produzione di acciaio da proiettili, mentre dopo la guerra dovendo riprendere tutte le antiche e svariate produzioni commerciali avranno bisogno di un maggior quantitativo di manodopera. Nelle stesse condizioni della Liguria si trovano poi in gran parte anche la Toscana e l'Italia Meridionale. Gli si è fatto l'appunto che con 60 lire non si risolve la questione ma egli af. ferma che neppure 180 lire potranno risolverla; non si potrà in nessun modo impedire l'emigrazione attraverso i sussidi perché i buoni operai che hanno volontà di lavorare, non attendo troppo tempo per trovare occupa1:ione; attenderanno soltanto i poltroni e se sono tali è meglio che vadano all'estero. Non si può dire che si salvi l'industria con tali provvedimenti perché sono atti ad impedire l'emigrazione; l'emigrazione non ci sarà se si troverà il modo di occupare tutti gli operai. Lo scopo principale deve esser quello di trascinare gli operai verso l'assicurazione della vecchiaia e della disoccupazione. Quest'ultima dobbiamo risolverla per mezzo dello stato che occorre incitare affinché provveda lavoro all'Italia non appena le industrie dovranno cessare la produzione bellica. In Liguria non esistono casse di disoccupazione, ma si è convinto che esse sarebbero inutili perché se dovesse veramente venire una crisi di disoccupazione data la natura delle industrie locali si avrebbe il 75% di operai disoccupati e quindi qualsiasi risparmio non potrebbe sopperire ai bisogni di sussidio. Col suo progetto egli si prefigge di far rimanere 300 o 400 mila operai aderenti alla Cassa Nazionale di Previdenza poiché è convinto che quando vedrà accumulate nel libretto 60 o 70 lire, l'operaio continuerà a pagare. Non comprende il progetto del Buozzi della cassa o meglio delle casse per la disoccupazione affidate ad istituti diversi nelle diverse località; le quote di tutti debbono andare in un centro unico ed il fondo sia dato ad ogni modo alla Cassa Nazionale di P revidenza anche p erché bisogna stabilire un criterio unico per tutti. I dati esposti dal Buozzi non valgono perché si riferiscono ad un periodo in cui non esisteva disoccupazione per i metallurgici, mentre i dati che si riferiscono ad altre classi operaie non è la Commissione competente a discuterli. Inoltre il progetto tenderebbe ad escludere dal pagamento tutti coloro che percepiscono meno di lire 5 di paga il che si rifcribbe a circa la metà dei lavoratori. Se si considera che nell'Italia Meridionale si hanno delle paghe basse gli operai di quelle regioni non contribuirebbero che in misura molto limitata ad ogni modo non ritiene sia giusto di escluderli. Ripete che per lui ha più importanza l'assicurazione per la vecchiaia che la disoccupazione, perché ci sarà molto lavoro dopo la guerra e non crede si verificheranno molti casi di disoccupazione alcuni dei quali del resto si rioccuperanno quasi automaticamente ritornando ai loro mestieri. Pensando alla vecchiaia si fa un bene per oggi e per l'avvenire. Sostiene quindi che il suo progetto è concretato in modo che dovrebbe soddisfare tutli e non comprende perché non dovrebbe venire accettato.
Il PRESIDENTE si compiace con i membri operai per la competenza addimostrata nella discussione.
Il Comm. PERRONE osserva come in tutte queste discussioni non si si sia ancora compresi del momento che attraversa il Paese, che è un momento in cui si g iuoca l'esistenza. Egli dice che i problemi si debbono

affrontare per il dopo guerra nella stessa forma con cui oggi si sta affrontando il presente. Il presente è costituito da una situazione tale che ci porterà ora alla grande vittoria o alla liquidazione definitiva; erede quindi che la discussione non sia praticamente possibile perché occorre portarla s u una via di mezzo che non sarà quella di domani. Si deve pensare ad elevarsi, pensare ad una grande Italia ed allora questo tema della disoccupazione gli sembra sia una cosa oltrepas sata, qualunque sia la forma di amministrazione di questo fondo che si vuol costituire. Quindi i trenta milioni ai quali accenna il Buozzi, se ci sarà la vittoria, saranno completamente inutili perché non vi sarà disoccupazione; serviranno per la disoccupazione che potrà avvenire in seguito, potranno servire a sostenere i grandi urti che eventualmente si verificheranno. O il problema nella peggiore ipotesi sarà molto più grave ed allora i trenta milioni saranno insufficienti. Si tratta invece di avviare il nostro popolo verso la previdenza per la vecchiaia, e quindi preferisce il progetto Ancillotti.
Il Comm. ORLANDO ripete che è d 'avviso che gran parte dei disoccupati tornerà ai primitivi mestieri e quindi anche egli non prevede una forte disoccupazione. Ritiene che la proposta più pratica e rispondente sia quella dell'Ancillotti, anche perché trova giusto il doppio contributo dell' industriale e dell'operaio. Con la proposta Buozzi invece avverrebbe che l'operaio non vedendo sul suo libretto personale iscritta la sua parte versata, farebbe certamente in modo che anche il suo contributo venisse pagato dall'industriale. Egli si associa al principio del collettivismo, ma gli operai non lo comprendono e quindi difficilmente darebbero la loro quota.
Al Signor BUOZZI replica dicendo subito che egli ha accennato in linea generale al suo progetto, mentre l'Ancillotti è sceso a più precisi particolari. L'Amministrazione dei fondi dovrà certamente essere coordinata; i fondi sono nazionali e non regionali. È evidente che accennando all'amministrazione locale egli era guidato dal concetto che è necessario esista in ogni regione chi controlli e sorvegli questi disoccupati. Il Comm. Perrone ba accennato a che cosa questi fondi possano servire e ad eventuali futuri urti; egli non ci pensa e non vuol pensarci, ma dice che si può fin d 'ora studiare uno statuto che venga approvato da tutti i membri. ][ due progetti non gli sembrano neppure diversi nel principio e dal punto di vista industriale pensa che sia di maggior vantaggio il suo.
Il PRESIDENTE osserva che la discussione, per quanto simpatica, abbia un pò degenerato in una questione generale che riguarda anche l'assetto dell'avvenire. Dapprincipio si disse di studiare l'idea di far mettere a parte un poco di quel denaro in più che oggi guadagnano gli operai; poi si è modificata e si è parlato anche del contributo degli industriali.
Il Comm. FERRARIS ammira lo spirito che anima i colleghi Colombino e Buozzi ed augurerebbe che tutta la classe operaia avesse tali principi poiché in tal caso la questione si risolverebbe assai facilmente. Non tutti invece la pensano ancora così e specialmente nell'Italia Centrale e Meridionale non si riscontra lo spirito di mutualità che si ha invece nell'Italia setteutrionale; quindi non si può chiedere là il sacrificio che facilmente si potrebbe ottenere dall'operaio settentrionale. Occorre l'intervento dello Stato perché se volessero far da sé e industriali ed operai non si concluderebbe nulla. Non dobbiamo preoccuparci che di ottenere il risparmio operaio e nella forma sociale migliore e questa l'Ancillotti pensa che sia la previdenza per la vecchiaia.
I dati statici del Buozzi non servono perché si riferiscono a tempi normali ed oggi si deve invece considerare un periodo anormalissimo ed in questo si associa il Comm. Perrone nell'idea che se tutto andrà bene anche per gli operai e industriali sarà bene, altrimenti invece sarà un disastro per tutti. Egli trova quindi che le idee del collega Ancillotti sono le più pratiche per giungere allo scopo per il quale la Commissione fu riu-

nita; è bene ridurre l'operaio a pensare un poco alla vecchiaia; sarà la forma più simpatica e gli industriali daranno volentieri il loro contributo per spingere l'operaio su questa strada.
Il Signor COLOMBINO dice che ha delle idee non troppo buone sulla Cassa Nazionale di Previdenza e spera che presto venga fatto qualche cosa di migliore. L'Unica obbiezione grave che egli ha inteso fare alla assicurazione collettiva è quella che difficilmente si possa vincere la opinione egoistica degli operai. Egli non è assolutamente d'accordo specie quando pensa che si è riusciti a far pagare la tassa di maternità anche a quelle donne che non avuto e non avranno figli. Per suo conto non trova nessuna difficoltà a vincere questa opinione; ad ogni modo si potrebbe lasciare ad ogni regione di adottare quel principio che crederà migliore.
II Comm. FERRARIS osserva che ciò non è possibile, perché ci vuole una forma ed un indirizzo unico.
Il Signor Colombino continua col dire che l'operaio buono r imarrà se avrà un sussidio ed in pochi giorni troverà certamente lavoro, magari provvisorio; ci può essere l'eccezione e che qualche individuo rimanga disoccupato tre mesi ed egli non emigrerà perché avrà di che vivere. Non è possibile fare la selezione delle maestranze, perché l'emigrazione è regolata da condizioni che superano la volontà degli uomini.
Il Comm. BREDA osserva che il progetto dell'Ancillotti è più beneviso agli industriali, gli sembra perciò sia quella la strada da battere. Il concorso dell'operaio dovrà essere coattivo e quindi occorrerà un Decreto Luogotenenziale ed egli non sa se sia possibile che questo venga emanato poiché dovrebbe essere limitato ad alcune categorie di lavoratori e non esteso a tutti.
II PRESIDENTE osserva che la Commissione non deve preoccuparsi di ques1o; essa deve esprimere il proprio parere e dire al Governo a mezzo di S. E. Dallolio, quello che è stato stabilito in merito al problema che la Commissione stessa è stata chiamata a studiare.
Il Comm. BREDA insiste che non vede la possibilità di emanare un simile Decreto Luogotenenziale.
II Comm. FERRARIS è invece del parere che sia possibile. La Commissione è stata chiamata a studiare la questione per gli stabilimenti ausiliari ed a questi si deve limitare; vedrà poi il Governo se troverà opportuno di far sua la proposta ed estendere il provvedimento anche agli altri.
Il Signor DI DIO osserva che appunto nell'Italia Centrale esistono pochi stabilimenti ausiliari, mentre piccoli interessano il munizionamento. Egli conosce molto bene le condizioni degli operai dell' Italia Centrale e non sa dove trovare nelle •paghe il superguadagno, poiché la media è di 40 centesimi all'ora; non vi è quindi la possibilità del risparmio. La preoccupazione degli operai è quella della disoccupazione di domani, più che della vechiaia e quindi ritiene che nell'Italia centrale se si parlerà di disoccupazione si otterrà qualche cosa, mentre se si parlerà di supermecedi per ottenere la previdenza per la vecchiaia, teme sarà assai difficile ottenere qualche cosa, perché le paghe non sono elevate e sono appena sufficienti a soddisfare i bisogni della vita dato l'alto prezzo dei viveri.
Il Signor ANCILLOTTI dice che la sua proposta l'avrebbe fatta anche in tempi normali se se ne fosse presentata l'occasione favorevole, non solo ma ogni qualvolta è stato possibile egli l'ha applicata a Genova. La proposta del Buozzi tenta ad avvicinarsi alla sua, ma egli dichiara che se quella dovesse essere accettata desidera venga accettata integralmente senza alcuna modifica.
Il BUOZZI osserva che la proposta Ancillotti porta una spesa di 60 lire annue come la sua; la differenza sta nel fatto che mentre l'Ancillotti dice a tutti che avranno 60 lire, egli dice agli operai che rimarranno disoc-

cupati che avranno un sussidio ed egli ritiene che le masse ad entrare in questo ordine di idee. Osserva che anche nel suo progetto è stato pensato alla pensione tanto è vero che si è detto di provvedere all'iscrizione alla Cassa di Previdenza con la somma eccedente i 14 milioni, ed è naturale che ogni operaio iscritto dovrebbe avere il contributo di lire 10 stabilito dal Governo. Alle osservazioni mossegli circa l'inesattezza dei dati statistici esposti, egli dichiara di aver moltiplicato i dati dei tempi normali per un certo numero, appunto per renderli approssimativi a quelli che si verificheranno nei tempi anormali che si prevedono; difatti dicendo 100 mila disoccupati ha preveduto una disoccupazione del 20% che è certamente esagerata.
Il Comm. Breda pensa che nel Decreto dovrebbero esser compresi anche gli operai che pur non appartenendo a stabilimenti ausiliari, fanno parte di stabilimenti che lavorano per lo stato.

Il Comm. FERRARIS concorda nell'idea che i due progetti portino la stessa spesa, ma nelle finalità e nello spirito differenziano moltissimo. Quello dell'Ancillotti risolve in gran parte anche il problema della vecchiaia.
Il Presidente chiude la discussione, ma desidera fare una osservazione e cioè quella che si riferisce alla necessità assoluta che la Cassa Nazionale di Previdenza, per questo speciale scopo destini un ufficio elastico più di quello che non sia di solito. Con i suoi attuali sistemi non sempre le cose si può dire che vadano bene; è assolutamente indispensabile quindi che nell'eventualità istituisca un Ufficio specialistico che non risenta affatto del solito andamento.
Il CAPITANO TONIOLO domanda se non fosse possibile far fare alla Cassa Nazionale di Previdenza il solo servizio di Cassa mentre per tuttoquanto riguarda amministrazione corrispondenza e criteri direttivi potrebbe incaricarsene un consiglio di amministrazione eletto dal Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale.
Il Comm. ORLANDO associandosi a quanto detto dal Capitano Toniolo crede che si potrebbe, in questo periodo transitorio, domandare alla Cassa Nazionale di Previdenza che i fondi che dovrebbero poi trasformarsi in pensioni fossero destinati alla Banca d'Italia o a qualche altra banca per avere un interesse maggiore, che su una somma cospicua può rappresent,are una cifra non indifferente.
Il Capitano TONIOLO dice che tale somma potrebbe distribuirsi fra la Cassa di Risparmio di Milano, il Monte dei Paschi di Siena il Banco di San Paolo di Torino e qualche altro importante e solido istituto che go. da anche la fiducia delle masse operaie.
Il Comm. FERRARIS os serva che potrà eventualmente investire in Buoni del Tesoro.
Il PRESIDENTE mentre invita il Signor Buozzi a presentare nella prossima seduta il suo ordine del giorno, da inserirsi a verbale, data la discussione avvenuta e ritenendo che tutti abbiano ornmai ben compreso il suo progetto e quello dell'Ancillotti propone di addivenire alla votazione.
Votano favorevolmente al progetto Ancillotti: Perrone, Breda, Fara, Orlando, Ferraris, Saldini e Ancillotti.
Votano favorevolmente al progetto Buozzi: Colombino, Di Dio, Sinigaglia, Buozzi.
Resta quindi approvato il progetto Ancillotti.
Il PRESIDENTE prega il Capitano Toniolo di leggere la sua relazione sul capo 4° del programa dei lavori e cioè sulla Mobilitazione Industriale, rimandando la discussione sul progetto all'indomani.
Il Capitano Toniolo legge la sua relazione.
La seduta è tolta alle 19,30.
Come da richiesta verbale ,in riguardo alle notizie specificate nell'oggetto di questa memoria, dò le seguenti particolari informazioni:
1) Modalità contrattuali seguite per le commesse di artiglieria (bocche da fuoco) nei seguenti successivi periodi:
fase della direzione generale di artiglieria e genio (1914 luglio 1915); fase del Sottosegretariato armi e munizioni (sino al giugno 1917); fase del Ministero anni e munzioni (sino al maggio del 1918);
fase del Ministero della guerra interim delle anni e munizioni (sino al settembre 1918);
fase del Ministero armi e trasporti con dipendente Commissariato generale per le anni e munizioni che , dal 28 novembre al 15 dicembre 1918, fu aggregato al Ministe ro della guerra e sotto questa ultima data abolito.
2) Organizzazione degli uffici e nome d e i Capi che stabilirono le acce nnate modalità, che ne cur arono lo svolgiment o, le norme costitutive e l'attuazione.
3) Enunciazione d elle p r incipali Ditte fornitr ici di artiglieria nel periodo anzidetto.
Fase della Direzione Generale di Artiglieria e Genio
Durante questa fase per la parte tecnica riguardante le commesse di artiglieria e per la parte amministrativa si se guirono le consuete norme del tempo di pace .fissate, nel primo campo, dalle funzioni dell'organo ministeriale come d e.finite dall'ordinamento interno del Ministero (vedi circ. 110 del 1911) e dalle mansioni, per regolamento, spettanti all'I spettore generale di artiglieria e d all'Ispettore delle costruzioni d'artiglieria nonché al Direttore dello stabilimento di artiglieria presso il quale era studiato e curato tutto lo svolgimento del contratto dipendente dalle commesse date. Nel campo amministrativo - escluso il prezzo del manufatto - le incombenze erano svolte dal detto stabilimento di artiglieria, che aveva in amministrazione il contratto; e la divisione amministrativa della Direzione generale di artiglieria e genio.
Le norme tecniche per le costituzioni e lo svolgimento di un contratto trovasi de.finito, oltre che nella circolare succitata in quella n . 122 e n. 283 d e l 1911 (G.M.U.) che stabilisce le attribuzioni dell'Ispettore generale di artiglieria e dell'Ispettore delle costruzioni, e dai quattro testi capisaldi per ogni contrattazione per conto dello Stato e cioè: 1) legge e regolamento di contabilità generale dello Stato; 2) il conseguente specifico Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria; 3) l'Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria, per l'applicazione dell'anzidetto regolamento; 4) l'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.
Ancora più specialmente pei servizi di artiglieria è da tener presente il Modello per gli inventori del materiale di artiglieria e genio di cui la Parte I porta, classificati in categorie (per gruppi di materiali similari)

la nomenclatura dei materiali e le tariffe per unità di misura, e la Parte II (in tre volumi) che per ogni dato materiale, enunciato con la propria regolamentare nomenclatura, dà il cenno descrittivo ed i dati delle principali dimensioni. Con esso Modello d'inventori fanno sistema, nei riguardi alla cognizione tecniche, l'Atlante del materiale di artiglieria adottato dal Ministero della guerra (fascicolo dei sunti descrittivi e fascicolo delle Tavole) e le Disposizioni speciali per l'artiglieria dalle quali ultime risultano in forma ufficiale le lievi varianti apportate ai materiali regolamentari e la descrizione di materiali nuovi di non grande entità, in attesa poi di conglobarle, a turno di stampa, nell'Atlante del materiale di artiglieria. Da ricordare ancora, sempre nel campo tecnico, il Regolamento per la collaudazione, visita a matricola delle artiglierie, il Prontuario per la compilazione di richieste provviste di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, la Classificazione dei ferri ed acciai che si impiegano nella costruzione dei materiali di artiglieria ed infine il Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza.
Nel campo amministrativo, oltre i regolamenti ed istruzioni citate avevano vigore le disposizioni in materia che eventualmente erano inserte nelle circolari del Gir. Mil. Uff. (pubblicazione settimanale) e nei fogli d'ordine (editi dalla Direzione Generale di artiglieria e genio) nei fascicoletti di « Parte Comune» come in quelli intitolati « servizio di artiglieria»), nei quali, ad ogni principio d'anno (Foglio d'Ordine n. O), sono raccolte le disposizioni degli anni precedenti in vigore continuativo.
A parte intese preparatorie, in conferenze al Ministero o per corrispondenza ufficiale, praticamente la commessa, la stipulazione del contratto, e la dipendente « amministrazione del contratto » per la provvista delle artiglierie, affidate in tutto o parte ad una Ditta privata, avveniva a questo modo.

Determinato di dover provvedere ad un certo quantitativo di bocche a fuoco, o di sole parti od elementi di esse, la Direzione generale artiglieria dava commesse di ciò alla Direzione di uno stabilimento (generalmente Arsenale militare ed officina) e queste, ricevuto la commessa, procedeva a studi, ricerche di dati e quanto pare necessario per la bisogna e poscia - da noi esclusa generalmente l'asta pubblica per esiguità del numero di possibili concorrenti - passava ad una licitazione a trattativa privata, conclusa la quale il risultato era concretato in una richiesta per provvista (in apposito modulo regolamentare) ed in uno o più schemi di contratto a seconda del caso.
Gli schemi e le richieste per provviste erano passati all'Ispettorato delle costruzioni di artiglieria per esame e parere.
Quest'ente superiore tecnico vagliate dette proposte sotto tutti gli aspetti, ed essenzialmente sotto l'aspetto della determinazione tecnica del manufatto e del prezzo, eseguite le correzioni che riteneva opportuno, in genere d'intesa con lo stabilimento proponente, trasmetteva gli incartamenti al Ministero per la determinazione ministeriale, per il tramitequando si trattava di artiglierie importanti - dell'Ispettorato generale di artiglieria, il quale emetteva anch'esso il proprio parere in merito.
Gli uffici amministrativi della Direzione generale di artiglieria e genio esaminavano i detti documenti pel contratto. Per la parte tecnica assentivano in massima quant'era parso accettabile all'Ispettorato delle costruzioni: per riguardo ai prezzi tenevano conto del parere di dettQ Ispettorato e generalmente non proseguivano ad altre indagini dirette, desumendo elementi di raffronto da altri contratti contemporanei similari od analoghi che in pari tempo altri stabilimenti andavano svolgendo, completando od esaminando. La decisione definitiva era presa dal Direttore Generale di artiglieria e genio, ed, occorrendo, si sottoponeva all'approvazione del Ministro con apposita motivata relazione.
Dopo di ciò l'Ente incaricato stipulava il contratto col fornitore, provvedeva agli inconvenienti legali e poscia inviava copia del contratto al Ministero, corredato da tutti i documenti probatori (capitoli d'oneri, cauzione ecc.).
Il Ministero riscontrato tutto regolare preparava il decreto di approvazione definitiva del contratto, e lo inviava (pel tramite della Ragioneria che prendeva nota dell'impegno) alla Corte dei Conti per la debita registrazione
Tosto che fosse ritornato dalla Corte dei Conti il decreto di approvazione ed i documenti allegati, il Ministero (divisione amministrativa di artiglieria) inviava copia del decreto stesso allo stabilimento interessato dando contemporaneamente l'ordine di esecuzione della commessa.
L'Ente che aveva ricevuto l'ordine di esecuzione del contratto ne avvertiva il provveditore, provvedeva alla registrazione del contratto originale, e, da questo momento, le commesse aveva il suo svolgimento di lavorazione e conseguente introduzione dei materiali in magazzino, dopo che le commissioni di vigilanza o le commissioni di collaudo avessero ufficialmente constatato la bontà dei manufatti secondo i dati del contratto.
Il verbale di collaudo serviva da una parte per formulare la richiesta di presa incarico, in virtù della quale il consegnatario è autorizzato ad introdurre il materiale in magazzino, e ad eseguirne la debita registrazione; d'altra parte passava all'ufficio della contabilità in materia dal quale, per l'ufficio della contabilità in contanti (cassa), veniva pagato il fornitore, oppure si compilava un mandato diretto il quale, passato per le verifiche alla divisione amministrativa, alla ragioneria e poi al Ministero del Tesoro era infine spiccato - intestato al fornitore - presso quella Tesoreria provinciale dove quest'ultimo aveva richiesto il pagamento dei suoi averi.
La nostra « Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria » considera (art. 4°) come prevede il Ministero all'acquisto dei materiali di artiglieria in tempo di guerra, cioè esattamente pei servizi d'artiglieria alle truppe sul piede di guerra, e dice che vi attende nel modo che reputa me. glia rispondente alle necessità del momento, prescindendo, qualunque sia l'ammontare delle spese, dalle norme proceduali stabilite pei contratti, considerando quindi le spese come eseguite ad economia, e cioè allargando i casi in cui è concesso esegi.ùre lavori o provviste ad economia come fissati nella stessa istruzione all'art. 34 « Provviste e lavori ad economia ». Poiché però nel tempo della fase considerata non si era propriamente in istato di guerra il Governo, a mezzo di R. Decreti, provvide a legalizzare la messa in atto sin dal tempo di neutralità degli or ora accertati criteri e questi decreti furono successivamente riportati nelle circolari n. 37 e n. 539 del 1914, n. 73, 252, 253, 293 del 1915.
Per quanto dunque sin dal 4 agosto 1914 (di tale data il R. Decreto n. 770 riportato oella circolare n. 371 del 1914) la Direzione generale di artiglieria e genio potesse derogare dalle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per quanto riguardava la provvista di materiali occorrenti all'amministrazione stessa, mai di fatto essa seguì praticamente una via differente da quella che abbiamo accennato per la definizione dei contratti, delle artiglierie ed arrestò soltanto le incombenze nell'ambito del Ministero stesso, non inviando i contratti ad organi collaterali centrali ed attendendo che la Ragioneria del Ministero guerra emettesse mandati di anticipazione agli stabilimenti militari affinché potessero essi stessi pagare sollecitamente i fornitori a collaudo effettuato ed introduzione regolare dei materiali in magazzino.
Neppur questa però fu regola costante ed inalterata, e si ricorse a questo sistema sol quando fu reputato necessario per le sollecitudini delle provviste.

Durante questa fase furono ministri della guerra il Generale Grandi (marzo '14-ottobre '14) e poscia il Generale Zupelli.
Fu direttore generale di artiglieria e genio il Generale Dallolio.
Fase del Sottosegretario per le Armi e Munizioni
Questa fase si aprì a guerra iniziata poiché il Sottosegretario fu istituito nel luglio 1915 e come organo efficiente del Comitato supremo per i rifornimenti delle armi e munizioni (istituito con R.D. 1065, 9 luglio 1915) da questo solo prendeva disposizioni e doveva precipuamente adempiere agli incarichi che da esso Comitato gli venissero affidati. Detto Comitato era poi, per decreto, perfettamente libero di prendere ogni deliberazione ha esso avesse ritenuta necessario per provvedere al più ampio e sollecito rifornimento delle armi e delle munizioni.

In definitiva il Governo, per sciogliere gli organi ministeriali da diverse pastoie burocratiche ed amministrative, non solo costituì il detto Comitato supremo, mi dispose con propri atti per provvedere a legalizzare le deroghe alle norme di contabilità e di procedura amministrativa, promulgando, dopo queUi pre<;ipitati, altri decreti in materia riportati nelle circolari del G.M.U. n. 338 e 574 del 1915, n. 5 del 1916.
Nella regolamentazione di guerra l'unico accenno specifico ai prezzi dei manufatti si trova all'art. 7 del R.D. n. 993, 26 giugno 1915, decreto che porta provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata durante lo stato di guerra, poiché in quell'articolo dopo di aver sanzionato che gli industriali non si possono rifiutare alla fabbricazione e fornitura del materiale necessario agli usi di guerra è detto che nel caso richiedessero prezzi eccessivamente elevati dovevano accettare i corrispettivi che saranno dall'amministrazione stabiliti per ciascuna fornitura, salvo diretto reclamo che sarà giudicato da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, con decisione non soggetta ad appello né a ricorso né a qualsivoglia altro gravame.
Per una serie di ragioni (in parte facili ad intuirsi quando in relazione all'anzi-esposto si consideri la sollecitudine necessaria nelle determinazioni da prendersi per le provviste dell'armamento durante guerra, ed in parte per motivi che non è qui il caso di esporre), con l'approvazione del Comitato supremo e del Ministro della guerra (da cui come Sottosegretario di Stato dipendeva) H Sottosegretario per le armi e munizioni costituì tra gli ufficiali ministeriali da esso direttamente dipendenti un Ufficio Tecnico che ebbe ufficialmente (vedi circ. G.M.U. n. 616 del 1915) le seguenti mansioni:
Organizzazione della produzione delle artiglierie, delle armi portatili e di tutti gli elementi che ne compongono le munizioni.
Contrattazioni relative all'organizzazione predetta ed alle provviste che vi si riferiscono.
Disposizioni relative al controllo della produzione ed al collaudo dei materiali forniti.
Ripartizione di questi ultimi in relazione ai bisogni dei centri di rifornimento ed ai depositi.
Detto Ufficio tecnico fu composto ,nelle principali personalità direttive, di funzionari dell'Ispettorato delle costruzioni di artiglieria e della divisione am1ninistrativa di artiglieria i quali già per le mansioni costantemente esercitate nelle loro sedi di pace avevano singolare pratica e conoscenza sia dei computi per la valutazione dei conti dei manufatti sia delle modalità di stipulazione dei contratti, e perciò - nel seno del Sottose-
gretariato - funzionavano come rappresentanti dei valori dell'Ispettorato delle Costruzioni e della divisione amministrativa di artiglieria.
Ciò premesso si può aggiungere che l'Ufficio tecnico del Sottosegretario
A.M. funzionavano rispetto ai contratti di artiglieria provenienti quali schemi cli contratto degli stabilimenti, come se rappresentasse l'Ispettorato delle costruzioni, e le sue approvazioni erano suffragate dall'accettazione del Sottosegretario per le A.M.; e, rispetto al Sottosegretariato in sé, quand'esso stesso Ufficio Tecnico stipulava un contratto coi provveditori, come Direzione di stabilimento vagliante un contratto e come I spettorato e poi, rispetto all'approvazione del Sottosegretario, quale organo proponente.
La conoscenza dei costi attuali dei materiali l'Ufficio Tecnico la detraeva dalle conoscenze specifiche dei propri componenti, dalle notizie attinte dagli stabilimenti militari e dalle Commissioni di collaudo o di vigilanza interessate che potevano fornire ogni elemento utile per valutare i successivi stadii di lavorazione; dagli uffici siderurgici, carboni, esteri e trasporti marittimi per quanto riguardava il costo delle materie prime in paese o provenienti dall'estero, ed ,infine dagli organi della Mobilitazione Industriale (centrali o regionali) per quanto rifletteva gli emulamenti della manodopera in ciascuna regione od officina privata.
Con le raccolte saltuarie o periodica, completa o frammentaria dei suddetti dati secondo le circostanze, l'Ufficio tecnico era in grado, col dipendente personale specializzato nei vari rami di costruzione di artiglierie, di compilare i propri prospetti di costo dei materiali e discuterli a raffronto di quelli presentati dai fornitori per ogni contratto che occorresse portare a termine.
Definiti i prezzi e le modalità di fornitura il contratto, con le solite formalità statali, era esteso da funzionari d ell'ufficio tecnico, firmato dal fornitore, ratificato dal Sottosegretario per le A.M. e registrato.

Dopo ciò il contratto era considerato perfetto ed inviato ad uno stabilimento militare in amministrazione, ciò che in termine sintetico si diceva « appoggiare un contratto ad uno stabilimento» al quale spettava in seguito considerarlo come fatto da sé stesso, e provvedeva pertanto ai collaudi, all'introduzione dei materiali accettati in magazzino (e all'invio diretto al fronte) ai pagamenti, alle ritenute per le multe e così via, a tutto il corredo infine di documenti contabili d imostranti lo svolgimento amministrativo del contratto.
Trascorsi i mesi di guerra del 1915 e giunti quasi alla fine del 1916 buona parte dell'industria di guerra in paese era nata e sufficientemente sviluppata, l'organismo della Mobilitazione I ndustriale erasi convenientemente esteso ed aveva presi ampi contatti colle industrie belliche, cosicché sembrò giunto il momento di poter più rigorosamente vagliare i prezzi dei manufatti e procedere a sensibili riduzioni di prezzo . Difronte però a questi motivi che sembrava potessero addurre alle dette riduzioni acuivasi il caro-viveri che alzava le paghe operaie, si accentuava la penuria dei trasporti marittimi e ferroviari, gli uni producendo rialzo di noli e rarefazioni delle materie prime di provenienza estera gli altri sovraspese per sorte, ritardi, magazzinaggi prolungati ecc., scemava la totale produttività delle maestranze per l'invio di operai di discreta abilità al fronte e sosti:tuzione con personale femminile e minorile, cosicchè riusciva molto difficile agli uffici, tecnici vagliare al vero la spesa industriale e quindi diminuire fino a l limite utile - cioè senza cagionare deficienza della produzione - il valore dei materiali.
Si pensò d i venire in ausilio all'Ufficio tecnico dandogli un appoggio morale ed un sollievo tecnico di responsabilità, sia quando diminuzioni non si r iuscissero a realizzare sia quando occorreva perfettamente chiarire q uale elemento di riduzione fosse stato possibile, istituendo una Com-
missione - composta essenzialmente di personalità tecniche e non militari, conoscitrici dell'industria - che avesse possibilità di tutto indagare nelel lavorazioni per le armi e munizioni onde essere edotta di ogni più idoneo elemento per esprimere il proprio parere sui prezzi e sulle modalità contrattuali osservate nelle commesse pattuite presso gli uffici del Sottosegretariato.
Il Ministro della guerra accedette alla proposta e venne pubblicato un decreto ministeriale, in data 1° marzo 1917 (vedi circolare G.M.U. n. 172 del detto anno) il quale istituì una« Commissione Consultiva e di revisione dei contratti di forniture di guerra» Commissione che in realtà aveva cominciato a-d esercitare le proprie funzioni sin dal gennaio 1917.

La Commissione aveva funzione di disamine dei contratti impegnanti l'Amministrazione Militare per somme superiori ad un milione sia per la parte legale sia per merito, in modo da garantire l'esatto adempimento, la corrispondenza alle condizioni dell'industria del tempo di svolgimento ed ai giusti prezzi del mercato.
Compravano la Commissione un senatore, presidente, membri, un generale del ruolo tecnico, due professori di politecnico, ed un avvocato erariale. Un'altra avvocato erariale funzionava da segretario.
Perché la Commissione potesse assumere con piena libertà ogni elemento di giudizio e di fatto che ritenesse necessario, ciascun commissario fu munito, sin dal primo giorno di costituzione, di una tessera di libero accesso in qualsiasi stabilimento (militare o privato) avente lavorazioni per conto del servizio armi e munzioni con facoltà di poter ottenere qualsiasi notizia dipendente ed attinente alla mansione che per conto della Commissione esso commissario esercitava.
Per quanto alla Commissione il D. Ministeriale faceva obbligo di presentare soltanto contratti per cifre superiori al milione, il Sottosegretario A.M. aveva disposto che i prezzi unitari, base della disamine che faceva, quando risultavano inferiori a quelli ritenuti giusti dall'Ufficio tecnico, si dovessero prendere come dati di partenza per manufatti analoghi, identici o similari, il di cui contratto, pel suo ammontare, non doveva essere presentato alla Commissione.
Compiuto il proprio esame su di un contratto la Commissione dava conoscenza del suo parere in merito all'Ufficio tecnico e questi doveva attenervisi nella stipulazione definitiva. * * *
Durante questa fase fu mfoistro della guerra il Generale Zupelli ed il Generale Morrone; Sottosegretario per le Armi e Munizioni il Generale Dallolio; Capo dell'Ufficio tecnico per poco tempo il maggiore De Sauteiron, indi il colonnello Martini del ruolo tecnico poco dopo promosso generale, e presidente della Comissione di Revisione il Senatore Conte Cencelli.
Fase del Ministero per le Arnù e Munizioni
Questa fase, nell'argomento che esam1mamo, non portò in principio sensibili conseguenze perché restarono per diverso tempo identiche le fun. zionj dell'Ufficio tecnico ma, verso la fine del 1917, istituito in servizio amministrativo delle armi e munizioni ed assunta dal Capo di questo servizio la funzione di controfirmare i contratti per conto del Ministro A.M. sorsero divergenze di vedute e di apprezzamento su quanto era stato fatto precedentemente.
P er diverse considerazioni furono variate - diminuite le funzioni del-
l'Ufficio tecnico e quindi si pensò di rimettere alla direzione sua un colonnello. Venne perciò trasferito dall'Arsenale di Torino alla sede del Ministero il Colonnello di Artiglieria del ruolo tecnico Cav. Cortese.
L'andamento generale del servizio e le funzioni precipue dell'Ufficio tecnico per vero mai variarono, ma il nuovo capo costituì subito un uffi· cio prezzi quale ufficio collegato col proprio, che assunse più propriamente la denominazione generale « Servizio Commesse Artiglieria ».
L'istituzione dell'Ufficio prezzi e così presentate nella motivazione della mia costituzione:
« il nuovo capo servizio ritiene necessario raccogliere una serie di dati, antichi e ·recenti, per meglio confortare con elementi di fatto, passati ed attuali, la propria esperienza in materia di allestimento di artiglierie e munizioni. Così nelle trattative con i fornitori si sarebbe potuto sem· pre essere sorretti da dati inconvertibili circa i costi delle materie prime e delle lavorazioni d'officina e perciò essere bene in grado di valutare le proposte ricevute ed, occorrendo, di controbatterla con validi elementi tratti da1la visione o quasi dalla conoscenza diretta della produzione.
« Questo Ufficio prezzi raccolse a mano a mano dati sulle forniture passate(dati di contratto, elementi di critica e di controllo forniti dalla Commissione consultiva e dj revisione dei contratti già funzionante da più di un anno, dati profferti dall'Ufficio Siderurgico) e precipuamente si servì di notizie fornite e richieste dalle Commissioni di vigilanza o di collaudo, cominciatino nel quale venivano riassunti in forma schematica a chiaro tutti i dati di costo unitari per ogni singola lavorazione e produzione unitaria di ciascun prodotto e per ciascuna Ditta dalle Commissioni controllate».
In questa fase un Ministro per le armi e munizioni il Generale Dallolio, capi del servizio commesse per artiglieria prima il Gen. Martini poscia il Col. Cortese, poco di poi promosso Generale; capo del Servizio Amministra· tivo il Gen. Gardini.
Fase dell'interinato del Ministero Arnù e Munizioni al Ministero della Guerra
Questa fase non portò nel campo delle commesse di artiglieria, una variante essenziale ai criteri or ora accennati come vigenti nell'ultimo tempo del la fase precedente, ché anzi instituito il « Servizio Centrale Acquisti » - con a capo l'ing. Sinigaglia - per quanto specialmente riguardava la trattazione dei contratti per forniture di materie prime, munizionamento di artiglierie, bombarde, bombe relative, bombe a mano ed esplosivi fu lasciato specificatamente al S ervizio Commesse Artiglieria la definizione dei contratti per quanto rifletteva artiglierie ed armi portatili, contratti che erano poi redatti e stipulati (dopo l'esame della Commissione di revisione e del Comitato di Revisione istituito con D. Luog. n. 620 del 9 maggio '18) dal Servizio Amministrativo dagli stabilimenti di artiglieria.
* * *
Durante questa fase tenne l'in terim del Ministero delle A.M., il Gen. Zupelli; fu Sottosegretario per le A.M. l'On . lng. Cesare Nava; capo del Servizio Commesse Artiglieria il Gen. Cortese e capo del Servizio Amministrativo il G en. Gardini.

Fase del Ministro Armi e Trasporti e Commissariato Generale per le Armi e Munizioni
Fu fase brevissima, praticamente dal 15 settembre all'armistizio, e non seguì nel fatto alcun'essenziale variante di criterio e norma su quelli già esposti, anzi se ne vide una larga applicazione con la costituzione, il 24 ottobre 1918, della Commissione Clavarino per condurre le trattative con la ditta Ansaldo onde definire i prezzi della fornitura dei materiali di artiglieria concessi alla Società stessa dal nov. 1917 in poi. Esse non avendo dati inappugnabili per costituire le basi dei propri calcoli ottenne la nomina di una sub-Commissione, quella del Gen. Stampacchia, onde si procedesse a!Ja valutazione del costo effettivo dei materiali di seconda lavorazione, e questa sub-commissione non potette inviare i primi dati dei suoi lavori che nel 1919. * * *
In questa fase fu Ministro per le Armi e Trasporti S.E. l'avv. Generale Erariale Villa, Commissario Generale l 'On. Ing. Nava, capo del Servizio commesse il Gen. Cortese e Capo del servizio amministrativo il Gen. Gardini.
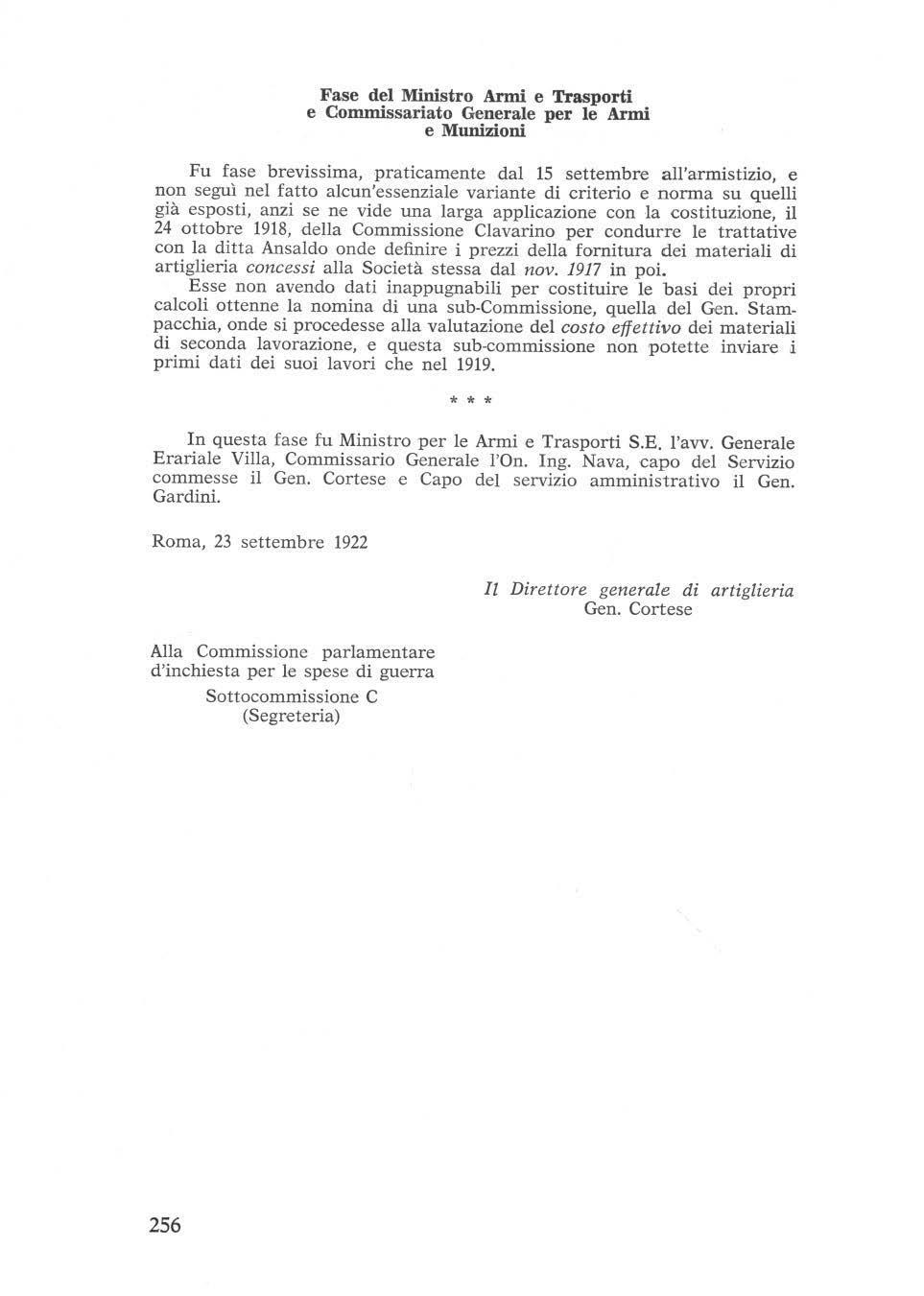
Roma, 23 settembre 1922
Il Direttore generale di artiglieria Gen. Cortese
Alla Commissione parlamentare d 'inchiesta per le spese di guerra
Sottocommissione C (Segreteria)
1. Relazione al Ministro della Guerra in data 28.2.1915 sul nizionamento dell'Esercito e sui provvedimenti per intensificare la produzione pag. 180
2. Relazione del Direttore Generale d 'Artiglieria e Genio sul rifornimento delle munizioni in data 27.6.1915 )) 186
3. Relazione del Sottosegretario di Stato per le Armi e Munizionamento sull'organizzazione industriale per risolvere il problema d el munizionamento in data 1° agosto 1915 )) 189
4. Lettera della S.A.I. GIO. ANSALDO & C. G. DRG/65 al Ministro della Guerra in data 3 maggio 1915 con oggetto: Materiale 105 campale - Affusti 210 - Mortai 250 - Lanciabombe e cannoni antiaerei . » 194
5. Lettera S.A.I. GIO. ANSALDO & C. al Sottosegretario di Stato alle Armi e Munizioni .in data 12 ottobre 1915 n. 30. DGR-314 con oggetto: Necessità di provvedimenti per facilitare lo svolgimento della vita industriale della Società )) 196
6. Lettera del Capo del Servizio Informazioni al Sottosegretario per le Armi e Munizioni in data 30 marzo 1917 n. pr. 2619/S - Riservatissimo - Confidenziale con oggetto: Comm. Perrooe )) 198
7. Lettera del M.inistro Z upelli al Sottosegretario di Stato alle Armi e Munizioni in data 3 agosto n. prot. 3316 con oggetto: Ditta Ansaldo & C.. )) 199
8. Lettera della S.A.I. GIO. ANSALDO & C. al Ministro per le Armi e Munizioni in data 21 novembre 1917 n. prot. 35 P /770 sulla produzione di artiglierie . )) 200
9. Lettera della S.A.I. GIO. ANSALDO & C. in data 3 gennaio 1918 n. prot. 38/P - PERSONALE RISERVAT A al M.inistro per le Armi e Munizioni circa la produzione delle artiglierie )) 201

10. Elenco materiali della S.A.I. GIO. ANSALDO & C. in data 15 gennaio 1918 n. prot. 39/P. 195 al Ministero Armi e Munizioni di Messina circa la produxione che potremo riserva.re al R. Esercito nel secondo semestre del 1918 ripartita secondo i calibri )) 203
11. Elenco materiali del Ministro per le Armi e Munizioni in data 20 gennaio 1918 n. prot. 328283, m risposta ai fogli 38/P. 310 in data 3 corr. - 39/P. 195 in data 15 corr. alla Commissione di Vigilanza presso Ansaldo (Roma) e per conoscenza alla Società Giovanni Ansaldo & C. (Sampierdarena) circa la produzione di artiglierie e nuove commesse )) 205
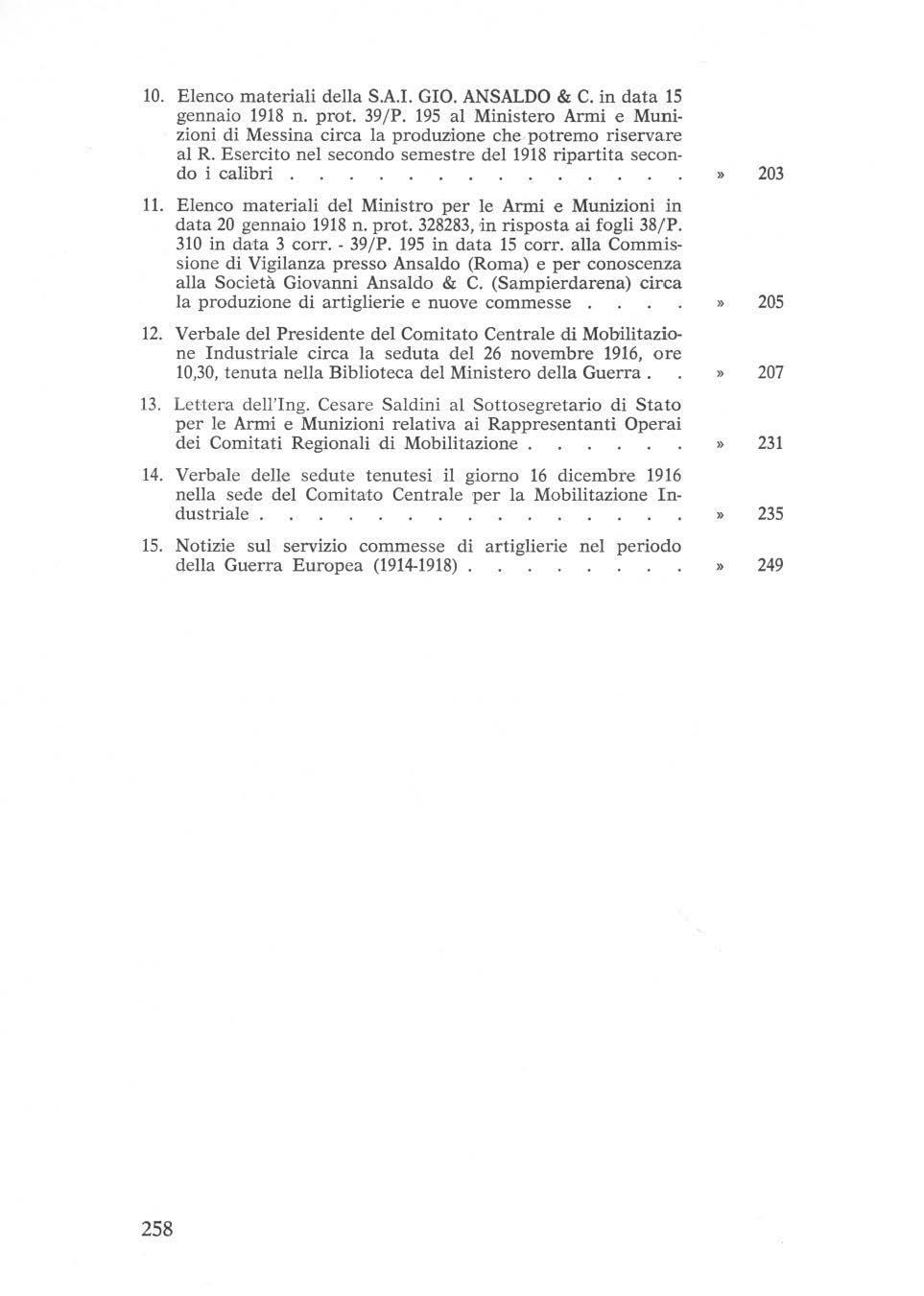
12. Verbale del Presidente del Comitato Centrale di Mobilitazione I ndustriale circa la seduta del 26 novembre 1916, ore 10,30, tenuta nella Biblioteca del Ministero della Guerra . )) 207
13. LcHera dell'Ing. Cesare Saldini al Sottosegretario di Stato per le Armi e Munizioni relativa ai Rappresentanti Operai dei Comitati Regionali di Mobilitazione )) 231
14. Verbale delle sedute tenutesi il giorno 16 dicembre 1916 nelJa sede del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale )) 235
15. Notizie sul servizio commesse di artiglierie nel periodo della Guerra Europea (1914-1918) )) 249
Finito di stampare nel dicembre 1979 presso la tipografia Ingred per conto dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito.