
58 minute read
A Sua Eccellenza
il Generale ALFREDO DALLOLIO
Sotto-Segretario di Stato per le Armi e Munizioni
Advertisement
Il Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale, nella sua Seduta del 17 Agosto 1916, ebbe a deferire ad una speciale Commissione l'esame e la risoluzione, in via consultiva, delle questioni sollevate in un Memoriale dei Rappresentanti Operai dei Comitati Regionali di Mobilitazione, ed in altro, della Unione Sindacale Milanese.
La Commissione venne costituita come segue:
Per gli Industriali i Signori: ed in rappresentanza degli Operai i Signori:
Fera Comm. Cesare Genova.
Breda Comm. Ernesto - Milano.
Orlando Comm. Giuseppe - Roma.
Perrone Comm. Pio - Roma.
Ferraris Comm. Dante . Torino.
Buozzi Bruno - Comitato Regionale, Milano.
Colombino Emilio - Comitato Region<ale, Torino. Ancilotti Ferruccio . Comitato Regio,1ale, Genova.
Di Dio Guido - Comitato Regionale, Roma.
Sinigaglia Carlo Comit,ato Regionale, Napoli.
Con la lettera del 21 Agosto 1916 l'E.V. dav:1 allo scrivente, Ing. Cesare Saldini, l'onorevole incarico di presiedere tale Commissione, lasciandogli facoltà di indire le sedute, ch'essa avrebbe dovuto tenere vuoi presso il Sottosegretadato Anni e Munizioni in Roma, vuoi anche a Milano presso il Comitato Regionale di Mobilitazione, richiedendo in tale caso uno degli Ufficiali del Comitato a fungere da Segretario.
In pieno accordo col Sottosegretariato e col cortese concorso di questo, furono diramati gli inviti ai singoli Commissari, indicendo la prima Seduta per il 6 Settembre alle ore 15, presso il Comitato Regionale di Milano, seduta che in fatto ebbe luogo coll'intervento di tutti i Commissari, meno il Commendatore Perrone, il quale ebbe a scusare la sua assenza causata da motivi di salute.
Argomenti Da Discutere
NEL MEMORIALE DEI RAPPRESENTANTI OPERAI DEI COMITATI REGIONALI, SI CHIEDE:
1. - Che per la parte disciplinare siano richiamati gli Ufficiali preposti a tale servizio, a voler tenere in maggior considerazione la Circolare 24 Ot- tobre ed 8 Novembre 1915 e le norme disciplinari stabilite dal Comitato Centrale di M. I. nella Seduta del Gennaio 1916.
2. - Che il trattamento degli operai militari sia ancora migliorato, quantunque si riconosca che molto già sia stato fatto.
3. - Che sia tolto agli Industriali il diritto di segnare sul libretto di paga il motivo per cui l'operaio venne licenziato - e sia - nel caso di mancanze - accelerata la procedura, affinché non avvenga che la condanna, magari di pochi giorni, non risulti in fatto aggravata da una punizione preventiva di durata molto maggiore.
4. - Che gli esoneri possano essere tolti, in caso di mancanza disciplinari, soltanto dai Comitati stessi che li hanno concessi.
5. - E come richieste di carattere economico, si crede giunto il momento di stabilire che i prezzi di cottimo in corso debbano rimanere invariati fino a quando gli Stabilimenti restaDo ausiliari, salvo che non si apportino variazioni ai sistemi di lavorazione. E si pensa poi che per i cottimi nuovi debba intervenire discussione fra le Parti - ed in caso di disaccordo, debbano intervenire i Comitati Regionali di Mobilitazione.
L' Unione Sindacale Milanese - dal canto suo - chiedeva che nel Comitato Regionale Lombardo si facesse posto anche agli aderenti dell'Unione; e desiderava anch'essa che le tariffe di cottimo non potessero essere diminuite per nessun motivo, e che i cambiamenti nel macchinario o nell'attrezzatura non dovessero essere fatti senza l'approvazione dei Comitati Regionali; e desiderava infine che i Militari comandati a lavorare presso gli Stabilimenti percepissero la paga oraria da essi goduta prima di essere richiamati sotto le armi e risultante dal libretto paga, noocbè gli stessi cottimi e percentuali degli operai borghesi, salvo la trattenuta di Stato. Presa conoscenza di tali documenti, la Commissione ha iniziato la discussione dei singoli punti, così come appare dagli allegati verbali.
Circa l'aumento dei Rappresentanti Operai, in seno ai Comitati, si ebbe solo da prendere atto che la richiesta è già stata soddisfatta dal Comitato Centrale con sua recente decisione portata a conoscenza degli interessati.
Circa alla parte disciplinare, di cui è cenno nel ricordato Memoriale degli Operai, ed ai commenti fatti al riguardo in seno alla Commissione dai Signori Buozzi, Colombino, Ancillotti e Di Dio, si ha solo da ricordare che il Sotto-Segretariato Armi e Munizioni ha già diramato ai Comandi di Divisione le necessarie disposizioni intese a vietare eventuali inframettenze da parte degli Uffici di sorveglianza disciplinare, intendendo il Sotto-Segretariato che siano anzitutto rispettate le discipline regolamentari già vigenti nei singoli stabilimenti.
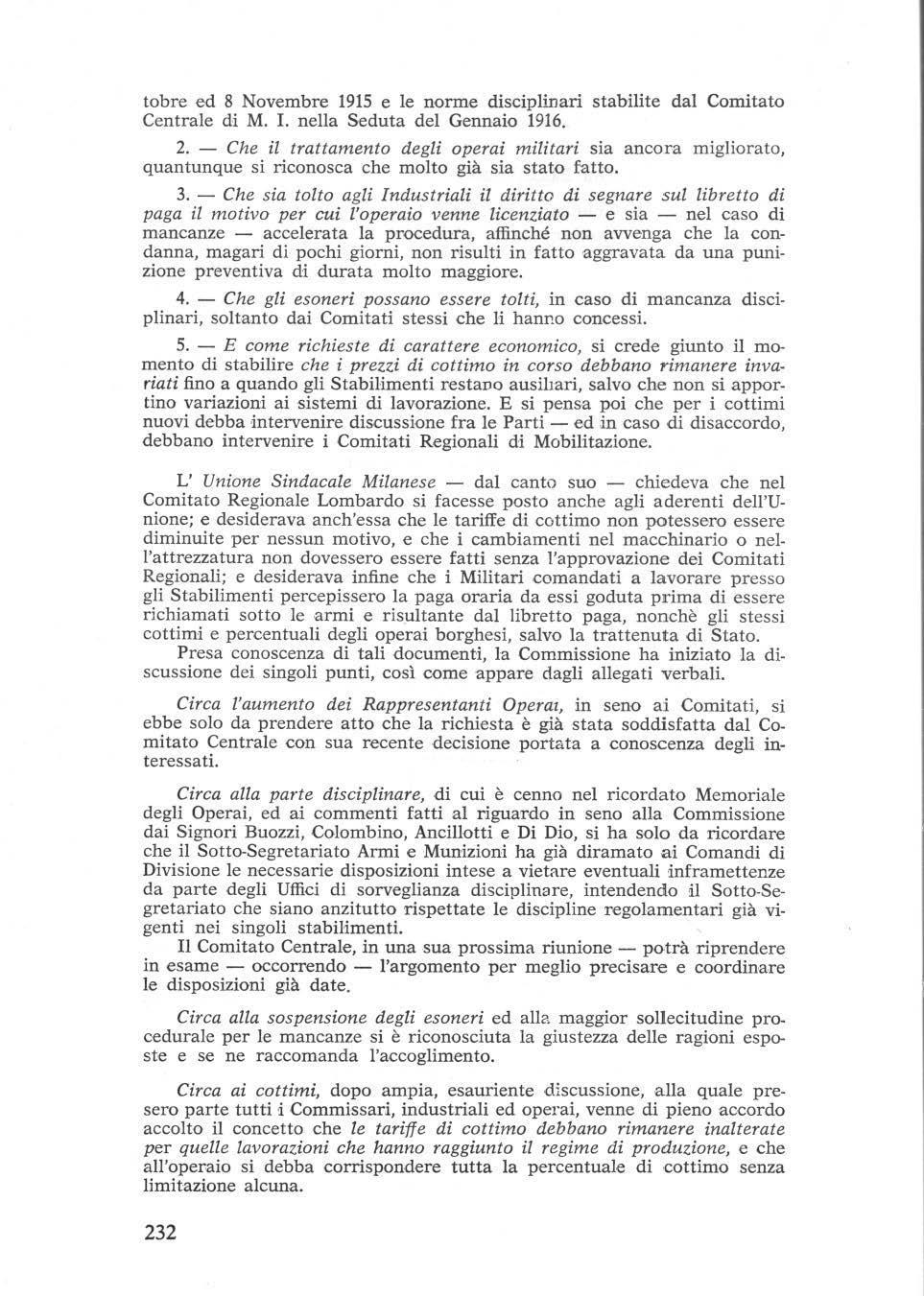
Il Comitato Centrale, in una sua prossima riunione - potrà riprendere in esame - occorrendo - l'argomento per meglio precisare e coordinare le disposizioni già date.
Circa alla sospensione degli esoneri ed alla maggior sollecitudine pro. cedurale per le mancanze s i è riconosciuta la giustezza delle ragioni esposte e se ne raccomanda l'accoglimento.
Circa ai cottimi, dopo ampia, esauriente discussione, alla quale presero parte tutti i Commissari, industriali ed operai, venne di pieno accordo accolto il concetto che le tariffe di cottimo debbano rimanere inalterate per quelle lavorazioni che hanno raggiunto il regime di produzione, e che all'operaio si debba corrispondere tutta la percentuale di cottimo senza Umitazione alcuna.
E parimenti - di pieno accordo - si è acconsentito che, per le lavorazioni nuove, per la introduzione di macchinario nuovo, o per l'impiego di materiali aventi caratteristiche diverse da quelle in uso, le tariffe dei cottimi pos sano essere variate durante il periodo di apprestamento degli impianti o di tirocinio preparatorio della mano d'opera, avuto riguardo, così come fanno già gli industriali maggiori, a che non ne venga soverchio disagio, per quanto transitorio, agli operai. Ad ogni modo, sia quando viene raggiunto il nuovo regime di produzione, od anche quando nasce un dissidio per cottimi già esistenti, le nuove tariffe dovranno essere stabilite di comune accordo fra la maestranza ed i datori di lavoro, ed in difetto, deferite al giudizio del Comitato Regionale, sentite, all'occorrenza, delle persone specialmente competenti.
Per g li operai specialisti (attrezzisti, tracciatori, elettrotecnici, sellai, manovratori di gru ed altri) che integrano il lavoro degli altri lavoratori si dovrà corrispondere una percentuale fissa od una percentuale proporzionale al medio cottimo raggiunto dagli operai nei reparti che essi servono, e ciò per interessare anche gli specialisti, com'è giusto, nei cottimi di lavoro ed all'aumento della produzione.
Per la mano d'opera non quafificata o semiqualificata, dovrà stabilirsi un minimo di paga corrispondente alla paga mmima corrisposta alla maestranza della località nella quale si trova lo stabilimento. Nel caso di dissidio la decisione è rimessa al Comitato Regionale.
Per il lavoro femminile non si è caduti d'accordo quanto alla determinazione di un minimo di paga giornaliera e si è invece accettato unanimemente che il lavoro femminile venga retribwto col medesimo cottimo del lavoro maschile, quando si tratti di lavoraz ioni analoghe e che si svolgano con identicità od equivalenza di mezzi.
Dovendosi però studiare delle tariffe per le n uove lavorazioni di guerra, si prenderà come base, nella determinazione delle nuove tariffe, la paga giornaliera di lire 2,50.
Ed infine, come espressione di voto, ed a proposta Orlando, si è deliberato di proporre e favorire lo studio di una forma di previdenza che, basandosi sulla larghezza delle attuali paghe, valga a salvaguardare gli operai dalle conseguenze dei probabili minimi guadagni temibili per l'avvenire. * * *
Nella seconda seduta tenuta il 19 Settembre in Roma presso il Comitato Centrale di Mobilitazione si è approvato il verbale d ella prima seduta e si è intrapresa la discussione su taluni punti o nuovi o che non erano stati considerati nel precedente convegno. Su questi punti non sono intervenute formali decisioni e tutto al più sono stati pronunciati dei voti, come ad esempio:
1) Che la proposta Orlando di un accantonamento di parte della paga a scopo di previdenza per tempi meno favorevoli sia assai delicata e che la sua eventuale realizzazione debba essere studiata da una Commissione mista di operai e di datori di lavoro.
2) Che non si possa a priori scartare l'idea della mobilitazione industriale anche pel dopo guerra, visti gli indiscutibili vantaggi ch'essa ha recato nel periodo di preparazione della guerra e visto il suo ottimo funzionamento.
3) Che si affermi il principio di una percentuale di compenso spettante al lavoro straordinario ed a quello notturno, senza per ora definire la entità.

4) Che nel periodo di assestamento di nuovi lavori quindi di nuovi cottimi si corrisponda alla maestranza un compenso che potrà essere equamente deliberato dai Comitati Regionali. Agli stessi Comitati dovrà essere deferita la decisione nei casi di cottimi pei quali non sia intervenuto accordo. * * *
Eccole riassunte, IUus. Generale, in brevi parole le conclusioni alle quali la Commissione mista è addivenuta. I verbali allegati danno più viva e più diffusa la fisionomia dei dibattiti che hanno avuto luogo Consenta per ultimo che io metta in rilievo alcune risultanze caratteristiche della discussione ed anzitutto constati, che tanto da parte degli Industriali che degli Operai fu manifestato un virn e sentito e logio, insieme ad una grande fiducia, per la ideazione della Mobilitazione I ndustriale, per le norme regolamentari che l'hanno tanto efficacemente e modernamente disciplinata; per la praticità degli organismi esecutivi. E consenta ancora ch'io le faccia noto il grande compiacimento provato per la serenità mirabile, la inappuntabile correttezza e la grande competenza che hanno sempre regnato nella discussione di argomenti tanto importanti come quello ad esempio dei cottimi di lavoro.
Col maggior ossequio
Cesare Saldin I
COMMISSIONE PER IL« RISPARMIO OPERAIO»
Verbale delle sedute tenutesi il giorno 16 dicembre 1916 nella sede del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale.
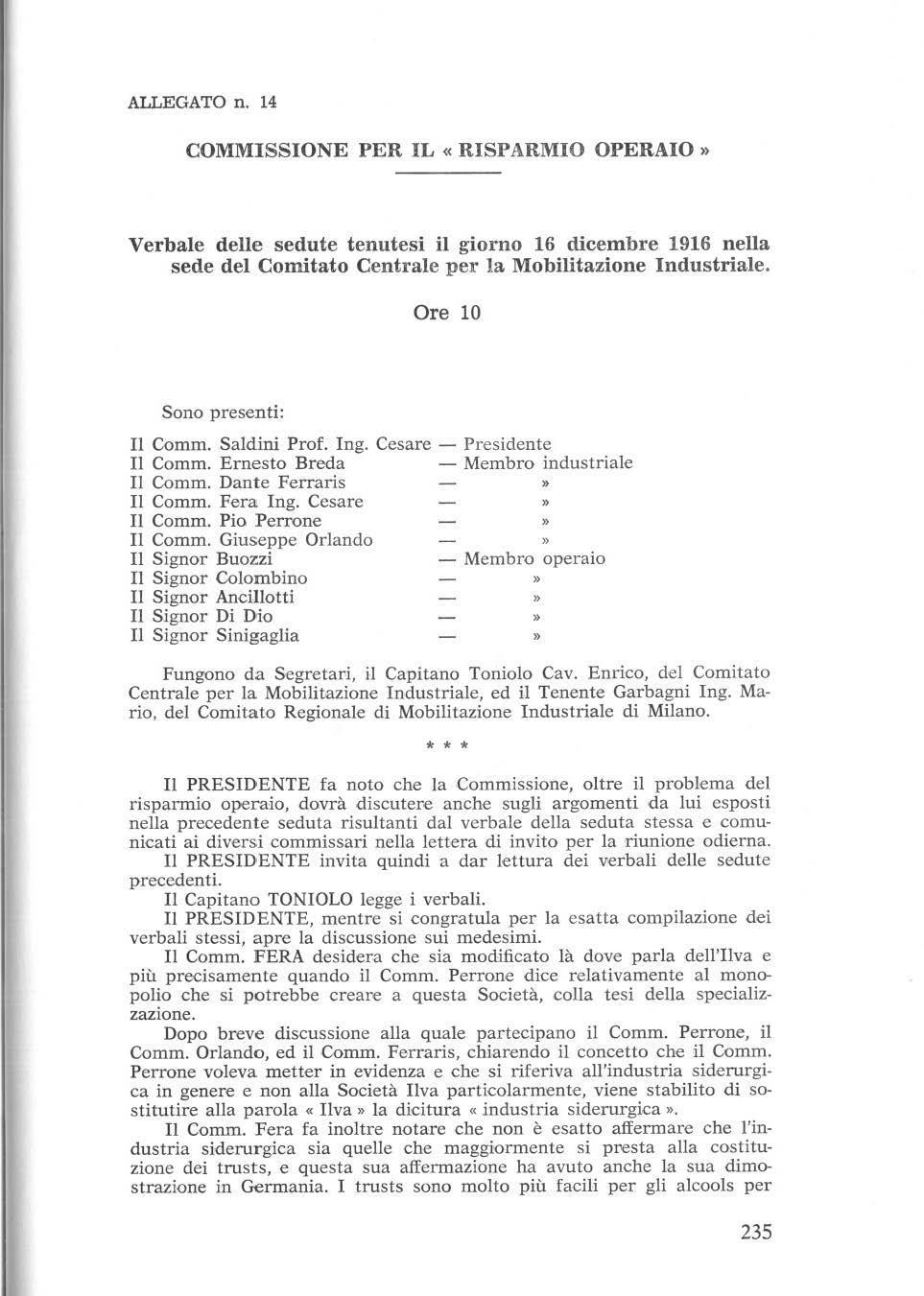
Ore 10
Sono presenti:
Il Comm. Saldini Prof. Ing Cesare - Presidente
Il Comm. Ernesto Breda - Membro industriale
Il Comm. Dante Ferraris »
Il Comm. Fera Ing. Cesare »
Il Comm. Pio Perrone »
Il Comm. Giuseppe Orlando »
Il Signor Buozzi - Membro operaio
Il Signor Colombina »
Il Signor Ancillotti »
Il Signor Di Dio »
Il Signor Sinigaglia »
Fungono da Segretari, il Capitano Toniolo Cav. Enrico, del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale, ed il Tenente Garbagni Ing. Mario, del Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale di Milano.
Il PRESIDENTE fa noto che la Commissione, oltre il problema del risparmio operaio, dovrà discutere anche sugli argomenti da lui esposti nella precedente seduta risultanti dal verbale della seduta stessa e comunicati ai diversi commissari nella lettera di invito per la riunione odierna.
Il PRESIDENTE invita quindi a dar lettura dei verbali delle sedute precedenti.
Il Capitano TONIOLO legge i verbali.
Il PRESIDENTE, mentre si congratula per la esatta compilazione dei verbali stessi, apre la discussione sui medesimi.
Il Comm. FERA desider.a che sia modificato là dove parla dell'Uva e più precisamente quando il Comm. Perrone dice relativamente al monopolio che si potrebbe creare a questa Società, colla tesi della specializzazione.
Dopo breve discussione alla quale partecipano il Comm. Perrone, il Comm. Orlando, ed il Comm. Ferraris, chiarendo il concetto che il Comrn. Perrone voleva metter in evidenza e che si riferiva all'industria siderurgica in genere e non alla Società Ilva particolarmente, viene stabilito di sostitutire alla parola « Ilva » la dicitura « industria siderurgica».
Il Comm. Fera fa inoltre notare che non è esatto affermare che l'industria siderurgica sia quelle che maggiormente si presta alla costituzione dei trusts, e questa sua affermazione ha avuto anche la sua dimostrazione in Germania. I trusts sono molto più facili per gli alcools per gli zuccheri, per i concimi, poiché i prodotti di queste industrie sono unici e semplici, mentre l'industria siderurgica si riferisce ad un grande numero di prodotti.
Il PRESIDENTE annuncia quindi che deve essere ripresa la discussione sul risparmio operaio e la apre intorno alle proposte fatte dai iliversi commissari. Poiché però tali proposte sono una conseguenza dell'idea lanciata dal Comm. Orlando, assente nelle precedenti sedute, dà a questi la parola.
Il Comm. ORLANDO dichiara che la sua fu una proposta fatta senza preliminari; dai verbali testé letti ha rilevato come essa, nella sua forma integrale, non sia stata approvata e quindi ritiene che debba essere nuovamente studiata e discussa. Certo egli crede fermamente, che nel momento attuale occorra fare una proposta di pronta attuazione e di limitati confini, perché se si divaga nel campo della soluzione delle questioni relative alla previdenza operaia e della disoccupazione, questo è così vasto che la Commissione non potrebbe essere in grado di venire ad una pratica de. cisione. Egli propone quindi di discutere e concretare qualche cosa in merito alla sua primitiva idea.
II PRESIDENTE osserva che la discussione in merito alla grave questione è già stata iniziata e quindi occorre sentire i pareri dei diversi commissari sulla proposta Orlando.
Avviene quindi una breve discussione circa le iniziative presi da altri Enti su quanto è oggetto di studio presso la Commissione, esprimendo l'augurio che la Mobilitazione Industrial e, venga interpellata quando si tratti di deliberare o decretare in materia economica che interessa direttamente industriali e maestranze dedite al munizionamento
Il Signor ANCILLOTTI espone quindi le sue idee in merito alla forma di previdenza che egli ritiene la più pratica e migliore per risolvere la disoccupazione nel periodo che passerà dalla fine della guerra all'assestamento delle industrie al regime di pace. Egli prende come base la proposta Orlando; trattenere agli operai qualche cosa di quello. che guadagnano. Egli fa notare subito che vi sono diverse categorie di operai che sono compresi nella Mobilitazione Industriale. Vi sono delle categorie che hanno interesse a che si formi questo fondo di previdenza, mentre vi sono altre categorie che non la riten-anno necessaria perché son convinte che non avranno bisogno di nulla. Tra queste ad esempio, si avrà la categoria degli operai appartenenti all'industria navale oggi essi guadagnano meno che per il passato e dì quanto guadagneranno in avvenire. Inoltre tale categoria, guadagna meno di quella addetta ai proiettifici che ha invece minori capacità tecniche e che sarà quella più colpita nel periodo che succederà alla guerra. Un'altra categoria sarà quella degli operai addetti a servizi pubblici, che difficilmente si assoggetterebbe a pagare una quota, avendo la sicurezza che non soffrirà della disoccupazione e che quindi pagherebbe solo per il vantaggio di altre categorie Occorre quindi tener presente l'interesse di tutti, non essendo possibile addivenire ad un provvedimento pratico adottando vari temperamenti.
Egli propone qtùndi per tutti l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza per una quota minima; poi una trattenuta a tutti, a seconda dell'entità del salario, che dovrebbe essere messa in un libretto individuale nel quale durante il periodo di guerra, si andrebbe così ad accumulare un fondo alla costituzione del quale dovrebbero anche contribuire anche gli industriali in misura eguale. Ad esempio se si stabilisse, a seconda dei salari, che ogni operaio deve versar mensilmente 1, 2 o 3 lire, egli proporrebbe che, in media, gli industriali versassero 2 lire, anche per far sì che essi non contribuissero maggiormente per quegli operai che hanno paghe più alte, e quindi minor bisogno degli altri. Come principio quindi, egual contributo degl ioperai e degli industriali. La Cassa Nazionale di Previ- denza, che potrebbe farsi amministratrice cli questo fondo, fatta la pace, agli operai che rimarranno disoccupati restituirà gradualmente il capitale versato. Il Governo potrebbe eventualmente intervenire dando un sussidio alla Cassa Nazionale di Previdenza, onde questa potesse a sua volta, meglio sussidiare i disoccupati. Per gli operai che ,resteranno occupati la Cassa Nazionale di Previdenza passerebbe quanto da loro accumulato nel libretto individuale al rispettivo libretto pensioni. Si approfitterebbe in tal modo di questa occasione per risolvere, almeno in parte, la questione delle pensioni, poiché vi si troverebbero iscritti 300 o 400 mila operai e sarebbe questo un primo passo non indifferente.

A questo suo ragionamento egli sa che si fanno molto obbiezioni, ma fa notare subito che occorre tener presente come la Commissione, su tale grave problema, tratta gli interessi di operai, organizzati e non, ragionevoli ed irragionevoli, e quindi per facilitare l'attuazione di un provvedimento occorre dire a tutti che se si chiede loro un sacrificio lo si fa nel loro esclusivo interesse, poiché non si costringe nessuno a pagare per conto di un altro, ma che tutti avranno beneficio.

Con tale ragionamento sarà meno facile incontrare degli ostacoli; egli è fautore dell'imposizione coatta della quale non si nasconde le difficoltà, ma è convinto che prospettando la cosa così come da lui esposta se difficoltà si incontreranno non saranno gravi e potranno facilmente superarsi.
Egli è d'accordo col collega Buozzi circa la risoluzione del problema attraverso quello dell'assicurazione, della disoccupazione, ma oggi si deve risolvere una questione di carattere transitorio, perché se si volesse discutere della complessa questione della disoccupazione, nei riguardi di tutti i lavoratori, bisognerebbe farlo in condizioni di fatto assai diverse dalle attuali. Oggi non si può preventivare la disoccupazione per le diverse categorie d'operai. Anche nel campo metallurgico non si può prevedere nulla dipenderà dalle sorti della guerra e dalle previdenze che adotterà il Governo per le industrie, se cioè le metterà in grado di continuare ad intensamente lavorare e svilupparsi oppure se invece alcune si troveranno in cattive condizioni. Nulla è possibile prevedere e quindi occorre addivenire ad un provvedimento transitorio, mentre se si ba in idea di fare una cassa di soccorso per il dopo guerra crede che la sua proposta possa essere più accettabile di quella dei suoi colleghi operai. Con essa se dopo la guerra non sì avrà disoccupazione ,non si sarà perduto nulla, ma si saranno fatti assicurare 3/400 mila lavoratori alla Cassa N azionale per le pensioni della vecchiaia. Il Comm. ORLANDO desidera fare una raccomandazione e cioè che la discussione sia fatta e porti ad una deliberazione, ma al di sopra di qualsiasi movente politico. Egli ultimamente ha dovuto con dispiacere constatare invece l 'opera a lui contraria fatta da qualcuno dei membri operai presenti nella Commissione, sia presso le sue maestranze di Livorno che presso quelle di Spezia. Gli stessi fenomeni si sono verificati fra quelle maestranze e cioè, in questo grave momento, il rifiuto di lavorare nelle ore straordinarie. Deve dichiarare che deve lodare il collega Ancillotti, il quale come Membro del Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale di Genova, fece opera veramente conciliativa e portò alla soluzione della vertenza. Gli spiace invece che il collega Buozzi abbia agitato a Livorno le sue classi lavoratrici, forse perché sorpreso nella sua buona fede da un memoriale presentato dagli operai e che non rispecchiava le loro vere condizioni. Avrebbe gradito che il Signor Buozzi si fosse recato da lui come membro del Comitato Regionale di Milano.
Il Signor BUOZZI r isponde che è spiacente di quanto affermato dal Comm. Orlando e che nessuna ragione politica lo spinse nel difendere gli interessi degli operai di Livorno. Occorre che il Comm. Orlando consideri che egli è segretario di federazioni metallurgiche e che tale carica non è cessata per lui in quanto fa parte della Mobilitazione Industriale. Ad ogni modo ritiene che egli non avrebbe potuto presentarsi al Comm. Orlando che come segretario di una federazione operaia e quindi forse non sarebbe stato ricevuto.
Il Comm. ORLANDO conferma che in questo momento bisogna prescindere da qualunque preconcetto o visione politica, mentre purtroppo ogni tanto la politica fa capolino. Gli industriali non sono federati e, in questo momento, anche gli operai debbono dimenticarsi di esserlo.
I membri operai sono stati scelti dal Governo perché persone intelligenti, ragionevoli e che hanno una grande ascendente sulle masse operaie; quindi essi non devono portare dei preconcetti o dei programmi di federazioni; si fiil'irebbe per non intendersi più. Nella Commissione sono tutti colleghi e quindi bisogna abbandonare la politica.
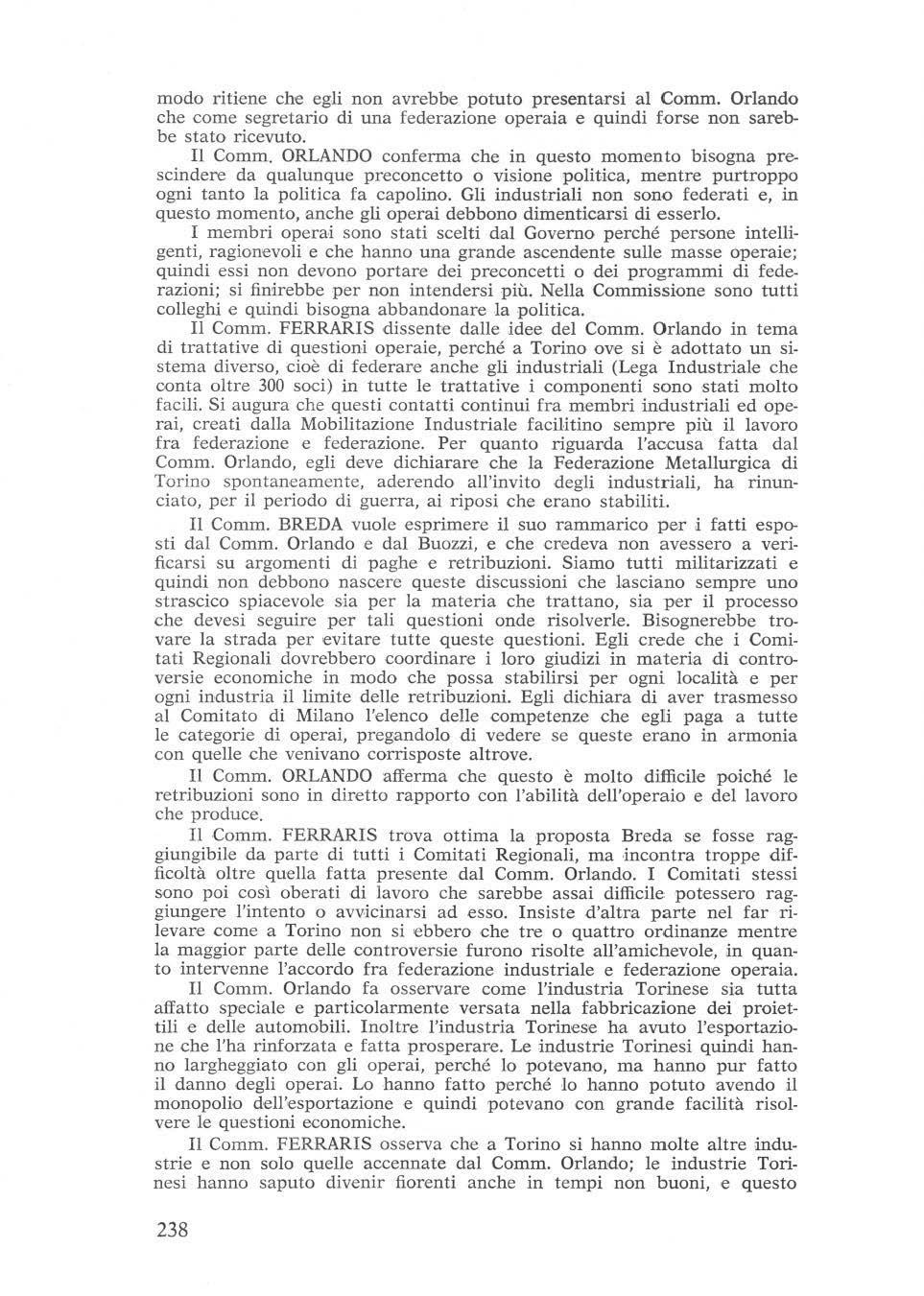
Il Comm. FERRARIS dissente dalle idee del Comm. Orlando in tema di trattative di questioni operaie, perché a Torino ove si è adottato un sistema diverso, cioè di federare anche gli industriali (Lega Industriale che conta oltre 300 soci) in tutte le trattative i componenti sono stati molto facili. Si augma che questi contatti continui fra membri industriali ed operai, creati dalla Mobilitazione Industriale facilitino sempre più il lavoro fra federazione e federazione. Per quanto riguarda l'accusa fatta dal Comm. Orlando, egli deve dichiarare che la Federazione Metallurgica di Torino spontaneamente, aderendo all'invito degli industriali, ha rinunciato, per il periodo di guerra, ai riposi che erano stabiliti.
Il Comm. BREDA vuole esprimere il suo rammarico per i fatti esposti dal Comm. Orlando e dal Buozzi, e che credeva non avessero a verificarsi su argomenti di paghe e retribuzioni. Siamo tutti militarizzati e quindi non debbono nascere queste discussioni che lasciano sempre uno strascico spiacevole sia per la materia che trattano, sia per il processo che devesi seguire per tali questioni onde risolverle. Bisognerebbe trovare la strada per evitare tutte queste questioni. Egli crede che i Comitati Regionali dovrebbero coordinare i loro giudizi in materia di controversie economiche in modo che possa stabilirsi per ogni località e per ogni industria il limite delle retribuzioni. Egli dichiara di aver trasmesso al Comitato di Milano l'elenco delle competenze che egli paga a tutte le categorie di operai, pregandolo di vedere se queste erano in armonia con quelle che venivano corrisposte altrove.
Il Comm. ORLANDO afferma che questo è molto difficile poiché le retribuzioni sono in diretto rapporto con l'abilità dell'operaio e del lavoro che produce.
Il ,Comm. FERRARIS trova ottima la proposta Breda se fosse raggiung-ibile da parte di tutti i Comitati Regionali, ma ,incontra troppe difficoltà oltre quella fatta presente dal Comm. Orlando. I Comitati stessi sono poi così oberati di lavoro c he sarebbe assai difficile. potessero raggiungere l'intento o avvicinarsi ad esso. Insiste d'altra parte nel far rilevare come a Torino non si ebbero che tre o quattro ordinanze mentre la maggior parte delle controversie furono risolte all'amichevole, in quanto intervenne l'accordo fra federazione industriale e federazione operaia.
Il Comm. Orlando fa osservare come l'industria Torinese sia tutta affatto speciale e particolarmente versata nella fabbricazione dei proiettili e delle automobili. Inoltre l'industria Torinese ha avuto l'esportazione che l'ha rinforzata e fatta prosperare. Le industrie Torinesi quindi hanno largheggiato con gli operai, perché lo potevano, ma hanno pur fatto il danno degli operai. Lo hanno fatto perché lo hanno potuto avendo il monopolio dell'esportazione e quindi potevano con grande facilità risolvere le questioni economiche.
Il Comm. FERRARIS osserva che a Torino si hanno molte altre industrie e non solo quelle accennate dal Comm. Orlando; le industrie Torinesi hanno saputo divenir fiorenti anche in tempi non buoni, e questo l'affiatamento che hanno sempre avuto con le loro maestranze. Non si deve prendere fa Fiat come esponente delle industrie di Torino, poiché ve ne sono molte altre e molto importanti, come quelle tessili, quelle del materiale Ferroviario ecc.
Il PRESIDENTE interviene perché desidera che termini questa discussione che non rientra affatto nei limiti del mandato che ha fatto riunire la Commissione. Prega quindi i Commissari di non insistere oltre, mentre dopo le spiegazioni avvenute potranno con calma ed obbiettività come sempre,discutere sui temi sui quali sono stati chiamati a deliberare.
Il Signo BUOZZI desidera ancora far osservare che la Mobilitazione Industriale ha limitato la libertà degli operai, in quanto non possono scioperare, ma non ha impedito che essi possono presentare dei memoriali quando lo credono opportuno. Egli afferma che la controversia ha inizio quando l'accordo non si sia ottenuto all'amichevole fra industriale e maestranze.
Il Comm ORLANDO afferma che non ha mai escluso di trattare cogli operai e che questo è stato invece sempre suo principio.
Il Signor ANCILLOTTI dice che ha piacere sentire il Comro. Orlando compiacersi della sua opera conciliatrice esercitata, e deve dichiarare che l'opera da lui fatta nel caso delle maestranze della Vickers Terni è quella che egli ha fatto presso tutti gli stabilimenti ausiliari della Liguria. Egli constata con piacere che mentre nei primi giorni della Mobilita. zione Industriale pochi erano gli industriali con i quali si poteva trattare, oggi le questioni con tutti vengono risolte da lui e dal suo collega Benato; anche in questi uJtimi giorni ha conseguito una conciliazione negli Stabilimenti Odero. La questione più importante che chiedono gli industriali è quella delle ore straordinarie ed egli ha sempre detto che gli operai hanno l'obbligo di lavorare. Il collega Buozzi ha affermato la stessa cosa. Se il Comm. Orlando ha trovato che egli ha fatto opera conciliativa, questo è dovuto al fatto che egli da 15 anni si trova nelle organizzazioni operaie ed in mezzo alle maestranze, quindi è divenuto conciliante in quanto comprende perfettamente fin dove le classi lavoratrici possono ottenere e fin dove gli industriali possono cedere, stante l'ora tarda, 12,45, la seduta viene tolta e rinviata alle ore 15,30.
Il PRESIDENTE apre la discussione sulle proposte ANCILLOTTI.
Il Comm. Ferraris dichiara di aver posto molta auenzione alle proposte del collega Ancillotti poiché gli parvero subito le più pratiche e tali da portare all'accordo fra le due parti. Però prima di entrare nella discussione, desidera far osservare come l'Ancillotti non abbia fatto parola dell'eventuale disoccupazione, e del modo col quale a questa si dovrebbe rimediare, per coloro ai quali oggi si deve pensare prima di tutti e cioè agli operai che ritorneranno dalla fronte.
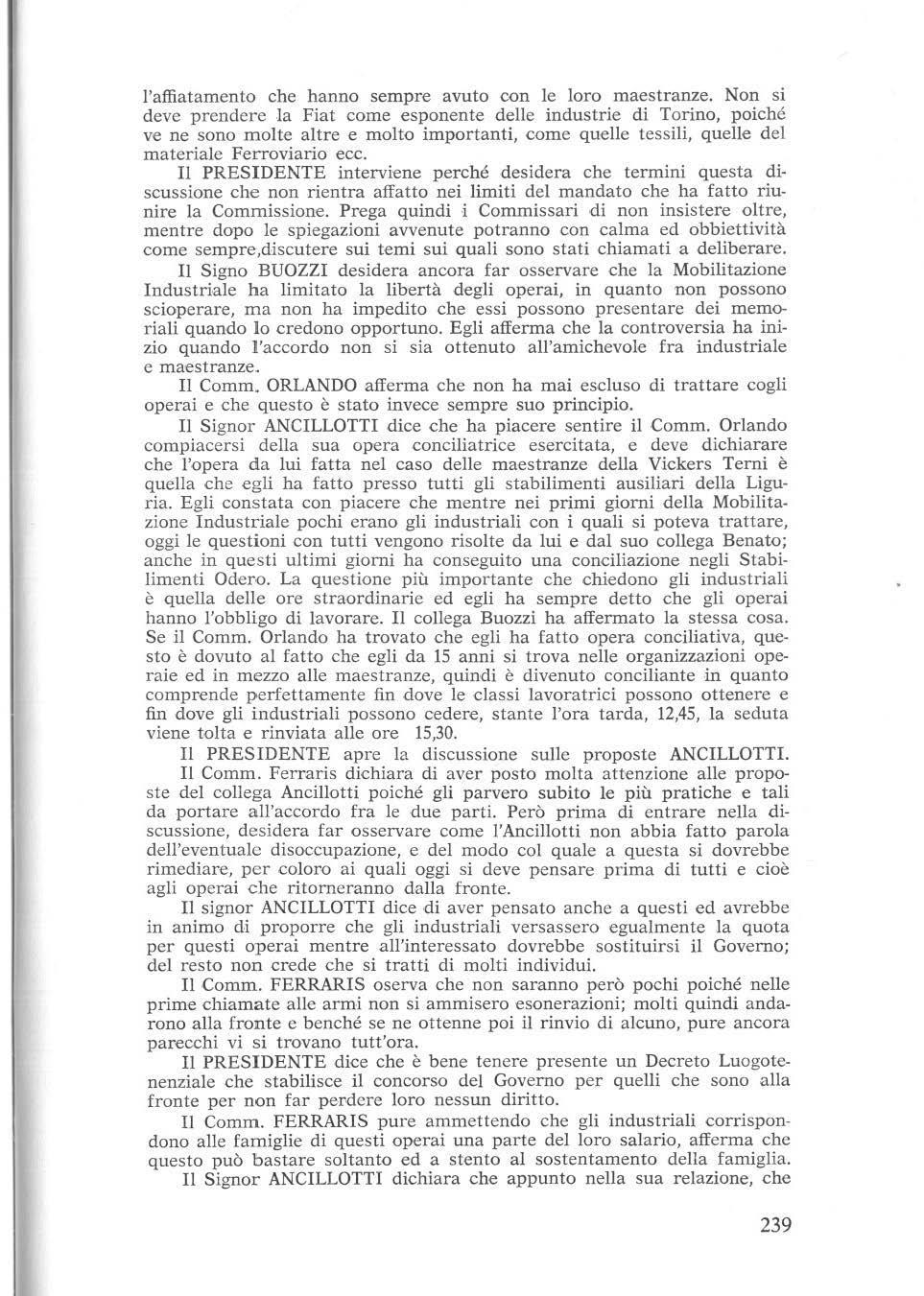
Il signor ANCILLOTTI dice di aver pensato anche a questi ed avrebbe in animo di proporre che gli industriali versassero egualmente la quota per questi operai mentre all'interessato dovrebbe sostituirsi il Governo; del resto non crede che si tratti di molti individui.
Il Comm. FERRARIS oserva che non saranno però pochi poiché nelle prime chiamate alle armi non si ammisero esonerazioni; molti quindi andarono alla fronte e benché se ne ottenne poi il rinvio di alcuno, pure ancora parecchi vi si trovano tutt'ora.
Il PRESIDENTE dice che è bene tenere presente un Decreto Luogotenenziale che stabilisce il concorso del Governo per quelli che sono alla fronte p er non far perdere loro nessun diritto.
Il Comm. FERRARIS pure ammettendo che gli industriali corrispondono alle famiglie di questi operai una parte del loro salario, afferma che questo può bastare soltanto ed a stento al sostentamento della famiglia.
Il Signor ANCILLOTTI dichiara che appunto nella sua relazione, che poi leggerà, ha previsto questo e quindi opina che il Governo debba pagare la quota all'interessato.
Il Comm. ORLANDO afferma anche per per gli operai che sono alla fronte tutti gli industriali passano un compenso alle famiglie, al quale va aggiunto quello che le famiglie stesse hanno dal Governo, per modo che tale sussidio complessivo corrisponde in genere alla paga nominale. Quando questi operai torneranno dalla fronte, essi banno acquistato il diritto di preferenza sugli altri nuovi ammessi e riprenderanno il loro posto. Ora caricare agli industriali tutti i compensi di coloro che sono tuttora alla fronte, ai quali si garantisce il posto e si corrisponde già un compenso, gli sembra sia tropo gravoso.
Conviene nel progetto Ancillotti, ma crede che occorr-erebbe apportarvi qualche variante; vorrebbe ad esempio fare un libretto a numero. La stessa forma che l'Ancillotti propone è stata studiata ed attuata dieci anni fa dalla Società di Terni, senza nessun frutto, ciò che denota la poca educazione industriale dei nostri operai e come sia nostro obbligo di educarli . Egli d'accordo con l'allora On. Bissolati, studiò la cosa e difatti la Società di Terni per tutti i suoi operai paga oltre che la quota minima un contributo annuo di incoraggiamento di lire sei ed un contributo di premio uguale ai versamenti che l'operaio dovrebbe fare durante l 'anno, entro certi limiti e con date modalità Come risultato di questo si ha che sopra quattromila operai forse una dozzina hanno compreso lo spirito della cosa e versano ancora oggi qualche cosa durante l'anno. Ciò malgrado egli afferma di associarsi alla proposta Ancillotti perché trova necessario che bisogna insistere per convincere gli operai al risparmio ed educarli industrialmente. Rinuncia pertanto alla sua primitiva idea di un libretto di cassa di risparmio e conviene che sia bene prendere accordi colla Cassa Nazionale di Previdenza anche per vedere che venga sulle somme accumulate corrisposto un adeguato interesse. Occorrerà anche accordarsi perché .l'industriale, se fa questo sacrificio, abbia anche il diritto di assicurarsi la continuità della sua manodopera.
Il PRESIDENTE dichiara che anche a lui e accaduto presso a poco lo stesso fatto cui ha accennato il Comm. Or lando, per una a zienda alla quale egli è particolarmente interessato e nella quale sono impiegate molte donne. Si sono fatti dei sacrifici notevolissimi assicurando tutte le donne; ebbene quasi nessuna ha ritirato il proprio libretto. Ciononpertanto anche egli è d'avviso che occore insistere onde a poco a poco gli operai si convincano; è un dovere che si ha di fare tutto il fattibile, se non altro a scopo educativo.
Il Comm. FERRARIS rispondendo al Comm. Orlando osserva che è ben vero che gli operai che torneranno dalla fronte hanno diritto di ritornare ai posti che hanno lasciato, ma bisogna anche prevedere che molte officine dove essi prima lavoravano, forse non avranno lavoro sufficiente per impiegarli quando torneranno dalla fronte. Circa la previdenza non vi è alcun dubbio che essa debba essere coattiva e non volontaria perché sia quanto esposto dai Comm . Orlando e Saldini, sia l'esperienza anche da lui personalmente fatta hanno dimostrato che occorre imporre all'operaio di risparmiare. Si è poi riscont rato che mentre per gli operai il provvedimento da lui escogitato non detta alcun frutto, per gli impiegati invece dette i risultati che si speravano. La non riuscita però è anche dovuta anche all'instabilità degli operai nelle officine; ,tal volta per la natura stessa delle industrie che in certi determinati periodi dell'anno hanno bisogno di un maggiore e minor numero di operai.
Il PRESIDENTE invita il Signor Ancillotti a leggere la sua relazione.
Il Signor ANCILLOTTI legge quanto segue: Dovendo profittare delle circostanze attuali per provvedere alla costi- tuzione di un fondo di previdenza per il dopo guerra, il sottoscritto si permette osservare:
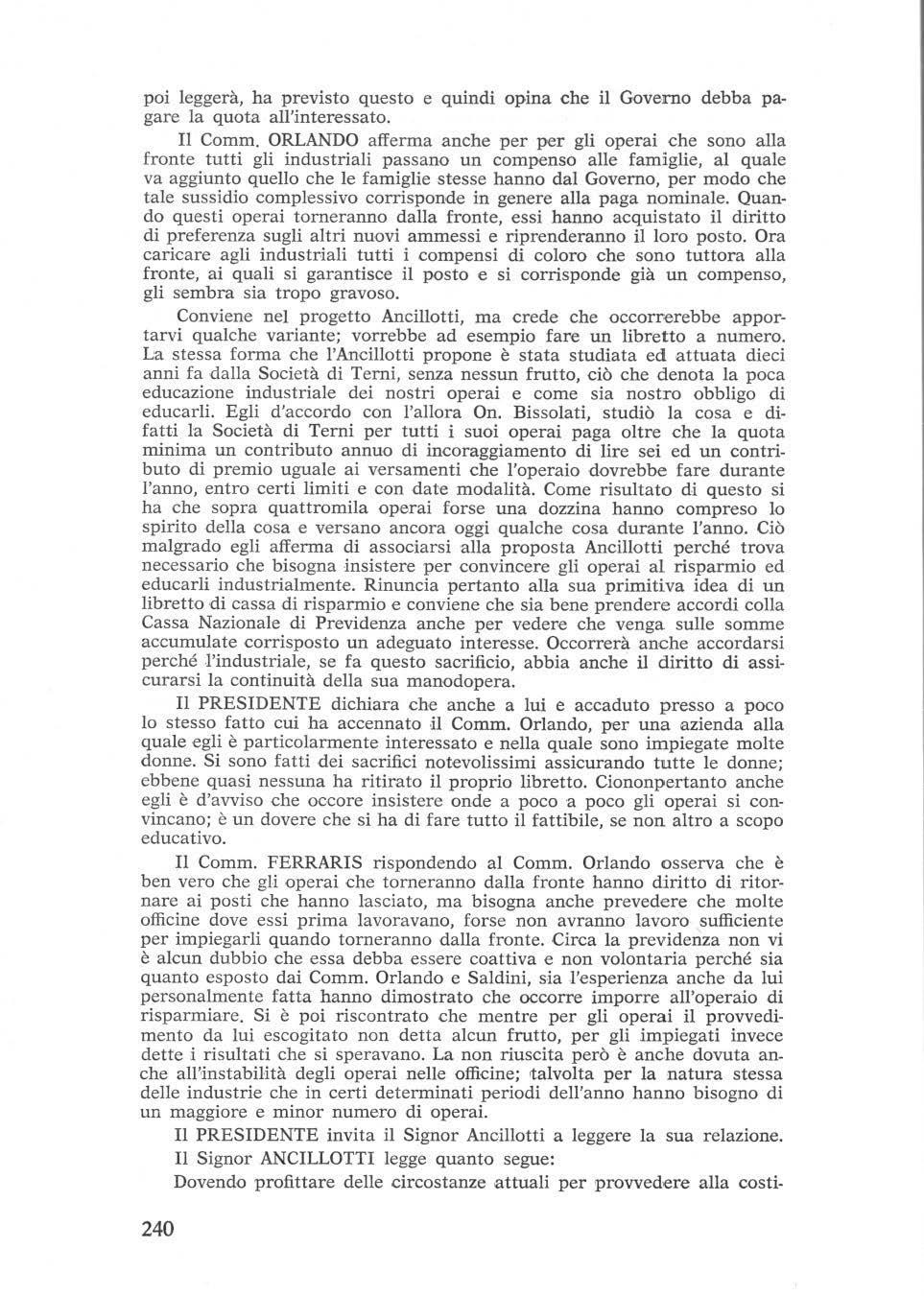
Tenuto presente che un provvedimento generale inteso a risolvere per sempre il problema dell'assicurazione sociale contro la disoccupazione non è oggi possibile appunto perché attraversiamo un periodo transitorio e perché oggi non si può stabilire quale sarà nel suo complesso il movimento industriale Italiano dopo la guerra.
Ricordato conseguentemente che ogni provvedimento in ordine alla disoccupazione resta oggi limitato agli operai degli stabilimenti ausiliari nonché considerato in rapporto alla odierna intensificazione del lavoro ed alla possibilità, dopo la guerra, di un transitorio e parziale arresto dell'attività degli stessi stabilimenti, nota:
Fra gli stabilimenti oggi dichiarati ausiliari vi sono inclusi:
Cantieri Navali - Stabilimenti Siderurgici - Servizi Pubblici - (Aziende Elettriche e Gas) Offici ne Ferroviarie - nonché una parte di stabilimenti meccanici i quali prima della guerra erano adibiti a lavorazioni quali: Locomotive Ferrovarie, Automotrici Elettriche Ferroviarie, Carrozzoni per linee tramviarie elettriche, ecc . lavorazioni che per essere state sospese dovranno essere riprese con la maggiore intensità non appena ritornati alla situazione normale. Ora gli operai degli stab ilimenti citati comprendono benissimo che per il dopo guerra la disoccupazione li colpirà né punto né poco e quindi poco volentieri accetterebbero il pagamento obbligatorio di una quota per la Cassa di Previdenza contro la disoccupazione, utilissima quest'ultima invece gli operai dei proiettifici e in genere di quelle altre industrie di guerra che per non esigere una eccessiva capacità tecnica dal personale hanno consentito un rapido e forte aumento della manodopera.
Convinto però, il sottoscritto, della necessità di un provvedimento che sia eguale per tutti, pur potendo essere diverso nelle finalità, propone:
1) Iscrizione di tutti gli operai degli stabilimenti ausiliari alla Cassa Nazionale di Previdenza (Ramo contribu ti riservati) per il minimo della quota e cioè L. 0,50 al mese.
2) A tutti gli operai, a seconda del loro guadagno medio giornaliero dovrebbe eserc fatta una trattenuta mercé la quale verrà aperto un libretto di risparmio individuale sul quale verrebbero segnate anche le quote stabilite per gli altri operai venissero stabilite quote di L. 1, L. 2, L. 3, la quota degli industriali dovrebbe essere di L. 2 per tutti.

Gli operai potrebbero essere divisi in tre ed anche in quattro categorie a seconda delle quali verrebbe fissata l'entità della trattenuta sul salario e cioè :
Fino al guadagno medio giornaliero di L. 3 L. 1 mensile
)) )) )) )) )) da L. 3 a L. 5 )) 2 )) » )} )) )) )) da L. 5 a L. 8 )) 3 )) Oltre il guadagno medio giornaliero di L. 8 )) 4 ))
L'Amministrazione di questo fondo dovrebbe essere delegata alla Cassa Nazionale di Previdenza la quale offre le maggiori garanzie nell'interesse comune. Dopo la guerra agli operai che rimanessero disoccupati la Cassa dovrebbe restitutire ratealmente il fondo individuale accumulato. Non è da escludere che t rattandosi di sussidio a disoccupati il Governo possa fare a favore dei detti operai quanto oggi fa a favore dei soci delle esistenti Casse contro la disoccupazione.
Per gli operai che non resteranno disoccupati, ent ro un anno dalla fine della guerra, la Cassa Naziona le verserà la soma accumulata nel libretto d'iscrizione contro l'invalidità e vecchiaia.
Con ciò si sarà fatto un passo pratico verso l'avviamento delle assicurazioni sociali e contro la disoccupazione e contro la vecchiaia, problemi la cui soluzione definitiva è da augurarsi il governo attui dopo la guerra. Nel tempo stesso avremo colpito nel minimo possibile la suscettibilità degli operai per questa forma coatta di assicurazione in quanto a tutti avremo assicurato un reale vantaggio individuale.
Si osserverà che il progetto, per quanto riguarda i sussidi per la invalidità e vecchiaia non favorisce i vecchi operai anziani i quali dalla loro tardiva iscrizione alla Cassa di Previdenza ritrarranno nessuno o pochi vantaggi. Anzitutto con la iscrizione al ramo Contributo riservato le somme pagate ritorneranno ai possibili eredi. Ma, è questo è il più importante, a tempo opportuno industriali, governo, comuni, potranno attuare speciali provvedimenti. Dicendo anche i Comuni, citerò l'esempio di Genova dove la Civica Amministrazione (su proposta del sottoscritto) fin dal 1912 versa un contributo di L. 4 a 12 annue a favore degli iscritti alla Cassa di P revidenza e che hanno pagato la quota annuale, e il contributo, nei limiti di cui sopra, è assegnato in maggior misura a secondo della maggiore età che aveva l'operaio al momento della sua iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza. II provvedimento ebbe tale partito risultato che se per il primo anno per soddisfare all'impegno preso bastarono L. 30.000 nel secondo anno ne occorsero L. 40.000 e nel terzo 50.000.
Resta da provvedere per gli operai che già facevano parte degli stabilimenti ora ausiliari e che attualmente si trovano tuttora alla fronte. Si potrebbe provvedere alla iscrizione dei detti operai lasciando al Governo di pagare quelle quote che non può pagare l'interessato. Ma del resto si tratta di un numero relativamente piccolo date le avvenute esonerazioni dal servizio militare.
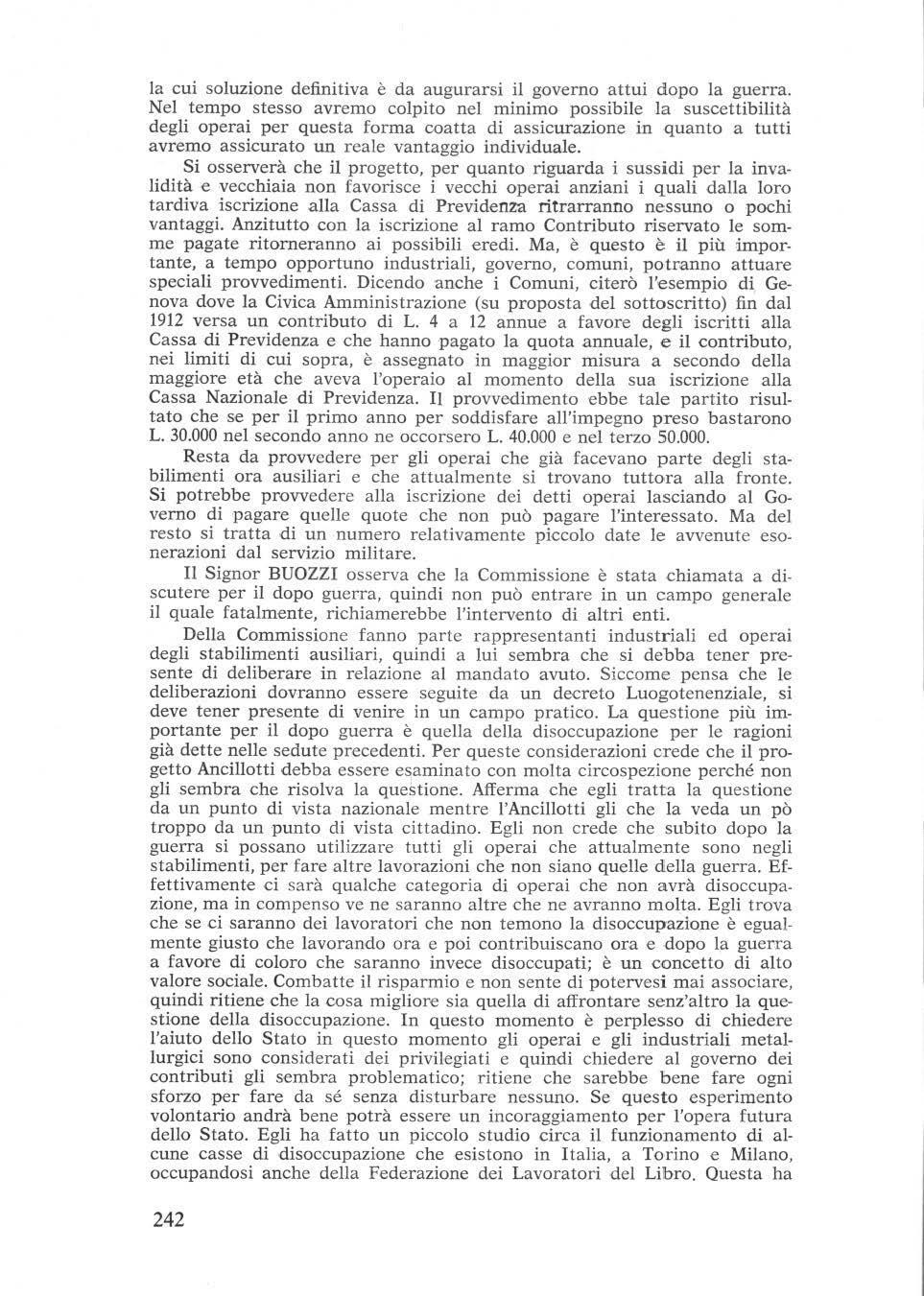
Il Signor BUOZZI osserva che la Commissione è stata chiamata a discutere per il dopo guerra, quindi non può entrare in un campo generale il quale fatalmente, richiamerebbe l'intervento di altri enti.
Della Commissione fanno parte rappresentanti industriali ed operai degli stabilimenti ausiliari, quindi a lui sembra che si debba tener presente di deliberare in relazione al mandato avuto. Siccome pensa che le deliberazioni dovranno essere seguite da un decreto Luogotenenziale, si deve tener presente di venire in un campo pratico. La questione più importante per il dopo guerra è quella della disoccupazione per le ragioni già dette nelle sedute precedenti. Per queste considerazioni crede che il progetto Ancillotti debba essere esaminato con molta circospezione perché non gli sembra che risolva la questione. Afferma che egli tratta la questione da un punto di vista nazionale mentre l'Ancillotti gli che la veda un pò troppo da un punto di vista cittadino. Egli non crede che subito dopo la guerra si possano utilizzare tutti gli operai che attualmente sono negli stabilimenti, per fare altre lavorazioni che non siano quelle d!ella guerra. Effettivamente ci sarà qualche categoria di operai che non avrà disoccupa. zione, ma in compenso ve ne saranno altre che ne avranno molta. Egli trova che se ci saranno dei lavoratori che non temono la disoccupazione è egualmente giusto che lavorando ora e poi contribuiscano ora e dopo la guerra a favore di coloro che saranno invece disoccupati; è un concetto di alto valore sociale. Combatte il risparmio e non sente di potervesi mai associare, quindi ritiene che la cosa migliore sia quella di affrontare senz'altro la questione della disoccupazione. In questo momento è perplesso di chiedere l'aiuto dello Stato in questo momento gli operai e gli industriali metallurgici sono considerati dei privilegiati e quindi chiedere al governo dei contributi gli sembra problematico; ritiene che sarebbe bene fare ogni sforzo per fare da sé senza disturbare nessuno. Se questo esperimento volontario andrà bene potrà essere un incoraggiamento per l'opera futura dello Stato. Egli ha fatto un piccolo studio circa il funzionamento di alcune casse di disoccupazione che esistono in Italia, a Torino e Milano, occupandosi anche della Federazione dei Lavoratori del Libro. Questa ha il 95% degli iscritti che sono assicurati. Parla quindi della Società Umanitaria di Milano la quale col versamento di 10,15 o venti centesimi settimanali, corrisponde un sussidio di L. 0,50, 1, o 1,50 al giorno; l'Umanitaria inoltre adottando il sistema di Gand aggiunge altri 50 centesimi al giorno.
L'Umanitaria nel 1914 aveva iscritti 14.764 soci; di questi nell'anno sono stati disoccupati 3.210; ogni disoccupato è stato disoccupato 37 giorni nell'anno in quanto le giornate totali di disoccupazione ammontano a 120.144. Ogni socio quindi ha dovuto 8 giorni e 2/10 di disoccupazione nell'anno.
Il 1914 occorre considerare che è stato normale nel 1° semestre mentre nel 2° semestre si è avuto un periodo di apprensione e di sospensione di parecchie industrie. Eppure nelle industrie metallurgiche la disoccupazione si è verificata in quell'anno in ragione di tre giorni per ogni associato.
A Torino, l'Associazione metallurgica fa pagare, come a Milano 10,15 e 20 centesimi; nel 1911 si sono avute una giornata e 3/10 di disoccupazione per ogni socio, nel 1912 1,25, nel 1913, 1,72, nel 1914, 2 nel 1915 1/2. La Federazione dei Lavoratori del Libro ha subito nel periodo della guerra la più grave crisi; questa fa pagare 30 centesimi alla settimana e corrisponde un sussidio di L. 2 al giorno.
Tale Federazione ha avuto una media di 13 giornate di disoccupazione per oggi socio. È bene però considerare specialmente tre mesi del 1914 perché i dati di essi possono dare una guida per gli eventuali progetti che si vorranno studia-re. In quei mesi fa la classe tipografica la più colpita. I metallurgici non passeranno certamente una tale crisi perché una parte degli attuali operai torneranno ai loro primitivi mestieri od alle campagne dopo la guerra; di conseguenza una parte del personale disoccupato avrà la sua nuova occupazione.
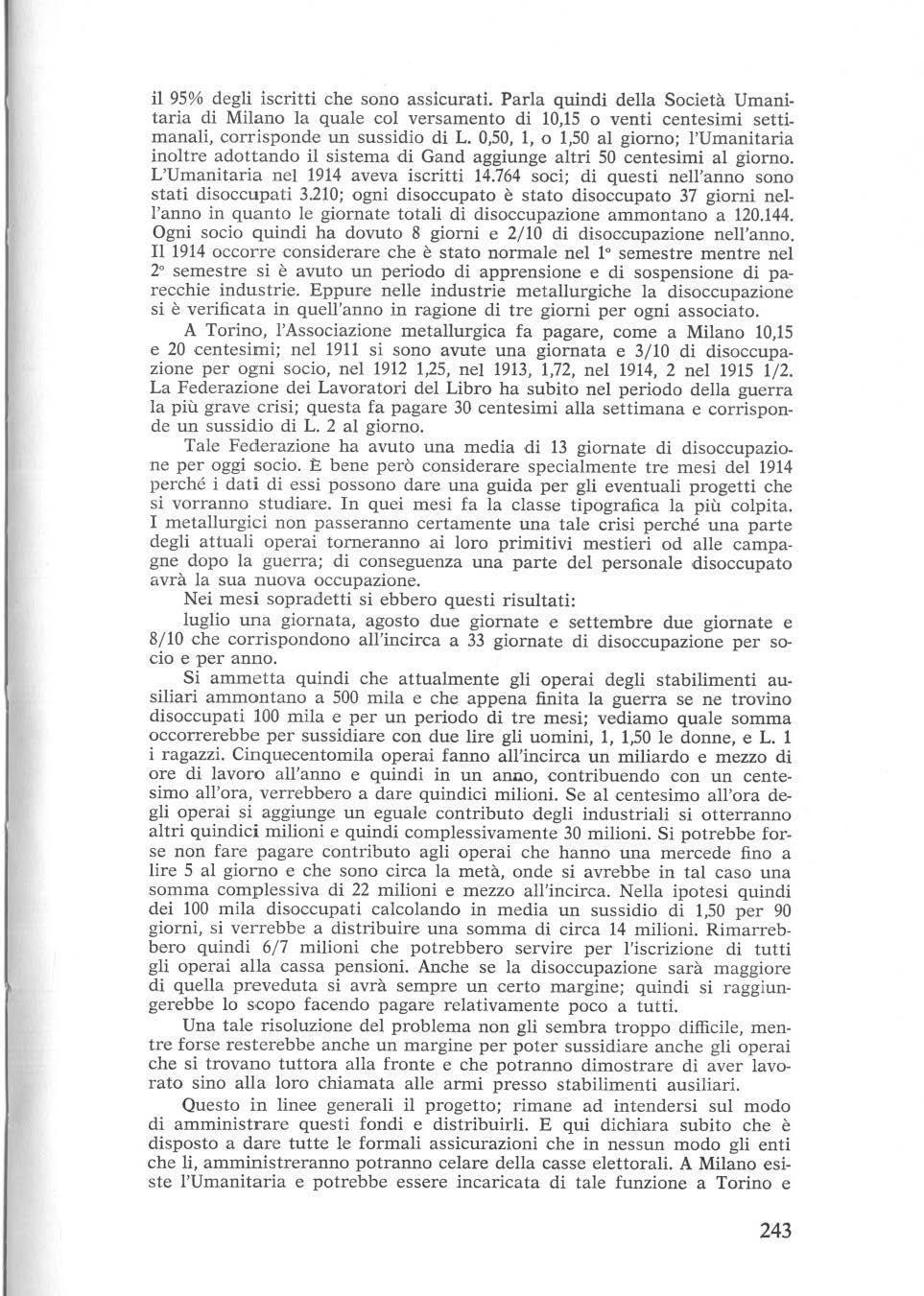
Nei mesi sopradetti si ebbero questi risultati: luglio una giornata, agosto due giornate e settembre due giornate e 8/10 che corrispondono all'incirca a 33 giornate di disoccupazione per socio e per anno
Si ammetta quindi che attualmente gli operai degli stabilimenti ausiliari ammontano a 500 mila e che appena finita la guerra se ne trovino disoccupati 100 mila e per un periodo di tre mesi; vediamo quale somma occorrerebbe per sussidiare con due lire gli uomini, 1, 1,50 le donne, e L. 1 i ragazzi. Cinquecentomila operai fanno all'incirca un miliardo e mezzo di ore di lavoro a ll'anno e quindi in un anno, contribuendo con un centesimo all'ora, verrebbero a dare quindici milioni. Se al centesimo all'ora degli operai si aggiunge un eguale contributo degli industriali si otterranno altri quindici milioni e quindi complessivamente 30 milioni. Si potrebbe forse non fare pagare contributo agli operai che hanno una mercede fino a lire 5 al giorno e che sono circa la metà, onde si avrebbe in tal caso una somma complessiva di 22 milioni e mezzo all'incirca. Nella ipotesi quindi dei 100 mila disoccupati calcolando in media un sussidio di 1,50 per 90 giorni, si verrebbe a distribuire una somma di circa 14 milioni. Rimarrebbero quindi 6/7 milioni che potrebbero servire per l'iscrizione di tutti gli operai alla cassa pensioni. Anche se la disoccupazione sarà maggiore di quella preveduta si avrà sempre un certo margine; quindi si ragg iungerebbe lo scopo facendo pagare relativamente poco a tutti.
Una tale risoluzione del problema non gli sembra troppo difficile, mentre forse resterebbe anche un margine per poter sussidiare anche gli operai che si trovano tuttora alla fronte e che potranno dimostrare di aver lavorato sino alla loro chiamata alle armi presso stabilimenti ausiliari.
Questo in linee generali il progetto; rimane ad intendersi sul modo di amministrare questi fondi e distribuirli. E qui dichiara subito che è disposto a dare tutte le formali assicuraz ioni che in nessun modo gli enti che li, amministreranno potranno celare della casse elettorali. A Milano esiste l'Umanitaria e potrebbe essere incaricata di tale funzione a Torino e
Brescia ci si potrà intendere direttamente cogli industriali, o fare dei consorzi fra industriali ed operai, o con i Comuni, o con gli Uffici del Lavoro.
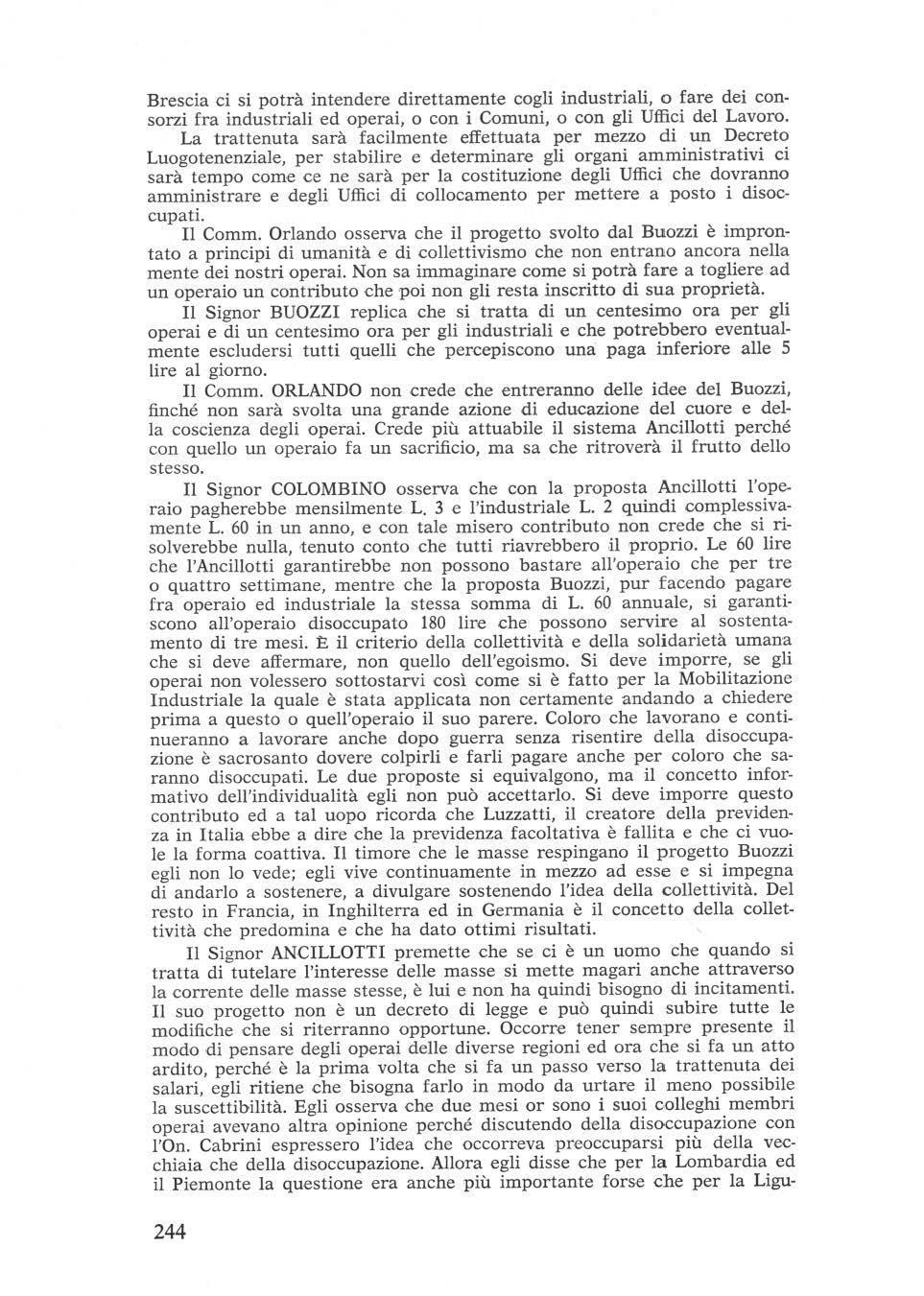
La trattenuta sarà facilmente effettuata per mezzo di un Decreto Luogotenenziale, per stabilire e determinare gli organi amministrativi ci sarà tempo come ce ne sarà per la costituzione degli Uffici che dovranno amministrare e degli Uffici di collocamento per mettere a posto i disoccupati.
Il Comm. Orlando osserva che il progetto svolto dal Buozzi è improntato a principi di umanità e di collettivismo che non entrano ancora nella mente dei nostri operai. Non sa immaginare come si potrà fare a togliere ad un operaio un contributo che poi non gli resta inscritto di sua proprietà.
Il Signor BUOZZI replica che si tratta di un centesimo ora per gli operai e di un centesimo ora per gli industriali e che potrebbero eventualmente escludersi tutti quelli che percepiscono una paga inferiore alle 5 lire al giorno.
Il Comm. ORLANDO non crede che entreranno delle idee del Buozzi, finché non sarà svolta una grande azione di educazione del cuore e della coscienza degli operai. Crede più attuabile il sistema Ancillotti perché con quello un operaio fa un sacrificio, ma sa che ritroverà il frutto dello stesso.
Il Signor COLOMBINO osserva che con la proposta Ancillotti l'operaio pagherebbe mensilmente L. 3 e l'industriale L. 2 quindi complessivamente L. 60 in un anno, e con tale misero contributo non crede che si ri· solverebbe nulla, <tenuto conto che tutti riavrebbero il proprio. Le 60 lire che l'Ancillotti garantirebbe non possono bastare all'operaio che per tre o quattro settimane, mentre che la proposta Buozzi, pur facendo pagare fra operaio ed industriale la stessa somma di L. 60 annuale, si garanti· scono all'operaio disoccupato 180 lire che possono servire al sostentamento di tre mesi. :E: il criterio della collettività e della solidarietà umana che si deve affermare, non quello dell'egoismo. Si deve imporre, se gli operai non volessero sottostarvi così come si è fatto per la Mobilitazione Industriale la quale è stata applicata non certamente andando a chiedere prima a questo o quell'operaio il suo parere. Coloro che lavorano e conti. nueranno a lavorare anche dopo guerra senza risentire della disoccupazione è sacrosanto doveve colpirli e farli pagare anche per coloro che saranno disoccupati Le due proposte si equivalgono, ma il concetto informativo dell'individualità egli non può accettarlo. Si deve imporre questo contributo ed a tal uopo ricorda che Luzzatti, il creatore della previdenza in Italia ebbe a dire che la previdenza facoltativa è fallita e che ci vuole la forma coattiva. Il timore che le masse respingano il progetto Buozzi egli non lo vede; egli vive continuamente in mezzo ad esse e si impegna di andarlo a sostenere, a divulgare sostenendo l'idea della collettività. Del resto in Francia, in Inghilterra ed in Germania è il concetto della collettività che predomina e che ha dato ottimi risultati.
Il Signor ANCILLOTTI premette che se ci è un uomo che quando si tratta di tutelare l'interesse delle masse si mette magari anche attraverso la corrente delle masse stesse, è lui e non ha quindi bisogno di incitamenti. Il suo progetto non è un decreto di legge e può quindi subire tutte le modifiche che si riterranno opportune. Occorre tener sempre presente il modo di pensare degli operai delle diverse regioni ed ora che si fa un atto ardito, perché è la prima volta che si fa un passo verso la trattenuta dei salari, egli ritiene che bisogna farlo in modo da urtare il meno possibile la suscettibilità Egli osserva che due mesi or sono i suoi colleghi membri operai avevano altra opinione perché discutendo della disoccupazione con l'On. Cabrini espressero l'idea che occorreva preoccuparsi più della vecchiaia che della disoccupazione. Allora egli disse che per la Lombardia ed il Piemonte la questione era anche più importante forse che per la Ligu- ria e si disse che lo Stato avrebbe dovuto eventualmente provvedervi. Oggi il Buozzi dice che non si deve neppur chiedere quel contributo, ma egli osserva che se domani si avranno 100 mila operai disoccupati e si avrà un sussidio anche dal Governo di altri 50 centesimi, non è poca nobilità accettare questo sussidio. Quando egli parla della duplice forma di assicurazione non si riferisce soltanto alla Liguria, ma a tutta l'Italia metallurgica. Non crede che nelle industrie metallurgiche vi sarà della disoccupazione perché oggi pur producendo di più come tonnellaggio hanno un minor numero di operai dato la proponderanza della produzione di acciaio da proiettili, mentre dopo la guerra dovendo riprendere tutte le antiche e svariate produzioni commerciali avranno bisogno di un maggior quantitativo di manodopera. Nelle stesse condizioni della Liguria si trovano poi in gran parte anche la Toscana e l'Italia Meridionale. Gli si è fatto l'appunto che con 60 lire non si risolve la questione ma egli af. ferma che neppure 180 lire potranno risolverla; non si potrà in nessun modo impedire l'emigrazione attraverso i sussidi perché i buoni operai che hanno volontà di lavorare, non attendo troppo tempo per trovare occupa1:ione; attenderanno soltanto i poltroni e se sono tali è meglio che vadano all'estero. Non si può dire che si salvi l'industria con tali provvedimenti perché sono atti ad impedire l'emigrazione; l'emigrazione non ci sarà se si troverà il modo di occupare tutti gli operai. Lo scopo principale deve esser quello di trascinare gli operai verso l'assicurazione della vecchiaia e della disoccupazione. Quest'ultima dobbiamo risolverla per mezzo dello stato che occorre incitare affinché provveda lavoro all'Italia non appena le industrie dovranno cessare la produzione bellica. In Liguria non esistono casse di disoccupazione, ma si è convinto che esse sarebbero inutili perché se dovesse veramente venire una crisi di disoccupazione data la natura delle industrie locali si avrebbe il 75% di operai disoccupati e quindi qualsiasi risparmio non potrebbe sopperire ai bisogni di sussidio. Col suo progetto egli si prefigge di far rimanere 300 o 400 mila operai aderenti alla Cassa Nazionale di Previdenza poiché è convinto che quando vedrà accumulate nel libretto 60 o 70 lire, l'operaio continuerà a pagare. Non comprende il progetto del Buozzi della cassa o meglio delle casse per la disoccupazione affidate ad istituti diversi nelle diverse località; le quote di tutti debbono andare in un centro unico ed il fondo sia dato ad ogni modo alla Cassa Nazionale di P revidenza anche p erché bisogna stabilire un criterio unico per tutti. I dati esposti dal Buozzi non valgono perché si riferiscono ad un periodo in cui non esisteva disoccupazione per i metallurgici, mentre i dati che si riferiscono ad altre classi operaie non è la Commissione competente a discuterli. Inoltre il progetto tenderebbe ad escludere dal pagamento tutti coloro che percepiscono meno di lire 5 di paga il che si rifcribbe a circa la metà dei lavoratori. Se si considera che nell'Italia Meridionale si hanno delle paghe basse gli operai di quelle regioni non contribuirebbero che in misura molto limitata ad ogni modo non ritiene sia giusto di escluderli. Ripete che per lui ha più importanza l'assicurazione per la vecchiaia che la disoccupazione, perché ci sarà molto lavoro dopo la guerra e non crede si verificheranno molti casi di disoccupazione alcuni dei quali del resto si rioccuperanno quasi automaticamente ritornando ai loro mestieri. Pensando alla vecchiaia si fa un bene per oggi e per l'avvenire. Sostiene quindi che il suo progetto è concretato in modo che dovrebbe soddisfare tutli e non comprende perché non dovrebbe venire accettato.
Il PRESIDENTE si compiace con i membri operai per la competenza addimostrata nella discussione.
Il Comm. PERRONE osserva come in tutte queste discussioni non si si sia ancora compresi del momento che attraversa il Paese, che è un momento in cui si g iuoca l'esistenza. Egli dice che i problemi si debbono affrontare per il dopo guerra nella stessa forma con cui oggi si sta affrontando il presente. Il presente è costituito da una situazione tale che ci porterà ora alla grande vittoria o alla liquidazione definitiva; erede quindi che la discussione non sia praticamente possibile perché occorre portarla s u una via di mezzo che non sarà quella di domani. Si deve pensare ad elevarsi, pensare ad una grande Italia ed allora questo tema della disoccupazione gli sembra sia una cosa oltrepas sata, qualunque sia la forma di amministrazione di questo fondo che si vuol costituire. Quindi i trenta milioni ai quali accenna il Buozzi, se ci sarà la vittoria, saranno completamente inutili perché non vi sarà disoccupazione; serviranno per la disoccupazione che potrà avvenire in seguito, potranno servire a sostenere i grandi urti che eventualmente si verificheranno. O il problema nella peggiore ipotesi sarà molto più grave ed allora i trenta milioni saranno insufficienti. Si tratta invece di avviare il nostro popolo verso la previdenza per la vecchiaia, e quindi preferisce il progetto Ancillotti.

Il Comm. ORLANDO ripete che è d 'avviso che gran parte dei disoccupati tornerà ai primitivi mestieri e quindi anche egli non prevede una forte disoccupazione. Ritiene che la proposta più pratica e rispondente sia quella dell'Ancillotti, anche perché trova giusto il doppio contributo dell' industriale e dell'operaio. Con la proposta Buozzi invece avverrebbe che l'operaio non vedendo sul suo libretto personale iscritta la sua parte versata, farebbe certamente in modo che anche il suo contributo venisse pagato dall'industriale. Egli si associa al principio del collettivismo, ma gli operai non lo comprendono e quindi difficilmente darebbero la loro quota.
Al Signor BUOZZI replica dicendo subito che egli ha accennato in linea generale al suo progetto, mentre l'Ancillotti è sceso a più precisi particolari. L'Amministrazione dei fondi dovrà certamente essere coordinata; i fondi sono nazionali e non regionali. È evidente che accennando all'amministrazione locale egli era guidato dal concetto che è necessario esista in ogni regione chi controlli e sorvegli questi disoccupati. Il Comm. Perrone ba accennato a che cosa questi fondi possano servire e ad eventuali futuri urti; egli non ci pensa e non vuol pensarci, ma dice che si può fin d 'ora studiare uno statuto che venga approvato da tutti i membri. ][ due progetti non gli sembrano neppure diversi nel principio e dal punto di vista industriale pensa che sia di maggior vantaggio il suo.
Il PRESIDENTE osserva che la discussione, per quanto simpatica, abbia un pò degenerato in una questione generale che riguarda anche l'assetto dell'avvenire. Dapprincipio si disse di studiare l'idea di far mettere a parte un poco di quel denaro in più che oggi guadagnano gli operai; poi si è modificata e si è parlato anche del contributo degli industriali.
Il Comm. FERRARIS ammira lo spirito che anima i colleghi Colombino e Buozzi ed augurerebbe che tutta la classe operaia avesse tali principi poiché in tal caso la questione si risolverebbe assai facilmente. Non tutti invece la pensano ancora così e specialmente nell'Italia Centrale e Meridionale non si riscontra lo spirito di mutualità che si ha invece nell'Italia setteutrionale; quindi non si può chiedere là il sacrificio che facilmente si potrebbe ottenere dall'operaio settentrionale. Occorre l'intervento dello Stato perché se volessero far da sé e industriali ed operai non si concluderebbe nulla. Non dobbiamo preoccuparci che di ottenere il risparmio operaio e nella forma sociale migliore e questa l'Ancillotti pensa che sia la previdenza per la vecchiaia.
I dati statici del Buozzi non servono perché si riferiscono a tempi normali ed oggi si deve invece considerare un periodo anormalissimo ed in questo si associa il Comm. Perrone nell'idea che se tutto andrà bene anche per gli operai e industriali sarà bene, altrimenti invece sarà un disastro per tutti. Egli trova quindi che le idee del collega Ancillotti sono le più pratiche per giungere allo scopo per il quale la Commissione fu riu- nita; è bene ridurre l'operaio a pensare un poco alla vecchiaia; sarà la forma più simpatica e gli industriali daranno volentieri il loro contributo per spingere l'operaio su questa strada.

Il Signor COLOMBINO dice che ha delle idee non troppo buone sulla Cassa Nazionale di Previdenza e spera che presto venga fatto qualche cosa di migliore. L'Unica obbiezione grave che egli ha inteso fare alla assicurazione collettiva è quella che difficilmente si possa vincere la opinione egoistica degli operai. Egli non è assolutamente d'accordo specie quando pensa che si è riusciti a far pagare la tassa di maternità anche a quelle donne che non avuto e non avranno figli. Per suo conto non trova nessuna difficoltà a vincere questa opinione; ad ogni modo si potrebbe lasciare ad ogni regione di adottare quel principio che crederà migliore.
II Comm. FERRARIS osserva che ciò non è possibile, perché ci vuole una forma ed un indirizzo unico.
Il Signor Colombino continua col dire che l'operaio buono r imarrà se avrà un sussidio ed in pochi giorni troverà certamente lavoro, magari provvisorio; ci può essere l'eccezione e che qualche individuo rimanga disoccupato tre mesi ed egli non emigrerà perché avrà di che vivere. Non è possibile fare la selezione delle maestranze, perché l'emigrazione è regolata da condizioni che superano la volontà degli uomini.
Il Comm. BREDA osserva che il progetto dell'Ancillotti è più beneviso agli industriali, gli sembra perciò sia quella la strada da battere. Il concorso dell'operaio dovrà essere coattivo e quindi occorrerà un Decreto Luogotenenziale ed egli non sa se sia possibile che questo venga emanato poiché dovrebbe essere limitato ad alcune categorie di lavoratori e non esteso a tutti.
II PRESIDENTE osserva che la Commissione non deve preoccuparsi di ques1o; essa deve esprimere il proprio parere e dire al Governo a mezzo di S. E. Dallolio, quello che è stato stabilito in merito al problema che la Commissione stessa è stata chiamata a studiare.
Il Comm. BREDA insiste che non vede la possibilità di emanare un simile Decreto Luogotenenziale.
II Comm. FERRARIS è invece del parere che sia possibile. La Commissione è stata chiamata a studiare la questione per gli stabilimenti ausiliari ed a questi si deve limitare; vedrà poi il Governo se troverà opportuno di far sua la proposta ed estendere il provvedimento anche agli altri.
Il Signor DI DIO osserva che appunto nell'Italia Centrale esistono pochi stabilimenti ausiliari, mentre piccoli interessano il munizionamento. Egli conosce molto bene le condizioni degli operai dell' Italia Centrale e non sa dove trovare nelle •paghe il superguadagno, poiché la media è di 40 centesimi all'ora; non vi è quindi la possibilità del risparmio. La preoccupazione degli operai è quella della disoccupazione di domani, più che della vechiaia e quindi ritiene che nell'Italia centrale se si parlerà di disoccupazione si otterrà qualche cosa, mentre se si parlerà di supermecedi per ottenere la previdenza per la vecchiaia, teme sarà assai difficile ottenere qualche cosa, perché le paghe non sono elevate e sono appena sufficienti a soddisfare i bisogni della vita dato l'alto prezzo dei viveri.
Il Signor ANCILLOTTI dice che la sua proposta l'avrebbe fatta anche in tempi normali se se ne fosse presentata l'occasione favorevole, non solo ma ogni qualvolta è stato possibile egli l'ha applicata a Genova. La proposta del Buozzi tenta ad avvicinarsi alla sua, ma egli dichiara che se quella dovesse essere accettata desidera venga accettata integralmente senza alcuna modifica.
Il BUOZZI osserva che la proposta Ancillotti porta una spesa di 60 lire annue come la sua; la differenza sta nel fatto che mentre l'Ancillotti dice a tutti che avranno 60 lire, egli dice agli operai che rimarranno disoc- cupati che avranno un sussidio ed egli ritiene che le masse ad entrare in questo ordine di idee. Osserva che anche nel suo progetto è stato pensato alla pensione tanto è vero che si è detto di provvedere all'iscrizione alla Cassa di Previdenza con la somma eccedente i 14 milioni, ed è naturale che ogni operaio iscritto dovrebbe avere il contributo di lire 10 stabilito dal Governo. Alle osservazioni mossegli circa l'inesattezza dei dati statistici esposti, egli dichiara di aver moltiplicato i dati dei tempi normali per un certo numero, appunto per renderli approssimativi a quelli che si verificheranno nei tempi anormali che si prevedono; difatti dicendo 100 mila disoccupati ha preveduto una disoccupazione del 20% che è certamente esagerata.

Il Comm. Breda pensa che nel Decreto dovrebbero esser compresi anche gli operai che pur non appartenendo a stabilimenti ausiliari, fanno parte di stabilimenti che lavorano per lo stato.
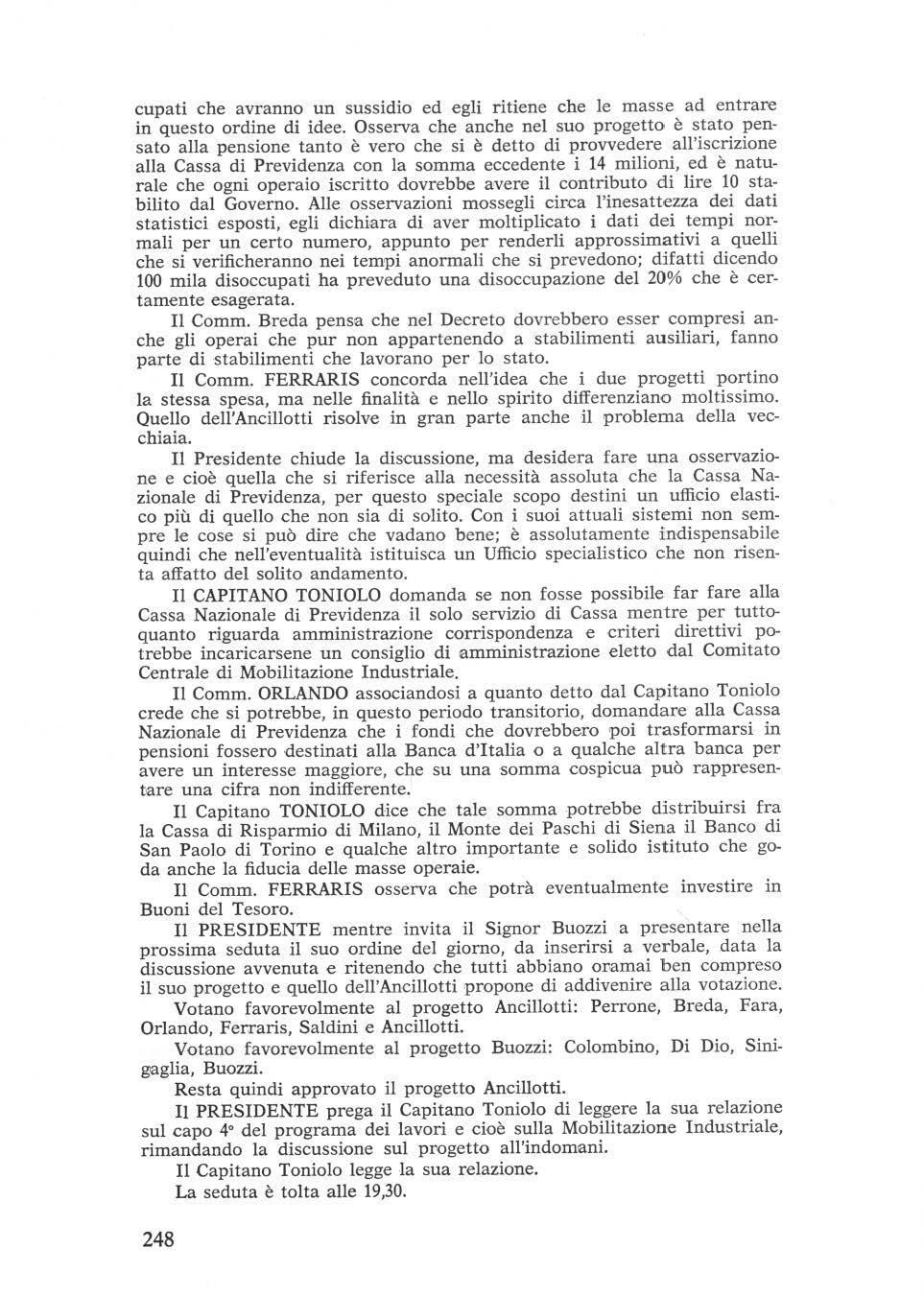
Il Comm. FERRARIS concorda nell'idea che i due progetti portino la stessa spesa, ma nelle finalità e nello spirito differenziano moltissimo. Quello dell'Ancillotti risolve in gran parte anche il problema della vecchiaia.
Il Presidente chiude la discussione, ma desidera fare una osservazione e cioè quella che si riferisce alla necessità assoluta che la Cassa Nazionale di Previdenza, per questo speciale scopo destini un ufficio elastico più di quello che non sia di solito. Con i suoi attuali sistemi non sempre le cose si può dire che vadano bene; è assolutamente indispensabile quindi che nell'eventualità istituisca un Ufficio specialistico che non risenta affatto del solito andamento.
Il CAPITANO TONIOLO domanda se non fosse possibile far fare alla Cassa Nazionale di Previdenza il solo servizio di Cassa mentre per tuttoquanto riguarda amministrazione corrispondenza e criteri direttivi potrebbe incaricarsene un consiglio di amministrazione eletto dal Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale.
Il Comm. ORLANDO associandosi a quanto detto dal Capitano Toniolo crede che si potrebbe, in questo periodo transitorio, domandare alla Cassa Nazionale di Previdenza che i fondi che dovrebbero poi trasformarsi in pensioni fossero destinati alla Banca d'Italia o a qualche altra banca per avere un interesse maggiore, che su una somma cospicua può rappresent,are una cifra non indifferente.
Il Capitano TONIOLO dice che tale somma potrebbe distribuirsi fra la Cassa di Risparmio di Milano, il Monte dei Paschi di Siena il Banco di San Paolo di Torino e qualche altro importante e solido istituto che go. da anche la fiducia delle masse operaie.
Il Comm. FERRARIS os serva che potrà eventualmente investire in Buoni del Tesoro.
Il PRESIDENTE mentre invita il Signor Buozzi a presentare nella prossima seduta il suo ordine del giorno, da inserirsi a verbale, data la discussione avvenuta e ritenendo che tutti abbiano ornmai ben compreso il suo progetto e quello dell'Ancillotti propone di addivenire alla votazione.
Votano favorevolmente al progetto Ancillotti: Perrone, Breda, Fara, Orlando, Ferraris, Saldini e Ancillotti.
Votano favorevolmente al progetto Buozzi: Colombino, Di Dio, Sinigaglia, Buozzi.
Resta quindi approvato il progetto Ancillotti.
Il PRESIDENTE prega il Capitano Toniolo di leggere la sua relazione sul capo 4° del programa dei lavori e cioè sulla Mobilitazione Industriale, rimandando la discussione sul progetto all'indomani.
Il Capitano Toniolo legge la sua relazione.
La seduta è tolta alle 19,30.
Notizie Sul Servizio Commesse Di Artiglierie
NEL PERIODO DELLA GUERRA EUROPEA (1914-1918)
Come da richiesta verbale ,in riguardo alle notizie specificate nell'oggetto di questa memoria, dò le seguenti particolari informazioni:
1) Modalità contrattuali seguite per le commesse di artiglieria (bocche da fuoco) nei seguenti successivi periodi: fase della direzione generale di artiglieria e genio (1914 luglio 1915); fase del Sottosegretariato armi e munizioni (sino al giugno 1917); fase del Ministero anni e munzioni (sino al maggio del 1918); fase del Ministero della guerra interim delle anni e munizioni (sino al settembre 1918); fase del Ministero armi e trasporti con dipendente Commissariato generale per le anni e munizioni che , dal 28 novembre al 15 dicembre 1918, fu aggregato al Ministe ro della guerra e sotto questa ultima data abolito.
2) Organizzazione degli uffici e nome d e i Capi che stabilirono le acce nnate modalità, che ne cur arono lo svolgiment o, le norme costitutive e l'attuazione.
3) Enunciazione d elle p r incipali Ditte fornitr ici di artiglieria nel periodo anzidetto.
Fase della Direzione Generale di Artiglieria e Genio
Durante questa fase per la parte tecnica riguardante le commesse di artiglieria e per la parte amministrativa si se guirono le consuete norme del tempo di pace .fissate, nel primo campo, dalle funzioni dell'organo ministeriale come d e.finite dall'ordinamento interno del Ministero (vedi circ. 110 del 1911) e dalle mansioni, per regolamento, spettanti all'I spettore generale di artiglieria e d all'Ispettore delle costruzioni d'artiglieria nonché al Direttore dello stabilimento di artiglieria presso il quale era studiato e curato tutto lo svolgimento del contratto dipendente dalle commesse date. Nel campo amministrativo - escluso il prezzo del manufatto - le incombenze erano svolte dal detto stabilimento di artiglieria, che aveva in amministrazione il contratto; e la divisione amministrativa della Direzione generale di artiglieria e genio.
Le norme tecniche per le costituzioni e lo svolgimento di un contratto trovasi de.finito, oltre che nella circolare succitata in quella n . 122 e n. 283 d e l 1911 (G.M.U.) che stabilisce le attribuzioni dell'Ispettore generale di artiglieria e dell'Ispettore delle costruzioni, e dai quattro testi capisaldi per ogni contrattazione per conto dello Stato e cioè: 1) legge e regolamento di contabilità generale dello Stato; 2) il conseguente specifico Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria; 3) l'Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria, per l'applicazione dell'anzidetto regolamento; 4) l'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.
Ancora più specialmente pei servizi di artiglieria è da tener presente il Modello per gli inventori del materiale di artiglieria e genio di cui la Parte I porta, classificati in categorie (per gruppi di materiali similari) la nomenclatura dei materiali e le tariffe per unità di misura, e la Parte II (in tre volumi) che per ogni dato materiale, enunciato con la propria regolamentare nomenclatura, dà il cenno descrittivo ed i dati delle principali dimensioni. Con esso Modello d'inventori fanno sistema, nei riguardi alla cognizione tecniche, l'Atlante del materiale di artiglieria adottato dal Ministero della guerra (fascicolo dei sunti descrittivi e fascicolo delle Tavole) e le Disposizioni speciali per l'artiglieria dalle quali ultime risultano in forma ufficiale le lievi varianti apportate ai materiali regolamentari e la descrizione di materiali nuovi di non grande entità, in attesa poi di conglobarle, a turno di stampa, nell'Atlante del materiale di artiglieria. Da ricordare ancora, sempre nel campo tecnico, il Regolamento per la collaudazione, visita a matricola delle artiglierie, il Prontuario per la compilazione di richieste provviste di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, la Classificazione dei ferri ed acciai che si impiegano nella costruzione dei materiali di artiglieria ed infine il Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza.

Nel campo amministrativo, oltre i regolamenti ed istruzioni citate avevano vigore le disposizioni in materia che eventualmente erano inserte nelle circolari del Gir. Mil. Uff. (pubblicazione settimanale) e nei fogli d'ordine (editi dalla Direzione Generale di artiglieria e genio) nei fascicoletti di « Parte Comune» come in quelli intitolati « servizio di artiglieria»), nei quali, ad ogni principio d'anno (Foglio d'Ordine n. O), sono raccolte le disposizioni degli anni precedenti in vigore continuativo.
A parte intese preparatorie, in conferenze al Ministero o per corrispondenza ufficiale, praticamente la commessa, la stipulazione del contratto, e la dipendente « amministrazione del contratto » per la provvista delle artiglierie, affidate in tutto o parte ad una Ditta privata, avveniva a questo modo.

Determinato di dover provvedere ad un certo quantitativo di bocche a fuoco, o di sole parti od elementi di esse, la Direzione generale artiglieria dava commesse di ciò alla Direzione di uno stabilimento (generalmente Arsenale militare ed officina) e queste, ricevuto la commessa, procedeva a studi, ricerche di dati e quanto pare necessario per la bisogna e poscia - da noi esclusa generalmente l'asta pubblica per esiguità del numero di possibili concorrenti - passava ad una licitazione a trattativa privata, conclusa la quale il risultato era concretato in una richiesta per provvista (in apposito modulo regolamentare) ed in uno o più schemi di contratto a seconda del caso.
Gli schemi e le richieste per provviste erano passati all'Ispettorato delle costruzioni di artiglieria per esame e parere.
Quest'ente superiore tecnico vagliate dette proposte sotto tutti gli aspetti, ed essenzialmente sotto l'aspetto della determinazione tecnica del manufatto e del prezzo, eseguite le correzioni che riteneva opportuno, in genere d'intesa con lo stabilimento proponente, trasmetteva gli incartamenti al Ministero per la determinazione ministeriale, per il tramitequando si trattava di artiglierie importanti - dell'Ispettorato generale di artiglieria, il quale emetteva anch'esso il proprio parere in merito.
Gli uffici amministrativi della Direzione generale di artiglieria e genio esaminavano i detti documenti pel contratto. Per la parte tecnica assentivano in massima quant'era parso accettabile all'Ispettorato delle costruzioni: per riguardo ai prezzi tenevano conto del parere di dettQ Ispettorato e generalmente non proseguivano ad altre indagini dirette, desumendo elementi di raffronto da altri contratti contemporanei similari od analoghi che in pari tempo altri stabilimenti andavano svolgendo, completando od esaminando. La decisione definitiva era presa dal Direttore Generale di artiglieria e genio, ed, occorrendo, si sottoponeva all'approvazione del Ministro con apposita motivata relazione.
Dopo di ciò l'Ente incaricato stipulava il contratto col fornitore, provvedeva agli inconvenienti legali e poscia inviava copia del contratto al Ministero, corredato da tutti i documenti probatori (capitoli d'oneri, cauzione ecc.).
Il Ministero riscontrato tutto regolare preparava il decreto di approvazione definitiva del contratto, e lo inviava (pel tramite della Ragioneria che prendeva nota dell'impegno) alla Corte dei Conti per la debita registrazione
Tosto che fosse ritornato dalla Corte dei Conti il decreto di approvazione ed i documenti allegati, il Ministero (divisione amministrativa di artiglieria) inviava copia del decreto stesso allo stabilimento interessato dando contemporaneamente l'ordine di esecuzione della commessa.
L'Ente che aveva ricevuto l'ordine di esecuzione del contratto ne avvertiva il provveditore, provvedeva alla registrazione del contratto originale, e, da questo momento, le commesse aveva il suo svolgimento di lavorazione e conseguente introduzione dei materiali in magazzino, dopo che le commissioni di vigilanza o le commissioni di collaudo avessero ufficialmente constatato la bontà dei manufatti secondo i dati del contratto.
Il verbale di collaudo serviva da una parte per formulare la richiesta di presa incarico, in virtù della quale il consegnatario è autorizzato ad introdurre il materiale in magazzino, e ad eseguirne la debita registrazione; d'altra parte passava all'ufficio della contabilità in materia dal quale, per l'ufficio della contabilità in contanti (cassa), veniva pagato il fornitore, oppure si compilava un mandato diretto il quale, passato per le verifiche alla divisione amministrativa, alla ragioneria e poi al Ministero del Tesoro era infine spiccato - intestato al fornitore - presso quella Tesoreria provinciale dove quest'ultimo aveva richiesto il pagamento dei suoi averi.
La nostra « Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria » considera (art. 4°) come prevede il Ministero all'acquisto dei materiali di artiglieria in tempo di guerra, cioè esattamente pei servizi d'artiglieria alle truppe sul piede di guerra, e dice che vi attende nel modo che reputa me. glia rispondente alle necessità del momento, prescindendo, qualunque sia l'ammontare delle spese, dalle norme proceduali stabilite pei contratti, considerando quindi le spese come eseguite ad economia, e cioè allargando i casi in cui è concesso esegi.ùre lavori o provviste ad economia come fissati nella stessa istruzione all'art. 34 « Provviste e lavori ad economia ». Poiché però nel tempo della fase considerata non si era propriamente in istato di guerra il Governo, a mezzo di R. Decreti, provvide a legalizzare la messa in atto sin dal tempo di neutralità degli or ora accertati criteri e questi decreti furono successivamente riportati nelle circolari n. 37 e n. 539 del 1914, n. 73, 252, 253, 293 del 1915.
Per quanto dunque sin dal 4 agosto 1914 (di tale data il R. Decreto n. 770 riportato oella circolare n. 371 del 1914) la Direzione generale di artiglieria e genio potesse derogare dalle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per quanto riguardava la provvista di materiali occorrenti all'amministrazione stessa, mai di fatto essa seguì praticamente una via differente da quella che abbiamo accennato per la definizione dei contratti, delle artiglierie ed arrestò soltanto le incombenze nell'ambito del Ministero stesso, non inviando i contratti ad organi collaterali centrali ed attendendo che la Ragioneria del Ministero guerra emettesse mandati di anticipazione agli stabilimenti militari affinché potessero essi stessi pagare sollecitamente i fornitori a collaudo effettuato ed introduzione regolare dei materiali in magazzino.
Neppur questa però fu regola costante ed inalterata, e si ricorse a questo sistema sol quando fu reputato necessario per le sollecitudini delle provviste.
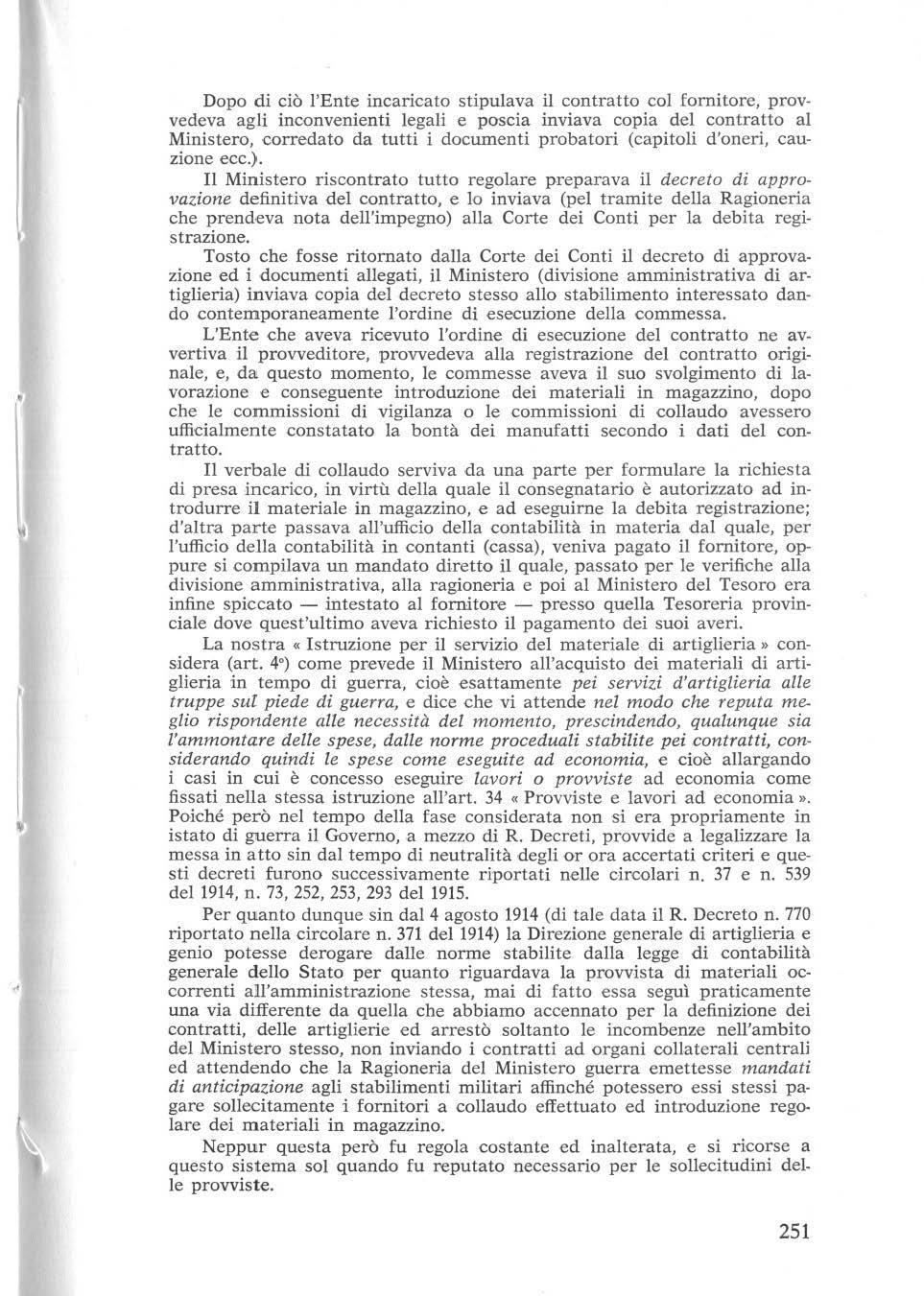
Durante questa fase furono ministri della guerra il Generale Grandi (marzo '14-ottobre '14) e poscia il Generale Zupelli.
Fu direttore generale di artiglieria e genio il Generale Dallolio.
Fase del Sottosegretario per le Armi e Munizioni
Questa fase si aprì a guerra iniziata poiché il Sottosegretario fu istituito nel luglio 1915 e come organo efficiente del Comitato supremo per i rifornimenti delle armi e munizioni (istituito con R.D. 1065, 9 luglio 1915) da questo solo prendeva disposizioni e doveva precipuamente adempiere agli incarichi che da esso Comitato gli venissero affidati. Detto Comitato era poi, per decreto, perfettamente libero di prendere ogni deliberazione ha esso avesse ritenuta necessario per provvedere al più ampio e sollecito rifornimento delle armi e delle munizioni.
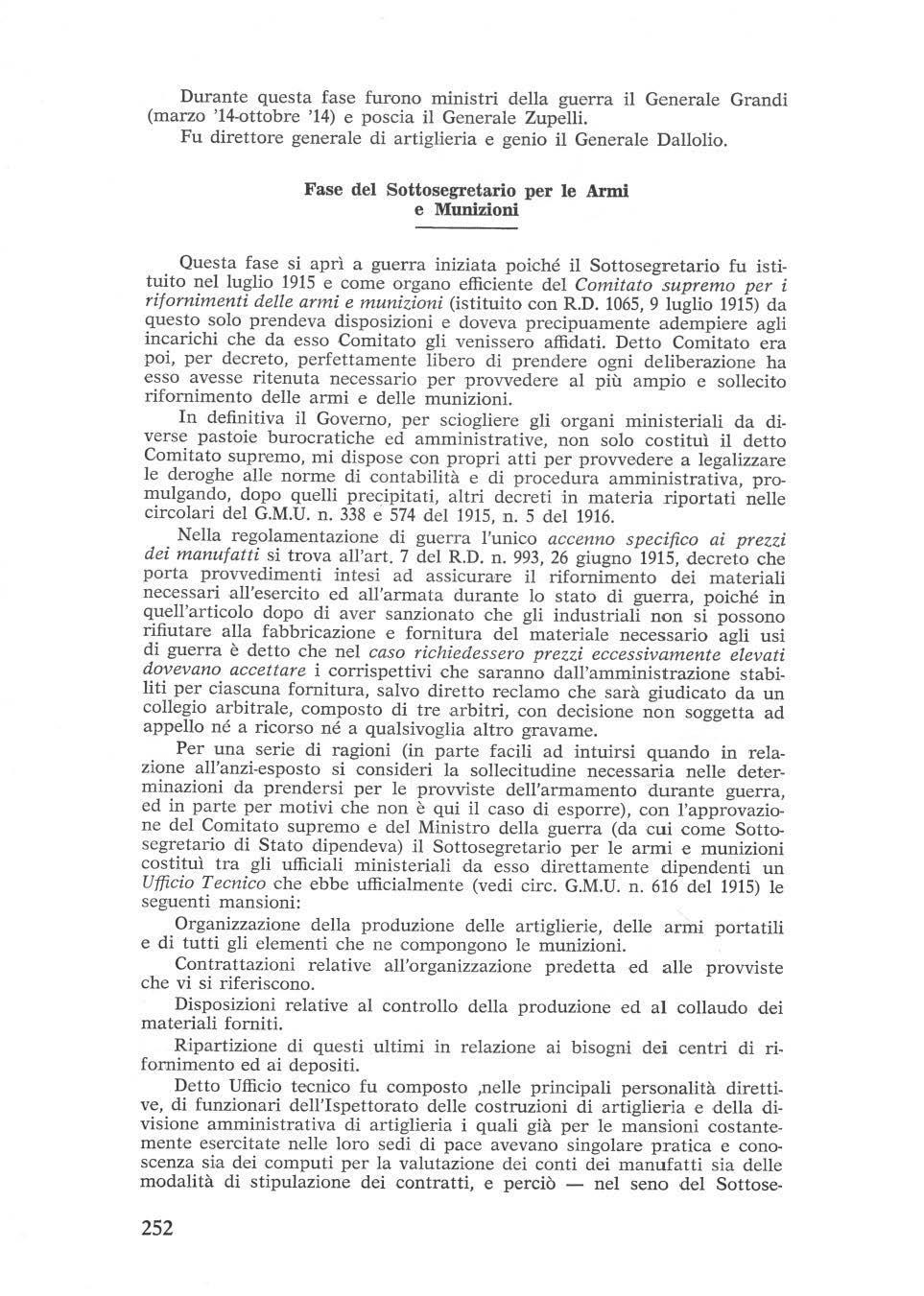
In definitiva il Governo, per sciogliere gli organi ministeriali da diverse pastoie burocratiche ed amministrative, non solo costituì il detto Comitato supremo, mi dispose con propri atti per provvedere a legalizzare le deroghe alle norme di contabilità e di procedura amministrativa, promulgando, dopo queUi pre<;ipitati, altri decreti in materia riportati nelle circolari del G.M.U. n. 338 e 574 del 1915, n. 5 del 1916.
Nella regolamentazione di guerra l'unico accenno specifico ai prezzi dei manufatti si trova all'art. 7 del R.D. n. 993, 26 giugno 1915, decreto che porta provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata durante lo stato di guerra, poiché in quell'articolo dopo di aver sanzionato che gli industriali non si possono rifiutare alla fabbricazione e fornitura del materiale necessario agli usi di guerra è detto che nel caso richiedessero prezzi eccessivamente elevati dovevano accettare i corrispettivi che saranno dall'amministrazione stabiliti per ciascuna fornitura, salvo diretto reclamo che sarà giudicato da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, con decisione non soggetta ad appello né a ricorso né a qualsivoglia altro gravame.
Per una serie di ragioni (in parte facili ad intuirsi quando in relazione all'anzi-esposto si consideri la sollecitudine necessaria nelle determinazioni da prendersi per le provviste dell'armamento durante guerra, ed in parte per motivi che non è qui il caso di esporre), con l'approvazione del Comitato supremo e del Ministro della guerra (da cui come Sottosegretario di Stato dipendeva) H Sottosegretario per le armi e munizioni costituì tra gli ufficiali ministeriali da esso direttamente dipendenti un Ufficio Tecnico che ebbe ufficialmente (vedi circ. G.M.U. n. 616 del 1915) le seguenti mansioni:
Organizzazione della produzione delle artiglierie, delle armi portatili e di tutti gli elementi che ne compongono le munizioni.
Contrattazioni relative all'organizzazione predetta ed alle provviste che vi si riferiscono.
Disposizioni relative al controllo della produzione ed al collaudo dei materiali forniti.
Ripartizione di questi ultimi in relazione ai bisogni dei centri di rifornimento ed ai depositi.
Detto Ufficio tecnico fu composto ,nelle principali personalità direttive, di funzionari dell'Ispettorato delle costruzioni di artiglieria e della divisione am1ninistrativa di artiglieria i quali già per le mansioni costantemente esercitate nelle loro sedi di pace avevano singolare pratica e conoscenza sia dei computi per la valutazione dei conti dei manufatti sia delle modalità di stipulazione dei contratti, e perciò - nel seno del Sottose- gretariato - funzionavano come rappresentanti dei valori dell'Ispettorato delle Costruzioni e della divisione amministrativa di artiglieria.
Ciò premesso si può aggiungere che l'Ufficio tecnico del Sottosegretario
A.M. funzionavano rispetto ai contratti di artiglieria provenienti quali schemi cli contratto degli stabilimenti, come se rappresentasse l'Ispettorato delle costruzioni, e le sue approvazioni erano suffragate dall'accettazione del Sottosegretario per le A.M.; e, rispetto al Sottosegretariato in sé, quand'esso stesso Ufficio Tecnico stipulava un contratto coi provveditori, come Direzione di stabilimento vagliante un contratto e come I spettorato e poi, rispetto all'approvazione del Sottosegretario, quale organo proponente.
La conoscenza dei costi attuali dei materiali l'Ufficio Tecnico la detraeva dalle conoscenze specifiche dei propri componenti, dalle notizie attinte dagli stabilimenti militari e dalle Commissioni di collaudo o di vigilanza interessate che potevano fornire ogni elemento utile per valutare i successivi stadii di lavorazione; dagli uffici siderurgici, carboni, esteri e trasporti marittimi per quanto riguardava il costo delle materie prime in paese o provenienti dall'estero, ed ,infine dagli organi della Mobilitazione Industriale (centrali o regionali) per quanto rifletteva gli emulamenti della manodopera in ciascuna regione od officina privata.
Con le raccolte saltuarie o periodica, completa o frammentaria dei suddetti dati secondo le circostanze, l'Ufficio tecnico era in grado, col dipendente personale specializzato nei vari rami di costruzione di artiglierie, di compilare i propri prospetti di costo dei materiali e discuterli a raffronto di quelli presentati dai fornitori per ogni contratto che occorresse portare a termine.
Definiti i prezzi e le modalità di fornitura il contratto, con le solite formalità statali, era esteso da funzionari d ell'ufficio tecnico, firmato dal fornitore, ratificato dal Sottosegretario per le A.M. e registrato.

Dopo ciò il contratto era considerato perfetto ed inviato ad uno stabilimento militare in amministrazione, ciò che in termine sintetico si diceva « appoggiare un contratto ad uno stabilimento» al quale spettava in seguito considerarlo come fatto da sé stesso, e provvedeva pertanto ai collaudi, all'introduzione dei materiali accettati in magazzino (e all'invio diretto al fronte) ai pagamenti, alle ritenute per le multe e così via, a tutto il corredo infine di documenti contabili d imostranti lo svolgimento amministrativo del contratto.
Trascorsi i mesi di guerra del 1915 e giunti quasi alla fine del 1916 buona parte dell'industria di guerra in paese era nata e sufficientemente sviluppata, l'organismo della Mobilitazione I ndustriale erasi convenientemente esteso ed aveva presi ampi contatti colle industrie belliche, cosicché sembrò giunto il momento di poter più rigorosamente vagliare i prezzi dei manufatti e procedere a sensibili riduzioni di prezzo . Difronte però a questi motivi che sembrava potessero addurre alle dette riduzioni acuivasi il caro-viveri che alzava le paghe operaie, si accentuava la penuria dei trasporti marittimi e ferroviari, gli uni producendo rialzo di noli e rarefazioni delle materie prime di provenienza estera gli altri sovraspese per sorte, ritardi, magazzinaggi prolungati ecc., scemava la totale produttività delle maestranze per l'invio di operai di discreta abilità al fronte e sosti:tuzione con personale femminile e minorile, cosicchè riusciva molto difficile agli uffici, tecnici vagliare al vero la spesa industriale e quindi diminuire fino a l limite utile - cioè senza cagionare deficienza della produzione - il valore dei materiali.
Si pensò d i venire in ausilio all'Ufficio tecnico dandogli un appoggio morale ed un sollievo tecnico di responsabilità, sia quando diminuzioni non si r iuscissero a realizzare sia quando occorreva perfettamente chiarire q uale elemento di riduzione fosse stato possibile, istituendo una Com- missione - composta essenzialmente di personalità tecniche e non militari, conoscitrici dell'industria - che avesse possibilità di tutto indagare nelel lavorazioni per le armi e munizioni onde essere edotta di ogni più idoneo elemento per esprimere il proprio parere sui prezzi e sulle modalità contrattuali osservate nelle commesse pattuite presso gli uffici del Sottosegretariato.
Il Ministro della guerra accedette alla proposta e venne pubblicato un decreto ministeriale, in data 1° marzo 1917 (vedi circolare G.M.U. n. 172 del detto anno) il quale istituì una« Commissione Consultiva e di revisione dei contratti di forniture di guerra» Commissione che in realtà aveva cominciato a-d esercitare le proprie funzioni sin dal gennaio 1917.
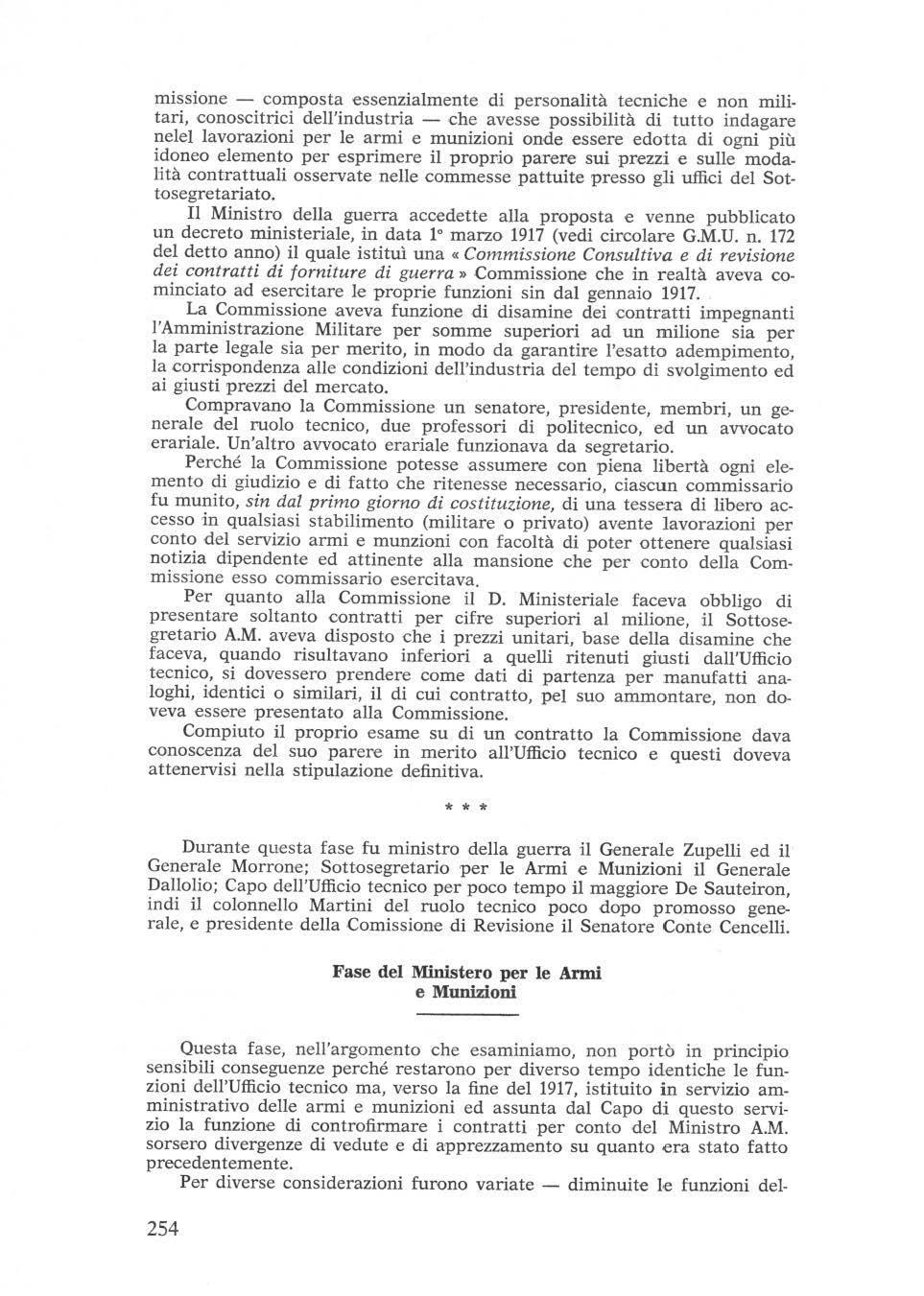
La Commissione aveva funzione di disamine dei contratti impegnanti l'Amministrazione Militare per somme superiori ad un milione sia per la parte legale sia per merito, in modo da garantire l'esatto adempimento, la corrispondenza alle condizioni dell'industria del tempo di svolgimento ed ai giusti prezzi del mercato.
Compravano la Commissione un senatore, presidente, membri, un generale del ruolo tecnico, due professori di politecnico, ed un avvocato erariale. Un'altra avvocato erariale funzionava da segretario.
Perché la Commissione potesse assumere con piena libertà ogni elemento di giudizio e di fatto che ritenesse necessario, ciascun commissario fu munito, sin dal primo giorno di costituzione, di una tessera di libero accesso in qualsiasi stabilimento (militare o privato) avente lavorazioni per conto del servizio armi e munzioni con facoltà di poter ottenere qualsiasi notizia dipendente ed attinente alla mansione che per conto della Commissione esso commissario esercitava.
Per quanto alla Commissione il D. Ministeriale faceva obbligo di presentare soltanto contratti per cifre superiori al milione, il Sottosegretario A.M. aveva disposto che i prezzi unitari, base della disamine che faceva, quando risultavano inferiori a quelli ritenuti giusti dall'Ufficio tecnico, si dovessero prendere come dati di partenza per manufatti analoghi, identici o similari, il di cui contratto, pel suo ammontare, non doveva essere presentato alla Commissione.
Compiuto il proprio esame su di un contratto la Commissione dava conoscenza del suo parere in merito all'Ufficio tecnico e questi doveva attenervisi nella stipulazione definitiva. * * *
Durante questa fase fu mfoistro della guerra il Generale Zupelli ed il Generale Morrone; Sottosegretario per le Armi e Munizioni il Generale Dallolio; Capo dell'Ufficio tecnico per poco tempo il maggiore De Sauteiron, indi il colonnello Martini del ruolo tecnico poco dopo promosso generale, e presidente della Comissione di Revisione il Senatore Conte Cencelli.
Fase del Ministero per le Arnù e Munizioni
Questa fase, nell'argomento che esam1mamo, non portò in principio sensibili conseguenze perché restarono per diverso tempo identiche le fun. zionj dell'Ufficio tecnico ma, verso la fine del 1917, istituito in servizio amministrativo delle armi e munizioni ed assunta dal Capo di questo servizio la funzione di controfirmare i contratti per conto del Ministro A.M. sorsero divergenze di vedute e di apprezzamento su quanto era stato fatto precedentemente.
P er diverse considerazioni furono variate - diminuite le funzioni del- l'Ufficio tecnico e quindi si pensò di rimettere alla direzione sua un colonnello. Venne perciò trasferito dall'Arsenale di Torino alla sede del Ministero il Colonnello di Artiglieria del ruolo tecnico Cav. Cortese.
L'andamento generale del servizio e le funzioni precipue dell'Ufficio tecnico per vero mai variarono, ma il nuovo capo costituì subito un uffi· cio prezzi quale ufficio collegato col proprio, che assunse più propriamente la denominazione generale « Servizio Commesse Artiglieria ».
L'istituzione dell'Ufficio prezzi e così presentate nella motivazione della mia costituzione:
« il nuovo capo servizio ritiene necessario raccogliere una serie di dati, antichi e ·recenti, per meglio confortare con elementi di fatto, passati ed attuali, la propria esperienza in materia di allestimento di artiglierie e munizioni. Così nelle trattative con i fornitori si sarebbe potuto sem· pre essere sorretti da dati inconvertibili circa i costi delle materie prime e delle lavorazioni d'officina e perciò essere bene in grado di valutare le proposte ricevute ed, occorrendo, di controbatterla con validi elementi tratti da1la visione o quasi dalla conoscenza diretta della produzione.
« Questo Ufficio prezzi raccolse a mano a mano dati sulle forniture passate(dati di contratto, elementi di critica e di controllo forniti dalla Commissione consultiva e dj revisione dei contratti già funzionante da più di un anno, dati profferti dall'Ufficio Siderurgico) e precipuamente si servì di notizie fornite e richieste dalle Commissioni di vigilanza o di collaudo, cominciatino nel quale venivano riassunti in forma schematica a chiaro tutti i dati di costo unitari per ogni singola lavorazione e produzione unitaria di ciascun prodotto e per ciascuna Ditta dalle Commissioni controllate».
In questa fase un Ministro per le armi e munizioni il Generale Dallolio, capi del servizio commesse per artiglieria prima il Gen. Martini poscia il Col. Cortese, poco di poi promosso Generale; capo del Servizio Amministra· tivo il Gen. Gardini.
Fase dell'interinato del Ministero Arnù e Munizioni al Ministero della Guerra
Questa fase non portò nel campo delle commesse di artiglieria, una variante essenziale ai criteri or ora accennati come vigenti nell'ultimo tempo del la fase precedente, ché anzi instituito il « Servizio Centrale Acquisti » - con a capo l'ing. Sinigaglia - per quanto specialmente riguardava la trattazione dei contratti per forniture di materie prime, munizionamento di artiglierie, bombarde, bombe relative, bombe a mano ed esplosivi fu lasciato specificatamente al S ervizio Commesse Artiglieria la definizione dei contratti per quanto rifletteva artiglierie ed armi portatili, contratti che erano poi redatti e stipulati (dopo l'esame della Commissione di revisione e del Comitato di Revisione istituito con D. Luog. n. 620 del 9 maggio '18) dal Servizio Amministrativo dagli stabilimenti di artiglieria.
* * *
Durante questa fase tenne l'in terim del Ministero delle A.M., il Gen. Zupelli; fu Sottosegretario per le A.M. l'On . lng. Cesare Nava; capo del Servizio Commesse Artiglieria il Gen. Cortese e capo del Servizio Amministrativo il G en. Gardini.
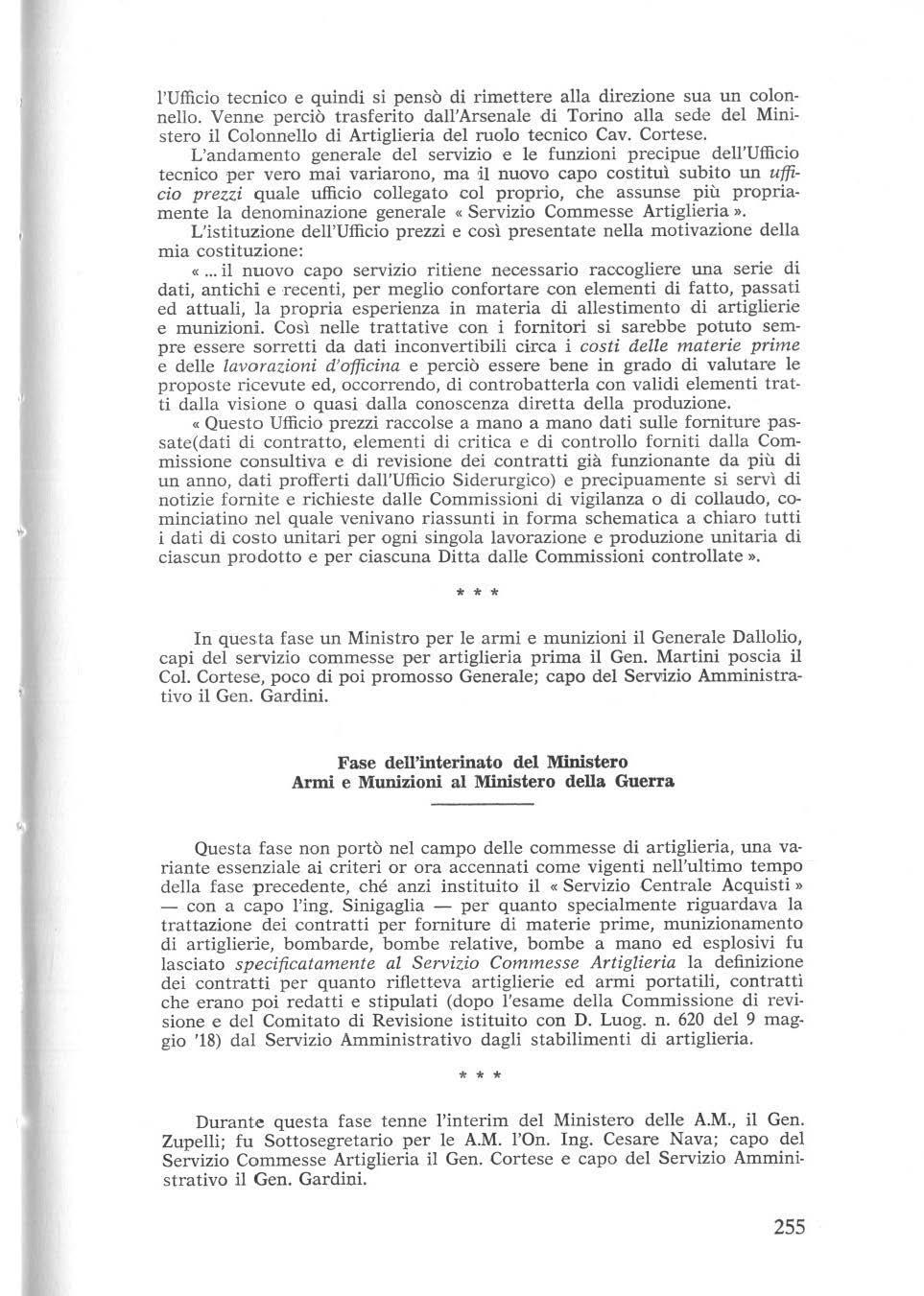
Fase del Ministro Armi e Trasporti e Commissariato Generale per le Armi e Munizioni
Fu fase brevissima, praticamente dal 15 settembre all'armistizio, e non seguì nel fatto alcun'essenziale variante di criterio e norma su quelli già esposti, anzi se ne vide una larga applicazione con la costituzione, il 24 ottobre 1918, della Commissione Clavarino per condurre le trattative con la ditta Ansaldo onde definire i prezzi della fornitura dei materiali di artiglieria concessi alla Società stessa dal nov. 1917 in poi. Esse non avendo dati inappugnabili per costituire le basi dei propri calcoli ottenne la nomina di una sub-Commissione, quella del Gen. Stampacchia, onde si procedesse a!Ja valutazione del costo effettivo dei materiali di seconda lavorazione, e questa sub-commissione non potette inviare i primi dati dei suoi lavori che nel 1919. * * *
In questa fase fu Ministro per le Armi e Trasporti S.E. l'avv. Generale Erariale Villa, Commissario Generale l 'On. Ing. Nava, capo del Servizio commesse il Gen. Cortese e Capo del servizio amministrativo il Gen. Gardini.
Roma, 23 settembre 1922
Il Direttore generale di artiglieria Gen. Cortese
Alla Commissione parlamentare d 'inchiesta per le spese di guerra
Sottocommissione C (Segreteria)
Indice Generale
Indice Allegati
1. Relazione al Ministro della Guerra in data 28.2.1915 sul nizionamento dell'Esercito e sui provvedimenti per intensificare la produzione pag. 180
2. Relazione del Direttore Generale d 'Artiglieria e Genio sul rifornimento delle munizioni in data 27.6.1915 )) 186
3. Relazione del Sottosegretario di Stato per le Armi e Munizionamento sull'organizzazione industriale per risolvere il problema d el munizionamento in data 1° agosto 1915 )) 189
4. Lettera della S.A.I. GIO. ANSALDO & C. G. DRG/65 al Ministro della Guerra in data 3 maggio 1915 con oggetto: Materiale 105 campale - Affusti 210 - Mortai 250 - Lanciabombe e cannoni antiaerei . » 194
5. Lettera S.A.I. GIO. ANSALDO & C. al Sottosegretario di Stato alle Armi e Munizioni .in data 12 ottobre 1915 n. 30. DGR-314 con oggetto: Necessità di provvedimenti per facilitare lo svolgimento della vita industriale della Società )) 196
6. Lettera del Capo del Servizio Informazioni al Sottosegretario per le Armi e Munizioni in data 30 marzo 1917 n. pr. 2619/S - Riservatissimo - Confidenziale con oggetto: Comm. Perrooe )) 198
7. Lettera del M.inistro Z upelli al Sottosegretario di Stato alle Armi e Munizioni in data 3 agosto n. prot. 3316 con oggetto: Ditta Ansaldo & C.. )) 199
8. Lettera della S.A.I. GIO. ANSALDO & C. al Ministro per le Armi e Munizioni in data 21 novembre 1917 n. prot. 35 P /770 sulla produzione di artiglierie . )) 200
9. Lettera della S.A.I. GIO. ANSALDO & C. in data 3 gennaio 1918 n. prot. 38/P - PERSONALE RISERVAT A al M.inistro per le Armi e Munizioni circa la produzione delle artiglierie )) 201
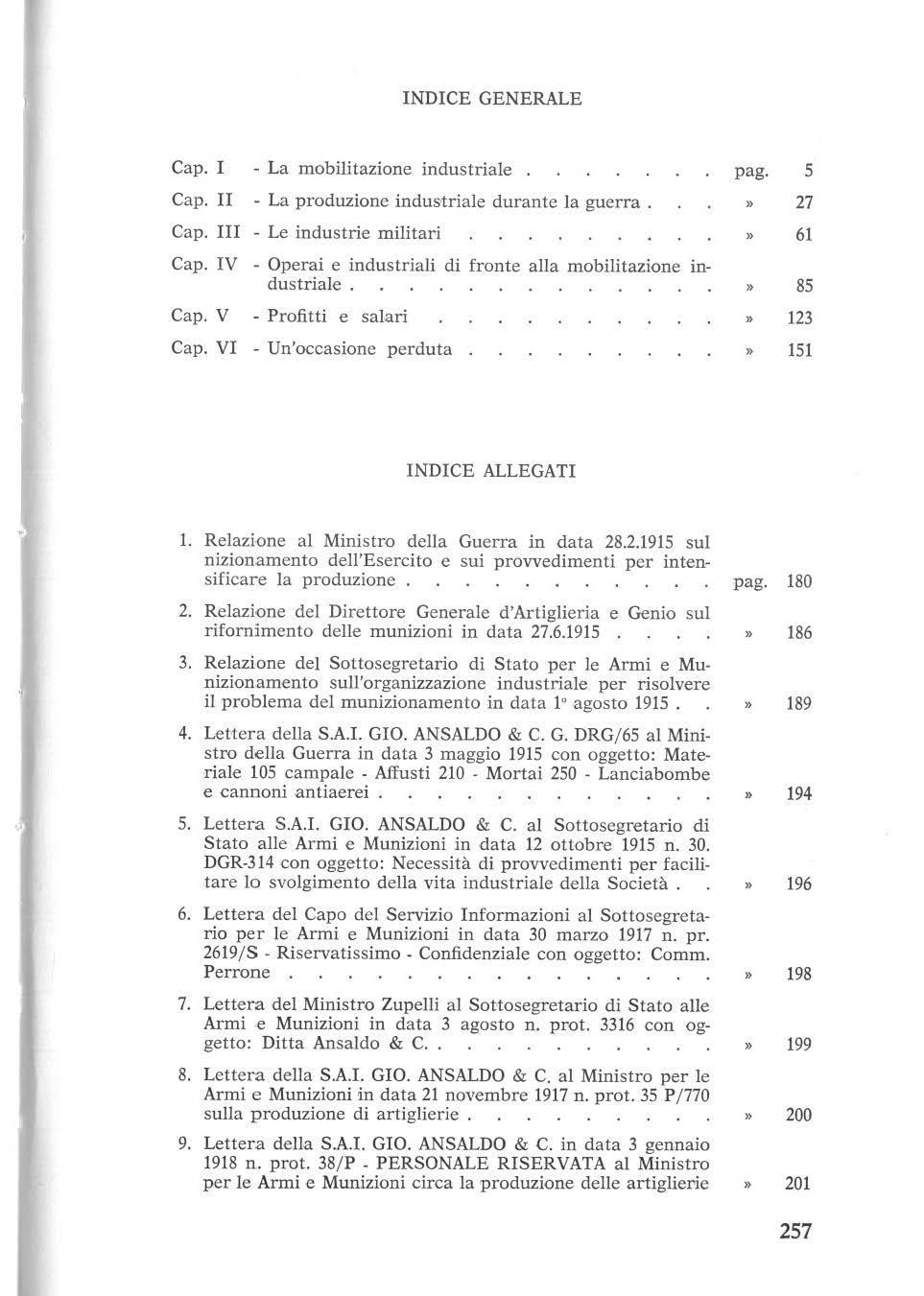
10. Elenco materiali della S.A.I. GIO. ANSALDO & C. in data 15 gennaio 1918 n. prot. 39/P. 195 al Ministero Armi e Munizioni di Messina circa la produxione che potremo riserva.re al R. Esercito nel secondo semestre del 1918 ripartita secondo i calibri )) 203
11. Elenco materiali del Ministro per le Armi e Munizioni in data 20 gennaio 1918 n. prot. 328283, m risposta ai fogli 38/P. 310 in data 3 corr. - 39/P. 195 in data 15 corr. alla Commissione di Vigilanza presso Ansaldo (Roma) e per conoscenza alla Società Giovanni Ansaldo & C. (Sampierdarena) circa la produzione di artiglierie e nuove commesse )) 205
12. Verbale del Presidente del Comitato Centrale di Mobilitazione I ndustriale circa la seduta del 26 novembre 1916, ore 10,30, tenuta nella Biblioteca del Ministero della Guerra . )) 207
13. LcHera dell'Ing. Cesare Saldini al Sottosegretario di Stato per le Armi e Munizioni relativa ai Rappresentanti Operai dei Comitati Regionali di Mobilitazione )) 231
14. Verbale delle sedute tenutesi il giorno 16 dicembre 1916 nelJa sede del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale )) 235
15. Notizie sul servizio commesse di artiglierie nel periodo della Guerra Europea (1914-1918) )) 249









