
37 minute read
UN'OCCASIONE PERDUTA
Lo scoppio della guerra sembrò porre fine all'annosa polemica tra liberisti e protezionisti sancendo la vittoria di questi ultimi. Sulla scia di questo successo e sotto l'incalzare delle necessità belliche, studiosi e giornalisti andarono oltre la primitiva affermazione dell'imprescindibilità del potenziamento dell'industria pesante italiana. « Il motivo dell'indipendenza dalla Germania, nella chimica come nelle industrie dei metalli, si univa spesso a quello dei compiti della guida economica di uno Stato moderno. Via via che la guerra si inoltrava si assisteva, d'altronde, a un tale sviluppo di produzioni già avviate e di creazione di rami nuovi di fabbricazione, che era difficile anche ai liberisti più rigorosi chiedere un ritorno al passato o negare l'utilità di tale apparato in circostanze come quelle di guerra » (1). I nfatti i più abili tra i liberisti non negavano più la necessità dell'intervento statale, preoccupandosi invece di circoscriverne la sfera d'azione. Così l'Einaudi, che, nel dicembre del 1916, chiedeva che i materiali militari navali e terrestri fossero costruiti unicamente da aziende controllate dallo Stato. Questo controllo doveva però avvenire senza alterare la struttura privatistica dell'impresa, secondo un sistema che anticipava le attuali industrie a partecipazione statale. Lo Stato avrebbe dovuto poi astenersi dall'ingerirsi nel resto dell'economia (2) .
Questa proposta, di chiaro contenuto limitativo, non poté esser presa in considerazione poiché in pratica, sotto la spinta delle imperiose necessità della produzione bellica, l'ingerenza dello Stato neH'economia non fece che accrescersi negli anni del conflitto. Questo intervento non corrispose ad un piano preordinato, né fu la conseguenza di ponderate scelte della classe politica. I dirigenti italiani avevano in gran parte un'esperienza di governo risalente all'età giolittiana, un'epoca in cui i problemi venivano in genere risolti attraverso mediazioni tra le forze in campo, senza perseguire un chiaro e definito disegno politico.
Advertisement
D'altra parte la totale divisione tra le sfere di competenza dei politici e d ei militari, non giocava certo a favore di una valida azione di direzione politica dello sforzo bellico. Per queste ragioni la classe dirigente, sia perché sprovvista delle conoscenze tecniche necessarie sia perché incapace di esprimere una propria organica linea politica nel settore, preferì abdicare nelle mani dei tecnici. Fu quindi il generale Dallolio, con la collaborazione di tecnici militari e civili, che organizzò e diress e lo sforzo industriale del paese. Questa soluzione, se si dimostrò efficace nei tempi brevi, era purtroppo destinata a mostrare la corda a l termine del conflitto poiché, fatalmente, la classe dirigente politica si sentiva estranea all'organizzazione creata dal Dallolio, la quale, in definitiva, divenne fatalmente, per i politici, uno strumento temporaneo di cui bisognava sbarazzarsi appena la situazione lo consentisse.
In ultima analisi fu Alfredo Dallolio a tracciare le linee direttrici della politica industriale del paese nel corso della guerra, e ciò, tutto sommato, fu senza dubbio un bene poiché il genera le, superando molteplici ostilità, seppe creare un clima di collaborazione tra industria e pubblica amministrazione e tra imprenditori e maestranze che non aveva precedenti nella storia italiana. Ciò era dovuto alla decisione di largheggiare nelle commesse e nei salari facendo in definitiva pagare al resto dd Paese l'espansione industriale e d il miglioramento delle condizioni di vita d elle masse operaie . Tutto questo non fu indubbiamente senza conseguenza per quanto concerneva la stabilità finanzi aria dell'Italia, tuttavja bisogna chiedersi se una linea politica alternativa, quella proposta dall'Einaudi consistente in « sottoporre a dura disciplina coercitiva industriali ed operai » ( 3 ), avrebbe consentito di raggiungere gli stessi risultati. Il generale Rodolfo Bianchi d'Espinosa che, come membro della Segreteria di Cadorna fu anche addetto ai rapporti con la « Mobilitazione Indus triale», ha scritto: « sono in grado di affermare che la sapiente e tenace opera di vigilanza, d'incitamento e di geniale organizzazione (e ripieghi) sviluppata dal generale Dallolio fu addirittura sbalorditiva» ( 4 ).

E f uor di dubbio però che l'azione de ll'organizzatore della Mobilitazione Industriale fu resa possibile dal clima di collaborazione che il generale Dallolio aveva saputo creare. Sarebbe stata concepibile una simile atmosfera se, invece di venire incontro alle richieste degli industriali e degli operai, li si fossero sottoposti a « dura disciplina coercitiva»? E lecito dubitarne.
La classe politica, se non seppe e non volle dirigere la politica economica del Paese in guerra, non seppe del pari formula- re una chiara e coerente linea di politica interna. Le indicazioni che pervenivano dagli ambienti militari erano su questo punto tutt'altro che univoche: infatti a differenza di Dallolio, il generale Cadorna, chiedeva con insistenza al Governo energici provvedimenti contro i « disfattisti » ed i gruppi politici ostili alla guerra. Questo atteggiamento derivava dal fatto che il Capo di Stato Maggiore non si preoccupava che della sicurezza delle retrovie dell'esercito operante, mentre il Ministro delle armi e munizioni era interessato principalmente all'efficienza della stuttura industriale del Paese.
Gli orientamenti del Cadorna e del Dallolio divergevano sostanzialmente perché ciascuno privilegiava il compito che gli era affidato, ma ciò non avrebbe impedito certo al Governo di sviluppare una coerente ed organica linea politica poiché si trattava di pareri di tecnici che vedevano inevitabilmente solo alcuni aspetti del problema, mentre la valutazione complessiva spettava naturalmente alle autorità politiche.
Nonostante ciò, mancò una coerente ed incisiva azione di governo nei confronti del problema dell'ordine pubblico. Vittorio Emanuele Orlando, che, come Ministro dell'Interno prima e come Presidente del Consiglio poi, ebbe per un lungo periodo le maggiori responsabilità in questo campo, si oppose alle misure repressive proposte dal Cadorna, cercò di assicurare il regolare rifornimento dei principali prodotti alimentari alle grandi città e tenne rapporti, per interposta persona, con il gruppo parlamentare socialista. Si trattava indubbiamente di un abbozzo di linea politica che fu però portato avanti senza risolutezza e con molteplici tentennamenti. Più di una circostanza fa infatti pensare che gli obiettivi di Orlando fossero alquanto modesti: prevenire disordini e mantenere un minimo di rapporti con i deputati socialisti. Si trattava insomma di una politica che nasceva più dell'esigenza di garantirsi un qualche spazio di manovra parlamentare, anche nei confronti dei socialisti, che dal proposito di coinvolgere l'opposizione nello sforzo bellico del Paese. Infatti Orlando non approfittò della situazione creatasi dopo Caporetto per tentare di coinvolgere stabilmente nella politica di « union sacrée » tutto o in parte il partito socialista, cosa che, in quel momento, sarebbe stata tutt'altro che difficile. In definitiva, anche ad Orlando mancò la visione del problema della politica interna nel suo complesso o, quantomeno, non ebbe la risolutezza e l'energia necessarie per portare avanti fino alle logiche conseguenze la sua azione politica, la quale appare, in conseguenza, più che come il frutto di un programma organico, come un tentativo di garanti- re l'ordine pubblico alla meno peggio e di assicurarsi in qualche modo i contatti con il gruppo parlamentare del P.S .I.


In una situazione caratterizzata dall'assenza di una valida iniziativa governativa, gli orientamenti degli operai e degli industriali acquistano un'importanza ancora maggiore, sia per quanto riguarda l'ordine pubblico, sia per quanto s i riferisce a l funzionamento e lo sviluppo della Mobilitazione Industriale.
Circa i problemi relativi all'ordine pubblico, gli orientamenti delle masse operaie non costituirono, come abbiamo visto innanzi, un serio problema nel corso del primo conflitto mondiale. Più complesso il discorso relativo alla Mobilitazione Industriale. Come si ricorderà, dopo un primo periodo di perplessità, industriali ed operai accettarono di buon grado di inserirsi nel1'organizzazione creata dal Dallolio; ciò era dovuto alla particolarissima situazione nata dalla guerra che, annullando qualsiasi rapporto fra costi e ricavi, aveva fatto si che profitti e salari potessero espandersi senza contrasto; al termine del conflitto la cessazione delle commesse militari avrebbe determinato inevitabilmente una ben differente congiuntw·a. L'organizzazione della Mobilitazione Industriale avrebbe potuto sopravvivere anche in simili condizioni o doveva limitare la propria azione al periodo bellico vero e proprio? Era questa una domanda a cui industriali ed operai dovevano comunque rispondere. L'atteggiamento del Dallolio riguardo a questo problema era delineato abbastanza chiaramente; infatti nella più volte citata riunione plenaria del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale del 26 novembre 1916, egli rilevava la necessità « importante ed urgente di preparare, fin d'ora, un vero e proprio piano di Mobilitazione Industriale, che permetteva di trasformare l'industria del regime di guerra a quello di pace, senza scosse brusche e pericolose, ma gradatamente e razionalmente così da facilitare anche, alle diverse classi operaie, un assestamento delle loro condizioni morali ed economiche, profondamente turbate dalla guerra». Il generale vagheggiava una Mobilitazione Industriale del periodo di pace che poteva continuare « con opportune modifiche, allargamenti e addentellati agli altri organi dello Stato interessati all'arduo problema; le tradizioni di questa istituzione che ha dimostrato i grandi tangibili vantaggi che si possono ottenere da un'intima, quotidiana collaborazione dei rappresentanti delle Amministrazioni Governative, con le forze vive e produttive del Paese, industriali ed operaie» ( 5 ). Secondo il generale Dallolio non era il caso che si definissero, fin da quel momento, le caratteristiche strutturali della Mobilitazione Industriale di pace. Infatti , nella seduta del 17 dicembre di quello stesso 1916 della Commissione mista che doveva esaminare il nuovo regolamento della M.I., il capitano Enrico Toniolo, parlando (praticamente) a nome del Sottosegretariato, sostenne il « concetto che preparare fin da oggi una Mobilitazione I ndustriale civile era troppo presto; però siccome il lavoro preparatorio per quello che si dovrà fare dopo la guerra non bisogna farlo a pace conclusa, ma anticipatamente, predisponendolo fin d'ora, esso dovrebbe essere espletato dallo stesso ente oggi esistente il quale già conosce quello che oggi si fa e cosa conviene studiare per l'avvenire. Con questo si eviterebbe appunto un'azione slegata e senza coesione fra le diverse iniziative che vanno ovunque sorgendo. L'organismo attuale si è dimostrato utile e quindi è bene aggregare ad esso altri elementi i quali possono portare il sussidio della loro competenza nel trattare questioni di diversa natura. Preparare fin da ora uno schema di mobilitazione civile è prematuro, ma siccome il periodo di guerra e quello delle trattative di pace non sarà certo breve, si potrà, durante questo periodo, fare un ottimo lavoro di preparazione e raccogliere quel materiale che potrà essere utilissimo» ( 6 ).
Si voleva in pratica che non fosse definita alcuna struttura alternativa alla M.I. ed, al contempo, si rafforzava quest'ultima chiamando a collaborare i ministeri interessati alla risoluzione dei problemi post-bellici. Quest'orientamento celava probabilmente la tendenza dell'allora Sottosegretariato per le armi e munizioni a far si che fosse incaricata la stessa struttura della Mobilitazione Industriale di risolvere i problemi del dopoguerra. Infatti, una volta che la struttura fosse stata convenientemente ampliata, chi avrebbe sentito il bisogno di crearne un'altra exnovo? In quanto ai programmi del Dallolio e dei suoi collaboratori, per la riorganizzazione della vita economica del Paese al termine del conflitto, ben poco si sa. Tuttavia, in quello stesso 1916, Enrico Toniolo diede alle stampe un breve studio sulla Mobilitazione Industriale in Italia in cui, dopo aver accennato all'opera svolta dagli altri paesi belligeranti per prepararsi ad affrontare i problemi del dopoguerra, si delineava, sia pure sommariamente, una possibile linea di sviluppo della organizzazione creata in Italia. « Ora per la Mobilitazione Industriale di pace è necessario che il concorso degli industriali delle diverse industrie sia raggruppato e coordinato in una specie di ente consultivo discipli.natore, il cui obiettivo dovrebbe principalmente essere questo: avviare gradatamente tutte le industrie che oggi lavorano per la guerra, a ridivenire industrie di pace, ma più forti, meglio organizzate, con una giusta razionale suddivisione dei campi di lavoro fra le varie industrie, le quali, in tal guisa, raggiungerebbero progressivamente quella specializzazione che è il più grande elemento di forza e di impero, perché evita alle industrie identiche ed affini di abbandonarsi fra loro a concorrenza eccessiva e dannosa, mentre invece la specializzazione ne assicurerebbe la prosperità sia prossima che lontana ». Ciò non poteva avvenire che per mezzo dell'intervento statale e con l'adozione di una politica doganale protezionistica che il Toniolo suffragava con il parere di economisti che, dopo aver sostenuto il libero scambio, si erano convertiti, con la guerra, al protezionismo. L'efficacia di una simile politica era però, in qualche modo, dipendente da un'altra serie di importanti provvedimenti: « I giornali hanno già esposto un grandioso programma di opere pubbliche, stradali, ferroviarie, idrauliche da eseguirsi dopo la guerra e per una più rapida messa in valore delle risorse naturali d el nostro paese. È stato anzi formulato un progetto per la espropriazione di tutte le terre incolte, espropriazione non pensata ora, ma vagheggiata da lunghissimi anni, anche da eminenti e illuminati conservatori.


Ciò dimostra p ertanto che il concetto di un grandioso compito che spetta a tutti dopo la guerra, è profondamente sentito, per quanto forse ancora senza contorni precisi » (7).
In definitiva, il programma proposto dal Toniolo può essere così riassunto: alcune industrie specializzate, appositamente selezionate, produrranno, con l'appoggio dello Stato, per l'esportazione, mentre una politica protezionistica riparerà le altre dall' invadenza della concorrenza estera ed un grandioso programma di opere pubbliche favorirà le comunicazioni interne, aumenterà il potenziale nazionale di energia idroelettrica, diminuendo la dipendenza dell'Italia dall'estero e permettendo all'industria di attuare, quasi senza scosse, ]a riconversione. Le opere pubblich e e la riforma agraria avrebbero inoltre permesso l'assorbimento dei congedati dall'esercito e dei licenziati dall'industria di gu erra.
Si trattava di un programma grandioso, ma non privo di coerenza che il Toniolo, segretario del Comitato Centrale per la Mobilitazione Industriale, non avrebbe potuto dare alle stampe senza il consenso dei suoi superiori ( 8 ).
In un simile contesto acquistavano senza dubbio una grande importanza gli orientamenti degli operai, degli industriali e della classe politica nei confronti di una possibile sopravvivenza dell a Mobilitazione Industriale per il periodo post-bellico.
Benché una commissione mista, di cui facevano parte alcuni tra i più cospicui industriali e i maggiori esponenti de1le organizzazioni operaie, avesse riconosciuto, in una riunione tenu- tasi a Roma il 19 settembre 1916, « che non si possa a priori scartare l'idea della Mobilitazione Industriale anche pel dopo guerra, visti gli indiscutibili vantaggi ch'essa ha recato nel periodo di preparazione della guerra e visto il suo ottimo funzionamento » ( 9 ), tuttavia, già nella riunione del 17 dicembre della stessa Commissione, il Buozzi « ritornando sulla discussione d'ordine generale, richiama l'attenzione sull'affermazione che la Mobilitazione Industriale deve durare tre mesi dopo la guerra; egli dice che, finita la guerra, comincerà la smobilitazione delle truppe e quindi non trova perché gli operai dovrebbero continuare a rimanere mobilitati. Il Decreto sulla Mobilitazione Industriale, inoltre è stato fatto in seguito alla facoltà dei pieni poteri accordati al Governo, che è limitata al periodo della guerra e quindi tutti i Decreti decadranno col termine della guerra a meno che non siano trasformati in legge. Ritiene quindi che non sia il caso di stabilire che la Mobilitazione continuerà ancora tre mesi dopo la guerra » ( 10 ).

Questo atteggiamento contrario all'attività, anche di un solo giorno dopo il termine del conflitto, dell'organizzazione creata da Dallolio verrà sostanziato di tutta una serie di ragioni, dallo stesso Buozzi al congresso della FIOM del novembre 1918. Egli sosteneva che quando lo Stato non avesse più commesse e materie prime da dare « ogni industriale reclamerà ed otterrà giustamente completa libertà d'azione» per cui sarebbero rimasti mobilitati soltanto gli operai, « ciò che è poco e troppo ad un tempo! » Il ragionamento del dirigente sindacale, che sottintendeva l'evidente preoccupazione che il protrarsi nel dopoguerra della Mobilitazione Industriale potesse risolversi in una forma di controllo delle masse operaie, si basava però su premesse evidentemente errate. Infatti , che cosa era la struttura creata dal Dallolio se non uno strumento per la ripartizione delle materie prime e delle commesse statali tra le varie industrie? Negarle un simile compito non significava in pratica negarne l'esistenza stessa? D'altra parte la conclusione della guerra non implicava automaticamente il termine delle commesse statali; se infatti si fosse posto mano all'ampliamento e al riordino della rete ferroviaria ed al rinnovo, tanto necessario, del parco vetture; alla costruzione di nuove centrali idroelettriche, al riordino della rete stradale ormai insufficiente, alla ricostruzione della marina mercantile tanto duramente provata dal conflitto, come si vagheggiava negli ambienti della Mobilitazione I ndustriale, un massiccio intervento statale sarebbe stato più che giustificato.
Era però un simile intervento che i dirigenti sindacali tenta- rono di eludere. Infatti, nella citata relazione, Buozzi si esprimeva decisamente contro l'arbitrato obbligatorio che riteneva lesivo alla libertà d'organizzazione e di sciopero e del pari respingeva qualsiasi proposta che tendesse a porre limitazioni legislative all'emigrazione. Per quanto si riferiva al problema delle leggi doganali, il segretario della FIOM non esitava a schierarsi contro il protezionismo nonostante la promessa di alti salari avanzata dai sostenitori di una simile politica, « Il proletariato non abboccherà » affermava recisamente « Noi siamo libero-scambisti » (11).
L'atteggiamento di Buozzi potrebbe lasciare perplessi se messo in relazione col fatto che una politica libero-scambista avrebbe inevitabilmente provocato il crollo di alcune iniziative sorte o sviluppatesi con la guerra, rendendo disoccupati migliaia di operai. Per comprendere la posizione del segretario della FIOM bisogna considerare però che, a parte l'evidente convinzione che il regime liberista fosse il più adatto a garantire un sano sviluppo industriale, il sindacato dei metalmeccanici si era grandemente rafforzato negli anni della guerra. Buozzi poteva quindi ragionevolmente prevedere che la sua organizzazione, di fronte agli inevitabili conflitti sindacali, impliciti nella scelta libero scambista, non solo avrebbe retto, ma si sarebbe ulteriormente rafforzata e potenziata.
Partendo da queste considerazioni era chiaro che qualsiasi arbitrato abbligatorio, come quello operato dalla Mobilitazione Industriale, diveniva implicitamente uno strumento per contenere l'espansione dell'attività sindacale e la stessa disoccupazione di migliaia di lavoratori il prezzo necessario e inevitabile da pagare, non solo per garantire la sanità del sistema economico, ma anche e soprattutto per assicurare lo sviluppo delle organizzazioni di classe.
Se la posizione della più importante organizzazione sindacale sul destino della Mobilitazfone Industriale era chiara ed univoca, non altrettanto può dirsi per gli orientamenti degli industriali. Per valutare questi orientamenti è necessario tener presente le grandi trasformazioni che la guerra aveva operato nella struttura economica del paese e in quella industriale in particolare. Nel 1914 il prodotto lordo delle attività industriali era stato di 4.653 milioni pari al 25% dell'intero prodotto privato lordo nazionale, nel 1918 aveva invece raggiunti i 16.774 milioni ed il 30,6%; questa colossale espansione era stata resa possibile dal trasferimento di capitali e di personale dagli altri settori in quello industriale (segnatamente dalle attività terziarie che avevano concorso con il 32 % alla formazione del reddito nazionale nel 1914, mentre nel 1918 erano discese al 21,4%!).

All'interno dello stesso settore industriale la guerra aveva provocato un nuovo spostamento di capitali e di manodopera dalle imprese non interessate alla produzione bellica a quelle « mobilitate » Indubbiamente le condizioni eccezionali in cui operavano le industrie, specie dopo la crisi delle materie prime verificatesi in seguito all'estensione della guerra sottomarina, fecero si che anche nei settori interessati alle commesse militari, si creassero dei processi di concentrazione. Tale fenomeno è sufficientemente illustrato dai seguenti dati relativi al movimento delle società ordinarie per

Anche se la somma totale dei nuovi investimenti appare un po' gonfiata, da questi dati risulta che, negli ultimi anni del conflitto, si ebbe un aumento del numero delle grandi e medie aziende. Tale incremento fu però quasi sicuramente pagato con la rovina di molte piccole aziende e con la scomparsa di gran parte dell'artigianato.
In definitiva, l'economia di guerra aveva rafforzato enormemente le grandi industrie, moltiplicato le medie, ridotto le piccole e danneggiate grandemente le industrie artigiane.
Il processo d'accelerazione provocato dalla Mobilitazione Industriale, se aveva fortemente accentuato la dequalificazione, già avviata in precedenza, delle maestranze operaie sostituendo al vecchio tipo di lavoratore fortemente professionalizzato un nuovo tipo di operaio che potremmo chiamare « di linea», per il rafforzamento contemporaneo della media e grande industria, non era riuscito a produrre concentrazioni industriali tali da potersi automaticamente imporre a tutto il settore. Conseguentemente, la forte presenza della media ed anche della piccola industria condizionava in modo notevole gli orientamenti del mondo industriale. Nel valutare gli orientamenti degli imprenditori non si potrà prescindere da questa situazione di fatto.
All'inizio della guerra quasi soltanto il segretario della Lega degli industriali torinesi Gino Olivetti « si mostrava preoccupato per l'eccessiva compenetrazione di interessi fra gli organi statali e ambienti economici privati » (1 3 ).
Nel 1917 l'atteggiamento degli industriali mutò; infatti nel luglio di quell'anno all'assemblea della Confindustria veniva presentata, dalla presidenza, una relazione che, pur riconoscendo l'insostituibilità della Mobilitazione I ndustriale, non esitava a formulare forti riserve sulle caratteristiche organizzative che questa aveva assunto: « Quest'organismo che era stato concepito con criteri pratici di sveltezza e di equità, lentamente si va trasformando in un ente burocratico, in cui l'impero della circolare, del regolamento, dell'ordine di servizio, viene a sovrapporsi a quella che doveva essere la principale guida dei comitati di mobilitazione: il buon senso pratico nell'applicare le direttive necessariamente generiche impartite dal centro, l'adattabilità rapida alle necessità industriali del luogo e del momento» (14 ). Indubbiamente la burocratizzazione era un male deprecabile anche se difficilmente evitabile e senz'altro comprometteva l'elasticità degl i organismi della M.I. ritardando la conclusione dei processi produttivi. Vi è da chiedersi però se le proteste degli industriali non fossero in realtà causate dalle misure adottate per tutelare gli interessi dell'erario.

Infatti, nei primi anni del conflitto, l'organizzazione della Mobilitazione Industriale, posta di fronte al problema di realizzare produzioni per qualità e quantità senza precedenti nella storia del Paese, si dov'é inevitabilmente preoccupare più dei risultati che dei costi.
Era stato si, fin dallo scoppio della guerra, costituito un « Ufficio Tecnico » che tra i suoi varii compiti aveva anche quello di effettuare un controllo sui costi dei manufatti ( 15 ); tuttavia la preoccupazione di sopperire nel più breve tempo possibile alle necessità dell'esercito e la stessa mole del lavoro affidato a questo ufficio resero molto problematica quest'opera di controllo.
« Trascorsi i mesi di guerra del 1915 e giunti alla fine del 1916 buona parte dell'industria di guerra in paese era nata e sufficientemente sviluppata, l'organismo della Mobilitazione Industriale erasi convenientemente esteso ed aveva presi ampi contatti colle industrie belliche, cosicché sembrò giunto il momento di poter più rigorosamente vagliare i prezzi dei manufatti e procedere a sensibili riduzioni di prezzi» ( 16 ). A questo scopo si decise di affiancare all'Uffì.cio Tecnico una « Commissione Consultiva e di revisione dei contratti di forniture di guerra » con il compito di esaminare tutti i contratti eccedenti il milione di lire. La Commissione, operante di fatto fin dal gennaio 1917 e legalizzata con un decreto del Ministro della guerra del 1° marzo di quello stesso anno, operò con criteri di grande rigore come dimostrano le cifre relative alla sua attività:
Oltre a ciò il Sottosegretariato A.M. dispose che i prezzi stabiliti dalla Commissione fossero presi per base all'Ufficio Tecnico anche per i contratti inferiori ad un milione quando i manufatti da acquistare fossero « analoghi, identici o similari » a quelli valutati dalla Commissione.
Questi provvedimenti non furono i soli; infatti, all'inizio del 1917, fu anche organizzato un vero e proprio « Servizio amministrativo » per le A. e M. e a dirigere questo nuovo ufficio fu chia- mato, nell'agosto di quello stesso anno, il tenente generale Ernesto Gardini « noto per il suo rigorismo e la sua rettitudine», il quale, pur agendo fra notevoli difficoltà, riuscì in breve a rendere operante il suo ufficio in molteplici direzioni.


L'azione del nuovo servizio ebbe infatti « ad esplicarsi in modo efficace e immediato innanzi tutto nell'accertamento di alcuno dei più tipici abusi ed errori commessi a danno dell'Amministrazione in occasione di alcune forniture ... Ma più ampio oggetto di indagine, di riorganizzazione e di interesse .finanziario per l'Amministrazione, offrì al nuovo servizio l'ampia materia dei recuperi, tanto in contanti che in materie prime, fino a quel momento, come si disse, quasi completamente trascurata» ( 18 ).
Questi avvenimenti chiariscono il fatto che le proteste degli industriali non erano provocate solo dalla « burocratizzazione » della M.I. Queste proteste erano destinate ad aumentare in seguito, in parte p er l'effettivo processo di burocratizzazione, ma soprattutto per l'aumento dei controlli. Infatti alla fine del 1917 l'Ufficio Tecnico era stato riorganizzato ed aveva assunto il nome di « Servizio Commesse Artiglieria» il cui nuovo capo, il capace colonnello Cortese, curò particolarmente la costituzione ed il funzionamento di un « Ufficio prezzi ». All'inizio del 1918 poi, a seguito dell'aumentato controllo deJlo stato sull'approvigionamento delle materie prime, a fianco del « Servizio Commesse Artiglieria» fu costituito w1 « Servizio Centrale Acquisti », con a capo l'energico ingegner Sinigaglia, che, con poteri di controllo e di intervento molto ampi, si interessò di tutti quei materiali che non rientravano nella specifica competenza del « Servizio Commesse » (19 ).
Indubbiamente il rallentamento, causato dagli aumentati controlli e dagli intralci burocratici relativi ai pagamenti, creò problemi agli industriali; va però ricordato che questi erano gravi soprattutto per la piccola industria con un giro di affari modesto e con un credito limitato. Per la grande industria indubbiamente i problemi erano minori anche in considerazione del fatto che gli anticipi « di rego la assommavano ad importi rilevanti » ( 20 ). Comunque, il 28 ottobre 1918, furono emanate disposizioni che consentivano di aumentare le commesse in corso e che facilitavano i pagamenti. Se il coro di proteste contro « la burocratizzazione » della Mobilitazione Industriale aveva visti uniti grandi, piccoli e medi imprenditori, non si deve per questo credere che tra loro non vi fossero divergenze sostanziali. Infatti la piccola e media industria reclamava una politica protezionistica, mentre le grandi imprese, soprattutto quelle meccaniche, erano in genere risolu- tamente liberiste. Ciò non deve sorprendere poiché gli industriali piccoli e medi si rendevano conto che le loro imprese create e fortemente ampliate nel corso della guerra, che operavano talvolta in settori in cui in precedenza l'Italia era stata completamente dipendente dall'estero, non potevano, da un giorno all'altro, essere esposte alla concorrenza straniera pena la rovina. Per loro, quindi, la protezione doganale era, almeno per il periodo della riconversione. una questione di vita o di morte.
Per questi motivi i rappresentanti della media e piccola industria erano, in genere, disposti ad accettare, in cambio di una legislazione protezionistica, la logica conseguenza di una politica di intervento statale, cioè il controllo pubblico dell'economia attraverso la sopravvivenza della Mobilitazione Industriale in tempo di pace (21 ). L'atteggiamento dei rappresentanti della grande industria era completamente diverso: interamente ostile e decisamente favorevole alla politica di basse barriere doganali.

I capitani d'industria ritenevano che l'inten,ento statale fosse accettabile soltanto in momenti eccezionali; assolutamente dannoso in condizioni normali, come dannoso era ritenuto il regime protezionista che manteneva in vita imprese anti-economiche mentre limitava la capacità di espansione delle industrie meglio organizzate. Le grandi imprese non si preoccupavano molto della concorrenza estera, avevano in gran parte rinnovato gli impianti nel corso della guerra e si ritenevano in grado, una volta che la situazione del commercio internazionale fosse tornata normale, di reggere il confronto con le imprese straniere, non nutrivano neppure soverchie preoccupazioni circa l'inevitabile aumento delle tensioni sociali che la linea politica da loro scelta implicava necessariamente. Probabilmente ritenevano che la massa degli operai delle piccole e medie imprese, condannate al fallimento, andando a raggiungere la manodopera che si sarebbe resa disponibile con la smobilitazione, avrebbe costretto i dirigenti sindacali ad essere« ragionevoli». D'altra parte le grandi industrie erano in grado di accettare nuovi aggiustamenti salariali senza troppe preoccupazioni.
In definitiva, un eventuale crollo di piccole e medie imprese avrehbe sgombrato il campo alle grandi aziende costituendo al contempo una riserva di manodopera i cui migliori elementi potevano essere facilmente acquisiti con l'offerta di alte paghe e la cui massa avrebbe indotto i sindacalisti a non tirare troppo la corda . Il teorico di una simile politica fu Gino Olivetti, non a caso destinato a divenire segretario della Confindustria.
Il pensiero dell'Olivetti si trovava, sia pure con motivazioni diverse, in pergetta sintonia con quello di Buozzi, come ha rilevato l'Abrate (22 ).
Ciò non deve sorprendere: sia l'uno che l'altro rappresentavano gruppi usciti estremamente rafforzati dalla guerra, erano convinti della propria forza e sicuri che, in caso di scontro, avrebbero superato la prova.
Scrive l'Abrate che « i frutti di questo non voluto, ma forse non inconsapevole consentire di due tra i più alti dirigenti delle organizzazioni imprenditoriali ed operaia italiana, su quelle ch e essi ritenevano le questioni più importanti del dopoguerra, furono assai scarsi, praticamente nulli» ( 23 ).

E. questo un giudizio che non ci sentiamo di condividere appieno poiché l'urto concomitante della grande industria e della maggiore organizzazione sindacale ottenne almeno un primo risultato: quello di liquidare la Mobilitazione Industriale.
Gli esponenti della grande industria e gli organizzatori sindacali rappresentavano senza dubbio due grandi forze in ascesa, certamente non rappresentavano però la totalità dei gruppi sociali del Paese, e soprattutto, gli interessi di queste forze erano difficilmente conciliabili con quelli della piccola industria e di quanti in essa lavoravano.
Se infatti sindacalisti e grandi industriali ritenevano, (e da qui la loro alleanza di fatto contro ogni controllo statale), ch e un eventuale conflitto si sarebbe comunque concluso con il proprio rafforzamento, ciò sarebbe avvenuto inevitabilmente a spese della media e piccola industria e degli operai non sindacalizzati, se non a scapito degli altri settori economici come era avvenuto durante la grande guerra. Gli interessi della media e piccola industria però erano meritevoli di protezione dal punto di vista dell'ordinamento statale quanto quelli delle grandi imprese. D'alt ra parte, la classe dirigente italiana dell'epoca non era parti colarmente legata alla grossa industria; avrebbe quindi dovuto sentire la necessità di conservare e rafforzare quegli strumenti come la Mobilitazione Industriale che potevano servire alla contemperazione delle varie esigenze evitando gli squilibri economici e garantendo la pace sociale. Certo, un'eventuale organizzazione della Mobilitazione Industriale di pace non avrebbe potuto operare nello specialissimo clima in cui aveva operato l'ente realizzato dal generale Dallolio nel corso della guerra. Bisogna infatti considerare che la tranquillità negli stabilimenti era stata assicurata, oltre che dagli alti salari, anche dalla possibilità, da parte delle autorità militari,, di revocare gli esoneri e di spedire al fronte gli operai riottosi e indisciplinati. Questa situazione al tempo stesso di coazione e di privilegio, di cui sia gli operai che l'opinione pubblica erano ben consci, non era ripetibile al termine del conflitto. Per quanto si migliorassero orari e condizioni di lavoro, era inevitabile che, nonostante tutta la buona volontà mediatrice spiegata da un nuovo ente, si apriva una stagione di notevoli rivendicazioni salariali con conseguenti astensioni dal lavoro. Comunque fosse organizzata la Mobilitazione Industriale di pace non avrebbe potuto impedire una massiccia serie di scioperi. La nuova struttura avrebbe potuto però limitarne il numero e facilitare le trattative tra le parti in causa.
Nota il Melograni che nel 1919 « fu solo in autunno che ebbe luogo un mutamento nelle relazioni fra imprenditori e maestranze, con la :fine di quel clima piuttosto "euforico" che aveva fino ad allora contrassegnato i rapporti di lavoro » ( 24 ).

Certamente le buone relazioni tra datori di lavoro e lavoratori non avrebbero potuto mantenersi molto a lungo, tuttavia è fuor di dubbio che se la Mobilitazione Industriale avesse continuato a svolgere la sua opera, la tensione tra industriali ed operai sarebbe cresciuta molto più lentamente. Infatti, la sopravvivenza dell'organizzazione creata dal Dallolio unita ad un piano di investimenti pubblici, come quello che era stato vagheggiato negli ambienti del Ministero delle Armi e Munizioni, avrebbe probabilmente permesso che la riconversione avvenisse senza brusche scosse e sotto il controllo pubblico. Si trattava è vero di continuare a far pagare, attraverso le commesse statali, la sopravvivenza delle industrie create dalla guerra a tutta la collettività nazionale. Durante il conflitto, come abbiamo visto, anche i più accaniti liberisti non avevano potuto fare a meno di convenire sulla necessità che il Paese disponesse di una propria industria pesante, al termine della guerra però questi orientamenti erano completamente scomparsi e i liberisti avevano ripreso le loro vecchie lamentazioni contro le industrie «parassitarie» che avrebbero dovuto essere messe a morte per garantire un sano sistema economico. Intanto però le industrie, costruite non senza sacrifici nel corso del conflitto, esistevano; il distruggerle non avrebbe comportato per l'intero Paese un danno maggiore di quello costituito dal sacrificio da affrontare per mantenerle in vita durante il periodo della riconversione?
È fuor di dubbio che il mantenimento delle piccole e medie imprese, create nel corso della guerra, fosse nell'interesse della economia del Paese; del resto anche il principio della « sanità» del sistema economico è alquanto relativo poiché è indiscutibile che, oltre alla capacità imprenditoriale ed all'efficienza dell'orga- nizzazione aziendale, influiscono, in modo determinante, sulla vita e sulla morte delle imprese, le condizioni economiche generali in cui sono chiamate ad operare. t:: indubitabile che abbandonare iniziative industriali, sorte con capitali modesti, alla concorrenza delle grandi imprese e dell'industria straniera, compresa quella dei paesi vinti, senza favorire in alcun modo il loro inserimento nelle produzioni di pace, significava votarne la maggioranza a certa rovina; e ciò indipendentemente dell'abilità degli imprenditori e delle maestranze e dalla stessa struttura organizzativa dell'impresa. Era del pari interesse dello Stato che la riconversion e non si tramutasse in un tracollo per l'industria pesante e che non si verificassero regressi in quelle che erano le industrie d'avanguardia dell'epoca. Si doveva cioè tutelare ad esempio lo sviluppo dell'industria chimica che, libera dalla concorrenza germanica, aveva potuto prendere finalmente quota, ed agevolare lo sviluppo dell'industria delle radiotelecomunicazioni che aveva cominciato a muovere timidamente i suoi primi passi negli anni del conflitto. Poiché le conoscenze tecnologiche e lo stesso sviluppo della ricerca teorica sono fortemente influenzate dalla potenzialità dei vari settori industriali, è fuori di dubbio che sostenere le industrie d'avanguardia significava tra l'altro cercare di impedire che si creasse una grossa sfasatura tra la t ecno logia del Paese e quella dei maggiori stati mondiali. Tutto ciò non aveva grande importanza agli occhi dei liberisti, se Luigi Einaudi scriveva ancora nel 1933 che tra le eredità della guerra erano stati inutili « i cantieri navali, gli stabilimenti dell'industria pesante, e quelli dell'industria chimica, i quali anzi lasciarono un'eredità pericolosa la quale non potrà essere liquidata per decenni» ( 25 ). A parte la questione dei cantieri navali il cui numero non aumentò nel corso della guerra, ma a seguito di questa, per l'acquisizione dei cantieri giuliani ed istriani; le affermazioni dell'Einaudi possono far sorridere in considerazione dello sviluppo che ha assunto oggi l'industria chimica e quando è sotto gli occhi di tutti il prezzo che i paesi dell'America latina hanno dovuto pagare per non aver saputo, o potuto, crearsi una propria industria pesante. Certamente ciò non appariva altrettanto evidente alla fine d el primo conflitto mondiale quando i rapporti tra indipendenza economico-industriale ed autonomia politica sembravano discorsi di guerra, superati, spazzati via, dalla pace perpetua garantita dalla istituenda Società delle Nazioni.
Tuttavia la conclusione del conflitto non aveva posto fine alla rivalità nazionali, né aveva fatto venir meno la situazione eccezionale in cui si trovava ad operare l'industria italiana. Come si ricorderà, il maggior problema che l'Italia si trovò ad affrontare nel corso della guerra fu, senza dubbio, quello del rifornimento di carbone. Dalla disponibilità di carbone praticamente dipendeva la continuazione dello sforzo bellico italiano. Con la fine del conflitto, dalla disponibilità di carbone dipendeva in buona parte la possibilità dell'industria italiana di tornare ad essere competitiva sui mercati esteri. Nell'ult imo periodo della guerra il traffico marittimo alleato era di fatto posto sotto il controllo dell'Inghilterra ed i dirigenti inglesi non avevano alcuna intenzione di favorire lo sviluppo industriale dei propri alleati al termine d el conflitto. Così, quando nel luglio del 1919, terminò l'accordo per il trasporto del carbone dal canale di Bristol a Genova al prezzo calmierato di 47,6 scellini la tonnellata, il costo del trasporto p r ese a salire e alla fine dell'anno oscillava tra i 70 e i 77,6 scellini la tonnellata. Nel 1920 l'immissione sul mercato dei noli dei tre milioni e mezzo di tonnellate di naviglio mercantile varate nel 1919 dagli Stati Uniti, cominciò a fare sentire il suo peso e da 65-70 scellini il costo del trasporto di una tonnellata di carbone dal canale di Bristol a Genova scese a 37,6 a luglio e a 22,6 a settembre; in conseguenza dei nuovi vari nel 1921, il costo del trasporto si ridusse ulteriormente oscillando tra i 18 e 20 scellini ( 26 ).

Come si vede la situazione si normalizzò molto lentamente e ciò non poté non influire negativamente sulla riorganizzazione industriale dell'Italia e sulla capacità dei prodotti italiani di essere competitivi sui mercati esteri. Infatti, anche nei primi anni del dopoguerra, la bilancia dei pagamenti registra fortissimi <lisavanzi:
Tabella 3
La situazione di eccezione non era dunque terminata; ora le dotte disquisizioni dei liberisti potevano essere valide soltanto nel caso che le condizioni del mercato internazionale si fossero normalizzate. Fino a che ciò non si fosse realizzato era evidente che bisognava procedere con mezzi eccezionali. Conseguentemente, prescindendo dall'opportunità o meno, una volta che le condizioni del mercato internazionale si fossero normalizzate, di smantellare una struttura come quella della Mobilitazione I ndustriale, è fuor di dubbio che uno strumento di controllo e pianificazione, come era appunto la M.I. si imponeva se si voleva superare, senza gravi scosse, il difficile periodo post-bellico.

Bisogna considerare, tuttavia, che al termine del conflitto, predominava in tutti gli strati sociali il convincimento che la situazione si sarebbe normalizzata da lì a breve tempo. Questo convincimento non giustifica che in parte i responsabili della politica economica del Governo italiano, ai quali non erano certo ignote le divergenze di vedute tra le potenze alleate e l'Italia, divergenze che sarebbero aumentate durante la discussione dei trattati di pace. D'altronde, uno dei maggiori requisiti di una buona classe dirigente è la capacità di compiere esatte previsioni per poter validamente orientare l 'azione del governo. La classe politica italiana, non solo mancava di una simile capacità di analisi, ma non aveva alcuna simpatia per l'organizzazione creata dal Dallolio.
Nei primi anni della guerra il Parlamento e la classe dirigente politica, probabilmente anche in conseguenza degli avvenimenti del maggio 1915, non avevano quasi svolto nessuna azione di direzione dello sforzo bellico del paese per cui la conduzione delle operazioni e l'organizzazione dell'economia di guerra era stata devoluta ai militari ed ai tecnici. Tutto ciò fece si che i politici, specie alcuni degli ex neutralisti, guardassero alla Mobilitazione Industriale come ad una creatura a loro estranea, ad un prodotto della guerra che doveva necessariamente aver termine con essa. Pesava probabilmente sull'atteggiamento dei politici la preoccupazione che, mantenendo in vita la Mobilitazione I ndustriale, i militari che l'avevano creata avrebbero finito con l'avere un forte peso nella economia, e quindi nella politica, della nazione. Si trattava però di una preoccupazione infondata visto che il generale Dallolio, « che solo conosceva e aveva segnato in un suo particolare taccuino tutti i dati dei fabbisogni e tutte le notizie stat istiche delle varie produzioni e solo ne poteva misurare e regolare la intensità e la necessità » ( 28 ), e che aveva saputo, con la sua politica, acquistare presso gli imprenditori e le maestranze un prestigio altissimo come dimostrarono le risposte al suo appello dopo Caporetto, lasciò, senza neppure abbozzare una protesta, il Ministero delle armi e munizioni nel maggio del 1918, ufficialmente per uno scandalo relativo ad alcuni contratti, in realtà per la guerra spietata che gli aveva fatto il Ministro del tesoro Francesco Saverio Nitti ( 29 ).

L'atteggiamento del generale Dallolio in questa circostanza è tanto più rimarchevole in quanto non gli si poteva rimproverare alcuna irregolarità. La decisione della classe politica di escludere l'organizzazione creata dal Dallolio, dallo studio dei problemi del dopoguerra, apparve evidente dopo la sostituzione del generale; infatti, invece di un ampliamento delle strutture già esistenti integrandole con i rappresentanti dei ministeri competenti, come voleva Dallolio , si costituì la famosa commissione per i problemi del dopoguerra, organismo pletorico in cui l'elemento tecnico passava in seconda linea rispetto alla componente politica. Si trattò di un organismo di utilità molto modesta, ma la cui creazione dimostrava la ferma volontà della classe dirigente politica di ridurre l'influenza dei tecnici e di non servirsi delle strutture della Mobilitazione Indus triale la quale, alla fine del conflitto, risultò essere una grande macchina di cui nessuno voleva più servirsi. La grande industria e le organizzazioni sindacali erano ostili a qualsiasi forma di controllo e di intervento statale, la classe politica non sentiva in alcun modo la necessità di un simile controllo, anzi il Ministro del tesoro dell'epoca, on. Nitti, non esitava ad affermare la necessità « che lo Stato tolga tutte le barriere inutili interne e svincoli la produzione, dia all'industria sicurezza e stabilità; quanto fu creato per necessità di guerra, deve scomparire con la guerra; tutti gli uffici devono essere ridotti in breve tempo a ciò che erano prima della guerra; presto e coraggiosamente bisogna sopprimere tutto ciò che è superfluo come dannoso; eliminare il più sollecitamente possibile quanto è stato prodotto da un'economia transitoria e perturbatrice». Commentando queste dichiarazioni s ul Corriere d ella Sera del 15 gennaio 1919, Luigi Einaudi scriveva: « bisogna abolire uffici e commissioni; mandare a casa impiegati e commissari ... Non basta essere più larghi di permessi di fare, di trasportare, di importare, di esportare. Bisogna rinunciare a dare i permessi; bisogna lasciare che ognuno faccia, trasporti ed esporti senza permessi, senza visti, senza bolli , senza inchinarsi a destra e a sinistra, senza fare viaggi a Roma... Non abolire i vincoli vorrebbe dire ridurre industriali ed operai a uno stato servile, vorrebbe dire immi serire la produzione della ricchezza, quando è più vivo il bisogno di accrescerla ». Il congresso della FIOM svoltasi nel novembre del 1918 a R om a e quello degli indus triali tenutosi nel gennaio del 1919 a Bergamo, dimostrarono che imprenditori e sindacati si muovevano sostanzialmente sulla stessa linea. Ebbe così inizio quella che lo stesso Einaudi chiamerà « rivolta contro il collettivismo bellico », si pose cioè bravamente mano a demolire quelle che venivano chiamate « bardature di guerra» nell'economia del paese.

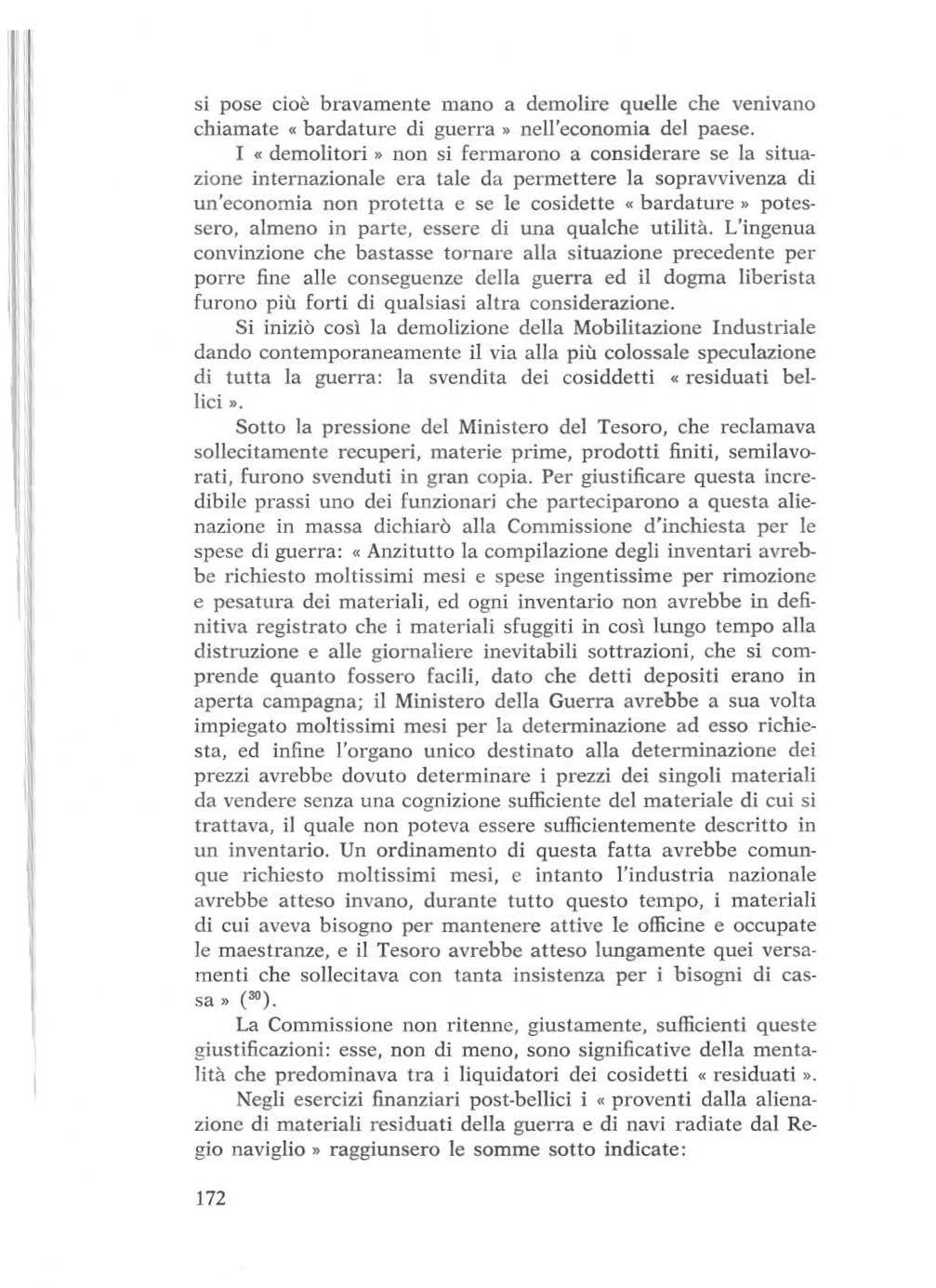
I « demolitori » non si fermarono a considerare se la situazione internazionale era tale da permettere la sopravvivenza di un'economia non protetta e se le cosidette «bardature» potessero, almeno in parte, essere di una qualche utilità. L'ingenua convinzione che bastasse tornare alla situazione precedente per porre fine alle conseguenze della guerra ed il dogma liberista furono più forti di qualsiasi altra considerazione.
Si iniziò così la demolizione della Mobilitazione Industriale dando contemporaneamente il via alla più colossale speculazione di tutta la guerra: la svendita dei cosiddetti « residuati bellici ».
Sotto la pressione del Ministero del Tesoro, che reclamava sollecitamente recuperi, materie prime, prodotti finiti, semilavorati, furono svenduti in gran copia. Per giustificare questa incredibile prassi uno dei funzionari che parteciparono a questa alienazione in massa dichiarò alla Commissione d'inchiesta per le spese di guerra: « Anzitutto la compilazione degli inventari avrebbe richiesto moltissimi mesi e spese ingentissime per rimozione e pesatura dei materiali, ed ogni inventario non avrebbe in definitiva registrato che i materiali sfuggiti in così lungo tempo alla distruzione e alle giornaliere inevitabili sottrazioni, che si comprende quanto fossero facili, dato che detti depositi erano in aperta campagna; il Ministero della Guerra avrebbe a sua volta impiegato moltissimi mesi per la determinazione ad esso richiesta, ed infine l'organo unico destinato alla determinazione dei prezzi avrebbe dovuto determinare i prezzi dei singoli materiali da vendere senza una cognizione sufficiente del materiale di cui si trattava, il quale non poteva essere sufficientemente descritto in un inventario. Un ordinamento di questa fatta avrebbe comunque richiesto moltissimi mesi, e intanto l'industria nazionale avrebbe atteso invano, durante tutto questo tempo, i materiali di cui aveva bisogno per mantenere attive le officine e occupate le maestranze, e il Tesoro avrebbe atteso lungamente quei versamenti ch e sollecitava con tanta insistenza per i bisogni di cassa» ( 30 ).
La Commissione non riteru1e, giustamente, sufficienti queste giustificazioni: esse, non di meno, sono s ignificative della mentalità che predominava tra i liquidatori dei cosidetti «residuati».
Negli esercizi .finanziari post-bellici i « proventi dalla alienazione di materiali residuati della guerra e di navi radiate dal Regio naviglio» raggiunsero le somme sotto indicate:
Tabella 4
Come si vede, pur trattandosi di somme rilevanti, i << proventi» non erano certo tali da consentire il pareggio del bilancio, ne è pensabile che il Ministro del tesoro avesse, nell'orgia di carta stampata di quegli anni, proprio bisogno di questi proventi. I n realtà tutta l'operazione fu caratterizzata dall'ingenua speranza che bastasse liquidare gli apprestamenti di guerra per por fine agli effetti della stessa. Così materiali di ogni genere, accumulati con grande sacrificio negli anni precedenti, furono svenduti a prezz i molto inferiori al loro valore. Dai numerosissimi enti, che si succedettero senza soluzione di continuità e senza un programma razionale nel compito di alienare i cosidetti residuati, furono venduti a infimo prezzo materiali necessari ai bisogni di mobilitazione del1'esercito che, negli anni successivi, si dovettero riordinare alle industrie oppure ricomprare dagli speculatori a prezzi di gran lunga superiori. Ciò avvenne perché nella frenesia di << normalizzare » si impedì al Ministero della Guerra di trattenere per sè i materiali che riteneva utili. :È fuor di dubbio che se la vendita dei « residuati » f~sse avvenuta con meno fretta i proventi sarebbero stati infinitamente maggiori.
:e. evidente inoltre che, se le materie prime disponibili nei magazzini dello Stato in copia notevole al termine del conflitto, invece di essere alienate a prezzi irrisori, fossero state destinate alle industrie per attuare il grande programma di opere pubbliche che il segretario del Comitato centrale della Mobilitazione Industriale aveva indicato nel 1916, non si sarebbe verificato alcun disastro finanziario.
La classe dirigente non nutriva però alcun desiderio di perpetuare ]a politica di intervento statale nel settore industriale come negli altri rami dell'economia. Cosicché alla fine del 1919, quando fu ormai chiaro a tutti che la normalizzazione era rin- viata a data indefinibile, di fronte al minaccioso aumento delle tensioni sociali, il Governo si trovò privo di qualsiasi strumento d'intervento.

Per colmo d'ironia fu proprio Nitti, il paladino della politica della normalizazzione a tutti i costi, a dover ripristinare nell'aprile del 1920 il razionamento del pane e di altri generi alimentari.
La crisi colpl particolarmente il settore industriale ; non solo le piccole e medie imprese, ma anche le grandi aziende vennero duramente provate. La produzione del settore siderurgicico scese da 992.529 tonnellate d'acciaio e 313.576 di ghisa nel 1918, rispettivamente a 731.823 e 239.710 nel 1919, a 773.761 e 88.072 nel 1920 ed a 700.433 e 61.381 nel 1921 ( 32 ), ed anche le grandi industrie meccaniche, senza dubbio meno esposte, subirono gravi colpi: la Fiat ridusse la propria produzione di autovetture da 14.835 a 10.320 ( 33 ). Per far fronte a questa congiuntura le grandi imprese si appoggiarono sempre più alle banche che furono coinvolte nel dissesto economico.
Difronte all'insorgere della crisi l'atteggiamento della classe dirigente politica fu privo di energia e di coerenza.
Infatti, da un lato , sotto la pressione dell'opinione pubblica che reclamava provvedimenti contro gli speculatori di guerra, venivano presi provved imenti come l'imposta straordinaria sul patrimonio, l'avocazione totale allo Stato dei sovrapprofitti di guerra, la nominatività dei titoli. « Quali che fossero le ragioni morali e di giustizia sociale che avevano ispirato quei provvedimenti, essi contribuirono ad accrescere le difficoltà dell'industria» (34 ).
DaJl'altro lato si cercava di venire incontro alle grandi imprese in difficoltà promuovendo consorzi bancari e autorizzando anticipazioni da parte della Banca d'Italia.

Anche nei confronti della crisi dei rifornimenti alimentari l'azione del Governo non fu delle più abili. Si preferì infatti spendere somme ingentissime per acquistare derrate alimentari da rivendere sotto costo a prezzo di calmiere invece di utilizzare le stesse somme in investimenti produttivi ch e, mantenendo alti i livelli dell'occupazione e dei salari, avrebbero consegu ito, almeno in parte, gli stessi risultati, permettendo inoltre la realizzazione di nuove infrastrutture. Ciò non sembri eccessivo, infatti le spese a fondo perduto per gli approvvigionamenti e i consumi aumentarono a 4.700 milioni nel bilancio 1920-21 e a 8.600 milioni in quello 1921-22 ( 35 ).
Tuttavia, a parte la pressione dell'opinione pubblica, che teneva ovviamente al mantenimento del sistema del calmiere, c'è da chiedersi se una decisa politica di intervento statale sarebbe stata possibile una volta che si erano smantellati tutti gli strumenti di pianificazione e controllo di cui il Governo disponeva al ter mine del conflitto.
In conclusione la crisi post-bellica avrebbe potuto essere affrontata e risolta in tempi più brevi e con minore perdita di ricchezza, se non fosse prevalsa la funesta illusione che gli effetti della guerra fossero cancellabili con un semplice tratto di penna e se, quindi, la classe dirigente politica avesse saputo resistere alle concomitanti pressioni della grande industria e delle organizzazioni sindacali, mantenendo in vita, sia pure per qualche anno ancora, la struttura della Mobilitazione Industriale, e sostituendo le commesse militari con investimenti destinati al potenziamento delle infrastrutture del Paese. Ciò avrebbe permesso di controllare la riconversione e limitare gli effetti della crisi. Effetti che, giova ricordarlo, compromisero seriamente in molti settori industriali i risultati conseguiti con l'e norme sforzo attuatosi nel corso del conflitto.
Purtroppo, però, le spinte particolaristiche e l'illusione che, con la fine della guerra, si sarebbe subito tornati alla normalità prevalsero. Questo fatto contribuì poderosamente allo scatenarsi, alla fine del 1919, di una crisi le cui conseguenze politiche sarebbero state ben maggiori delle stesse gravissime conseguenze economiche.
In definitiva, gli sconvolgimenti che subì l'economia italiana negli anni immediatamente seguenti il primo conflitto mondiale non furono solo conseguenza diretta delle condizioni create dalla guerra, ma anche e soprattutto dal « modo » di affrontare i problemi del dopoguerra scelto dalla classe politica, che, al termine del conflitto, disponeva di tutti gli strumenti necessari per controllare e dirigere l'attività industriale del paese nel difficile periodo dii transizione. La prosecuzione di una politica di intervento statale nel settore industriale, che favorisse con commesse per costruzioni ferroviarie, impianti idroelettrici ecc. il processo di riconversione, non avrebbe inciso sul bilancio molto di più di quanto fecero i successivi e tardivi provvedimenti adottati negli anni seguenti per fronteggiare, in qualche modo, la crisi post-bellica. La Mobilitazione Industriale rimase quindi in buona parte un'occasione perduta per sviluppare e razionalizzare l'industria italiana; il cedimento della classe dirigente difronte alle spinte particolaristiche era inevitabilmente foriero di successivi gravissimi cedimenti.

Note
(1) A CARACCIOLO: La formazione dell'Italia industriale, cit. , p 171.
(2) CfT. Ibidem, p. 173.
(3) L. EINAUDI: La condotta economica, cit., p. 129.
(4) R. BlANCm D'ESPINOSA: Ricordi, riflessioni di un vecchio generale, Milano 1963, pp. 235-236.
(5) Vedi allegato n. 13.
(6) A.C.S. Ministero Armi e Munizioni, b. 42, verbale della riunione 17 dicembre della Commissione per il • risparmio operaio •, p. 5.
(7) E. TONIOLO: La mobilitazione industriale in Italia, Milano 1916, pp. 31-38.
(8) Che il generale Dallolio non fosse estraneo allo scritto del Toniolo è provato anche dal fatto che in alcuni punti questo riproduce quasi letteralmente la relazione fatta dal sottosegretario al Comiato Centrale della M.I. del 26.11.1916.
(9) Vedi allegato n. 11.
(10) A.C.S. Ministero Armi e Munizioni. Verbale della seduta del 17 dicembre della Commissione per il • risparmio operaio •, p. 6-7.
(11) Per le affermat.foai di Buozzi sul problema della M.I. B. Buo22.I: L'opera della Federazione metallurgica dal 1910 al 1918, cit., p. 18 ss.
(12) Banca Commerciale Italiana: Cenni statistici sul movimento economico dell'fta lia anno XII, Milano 1920, p 145.
(13) V. CASTRONOVO: Giovanni Agnelli, Torino 1971, p. 102.
(14) Problemi operai e sociali della guerra e del dopoguerra, in • Bollettino della Lega Industriale•, anno IX (1917), numero unico, p. 6 ss.
(15) Vedi allegato a. 14
(16) Ibidem.
(17) Commissione Parlamentare, cit., voi. II, p. S3.
(18) Ibidem , voi. II, p. 89.
(19) Vedi allegato n. 14.
(20) Commissione Parlamentare, cit., voi. li, p. 20.
(21) Una posizione analoga a quella dei piccoli e anche gli esp0aenti degli agrari che temevano di venire industria tanto rafforzatasi nel corso del coauitto. Cfr. tenden ze dell'associazione padronale durante la • Gra11de settembre-dicembre 1977, pp. 816 ss.
(22) M ABRATI!, op. cit., pp. 181-188 medi industriali avevano assunto schiacciati anch'essi dalla grande F. PlvA: Mobilitazione agraria e Guerra•, in « Quaderni Storici•,
(23) Ibidem, p. 186.
(24) P. Mm.ooRAN1: Op. cit , p. 557.
(25) L. EINAUDI: La condotta economica, cit., p. 390.
(26) I dati relativi al costo dei trasp0rti sono desunti dalle annate 1919, 1920 e 1921 della citata opera R. BAcm: L'Italia economica, rispettivamente alle pp. 218, 249, 249.
(27) Cfr. R ROMEO: op. cit., p. 237.
(28) Commissione Parlamentare, cit., voi. lI. p. 86.
(29) II GaUioari io un, peraltro pregevole, saggio su Dallolio sostiene che la campagna contro il Minis tro delle armi e muni1.ioni fu orchestrata dai fratelli Perrone. Per quanto è fuor di dubbio che i due industriali non amassero molto Dallolio, il ridurre la vicenda ad una faida dei Perrone, significa, in pratica, attribuire a Nitti la parte del sicario il che è indubbiamente eccessivo. In realtà il Ministro del tesoro aveva elaborato un disegno politico per il dopoguerra che s i basava essenzialmente sull'accordo dei maggiori gruppi industriali e delle organizzazioni operaie; un quadro in cui non vi era posto per la Mobilitazione Industriale per distruggere la quale era indispensabile allontanarne il fondatore. Sull 'intera vicenda cfr. V. GAU.INARI: /I generale Alfredo Dallolio nella prima guerra mondiale, in • Memorie storiche militari•, t9n, pp. 139-141 , e A. MONTICONE: Nitti e la Grande Guerra, Milano 1961, pp. 214 ss.
(30) Cfr. Commissione Parlamentare, cit., voi. II, p. 780

(31) Minfatero delle Finanze: li bilancio dello Stato dal 1913-14 at 1929-30 e la finan za fascista a tutto l'anno VIT, Roma 1931, pp 96, 210, 211, 224.
(32) Cfr. R. ROMEO: op. cii., p. 227.
(33) Ibidem, p. 127.
(34) Ibidem, p. 128.
(35) Ministero delle Finanze: op. cit., p. 312









