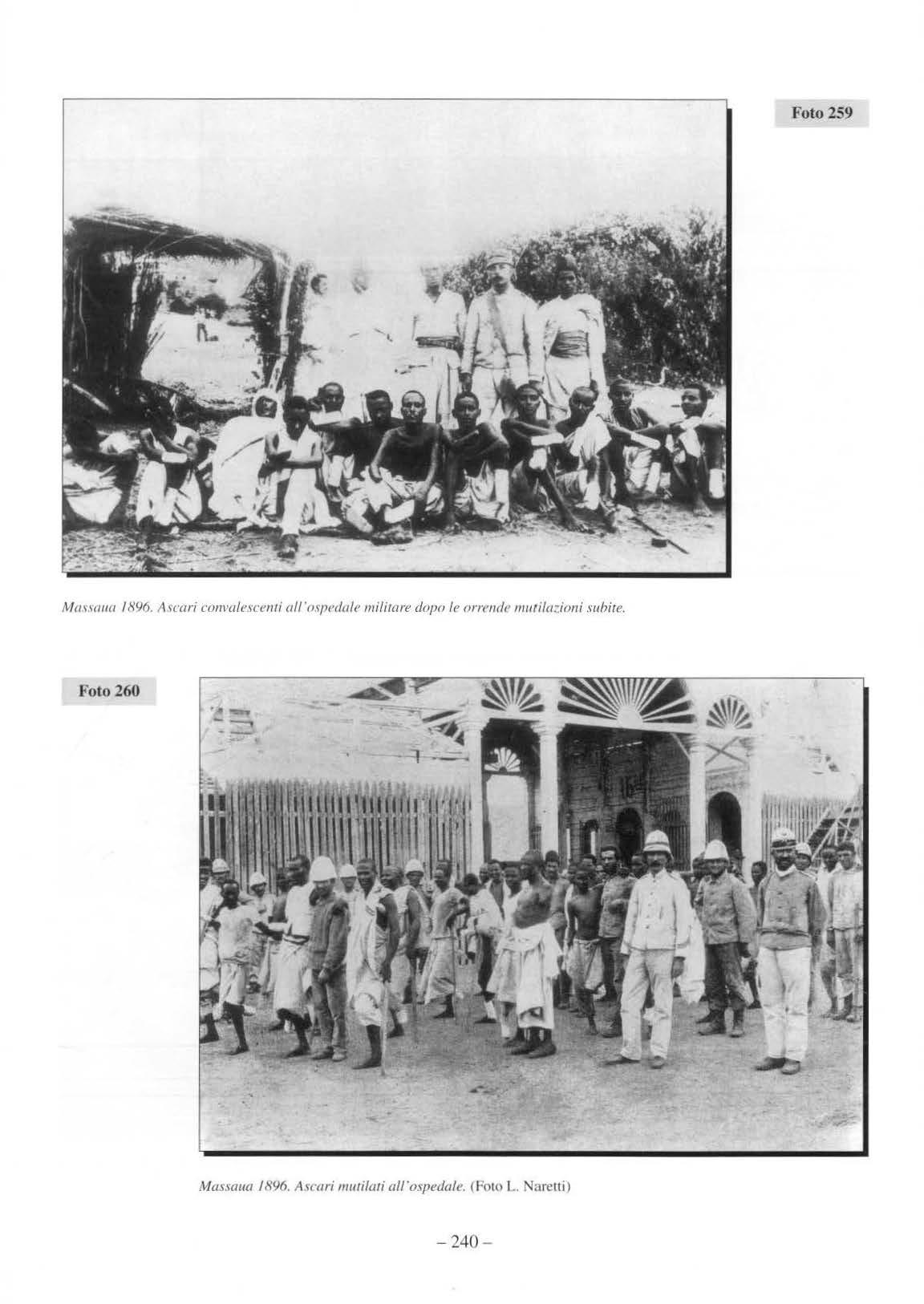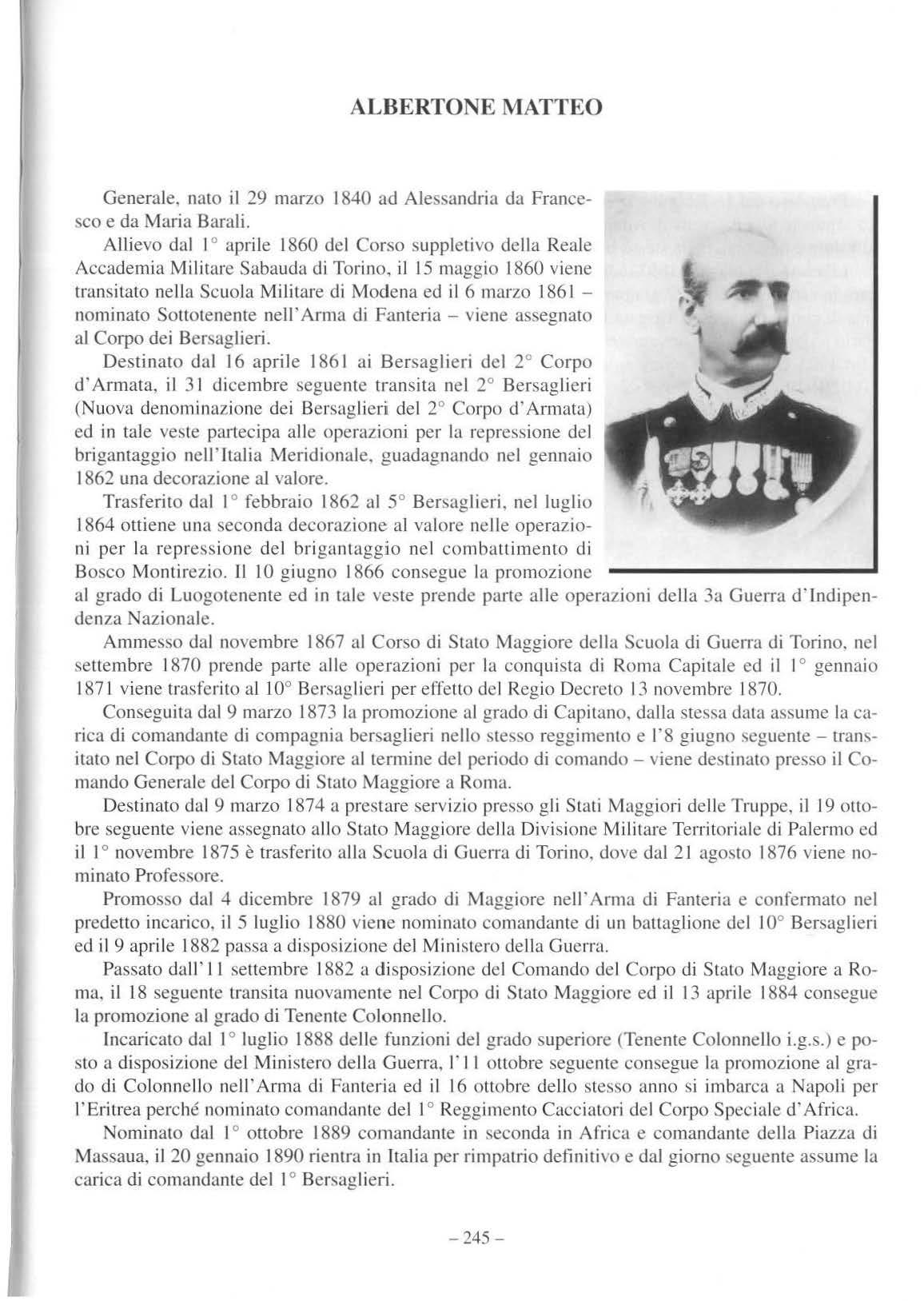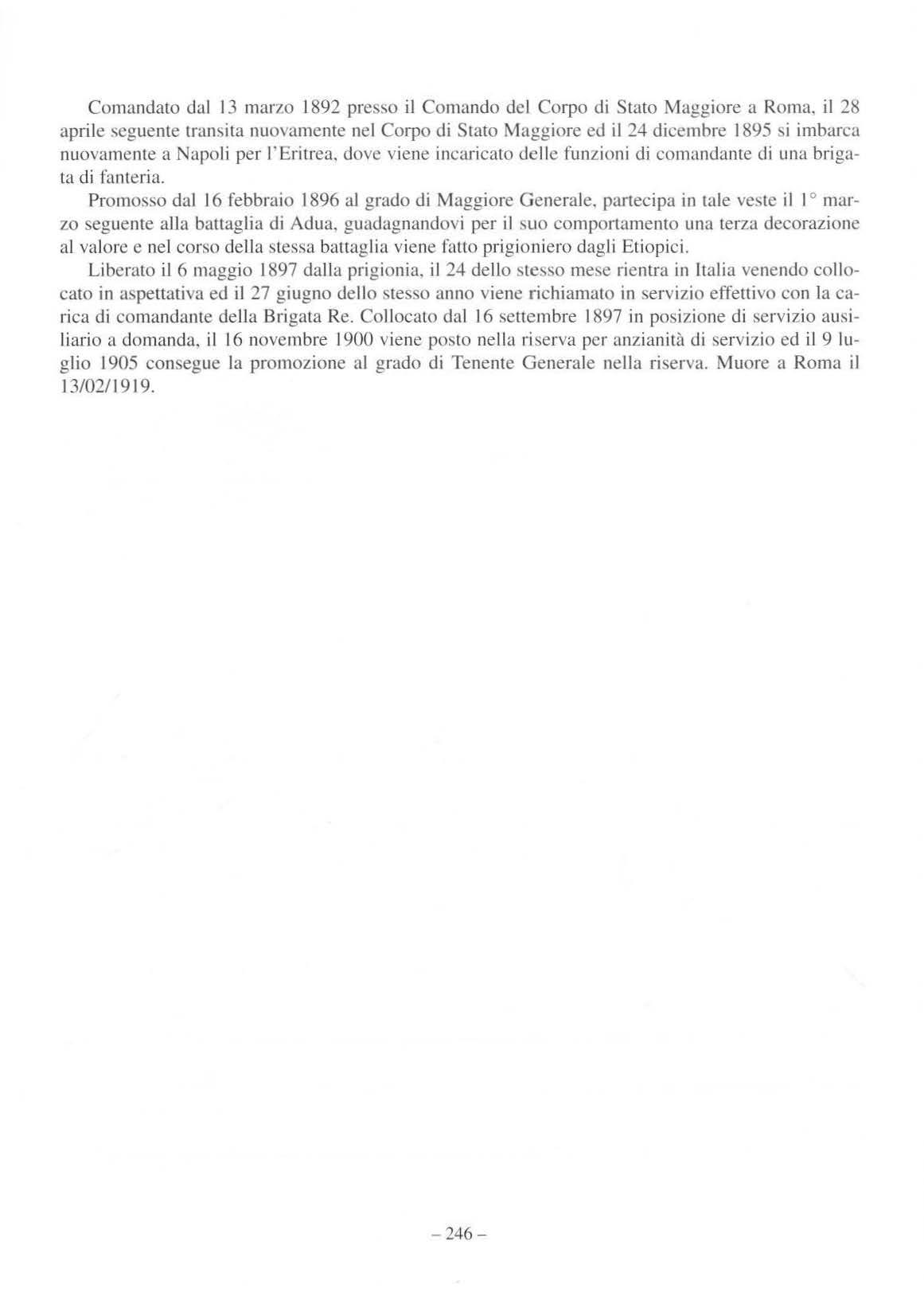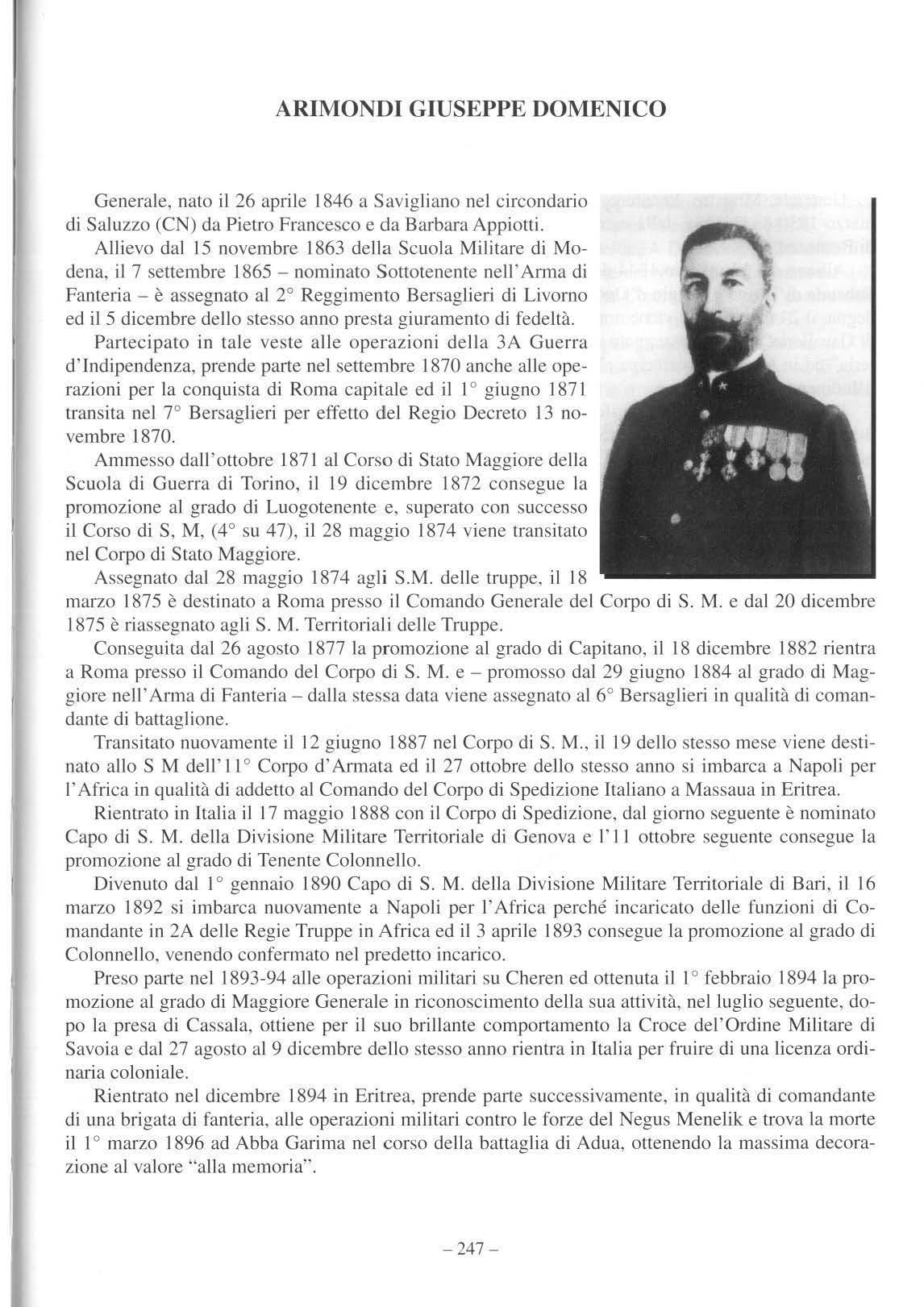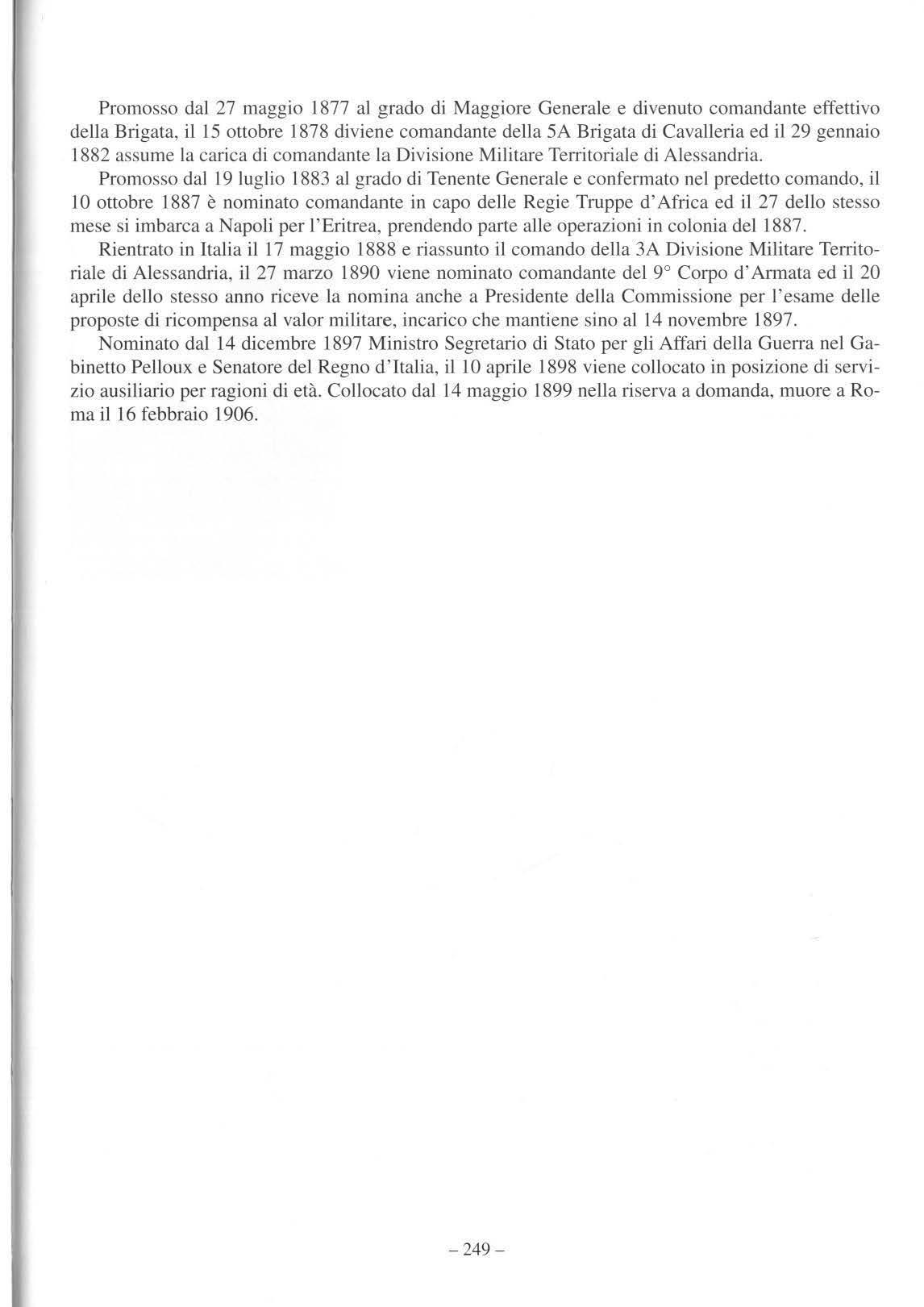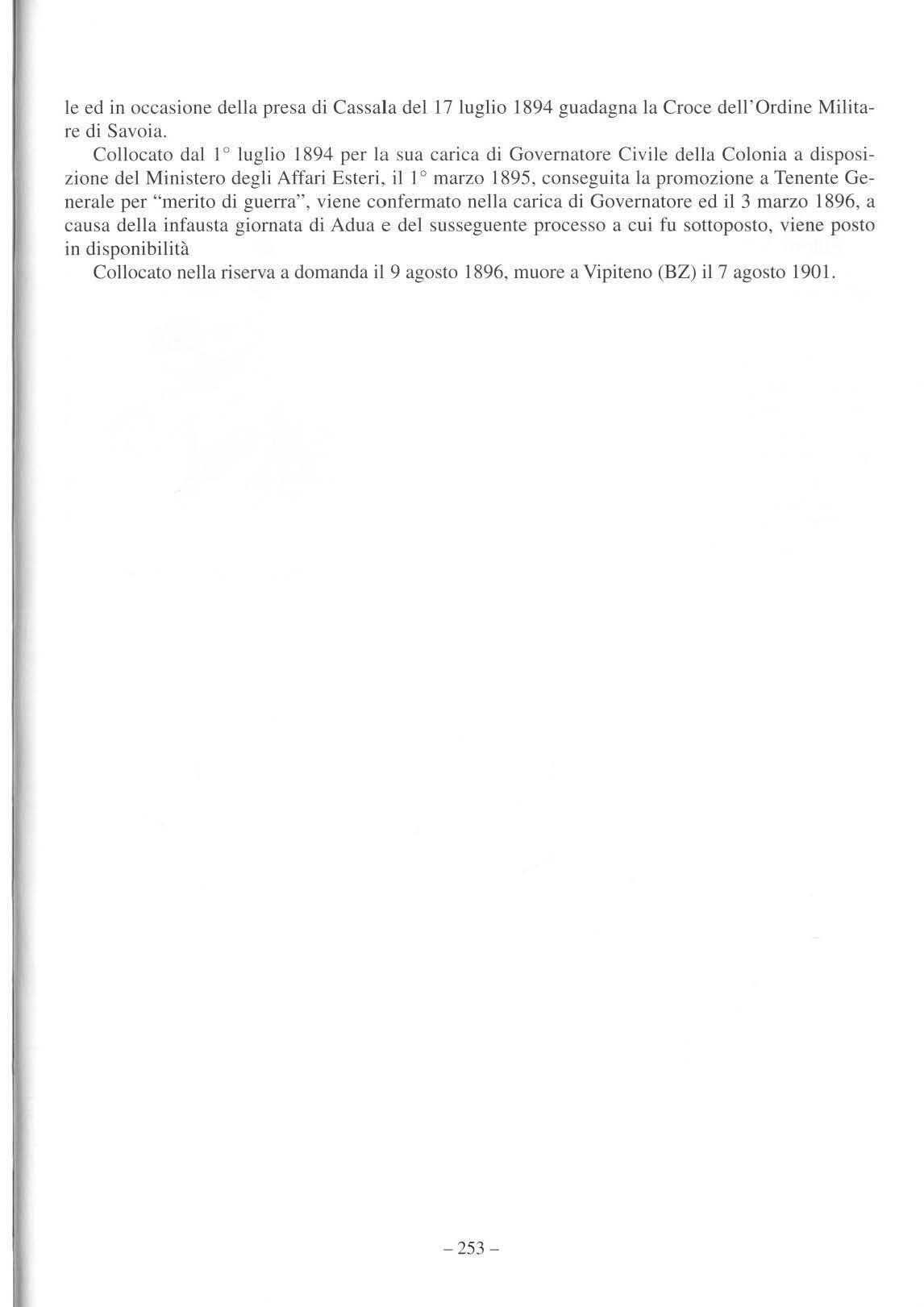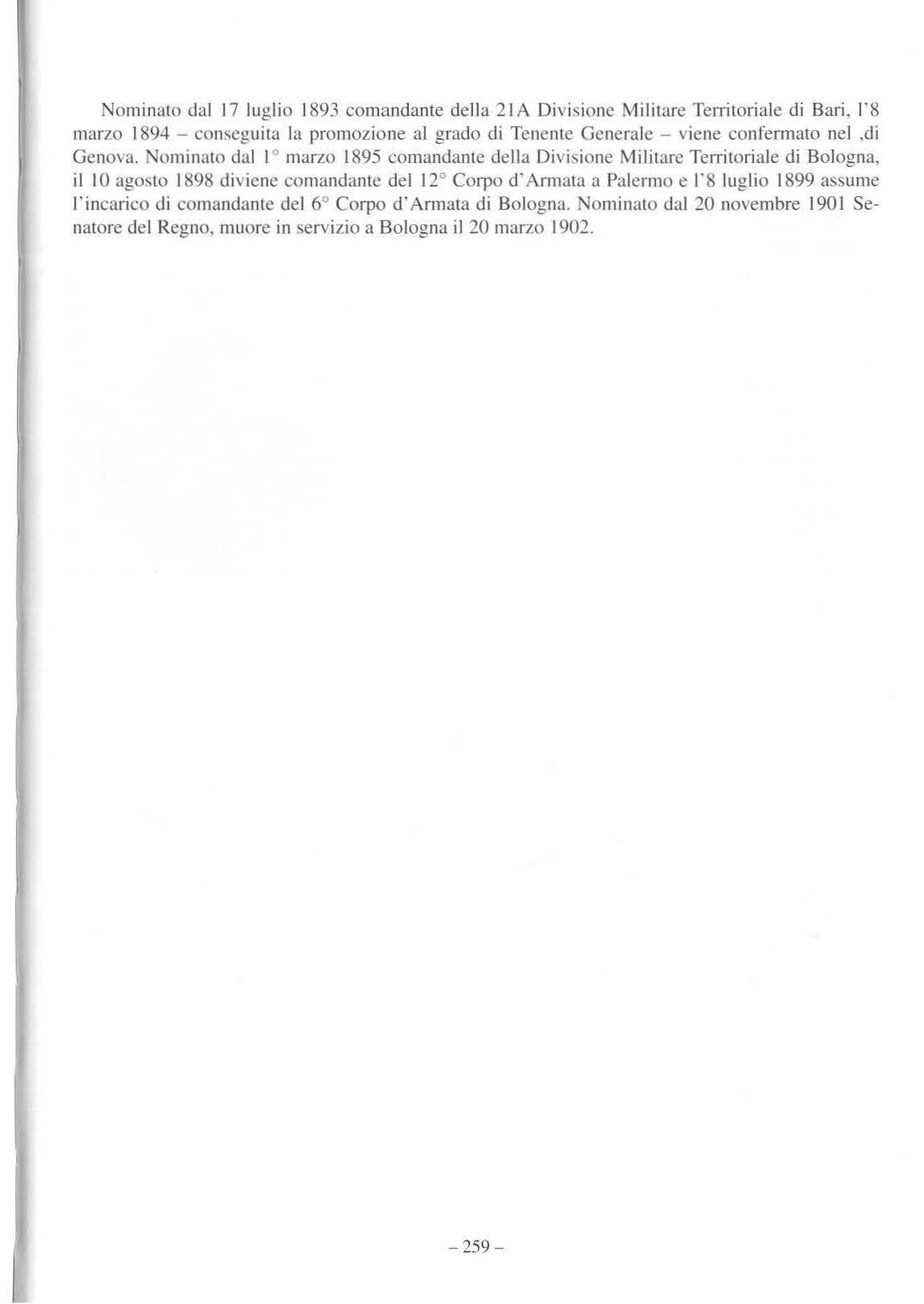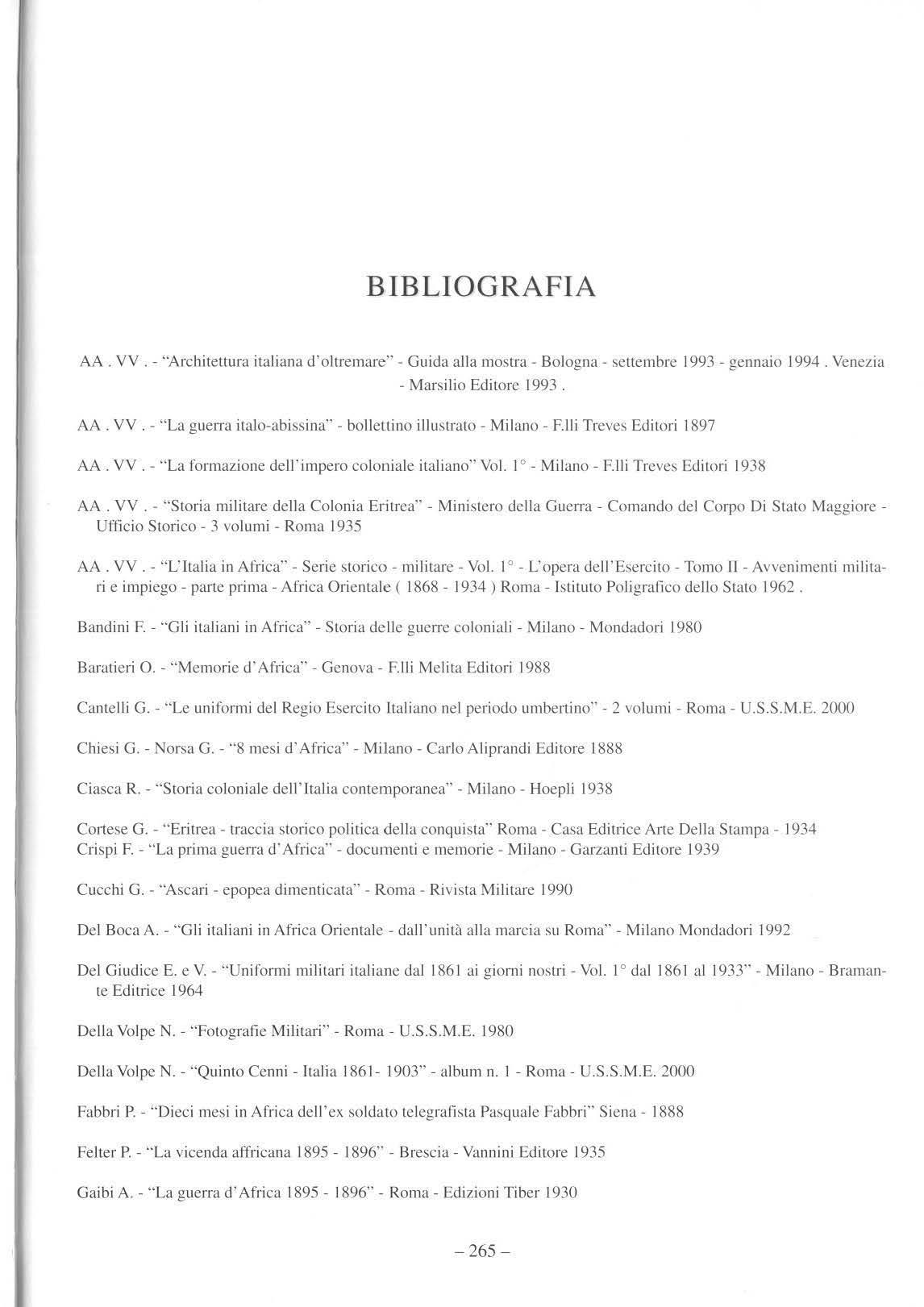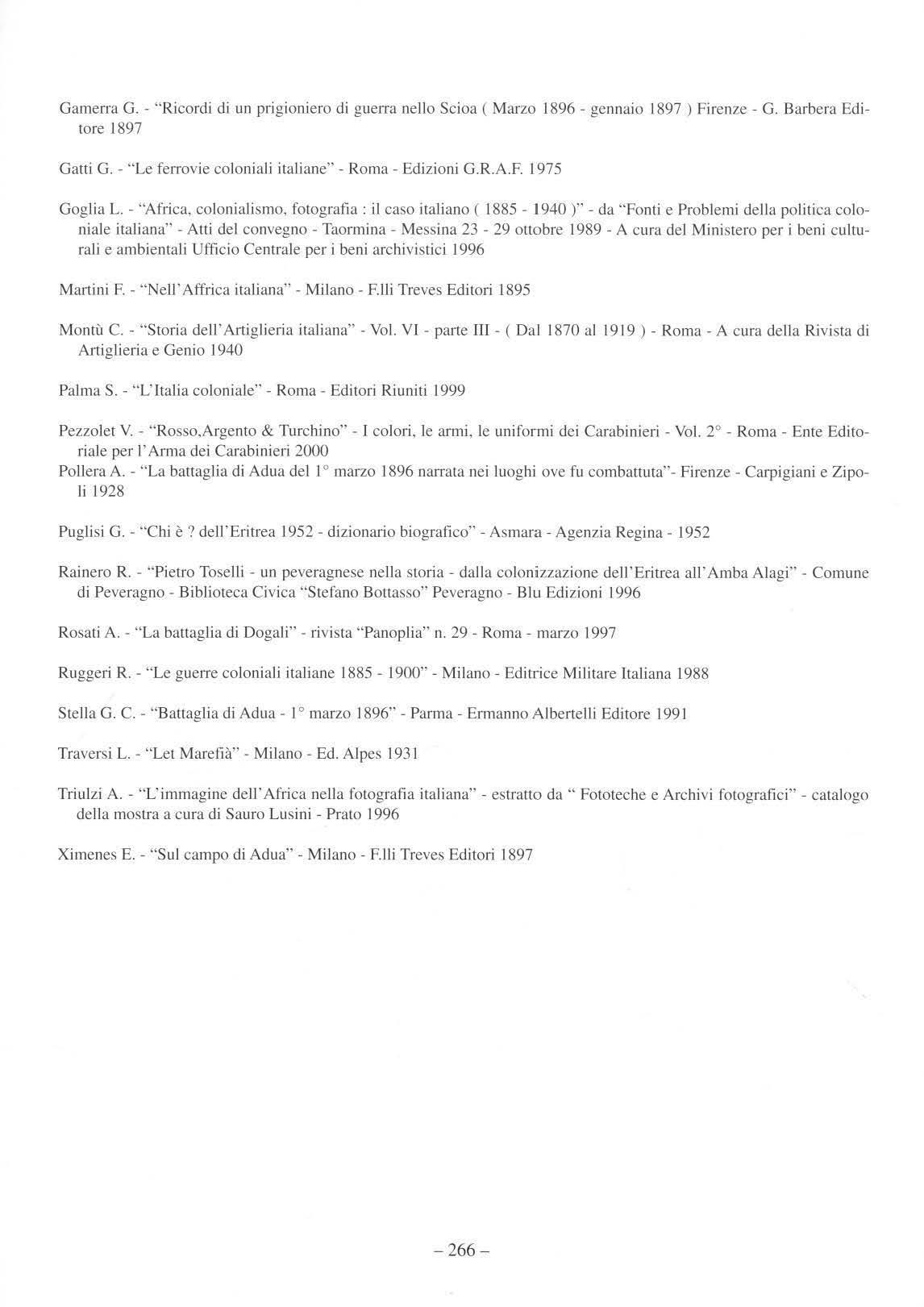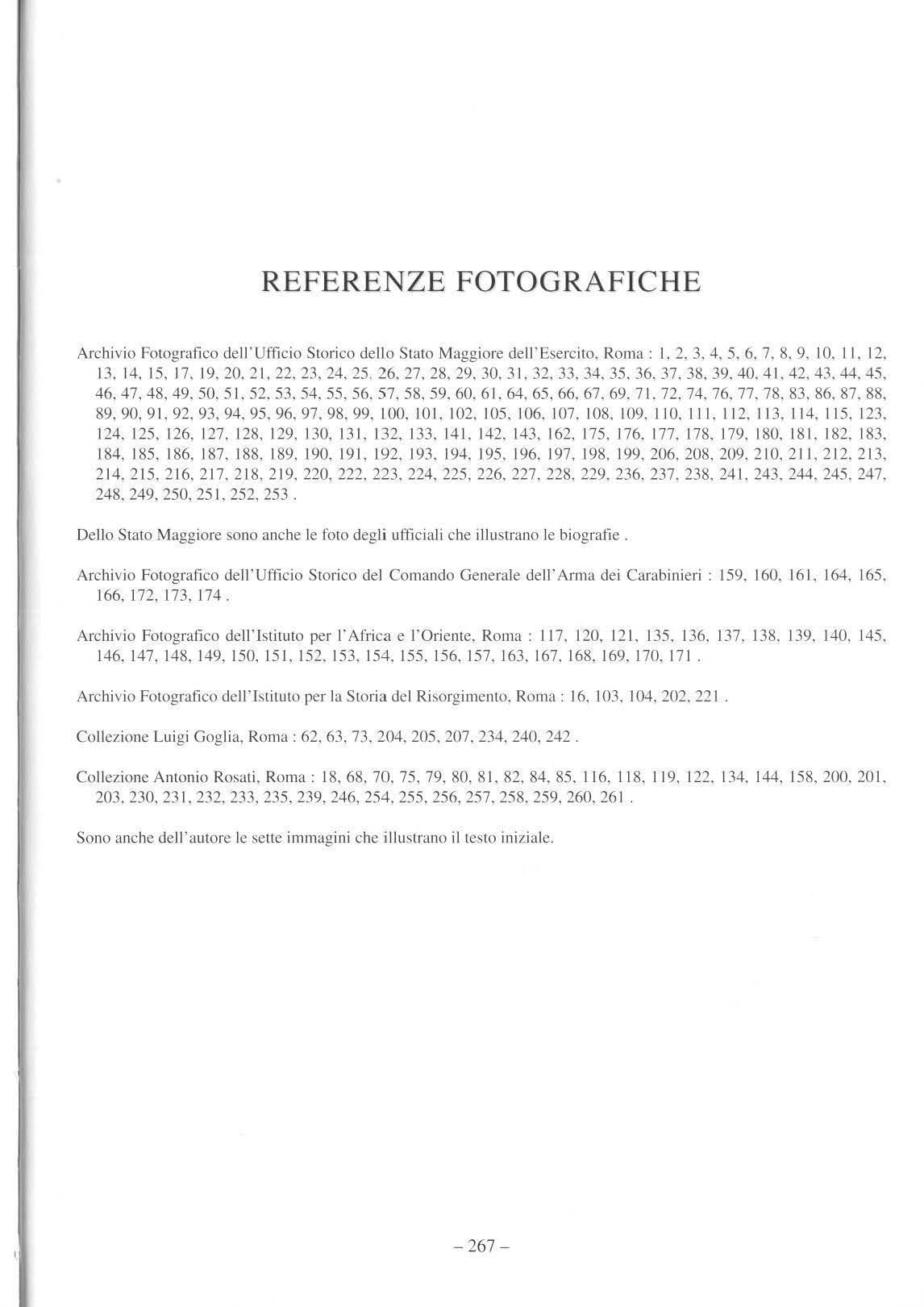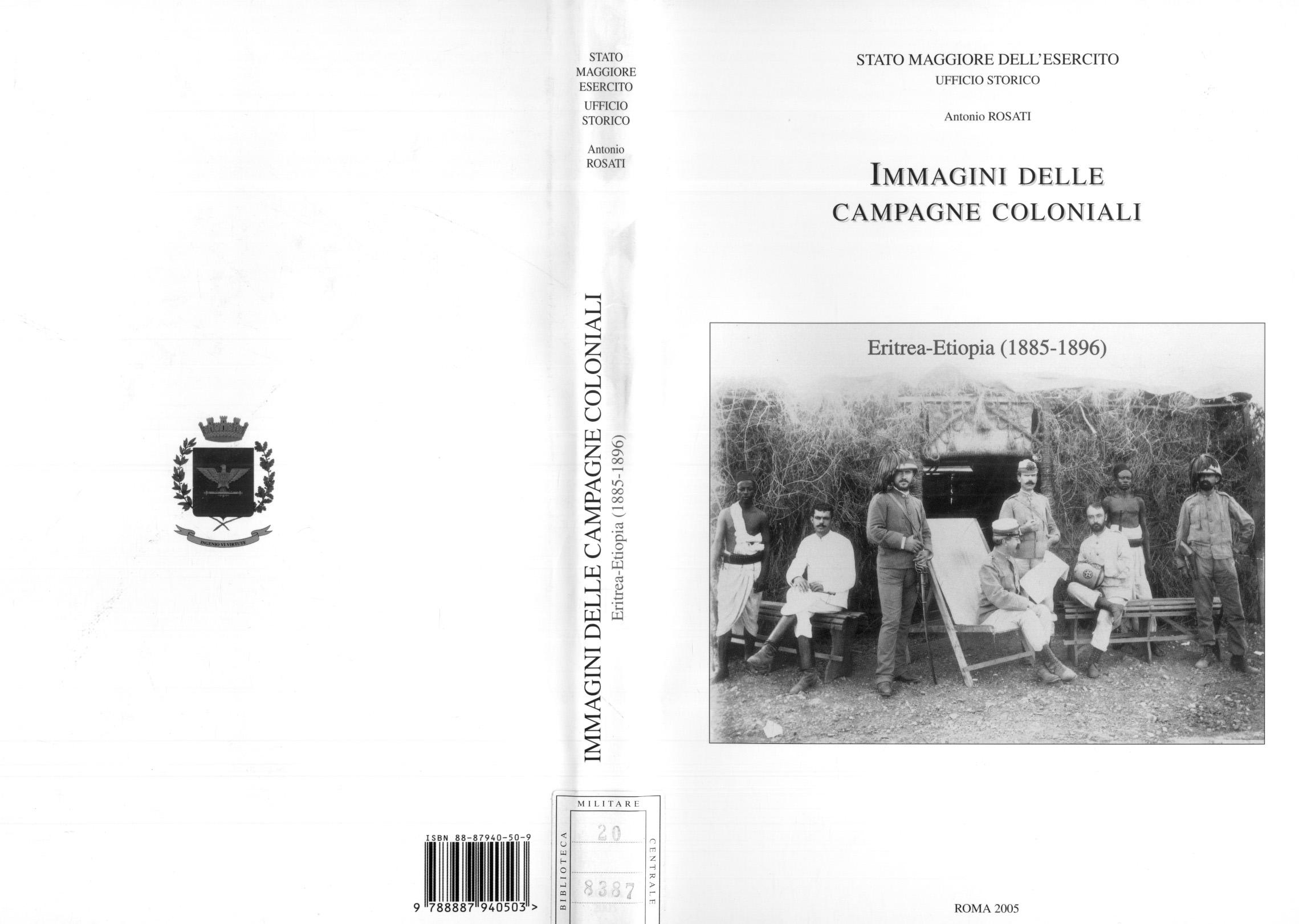

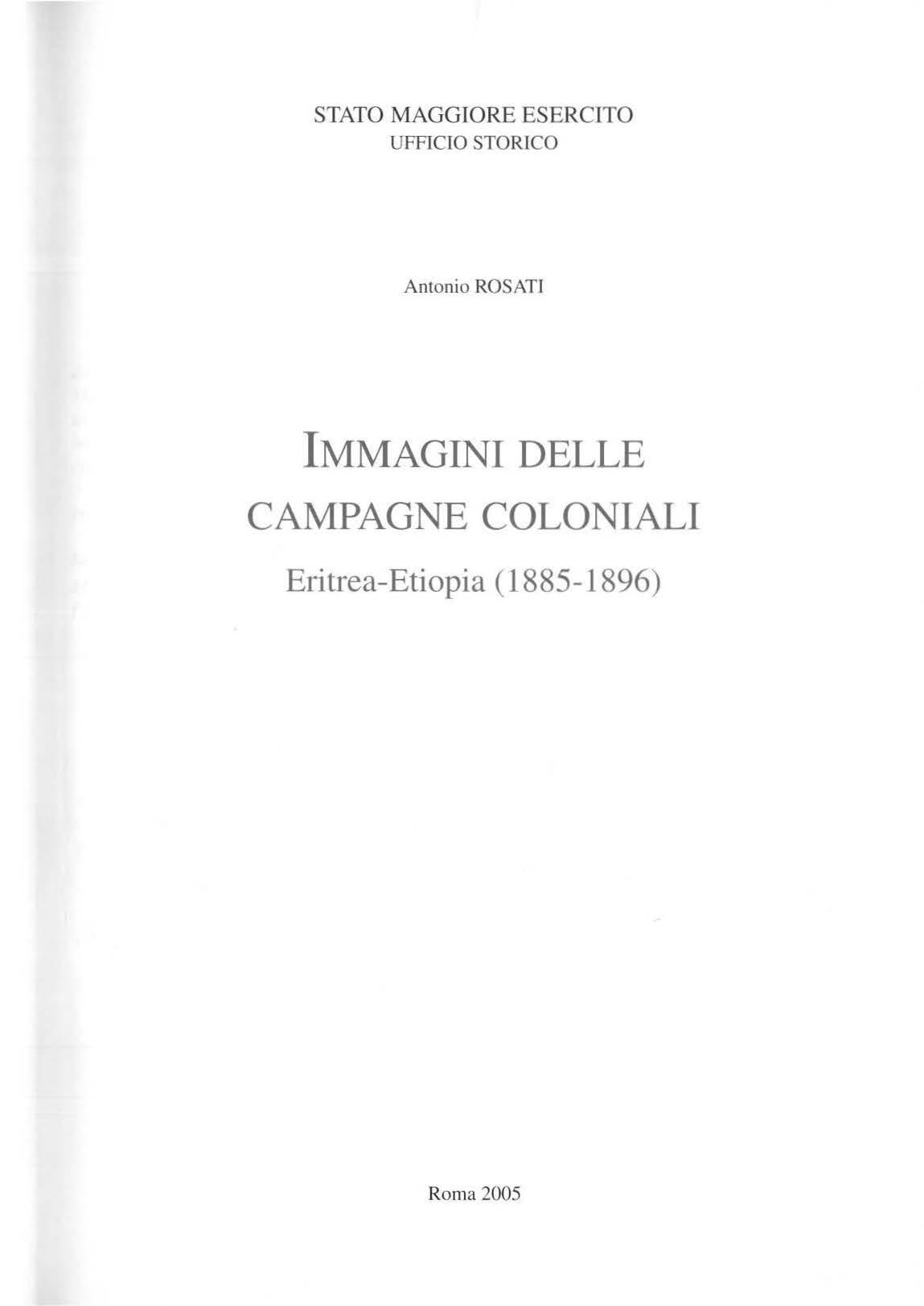
IMMAGINI DELLE CAMPAGNE COLONIALI Eritrea-Etiopia (1885-1896) Roma 2005
STATO MAGGIORE ESERCITO UFFICIO STORICO Antonio ROSATI
PROPRIETÀ RISERVATA
Tutti i dirilfi riservati
Vìetata la riprodu zione anche parziale sen;;.a autori::=ozione
© Copyright Stato Maggiore deli'Eserciw Ufficio Storico - Roma 2005
ISBN 88-87940-50-9

S1ampa· STILGRAFICA srl 00159 Roma Vlalgnazw l'ei1111Cng<•. 31/:13 · Tcl.
PRESENTAZIONE

Questo volume. il secondo della collana " Imma gini delle carnpagne coloniali", affronta il periodo della prima penetrazione militare italiana in Africa. Partendo dal l 885, anno dello sbarco a Massaua, e arrivando all896, anno del disastro di Adua, l'autore ha raccolto duecentosessanta foto scattate dai più noti fotografi allora operanti in Eritrea e in Abissinia. Questi, per la prima volta, inviarono in patria/e immagini di terre sconosciute ed affascinanti, mostrando le imprese dell'Esercito ma anche l e popola z ioni locali, i luoghi e la natura di quei paesi.
Lentamenre, l'usan za di c reare litografie dalle stesse foto per illustrare i quotidiani e le pubblicazioni dell'epoca, cedette lo spazio esclusivamente alle immagini fotografiche.
Anche qu esta volta l'autore, cui vanno i ringraziamenti del/' Ufficio Storico per il lavoro svolto, ha effettuato un 'efficace selezione delle immagini (utili:zando come fonti non solo l'archivio fotografico dell'Ufficio Storico ma anche altre raccolte fotografiche pubbliche e pri vate), mostrando esaurientem ente quale fu l'operato dell'Esercito Italiano al/'ini :.i o della nostra avvenfltra africana.
-3-
Il Capo dell'Ufficio Storico Col. Massimo Multari
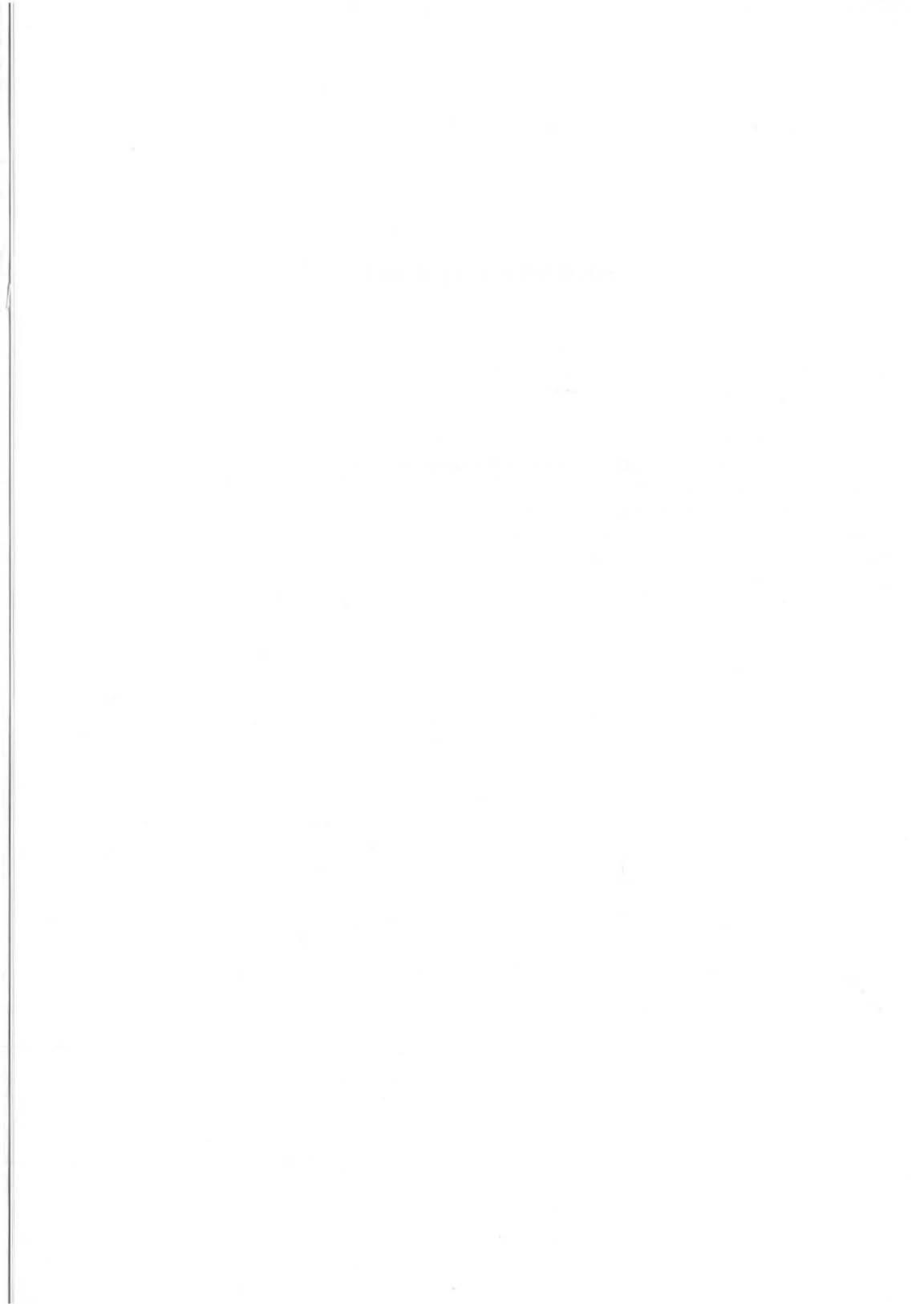
RINGRAZIAMENTI
L'a utore ringrazia per la collaborazione prestata alla realizzazione del volume: !"Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, in particolare il Gen. Nicola della Volpe , il Ten en te Colonnello Antonino Di Gangi, il Tenente Colonnello Fi lipp o Cappellano , i Marescialli Mauri zio Saporiti e D aniele Prinari .
Si ringraziano poi il Colonnell o Vincenzo P ezzolet, dell 'A rma dei Carabinieri, la Dotloressa Stefania Bonanni dell ' Istituto per la storia del Risorgimento , i] Professa r Luigi Goglia per le immagini tratte dalla sua importante collezione, gli amici Ciro Paoletti e Piero Crociani.
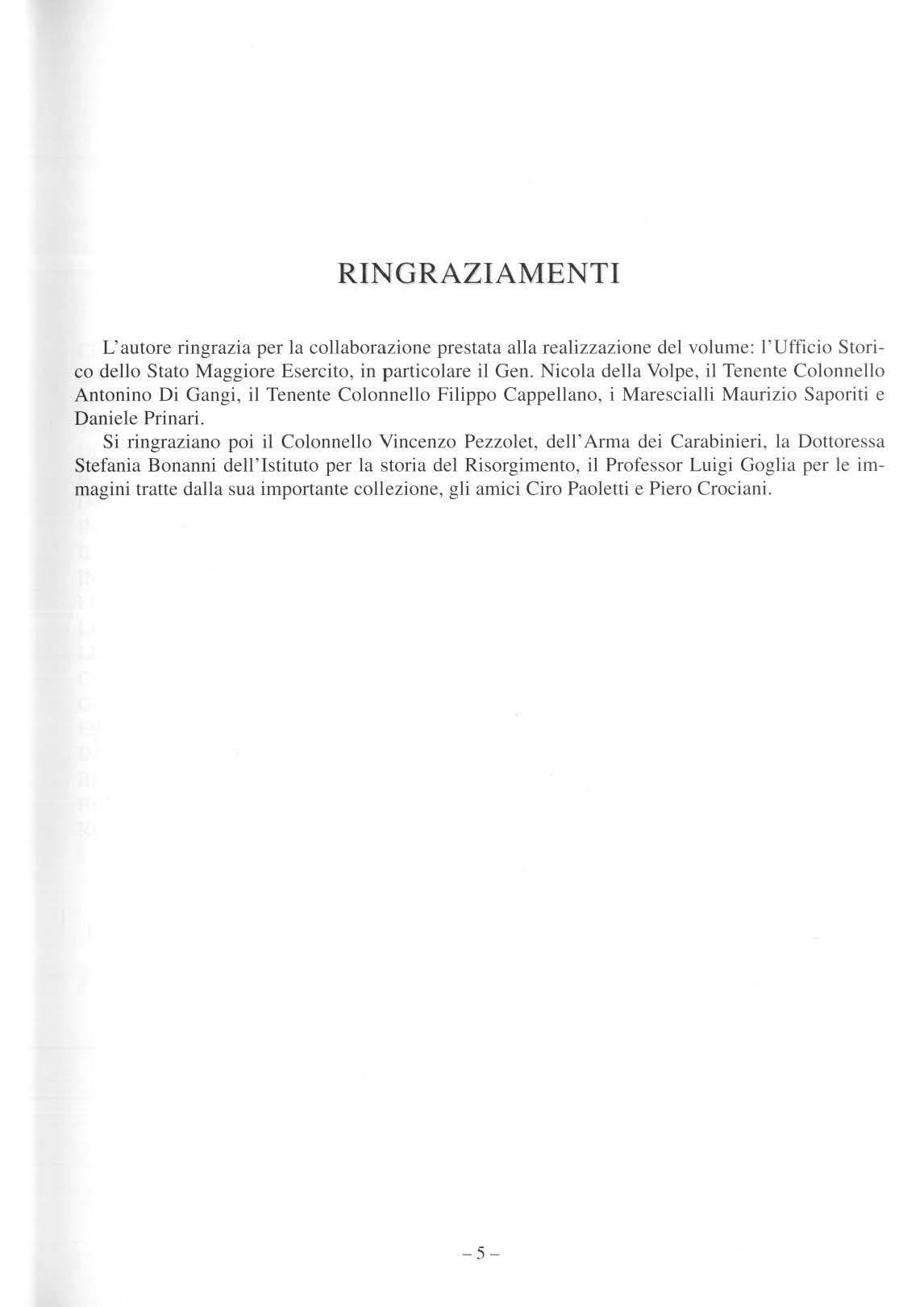
- 5 -
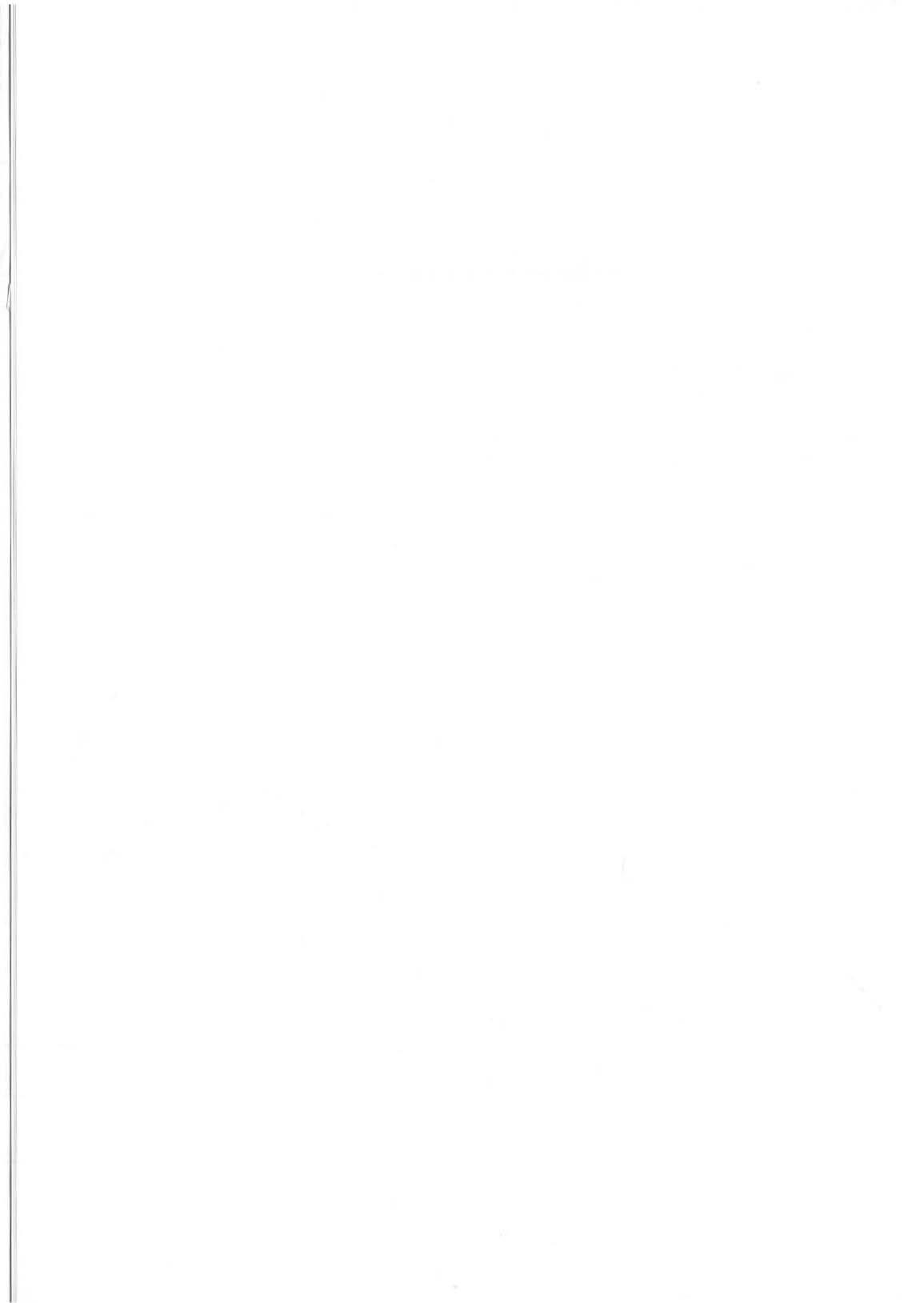
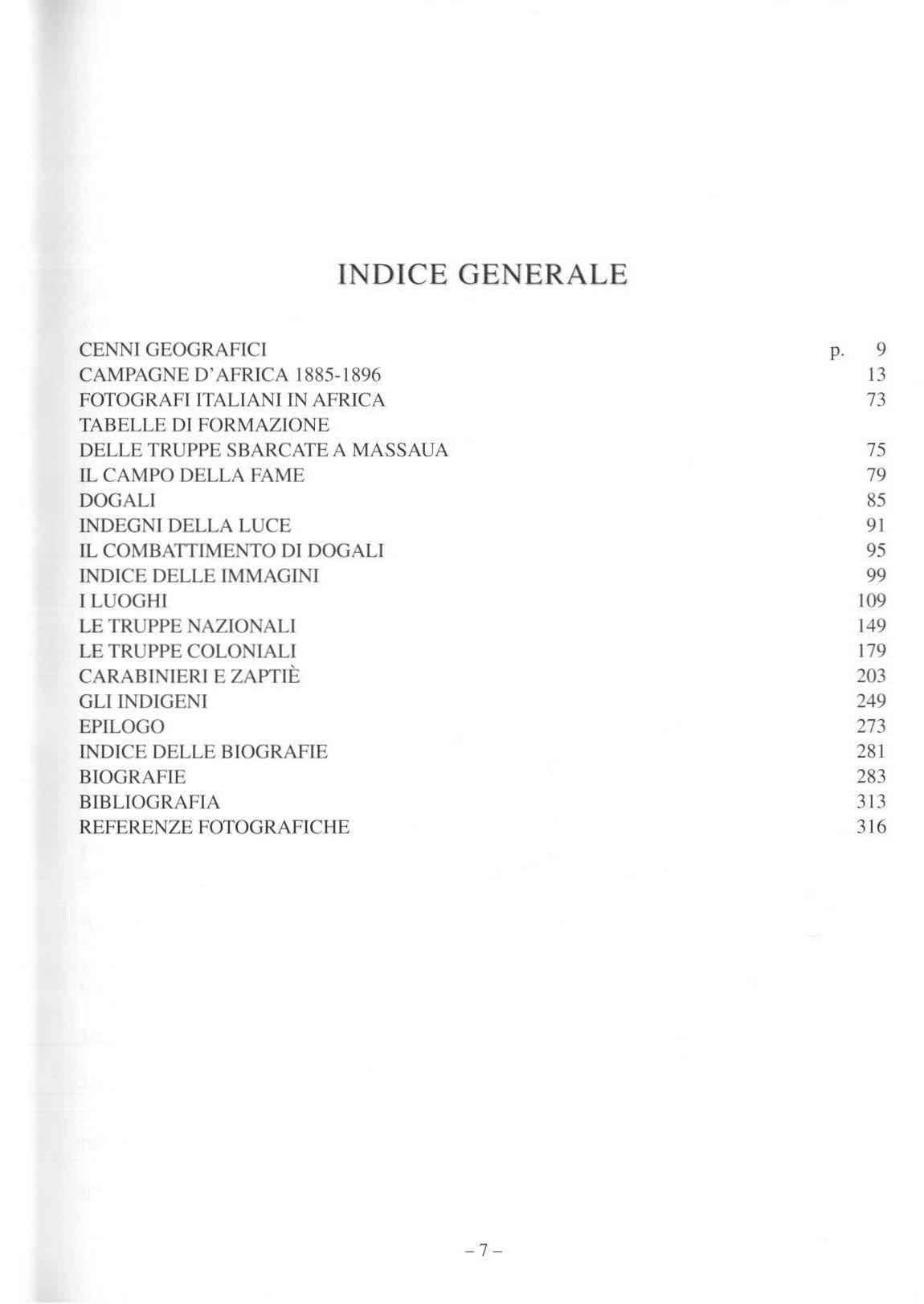
CENNI GEOGRAF IC I p. 9 CAMPAGNE D'AFRICA 1885-1 896 13 FOTOGRAFI ITALIANI IN AFRlCA 73 TABELLE D I FORMAZ IONE DELLE TRUPPE SBARCATE A MASSAUA 75 IL CAMPO DELLA FAME 79 DOGALI 85 INDEG N I DELLA LUCE 91 IL COMBATifMENTO DI DOGALI 95 INDICE DELLE IMMAGINI 99 I L UOG HI 109 LE T RUP PE NAZ IONALI 149 LE TRUPPE CO LO NIALI 179 CARAB I NIER I E ZA PTIÈ 203 GLI IND IGE NI 249 EP ILOGO 273 I ND ICE DELLE B l OGRAFIE 281 BIOGRAFIE 283 BIBLIOGRAFIA 313 REF ERENZE FOTOGRAFICHE 316 - 7 -
INDICE GENERALE
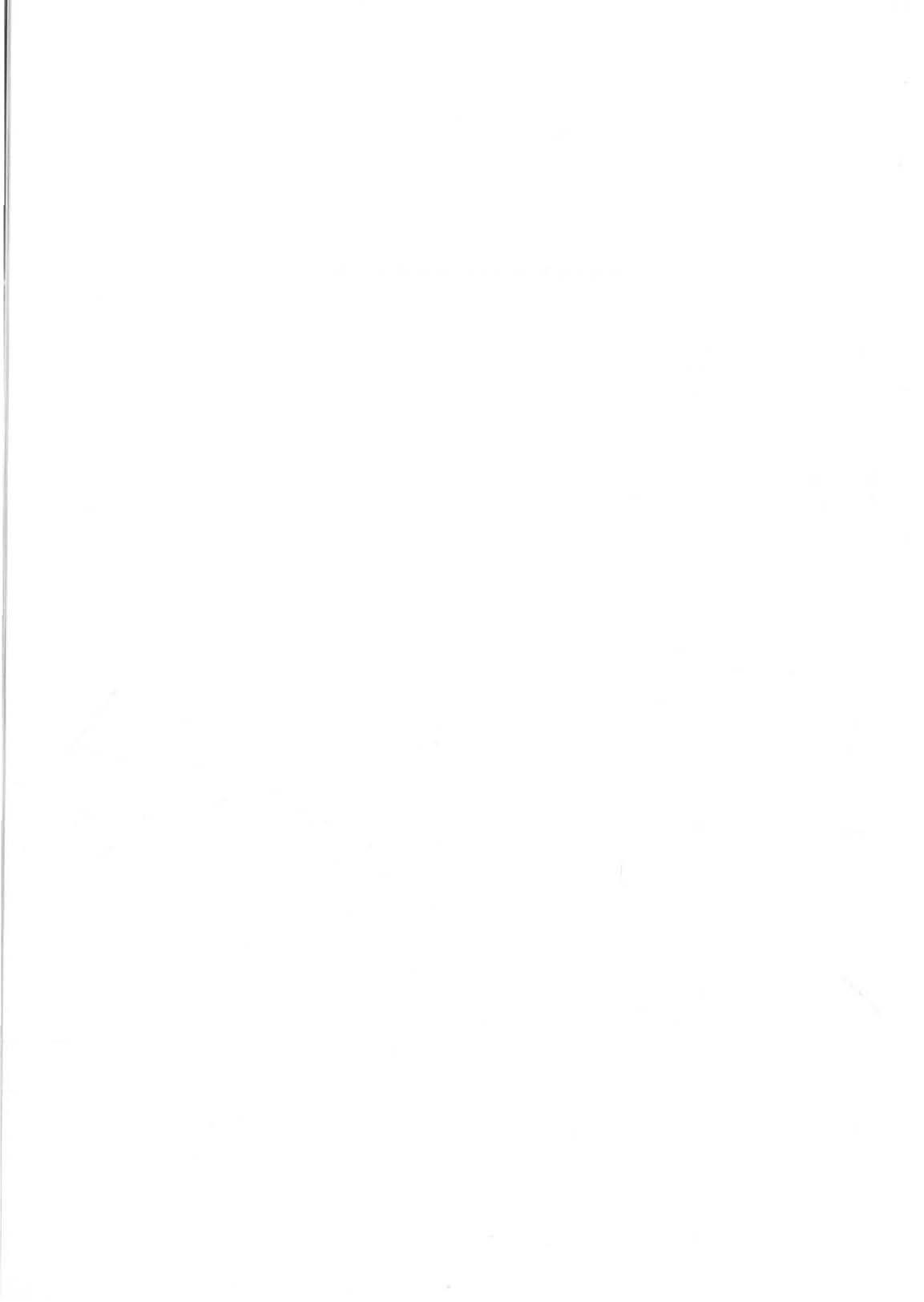
CENNI GEOGRAFICI
ETIOPIA: REGIONI FISICHE
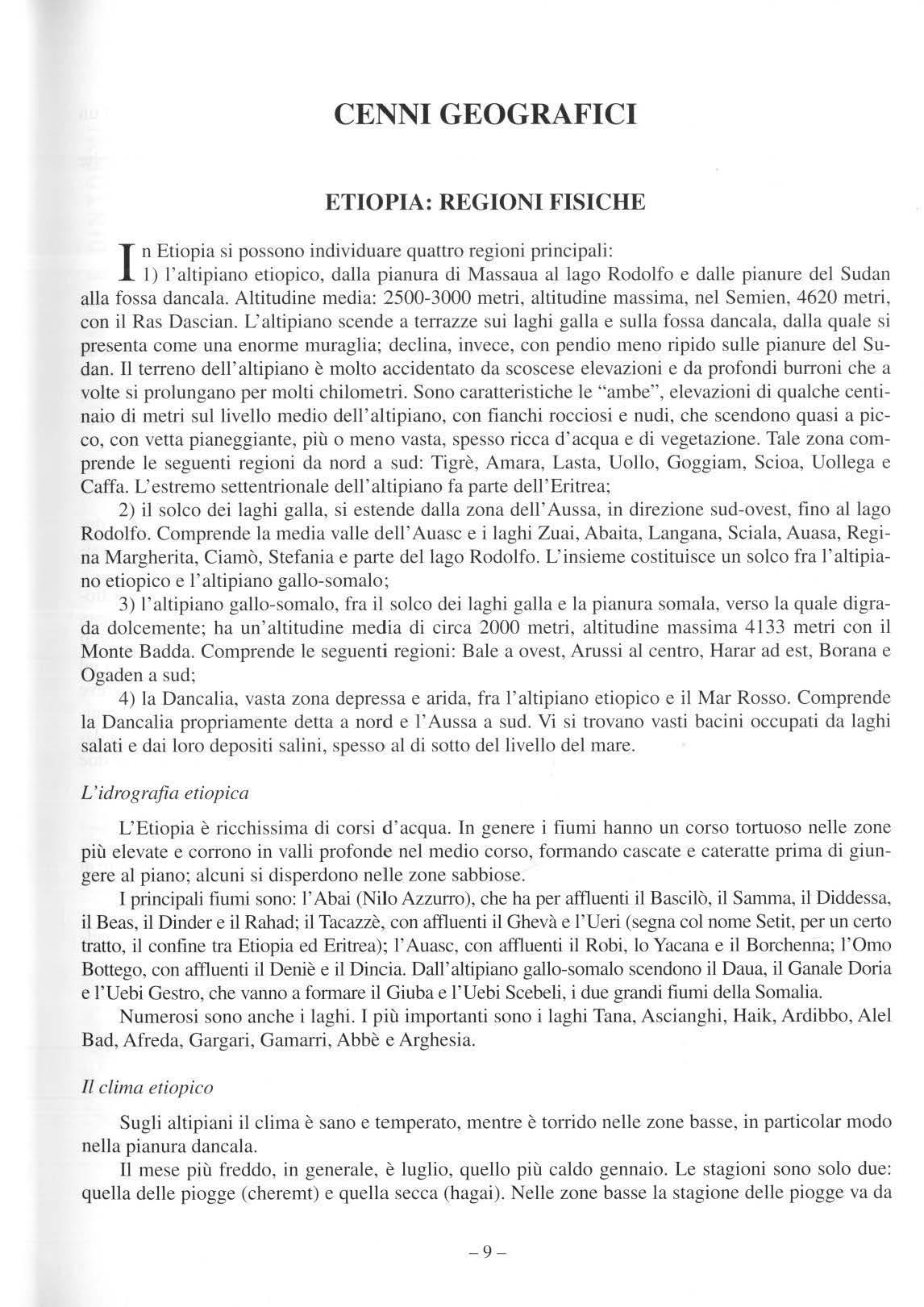
In Etiopia si possono individuare quattro regioni principali:
l) l' altipiano etiopico, dalla pianura di Massaua al lago Rodolfo e dalle pianure del Sud an alla fossa dancala. Altitudine media: 2500-3000 metti, altitudine massima, nel Semien , 4620 metri , con il Ras Dascian. L' altipiano scende a terrazze sui laghi galla e sulla fossa dancala, dalla quale si presenta come una enorme muraglia; declina, invece, con pendio meno ripido sulle pianure del Sudan. Il terreno dell'altipiano è molto accidentato da scoscese elevazioni e da profondi burroni che a volte si prolungano per molti chilometri. Sono caratteristiche le "ambe" , elevazioni di qualche centinaio di metri sul livello medio dell'altipiano, con fianchi rocciosi e nudi, che scendono quasi a picco, con vetta pianeggiante, più o meno vasta, spesso ricca d'acqua e di vegetazione. Tale zona comprende le seguenti regioni da nord a sud: Tigrè, Amara, Lasta, Uollo, Goggiam, Scioa, Uollega e Caffa. L'estremo settentrionale dell ' altipiano fa parte dell ' Eritrea;
2) il solco dei laghi gal1a, si estende dalla zona dell' Aussa, in direzione sud-ovest, fino al lago Rodo lfo. Comprende la media valle dell' Auasc e i laghi Zuai, A baita, Langana, Sciala, Auasa, Regina Margherita, Ciamò, Stefania e parte del lago Rodolfo. L' in sieme costituisce un solco fra l'altipiano et iopico e l'altipiano gallo-somalo;
3) l'altipiano gallo-somalo, fra il solco dei laghi galla e la pianura somala , verso la quale digrada dolcemente; ha un'altitudine media di circa 2000 metri, altitudine massima 4133 metri con il Monte Badda. Comprende le seguenti regioni: Baie a ovest, Arussi al centro, Harar ad est, Borana e Ogaden a sud;
4) la DancaJ.ia, vasta zona depressa e arida, fra l ' altipiano etiopico e il Mar Rosso. Comprende la Dancalia propriamente detta a nord e l' Aussa a sud. Vi si trovano vasti bacini occupati da laghi salati e dai loro depositi salini, spesso al di sotto del livello del mare.
L ' idrografia etiopica
L'Etiopia è ricchissima di corsi d'acqua. In genere i fiumi hanno un corso tortuoso nelle zone più elevate e corrono in valli profonde nel medio corso, formando cascate e cateratte prima di giungere al piano; alcuni si disperdono neale zone sabbiose.
I principali fimni sono : l' Abai (Nilo Azzurro), che ha per affluenti il Bascilò, il Samma, il Diddessa, il Beas , il Dinder e il Rahad ; iJ Tac azzè. con affluenti il Ghevà e l'Ueri (segna col nome Seti t, per un certo tratto, il confine tra Etiopia ed Eritrea); l' Auasc, con affl ue nti il Robi, lo Yacana e il Borchenna; l'Orno Bottego, con affluenti il Deniè e il Dincia. Dall'altipiano gallo- somalo scendono il Daua, il Ganale Doria e l'Uebì Gestro, che vanno a formare il Giub a e l'Uebi Scebeli, i due grandi fiumi della Somalia. Numerosi sono anche i laghi. I più importanti sono i laghi Tana, Ascianghi, Haik, Ardjbbo, Alel Bad , Afreda , G argari, Gamarri, Abbè e Arghesia.
ll clima etiopico
Sugli altipiani il clima è sano e temperato, mentre è torrido nelle zone basse, in pmticolar modo neJla pianura dancala.
Il mese più freddo, in generale, è lu g lio , quello più caldo gennaio. Le stagioni so no solo due: qu ella deJle piogge (cheremt) e quella secca (ha ga i) . Nelle zone basse la stagione delle piogge va da
-9-
aprile a sette mbre. nelle zone a lte va da luglio a ottob re , n elle zone cos ti e re corrisponde circa ad un in ve rno medit e rran eo .
L'E tiopi a ha un 'es ten sione geog rafica di 1.200.000 ch ilom e tri quadrati, cioè quasi quattro volte quella dell ' Ita li a.
E RITRE A: L' ORO G RA F IA
T ' Eritrea ha in comune co n l' Etiopia la linea di sollevamento che la divid e ne i versanti: L orientale del Mar Ro sso e d occidentale del Nilo.
Su qu es ta linea di so llevamento è adagiata la formazione di rocce vulc anich e c he cost ituisce la massa dell ' altipi an o, estremo le mb o se ttentrion ale d e ll 'acroco ro e ti opico-so malo d e l quale presenta le caratteri s tich e geo logich e e mo rfologiche; vero s is tema montan o co n c ime molto e levate, che s i agg irano sui tre mi la metri. La regione montuo sa dan cala si può co ns iderare come un g rande contrafforte dell 'a ltipi a no e come facente parte di un s is te ma a sé.
Idrografia eritrea

Il regim e dei co rs i d 'acqua d e ll 'E ritrea è torrentizio, poich é in ess i l 'acq ua sco rre so ltanto durante la stagione d e lle piogge. Quas i tutti però po ss iedono una falda s otterranea, alla quale è poss ibi le attingere mediante l 'escavaz ion e di pozzi.
Sul ve rsante de l Nilo i fiumi più impot1anti so no il Se t it. c he nasce co me abbiamo visto in Eti opia, co l nom e di Tacazzè e si ge tt a nell'Atbara, ed il M are b che n asce dall'altipiano a s ud di Asmara e pre nde s uccess iva mente i nomi di Sona e di G asc, perdendosi nell e pianure sa bbiose di Cassala. Il M areb, che interessa per gran parte del s uo corso l'E ritrea, ha un a lunghezza di 680 c hilometri ed un bacino , in territorio er it reo, di c irca 30.000 chilometri quad rati. Il Setit la interessa per più breve tratto. Entrambi fun se ro da se mpre co me confine co n l'A b i ssinia. Sul versante d el Mar Ro sso, l'unico fiume imp o r1 a nt e è il Barca, c he nasce ne ll ' H amasie n e s i ge tta ne l Mar Ro sso in te rritorio sudanese: ha un a lun g hezza di 450 c hil o me tri ed un bacino di circa 60.000 c hilome tri qu a dra ti per due terl i in Eritrea.
l/ c lima eritreo
Agli effetli del clima 1' Eritrea può di vider s i in tre zone: costiera e bassa, montu osa (s uperiore ai 1.000 metri ) e d i ntermedia delle p e ndi c i, detta dagli indigeni "quoll à".
L e s ta g ioni o no ovviamen te le s tesse che in Etiopia.
L ' Eritrea ha un 'es tensione geog rafica di circa 119 .000 chilom e tri quadrati, dei qu a li 1.452 spettano a ll ' arcipelago delle I s ole Da hlac h, composto da 122 isole.
- IO -
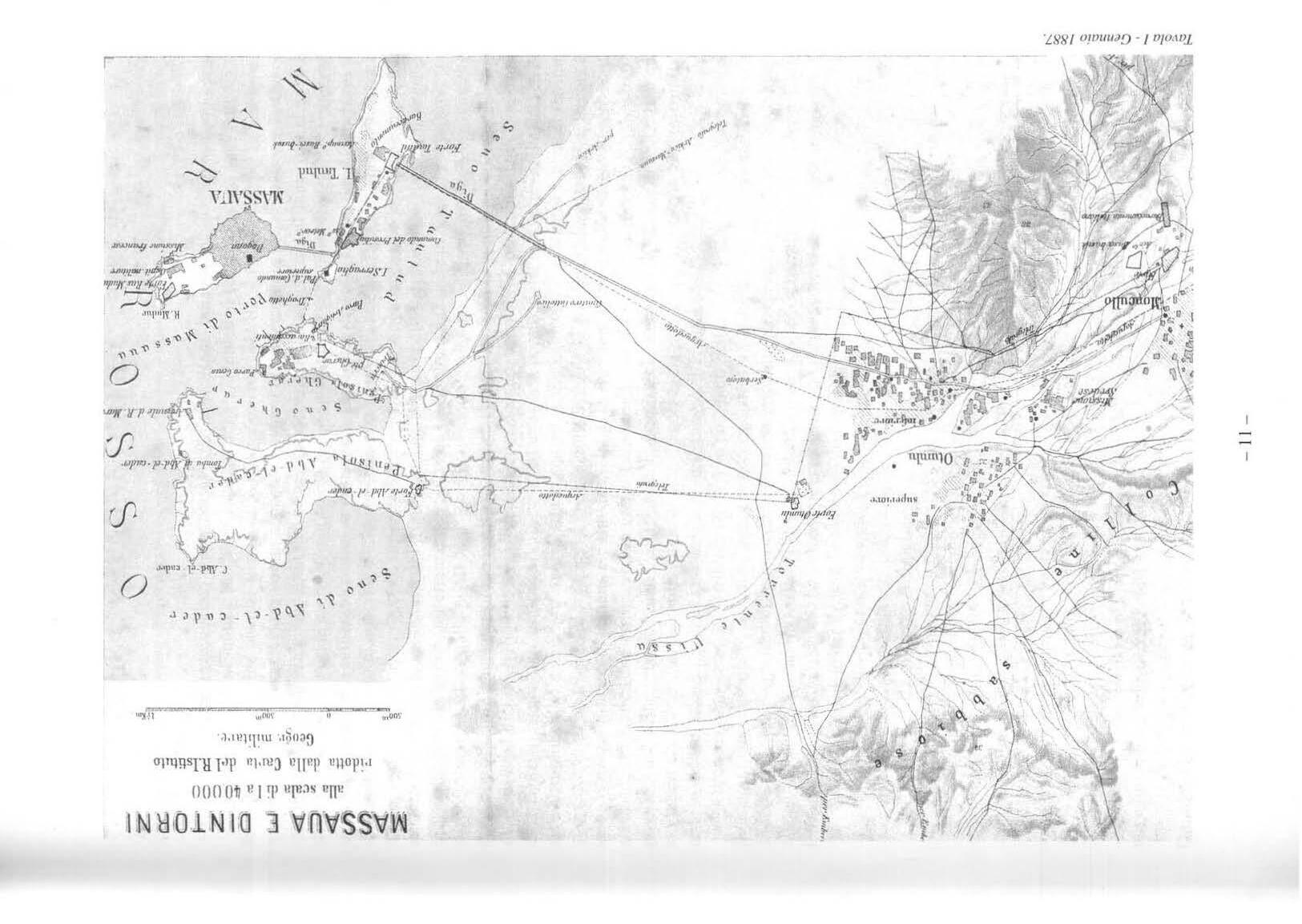
"' l, • l --•1.--.; 'Ill l

In Italia si era cominciato a pens are ad una futura espansione coloniale diverso tempo prima di conseguire l'unità e l'indipendenza nazionale. Numerosi tentativi erano stati fatti sia dal Regno delle due Sicilie che dal Regno di Sardegna per ottenere da altri stati europei la cession e di territori in Africa o in Oceania con lo scopo di fondarvi qualche colonia penale. Il conte di Cavour, con maggiore chiarezza e ampiezza di vedute, aveva pensato di assicurare all'Italia una sfera di influenza in Abissinia. A tale scopo, Cristoforo Negri, capo divisione al Ministero degli Esteri, era stato da lui incaricato di utilizzare l'aiuto di monsignor Massaia e di padre Leone des Avranchères per concludere un trattato di amicizia e commerciale con Negussiè , ras del Tigrè, il quale sembrava interessato ad intraprendere rapporti diplomatici con una potenza europea che lo potesse appoggiare nel suo progetto di impossessarsi del trono etiopico. Senonchè, le sopravvenute vicende risorgimentali , distrassero il Cavour dali' argomento. Solo con l'apertura del Canale di Suez ( 17 -11-1869) si risvegliò l'interesse dell' I talia per il Mar Rosso, cercando comunque di muoversi con circospezione onde non attirare l'attenzione delle potenze europee che già avevano in zona i propri interessi commerciali e politici. Nel 1869, illazzruista Giuseppe Sapeto, acquistava, per conto della Compagnia di navigazione Rubattino , un tratto deHa costa ed una certa porzione del retroterra, nella Baia di Assab. Naturalmente l'acquisto avven iva con la segreta acquiescenza del gabinetto Lanza. Il teiTitmio si estendeva su un triangolo, fra Capo Lumà, Monte Ganga e la gola di Alalè, ottenutane la concessione parte dal Sultano di Raheita e parte dal Sultano di Berehan. Poco dopo lo stesso Sapeto acquistava anche alcune isole prospicenti la costa. Dopo tredici anni di gestione privata, Assab passò in proprietà dello Stato italiano , che J'acquistò dalla Compagnia Rubattino il 12 marzo 1882. E' a questo punto che l'Inghilterra, sia in funzione anti-francese, sia per avere un aiuto in Sudan contro le orde mahdiste, spinse l'Italia ad un vero e proprio intervento militare.
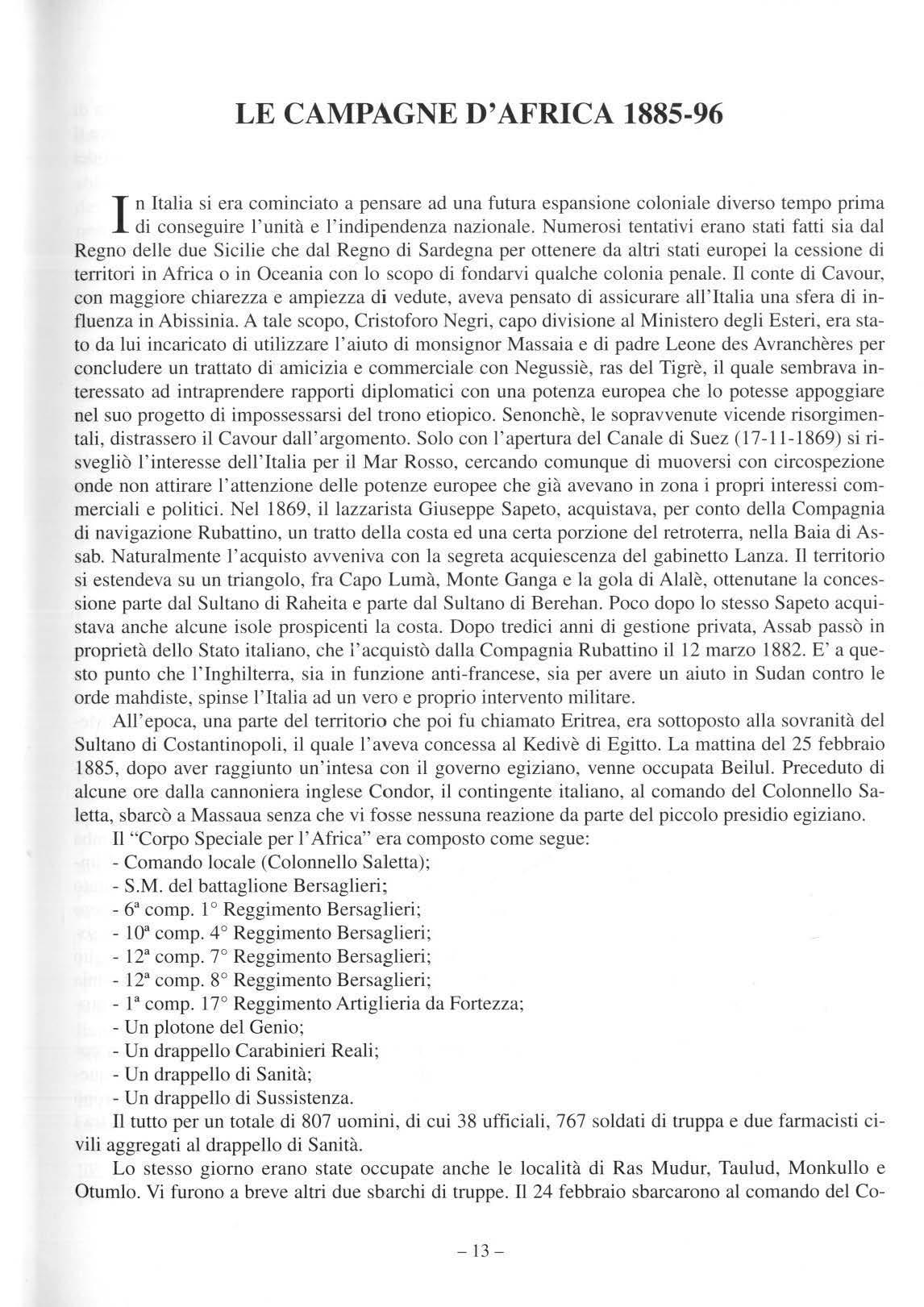
All ' epoca, una parte del territorio che poi fu chiamato Eritrea, era sottoposto alla sovranità del Sultano di Costantinopoli, il quale l'aveva concessa al Kedivè di Egitto. La mattina del 25 febbraio 1885 , dopo aver raggiunto un'intesa con il governo egiziano, venne occupata Beilul. Preceduto di alcune ore dalla cannoniera inglese Condor, il contingente italiano, al comando del Colonnello Saletta, sbarcò a Massaua senza che vi fosse nessuna reazione da parte del piccolo presidio egiziano.
Il "Corpo Speciale per l'Africa" era composto come segue:
- Comando locale (Colonnello Saletta);
- S. M . del battaglione Bersaglieri;
- 6" comp. l o Reggimento Bersaglieri;
- 10a comp. 4 ° R eggimento Bersaglieri;
- 12a comp . 7 ° Reggimento Bersaglieri;
- 123 comp . 8° Reggimento B ersaglieri;
-l a com p. 17 ° Reggimento Artiglieria da Fortezza;
- Un plotone del Genio;
- Un drappello Carabinieri Reali;
- Un drappello di Sanità;
- Un drappello di Sussistenza.
ll tutto per un totale di 807 uomi ni, di cui 38 ufficiali, 767 soldati di truppa e due farmacisti civili aggregati al drappello di Sanità.
Lo stesso giorno erano state occupate anche le località di Ras Mudur , Taulud, Monkullo e O tumlo . Vi furono a breve altri due sbarchi di truppe. Il 24 febbraio sbarcarono al comando del Co-
L E CAMPAG NE D 'AFRI CA 1885-96
13-
-
lonn e llo Leiteni z quattro co mpag ni e del 4 °, 41 ° , 54° e 91 ° Reggimenti Fanteria, una co mpagnia di Art ig li e ri a da Fortezza con 8 pe zzi, un plotone de l Ge nio c i servizi. n 7 m arzo sbarcaro no in vece il I e il II battag li o ne di Fanteria d 'Afri ca, una sezione di Artiglieria da Forte zza, un a compag ni a del G e ni o, i servizi e materi a li vari.
LE REAZI ONI ALL'ESTE R O
La presa di possesso di M assa ua e zo ne limi t ro fe pro vocò in mani e r a parti co l are le pro teste de lla Turc hi a. La cess ione dei po rti del Mar R osso, da essa fatta i n passa to atr Egi tt o, non aveva cessa to di fatto il suo di ri tto, s ia pure formal e; quindi qualora l'E g itto s i fosse di si nt ere ssa to di tali p o rti, il diritto d ella Turc hi a av re bbe dovuto, seco ndo la tes i di Costantinopoli, avere pi e n a vali dità, né essa e ra di s pos ta a rinun c ia rvi. M a la cosa, c he com e s i vede e r a un a qu es tione puramente g iuridi ca, s i esaurì con uno sca mbio di corri sponde nz a tra la ca nce ll eria turca e qu e ll a italiana.
Qualche tiserva fu avanzata dalla Fran cia e dalla Ru ss ia. Qu es t'ultima co min ciava ad avere nei rigu a rdi dell'Abi ss ini a un interessamento che veniva g iu s tificato co n una pretesa comunanza di fede reli giosa.

IL C ONDOMINIO I TAL O- EGIZIA N O A MASSAUA
C on ro cc upazion e di Ma a ua , ritalia si era m essa in co ndi z i o ne di dove r affrontare due nemi c i, entr ambi di una ce rta peri co los ità: l ' Abi ss inia cd il Mahdi s mo. L'im presa s i riv elava s in dall ' ini z io piena di incognite e min acce. Si cercò per prima cosa eli tra nquilli zzar e il N eg us J ohannes. In tutta r Abi ss ini a la not iz ia cl e ll 'occ upazion e d i M assa ua aveva naturalmente creato un sen o di diffid e nza e di ra nco re. Fin o a llo ra l'Italia e ra s ta ta considerata. no n solo a ll a corte di Menelik , ma dallo stess o Imp e ra tore, come una delle po c he potenze euro pee c he, non avendo int e ress i e amb izion i territoriali in Africa , o ffri va l e mi g liori ga ranzie di amic iz ia. Ora la s i tuazione era ca mbiata , g iu s tifica ndo i pegg io ri so spe tti sulle inte nzioni e pans ioni s te ita li a ne.
Conscio di questa sfavo revol e ripercus s ione, il governo i taliano inviò ne l marzo 1885 un 'ambasce ri a, com pos ta dal Capitano Vinc e n zo Ferrari e dal Do t tor Cesa re Nerazzini da Ma ssa ua ad Amba Cerà , luogo di resi denza de ll'Imperato re, co n doni e un messagg io. In esso l'Italia s i a. s umev a l'imp egno di mante nere sc rup olo s amente tutt i i va nt aggi c he l'Inghilte rra e l 'Eg itt o aveva no assic ura to in M assa ua all'Ab issi ni a; c he anzi , se le circos ta nze lo avessero permesso, tali vantaggi sa rebbero stati anche acc resc iuti . Ve nne anch e promesso l ' invio di una apposita mi ss ione per co nfermare solenn e mente c iò c he era sc ritto al riguardo ne l "Trattato di H ewett" (d al n ome d e l Vice Ammirag li o in glese che il 3 giugno 1884 riusd a concl ud ere un trattato con il quale l'E gitto ced eva all'Abissin ia i l Senahit o paese dei Bogos, accordandole inoltre lib ertà di tran s ito ne l porto di M assaua so tto protezione britanni c a ) .
L' Imp eratore prese at to delle promesse e se mbrò c re dere alle assicu razioni ri cev ute. Era comunqu e prese nt e in lui l 'a marez za di esser e s tato prevenuto dall ' Italia e la preoccupazione che ques ta ini z iasse ad a llarg a re ulla terra ferma le zo ne in s uo possesso. I sos pe tti del Neg us se mbrarono giu s tifi ca ti quando ne ll 'aprile dello stesso anno il Colonn e llo Sale ua , per s tab ilire l a co ntinuità tra i territori fra A ssa b e M assa ua, fece occ upare Arafali nella baia di Zula, Arch ico, Med e r ne ll a baia di Anfa le, la baia di Edd , oltre a lle iso le Hauachil.
Ne i confront i del Mahdi smo l a s itu az ione non e r a me no seria.
- 14 -
Il 22 giugno 1885 morì il Mahdi e gli successe come califa il nero Abdalla at Taaischi. suo fidato luo gotenente. Non per questo gli scontri cessarono. Il 30 luglio infalli, dopo venti mesi di asse dio , cadeva Ca ala. Il Negus aveva inviato invano ras Alula con 10.000 uomini a tentare di sb lo ccare la guarnigione. A sbanare la strada a ras Alula era sceso sul torrente Cufit, nel territorio dei Bar ia, Osman Digma, che si era trincerato sull'argine del ton·ente. La sua avanzata minacciava non solo i paesi del bassop ia no ma anche Cheren e le regioni sui monti, tanto più che Osman Digma aveva intenLione d i riunire gli Algheden. i Sabderal e i Baria per farne r avanguardia del moviment o mahdista. Ras Alula si sco ntrò con Osman il 22 settembre. Con la loro c la ssica mossa avvolgente, g li Abissini minacciarono i Dervi sci alle spalle, ma questi, protetli dai trinceramenti, non si la sciarono imp ress ion are. Due poderosi attacchi sferrat i contro le loro posizioni furono respinti. Alla fine però ras Alula fece inter venire le sue riserve, che decisero dello scontro. Questo costò agli Abissini m ol ti ssime perdite, re s tando ferito lo s te sso Alula. Nonosta nte la sco nfitta, i Der visci da Cassala to rn arono ben presto a minacciare il bassopiano. Tn preda al panico, l e tribù invocarono la prote zio ne italiana.
Nel g iu g no 1885 il Mini stro Mancini si dimi se e il Mini stero degli Esteri fu assunto dal Generale Robil ant. Il primo provvedimento da prendere era quello di porre fine all'equivoca s ituazion e esistente riguardo al con dom inio italo-egiziano a Massaua. Nel nove mbre dello stesso anno il comando del corpo di spedizione fu ass unto dal Generale Genè. pochi giorni dopo, il 2 dicembre, il nuo vo comandante faceva occupare tutti gh uffici e gli edifici pubblici e procedeva al rimpatrio delle truppe e dei fu nzio nari egiziani I soldati indigeni, i famosi ·basci-buzuk"' (in turco ·'teste matte", e rano un corpo di irregolari c reato dai Turc hi al se r vizio del governatore egiziano) che chieser o di prestare servizio sotto bandiera italiana. formarono il prim o nucleo delle truppe co loni a li italiane.
POLITICA DELL'ITALIA NELLO SCIOA

Qualche mese prima dell'occupazione di Massaua, nello Sc ioa era tornato il conte Antonelli, per co ntro llare gli effetti della politica commerciale da lui intrapresa con i trattati da lui st ipulati con Menelik c con l ' Anfari dell' Aussa. Il conte constatò presto che en tr ambi i trattati non avevano avuto la benchè minima applicazione pratica. Le corre nti comme rciali c h e l' Antonelli aveva sperato di dirottare s u Assab erano state invece indirizzate dai Francesi verso i porti di loro dominio.
M e ntre Antonelli cercava di sti molare Menelik all'osservanza dei trattati, giunse nello Scioa la notizia dello sbarco italiano a Ma ssa ua. L' effe tto di tale noti z ia fu no tevo lm en te deleterio per i rapporti co n gli Italia ni. Mc nelik rima se scosso dalla notizia e, ancor più di lui , s i indign ò la regina Taitù s ua mog li e, la quale non na scose il s uo odio per g li It a li an i c he a suo g iudi zio compromettevano l 'avve nire d e l paese. Int orno alla regina Taitù si radunò un g rupp o di seguaci animati anc h 'ess i dall 'o dio per g li in vasor i bianchi. Tale gruppo fu chiamato · ' Il partito del Tig rè".
D e i freddi rapporti c he da allora c ircondarono l' Antonell i. approfittarono i Francesi c he, presso la corte di Menelik, s parse ro tutta una se rie di notiL.ie perlopiù false, a tte a scred itare L"incaricato italiano. Come no n ba ta s e, i Fran cesi continuarono a forni re armi allo Scioa. cosa c he se anche sembra assurda fecero anc he gli Italiani , cercando così di riguadagnare la fiducia perduta.
Me ne l ik intanto co ntinua va la s ua politi ca di espansione ad ovest. ben co nscio delle difficoltà in cui s i trovava il Negus Johann es occupato a fronteggiare le mosse italiane. Il ras dello Scioa ricominci ò a sobillare le popolazioni degli Uollo Galla c he a ttualm ente non era no più so tto il suo dominio. Verso la fine d e l 1885 il Negus, che sapeva benissimo che le rivolte era no provocate daMenelik , gli impose, per co mprometterlo agli occhi dei rivoltosi, di inviare un co ntingente di s uoi armati per dom are g li in sort i. Me nelik obbedì, mandando ne i primi mesi del 1886 un corpo sc ioano che si -15-
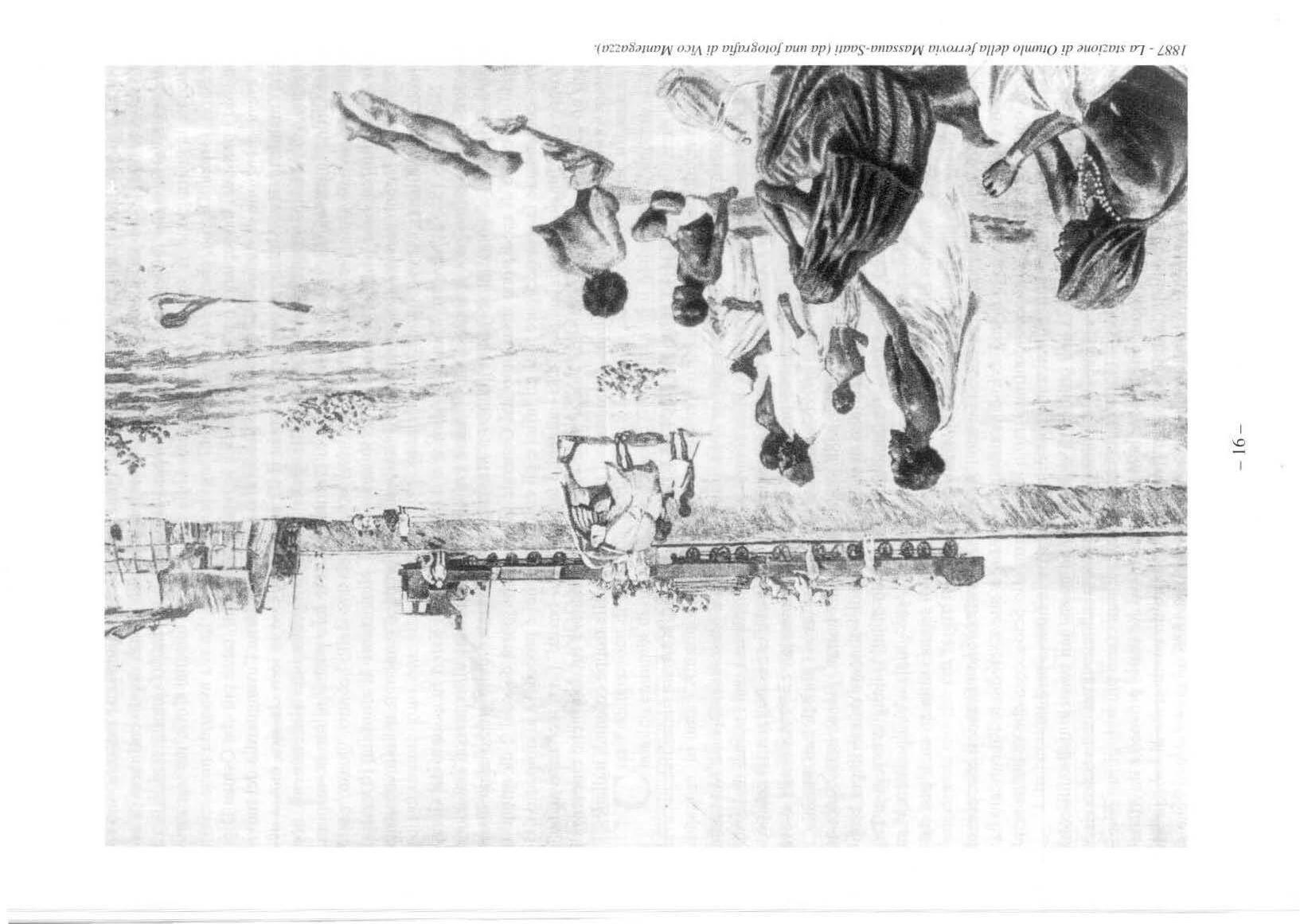
16-
congiunse co n quello tigrino. Non mancarono scontri tra i due ese rci ti , tant o c he si temette per una guerra tra "all ea ti' ' .
Il Negus era ancora ne ll o Uo ll o quando il governo italiano, secondo le promesse fatte nel marzo pre cedente dal Capita no Ferrari, g li inviò una mi ss ion e ufficiale per co nfermare g li impegni presi e s tabilire con l ' Abi ss inia rapporti di fiducia e co ll abo raz io ne. La mi ss ione e ra g uidata dal General e P ozzoli ni e dal Dottor Nerazzini. Ques t'ultim o precedette a n z i la missione recandosi d a ra s Alu la per co nco rdare con lui le modalità dell'incontro, con. eg na nd og li inoltre un messaggio di preavviso per l'Imp e ratore Joh a nn es si li mitò ad incaricare ra A lul a d i co muni care verba lm e n te agli It alian i il pe rme sso di raggiun ge rl o. Ta le a tteggiam e n to rite nut o arrogan te dagli It ali ani e le so li te r azzie di ras Alu la a danno di ge nti o tt o protezione it a li ana, risolsero il Generale Pozzoli ni a rinunciare all'in co ntro . Il che aumentò la diffidenza dell ' Imp era tore. Qu esti si lamentò co n gli In g lesi c he il trattato H ewe tt non e ra s tato ri spettato. Quasi neg li stess i g io rni una parte delle truppe italian e venne reimb arcata per l ' It a li a. Il rit iro di tali truppe fu una mo ssa imprudente , viste le co ntinue incursio ni degli uomini di ra s Alula. Il Coma ndo decise co munqu e di allargare l a ce rc hi a d eg li avamposti c he e ra no troppo vicini a M assa ua e fece occupare Saati. Nel settembre 1 886 un a banda proveniente dall' Aussa al co man do di Debeb, c ugi no di J o hann es, s i sco ntrò con le trupp e it a li ane c he pre sidiava no Z ul a. TI Gen e ra l e Genè a nove mbre o rdin ò di occupare Ua -à, a ci rca quaranta chi lom etri a sud di Massaua. co n lo sco po di proteggere le carova ne c he da ll' altop ian o affluivano ai porti di con trollo italiano . In questo mod o me ntre si diminuivano le truppe si creava no negli Abissini nuovi sospetti sulle m osse italiane.
L'ECCIDIO DELLA SPEDIZIONE PORRO
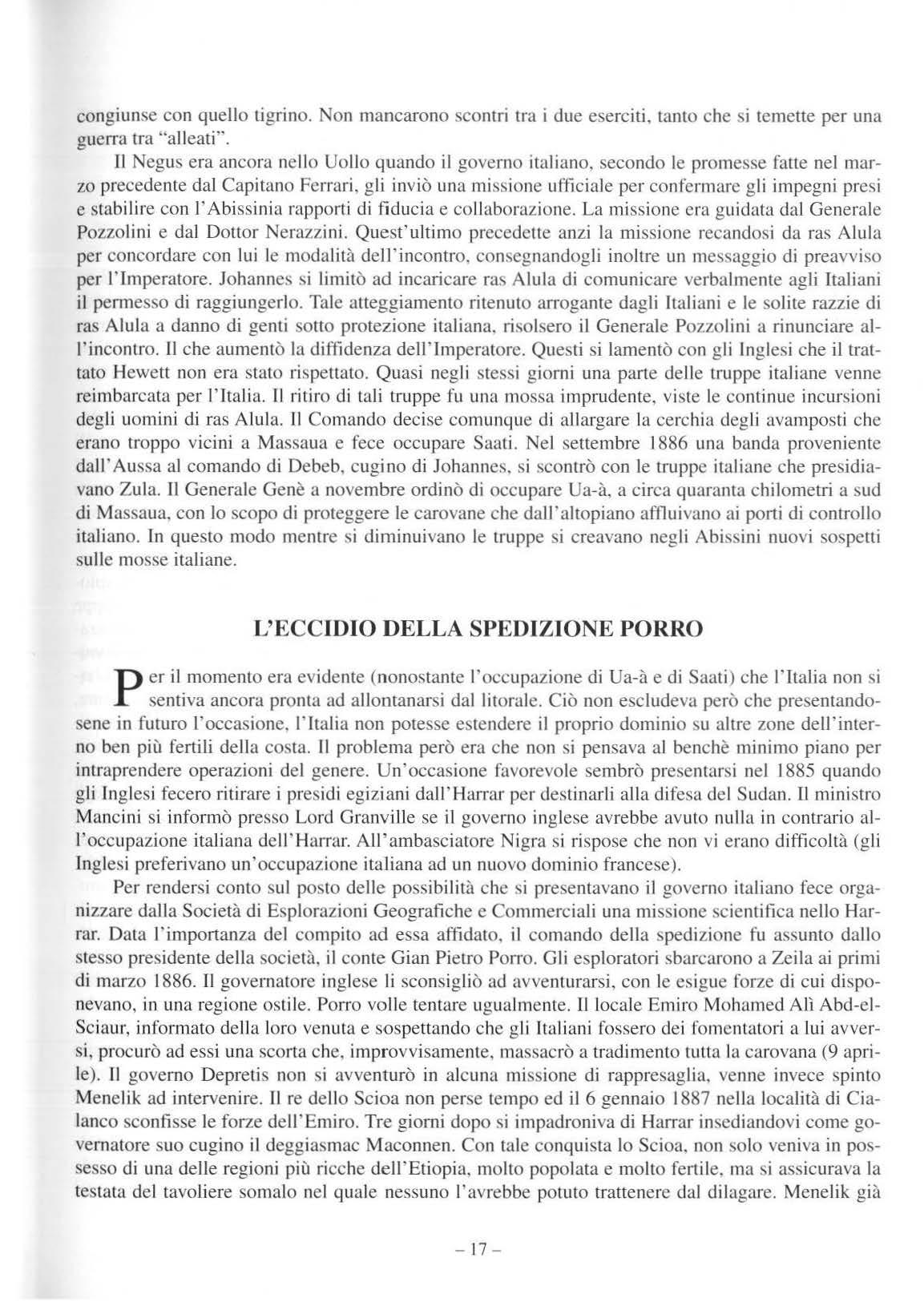
Per il momento era ev id e nte ( n onostante l 'occupaz ione di U a-à e di Saat i ) che l'Italia non si se nti va ancora pronta ad a ll ontanarsi dal litorale. C iò no n esclu d eva pe rò c he presentandosene in futuro l' occasione, l'Ita li a no n potesse estendere i l p ro pri o domin io su altre zone dell' interno be n più fertili dell a costa. Il proble ma però era che non si pensava a l benchè minimo piano per intr a pre nd e re operazion i del ge ne re Un'occa s ion e favorevole se mbrò presentarsi ne l 1885 quando gli I ngl es i fecero ritirare i presidi eg i z iani daii'H a rra r pe r destinarli alla difesa del Sudan. Il ministro Man c ini si inform ò presso Lord Granville se il governo in g lese avrebbe avuto nulla in contrario all' occupazione italiana de li ' H arrar. AH' ambasciatore N ig ra s i ri s po se c he n o n vi era no difficoltà (g li In g lesi preferivano un 'occ up az io ne italiana ad un nu ovo dominio france se)
Pe r re nd e rs i conto s ul po to d e ll e poss ibilità c he si presentavano il gove rn o italiano fece organi zzare dalla Soci e t à di Esplorazioni Geografich e e Com mercial i un a mi ssio ne scie ntifi ca nell o H arrar. Data l'importanza d e l co mpit o ad e ss a affidato, il co mand o dell a spedizione f u assu nt o dallo s te sso pres idente della soc ietà, il co nte Gian Pi etro Porro. Gli esplo ratori sbarca ro no a Zeila ai primi di marzo 1886. Il governatore ingle se li sconsigliò ad avve nturarsi, con l e es ig ue forze di cui di s p onev a no, in una regione os til e. Porro volle tentare ug ualm e nte. Il loc a le Emiro M ohamed Alì Abd -eiSciaur, informato della loro venuta e sos pettando c he g li Italiani fossero dei fom e ntatori a lui avvers i, procurò ad essi una sco rta c he, improvvi sa mente , ma ssac rò a tradjmento tulta la carova na (9 a prile). Il gove rno D epr etis non s i avventurò in alcuna mi ssio ne di rappre sag li a, ve nn e in vece sp int o M e nelik a d intervenire. Il re de ll o Scioa non pe rse te mp o ed il 6 gennaio 1887 ne ll a lo ca lità di Cialan co sconfi sse le forz e dell'Emiro. Tre giorni dopo si impadroni va di Harra r in sed iand ov i come gove rnatore s uo c u gino il deggiasmac Maconnen. Con tale co nqui sta lo S c i oa, no n so lo ve ni va in posse so di una delle regioni più ricche dell ' Etiopi a, molto popol a ta e molto ferti le . m a si assicurava la testata del tavoliere so mal o ne l quale ne ss uno l 'av re bb e potuto trattenere dal dil agare . Menelik g ià
- 17 -
da tempo compiva spedizioni tra gli Arussi razziando molte mandrie di bestiame. L'ultima di tali scorrerie risaliva al 1886. Da Harrar le spedizioni si ripeterono fino a quando quelle popolazioni non furono del tutto assoggettate nel 1895.
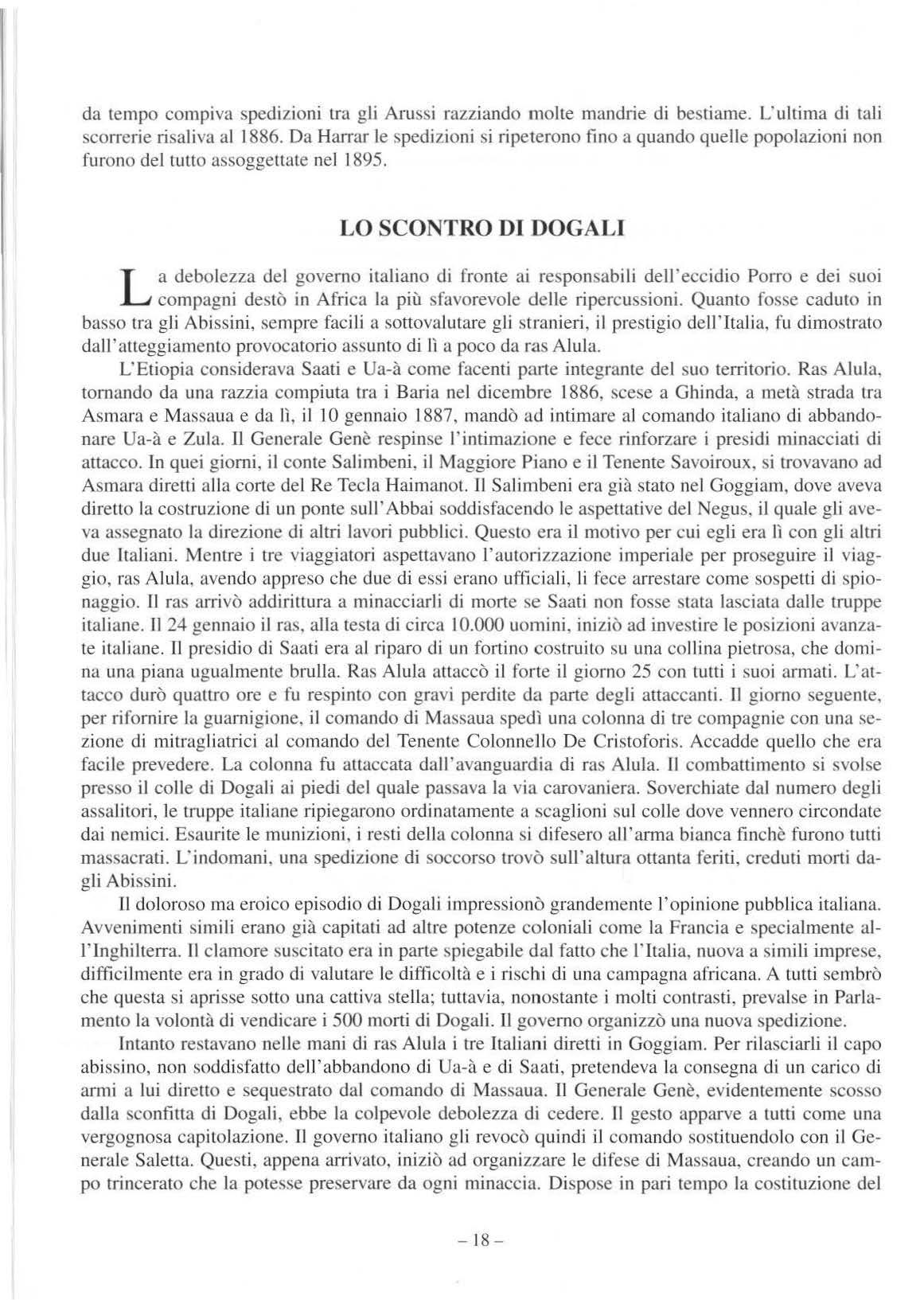
LO SCONTRO DI DOGALI
La debolezza del governo italiano di fronte ai responsabili dell'eccidio Porro e dei uoi compagni destò in Africa la più sfavorevole delle ripercussioni. Quanto fosse caduto in basso tra gli Abissini, sempre facili a sottova lutare gli stranieri, il prestigio dell'Italia, fu dimostrato dall'atteggiamento provocatorio assunto di lì a poco da ras Alula.
L'Etiopia co nsiderava Saati e Ua-à come facenti parte integrante del suo territorio. Ras Alu la, tornando da una razzia compiuta tra i Bari a nel dicembre 1886, scese a Ghinda, a metà strada tra Asmara e Mas saua e da lì, il 10 gennaio 1887, mandò ad intimare a l comando italiano di abbandonare Ua-à e Zula. n Generale Genè respinse l'intimazione e fece rinforzare i presidi minacciati di attacco. In quei giorni, il conte Salimbeni, il Maggiore Piano e il Tenente Savoiroux, si trovavano ad Asmara diretti a ll a corte del Re Tecla Haimanot. Il Salimbeni era già stato nel Goggiam, dove aveva dirello la costruzione di un ponte s ull'Abb ai oddisfacendo le aspettat ive del Negus. il quale gli aveva as egnato la direzione di altri lavori pubblici. Questo era il motivo per cui egl i e ra lì con g li altri due Italiani. Mentre i tre viaggiatori aspettavano l'autorizzazione imperiale per proseguire il viaggio, ras Alula, aven do appreso che due di essi era no ufficiali, li fece arrestare come sospett i di spionaggio. li ras arrivò addirittura a minacciarli di morte e Saati non fosse stata lasciata dalle truppe italiane. Il 24 gennaio il ras, alla testa di circa l 0.000 uomini, iniziò ad investire le posizioni avanzate itali ane Il presidio di Saati era a l riparo di un fortino costruito su una co llina pietrosa, che domina una piana ugualmente brulla. Ras Alula attaccò il forte il giorno 25 con tutti i suoi arn1ati. L'attacco durò quatrro o re e fu respinto con gravi perdite da parte degli attaccanti. Il giorno seguente, per rifornire la g uarnigione, il comando di Massaua spedì una colonna di tre compagnie con una sezione di mitragliatrici al coman do del Tenent e Colonnello De Cristoforis. Accadde quello che era facile prevedere. La colonna fu attaccata dall'avanguardia di r as Alula. Il combattimento si svolse presso il co ll e di Dogali ai piedi del quale passava la via carovan iera. Soverchiare dal numero deg li assalitori, le truppe italiane ripiegarono ordinatamente a scaglioni su l colle dove vennero circondate dai nemici. Esaurite le munizioni, i resti della colonna si difesero all'arma bianca finchè furono tutti ma aerati. L'ind omani, una spediz io ne di soccorso trovò su ll 'altura ottanta feriti, c reduti morti dagli Abissini.
Il doloro so ma eroico episod io di Dogali impressionò grandemente l 'op inione pubblica italiana. Avvenimenti simili erano già capitati ad altre potenze co loniali come la Francia e specialmente all'Inghilterra. Il clamore susc itato era in parte spiegab il e dal fatto c he l'Italia, nuova a sim ili imprese, difficilmente era in grado di valutare le difficoltà e i ri sch i di una ca mpagna africa na. A tutti se mbrò che questa si aprisse sotto una cattiva ste lla; tuttavia, nonostante i molti contrasti, prevalse in P arlamento la volontà di vendicare i 500 morti di Dogali. Il governo organizzò una nuova spedizione. Int anto restavano nelle mani di ras Alula i tre Itali a ni diretti in Goggiam. Per rilasciarli il capo abissino, non sod disfatto dell'abbandono di Ua-à e di Saati, prete ndeva la consegna di un carico di armi a lui diretto e seque trato dal comando di Massaua. n Generale Genè, evidentemente scosso dalla confitta di Dog a li , ebbe la colpevole debo lezza di cedere. Il gesto apparve a tutti come una vergognosa capitolazione. Il governo italiano g li revo cò quindi il comando sostituendo lo con il Generale Saletta. Questi, a pp e na anivato, ini ziò ad organizzare le difese di Massaua, creando un campo trincerato che la potesse preservare da ogni minaccia. Dispose in pari tempo la co tituzione del
-18 -
primo corpo di truppe indigene. La risolutezza ed il prestigio del nuovo comandante ebbero subito un primo effetto, con la sottomissione di Debeb c della sua banda di Assaortini.
In Italia nell'aprile di quell'anno il gabinetto Depretis si rico tituì con la partecipazione di Crispi quale mini tro dell'interno. Non erano passati sei mesi che Crispi assunse la Preside nza del Consiglio. Il nuovo governo, ottenuti altri fondi dal Parlamento, aumentò le truppe prese nti in Massaua a 20.000 uomini. Di fronte all'entità delle forze italiane, che dimo st ravano il ch iaro proposito di rivincita, era da aspettarsi che in aiuto di ras Alula sarebbero scesi in campo gli armati dell'Imperatore Johann es. Questi tuttavia, prima di dar inizio a ll e ostilità, volle tentare un accordo per via diplomatica. Scrisse qui ndi alla Regina Vittoria lam entando il comportamento aggressivo degli rtali ani. Il governo britannico propose un tentativo di mediazione. L'Italia accondiscese, a patto di ricevere un'adeguata riparazione. Il gabinetto di Londra incaricò della difficile trattativa Sir Gerald Portai, segre tario dell'Alto Commissario in Egitto Sir Evelyn Baring, divenuto poi L ord Cromer. Il 25 dicembre Sir Portai rit ornò dalla sua vmsita a l Negus con un nulla di fatto. J ohannes, istigato da ra s Alula, aveva ritiutato ogni soddisfazio ne e s i preparava alla gue rra. Il governo italiano, ritenendo che l'entità del corpo di spedizione concentrato a Massaua richiedesse la presenza di un ufficiale superiore in grado a l Saletta. mandò ad assumere il comando il Generale Asinari di San Marzano. Egli ri cevette l'ordine di ri occupare Ua-à e Saati.
SAATI VIENE RIOCCUPATA
La spedizione di San Marzano fu l'inizio di un metodo d i guerra, che rimase più o meno lo stesso per tutta la durata della prima campagna d'Africa. Dando per sconta to che l a sproporzione delle forze tra It a li ani ed Abissini non pennetteva ai primi di imporre all'avversario la propria iniziativa affrontando li in campo aperto, il comando italiano si accontentò inizialmente di occupare una posizione, fortificandola e aspettando che il nemico venisse a logorarv isi contro. Se gli It aLiani difettavano di truppe, gli Abissi ni mancavano di artiglierie e di rifornimenti: erano quindi nell'impossibilità di con durre delle lunghe guerre di posizione. Con eguenza di que ro s istema di lotta e ra impedire ad en trambi gli avversari di darsi dei colpi risolutivi. Fu questa la ragione principale per cui la prima campagna d'Africa durò dodici anni.
Il Generale di San Mar zano ne l proced e re alla rioccupazione di Saati agì con una prudenza che non fu esente da crit iche. Il grosso deHe truppe avanzò a piccoli sba lz i, trincerandosi so lidamente ad og ni fermata. Per agevolare i rifornimenti venne costruita, mano a mano che le truppe avanzavano, una ferrovia a scartamen to ridotto. In questo modo in quattro mesi fu coperto il tragitto di trenta chilometri da Massaua a Saati. Verso la metà di marzo del 1888 il corpo di spedizione era tutto concentrato s ulle nuove posizioni. Subito s i iniziò a costru ire un poderoso campo trincerato. Tr ascorsero appena pochi giorni dall'arrivo degli Italiani a Saati che dall 'a ltipiano calò l 'ese rcito di Johann cs forte di 80.000 uomini accampandosi nella piana di Sabargurna. Gli ava mpo sti dei due contendenti vennero presto a contatto. Questo bastò perché il capobanda Dcbeb passasse dalla parte abissina. Il Negus ordinò agli Ita liani di sgomberare. n coma ndo rispose esigendo a titolo di riparazione l a conseg na di Ailet, di Ghinda e dei territori fino al margine dei monti. La co nsistenza delle forze italiane convinse J oha nnes c he un attacco poteva essere seonsigliab il e. Egli cercò inva no con piccole sca ramucce di avamposti di attirare fuori delle difes e le truppe italiane, come era riu scito a fare nel 187 6 a Gura con gli Egiziani. In pochi giorni la scarsezza di acqua, le e pid emie c he cominciarono a diffondersi in qu e ll a massa di uomini, lo scor agg iamento e le defezioni che ne segu irono, obbligarono Johannes a rinunciare all'impre a. Per mascherare il ritiro, iniziò, secondo l a tradizione abiss in a, trattative di pace. Mentre occupava in tal modo gli It aliani, con gra nd e rapidità riportò il grosso del
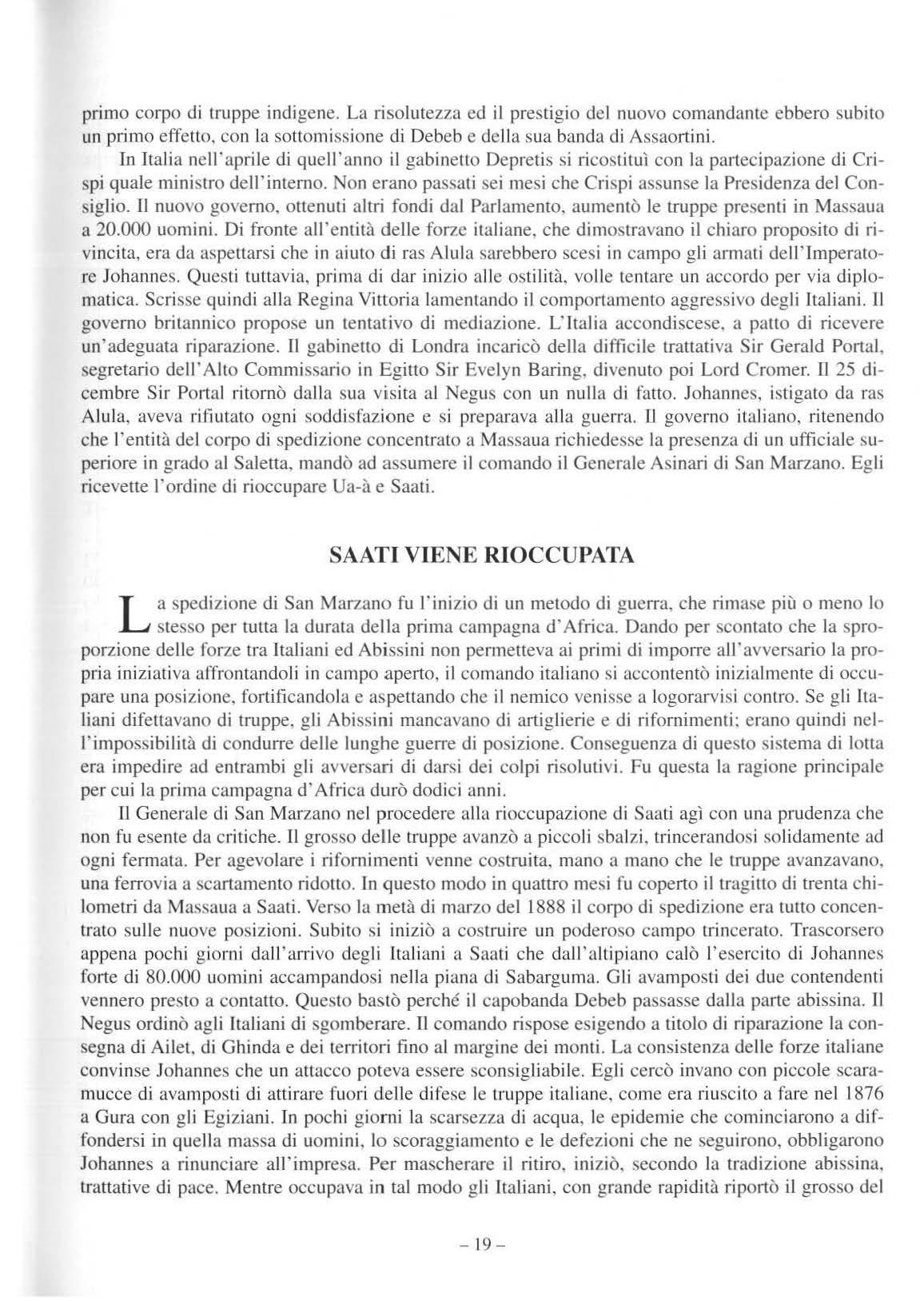
- 19 -
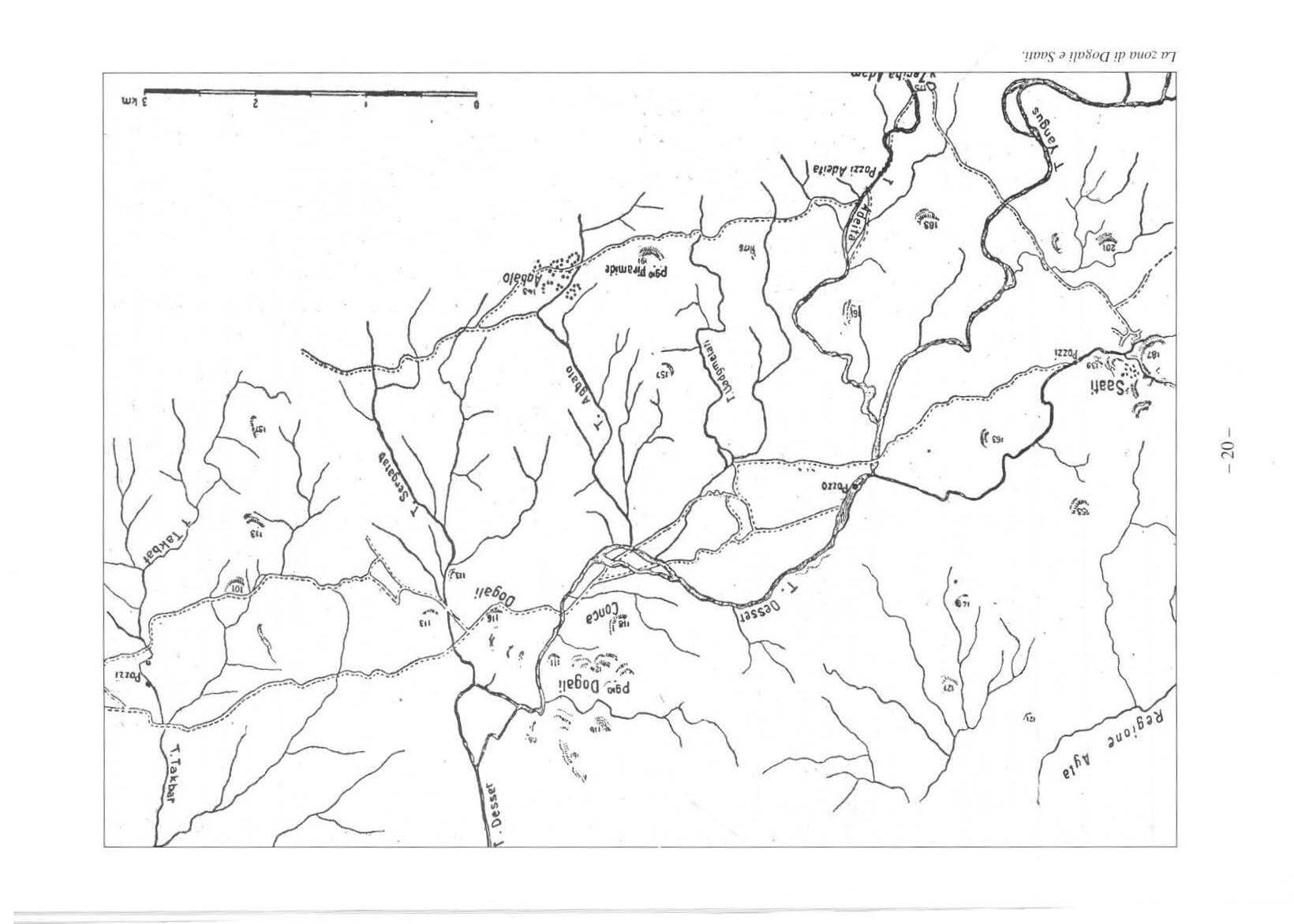
20 -
suo e ercito sull'altipiano, lasciando davanti alle posi.lioni italiane un ve lo di truppe. Quando il comando italiano si accorse del movimento, pensò c he si trattasse di una manovra avversaria per costringerlo fuori delle difese e farlo cadere in un'imboscata, e per questo non s i mosse. Svanì così la possibilità di vittoria dell' Imperatore.
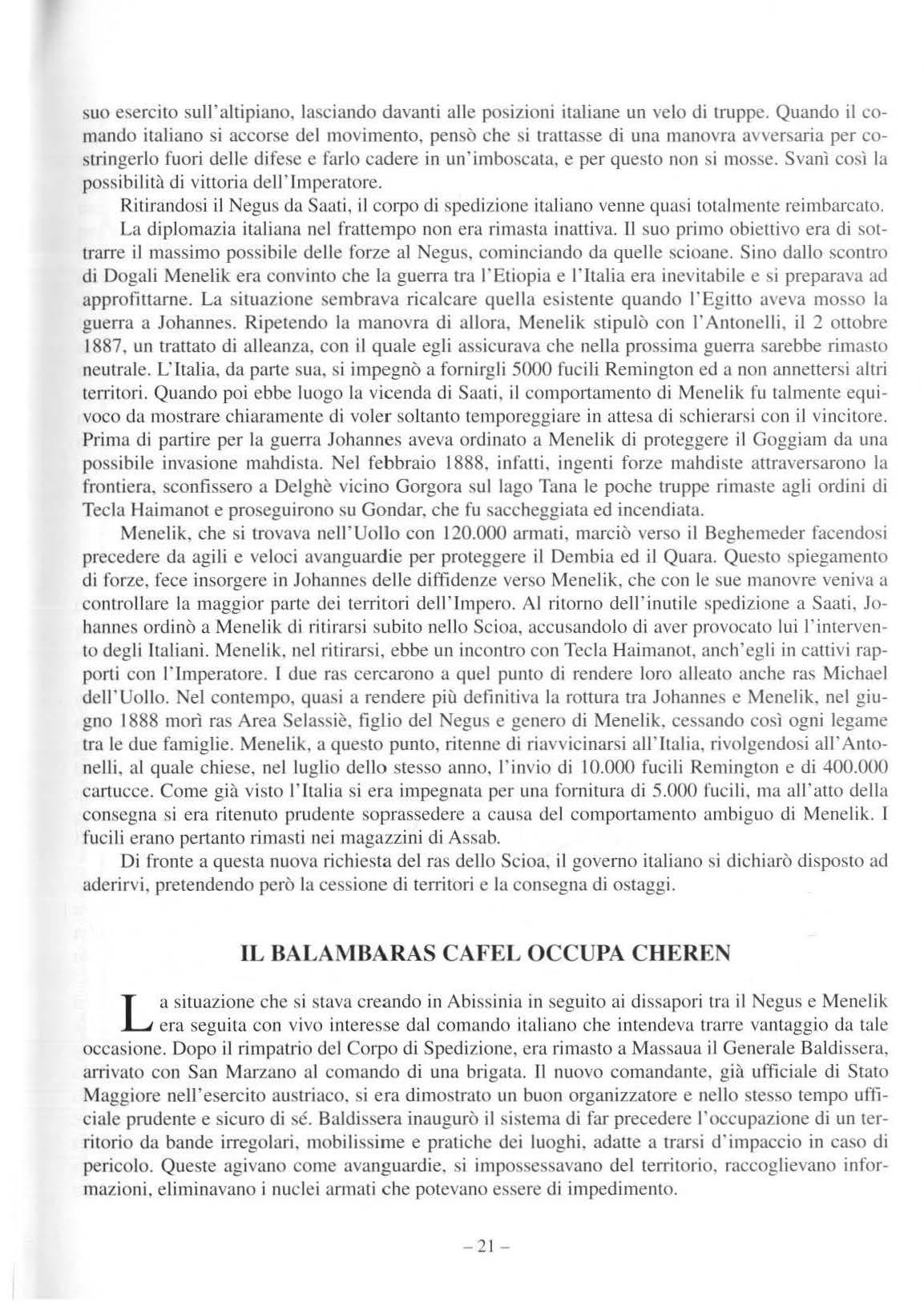
R itirandos i i l Negus da Saati, il corpo di spedizione ita l iano venne qua si totalmente reimbarcato.
La dipJomazia italiana nel frattempo non era rimasta inattiva. H suo primo obiettivo era di sottr arre il massimo possibile delle forze al Negus, cominciando da quelle scioane. Sino dallo scontro di DogaJi Menelik era convinto che la guerra tra r Etiopia e l'Italia era inevitabile e si preparava ad app rofittarne. La s ituazione se mbrava ricalcare quella es iste nte quando l'Egitto aveva mosso la guerra a Johannes. Ripetendo la manovra di allora, Menelik st ipulò con l' Antonclli, il 2 ottobre 1887, un trattato di alleanza, con il quale egli assicurava che nella prossima gueJTa sarebbe rimasto neutra le. L'Italia, da parte sua, s i impegnò a fornirgli 5000 fucili Remington ed a non annettersi altri territori. Quando poi ebbe luogo la vicenda di Saati, il comp011amento di Men e lik fu talmente eq uivoco da mostrare chiarame n te di voler soltanto temporeggiare in attesa di schierarsi con il vincitore. Prima di partire per la guerra J ohannes aveva ordinato a Menelik di proteggere il Goggiam da una poss ibile invasione mahdi s ta. Nel febbraio 1888. infatti, ingenti forze mahdi ste attraversarono la frontiera, sconfissero a Del g hè vicino Gorgora s ul lago Tana le poche truppe rimaste agli ordini di Tecla Haimanot e pro eguirono s u Gondar, che fu sacc hegg iata ed incendiata.
Menelik, che si t rovava ncli'Uollo con 120.000 armati, marciò ve rso il Bcghemeder facendosi precedere da agili e veloci avanguardie per proteggere il Dembia ed il Quara. Questo spiegamento di forze , fece insorgere in Johannes delle diffidenze verso Menelik. che con le s ue manovre veniva a contro ll are la maggior parte dei territori dell ' Impero. Al ritorno dell'inutile spedizione a Saati, J ohannes ordinò a Menelik di ritirarsi subito nello Scioa, accusandolo di aver provocato lui l'intervento degli Italiani. Menelik, nel ritirarsi, ebbe un incontro con Tecla Haimanot , anch'egli in cattivi rapporti con l'Imperatore. l due ras cercarono a quel punto di rendere loro alleato anche ra. Michael dcii'Uollo. Nel contempo, qua si a rendere più definitiva la rottura tra J ohan nes e Menelik, nel giugno 1888 morì ras Area Sclassiè, figlio del Negus e genero di Menelik. cessando così ogni legame tra le due famiglie. Menel i k, a que s to punto, ritenn e di riavvicinarsi all'Italia, rivolgendosi all' An tonelli , al quale chiese. nel luglio dello stesso anno, l'invio di 10.000 fucili R emi ngton e di 400.000 ca rtucce. Come già visto I' l talia si era impegnata per una fornitura di 5.000 l'ucili, ma all'atto del1a co nsegna si era Iitenuto prudente soprassedere a causa de l comportamento ambiguo di Menelik. I fucili erano pertanto rima st i nei magazzini d i Assab. Di fronte a questa nuova rich iesta de l ras dello Scioa, il governo italiano s i dichiarò disposto ad ader irvi, pretendendo però la cessione di territori e la consegna di ostaggi.
IL BALAMBARAS CAFE L OCC U PA CHER EN
La situazione che s i stava creando in Abissinia in seguito ai dissapori tra il Negus e Menelik e ra segu ita con vivo i nteresse da l comando ita li ano che in tendeva trarre van taggio da tale occasione. D opo i1 rimpatrio del Corpo di Spedizione , era r i masto a Massaua il Generale Baldissera, arr i vato con San Marzano al comando di una brigata. Il nuovo comandante, già ufficiale di Stato Maggiore nell'esercito aust r iaco. si era dimostrato un buon organizzatore e nello stesso tempo ufficiale prudente e s i cu ro di sé. Baldi ssera inaugurò il di far precedere l 'occupazione di un territorio da bande irregolari. mobili ss ime e pratiche dei luoghi. adatte a trarsi d"impaccio in caso di pericolo. Queste agivano come avanguardie, s i impo ssessava no del territorio. raccoglievano informazioni, eliminavano i nucl e i armat i che potevano essere di impedimento.
- 21 -

-22 -
Baldissera si servì, a tale scopo, di Debeb, ancora incetto se schierarsi con gli Italiani o con il Tigrè, e in special modo utilizzò il balambaras Cafel (Balambaras: "capo dei cavalieri armati di corazza ") . Costui era un capo tigrino, acerrimo nemico di ras Alula , molto ambizioso ed intrigante. Dai primi tempi dell'occupazione italia na Cafel si era rifugiato a Massaua, chiedendo insi stentemente al comando italiano di poter prendere parte ad operazioni militari. Baldissera si se rv1 di lui per togliere a ras Alula il possesso dì Cheren e dei Bogos. Il comando italiano dava a Cheren un'importanza strategica forse superiore a quella stessa di Asmara. L'o perazione riuscì pienamente e senza grandi difficoltà. CafeJ nel luglio 1888 si stabiliva, in nome del Governo Italiano nel forte d i Cheren e ne assumeva il controllo. Baldissera nello stesso tempo intraprendeva trattative con Debeb, che si era impadronito dell' Acchelè Guzai, per cercare di farne un alleato. Le offerte italiane vennero però respinte, anzi, Debeb iniziò delle razzie ai danni di tribLJ sottomesse ali ' Italia. Gli fu mandata contro una colonna di 400 ascari al comando del Capitano Cornacchia che avrebbe dovuto piombare di sorpresa su Saganeiti. Debeb era riuscito invece a prevenire gli Italiani: la colonna di ascari, circondata da forze soverchianti, fu sterminata per i due terzi 1'8 agosto 1888. Perirono anche tutti gli ufficiali.
LA B AT TAGLIA DI M E T EMMA E LA MORTE DEL NEGUS
Il Negus Johannes , tornando dalla spedizione di Saati , trovò una coalizione dei maggiori feudatari contro di lui. Come spesso era successo in passato, mentre il Negus era impegnato contro un nemico esterno, la compagine dell'Impero s i sgretolava. Johannes iniziò la sua rappresaglia attaccando il Goggiam , abbandonato al saccheggio delle sue milizie. Tecla Haimanot fuggì e si asserragliò sui monti.
Attraversato il Goggiam, il Negus puntò sullo Scioa, .tisoluto a farla finita con Menelik. Questi, mentre chiamava a sé le sue bande, faceva pressioni sul governo italiano affinchè intensificasse le operazioni militari occupando Asmara. Nonostante Menelik si dimostrasse ben risoluto nei s uoi propositi, gli Italiani ritenevano che prima di approdare ad uno scontro decisivo il re dello Scioa si sarebbe per l'ennesima volta sottomesso al Negus. Per questo motivo gli Italiani , diffidando delle intenzioni di Menelik, non intrapresero operazioni militari suU'altipiano finchè non lo videro impegnato in guerra. Nel gennaio 1889 Crispi inviò a Baldissera l'ordine di effettuare una 1icognizione su Asmara. ll movimento fu però sospeso visto che lo Scìoa era ancora incerto se battersi o sottomettersi.

Nel frattempo il Negus era aiTivato ad Ammù sull'Abbai e si accingeva ad attraversare il fiume, quando improvvisamente tornò sui suoi passi dirigendosi verso la frontiera occidentale. Johannes aveva saputo che ingenti forze mahdiste si stavano radunando sull' Atbara, e temeva dunque di essere preso alle spalle mentre era nello Scioa. Menelik, appena apprese della ritirata del l'Imperatore, si recò nello Uollo, e prese nuovamente possesso della regione.
Il IO marzo 1889 il Negus, alla testa di 100 000 guer rieri , si trovava sulla destra dell'Atbara di fronte a Gall abat. Una fitta nebbia occultava ai due eserdti le rispettive posizioni. Appena la nebbia si diradò iniziò una furiosa battaglia, resa ancor più aspra dal fanatismo religioso di entrambi gli schieramenti. Quando già le sorti dello scontro volgevano in favore del Negus, Johannes, sceso da cavallo, andò in prima linea per combattere al fianco dei suoi armati. Appena giunto, un colpo di fucile lo colpì mortalmente. Traspor1ato nella sua tenda, dichiarò ai presenti che Mangascià, ras dello Scirè, era suo figlio, nato, a quanto sembra, dalla moglie di suo fratello durante l'assenza di quest'ultimo. A ras Alula, a lui molto devoto, raccomandò di occuparsi di Mangascià e di sostenere i suoi diritti al trono. La salma dell'Imperatore fu deposta in una bara per riportarla nel Tigrè. La notizia della sua motte aveva gettato il panico tra le truppe tigrine e ne aveva provocato lo sbandan1en-
- 23 -
to Nonostante un g rup po di fede li ss im i ten tasse di p roteggere la sa lm a di J ohannes,il feretro fu preso dai mahdi s ti , la salma fu decap itata e la tes ta portata co m e trofeo di vittor ia al califa.
I PRELIMINA RI D EL T RATTATO D I UCC IALL I
App ena s i diffu se in Abiss inia la not i z ia dell a morte di J o h a nn es, Menelik si autop roclamò Imp e ratore . Ciò avveniva a l termin e di una st rategia politi ca co nd otta co n ogni meuo, pur di raggi un ge re l 'o bi ettivo de s id e rato. Menelik s i trovava n e li ' Uollo con un eserc ito di 120.000 uom ini, cos titu e nd o l 'ese rc ito più potente dell'Etiopia. Tu tt i i ra s s i affrettaro no a ri co nosce rl o come Impe ra tore, tranne r as M a ngascià e ras Alula. nTigrè s i preparava a co ntende re a ll o Scioa l a corona imp eria le. Nello sco ntro c he stava per iniziare tra le du e e tni e rapporto del rit alia a favo re o cont ro una d i esse av reb be avuto una ce rta rilevan za.
Da lla fine del ge nn a io 1889 il co nte Anto ne lli era tornato n e ll o Scioa. A Ro m a aveva sottopo sto a C ri s pi le ri chieste di M e nelik riceve ndo l 'i ncarico di far firm are al ras un tra ttato commerciale preparato da l Mini stero degli E steri , che sa rebbe po i div e nuto il famo o trattato d i Uccialli. L' Anton e lli era s tato inc aricato di chiede re l a cess ione di terr it o ri s u li ' altipiano e l'invio a Rom a di un rapprese nt an te etiopi co.
Mene lik accettò tutt e le richies te. Una vo lta proclarnatosi Imperatore, caldeggiò anim o arnente una presa d i posizione da parte italiana co ntro il Ti g rè, c hi ede nd o l 'occ upazion e di Asmara e una attenta sorveg lianza de ll e mosse di ras Alula e di ra s Ma ngasc ià A questo proposito C ri sp i di ede precise is truzioni a l Generale Ba ldi sse ra, il quale tuttav ia e ra dell ' avvi so ch e fo sse prematuro interve nire tra i due contende nti la sc ia ndo piuttos to che prim a si indebolissero a v icenda, qu indi il ge nerale non si mosse.
ASMA RA E CHE REN VENGON O OCCUPATE
Sin da l febbraio 1889 il co m a ndo italiano serv e ndo s i come già visto di bande a rma te aveva pe rrn es o a D ebeb, c he intanto s i e r a nuovamente so tt omesso, di occ upare A mara, approfittando dell'a e nza di ra Al ul a co r o in aiuto di J oha nn es. L a pri m a mo s a fu p erò ve rso C h ere n. Arrivata la noti zia che il balambaras Cafel, prevedendo i l sopraggiungere delle truppe italiane, aveva ini ziato de ll e trattative co n r as A lula. Il 29 maggio fu inviata una co lonn a agli ordini del M agg iore di M ajo. Il 2 g iugno Cheren fu c ircondata e presa e nz a resiste nza. Cafe l fu arre tato e in v iato nelle carce ri di A ss ab.
Ve rso la fine di l ug l io, g iuns e la notizia c he De beb, recato si a Macall è per un incontro con ras Manga sc ià e ras Alula, era s tato fatto prigioni e ro e confinato nell o Scirè . v ittim a. prob a bilme nte, dei s uoi intrighi doppiogiochi sti. In tal modo , com unqu e . la s tr ad a per Asmara e ra libera. Il 3 agosto infatti, le trupp e italiane v i g iun sero dopo un a ve loc e m a r cia no tturna , alle s te ndo s ubit o un campo tlin ce ra to. Ras Alula, che s i trova va ne li'Enti cc iò, s i port ò in direz i o ne di Gura, ma fu prevenuto d a l Mag g iore di M ajo che occupò il vi ll agg io il 17 seguent e. Ra s A lul a si ritirò qu indi ne l Tigrè , incalzato dagli Ita li a ni . Nei m esi s ucce ss ivi l' occ up az io ne italiana s i e. tese fino al Mareb.
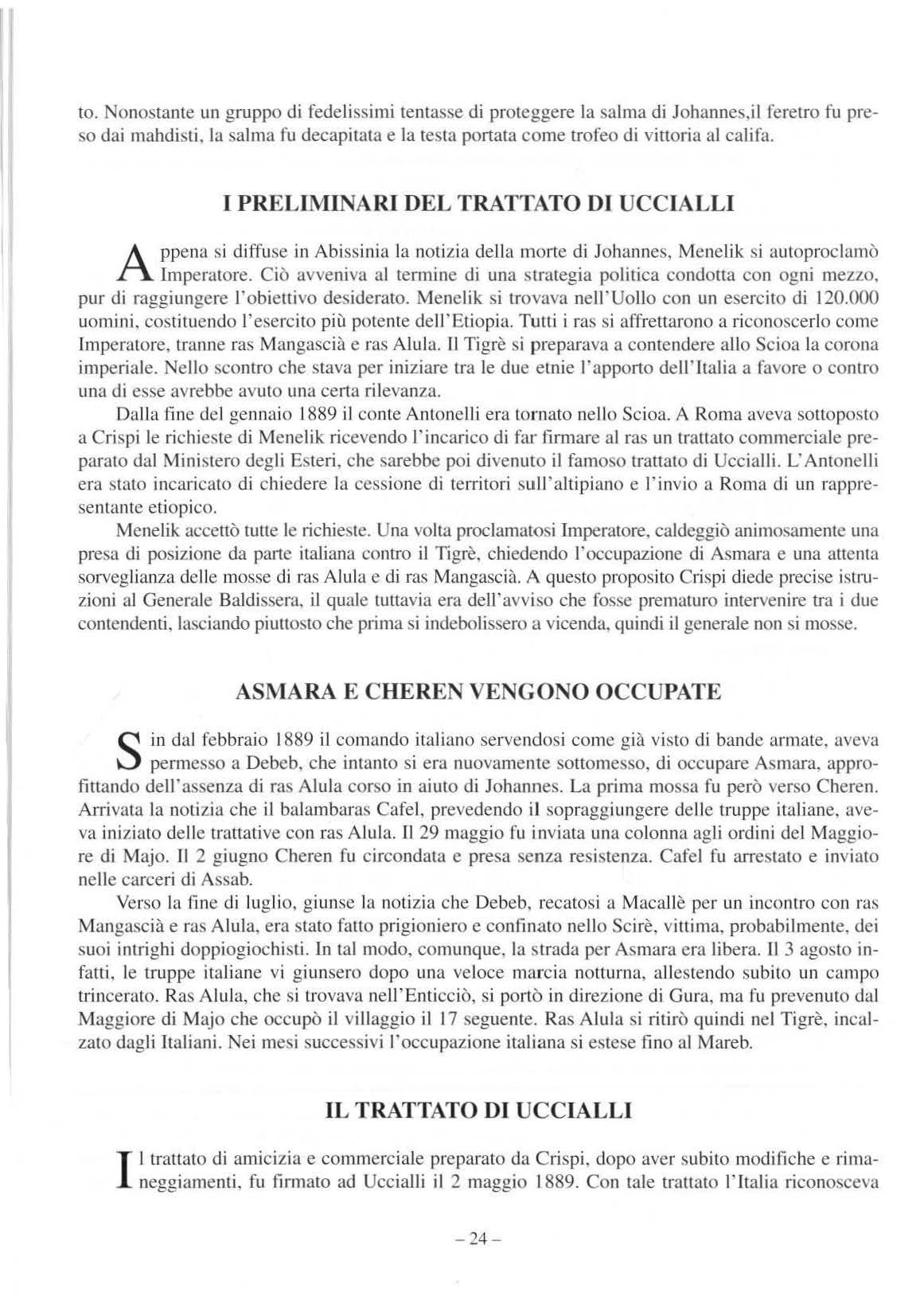
IL TRATTAT O DI UCC IA L LI
Il trattato di amicizia e commerciale preparato d a Crispi , dopo aver s ubit o m od ifi c he e rim aneggiam e nti , fu firmato a d Uccialli il 2 maggi o 1889. Con tale trattato J' [talia rico nosceva
- 24 -
Menelik come Imperatore d'Etiopia. Ciò era quello a cui maggiormente egli teneva. Delle varie clau , o le del trattato due erano particolarmente importanti: l'articolo 3, con il qual e e ra s tabilito che il confine tra i possedimenti italiani e l'Impero etiopico sa rebbe stato tracciato da una commissione mi s ta ed avrebbe incluso nei terr it ori italiani , partendo da Arafali, i centri di Halai , Saganeiti, Asmara, Addi Nefas e Ad Johann es; e l'art icolo 17 del seguente tenore: "Sua Ma es tà il Re dei Re d ' Etiopia consente di servirsi del governo di Sua Maestà il Re d ' Italia per tutte le tratta z ioni di affari che avesse con altre Potenze o governi". Per ottemperare alla richiesta italiana di mand are in Italia una delegazione ufficiale , Menelik incaricò suo cug in o il deggias mac Maconnen di questa incombenza. Il 28 agosto Maconnen venne ricevuto al Quirinal e. Seguendo le is truzioni di M eneli k egli il l o ottobre introdu sse un atto addizionale. In esso, l 'articolo l , il Re d'Italia ricon o ceva esp li citamente il Re Mcnelik Imperatore d'Etiopia. Questi a sua vol ta, nell 'a rticolo 2, riconosceva la sov ranità del Re d'Italia nelle colonie "che vanno sotto il nome di Pos se dimenti italiani nel Mar Ro sso". Particolare importanza, per le contestaz ioni cui dette luogo in seg uito, aveva l'articolo 3 del nuovo atto. Secondo questo, per la definizione dei co nfini , sarebbe s tato preso come base "il possesso attuale". Con l'art ico lo 5, l'Italia concedeva all'Et iop ia un prestito di quattro milioni, attraverso una banca e con la garanzia del governo italiano. Ne l mese di ottobre l' Italia notificò alle pot e nze e uropee l'arti.colo 17 de l trattato. Il 6 novemb re ad Entotto, capitale dello Scioa, r Abuna Math eos incoronò so lennemente Menelik imperatore. Con un decreto reale de l l 0 gennaio 1890 ven ne ufficialmente creata l a Colonia Eritrea.
IL GENERALE ORERO MARCIA SU ADUA
Verso la fine del 1889 il Generale Baldissera la sc iò il comando. sost ituito dal General e Orero. Cris pi aveva incaricato il nuovo co mandant e di fac ili tare a M e ne lik la so ttomis sione del Tigrè. Orero deci se di occ upare Adua per po i farne dono a Menelik in seg no di amicizia e collaborazione. Tale manovra in effett i non era priva di rischi, correndo il ri schio di ottenere un risu ltato contrario all'obiettivo prefi ss ato, visto che la prese nz a italiana oltre i l Mareb s arebbe sta la considerata da molti Abissini come un atto di grave intromissio ne. Il progetto d i muovere con 6000 uomini in una zona ove erano presenti le considerevoli forze di ras Alula e di ra s Mangascià poteva riservare s piacevoli sorp rese. Sbarcato nel frattempo a Massaua il deggiasmac Maconnen accompagnato dall' Antonelli , si recò s ubito dal Gen erale Orero cercando di dissuaderlo dal suo progetto. Tutto fu vano. Orero il 26 genna io con una marcia priva di difficoltà giunse ad Adua per celebrarvi l' anniversario dello sco ntr o di Dogali. ll Capitano To se lli fu inviato con l'avanguardia fino a Macallè. L a presa di Adua fu interpretata dall e ge nti ti grine come l'affermazione della potenza italiana nella reg ione. Fu dunque un duro co ntracco lpo il fatto che dopo pochi giorni le trup pe italiane ripresero la via del Mareb per ordine di Orero, sordo alle ingiunzioni di Crispi che a que sto punto avrebbe voluto trarre dalla marcia in avanti del generale il massimo vantaggio. Ad Adua ve nn e lasciato il Maggiore di Majo con l'incarico di mettere a capo del governo del Tigrè un capo favorevole all'ltalia, Sebhat , proveniente dali'Agamè. Nel frattempo M ene lik si stava avvicinando a Macallè. Da Massaua gli andarono in contro Maconnen e l' Antonelli. Quest i doveva sottoporre alla sua ratifica la conve nzio ne addizionale a l trattato di Uccialli.
Secondo tale convenzione il confine tra l'Eritrea e l'Abi ss inia doveva e se re tracciato in base a l po ssesso italiano effettivo. Ques to, a ttualm ente, era arri va to fino al Mareb; il confine, perciò, pret eso dal governo era la linea del Mareb - Belesa- Muna, l' unica c he desse alla co lon ia dei limiti geog rafici ben definiti e fac ilm ente difendibili. Il nuovo N eg us s i dimostrò sorpreso dalle ri chieste delI'Antonelli ed oppose a ll e proposte i limiti territoriali indicati nel trattato di Uccialli. Cercò di con-

-25 -
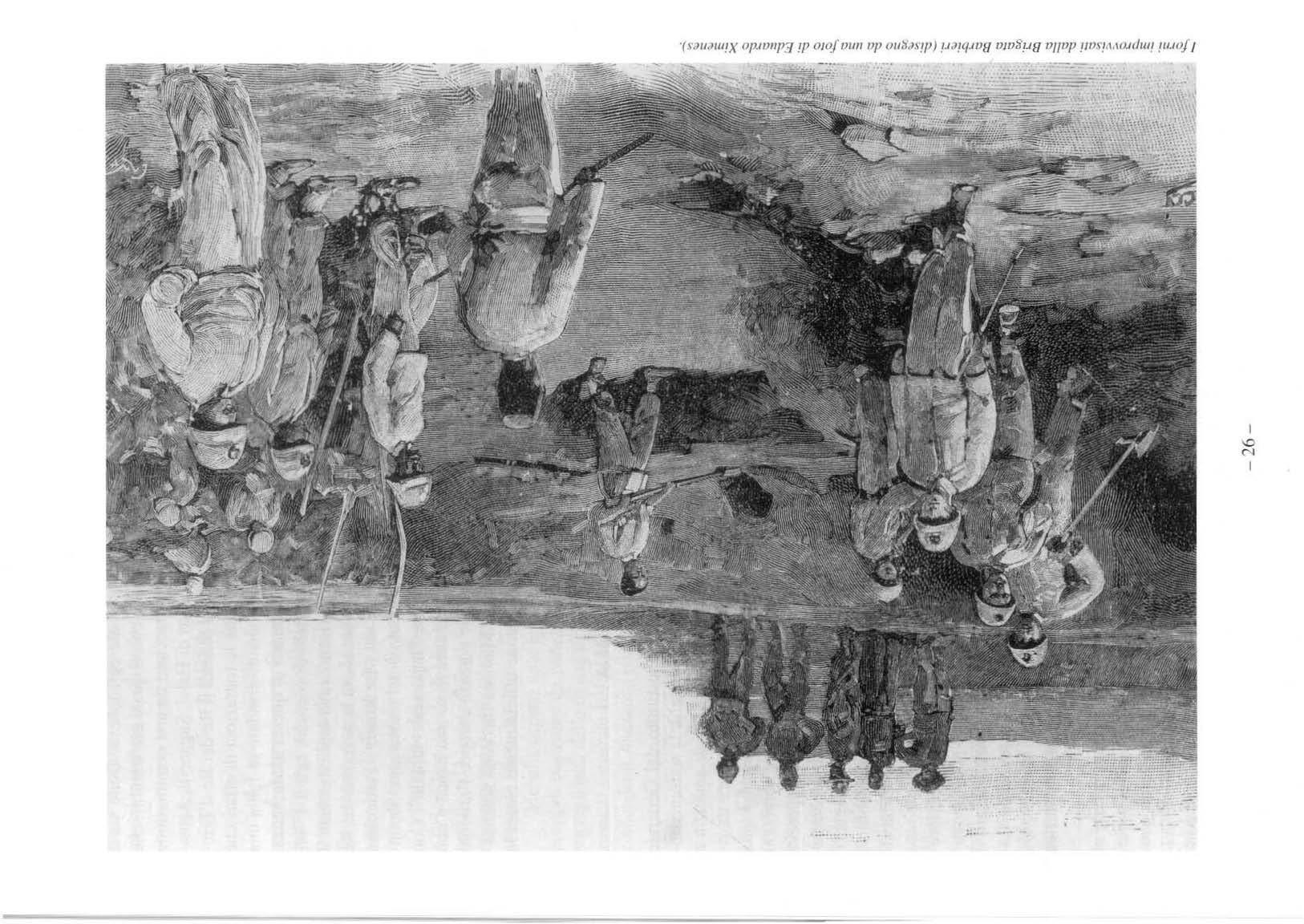
26 -
vincere il delegato italiano che al massimo era disposto a cedere I'Hamasien. Propose quindi come confine la linea H alai-Saganeìtì-Scichet. L'Antonellì accettò. Egli firmò il 20 marzo 1890 una convenzione in cui era stabilito il contìne predetto. Il governo italiano non acceuò tale convenzione. La delimitazione territoriale non ebbe più luogo c la questione rimase insoluta gravando sui rapporti ita io-etiopici.
Menelik. prima di ritornare nello Scioa, incaricò Mesciascià Uorchiè di governare Adua e Axum, lasciò il Tigrè orientale ad uno dei suoi fidi e quello occidentale a ras Mangascià. In tal modo il Tigrè non era in g rado di costituire un pericolo per il nuovo Imperatore.
L' Antonelli. accompagnato dai delegati etiopici con i qual i si dovevano stabilire i nuovi confini, ritornò in Eritrea. Da quel momento iniziarono gli intrighi.
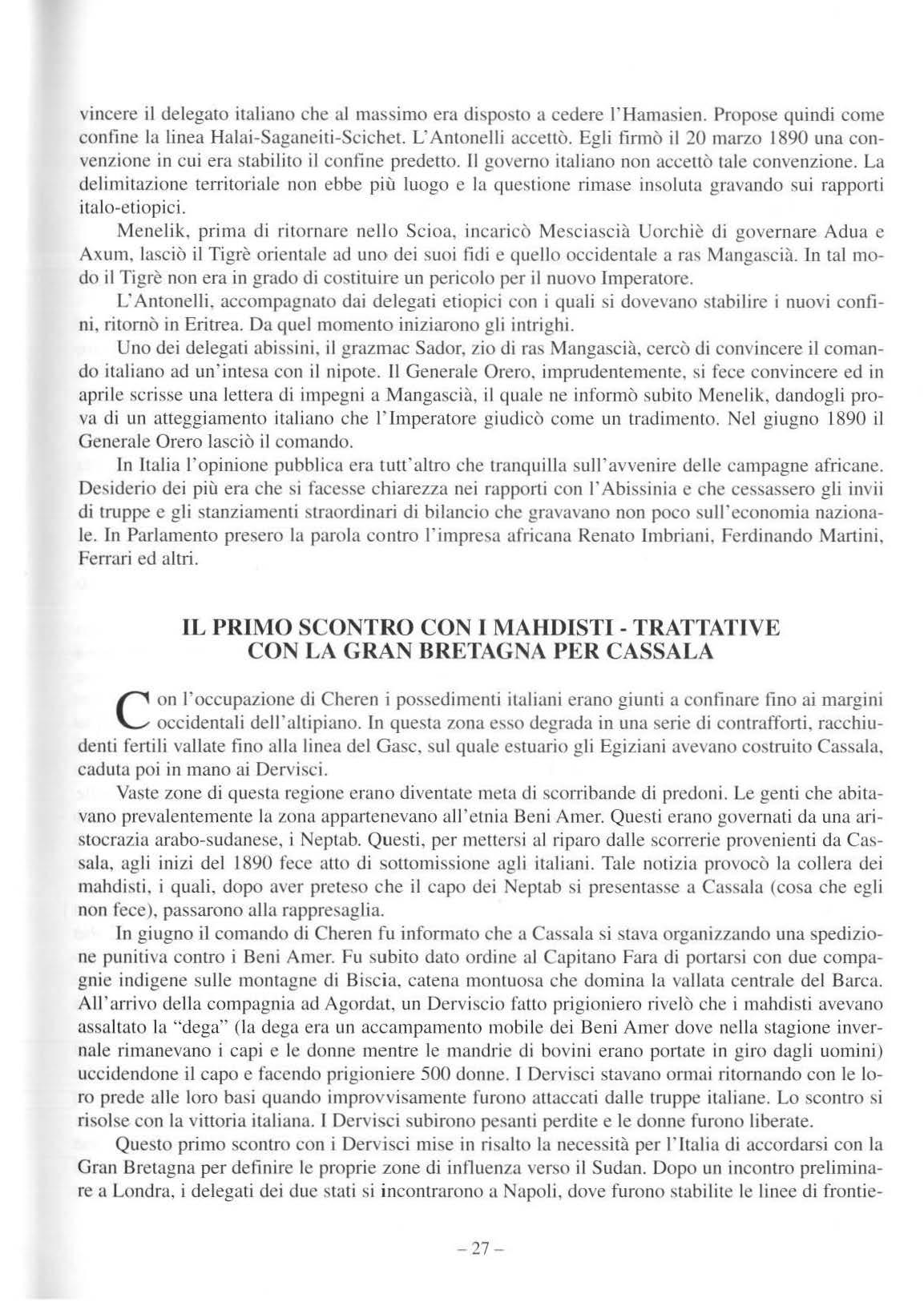
Uno dei delegati abissini, il grazmac Sador, zio di ras Mangascià. cercò di convincere il comando italiano ad un'intesa con il nipote. Il Generale Orero. imprudentemente, si fece convincere ed in apr i le scrisse u na lette ra eli impegni a Mangascià, il quale ne informò subito Mcnclik, dandog li prova di un atteggiamento ita l iano che l' I mperatore giudicò come un tradimento. Nel giugno 1890 il Generale Orero lasciò il comando.
Jn lt alia l 'opinione pubblica era tutt'altro che tranquilla sull"avvenire delle campagne africane. Desiderio dei p i ù era che i facesse chiarezza nei rapporti con l'Abissinia c che cessassero gli invii d i truppe e gli stanziamenti traordinari di bilancio che gravavano non poco ulreconomia nazionale. In Parlament o presero la parola contro l'impresa africana Renato lmbrian i , Ferdinando Martini, Ferrari ed altri.
IL PRIMO SC ONTRO C ON I MAHDISTI- TRATTATIV E
Con l'occupazione di Cheren i possedimenti italiani erano giunti a confinare fino ai margini occidentali dell'altipiano. In questa zona esso degrada in una serie di contrafforti, racchiudenti fertili vallate fino alla linea del Gasc. sul quale e tuario gli Egiziani avevano costruito Cassala, caduta poi in mano ai Dervi . ci.
Vaste zone di questa regione erano diventate meta di scorribande di predoni. Le genti che abitavano prevalente m en t e la wna appartenevano a ll 'etnia Beni Amer. Questi erano governati da una aristocrazia arabo-sudanese, i Neptab. Questi, per mettersi a l r iparo daJle sco1Terie provenienti da Cassala, agli inizi del 1890 fece atto di sottomissione agli italiani. Tale notizia provocò la collera dei mahdisti, i quali, dopo aver p reteso che il capo dei Neptab si presentasse a Cassala (cosa che egli non fece), passarono alla rappre aglia.
In giugno il comando di Cheren fu infonnato che a Cassala si stava organìnando una spedizione punitiva contro i Beni Amer. Fu subito dato ordine al Capitano Fara di portarsi con due compagn ie i ndigene sulle montagne di B iscia, cate na montuosa che domina la vallata centrale del Barca. Al l 'a rrivo de ll a compagnia ad Agordat, un Derv iscio fatto prigioniero rivelò che i mahdisti avevano assa lt ato l a "dega" ( la dega era un accampame n to mob il e dei Ben i Amer dove nella stagio n e inverna l e r imanevano i capi e le donne mentre le mandrie di bovini erano portate i n giro dagli uomini) uccidendone il capo e facendo prigioniere 500 donne. l Dervisci stavano ormai ritornando con le loro prede alle loro basi quando improvvisamente furono attaccati dalle truppe i ta l iane. Lo scontro sì riso ! e con la vittoria italiana. l Dervisci subirono pesanti perdite e le donne fu rono liberate.
Questo primo scontro con i Dervisci mise in risalto la necessità per l'Italia di accordarsi con la Gran Bretagna per definire le proprie zone di influenza verso il Sudan. Dopo un incontro preliminare a Lond ra, i delegati dei due stati si i ncontraro no a Napoli, dove furono stabilite le linee di frontie-
CON LA GRAN BRETAGNA PE R CASSAL A
- 27 -
ra c la f acoltà pe r e ntr a mbi di sco nfm a re tali limiti in caso di esige nze mili tar i. L' uni co punto d ove no n s i trovò acco rd o fu qu e llo c h e co nce rn e va il possess o di C ass al a. G li Ingl es i vo leva no c he l' I talia occ up asse Cassa la p e r p o i ce de rl a all'Egi tto. Cr is p i pro pose in vece, un a vo lta occ up a ta la loca lità, c he i diritti de ll 'Eg i tto fossero ri se rva ti , sa l vo d isc ute rli qu a ndo i D e rv isc i sare bbero s ta ti ri caccia ti d a Be r be ra e da K art um T a le so lu zio ne no n f u acce tt a ta d ag li Ing lesi e le tr a tta t ive fa lliron o.
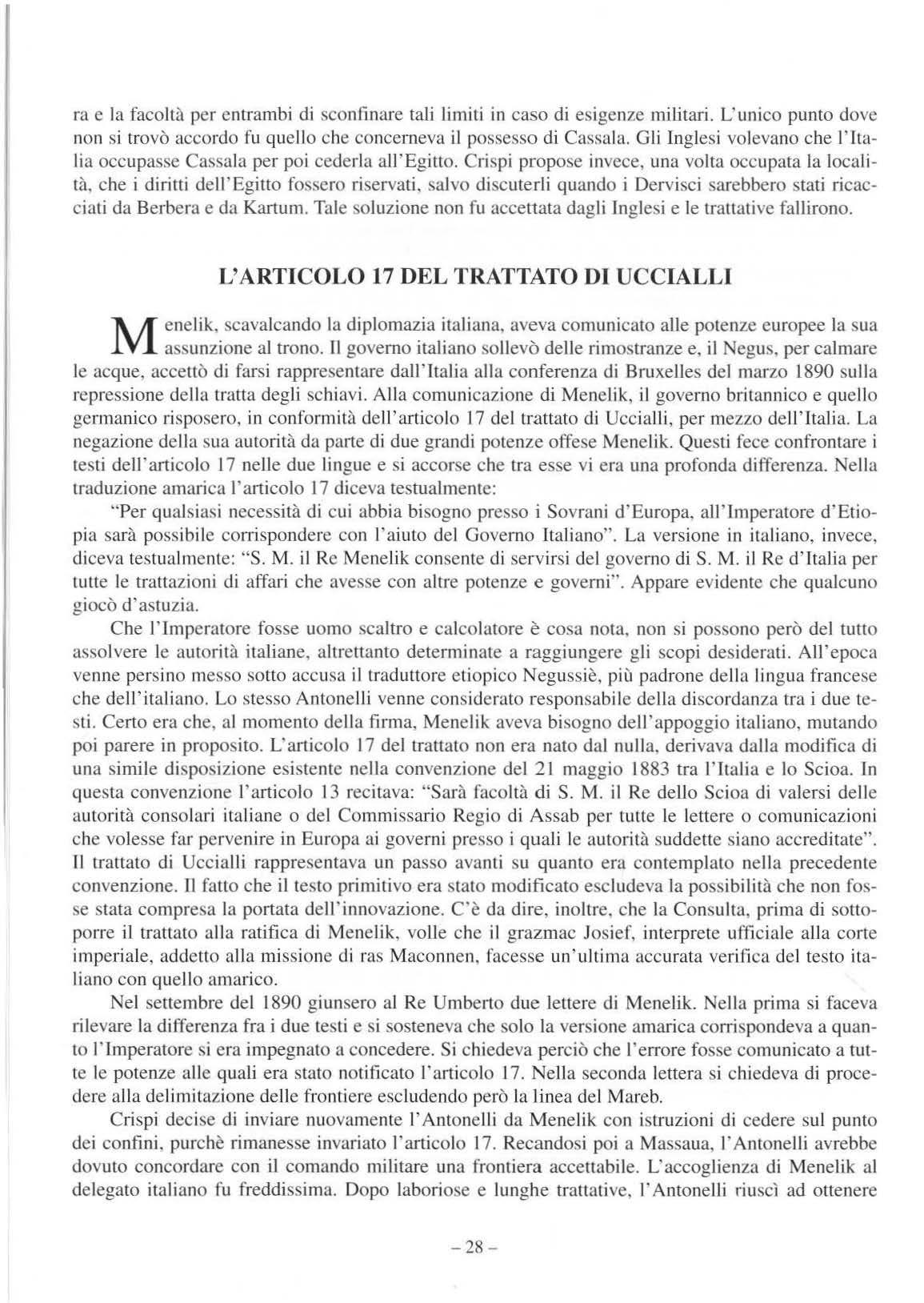
L'ARTI COLO 17 DEL TRATTATO DI UCC IALLI
Me ne li k, scava lc a nd o la d ip lom az ia it a li a na, aveva com uni cato alle p o te nze e uro pee la s ua ass un zione al tron o TI govern o itali an o so ll evò de ll e rim os tranze e, il Neg us, pe r calm are le ac qu e, acce ttò di fa rs i ra pprese nta re dall'lta )j a a ll a co nfe renza d i Bru xell es d e l mar zo 1890 s ull a re press ione d e ll a tr a tt a d e gli sc hi av i. All a comuni caz ion e di M e nc lik , il g o verno brit a nni c o e qu e ll o ge rmanico ri s pose ro, in conformità d e ll ' artico lo 17 d e l trattato di Ucc ia ll i, p e r m ezzo de ll ' I talia . La negazion e d e ll a s ua a utorità d a p a rt e di due g randi po te nze offese M e ne li k. Questi fece co nfron tare i tes ti de li ' art ico lo 17 ne ll e du e li ng ue e s i accor e c he t ra e sse vi e ra un a profo nda d iffere nza Ne ll a t rad u zio ne amari ca l'art ico lo 17 di ceva tes tualm ente:
" Per qu als ias i necess i tà d i c u i a bbia bi sog no press o i Sov ra ni d'E uropa , a ll ' Imp e r a to re d ' Eti opi a sarà po ss ib il e co ni spondere co n l' aiuto d e l G ove rno It a li a no" . La ve rs ion e in it a liano , invece, di c eva testual me nt e: " S. M . il Re Me ne lik c on se nte di s ervirs i d e l gove rno di S . M . il Re d ' Ita li a pe r tutt e le tra tt azio ni di affari c he avesse c on a ltre po te nze e gove rni ". A pp are ev id e nt e c he qu alcun o g iocò d'a stuzia.
Che l'Impe rato re f osse uo mo sc a l tro e ca lc o lato re è cos a nota, no n s i p osso no pe rò d e l tu tto asso lvere le a u to rit à ita li a ne, a l tre tta nto d e te rmin a te a raggi un ge re g li sc opi d es ide ra ti. All 'epoca ve nne pers in o mess o s otto a cc u sa il tra duttore e ti o pi c o N e gu ss iè, più p a dron e de ll a lin g ua fran cese c he del l ' itali an o. Lo s tesso A n to ne ll i ve nn e co ns id e ra to r es p o nsa bil e d e lla di scord a nza tr a i du e tes ti. Certo e r a c he, a l mo me nt o d e ll a firma , M e ne lik aveva bisog no de ll' a ppo gg io ita li a no, mut a nd o po i parere in p ro pos i to. L'arti co lo 17 d e l tra tt a to no n e r a na to d a l null a, de ri vava d a ll a mo difi ca d i un a s imi le di sp o i z ione es is te nt e ne ll a co n ve nz io ne de l 21 magg io 1883 t r a l ' Ita lia e lo S c ioa. In qu es ta co nve nz io ne l ' arti c ol o 13 rec itav a: " S ar à faco lt à d i S. M. il Re dello Sc i oa di valer si d e ll e a uto r ità conso lari it a li an e o d e l Co mmi ss ari o R eg io di A ss ab pe r tutte le lett e re o co municaz io ni c he v oless e far pe rve nire in Euro pa ai go verni presso i quali le a uto rit à s udd e tte s ia no acc re dit a te". Il tr a ttato di Ucc ia lli rapprese ntava un passo ava nti s u qu a nto era co nt e mpl a to ne ll a prece de nt e co nve nz io ne . n fa tt o c h e il tes to pri miti vo e ra sta to mo di fica to es clud eva la poss ibilit à c he non fose s ta ta c omp re a la p o rta ta d e ll ' inn ovaz ion e. C'è d a dire, in o ltre, c he la Cons ulta, prima di s ottopo rre il tratta to a lla ratifica di M e ne lik , v oll e c he il gr az m ac J os ie f, i n terprete uffic ia le al la co rt e imp e ria le , adde tt o alla mi ss ion e d i ras Maconn e n, f ac es s e un ' ultima ac c urata ve rifi ca de l te s to it ali a no c on qu e ll o a marico
N e l se tt e mbre de l 1890 giun se ro a l R e Umb e rto due le ttere di Me ne lik. N e ll a p rim a s i faceva r il evare la diffe re nza fr a i du e tes ti e s i so sten eva c he o lo la ve rs io ne a mari ca c orri po ndeva a qu a nto l' Imp e ra to re. i e ra impeg n a to a co nce dere Si c hi e d ev a perc iò ch e l'e rro re fo sse co muni c ato a tutte le potenz e a ll e quali era s tat o no tificato l' arti co lo 17 N e ll a seco nda le ttera si c hi e dev a di pro ced e re a ll a d e li mi taz ione de ll e fr o nti e r e es cl ud e n do pe rò la linea de l Ma reb.
Cri spi dec ise di i nviare nu ova me nte l ' Ant o ne ll i da M ene l ik co n is tru zioni di ce de re s ul punto d e i co nfini. purc hè riman esse in va riato l' arti co lo 17. Re c andos i po i a M ass au a, l' A nt o ne lli av re b be d ovuto c on co rda re co n il c om a nd o mili tare un a fro nti e ra accetta bil e . L' accog lie nza d i Me ne lik a l d e lega to ita li a no fu freddi ss im a. Dopo lab o ri ose e lun g he tra tta ti ve, I'Antonelli r iu scì ad otte ne re
-28 -
che l'articolo 17 rimanesse tale nei due testi, salvo modificarlo al termine dei cinque anni previsto dal trattato stesso. Menelik promise di scrivere una lettera al R e Umberto per dargliene comunicazione ed esprimergli la volo nt à che i suoi affari con le potenze estere fossero trattati dal governo italiano. Per quanto riguardava i confini, Menelik accettò, sal vo qualche lieve modifica, la linea concordata con l' Antonelli a Massaua. Essa concedeva all'Italia Halai , Saganeiti e Ad di Baro.
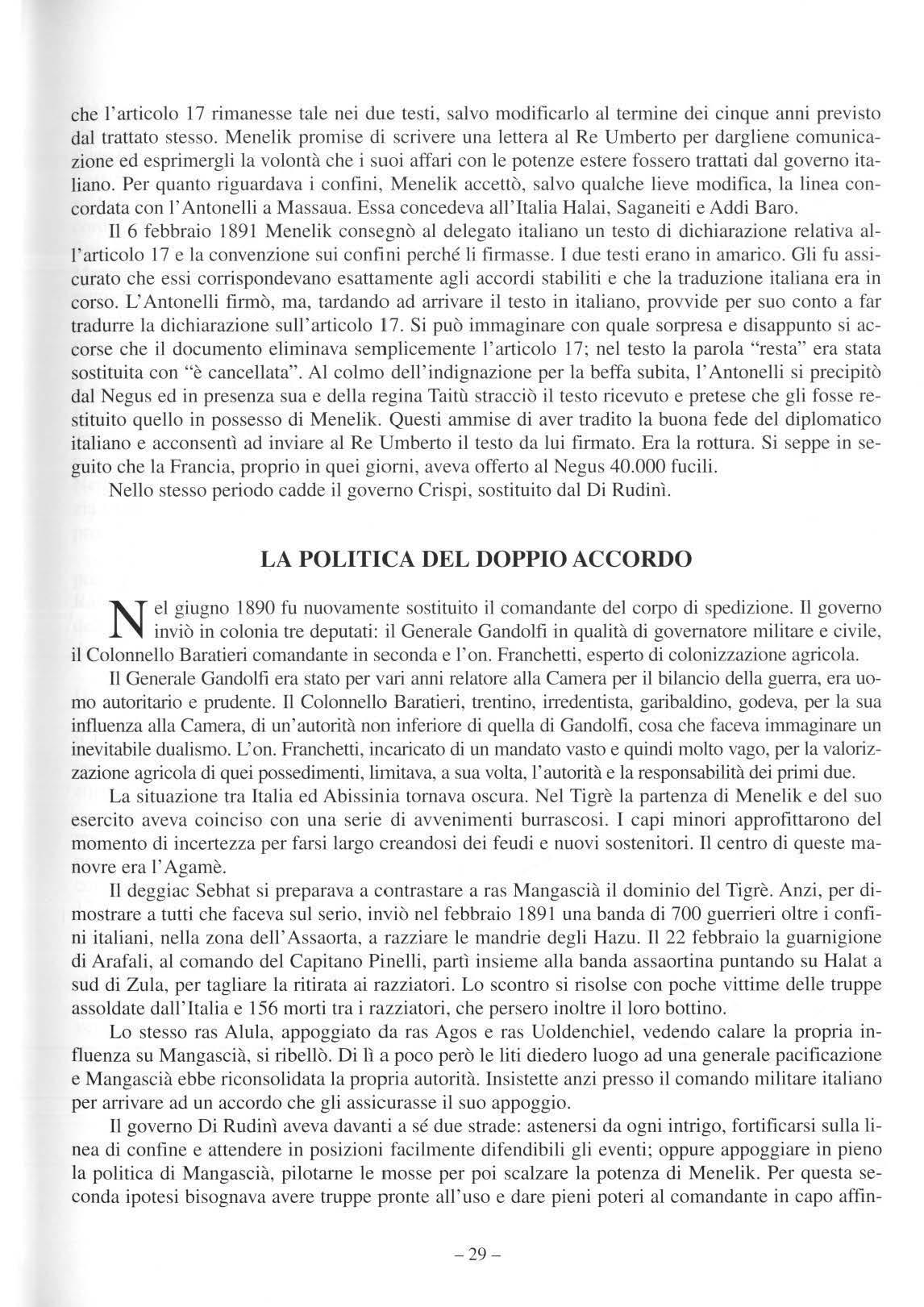
Il 6 febbrai.o 1891 Menelik conseg nò al delegato italiano un testo di dichiarazione relativa all'articolo 17 e la convenzione sui confini perché li firmasse. l due testi erano in amarico. Gli fu assicurato che essi corrispondevano esattamente agli accordi stabiliti e che la traduzione italiana era in corso. L' Antonelli firmò, ma, tardando ad arrivare il testo in italiano, provvide per suo conto a far tradurre la dichiarazione sull'ruticolo 17. Si può immaginare con quale sorpresa e disappunto si accorse che il documento eliminava semplicemente l'a rticolo 17; nel testo la parola "resta" era stata sostituita con "è cancellata". Al colmo dell'indignazione per la beffa s ubita , l' Antonelli si precipitò dal Negus ed in presenza sua e della regina Taitù stracciò il testo ricevuto e pretese che g li fosse restituito quello in possesso di Menelik. Questi ammise di aver tradito la buona fede del diplomatico italiano e acconsentì ad inviare al Re Umberto il testo da lui firmato. Era la rottura. Si seppe in seguito che la Francia, proprio in quei giorni, aveva offerto al Negus 40.000 fuc ili.
Nello stesso periodo cadde il governo Crispi. sostituito dal Di Rudinì.
LA POLITICA DEL DOPPIO ACCORDO
Nel giugno 1890 fu nuovamente sostituito il coma ndante del corpo di sped izion e. li governo inviò in colonia tre deputati: il Generale Gandolfi in qualità di governatore militare e civile, il Colonnello Baratieri comandante in seconda e J'on. Franchetti, esperto di colonizzazione agricola. n Generale Gandolfi era stato per vari anni relatore alla Camera per il bilancio della guerra, era uomo autoritario e prudente. n Colonnello Baratieri , trentine , irredentista, garibaldino, godeva, per la sua influenza alla Camera, di un'autorità non inferiore di quella di Gandolfi, cosa che faceva immaginare un inevitabile dualismo. L'on. Franchetti, incruicato di un mandato vasto e quindi molto vago , per la valorizzazione agricola di quei po ssed imenti, limitava, a sua volta, l 'autori tà e la responsabilità dei primi due.
La situazione tra It alia ed Abissinia tornava oscura. Nel Tigrè la partenza di Menelik e del s uo esercito aveva coinciso con una serie di avvenimenti burrascosi. I capi minori approfittarono del momento di incertezza per farsi largo creandosi dei feudi e nuovi sostenitori. Il centro di que ste manovre era l' Agamè.
li deggiac Sebhat si preparava a contrastare a ras Mangascià il dominio del Tigrè. Anzi, per dimostrare a tutti che faceva sul serio, inviò nel febbraio 1891 una banda di 700 guerrieri oltre i confini italiani, nella zona dell' Assaorta, a Tazziare le mandrie degli Hazu. 11 22 febbraio la guarnigione di Arafali, al comando del Capitano Pinelli , partì insieme alla banda assaortina puntando su Halat a sud di Zula, per tagliare la ritirata ai razziatori. Lo scontro si 1isolse con poche vittime delle truppe asso ld ate dall' lt al ia e 156 morti tra i razzia tori, che persero inoltre il loro bottino.
Lo stesso ras Alu l a, appoggiato da ras Agos e ras Uoldenchiel, vedendo calare la propria influenza su Mangascià, si ribellò. Di lì a poco però le liti diedero luogo ad una generale pacificazione e Mangascià ebbe riconsolidata la propria autorità. Insistette anzi presso il comando militare italiano per arrivare ad un accordo che gli assicurasse il suo appoggio.
Il governo Di Rudinì aveva davanti a sé due strade: astenersi da ogni intrigo, fortificarsi sulla linea di confine e attendere in posizioni facilmente difendibili gli eventi; oppure appoggiare in pieno la politica dì Mangascià , pilotame le mosse per poi scalzare la potenza di Menelik. Per questa seconda ipotesi bi sog nava avere truppe pronte all'uso e dare pieni poteri al comandante in capo affin-
-29-
La spedizione
Addio m1e1 cari. addio, Parte la sped}zione, Anch'io voglio parlire
Col terzo batt.agt 10ne.
Parto per l'Africa

Per vendi'Car
Il sparso
Degl' lta li an.
Il sacco e preparato
E pronto il mio fucile:
Anch'io da buon soldato
Non vuo' most.ranni vtle:
lo vado là.
Ptr vendicar
L'ossa de1 ro iseri
Fratelli !
Quando g•unti saremo
Là con la mun1zione.
Ma piangeranno 1 vtl i.
Al rombo cJnnone.
lo vado in Afn ca
Per truc1dar
La stirpe nera.
Deg li ·" fncan.
Africa dev1 piangere.
Il tuo commesso errore ; Dogali e Saati.
Allo stato maggiore.
lo vado in Afric:\
Per vendicar
11 :sparso
Degl' ltallilnl.
T'' c 13S$
Una can:one popolare del 1888.
Fn Dogali e Saati.
Fu commesso ..
A quel prod• soldats.
Ma pient di valere.
Il mio dovere.
È di andar là.
Per vendicare
l fratelli ltalian
Povero colonnello! '
Con t utti i tuoi soldati
Mor·isu \·aloroso.
Fra Dogali e Saati. .
E sempre avao t1
Gndavl là
Finchè abb1am sangue
$1 pugncrà .
l o gnderò vt!ndetta.
C(lntro l'A fr1cano.
Prendo li ba1oneLta
Da vero haltano.
lo vado 1n Afnca
Per •mpngionar
Il Ras Alula
E il Rt! Giovan.
Addio ltalica terra!
Addio padre e madre l
se morissi io guerra
Fra le Africane squadre; Se valoroso
lo re:)terO,
Se psàce a Dio
Yi rtvedrò [
@ l ! i l
PER Canzonetta nuovissima
@
_____ .... _ - 30 -
chè potesse prendere liberamente le risoluzioni del caso. Quest'ultima era una politica rischiosa, anche se era la più adatta all ' ottenimento dei maggiori acquisti ten-itoriali e al consolidamento dell ' influenza italiana sull'Etiopia. Il governo italiano non ebbe il coraggio di seguire né la politica dell 'assoluta passività, né quella dell'ingerenza attiva, si attenne invece ad una linea intennedia , che in sostanza non avrebbe dovuto urtare né lo Scioa né il Tigrè. Tale politica, chiamata del "doppio accordo" , mirava essenzialmente a risolvere direttamente col Tigrè la questione sempre apetta dei confini. I delegati italiani avrebbero dovuto mettere in evidenza che gli accordi erano conclusi con Mangascià, non in quanto potenza autonoma , in grado di trattare con un altro stato, ma in quanto rappresentante di Menelik. Questo era l'errore. Il tentativo era goffo ed ingenuo. Esso non fece altro che irritare sia Mangascià che Menelik, il primo perché vedeva svanire l'aiuto italiano , il secondo perché non avrebbe certo potuto tollerare che si trattassero tali argomenti con un suo sottoposto. Coerentemente con la strategia politica intrapresa, il governo italiano mandò nello stesso tempo il dottor Nerazzini ad Adua e il dottor Traversi nello Scioa. Nerazzini era latore di una lettera del Re Umberto per Mangascià. Questi, essendosi accmto delle mosse italiane , disse di non poter firmare accordi che non fossero stati preventivamente approvati dall' Imp eratore. Nello stesso tempo, per non inimicarsi l'Italia, si mostrò molto arrendevole nella questione del regolamento dei confini. Tra Nerazzini e Mangascià alla fine vennero conclusi tre accordi: una dichiarazione di pace e di amicizia tra l'Italia ed il Tigrè; il riconoscimento della frontiera del Mareb, Belesa, Muna; l'obbligo reciproco di rispettare la sicurezza dei confini.
Preparato il terreno, il Generale Gandolfi si incontrò con Mangascià e ras Alula sul Mareb nei pressi di Ad di Qual a. L ' incontro durò dal 6 all' 8 dicembre 1891. Fu giurata solennemente la pace. Ras Alula si limitò a giurare di essere amico degli amici del suo signore. Mangascià diede notizia dell'avvenuta pace al Re Umberto; nella lettera , abbandonata ogni remora, si atteggiò a sovrano indipendente, omettendo ogni accenno all ' lmperalore ed alla sua dipendenza da esso.
In tal modo l'Italia si rendeva complice di un atto che era un ' aperta violazione del trattato di Uccialli, con il quale essa aveva riconosciuto la sovranità di Menelik su tutta l'Etiopia.
In questa situazione la missione di Traversi nello Scioa non si mostrava affatto facile. Ufficialmente il delegato italiano andava a dirigere la stazione di Let Marefià che, dopo la mo11e di Antinori, era retta da un medico della Regia Marina, il dottor Vincenzo Ragazzi. Traversi, era un ottimo conoscitore del mondo etiopico. Da sei anni aveva percorso buona parte dell'Impero, in particolar modo i territori del sud.
Menelik lo aveva voluto con sé nelle sue spedizioni contro i Galla e gli Arussi; il che aveva permesso all' Antinori di esplorare il bacino del lago Zuai, avvicinarsi alle sorgenti deli ' Uebi Scebeli e percorrere il Gimrna. Questo comunque non garantiva che l ' italiano fosse la persona più indicata a condurre delle difficili trattative diplomatiche. Le sue proposte per un accordo sul famoso articolo 17 furono tutte rifiutate da Menelik. Egli pretendeva la totale abrogazione dell ' articolo in questione.
L'Imperatore convocò Mangascià a Bon-umieda. n capo tigrino, impegnatosi onnai con l'Italia, non si mosse, dicendo che doveva tener d'occhio l'incerto comportamento di ras Sebhat. Giunse invece all'Imperatore la notizia dell'incontro del Mareb. Menelik era ben conscio dei lischi che poteva correre. Da allora egli cercò in tuW i modi di riguadagnare a sé il ras, alimentando in esso la diffidenza verso l' l tal ia.
D'altra parte questa agevolò il compito al Negus, con la dissennata politica del "doppio gioco".

UNA COMMISSIONE D' I NCHIESTA IN ERITRE A
Il Di Rudinì, per poter dare concrete direttive sull'azione in Africa, istituì una Commissione d'inchiesta.
- 31 -
Essa era pres ied uta da l Sena tore Borgi ni e, composta, tra g li altri, d al Di San Giuli ano e da Ferdinando Mru1i ni che, da acceso an t ico lon ial ista, cam bi ò in seg uit o co mpl etame nte parere. n rap porto c he ve nn e presentato alla Camera il 12 novembre 189 1 fu mo lto fa vorevo le alle idee di sviluppo della co lonia, anc he se alc uni aspetti nega ti vi, e non e rano po c hi , furono vo lutamente ig norati . S i ribadì comunque la nece si tà di mantenere buo ni rapporti co n le popolazioni confinanti. Si in s is teva cioè s ull a p oli ti ca tigrina
Fu que sta la linea a ll a qual e s i atte nne il General e Baratieri quando, ne l mar zo 1892. sos tituì il Generale Gandolfi. il cui rigido attegg iamento no n e ra stato grad ito dai membr i della co mmi ssio ne d'inchiesta.
TI nuovo gove rnatore e ra un in s tancabile lavo ratore, un buon o rga niz za tore, ma deb o le, sot to l'appare nza di uffi c ial e energ ico e d eciso. Durante tutto il periodo de l suo comando, egli fu di fatto so tto l'influenza del Capi tano dello Stato Maggiore To mma o Salsa. del quale ebbe il torto di non seg uire i co ns ig li nel frangente di Adua. Bara ti e ri riorganizzò il Corpo Spec iale d'Africa, che alla fine del 1892 ra gg iun se la f o rza di 6.5 60 uomini , dci quali 2.100 nazionali ed il res to formato da trupp e co loni ali. In un periodo success ivo, aume ntand o il ri sc hi o di una guerra con l'Etiopia. B aratieri istit uì una mili z ia mobile indi gena di circa 2.000 uomi ni , di s ponib il e ad accorrere ovunque ce ne fosse bisogno. Anche gli armat i delle bande del Seraè e deii'Acchele'Guzai furono aumentati fino a 1. 200 elementi. Ai primi d el 1894 gli Italiani posse devano una forza tot ale di circa l 0.000 uomi ni, sc hi era ti in un a se rie di fort ificazioni che difendevano lo scacchiere sud (A mara. Saga ne iti , Adi Ugri) e lo scacchiere ovest (C hereo e Ago rdat ). Alle dipe nd enze di Baratie ri c'e ra il Tenente Colonnello Arimondi, coma ndante delle trupp e. Si creava così un pericoloso duali s mo, che si accentuò quando, in assenza del governatore, il prestigio del coma nd an te militare cre bbe favorito dai suo i s uccess i s ui Derv isci.
L'ATTEGGIAMENTO AMBIGUO DI RAS MANGASCIÀ

Il ministero Di Rudinì fu sosti tuito il 15 maggio J 892 da quello Giolitti. Del mini stero degli Esteli fu in cari cato Benedetto Brin. Nonostante g li imp eg ni pres i co n Man gasc ià, nean che il nuovo gove rn o si astenne dal tentare una politi ca di accordi co n Mene lik. Il governo , convinto dall e argomentazioni del Traversi, co nv into di poter ri g uadagnare la fidu cia d e ll ' Im peratore con un gesto, commise il madornale errore di far proseguire per lo Scioa il cari co di du e milioni di cartucce d epositate ad Assab.
Il ri s ultato del gesto di fiducia italiano non si fec e a ttendere a lungo. Appena il Travers i g iun se co n le cru1 ucce nello Scioa, il Negus fece in v iare ai governi europei in data 27 febbra io 1893 le lettere preparate da te mp o per denun c ia re il trattato di Ucc ialli. Tali le tte re prec isavan o c he allo sca dere de l trattato ne l 1894, que sto non sa rebbe s tato rinnovato. Alla tesi sos tenuta da Me nelik l ' It a li a oppose il criterio della perpetuità de l trattato, in co nseg uen za della s ua spec iale natur a. L a Gran Bretag na e la Germania aderi ron o a l punto di vista soste nut o dal l'Italia. Anche questa vo lta la mediazione d e l Trave rs i ebbe es ito nega ti vo A questo punto all' It alia non rimaneva che pot1are avant i la politica di ami c izia con Manga sc ià .
Qu esti. r affo r za ta orma i la sua autorità nel Tigrè. ini ziò un a polit ica di es pans io ne nelle regio ni limitrofe.
Tra la fin e del1891 c d i primi dcll892, per mez zo di uomini a lui fed eli , occupò alc un e de ll e prov in cie o ltre il Tacazzè: il S e mi c n, I'Uolcait, lo T seg hed iè , lo Tsellenti e l'Uogherà. Era evi d e nt e c he l'Italia avrebbe do v ut o ce rcare, a que s to punt o, di dividere per se mpre g li interessi di Man gasc ià e eli Me nelik .
L'e terna in certez za d e lla politi ca italian a invece, non permi se concretame nt e l' e pan s ion e di Ma ngasc ià oltre il Tigrè. Le s ue conqu iste furono effimere. Più fo rtuna egli eb be con ras Sebhàt. c he
-32 -
fece atto di sottomissione 1'8 maflo 1892. L'unico risu lta to che sembrava fos e tato ottenuto fu che Man gascià si atteggiava ormai a sovrano autonomo. Eg li per rafforzarsi chiedeva armi. L"ltalia non gliene aveva mai fomite in gran numero, e proprio in quel momento lo Scioa riceveva i due milioni di cartucce. La ripercussione di questo fano non poteva che essere funesta. Fu allora che Mangascià riallacciò i rapporti co n l'Imperatore tramite il belatà Tesfai Antalò. A questa seque la di errori, l'Italia ne aggiunse uno ancora maggiore. Il governo Giolitti, ebbe l'idea di tentare una pacificazione tra Menelik e Mangascià, senza rendersi conto che, finchè permanevano le pretese italiane sull'articolo 17 e s ull a linea del Mareb, i rapporti con lo Scioa non sarebbero mai migliorati. L'idea dunque di spingere Man gascià verso una riappacificazione con il Negus era nella migliore delle ipote i il colmo dell'ingenuità. E tale fu ugualmente la missione affidata al Capitano De Martino. Questi si recò a Macallè durante il Mascal 1892 per colloquiare con Mangascià sul nu ovo programma di pacificazione. Il tramite del riavvicinamento tra i due avversari sarebbe dovuto essere il Generale Baratieri, il quale avrebbe inoltrato a Menelik una lettera di sottomissio ne di Mangascià. L'aspetto tragicomico della cosa e ra c he, mentre l 'Ita li a cercava di convincere il capo tigrino ad un accordo con l'Imperatore, Manga scià all'insaputa dell'Italia aveva già ripreso i contatti con lo Scioa per mezzo di TesfaiAntalò. Le mosse italiane dimostrarono al ras soltanto debolezza c timore di un conflitto. Con gli accordi del Mareb gli Italiani lo avevano compromesso, ora lo spingeva no a far atto d i sottomissio ne al Negus. L'unica conclusione alla qua le po teva arrivare Mangascià era che degli It aliani era rnegUo non fidarsi. Il capo tigrino chiese al Generale Barat ieri un incontro. Questi non accettò. L'atteggiamento ondivago di Mangascià esasperò i capi a lui sottoposti, in particolar modo ras Alula che. circa a metà dicembre, fece prigioniero il Capitano De Martino ad Adua e si ribellò apertamente al suo signore. Senza però l'appoggio eli ras Sebhàt, dovette sottometters i. In febbraio Alula si ribellò nuovame nte, attestandosi su ll 'Amba Dibuch. Con Ja mediazione di alcuni emissari dell'Imperatore, AJula venne perdonato. Da allora eg li divenne fedele all' Imp eratore, dopo essere stato uno dei più fieri oppositori di una riconciliazione con lo Scioa. Infin e, il 16 maggio 1893, a Macallè, Mangascià giurò fedeltà a Menelik. In fondo agendo in questo modo non aveva fatto che segu ire i consigli italiani. M angascià chiese nuovamente a Baratieri un incontro. Questi fu invitato, prima di dare una risposta, ad andare in Italia. A Roma Baratieri non dovette faticare per convince re il governo che era inutile cercare di riallacciare i rapporti con Menelik, perciò, secondo lui, bisognava continuare l'alleanza col Tigrè. Fece sapere a Mangascìà che nel prossimo novembre, al suo ritorno, si sarebbe incontrato con lui. Proprio in quei g iorni però cadde il governo Giolitli s ucceclenclo gli Francesco Crispi, con Blan c agli Esteri e l ' Antonelli a l sottosegretariato alla Consulta. Si tornava alla politica sc ioan a.

SCONTRI CON I DERVISCI: SAROBEITI-AGORDAT-CASSALA
Baratieri tornando in colonia evitò di incontrare Mangascià giustificandosi con la motivazio ne che doveva preparare una nuova campag na contro i dervisci. Dopo il primo scontro avuto ad Agordat, s i era stab i l il a una sorta di tregua tra i Dervisci e gli avamposti italiani del bassopiano, tanto da avviare un discreto movimento di carovane commerciali tra il Sudan e Ma ssaua. Questa tregua fu rotta improvvisame nte da un colpo di mano te ntato dai Dervisci ne l g iugno 1892. Circa un migliaio di essi, partiti da Cassala, fecero una razzia ai danni di tribù protette dall'Italia. Intervenne il presidio di Agordat, forte di 120 uomini, affiancato dalla banda del Barca, composta da circa 200 uomini. I Dervisci furono sbaragliati a Sarobetì il 15 giugno. perdendo 150 uomini. Verso la fine del 1893. mentre Baratieri si trovava in ftalia. giunsero a Cheren le prime voci di forti conce ntramenti di armati a Cassala Il Generale Ari mondi alla testa delle sue forze per un totale di 2500 uomini, mosse verso Agordat. Contemporaneamente una massa di circa 10.000 Dervisci al
- 33 -

- 34-
Menelik e il suo sta/O maggiore (diJegno di Amato).
comando dell'Emiro Ahmed Alì partiva da Cassala per aprirsi la strada verso Cheren e di 1ì a Massaua. Era un tentativo di estendere il loro dominio sul Mar Rosso. L'Emiro , arrivato vicino ad Agordat il 21 dicembre, si trovò di fronte il forte presidiato dalle truppe accorse da Cheren. Con una manovra aggirante passò il fiume Barca, arrivando alle spalle degli Italiani isolandoli da Cheren. La linea di difesa italiana comprendeva due capisaldi, a nord di Agordat , sul fiume, e alla collina verso sud. Qui era stato schierato il Battaglione Galliano. Esso aveva avuto l'ordine di snidare i Dervisci dalle loro posizioni e ricacciarli oltre il fiume. Per tre volte le truppe italiane andarono all ' attacco e per tre volte dovettero ritirarsi a causa delle soverchianti forze nemiche. Allora il Generale Ari mondi chiamò a sé la riserva tentando lo sfondamento per la quarta volta. Nello stesso tempo. protetta dal fuoco del forte, l'ala sinistra italiana si insinuò in un paJmeto lungo il fiume, cercando di aggirare il nemico. La manovra riuscì p ienamente e i Dervisci si scompaginarono, anche perché l'Emiro Ahmed Alì ebbe la testa troncata da una cannonata.
Tale vittoria ebbe larga risonanza sia in Africa che io Europa, poiché pochissime truppe avevano affrontato un nemico numeroso e famoso per la foga combattiva. Le orde che attaccavano non erano state affrontate questa volta, come era avvenuto finora nel Sudan, da quadrati di truppe, ma da colonne agili ed aggressive.
Era una nuova tattica che aveva dato ottimi risultati.
A questo punto si prospettava la necessità di togliere Cassala ai nemici, assicurando definitivamente al bassopiano la tranquillità. Appena Baratieri tornò dal suo viaggio in Italia, organizzò la spedizione.
Nel luglio 1894, approfittando della stagione delle piogge, che a causa delle piene dei fiumi Gasc e Atbara isolava Cassala dalle altre basi mahdiste, Baratieri concentrò ad Agordat 10 compagnie indigene, oltre ad una sezione di artiglieria da montagna e la banda del Barca. Assumendone egli stesso il comando, la colonna giunse alla gola di Sabderat. Dopo una marcia notturna di sei ore , le truppe si trovarono all'alba del 17 luglio 1894 di fronte al campo mahdista forte di 2.600 uomini. 11 fattore sorpresa giocò un ruolo importante nella breve battaglia. Dopo un breve scontro tra cavallerie, le mura della città vennero bombardate e la guarnigione nemica fuggi disordinatamente al di là del Gasc e dell ' Atbara. A presidio della città (che fu s accheggiata e data alle fiamme). vennero lasciati, al comando del Maggiore Turitto, 1.000 uomini con due cannoni e quattro mitragliatrici.

LA SOTTOMISSIONE DI MANGASCIÀ AL NEGUS
La campagna contro i Dervisci distolse per alcuni mesi l'attenzione del comando militare italiano dalla situazione generale, che, nel frattempo, si era fatta molto grave. Il Generale Baratieri, cercando di concretizzare in qualche modo la collaborazione con Mangascià, gli aveva proposto di collaborare alla sconfitta dei Dervisci, per dirottare parte delle loro forze al momento dell'attacco italiano su Cassala.
Mangascià aveva assicurato la propria partecipazione cominciando a concentrare alcune forze nell'Uolcait.
In direzione del Ghedaref. Chiedeva però armi e munizioni che invece gli furono negate.
Il governo italiano nel frattempo tentò un'ultima conciliazione con il Negus, incaricando di questo il Traversi.
Menelik rispose,come a l solito, chiedendo l'abolizione dell'articolo 17 del trattato di Uccialli. Mentre Traversi cercava di convincere Menelik, questi tempestava Mangascià per convincerlo della malafede italiana. Mangascià esitò ancora per qualche tempo, poi, vedendo che Baratieri gli negava ogni colloquio, si decise a muovere verso lo Scioa. 11 2 giugno 1894 Mangascià arrivò ad
-35-
Addis Abeba. M ene lik lo accolse freddame nt e. Il ras tigrino, in vesti dimesse, con l e spalle nude in atto servil e e con una pietra a l collo fece il suo "abìe t" (sorta di pentimento pubblico in cui il colpevole di qualche reato o di tradimento cercava il perdono) prostrandosi davanti all'Imperatore. Ras Alula c gli altri capi del Tigrè furono trattenuti nello Scioa. Man gascià. dopo il perdono imperiale, tornò da solo nel Tigrè, co nscio che, se non s i fosse comportato secondo il volere di Menelik, sarebbe stato sostituito con ras Alula. Ormai egli e ra d i ventato un nemico dell'Italia ed agì in conseguenza.
Mentre Mangascià tornava nel Tigrè, an·ivava in Addis Abeba un nuovo inviato italiano, il Colonnello Pian o.
Crispi e l' Antonelli non sapevano rassegnarsi alla rottura definitiva con lo Scioa. L'accoglienza fa tt a da Menelik a Pian o fu glaciale e, dopo aver ribadito la propria posizione, invitò il rappresentante italiano ad a ndarsene. Il 9 luglio il Colonnello Piano e il Traversi l asciava no lo Scioa. I rapporti erano definitivamente int errotti. Traversi consegnò la s tazione di L et Marefià all'ing. Capucci, che la tenne fino ai fatti di Adua.

BATHA AGOS SI RIBELLA
T ' insuccesso della missione Piano determinò le dimissioni dell' Antonelli e fece comprenL derc a Crispi l'impossibilità di un accordo con lo Scioa. Da allora egli divenne un acceso fautore della politica tigrina, ma era ormai troppo tardi. Mangascià, tornato da Addis Abeba. dimostrò ancora modi amic hevoli ver o l'Italia, ma con un piano recondito. Il piano cons isteva nell'instaurare con gli Italiani un· alleanza militare contr o i Dervisci, penetrando in tal modo con i suoi armati nell e linee italiane, fomentando poi la rivo l ta tra le truppe indigene. Egli, per conseg ui re il 1-.i.IO piano, intratteneva trattative segrete con Batha Agos, capo deii'Acchele' Guzai. Qu esti , nemi co per antichi rancori di Johann es c di ra s Alula, si era sottomesso a ll 'Ita lia sin dai primi tempi dell'occupazione dell'Eritrea. Uomo astuto autori tario, era se nz'a ltr o il capo più influente della colonia. A motivare il suo voltafaccia co n co rse la notilia, arrivatagli tramite i Lazzaristi francesi, che l'Italia e ra disposta ad accettare la frontiera di Saganeiti , lasciando a ll'Abi ss ini a r Acchele' Guz a i e il Seraè. Un'altra grave causa di malcontento e di sospetto tra le popolazioni indigene era stato l'infelice tentativo di colonizzazione agricola promosso dal barone Franchetti. Verso la fine d el 1893 alcune famig li e coloniche e rano sta te in sed iate a Godofelassi su terreni esp rop riati agli indigen i. Dopo poco però tali famiglie di rurali, male sce lte e male attrezzate. fallirono l'impresa e furono rimpatriate.
Per mezzo del clero cattolico, Menelik e r a riu sc i to a tenere i rap porti co n Ba th a Agos. Qu esti, stre tti i contatti anche con Man gascià, ne assecondava la manovr a, aspetta ndo iJ momento giusto per in sorgere. Senonchè, per cause non bene accertate, ma forse per il sos petto di essere stato scoperto, Batha Agos affrettò i tempi. Il 15 dicembre 1894 fece prigioniero il residente di Saganeiti, il Tenente Sanguinetti, e due telegraftst i Con un proclama alle popolazioni le incitò a ribellarsi agli Italiani co lpevoli di sottra rgli la terra , imporgli pesanti tributi, render li sc hi avi. Il Maggiore Tosell i accorse a Saganeiti e intimò la liberazione del residente. Batha Agos mosse velocemente su Halai, cercando di impadronirsi del forte presidiato da circa 250 uomini a l comando del Capitano Castellazzi. Pur esse ndo in sc hia ccia nte maggioranza di uomini (circa 1.600), si trovò ben presto tra due fuochi, essendo arrivato il Tosclli in aiuto del presidio. Durante il combattimento. svo ltosi il 18. Batha Agos fu ucciso e i s uo i armati si ritirarono in di sordi ne. TI fratello di Bath a Agos, Singal, si rifugiò nell 'Enticciò con i pochi ri vol to si rima tigli fed e li. La rivolta era sta ta eliminata in quattro g iorni ma e ra stata com unqu e un campanello d'allarme s ull a situazione nella co lonia.
- 36-
GLI SCONTRI DI COATIT E SENAFÈ
Nonostante fosse ormai palese il comportamento di Mangasci.à, egli continuò a professars i amico degli Italiani. Il Generale Barati e ri lo invitò a consegnargll i ribelli e a sciogliere il suo esercito. Il ras non dette alcuna 1isposta. Per prevenirne r ini ziat iva, allora, B aratieri con 3.500 uomini il 26 dicembre marciò su Adua, accolto benevolmente d a lla popolazione. M a, mentre egli s i allontanava dall'Eritrea, Mangascià alla te sta di circa 19.000 uomini, puntava su l M areb per tagliargli la ritirata; Baratieri dovette quindi tornare celermente sui suoi passi.
Il 3 gennaio 1895 era ad Adi Ugri e il 12 a Coatit, s u una posi zione che sbaiTava una possibile ulteriore avanzata di Mangascià. Alle prime luci del 13 l'artiglieria itahana aprì il fuoco su l campo tigrino , quando Baratieri si accorse che con un ampio movimento aggirante i nemici minacciavano di avviluppare l'ala sinistra italiana. Egli fece s ubito intervenire la riserva e ordinò un cambiamento di fronte da est a nord. Per alcune ore le so rti dello scontro sem brarono arridere alle orde tigrine, poi la manovra di Baratieri riu scì e il nemico fu arrestato. 1 due schieramenti rimasero fermi per tutta la notte e anche il 14 s ucce ss ivo. Al calare della notte successiva gli Abissini ripieg arono su Senafè. Baratieri li inseguì instancabilmente. Il giorno dopo i cannoni italiani erano già appostati sulle alture che dominano la co nca di Senafè nella quale vi era il campo di Manga sc ià La batteri a agli ordini del Capitano Ciccodicola seminò morte e panico tra i quasi 10.000 uomini d el ras. Un colpo di cannone colpì anche la sua tenda . All ' interno di essa furono trovati svariati carteggi contenenti lettere di Menelik che lo incitavano alla rivolta, lettere di Batha Ago s che preannunciava la Jivolta e lettere dei padri Lazzaristi che avevano fatto da tramite.
L'OCCUPAZIONE DEL TIGRÈ
Iv ittorios i sco ntri di Coatit e S e nafè avevano provocato in Italia e nella colonia Eritrea uno stato di euforia generale, tanto che Crispi, il 18 gennaio J 895, inviò un telegramma a Baratieri con il quale lo sp ronava ad impossessarsi se nza indugi del Tigrè. Be n presto però una più attenta considerazione dei fatti indu ssero il vecchio statista a frenare gli entusiasmj. Egli cercò con nuovi di spacci di arrestare il movimento che lui stesso aveva ca ld eggiato. I suoi ordini giunsero in ritardo I militrui avevano già varcato i confini, e quel che è peggio, il governo non appoggiò con mezz i adeguati il nuovo balzo in avanti. Gli aiuti si lirnitru·ono all'invio di tre battaglioni.
Al campo di Senafè, dopo la battaglia, s i era presentato al comando italiano un membro della famiglia di Sabagadis, feudatcu·io dell ' Agamè, in lotta da decenni con quella di Manga sc ià dominante il Tembien. La lotta era passata, negli ultimi tempi , attraverso fasi alterne di s uccesso ora dell ' uno ora dell'altro contendente. Poi Sebhat, capo dell' Agamè, era s tato catturato e sostituito con Tesfai. Ma un congiunto di Sebhat, Agos Tafari, aveva ripreso la guen·a per suo conto, tenuto in scacco Tesfai e a l momento della sconfitta di Mangascià si e r a imp adronito dei suoi viveri impedendogli inoltre la ritirata. Ora egli veniva dagli Italiani a chiedere il prezzo del suo intervento sottomettendosi all'Italia. Barati eri lo armò e lo mandò nell' Agamè. Con g li a iuti ri cevut i Agos Tafari occupò Adigrat, che passò così sotto il controllo italiano.
Mangascià, preoccupato della perdita del l' Agamè, olirì la pace. In due lettere, una di febbraio a Baratieri e l'altra di marzo al Re Umberto, rinnovò le profferte di amidzia. Ma Baratieri gli intimò di di s armare gli uomini che nel frattempo il ras stava ammassando nel Gheralta.
Per tutta ri s posta Mangascià mosse su Ad igrat. Il 25 marzo Baratieri occupò Adigrat e annettè l' Agru11è all'Eritrea. Il l 0 aprile entrò i n Adua e il 5 in Axum. Il Tigrè fu presidiato dal IV Battag lione del Maggiore Toselli di stanza ad Adigrat e dal V Battaglione di Ameglio ad Adua.

-37-
L'occupazione del Tigrè preoccupò il governo italiano. Si cap iva che mantenere il possesso di Adua e di Axum avrebbe reso inevitabile la gue rr a. Baraticri alle richieste di Crispi di abbandonare Adua rispose che, dal punto di vista strategico, senza tenere Adua non si poteva tenere neanche Adigrat, visto che i due centri costituivano i capisaldi di una linea che contro ll ava le vie di accesso all'Eritrea. Crispi ribattè che c'erano anche problemi di bilancio e chiese il rimpatrio di due battaglioni. Questa era dunque la priorità del momento per Crispi. Del resto anche il comando in Africa era convinto di poter muovere g uerra a ll'Abis sinia con colonne agili, di grande autonomia, che potessero contare sull'audacia, la mobilità e la sorpresa. Di conseguenza. l'organizzazione dei rifornimenti era tata limitata strettame nte ad una truppa, come quella indigena. che si acco ntentava di poco. L'errore del coman do fu di non aver comp letato tale organ izza zione con una linea arretrata di difesa. tale da poter costituire in ogni evenienza un inviolabile rifugio per le colonne volanti. Oltretutto la frontiera del Mareb non e ra stata munita con opere s t abi li di fortificazione. La stessa linea Adigrat-Adua fu lasciata senza difesa. Solo ad Adigrat fu costruito un forte
Di fronte alle insistenze del governo per una politi ca di raccoglimento, Baratieri capì di essersi spi nto troppo oltre ed il 23 aprile chiese di essere esonerato dalle sue funzioni. Era stanco e demoralizzato. Egli vedeva che a causa dell'occupazione del T i grè la gue rr a era inevitabile. L'unica o luzione sarebbe stata quella di prepararsi a sostenerla con mezzi adeguati. Le dimissioni di Barati eri furono respinte. Egli allora il 20 maggio inviò a Roma un rapporto dove si faceva un quadro preciso della situazione dimostrando che la guerra sarebbe iniziata dopo le piogge c che dunque occo rrevano nuovi mezzi per fronteggiarla. Vedendo che il suo rapporto non era stato considerato, ripresentò le dimissioni. A quel punto fu convocato in Itali a dove gi un se a fine lu g lio.
PREPARATIVI DI GUERRA

Il Generale Baratieri fu accolto in Italia come un tri onfatore. Le ultime elezioni avevano rafforzato la posizione di Crispi. Non fu difficile a quel punto per il generale ottenere ascolto alle sue 1ichiestc. Gli fu co ncesso di co nserv are le truppe a sua disposizione, circa 16.000 uomini tra nazionali. ascari c mobilizzati. oltre a 1.000 ascari da anuolare. Il bilancio per l'Eritrea quell'anno fu elevato a 14 milioni. Nulla fu però previsto di quanto potesse occorrere ad un corpo di truppe metropolitane qualora si fosse presentata la necessi tà di inviarlo in co lo nia. Le st rade erano pressochè inesistenti, scarsi i depositi, del tutto inadeguati i mezzi di trasporto. Baraticri calco la va di non trovarsi di fronte più di 20.000 uomini: egli riteneva quindi sufficie nti le forze ai uoi ordini e non concepiva neppure l'ipotesi di rincalzi di truppe dall'Italia. Non si era quindi preoccupato eli predisporre un 'o rganiz zaz ione, sia pure embrionale, di se r vizi logi s tici per le truppe nazionali.
Verso la metà di settembre Barati eri ripartì per l'Eritrea. Nello stesso periodo Menelik emanava il famoso proclama di mobilitazione: "E' arrivato da noi un nemico. che rovina il paese, muta la religione e ha passato il mare datoci da Di o come frontiera Qu es to nemico incomin c ia ad avanzare, forando la terra come le talpe. Con l'aiuto di Dio non g li abbandonerò il mio paese... Nessuno deve rimanere a casa perché tutti devono prender pmte alla dife a della loro terra e delle l oro case". Secondo le parole stesse del proclama, la guerra era stata determinata dalla ava nzata italiana nel Tigrè. Menelik vi era costretto dalla necessità di sa lvare il proprio pres ti g io personale. I capi tigrini rimast i a lui fedeli reclamavano, come prezzo della loro sottomissione. che il loro paese fosse liberato. Già da aprile la guetTa era stata decisa. Alla fine de ll e piogge, Mangascià con rinforzi i nviatigli dali" Imp eratore si s tabilì a Macallè. In Eritrea le forze itali ane, circa l 0.000 uomini, vennero radunate ad Adigrat. Baratie ri decise di affrontare Manga sc ià prima c he la mobilitazione e il concentramento degli Abissini fossero comp letati. Ma all'avvicinm·si del1e co lo nn e italiane il capo abissino si ritirò, lasciando solo una modesta retro-
- 38-
guardia a Debra Hai la a sud di Antalo. Tale retroguardia fu facilmente dispersa il 9 ottobre. Era mancato il combattimento vero e proprio. Ras Sebhal, che era prigioniero sul l 'Amba A lagi, cercò l'aiuto dcgli Italiani, che lo liberarono il 13 ottobre dandogli il comando dell'Endertà. Completata in tal modo l'occupazione de l Tigrè, fu la sc iato a Macallè il Maggiore Toselli con l'ordine di f011ificarvis i Il forte doveva serv ire da osservatorio avanzato. pronto ad essere abbandonato al primo urto, sulla linea Adigrat-Adua. Questa, seco ndo Baratieri. doveva serv ire da dife sa. Fu fortificata l'altura di Fremona su Adua. Poi il grosso delle truppe rientrò in Eritrea c furono smobilitate le bande.
AMB AALA GI
Mentre il comando italiano s mobilitava, Menelik intraprendeva la marcia di avvicinamento. Egli aveva indicato ai suoi armati come zona di concentrazione la regione deii'Asciang h i. Ras Maconnen fu mandato avan ti con l'avanguardia la cui estrema punta era al comando di ras Alula.
n Generale Baratieri, incerto s ull'entità delle forze e sui movimenti del nemico , verso la metà di novembre deci e di inviare in esplorazione un distaccamento sul ma ss iccio dell'Amba Alagi, c he barra l'accesso al Tigrè. Vi inviò prima una compagnia, poi l ' intero battaglione di Toselli. Quest i spinse la ricogniz ione su Belegò il 27 novembre ad una tappa dal lago Ascianghi. Solo allora, per la prima volta, accortisi dell'entità nemica, si ebbe la sensazione della gravità del pericolo. Avvertito dai dispacci di Toselli, Baratieri ordinò l'adunata delle forze a Macallè sotto gli ordini di Arimondi. Intanto Toselli, incalzato dall 'avanguardia etiopica. ripiegava da Belegò ve rso I'Aiagi. TI Generale Arimondi, preoccupato per la so rte di questo lontano distaccamento, decise di mu ove rgli incontro da Macallè e ne informò Toselli. Ma Baratieri, per non disperdere le forze, non autorizzò il movimento. Per una serie di circostanze e di malintesi il contrordine non arrivò a To sc lli, come non gli giunse mai l'ordine di ritirarsi su Macallè; così, giunto all' A lagi, il battaglione vi s i trincerò. Erano 1. 800 uomini , che la mattina del 7 dicembre furono investiti da circa 30.000 armati d e ll'avanguardi a di Maconnen d is tribuita in tre colonne. Avvertito da Toselli del per icolo che lo minacciava, Arimondi, senza aspettare una nuova autorizzazione del comando, mo sse in s uo aiuto. Ma era ormai troppo tardi. La posizione dell'Amba Alagi fu tenuta per sette ore. Toselli, con un sangue freddo che non g li venne mai meno, ebbe cura costante di tenere libera l a sua sinistra verso il sentiero dal quale dovevano arrivargli i soccorsi. Qui fece affluire le riserve, qui con rinnovati attacchi alla baionetta cercò di tenere a bada le masse degli Abissini. Ma la destra e il centro furono travolti. Stretto contro la parete roccio sa del monte, cercò, con un disperato contrattacco, di farsi largo; ma le fila furono decimate e le muniz ioni si esaurirono ben pres to. Prima di dare il egnale della ritirata, Toselli mandò a scrutare l'ori1.zonte verso nord. Dall'espressione del volto de l l'ufficiale tornato per riferire, comprese la sua sorte e dei suoi uomin i L a ritirata fu u n ecatombe. Il senlìero stretto, sul marg ine dì un bu1Tone, si riempì presto di salmcrie e di fetit i, ment re dalla cresta del monte, ad una distanza di poche decine di metri, gli uomi n i di ras Alula CJivellavano d i colpi le truppe che ripiegavano disordinatamente. In tale disperata situazione. il Tenente Manfredini ebbe il coraggio di mettere in batteria i cannoni che comandava e di sparare a mitraglia contro le orde abissine che minacciavano la ritirata. Esauri te poi le munizioni , i pezzi, intrasportabili, furono prec ipitati nel burrone.
Tose lli si preoccupava ancora d i Alimond i Gli mandò incontro un uffic i a le per infonnarlo dello scontro e per esortarlo a non esporsi. Poi, fermatosi, attese la fine. La sua salma e quella degli ufficiali caduti s ul campo furono se polte da Maconnen con gli onori militari.
Arimondi, raccolti 300 degli scampati al combattimento, riu cì, con una fortunata manovra a svincolarsi da una mi naccia di aggiramento sulla destra e a ritirarsi in Macallè. Anche questa pos i-

- 39 -

40-
zione sembr ò troppo esposta; occorreva ri servare il grosso delle forze alla d ifesa della linea Adi g rarAdua. Non si voleva pe rò abbandonare il forte, dove erano s ta ti concentrati ingenti rifornimenti. Pe rt a nt o vi fu lasciato di presidio il Maggio re Galliano con il suo battaglione.
Lo sco ntro di Amba Alagi non era sta to voluto da Maconnen. Il ras aveva ricevuto ord in e da Menelik di agire con la massima prudenza e di no n trascurare la possibilità di concludere un accordo. Giunto quindi davanti ag li avamposti ita li an i, aveva avviato, tramite Tose lli , dci co nta tti co n Barat ieri. Questi, per comprende re le inte n zioni abissine, aveva mandato da lu i il commerciante Pietro F e l ter. Mentre erano in cor o tali app rocci, le truppe tigrine, insofferent i di non combattere, rup pero ogni i ndu gio e a ttaccaro no gl i It al iani. U na vol ta riportata l a vittoria, og n i esitazione cessò. Tuuo concorreva verso l a c ri si.
Baratieri, sgombrata Adua, concentrò le truppe in Adigrat. L e fo r ze di cui disponeva ora apparivano insufficienti. D Pa rl amen to votò nuo vi fond i, c hi ede nd o c h e fosse tutelato il prestigio militare. Di quante forze avesse bi sog no Barati e ri , egli no n lo precisò mai. Da q ues to momento sem brò c he la fiduci a in se stesso abba nd o na sse i l generale. Appariva fortemente ind ec iso e il s uo prestigio comin ciò a vac illare
Il govern o di sua ini z iat iva a pprestò quattordici battaglioni e cinque batte ri e. Verso i primi di feb braio 1896 Baratieri aveva già a sua disposizione 24.000 uomini, dei quali 14.000 nazionali. La m aggior p arte delle fo rLe era dunque cost ituit a da truppe naz ional i. Ciò camb iò radicalmente la natura de ll a guerra; non più colonne agili e mosse di sorpresa, ma un a guerra lenta e di posizione. Si comprese allora in pieno il grav issimo danno di non aver preparato gli adeguati mezzi logistici necessa ri al rifornimento di in ge nti truppe metropolitane.
MACALLÈ
Il forte di Macallè com in ciò a d essere investito dagli Abissini il l o gennaio 1896. Nell o scegliere la l ocalità per edificare le ridotte, era stato com messo un g rave e rTore: non si era tenuto con to della necessità di assicurarsi i rifornimenti di acq u a. Tra i dirupi del monte c'e ra no due fo nti , una, l a meno abbo ndante, era sit uata in un burrone ai piedi del forte, l' altra, più copiosa. ad una distanza di c irca me zzo ch il o m etro. Nessuna delle due e ra stata inclusa ne l s is te m a di for tifi cazione. Un a pic co la ridotta a nord -es t difendeva la fonte più vicina.
Me n e lik giunse a M aca ll è il 7 ge nnaio e lo s tesso gio rn o sfe rrò un viol e nto at tacco Tutti gli assa lti però furono r es pinti co n acca nim e nto. La rid o tt a a difesa d e lla fo nte più vicin a fu perduta, ripresa e infin e fatta saltare ap pena ca duta d efinitivame nte in mano nemica. Le proprie perdite di uomini impressionarono M enel ik il quale, in un con iglio di g uerr a al qu a l e partecipò an c h e l'Imp e ratri ce Taitù, propose di ripe tere g li attacc hi nei giorni uccessivi. L a sov rana sugge rì di prend e r e il forte per se te. Fu essa infaui che ordinò ai s uo i armat i di occ upare e ntr a mb e le fon ti facendole riempir e di terra e presidiare costan temen te. Og ni te ntati vo ita lian o di riprendere le fonti fu vano. I gio rni trascorsero e l'esercito a bi ssi no era sempre intorn o alla "fossa" come Me ne lik c hi amav a il fort e, e i ri fornimen ti cominciavano a scar segg iare. L ' Imp e ra to re e ra impaz iente . tanto più c he i rinforzi inv ia ti dall ' Italia afflu ivano o rmai a Ma ss aua. Fin dai primi di ge nnaio era arrivato a l campo del N egus Pi e tro Felter. M e ne lik lo rima nd ò da Barati e ri pe r proporg li di iniziare sub ito t ra ttati ve di pa ce. Come prova della sua disponibilità a trattare l' Impe rato re si dichiarò di spos to a la sc iar partire il pres idi o sotto la gara nzia e scorta di Maconnen. Il 19 i patti f uron o com uni cat i a Galli a no L" eroico pres idi o c he resisteva da più di due sett imane era ridono a llo stre mo. G alli a no aveva deciso. piuttosto c he arre ndersi, di far sa lt a re il forte. I1 p res idi o uscì dalle ridotte il 21 ge nn a io portando co n sé tu tto l 'eq uipa gg iamento Gli furono resi gli onori delle am1i. Ma, co ntrariam e nt e a l patto de ll a resa , non

-4 1 -
gli fu concesso di raggiungere subito le linee italiane. Esso dovette procedere a piccole tappe. circondato dal grosso delle truppe scioane dirette verso Hausien. Il forte fu distrutto dagli Abissini i quaJi ripresero la marcia il giorno 23.

LA l\tiARCIA PROTETTA
Dall'l l gennaio Baratieri aveva concentrato l'esercito in Edaga Hamus pronto a gettarsi sul fianco nemico, se questi avesse tentato di puntare verso nord. Ma Menelik aveva ben compreso il piano italiano. P er sventarne la minaccia, egli si avvalse del Battaglione Galliano come di un ostaggio. al coperto del quale fece avanzare il grosso delle forze. Intanto. per tenere a bada l'avversario, in isteva perché si iniziassero le trattative di pace. facendo no tare che l a sortita del presidio di Macallè era stata concessa a tal fine.
Baratieri ch iese istruzioni a Crispi, il quale rispose che l'Italia doveva riportare una vittoria sui nemici e poi si sarebbe potuto parlare di serie trattative. Tuttavia Baratieri, pur di farsi restituire gli ostaggi dal nemico, promise a Menelik di mandargli il Maggiore Salsa. ma solo dopo che il Battaglione Galliano fosse stato liberato. Visto che nel frattempo il grosso dell'esercito aveva raggiunto l'Hausien, il Negus acconsentì.
Portata a term ine la marcia di avvicinamento, si presentava per Menelik la necessità di stabilire un piano di guerra. Ras Alula fece prevalere la decisione di invadere l'Eritrea. Era il vecchio piano seguito da J ohannes contro gli Egiziani nella campagna del1894. Fu perciò ripresa la marcia in avanti.
Baratieri, per controllare meglio le mos e avversarie, il 3 febbraio si trasferì a Mai Gabetà. al centro delr Enticciò, una regione ricca d i acqua c di pa col i, dopo aver effettuato una rischiosa ma rcia tra forre e dirupi, dove una sorpresa nemica sarebbe stata fatale. I due eserciti si trovarono così ad una decina di chilometri l 'uno dall'altro, separati solo da una dorsale di alture roccio e.
L'obiettivo di Baratieri era semplice: come ai tempi di San Marzano. egli ce rcò di farsi attaccare su una posizione fortificata, in modo da compensare, con la strategia, l'inferiorità del numero. Cercò in tutti i modi di provocare l'attacco nemico. Gli Abissini, che aveva no ormai una lunga esperienza di questa st rategia, evitarono le posizioni fortificate italiane. Questa schermaglia durò per un mese La tattica di Menelik, una volla compreso il piano italiano, mirava a sorprendere le truppe nemiche in movimento mentre si trasferivano da una posizione all'altra. Visto che gli Italiani, a causa della schiacciante inferiorità numerica, non erano in condizioni di attaccare, g li Abissini sfmttarono il grande vantagg io dell'iniziativa, tan to da evitare la battaglia come di provocarla nel momento e nelle condizioni che apparissero loro più favorevoli.
Baratieri fu il solo che sembrò capire che tutti i rischi erano per gl i Italiani e cercò quindi di porre rimedio ad una strategia che si stava rivelando perdente. Il 23 febbraio iniziò il movimento di ritirata da Sauria, dove s i era rafforzato, su Adi Caieh, per trincerarvisi. I gene rali brigadieri che lo coa diu vavano furono però di avviso contra1io ed eg li , avvilito e dubbioso cedette a lle Clitiche di questi. Il 7 febbraio, Baratieri, per aderire alle richieste di Menelik, aveva inviato al campo abissino il Maggiore SaJsa per ascoltare le proposte nemiche. L'Impe rato re pretendeva che il confine eritreo fosse riportato a i limiti del trattato d i Uccialli e c ioè a Saga neiti. Da parte italiana si richiese l a linea Adigrat-Adua. l negoziati furono interrotti. Per rendere se mpre piC1 precaria la pos iz ione italiana, Menelik minacciò la con1isca dei beni a quanti parteggiassero per l'Italia. Ciò fu sufficiente perché ras Sebhat e Agos Tafari passassero senza più indugi dalla parte del Negus. Le popolazioni d elle reg ioni da loro govemate, si sollevarono, minacciando le retrovie italiane. La si tuazione s i fece talmente delicata che un intero battaglione, comandato dal Colonnello Stevani, ru distaccato dal grosso delle truppe per assicurare le comunicaz ioni con l'Eritrea. Il 20 febbraio Menelik. con mosse pru-
- 42-

-43.. ..
Uno degli assalt i al Forte di Macallè (xilografia di Eduardo Ximenes).
denti, s i trasferì nella co nca di Adua, sp in gendo la sua avanguardia su l Mareb. L a manovra se mbrava propedeutica all'invas ione dell'Eritrea. Essa obbligò B aratieri a distaccare un altro battaglione. il V di A meglio, per dislocarlo sul ciglione di Gundet per proteggere Adi Quala.
Int anto in Italia vi era molta agitazione per i fatti af1icani. Il governo Crispi ebbe la sensazione, seco nd o i rapporti in v iat i gli, che le forze in Africa non fosse ro suffic ient i. Furono perciò prepar ati nuovi rinforzi, a ltri 20.000 uomini. Infin e nel Consiglio dei Ministri del 22 febbraio fu deciso di revocare il comando a Baratieri sost iru endo lo col Generale Baldissera. Questi due giorni dopo si imbarcò segretamen te a Napo li . Non restava che attender e l'arrivo sul posto del nuovo comandante e dei rinforzi g ià invi at i. In spiegabi lm ente però il 25 Crispi inviò a Barat ieri un telegramma dove definiva l a g ue n·a una "t isi militare".

Tale sfe rzata g iun e al comando in Africa proprio n e l momento più cr iti co della ituazione. La prevalenza delle truppe metropol1tane ne l corpo di sped i zione aveva richiesto un ta l e sforw logi t ico, sopra ttutto a causa della distanza delle basi, che in poco tempo più della metà dei dromed ari adibiti ai trasporti erano morti. All a fine di febbraio c'eran o v iveri so lo per circa se tte giorni. In tale cont in genza B aratier i il 28 febbraio si decise a tenere un cons i glio di g ue rra Durante la riunione tutti i brigadieri s i pronunciarono per un attacco immediato. Il Maggiore Salsa non e ra presente; convocato d a Baratieri e messo a l corrente della proposta, i dichiarò di parere nettamente contrario. Egli aveva co n statato, ne lla s ua visi ta al campo abissino per i negoziati di pace, l'entità delle forze avversarie, conoscendo per di più le difficoltà del terreno.
Propose quindi di resister e fino agu estremi su ll e posizioni di Suarià, salvo ri p iegare in Eritrea qualora i rifornimenti fossero ve nuti a mancare. Probabi l mente questa sareb be stata l a sce lta più asennata, a nc he perché g li s te ssi Abissini cominciava no ad ave re grosse difficoltà ad approvv1g i onare di viveri il loro sterm inat o esercito. B arati e ri sce lse una via di mezzo. Ordinò per l a mattina del l 0 marzo un nuovo balzo in avanti sulle a lture c he dominano da levante la co nca di Adua, per contro llare più da vici no il nemico e provocarlo finalmente alla battaglia. Era quindi uno de i soliti movime nti effe ttu ati nel percorso d a Adigrat ad Ad ua. Fu distribuito ai comandi uno sc hi zzo ap prossimativo d e lten·eno da percon·ere e delle po s izioni da presidiare. Ta le schizzo era tutt'altro che esatto e per di più molto somma ri o. Nell'eseguire il movimento avvenne quello c he gli Abissin i avevano sperato sin dall'inizio de ll a campagna: riuscire a orprendere l e forze italiane prima che avessero av uto il tempo di rafforzarsi su ll e nu ove posizioni e accerchiar le.
LA BATTAGLIA DI ADUA
Il cen tro del sistema difensivo tigrino era cost ituito dalla conca di Adua, una spec ie di co rte bastionata circondata a no rd e ad est d a una serie di a lture. I va li c hi tra amba e amba sono a ngu sti e difficili. I detriti delle rocce, caduti durante i seco li , hanno fatto del terreno una pietr aia. Nella corti na di alture che separa la conca di Ad ua da quella dell'Enticciò, il pi cco ce ntral e è quello del Raj o, fac ilmente riconoscibile tra gli a l tri pe r la s ua cuspi d e terminale, so mi glia nte ad un pollice umano vo lto contro il c ie lo.
Bara ti e ri aveva pensato di fa r e del mont e Rajo il perno della sua nuova lin ea. Di s pone va di quattro brigate, delle quali un a indi ge na. n comando di quest'ultima era tato tolto a l Generale Arimondi per darlo al Generale Albertone, ufficiale di minor esperie nza del suo predecessore. ln tutto g li Itali a ni di s pon eva no di 14.500 uomi ni e 56 pe zz i di art iglieria . Aveva no di fronte una ma ssa di circa 120.000 armati, di cui 70.000 forniti di fucili.
Il piano di Baratieri era il seg ue nte: consi teva nello schie rare l e truppe alla destra e alla sinis tra del monte Rajo in modo da contro ll are la piana di Adua appoggiand osi ad un formidabile bastione
- 44-
Q= · Siiiiit1=::E2 Km.
l s uccessi vi momenti d e lla ba11ag lia di Adua
•• • j Brigata Alber fone- ore6
2 . 8rigata Albertone- ore 8
3.Avang. Br/gala Oabormida- o.9
4 . 8rigata Oaborm/da- orto 11

5.8rigata Art'moncl/ - ort- ff
6.Brigata R/serva E/lena- o. /P
7. Comando- ore 11
naturale. Dispose perciò che le Brigate Arimondi e Dabonnida occupassero il valico di Rebbi Arienni a destra del Rajo e la brigata indigena il passo di Erara sulla sinistra. La riserva, costituita della Brigata Ellena, doveva concentrarsi dietro il Rajo. Tutto sembrava stabilito nel migliore dei modi. Il centro della linea di schieramento era i l Rajo. Le posizioni dovevano essere occupate alle prime luci dell ' alba, con un movimento sincronizzato e nella massima sorpresa. Ogni soldato aveva una dotazione di 112 cartucce; ogni pezzo di a1tiglieria 90 colpi. Una massa di fuoco del tutto insufficiente, ma si difettava di muli ed era il massimo che i soldati potessero portare.
Tra le colonne in marcia mancò quasi subito il collegamento. Prima l'ala sinistra , poi la destra oltrepassarono di vari chilometri gli obiettivi loro assegnati; in questo modo le singole brigate si trovarono impegnate in combattimento l'una dopo l'altra e dovettero sostenere isolate l'urto di tutte le forze nemiche.
.. .
N··
-45-
11 primo errore che segnò l'inizio deJJa catastrofe, fu commesso dal Generale Albcrtone. La brigata indigena, che formava l'ala sinistra, andò ad invadere la direttrice di marcia della Brigata Arimondi che era al centro; questa dovette altendere che i battaglioni di ascari sftlassero; il che fece perdere oltre un'ora. La sincronia dei movimenti venne a mancare. Ritrovata la sua via, la Brigata Albertone non attese che la Brigata Arimondi si portasse alJa sua altezza, né si curò di stabilire con essa i necessari collegamenti. Giunti gli ascari al colle di Erara, dove avrebbero dovuto schierarsi, procedettero oltre. La scusante poi addotta da AJbertone fu che sullo schizzo dimostrativo, consegnatogli da Baratieri, il Colle di Erara era stato denominato per errore "Chidane Meret'', mentre il vero Chidane Merct era qualche chilometro pii:J lontano in direzione di Adua. Ci fu un momento in cui il comandan te del battaglione di avanguardia, il Maggiore Turitto. preoccupatosi di allontanarsi troppo dal monte Rajo, si fermò a chiedere ordini al Generale Albertone. Sembra che per tutta risposta gli sia stato risposto "Vada avanti, non abbia paura". Il battaglione proseguì infatti per Adua. Albeggiava, quando dagli accampamenti abissini si videro le creste delle alture di fronte popolarsi di nemici.
Menclik ed i ras er ano nella Chiesa di San Gabriele ad ascoltare la messa celebrata dall'Abuna Matteos quando, al momento dell'elevazione, risuonò il segnale di allarme. Subito fu sferrato l'attacco. Gli ascari si batterono con grande coraggio e slancio. Ma torrenti di armati abissin i, agli ordini dei ras Mangascià e Micael si rove ciarono su di loro. 11 battaglione fu accerchiato e in gran parte distrutto. Il combattimento durò dall'alba alle otto circa. l superstiti ripiegarono sulla linea dove si erano sc hi e r ati nel frattempo g li altri battaglioni della Brigata Arimondi. Le sch iere della compagnia Cesarini. che costituiva l'estrema ala sinistra del Battaglione Turitto, i addo arono, sempre combattendo, su di un· altura. Contin uamente incalzate, esse retrocedettero di roccia in roccia contrattaccando alla baionetta ogni volla che il cerc hi o dei nemici si st rin geva. Giunte in cima all'altura. non potendo più procedere, piuttosto che arrendersi ì combattenti si lasciarono cadere nel baratro. dove vennero poi trovati accatastati gli uni sugli a ltri .
La linea Albettone fu sub ito investita. Il fuoco di fucileria c dei cannoni itali<mi aprì immensi varchi nelle compatte orde attaccanti. Ci furono da parte cti queste degli attimi di esi tazione. Si fece avanti per rincuo rare le truppe il fìtaurari Gabeicheu, lo stesso che sull'Amba Al agi aveva dato il segnale dell'attacco. Una scarica di fucileria lo freddò. Le masse abissine retrocedettero, lasciando il terreno disseminato di cadaveri. Un gruppo di donne s i fece incontro agli armati che si ritiravano. Tra loro c'era l'Imperatrice Taitù vestita a lutto, sotto un ombrello nero, accompagnata dalle sue ancelle. Menelik, che assisteva alla scena impressionato dalla grande strage dei suoi uomini ed esitante ad impegnarsi a fondo, fu apostrofato da Mangascià con le seguenti parole: "Da otto anni facc io la guerra agli Italiani c voi per un giorno solo non osate''. La guardia imperiale fu allora lanciata all'attacco. La battagJja s i riaccendeva. l nuovi combattenti, più addestrati. più cauti e meglio inquadr ati, avanzarono a piccoli gruppi tra i ces pu gli, dando tempo al grosso delle forLe di errar e so tt o. Fu scalata la vetta del Monoxeito. il pilasu·o della linea Albettone. L'accerchiamento allora di ventò inevitabile. Le batterie con un fuoco infernale tentarono di tener testa agli assalitori. ma ben presto le munizioni si esaurirono. Gli ultimi colpi furono sparati per coprire la ritirata dei fant i verso il colle di Erara. Albertone eb be ucciso il suo muletto e fu quindi fatto prigioniero.
Baratieri dal colle di Rebbi Arienni sulla destra del R ajo, aveva visto i battaglioni di Albertone spiegars i in combattimen to e scomparire dietro la cresta delle alture. Davan ti alla piega presa dagli avvenimenti, Baratieri modificò il piano del giorno prima; invece di far schierare le brigate a destra e a sin istra del Raj o, le dispose davanti al monte; fece perciò occupa re da Ari mondi le falde del Rajo c he fronteggiano Adua; dispose che alla sua inistra, ul colle di Erara, erroneamente chiamato Chidane Me ret, si raccogliessero i battaglioni dì Albertone, a) quale era stato ingìunto di ripiegare. Sulla destra Dab o rrnida ricevette l'ordine di occupare le posizioni antistanti a quelle in precedenza asse-

-46 -
gnategli e c ioè di s tabi lirsi su i monti Zeban Darò e Be ll ah, formando così un semicerchio aperto verso s ud in modo d a pre nd e re d'infi l ata le truppe ab issine che avessero attaccato il Raj o. Con il nuo vo dispositivo ven iva no sa ldam e nte co ntro lJ ate tutt e le vie provenienti da Adua e dirette verso no rd e l'e s t. Dabormid a effettuò il mo v imento ma , in vece di ri sa lire le pendici dei monti indica t igl i, pro ce dette molto più avanti (ve r so la valle di Mariam Sciauitò), evidentemente per portarsi in po siz ione dove gli fo sse poss ibile appogg i are la ritirata di A lbertone. Ma , age nd o così, si allontanò di qualch e chilometro dal teatro delle operazioni, perdendo ogni collegamento con A.rimondi . Qu est i ve nn e a trovars i co n l a des tra co mplet amente scope rta. Stessa cosa accadde alla sua sinistr a, visto che i resti de i battaglioni indigeni. d e m ora li zzat i dalla tremenda sco nfitta, si e rano dis pers i. Arimondi p e rciò era isola to s ul Raj o. Gli Abissini ne ap pro fittaro no immediatamente per stab ilirs i su ll e pos izi o ni circostan ti rimaste indifese e ripetere la mano vr a avvolgente riuscita co n la Brigata Albertone.

Per prima cosa inves tir o no la posizione di destra (mo nt e Zeban D arò). S i o rdinò ad un battaglion e di Bersag lieri di imp ad ronirsi della c im a preve ne ndo g li Abissini. Ma a ll ' in saputa del comando la maggior parte del ba ttag lion e e ra già stata imp eg na ta e non riman eva no disponib il i che po c hi uomini. I bersagli e ri al co m a nd o del Colonnell o Compiani g iun se ro in quarama sulla vetta, in gagg iando un fu rioso co rp o a co rp o co n g li S cioa ni m a rutto f u va no; b e n pres to furono tutti uc cis i L a s itu az ione stava diven ta nd o in os te nibil e
Da de stra e da s ini stra gl i Abissin i sce nde va no alle s pa ll e del R aj o per completarne l'accerchiam e nto. Si imbattero no ne ll a ri erva de l Gen e ral e Ell e na c he non aveva av uto la p oss ibilit à di esse re imp eg nata organica me nt e. Poco prima di mezzogiorno le Bri ga te Ellena e Arimondi dove ttero ripi egare. Arimondi congedò l'att e nd e nte c h e era pre sso di lu i e attese la morte s ul campo.
M e ntre infuliava il co mbattimento s ul Raj o, Dab ormida , spintosi se nza accorgersene nella valle di M aria m Sc iauitò, sb ucava in una larga valle acquitrin osa, co perta di erbe. Informato dell'avvicinarsi di forti masse nemiche, il ge ne ral e fece schierare le truppe su una linea dalla quale era possibile dominare la vall e. Di fronte a lu i ve nn e ro a sc hierarsi le truppe di ra-; Maconnen. In vano il Co lo nne llo Airaghi cercò, a più riprese. di in erpi carsi s ui ben difesi pendii. Ver o le tre del pomeriggio. non avendo notizie dalle a ltre zo ne del fronte, Dabormida si dec ise ad un ultimo tentativo di sfo ndam ento. Anche questo a tt acco f u p erò respinto. Quasi tuui gl i ufficiali e rano cad uti ; notevoli le perdite. Non rim aneva c he ritirarsi. Ma la via del ritorno doveva essere aperta passo passo, a ll 'arma bianca. Tutti i va lic hi e rano in mano al n em ico. L a ritirata era cope rta da Airaghi che riu scì a far piazzare due cannoni e a te ne re a bada le o rd e in calza nti P er non esse re ann ientate le truppe dovett e ro lanciarsi all ' attacco co n il co raggio della di speraz ione. Jl passo di D o ngo lò Harmaz fu esp ugnato so lt o una pioggia scrosciante. Poco prima era caduto il C o lo nnello Airaghi, ferito a ll e gambe e finito d a un a torma inferocita I1 suo posto ne ll a retroguardi a fu subito preso dallo stes o Da bo rrnida. Presso il vi ll agg io di Su nc uhena la retrog ua rdi a s i trovò sbarrato il passo mentre co min ciava a fars i notte. Ne ll o sco ntro che ne seguì Dab o rmida fu co lp ito a l petto. Tn cond iz ioni no n m o lto dissimili e ra avvenuta, a ttra verso la va ll e di l e ha , la ritira ta delle al tre tre briga te Stormi di cavalleria galla non dettero treg ua alle trupp e che ripi egava no. avvo lgend o le con v io lente cariche.
li massacro era compiuto. Jl 3 marzo quanto res tava delle quattro brigate s i co nce ntrò in Adi Caiè h L'ese rcito aveva avuto 6 .000 morti , dei quali 4.600 nazionali e 268 uf-fi c ia li ; oltre a 500 feriti e a l .700 prigionieri. Ben più grav i erano s ta te le perdit e deg li Abi ssini, che avevano pers o 7.000 morti e l 0 .000 feriti dei qu ali 2.000 morirono nei giorni s uccess i vi All ' imbrunire Ta itù , e ntrata nella tenda rega le, appose all 'or ecchio di Me nelik il cerchio d"o ro de l vi nc it ore. P e r tutta la notte co ntinuò l'org ia di san g ue: i morti e i feriti furo no evirati e affi nc hè ness un o s fuggi sse alla crude le so rte fu dato fuo co ai cespug li. Seco ndo alc uni test im o ni , quella no tte si vi d er o parecchi feriti brancola re nell a piana in preda alle fiamme. L'ira d e i vincitori s i ri vo lse a nc he co ntro gli ascati ca duti pri gionieri. Intorno
-47 -
a Menelik c'er a c hi pretendeva c he fossero tutti m assac ra ti ; egli pe rò rimise la decisione all 'Abun a Matteos c he con d an nò g li sve nturati ascari a l taglio de ll a man o destra e de l piede si ni stro.
In I talia l ' impress ion e per il disastro militare fu e norm e. Vi furono disordini di piazza e la prima conseguenza a li vello poli t ico furono le dimissioni di C ri sp i volute dal R e Umberto. Al posto de ll o statista sicilia no fu chiamato Di Rudinì.
ULTIME OP ERAZIONI MILITARI
Il 4 m arzo a Massaua sbarcò il G e nerale B aldisser a. Egli pensò prima di tutt o ad arginare la minaccia proveniente d a ove t. Me ntre g li lt a li aru era no alle prese con gl i Abissini infa tti , i Dervisci avevano occ upat o Cassala e me sso so tto assedio il fo rte di Agordat, fornito di una g u a rnigione di c irca 300 uomini mal equi p aggiati e dotati di scars i vive ri. Baldissera inviò il Colonnello Stcvani a ll a testa dì tre battaglioni, in aiuto de l presidio di Agordat. Il 2 aprile Cassala fu ripresa e furono riap erte le com uni caz ioni co n Cheren ed Agordat. 11 g i o rno dopo fu preso il forte trin ce rato ma hdì sta di Tucruf, determinando il frettolo o ritiro delle truppe nemic he oltr e I'Atbara. Anche le operazioni co ntro g li A bi ss ini f uron o a lt rettanto positi ve. Appena riorganiz zato il co rpo di spe di zio ne. B a ldi ssera m osse co n un a fo rza di c irca 17.000 uomini da Addì Cai e h , penetrando ncll" Agamè. liberando poi il forte dì Adigrat.
CONCLUSIONE
Il 6 marzo Ba ldì ssera aveva in v ia to il Magg iore Salsa ad Adua per occuparsi del se ppellime nto dei morti. fn r ea lt à l'ufficia le doveva i niziare l e tratta ti ve di pace con Men e lik. Fu preparata una bozza dì trattato c he prevedeva il co nfine e ritreo s ull a line a Mareb-B e le sa-Muna; l 'escl us io ne dì protettorati s ull 'Ab iss inia ; l a nomin a nel Ti g rè di un ca po ab issi no c he fosse gra dito all'Italia; infine l'abbandono da parte degli Ital i ani di Adigrat.
Le co ndi z ioni ve nn ero accettate d a l gove rno Di Rudìnì, a co ndi z io ne però c he il Ne g us non accettasse pr o te ttorati da a ltre nazioni e urop ee. A qu es te condizioni le trattati ve naufraga ron o. Il 6 maggio finalmente il gove rn o italiano accettò le condizio ni ab issine. anche p er poter arri vare a ll a liberazione dei 1. 900 pri gio ni e ri che per m es i s ubiro no maltratt a ment i di ogni so rta. Fin a lm ente il 26 ottob re 1896 fu s tipulato un trattato di pace co mprend e nte tutti i punti di quell o del 6 m arzo, più l a dichiar azi one c he se l ' Italia avesse a bbandon ato l'Eritrea, questa sareb be passa ta all 'Ab issi ni a.
L ' Itali a s i impeg nò inoltre a pa ga re la so mma dì dieci milioni di lire al Neg us come rimb o rs o per il mant e nimento dei pri g io nieri.
IL PROC ESSO BARATIERI
l1 processo a d uno dei du e capri es piatori del di sas tro di Adua ( l 'altro fu Crispi) s i a prì il 5 g iug no 1896 ad Asmara, concludendosi il 14 seg uente . L e accuse c he vennero m osse al ge nerale e ra no della m assi ma g rav it à . Tuttavia eg li ve nn e as o lto, anche se il tribunale so ttolin eò la m a nca ta azione d e l co mand a nte dura nte la battaglia e la con eg uente ritirata.

Si c hiudeva così un 'epoca, dur a ta circa di eci anni, con alternanze di offensive e di ritirate, di o p erazio ni condotte a li" in seg na dell'approssimazione e di g ra ndi ambi z io ni e di rinun ce.
Da allora l'Eritrea conobbe un lungo periodo dì tranquillità fino a lla nu ova impresa coloniale intrapresa dal fa scismo nel 193 5-36 c he portò alla conquista d e ll'Etiopi a .
- 48 -
FOTOGRAFI ITA LIAN I I N ERITRE A ( 1885-96)
In queste brevi not e ss i fa un accenno ai fotografi operanti in Eritrea nel decennio preso in esame dal presente volume.
Fra i prim.i fotografi italiani c he giu nsero per lavoro in E ritrea vi fu certamente Luigi Fi orillo, del quale, presso l'archivio fotografico dell'Ufficio Storico dello SME. si co n ervano numerose foto. A lui si devo no i primi sca tti esegu iti nella colonia italiana, raffiguranti le fortificalion.i, le prime costruzion.i ed insediamenti militari, Ma ssaua con il porto, Assab e le prim e località occupate, le trupp e con i propri ufficiali. Fi orillo illu stra in mani era senz'altro esauriente g li aspetti dell'Eritrea d i queg li anni, forte anche della propria notori età non so lo in Italia. Non bi sogna infatti dimenticare l a sua presenza ad Alessandria d'Egitto sin dal 1882 co n un s uo studio, docum e ntando il bombardamento inglese della città proprio di quell'anno.
Altri importanti fotografi, indubbiamente più attenti a ll 'elemento umano locale, furono i fratelli sici liani Francesco e Giova nni Nicotra, la cui prod u.d one fotograììca più inte ressante risale al 1886, i quali co llaborarono co n un al tro co llega, Mauro Ledru. Anche di loro, a ll o SME, si conservano la ma gg ior parte delle immagini di questo vol ume.
Luigi Naretti, altro foto g rafo altrettanto importante di quelli prima ricordati. è quello che però seppe calarsi in man.iera integrale nel tes s uto del pa ese dove operava. Giunto in Eritrea dalla nativa Ivrea intorno al 1883, lo troviamo attivo a Mas sa ua e dintorn.i fino alla sua mo1te, avvenuta nel 1922. Il lavoro del Naretti non co nosce pause. I suoi sogge tti più ricoiTenti so no notabili e capi locali, paesaggi, i rappresent a nti di svariate razze , ritratti e g ruppi fotografici di militari, cerimonie sia civili che rn.ilitari ecc.
Non poss iamo dim e nti ca re un altro grande della fotografia italiana operan te in Africa: Eduardo Xim e ne s. Personaggio poli e dri co, pittore, giornalista, fotografo. lo Ximenes ci ha lasciato numerose immagin i afri cane, con la particolarità però, di trasformare s pesso le foto in splendide Xilografie des tinate ad illustrare le pubbli caL.ion.i del tempo. Giunt o in Eritrea poco dop o la co nfitta di Adua, lavorò intensamente per circa quattro mesi. I frutti del s uo lavoro confluirono in varie pubblicazioni , le più famose de ll e quali so no quelle della Treve s Editori (" La guerra !taio -Ab iss ina ") . Da non dimenticare anche un suo volume. "Sul campo di Adua", illu s trato anche da a ltri disegnatori. che ebbe un g rande successo.
Molte immagini fotografiche ci so no state la sc i a te a nch e dal capitano barone Errando Di Aichelburg, il cui fratello E r vedo morì nella battaglia di Ad u a. Anche il s uo reperto1io è molto vasto, s paziando s ui sogge tti più vari.
Ri co rdiamo per ult i m o, tra gli autori di fotografie che formano questo vo lum e. il dottor Gi ovanni Quattrociocchi, medico d e lla Croce Ro ssa Italiana ope rante in Eritrea dopo Adua.
Ovviamente quelli fin qui norn.inati non sono gli unici fotografi ad aver operato in Eritrea. Essi sono pe rò (come accennato all'in iz io) g li a u to r i de ll e foto prese nti in questa pubblica zio ne.
Per saperne di più si rimanda a ll e pubblicazioni speci!ìche citate nella bibliogra!ìa.

- 49 -
TABELLE DI FORMAZIONE DELLE TRUPPE SBARCATE A MASSAUA IL 25 FEBBRAIO 1885
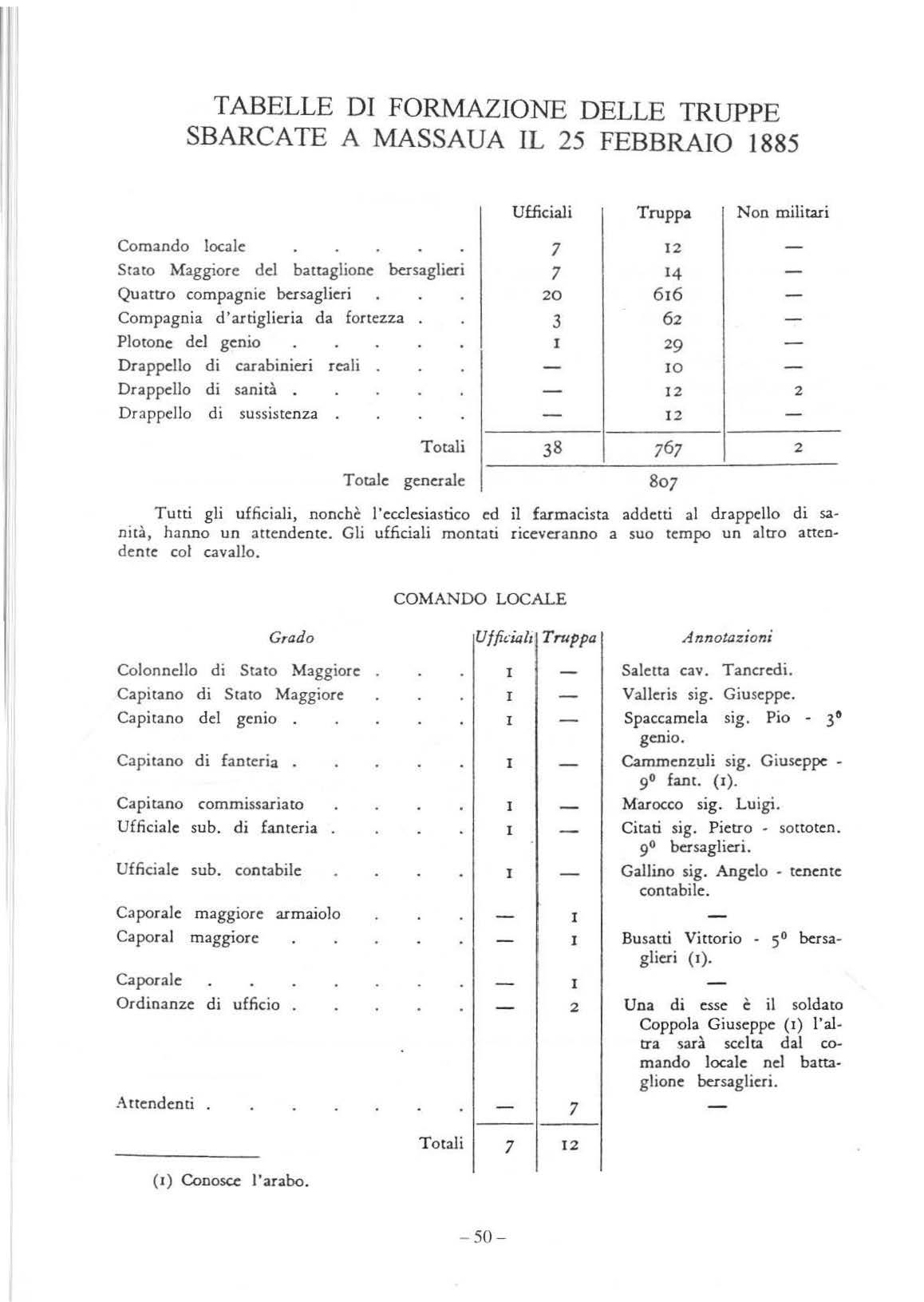
Comando locale
Srato Maggiore dd battaglione bersaglieri
Quattro compagnie bersaglieri
Compagnia d'artiglieria da fortezza
Plotone del genio
Drappello di carabinieri rea li Drappello
Tutti gli ufficiali, noncbè l'ecclesiastico ed il farmacista addetti al drappello di sanità, hanno un attendente. Gli ufficiali montati riceveranno a suo tempo un altro attende nte col cavallo. Grado
Colonnello di Stato Magg io re
Capitano di Stato Maggiore
Capitano del genio
Capitano di fanteria
Capitano commissariato
Ufficiale sub. di fanteria
Ufficiale sub. contabile
Caporale maggiore armaiolo
Capora l maggiore
Caporale
Ordinanze di ufficio
COMANDO LOCALE
1 Saletta cav. Tancredi.
I Valleris sig. Giuseppe.
I Spaccamela sig. Pio - 3G genio.
I Cammenzuli sig. Giuseppe 90 fant. (I)
Marocco sig Luigi.
I Citati sig. Pietro - sotto ten. 90 bersaglieri.
I Gallino sig. Angelo - tenente
contabile.
I Busatti Vittorio - 5° bersa-
glieri (I).
Una di esse è il solda to Coppola Giuseppe (t) l'altra .sarà scelta dal comando locale nel battaglione bersaglieri.
sanità Dr appell o dì sussistenza Totali T o tale generale Ufficiali 7 7 20 3 I Truppa 12 14 616 62 29 IO 12 12 807 Non militari 2 2
di
Attendenti . ( 1) Conosce l'arabo.
Totali Uffù:wli Truppa Annotazioni
7
I
I 2 7 12
- 50-
STATO MAGGlORE DEL BATTAGLIONE BERSAG LIERI
Tenente colonnello
Capitano mec!ico
Grado
Aiutante maggiore in 2"
Ufficiali sub. medici .
Ufficiale sub. contabile
Furiere maggLorc:
Caporale maggiore
Sergente zappatore
Caporale trombettiere
Capora.l magg. o caporale
Sotrufficiale armaiolo
Allievo armaiolo
Attendenti Capitano
Sotto tenenti
Furiere
Sergenti
Caporali maggiori
Caporal furiere
Caporale zappatore
Caporali Appuntati
Trombettieri
Zappa tori.
Portaferiti Soldati
Annotazioni
Putti cav. E milio - 40 bers.
del 40 bersaglieri.
d d 3° batt aglio ne del 40 b ersa glieri.
I del t 0 bersagl., I dd 7 0, I ddi'S 0
del 40 bersaglieri.
dd 40 bersaglieri.
del 4 ° bersaglieri.
dell'S 0 ber saglieri
dd I 0 bersaglieri .
dell'S 0 bersaglieri.
dd 70 bersaglieri
dd Io bersa g lieri
An notazio ni Le compag nie bersaglieri:
a) la 6a. compagnia del 1° rc:gg. bers., comandata dal capitan o Ga rdini signor Enrico;
b) la I Ò" compagnia dd 40 re gg. bers. comandata dal cap. Viandli sig. Ce sare;
c) la Il" compagnia del 70 regg bers. comandata dal capitano Rovida signor Fr ancesco;
d) la 12" compagnia del· rso regg. bers. comandata dal capitano Garofalo sig. Domenico.
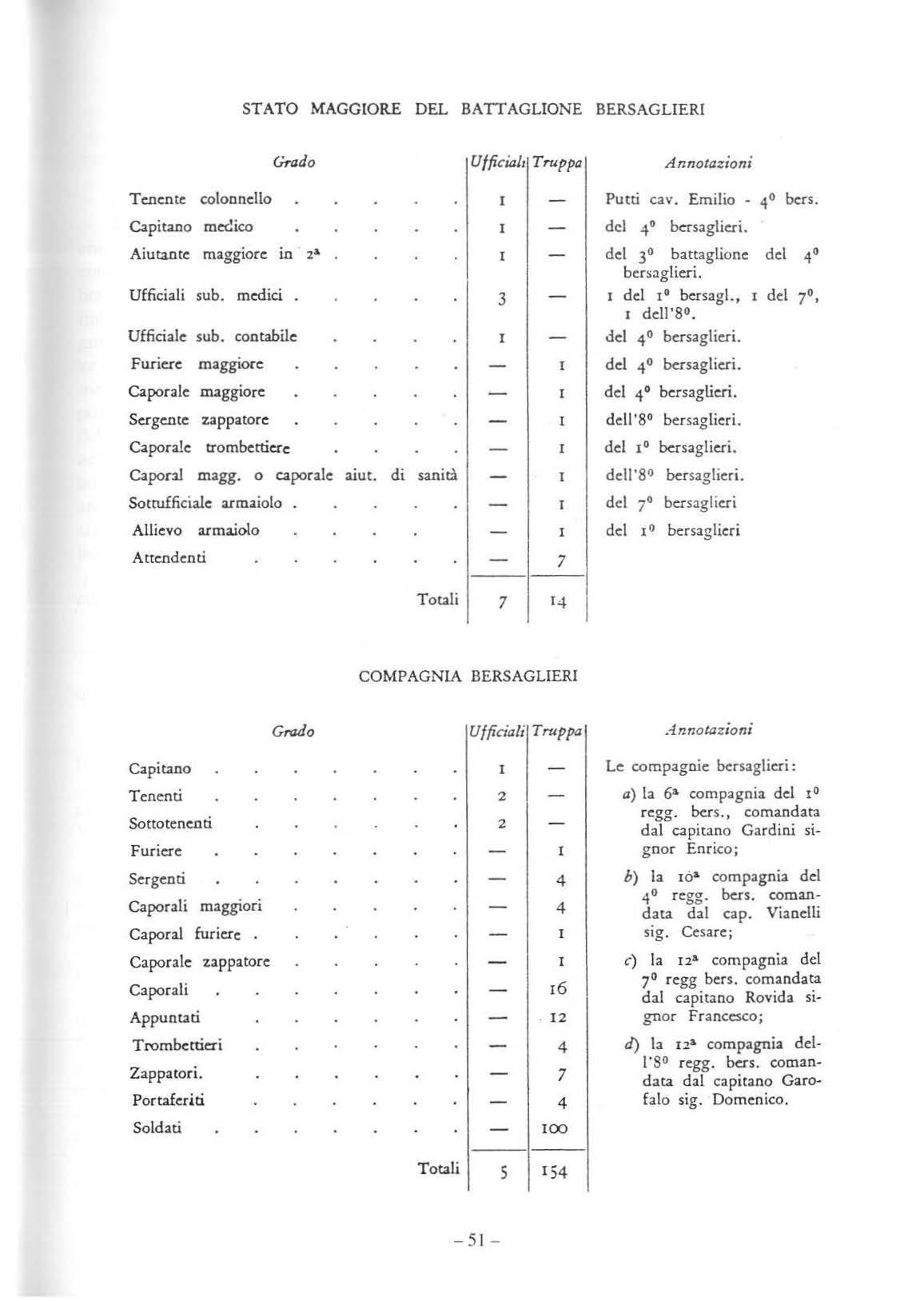
Tenenti
Grado Ufficialz Truppa I I I 3 I I l aiut. di sanità I I I 7 Totali 7 14 COMPAGNIA BERSAGLIERI Ufficia li Truppa I 2 2 4 4 I I r6 12 4 7 4 100 Totali 5 154 -5 1 -
DRAPPELLI DI SANITA' E SUSS ISTENZA
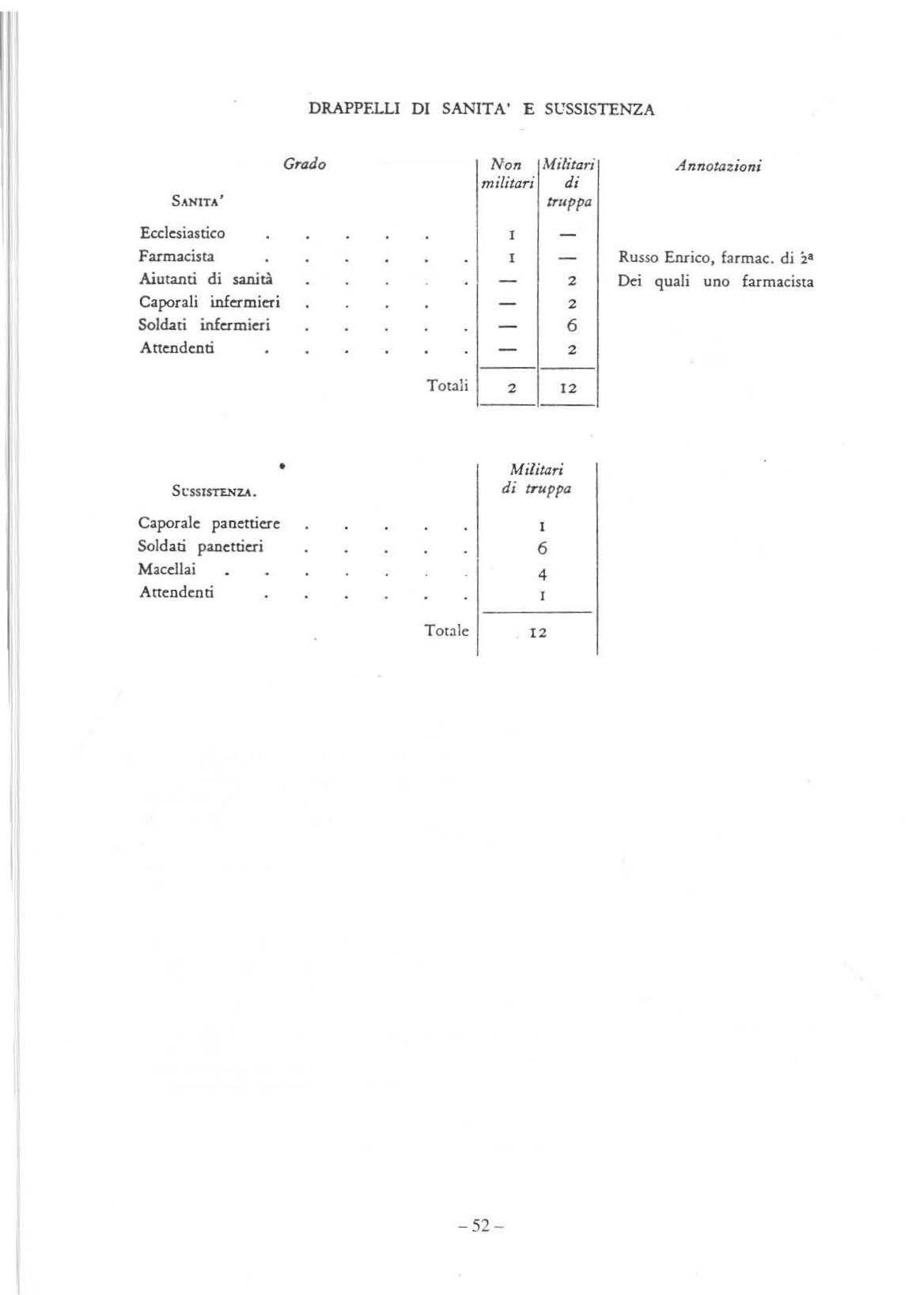
Grado SANlTA' Ecclesiastico Farmacisu Aiutanti di sanità Caporali infermieri Soldati infermieri Attendenti • St:SSISTE.NZA. Totali Non Militari militari di truppa I I z 2 6 2 2 12 Militari di t ru ppa Caporale panettiere 1 Soldati panettieri 6 Macdlai 4 Attendenti I Totale 12 -52Annotazioni Russo Enrico, farmac. di 2a Dei quali uno farmacista
Il palazzo del Comando edificato non dal M un zinger né dal Gordon, come fu credu t o, ma da Arake l-bey governato re pe r rE g itto è un vasto rettangolo ad arc hi di sesto acuto dolcissimo, che lo recingono da og ni lato e a t erre no si distendono in portico. nel piano superiore in terrazza. congiunti, l'un con l'altro, da una balaustrata. Nel mezzo della facciata, a pochi metri da l mare. due bran c he semi-c irco la ri di g radi ni mettono ad un pianerottolo, su cu i poggia una scala rettilinea, che imbo cca ne ll a terrazza di fro nte all'arco mediano. La piant a del piano uperiore h a la forma di croce greca. Nel ce ntro un a sa la ottagona, a cupola: quattro galle ri e, i quattro lati d ella croce, dalla terrazza conducono ne ll a sala ; terrru nano dalla parte este rna co n port e munite di battenti massicci, riccame nte istO ri a ti d ' inta g li a rilievo ; dall'interno con g randi archi di pi e no ce ntro, g uarniti s ino all'impostatura di usc iali a t rafor i. Nei quattro angoli della c ro ce altrettante sta n ze, in c iasc un a d e ll e quali dal so ffitto a l pav im ento due g randi vetrate che danno s u du e lat i della terrazza. una porta che dà ne ll a sa la. Di co no di ave rlo re s taurato, ma in realtà lo g uas t a rono; per fortuna, cor t i forse a qu a ttrin i, no n poterono sco nc i are se non l e forme e l a struttura rim ase quella di pr i ma. L'aria c he per ventise i arca te (so no se t te nei l ati più lun g hi , negli altri sei) e ntr a ne ll a terrazza trova, tra finestroni, porte e archi inte rni , ve nti a mpli ss imi aditi a penetrare nell'ottagono ccmrale; finchè un ·aura spira, anche lieve, ci si s ta , co me ho d etto, d' in canto: nell 'a pril e co n veniva gua rd a rsi da' r iscontri e da ll e correnti.
Ero lì una m att i na leggiucchiando e fan t ast ic and o, quando capita un amico e mi domanda a bruciape lo:
- M a nella piana d'Otumlo ci si ete ancora sta t o?
-Co n que ti bollori? A c he fare?
-A che fare, lo ved rete da voi. Dalle quattro in poi, di questa stag ione, non si bolle più. Alle cinque ve ngo a pigliarvi. Vi ripeto, ve drete .
E av re i visto cose da far fremere; me le accennò in poche paro le, chè non aveva tempo di trattenersi
Rima s t o so lo: co m e?- pe nsavo tr a me- affa m ati, morti, s u la pubblica st rada, un chilometro fuori di Massaua, e da tr e g iorni s ia mo qui e nessuno ce ne ha detto nulla?

Mi pareva imp oss ibil e . Nondimeno bi sog nava c re d erc i ; l 'a mi co non e ra uomo da accendersi fac ilm e nte ne ll a fanta sia; e a veva veduto coi propri occhi e profferto di con durmi a vedere co'miei. Venne , a ll e c inqu e in punto, ed andammo.
La pi a na di Otuml o, è una sterminata dis te sa di sa bbie, ne ll a pa rte verso c ui m 'avv iavo e che cos teggia la ba ia d' Archico, s parsa, con lunghi inter va lli , di r ad i e g rac ili cesp ug li di tamerici. Qu e l giorno la di ga di Ta ulud c he vi conduce, era, come se mpre ve rso il tramonto. gre mit e di persone d 'og ni ri s ma e d 'og ni co lore : gente che dimora ad Otuml o, il giorno sbr iga le faccende o attende a i commerci in M assaua, e la se ra se ne torna al vi lla gg i o. Passava no a cavallo i ricchi m e rcanti musulm ani ra cco lti ne ll e a mpi e ves t i bianche e c o l bian co turbante d i mu so lin a: e d ietro a loro le mogli vela t e, anc h 'e ll e no inforcato il muletto trottere llante, os t en t a nd o a l o l e la eleganza d eg li ombrellini rossi frang ia ti , e il lu cc ic hio d e'pi cco li di sc hi di latta c he vi ricorrono in cerc hi o s ull 'o rl a tura; il pollice del pi e d e nudo p remente. a gu i s a di gancio, l a s t affa; la veste raccolta per non impacciare le gambe, o for e per pompegg iars i nell a mo s tra d e ll e brac he bi anche o rn ate con gra n s far zo di freg i ro ss i in ri ca m o. P o i la lun ga pro cessio ne de'pedoni: frati co pti dal l 'a nd at ur a pigra, in lunghe tuniche g ia ll e bisunte e co ns unte e il g iallo turbante c ilindri co sopra la testa: i Sudanesi neri co n l e labbra tumid e, s porge nti , lu s tri da parere in ve miciati , g li A ssaort ini bron.Lei, una breve ' ·futa" cinta s ull e anche, in mano la lancia, al br accio lo scudo. negli occhi torvi e ne i lin eame nti duri i segni d'una covata feroc ia
IL CAMPO D ELLA FAME
-5 3-
Seguitavo a pensare: qui affamati, qui morti? Perché, "si parva licet componere magnis", dire la diga di Taulud, a Massaua. è come dire i Portici di Po a Torino, o a Venezia le Procuratie.
Dubitavo: ne'racconti uditi strada facendo ci aveva a essere dell'esagerato. Pur troppo innanzi alla realtà de'fatti ogni descrizione mi parve biadita.

Che era egli dunque avvenuto?
Da cinquant'anni le guerre civili travagHano l'Abissinia: ne'recenti vi piombarono sopra ca lamità d'ogni pecie: ep izoozia, cavallette. colera e da tante maledizioni un ultimo nagello: la fame. Gli abitanti, poco propensi per indole all'agricoltura e più avvezzi oramai a maneggiare il fucile che a guidare l'aratro, si sveglia rono dal coltivare. Coltivare con che, se i buoi li ha uccisi la peste? Coltivare perché? Perché le cavallette divorino c i rase i pre ti piglino quel che rimane? Così, dopo aver patita la carestia piC1 anni, ora la cagionavano. La dogana di Massaua rigurgitava di sacchi di "dura", principale alimento agli indigeni: veniva da Bombay. pareva segno d'abbondanza ed era prova di miseria. Miseria crescente, minacciosa verso i ricchi medesimi, perché un sacco di dura delle Indie che costa quattordici lire a Massaua , portato a spa ll a d'uomo o a dorso di mulo o di cammello, ne costa quarantatre a Cheren, a Adua cento o poco meno. L o sbarco degl'Italiani, la occupazione dell ' altipiano, furono occasione a lavori molti, diversi, urgenti; c'era bisogno di braccia, e in quel tramestio anche i più disadatti trovarono il verso eli guadagnare. Di là dal Mareb fu detto e creduto che Dio. misericordioso alle colpe delfAbissinia, aveva intanto perdonato all'Hamasen, dove era pane per tutti; e da l Tigrè cominciò e proseguì per mesi e mesi l'esodo delle famiglie, volgenti a Massaua come alla terra promessa. Tardi. I privati a ll e proprie necessità avevano già sopperito, la più parte delle opere pubbliche erano ultimate. di altre s'era rimandato il compimento ad anni migliori. E intanto dal Tigrè arrivavano a centinaia ogni giorno mace ri , piagati, rifiniti dagli strapazzi e dalle privazioni del lungo viaggio. Per giunta, venivano da regioni infette e, se duravano in quelli stenti, era da temere coppiasse qualche malanno. ll governatore ordinò che quanti mancavano di lavoro quotidiano si sfrattassero o ltre la diga.
Scacciati dall'asilo sospirato per tanto tempo, tra l'inopia più squallida, s'erano attendati nella piana d'Otumlo. Allenda ti? In quel lembo di deserto alcu ni s'eran fatti un tucul più misero, se è possibile, del consueto, alni rizzata una stuoia; i più fortunati avevano per casa un cespug lio, tutti per letto la sabbia cocente. Qua, là cadaveri abbandonati, co perti da un cencio la faccia; un o, orribile a vedere. pareva muoversi. tanto brulichio d'in etti gli erpeggiava per le membra disformate e disfatte dalla sferza del sole. I morti aspettavano le iene, i v ivi la morte. Da un cespuglio escono fili di voce, sporgono e si stendono mani scarne, tremanti dell'ultimo brivido. Qui, dalla rena un moribondo con supremi sforzi si rizza ul torso, guarda con gli occhi sbarrati, vitrei, non vede, manda un rantolo, ripiornb a sul terreno battendo la schien a e la nuca; là una donna accoccolata, c he non può più parlare, accenna con un moto cont inu o del capo un bambino di quattro o c inqu e anni, prossimo allo sfinimento; e che teso a'suoi piedi vo lgendoci le pupille smorte sussurra "meschin. meschin" con voce languida, rauca. Ci accostiamo per soccorrerla e da'giacigli immondi sub ito si l eva una turba di sche l etri ti, nel corpo de'quali sotto l a pelle tesa, si distinguono ad una ad una le ossa. come ne'carcami mummificari del Gran San Bernardo. Tentano di segu irei, sussunano anch'eglino "meschin meschin" esausti di forze cascano , fan per rialzarsi, s trapiombano , ricascano, si s tra sc ica no dietro a noi carponi, chiedendo aiuto con gemiti che paiono ululati. Le madri alzano a fa ti ca da terra i lattanti e ci seguono con pianti e con strida, additandoci, là dove fu il seno, una grinza. Di st ribuimm o qualche lira, soccorso risibile in tanta indig enza, inutile a chi sarà morto fra un 'ora. E la processione de'pedoni, de'muli, de'mercanti. delle donne seguitava folta e chiasso a. Mi ritraggo per isca nsarl a e m'abbatto in fanciulli che frugano nello sterco de'cammelli a cercarvi un chicco di dura; mi volto raccapricciato e sco rgo altri fanciulli, c he gli ··zaptiè'' a forza allontanano da una carogna di cavallo, fetido avanzo di iene. alla quale, abbrancati, strappavano co 'denti le interiora: l e interiora perché più
-54 -
molli, e più molli perché più imputridite. Fuggo, inorridito, istupidito , vergognoso della impotenza mia, na scondendo per vergogna la catena dell'oriolo, vergognando in me stesso della colazione che ho fatta, del desinare che m'aspella. Lo so, lo so, ciò che avete da dirmi: sovvenire è imposibile, non v'è soccorso che basti, e se oggi s i soccorresse, s i rovescerebbe domani qui tutta l'Abissinia. Lo so, lo so. che non tutto è disgrazia e c'è la pigrizia, l'imprevidenza, l'incuria; ma chi ha cuore di rimproverare moribondi che invidiano i morti? Udii per più giorni ragionamenti savissimi, ma per più notti tra l'allucinazione ed il sonno, nel corrompersi e confondersi delle immagini mi gravarono inc ubi, mi perseguitarono visioni, di alcuna delle quali tuttavia mi rammento. Ora mi svegliava di sobbalzo il contallo di un corpo gelido, ora una mano gelida e ossuta mi premeva sul petto e mi toglieva il respiro; e nel sogno affannato, mi pareva fuggire fuggire, sotto un so le ardenti ss imo, senza meta , senza scampo, per lande senza confine riarse , inseguito da iene che mugliando si approssimavano, inseguite alla lor volta da una sc hiera di Sudanesi, so pra cavalli giganteschi che correvano a briglia sciolta, fra torme di frati. di mercanti , di donne, di scheletri con la lancia e con l'ombrellino.

-55-
Da "Nell'Affrica Italiana" di Ferdinando Martini- Milano. 1895
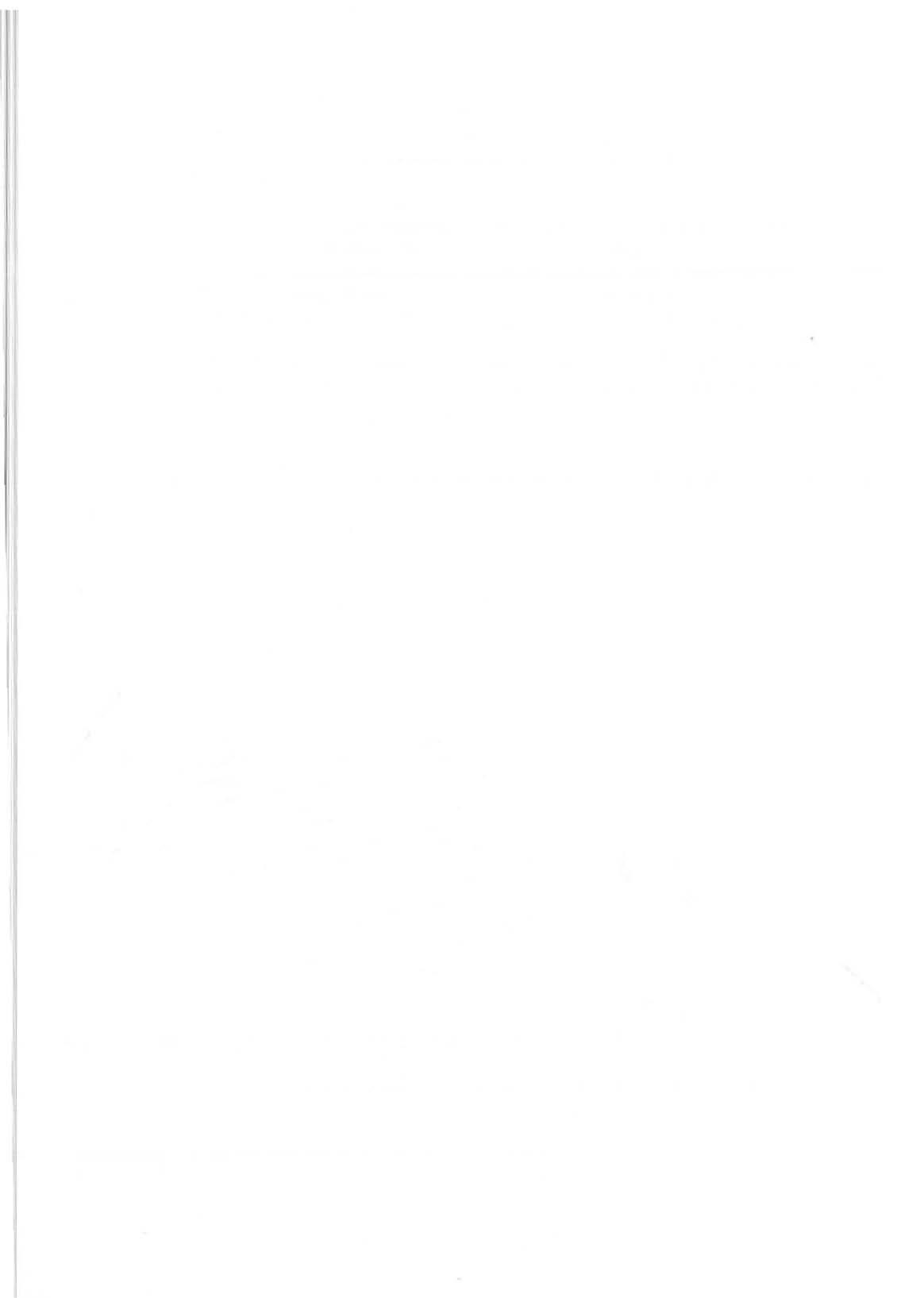
l l l
Poveri mor1i! Deponete corone di fiori pallidi sulle zolle ove caddero, piangete sui loro tumuli lacrime interiori, che si asciugano più tardi.
Andammo a Dogali, e deponemmo una corona anche noi.
Sabbie, sabbie, dappertutto sabbie che scottano e abbacinano; e per le sabbie qualche solo arbusto di "calotropis" dalle grosse bacche ovate, verdi con riflessi celestognoli, il cui sugo latteo, a detta degl'indigeni, infiamma la pelle di chi s'arrischia a toccarlo. Più innanzi un torrente, il Desset, traversa la valle e, lambendo un labirinto di alture aspre e aride, va a perdersi nel deserto che congiunge Moncullo col mare. Sulla pianura biancastra s'alzano i poggi lividi, nudi alla cima: paiono teste calve di cadaveri giganteschi, sorgenti di sotto a un immenso lenzuolo, prossime ad imputridire. Il Desset, come molti torrenti dell'Abissinia, asciutto la più gran parte dell'anno, si gonfia a volte per la pioggia in un tratto, così da abbattere e subissare ogni cosa che trovi. Guai allora la notte alle carovane accampate sulle sue rive! Poco innanzi che giungessimo a Massaua, ingrossato in un attimo, travolse e annegò più di quaranta persone, senza che avessero il tempo neppur di svegliarsi. Altre carovane vi si accampano ancora. Quella è la via che fu sempre percorsa; perché mutarla? Lì sono le acque ove da tempo immemorabile si abbeverarono i cammelli; perché cercarne altre altrove? Si può rischiare la vita: ma che va]e la vita per un Abissino?

I nostri procedevano nell'alveo del torrente, diretti a Saati. Alla loro destra, i lievi pendii di due colline isolate e, indietro più alti, i poggi che chiudono da quel lato la valle; a sinistra altri poggi separati da va11once11 i e da forre, onde sbucano di quando in quando verso il Desset acque repentine
Di là sbucarono quel giorno, altrettanto repentini, i nemici. Allora la valle era folta di cespugli, dietro a'quali gli Abissini poterono avanzarsi nascosti. Non pretendo descrivere il combattimento che non vidi: ma i luoghi li ho visti, e chiunque li ha visti, anche senza essere stato a scuola di strategia, intende alla prima che per i nostri, quando s'accorsero d'avere il nemico di fianco, a sinistra, non c'era da scegliere: bisognava guadagnare le colline a destra e appostarvisi. E poterono difatti guadagnare la più vicina e meno e levata; ma su la cima lo spazio era così breve, che i cinquecento soldati non avevan o luogo a schierarvisi, né a rigirarvisi le mitragliere; il fuoco per conseguenza non o rdinat o e poco efficace.
Intanto, i fucilieri abissini salivano affrontando e intorno intorno la cavalleria si distendeva a guisa di ventaglio per congiunge r si poi in corona e ci rco ndare ambedue le colline. Cercarono migliore difesa sul co ll e più alto, e discesero e riascesero combattendo e vi g iun sero: ma so l tanto per vedersi accerchiati.
Là sul colle di D oga li , se alcuno, come a noi, descriva le poche vicende del combattimento, cresce la pietà per i cadu ti, l'ammirazione diminuisce. Vittime intre pide s i , ero i no: non sfidarono la morte, la morte li sopraggiunse impensata. Mmirono degnamente, se nz a cercare scampo, ma videro che il ce rcarlo era inu ti le. Vittime, non eroi: ed è questione questa, di ben al tro c h e di parole; vantando l'audacia di tutti, si ce la o si sc u sa la crudele spensieratezza di alcuni. Nel 1887 paragonammo Dogali con le Termopili, senza neanche pe nsare c he in quel raffronto ci affibbiavamo la parte di Serse, e di un Serse sprovvedu to e scon fitt o . Poco danno, se nella foga frasaiola di un'orazione funebre si dimentica la storia greca; il danno gr ave si fu di andare in Affrica igno r ando la storia, i cost umi, og ni cosa del popolo che vo le vamo, prima o poi, soggioga re, e fm la topografia del paese che ci proponevamo di co nqui s tare li colonne llo Saletta, la prima volta che sbarcò a Massaua con un battaglione di bersaglieri, aveva questi o rdini: adoperare molta prudenza verso il presidio eg iziano, e
DOGALI
-57-
fare una " recognizionc " fino a Cartum. Per quanto lo sproposito possa parer grossolano a chi abbia veduto, una volta so la , una carta dell' Affrica, nondimeno fu scritto, e i documenti son lì.

A furia di sb ra cc iarci nel decretare apoteo s i, abbiamo guastato quanto v'er a di schiettamente alto nella rassegnazione serena di qu e l sac rifi z io. Quando le ip erbo li furono esaurite , si pose mano a'monumenti: la ro zza croce che 11 capitano Mi c helini ha piantata sulla collina inferiore di Do ga li, tra le ossa de'"compagni della prima posizione" fa ripensare all'orrore di quella carneficina e venire le la crime agli occhi: la co lonna marmorea eretta sulla più elevata induce a tri ste zza molto div ersa: e come dimostra che non sap pian1 o più fare i monumenti, prova forse a ltresì che non s iamo ancora educati a fare le colonie. Chi nell 'ottantase tte c nell'ottantotto, presc indendo dai principii e dalle dottrine, diceva: "Venite via; Saati non è una meta, è un riposo: restando sare te spinti tant'oltre, c he il venirvene poi, si dimostrerà più difficile le cento volte"; chi allora e ortava a questo modo, più c he i dife tti dell ' Affrica considerava i mancam e nti nostri: se noi avessimo tanto di pazienza e di pertinacia, da preparare con sforzi quotidiani, profitti, quand 'a nc he certi, non prossimi; se fossimo abbastanza tetragoni, da sop portare i g uai che le colonie cagionano in sulle prime; se abbastanza pac ati per un a sim ile impresa, o non invece troppo facili a lasciarci sopraffa re da confidenze o timori troppo subitanei. E per tornare a Do gali, io tuttavia mi sgo me nto se rip enso lo sgome nto che a ll ora ci colse. Dico sgomen to, badiam o: il dolore, c hi non lo provò? E finchè si pianse quei poveri morti , tanto più meritevoli de l nostro cordoglio quanto più fu inutile il sacrifizio loro; finchè eruppero le collere contro chi non aveva saputo risparmiarl o, s i dette sfogo a ciò che l'anima umana ha in sé di migli ore. Ma i più accalorati per la sped izion e d' Affrica, co loro che più batterono le mani a'soldati quando s' imbarcavano a ll ' Imma co latella, rima ero sbigottiti: in poche parole avevamo creduto, o parve, di poter marciare per l'Abissinia in lun go ed in largo, se nza farci neanche una s tincatura E da quel tempo, sia detto tra parentes i, cominciò l'a ltra esagerazione di cacciare alte grida ognj volta che un de'nostri so ldati , o io Affrica o in Italia dormendo all'aperto. busca un reuma o un 'infreddatura. Sta bene: i soldati non so no carne da ma ce ll o, né debbono esporsi a fatiche improbe, o a perico li, se nza ragion e adeguata: e chiunque vigila affi nchè c iò non avvenga fa opera buona, chiunque redargui sce l'incuria o la cocciutagine per le quali ciò avvenga merita lode. Non tutti bensì sanno serbare quella vigilanza nei giusti limiti: e le querimonie smode rate che il popolo ascolta, non credo valgano a ringagliardirlo. Potete dire degli eserciti tutto il prò e tutto il co ntro: magari affermare, se tale è il vostro pensiero. che so no una necessità tristissima, un danno , anzi addirittura una rovina dell'economia nazional e; ma quando avrete detto bene bene, se vorrete esse re ragionevoli, conchiuderete come il Padre Ricci dei suoi Gesuiti: "s int ut sunt aut non sint". Né io m'adatto a credere c he si sia decretata la leva de'chierici, per portare ne'battaglioni le cure riguardose de 'sem inari .
Da quella condizione degli animi no stri , dopo la strage di Dogali , pro vennero i tentennamenti e le circospezioni, dei qu a li noi risentiamo in Affrica tuttora l'effe tto. Ra s Alula di sse recentemente ad un italiano "Ai vostri cannoni e ai vostri fucili non si res iste: ma in un combattimento con altre armi la vittoria non sarebbe per voi ". Questo, o g iu s to o no, è il g iudizio dell a mente forse più acuta c h e sia in Abissinia, e perciò temp erato, nono stan te l'orgoglio dell'uomo e la va nità della razza. Gli altri danno di noi giudizi più crudi. Ci sa nno più forti di loro per la quantità e la qualità delle armi, ma dicono: "E h! le armi s iete molto bravi nel fabbricarle: no i bensì le maneggiamo meglio di voi.". Mc lo sono se ntito dire io e più volte: c poiché la ret icenza è tìgura usitati ss ima in Abi ss inia , si capisce ciò che i mi e i interlocutori, pur tacendolo. intendevano s ignificare.
Fatemi la grazia, c he vo lete c he pensino? Parlamento, bilancio, giornalismo so no parole intraducibili in tigrigno e in amarico. Batha Agos, a d es ignarmi un corris pondente di giornali di cui aveva dimenticato il nome, si servì di que s ta perifras i: "quegli che sc rive la storia". La definizione, se vogliamo, no n è precisa. Guerra , generali, soldati, so ldati , generali e guerra: altro non sa nno; non fu pos sibil e intendessero mai che cosa sia una commissione d'inchiesta: ci c hiamavano g li "Afar Ne-
- 58 -
gu ", oss ia ( ignora n o perfino che la coro na è inviolabile) le "bocche del re". Ne 'primi giorn i io c he avevo un reuma in una gamba e pativo ne l m ontare a cava ll o, passru per un generale ferito. D e'fa tti nostri quali co no scono?

J ohannes venne tra Sabarguma e Ailet, ci nqu e o re di m arc ia di sta nt e da Saat i, v i rimase otto giorn i. Costretto dalla penuri a di vettovaglie (la ten·ibilc ne mica che gli Abis s ini con ducono in guerra tra le lo ro file e c he su l più bello l e accascia e di s perde) la sc iò il campo e ritornò s ui propri pass i. Pe r o rdin e de l ge nera le San Marzano sq uadre e so tt o-squadre con taro no i tu cu l abban do nati : e r ano ve ntidu emila: date le cost uman Le abiss in e s i può adunque calcolare c he col Neg us s i avviassero per I' Ha mase n c irc a ottan tam il a perso ne.
Si sa che cos'è la marcia e, peggio, la ritirata di un esercito abissino. Il r e. i ca pi innanzi: dietro a lo ro per se ntieri aspri e a ngust i un a lun ga process ione di so ld at i, di ca nt ori, di timballieri, di vecchi, di pret i. di fanciulli, di d on ne, di muli: con a rmi , tende a ttrezzi, vasi di idrome le e di birra , ute ns ili d'o g ni ge nere e d'o g ni s pec ie: soldati cantori, timballieri, donne, preti, vecc hi , fanciulli tutti fre tt olosi de l pari , tutti trattenuti a quando a quando da qu e lla fa rragine d'impedim e nti , tutti per la via rifatta li bera, riaffollanti s i in s iem e in una calca ondeggiante, nuovo impedimento a sé s tessa.
Ta lora un Capo, o un degiacc, o un fitaurari a tt ardato, a rriva trottando s ul mulo, vuo l passo per ra ggiu ngere il re, e a d o ttener lo distribuisce frustate a dritta e a mancina. A ll o ra c hi s i s tringe con tro g li a l beri , c hi vi si avviticc hi a, chi s i rifugia, sco rti candos i, rra'cespi degli arb ust i s pin osi, chi si arrisc hia s ugli o rl i scab ri d'un preci pi z io: per tutti poi a un punto ri ver sarsi ne ll a stretta, pigiandos i, cozza ndo s i, se minand o bre nd o li di vesti, frantumi di masseri zie , quegli ca de nd o, questi in ciam pa nd o ne l caduto , tra le ri sa, i lamenti, le st rid a.
Im ag inate ottantamila perso ne, deJle quali un quarto ama la pena atte a co mb a tte r e, che a que sto modo s i se1Tano fra gli scosce ndimenti del Ghind a, o s'a rram picano per le bal ze dirup a te dell ' Arboroba, stre mate , se nza pane , se nz'acq ua: e ditemj poi quale res is ten za pot eva no oppo rre a chi le avesse assa lt a te in calzando. No i s temmo co ll 'arm e in s palla a g uardarli , e quel co nteg no non g i ovò ad accrescere la es tim azione che grindi ge ni facevano de l nostro val or militare. So c he l'Abissinia è a ta l i estre mi che nessuno u·a i s uoi re, n é i s uo i re tutti quant i adunati sono in g rado di muoverei per o ra la g ue rra ; vo persuaso che ove s i dovesse co mb a tte re, sa pre mmo an che v ince re: ma persuaso altre sì c he il co mbattere e il v in ce re allora c i avrebbe procurato, assai m eglio che l'a ltrui mi seria prese nte la pace per lunghi ss imi anni.
P e r vendicare i caduti di Dog a li , mandammo in Affrica di ec imila so ld a ti e qu aranta milioni: i milioni usc irono dalle casse, i so ldati non usc iron o dall e fortezze. Poi ché s'e ra fatta quella s pedizione, rag ion voleva si insegnasse un a volta per se mpre ag li Abissini che s iamo un popolo militare anc he noi ; e l egge mmo passa re pe r un popolo di sc ie nziati e c i bastò irradiare co n la luce elettrica il ca mp o dell'imperatore. Chi dice c he gl'Italiani non sa nno mai ciò che vog li a no? Su cert i punti a n zi, s ia m o o ramai irremo vi bili : vogliamo la gra nd ezza se nza spesa. le economi e se nza sacrifizi, e la g ue rra se nza morti. Il di seg no è stupendo: forse, difficile ad effettuare .
- 59 -
D a " Ne ii " Affrica Italiana" di Fe rdinando Martini - Milano , 1895
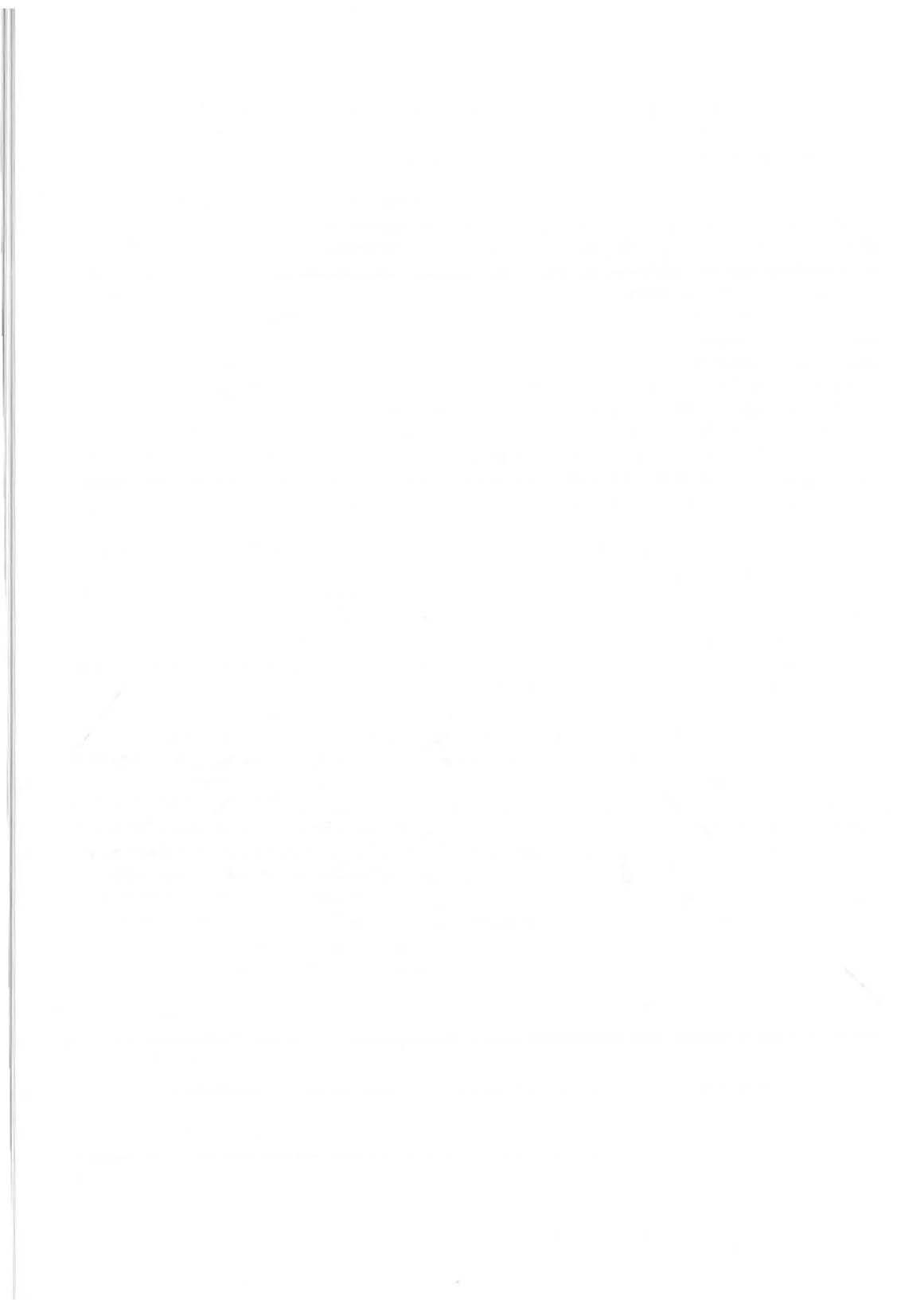
INDEGNI DELLA LUCE
Ho ancora nelle ossa ìl ribrezzo della notte senza sonno, trascorsa aJI'aria aperta, in piedi per quattro o cinque ore su quel terreno scabroso e infido dell'arsenale pieno di buche, di sassi, di binarii, di corde, sotto il lume bianco e affaticante della luce elettrica, co n gli occhi fissi sul fondo del mare , su l bordo nerastro del "S umatra" dove si agitavano delle ombre. E ho nel cuore la tristezza di quella visione lugubre, nella notte, nel silenzio, fatta di poveri soldati che avevano sul volto la espressione della sofferenza di dolori atroci patiti e appena calmati e che portavano negli occhi un ricordo invincibile, ineluttabile di cosa tragica: a vo lte, quella sfilata di feriti , di malati, di convalescenti, di san i mi riappare, come mi apparve, come apparve ai meno fantastici dei miei compagni, un convoglio funebre.
Tutto l ' apparato scenico, bizzarro , inopinato , a nulla rassomigliante, di quella folla muta e immobile sotto 1' alto e stellato cielo notturno, su quel lembo di te rra, innanzi a quel mare nero e come chiazzato di macchie di olio, innanzi a quel lungo e stretto ponte perdentesi lontano , saliente e abbrunantesi al fianco della nave, con quelle ombre lente, so rgenti a un tratto nel pallor freddo della luce elettrica, tutto questo apparato scenico era fatto per dare delle alluci naz ioni a immaginazioni quietissime. L'allucinazione massima: quella di un fatto misterioso e funereo , compito a tarda notte, fra testimoni sgomenti ed oppressi, fra ordini dati a bassa voce e ad occhi ch ini, con la fuga delle carrette per una via inusitata, per quartieri remoti; l'allucinazione, cioè, di qualche cosa di vergognoso e di vile, d i colpevole e di drammatico, di necessar io e di terribile. Questo!
Ancora, quando la vergognosa e triste cosa fu fmita, quasi alle cinque del mattino, ancora i nostri piedi restavan confitti colà e un irrigidimento colpiva l e nostre membra, mentre sentivamo in noi la s tanchezza morale dei massimi esaurimenti, come chi ha troppo visto, non so che di tremendo e di vigliacco, l'uccisione di un bimbo , l'esecuzione capitale di un assassino, la consumazione di un misfatto legale o illegale. Inoltre, troppe cose ha la nostra memoria di cronisti da rammentare: ma poche superano in tristezza, in nausea, in indignazione muta e repressa, che questa notte in cui noi vedemmo giu n gere, dai mari eritrei, i primi gloriosi avanz i di una battaglia che i soldati vollero vincere ma che il generale, fatalmente, volle perdere!

Non così , non così dovean toccare il suolo della patria coloro c he avevano combattuto valorosamente per essa, coloro che tornavano feriti, feriti perché la bandiera nostra sventolasse glor io sa, feriti perché l ' Italia e il Re fossero onorati! Non così! Erano partiti alla luce del sole, in pieno mezzogiorno, ad ora fissa, in modo che tutta la città lo sapesse e po tesse riversarsi nelle vie, come avrebbe fatto, come fece nella g iornata ri co rdevole in cui ritornarono i feriti di Dogali: fu proprio allora che il gran cuore gentile di Napoli, fra duecentomila , trecentomila persone palpitanti lasciò passare quelle barelle fra il più tenero e rispettoso si lenzio e le più tenere lacrime.
In piena luce, in piena lu ce, dovevan porre piede fra noi, que sti bravi: cari fieri soldati nostri, cari figli dei campi, cari operai tolti aJ lavoro, cari ufficiali tolti alle case loro e intanto battutisi con un coraggio, con un impeto degno di te mpi a ntichi. Costoro non erano dei malfattori, non erano dei ladri, non erano banditi, non erano pericolosi cospiratori: erano sangue no s tro , bel sang ue di guerrieri, sangue lasciato in parte sulla terra d'Africa, per noi: erano galantuomini, erano figli di galantuomioi: era no nobili c itt adi ni italiani anche se nati di umile ceto erano so ldati , erano uffici ali, non m asca lzo ni, non ladri! La no tte , l'ombra, il sile nzio, il mi stero so no fatt i per gli assassini: sono fatti per le azioni turpi e miserabili: sono fatti per le corruzioni e le degenerazioni del vizio: so no fatti per tutto quello c he teme la luce e teme la verità.
- 6 1 -
Nell'o r a più be ll a pomeridiana, avrebbe dov ut o gi un ger e il "Sumatra" e portare fieramente il vess illo tr1 colore: a ltre bandiere av rebbero adornato la ci tt à: il magistrato del Comune avrebbe fatto un proclama invitando i napoletani a onorare il coragg io di queste v ittime del dovere e della guerra; le associazioni sarebbero a nd ate a incontrare i fe ri ti: e tutte le autor i tà, tutti sarebbe ro sces i al l 'arsen ale per salutare q ues t o gru p po di onesti e di va lo ros i e tu tt a la c ittà avrebbe voluto vederli e sarebbero pi ovuti fiori sulle barelle, su i carri, co m e quando tornaro n o i feriti di D ogali. C he cosa bella s arebbe stata e come avrebbero pianto tutte le persone di cuore e come pensando a ciò, scrivendo di ciò, i n ostri occhi si riempiono di lacrime, e come noi, tutti, rimpi angiamo questa g rande scena di gentil ezza, di affetto, di ri co no scenza, mancata, perché il G overno aveva paura, c h e Napoli facesse un a manifestazione co ntro la diso nesta e vile pace che esso v uo le. Ma in che epoca infelice e bas a v iv iamo noi, dunque, c h e per un così meschino sco po, si d ebbano accogl iere dei so ld ati feriti come dei galeo tti e deg li uffi ciali crivella t i di co l pi nemici co m e dei malviventi?
Ed è così c h e il nostro eserc ito ha ricevuto un'altra offesa mortale: questo esercito che è il n ostro amo re e il nostro baluardo , che è il palpito d el nostro c uore e il sogno d e lla nostra fantasia, questo ese rc ito c h e Rudinl e Ricotti h anno lasciato in s ultare da quel filodrammatico di Emico Fe rri , ne l Parl amento, è stato anco ra v ilipeso da questo ricevimento. Quei soldati, l 'a ltr a notte, avevan l 'aria smarrita; pareva non capisse ro nulla. Non cap ivano, infatti. i poveretti, il perc h é di quell'arrivo alla ch e t iche ll a nella città addorme ntata, per vie lontane e deserte: e vagamente, senti vano tutta l'onta di quel mistero. Oh, più di un o, che nella o rribil e confusione di Abba G arima si è g inaro fra i ne mjci ed è stato ferito a lle g ambe, a l braccio, alla testa, c cade ndo ha pensato con amore e co n o rgog lio a l s uo paese, e, ri a lzan d osi, ha pensato a questo minuto del ritorno, fra i sal uti , gli abb racci e gU ap pl ausi, più di un o, nel suo c uore l'a ltra notte avr à avuta la più amara delle d elusioni. Perché h a egli lasciato la sua casa. i suoi affetti, perché ha sofferto fatiche, stenti, privazioni, perché ha egl i sostenuto la prova del fuoco, quando il suo paese, cioè, n o, il G overno del suo paese, d oveva prerniarlo così? A che esser solda t o, dunque, se nepp ur la consol azio ne della pietà e dell'ammirazione so no serbate a c hi offre la vita pel suo paese?

Poveri feriti g iace nti nei letti degli ospedali , ieri, tutto ieri , l e vostre fe rite v i h an n o dovuto fare molto male: e gli in fermieri vi av ra nn o detto che sarà stato il ve n to della notte, i d i sagi del trasbordo, le scosse e che so io. Vo i vi sarete rivoltati su l l etruccio, cerca ndo schermo al dolore, invano: e né le buone medicature, né le mani leggere d ei medici e degli infermieri, né il riposo av ran potuto v in cere il sottile t or me nt o. Nel ca ld o di una mischia un a ferita non fa male: nel caldo d ell'amore, il dolore si dimentica. Ma voi siete stat i colpiti da ll a freddezza de l vostro paese- il paese donnivainn anzi a queste sac re ferite: ma s ull e vostre ca rni a pe rte dru fucili sc ioani, dall e lanc ie abissine, vo i ave te se ntit o cadere l 'aceto d e ll a ingratitudine e del disdegno. Vi h anno intossica to il vostro migliore g io rn o: que ll o de l ritorn o. Ciò che doveva e ere la vos tra ora di benedizione e di co nso l azione, ciò c he do veva esse re l a nostra emozione, vi è st ata rubata: e i ladri n on si ete voi, entrat i in città alla macchia, m a sono ·'Joro", è il Governo il ladro, che v i h a tolto il premio del vostro sangue versato. n sacro vincolo c he c i uni sce a voi, fratelli, figli nostri diletti , anche più diletti perché pericolas te e vi salvas te, questo sacro vincolo c h e ie li si dov eva più profondam e nte saldare, è stato infranto: e come voi v i g uardavate atto rn o, s marriti , noi ci guardiamo atto rn o, sgomenti, pensando se n on sia un sogno, ques t' ora fosca e c hi e d e nd o a Dio che lo faccia dileg uare. O inutili ferite di questi bravi so ldati, poveretti: ma ieri, nello s pac;imo rinnovato delle carni sanguino le nti hanno pensato, certo, se non f osse stato inutile battersi per l ' I tali a: o, se non fosse stato meglio, pe r lo ro, morire co n gl i altri, nella tragica vall e di Adua!. ..
D a " JI Mattino", 25-26 m arzo 1896
Matilde Serao
- 62 -
COMB AT TIM ENT O DI DO GAL I
(Rapporlo compilato dal Comando Supremo in Afrim in base alle nO/de .fomite dal Capile/IlO Miche/in i. dal '! '<'nenie Comi e dai f eri ri ricovermi a Ma ssa ua )

Stante le difficoltà di provvedere sollecitamente i quadrup edi necessari per il trasporto del carico, munizioni e viveri, des tin at i a Saati. il convog li o non potè lasciare Monkullo prima delle 5.20 a nt. Del 26 gen na io u. s. La co lonn a venne composta nel modo seguente:
Estrema avang uardia. nucleo di irregolari con il Te nente Comi del 37 ° Fanteri a.
Avanguardia. co mp agnia del 15 ° Reggimento Fante ria.
Grosso, formato da 2 mitragli e re trainate da muli; le co mpag ni e del 20° e 4 1° Fanteria; i drappe lli del 6° e 7° Fanteria giunti dall'Italia il 24 col S.Got tardo ; convog li o vive ri e munizioni.
R etrogua rdi a, mezza compagnia.
Ebbe il co m ando di detta co lonna il Tenente Colonne ll o De Cri tofo ri s co mand ante il 3° battaglione Fa nteria Africa.
La marcia procedette cele rm e nte per quanto consentì l'andatura dei camme lli .
Verso l e ore 8.30 ant. Quand o g ià tutta l a co lo nna aveva oltrepassato il letto del torre nte Do gali c l a testa del grosso s i t rovava a poco più di un 'ora c irca di marcia da Saat i venne segnalato il nemico.
La co lonna venne tos to arre tata ed il Tenente Co lo nn ello co l Capita no del 17 ° artigl ieria Signor Michelini che aveva il coman d o delle du e mitrag li ere. si portarono celerme nt e ava nti p er vedere di c he s i tratta sse c cerc are pos izioni atte alla circostanza.
Giova osserva re a questo propos ito c he il Cap it ano Michelini si recava colla sez ione mitragliere a Saati per pre nd e re il co m ando del di staccamento d'artiglieria c he sa reb be p oi sta to cos tituit o da un a sezio ne d'arti glie ria da montagna, g ià su l po sto, e da quella di mitragliere; con quest'ultima sez ione quindi era pure partito il Te ne nte Tironi d e l 17 ° Reggimento Artiglieria.
Si deli neava dag li 800 ai 1.000 metri di dis tanza il movim e nto de l nemico , a cavallo ed a piedi, ininterrottamente ed in m odo no n be n appariscente; ta le però da la sc iar presupporre uno s postam e nto di num e rose forze.
Mentre il plotone d 'ava ng ua rdi a s i di s te nd eva a cava llo dell a s trada le re s ta nti for ze e mitragliere in seg uit o ad ord in e del Tene nt e Colonnello prendevano posizion e s u di un m on ti ce ll o a destra della s trada ed i l co nvog li o ve ni va co ll oca to a rid osso di de tt o monticello dalla parte meno es posta.
A qu an to pare il fuoco fu aperto dagli Ab is ini, cd i no stri. accent uatosi meglio il ne mico , in cominciarono su questi f uoc hi a comando
Sul tene no a nti stante appa rir ono saltuariam e nte e ad i nte r va lli g ruppi di Abi ssin i ; faceva no fu oco, sco mpariv a no, cd in altri punti nu c le i riapparivano a nco ra , ripete nd o lo stesso mo vi mento e la scia nd o così ai no stri bersag li poco visibi li ; quan do poi un Abissino cadeva colp ito dai nostri , veniva tosto allontanato dai co mpagni ed immediatamente un a ltro lo s os titui va impugnando il fucile del caduto.
Vennero tos to messe in azione le mitragliere e d il fuoco a comando della fa n teria con tinuò per qu a lc he tempo.
Dopo m ezz'o ra c irca d'azione la mitragliera coma ndata dal Tenente Tiro ni cessò di funzionare ca usa le feccie e l'i mperfe z ion e d e l meccanismo ; quella del Capitano Mich e l ini cont inuò per un quarto d 'o ra; poi poco per volta i rese inutili zzab il e essa pure.
Sulla destra d ella posizione occupata dai no tri e d a 200 m etri c irca, un monti ce ll o dominante la posizione stessa si prot e ndeva per un lato verso il fronte del nemico, nella co ns id e raz ione p erta nt o
- 63 -
che gli Abissini col movimento aggirante tendevano ad occupare detta altura, il Comandante la colonna ordinava si abbandonasse la posizione per occuparne aJtra retrostante e dominante l'altura di cui sopra è parola.
lJ movimento venne eseguito per scaglioni e se nza interrompere il fuoco. Si tentò il trasporto dell e mitragliere ma si abbandonò to sto l'impresa avuto riguardo air im piego di uomini e di tempo che ric hiedeva alle g rav i difficoltà inerenti all'esegu i mento di tale operazione ed inoltre a ll a considerazione che dette mitragli e re era no inutilizzabil i; il Capitano Signor MicheUni asportò alla s ua la vite di mira.
Il convog li o venne pure s pos tato a ridosso della nuova posizione. A quanto pare nell'eseguimento di detto cambiamento di posizione i nostri ebbero a toccare molte perdite.
Le forze nemiche intant o continuano ad ingro ssare e protette dagli sterpi ed arbusti, dalle ondulazioni del terreno ava nz ano man mano accerchiando la posizione occupata dai no st ri.
Il fuoco continua con accanimento da entrambe le parti ed agli urli selvaggi degli Abiss ini rispondono ripetute e frequenti le grida di viva il Re , viva l ' Itali a.
L ' accerchiamento diventa comp leto, gli ufficiali a ncora sup erstit i, ora distribuiscono le muni z ioni del convoglio c quelle dei caduti, ed ora fanno fuoco coi fucili di questi ultimi e quelli tra i feriti, ormai nell"impo ss ibilità di combattere, porgono ai vicini le loro cartucce.
11 nucleo d ei no s tri che ancor ti ene l'arma in pugno è diventato piccoli ssimo ed a ll ora da tutte le parti fanno irru z ione gli Abissini.
La lotta si svolge corpo a corpo, la difesa è disperata, colle baionette, coi calci dei fucili, coi sass i, finchè tutti i nostri o morti o feriti soccombono sc hiacciati dal numero del nemico irruente.
Verso le l l .30 circa si può ritenere a bbi a cessato completa m ente il combattimento.

In cominciarono allora scene d'orrore e di efferata cmde lt à: i poveri no stri cadu ti vengo no spog liati , denudati. ol traggia ti: con sass i, colp i di lancia. di sciabola e d'arma da fuoco sono colpi t i quelli che anco r danno segni di vita, alcuni vengono evirati, altri abbruciati; finalmente dopo una ridda feroce su l corpo dei nostri g li Abissini si allontanano asportando armi, indum e nti , quanto insomma possono rinvenire sul campo di battaglia.
Quelli dei no s tri che scampa rono aLl'eccidio devono la loro sa lvezza all'essere s tali cred uti morti in seguito alle ferite riportate, od all'essersi finti tali. Il trasporto dei feriti cominciò per opera della co mpagnia de l 54° Fanteria nel giorno stesso de l combattimento (26) al so praggiungere del quale l> i a llontanarono g l i Abissini che ancora restavano s ul campo di battaglia e si riunirono a l grosso che in gran numero s i vedeva a non grande distanza.
L'incertezza della situazione cons igliò di cont inuare l'opera di soccorso inviando dapprima sul ca mpo di battaglia nostri fidati informatori , in seg uito poi vi si recarono soldati, ufficiali ed il cappellano e s i procedette alla tumul azione dei cadaveri s ul si to stesso del combatt im ento.
Il Tenente Colonnello cav. De Cristofo ri s venne trasportato a Ma ssaua e seppell it o nel nostro cimitero.
Immen se furono le soffe ren ze a ll e quali doveuero sottostare i poveri feriti il cu i arrivo a Monkullo durò fino a tutto il 28 corrente.
Colpiti tutti da più ferite, esausti di forze. denudati esposti a ll a pioggia ed a l so le. affamat i. ars i dalla sete, cer carono ristoro bevendo l e proprie orine. il sangue che sg orgava dalle ferite: altri più fortunati cui la so rte aveva fatto capitare sotto mano qualche pezza da piedi, di s tendevano queste s ul proprio corpo perc hé restassero inzuppate dalla pioggia e poi avidame nte le succhiavano.
Alcuni malgrado le ferite , gli stenti, le crudeli sofferenze riescirono a trascinar s i da so li fino a Monkullo, altr i affrant i e s possati, dovettero fermarsi lungo la via nella impo ss ibilità di pitJ oltre proseguire fino a che raccolti dai nostri inviati in socco rso vennero trasportati a Monkullo; altri infine, dei quali non s i è trovato tracc ia, si ha motivo per ritenere che mal pratici delle località non si s iano messi per la buona via ed abb i ano così mi se ramente dovuto perire.
-6 4 -
INDICE DELLE IMMAGINI
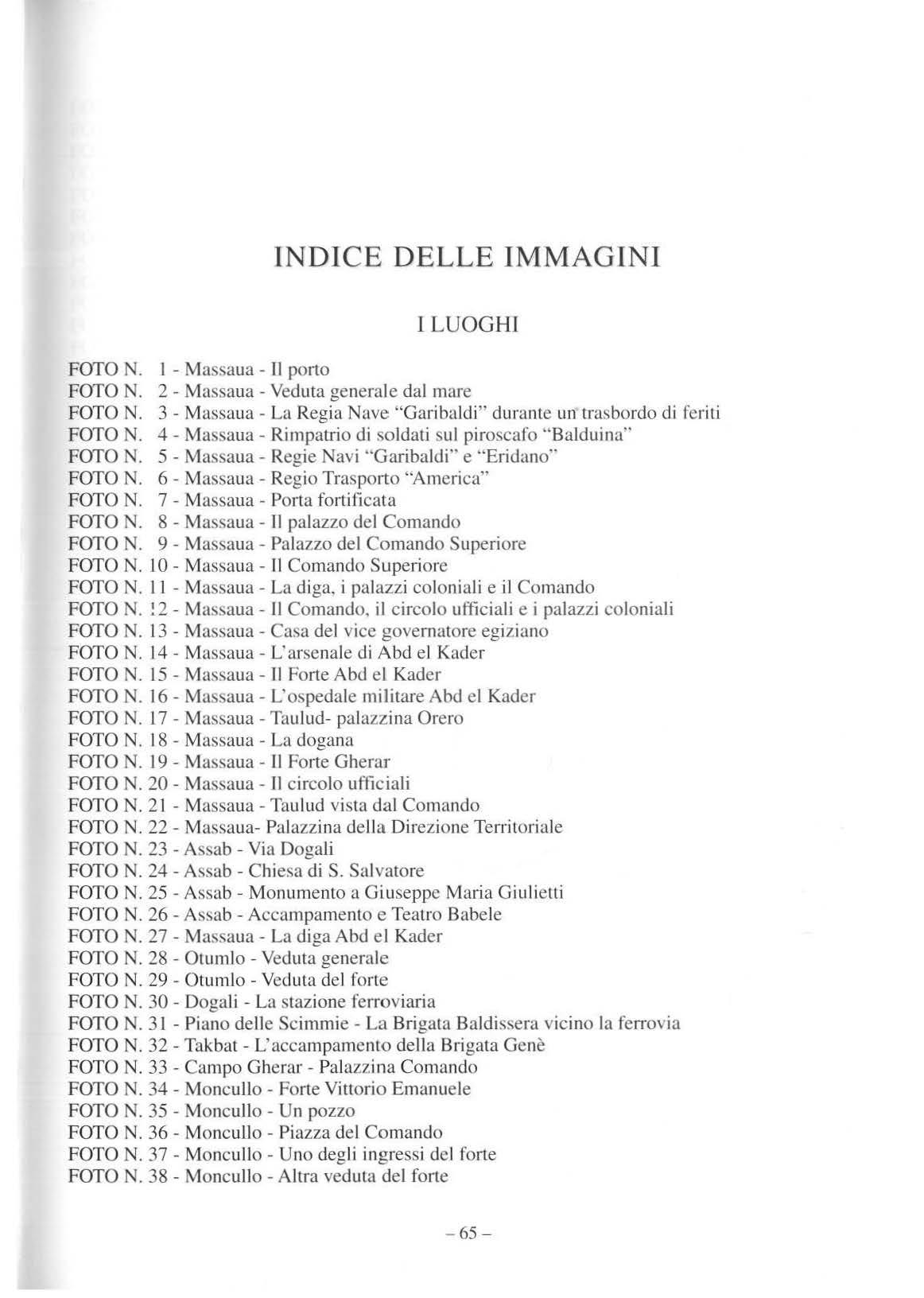
I LUOGHI
FOTO N. l - Massaua - Il porto
FOTO N. 2- Massaua- Vedu ta generale dal mare
FOTO N. 3- Massaua- La Reg ia Nave " G ar ibald i" durante un trasbo rdo di fe riti
FOTO N. 4- Ma sa ua- Rimpatrio di soldati ul piroscafo " Ba ldui na"
FOTO N. 5- Massaua- Regie Navi ''Gariba ldi'' e "Eridano··
FOTO N. 6 - Massaua - Regio Tras po1to "America"
FOTO N. 7- Massaua- Porta fortifi cata
FOTO N. 8 - Ma ssa ua - Il palazzo de l Comando
FOTO N. 9- Massa ua- Palazzo del Coma nd o Superiore
FOTO N. lO- Massaua- Il Comand o Superi o re
FOTO N. Il - Massaua- La diga. i palazzi co lonia li e il Comand o
FOTO N. !2- Massaua- Il Comando, il ci rcolo ufficiali e i palazzi co loniali
FOTO N. 13- Massaua- Casa del vice gove rn atore egiziano
FOTO N. 14- Massaua- L'arse na le di Abd e l Kader
FOTO N. 15- Massaua- Il Forte Abd el Kader
FOTO N. 16 - Massaua- L'ospeda le militare Abd el Kader
FOTO N. 17- Massaua- Taulud- palazzina Orero
FOTO N. 18- M assa u a- La dogana
FOTO N. 19- Massaua- Il Forte Gherar
FOTO N. 20 - Massaua- TI circolo ufficiali
FOTO N. 2 1 - Massaua- Taulud vista dal C oma nd o
FOTO N. 22- M assa ua - Pa lazzina della Direzione T er rit oriale
FOTO N. 23 - A ab - Via Dogali
FOTO N. 24- Assab- Chiesa di S. Salva tore
FOTO N. 25- A ssab - Monum e nto a Giuseppe M a ria Giulietti
FOTO N. 26- Assab- Accampa me nt o e Te a tro Babe le
FOTO N. 27 - Massaua - La diga Abd e l Kader
FOTO N. 28 - Otumlo - Veduta generale
FOTO N. 29- Otumlo - Ve duta de l forte
FOTO N. 30- Dogali- L a s tazione fe rro via1i a
FOTO N. 31 - Pi a no delle Scimmi e- L a Brigata B a ldi ssera v ici no la ferrovia
FOTO N. 32- Takbat- L 'acca mpam ento d e ll a Briga ta Genè
FOTO N. 33- Campo Gh erar- Pa lazz ina Com a ndo
FOTO N. 34- M o ncu llo - Fo rte Vittorio Emanuele
FOTO N. 35 - Moncullo - Un pozzo
FOTO N. 36 - Moncullo - Pia zza de l Co mand o
FOTO N. 37 - M o nc ullo - Uno degli in g re ss i del forte
FOTO N. 38 - M onc ull o - Altra ve dut a d el f orte
- 65-
FOTO N. 39- Moncullo- Baraccamenti in costmzione
FOTO N. 40 - Archico- L a Ridotta Garibaldi
FOTO N. 4 1 - Archico- Vill agg io indigeno e mosc hea
FOTO N. 42- A rchico- Veduta de l forte
FOTO N. 43- Archico- A nco ra il fo rte
FOTO N. 44- Tamari sco - Il padiglione uffic ia li della 3A compagnia cacc iatori d'Africa
FOTO N. 45 - Tamari co- Il Comando del 2 ° R eggimento caccia tori d'Africa
FOTO N. 46 - Tamarisco- L'acc ampamento dell o Regg im e nto cacciato ri d'Africa
FOTO N. 47- Dessct- Poggio San Marzano
FOTO N. 48 - D esse t - La sede della Sussistenza
FOTO N. 49- Taulud- Cisterna pubblica
FOTO N. 50- Tau lud - Ve duta inte rna d e l fort e
FOTO N. 5 1 - D oga li - Fortino A
FOTO N. 52- Doga li - Fortino B
FOTO N. 53- Do ga li - Un 'a ltra veduta del Fortino A
FOTO N. 54- Do ga li - Co llin a d e i Caduti
FOTO N. 55 - Saati - Il Fo rte Sud
FOTO N. 56- Saati- La s tazio ne ferroviaria
FOTO N. 57- Saati Sud- L'a cca mpam e nto de l 3 ° battaglione B ersag li e ri
FOTO N. 58- Saati- Attendamento de l Maggiore Ca g ni
FOTO N. 59- Saa ti - Pogg io Ciuffo
FOTO N. 60- Saa ti - Il Forte Boretti
FOTO N. 61 - Saa ti - S taLion e fe rrovi ari a e Forte Nord
FOTO N. 62- M aca ll è- Il pa lazzo d e ll'Impera tore J ohanne
FOTO N. 63- Axu m - La cattedrale
FOTO N. 64- A use n - Al centro la capanna di ras Alula
FOTO N. 65- Add ì Caiè- R ovi ne dell'antica C oloè
FOTO N. 66- Ghinda- Panorama
FOTO N. 67 - Sabarguma -Acca mp amento abissi n o
FOTO N. 68 -L'Amba Al agi
FOTO N. 69 - Adua - Ve dut a ge ner a le de l villaggio
FOTO N. 70 - La co nca di Adua e i monti di Abba Garim a
FOTO N. 71 -As ma ra - Chiesa catto li ca e case di ras AJul a
FOTO N. 72- Asmara- Villaggio abissino
FOTO N. 73- Asmara- Camp cannonieri e campo cintato Comando
LE TRUPPE NAZIONALI
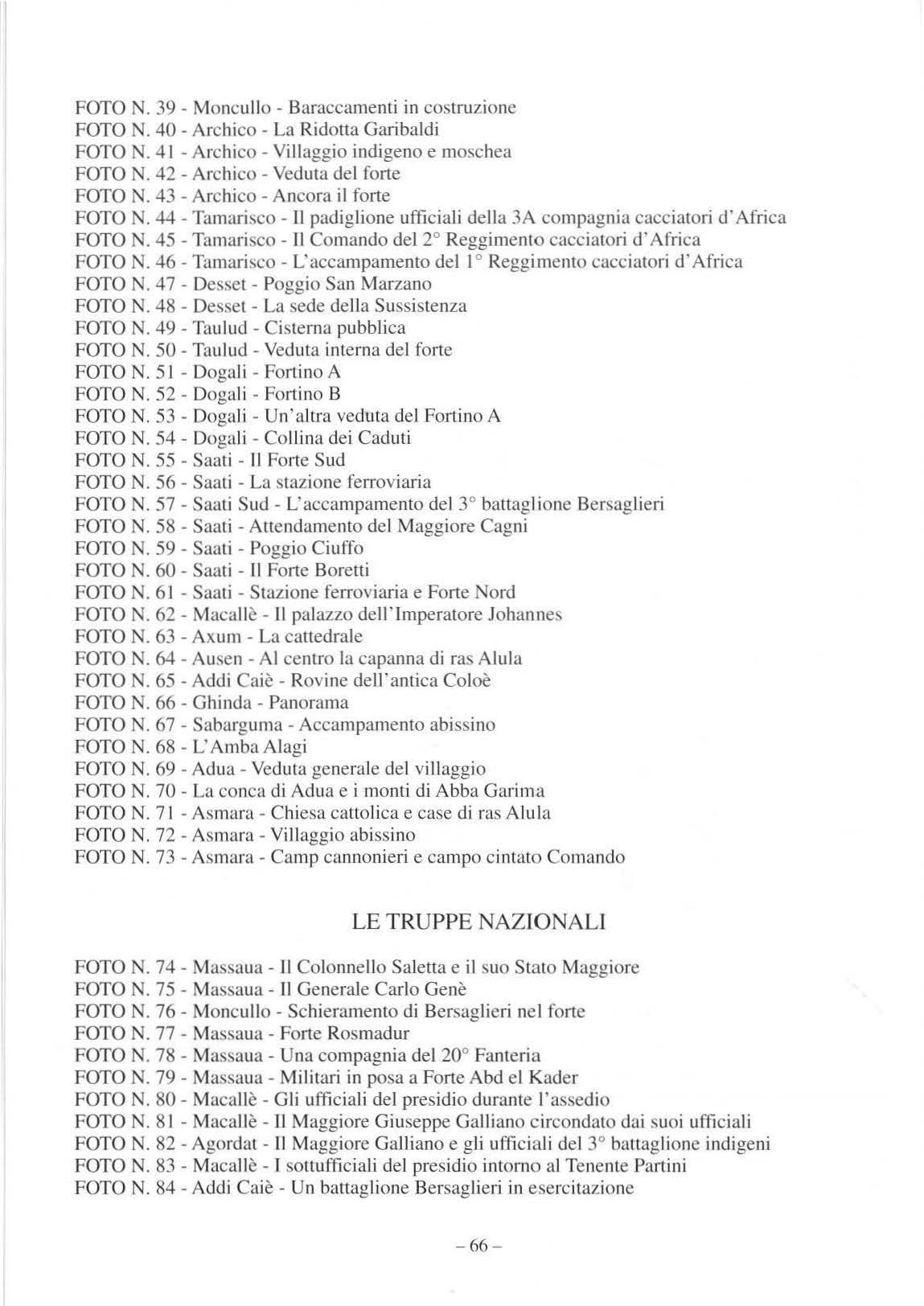
FOTO N. 74 - M assa ua- Il Colonne ll o Sale tta e il s uo Stato M agg io re
FOTO N. 75- M as a ua- Il Generale Carlo G e nè
FOTO N. 76 - M o nc ull o- Schieramento di Bersag li e ri ne l f orte
FOTO N. 77 - M assaua - Fo rte Ros madur
FOTO N. 78 - M as a ua - Una co mpagnia del 20° Fanteria
FOTO N. 79- M assa ua- Militari in posa a Forte Abd el K a de r
FOTO N. 80- Maca ll è- Gli uffi c iali del presi dio durante l' assed io
FOTO N. 8 1 - M aca ll è- Il Ma gg iore Giu sepp e Gallian o c irconda to d a i s uo i uffi cia li
FOTO N. 82- Agordat- Il Maggio re Galliano e gli uffi c iali del 3 ° battag lion e indigeni
FOTO N. 83 - Maca ll è - I sottufficiali del pres idio intorno al Te ne nte Partini
FOTO N. 84- Addì Caiè- Un battaglione B ersaglieri in eserc itazione
- 66 -
FOTO N. 85- Cassa la- Gli ufficiali che presero parte allo scontro
FOTO N. 86- Saati- L a sezione lopografica del 3 ° Bersaglieri
FOTO N. 87 - Desset - Un gruppo di ufficiali della Sussistenza
FOTO N. 88- Massaua- Il Maggiore Carlo Melloni della Regia Guardia di Finanza
FOTO N. 89- Saati - Ufficiali in posa
FOTO N. 90 - Saati Sud - L" accampamento del 2 ° Bersaglieri d· Africa
FOTO N. 91 - Saati Sud- Accampamento della l A compagnia del 3° Bersaglieri d'Africa
FOTO N. 92- Saati- Ufficiali del 3° Bersaglieri d'Africa
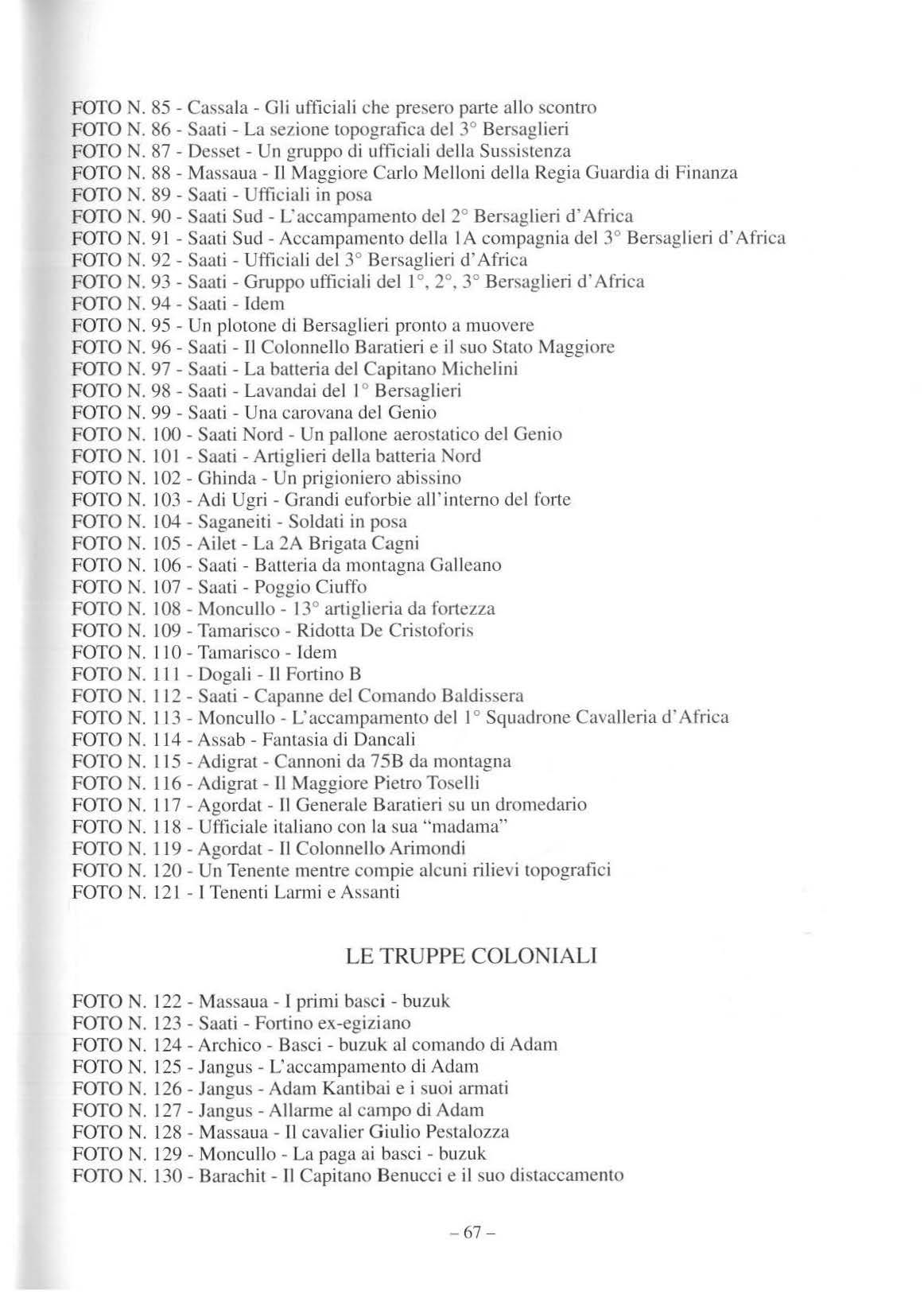
FOTO N. 93- Saati- Gruppo ufficiali dell 0 , 2° ,3 ° Bersaglieri d'Africa
FOTO N. 94 - Saati - Idem
FOTO N. 95- Un plotone di Bersaglieri pronto a muovere
FOTO N. 96- Saati - Il Colonnello Baratieri e il suo Stato Maggiore
FOTO N. 97 - Saati - L a batteria del Capitano Michelini
FOTO N. 98- Saati- Lavandai del l 0 Bersaglieri
FOTO N. 99- Saati- Una carova na del Genio
FOTO N. l 00 - Saa ti No rd - Un pallone aerostatico del Genio
FOTO N. IO l - Saati - Artig li eri della batteria Nord
FOTO N. 102- Ghinda- Un prigioniero abissino
FOTO N. 103- Adi Ugri- Grandi euforbie all'interno del forte
FOTO N. 104 - Saganeiti - Soldati in posa
FOTO N. l 05 -A iJet - La 2A Brigata Cagni
FOTO N. 106- Saati- Ba tteria da montagna Galleano
FOTO N. 107 - Saati- P oggio Ciuffo
FOTO N. l 08- Moncullo- 13 ° artiglieria da f011ezza
FOTO N. 109- Tamarisco- Ridotta De Cristoforis
FOTO N. l l O- Tamarisco - ld em
FOTO N. 111 -Dogali- Il Fortino B
FOTO N. 112 - Saati - Capanne del Comando Baldissera
FOTO N. 113- Moncullo- L'accampamento del l o Squadrone Cavalleria d'Africa
FOTO N. 114- Assab- Fantasia di D a ncali
FOTO N. 115- Ad igrat- Ca nn oni da 75B da montagna
FOTO N. 116- Adigrat- li Maggiore Pi etro To elli
FOTO N. 11 7- Agordat- Il Generale Baratieri su un dromedario
FOTO N. 118- Ufnciale italiano con la sua "madama"
FOTO N. 119 - Agordat - Il Colonnello Arimondi
FOTO N. 120- Un Ten ente mentre compie alcuni rilievi topografìci
FOTO N. 121- l Tenenti Larmi e Assanti
LE TRUPPE COLONIALI
FOTO N. 122- Massaua- l primi basci- bu zuk
FOTO N. 123- Saati- Fortino ex-egiziano
FOTO N. 124- Archico- Basci- buzuk al comando di Adam
FOTO N. 125- J a ng u s- L'accampamento di Adam
FOTO N. 126- J angus- Adam Kantibai e i suoi armati
FOTO N. 127- Jan g u s- Allarme al campo di Adam
F OTO N. 128 - Massaua- Il cavalier Giulio Pestalozza
FOTO N. 129 - Moncull o- La paga ai basci- buzuk
FOTO N. 130- Barachit- 11 Capitano Benucci e il suo di taccamento - 67-
FOTO N. 131 - Cheren- Tiri di una batteria indigena
FOTO N. 132- Adua- Sezione artiglieria indi ge na
FOTO N. 133- Adigrat- fdem
FOTO N. 134 - Ascari artiglieri in esercitazione
FOTO N. 135 - Ascari di una batleria mortai da 87
FOTO N. 136- Ascari d i artiglieria
FOTO N. 137 - Ascari artiglieri fanno manuten zio ne
FOTO N. 138 - Due ascari trasportano una mitragliatric e
FOTO N. 139 - Mitragliatri c i Gardn e r in batteria
FOTO N. 140- Una mitraglia trice pronta allo sparo
FOTO N. 141 - Adigrat- La lA compagnia del battaglione ' 'Toselli "
FOTO N. 142 - Adigrat- La 2A compagnia del battaglione ''Toselli"
FOT O N. 143- Agordat- Fanteria indigena
FOTO N. 144- Adi Quala - La banda del Mareb
FOTO N. I 45- Consegna di decorazioni ad un reparto indigeni
FOTO N. 146 -Ascari trombettiere di artiglieria
FOTO N. 147- Uno sciumbasci
FOTO N. 148 - Ascari a rapporto
FOTO N. 149 - Un gruppo di valorosi muntaz
FOTO N. 150- Ascari di cavalleria
FOTO N. 151 -" Penne di falco" in ri cogn i zione
FOTO N. 152 - Una penna di falco s upera un ostacolo
FOTO N. 153 - Due ufficiali seguiti da numero si ascari
FOTO N. 154- Penna di falco trombettiere
FOTO N. 155 - Ascari armato di "sie t"
FOTO N. 156 - Ascari che fanno "Fantasia"
FOTO N. 157 - Fantas ia di ascari
CARAB INIERI E ZAPT l E'
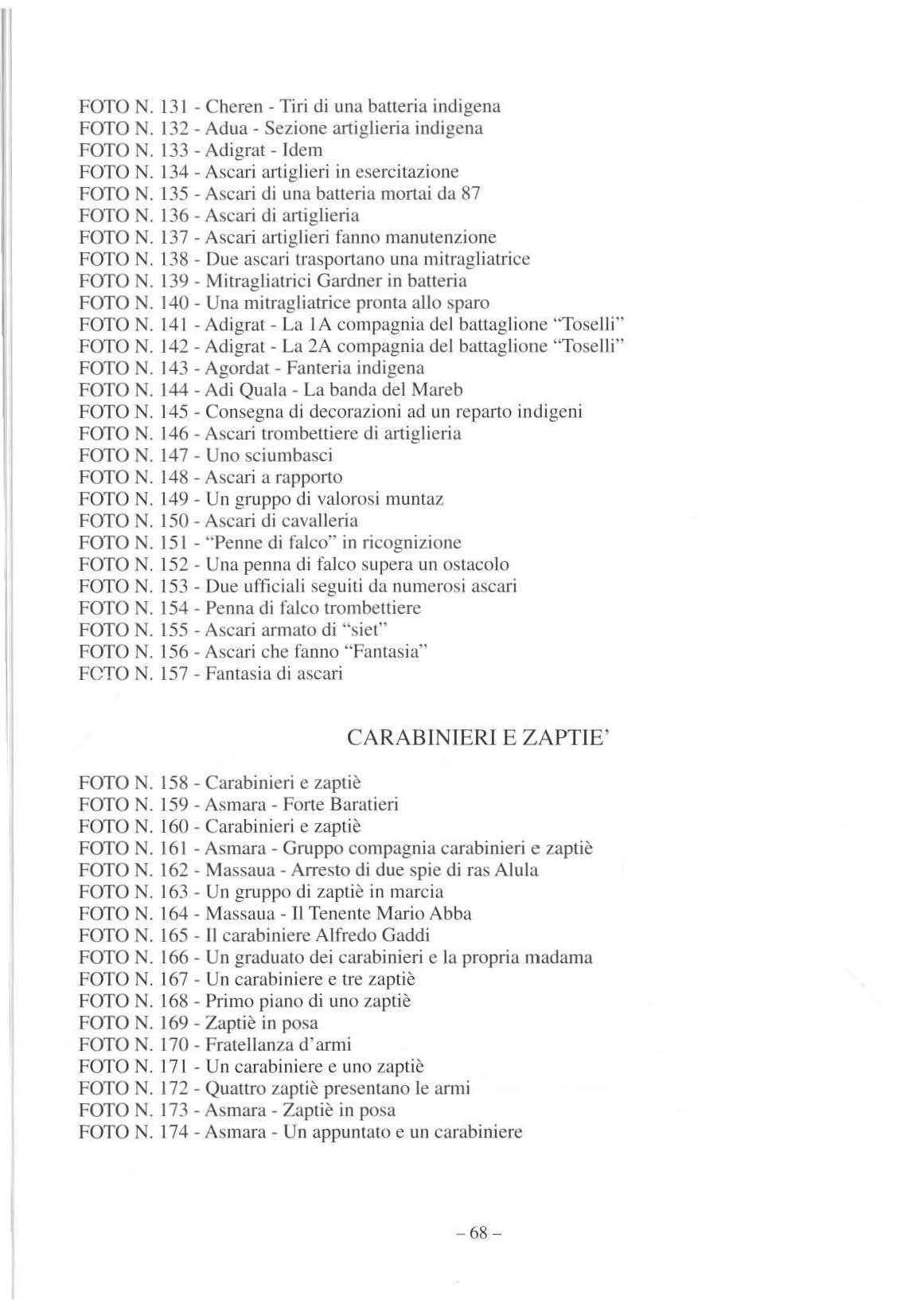
FOTO N. 158 - Carabinieri e zaptiè
FOTO N. 159- Asmara- Forte Baratieri
FOTO N. 160 - Carabinieri e zaptiè
FOTO N. 161 -As mara- Gruppo compagnia cara binieri e zaptiè
FOTO N. 162- Massaua- Arresto di due spie di ra s Alula
FOTO N. 163 - Un gruppo di zaptiè in marcia
FOTO N. 164 - Massaua - Il Tenente Mario Abba
FOTO N. 165- Il carabiniere Alfredo Gaddi
FOTO N. 166 - Un graduato dei carabinieri e la propria madama
FOTO N. 167 - Un carabiniere e tre zap ti è
FOT O N. 168 - Primo piano di uno zaptiè
FOTO N. 169- Zaptiè in posa
FOTO N. 170 - Fratellanza d'armi
FOTO N. 171 -U n carabiniere e uno zap ti è
FOTO N. 172- Quattro zap tiè presentano le armi
FOTO N. 17 3 -A mara- Zaptiè in posa
FOTO N. 174 -As mara - Un appuntato e un carabiniere
- 68-
LA VITA QUOTIDIANA
FOTO N. 175 - Moncullo- Interno del Forte Vittorio Emanuele
FOTO N. 176- R as Modur- Preghiera alla fine del Ramadan
FOTO N. 177 - Mas saua - Investitura di Kantib ai Hamed Hassan
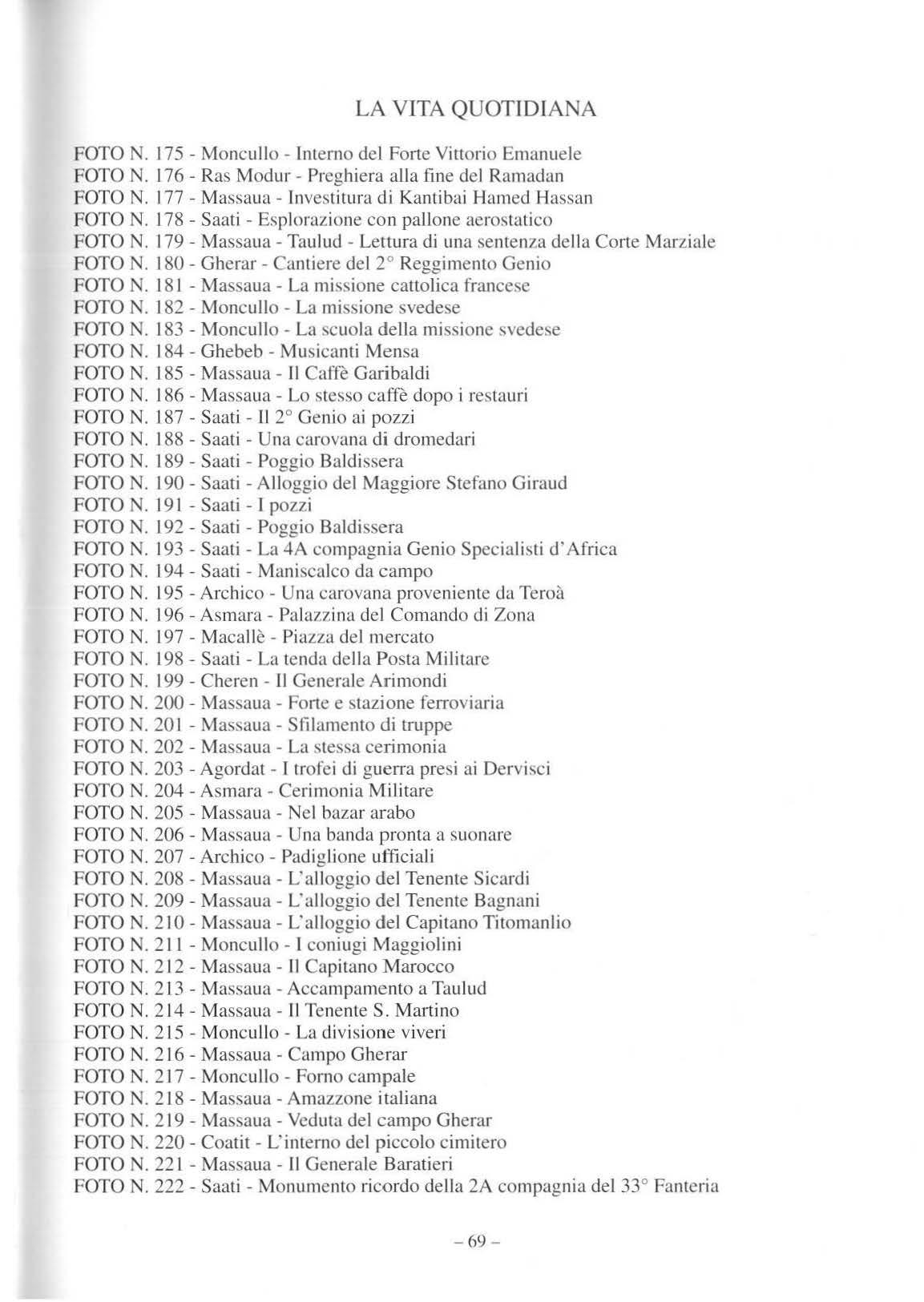
FOTO N. 178 - Saati - Esplorazione con pallone aerostatico
FOTO N. 179- Massaua- Taulud- Lettura di una sentenza della Corte Marziale
FOTO N. 180- Gherar- Cantiere del 2 ° Reggimento Genio
FOTO N. J8 1 - Massaua - La missione cattolica france c
FOTO N. 182 - Moncullo - La missione svedese
FOTO N. 183- Moncullo- L a scuola della missione svedese
FOTO N. 184 - Ghebeb- Mu icanti Mensa
FOTO N. 185- Massaua- Il Caffè Garibaldi
FOTO N. 186 - Ma ssaua - Lo stesso caffè dopo i restauri
FOTO N. 187- Saati - Il 2 ° Genio ai pozzi
FOTO N. 188- Saati- Una carovana di dromedari
FOTO N. 189 - Saati - Poggio Baldissera
FOTO N. 190- Saati- Alloggio del Maggiore Stefano Giraud
FOTO N. 191 - Saati- I poni
FOTO N. 192- Saati- Poggio Baldissera
FOTO N. 193- Saati- La 4A compagnia Genio Specialisti d'Africa
FOTO N. 194 - Saati - Maniscalco da campo
FOTO N. 195- Archico- Una carovana proveniente da Teroà
FOTO N. 196- Asmara- Palazzina del Comando di Zona
FOTO N. 197- Macall è- Pia zza del mercato
FOTO N. 19 8 - Saati -La tenda della Posta Militare
FOTO N. 199- Cheren- ll Generale Arimondi
FOTO N. 200- Massaua- Forte e stazione ferroviaria
FOTO N. 201 - Massaua- Sfìlamento di truppe
FOTO N. 202 - M assaua - L a stessa cerimonia
FOTO N. 203 - Agordat- I trofei di guerra presi ai Dervisci
FOTO N. 204- Asmara- Cerimonia Militare
FOTO N. 205 - Ma ssaua- Nel bazar arabo
FOTO N. 206- Massa ua - Una banda pronta a suonare
FOTO N. 207- Archico- Padig lione ufficiali
FOTO N. 208- Massaua- L'alloggio del Tenent e Sicardi
FOTO N. 209- Massaua- L'alloggio del Tenente Bagnani
FOTO N. 21 O- Massaua- L'alloggio del Capitano Titomanlio
FOTO N. 211 - Moncullo- l coniugi Maggiolini
FOTO N. 212 - Massaua - I l Capi tano Marocco
FOTO N. 213- Massaua- Accampamento a Taulud
FOTO N. 214- Massaua- Il Tenente S. Martino
FOTO N. 215- Moncullo - La divis io n e vi ve ri
FOTO N. 216- Massaua - Campo Gherar
FOTO N. 217- Moncull o- Forno campale
FOTO N. 218- Massaua- Amazzone italiana
FOTO N. 2 19 - Massaua - Veduta del campo Gherar
FOTO N. 220- Coatit- L'in terno de l piccolo cimitero
FOTO N. 221 - Massaua - Il Generale Barati eri
FOTO N. 222 - Saati - Monumento ri cordo della 2A compagnia del 33 ° Fanteria
- 69 -
FOTO N. 223 - Saati - Forte gazzella
FOTO N. 224 - Do gali- Croce comme morati va i caduti della battaglia
FOTO N. 225 - Otuml o - In terno del c imite ro
FOTO N. 226 - Saati - Monumento e se poltur a del Te ne nte Cuo m o
FOTO N. 227 - Saati - Ide m
FOTO N. 228 - Saati - M o num e nt o a i caduti del 78 ° Fanteria
FOTO N. 229 - Otuml o - M onumento dedica to dal Genio a i caduti di Dogali
GLI I NDIGENI
FOTO N. 230 - L' I mperatore Men e lik II
FOTO N. 231- Un'immagine giovanile dell'Imperatrice T ai tù
FOTO N. 232- R as Maconnen
FOTO N. 233- Ra s Mang asc ià
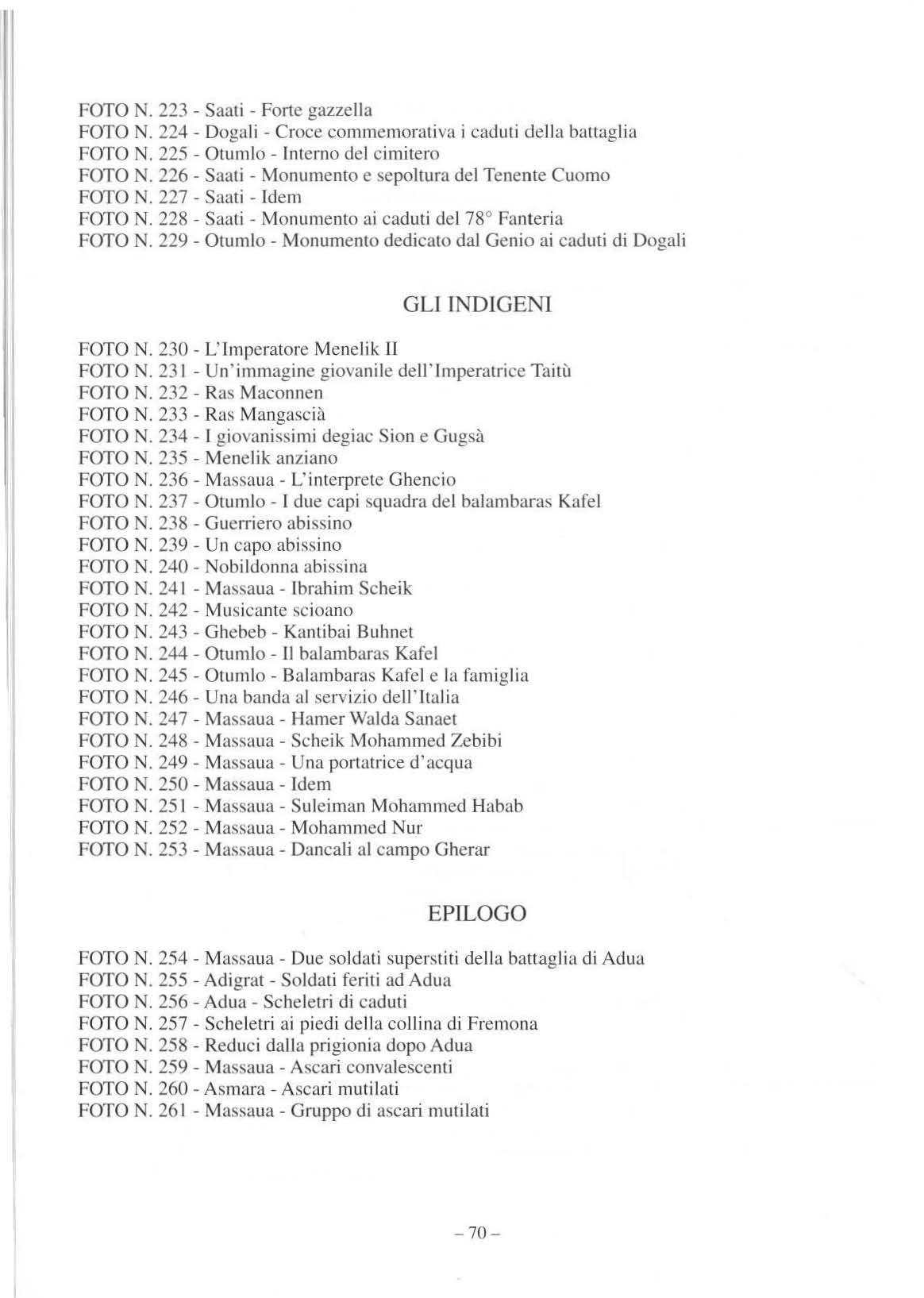
FOTO N. 234 -l giovani ss imi degiac Sion e Gugsà
FOTO N. 235- Menelik anziano
FOTO N. 236 - M assaua - L' i nterpre tc Ghen cio
FOTO N. 237 - Otumlo - l due ca pi squadra del balambaras Kafe l
FOTO N. 238- Gu e rri e r o ab issino
FOTO N. 239- Un ca po abissino
FOTO N. 240- Nobildonna a bi ss in a
FOTO N. 241 - Massaua- Ibrahim Sc heik
FOTO N. 242 - Mu s ican te sc ioano
FOTO N. 243 - Gh e beb - Kantibai Buhnet
FOTO N. 244- Otu m lo- I l balambaras Kafel
FOTO N. 245- Otumlo- B a l a mbara s Kafe l e la famiglia
FOTO N. 246- Una banda al serv i zio dell'Italia
FOTO N. 247 - Massaua- H amer Walda Sanaet
FOTO N. 248- Massaua- Scheik Mohammed Zebibi
FOTO N. 249 - Massa u a- Una port at ri ce d'acqua
FOTO N. 250 - Massaua - I dem
FOTO N. 25 1 - Massaua- Suleiman Moh amm ed H abab
FOTO N. 252 - Massaua- Mohamm ed Nur
FOTO N. 253- Massaua- Dancali al campo Gherar
EPILOGO
FOTO N. 254- Ma ssa ua - Du e so ldati s uperst iti dell a battaglia di Adua
FOTO N. 255 - Adi g rat - Soldati feriti a d Adua
FOTO N. 256- Adua- Scheletri di cad uti
FOTO N. 25 7- Sche letri ai piedi dell a collina di Ft·emo na
FOTO N. 258- Re du c i dall a prigionia dopo Ad ua
FOTO N. 259 - M as a ua - Ascari conva lescent i
FOTO N. 260- A s mara- A sca ri mutilati
FOTO N. 261 - Massaua- Gruppo di ascari mutilati
- 70 -
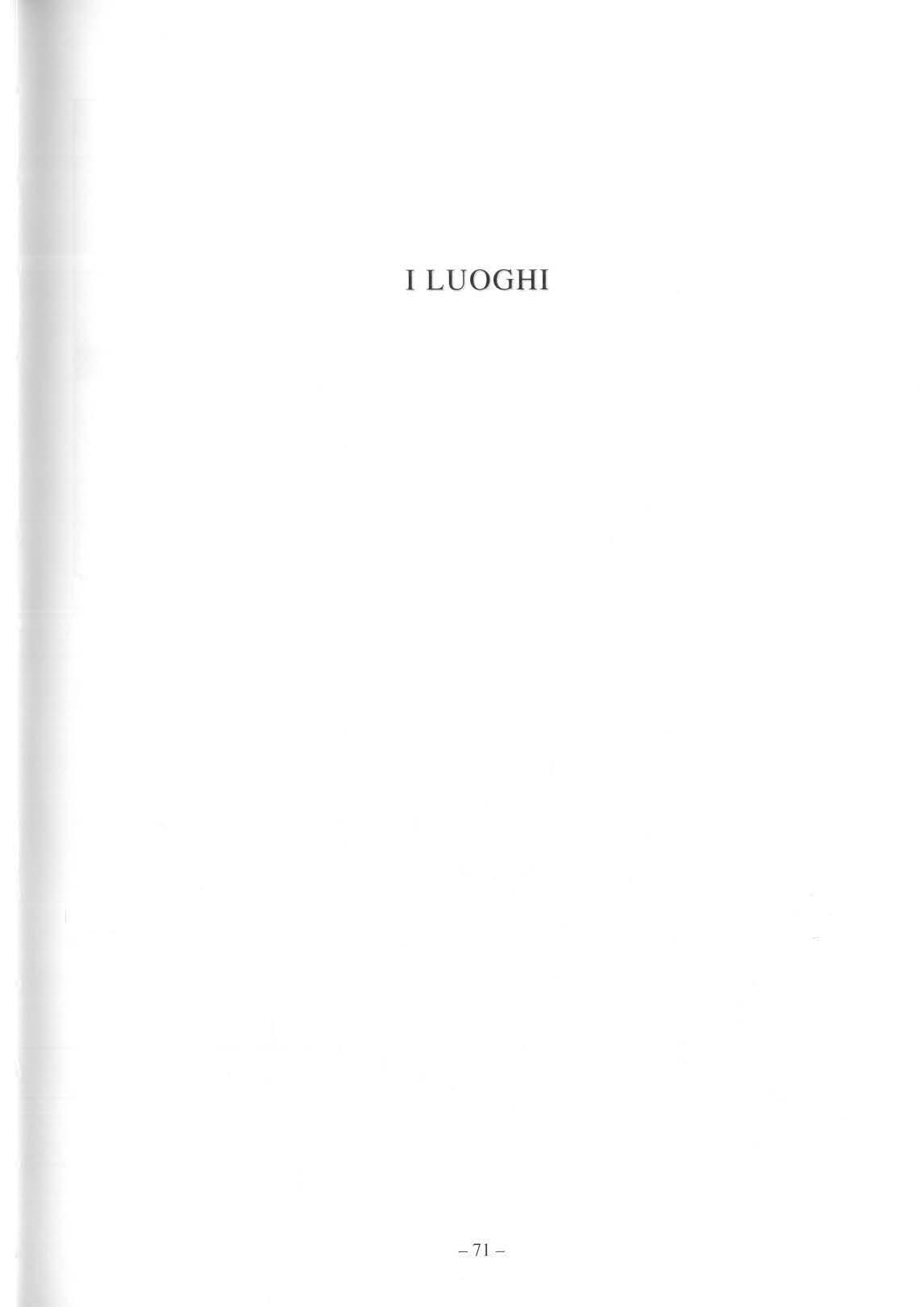
I LUOGHI - 7 1 -
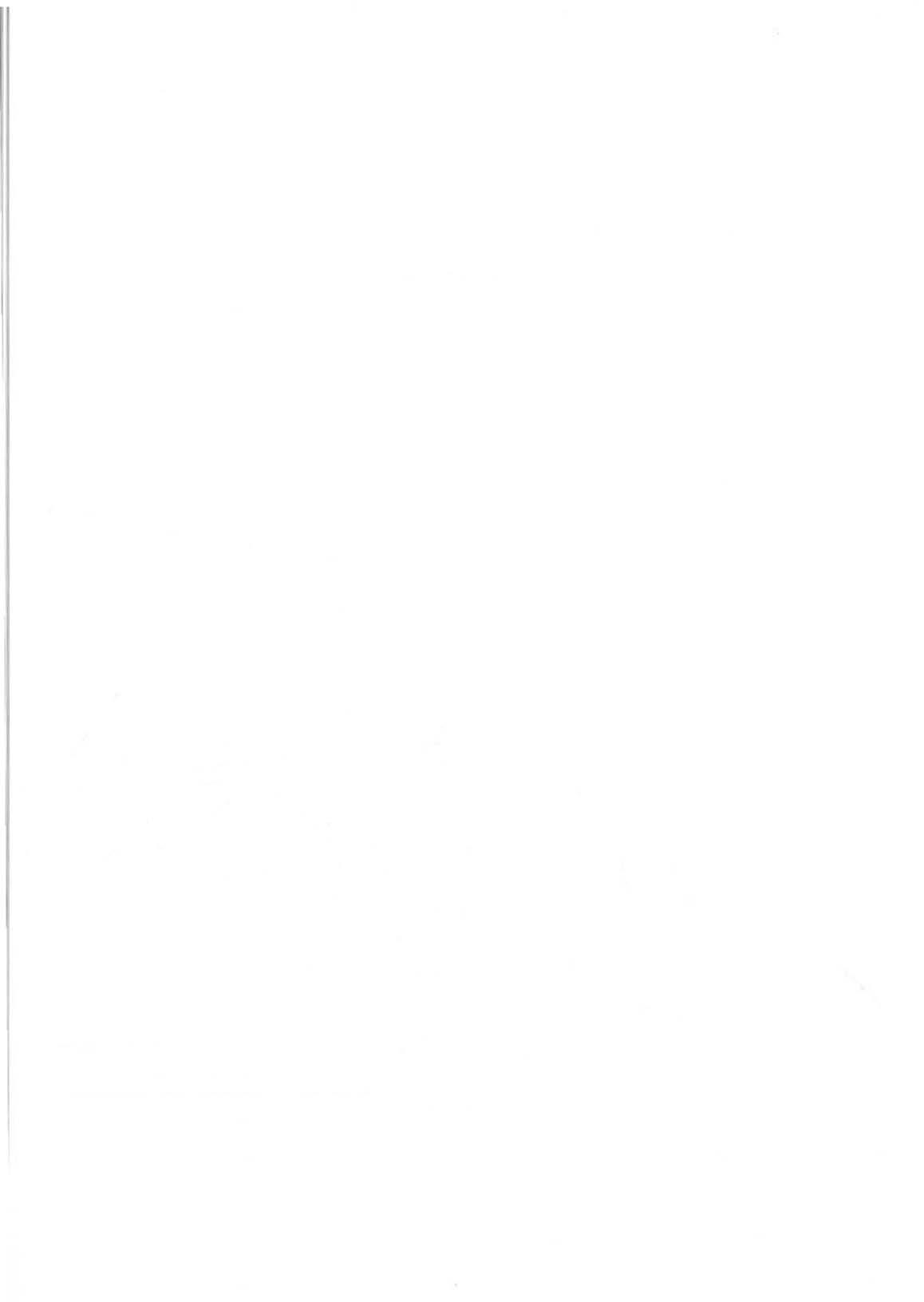
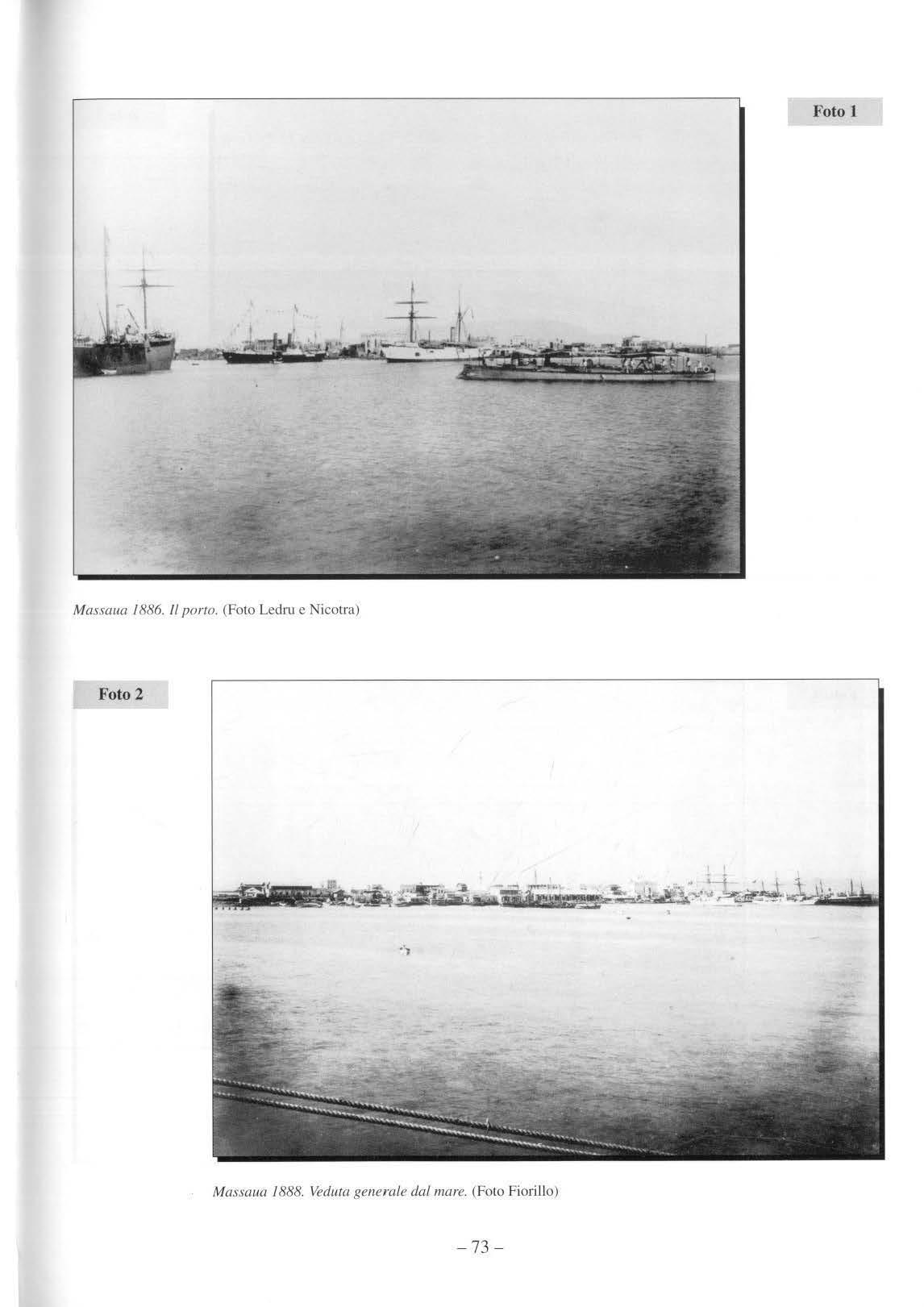
Foto l
Massaua /886. Il porto. (Foto Ledru e Nicotra)
Foto 2
-73-
Massaua / 888. Vedttta genemle dal mare. (Fo to Fiorillo)
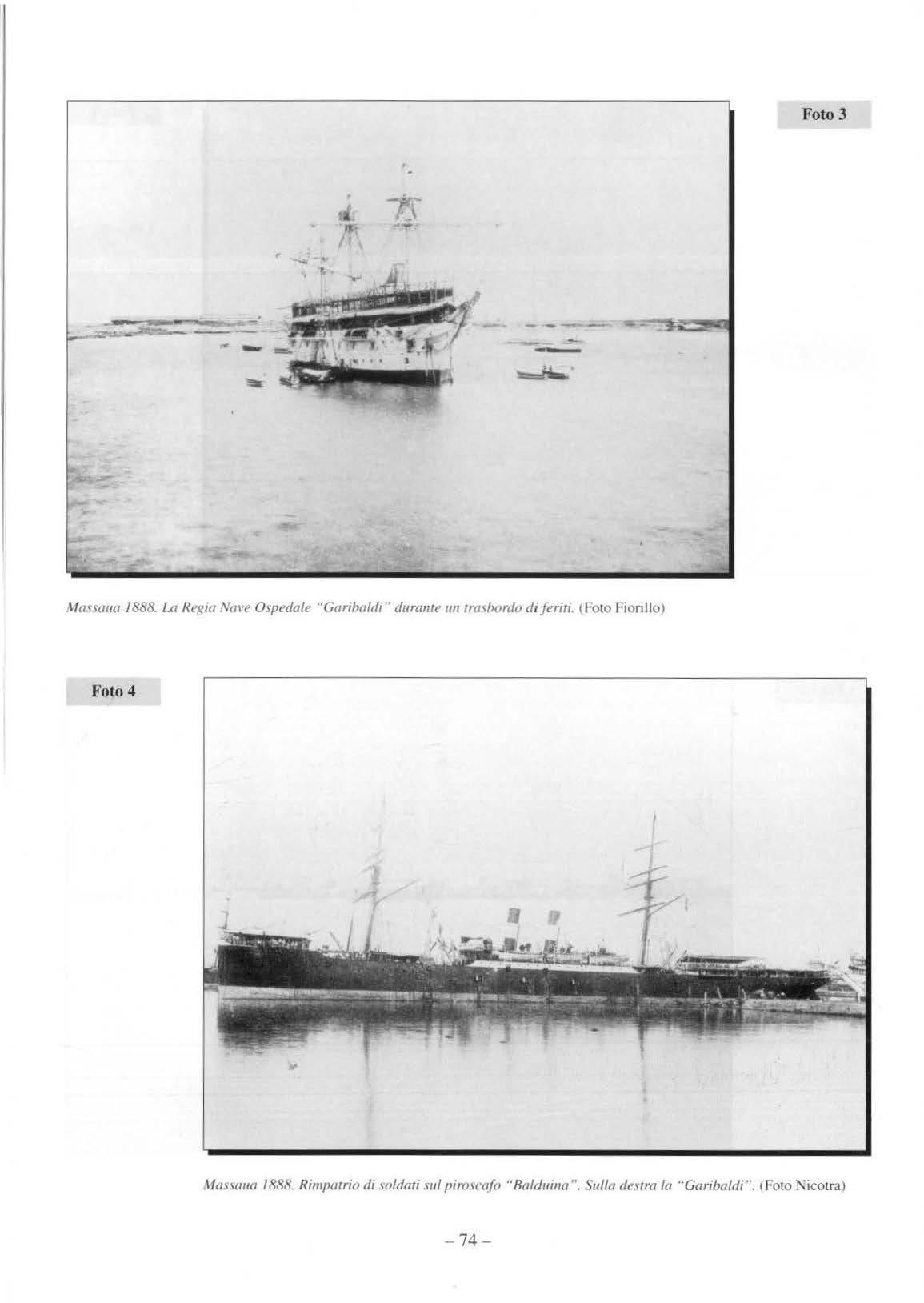
Foto 3 .... ..-
Mamma 1888. Ln ReKia Nm·e Ospedale "Garibaldi" durame tmlra\hordo di feriti. ( Foto Fiori Ilo)
4
Foto
- 74-
Massaua /888. Rimpmrio di .soldati .wl pim.scafo Ba/duina". Sulla dr.wra la ··cari/m/di". (Foto 1\icotra)
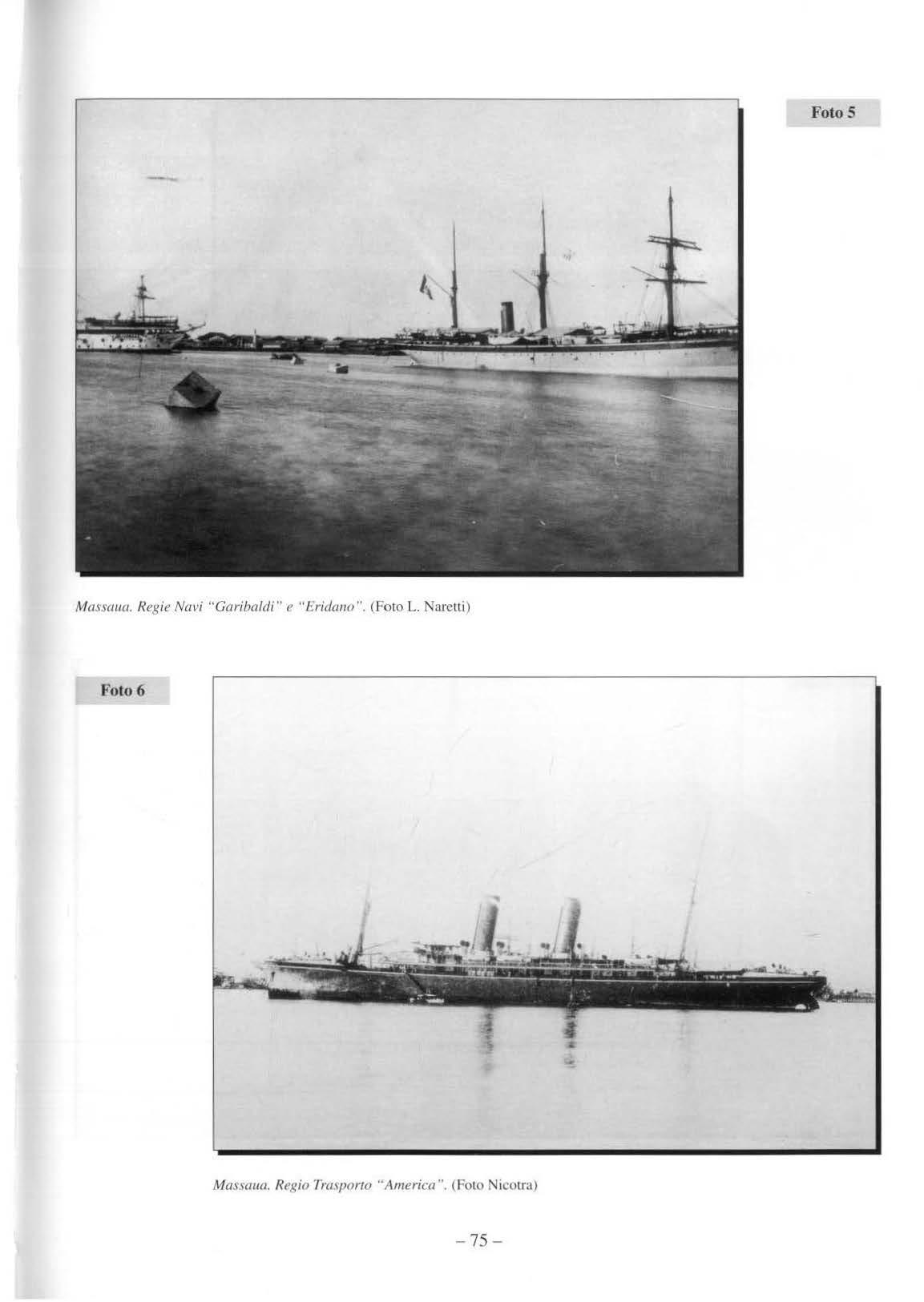
-
FotoS
Massaua. Regie N m•i carihnldi" r "Eridww ". (Foto L. Narctti)
Foto6
- 75 -
Massaua. Regio TmJporto ''America". (Foto Nicotra)
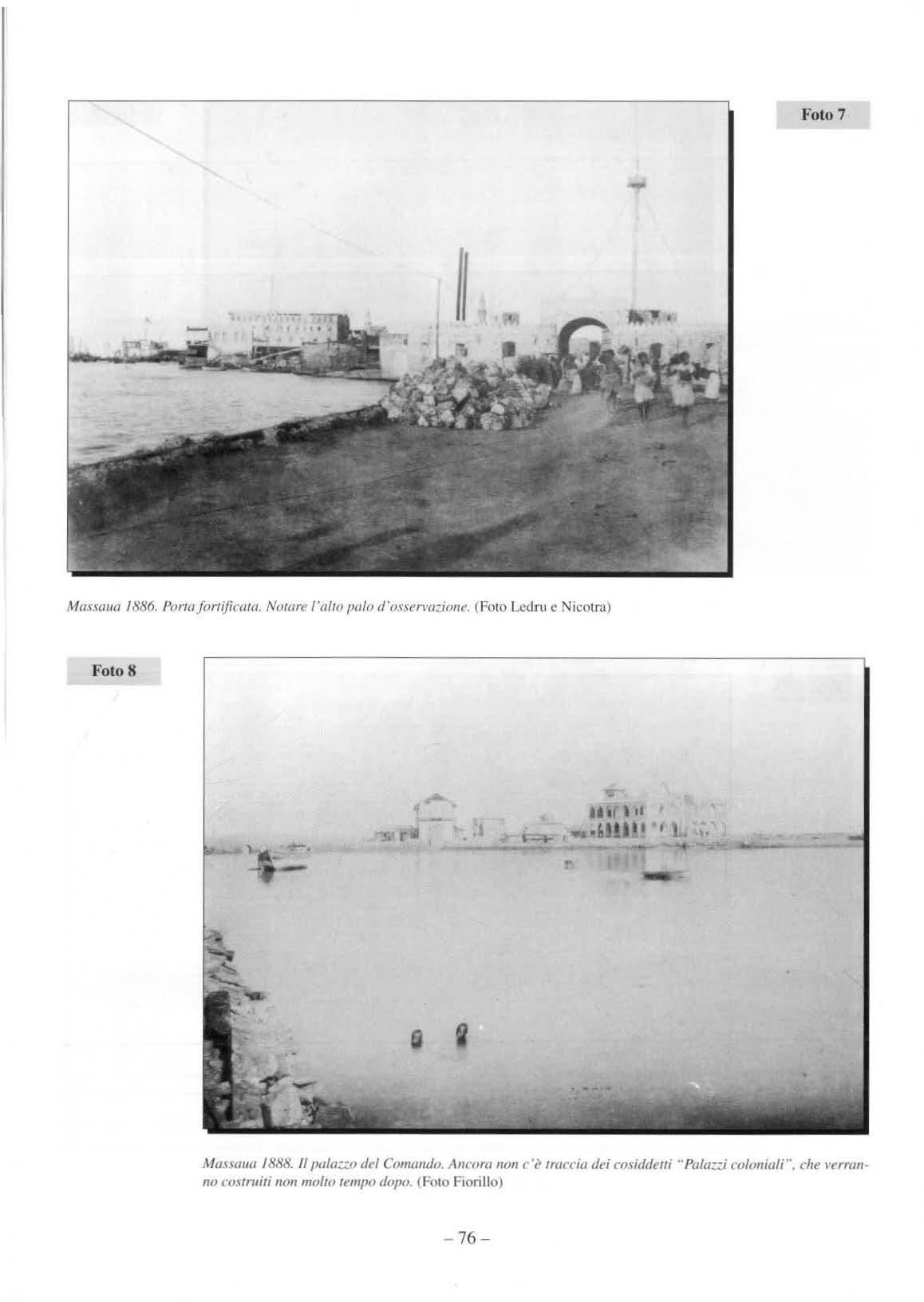 Foto7
Massaua 1886. Portafortijicalll. Notare l'alto palo d'osserwr:io11e (Fo to Ledru e Nicotra)
Foto7
Massaua 1886. Portafortijicalll. Notare l'alto palo d'osserwr:io11e (Fo to Ledru e Nicotra)
, r
Foto8
- 76-
Mas saua 1888 fl pala:::.o del Comando. Ancora non c'è tmccia dei cosiddeui " Pala:::.i coloniali". che verranno cOli miti non molto tempo dopo. ( Foto Fiori Ilo )
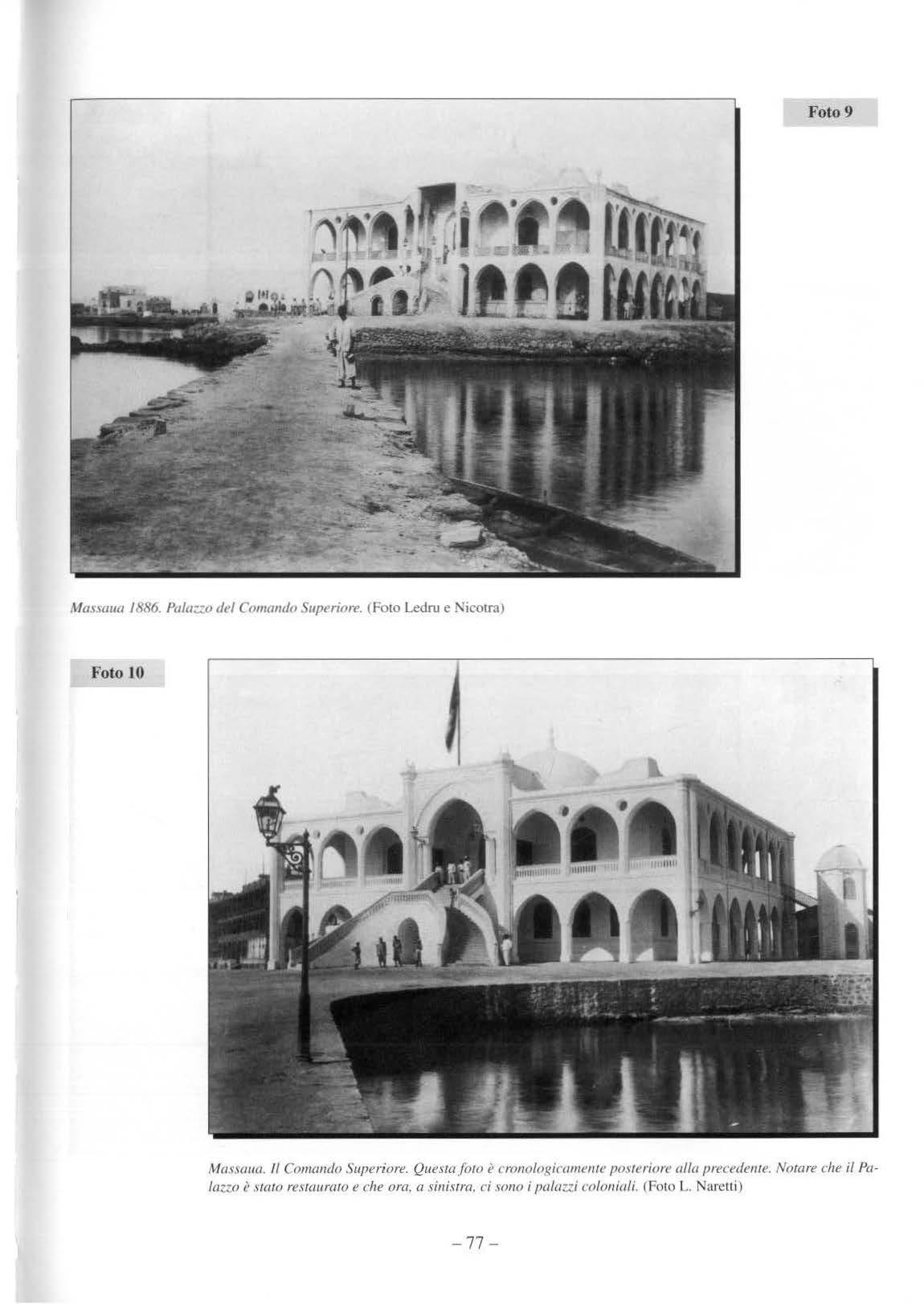
Foto 9
Mas.1mw /886. Pala:.:;o del Comando Superiore. (Foto Ledru e J'l:icorra)
Foto IO
-77-
Massaua. Il Comando Superiore. Questa foro è cronologicamente posteriore alla precede/Ile. Notare che il Pa/a z::.o è stato restaurato e che ora. a sinistra. d l'OliO i coloniali. (Foto L. NareLLi )
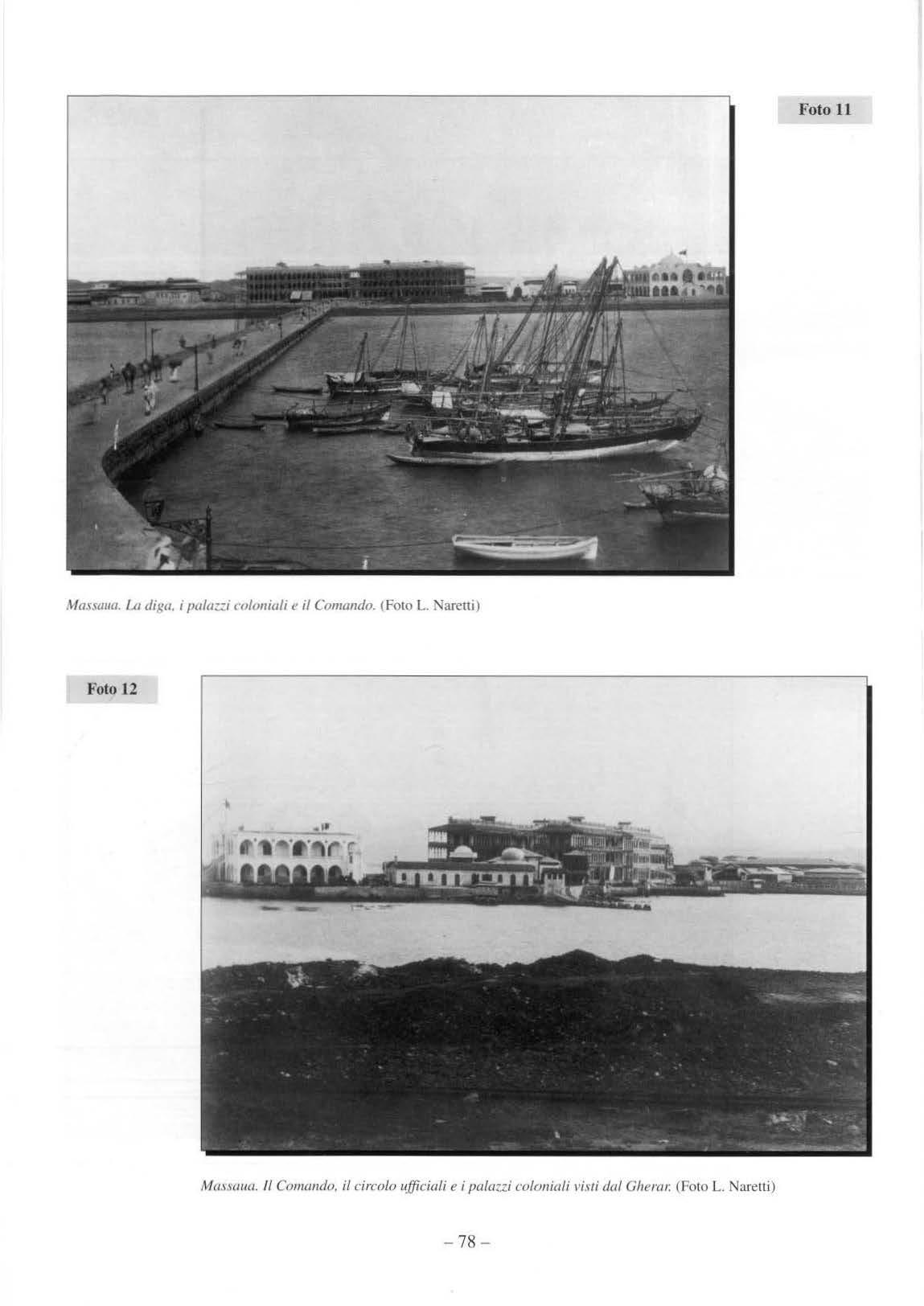
Foto 11
Ma.mma. La diga. i pala:;:.i coloniali e il Comando. (Foto L. Nareni)
Foto 12
- 78 -
Il Comando, il circolo ufficiali e i co lo niali 1•isr i dal Gherar. (Foto L. Naretti)
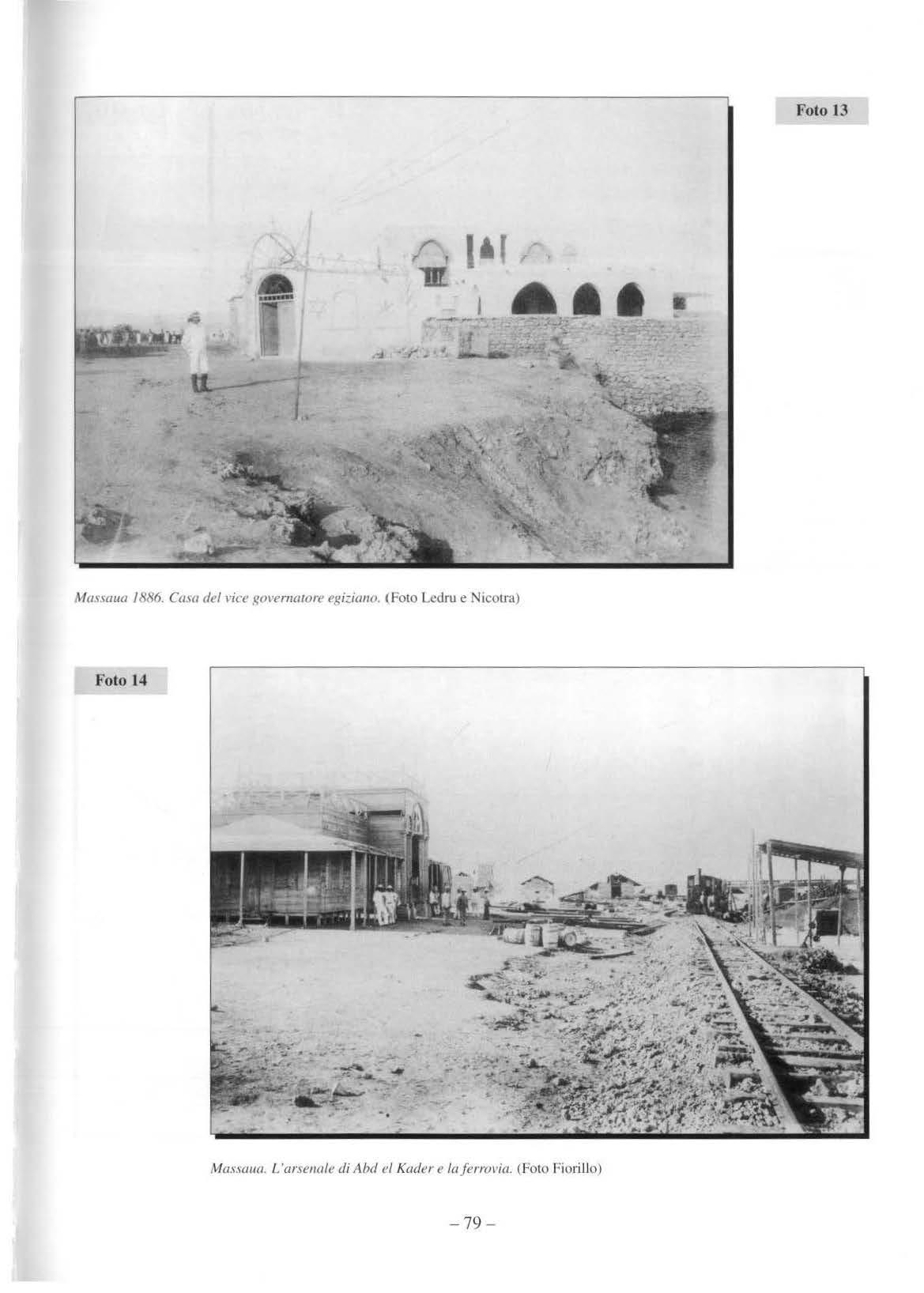
Foto 13 ,, l
Ma .uaua /886. Cwa del vice g<ll'ernatore egi:iano. (Foto Lcdru e Nicolra)
Foto 14
-79 -
Massaua. L'arsenale di Ahd el Ktufer e la ferrovia. (Foto FioliJ Jo)
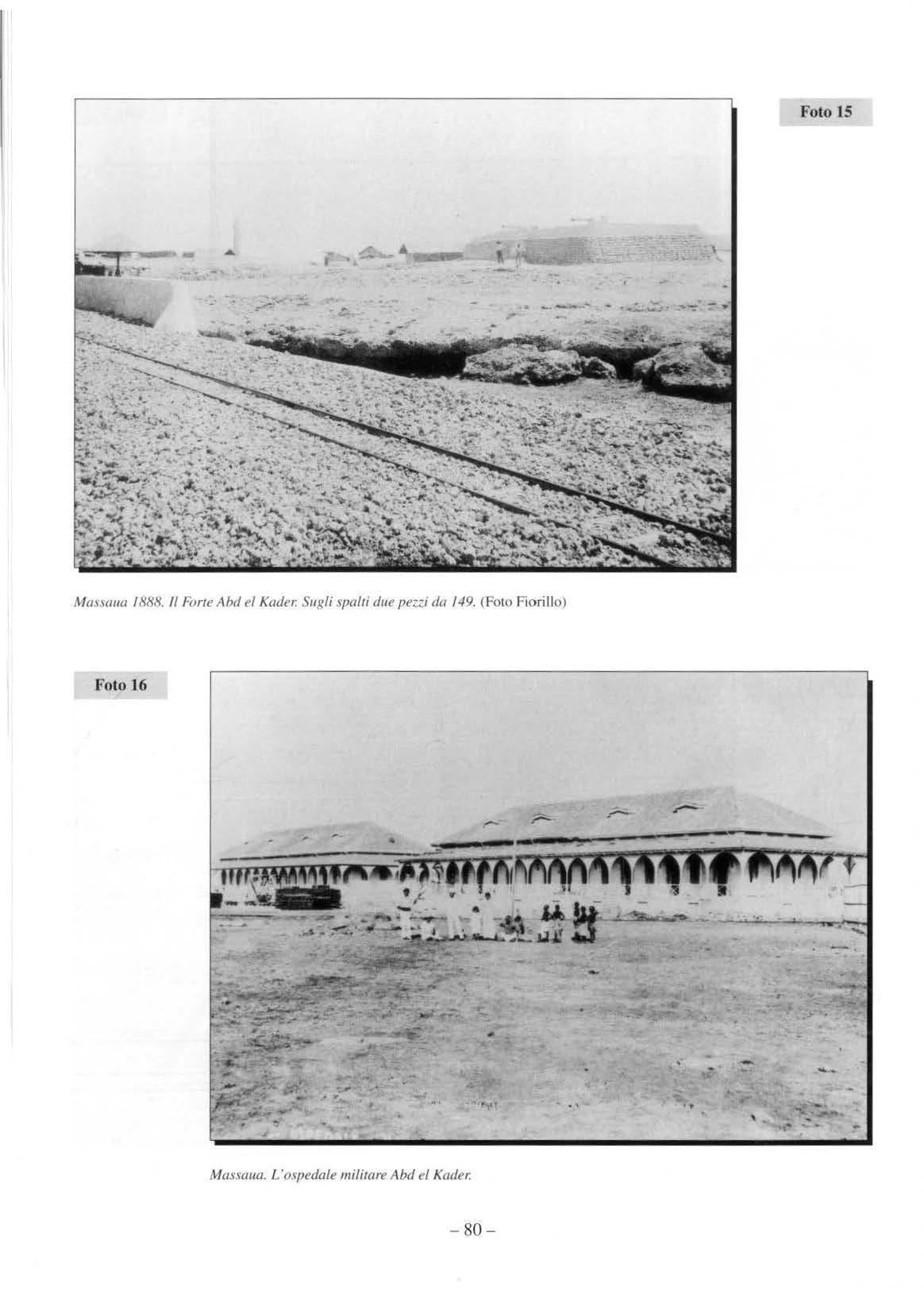
Foto 15
Mawuw 1888. Il Forre Ahd el Kade1: SuJ?Ii spa/ri due da 149. (Foto Fiorillo)
--
Foto 16
- 80 -
Massaua. L'ospedale militare Abd el Kader.
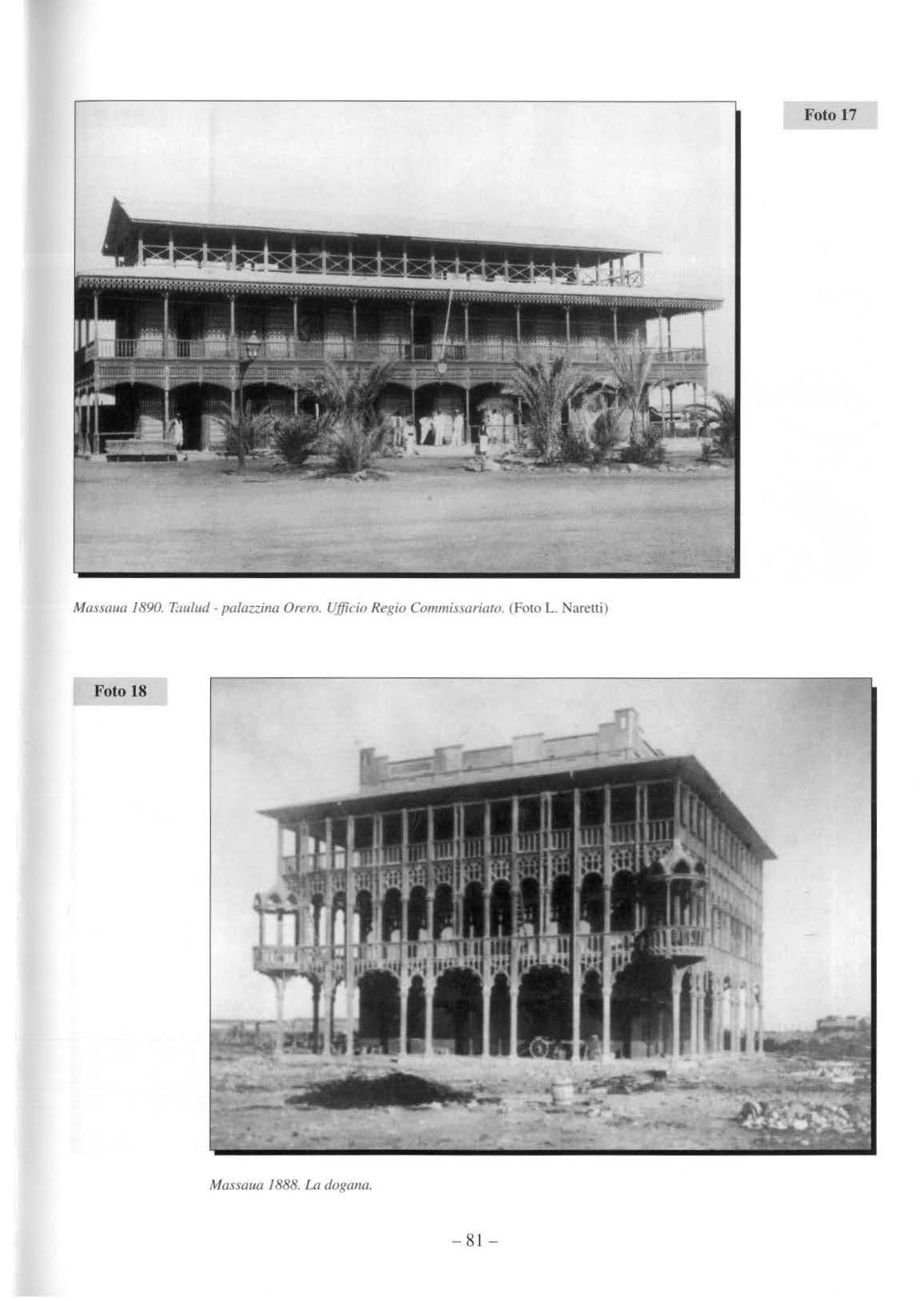
Foto 17
Ma:>saua 1890. Taulud • Orero. Ufficio Regio Conunij\ctrimo. (Fo to L. areni)
Foto 18
- 8 1 -
Ma:.saua 1888. La dof.(ww.
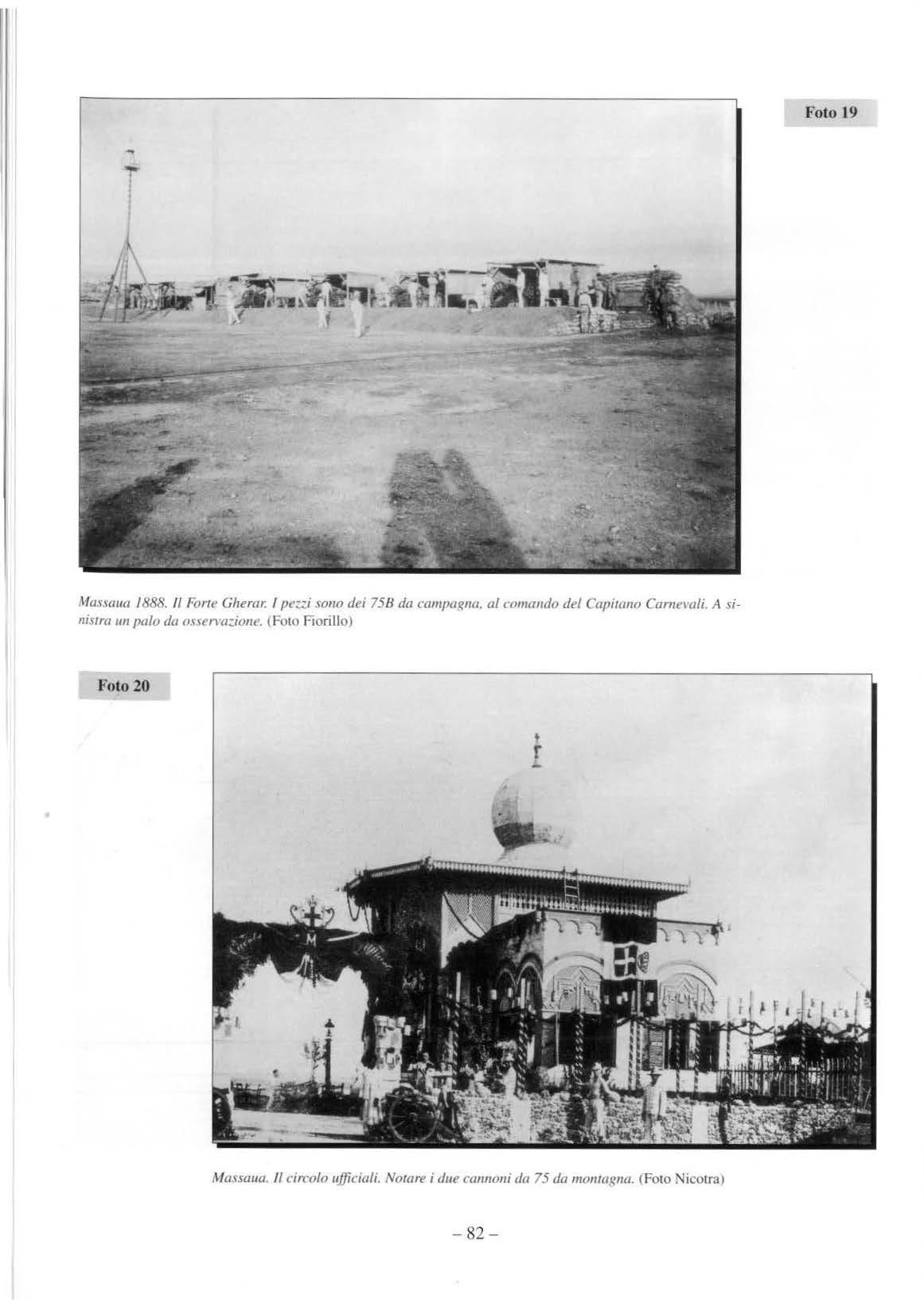
-
/ 888. Il Forre Glzerar. l pe:;:.i son o dei 75 8 da campaf?na. al comando del Capitano Camemli. A sinistra 1111 palo da osun a::.ione. (Foto Fiorillo)
t r
Foto 20
- 82-
Massaua. Il circolo ufficiali. Notare i due cannon i da 75 da montagna. (R> to Nicotra)
19
Foto
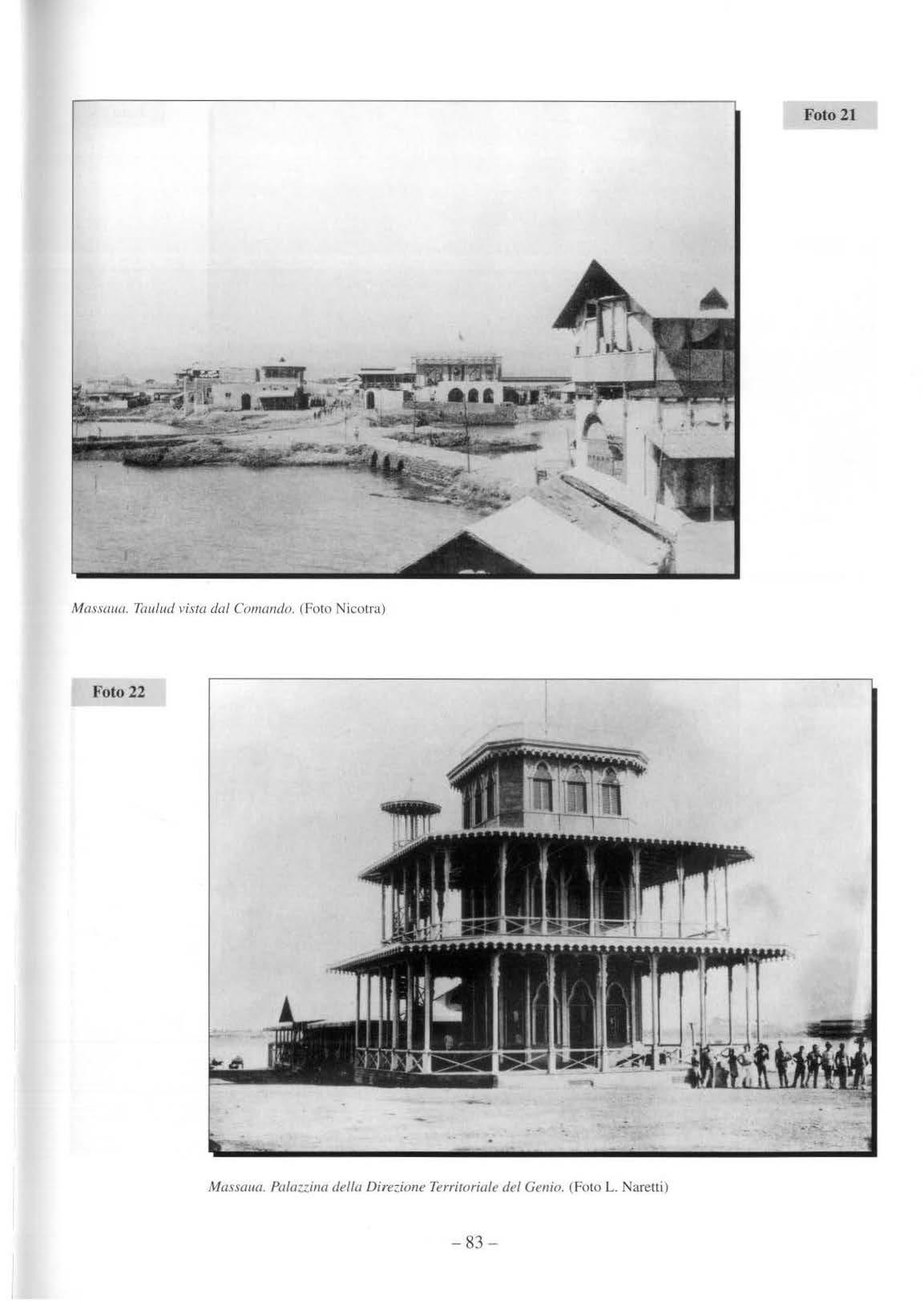
Foto 21
J<'oto 22
MaS.\lllm. Taulud vista dal Comando. (Foto Nicotra)
-83 -
Massaua. Pala::.::. ina della Territoriale del Genio. (Foto L. Naretti)
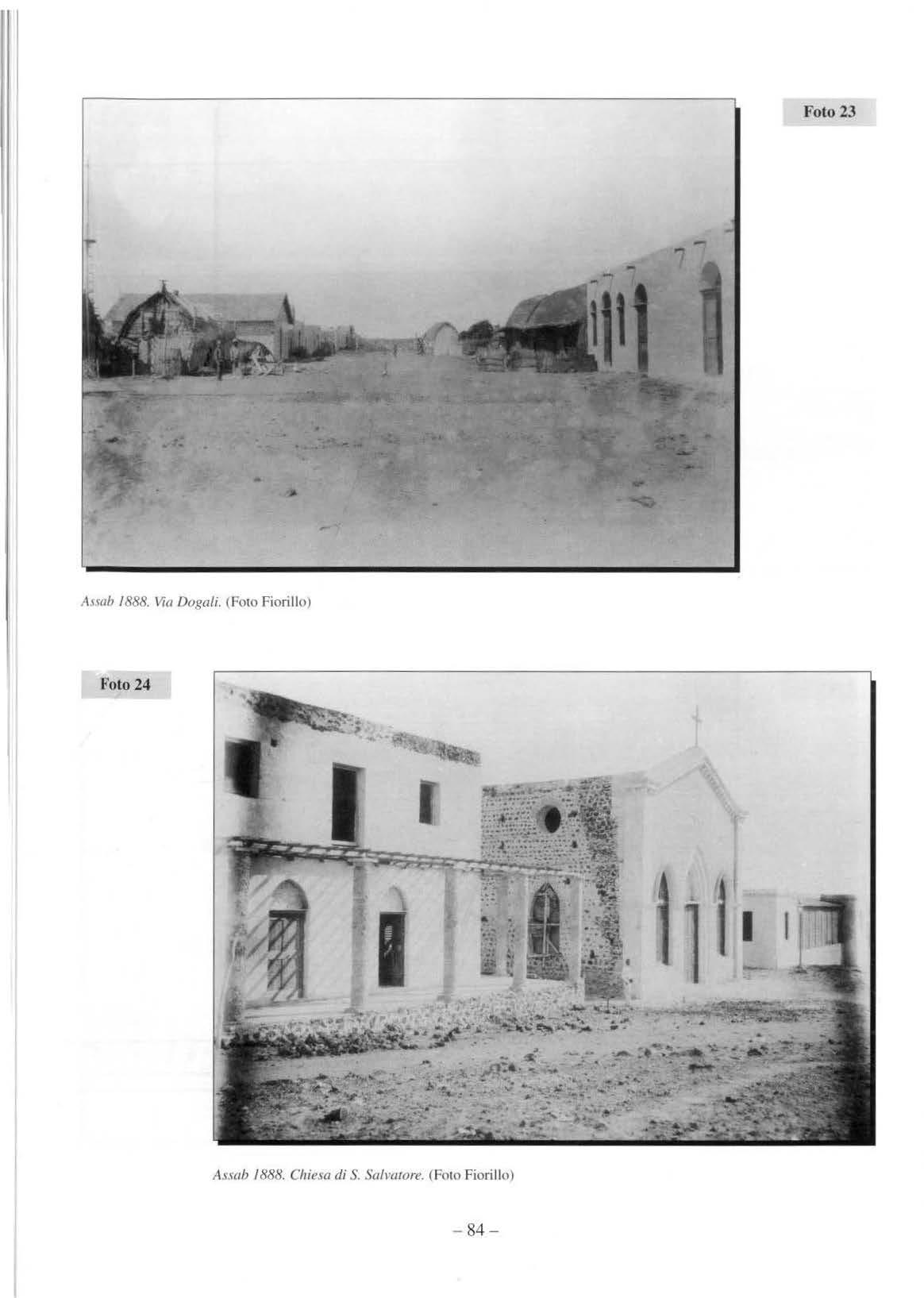
Foto 23
A.ssab 1888. Vir1 Dogali. (Foto Fiorì Ilo)
Foto 24
- 84-
A uab 1888. Chiesa di S. Sa!l•atore. (Foto Fì orì ll o)
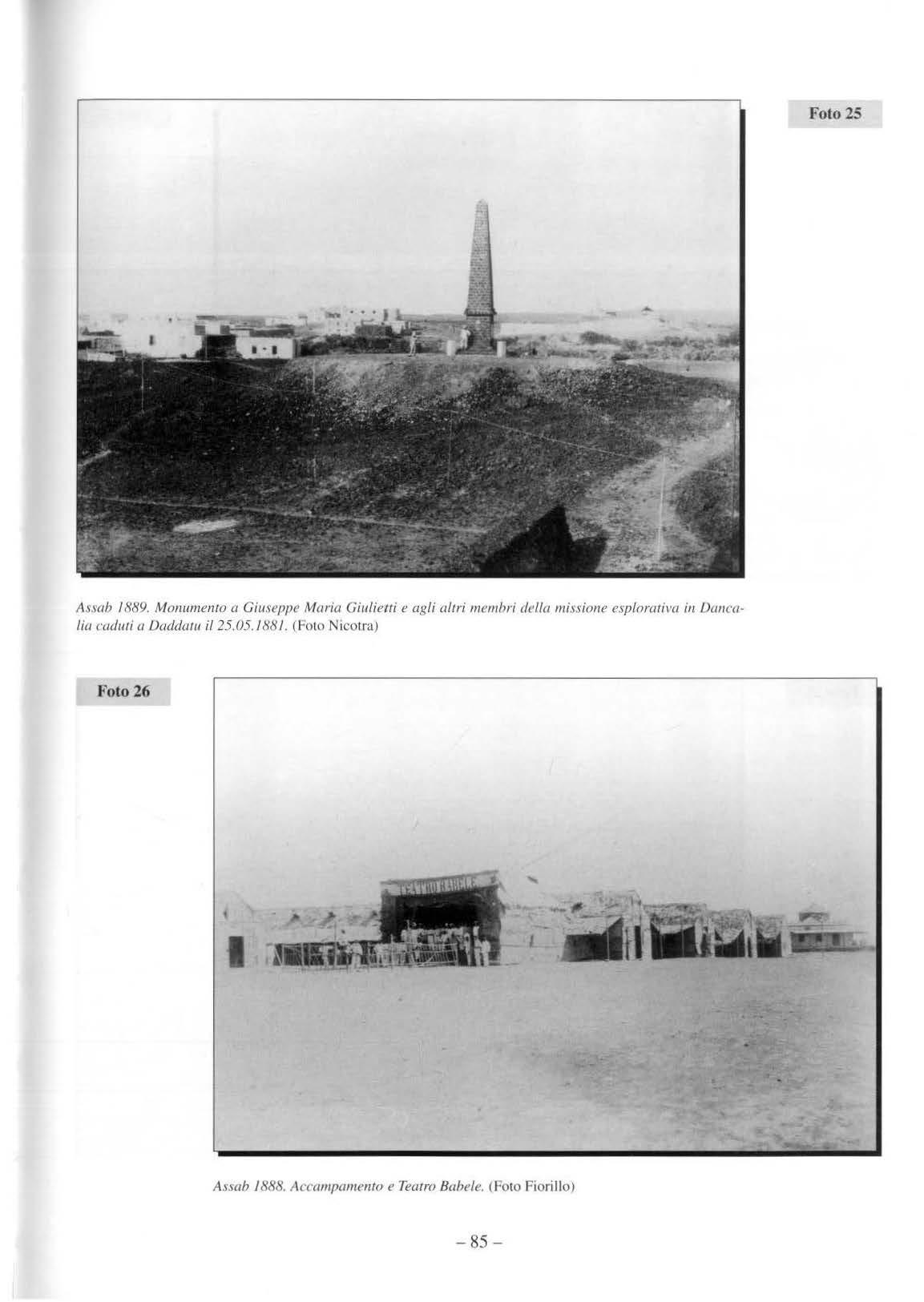
26
Assab 1889. Monumento a Giuseppe Maria Giulietti e agli altri m emhri della missionP Psplorati1•a in Dancalia cadwi a Daddatu i/25.05.1881. (roto Nicotra)
-85Foto 25
Assab 1888. Accampamento e Teatro Babele. (Foto Fiorillo)
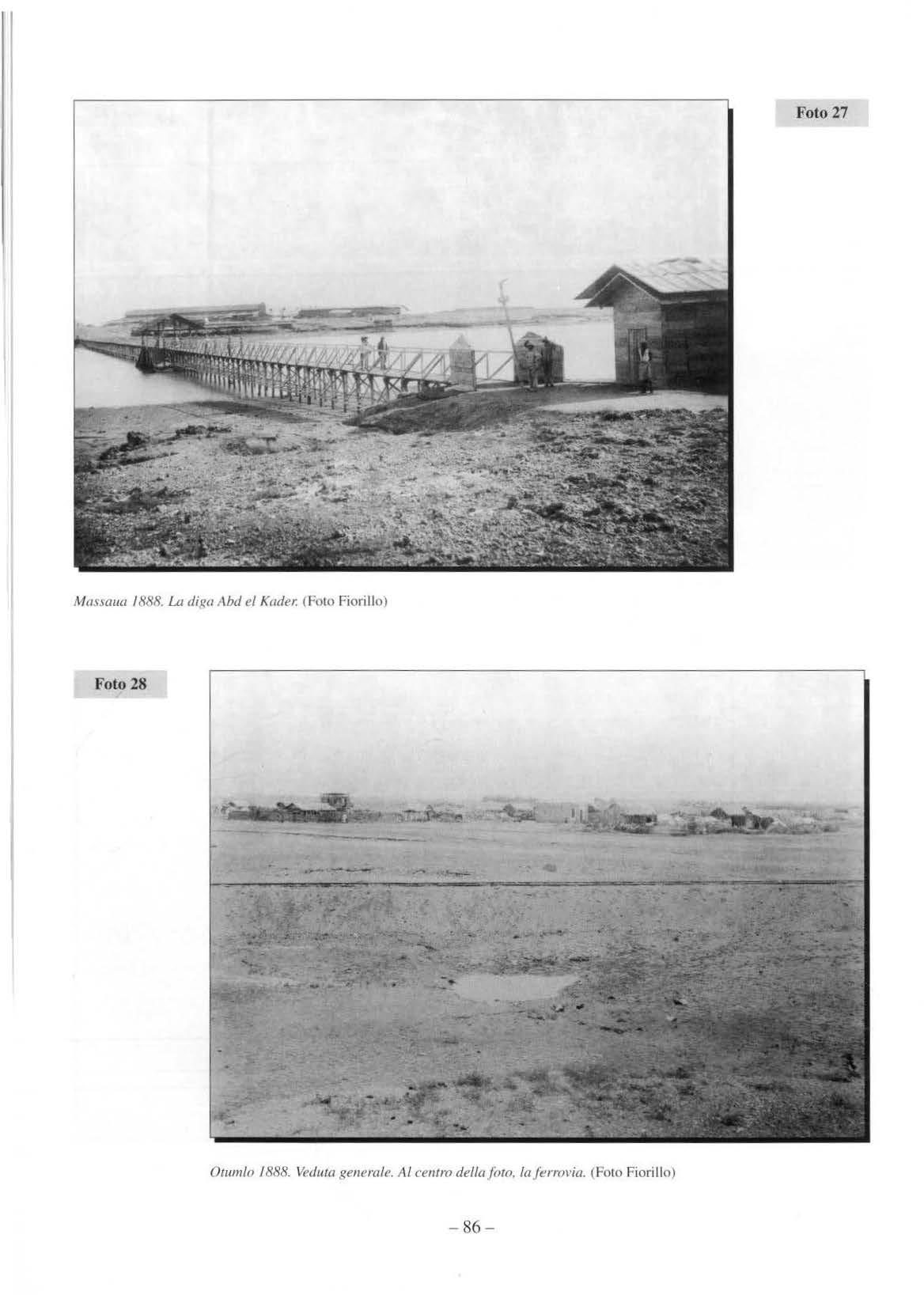
Foto 27
28
Ma ssa ua 1888 La diga Abd el Kader. (Foto Fiori Ilo ) Foto
- 86 -
Otumlo 1888. Vedma generale. Al centro del/afmn. la ferrovia. (Foto Fiori ilo )
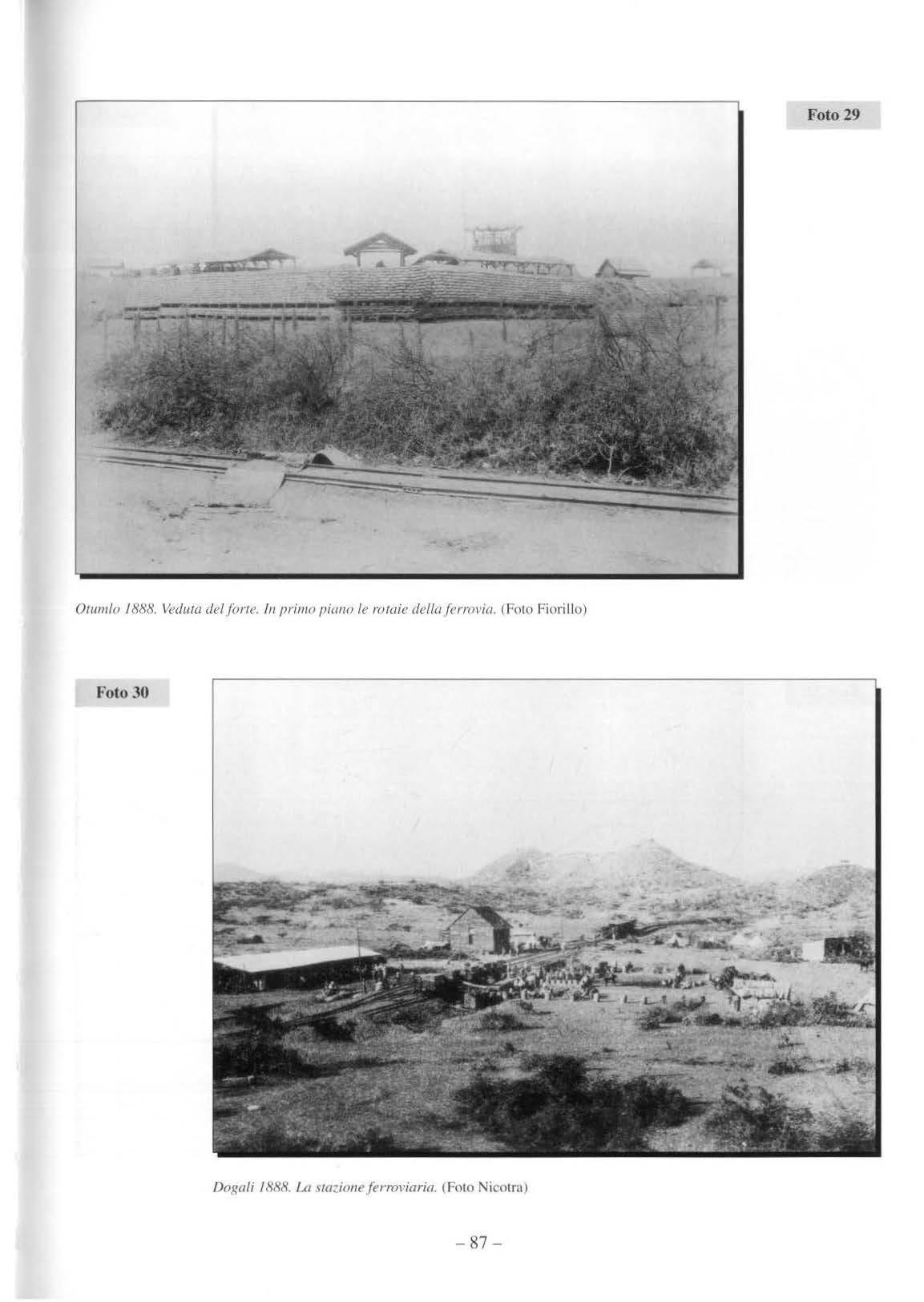
Foto 29
Owmlo 1888. Vedula de/forte In primo piano le tvtaie de/lafcrrOl'itl. (Foto Fiorii lo)
Foto 30
- 87 -
Dogali 1888 La stttzione ferro1 iaria. (Foto Nicolra)
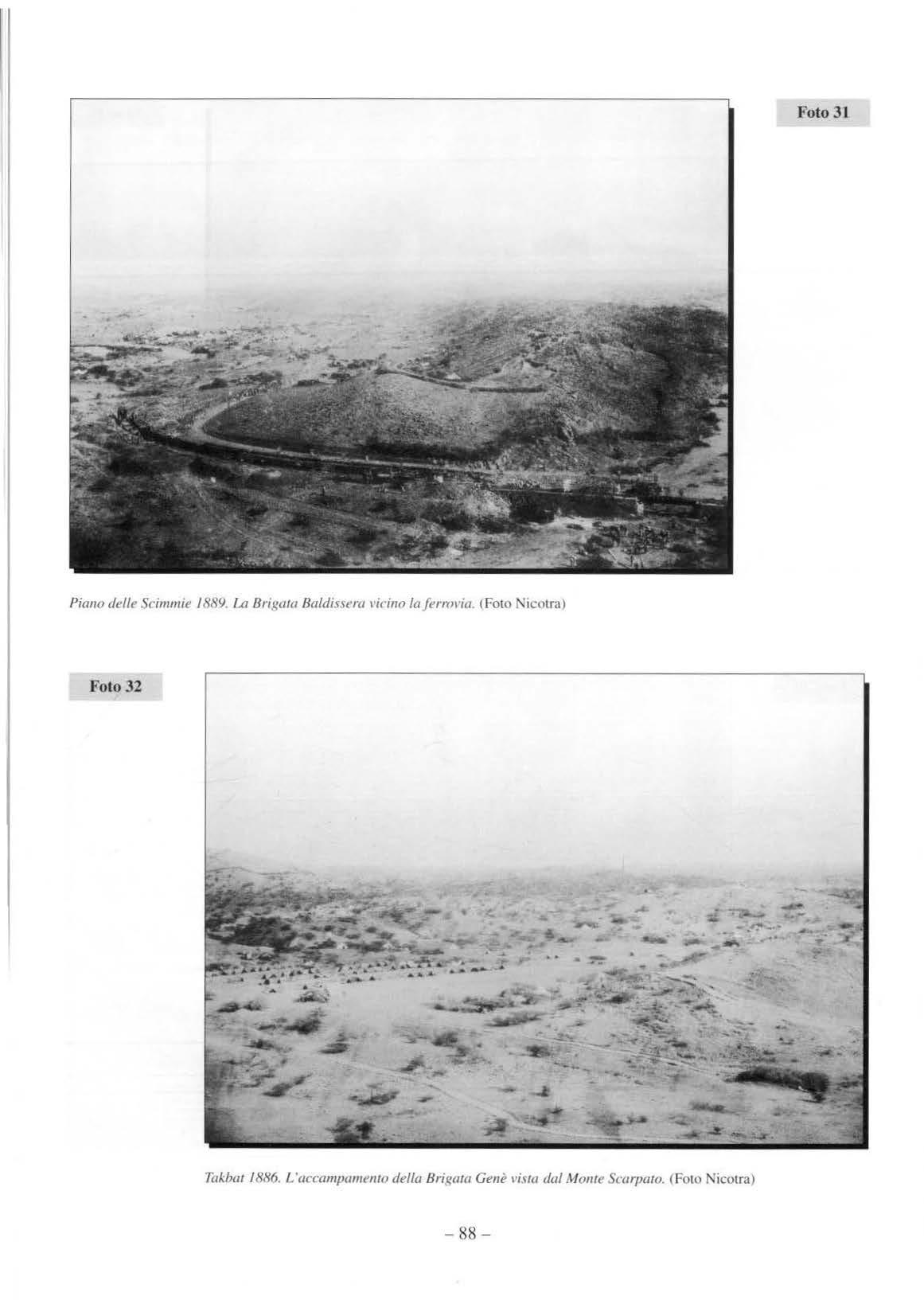
Foto 31
Piano delle Scimmie /889. La Briga w Baldissem 1•icino laferroria. (Foto Nicotra)
Foto 32
- 88-
Takbat 1886 L'accampamento della Bri,c:ata Cenè 1•i.wa dal Mome Scarpato. (Foto 'icotra)
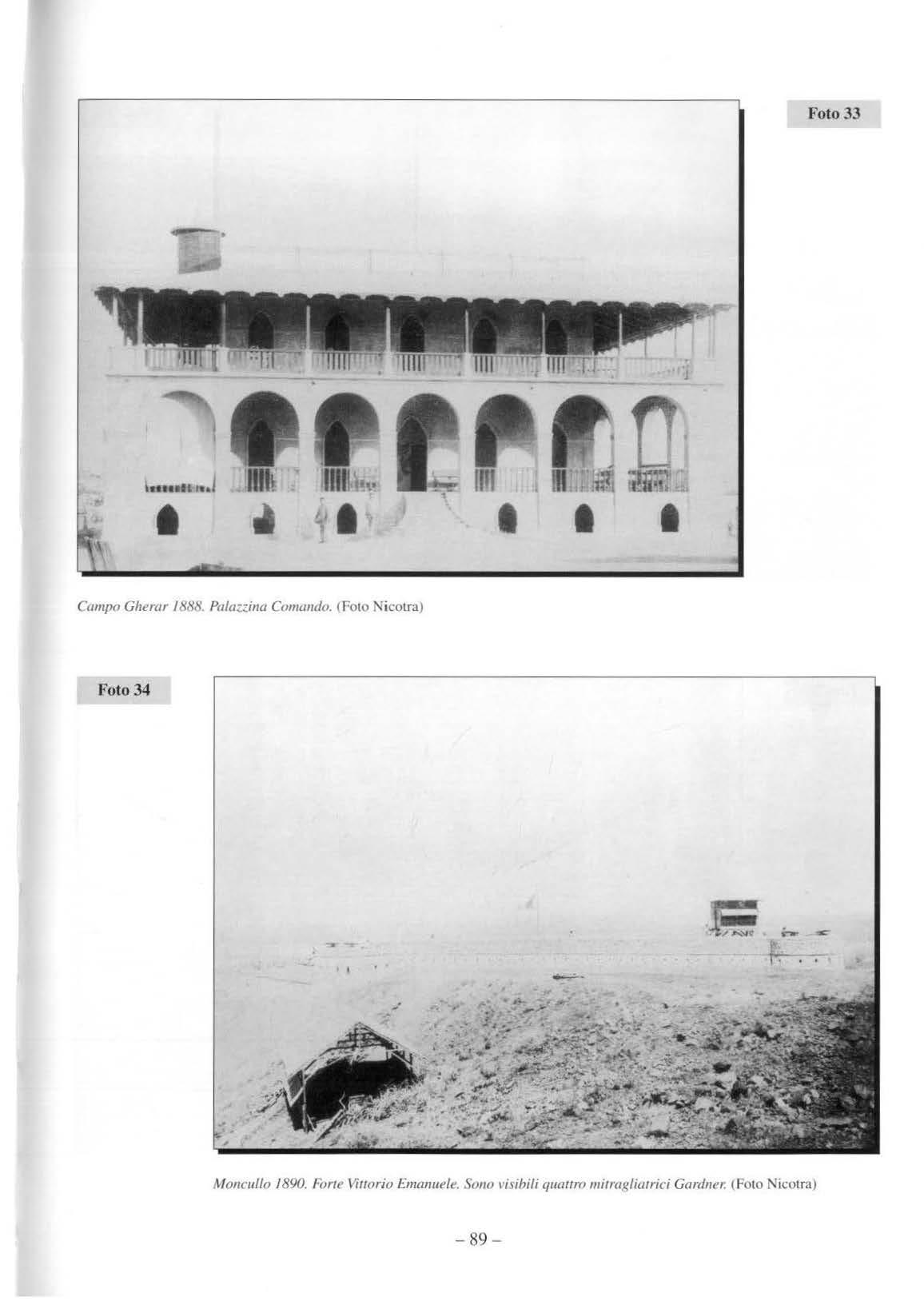
Foto33
Campo Gherar 1888. Pala;:.::.ina Comando. (Foto icotra)
Foto 34
- 89 -
M oncullo /890. Fvne \/ittorio Emanuele. Sono l'Ìsibili quattro mitraxlimrici Gm·dner. ( l- oto Nicotra)
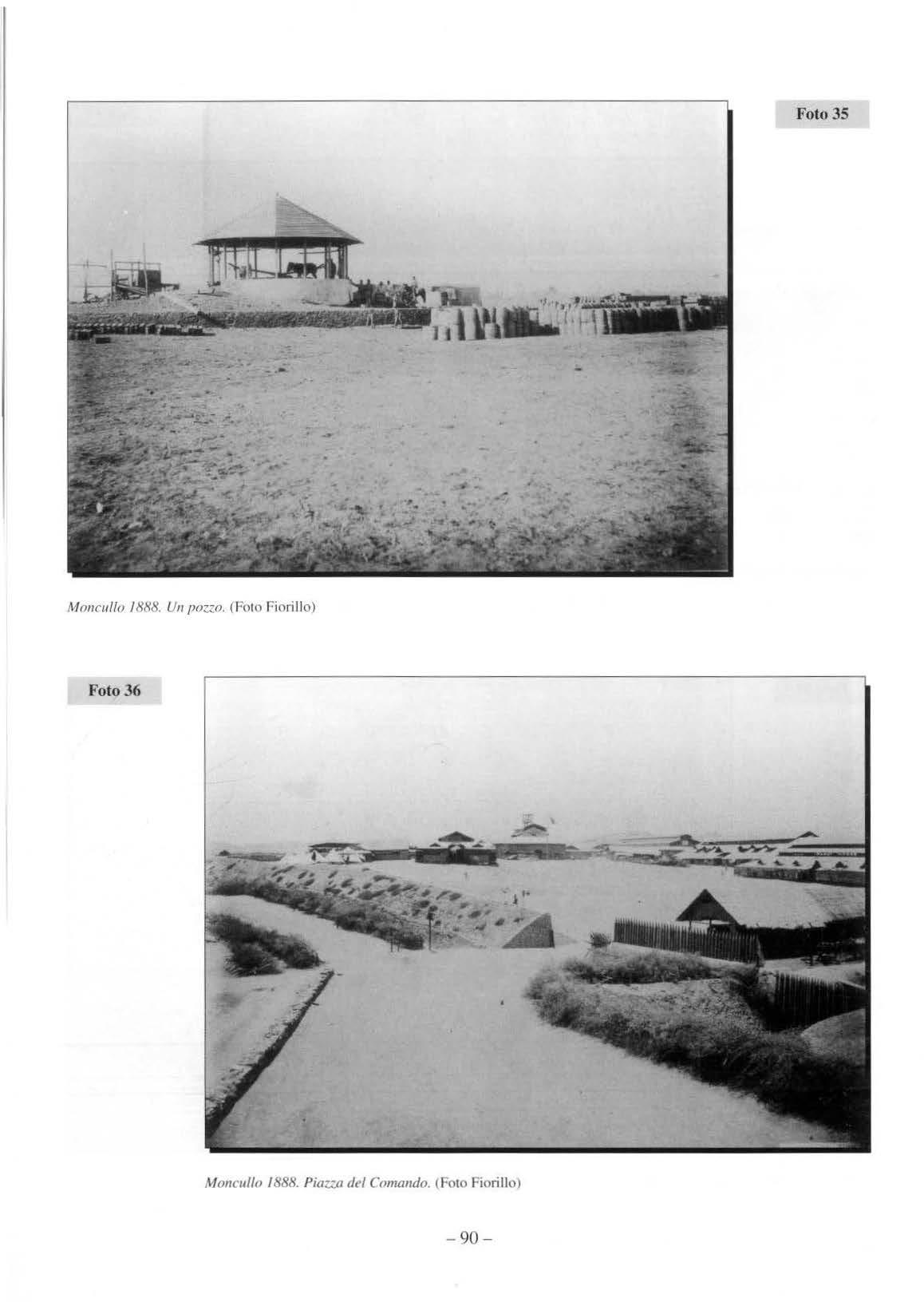
Foto 35
36
Mrmculfo 1888 Un poz:.o. (Fo l a ri ori llo) Foto
-90-
Moncul/o /888. Pia -:;::p del Comando. ( Fola Fiori Ilo)

Foto 37
Moncullo /888. Uno degli ingressi del forte. Notare i ca1·alli di Frisia. (Foto Fio1illo)
38
Foto
- 91 -
Monculfo 1888. Altra vedura de/forre. (Foto Fior illo)
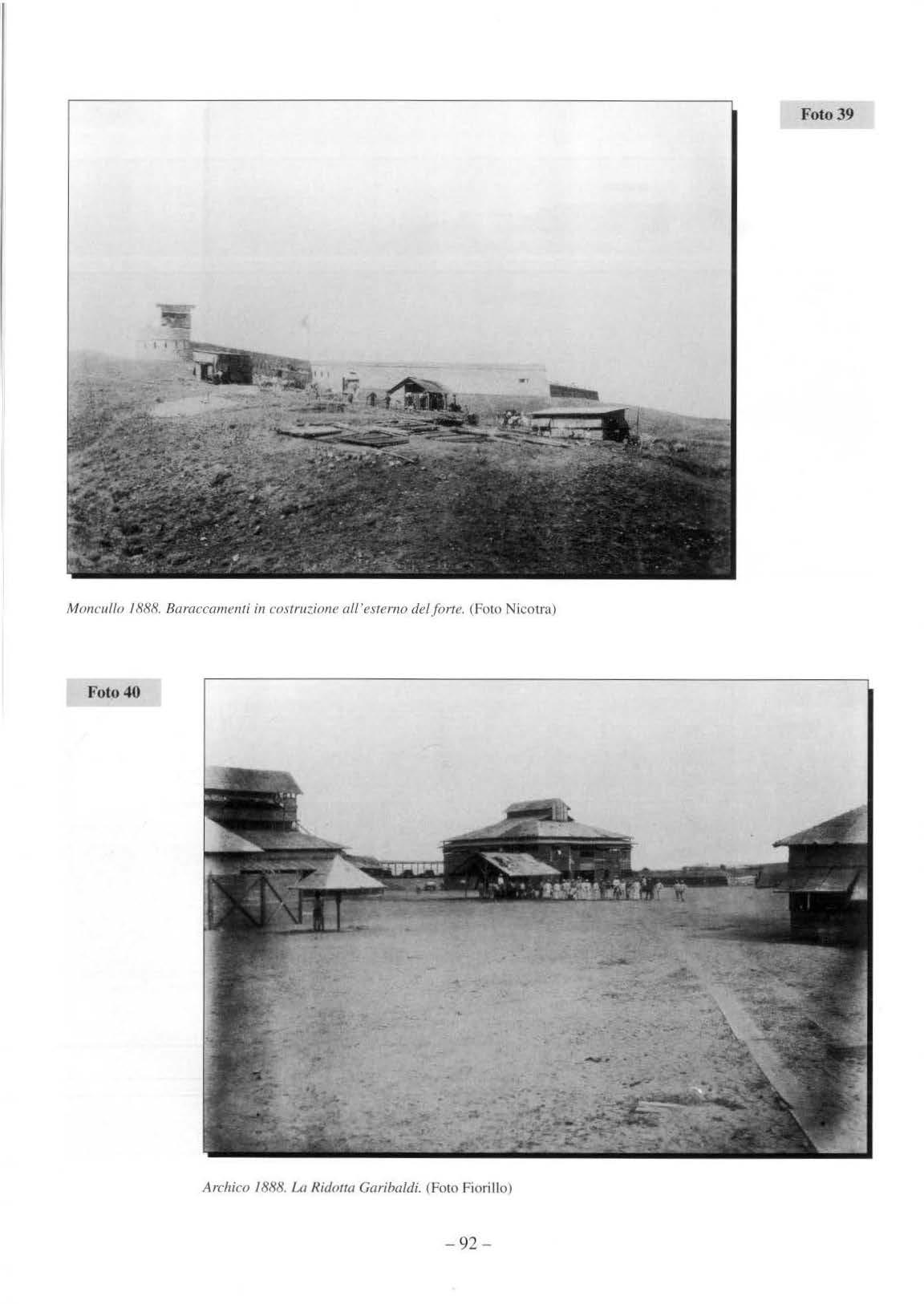
Foto39
Moncullo UIHH. Baraccamenti in cmtrtdone alf'es1erno del forte. (F<Jto Nicotra)
Foto 40
-92-
Archico 1888 Lt1 Hidrma Garibaldi. (Foto Fioril l o)
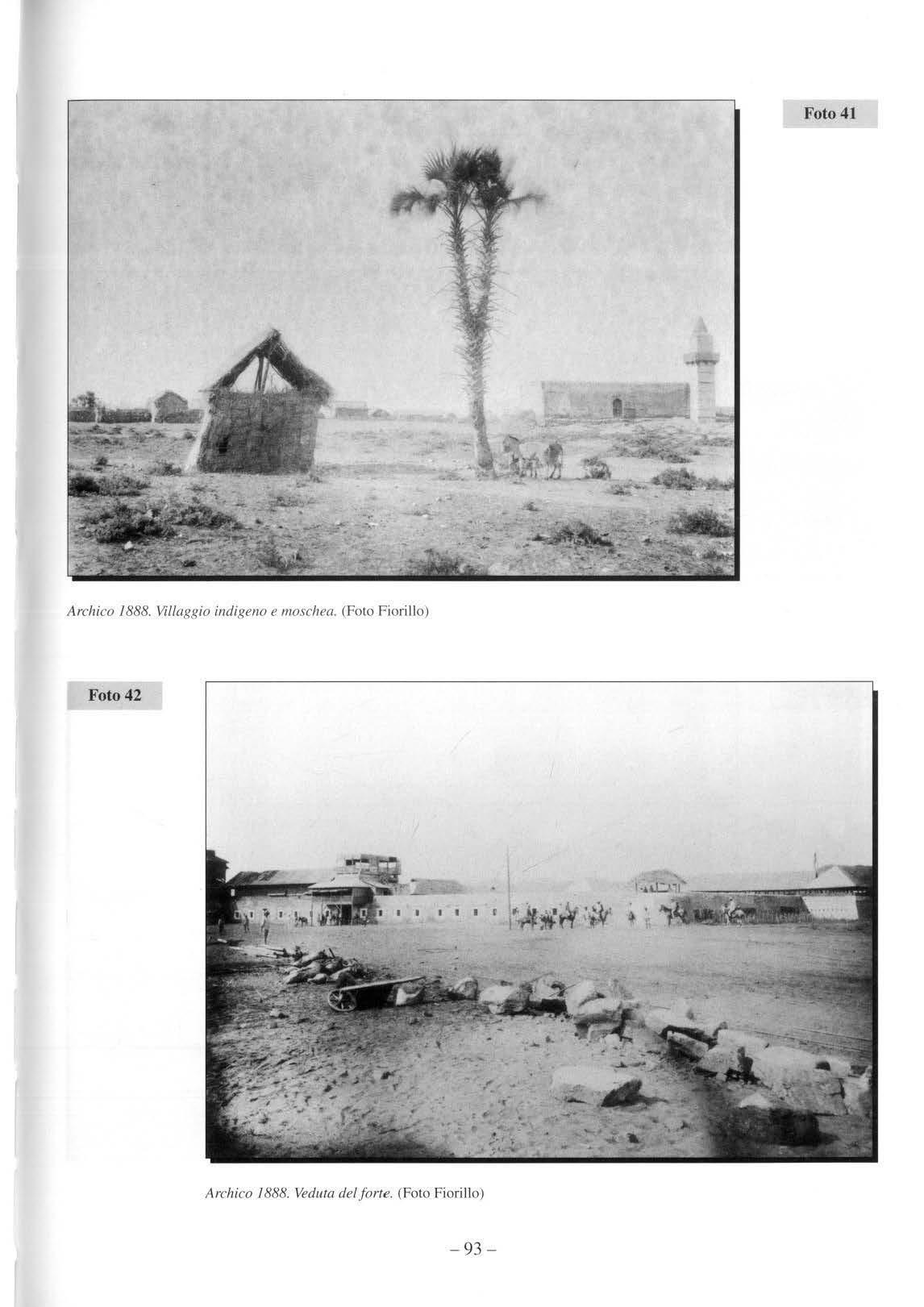
Foto 41
42
Archico 1888. Villaggio indìgeno e moschea. (Fo to Fiorii lo) Foto
- 93 -
Arch ico 1888. Ved uta de/forte. (Fo to Fiori ll o)
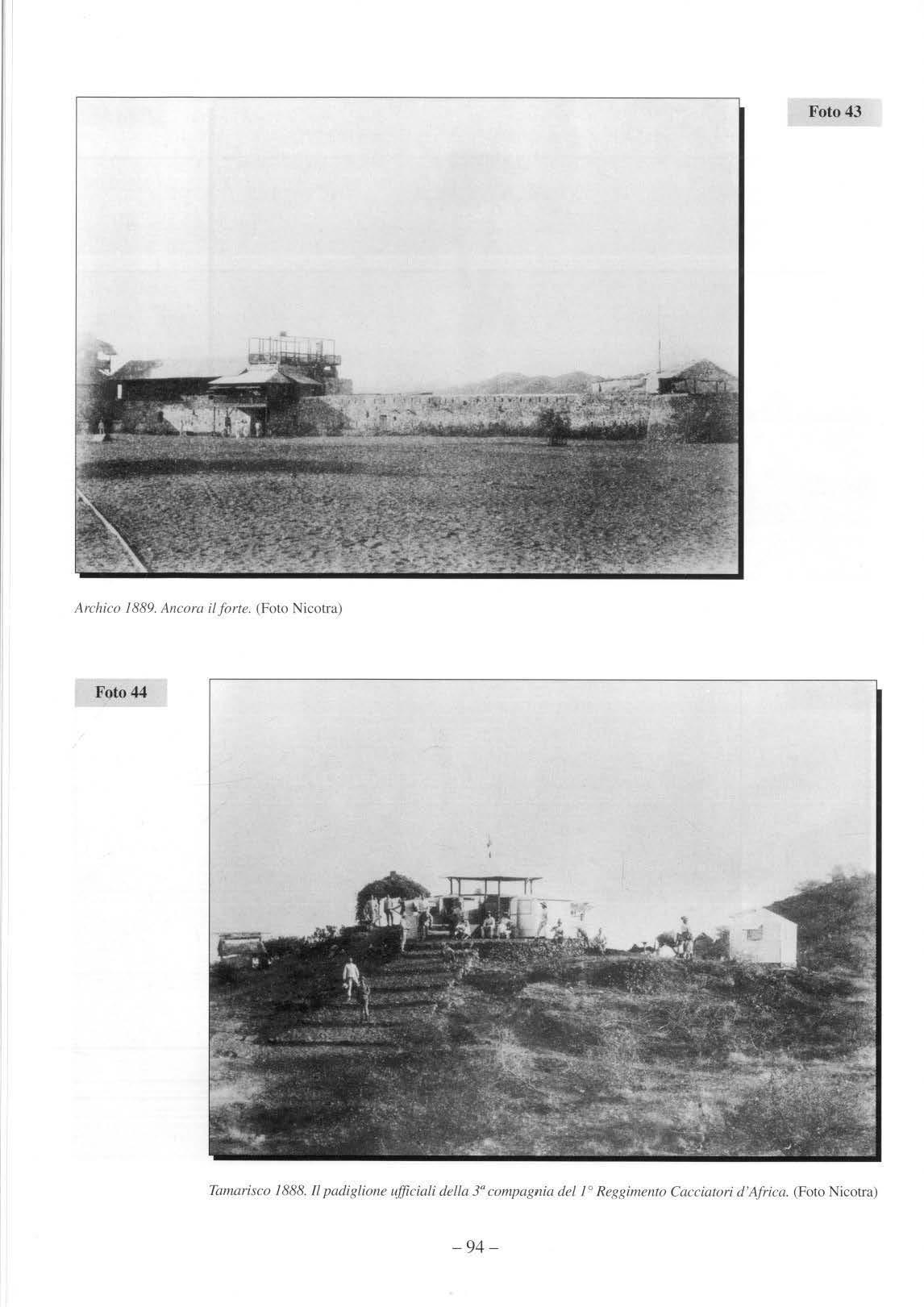
Foto 43
Archico 1889. Ancora ilforte. (Foto NicotTa)
Foto44
-94 -
Tamarisco 1888. Il padiglione L!fficiali della 3a compagnia dell o Reggimento Cacciatori d'Africa. (Foto Nicotra)
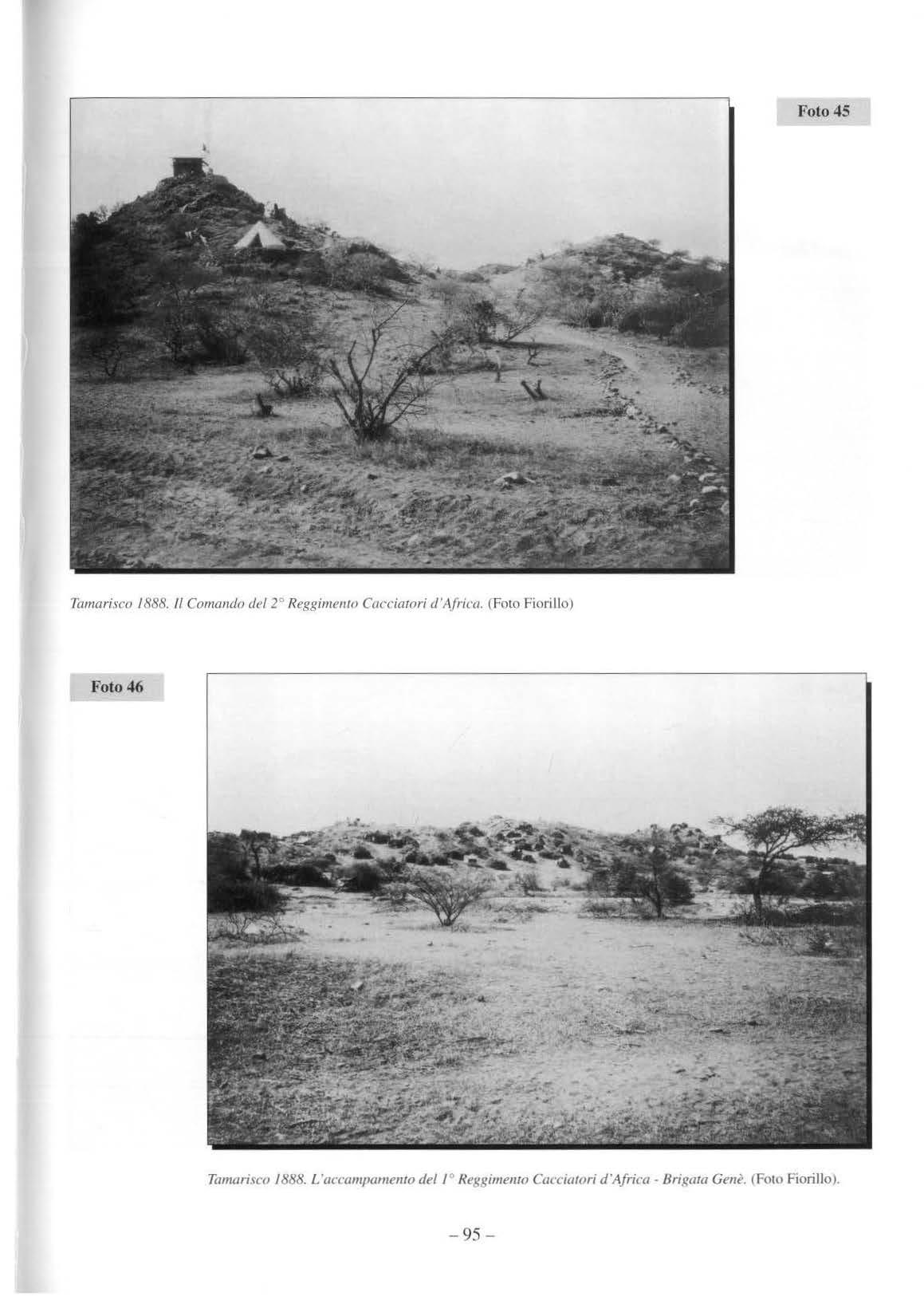
45
Foto
Tamarisco 1888.1l Comando del r Reggimemo Cacciatori d'Africa. (Foto Fiorillo)
46
Foto
-95-
Tamaris co 1888. L'accampamento del / 0 Reggimemo Cacciatori d'Africa· BriKata Genè. (Foto Fiorillo).
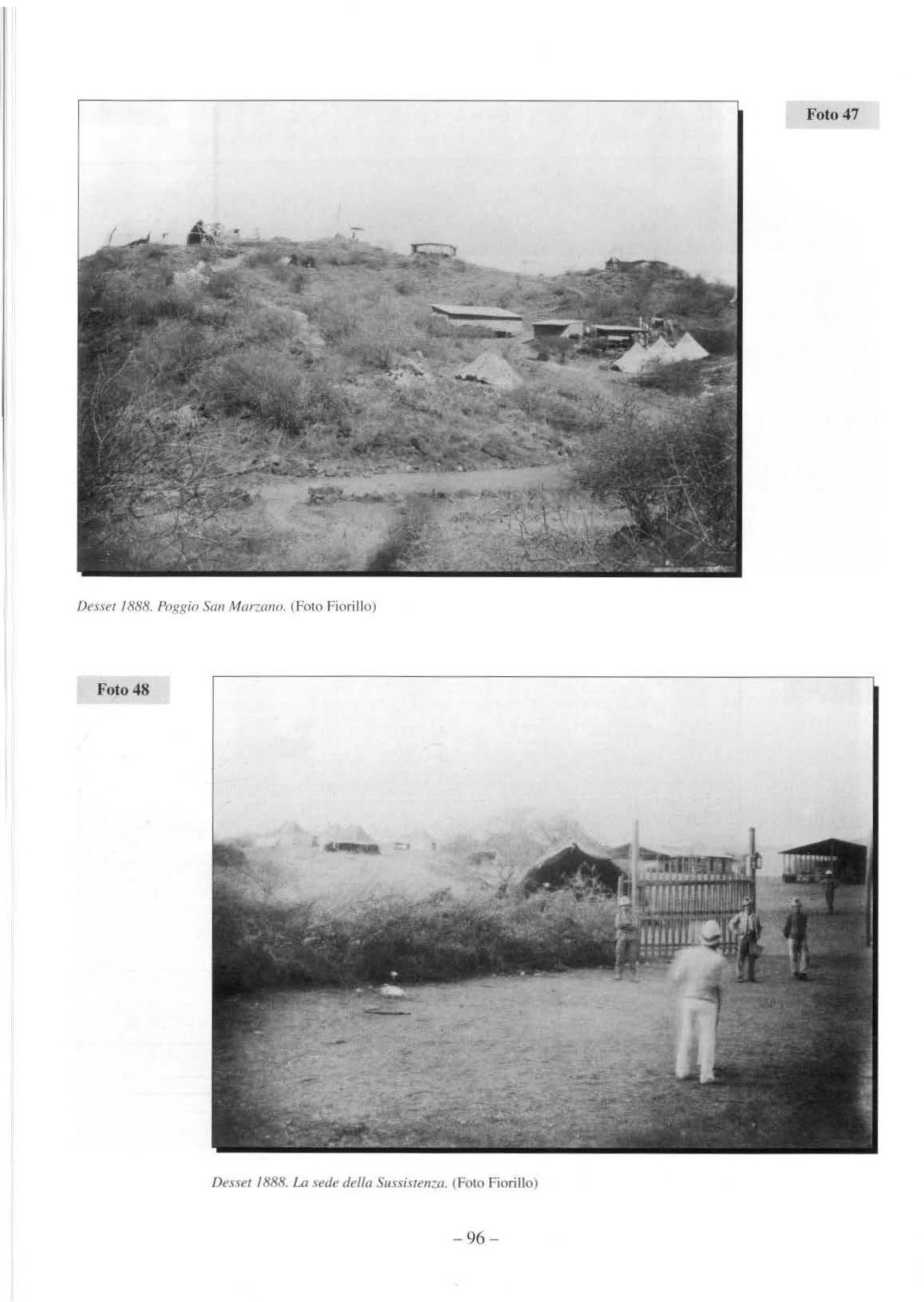
Folo 47
Desse/ 1888. Po8gin San Mar::ano. (Fow Fiori i lo)
Foto 48
-96-
De uet /888. La sede della Sussisren:tl. <Foto Fiori Ilo)
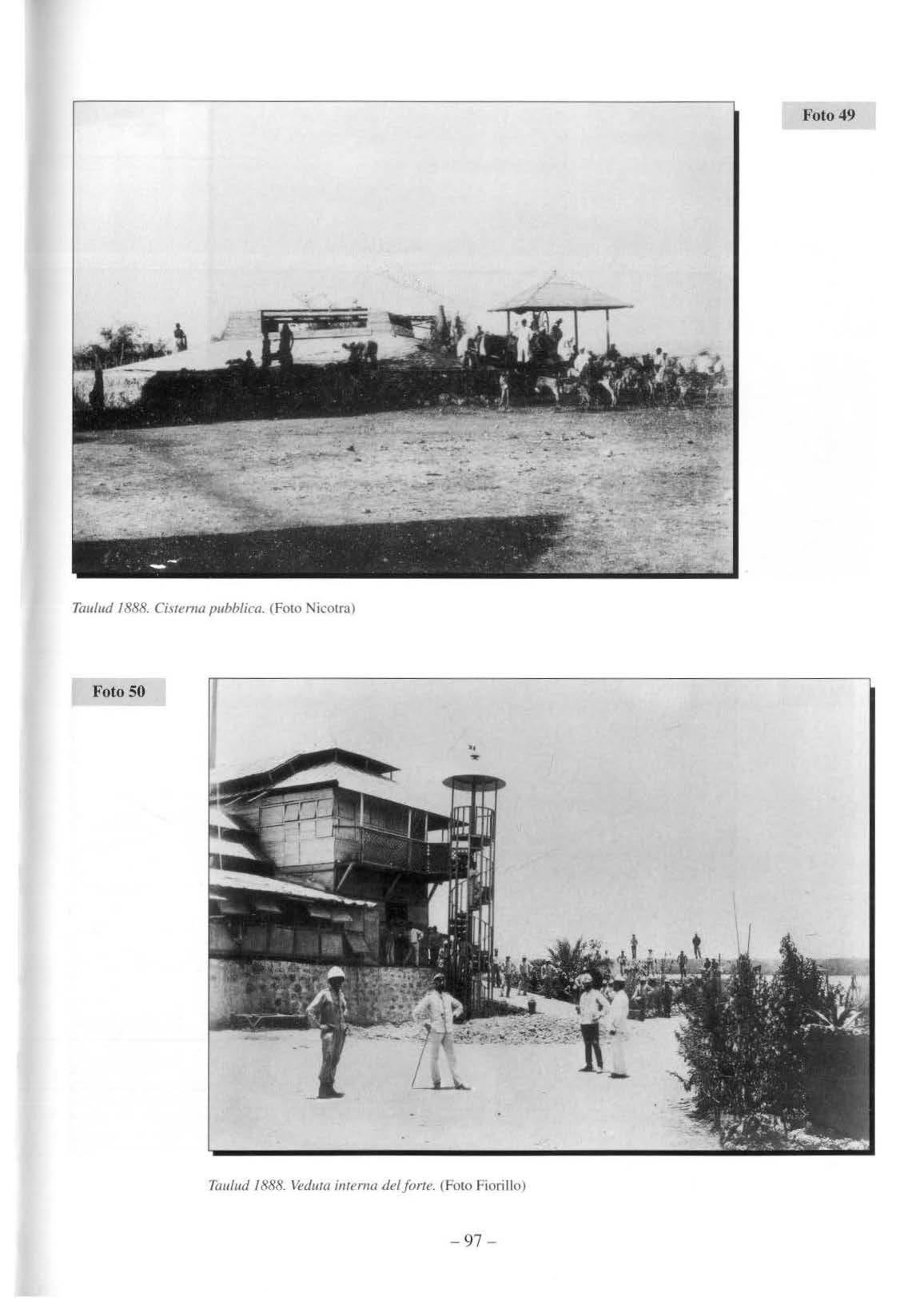
Foto 49
Taulud 1888. Cistenw pubblica. (FOlO icotra)
Foto 50
-97 -
Tt.wlud 1888. Veduta ime ma del forte. (Foto h ori Ilo)
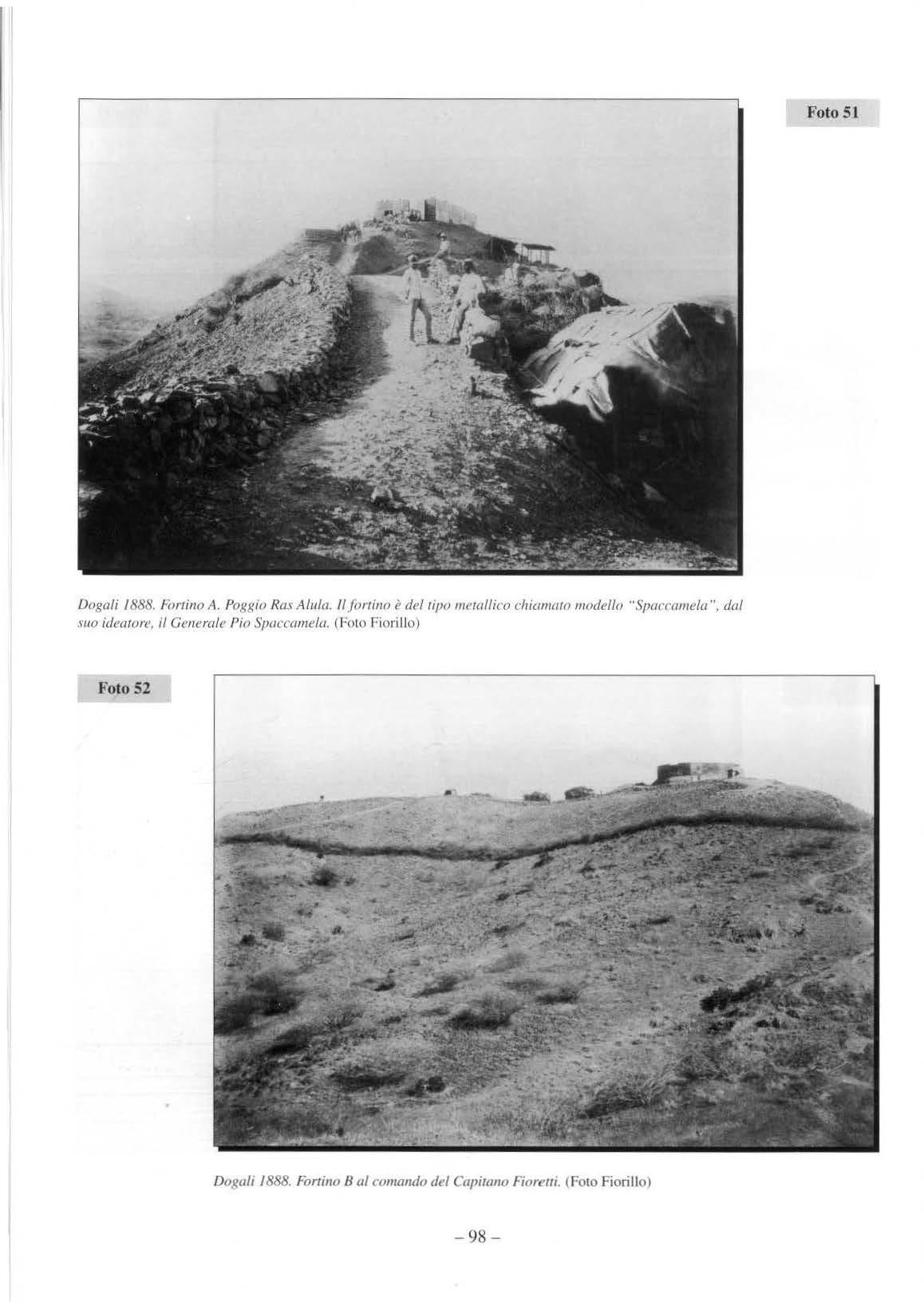 Dogali 1888. Fortino A. Pogg io Ras Alula. Il fortino è de/tipo metallico chiamato modello "Spaccnme/a'', dal suo ideatore, il Generale Pio Spaccamela. (foto Fiorillo)
Foto 52
Dogali 1888. Fortino A. Pogg io Ras Alula. Il fortino è de/tipo metallico chiamato modello "Spaccnme/a'', dal suo ideatore, il Generale Pio Spaccamela. (foto Fiorillo)
Foto 52
- 98 -
51
Dogali 1888. Fortino 8 al comando del Capitano Fioretti. CFoto Fiori Ilo)
Foto

Foto 53
Dogali l 888 U11 'altra veduta del Forti110 A. (Foto N icotra)
Foto
54
- 99 -
D ogali 1888. Collimi dei Caduti (lato Sud) l'iSili dal Monte Guadai- Malafi (Foto icotra)
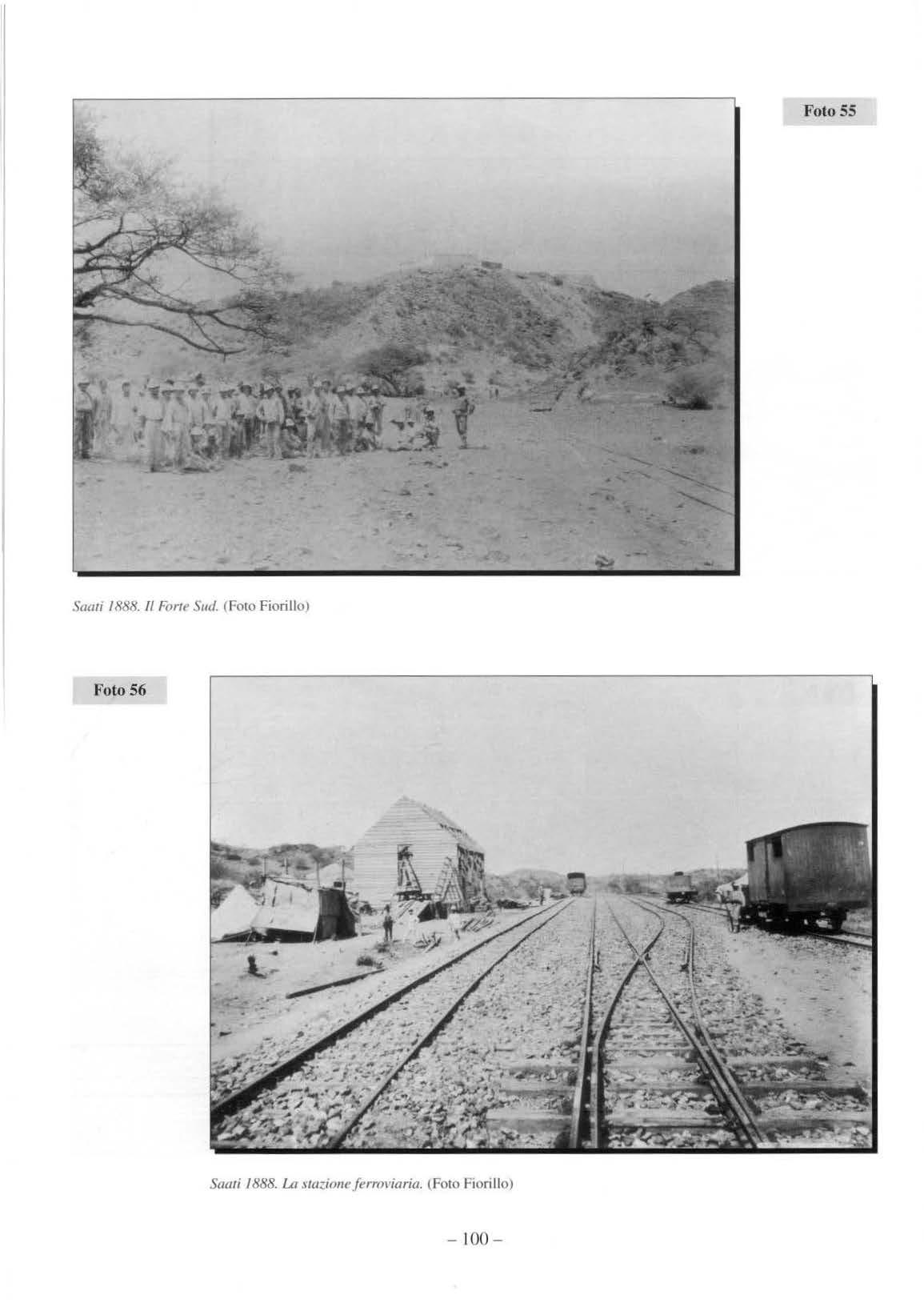
Foto 55
56
Saati /888. Il Forte Sue/. (Foto Fiorillo) Foto
- JOO-
Saari l 888. La lla::.ione ferrm·iaria. (Foto Horillo)
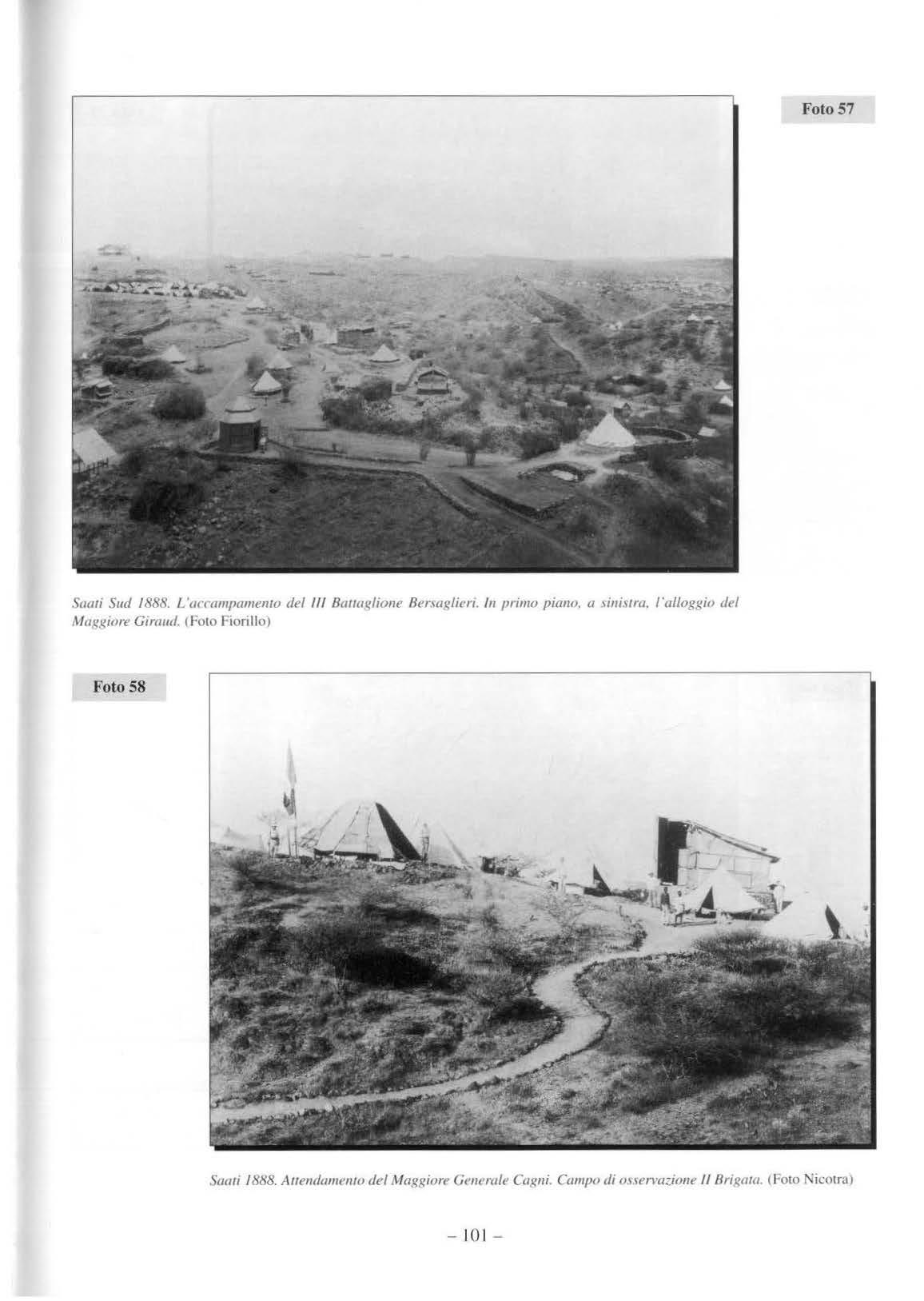 Saati Sud /888. L'acmmpamento del 111
In primo piano. a lillll/1'0. l'alloggio del Maggiore Girami. !roto Fiorillo>
Saati Sud /888. L'acmmpamento del 111
In primo piano. a lillll/1'0. l'alloggio del Maggiore Girami. !roto Fiorillo>
Foto 57
Foto 58
- 10 1 -
Saati /888. A11endamento del Maggiore Generale Ca!(ni Campo di oHen·a:::imle Il Bngma. (Foto 'icoLra)
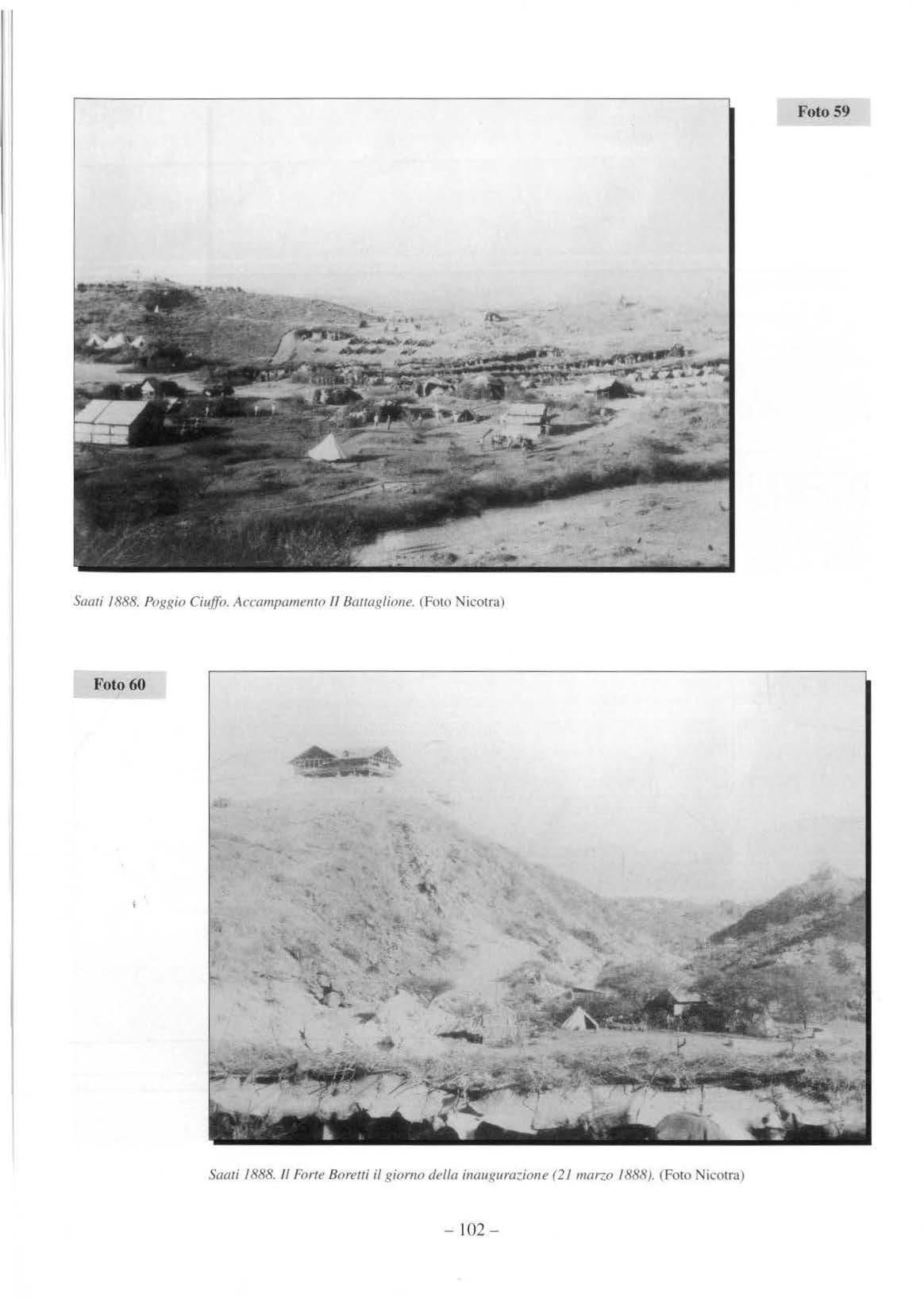
Foto 59
Saati 1888. Poggio Ciuffo. Accampameli/o Il Bauaglione. (Fol<l Nicotra)
Foto 60
- 102 -
Saati /888. Il Forte Bore/li il giorno della inau!(ura:ione (2/mm<.o 1888). (Foto Nicotra)
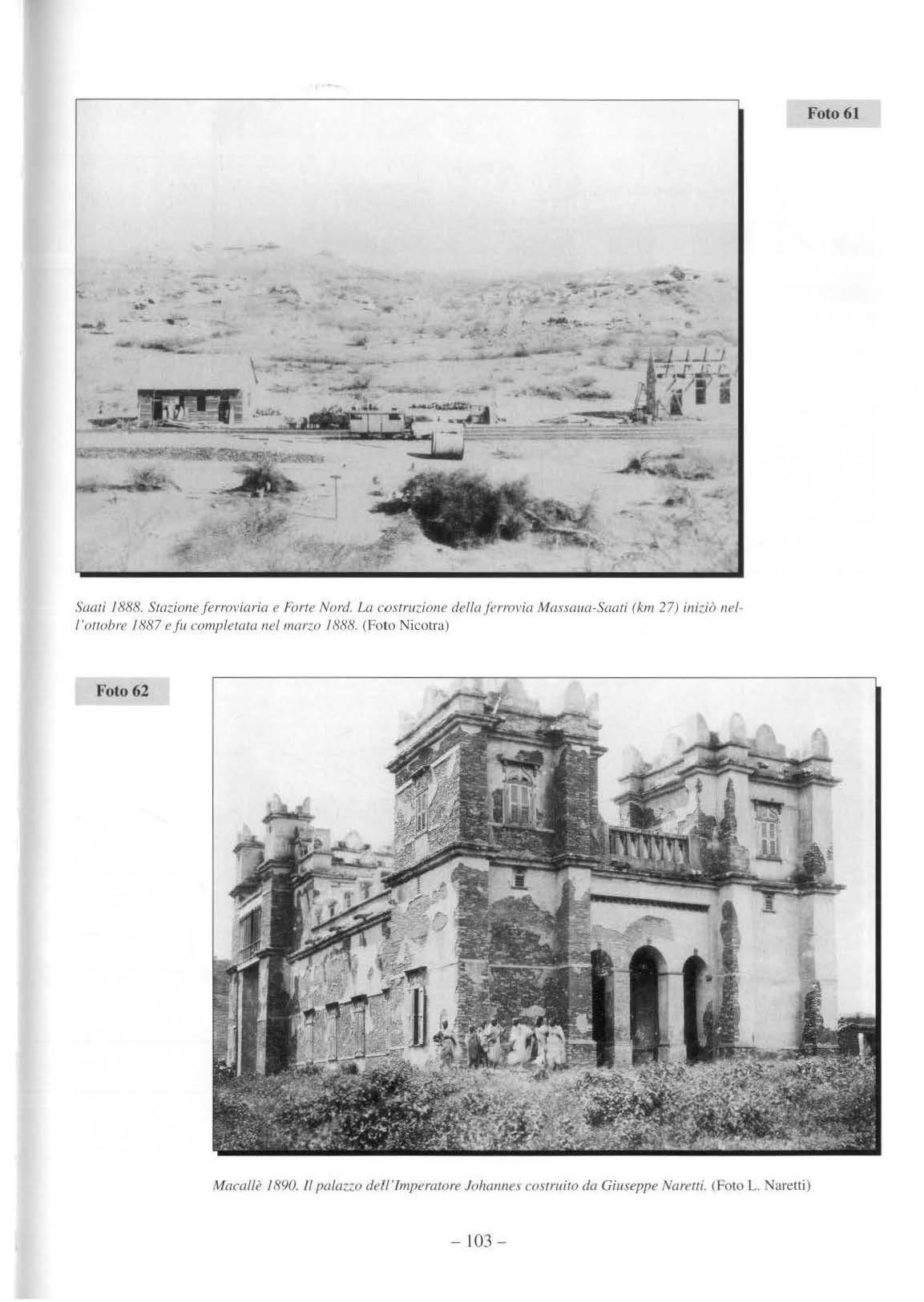 Saati 1888. ferrm·iaria e Forte Nord. La costrtdone della frnm •ia Mas 1·aua-Sami (km 27) ini:ià nell 'o11obre l 887 r fu completata ne/marzo /888. (Fo t o N icotra)
Saati 1888. ferrm·iaria e Forte Nord. La costrtdone della frnm •ia Mas 1·aua-Sami (km 27) ini:ià nell 'o11obre l 887 r fu completata ne/marzo /888. (Fo t o N icotra)
61
Foto 62
Foto
- 103-
Macallè !890. lf pala<.:.o deli' Jmperawre Jolumne.\ coJtruito da Giuseppe Nare11i. (Foto L. Naretti)
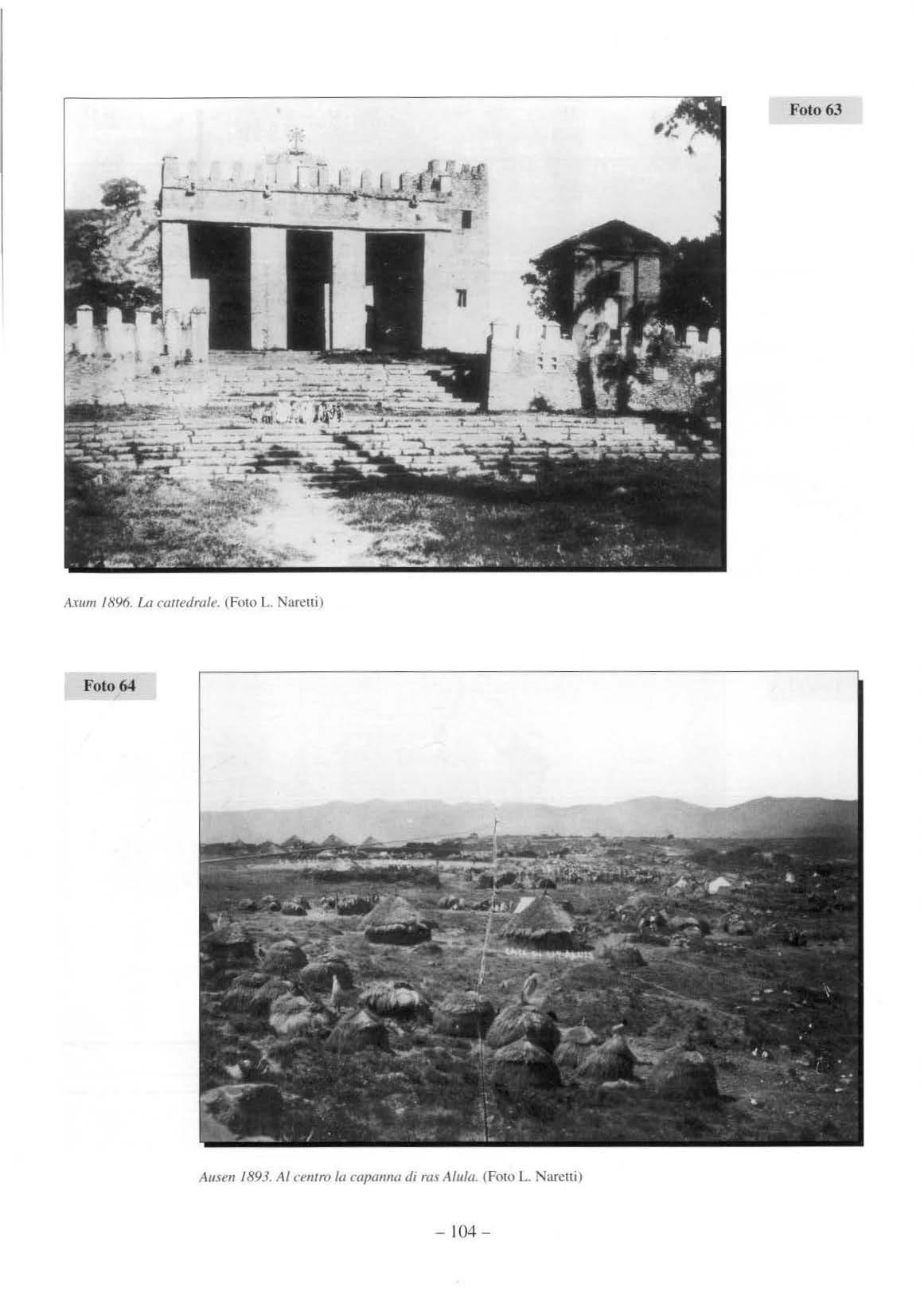
Foto 63
Anun 1896 /.a cauedrale. (Foto L. Nareni)
Foto 64
- 104 -
Ausen 1893 Al centro la capanna di m 1 Alula. (Foto L. Narctti)

65
Foto
A ddi Caiè 1890. Rol'ine del/" antica Co/oè. wtraltipiano di Colraiw (Fo to L. aretti)
Foto 66
- 105 -
Ghinda 1889. Panomma. (Foto L. areni)
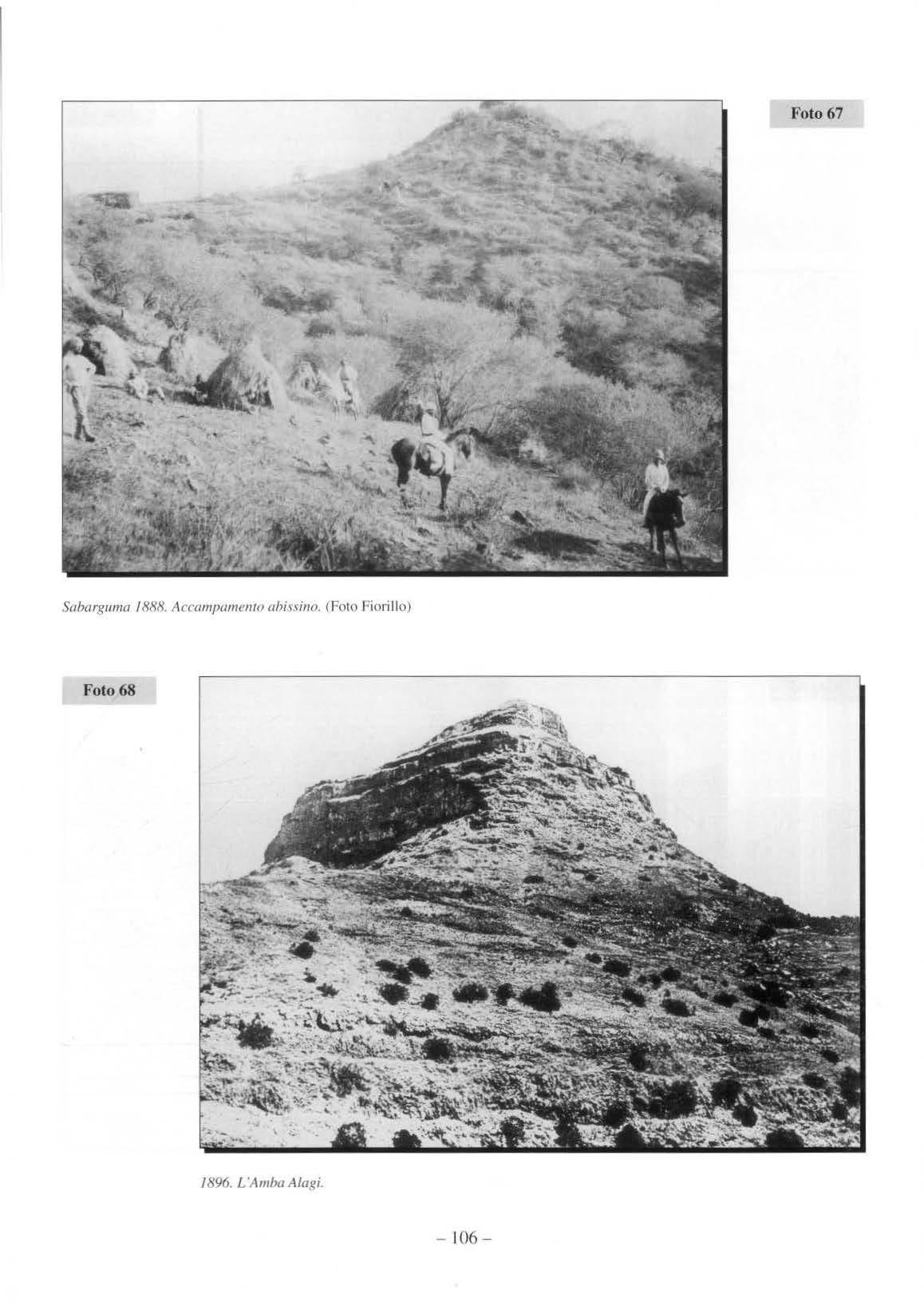
Foto 67
Foto 68
Sabargwna flUiR. ilccampwnento ahiuino. (Polo Fiorillo)
- 106-
1896. L'ilmbaAlagi.
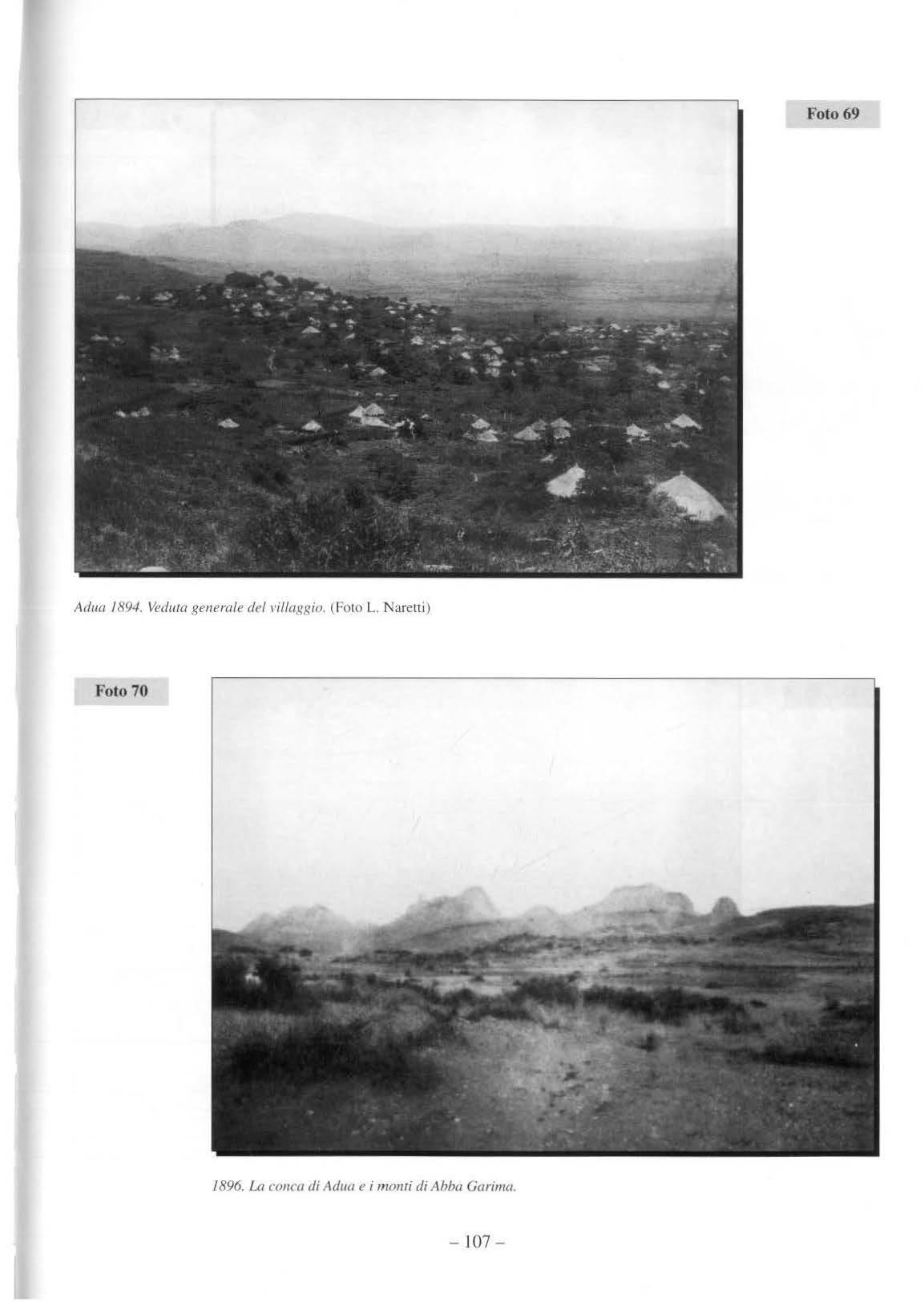
Foto 69
Adua 1894. Veduta generale del l'il/aggio. (roto L. Nareni)
70
Foto
- 107-
l 896. La conca di Adua e i monti di Abba Garima.
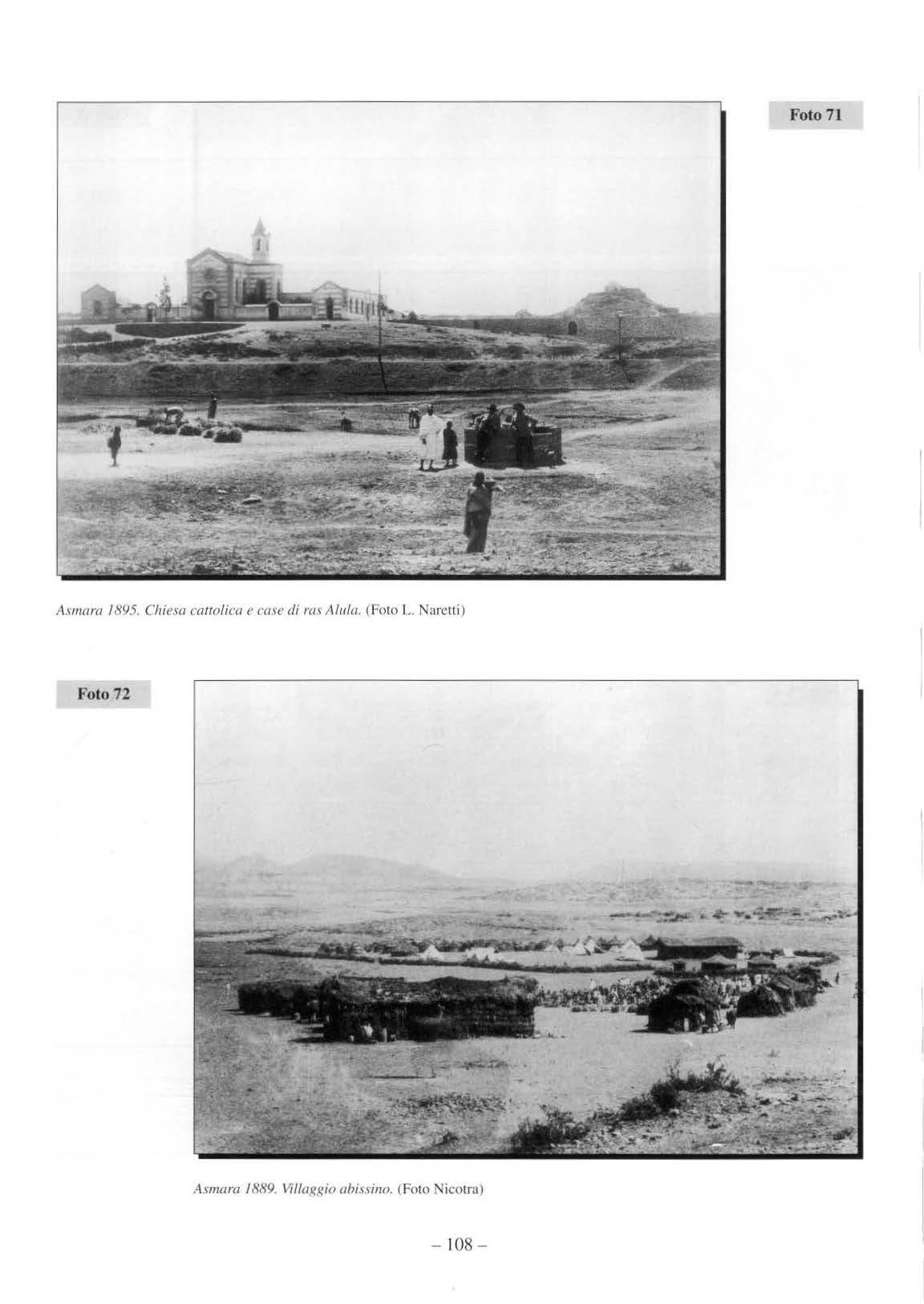
Foto 71
Asmara /895. Chiesa carrolica e mse di ras A/11/a. (Foto L. Narctti)
72
Foto
- 108 -
A.mwra /889 VìllagJ?io abi.1si11o. (Foto Nicotra)
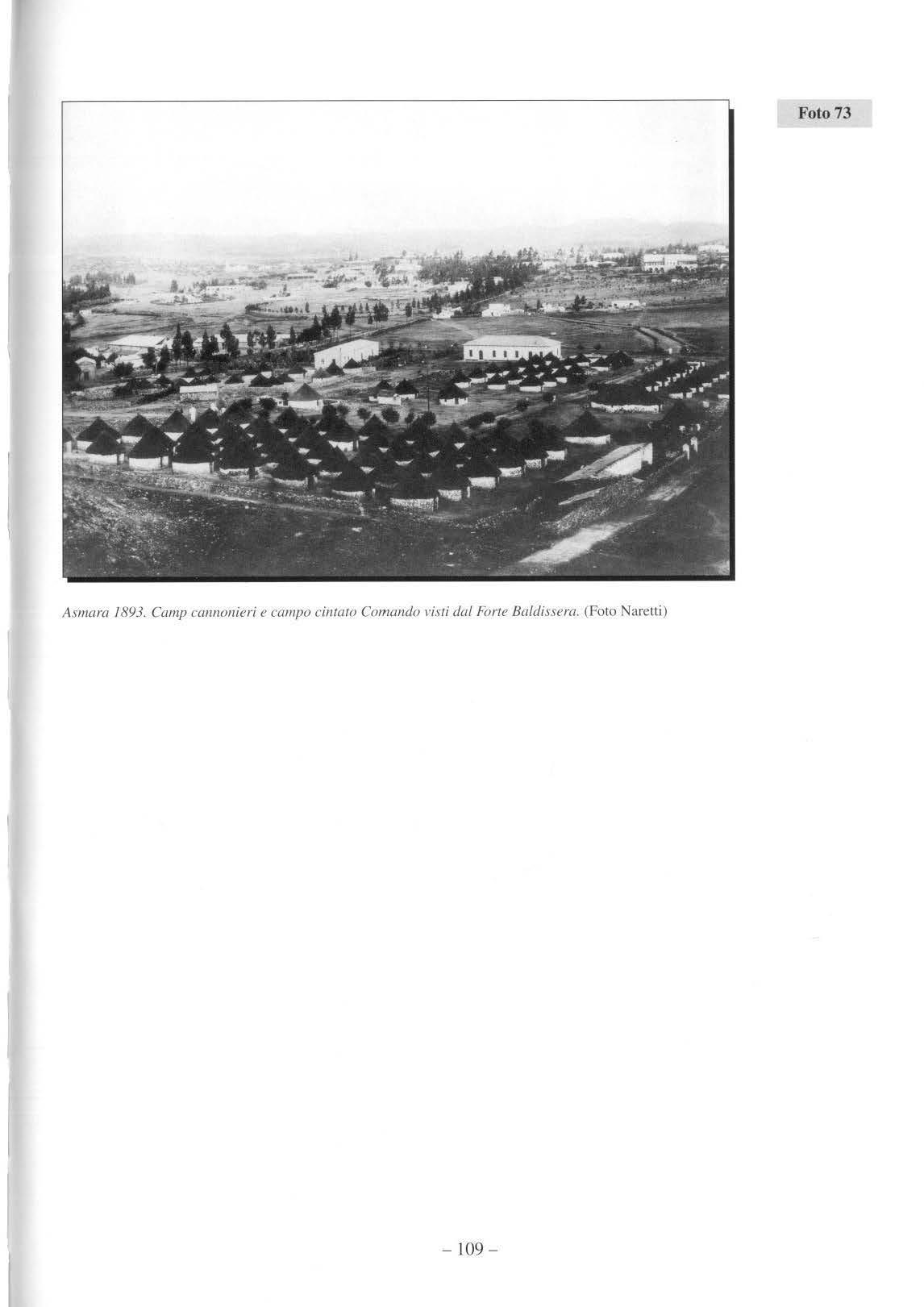
Foto 73
- 109 -
Asmara / 893. Camp cmuwnieri e campo cintato Comando 1'isri dal f ò rt e Bafdissera. (Fo to Na retti)

LE TRUPPE NAZIONALI
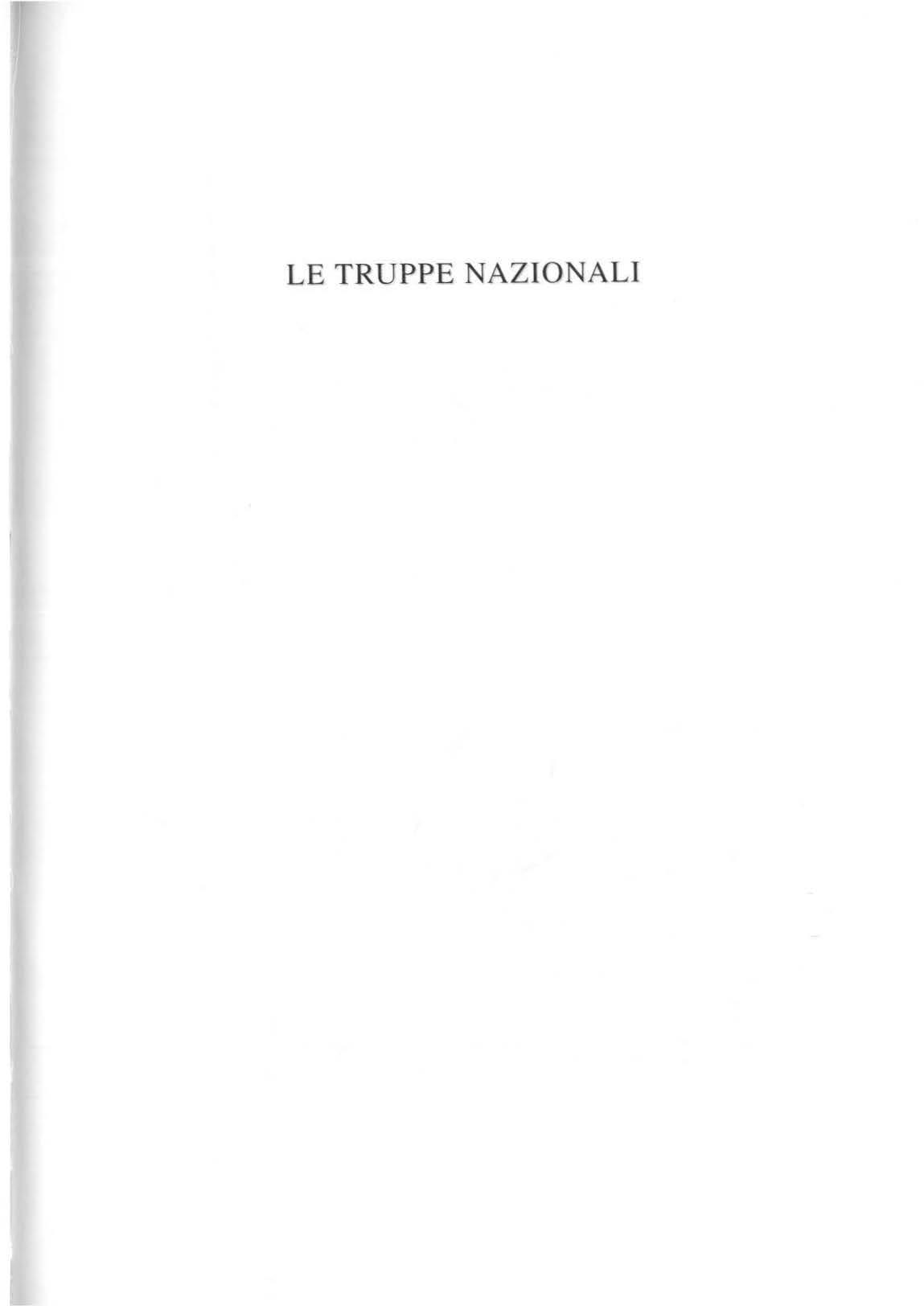
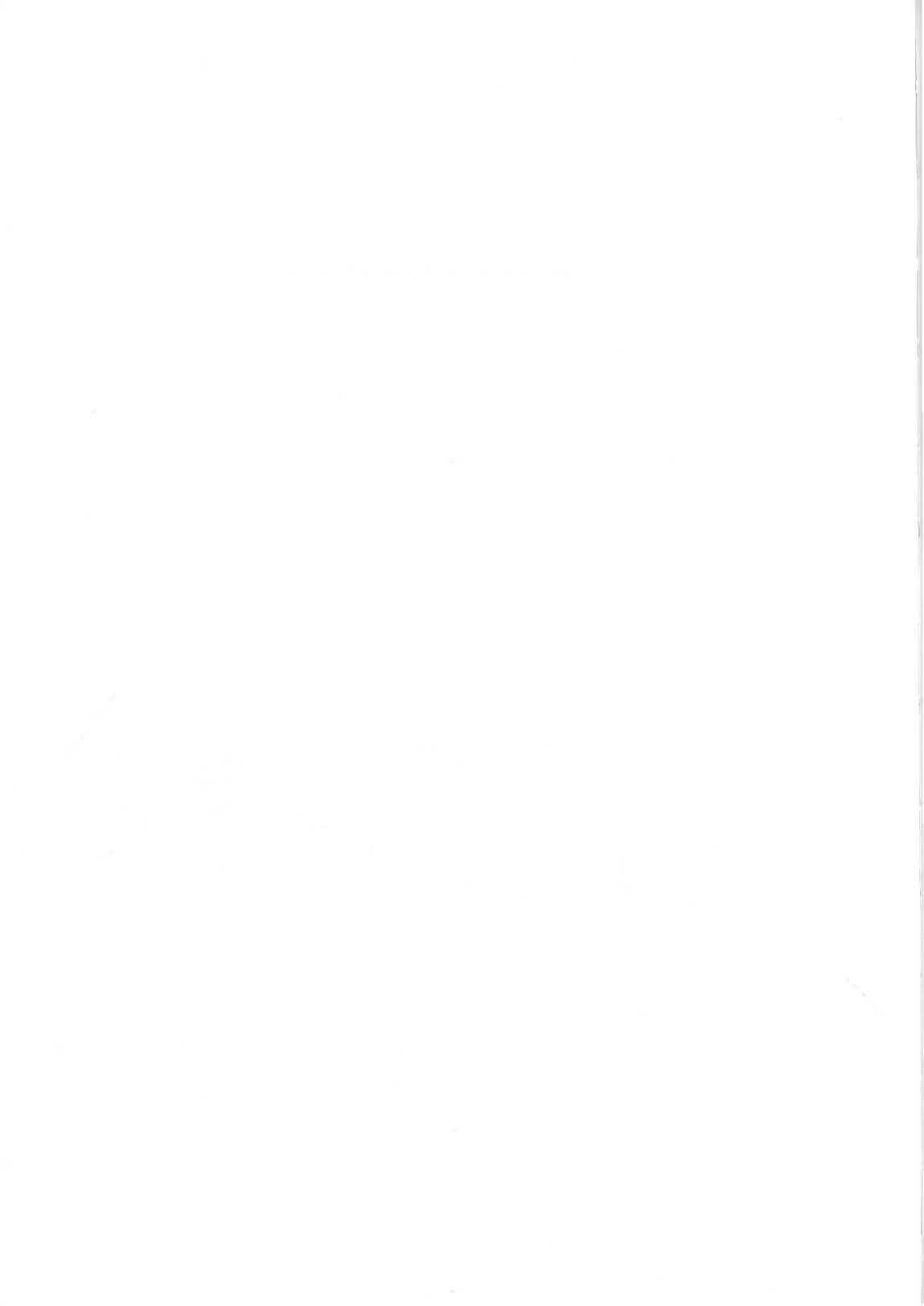
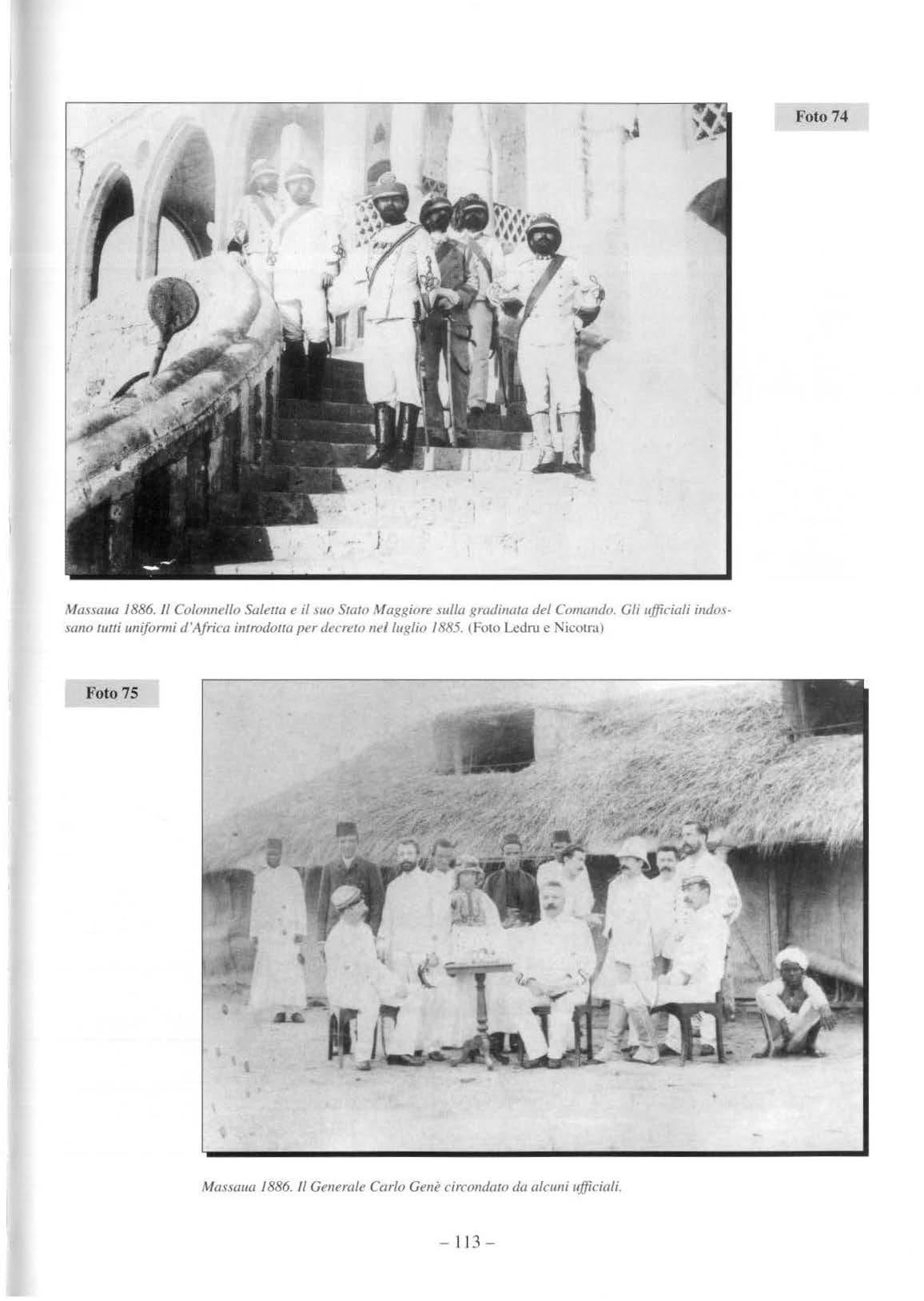 Massmta 1886. Il Colonnello Saletta e illuO Stato sulla gradinma del Comando. Gli ufficiali illliO.\· :.ano tutti uniformi d'Africa introdotta per decreto nel luglio 1885. (Foto Ledru e Nicotra)
Foto 75
Massmta 1886. Il Colonnello Saletta e illuO Stato sulla gradinma del Comando. Gli ufficiali illliO.\· :.ano tutti uniformi d'Africa introdotta per decreto nel luglio 1885. (Foto Ledru e Nicotra)
Foto 75
- 11 3-
74
Mas.mua 1886. Il Generale Carlo Genè circondato da alcuni ufficiali.
Foto
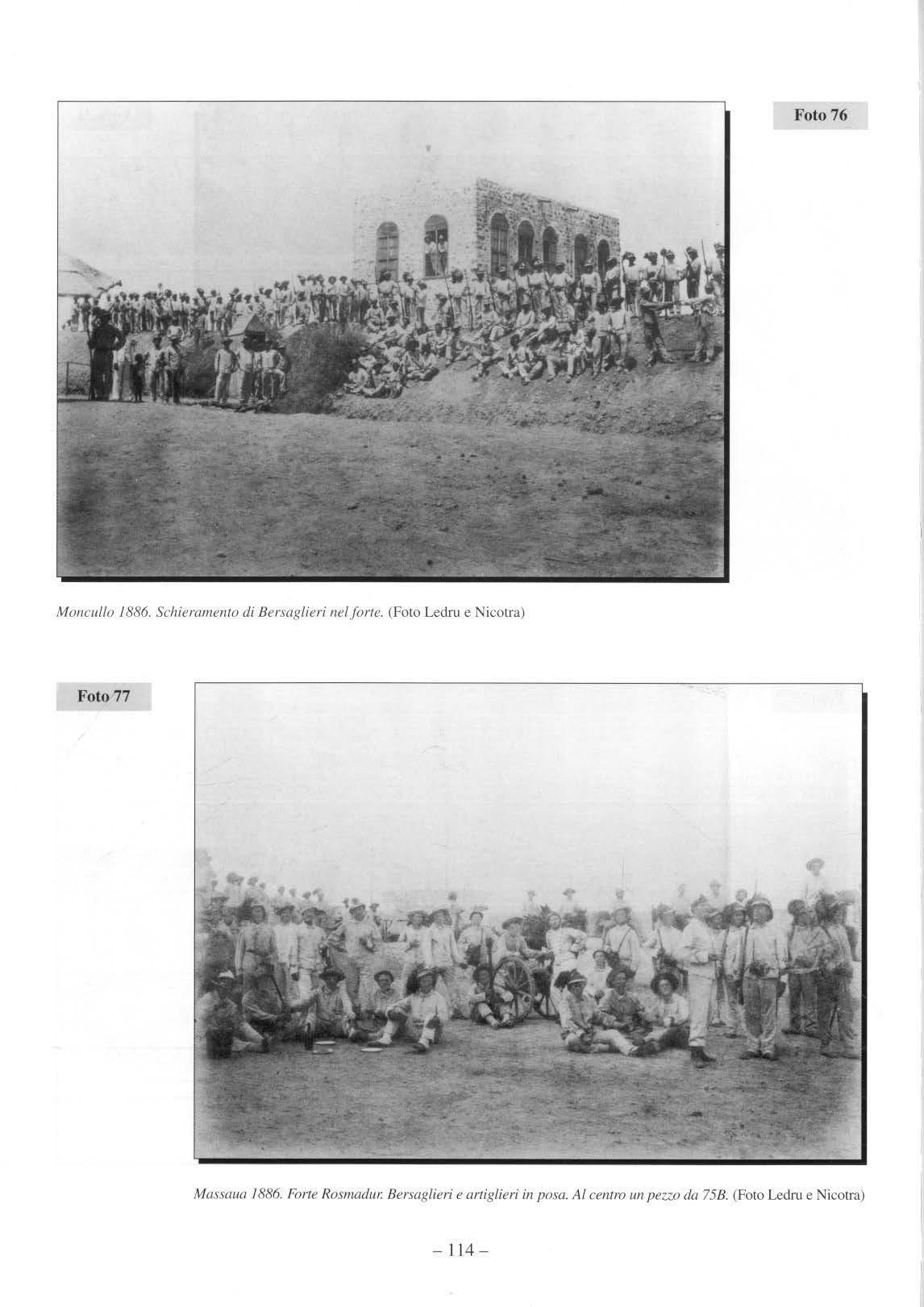
Foto 76
Moncul/o 1886. Schieramento di Bersaglieri nel forte. (Foto Ledru e NicOLra)
Foto 77
- 114 -
Massaua 1886. Forte Rosmadur. Bersaglieri e artiglieri in posa Al cemro 1111 pezzo da 758 (Foto Ledm e Nicotra)
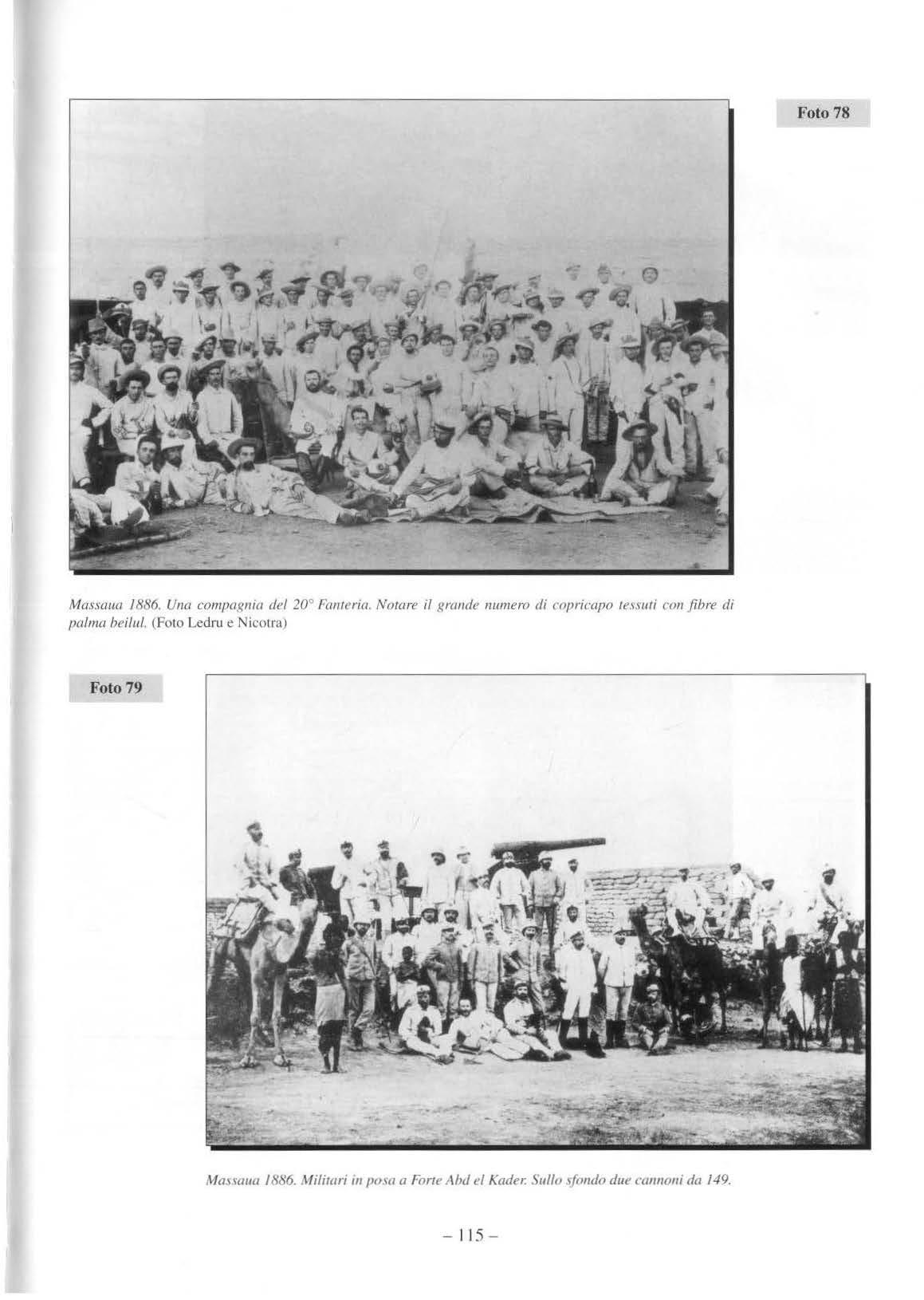 Massaua 1886. Una compagnia del 20° Fanreria. Notare il f{rllfl(/e numero di copricapo re.\suri ton fibre di palma lJeilul. (Fo to Lcdru e Nicotra)
Foto 79
Massaua 1886. Una compagnia del 20° Fanreria. Notare il f{rllfl(/e numero di copricapo re.\suri ton fibre di palma lJeilul. (Fo to Lcdru e Nicotra)
Foto 79
- 115 -
Mas.fww 1886. Miliwri in fWSa a Forre Abd el Kader. Sul/u 1/011do due cwmoni da 149.
78
Foto
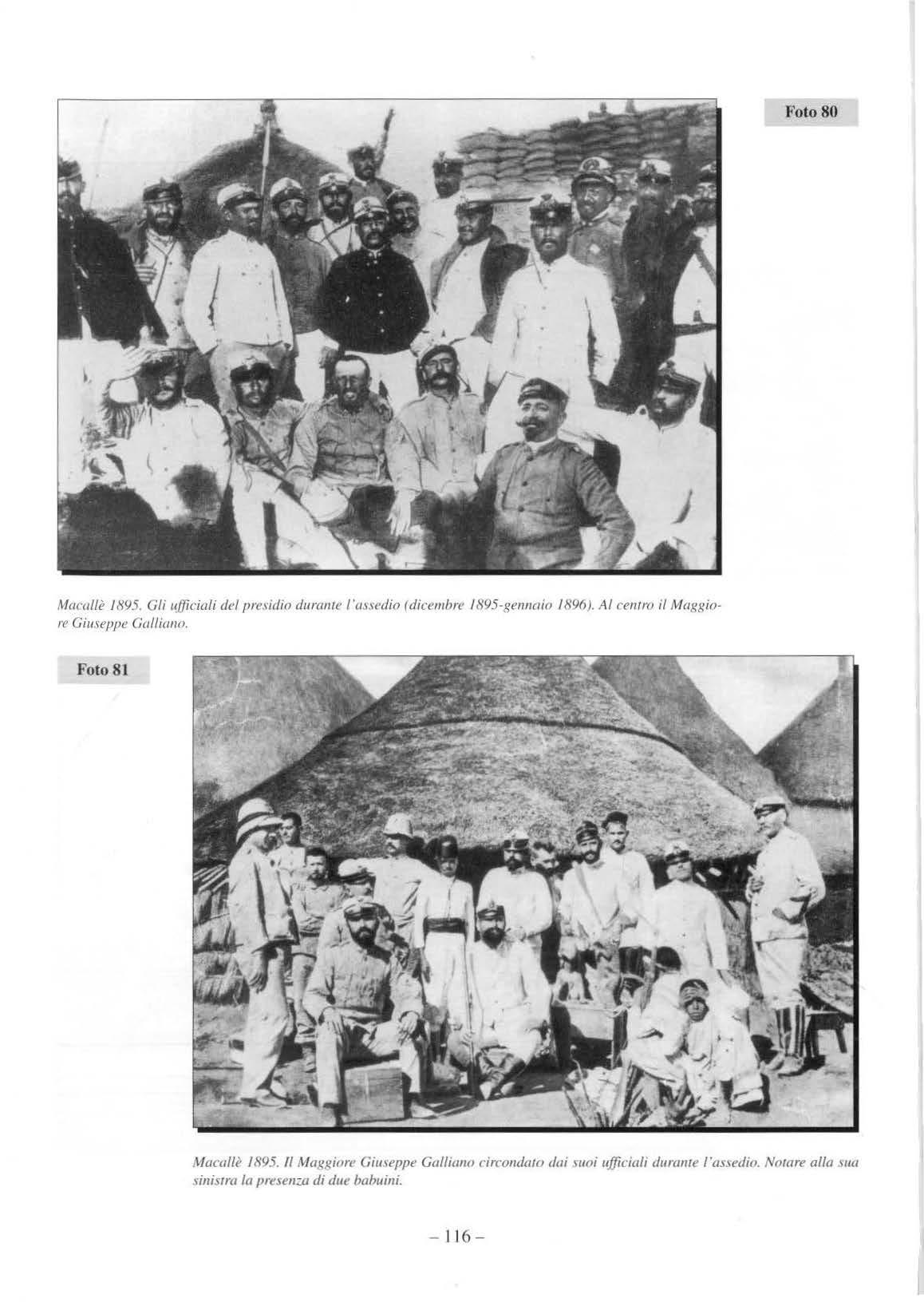 Macallè 1895 Gli t(ffrciali del presidio durante (dicembre /895-gennaio 1896). Al rentro il Maggiore Giuseppe Gttlliono.
Macallè 1895 Gli t(ffrciali del presidio durante (dicembre /895-gennaio 1896). Al rentro il Maggiore Giuseppe Gttlliono.
Foto 80
Foto 81
- 11 6-
Macallè 1895. Il Maggiore Giuseppe Calliano rircondaro dai woi ufficiali durame /"assedio. Notare alla sua sinistra la presen:a di due babuini.
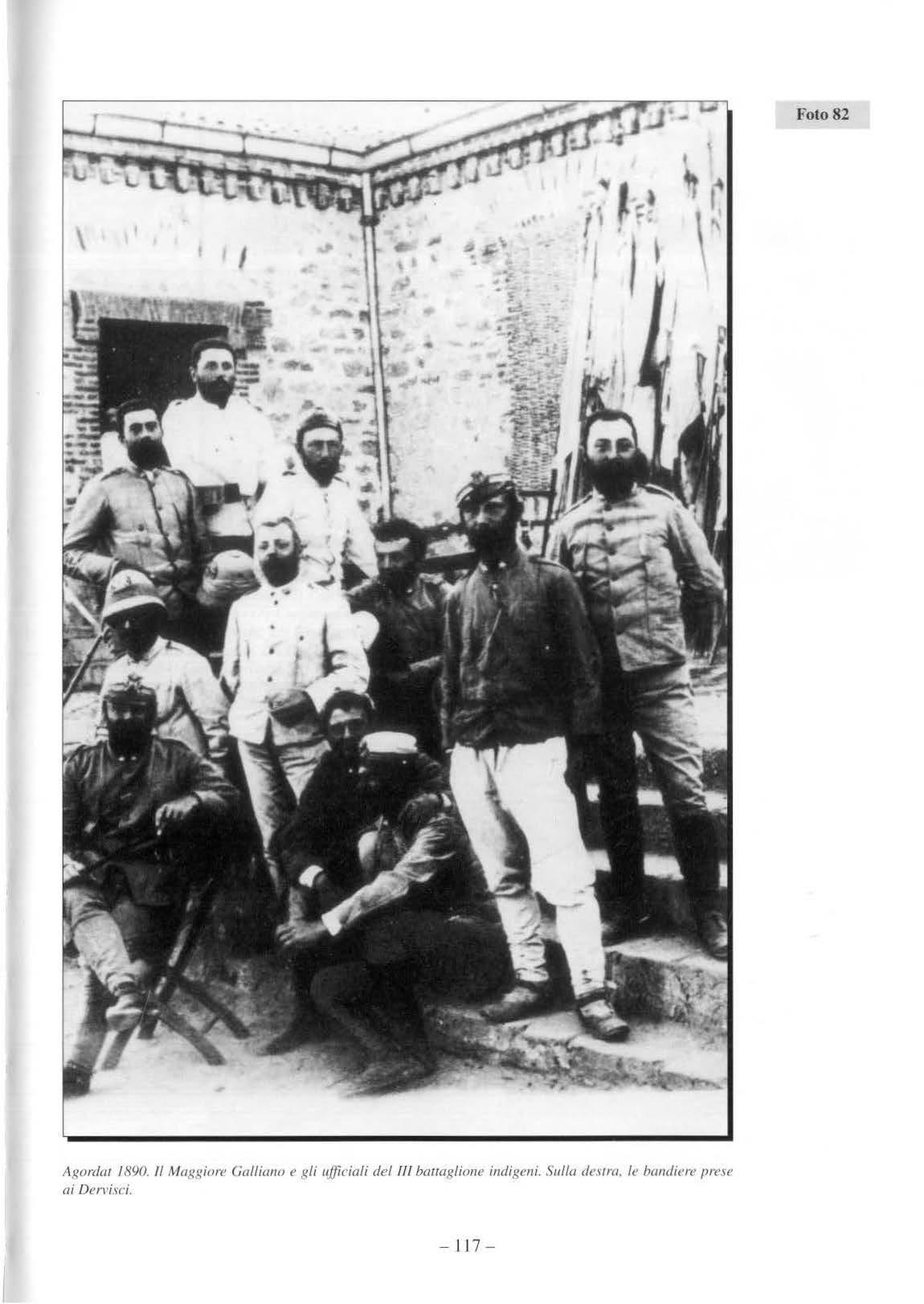
-J J7Foto 82
Agordal /890. Il Maggiore Calliano e gli ufficiali del 111 battaglione indigeni. Sulla de.11ra. le bandiere prese ai Den •isri.
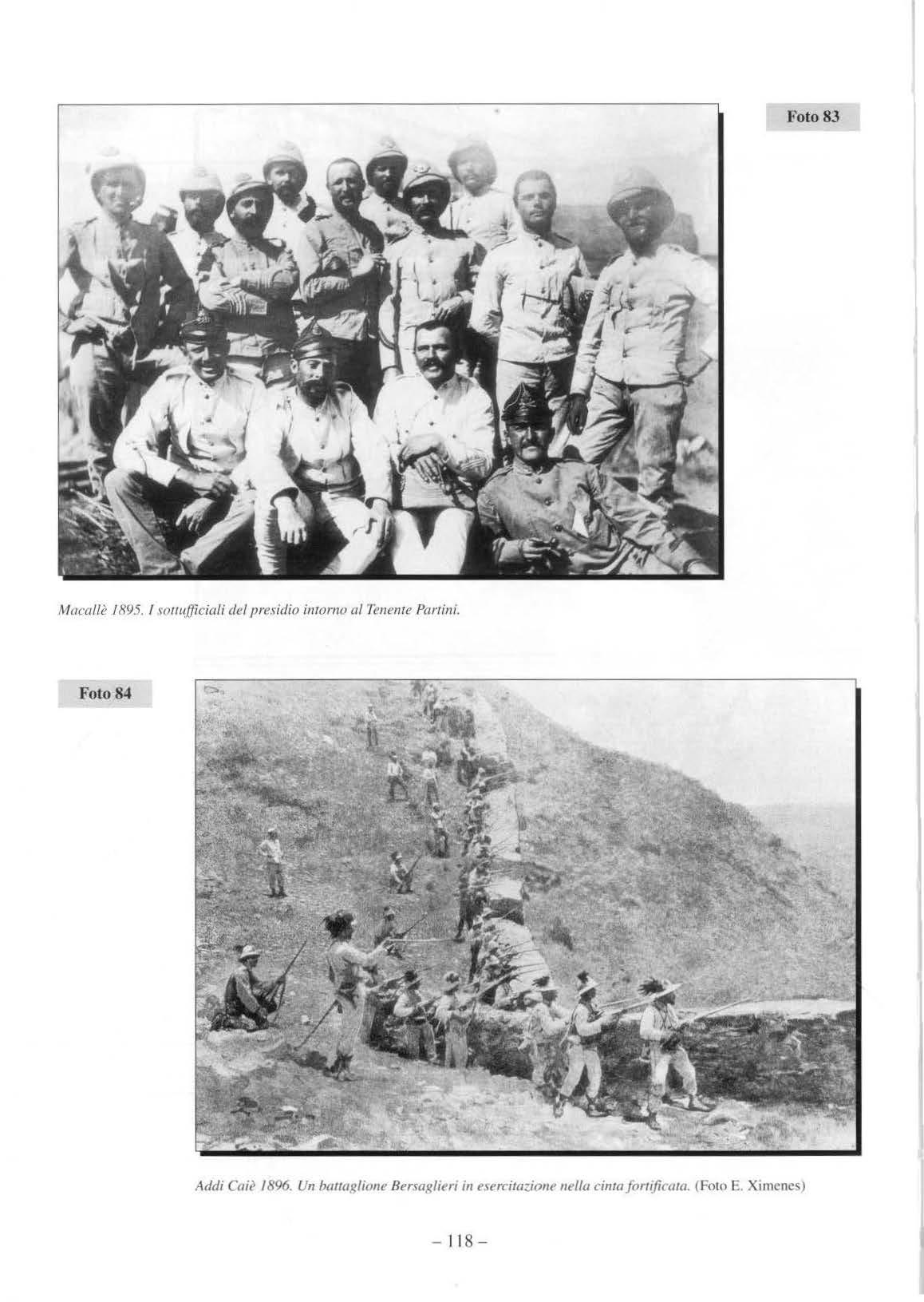
83
Foto
Macallè !895. l Wlltifjìciali del presidio in tomo al Tenenre Panini.
Foto 84
- 11 8-
Addi Caiè 1896. Un battaglione Bersagliert in eJercita::.iont• nella cintafort(fìcata. ( Foto E. Ximcncs)
Cassala /894. Gli ufficiali che pm,ero parte allo .\contro: l) Te11. Gerwula. 2) Cap. Acerbi, 3) Ten. M ed. Gerbaldi, 4) Ten. Baratieri di S. Piero. 5) Te11. Vecchio, 6) Sorroten. Ferrari. 7) Te11. Cesarini. 8) Cap. MaRIIOf(hi, 9) Cap. flarhanti, 10) Cap Artall', l/) Cap. Severi, 12) Ten. Lori. /3) Magg. Turitto. 14) Cap. Peri11i. 15) Ten. Ucl'elli, 16) Ten. Mercurelli. 17 ) Cap. Martinelli. l 8) Ten. Rigu z:i. 19) Cap. Salsa. 20) Ten. Matj[redini. 21) Gen. tlrimondi. 221 Cap. F'vlchi. 23) Ten. Speck. 24) Gen. Baratieri 251 'len. F11.1e. 26) Ten Med. Me:;::ett i. 27) Ten. Bramanti. 28) Ten. Vara/e. 29) Ten. Bunora. 30) Ten. Angherà. 31) Ten. Pal'(mi, 32) Ten. Della Cllir.1a, 33 J Cap. 0(/done, 3.J) Cap. Casrella:;::i, 35) Ten. flenincasa, 36) Te11. Vet. Pierucci. 37) Te11. Locasali, 38) T<•n. Solioni, 39) Magg. Hidalgo. 40) Ten. Mitmi .Jl) Ten. Floccardi, 42) Te11. De Dominicis. 43) Cap. Sandrini. -U) Cap. Spreafico. 45) Ten. Giardino .J6) Te11. \'pcc/Ii.
Foto 86

85
Foto
- 11 9 -
Saari 1888. La 1e:ione topof(rafica de/3 ° BersaRiieri al comando del Capitano Un·alll!a. (Foto Fiorillo)
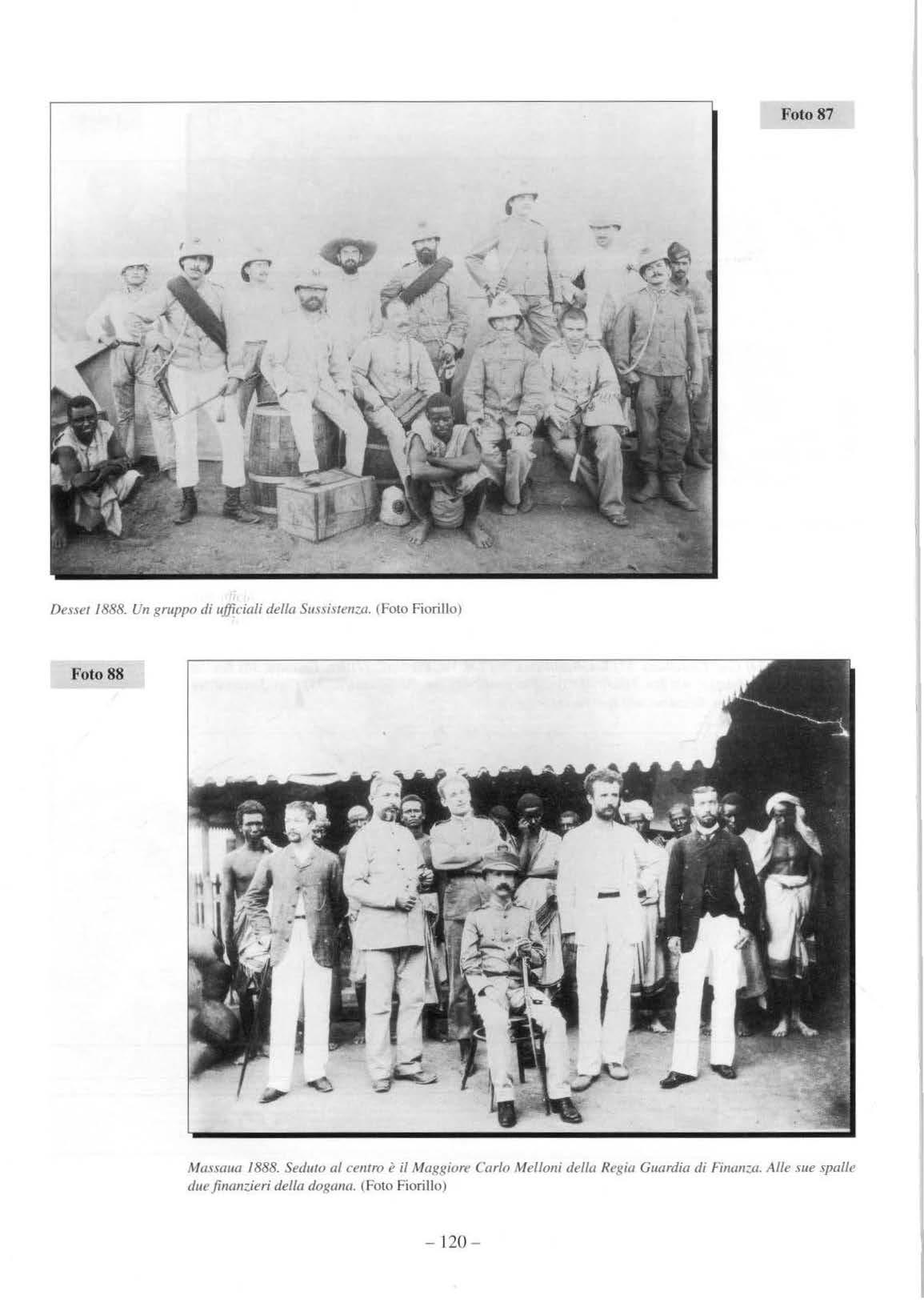
Foto 87
/888. Un gruppo di ufficiali della Sus:.ilten:.a. (Foto Fiorillo)
Foto 88
- 120 -
Ma.uaua 1888. Seduto al centro è il Maggiore Carlo Me/Ioni della Regia Guardia di Fimm:;a. Alle sue spalle due finanzieri della dogana. (Foto Fiori Ilo)
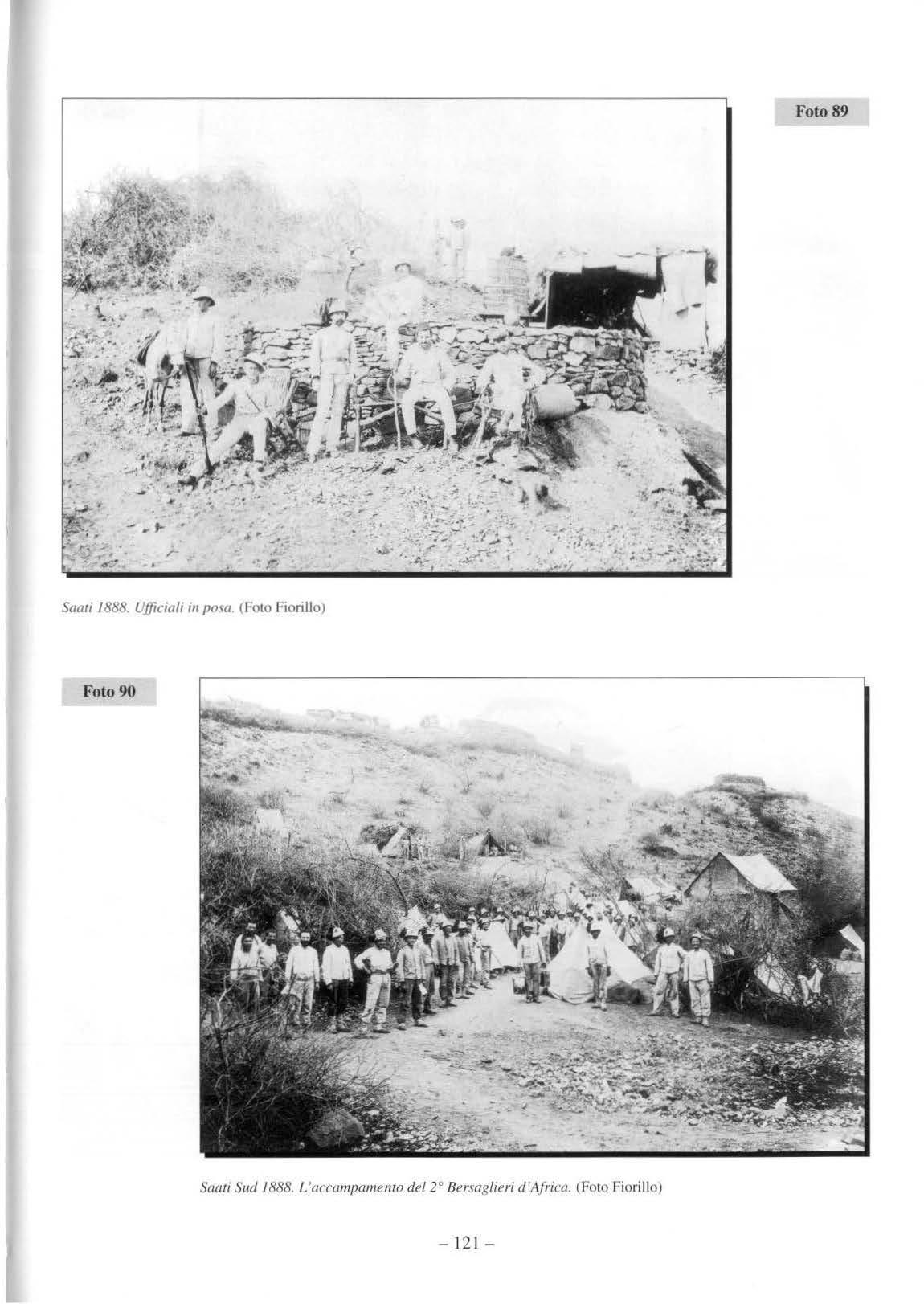
Foto89
90
Saati /888. Ufficiali in pom. (Foto Fiorillo)
Foto
- 12 1 -
Scwti Sud 1888. L'accampamento del 2° Bersaglieri d'Africa. (Foto Fioril l o)
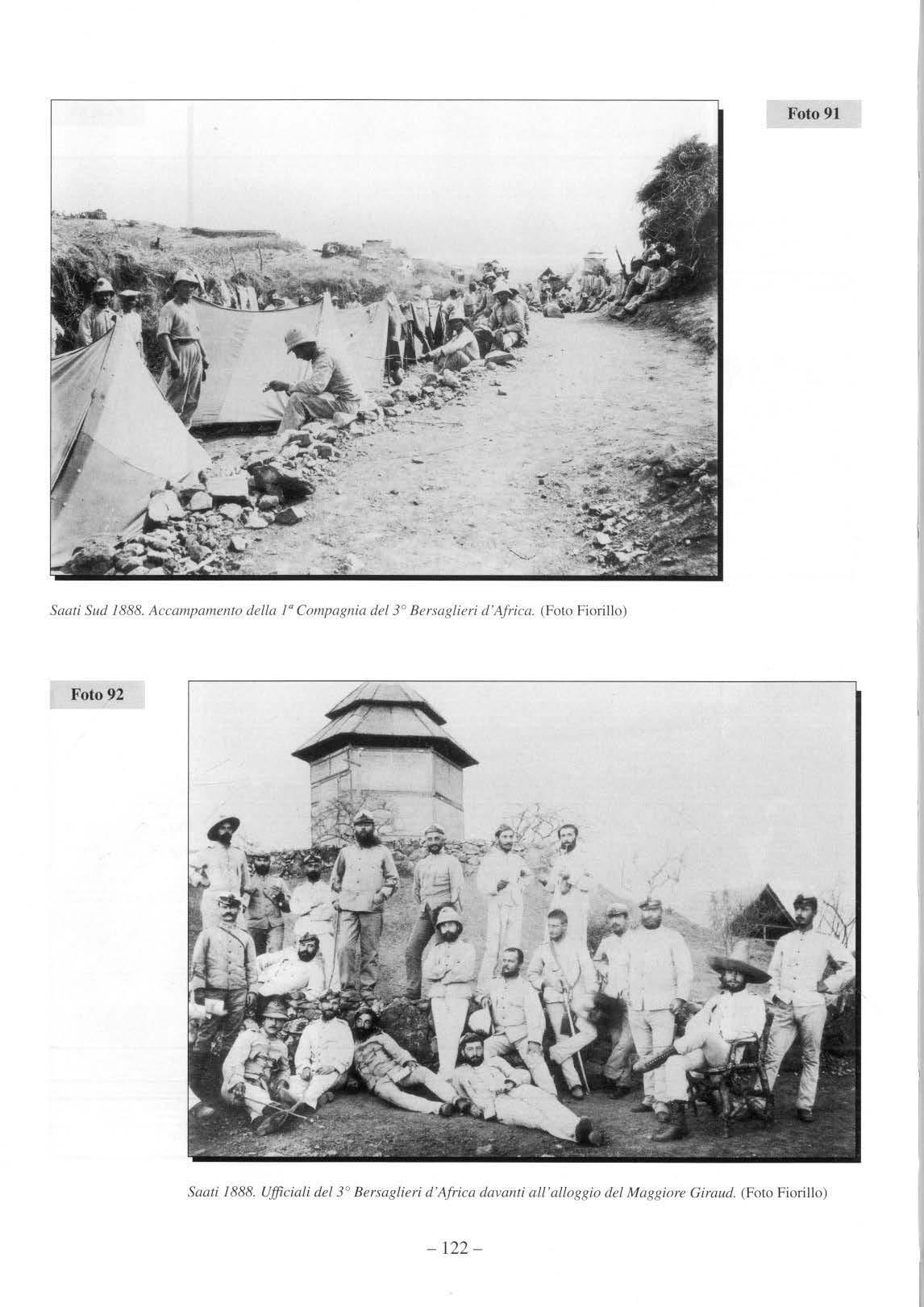
Foto91
Saari Sud 1888. Accampamento della JU Compagnia de/3 ° Bersaglieri d'Africa. (Foto Fiori Ilo)
Foto
92
-122 -
Saati 1888. Ufficiali del 3 ° Bersaglieri d'Africa davami all'alloggio del Maggiore Giraud. (Foto Fiori Ilo)
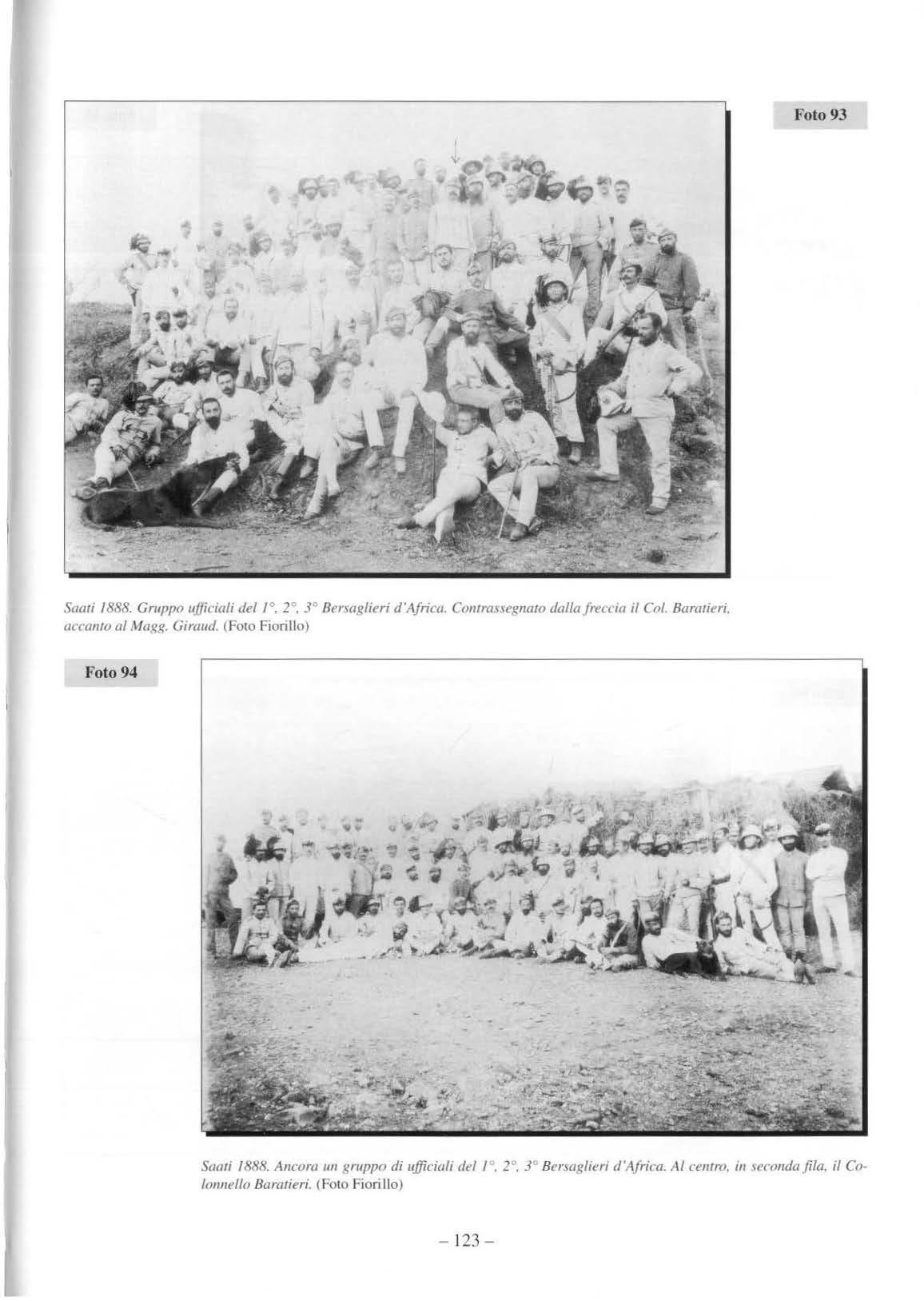 Saatì 1888. Gruppo ufficiali del ]0 zc . 3 Benaglieri d'Africa. Comra.1 segnato dalla .freccia il Col. Baratieri. accanto al Magg. Giraud. ( Foto Fiori !lo)
Saatì 1888. Gruppo ufficiali del ]0 zc . 3 Benaglieri d'Africa. Comra.1 segnato dalla .freccia il Col. Baratieri. accanto al Magg. Giraud. ( Foto Fiori !lo)
Foto 93
Foto 94
- 123-
Saati 1888. Ancora 1111 gruppo di ufficiali del l 2 ° 3 ° Ber.wglieri d'Africa. Al cemro, in remnda fila. il Colmmello Baratieri. (Foto Fiori Ilo)
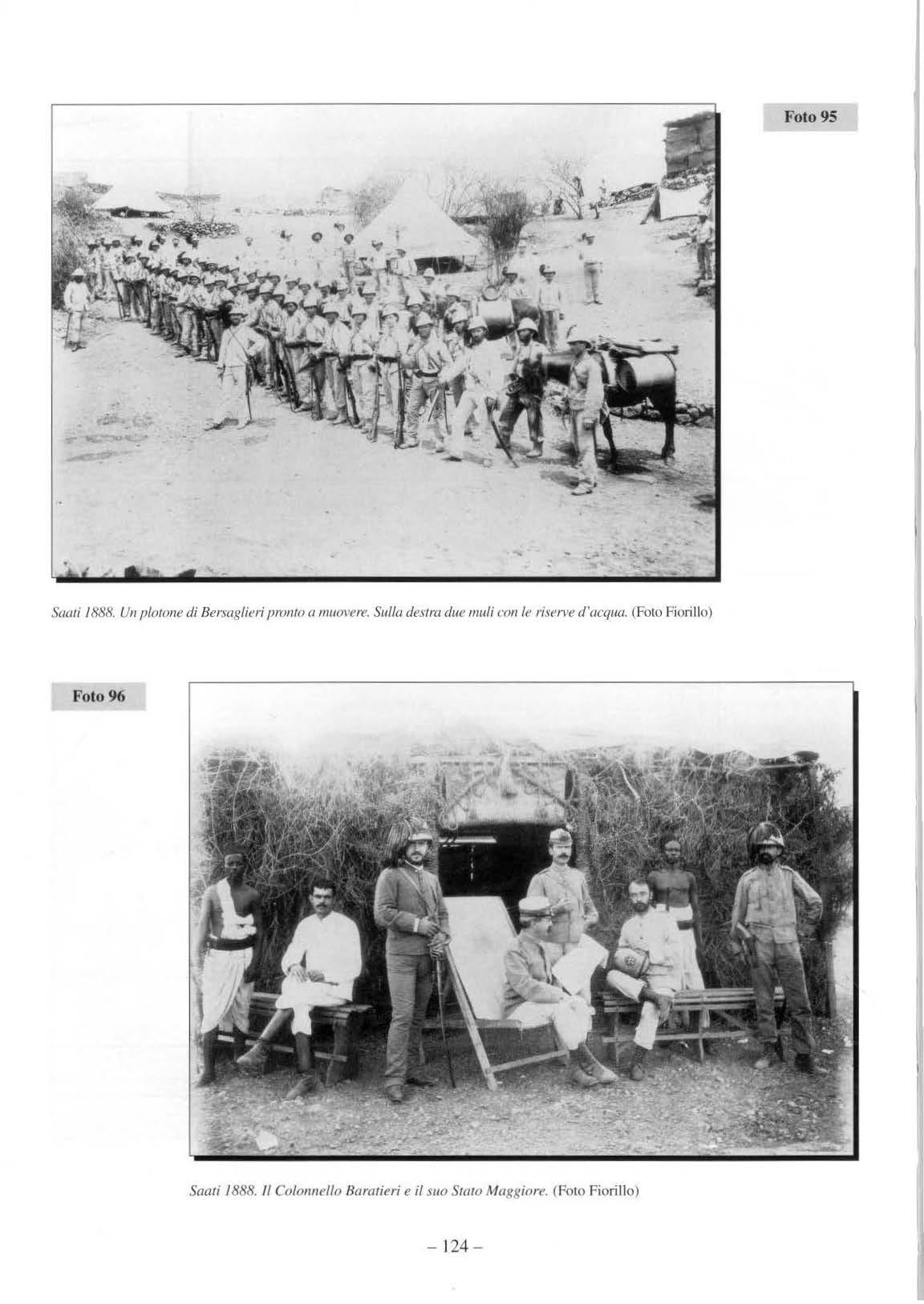
Foto 95
96
Saati 1888. Un plotone di Bersagliai pronto a muovere. Sulla destra due muli c·onle rise1w d'acqua. (Foto Piorillo) Foto
- 12 4 -
Saati 1888. Il Colonnello Bararieri e il suo Stato Maggiore (Foto Fiorillo)
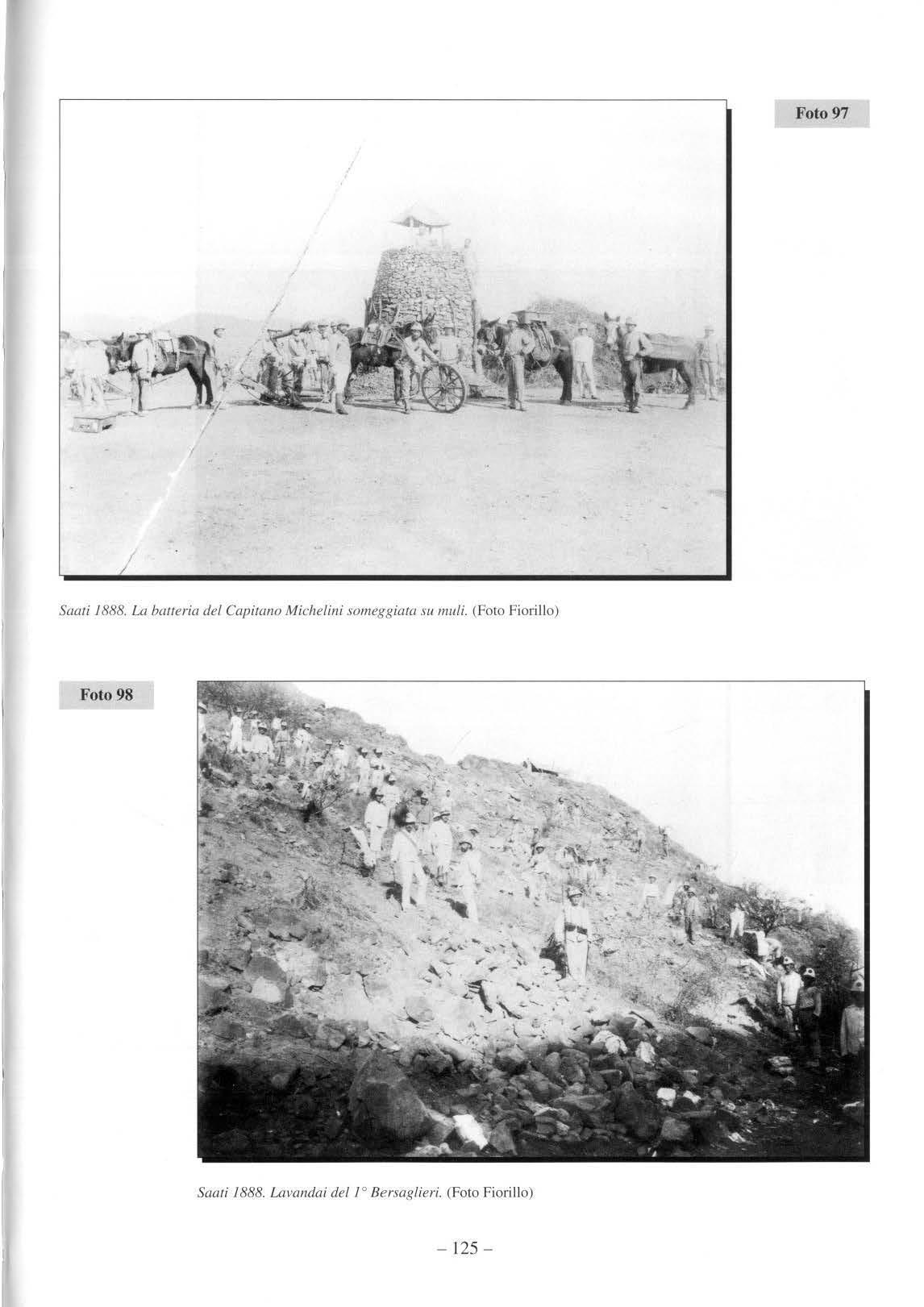
Foto 97
Saali 1888. La balteria de{ Capitano Michefini someggiala su mufi. (Foto Fiorillo)
Foto 98
- 125 -
Sawi 1888. Lavandai del r o Bersaglieri. (Foto Fiorillo)

Foto 99
- 126 -
Saari 1888. Una CUIVI' l/IW del Genio. (folo Fiorillo)
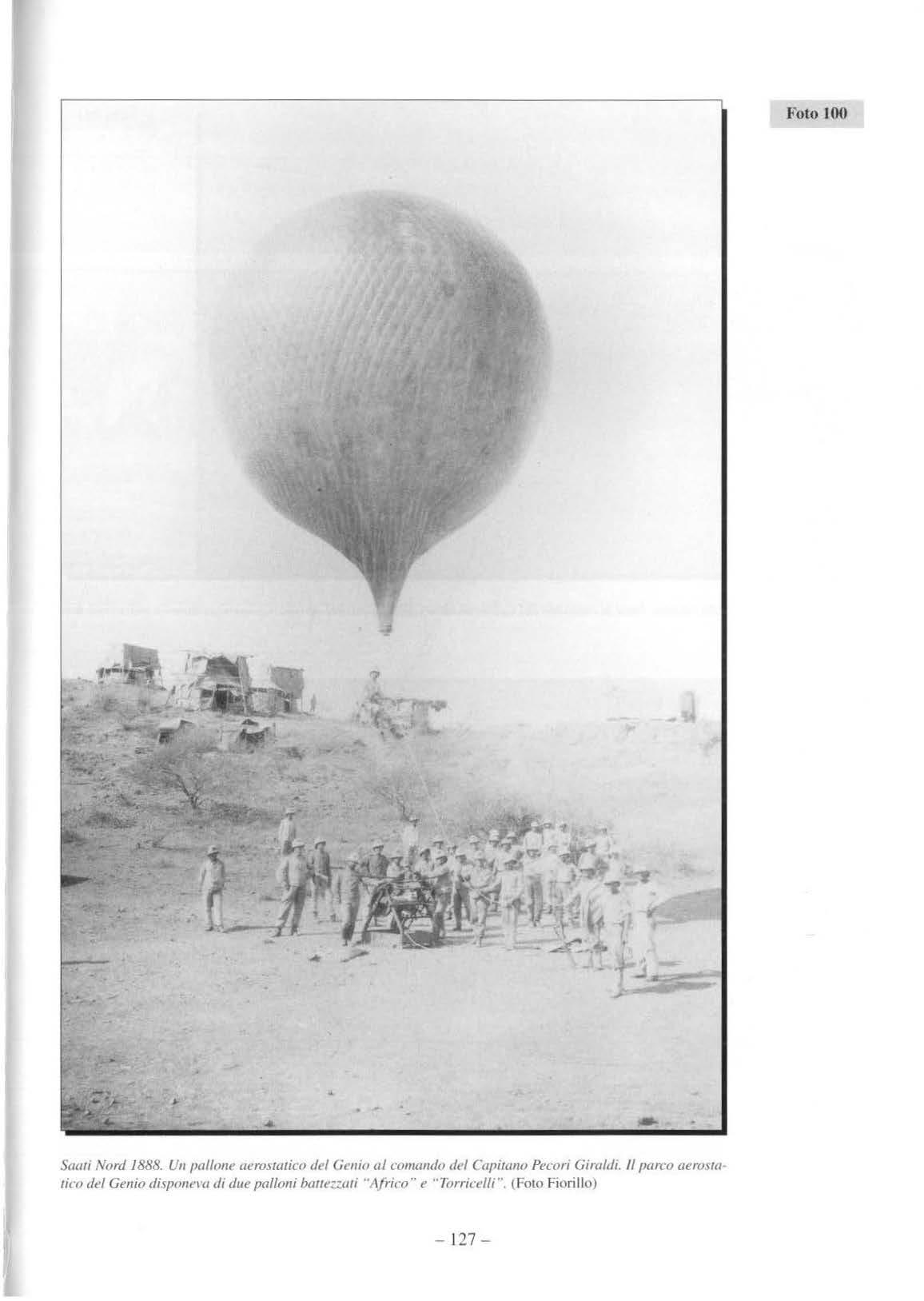
..
- 127Foto 100
Sami Nord 1888. Un pallone aerostatico del Genio al comando del Capiwno Pecori Gira/di. Il parco aeroswtico del Genio dispone1 •a di due palloni baue::mi "Aji'ico" e "Torrice/li". (Foto Fiorillo)
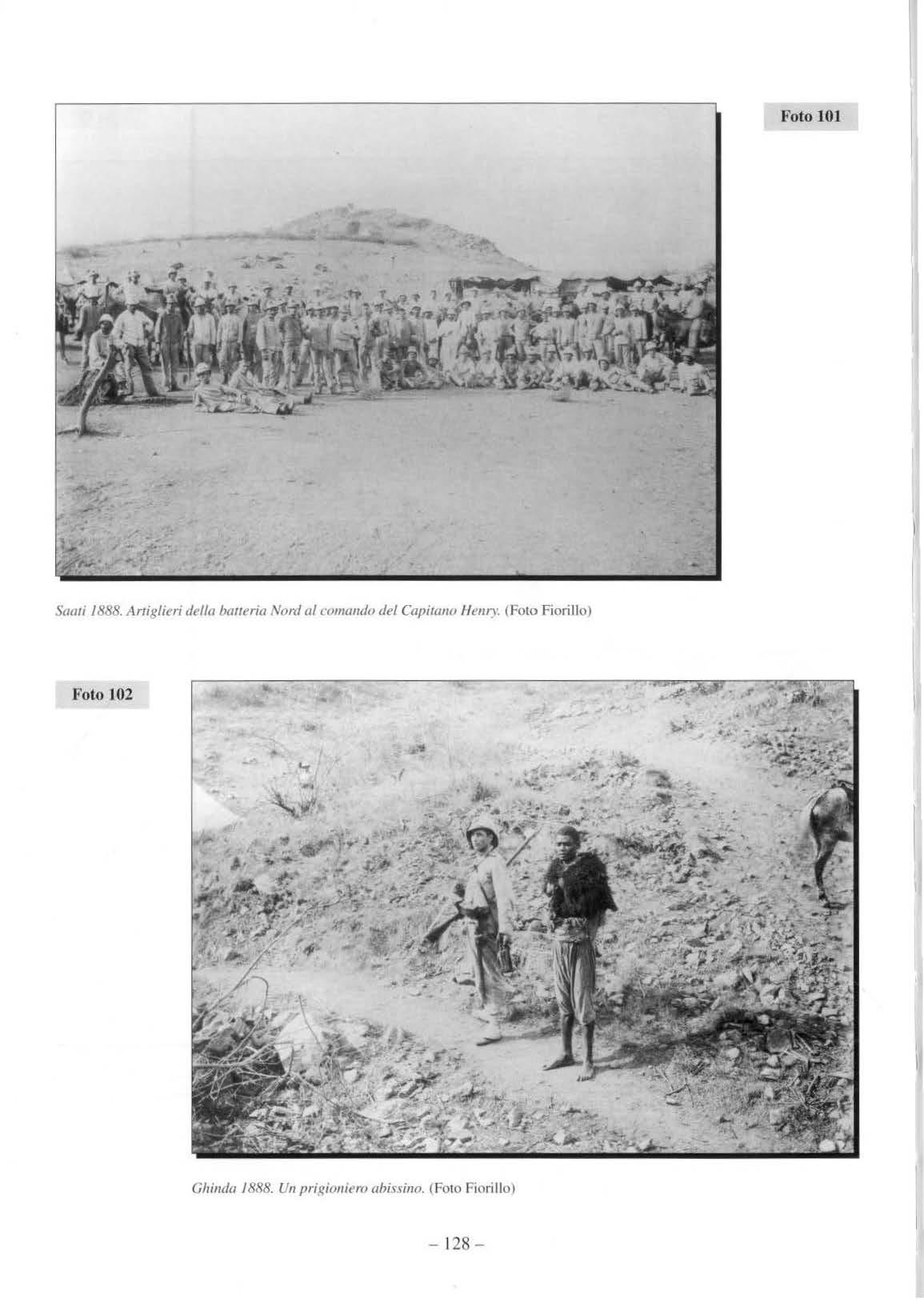
Foto 101
Saati /888. Artiglien della baueria Nord al comando del Capiwnu 1-/enrr. (Foto FioriUo)
102
Foto
- 128 -
Ghinda /888. Un priRioniero abissino. (Foto Fiori Ilo)
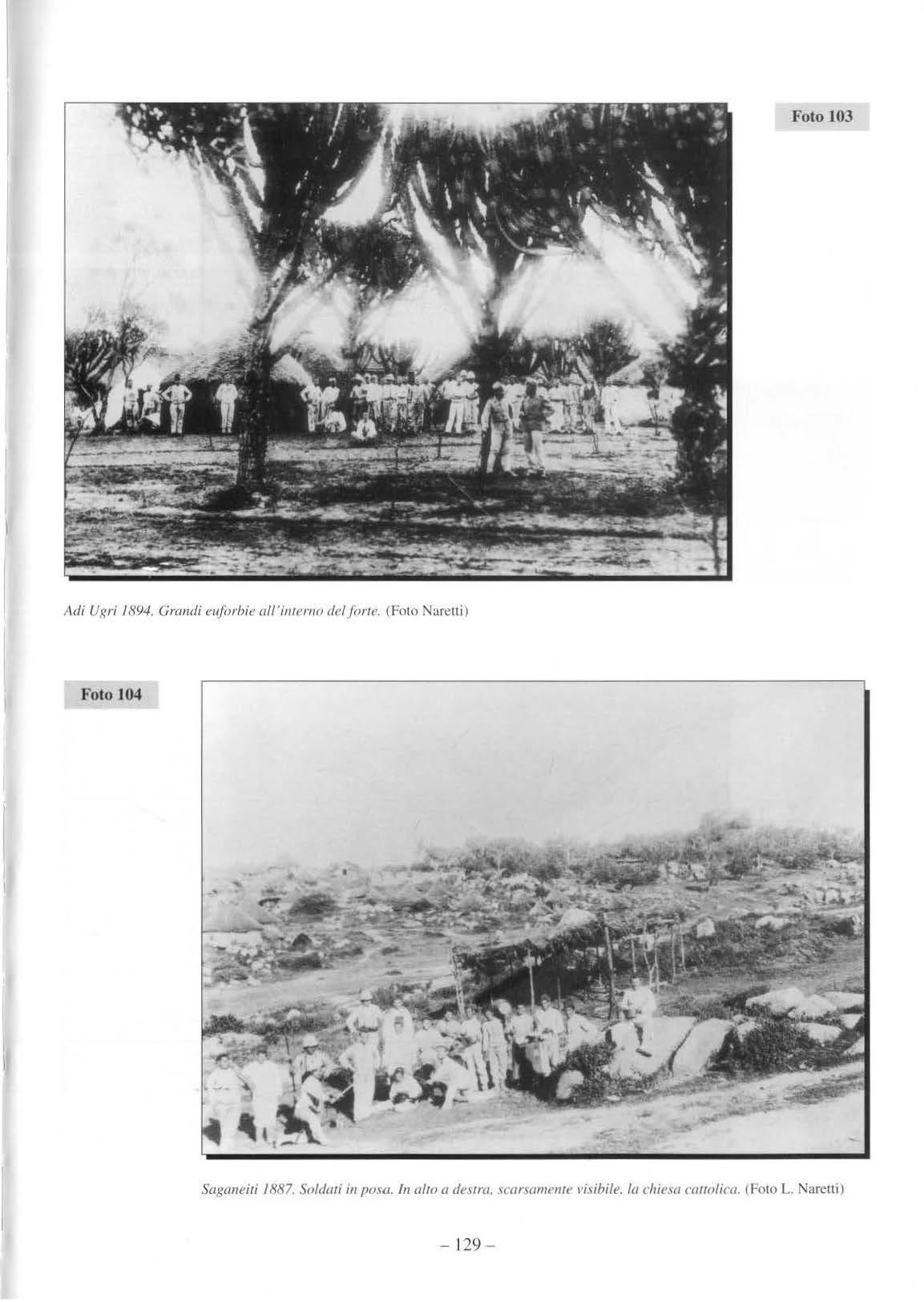
103
Foto
Adi Uxri 1894 Grandi euforbie tt!l'intemo del forre. (Fo to Naretti)
Foto 104
- 129 -
Saganeitì /887. Soldllfì in posa. In allO a destra \CllfW/Ile/1/1! I'ÌSìbile. la chiem ('(/1/(l/im. (roto L. N areni)

Foto 105 ..
Ai/et 1887. 1-a Il Rrigata Cagni in ricogndone. (Foto N icotra)
.Foto 106
- 130 -
Saati 1887. Balleria da montagna Ga/Jeano al Gli artiglieri 10110 intenti nella puli:ia dei pe::.:.i da 758. (Foto Nicotra)
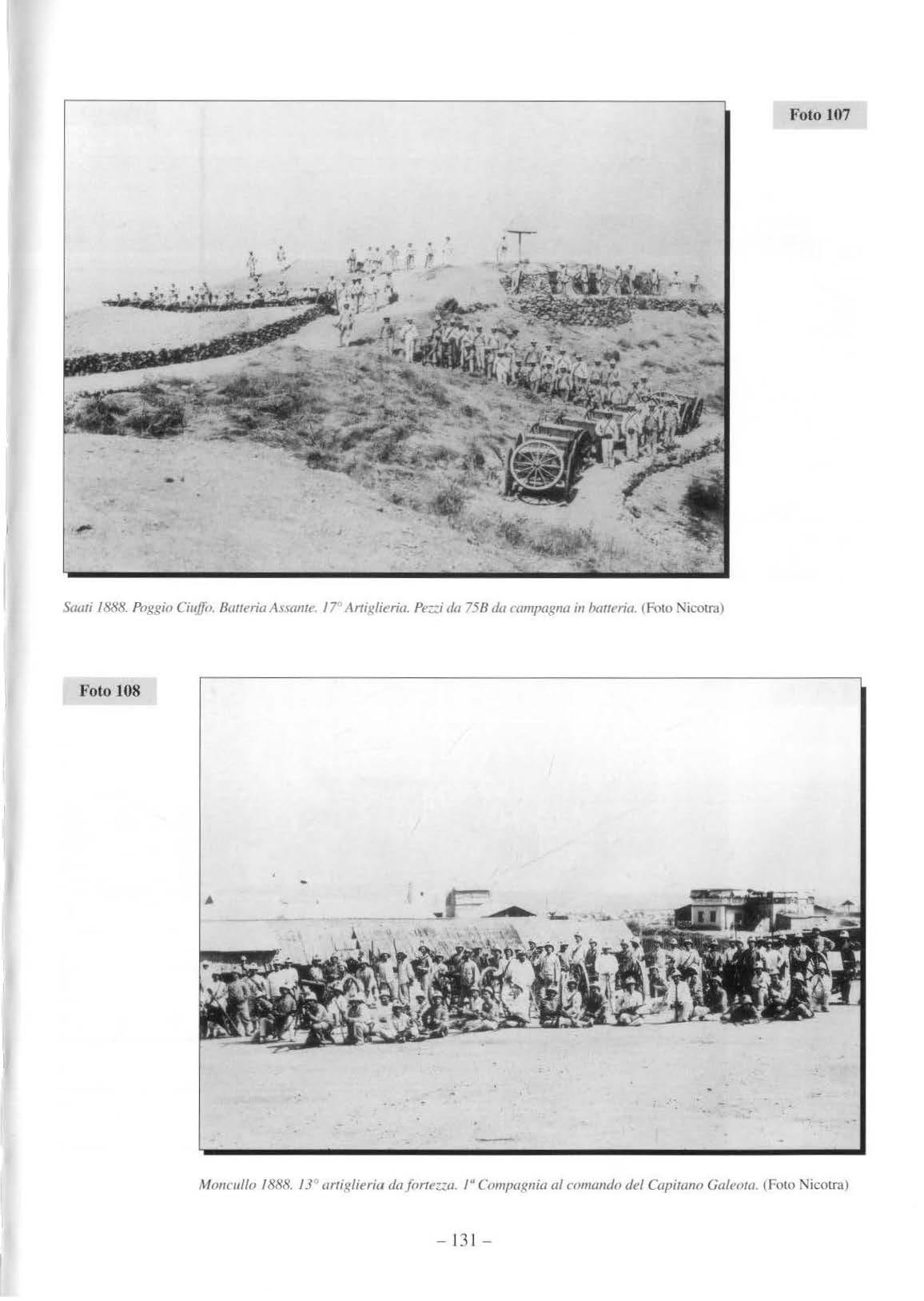
Foto 107 .--, ..
J<'oto 108
Sami 1888. Poggio Ciuffo. Balleria Assame. 17 Arti11lieria. Pe:::.i da 758 da campagna in bmtrria. (Foto icotra)
- 13 1 -
Moncuflo 1888. /3 , da fnne::_a. 1° Compagnia al comwulo del Capitano Ga/eow. (Foto Nicotra)
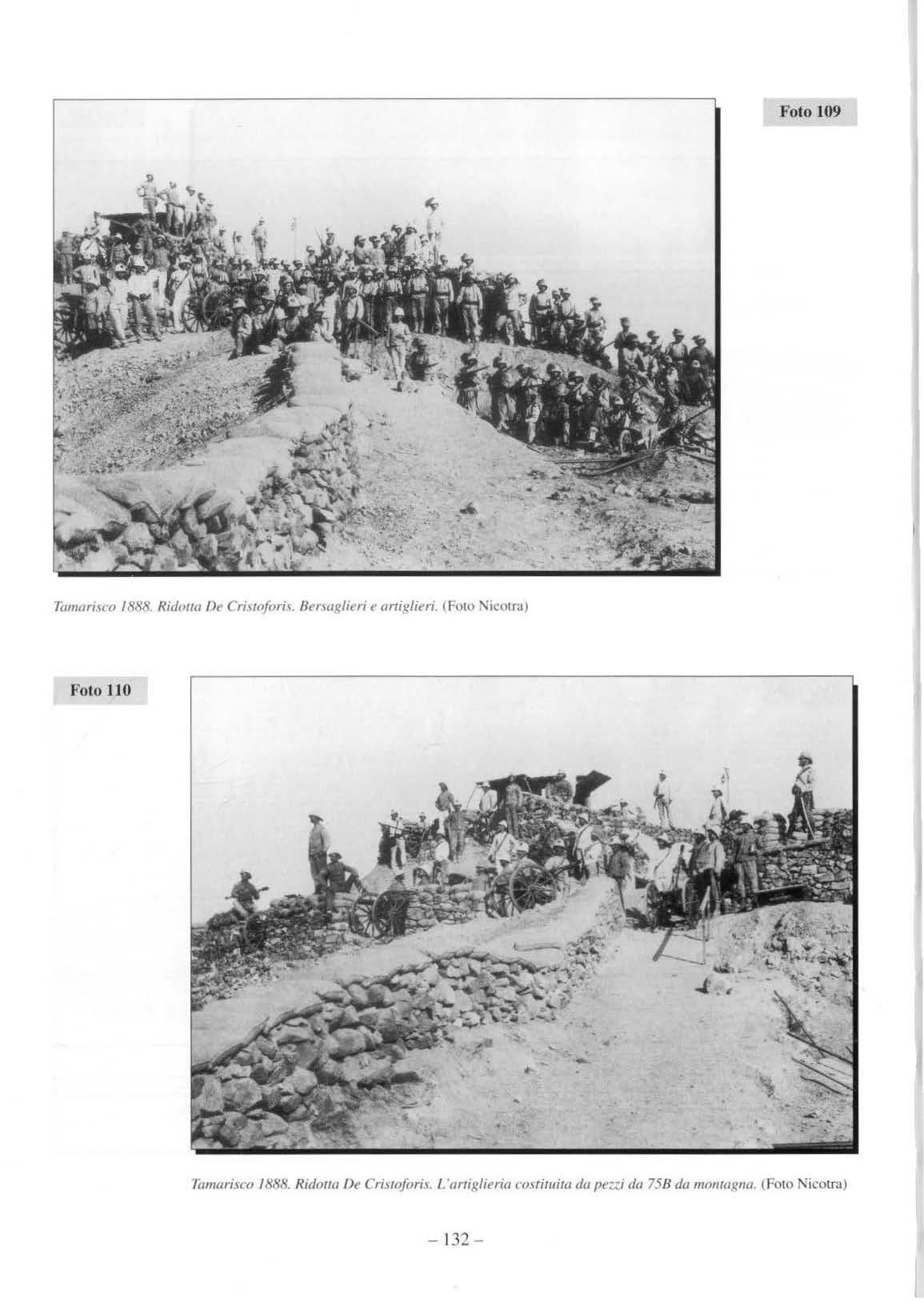
Foto 109
Tamarisco 1888. Ridoua De Cri.llojoris. e artiglieri. (Foto icotra)
Foto
110
- 132-
"/àmarisco 1888. Ridotta De Cristoforis. L'artiglieria costituita da da 758 da momagna. (Foto icotra)
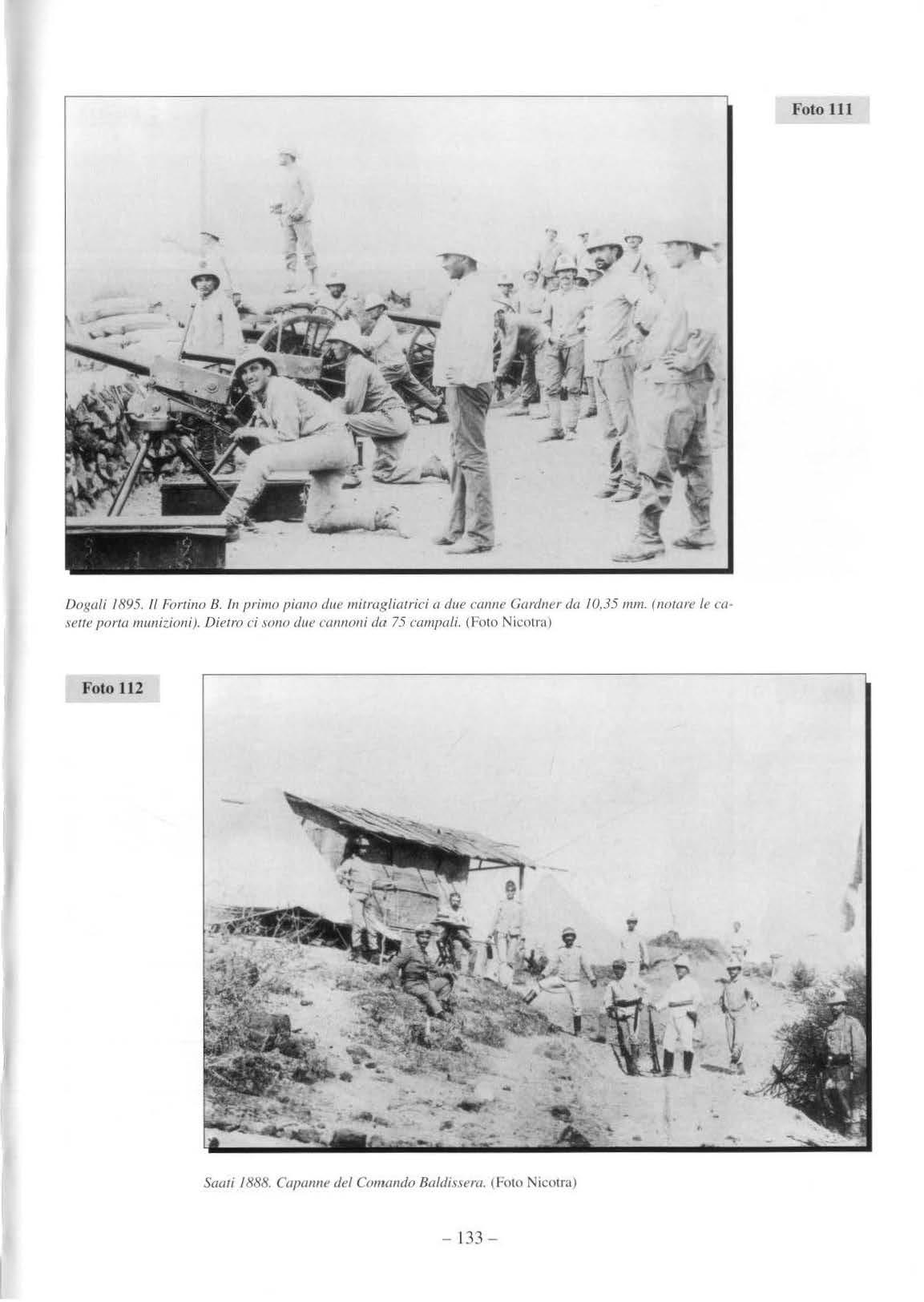
112
Dogali 1895. Il Fortino B. In primo piano due mitragliatrici a due canne Gardner da 10,35 111111. (notare le wsette porta munizioni). Dietro ('Ì sono due callnolli da 75 campali. (Foto Nicolra) Foto
- 133 -
111
Scwti 1888. Capa11ne del Comando Baldissera. (l-oto Nicolra)
Foto
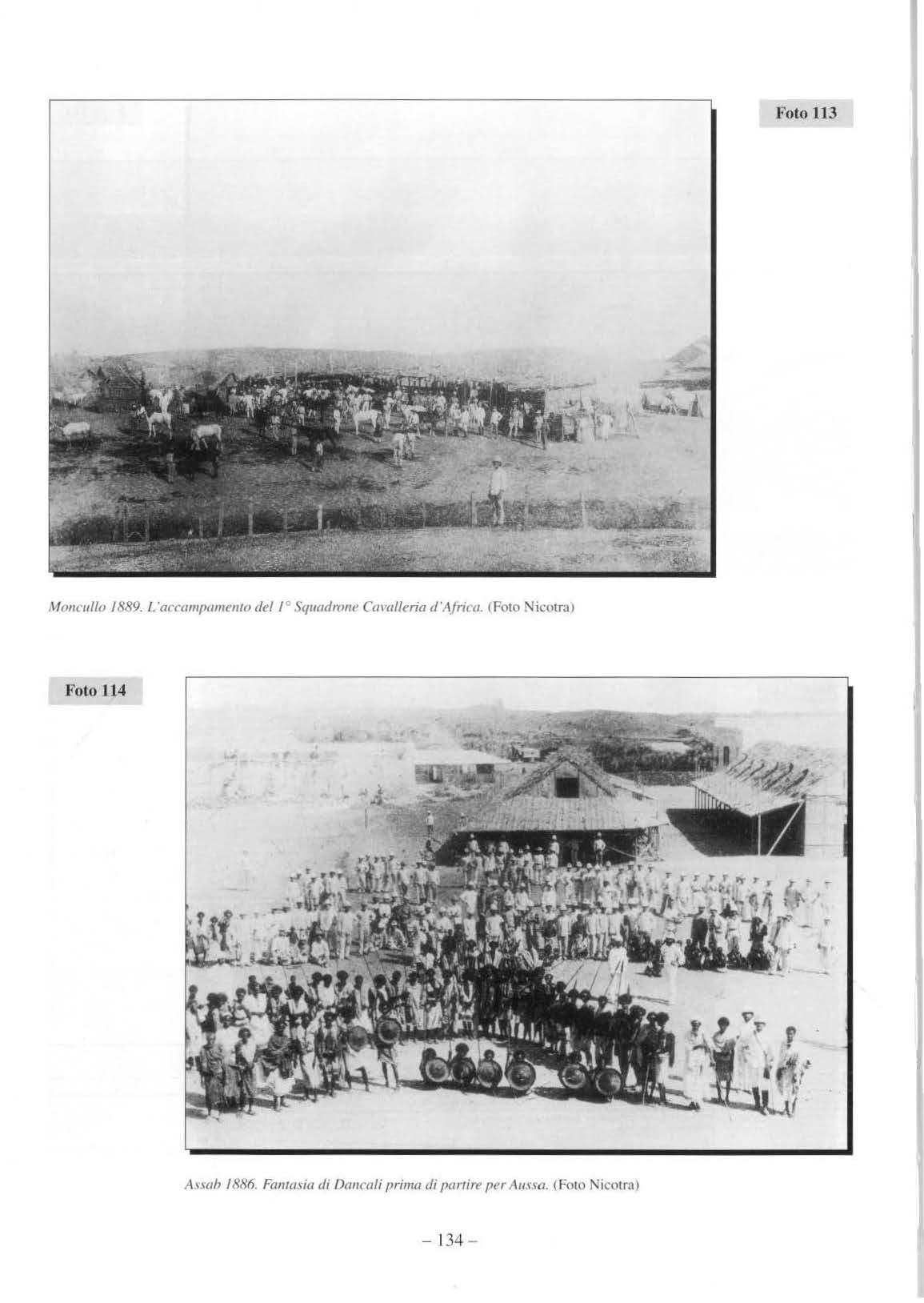
Foto 113
ll-foncullo 1889. L"acrampamemo del 1° Squadrone Camlleria d"Africa. t Foto Nicotra)
114
Foto
-134-
A \.\(/b 1886. Fam asia di Da neo/i prim(l di partire per A11ssa. (Foto icotra)
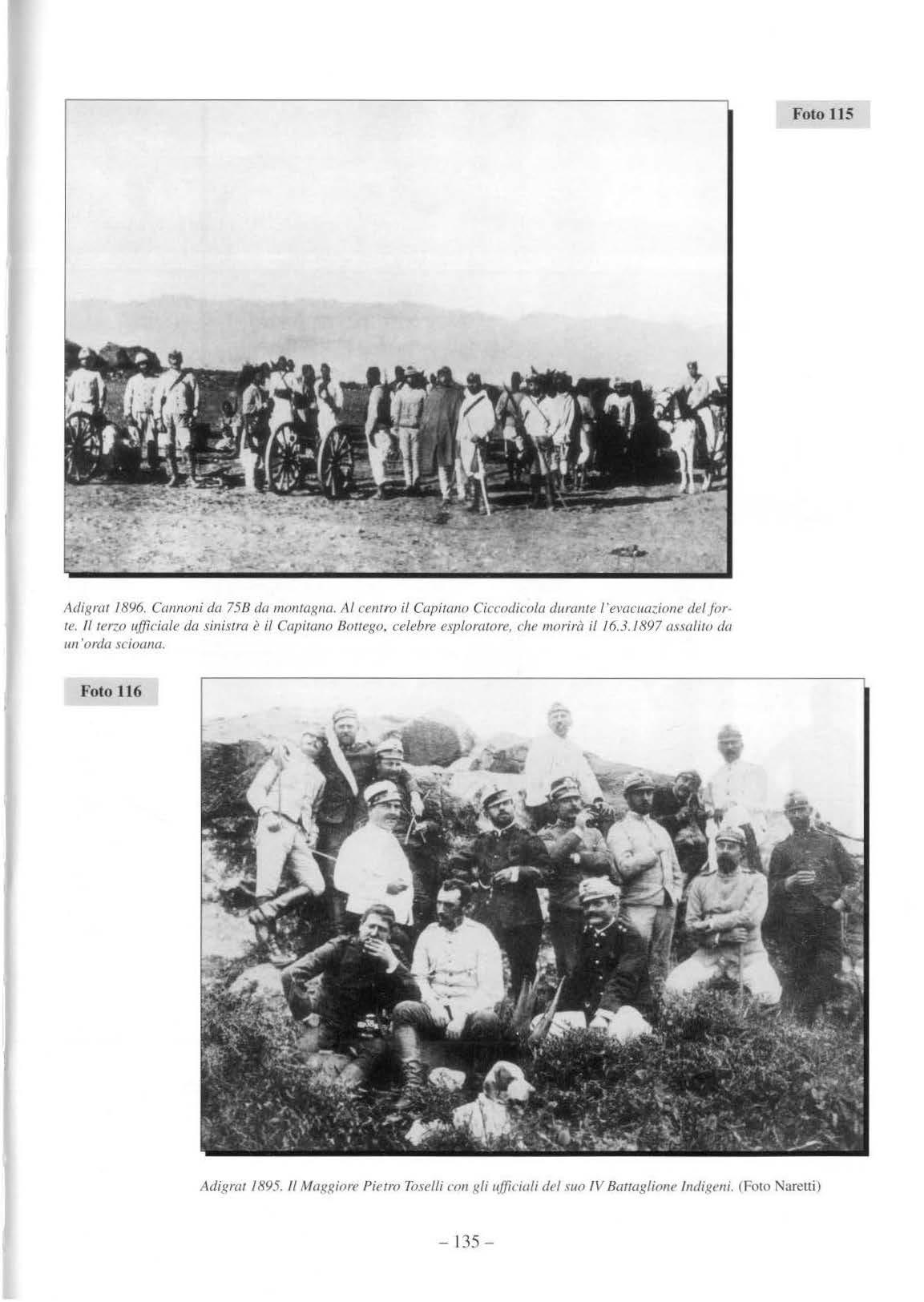 Adigmr 1896. Cannoni da 758 da mon/agna. Al cemro il Capirano Ciccodicola duranre l'evacuazione del forre. Il terzo ufficiale da sinisrra è il Capiremo Bortego. celebre esplormore, che morirà il 16.3 /897 assalito da 1111 'onta scioana.
Adigmr 1896. Cannoni da 758 da mon/agna. Al cemro il Capirano Ciccodicola duranre l'evacuazione del forre. Il terzo ufficiale da sinisrra è il Capiremo Bortego. celebre esplormore, che morirà il 16.3 /897 assalito da 1111 'onta scioana.
Foto 115
Foto 116
- 135-
Adigrat 1895. Il Maggiore Pietro TMelli cmz gli ufficiali del suo lV BaTtaglione Indigeni. (Foto Naretti)
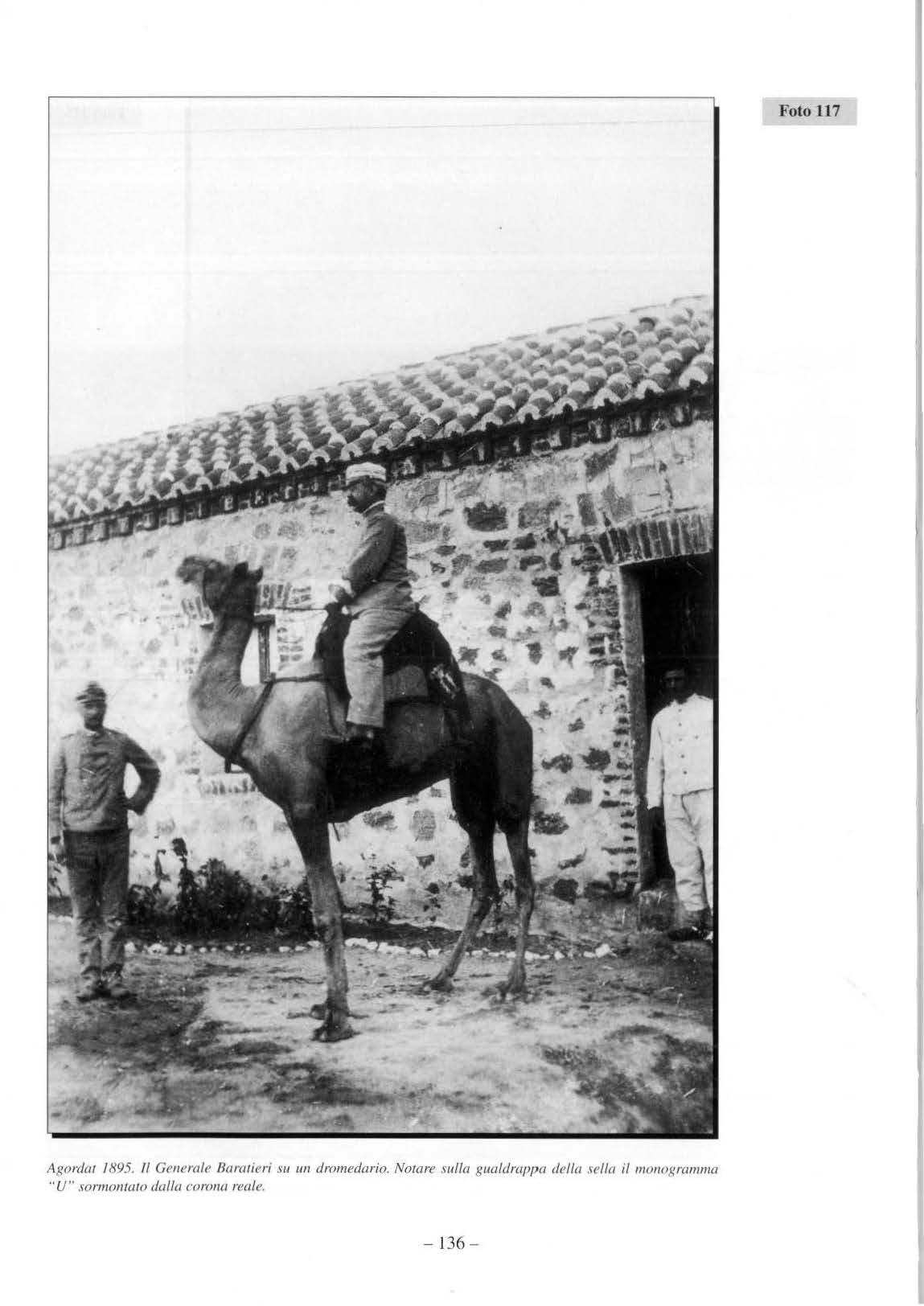
-136Foto 117
Agordo t l 895. 1/ Generale Bararieri s11 1111 dromedario Nora re sulla gualdrappa della sella il monogramma U sormonraw dalla corona reale.
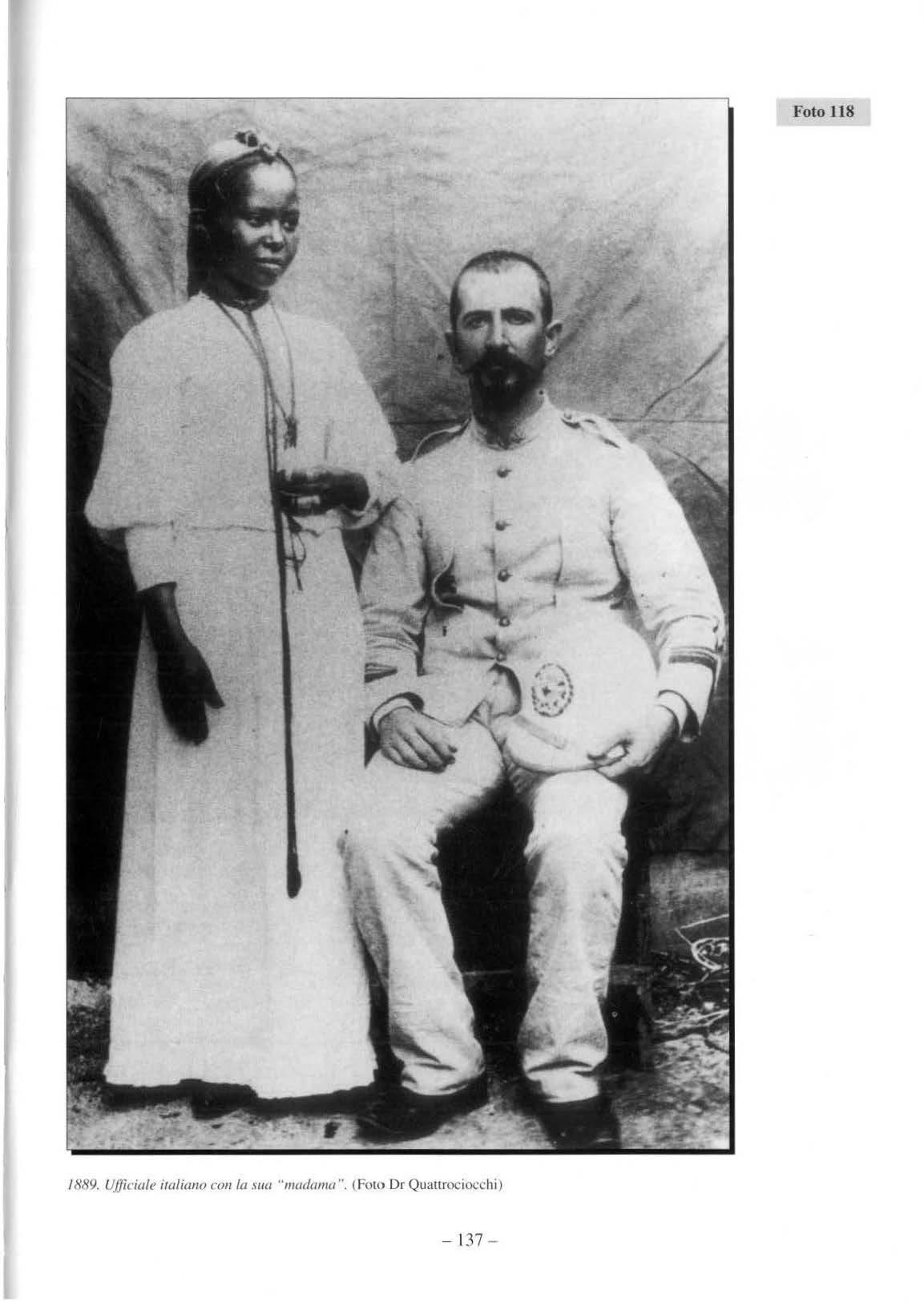
Foto 118
- 137 -
1889. Ufficiale italiano conia sua ··madama··. (Foto Dr Quaurociocch i)

Foto 119
-138-
Agordat 1894. Il Colonnello Arimondi co11 i suoi ufficiali dopo la 2° bauaglia di Agordat (21 dicembre 1893).
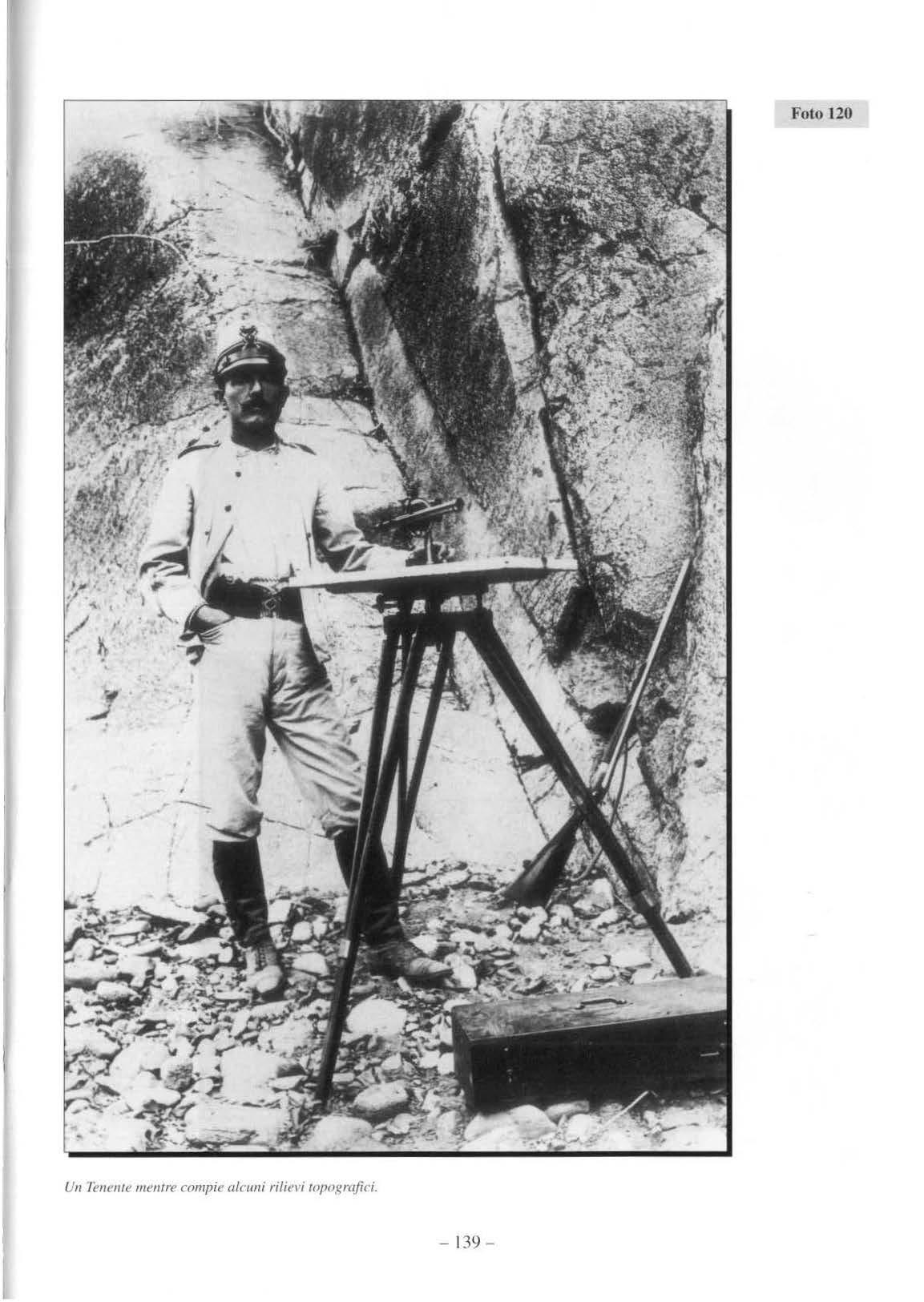
Foto 120
- 139 -
Un Tenente mentre compie alcuni rilie1 •i WPOE!fafici.

Foto 121
- 140 -
l Tenenti Lanni e A.nanti in posa africana.
LE TRUPPE COLONIALI
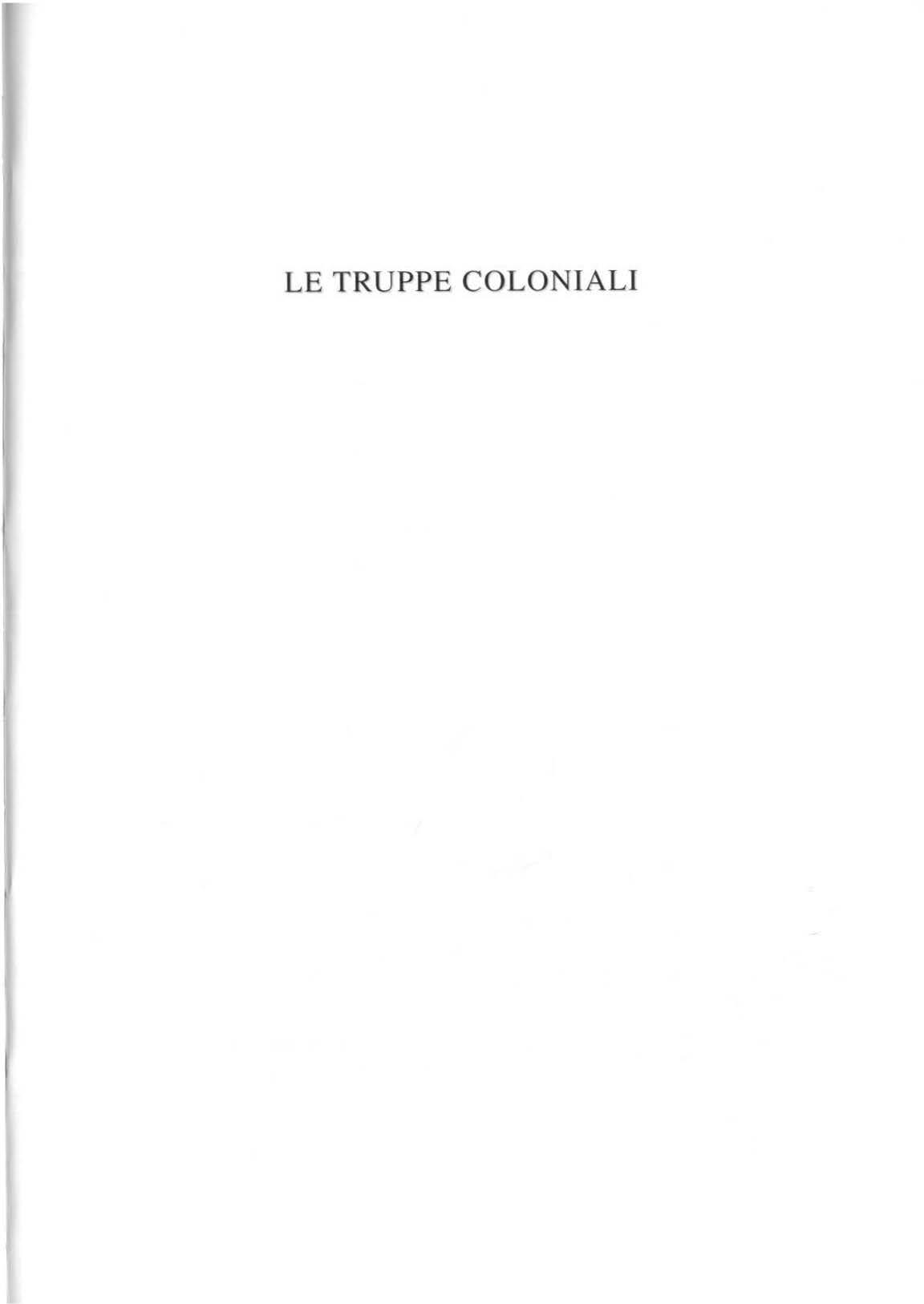
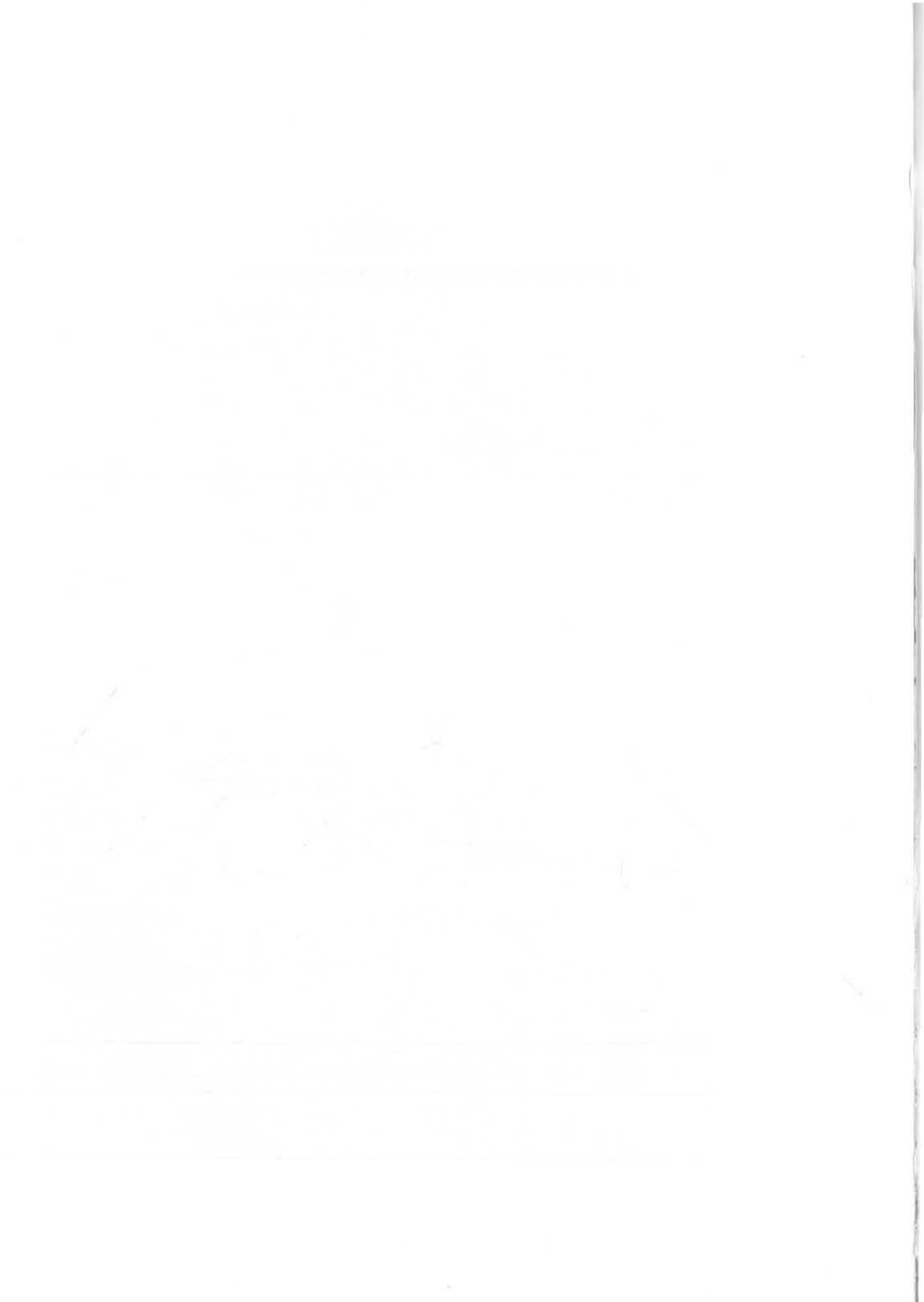
Ma:.saua l 885. l primi basci-lm:.uk. Poco tempo dopo lo .1·barco italiano. questi reparti di indigt' ll i irregolari al sen-i:.io egi:.iano, passaro11o wtto la bandina iwliana fomumdo due reparti (orde) di circa 2000 uomini. Due (///Ili dopo le orde d i ve11nero tr('.
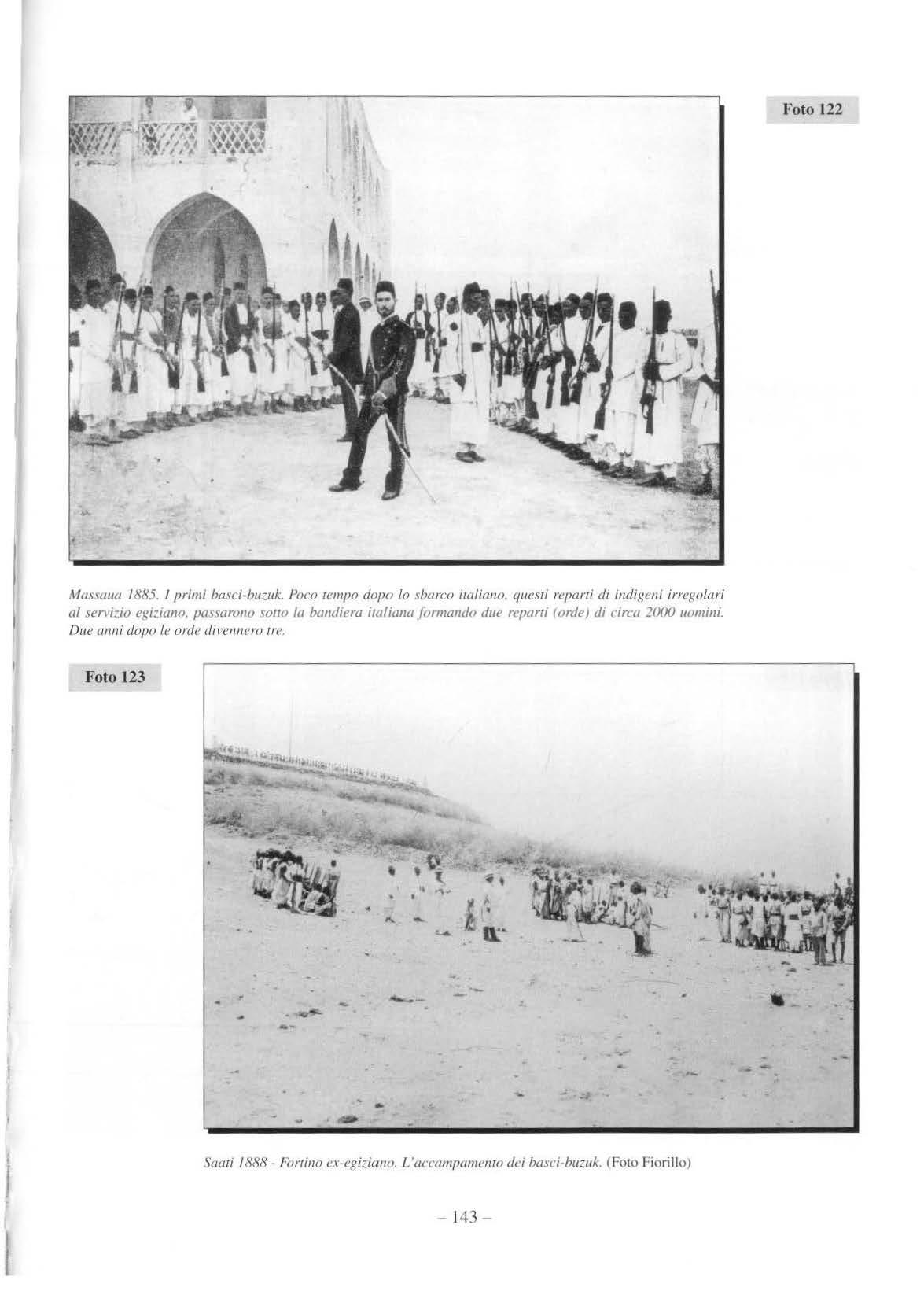
l
---...
Foto 123
- 143Foto 122 ...
Saati 1888- Fortino ex-egdww. L'accampamento dei (Foto Fiorillo)
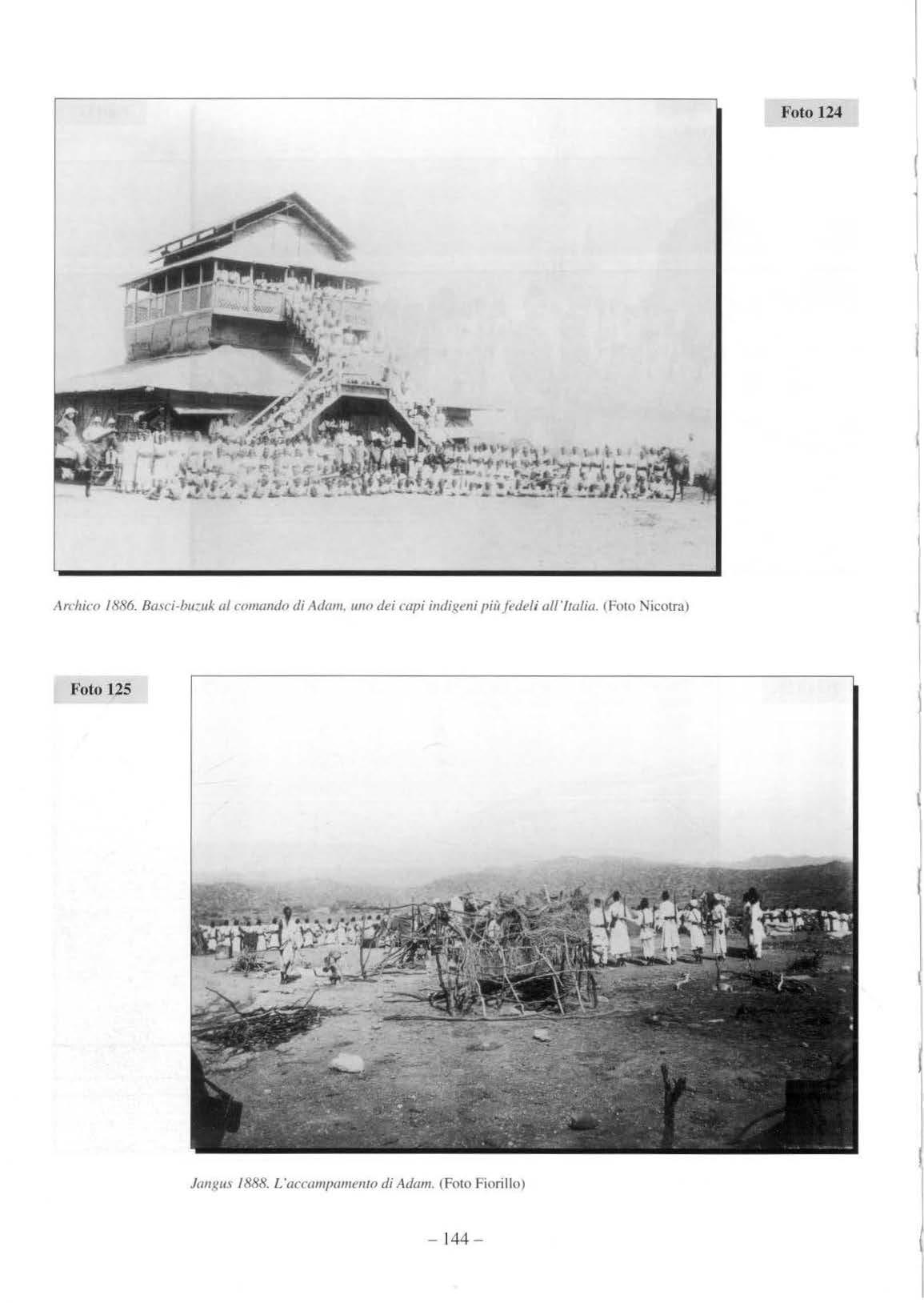
124
Foto
Arcllim /886. al comando di Adam. 11110 dei capi indigeni più fedel i all'Italia. !Folo icotra)
Foto 125
- 144 -
Jangu.1 /888. L'accampameli/o di Adam. !Folo Fiori ll o)
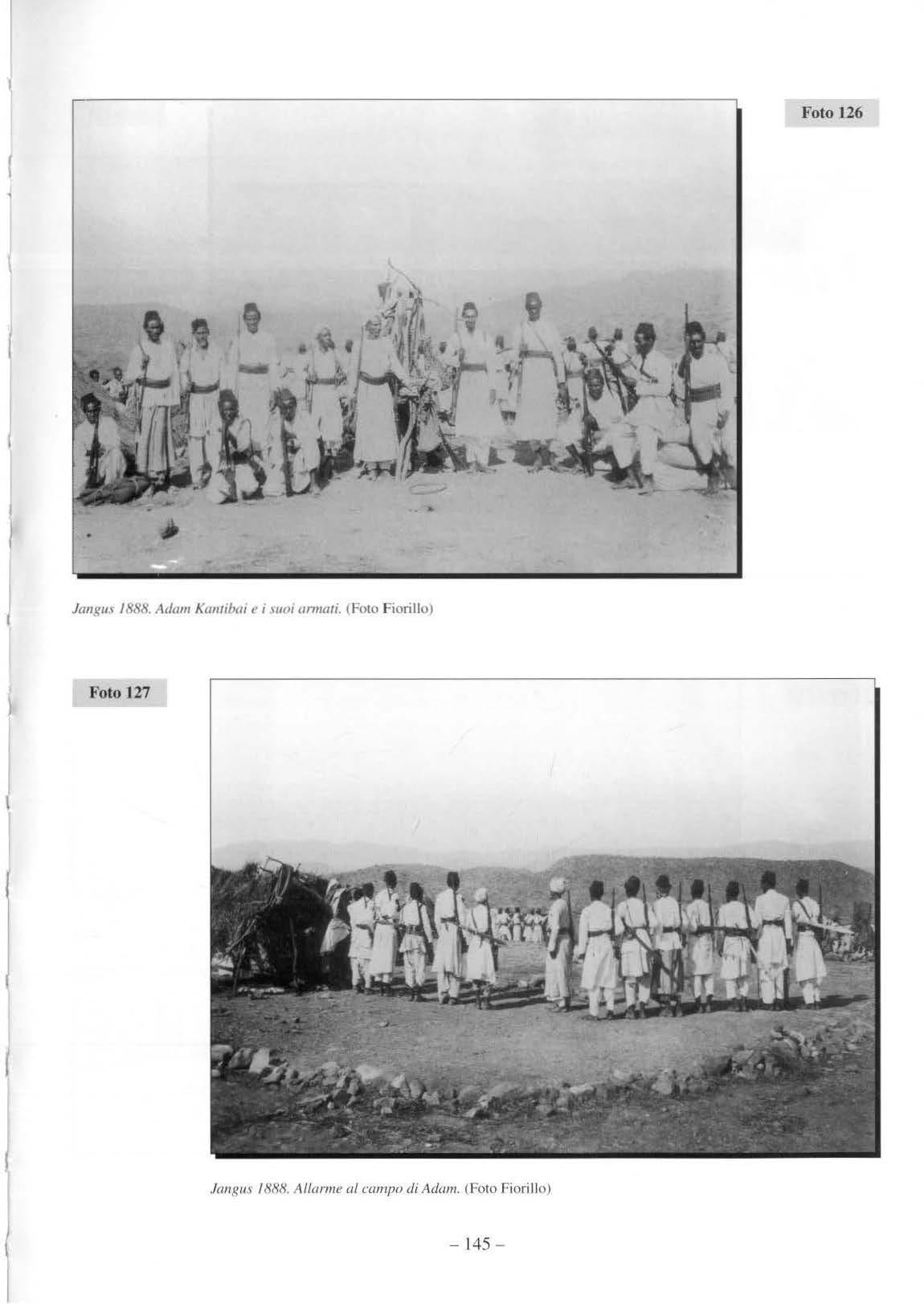
Foto 126
Jangus 1888. Adam Kcmtìbm e i 111oi annali. (Foto F iorillo)
Fo to 127
- 145 -
Jnll fi ii S 18XX. Allarme al campo di Ada m. (Foto Fiori Il o)
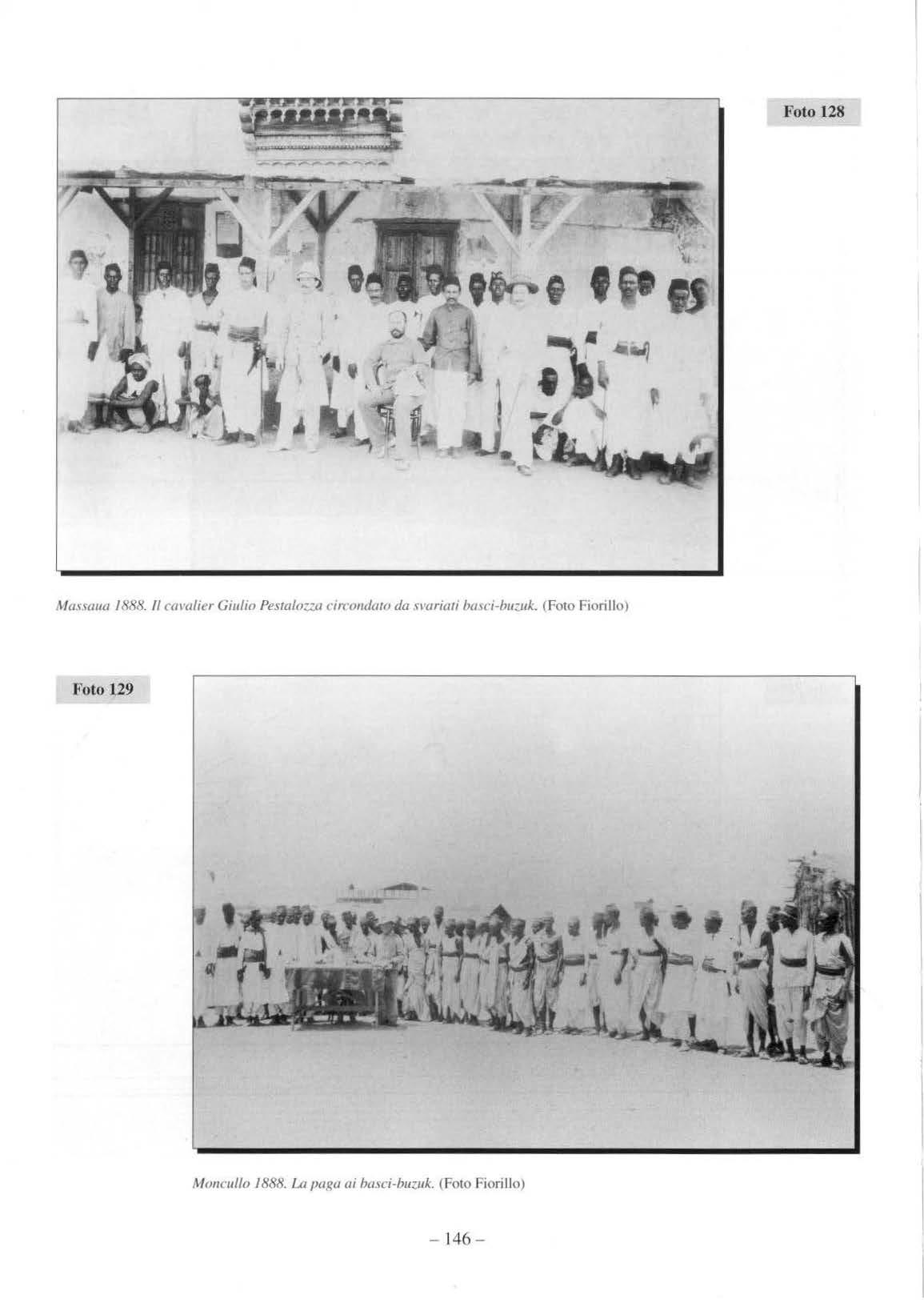
Foto 128
Ma.naua 1888. Il cal'alier Giulio Pestalo::.::.a circondato da wariati b(/\ci-lm:uk. (Foto Fiorillo)
Foto l29
- 146-
Moncullo 1888. Lo pap,a ai ba.1-ci-bu::.uk. (Foto Fiorillo)
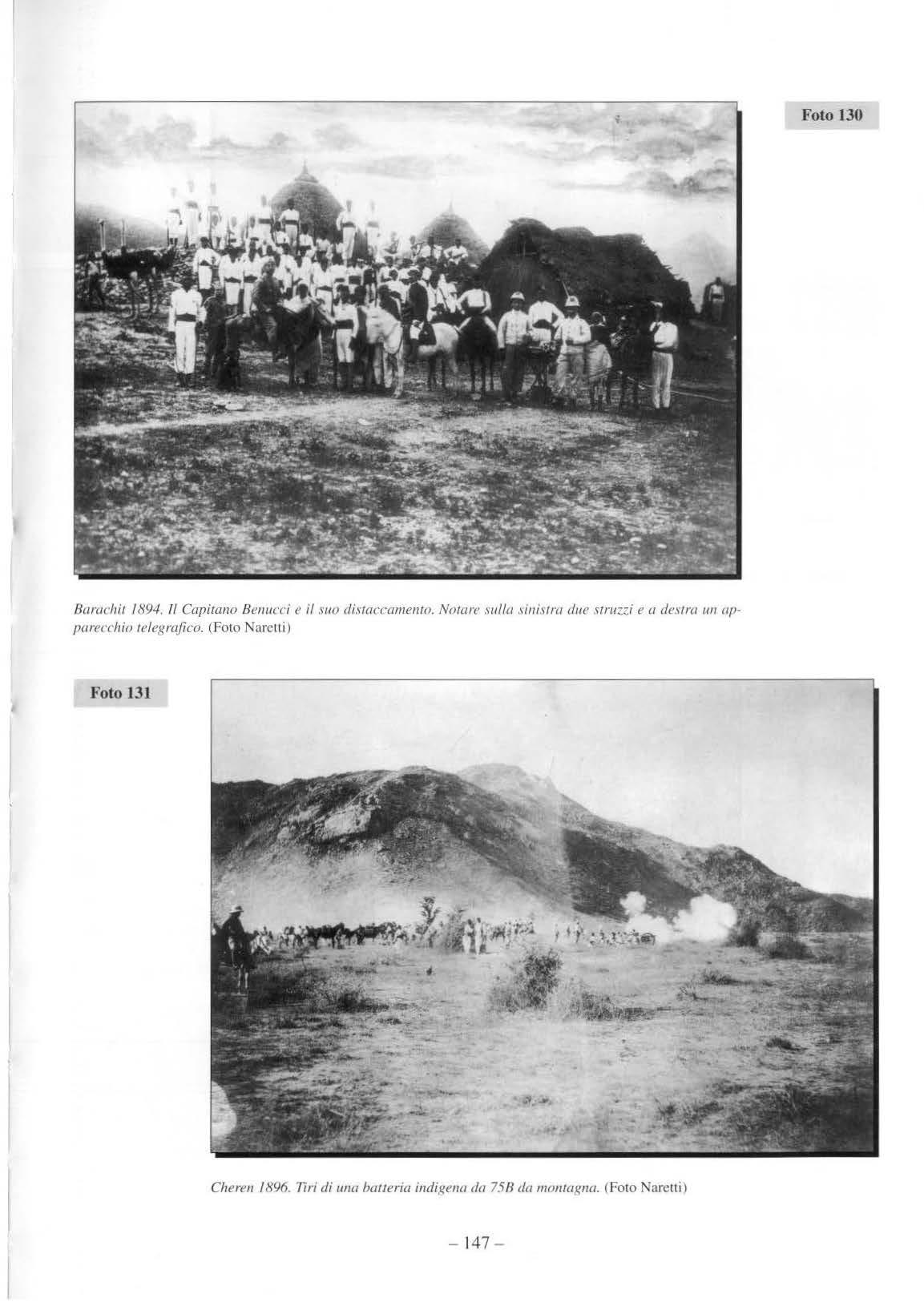 Barachir 1894. Il Cap itan o Benucci e il suu disracc-amento. Norare .\111/a due stru::.zi e a destra 1111 ap · parel'chio telegrafico. (Foto Nurcui)
Foto 131
Barachir 1894. Il Cap itan o Benucci e il suu disracc-amento. Norare .\111/a due stru::.zi e a destra 1111 ap · parel'chio telegrafico. (Foto Nurcui)
Foto 131
- 147 -
Cheren 1896. Tiri di ww batteria indit:ena da 75/J da monwww. (Foto Nurctti)
130
Foto
 Adua 1895. Se;ione artiglieria indit:ena al comando del Tenente Camso. l i soliti 758 da lllcJ/lta· t:lw. (rotu Narctti)
Foto J33
Adua 1895. Se;ione artiglieria indit:ena al comando del Tenente Camso. l i soliti 758 da lllcJ/lta· t:lw. (rotu Narctti)
Foto J33
- J48Foto132
Adigrat/893. Se<.ione aniglieria indigena al comtmdo del Tenente Scala. (Foto areni)

134
Foto
/889. A:.cari in esercitazione con 1111 75 8 da
Foto 135
- 149-
Fone Baldùsera 1896. Ascari di una baueria monai da 87 in eserciudone. Notare a destra 1111 ''Muma: (caporale).
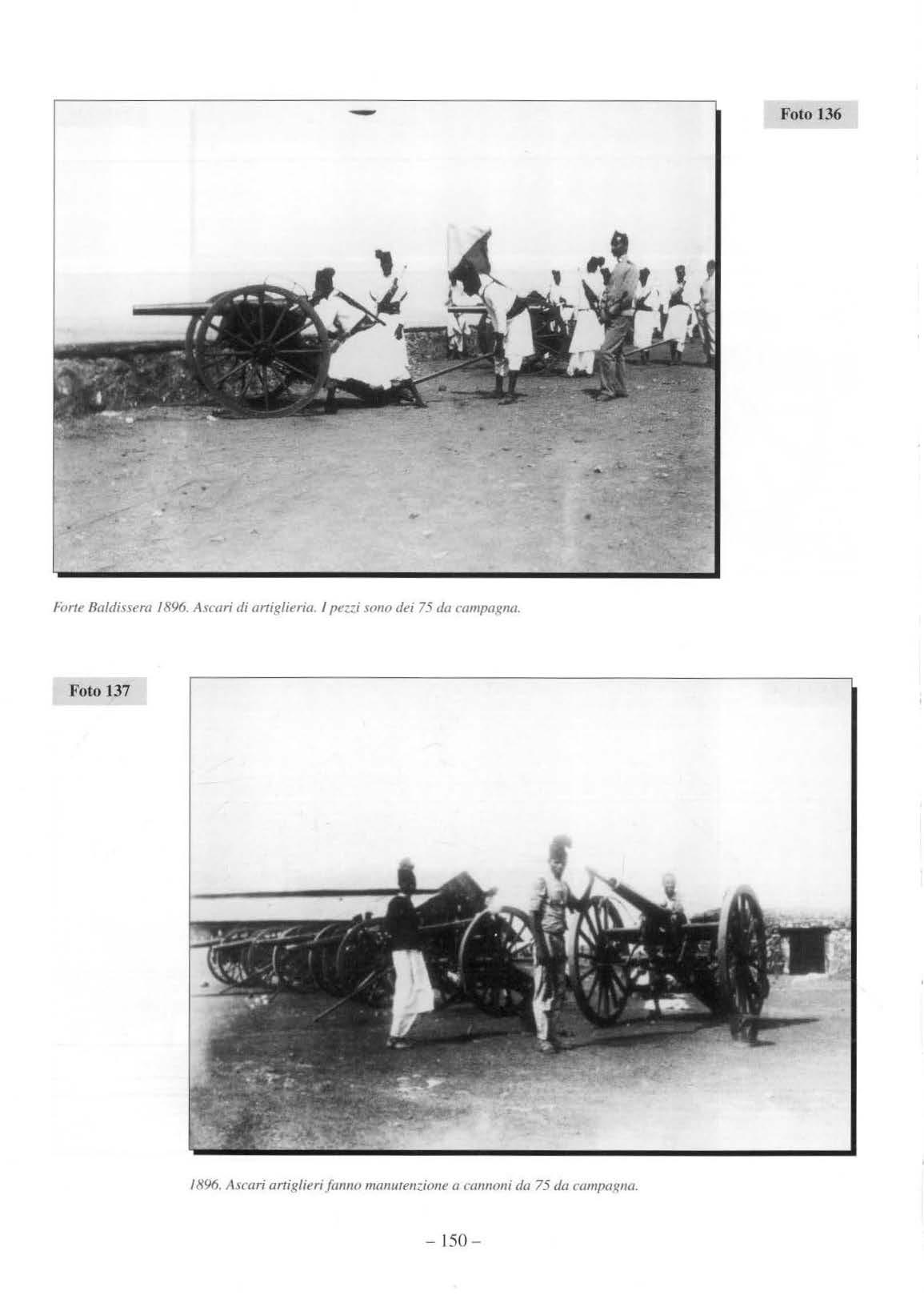
- Foto 136
Nme Baldissero 1896. Ascari di artiglieria. l pe:::i sono dei 75 da mmpa,f(na.
Foto 137
-150-
1896. Ascari artiglieri fanno m anutenàone a ccmnoni da 75 da
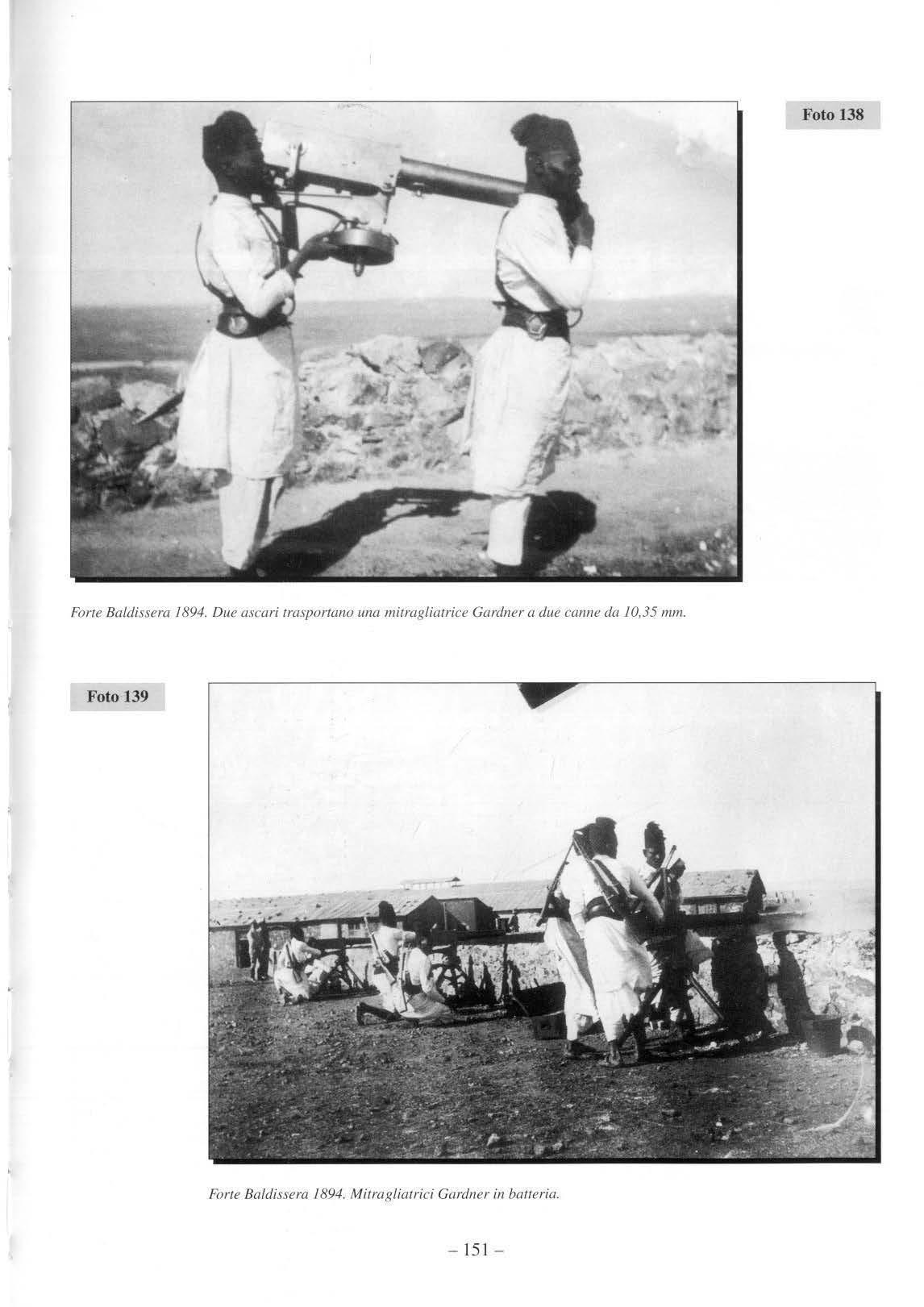
Fotol38
Forte Baldissero 1894. Due ascari trasportano urw mitragliatrice Gardner a due canne da 10,35 mm.
Foto 139
- 151 -
ròrte Baldissero 1894. MitraJ?Iiatrici Gardner in batteria.
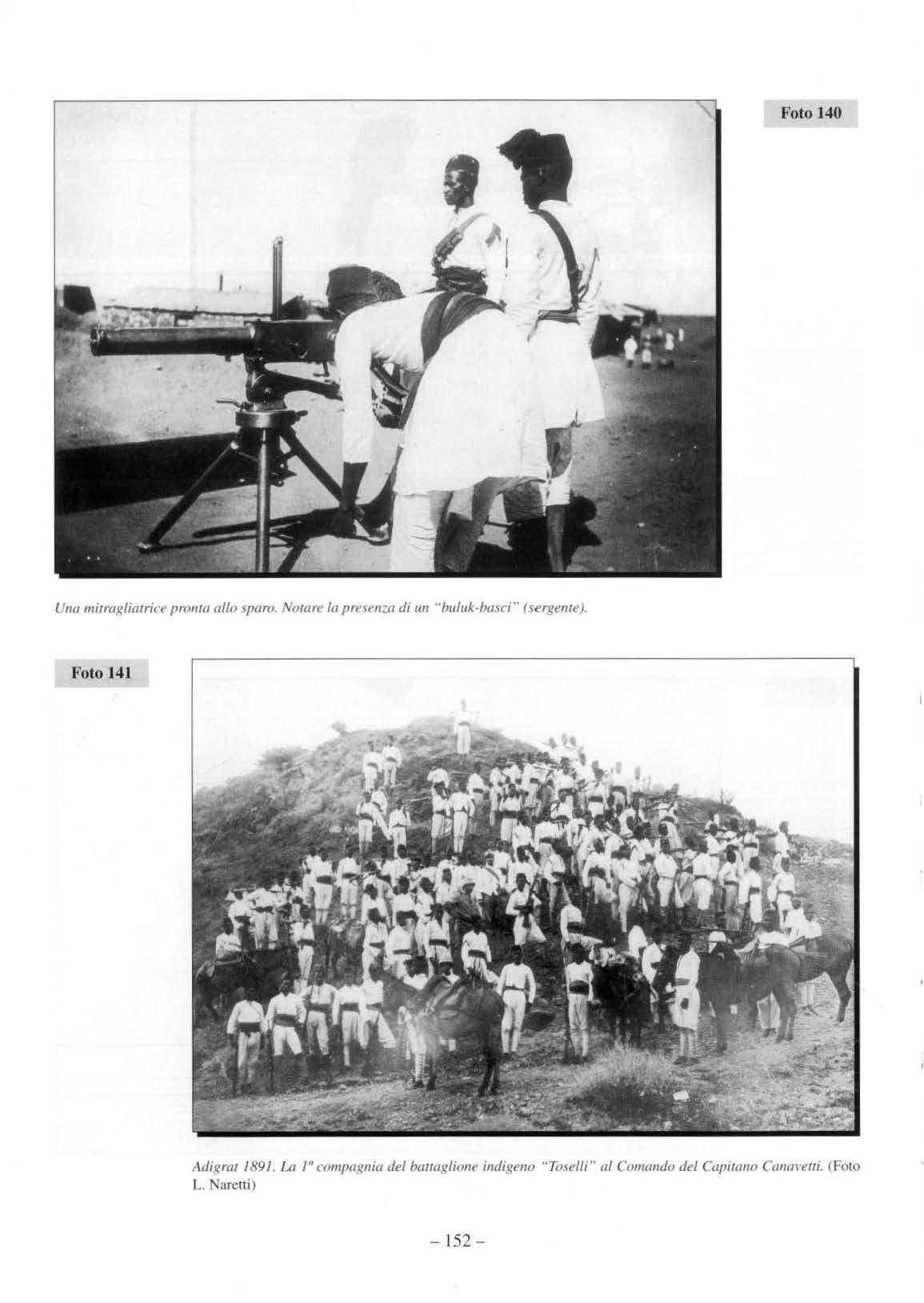
140
Foto
Una mitragliaTrice pronwallo ,\paro. Nowre la preirn:::n di 1111 ··buluk-basci'. (sergenTe).
Folo 141
- 152 -
AdiRrar 1891. La l" compagnia del baTtaglione indigeno '"Toselli" al Comando del CapiTano Canareui. (Fo to L. 'areni}
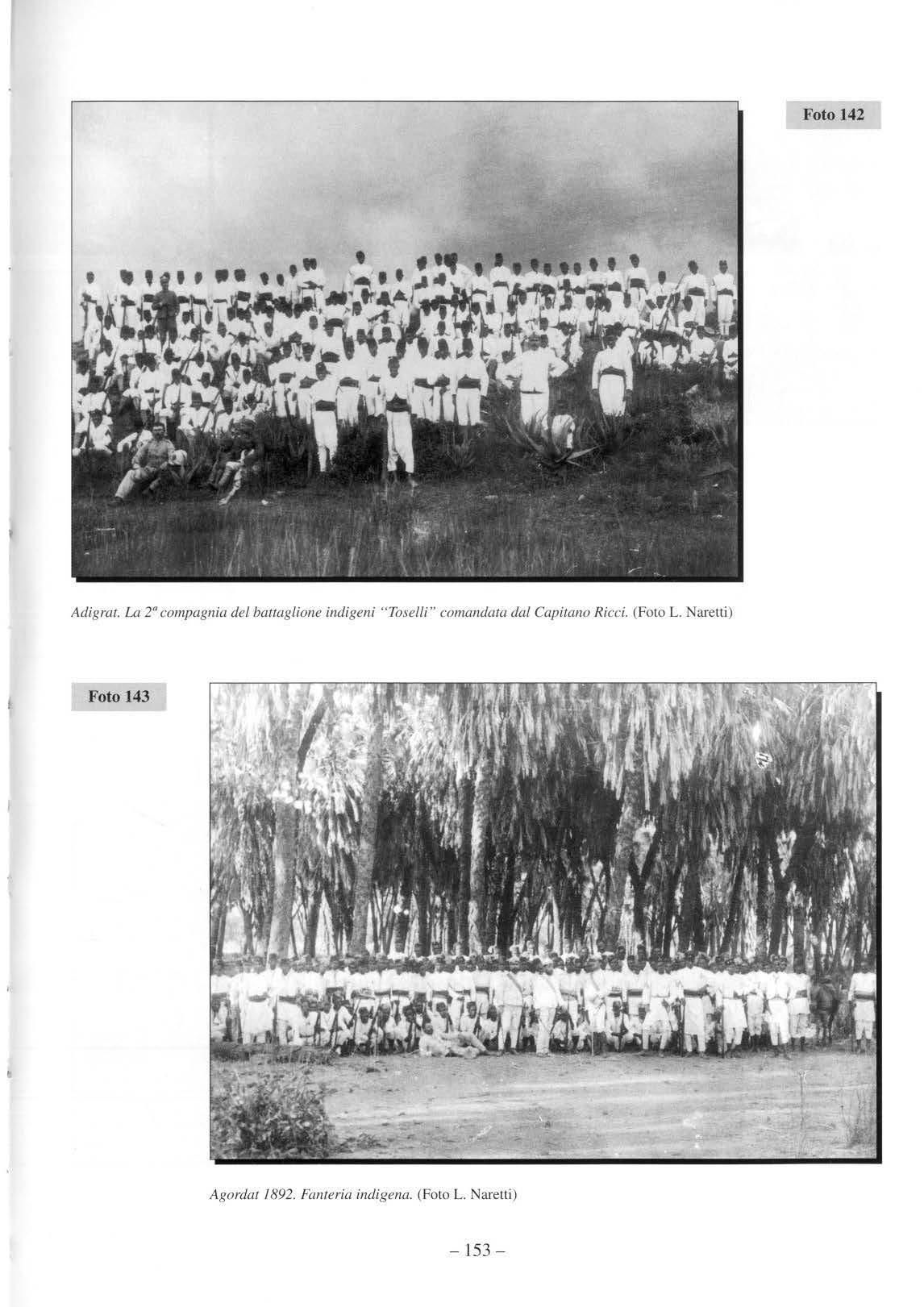
142
Foto
Adigrat. La 2a compagnia del battaglione indigeni "Toselli ,. conwndata dal Capitano Ricci. (Fow L. Naretti)
t
Foto 143
- 153-
Agordat 1892. Fanteria indigena. (Fo to L. Narett i )
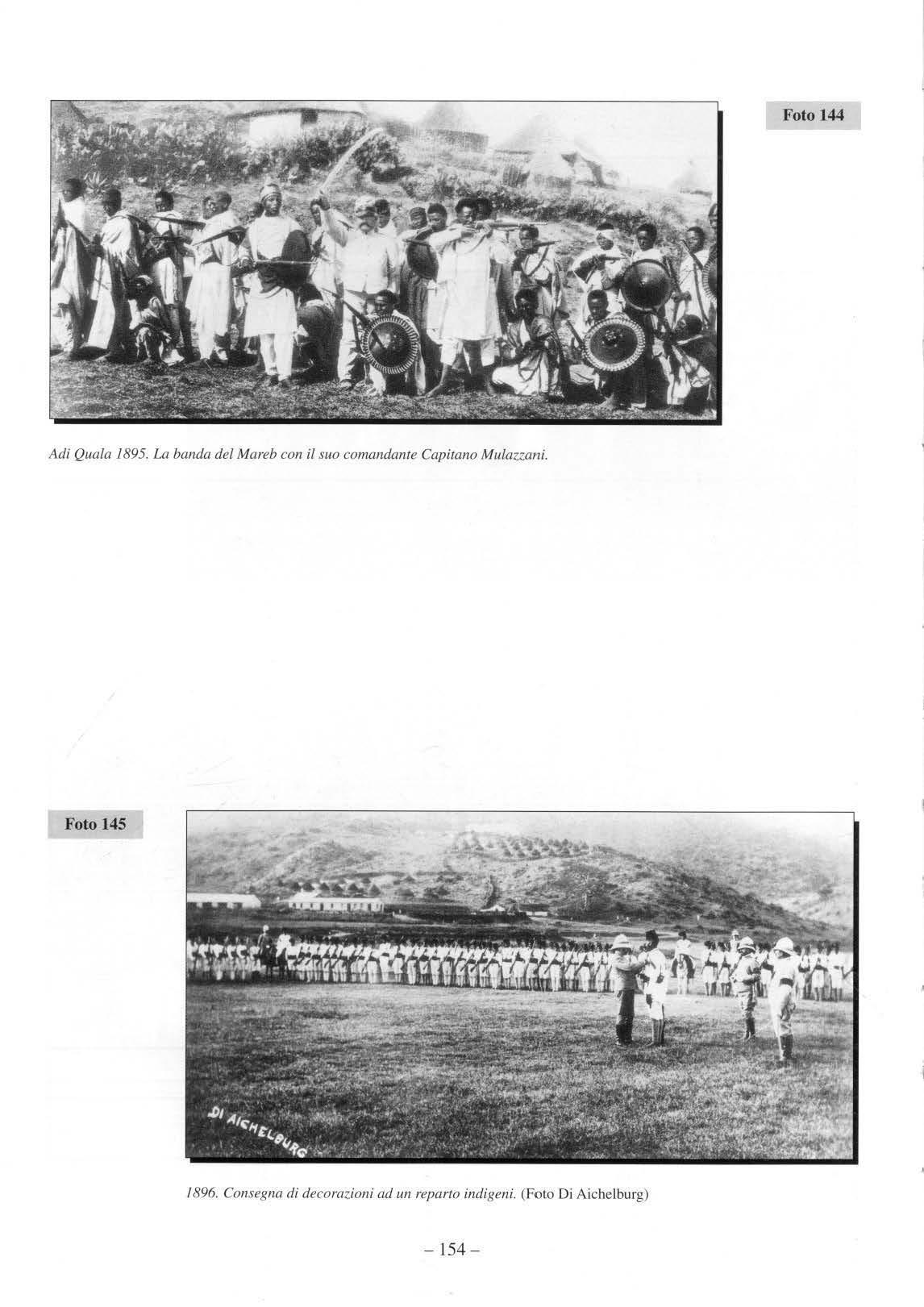
144
Foto
Adi Quala 1895. La banda del Mareb con il suo conumdante Capi tano Mula zza ni.
Foto 145
-154-
1896. Consegna di decora zioni ad un reparto indigeni. ( Foto Di Aichelburg)
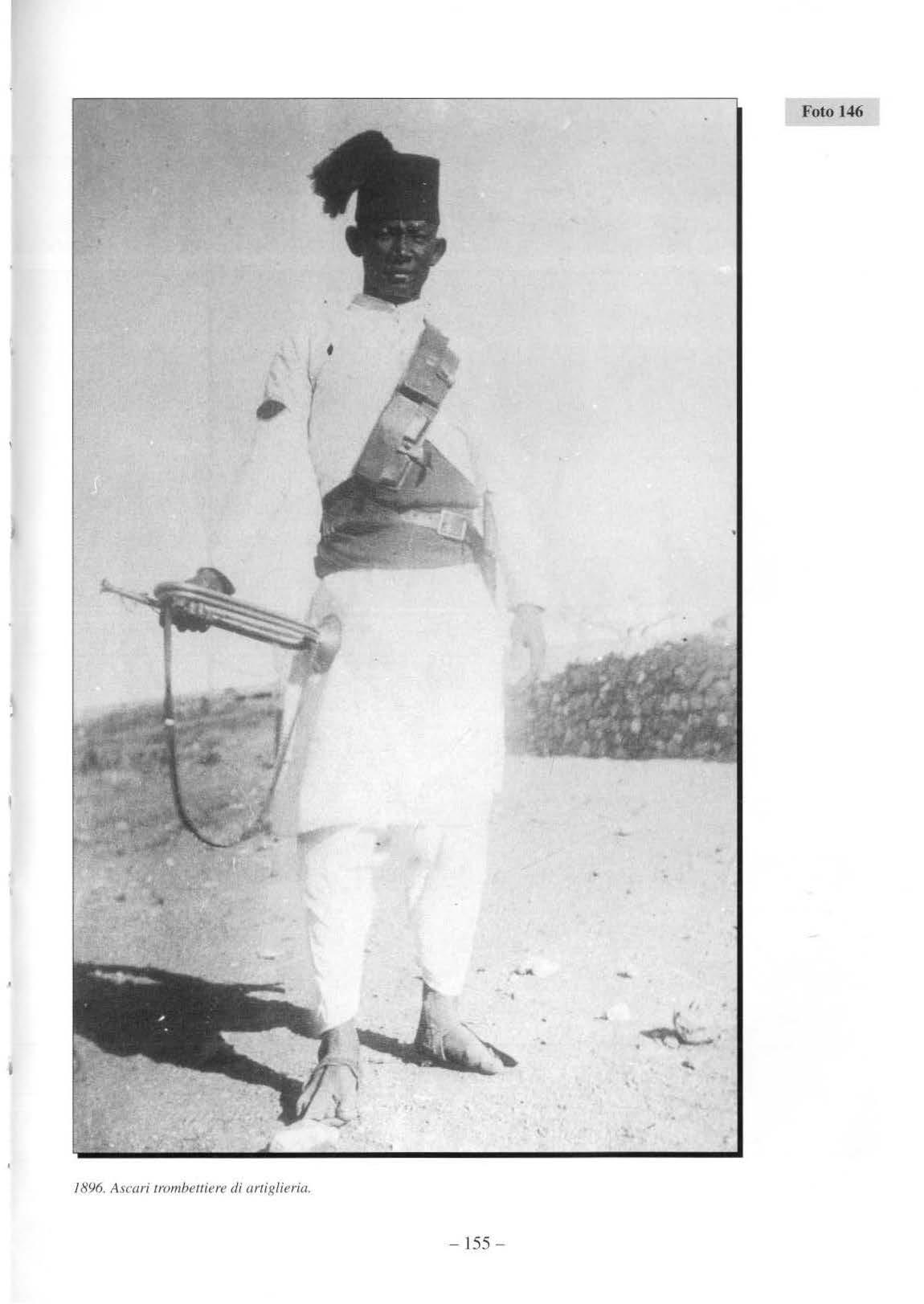
Foto 146 -
- 155 -
189fJ Asrari trombeniere di artig fi eria
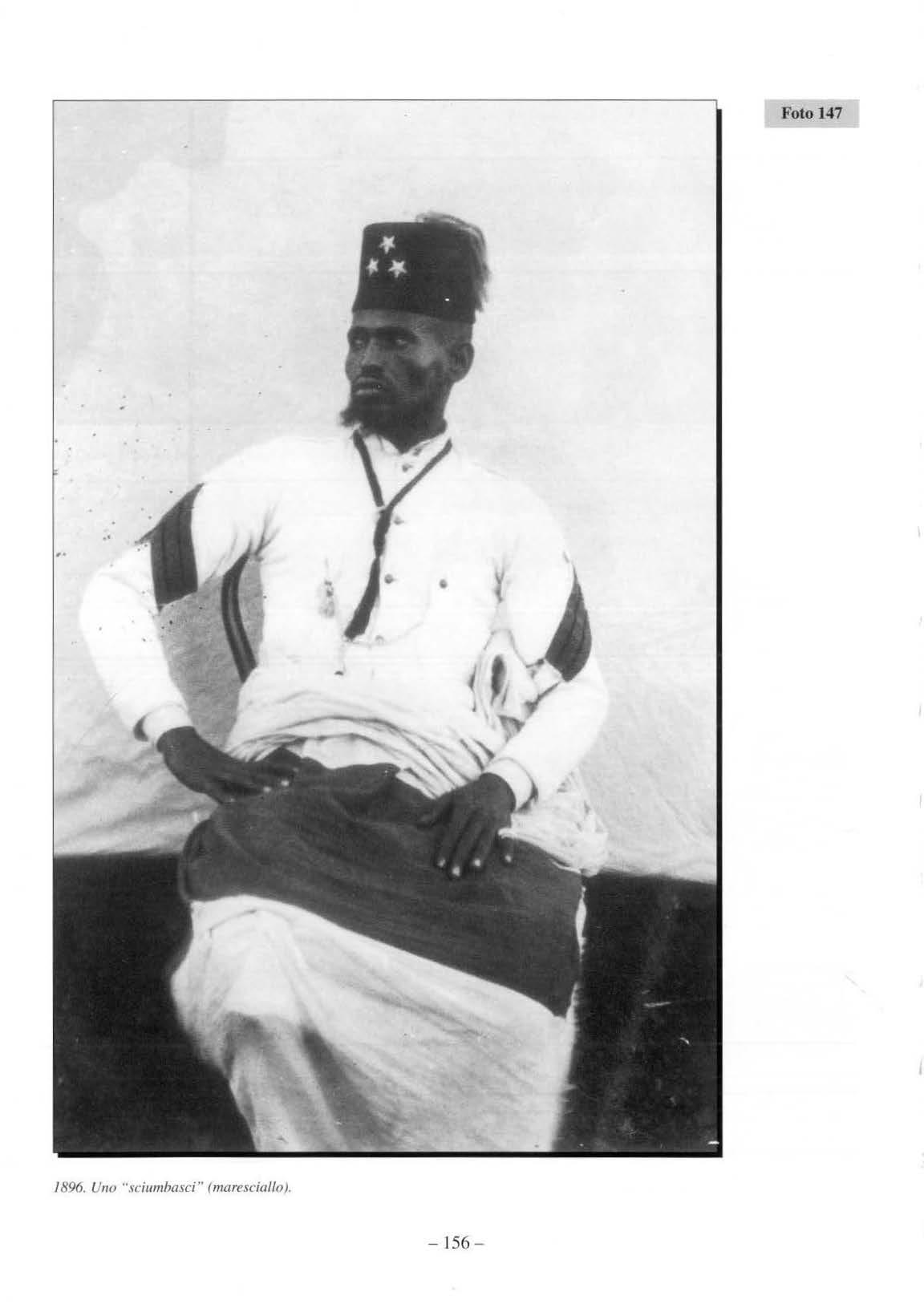
Foto 147
- 156 -
1896. Uno sciumbasci'' (nwresciallo).
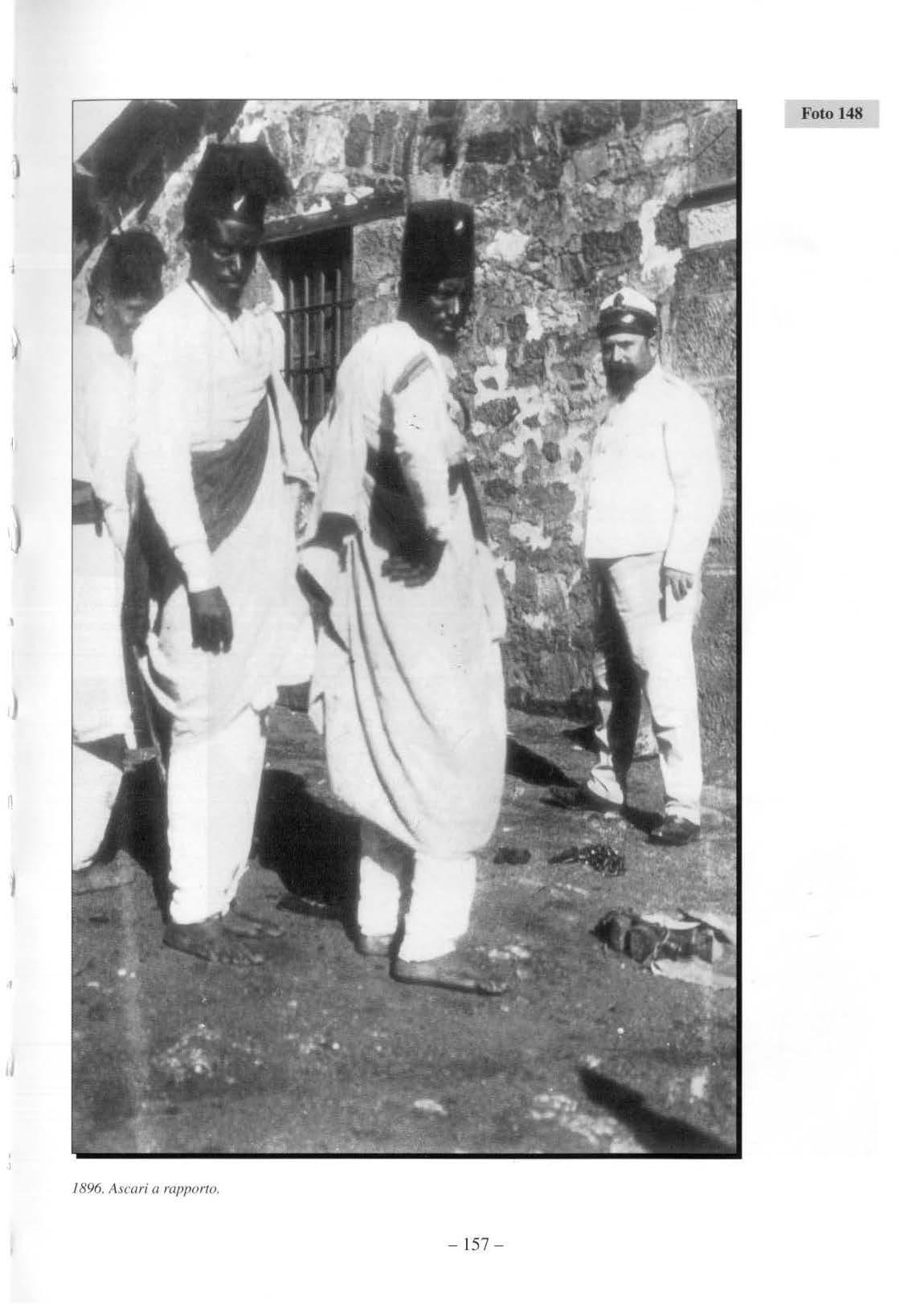
Foto 148 }
- 15 7-
1896. Ascari a rapporto.

Fo to U 9 )
-158 -
1896. Un gruppo di mlomsi "mwua:::." (caporali).
1896. Ascari di cavalleria con il/oro comandante. Le due "penne di jàlco" sedute a destra sono armate di una spada di origine sudanese chiamata "si et''. preferita in genere dai musulmani.
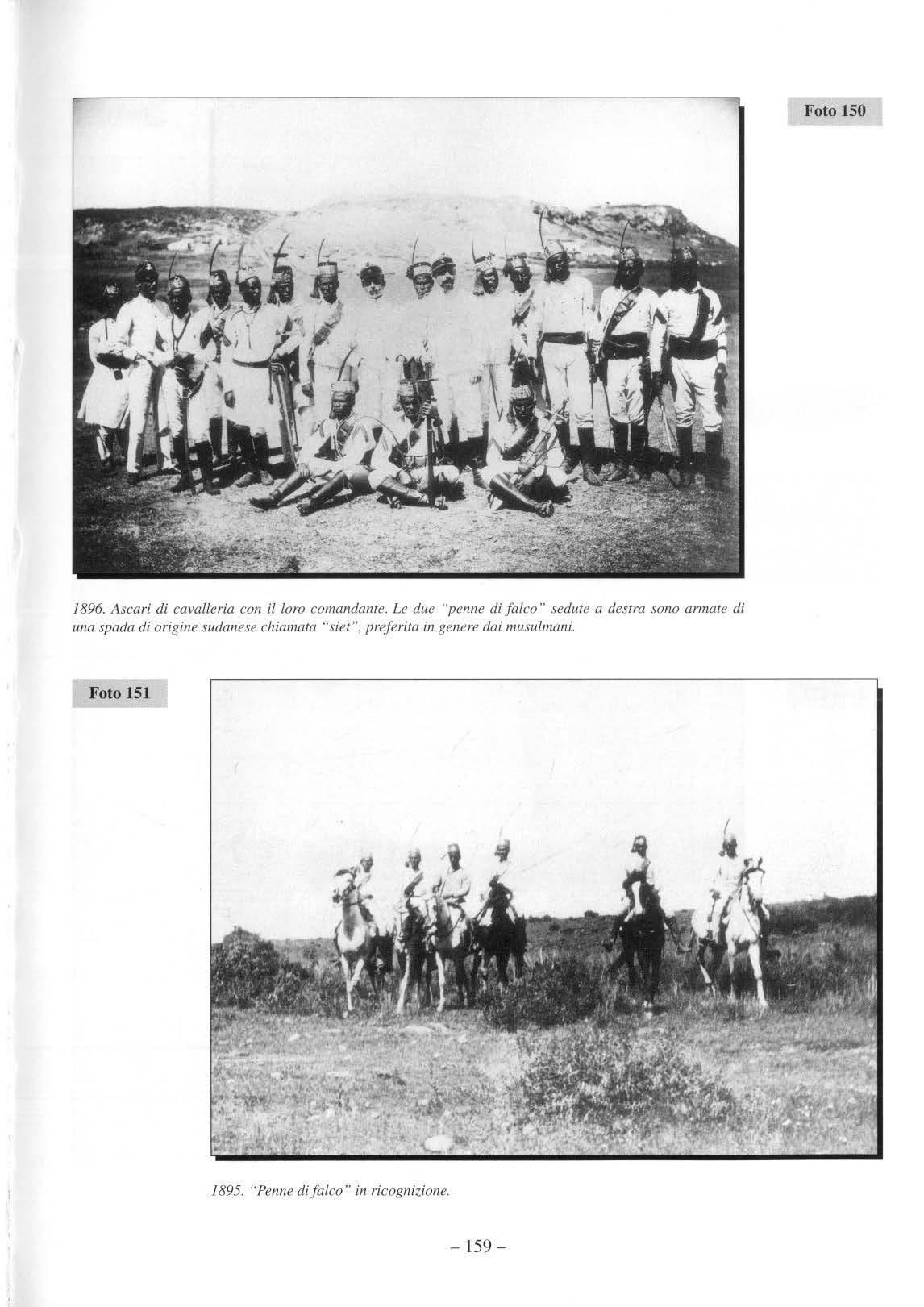 Foto 151
Foto 151
- 159-
150
l 895. "Penne di falco" in ricognizione
Foto
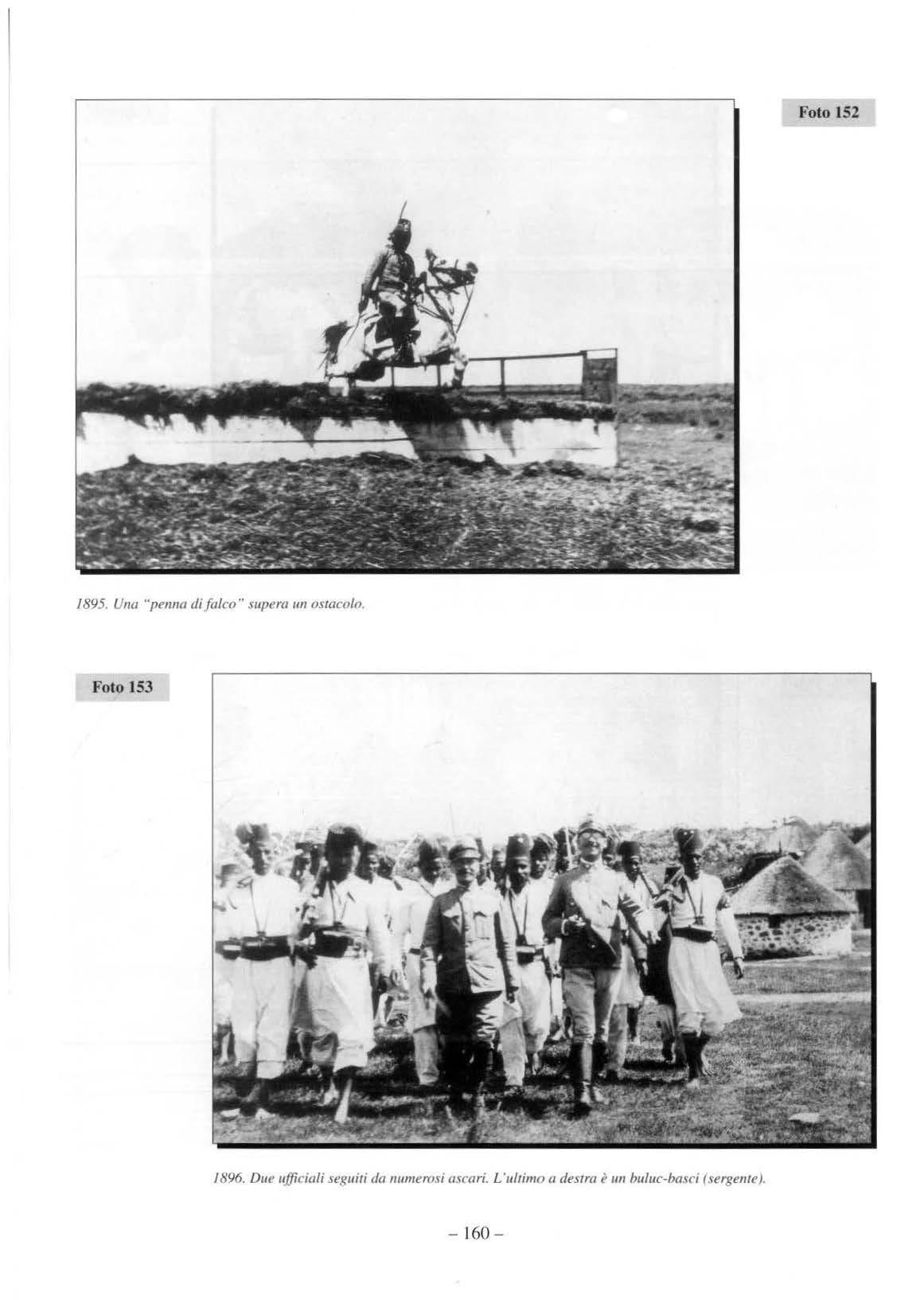
152
Foto
1895. Una "penna di falco" supera un ostacolo.
Foto 153
- 160 -
1896. Due uffiriali seguiti da numerosi ascari. L 'ultimo a destra è 1111 buluc-basci (sergente).
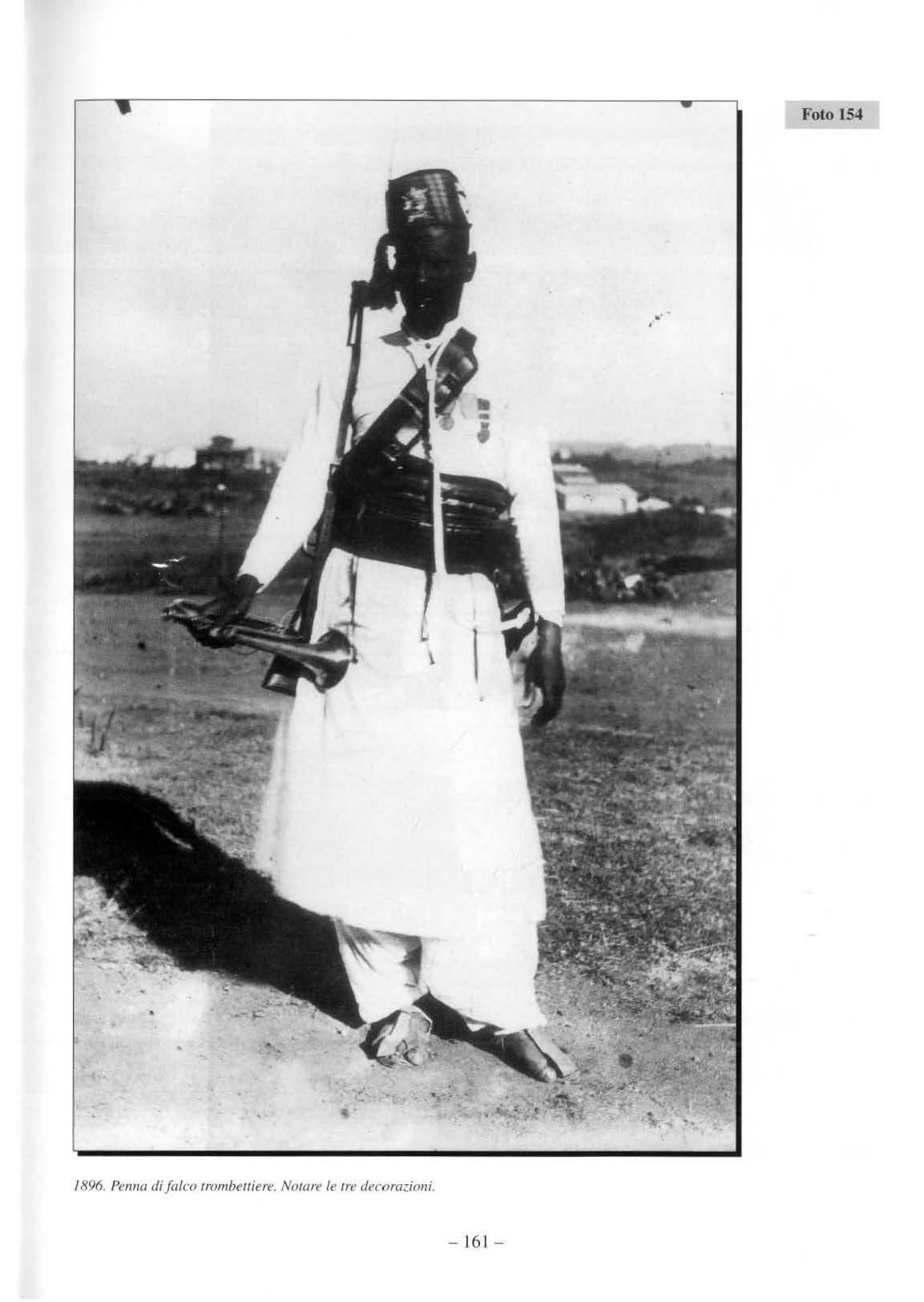
Foto 154
- 16 1 -
/896. Penna di falco trombeuiere. Notare le tre decora-;.ioni.
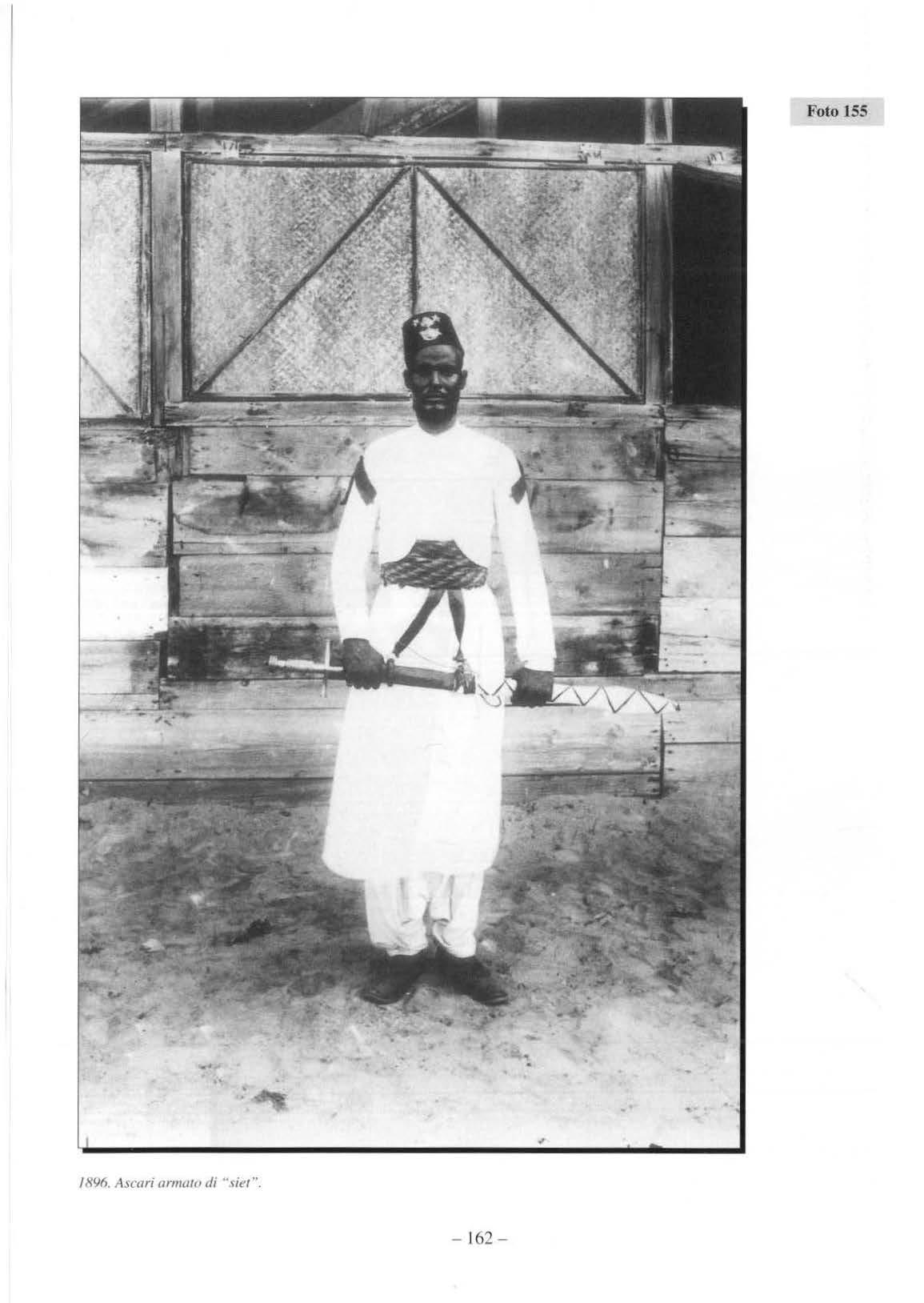
Foto 155
- 162 -
1896. Ascari ormaw di "siet''
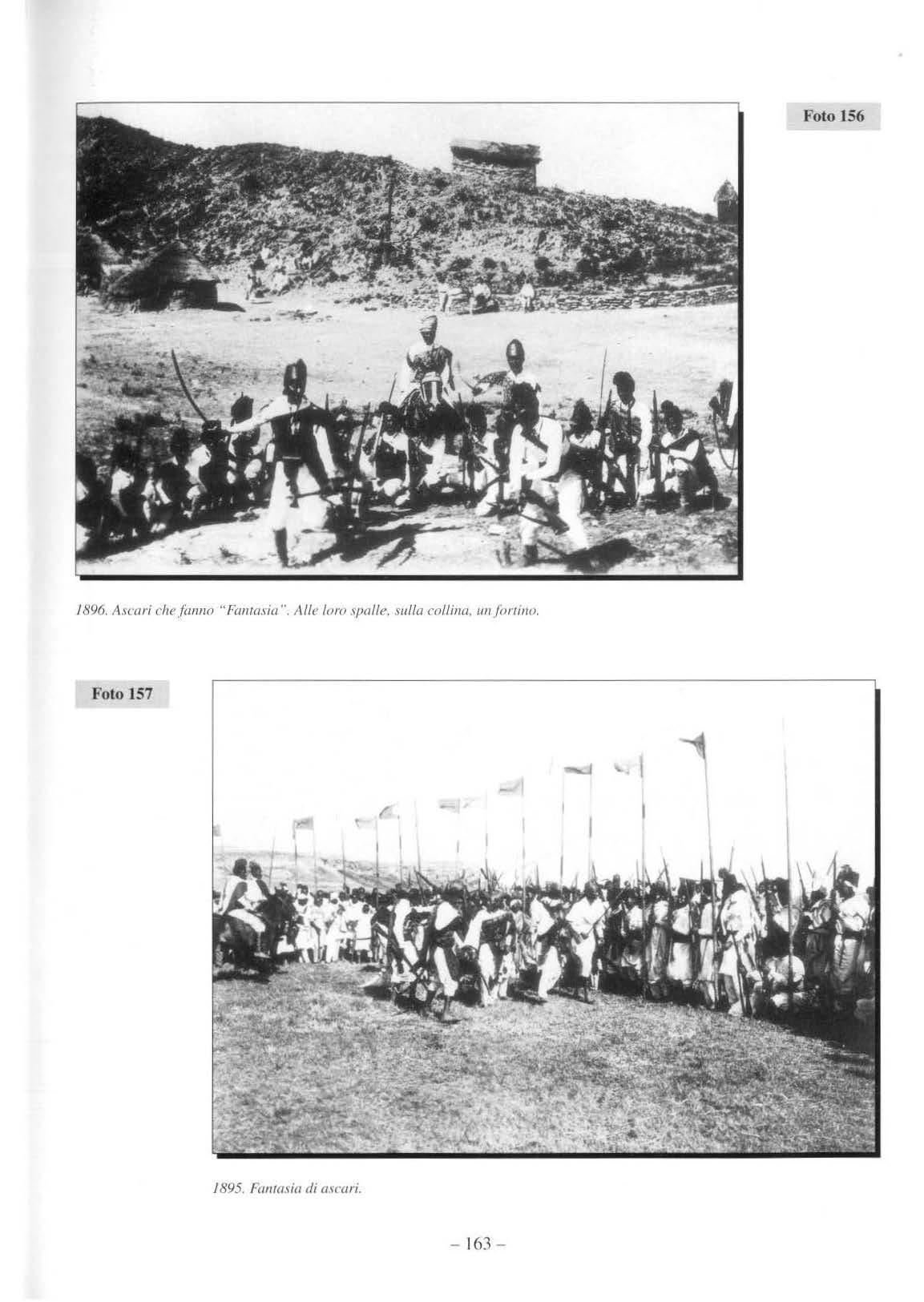
156
Foto
1896. A.1cari c!Jefcmno "Fantasia". Alle loro spalle SII Ila collina, 1111.{ortino.
Foto 157
- 163 -
/895. Famasia di a.vcari.

CARABINIERI E ZAPTIÈ


 Foto 158
1894. Carabinieri e :.aptiè.
Foto 159
Foto 158
1894. Carabinieri e :.aptiè.
Foto 159
-
- 167 -
A smara /895. Forte Baratieri. Un Vice Brigadiere e 1111 ca rabinie re CO li due :aptiè. Tutti sono armati di m o
schetto da cai'GIIeria mod. /891.
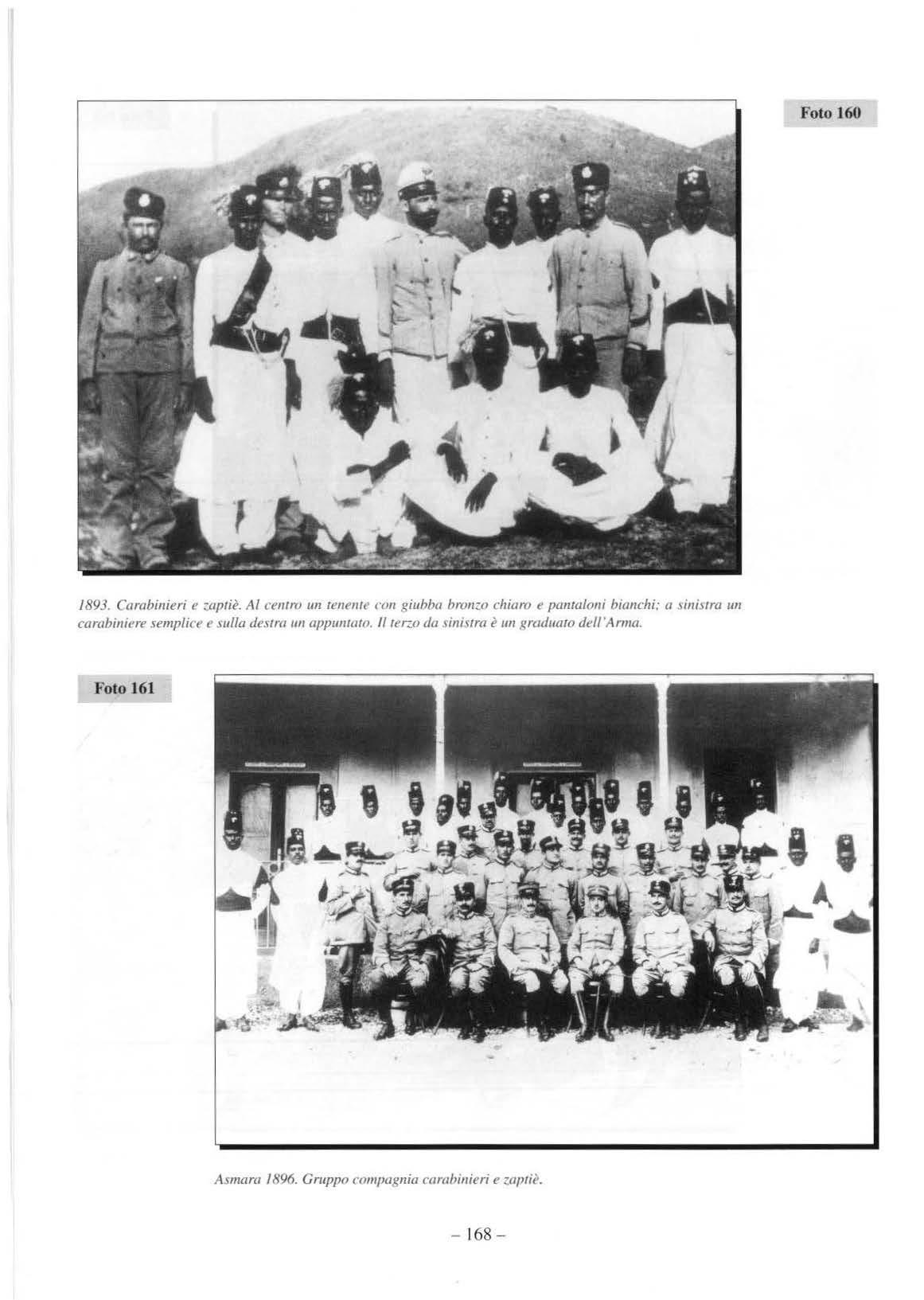 /893. Carabinieri e ::.aptiè. Al cemro 1m tenente con giubba btvnz.o chiaro e pantaloni bianchi; a 1m carabiniere semplice e :.u((a destra 1111 appuntato. lf ter..o da è 1111 gradua w de(( 'Arma.
Foto 161
Asmara 1896. Grttppo compagnia carabinieri e ::.aptiè.
/893. Carabinieri e ::.aptiè. Al cemro 1m tenente con giubba btvnz.o chiaro e pantaloni bianchi; a 1m carabiniere semplice e :.u((a destra 1111 appuntato. lf ter..o da è 1111 gradua w de(( 'Arma.
Foto 161
Asmara 1896. Grttppo compagnia carabinieri e ::.aptiè.
- 168-
Foto
160
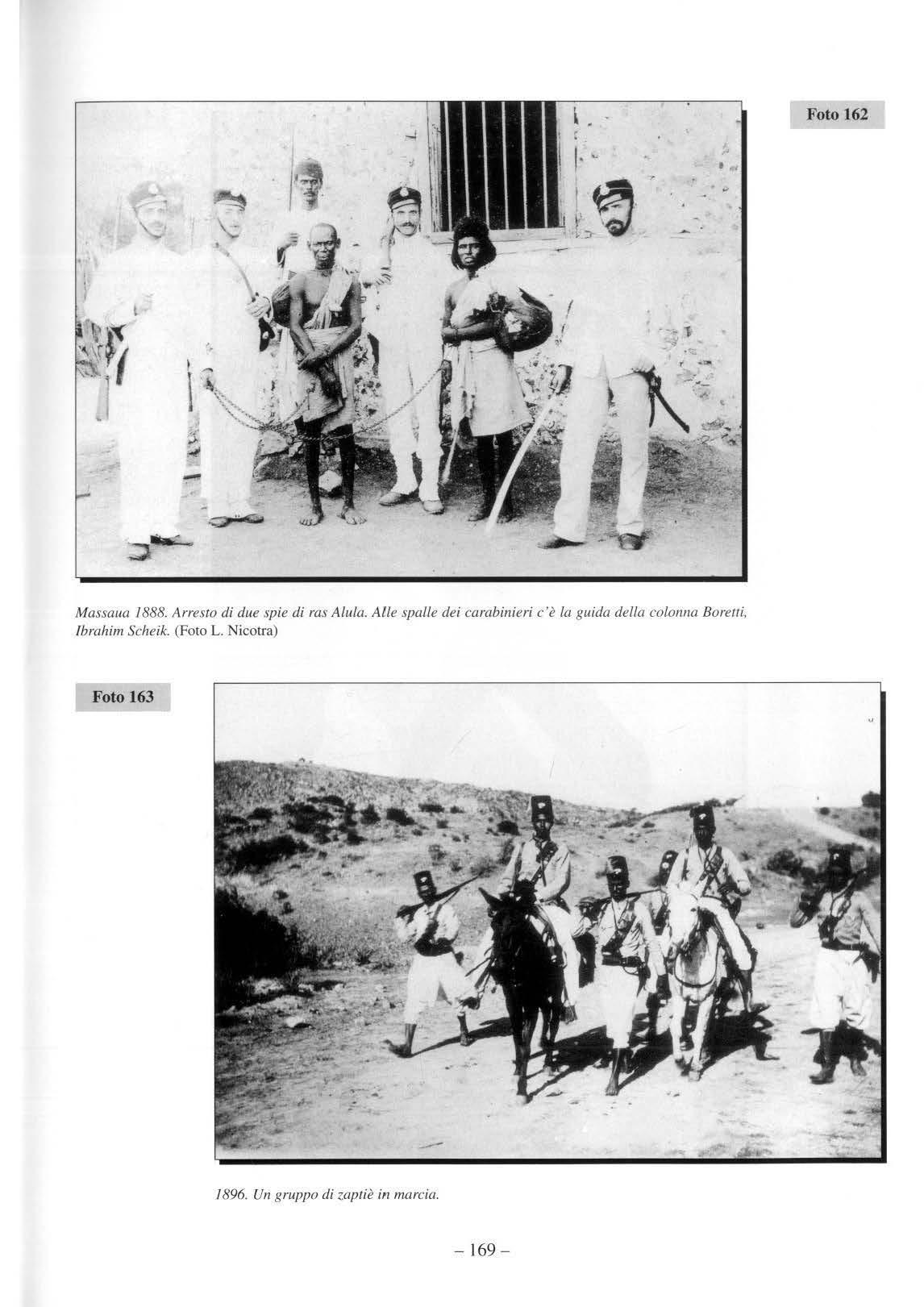
l l -
Massaua 1888 Arresto di due spie di ras Alula. Alle spalle dei carabinieri c'è la. guida della colonna Bore/li. Ibrahim Scheik. (Foto L. Nicotra)
Foto 163
- 169 -
1896. Un gruppo di zaptiè in marcia
,,
Foto 162

Foto 164
- 170 -
Massaua /895 Il Teneme Mario Abba dei carabinieri in grande tmiforme coloniale estiva.
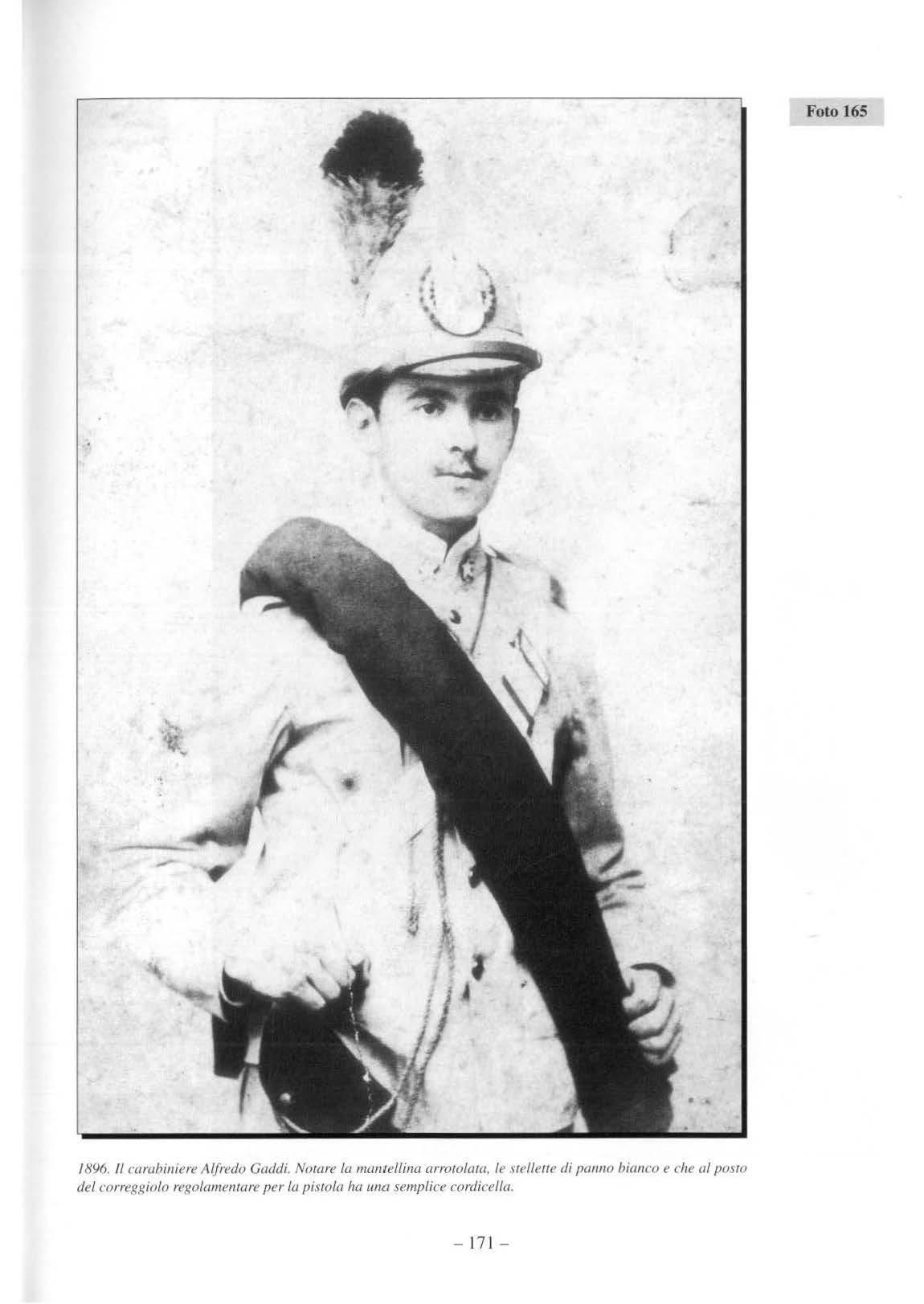
. ..
- 17 1Foto 165
18Y6. Il mrabiniere Alfredo Caddi. Notare la manlellina arroto/ma le stelielle di panno bianco e cl1e al posto del correggio/o regolamentare per fil pis tola Ila una semp lice cordicella.
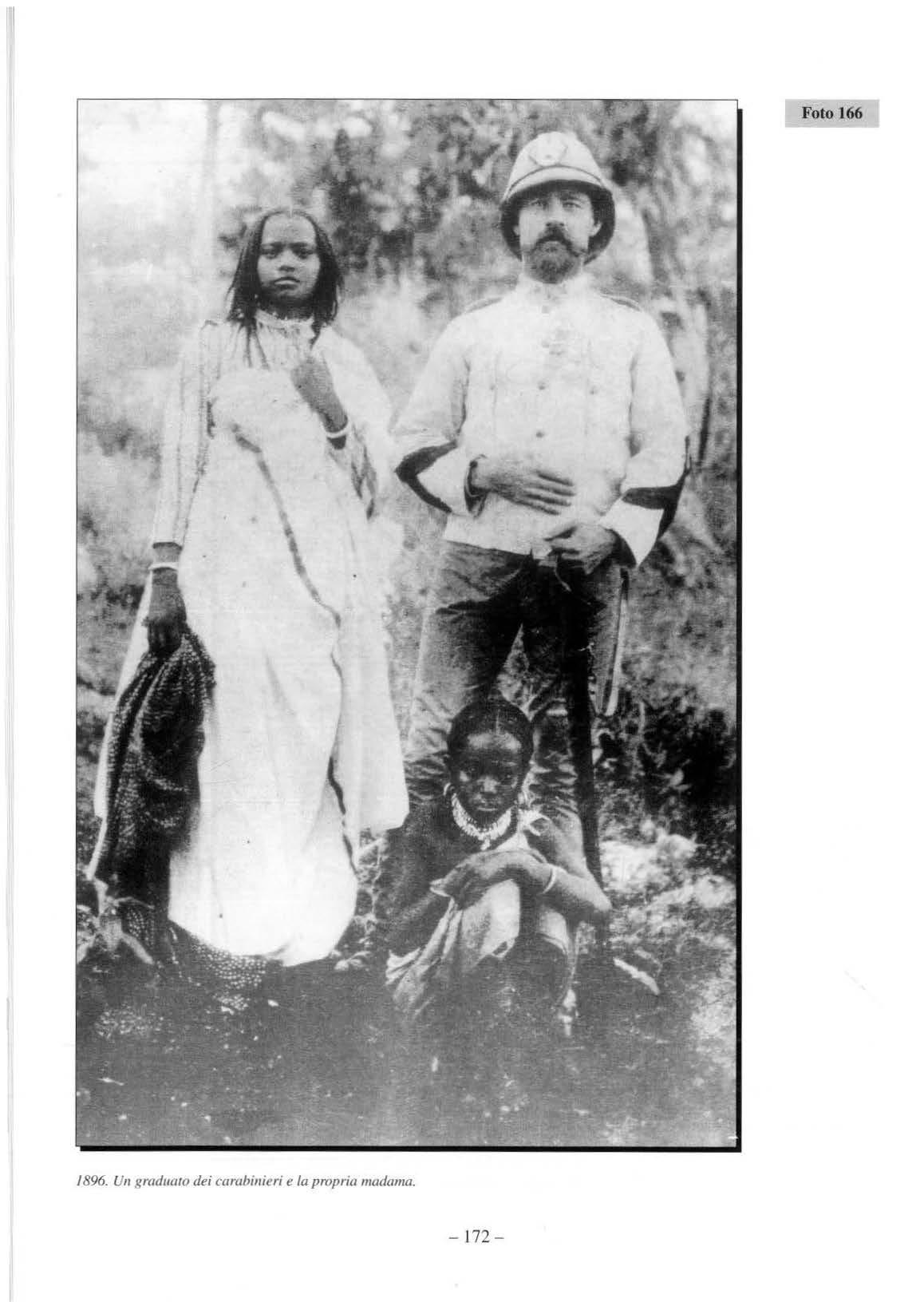
Foto 166
- 172-
/896. Un graduato dei carabinieri e la propria madama.
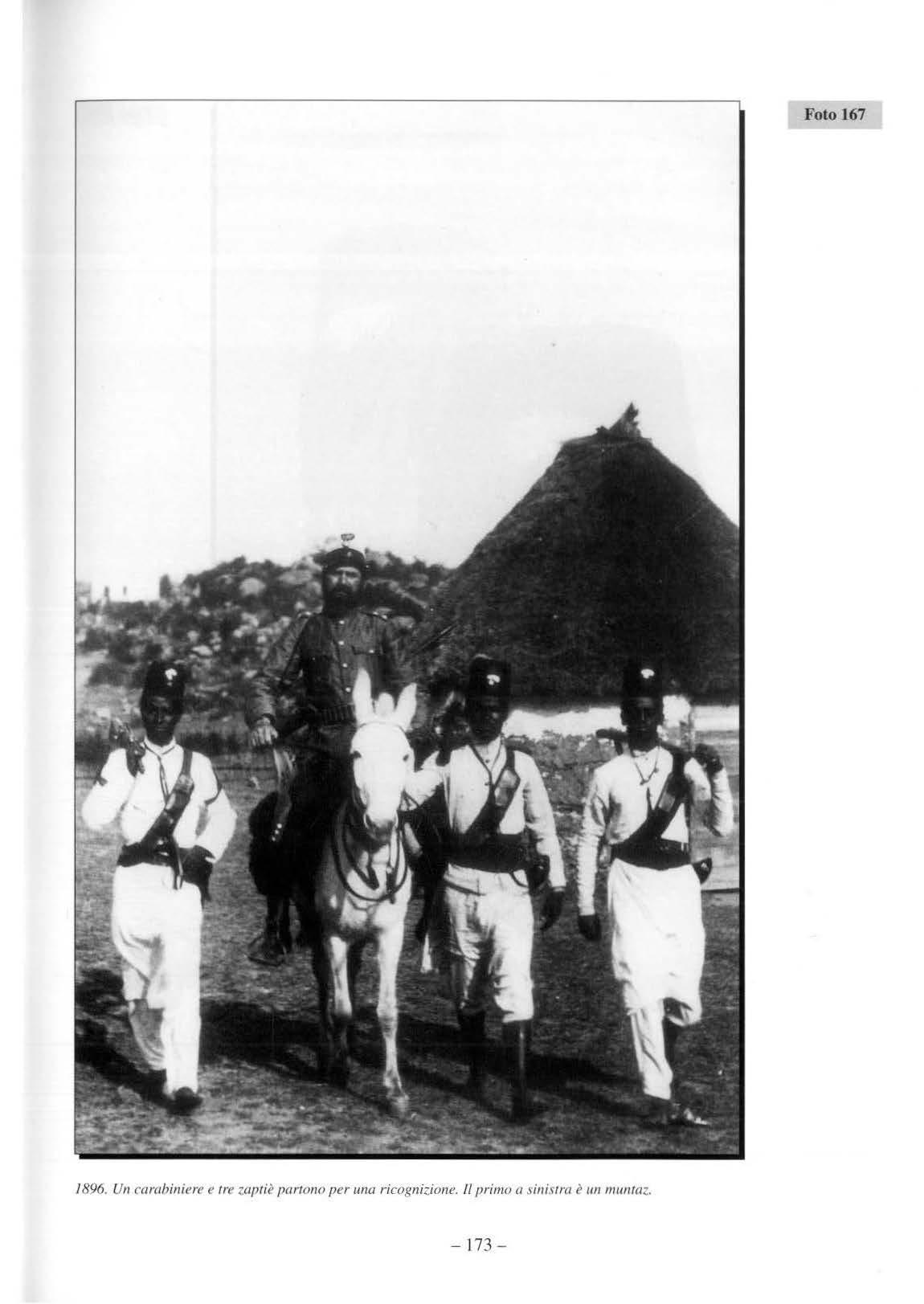
Foto 167
- 173-
1896. Un carabiniere e tre zaptiè partono per una ricognizione. Il primo a sinistra è 1111 1111111ta z

Foto 168
- 174 -
1894. Primo piano di 11110 :aptiè.
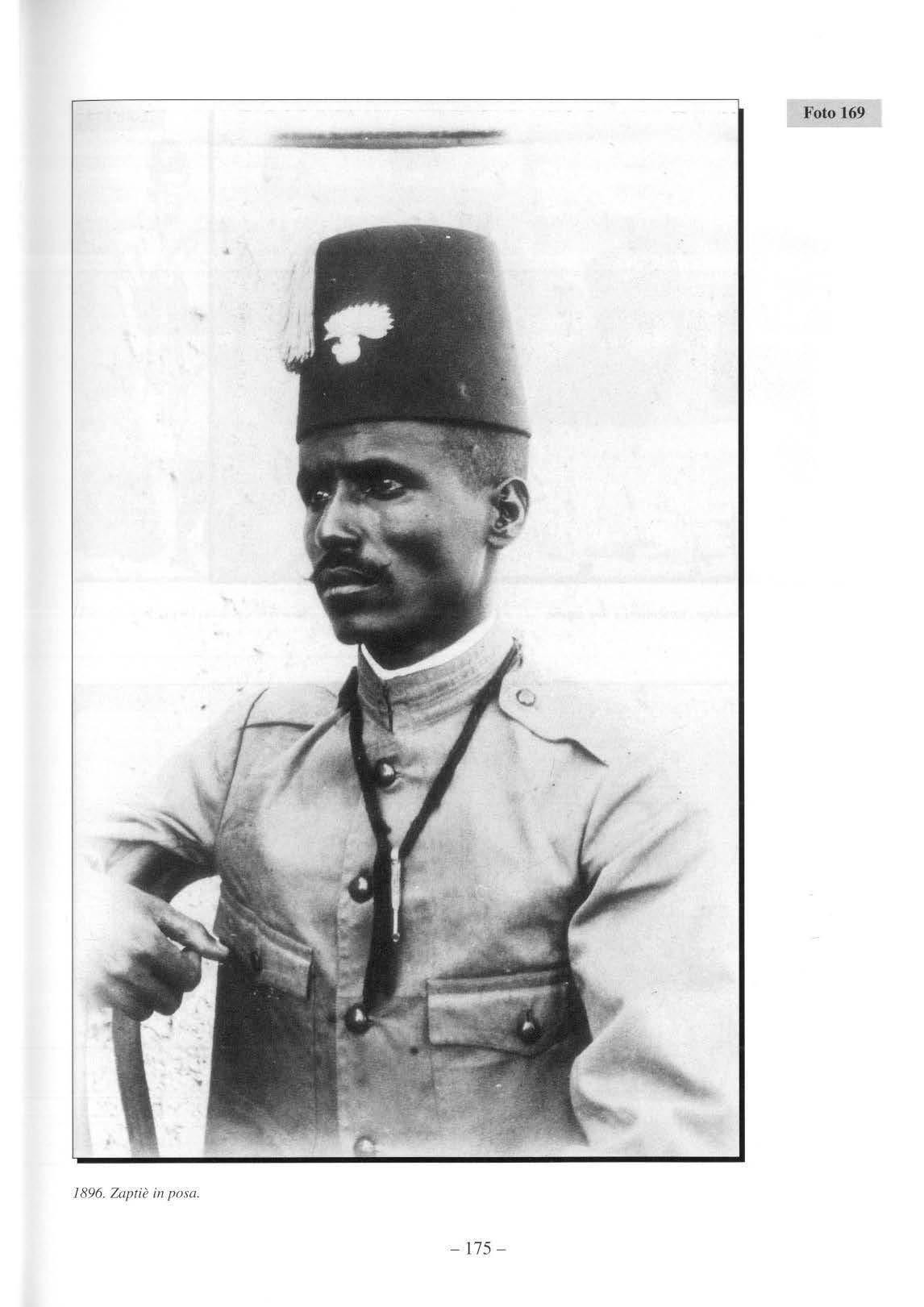
Foto 169
- 175 -
1896. Zapriè in posa.
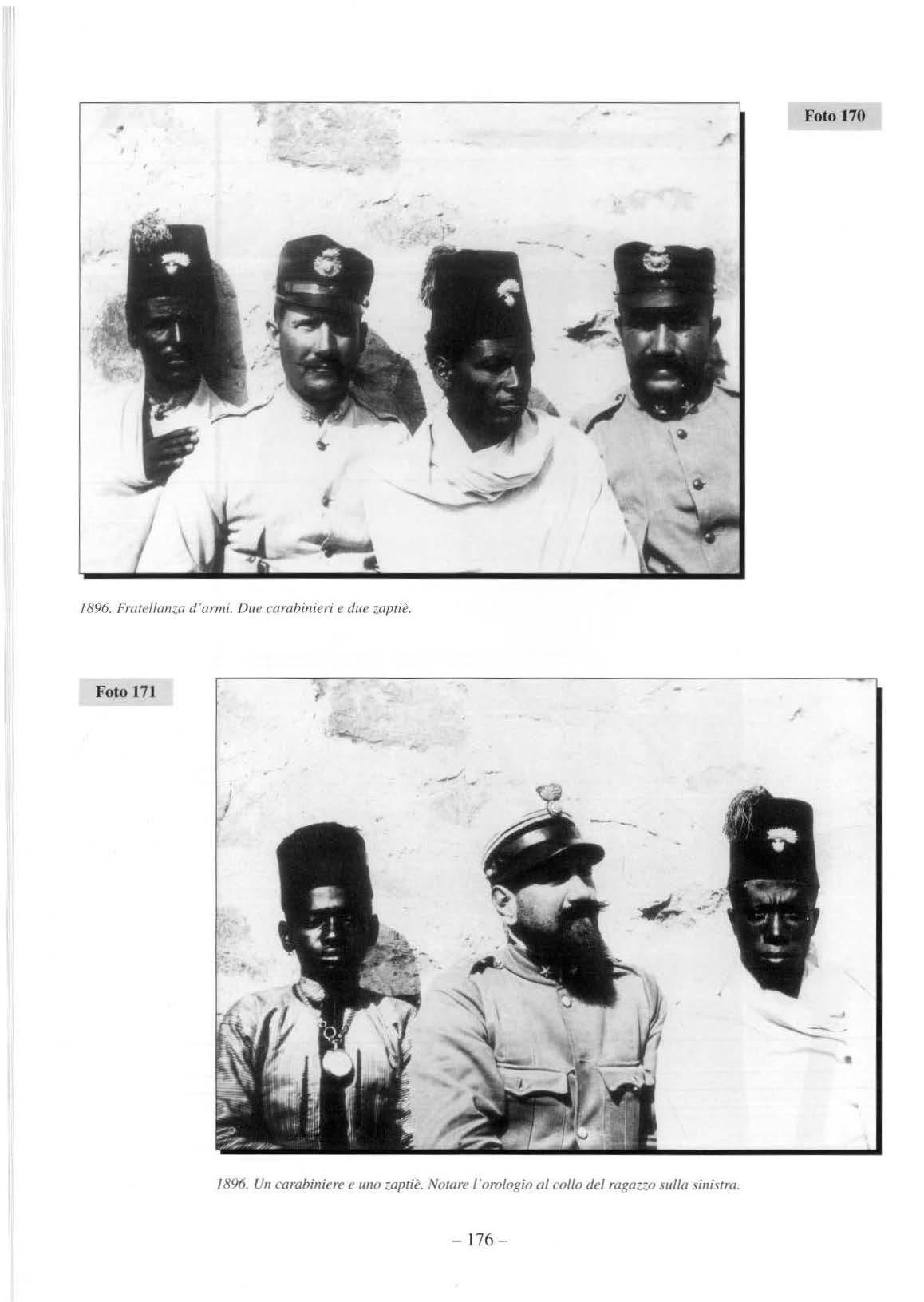
Foto 170
/896. Frare/lanza d'am1i. /)up ('arabi nieri e due :aptiè.
•
Foto 171 , ,.
- 176 -
1896. Un carabiniere e uno ::aptiè. Notare l'orologio al collo del wl/a sinistra.
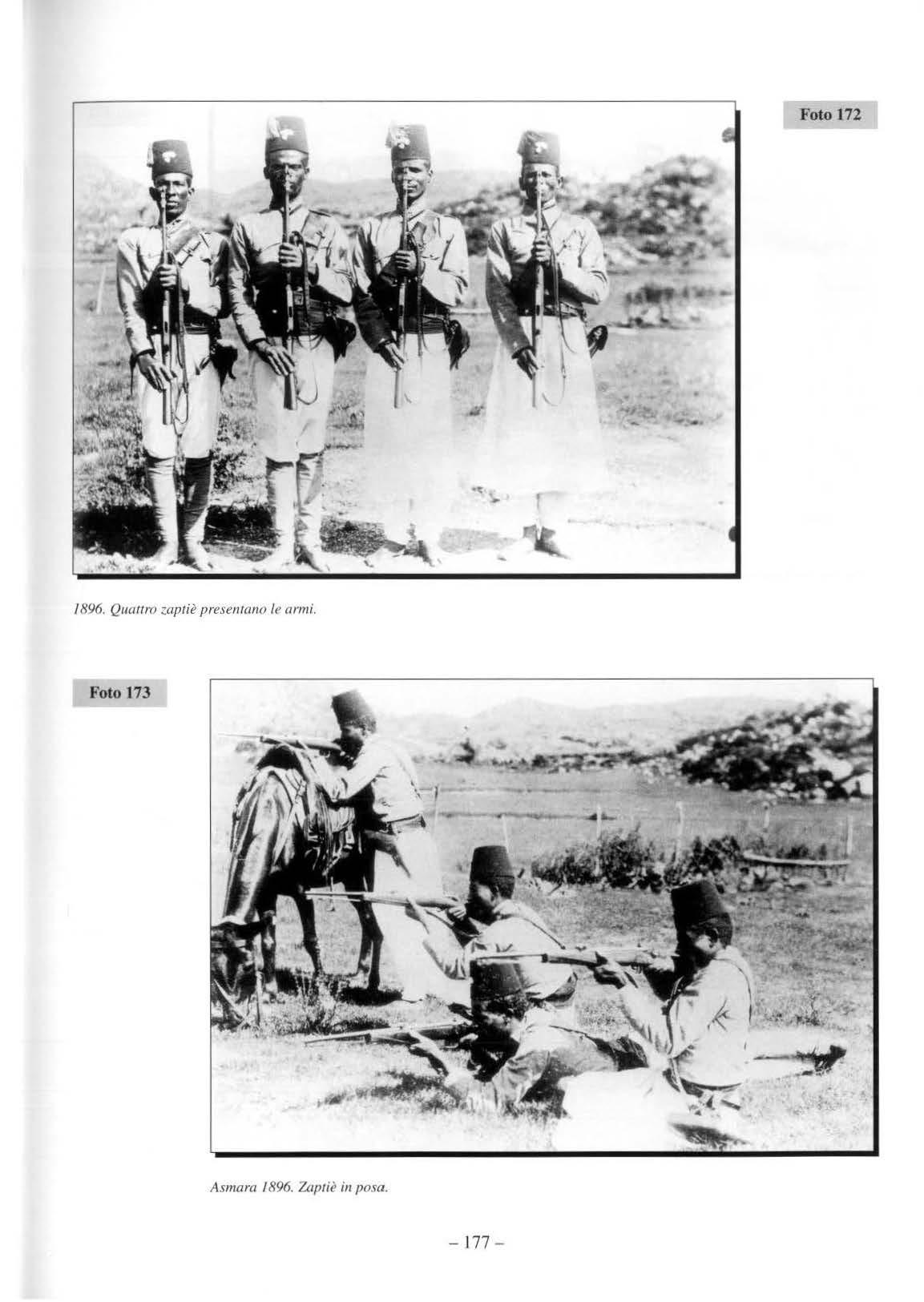
Foto 172
l 896. Quattro zaptiè presentano le armi.
173
Foto
- 177 -
Asmara 1896. Z(lptiè in posa.
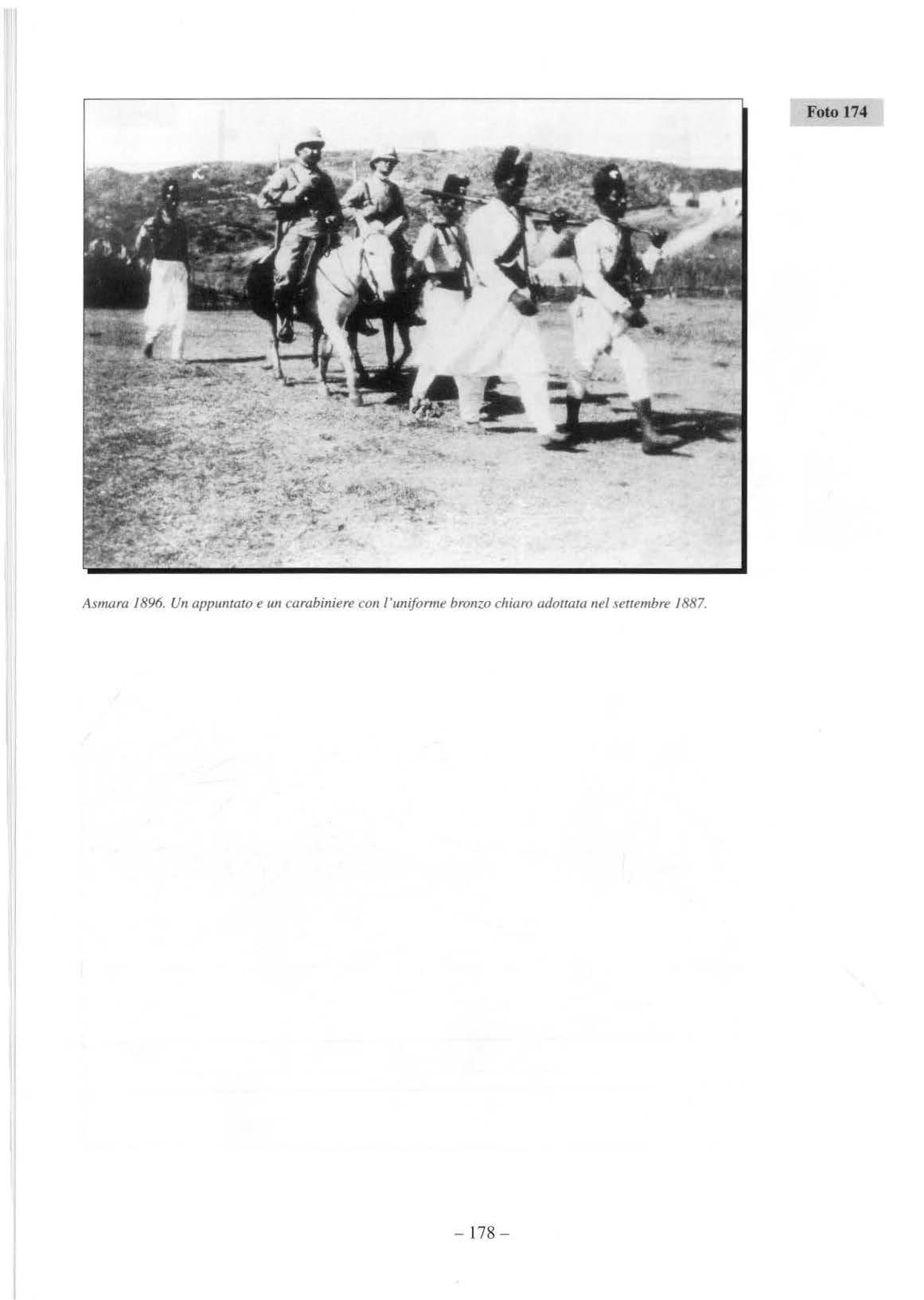
Foto 174
- 178 -
Asmara 1896. Un appuntato e tm carabiniere co11 /'u11iforme chiaro adottata nel settembre 1887.
LA VITA QUOTIDIANA

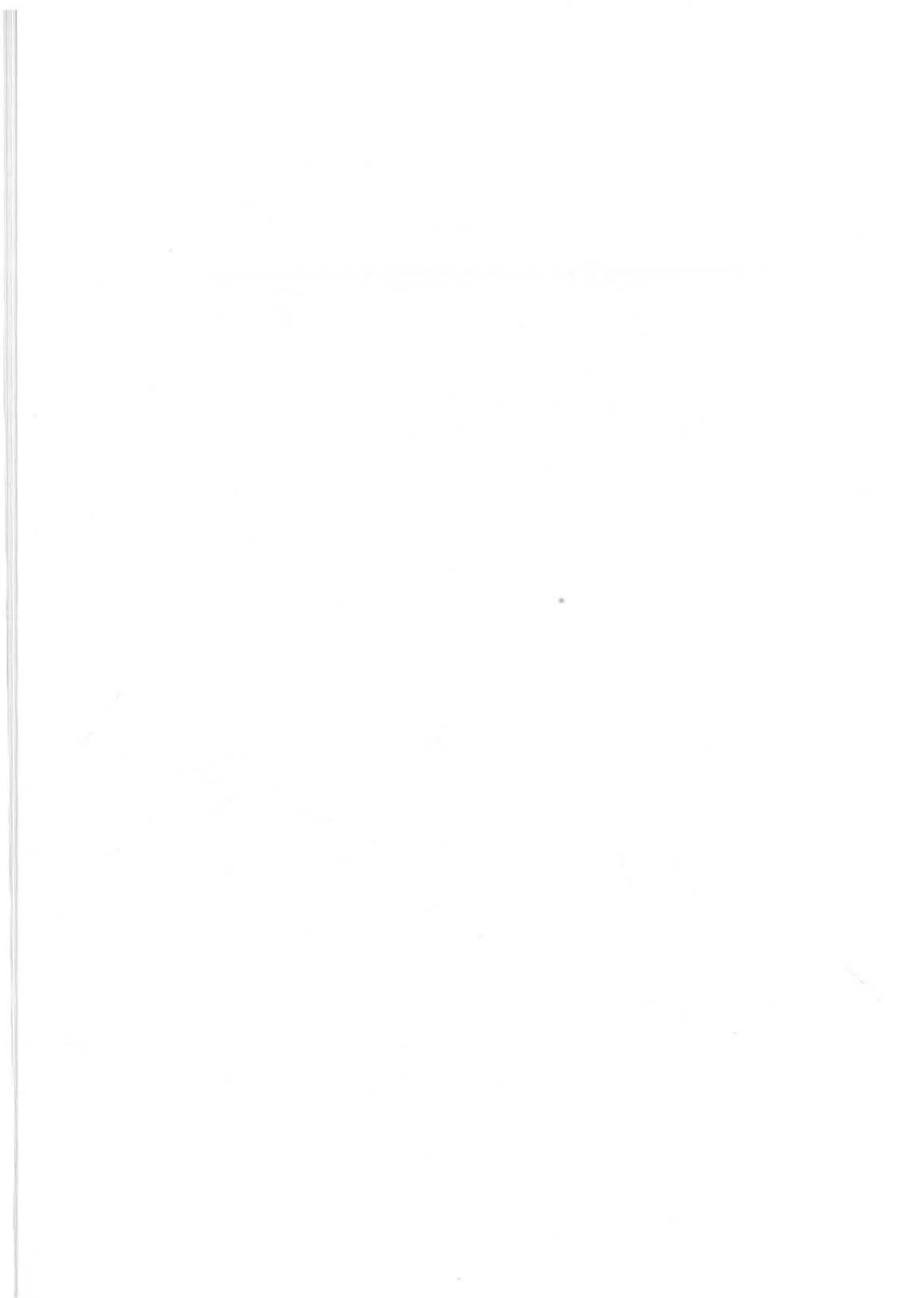
Ili
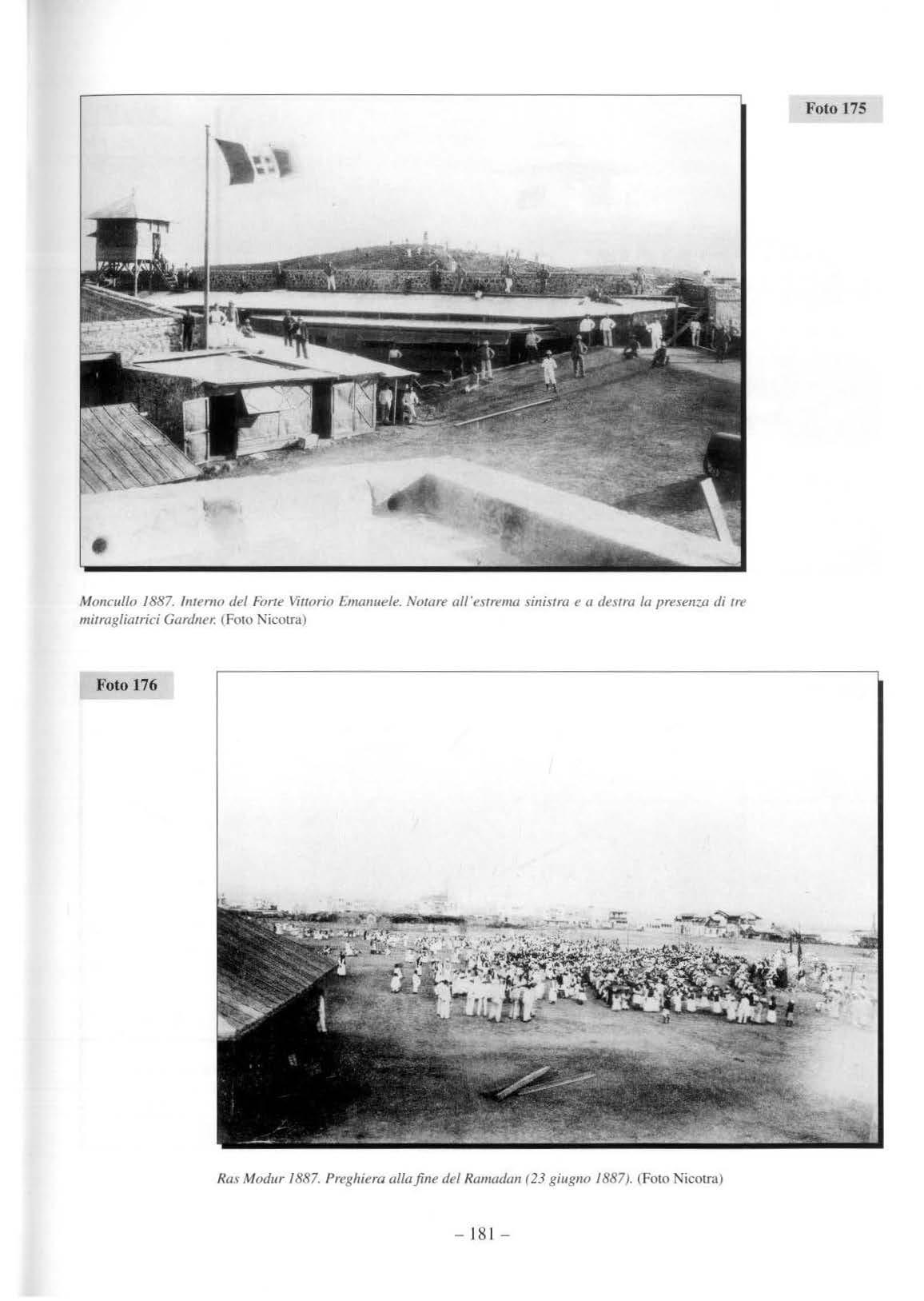 Moncullo 1887. lmemo del Forre Vìuorio Emmmele. Notare atre Hrema sinistra e a destra la presen:_a di tre mitragliatrici Gardner. (Foto 'icoLra)
Foto 176
Moncullo 1887. lmemo del Forre Vìuorio Emmmele. Notare atre Hrema sinistra e a destra la presen:_a di tre mitragliatrici Gardner. (Foto 'icoLra)
Foto 176
- 18 1 -
175
Ras Modur 1887. Preghiera a/la fine del Ramadan (23 giugno 1887). (Foto Nicotra)
Foto
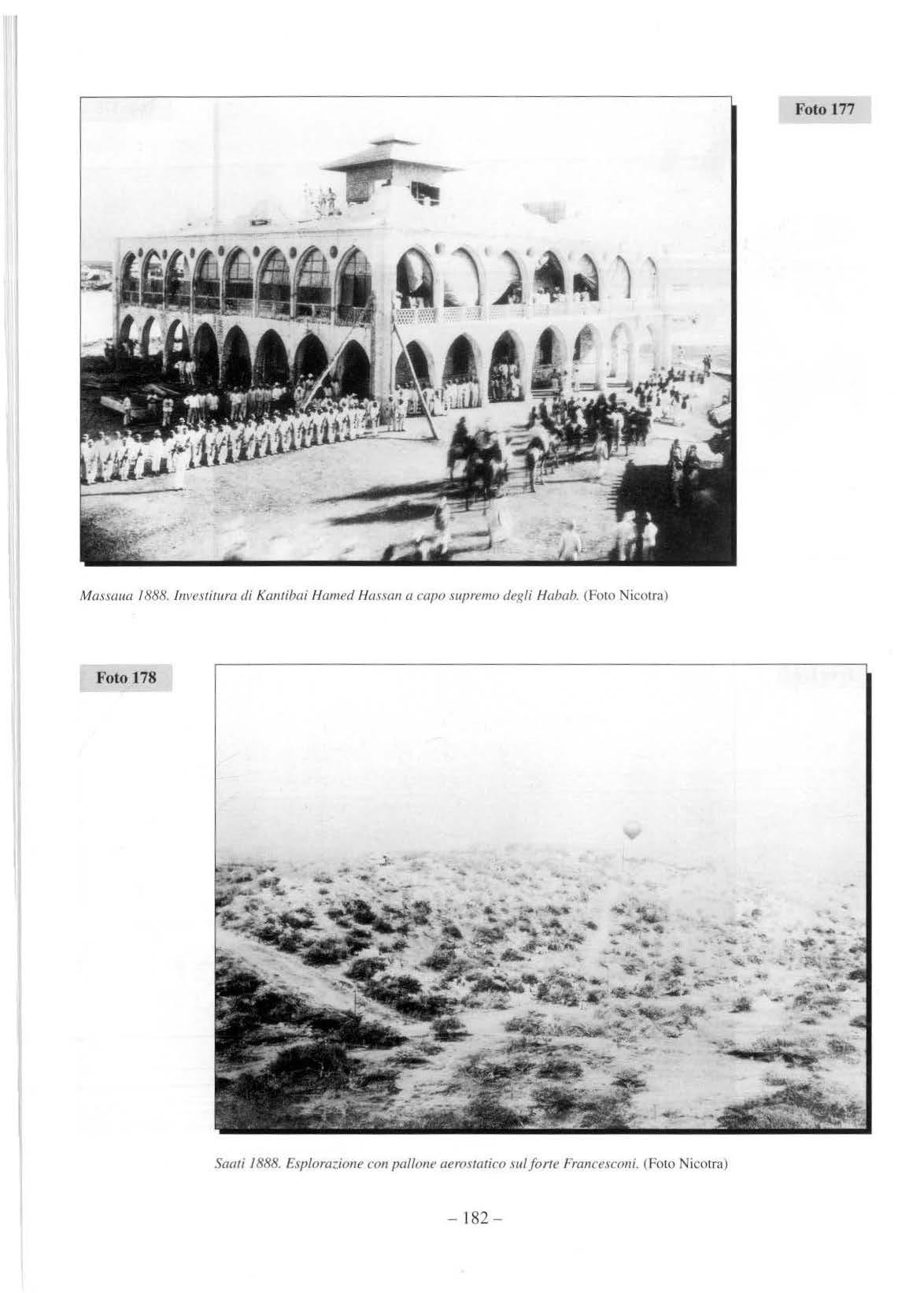
Foto 177
178
Massaua 1888. b ll'eStìtura dì Kantìhaì Hamed H assan a capo supremo degli Habab. (Foto Nicolra)
- 182-
Saari /888. Esplorazione con pallone aero sta tico :,u/ forte Francescani. (FotO Nicotra)
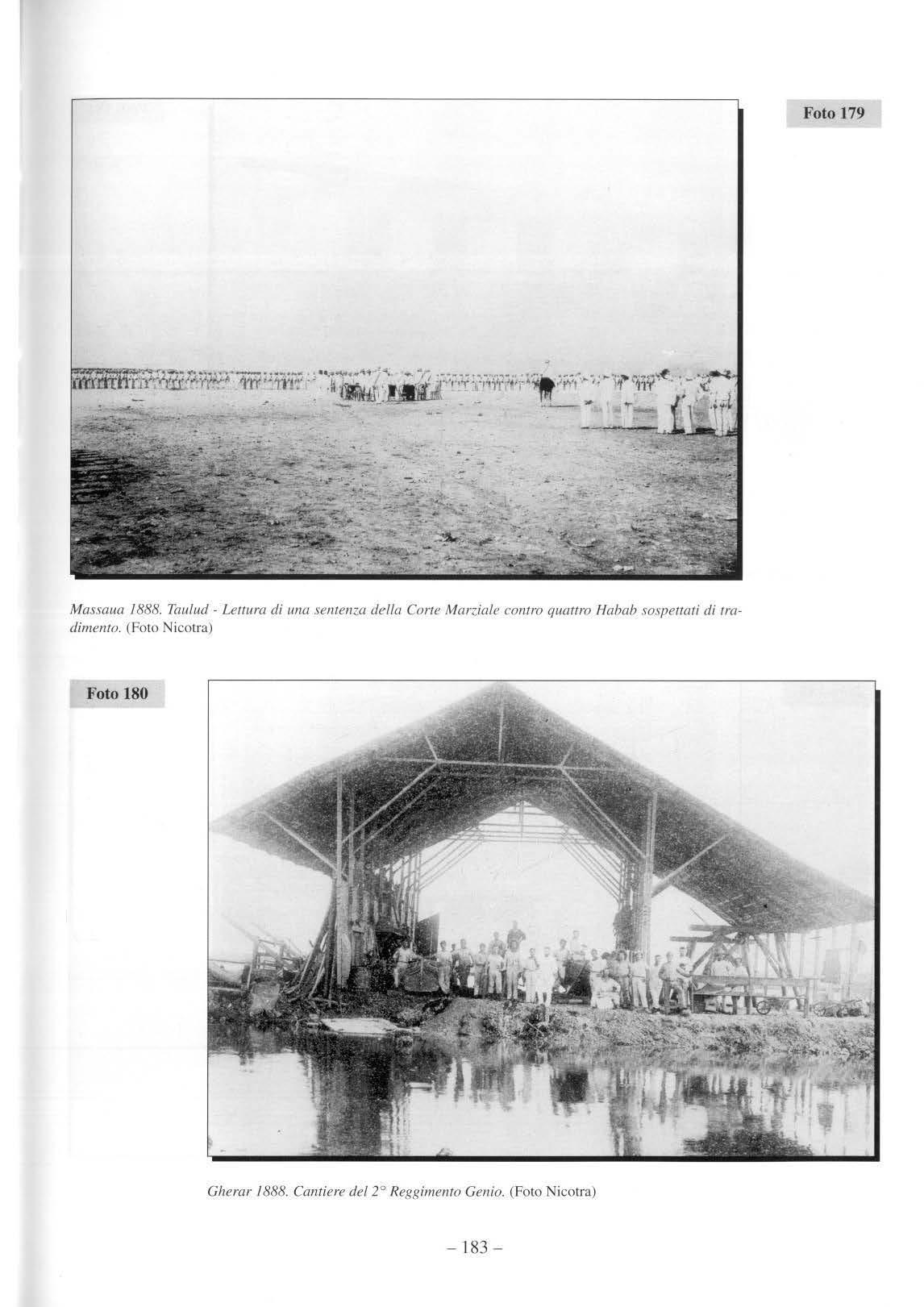 Massaua 1888. Taulud - Lellura di una sentenza della C011e Marziale contro quattro Ha!Jab sospeuati di tradimento . (Foto N ico tra)
Foto 180
Massaua 1888. Taulud - Lellura di una sentenza della C011e Marziale contro quattro Ha!Jab sospeuati di tradimento . (Foto N ico tra)
Foto 180
- 18 3 -
Gherar 1888. Camiere de/2 ° Reggimento Genio. (Foto Nico rra)
Foto
179
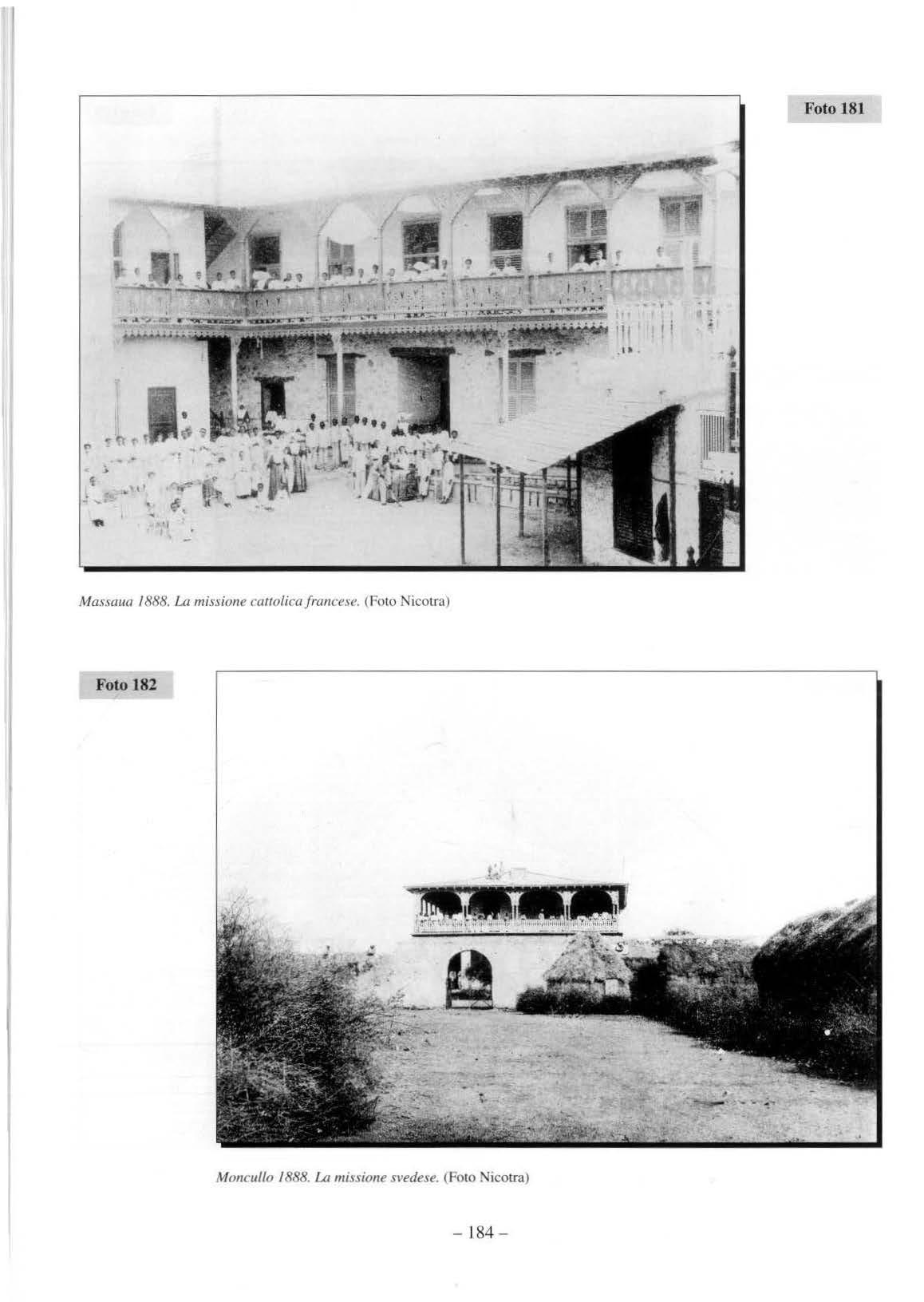
181
Foto
Massaua 1888. La mission e ca rro/i cafran cese. ( Foto Nìcotra)
Foto 182
- 184 -
M oncullo 1888. La missione svedese. (Fo to ìcotra)

F oto 183
Moncullo 1888. La della missione wedese. R aga::::.e a/lm·oro. (Foto icotra)
Foto 184
-185-
Gh ebeb 1889. Musicanti M ensa. (Fo to Nicotra)
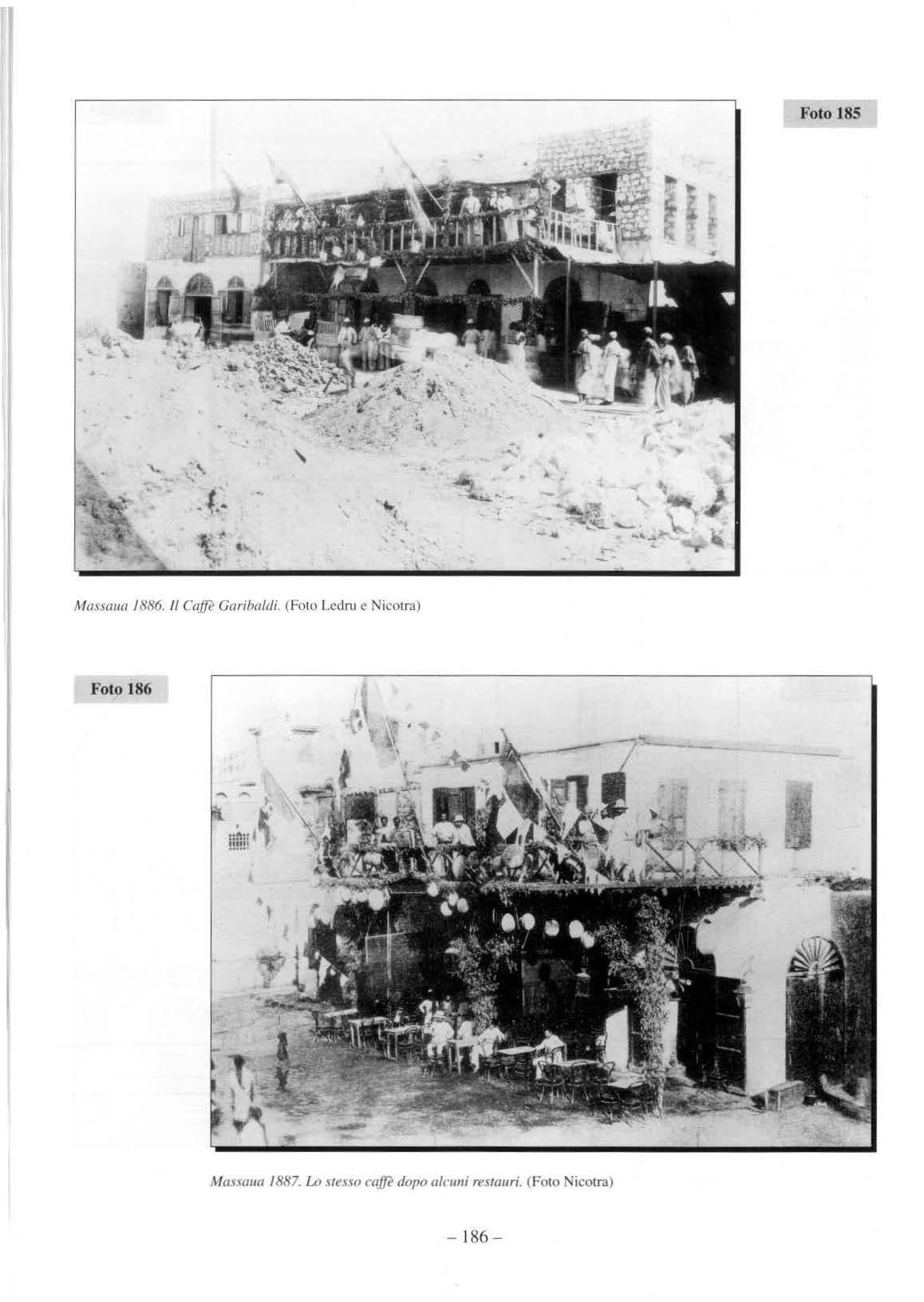 Massaua 1886. Il Caffè Garibaldi. (Foto Lcdru e Nicotra)
Massaua 1886. Il Caffè Garibaldi. (Foto Lcdru e Nicotra)
!!!!!l .,
Foto 186
Mas.1aua 1887. w stesso caffè dopo alcuni restauri. (Foto icotra) -
186-
Foto 185
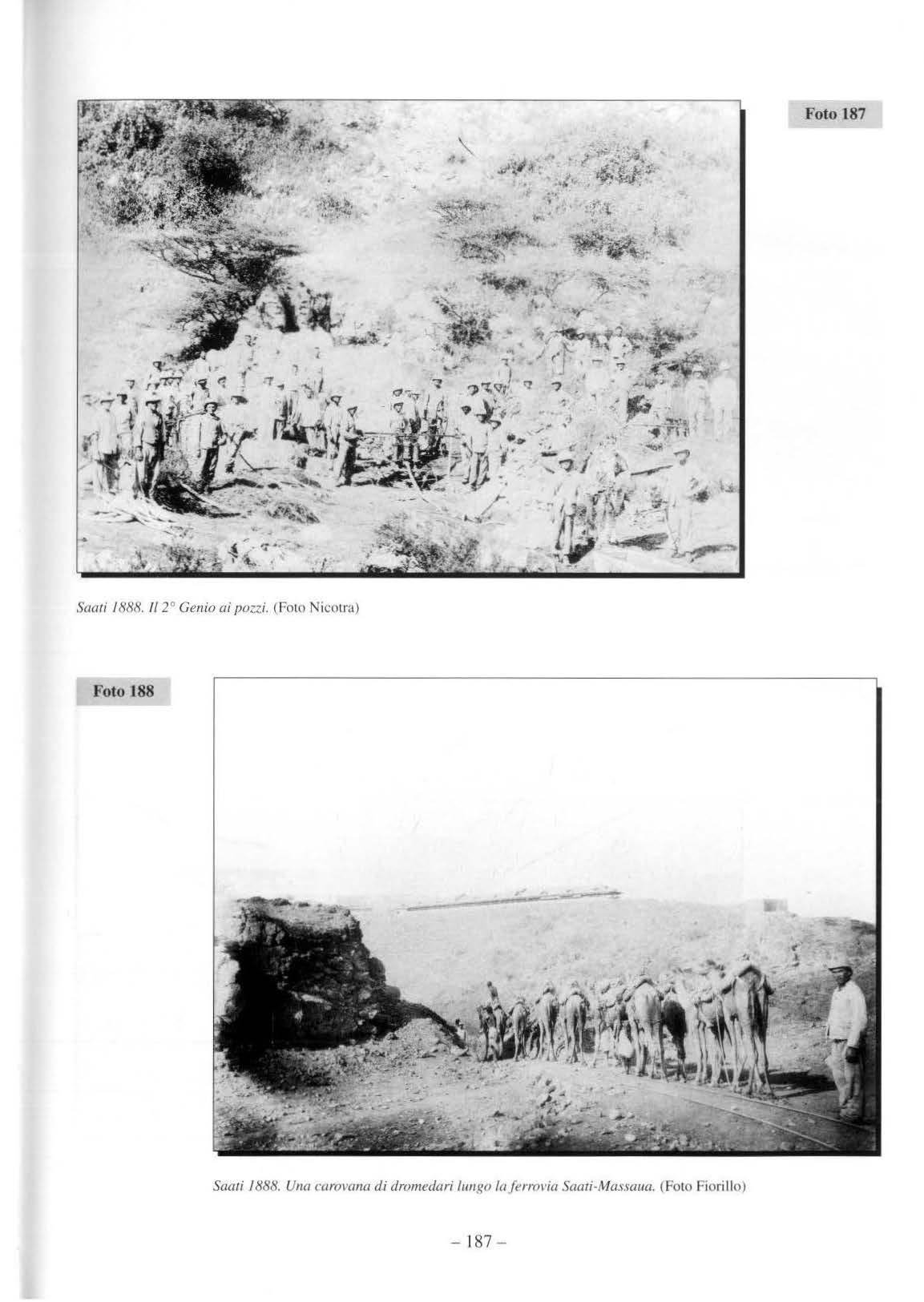
Foto 187
Saati 1888. 1/2 ° Genio ai po:;.z.i. (Fo10 NicoLra)
Foto 188
- 187 -
Saari 1888. Una c wm•c11w di dromedt1ri lungo laferrol'ia Saati -Massaua. (Foto Fiori i lo )
Saati l 888. Poggio /)a/dissera. Alcuni corrispondenti della stampa nazionale Molti furono i giomali.lli che si awicendarono in quegli anni: Scwfoglio. Moti/de Serao. Mert:a telli. Cora:,;:.im, Be/credi, Norsa, Camperio, Ximenes , Del Valle, Di Gennaro. ecc. (foto Fiorillo)
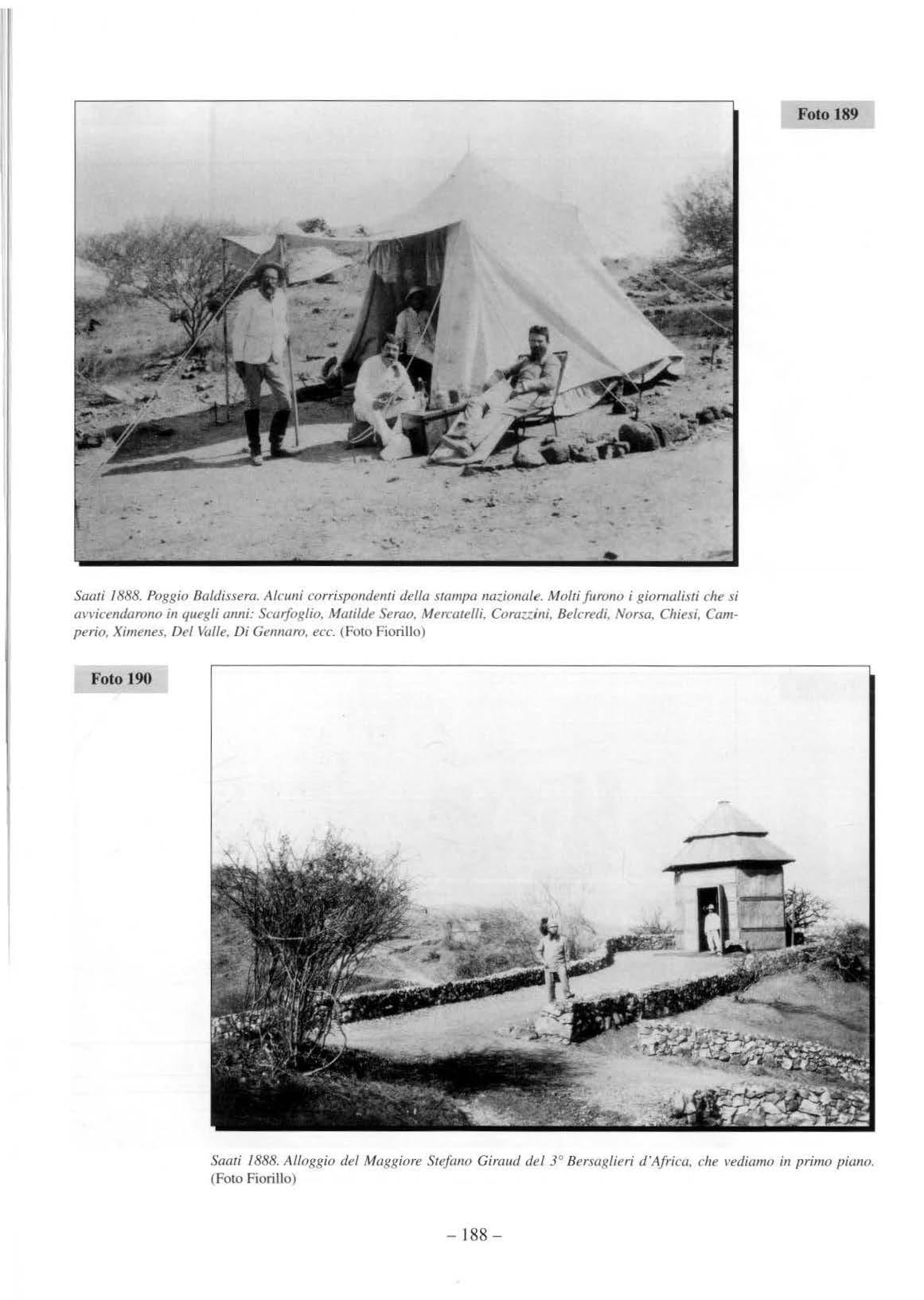
189
Foto 190
Foto
- 188-
Saati 1888. Alloggio del Maggiore Stefano Giraud del 3 ° Bersaglieri d'Africa, eire vediamo in primo piano ( Foto Fiori Ilo )
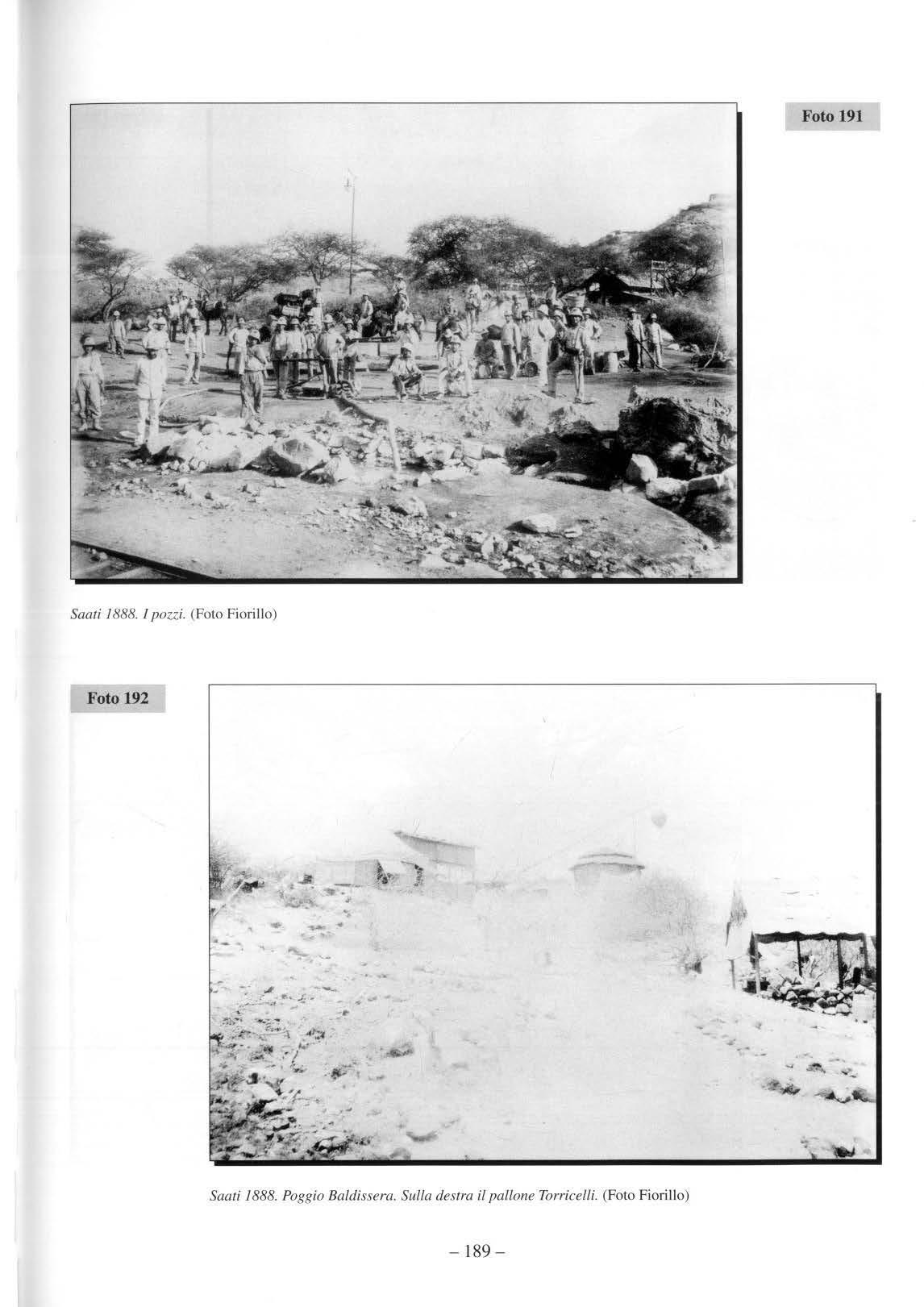
191
Foto
Saati 1888 l pozzi. (Foto Fiorillo )
..
Foto 192
- 189 -
Saati 1888. Poggio Baldissero Sulla destra il paflone Torrice/li. (Foto F iori Il o)
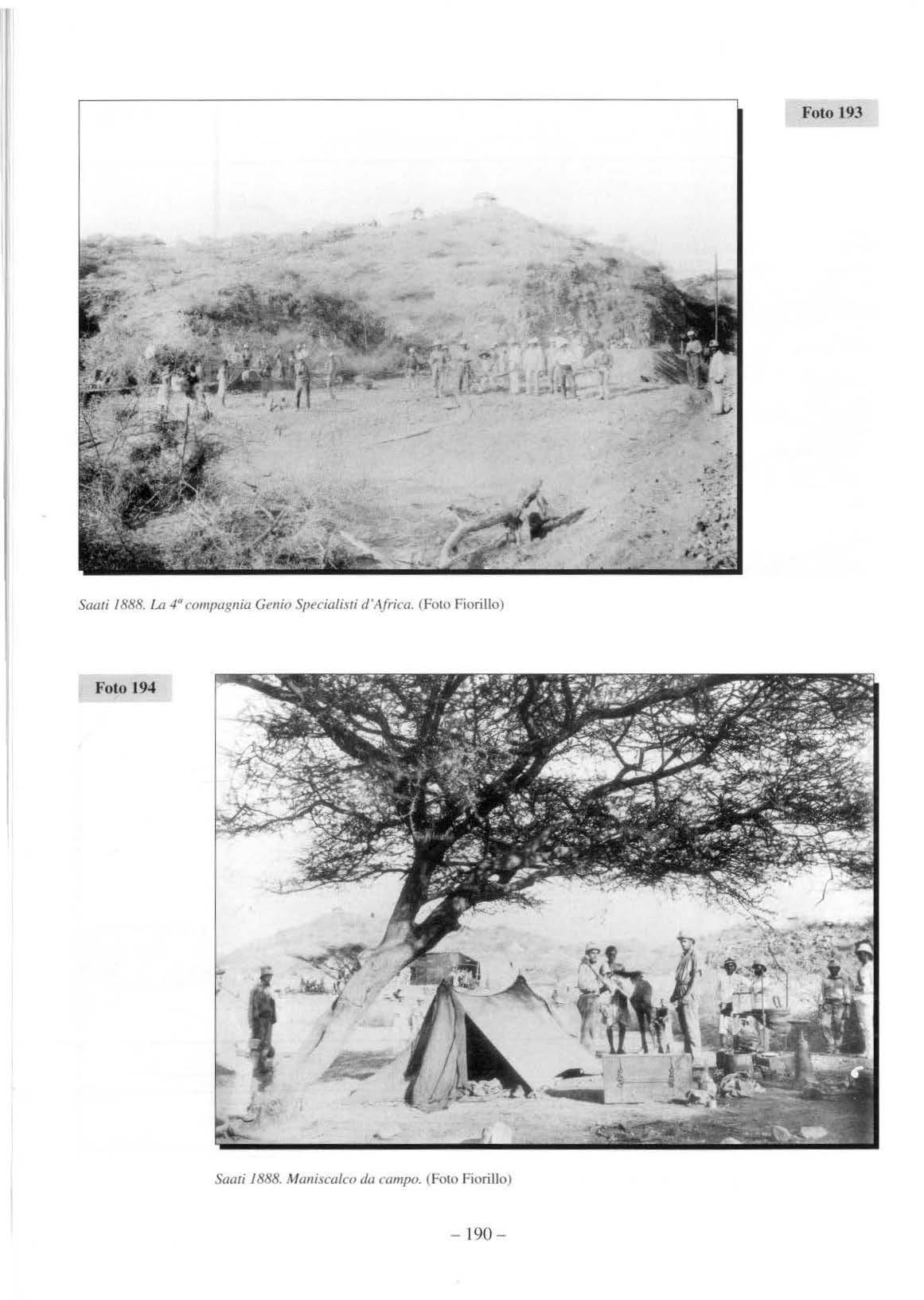
193
Foto
Saali l 888. La 4a compagnia Genio Specialisli d'Africa. (Foto Fiori ilo)
Foto 194
- 190 -
Sami 1888. Maniscalco da campo. {Foto Fiorillo)
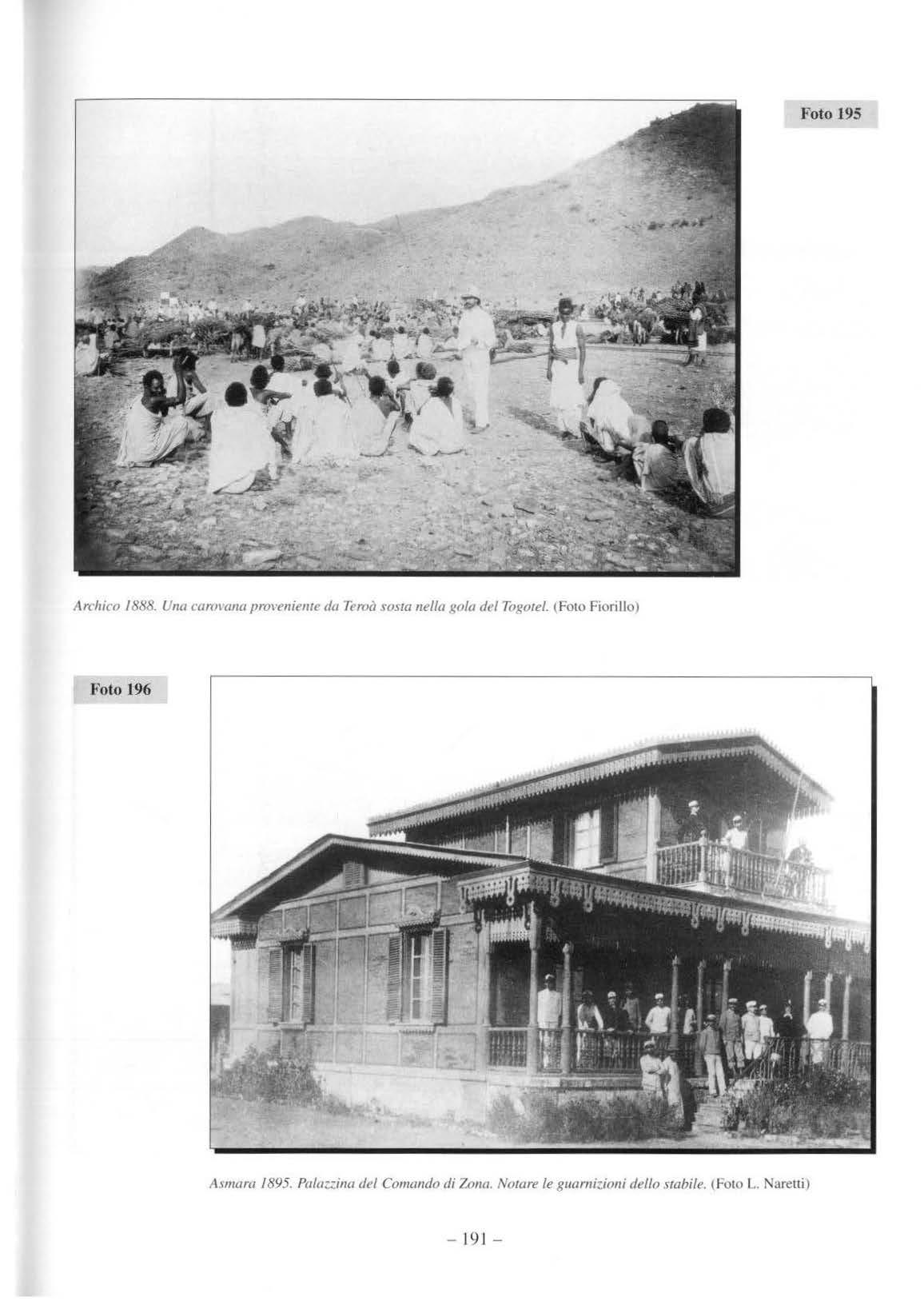
195
Foto
196
Arcllico 1888. Una caml"(lna pro,·eniente da TemlÌ sosta nella gola d('[ Togotel. (Foto Fiori Ilo) Foto
- 19 1 -
Amwra 1895. Pala::.:ina del Comando di Zona. Nowre le guami:.ioni dello stabile. (Foto L. NaretLi)
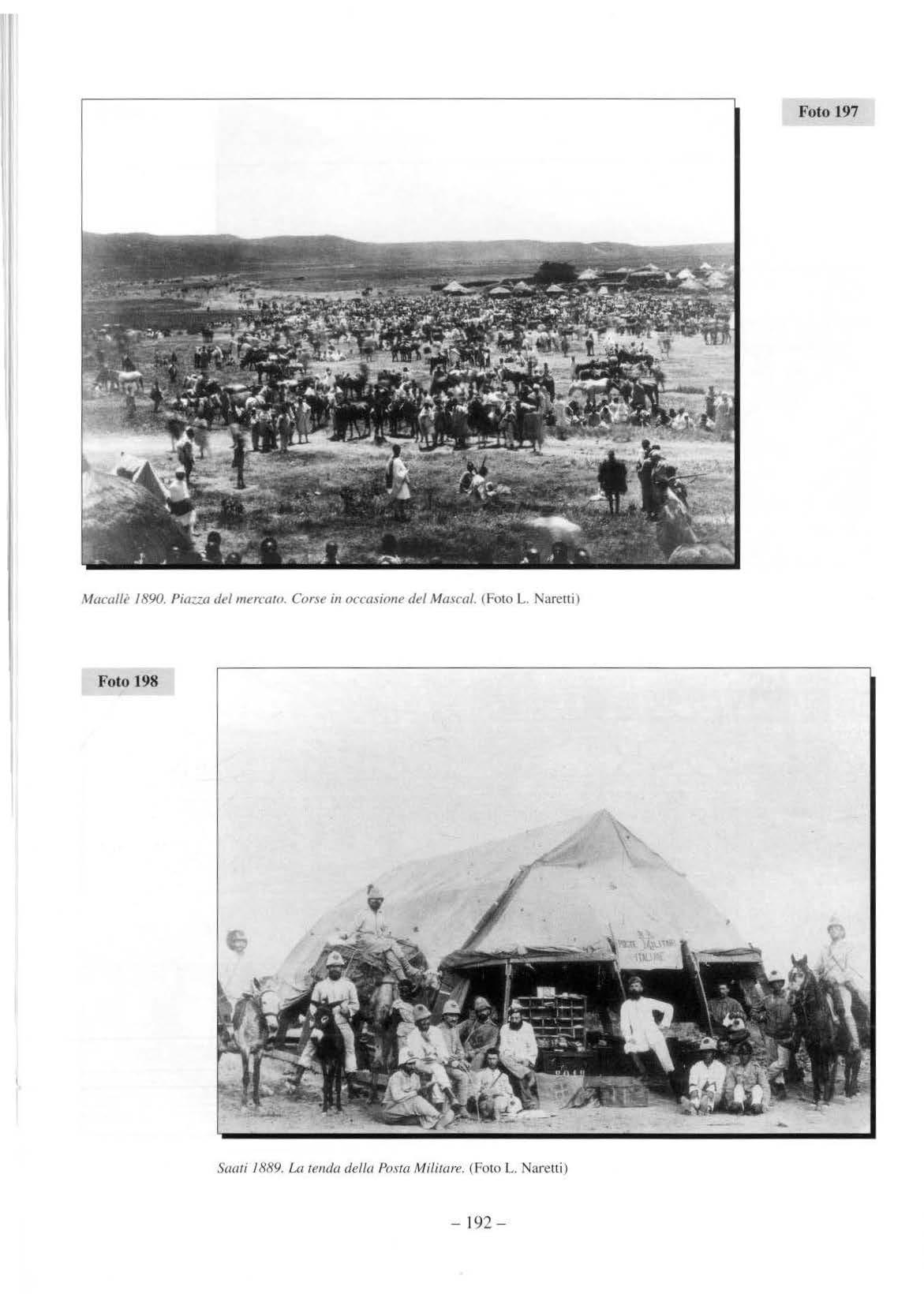
Foto 197
Macallè /890. Pia::.:.tl del mercato. in occasione del Mascal. ( l-oto L. Nareni)
Foto 198
- 192-
Saari /889. La tenda della Po vra Militare. (Fo to L Na re tti )
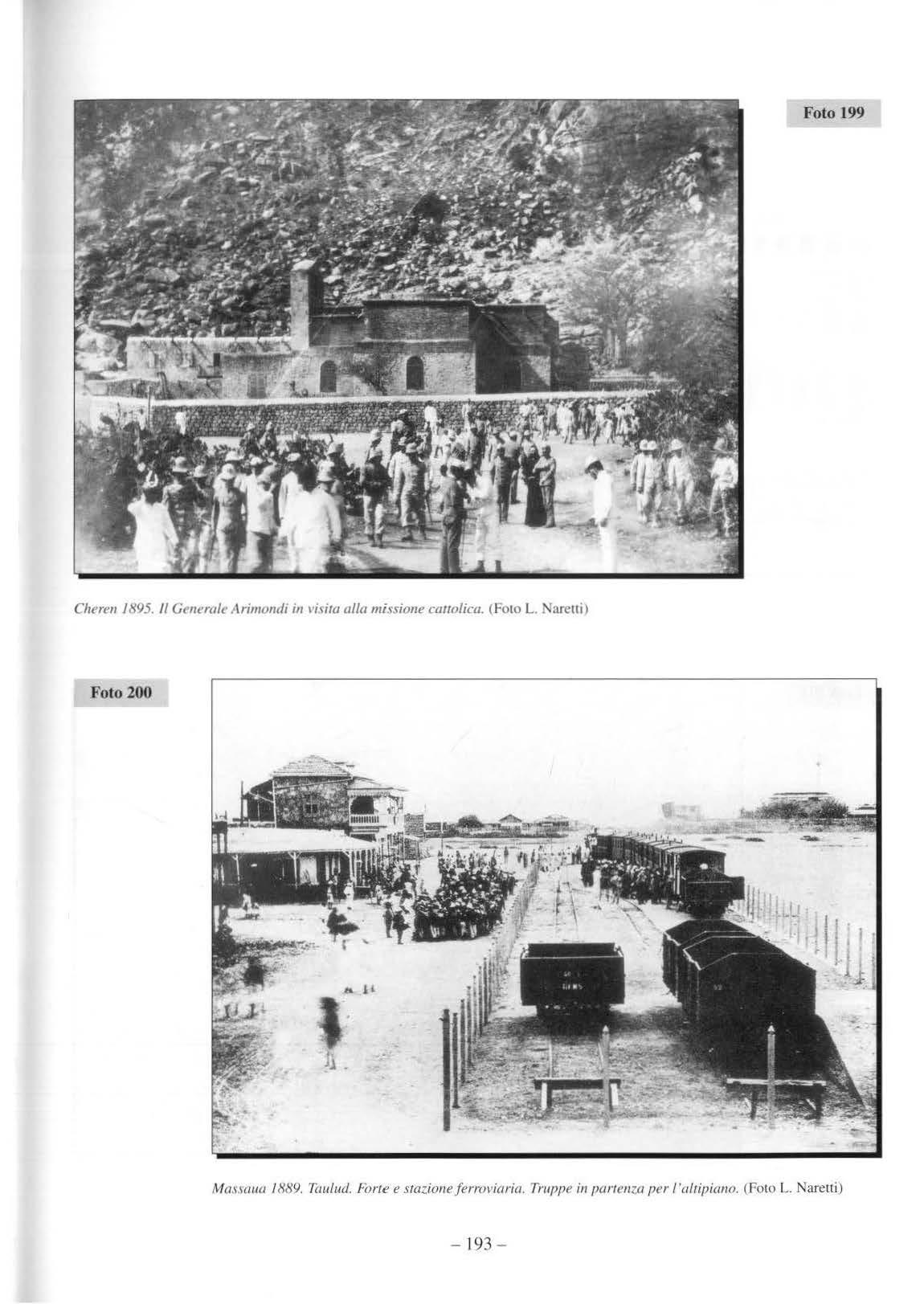
Foto 199
Cheren 1895. Il Generale Arimondi in alla missione cattolica. (Foto L. N areni)
Foto 200
- 193 -
Ma ssa tw l X89. Taulud. r ènte e stazione ferroviaria. Truppe in partenza per l 'altipian o. (Foto L. Nareni)
 MafSOLIO 189+. Sjìlamento di lrtlppe per celebrare la preMI di tH' \'(!/Il/lll il l+ luglio 1894. Norare la presen::.a rra le mtppe anche di marinai. !Foto L. areni)
Foto 202
MafSOLIO 189+. Sjìlamento di lrtlppe per celebrare la preMI di tH' \'(!/Il/lll il l+ luglio 1894. Norare la presen::.a rra le mtppe anche di marinai. !Foto L. areni)
Foto 202
- 194 -
M assa ua 18 94. Lc1 sressa cerim onia. ( rot o L. Na.retti )
Foto201
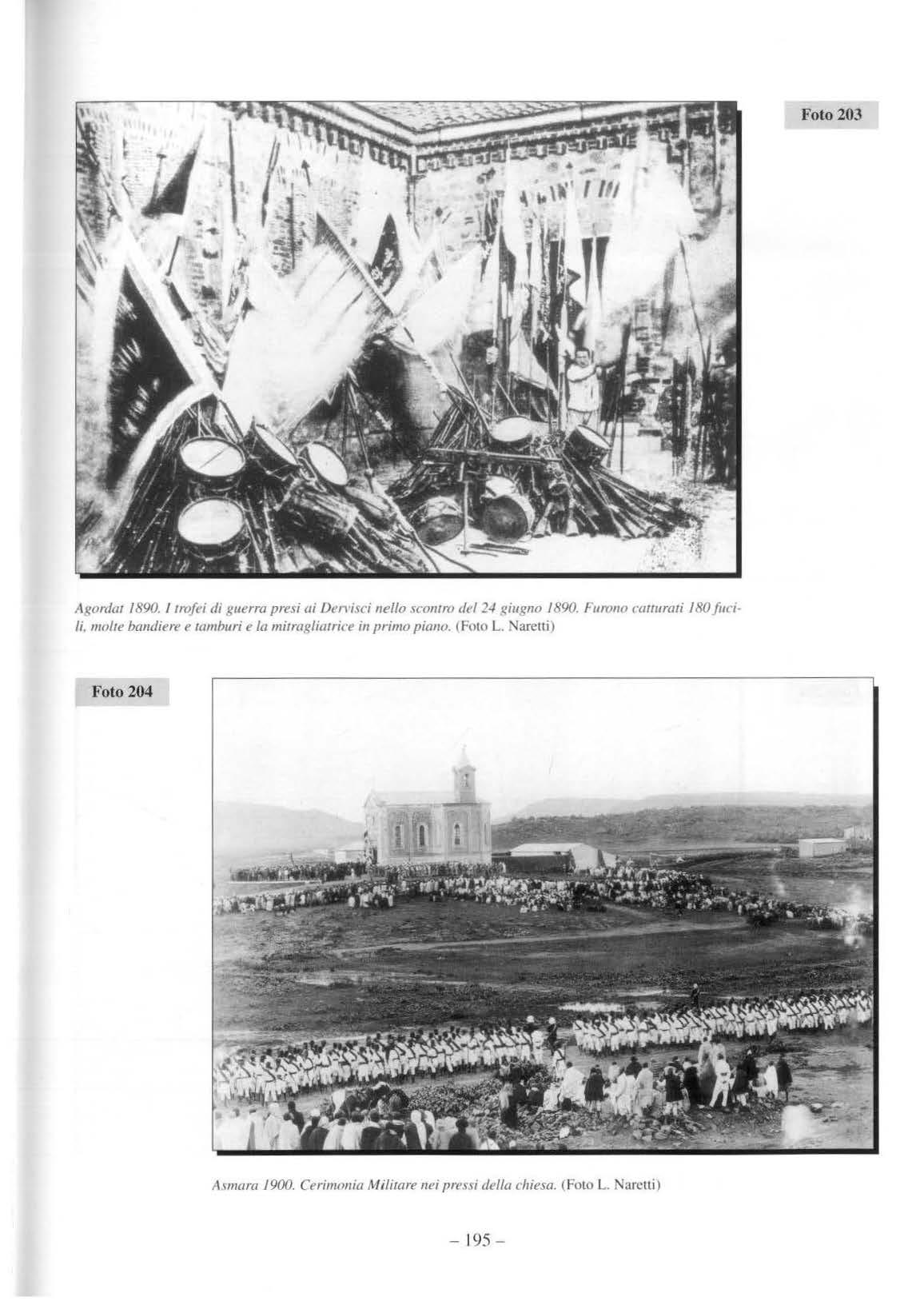 Agordat 1890. ltmfei eli guerra presi ai Derl'isci nello scoli/m del 2-4 giugno 1890. Fumnn catturati 180 fucili. molte bandiere e tamburi e la mitragliatrice in primo piano. (Foto L. , areni)
Foto 204
Agordat 1890. ltmfei eli guerra presi ai Derl'isci nello scoli/m del 2-4 giugno 1890. Fumnn catturati 180 fucili. molte bandiere e tamburi e la mitragliatrice in primo piano. (Foto L. , areni)
Foto 204
- 195-
203
A.wrara 1900. Cerimonia M i litare nei pressi della chiesa. (Foto L. Narcni)
Foto
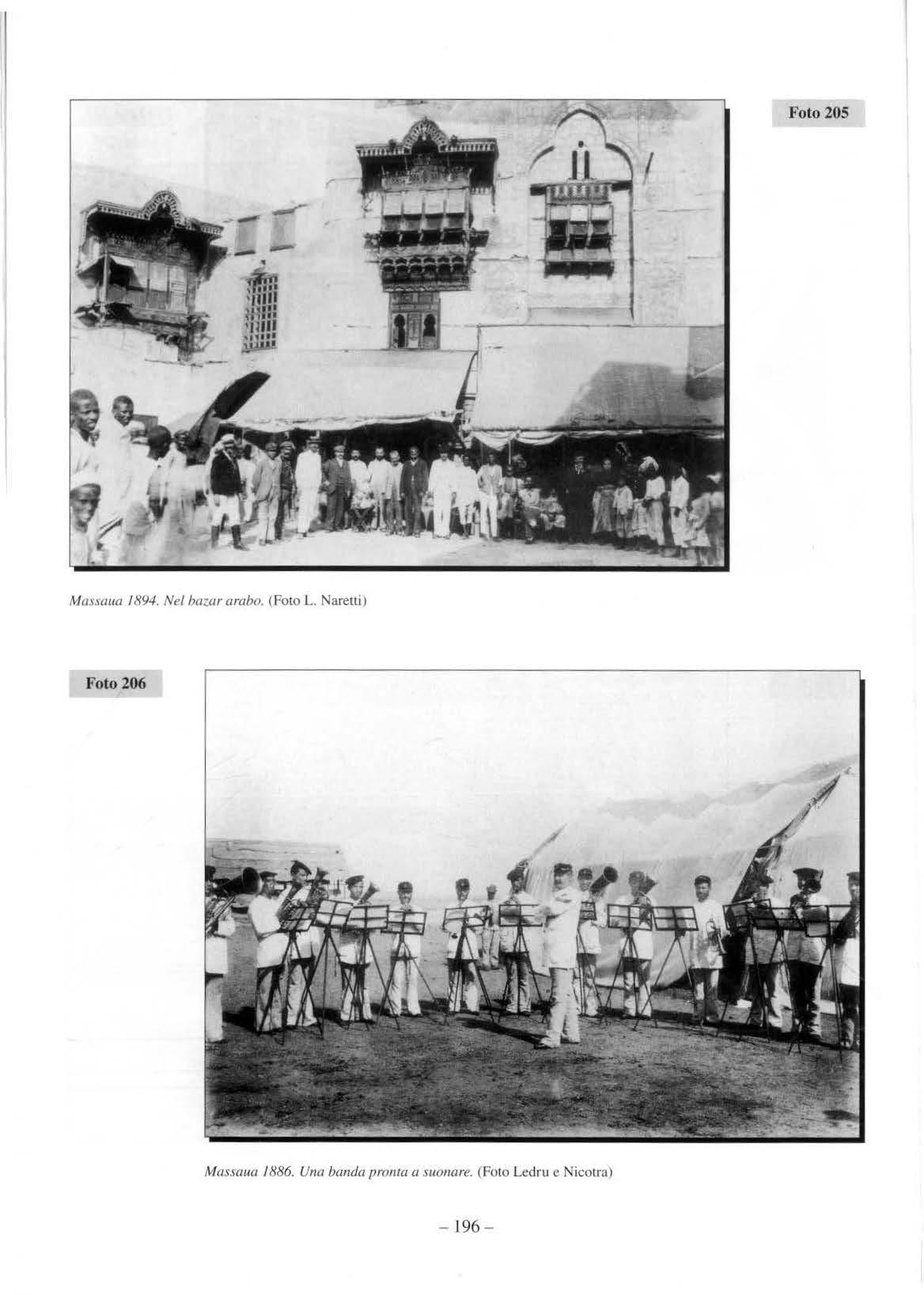
205
Foto
Massaua 1894. Nel (Foto L. Naretli)
Foto 206
- 196 -
M assaua 1886. Una banda pronJa a suonare (Fo to Ledru c Nico tra)
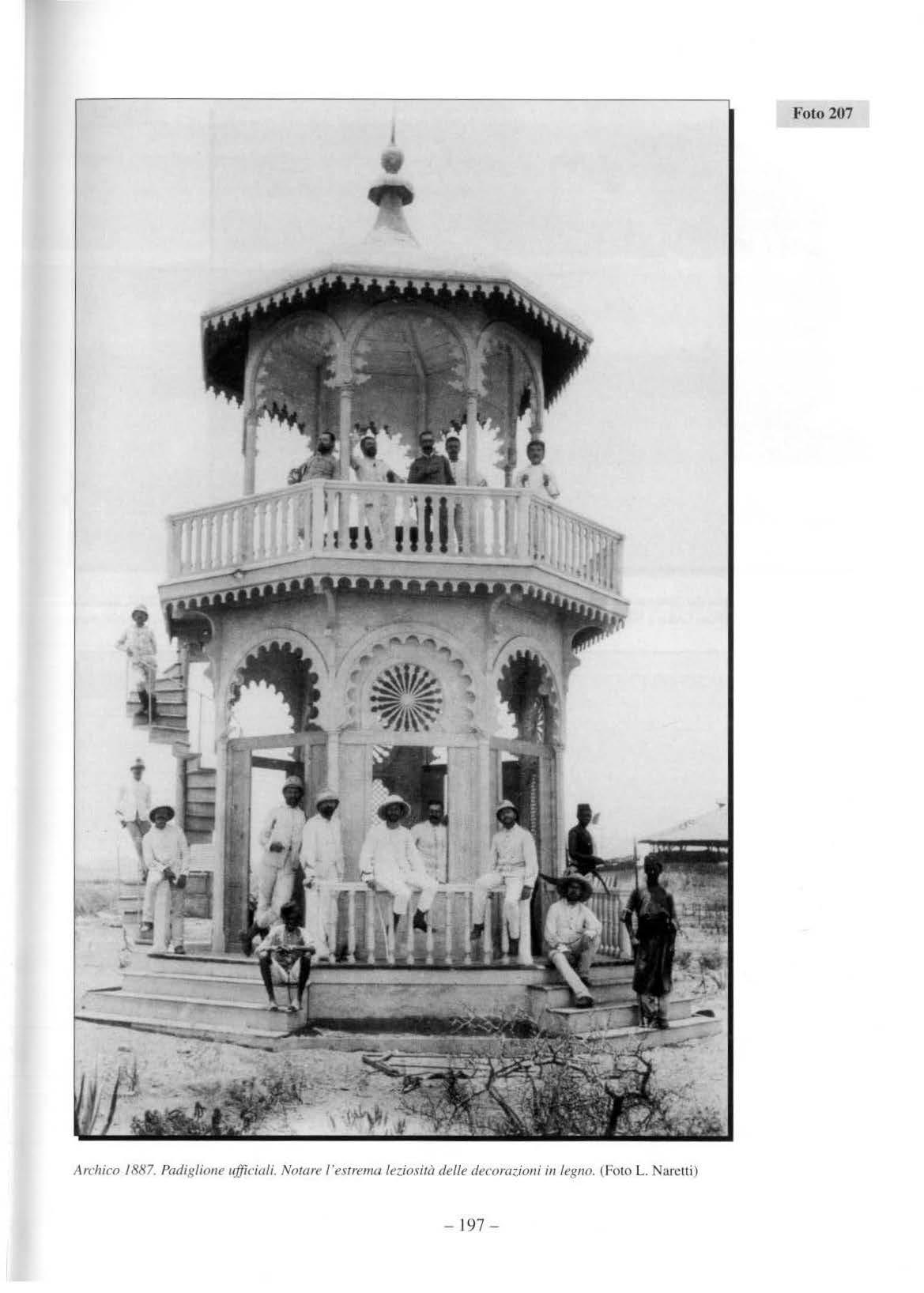
Foto 207
- 197-
Archico 1887. Padiglione ufficiali. Notare l'esi rema leziosiià delle derora<,ioni in legno. (Foto L. Nare lii )
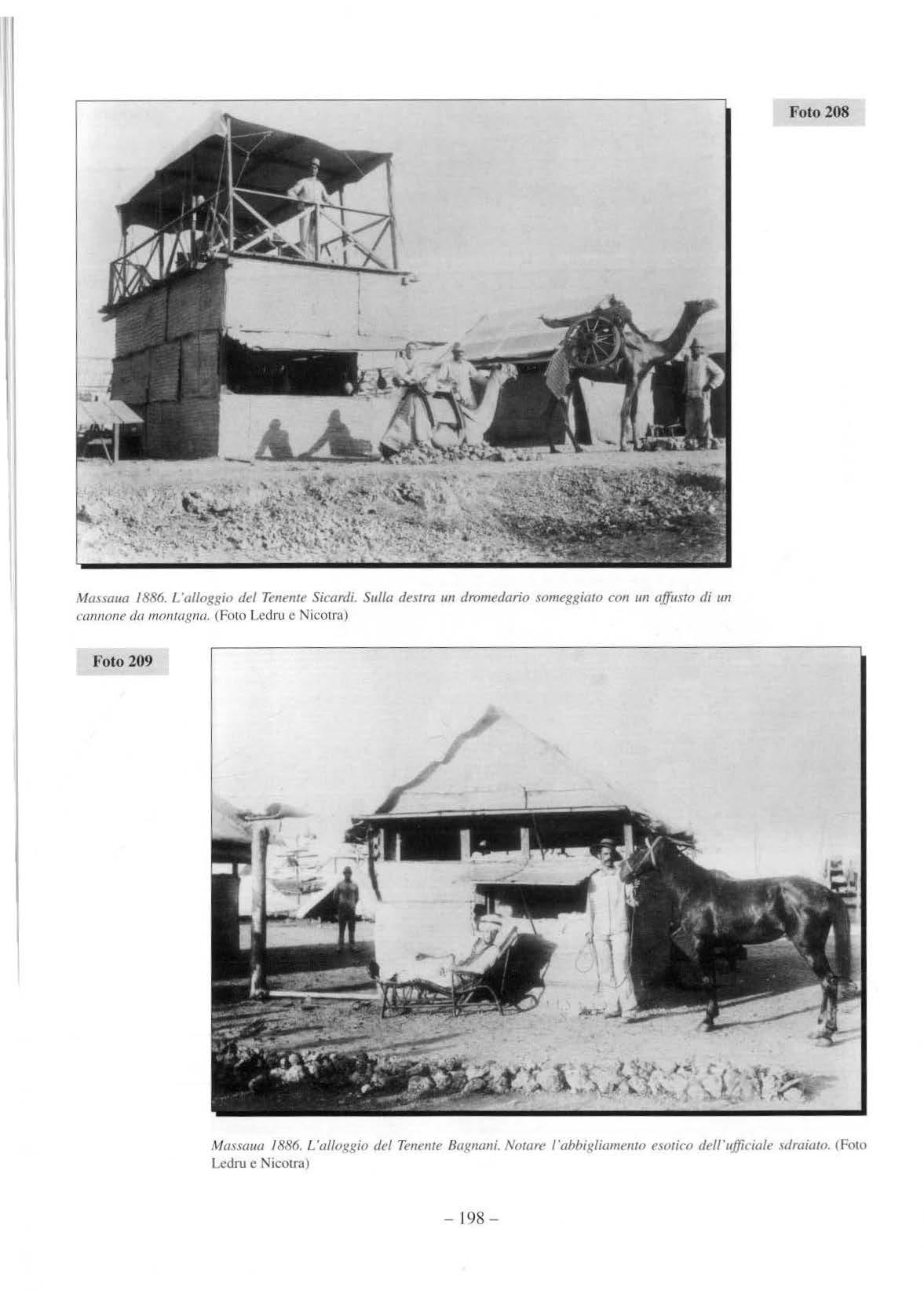 Ma:,.mua /886. l-'alloggio del Tenente Sicardi. Sulla destra 1111 dronwdario someggiaro c011 rm affusto di un can11one d(l montagna. (Foto Lcdru e Nicotra)
Ma:,.mua /886. l-'alloggio del Tenente Sicardi. Sulla destra 1111 dronwdario someggiaro c011 rm affusto di un can11one d(l montagna. (Foto Lcdru e Nicotra)
208
Foto209
Foto
- 198-
Massaua 1886. L'alloggio del Te11e11te Notare esotico dell'ufficiale sdraiaw. (Foto Lcdru e icotra)
 Marsaua 1886. L'allox,;:io del Capitano Tttoman/io. Notare /a fascia a::.::.urra sul casco dell'ufficiale. (Foto Ledru e ' icotral
Foto 211
Marsaua 1886. L'allox,;:io del Capitano Tttoman/io. Notare /a fascia a::.::.urra sul casco dell'ufficiale. (Foto Ledru e ' icotral
Foto 211
-199-
M oncu lfo 1886. l coniugi Magg iofini di ftvme al foro alloggio. (Fo to Ledru c Nicolra)
Foto 210
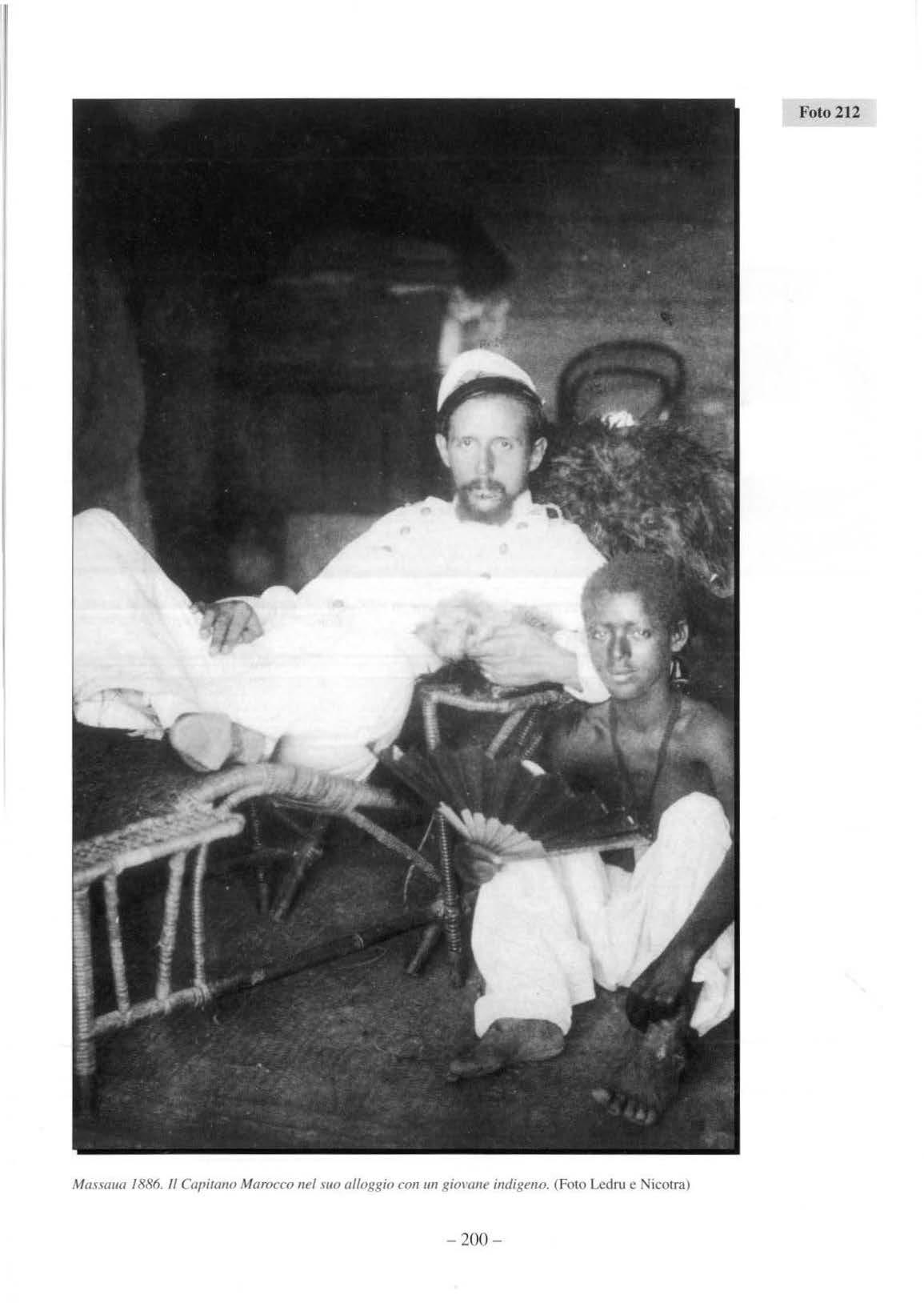
Foto 212
- 200 -
Massaua 1886. Il Capìta!IO M arocco 11el MIO co11tm gÌO\ '{llle ìndige11o ( F oto Ledru e :-.licotra)
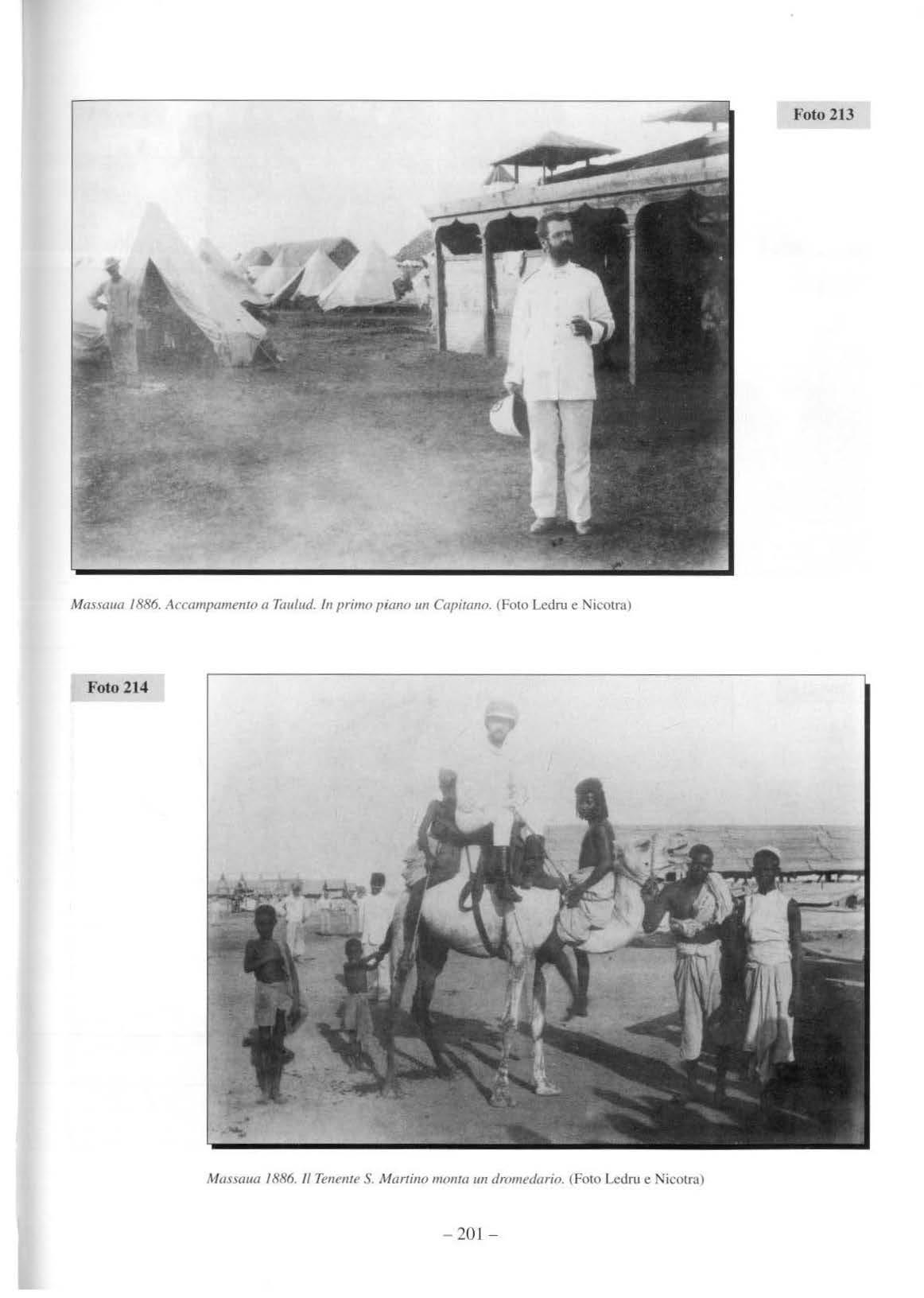
Foto 21 3
Massatw 1886. Accampamento a Taulud. In primo piano 1111 Capiwno. (Foto Lcdru e icotra)
Foto 214
- 201-
Ma Baua 1886. Il Teneme S. Manina mo11W 1111 dromedario. (Foto L cdru e icmra)
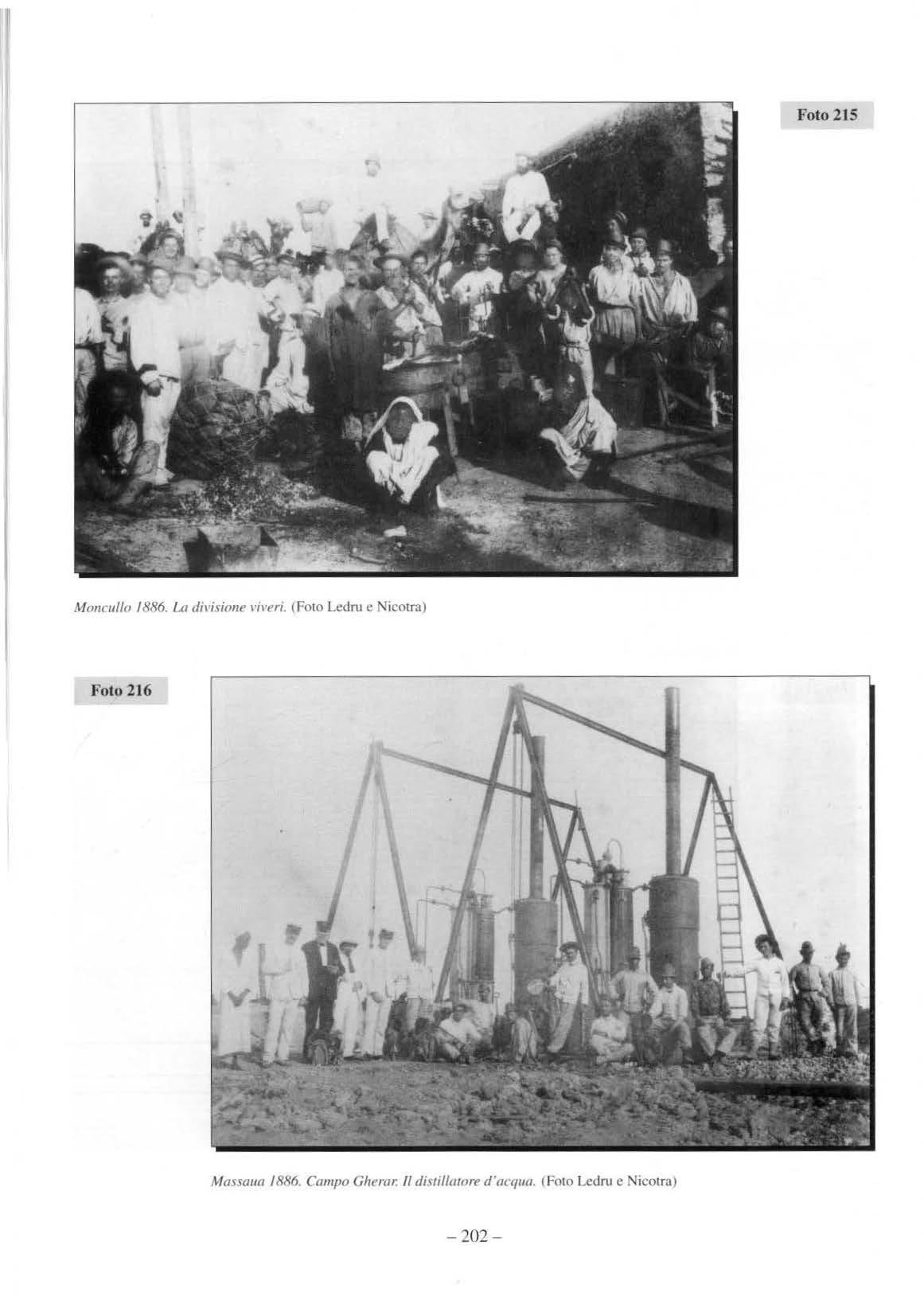
215
Foto
Moncullo /886. La di1•isione l'il'eri. (Fo to Ledru c icotra)
Foto 216
- 202 -
Massaua 1886. Campo Gher01: Il distillatore d'acqua. ( Fo to Lcdru e, ico tra )
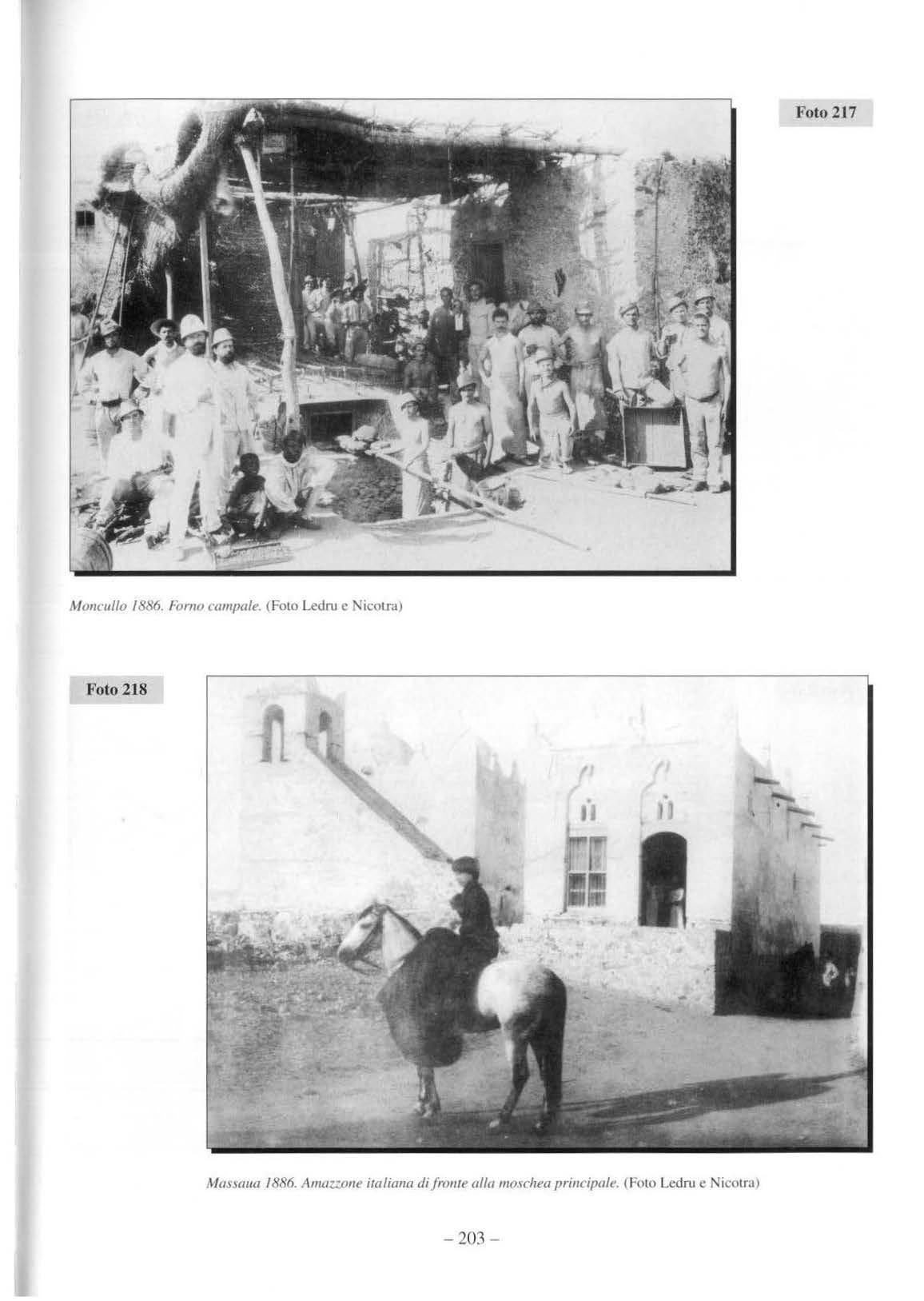
217
Foto
Moncullo 1886. Foma campale. (Foto Ledru c icolra)
Foto 218
-203 -
Maswua 1886. Ama:;;one iraliana di frome al/amosrhea principale. (Foto Ledru e icotra)
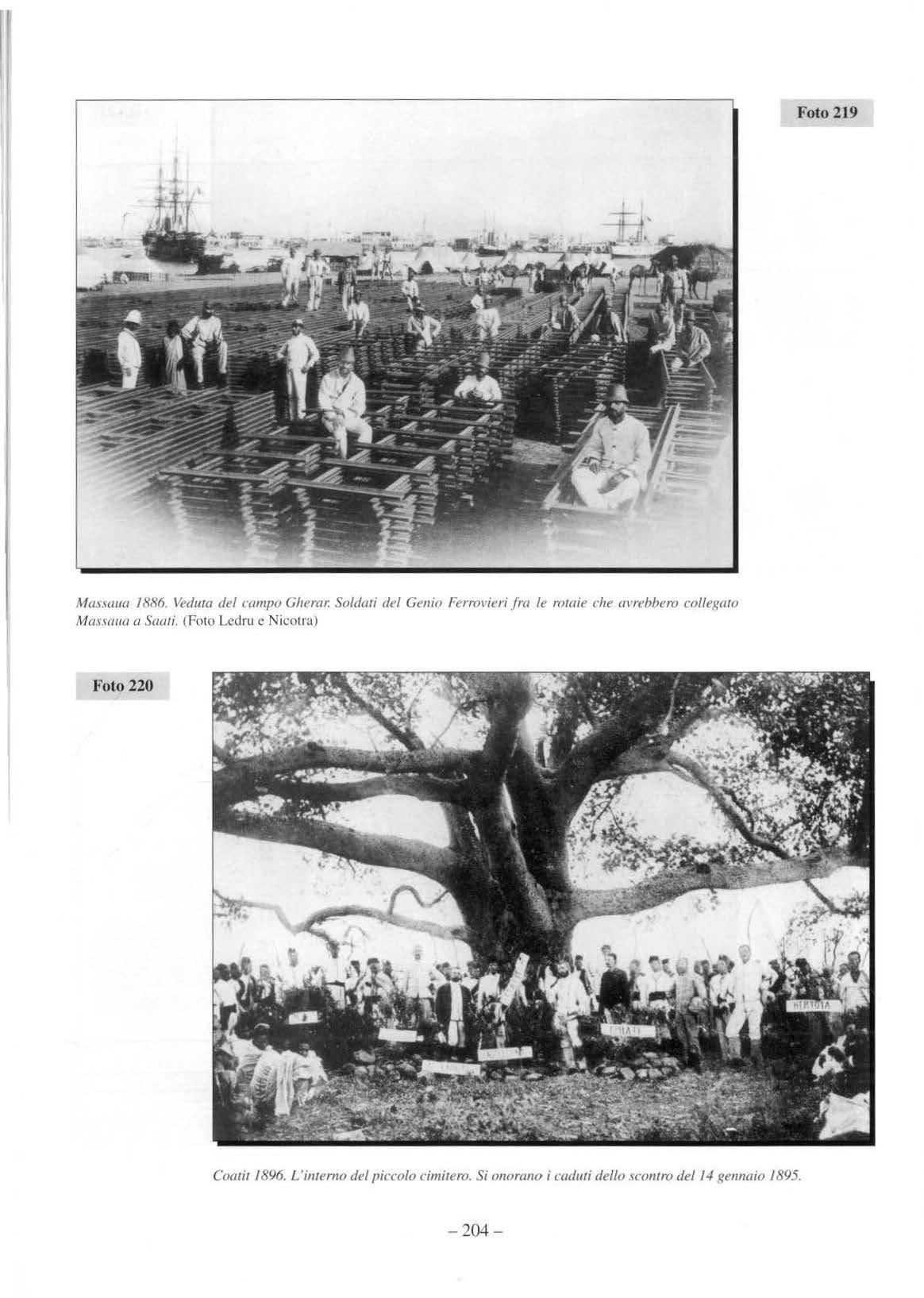 Ma!lsmw l 886. Veduta del campo Gherar. Soldari del Genio Fenvl'ieri fra le mraie che mn'hhero collegato Mas sw w a Sa ari. (Foto Ledru..: Nicotra)
Ma!lsmw l 886. Veduta del campo Gherar. Soldari del Genio Fenvl'ieri fra le mraie che mn'hhero collegato Mas sw w a Sa ari. (Foto Ledru..: Nicotra)
Foto 220 219
Foto
- 204 -
Coatit 1896. L'imemo del piccolo cimitero. Si onorano i cadwi dello sco11/ro del 14 gennaio 1895.
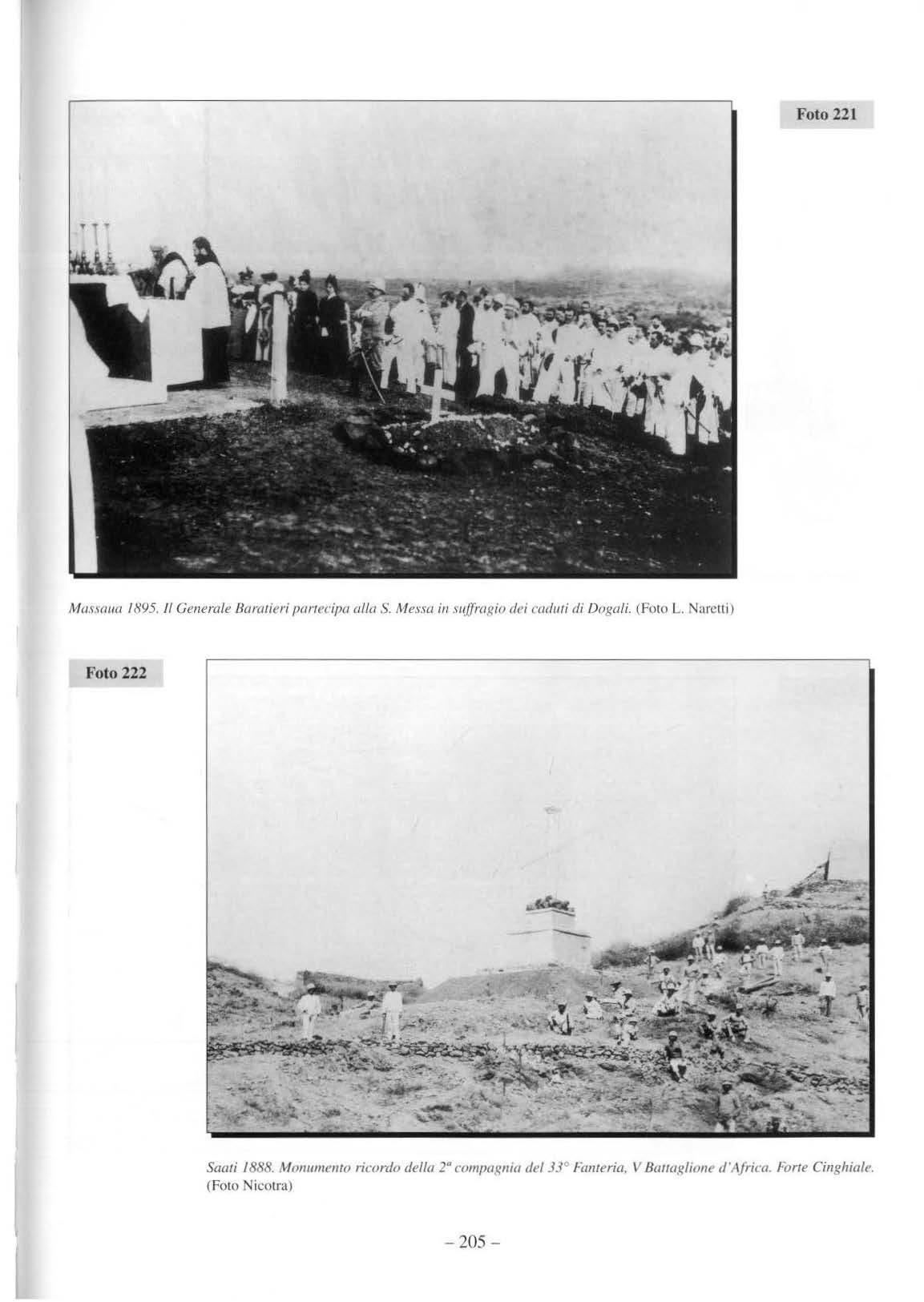
221
Foto
Ma.wwa 1895. Il Generale Baratieri partecìpa alla S. Messa in suJrmf(io dei caduti di Dogali. (Foto L. Narcll i )
Foto 222
- 205 -
Saali /888. Monumento ricordo della 2" compagnia del JJ ° Fanteria, V Bauaglione d'Africa. Forre Cinghiale. ( Foto Nico tra)
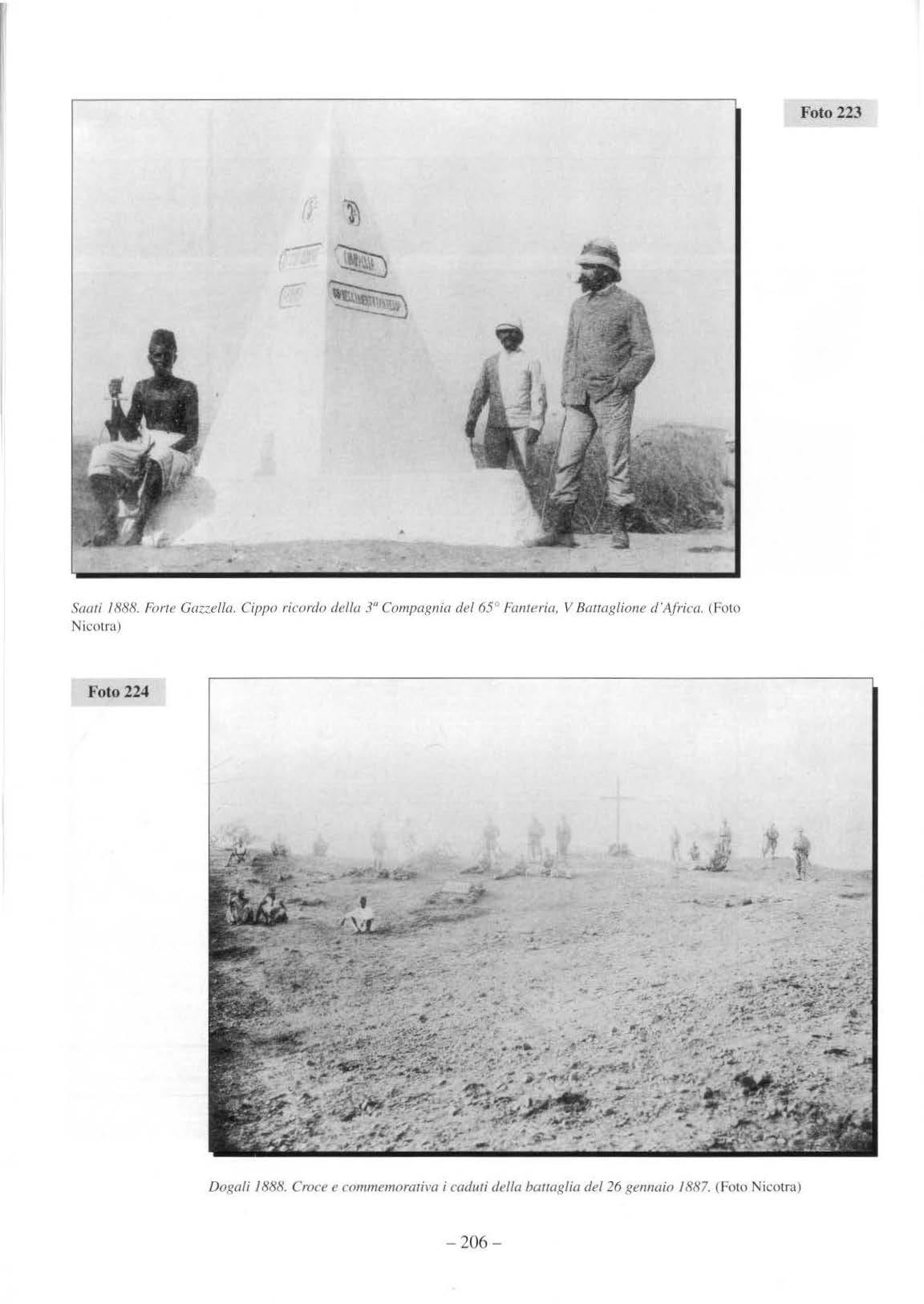
Foto 223
Saari IHX8. Forre Ga::.::.ella. Cippo ricordo della 3u Compagnia de/65 ° Fanreria. V Barraglione ri"Africa. {Poto Nico tra)
.Foto 224
-206-
Dogali 1888. Croce e cnmmemorariva i coduri dello batraglia del 26 gennaio /887. (Fo to Nicotra)
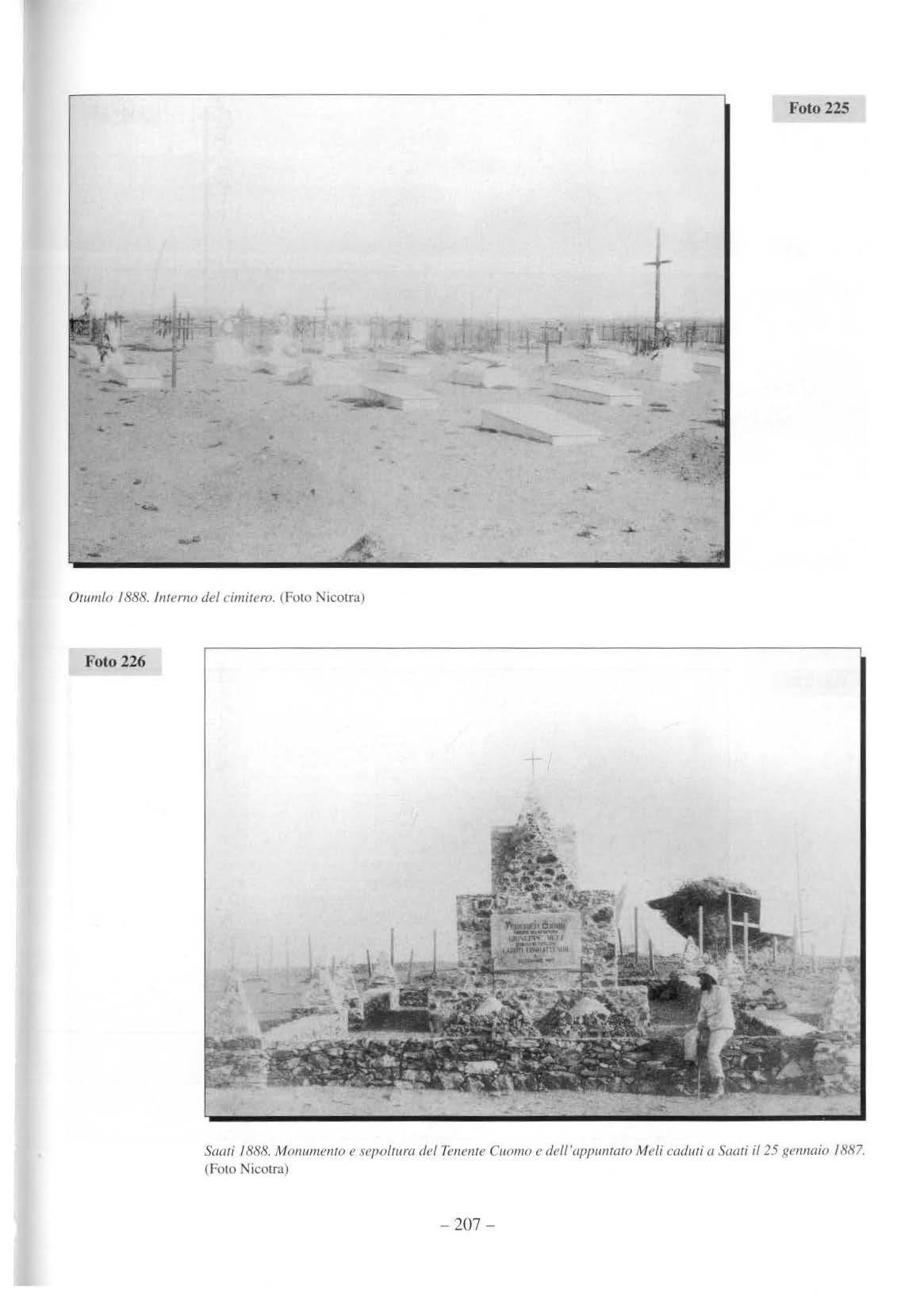
Foto 225-
Otumlo 1888. ll/lerno del cimitero. (Foto Nicotra)
Foto 226
- 207-
Saati 1888 Monumento e sepoltura del Te neme Cuomo e del/ 'appuntato Meli caduti lt Saati il 25 gennaio 1887. (Fo to icotra)
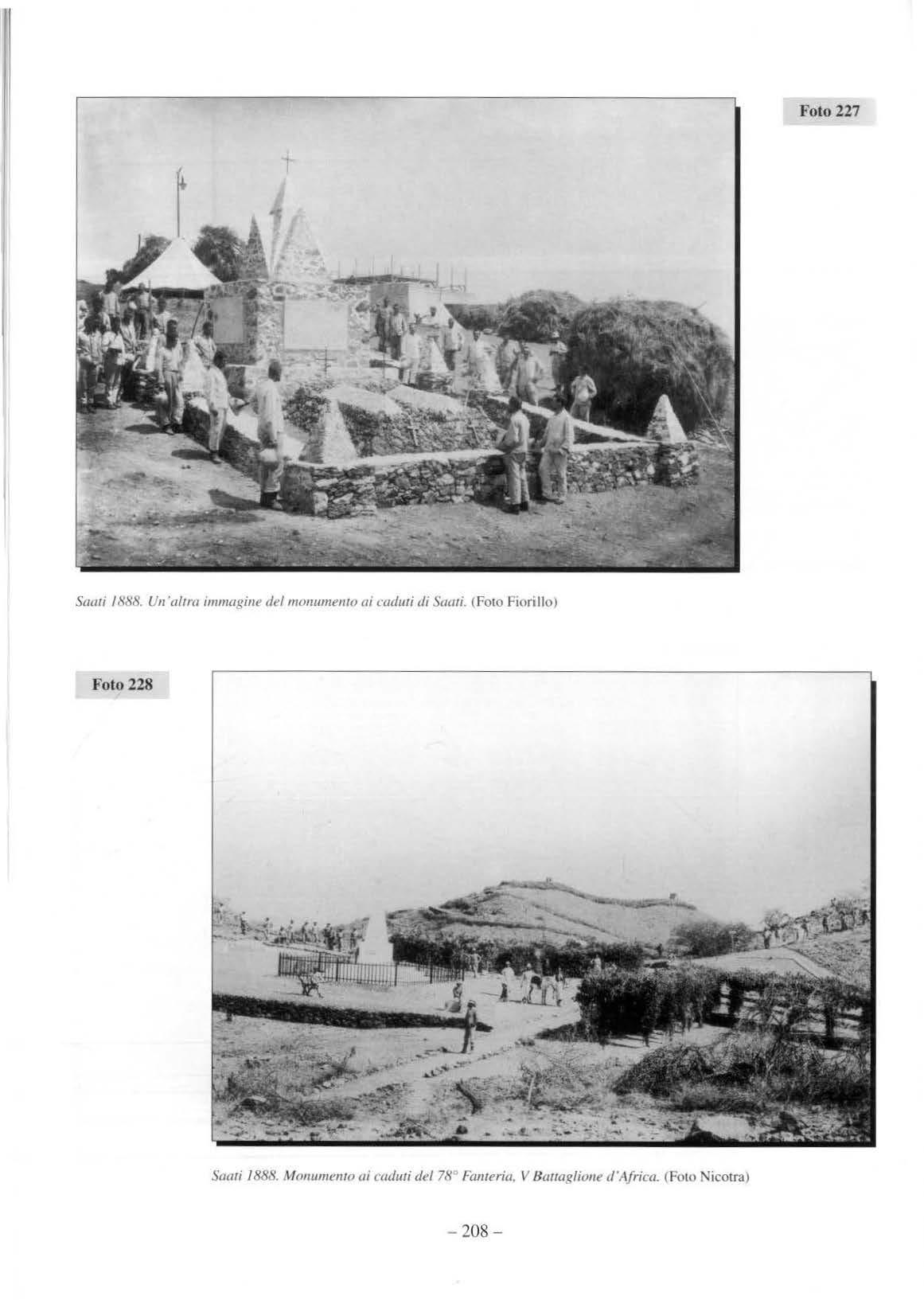
227
Foto
Saari !888. Un "altra immagine del mo11wnelltO oi cadwi di Sumi. (Foto Fiori Ilo)
Foto 228
-208-
Saari 1888. Monumento ai caduti del 78 " Fameria. V 8auagfio11e ti"Africa. (Foto icotra)
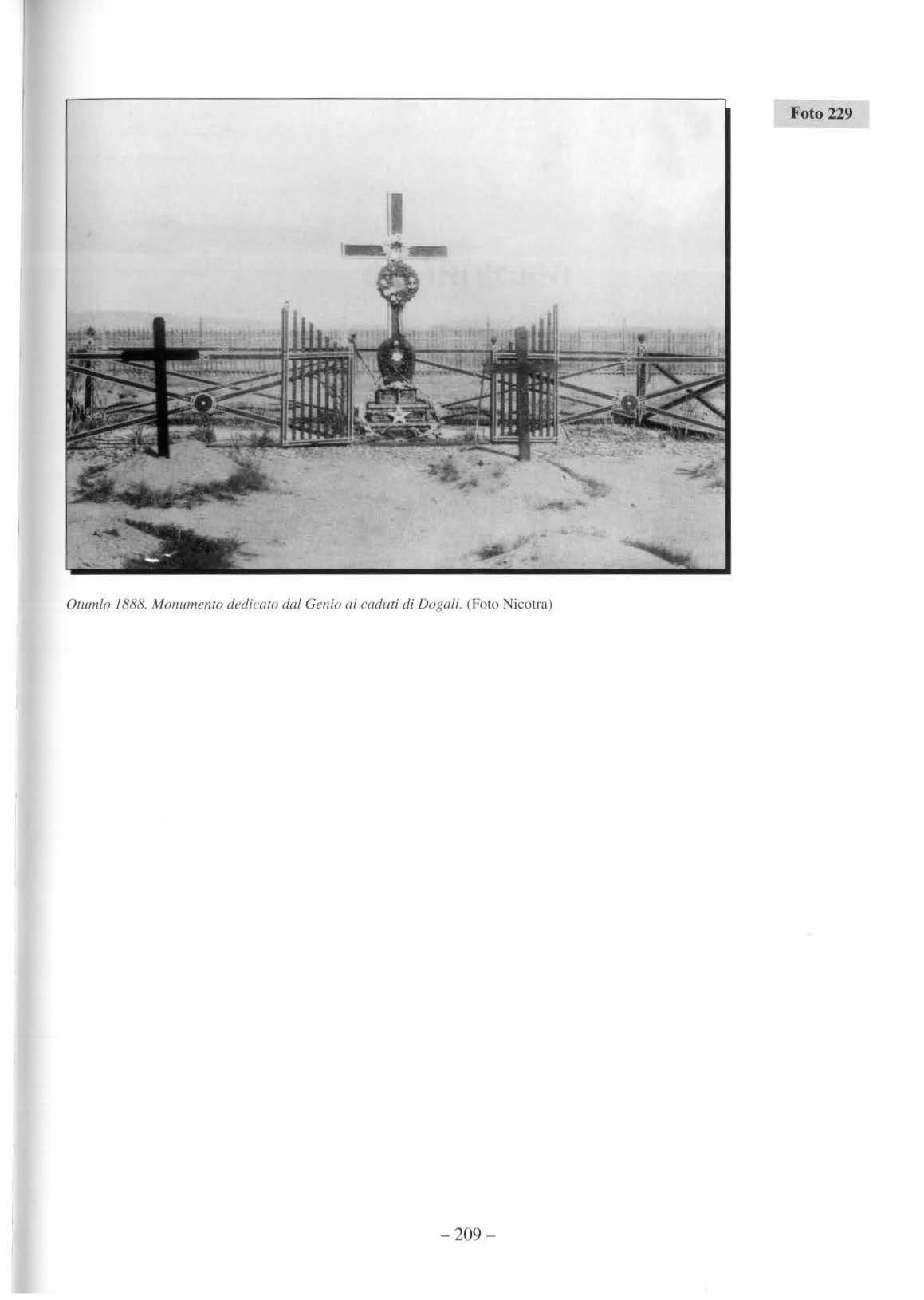
Foto229
-209-
Otumlo 1888. Monumento dedicato dal Genio ai caduti di Dogali. (Foto Nicotra)

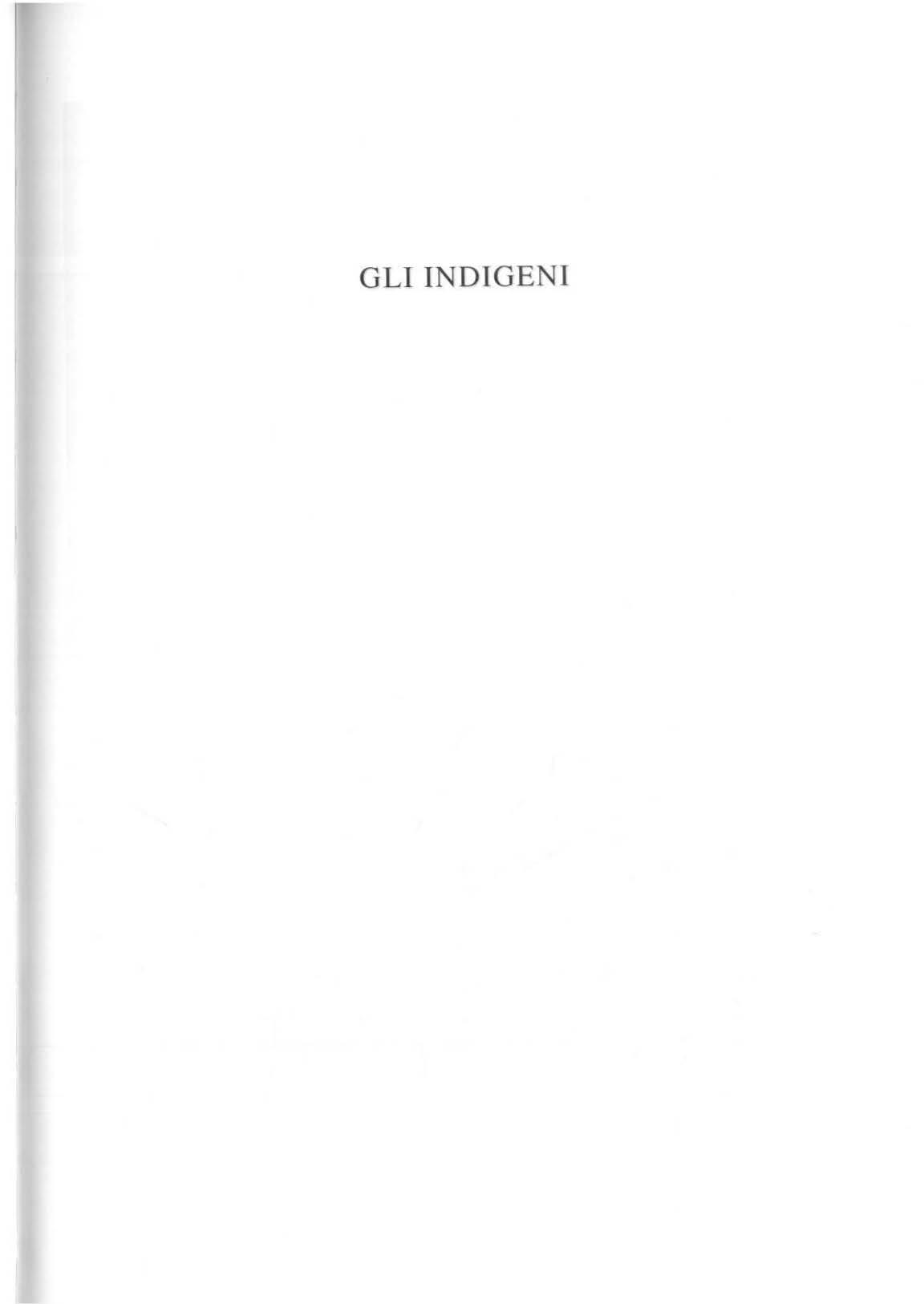
GLI INDIGENI

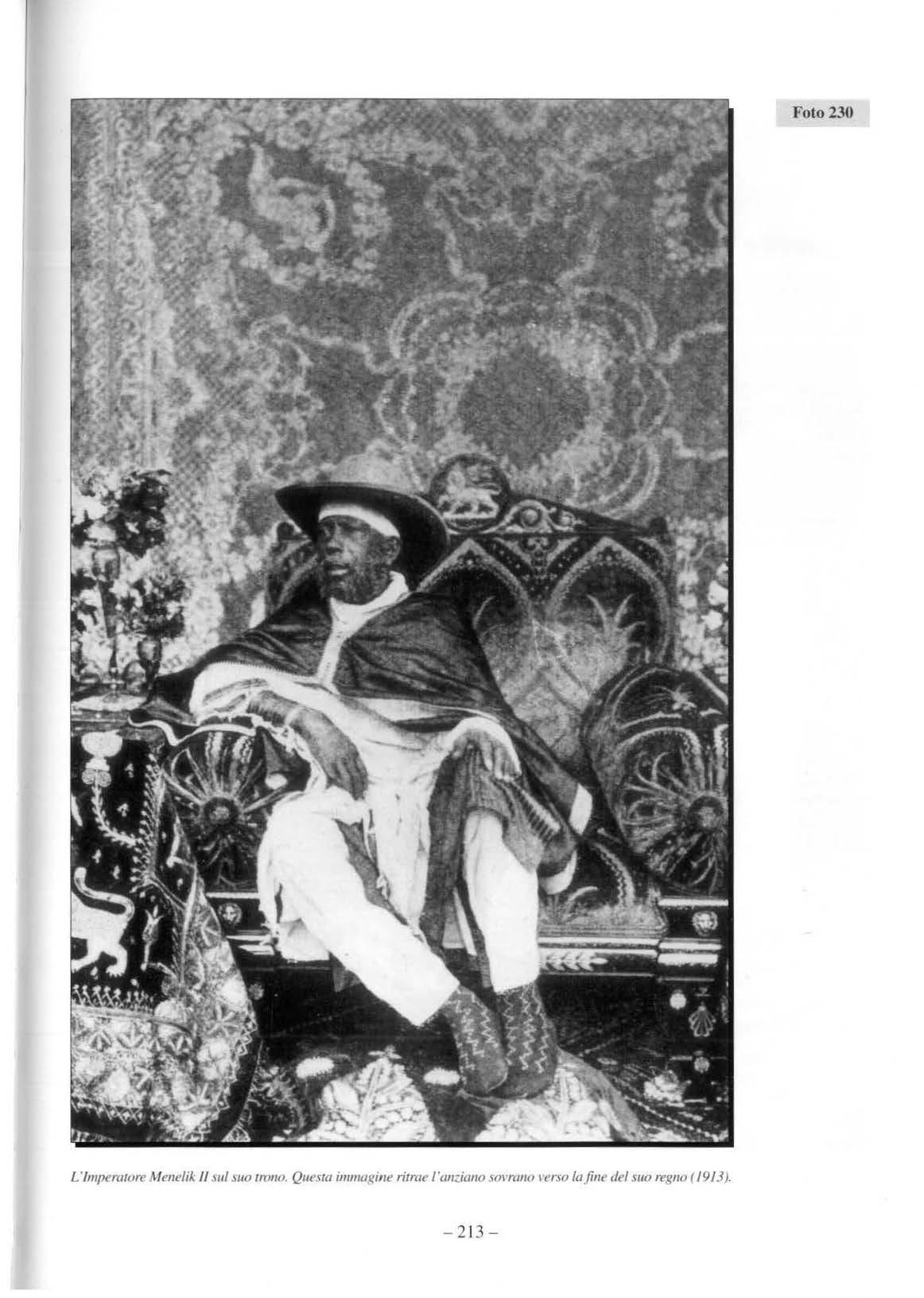
Foto 230
-2 13-
L'Imperatore Menelil.. /1 3111 suo trotw. Quesra immo,::in e rirrae l'cm:.iano SO\ 'rt/110 la fine del suo regno ( 1913).

Foto 231
-2 14-
Un ' imm agine girJI'ani/e dell' f mperatore Tainì con due ancelle.
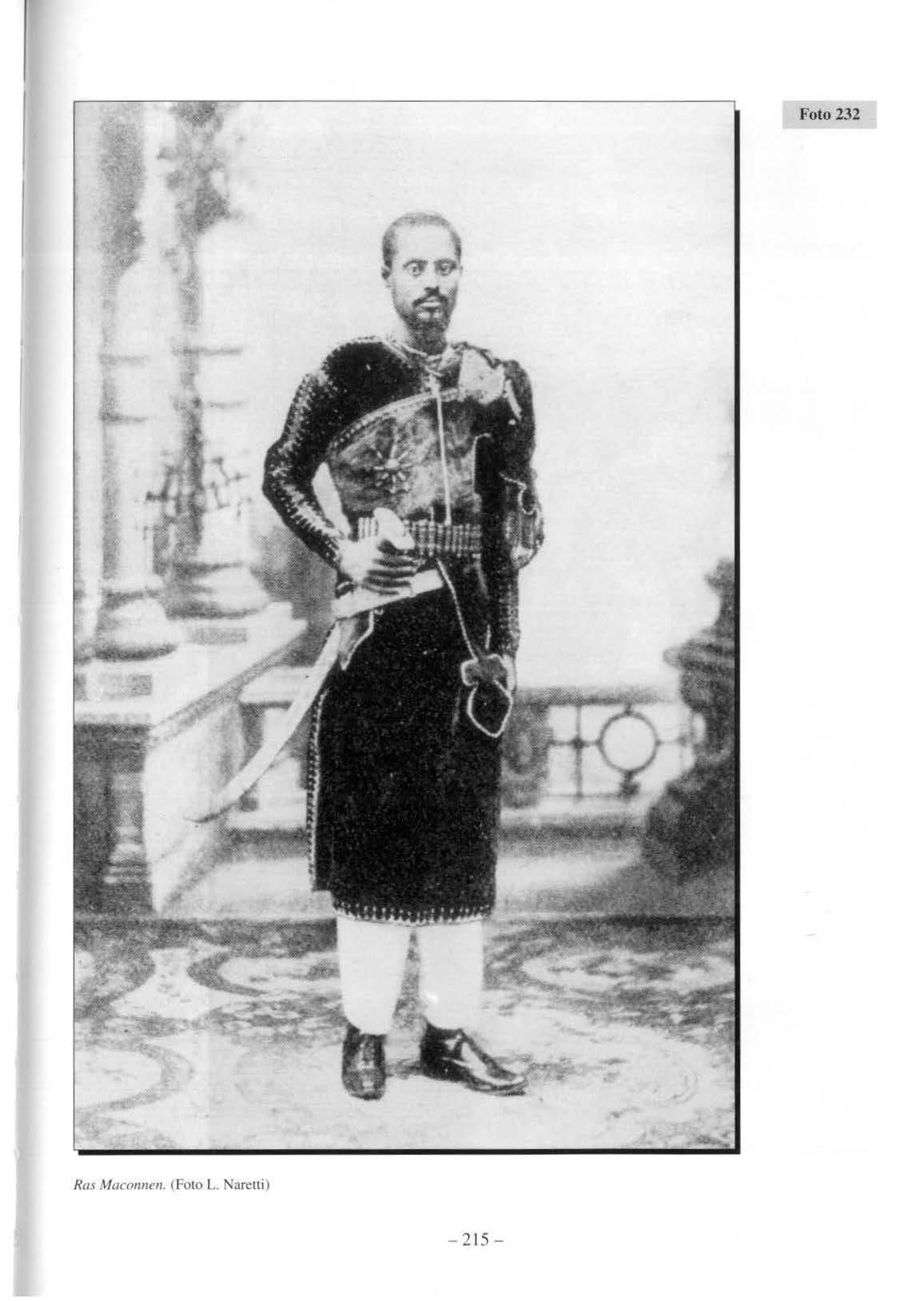
Foto 232
- 2 15-
Maconnen. (FOIO L. Nareui)

Foto 233
- 2 16-
Ras Mcmgascià. (Foto Nareui)
l giovanissimi degiac Sion e Gugsà, rispeuivamente figlio e n i pore di Ras Mallf(ascià. (Foto L.
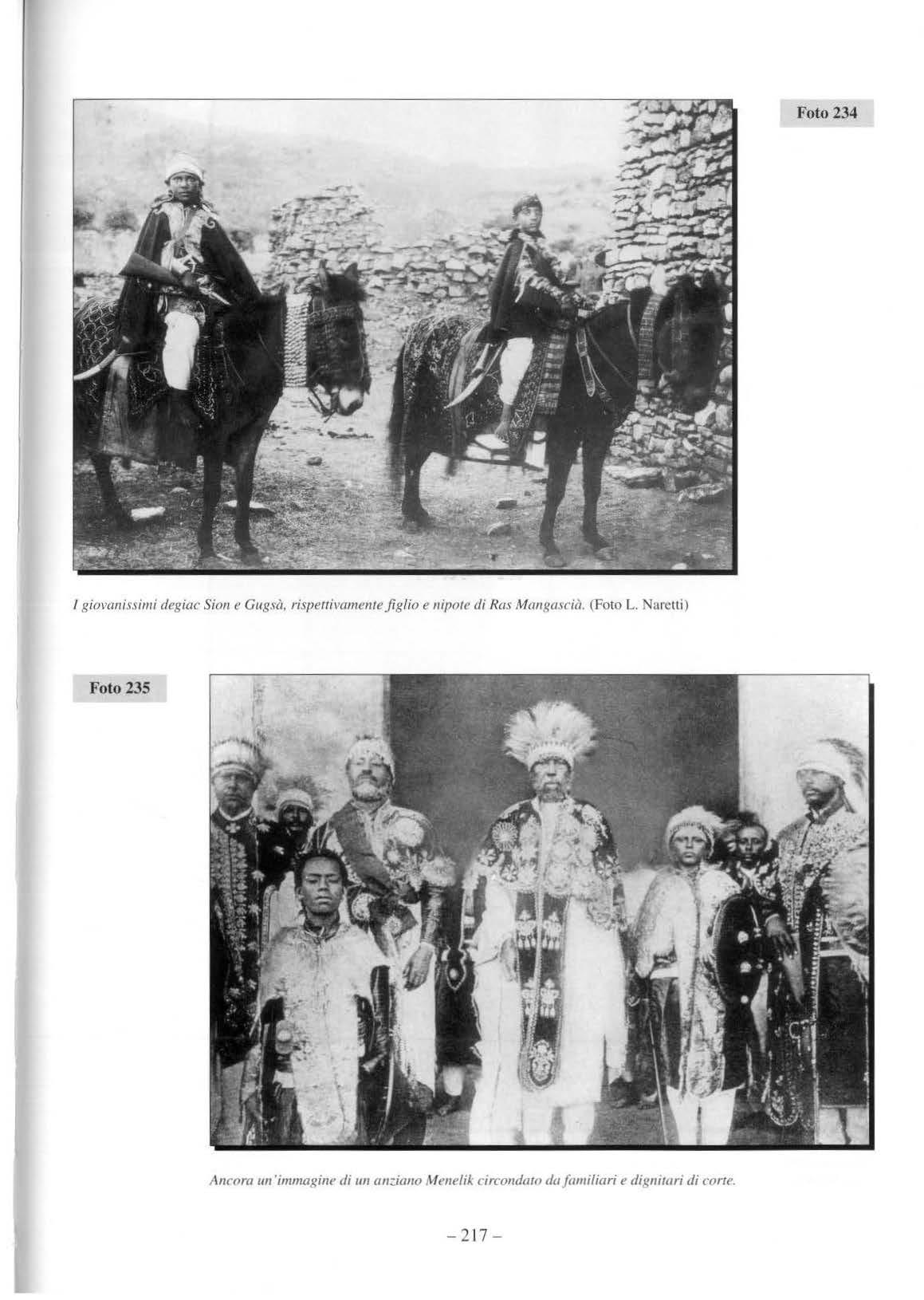
Foto 234
Narctti)
Foto 235
-2 17 -
Ancora tm'immagine di 1111 a11::.iano Me11elik circonda m da familiari e diRnirari di corre.
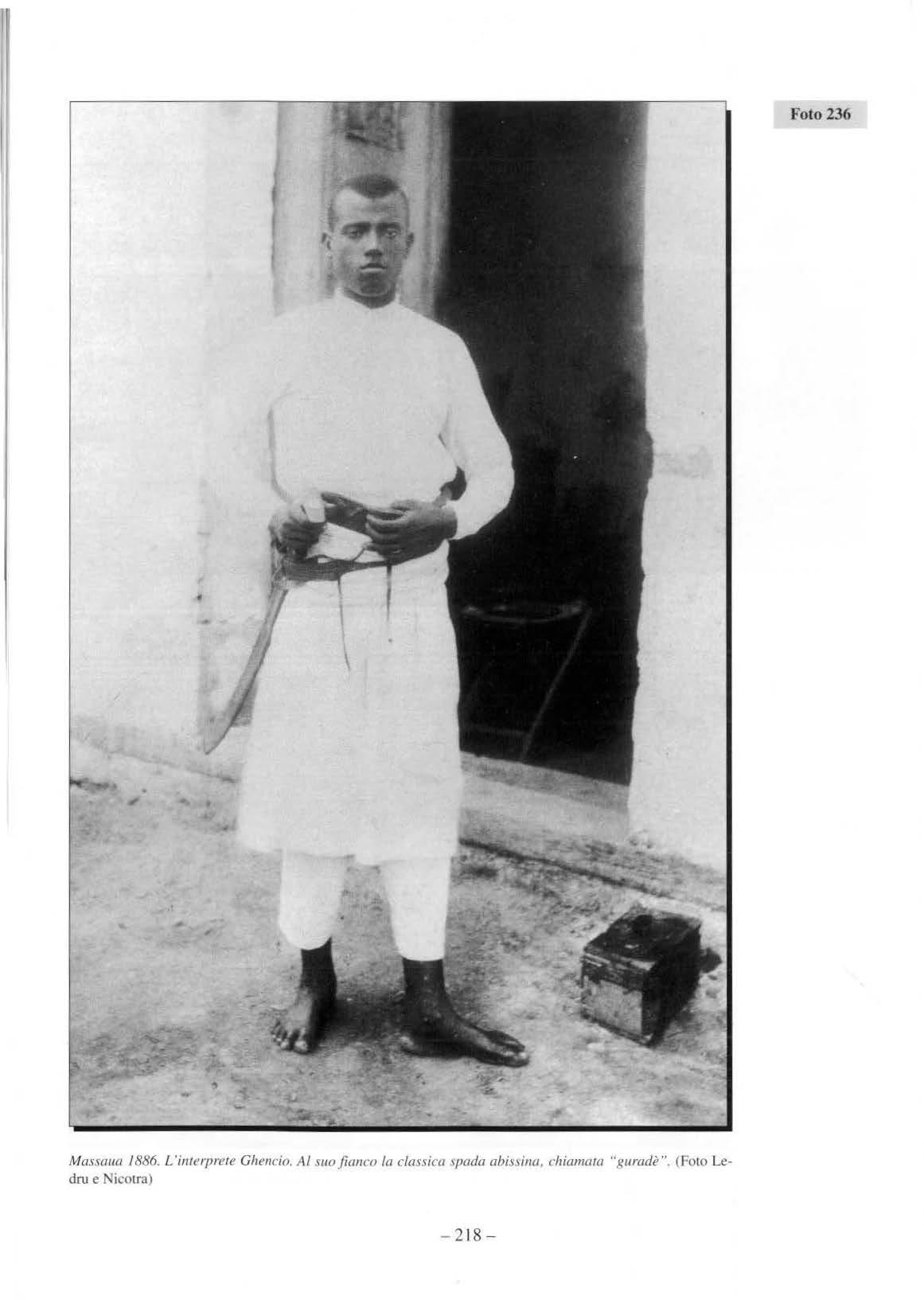
•
- 2 18Foto 236
Massmw 1886. C interprete Ghencio. Al suo fianco la classica chiamata "guradè"". (Foto Ledru e icotra)
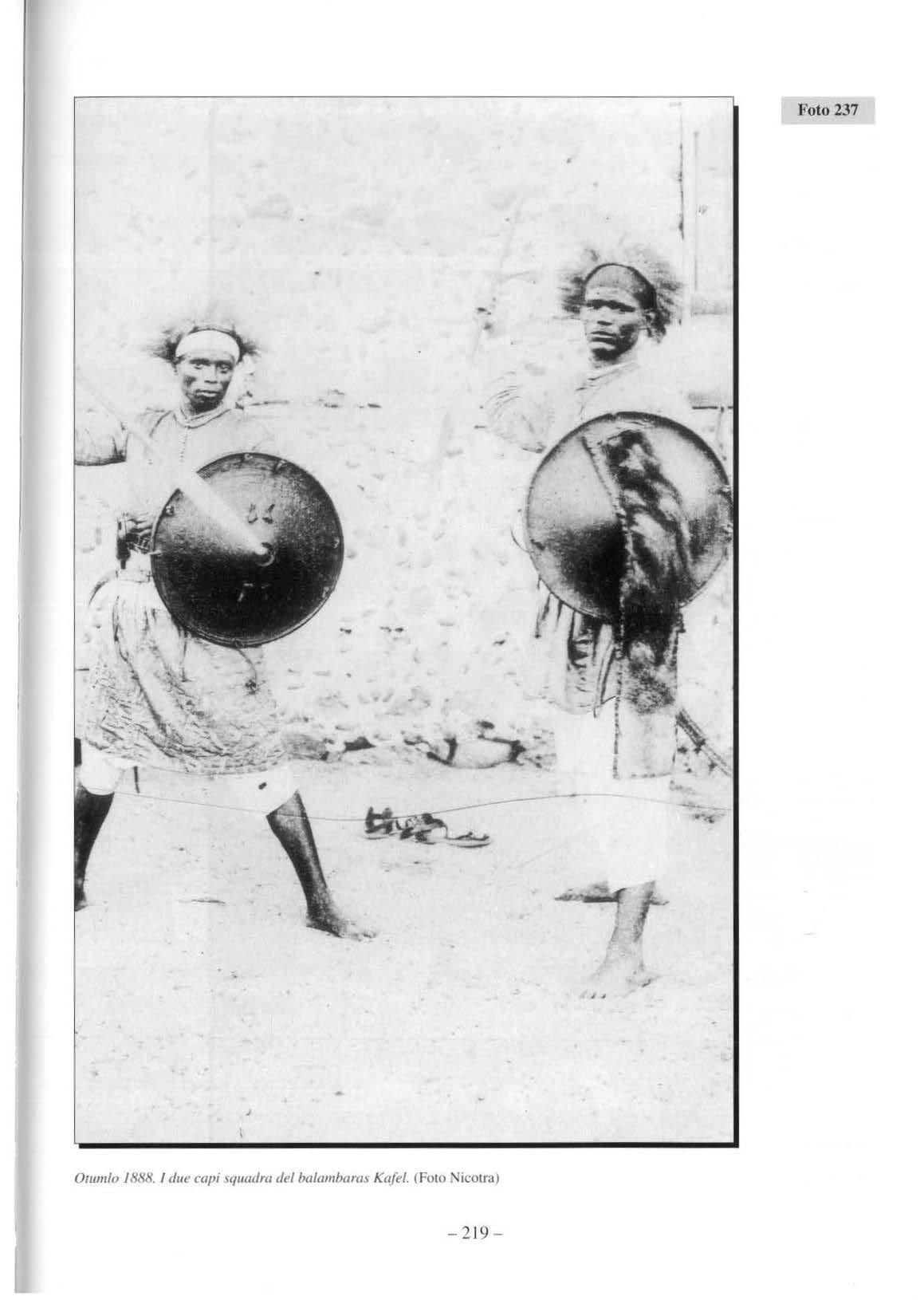
Foto 237 .... l J
-2 19 -
Olllmfo /888. l due capi squadra del Ka{el. (Folo. icotra)
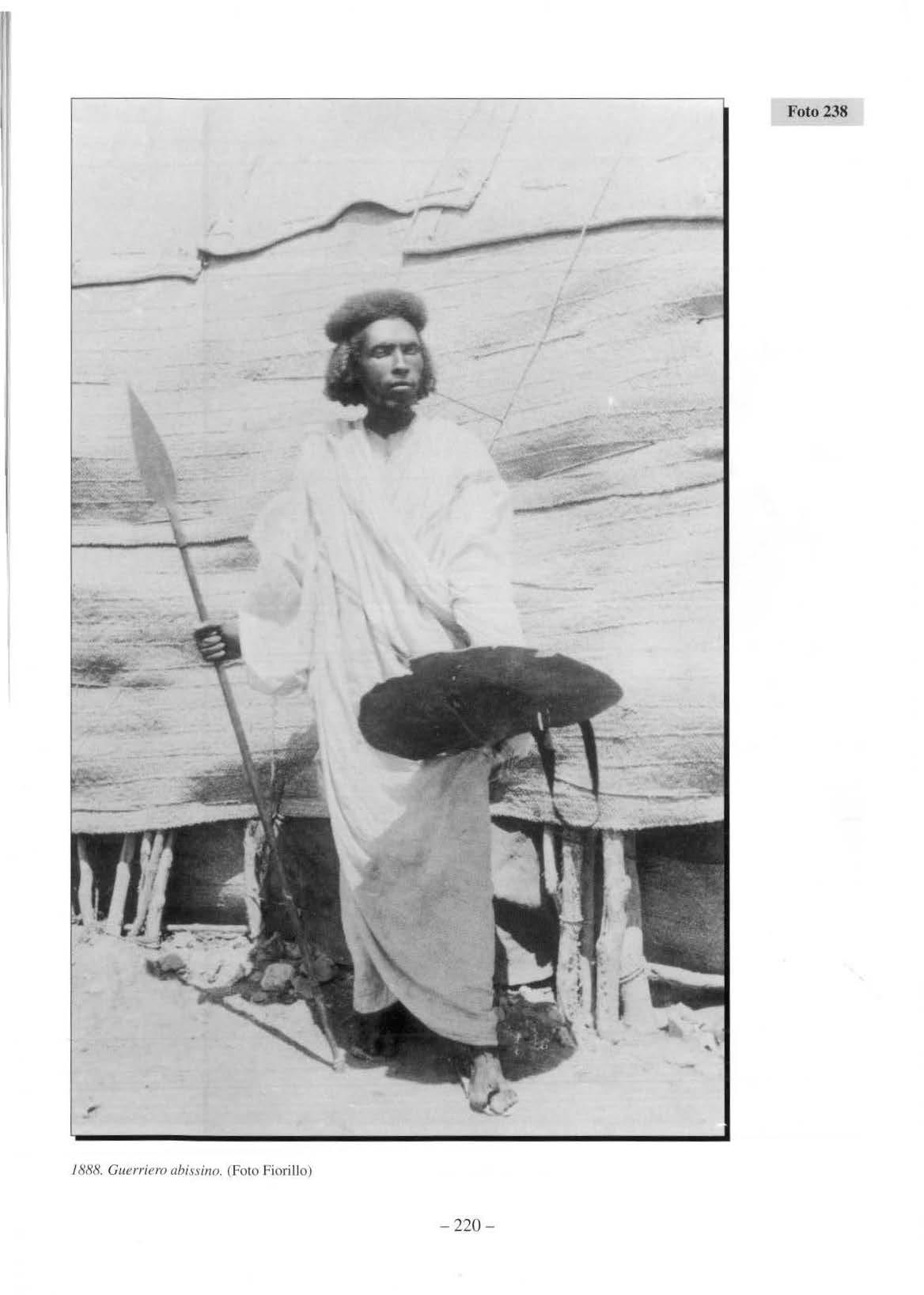
Foto238
- 220 -
1888. Gu erriero abissino. (Fot o Fiori Ilo)
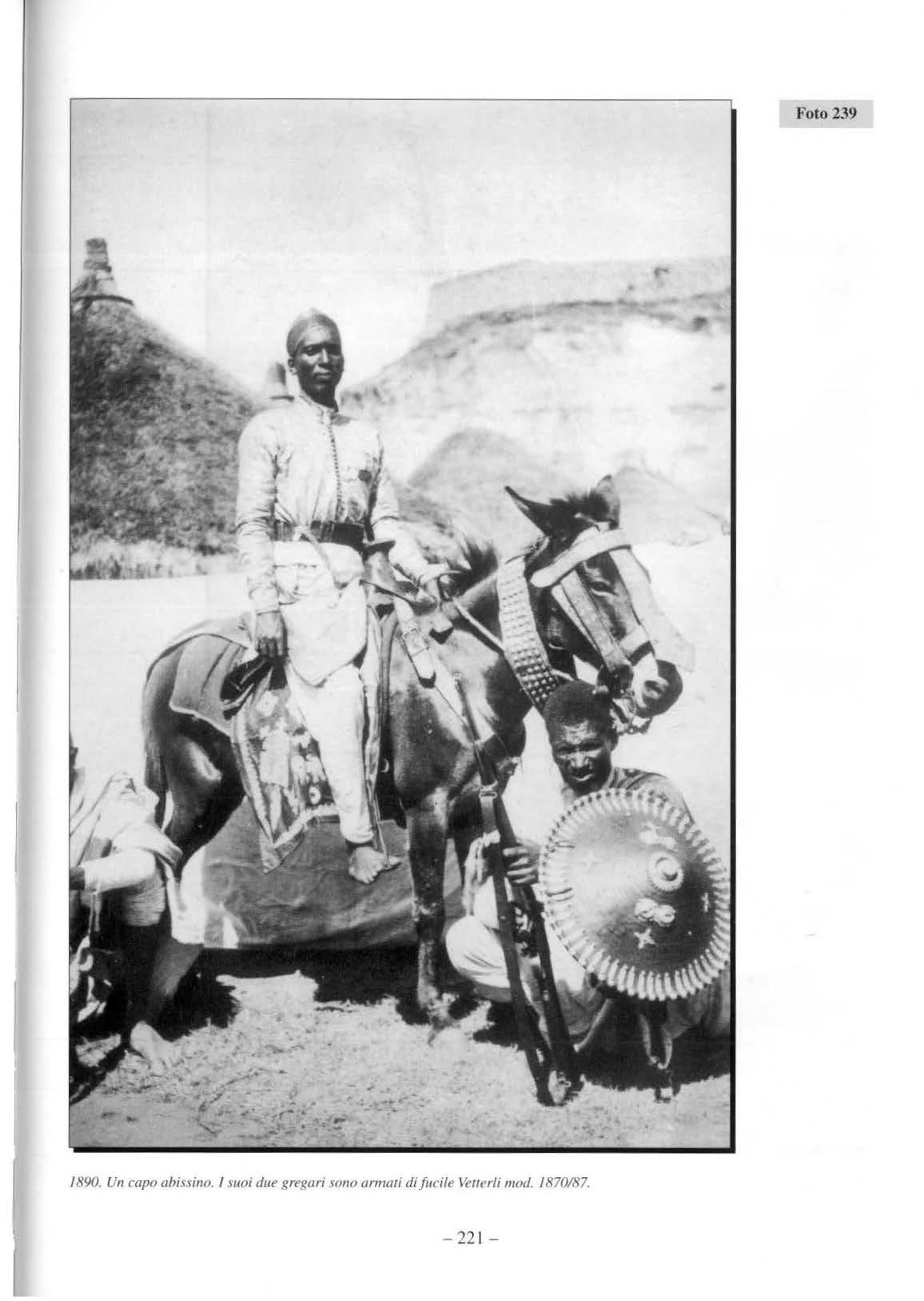
Foto 239
-2 2 1 -
1890. Un capo abissino. l suoi due gregari sono wmarì dì fucile \ feuerlì mod. 1870187.
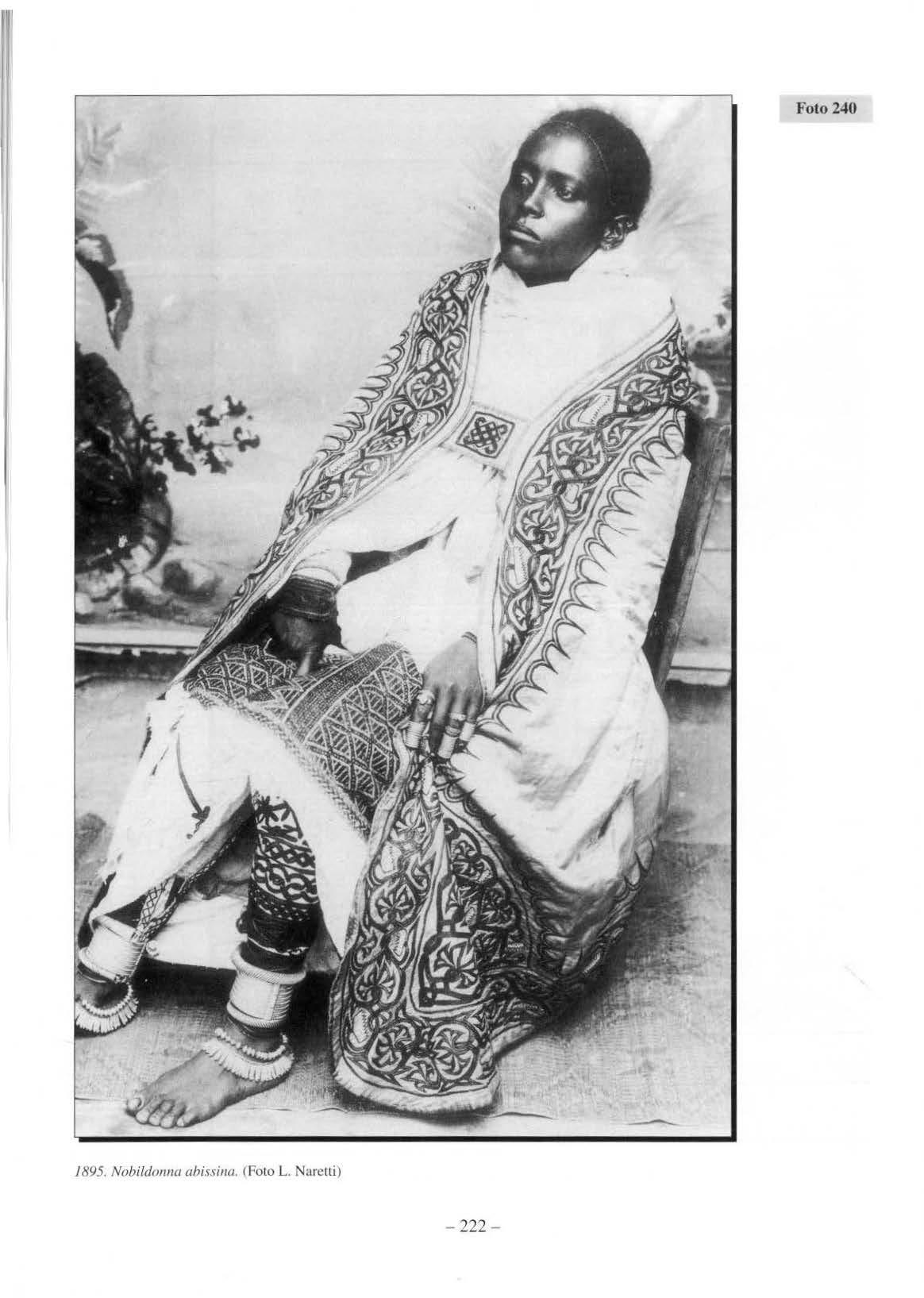
Foto 240
-222-
1895. Nobildomw abissina. (Fo to L. Naretti)
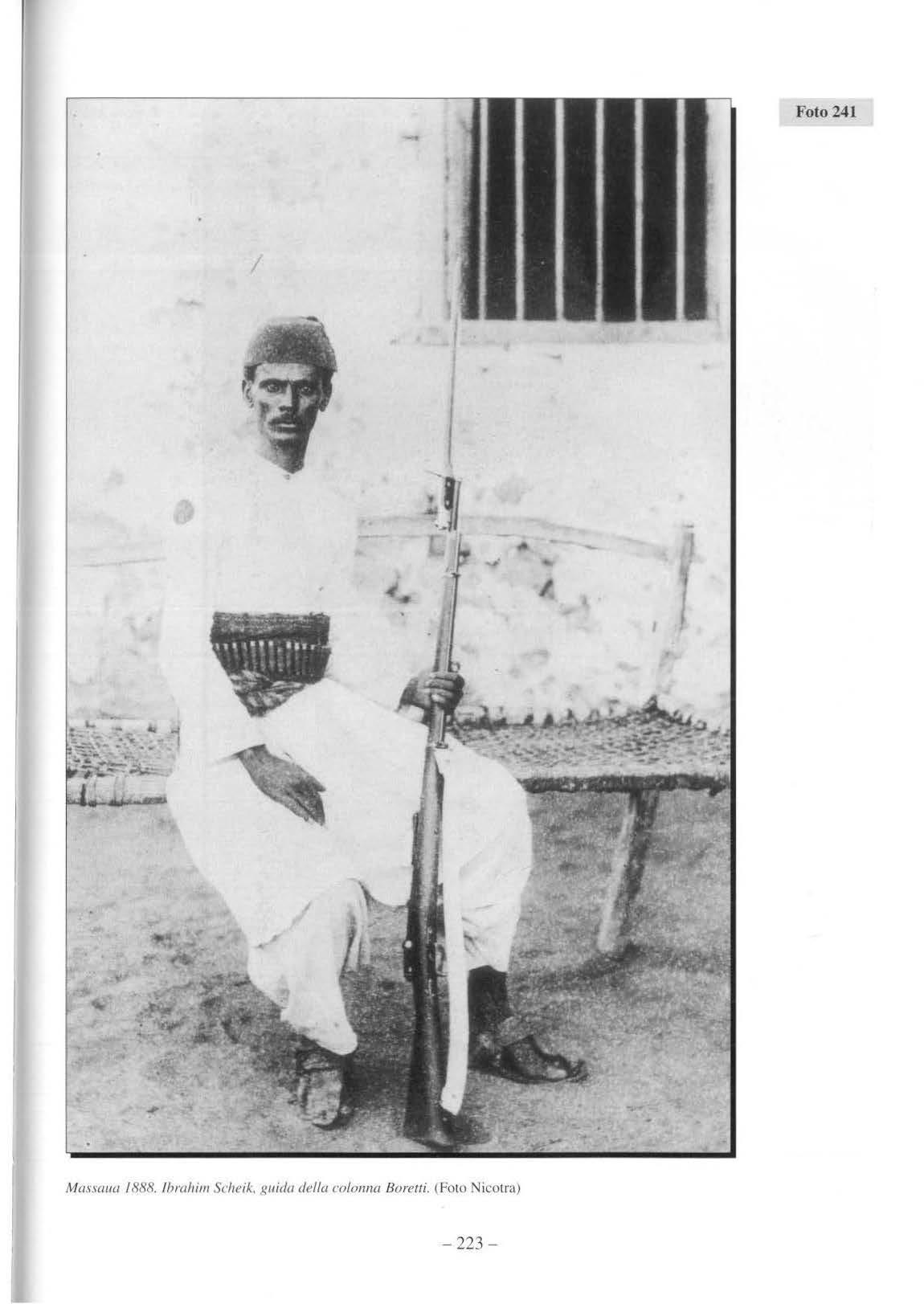
Foto 241 --''
-223-
Massaua 1888. !bmhi111 Sdteit guida della colonna Baretti. (Foto Nicotra)
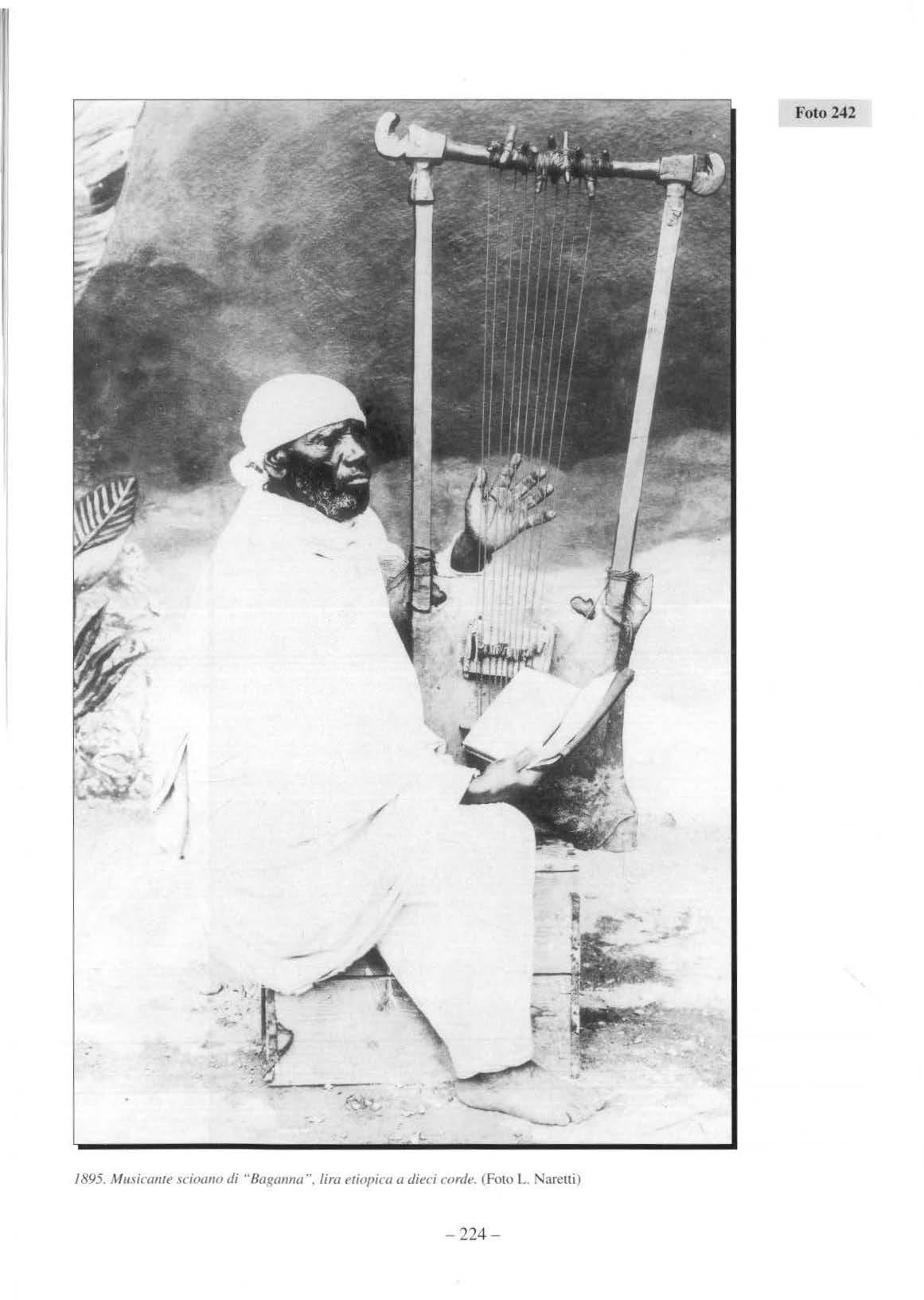
j ) L..
- 224Foto 242
/895. Musica11te :.ciocmo di .. Bagallllil''. lira etiopica a dieci corde. (Foto L. areni)
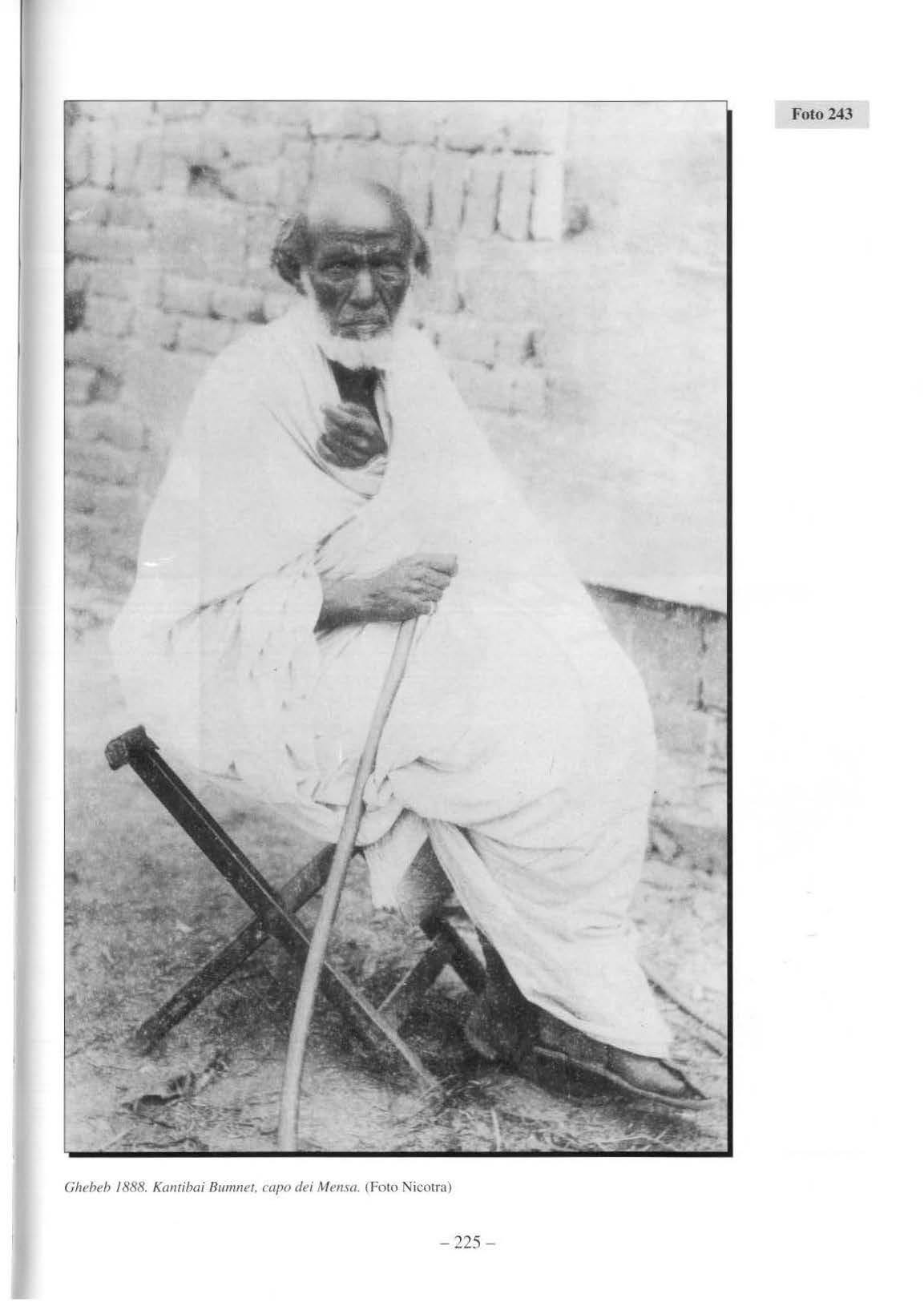
Foto243 l
-225 -
Glrebeh 1888. Kantibai Bumn et. capo dei M ema. ( Foto Nicotra )
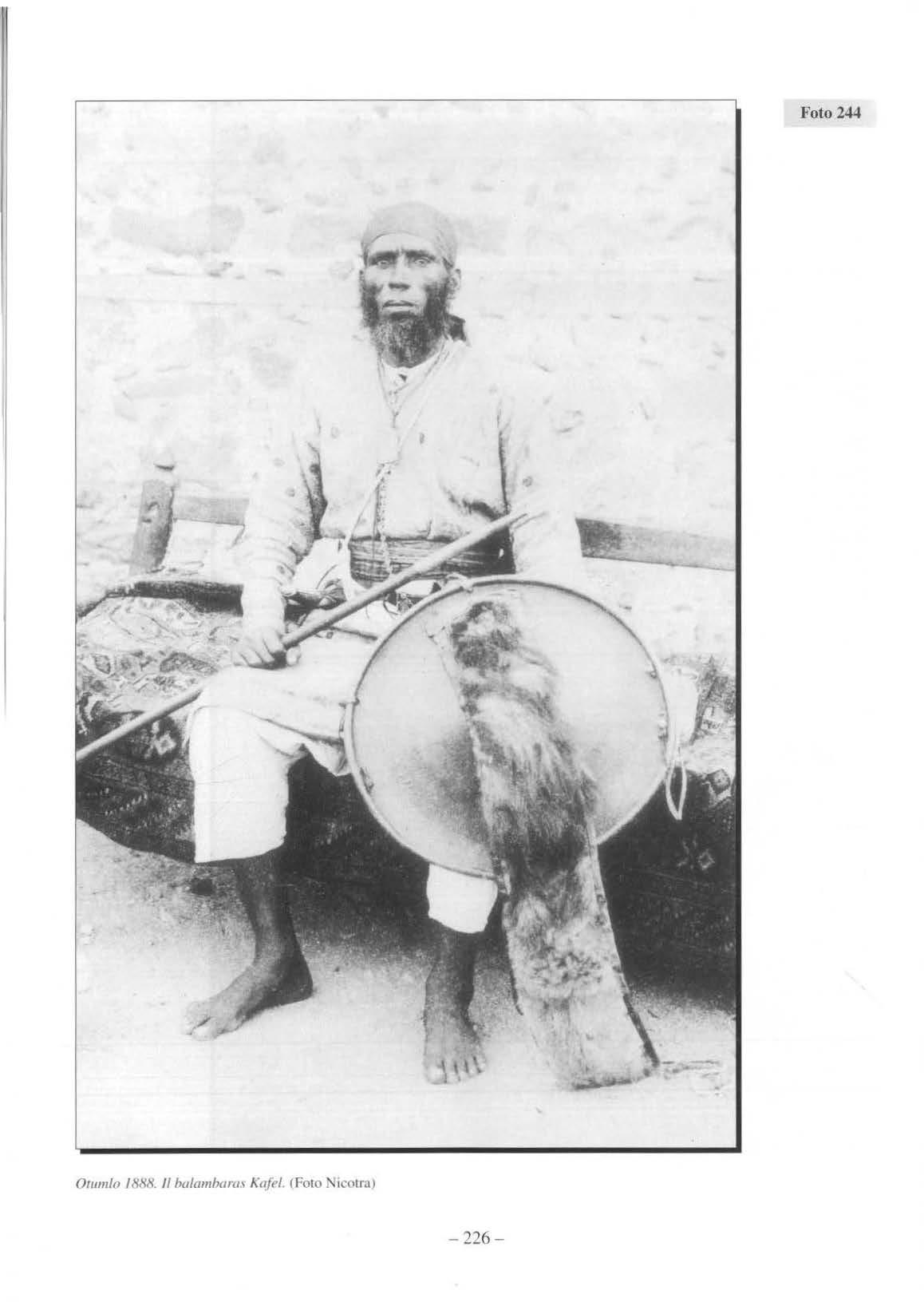
Foto 244
-226 -
Orwnlo 1888. Il balambarcn KafPI. (Foto J icotra)
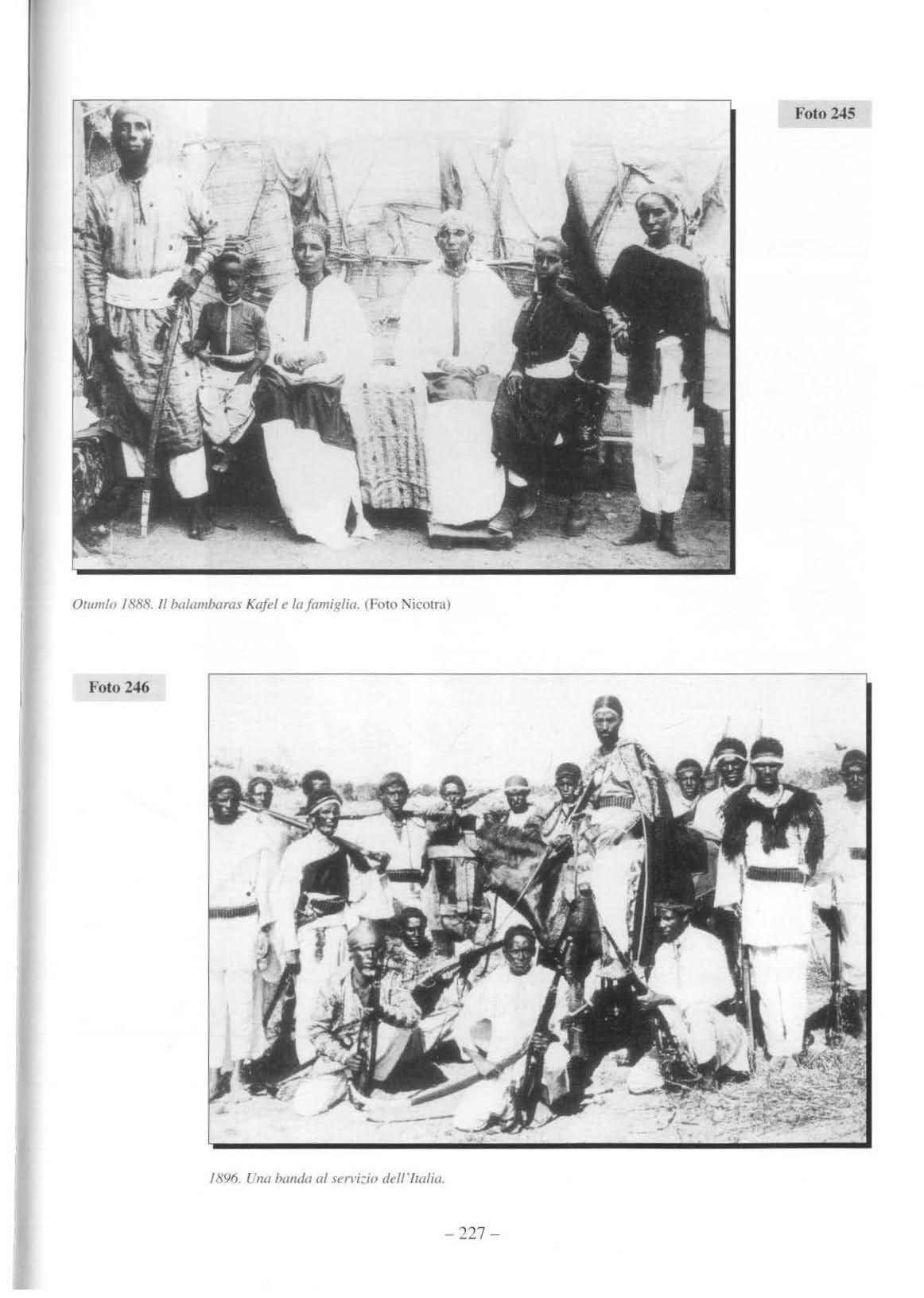 Foto 245
Owmlo /888. Il balamharaç Kafel e lafamir:lia <Foto ·icotra)
Foto 246
Foto 245
Owmlo /888. Il balamharaç Kafel e lafamir:lia <Foto ·icotra)
Foto 246
-227-
1896. Una handa al snTi::io del/" Italia.
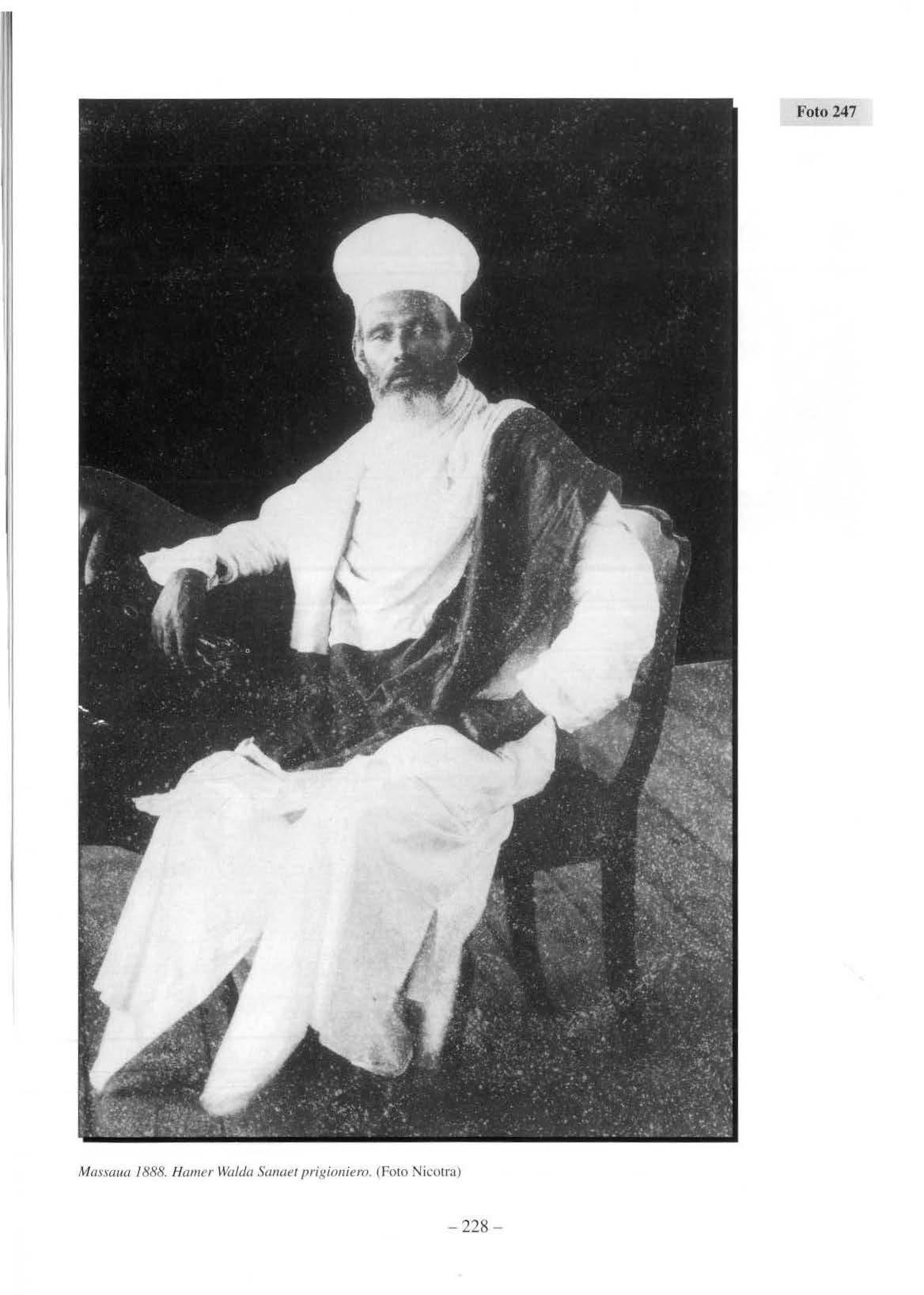
Foto 247
- 228 -
Massaua 1888 Hamer Wa/da Scmaet prigioniero (Foto Nicotra)
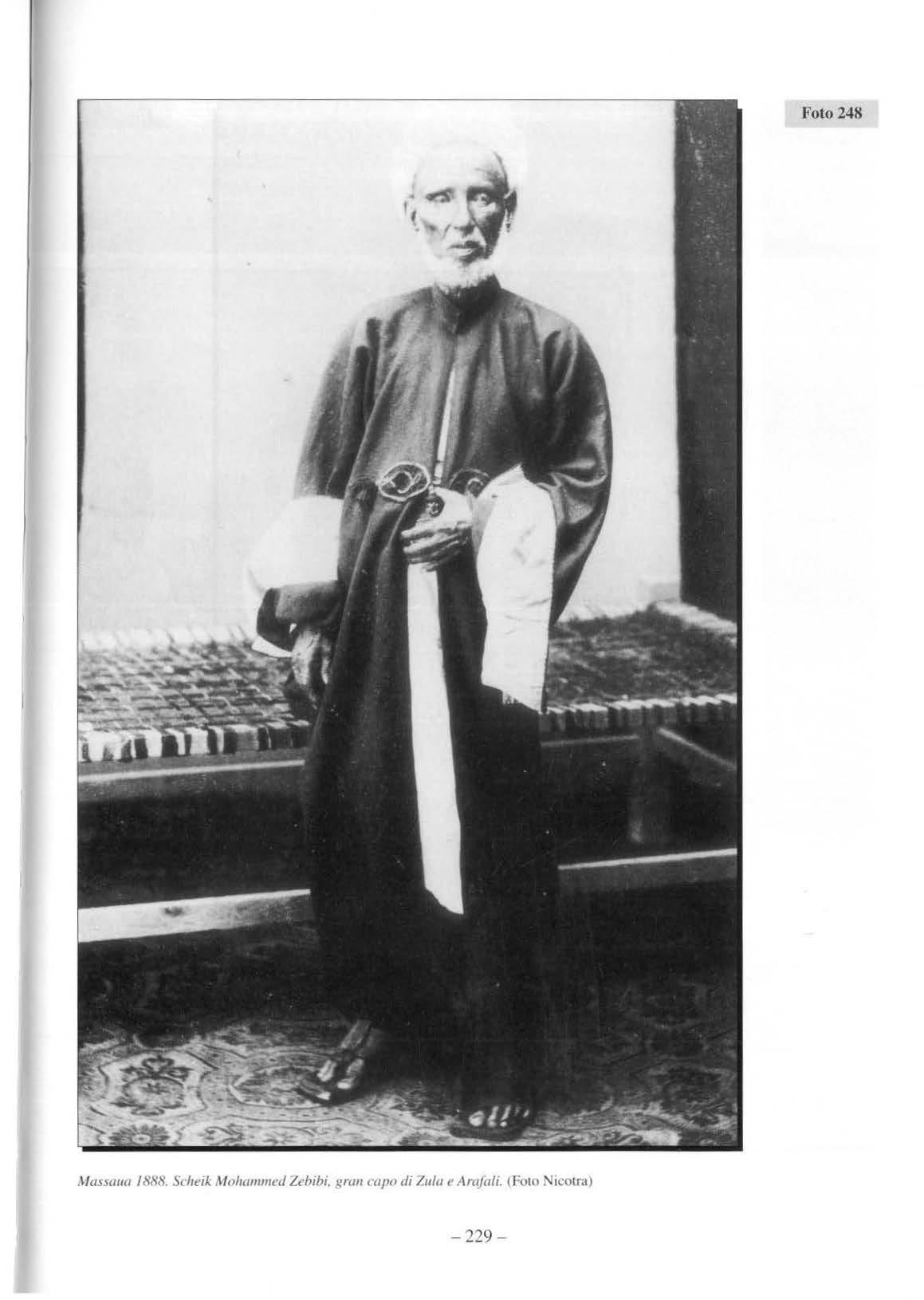
Foto 248
-22 9 -
Ma:.saua 18H8. Scheik Molwmmecl Zebibi. !:rcm capo di Zula e Arafali. (Foto. icotra)

Foto 249
- 230 -
Massaua 1886. Una porwrrire d'acqua. (Foto Ledru e Nicotra)
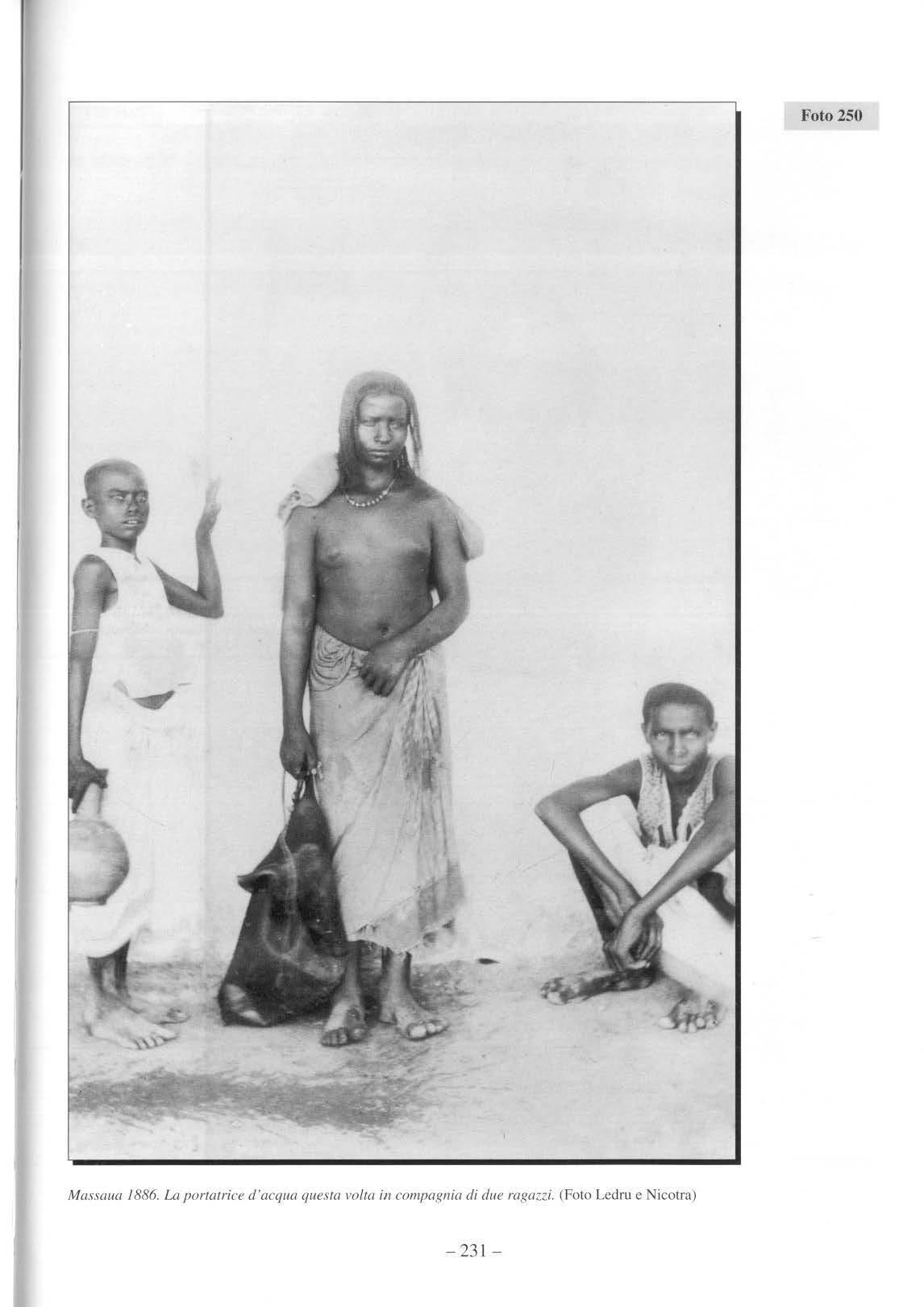
Foto250
- 23 1 -
Massaua 1886. La portatrice d·acqua questa FOlta in compagnia di due raga zz i. (Foto Lcdru e Nicotra)
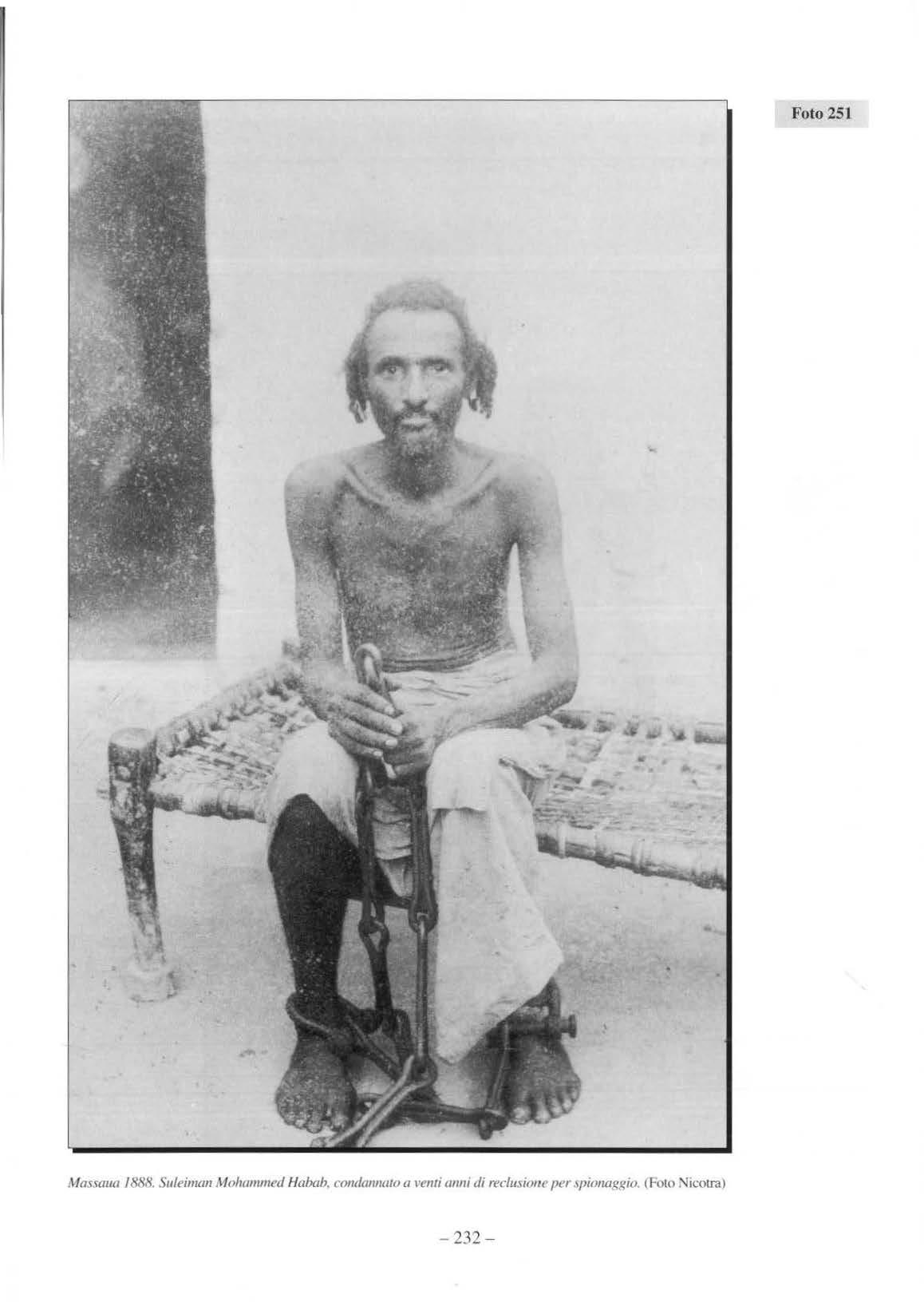
Foto 251
-232 -
Massaua 1888. Suleiman M olwmmed Habab. condannato lll'ellli wmi di reclusimu• pt•r .\pitmaggio. (Foto .'olicotra)
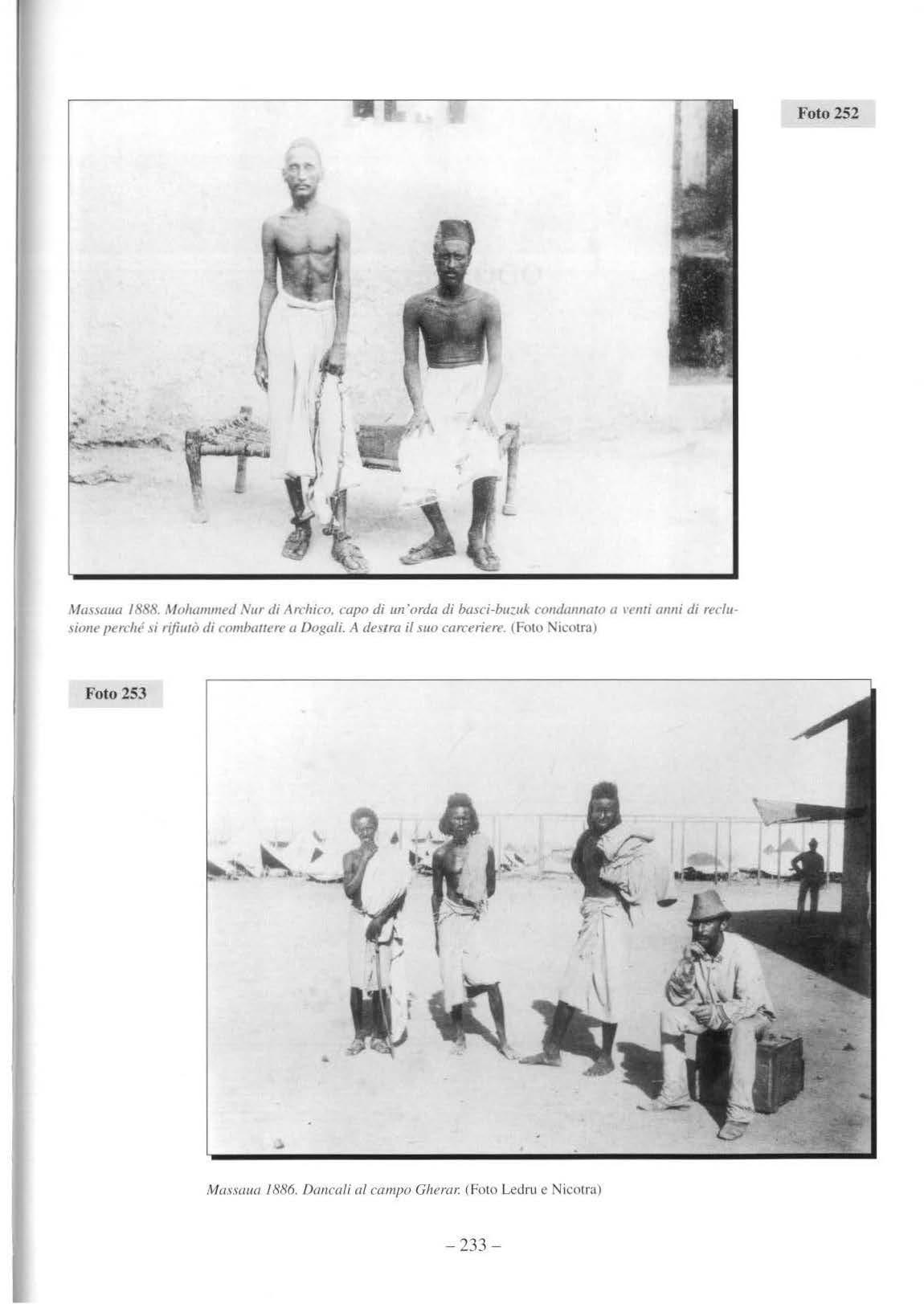 Massaua /888. Mohammed Nur di Archico. capo di w1'orda di ccmdalltWm a remi mmì di redulÌone perché .\t rijiu1ù dì comhauere a Dogali. A deSira il suo carceriere. (Foto Nicotm)
Foto 253
Massaua /888. Mohammed Nur di Archico. capo di w1'orda di ccmdalltWm a remi mmì di redulÌone perché .\t rijiu1ù dì comhauere a Dogali. A deSira il suo carceriere. (Foto Nicotm)
Foto 253
-233-
Ma.vsaua 1886. Dan ca li al campo Gher01: (Fo to Ledr u e N icotra)
Foto 252
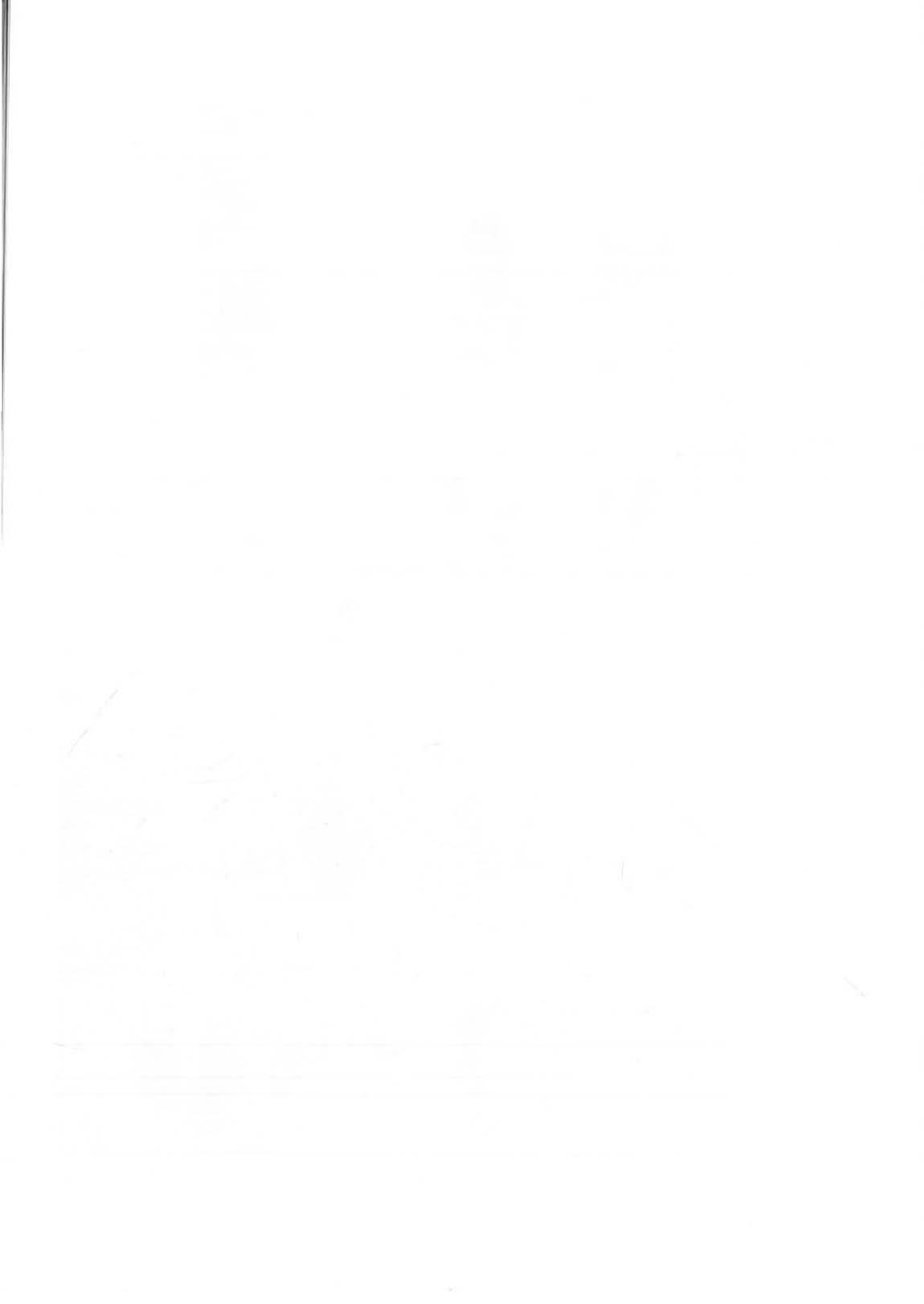
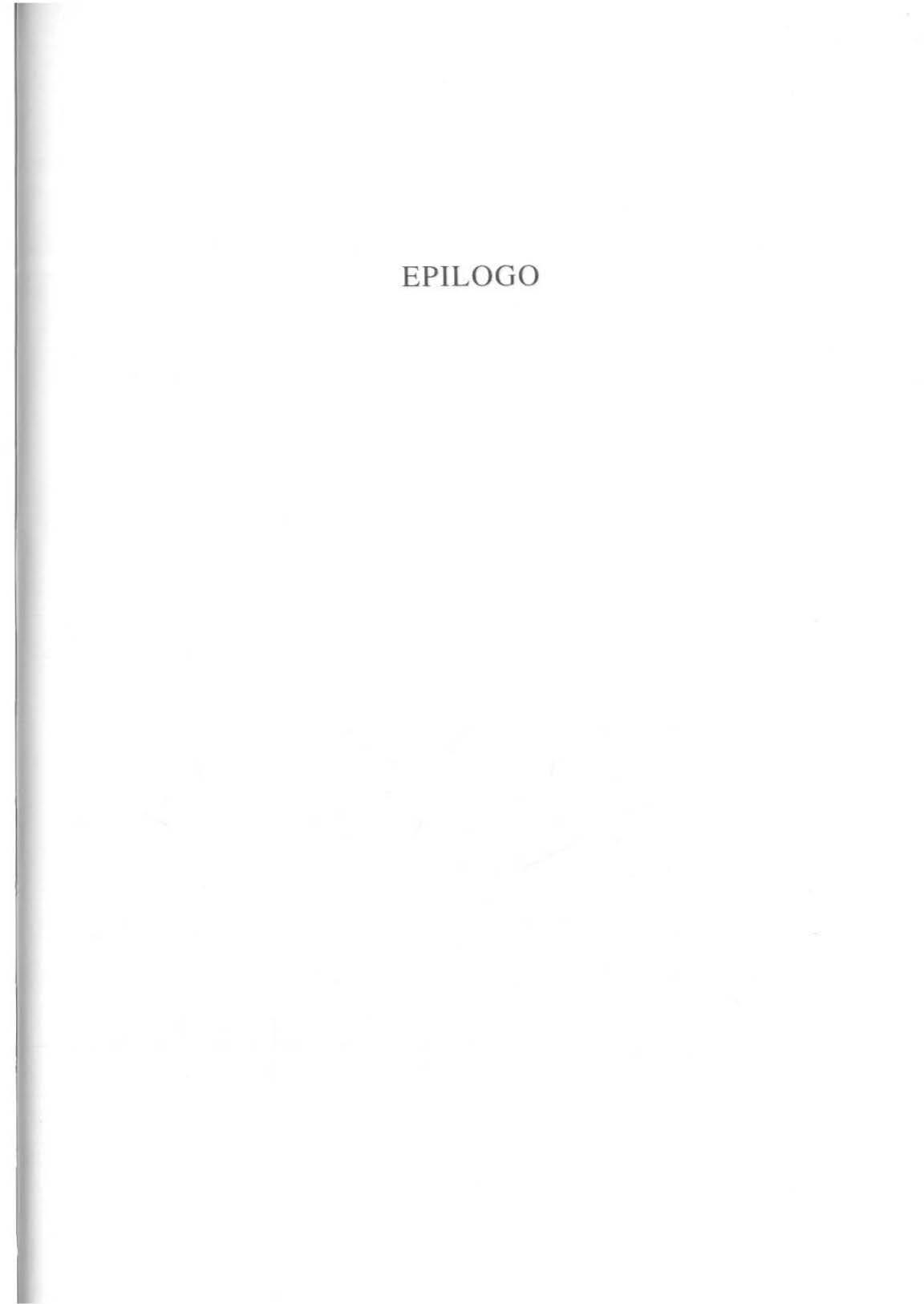
EPILOGO
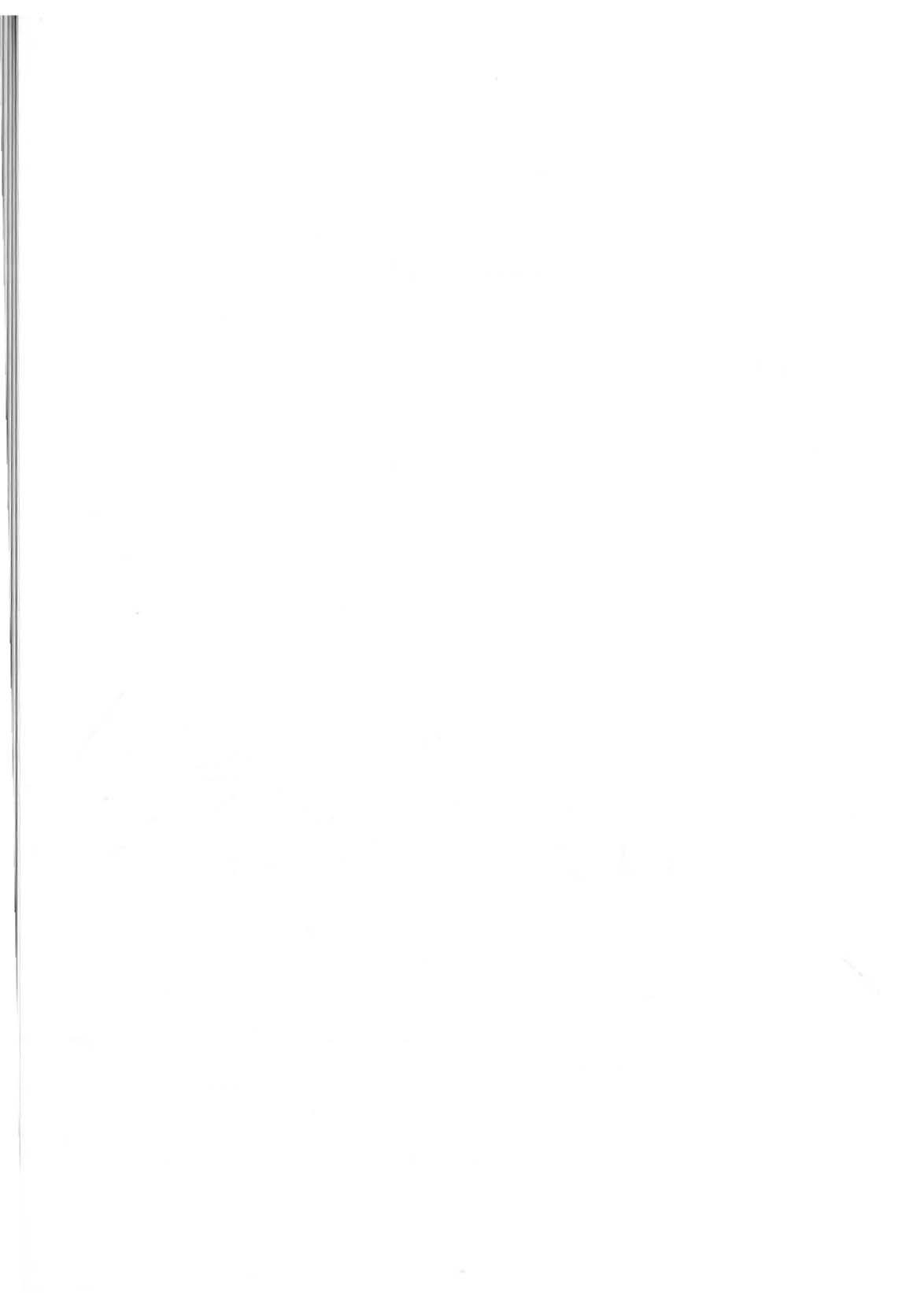

Foto 254
- 237 -
Massaual896. Due s o/dal i s upers t it i della banaglia di Adua al loro ritorno a Massaua.
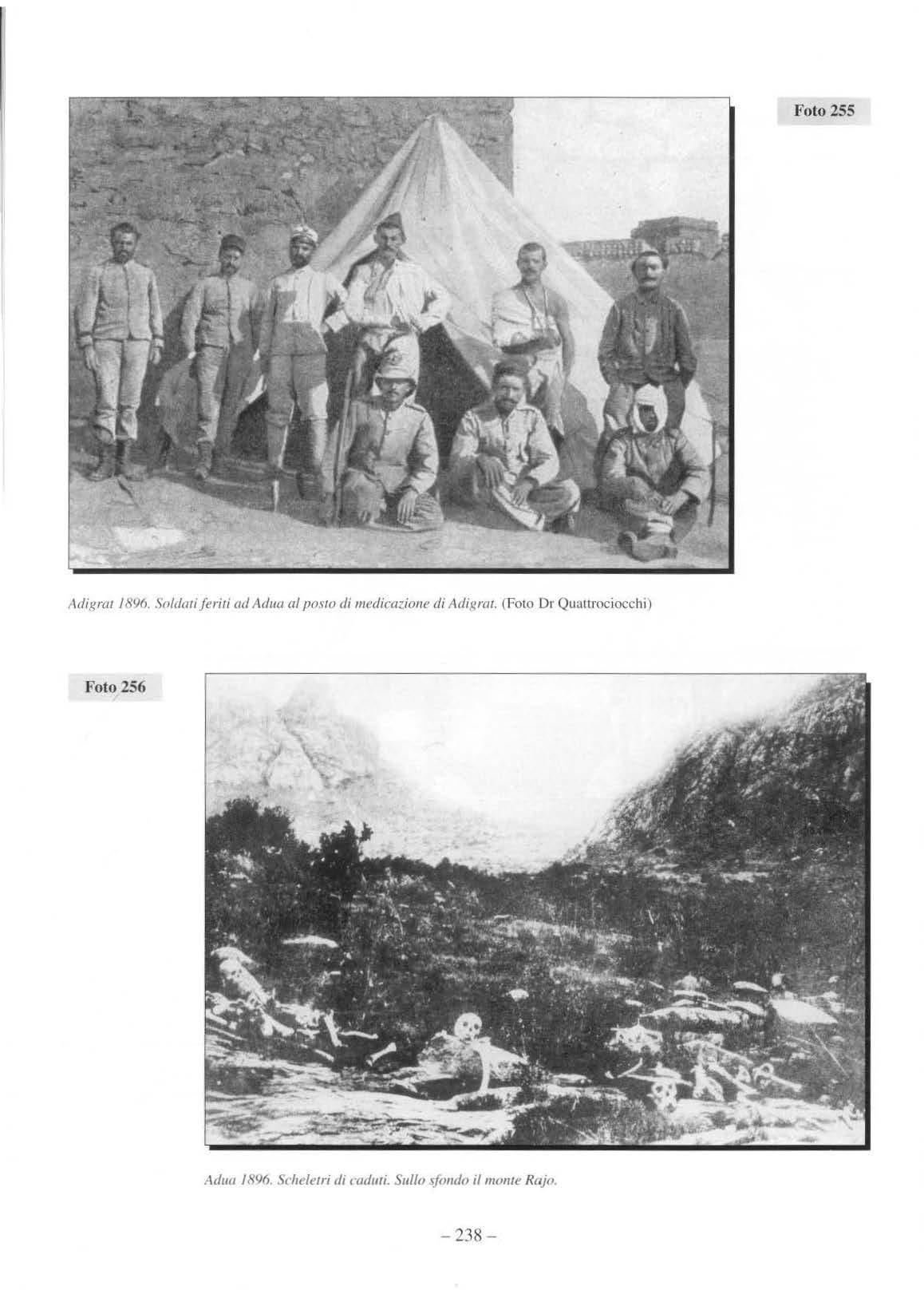
Foto 255
1\dixrat /8<J6. Soldmi.feriti ad Adua al posto di medica::.ione di Adigrat. (Foto Dr QuatLrociocchi)
Foto256
-238-
Adua /896. Scltelnri di nulli/i. Sullo sfondo ilnwnte Rajo.
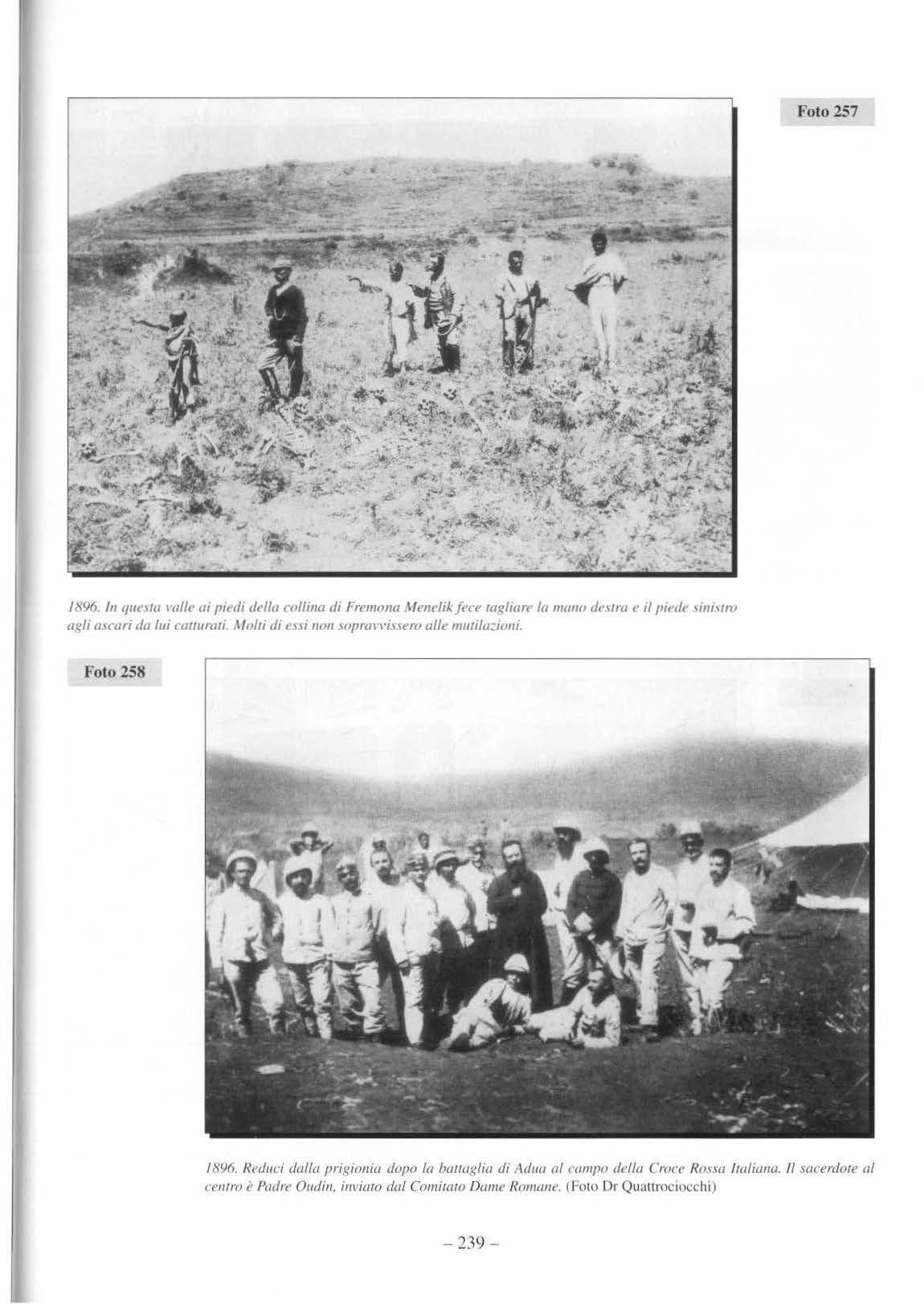 1896. Jnque.\/a l'alle ai ptedi e/t'Ila collina dt Fremono Menelikfece tagliare la ma11o de.1tra e il pwde Jinùtro agli mcari da lui cattt11mi Molti dt eui 11011 soprtiiTi.nero alle mwila::.ioni.
Foto 258
Foto 257
1896. Jnque.\/a l'alle ai ptedi e/t'Ila collina dt Fremono Menelikfece tagliare la ma11o de.1tra e il pwde Jinùtro agli mcari da lui cattt11mi Molti dt eui 11011 soprtiiTi.nero alle mwila::.ioni.
Foto 258
Foto 257
-239 -
189(). Reduci dalla prigionia dopo la batwgfia di Adua al campo della Croce Rossa Italiana. Il sacerdote al centro è Padre Oudin. im·iluo dal Comitato Dam<' Roman e. (Foto Or Quallrociocchi)
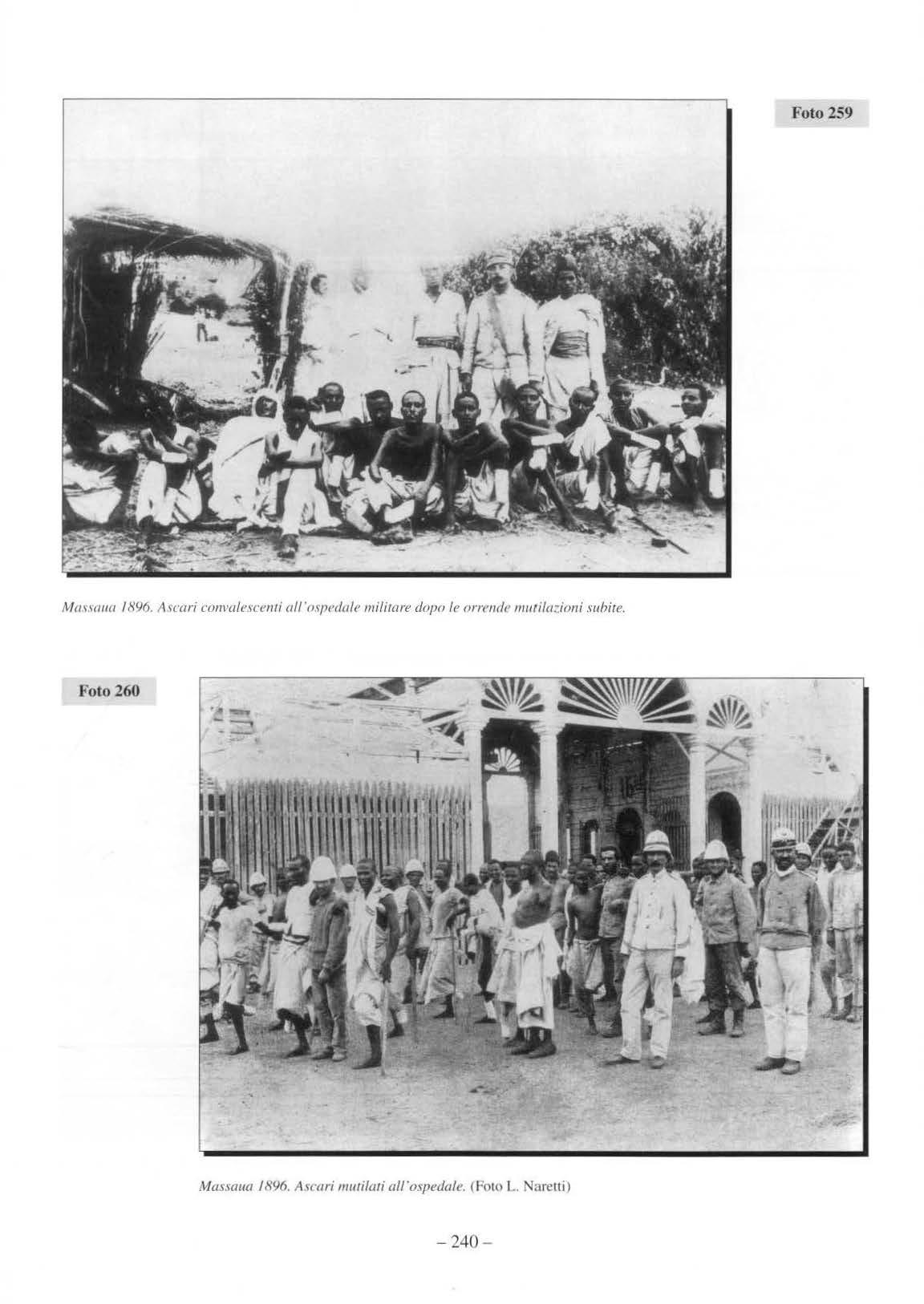
Foto 259
.Foto 260
Ma.v.1mw 1896. Ascari com·ale I'Cl'llti ali 'ospedale miliwre dopo le orrPIIde 111/ltila;:.ioni subire
-240-
Massaua 1896. Ascari muri/ari all'ospedale. (Foto L. Nnretti)

Foto 261
-24 1 -
Ma.uaua /896. Gruppo di afcari mutilati. (Folo L


PRESENTAZIONE Generale Albertone Marreo Generale Arimondi Giuseppe Domenico Generale AsiTzari di S. Marzano Conte Alessandro Generale Baldissera Antonio Giol'{lnni Generale Baratieri Oresre Generale Dabormida Vittorio Colonnello De Crisroforis Tommaso Generale E/lena Giuseppe Maggiore Calliano Giuseppe Generale Gando(fi Antonio Generale Genè Carlo Generale O rero Baldassarre Generale Sa/ella Tancredi Magg iore Tose ll i Pietro - 243pag. 245 247 248 250 252 254 255 256 257 258 260 261 262 263

ALBERTONE MATTEO
Generale, nato il 29 marzo 1840 ad Alessandria da Franceco e da Maria Barali.
Allievo dal l o aprile 1860 del Corso supplet ivo della Reale Accademia Mili ta re Sabauda di Torino, il 15 maggio 1860 viene transitato ne ll a Scuola Milita re di Modena ed i l 6 marzo 1861nominato Sottotenente nell'Arma di Fanteria - viene assegnato al Corpo dei B ersaglieri.
Destinato dal 16 a pril e 1861 ai Bersaglieri del 2 ° Corpo d'Armata, il 3 1 dicembre seguente transita ne l 2 ° Bersaglieri ( Nuova denomina z ion e dei B e rsag li eri del 2 ° Co rp o d'Armata) ed in tale ves te partecipa a ll e operazioni per la repressione del brigantaggio nel!' It alia Meridionale, guadagnando nel gennaio 1862 una decorazione al va l ore.
Trasferito dal l o feb braio 1862 al 5 ° Bersaglieri, nel luglio 1864 ottiene una secon d a decorazione al valore nelle operazioni per la r epress ione d e l brigantaggio nel combattimento di Bosco Montirezio. Il l O g iu gno 1866 co n segue la p ro m oz ione a l gra d o di Lu ogote nente ed in ta le veste prende parte alle operat. ion i della 3a Guerra d' Indip endenza Nazionale.
Ammesso dal novembre 1867 al Corso di Stato Maggiore della Scuola di Guerra di Torino. nel se ttembre 1870 prende parte a ll e operazion i per la conquista di R oma Capitale ed il l o gennaio 1871 vien e trasferito a l 10° Bersaglieri per effetto de l Reg io Decreto 13 novemb re 1870.
Conseguita dal 9 marzo 1873 la promozione a l grado di Capi tano, dalla stessa data assume la carica di co m a ndante di co mpa g ni a bersaglieri nello stesso reggimento e 1'8 giugno seguente - transitato nel Corpo di Sta t o Maggiore al termine del pe ri odo di comando - viene destinato presso il Com ando G ene ra le del Corpo di Stato Maggiore a Roma.
Des tinato dal 9 ma rzo 1874 a prestare serviz io presso gli Stati Maggiori delle Truppe, il 19 ottobre seg uente viene assegnato allo Stato Ma gg io re della Divi s io ne Milit are Te JTi tor ia le di P a le rm o cd il l o novembre 1875 è trasferito a ll a Scuola di Guerra di Torino, dove dal 2 1 agosto 1876 viene nominato Professore.
Promos o dal 4 dicembre 1879 a l grado d i M aggio re nel l' Arma di Fanteria e confermato nel predetto incarico, il 5 lugli o 1880 vie n e nominat o comanda nte di un battagl ione del J0 ° Bersaglieri ed il 9 aprile 1882 passa a disposiz.ione del Mini s tero della Gu e rra .
P assa to d a ll ' Il se ttembre 1882 a disposizione d e l Comando de l Co rpo di Stato M agg io re a R oma, il 18 seg ue nte tran sita nuovamente nel Corpo d i Stato Maggiore ed il 13 apri le 1884 consegue l a pro mo zio ne a l grado di Te ne nt e Colonnello.
[ncari cato da l l 0 luglio 1888 de ll e funzioni d el grado superiore (Tene nte Colonnello i.g.s.) e posto a di s po s iz io ne d e l Ministero della Guen·a, r l l ottobre seguente consegue la promozione al grado di Colonn e ll o ne ll'Arm a di Fanteria ed il 16 ottob r·e d e llo stesso a nno si imb a rca a Napoli per l 'E ritrea perc hé no minato comandante del 1° R egg im e nto Ca ccia tori del Corpo Speciale d'Africa.
Nominato dal l 0 otto bre 1889 coma nd a nt e in seco nda in Africa e coman d ante della Piazza di Massaua, il 20 gen nai o 1890 rientra in Ita li a pe r rimpa tri o definitivo e dal giorno seguente assume la car ica di coma nd a nt e del 1° Be rsag li eri.
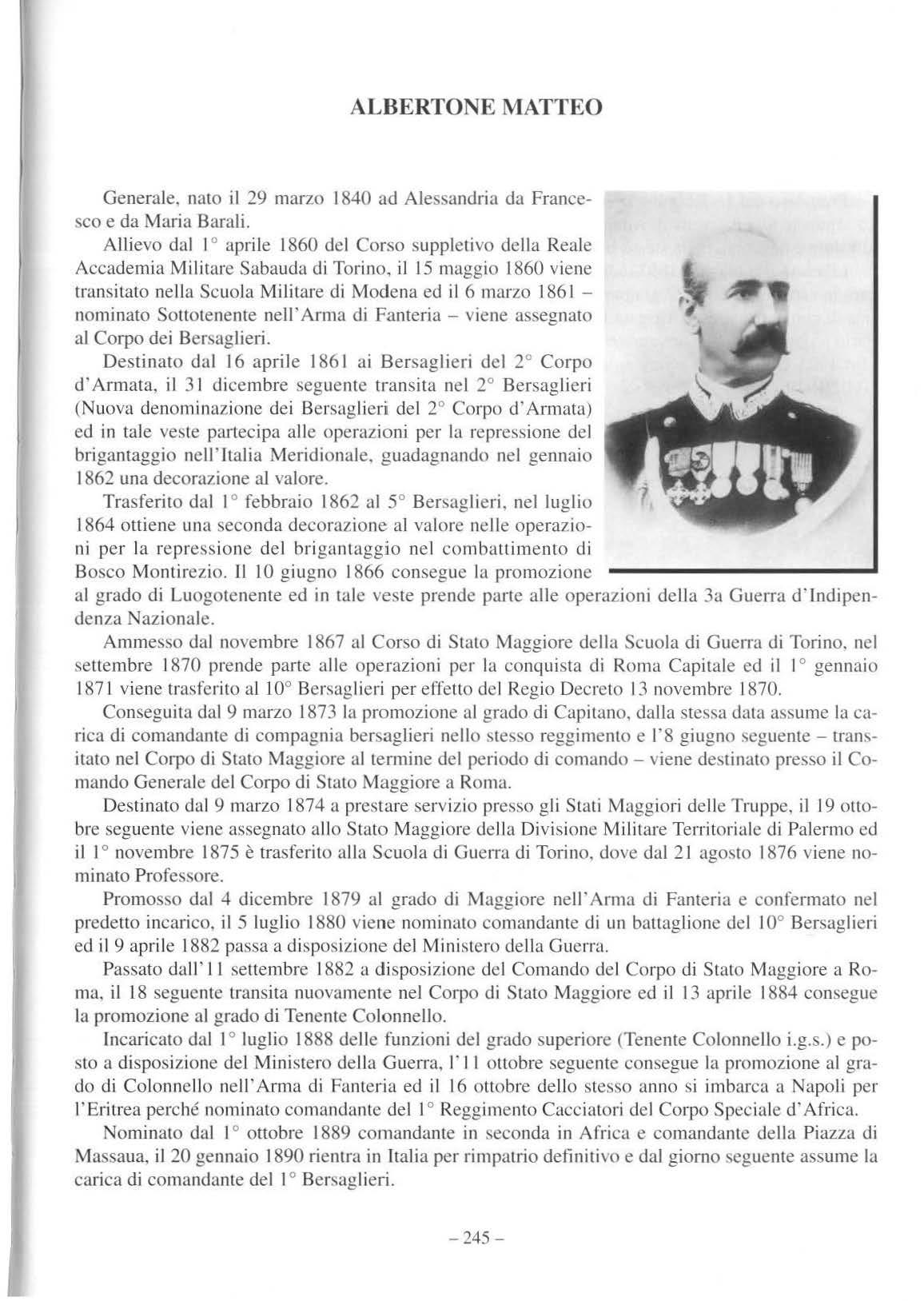
- 245 -
Comandato dal 13 marzo 1892 presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore a Roma, il 28 april e seguente transita nuovamente nel Corpo di Stato Maggiore ed il 24 dicembre 1895 s i imbarca nuovamente a Napoli per l'Eritrea, dove viene incaricato dd lc funt.ioni di comandante di una brigata di fanteria.
Promosso dal 16 febbraio 1896 al grado di Maggiore Generale. partecipa in tale veste il l o marzo seg uente a lla battaglia di Ad u a, guadagnandovi per il suo comportamento una t erza decorazione al valore e nel corso d ella s tessa batta g lia v ien e fatto pri g ion ie ro dagli Etiopici.
Lib e rato il 6 maggio 1897 dalla prigionia, il 24 dello s tesso me se rientra in Italia venendo collocato in aspett a ti va ed il 27 giug no dello s tesso a nn o vie ne richiamato in se rvizio effettivo con la cari ca di co mandant e della Bri gata R e. Coll oca to dal 16 settemb re 1897 in posizione di serv izio aus iliario a domanda, il 16 no vembre J 900 vie ne posto ne lla ri se r va per a n z ianit à di servi zio ed il 9 luglio 1905 consegue l a promozione al g ra d o di Te ne nte Generale nella riserva. Muore a Roma il 13/02/ 1919.
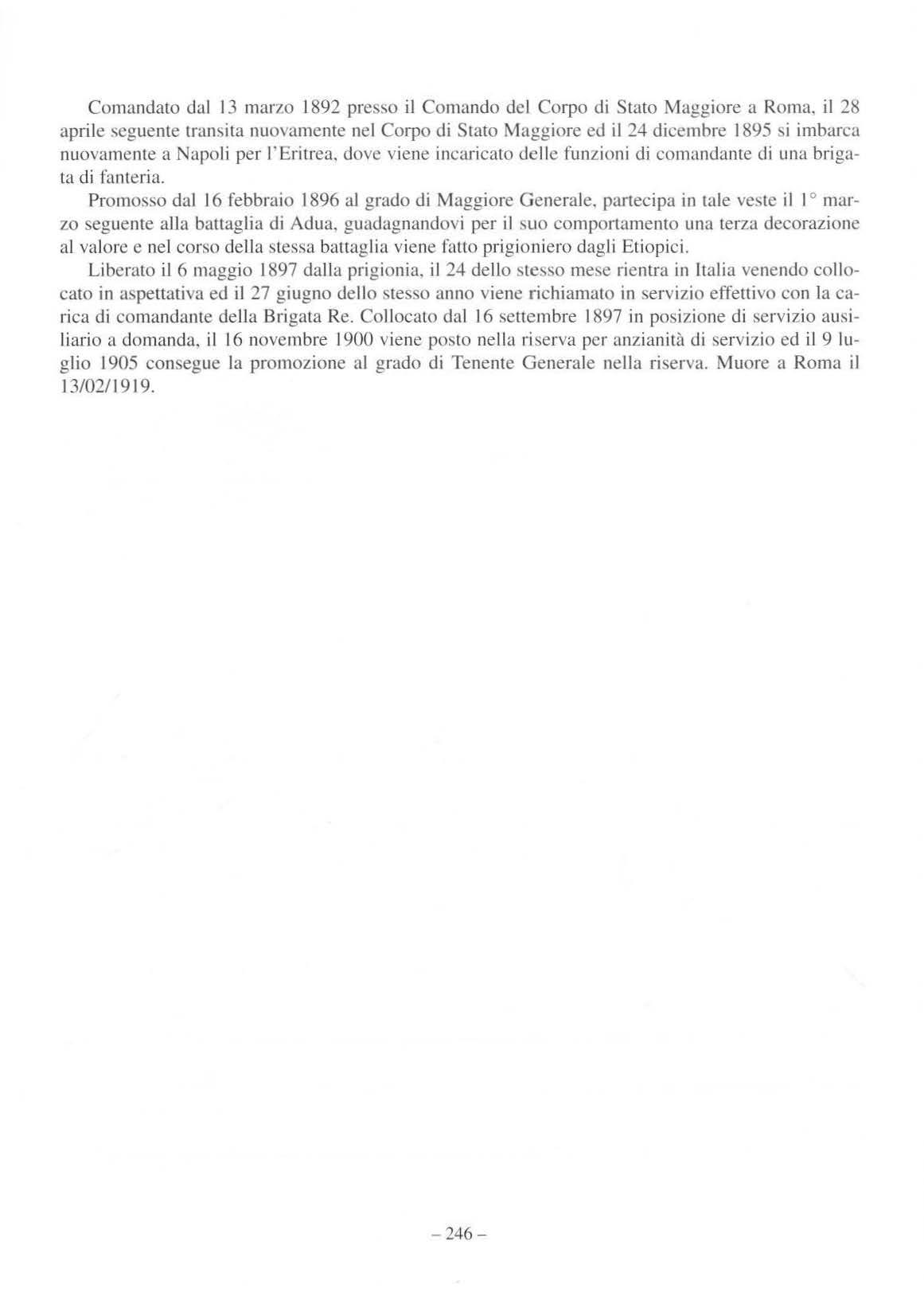
- 246-
ARIMONDI GIUSEPPE DOMENICO
Generale, nalo il 26 aprile 1846 a Savigliano nel circondario di Saluzzo (CN) da Pietro Francesco e da Barbara Appiatti.
Allievo dal 15 novembre 1863 della Scuola Militare di Modena, il 7 settembre 1865 - nomi nato Sotto tenente neu· Arma di Fanteria - è assegnato al 2 ° Reggimento Bersaglieri di Livorno ed il 5 dicembre dello stesso anno presta giuramento di fedeltà.
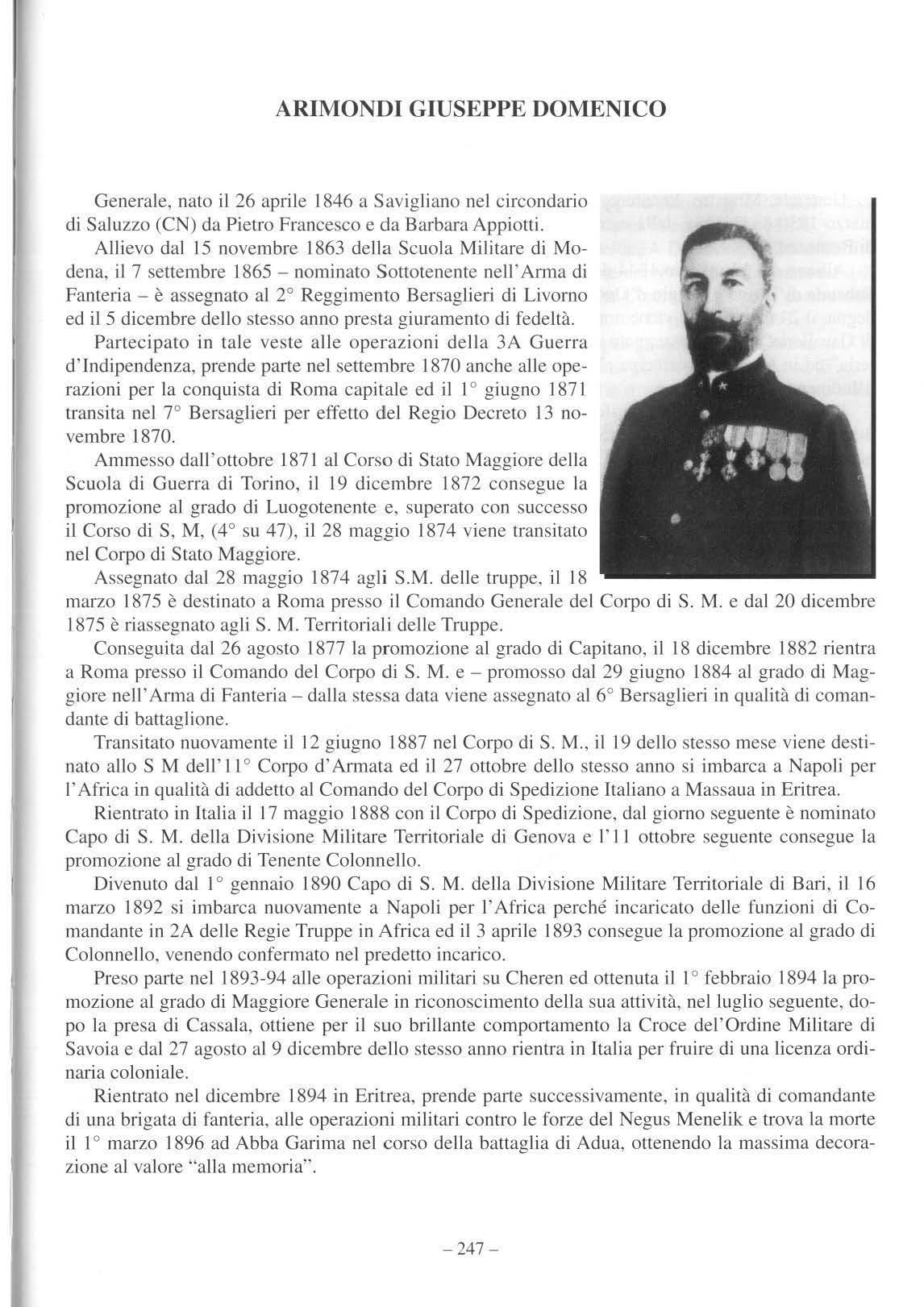
Partecipato in tale veste aJJe operazioni della 3A Guerra d'Indipendenza, prende pa11e nel settembre 1870 anche alle operazioni per la conquista di Roma capitale ed il l 0 giugno l 871 transita nel 7 ° Bersaglie1i per effetto del Regio Decreto 13 novembre 1870.
Ammesso dall ' ottobre 1871 al Corso di Stato Maggiore della Scuola di Guerra di Torino , il 19 dicembre 1872 consegue la promozione al grado di Luogotenente e, superato con successo il Corso di S, M, (4 ° su 47), il 28 maggio 1874 viene transitato nel Corpo diStalo Maggiore.
Assegnato dal 28 maggio 1874 agli S.M. delle truppe , il l 8 marzo 1875 è destinato a Roma presso il Comando Generale del Corpo di S. M. e dal 20 dicembre 1875 è riassegnato agli S. M. Territ01iali delle Tmppe.
Conseguita dal 26 agosto 1877 la promozione al grado di Capitano, il 18 dicembre 1882 1ientra a Roma presso il Comando del Corpo di S. M . e - promosso dal 29 giugno 1884 al grado di Maggiore nell ' Anna di Fanteria- dalla stessa data viene assegnato al 6° Bersaglieri in qualità di comandante di battaglione.
Transitato nuovamente il 12 giugno 1887 nel Corpo di S. M., il 19 dello stesso mese viene destinato allo S M dell' 11 o Corpo d'Armata ed il 27 ottobre dello stesso anno si imbarca a Napoli per l'Africa in qualità di addetlo al Comando del Coq)o di Spedizione Italiano a Massaua in Eritrea.
Rientrato in Italia il 17 maggio l 888 con il Corpo di Spedizione, dal giorno seguente è nominato Capo di S. M. della Divisione Militare Territoriale di Genova e r Il ottobre seguente consegue la promozione al grado di Tenente Colonnello.
Divenuto dal 1o gennaio 1890 Capo di S. M. della Divisione Militare Territoriale di Bati, il 16 marzo 1892 si imbarca nuovamente a Napoli per l'Africa perché incaricato delle funzioni di Comandante in 2A del1e Regie Truppe in Africa ed il 3 aprile 1893 consegue la promozione al grado di Colonnello, venendo confermato nel predetto incarico.
Preso pm·te nel 1893-94 alle operazioni militari su Cheren ed ottenuta il l o febbraio 1894 la promozione al grado di Maggiore Generale in riconoscimento della sua attività, nel luglio seguente, dopo la presa di Cassala, ottiene per il suo brillante comp011amento la Croce del ' Ordine Militare di Savoia e dal 27 agosto al 9 dicembre dello stesso anno rientra in Italia per fruire di una licenza ordinaria coloniale.
Rientrato nel dicembre 1894 in Eritrea, prende parte successivamente, in qualità di comandante di una brigata di fanteria , alle operazioni militari contro le forze del Negus Menelik e trova la morte il 1° marzo 1896 ad Abba Garima nel corso della battaglia di Adua, ottenendo la massima decorazione al valore ''alla memoria'·.
- 247-
ASINARI DI S. MARZANO CONTE ALESSANDRO
Generale, Mini stro, Senatore, Dep utato, nato a Torino il 20 marzo 1830 da Guido e dalla marchesa Giu seppa Maria Asina ri di Bernezzo.
A lli evo dal 13 maggio 1844 della Regia Militare Accademia Sabauda di Torino e Paggio d'Ono re di Sua Maestà il Re di Sardegna, il 24 marzo 1848 viene nominato Sottotenente nell'Arma di Cava ll eria, ven e ndo assegnato al Reggi mento "Novara Cavalleria" e d in tale veste partecipa alle operazioni della l A Guerra d' Indip e nd e nza.
Dopo la partecipazion e alla sfo rtunata campagna del 1849, il 3 lu g li o seg uente consegue l a promozione al grado di Lu ogo tenente ed il 2 luglio 1855 div e nt a Lu ogotenen te di lA Classe.

Imbarcatosi il 26 aprile 1855 a Genova perché destinato a far pru1e del Corpo di Spedizione Sardo in Ori e nt e, partec ip a i n tale ves te a ll e operazioni della Guerra di Crimea, rientrando in Pi emonte il 7 maggio 1856 ed il 7 marzo 1858 è nominato Aiutan te Maggiore in lA del "Novara Cavalleria".
Pr o mosso dal 5 marzo 1859 a l grado di Capitano nel Corpo di S. M., p artecipa in tal e veste aJle ope raz ioni d e lla 2A Guerra d' In dipendenza ottenendo ne l g iu g no seg ue nte un a decorazione al valore e l' 11 mar zo 1860 viene nominato Capo di S. M . della Bri gata di Cavall eria.
Divenuto dallO apr il e 1860 Cap it a no di lA Classe. par tecipa in tale veste alle o perazion i per la conqu is ta de ll e Marche e dell' Um bri a ed il 3 ottobre 1860 consegu e la p romozione al grado di Maggiore per "me riti di guerra" nella battaglia di Castelfidardo. Ottenuta la Croce dell'Ordine Militare di Savo ia nel febbraio - marzo 186 1 per il s uo comportamento ri s pett i va mente negli assedi di G aeta e di Me si na, il 9 aprile seg ue nte è nominato Capo di S. M. della Bri gata di Cava ll eria di Ri serva ed il 12 dello stesso mese ass um e la ca ri ca di Capo di S. M. della 7 A Divi sio ne a tti va.
Nominato dal1 '8 dice mbre 1862 Capo di S. M. della Di visione Militare Territoriale di Alessandria , il 12 marzo 1863 consegue la promozion e al g rado di Luogotenent e Colonnello ed il 5 luglio 1865 si sposa con la damigella Claudina Pill er.
Di ve nuto nu ov ame nt e dal 27 maggio 1866 Capo di S. M . d e lla 7A Di vis ione attiva. part ecipa in tale ves te alle operaz io ni della 3A Guerr a d'Indipendenza. g u adag n a nd o nel giugno seguen te una eco nd a Croce d e lrOrdin c Militare di Savoia nel fatto d'armi di Villafranca ed il 27 settembre, a l termine de lle o p eraz ion i, è no minat o Capo di S. M. della Di visio ne Militare Territoriale di Bre e ia.
Div e nuto dall' 11 nove mbre 1867 Capo di S. M. de ll a Divi sione Militare Territoriale di Perugia, il 28 nov e mbre dello stesso a nno co nseg ue la promozion e a l grado di Colonnell o c d il 9 luglio 1869 assume a nc he la carica di Capo di S. M. della 3A Divi s io ne attiva.
Nominato dal 26 sette mbre 1869 Capo di S. M. d e lla 4A Divi s ion e attiva e de ll a Di visio ne Militare Territoriale di Li vo rn o, il 5 se ttembre l 870 ass um e la carica di Cap o di S. M. della 2A Di v isione attiva ed in ta l e ves te p arteci pa a lle operazioni pe r la conq ui s ta di Rom a capit a le.
Nominato dal 23 settembre 1870 C a p o di S. M della Di visio ne Militare Territoriale di Bologna, il 6 dicembre segue nte è tra sfe rito a l Comando Generale de l Corpo di S. M. e d il 23 novembre 1875 vie ne in cari c ato dell e funzioni di co m a ndante dell'SA Bri ga ta di Cavalleria.
-248 -
Promosso dal 27 maggio 1877 al grado di Maggiore Generale e divenuto comandante effettivo della Brigata, il 15 ottobre 1878 diviene comandante della SA Brigata di Cavalleria ed il 29 gennaio 1882 as sume la carica di comandante la Divisione Militare Tenitoriale di Alessandria.
Promosso dal 19 luglio 1883 al grado di Tenente Generale e confermato nel predetto comando, il 10 ottobre 1887 è nominato comandante in capo delle Regie Truppe d ' Africa ed il 27 dello stess o mese si imbarca a Napoli per l'Eritrea, prendendo parte alle operazioni in colonia del 1887.
Rientrato in Italia il 17 maggio 1888 e riassunto il comando della 3A Divisione Militare Territoriale di Alessandria, il 27 marzo 1890 viene nominato comandante del9 ° Corpo d'Annata ed il 20 aprile dello stesso anno riceve la nomina anche a Presidente della Commissione per l ' esame delle proposte di ticompensa al valor mj]itare, incarico che mantiene sino al 14 novembre 1897.
Nominato dal 14 dicembre 1897 Mini stro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra nel Gabinetto Pelloux e Senatore del Regno d'Italia, il lO aprile 1898 viene collocato in posizione di servizio ausiliario per ragioni di età. Collocato dal 14 maggio 1899 nella riserva a domanda, muore aRoma il 16 febbraio 1906.
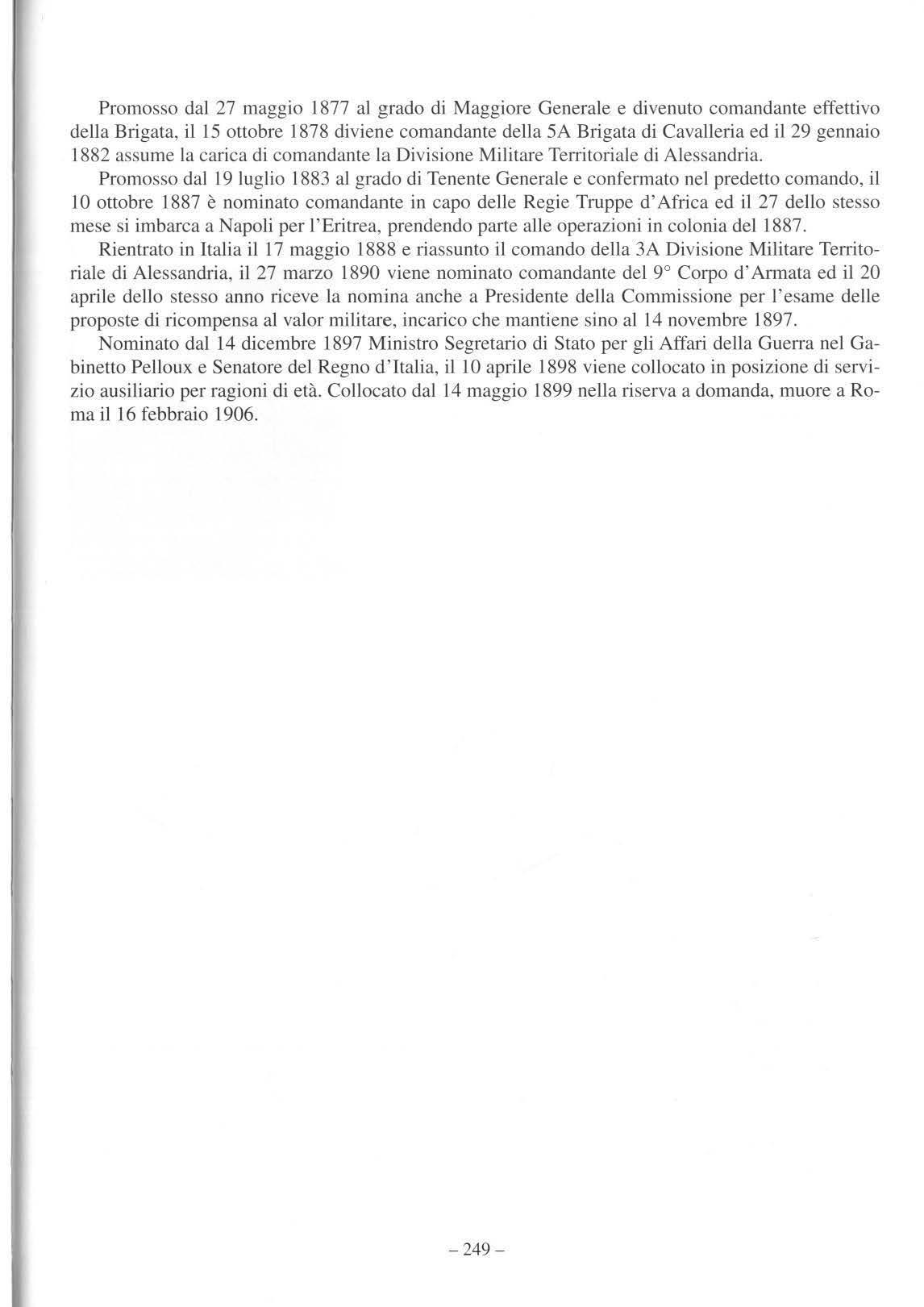
-249-
BALDISSERA ANTONIO GIOVANNI
Generale, Senatore, nato a Padova il 25 maggio 18 38 da Antonio e da Maddalena Marini.
Allievo dell'lmperial Regia Accademia Militare AustroUngarica eli Wiener Neustadt, il l o settembre 1857 viene nominato Sottotenente di 2A Cl a se nelr Arma di Fanteria e dalla stes a data è assegnato al 59° Fanteria dell'Esercito Au triaco.
Di ve nu to dal12 aprile 1859 Sottotenente di lA classe e confermato nello stesso reg gimento, prende parte in tale veste alle operazioni austriache della 2A Guen·a di Indipend enza, guadagnando una decorazione al valore austriaca nei combattimenti iniziali della campagna sul tlume Sesia ed il 27 maggio dello ste so anno consegue la promozione a l g rado di l o Tenen te.
Promosso dal 20 luglio 1859 Capitano di 2A Classe nello Stato Maggiore GeneraJe austriaco. il 27 maggio 1860 v iene deal V li Battaglion e Cacciatori ed il 27 febbraio l 867 co nsegue la promozione al grado di Capitano di l A Clas e nel Corpo di S.M ..
Ottenuta una seconda decorazione al valore austriaca nella g iornata di Custoza nel quadro delle opera:t.ioni austriache della 2A Gucn·a d' Indipendenza, da l l 0 luglio 1866 è assegnato al XXXVII Battaglione Cacciatori cd il 30 dicembre dello stesso anno sulla base de li' articolo 16 del Trattato di Pace del 3 ottobre 1866 con l'Austria, viene transitato ne ll 'Eserc ito Italiano con il grado di Capitano di l A Classe nell'Arma di Fanteria. venendo collocato in a<;pettativa dalla stessa data per riduzione di Corpo.
Riassunto in servizio effettivo dall'8 settembre 1867 ed assegnato al3l ° Fanteria a Firenze, il29 ottobre seg uente, conseguita la promozione aJ grado di Maggio re, è nominato comandante di un battaglione del 45 ° Fanteria ed il 22 novembre dello stesso anno 1itorna nelle tìle del 3 l o Fanteria.
Ri cope rta dal 13 aprile 1874 al 27 marzo 1876 la ca ri ca di Relatore del Consiglio di Amministrazio ne del reggimento , il 2 1 maggio 1876. conseguita la promozione al grado di Tenente Colonnello. è destinato al 22° Fanteria ed il 25 settembre 1879 s i sposa con la signorina Luisa Mariani.
Promosso dal 30 novembre 1879 a l grado di Colonnello e nominato coma ndante del 10° Fanteria, dal 2 gennaio 1881 diviene comanda nte del 7 ° Bersaglieri e d il 2 agosto 1886 vie ne incaricato delle funzioni di comandante della Brigata di Fanteria " Re".
Promosso dal 2 ottobre 1887 al grado di Maggiore Generale e divenuto coma nd a nte effettivo della Bri gata, il l O dell o stesso mese è nominato comanda nte di B1igata presso le Regie Truppe in Africa cd il 27 seguente si imbarca per l'Eritrea, partecipando in tale veste a lle ope ra z ioni per l 'allargamento della conquista di Massaua.
Nominato dal 19 aprile 1888 comandante Superiore in Africa e guadagnata nel 1888 la Croc e dell'Ordine Militare di Savoia per la sua brillante azione. il 16 gennaio 1890 ri entra in Italia per fine missione e dalla stessa data a urn e il comando della Bri gata di Fanteria "Calabria".
Ritornato a Massaua dal 15 ottobre al 15 d icembre l 89 1 pe r deporre quale teste nel processo Livraghi - Cagnassi presso il Tribunale Militare locale, il 9 g iu gno 1892 è incaricato delle funzioni di comandante della Div isione Milit are Territoriale di Catanzaro e l' 11 dicembre seguente, conseg uita la promozione al grado d i Tenente Generale, ne diviene il coma ndante effettivo.

- 250 -
Nominato dal 17 luglio 1893 comandante della Divisione Militare Tenitoriale eli Novara, il 22 febbraio 1896 diviene comandante in Capo delle Truppe nella Colonia Eritrea con pote1i civili e politici durante la guerra ed il giorno seguente parte per Massaua.
Giunto in Eritrea dopo il disastro eli Aclua, attende nel periodo success ivo al riordino ed alla difesa della colonia, divenendone Govern ato re ed ottenendo per il suo efficace comportamento una seconda Croce dell'Ordine Militare di Savoia, mentre il 16 ottobre 1896 viene nominato comandante del 7 ° Corpo cl ' Armata della Colonia Eritrea.

Esonerato dal l o aprile 1897, a domanda, dalla carica eli Governatore della colonia e rientrato in Italia, il 14 giugno 1898 viene nominato comandante clell'8 ° Corpo d'Armata a Firenze ed il 18 giugno dello stesso anno, durante i moti politici di quell 'anno in Toscana ed in Romagna, diviene Regio Commissario Straordinario con pieni poteri su tutto il territorio di giurisdizione ad eccezione della Piazza Marittima di La Spezia.
Cessato dalla predetta carica progressivamente dal luglio al settembre 1898 nelle varie provincie, è nominato Senatore del Regno d ' Italia ed il l o giugno J 906 viene posto in ausiliaria per età.
Collocato dal 23 giugno 1910 nella riserva per anzianità di servizio, muore a Firenze 1'8 gennaio 1917.
- 251 -
BARATIERI ORESTE
Generale, nato a Cond in o (TN) i l 12 novembre 1841 da Domenico e da Lucia Zane ll a.
Sbarcato a Marsala l'Il maggio 1860 con i Mille di Giuseppe Garibaldi, i l J6 g iu gno seguen te è nominato Sottotenente, Ufficia l e d'Ordinanza nel Corpo d'Artiglieria delrEsercito dell'Italia Meridionale e nell 'ottob re dello s te sso an no guadagna una decorazione a l va lo re ne i co mb a ttimenti so tto Capua.
Nomi n a to dal 6 no vemb re 1860 per Decreto Dittator ia le (Gen. Ga ri ba ldi) Capitano nell'Anna di Cavalleria, il 2 1 luglio 1861 v ie ne co nfe rm ato co n lo s te sso grado nell 'A rma di F a nteria del Corpo Volontari italiani ede il 16 aprile 1862 è tran sitato nell'Esercito I taliano ed assegnato al 6° Fanteria.
P osto in aspettat iva dal l 0 marzo 1865 il 25 giug no seg uente ri entra in servizio effettivo presso il 36° Fanteria e d in tale ve te partecipa alla 3A Guerra d' Indip endenza guadag na nd o una seconda decorazione al va lore ne i co mbattim enti della giornata di Custoza.
Sposatosi il 3 gennaio 1867 co n la damigella L idia Cerracchini, il 18 maggio seguente vien e pos to nu ovamente in aspettativa per riduzione di corpo e r 11 giugno 1868 è richiamato in servizio effettivo ne l 35 ° F a nteria.
Di venuto dal 30 di cembre 1868 Capitano di lA Classe, il 19 se tt embre 1869 è trasferi to a l 45 ° Fanteria ed il l o marzo 187 1 viene nominato Sottosegretario presso il comitato delle Armi di Lin ea.
Desti nato dall'8 novembre 1875 al9° Bersaglieri. il3 luglio 1876 è nomina to Ap pli cato al Corpo di Stato Maggiore e contempo raneamente comandato presso il Ministero della Guerra ed il 15 ottobre 1876, promosso a l g rad o di Mag g io re, torna nella forza ammi ni strata del 9 ° Bersaglie ri , pur rimanend o nella posizione di co m a ndante presso il Mini stero d e ll a Guerra.
Tornato dal 25 ottob re 18 80 a disposizione del Mini stero d e ll a Guerra e no min ato direttore della Rivi sta Militare, il 2 1 m agg io 1882 co nsegue Ja promo z ion e a l g r ado d i Tenente Colonnello ed il 22 gennaio 1885 è d es tinat o a l4 ° B e r sag li eri per il periodo di comando.
Incaricato da l 2 lu g li o 1885 del coma nd o del 4 ° Bersaglieri, l'Il ottob re segue nt e, promosso al grado di Colonnello, ne diviene il comandante effetti vo ed il 16 ottobre 1887 è designato quale comandante di più battaglioni in Africa.
Partito il 16 novembre per Massaua, parteci pa a11e ope razio ni nella co lonia della fine 1887- inizi 1888 (s pedizione d i Ca sala) ed i l 26 a pril e 1888, rientrato in Italia, ri assume il comando del 4 ° Ber sagl ieri.
Nominato dal 12 giugno 1890 co mand ante in 2A e comandante della P iazza di Massaua, parte nuovamente per l'Afri ca il 18 dello s tesso m ese e d il l 0 o ttobre dello stesso anno diviene comandante della zo na di Che ren.
Lasciato il l 0 luglio 1891 il predetto comando, dalla s tessa data è nom in ato coma nd ante delle Reg ie Truppe d'Africa ed il 1° no vemb re 1891 passa a dispo izione del Ministero de ll a Gu erra , rie ntrand o in It a li a il 26 de ll o stesso mese.
Nominato dal 22 febbraio 1892 Governatore C i vile della co lon ia Eri trea e, partito il 14 marzo seg uente nuov ame nt e pe r l 'A fri ca, il 17 luglio 1893 consegue l a promozione a Maggio re Genera -

.....
-25 2 -
le ed in occasione della presa di Cassa la dell7 luglio 1894 guadagna la Croce dell ' Ordine Militare di Savoia.
Collocato dal l 0 luglio 1894 per la s ua carica di Governatore Civile della Colonia a dispo sizione del Ministero degli Affari Esteri il l 0 marzo 1895 , conseguita la promozione a Tenente Generale per "merito di guerra", viene confermato nella carica di Governatore ed il 3 marzo 1896 , a causa della infausta giornata di Adua e del susseguente processo a cui fu sottoposto, viene posto in disponibilità
Collocato nella riserva a domanda il 9 agosto 1896, muore a Vipiteno (BZ) il 7 agosto 1901.
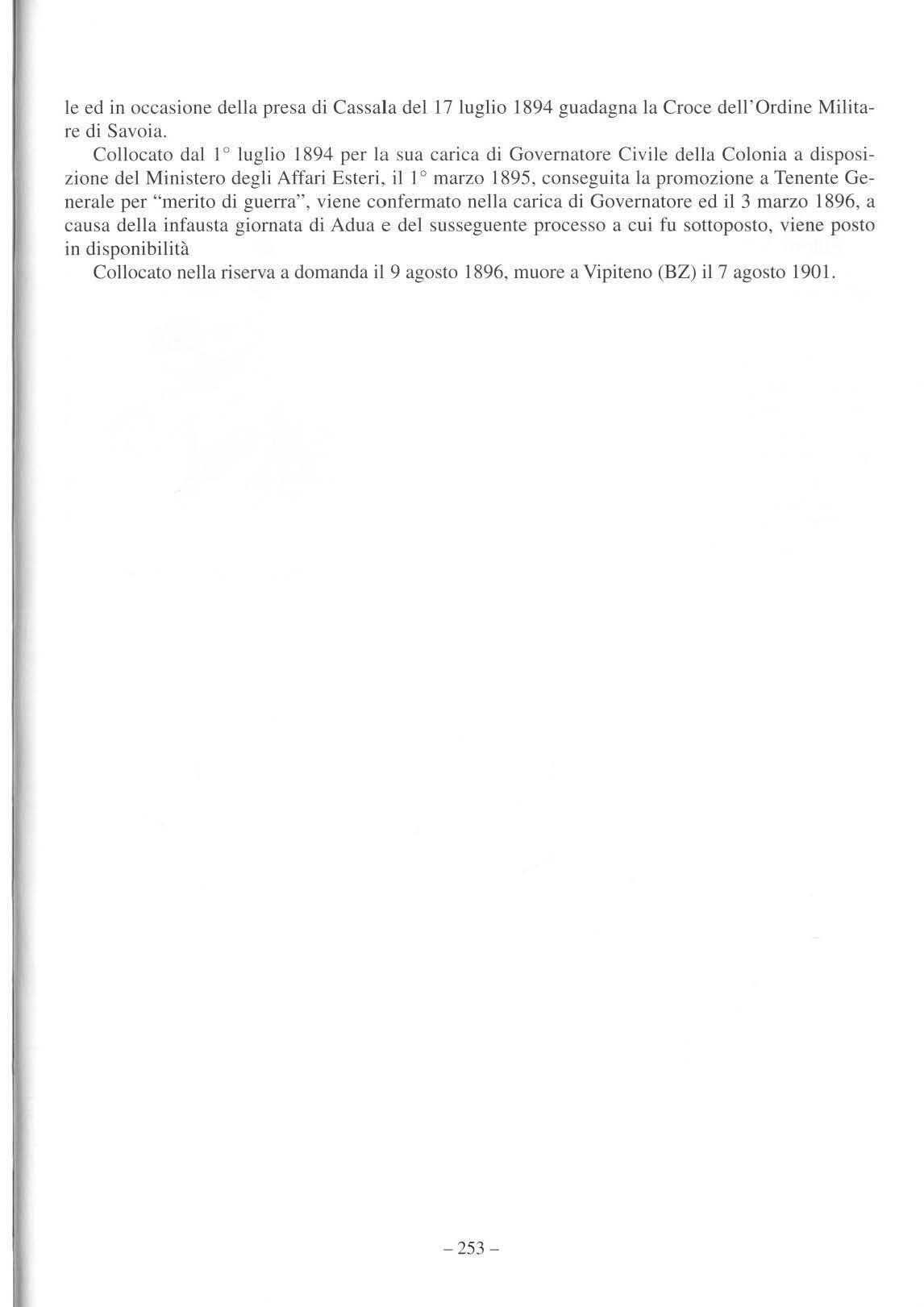
- 253 -
DABORMIDA VITTORIO
Generale,conte, nato il 22 novembre 1842 a Torino da Giuseppe e da Denig1i Angelica.
Allievo della Regia Accademia Militare in data 29 agosto 1859, diviene soldato volontario di ordinanza il 22 dicembre dello stesso anno. Promosso Sottotenente il 15 dicembre 1861 viene transitato nello Stato Maggiore di Artiglieria il 2 marzo 1862, quindi transita nel 5 ° Reggimento Artiglieria il 30 marzo 1863. Promosso Luogotenente nello stesso reggimento il 31 dicembre 1863. diviene ufficiale di ordinanza di S .M . il 28 gennaio 1864. Il 24 ottobre 1866 viene nuovamente transitato nel Corpo di S.M .. Come tale il 29 luglio 1867 passa negli Stati Maggiori delle truppe e il 19 dicembre 1867 transita al Comando Generale del Corpo. Promosso Capitano nello stesso , il 3 agosto 1868 passa nuovamente agli S.M. delle truppe il 30 maggio 1878 viene promosso Maggiore e trasferito al 74 ° Fanteria. U 19 luglio 1883 è promosso Tenente Colonnello e in tale veste comanda il 3° Reggimento Fanteria. Il 30 marzo 1890 viene dest inato al Comando del Corpo di S.M Il 4 luglio 1895 viene promosso al grado di Maggiore Generale e posto al comando della Brigata Cagliari Esonerato dal predetto incarico, viene nominato comandante di una brigata di fanteria in Afrìca il 12 gennaio 1896. Posto al comando della colonna di destra nello scontro di Adua morì in quella giornata (l o marzo 1896).

- 254 -
DE CRISTOFORIS TOMMASO
Tenente Colonnello, nato il5 giugno 841 a Casa le Monfen·ato. Ufficiale di Fa nt eria in S.P.E. aveva pat1ecipato con il grado di Te nente a ll a campagna del 1860 nelle Marche e nell'Umbria, guadagnando una medaglia d'argento. Promosso Tenente Colonnello nel 1886. nel settembre dello stesso anno partì per l'Eritrea, trovando g lorio sa fine nella battaglia di D oga li . Gli fu co nferita la medaglia d'oro alla memoria co n la seguente motivazione : '·P e r avere spo ntaneamente impegnato il combatt im ento contro forte s proporzionatamente e per aver in seguito o ppo sta e roica difesa ne ll a qu a le eg li fu uc ciso c tutti i suoi d ipendenti rima se ro morti o feriti " ( Dogal i , Erit rea 26 gennaio 1887). Quella conces a a D e Cristoforis fu la prim a medaglia d. oro delle ca mp agne coloniali ital ia ne.

- 255-
ELLENA GIUSEPPE
Generale, nato a Saluzzo (CN) il 29 marzo 1839 da Matteo Domenico e da Paola Francesca Raseri.

Nominato dal 19 ottobre 1859 Sottotenente nell"Arma di Artiglieria, il 28 marzo 1860 è assegnato al Reggimento Operai d'Artiglieria ed il 27 giugno seguente consegue la promozione al grado di Luogotenente. Tran itato dal l 0 agosto 1860 nel l 0 Reggimento Artiglieria, il l 0 aprile 1861 passa nel Reggimento Art iglieria ed il 7 dello stesso mese diviene Luogotenente di l A C lasse.
Promosso dal 23 marzo 1862 al grado di Capitano, il I o settembre 1863 è assegnato allo Stato Maggiore di Artiglieria ed il 2 luglio 1866 viene destinato al Ministero della Guerra a Firenze.
Divenuto dal 5 luglio 1866 Capitano di lA Classe, il 6 settembre seguente rientra nello S.M. d'Artiglieria cd il l 0 gennaio l 874 seguente viene nuovamenLe trasferito al 1o da Campagna.
Destinato dal l o giugno 1875 alla Direzione di Artig l ieria e Genio del Ministero della Guerra a Roma, il 4 novembre dello stesso anno consegue la promozione al grado di Maggiore, divenendo Capo Sezione della Direzione del Ministero ed il 24 novembre 1879 è trasferito al 7 ° da Campagna di Pisa per il periodo di comando di Brigata.
Destinato dal 7 luglio 1881 in qualità di addetto al Comitato di Artiglieria e Genio, il 21 maggio 1882 consegue la promozione al grado di Tenente Colonnello ed il 25 maggio dello stesso anno è nominato Segretario di Sezione del predetto Comitato. Divenuto dal 18 ottobre 1884 Comandante in 2A della Regia Accademia Militare di Artig li eria e Genio, il 7 ottobre 1887 è nominato comandante del 7 ° da Campagna di Pisa ed il 25 luglio 1892 viene incaricato delle funzioni di Direttore Generale di Artiglieria e Genio a Roma, subentrando al Generale Nicola Quaglia.
Promosso dal 16 marzo 1893 al grado di Maggiore Generale e confermato nel predetto incarico, nel 1896 lascia tale incarico per essere inviato in Eritrea per assumere l 'incarico di dirigere i servizi tecnici. Fu invece assegnato al comando di una Brigata costituita dal Generale Baratieri con un reggimento tolto alla Brigata Dabormida ed altro alla Brigata Arimondi. Alla battaglia di Adua ebbe il comando della B rigata di riserva. Ferito ad una gamba. rimpatriò da Massaua con il piroscafo "''Sumatra·· il 14 marzo 1896. Morì a Firenze nell918.
-256-
GALLIANO GIUSEPPE
Tenente Colonnello, nalO a Vicoforte (CN) il 27 se llembre 1846.
Proveniente dalla Scuola di Fantelia e Cavalleria, fu nominat o urtìciale nel 1866 e nello st esso anno prese parte a ll a campagna di guerra contro l 'Aus tria.
Nel 1883 con il grado di Tenente passò negli Alpini ma. promo sso Capitano. ritornò in Fant er ia.

Nel 1887 fu inviato in Eritrea dove rimase sino alla sua morte. Prese parte valorosamente ai combatti menti di Agordat, Coat it, Macallè ed Adua.
Al comando del III Battaglione Indigeni meritò la p rim a medag li a d 'o ro al Valor Milit are nel combattimento di Agordat contro i D ervisci. Ottenne una medaglia d'argento nelle d iffi cili operazioni contro le formazioni del Fit aurari Destà a Coatit ( 13 gennaio 1893 )
Difese s trenuamente il forte d i Macallè durant e il periodo dell'assedio dal l o al 23 gennaio 1896 e ne uscì con l'onore delle armi.
Durante tale operazione fu promosso Tenente Colonnello per meriti di guerra.
Nella battaglia di Adua, se mpre al comando del Hl Indi geni, fu accerchiato ad Abba Garima e cadde eroicamente. Il s uo corpo non fu mai ritrovato.
Alla s ua memoria fu concessa una seconda meda g lia d'oro a l Y.M
-257
GANDOLFI ANTONIO
Nobile, Generale , S ena tore, D ep utato. nato a Carpi ( MO ) il 20 febbra io 1835 da Giov a nni c da Elisabetta Ferrari Carbo lani. CadettO dal l 0 no ve mbre 1853 della Regi a Accademia Milit are Estense, il 18 novembre eguenLe diviene Caporale ed il 30 g iu gno 1857 -al termine del corso di fo rmazi o ne- viene aggregato a ll a Facoltà di Matematica delrUniversità di M ode n a per comp letare g li studi e dove il 20 novembre 1858 consegue la l aurea in In gegneria. Nominato per D ecreto Dittatoria le d a l 3 ottobre 1859 Sottotenente del G e nio ne ll 'Eserc ito m ode nese- parm e n se, il 2 5 marz o 1860 viene tran s itato con lo Rt esso g rado ne ll ' Arma del Genio deH'Ese rc ito Sardo ed il l 0 g iu g n o seg ue nte è assegnato al 2 ° Genio Zappatori. Promosso dal 24 g iu g no ' 1860 a l grado di Lu ogotene nte, il 2 ge nn a i o 1861 diviene Lu ogote ne nt e di 1A Cl asse e d in t a le ves t e ottie ne nel marzo egue nte una decorazione a l va lore ne ll 'assed i o e presa di Civ itella del Tronto, nel quadro delle operazio ni n ell' Itali a Meridionale. P assa to d a l 4 ottobre 186 1 a llo Stato Maggiore dell'Arma d e l G e ni o, il 23 marzo 1862 co nsegue l a promozione al grado di Capitano ed il 3 lu g li o 1864 viene agg regato al Corpo di S.M. , ne l quale diviene effettivo a pa rt ire dal 22 aprile 1866. Assegnato dal 27 m agg io 1866 agli S.M d e ll e Truppe, partecipa in tale veste alle operazioni della 3A Guen·a d ' Indipendenza ed il 30 g iu gno dello stesso anno di viene Ca pit a n o di l A Classe.
D es tin ato dal l O o ttobre 1866 all'Uffic io Superiore del Co rp o di S.M il l O novembre 1868 è nu ovame nte riassegnato agli S.M. delle Truppe ed in t ale veste partecipa alle opera7ioni del settembre 1870 per l a conq ui sta di Roma cap it ale. Il 22 n ovembre 1871 co n seguita la promozione al g r a d o di Maggiore nell'Arma di Fanteria, è tr asfe rit o al 7 l ° Fan teria per il periodo di coma nd o di battag li one e l ' l l di ce mbre 1873 - a l termine del periodo di coma ndo - transita nuovamente ne l Corpo di S.M ..
A seg nato dal 15 dic e mbre 187 3 agli S.M. d e ll e Trupp e, il 15 lu g li o 1877 co nseg ue la promozio ne a l g rado di Tenente Colo nn e ll o e d il 3 0 maggio 1878 è no minato Uffi ciale d'Ordinanza On ora ri o d e l R e Umb e rto I.
Nominato d a l 27 m arzo 1879 Capo di S.M. della 9A Divisione Milit are Territoriale di Bologna. 1'8 novembre 1880- co nseguita la promo zio ne a l g rado di ColonneJlo nell'A rm a di Fanteria - divie ne comandante del 3 ° Fanteria ed il 2 gen nai o 1881 a urne il tit o lo di Aiutante di Campo On o r ario de l R e. Transitato nu ovame nt e dal 7 g iu g n o J 883 - a l tem1 in e d e l periodo di coma nd o - nel Corpo di S.M., dalla s te ssa data è n o minato Capo di S.M. del 7 ° Co rpo d 'A nn a t a ed il 20 gi u g no 1884 divi e ne Capo di S.M. d e l 9 ° Corpo d 'A rmata di Rom a.
P romosso dal 2 ottobre 1887 Colonnello Bri gad ie re e nominato comandante della Brigata di Fanteria " Parma", l' 8 aprile 1888 - co nseg uita la pr o m oz io ne a l grado dì Ma ggio re G e ne rale- v iene co nfe rm ato nel pre d etto coma nd o ed il 18 giugno 1890 s i imbarca a Napoli per l 'Afri ca in quanto n omi n ato Go verna to re C ivi le e Militare della Colonia Eritrea.
Esonerato a d o ma nda dal 28 feb braio 1892 dalla carica di G overnatore d etrEr itrea, rientra in It alia il I O a prile seg uente e r Il dicembre dello stesso a nn o v ien e n o min ato coma nd a nt e d e ll a Brigata di F a nteria ..Friuli ''.

-258 -
Nominato dal 17 luglio 1893 comandante dell a 21 A Divisione Militare Territoriale di Bari, 1'8 marzo 1894 - conseguita la promozione al grado di Tenente Generale - viene confermato nel ,di Genova. Nominato dal l o marzo 1895 comandante della Divisione Militare Terri to r iale di Bologna, i l l O agosto 1898 diviene comandante del 12 ° Corpo d'Armata a Palermo e 1'8 lugl io 1899 assume l' incarico di comandante de l 6° Corpo d'Armata di Bologna. Nominato dal 20 novembre L901 Senatore del Regno, muore in servizio a Bologna il 20 marzo 1902.
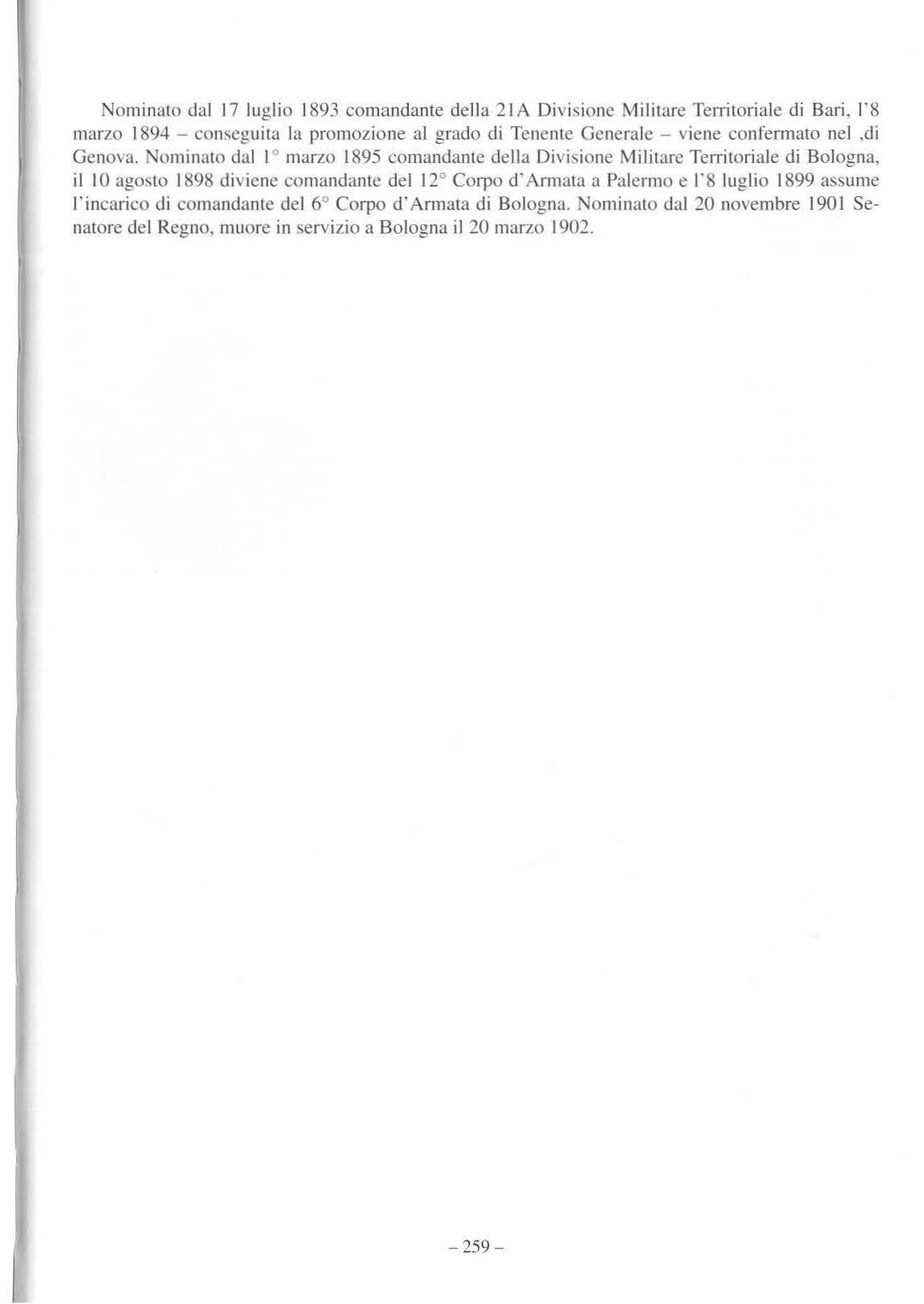
-259-
Generale. nato a Torino il 16 ap1ile 1836 da Giu seppe e Teresa Melchioni.
Entrato nel 1851 come allievo nella Regia Accademia Militare di Torino, ne uscì nel 1856 come Sottotenente del Genio. Dopo un periodo iniziale di servizio nello Stato Maggiore di quest 'A rma , nel 1858 venne trasferito con il grado di Tenente nel l o Reggimento Zappatori. Partecipò alla Seconda Guerra d ' indipendenza r anno successivo, meritando una menzione onorevole (medaglia di bronzo) "Per essersi distinto ne'lavori sotto Peschiera".
Alla fine del 1859 venne promosso Capitano e nel 1863 Maggiore. Con tale grado prese parte nel 1866 alla Terza GueJTa d'Indipendenza venendo insignito della croce di ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia per il suo comportamento durante i lavori di attacco a Borgoforte, da lui diretti tra il 5 ed il 17 luglio.
Trascorse i sei anni successivi impiegato presso lo Stato Maggiore della propria Anna e presso il Ministero della Guerra, transitando come Tenente Colonnello nel Corpo di Stato Maggiore nel 1873.
Colonnello nel 1876 - a quarant'anni - era poi Capo di Stato Maggiore del VI Corpo d'Armata tra il 1878 ed il 1880 ed al comando del 6 ° Reggimento Bersaglieri fino al 1881.
Capo di Stato Maggiore del IV Corpo d 'Armata , era successivamente posto alla testa della Brigata Regina e, promosso Maggiore Generale il 17 novembre 1883, era nominato direttore dell ' lstiGeografico Militare di Firenze.

Quest'ultimo incarico non dovette e ssere estraneo alla successiva destinazione del Genè che, con decreto del 6 ottobre 1885, era nominato Comandante Superiore delle Truppe Italiane in Africa.
Genè con tale nuova qualifica, sostituì a Massaua il l 2 novembre il Colonnello Saletta che vi era sbarcato in Febbraio. Fu sotto il comando di Genè che si verificò lo scontro di Dogali (26 gennaio 1887). Dopo tali avvenimenti fu richiamato in Italia e sottoposto al giudizio di una commissione di Generali che doveva far luce sui fatti di Dogali. Prosciolto da ogni accusa, gli fu affidato il comando della lA Brigata (l o e 2° Reggimento Cacciatori) ricevendo anche una medaglia di bronzo.
11 24 settembre 1888 fu promosso Tenente Generale e, con tale grado. una volta rimpatriato, fu posto al comando della 24A Divisione Militare di Messina, comando che esercitò per poco più di un anno prima di rassegnare le dimi ss ioni dal servizio.
Ritiratosi in Piemonte, morì a Stresa nel 1890.
GENÈCARLO
-260-
Generale, nato a Novara il l o giugno 1841 da Giuseppe e da Magda Ricotti Magnani.
Nel 1855 entra nell'Accademia Militare per entrare poi nel 1859 nel Corpo dei Bersaglie1i. n 2 maggio 1860 viene nominato Sottotenente e, il 24 agosto seguente viene aggregato al Corpo di Stato Maggiore. Si distingue agh assedi di Borgo Pio e di Gaeta, meritando la Croce di Savoia. Il 16 ap1ile 1861 entra a far parte del 1o Corpo d'Annata con il l o Reggimento Bersaglieii. D 23 marzo 1862 viene nominato Capitano e nel marzo 1863 viene transitato nel Corpo di Stato Maggiore. Il 22 settembre 1870 è promosso Maggiore e viene assegnato ali' l 1o Fanteli a. li 21 aplile I 872 transita nel Corpo di Stato Maggiore ed il 6 agosto seguente entra a far parte della Divisione Militare di Firenze. Il 19 luglio 1877 è promosso al grado di Tenente Colonnello ed assegnato al comando del 21 o Reggimento Fantelia. li 13 ottobre 1882 è nominato Capo di Stato Maggiore del lX Corpo d'Armata. Il 7 dicembre seguente, con lo stesso incarico, passa al IV Corpo d'Armata. ll 13 marzo l 887 è al comando della Brigata Calabria. LI 2 ottobre dello stesso anno è nominato Maggiore Generale. Il 6 novembre 1889 viene inviato in Aftica per sostituire il Generale Baldissera dimessosi per contrasti con il Governo di Roma.
Rientrato in Italia l'l l luglio 1890, il 16 settembre 1891 è collocato in disponibilità. Il 4 febbraio 1892 è richiamato in servizio e nominato comandante della Btigata Parma. Dall'li dicembre comanda anche la Divisione Militare di Brescia. Il 17 luglio l 893 è promosso Tenente Generale. Il 13 gennaio 1895 passa al comando della Divisione Militare di Roma. Il 28 maggio 1898 è al comando dell'Xl Corpo d ' Armata. In disponibilità dal l 0 luglio 1900 è co ll ocato a riposo e iscritto nella riserva in data IO novembre 1905. Muore a Novara nell914.

ORERO BALDASSARRE
-261-
SALETTA TANCREDI
Conte. Generale, Senatore, nato a TOtino il 27 giugno l 840. Allievo dal 20 ottobre 1856 del la Regia Accademia Militare di Torino. viene nominato Sottotenente il 26 aprile 1859 ed il 30 giugno seguente è assegnato all'Arma di Artiglieria. Destinato dal 18 gi ugno 1859 al l 0 da campagna, viene promosso Luogotenente di l A Classe.
Pa ssa to dal l o agosto 1860 al 5 ° da campagna di Venaria Reale, partecipa alla Campagna delle Marche c dcll'Umbria, guadagnando una decorazione al valore durante l'assedio di Ancona ed i l 17 marzo 1861 - promosso al grado di Capita nov iene trasferito al4° Artiglieria in qualità di Comandante di batteria. Guadagnata un'altra decorazione al valore durante l'assedio di Gaeta, 1'8 aprile 1862 viene destinato con lo s te sso incarico a l l'8 ° da campagna di Verona. dove il 16 novembre seguente divi e ne Capitano di 1A Clas e e nel cui ambito partecipa alle operazioni della Terza Guena d' Ind ipendenza nel 1866.
Promosso aJ grado di Maggiore i l 12 luglio l 872, viene trasfe rito al 9 ° da campagna in qualità di comandante di brigata e nel l 875 - dopo il periodo di comando - torna nello Stato Maggiore di A11ig li er ia. Nominato dal 22 maggio 1876 Relatore dell'Accademia Militare di Artiglieria e Genio di Torino e Direttore delle Istruzioni Militari. il 31 maggio 1877 viene trasferito nel Corpo di Stato Maggiore e destinato presso il Comitato del Corpo di Stato Maggiore Generale.
Promosso al grado di Tenente Co lonnello il 15 luglio L877. il 19 dello te sso mese è assegnato ag li Stati Maggiori Territoriali ed il 27 marzo 1879 è nominato Capo di Stato Maggiore della Di visione Militare Territoriale di FirenLe. Promosso 1'8 novembre 1880 al grado di Colonnello nell' Arma di Fanteria, dalla stessa data diviene Comandante del 17 ° Fanteria ed il 6 dicembre 1883, aJ termine del periodo di comando, è nominato Cap o di Stato Maggiore del 10 ° Corpo d'Armata .
Divenuto dal 29 giugno 1884 Capo di Stato Maggiore del 12 ° Corpo d'Annata, il 17 gennaio 18 85 viene incaricato delle funzioni di Comandante della Spedizione It aliana a Massaua cd il l 0 aprile seguen te è nominato l ° Comandante Superiore delle Regie Truppe Italiane in Africa - incarico che mantiene fino al l 0 novembre s uc cess ivo - mentre ill3 dello stesso mese di novembre fa rienrro in Italia.
I ncaricato dal 3 dicembre 1885 delle funzioni di Comandante della Brigata di Fameria Basilicata, il 13 marzo 1887 viene promosso al g rado di Maggiore Generale divenendo comandante effenivo della Brigata ed il 17 dello stesso mese è nominato nuovamente Comandante Superiore in Africa (in conseguenza della battaglia di Do gal i). P artito per M assaua il 28 marzo 1887, rientra in Italia nel 1888 cd il 29 marzo 189 1 diviene Comandante della Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio di Torino. Promosso a l grado di Tenente Generale l'l l dicembre 1892, viene confermato nel comando della Scuola e quindi ricopre in successione le funz i oni di Comandante delle Divisioni Militari Territoria li di Firenze e Genova.
Nominato dal 16 febbraio 1895 Comandante in 2A del Corpo di Stato Maggi ore, il l o ottobre 1896 assume la carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Nominato Senatore del Regno nel 1900, il 27 giugr!0 1908 - la sc iata la carica di Capo di SME- viene collocato in Posizione Ausiliaria per età e muore a Roma nel 1909.

-262 -
TOSELLI PIETRO
Maggiore, nato a Peveragno (CN) il 22 dicembre 1856 da Giovanni Maria e Teresa Bottasso.
Ammesso alla Accademia Militare di Modena il l o ottobre 1874 , passò l'anno successivo all'Accademia Militare di Torino. Nominato Sottotenente di Artiglieria il 31 luglio 1878, venne assegnato al 12° Reggimento e con la promozione a Tenente, avvenuta il 25 luglio 1880, ebbe varie successive destinazioni. Promosso Capitano il26 settembre 1886 nel 13° Reggimento, fu ammesso poco dopo alla Scuola di Guerra ed al termine del corso, l' Il dicembre 1887, passò nel Corpo di Stato Maggiore in servizio alla Divisione Militare TetTit.ariale di Milano. Nel novembre 1888 ottenne di essere destinato in Eritrea. Per l' attività e l'e nergia dimostrate , fu prescelto l'anno successivo per la costituzione di uno squadrone di esploratori indigeni con il quale partecipò nelr agosto all'occupazione di Asmara ed il 25 gennaio 1890 a quella di Adua.
Rimpatriato nel settembre 1890 e rientrato nel Corpo di Stato Maggiore, fu destinato al Ministero della Guerra. Dopo la promozione a Maggiore avvenuta nel marzo 1894, ritornò in Africa ed assunse il comando del IV Battaglione Indigeni che tanto si distinse in molti combattimenti futuri.

Con esso, nello scontro di Halai, nel dicembre 1894, in cui fu ucciso il capo banda Batha Agos, Toselli sconfisse i ribelli dell'Acche! e Cusai e restituì l'ordine nella regione. A Coatit, nel gennaio 1895 , sconfisse ras Mangascià, inseguendolo poi nella conca di Senafè, meritando per questi fatti d ' arme la Croce di Ufficiale dell'Ordine Militare dì Savoia.
11 24 novembre 1895, dal forte di Macallè si portò con il suo battagllone ed una batteria da montagna sull'Amba Alagi e dispose distaccamenti verso il lago Ascìanghi e Belagò per prevenire imovimenti del nemico. Sotto la minaccia delle masse abissine, Toselli non ebbe incertezze. Il 5 dicembre respinse fieramente l'invito di lasciare libero il passo e si schierò a difesa dell'Amba Alagi. Poi , dall ' alba del 7 dicembre 1895 fu l'anima di una resistenza eroica. Alle ore 13.00, perduta la speranza di ottenere i rinforzi richiesti, cadde combattendo fra i suoi ascari.
Alla sua memoria fu concessa una medaglia d ' oro al valor militare.
-263-

BIBLIOGRA FIA
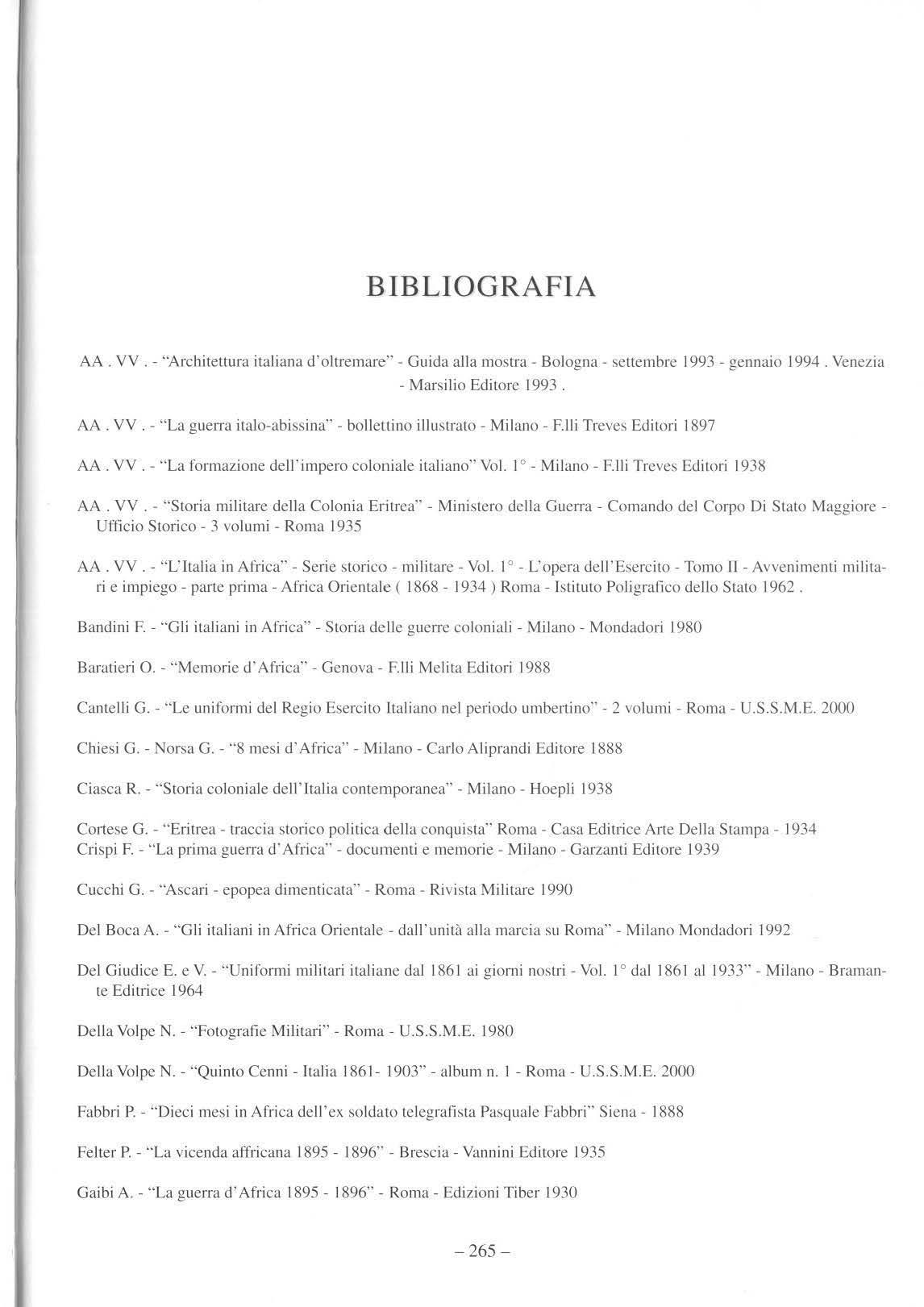
AA . VV.- 'Architettura italiana d'oltremare'' - Guida al la mostra- Bologna - 1993- gennaio 1994. Venezia - Marsilio Editore 1993
AA VV. - "La guena italo -a bissina" - bollettino illustrato- Milano- F.lli Trevcs Editori 1897
AA VV - ''La formazione de li' impero coloniale italiano" Vol. l o - Milano- F.lli T re ves Ed i tori 1938
AA . VV . - "Storia militare della Colonia E1itrca"- Ministero de ll a Gucn·a- Comando de l CoqJO Di Stato Magg ioreUfficio Storico- 3 volumi - Roma l 935
AA.VV .- ''L'Ita li a in Africa"- Serie sto ri co- militare- Vol. 1° - L'opera dell'Esercito- Tomo U- Avve nimenti militari e impiego- parte prima- Africa 01icntalc ( 1868- 1934 ) Roma- Istituto Poligrafic o dello Stato 1962
Bandini F.- ''Gli italiani in Africa' ' - Sto ria del le guerre coloniali- Mi lano- Mondadori 1980
Baratieri O.- "Memorie d ' Africa"- Genova- F.lli Melita Editori 1988
Cantelli G.- "Le uniformi del Regio Esercito Italiano nel periodo umbertino ' '- 2 volumi - Rom a- U.S .S .M.E. 2000
Chiesi G.- Norsa G.- ' '8 mes i d'Africa "- Milano - Carlo Aliprandi Edi tore 1888
Ciasca R.' Storia coloniale dell'Italia contemporanea" - Mi l ano - Hoepli 1938
Co1iese G. - "Eritrea - trac cia storico politica della conqui s ta" Roma - Casa Editrice Arte Della Stampa - l 934
Crispi F. - "La prima guerra d' Aflica" - documenti e memorie - Milano - Garzanti Editore 1939
Cucchi G. - "Ascari - epopea dimenticata" - Roma - Ri v ista Militare 1990
Del Bo ca A. - ''G l i it aliani in Africa Orientale- dall'unità alla marcia su Roma "- Milano Mondadori 1992
Del Giudice E. e V. -'·Uniformi mi l itmi italiane dal 1861 ai giorn i nostri- Vol. l o dal 1861 al 1933"- Milano - Br<unantc Edi tri ce l 964
De ll a Volpe N.- "Fotografie Militari"- Roma- U.S.S.M E. 1980
De ll a Volpe N.- ' Quinto Cenni - Italia 1861- 1903"- a l bum n. l -Roma - U.S.S. M.E. 2000
Fab bri P'' Di eci mes i in Afr ica dell'ex so ld ato Lc legralìs ta Pasquale Fabbri" Siena - 1888
Felter P.- '·La vicenda affr icana 1895- 1896''- Brescia- Vannini Editore 1935
Gai bi A . - "La guerra d'Africa 1895- l 896"- Roma- Edizioni Ti ber 1930 -265-
Gamerra G. - Ricord.i di un prigioniero di guerTa nello Scioa ( Marzo l 896 - gennaio l 897 ) Firenze - G. Barbera Editore 1897
Gatti G. - ''Le ferrovie coloniali italiane" - Roma - Edizioni G.R.A.F. 1975
Goglia L.- " Africa. colonialismo, fotogratìa: il caso italiano ( 1885 - 1940 )''-da "Fonti e Problemi della politica coloniale italiana" - Atti del convegno - Taormina - Messina 23 - 29 ottobre 1989- A cura del Mini s tero per i beni culturali e ambientali Ufficio Centrale per i beni archivistici l 996
Martin i F. - "Nell' Affrica i tal i an a" - Milano - F.lli Treves Editori 1895
Montù C. -"Storia dell'Artiglieria italiana" - Vol. VI - parte III -( Dal 1870 al l 9 l 9) - Roma - A cura della Rivista di Artiglieria e Genio 1940
Palma S.- "L' Italia coloniale''- Roma - Editori Riuniti 1999
Pezzolet V. - '·Rosso.Argento & Turchino'· - I colori. le armi , le uniformi dei Carabinieri - Vol. 2 °- Roma - Ente Editoriale per l'Arma dei Carabinieri 2000
Pollera A ." La battaglia di Adua del 1° marzo 1896 narrata nei luoghi ove fu combattuta' '- Firenze - Carpigiani e Zipoli J928
Pugli s i G. - "Chi è? dell'Eritrea 1952 - dizionruio biografico"- Asmara- Agenzia Regina - 1952
Rainero R. - ''Pietro Toselli - un peveragnese nella storia- dalla colonizzazione dell'Eritrea all'Amba Alagi - Comune di Peveragno - Biblioteca Civica ''Stefano Bouasso" Peveragno- Blu Edizioni 1996
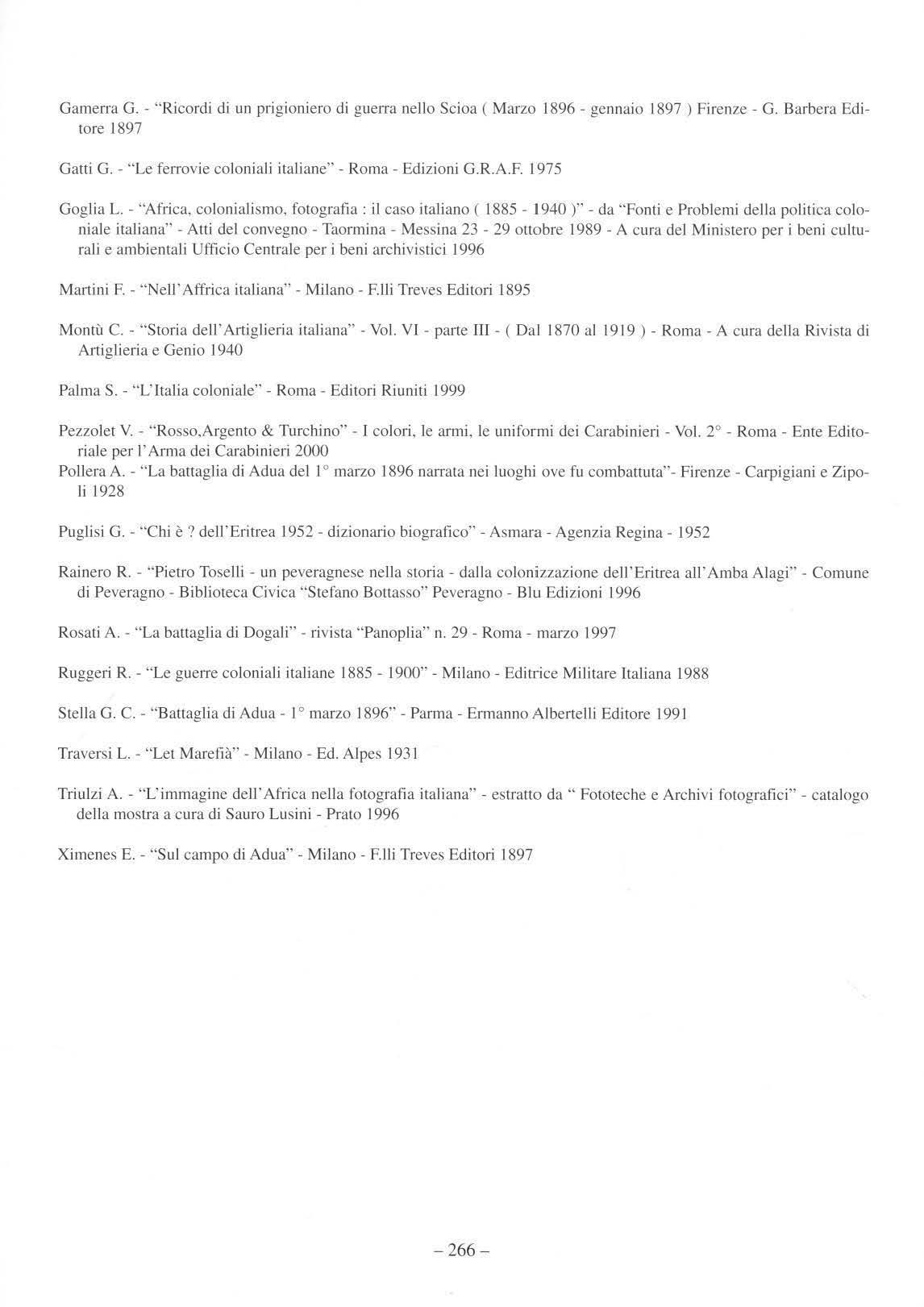
Rosati A. - "La battaglia di Dogali" - riv ista ·'Panoplia" n. 29- Roma- marzo 1997
Ruggeri R. - "Le guene coloniali italiane 1885 - 1900"- Milano- Editrice Militare Italiana 1988
Stella G. C... Banaglia di Adua - J o marzo 1896'' -Parma- Ermanno Albertelli Editore 1991
Traversi L. - "Let Marefià" - Milano- Ed. Alpes 1931
Triulzi A. - ''L'immagine dell'Africa ne lla fotografia italiana"- estratto da" Fototeche e Archivi fotografici " - catalogo della mostra a cura di Sauro Lusini - Prato 1996
Ximcnes E.- "Sul campo dj Adua"- Mi lano- F.lli Treves Editori 1897
-266-
REFERENZE FOTOGRAFICHE
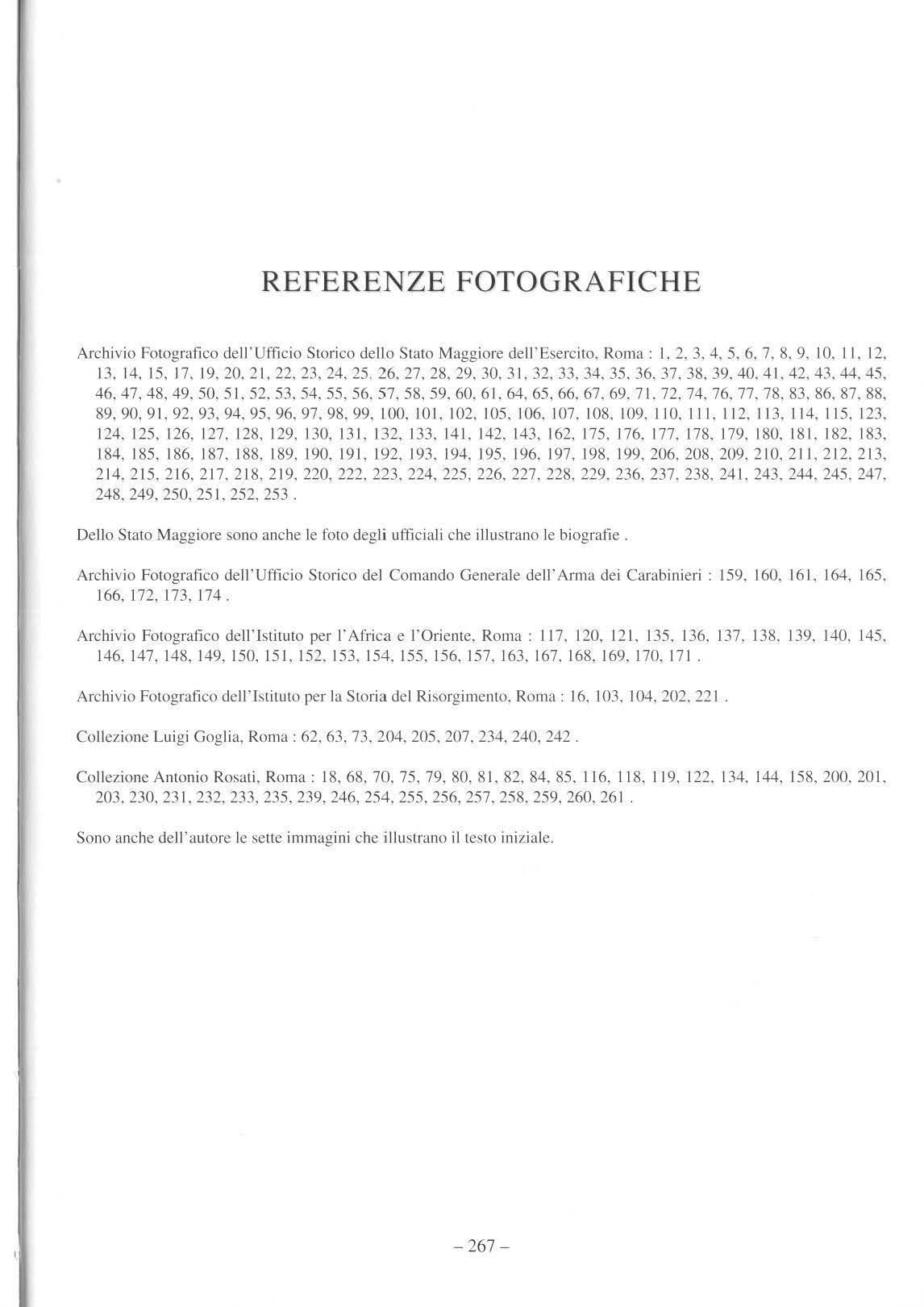
Archivio Fotografico delr Utncio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Roma: L 2. 3. 4, 5. 6, 7. 8. 9. LO. Il. 12. l 3, 14 , 15, 17. l 9. 20, 21, 22, 23, 24. 25 . 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35 . 36. 37, 38. 39. 40. 41 , 42 , 43, 44, 45, 46.47,48,49 50. 51.52.53.54.55 56.57, 58.59.60. 6 1. 64.65,66.67.69. 71. 72. 74. 76, 77. 78. 83. 86.87,88, 89,90.91,92.93.94.95.96.97.98.99. 100.10J. I02.l05. J06.l07.108.109.1J0.111.112.113. 114.115,123. 124. 125. 126. 127 , 128 , 129, 130, 131, 132, 133, 141. 142. 143. 162, 175. 176, 177. 178, 179, 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187, 188, 189, 190. 191, 192, 193. 194, 195. 196. 197, 198. 199,206,208.209.210,211.212.213, 214.215.216,217,218,2 19.220,122.223.224,225,226,227 228,229.236 237,238,241.243.244 , 245 , 247 248,249.250,251,252,253. Dello Stato Maggiore so no anche le foto degl i ufficiali che illu stra no le biografie Archivio Fotografico dell'Ufficio Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri : 159. 160. 161. 164, 165. 166. 172, 173.174. Archivio Fotografico dell'I st ituto per l'Africa e l'Oriente. Roma: 1 17, 120, 121. 135, 136. 137. 138. 139. 140. 145 , 146, 147,148,149.150,151. 152.153. 154,155, 156,157 , 163 , 167, 168. 169. 170. 171. Archivio Fo tografico de ll 'Is tituto per la S toria del Risorgimento, Roma: J 6, 103, 104. 202, 221 . Col lezione Luigi Goglia, Roma: 62. 63. 73. 204. 205,207, 234. 240, 242. Co ll ez ione Antonio Rosati , Roma : 18 , 68. 70, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85. 116, 118, 119, 122. 134. 144 , 158. 200, 201. 203,230,231.232,233,235,239.246,254.255.256,257.258.259.260,261.
no anc he dell'autore le sette immagini che i llustrano il testo iniziale. -267-
So
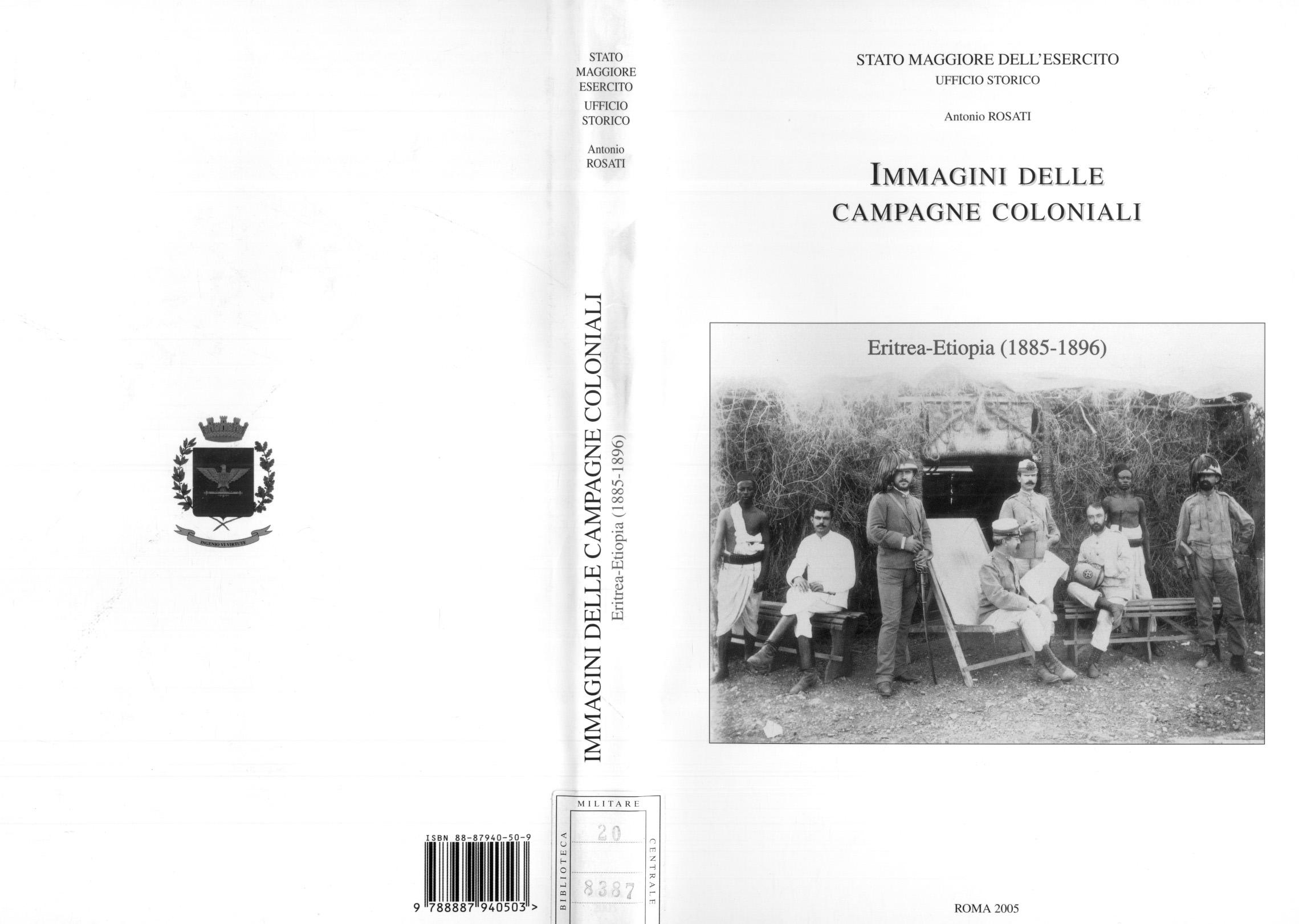

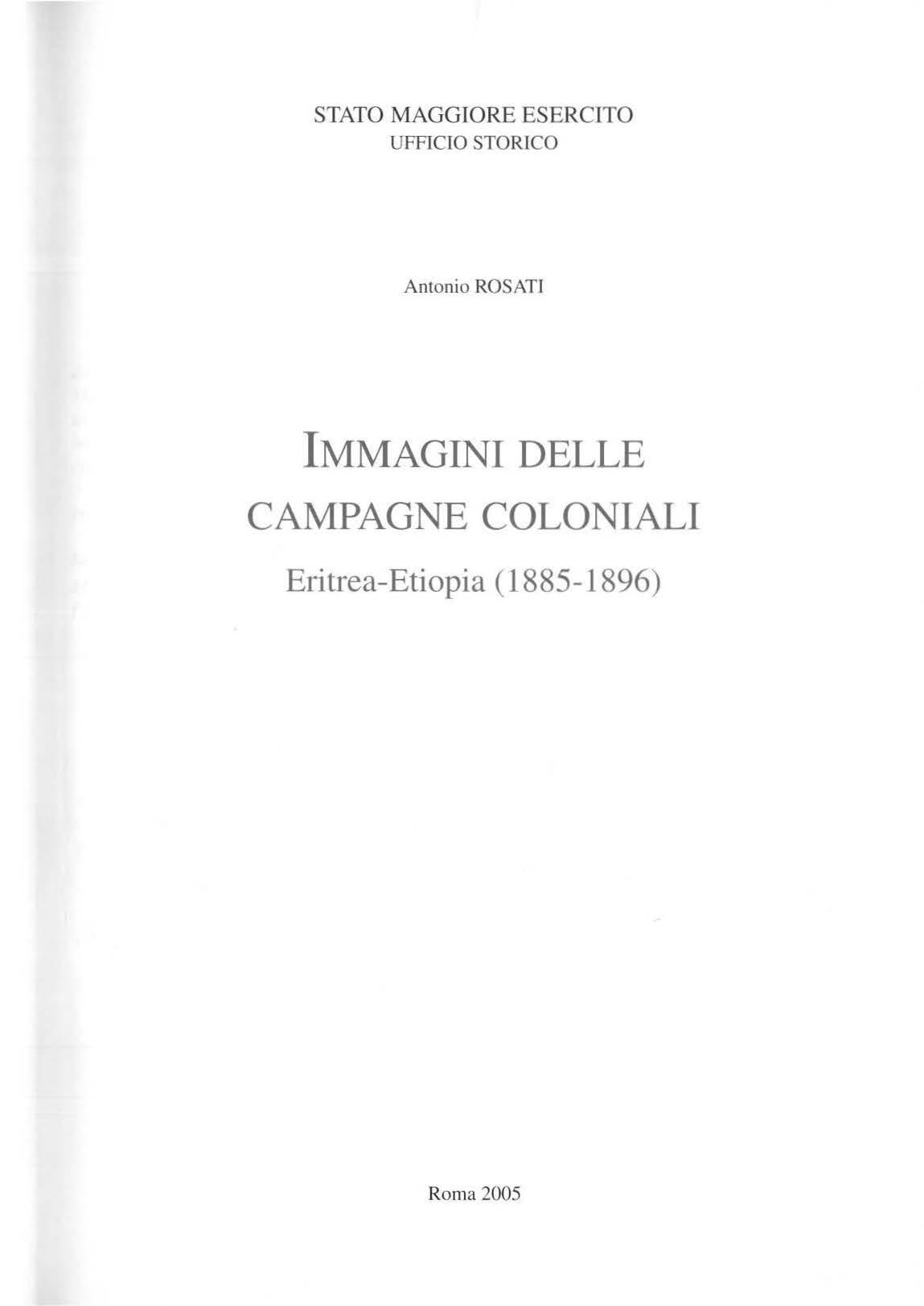


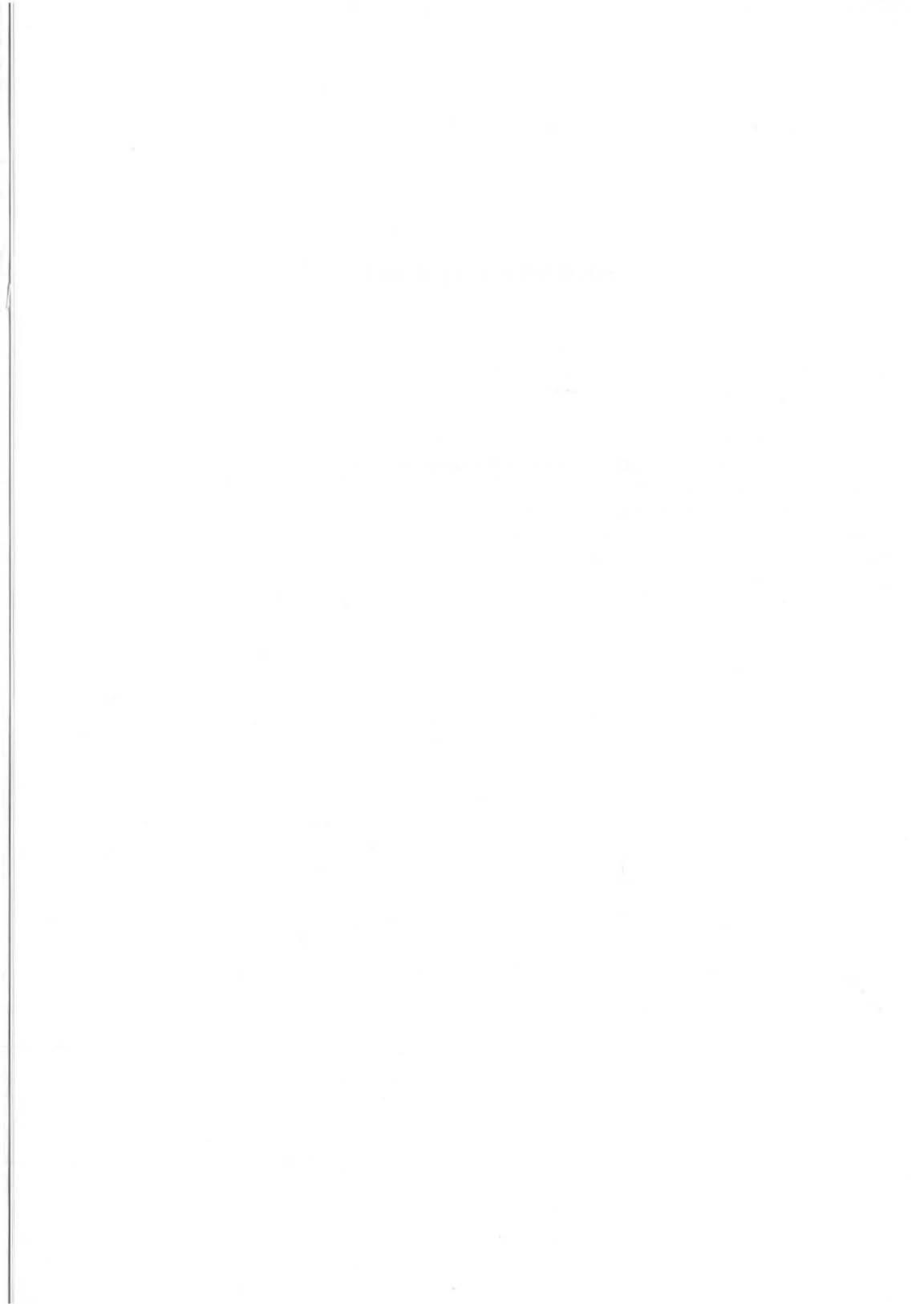

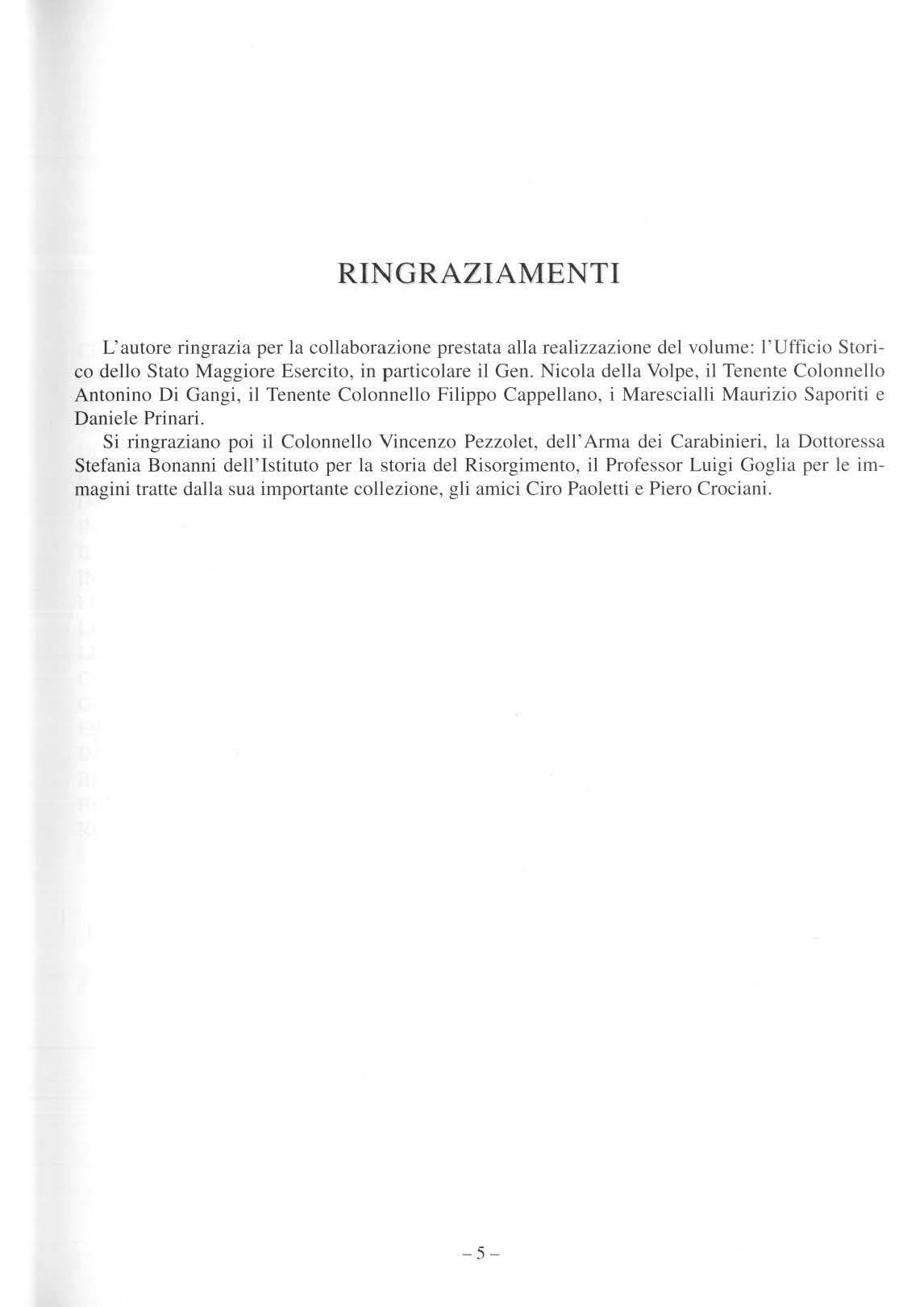
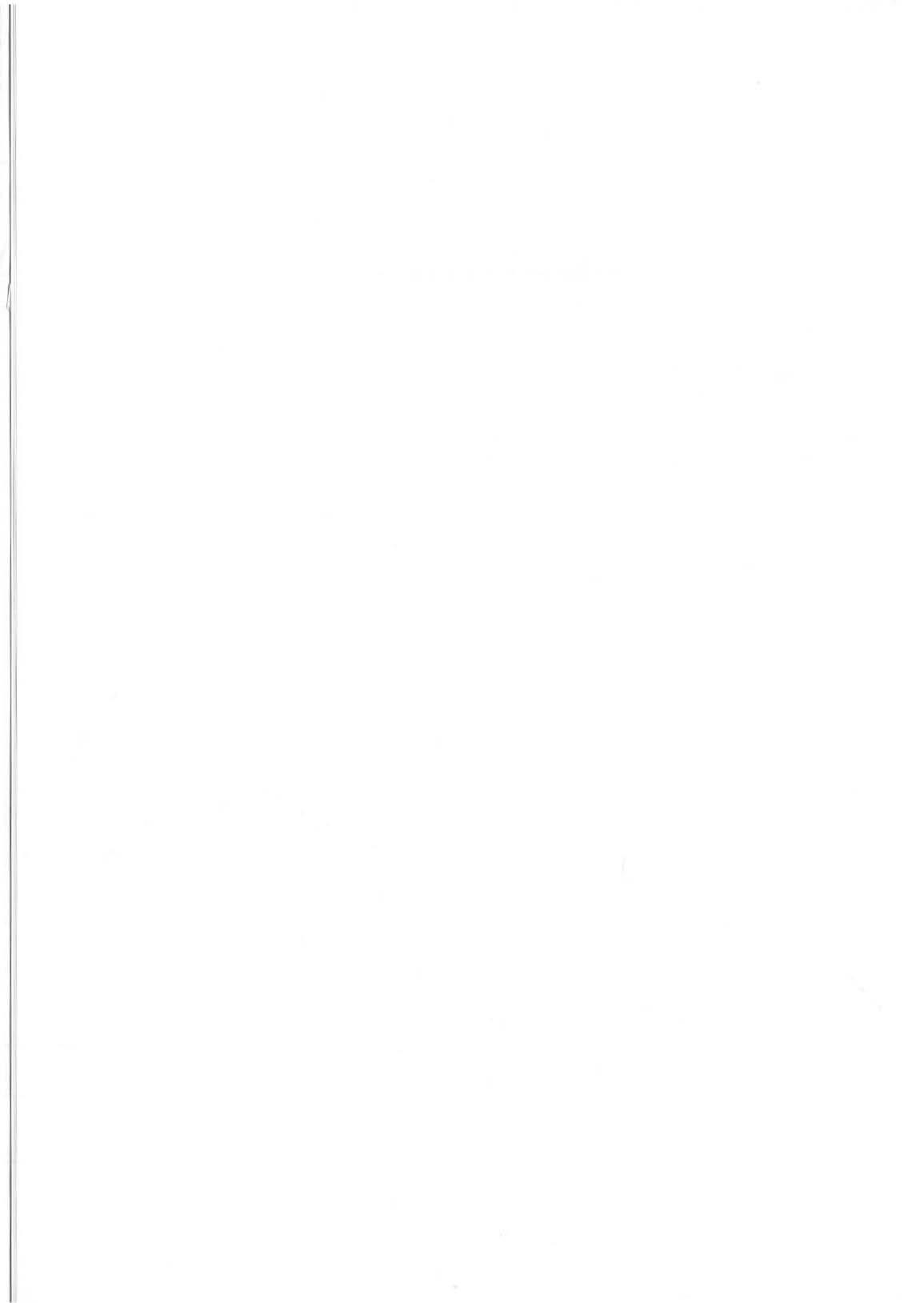
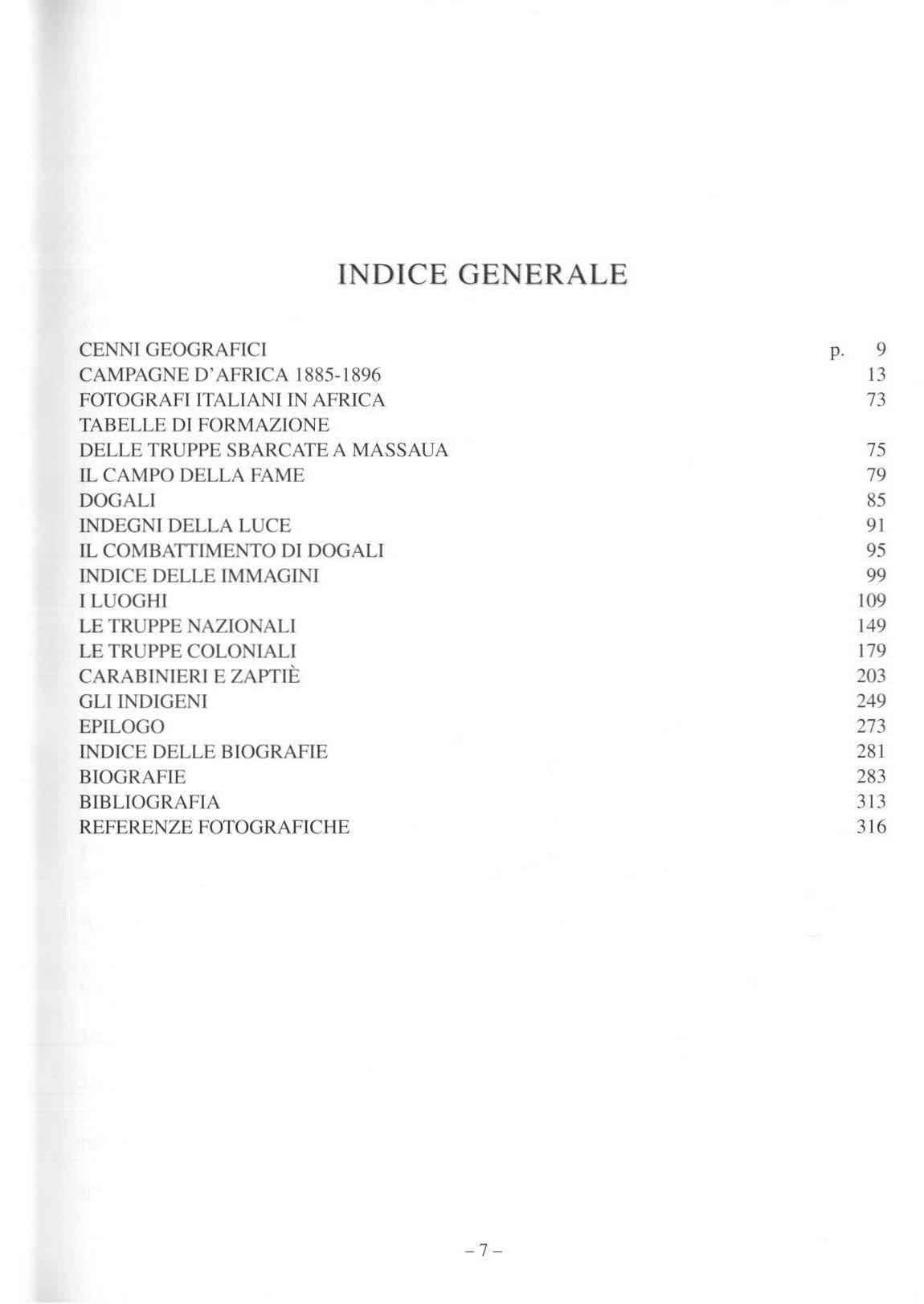
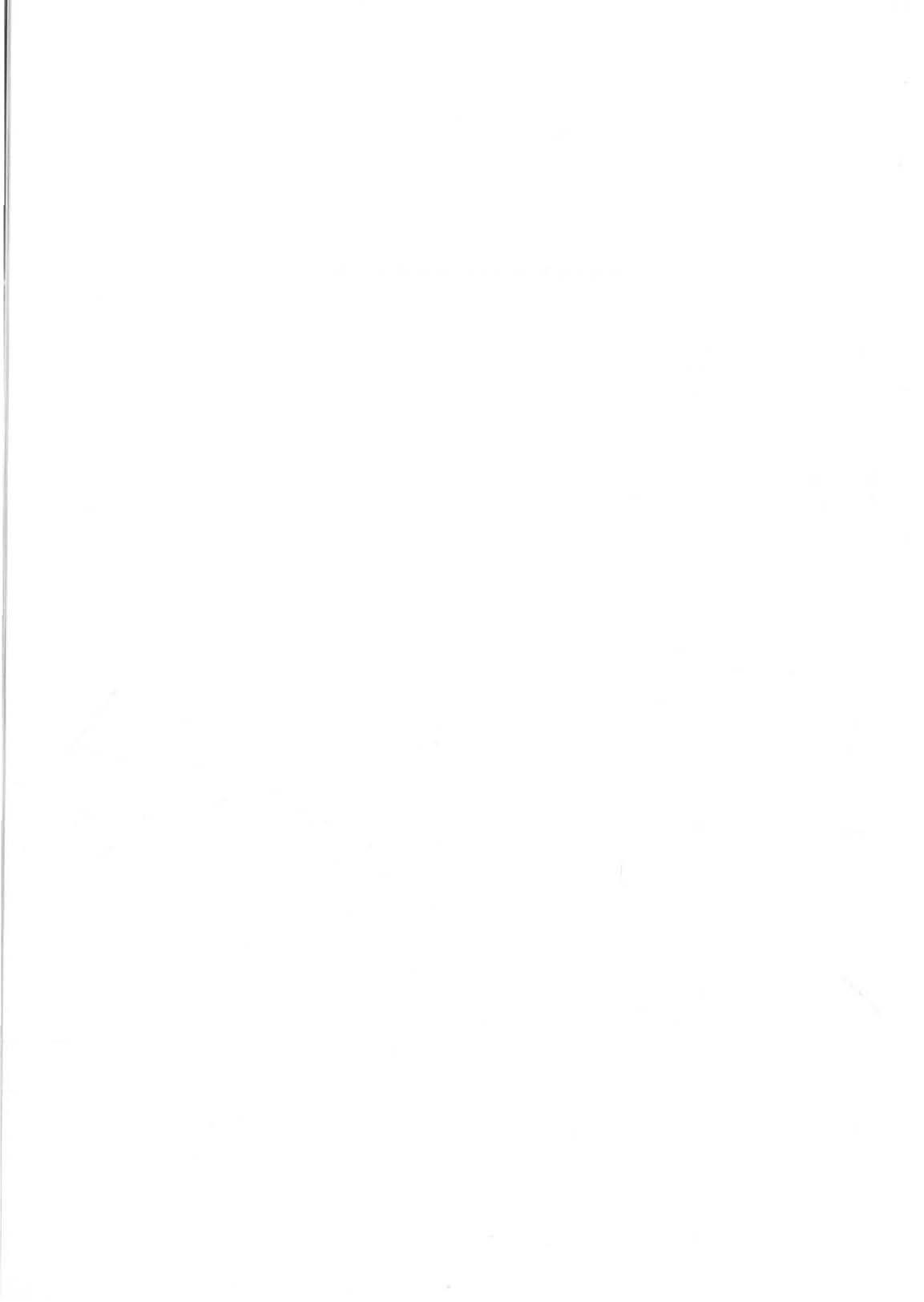
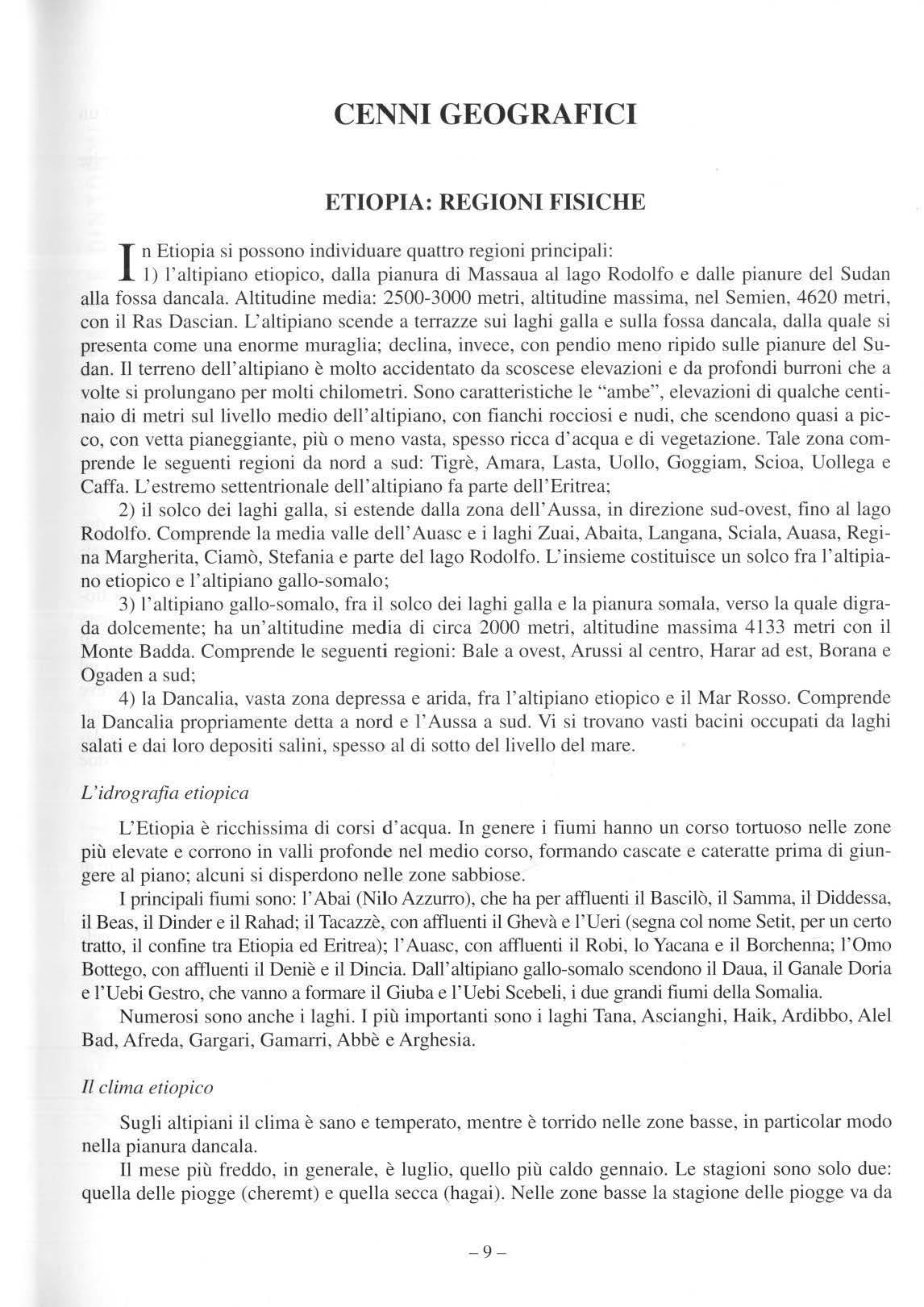

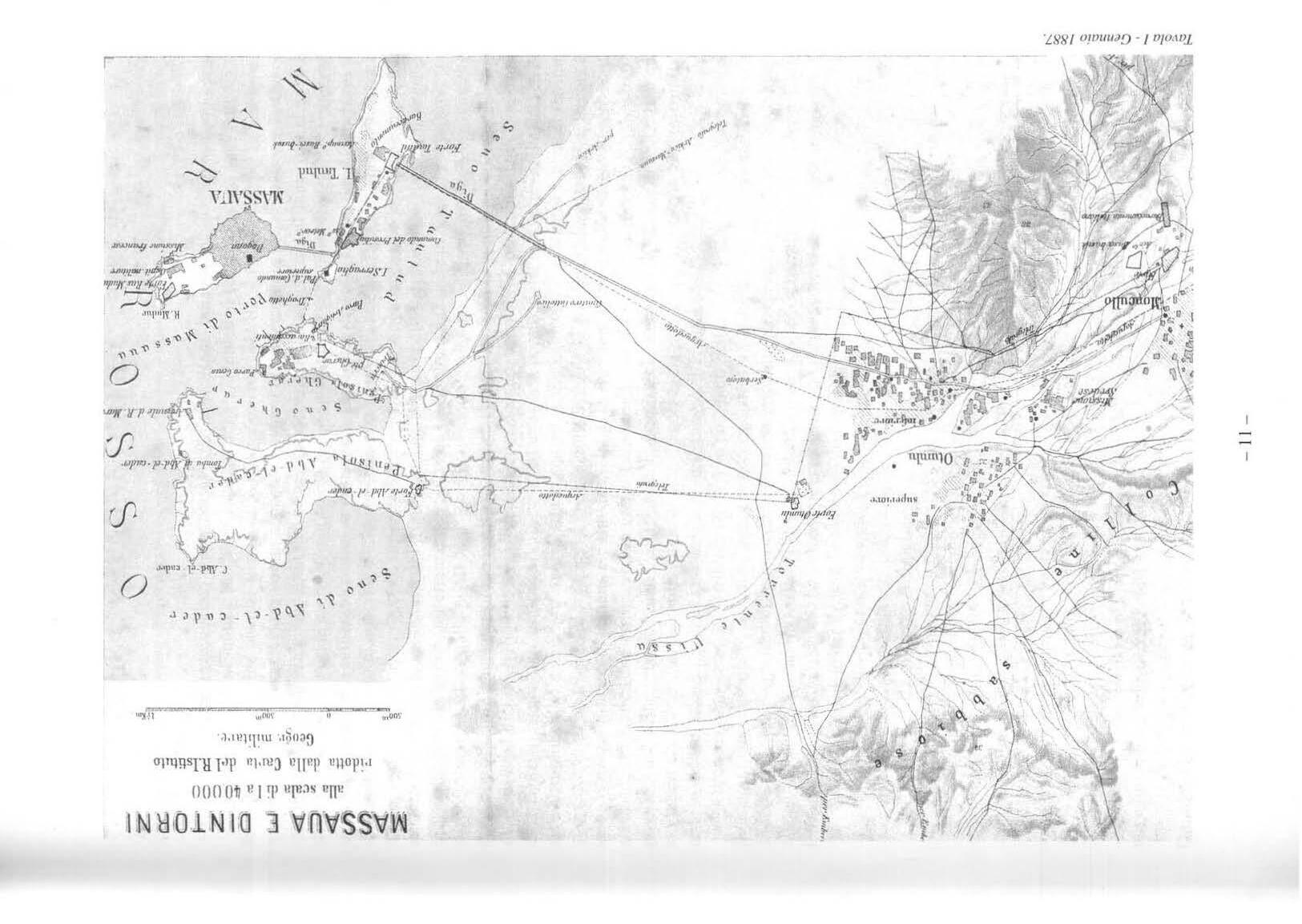

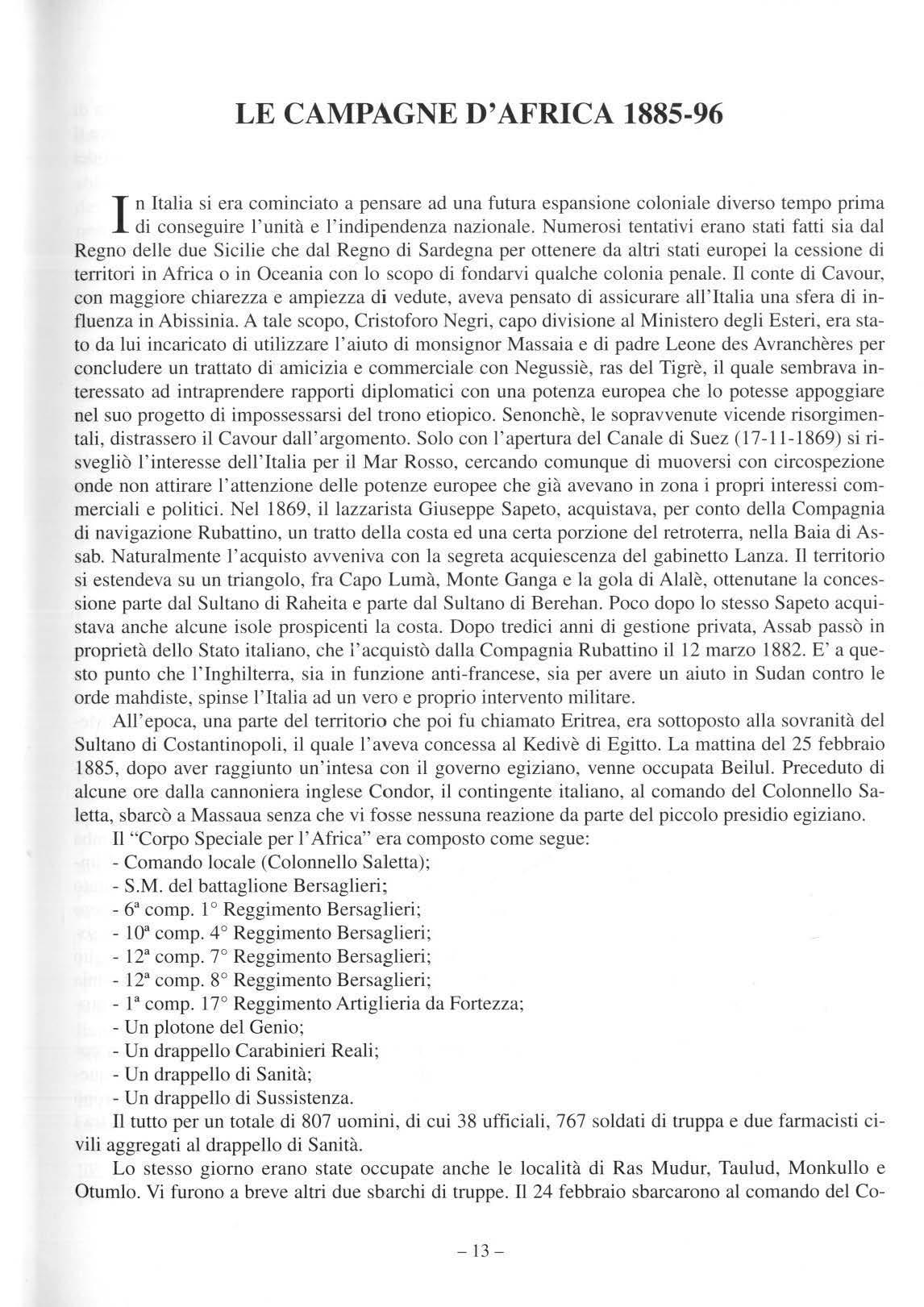


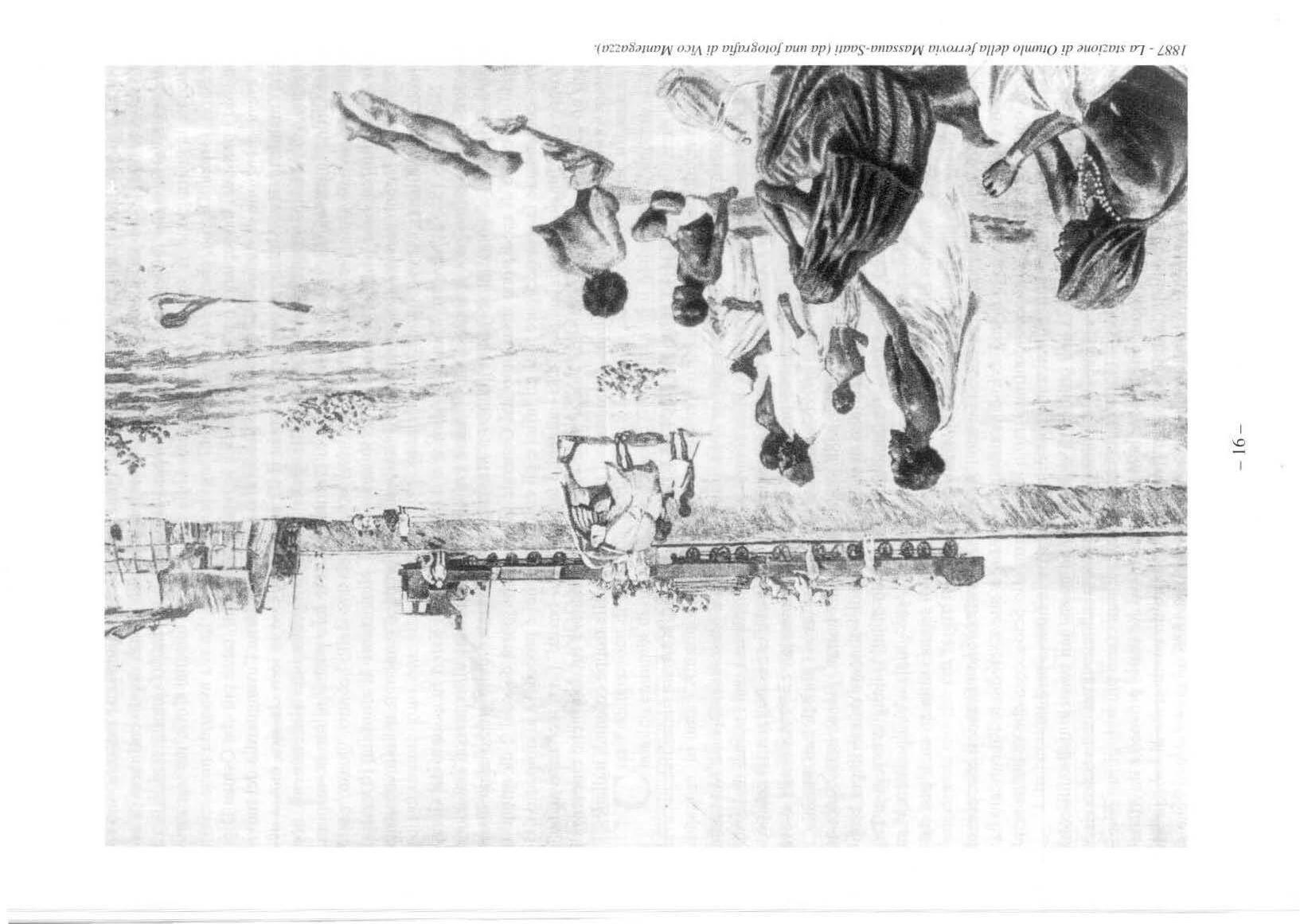
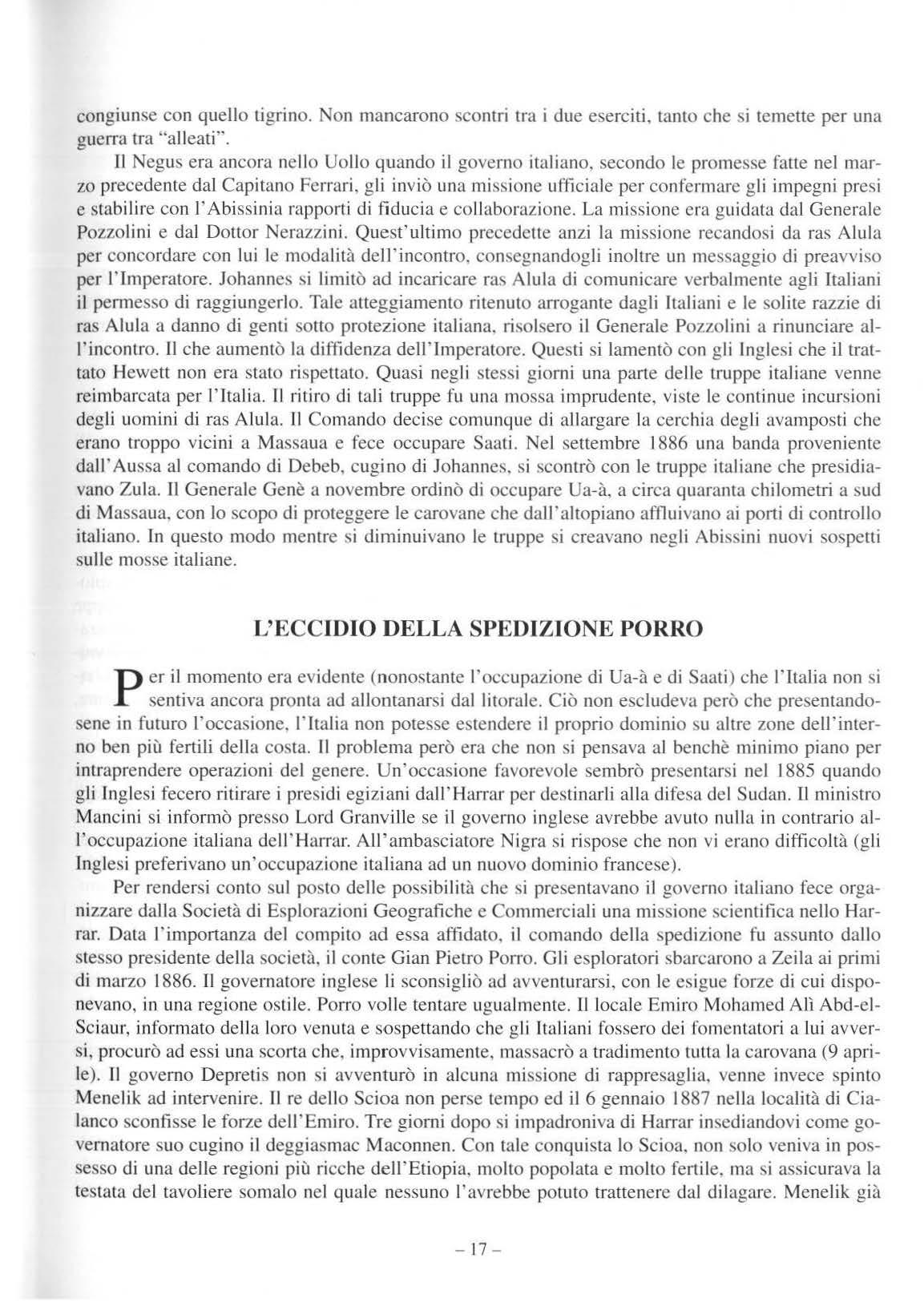
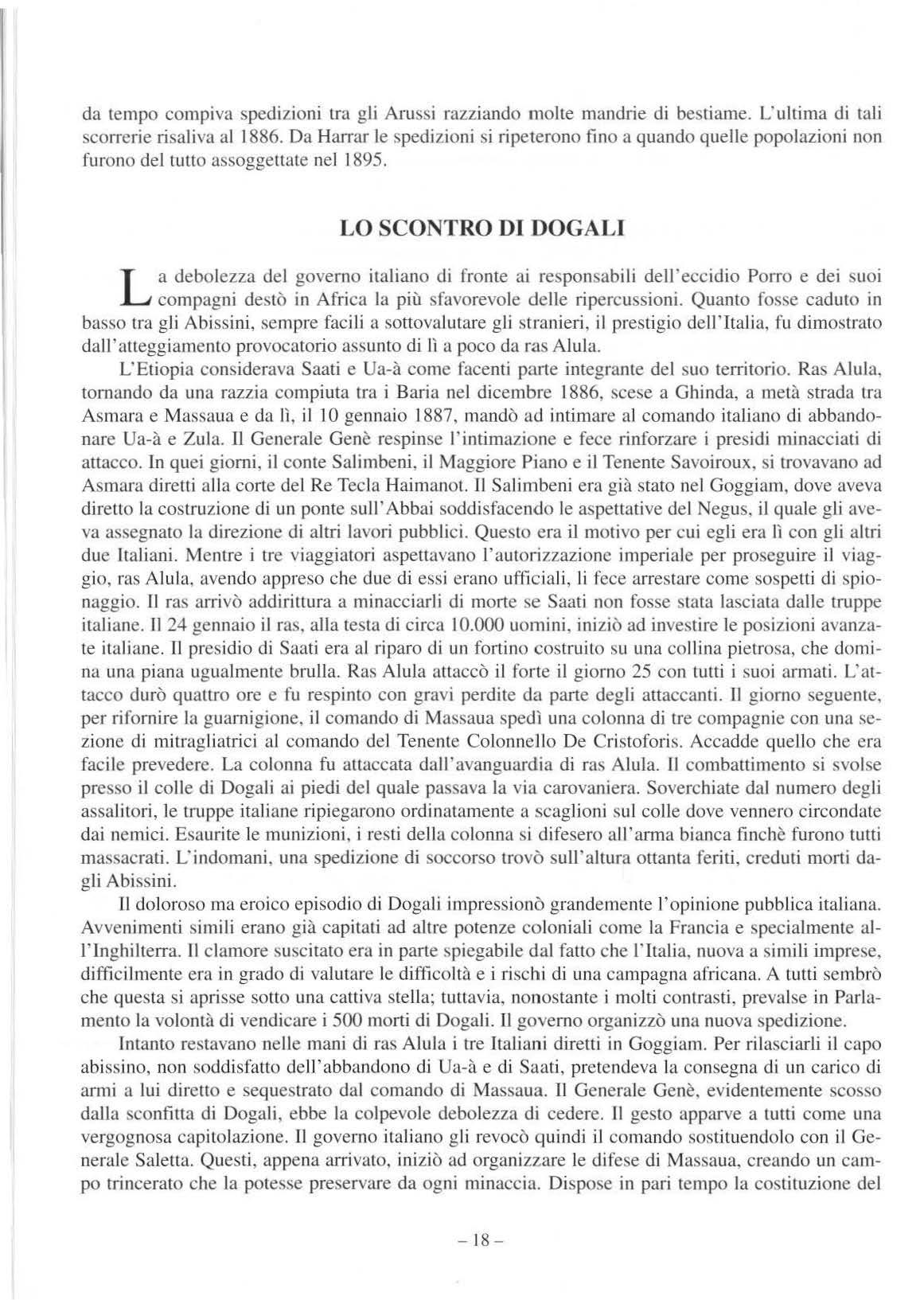
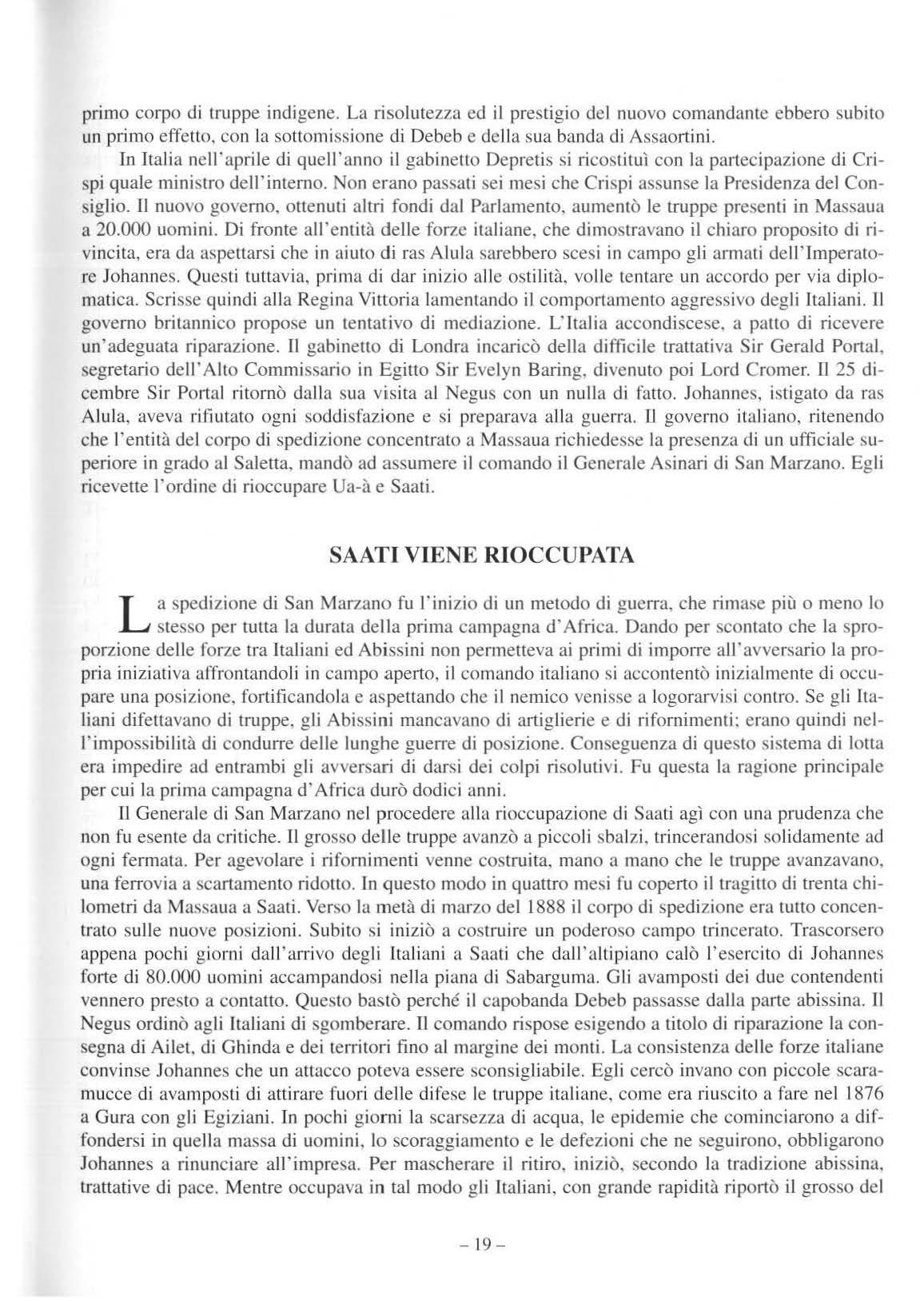
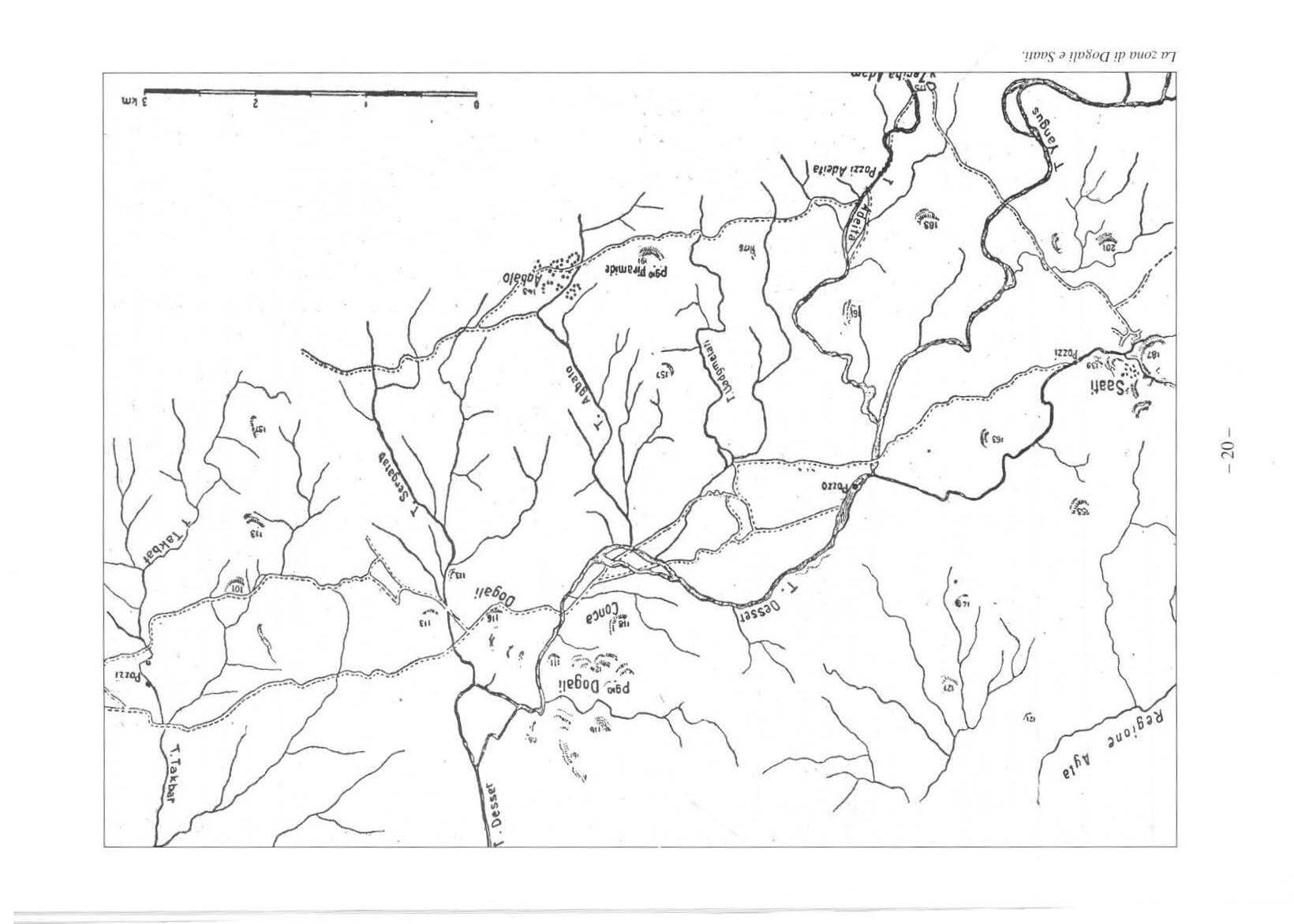
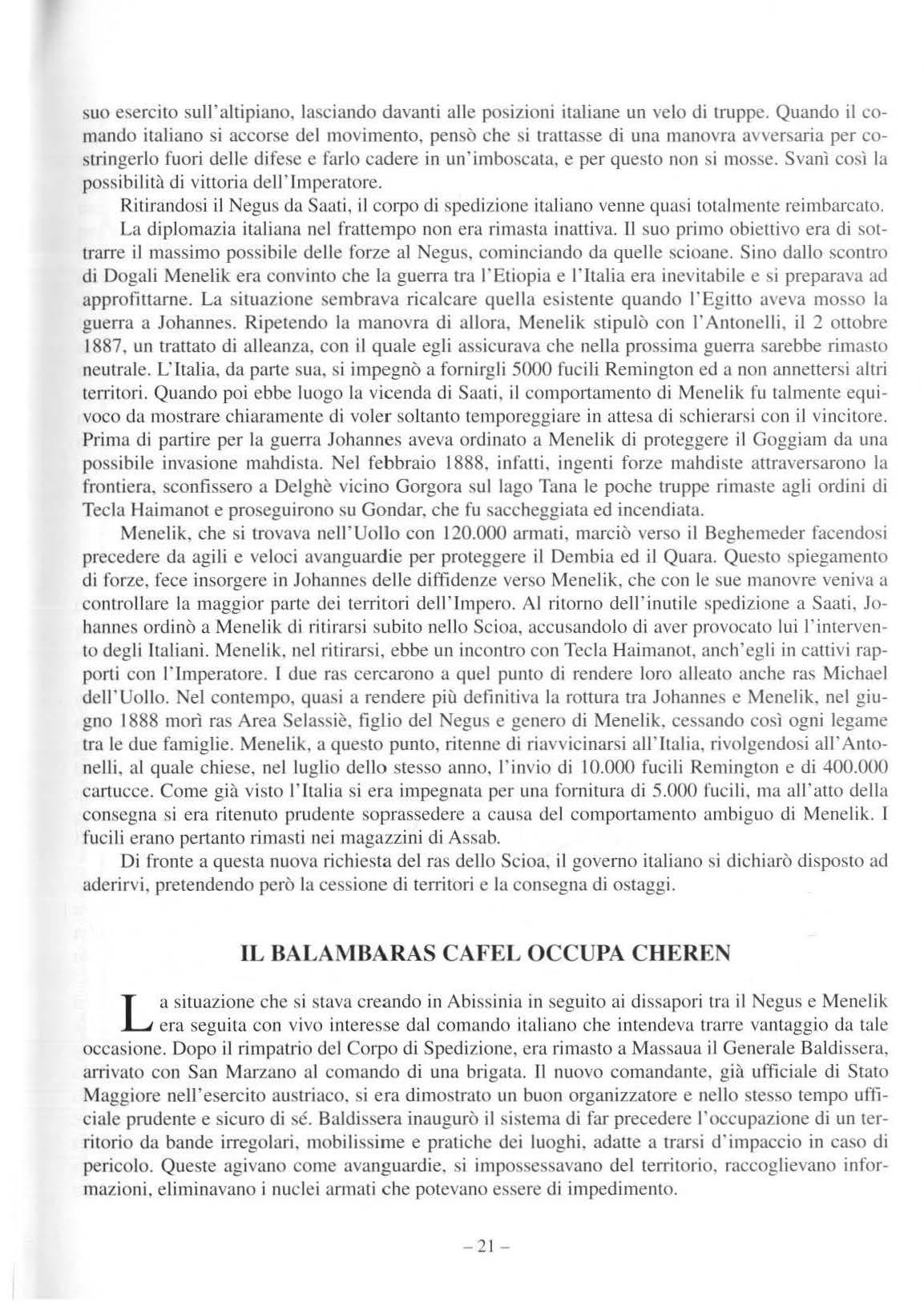


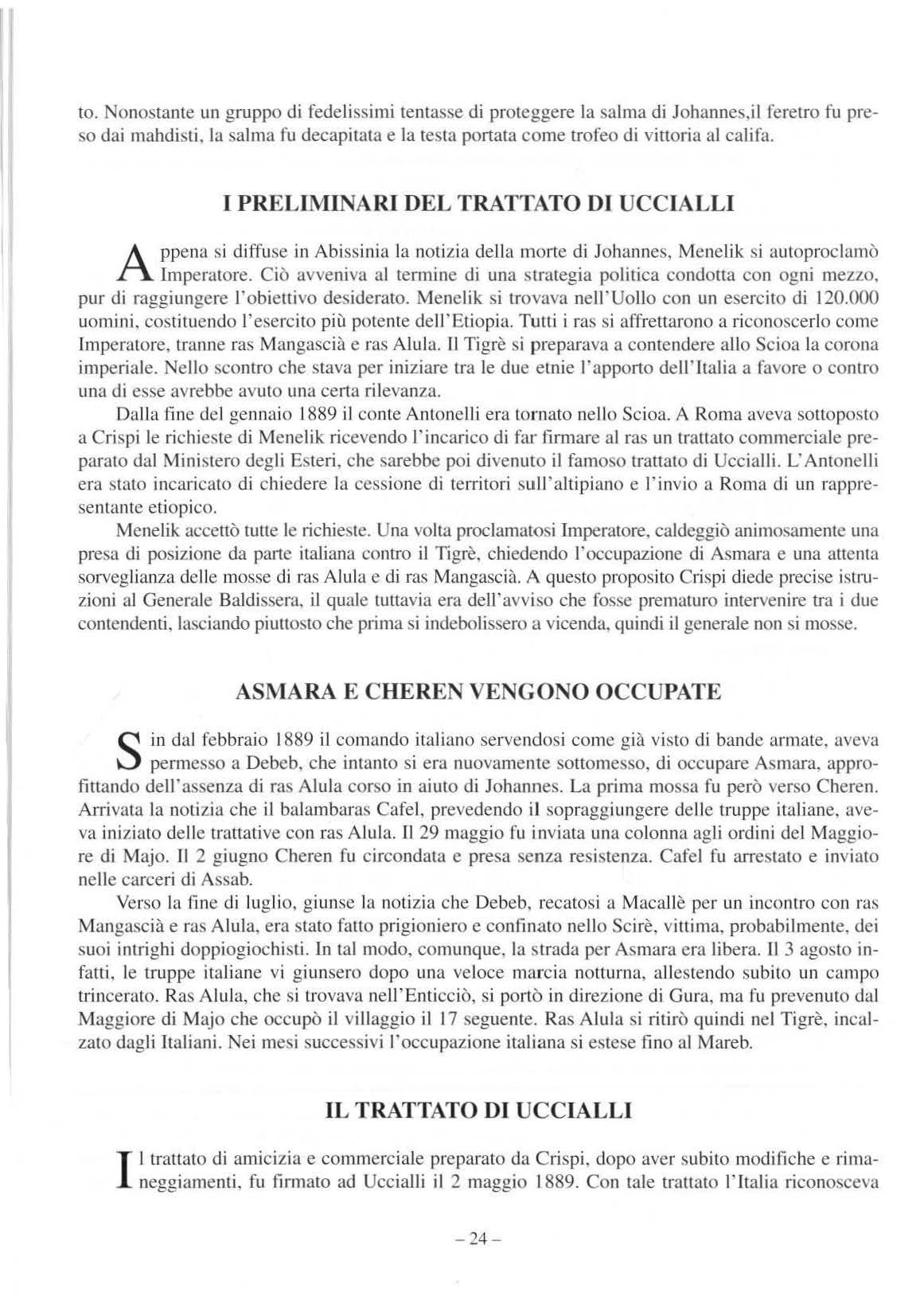

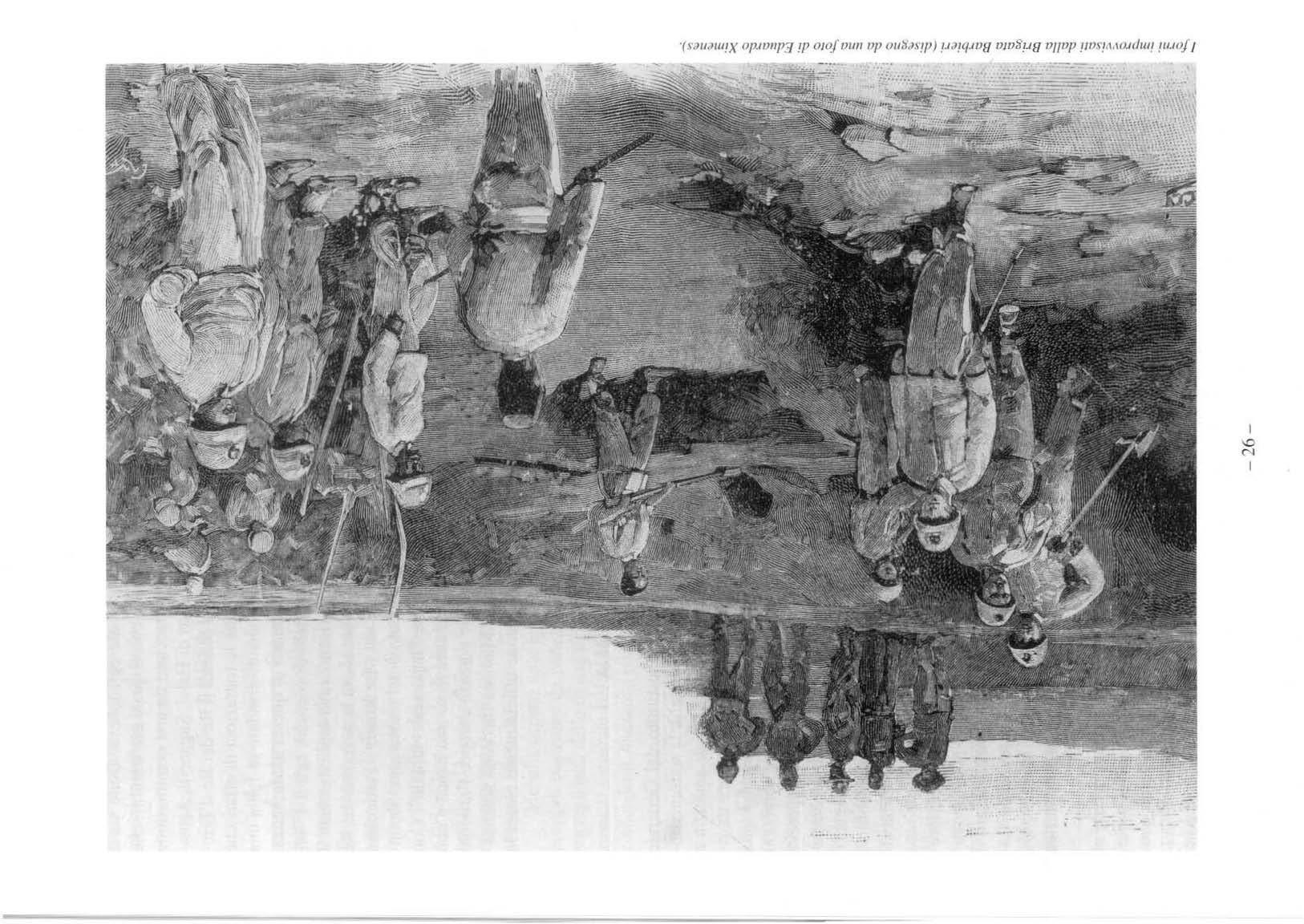
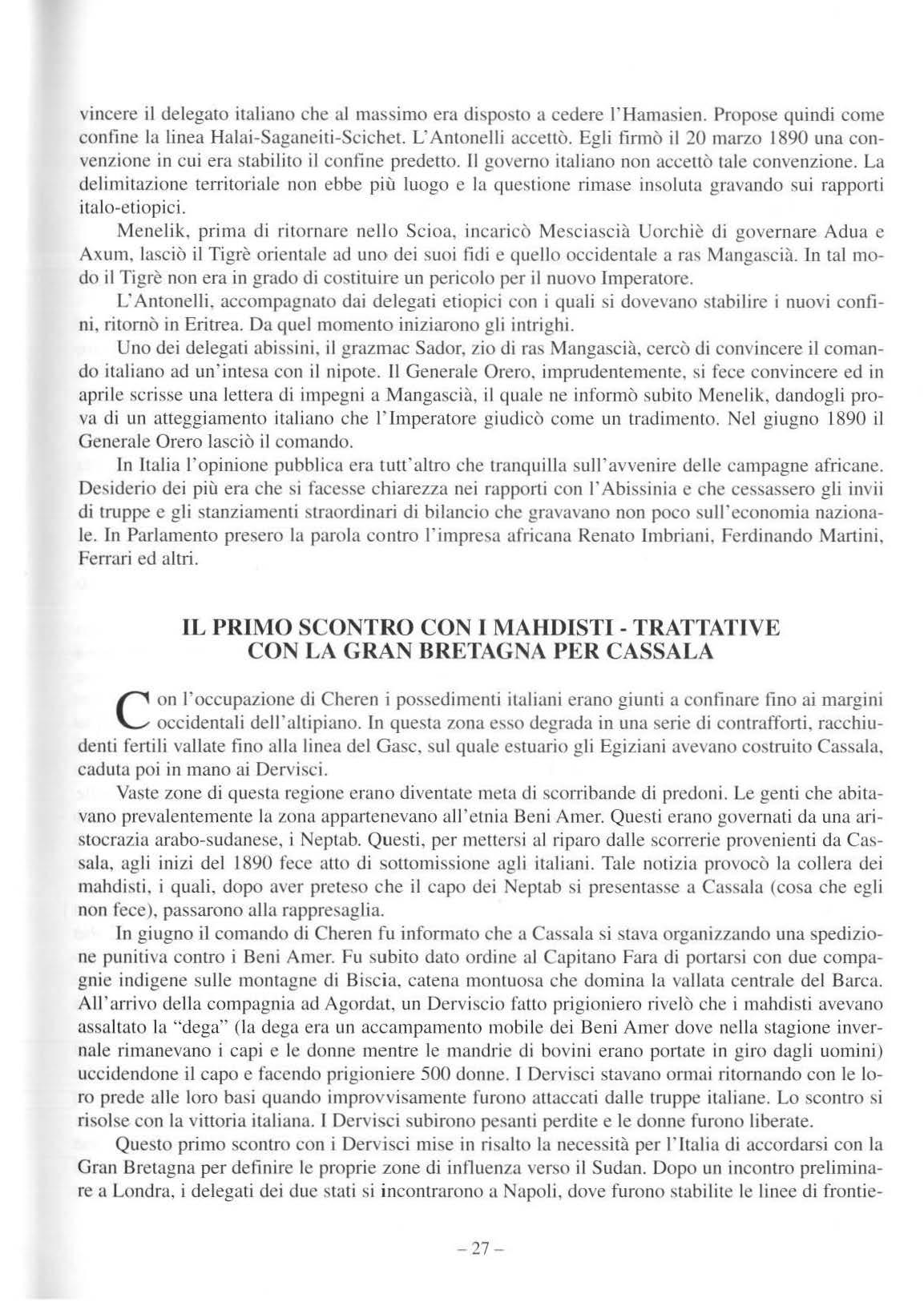
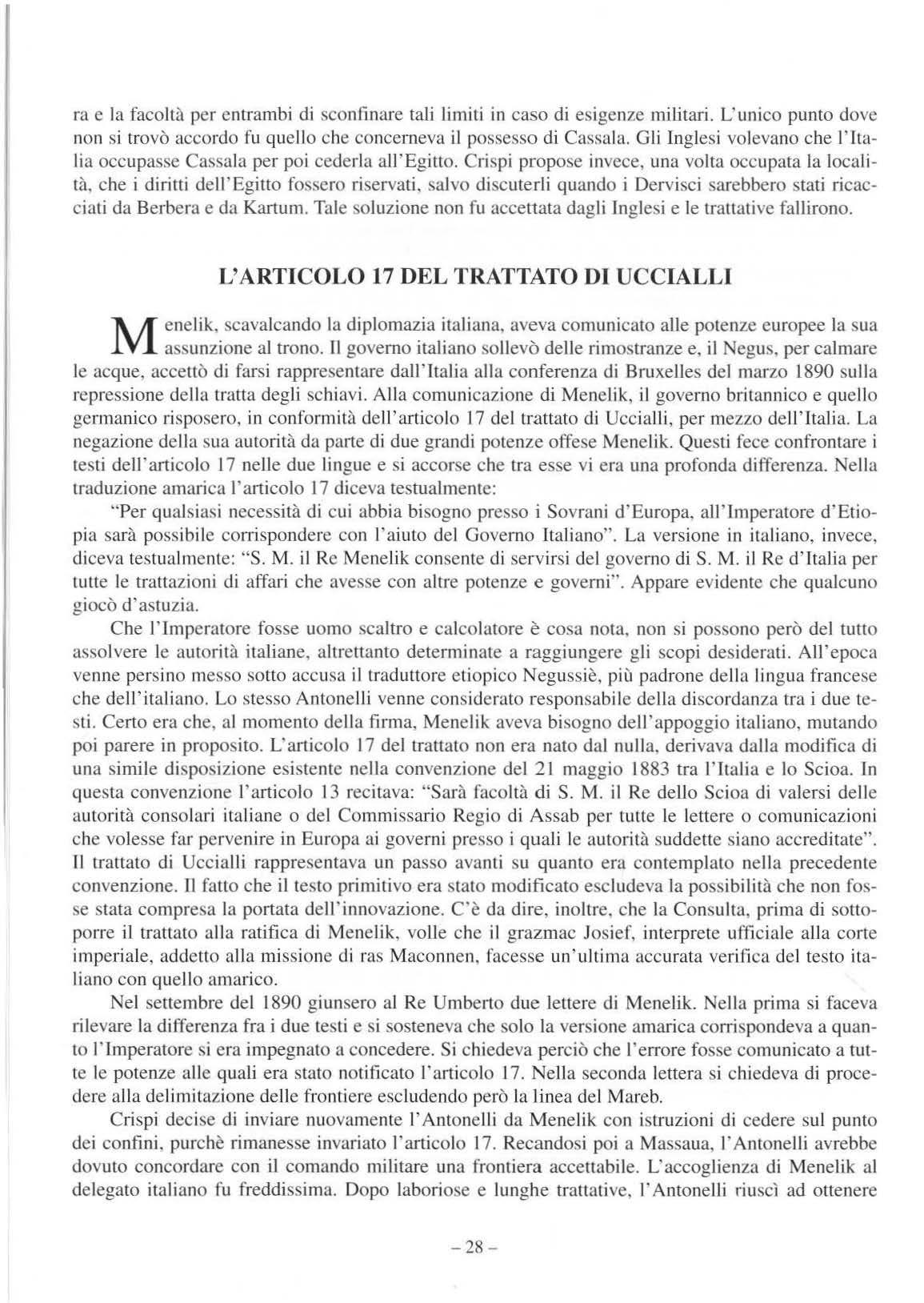
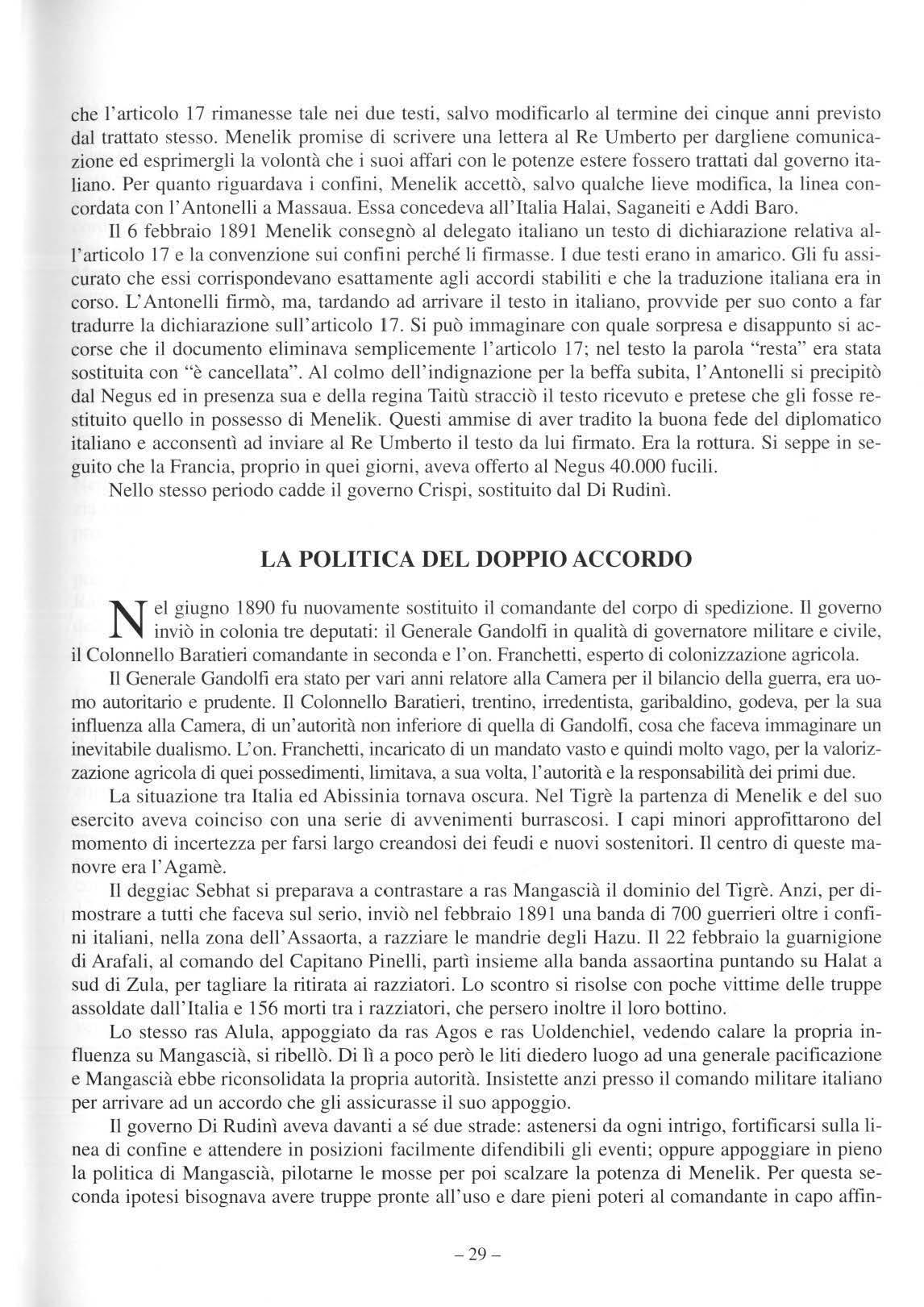




















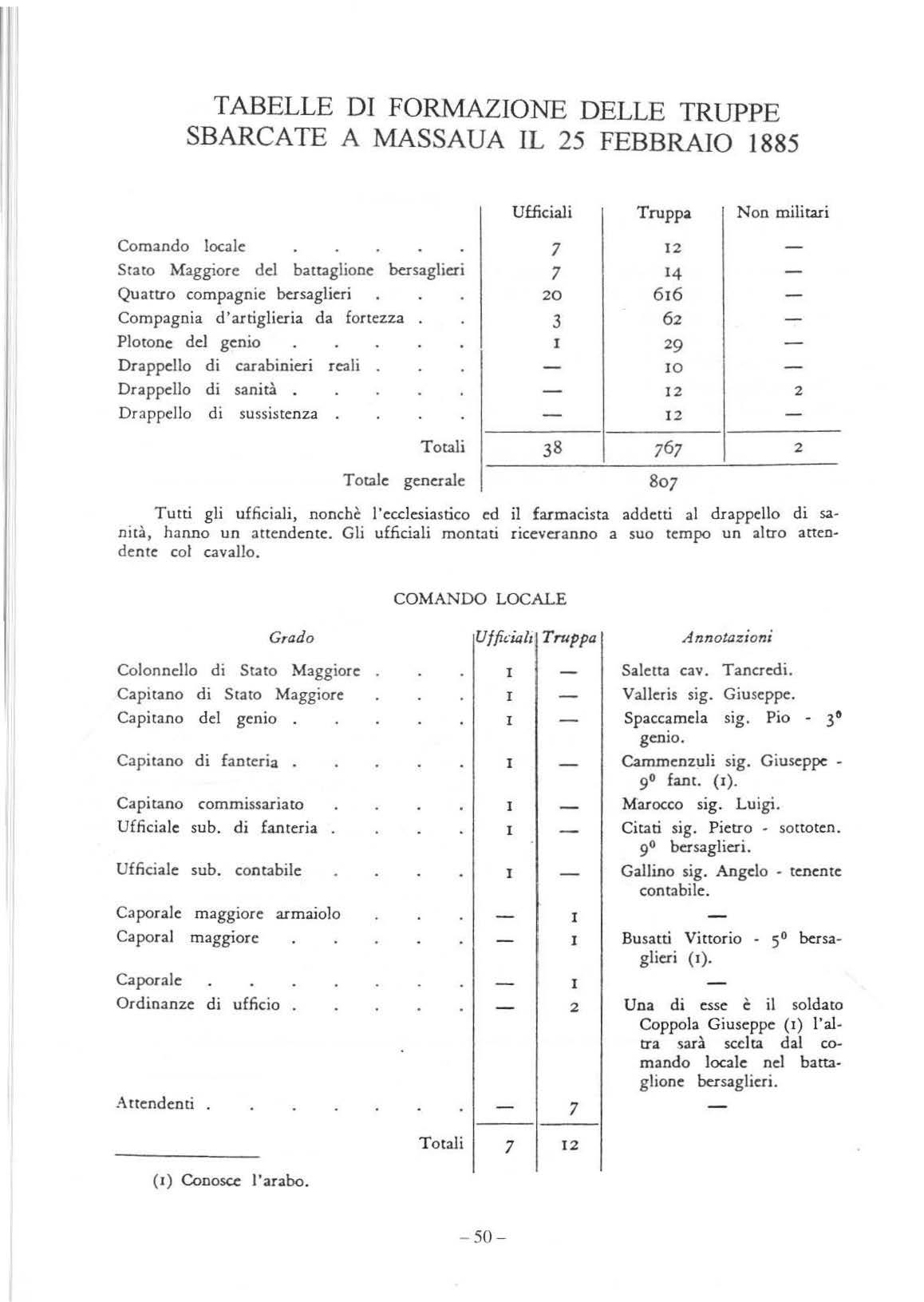
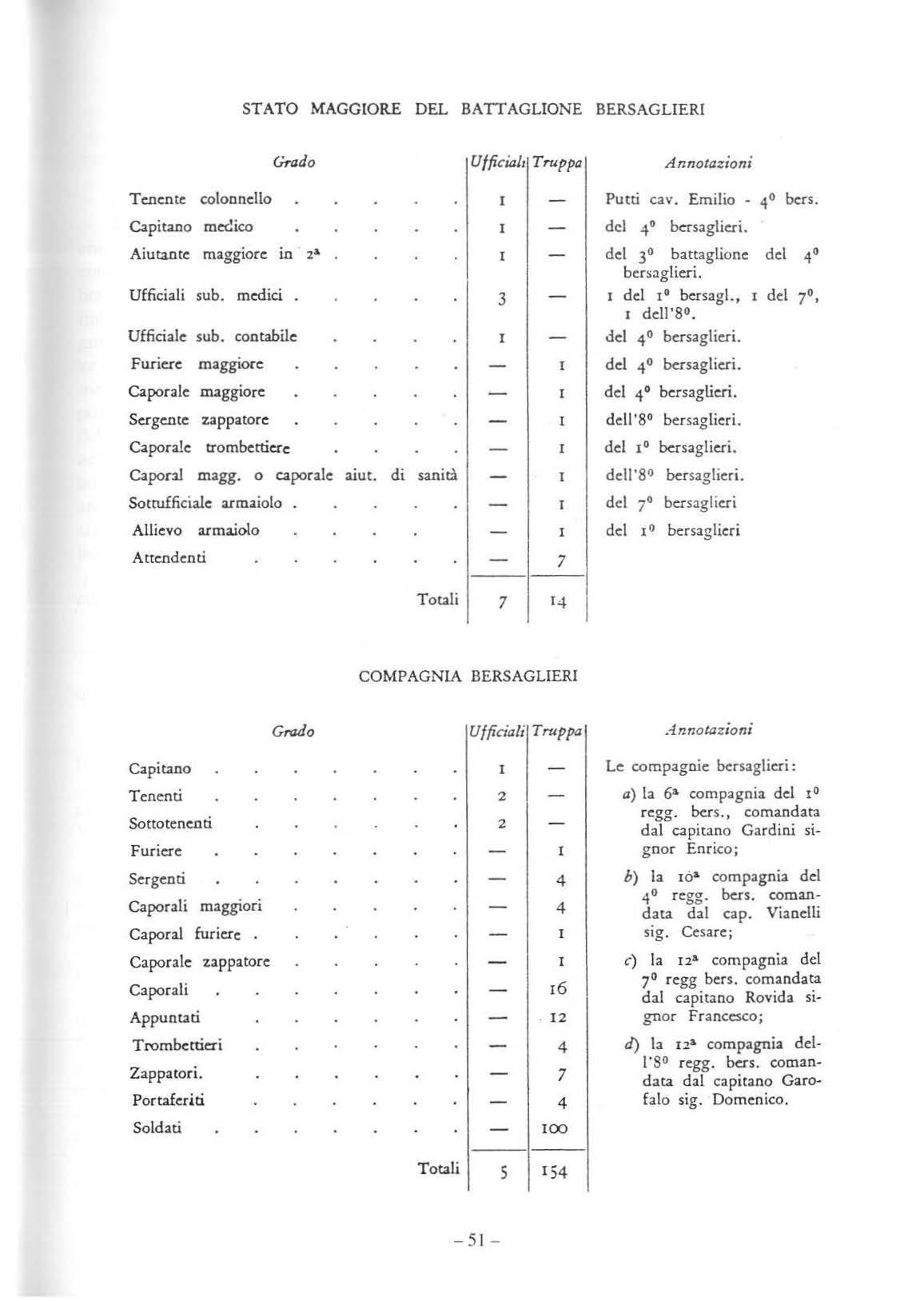
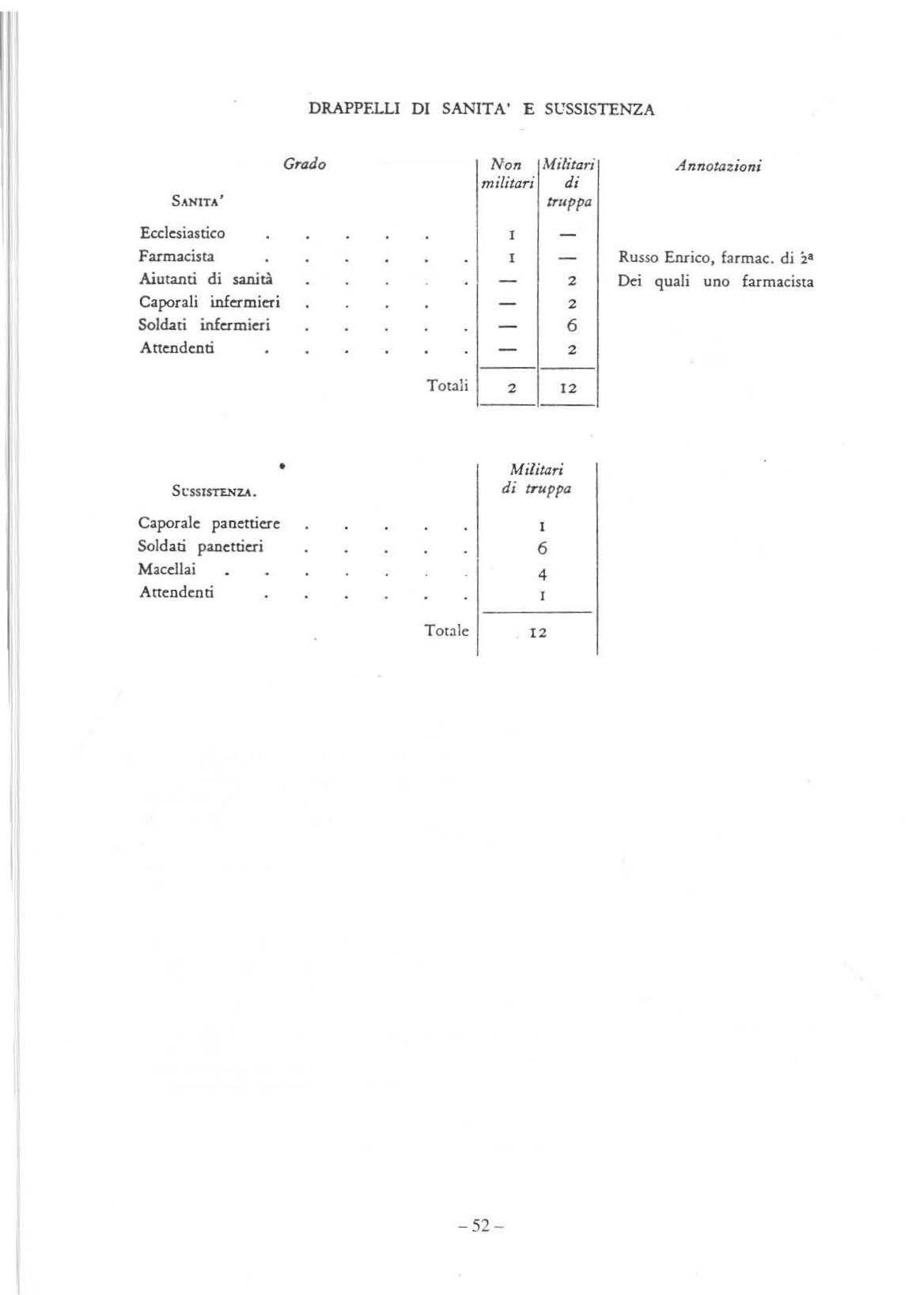



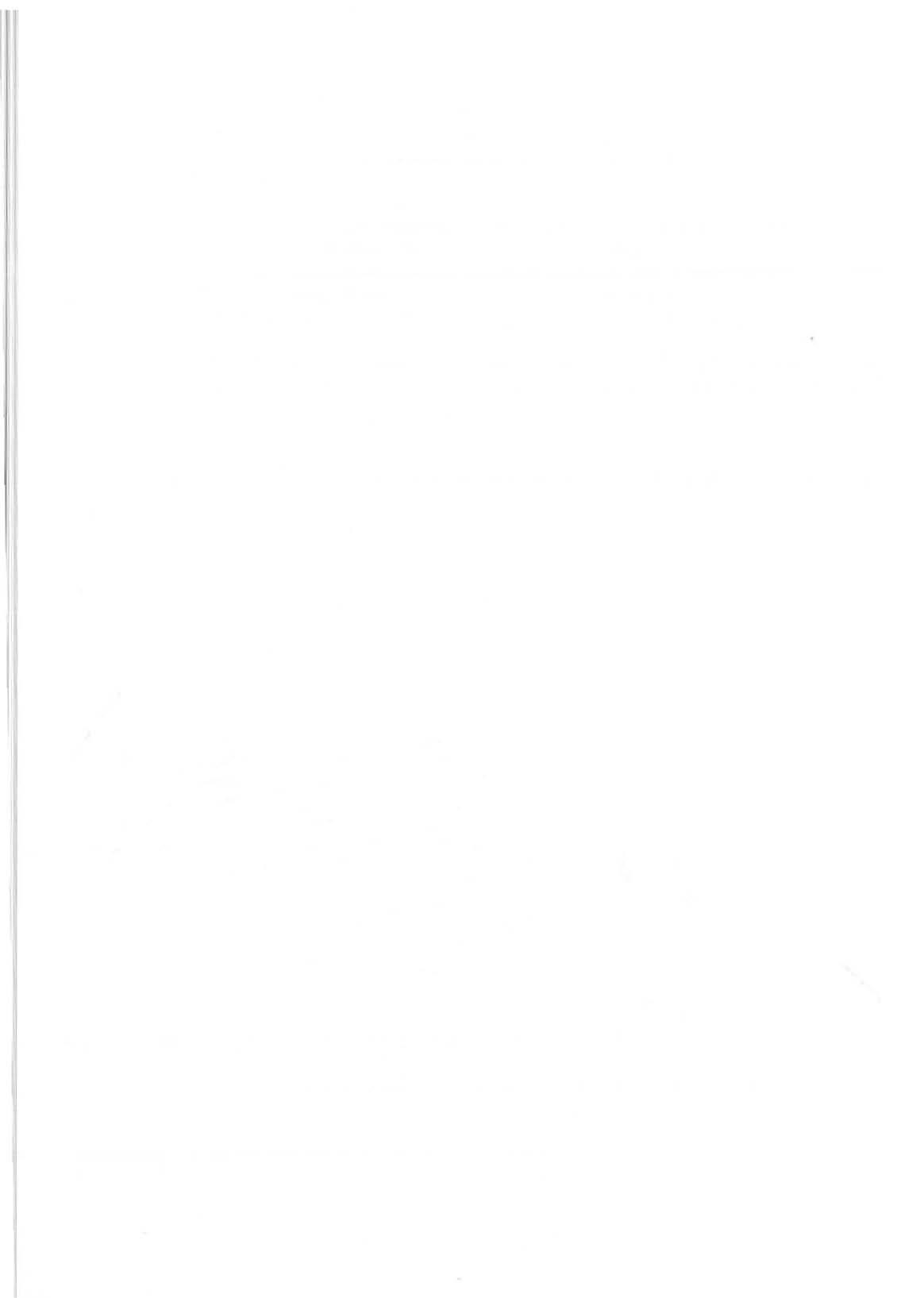



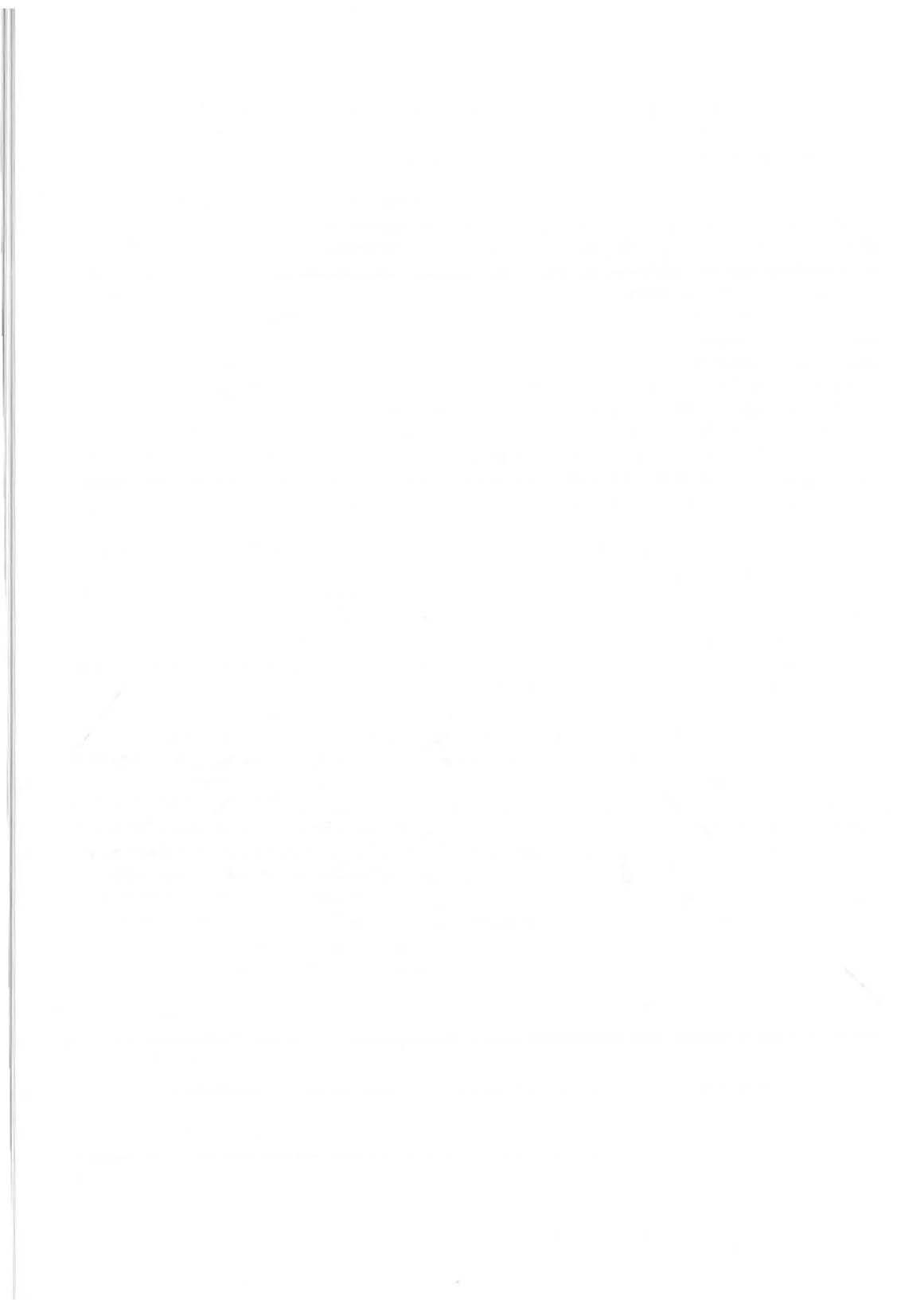




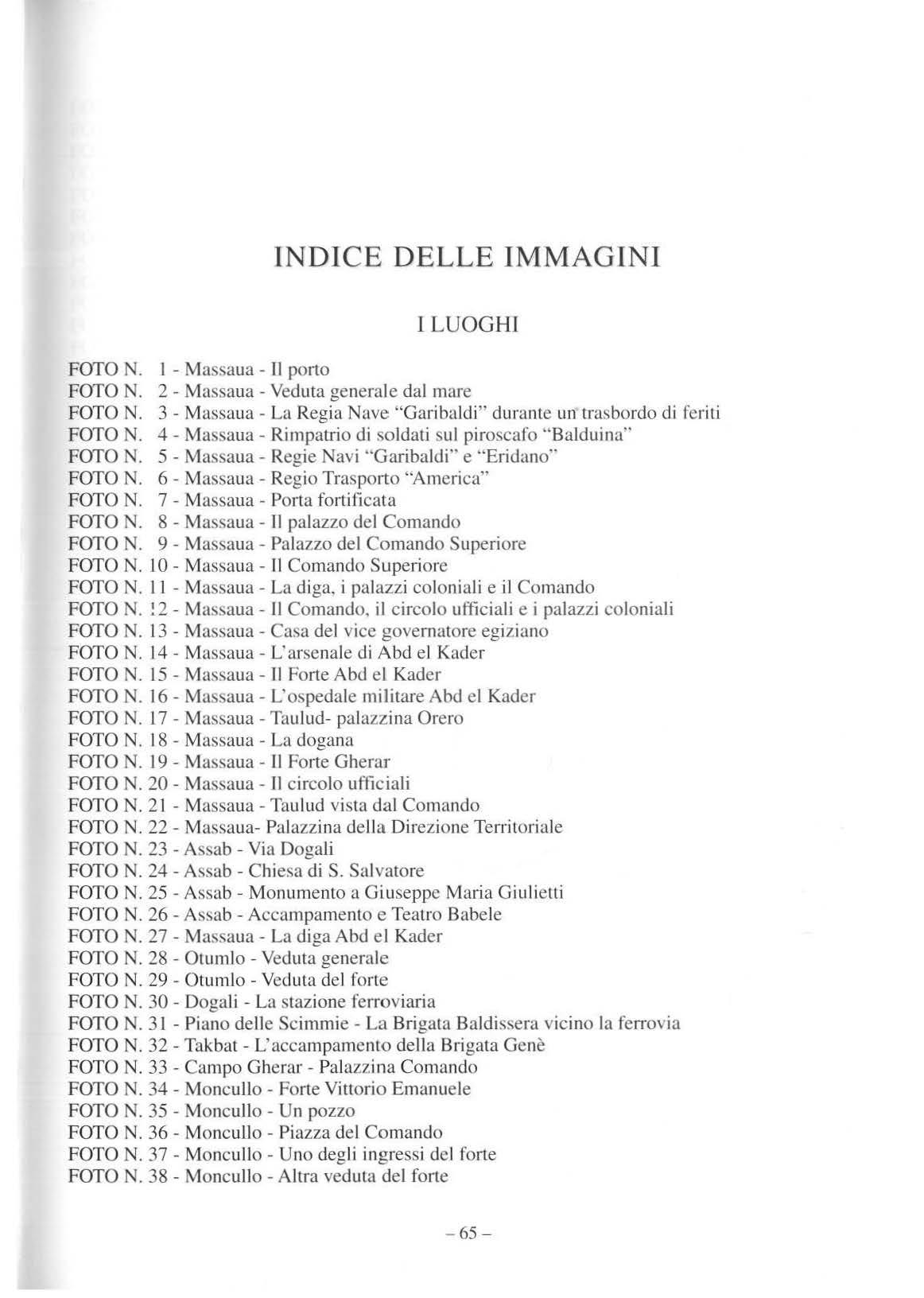
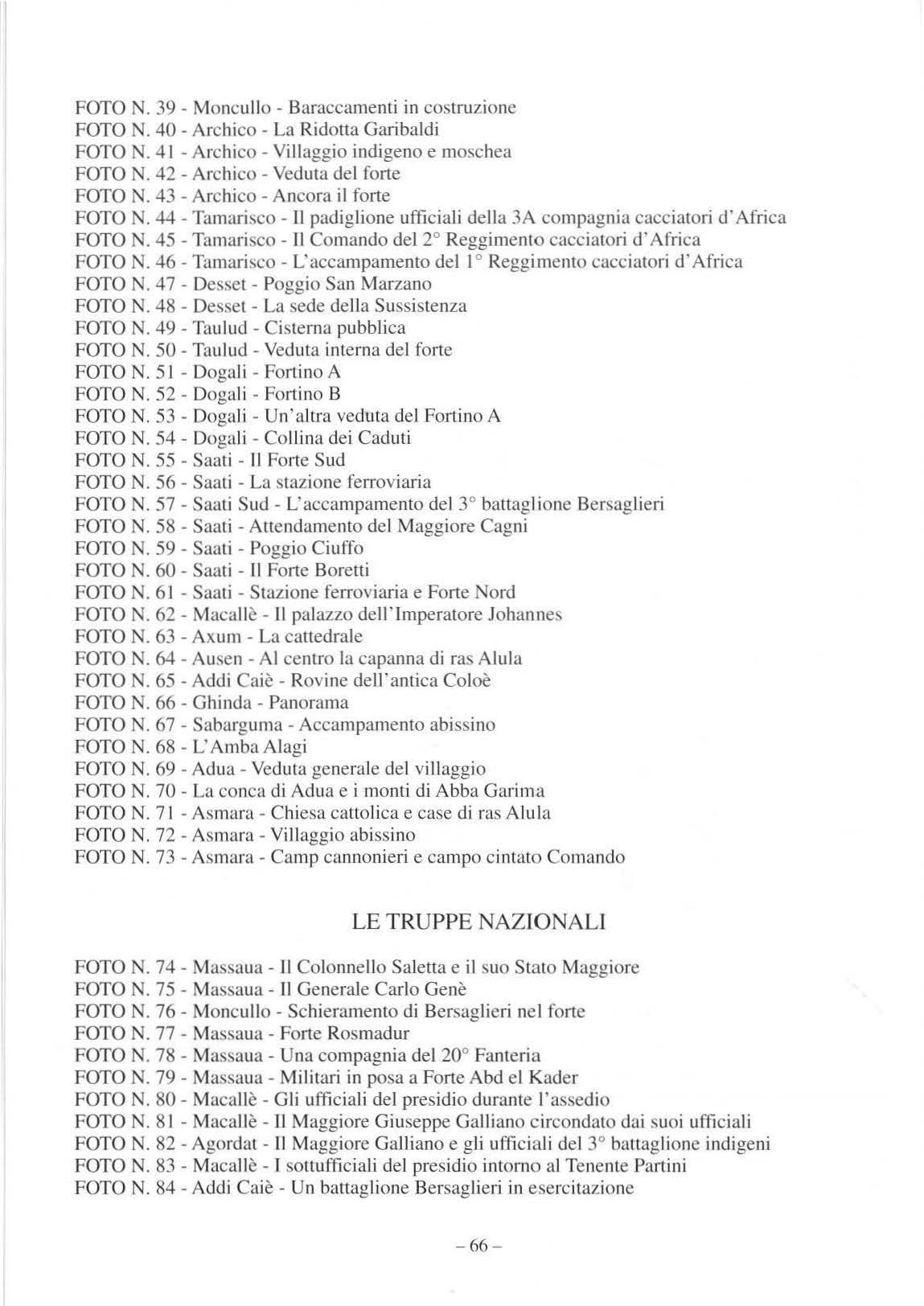
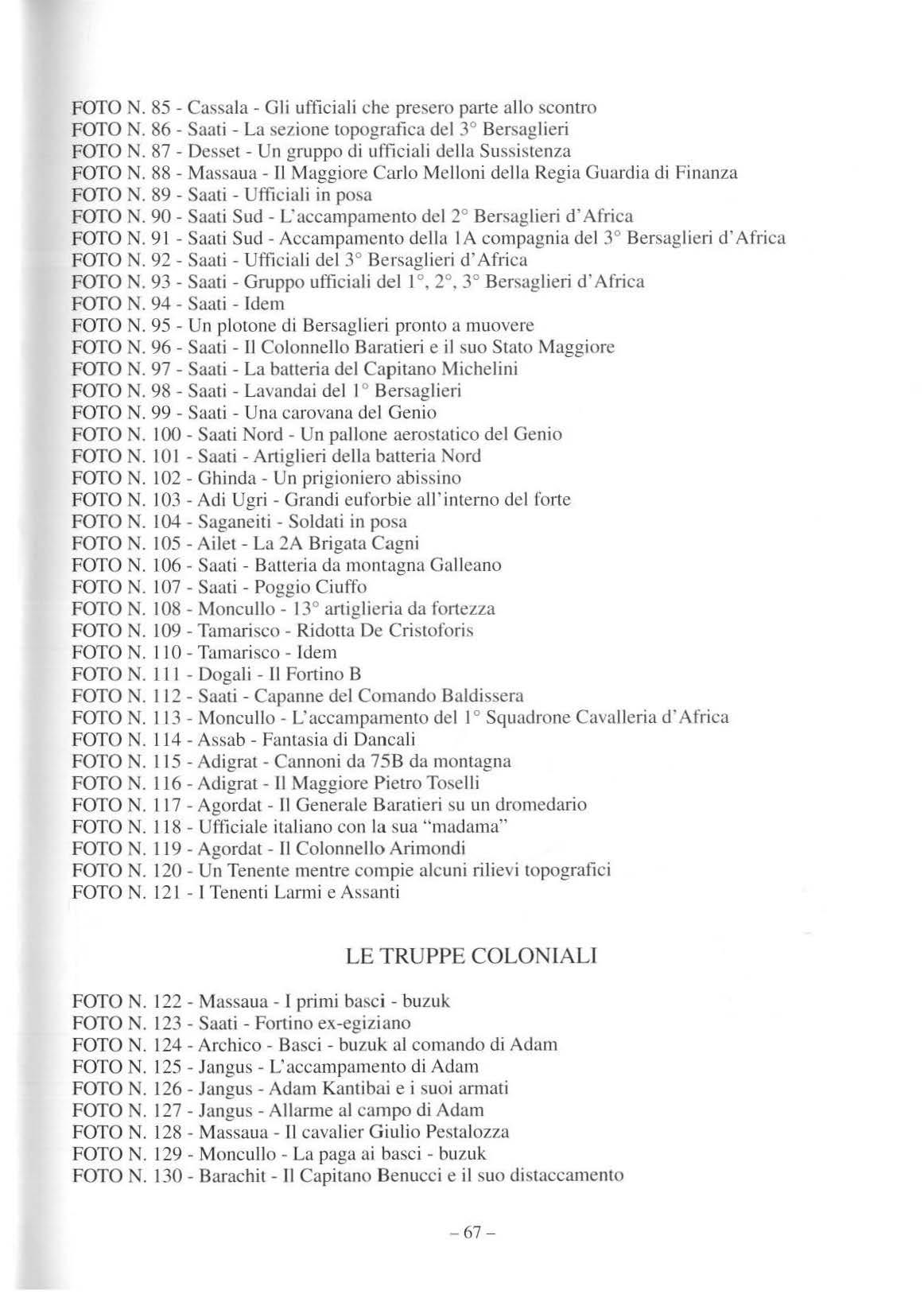
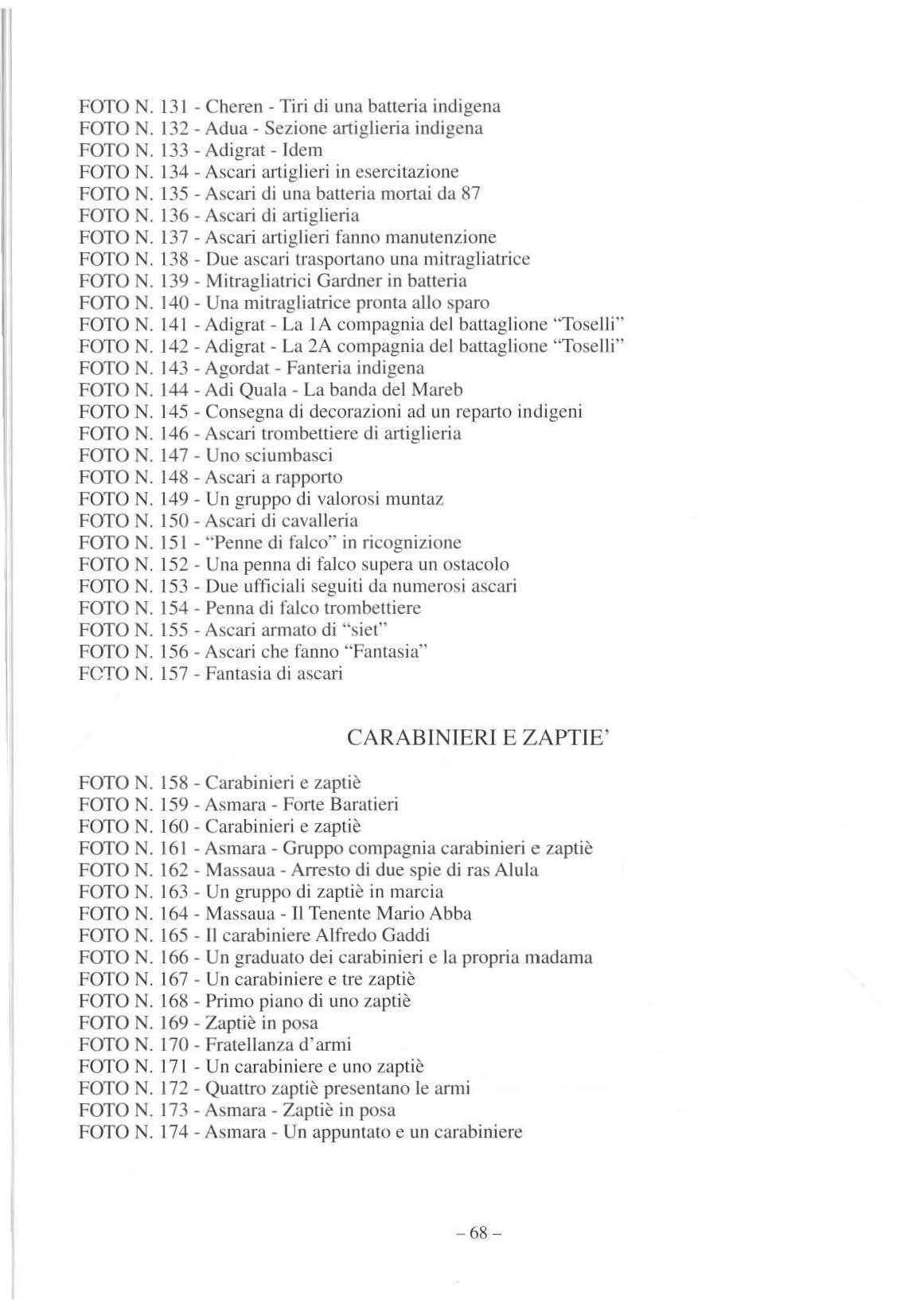
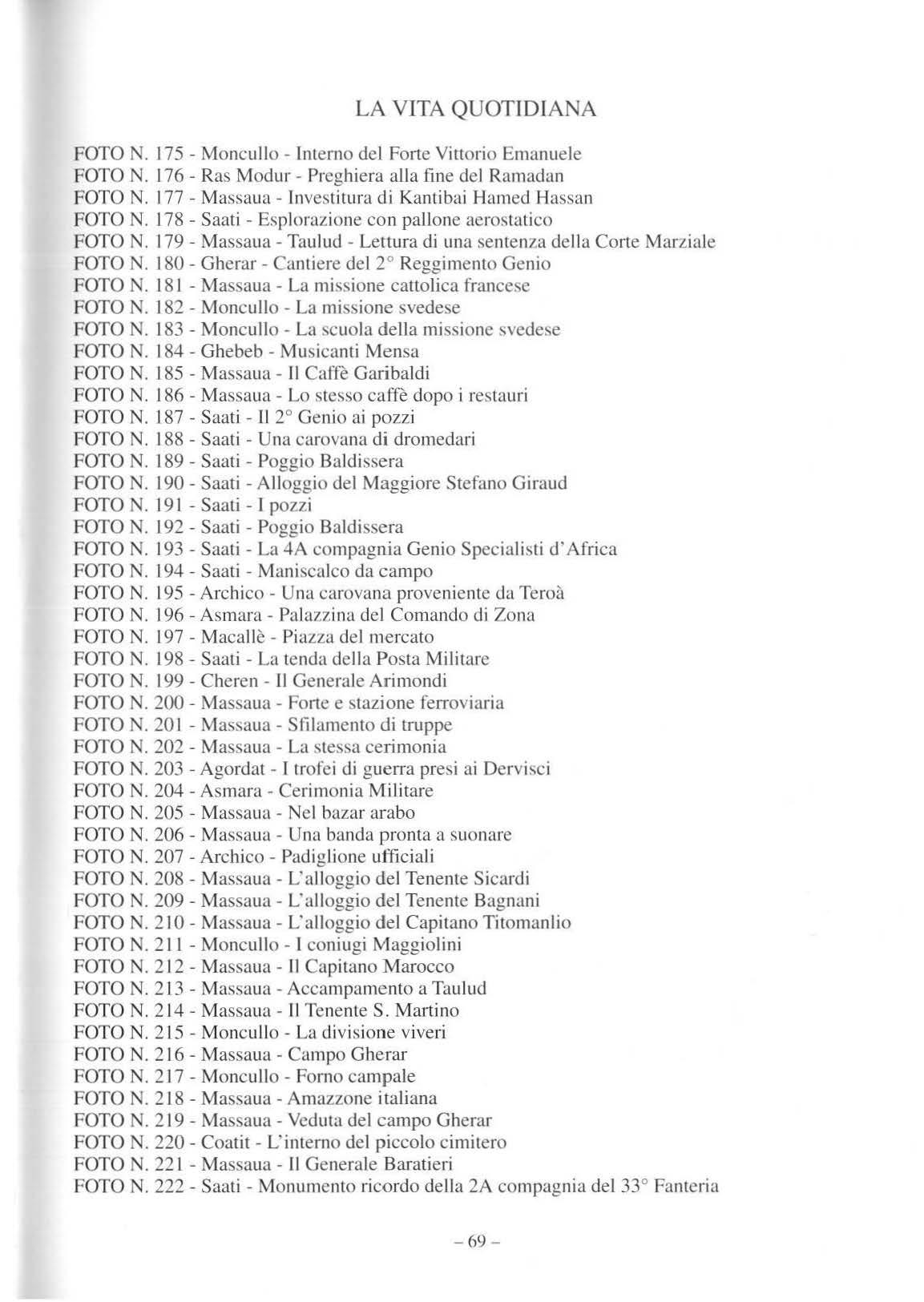
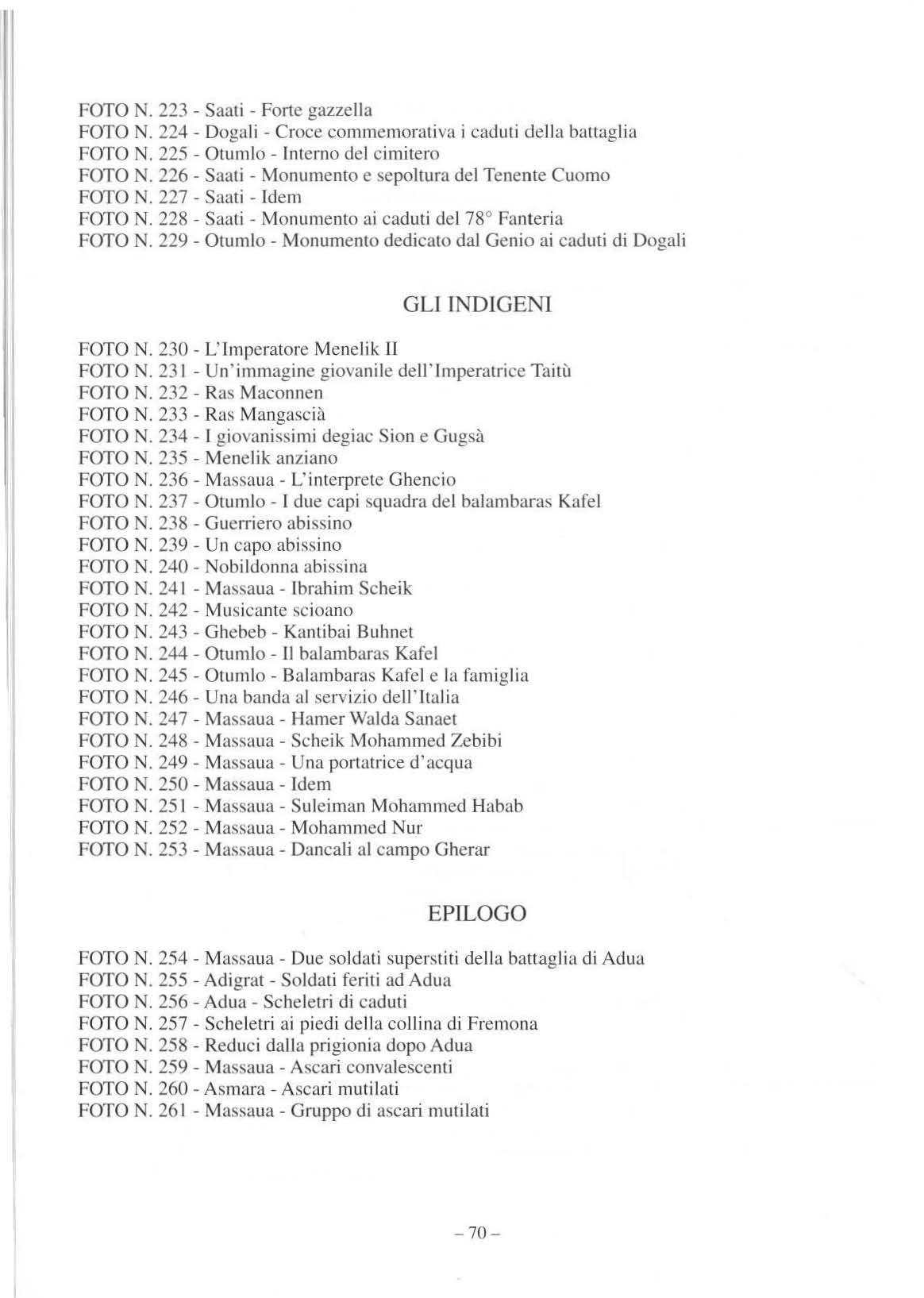
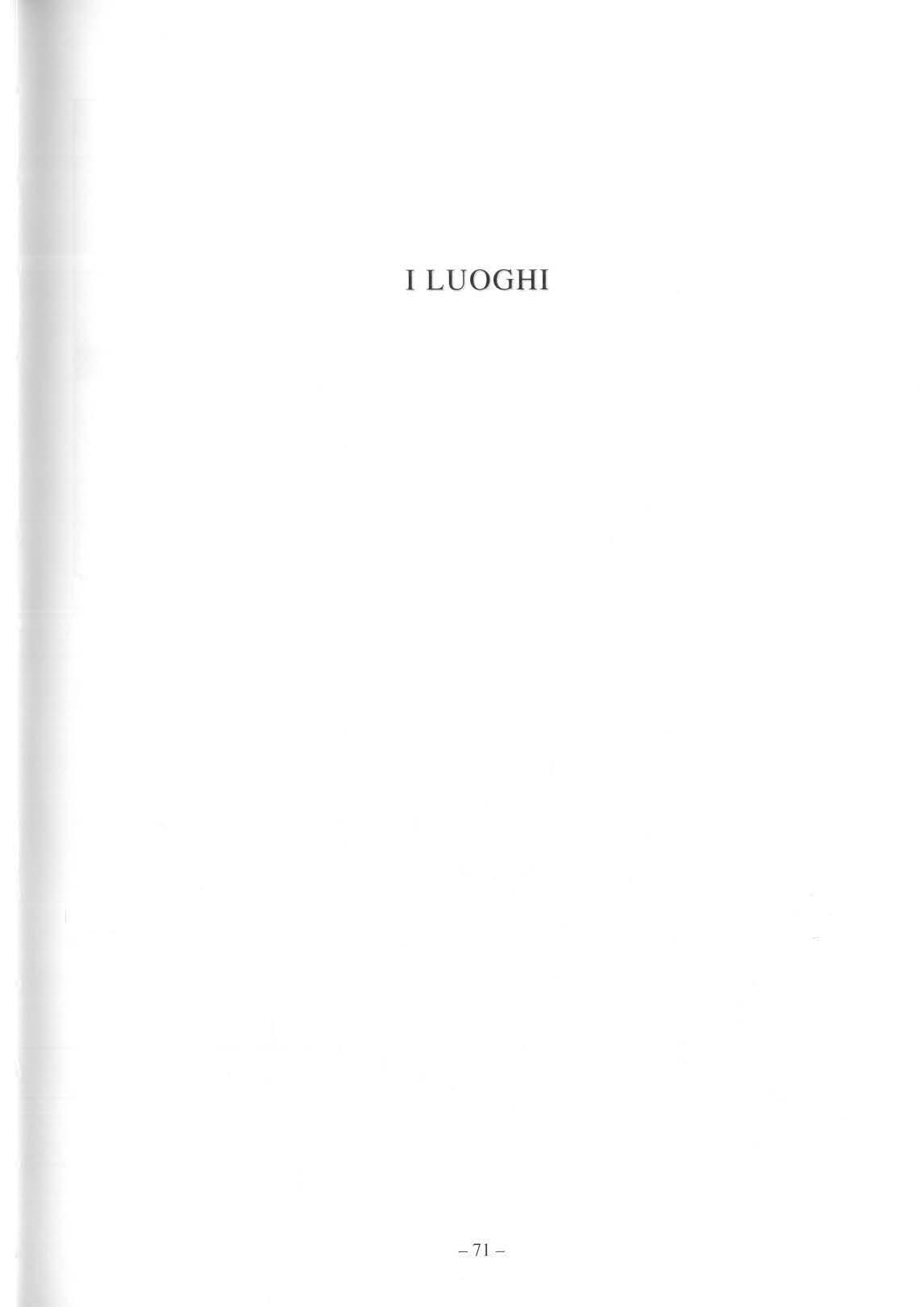
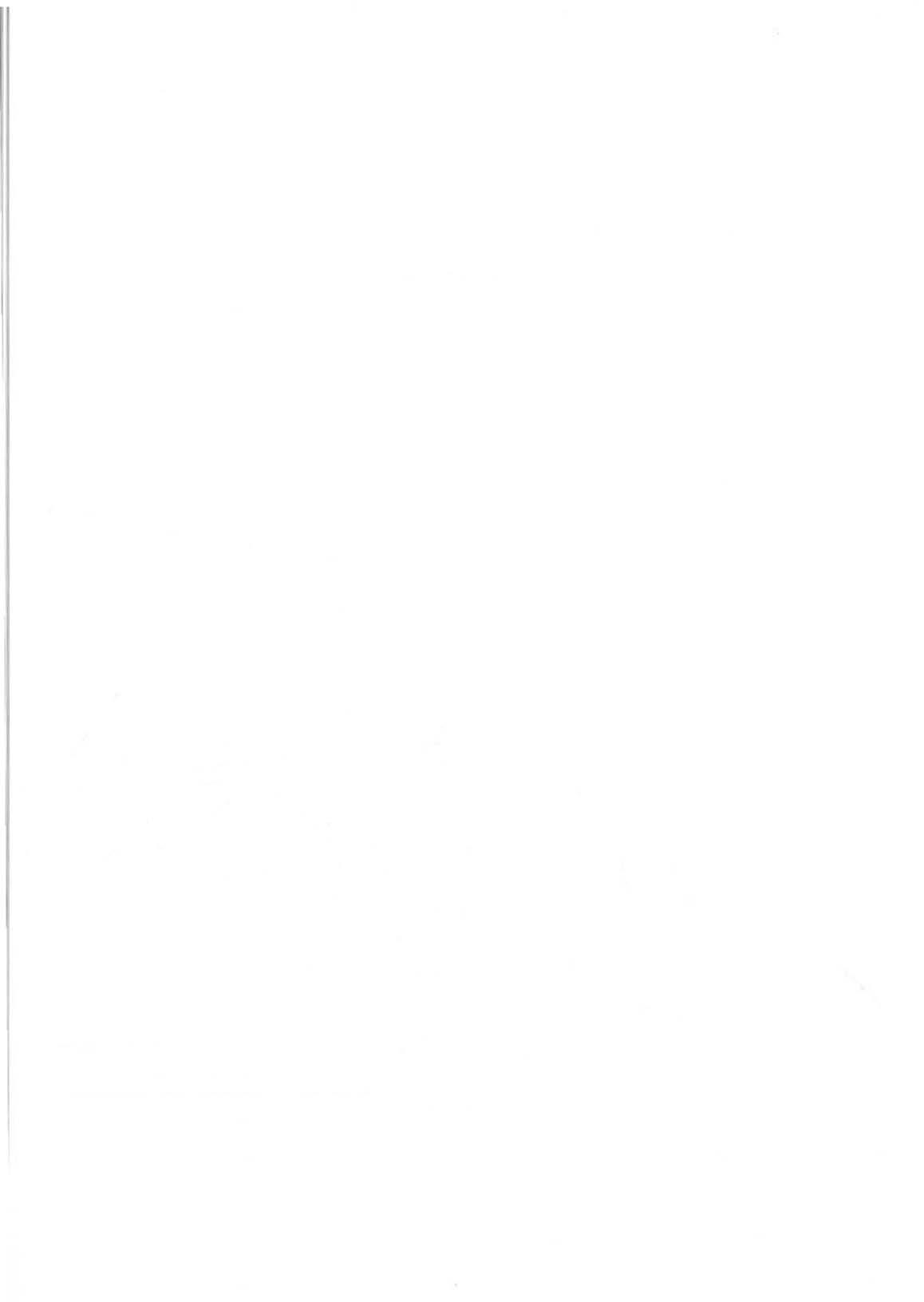
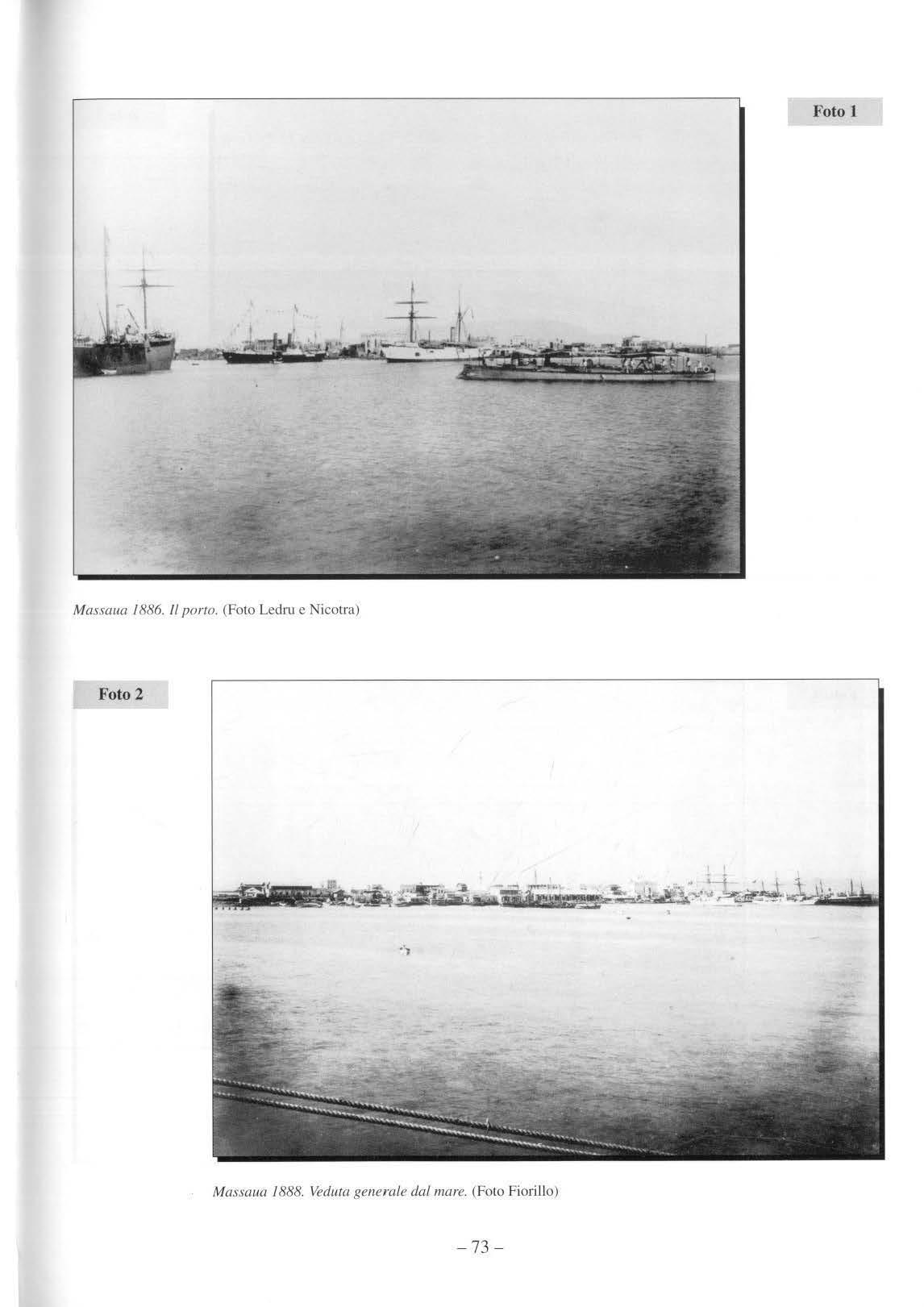
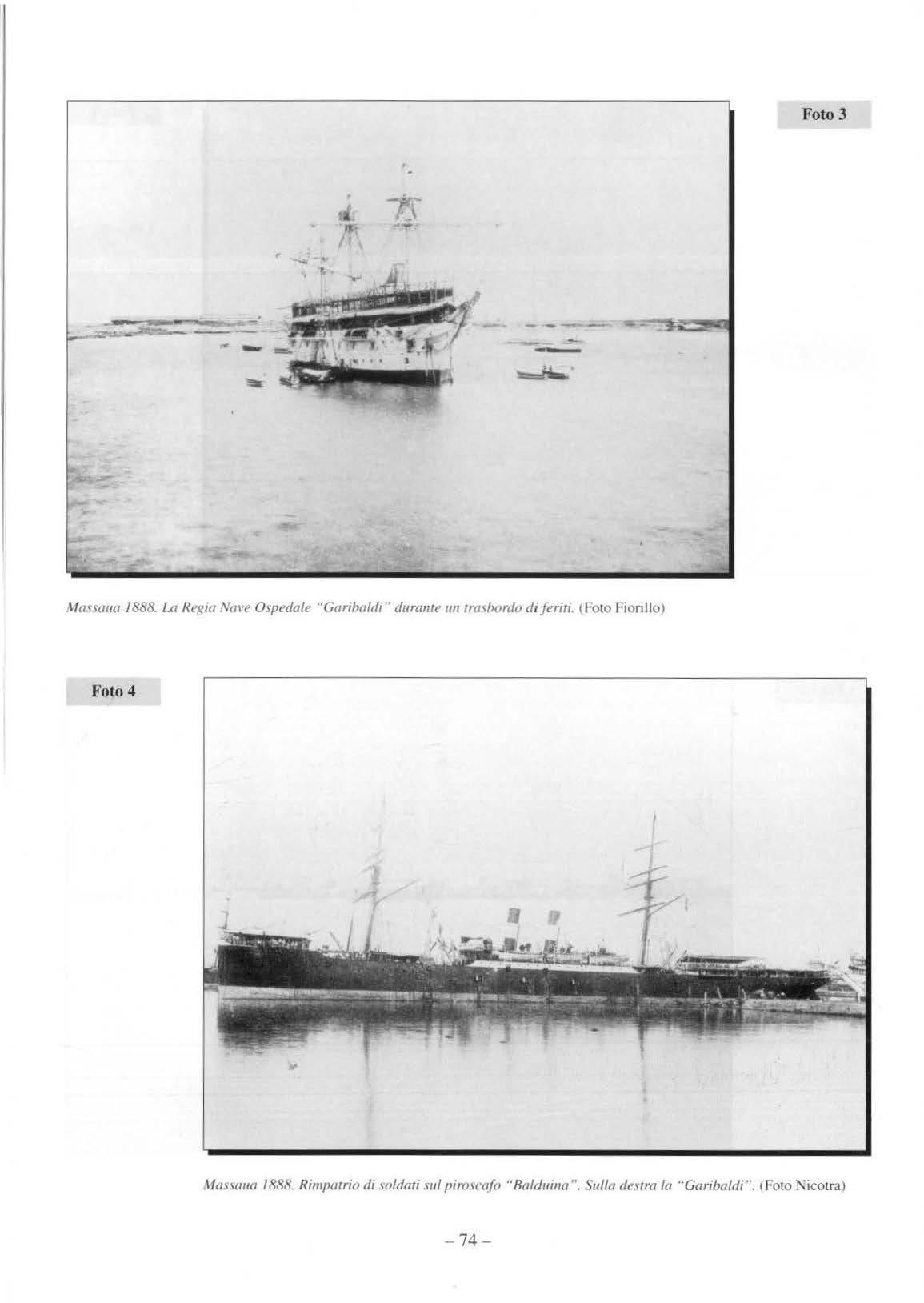
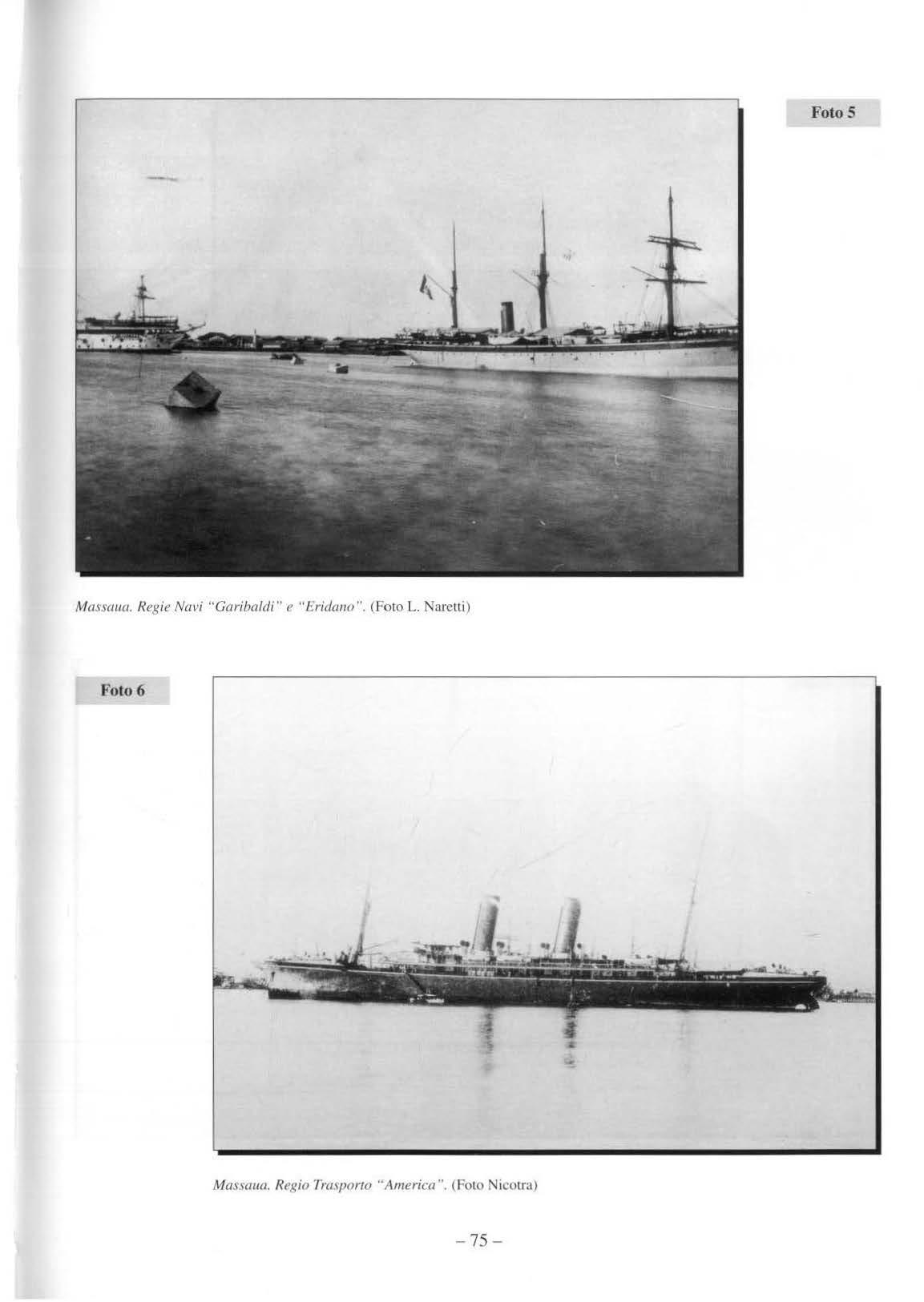
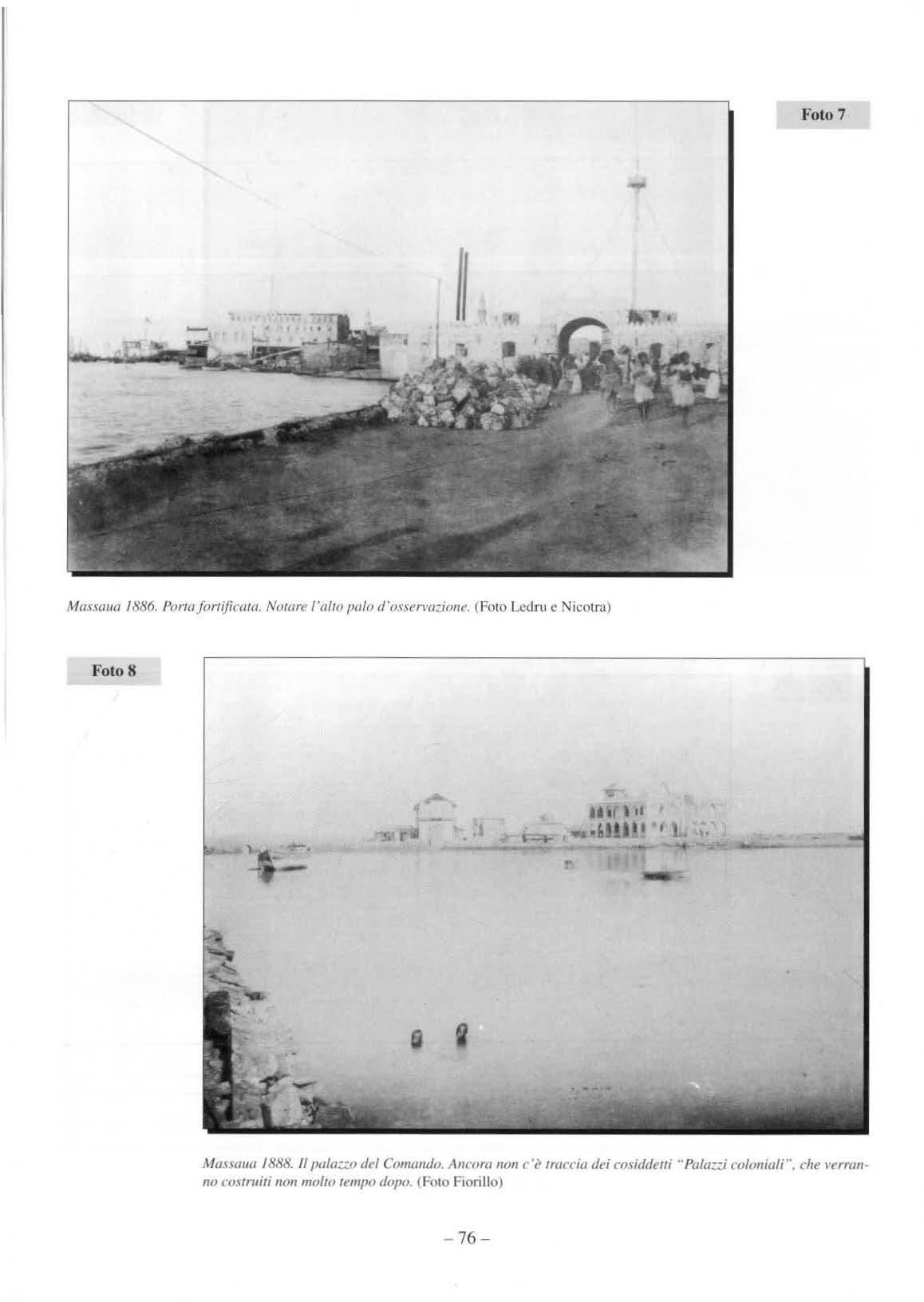 Foto7
Massaua 1886. Portafortijicalll. Notare l'alto palo d'osserwr:io11e (Fo to Ledru e Nicotra)
Foto7
Massaua 1886. Portafortijicalll. Notare l'alto palo d'osserwr:io11e (Fo to Ledru e Nicotra)
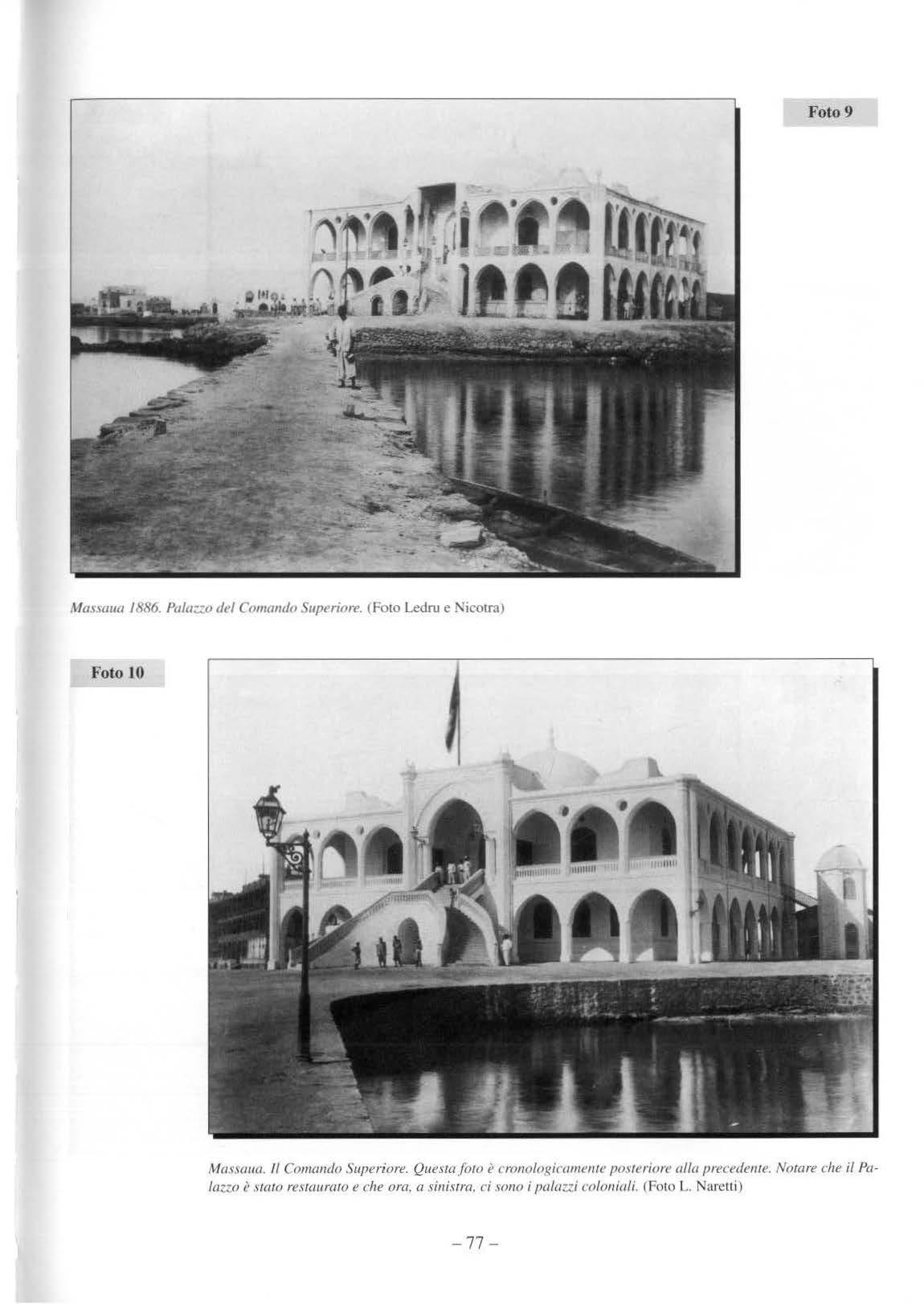
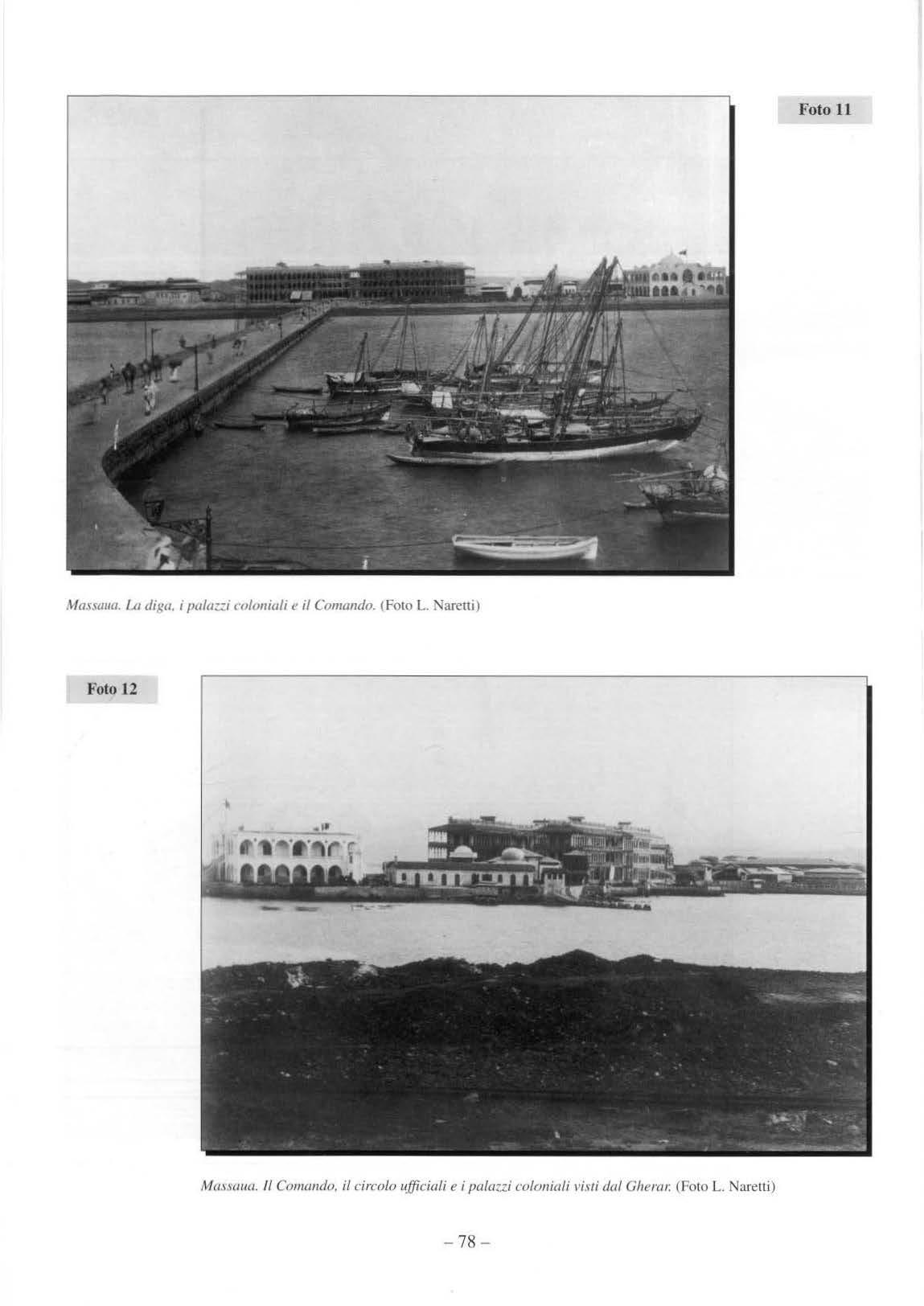
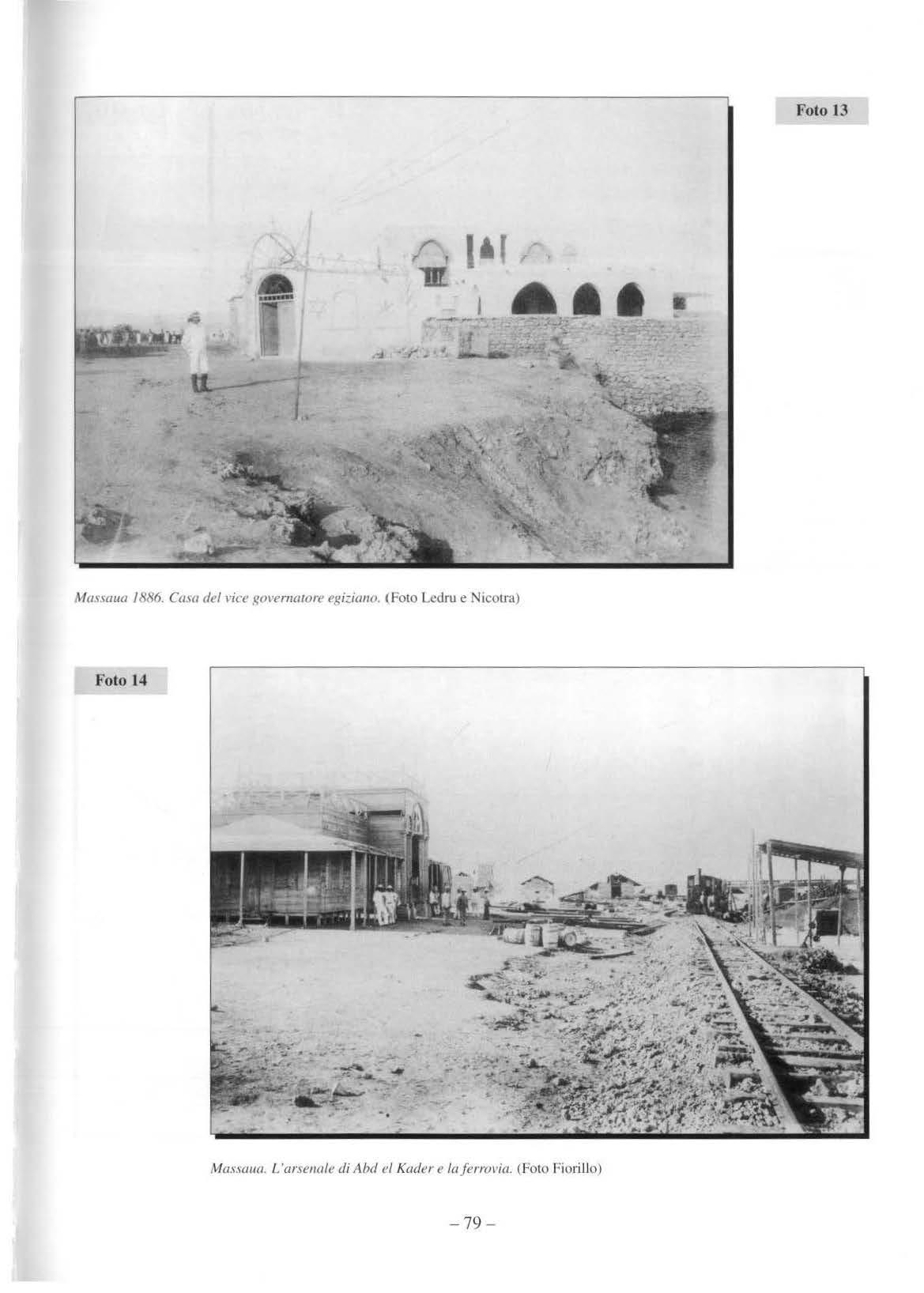
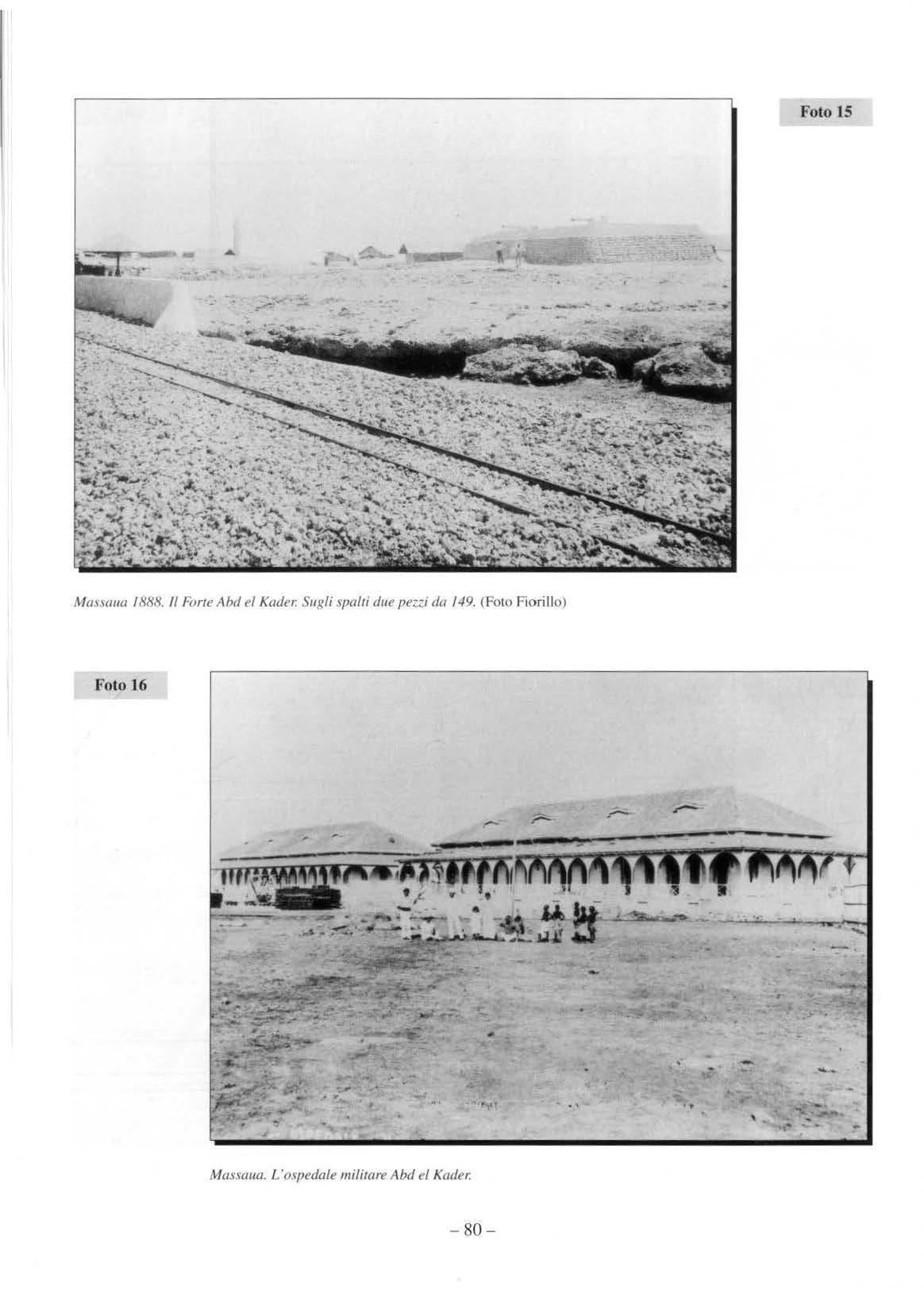
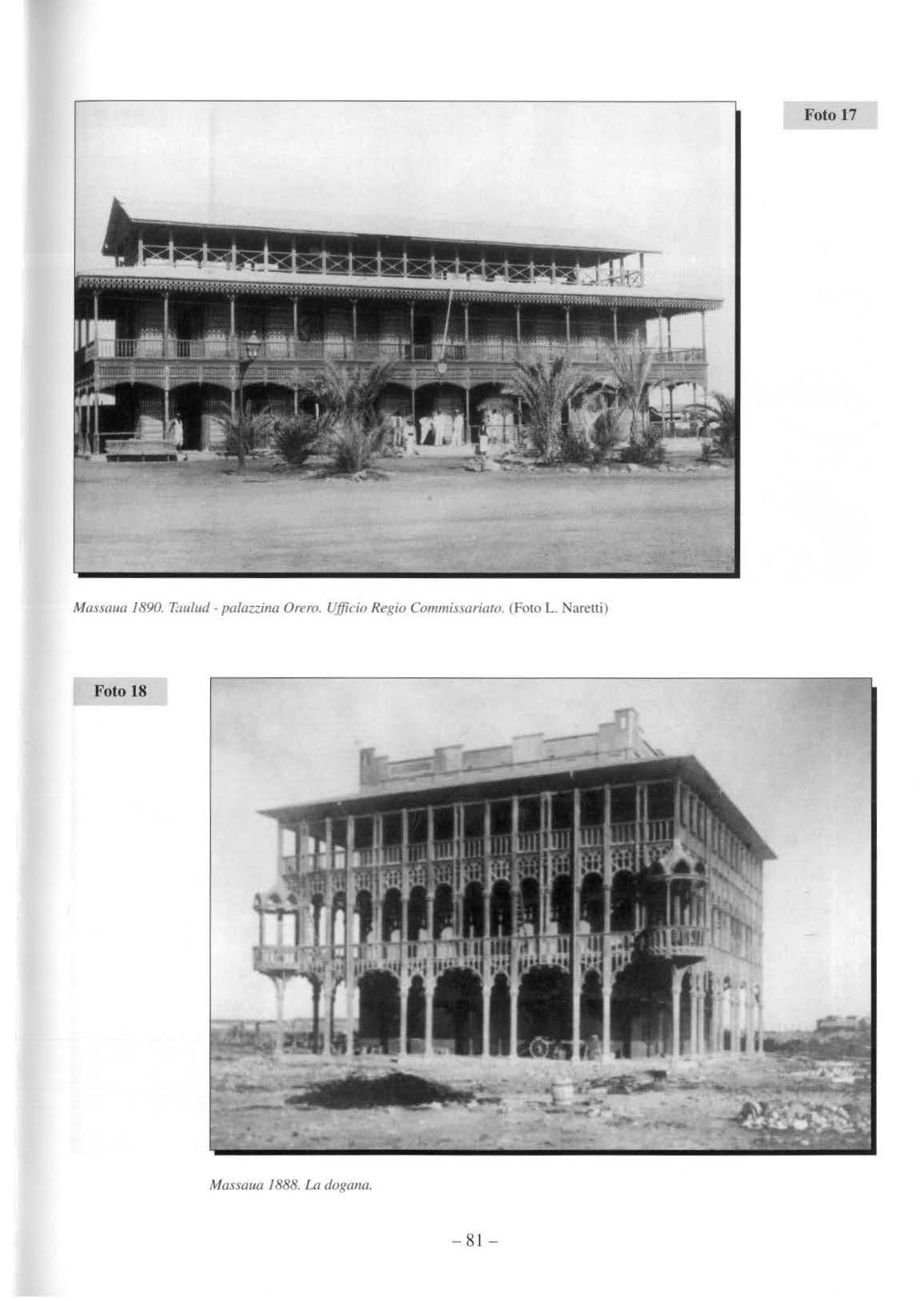
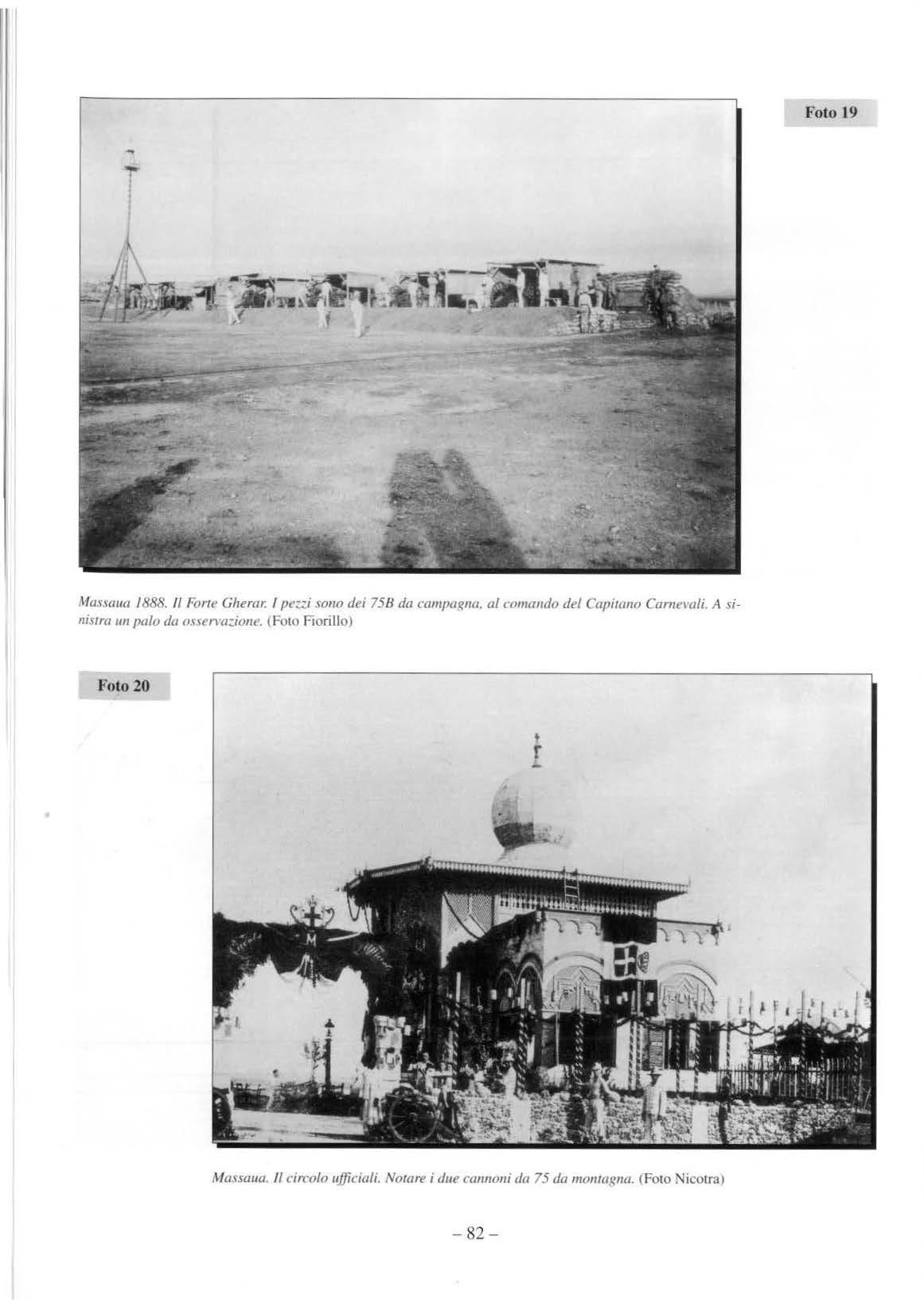
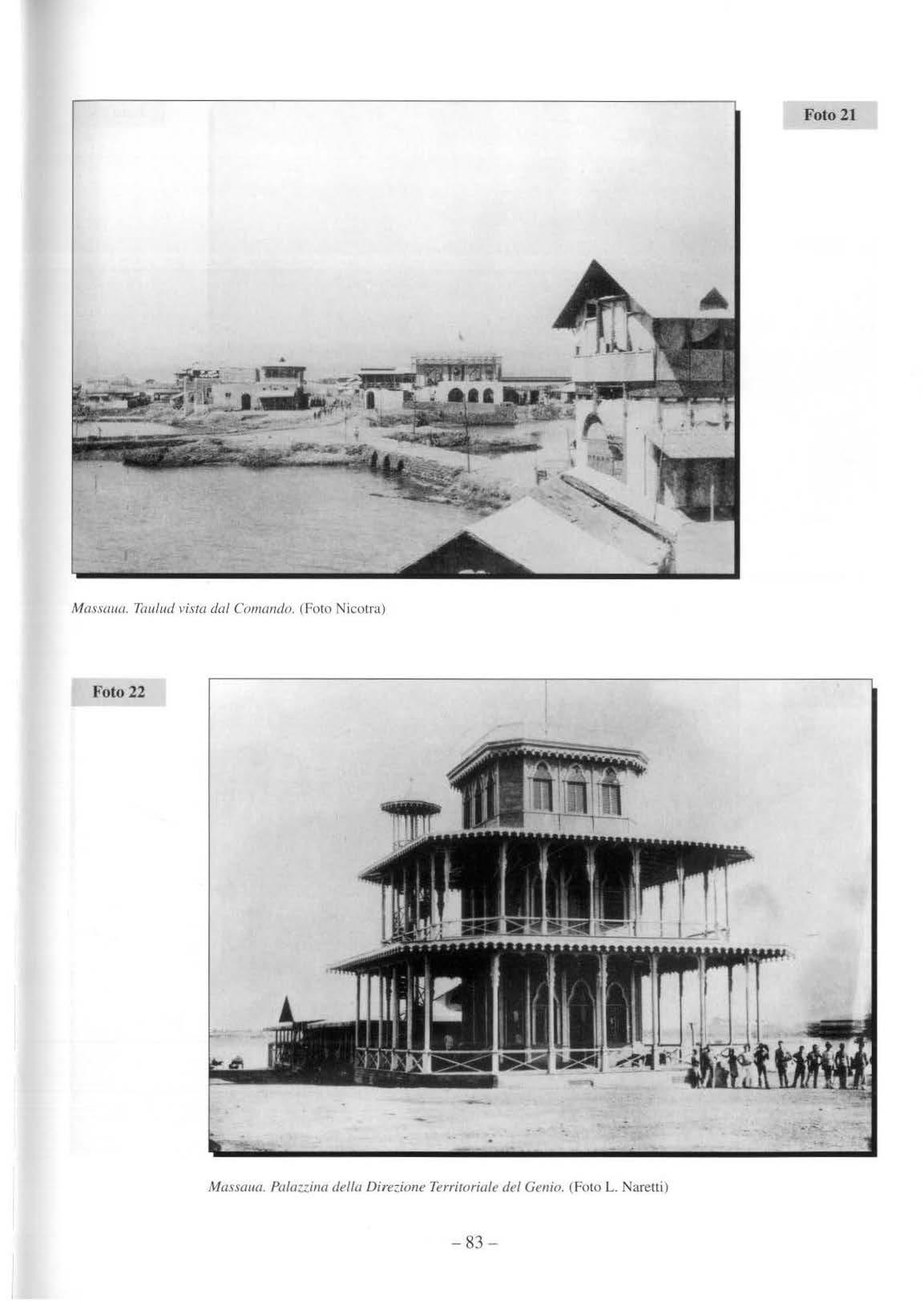
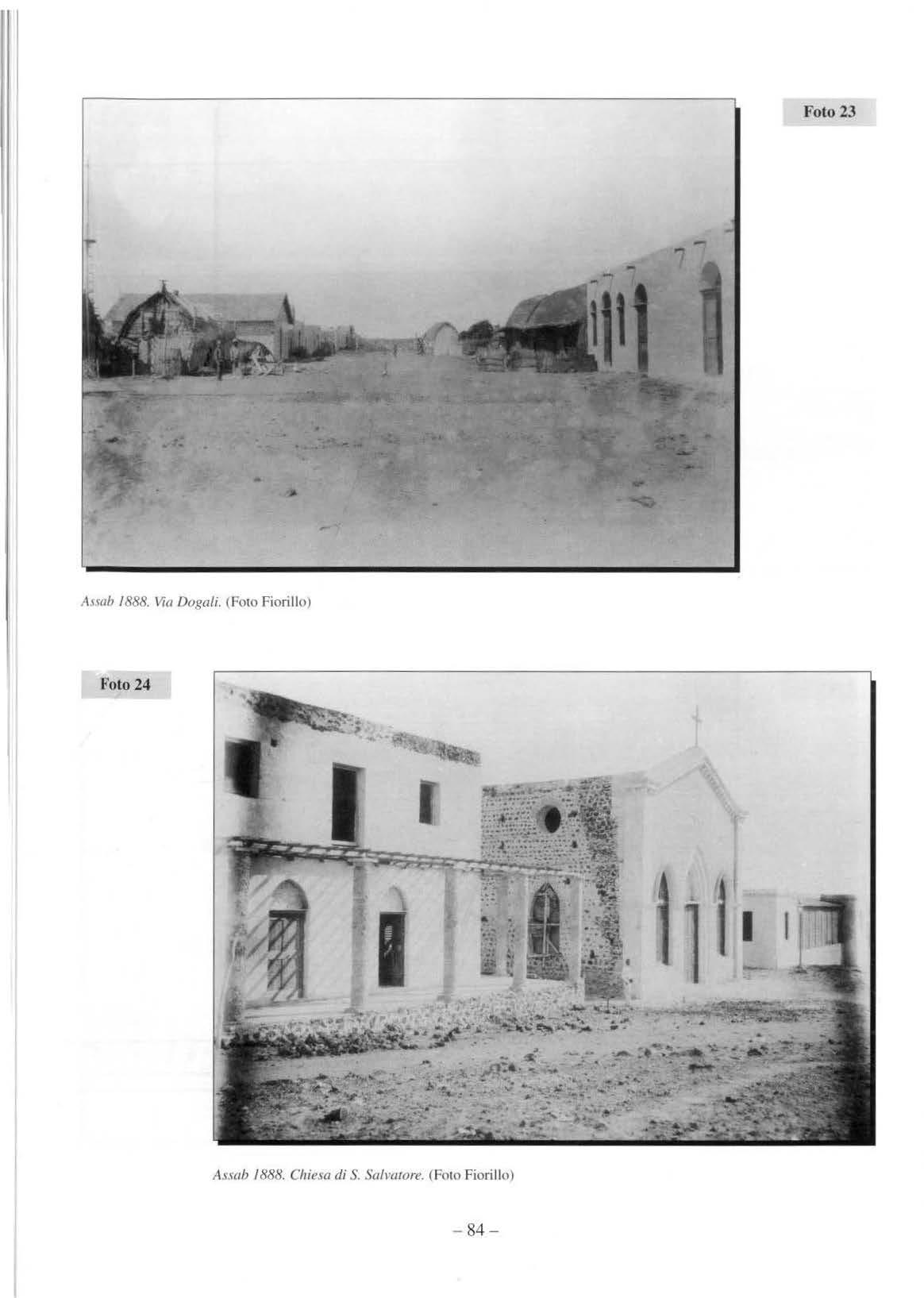
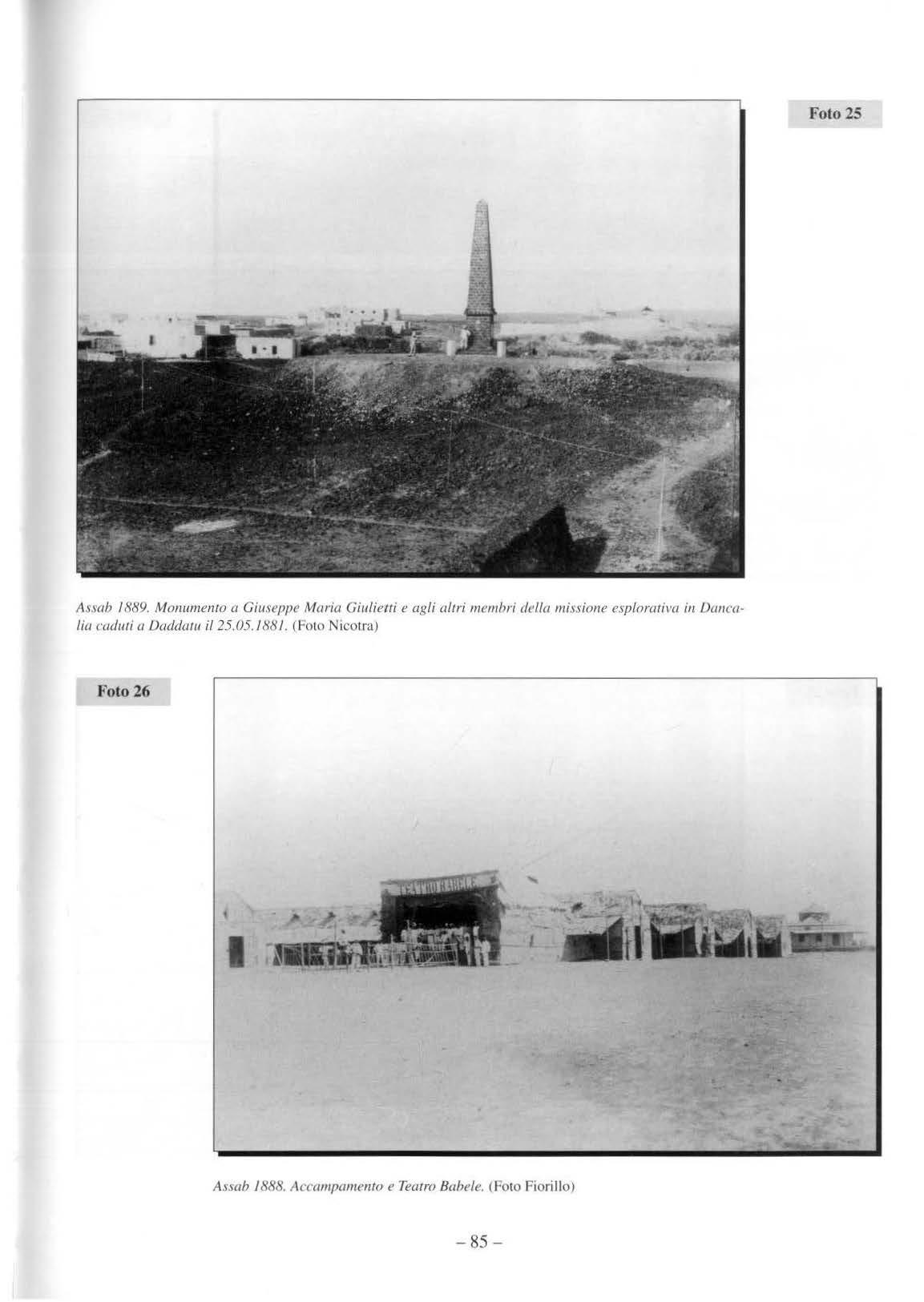
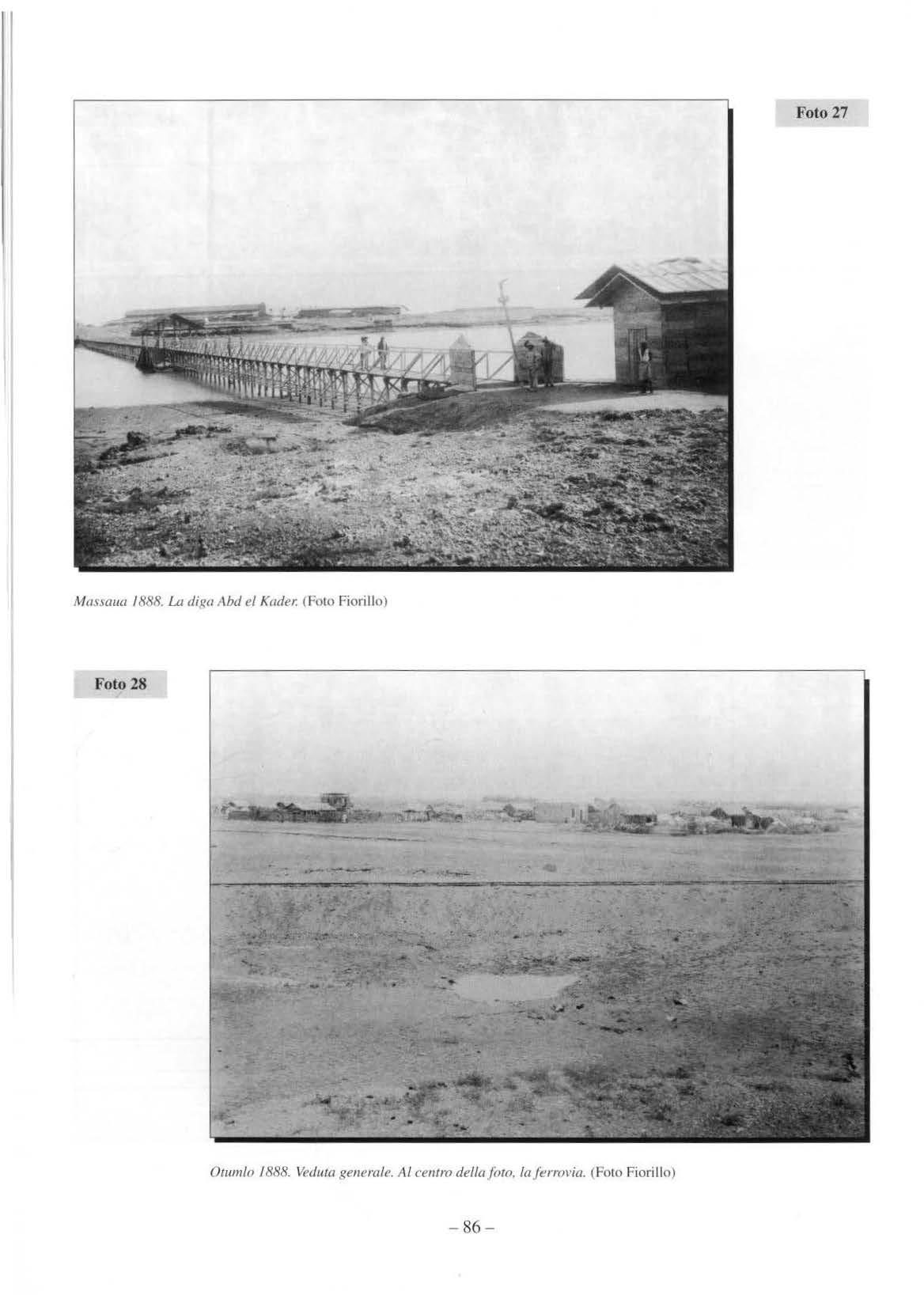
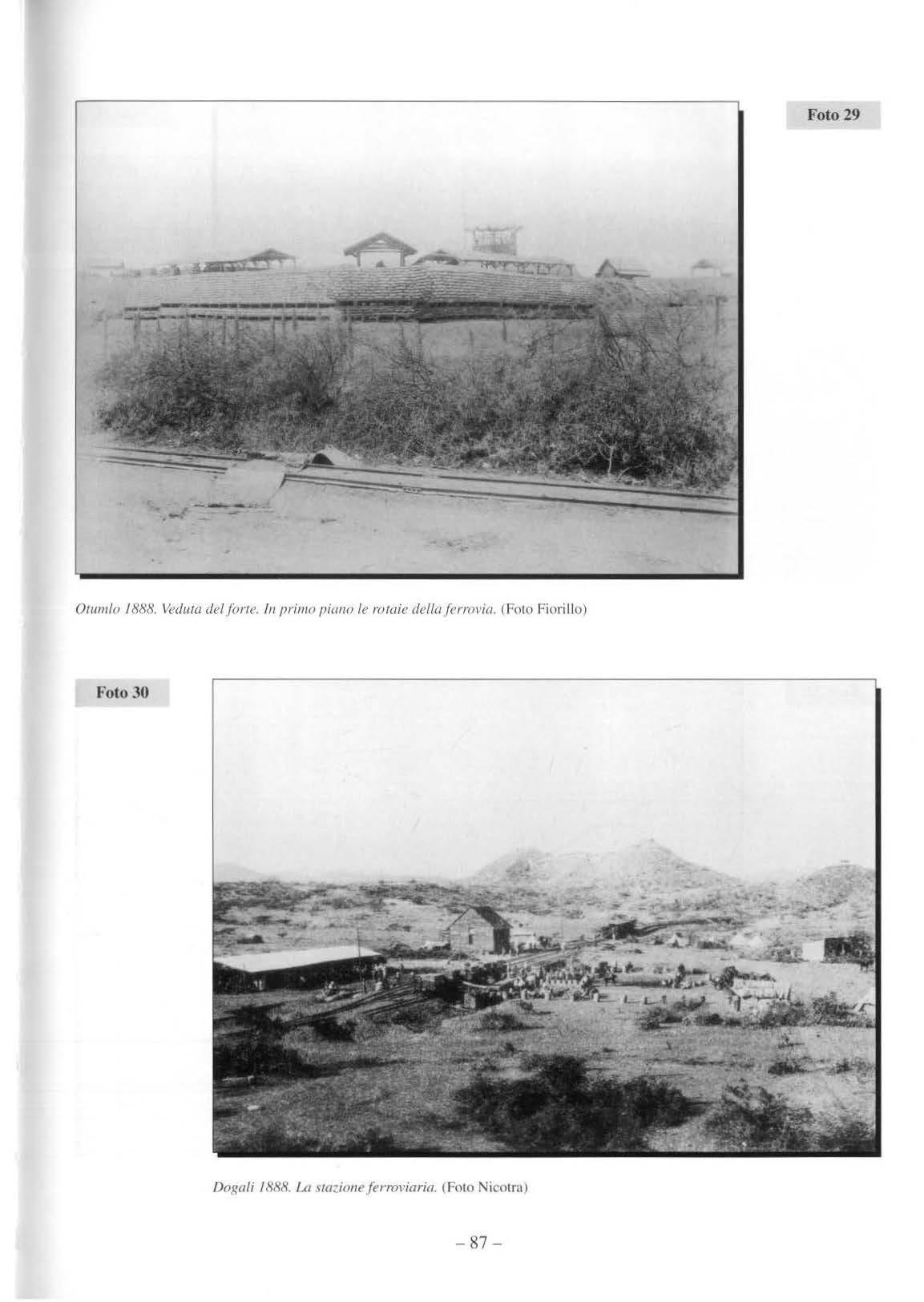
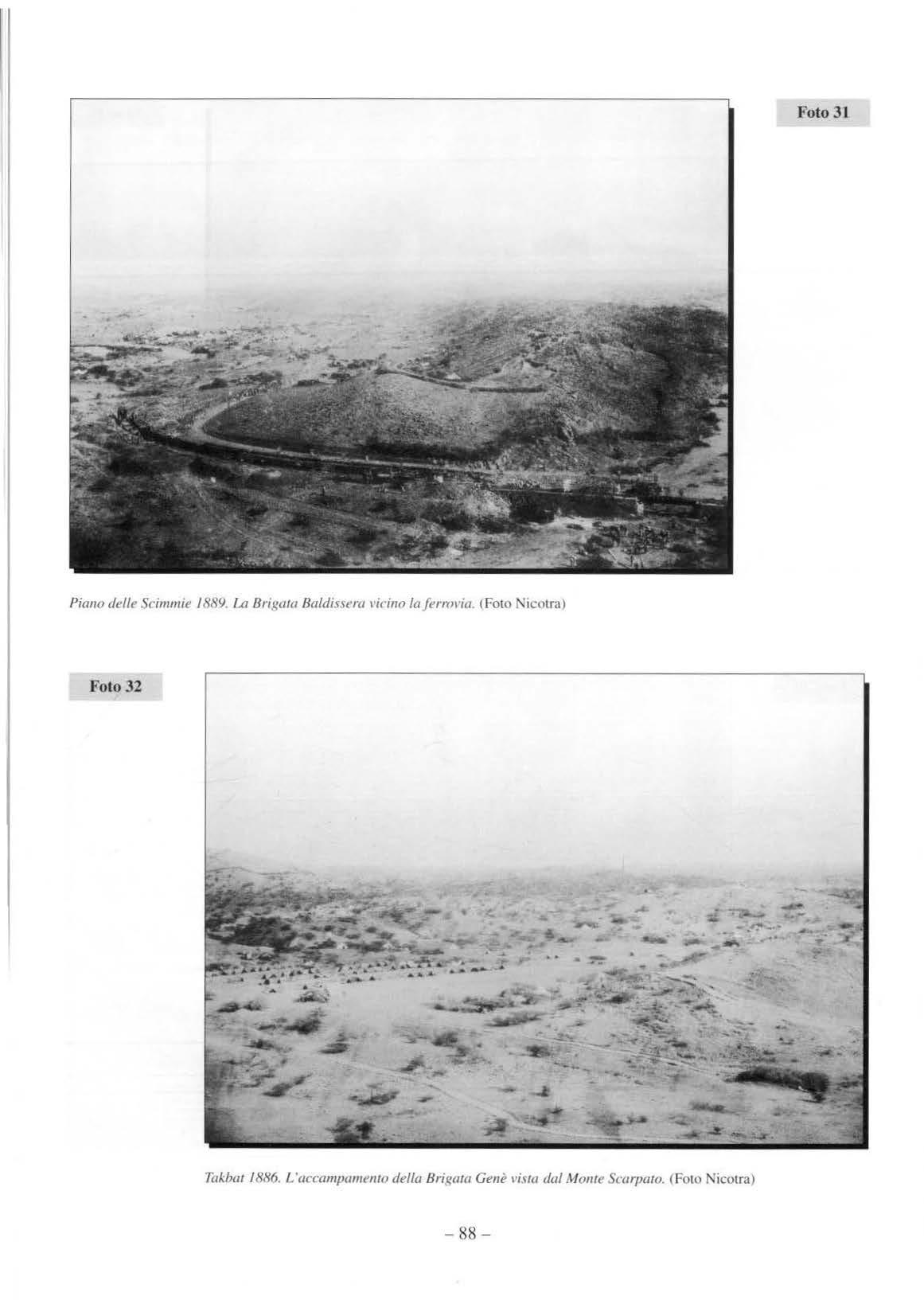
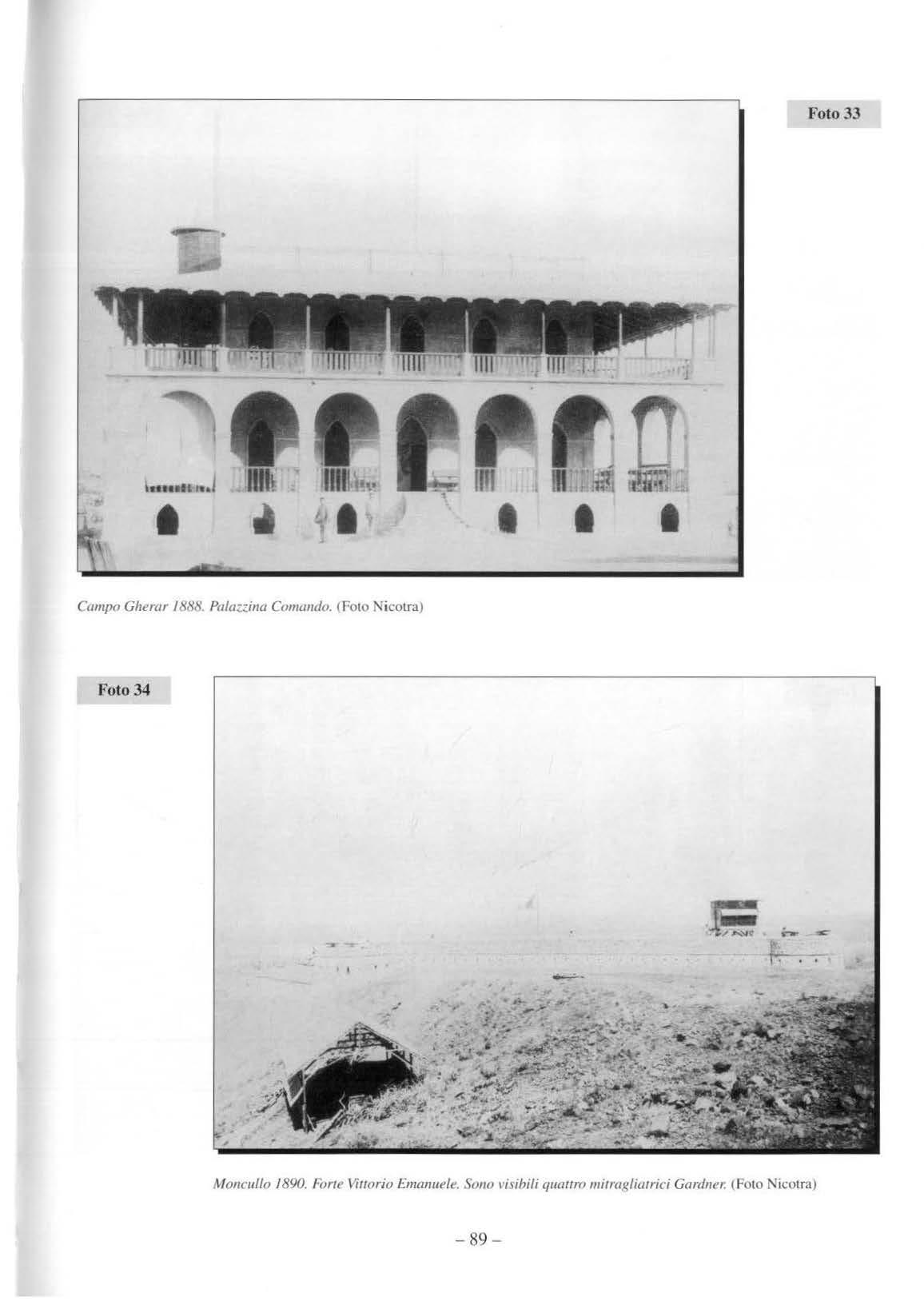
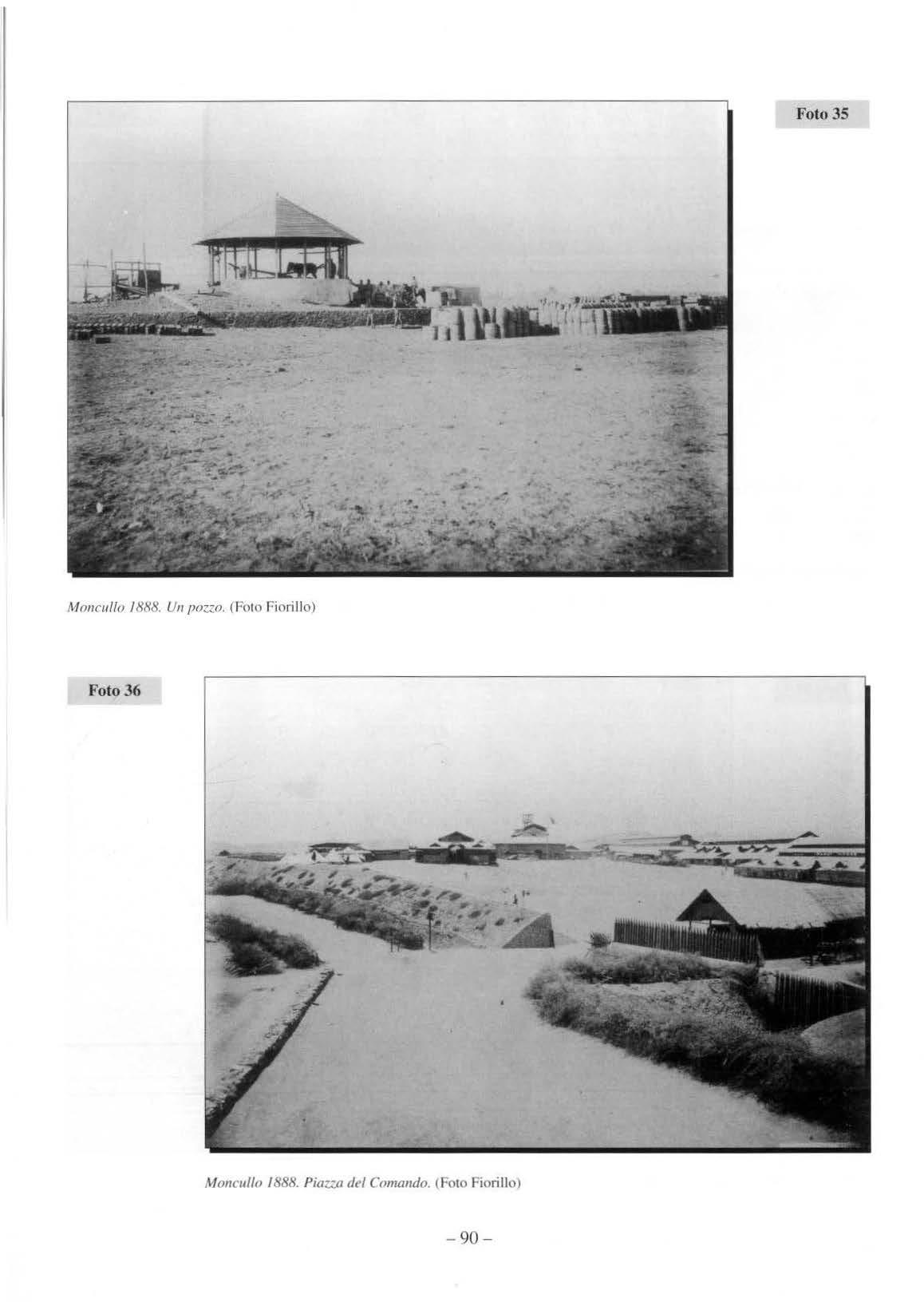

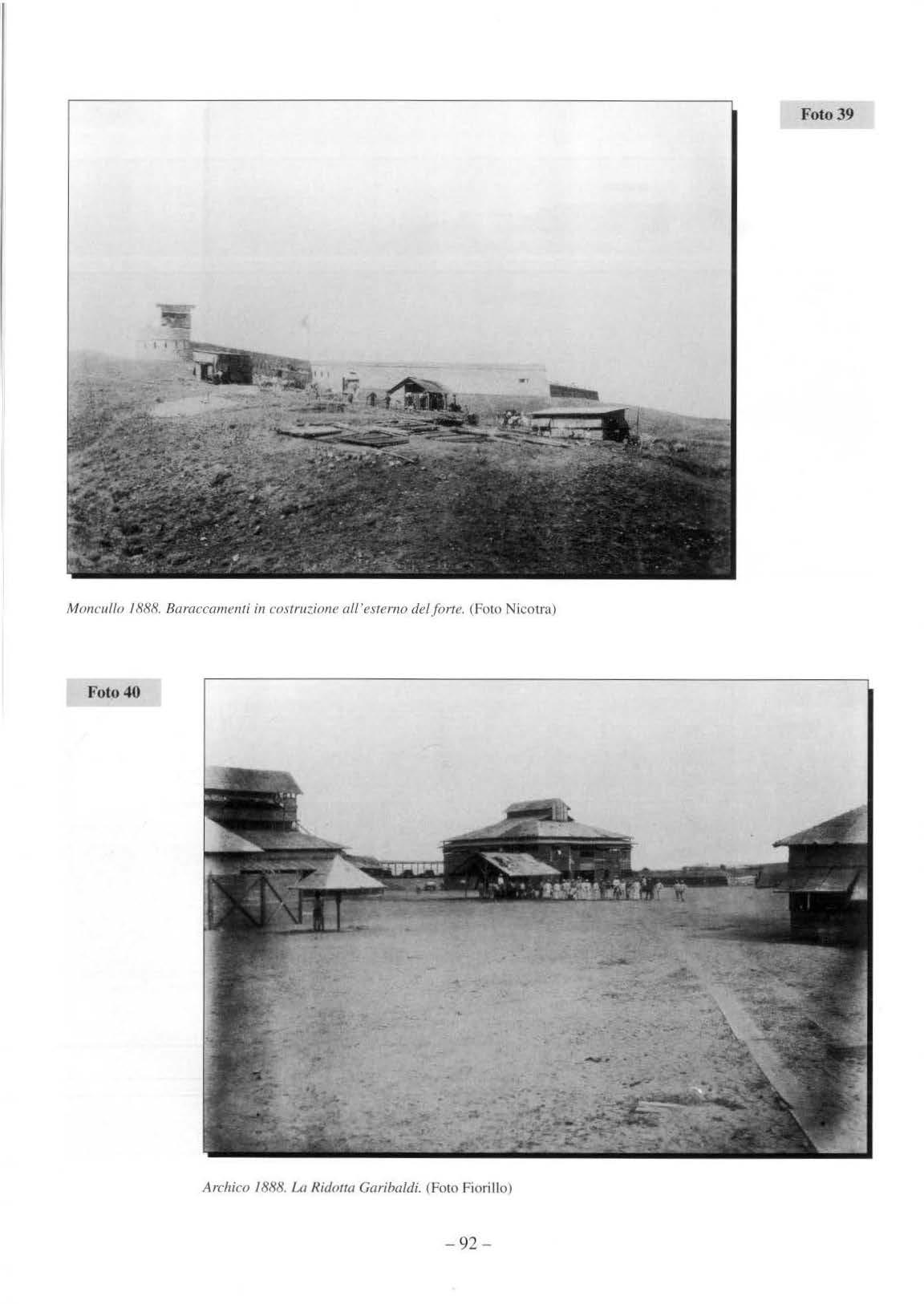
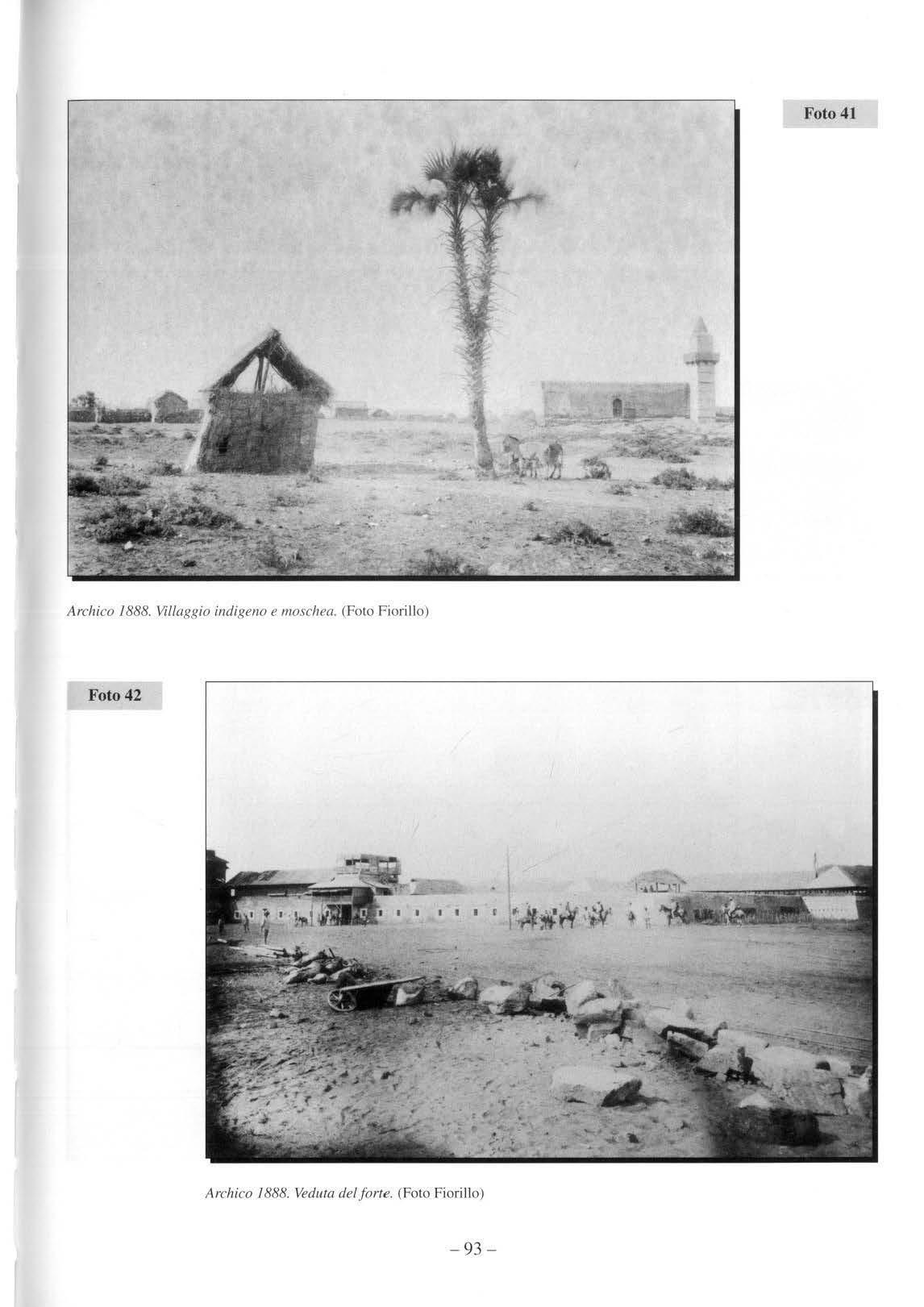
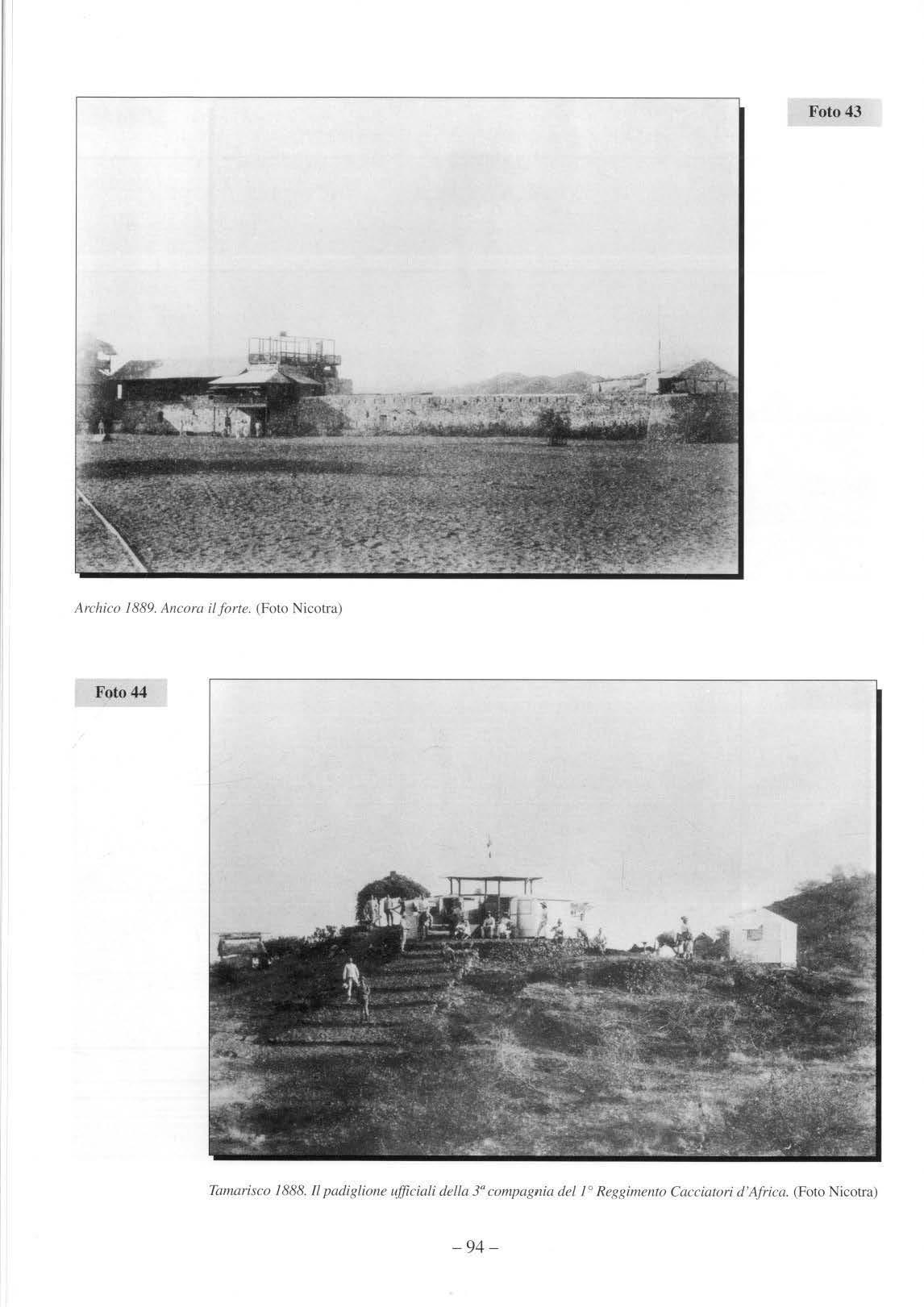
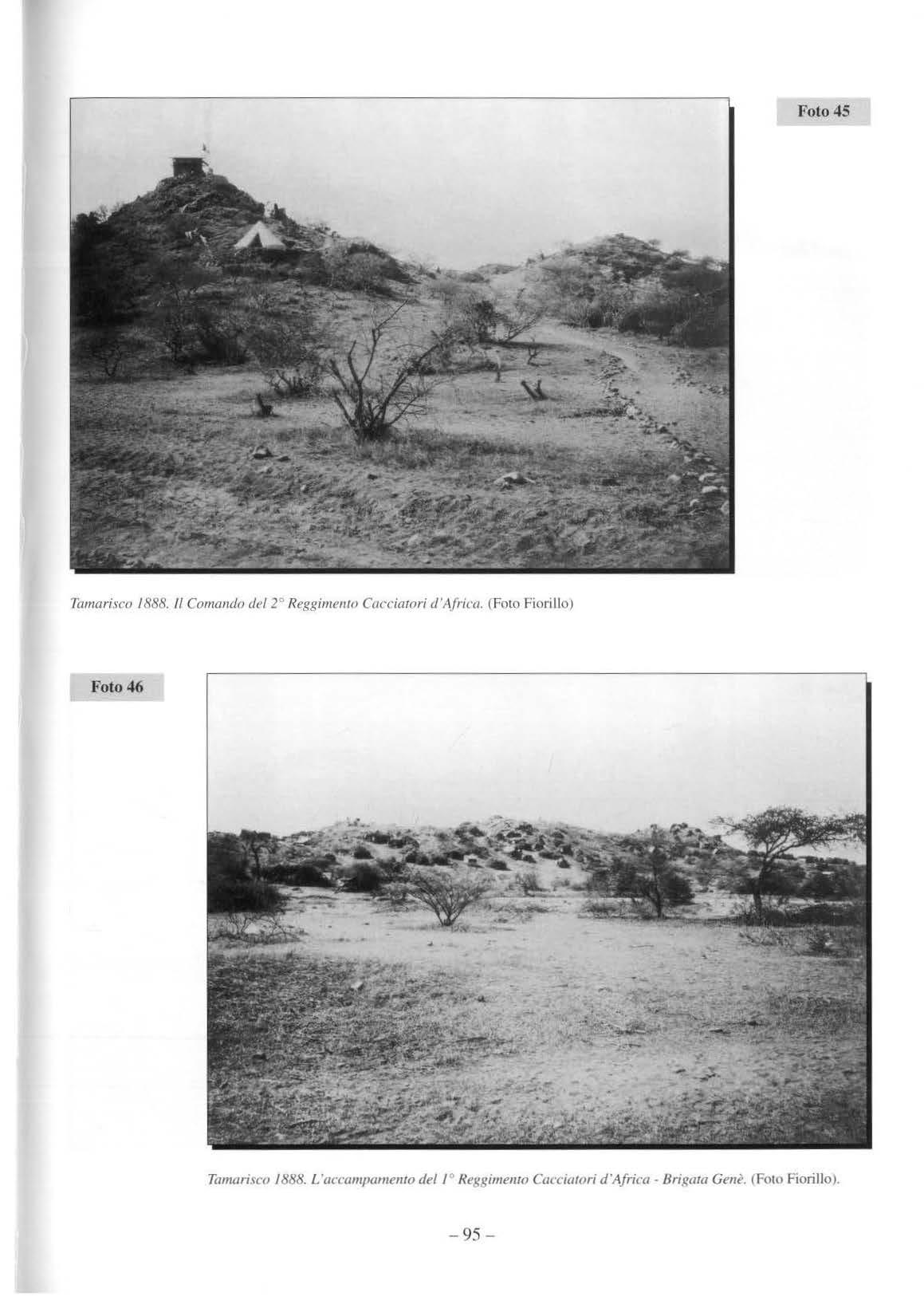
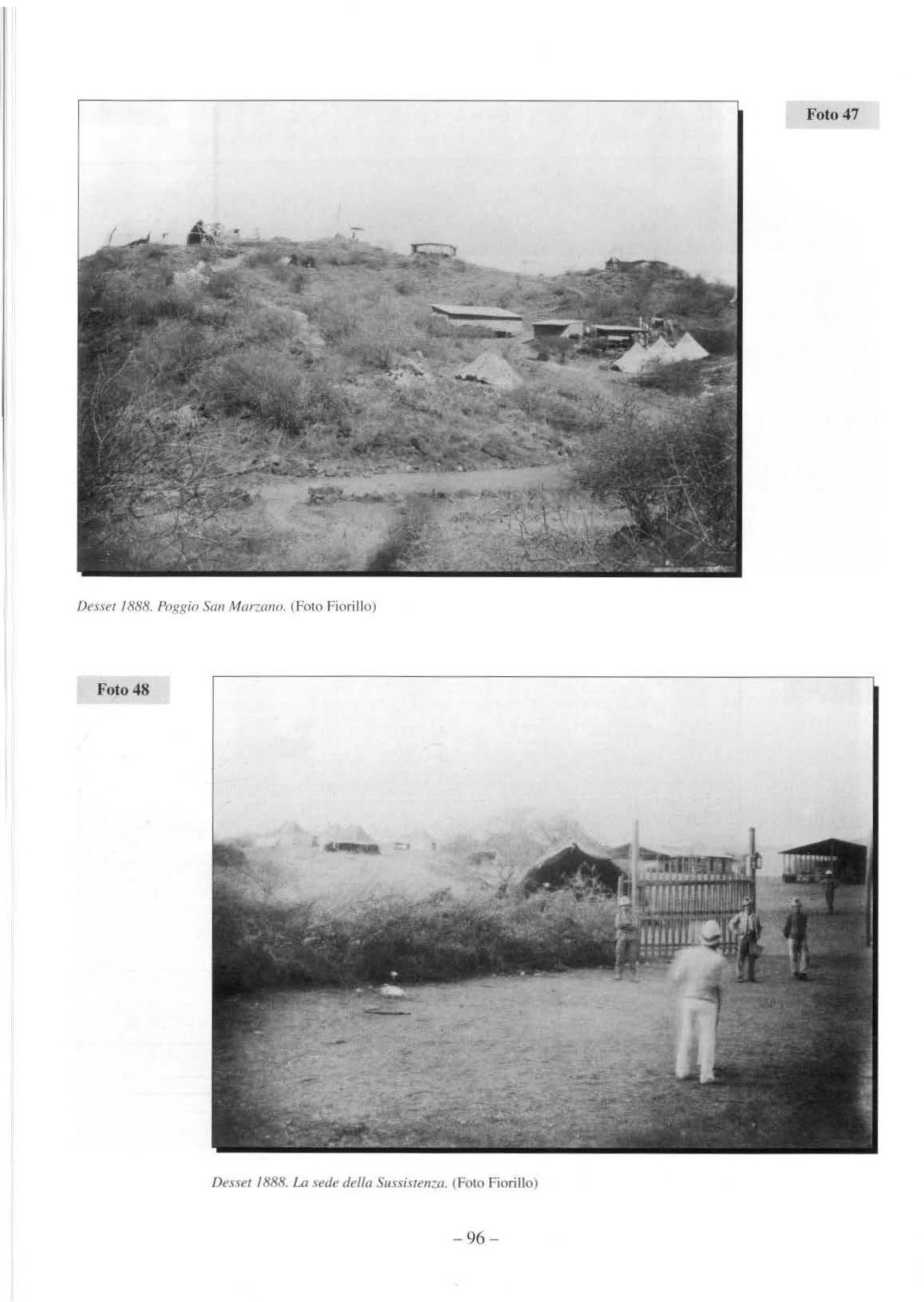
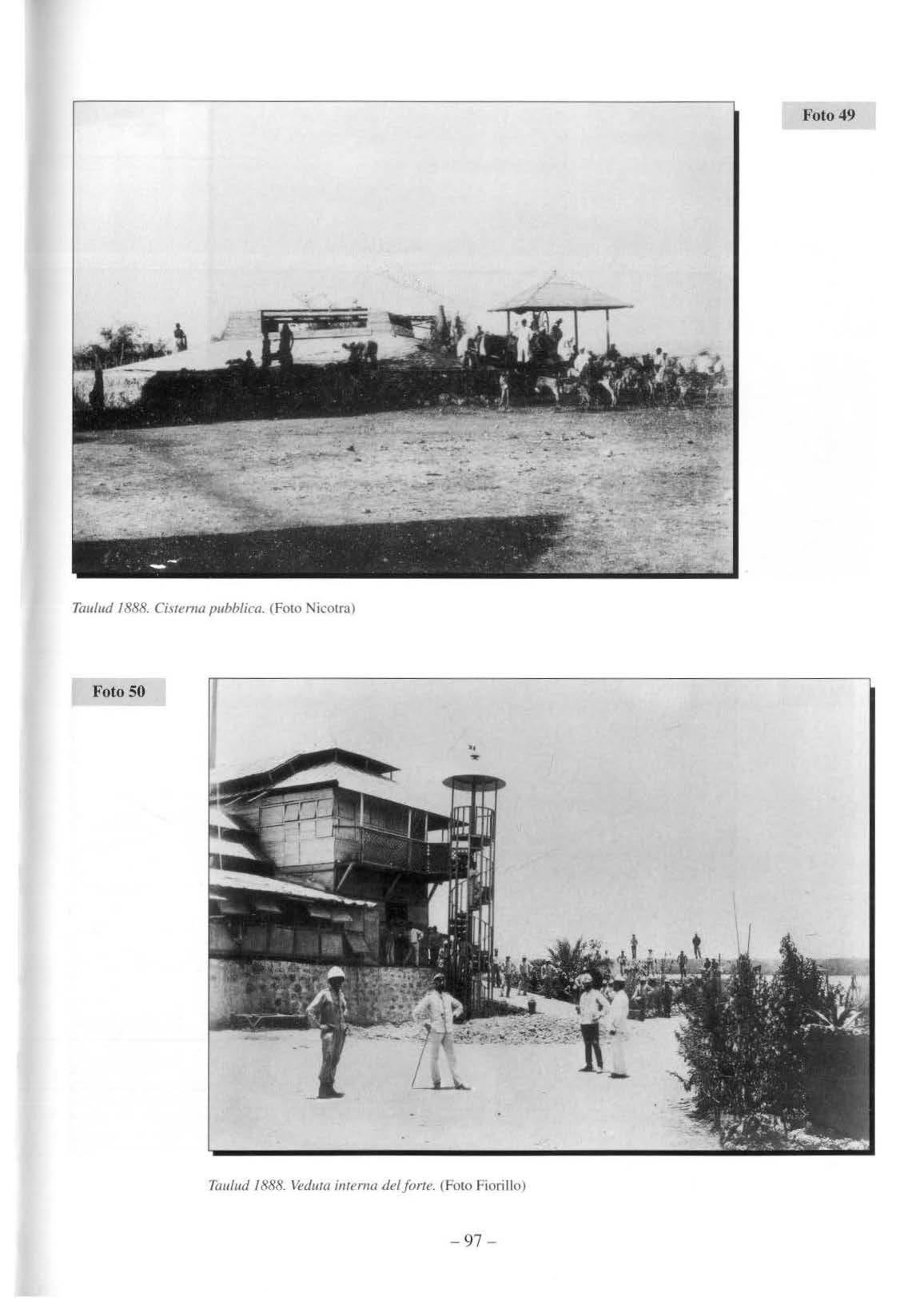
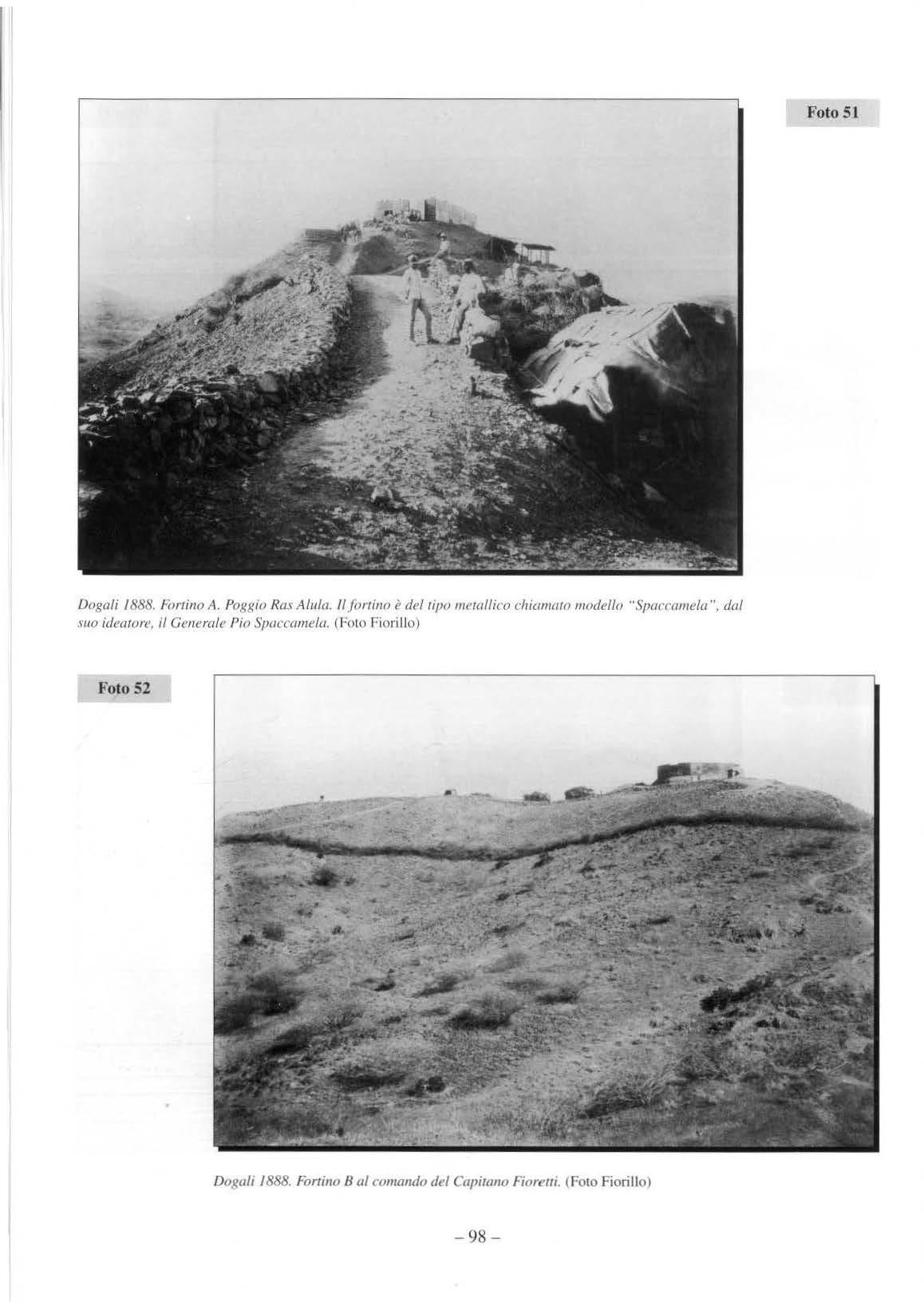 Dogali 1888. Fortino A. Pogg io Ras Alula. Il fortino è de/tipo metallico chiamato modello "Spaccnme/a'', dal suo ideatore, il Generale Pio Spaccamela. (foto Fiorillo)
Foto 52
Dogali 1888. Fortino A. Pogg io Ras Alula. Il fortino è de/tipo metallico chiamato modello "Spaccnme/a'', dal suo ideatore, il Generale Pio Spaccamela. (foto Fiorillo)
Foto 52

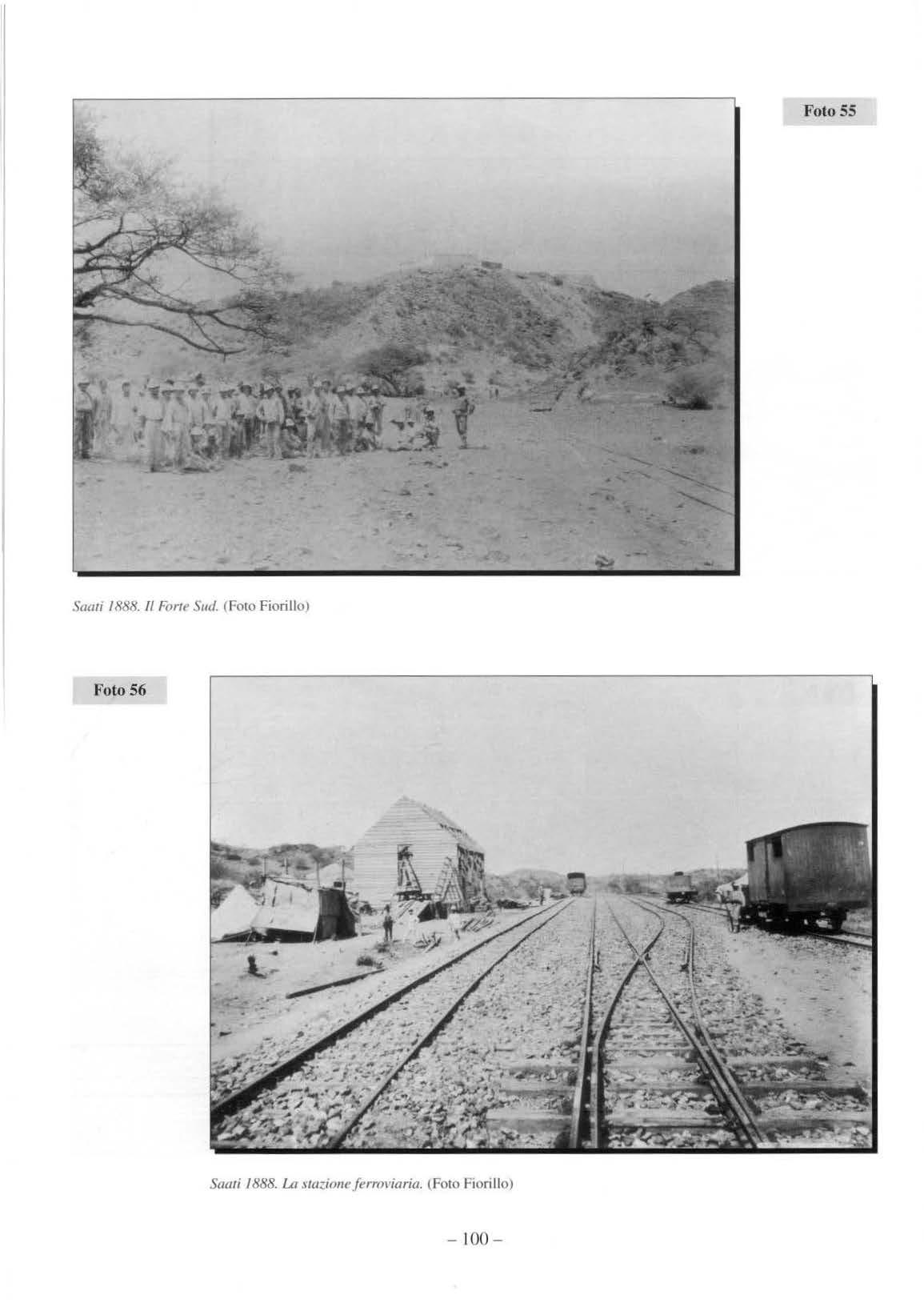
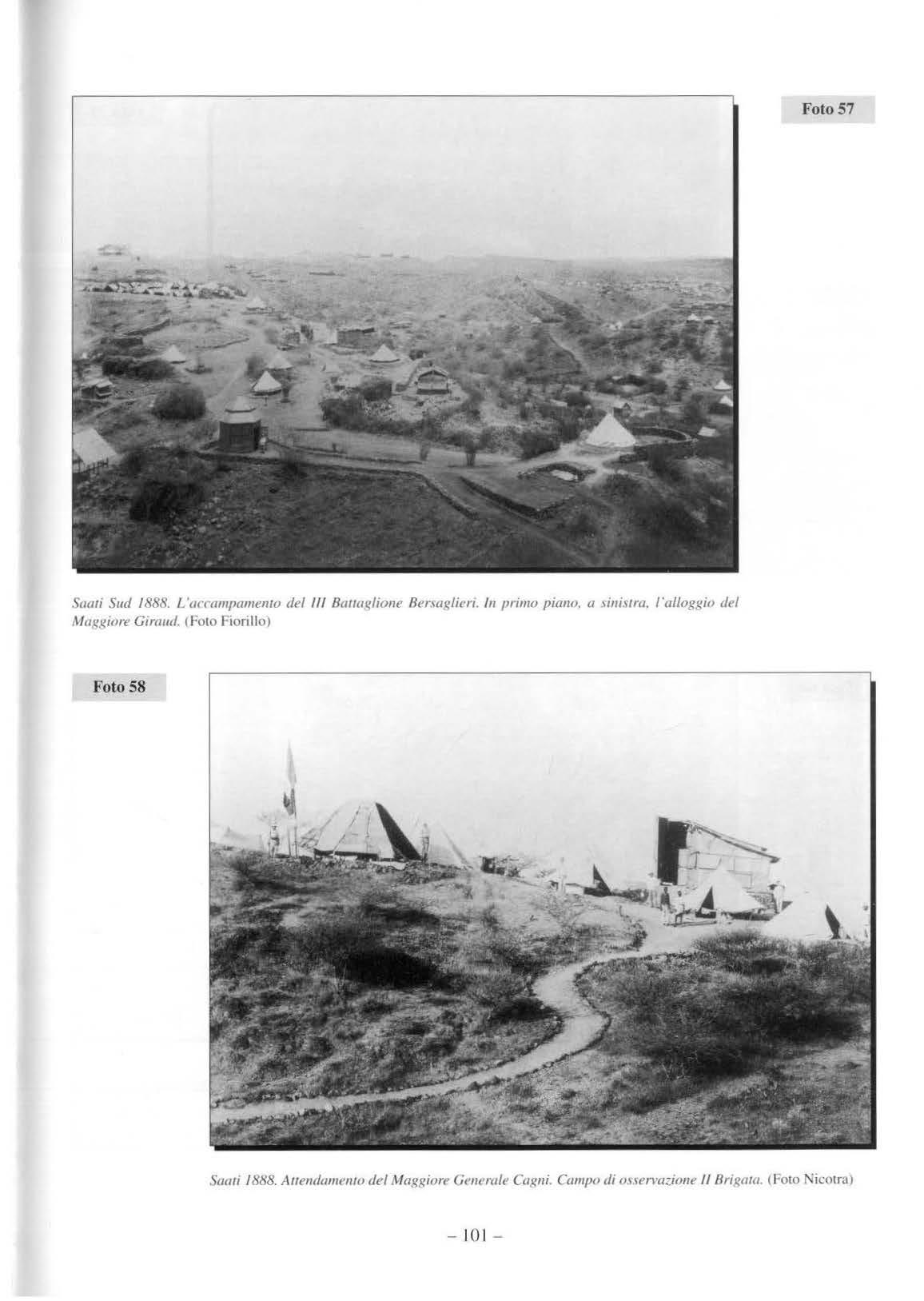 Saati Sud /888. L'acmmpamento del 111
In primo piano. a lillll/1'0. l'alloggio del Maggiore Girami. !roto Fiorillo>
Saati Sud /888. L'acmmpamento del 111
In primo piano. a lillll/1'0. l'alloggio del Maggiore Girami. !roto Fiorillo>
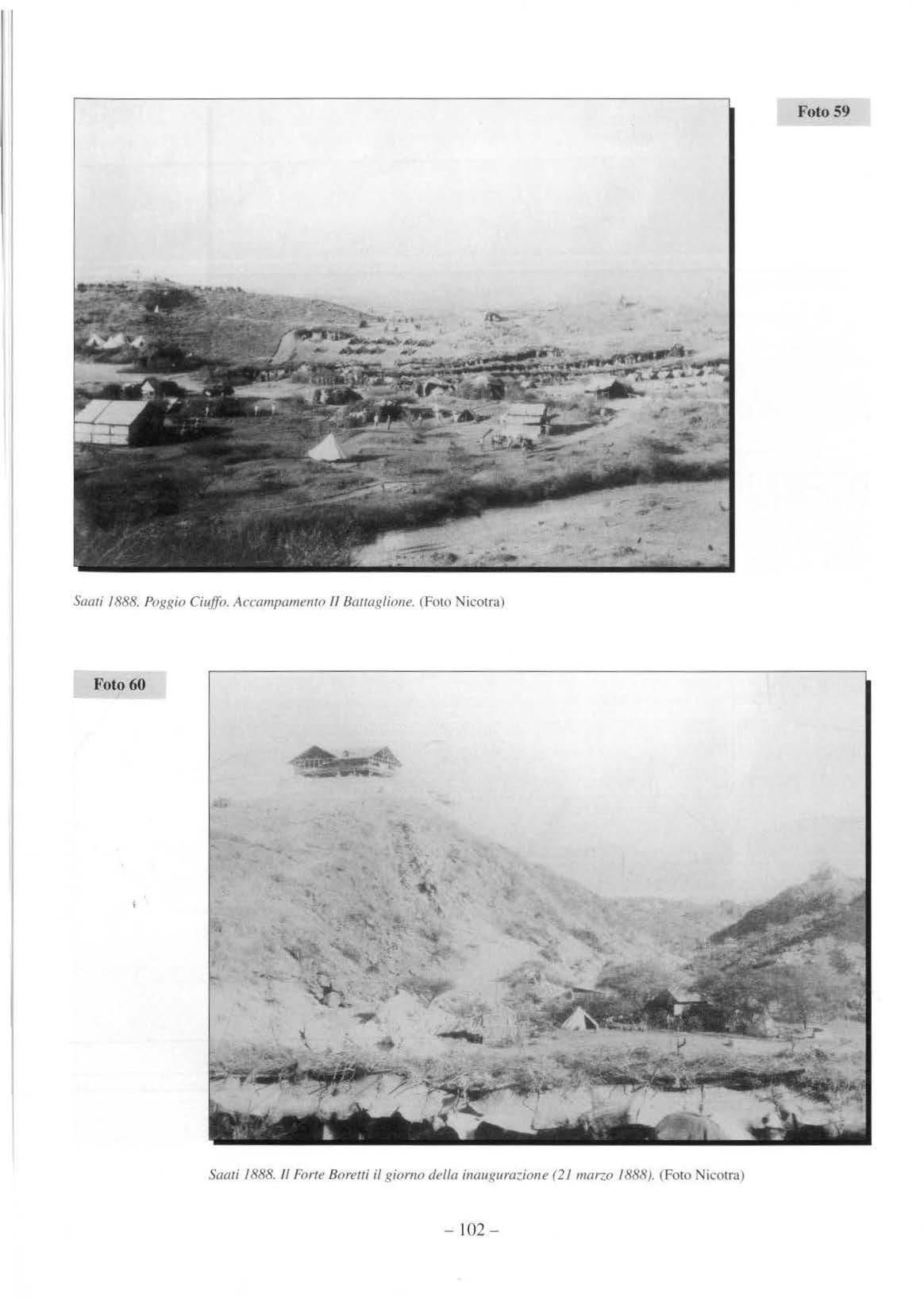
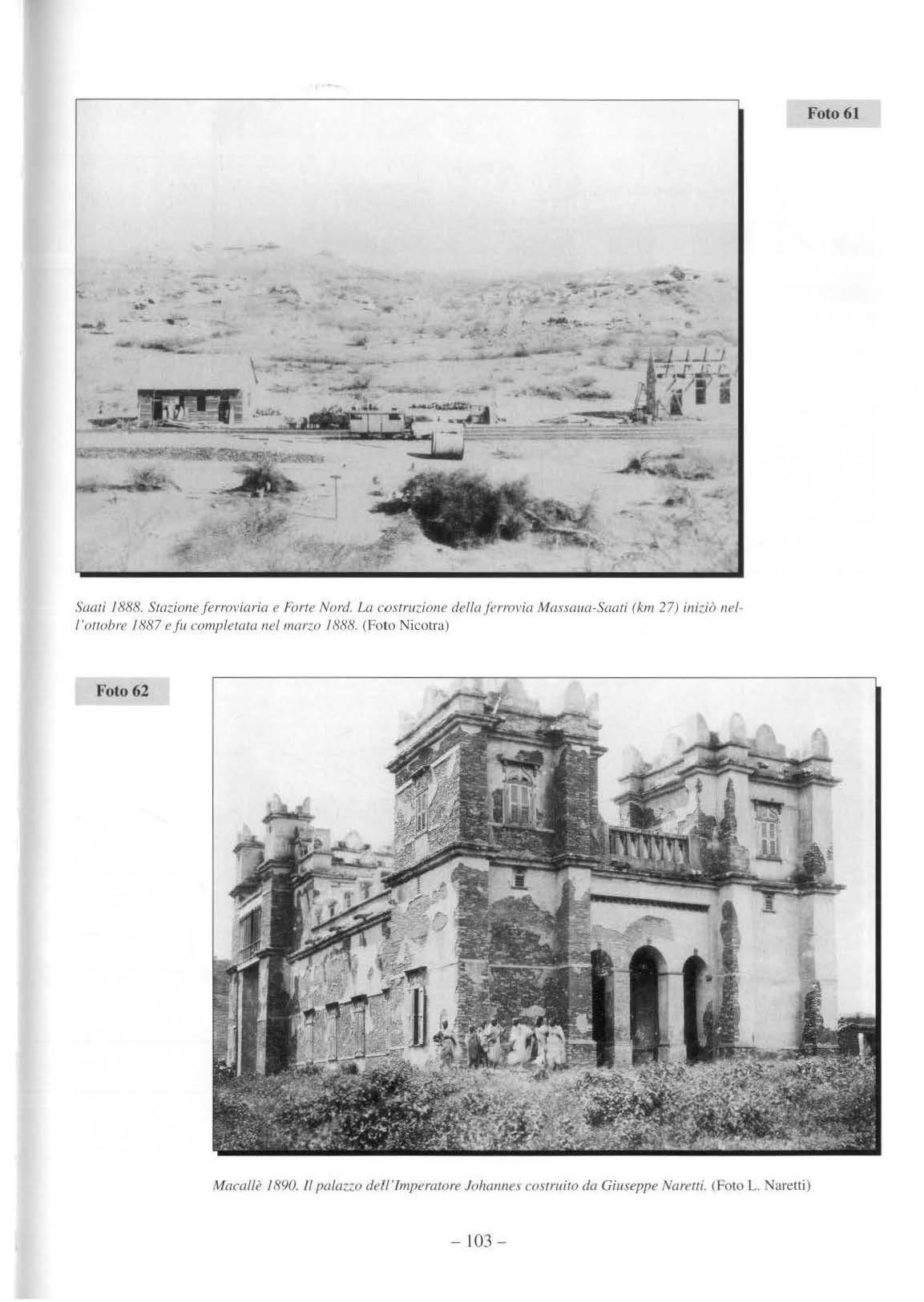 Saati 1888. ferrm·iaria e Forte Nord. La costrtdone della frnm •ia Mas 1·aua-Sami (km 27) ini:ià nell 'o11obre l 887 r fu completata ne/marzo /888. (Fo t o N icotra)
Saati 1888. ferrm·iaria e Forte Nord. La costrtdone della frnm •ia Mas 1·aua-Sami (km 27) ini:ià nell 'o11obre l 887 r fu completata ne/marzo /888. (Fo t o N icotra)
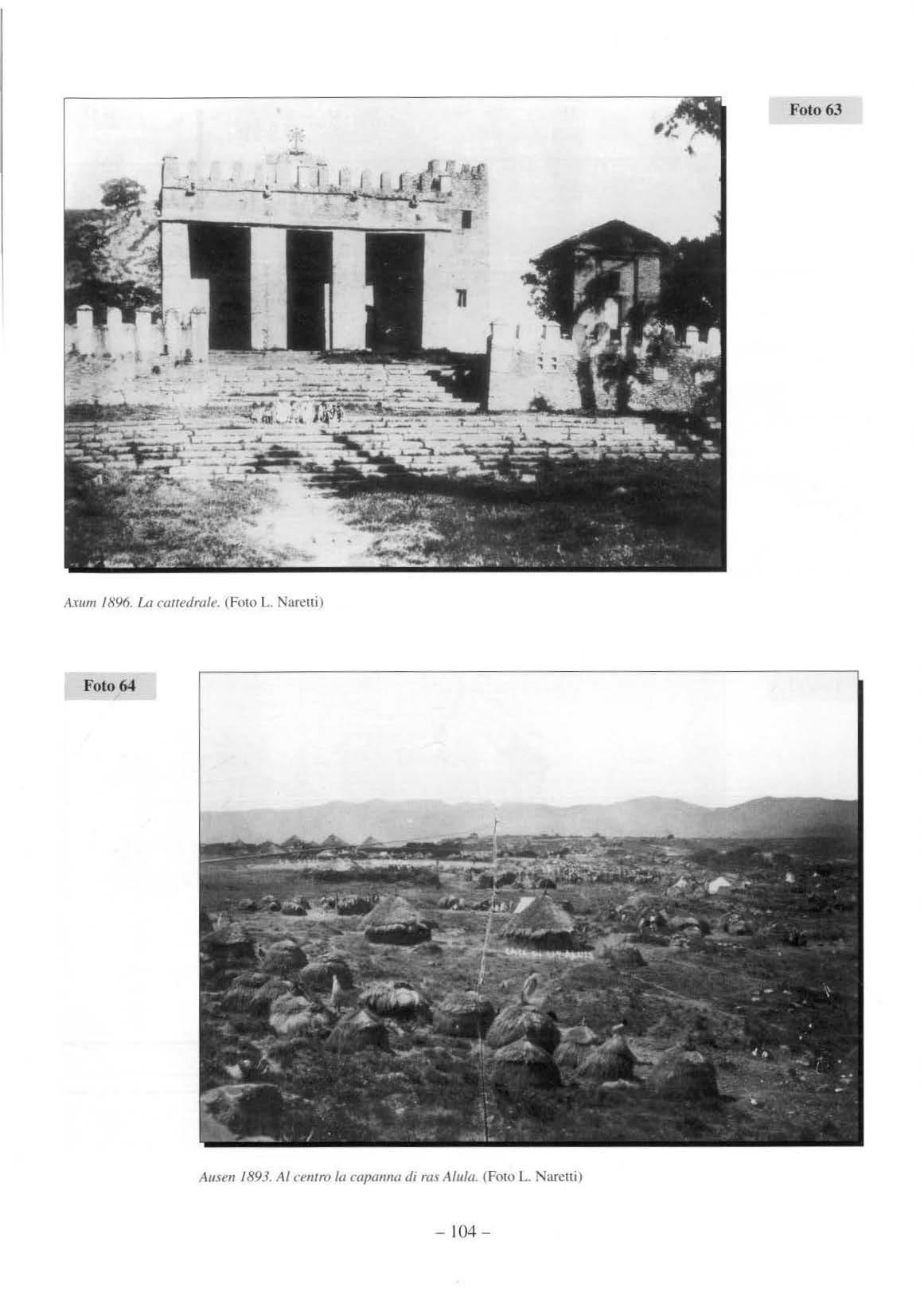

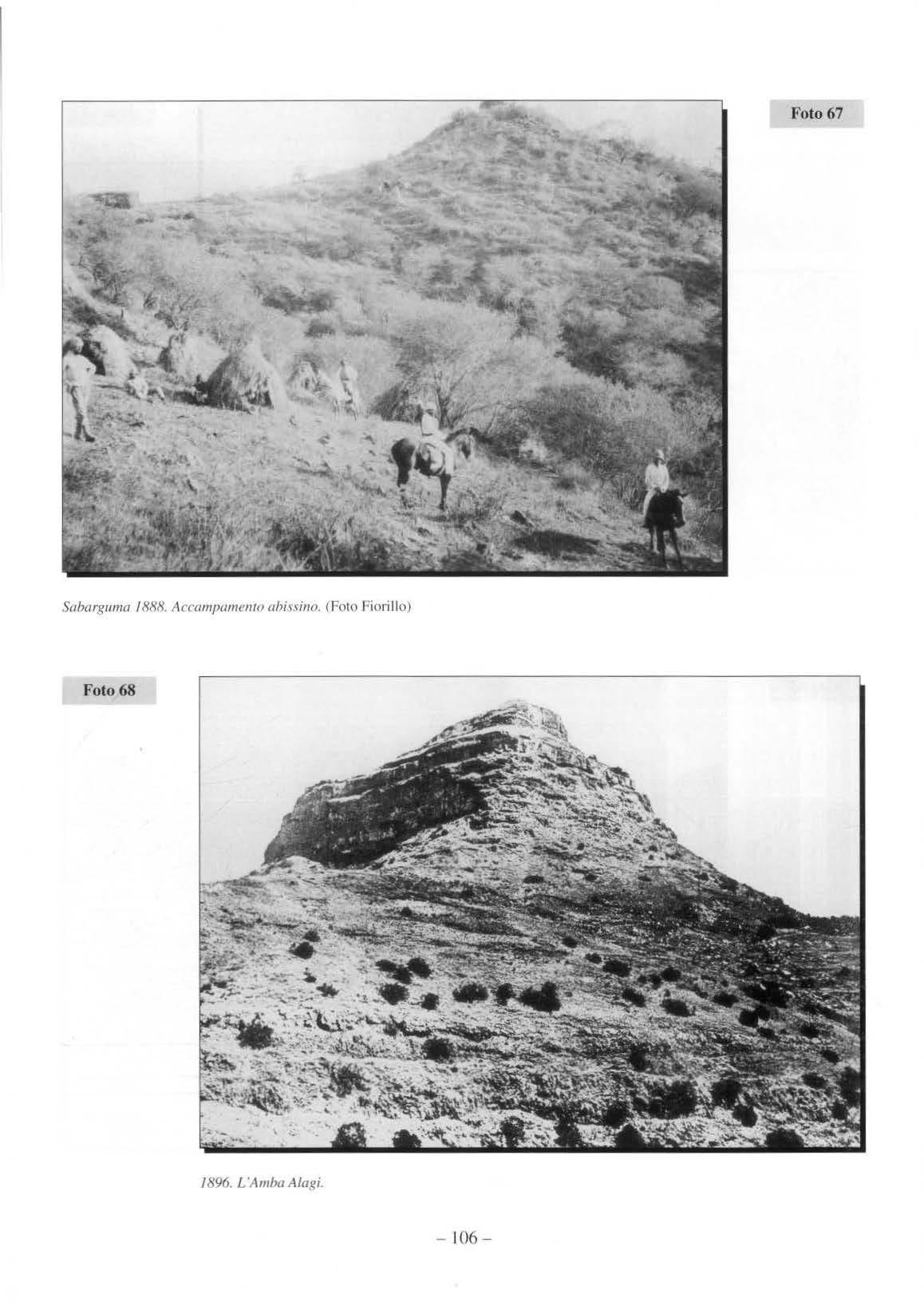
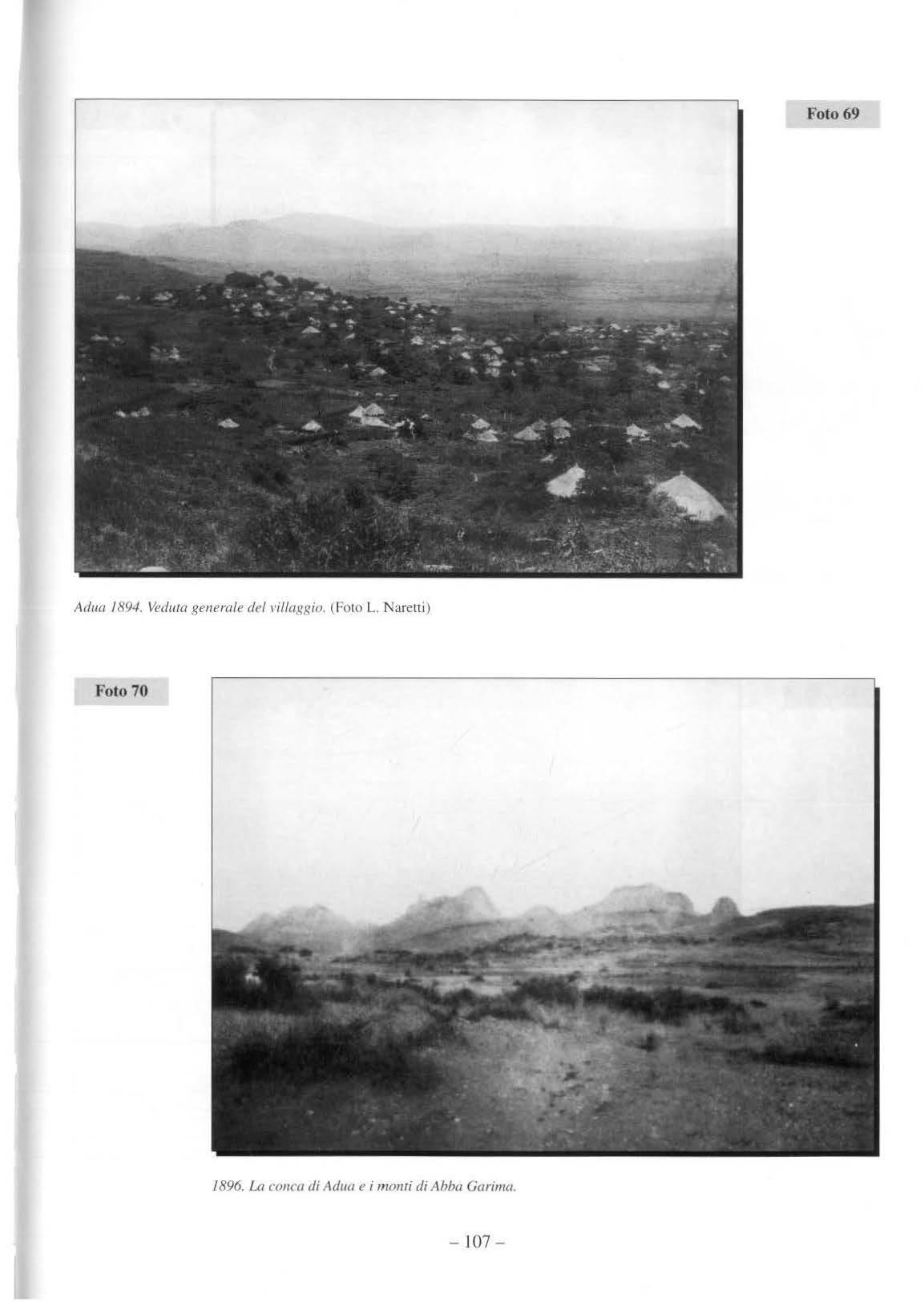
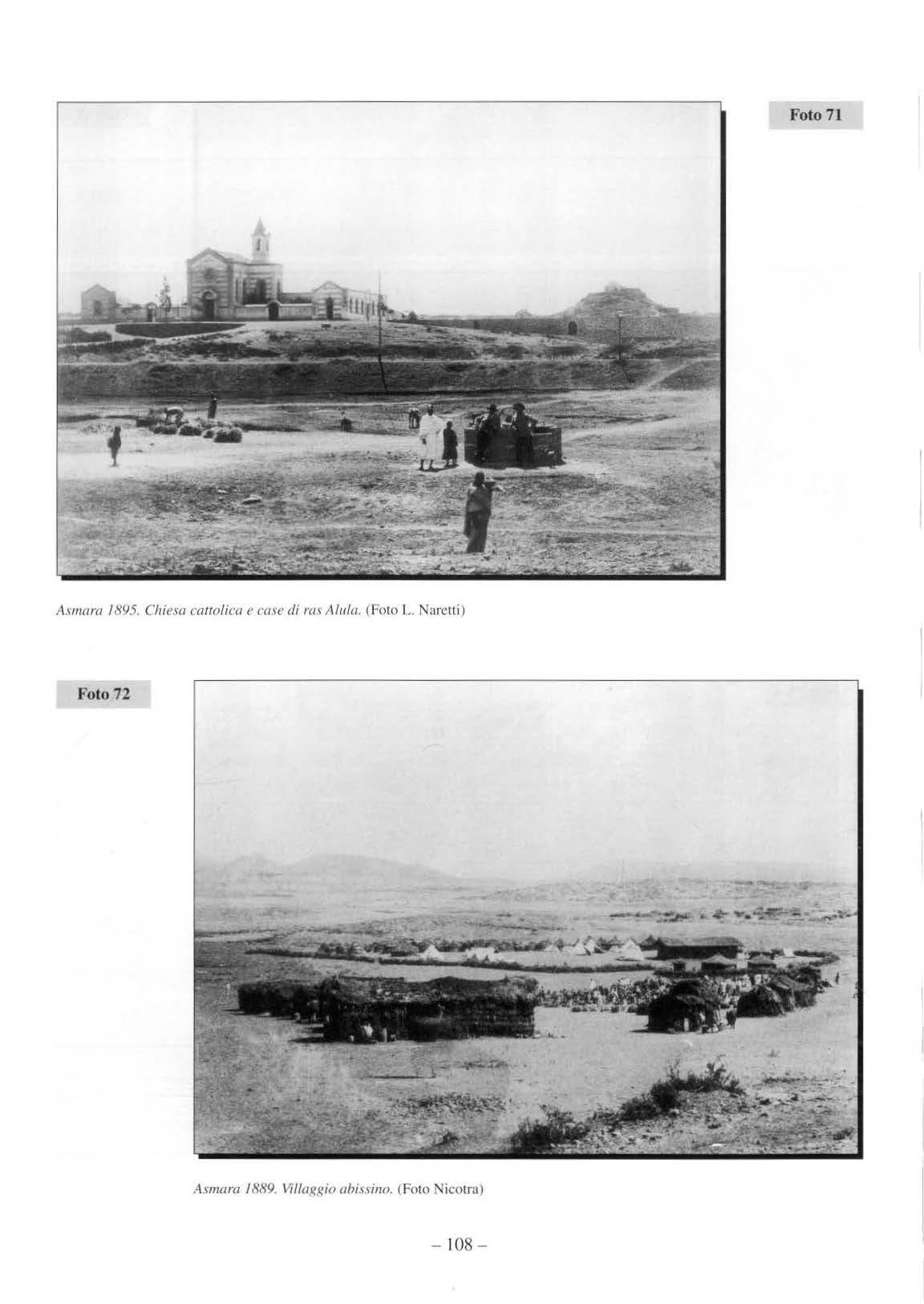
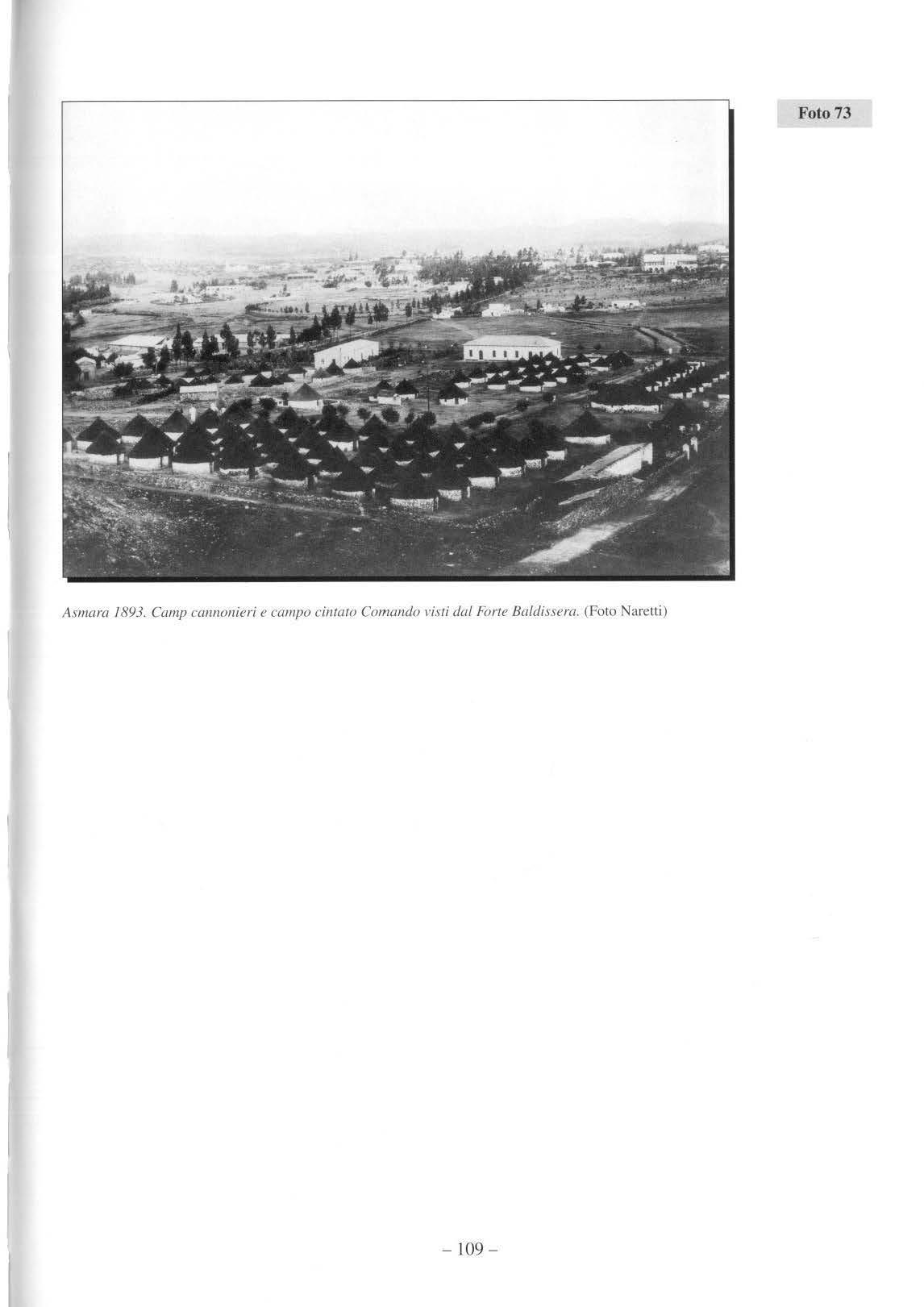

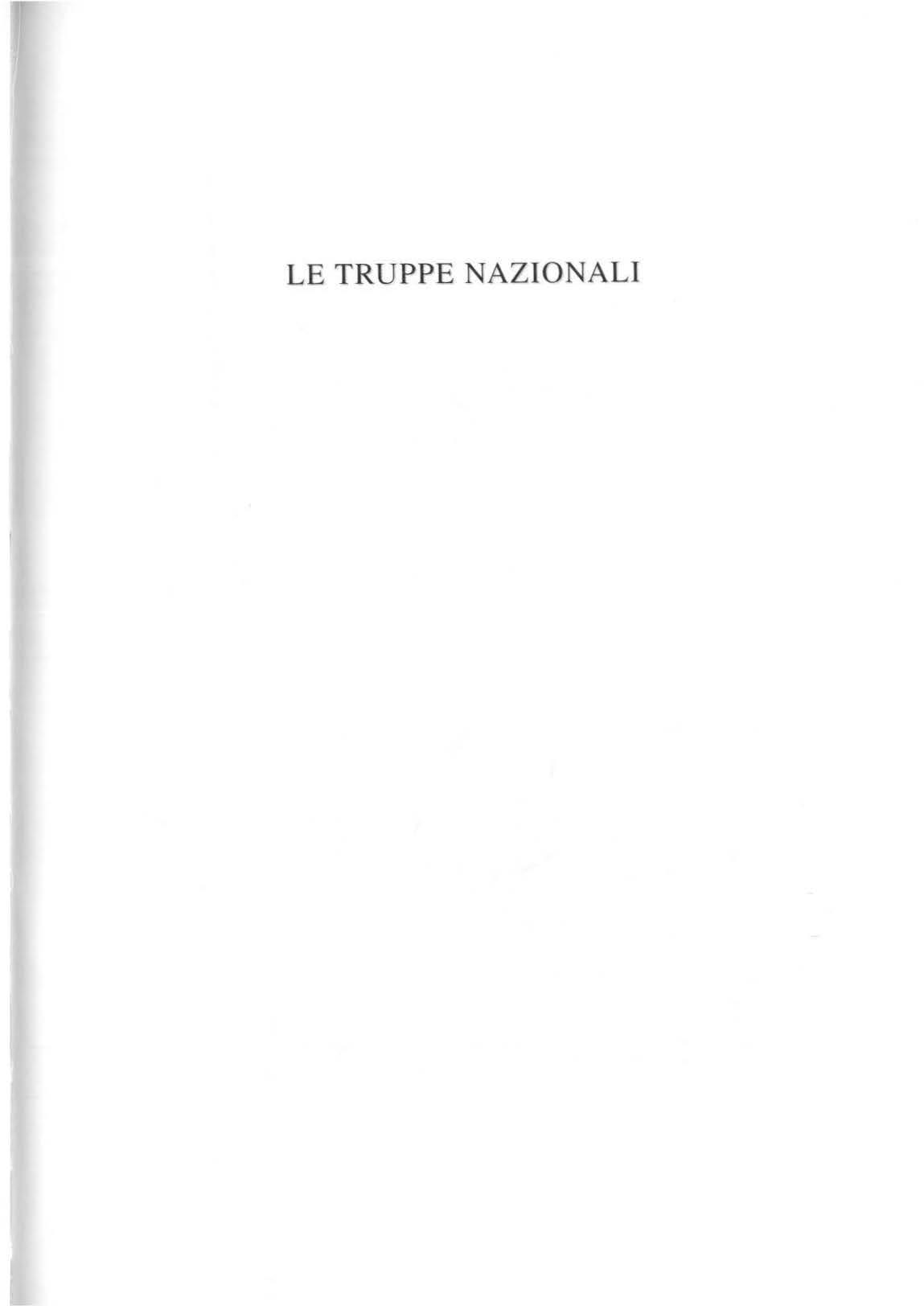
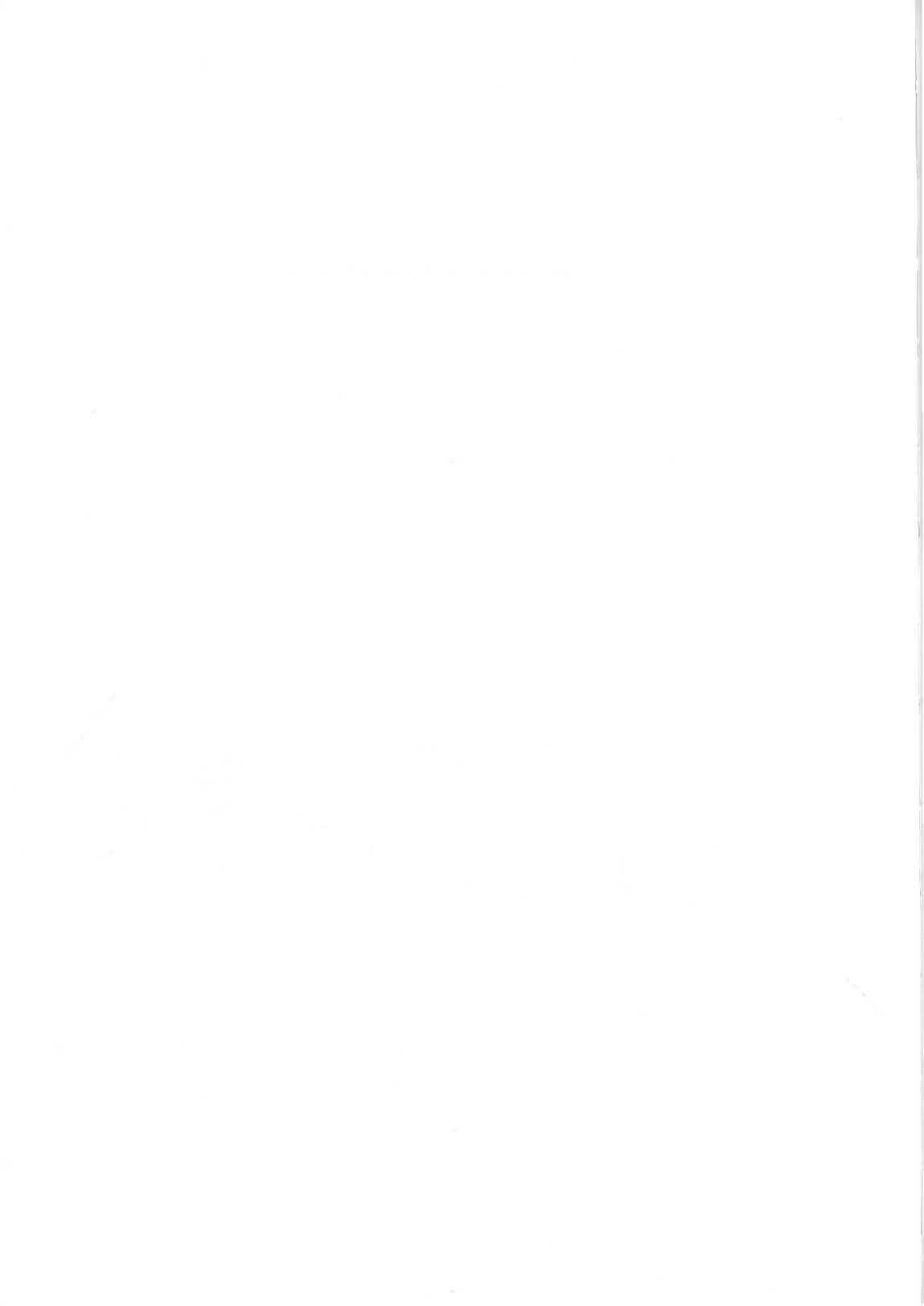
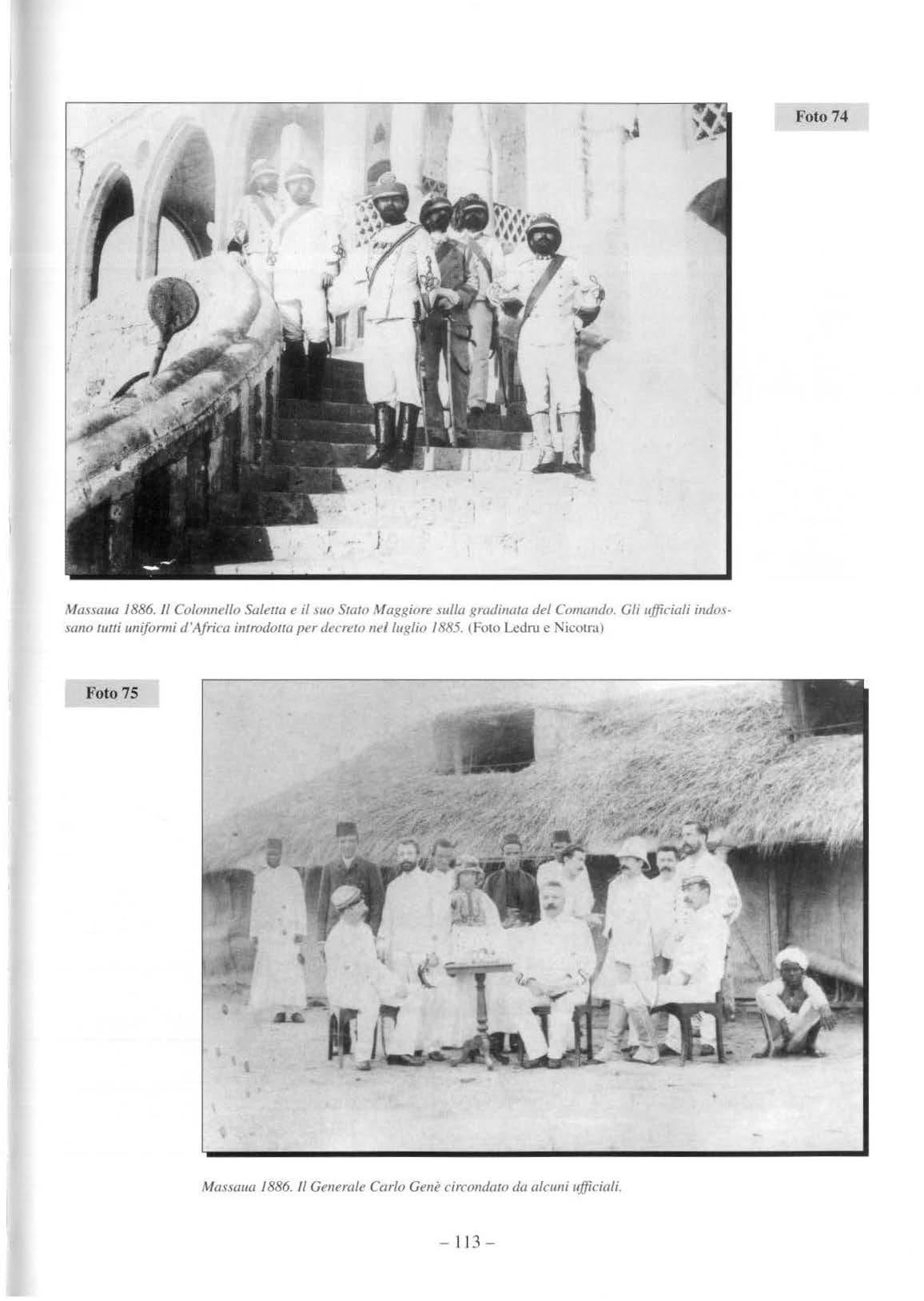 Massmta 1886. Il Colonnello Saletta e illuO Stato sulla gradinma del Comando. Gli ufficiali illliO.\· :.ano tutti uniformi d'Africa introdotta per decreto nel luglio 1885. (Foto Ledru e Nicotra)
Foto 75
Massmta 1886. Il Colonnello Saletta e illuO Stato sulla gradinma del Comando. Gli ufficiali illliO.\· :.ano tutti uniformi d'Africa introdotta per decreto nel luglio 1885. (Foto Ledru e Nicotra)
Foto 75
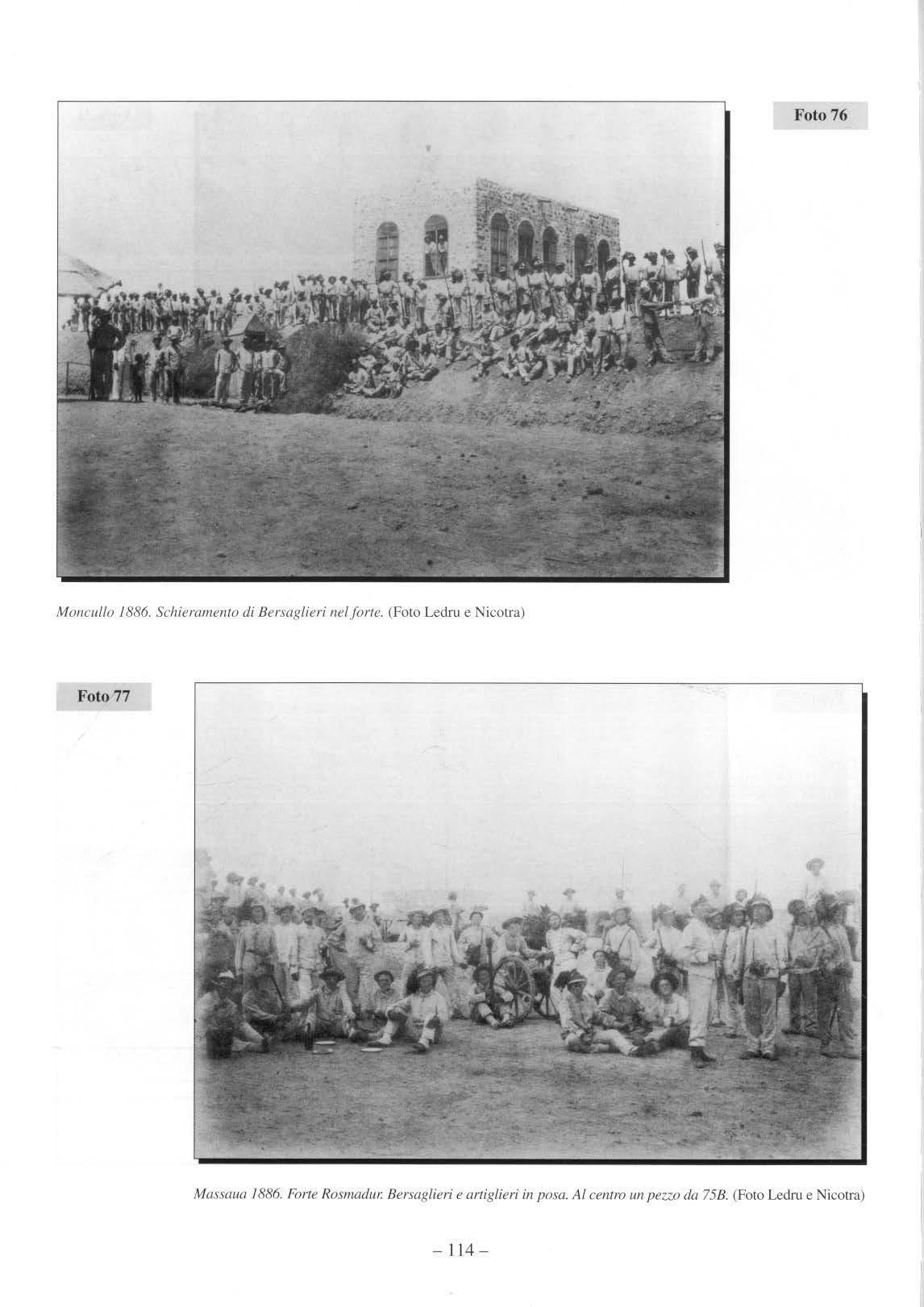
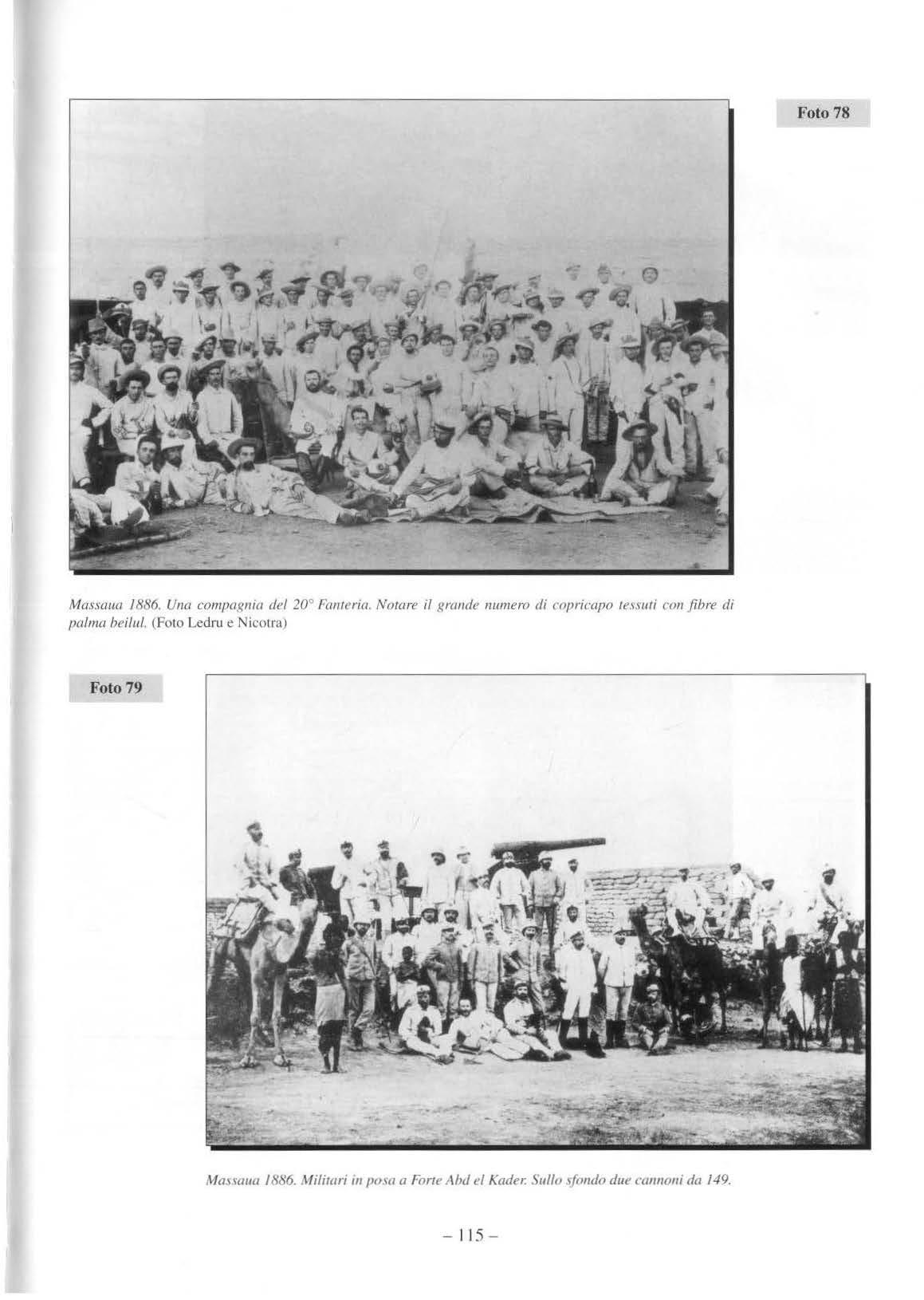 Massaua 1886. Una compagnia del 20° Fanreria. Notare il f{rllfl(/e numero di copricapo re.\suri ton fibre di palma lJeilul. (Fo to Lcdru e Nicotra)
Foto 79
Massaua 1886. Una compagnia del 20° Fanreria. Notare il f{rllfl(/e numero di copricapo re.\suri ton fibre di palma lJeilul. (Fo to Lcdru e Nicotra)
Foto 79
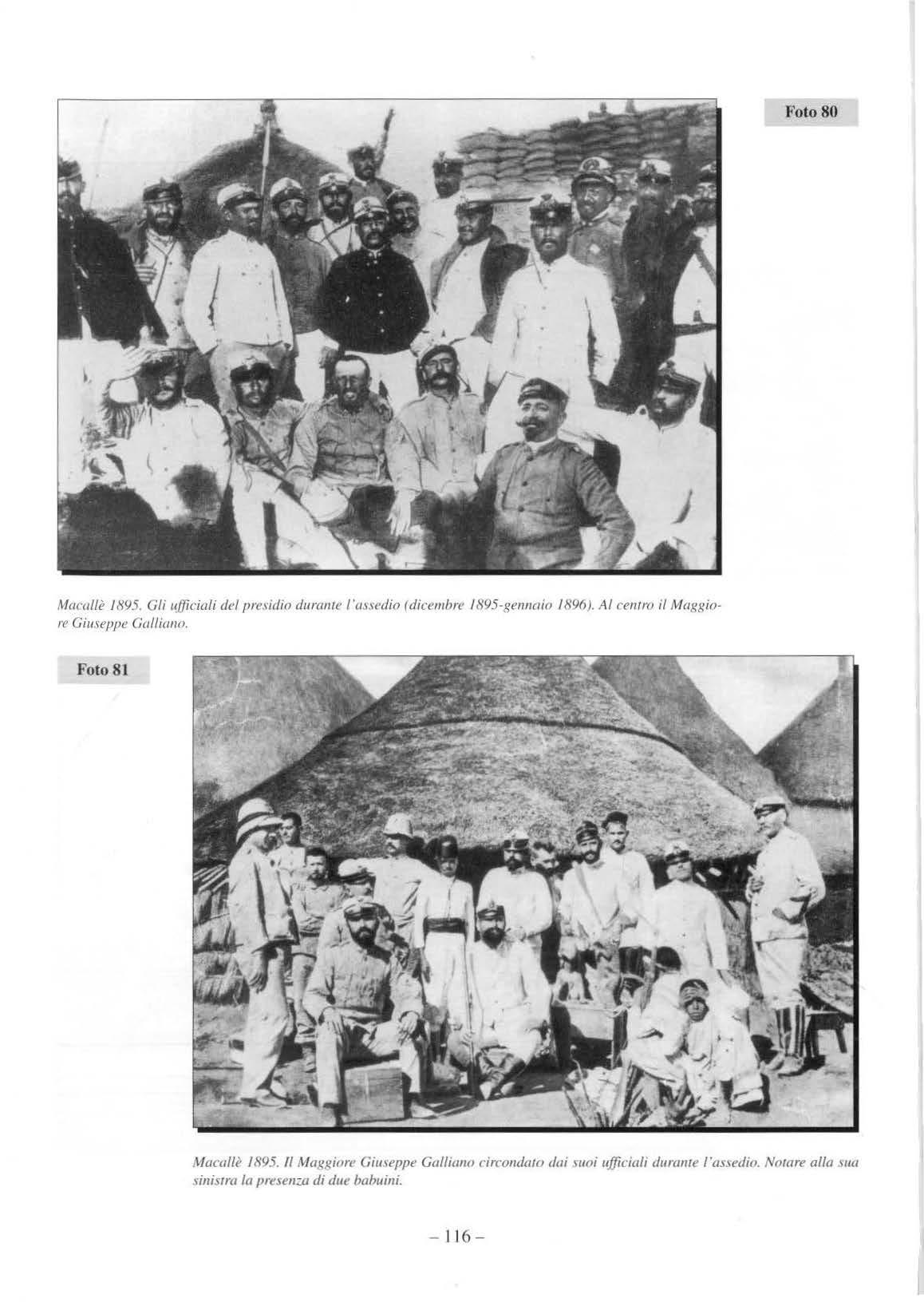 Macallè 1895 Gli t(ffrciali del presidio durante (dicembre /895-gennaio 1896). Al rentro il Maggiore Giuseppe Gttlliono.
Macallè 1895 Gli t(ffrciali del presidio durante (dicembre /895-gennaio 1896). Al rentro il Maggiore Giuseppe Gttlliono.
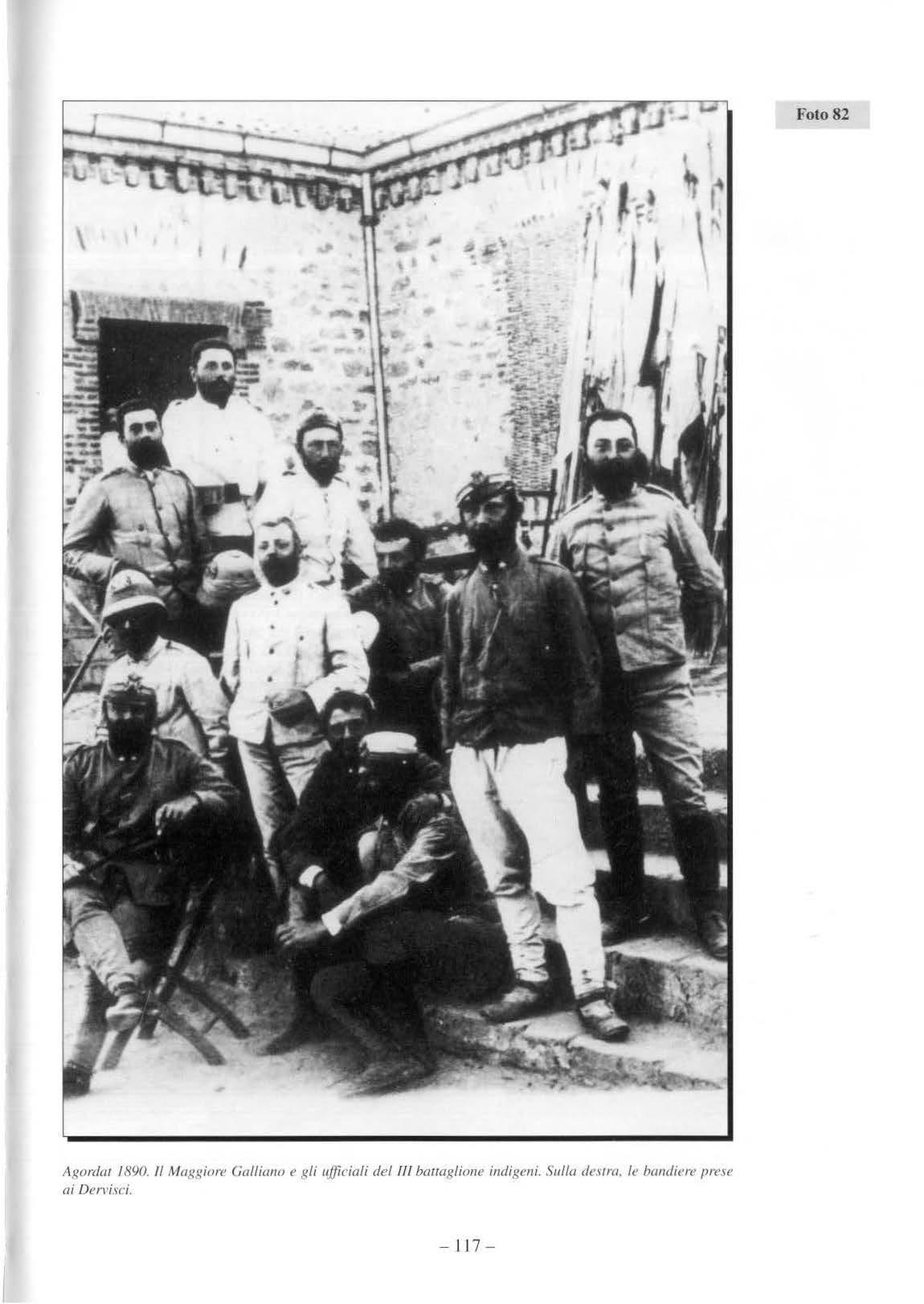
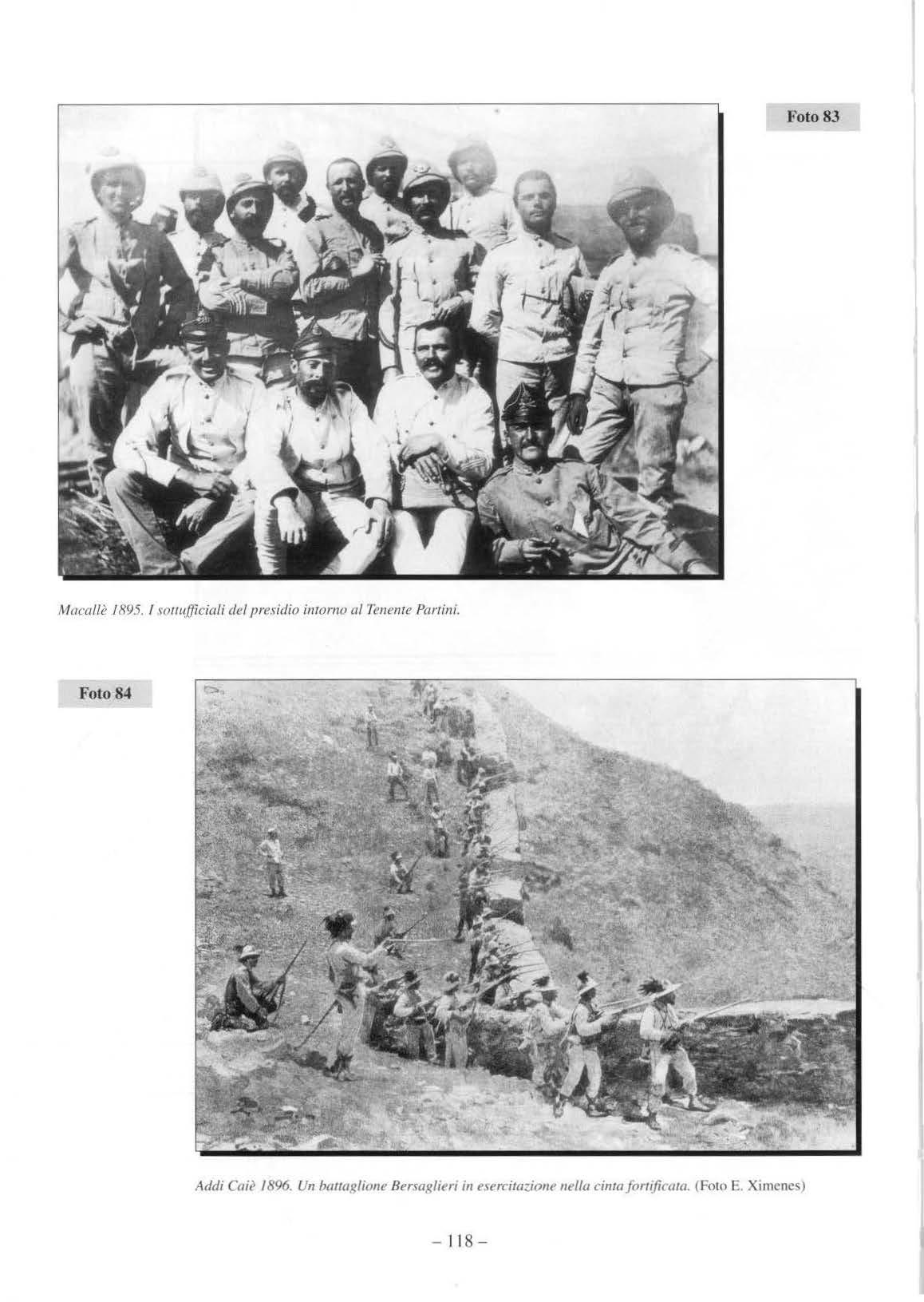

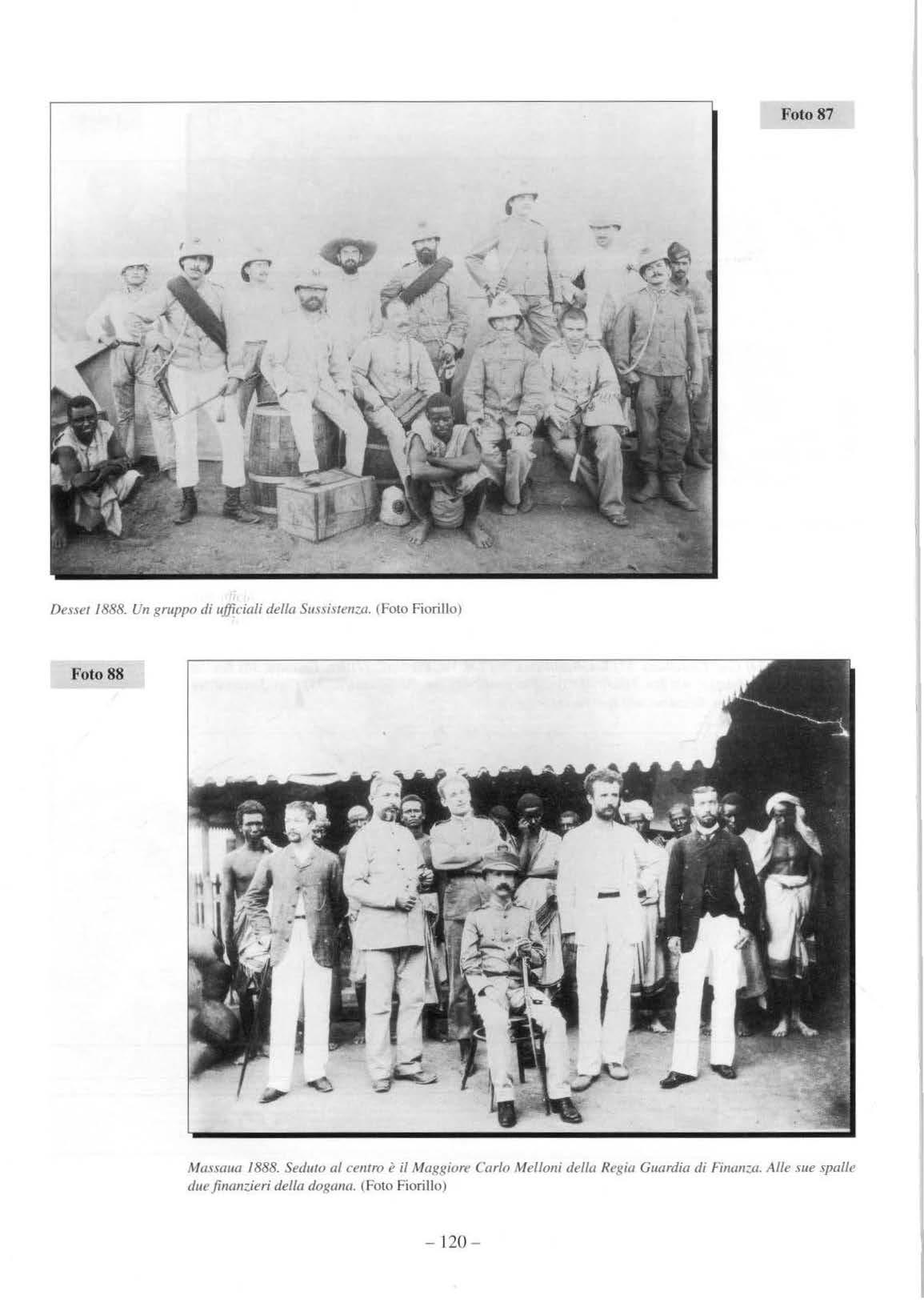
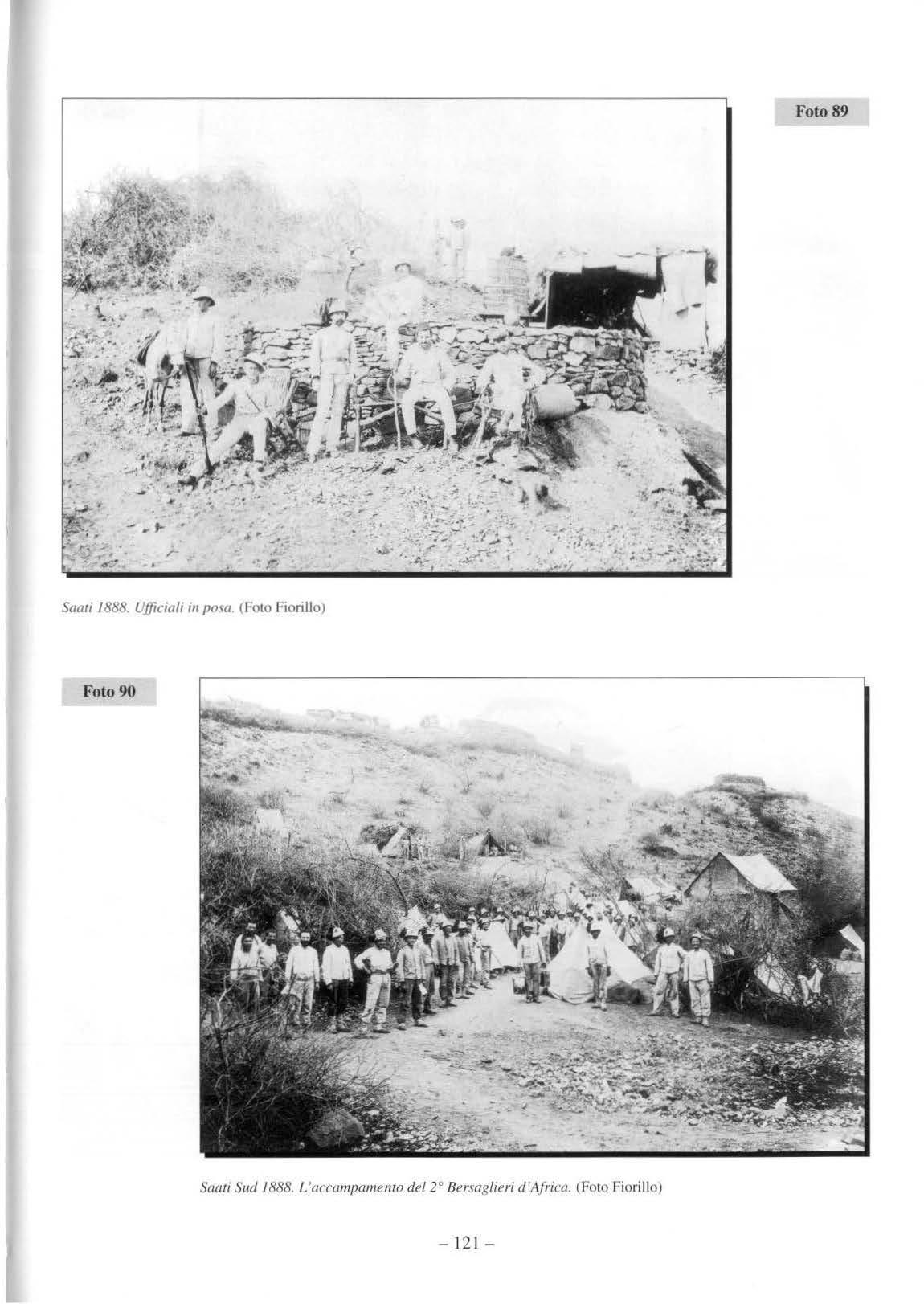
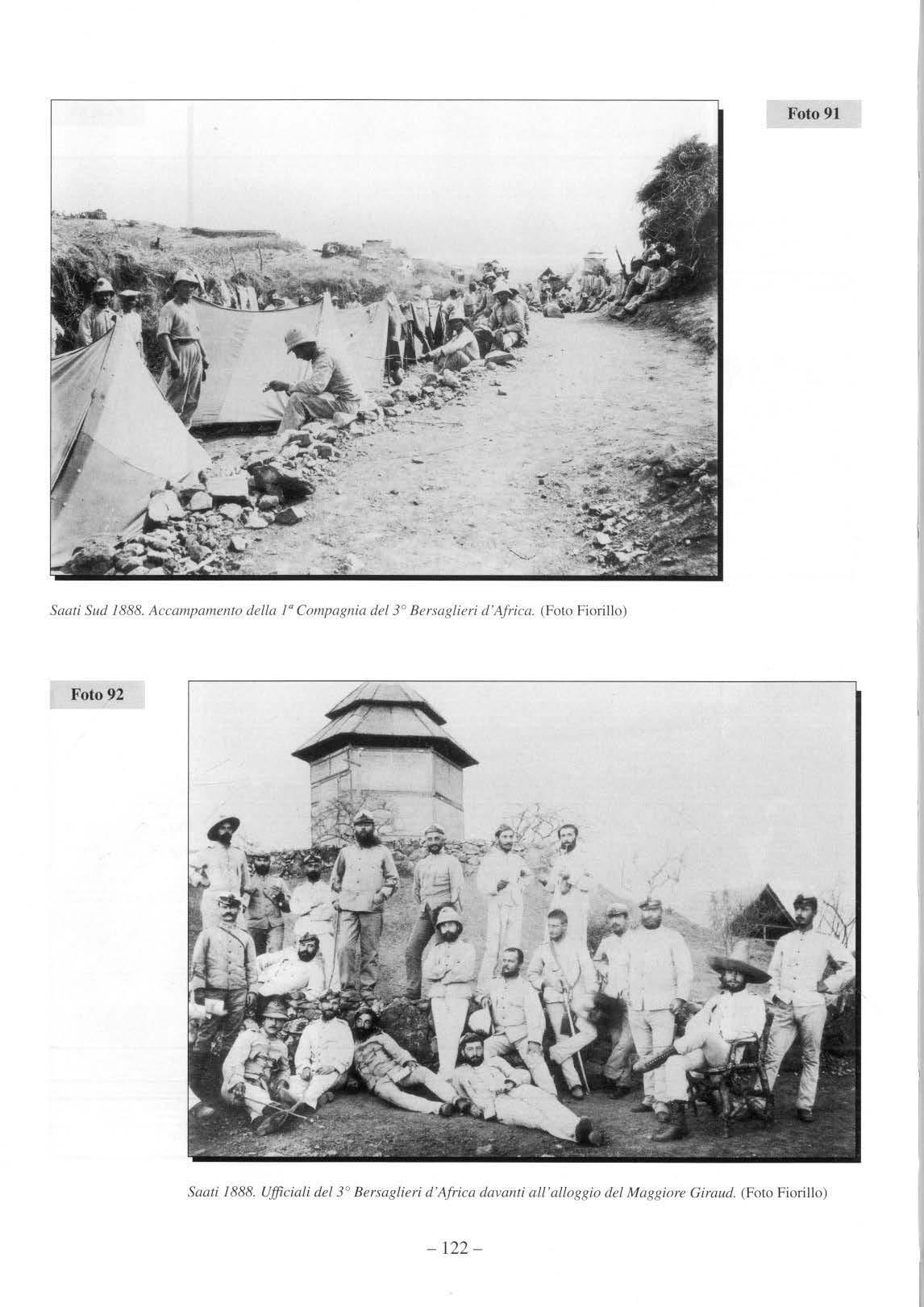
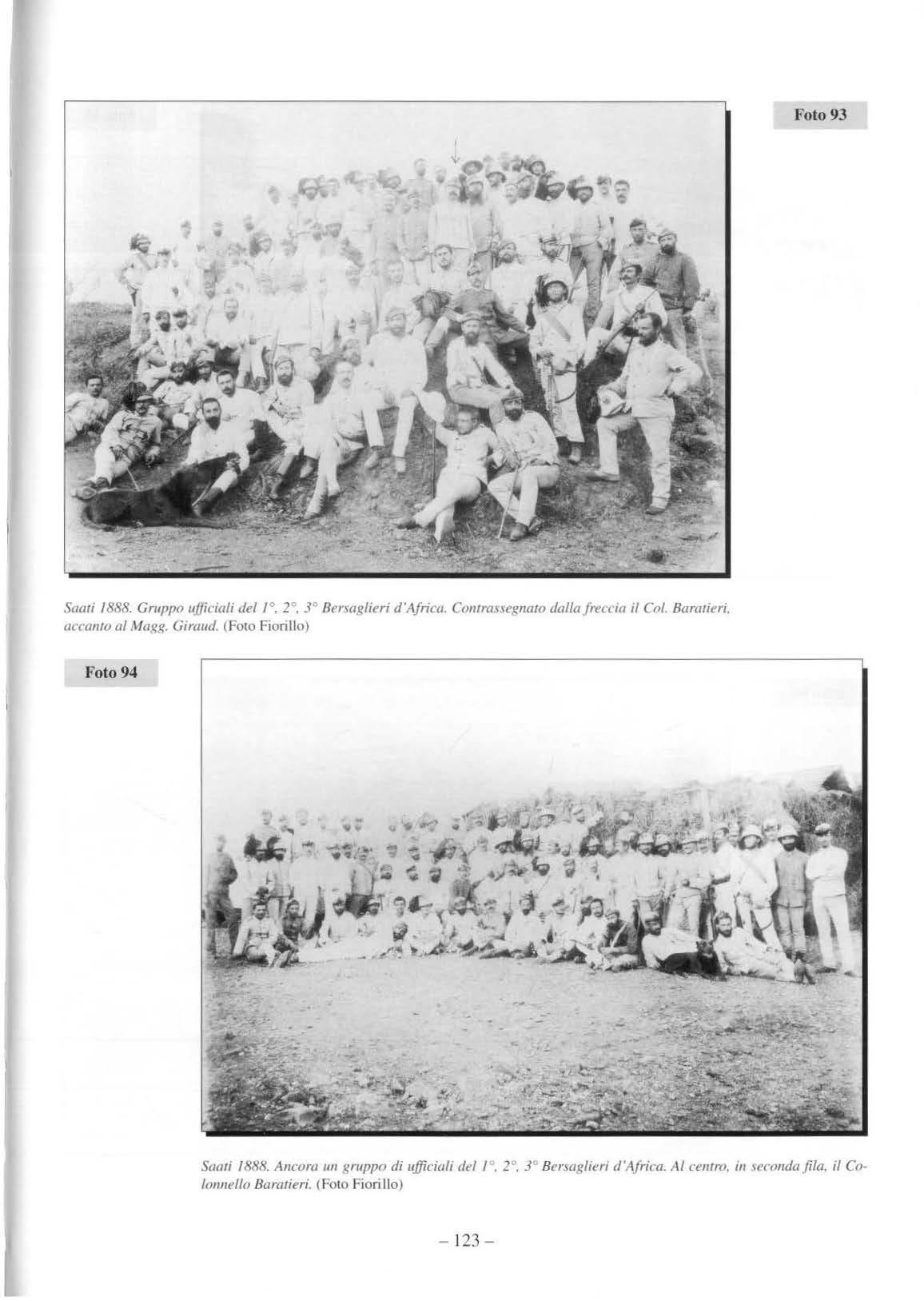 Saatì 1888. Gruppo ufficiali del ]0 zc . 3 Benaglieri d'Africa. Comra.1 segnato dalla .freccia il Col. Baratieri. accanto al Magg. Giraud. ( Foto Fiori !lo)
Saatì 1888. Gruppo ufficiali del ]0 zc . 3 Benaglieri d'Africa. Comra.1 segnato dalla .freccia il Col. Baratieri. accanto al Magg. Giraud. ( Foto Fiori !lo)
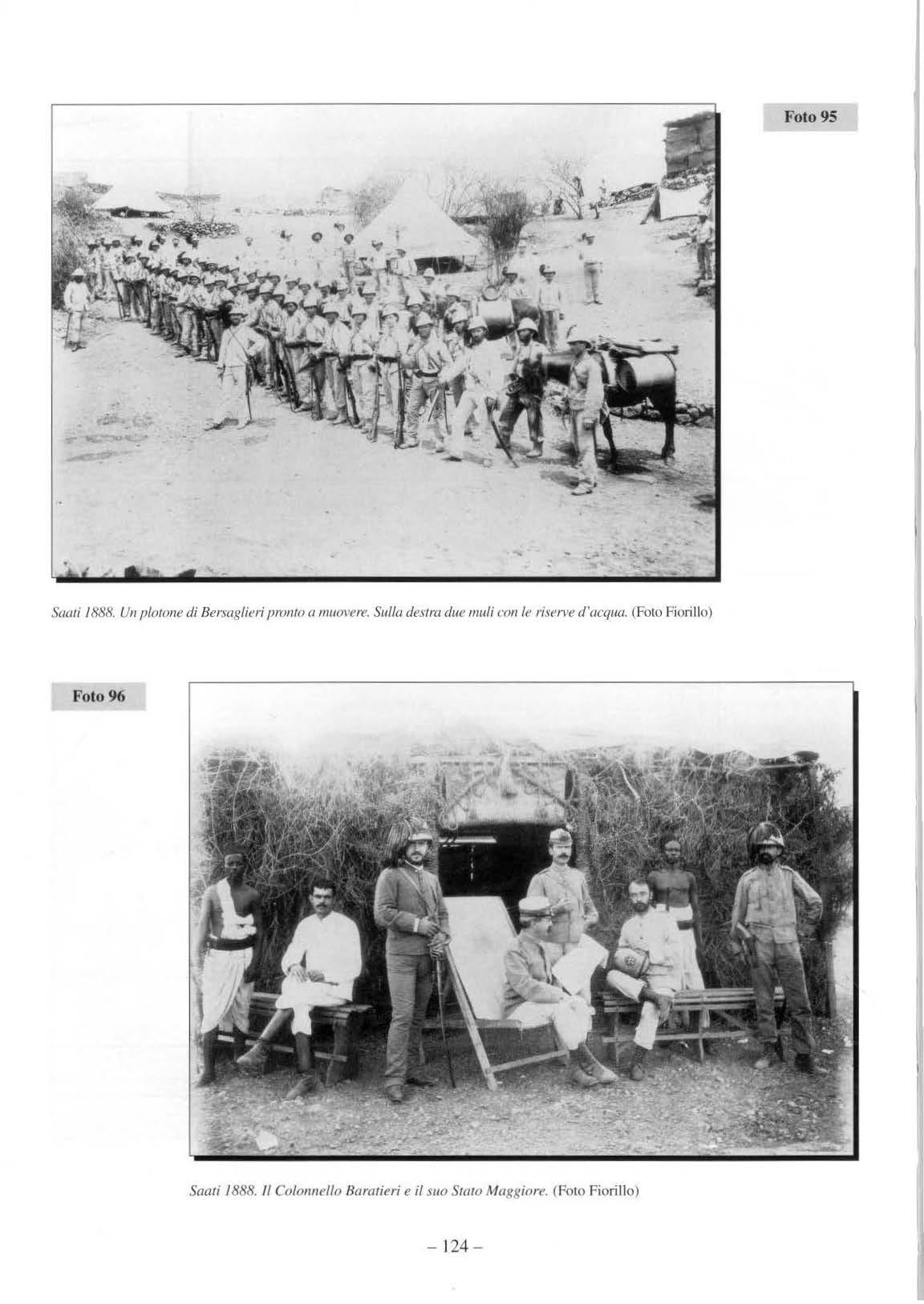
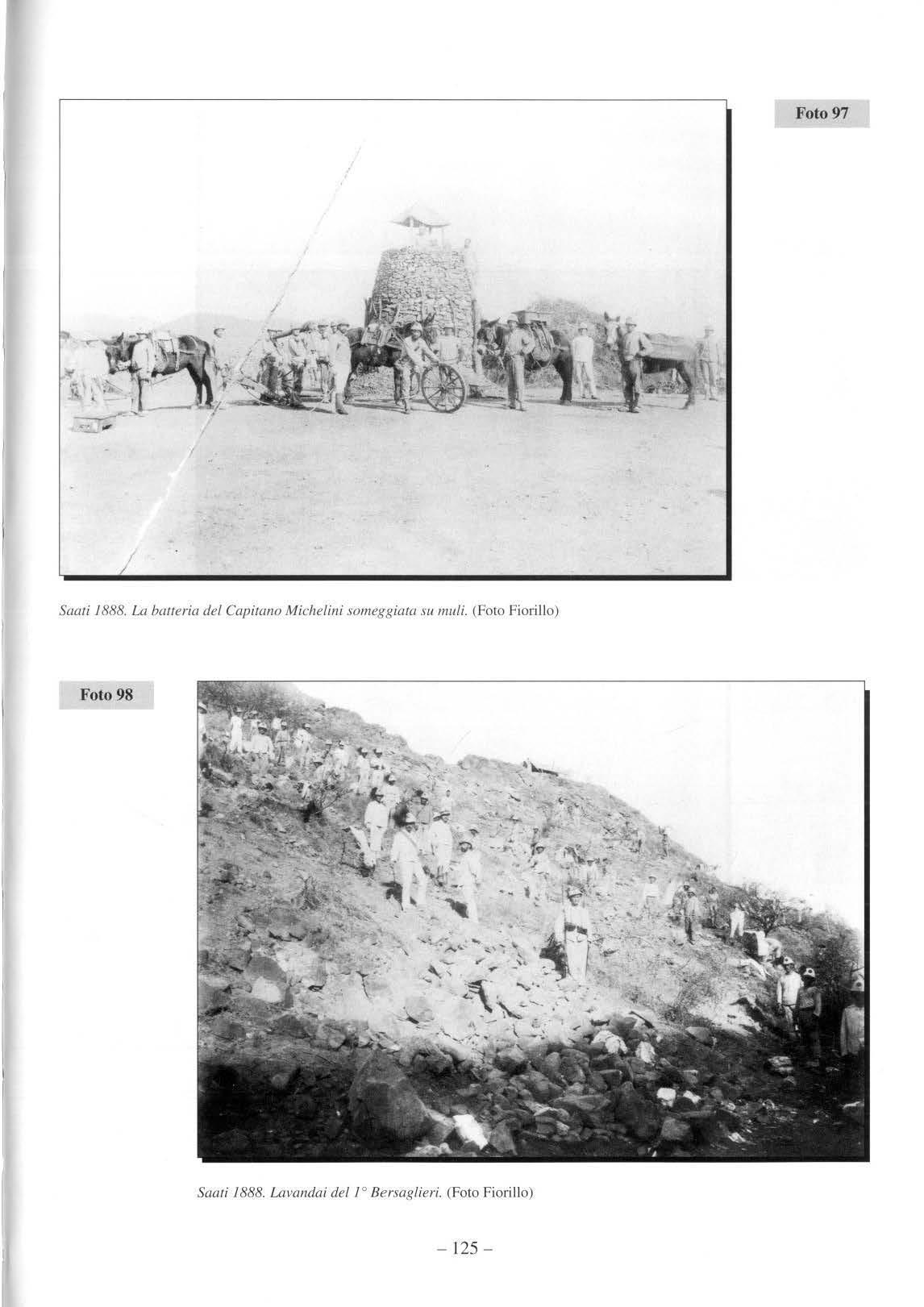

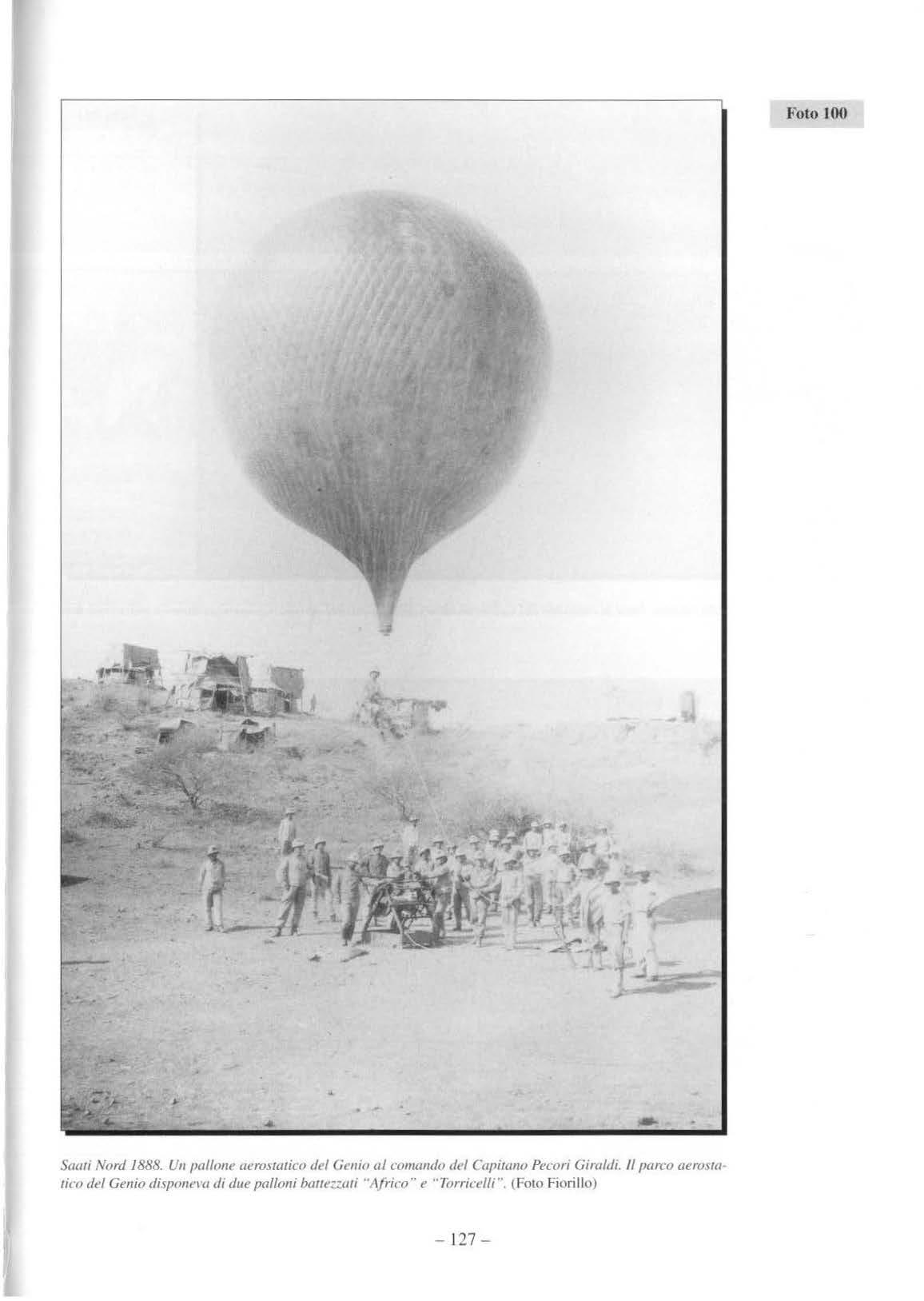
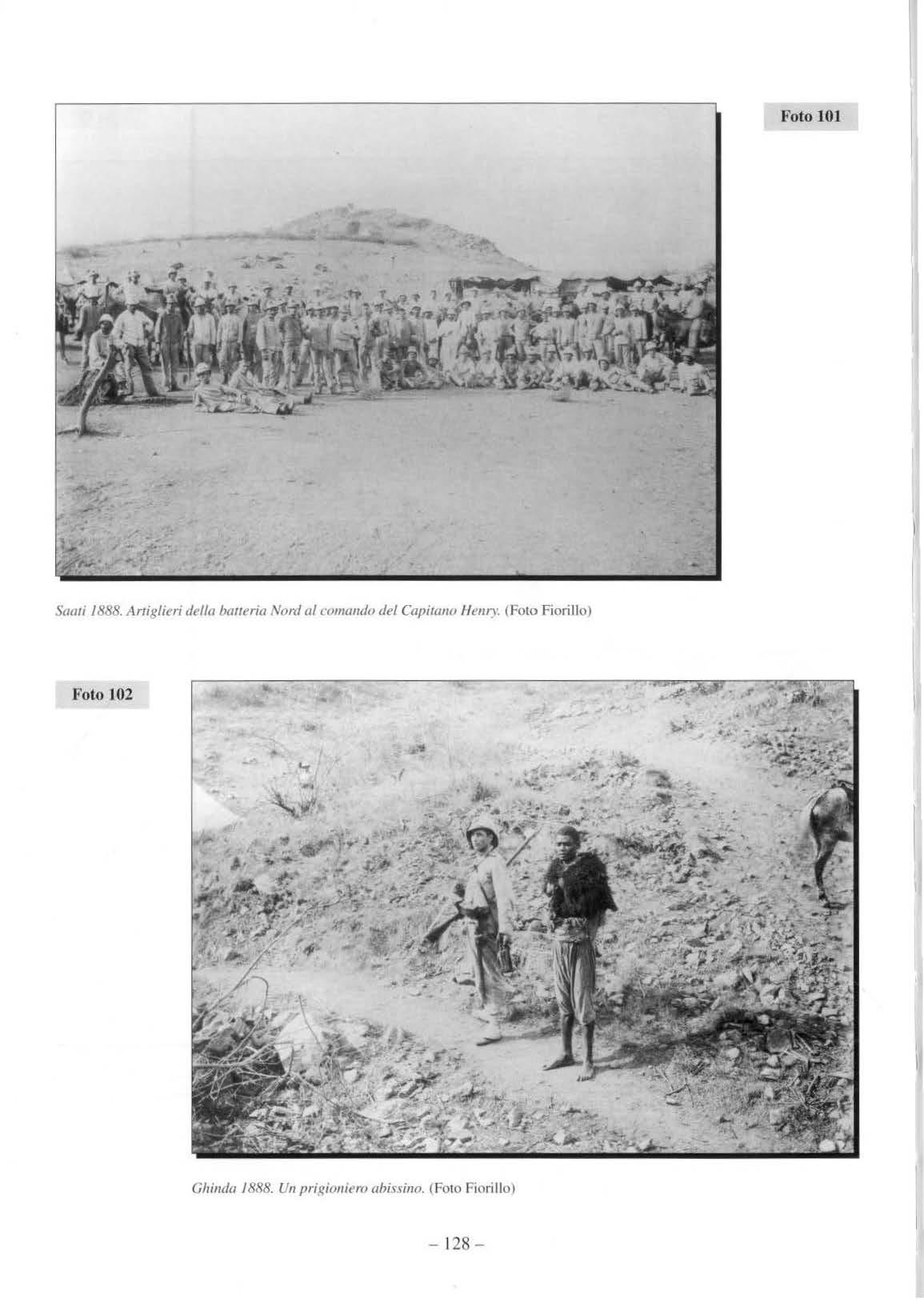
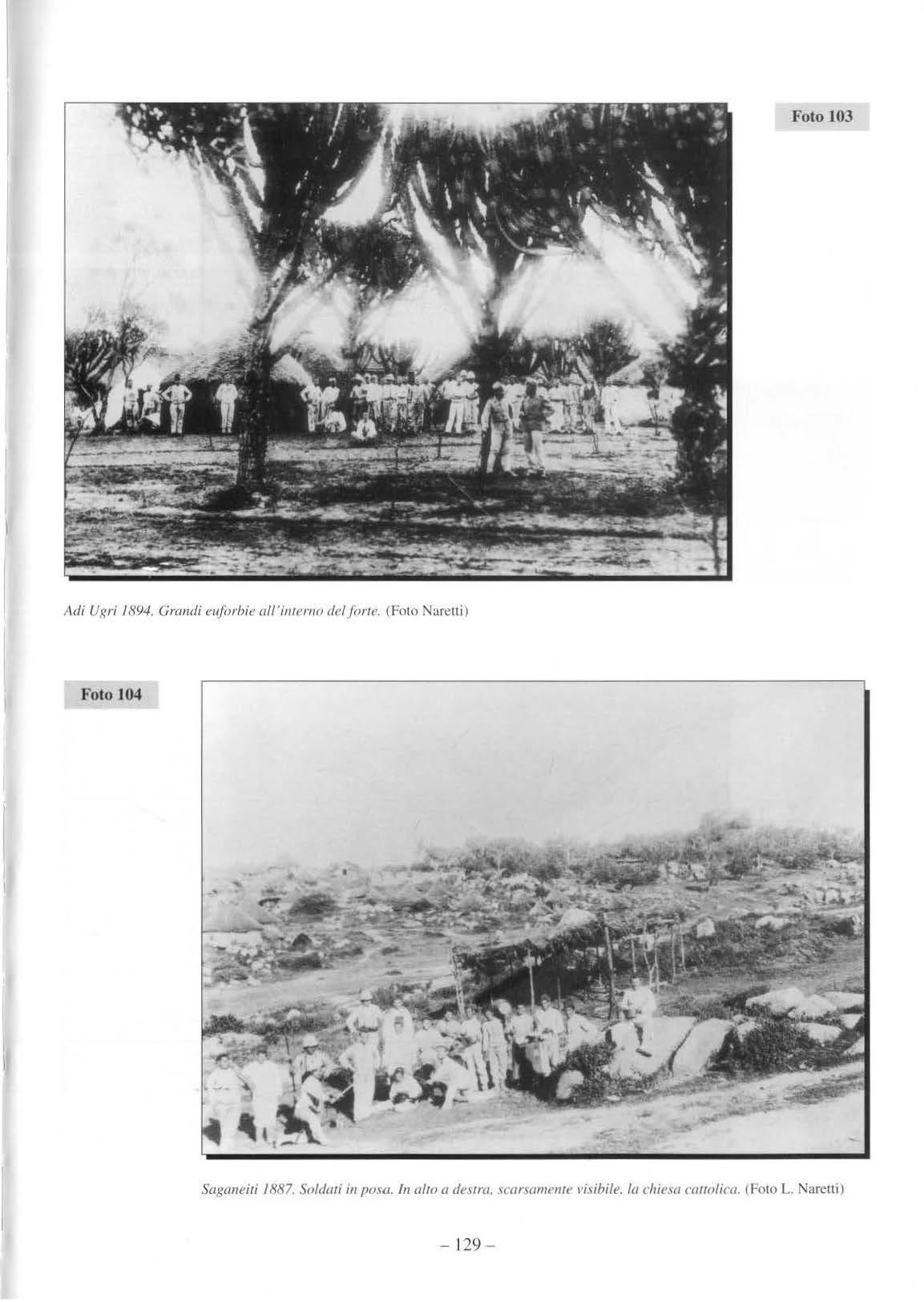

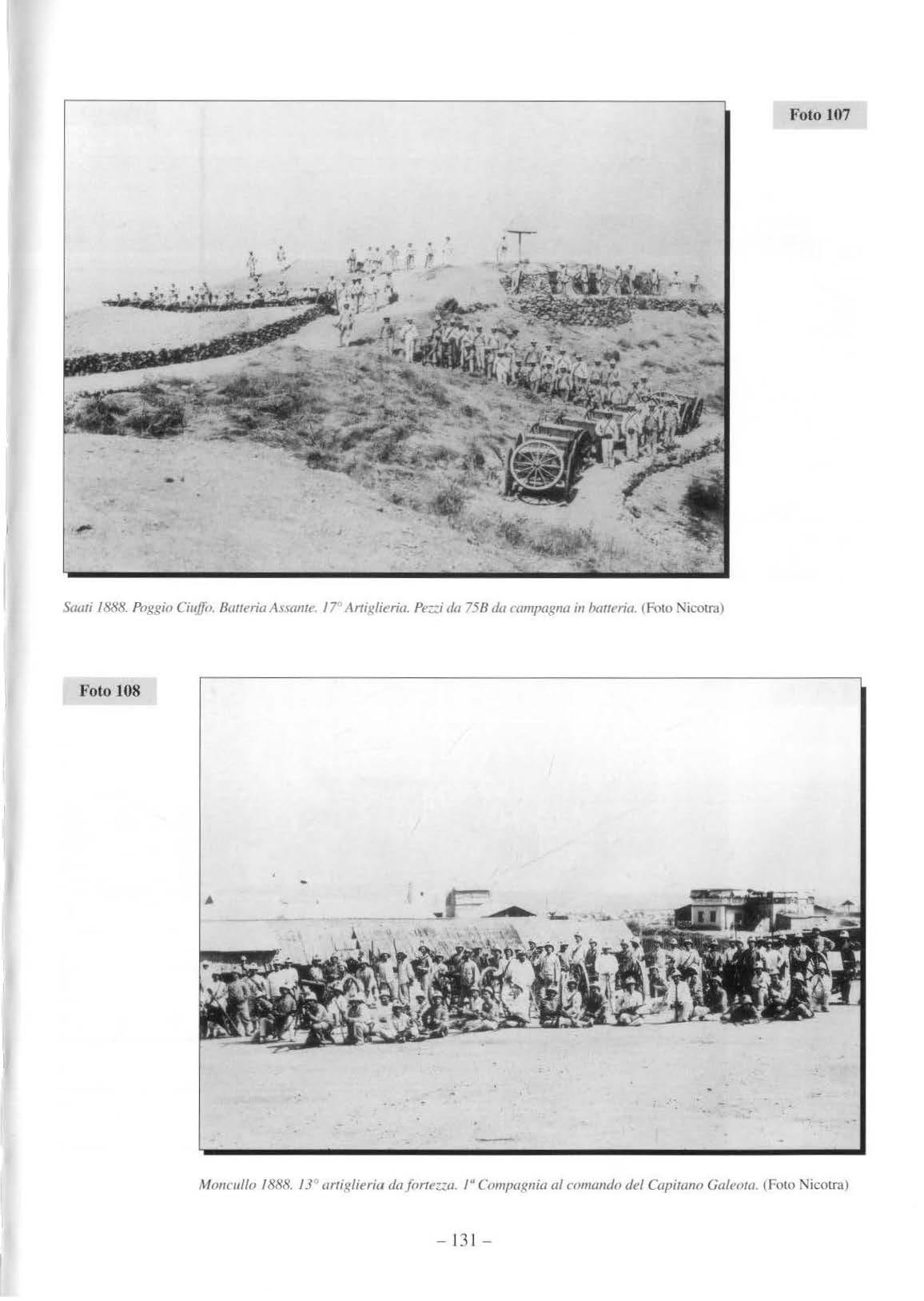
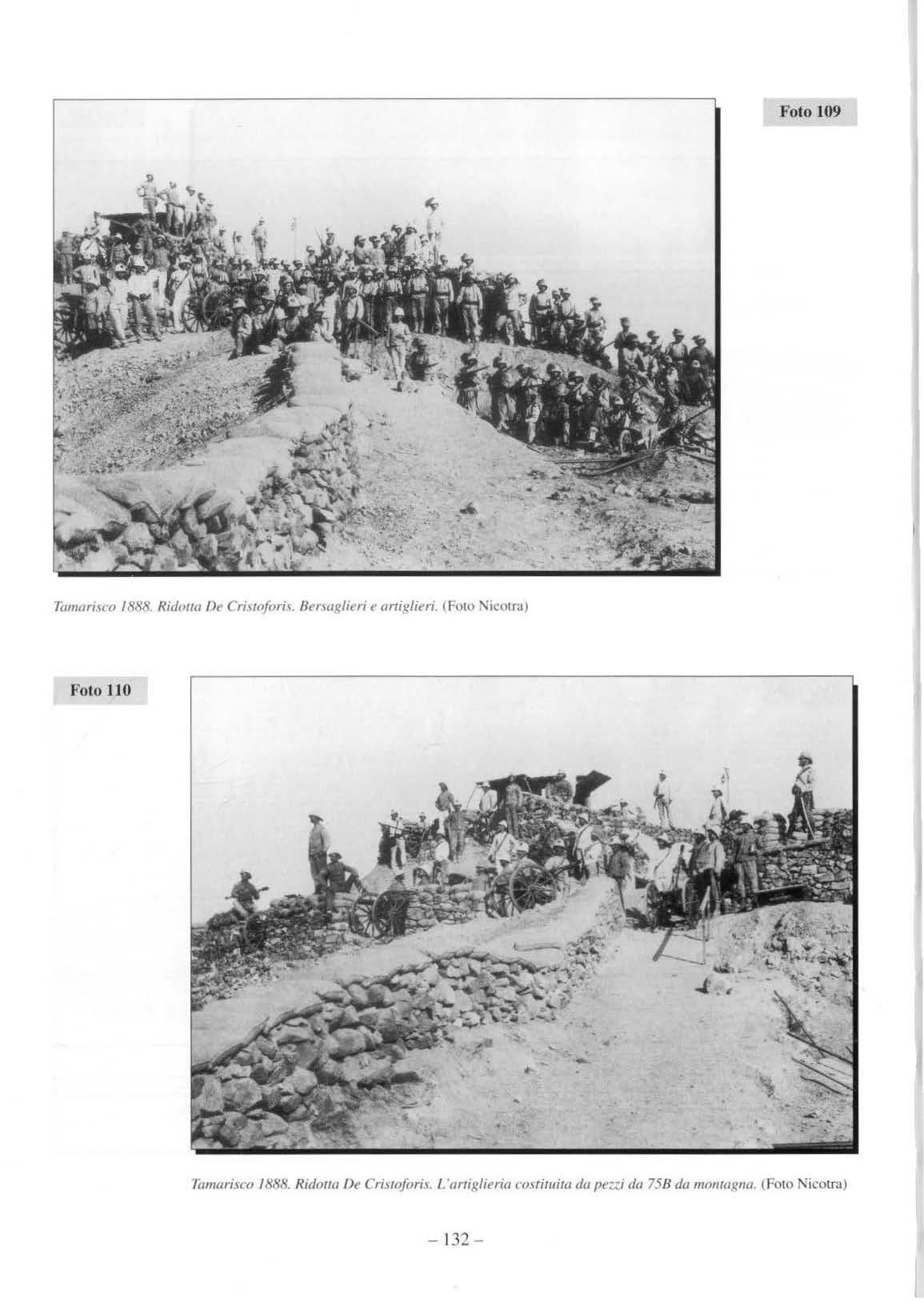
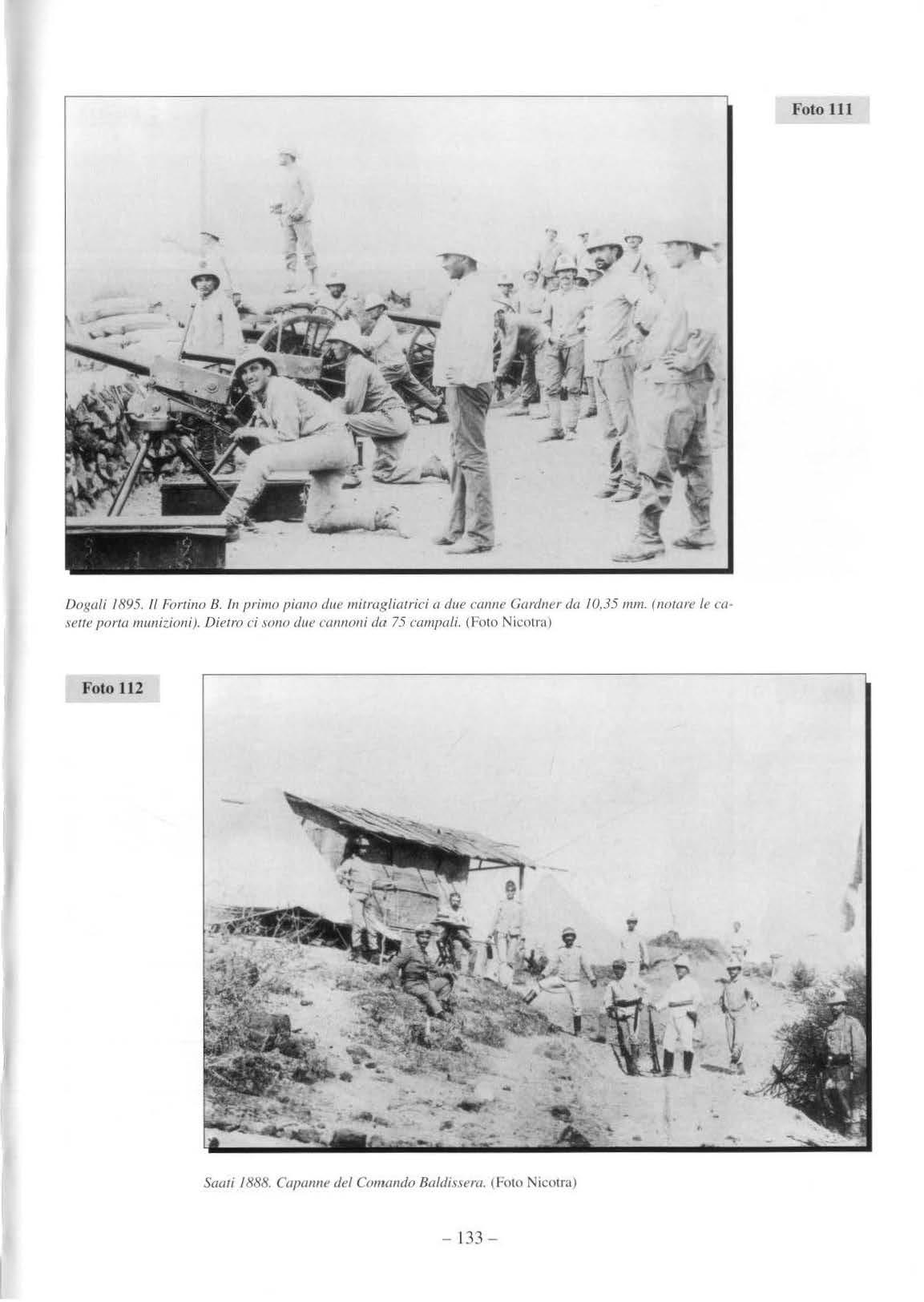
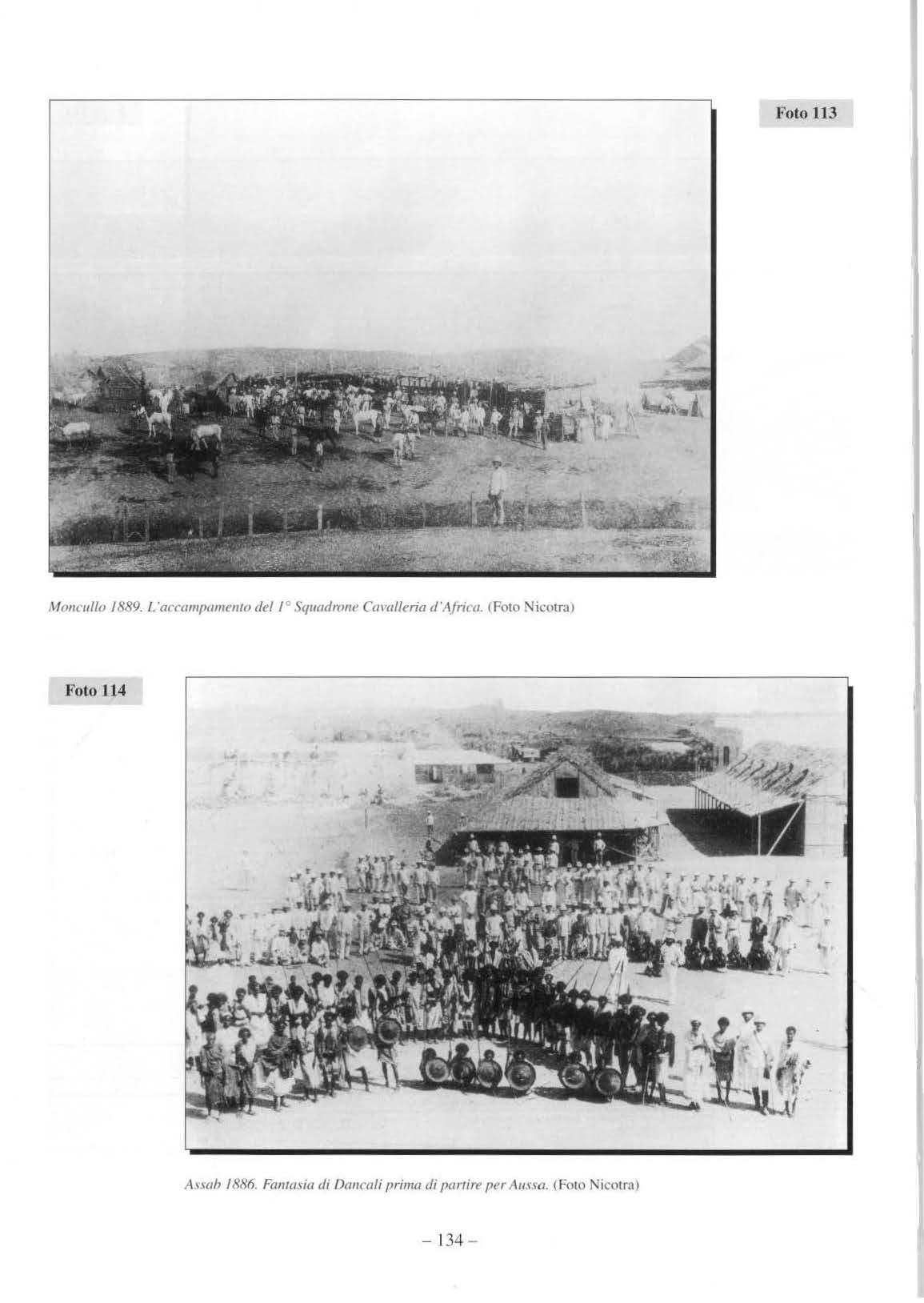
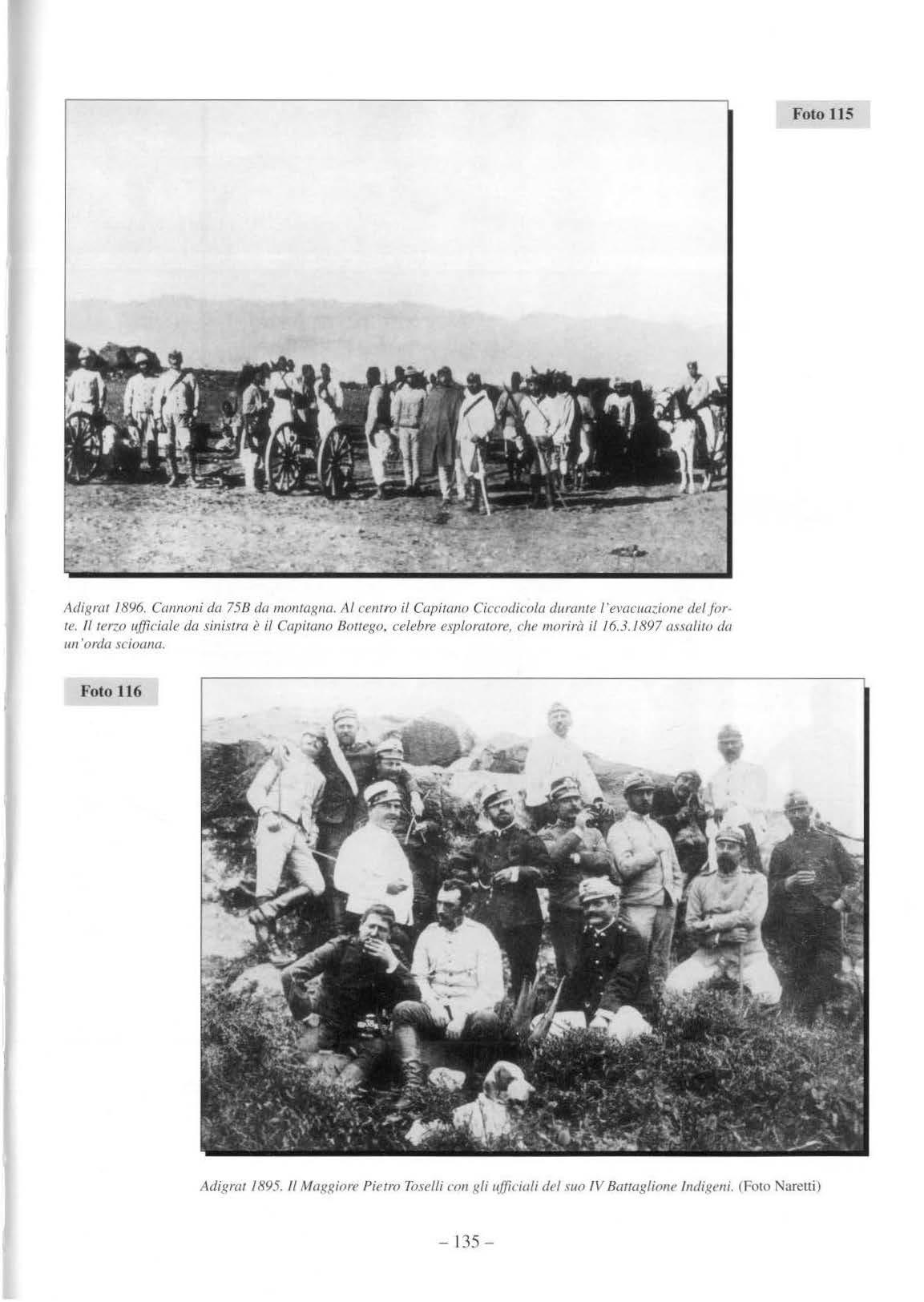 Adigmr 1896. Cannoni da 758 da mon/agna. Al cemro il Capirano Ciccodicola duranre l'evacuazione del forre. Il terzo ufficiale da sinisrra è il Capiremo Bortego. celebre esplormore, che morirà il 16.3 /897 assalito da 1111 'onta scioana.
Adigmr 1896. Cannoni da 758 da mon/agna. Al cemro il Capirano Ciccodicola duranre l'evacuazione del forre. Il terzo ufficiale da sinisrra è il Capiremo Bortego. celebre esplormore, che morirà il 16.3 /897 assalito da 1111 'onta scioana.
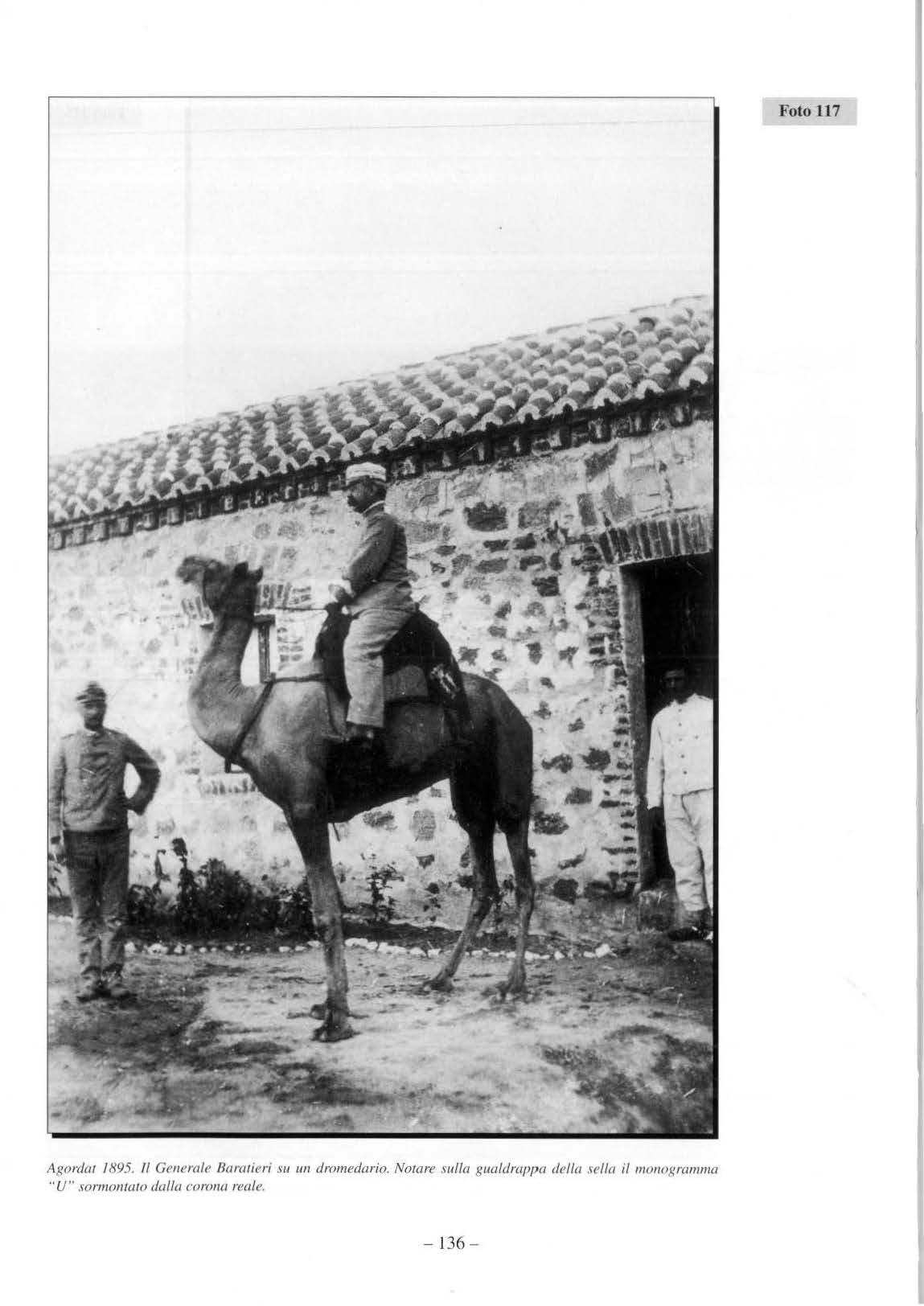
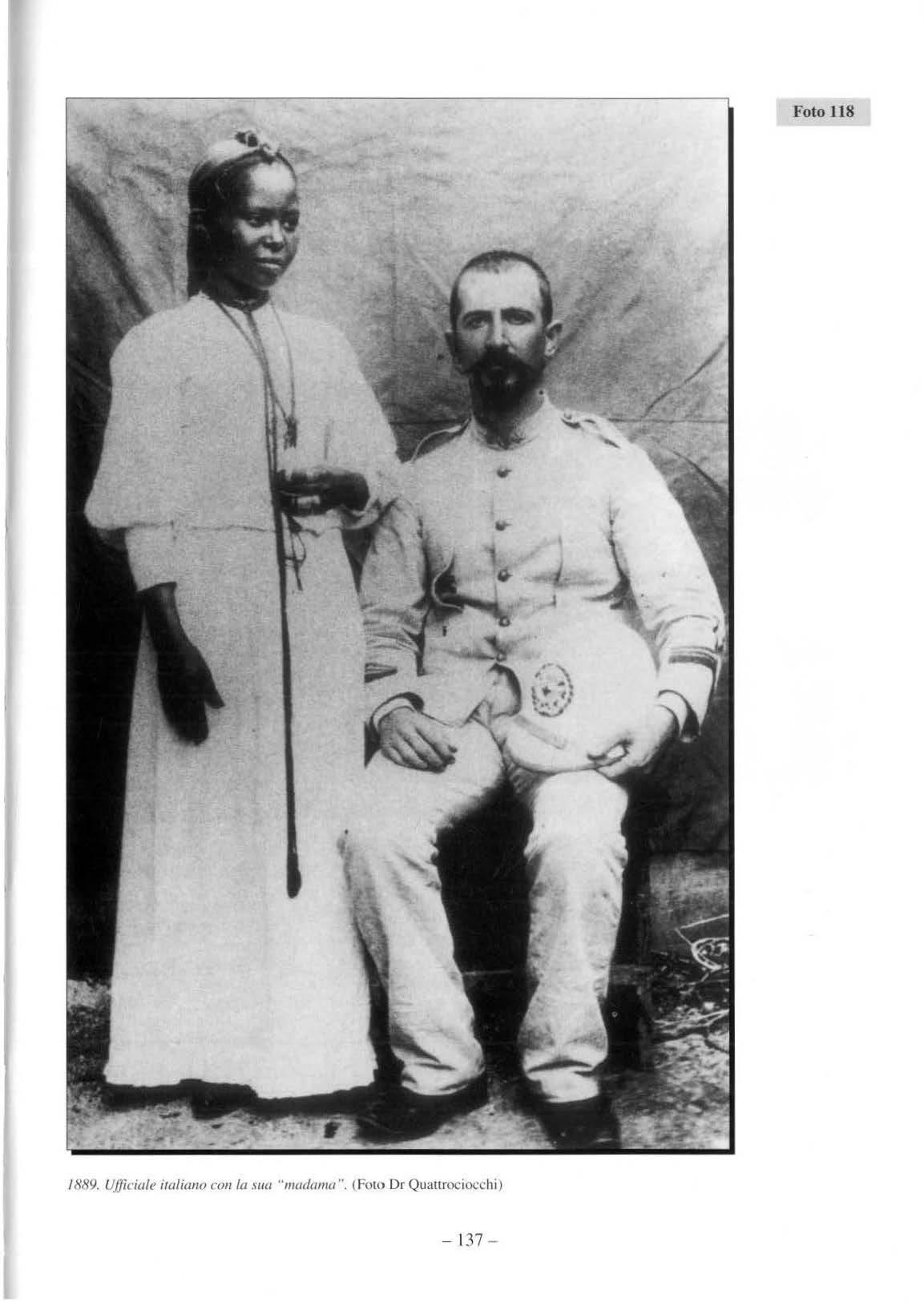

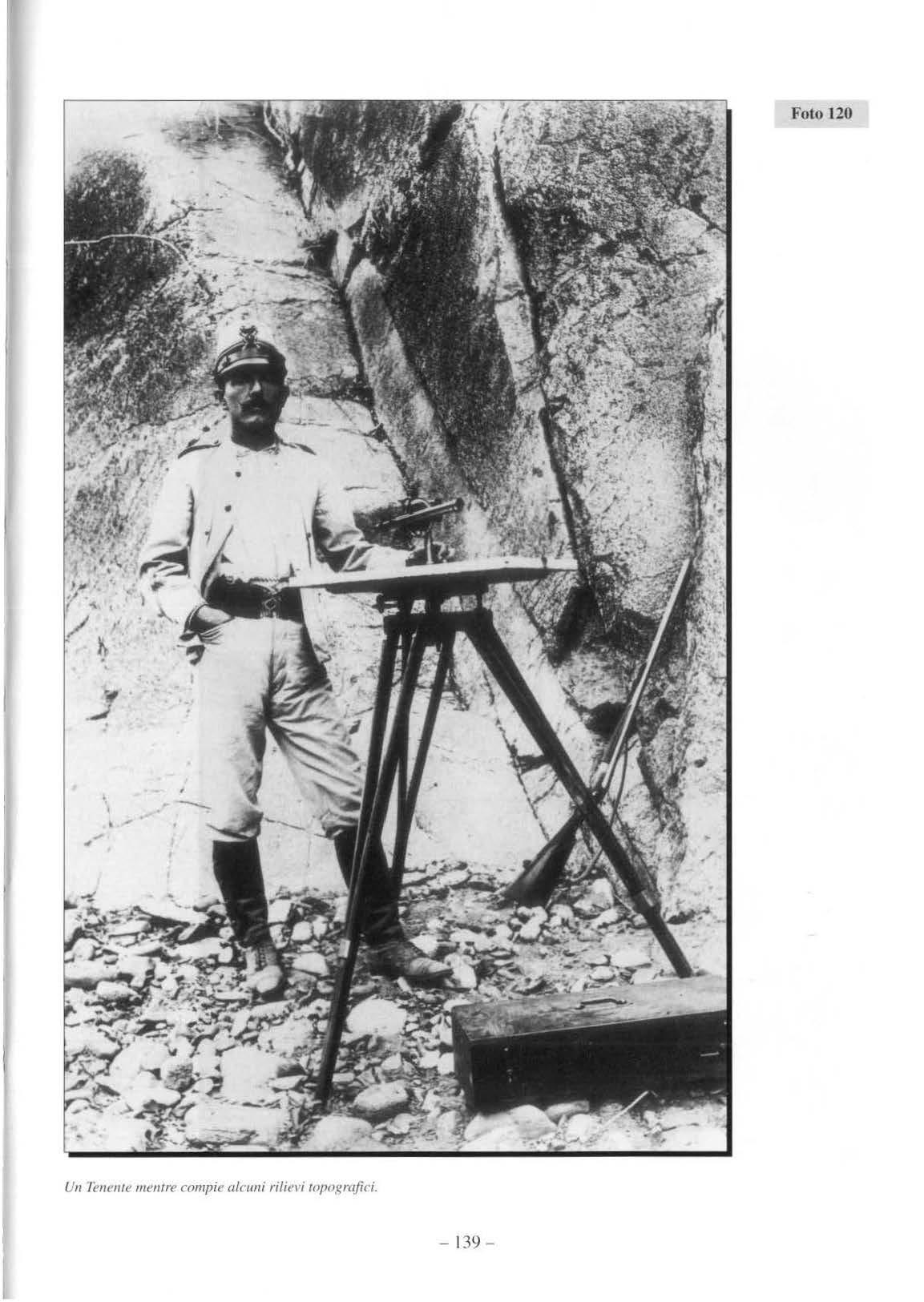

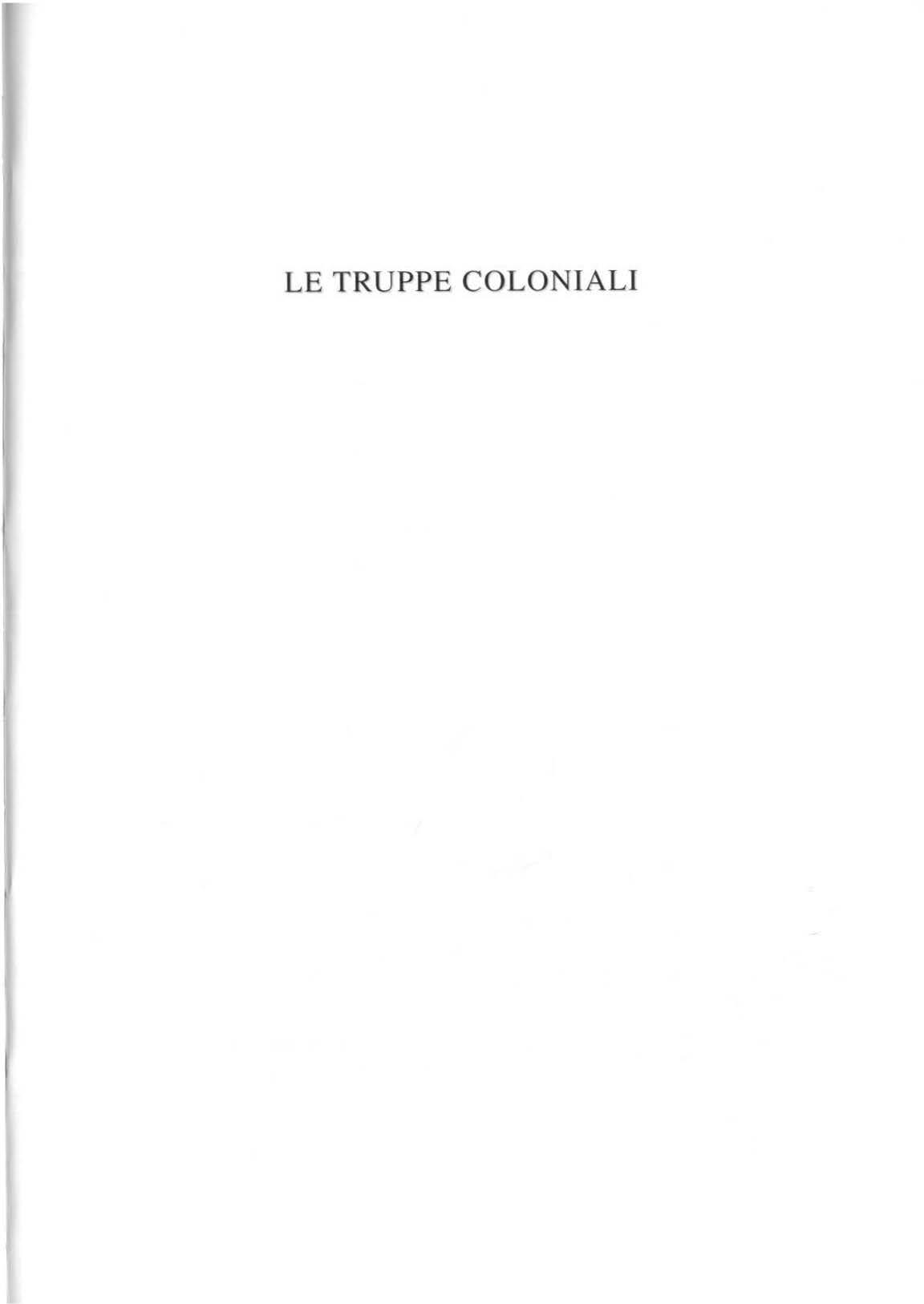
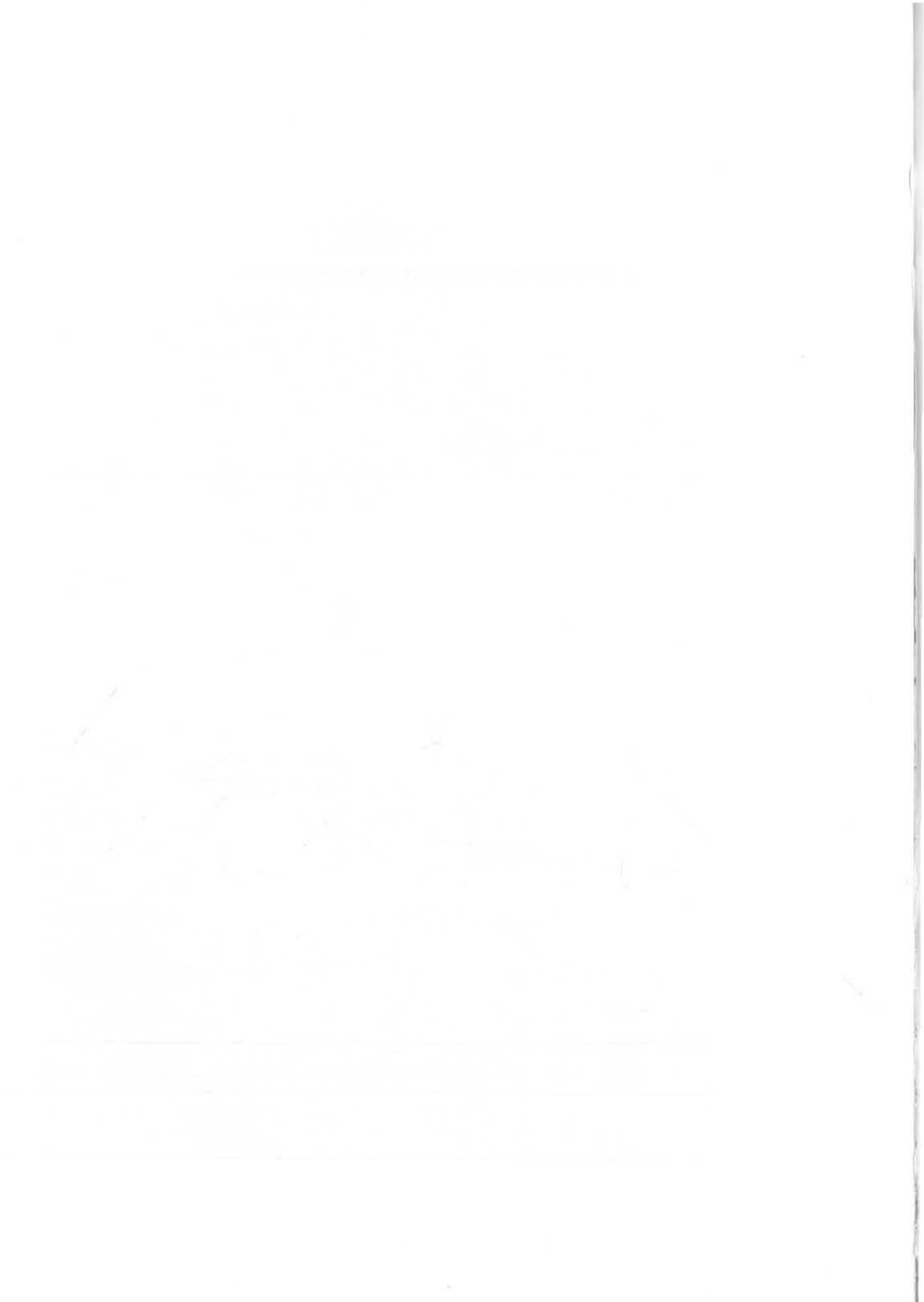
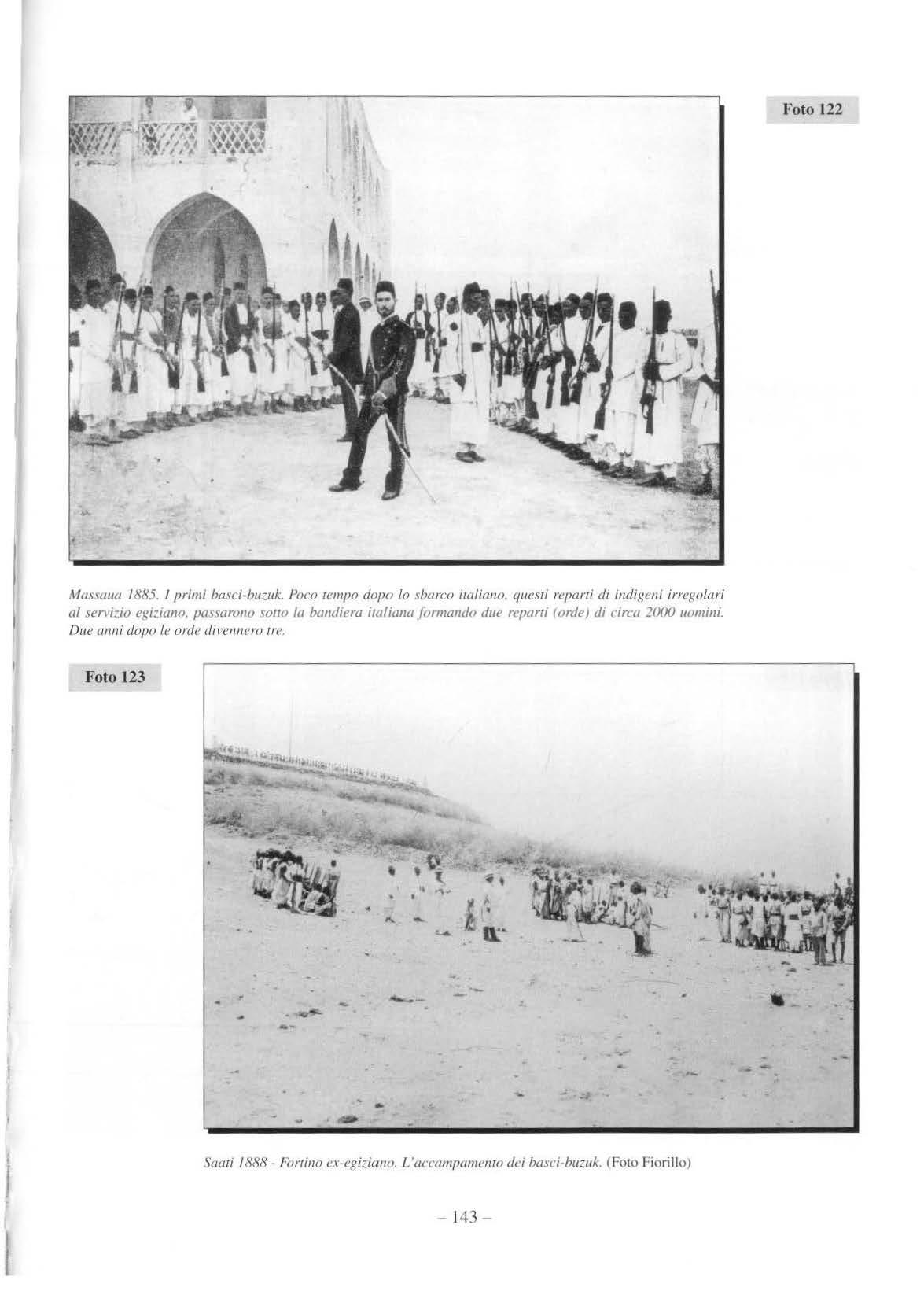
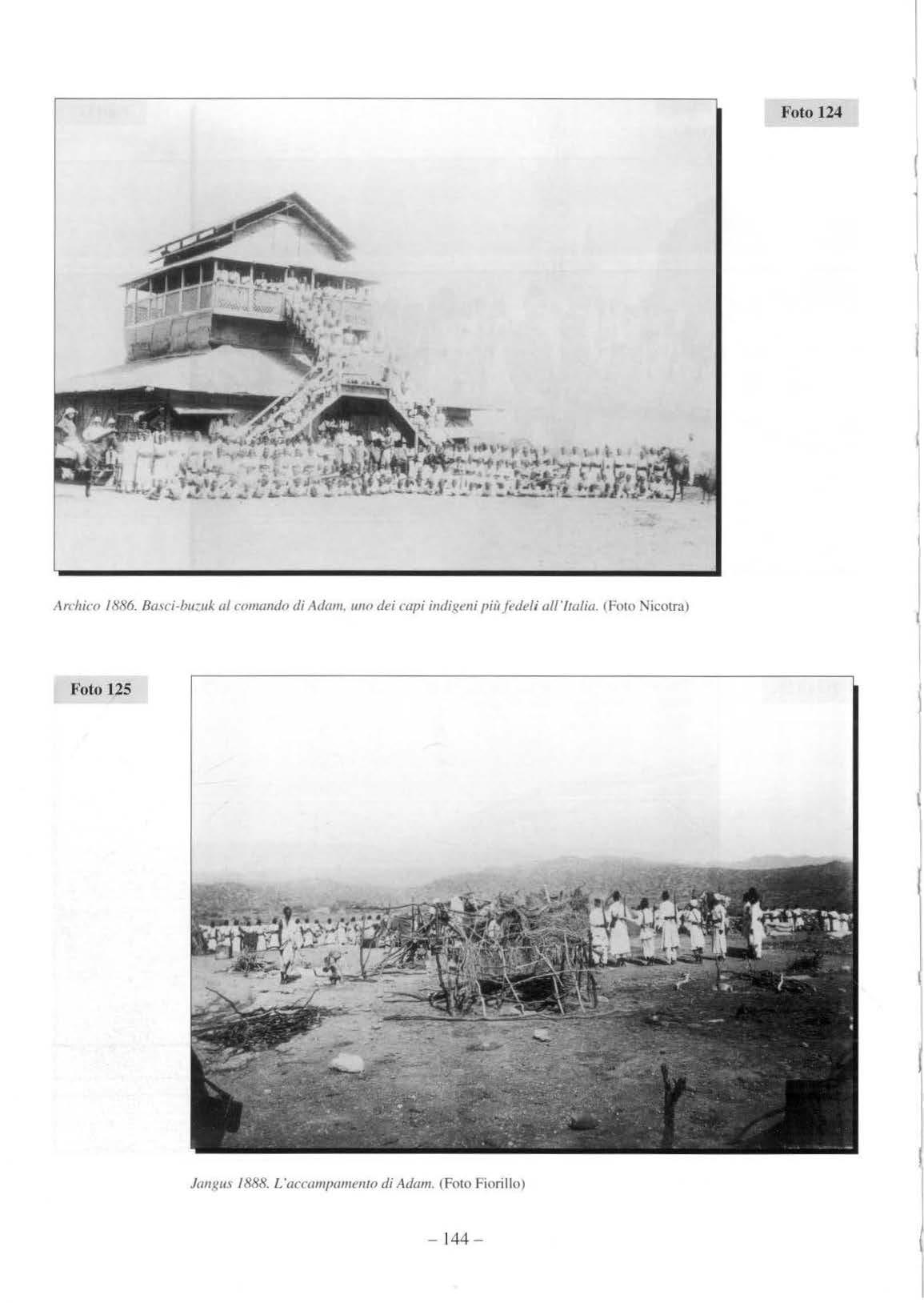
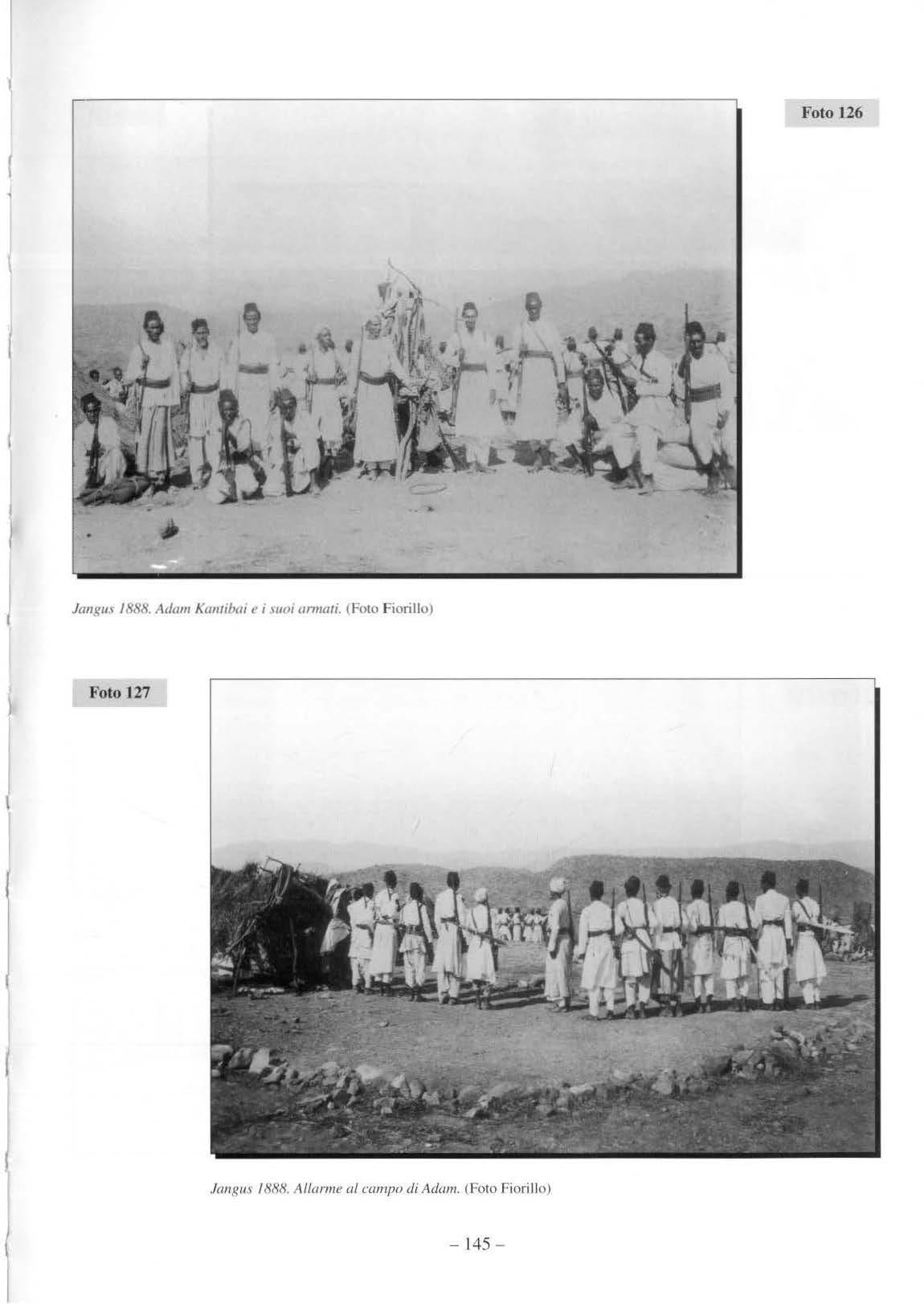
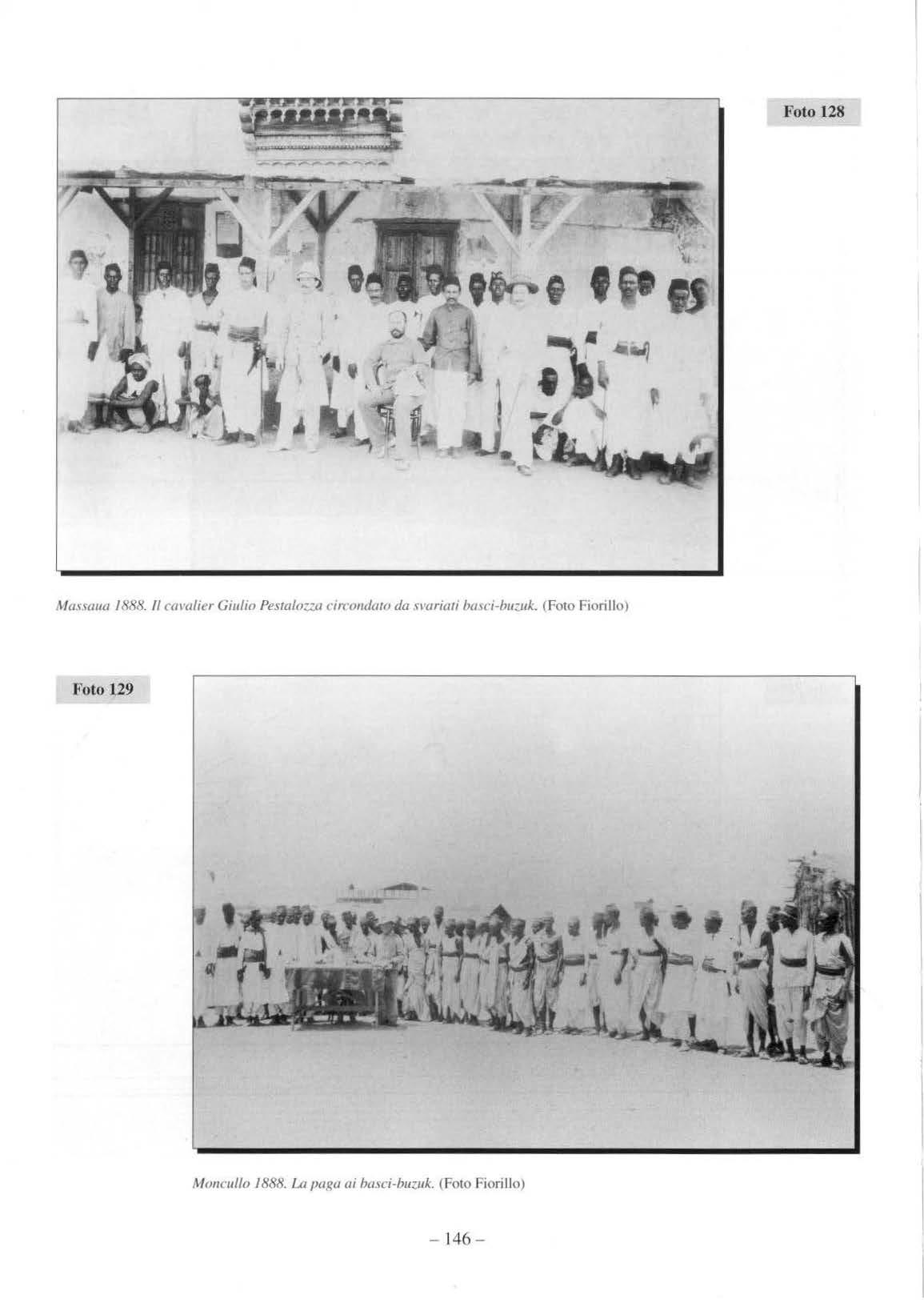
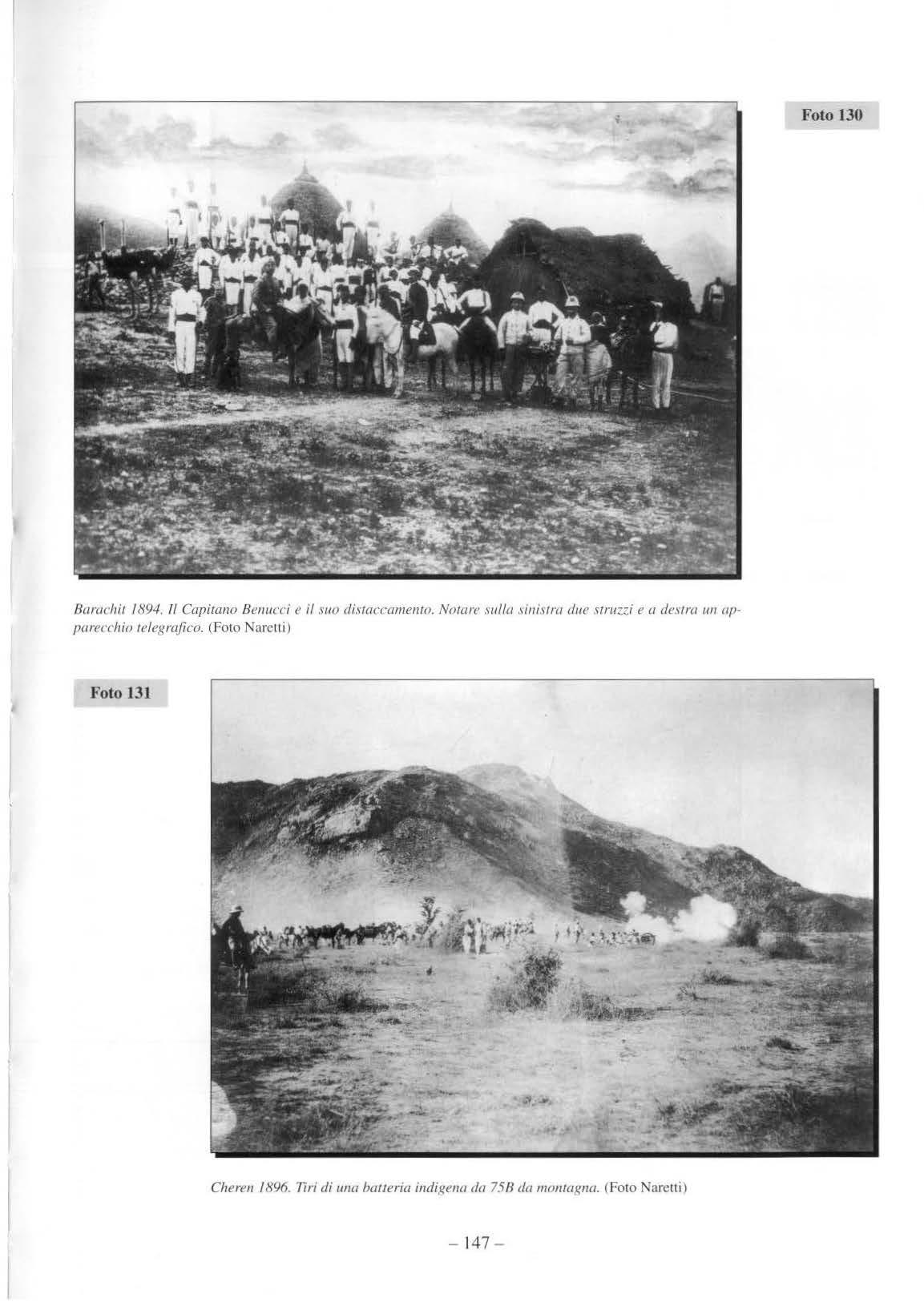 Barachir 1894. Il Cap itan o Benucci e il suu disracc-amento. Norare .\111/a due stru::.zi e a destra 1111 ap · parel'chio telegrafico. (Foto Nurcui)
Foto 131
Barachir 1894. Il Cap itan o Benucci e il suu disracc-amento. Norare .\111/a due stru::.zi e a destra 1111 ap · parel'chio telegrafico. (Foto Nurcui)
Foto 131
 Adua 1895. Se;ione artiglieria indit:ena al comando del Tenente Camso. l i soliti 758 da lllcJ/lta· t:lw. (rotu Narctti)
Foto J33
Adua 1895. Se;ione artiglieria indit:ena al comando del Tenente Camso. l i soliti 758 da lllcJ/lta· t:lw. (rotu Narctti)
Foto J33

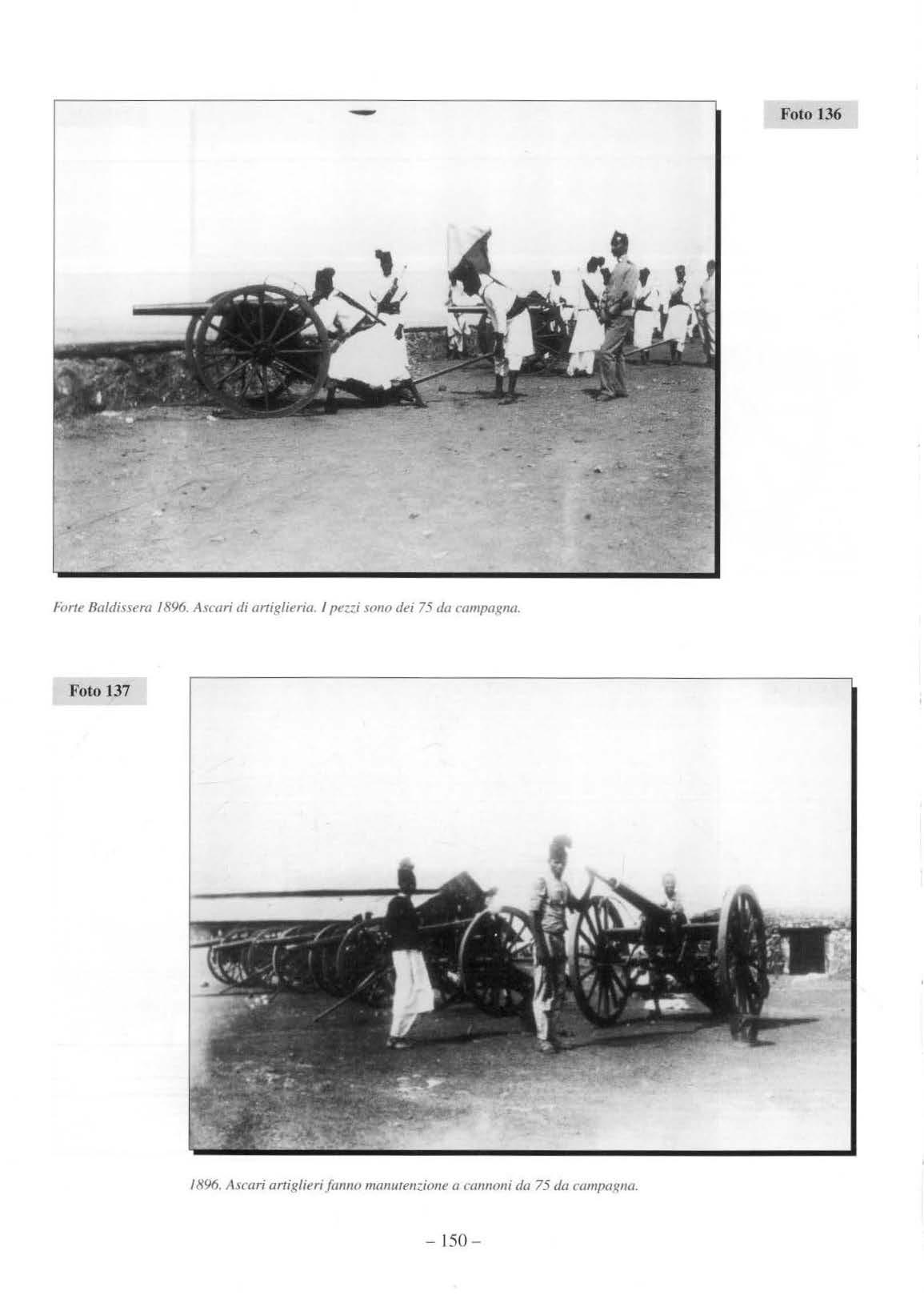
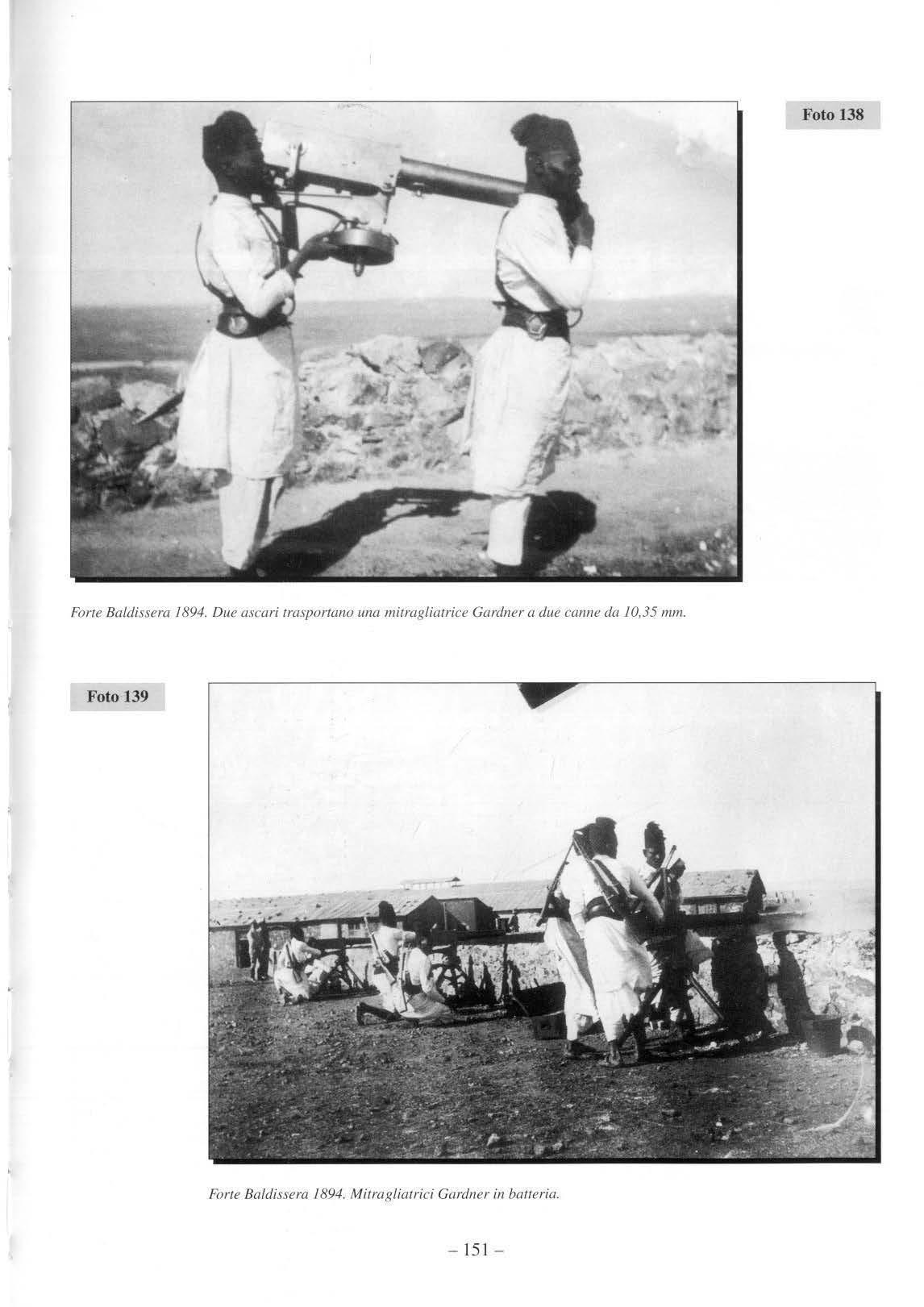
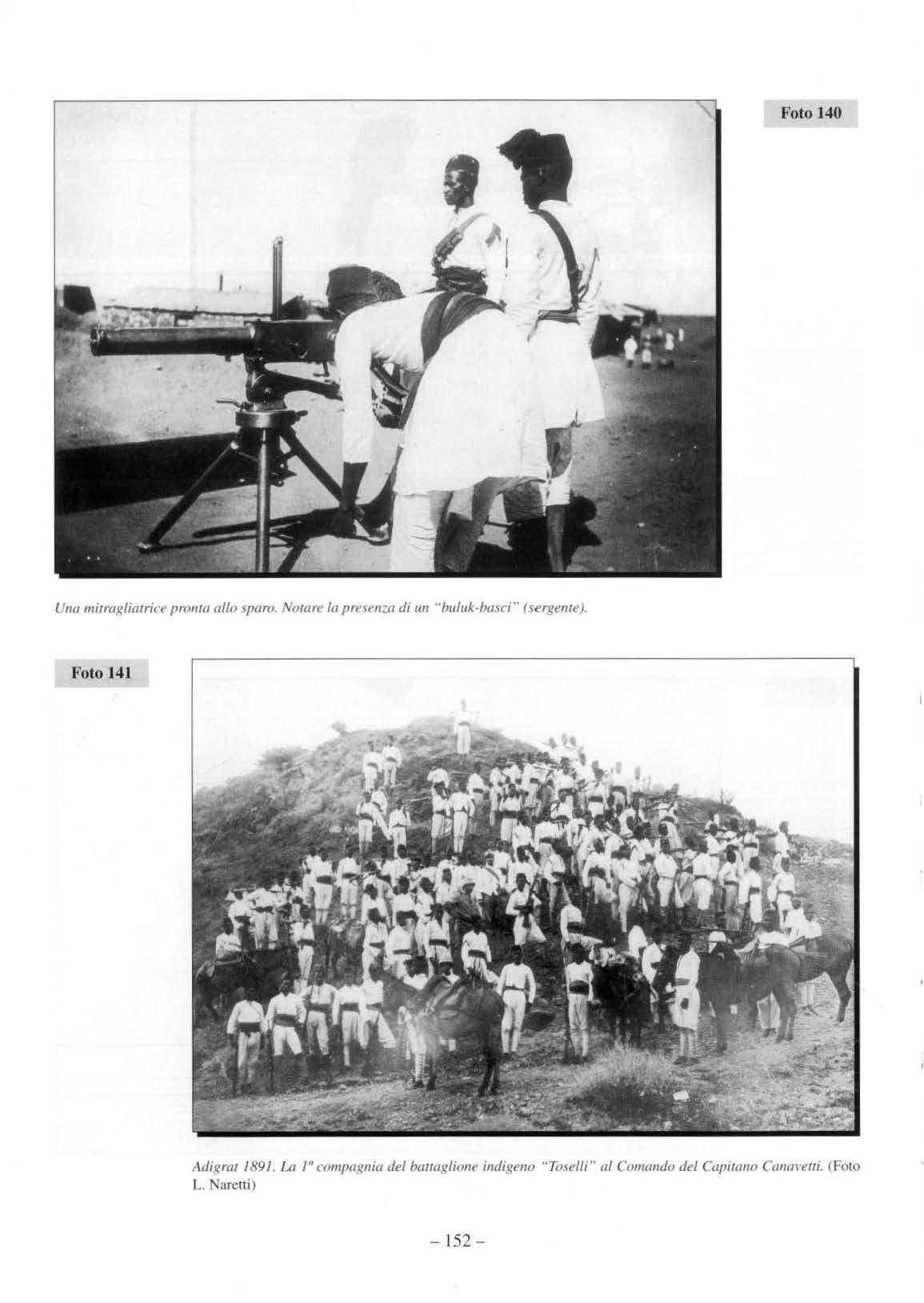
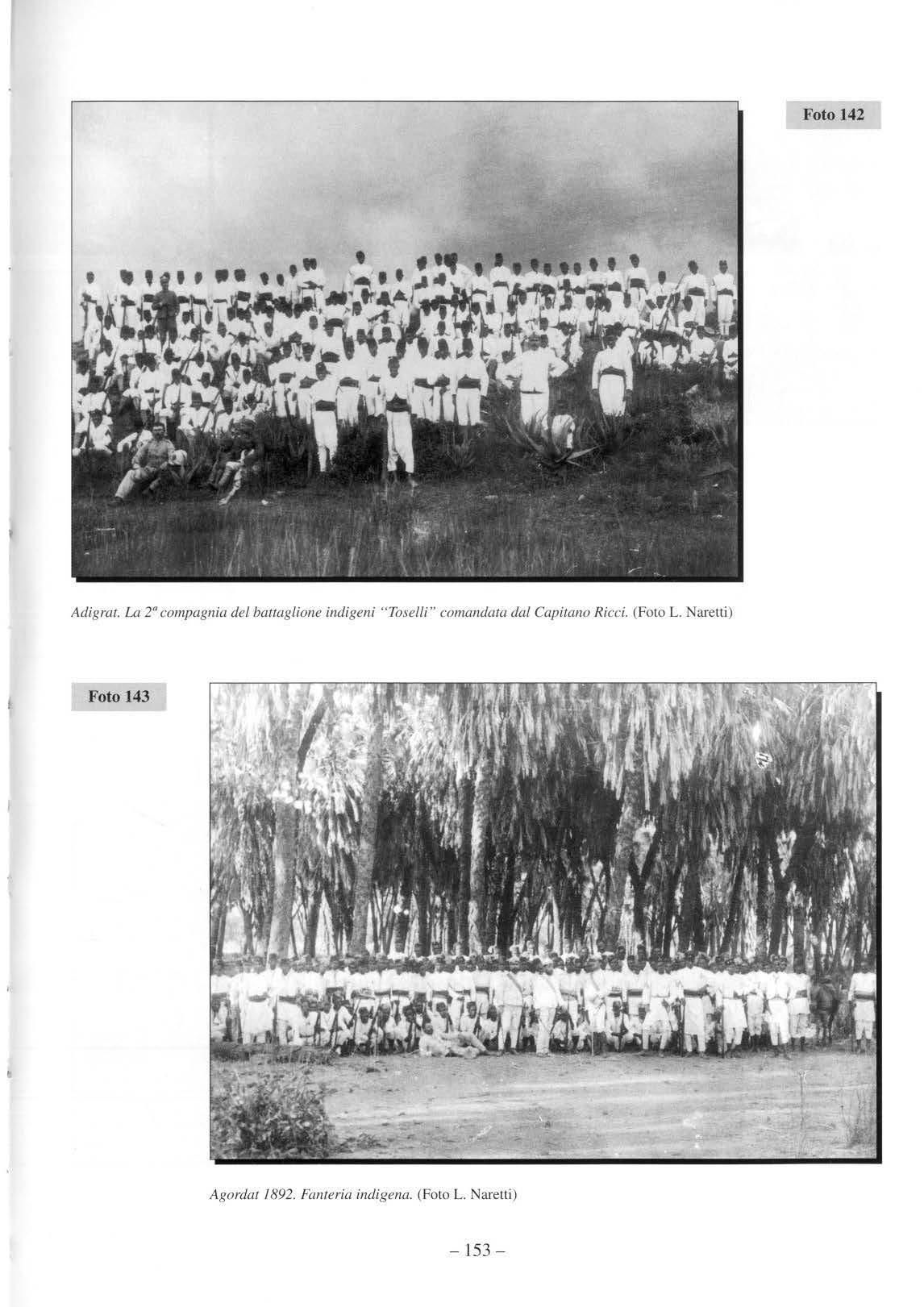
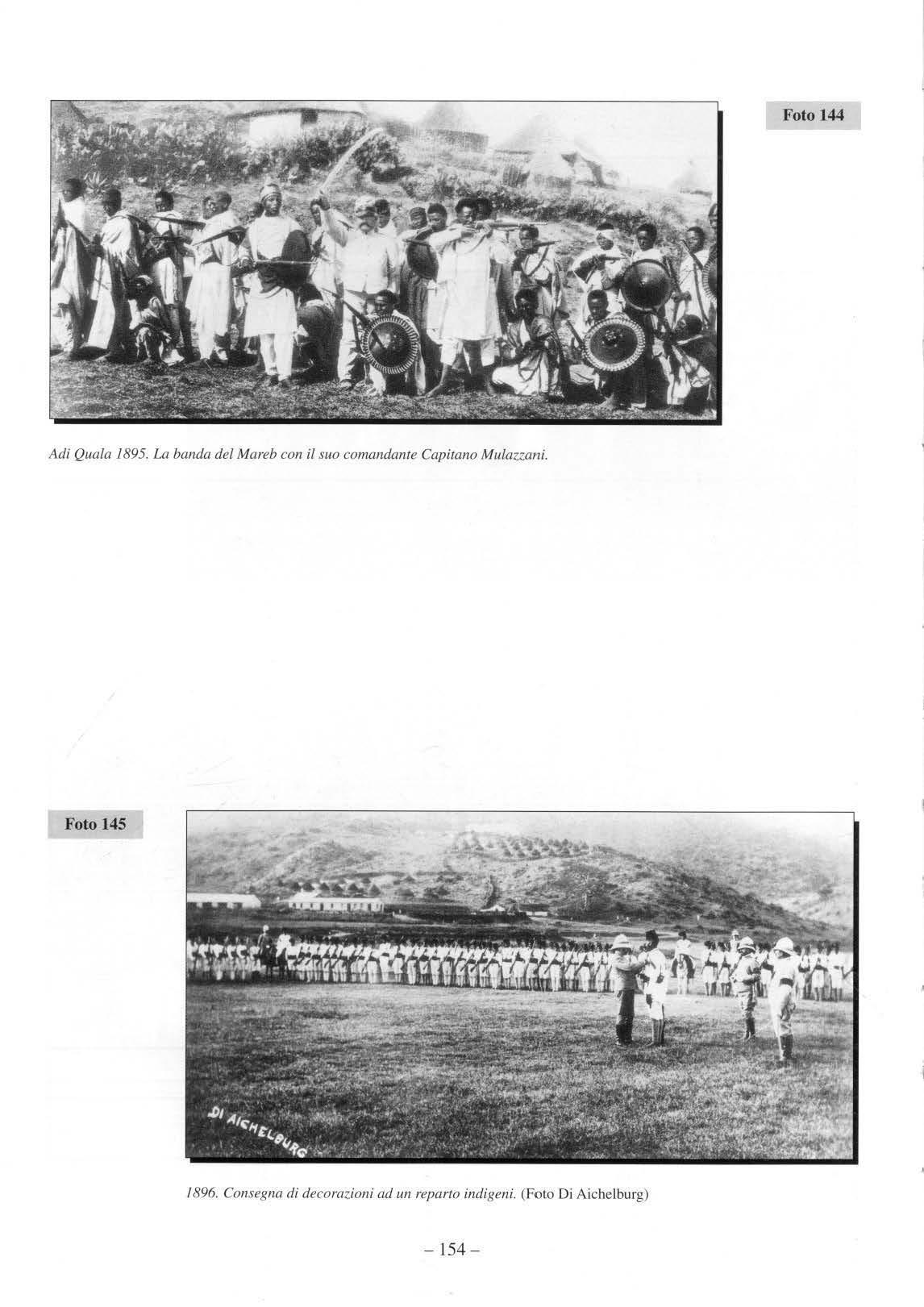
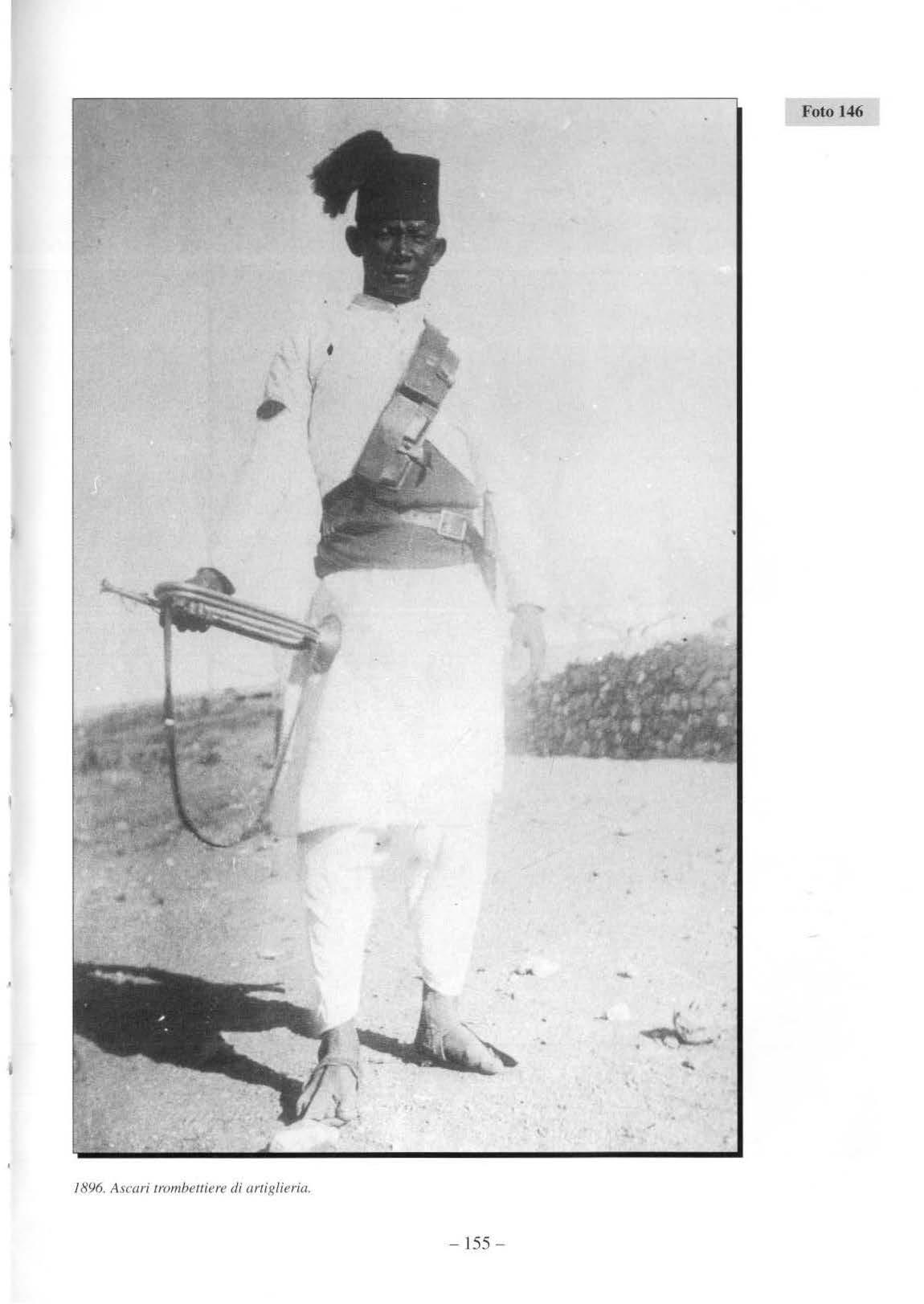
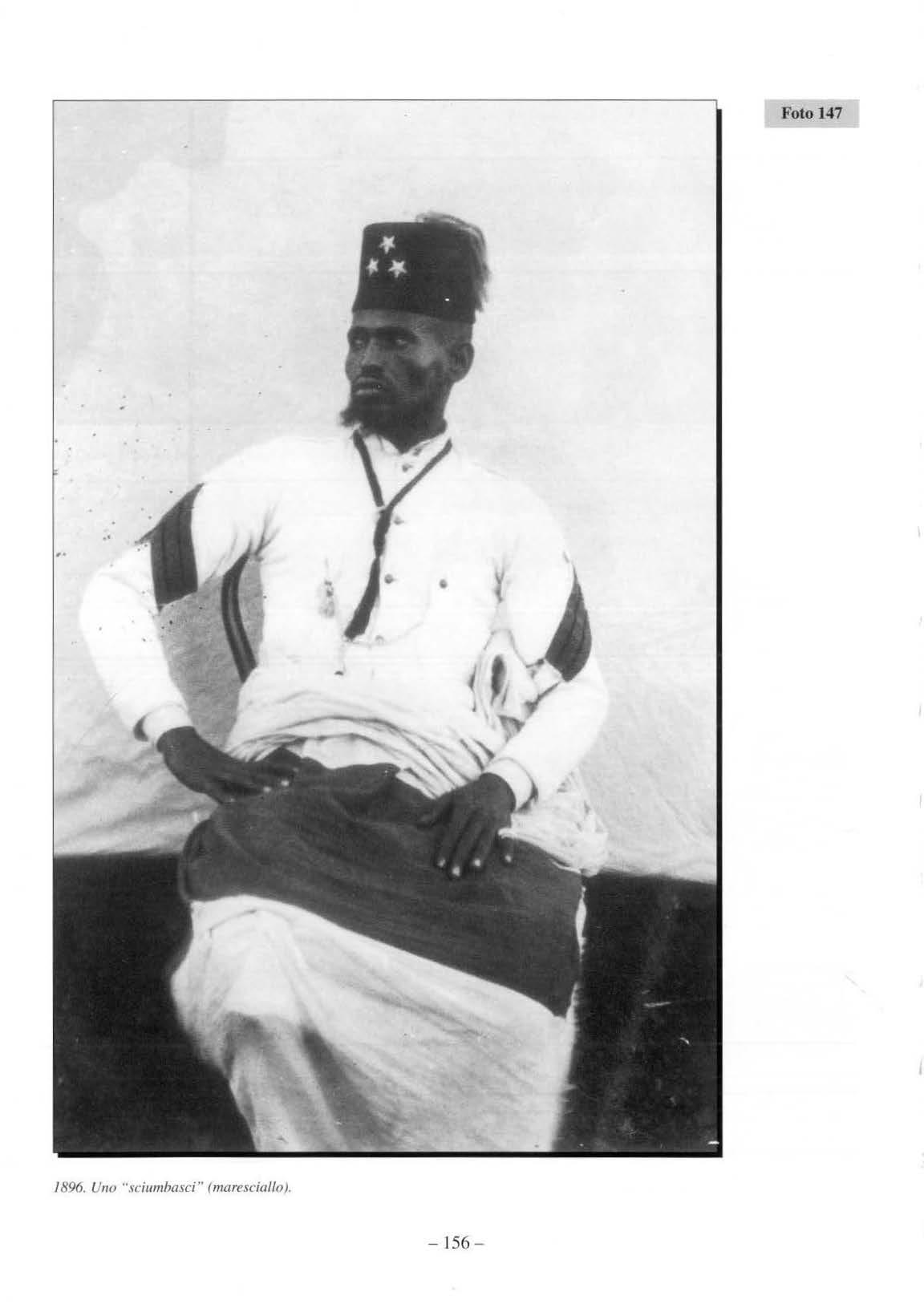
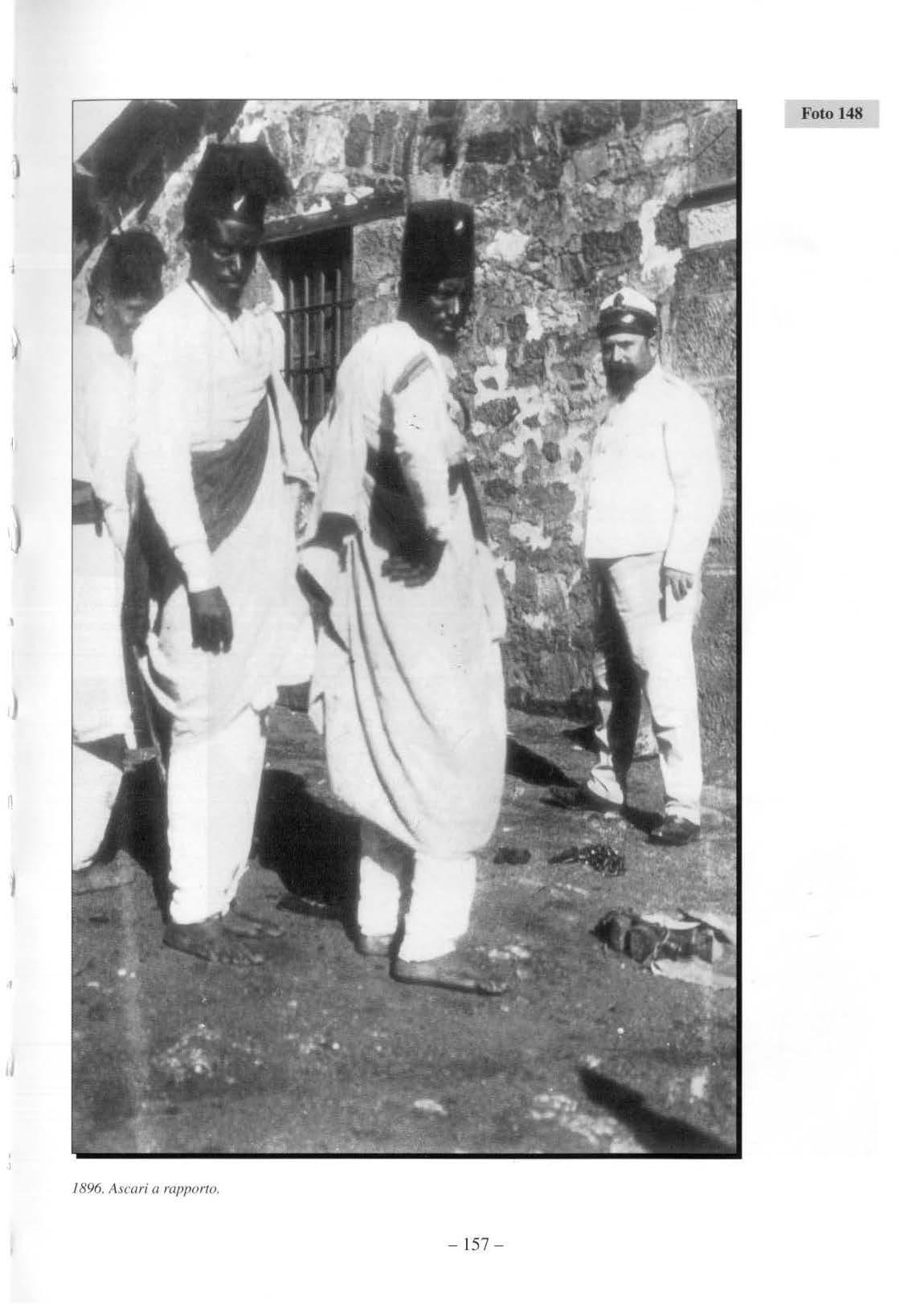

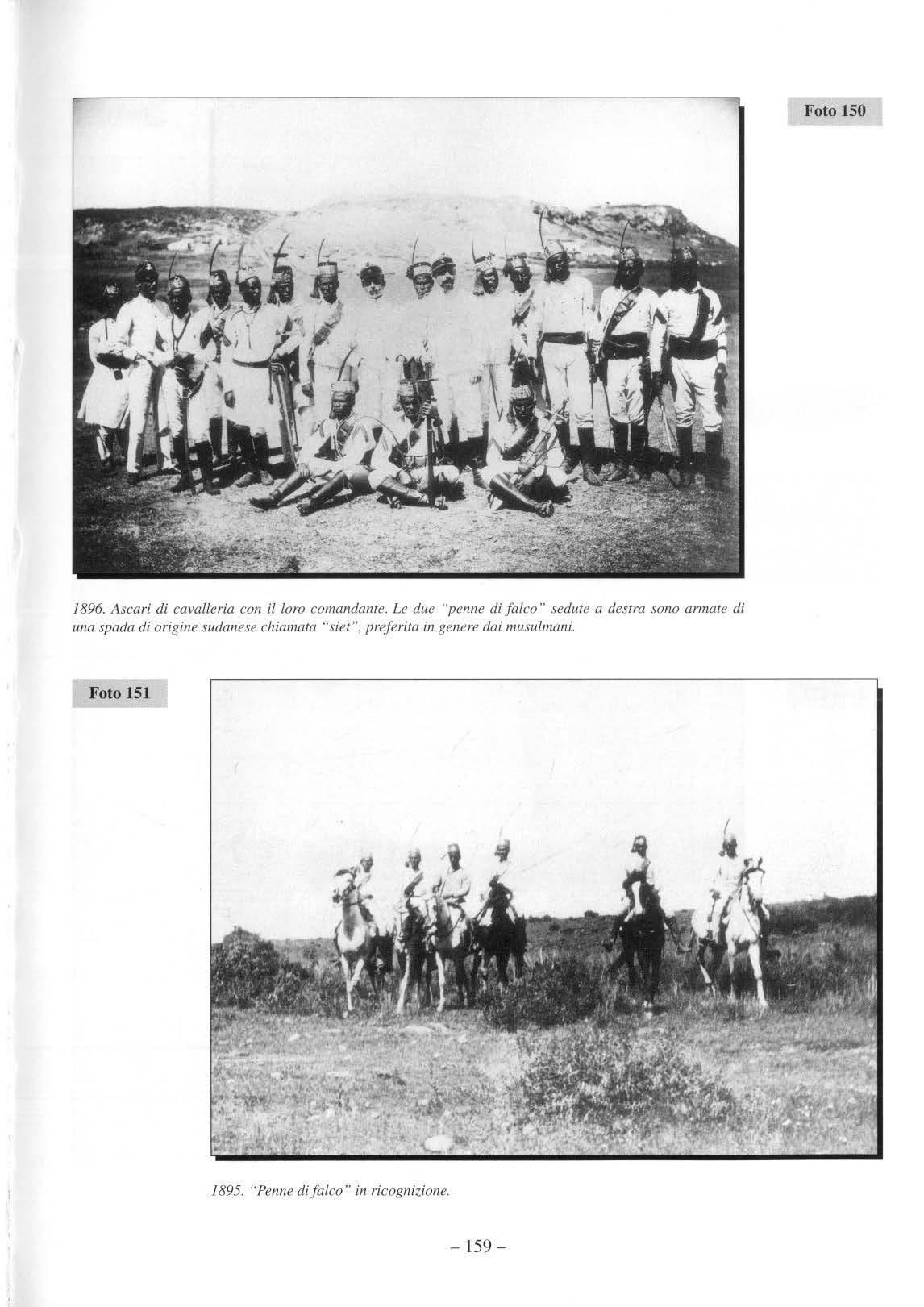 Foto 151
Foto 151
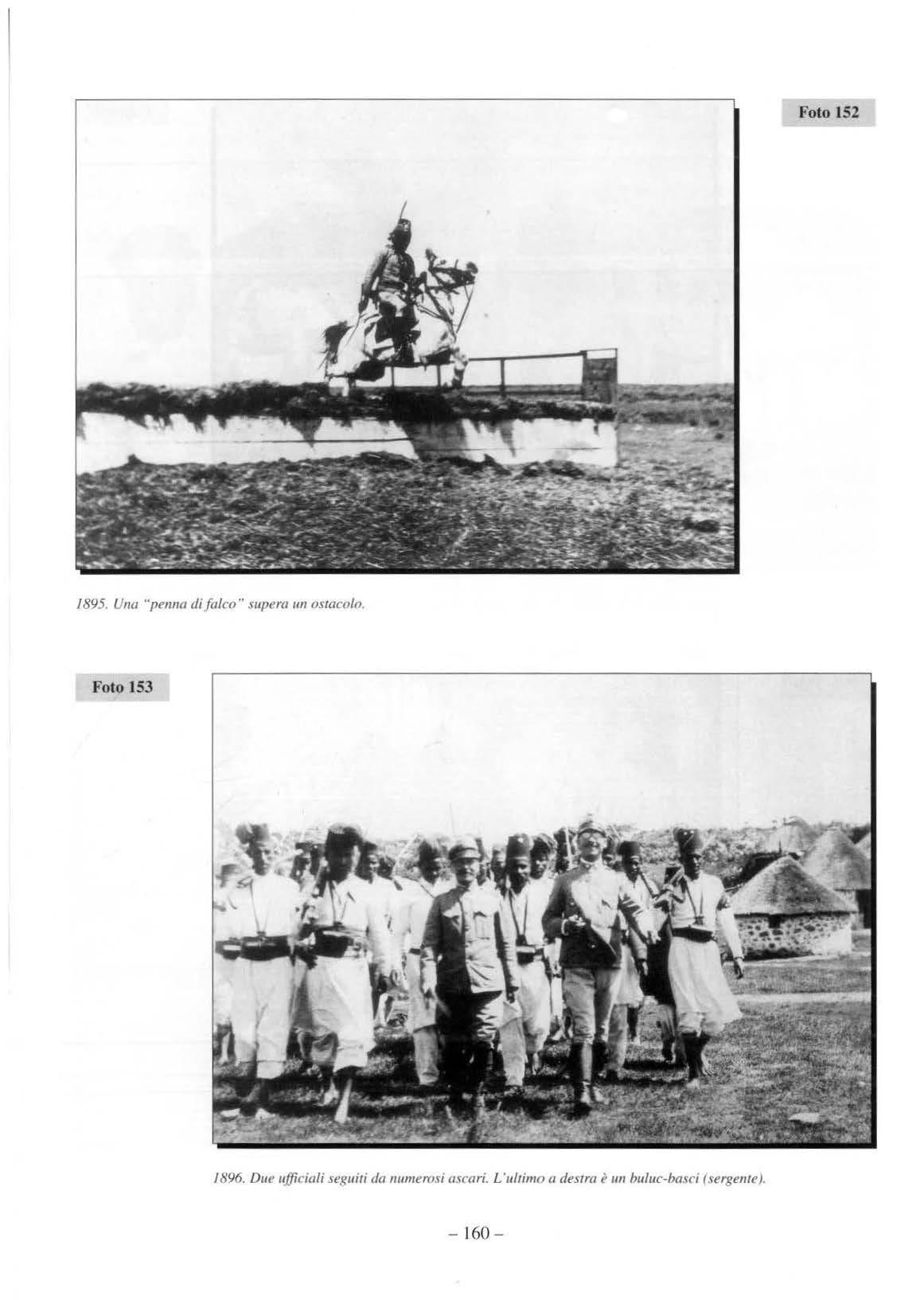
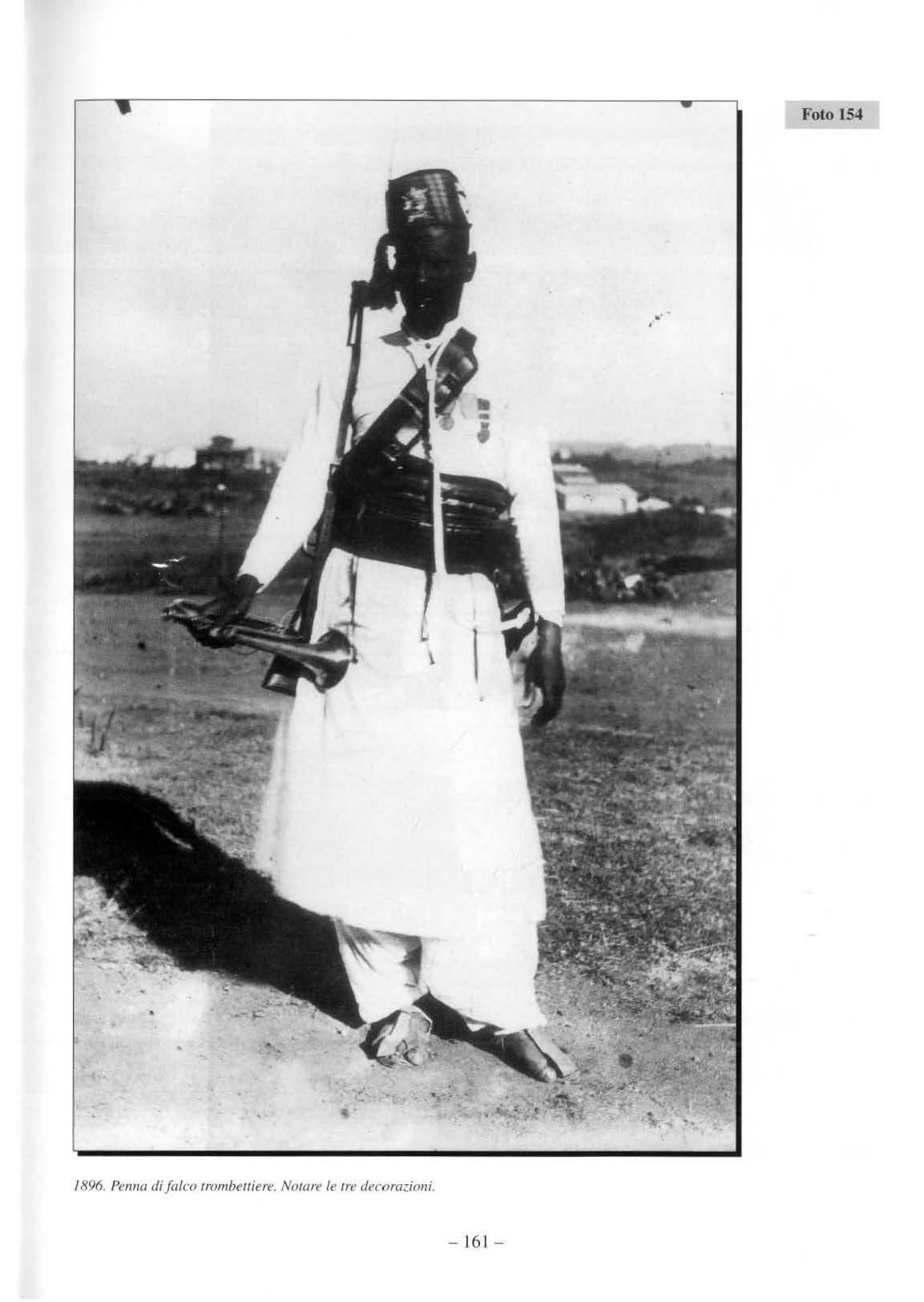
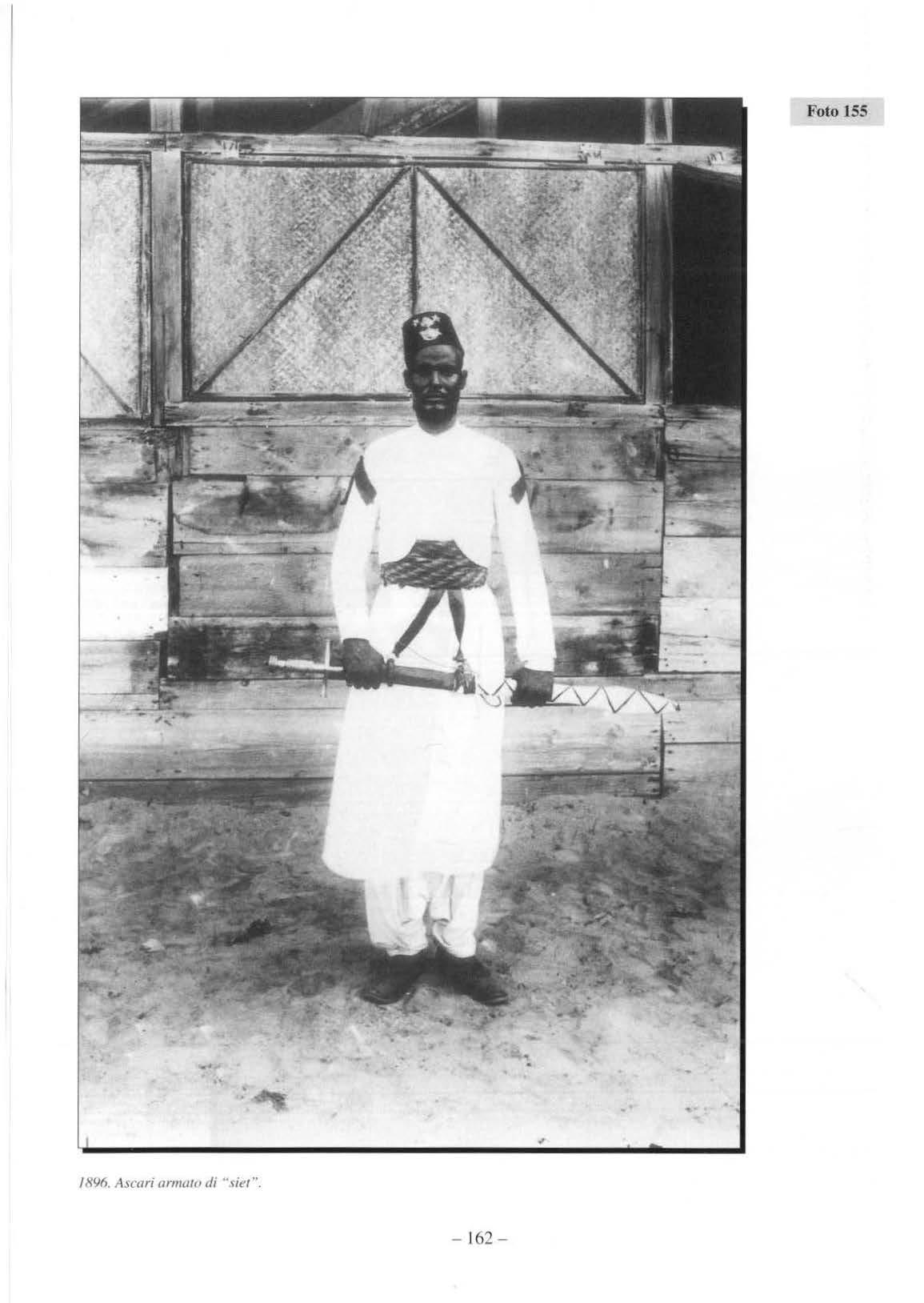
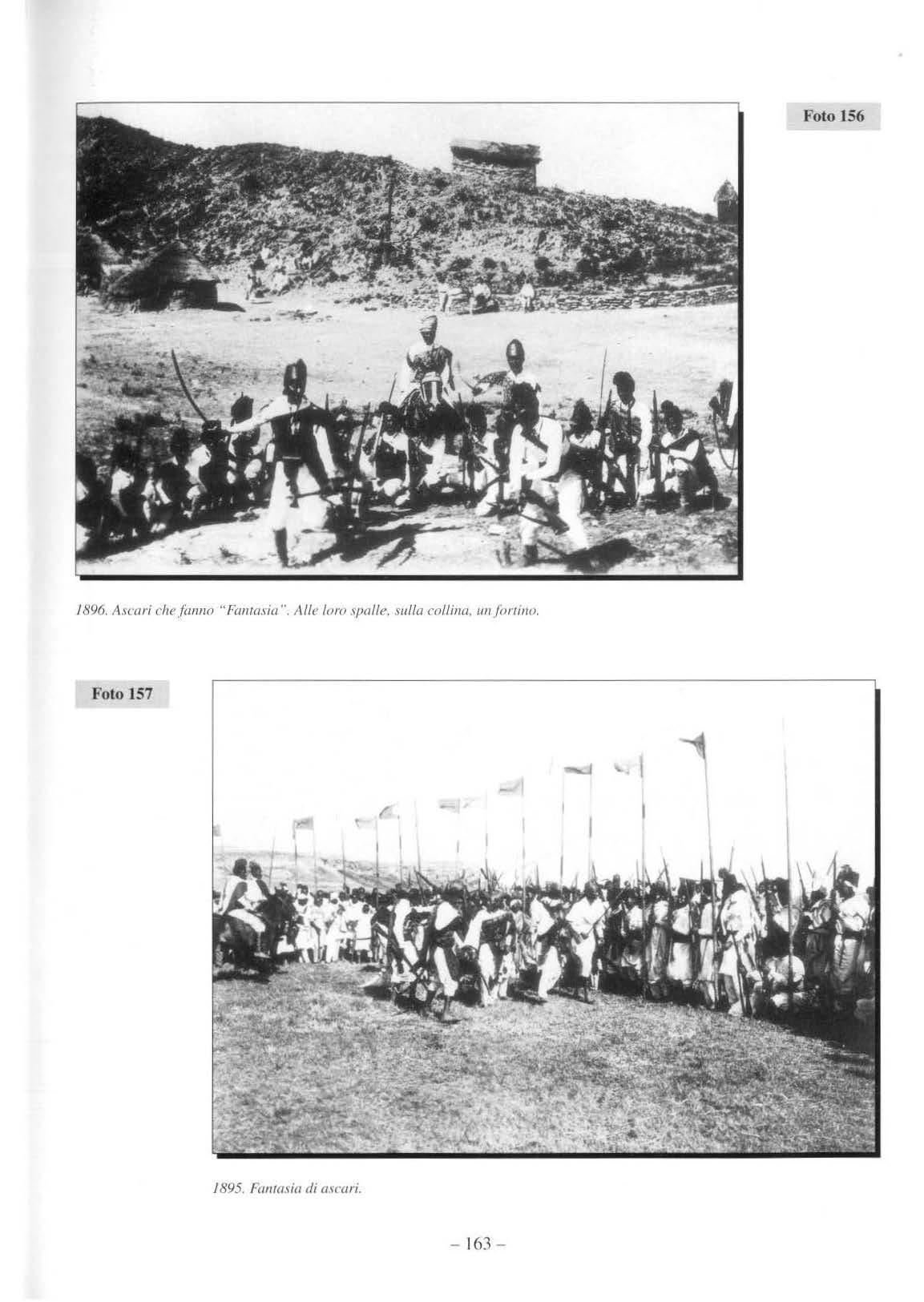



 Foto 158
1894. Carabinieri e :.aptiè.
Foto 159
Foto 158
1894. Carabinieri e :.aptiè.
Foto 159
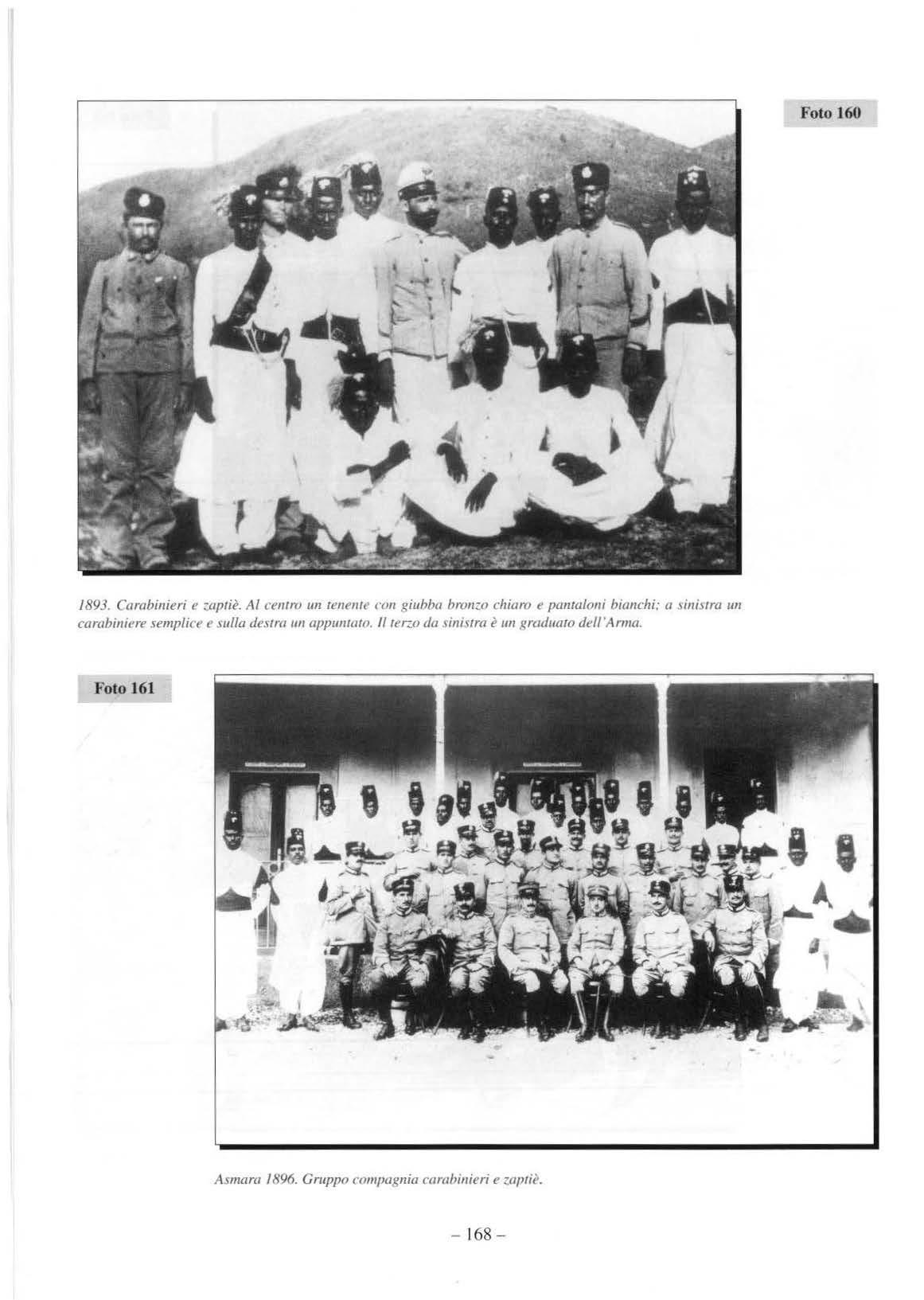 /893. Carabinieri e ::.aptiè. Al cemro 1m tenente con giubba btvnz.o chiaro e pantaloni bianchi; a 1m carabiniere semplice e :.u((a destra 1111 appuntato. lf ter..o da è 1111 gradua w de(( 'Arma.
Foto 161
Asmara 1896. Grttppo compagnia carabinieri e ::.aptiè.
/893. Carabinieri e ::.aptiè. Al cemro 1m tenente con giubba btvnz.o chiaro e pantaloni bianchi; a 1m carabiniere semplice e :.u((a destra 1111 appuntato. lf ter..o da è 1111 gradua w de(( 'Arma.
Foto 161
Asmara 1896. Grttppo compagnia carabinieri e ::.aptiè.
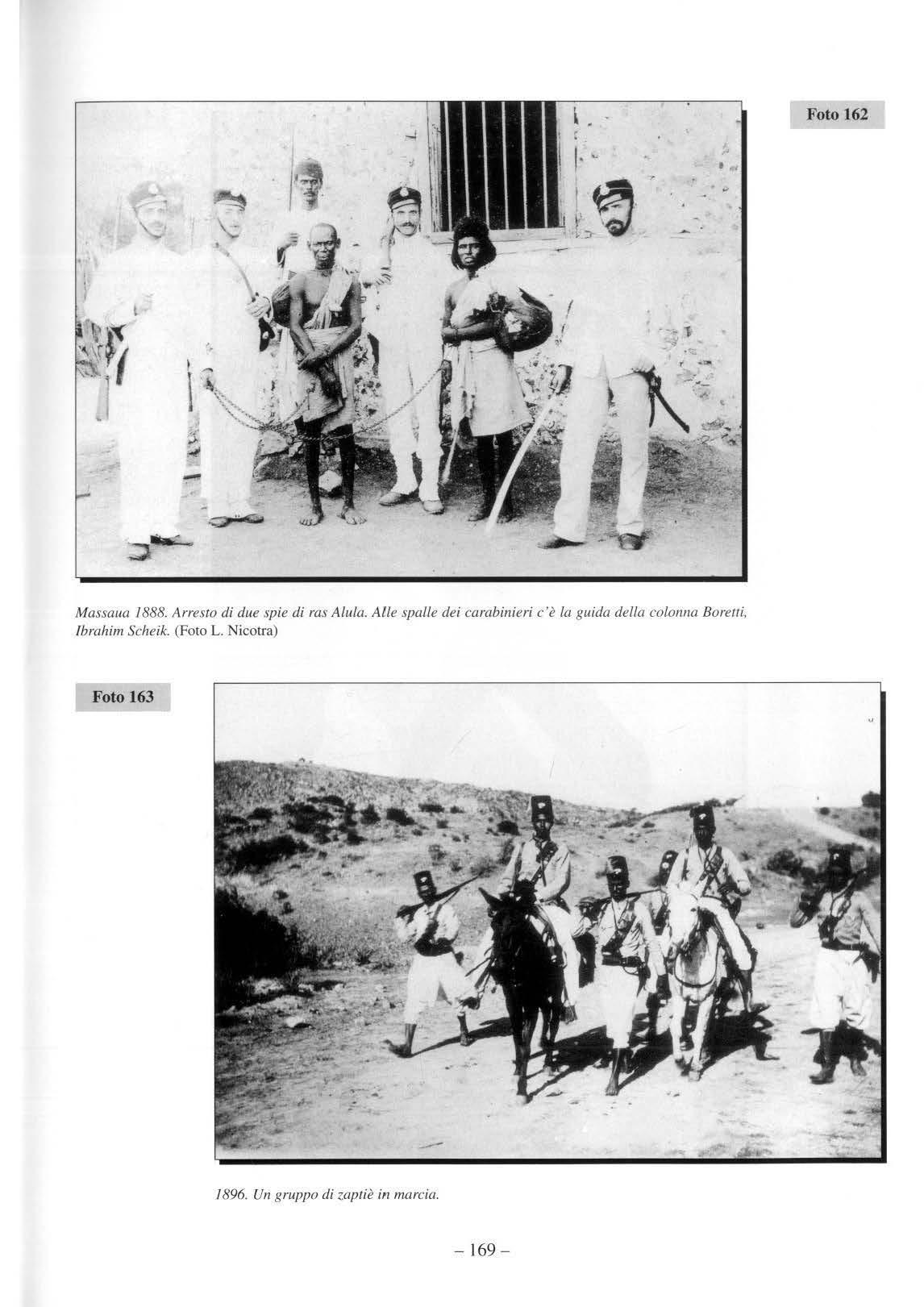

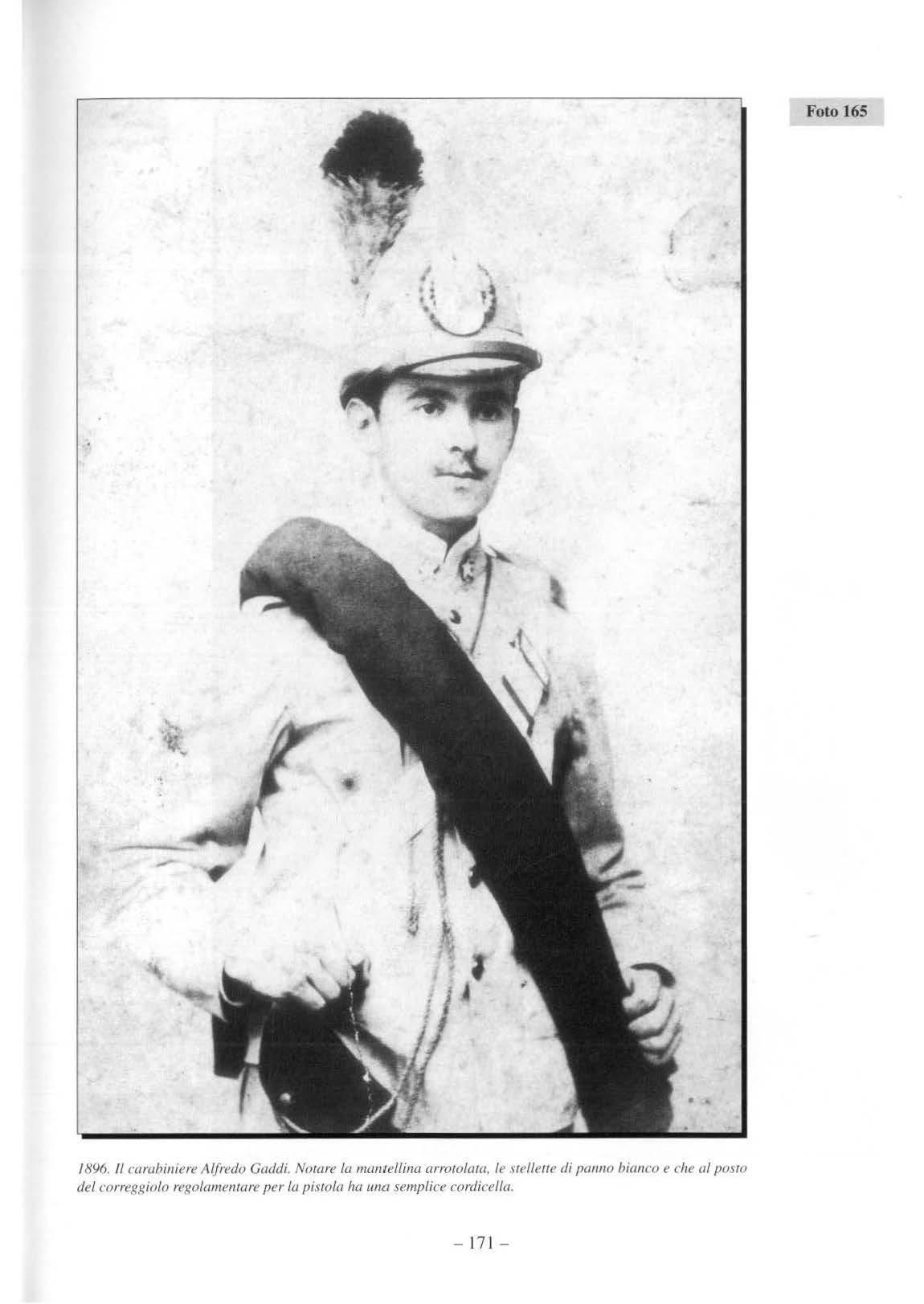
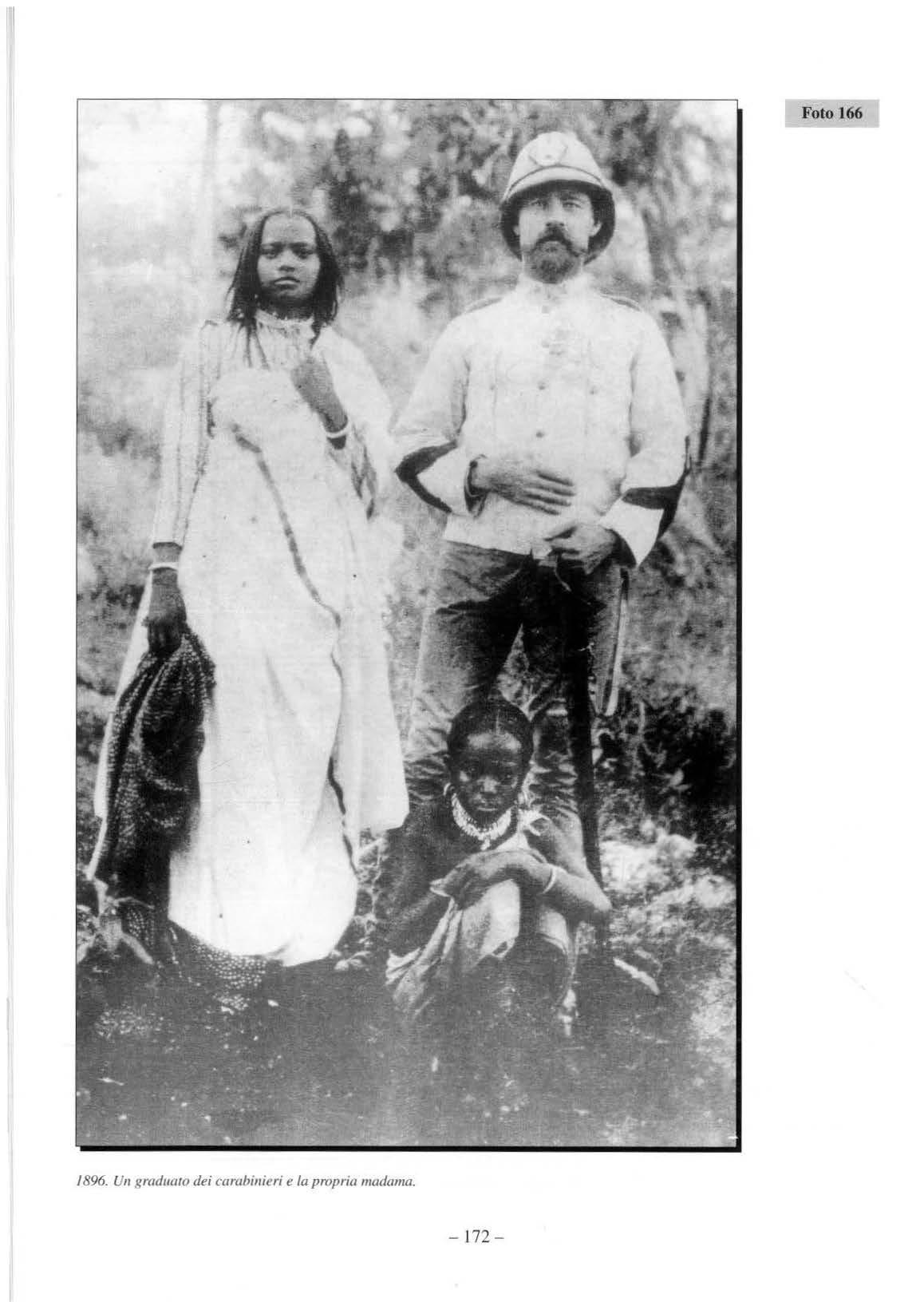
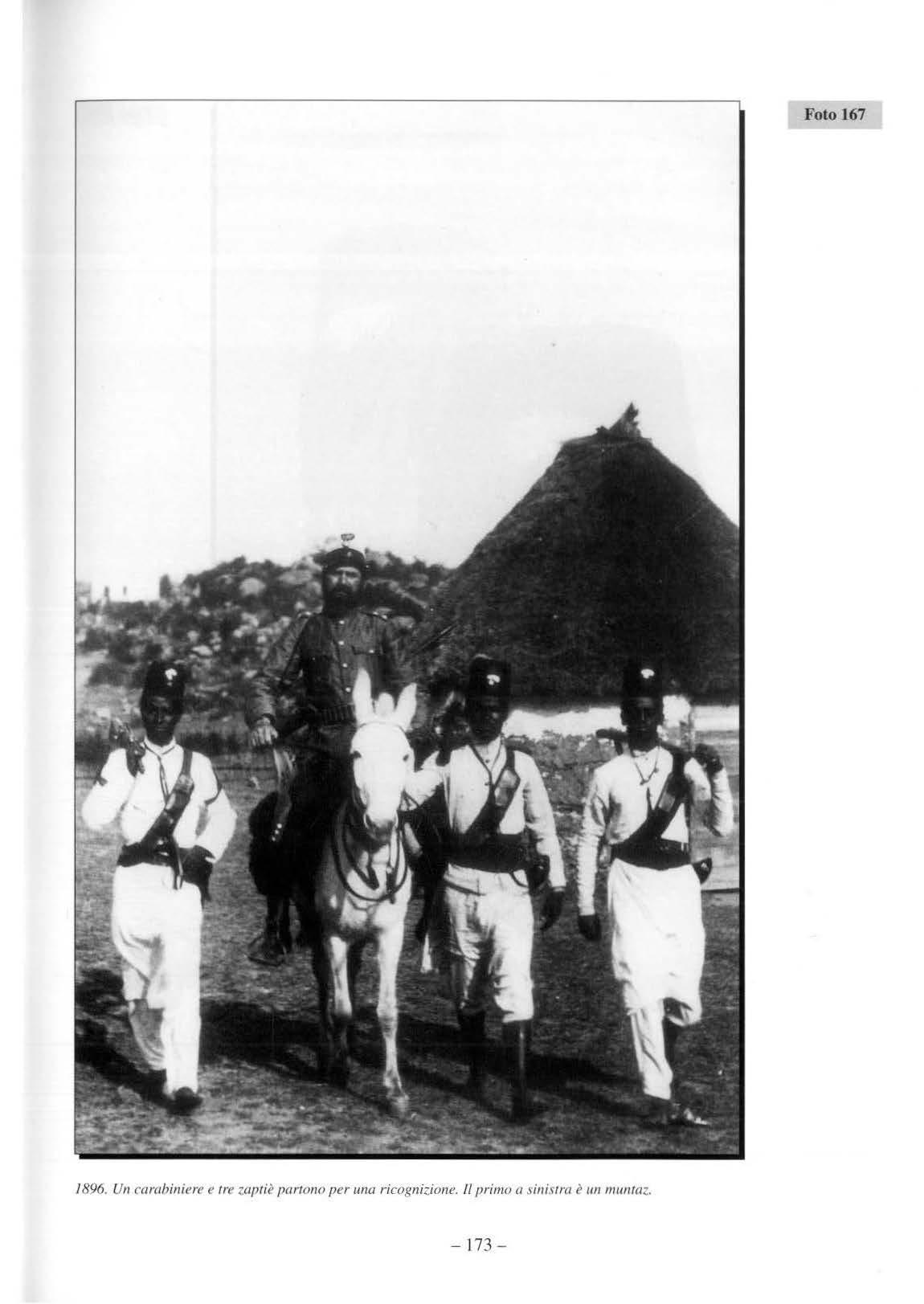

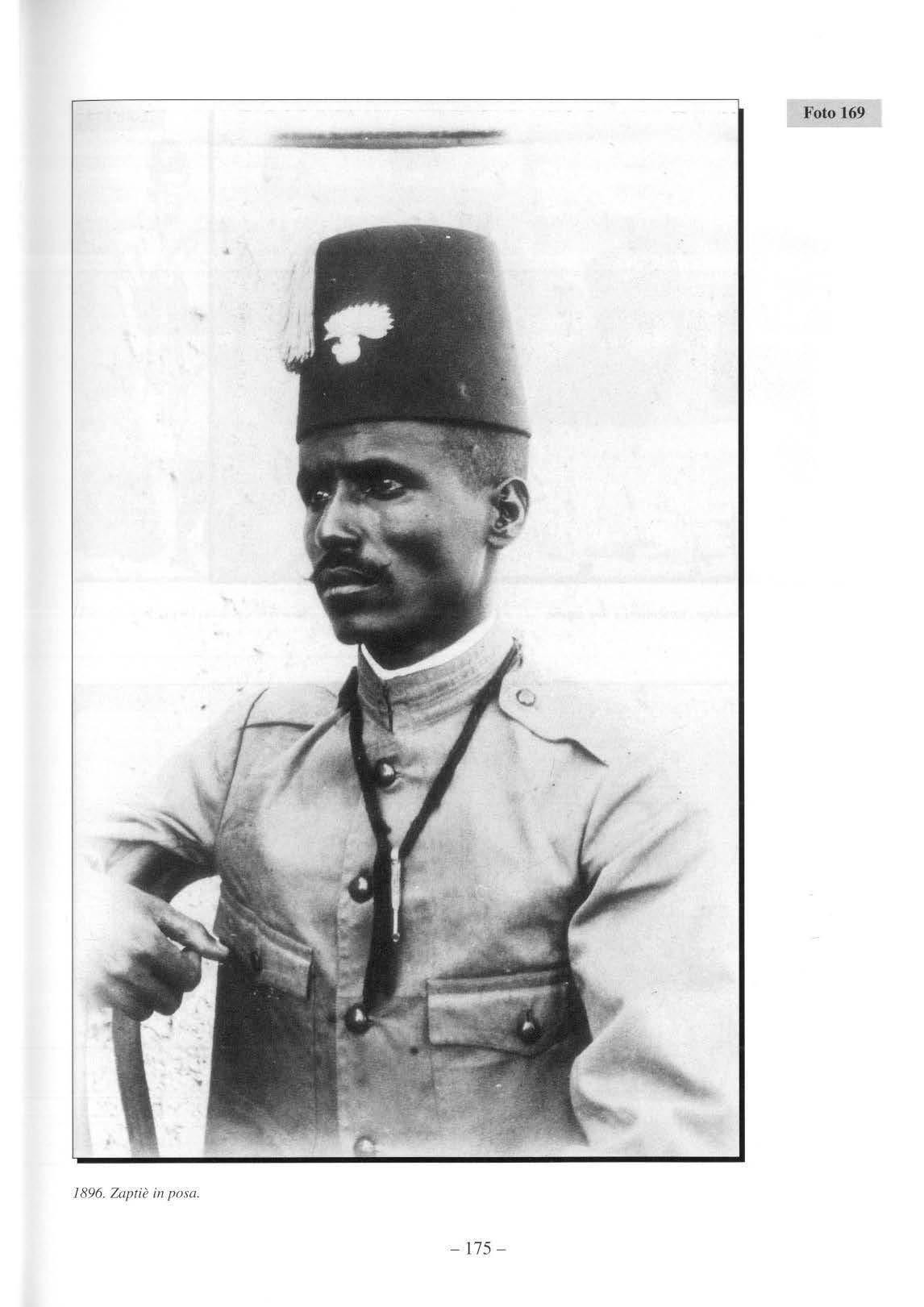
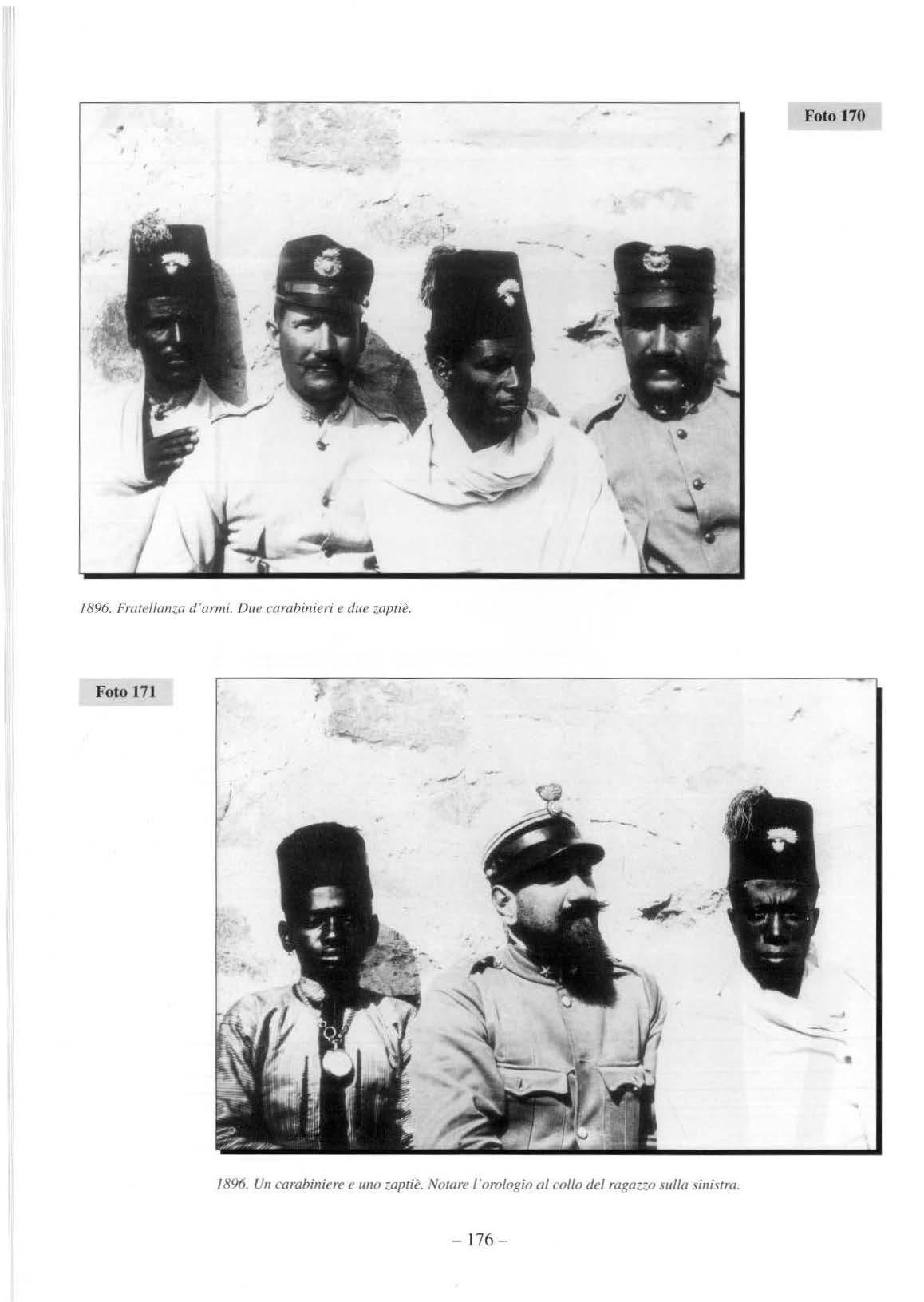
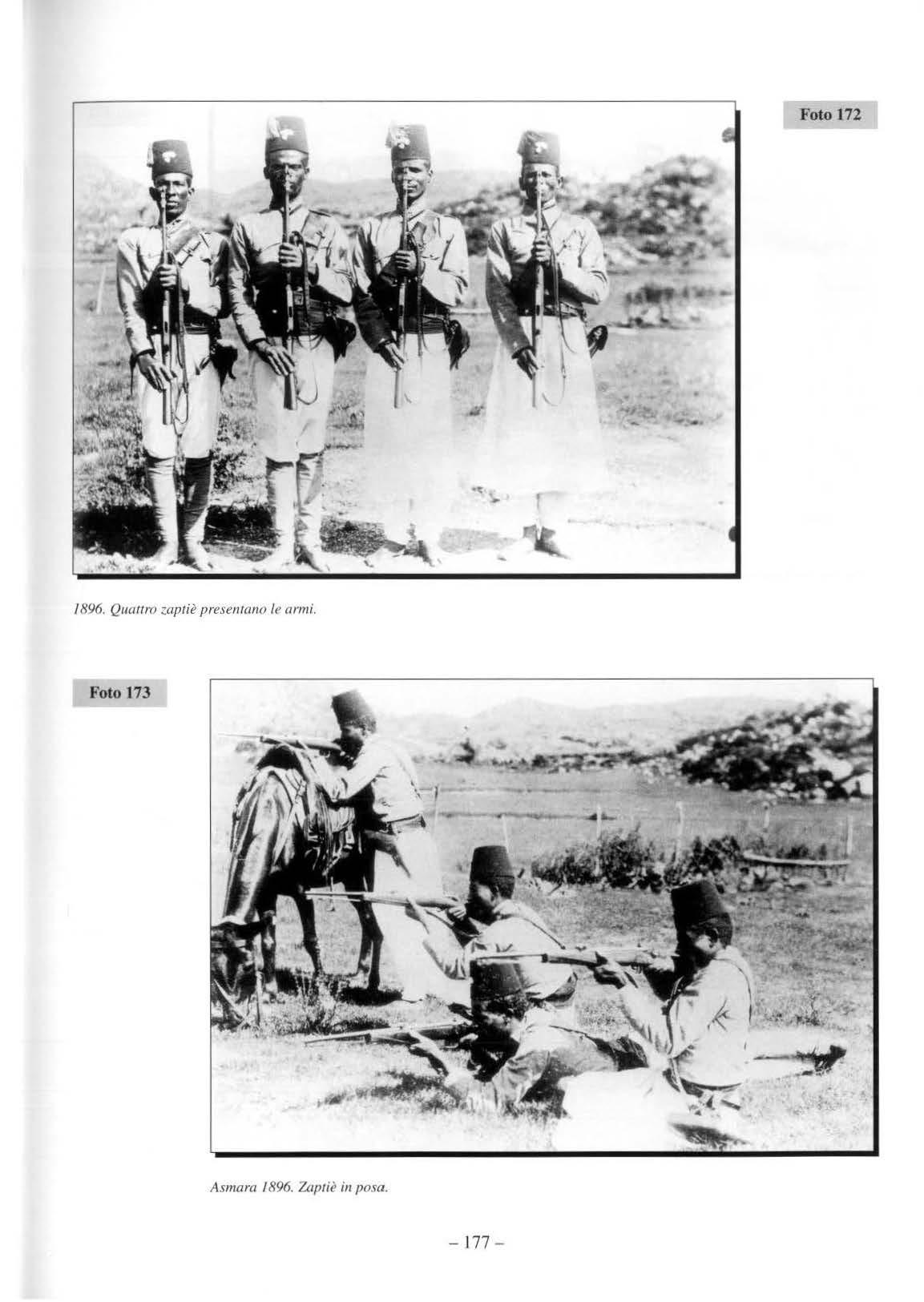
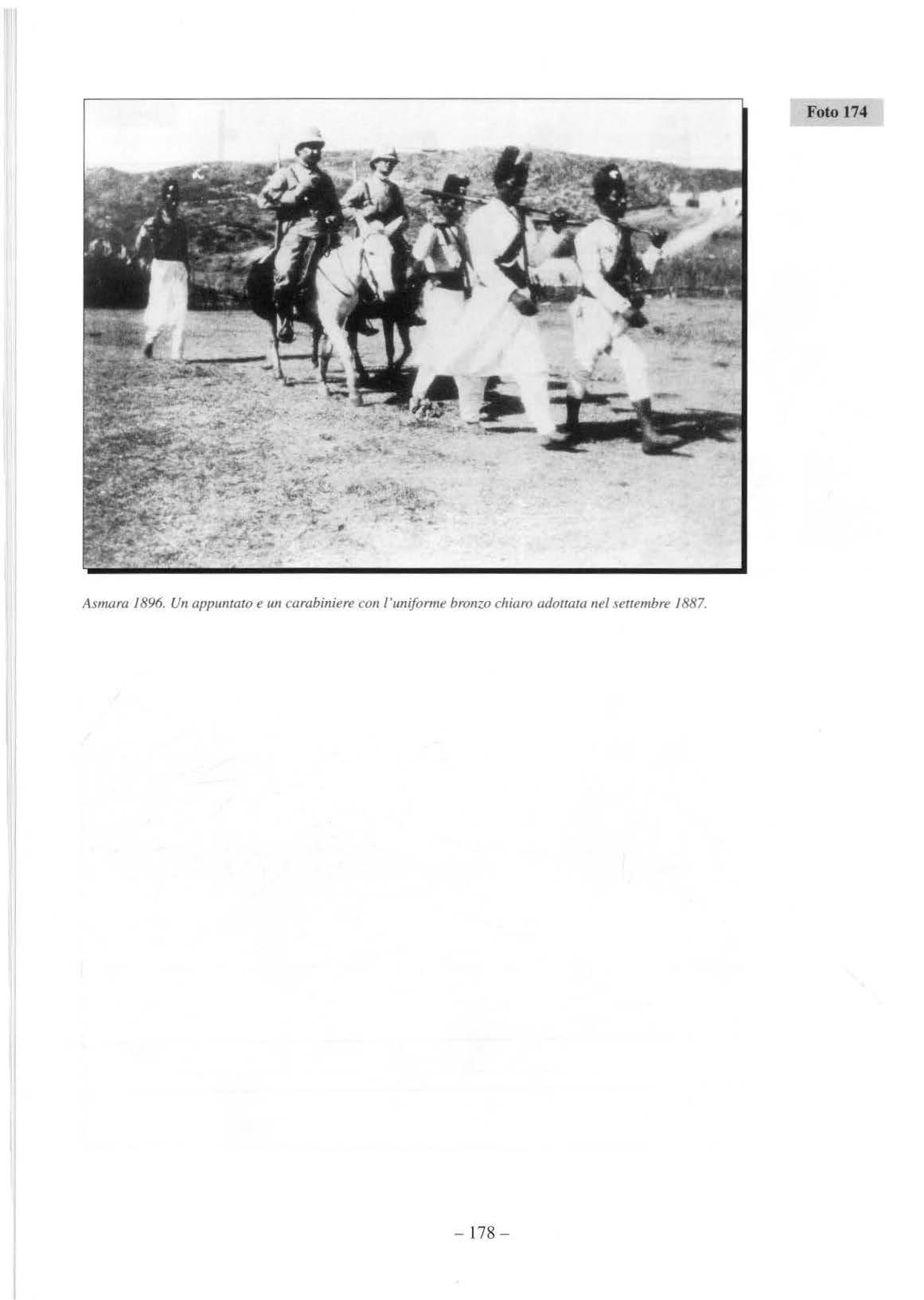

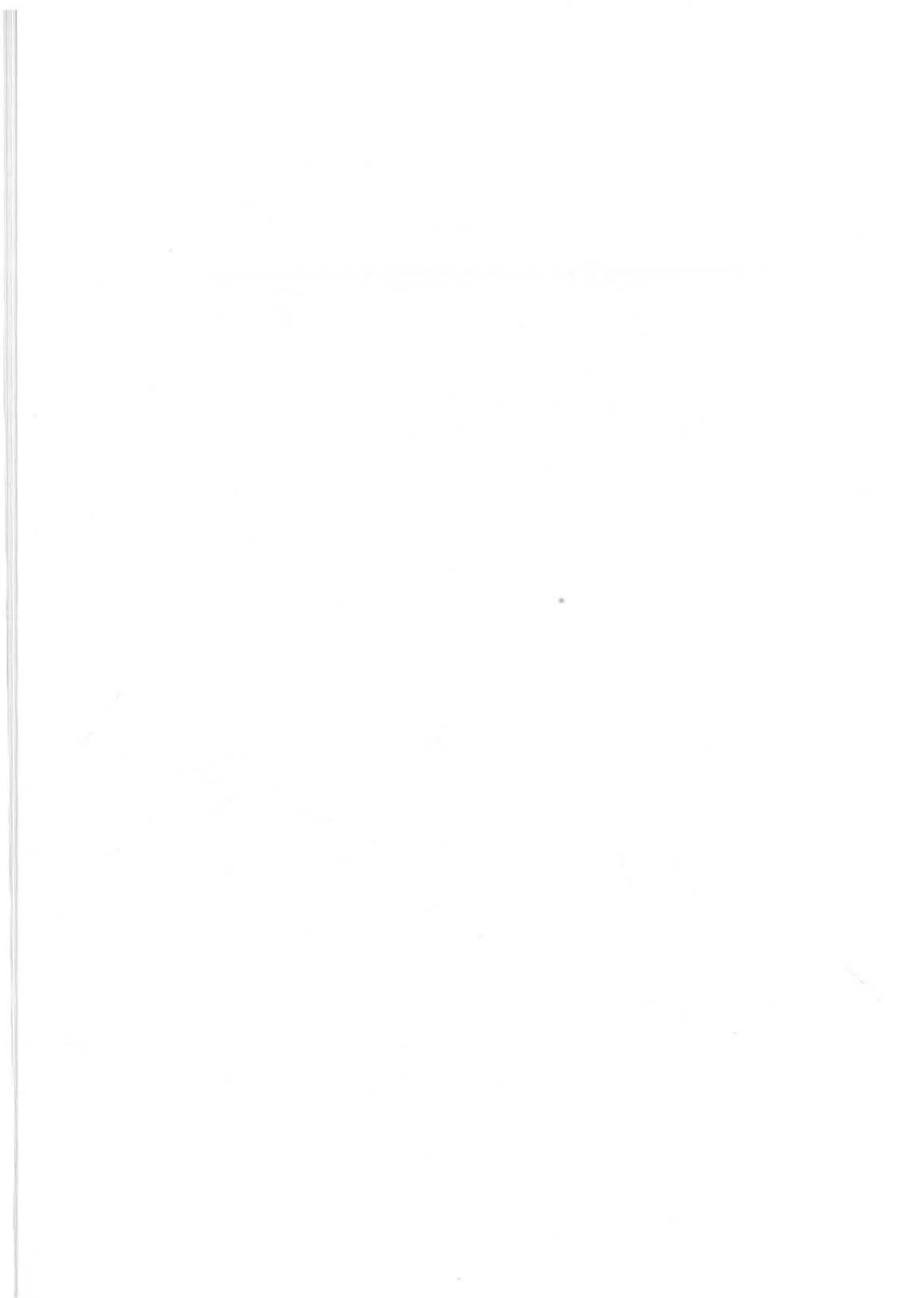
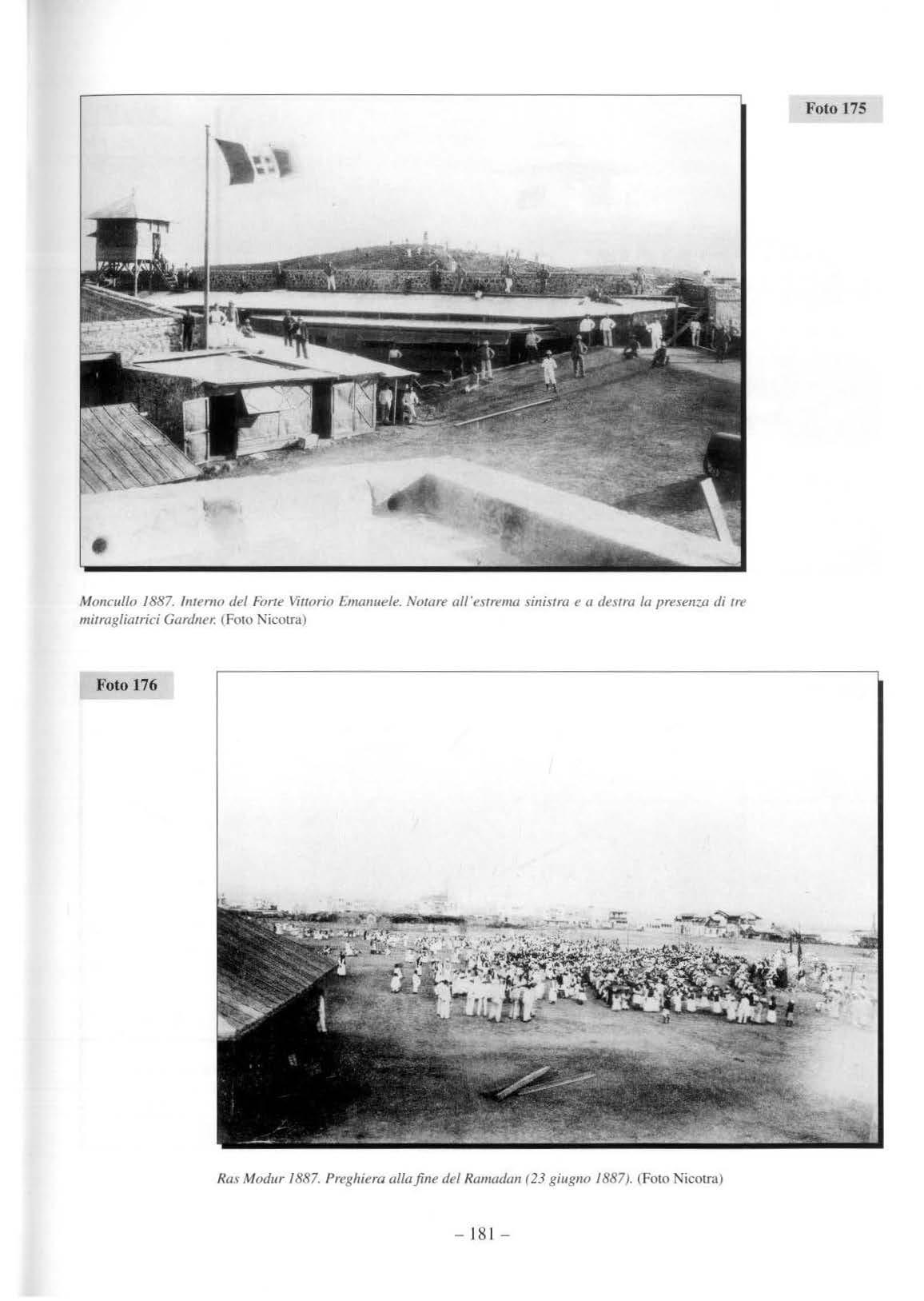 Moncullo 1887. lmemo del Forre Vìuorio Emmmele. Notare atre Hrema sinistra e a destra la presen:_a di tre mitragliatrici Gardner. (Foto 'icoLra)
Foto 176
Moncullo 1887. lmemo del Forre Vìuorio Emmmele. Notare atre Hrema sinistra e a destra la presen:_a di tre mitragliatrici Gardner. (Foto 'icoLra)
Foto 176
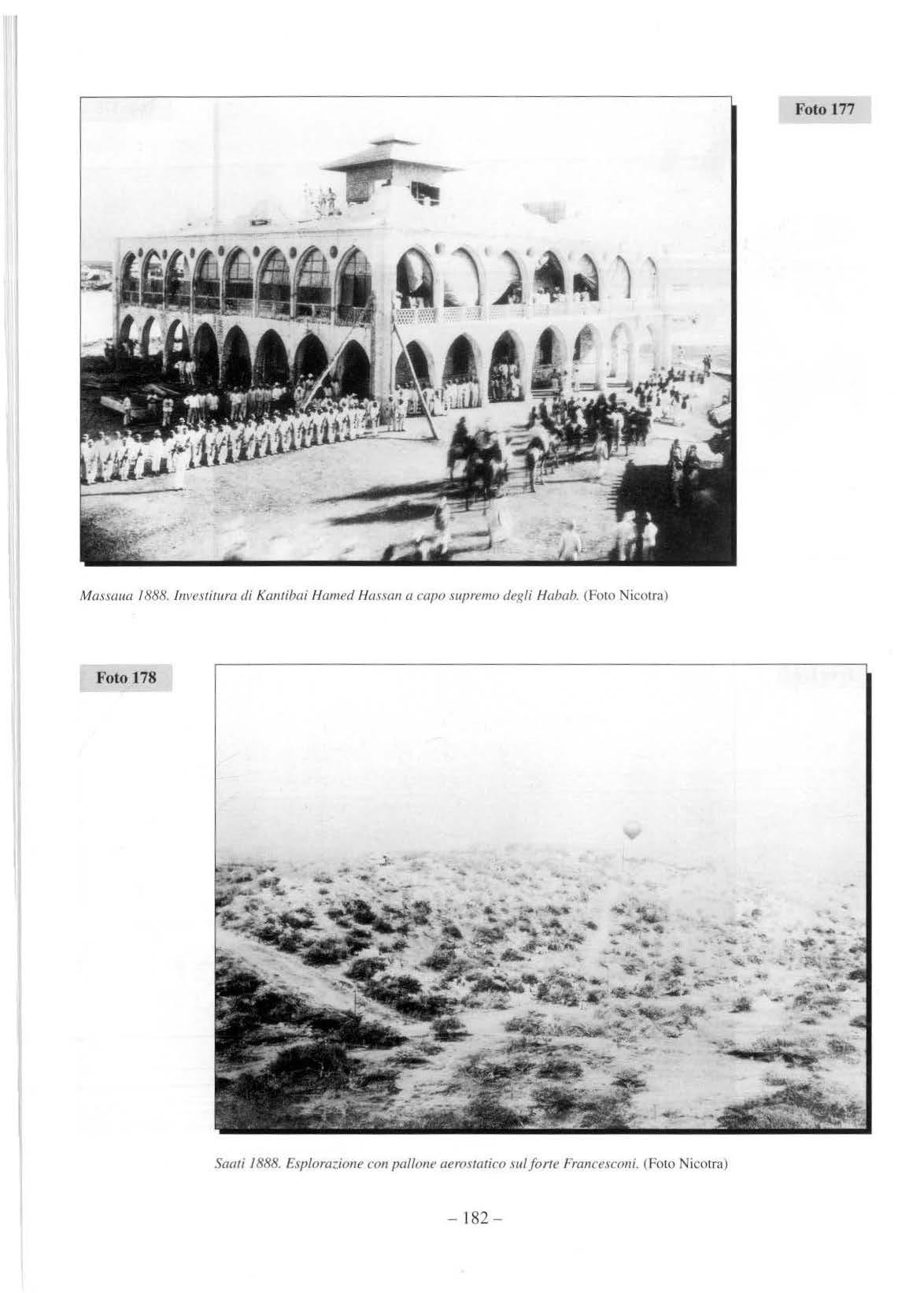
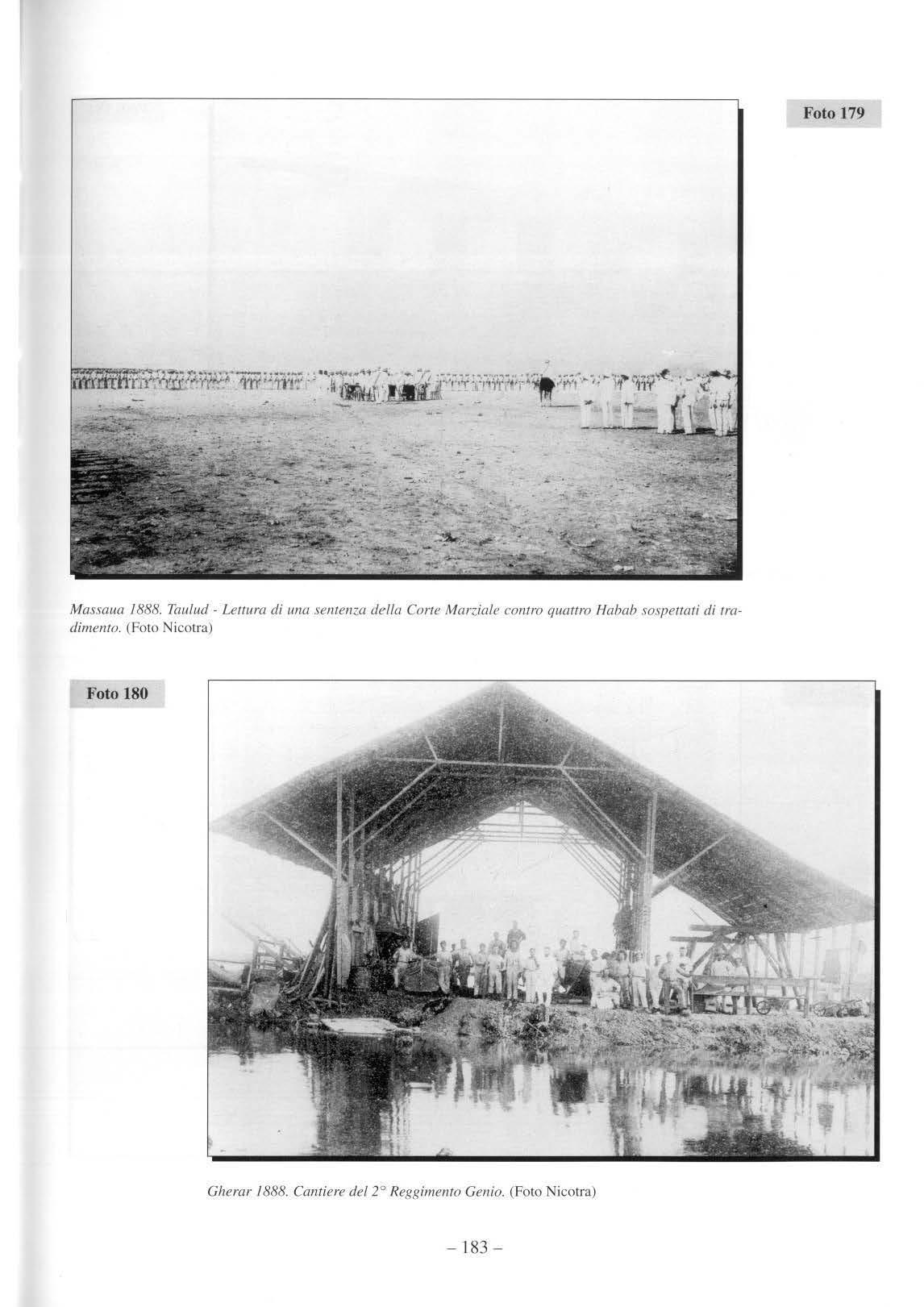 Massaua 1888. Taulud - Lellura di una sentenza della C011e Marziale contro quattro Ha!Jab sospeuati di tradimento . (Foto N ico tra)
Foto 180
Massaua 1888. Taulud - Lellura di una sentenza della C011e Marziale contro quattro Ha!Jab sospeuati di tradimento . (Foto N ico tra)
Foto 180
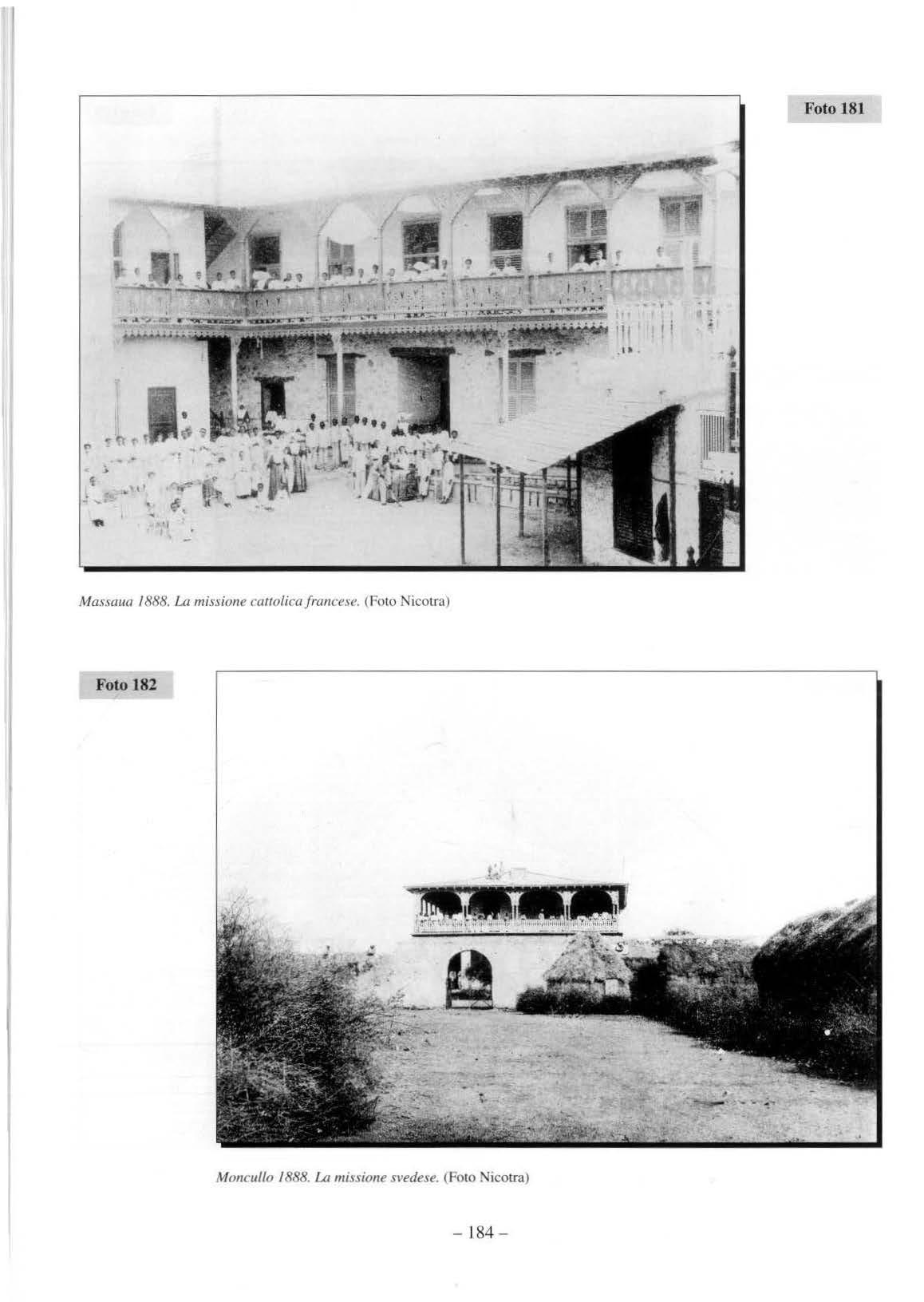

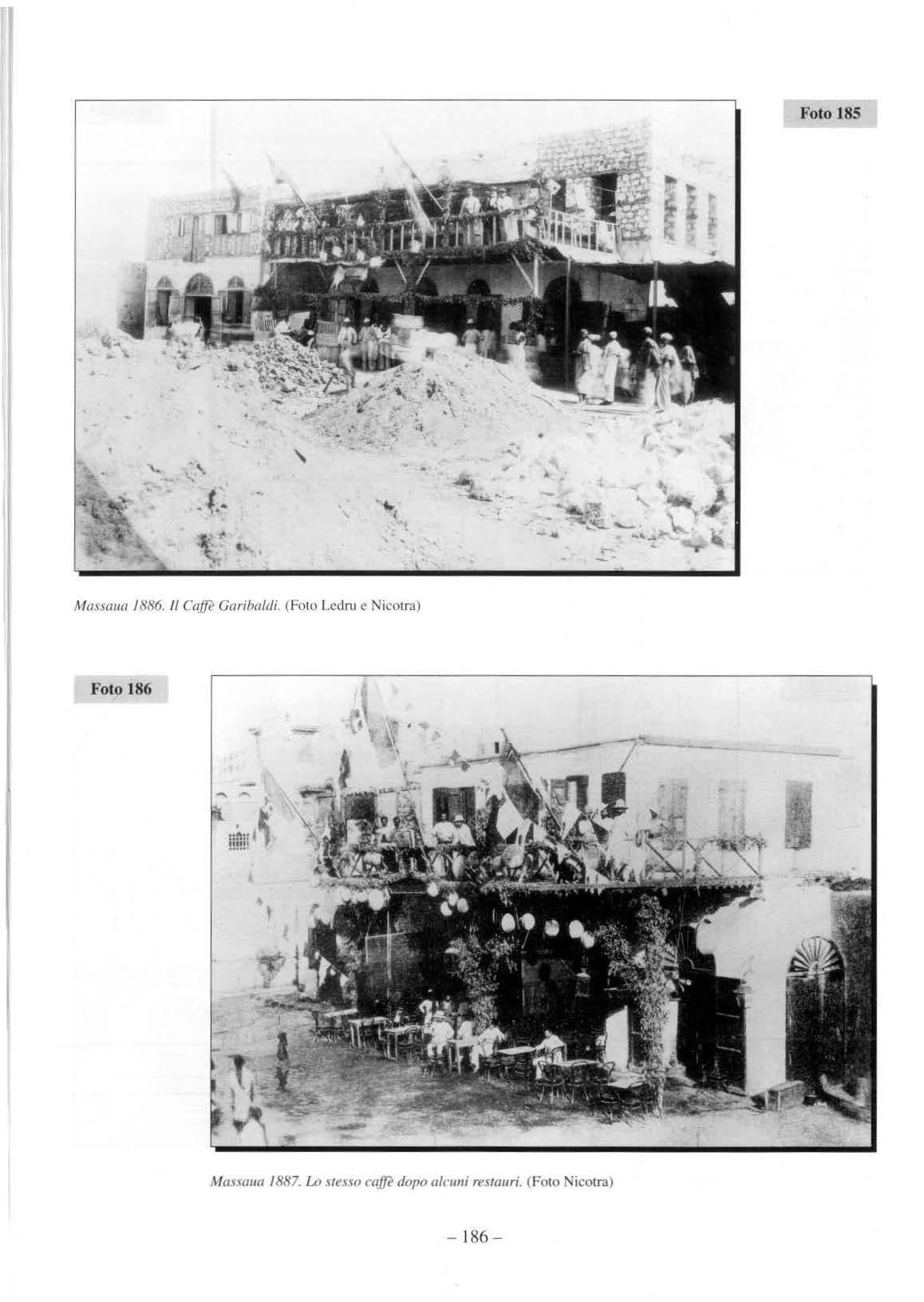 Massaua 1886. Il Caffè Garibaldi. (Foto Lcdru e Nicotra)
Massaua 1886. Il Caffè Garibaldi. (Foto Lcdru e Nicotra)
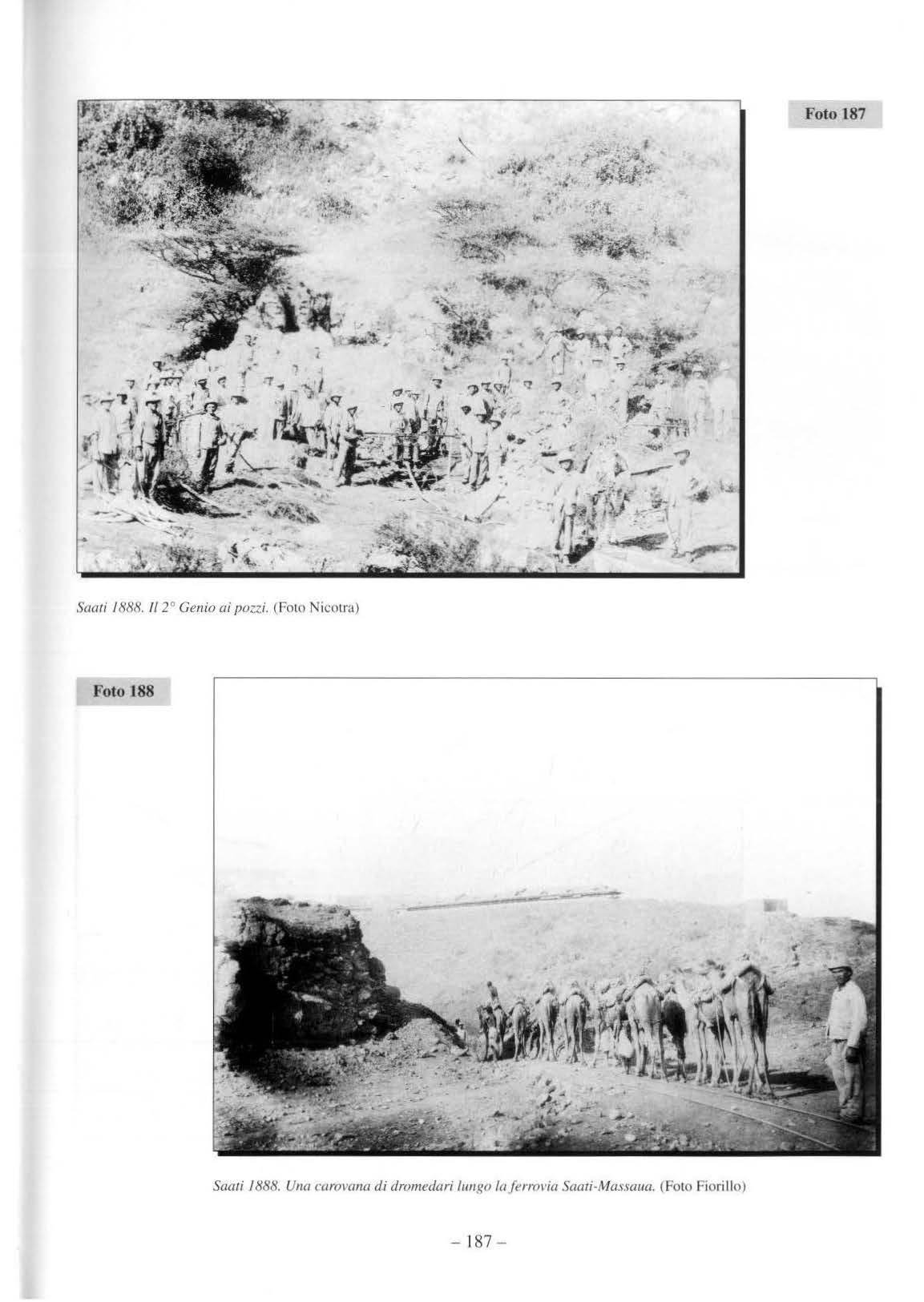
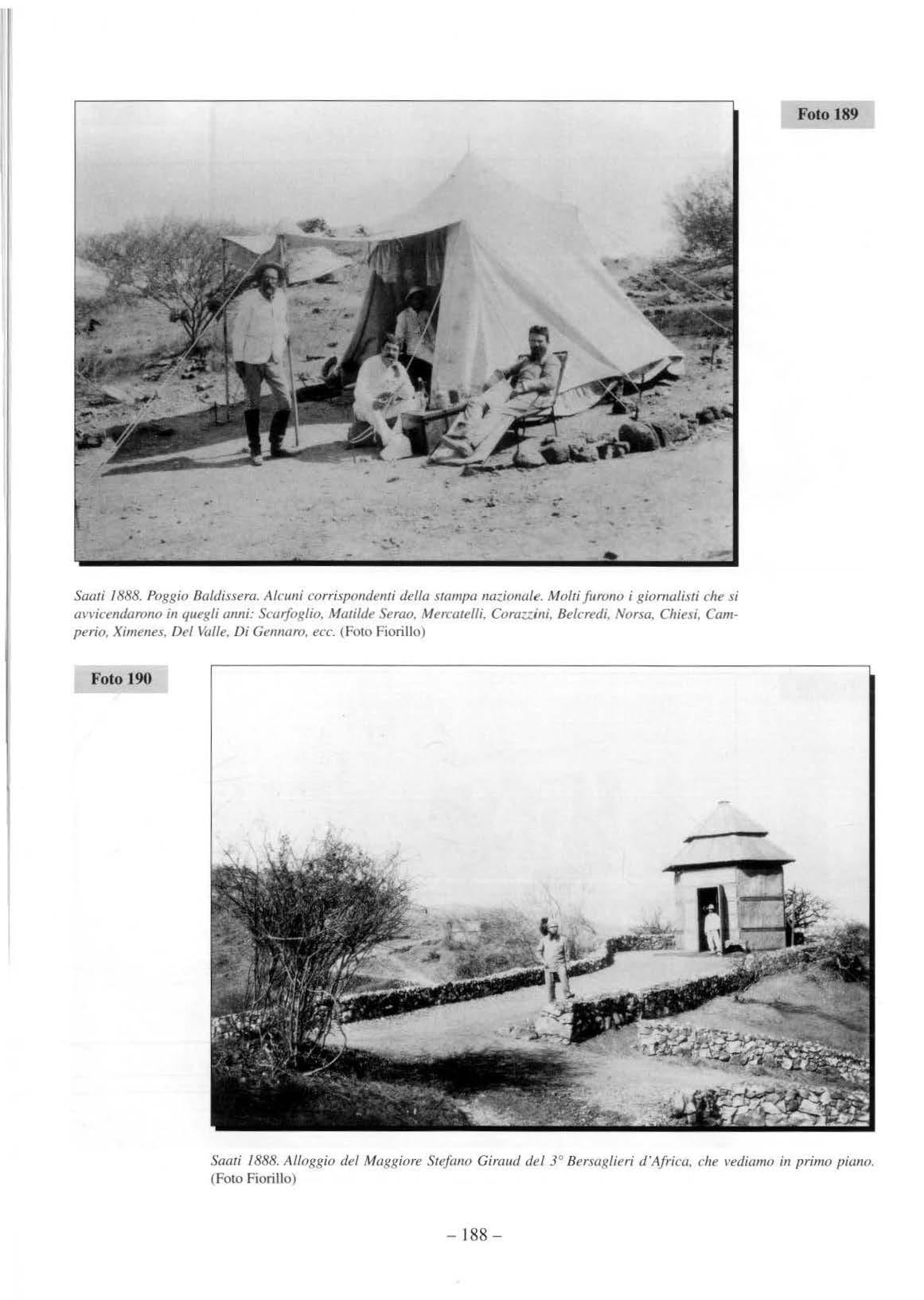
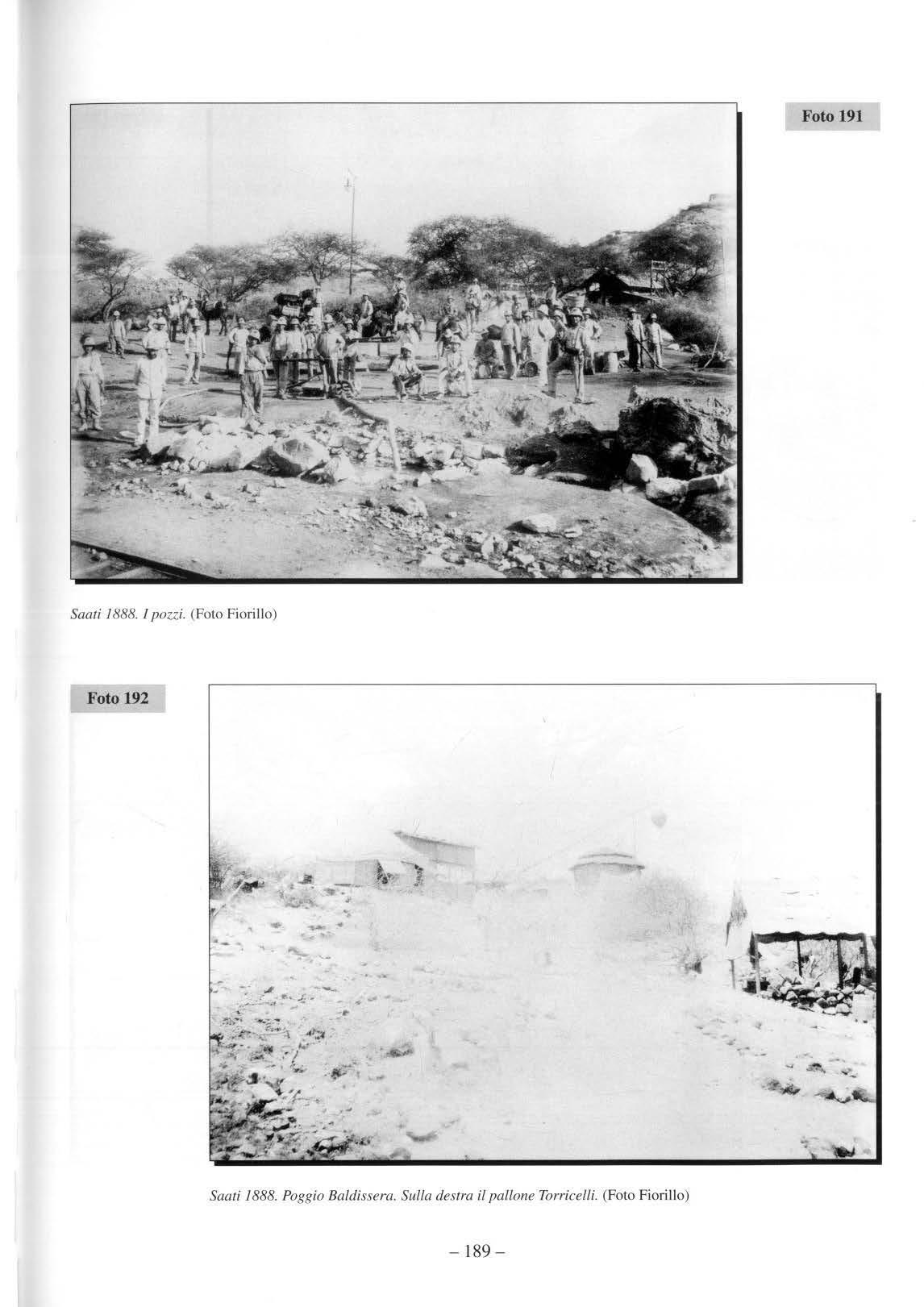
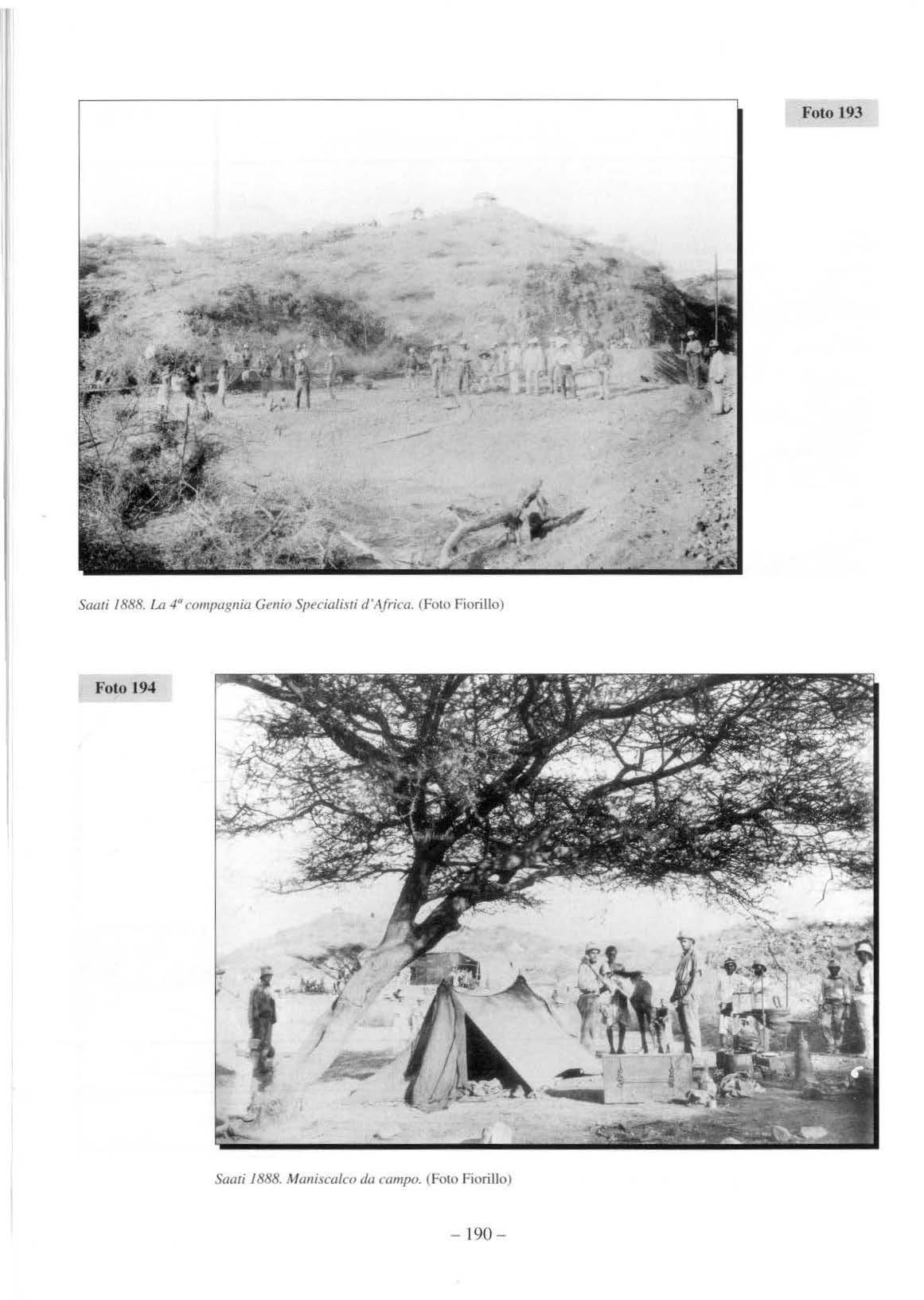
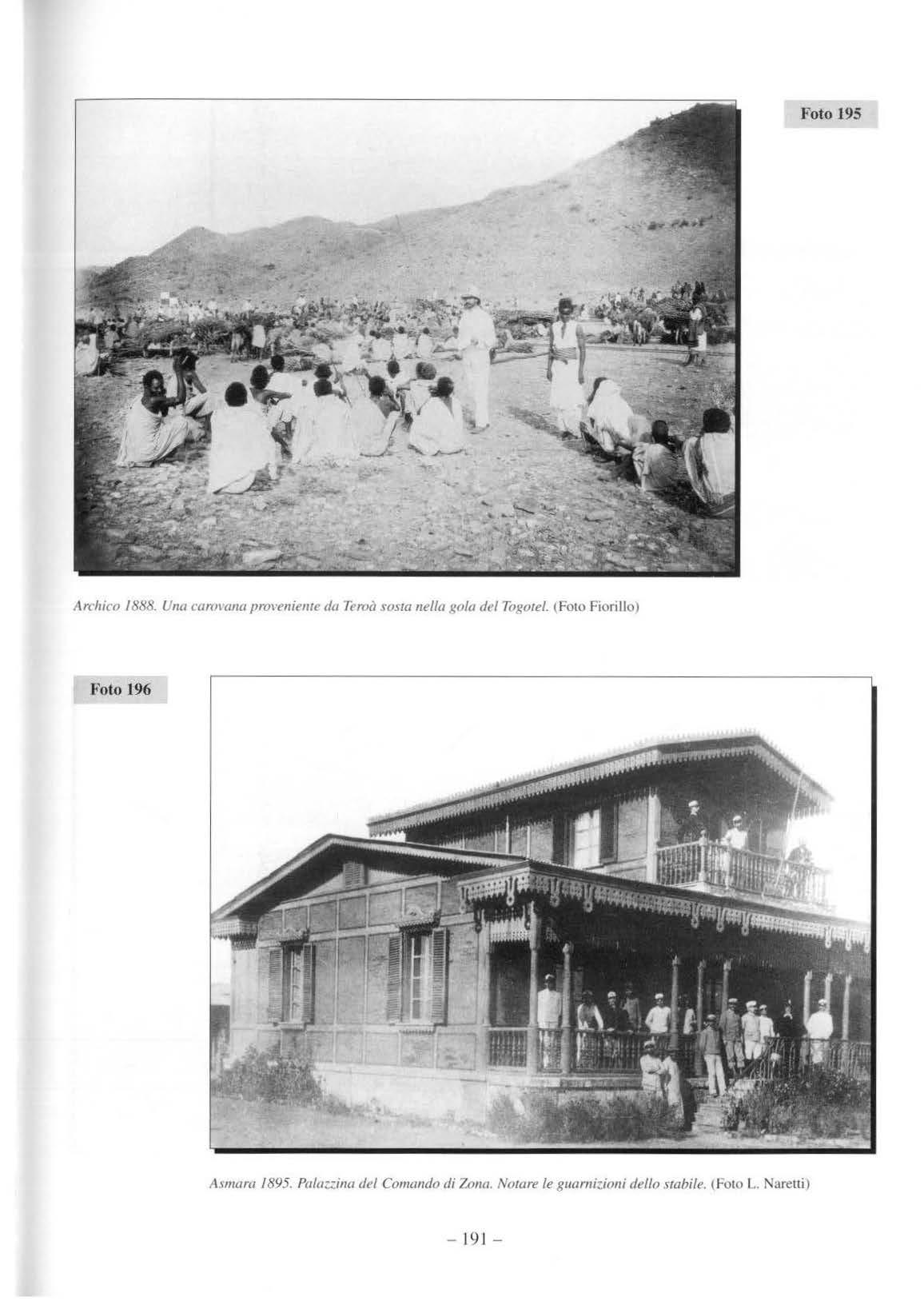
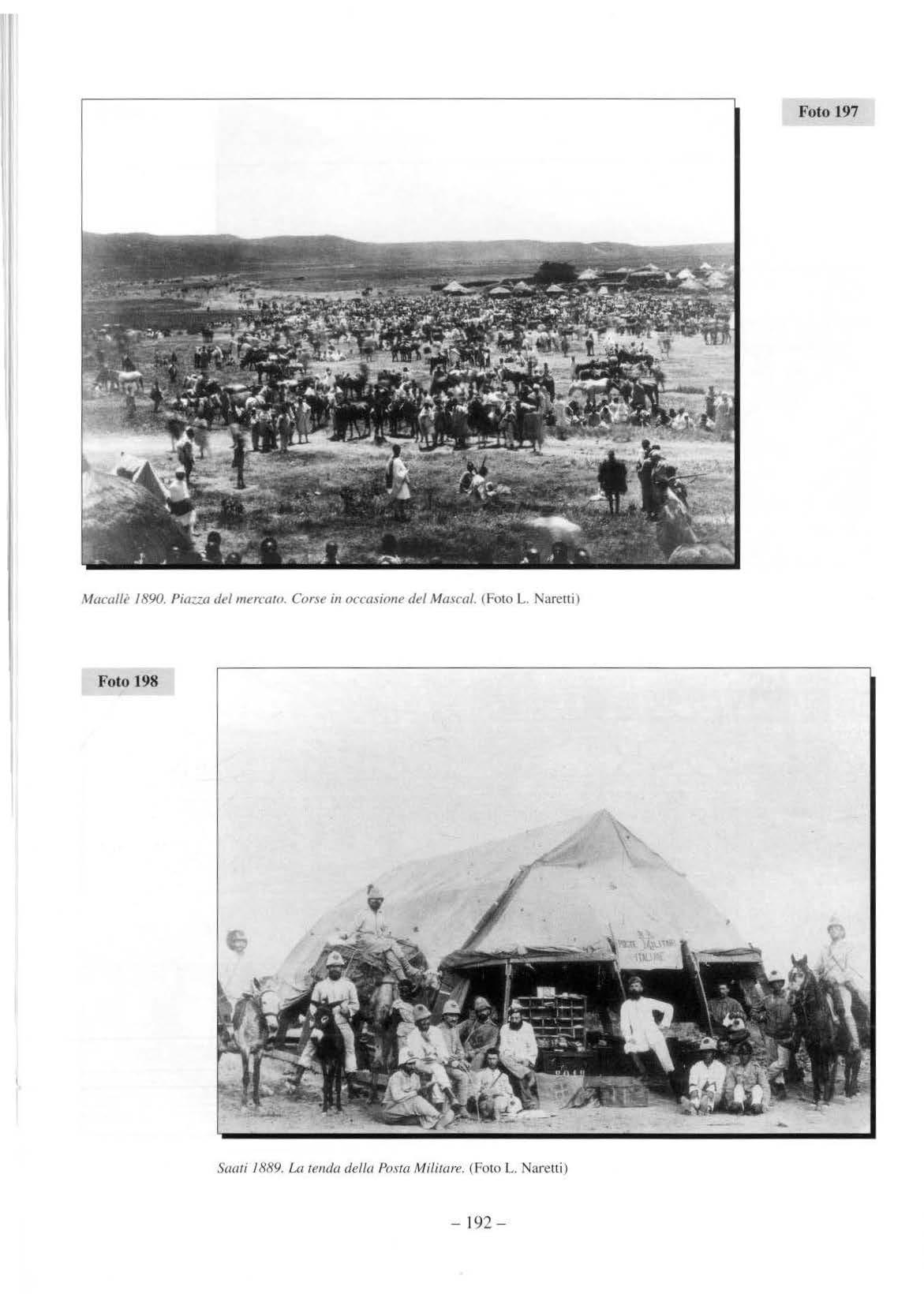
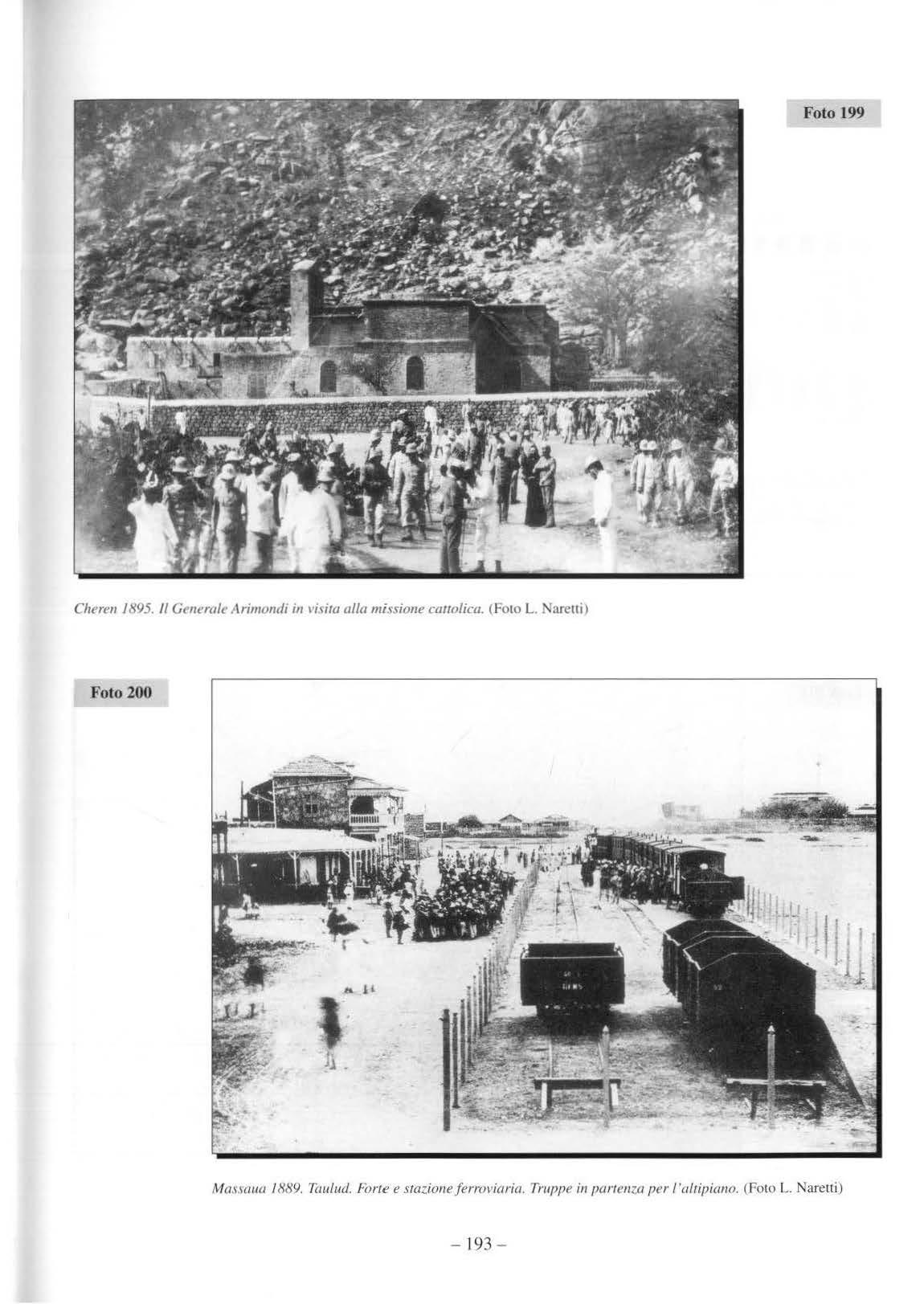
 MafSOLIO 189+. Sjìlamento di lrtlppe per celebrare la preMI di tH' \'(!/Il/lll il l+ luglio 1894. Norare la presen::.a rra le mtppe anche di marinai. !Foto L. areni)
Foto 202
MafSOLIO 189+. Sjìlamento di lrtlppe per celebrare la preMI di tH' \'(!/Il/lll il l+ luglio 1894. Norare la presen::.a rra le mtppe anche di marinai. !Foto L. areni)
Foto 202
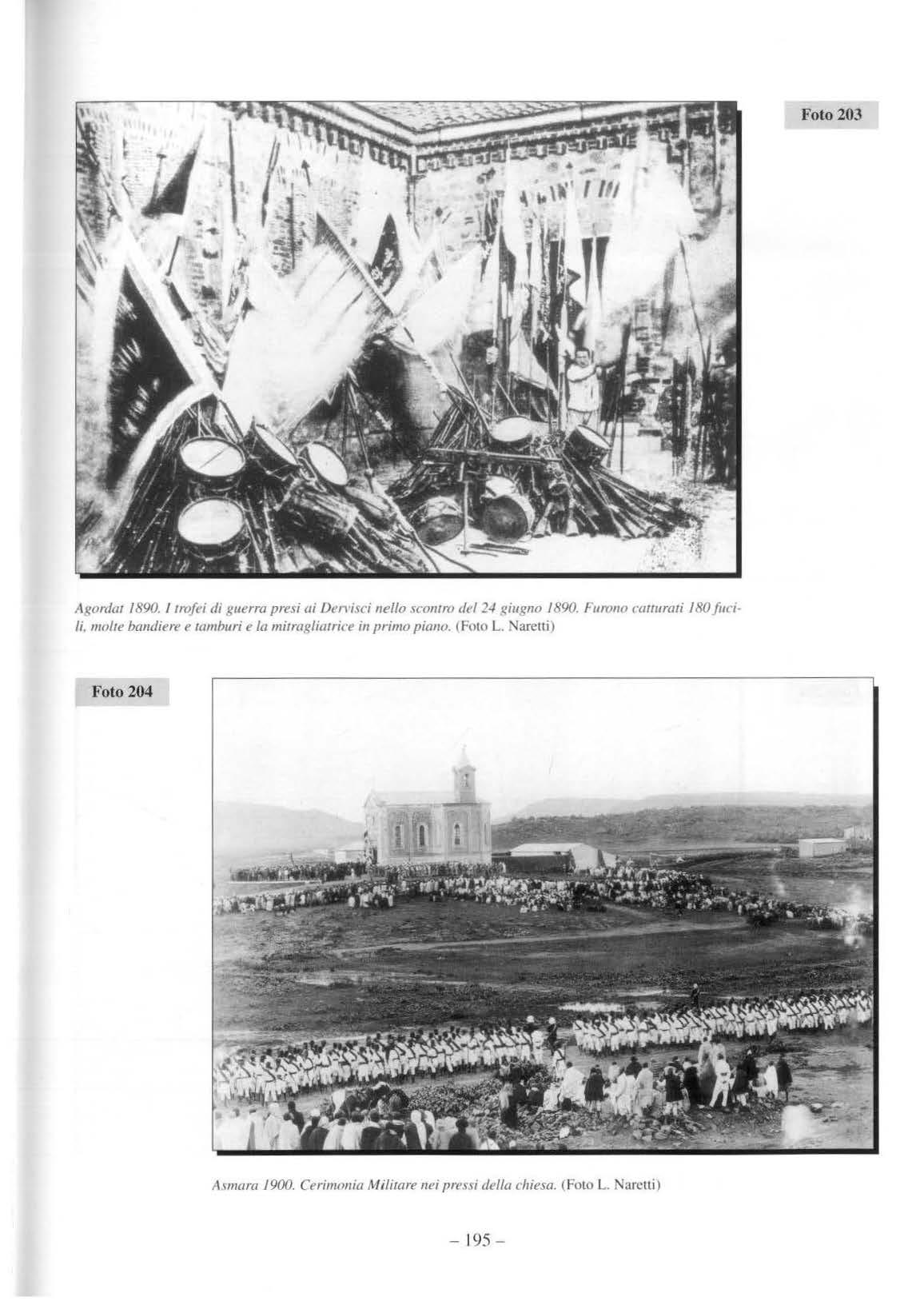 Agordat 1890. ltmfei eli guerra presi ai Derl'isci nello scoli/m del 2-4 giugno 1890. Fumnn catturati 180 fucili. molte bandiere e tamburi e la mitragliatrice in primo piano. (Foto L. , areni)
Foto 204
Agordat 1890. ltmfei eli guerra presi ai Derl'isci nello scoli/m del 2-4 giugno 1890. Fumnn catturati 180 fucili. molte bandiere e tamburi e la mitragliatrice in primo piano. (Foto L. , areni)
Foto 204
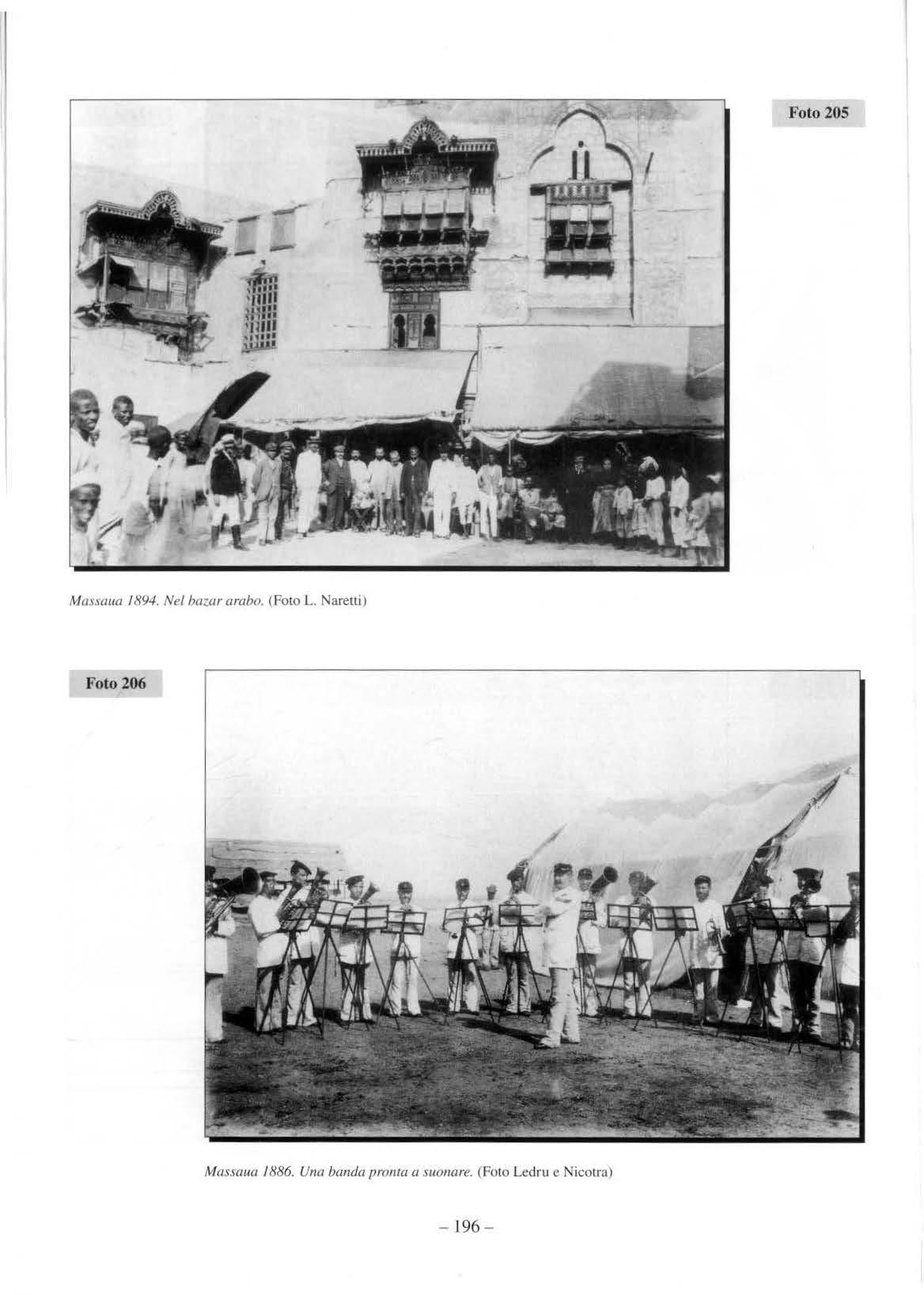
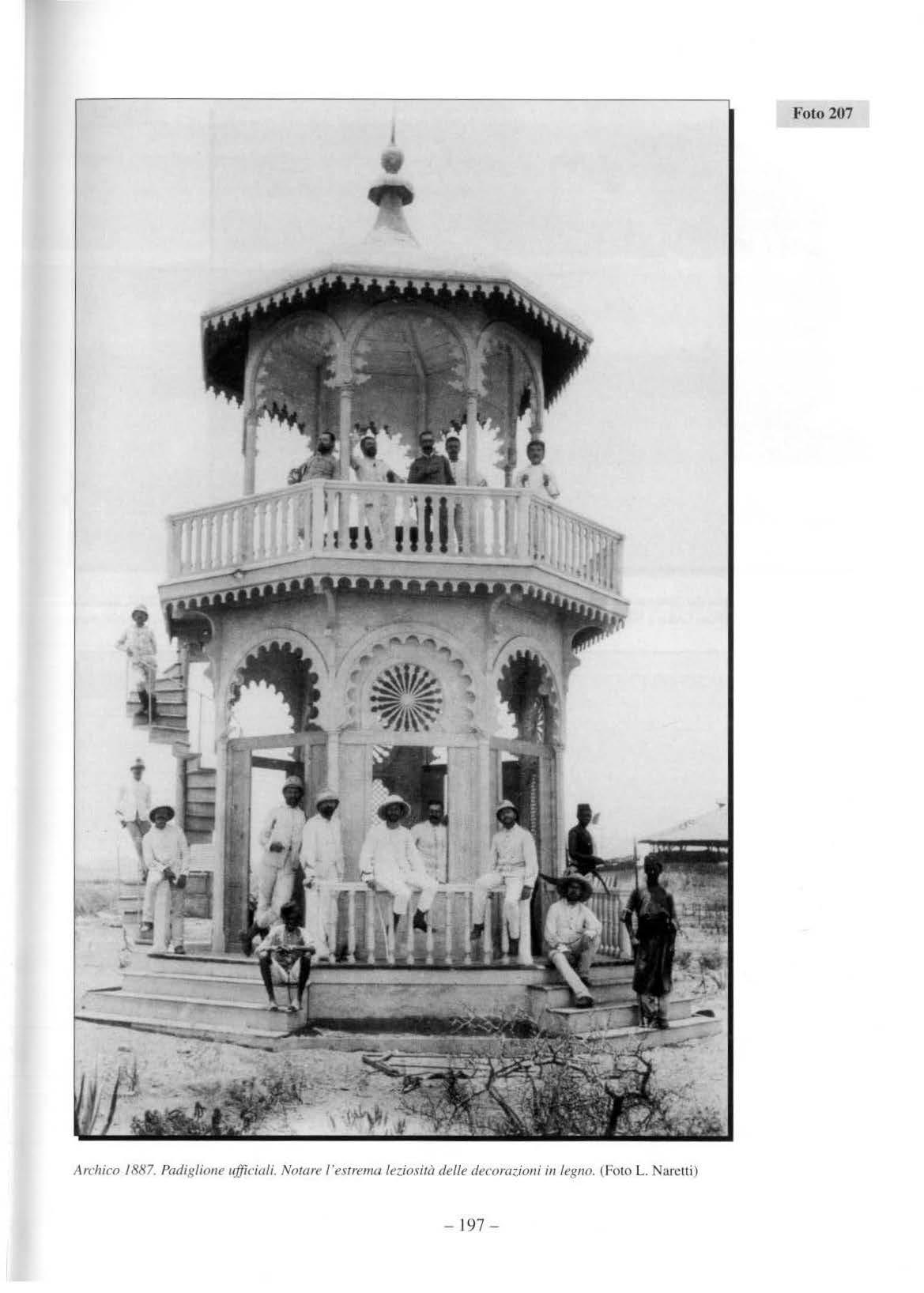
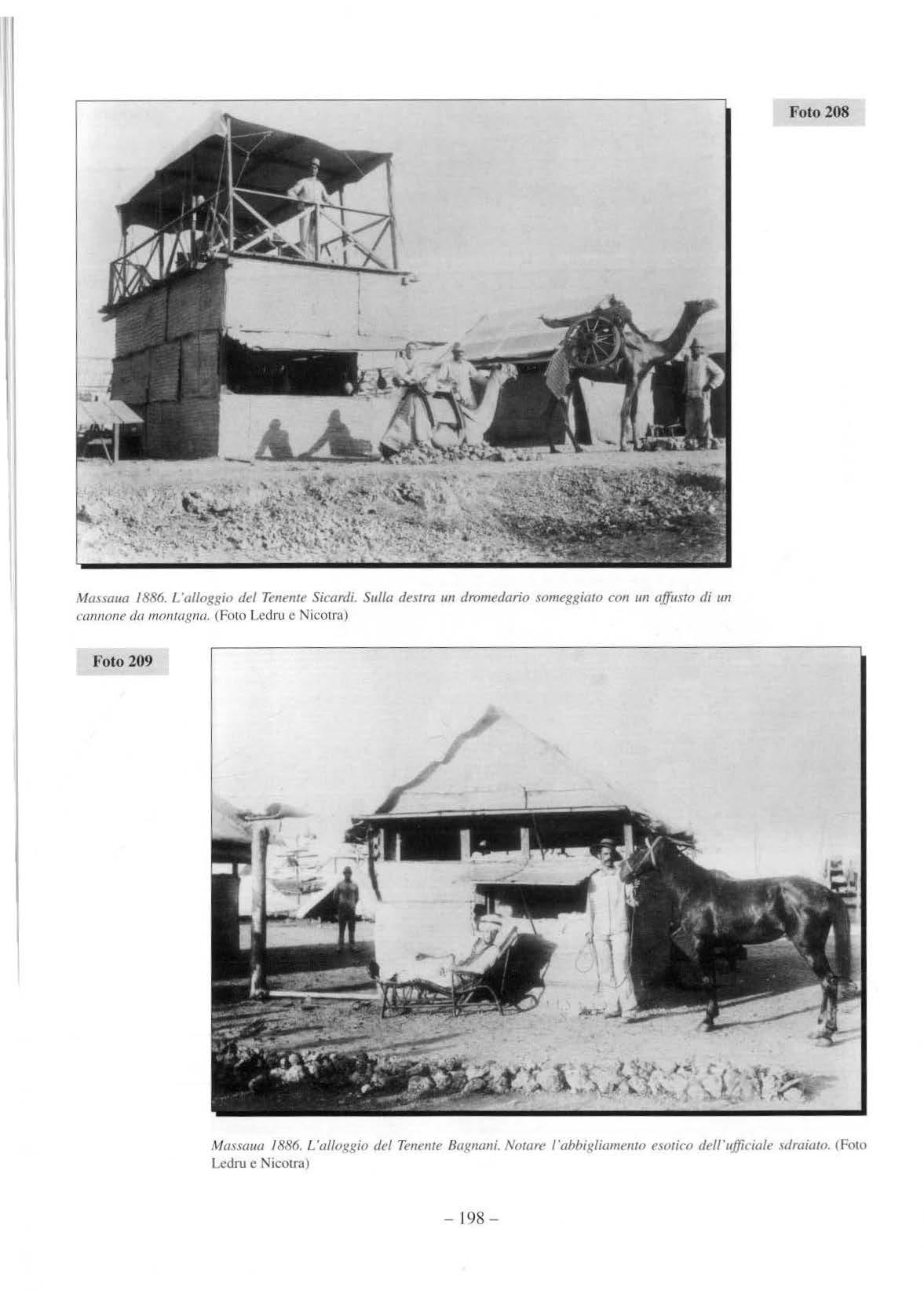 Ma:,.mua /886. l-'alloggio del Tenente Sicardi. Sulla destra 1111 dronwdario someggiaro c011 rm affusto di un can11one d(l montagna. (Foto Lcdru e Nicotra)
Ma:,.mua /886. l-'alloggio del Tenente Sicardi. Sulla destra 1111 dronwdario someggiaro c011 rm affusto di un can11one d(l montagna. (Foto Lcdru e Nicotra)
 Marsaua 1886. L'allox,;:io del Capitano Tttoman/io. Notare /a fascia a::.::.urra sul casco dell'ufficiale. (Foto Ledru e ' icotral
Foto 211
Marsaua 1886. L'allox,;:io del Capitano Tttoman/io. Notare /a fascia a::.::.urra sul casco dell'ufficiale. (Foto Ledru e ' icotral
Foto 211
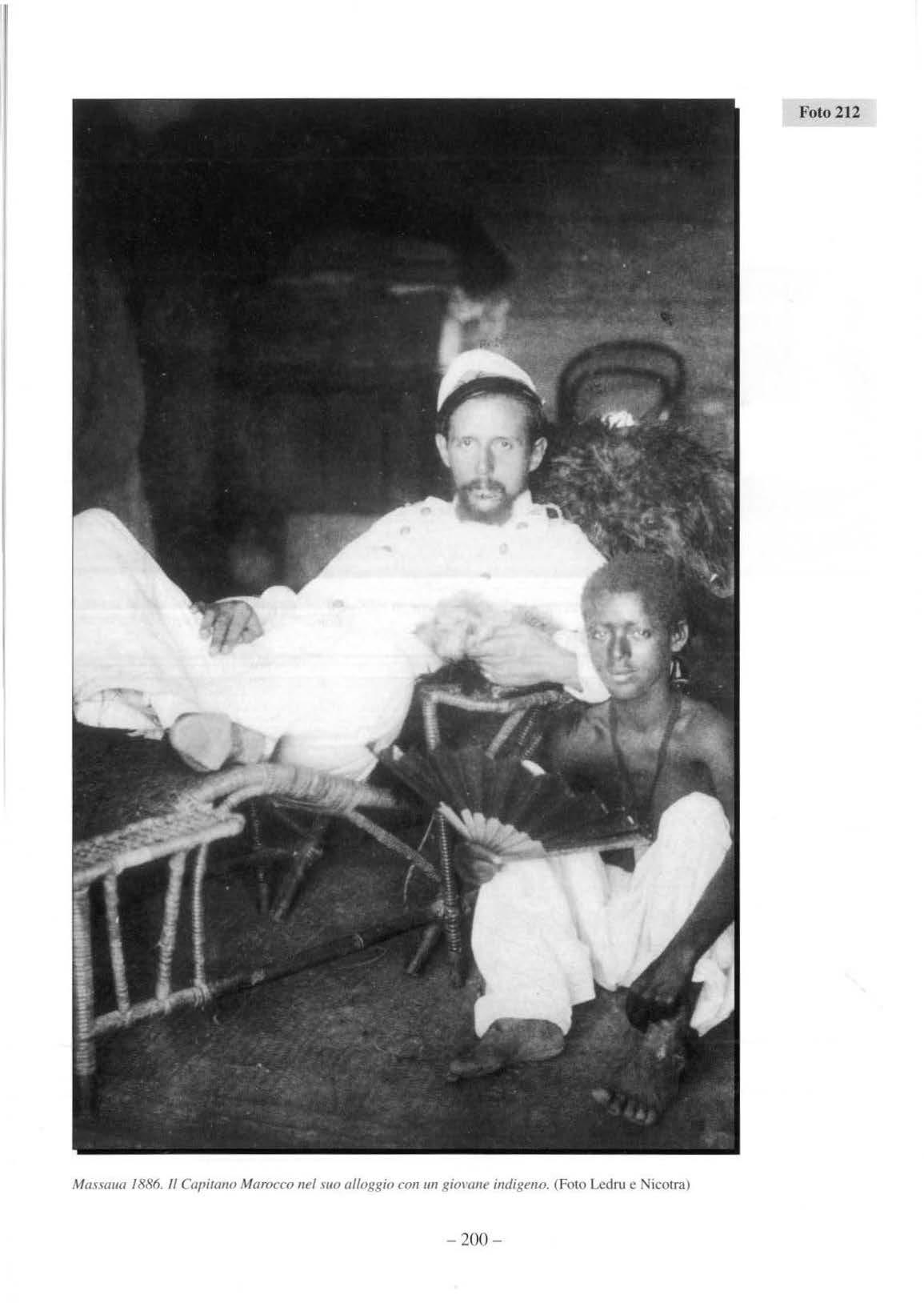
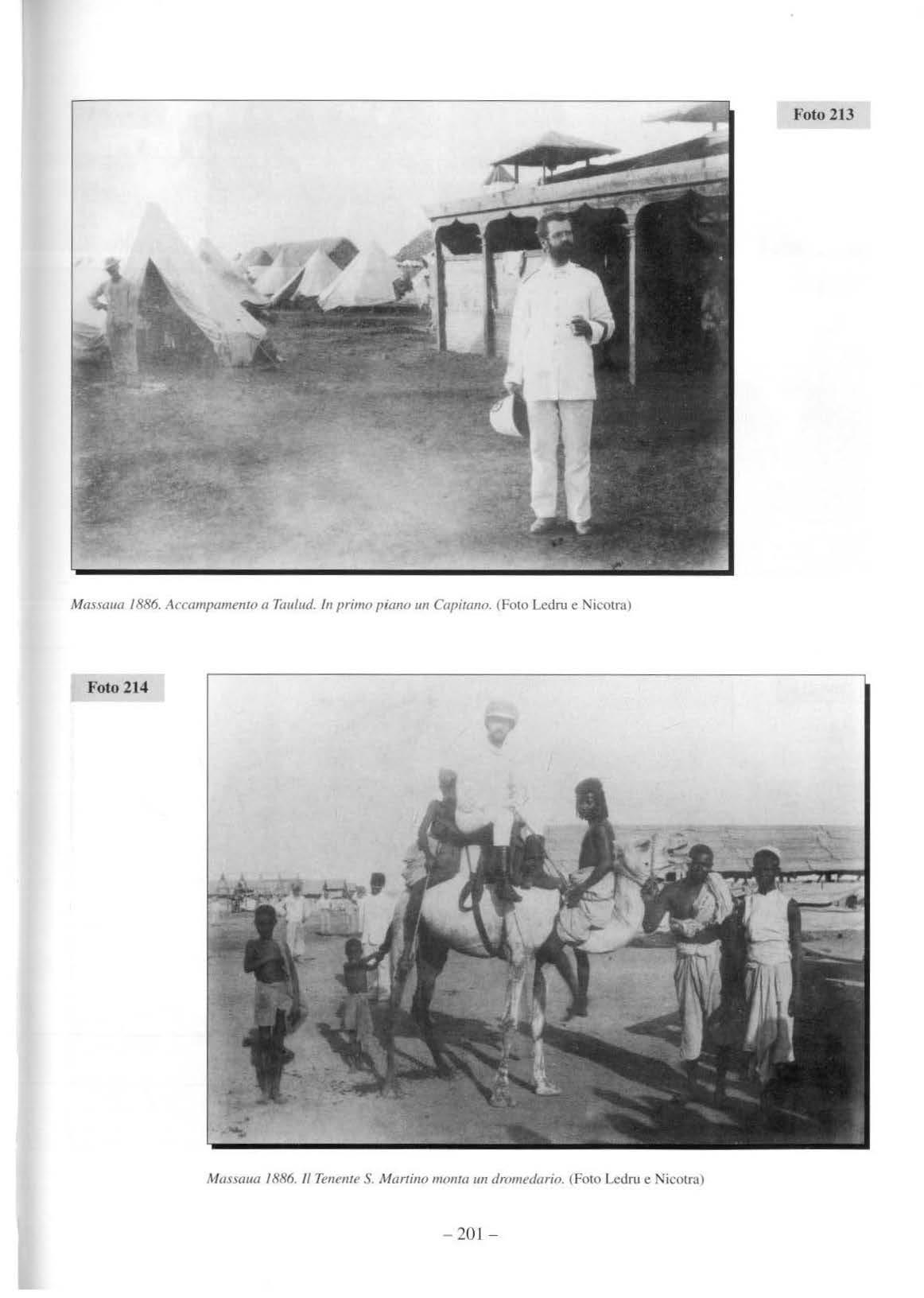
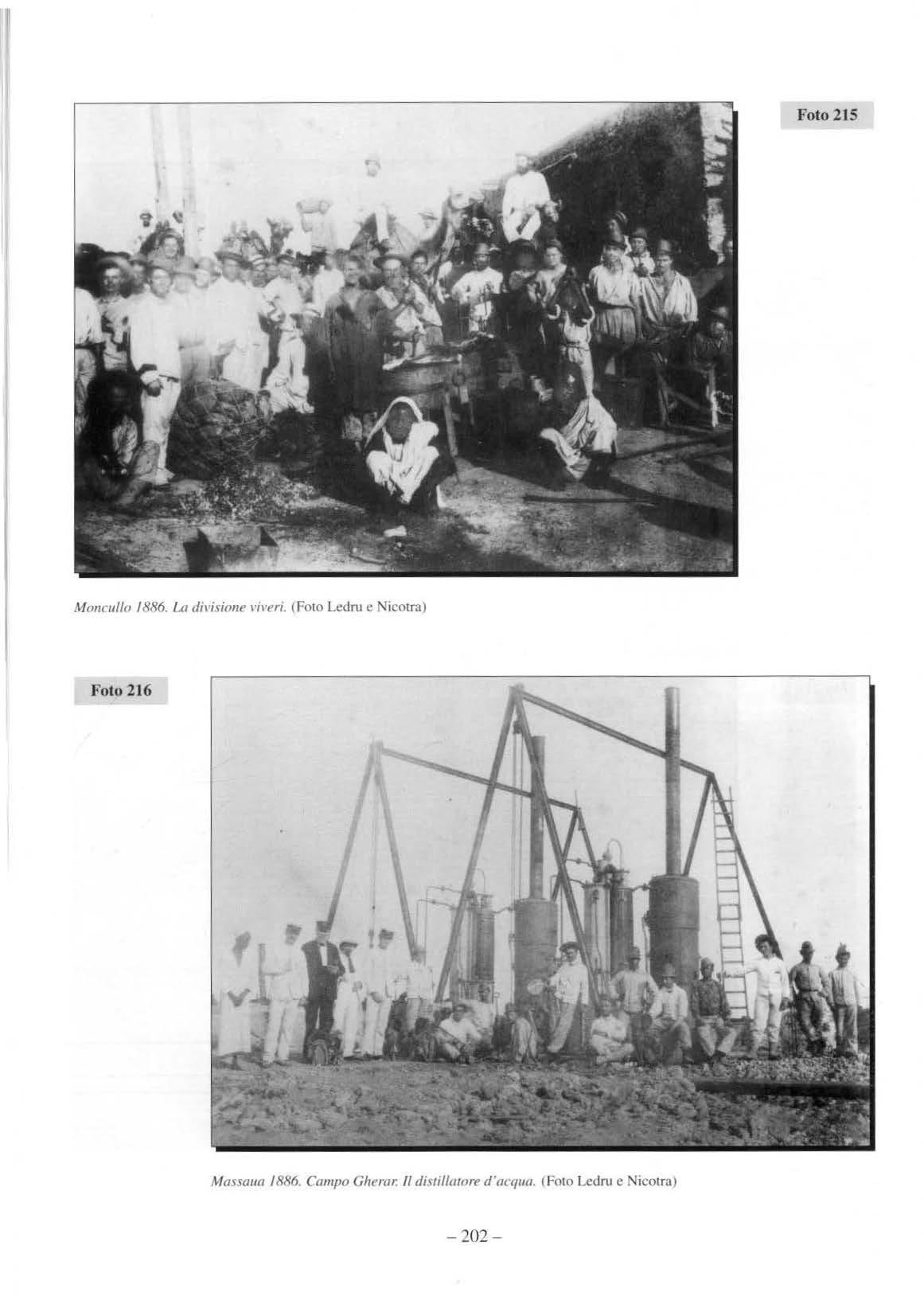
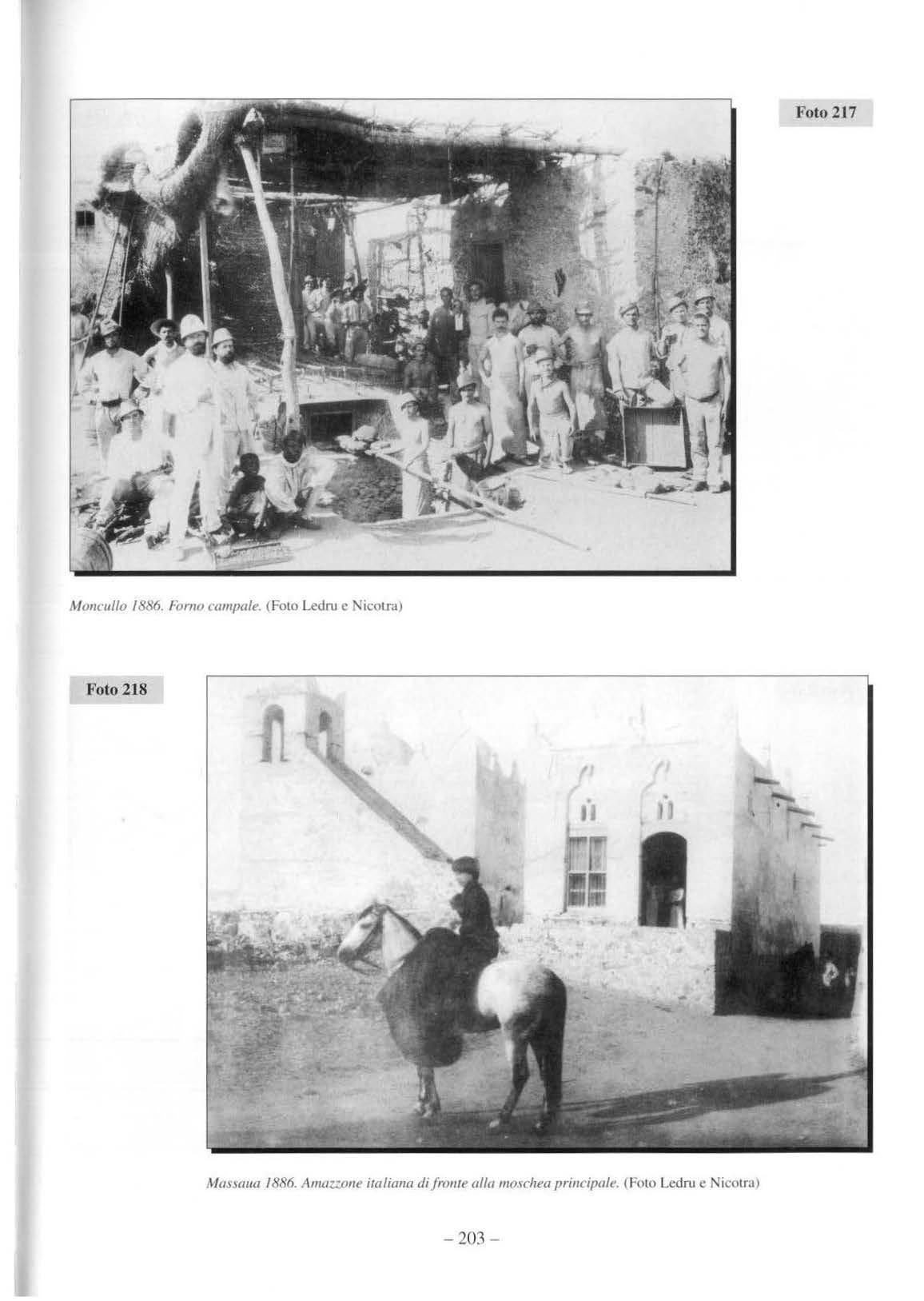
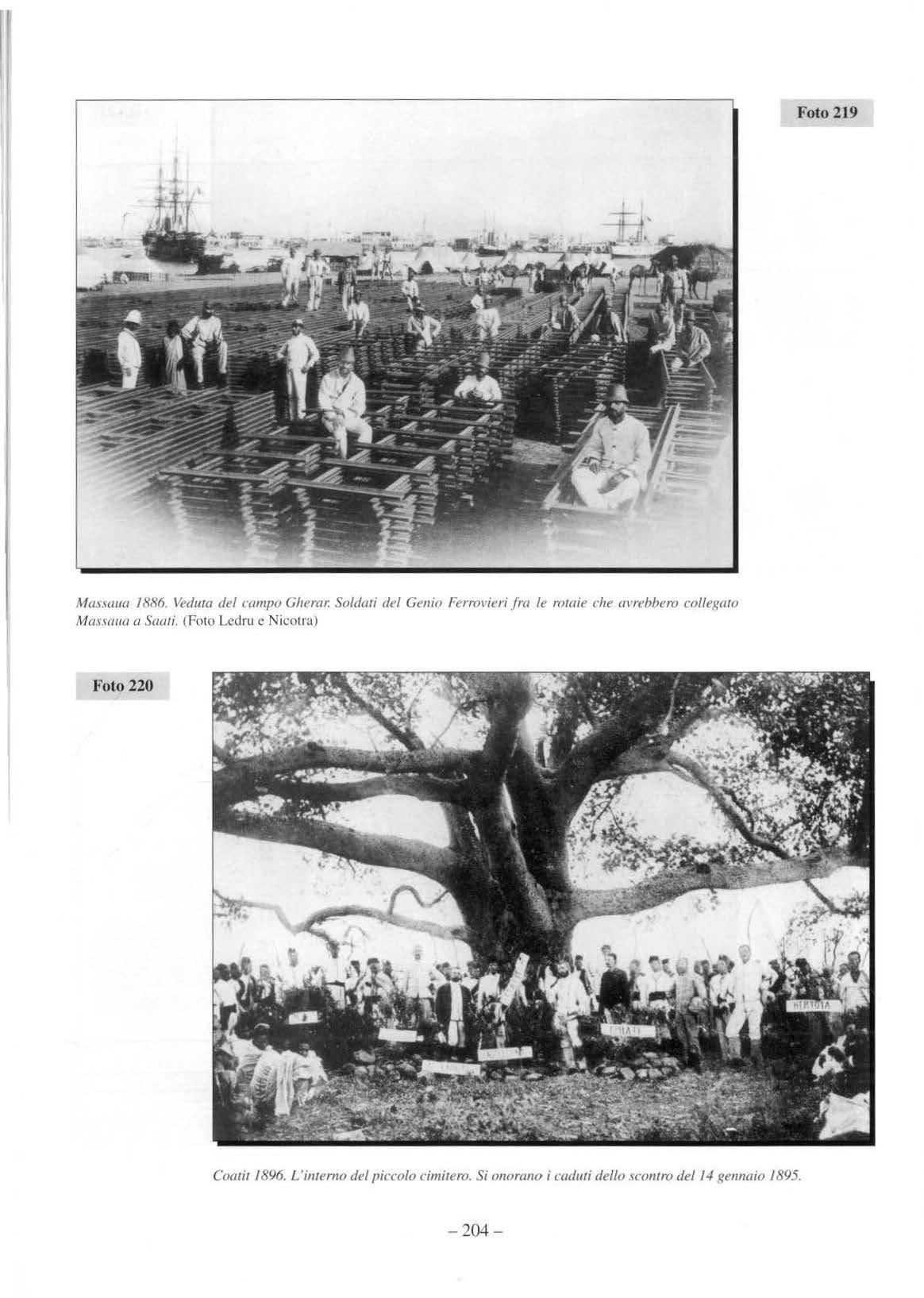 Ma!lsmw l 886. Veduta del campo Gherar. Soldari del Genio Fenvl'ieri fra le mraie che mn'hhero collegato Mas sw w a Sa ari. (Foto Ledru..: Nicotra)
Ma!lsmw l 886. Veduta del campo Gherar. Soldari del Genio Fenvl'ieri fra le mraie che mn'hhero collegato Mas sw w a Sa ari. (Foto Ledru..: Nicotra)
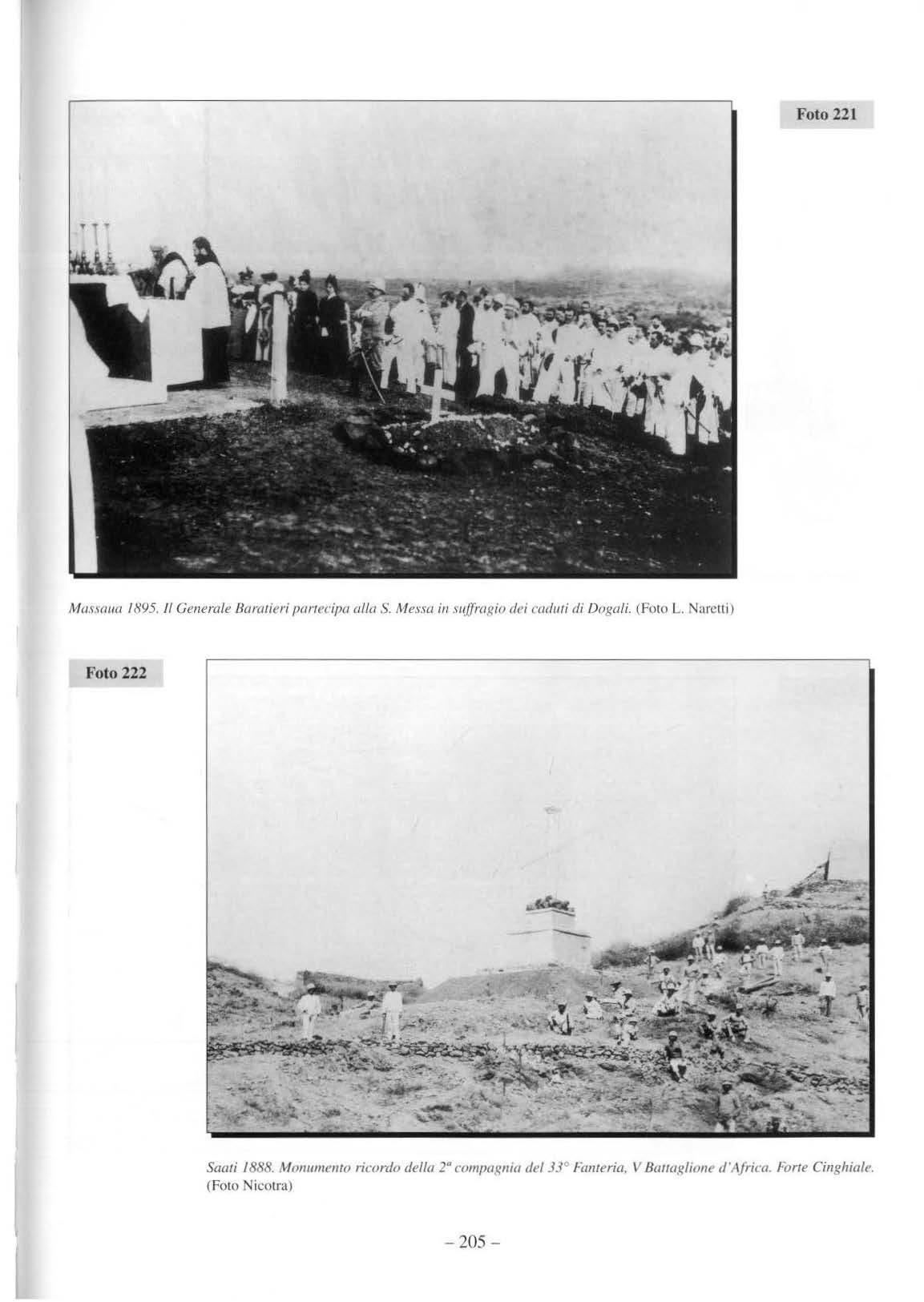
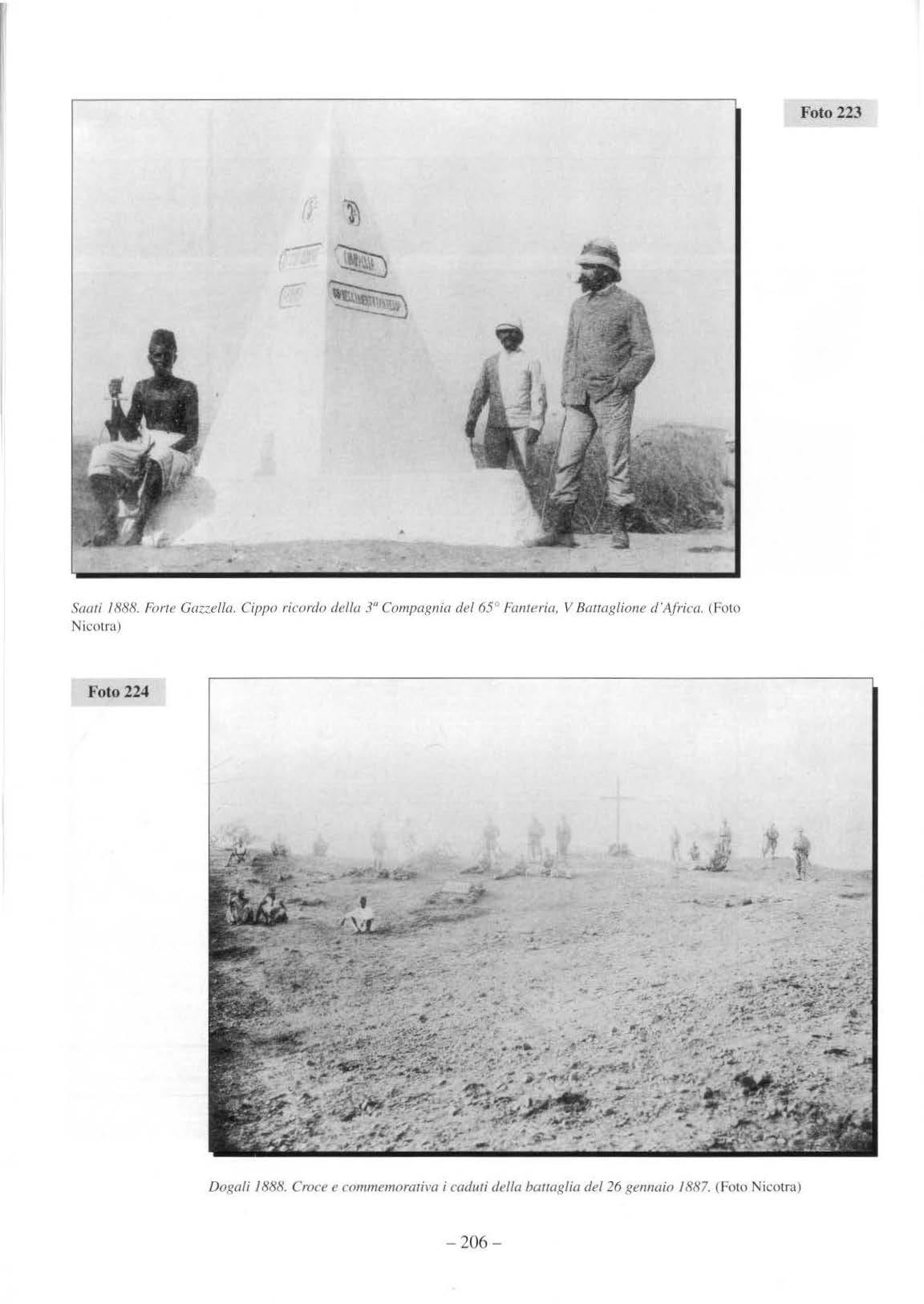
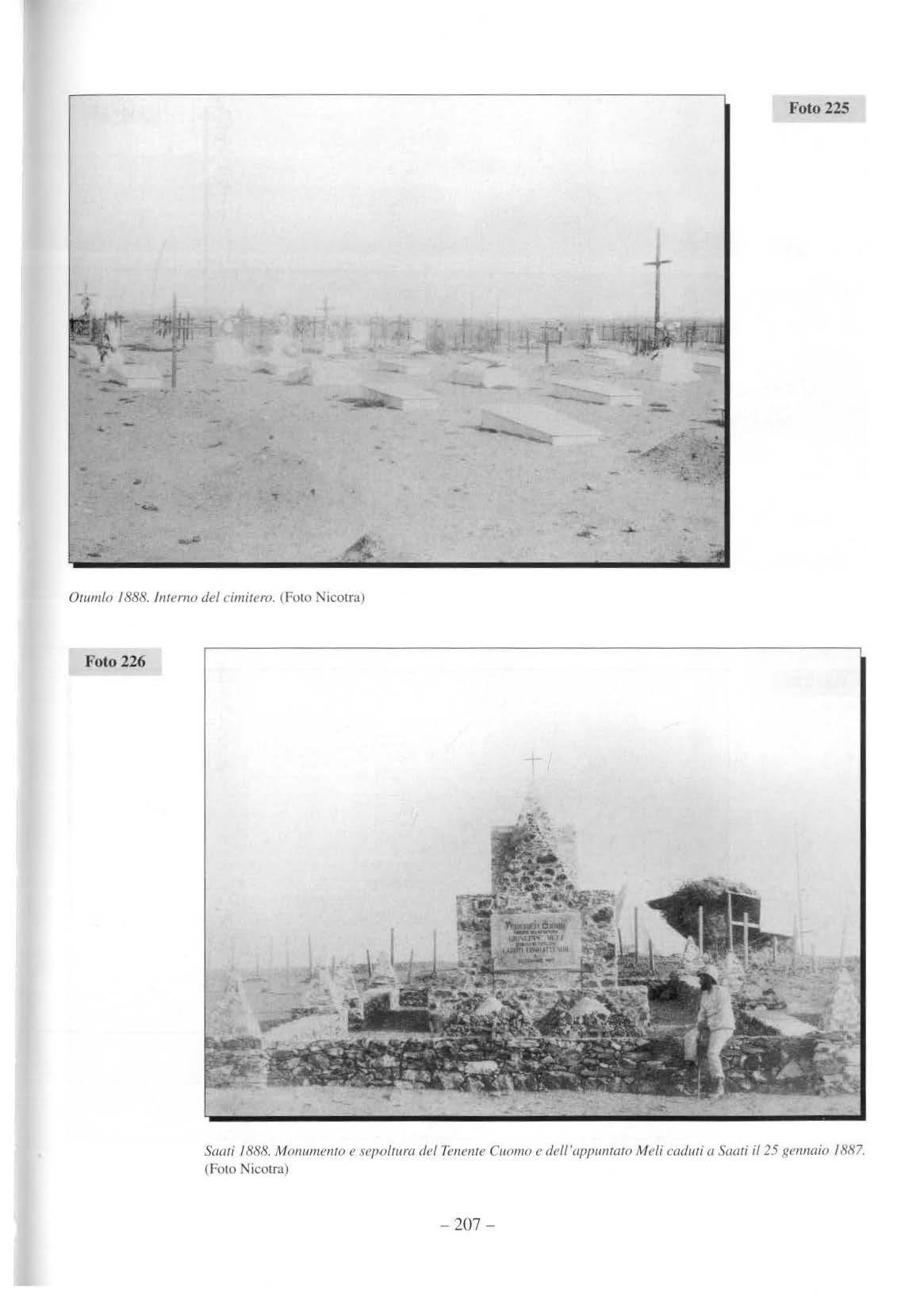
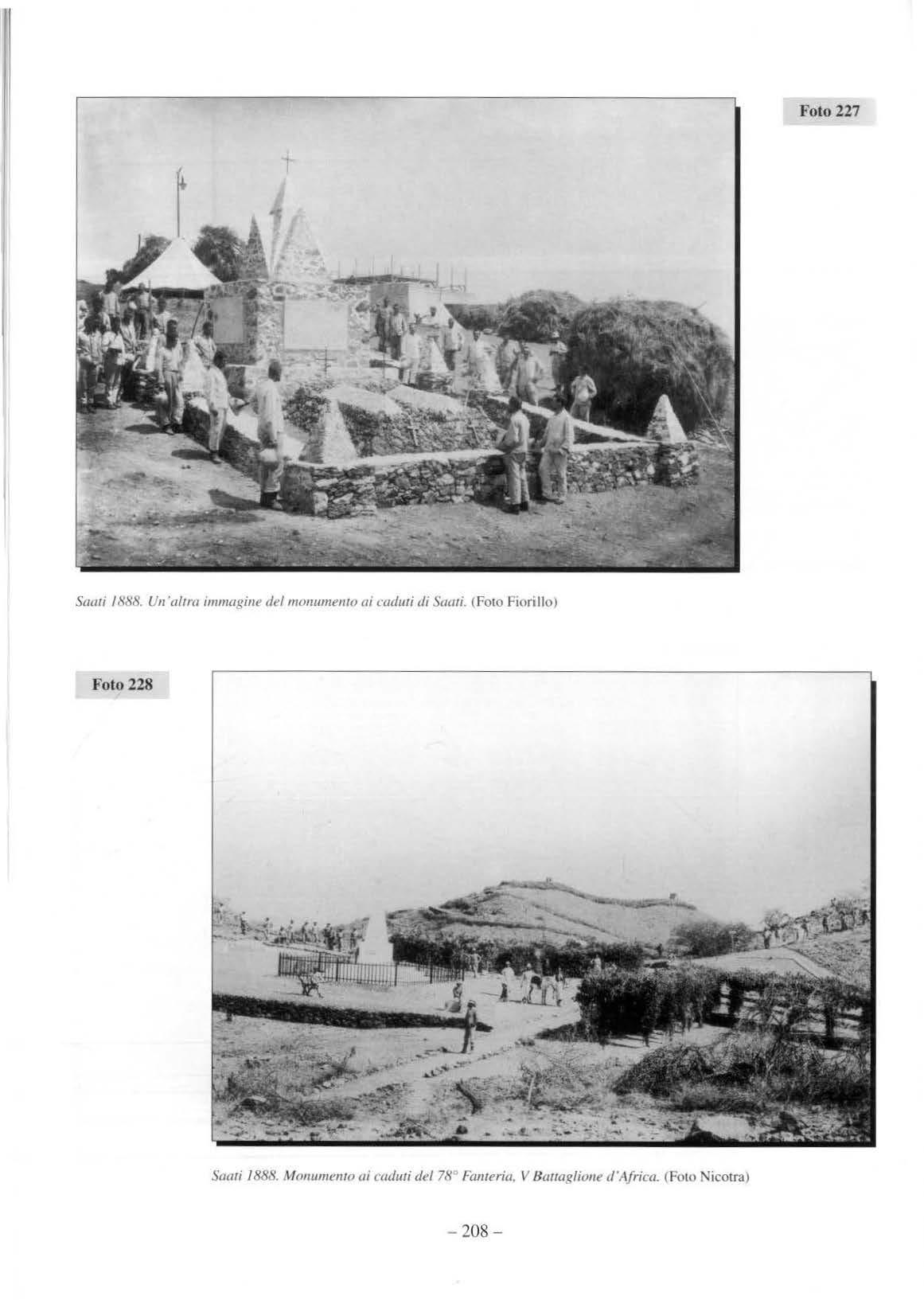
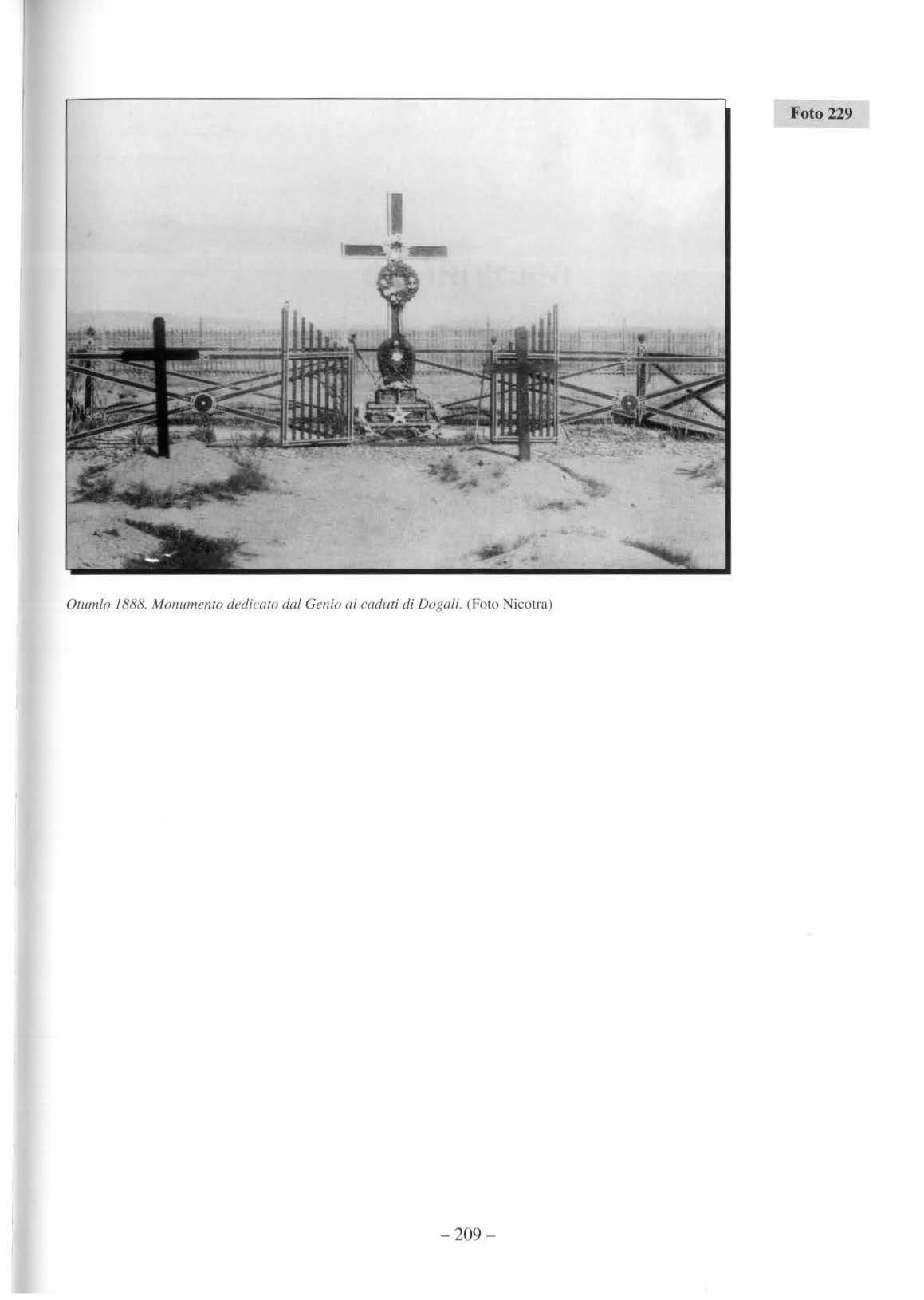

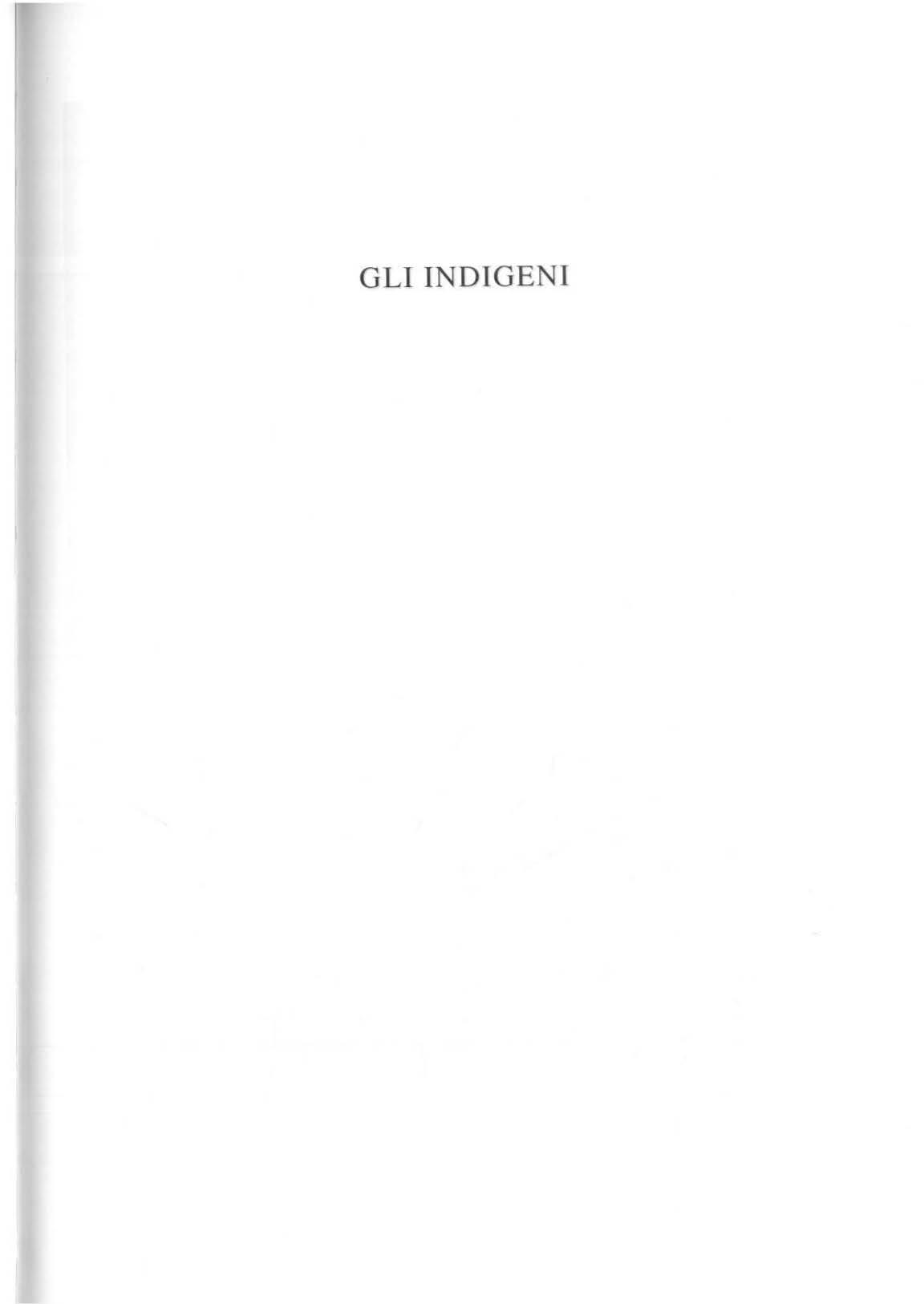

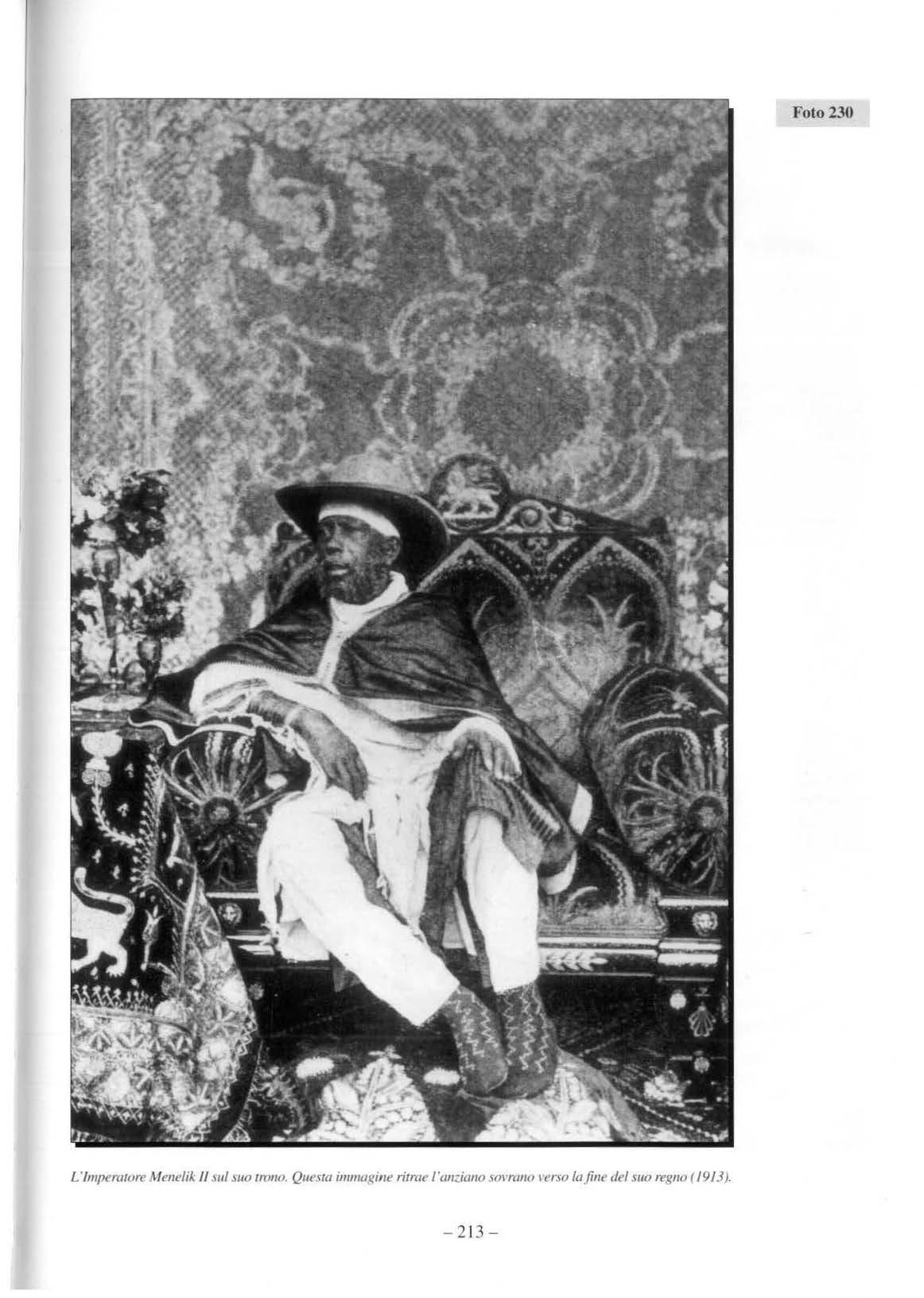

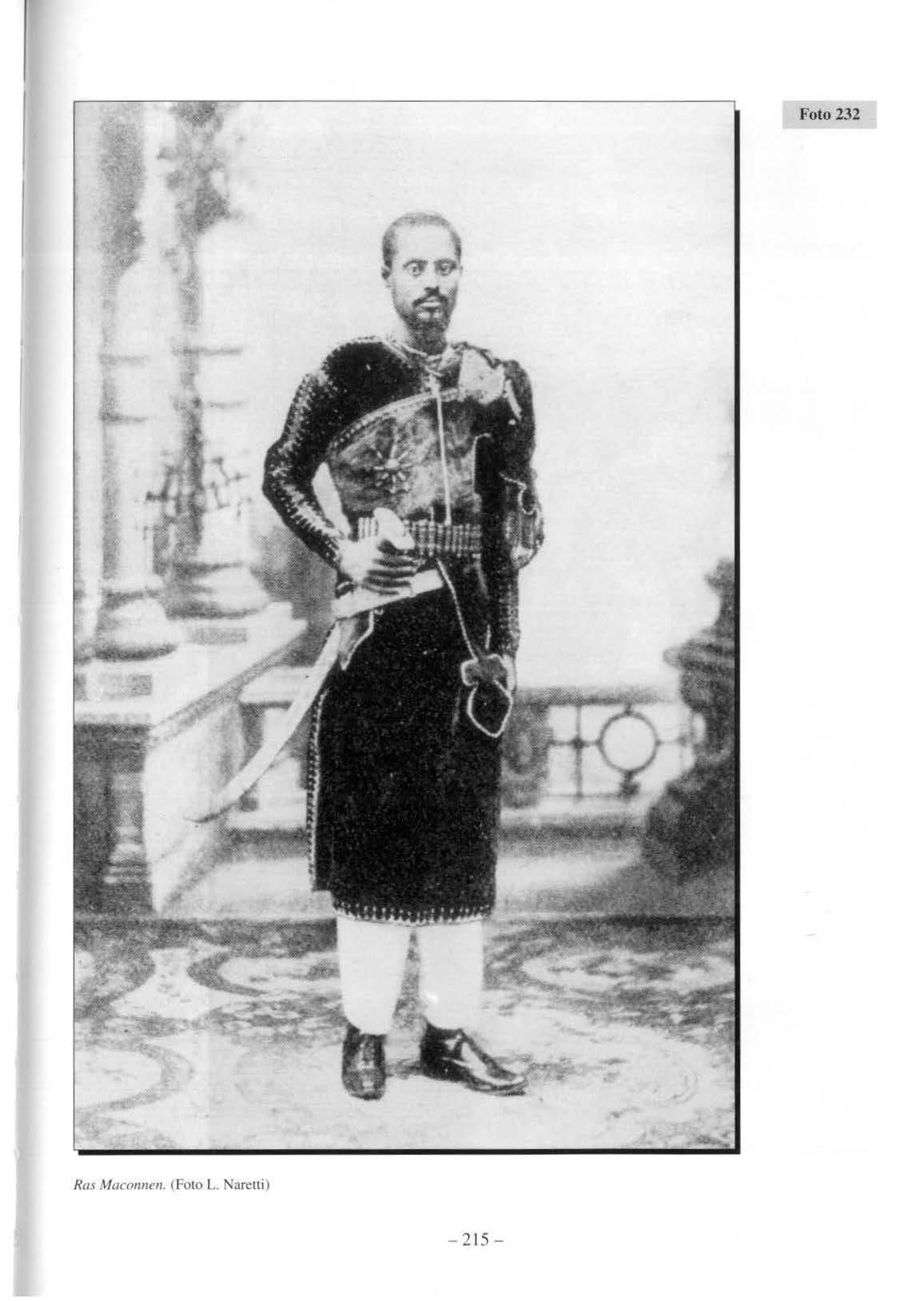

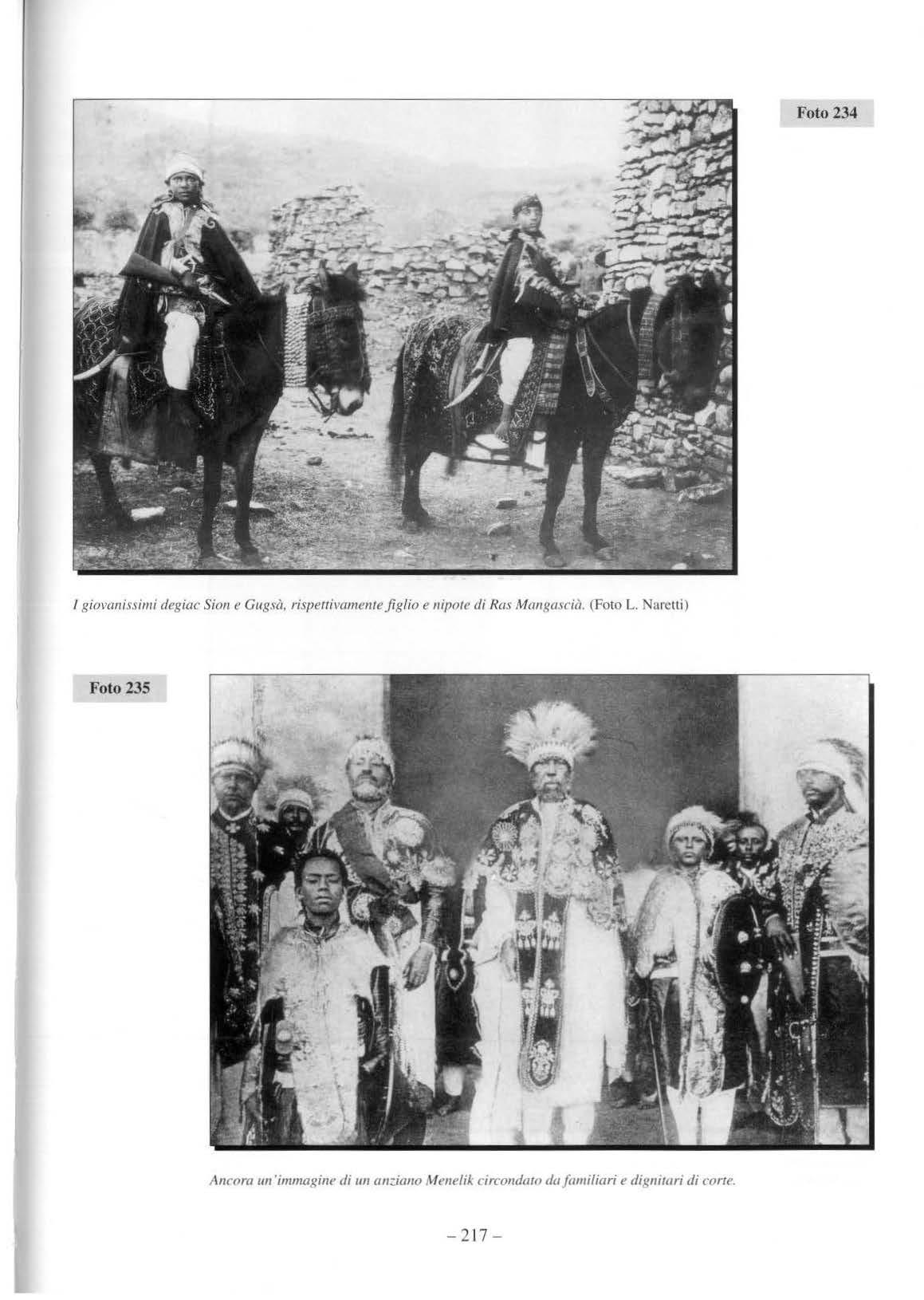
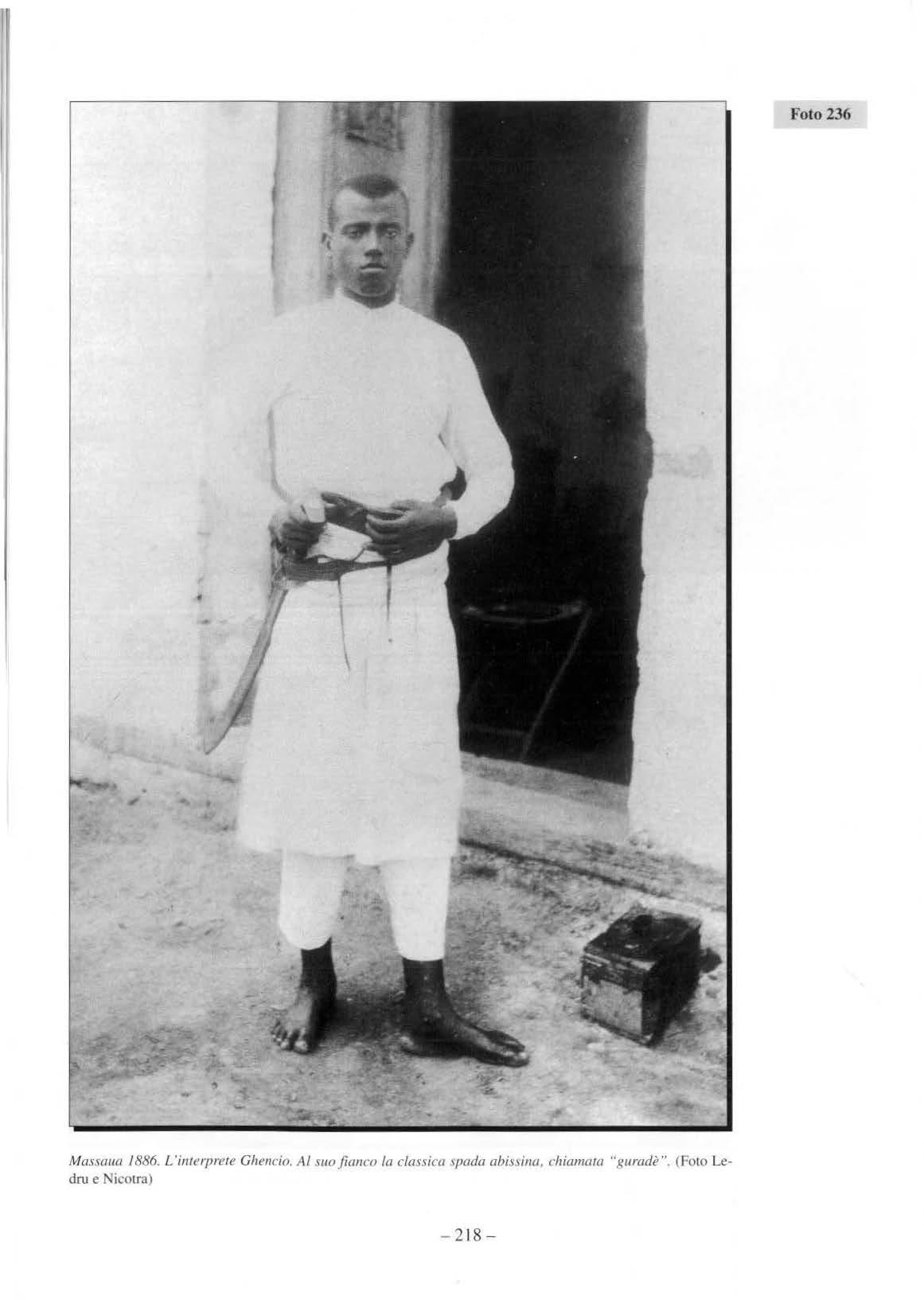
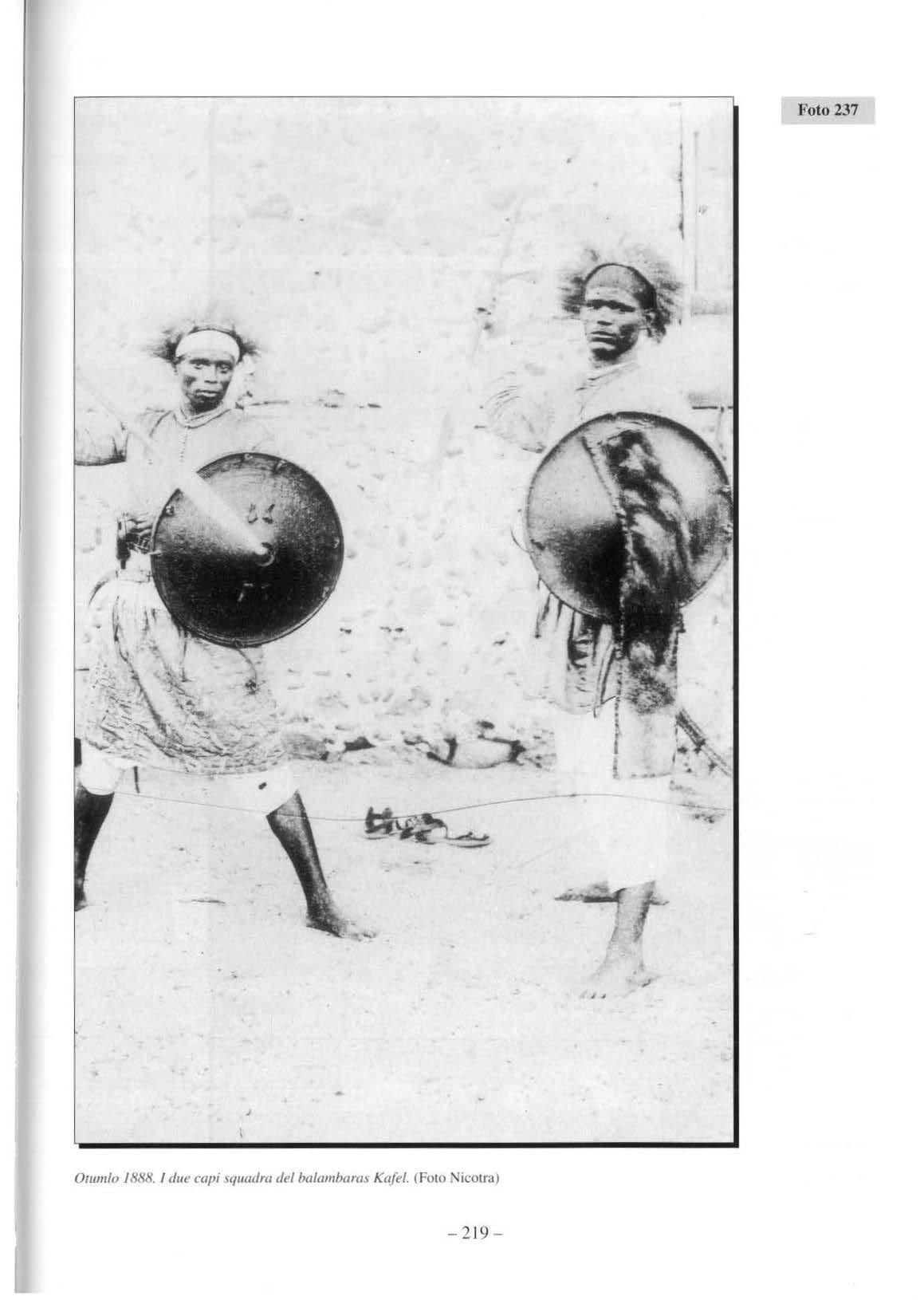
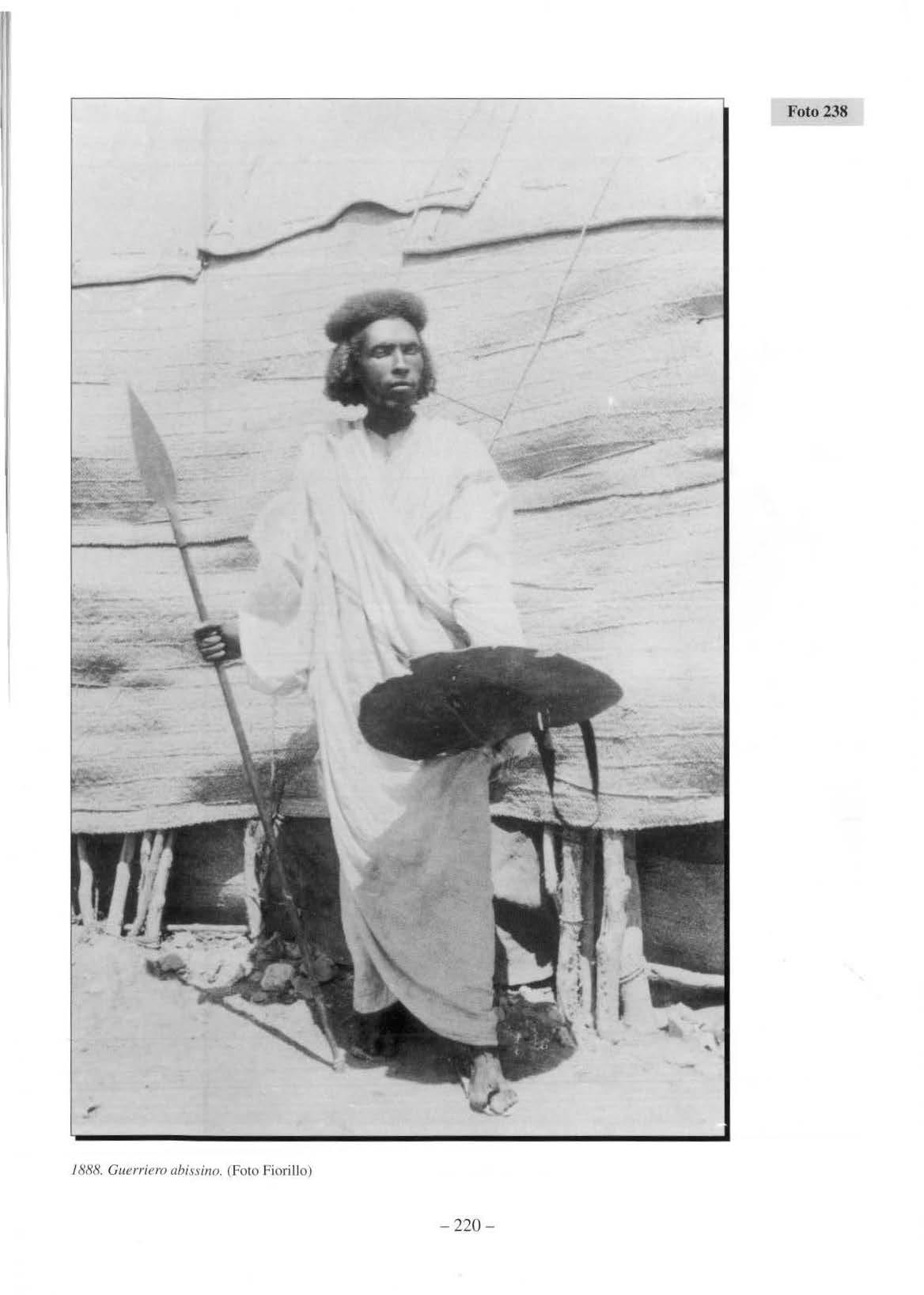
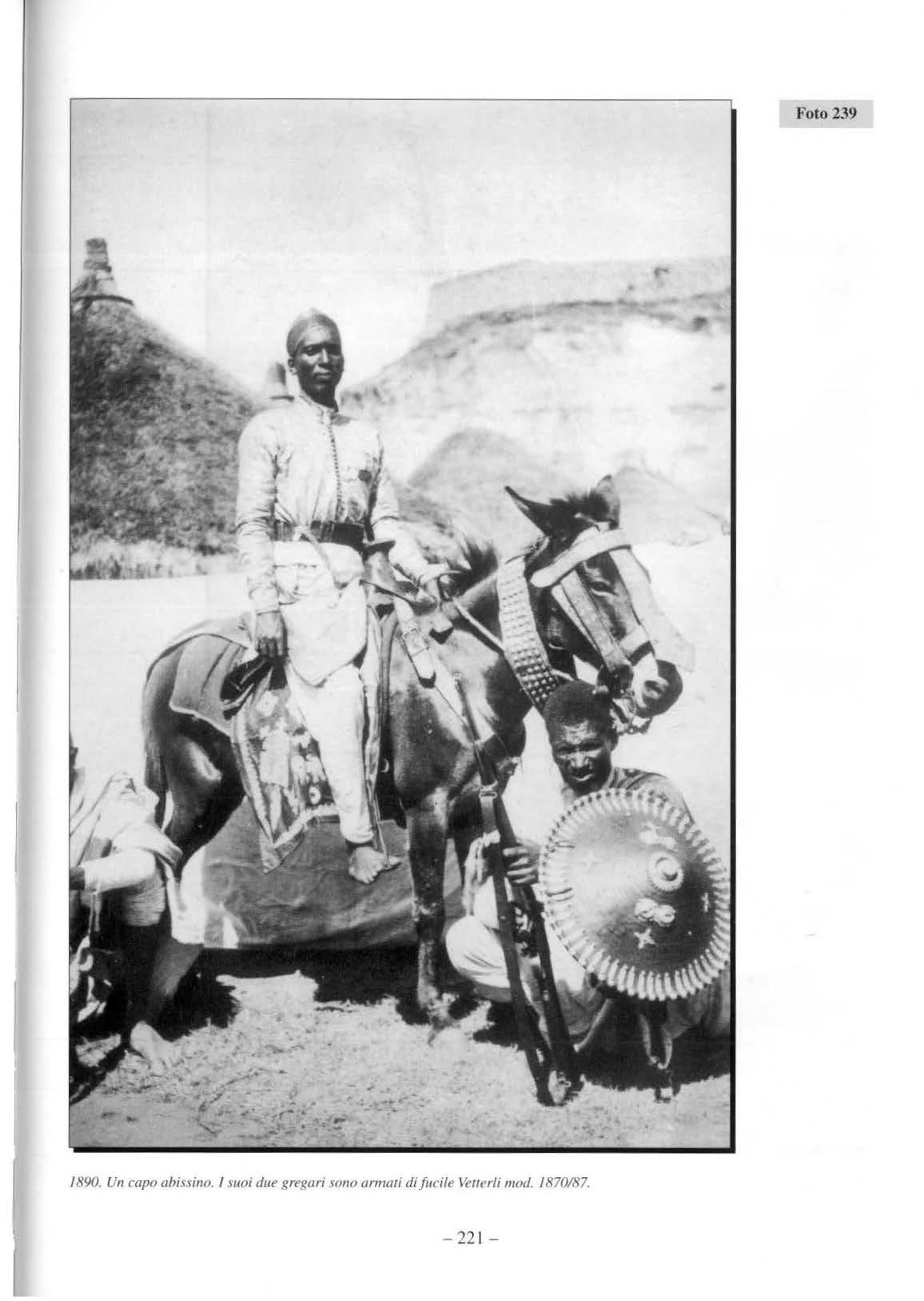
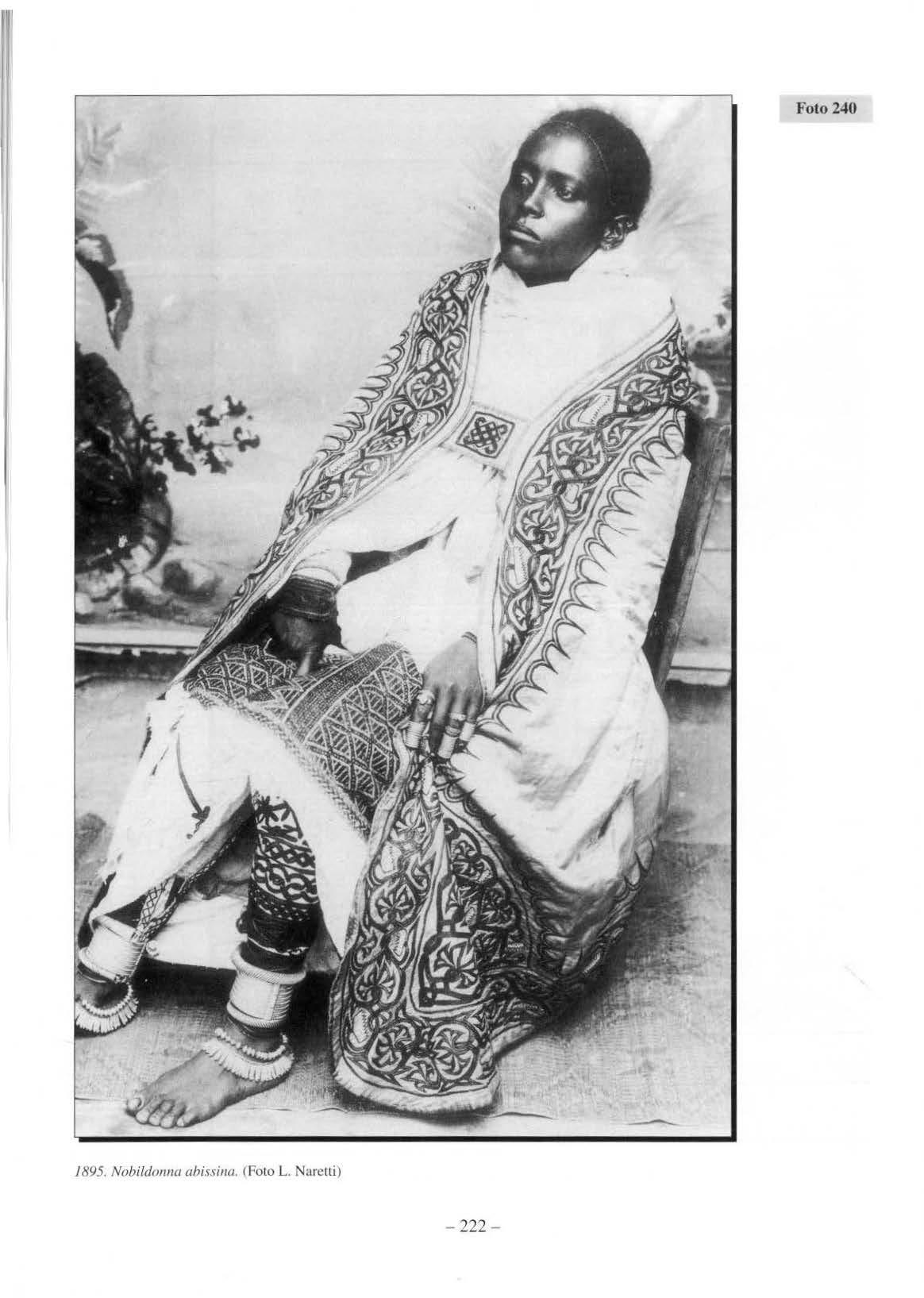
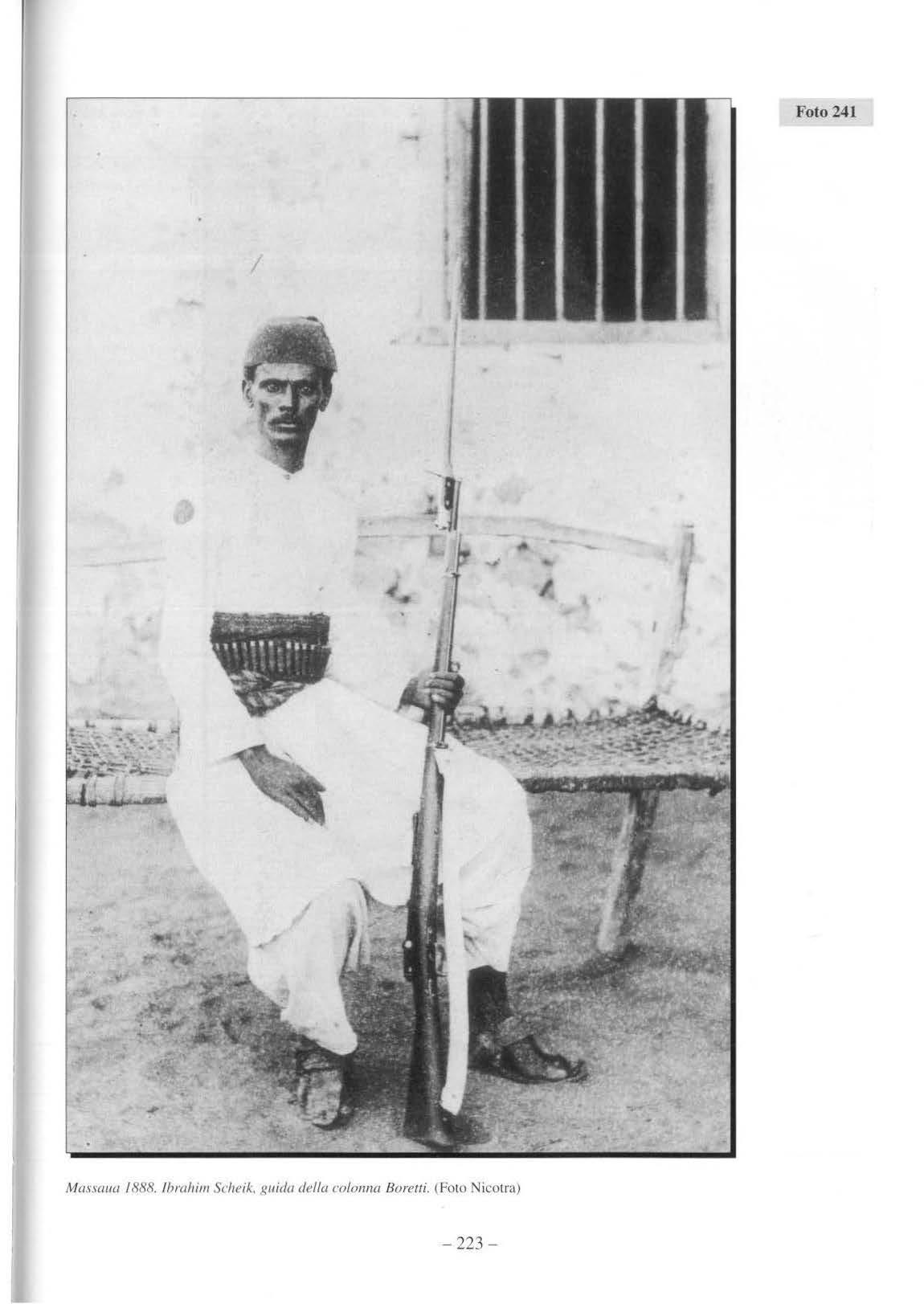
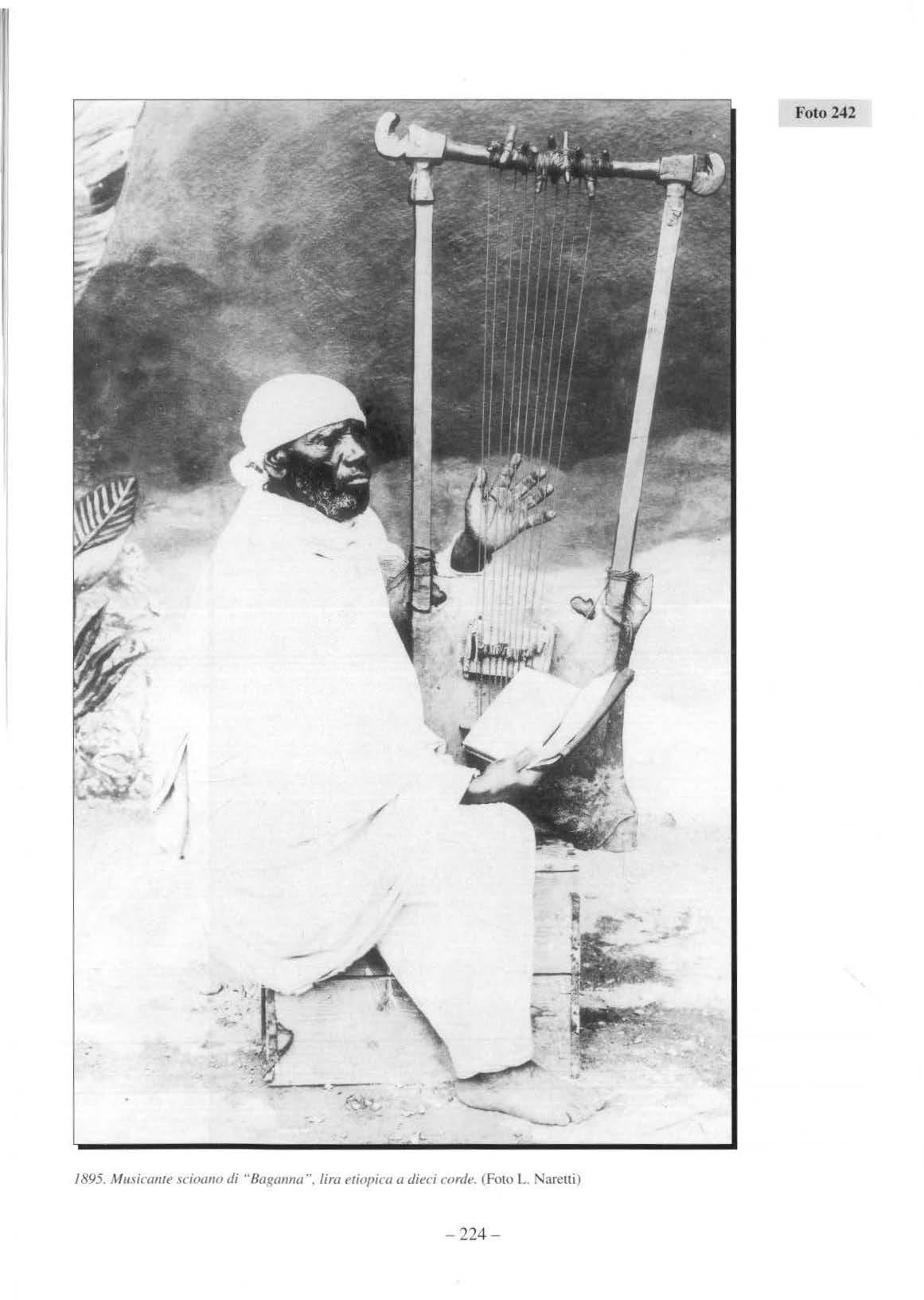
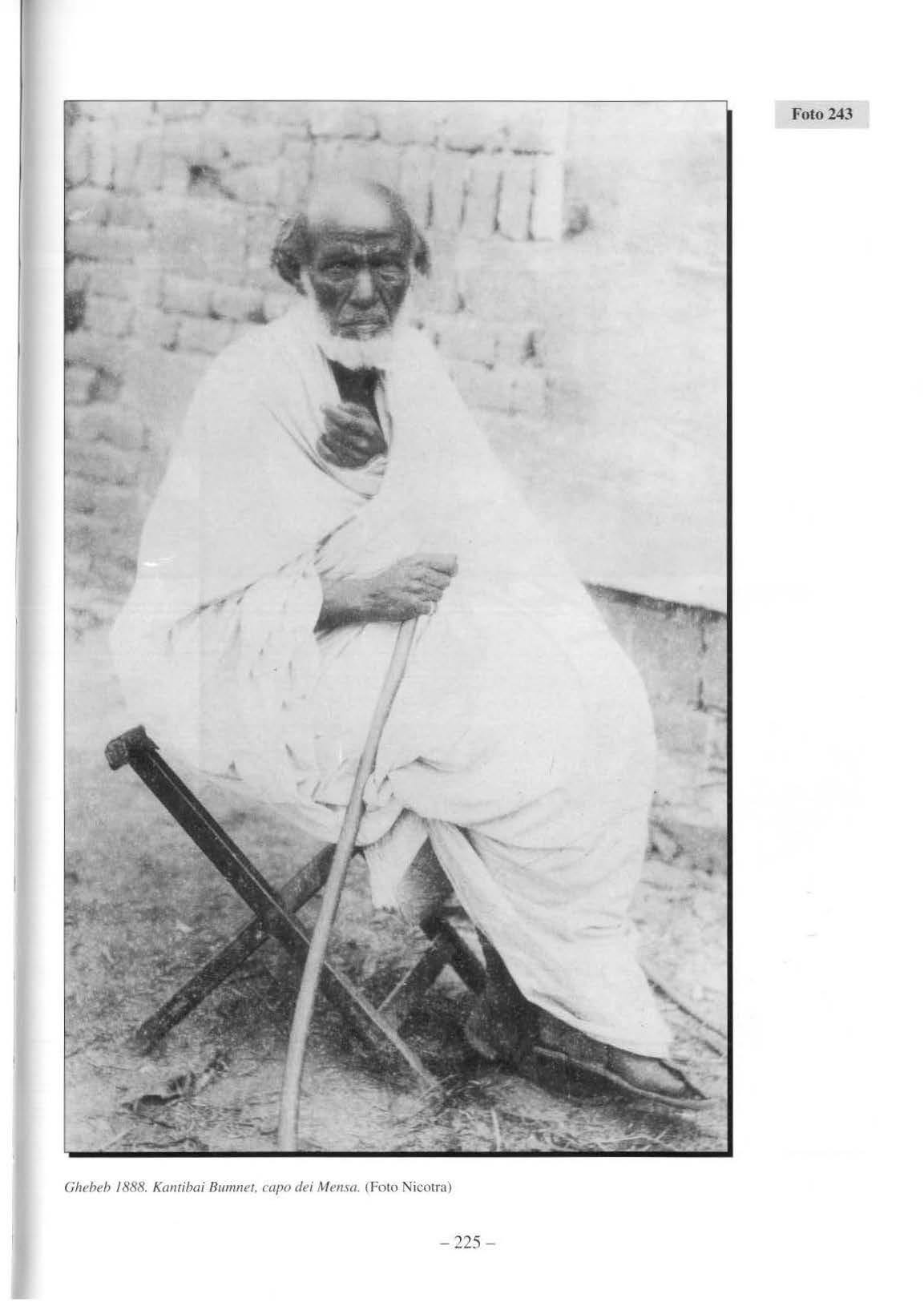
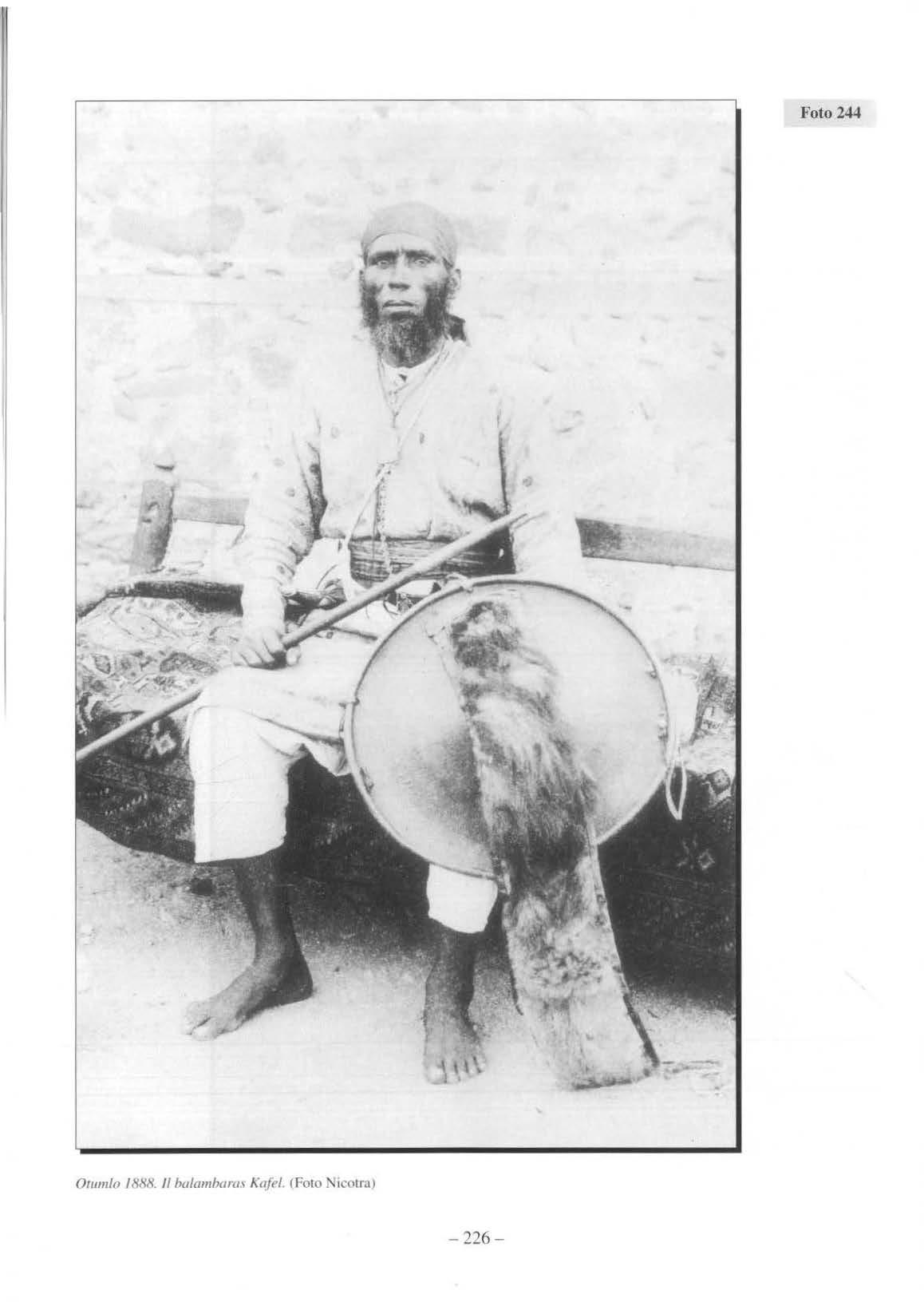
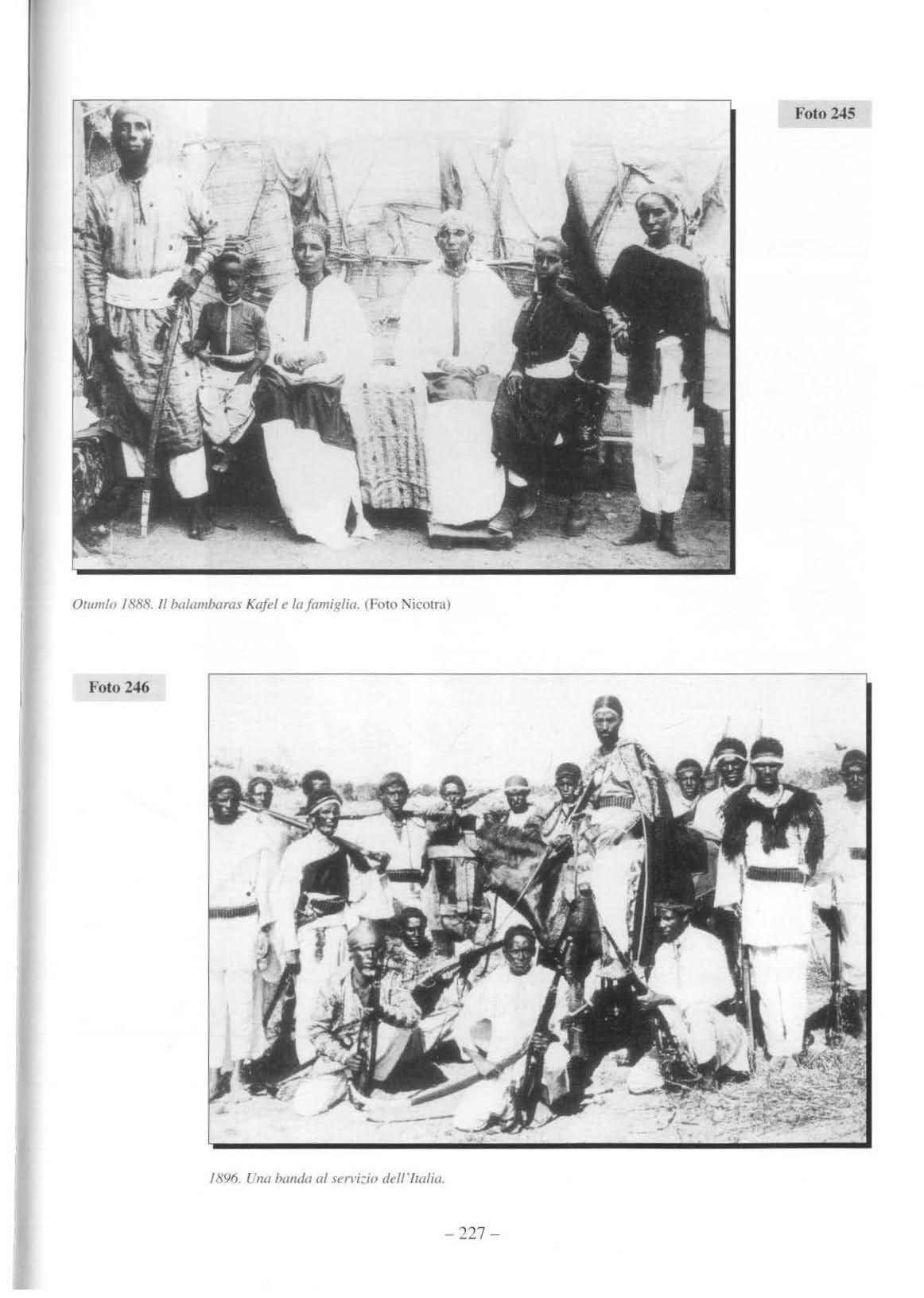 Foto 245
Owmlo /888. Il balamharaç Kafel e lafamir:lia <Foto ·icotra)
Foto 246
Foto 245
Owmlo /888. Il balamharaç Kafel e lafamir:lia <Foto ·icotra)
Foto 246
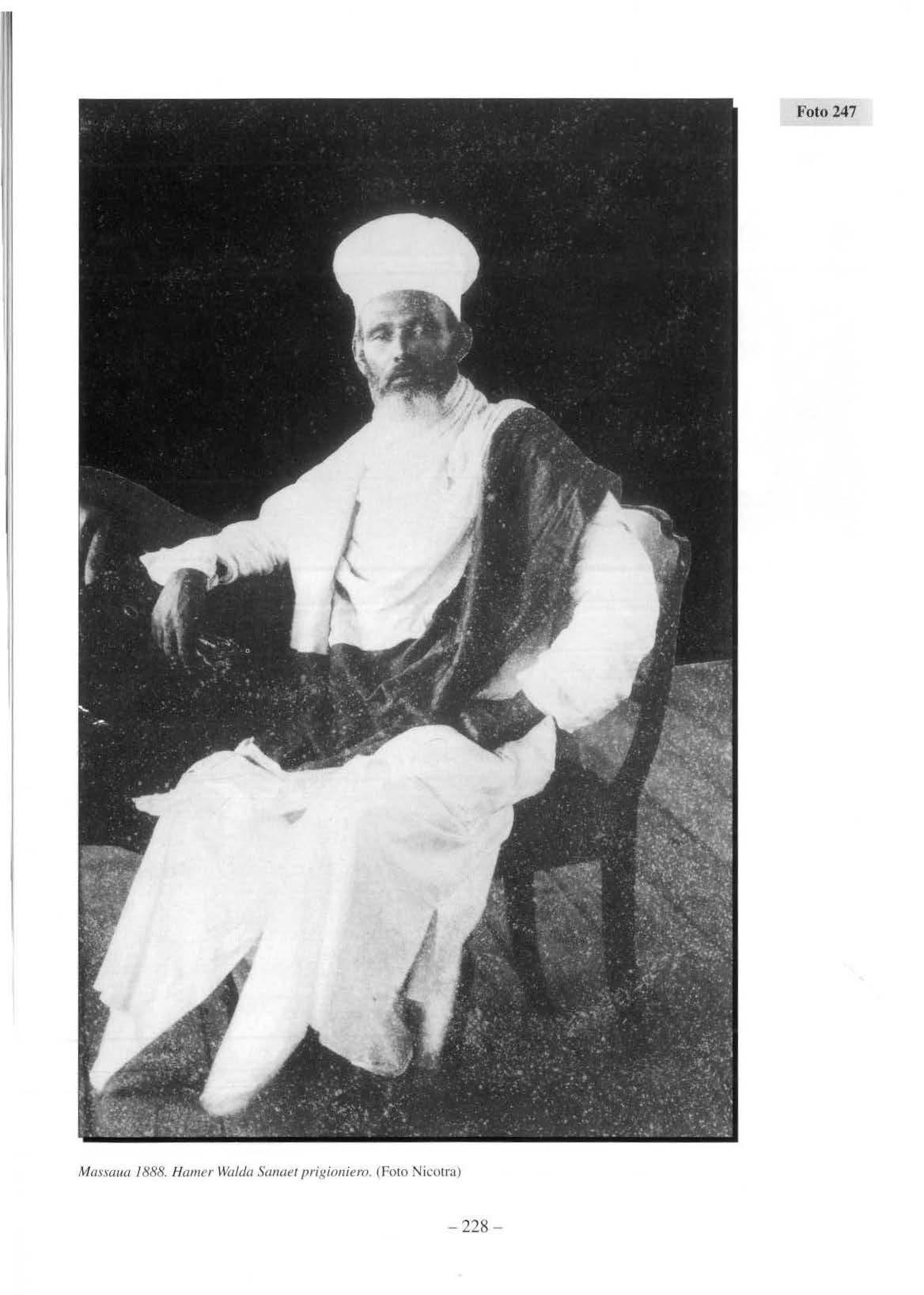
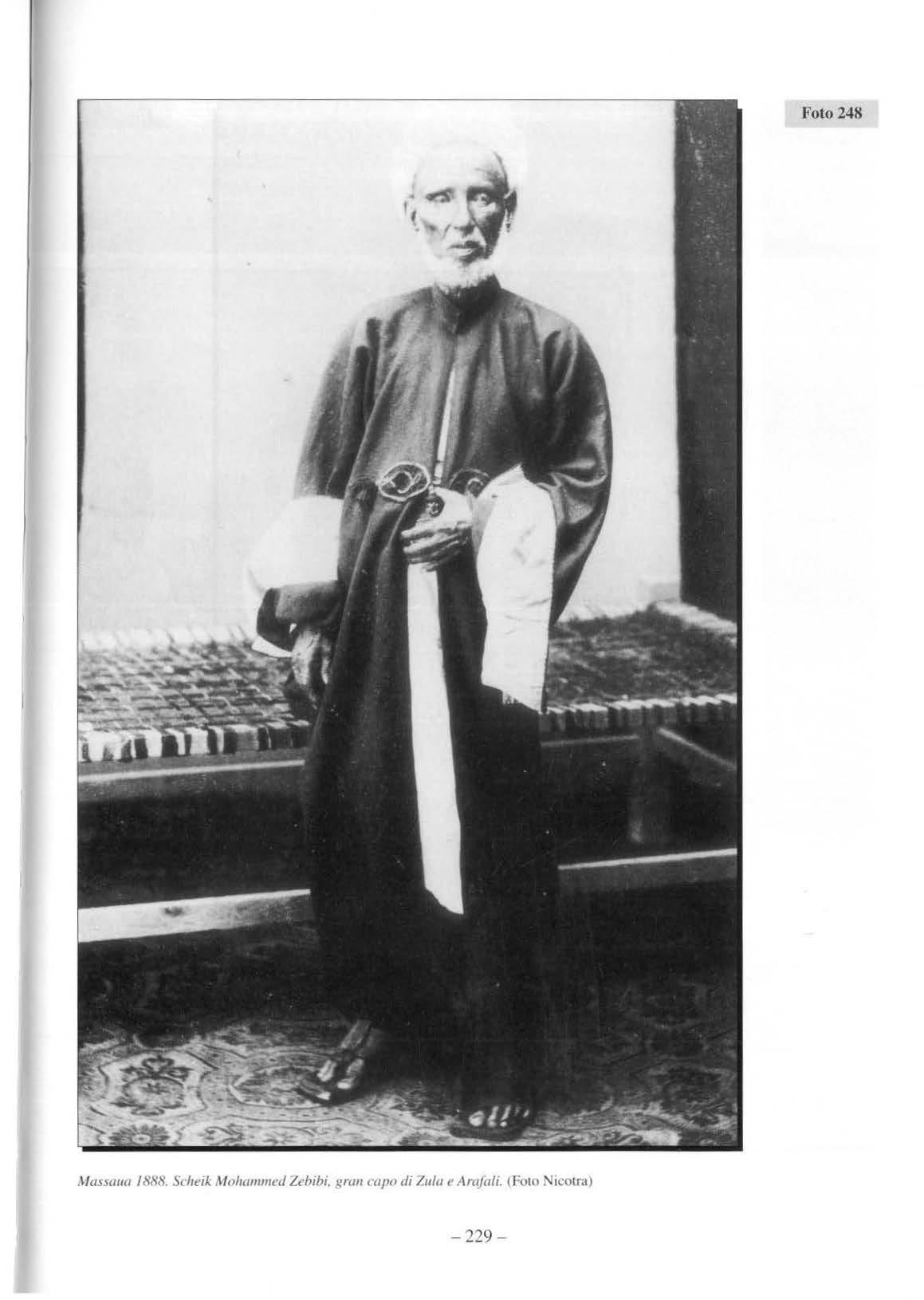

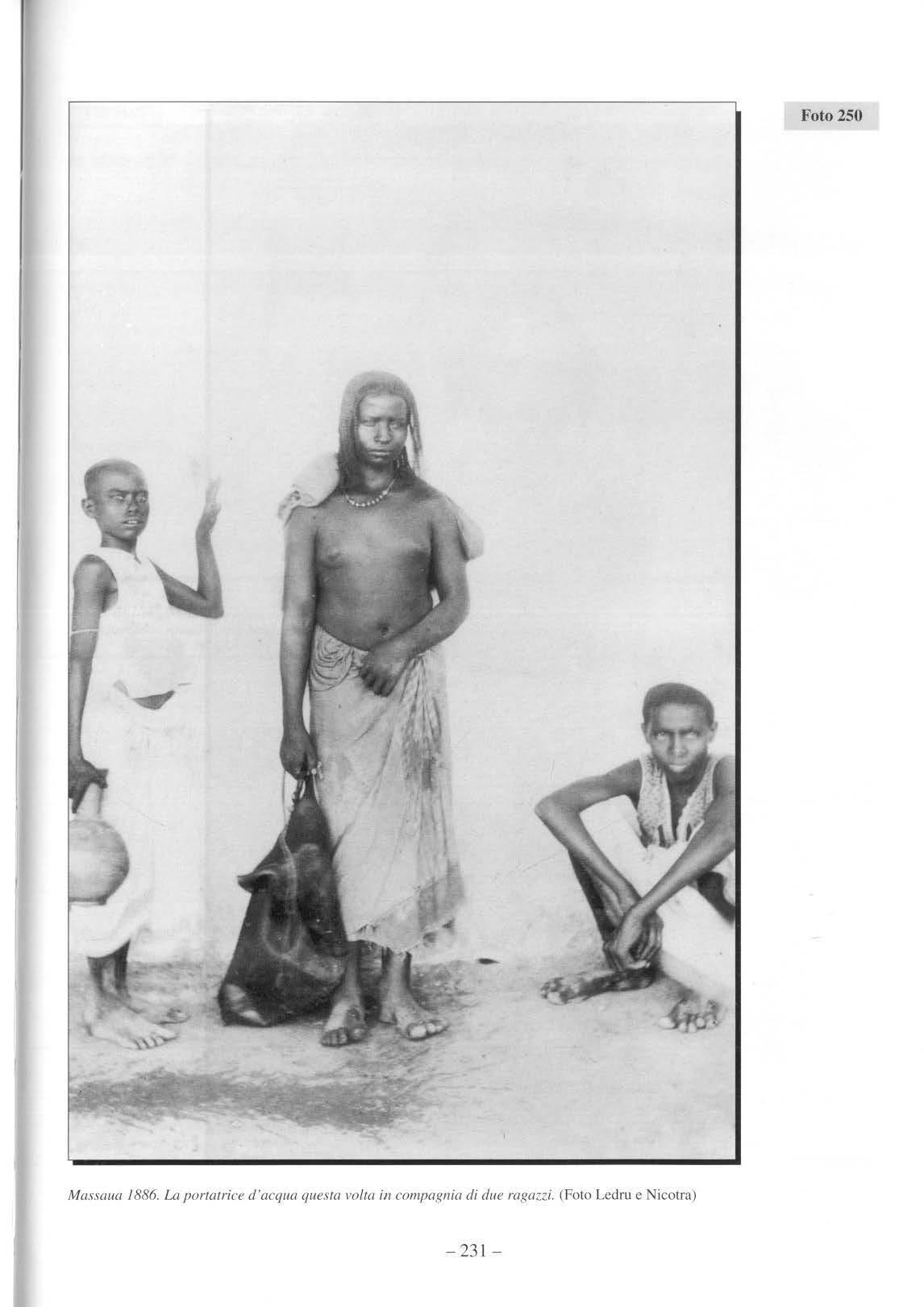
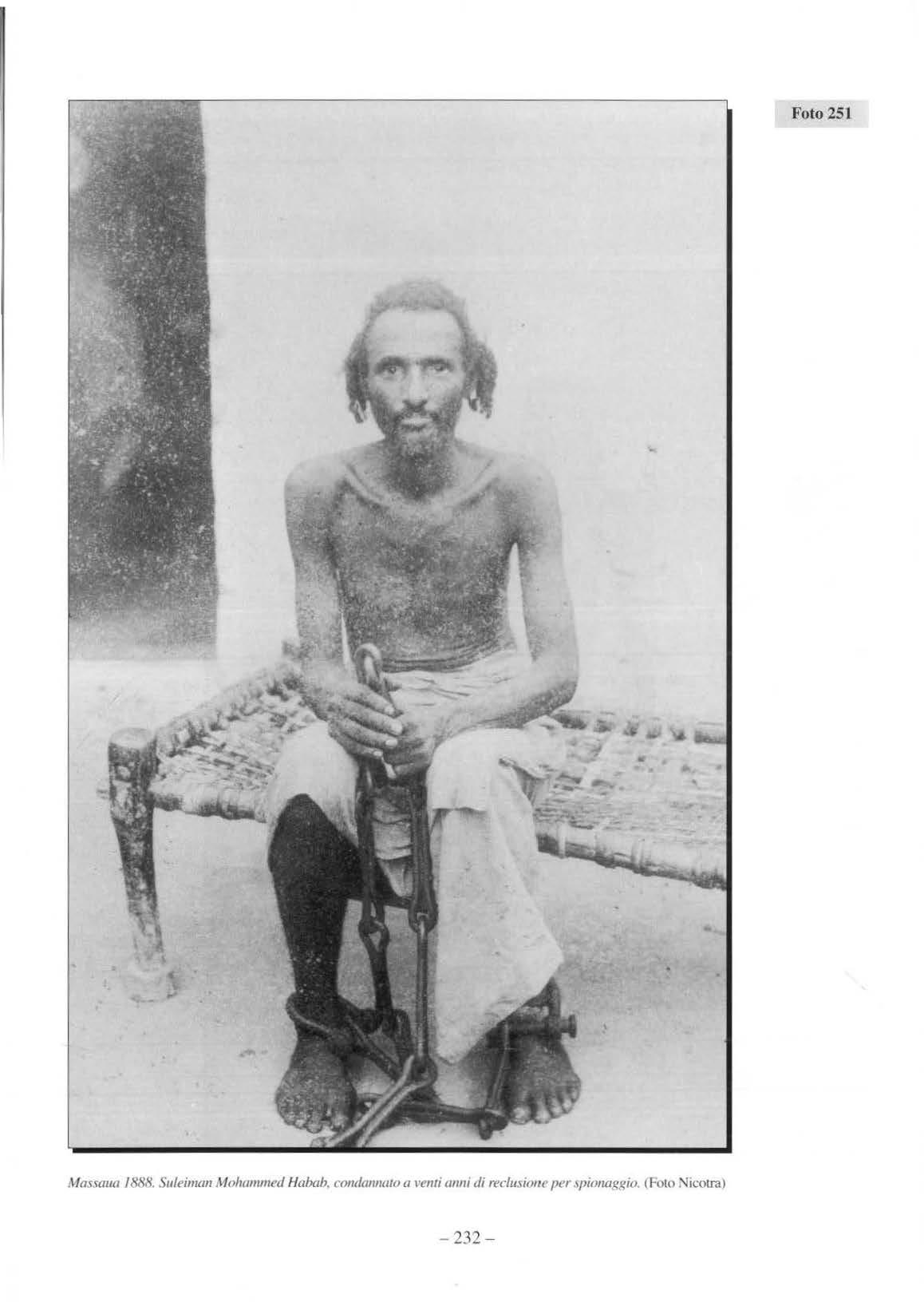
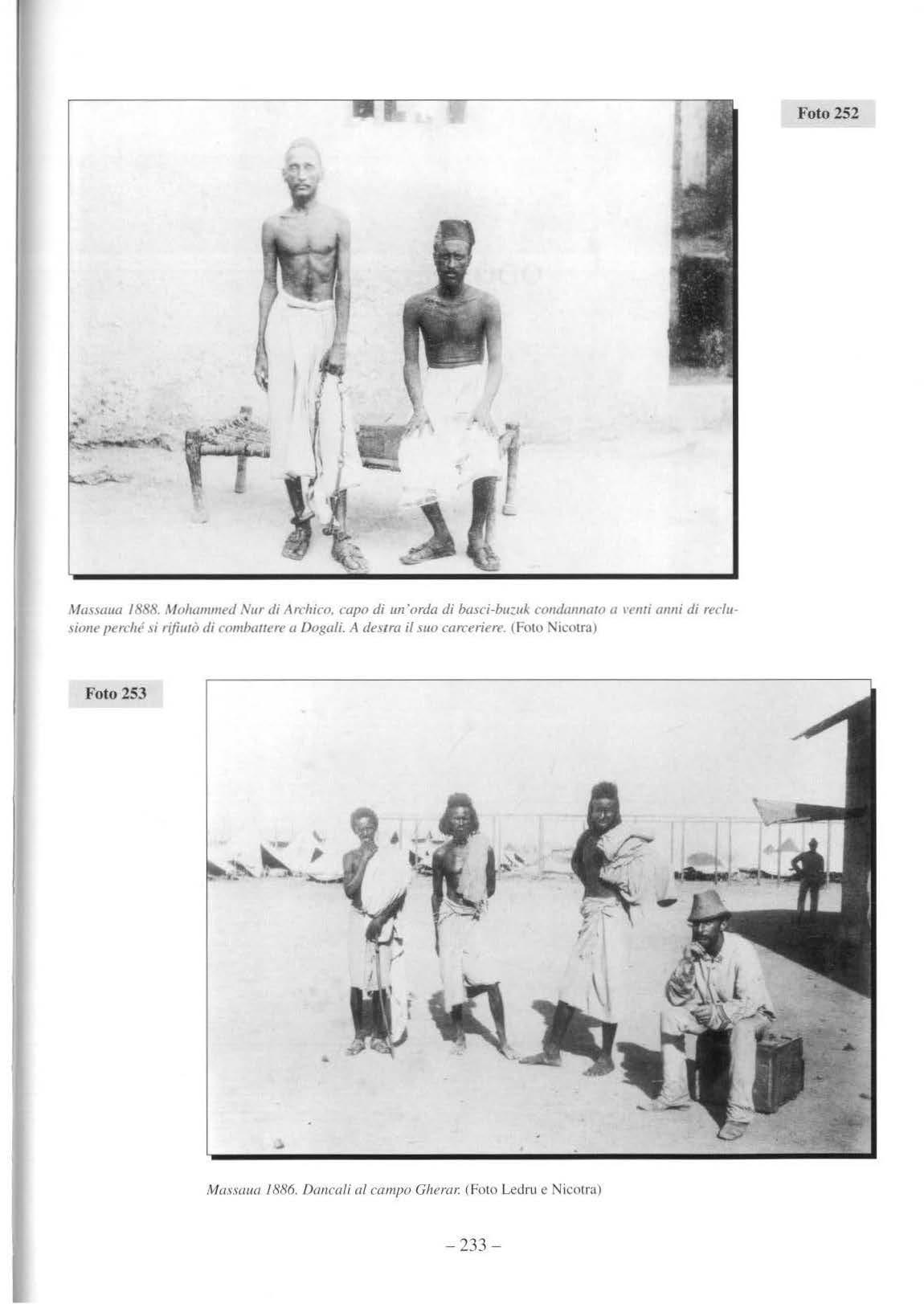 Massaua /888. Mohammed Nur di Archico. capo di w1'orda di ccmdalltWm a remi mmì di redulÌone perché .\t rijiu1ù dì comhauere a Dogali. A deSira il suo carceriere. (Foto Nicotm)
Foto 253
Massaua /888. Mohammed Nur di Archico. capo di w1'orda di ccmdalltWm a remi mmì di redulÌone perché .\t rijiu1ù dì comhauere a Dogali. A deSira il suo carceriere. (Foto Nicotm)
Foto 253
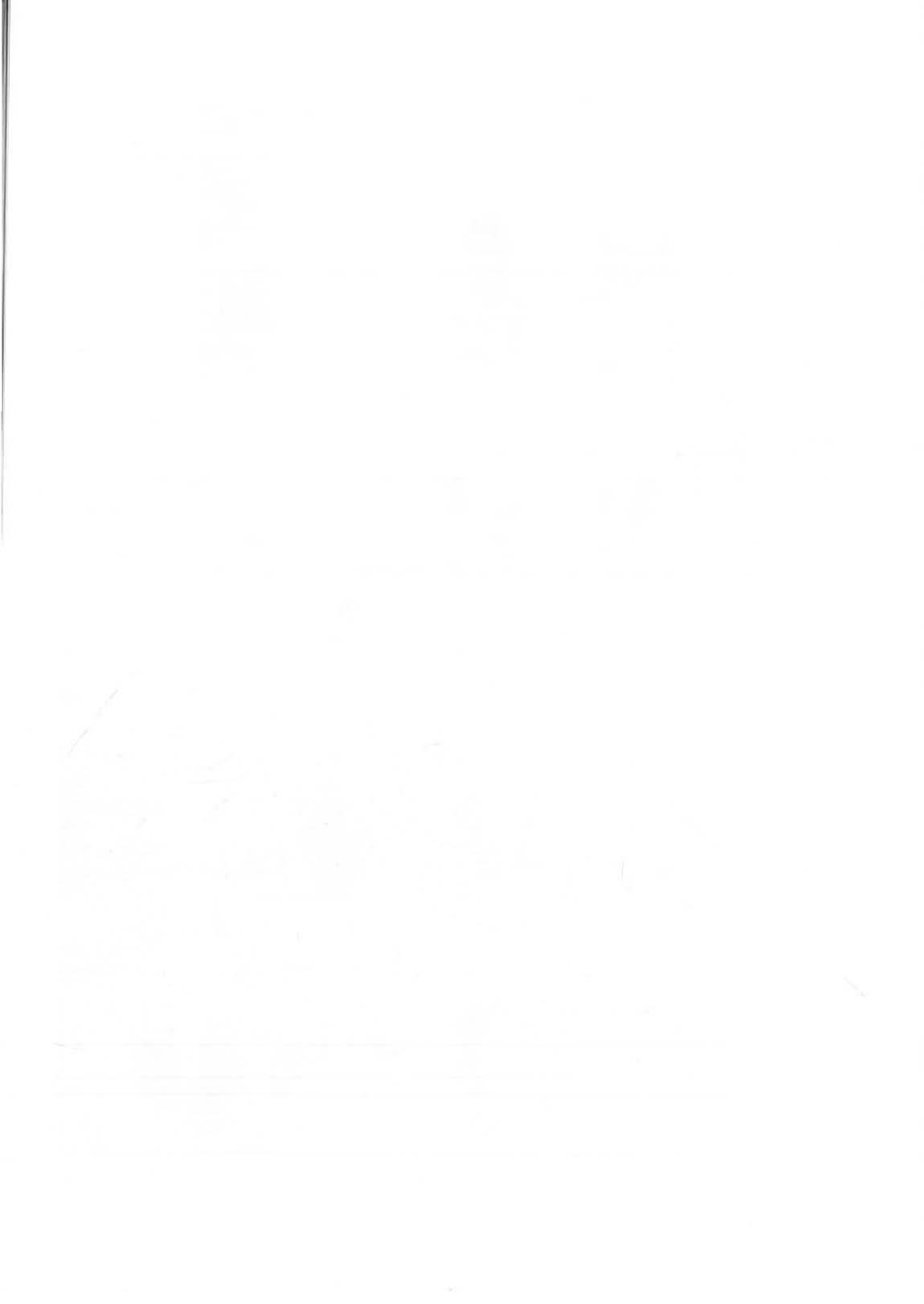
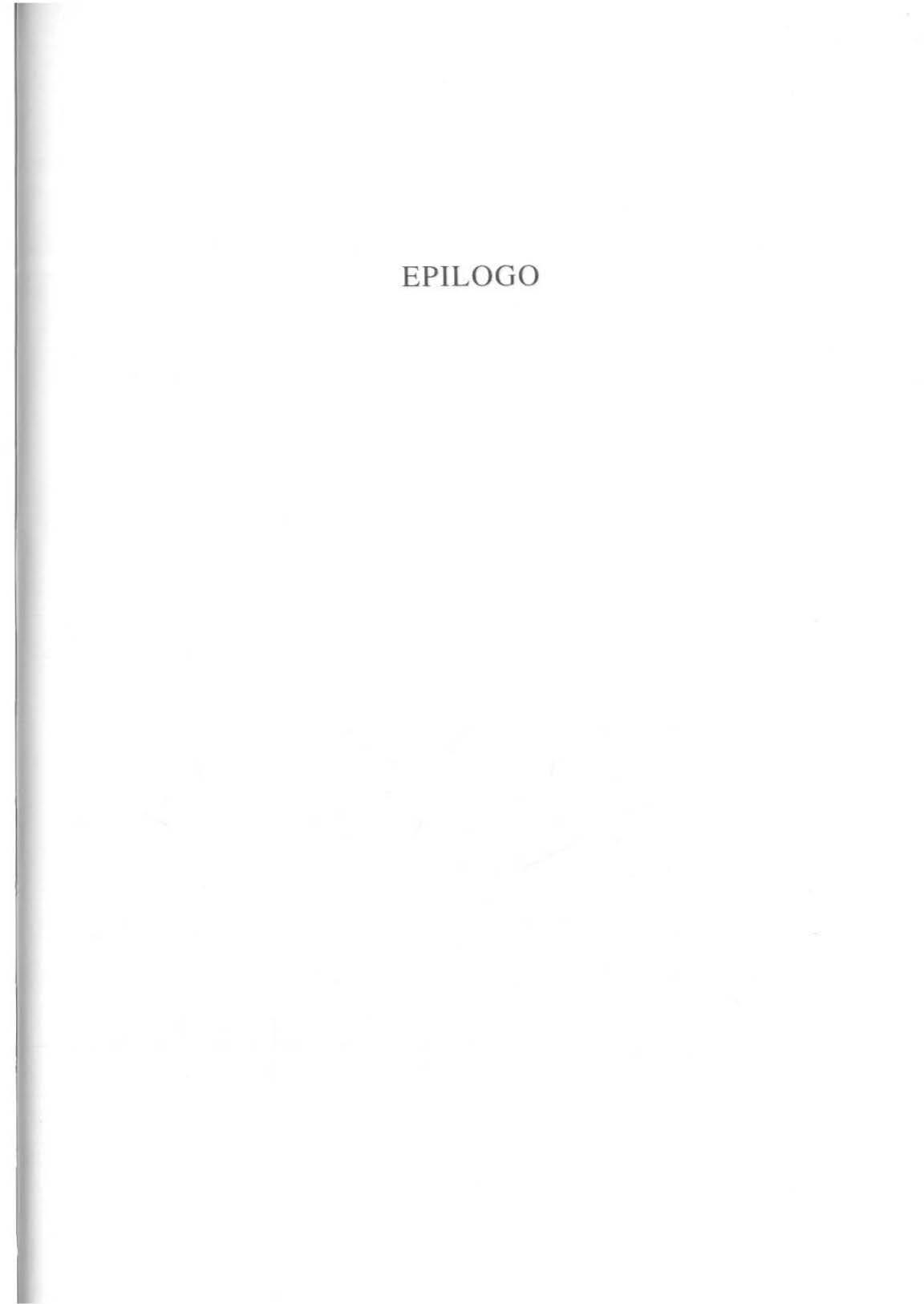
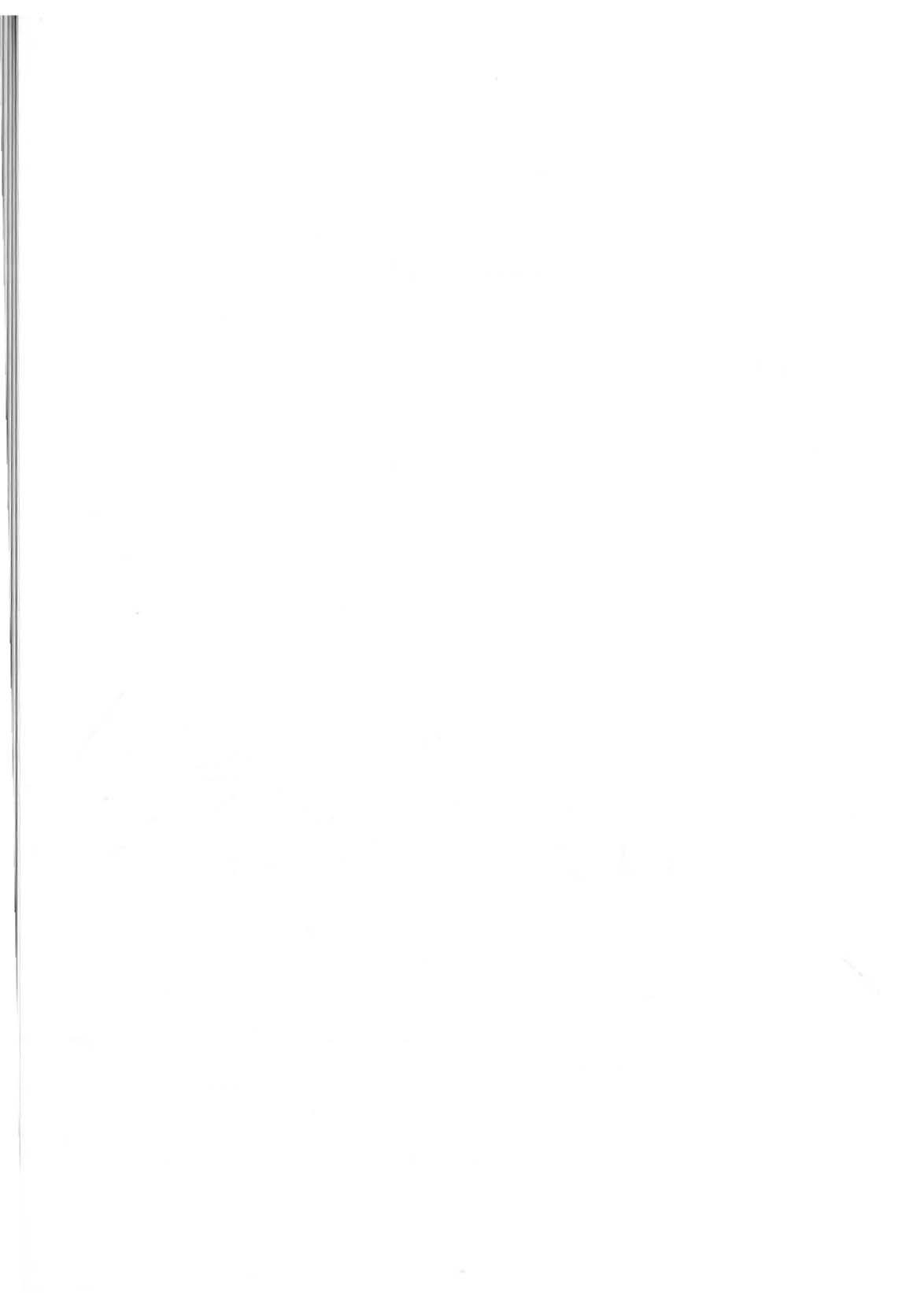

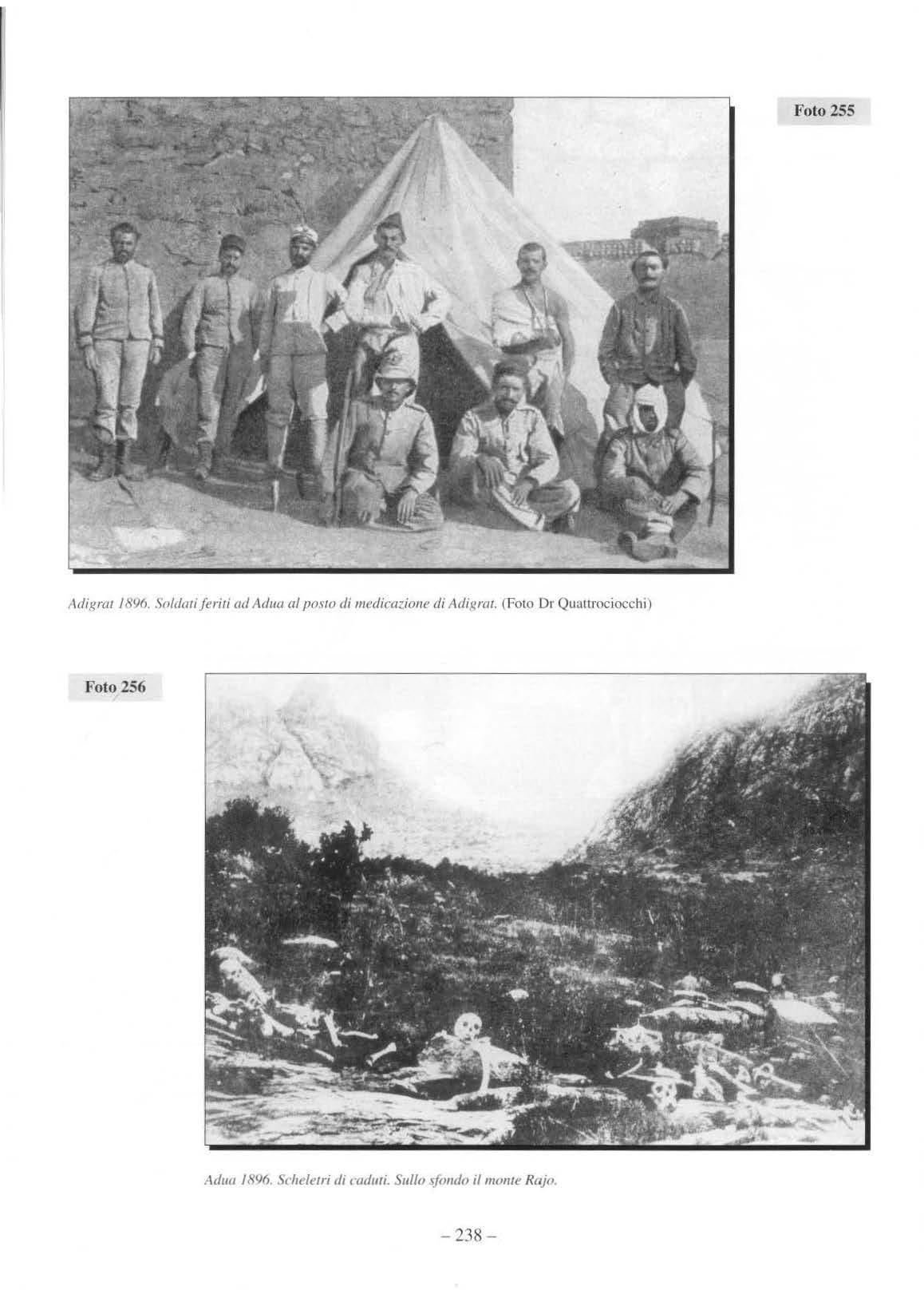
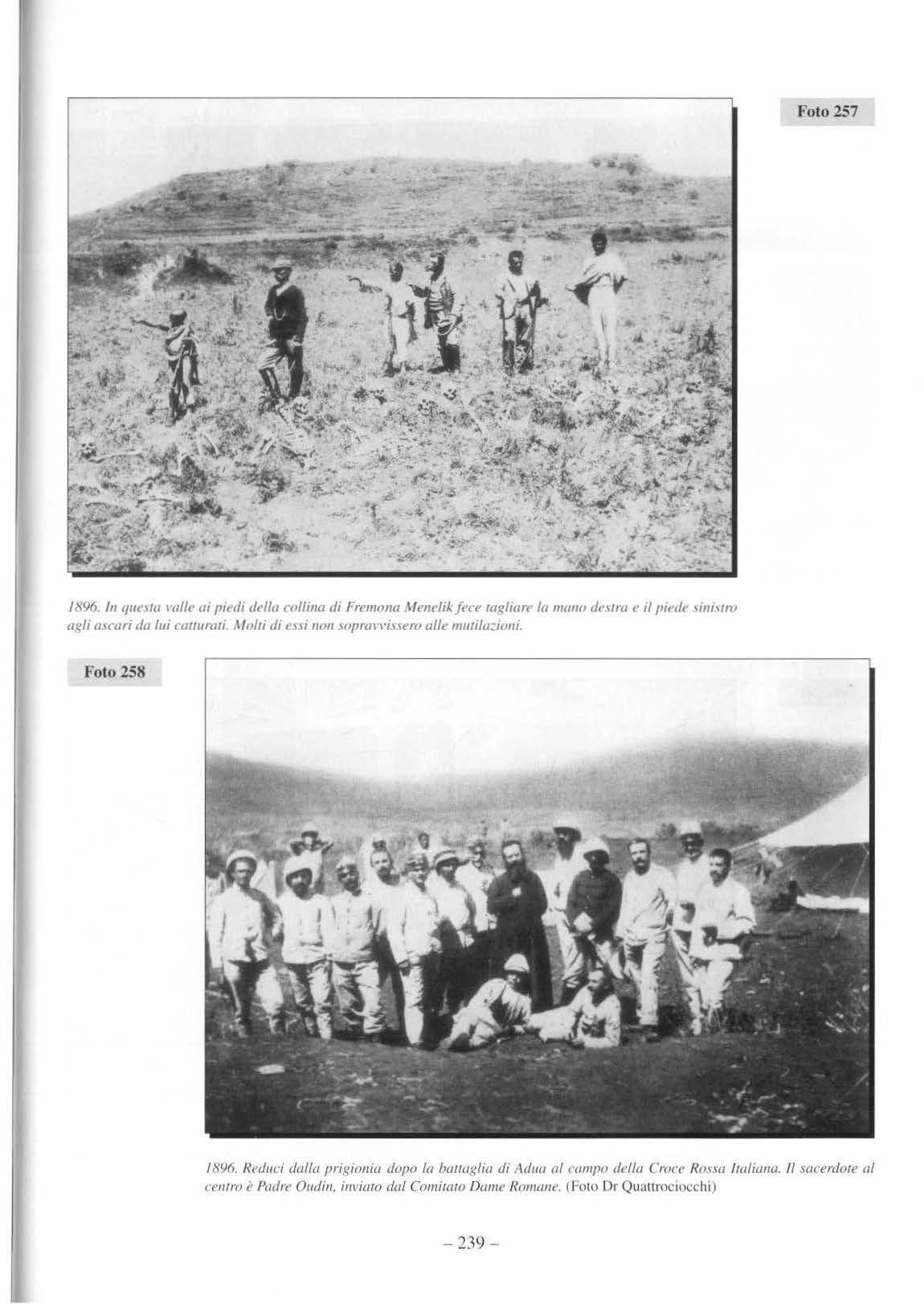 1896. Jnque.\/a l'alle ai ptedi e/t'Ila collina dt Fremono Menelikfece tagliare la ma11o de.1tra e il pwde Jinùtro agli mcari da lui cattt11mi Molti dt eui 11011 soprtiiTi.nero alle mwila::.ioni.
Foto 258
Foto 257
1896. Jnque.\/a l'alle ai ptedi e/t'Ila collina dt Fremono Menelikfece tagliare la ma11o de.1tra e il pwde Jinùtro agli mcari da lui cattt11mi Molti dt eui 11011 soprtiiTi.nero alle mwila::.ioni.
Foto 258
Foto 257