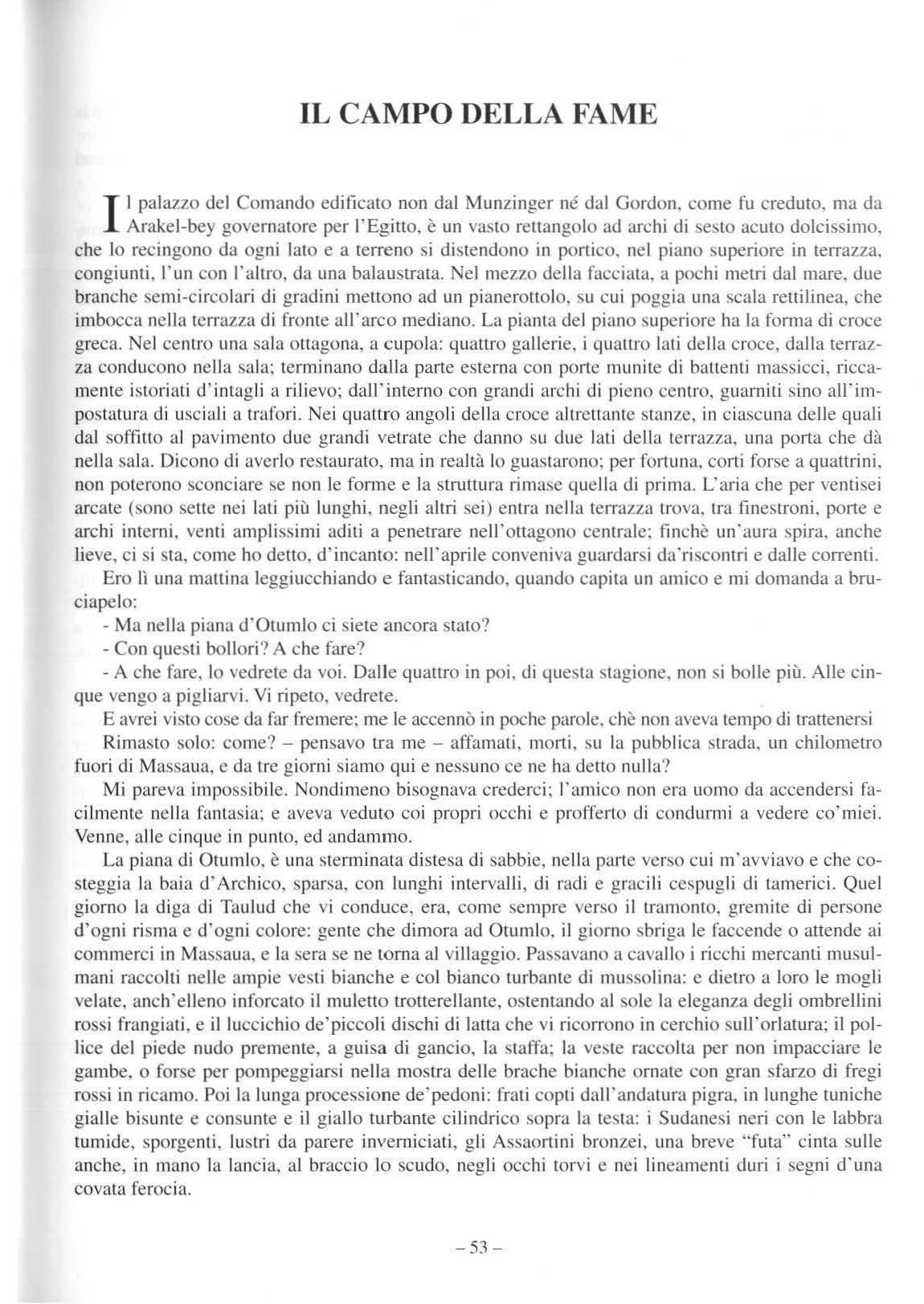
19 minute read
STATO MAGGlORE DEL BATTAGLIONE BERSAG LIERI
Tenente colonnello
Capitano mec!ico
Advertisement
Grado
Aiutante maggiore in 2"
Ufficiali sub. medici .
Ufficiale sub. contabile
Furiere maggLorc:
Caporale maggiore
Sergente zappatore
Caporale trombettiere
Capora.l magg. o caporale
Sotrufficiale armaiolo
Allievo armaiolo
Attendenti Capitano
Sotto tenenti
Furiere
Sergenti
Caporali maggiori
Caporal furiere
Caporale zappatore
Caporali Appuntati
Trombettieri
Zappa tori.
Portaferiti Soldati
Annotazioni del 40 bersaglieri. d d 3° batt aglio ne del 40 b ersa glieri.
Putti cav. E milio - 40 bers.
I del t 0 bersagl., I dd 7 0, I ddi'S 0 del 40 bersaglieri. dd 40 bersaglieri. del 4 ° bersaglieri. dell'S 0 ber saglieri dd I 0 bersaglieri . dell'S 0 bersaglieri. dd 70 bersaglieri dd Io bersa g lieri
An notazio ni Le compag nie bersaglieri: a) la 6a. compagnia del 1° rc:gg. bers., comandata dal capitan o Ga rdini signor Enrico; b) la I Ò" compagnia dd 40 re gg. bers. comandata dal cap. Viandli sig. Ce sare; c) la Il" compagnia del 70 regg bers. comandata dal capitano Rovida signor Fr ancesco; d) la 12" compagnia del· rso regg. bers. comandata dal capitano Garofalo sig. Domenico.
DRAPPELLI DI SANITA' E SUSS ISTENZA
Il palazzo del Comando edificato non dal M un zinger né dal Gordon, come fu credu t o, ma da Arake l-bey governato re pe r rE g itto è un vasto rettangolo ad arc hi di sesto acuto dolcissimo, che lo recingono da og ni lato e a t erre no si distendono in portico. nel piano superiore in terrazza. congiunti, l'un con l'altro, da una balaustrata. Nel mezzo della facciata, a pochi metri da l mare. due bran c he semi-c irco la ri di g radi ni mettono ad un pianerottolo, su cu i poggia una scala rettilinea, che imbo cca ne ll a terrazza di fro nte all'arco mediano. La piant a del piano uperiore h a la forma di croce greca. Nel ce ntro un a sa la ottagona, a cupola: quattro galle ri e, i quattro lati d ella croce, dalla terrazza conducono ne ll a sala ; terrru nano dalla parte este rna co n port e munite di battenti massicci, riccame nte istO ri a ti d ' inta g li a rilievo ; dall'interno con g randi archi di pi e no ce ntro, g uarniti s ino all'impostatura di usc iali a t rafor i. Nei quattro angoli della c ro ce altrettante sta n ze, in c iasc un a d e ll e quali dal so ffitto a l pav im ento due g randi vetrate che danno s u du e lat i della terrazza. una porta che dà ne ll a sa la. Di co no di ave rlo re s taurato, ma in realtà lo g uas t a rono; per fortuna, cor t i forse a qu a ttrin i, no n poterono sco nc i are se non l e forme e l a struttura rim ase quella di pr i ma. L'aria c he per ventise i arca te (so no se t te nei l ati più lun g hi , negli altri sei) e ntr a ne ll a terrazza trova, tra finestroni, porte e archi inte rni , ve nti a mpli ss imi aditi a penetrare nell'ottagono ccmrale; finchè un ·aura spira, anche lieve, ci si s ta , co me ho d etto, d' in canto: nell 'a pril e co n veniva gua rd a rsi da' r iscontri e da ll e correnti.
Ero lì una m att i na leggiucchiando e fan t ast ic and o, quando capita un amico e mi domanda a bruciape lo:
- M a nella piana d'Otumlo ci si ete ancora sta t o?
-Co n que ti bollori? A c he fare?
-A che fare, lo ved rete da voi. Dalle quattro in poi, di questa stag ione, non si bolle più. Alle cinque ve ngo a pigliarvi. Vi ripeto, ve drete .
E av re i visto cose da far fremere; me le accennò in poche paro le, chè non aveva tempo di trattenersi
Rima s t o so lo: co m e?- pe nsavo tr a me- affa m ati, morti, s u la pubblica st rada, un chilometro fuori di Massaua, e da tr e g iorni s ia mo qui e nessuno ce ne ha detto nulla?
Mi pareva imp oss ibil e . Nondimeno bi sog nava c re d erc i ; l 'a mi co non e ra uomo da accendersi fac ilm e nte ne ll a fanta sia; e a veva veduto coi propri occhi e profferto di con durmi a vedere co'miei. Venne , a ll e c inqu e in punto, ed andammo.
La pi a na di Otuml o, è una sterminata dis te sa di sa bbie, ne ll a pa rte verso c ui m 'avv iavo e che cos teggia la ba ia d' Archico, s parsa, con lunghi inter va lli , di r ad i e g rac ili cesp ug li di tamerici. Qu e l giorno la di ga di Ta ulud c he vi conduce, era, come se mpre ve rso il tramonto. gre mit e di persone d 'og ni ri s ma e d 'og ni co lore : gente che dimora ad Otuml o, il giorno sbr iga le faccende o attende a i commerci in M assaua, e la se ra se ne torna al vi lla gg i o. Passava no a cavallo i ricchi m e rcanti musulm ani ra cco lti ne ll e a mpi e ves t i bianche e c o l bian co turbante d i mu so lin a: e d ietro a loro le mogli vela t e, anc h 'e ll e no inforcato il muletto trottere llante, os t en t a nd o a l o l e la eleganza d eg li ombrellini rossi frang ia ti , e il lu cc ic hio d e'pi cco li di sc hi di latta c he vi ricorrono in cerc hi o s ull 'o rl a tura; il pollice del pi e d e nudo p remente. a gu i s a di gancio, l a s t affa; la veste raccolta per non impacciare le gambe, o for e per pompegg iars i nell a mo s tra d e ll e brac he bi anche o rn ate con gra n s far zo di freg i ro ss i in ri ca m o. P o i la lun ga pro cessio ne de'pedoni: frati co pti dal l 'a nd at ur a pigra, in lunghe tuniche g ia ll e bisunte e co ns unte e il g iallo turbante c ilindri co sopra la testa: i Sudanesi neri co n l e labbra tumid e, s porge nti , lu s tri da parere in ve miciati , g li A ssaort ini bron.Lei, una breve ' ·futa" cinta s ull e anche, in mano la lancia, al br accio lo scudo. negli occhi torvi e ne i lin eame nti duri i segni d'una covata feroc ia
Seguitavo a pensare: qui affamati, qui morti? Perché, "si parva licet componere magnis", dire la diga di Taulud, a Massaua. è come dire i Portici di Po a Torino, o a Venezia le Procuratie.
Dubitavo: ne'racconti uditi strada facendo ci aveva a essere dell'esagerato. Pur troppo innanzi alla realtà de'fatti ogni descrizione mi parve biadita.
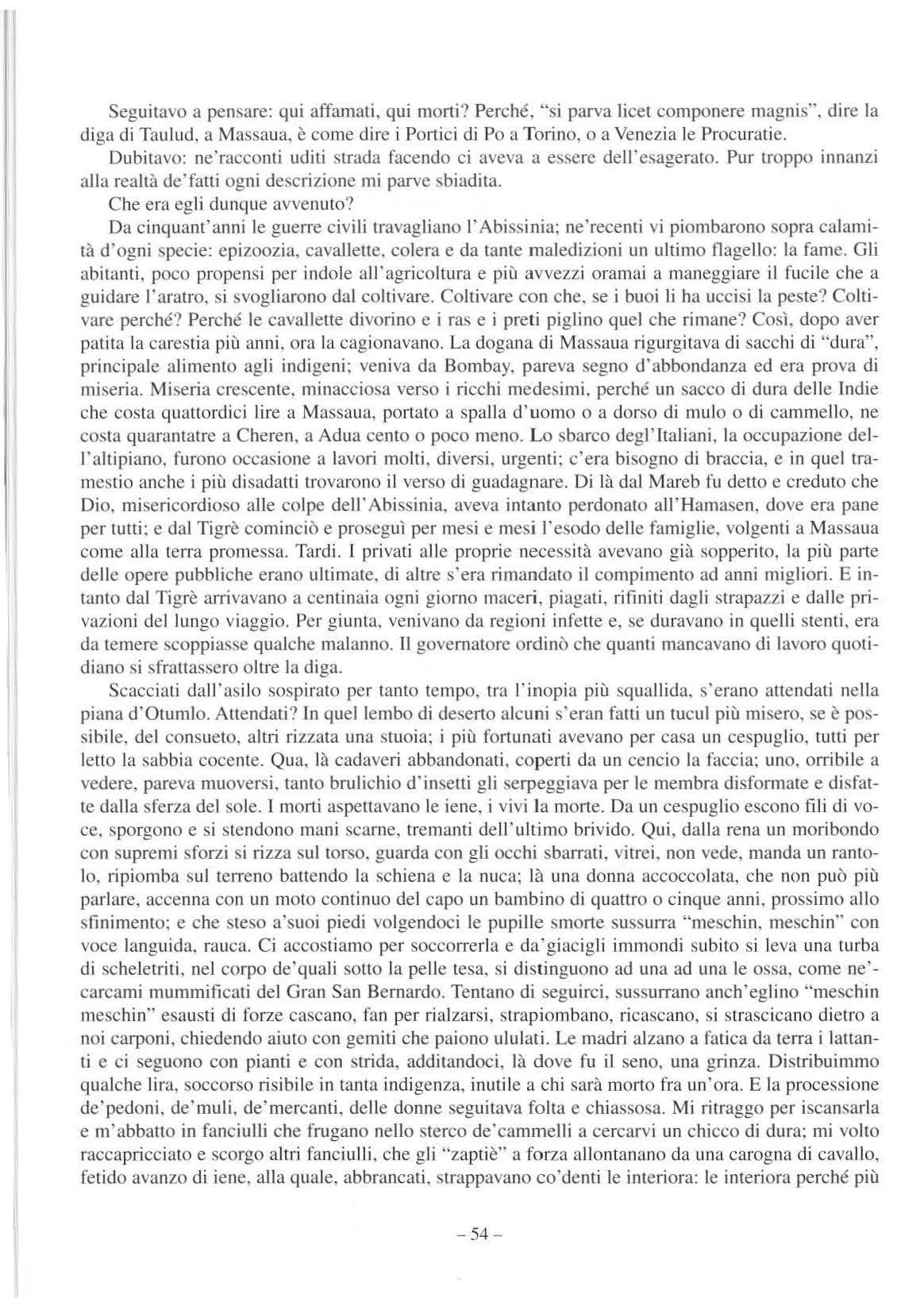
Che era egli dunque avvenuto?
Da cinquant'anni le guerre civili travagHano l'Abissinia: ne'recenti vi piombarono sopra ca lamità d'ogni pecie: ep izoozia, cavallette. colera e da tante maledizioni un ultimo nagello: la fame. Gli abitanti, poco propensi per indole all'agricoltura e più avvezzi oramai a maneggiare il fucile che a guidare l'aratro, si sveglia rono dal coltivare. Coltivare con che, se i buoi li ha uccisi la peste? Coltivare perché? Perché le cavallette divorino c i rase i pre ti piglino quel che rimane? Così, dopo aver patita la carestia piC1 anni, ora la cagionavano. La dogana di Massaua rigurgitava di sacchi di "dura", principale alimento agli indigeni: veniva da Bombay. pareva segno d'abbondanza ed era prova di miseria. Miseria crescente, minacciosa verso i ricchi medesimi, perché un sacco di dura delle Indie che costa quattordici lire a Massaua , portato a spa ll a d'uomo o a dorso di mulo o di cammello, ne costa quarantatre a Cheren, a Adua cento o poco meno. L o sbarco degl'Italiani, la occupazione dell ' altipiano, furono occasione a lavori molti, diversi, urgenti; c'era bisogno di braccia, e in quel tramestio anche i più disadatti trovarono il verso eli guadagnare. Di là dal Mareb fu detto e creduto che Dio. misericordioso alle colpe delfAbissinia, aveva intanto perdonato all'Hamasen, dove era pane per tutti; e da l Tigrè cominciò e proseguì per mesi e mesi l'esodo delle famiglie, volgenti a Massaua come alla terra promessa. Tardi. I privati a ll e proprie necessità avevano già sopperito, la più parte delle opere pubbliche erano ultimate. di altre s'era rimandato il compimento ad anni migliori. E intanto dal Tigrè arrivavano a centinaia ogni giorno mace ri , piagati, rifiniti dagli strapazzi e dalle privazioni del lungo viaggio. Per giunta, venivano da regioni infette e, se duravano in quelli stenti, era da temere coppiasse qualche malanno. ll governatore ordinò che quanti mancavano di lavoro quotidiano si sfrattassero o ltre la diga.
Scacciati dall'asilo sospirato per tanto tempo, tra l'inopia più squallida, s'erano attendati nella piana d'Otumlo. Allenda ti? In quel lembo di deserto alcu ni s'eran fatti un tucul più misero, se è possibile, del consueto, alni rizzata una stuoia; i più fortunati avevano per casa un cespug lio, tutti per letto la sabbia cocente. Qua, là cadaveri abbandonati, co perti da un cencio la faccia; un o, orribile a vedere. pareva muoversi. tanto brulichio d'in etti gli erpeggiava per le membra disformate e disfatte dalla sferza del sole. I morti aspettavano le iene, i v ivi la morte. Da un cespuglio escono fili di voce, sporgono e si stendono mani scarne, tremanti dell'ultimo brivido. Qui, dalla rena un moribondo con supremi sforzi si rizza ul torso, guarda con gli occhi sbarrati, vitrei, non vede, manda un rantolo, ripiornb a sul terreno battendo la schien a e la nuca; là una donna accoccolata, c he non può più parlare, accenna con un moto cont inu o del capo un bambino di quattro o c inqu e anni, prossimo allo sfinimento; e che teso a'suoi piedi vo lgendoci le pupille smorte sussurra "meschin. meschin" con voce languida, rauca. Ci accostiamo per soccorrerla e da'giacigli immondi sub ito si l eva una turba di sche l etri ti, nel corpo de'quali sotto l a pelle tesa, si distinguono ad una ad una le ossa. come ne'carcami mummificari del Gran San Bernardo. Tentano di segu irei, sussunano anch'eglino "meschin meschin" esausti di forze cascano , fan per rialzarsi, s trapiombano , ricascano, si s tra sc ica no dietro a noi carponi, chiedendo aiuto con gemiti che paiono ululati. Le madri alzano a fa ti ca da terra i lattanti e ci seguono con pianti e con strida, additandoci, là dove fu il seno, una grinza. Di st ribuimm o qualche lira, soccorso risibile in tanta indig enza, inutile a chi sarà morto fra un 'ora. E la processione de'pedoni, de'muli, de'mercanti. delle donne seguitava folta e chiasso a. Mi ritraggo per isca nsarl a e m'abbatto in fanciulli che frugano nello sterco de'cammelli a cercarvi un chicco di dura; mi volto raccapricciato e sco rgo altri fanciulli, c he gli ··zaptiè'' a forza allontanano da una carogna di cavallo, fetido avanzo di iene. alla quale, abbrancati, strappavano co 'denti le interiora: l e interiora perché più molli, e più molli perché più imputridite. Fuggo, inorridito, istupidito , vergognoso della impotenza mia, na scondendo per vergogna la catena dell'oriolo, vergognando in me stesso della colazione che ho fatta, del desinare che m'aspella. Lo so, lo so, ciò che avete da dirmi: sovvenire è imposibile, non v'è soccorso che basti, e se oggi s i soccorresse, s i rovescerebbe domani qui tutta l'Abissinia. Lo so, lo so. che non tutto è disgrazia e c'è la pigrizia, l'imprevidenza, l'incuria; ma chi ha cuore di rimproverare moribondi che invidiano i morti? Udii per più giorni ragionamenti savissimi, ma per più notti tra l'allucinazione ed il sonno, nel corrompersi e confondersi delle immagini mi gravarono inc ubi, mi perseguitarono visioni, di alcuna delle quali tuttavia mi rammento. Ora mi svegliava di sobbalzo il contallo di un corpo gelido, ora una mano gelida e ossuta mi premeva sul petto e mi toglieva il respiro; e nel sogno affannato, mi pareva fuggire fuggire, sotto un so le ardenti ss imo, senza meta , senza scampo, per lande senza confine riarse , inseguito da iene che mugliando si approssimavano, inseguite alla lor volta da una sc hiera di Sudanesi, so pra cavalli giganteschi che correvano a briglia sciolta, fra torme di frati. di mercanti , di donne, di scheletri con la lancia e con l'ombrellino.
Poveri mor1i! Deponete corone di fiori pallidi sulle zolle ove caddero, piangete sui loro tumuli lacrime interiori, che si asciugano più tardi.
Andammo a Dogali, e deponemmo una corona anche noi.
Sabbie, sabbie, dappertutto sabbie che scottano e abbacinano; e per le sabbie qualche solo arbusto di "calotropis" dalle grosse bacche ovate, verdi con riflessi celestognoli, il cui sugo latteo, a detta degl'indigeni, infiamma la pelle di chi s'arrischia a toccarlo. Più innanzi un torrente, il Desset, traversa la valle e, lambendo un labirinto di alture aspre e aride, va a perdersi nel deserto che congiunge Moncullo col mare. Sulla pianura biancastra s'alzano i poggi lividi, nudi alla cima: paiono teste calve di cadaveri giganteschi, sorgenti di sotto a un immenso lenzuolo, prossime ad imputridire. Il Desset, come molti torrenti dell'Abissinia, asciutto la più gran parte dell'anno, si gonfia a volte per la pioggia in un tratto, così da abbattere e subissare ogni cosa che trovi. Guai allora la notte alle carovane accampate sulle sue rive! Poco innanzi che giungessimo a Massaua, ingrossato in un attimo, travolse e annegò più di quaranta persone, senza che avessero il tempo neppur di svegliarsi. Altre carovane vi si accampano ancora. Quella è la via che fu sempre percorsa; perché mutarla? Lì sono le acque ove da tempo immemorabile si abbeverarono i cammelli; perché cercarne altre altrove? Si può rischiare la vita: ma che va]e la vita per un Abissino?
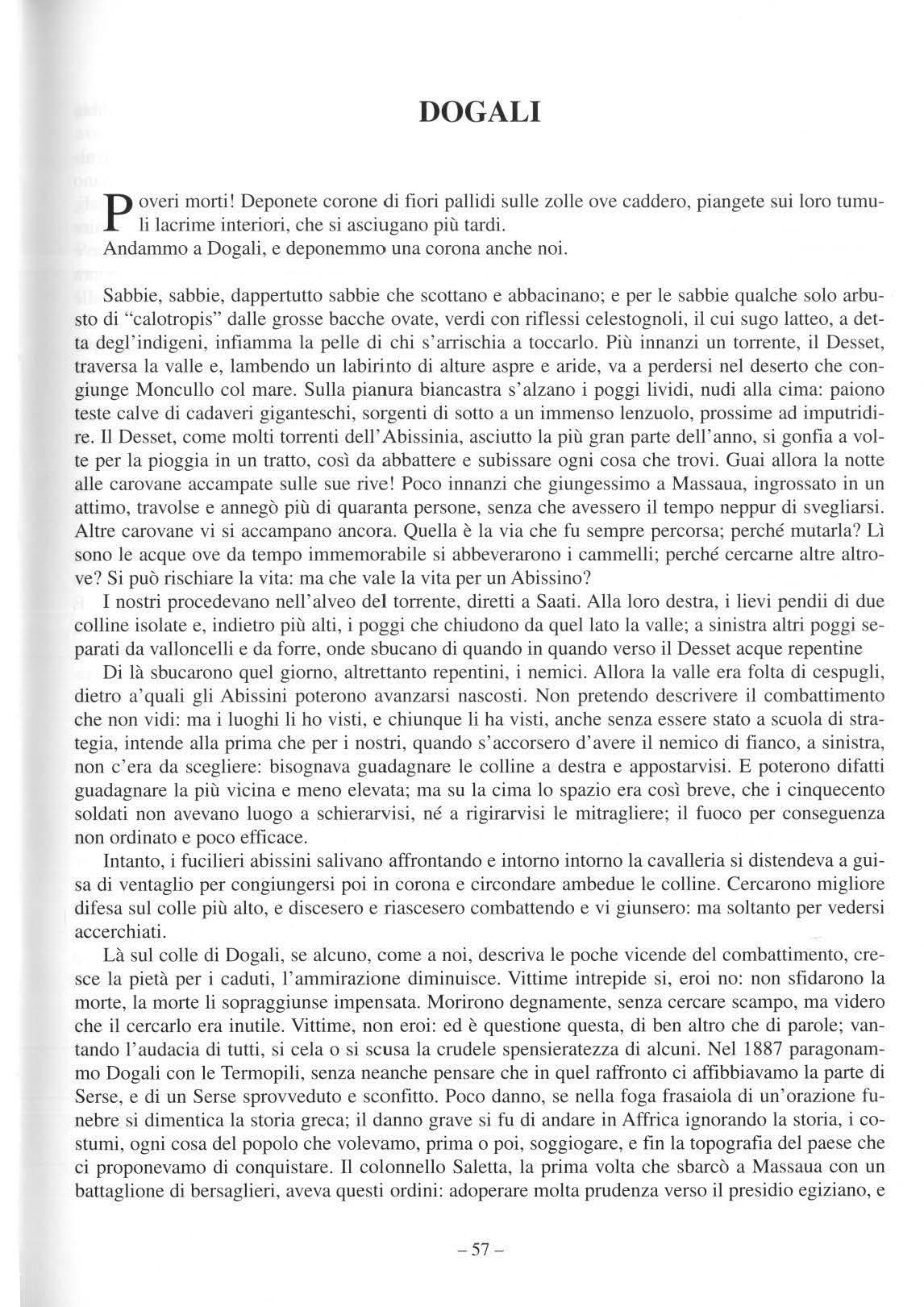
I nostri procedevano nell'alveo del torrente, diretti a Saati. Alla loro destra, i lievi pendii di due colline isolate e, indietro più alti, i poggi che chiudono da quel lato la valle; a sinistra altri poggi separati da va11once11 i e da forre, onde sbucano di quando in quando verso il Desset acque repentine
Di là sbucarono quel giorno, altrettanto repentini, i nemici. Allora la valle era folta di cespugli, dietro a'quali gli Abissini poterono avanzarsi nascosti. Non pretendo descrivere il combattimento che non vidi: ma i luoghi li ho visti, e chiunque li ha visti, anche senza essere stato a scuola di strategia, intende alla prima che per i nostri, quando s'accorsero d'avere il nemico di fianco, a sinistra, non c'era da scegliere: bisognava guadagnare le colline a destra e appostarvisi. E poterono difatti guadagnare la più vicina e meno e levata; ma su la cima lo spazio era così breve, che i cinquecento soldati non avevan o luogo a schierarvisi, né a rigirarvisi le mitragliere; il fuoco per conseguenza non o rdinat o e poco efficace.
Intanto, i fucilieri abissini salivano affrontando e intorno intorno la cavalleria si distendeva a guisa di ventaglio per congiunge r si poi in corona e ci rco ndare ambedue le colline. Cercarono migliore difesa sul co ll e più alto, e discesero e riascesero combattendo e vi g iun sero: ma so l tanto per vedersi accerchiati.
Là sul colle di D oga li , se alcuno, come a noi, descriva le poche vicende del combattimento, cresce la pietà per i cadu ti, l'ammirazione diminuisce. Vittime intre pide s i , ero i no: non sfidarono la morte, la morte li sopraggiunse impensata. Mmirono degnamente, se nz a cercare scampo, ma videro che il ce rcarlo era inu ti le. Vittime, non eroi: ed è questione questa, di ben al tro c h e di parole; vantando l'audacia di tutti, si ce la o si sc u sa la crudele spensieratezza di alcuni. Nel 1887 paragonammo Dogali con le Termopili, senza neanche pe nsare c he in quel raffronto ci affibbiavamo la parte di Serse, e di un Serse sprovvedu to e scon fitt o . Poco danno, se nella foga frasaiola di un'orazione funebre si dimentica la storia greca; il danno gr ave si fu di andare in Affrica igno r ando la storia, i cost umi, og ni cosa del popolo che vo le vamo, prima o poi, soggioga re, e fm la topografia del paese che ci proponevamo di co nqui s tare li colonne llo Saletta, la prima volta che sbarcò a Massaua con un battaglione di bersaglieri, aveva questi o rdini: adoperare molta prudenza verso il presidio eg iziano, e fare una " recognizionc " fino a Cartum. Per quanto lo sproposito possa parer grossolano a chi abbia veduto, una volta so la , una carta dell' Affrica, nondimeno fu scritto, e i documenti son lì.
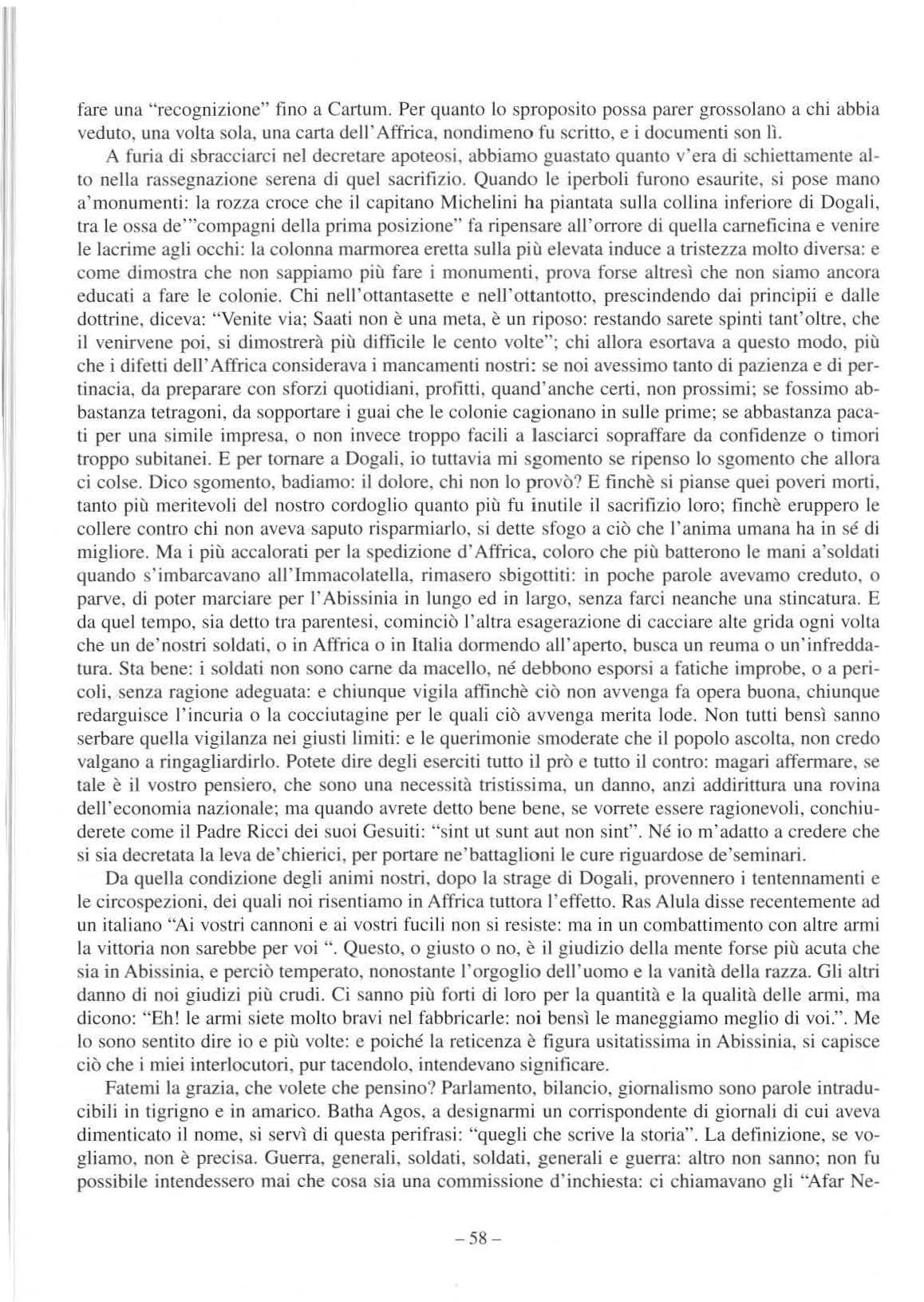
A furia di sb ra cc iarci nel decretare apoteo s i, abbiamo guastato quanto v'er a di schiettamente alto nella rassegnazione serena di qu e l sac rifi z io. Quando le ip erbo li furono esaurite , si pose mano a'monumenti: la ro zza croce che 11 capitano Mi c helini ha piantata sulla collina inferiore di Do ga li, tra le ossa de'"compagni della prima posizione" fa ripensare all'orrore di quella carneficina e venire le la crime agli occhi: la co lonna marmorea eretta sulla più elevata induce a tri ste zza molto div ersa: e come dimostra che non sap pian1 o più fare i monumenti, prova forse a ltresì che non s iamo ancora educati a fare le colonie. Chi nell 'ottantase tte c nell'ottantotto, presc indendo dai principii e dalle dottrine, diceva: "Venite via; Saati non è una meta, è un riposo: restando sare te spinti tant'oltre, c he il venirvene poi, si dimostrerà più difficile le cento volte"; chi allora e ortava a questo modo, più c he i dife tti dell ' Affrica considerava i mancam e nti nostri: se noi avessimo tanto di pazienza e di pertinacia, da preparare con sforzi quotidiani, profitti, quand 'a nc he certi, non prossimi; se fossimo abbastanza tetragoni, da sop portare i g uai che le colonie cagionano in sulle prime; se abbastanza pac ati per un a sim ile impresa, o non invece troppo facili a lasciarci sopraffa re da confidenze o timori troppo subitanei. E per tornare a Do gali, io tuttavia mi sgo me nto se rip enso lo sgome nto che a ll ora ci colse. Dico sgomen to, badiam o: il dolore, c hi non lo provò? E finchè si pianse quei poveri morti , tanto più meritevoli de l nostro cordoglio quanto più fu inutile il sacrifizio loro; finchè eruppero le collere contro chi non aveva saputo risparmiarl o, s i dette sfogo a ciò che l'anima umana ha in sé di migli ore. Ma i più accalorati per la sped izion e d' Affrica, co loro che più batterono le mani a'soldati quando s' imbarcavano a ll ' Imma co latella, rima ero sbigottiti: in poche parole avevamo creduto, o parve, di poter marciare per l'Abissinia in lun go ed in largo, se nza farci neanche una s tincatura E da quel tempo, sia detto tra parentes i, cominciò l'a ltra esagerazione di cacciare alte grida ognj volta che un de'nostri so ldati , o io Affrica o in Italia dormendo all'aperto. busca un reuma o un 'infreddatura. Sta bene: i soldati non so no carne da ma ce ll o, né debbono esporsi a fatiche improbe, o a perico li, se nza ragion e adeguata: e chiunque vigila affi nchè c iò non avvenga fa opera buona, chiunque redargui sce l'incuria o la cocciutagine per le quali ciò avvenga merita lode. Non tutti bensì sanno serbare quella vigilanza nei giusti limiti: e le querimonie smode rate che il popolo ascolta, non credo valgano a ringagliardirlo. Potete dire degli eserciti tutto il prò e tutto il co ntro: magari affermare, se tale è il vostro pensiero. che so no una necessità tristissima, un danno , anzi addirittura una rovina dell'economia nazional e; ma quando avrete detto bene bene, se vorrete esse re ragionevoli, conchiuderete come il Padre Ricci dei suoi Gesuiti: "s int ut sunt aut non sint". Né io m'adatto a credere c he si sia decretata la leva de'chierici, per portare ne'battaglioni le cure riguardose de 'sem inari .
Da quella condizione degli animi no stri , dopo la strage di Dogali , pro vennero i tentennamenti e le circospezioni, dei qu a li noi risentiamo in Affrica tuttora l'effe tto. Ra s Alula di sse recentemente ad un italiano "Ai vostri cannoni e ai vostri fucili non si res iste: ma in un combattimento con altre armi la vittoria non sarebbe per voi ". Questo, o g iu s to o no, è il g iudizio dell a mente forse più acuta c h e sia in Abissinia, e perciò temp erato, nono stan te l'orgoglio dell'uomo e la va nità della razza. Gli altri danno di noi giudizi più crudi. Ci sa nno più forti di loro per la quantità e la qualità delle armi, ma dicono: "E h! le armi s iete molto bravi nel fabbricarle: no i bensì le maneggiamo meglio di voi.". Mc lo sono se ntito dire io e più volte: c poiché la ret icenza è tìgura usitati ss ima in Abi ss inia , si capisce ciò che i mi e i interlocutori, pur tacendolo. intendevano s ignificare.
Fatemi la grazia, c he vo lete c he pensino? Parlamento, bilancio, giornalismo so no parole intraducibili in tigrigno e in amarico. Batha Agos, a d es ignarmi un corris pondente di giornali di cui aveva dimenticato il nome, si servì di que s ta perifras i: "quegli che sc rive la storia". La definizione, se vogliamo, no n è precisa. Guerra , generali, soldati, so ldati , generali e guerra: altro non sa nno; non fu pos sibil e intendessero mai che cosa sia una commissione d'inchiesta: ci c hiamavano g li "Afar Ne- gu ", oss ia ( ignora n o perfino che la coro na è inviolabile) le "bocche del re". Ne 'primi giorn i io c he avevo un reuma in una gamba e pativo ne l m ontare a cava ll o, passru per un generale ferito. D e'fa tti nostri quali co no scono?

J ohannes venne tra Sabarguma e Ailet, ci nqu e o re di m arc ia di sta nt e da Saat i, v i rimase otto giorn i. Costretto dalla penuri a di vettovaglie (la ten·ibilc ne mica che gli Abis s ini con ducono in guerra tra le lo ro file e c he su l più bello l e accascia e di s perde) la sc iò il campo e ritornò s ui propri pass i. Pe r o rdin e de l ge nera le San Marzano sq uadre e so tt o-squadre con taro no i tu cu l abban do nati : e r ano ve ntidu emila: date le cost uman Le abiss in e s i può adunque calcolare c he col Neg us s i avviassero per I' Ha mase n c irc a ottan tam il a perso ne.
Si sa che cos'è la marcia e, peggio, la ritirata di un esercito abissino. Il r e. i ca pi innanzi: dietro a lo ro per se ntieri aspri e a ngust i un a lun ga process ione di so ld at i, di ca nt ori, di timballieri, di vecchi, di pret i. di fanciulli, di d on ne, di muli: con a rmi , tende a ttrezzi, vasi di idrome le e di birra , ute ns ili d'o g ni ge nere e d'o g ni s pec ie: soldati cantori, timballieri, donne, preti, vecc hi , fanciulli tutti fre tt olosi de l pari , tutti trattenuti a quando a quando da qu e lla fa rragine d'impedim e nti , tutti per la via rifatta li bera, riaffollanti s i in s iem e in una calca ondeggiante, nuovo impedimento a sé s tessa.
Ta lora un Capo, o un degiacc, o un fitaurari a tt ardato, a rriva trottando s ul mulo, vuo l passo per ra ggiu ngere il re, e a d o ttener lo distribuisce frustate a dritta e a mancina. A ll o ra c hi s i s tringe con tro g li a l beri , c hi vi si avviticc hi a, chi s i rifugia, sco rti candos i, rra'cespi degli arb ust i s pin osi, chi si arrisc hia s ugli o rl i scab ri d'un preci pi z io: per tutti poi a un punto ri ver sarsi ne ll a stretta, pigiandos i, cozza ndo s i, se minand o bre nd o li di vesti, frantumi di masseri zie , quegli ca de nd o, questi in ciam pa nd o ne l caduto , tra le ri sa, i lamenti, le st rid a.
Im ag inate ottantamila perso ne, deJle quali un quarto ama la pena atte a co mb a tte r e, che a que sto modo s i se1Tano fra gli scosce ndimenti del Ghind a, o s'a rram picano per le bal ze dirup a te dell ' Arboroba, stre mate , se nza pane , se nz'acq ua: e ditemj poi quale res is ten za pot eva no oppo rre a chi le avesse assa lt a te in calzando. No i s temmo co ll 'arm e in s palla a g uardarli , e quel co nteg no non g i ovò ad accrescere la es tim azione che grindi ge ni facevano de l nostro val or militare. So c he l'Abissinia è a ta l i estre mi che nessuno u·a i s uoi re, n é i s uo i re tutti quant i adunati sono in g rado di muoverei per o ra la g ue rra ; vo persuaso che ove s i dovesse co mb a tte re, sa pre mmo an che v ince re: ma persuaso altre sì c he il co mbattere e il v in ce re allora c i avrebbe procurato, assai m eglio che l'a ltrui mi seria prese nte la pace per lunghi ss imi anni.
P e r vendicare i caduti di Dog a li , mandammo in Affrica di ec imila so ld a ti e qu aranta milioni: i milioni usc irono dalle casse, i so ldati non usc iron o dall e fortezze. Poi ché s'e ra fatta quella s pedizione, rag ion voleva si insegnasse un a volta per se mpre ag li Abissini che s iamo un popolo militare anc he noi ; e l egge mmo passa re pe r un popolo di sc ie nziati e c i bastò irradiare co n la luce elettrica il ca mp o dell'imperatore. Chi dice c he gl'Italiani non sa nno mai ciò che vog li a no? Su cert i punti a n zi, s ia m o o ramai irremo vi bili : vogliamo la gra nd ezza se nza spesa. le economi e se nza sacrifizi, e la g ue rra se nza morti. Il di seg no è stupendo: forse, difficile ad effettuare .










