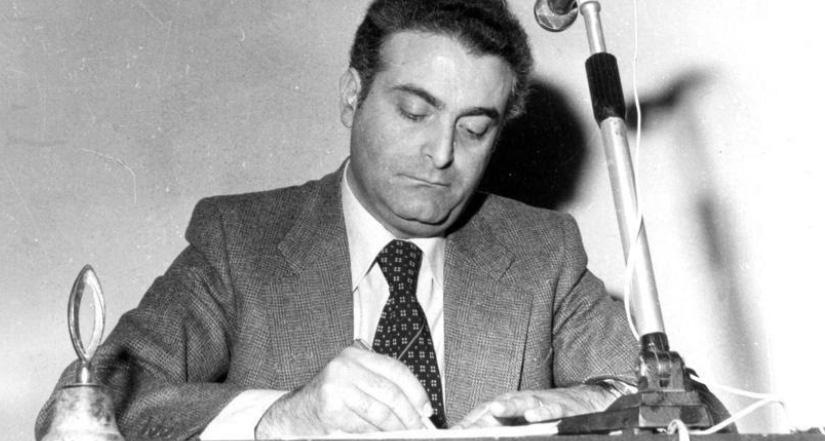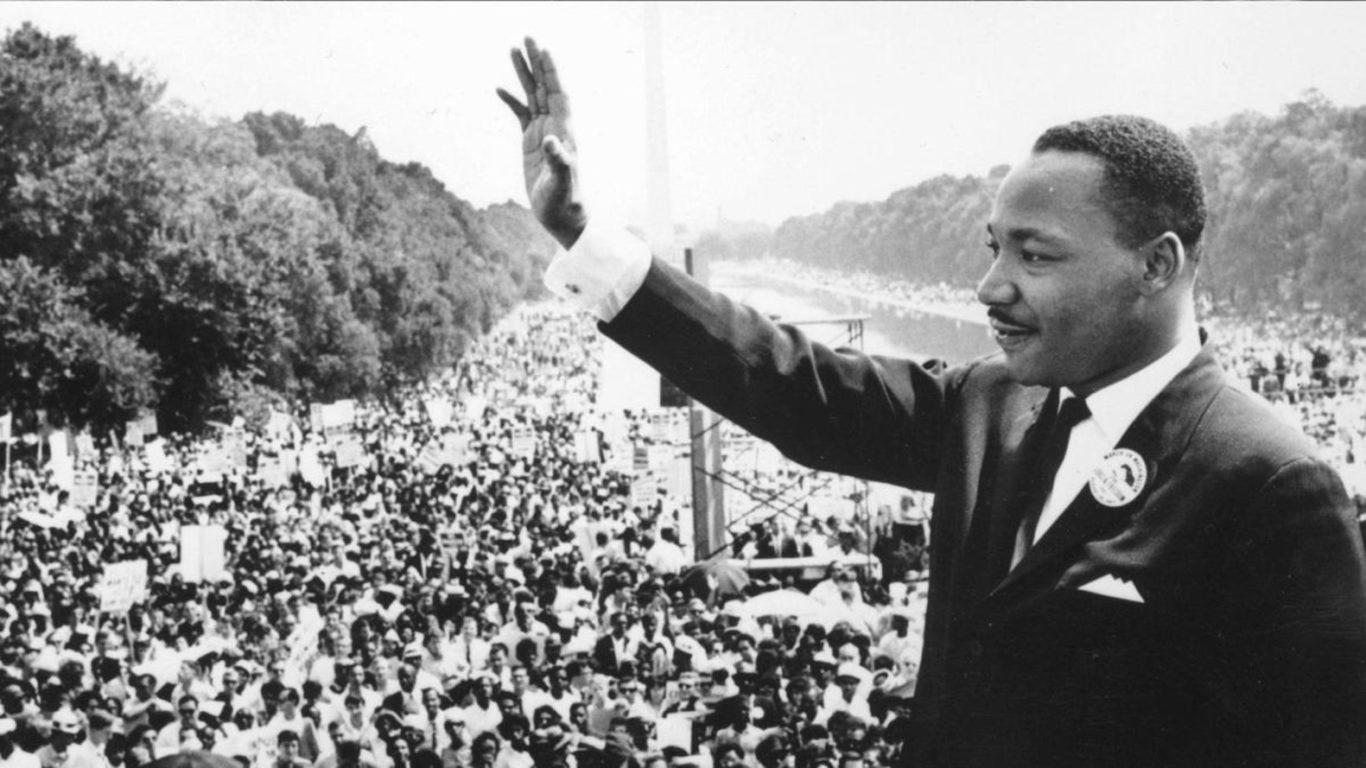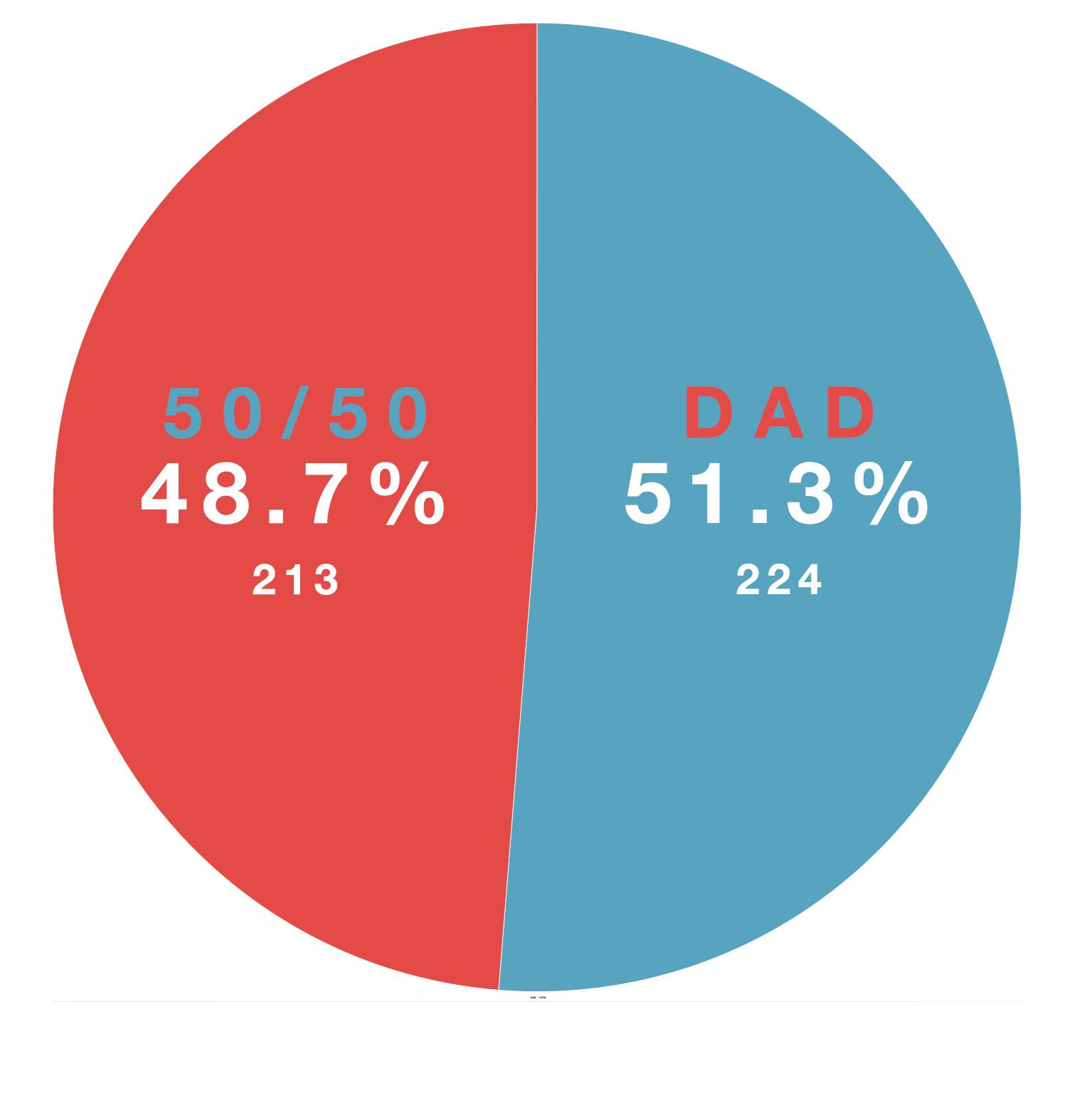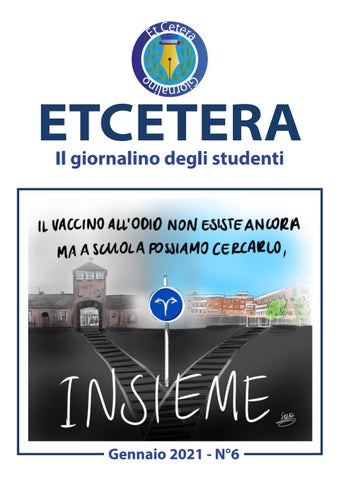6 minute read
Villa Reale, monumento alla nostra identità culturale
TERRITORIO VILLA REALE MONUMENTO ALLA NOSTRA IDENTITÀ CULTURALE
REBECCA MARASCO, 4bb È la sera del 19 luglio 1900. I destini di due uomini stanno per incrociarsi in via Matteo da Campione, Monza. Il primo è un cinquantaseienne di Torino, coinvolto nella vita militare e da poco sostenitore di una politica autoritaria; il secondo è un trentunenne nato a Prato ma che vive ormai da alcuni anni in New Jersey. Quella sera le strade della cittadina milanese sono popolate da una moltitudine di persone che ha appena finito di assistere a delle competizioni sportive, quando all’improvviso nell’aria risuonano quattro colpi. Nello scompiglio generale si scorge il trentunenne di Prato con una rivoltella in mano. Tre dei proiettili raggiungono il torinese mentre si sta dirigendo a casa in carrozza. Il 30 luglio esce il primo comunicato stampa a riguardo: re Umberto I è stato assassinato dall’anarchico Gaetano Bresci. Inutili furono i tentativi di trasportare il sovrano, fatalmente ferito al collo e al petto, nella sua residenza di villeggiatura preferita, la Villa Reale. Il regno, che aveva già cominciato ad accusare i primi sintomi del disordine sociale, sprofonda nel caos totale: l’attentato avrebbe potuto aprire la strada ad irrimediabili sconvolgimenti politici e sociali, quindi si preferisce non diffondere subito la notizia della morte del re. Il suo cadavere viene deposto su un letto di uno degli appartamenti privati della reggia, dove rimane svariati giorni quasi a ricordare che debba essere presa alla svelta una decisione. Basta con i temporeggiamenti. Nel chiarore di quella sera tumultuosa, in controluce, si stagliavano le forme della Villa Reale, sfondo suggestivo ad un evento storico di tale portata quale un regicidio. Progettato dall’architetto Giuseppe Piermarini su commissione dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo, penultimo figlio dell’imperatrice Maria Teresa, l’edificio in stile neoclassico adempì alla funzione di residenza di villeggiatura fino all’arrivo delle truppe napoleoniche nel nord Italia, quando Bonaparte lo occupò e donò a Eugenio di Beauharnais, figlio della moglie. Con il ritorno degli Austriaci fu lasciato in stato di relativo abbandono e infine acquisito dalla casa regnante dei Savoia. Compiendo un cospicuo
Advertisement
salto temporale, si giunge ai giorni nostri: la Villa è ora lo sfondo di un mondo diverso rispetto ai primi anni del Novecento, spiccando tra le nuove costruzioni moderne. È ormai elemento insostituibile nel paesaggio e, nonostante siano passati ormai molti anni in cui ha padroneggiato sul territorio, continua a regalare incredibili suggestioni a chi si avvicina. La reggia conserva una bellezza immortale nei secoli, che trasporta l’osservatore in un tempo passato lontano e lo avvolge in questa dimensione con i suoi 700 ettari di giardini, divenendo una sorta di fuga dalla realtà. Tuttavia, la costruzione non appare segregata dalla moderna città di Monza, piuttosto costituisce una parte indispensabile della stessa. Essa, come tutto il patrimonio artistico-culturale, rappresenta infatti la nostra memoria culturale, di popolo italiano e anche mondiale. In un’opera d’arte rivive il periodo storico durante il quale essa fu concepita, con i costumi del tempo, e in essa affondano le nostre radici, seguendo le quali possiamo ricostruire la nostra stessa identità. Non si tratta però di un fenomeno riconducibile esclusivamente al particolarismo, ossia intendendo il patrimonio culturale come elemento fondante dell’identità nazionale di un singolo popolo, ma anche di uno con una prospettiva a più largo raggio come quella mondiale. Inoltre, il concetto di memoria culturale sottintende da una parte la volontà di conservare e preservare il bene artistico, dall’altra quella di contribuire alla trasmissione ai posteri di valori in esso rispecchiati; in entrambi i casi, comunque, il suo valore non si esaurisce nel frammento di passato riportato alla luce, ma crea un raccordo con il nostro presente. Di conseguenza, la memoria culturale (come ad esempio l’osservazione passiva di un’opera d’arte cessa di essere fine a se stessa) ma diventa atta a generare riflessioni o discussioni sui tempi correnti (a tal proposito vi inviterei a riflettere sul significato del Giorno della Memoria, visto che la funzione di memoria culturale non è assolta dalle sole opere artistiche, argomento questo su cui non mi soffermerò per non uscire dal tema dell’articolo). Talvolta, però, il grande patrimonio artistico-culturale italiano viene assunto per certo, come se ci si fosse abituati alla presenza di quell’edificio storico o di quella scultura, e di conseguenza messo in secondo piano o svilito nel suo significato. Un esempio inconsistente ma lampante di questo atteggiamento nei confronti dei beni artistici è costituito dalle tag, quelle firme che i visitatori si sentono quasi in dovere di lasciare sui muri ad affermazione del loro passaggio in quel luogo, azione questa non poi così diversa dalle scritte indelebili sulle porte dei bagni scolastici e sui banchi. La Villa Reale di Monza dunque, oltre ad essere un simbolo della città, richiama alle nostre menti quell’identità culturale di
cui abbiamo già parlato: anche chi non sia un amante delle forme artistiche, dopo una profonda riflessione, potrà convenire sul valore di tale monumento (inteso nell’accezione latina di monumentum da monere, ossia “ricordare”). È per questo motivo le voci circa una probabile chiusura della struttura e messa all’asta degli arredi ci hanno colpito così tanto: ad essere messa a repentaglio è la nostra Villa, la nostra identità culturale. In realtà, le notizie circolate riguardo la reggia non sono state sempre veritiere e hanno talvolta creato allarmi inopportuni. Essa, dopo un lungo lavoro di restauro, aveva riaperto le sue porte ai turisti nel settembre 2014 con una gestione di partenariato pubblico-privato, rispettivamente del Consorzio e del concessionario privato Nuova Villa Reale spa. Tuttavia, tra i due enti i rapporti sembrano essere sempre stati tesi e ora ulteriormente aggravati dalla pandemia: da una parte il concessionario rimprovera alla parte opposta l’indifferenza di fronte alle richieste portate alla luce e conseguentemente la mancanza di dialogo, dall’altra il Consorzio contesta le “gravi inadempienze” della società privata, quali un debito di 100mila euro per il riscaldamento e la mancata riapertura degli spazi museali dopo il primo lockdown. Di recente, l’annuncio del divorzio definitivo tra Consorzio e concessionario avvenuto il 15 gennaio, quando quest’ultimo ha riconsegnato le chiavi della Villa al Consorzio, ponendo fine in anticipo all’accordo ventennale stipulato. Quindi ora ci si interroga sulle sorti della struttura e, soprattutto, degli arredi storici. Innanzitutto, la messa all’asta riguarda solo il mobilio del piano terra, quello della caffetteria, ed è accompagnata dalla cancellazione delle mostre in programma. Per quanto riguarda gli arredi degli appartamenti privati, invece, il sindaco Allevi ci tranquillizza ribadendo “nessun arredo storico uscirà dalla Reggia”; sappiamo anzi che il consigliere regionale Alessandro Corbetta ha sollecitato la restituzione dei numerosi pezzi appartenenti alla Villa oggi situati nel Quirinale e in altre sedi di rappresentanza. Per il momento le suppellettili sembrano essere al sicuro, anche se è inevitabile la preoccupazione per le sorti della costruzione, che è stata privata del lieto fine promessole sette anni fa con la riapertura al pubblico. Il mio augurio – e credo quello di tutti- è che la Villa Reale possa ritornare ad accogliere al suo interno nelle sale del primo e secondo piano nobile i turisti e che vengano nuovamente programmate le date delle esposizioni, in modo tale che essa possa tornare ad assumere il suo importante ruolo di monumento, di esperienza didattica e infine di spunto di riflessione sul presente.