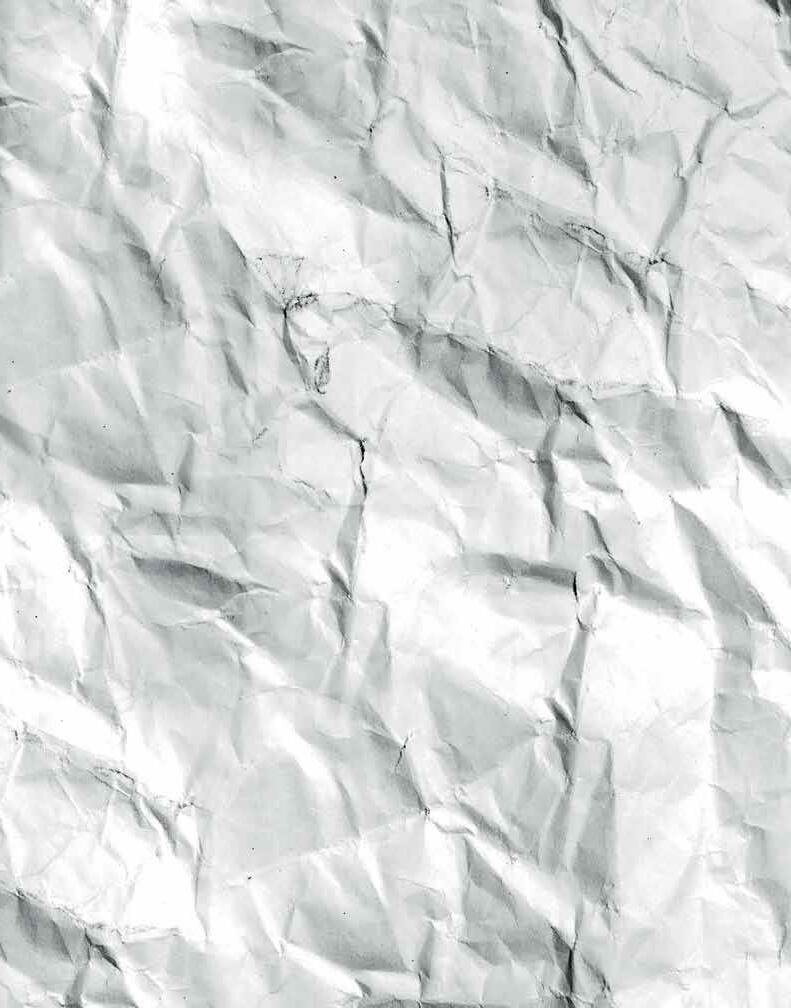
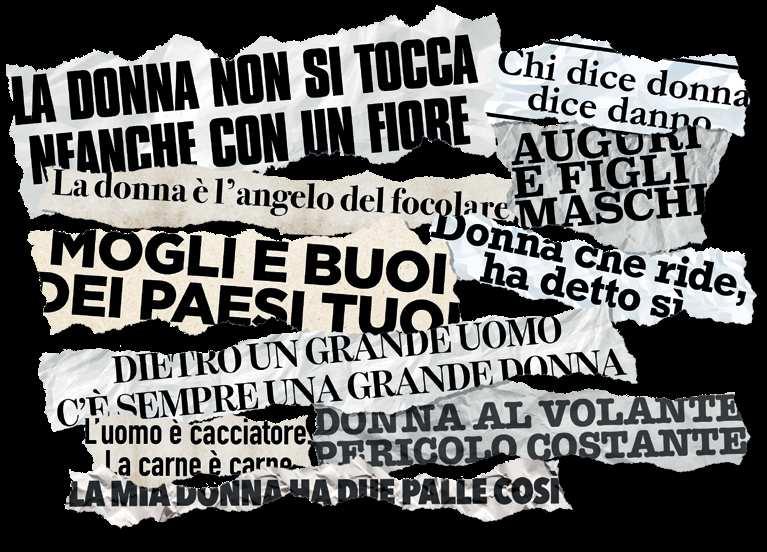




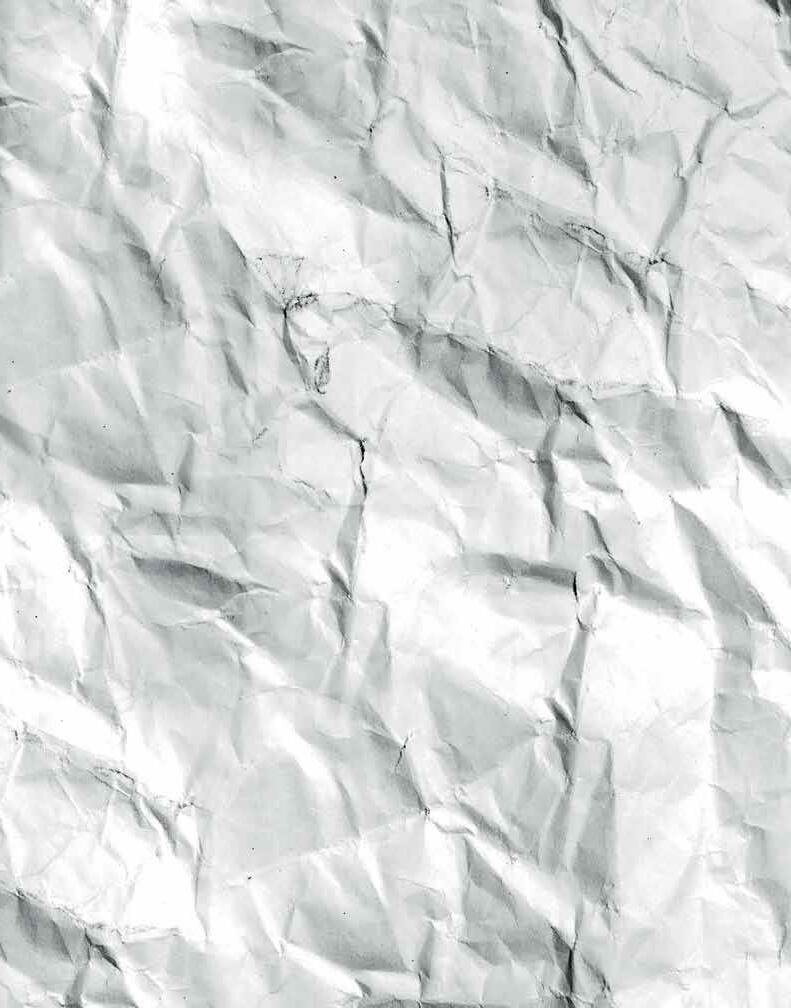
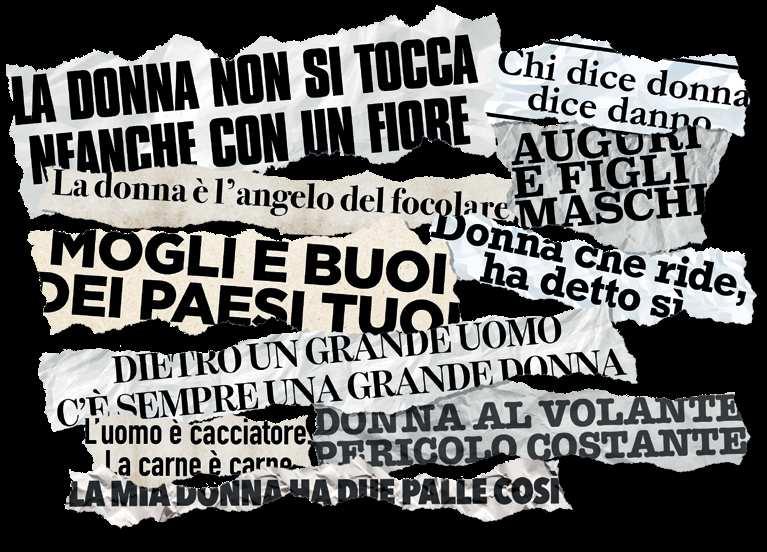



Il muro delle donne



Simone Alliva 12
Silvia Andreozzi e Valeria Verbaro 16 Cambiamo visuale, guardiamo all’uomo Celeste Costantino 19 La verità, vi prego, sui femminicidi Loredana Lipperini 22 Al governo conta solo la famiglia Susanna Turco 24 Dopo la piazza aiuti concreti colloquio con Fiorella Mannoia di Emanuele Coen 27 L’esercizio della memoria serve all’immaginazione

Chiara Valerio 29

Per cosa lottano le iraniane Patrick Zaki 30 Sciogliete le righe Susanna Turco 36 Autorità è cambiamento, a destra solo autoritarismo
Piero Violante 40 L’illusione della nostra democrazia
Paola Di Lazzaro e Giordana Pallone 42 Macron l’equilibrista, fermo e umano sui migranti Camille Vigogne Le Coat 46 Giubileo all’anno zero Carlo Tecce 48 Consoli onorari, gli intoccabili Paolo Biondani, Gloria Riva e Leo Sisti 52 Il Parlamento faccia le leggi, i magistrati le interpretino Nicola Graziano 57 Gli Usa oltre Biden e Trump Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni 58 Se l’arbitro entra in partita colloquio con Alec Ross e Isabella Weber di Federica Bianchi 64 Israele, estremisti al potere. In Medio Oriente cambia tutto Zlatko Dizdarevic 67 Doppio binario per la pace Sabato Angieri 68 Per la tregua separeranno i vivi Gigi Riva 72 Ipocrisia mondiale, calcio ai diritti Gianfrancesco Turano 74 Valuta virtuale, crack reale Vittorio Malagutti 78

Politica è curiosità colloquio con Martha Nussbaum di Wlodek Goldkorn 82 Il signore dei nonsense Gaia Manzini 88 Un marziano a Pescara Antonia Matarrese 90 Galassia Agamben Donatella Di Cesare 92 Professione “sensitivity reader” Alessandro Leone 94 Lettera alle Muse Tiziana Faraoni 98 Il segreto è il passo lento colloquio con Violante Placido di Claudia Catalli 100
Le miniere del Perù avvelenano i paesi
Chiara Sgreccia 104 I cavalli selvaggi dell’Appennino ligure Massimiliano Salvo 110 Quella libertà effimera dei Caminanti di Noto Salvatore Di Mauro 114
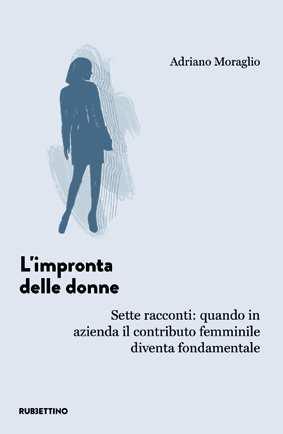
Il “lunario” era una sorta di almanacco che segnava tutte le fasi dell’anno, con riferimento particolare all’agricoltura e in base ai movimenti del nostro satelli te; pian piano, passò a designare l’anno e «sbarcare il lunario» divenne un mo do per esprimere il successo di aver vin to contro la miseria anche per quei dodici mesi. Molti italiani hanno ripreso a considerare un’impresa quel farcela, alla fine anche solo del mese, a pagare tutto e avere anche la pancia moderatamente piena, ma per qualcuno lo «sbarco» non è questione di debiti, di scegliere se cenare con la carne o con il pesce, di rimandare al mese venturo l’acquisto di un capo: per i migranti in mare «sbarcare» è letteralmente essere stati scelti per vivere o morire, secondo un’interpretazione, come minimo, ar bitraria. E già, li avevamo dimenticati, nell’emergenza sanitaria del Covid-19 di questi ultimi anni e, vedi un po’, si
affrettano a disturbarci adesso che l’Italia è lì lì per diventare una Patria si cura e meravigliosa, che tutto il mon do eleggerebbe a proprio eden, tranne gli italiani che sempre di più cercano altri lidi per poter almeno lavorare. E ritorna in mente la figura di Rackete, quando si sentono le parole ferme di Ebeling, che rifiuta di lasciare il porto di Catania, 568 persone a bordo, obbe dendo a una legge che se ne frega degli equilibrismi e dei salvataggi selettivi, legge internazionale e dettato morale. E mentre il ministero degli Interni pro va a scaricare la responsabilità sui capitani, ora più che mai coraggiosi, poteva tacere chi avevamo lasciato al Papeete? È sbarcato alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, si muove; quanto sia sostenibile, in questo giochetto da irri ducibile duro con la fissazione contro i migranti, lascio giudicare agli italiani, brava gente.
LARA CARDELLA
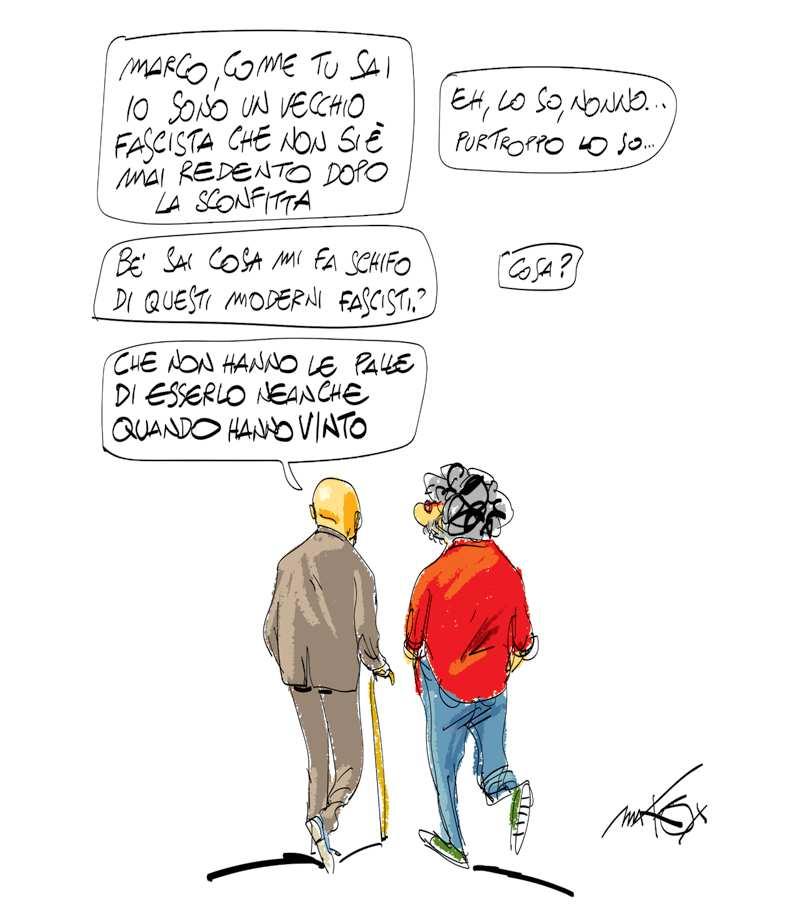


Quella che le vittime di violenza ci raccontano è una società malata e si deve intervenire a tutti i livelli per curarla e sanarla. La sopraffazione non è, e non può essere, un luogo comune. Mentre, al contrario, l’abuso rimane spaventosamente comune
La violenza contro le donne e le ragazze è una delle viola zioni dei diritti umani più dif fuse, persistenti e devastanti nel mondo di oggi. Rimane in gran parte non denunciata a causa dell’impunità, del silenzio, dello stig ma e, purtroppo, della vergogna che la circondano. E si manifesta in forme fi siche, sessuali e psicologiche.
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha definito nel 1993 la violenza contro le donne come «qualsiasi atto di violenza di genere che provochi, o sia suscettibile di provocare, violenza fisica, sessuale o danni o sofferenze psicologiche alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichino nella vita pubblica che in quella privata».
Questa violenza, registrata quotidia namente, continua a essere un ostaco lo al raggiungimento dell’uguaglianza, dello sviluppo, della pace, nonché al rispetto dei diritti umani delle donne e delle ragazze.
Occorre sapere che negli ultimi due anni il 45 per cento delle donne ha rife rito ad associazioni o gruppi che si oc cupano di difenderle, che loro o una ragazza che conoscono, hanno subito una forma di aggressione. E sette don ne su dieci hanno affermato di pensare che l’abuso verbale o fisico da parte di un partner sia diventato più comune. Mentre sei su dieci hanno ritenuto che le molestie sessuali negli spazi pubblici siano peggiorate. Sono dati che devono portarci a riflettere che questa che le vittime ci raccontano è una società malata e si deve intervenire a tutti i li velli per curarla e sanarla.
Pochi mesi fa è stata aperta al pub blico una mostra d’arte nella sede delle Nazioni Unite a New York dal titolo: “Cosa indossavi?”. Si rifà alla domanda che spesso viene rivolta alle vittime di violenza sessuale come a insinuare una qualche responsabilità, quasi a voler accennare che l’aggressione non si sarebbe verificata se la donna si fos se vestita in altro modo. Una domanda velenosa che porta quasi a giustificare qualsiasi forma di violenza in base all’abito indossato. Una domanda troppo spesso utilizzata per provare a incolpare le sopravvissute del crimine perpetrato nei loro confronti. Una mo stra, in una sede istituzionale mondia le, con gli abiti indossati dalle donne quando sono state vittime di aggres sione. Un’installazione che provoca brividi ma vuole sfatare gli stereotipi su quello che le donne subiscono.
La violenza non è, e non può essere un luogo comune. Mentre, al contra rio, la violenza contro le donne rimane spaventosamente comune.
Si deve partire dalla scuola, dai più giovani, per iniziare a inculcare valori sani a tutela delle ragazze. Chiedo ai presidi, ai docenti, di fare un ulteriore sforzo per formare studenti che diano valore alla vita sociale e recuperare chi sta indietro. Gli insegnanti possono far comprendere agli studenti il rispet to per le adolescenti durante le lezioni. E gli allenatori sportivi possono inse gnare ai ragazzi che i veri uomini non feriscono le donne.
C’è tanto ancora da fare.
A partire dal fatto che la violenza non può essere giustificata e tantome no coperta da luoghi comuni.







uando mi diceva che non valevo niente, quando a ce na con amici se ne usciva con quelle frasi, io ridevo. Ci ho messo del tempo. An ni di violenza psicologica. Poi è esplosa quella fisica. Non è stato facile risalire l’abisso che ti inghiotte. Ti salvi solo se tendi la mano e qualcuno la afferra. Io sono risalita da qui». Qui è la Casa internazionale delle donne. Dafne si racconta di fronte a un’intera parete tappezzata di nomi di donne morte per fem minicidio. Nella «casa di tutte» ha sede an che l’associazione Cco, Crisi come opportu nità che insieme a Urban Vision ha realizza to la campagna #laviolenzanonèunluogoc omune, ideata da Celeste Costantino, coordinatrice dell’Osservatorio sulla parità di genere del ministero della Cultura: «La campagna gioca su un doppio livello di falsa narrazione ai danni delle donne: da una par te ci sono gli stereotipi “benevoli”, quelli più

vicini a dei proverbi piuttosto che a dei giu dizi ragionati, e che costituiscono un ostaco lo all’emancipazione dell’immagine della donna nella società italiana. Dall’altra parte invece ci sono quelli esplicitamente perico losi, quelli che comprendono o addirittura giustificano la violenza sulle donne», spiega Costantino. La lingua indirizza il modo di pensare. Modi di dire come «chi dice donna dice danno», riverberano una visione pa triarcale spiega Giulia Mino li, presidente di Cco: «In Ita lia il 67 per cento delle don ne si occupa della cura della casa, il 37 per cento non ha un conto corrente intestato, una donna su due non ha la voro, ogni tre giorni un fem minicidio. Nel 2022 sono state uccise 77 donne. Il da

to è drammatico, il momento è difficile ma la crisi è opportunità. Ci mette alla prova. Noi ci siamo». #laviolenzanonèunluogoc omune sarà proiettata su tutti gli impianti pubblicitari digitali di Urban Vision, disloca ti sul territorio italiano. «L’obiettivo è inco raggiare le donne a denunciare, a rompere il silenzio e chiedere aiuto prima che sia tar di», dice l’amministratore delegato Gianluca de Marchi. I pensieri, le intenzioni, la memo ria e le emozioni si formano sulle parole, spesso si guastano. Lo si può vedere con l’a bisso che si è spalancato davanti ai nostri occhi e che parla soprattutto agli uomini, racconta quanto il mondo fuori sia cresciuto deforme dentro di loro. La questione femmi nile non è altro che una questione maschile: sono gli uomini i primi a doversene occupa re. Fermarsi, non solo il 25 (Giornata inter nazionale contro la violenza) e il 26 novem bre (Manifestazione nazionale a Roma) ma ogni giorno, guardarsi dentro e riflettere. Ri conoscere i volti della violenza - fisica, ver bale, psicologica - e liberarsene.

L’ex presidente della commissione parla mentare sui femminicidi e senatrice del Pd, Valeria Valente scorre l’elenco della cam


Dal 25 novembre sugli impianti pubblicitari digitali di Urban Vision, dislocati su tutta Italia sarà proiettata la campagna #laviolenzanonèunluogocomune realizzata dall’associazione Crisi Come Opportunità e ideata da Celeste Costantino. In collaborazione con L'Espresso si potrà accedere attraverso un qr-code ai contenuti informativi online scritti per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una grande campagna di sensibilizzazione che vede L’Espresso, da 67 anni il più grande settimanale italiano, in prima linea per i diritti delle donne.
pagna e si sofferma sul primo luogo comu ne che incornicia il femminicidio: «Una violenza che non ha conosciuto nessuna battuta di arresto anche se è cresciuta la consapevolezza nella società. Sono molti i passi avanti sulle leggi, ma qualsiasi norma deve essere applicata da uomini e donne».
Non c’ è altro modo che non sia quello di cominciare dall’educazione. Dal rifinanzia mento dei centri antiviolenza che sono luo ghi per ribaltare la cultura della sopraffa zione, per evitare quando vai a denunciare il tuo ex che ti perseguita o il tuo compagno che ti massacra, che non ci sia, come è suc
cesso, qualcuno al commissariato che dica: «Torni a casa». «Questi uomini e queste donne sono anche loro espressione della società. Portatori di stereotipi. Nelle aule di giustizia si fa fatica a credere alle donne. Nei processi di separazione spesso il giudi ce non considera gli attestati di violenza. Un’indagine Istat del 2019 dice che il 74 per cento delle donne vittime non si racconta neanche a un’amica. Leggere prima la vio lenza conta. L’aggressione, quando arriva, non è un fulmine a ciel sereno, il tormento di mesi o di anni ha rilevanza».


«La questione è semplice: senza autono mia economica, non ci può essere una rea le indipendenza». È netta Daniela Santar pia, presidente di E.v.a la cooperativa so ciale nata nel 1999 a Casal di Principe in un bene confiscato alla camorra e che for ma e trova lavoro alle donne in uscita dal la violenza. Fondata da Lella Palladino, E. v.a custodisce storie luminose, come quel la di Giusi: «Non avevo nessuna compe tenza, pensavo di non poter fare nulla. Ho denunciato mio marito dopo anni di vio lenze fisiche, psicologiche ed economiche. A cinquant’anni sono arrivata sotto prote zione al centro antiviolenza. Non pen
savo di poter fare niente. Gli anni con lui mi avevano annullata». Giusi che per anni aveva gestito il bar del marito senza percepire un centesimo, si è riscoperta. «Adesso è un nuovo inizio».
Nelle rotte dei migranti ci sono i trafficanti, stupri, botte, abusi, mutilazioni. Donne tra sformate in giocattoli, fino a che non si rompono. «Spesso sono giovanissime. Quando arrivano qua in Italia sono già de vastate. La nostra sensazione è che di loro non importi più nulla a nessuno», dice Oria Gargano, presidente di BeFree, la coopera tiva sociale nata nel 2007 per contrastare tratta, violenza e discriminazione. «Negli anni 90 erano tutte bianche, veni vano dall’Europa, oggi sono per lo più ra gazze provenienti dall’Africa. Per la gran parte dalla Libia. Torturate e costrette a prostituirsi. Partono da Benin City, poi at traversano tutto il deserto del Niger, arri vano nella Libia settentrionale e lì vengo no messe in case chiamate Africa house e che in genere sono gestite dalla mafia ni geriana che spesso collabora con la mafia libica. Destinazione Lampedusa. Queste donne riescono ad arrivare in Italia con vinte di trovare accoglienza e invece ven gono messe in strada. È un copione rigido: non conoscono la lingua ma vengono istruite per chiedere subito il modulo C2, per il diritto d’asilo, per non essere espul se». Sostenere queste ragazze dopo, aiu tarle a ripartire non è mai facile ma è pos sibile: «Di recente, tra le tante, due ragaz ze giovanissime sono diventate operatrici anti-tratta. Ci vuole tanta competenza, empatia. Evitare la ri-vittimizzazione. Ci sono molte strade aperte per chi riesce a salvarsi, bisogna dar loro la possibilità di percorrerle».

L’avvocata Teresa Manente da 30 anni as siste le donne dell’Ufficio legale di Diffe renza Donna. Da qui sono passate 48 mila donne ospitate in centri antiviolenza e ca se rifugio.
Conosce bene il coraggio delle donne quando decidono di denunciare, le loro paure, la vergogna del sentirsi a un tratto carnefici e non più vittime, il dover fuggire
«Quando arrivi a casa scrivimi». Un rito, una cura reciproca alla fine di una serata. Tornando a casa da un allenamento, quando la giornata di lavoro si è conclusa, «quando arrivi a casa scrivimi».
Tra donne lo si dice e lo si sente spesso. Come spesso succede di dover chiamare qualcuno lungo un tragitto. Un’amica, una persona cara. Percorrendo una strada, buia o meno, conosciuta o nuova, chiamare per sentirsi meno esposte. Da questa esperienza condivisa nasce l’associazione DonnexStrada, dalla presa di coscienza della sua fondatrice, la psicologa Laura De Dilectis. «Era una domenica mattina quando ho saputo della morte di Sarah Everard, rapita, stuprata e uccisa a Londra nel 2021. Ho provato una sensazione di rabbia e paura al pensiero di quante volte avevo rischiato in passato, passeggiando di notte da sola, a piedi, con il telefono scarico. Invece di trattenere la frustrazione, l’abbiamo trasformata in un’azione che ha coinvolto sempre più persone in una call to action». Il movimento è nato dalla pagina
per evitare il peggio. E le contraddizioni della giustizia: «I pregiudizi contro le don ne sono talmente radicati nella nostra cul tura e in tutti noi da non permettere di ri conoscere la gravità dei fatti denunciati e applicare le leggi. Questo è visibile nelle condanne della Corte europea dei diritti umani nei confronti dell’Italia. Quattro negli ultimi mesi.
L’ultima, emessa su nostro ricorso pochi giorni fa, ha condannato l’Italia per aver violato l’articolo 8 della Convenzione (dirit to al rispetto della vita privata e familiare) e non protetto i figli di una madre costrin gendoli per tre anni a incontrare il padre accusato di maltrattamenti, nonostante lo stesso continuasse a esercitare violenza e minacce». Madri ancora oggi considerate alienanti, manipolatrici, malevole. «Men tre gli uomini vengono considerati dispera ti dall’essere stati “abbandonati” o “delusi” dal comportamento della donna che si è sottratta al loro potere».
Qui e nelle altre pagine, una carrellata di immagini della Giornata contro la violenza celebrata negli anni scorsi. Il 26 novembre prossimo, la manifestazione a Roma
L’UOMO È CACCIATORE. LA CARNE È CARNE
«Ancora oggi le nuove generazione ritengo no, a seguito di un’acquisizione stereotipata del mito dello stupro, che l’uomo agisce in base a impulsi naturali e incontenibili men tre la donna scatena questi impulsi». Nella sua carriera di magistrata, Paola Di Nicola si è occupata a più riprese di reati di violenza contro le donne e di pari opportunità. «È an cora radicatissimo il principio per cui l’uo mo è cacciatore e la donna è preda. Ci sono vari livelli. C’è quello culturale dove è sal
Instagram omonima all’associazione. L’idea era quella di poter fornire un supporto a chi, rincasando da sola, si sentisse in pericolo. Le dirette inizialmente erano collettive, poi il progetto si è trasformato. Oggi a gestire le videochiamate è Violawalkhome, una start-up che conta volontari da diversi Paesi. DonnexStrada continua a occuparsi del sostegno psicologico e legale e della prossima creazione dei “punti viola”, attività di frequentazione quotidiana il cui personale, dopo una formazione specifica, sarà in grado di dare sostegno alle donne che lo richiederanno in caso di pericolo.
Le volontarie di Violawalkhome portano avanti in diciassette lingue lo stesso obiettivo per cui Laura ha dato inizio a questo percorso, «rivendicare la pretesa di poter camminare con tranquillità, con una sensazione di libertà. Essere libere, non coraggiose». E tutte, come la fondatrice, si sono avvicinate a questo impegno spinte da storie personali.
È il caso di Simona Mancino che ha iniziato come volontaria di Violawalkhome un anno fa: «Avevo notato alcune sfumature nel comportamento del mio ragazzo, quasi verso una violenza psicologica. Ho bloccato il rapporto e dentro di me mi sono detta: io ho avuto la prontezza di lasciarlo ma non so se altre ragazze hanno questa possibilità». Sul web ha trovato DonnexStrada ed è diventata volontaria: «Siamo divisi in turni. Quello diurno arriva alle 18, il serale va dalle 18 a mezzanotte, il primo turno notturno, di cui sono corresponsabile, va da mezzanotte alle 3 e il secondo turno notturno dalle 3 alle 6
del mattino». Secondo la sua esperienza, il maggior numero di richieste si concentra tra le 18 e le 3 di notte, quando «ci sono delle ragazze che più spesso prenotano una chiamata perché lavorano o fanno attività sportiva fino a tardi».
Difficile, comunque, trovare uno schema fisso. La cosa certa è che qualcuno chiamerà.
«C’è una percezione di pericolo diffuso. Il più delle volte le ragazze che ci contattano hanno una sensazione di paura, a volte tremano, non sono lucide. Magari in quel momento non è successo nulla, ma il contesto non le fa stare tranquille. Altre volte accompagniamo persone che hanno subito violenze in passato, sono rimaste segnate. C’è una realtà che vediamo e che sentiamo anche noi volontarie, che spesso usufruiamo delle dirette. È una cosa che ci accomuna tutte, che tutte sentiamo paura».
Alessandra C., un’altra volontaria, ha conosciuto Violawalkhome da utente: «utilizzavo DirettexStrada quando tornavo a casa da sola, dato che abito in una zona periferica della mia città, quindi è successo di trovare la strada poco illuminata». Superati i primi dubbi ha deciso di dedicare il proprio tempo al progetto che l’aveva aiutata. Anche lei, come Simona, copre il primo turno notturno. Durante le chiamate, dice, «si chiacchiera normalmente, in modo tranquillo, come tra amiche. Alla fine mi dicono “guarda, grazie. Sono a casa, tutto bene”. A quel punto le saluto e ricomincio il turno».
da la difficoltà nel riconoscere il valore del consenso: i maschi considerano che non debba essere espresso perché nella rappre sentazione che si fa del sesso il consenso non c’è mai, è presunto». Nel Codice penale la parola “consenso” è assente. «I termini ri correnti sono violenza, minaccia, induzione. Andrebbe riformato. La parola delle donne sul consenso non è mai stata realizzata. La gran parte delle violenze avvengono senza alcuna minaccia. Pensiamo al caso della stu dentessa di un liceo avvicinata da un adulto. La condizione è di tale soggezione che si re sta immobilizzati». Errato anche parlare di violenza sessuale. «La gran parte dei casi av vengono senza violenza e non hanno a che vedere con il sesso. È un atto di potere eser citato da un uomo nei confronti di una don na, sulla sfera intima e senza, bisogna riba dirlo, il consenso».
CHI DICE DONNA DICE DANNO «È una frase estremamente subdola che si insinua all’interno del nostro cervello con
una facilità che addirittura superiore a quella di altre locuzioni, per la struttura fonica e ritmica che ha», commenta Fran cesca Dragotto, direttrice del centro di ri cerca “Grammatica e sessismo” dell’Uni versità di Roma “Tor Vergata”. «Sono modi di dire che creano una sorta di cantilena nel cervello, vengono immagaz zinate e si riattivano tutte le volte che sen tiamo donna e sentiamo danno. Avere an cora nella nostra cultura un’affermazione come questa e come le altre favorisce che nei più piccoli si crei da subito l’idea che vi sia un pericolo nella donna».
La storia delle donne è quella della so cietà intera. Sembra dire Loretta Bondi, presidente di Archivia-archivi bibliote che e centri di documentazione, una

Il muro con i manifesti delle vittime di femminicidio alla Casa internazionale delle donne di Roma. A destra, l’ingresso della struttura
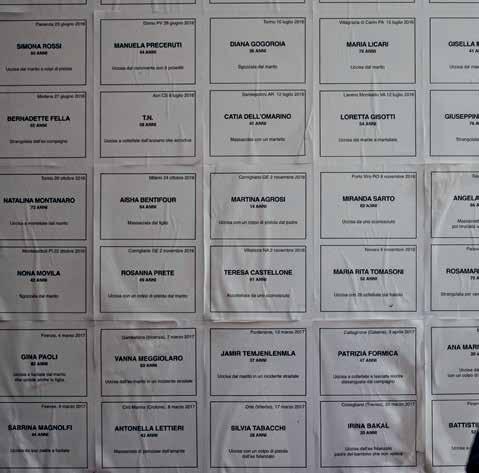
La violenza maschile sulle donne nel tempo è diventato un fenomeno sempre più complesso. Per questa ragione quando l’associazione Crisi come opportunità mi ha coinvolta per l’ideazione della campagna di comunicazione di Urban Vision sul 25 novembre ammetto di aver avuto paura della semplificazione. Con #laviolenzanonèunluogocomune è invece successo l’inimmaginabile. È successo che con Giulia Minoli, Noemi Caputo e Benedetta Genisio ci sia stata subito la sintonia di non rinunciare alle sfumature del fenomeno. Il primo obiettivo è stato spostare finalmente l’attenzione sugli uomini, cioè su chi agisce la violenza. Uomini diversi tra loro, esattamente com’è nella realtà. Perché non esiste un identikit dell’uomo maltrattante. La violenza è un fenomeno frutto di un guasto culturale e per questo non deve essere vissuto come una condizione privata ma invece assunto come un problema collettivo. Ed è stato questo il secondo obiettivo della campagna: fare un’opera di svelamento sul sessismo ambivalente di cui è affetta la nostra società. Da una parte ci sono gli stereotipi “benevoli” e apparentemente innocui, quelli ormai più vicini ai proverbi che ai giudizi ragionati, quelli che danno una visione delle donne come esseri indifesi, da proteggere e tutelare (“la donna non si tocca neanche con un fiore”, “la donna è l’angelo del focolare”) e gli stereotipi “simpatici” che vogliono ironizzare sull’incapacità delle donne (“donna al volante pericolo costante”). Ci sono poi gli stereotipi “ostili”, quelli che dichiarano apertamente l’inferiorità della donna ritenuta sostanzialmente un oggetto (“donne e buoi dei paesi tuoi”) o un essere malvagio (chi dice donna dice danno”) o quelli che valorizzano le donne solo se nel confronto con uomo (“è una donna con le palle”). In tutto questo proliferare di false narrazioni, naturalmente l’uomo dal canto suo è cacciatore e i suoi impulsi sono dettati dalla carne. Arriviamo quindi al terzo obiettivo, quello più ambizioso ma anche più doloroso di questa campagna: il racconto della comprensione, della tolleranza e spesso anche della negazione sociale della violenza maschile sulle donne. Nessuno oggi infatti sosterrebbe apertamente che è giusto uccidere una donna che ha tradito il marito ma… Quel “ma” è il sintomo di un irrisolto, il segno che nella nostra società è ancora presente l’idea di proprietà della vita delle donne. Vale per la violenza domestica, vale per lo stupro e per il cosiddetto revenge porn. Perché la verità è che la violenza sulle donne non è un luogo comune, ma nello stesso tempo lo è. E questa campagna racconta di un 25 novembre che sia di Liberazione per le donne. Dall’immaginario e nella realtà.

*Coordinatrice dell’Osservatorio sulla parità di genere del MiC

vita per il femminismo, con esperienze anche internazionali. Ora che si mette in discussione anche il diritto all’aborto, ora che i fondamentalismi cattolici tornano con prepotenza in campo. Ora che per le nuove generazioni, soprattutto per le ra gazze giovanissime, il futuro è così incer to bisogna guardarsi indietro per capire da dove ripartire: «In passato la violenza contro le donne veniva concepita come un reato contro la morale. Da qui abbia mo iniziato una riflessione e una batta glia per vederlo come un reato contro la persona. È stato quello che ha aperto la strada a tut te le declinazioni. Le donne si sono sem pre dovute battere contro vecchie e nuove forme di violenza: la tratta, i matrimoni forzati, l’infibulazione. Oggi c’è una mag giore consapevolezza che non sempre le nuove generazioni traducono in impegno, come accadeva negli anni ’70.
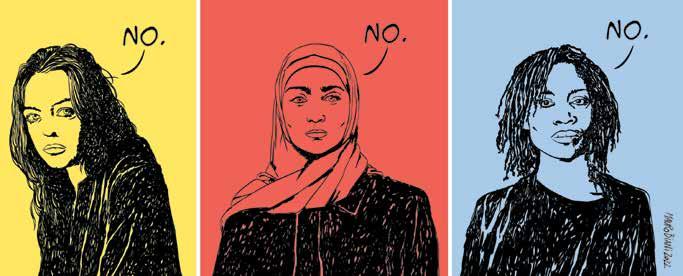
Archivia custodisce 30 mila volumi ma an che 600 pubblicazioni. Ecco, una volta ci si riuniva intorno a testate come “Effe”, “Noi Donne”, ora sembra che basti un post so cial. Dentro questo tempo serve un ritor no dei corpi in contrapposizione rispetto a quello che già questo governo sta espri mendo e in contrapposizione con il pa triarcato e non in mediazione. Un 25 e 26 novembre costante, che diano luce a un tempo nuovo.



Qualche giorno fa la presidente del Consiglio ha risposto alle non poche polemiche relative al decreto anti-rave con queste parole: «È una norma che rivendico e di cui vado fiera per ché l’Italia – dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all’illegalità – non sarà più maglia nera in tema di sicurezza».
In verità, se andiamo a consultare i dati forniti a dicembre scorso dalla Polizia criminale, i reati calano: «Sono in lieve crescita (5,4 per cento) in Italia nel 2021 rispetto al 2020, ca ratterizzato dal calo verticale dei reati, ma comunque in calo del 12,6 per cento in confronto al 2019». Tranne che per i fem minicidi: «116, come nel 2020, a fronte dei 110 del 2019, su un totale di 289 omicidi». Continuiamo con i numeri, per favore. Se consultiamo i dati forniti da Istat relativi al 2020, vediamo che gli omicidi con vittime maschili sono diminuiti in 26 anni (da 4,0 per 100.000 maschi nel 1992 a 0,7 nel 2018), mentre le vittime donne di omicidio sono rimaste complessivamente stabili (da 0,6 a 0,4 per 100.000 femmine). Significa che nel caso degli uomini ci sono stati progressi, mentre per le donne le cose sono andate peggiorando proprio perché rimaste identiche.
Per quanto riguarda l’anno in corso, secondo il dossier an nuale del Viminale, tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022 nel nostro Paese sono state uccise 125 donne, in aumento ri spetto alla rilevazione precedente. Inoltre, sono state regi strate 15.817 denunce per stalking, 3.100 ammonimenti del questore e 361 allontanamenti per lo stesso reato. Difficile dire quali siano i numeri reali, perché, secondo Istat, i tassi di denuncia «riguardano il 12,2 per cento delle violenza da par tner e il 6 per cento di quelle da non partner».
La sicurezza, già. Qualche mese fa, su questo giornale, ri cordavo quanto scritto da Paolo Del Debbio in Appunti per un programma conservatore, bozza su cui Fratelli d’Italia avrebbe costruito il proprio programma: lo Stato, diceva, de ve garantire sicurezza perché «non è possibi le accettare che una donna non possa torna re a casa da sola senza essere importunata».
Il problema è che la violenza o la morte av vengono non in strada e non per mano di un estraneo: sempre Istat ci ricorda che «del le116 donne uccise nel 2020, il 92,2 per cento è stata uccisa da una persona conosciuta.
Per oltre la metà dei casi le donne sono state uccise dal partner attuale, in particolare il
Lo striscione di Non una di meno alla manifestazione contro la violenza sulle donne del 2021 a Roma

51,7 per cento dei casi, corrispondente a 60 donne, il 6,0 per cento dal partner precedente, pari a 7 donne, nel 25,9 per cen to dei casi (30 donne) da un familiare (inclusi i figli e i genito ri) e nell’8,6 per cento dei casi da un’altra persona che cono sceva (amici, colleghi, ecc.)».
Se avete letto fin qui, sapete che questi sono appunto nu meri e fatti, e che questi numeri e questi fatti non sono una novità, perché da anni vengono resi pubblici, commentati, diffusi. Ma con ogni probabilità sapete anche che tutto que sto non basta per far comprendere che la violenza sulle don ne è un problema reale: è molto più semplice credere alla periferia degradata e al molestatore ignoto che comprende re che l’assassino e spesso lo stupratore sono persone che le donne conoscono già, si tratti di un familiare o di un amico che sembrava tanto per bene. Faccenda antica. Nel 2007, do po la morte di Giovanna Reggiani a Roma si scatenò una cac cia al rumeno, complici certe improvvide dichiarazioni poli tiche: e anche allora si parlò di emergenza sicurezza. L’emer genza, in quell’anno, non c’era: gli omicidi e i reati erano ai livelli più bassi rispetto a tutto il ventennio precedente. Men tre crescevano tragicamente i reati commessi fra le pareti domestiche: uno su quattro degli omicidi avveniva in casa. Sette volte su dieci la vittima era una donna.
Oggi siamo ancora in stallo. Leggiamo i nomi. Alexandra,
Giulia, Carol, Simona, Rosa. Conosciamo i modi: per arma da fuoco, per martello, per coltello, per soffocamento, per acqua e per fuoco. Ma dal punto di vista dell’immagina rio, al di là delle manifestazioni che vengono organizzate per il 25 novembre (e, certo, no nostante l’enorme lavoro dei Centri antivio lenza e dei femminismi), non riusciamo a co struire un’alternativa: che, per esempio, parta dalle scuole e permetta di introdurre corsi di educazione sentimentale e sessuale per poter ragionare sul maschile e sul femminile, senza che qualcuno blocchi tutto evocando lo spettro del gender. Succede continuamente, suc cederà in futuro.

Già la stessa parola, femminicidio, fatica ancora oggi a dif fondersi, a circa trent’anni dal suo conio: è brutta, è cacofoni ca, non ha senso, non mi piace, è scorretta, dicono, e chiun que l’abbia pronunciata o scritta su un social conosce le rea zioni. Che in molti casi si accompagnano alla negazione del fenomeno: gli uomini muoiono di più, viene detto. Le donne sono ugualmente violente, si insiste. E quasi nessuno accetta un’evidenza semplicissima: se abbiamo davanti un’incidenza percentuale che ci dice che, a differenza di altri delitti, il fem minicidio non cala come gli altri crimini, si dovrebbe conclu
dere – e sarebbe logico farlo – che abbiamo un problema. I tanti presunti fact-checker che si sono espressi negli anni e rialzano la testa alla prima occasione utile concludono, inve ce, che non lo abbiamo.
Bisognerebbe agire sul prima, o quanto meno capire com’è, quel prima. Come hanno fatto, per esempio, le due studiose Lucia Bainotti e Silvia Semenzin nel libro “Donne tutte putta ne”, pubblicato da Durango, e nei loro successivi lavori: spie gano molto bene come i gruppi Whatsapp o Telegram di ra gazzi che si scambiano video intimi di ragazze senza il loro consenso siano determinanti per la costruzione di un maschi le tossico. Che non necessariamente sfocerà in violenza fisica, certo, ma che incide pesantemente sulla formazione di quella mascolinità. Le due studiose sostengono che la struttura stes sa di alcune piattaforme favorisca la creazione di gruppi di soli maschi basati sulla solidarietà reciproca. Una forma di conferma e rassicurazione davanti alla crescente libertà delle donne, e una forma spietata di oggettivazione dei loro corpi. Qualcosa di simile avviene, a pensarci bene, nelle ondate di odiatori che si rivolgono sui social a donne autorevoli e visibi li per annichilirle: recentemente, Laura Boldrini ha postato sui suoi profili una serie di interventi violentissimi che lascia
senza fiato. Non è violenza fisica, ma è violenza comunque. Il che fare va al di là delle leggi repressive. Bisognerebbe superare le cronache. Bisognerebbe, anche, saper raccontare al di là del libriccino d’occasione. Come fece colui che trasfor mò in letteratura l’inchiesta di Sergio González Rodríguez, “Ossa nel deserto”, condotta sul luogo da cui nacque la stessa parola femminicidio. Ciudad Juárez, nello Stato messicano del Chihuahua, dove le donne morirono a centinaia. Lo fece, in “2666”, Roberto Bolaño, che alla domanda su come si im maginasse l’inferno, rispose: «Come Ciudad Juárez, che è la nostra maledizione e il nostro specchio, lo specchio inquieto delle nostre frustrazioni e della nostra infame interpretazio ne della libertà e dei nostri desideri».

Quel che colpisce, prima di tutto, è la coerenza. Nem meno un elemento, un pie de, una mano, un pezzo di stoffa, una quota rosa in ef fetti si discosta dall’impo stazione asburgica, austroungarica, e si vorrebbe dire alla Klemens von Metternich, data da Giorgia Meloni alla questione co siddetta “delle donne”. Nemmeno il tempo di celebrare un mese di governo e già il pas so si vede chiarissimo.
La prima premier donna della storia d’I talia che, scambiando il maschile per neu tro, si fa chiamare «il» presidente del Con siglio come se fosse un uomo, suscitando inciampi linguistici persino negli uomini della destra col vizio momentaneamente imperdonabile di usare l’articolo «la» quando parlano di una donna, ha di con seguenza composto un governo e un sot
togoverno piuttosto maschile anche nei modi (neanche una gonna c’era al giura mento al Quirinale) e dato in generale il via a una fase nella quale il potere declina to al femminile paradossalmente perde posizioni, piuttosto che guadagnarle. Con una premier che ridicolizza l’intera que stione proclamando che il potere delle donne non passa per termini come «capa trena» era del resto immaginabile. Gli ef fetti già si vedono, dimostrazione che la questione della difesa dei diritti sta precisamente nei termini in cui l’ha enuncia ta in una delle sue più re centi interviste, puntuale come sempre, la radicale Emma Bonino: «Dire che non si toccheranno i diritti esistenti vuol dire che si tornerà indietro», perché

«i diritti civili sono una cosa fragile, vanno coltivati, curati difesi e promossi ogni giorno, se no una bella mattina ti svegli e non li hai più. È questo che sta succeden do», diceva al Corriere della Sera. Così in pratica è bastato avere una premier tena cemente convinta dell’inutilità della quote rosa, o meglio, dell’utilità di una quota rosa a spanne, cioè della rappresentanza femmi nile come qualcosa di vago, da non legare ai numeri, per avere quindi soltanto 6 donne su 24 ministri (un quarto del totale) e 13 donne su 39 sottosegretari (un terzo del to tale), un antiabortista, Lorenzo Fontana, che ricopre la Terza carica dello Stato, una ultraconservatrice, Eugenia Roccella, come ministra della Famiglia, natalità e pari op portunità, il partito di maggioranza ossia Fratelli d’Italia maglia nera nella rappre sentanza femminile, con 52 donne su 185 parlamentari, pari al 28 per cento. E, gran
La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, lascia il Quirinale dopo il giuramento del nuovo governo lo scorso 22 ottobre

finale (ma solo per il momento) soltanto 2 donne, Giulia Bongiorno e Stefania Craxi, su 24 presidenti di commissione tra Came ra e Senato (un dodicesimo del totale).
«Onorevole Serracchiani le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?», ha do mandato Meloni in uno dei passaggi più noti del dibattito alla Camera sul voto di fi ducia al governo: lei no, Meloni non sta un passo dietro agli uomini, ma lascia che le altre ci vadano a finire. Anche su questo punto, c’è da dire, ha impiegato assai meno tempo del previsto a segnare una stagione, un’epoca. Una velocità da perdifiato, come sull’immigrazione, sugli sbarchi, sui ra ve-party, sui rapporti con la Francia.
Era tutto già segnato, lo si vede ora più chiaramente, ai tempi della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano, a fine aprile 2022. Una tre giorni che ha de lineato in anticipo, con una precisione dav vero invidiabile, i confini del futuro gover no e dove non a caso di donne non s’è parla to, se non come di madri. «Famiglia, cuore d’Italia. Interventi in favore della natalità, tutela della famiglia naturale, sostegno alla maternità e alla paternità, lotta all’ideolo gia gender, sacralità della vita e valori non negoziabili» era del resto il panel al quale partecipò la futura ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, insieme con il portavoce di Pro Vita Jacopo Coghe e il direttore di Tempi Emanuele Boffi. Sempre a Milano, in quei tre giorni, Isabella Rauti, ora sottose gretaria alla Difesa, nella sua veste di “Re sponsabile pari opportunità, Famiglia e va lori non negoziabili” di Fratelli d’Italia, de cantava dal palco principale, nella sezione significativamente intitolata “Crescere nel la famiglia. Sostenere le scelte di maternità e di paternità per rimettere in cammino la speranza di un popolo”, le virtù del «più permanente aggregato sociale» che abbia mo a disposizione (la famiglia appunto) e la terribilità al contrario della ideologia gen der che ha appestato di sé anche le fiabe tanto che persino «la povera Biancaneve non si sveglierà più perché il principe non la può baciare». Tutto già chiaro lì: senza il principe che la bacia, scordiamoci pure Biancaneve. Si dirà che non abbiamo ancora parlato di violenza di genere: c’è un motivo perché la questione, che pure in Fratelli d’Italia è trattata con la dovuta serietà, ha il posto
e la priorità che deve avere, nel quadro che si va delineando. Del resto Meloni non s’è mai spostata dal preciso orizzonte che indicò in Noi crediamo nel suo primo libro dato alle stampe, nel 2011, ai tempi in cui era ministra della gioventù: «Questo è il mio modo di essere femminista: difendere il nostro essere donne, fiere di essere tali e consapevoli che questa nostra specificità è l’unico modo per rappresentare un valore aggiunto. Il valore della famiglia, il coraggio della maternità, la difesa della vita, la soli darietà sociale: ecco che cosa rende le don ne uniche e indispensabili». Ecco cosa fa delle donne delle vere donne: la maternità, la solidarietà sociale, la famiglia. Una con cezione di smagliate modernità.
D’altra parte, nelle spiegazioni di Meloni, così come nei programmi elettorali di Fra telli d’Italia (che ora si attende siano realiz zati), le misure che servono ad aiutare le donne sono praticamente solo quelle che servono ad aiutare le madri. Assegno unico familiare, potenziamento dei nidi e delle
scuole d’infanzia, far coprire allo Stato il costo di sostituzione di maternità. Il tema dell’occupazione femminile, è presentato soltanto se e quando intrecciato alla natali tà, alla questione demografica. Anche per la legge 194 è così: Meloni immagina di «istituire un fondo per aiutare le donne sole e in difficoltà economica a portare a termi ne la gravidanza», cioè si occupa di soste nere la donna in quanto potenziale madre (prima parte della legge) e si mostra invece indifferente verso le difficoltà ad applicare la seconda parte della legge, quella che ri guarda il diritto all’aborto vero e proprio, quello che diciamo fa pendere le donne dal la parte delle non madri.
Proprio sulla 194 si sono del resto con centrate le prime dichiarazioni e le prime polemiche della neoministra Roccella, co lei che si occupa di famiglia, natalità e pari opportunità, e dunque di donne per conto del governo. La ministra, oltre ad afferma re (contrariamente a quanto faceva da ra dicale negli anni Settanta) che l’aborto non è un diritto, si è precipitata a riaffermare il legame tra donne e maternità in un modo analogo a quello della premier: «Non vo glio convincere le italiane a fare più figli: vorrei solo che fossero libere di farli. Ma libere davvero, cioè non spinte a scegliere tra carriera e figli, non costrette a essere multitasking per forza», ha detto a Libero in una delle prime interviste. «Considero una sconfitta che una donna debba rinun ciare alla maternità per avere un lavoro ma anche debba rinunciare ad avere un bambino per lavorare», ha detto Meloni nel suo primo discorso alla Camera. La ve ra libertà, per le donne, si regola dunque da quelle parti: diritto al lavoro ma intrec ciato al diritto alla maternità. Un punto le cui implicazioni si vedranno nei mesi a ve nire. «Mi sembra un modo per garantire piene libertà, è una sfida su cui spero sia mo d’accordo. Chiedo libertà concreta e reale», dice ancora Meloni. Certo poi nel programma politico di FdI si prevede «l’ag giornamento del codice rosso, la normati va in materia di violenza domestica e di genere». Due righe, nel contesto di un oriz zonte di un Paese che si vuole saldamente rifondato sulla famiglia e sulle madri. Ci voleva giusto una donna alla guida del go verno, per arrivarci.


Parole, canzoni e concerti come “Una. Nessuna. Centomila”, la scorsa estate sul prato di Cam povolo, vicino a Reggio Emilia. Dove Fiorella Mannoia è salita sul palco assieme a sei grandi protagoniste della musica (Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini) davanti a un pubblico oceanico, per raccogliere fondi a fa vore di sette centri antiviolenza sparsi per l’Italia. Due mi lioni di euro in beneficenza per sostenere le donne vittime di abusi, stupri, brutalità da parte di uomini. La cantautrice riparte da qui e ribadisce il proprio impegno. Fiorella Mannoia, il 26 novembre si terrà a Roma una manifestazione nazionale femminista e transfemmini sta. Scenderà in piazza?
«Certo, ho sempre partecipato e lo farò pure stavolta. Oggi hanno ammazzato un’altra donna, purtroppo è una piaga totale. Dobbiamo tutti impegnarci, nella famiglia, nella scuola e nella comunicazione, per cambiare questa menta lità contorta che ci vede coinvolti tutti, uomini e donne. An che noi donne dobbiamo interrogarci sul perché ci infilia mo in certe situazioni, scambiamo l’amore per il possesso, abbiamo la sindrome della crocerossina».
Servono nuove leggi o una rivoluzione culturale?
«La legge è necessaria e deve essere severa. Fino a poco tempo fa le pene erano minime, con le solite attenuanti: co me eri vestita, come sei andata in giro, perché ti trovavi in quel posto e così via. Tutte queste domande, violenza che si aggiunge a violenza. La legge serve perché non si tratta di reati minori, ma molto gravi. Le norme però da sole non ba stano, ci vuole una rivoluzione culturale, la buona volontà delle istituzioni, della scuola, il rispetto dell’altro. Serve un impegno sociale forte, affinché il giorno dopo la manifesta zione non torni tutto come prima».
Secondo il report annuale dell’associazione nazionale Donne in Rete contro la violenza, nel 2021 sono state accolte nei centri antiviolenza oltre 20mila donne, in
crescita rispetto all’anno precedente. Ma solo una su tre denuncia il proprio aggressore…
«Le donne non si sentono tutelate ma soprattutto non san no dove andare. Ci dovrebbe essere un centro antiviolenza in ogni quartiere. Se una se ne va di casa dove va? Oggi una donna su tre non ha un conto bancario proprio. Per indivi duare alcuni centri antiviolenza da sostenere mi sono affi data a Giulia Minoli, Lella Palladino e Celeste Costantino, che hanno molta esperienza sul campo. Dopo aver raccolto assieme alle mie colleghe più di due milioni con l’evento di Campovolo, sono andata a visitare il centro antiviolenza di Casal di Principe, vicino a Caserta, per rendermi conto della situazione».
Cosa ha scoperto?
«Non basta ricevere le donne quando scappano ma bisogna ricollocarle nella società. Trovare loro un posto di lavoro, solo attraverso l’indipendenza economica riescono a scar dinare la dipendenza dal compagno».
Qualche anno fa ha scritto la canzone “Nessuna conse guenza”, che parla della forza di reagire contro la vio lenza. È ancora attuale?
«Penso di sì. È una canzone di speranza, positiva, dedicata a chi ce l’ha fatta».
La musica può cambiare le cose?
«Non ha mai cambiato la società, ma contribuisce a focaliz zare un problema. Niente come la musica possiede questo potere di aggregazione, è sempre stata lo specchio dei tem pi, anche per me. Quando ero adolescente le canzoni di De André mi hanno cambiato la vita».


La violenza sulle donne non è faccenda di un giorno solo, ep pure è necessario che il 25 no vembre, ogni 25 novembre, sia dedicatoallagiornatamondialecontro la violenza sulle donne. È necessario perché, in società complesse e distrat te dalla complessità come quella che abbiamo costruito, che contribuiamo a sostenere e nella quale viviamo, i riti sono fondamentali per la memo ria, la memoria è fondamentale per l’immaginazione, l’immaginazione è fondamentale per immaginare una re altà diversa da quella che ci occupa, ci riempie e che riempiamo, giorno dopo giorno. Le donne muoiono, e muoiono gli uomini. Ma mentre, storicamente la morte degli uomini – non intesi come specie umana, ma come maschi – è eroica, materia e fomento di poemi epici, la morte delle donne è una con seguenza. La morte delle donne è una conseguenza della vita degli uomini –non intesa come specie umana, ma co me maschi – e questo è ciò che dicono i numeri, le statistiche che misurano i nostri comportamenti. La questione, tuttavia, non riguarda solo i comporta menti, ma pure le intenzioni, e dunque l’educazione. Non esiste ancora suffi ciente pratica quotidiana con la quale si combatte la violenza sulle donne.

Lo scorso anno sugli schermi a im patto zero – pur se giganteschi – di Urban Vision, società leader naziona le nel settore dei restauri sponsorizza ti di edifici, opere d’arte e monumenti, sono comparsi i nomi di tutte le vitti me di femminicidio negli ultimi anni. Il lavoro, in collaborazione con La ventisettesima ora del Corriere della Sera, è stato di grande impatto emo tivo. Sugli schermi dove siamo abitua
ti a vedere opere d’arte del passato o del presente, copertine di libri o ma nifesti cinematografici, sono passati per un’intera giornata i nomi listati a lutto di tutte le donne ammazzate. Quest’anno l’iniziativa è realizzata in collaborazione con L’Espresso.
Che il troppo amore sia una giu stificazione per uccidere, deturpare, ledere, ferire ce lo dicono i bambini e i loro pupazzetti preferiti che di solito non hanno gli occhi, sono pieni di bu chi, umidi di saliva, e la cui pelliccia è spesso interrotta da morsi amorosi. È dunque da bambini che ci esercitiamo a consumare ciò che amiamo. Tutta via, come ha scritto Fleur Jaeggy nel suo primo romanzo, “Il dito in bocca” (Adelphi, 1968), i gesti dell’infanzia protratti nell’età adulta diventano vi zi. Questo il senso e questa forse an che la via. Esiste e persiste il vizio di soffocare, non solo metaforicamente, i nostri oggetti d’amore. La via è dun que quella di imparare, di esercitarsi ad amare le persone, e dunque le cose, e dunque il mondo tutto, non fino alla
morte – come pure si dice, come pure recita la formula «finché morte non vi separi» – ma fino alla vita.
Credo anche che le nuove genera zioni, e se non credo confido, inten zionate a praticare e far fiorire una coscienza ecologica, possano anche insegnarci quanto la violenza sulle donne non sia che una manifestazio ne della violenza che l’uomo bianco ha perpetrato – anche qui forse per troppo amore di conoscenza e con quista – su ciò che riteneva assogget tabile al proprio dominio: animali non umani, piante, animali umani ritenuti più deboli.
E così, mi pare, che questa giornata dedicata all’eliminazione della violen za sulle donne sia un’ulteriore giorna ta dedicata all’esercizio di considerar si non l’apice della catena alimentare e culturale, ma una possibile espres sione di un mondo più complesso fat to di natura e cultura. Di cose che non dipendono da noi, e di cose che invece dipendono da noi.
o imparato fin da quando ero piccolo che l’Iran occu pa uno spazio vuoto nella cartina geografica del mon do. Tenuto conto che la maggior parte delle nazioni arabe, Egitto incluso, hanno interrotto i rap porti diplomatici con l’Iran a causa delle dif ferenze politiche e religiose, è insolito trova re chi si interessi allo studio della lingua per siana o che la parli. Per questi motivi ho sen tito il bisogno di saperne di più, ma dagli iraniani stessi, senza intermediari. Ho inizia to a cercare donne iraniane che potessero aiutarmi a comprendere le foto e i filmati che stavano dilagando sui social media e nei ca nali di informazione. Volevo ascoltare le voci e le spiegazioni delle donne presenti a quegli avvenimenti, così da riuscire a capire meglio la realtà che si nasconde dietro le immagini.

In circostanze normali avrei iniziato la mia ricerca direttamente dalle fonti che mi
sarebbe piaciuto intervistare, ma questo mi è risultato difficoltoso per più ragioni. Non so no ancora autorizzato a viaggiare, e quindi non posso recarmi in Iran o da qualsiasi altra parte. In secondo luogo, se anche avessi l’op portunità di prendere un aereo, visitare l’Iran sarebbe estremamente rischioso per qualsia si egiziano. Per settimane ho cercato chi po tesse a sua volta avere contatti in Iran. È complicato trovare cittadini iraniani disposti a parlare. Ho infine intervistato quattro don ne: la prima vive ancora lì, due si dividono tra l’Europa e l’Iran, la quarta è fuggita dal suo Paese pochi anni fa. Tutte hanno chiesto di rispettarne l’anonimato, e quindi io ne parlo chiamandole con il titolo professionale. La storia inizia con l’assassinio di Mahsa Amini, arrestata dalla “polizia della morale islami ca” per aver indossato male l’hijab. LA POLIZIA DELLA MORALE ISLAMICA L’idea di indossare il velo sul capo si fece

strada per la prima volta dopo la rivoluzio ne del 1979, ma la “polizia della morale isla mica” debuttò ufficialmente soltanto nel 1990. Tra il 1979 e il 1990, la polizia costrin se le donne iraniane a indossare l’hijab, e il problema persistette fino a quando non fu creata una forza di polizia incaricata di vigi lare sul comportamento dei cittadini in ge nerale per strada e in particolare sul modo di vestire e di comportarsi delle donne.
«Il concetto di polizia della morale non ci è nuovo. Eravamo abituati a vederla in azione tutti i giorni per le strade del Paese. Il 4 no vembre 2009, durante il Movimento Verde, ho avuto io stessa a che fare con loro». Così parla una ricercatrice iraniana che oggi risie de in Europa: «Ero diretta in via Hafte tir, una delle più importanti arterie di comunicazio ne che portano a Teheran. A un certo punto decisi di togliermi l’hijab e lo gettai a terra. Mi trovai circondata da parecchi uomini che mi urlarono contro di rimettermi subito il ve
lo, ma io risposi che non erano fatti loro».
Il Movimento Verde iraniano, o “Jonbesh e Sabz”, scese in piazza nel giugno 2009. Do po che i risultati elettorali mostrarono che Ahmadinejad aveva vinto con discreto mar gine, coloro che si erano candidati contro di lui protestarono insieme a numerosi mem bri dell’Assemblea del Popolo che espresse ro il loro disappunto. Questo diede il via al più grande movimento popolare in Iran dal 1979. La mia interlocutrice ha così prose guito nel suo racconto: «Arrivarono quattro donne e mi trascinarono verso un autobus, a bordo del quale c’erano molti manifestan ti in manette e bendati. A me non fecero niente del genere». La ricercatrice aveva sentito parlare di donne condannate ad an ni di prigione per aver indossato male l’hi jab, quindi fu presa dal panico. «Quando arrivammo alla stazione di polizia, una di loro mi portò un modulo da firmare nel quale giuravo che non avrei mai più ripe
Sul sito de L’Espresso la versione integrale del lungo raccontotestimonianza di Patrick Zaki sulle donne del movimento di liberazione dell’Iran dall’oppressione del regime islamico.
In alto, una donna iraniana cammina per le strade di Teheran senza il velo obbligatorio. La foto è stata scattata il 1° novembre a Teheran, dopo le proteste iniziate con la morte di Mahsa Amini

tuto il mio gesto. Considerato che quella è una strada dalla quale non c’è un ritorno assicurato, fui abbastanza fortunata».
La “polizia della morale” ha fatto ricorso alla violenza in altri casi, prima di quello di Mahsa/Jina Amini, ma gli episodi preceden ti non avevano attirato l’interesse dei media o scatenato una reazione simile. Sattar Beheshti, attivista dei lavoratori, è stato uc ciso dopo essersi lamentato con la polizia di aver subito torture mentre si trovava in car cere. Oltre a questo, la “polizia della morale” aveva tenuto reclusa in un centro di deten zione la fotogiornalista iraniano-canadese Zahra Kazimi, poi assassinata in una delle stazioni della polizia.
Un’altra delle donne che ho intervistato è un’artista. Mi dice che è stata sottoposta a va rie persecuzioni da parte degli agenti di que sta divisione: «Immagina un gruppo di poli ziotti che ti si avvicina mentre esci dall’uni versità e ti chiede di indossare il velo in un dato modo perché non gli va bene come lo stai portando». Due avvenimenti hanno in fluito sulla sua decisione di lasciare l’Iran. Il primo risale a quando un poliziotto la avvi cinò ed espresse insoddisfazione per come si era seduta e la accusò di non avere rispetto. «Il secondo episodio fu quando decisi di tor nare a casa da un esame che si era concluso di sera in compagnia di un gruppo di colleghi, uomini inclusi. Mi sequestrarono i documen ti d’identità. Il giorno seguente dovetti anda re a riprenderli alla stazione della polizia den tro l’università, accompagnata dai miei fami liari». La “polizia della morale” è uno dei volti della repressione in Iran delle donne, ma è anche la manifestazione più visibile della vio lenza diretta e quotidiana perpetrata contro il corpo femminile in generale.
«Non sapevo se mi avessero trascinata via perché non indossavo correttamente l’hijab o perché avevo partecipato alle manifesta zioni», mi ha detto un’altra delle intervistate, che adesso lavora come assistente presso un’università europea. «Ero terrorizzata e scioccata, ma mi reputo fortunata perché sono libera e sono qui a parlarne con te».
Non c’è donna iraniana che abbia potuto sottrarsi ai commenti della “polizia della mo rale islamica” riguardanti il suo corpo, il suo aspetto, il suo abbigliamento. L’assistente universitaria aggiunge di essere stata vessata in più occasioni quando viveva in Iran, oltre a essere stata arrestata almeno due volte, una a
Manifestanti a Teheran nel corso di una delle molte iniziative di protesta seguite alla morte di Mahsa Amini, rimasta uccisa all’interno di una centrale della “polizia morale” dopo essere stata fermata mentre faceva shopping con i familiari con l’accusa di avere indossato il velo in modo non conforme alle prescrizioni
Teheran e una a Isfahan. In quest’ultimo caso, è stata fermata insieme a un’amica per aver messo il rossetto: entrambe sono state co strette a firmare un documento nel quale di chiaravano che non l’avrebbero fatto mai più. Secondo le testimonianze, malgrado il suo potere e la sua organizzazione, la “polizia del la morale” non è in grado di tenere sotto con trollo le azioni di tutte le donne. Anzi, ho sco perto che niente di quello che gli agenti face vano o fanno ha avuto effetto di alcun genere sul loro modo di vestire o sul loro modo di credere nella libertà di vestirsi, sedersi, o perfino stare insieme ad altri.
La prima scintilla delle proteste non è parti ta da Teheran. Secondo l’assistente universi taria, «abbiamo ascoltato nomi di città e paesi mai sentiti prima. Questo movimento è diverso da tutti quelli che l’hanno precedu to. È andato crescendo rapidamente, dopo la notizia della morte di Mahsa/Jina Amini. Le donne si danno appuntamento sulla tomba di Mahsa/Jina Amini per togliersi il velo e scandire ad alta voce “Jin, Jiyan, Azadî”, che significa donne, vita, libertà, ed è uno slogan curdo in uso da tempo», ha detto. In risposta alla stessa domanda, ha aggiunto che «con trariamente a quanto è accaduto dal 2009 al 2017, il movimento si è rafforzato proprio nei paesini e nelle piccole città che di solito non si univano alle proteste».
Sulla tomba di Mahsa, nella sua città na tale, è scritto: “Cara Mahsa, non sei morta,

continuerai a vivere come icona per sem pre”. Questo mi ha spinto a chiedermi per ché la sua morte abbia fatto infuriare le don ne iraniane più di qualsiasi evento passato. Le proteste non sono soltanto contro il velo, ma anche contro un sistema patriarcale ra dicato in profondità. «Noi abbiamo uno slo gan curdo che dice “donne, vita, libertà”. È questo lo slogan attorno al quale ci stringia mo tutte, perché difende tutti gli oppressi. Rappresenta la libertà totale per noi, e il mo vimento non è soltanto femminista, ma an che un movimento popolare di massa». Se condo la ricercatrice non si può definire con precisione il movimento femminista irania no. Tutte le correnti difendono le donne e hanno usato i social media per migliorare la consapevolezza delle altre donne. La profes soressa con cui mi sono confrontato crede che il movimento femminista iraniano sia profondo e ramificato in più località, ma ha citato anche movimenti come “Le ragazze di Enghelab Street” (il corrispettivo iraniano del movimento MeToo) e il “Movimento dei mercoledì bianchi” (che si batte contro l’ob bligo di portare l’hijab). Tutti si caratterizza no per il fatto di essere decentrati.
Dopo circa quaranta giorni, ci si presenta una scena spaventosa: migliaia di persone si diri gono verso la tomba di Mahsa Amini mentre gli agenti della sicurezza iraniana cercano in ogni modo di impedire che raggiungano la loro meta. Ma ci sono troppe persone per
Due ragazze scattano foto in piazza Azadi a Teheran. Anche questa è una forma di protesta contro le restrizione imposte dal regime islamico che governa il Paese e che hanno portato al fermo e alla morte, il 16 settembre scorso, in un ufficio della cosiddetta polizia morale della ventiduenne Mahsa Amini

controllarle tutte. Inoltre, tutte le persone con cui ho parlato hanno confermato che gli agenti sono in ranghi assai ridotti. Di conse guenza, nel suo tentativo di tenere sotto con trollo i movimenti popolari in tutte le città iraniane, il governo ha dovuto fare ricorso al la forza bruta come mai prima d’ora. Secondo la professoressa, è difficile de terminare se quello in piazza sia un movi mento o una rivoluzione. Si è alle prese con un regime molto potente che dispone di tut ti i mezzi per sbaragliare qualsiasi spinta al cambiamento. Tuttavia, niente è impossibi le. La ricercatrice mi ha detto: «Non si può giudicare un movimento dalle sue dimen sioni. La gente in strada si arrabbia quando le dici di andarsene. Così oggi scandisce di continuo due slogan: “Non un movimento, ma una rivoluzione” e “Questo è l’anno del sangue, rovesceremo Sayyd Ali”, in riferi mento ad Ali Khamenei». L’assistente ha detto che «finché sfileremo per le strade c’è speranza. Continuità significa vittoria, per ché la gente in strada parla di rivoluzione e la rabbia è arrivata a livelli altissimi».
Infine, ho cercato di saperne di più riguardo ai sogni delle donne iraniane. Che cosa si aspettano da quello che sta succedendo? L’assistente universitaria sogna di diffondere la democrazia e dice che «non dobbiamo tornare al passato». Non vuole però che la popolazione debba subire altre perdite e sof ferenze: non potrebbe mai realizzare il suo sogno a partire da altre perdite. La professo ressa spera di avere l’opportunità di tornare ancora una volta in Iran. Negli ultimi anni è stata molto attiva in Europa e, se dovesse tor nare, sarebbe arrestata. Il suo desiderio è ve dere riunita la sua famiglia, senza più paura. I sogni della ricercatrice si limitano a una lettera scritta da Mir-Hossein Mousavi su Statement No. 13 nel 2009, dove si legge: «La nostra vittoria non è qualcosa per cui qualcuno poi si ritrova in condizioni peg giori di prima. Dobbiamo arrivare alla vit toria tutti insieme, anche se alcuni di noi sono lenti a riconoscere le buone notizie». Desidera la libertà non solo per sé stessa e ciò in cui crede, ma anche per i suoi nemici. E l’artista conclude: «Non penso che siano sogni: o conquisteremo la libertà, oppure moriremo a testa alta».

La maglietta della Decima Mas indossata da Enrico Mon tesano durante le prove di “Ballando con le stelle” era solo il frutto di un equivoco. Il popolare attore credeva che Mas fos se l’abbreviazione di Masterchef, e dunque la scritta celebras se la decima edizione della popolare gara tra cuochi. Chiarito l’incidente, la Rai ha riammesso Montesano a “Ballando”. Molto solle vato, per riconciliarsi con il pubblico, per la prossima puntata Montesa no ha lungamente provato, con un coreografo tedesco, il difficile passo dell’oca.

I precedenti Antonella Clerici presentò lo Zecchino d’oro indossando una ma glietta di Padre Pio, la cui effigie truce seminò il terrore tra i bambini presenti, e perfino tra le suore dell’Antoniano. Inter venne il Codacons. Sempre il Codacons denunciò la maglietta bianca indossata dal presentatore Milo Pirolli al Festival Gospel di Saint Vincent, chiaro segno di discriminazione nei confronti dei cori di afroamericani; e la maglietta pervinca della soubrette Vanja Go al concerto di Capodanno del 2016, oggetto di dure po lemiche non per il colore, ma perché era orribile.
Il record Quest’anno il Codacons ha fe steggiato il centomillesimo esposto-de nuncia dell’associazione contro abusi, oltraggi, vergogne, scandali, soprusi, ignobiltà di ogni genere. L’occasione è stata l’esposto contro il fenomeno degli autogol nel calcio, lesivo dei diritti del tifoso. Il direttivo del Codacons, per fe steggiare il prestigioso traguardo, si è autodenunciato come misura preventiva per eventuali future degenerazioni mora li dei suoi membri.
Nella bufera Ma “Ballando sotto le stel le” è nella bufera anche per altre pole miche. L’Associazione Geriatri, con una severa nota, ha protestato perché, nono stante l’età media dei concorrenti sia di 72 anni, il decano della geriatria italia
na, professor Bartolo Buzzi Pinzi, non è stato invitato a fare parte della giuria, dopo essere stato scartato anche come concorrente. La Rai replica che l’età me dia dei suoi spettatori è molto superiore agli ottant’anni, e dunque l’Associazione Geriatri si occupi di assistere il pubblico, non gli artisti.
Ancora Codacons Perché a “Ballando” non è stato ammesso nessun concorrente con le lentiggini? Il Codacons considera questo atteggiamento seriamente discri minatorio nei confronti dei portatori di lentiggini, e ha presentato un esposto. Uguale discriminazione, in questa e altre trasmissioni, è stata perpetrata ai danni di gemelli siamesi, palombari con il ca ratteristico scafandro, persone affette da scorbuto e molte altre categorie. La Rai sta studiando un nuovo protocollo per selezionare cast che non discriminino al cuna categoria di viventi. Di conseguen za, si stanno studiando format che pre vedano circa milletrecento concorrenti a puntata.
Altri casi Ma la Rai è nella bufera anche per altri casi. Il tradizionale libro annua le di Bruno Vespa, pubblicizzato in tutte le reti e venduto in decine di migliaia di copie, è stato finalmente letto da qual cuno. Questo qualcuno si è accorto che il libro, con una copertina diversa e il titolo cambiato, è lo stesso dal 1973. Si parla di Andreotti, Rumor, La Malfa, con un capi tolo dedicato a Gustavo Thoeni e ai suoi trionfi nella Coppa del Mondo di sci. Vespa si è difeso sostenendo che ogni edizione ha un aggiorna mento (quest’anno, per esempio, il capitolo su Thoeni è arricchito da un’intervista ad Alberto Tomba). Altro episodio molto controverso, la programmazione di una fiction sulle vittime del comunismo incentrata sulla figura di Luciano Moggi. E uno speciale di Raidue sulla questione degli sbarchi dei migranti vista dalla parte dei gestori degli stabilimen ti balneari, spesso costretti a spostare le sdraio.
Finalmente qualcuno lo ha letto e si è accorto che cambiano solo titolo e copertina. Mentre il Codacons protesta perché a “Ballando con le stelle” non ci sono concorrenti con le lentiggini
Dall’alto, in senso orario, Dario Nardella, Elly Schlein, Andrea Orlando, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Matteo Ricci





 DI SUSANNA TURCO
DI SUSANNA TURCO
Nel Pd sono tornati a soffiare forte i venti di scissione: era da anni che non accade va con questa intensità. In privato è tut to un «se vince Tizio, se ne va Caio». Ad esempio: «Se vince Stefano Bonaccini se ne va la sinistra», «se vince Elly Schlein se ne va Base Riformista», se vince Dario Nardella se ne vanno i violinisti eccetera. E la partita non è nemmeno cominciata.
Ma nelle conversazioni a latere della tumultuosa pa lude in cui è immersa la costruzione del percorso verso il congresso, tra l'assemblea di sabato 19, la babele nota rile delle regole e il bilancino farmaceutico delle date, da intrecciare con le elezioni regionali in Lombardia e Lazio che si annunciano un nuovo simpatico bagno di sangue, pare al momento non ci sia nessuno disponibile a credere nella possibilità di rimescolare ancora una volta quello che Massimo D'Alema, già dopo un solo an no dal battesimo, definì «un amalgama mal riuscito», cioè il Pd. Appena un gradino sotto il livello del mare guizzano tentativi di costruire percorsi credibili, oltre un partito invecchiato dentro al suo gruppo dirigente e congelato dalle cor renti, ma è ancora tutto troppo sottotrac cia e acerbo per venire a galla, sempre che ci arrivi in tempo. Perché, in effetti, se si guarda ancora meglio dentro il poz zo del Nazareno, più che la parola scis sione brilla nel fondo un'altra spaventosa eventualità: lo scioglimento.
Su un Pd che così, tra svogliatezza e paura, si applica ai blocchi di partenza per scegliersi un nuovo capo e una ulteriore identità si è abbattuta come una saetta – anche se tutt’altro che im prevista – la discesa in campo di Elly Schlein. Che ha terremotato il quadro sin lì composto dai probabili can didati alle primarie, quelli annunciati: il solito Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna pronto a candidarsi sin da quando vinse in Regione nel gennaio 2020; Paola De Micheli, ex ministra dei Trasporti, sem pre lesta a trarre da una situazione data il massimo del vantaggio possibile; il sindaco di Firenze, il sempre am modo Dario Nardella, pronto a scendere in campo il 26 novembre, data in cui ha convocato «un’assemblea na zionale con tutte le forze culturali sociali e politiche che credono in un nuovo progetto per il centrosinistra ita liano»; e il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, considerato da tempo una promessa democratica di un partito che non è mai sbocciato.
annunciato che farà parte anche lei del processo costi tuente del Pd, partito al quale non è sin qui iscritta. An tipasto di una corsa alle primarie che, già di per sé ha fatto drizzare le antenne a un bel pezzo di dirigenza de mocratica, che la percepisce come un corpo estraneo e quindi nello stesso tempo la sminuisce e la teme. «Im prevedibile», «eccentrica», «pericolosa», sono infatti alcuni aggettivi che le si affibbiano nelle conversazioni private, come se si trattasse di un’attivista stile «Just Stop Oil» (gli ambientalisti che lanciano le zuppe con tro le opere d’arte) e non di un’amministratrice di quella che fu la regione più rossa d’Italia.
Di fatto la sua discesa in campo ha infastidito, nello stesso tempo, la sinistra e i moderati, a tenaglia. Emble matico, mercoledì scorso, che il suo nome comparisse sia in una intervista al coordinatore di Articolo 1 Arturo Scotto al Manifesto, sia in una intervista al capolista della civica per Gualtieri, Alessandro Onorato. In en trambi i casi, non propriamente per sperticati compli menti. «Non ho capito se è davvero libera o se è l'ultima trovata delle correnti per tenere il potere a sua insapu
ta», diceva l'assessore al Turismo di Roma. «Anche lei è consapevole che senza ridefinire identità e missione, le primarie non risolveranno nessun problema. Sa bene che la sfida non è una nuova leadership individuale», di ceva invece Scotto. È tutto un ridefinire, un precisare, un contenere, un annodare.
Quanto a Schlein, sempre tra il dico-non dico nel suo stile di smodata prudenza, la neodeputata, che conqui stò la vicepresidenza dell'Emilia-Romagna dopo essere risultata da leader di Coraggiosa la più votata nelle Re gionali 2020 (23 mila preferenze, solo a Bologna 15 mila, più dei big dem), giorni fa, con una diretta Instagram, ha
Di certo lo è da sinistra, dove il mancato trionfo all'Au ditorium durante la presentazione dell'ultimo libro di Goffredo Bettini ("A sinistra. Da capo": praticamente una minaccia) dell'ex premier Giuseppe Conte, una vol ta adorato come futuro luminoso del progressismo mondiale e adesso maldigerito replicante in dolcevita esistenzialista da pseudo-sinistra, fa da pendant a un grande attivismo finalizzato al congresso dem - si muove soprattutto l'ex ministro Andrea Orlando. Un attivismo che però non riesce a farsi proposta, candidatura, spinta in avanti. Mancata la sintonia con Schlein, al massimo si fa corda, laccio, in ciampo.
L'elezione all'unanimità, il 15 novem bre, di Dario Franceschini a presidente della Giunta delle elezioni e delle im

munità di Palazzo Madama è piombata su tutto que sto come un ulteriore avvertimento sul futuro in aggua to: non bastava la grande chiesa franceschiniana che passa da Che Guevara e arriva a Madre Teresa, è adesso abbastanza chiaro che l'arco di consenso a cui punta l'ex ministro è ulteriormente ampliato. Da El ly Schlein a Ignazio La Russa. Su di lei l'ex ministro della Cultura sta valutando di lanciare un'opa - un interesse puntual mente resocontato dalle veline. E lo sta valutando anche a rischio di spaccare la sua Areadem: un assaggio del disagio si è visto martedì sera, all'assemblea regiona le del Pd del Lazio. Quando a Bruno Astorre, pilastro del Pd romano che certo non ha un'idea iperurania della politica («è di quelli che magari non riescono ad allacciarsi le scarpe, ma non vorrei averlo contro al congresso», ebbe a dire di lui Luca Lotti) veniva chiesto se si vedeva a so stenere la mozione Schlein, egli rispondeva tra il laconi co e lo sbruffone: «Ma se non so manco come si scrive!». Quanto a Ignazio La Russa, come era stato ricostruito a suo tempo, ormai è un pochino più chiaro - lo svelano per l’appunto gli assetti successivi - grazie a quali voti, all'interno dell'opposizione, sia riuscito a diventare pre sidente del Senato nonostante la defezione in massa di Forza Italia nel momento dell'elezione. Matteo Renzi,
all'epoca primo sospettato dell'inghippo, dichiarò che «non lo sapremo mai» ma precisò che comunque i suoi voti da soli non sarebbero bastati. «Poi io non sono uno bravo a fare questo tipo di calcoli. Non sono, per dire, un Franceschini», precisò in Transatlantico felicemente as sediato dai giornalisti. Per poi passare la giornata, mo dello assassinio sull'Orient Express, a scherzare con quello che una volta chiamava «il vicedisastro» (appun to Franceschini) e con un altro personaggio che non si può definire estraneo a questa partita: il cinquestelle Stefano Patuanelli.
Con questa magnifica opposizione-non-opposizione in Parlamento, il Pd si avvia così a fronteggiare l'unica tra le sue battaglie che ha una data (quasi certa), e un esito pressoché scontato: le regionali di Lazio e Lombar dia. Una doppia partita nella quale sin qui il partito gui dato da Enrico Letta si è comportato in modo schizofre nico. La decisione finale non è stata ancora presa, co munque in sintesi l'unico filo rosso finora visibile è quel lo di scansare il più possibile un assetto competitivo. Non sia mai. Nel Lazio, infatti, i dem si sono buttati su Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della giunta Zin garetti, messo sul piatto però dal terzo polo di Calenda e Renzi, col risultato di spaccare, rendendola di fatto im possibile, quella che era stata l'alleanza pilota dei gial lo-rosa, l'accordo locale per il governo tra dem e grillini, il campo largo che l'ex governatore e segretario dem era riuscito a mettere in piedi in una delle regioni dove i Cin que Stelle sono tradizionalmente più forti. Al contrario in Lombardia, dove il partito di Conte è da sempre debo le, il Pd ha scelto di abbracciare la strada di una possibile alleanza proprio coi grillini (c'è stata una qualche timida apertura), a scapito di un eventuale abbraccio al terzo
polo che colà appoggia la corsa di Letizia Moratti, nome simbolo del centrodestra (già sindaca di Milano, candi data da Salvini e Meloni al Quirinale) e oggi in transito verso altrove dopo aver lasciato il posto di vice di Fonta na. È proprio il prevedibile, pessimo, risultato elettorale a rendere ancora più opaca la sciarada del congresso dem, che può essere anticipato a patto però di non coin cidere con la batosta alle porte. Anche questo busillis dovrà essere sciolto, nel groviglio in cui il Pd si annoda ogni giorno peggio.

Caro Enrico Letta, non ci siamo mai incontratə come persone, ma è al segretario del Pd che scrivo questa lettera pubblica per fare una sola domanda. Qualche settimana fa, all’indo mani della firma del presidente Mattarella sul decreto cosid detto anti-rave - in realtà anti-qualsiasi espressione pubblica di dis senso collettivo a discrezione delle questure - sulla prima pagina di un giornale ho letto il titolo “Mattarella sconfessa Saviano e la Murgia”. È spontaneo chiederle: perché ci sono il mio nome e quello di Savia no, invece che il suo o di qualcun altro dell’opposizione? Perché siamo noi quelli che i capi dell’estrema destra espongono alla rabbia della lo ro base sui social media? Come mai la destra si comporta come se la sua opposizione fossero gli intellettuali, invece che gli avversari politici seduti in parlamento? La risposta è brutta, ma evidente: non state facendo il vostro la voro e noi ci ritroviamo nostro malgrado a farlo al posto vostro.
In questo vi siamo anche comodi. Basta l’atto di prendere posizioni pubbliche contro il nuovo fascismo governativo per essere associati a voi, il soggetto politico che per eredità storica dovrebbe essergli antagonista, tanto che ad alcuni sembra persino che siate voi, attraverso le nostre voci, a prendere posizione. Invece non è così: siete troppo impegnati a giocare al vostro Risiko interno, un congresso che nella migliore delle ipotesi tirerà fuori una faccia pulita in cui la base può an cora credere, ma che avrà dietro il solito verminaio di piccoli potentati a reggere i veri fili. Nel mentre, il governo Meloni fa una scelta catastrofica e illiberale al giorno e l’urgenza civica impone a chiun que abbia una voce pubblica di usarla. Lo stiamo facendo, ma siamo stanchə di fare da supplenti morali a un partito incolore, che tace invece che parlare, che sussurra dove dovrebbe gridare e che cerca media zione dove dovrebbe innalzare barricate. Siamo stanchə di dire le parole che voi non dite e di vederci arrivare le shitstorm (e talvolta pure le querele) per aver difeso i temi e i valori che voi avete messo in di sparte per inseguire il consenso al “cen
tro”, il fantomatico centro che non esiste se non come secca che si sposta a ogni cambio di marea. Il centro è una sintesi, un punto di arrivo, non un metodo poli tico. Nel pur malato sistema bipolare in cui ci avete costrettə a votare, quello che chiamate centro è la fine di un percorso di mediazione tra una destra e una sini stra, ma la premessa per raggiungerlo è partire almeno da uno dei due punti, non bivaccare nella medianità, evitando ogni tema scomodo e strizzando l’occhio per sino a chi su quei temi dice l’opposto.
Il mestiere degli intellettuali è interro gare la realtà nelle sue contraddizioni. Noi non dobbiamo parlare per voi, ma restare liberi di parlare anche contro di voi, come in questi anni peraltro abbia mo sempre fatto, dato che spesso avete compiuto scelte che contraddicevano i valori di una sinistra vicina ai più deboli. Siamo confortatə nel vedere Aboubakar Soumahoro salire su una nave umanita ria a denunciare quanto sia miserabile la selezione delle vite a bordo, consapevoli però che a sinistra quella dovrebbe es sere la risposta naturale di sistema, non l’iniziativa solitaria di un parlamentare. Per voi invece sarebbe difficile fare altret tanto, dopo che avete votato per anni i rifinanziamenti ai torturatori libici che chiamavate “guardia costiera”.
Così vi viene altrettanto difficile dire che l’immigrazione non va fermata, e non solo perché ci serve, ma perché riconoscere alle persone il diritto di cercare condizioni di vita migliori è un principio portante dell’idea di mondo che una sinistra degna di questo nome dovrebbe voler costruire. Se non potete dire nemmeno questo, fate bene a stare zitti. Parleremo ancora noi, pagandone il prezzo in termini di esposi zione extraprofessionale e assunzione della conflittualità. Però allora smettete di fingervi alternativi a questa destra, che sarà pure radicata nel più rozzo fascismo, ma almeno è coerente nel suo rapporto tra in tenzioni e azione.

Sulla questione dei migranti sono finiti nel mirino gli intellettuali invece del principale partito di opposizione. Perché ha idee troppo simili a quelle di chi governa
Dei quattro provvedimenti del governo Meloni: il reintegro immediato dei sani tari No Vax, e l’introduzione del nuovo reato d’invasione di terreni ed edifici, indicano - come ha ben chiosato Luigi Manconi - la rotta del governo della Fiamma verso un libertarismo reazionario «insoffe rente verso regole e vincoli»; e insieme una nuova dire zione autoritaria «che inventa un nuovo reato e lo tra scrive in una norma, priva di quel requisito di tassati vità richiesto dallo Stato di diritto». Rotto in parte lo charme, la Meloni, dismessa la maschera, ha mostrato il volto. Ed è un volto supponente e autoritario. Sicco me nei mesi a venire avremo da fare per definire il con fine tra autorità e autoritarismo, non dovendo abban donare alla Destra una parola chiave come «autorità», è bene riassumere in pillola il si gnificato della parola ed il suo mu tamento.
Questa rivalutazione dell’autorità, che non dimenti ca la natura sociale e l’asimmetria sociale - analizzata da Marx - della relazione tra chi gestisce o incarna l’autorità e chi l’accetta o la subisce, avviene dopo due secoli di dismissione concettuale a partire dall’illumi nismo, dalla negazione dell’autorità come tradizione, dal processo di secolarizzazione della modernità, dall’uccisione del padre. A metà degli anni Trentaall’inizio della risolutiva caccia all’ebreo - la scuola di Francoforte: Horkheimer, Marcuse e Fromm con gli Studi sull’autorità e la famiglia, che troveranno il loro compimento nel monumentale lavoro di Adorno “La personalità autoritaria” del 1950, denunciò come ideo logia, cattiva rappresentazione, l’idea dell’autorità in troiettata come libertà, portando alle sue estreme conseguenze la teoria del carattere di feticcio delle
Negli anni Ottanta un sociologo ma anche musicista, violoncellista di formazione, Richard Sennett, si è occupato dell’autorità distin guendo la buona dalla cattiva; so stenendo che l’arte, la musica so prattutto, offre modelli di buona autorità. Per Sennett l’autorità non è mai statica, definita, fissata una volta per sempre, come invece pretenderebbe il potere politico autorita rio. La buona autorità è quella che si mette perenne mente in discussione, in metamorfosi, in cambiamen to. Per Sennett, gli artisti e soprattutto i musicisti, dal direttore agli esecutori, si mettono continuamente in discussione. È soprattutto il direttore che agisce un diverso modo d’interpretare l’autorità, una buona au torità, capovolgendo così la lettura che ne dà Elias Ca netti. È seducente questa idea dell’autorità in trasfor mazione, anche perché appare legata ad un’altra idea di Canetti, l’idea del potere come antimetamorfosi. L’autorità che nega la sua istanza al mutamento si con gela nel potere totalitario che è appunto l’antimeta morfosi per eccellenza. Autoritario sarebbe allora ciò che congela la dinamica, la mutevolezza dell’autorità?
TRASFORMAZIONE. QUANDO NEGA LA SUA ISTANZA AL MUTAMENTO SI CONGELA NEL POTERE TOTALITARIO CHE È L’ANTIMETAMORFOSI PER ECCELLENZA
merci analizzato da Marx. L’autorità diviene autorita ria prosciugandone la libera adesione nella macchina del dominio. Augusto Del Noce aveva visto sorpren dentemente giusto quando scrisse di temere la misce la tra marxismo, scuola di Francoforte e il surrealismo come una gigantesca molotov messa sotto l’impalca tura borghese. Foucault, come si sa, radicalizzando la critica all’autorità, accenderà altre micce rendendo evidente come la libertà sia la recita sul palcoscenico della storia del disciplinamento capillare che si svolge nel sottopalco.
La destrutturazione del lessico politico alla quale assistiamo dalla fine del secolo scorso, porta ad inter rogarci sull’autorità perché condividiamo con Kojève, il grande autore che all’autorità ha dedicato già nel ’42 un libro denso per «saggiarne forme e flessibilità», l’i
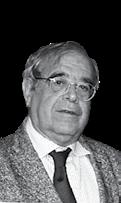
dea che essa sia ancora fondamentale per intendere lo Stato, ora che anche lo Stato sembra in lenta dissolu zione.
Dell’autorità ci attrae, come nel caso della democra zia, la sua trasformazione. Da un lato l’autorità sempre più concettualmente distaccata dalla sfera pubblica; deistituzionalizzata, depoliticizzata e indebolita nella sublimata categoria morale e culturale. Con un aggra vamento nel pulviscolo postmoderno perché alla rela tivizzazione soggettiva corrisponde la relativizzazio ne dell’autorità intesa come elemento di tradizione sia politica che culturale. Insisto sull’idea che lo svuota mento della democrazia così come dell’autorità ri specchi lo svuotamento della soggettività sociale. La crisi dell’intellettuale, la crisi dell’autore è un aspetto cruciale della crisi della nozione di autorità. Si sono
costruite altre autorità mentre le istituzioni depoliti cizzando l’autorità diventano complessivamente più autoritarie, magari dandosi un volto tecnico. Ha scrit to Kojève: «Esiste autorità soltanto là dove c’è movi mento, cambiamento, azione (reale o almeno possibi le): si ha autorità solo su ciò che può “reagire”, cioè cambiare in funzione di ciò o di colui che rappresenta l’autorità (la incarna, la realizza, la esercita), E, in tut ta evidenza, l’autorità appartiene a chi opera il cam biamento e non a chi lo subisce.» Prima di Sennett, Kojève aveva indicato la dinamica dell’autorità, aveva puntato sulla flessibilità indotta dall’autorità per sot trarre questa parola chiave alla destra, già nel ’42.
*Politologo, docente di Storia del pensiero politico e Sociologia della musica all’Università di Palermo
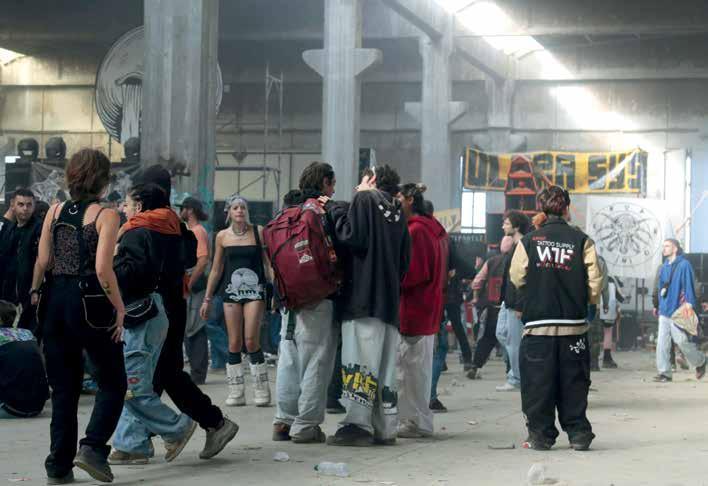
Forse è iniziato con le elezioni del 2013. O forse prima. E poi è successo sempre più spesso. Con picchi di intensità a ogni tornata elettorale. Amici che si incontrano. Che parlano. Finché uno tira fuori la stessa domanda. «Ma come è successo?». Già. Come è successo. Com’è suc cesso che «politico» sia diventato un insulto nel sentire co mune e l’essere unicamente cittadini sia diventato l’ele mento necessario e qualificante per avere responsabilità pubbliche? Com’è successo che i segretari di partito abbia no cominciato ad avere più rilevanza dei programmi politi ci e che dirsi «né di destra né di sinistra» sia diventato un valore in cui riconoscersi? Com’è successo che il susseguirsi dei governi sia stato considerato tradimento della volontà popolare e il taglio dei parlamentari la panacea di tutti ma li? Come è successo che l’elezione diretta del capo del go verno (sia presidenzialismo, sindaco d’Italia o altro) sia in vocata da più parti come il modello da adottare?
Com’è successo che i diritti sociali siano diventati privile gi e la condizione di vulnerabilità una colpa? Com’è succes so che uno sconosciuto all’opinione pubblica sia diventato presidente del Consiglio (e di due schieramenti opposti nell’arco della stessa legislatura) e la sorte di politiche e go verni sia stata decisa con votazioni online sulla piattaforma di una società privata? Com’è successo che si parlasse di «taxi del mare» riferendosi alle imbarcazioni di fortuna uti lizzate dai migranti per attraversare il Mediterraneo e che il ministro dell’Interno sostenesse il diritto di difendere la propria incolumità e i propri beni con armi personali? Com’è successo che i tagli alla spesa pubblica e lo smantel lamento dello stato sociale siano diventati un destino ine luttabile e fare da soli sia diventata l’unica strada? Com’è successo che la rappresentanza e il confronto siano stati ri tenuti un ostacolo e la velocità delle scelte e la partecipazio ne con un clic l’orizzonte da perseguire? Com’è successo che di fronte a drammatiche crisi economiche e sociali si siano ricondotte a una sola persona la capacità e la compe tenza per rispondere ai bisogni del Paese? La lista dei «co me è successo?» sarebbe ancora molto lunga e la risposta non può essere una sola. Ma come trovarle? Voltandosi in dietro e cercando di rifare la strada al contrario, per capire questa trasformazione politica e culturale. E le tracce più evidenti sono da riconoscere nel linguaggio. E nei suoi mu tamenti.
Senza pretese di esaustività, consapevoli degli inevitabili
condizionamenti indotti da storia e convinzioni personali, abbiamo provato a raccontare il «come è successo», assu mendo come punto di partenza gli inizi degli anni ’90, quel li comunemente noti come gli anni di Tangentopoli, della crisi irreversibile dei partiti che hanno governato l’Italia per cinquant’anni, della comparsa di Silvio Berlusconi sulla sce na politica e dell’avvio della cosiddetta seconda Repubblica. Dal 1994 in poi il libro ricostruisce – parola per parola – la metamorfosi di un linguaggio che non si limita alla sempli ce inflazione di grossolana volgarità e artificioso turpilo quio cui ci siamo abituati ma che contribuisce in maniera determinante alla messa in discussione dei principi cardine del nostro sistema politico e dei meccanismi della rappre sentanza. È intorno al proliferare di parole come inciucio, ribaltone, poltrone, casta, fannulloni, ecc. che progressiva mente si è strutturata una neolingua che alimenta una mol teplicità di fenomeni, ancora in corso, caratterizzati dal per seguimento spasmodico e acritico di una semplificazione della vita pubblica e delle istituzioni democratiche. Sempli ficazione dei partiti, sempre meno radicati territorialmen te, sempre più personalistici. Semplificazione della compe tizione politica, ridotta a una continua ricerca della contesa tra due soli poli e della mitologica ricetta elettorale e istitu

Anticipiamo qui un brano di “Come è successo”, di Paola Di Lazzaro e Giordana Pallone (Fandango Libri, 176 pagine, 17 euro) appena arrivato in libreria

l’immigrazione soccombe ad un immaginario fatto di «in vasioni», «gite in gommone con gli smartphone», «hotel a 5 stelle». Anche la povertà diventa una colpa. Chi non ce la fa, non è più un tema da affrontare con gli strumenti del welfa re, ma un «fannullone sul divano». Ultimo, ma non meno importante è il colpo sul piano della partecipazione pubbli ca. Dalla messa in discussione della forma partito, che viene «rottamato», all’illusione della democrazia diretta (...).
Il risultato di questo processo è lo spostamento oltre il punto di non ritorno di quella linea invisibile che delimita ciò che è ritenuto ammissibile nel dibattito e nelle pratiche pubbliche e private. La semplificazione del linguaggio di venta, allora, una semplificazione dei processi democratici e della vita pubblica. La democrazia rappresentativa e i suoi
zionale per la governabilità ad ogni costo. Semplificazione della rappresentanza, con un progressivo svilimento dei corpi inter medi e del loro ruolo, l’esaltazione dell’ele zione diretta e di figure salvifiche o leader onniscienti a cui affidare le sorti di comuni, regioni, o di un governo intero. Filtrata dalla cartina di tornasole di questa neolingua nel libro si ricostruisce la progressiva e inesora bile delegittimazione di ruoli e funzioni, in primo luogo sul piano istituzionale: è la stessa legittimità dei governi che viene messa in discussione ripetutamente con il refrain della volontà popolare tradita e dei governi non eletti dal popolo. Mentre parti dello Stato, subiscono attacchi reiterati, dai giudici considerati «eversivi» o rei di condurre «indagini a orologeria», ai dipendenti pubblici di pinti come troppi e nullafacenti, alle amministrazioni stesse identificate come uno spreco di risorse. La neolingua agisce anche sul piano democratico, minando la costituzionalità del confronto e del dissenso. I giornalisti diventano «penni vendoli», gli intellettuali «professoroni con l’attico a New York», i critici e gli oppositori «gufi». Il terzo piano a essere compromesso è quello civile. La complessità di temi come
strumenti collettivi non sono più funzionali alla necessità di avere governi forti in tempi certi (meglio se un minuto dopo le elezioni), e di legiferare senza intoppi (il Paese deve corre re). Meglio un consenso plebiscitario attraverso forme di pseudodemocrazia diretta cui si accompagnano la centrali tà del leader e la primazia del governo sul Parlamento (...). Uno spostamento che non può non incidere su interessi pubblici e di comunità che vengono surclassati dal torna conto personale, con l’orizzonte politico che si sposta dal piano collettivo al piano individuale e dalla responsabilità collettiva verso il bene comune, alla preminenza dell’inte resse privato. Ecco come è successo.

Dice il saggio che nei rap porti umani non conta solo ciò che sei, ma anche ciò che gli altri pensano di te. È così anche in politica. Specie nelle relazioni internazionali. Pre giudizi? Certo, non mancano, ma spesso si fondano su dati di fatto. E dunque se si vuole capire perché tanti in Europa giudichino poco affidabile l’Italia, e sia sempre così difficile muoversi a Bruxelles, e poi «i francesi che s’incazzano… che le balle ancor gli girano» (copyright Paolo Conte), sarebbe necessario non solo sbandierare l’orgoglio na
Grecia o Spagna. Le richieste d’asi lo qui sono la metà che in Francia, un quarto che in Germania, e i rifu giati sono 130 mila, un paio di stadi di calcio: in Germania sono quattro volte tanto. Ce lo rinfacciano quan do chiediamo aiuto agli altri; ce lo rinfacceranno presto ai prossimi tavoli di trattativa.
Un mio cugino tedesco, per esem pio, ogni volta che gli parlo dei no stri guai, tira fuori il solito campio nario. Mi ricorda che da anni l’Italia detiene il record del debito pubbli co, che alle nostre spalle c’è un ven
Debito pubblico record, ma anche risparmio privato. Richieste di aiuto e un tenore di vita invidiabile. Il lungo elenco delle lamentele dei nostri alleati
zionale, ma prendere atto dei rim proveri che ci vengono da partner e alleati. Non per punirci, ma per rimediare. Segue breve elenco.

Della questione immigrati si è detto molto, e però: è vero che quest’anno sono stati accolti 90 mi la uomini, donne e bambini in fuga da guerre, torture e miseria, e ben trattati come i francesi se lo sogna no, ma è anche vero che una volta arrivati vanno altrove, in cerca di un lavoro che qui non c’è. Risultato, in rapporto alla popolazione l’Ita lia ospita oggi la metà degli immi grati dell’Austria, e molti meno di
tennio di crescita allo zero virgola; che però vantiamo il primo posto in Europa, contemporaneamente, sia per risparmio privato che per eva sione fiscale, e nonostante questo il governo Meloni-Salvini pensa di premiare chi paga meno tasse (flat tax, contanti a go-go, riduzione d’imposte, condoni). Altissima è la spesa per le pensioni, il doppio del la media Ocse. La giustizia è lenta o non funziona; la burocrazia è ap pesantita e frenata da leggi e rego lamenti; la criminalità organizza ta allunga i tentacoli sulle attività economiche e finanziarie allonta nando gli investitori stranieri.
Sette-otto italiani su dieci denun ciano al fisco una casa di proprietà, a volte più di una, ma su questa pa gano meno tasse di altri, per esem pio la metà dei francesi, e non solo perché la prima casa è esentasse, ma per via dei valori catastali spesso ir risori pure per appartamenti ampi e costosi nel centro storico delle città.
Non basta. Il Pnrr, Piano Marshall degli anni Duemila, ha concesso all’Italia più soldi che a tutti gli altri, 122 miliardi e mezzo in pre stito più 69 a fondo perduto. Ma in cambio Bruxelles ha chiesto di approvare finalmente un pacchet to di riforme utili a svecchiare, innovare, migliorare un sistema per molti versi bloccato. Eppure, i primi messaggi del nuovo governo sono andati in direzione ostinata e contraria: al suo esordio, Meloni ha cassato la norma che apriva la con correnza tra taxi, cincischiato sulle concessioni balneari, dimenticato la revisione del catasto, rimandato la riforma della giustizia firmata da Marta Cartabia.
Siete sempre gli stessi, commenta l’implacabile cugino. Ora, per cari tà, si può anche arrivare alla conclu sione che ci sta bene così, che questo è il migliore dei mondi e che proprio quelli che gli altri giudicano limiti e difetti hanno garantito alla mag gior parte degli italiani la migliore vita possibile. E vabbè, però almeno non dovremmo far finta di non ca pire perché in Europa, parafrasando Luca Ricolfi, «siamo antipatici».



L’idillio è stato (molto) breve. Diciotto giorni precisi sono intercorsi tra il primo incon tro Meloni-Macron a Roma, il 23 ottobre, e la prima crisi diplomatica tra i due Paesi, il 10 novembre, conse guenza del rifiuto italiano di concedere l’autorizzazione allo sbarco dei 234 mi grantiabordodellaOceanViking.L’im barcazione della ong Sos Méditerranée è finita nel porto di Tolone, in Francia, suscitando l’ira del governo francese. Le misure di ritorsione sono state an nunciate con effetto immediato. Per cominciare, la sospensione dell’accor do firmato a giugno scorso, che preve de l’accoglienza da parte della Francia di3.500migrantiprovenientidall’Italia. Maanchel’invioimmediatodi500poli ziotti al confine italo-francese. La Fran cia ha inoltre chiesto sanzioni da parte degli altri Paesi europei.
Come spiegare una risposta così ca tegorica? La durezza della reazione di mostra il nervosismo dell’esecutivo francese: l’episodio non può ripetersi una seconda volta. Il rischio politico è troppo importante. Di sicuro, non è una novità: a giugno 2018, Emmanuel Macron aveva rifiutato di far accosta re l’Aquarius a Marsiglia. «Avere uma nità non implica necessariamente far si guidare dall’empatia. Se avessi se guito questa strada, non avrei fatto al tro che rinforzare gli estremismi xenofobi», aveva dichiarato l’inquilino dell’Eliseo. Quattro anni più tardi, i consiglieri del presidente giustificano il cambiamento di rotta sulla base del la «dimensione umanitaria» e dei nu merosi minorenni a bordo, ma senza tardare a sottolineare il carattere ecce zionale dell’accoglienza. Sono cinque anni che Emmanuel Ma
cron gestisce con difficoltà il tema dell’immigrazione, sottoposto a una doppia pressione. Da un lato, la sinistra che lo accusa di applicare una politica disumana nei confronti dei migranti, in particolare a seguito della promulga zione, nel 2018, di un’ennesima legge restrittiva sull’immigrazione (aumento della durata della detenzione ammini strativa, riduzione dei termini per pre sentare una domanda di asilo, ecc.). Dall’altro, la destra e l’estrema destra di Marine Le Pen che si sono specializzate nel denunciare l’impotenza del suo go verno nell’imporre una riduzione del numero di clandestini presenti sul ter ritorio. In equilibrio tra le due fazioni, Macron naviga con difficoltà su un cri nalestrettoinvocandoagranvoce«fer mezza» e «umanità».
A Parigi, la polemica è subito diventa ta nazionale. «Oggi il nostro Paese ha ceduto attraverso la voce del suo diri gente», ha dichiarato Marine Le Pen, anticipando una lunga serie di altre navi. Alcune affermazioni sono più difficili e sorprendenti di altre… L’at tacco più feroce è venuto da Gérard Collomb, l’ex ministro dell’Interno e
mentore di Macron, ormai in rotta di collisione con il presidente. «Acco gliendo l’Ocean Viking, si apre una breccia», ha allertato Collomb che ve de nel gesto del presidente «una svolta pericolosa nella gestione della politica migratoria del Paese».
EseEmmanuelMacron, allacostante ricerca del consenso, avesse voluto controbilanciare il suo incontro con Giorgia Meloni? A Parigi, il colloquio discreto è stato molto criticato. Ma cron è stato, infatti, il primo capo di Stato europeo a incontrare la leader di Fratelli d’Italia. «Una banalizzazione senza confini dell’estrema destra», ha detto il capo dei socialisti Olivier Faure. Argomenti, questi, spazzati via dai membri della maggioranza. «La tra dizione francese è una tradizione di accoglienza. C’è il diritto, ma c’è an che quello che si deve fare in quanto esseri umani», ha dichiarato la presi dente dell’Assemblea nazionale, Yaël Braun-Pivet. A volte, può anche suc cedere che l’interesse politico incontri il dovere di umanità.

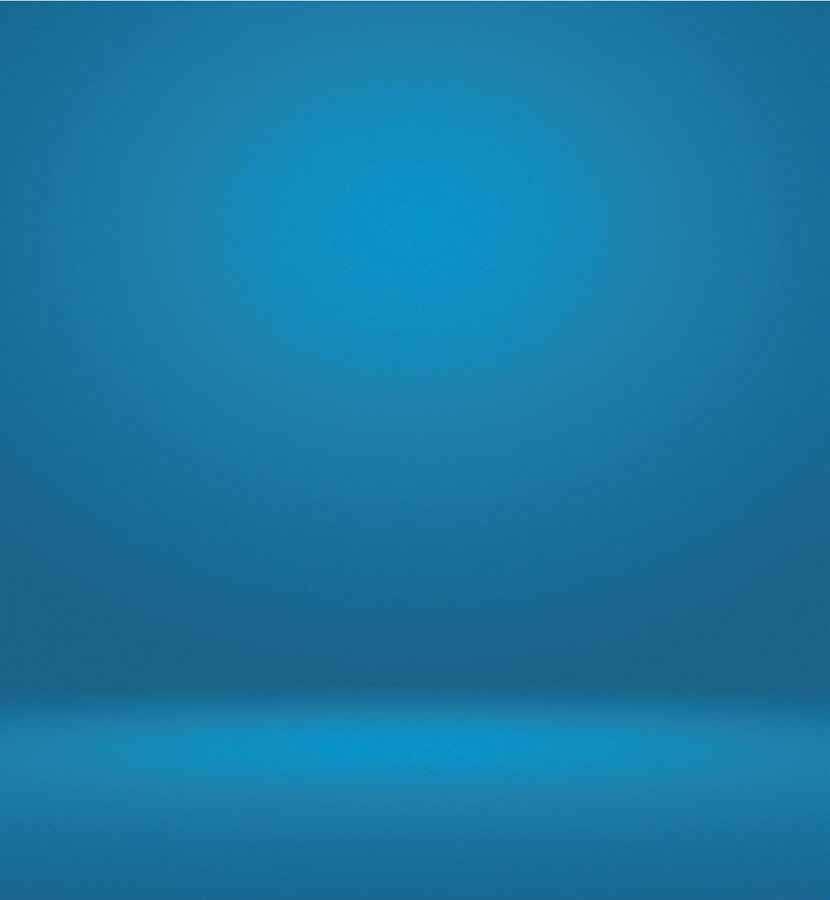
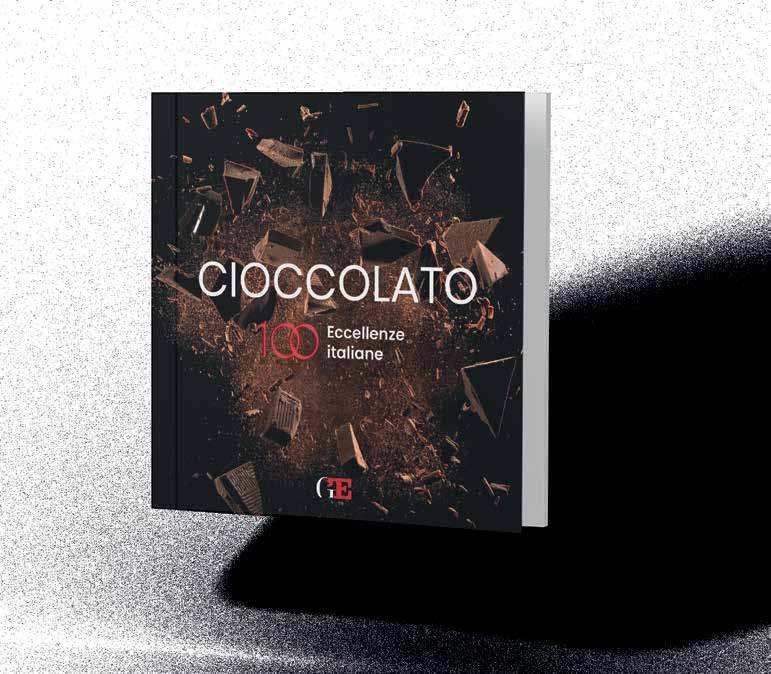
governi storti e corti fanno male. È un effetto indesiderato della demo crazia italiana, direte. Però è un ef fetto indesiderato che si ripete con masochistica (e chissà, desiderata) frequenza. Ecco qui un effetto inde siderato di proporzioni esagerate. Il 24 dicembre 2024, in diretta mondiale, a di spetto di fusi orari e fasi lunari, papa Fran cesco spalancherà la Porta Santa di San Pie tro sul Giubileo 2025 per chiamare alla re denzione dei peccati circa 1,4 miliardi di cattolici. Quanti cantieri di piazze, strade e palazzi su 135 sono partiti e quanti inter venti per il “decoro del patrimonio cultura le” su 335 sono in atto? Ok, facile: zero. Ep
Papa Francesco alla Porta Santa all’apertura del Giubileo straordinario della Misericordia nel 2015
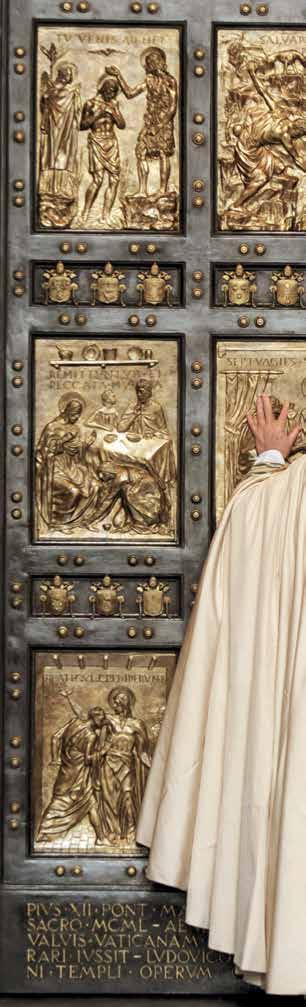
pure il Giubileo in formato ordinario - che si tiene ogni quarto di secolo - non è un evento imprevisto. Un margine per organizzarsi c’era, margine addentato, rosicchiato e infi ne spolpato dalle tipiche esitazioni dei ca duchi governi italiani. Giorgia Meloni guida l’esecutivo numero 68 dal 1948. In cassa ci sono circa 2 miliardi di euro da spendere per il Giubileo entro il 2025 più altri 8,2 mi liardi per la mobilità e il turismo di Roma acclusi al piano nazionale di ripresa e resi lienza (Pnrr) che scade nel 2026. Com’è po tuto succedere.

Il 3 novembre 2020, fra il ponte dei santi e la festa delle forze armate, con un inedito anticipo, quasi fastidioso, il presidente Giu seppe Conte convocò un incontro per il Giubileo 2025 con Nicola Zingaretti, il go vernatore del Lazio e monsignor Rino Fisi chella, il delegato vaticano. La sindaca Vir ginia Raggi, esclusa, protestò vibratamente. Nessuna comunicazione particolare, era un modo per avviare il percorso e fissare agen da e intenzioni. Ci si rivede. Fammi sapere. I soldi li mettiamo con la legge di Bilancio. La prossima volta meglio da me.
A gennaio il secondo governo di Conte era già barcollante. Il 13 febbraio 2021 Ma rio Draghi giurò al Quirinale. Come eredità di Conte, Draghi si ritrovò per il Giubileo un cosiddetto “tavolo istituzionale” introdotto proprio con la legge di Bilancio assieme a un paio di milioni di euro. Attorno al “tavolo istituzionale”, capeggiato ovviamente dal presidente del Consiglio, si accomodano i ministri di Economia, Trasporti, Esteri, In terno, Cultura, Turismo, il sindaco di Roma, il governatore del Lazio, due deputati e due senatori nominati dai presidenti di Camera e Senato. I componenti parlamentari erano Francesco Silvestri (5S) e Marianna Madia (Pd) per la Camera e Isabella Rauti (Fdi) e Alberto Bagnai (Lega). Siccome il legno per rafforzare la partecipazione democratica non manca mai, i deputati e i senatori invi tati al tavolo con il governo Draghi - la maggioranza era più larga e varia rispetto a Conte – sono diventati in totale sei con l’onorevole Annagrazia Calabria (Fi) e la senatrice Annamaria Pa rente (Iv).
Il tavolo istituzionale di Conte era forgiato per

stabilire come e dove spendere il denaro e monitorare - «aggiornare e rimodulare», precisa la norma - i progetti su base seme strale. Conte non ebbe il tempo di sedersi. Draghi l’ha inaugurato il 15 luglio 2021. Il sottosegretario Roberto Garofoli è stato pa recchio attento all’argomento. Le stime di crescita nazionale in quel periodo erano sempre ritoccate al rialzo. Il governo brilla va col sostegno della gente e della sorte. A qualsiasi esecutivo, al più secolarizzato co me al più conservatore, fa piacere farsi pia cere dal Vaticano. C’era una legge di Bilan cio da riempire con tanti soldi. Quella di Conte era limitata all’architettura politica. Le nozze di Cana per Draghi si sono rivelate una banalità. Ha stanziato 1,335 miliardi di euro per pianificare e realizzare le opere at tinenti al Giubileo e 110 milioni per gestire con la Santa Sede l’accoglienza dei pellegri ni (si stimano arrivi a Roma attorno ai 22 milioni, aggiuntivi ai 20 milioni di un anno medio non pandemico).
A differenza del Giubileo 2000, quello di Francesco Rutelli sindaco e di tre governi di centrosinistra da Romano Prodi a Massi mo D’Alema sino a Giuliano Amato, Draghi ha preferito affidare le “dotazioni finanzia rie” e perciò le funzioni di stazione appal tante e soggetto pagatore e vigilante non a un’agenzia comunale, ma a una società di scopo interamente controllata dal ministe ro dell’Economia denominata “Giubileo 2025”. Un espediente per proteggere il Giu bileo (e il denaro pubblico) dalle contese politiche, ma comunque il “programma dettagliato” e la relativa burocrazia è attri buita al commissario straordinario e cioè al sindaco Roberto Gualtieri.

Affianco al tavolo eccessivamente riflessi vo di Conte, il governo Draghi ha costruito una cabina di “coordinamento” per la «veri fica semestrale del grado di attuazione degli interventi» e per «assegnare poteri surroga tori in caso di inerzia». È la cabina per le
Matteo Del Fante, presidente della società Giubileo 2025. Sopra: il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

emergenze e vi possono accedere il governo, la società Giubileo 2025, la regione Lazio, il comune di Roma, il commissario straordi nario, il delegato vaticano.
Un successivo decreto ha inserito, per il ministero del Turismo oggi di Daniela San tanché, un altro capitolo di spesa definito “caput mundi”. Con un misto di fondi, ad aprile, il governo ha reperito 500 milioni di euro per «la rigenerazione del patrimonio culturale romano», che il comune di Gual tieri ha convertito in una lista di 335 lavori per decine di siti archeologici e poi parchi, giardini, palazzi, fontane e ville storiche.

Un ulteriore decreto a metà giugno ha of ferto l’ultima spinta per il lancio. All’articolo 1 si «recano disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di valuta zione e di verifica». La società Giubileo 2025, amministratore delegato Marco San giorgio (ex di Redo sgr e di Cassa Depositi e Prestiti), presidente Matteo Del Fante (ad di Poste Italiane), risulta formalmente attiva dal 15 luglio 2022 e da quel momento è più o meno pronta a muovere il conto della Teso riera dello Stato che custodisce i circa 1,5 miliardi di euro.
Il 20 luglio 2022 il governo Draghi non ha
ottenuto la fiducia. Il presidente della Re pubblica ha sciolto le Camere. Il 1° settem bre, per la terza volta, a tre settimane del voto, Draghi ha riunito a Palazzo Chigi il “tavolo istituzionale” e il 9 settembre il sot tosegretario Garofoli ha inviato lo schema degli interventi e delle opere per il Giubileo ai presidenti di Camera e Senato per il pare re delle commissioni competenti. Si tratta va di un documento diviso in cinque «am biti tematici»: tanta manutenzione, ferma te metropolitane e ferroviarie, acquisto di treni, percorsi ciclabili, parcheggi interrati, illuminazione del Grande raccordo anula re, sottovia a Porta Pia, cammini per pelle grini, pulizia e sponde del fiume Tevere, deposito tramviario a Porta Maggiore, rifa cimento di piazze (per esempio quella dei Cinquecento di fronte a Termini e la spia nata di San Giovanni). Cose che non stra volgono il volto urbano di Roma come av venne nel 2000, ma che possono darle una ripulita, una sana sciacquata. Per procede re, sbloccando sia la società Giubileo 2025 che i 500 milioni del ministero del Turismo, però c’era bisogno di un decreto del presi dente del Consiglio dei ministri (un dpcm) che contiene il “programma dettagliato”
Roma, Piazza San Pietro durante una cerimonia di canonizzazione. A destra: monsignor Rino Fisichella, delegato vaticano per il Giubileo del 2025


(cantiere e importi) preparato dal sindaco/ commissario Gualtieri e vagliato dal mini stero dell’Economia. La campagna eletto rale ha indotto alla prudenza, le trattative per il governo alla ibernazione.
Il 22 ottobre Meloni ha ricevuto il testi mone (e la campanella) da Draghi. Ormai è dicembre e per il Giubileo non c’è neanche lo schizzo a matita per immaginare, non capire, come scippare il Tevere all’incuria con una massiccia dose di «parchi pubblici e oasi naturalistiche». Soltanto il 10 no vembre gli uffici del Tesoro e la Ragioneria Generale hanno ricevuto il “programma dettagliato” di Gualtieri. Dopo l’esame dei tecnici, tocca alla politica col ministro Giancarlo Giorgetti e la premier Meloni che dovrà firmare il dpcm. Questioni di giorni, certo, con ciascun giorno che incupisce chiunque si avvicini al Giubileo: è la solita corsa disperata all’italiana con il piombo nelle scarpe, la solita scommessa in sospe so tra fallimento e miracolo. Per tacere del tripudio di cantieri da 10 miliardi di euro che attende i romani con il Giubileo e il Pn rr fino al 2027. Oltre alla Porta Santa, ci vor rà una santa pazienza.
L’inchiesta “Shadow Diplomats”, pubblicata in queste pagine, ha unito 160 giornalisti di 61 testate di 46 nazioni, tra cui L’Espresso in esclusiva per l’Italia, coordinati dal consorzio Icij e dalla fondazione ProPublica. Illustrazioni di Matt Rota
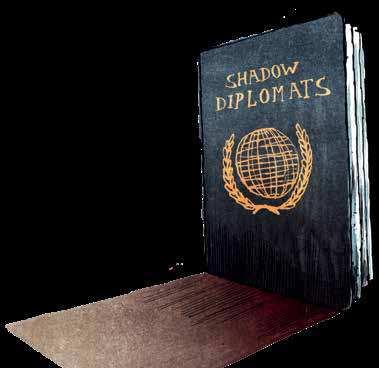


l 26 novembre 2019 la Guardia di Finanza si pre senta negli uffici a Firenze di Marco Carrai, im prenditore e uomo di fiducia dell'ex premier Matteo Renzi. I militari mostrano un mandato di perquisizione firmato dai pm Luca Turco e Antonino Nastasi, che indagano sui finanzia menti ricevuti dalla fondazione Open, di cui Carrai è uno dei dirigenti. La perquisizione però è parziale: i magistra ti riconoscono che una parte dell'immobile è inviolabile. A delimitarla è lo stesso Carrai, che detta le sue indicazio ni nel verbale dei finanzieri: «L'anticamera e la stanza adiacente, con funzione di uffici consolari, sono stati esclusi dall'attività di polizia giudiziaria». Poter decidere cosa può essere perquisito e sequestrato dalla magistra tura, e quali stanze e documenti devono invece restare segreti, è il sogno di ogni indagato.
Carrai ha beneficiato di questo privilegio legale perché è
il console onorario di Israele a Firenze. Riveste questa ca rica dal 10 settembre 2019, data dell'accreditamento (exe quatur) del ministero degli Esteri italiano. Quel giorno l'ambasciatore israeliano a Roma, Dror Eydar, annuncia via Internet che Carrai è il primo a rivestire quel ruolo a Firenze, con competenze su tre regioni: Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Il tempismo della nomina è note vole: appena nove giorni dopo, il 19 settembre, l'agenzia Ansa informa che Alberto Bianchi, il presidente della Fondazione Open, si è visto perquisire, a sorpresa, la casa e gli uffici. Due mesi dopo, quando tocca a Carrai, è ormai diventato un con sole, per cui è protetto dall'immuni tà diplomatica. E la Finanza si deve fermare.



Nel mondo esistono migliaia di consoli onorari, diverse centinaia solo in Italia. Non sono ambasciatori o diplo matici pubblici. Sono privati, ma rappresentano uno Sta to all'estero. Quindi godono di una forma minore d'im munità diplomatica: non possono essere perquisiti o in tercettati per tutte le attività, non prefissate dai trattati, di possibile interesse statale. Uno scudo legale che ha fini to per attirare molti personaggi spregiudicati e perfino criminali. Questa inchiesta giornalistica inter nazionale, chiamata Shadow Diplo mats (diplomatici-ombra), ha iden tificato, per la prima volta, più di 500 consoli onorari che sono stati accusati pubblicamente di aver vio lato la legge o gestito affari contro versi per interessi privati. Molti
 Paolo Biondani Giornalista
Leo Sisti Giornalista
Paolo Biondani Giornalista
Leo Sisti Giornalista
risultano tuttora in carica. L'inchiesta ha unito più di 160 giornalisti di 46 nazio ni, tra cui L'Espresso in esclusiva per l'Ita lia, coordinati dall'International Consor tium of Investigative Journalists (Icij) e dalla fondazione indipendente ProPubli ca. Nell'elenco degli oltre 500 casi docu mentati di cariche problematiche compa iono politici e imprenditori condannati per corruzione, tesorieri di organizzazio ni terroristiche, riciclatori di capitali ma fiosi, spie di regimi autoritari, falsari, truf fatori, trafficanti di cocaina e armi.
Carrai è entrato nella lista internaziona le perché è indagato e il suo ruolo ha in fluenzato l'istruttoria. I giudici decideran no nelle prossime settimane se dovrà esse re processato, con l'ex premier Renzi e al tri, per il reato di finanziamenti illeciti. L'indagine di Firenze ha accertato che la fondazione Open, tra il 2014 e il 2018, ha in cassato oltre 3,5 milioni di euro da diverse aziende private, senza dichiararli come contributi politici. Renzi si proclama inno cente, anzi perseguitato, e tutte le difese sostengono che la fondazione non è un partito, quindi non ha obblighi di trasparenza. A questo verdetto è appesa la sorte di molte altre indagini sui soldi ai partiti, in un quadro giuridico incerto, che si può riassu mere in un solo quesito: per sfuggire alla storica legge che fu alla base di Tangentopoli, quella che impone di comuni care e registrare i finanziamenti ai politici, basta intestare una fondazione agli amici?
L’Espresso ha fatto pervenire a Carrai molte domande sul suo ruolo di console onorario: quali personalità hanno
parlamentare di Fratelli d'Italia eletto nel 2022 in Piemon te, la regione di Guido Crosetto, l’attuale ministro della Difesa. Alla Camera, Comba è stato inserito proprio nella commissione Difesa, ruolo delicatissimo in tempi di guer ra. Anche perché lui non è mai stato un sostenitore della Nato e tantomeno dell'Ucraina. Torinese, 56 anni, laurea to in Giurisprudenza, imprenditore nel settore delle auto, è stato nominato console onorario della Bielorussia già nel 2004 e ha continuato a ricoprire quella carica fino a pochi mesi fa, con una sola pausa per «sopraggiunta incompatibilità», come ha spiegato lui stesso, riferendosi al periodo in cui era consigliere re gionale in Piemonte.
favorito la sua nomina, cosa ha fatto in questi anni per il governo di Tel Aviv, che interessi ha in quella nazione, qua li affari ha gestito con i suoi soci israeliani come Jonathan Pacifici. L'imprenditore però ha preferito, diplomatica mente, non rispondere.
Tra gli oltre 500 «diplomatici-ombra» ci sono anche consoli non indagati, ma in situazioni di conflitto d'inte ressi: ad esempio, politici che rappresentano regimi consi derati nemici dai loro stessi governi. Fabrizio Comba è un
Caduta quella giunta a guida leghista, Com ba torna a fare l'imprenditore, proprietario di una carrozzeria e una concessionaria d'auto. E dal 2016 ricomincia anche a fare il console onorario per la Bielorussia, promettendo di rafforzare i rapporti economici con l'Italia, specialmente nella chimica, agricoltura, cel lulosa, legno, pelle e, naturalmente, automobili. Un compi to non facile, perché da molti anni l'Unione Europea sta sanzionando la Bielorussia per violazione dei diritti uma ni, repressione sociale, falsificazione dei risultati elettora li. Nel febbraio scorso, quando il presidente-dittatore Alexandr Lukashenko si è schierato al fianco di Putin nel la guerra in Ucraina, le sanzioni si sono aggravate. Comba però si è dimesso dalla carica di console solo nella tarda estate di quest'anno, in piena campagna elettorale, dopo

Dall’alto a sinistra, in senso orario: il manager Carlo Sama, l’onorevole Fabrizio Comba, l’imprenditore Marco Carrai assieme all’ex premier Matteo Renzi. Sono tutti consoli onorari: sono privati, ma hanno poteri di rappresentanza di Stati esteri e quindi godono di un’immunità diplomatica garantita dai trattati


essersi visto rinfacciare le sue richieste, ripetute più volte fin dal 2014, di revocare le sanzioni contro la Russia, per ché danneggiano anche aziende italiane. L'onorevole Comba non ha risposto a nessuna domanda de L'Espresso.

Un altro diplomatico privato in bilico tra Est e Ovest è Antonio Fallico. È l'italiano più potente di Mosca. Presi dente di Banca Intesa Russia, gestisce da decenni affari e relazioni politiche con l'ex Blocco sovietico. E fin dal 2008 è console onorario della Federazione Russa a Verona. Ha difeso pubblicamente il regime di Vladimir Putin anche alla vigilia della guerra contro l'Ucraina. Il 10 febbraio scorso, in un convegno a Mosca, ha dichiarato che «la Russia in tutta la sua storia non ha mai attaccato nessu no», chiedendo se l'allarme americano non fosse «un nuo vo pretesto per l'allargamento della Nato ad Est». Una tesi rilanciata in un'intervista del 15 febbraio, nove giorni pri ma della guerra.
Fallico, classe 1945, ha conosciuto tutti i leader di Mosca degli ultimi 50 anni, da Breznev ad Andropov, da Gorba ciov a Eltsin, fino a Putin e Medvedev. Originario di Bron te, in Sicilia, laureato in Lettere a Catania, si è trasferito come insegnante a Verona, dove negli anni '70 si è iscritto al Pci. Dal Veneto, con la tessera comunista, è diventato consulente della Banca Cattolica, poi confluita nel gruppo Intesa. Con Putin ha un rapporto molto stretto. Lo cono sce da quando era vicesindaco di San Pietroburgo. All'i naugurazione della sede di Banca Intesa a Mosca, Putin è intervenuto di persona, con un altro ospite eccellente: Sil vio Berlusconi. A Verona, Fallico è presidente dell'«Asso
ciazione conoscere Eurasia», fondata nel 2007 per «svilup pare le relazioni tra Italia, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan», che organizza ogni anno un fo rum con i big del gas e petrolio. L'ultima edizione, la quin dicesima, si è trasferita da Verona a Baku, in Azerbaijan, perché le sanzioni hanno tenuto lontano dall'Italia gli oli garchi invitati da Fallico, come Igor Sechin, il numero uno della Rosneft.
L'Espresso e il consorzio Icij hanno inviato 15 domande a Fallico, per chiarire la sua attività di console; gli accor di tra Banca Intesa e Mir Capital, una finanziaria di GazpromBank di cui era presidente; i negoziati tra Berlu sconi e Putin, tra il 2002 e 2006, per modificare i contrat ti dell'Eni con Gazprom, che hanno raddoppiato la di pendenza italiana dal gas russo. Fallico non ha risposto. Non ha voluto correggere neppure le sue dichiarazioni sull'Ucraina.

La carica diplomatica offre una rete di supporto politi co internazionale anche a diversi imprenditori italiani. Roberto Gotti è un industriale bresciano che dal 2018 è console onorario della Bielorussia. La sua azienda, Di smas Trading, ha l'esclusiva per l'Italia nel commercio dei prodotti in acciaio fabbricati dall'industria statale bielorussa Bmz, che nel 2021 gli ha garantito ricavi per oltre 34 milioni e utili netti per 412 mila euro. Gotti è an che un appassionato di scherma, a cui ha dedicato un museo e una scuola a Botticino, dove vive.
La Bmz, in Bielorussia, è accusata di repressione delle proteste operaie. Tra il 2020 e il 2021, nei mesi delle
rivolte di massa contro il regime, lo sciopero dei lavo ratori dell'acciaio è stato stroncato con l'arresto dei loro rappresentanti sindacali, condannati a tre anni di galera. Molti operai sono stati licenziati, altri sono scappati all'estero.
Gotti ha risposto a tutte le domande inviate da L'Espres so e da altre testate europee. «Ho iniziato a lavorare con la Bielorussia 22 anni fa, sono i rapporti commerciali che han no spinto la diplomazia, non la politica, a chiedermi di di ventare console onorario. Sono un europeista convinto, la guerra in Ucraina è una tragedia per tutti». In una serie di mail dell'estate 2022, ottenute dal quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, l'ambasciatore bielorusso a Roma lo definisce «il più attivo console onorario in Italia». E afferma che Gotti «non ha interrotto i rapporti economici» neppure dopo le sanzioni di guerra, anzi si sarebbe offerto di «svi lupparli ulteriormente». L'imprenditore però smentisce di aver mai aggirato le sanzioni: «Molti nostri contatti sono svaniti già nella prima notte di guerra in Ucraina. Dal 4 giugno, con le sanzioni sull'acciaio bielorusso, la mia azienda ha dovuto riconvertirsi totalmente: da allora compriamo da altri Stati. Penso che la mail dell'ambasciatore si riferisca ai pochissimi prodotti bielorussi esclusi dalle sanzioni». Gotti poi conferma, come si ricava dalle mail, di aver chiesto alla Bielorussia, trami te l'ambasciatore, di votare per un suo ami co italiano, Giorgio Scarso, per la carica di vicepresidente della Federazione europea di scherma, no mina in effetti ottenuta il primo ottobre scorso.
L'azienda del console bresciano è sensibile agli equilibri strategici. Gotti ha avuto per anni tra i soci un'azienda au striaca controllata da ex manager bielorussi dell'acciaio: la loro quota è stata venduta a un gruppo italiano il 24 feb braio 2022. Il giorno dell'invasione russa dell'Ucraina. Dif ficile non pensare a una mossa in extremis per sfuggire alle sanzioni di guerra.
Altri diplomatici privati hanno forti legami con la politi ca. Il professor Giacomo Gargano è considerato un fedelis simo dell'ex governatore siciliano Nello Musumeci, oggi ministro. Ed è il console onorario del Sudafrica a Catania. Gargano, 43 anni, avvocato e docente di Diritto ammini strativo all'università Kore di Enna, dal 2018 siede su una poltrona chiave per l'economia siciliana: è presidente dell'Irfis, la banca regionale che gestisce gli aiuti pubblici alle imprese e i fondi per il Covid-19. E per il Sudafrica che fa? Il console non ha risposto.

Tra gli imprenditori italiani che rappresentano nazioni straniere, il più conosciuto è Carlo Sama, ex azionista e amministratore del colosso Ferruzzi-Montedison, travol to dalle indagini di Mani pulite. Al processo Enimont, fu tra i primi a confessare la cosiddetta «madre di tutte le tangenti» e ha limitato la condanna definitiva a tre anni, evitando il carcere. Nel 2018 ha ottenuto la riabilitazione giudiziaria, che cancella tutti gli effetti della pena. In que sti anni ha trasferito le attività all'estero: nel Principato di Monaco ha creato la holding, FerSam, che rimanda ai cognomi di lui e della moglie, Alessandra Ferruzzi, figlia di Serafino, il fondatore dell'impero di famiglia. Il tesoro del gruppo oggi è soprattutto in Sudamerica: enormi te nute agricole, proprietà immobiliari, investimenti finan ziari. Sama è anche console onorario del Paraguay pro prio a Montecarlo.
L’Espresso gli ha chiesto chi gli ha offerto quel ruolo di plomatico nel paradiso fiscale europeo. Carlo Sama ha ri sposto in modo esauriente: «Sono stato nominato dal pre sidente Horacio Cartes nel novembre 2016. Amo il Para guay, un paese aperto al mercato dei cereali, che ha assun to una rilevanza mondiale per la soia. La nostra azienda agricola è una delle più avanzate, nell'Alto Paranà, la zona più fertile. Viaggiando spesso per lavoro, ho conosciuto il ministro degli Esteri, Eladio Loizaga. È stato lui a propor
mi Monaco». Sama precisa che «la procedura è iniziata nel 2015» e la nomina è stata riconfermata «dai successivi mi nistri, Castiglioni, Acevedo, Arriola, oggi tutti membri del governo dell’attuale presidente Mario Abdo Benitez». E in cosa consiste la sua attività di console? «Promuovere il Pa ese sotto il profilo delle potenzialità economiche di svilup po». La carica diplomatica ha mai favorito le sue aziende? La risposta di Sama è netta: «Lo escludo».

Non può dirsi ancora archi viato il procedimento che porta al rinnovo del Csm visto che, dopo l’elezione della componente togata secondo il nuovo sistema elettorale, è stato convocato per il prossimo 13 dicem bre il Parlamento in seduta comune per l’elezione dei membri laici che dovrebbe avvenire secondo proce dure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere ma con un inevitabile accor do tra maggioranza ed opposizione in considerazione del quorum mini mo richiesto.
Ed è probabilmente in vista di que sta elezione che divampa il conflitto tra le correnti della magistratura che tutt’altro che essere state mitigate nella loro forza risultano essere net tamente fortificate da un sistema elettorale che non ha affatto rag giunto l’obiettivo del loro supera mento. L’esito delle elezioni ha visto infatti una netta contrapposizione tra la corrente moderata e quella progressista secondo un esito abba stanza scontato, con un deludente effetto del sistema proporzionale che ha consentito solo in minima parte l’elezione di soggetti non ap partenenti ad alcuna corrente. Oltre le righe si deve però leggere con fa vore il risultato elettorale di magi strati come Stanislao De Matteis, candidato nel difficile collegio unico di legittimità, il quale - scegliendo di candidarsi come indipendente per
superare gli steccati ideologici delle correnti - ha raccolto un importante numero di voti coagulando intorno a sé un gruppo eterogeneo di magi strati che si riconoscono in un mo dello di consigliere non necessaria mente appartenente ad un gruppo prestabilito.
Resta però sullo sfondo un generale insuccesso del nuovo sistema eletto rale con sostanziale pareggio tra le correnti che attende di essere com pletato con la nomina dei membri laici che faranno da vero e proprio ago della bilancia. Intanto iniziano le prime scherma glie. Dai comunicati stampa degli esponenti delle correnti trasuda una chiara ed evidente presa di posizio ne politica che non dovrebbe certa mente caratterizzare l’attività dei magistrati, se non nei limiti della in terpretazione delle leggi che non può andare oltre il principio della separazione dei poteri.
E invece si assiste ad un dibattito sui primi atti del governo di centrode stra con toni accesi quali la prean nunciata necessità di una stagione di resistenza costituzionale da una parte e dall’altra la stigmatizzazione a non diventare attori della scena politica, culminato poi con un invito ad una pubblica tenzone sul modo di declinare la giurisdizione dal pun to di vista della necessaria difesa dei diritti civili ed umani.
C’è però da domandarsi cosa c’è ol tre le correnti e la loro rumorosa de
Solo seguendo questa strada si potrà dire di aver effettivamente superato il problema costante della commistione tra poteri
riva che sempre meno rappresenta no quella parte silenziosa dei magi strati che, lavorando alacremente, oggi fanno i conti con il sistema dei controlli dei capi degli uffici nell’ot tica del perseguimento dei sempre più ambiziosi ma al contempo diffi cili obiettivi di riduzione dei tempi della giustizia in chiave Pnrr.
Io credo che, sia pure non volendo affatto rinnegare il ruolo che la ma gistratura è chiamata a svolgere co me un potere dello Stato che si fa attore nella società a difesa dei dirit ti fondamentali (si pensi alla giuri sprudenza pretoria degli anni 70 che ha contribuito e non poco alla emer sione del concetto di ambiente da tutelare anche in ottica di futuro del le nuove generazioni), in questo mo mento la magistratura debba andare oltre posizioni politiche o di parte e considerare i problemi che ha al suo interno, primo fra tutti quello di re cuperare la credibilità che sempre più è persa per colpa di pochi con conseguenze per tutti.
In questa ottica il Parlamento faccia le leggi che ritiene tenendo in debito conto i principi della nostra Carta fondamentale e la magistratura ri torni al suo ruolo di interprete della legge perché è forse solo seguendo tale strada che si potrà dire effettiva mente superato quel problema co stante della commistione tra politi ca e magistratura che interessa sem pre meno ai cittadini che a gran voce invocano una giustizia celere ed effi cace che solo così si fa difesa di dirit ti fondamentali che nella loro tutela esprimono il senso democratico del nostro Stato di diritto.
ntrambi i partiti si trovano ad un bivio. La questione è generazionale: Biden è anziano e lo è anche Trump. Io scommetto che nel 2024 il nuovo batterà il vecchio. In quale partito succederà, non è dato saperlo». All’indomani delle elezioni di metà mandato, lo stratega conservatore Scott Jennings, come tutti gli analisti, è già proiettato alla corsa per la Casa Bianca. «Trump e Biden hanno dominato la politica per molto tempo. I partiti ora vogliano candidare persone nuove, più giovani», ci spiega l’esperto che ha lavorato per il presidente George W. Bush ed è consulente di Mitch McConnell, leader Gop al Senato.

A seggi chiusi, il quadro che va abbozzandosi in vista delle prossime presidenziali, ha contorni confusi. Per la prima volta, democratici e repubblicani si trovano a fare i conti con complessità speculari: due leader ingombranti, che si preferirebbe non rican didare, pur con motivazioni diverse. Da un lato, Joe Biden. Sul secondo mandato di un presidente, solitamente i partiti si compat tano, eppure la sua possibile ricandidatura non entusiasma i vertici e neppure la base, nonostante sia il vincitore morale delle ul time elezioni. Gli gioca contro l’età - nel 2024 avrà 82 anni - e anche il basso indice di gradimento. Dall’altro, Donald Trump, settantaseienne, che aveva promesso di sfinire i suoi per le troppe vittorie e che invece ha inanellato una serie di scon fitte: le midterm del 2018, le presidenziali del 2020 e adesso i modesti risultati dei candidati che ha sostenuto l’8 no vembre. Il pronostico era quello di una “red wave”, un fiume in piena che avrebbe umiliato i progressisti. E invece, nono stante inflazione ed economia incerta, l’onda rossa «si è trasformata in un piccolo rivolo» ha sintetizzato sarcastica la speaker della Camera Nancy Pelosi. Tra gli sconfitti alcu
ni nomi pesanti, voluti e appoggiati proprio da Trump. Ad esempio, in Pennsylvania, Mehmet Oz, candidato al Sena to, e Doug Mastriano, in corsa per la carica di governatore; o in Arizona, dove “il suo” Blake Masters ha ceduto la pol trona al democratico Mark Kelly.
Seggi che sono costati il Senato ai repubblicani. La vitto ria in Nevada di Catherine Cortez Masto contro Adam La xalt ha ufficialmente consegnato ai democratici i 50 seggi necessari ad afferrare la maggioranza. Questo perché in
caso di parità - 50 e 50 - a contare è il voto della vicepresi dente Kamala Harris. E la forbice potrebbe allargarsi, se il ballottaggio del sei dicembre in Georgia confermerà il se natore democratico Raphael Warnock, pastore battista in corsa per il secondo mandato, sfidato dall’ex stella del fo otball Herschel Walker, pupillo di The Donald.

Alla Camera, invece, pochi dubbi sulla conquista repub blicana della maggioranza a spoglio concluso. Il margine, strettissimo. Tra i quadri del partito conservatore ci sono tensione e spaesamento. Come sempre accade all’in domani delle débâcle (o al meno delle non-vittorie) è tempo di dita puntate. La gestione di McConnell è in discussione, con il senatore Rick Scott deciso a sfidarne la leadership.vMa è l’ipotesi di un Trump ’24 a sbriciola-
re il Gop tra indefessi sostenitori, trumpiani barcollanti e detrattori pronti a scaricarlo. La retorica del tycoon, anco ra incentrata sulla falsa denuncia delle elezioni rubate nel 2020, piuttosto che sui temi cari al partito, ha iniziato a stancare. Come pure le tante inchieste in corso. Iniziano ad abbandonarlo anche media amici come Fox News e New York Post. La lista dei possibili sfidanti è già lunga: Glenn Youngkin, governatore della Virginia; Nikki Haley, ex am basciatrice delle Nazioni Unite; Mike Pompeo, ex direttore della CIA e Segretario di Stato; Tim Scott, senatore della Carolina del Sud; l’ex vicepresidente Mike Pence e l’ex go vernatore del New Jersey Chris Christie.

Ma soprattutto Ron DeSantis, governatore della Florida fresco di rielezione. «È quello con le migliori possibilità al momento - continua Scott Jennings - Ha vinto bene in uno Stato considerato competitivo per entrambi i partiti. È giovane, il suo stile piace, per certi versi è come Trump, in versione meno caotica». Gli occhi, ora, sono puntati sul convegno della Republican Jewish Coalition di Las Ve

gas, primo appuntamento post elettorale di spessore a cui tutti loro parteciperanno.
Mancano comunque due anni al voto. Quanto Trump e il trumpismo siano effettivamente fiaccati è da vedere. Trump, intanto, scommette ancora su se stesso. Martedì scorso l’annuncio della candidatura da Mar-a-Lago. «È un movimento - ripete - Non sarà la mia, ma la nostra campa gna». Guai a sottovalutare la capacità di ripresa del leader del mondo Maga, avverte tra gli altri il Washington Post che ricorda i momenti in cui, ingenuamente, nel 2016, lo si dava per spacciato: quando mise in dubbio l’eroismo in guerra del defunto senatore John McCain o, negli ultimi giorni della campagna, quando emersero le registrazioni di Access Hollywood in cui si vantava di aver palpeggiato donne.
Se nel quartier generale del Gop domina un clima di confusione, poco meglio va in casa democratica. Il presidente scioglierà a gennaio il riserbo su una eventuale ri candidatura. Nel frattempo, galvanizzato dell’esito delle urne, Biden è arrivato al G20 di Bali e all’incontro con il leader ci nese Xi Jinping in “posizione di forza”. «Con questo risultato elettorale - riflette la dem Capri Ca faro, ex senatrice statale dell’Ohio - si placheranno, alme no per ora, le voci che suggerivano un’uscita di scena». Il nodo da sciogliere però resta: confermare Biden, puntare su un candidato alternativo? Oppure aprire il campo delle primarie? In fondo, quest’ultimo approccio aveva per messo la levata dell’astro di Obama. Di certo nelle fila del partito, spiega, mancano personaggi carismatici pronti per l’arena. Tra i nomi in lizza, al momento, c’è quello del la vicepresidente Kamala Harris; del ministro dei traspor ti Pete Buttigieg; dei governatori Gavin Newsom, califor niano, e Gretchen Whitmer, del Michigan, appena rieletti. Il cielo è più sereno se si guarda in prospettiva, avverte

Cafaro. Le elezioni di midterm hanno iniettato linfa nuo va tra i progressisti: le prime governatrici lesbiche, il pri mo governatore nero in Maryland, il primo membro della generazione Z al Congresso. Sono loro il futuro del parti to, insieme alla già rodata squadra capitanata da Alexan dria Ocasio-Cortez.
In attesa delle politiche del 2024, però, ci sarà da porta re avanti l’agenda di governo, con lo scenario, che va con cretizzandosi, di un Congresso spaccato. Al sicuro saran no le nomine giudiziarie di Biden, la cui conferma è com petenza del Senato; ma alla Camera sarà difficile arginare la paralisi legislativa. Qui, i deputati Gop hanno già an nunciato commissioni di inchiesta, su Hunter Biden, fi glio del presidente, sul ritiro dall’Afghanistan, un processo di impeachment al presidente. A livello legislativo, due possibilità: fare muro contro muro, approvando leggi pro mosse dalla frangia più estrema o spingere pacchetti più moderati, accettabili anche per Biden, per dimostrare al Paese di saper governare.
Sul fronte economico, è il tetto di spesa a togliere il son no ai democratici. I repubblicani potrebbero minacciare di non votare nessun aumento del debito, se le loro richieste non venissero accontentate. «Un’eventualità che escludo, perché la maggioranza è troppo risicata», ci dice Dean Ba ker, economista e cofondatore del Center for Economic and Policy Research. Il vero problema per lui è l’eventualità di una recessione nel 2023. «Cosa che accadrà, se la Federal Reserve esagererà nell’aumentare i tassi. A quel punto, il modo migliore per uscirne sarà spendere. Ma sarà più diffi cile far passare il messaggio del presidente quando dirà: “Abbiamo bisogno di un pacchetto di 300 miliardi per ri
lanciare l’economia” e i repubblicani risponderanno “Non permetteremo più i vostri sprechi”. Purtroppo, in media la gente non capisce come funziona l’economia». Se il Gop dovesse bloccare qualsiasi stimolo, avverte Baker, si trat terrebbe del «rischio economico più grande derivato dai risultati delle elezioni, che potrebbe causare un periodo prolungato di crescita debole e alta disoccupazione, nel tentativo forse di ripetere il 2011. Ovvero, arrivare alle pre sidenziali con una economia debole». “Colpa” che ovvia mente ricadrebbe sul presidente e ridimensionerebbe le chance di rielezione. «Quella volta non funzionò, però, Obama rivinse. Speriamo ricordino la lezione».
I PROSSIMI DUE ANNI SARANNO COMUNQUE SEGNATI DAL RISCHIO DI PARALISI LEGISLATIVA CON CAMERA E SENATO GOVERNATI DA DUE MAGGIORANZEIl presidente degli Stati Uniti Joe Biden con la vicepresidente Kamala Harris




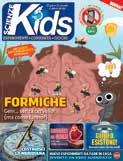
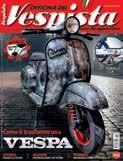
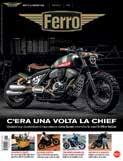










































Che la Storia dell’umanità sia giunta a un cro cevia fondamentale nessuno ha dubbi. Tra pandemia, guerra, cambiamenti climatici e le più gravi tensioni geopolitiche degli ulti mi settant’anni, il mondo di oggi è molto di verso da quello di soli tre anni fa. Su questo punto un’economista come la tedesca Isabella Weber e un esperto di nuove tecnologie come l’americano Alec Ross concordano. È sulla ricetta e sui cammini da intraprende re guardando avanti che le opinioni divergono. È tempo di confrontarsi. Motivo per cui Fondazione Feltrinelli e Re gione Toscana hanno dato vita a una tre giorni di dialoghi che si terrà alla Normale di Pisa e a Firenze tra il 23 e il 25 novembre su come i fondi del Pnrr potrebbero con tribuire a reimpostare il nostro sistema economico, con una rinnovata attenzione alle risorse naturali e alle disuguaglianze.
«L’Unione europea ha bisogno di un suo modello specifico per affrontare la doppia transizione ecologica e digitale», dice al telefono dall’Università di Bologna, dove insegna, Ross, ex consigliere per l’Innovazione di Hillary Clinton durante la sua permanenza al vertice della segre teria di Stato statunitense: «Deve mettere in campo una sua squadra con una sua strategia, smettendo di fare da arbitro tra americani e cinesi perché alla fine l’arbitro non vince mai». Tanto più che per Roma, Parigi e Berlino non vanno bene i modelli di sviluppo tecnologici creati da ragazzini californiani ora miliardari e nemmeno quel li messi a punto da uno Stato sempre più autoritario co me la Cina, dove ci sono oltre tre milioni di telecamere di sorveglianza. «Pechino vorrebbe sostituire i G20 e i G8 con i G0», sottolinea Ross nella settimana in cui i leader del G20 si sono incontrati a Bali per discutere dell’econo mia mondiale e delle conseguenze dell’aggressione russa contro l’Ucraina: «In un mondo senza alleanze tradizio
nali Pechino sarebbe libera di stringere gli accordi bilate rali che vuole e ottenere vantaggi». Lo sta già facendo con la Russia: gran parte di quello che Putin non riesce più a esportare verso Usa ed Europa prende la via della Cina con uno sconto di almeno il 20 per cento. E India e Paesi del Golfo seguono. «Fino a cinque anni fa in Italia si pensava che dovessimo stringere i rapporti con la Cina, se non copiare parti del suo modello di sviluppo», dice Ross: «Adesso devi essere uno sciocco per abbracciare un modello che è contrario a tutti i valori italiani, a partire dalla libertà. È chiaro che il modello cinese sia un model
lo bruttissimo».
Brutto o buono che sia il modello, secondo Weber, at tualmente consulente del governo tedesco per l’econo mia, le interdipendenze con esso costruite negli ultimi trent’anni dai Paesi europei non possono essere recise in modo frettoloso. «Stiamo vivendo un cam biamento totale dell’economia mondiale come non lo vedevamo da secoli e non è chiaro come affrontarlo, non ci sono ri sposte pronte. La cosa importante è agire con cautela», dice. Cautela (di sapore mer keliano) è lo slogan di questa economista sulla cresta dell’onda, esperta di Cina. In un momento in cui i cambiamenti climati ci, la pandemia e la guerra hanno scon

Da sinistra, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. Sotto, il porto di Amburgo, in Germania


volto le tradizionali catene di rifornimento servirebbe un’azione congiunta per ripristinarle, ma a causa di un’a cuita rivalità tra Usa e Cina la cooperazione internaziona le è sempre più difficile. Il recente tentativo di evitare una seconda guerra fredda con il dialogo di oltre tre ore tra Joe Biden e Xi Jinping a margine del G20 di Bali ha forse scon giurato una guerra nucleare in Ucraina, ma non l’eventua lità di un conflitto mortale per la salvaguardia dell’indi pendenza de facto dell’isola di Taiwan, che la Cina riven dica come suo territorio. In questa nuova era, gli intrecci economici sono divenuti funzionali alle ambizioni politiche. La crescita non è più un obiettivo in sé: è tornata a essere uno strumento dei fini politici delle grandi po tenze mondiali.
«È la situazione di un gatto che si mor de la coda», dice Weber: «È facile parlare di “decoupling”, di spezzare le linee di ri fornimento dalla Cina per non diventar ne oggetto di ricatto. Ci sono voluti de cenni per crearle. Forse abbiamo bisogno di più resilienza, di costruire uno stoccag gio europeo maggiore e di essere meno esposti. Ma il rischio di tagliare prematu ramente i legami con la Cina è quello di finire per dovere fare a meno degli attrez zi che ci servono per costruire quella resi lienza». Un esempio? «Nel costruire un’e conomia più verde abbiamo ancora biso gno dei prodotti cinesi: è difficile rico struire una catena di rifornimento mentre stiamo già ricostruendo un’economia na zionale più verde».
Molto più ottimista è invece Ross: «I fondi del Pnrr non saranno sufficienti ma sono comunque un’opportunità storica per cercare di arginare i cambiamenti cli matici e costruire un’economia circolare». Non solo. Per l’Europa sono l’opportunità per conquistare la leadership mondiale del green. Ne ha le competenze e la capaci tà innovativa. Ora deve metterci i soldi e orientare la propria politica al cambia mento». Ad esempio, gli Stati europei, Germania compresa, devono smetterla di guardare a Cina e Usa per l’auto elettrica: «Le soluzioni arrivano sempre dalle startup, è ora di investire in quelle europee che crea no le batterie di nuova generazione». Il maggior parados so è che l’80 per cento dei lavoratori di Silicon Valley sono europei. «Vanno in Usa perché trovano terreno fertile: fondi a parte, la ricerca universitaria non è considerata patrimonio esclusivamente statale, ma ha connessioni fortissime con il mondo dell’impresa. Non c’è quel muro tra ricerca e commercializzazione che c’è qui. Negli Usa come in Cina la ricerca universitaria è alla base dell’eco


nomia. Non a caso Google è nato a Stanford. E poi sia in Usa sia in Cina c’è una strategia politica che aiuta la nasci ta delle imprese». E questa ancora manca all’Europa. «La Germania in particolare è in una posizione diffici le», ribatte Weber: «Non abbiamo Google, non abbiamo Londra, non abbiamo le multinazionali dei servizi. Abbia mo Bosch e Siemens, aziende energivore». Un quarto dell’economia tedesca dipende dalla manifattura. E il 40 per cento di quella manifattura dipende dalla Cina. «La Cina diventerà la maggiore economia mondiale e per le nostre aziende sarà difficile restare leader globali e non stare in Cina. Certo, potrem mo riorientare le catene di rifornimento verso il Sud-Est asiatico ma il mercato ci nese dove lo troviamo?».
La risposta non è facile. Certo pesa la miopia tedesca nei confronti della Russia, l’incapacità della Germania di costruire in tempo un’infrastruttura verde così da non trovarsi oggi in recessione, con il rischio di trascinarsi dietro mezza Europa, a causa del ricatto del gas di Putin. Ma come non ripetere l’errore in futuro senza darsi la zappa sui piedi? «La soluzione deve passa re per la nazionalizzazione di alcune aziende di interesse pubblico, come han no fatto in Francia, nella costruzione di infrastrutture verdi che ci permettano di affrontare il cambiamento climatico», di ce Weber. E la tutela dei settori di interesse nazionale dalle mire dei Paesi “non così amici”? «Non è facile individuare i settori che debbano davvero essere messi al ripa ro dalle catene di rifornimento mondiali, ci stiamo lavorando». «Pigri! Gli europei sono stati pigri fino ad adesso!», esplode Ross: «L’Europa non ha una sua indipen denza energetica a causa della pigrizia della sua classe politica». Prendiamo l’Ita lia: «Dovrebbe avere un parco eolico in Abruzzo, uno solare nel cuore di Sicilia do ve tutto brucia e poi è circondata ovunque dall’acqua ma non ha fatto abbastanza in vestimenti ed è oggi più indietro del Ma rocco». E se gli Usa hanno risposto al neo-sovranismo ci nese con il “made in America”, ora gli europei dovrebbero avere più coraggio nel costruire una propria risposta, nel loro solo interesse, «come dice Emmanuel Macron». «Non occorre rovesciare la globalizzazione a 180 gradi ma dovete avere più capacità e meno dipendenza», conclude Ross. Una pausa. «Merkel (e le sue interdipendenze con Russia e Cina) è la leader più sopravvalutata della storia d’Europa. L’Europa oggi non può più permettersi di segui re quel modello tedesco».

Dopo quindici anni, e due brevi pause, Benjamin Ne tanyahu sarà di nuovo il premier d’Israele. Si potreb be pensare che non sia cambiato nulla rispetto alla variopinta coalizione che lohapreceduto,manonècosì.Ilfatto re decisivo non sarà il Likud di “Bibi”, nonostante sia il partito con più seggi nella Knesset (32), bensì le due figure d’ombra dell’estrema destra: Bezalel Smotrich con il “Partito Sionista Re ligioso” e Itamar Ben-Gvir col partito “Otzma Yehudit”, lett. Potere Ebraico. Questo “potere” raccoglie perlopiù i simpatizzanti del noto estremista sio nista Meir Kahane e del partito Kach, fondato nel 1971 e vietato in Israele nel 1994 da una legge anti-terrorismo.
La coalizione dei due estremisti si è piazzata al terzo posto (14 seggi), su bitodopoilLikudel’expartitodimag gioranza Yesh Atid (24) del premier Yair Lapid, un risultato che porterà un forte cambiamento nel Paese, una ra dicalizzazione estrema fino al fanati smo. La conseguenza di questa linea sarà un ritorno al passato per Israele, i palestinesi e tutto il Medio Oriente.

Netanyahu in questo schema non appare, per assurdo, né come il player più importante né come quello più pericoloso. È inebriato avendo soddi sfatto tutte le sue ambizioni, potrà “congelare” nuovamente il suo corpo so fascicolo giudiziario che lo vede indagato per corruzione e diverse malversazioni. Ma per quanto sia fur bo, esperto e importante per quelli che in Israele esclamano «o Ne tanyahu o nessuno», sarà per lui diffi cile bilanciare le crude realtà rappre sentate dai due veri vincitori, Smotri ch e Ben Gvir, a cui deve la sua vittoria.
Questa porterà all’estrema radicaliz zazione dello stato d’Israele che pre sto verrà profilato come religioso e sionista. Le forze moderniste e mode rate, se ci sono, oggi sono sconfitte. Soprattutto quelle che sono inequivo cabilmente contro Netanyahu.
Da oggi anche quella piccola misu ra di realismo che Netanyahu suo mal grado ha dovuto mostrare nei manda ti precedenti a favore dei vicini e dei “grandi”partnernelmondo,saràsotto enorme pressione. Ben-Gvir ha già chiesto la poltrona di ministro per la pubblica sicurezza, affermando che per ogni pietra lanciata, ogni molotov e ogni atto distruttivo, la risposta sarà solo armata. Secondo Smotrich e Ben Gvir, tutti quelli che non sono a favore di Israele saranno espulsi! Non dimen tichiamo che a suo tempo Ben-Gvir ha minacciato brutalmente il premier Yitzhak Rabin, andato ad Oslo nel 1995 per trattare con Arafat. Tre setti mane dopo Rabin è stato ucciso da un attentatore israeliano.
Smotrich, di professione avvocato, ha proposto leggi e misure legali con tro tutti quelli ritenuti nemici d’Israe le, contro i richiedenti asilo, gli avver
sari politici, e contro i diritti Lgbt. Se condo lui gli stranieri sono un perico lo, e bisogna “ridefinire” i diritti delle donne.
Il ritorno di Netanyahu, è chiaro, non è una good news per Biden. Tre anni fa il presidente Usa ha chiara mente favorito il “Bennett di destra” come premier, mantenendo un quieto “status quo” nelle relazioni Usa-Israe le. Ciò difficilmente potrà continuare. Netanyahu e i partner sono un terre moto per la regione e Biden ha altre cose di cui occuparsi. Si sta aprendo un nuovo vaso di Pandora in Medio Oriente con nuovi giovani palestinesi ma anche con Iran, Siria, Russia.
Se finora potevamo pensare che le cose si stessero sistemando - ci sono state addirittura trattative per stabili re i confini marittimi - le elezioni in Israele riportano sul tavolo i vecchi giochi più pericolosi. Una volta contro Meir Kahane è stata fatta una legge, d’ora in poi non sarà più possibile. Lo spirito di Meir Kahane sta diventando un fenomeno d’Israele, e del mondo.
Il futuro non promette bene, per nessuno.

Una casa distrutta dopo i bombardamenti ad Arkhanhelske, villaggio da poco liberato nella provincia di Kherson

Con l’Ucraina fino alla vittoria», abbiamo spesso sentito ripetere in questi mesi. Ma se la vittoria è impossibile? Allora si inizia ad agire su un doppio binario, co me stanno facendo gli Stati Uniti nelle ultime settimane. Da un lato c’è la linea dura, quella che dal 24 febbraio ha insistito urbi et orbi per il sostegno militare a Kiev e l’interruzione di ogni re lazione con la Russia. Dall’altro, la convenienza che pro babilmente è sempre stata nell’ombra, o meglio, che noi non abbiamo potuto vedere, ma ora entra in scena con la prepotenza del realismo. Anche in seguito ai frammenti di missili caduti in Polonia, sul territorio della Nato, gli Usa sono stati fin dalle prime ore i più cauti. Mentre i Paesi bal tici e la Repubblica Ceca invocavano subito l’articolo 5 dell’Alleanza, Washington ha parlato di «verifiche necessa rie» e ha stemperato i toni.

D’altronde, non è la prima volta che i funzionari e i mili tari Usa adottano questa strategia comunicativa. Mark
Milley, il capo di stato maggiore congiunto statunitense, ovvero una delle tre figure al comando delle forze armate a stelle e strisce, è stato il primo alto ufficiale dei Paesi Nato ad ammettere la possibilità di uno stallo a tempo in definito sul campo di battaglia. «Deve esserci un ricono scimento reciproco [tra Russia e Ucraina, ndr] del fatto che la vittoria nel senso proprio del termine probabil mente non è ottenibile con mezzi militari e quindi biso gna guardare ad altri metodi», ha dichiarato Milley all’E conomic club di New York. Difficile pensare che le dichia razioni di un ufficiale di quel rango siano improvvisate. Al contrario, ne dobbiamo trarre la conclusione che i vertici militari del principale alleato di Kiev, nonché leader della Nato, intravedono la necessità di trovare una soluzione diversa alla guerra. Si noti che lo stesso giorno (10 novem bre) il presidente Biden aveva chiarito che il sostegno all’Ucraina continuerà, ma che a Kiev non è stato dato «un assegno in bianco»; in altri termini, non tutte le ri chieste ucraine devono essere soddisfatte. I droni di ulti ma generazione, per esempio, non saranno forniti «per scongiurare un allargamento del conflitto». Tuttavia, altri 400 milioni di dollari di aiuti militari sono stati approvati dal Congresso e inizieranno a essere consegnati a breve.
Il lunedì seguente due fatti hanno rafforzato la tesi che le dichiarazioni di Milley non fossero un caso isolato. In un lungo articolo sul quotidiano Wall Street Journal, si raccontava di come il consigliere per la sicurezza nazio nale statunitense, Jake Sullivan, il 4 novembre fosse atter rato a Kiev per provare a convincere il presidente ucraino a «mostrarsi aperto ai negoziati». Tale atteggiamento, se condo la diplomazia americana, contribuirebbe a mettere Kiev in una «posizione vantaggiosa» rispetto alla contro parte sia sul piano della politica internazionale sia su quello mediatico. Sullivan avrebbe consigliato al presi dente ucraino di pensare a «priorità e richieste realisti che» da presentare al tavolo negoziale con la Russia in modo da poter aprire una trattativa. Tuttavia, al G20 di Bali, Zelensky sembra non aver recepito affatto i consigli americani e i «10 punti per la pace» presentati all’assem blea si sono rivelati dei desiderata più che delle proposte concrete. Poco dopo, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha bollato le proposte del presidente ucraino co me «non realistiche e non adeguate» in quanto «la Russia vuole fatti concreti e non parole» per iniziare un eventua le negoziato. Si noti che fino alla scorsa settimana i russi, Putin in testa, avevano sempre affermato di essere «aperti a trattare la pace», ma «partendo dall’attuale situazione sul cam po». Mosca sa che Kiev non vuole rinun ciare ai territori perduti dall’invasione a oggi e che quindi non accetterà di parteci pare a una trattativa in cui Mariupol, Meli topol o la regione di Zaporizhzhia sono la moneta di scambio. Almeno per ora. Da qualche tempo, invece, i russi si dicono
molto significativo.
aperti alle proposte ucraine «senza pregiudizi». A dirlo è stato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, quindi, anche qui, non un personaggio che può permettersi di parlare senza consultarsi prima con il capo.
Per gli stessi motivi Sullivan avrebbe chiesto a Zelensky di «riconsiderare» la riconquista della Crimea. A differen za di quanti sostengono che entro la prossima primavera Kiev otterrà dei successi fondamentali, come l’ex capo delle forze armate Usa in Europa, Ben Hodges. Stando all’analisi del militare, il danneggiamento del ponte sullo stretto di Kerch e l’avvicinamento delle batterie ucraine al fiume Dnipro permetteranno alle forze ucraine di indebo lire a tal punto i russi da poter riconquistare la penisola. Ma con i soldati di Mosca in ritirata dalla sponda ovest del fiume Dnipro parlare anche di restituzione della Crimea sarebbe forse eccessivo per intavolare una trattativa. Gli ucraini, tuttavia, non fanno che ripetere che presto a Se bastopoli sventoleranno di nuovo le bandiere gialle e blu. E poi ci sono i contatti diretti con Mosca. In tale conte sto il nome di Jake Sullivan è ricorrente. La settimana scorsa abbiamo scritto delle rivelazioni (sempre del Wall Street Journal) sulla linea aperta tra il consigliere ameri cano e alcuni funzionari molto vicini al Cremlino. Ora scopriamo che si è passati agli incontri confidenziali in territorio neutro. La Cnn ha diffuso la notizia che il diret tore della Cia, William Burns, ha incontrato il capo del Svr (l’intelligence estera russa), Sergei Naryshkin, ad Ankara. Si noti che l’incontro è stato voluto proprio da Washin gton, come il Cremlino non ha mancato di sottolineare. Stando a quanto dichiarato ai media, la missione di Burns era parlare della «gestione del rischio, in particolare il ri schio nucleare e i rischi per la stabilità strategica» con la controparte russa. Si è anche tenuto a sottolineare che Kiev era stata informata per tempo dell’incontro, il che è

Diversi analisti iniziano a chiedersi se i rapporti interni nel governo di Kiev siano effettivamente così armoniosi come sono stati presentati. Il capo riuscirà, se dovesse presentarsene l’occasione, a imporre una linea che si di scosta dalla riconquista totale dei territori occupati? La domanda è tutt’altro che scontata e rima con il ruolo pre ponderante che hanno le forze armate e i gruppi più na zionalisti all’interno dell’attuale amministrazione ucrai na. Quanto, negli ultimi mesi, Volodymyr Zelensky sia riu scito a costruirsi un entourage in grado di assecondarlo e di difenderlo in caso di scelte impopolari è tutto da verifi care. Dall’esterno abbiamo solo potuto prendere atto dei frequenti licenziamenti al vertice delle cariche statali e alla loro sostituzione con figure in apparenza più vicine alla linea del presidente.
Per lo stesso motivo anche la ritirata russa da Kherson e la liberazione della parte ovest della città non costitui scono di per sé un catalizzatore della pace. Anche se Ze lensky stesso ha dichiarato che è «l’inizio della fine della guerra» e che il suo Paese è «pronto per la pace», tali pa role sono (forse volutamente) ambigue. Si tratta della pa ce voluta dagli ufficiali ucraini, ovvero la vittoria contro l’invasore e la riconquista del territorio nazionale, o della pace tout court? Del resto, dopo gli attacchi di martedì, gli ucraini sono tornati a sostenere che «il terrore russo si può fermare solo con la forza delle nostre armi».
Tra i rappresentanti Usa sembra esserci chi ancora cre de al sostegno all’Ucraina «a tutti i costi». Parlare di soldi non è fuori luogo se si pensa alle forniture di gas russo e ai rincari in Europa. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg continua a ripetere che servono più armi e che la Russia è «ancora pericolosa, anche se indebolita». L’ex vicesegretario alla Difesa statunitense, Evelyn Farkas, afferma che «l’Occidente non deve permettere a Putin di chiedere un cessate il fuoco» e la rappresentante perma nente degli Usa alla Nato, Julianne Smith, dice che «la Na to e l’Ucraina godono di un forte sostegno bipartisan al Congresso […] non sappiamo quando la guerra finirà, ma siamo certi che l’Ucraina prevarrà».
Tale dicotomia si spiega facilmente se ci si appella alla forma. Gli Usa sono talmente coinvolti da non potersi permettere di passare da voltafaccia di fronte a Kiev e, soprattutto, agli alleati europei. Tuttavia, la sproporzio ne di potere all’interno della Nato permette a Washin gton di poter agire in autonomia. Con buona pace del presidente francese Macron che, tra i leader europei, sembra il più infastidito dal ruolo di gregario che questa guerra gli ha riservato. D’altronde, non sarebbe il primo ripensamento della Casa bianca in anni recenti, basti ci tare l’Afghanistan, anche se per gli Stati Uniti in Ucraina c’è una posta molto più alta in gioco: l’indebolimento del la Russia e la riaffermazione dell’egemonia strategica sull’Unione europea.


Come sarà l'Ucraina dopo una trattativa che più o meno sotterraneamente è già iniziata e che dovrebbe sfociare se non nella pace in una tregua per congelare il conflitto? È tem po di chiederselo nonostante l'infittirsi dei bombardamenti russi, l'offensiva ucraina che prosegue e gli ordigni caduti in Polonia che hanno ucciso due persone: quando si avvicinano negoziati decisivi sem pre succede che si alzi la temperatura per sedersi al tavolo da una posizione più vantaggiosa e sempre sono in aggua to incidenti che possono ostacolare il dialogo: nel caso po lacco, dagli Usa alla Nato alla stessa dirigenza di Varsavia si è subito cercato di buttare acqua sul fuoco per non far de ragliare il delicato percorso in atto.
Come sarà dunque? Viene in mente uno slogan cinico, già usato nel passato, qui ammantato però di valenze diver se: separare i vivi per non continuare a contare i morti che avrebbero superato, sui due fronti, il numero esorbitante di duecentomila. Separarli attraverso una pulizia che sarebbe improprio definire etnica per la confusa serie di varianti of ferte da una popolazione di confine. Ci sono ucraini, ci so no russi, ci sono ucrainofoni che stanno con Mosca (pochi), russofoni che stanno con Kiev (molti). E dunque le catego rie da prendere in esame sono piuttosto l’identità e l’ideo logia. Per definizione l’identità e l’ideologia sono autocerti ficate, sono quanto ciascuno si sente nel profondo. E que sto provoca le complicazioni.
A inizio conflitto l’Ucraina aveva quasi 44 milioni di abi tanti. Di questi 8 milioni sono sfollati interni, altri 7 milioni sono profughi all’estero. Quindici milioni in totale, un terzo della popolazione. Quando tacerà il cannone la loro scelta non sarà se tornare a casa ma dove tornare a casa, dove è casa. E, il fenomeno è già parzialmente in atto, casa è dove saranno coloro che condividono la stessa visione del mondo. Stare nell’Ucraina di Zelensky (sempre che rimanga al pote re) con uno sguardo rivolto verso le democrazie europee cer cando di perseguire gli stessi standard in fatto di diritti civili ed economia di mercato, o stare nella Russia di Putin (sempre che ri manga al potere, più facile) dove la democra zia è considerata obsoleta e dove vige una democratura muscolare con forti venature autoritarie (eufemismo).
Una “pulizia identitaria” obbligatoria per ché il numero esorbitante di vittime, la pro
fonda spaccatura prodotta impediranno una conciliazione, almeno nei tempi brevi. Solo più avanti, e mutata qualche circostanza, popolazioni così interconnesse potranno ri prendere le vecchie consuetudini di una mescolanza favorita da legami familiari oltre che storici. Il presente sarà la divi sione dei destini, una sconfitta non solo delle parti in causa ma anche dei valori su cui si è costruito il Vecchio Continen te. Succede alle porte dell’Unione Europea ed è un segnale catastrofico, un cattivo esempio che potrebbe dunque dila gare nell’epoca delle tentazioni sovraniste purtroppo non naufragate nemmeno sotto i colpi di una pandemia che ave va illuso circa un futuro di maggiore condivisione perché «non ci si salva da soli» nel pianeta interconnesso.
È ormai del tutto evidente che la trattativa, al netto di alcu ne reboanti dichiarazioni ad uso interno per meglio posizio narsi ai round finali dei tavoli di negoziato, muove dal dise gno di nuovi confini frutto di una realtà del terreno sulla via di essere accettati. Lo sgombero dei russi da Kherson è la cartina di tornasole di una diplomazia sotto traccia che ha già stabilito alcune linee guida evidentemente concordate mentre si muove una pluralità di attori attorno al nocciolo decisivo Zelensky-Putin. Ne sono la riprova i primi contatti da febbraio dei capi degli 007 di Russia e Stati Uniti, l’incon

trimenti sarebbe la terza guerra mondiale.
Si chiama realismo cinico. O, se volete, la finestra di oppor tunità spalancata dall’inverno per non continuare il massa cro. Zelensky, in collegamento video con il G-20 di Bali (e il ministro degli Esteri russo lo è stato a sentire senza lasciare la sala...) ha enunciato i dieci punti per la pace, molti dei qua li facilmente sottoscrivibili dal nemico come sicurezza nu cleare, sicurezza alimentare, sicurezza energetica, rilascio di tutti i prigionieri e deportati, meccanismo di compensazio ne dei danni di guerra, protezione dell’ambiente. Ha invoca to poi una carta delle Nazioni Unite largamente bistrattata ovunque negli ultimi decenni per il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina e chiesto, per la protezione futura del suo Paese, alcune garanzie visto che non fa parte di alcu na alleanza militare: non ha citato l’adesione alla Nato.
È chiaramente la questione del ripristino dell’integrità ter ritoriale che sarà motivo d’attrito. Risolvibile solo con l’ausi lio della gamma di sfumature di cui dispone l’arte diplomati ca. L’ipotesi più probabile è il congelamento del riconosci mento delle aree conquistate dai russi con la promessa di un referendum sul futuro status da svolgersi sotto il controllo di osservatori internazionali. Già ma con quali regole? Chi po trà votare? I residenti attuali o quelli al 24 febbraio 2022, ini

tro tra Biden e Xi Jinping sullo scenario di Bali. La riprova che, dopo la lunga notte della guerra, è giunto il momento della pre sa d’atto di una situazione difficilmente modificabile dalla forza d’urto dei due eser citi belligeranti. Lo zar del Cremlino ha per so, non potrà mai prendere Kiev e il Paese tutto, come era nei suoi auspici iniziali e la Cina desiderosa di riprendere a pieno ritmo i commerci dovrà ridurlo alla resipiscenza. Permettendogli tuttavia di poter contrabbandare il clamo roso rovescio di quella che fu l’Armata Rossa con un surrogato di vittoria per aver allungato le mani su una fetta ulte riore di Donbass e mantenuto la contesa Crimea. «Tutti i russi in uno Stato», era la sua parola d’ordine che andrà modificata, vista la riottosità di una parte di loro a tornare sotto il dominio del Cremlino, in «tutti i russi che lo voglio no in uno Stato». Quanto a Joe Biden, rafforzato dalle ele zioni di Midterm, dovrà faticare per convincere Zelensky, in piena euforia da riconquista, che a sua volta può procla mare la vittoria per aver fermato i russi nonostante la dolo rosa concessione di una fetta di territorio ma questo era il massimo risultato possibile perché il prezzo da pagare al
zio delle ostilità? E si torna alla questione iniziale della puli zia identitaria nel frattempo intercorsa. È il perenne duali smo tra autodeterminazione e inviolabilità dei confini che rientra in gioco. Due principi inconciliabili e motivo di ten sioni non solo a Oriente, anche nel pacifico Occidente (Spa gna, Irlanda, Scozia, Belgio...).
In ogni caso è prevedibile, dopo la tregua, che non si arri verà alla pace giusta. E torna in mente la famosa massima di Blaise Pascal: non potendo fare che ciò che è giusto fosse forte, abbiamo fatto che ciò che è forte fosse giusto. All’a mara frase si può opporre solo un alibi: sì, ma abbiamo fer mato la carneficina.
 DI GIANFRANCESCO TURANO
DI GIANFRANCESCO TURANO
Calcio e ipocrisia vanno a braccetto. Ma in Qatar si stanno battendo record an cor prima del debutto del mondiale, previsto domeni ca 20 novembre con un ma tch non proprio di cartello fra la nazione ospitante e l’Ecuador.
In breve, il Qatar è buono quando investe in Europa e in Italia. È buono quando l’Ita lia vince appalti nel Paese del Golfo con im prese come Eni, Saipem, Webuild. È buono quando il suo gas naturale liquefatto ci aiu ta a superare la crisi energetica provocata dall’invasione russa dell’Ucraina. È buono quando fa divertire gli spettatori con le stel le del Paris Saint-Germain, da Leo Messi a Kylian Mbappé, e quando riempie le casse
voraci di club e federazioni con i diritti tv comprati dal network al Jazeera.

È cattivo quando un suo rappresentante impropriamente definito ambasciatore, tale Khalid Salman, ex calciatore dell’al Sadd e della nazionale, dichiara che i gay vanno curati. È cattivo quando continua a intrattenere rapporti preferenziali con gli ayatollah iraniani e con Vladimir Putin. È cattivo quando dichiara, contro ogni vero simiglianza, che la prima coppa del mondo invernale sarà a zero emissioni di carbonio nonostante si giochi in impianti ad aria condizionata.
Il Qatar infine è cattivo quando, nella corsa forsennata a costruire sette stadi, una metro colossale, opere stradali e idrau liche per una bolletta complessiva di 220
“NIENTE POLITICA”
miliardi di dollari, manda al massacro al meno 6.751 lavoratori immigrati fra il 2011 e il 2020, secondo una statistica ricostruita dal Guardian nel febbraio del 2021 su dati delle ambasciate di India, Pakistan, Ban gladesh, Nepal e Sri Lanka e, dunque, sen za contare altre comunità molto diffuse nei Paesi del Golfo, gli afghani, i filippini, i kenioti. È una strage che ha colpito una forza lavoro di due milioni di persone su 2,9 milioni di residenti totali ma il saldo del decennio non è lontano da quello di cui do vrebbe vergognarsi l’Italia.
Per chi ha costruito il sogno, l’incubo non è finito. Dalla fine di settembre, a stadi completati, l’autorità dei lavori pubblici di Doha (Ashghal) ha vietato a migliaia di edili di cercar si un altro lavoro. Questo significa espulsione dai confini dell’emirato retto da Tamim al- Thani. La pri ma conseguenza è che mol ti di questi lavoratori non avranno la possibilità di estinguere i debiti da re
Lo stadio 974 di Doha, chiamato così dal numero di container riciclati utilizzati per la sua costruzione. Verrà dismesso dopo i Mondiali

cruitment fees. In italiano si chiama ca poralato. Nei loro Paesi di provenienza i migrant workers hanno dovuto pagare l’e quivalente di somme a tre zeri in valuta occidentale ai reclutatori che li hanno spe diti a Doha e dintorni. Tutto legittimo o quasi. In fondo, sono agenzie di lavoro in terinale che propongono ingaggi biennali in cambio di una fetta della magra torta. Chi non ha soldi in anticipo può prenderli a prestito con interessi che superano il 30 per cento, secondo l’indagine di Mi grant-Rights.org.
Chi è arrivato nella fase iniziale dei can tieri avviati nel 2011, se non è morto e non ha riportato danni permanenti lavorando a temperature che d’estate superano facil mente i 50°, ha potuto almeno coprire le spese. Chi è stato ingaggiato dopo, anche se ha trovato migliori condizioni per la pressione esercitata da organizzazioni co me Amnesty international o Human rights watch, non ha avuto il tempo di risparmia re il denaro sufficiente da un salario che, per uno specializzato, si aggira sui trecen to-quattrocento dollari al mese e scende a duecento per un manovale semplice.
Ma il calcio è spensieratezza. Così il 3 no vembre la Fifa guidata da Gianni Infantino, figlio di due lavoratori italiani emigrati in Svizzera, ha scritto una lettera alle nazioni partecipanti nella quale si suggerisce di mettere da parte la politica. «Focus on fo otball» è lo slogan cofirmato dal successore di Joseph Blatter e dalla segretaria generale della Fifa Fatma Samoura, lei sì provenien te dal corpo diplomatico senegalese ma a digiuno di calcio fino alla sua nomina nel giugno 2016, a valle dell’azzeramento dei vertici scatenato dall’inchiesta degli agenti federali statunitensi contro Blatter e il suo amico-nemico Michel Platini, al tempo alla guida della federazione europea (Uefa).
Nella mail urbi et orbi Infantino si dice soddisfatto dei progressi del Qatar sia nei rapporti di lavoro, citando un report posi tivo dell’Ilo (International labour organi zation), sia nell’accoglienza dei tifosi della comunità Lgbt, gli stessi che l’8 novembre hanno protestato davanti al museo della Fifa a Zurigo.
«Per favore», scrive la Fifa, «non permet tete che il calcio sia trascinato in ogni bat taglia politica o ideologica esistente». L’in tervento di Infantino ha scatenato polemi
Il Lusail stadium. A destra Lionel Messi in azione con il Paris Saint-Germain
che di ogni genere. Squadre qualificate alla fase finale come l’Australia, la Danimarca e l’Olanda hanno puntato l’indice contro la criminalizzazione dell’omosessualità in Qatar. Tre giorni dopo la missiva di Infanti no, l’Uefa ha ribadito che «i diritti umani sono universali e si applicano dovunque». Dieci federazioni europee, fra le quali In ghilterra e Germania, hanno replicato con una lettera aperta nella quale si rilancia la proposta fatta da Amnesty e Hrw di creare un fondo Fifa da 440 milioni di dollari per risarcire i lavoratori e le loro famiglie. La cifra è pari al montepremi totale del Mon diale, che prevede 42 milioni di dollari per la squadra campione, ed è quasi il triplo dei 164 milioni che l’Emirato ha versato a 37 mila lavoratori a titolo di compensazione nel 2020, poco più di 4.400 dollari a testa.
La Fifa ha fatto orecchie da mercante. Il colosso con sede a Zurigo, che raccoglie più iscritti delle Nazioni unite (211 contro 193) non intende in alcun modo pregiudi

care il suo conto economico con oneri stra ordinari. Il 2022 è l’anno della grande rac colta per l’organizzazione del calcio mon diale che pianifica i suoi bilanci in periodi di quattro anni. Il 2015-2018 ha portato un incasso di 6,41 miliardi di dollari, di cui 5,41 miliardi dal solo mondiale vinto dalla Francia. Ci si poteva aspettare che il 20192022, segnato da una pandemia che ha te nuto chiusi gli stadi per mesi, segnasse un passo indietro. Ma la federazione interna zionale, a differenza dei club, non conosce recessione. Il quadriennio che si chiuderà con la proclamazione dei campioni del mondo domenica 18 dicembre al Lusail Iconic Stadium progettato da Foster+Part ners fa segnare una previsione di ricavi da 6,44 miliardi di dollari che sarà certamente superata. La proiezione sull’utile netto fi nale è di 3 miliardi di dollari per un rappor to ricavi-profitti senza paragoni con altri settori dell’industria, anche perché lo sti pendio ai calciatori e gli altri costi li paga no i club, non la Fifa.
E sono stati proprio i presidenti dei gran di club a dissuadere Infantino, che si conce de un modesto emolumento da 3 milioni di franchi svizzeri l’anno, dal mettere in atto il suo progetto di Coppa del mondo biennale.
Il fronte del boicottaggio verso il mon diale sul Golfo si allarga di giorno in gior no. Persino Sepp Blatter, ringalluzzito dal la recente assoluzione decretata dal tribu
nale di Bellinzona sul Fifagate del 2015, si è coperto il capo di cenere dicendo che il Qatar, dichiarato vincitore dal medesimo Blatter nel dicembre 2010, è stato una catti va scelta. L’ex ras della Fifa ha accusato Pla tini e l’allora presidente francese Nicolas Sarkozy di avere rovesciato l’esito della vo tazione, che vedeva favoriti gli Usa, in cam bio di un ordine di aerei da guerra made in France da 14,6 miliardi di dollari dopo una cena a tre all’Eliseo con l’emiro. Pochi mesi dopo Qsi, una delle holding di investimento qatariote, comprava il Psg e trasformava un club in decadenza in corazzata del football sotto la guida di Nasser al Khelaifi, ex tenni sta che ha avuto la fortuna di giocare in doppio con il principe Tamim.
Oltre ai nemici interni come Blatter, la Fifa soffre l’antagonismo dell’Uefa, che è la federazione regionale più potente con i suoi 55 membri fra i quali nazionali asiati che come la Turchia, la Georgia e l’Azerbai jan. Il presidente Uefa, l’avvocato sloveno Aleksander Ceferin, ha gradualmente tra sformato la sua organizzazione in partito di opposizione permanente nel parlamen to del football mondiale. Nemico giurato della superlega dei grandi club, Ceferin ha costretto Infantino, accusato di essere il re gista occulto dell’operazione, a smentire ogni coinvolgimento nel progetto sostenu to da Andrea Agnelli e avversato dal qata riota al Khelaifi.
Ceferin ha inoltre varato una task force per verificare le condizioni dei lavoratori nei cantieri e l’ha affidata al coordinamen to del vicepresidente italiano Michele Uva. Le conclusioni di visite e ispezioni sono state in linea con le valutazioni positive dell’Ilo. Ma è difficile ispezionare quello che non c’è più.
Il presidente della Fifa Gianni Infantino.
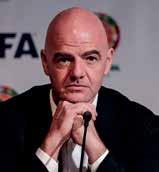


In alto, l’emiro del Qatar, Tamim al-Thani
L’espulsione dal Paese di decine di mi gliaia di lavoratori sembra dovuta a un mi sto di ragioni. C’è la chiusura definitiva di molti cantieri. Ma c’è anche il sospetto che si siano voluti togliere dalla circolazione i veri artefici del miracolo di Qatar 22 per ché, in fin dei conti, i poveri non sono un bel vedere. Il rischio è trovarsi con stadi meravigliosi, coperti, rinfrescati e mezzi vuoti. È vero che Infantino è dato per favo rito alle elezioni Fifa programmate per l’i nizio del 2023. Ma un flop al mondiale po trebbe cambiare le carte in tavola.
Avviso ai naviganti, quelli in Rete: nel fanta stico mondo delle criptofinanza succede anche questo. Quella che segue è una breve storia di balene, pesci piccoli, crack annun ciati. E di un mercato globale da mille mi liardi di dollari che d’ora in poi non sarà più lo stesso. Il primo atto va in scena il 6 novembre scorso, una domenica. Quel giorno Changpeng Zhao, fondatore e padrone di Binance, annuncia su Twitter ai suoi 7,7 milio ni di follower che venderà 500 milioni di dollari in monete virtuali (token) del suo concorrente Ftx. Quest’ultimo, così come Binance, è un cosiddetto exchange, cioè una borsa digitale, senza una sede fisica, in cui milioni di clien ti in tutto il mondo comprano e vendono Bitcoin, Ethe reum e decine di altre criptovalute.

Il tweet di Cz la sigla con cui è conosciuto il miliardario di origine cinese, viene letto dal mercato come un’implici ta conferma delle voci ricorrenti sulle difficoltà finanziarie di Sam Bankman-Fried, il ragazzo prodigio, ora trentenne, che ha creato dal nulla la piattaforma di scambi Ftx. Nei tre giorni successivi succede di tutto. Prima il gran capo di Binance racconta, sempre via Twitter, che il suo gruppo è pronto a scendere in campo per evitare il crack della crea tura di Bankman-Fried. Anzi no, a ventiquattro ore di di stanza dalla prima dichiarazione d’intenti, Cz fa marcia indietro, abbandona al suo destino l’exchange rivale e Ftx scivola così verso una bancarotta da 10 miliardi di dollari, con un milione di clienti in tutto il mondo, decine di mi gliaia anche in Italia, che potrebbero aver perso per intero il loro investimento.
Questi però sono solo i danni collaterali di una classica storia di malafinanza. La triste parabola di un presunto genio con buoni appoggi nel giro che conta, figlio di pro fessori di grandi università Usa, finanziatore del Partito
Democratico americano, sostenuto a più riprese per centi naia di milioni di dollari da fondi e banche internazionali. Serviranno mesi, forse anni, per ricostruire il labirinto di società, quasi tutte con base nei paradisi fiscali dei Ca raibi, che ha fatto da schermo agli affari, quelli in dollari, soldi veri non virtuali, dell’imprenditore californiano pre cipitato dal sessantesimo posto della classifica dei miliar dari stilata dal periodico statunitense Forbes. Fin d’ora però sono evidenti le conseguenze del crack di Ftx sulla credibilità e la stabilità dell’intero sistema delle criptova lute. Un mondo da sempre in equilibrio precario che me no di sei mesi fa è stato scosso da un altro colossale falli mento come quello di Terra, una valuta digitale, una stablecoin, tra le più scambiate sul mercato. Il doppio crack amplifica gli effetti della crisi di liquidità innescata dal rialzo dei tassi varato quest’anno da tutte le banche centrali del mondo. In sostanza, è diventato molto più co
stoso farsi prestare soldi da investire in criptovalute e affi ni. E così il valore globale di questo tipo di attività, che un anno fa superava i 2.500 miliardi di dollari, si è sgonfiato fino agli 800 miliardi di questi giorni. Il Bitcoin, di gran lunga la più diffusa delle monete digitali in circolazione, è arrivato a perdere oltre il 70 per cento del suo valore nell’arco di un anno.

«Le criptovalute sono un nuovo Far West che minaccia la stabilità finanziaria globale», aveva avvertito già nell’aprile scorso Fabio Panetta, il banchiere italiano che siede nel comitato esecutivo della Bce. E infatti in questi anni il mercato è cresciu to a gran velocità senza regole né controlli. In Rete si sono moltiplicate le offerte con promesse di guadagni mirabolanti per gli investitori. E la crescita velocissima delle
quotazioni a partire dal 2017 ha attirato milioni di rispar miatori insieme a molti profeti di una presunta nuova frontiera che prometteva soldi facili in un universo alter nativo, libero e irraggiungibile dalla casta dei politici e dei finanzieri del vecchio mondo.

«Ci sono migliaia di valute digitali, se ne contano alme no 21 mila, e gran parte di queste sono semplici strumenti speculativi senza nessun concreto progetto d’investimen to», riassume Leonardo Maria De Rossi, responsabile dei corsi "Blockchain and Cryptoassets" all’università Bocco ni di Milano. E mentre gli azionisti delle società quotate, così come i clienti delle banche tradizionali, possono con tare su un sistema di regole che, tra l’altro, serve a limitare i danni di eventuali fallimenti, chi si avventura nel mondo della criptofinanza lo fa suo rischio e pericolo.
Esemplare, a questo proposito, è la catena di eventi che ha portato al fallimento di Ftx. La notizia che ha dato il
colpo di grazia alla società già sull’orlo del collasso è stata diffusa sul mercato dal principale concorrente di Bankman-Fried, cioè il patron di Binance, Changpeng Zhao. Inevitabile il sospetto che il tweet di Cz facesse par te di una manovra per affossare il rivale. Tanto che il mi liardario cinese, ma cresciuto in Canada e residente a Du bai, ha dovuto smentire, sempre via twitter, di aver pianifi cato in anticipo l’attacco. Anzi, ha spiegato, «il crack pro voca danni enormi per la credibilità di tutto il mercato». Difficile negarlo, tanto è vero che nei giorni scorsi diverse altre piattaforme di scambi, tra cui la statunitense Coinba se, l’unica quotata in Borsa, a Wall Street, si sono affrettate a tranquillizzare i clienti, affermando che la situazione era sotto controllo. Sarà, ma intanto il titolo Coinbase ha per so quasi il 20 per cento in un mese, addirittura l’80 per cen to nell’arco di un anno. «Il nostro bilancio è tremenda mente forte», si è sbilanciato Kris Marszalek, numero uno di Crypto.com, un altro importante exchange. E lo stesso Cz ha minimizzato («registriamo solo un trascurabile aumento dei prelievi») il deflusso di fondi, un paio di miliardi in soli sei giorni, segnalato da alcuni analisti.
«La falla nel sistema è proprio nel mo dello di business degli exchange», spiega Christian Miccoli, fondatore di Conio, so cietà di gestione di portafogli di criptova lute. «Nella gran parte dei casi i clienti con segnano ai gestori della piattaforma di scambi le chiavi private (una sequenza di lettere e numeri) che danno accesso al proprio portafoglio digitale. Va da sé - conclude Miccoli - che questo espone i risparmiatori al rischio che il gestore si appropri del loro denaro per investirlo altrove». E visto che i controlli sugli exchange sono pressoché inesistenti, la tentazione di pre levare i soldi altrui può diventare irresistibile per gli ope ratori disonesti.
Nel caso di Bankman-Fried, le criptovalute depositate presso Ftx sono andate a finanziarie le attività di Alameda, un fondo d’investimento del vulcanico miliardario califor niano con base e faraonica residenza alle Bahamas, ospite
di convegni con Tony Blair e Bill Clinton e anche gran fi nanziatore di svariate organizzazioni non profit, tra le quali il sito americano di giornalismo investigativo ProPu blica. Con l’andar del tempo, evidentemente, gli investi menti (col denaro altrui) del giovane e rampante miliarda rio hanno scavato un buco sempre più profondo nei conti del gruppo. Il colpo di grazia è arrivato con il tweet del patron di Binance, che confermando i sospetti già in circo lazione sul mercato, ha funzionato come lo sparo dello starter per quella che può essere definita una sorta di bank run, la corsa agli sportelli delle banche tradizionali. Un numero imprecisato di clienti, di certo nell’ordine delle centinaia di migliaia, ha cercato di ritirare le proprie crip tovalute incautamente affidate a Ftx.
Com’era prevedibile, l’exchange è collassato nel giro di poche ore e siccome non esiste alcun meccanismo di pro tezione dei depositi, come invece succede per gli istituti di credito in Italia e quasi ovunque nel mondo, adesso i ri
sparmiatori sono costretti a sperare che dalla liquidazione dell’impero di Bankman-Fired emergano attività sufficien ti a rifondere almeno in parte le loro perdite. L’unica cer tezza è che la procedura durerà anni. Intanto, Chanpeng Zhao, mister Binance, si è fatto promotore di quello che ha definito un «industry recovery fund» col lodevole intento di contenere i danni della crisi di liquidità (e credibilità) innescata dal crack del rivale e sostenere altri operatori in difficoltà. Da incendiario a pompiere è un attimo, miracoli della criptofinanza.







La fiducia, il disgusto, la vergogna. La grande filosofa americana riflette sul valore delle nostre emozioni. Alleate di democrazia e giustizia
colloquio con Martha Nussbaum di Wlodek Goldkorn illustrazione di Ivan Canu


In alto: Ucraina, graffito sul muro di un edificio distrutto dall'esercito russo a Borodyanka, a nord-ovest di Kiev; la filosofa Martha Nussbaum

Martha Nussbaum è filosofa, fra le più ascoltate degli ultimi decenni. Clas se 1947, una carriera da Harvard alla Brown University e fino all’Università di Chicago, dedicata agli studi su etica, dirit ti, giustizia sociale, teoria delle emozioni e all’insegna di una ricerca calata nella real tà dei fatti e che vada oltre i principi astrat ti e i dibattiti accademici. Ha pubblicato quasi una trentina di volumi, in Italia so prattutto con il Mulino. Fra questi: “La fra gilità del bene”, “Rabbia e perdono. La ge nerosità come giustizia”, “Disgusto e uma nità. L’orientamento sessuale di fronte alla legge” (Il Saggiatore). Di prossima pubbli cazione “Justice for Animals. Our Collecti ve Responsibility” (Giustizia per gli ani
ovunque nel mondo.
mali. La nostra responsabilità collettiva). Il 25 novembre riceverà dalle mani del pre sidente della Repubblica il Premio Balzan per Filosofia morale. Per la cronaca: i pre mi Balzan ammontano a circa 770 mila euro. Metà da destinare a progetti che coinvolgano giovani ricercatori.

Si comincia questa intervista (che si è svolta per iscritto) con l’attualità e lo stato della democrazia negli Usa: «La democra zia è una forma fragile di governo dato che dipende dai cuori e dalle menti di molte persone. E in questo momento è a rischio negli Stati Uniti. Tuttavia, sono ancora ot timista grazie alla grande vitalità delle no stre organizzazioni della società civile. I risultati delle elezioni di mid-term sono incoraggianti: l’elettorato ha a cuore i di ritti delle donne, la verità e la decenza». Tuttavia, il nazionalismo è tornato

«Voglio fare una distinzione fondamentale tra patriottismo e nazionalismo. Il patriot tismo è amore per il proprio Paese e per gli obiettivi che il Paese vuole raggiungere. Ammesso che gli obiettivi siano degni di rispetto, il patriottismo è buono e perfino essenziale, dato che l’amore del popolo è essenziale perché la democrazia proceda verso obiettivi buoni. Uno degli obiettivi del patriottismo può e deve essere un mondo di pace e cooperazione. Il naziona lismo, al contrario, implica l’idea di supe riorità della propria nazione. È quindi in trinsecamente competitivo».
Ha scritto molto della paura: un senti mento diffuso in questo momento di grande incertezza globale. Cos’è la paura?
«Sembra ancora utile la definizione che ne dava Aristotele. La paura, per lui, era una dolorosa attesa di un danno grave, immi nente, insieme alla convinzione di non po terlo prevenire. La paura, quindi, è utile e necessaria alla conservazione di ciascuno di noi e di coloro che amiamo. Senza, sa remmo presto morti. Ma la paura compor ta pericoli. È una nostra emozione primor diale, ha la forma di un pensiero arcaico
“La paura è utile e necessaria alla conservazione di ciò in cui crediamo e di coloro che amiamo. Ma la paura porta anche a negare i diritti degli altri”
dell’infanzia, e il timore infantile resta an che quando siamo ormai persone adulte. È anche (e per questo motivo) facilmente manipolabile dalla retorica, qualcosa che i politici conoscono da millenni. Alcune fi gure retoriche possono salvare la vita: ad esempio, quando un politico convince le persone a credere nella gravità di un ura gano o di un incendio. Ma troppo spesso la manipolazione prende la forma di demo nizzazione di certi gruppi sociali: immi grati o fedeli di una determinata religione, o gay e lesbiche. Così la paura porta a ne gare i diritti agli altri. Non solo, la paura può indurre le persone a cercare la prote zione di un leader autocratico e per questi motivi è un pericolo per la democrazia». C’è anche quello che lei chiama il “di sgusto” per chi viene definito come “di verso”. Come difenderci?
«Si pensava che il disgusto fosse semplice mente una risposta viscerale a certe solle citazioni. Ma importanti ricerche hanno dimostrato che il disgusto ha un contenu to cognitivo. Ciò che lo ispira è qualcosa che consideriamo contaminante, e i soliti contaminanti sono tutti “promemoria ani mali”, segni di ciò che è mortale e vulnera bile nei corpi. Però non è la stessa cosa
Il mondo classico, la filosofia greca e romana, il femminismo, i diritti degli animali. Vasto è il campo di studio della filosofa statunitense Martha Nussbaum, autrice di importanti saggi dedicati, in special modo, alle disuguaglianze e ai diritti negati delle donne. Tra i suoi libri più noti “La fragilità del bene”, “Rabbia e perdono”, “Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica” (tutti editi da Il Mulino), “Disgusto e umanità” (Il Saggiatore).

della paura, visto che molti oggetti perico losi non sono disgustosi (per esempio fun ghi velenosi) e molti oggetti disgustosi non sono pericolosi. Quello che io chiamo dunque “disgusto primario” è una risposta avversa ai “contaminanti primari”: cattivo odore, melma, viscidità».
Fin qui niente di strano.
«Poi però accade che le persone proiettino le proprietà del disgusto su un gruppo di umani. Capita, in forme diverse, a tutte le società. Possiamo iniziare a rimediare con l’adozione di leggi contro la discriminazio ne e per proteggere i gruppi vulnerabili. Ma l’unica soluzione è imparare ad amare il nostro corpo, una lezione difficile per umani timorosi».
Continuiamo a parlare delle sue ricer che sul ruolo delle emozioni nello spa zio pubblico. Una di queste è la vergo gna. Esiste anche la vergogna delle vittime, per l’impotenza di fronte all’abu so, alla violenza.
«Penso che la vergogna sia di solito un’e mozione improduttiva e ingiustificata: im produttiva perché ci porta a nasconderci anziché ad agire in modo costruttivo, in giustificata perché, mentre la colpa ri guarda una determinata azione, la ver

gogna riguarda l’intera identità della persona. Le società sono sempre state abi li a far vergognare le minoranze, sia con rituali pubblici, come con la “lettera scar latta” di Hester Prynne (la protagonista dell’omonimo romanzo di Nathaniel Hawthorne), sia imponendo alle minoran ze una sorte di invisibilità forzata, come nel caso di gay e lesbiche. Ma le persone dovrebbero resistere alla vergogna, do vrebbero affermare la propria dignità. Sia mo tutti impotenti in molti modi. Le don ne stuprate spesso provano vergogna, co me se lo stupro fosse colpa loro, perché le società insegnano che la sessualità femmi nile è cattiva e provoca azioni violente ne gli uomini. Ai miei studenti di Giurispru denza mostro il film “Sotto accusa” con Jodie Foster, storia di un processo per stu pro che ha finito col cambiare la legisla zione americana in materia. I miei alunni ne sono entusiasti perché vedono come un buon avvocato possa migliorare lo stato di cose esistente. In quel procedimento i giu dici stabilirono che “no significa no”, e non importa se una donna balla o ha atteggia menti sexy».
Un film simile, “Processo per stupro” del 1979, con l’arringa di Tina Lagoste na Bassi, ha influito nella stessa dire zione sulla legislazione italiana. Ma un’altra domanda emerge dai suoi stu di. Dobbiamo fidarci gli uni degli altri? A quali condizioni?
«Non ci sono risposte univoche alla sua domanda, né nella vita né nella filosofia. Ma se comprendiamo quanto la fiducia sia essenziale per le relazioni personali e poli tiche, possiamo adottare una politica di fiducia in determinate circostanze come quelle che Kant chiamava un “postulato pratico”: non dimostrabile, ma necessario per poter vivere. Vede, la cautela è sempre utile all’inizio di una relazione, ma a un certo punto occorre abbassare le difese, altrimenti non si possono ottenere i van taggi che dà l’amore, sia personali che po litici».

Ma allora, è possibile una politica fatta di gentilezza? Una politica che non se gue la contrapposizione amico-nemi co?
«Ciò che serve è una politica di curiosità, desiderio di verità, disponibilità all’ascolto e a vivere assieme a coloro con cui non sia

Dall’alto: Olga Tokarczuk, Premio Nobel Letteratura ; la politica Liz Cheney, figlia dell’ex presidente Usa. A destra: un recente raduno a sostegno dei candidati repubblicani, in Ohio
mo d’accordo. Ad esempio: la mia ex stu dentessa Liz Cheney (figlia di Dick Che ney, ex vicepresidente Usa e deputata per il Partito repubblicano, in dissenso totale da Trump; Ndr) è tornata nel nostro cam pus per tenere una conferenza. Non sono d’accordo su molto di ciò in cui crede, e quando era una studentessa sembrava una piantagrane. Ma è diventata una pian tagrane nel senso migliore, disposta a scommettere tutta la sua carriera sulla di fesa della nostra fragile democrazia. Ab biamo bisogno di persone come lei». Definiti i parametri della politica resta la domanda sui diritti. Dai suoi libri si evince che non sono un concetto astrat to, ma debbono essere commisurati al le condizioni concrete in cui vivono gli esseri umani. Può spiegarlo?


«Le scelte di ciascuno di noi sono fatte in condizioni sociali concrete, appunto. Dal momento che le donne hanno il diritto di essere libere dalla violenza maschile, quel diritto deve essere reso reale: dalle leggi che rendono reato le aggressioni sessuali, dal lavoro delle forze dell’ordine che fanno rispettare le leggi e dall’istruzione pubbli ca che informa i giovani cittadini sull’im portanza dell’autodeterminazione femmi

nile e inviolabilità dei corpi. Altrimenti “il diritto” è solo una parola scritta su un pez zo di carta. Lo stesso vale per tutti gli altri diritti. Le persone non hanno il diritto alla libertà di parola semplicemente perché hanno idee e sanno parlare. Devono avere quello che io chiamo la “capacità” di paro la, cioè una situazione in cui la libertà di parola non è soppressa né è impedito il suo esercizio».
L’esempio che ha appena fatto riguarda le donne. E in questa conversazione la situazione delle donne è stata molto presente. Del resto, l’universo che ve deva al centro il maschio bianco è stato decostruito dal femminismo. Ma quali sono i limiti del pensiero femminista? «Non sono sicura di essere del tutto d’ac cordo con la formulazione della sua do manda. Ci sono molte varietà di femmini smo e molti disaccordi, alcuni produttivi e altri meno. Ma tutte le femministe sono unite nella convinzione che le donne subi scono ingiustizie ovunque e che dobbia mo combatterle: in ambito politico e a ca sa. Mi chiede del pensiero? Ogni pensiero ha sempre dei limiti: serve quindi un atti vismo coraggioso. Ma senza che il pensie ro femminista diriga l’azione è improbabi
le che l’azione faccia progredire le donne e la loro causa».

E allora rendiamo esplicita la domanda sui limiti. Le femministe ucraine, po lacche e in genere dei Paesi dell’ex blocco sovietico sottolineano di non essere comprese dalle sorelle in Occi dente. Il dissenso verte intorno alla questione della guerra e l’invio delle armi a Kiev. Lei cosa ne pensa?
«La guerra di Putin contro l’Ucraina è qualcosa di orribile e Biden ha ragione a sostenere Kiev e a inviare armi. L’unico modo per prevenire le guerre di conquista più ampie è restare saldi in difesa degli al leati. Abbiamo imparato questa lezione dall’esperienza degli anni Trenta».

Olga Tokarczuk, Nobel per la Letteratu ra, dice spesso che il romanzo è l’inven zione più bella della modernità perché permette di dire cose che la filosofia in senso stretto non può dire e quindi di comprendere il mondo. Lei da sempre è interessata alla Letteratura, l’ha praticata, cita spesso i classici greci.
«Penso che tutte le arti siano essenziali per comprendere il mondo. In questo mo mento sto scrivendo due libri sulla musi ca: uno sull’opera e il suo rapporto con i valori dell’Illuminismo (incentrato su Mo zart, ma anche su Beethoven e Verdi), l’al tro su “Il Requiem di guerra” di Benjamin Britten e su come la musica ci aiuti a capi re gli orrori della guerra e a muoverci, per quanto possiamo, verso un mondo di pace e di amore fraterno».
Ma in fondo, quanto sono importanti nel nostro sistema di valori i principi filosofici e quanto conta la contingen za, il caso?
«Rispondo così: non sappiamo mai cosa ci aspetta, quindi dobbiamo sviluppare prin cipi che siano flessibili e ci preparino ad adattarci al mondo mentre cambia».
“I diritti non sono concetti astratti: fanno i conti con condizioni sociali e culturali concrete. Gli esseri umani devono avere la capacità reale di goderne”
Itopi abbandonano l’aereo che cade?... Ennio Flaiano, di cui quest’anno si festeggiano i cin quant’anni dalla morte, era un indipendente. Un indipendente, diceva Geno Pampaloni, che vi veva nella solitudine dell’intelligenza. Dove per intelligenza si intende la ver satilità - quel suo essere giornalista, sceneggiatore, scrittore, geniale afori sta, che attraverso l’acume metteva in prospettiva la realtà, seppur, come scri veva in una lettera a Enzo Forcella, de testasse essere trovato divertente, per ché lui non si divertiva affatto. Si sareb be detto il contrario a vederlo scendere in via Veneto dopo aver incrociato Brancati in bicicletta. Si sarebbe detto un burlone a vederlo inseguire una ra gazza con il fisico da modella, fermarla e invitarla a mangiare di più: «La prego, lo faccia per me!».
Era uno degli sceneggiatori più ri chiesti: aveva scritto per Fellini (“La dol ce vita, “I vitelloni”, “8 e mezzo”, ecc.), ma anche per Rossellini, Lattuada, Pie trangeli, Risi, Antonioni, Monicelli, Zampa, Ferreri. Era nato a Pescara ma visse a Roma, sempre. La amava e la odiava; la sapeva raccontare come nes suna altro, soprattutto nei film. «Sto la vorando con Fellini e Tullio Pinelli a ri spolverare una nostra vecchia idea per un film, quella del giovane provinciale che viene a Roma a fare il giornalista. Fellini vuole adeguarla ai tempi che cor rono, dare un ritratto di questa società del caffè che folleggia tra l’erotismo, l’a lienazione, la noia e l’improvviso benes sere...». Leo Longanesi gli disse dopo averlo conosciuto: «Che aspetta? Non perda tempo, vada, vada. Vada a scrive


re». E infatti Flaiano scriveva, non solo per il cinema. A ventitré anni, cominciò la sua attività di giornalista. Scrisse su Oggi, Documento, Mondo, Il Corriere della sera, L’Espresso, Il Risorgimento liberale, Omnibus. E non solo, continua va a scrivere anche in altre forme, in al tre posture. Come se in quella sua pri smaticità e in quel suo trasformismo ci fosseunevitamento:unosfuggireall’im possibilità di dare un senso alla vita.
Nel “Diario degli errori”, che tenne per vent’anni dal 1950, il suo sguardo si frammenta. La realtà è quel ragazzo scorto per caso a Valenza che giocava da solo a guardie e ladri, facendo en trambe le parti: correndo, sparando e cadendo, prima come ladro e poi come
gendarme. La vita prende un senso e poi quello opposto, perché se c’è la Di vina Provvidenza, c’è sicuramente an che la “Divina Imprevidenza”, altret tanto vigile. E poi «un corso delle cose, che non è giudicabile». E quel corso delle cose, talvolta - per puro caso - può essere generoso; come quel 22 agosto in spiaggia, quando il teatro viaggiante declamava dall’altoparlante il canto V dell’Inferno e intanto, come colombe dal disio chiamate, arrivarono quattro reattori a fare le loro bellissime evolu zioni sopra la linea dell’orizzonte.
Il caso, che torna e ritorna in tutta la sua opera. «Se potessimo saperlo avremmo una chiave della sua storia. Invece così ci appare non più importan
te di una partita a dadi, dove tutto è affi dato al caso», scrive nel suo primo e unico romanzo, “Tempo di uccidere” (1947), con il quale vinse il premio Stre ga. Il caso come aspetto tangibile di un mondo privo di scopo e direzione. È per puro caso che il camion su cui viaggia il protagonista, un ufficiale che ha preso parte all’invasione italiana in Etiopia, si rovescia. L’ufficiale prosegue il suo viag gio a piedi in cerca di qualcuno che curi il suo terribile mal di denti, ma poi si perde. Quella che ha intorno è una real tà allucinata dal caldo, come calata in un quadro del doganiere Rousseau, con la vegetazione che nell’afa assume l’a spetto di animali impagliati. E mentre cammina senza un’idea precisa del per

corso da compiere, intravede tra gli ar busti una ragazza. La donna si sta la vando, strofina la pelle come se il corpo non le appartenesse. Ha un fazzoletto in testa portato con tanta regalità da farla sembrare vestita. L’ufficiale le chiede in dicazioni e lei gli risponde, ma a quel punto lui non è più interessato al suo mal di denti. Vorrebbe andarsene, ma non ci riesce. Si trattiene con quella donna incontrata per pura fatalità, fa l’amore con lei, e non se ne andrebbe mai più. Poi, all’improvviso, succede che l’uomo scorge un’ombra nella bo scaglia, potrebbe essere un animale, op pure un agguato, e allora, terrorizzato, spara. Quando torna dalla donna, però, la trova ferita. La pallottola è stata de
viata da una pietra e ha colpito la ragaz za al ventre. L’uomo la fa sdraiare, l’acca rezza, ma è troppo tardi per prendersi cura di lei. La ferita è profonda e insana bile, e allora per pietà la finisce: spara il suo colpo attraverso il turbante bianco. Si è trasformato in un assassino; ancora una volta per colpa del caso. Dopo aver la seppellita con amore, se ne andrà senza andarsene mai.
C’è qualcosa di inspiegabile nella re altà, sembra ripetersi l’autore. «Quan do credo di essere, non sono. Di avere, non ho»: la Mostra a lui dedicata, al 39° Festival internazionale del film di Lo carno, aveva scelto questa didascalia per accompagnare la fotografia di co pertina in cui Flaiano appare tra le luci argute e le ombre malinconiche del suo viso. Per Carlo Bo, Ennio Flaiano è il primo a essere colpito dall’universale tristezza delle cose. Lui che aveva una figlia amatissima, Lelé, malata di ence falite e preda di continue crisi epiletti che. «C’ è un amore», confessò Flaiano ad Aldo Tassone, «quello che ho io per mia figlia o quello che ha mia moglie per mia figlia, che è un amore purissi mo». Un dramma che proteggeva con la sua discrezione, il suo essere appar tato. E allora se tutto è demandato al caso, non si può che essere estatici os servatori dei nonsense: gli eventi inspie gabili che popolano la realtà; come il camaleonte che se ne va per la foresta africana con una sigaretta in bocca. Op pure come “i divorziati” del “Diario de gli errori”: un giornalista lascia la mo glie per una mannequin, ma nel frat tempo la mannequin sposa un omoses suale perché molto affezionata al cane di quest’ultimo, e così il giornalista
divorziato rimane senza donna. Non trova alloggio ed è costretto a vivere dal la ex coniuge, che intanto riceve il suo amante ogni sera. Oppure i nonsense della guerra che racconta in “Aethiopia”, diario della sua avventura militare tenu to tra il 1935 e il 1936. Pare che gli etiopi continuassero a ripetere: «Italiani ba ciare bene, noi baciare male». Ma, scri ve Flaiano, l’attività sessuale c’entrava ben poco. I fanti dell’esercito italiano erano soliti partire all’attacco con il fuci le e una bomba nella mano libera. Per innescare la bomba strappavano la lin guetta con i denti. Gli etiopi li avevano osservati a lungo, così una volta inter cettate e rubate diverse casse di esplosi vo, passarono al contrattacco nell’azio ne dello Scirè. Prima di lanciare le bom be, tuttavia, si limitavano a baciarle, perché così gli era sembrato che faces sero i nemici. «Col risultato che le bom be rimanevano inesplose e venivano subito usate dagli italiani».

Adamante, protagonista di uno dei due racconti della raccolta “Il gioco e il massacro” (1970), gelido, tagliente, bril lantissimo con la sua faccia da Hum phrey Bogart vive disorientato dal caos della realtà. Liza Baldwin, invece, fidan zata a New York con lo sceneggiatore Giorgio Fabro, si rivela diversa da come sembra. Una sera litigano, lei ha strappa to i racconti di Giorgio. Liza si nasconde sotto un letto, lui la prega di uscire ma lei gli morde la mano, per poi cedere alla prima carezza e strofinargli la testa sul petto. Liza si mostra in tutta la sua ina spettata natura di donna-cane.
«Il gioco è questo, un gioco di parole: / Se dico cielo, tu rispondi fango. / Se dici: amore, io rispondo prigione, / il gioco è fatto. Tanta è l’abitudine / alle parole! Ma capirsi è inutile”, scrive nel la “Valigia delle Indie” (1996).
Se le parole non servono, se tutto è dominato dal caso, non ci resta che ri petere i nostri errori e nella ripetizione cercare di trasformarci: trovare una salvezza nella metamorfosi, mentre ri diamo di ogni nonsenso. E mentre ri diamo, non facciamo che diluire ogni tristezza. «La ragazza baciò il ranoc chio e divenne una rana».
«Una volta andai a trovarlo a Roma, nell’albergo Leonardo da Vinci dove viveva dopo che il primo infarto l’aveva colpito. Entrai nella sua stanza e lo trovai carponi guardare sotto il letto. Mi disse con aria disperata: “Aiutami, ho perduto il talismano che mi ha donato Silvana Mangano. Me lo ha portato dall’India!”. Con grande desolazione mia, e soprattutto sua, il talismano non riuscimmo a trovarlo né ho saputo se in seguito riuscì a recuperarlo. La Mangano era una sua grande passione».
A raccontare questo curioso episodio della vita di Ennio Flaiano era Edoardo Tiboni, ideatore del Premio Flaiano, che si prepara alla cinquantesima edizione. L’amicizia fra i due conterranei era nata per merito di Gabriele D’Annunzio: la città di Pescara aveva da poco intitolato un teatro al Vate e Tiboni chiese aiuto a Flaiano per la trasposizione delle novelle dannunziane. Non se ne fece nulla. Lo sceneggiatore, fresco della notorietà raggiunta con “La dolce vita” felliniana e con “La notte” di Michelangelo Antonioni, si mostrò scettico sull’operazione.
«Iperproduttivo, per nulla salottiero e un po’ in controtendenza rispetto alla società del suo tempo», lo definisce così Carla Tiboni, che nel 2016 ha preso la guida dei Premi Internazionali Flaiano, dell’Associazione Culturale e della Fondazione Edoardo Tiboni. «Una figura fondamentale per la vita culturale di Pescara: nel 1966 è stato il primo presidente della Società del Teatro e della Musica, ancora oggi attiva. Quando tornava in riva all’Adriatico incontrava sempre gli stessi amici». Per l’edizione 2023 del Premio Flaiano, Carla Tiboni anticipa un convegno internazionale su Flaiano e la comunicazione: «I celebri aforismi sono molto diffusi sui social fra i giovanissimi e si moltiplicano le tesi di laurea perché leggere Flaiano significa ritrovarsi in quello che scrive». Ma,
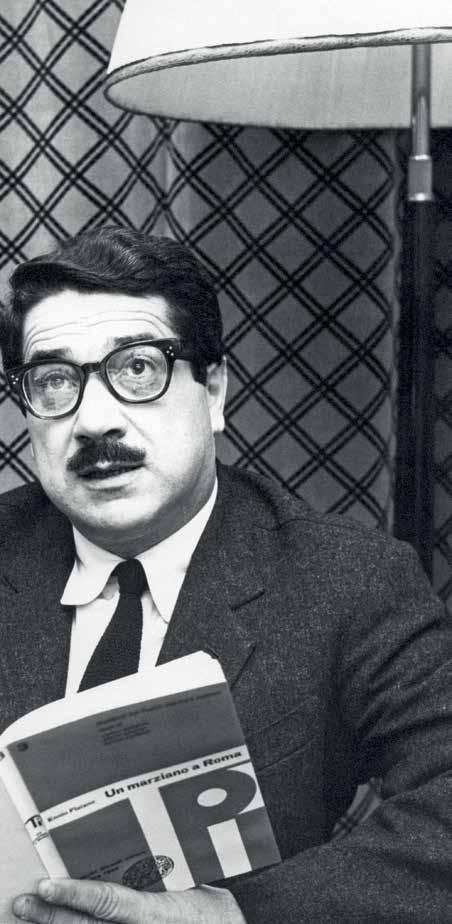
nell’immediato futuro, si intravedono progetti più ambiziosi: «Entro la primavera prossima, inizieranno i lavori del nuovo MOC (Museo Officina del Cinema Ennio Flaiano) nella piazza che ospita l’attuale Mediamuseum la cui attività non si è fermata neppure durante la pandemia». Si snoderà lungo tutto il 2023 il lavoro di drammaturgia su “Tempo di uccidere” dell’attore e regista pescarese Domenico Galasso, diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico insieme ad Alfredo Troiano: «Un Flaiano insolito, intimo, in dialogo profondo con se stesso, che mette a nudo le sue fragilità e contraddizioni», spiega Galasso, che porterà lo spettacolo anche nei licei. Sempre diviso fra cinema e letteratura, radio e televisione, Roma e New York, Fregene e Pescara, Ennio Flaiano porta in sé quella modernità che si ritrova oggi nella città che gli ha dato i natali: «Pescara è molto più flaianea che dannunziana. Rappresenta la crescita, la velocità con la Coppa Acerbo, è curiosa, accogliente, aperta verso chi sceglie di viverci. Ma è una città senza storia. Roma, per Flaiano, è stato l’approdo naturale», sottolinea Giovanni Di Iacovo, scrittore ed ex assessore alla Cultura del Comune. Esattamente venti anni fa, insieme a tre amici, ha ideato il FLA, festival letterario sostenuto da fondi pubblici e privati, che mixa oltre duecento appuntamenti in gran parte gratuiti spalmati per quattro giorni. E siccome Pescara conta ben quaranta chilometri di pista ciclabile e quasi tutti usano le due ruote, è stata organizzata una pedalata urbana letteraria sui luoghi di Flaiano: «È una iniziativa che unisce la passione per la bicicletta e quella per le quartine», racconta Alessandro Ricci, anima di Borracce di poesia. «Sotto la casa natale dello scrittore leggerò la lettera a Pasquale Scarpitti (“Sono nato a Pescara: in

un 1910 così lontano e pulito che mi sembra un altro mondo. Una Pescara diversa, di cinquemila abitanti, al mare ci si andava con il tram a cavalli e le sere d’estate si passeggiava, incredibile, per quella strada dove sono nato, il Corso Manthoné, ora diventato un vicolo e allora persino elegante”, scrive Flaiano nel 1972, poco prima della morte, ndr) per poi proseguire verso il Ponte Flaiano». Un ponte sospeso sul fiume Aterno che porta incisa sulla base in pietra della Maiella forse la massima-simbolo dello scrittore: “Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole”. «Per intitolare il ponte coinvolgemmo gli alunni delle scuole primarie. Furono loro a decidere che si chiamasse Ponte Flaiano», ricorda Marco Alessandrini, ex sindaco di Pescara. Nessuna nuova, invece, per quanto riguarda l’idea dell’amministrazione comunale di riportare le spoglie dello scrittore da Roma a Pescara: «La tomba di Flaiano è nel cimitero di Maccarese, non lontano dalla spiaggia di Fregene a lui cara. Abbiamo scritto al sindaco di Fiumicino per parlarne ma ci ha fatto presente che il nostro interlocutore era Gualtieri. Da cui non abbiamo mai ricevuto risposta», conferma l’attuale sindaco, Carlo Masci che, per il 20 novembre ha in serbo la pubblica lettura di due lettere inedite dell’illustre pescarese a Palazzo di Città. «Flaiano, sua moglie Rosetta e la figlia Lelé trascorrevano molto tempo a Fregene dove si sentivano protetti. Lui frequentava assiduamente il ristorante Mastino e il villaggio dei pescatori dove ha conosciuto mio padre Armando che gli vendeva il pesce fresco e le telline che tanto gli ricordavano la sua Pescara», ricorda Mariano Micco. «Ogni settimana mi prendo cura della tomba e porto i fiori. L’altro giorno ho scelto i girasoli». Mariano Micco aveva poco più di quattro anni nel 1972 invece Enrico Vanzina, premio Flaiano alla carriera nel 2010, era più grandicello e di Ennio Flaiano ha ricordi nitidi. «Liberale, intelligente, scettico», così lo sceneggiatore romano definisce uno dei suoi autori preferiti. «Ha avuto un rapporto molto difficile con Pescara forse per il continuo paragone con D’Annunzio. Era un uomo di provincia che ha capito e raccontato Roma meglio di tanti romani. Non tollerava gli stupidi. Sapeva che la satira in Italia poteva portare guai e lui non voleva cercarsi nemici. E aveva capito che la centralità del cinema è la scrittura. Con mio padre (lo sceneggiatore Steno, ndr) sono stati amici fino alla fine. La sera si andava a cena da Suso Cecchi D’Amico. Intorno ai diciassette anni, avevo deciso di fare lo scrittore e pensai di rivolgermi a Flaiano per un consiglio. Gli chiesi a bruciapelo: “A cosa serve scrivere?”. E lui rispose lapidario: Serve a sconfiggere la morte».


uscito negli “Struzzi. Nuova serie”, la collana diretta da Ernesto Franco per Einaudi, il libro di Giorgio Agamben che si intitola “Quel che ho visto, udito, appreso...”. Si tratta di un florilegio di testi brevi, o bre vissimi, che hanno il carattere di fram menti filosofici, ma sono al contempo permeati da un timbro poetico, capace di mantenersi alto e cristallino lungo tutte le pagine. «A teatro, ascoltando la Callas, ho capito che, quando scriviamo, la cosa più difficile è sostenere a lungo la mezza voce nel registro più acuto».
Il foglio di uno scritto infantile smar rito per sempre, una perdita immemo riale, e una scrittura che si dispiega in torno a quel vuoto, al bianco che segna ogni scrittura, nel tentativo incessante di recuperare il non-pensato, il non-det to. È quasi come un bilancio sul proprio percorso, il testamento di un filosofo che si ferma per lanciare uno sguardo sulla vita passata in un lampo, sulle op portunità avute, su quelle sfuggite. L’ul tima parte è dedicata non per caso a “quel che non ho visto, udito, appreso...”.
Roma, Parigi, Vienna, Weimar e Bu chenwald, le grotte di Ajanta in India, le necropoli della Tuscia, le chiese scavate nella roccia in Cappadocia, Cala Felci, Ponza e Ginostra, i luoghi di Venezia, come gli Alberoni, le Zattere, la Chiesa di San Giacomo da l’Orio, disegnano l’i tinerario di Agamben. «Da luoghi che hai amato e che hai dovuto lasciare: se, come il gigante della favola, ci nascondi il cuore, certo diventi invulnerabile, ma correrai il rischio di dover sempre ricor dare – cioè tornare al cuore che avevi
voluto nascondevi. E di essere, per que sto nuovamente vulnerabile». È un iti nerario suggestivo e a tratti amaro. Quando, ad esempio, considera il tem po in cui ha vissuto. Che cosa ha appre so? «Dal XX secolo: che certamente gli appartengo e ne sono uscito nel XXI solo per prendere una boccata d’aria. Questa era, però, così irrespirabile, che sono subito tornato indietro – non nel XX secolo, piuttosto in un tempo den tro il tempo, che non sono in grado di situare in una cronologia, ma che è l’u nico tempo che ora mi interessi». Que sta sorta di anacronia, essere calati nel proprio tempo restando al contempo fuori, è ciò che Agamben spiegava nel suo breve saggio sul significato di “con temporaneo” scrivendo che contempo raneo è colui che in pieno viso riceve il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo. Capacità di rispondere alle te nebre dell’ora: si compendia qui la sfi da del filosofo.
Ma l’amarezza investe il rapporto con l’Italia di questi tempi in una pagina la pidaria: «Dagli italiani miei contempo ranei ho preso la distrazione. Attenzio ne non ne ho trovata». Parla con tono comprensibilmente risentito l’autore di opere filosofiche come “Homo sacer”, tradotte in decine di lingue, lette e di scusse ovunque nel mondo, e non solo all’interno delle università, l’autore che non ha avuto mai davvero quel ruolo che gli sarebbe spettato nello spazio pubblico. Non si tratta solo del ricono scimento che dovrebbe essere tributato a un intellettuale raffinato, un pensato re profondo e radicale, capace di aprire nuovi scenari, la voce più significativa
Tanti luoghi, dall’India alla Cappadocia. E tanti nomi, da Heidegger a Morante. Il saggio del pensatore è un mosaico di frammenti filosofici. E anche un atto d’accusa all’Italia
della filosofia contemporanea. Il pro blema riguarda l’Italia, distratta, sbada ta, smemorata, incantata e assente. E in questi giorni bisognerebbe chiedersi su quella che viene chiamata, a torto o a ragione, “crisi della sinistra” non derivi anzitutto proprio dalla mancanza di pensiero, dalla ripetizione di stereotipi, come quelli costruiti intorno al termine “liberale” e al concetto di liberalismo. Se non sono state elaborate nuove catego rie politiche, indispensabili per inter pretare il paesaggio attuale, è certo an che perché ci si è limitati a ripetere ste reotipi, senza confrontarsi con la rifles sione di Agamben. Distrazione, dunque, che mentre porta al conformismo, è fonte di dissipazione di idee ed energie.
Tanti sono anche i nomi, esplicita mente menzionati, o solo sottintesi, dei personaggi che compaiono nelle pagi ne, altrettanti punti di riferimento per Agamben, maestri, compagni, interlo cutori. Dal burattinaio Bruno Leone a Franz Kafka, da Averroè a Erigena, da Elia del Medigo a Ugo da San Vittore, da Platone a Epicuro e Lucrezio, da Gioac chino da Fiore a Bachofen, da Bonnard a Bachelard, da José Bergamin a Co stantino Kavafis, da Elsa Morante a In geborg Bachmann – per menzionarne solo alcuni. Fedele al non-detto, a quel foglio perduto, Agamben rammemora però il confronto serrato con coloro da cui ha appreso, perché «quando pensia mo il vero, allora la molteplicità delle opinioni si spegne e finalmente a pensa re non sono più io».


Non manca un richiamo a Martin Heidegger: «A Le Thor, nel 1966, ho vi sto di notte il cielo trafitto da innumere
voli stelle. E ho promesso di restargli fe dele. Nello stesso luogo, in quello stesso anno, ho fatto appena in tempo a affer rare l’ultimo lembo della giacchetta del la filosofia occidentale, prima che scomparisse per sempre», così scrive, ricordando il seminario tenuto da Hei degger e rivendicando quel solco in cui il suo pensiero si inscrive. E molte sono le riflessioni sulla filosofia – non solo sul modo di intenderla, ma anche su quei tentativi riusciti di mutarne e ampliar ne l’inventario. «Che cosa mi ha inse gnato la filosofia? Che essere uomini si gnifica ricordarsi di quando non si era ancora umani, che compito dell’uomo è la memoria del non ancora e del non più umano – del bambino, dell’animale, del divino». E affiora quell’afflato che attra versa tutte le pagine di Agamben: «Ma l’angelo silenzioso che prende ora il po sto di Ariele si chiama: Giustizia. Detto in altre parole: la filosofia consiste nel tentativo di un poeta – così arduo che quasi nessuno ci riesce – di far coincide re l’ispirazione con la giustizia».
Parole penultime di un filosofo che si accorge forse di non avere eredi – qual siasi cosa oggi voglia dire la parola im pegnativa “eredi” e il verbo vincolante e scomodo “ereditare” – e che con inevi tabile rimpianto guarda al suo non det to e al non vissuto, quel limite incerto e labile tra ciò che è riuscito a scrivere e ciò che poteva soltanto tacere. Perché sebbene ciò che si perde è di Dio, si piange incessantemente il perduto. È un libro molto diverso da quelli prece denti, dai saggi filosofici, un testo all’incrocio tra generi diversi, una rac colta di frammenti, schegge poetiche di pensiero, spiragli verso il non-detto, che sono alla fin fine anche un invito a leggere e rileggere la sua opera. Che co sa resta dei luoghi, degli incontri, degli amici, dei maestri in quella vita che sembra già passata in un lampo?
«Come la colomba, siamo stati man dati fuori dall’arca per vedere se c’era sulla terra qualcosa di vivo, anche sol tanto un ramoscello di ulivo da pren dere nel becco – ma non abbiamo tro vato nulla. E, tuttavia, nell’arca non abbiamo voluto tornare».

Sulla propria pelle hanno vissuto traumi e pregiudizi. E ora rileggono le bozze degli scrittori a caccia di stereotipi e inesattezze. Arriva dal mondo anglosassone
di Alessandro Leone illustrazione di Carla Indipendente
Il romanzo “The Continent” raccon ta la storia di un mondo dove turisti privilegiati osservano dai loro eli plani due popoli nativi che si com battono a vicenda in una guerra perenne. La protagonista, un’ap prendista cartografa di 16 anni, si ritrova improvvisamente a terra dopo un inciden te quando uno degli autoctoni la salva da un tentato stupro e lei lo ricambia aiutan do la sua gente a evitare la catastrofe. La trama di questo fantasy ha fatto molto di scutere negli Stati Uniti e l’autrice, Keira Drake, è stata accusata di aver scritto l’o pera da una prospettiva colonizzatrice e stereotipata, dove i bianchi agiscono anco ra una volta da salvatori.

Cinque mesi dopo la pubblicazione, la scrittrice afroamericana di young-adult Ju stina Ireland definì “The Continent” «im mondizia razzista». Drake era incappata in alcuni stereotipi senza rendersene conto, a suo avviso. Per esempio, la tribù chiamata Topi somigliava a una versione razzista de
gli Hopi, un popolo nativo americano. L’au trice allora spiegò di essersi in realtà ispira ta agli Uruk-hai di J.R.R. Tolkien, creature metà uomo e metà orco, ma anche in que sto caso non sapeva che lo scrittore del “Si gnore degli anelli” si fosse basato sulla sua visione degli abitanti dell’Asia Centrale. Alla casa editrice, Harlequin, non restava che af fidarsi a un “sensitivity reader”.
Conosciuti anche come “expert reader” o “authenticity reader”, studiano testi che presentano personaggi con identità o espe rienze lontane dagli autori, alla ricerca di inesattezze, stereotipi, pregiudizi o espres sioni offensive. Mentre lo fanno, al contem po cercano di preservare l’integrità dell’ope ra, consigliando allo scrittore modifiche che possano impedire situazioni simili a quella vissuta da Drake. Ognuno di loro offre cono scenze o competenze che vanno dall’appar tenenza culturale, etnica o religiosa (cristia na, afroamericana, asiatica) alle esperienze traumatiche (stupro, abuso emotivo da par te di un genitore), fino a includere gli hobby.
Nathaniel Glanzman, per esempio, met te a disposizione la propria esperienza co me persona autistica, bipolare, uomo tran sgender, asiatico-americano e paziente di un ospedale psichiatrico. Due anni fa ha abbandonato un lavoro di professore di in glese che, pur piacendogli, costituiva al contempo una fonte di pressione talmente profonda da portarlo al ricovero. Quelle che prima vedeva come vulnerabilità ades so sono, paradossalmente, abilità essen ziali per il suo lavoro da “sensitivity rea der”: «Dimettermi da professore ha di strutto la mia autostima e mi ha fatto sen tire come se non fossi intelligente e capace. All’improvviso, però, mi sono trovato in un settore dove conosco tutto e so cosa sto fa cendo», racconta.
Perché il requisito più importante per questa professione, molto diffusa negli Stati Uniti e in parte nel Regno Unito, è attingere esclusivamente dal proprio vissuto. Per questo, Glanzman si pente di aver accettato il suo primo lavoro, la lettura di un romanzo con un personaggio transgender femminile: «Non sono una donna trans e non avrei do vuto leggerlo perché è una regola dei “sensi tivity reader”: non puoi consigliare su iden tità che non hanno a che fare con la tua esperienza personale», sottolinea.
Come lui, molti lavorano da freelance per grandi gruppi editoriali, nel suo caso Harper Collins e Penguin Random House, che nel loro sito raccomandano il database “Writing in the Margins”, dove è apparso per la prima volta il profilo di Glanzman. Sage and Salt è tra i leader del servizio e di spone di decine di “sensitivity reader” nel suo catalogo online.
Nel cinema il processo è molto simile, ma lo sceneggiatore gioca un ruolo diverso, co me spiega la “sensitivity reader” Alexandra Creswick: «I copioni non sono fatti per esse re letti, sono solo un progetto che si conver te in immagini. Lo sceneggiatore è il princi pio del progetto, non la sua fine».
Gran parte del suo lavoro si concentra sui temi della riproduzione che si trasformano a volte in un dibattito sul cambiamento cli matico. Ad esempio, quando un personag gio dice qualcosa del tipo: «Non voglio figli perché il mondo è sovrappopolato», secon do Creswick «si sta ponendo sulle spalle dei poveri tutta la responsabilità di quello che succede all’ambiente e ignora il fatto che

abbiamo abbastanza risorse per aiutare tutti, ma non lo facciamo per ragioni econo miche».
Alcuni autori hanno accolto la diffusio ne del “sensitivity reading” con critiche e dubbi, come se si trattasse di una minac cia alla libertà d’espressione o una sorta di censura.
Francine Prose, sulle pagine della New York Review of Books, si è chiesta se sia giu sto dire addio a Madame Bovary, dato che a Flaubert mancava «l’esperienza di una ca salinga inquieta», oppure a Otello perché «Shakespeare non era nero».
Lionel Shriver, sul Guardian, ha minac ciato di abbandonare la letteratura il gior no in cui una delle sue opere dovesse finire nella mani di un “sensitivity reader”: «C’è una linea sottile tra il setacciare i mano scritti per qualsiasi cosa potenzialmente
Alcuni autori hanno criticato questo tipo di rilettura. Come se si trattasse di una minaccia alla libertà d’espressione o una sorta di censura
discutibile per determinati sottogruppi e l’aperta censura politica».
Gli scrittori, tuttavia, possono rifiutare le raccomandazioni se lo considerano neces sario e non sono obbligati ad applicare le modifiche se non lo desiderano: «Sono la loro dipendente e non ho potere», dice Creswick: «La ragione per cui dedico molto tempo a chiedermi cosa vuole ottenere l’au tore è perché voglio che lo ottenga. Io sono semplicemente un altro strumento per aiu tarlo», aggiunge. «Non è censura, ma accu ratezza. Si tratta di sapere di cosa si sta scri vendo», pensa invece Glanzman.
In effetti, nella maggioranza dei casi, chi decide di affidarsi a un “sensitivity reader” spontaneamente lo considera un buon ser vizio, che aiuta a migliorare il suo scritto.
Melissa Scholes Young ha assunto un esper to per analizzare la rappresentazione di un personaggio dalle origini etniche diverse in un mondo di bianchi: «Tutti abbiamo i no stri punti ciechi perché ci portiamo dietro un background culturale, la nostra espe rienza. Il mio “sensitivity reader” mi ha aiu

tato a capire dov’erano questi punti ciechi affinché io potessi vederli più chiaramen te», spiega.
Il revisore ha letto cinque capitoli del suo secondo romanzo, “The Hive”, ambientato nelle località rurali del centro-ovest statuni tense, tradizionalmente isolate e poco mul tietniche. «Non mi sembra rivoluzionario chiedere aiuto. Devo essere cosciente di quelli che possono essere i miei limiti nella scrittura. È più accettabile assumere un “sensitivity reader” per un’opinione profes sionale, piuttosto che chiedere a qualcuno di una comunità marginalizzata quello che pensa. Questo è poco professionale e insen sibile», pensa Scholes Young. La richiesta di romanzi con personaggi appartenenti a minoranze cresce ma continuano a essere i bianchi a impossessarsi delle storie. Secon do il New York Times rappresentano infatti l’89 per cento delle opere pubblicate.

Anche per questo motivo, Glanzman cre de che nel futuro la situazione migliorerà e che le grandi etichette editoriali cercheran no di assumere molti di loro.
E in Italia? La figura del “sensitivity rea der” sembrerebbe una prerogativa pretta mente anglosassone, come dichiarano al cune case editrici. Il lavoro di revisione è in genere integralmente affidato a redattori interni, che cercano di svolgere questo ruolo con rigore e attenzione, senza la ri chiesta di particolari esperienze personali. Come racconta l’editore romano Minimum Fax: «Essendo una casa editrice di picco le-medie dimensioni non abbiamo la capa cità di assumere una figura di questo tipo. Tuttavia i nostri editor sono molto consape voli e informati, e svolgono questo ruolo contestualmente al lavoro di editing e di se lezione dei testi. Siamo molto attenti a que sto genere di tematiche».
Un atteggiamento confermato anche da Fazi Editore, che affida a lettori preparati l’individuazione di eventuali “inesattezze”.
Ma il pubblico italiano è diverso da quello anglosassone e questo, per Fazi, è una fortuna: «È successo qualche volta di trovare passaggi poco piacevoli per la sen sibilità del momento o per un certo tipo di lettori, ma in generale in Italia siamo me no sensibili e più permissivi di fronte ad alcune licenze che si concedono gli autori nei loro testi».

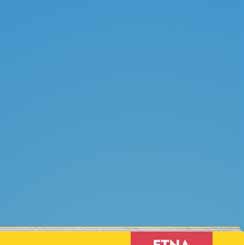


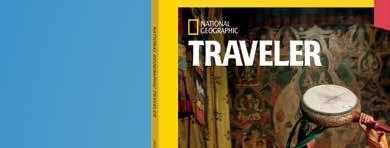
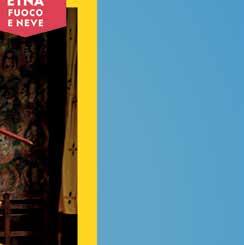



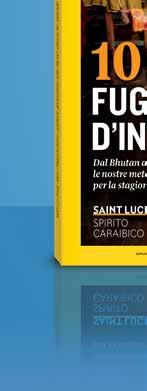








Emma Summerton firma The Cal 2023
Pirelli. Più che un calendario un manifesto sulle donne per le donne. Come mostrano le foto in esclusiva per L’Espresso
Resilienza, inclusività, fra gilità, energia, sensualità. Sono solo alcune delle pa role chiave che marcano la svolta nel pensiero foto grafico del calendario Pi relli 2023 “Love letters to the muse”. Scioccante per intensità, meraviglioso nelle ambientazioni e colori, non un ca lendario ma un vero e proprio manifesto per le donne e sulle donne.
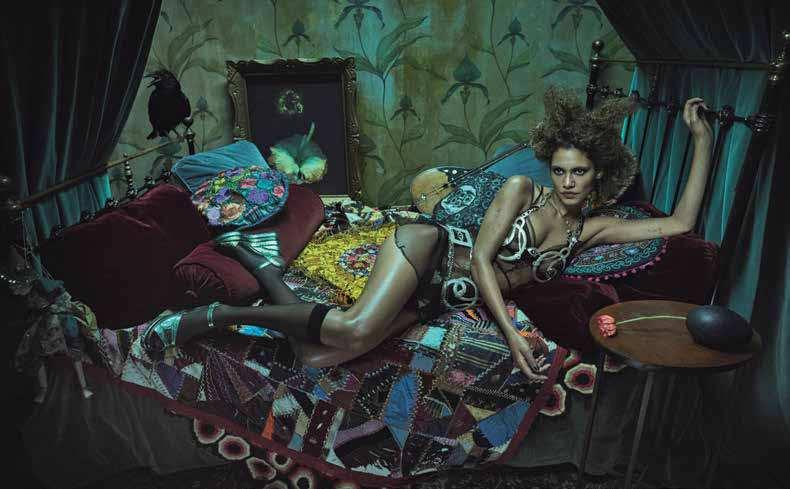
Un genio creativo dai lunghi capelli rossi che attraverso il suo realismo ma gico è riuscita a percorrere la bellezza fino all'anima. Emma Summerton, foto grafa e artista australiana, ha creato un sogno, instaurando una conversazione che va al di là delle immagini: «Ho volu to creare uno spazio dedicato alle muse dove potessero esprimere chi sono, che cosa fanno, che cosa provano, qual è il loro posto nel mondo». Il corpo non più come materia ma come rappresentazio ne di un concetto. Un inno non solo alla bellezza femminile ma all’intero univer so delle donne, a ciò che rappresentano e che spesso si ignora.
Summerton ha fissato un precedente: modelle non solo nei panni di sé stesse
di Tiziana Faraoniin un tripudio di corpi e bellezza, ma donne consapevoli, forti e fragili insie me, che alzano la voce in un momento storico nel quale il loro ruolo in molte parti del mondo è in pericolo, con diritti acquisiti che traballano. “Love letters to the muse”, lettere d'amore alla musa, 14 modelle, 14 individualità corrisponden ti alle sue vere muse, personaggi imma ginari e archetipi che da sempre l'hanno ispirata: «Volevo che il calendario di ventasse una piattaforma per permette re a queste donne di diventare fonte di ispirazione per le altre». E svelano le lo ro identità, le loro battaglie, l’intimità, per quattordici mesi. Un numero ano malo per un calendario, ma la fotografa ha voluto rendere omaggio a due muse in più. Supermodelle, conosciute in tut to il mondo, si spogliano del loro ruolo quotidiano, per cambiare forma ma non pelle, trasformandosi in creature miti che, nelle quali sogno e reale si fondono in un’ unica essenza.
È cosi che Ashley Graham, attraverso lo sguardo della Summerton, tira fuori il suo altro sé: l'Attivista. La modella curvy continua la sua battaglia per l'inclusio ne del corpo di tutte le donne. «Un com
pito monumentale. C’è anco ra molto da fare affinché tut te si sentano rappresentate. Tutte noi dobbiamo fare qualcosa. Io vivo con respon sabilità il mio essere», dice fiera. Lauren Wasser è l'atleta che come Giovanna D'Arco non si tira mai indietro. Com batte i preconcetti su disabilità e bellez za e trasforma la sua storia in una fonte di ispirazione per chi deve affrontare sfide difficili: «Dopo aver perso le gam be ho imparato a usare la forza che ave vo dentro il mio corpo per fare in modo che non siano le cose che accadono a definirmi. O che definiscano il nostro futuro. Le cose che ci accadono non possono circoscrivere la nostra vita», racconta con delicatezza, ma lasciando trapelare una forza inarrestabile. Il viag gio della fotografa continua con Bella Hadid, la musa Folletto, o Fata sexy, dol ce, tosta, dispettosa, e a volte altezzosa, che spinge le donne a ritrovare sé stesse. Guinevere van Seenus la Fotografa, Lila Moss la Veggente, Cara Delevingne, l’In terprete, He Cong la Saggia, Adwoa Aboah la Regina, Emily Ratajkowski, la
Due immagini esclusive dal Calendario Pirelli: Kaya Wilkins, la musicista, interprete di Settembre; Sasha Pivovarova, la musa pittrice, Aprile
Scrittrice. Karlie Kloss, l’E sperta di Tecnologia che nel 2015 ha dato vita a un pro gramma che permette alle giovani tra i 13 e i 18 anni di studiare gratuitamente inge gneria del software negli Sta ti Uniti. E immancabile è la Cacciatrice di sogni, la sud-sudanese Adut Akech, da anni in lotta contro le discriminazioni, che ha trasformato in realtà il suo desiderio di libertà. E come non innamorarsi di Pre cious Lee, “super model” che rappresen ta la Storyteller? «Non ho mai visto il mio corpo come una limitazione. Mi impegno per offrire al cinema moda e tv un’immagine alternativa della donna, perché non parliamo solo di taglie ma di sostenere la diversità». Mentre Sasha Pivovarova usa l'arte come strumento per raggiungere l'anima delle persone, per Kaya Wilkins, in arte Okay Kaya, la musica è il modo per evidenziare te matiche spesso dimenticate. E The Cal 2023 le porta all’attenzione, rom pendo il concetto stereotipato della donna. E dando voce a tutte noi.


Tanti anni fa mi chiesero co sa avrei preferito tra una carriera veloce e una lenta. Risposi “al trotto”: ho biso gno di avere consapevolez za quando faccio dei passi». A parlare da paladina del passo pon derato in un mondo troppo veloce è Violante Placido, attrice e cantante. Alla fine dell’intervista farà una cosa insolita: mandarmi il videoclip del suo brano “Tu stai bene con me”, in cui il suo compagno Massimiliano D’Epiro la ritrae con la barba, in omaggio a “La donna scimmia” di Marco Ferreri. Proprio lei, che fece impazzire il pubblico maschile italia no nel 2009 con la sua versione di Moana Pozzi. Ci ha tenuto a non ri manere intrappolata nell’immagine della femme fatale diversificando ruoli ed esperienze, fino a interpreta re Alberta, donna in crisi e mamma in via di separazione nella commedia “Improvvisamente Natale”, dal primo dicembre su Prime Video. Partiamo con una constatazione: nel film gli unici in crisi sono gli adulti, i bambini la sanno più lunga. «Proprio così, io e mio marito (Lodo Guenzi, Ndr.) viviamo il crollo di una costruzione familiare e andiamo dal nonno interpretato da Diego Abatan tuono per chiedergli di dare lui la noti zia della nostra imminente separazio ne a nostro figlio, così che possa pren derla meglio. Il problema è che nean che il nonno se la passa bene, l’hotel che possiede e in cui ogni anno si pas sa tutti insieme il Natale rischia di es
sere venduto. In questa situazione di crisi generalizzata gli unici che capi scono e si dimostrano pieni di soluzio ni sono i bambini».
Dal cinema alla realtà, la sua espe rienza di madre le conferma che le nuove generazioni hanno una mar cia in più?
«Assolutamente sì. I bambini hanno una sensibilità pura e senza filtri, av vertono le tensioni familiari e i cambi di atmosfera anche quando da genito re cerchi di non far trapelare nulla. Non trovo sano cercare di essere una famiglia perfetta agli occhi dei figli, l’i pocrisia fa male. Non dico di farli assi stere continuamente a crisi e batti becchi, ma metterli di fronte alla real tà della vita è importante. Anche per ché non sappiamo mai fino a che punto riusciamo a mantenere ciò che ci siamo prefissati nella vita».
Lei sente di essere riuscita a mante nereciòchesieraprefissatadabam bina?
«Penso di sì. Fino a 14 anni, prima dell’arrivo dei miei fratelli, sono stata figlia unica, nella mia stanza già so
gnavo già di fare la cantante e l’attrice. Poi nell’adolescenza i due obiettivi fu rono accantonati perché prevalse la passione per lo sport, ma alla fine so no riemersi e li ho realizzati. Anche se poi, a dirla tutta, “realizzata” non mi ci sento mai».
Perché?
«Cerco sempre di rimanere su una strada autentica, anche quando ral lenta il percorso. Abbiamo troppa paura della lentezza oggi, io l’ho sem pre trovata il giusto ritmo per come sono fatta. Mi avrebbe spaventato ave re un successo improvviso. Infatti quando il cinema ha bussato alla mia porta all’inizio ero piena di paure, te mevo di non avere l’esperienza neces saria per sfruttare al meglio le possibi lità del mestiere».
In questa sua carriera “al trotto” suo padre Michele è mai stato una pre senza ingombrante?
«No, semmai un po’ assente perché ha sempre messo davanti il suo lavo ro e la sua passione. Non mi ha mai spinto per fare l’attrice, né detto co me fare. A volte anzi erano i suoi si
lenzi ad essere pesanti. Non mi ha mai paraliz zato il confronto con lui, non l’ho neanche cercato, forse perché mi spaventava. Non volevo sapere nean che cosa pensasse prima che lo capissi io, ho sempre tenuto a coltivare la mia indi
Oggi che rapporto ha con suo padre? «Siamo molto uniti, in un senso profondo. So che quando ho problemi di natura pratica lui mi aiuta e mi aiuterà sempre. Lo re darguisco ogni tanto, per ché è un nonno che va inse guito, a differenza di Abatan tuono in “Improvvisamente Natale”. Più simile a lui erano i miei nonni, specie quelli ma terni, sono stati importanti per me: mi hanno cresciuto e trasmesso tanto». Quando canta si sente più libera di quando
«Più libera e leggera: la musica è catartica, è un’estensione dell’e splorarsi e del dare voce alle nostre sen sibilità. Poi quando
canto non sono mai in attesa di un pro getto, semmai della mia ispirazione». Che cosa la ispira?

«Sono curiosa della vita, amo viaggia re per il mondo come perdermi per la mia Roma. Lavoro bene con il mio compagno, che ha curato la regia di alcuni miei videoclip e il primo dicem bre debutta al cinema con il suo film “La prima regola”. C’è dentro il mio brano “Come un sasso” nella colonna sonora curata da Boosta. A me basta prendere in mano la chitarra: quelle vibrazioni mi aprono canali da cui sgorgano idee senza che me ne renda conto. La musica mi permette di tirare fuori tutto quello che ho dentro». Come lo yoga e la meditazione, che pratica da sempre?
«Meditazione e yoga mi aiutano a li berare la mente e mi affascinano. Ogni tanto parto per ritiri spirituali da cui torno più lucida. Oggi non si può più vivere senza la ricerca di una consape volezza profonda di noi stessi e del vi vere in armonia con gli altri: siamo andati completamente fuori strada nel mondo, non sappiamo che fine sa remo anche solo nel prossimo futuro, tra emergenza climatica, minaccia nucleare e pandemia».
Sono tempi complicati, tempi di guerra: nutre più preoccupazione o più speranza?

«Sono una pacifista convinta e mi ren do conto che siamo arrivati a un pun to deleterio, con meccanismi che non vedo affatto facili da scardinare. Sap piamo bene che le guerre non posso no durare per sempre, perché allora aspettare migliaia di morti innocenti?
Cinquecentomila solo in Etiopia, non ha senso: dobbiamo dire basta a ogni guerra, è anacronistica nel 2022. Do vremmo aver imparato anche quello che costa, in termini economici ed emotivi, ricostruire. Quindi sono pre occupata, certo, ma anche convinta che questo sia il tempo di fare scelte giuste e tempestive senza perdere la speranza di un futuro migliore per i nostri figli. Una speranza attiva: dob biamo agire, tutti, per cercare di ag giustare le cose».




Rischiare per avere tutto. Marco Missiroli scandaglia il rapporto tra padre e figlio. Nel tempo dell’addio
Tornare a Rimini fuori stagione. Lasciare a Milano la vi ta nuova e puntare dritti, sicuri, all’ombrellone dell’a dolescenza, alle gelaterie multicolor e ai suoni della sala giochi, al posto dove piade e cassoni sono i più buoni. Ripercorrere un intrico di strade – Viale Tripoli e il lungoma re, Marina Centro e “i negozi che traboccano di secchielli e si sono ingoiati le edicole” – che non è solo una ricognizione di luoghi, un contare gli identici passi tra un campanile e una casa, ma uno slalom rallentato tra le memorie di una vita: la madre che non c’è più, le risate e la malinconia di una cop pia che amava ballare. E un padre che all’improvviso fa cose strane, come uscire la sera, sempre alla stessa ora, con l’aria clandestina di chi serba un segreto. Senza troppe cautele, però: deciso ad avviarsi alla fine con disinvoltura. Marco Missiroli ha scritto un romanzo, “Avere tutto” (Einau di), che si poggia lievemente sul cuore e scava incessante, fino al profondo. Millimetro dopo millimetro, senza mai mollare la presa. Solo ruotando intorno alla forza necessaria per curare e dire addio a un padre: persona prima che ruolo, con ciò che di lui sappiamo o che volutamente ignoriamo, con i momenti indelebili e le occasioni sprecate. Ma nulla è indicibile fino alla fine, specie se un gioco apparente ti arriva in soccorso: cosa faresti se avessi un milione di euro in più e
Per un quadro si può uccidere. E se l’autore del dipinto è Caravaggio il sospetto è più che fondato. L’omicidio di una gallerista a Milano. L’assassinio di un senzatetto a Siracusa. L’intuizione di un esperto di crimini d’arte collega le due vicende. Da una studiosa che padroneggia da anni “il mistero Caravaggio”, scavando nei risvolti più torbidi e ambigui della vita del genio maledetto, una storia che mescola antropologia e misteri siciliani ad affascinanti curiosità artistiche.
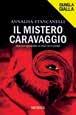
Annalisa Stancanelli Mursia, pp. 182, € 17
parecchi anni di meno? Avere, avere. Nei suoi tempi diversi: aver avu to, poter ancora avere. In tutti i suoi significa ti: possedere e godere, provare e sentire. Avere in sé tutto ciò che fino a quel mo mento hai imparato. «Averti come sei fatto per intero, boiate comprese, Sandro Pagliarani», esclama a quel figlio unico Nando, e’ Pasadèl, il passatello della minestra, sottile sem plice e sostanzioso. Averti tutto, così come sei: formula che assolve la colpa. E restituisce, proprio quando più è difficile: il gusto di assaporare le caramelle di quando eri piccolo, i coccodrilli gommosi e le lenticchie di cioccolato. Il tempo di soffermarsi sui disegni delle elementari, preservati dalle ma dri. L’occasione di fare i conti con le boiate: quelle da cui sei fuggito e che tuo padre conosceva perfettamente, amandoti lo stesso, anzi di più. Il dono di rinascere padre.

Marco Missiroli Einaudi, pp. 159,€ 18
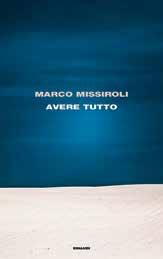
Con una bella prefazione di Michela Marzano, un’antologia che cuce poesia e prosa della poetessa, riunendo aforismi, brevi racconti, magie accomunati dal suo tono appassionato e dalle sue immagini in perenne bilico tra estasi e dolore. Un camminare sull’orlo del precipizio che rende omaggio soprattutto alla sua maestria al di fuori dei versi, meno nota della grandiosa epopea del corpo rifiutato, della solitudine e dell’amore mendace per la quale la amiamo.

Alda Merini
Bur Rizzoli, pp. 780, € 20
Il nuoto come metafora di libertà e di padronanza del proprio corpo. Una crepa sul fondo della piscina, come spia di una ferita destinata ad allargarsi, a far sanguinare la pelle, a produrre un danno irreparabile. In mezzo il tenerissimo rapporto tra una madre e una figlia che assiste al suo declino, alla progressiva smemoratezza, all’inversione di ruoli. Con l’acqua come elemento unificante: liquido puro, simbolo di rinascita e di purificazione. E di femminile.
“NUOTO
Julie Otsuka (trad. Silvia Pareschi)
Bollati Boringhieri, pp. 140, € 16

Territori devastati, fiumi inquinati, popolazioni malate. L’attività estrattiva doveva sostenere il Pil, le multinazionali hanno razziato tutto
di Chiara Sgreccia foto di Alessandro Cinque
Da lontano, Alto Huancané sembra una città fanta sma. Le case costruite con un impasto fatto d’argilla, sabbia e paglia si sgretolano quando il vento tira forte. Dentro, gli abitan ti della piccola comunità contadina nella provincia di Espinar, in Perù, dormono sulle pelli di pecora o alpa ca che coprono il pavimento di terra battuta. A pochi chilometri sorge la miniera di Tintaya. Un’enorme vora gine che spacca il terreno da cui si estraeva rame fino al 2011.
Quando l’attività è cominciata, nel 1980, gli abitanti avevano pensato che fosse una buona notizia. La mi niera apparteneva allo Stato peruvia no e doveva portare sviluppo, soldi e garantire nuove possibilità di crescita e istruzione anche a chi vive nella mi riade di piccole comunità che puntel lano la cordigliera delle Ande, accan to al sito. Ma così non è stato. Sebbe ne Tintaya sia diventato, in pochi an ni, il terzo polo del Paese per l’estrazione di rame.
Nel 1994, con il periodo delle priva tizzazioni reso possibile dalla Costi tuzione,ancoravigente,volutadall’ex dittatore Alberto Fujimori, la miniera è stata acquisita da un consorzio americano, che poi è stato assorbito da un’azienda più grande che si è fusa con un’altra società, che è stata rileva ta da una nuova compagnia. Oggi la miniera è di proprietà della multina zionale svizzera Glencore. Che da quando Tintaya ha esaurito il suo po tenziale ha iniziato a gestire un nuo vo sito estrattivo: Antapaccay. Di stante solo pochi chilometri dalla prima voragine e dalle piccole comu nità contadine dove vivono per la maggior parte autoctoni.
Così nella provincia di Espinar l’at tività mineraria prosegue da oltre 40 anni. Ha devastato l’area e l’ha tra sformata in una prova dell’impatto che l’estrazione di materiali dal sotto suolo genera su persone e ambiente, soprattutto quando è scarsamente regolamentata. A meno di cinquecen to chilometri da Cusco, la storica ca pitale dell’Impero Inca, celebre at

trazione per turisti che arrivano da tutto il mondo, patrimonio dell’u manità secondo l’Unesco.
«Penso che l’estrazione mineraria sia l’attività che sta facendo più danni al nostro pianeta. Sta distruggendo le sorgenti d’acqua, inquinando i fiumi, uccidendo la gente. Per me è il peg giore genocidio che ci sia mai stato», spiega Vidal Merma, attivista, giorna lista peruviano nato e cresciuto nei dintorni di Yauri, il capoluogo della provincia di Espinar. «Quando l’im presa mineraria è arrivata ci aveva promesso nuovi posti di lavoro, nuo ve opportunità di studio. Sono passati più di quarant’anni e non abbiamo neanche l’acqua». Infatti, a Yauri l’ac qua potabile arriva solo per un paio d’ore al giorno, mentre chi vive nelle campagne continua a utilizzare quel la dei fiumi che, da quando si è inten sificata l’estrazione dei minerali, è in quinata.

Un danno collaterale dovuto alle ingenti quantità d’ac qua di cui le miniere hanno bisogno per raffreddare i si stemi e lavorare i minerali per prepa rarli all’esportazione che avviene at traverso il corridoio minerario, quasi cinquecento chilometri di strada che taglia il Perù. Collega i principali si ti estrattivi del Paese dalla regione di Apurimac, al porto di Matarani, a Sud, da cui migliaia di tonnellate di rame, oro, argento e altri minerali partono per Europa e Asia.
Secondo l’organizzazione Human rights without borders, nel 2012 la produzione di rame nella miniera di Antapaccay è stata di oltre 51 mila tonnellate. Nel 2018 è salita a più di duecentomila. Nel 2016 Glencore avrebbe ricavato più di 3 miliardi dal le vendite dei minerali estratti dalla miniera. Eppure, i benefici per le po polazioni locali sono stati minimi. Per alcuni inesistenti. Per tanti altri le condizioni di vita sono peggiorate.

«I nostri animali muoiono. E le per sone si ammalano misteriosamente. Come se una nuova e sconosciuta piaga stesse colpendo solo chi vive
qui. Ma in realtà questa malattia ha un nome, è il cancro. Ha ucciso tanti miei compaesani. Ed è una conse guenza dell’intossicazione da metalli pesanti», dice Merma. Più studi, co me quello del Censopas, Centro na zionale per la salute sul lavoro e la protezione ambientale, del ministero della Salute, hanno dimostrato la pre senza di piombo, arsenico, mercurio e di altre sostanze dannose nel san
gue e nelle urine delle persone che vivono in prossimità della miniera.
Come spiega Gloria Gabriel Carde nas Alarcon, chirurga dell’ospedale Espinar: «Il danno dell’intossicazione da metalli pesanti è incommensurabi le. Ci sono analisi che dimostrano che l’acqua dei fiumi è contaminata. Ed è l’acqua che utilizziamo tutti. Anche l’a ria qui è contaminata. C’è una relazio ne molto forte tra i casi di danno neu
Un altro scorcio delle dighe di scarico della miniera di Espinar rologico ai tessuti, alle cellule, e la pre senza di metalli nel sangue delle per sone. Si tratta di un avvelenamento lento che dà origine a malattie endo crine, è associato al diabete, al cancro, a problemi di tiroide e di sviluppo mentale, alla leucemia». Ma nessuna istituzione ha mai certificato la corre lazione tra acqua e terre contaminate, la salute della popolazione e l’attività mineraria. Per questo le imprese con
tinuano a lavorare senza farsi carico delle responsabilità. «Guadagnando sulle spalle di chi vive vicino ai siti estrattivi», aggiunge Merma.
Nella provincia di Espinar, secondo la mappa dell’Isti tuto di statistica peruvia no, tra il 24 e il 38 per cen to della popolazione è sotto la soglia di povertà. Cinque bambini su dieci

soffrono di anemia. È tra le aree del Paese in cui più persone hanno una cattiva alimentazione. Infatti, sebbe ne l’attività mineraria sia vista come un generatore di reddito perché con tribuisce alla crescita del Pil, è anche un settore che crea conflitti sociali e incide sul modo di vivere, sugli usi e sui costumi delle comunità. Così mentre Lima, la capitale, e le altre grandi città del Perù crescono, le co munità contadine si spopolano. E se prima vivevano di agricoltura e alle vamento oggi rimangono senza risor se, con le sorgenti d’acqua inquinate, i campi aridi e il bestiame decimato. Anche perché non esiste un piano di sviluppo organico per l’intero Paese, non ci sono progetti municipali o sta tali pensati a vantaggio delle popola zioni delle aree accanto alle miniere, come Espinar. E poi c’è il problema della corruzione: l’uso improprio del le risorse pubbliche che perpetua la povertà.
«L’estrazione mineraria mette a ri schio i diritti delle persone e dell’am biente», spiega Rocio Silva-Santiste ban, ex deputata peruviana, avvoca tessa per i diritti umani, specializzata nella difesa delle donne vittime di violenza durante i conflitti sociali: «L’arrivo della miniera stravolge completamente la vita delle comuni tà. È una forma di violenza da parte dello Stato, che porta alla criminaliz zazione della protesta sociale. Il grandissimo potere economico degli imprenditori permette la violazione dei diritti delle popolazioni indigene. Che sono le legittime proprietarie delle terre ma non di quanto c’è sot to. Ecco perché lo Stato dà le conces sioni alle compagnie minerarie che in una prima fase di esplorazione do vrebbero quantificare l’impatto am bientale e dovrebbero consultarsi con gli abitanti della zona. Ci sono leggi che impongono queste proce dure. Il problema è che non vengono rispettate». Come aggiunge Merma, infatti, «molto spesso il processo di istallazione di una miniera non av viene con trasparenza. Gli imprendi tori fanno promesse che non man

tengono e ingannano la popola zione. Per fortuna la conoscenza di quanto è avvenuto in altri territori, come a Espinar, sta portando sempre più comunità a prendere coscienza dei rischi della miniera. E ci sono progetti che vengono bloccati dalla lotta della popolazione per difendere il territorio come Tia Maria, nella re gione di Arequipa».
Ma l’incremento esponenziale dell’estrazione non regolamentata non è una piaga che affligge solo il Perù. Come si capisce dal documen tario “Il prezzo della terra”, realizzato dal fotografo Alessandro Cinque e dal videomaker Giorgio Ghiotto in Perù, Bolivia ed Ecuador per WeWorld, on lus impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 27 Paesi nel mondo, le storie di chi vive sulla propria pelle i devastanti

impatti ambientali, sociali, economi ci e di genere arrivano da tutta l’Ame rica Latina. Nella maggior parte sono conseguenza dell’attività di imprese straniere, il cui obiettivo è il profitto a scapito del rispetto dei territori in cui operano. Causando danni che colpi scono l’intero pianeta, che dal locale si riflettono sul benessere globale. «Le aziende dovrebbero farsi carico delle responsabilità sociali che deri vano dalla loro attività», conclude Merma.
Proprio affinché accada, lo scorso febbraio la Commis sione europea ha proposto la Direttiva sulla “Due dili gence”. Secondo cui le aziende sono legalmente responsabili delle con seguenze del loro operato e devono garantire accesso alla giustizia alle
vittime degli abusi. Mappare i rischi su ambiente e diritti umani, prevenire gli impatti negativi e definire le misu re di rimedio non saranno più scelte ma obblighi che le aziende dovranno rispettare. Sebbene la Direttiva con tenga alcuni punti critici che limita no la sua capacità effettiva di tutelare ambiente e persone, si tratta di un passo importante per dare vita a un’e conomia più sostenibile e per rende re i consumatori consapevoli. Anche per questo è stato realizzato il docu mentario “Il prezzo della Terra”, pre sentato in anteprima al festival “Terra di Tutti” lo scorso ottobre a Bologna, per sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale su quanto accade in aree remote del mondo, spesso dimentica te. Perché la conoscenza sia strumen to di miglioramento sociale.









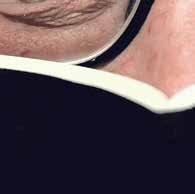




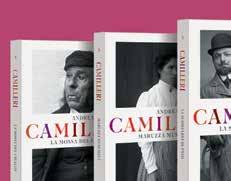
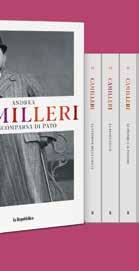


Il loro habitat è il Parco dell’Aveto ma si spingono a ridosso dei paesi. L’ok della Regione alla cattura di sette esemplari fa insorgere gli ambientalisti
di Massimiliano Salvoinverno è più facile in contrarli, perché, quando la tramontana trasforma i crinali in lande gelate, loro scendono a valle. D’estate è più dura, perché si arrampicano al fresco in cima ai monti, su radure disabitate. Ma questa regola non è infallibile: per ché tra i cavalli selvaggi della Liguria, un centinaio di bestie che popolano i monti intorno al Parco dell’Aveto, al cuni esemplari si avvicinano sempre più spesso ai paesi nell’entroterra di Chiavari. Un’emozione per chi si spinge in questa zona remota della provincia di Genova, una fatica per chi in questa zona vive e si ritrova i cavalli nell’orto o in mezzo alla stra da. Dopo anni di proteste degenerate nel bracconaggio, liti tra compaesani e ombre di macellazioni clandestine, la situazione si era tranquillizzata. Ma la tensione è tornata alle stelle: a fine ottobre sette animali sono stati catturati con l’ok della Regione Ligu ria, per essere trasferiti. Gli animalisti sono insorti, i naturalisti pure. E così i cavalli sono stati nuovamente liberati, spezzando la valle tra chi esulta e chi è inferocito.
«Sono una meraviglia», «levano il fiato», «sembrano un sogno», ripeto no gli amanti della natura, gli escur sionisti e le famiglie che salgono al Lago di Giacopiane, mille metri sul li vello del mare, dove è facile avvistare i branchi che si abbeverano, brucano
sui pendii e si rincorrono sui prati. Un tipo di poesia non gradita a molti abi tanti di Borzonasca, paesone con ca se a ridosso dei boschi da cui spunta no gli equini più avventurieri. «Questi cavalli sono amati da chi vive in città, viene qui per fare le foto e poi se ne torna a casa», sbotta Davide Gazzolo, che ha messo in piedi un comitato per chiedere che i cavalli vengano recin tati sopra al Lago di Giacopiane. «Mi ca vogliamo mandarli al macello», assicura. «Ma qui c’è chi vuol fare pas sare dei cavalli bardigiani come fosse ro selvaggi cavalli del Wyoming, quando sappiamo tutti bene da dove arrivano».
I cavalli selvaggi dell’Aveto hanno infatti un nome che sa di leggenda, ma in realtà sono una storia recente. A Borzonasca in tanti ricordano “Giò”, quel signore che ogni estate, come tanti altri, lasciava le sue bestie libere di pascolare alle pendici del Monte Aiona.Neglianni’90Giòdivennetrop po anziano e i suoi cavalli rimasero in cima al monte. Quando comparirono i primi branchi in valle Sturla e val Pen na, l’entusiasmo durò poco: nel 2009 due cavalli furono ammazzati a fucila te. Le amministrazioni decisero così di dare gli esemplari liberi in adozio ne, ma molti di loro dopo la cattura morirono e il progetto fallì. All’allora presidente ligure della Federazione italiana turismo equestre, Paola Mari nari, venne un’intuizione: per i ca

valli e il territorio poteva esserci un futuro di turismo sostenibile.

Con il supporto della naturalista ge novese Evelina Isola sono così nate le escursioni di osservazione e monito raggio dei branchi, affiancate alla ri cerca su habitat e biodiversità. «Avere dei cavalli inselvatichiti consente di studiare i loro comportamenti come animali “selvatici” e non destinati al lavoro con l’uomo», spiega la naturali sta Isola, che con il progetto “Wild Horse Watching – I Cavalli Selvaggi dell’Aveto” dell’associazione ReWild Liguria ha attirato quasi duemila visi tatori in dieci anni. Il cavallo che co nosciamo è infatti il cavallo domesti co, addomesticato dall’uomo tra il diecimila e il cinquemila a.C., il caval lo selvatico è invece scomparso: l’ulti ma specie - il tarpan o cavallo euroa siatico – si è estinto in uno zoo nel 1918. «I cavalli inselvatichiti, spesso chiamati “selvaggi” – continua Isola –sono invece cavalli che vivono da po
che generazioni in natura senza con tatti con l’uomo, i cui antenati erano cavalli domestici».
Nella zona dell’Aveto, in un territorio di 33km quadra ti, i ricercatori delle Uni versità di Genova e Parma calcolano un centinaio di cavalli di visi in 11 branchi, che hanno attirato interesse accademico in vari campi. Da qui è nato un progetto dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Ligu ria-Piemonte-Valle d’Aosta. «Le po polazioni note di cavalli inselvatichiti sono pochissime, esistono in Polonia, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti. Il cavallo è un bene economico eovviamentenonvienelasciatofuggi re», spiega il professor Marco Genchi, docente di Parassitologia e malattie parassitarie dell’Università di Parma. «Quelli dell’Aveto sono qualcosa di unico: per questo sono interessantis simi da studiare».
In questi monti disseminati di cac ciatori c’è però scetticismo sulla loro valenza scientifica, e bastano due chiacchiere nei bar per rendersi conto di come molti risolverebbero il pro blema: con le bestie trasformate in bi stecche. Dopo anni di lamentele rivol te al sindaco di Borzonasca, a fine ot tobre sette cavalli sono stati catturati dal Comune con l’autorità sanitaria locale. «Poco hanno questi cavalli di selvaggio», ha spiegato il vicepresi dente della Regione Liguria, Alessan dro Piana, per cui quella dozzina di cavalli abituati a vagare tra le case e sulle strade senza paura dell’uomo «rappresentano un costante pericolo per l’incolumità pubblica». La pensa così anche Andrea Marsan, biologo della fauna selvatica, a lungo docente dell’Università di Genova. «Il proble ma è che ormai trattiamo il cavallo come fosse sacro, dimenticandoci che è un animale domestico destinato al lavoro o al macello».
E forse è anche per questo che non è stato possibile per la Regione tra sferire i sette cavalli a un allevatore in alta quota, pur con l’accordo che non venissero macellati. Si è scatenato il putiferio con la mobilitazione lancia ta da ReWild Liguria, supportata da un variegato mondo animalista che dall’associazione Meta Parma è arri vato alla deputata Michela Vittoria Brambilla. La Regione ha così cam biato idea: i cavalli sono stati micro chippati e liberati nel Parco dell’Ave to, con la promessa del presidente Giovanni Toti di trovare le risorse per «garantire la gestione, il manteni mento, il monitoraggio e anche la va lorizzazione dei cavalli dell’Aveto co me elemento di attrazione turistica e di biodiversità».
L’intervento regionale è necessario poiché i cavalli sono considerati «ani mali da reddito agricolo», ma quelli dell’Aveto non avendo un proprietario risultano vaganti e quindi i costi rica
dono sui sindaci. Non possono essere considerati patrimonio dello Stato (come i cinghiali, i cui costi ricadono sulle Regioni) perché non sono fauna selvatica: lo status di animale dome stico inselvatichito li pone tra le due categorie. «Ogni volta che un’auto in veste un cavallo tocca a me chiamare il veterinario e pagare lo smaltimento della carcassa», conferma Giuseppe Maschio, sindaco di Borzonasca. «E gli abitanti sono esasperati perché de vono pagare di tasca loro perdite e danni». È quello che ripete Patrizia Ferretti, 65 anni, che nella sua casa a ridosso del bosco in località Perlezzi si ritrova i cavalli in giardino. «Distrug gono i funghi, mangiano le castagne e le piantine delle faggete».

Questi problemi sono noti all’associazione ReWild Li guria, che a Borzonasca ha creato una rete di ristorato ri frequentati dagli escursionisti ma
deve fare i conti con la frangia più intransigente di abitanti, che l’accusa «di inventarsi l’inselvatichimento» delle bestie per organizzare le escur sioni. «I cavalli non devono certo stare in strada», ripete la naturalista Eveli na Isola, che preme da tempo affinché lo status dei cavalli sia regolamenta to e si è resa disponibile ad aiutare le amministrazioni nel trasferimento ad alta quota dei cavalli che scendono tra le case. «Ci sentiamo ripetere che i ca valli selvaggi dell’Aveto sono animali domestici, ma negare la loro esistenza non risolve il problema», spiega Isola. «Bisogna guardare la realtà, gli ultimi cavalli selvaggi in Europa risalgono alle pitture rupestri. Dopo millenni nella zona dell’Aveto si sono ricreate le condizioni affinché alcuni branchi vi vano liberi in natura. Sono una risorsa per la montagna, un patrimonio uni co. Per questo li dobbiamo studiare e difendere».
Un ambulante dei Caminanti prepara uno dei palloncini in vista di una fiera. A destra, una donna della comunità
Hanno una rigida organizzazione e rifiutano di essere assimilati ad altri nomadi. Vendono palloncini nelle fiere di paese. Una fotografa ha vissuto con loro. E ne ha documentato vita, diffidenze e discriminazioni di Salvatore Di Mauro foto di Arianna Todisco

Un progetto foto-antropologi co, l’espressione dell’effime ra libertà della comunità no made dei Caminanti di Noto. Ephemeral freedom è l’esperimento socio-culturale della giovane fotografa pugliese Arianna Todisco che ha de ciso di intraprendere un’avventura di quattro mesi, trasferendosi presso una famiglia di girovaghi per vivere ogni istante alla loro maniera. Una quoti dianità poco raccontata da immorta lare con una serie di fotografie schiette e spontanee, volte a cogliere la parte sensibile degli “invisibili” nomadi sici liani, considerati gli unici continuatori di un’antica tradizione fondata ancora

sulla parola, la presenza di un capo gruppo anziano e matrimoni stabiliti all’interno del clan, anche tra cugini primi. «Sbarcati in Sicilia alla fine del Trecento, al seguito dei profughi Arbe res’h, i Caminanti netini sono caratte rizzati da una costante malinconia e instabilità», spiega Arianna Todisco che ha vissuto in prima persona la dif ficoltà di questo popolo di 2500 perso ne di amalgamarsi con i siciliani stan ziali. I Caminanti rifiutano di essere assimilati ad altre popolazioni nomadi e provano a scrollarsi di dosso il pre giudizio. Che resiste, nonostante tutto e si trasforma in una segregazione di fatto. «Il loro nome deriva dal termine
siciliano “camminanti o camminato ri”, ma non ci sono documenti etno grafici che parlano effettivamente di questo popolo. Questi “siciliani erran ti” sono gli ultimi eredi di una cultura basata sul movimento, ma rimangono “siciliani” in ogni gesto: dal culto della campagna all’abito di panno “buono” indossato per la messa domenicale, fi no al modo di cucinare e disossare gli animali o alla gestualità, tipica di chi ha conosciuto l’alternanza di domina zioni diverse e che trova nel segno un formidabile strumento di comunica zione. Un mimetismo colorato che de riva dalla loro essenza errante», spiega Arianna Todisco. Ancora oggi la
professione che caratterizza i Ca minanti è quella di venditori di pallon cini, quasi dei “commercianti” ambu lanti di gioia per i bambini. «Quando ero piccola e vivevo in Puglia, durante le feste patronali il corso centrale di Barletta era pieno di questi venditori di palloncini. Mio papà me ne compra va sempre uno; ricordo i sorrisi di quei venditori stranieri e la diffidenza degli adulti nei loro confronti. Da lì è nato il desiderio di partire per incontrarli», ricorda Arianna Todisco, che ha deci so di porre ad icona del suo progetto proprio il palloncino. «Inizialmente, durante il mio viaggio alla scoperta di questo popolo, ho alloggiato in un b&b di Noto per chiedere informazioni e trovarli». Ephemeral freedom si è tra sformato subito in un viaggio alla sco perta di una nuova cultura, un mezzo istantaneo per raffigurare la verità di questo popolo. «Dapprima, facendo le mie ricerche ho scoperto che i Ca minanti sono stati riconosciuti come cittadini di Noto a partire dagli anni ’80 e uno dei primi sindaci di quegli anni faceva parte della loro comunità, veicolando il riconoscimento di mol ti loro diritti. A Noto però non è stato semplice trovare una guida che cono scesse i loro costumi, poiché i netini non vogliono avere molto a che fare con questi girovaghi. Così ho improv visato,chiedendoailocaliseconosces sero una famiglia di Caminanti».



Nell’elegante cittadina, patria del barocco, c’è un princi pio di coesistenza e intesa che lega questa comunità ai locali, ma non di integrazione. Do po non poche difficoltà, finalmente, Arianna ha localizzato una comunità vicina e senza ripensamenti ha bussa to alla porta di una di quelle famiglie, raccontando loro il motivo della sua visita, ovvero il desiderio di documen tare dal vivo la loro quotidianità. I ca minanti hanno accolto la sua richiesta e permesso ad Ephemeral freedom di veicolare la loro voce, in una missione per esaltare l’aspetto di un’esistenza vissuta da sempre in un limbo, soste nuta da una propensione a spostarsi
di continuo e mostrando a tutti la dura realtà di un popolo emarginato. Quella dei caminanti è una situazione para dossale, di chi oscilla tra una tensione al viaggio e la tragicità di una realtà fissa che li emargina, eppure non si scompone di fronte alla loro presen za. La famiglia di caminanti scelta da Arianna, l’ha subito accettata con grande entusiasmo, raccontandole molti episodi di discriminazione di cui il gruppo è costantemente oggetto, nonostante sia riconosciuto a livello burocratico. I più piccoli che frequen tano ancora la scuola, sono spesso vit time di isolamento e bullismo e nella maggioranza dei casi, i genitori, a loro
volta analfabeti, decidono di lasciare i figli a casa, privandoli della possi bilità di completare gli studi, senza ascoltare le loro aspirazioni, ma indi rizzandoli piuttosto a svolgere il loro mestiere senza formazione scolastica. «Si diventa consapevoli di che realtà si tratti, soltanto una volta entrati in contatto con loro. Nella famiglia con cui ho vissuto, la mamma e i suoi figli risentivano molto della discriminazio ne locale, nonostante si trattasse di un gruppo ormai stanziale, che lavora a Noto da molti anni», prosegue. La giovane fotografa ha condiviso anche alcuni gesti essenziali, come la vendita nelle fiere con le bancarelle, la siesta
Uno degli stand con i palloncini. Il commercio ambulante è l’unica fonte di reddito della comunità. Sotto, un gruppo di giovani e, a destra, mamma e figlia si dirigono verso l’accampamento dove abitanopomeridiana o i viaggi in gruppo fuori porta con i loro furgoni camperizzati. In mezzo a racconti carichi di malin conia e rassegnazione, ci sono stati an che molti episodi divertenti di chi è ca pace di gioire soprattutto per le piccole cose. «Un momento buffo del mio sog giorno è stato quando una volta andai al mare con una parte della comunità e per rispetto decisi di fare il bagno con il vestito lungo. Nonostante fossi com pletamente coperta, presi ugualmente un’insolazione, rimanendo due giorni a letto. In quell’occasione, tutto il grup po si preoccupò per me, prendendomi anche un po’ in giro». Dopo qualche settimana insieme ai nomadi, Arianna
è riuscita a trovare una chiave di let tura che potesse bene rappresentarli, innalzando ad icona proprio il pallon cino che incarna perfettamente la loro condizione, un misto di spensieratezza e malinconia. «Quella dei caminanti è un’identità fratturata e scomposta, che oscilla tra l’ideale di una vita nomade e il desiderio delle nuove generazioni di rimanere legati ad un territorio, al quale alla fine non sentono ancora di appartenere», conferma Arianna. Sen sazioni simili a quelle provate da un bambino quando perde il palloncino appena acquistato, che per la sua inna ta volatilità cerca prepotentemente di staccarsi dal filo attaccato al polso per

vagare verso altri luoghi. «Prima erano giocattolai, arrotini, stagnini, uomini e donne di fiducia, poi sono diventati venditori di palloncini, venendo inevi tabilmente associati soltanto a quella determinata professione. Vivendo con loro si è creato un legame fortissimo e familiare».
Durante la permanenza ci sono stati anche alcuni mo menti difficili, conseguenza del naturale scetticismo di chi non si sente ben visto dagli altri. «I caminanti non accettano facilmen te gli estranei, perché si tratta di una rigida organizzazione. Sono un’unica e grande famiglia, ma credo abbiano capito la sincerità con la quale vole vo documentare la loro quotidianità e l’abbiano apprezzata. Dopo avermi conosciuta sono sempre stati protetti vi, gentili e ospitali con me», racconta Arianna Todisco. Inoltre, in seguito alla pandemia, anche il loro carattere tipicamente errante è cambiato, cre scendo al contrario il desiderio di ri manere fermi in un luogo che li facesse sentire totalmente integrati, pur man tenendo intatte le antiche tradizioni. La freschezza di un’esperienza di vita si è così materializzata in un libro di fotografie, ma per Arianna il passo suc cessivo sarà l’esplorazione delle radici Arberes’h dei caminanti in Italia e la ri costruzione della loro storia: un nuovo progetto sostenibile sulla piattaforma di crowdfunding SelfSelf, che supporta i fotografi emergenti. Ephemeral free dom è stata un’avventura doppiamente proficua, poiché ha arricchito Arian na, come artista e donna, ma anche gli stessi caminanti che hanno avuto la possibilità di alzare la voce, senza essere giudicati, per riconquistare una piccola parte di quella considerazione cercata nel tempo e ritrovare un’iden tità soffocata, quale espressione di una cultura che non merita di scomparire. «Prima di andare via, ho fatto loro una promessa, ovvero che avrei donato il li bro fotografico che li racconta a scuole e biblioteche ed è un impegno che vo glio portare avanti».


The Crown 5: il capolavoro intoccabile di Netflix si trasforma in effetto già visto. Come spiare i Ferragnez

Vorrei essere il tuo Tampax..., è una di quelle frasi che se ti vengono una volta nella vita e, puta caso, fai lo sceneggiatore, sai per certo che ci puoi costruire intor no un’intera serie tv con cui campare serenamente di rendita. Peccato che la farina sia stata pescata nel sacco delle intercettazioni tra Carlo d’In ghilterra (all’epoca solo principe) e
la sua spettinata Camilla (oggi qua si regina consorte). E ha fatto il giro dell’intero globo. In buona sintesi il problema della quinta stagione di “The Crown” (Netflix), capolavoro sin qui intoccabile, si riassume così. È tutto talmente detto, sentito, letto, ripetuto a memoria che quella son tuosa sensazione di entrare in punta di piedi nei corridoi del regno, che aveva accompagnato negli anni lo spettatore plaudente, scompare di colpo. Un po’ come se, per fare un esempio nostrano, si chiedesse a una storia di Instagram di rivelare aspetti inediti della vita familiare di Fedez e Ferragni. Così per dieci lunghissimi episodi, tra tradizione e modernità,
senso del dovere portato allo stremo, monarchia in crisi e sprazzi di futuro, si trascina la fine infausta del matri monio tra Carlo e Diana. Un naufra gio di cui si conoscono a menadito i dettagli, dall’abito nero della vendet taallafamigerataintervistatelevisiva Bbc, dove l’unico aspetto inaspettato sono le scelte discutibili del nuovo cast. Lady D è imprigionata dentro all’espressione immota di Elizabeth Debicki, un’altezza spropositata per una sola espressio ne ai limiti della carica tura (come gli imitatori da villaggio vacanza che ancora pensano di far ridere con l’intona zione di Beppe Grillo comico). Mentre Carlo è posseduto dalla fisi cità sensualissima di Dominic West che, con rispetto parlando, non è la prima caratteristica che si coglie pensando al futuro re. Nel mezzo, a sprazzi, la sontuosa Imelda Stauton, una queen più Li libet che Elisabeth dai tratti umani, qualche lacrima sfuggita di troppo e un cappellino ben saldo sul capo, che prova in qualche modo a riportare il racconto al di là del chiacchiericcio scandalistico. Ma gli anni Novanta sono lì dietro l’angolo, troppo vissuti per essere già dimenticati. E quel pia cere indomito dello sguardo sul pri vilegio inarrivabile, le porcellane, gli snodi politici, da Churchill alla Tha tcher che avevano così intrigato le stagioniprecedenti,siperdonoinuna tazza di tè, precipitando in quel filo di noia che rende, checché se ne dica, le famiglie infelici tutte uguali.
Ma davvero, come auspicano gli organizzatori, il tormentone dell’inverno sarà “Hayya hayya”, la sigla dei mondiali di calcio in Qatar che ascolteremo a partire da oggi? Per realizzarlo ci si sono messi in tre, tali Trinidad Cardona, Davido e Aisha, e il significato occidentale del titolo è “better together”, insieme è meglio, ma il pezzo è decisamente bruttino, una tamarrata da stadio piccina piccina, che ci spiega come talvolta non sia affatto vero che “insieme è meglio”, anzi. Non che da una sigla ufficiale ci si aspetti una sonata di Clementi o un pezzo di De André, è vero, ma qualcosa di meglio si poteva fare, di certo non mancava il necessario budget, visto che la motivazione economica continua a sembrare l’unica ragione per cui sia finità lì la più amata delle manifestazioni di calcio. Ricordiamo alcuni precedenti: Nannini/Bennato, Shakira, Vangelis, Santana, Ennio Morricone, Placido Domingo, tanto per citarne alcuni a caso. Sono pur sempre i mondiali di calcio. Oppure no? A molti la scelta di organizzare il campionato d’inverno, e in Qatar, è sembrata a dir poco singolare, un po’ come organizzare le Olimpiadi invernali a Essaouira o il campionato mondiale di scacchi a Piccadilly Circus, generando alcune inevitabili domande del tipo: in Qatar hanno mai giocato a pallone? La risposta è sì, ma non tanto, e infatti la nazionale di calcio del Qatar non ha mai partecipato a un Mondiale in vita sua, appare per la prima volta quest’anno in quanto Paese organizzatore, che è come dire «il pallone lo porto io», per essere sicuri di giocare. Ma al di là della sigla Hayya hayya, la musica, va detto, si è distinta ancora una volta per aver preso

le distanze da una manifestazione così discutibile, seguendo una ineccepibile logica. Rod Stewart ha rivelato di aver rifiutato un ingaggio di un milione di dollari, perché non gli sembrava il caso di andare a cantare in un Paese dove non si rispettano i diritti civili, e lo ha deciso probabilmente dopo aver sentito l’ambasciatore qatarese dei Mondiali il quale in Germania si è lasciato scappare in una trasmissione televisiva che l’omosessualità è una malattia mentale. Di sicuro Rod Stewart non andrà fallito per questa scelta, ma è comunque un bel gesto. Ancora più netta è stata Dua Lipa, che molte voci davano per certo alla cerimonia d’inaugurazione. Dua Lipa si è dichiarata addirittura sdegnata solo al pensiero che qualcuno avesse potuto immaginare che lei partecipasse a tale infamia. Pensassero a rispettare gli impegni per diritti civili, e poi forse visiterò il Paese, ha detto la regina. Anche Fiorello si è espresso duramente contro la scellerata scelta, sostenendo che Dua Lipa ha dato ascolto al suo appello, ma sarà interessante vedere chi invece sarà lì in Qatar in prima fila a cantare per questi campionati. L’inno è “Hayya hayya”, e si comincia malissimo.

Una ricognizione pietosa e spietata dei lati oscuri del presente. Il film da non perdere dei fratelli Dardenne
In questi tempi assuefatti allo sper pero i fratelli Dardenne praticano un’arte rara: quella della concen trazione. Dove altri aggiungerebbero una scena, loro asciugano e com primono. Dove molti vorrebbero un dialogo, a loro basta uno sguardo. Se la norma prevede una spiegazione, meglio limitarsi a un’allusione. Eppure nei loro film nitidi come cristalli tutto è così chiaro e incalzan te che non si vorrebbe svelarne nemmeno un fotogramma. Lasciando allo spettatore l’affanno e il piacere (parados sale) di scoprire da sé questa nuova puntata all’inferno.
Rovesciando il motto di Calvino («Cercare e sa per riconoscere chi e co sa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo du rare, e dargli spazio»), i due registi belgi condu cono infatti dai tempi de “La promessa”, 1996, una ricognizione pieto sa e insieme spietata dei lati più oscu ri del presente. Mettendo sempre al centro i personaggi e la loro lotta per la sopravvivenza, sicché sentimenti e psicologie affiorano dai fatti, non vice versa. Ed ecco Tori e Lokita, lui 10 an ni, lei 16, due migranti africani che co me capiremo sono approdati in Belgio via Italia e hanno una sola speranza di farcela. Passare per fratelli, di modo che pure lei ottenga i documenti con cessi a lui in quanto bambino-strego ne minacciato in patria.

Altro non diremo, anche perché qui il “plot” conta solo per come prende forma, scaturendo da una rigorosa sequenza di fatti. Fra trafficanti di droga e di esseri umani, chiese usate
come luoghi segreti d’incontro, e mol to altro, ogni scena aggiunge dunque un’informazione (e un’emozione) al le game struggente che unisce questi due ragazzini, capaci di cantare “Alla Fiera dell’Est” in un ristorante con voci da usignolo, e un attimo dopo di vendersi o spacciare. Ogni inquadratura rivela e nasconde, perché il voyeurismo è in agguato e davanti all’orrore lo sguar
do non può che ritrarsi. Mentre ogni primo piano, soprattutto di Lokita, riporta il cinema di questi due grandi ritrattisti verso gli scritti di Lévinas sulla profondità inesauribile del volto umano. Coniugati a un senso del rit mo, dell’azione, del movimento (fisico e affettivo) che fanno di “Tori e Lokita” anche un atipico, moralissimo, stra ziante anti-thriller calato come una sonda nelle viscere dell’Europa. In sa la dal 24. E c’è pure chi dice che fanno sempre lo stesso film.
“TORI E LOKITA” di Jean-Pierre e Luc Dardenne Belgio, 88’, dal 24 novembre aaaab
CAPOREDATTORI CENTRALI: Leopoldo Fabiani (responsabile), Enrico Bellavia (vicario)
UFFICIO CENTRALE: Beatrice Dondi (vicecaporedattrice), Sabina Minardi (vicecaporedattrice), Anna Dichiarante
REDAZIONE: Federica Bianchi, Paolo Biondani (inviato), Angiola Codacci-Pisanelli (caposervizio), Emanuele Coen (vicecaposervizio), Antonio Fraschilla, Vittorio Malagutti (inviato), Antonia Matarrese, Mauro Munafò (caposervizio web), Gloria Riva, Carlo Tecce (inviato), Gianfrancesco Turano (inviato), Susanna Turco
ART DIRECTOR: Stefano Cipolla (caporedattore)
UFFICIO GRAFICO: Martina Cozzi (caposervizio), Alessio Melandri, Emiliano Rapiti (collaboratore)
PHOTOEDITOR: Tiziana Faraoni (vicecaporedattrice)
RICERCA FOTOGRAFICA: Giorgia Coccia, Mauro Pelella, Elena Turrini
SEGRETERIA DI REDAZIONE: Valeria Esposito (coordinamento), Sante Calvaresi, Rosangela D’Onofrio
CONTROLLO DI QUALITÀ: Fausto Raso
OPINIONI: Barbara Alberti, Altan, Mauro Biani, Massimo Cacciari, Lucio Caracciolo, Franco Corleone, Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Luciano Floridi, Bernard Guetta, Sandro Magister, Marco Dambrosio Makkox, Bruno Manfellotto, Ignazio Marino, Ezio Mauro, Michela Murgia, Denise Pardo, Massimo Riva, Pier Aldo Rovatti, Giorgio Ruffolo, Michele Serra, Raffaele Simone, Bernardo Valli, Gianni Vattimo, Sofia Ventura, Luigi Vicinanza, Luigi Zoja
COLLABORATORI: Simone Alliva, Erika Antonelli, Viola Ardone, Silvia Barbagallo, Giuliano Battiston, Marta Bellingreri, Marco Belpoliti, Caterina Bonvicini, Ivan Canu, Gino Castaldo, Giuseppe Catozzella, Manuela Cavalieri, Rita Cirio, Stefano Del Re, Alberto Dentice, Francesca De Sanctis, Cesare de Seta, Roberto Di Caro, Paolo Di Paolo, Fabio Ferzetti, Alberto Flores d’Arcais, Marcello Fois, Antonio Funiciello, Giuseppe Genna, Wlodek Goldkorn, Marco Grieco, Luciana Grosso, Helena Janeczek, Stefano Liberti, Claudio Lindner, Francesca Mannocchi, Gaia Manzini, Piero Melati, Luca Molinari, Donatella Mulvoni, Matteo Nucci, Eugenio Occorsio, Marco Pacini, Massimiliano Panarari, Gianni Perrelli, Simone Pieranni, Paola Pilati, Sabrina Pisu, Laura Pugno, Marisa Ranieri Panetta, Mario Ricciardi, Gigi Riva, Stefania Rossini, Evelina Santangelo, Elvira Seminara, Caterina Serra, Chiara Sgreccia, Francesca Sironi, Leo Sisti, Elena Testi, Chiara Valentini, Chiara Valerio, Stefano Vastano

PROGETTO GRAFICO: Stefano Cipolla e Daniele Zendroni
L’ESPRESSO MEDIA SRL
Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano P. IVA 12262740967 - Iscr. Reg. Imprese n. 12546800017 - N. REA MI - 2649954
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE: Denis Masetti
AMMINISTRATORE DELEGATO: Marco Forlani
DIRETTORE GENERALE: Mirko Bertucci
CONSIGLIERI: Maurizio Milan, Massimiliano Muneghina, Margherita Revelli Caracciolo, Alessandro Mauro Rossi
DIREZIONE E REDAZIONE ROMA: Via in Lucina, 17 - 00186 Roma - Tel. 06 86774111
E-mail: espresso@espressoedit.it
REDAZIONE DI MILANO: Via Luigi Galvani, 24 – 20124 Milano Registrazione Tribunale di Roma n. 4822 / 55 Un numero: € 4,00; copie arretrate il doppio
PUBBLICITÀ: BFC MEDIA SPA info@bfcmedia.com - Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano ABBONAMENTI: Tel. 0864 256266 - Fax 02 26681991

E-mail:abbonamenti@gedidistribuzione.it Per sottoscrizioni www.ilmioabbonamento.it Servizio grandi clienti: Tel. 0864 256266
DISTRIBUZIONE: GEDI Distribuzione S.p.A. - Via Nervesa, 21 - 20139 Milano Arretrati e prodotti multimediali: Tel. 0864 256266 - Fax 02 26688669 - arretrati@gedidistribuzione.it
STAMPA E ALLESTIMENTO: Stabilimento Effe Printing S.r.l. - località Miole Le Campore-Oricola (L’Aquila); Puntoweb (copertina) - via Variante di Cancelliera snc Ariccia (Rm).
Titolare trattamento dati (Reg. UE 2016/679): L’Espresso Media Srl - info@lespresso.it - Soggetto autorizzato al trattamento dati (Reg. UE 2016/679): Lirio Abbate
Cara Rossini, il fatto che Roberto Saviano sia chiamato a processo per rispondere delle accuse di diffamazione nei confronti della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, a mio parere la dice lunga sul tenore della classe politica che attualmente governa il Paese, ma anche di un popolo che di fronte a ciò avrebbe dovuto mobilitarsi. Qual è stata la colpa di Saviano? Quella di aver chiamato “bastardi” Giorgia Meloni e Matteo Salvini in tv nel 2020, riferendosi alla strumentalizzazione de strorsa dei flussi migratori e delle morti nel Mediterraneo. Cioè, di aver fatto una opposizione dura e imbastita con parole forti all’operato e all’i deologia di uno schieramento politico, colpendo i potenti che di questo modus operandi hanno fatto il proprio vessillo (e che, non dimentichia molo, sono responsabili delle sue conseguenze). Da quando, in uno Stato democratico, questo costituisce un reato? La libertà di parola si applica solo a un dissenso sussurrato in circoli che nessuno ascolta? Roberto Saviano è uno scrittore di fama mondiale. La sua voce non si può facil mente ignorare, ed è voce contro la destra italiana in maniera partigiana, polemica, senza sconti. Meloni e Salvini hanno il diritto di sentirsi insul tati da Saviano, gli elettori di destra hanno il diritto di non condividerne le posizioni. Ma nessuno ha il diritto di portare a processo uno scrittore per aver esternato le proprie opinioni. Specie in un Paese in cui le voci di destra,affiniallalineadell’attualegoverno,hannotuttiimezziperpropa gare la propria versione dei fatti. Gli attacchi e i contrattacchi d’opinione sono normali, non è normale che la presidente del Consiglio dei ministri chieda a un tribunale di condannare chi l’ha criticata. Fosse successo al trove, avremmo gridato allo scandalo. Invece in Italia uno che si è costru ito la carriera politica con nostalgie neofasciste e con l’omotransfobia, presiede in Senato, mentre una delle voci più eminenti dell’opposizione viene convocata in tribunale. Non è abbastanza per intravedere una chi na pericolosa, al cui termine stanno già Paesi come la Polonia e l’Unghe ria? Non è questo abbastanza, per avere paura? Simone Santini Paura no, signor Santini, semmai vigilanza affinché episodi come questo non passino inosservati, aiutando l’avvio di una gestione autoritaria del potere. Ma per ora non se ne vedono segnali credi bili, almeno se non si dà credito a dichiarazioni e a smargiassate senza costrutto dei tanti arrivati a governare senza un minimo di esercizio. Portare in tribunale un cittadino da cui ci si è sentiti of fesi, per un politico non è vietato: è ridicolo. Troppo facile dichia rarsi come tutti gli altri quando si incassa il consenso, rischioso continuare a fare la persona qualunque quando si è al comando di un Paese. Chi ha tutti gli strumenti di un ruolo egemone sa che non può più fingere di essere come tutti gli altri. E infatti Giorgia Meloni ha già fatto dichiarare ai suoi avvocati che valuterà il ritiro della querela mentre Salvini, a quanto se ne sa, andrà avanti a mu so duro. Due protagonisti di questa disgraziata stagione politica
non marciano all’unisono.


Gli antiabortisti dicono che l’aborto è un assassinio. Hanno ragione. Noi donne lo sappiamo bene. Ed è il più paradossale dei suicidi, la madre uccide sé. Sopprime il feto che è in lei, il germoglio, parte del suo corpo, non ancora bambino e già figlio. Essere tomba invece che culla. Non si guarisce dall’aborto. Se ne esce vive a metà. Portare un lutto segreto per sempre. Questo noi lo sappiamo. Nel millenario massacro dei nostri corpi, nel rimpianto che non dimentica. Solo le donne lo sanno. C’è quella favola cattiva secondo la quale, la libertà di aborto spin gerebbe le donne all’imprudenza, tan te ragazze si darebbero al sesso più spensierato, e se restano incinte che importa, tanto c’è l’aborto. Niente di grave, come cavarsi un dente. A questa dicerìa sembravano rispondere le pa role di papa Francesco, quando parlan do dell’aborto lo definì la tragedia delle donne. Ecco, la pietà. Nelle parole del Papa c’era pietà per quell’atto di vio lenza che comprende madre e figlio, lui sentiva il dolore della madre-non-ma dre. Le donne NON vogliono abortire. Le donne hanno in abominio l’aborto, più del Papa. Per arrivare alla negazio ne di sé dev’esserci un motivo insinda cabile, che riguarda solo la madre: la sua volontà di rinuncia. La maternità, anche se minuziosamente spiegata dalla scienza, resta un atto magico. Da re la vita. Una vita mortale. Fa tremare. L’uomo nasce figlio, la donna madre. Magari di sé stessa (le donne sono ca paci di tenerezza anche verso di sé, sanno darsi consolazione. Il maschio è meno capace di volersi bene, si misu ra con gli altri, sa meno sorridere di sé, più difficilmente si perdona). Le don ne non vogliono abortire. Si assumono questo delitto per non commetterne un altro, fare un figlio che non si vuole. So lo la madre può decidere. Non esistono metodi sicuri al 100 per 100 per evitare il concepimento. L’errore è sempre in agguato, in certi casi nemmeno la pillo
la preserva. Esistono solo due anticon cezionali infallibili, la sterilizzazione e la castità. Non si guarisce dall’aborto. Forse in traumi atroci come la violenza di gruppo, quando si vuole distruggere quel ricordo, e si ha orrore di avere in sé in figlio dell’aguzzino. Ma perfino chi lo vede come incidente e ostacolo, lo strappa da sé con dolore.
L’impero maschile e le religioni del dominio hanno sempre saputo che la donna è la chiave di ogni potere, perché produce la vita. Se ci hanno rinchiuse imprigionate atterrite divise dal nostro corpo bruciate violate calunniate deri se schiacciate nell’ignoranza, è perché siamo pericolose davvero. Se sfugge di mano la donna, ogni potere è perduto. Oggi i maschi hanno molta molta mol ta più paura di noi di quanto non con fessino, le loro adulazioni e la strage di donne ne sono la prova. Una volta sma scherati, che ne faranno della loro de bolezza? Anche per questo ci ammaz zano. Hanno paura delle streghe? Non abbastanza. La nostra libertà è terri bile. Contemplava fin dall’inizio que sto durissimo arbitrio, e che un giorno dicessimo Vogliamo potere di vita e di morte, perché siamo le padrone del creato. Nessuno può entrare fra noi e il figlio che abbiamo concepito. Non è giusto. È un fatto. In un mio libriccino di gioventù, “Vangelo secondo Maria”, la Madonna è una ragazzina di Nazareth che si è montata la testa con la Bibbia, come don Chi sciotte coi romanzi d’avventura. A lei come donna tutto è proibito, ma quando in sinagoga sente i profeti che chiedono conto a Dio, trattandolo da pari a pari, apprende da loro il sollievo della rivolta. E quando scopre di essere la prescelta a far nascere il Redentore, oppone il suo piccolo disegno a quello immenso di Dio, e in nome del libero arbitrio rifiuta la maternità divina. Maria nega il peccato originale, e rifiuta d’essere il vaso del Dio. Ma la sua rivolta è possi bile solo perché, come donna, ha in sé il potere della nascita.
madre

È un lutto segreto, la
che nega sé stessa, dal quale non si guarisce. E invece circola la favola cattiva che lo descrive come un semplice mezzo di contraccezione


