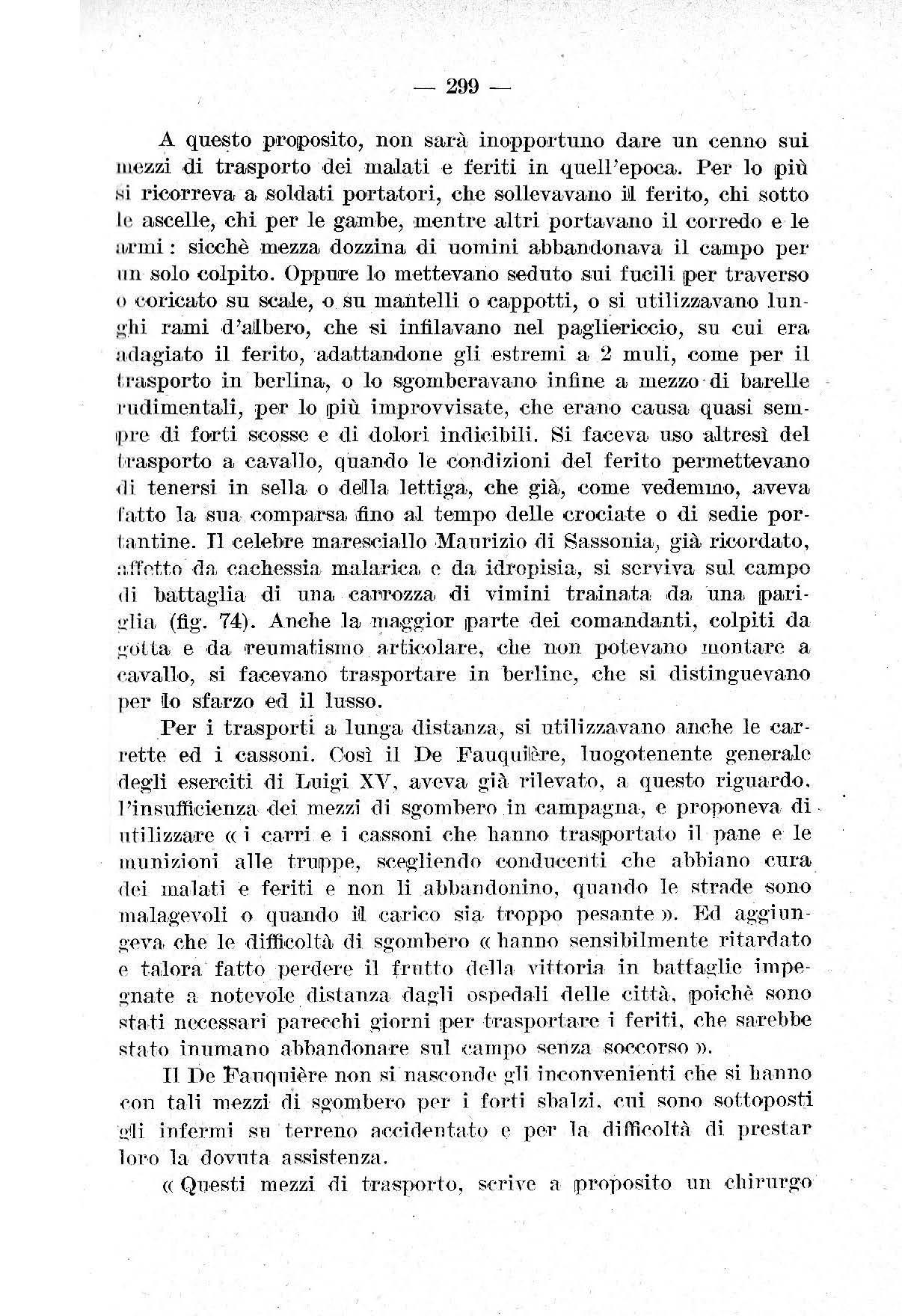6 minute read
J7&'l). (Quadro del pittore Lntinville
(·onsiclerava già, un privi1Jegio· pe,1· i sottu1ìiciaJ.i disporre di un 1dto a due.
G. Pidw.ut dc la l\fartinière (lGH<i-1783), già ricordato fra i <' .hii·nrghi rnilitar·i france~.:i, (fig. 73) ed addetto a!lla persona, di Luigi XV, nel 1783 .si era distinto neilla. campagn~1., d'Italia, nel 1734 a.ll'assedio di. Praga., ne] 1746 ;ci.gli atta-echi di. Mons,' di Namur ed alfa. battagHa di nacm1x. Aillo sco1po ,cli elimina1~e qnesti abusi ed inconvenienti, fn l'ir1~piÌ'atore dell'ordinanza del 4 agosto 1772.
Advertisement
Fig. 73 - G. Pichaut de la Mm:tinière, primo chirurgo di Luigi XV (1696-1783). (Quadro del pittore Latinville).
per la, quale fu costituito un Comitatò cli sanità pernrn.nente per l'amministrazione degli ospeda.Ji militari, alla òipendrnza del Segretario di Rtato per· la, guc,rra, coll'inca,rico cli hiprzioni annuaili o i;:altnarie agli stabilimenti sanitari, <;lPl controllo sull'istruzione t.ecnka, del personale, della vigila1w.a, sull'alimentazione ed ig'icne dl'lla truppa,, e di fondare nn iperiodico scientifico che prese il nome di Giornale di medicina, chirurgia e farmacia, militare. La
1·edazioue di quei,b l'ivista' sd·elltifica militare vcnuc afiidafa1 a l lehomc, con 11a. <>ollabora.zione di Bourifmne, chirm·go maggiore .~cnerale degli ospedaH militari de1la CorRica (~d autol'e d.i preg1woli op,e,rc -sulla cons-ervazio1;1-e degli a,rti nelle ferite di guerra e i-;ulla commozione cerebrale nelle lesioni del ,erauio, di Chastenet, dte recò un importante contributo alle 'ksioni del cuore e dei g·,·ossi vasi, !li Dupont, che lasdò soriUi intcressa,nti sulle ferite del tora<:e, cli necquet su quelilc addomina,li C\.'.c.
Detto Comitato era, composto <li un gcnen1le medico ispet1 ,m·<\ di nwdici iRpettori e èli 2 d1i-rnrghi col gTa,lo cli fr-1pettore. 1,'nrono inoltre costituiti degli ospcdal i reggimentali, a{.'(;.:-.u1to al qna.Ji dovevano funzionare degli ospedali a.usilia,ri per il ricovero dei so,lda.ti del 11wesidio, cle]fo 1·Pclnte e· delle tl'nf)lpe ·ai passaggio, .ippartenenti ad a,lt, rc guarnigioni.
Durante. il regno di Luigi XVI, furono i:-ititùite ,per l'arruola111ento e l 'h1trnzione tl><',nica del personale sanitario aggregandole
.ig'li. ospedali auRiliari più im'pm·t:rnti (!Vfof,7., Lilfo., Rtn1,Rl11n·go, 'l'olm1e e nrcst), delle Scuole· di sanità, che funzion:irono fino alla 1·ivo]nzio11e, con r-;votTp;irnento '{ 'li <'(l'l'si · tr·iennali e seffs<~mrn:U, di :1 natomia, mNlieina (lJ)PT·atoria, fa,sciatnre ed ùpparccc.hi, di imlf)or1 ,111za: uguale, se non su1pe,riorc, a quelli impartiti nelle univPrsità.
A iJUesti si agg-innsero, in s<:'p;nit.o, gli iusegnamenti ·<lelhi tisiologia, deHa mat,~ria me1lica, dclilc· malati.i<~ Y('ncrcc ·e dell'igiene, la. qua1c si 1puù ben ritrncre ·Ria gerrno/:i;liata, per opera dei medici 111ilitari, chiamati per i p,rimi a 1prevP11ir,c le rmilattfo della colletlivit:'ì., r-npp1·escntata in <p1est'cpoca qnasi escl 11si ,·amen te iiaJlc 111i1Jizir. I 11 (JlH!Rto 1w1•i,odo si 11ota an<'m'a un t<:'ntafi vo · ,(li soppdnwre il s1·1·vizio deg·li ospedali militari, ,provvedendo alla c111·a dei malati " fp,riti a. nwzzo ,li i'nformp1·ie p·re:.:iidiariP o !f)reRRO i 1·eggirnenti i-;t(•ssi, con rnppalti PRprf'sRn1néntP striMliti: ma. nel 1792, dopo nn <''Rperimènto sfa,,,orevolé, si rii.ornò nll'ant.ico i-i~t.erna.
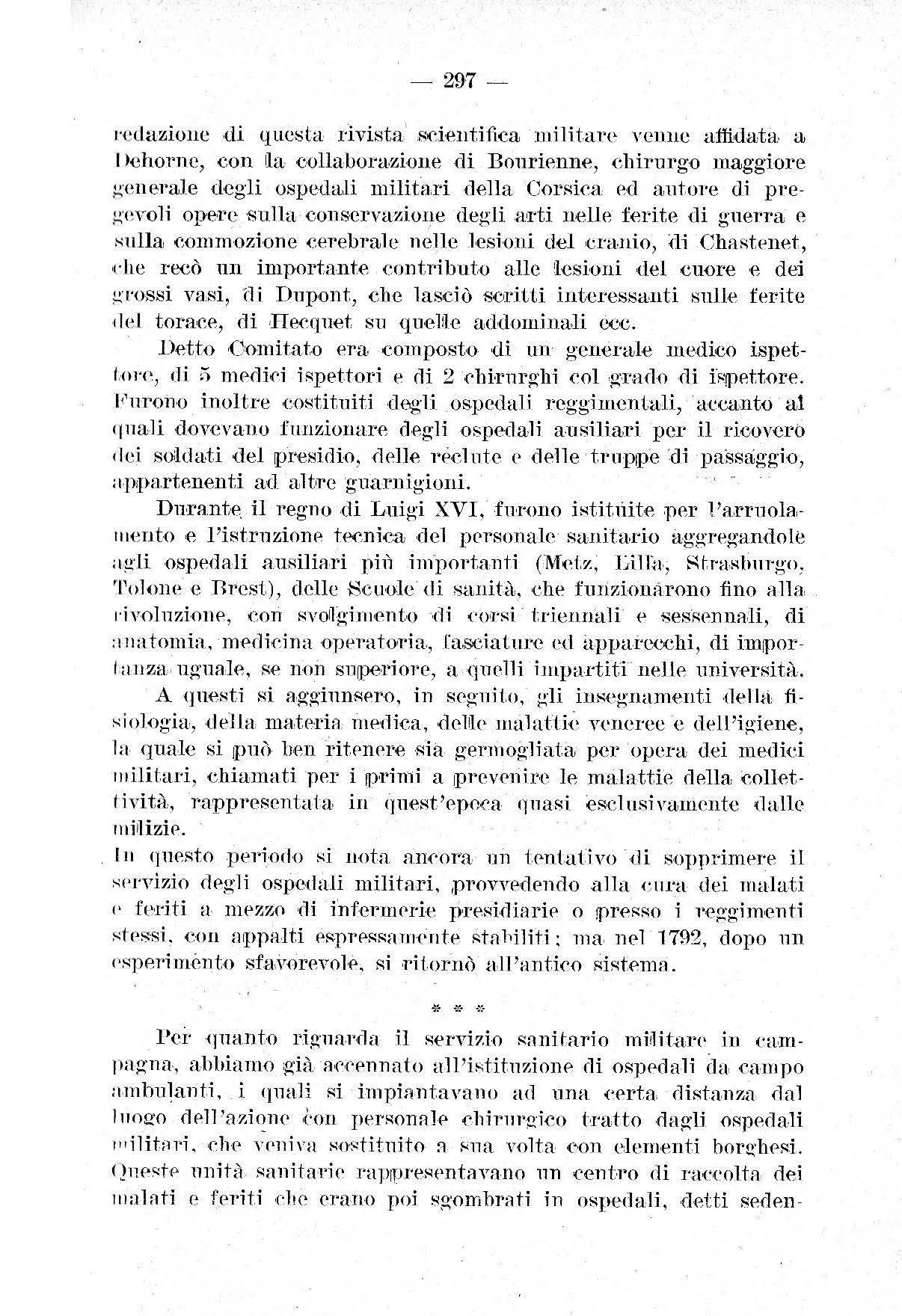
PcÌ· ·quanto ri,g1rnrrla il :-ierv1z10 snnit.ario mi1litar(• in eantpng·nn, abbiamo g·ià a<',f'f'Jrnato all'i1,;t.itnzio1w rli os1wdali ;fa campo :m1hulanti, i qnali :.:ii impiantavano ad una <·f>rta clistanza òal I 110Q'o clell 'azi~nc• hm per,-omilP el1frm·gieo (-,ratto .flag li oRpedaH 11iilit:n·i, dw , ·pnint :.:io:-;titnito f<na volta eon d e1nenti horQ·lwi-i. Qne"<tP nnità Ranita,riP raprru·p:.:ipntavano 1m <:entl·o di r~wcolfa dei 111:11:lti e feT·iti f'.lJe erano poi l'lgomhr:1ti in ospedali, rfotti seden-
ta,ri, a.llestiti nelle città vidniori. Queste unità sanitarie erano d-0tate di materiale chir-u1'gico e di _ medicazione e di medicinali. convenientemente ripartiti, traspor-tati su s1pedali vetture, munite di a:pp,ositi scompa,rtimenti, in modo da poter esl:>'el'C rilevati prontamente e facilmente.
Per !lo sgombero dei malati <.! .feriti, si utilizza vano ailtresì carri a 4 ruote .a sospensione, capaci òi contenere 8 individui per fila. Ad ogni arrmata, di 20000 nomini erano assegnati 20 di questi mezzi di trasporto: inoltre se ne destinava uno per ogni 1000 uomini in più. Agli ospeòali sodenta,ri venivano trattenuti i malati e feriti intraSIJ)orta.hili; gli atltri erano sgombrati ncll 'interno: -quelli leggeri, che [Jotevano in breve tempo rientr·are a-i corpi !'.ispettivi, c1·ano ricoverati temporaneamente in re;pa,rti -speciali, detti Uhambrées, istituiti presso gli DRpedali sooenLa,ri.
Raramente si operavano i feriti sul ca.mrpo di battaglia..: gli interventi si pra.tka,va,no in (JUeRte unità sanitarfo tla] dùrurgo maggior-e, .uisisd.ito da.gli altri {'}rirurghi, senza akun mf>zzo fli. anestesia e col paziente t<>nuio semplicemente formo dagli aiufamti.
A quei tempi si ,el'a già, di f'fusa la convinzione che la miglior scuola, per i chfrurghi fosse la gu<.!1Ta,; e le ba,tta.glic e g11i assedi erano -pa.lestre <li proficni im;,eg·nmnenti per Fingente nnmero di feriti da soccorrere: non bastava di avere a disp,osizion~ nn buon airmamentario, ma era inòispensahilf> servirsene con ahiliiù ed intelligenza. Ravaton, che abuiamo ricvocafo come una, delle :figure ipiù t ipiche cli chiru1'go militare di ,qnell'è[)oca, in base a.ll'espericm~a di 36 anni di servi zio, trascori-;i pe1· la più gran parte in guerira e negli -0spedali, aveva concepit-0 j] iprogett.-0 <li costitnire 1folle brigate sanitarie mohi]i al seguito (lellè trn1ppe operanti, formnte dai un chirurgo aiutante maggiore, <hl allievi, òa, uno 8'I)eziale, un elemosiniere e da. 5 inf ermÌ(!ri, -e• fornite fli nn cano contenente una cassa, <li stntmenti cbi,rnrg;id <'<1 ap'J)arecchi, un sacco di inateria1 le da mooicazione, scatoJc fli fihwdc e ,li 111còicinali. R-ei bal'elle, nn lm,rilrtto di vino e -dota½io11i -cli vivel'i <li riserva. E ciò, « [Per evitare gli inc-0nvenienti ve,rifka,1 isi molte volte <.li fa1' rimanere i rnatlati e feriti privi di soccorso per parecchi gi<H'ni, e per avere il vantaggio di ipoter caricare sul Nn·ro gli infetmi che non fossero in conrlizion<~ da poter camminare >>- M::i, deve ancora ipas!mre mezzo secolo 1prima. che questa, iòea, diventi realtù, e sia tradotta in atto da L:urey e Percy 1wll<' campagne napoleonkhe con le famose ambulan7R volanti.
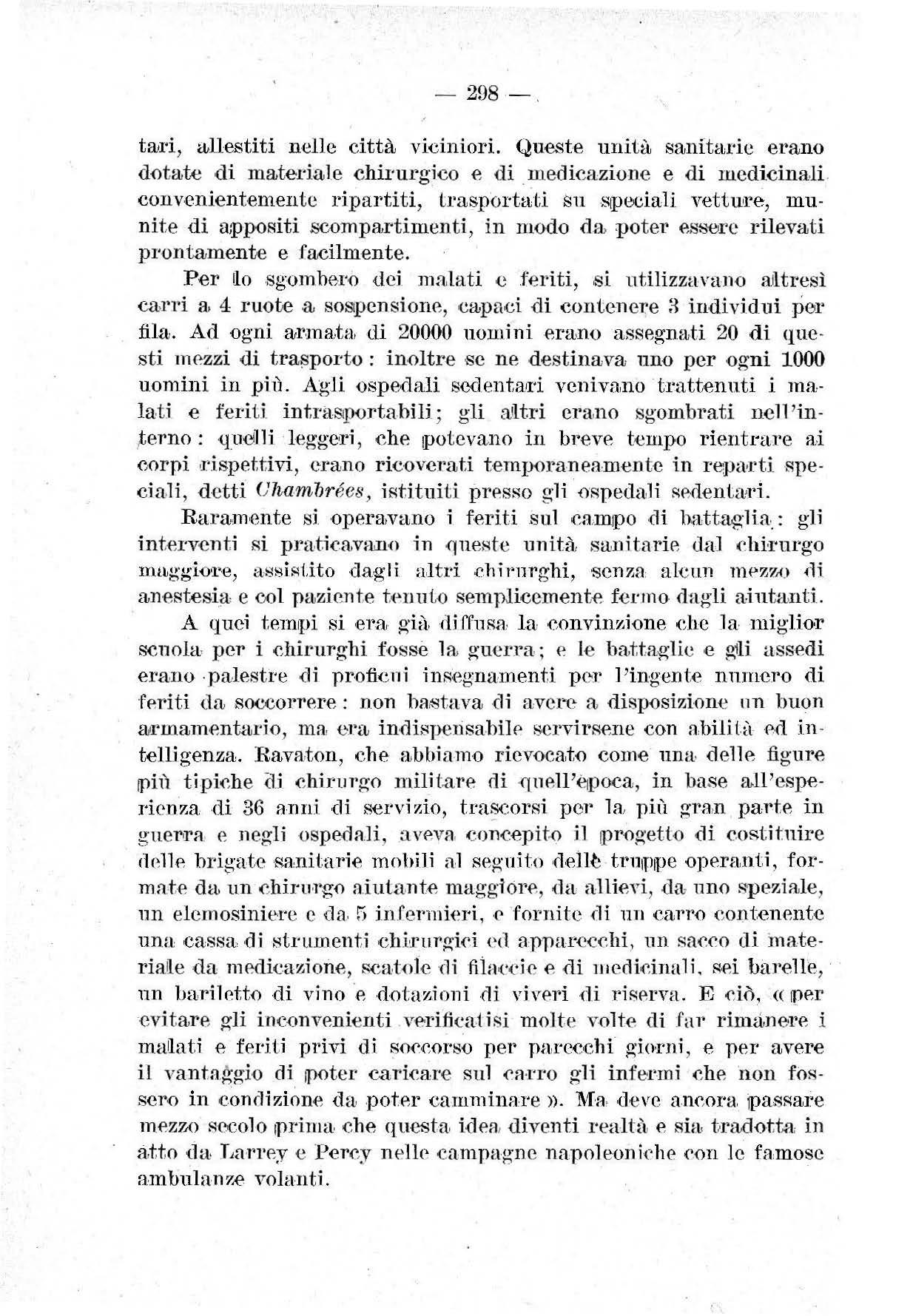
questo p,roiposito, non sarà inopportuno dare un cenno sui mez.zi di trasporto dei maJati e feriti in quell'epoca. Per lo più Ni ricorreva a solda,ti portatori, che sollevavano iiJ. ferito, chi sotto le ascelle, chi per le gambe, mentre altri portavano il corredo e le 1wmi: sicchè mezza dozzina di uomini abbandonava il campo per nn solo colpito. Oppure lo mettevano sed.uto sui fucili [)er traverso o c-0ricato su scale, -0 su mantelli o cappotti, o si utiliz:,,iavano lun~·hi rami d'atlbero, che si infilavano nel pagl{ericcio, su cui era acla.giato il ferito, adattandone gli estremi a 2 muli, come per il Lr·asporto in· berlina, o lo s,gombcravaJ10 infine a mezzo· di barelle l'LldiÌncntali, pe,r lo 1più improvvisate, che erano causa quasi sem1pre di forti scosse e di dolori indidbili. Si faceva uso aJ.tresì del t•rasporto a cavalJo, quan<lo le condizioni del ferito permettevano i·1 i tenersi in sella. o deUa lettigà, che già, come vedemmo, aveva ra,tto la sua ,comparsa ifino al tempo delle crocia.te o di sedie portantine. Jl celebre ma,resdallo .Maurizio fli Sassonia, già rfoordato, :1.ff0.tto ffa, cachessin, mularica, e dn, idl'opisia, si serviva sul campo di battaglia di una ca.nrozza <li vimini trainata .da una [Pari~lia (fig. 74). Anclle ]a 1~·1agg:ior ivarte dei comandanti, colpiti da g-otta, e da ,reumatismo. artic<lla.re, che non potevano montare a C'.avallo, si facevano trasportare in berline, che si distinguevano per ilo sfarzo ed il lusso . . P,er i trasporti a lunga distanza, si utilizzavano a,nche le careett.P. ed i cassoni. Così il De Fauquilèrc, luogotenentt~ genera.Jc dP.gli eserciti fli Luigi XV, aveva già rilevato, a questo riguardo. l 'im:ufficienza. dei mezzi di sgombero in campagna, ,e proponeva di utilizza,re cc i cani e i casi:mni che hanno traSlportato il pane e le m rrni ,-,ioni alle truppe, sce~·lif'ndo conducciiti che a bhiano cura ,lei malati e feriti e non li abbandonino, quando le strnde sono mala,gevoli o quando i1l ca,ri<'.o sia. t,roppo pesante)). Ed ag.gfong-eva. chf' le difficoltà di sgom he1·0 cc lrnnno sensibilmente ritawlato e~ tn.lora· fatto perd<:>re il frntto d0lln vittoria in batfaidic impeg;nate R notevole. distanza {lag·li ospr>da-1i <'lelle città, 1poichè sono stn.ti necessari pare<'clli giorni per frasportm·c i feriti, che sa,rebbe stato inumano ahhnndona·re sul campo se11za soccorso)).
Il De Fanqni,Ìire non si nascondt> gli i11convenit>nti che si ha.m10 rnn tali mezzi cli sgombero prr i forti sbalzi. cni sono sottoposti t!'li infermi su terreno accirl('ntato e per la di flì<'olt.à di pL'estar lor·o la, dovnta assistf:mza. << Questi mrzzi <li trasporto, s<·rive a proposito nn chirurgo·