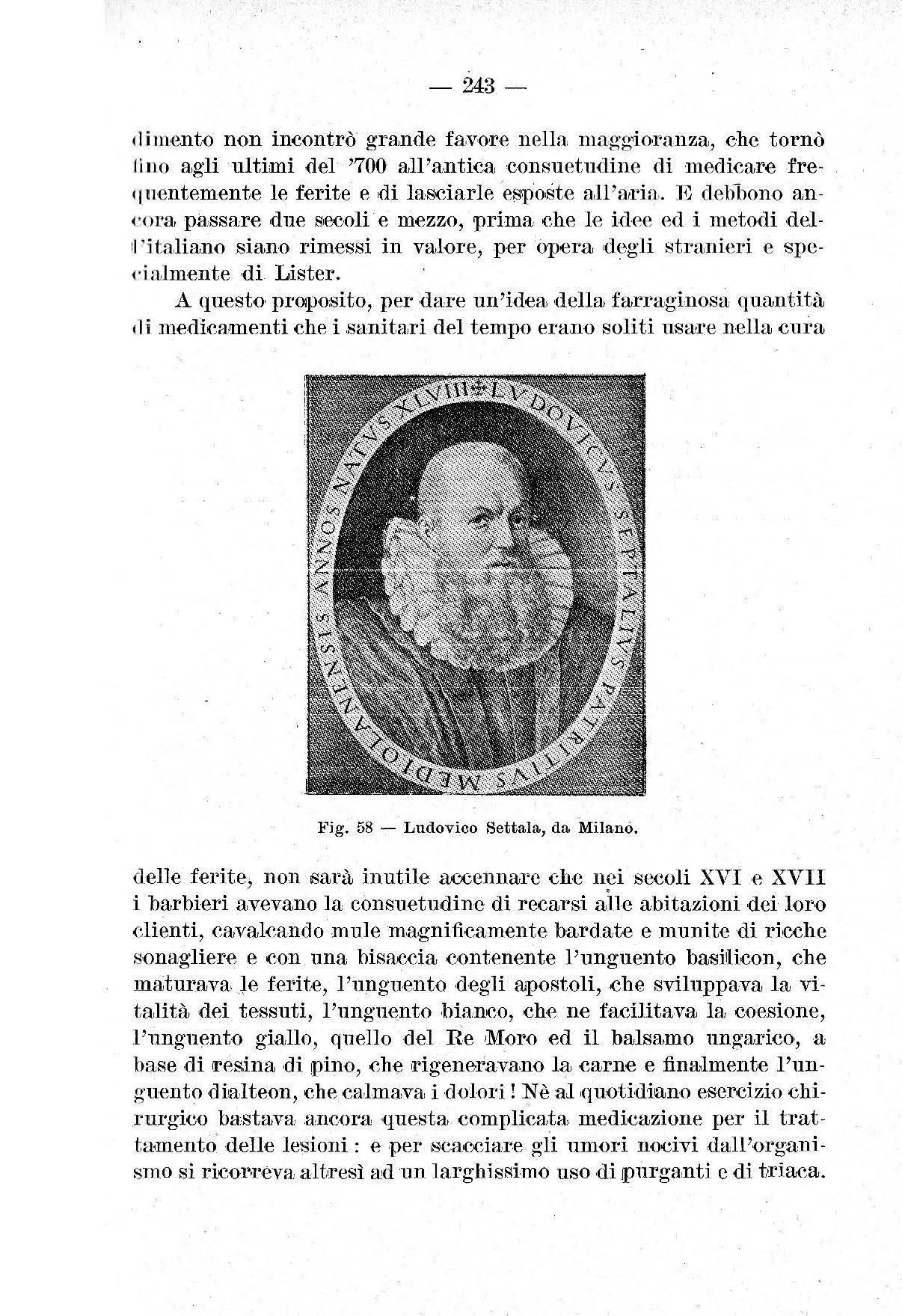
8 minute read
». 58. - Ludovico Settala, d.a Mi!:mo
di mento non incontrò grande faNo,r.e nella maggioranza, che tornò li 110 agli ultimi del '700 all'antica commetudine di medicare freq nentemente le ferite e idi la.sciarle 'esposte all'a,rirt. F, dehl)ono ani·ora passare due s,oooli e mezzo, prima che le idee ed i metodi del11 'italiano siano rimessi in valore, per opera degli strarnieri e spc.,i n,lmente di Lister.
A questo proposito, per <fare un'idea della farraginosa quantità di medicamenti che i sanita,ri del tempo erano soliti usa:r:e nella cui·a
Advertisement
Fig. 58 - Ludovico Settala, da Milano.
delle ferite; non sarà inutile a(X;ennarc che nei secoli XVI ,e XVII i barbieri avevano 1a consuetudine di recarsi alle abitazioni dei loro clienti, cavalcando mule magnificamente barda.te e munite di ricehe sonagliere e con una bisaccia oontenente l'unguento basiilicon, che maturava Je ferite, l'unguento degli rupostoli, che sviluppava la vitarlità dei tessuti, l'unguento bianco, che ne facilitava la coeBione, l'ungn!:lnto giallo, quello <lel Re ,Moro ed il ba,lsamo ungarico, a base di ll'es.ina di ipino, che ,rigeneravano la carne e finaJmente l'unguento di1alteon, che calmava i dolori! Nè al (]UOtidiano esercizio chir urgico bastava, m1cora '<IUesta, complica,ta medicazione per il trattamento· delle le"Sioni : e ,per ,scaccia.re gÌi umori nodvi dall'organismo si ricor,reva, altresì ad un larghisRimo uso di ipnrganti e di t•riaca.
E per offrire un altro esempio della cura delle fel'ite in queli]_'epoca, ricorderemo che Dionisio Oachon, celebre chirurgo dello Studio di Salamanca, nel riferi,re sulla lesione al capo ,riportata da Don Carlos, fi,glio di l!'ilippo II ad Alcalà de Henores, in seguito a caduta da,lla, Rcala, accenna come Vesalio avesse [)l'Oposto la craniotomia, ma <1i1esta non fu [)raticata, e la ferita fu trattata semplicemente con empiast;ri, dctergendola e sfasciandola fin tre vOllte al giorno. ~opravvennta febbre altissima, · furono in Beguito applicate diverse pomate, ma fortunatamente coll'eliminazione di un sequestro osseo, che i:,i era nel frattempo formato, il ferito andò lentamente ·~igliorando. Dopo parecchio temipo dalla lesione si adottarono altri farmaci incarnativi e glutinanti e :finalmente. a distanza di qualche mese, si ritenne conveniente di fare un po' di !Pulizia e di raid.ere i c~1pelli attorno alla piaga !
Ed aggiungeremo ancora che ne1 1563 insorse una vivace polemica fra 1'Jng,rassia, l'Eustachio ed il Vesalio circa una ferita al toraic-e, rip01·ta.ta, du.rnnte un torneo a Palermo, dal Duca di. Terranova e di Aiagona, : ciascuno vantava un iprop,rio metodo di cura, ma tutti e,ra,n9 d'accordo sulla nccessità di scopri,re <li frequente la lesione e di applicarvi una grande quantità di unguenti_
D'altira pa,rte il 1'achflnio non esitava a chiamarr-e l'acquavite 1·ime<lio sovrano nel trattamente delle ferite di guerra : unico 1Jerbo, balsam11s incomparabile vulnerum p1,1;tridarum. E na,rrava di un soldato, ferito all'assedio di Creta, il quale doveva essere sottoposto all'am1pntazione di. una gamba, ma, ip,referendo all'intervento . Ja morte, volle curarsi (la sè con ripetute lava,nde della JesioÌ1e fatte con acquavite; e guarì co1n,pletamente !
Fra i chirurghi italiani del '(iOO P- da menzionare inoltre Marco Aurelio Sev,erino (1580-1.656), da, 'rarsia. Fu nno dei IJ)rimi a pratica.re nel 1610 wrdita.mente la t,racheotomfa durante un'epidemia di difterite, la qua1Ie aveva, causato grande mortalità in Naipolì, Ol{>e~ razione · già iproconizzata <lal San toro, che aveva, ideato speciale st,rumento, dal Guidi e da Fa,brizfo d'Acquapendente. Il Severino si procacdò inoltre grande fama, rp.er la legatura deliJ'arteria femo•ra,le sotto l'arcata crurale in un .caso d'asportazione di v,òluminoso aneurisma, 'f)OpJiteo e per avere praticato fompestivamènte là resezione dei calJ)i &rticola,ri cariati. Pubblicò numerose orpere, fra cui un trattato di chirurgia, stampato a Francoforte nel 16n3, per il quale il De Renzi non esita a prnclamarlo un rigeneratore della chirurgia ttaJliana.
Ed ancora citeremo Pietro Ma,rchetti (1589-1673), che pubblicò
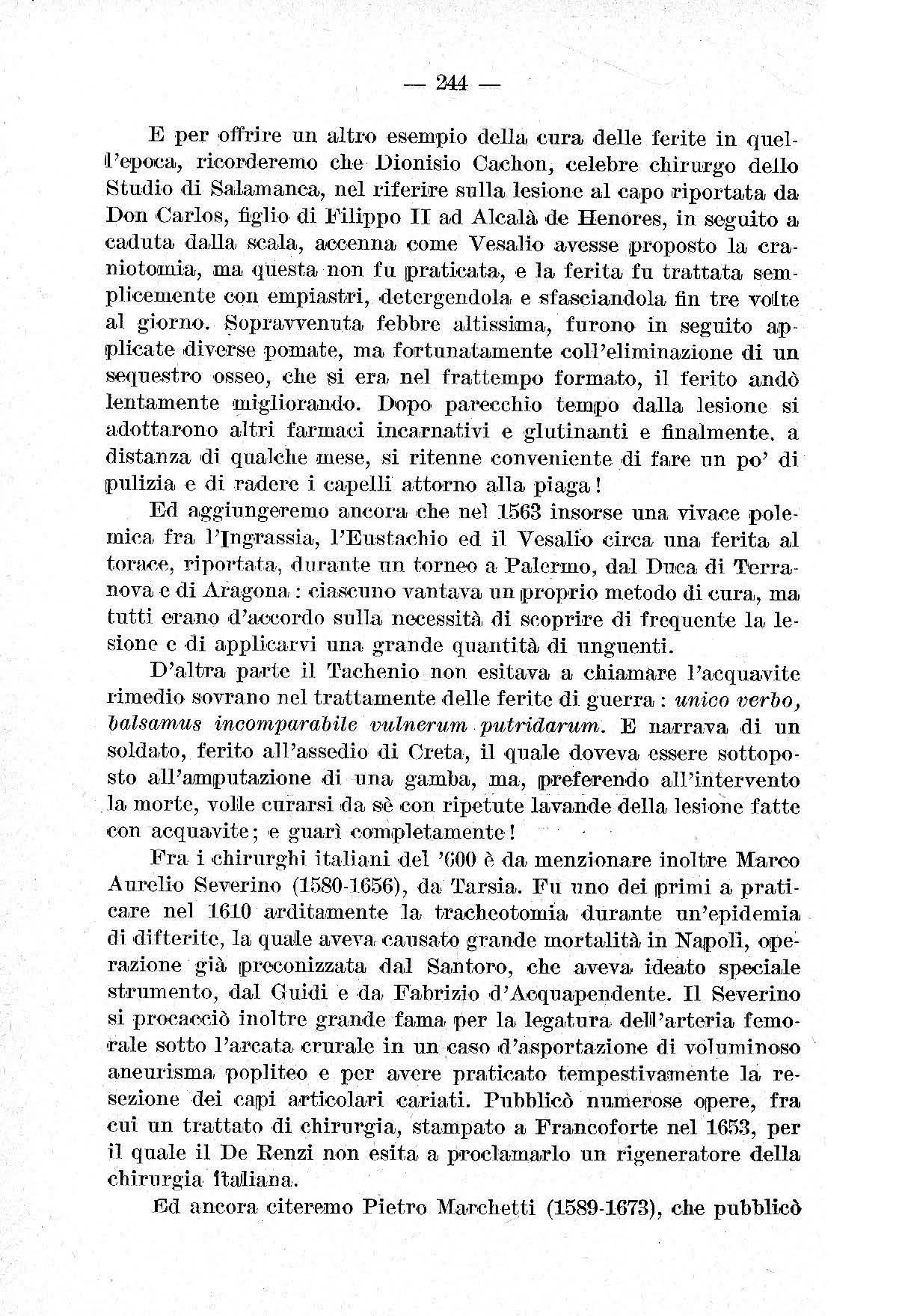
nel 1664 un interessante trattato di medicina, e di chirurgia, frutto ili numerose osservazioni rpersonali. Ed infine Giuseppe Zambeccarì, i L quale si ,può ritenere un ipirooursore della clti,rur,gia sperimentale, avendo praticato fra i primi la vivisezione sui cani per lo studio ls aumatologico delle ferite e lesioni.
Nè solo la chirurgia è in continuo sviluppo nel '(iOQ in Italia, ma comincia anche ad affermarsi l'igjene mi11itarc nella difesa con1.ro le ma.lattie castirensi. ·
E opportuno premettere che, durante la guerra dei trent'anni, infierirono in Euroipa· miei.di ali €[)id emi e di f.ebbri tifoidee, dissenteria, scorbuto, a,ggraNate dalla, carestia., tanto che a,lla fine della lunga campagna, la popolazione della Germania era ridotta, secondo il Lammer, da 17 a 4 milioni l Inoltre il continuo movimento di eserciti ,e di miilizie mercena-rie contriibuì sensibilmente a diffondere vieppiù la peste nelle varie rntzioni : a, ;M:osca., nel 1601, si nbbero a verificare 127 .000 dcccssi; 69.000 a T,onòra, nel Hi6F>; 70.000 a 'Vienna nel 1679; 83.000 a Praga. nel 1680. La ipf'A'lte scoppiò anche nel nostro paese tra il 1629 e il 1631, con 86.000 decessi nella sola Milano; e quest'epidemia., conosciuta col nome di « peste degli. untori)), fu magistralmente descritta dal Manwni nell'aureo romanzo dei Promessi ,sp:osi. E citiamo ancora,· f~·a le maJattic epidemiche, H tifo esantematico, che si diffuse specialmente tra le truppe durante la guerra dei trent'anni in Gc,rma,nia, in Francia ed in Olanda,; il vaiuolo, che diaagò in Inghilterra; la. difterite., che menò stra.ge nella Spagna e nel Napoletano; .fa scartla.ttina, dèscritta. per la prima v01lta da Giovan li'ilipiro TngralilRÌft, fin òa.J l!°>F>O; la; ma,laria,, che imperver,sò nel 1600 nel Naipoletano, ca,usando 40.000 morti ecc. Non è perciò da mcipviglia;re se Leibnitz definiva i ilazzantti: Seminarium mortis et thesaurum infectwnis.
Nel 1606 Tobia, Oober, medico di Gor1itz (Boemia), ·che av·eva rpTestato scrvizfo per sette anni nell'esercito ungherese nella guerra oonfa·o i Turchi, ipubblicò tre memorie sul tifo castrense, conosciuto a,nche sotto il nome di morò1rn H.1tng<tric11/s, lues pannonica) langiwr pannonica) ascrivendo fra le cause 1pr.edis,ponenti dell'infezione la fatica, p,d i dil":a,gi della campagna, nonchè l'e,ecita:mento psichico J)'rodotto da,gli inrnrmerP-voli sciami di moschP, e zanza,re che non ·davano tregua· ai soiò::i.ti P, coimi agenti tl'asmettitori i pidocchi, che infestavano 1~ truppe in modo impressionante.
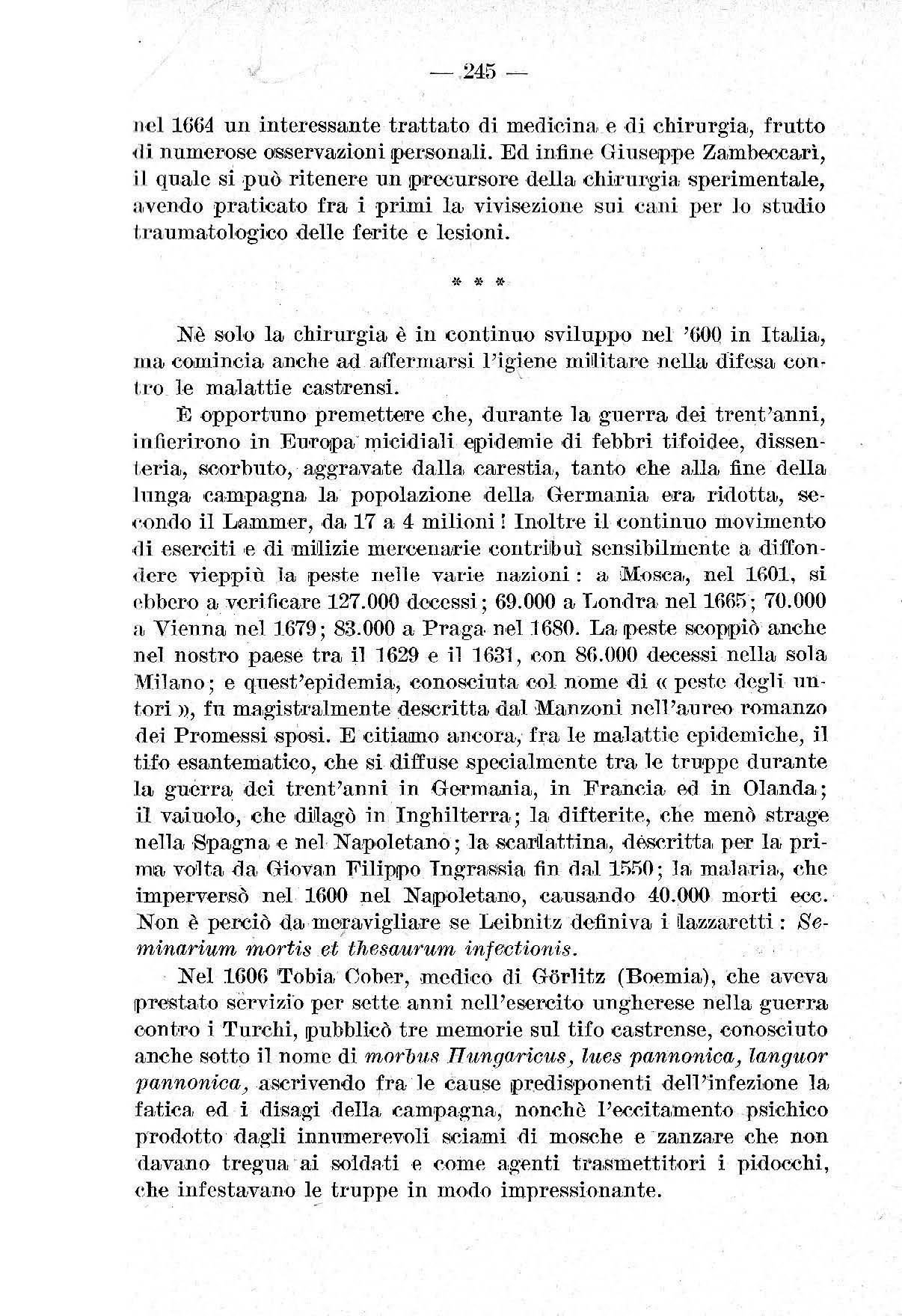
Le dette memorie .furono stam1pate ad Helmstadt col tit-Olo: « ObservationU/m rneàicarum ca,strensiitm Hungariçum decades tre.s)). In. queste il Qoher, intravede p~r il primo !l'origine parassitaria del tifo esa:r1tema,tico a mezzo dei pidocchi ,che sono da lui chiamati vermi Sylliani, di cui ebbe a consta.tare una grande quantità negli indumenti dei soldati, lava.ti con vapore acqueo ed esrpo,sti per lungo tempo .al sole. N è il continuo ca,mbiamento di bia,ncheria e di vesti, osi,;e,rva l'autore, niusciva a eombattcre l'infezione, la quale si manifoi,;tava eon un'·eruzione cutanea di tutto il 001·po, 0It1·emodo mo1Iesta, tanto da rendere le truppe grandemente eccitabi1i.
Nello stesso '600 in Germania furono adottate particolari mi. snre igieniche contro la diffusione delle malattie infettive negli eserciti e soprattutto contro le affezioni veneree, le quali erano alfora frequentissime per il dilagare tklla-ipl'ostituzione, che tenacemente i,;i infiltrava in mezzo a,lle truppe belligera,nti.
Schiller ,riferisce a ,questo rignar,do che nel rn:~2, durante l'assedio di Norimberga,, nel ca,mpo di Wallenstein 1wll ula,vano Oiltre 15.000 donne di malaJ'fa.re; e si narm, che nel 1648 il nume:ro delle prostitute, che segnivaa10 gli eserciti in camipa,gna,, avesse raggiunto il dopipio della, forza delle milizie, e si .aveva, inoltre un grande codazzo di figli iJilegittirni, che ingombravano le colonne in ma/l'eia, con gravissimo danno della disciplina. Queste masna{le òi femmine (Weibertr088e) ralJ)presentavano un pericolo permanente d'infezione iper i soldati, e le ordinanze più rigorose degli imperatori e dei comandanti furono impotenti a, reprimere tale flagello. che perdurò .pe1· tutto il secolo xv;u. · Così nel 1648, terminata la guerra dei trent'anni, il generale Kromifr.ld ,riferiva all'Elettore Massimiliano di Baviera che nell'esercito mobilitato, della forza di circa 40.006 uomini, si t,rovavi;mo oltre 14.000 fra donne e prostitute al seguito delle truppe. Nel 1650, in ·quatt.ro compagnie svedesi, ammutinatesi a Kothen, dell'effettivo di 690 uomini, si contavano 650 femmine e 900 figli illegittimi! Tn un periodo più avanzato, per potere utilizzade in qualche modo, que5'te donne· furono adibite nell'esercito a, va.rie mansioni : cuoche, vivandiere, infermiere, f'CC.
Lo stesso Elettore ·Massimiliano, per eliminare questi gravi inconvenienti, ema,nò nel 1570 un regolamento per disciplinare la pro,:titm;ione diffusa in modo imrpressiònante nell'esercito, che fu poi preso a modello !8necessi va mente nelle . norme per i[ s,ervizio ,folla cavalleria, da Wa.llenstein nel 1G17, e nei reg·ola1ment1 militari
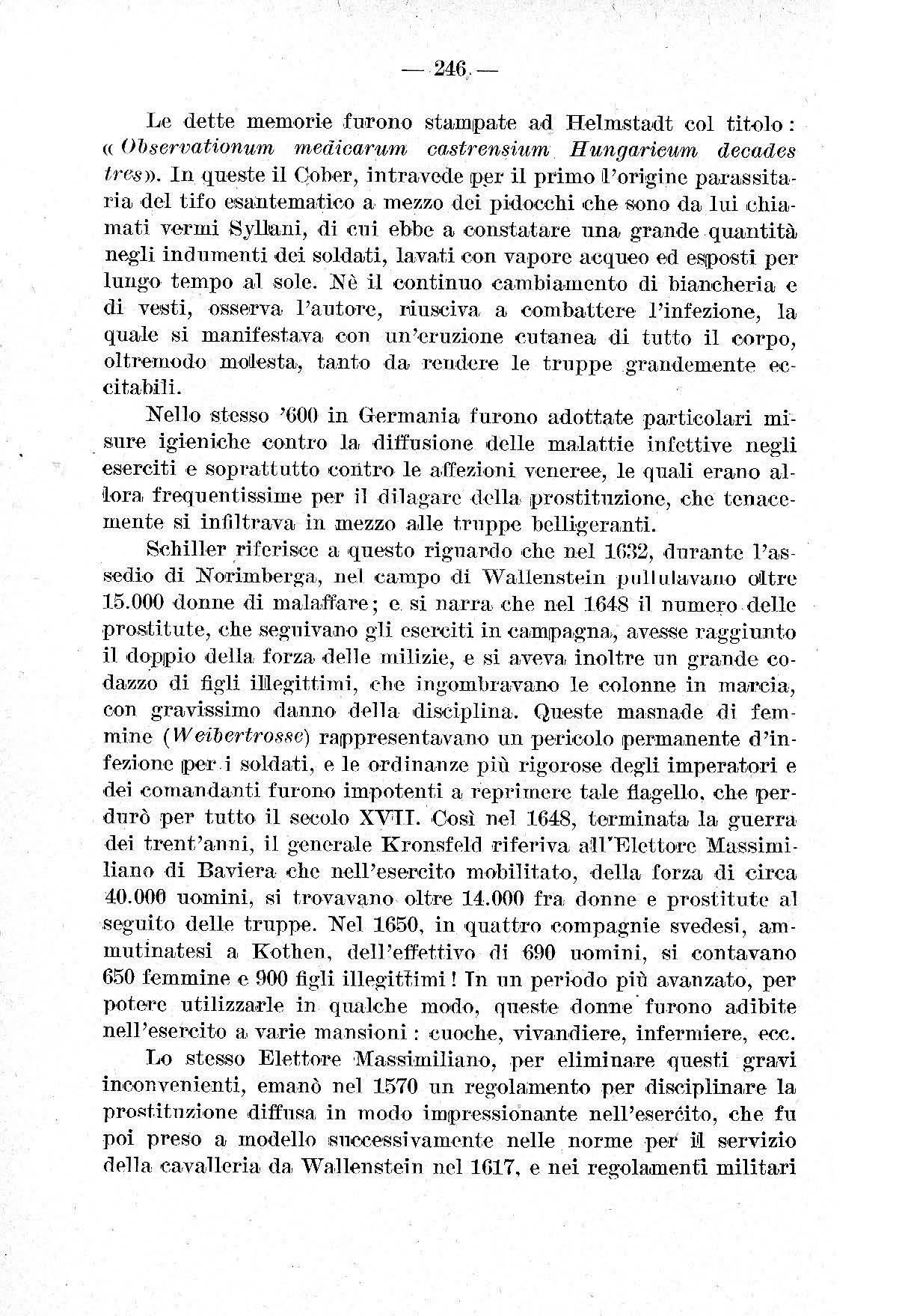
da, Gustavo Adolfo nel 1621 e da,l grande Elettore nel 1656. Per tali disposizioni era assol utaimente in tordetta la p,resen za di femmine 11 ogli accampamenti, a meno che non si trait.asse di donne legal111 ente maritate. Ma a,nche ,questo provvedimento riusci poco efficace, poichlè le sol<latesch~, per eludere la legge, contraevano a:ff.ret1.atamente matrimoni con femmine dei più bassi strati sociali : ed i I W allhauscn riferisce che in · soli <l uc giorni se ne conchu,ero oltre 800 . .
Ferdinando III d'Ungheria nel 1643 ordinò altri severi 11n·ovvedimenti contro il dilagare della 1p,1•ostitnzione e per eliminare q ues~o elemento turbolento e pa,rassita-rio femminile, tanto più che l'esercito, per la grande carestia da cui era invaso il territorio in q nel tempo, non riusci.va a .f!famarsi cd era, costretto per vivere ad abbandona,rsi ai fUJ'ti ed alle rapine. Giovanni di Nassau-Silgen, 11 no dei capi dell'unione protestante ·(160~), in uno dei suoi discorsi n.ll'esercito tedesco (>JSor.ta.va vivamente i comandanti ad allontana.1-e {fagli accamipamenti questa turba dj donne di malaffare, che <:0Stitu jvano lllla pel'l~llll~ minaccia alla salute del Sol(la,to.
Anche durante la gueN·a spagnola del 1681 un editto del mag-istrato di Strasburgo sanciva oròini rigorosi per la difesa degli a,ccantonamenti dà.ll'inva,'.lione di ,queste ,prostitute. Ma bisogna ninivare fino . alla metà del settecento perchè dette misure profilattiche f1bbiano qualche effetto, a,llorchè si comincia,rono ad adotta.re pil) razionali di~Òsizioni per la visita e ipcr jl pronto allontanamento e cura delle donne infette.
In mez7,0 .a questa terribile propargazione di malattie e.ipide- . rnico-contagfosc fra le milizfo sorge in Italia una iprima rudi'mentale legisla.zione igienica, già preconizzata da Gerolamo Fracastoro, e continuata per opera ~pccialmente di Orazio Monti da Fircn7..e, di Antonio Porzio da Na,poli, di Giovanni M',aria, Lancisi <la Roma e di Bernardino. Ramazzini. da Caripi. Q1Jantùnque a,ppa,rtenga effettivamente al secolo precedente, 1•iteniarno opportuno di rievocare, come pioniere delil'igicne militare, Oeròlamo Fracastoro (rfig. 59). Nato a VerQ'Iia nel 14-78 da famiglia d'inustri scienziati, studiò a Padova con Nicolò Coiperni.co ed ebbe a mMstro in anatomia il bolognese Alessandro Achillini, e in mooicina Girolamo Della Torre, suo concittadfoo. Fu medico del .pontefice Paolo JTI e del C,oncili~ di 'Drento, che fece tra~o_rtàre a, Bologna, essendo scoppiato nrJl'alto Adig~ il tifo esantematico. Egli si rpuò ritenere indubbià.mcnte il ,prècUl'sore dcl1à mo-











