
9 minute read
Un'amputazione del 1>raccio destro sotto il primo impero
111 e 11 Le adattarsi al conoetto che il civis rornciniis dovesse ti·a1scor,1·1~1·e l'intera g'iornat11 a visitare e<l a curare le più infime e.lassi Nociali. Ma, aLlorchè comincia.rono ad emigra.re dalla Grecia- meilid di una certa fama e Roma cominciò l;lid }Weoglierli con riguardo 1· IL·eg~i ultimi tempi della- repubblica.. .a <:onc-ede1·e loro anche il didtto di cittadinanza, l'a, rte sanitaria,, e..<:;ercitata pc1· lo innam1i <lai ;sc _ hiavi, iniziò la sua rapida asèiesa,, e ila posizione sodale dei 111-edici aumentò di gra,nde prestigio per merito. specitt}mente di ,\_i,deipiade di l)1·us~1, giunto nell'urbe drulla Ritiniai a.I sorgere del p1· .imo seeolo a .. C. Queisti riuscì a procacciarsi un.a larga-clif>.illtela i II Roma fr.a le famigili-e di maggior censo e a,cl acqui.sta.rsi l'amic:i7. in. delle più oospicne pm·sonalitù,, eome M .. A11tonio, Cicerone e L. C1'a.Sso, ed a ll'aggi.ungere una, posizione eminente nella classe ~a.nitaria,, con una lairga schiera. di disceipoli, fra cui Ant,onio Musa, :11·cl1iatra, di Augusto, Clodio e Crisippo:
A.<sdepia<le, a.r,rivato poverissimo a, Ihnnà, e desideroso di app1 ·endere, id.i giorno andava~ scuola da.i ffl<>so:fi e di notte, pe!r vivr,re, si riduceva a girare la macina di un mulino per guadagnarsi ti Ut'\ dramme. Morì in età molto avanza.ta, in seguito a caduta da, 111ta, scala ..
Advertisement
La fa11na di <1uesto 1sa.nitario, eh-e fu d1i.arnato il principe dei n1 ec1ici, :si consolidò soprattutto in seguito a,d un episvdio che ci 11nrra Lucio Apuleio nel libro IV delle sue ,Storie. Un giorno, uwn1 .re Asdepiade si dirigeva alh,!, prorpria villa,, s'imhattè sulla Via ~aora in un corteo funebre, che aveva fatto una piccola sosta, per ,, lairc un ipo' di riposo a coloro che trasporta,vano la sa,1,ma. 11 medico p·e-r· cnrio.sità si avvicinò ai familiari piangenti è domij,ndò la causa della, morte d.el congiunto, ma non avendo avuto alcuna rispo,sta ;·onvincente, si avvicinò l:l,l ca<lavere ,e con iso.l'pre.sa, notò che pref.:Cntava ancor.a .segni di vita,. Allora consigliò òi sospendere s1nbito le cerimonie funebr,i e foce fa'aStportare la salma in una ca,sa, vicin~ ove, con mera.vigilia generale, dopo alcuni e.sa1II1.i e .rrn-m11alità 1 il morto rupr~ J:ent~mente g1li occhi e ~ominciò a fare qualche movimento.
P,recursore di una dottrina .meccanica atomistica, per la quale la salute non è a.ltro che il rh<.:nltato d-ell'a,11monico, perenne movimento deg,Ii atomi f;-ntro .<speciali cana.licoli cleU 'organismo detti pori, Asel~piade impres.<s•e a.llla, terrupia1 un indirizzo eminentemente dietetico e fì.sico; basato soprattutto 811] digiuno, sulla ginnastica,
6
sui bagui e sul miIBsaggio, bandendo qurusi del tutto· le prescrizioni me,diche ed isipirandosi aJ famoso aforisma << Cito) tuie et j1wunde )).
Per ave'.re un'idea dell'esercizio dell'a.rte sa.nit:win in •1uei tempi possiamo, per un istante, portarci coilla mente a Polll.Jpei ove, prossima alla porta di Ercoila.no, motlto .vicina a.lla villa di Cicerone, dove svernava il re dell'el0<1uenza., si trova la casa, di un medico del I secolo dell'erw nostra.
Attraversando l'ing,resso a ca.ncello si cnt.ra nel primo cortile (atrimn) oon portid, e a destr~1 e a sinistra vi sono quattro porte per ciaiscun lato, le quali comunicavano coi dormitori. degli info1,mi, desiderosi di alloggiare in casa, del medico durante le cm~e cui si assoggettavano.
Di f,ronte alla porta d'enkata. si aipre un passaggio al se-condo cortile (peristyliu,m.), con un'artistica vasca, circonf)ata da un ele-· gante giardino, W{°Lornato da s:pLendide colonne di marmo, a so,-,tegno òi una, piccola, tettoia. Vwrie porte davanq poi acce:sso alle ftbita:;i;ioni familfa,ri.
Il solitario visita,tore in me:,;:,;o a questi ruderi e ad un silenzio di morte ,p11ò qui oggi iricvorare nella sua fantasia, ]a, numerosa clientela .che attendeva nell'airium.) o passegg'i:mdo o stando seduta, ii1torno all'im.pl'uviiim_, d'essere 1·icevnta dal medico, e raffigurarsi i 1più caratteristici tipi. << Dai gladiatori muscolosi, dalle mmnhra enormi, dail coillo robm.:to e da1la t<>sta pic,eola, presentanti ferite, distorsioni e fratture, prodottesi nelle pa1est1'e delile terme o nelle lotte òeJ circo, a.gli Egizii, maf'.stosi, colle tuniche multicolori, colJa bairba posticcia airricda,ta, ed aventi negli occhi l'espressione misteriosa delle sfingi; dai poeti latini, con la testa rot.oÌtcla soop01·ta, intenti a rooita.re ,fra i denti giambi ·cd emistichi, ai marinai ,g,reci, ool loro tradiziona]e berretto rosso, gli ampii e pieghctta,ti calzoni e il mantcllo fermato ~mpra, urnL spa,lla; da,llle belle. vcstnili, involte nei loro ma,nti bianchi di finissimi lini, ai sacer: doti di Iside dall'aspetto feroce; cd etère e schi:we greche, dal viso bistra,to e da.lle fl,p~qsnose movcrn,,e; ed elega,nti pa,iri:t,ii, i cui linea.menti esprimeva.no la, mollezza., il deperimento organico · prodotto dalle co1pios,e Jiihazioni, daJle orgie e dai baccanali; e le opùlente matrone dalle o<'..ehiate provocanti. esp,rfanenti cliia;r·a.mente nell'aspetto d-ei lor·o volti n tedio originato da.gli ,obliosi mariti, semp:re infangati in ,ma vita <li vizio e di c,rap11la )).
Tutta questa eterogenea1 moltitudine di clienti, tanto diversi

1' 1·11, 101·0, acconev:1 HHa ca$n del medioo pompeiano, per consulta,rlo 1- 11 llc soffcrcnzei fisiche e alcuni. anche su quelle morali. E il sanif :11·io non si faceva attendere: veniva dalla sua abitazione ipa,rti1·0 la.re, attra,veri:;io il peri8tyliu,m e si dirigeva verso 1 l'a,trium ed cn f,r•:-i,to in uno dei citbù;nla cominciava la vi.sita degli infermi che lo :i.ttendeva,no.
Il cu,biculitm o camera <li consultazione iè ancora ornato da pitture ad affresco sul caratteristico fondo rosso pompeiano e da, :1 r·tistici quadri in mosaico co-n figure aU-egoriehe <lcll'a,rt0 sa11 i taria,.
Il medico procN!eva i:;ipeditn.mente alla visita, praticando con ~wande maesti·ia l'esame clinico. Dopo averli interroga.ti e visitati nocuratamente, prescriveva,. loro il trattamento terapeutico s.pedale rig_ uardo alla dieta,, quando soffrivano- di p1·ocessi febbrili ;i.· .nti; e ordfoava loi·o dei regimi alimenta.ri appropriati. A quelli, -d:1,i quali non credeva <li ottenere esiti efficaci da!lle medicine, con :-:igli.wa eome indicatissimo il caml>ja,mt·nto d 1arh.1i e di luoghi.
Ritiirando~i. cia.sc11n informo por1 a,va l"!~(), scritte con uno ~tiletto su di una tavoletta, cerata, lè p,r~I'izioni suggerite, con pfona e<l Af'!soluta obbedienza di osservarle, poichè era convinzione 01·mai ge1rnra,lizzata che 11ttl1 l~1 il medico iJJoteva con:-1egnire se non veniva l:l;ÌUtato òn.Ua buona volontà ,d{'-Jl'informo, ben ricordando il fn,moRo aforisma del maestro l1P1Pocrate : « La vita è breve e l'arte è lunga; l'empirismo è rperiooloso; il raziocinio è difficile. To ·neces:::a.rio non solo fare, comunque, ciò che conviene, ma, altresì essere aiutafo ·<'lalll'informo, da coloro che lo assistono e (falle cose este,l'iori )).
Col p,rogl·,edire e coll'affermarsi dcU'a,rte saluta.re in Roona. i guadagni dei medici in quei tempi ragginngevano somme favolose. Lo stesso PHnio ci riferii;~e che non v\ era altra professione ipiù r,edd it.faia <li quella deil medico. Il caipo del Collegio degli al'chiatri n,veva in ,compenso venticinquemila sesterzi all'anno e narrasi che Gakno per nna, sola, visita a.ve.-.,s·e 1·iS<;.osso qm:.iJsi aJtretta,nto. Cassio perccpi~a ('.omc .&mitario uno stipendio annuo di 250.000 sesterzi7 e<Jnivalenti a circa 100.000 d,elle nostre lfre anteguena. Quinto Ster1.inio, iper ave1·c prestato le .sue cure ailla. famigliia, imperiale, non P~itò a, cllied,erc un compenso di 800.000 sesterzi (123.000 li•re in

cif.ra tonùa), mentre dalla, smt clientela ,priv.:~la r-ica.va,ya un provento annuo di 600.000.
Lo stesso onora.rio ipeI'<!G'lpiva, Ola-ndio Ce.sare, ~no fra.teno, ed entrambi, dopo a,ver speso ingentissime .sonnue pel' l'a!Jbcllimentc della città di Na.poli, lasciarono nn'er-edità, cli circa 60.000 sesterzi. Il chirurgo Akone, salito in fama per .la cnra delle fra,tture e delle ernie, in pochi anni potè rifar~i di una multa di 10 milioni di sesterr,i, pi:i,ri. 31 4 rnilioni e 100.000 lire. E Orinate, che eserci.tav:1 una medicina astrologica fondata sul movimento dei pianeti, lascit ailla morte un. caipitale di a,ltrett,aJ:1ti milioni, dopo, ,1v-e1· spese un'eguale .somma nella costruzione ùellc mura di Marsiglia, ~UH città nata.le, e nella fortifica~Ìone di a,ltre d(;tà,. D'altra, p:a,rte il medico no.n poteva essere citato in giudizio che in Roma, eù un:i offf>~~a fatta alla sua persona veniva punita con ona mu~ta di 100.000 sesterzi.
A questo fonto sviluppo ~i.:ua medidnn, in !{orna, 11011 deve f'.<sse1·<
f'lfafa. f~!';f.rn,nen, la, drcosta,n zn, che gli stndi mcdid non <'ra110 r qnell'epoci:i iper .nulla ancora {)rganiz,r,ati e che i tc1:>ti ~,,
· .i<~nti1ic era.no n,ssai SClH'Si e raggiungeva.no prezzi proibitivi, per coi i me did dovevano istruirsi a.Ila, meglio comr. poteva.no. R bi~ogna, al' 1·ivare :1, Settimio Severo (143-211 d. O.), pe,rch,è l'{Ìa, prcsc,ritt< un diploma, ip,er l'c~ercii;io in Homa d,eJll'a,rte che in1-:igniva del ii tolo di medicus a repu,blica e laJSCiarc p~sa~e .altri venti anni, :fini al tempo di Alessaiuù·ro Severo (~03-255 <l. C.), per aver trareia delli iprirmc scuole <li medicina, i~tituitc nella, dttà.
Ma fin da.Jil'Impero i medici çominda.no ad essere tenuti iJ gra.nde oonsidcrazione ,e sono chiamati alle ,più alte cariche delli Stato, pa.rtocipando a.11 'amministra¼ione dell'U1·be, in Yirtù <lell: cittadinanza, romana concessa, da U-inlio Cesare nP.ll 4G d. ··o _ E s

pnò concludere che da allora essi C{)Stitui,soono un.a classe privile
gia.ta sotw la h1t,<>fa. deilla leggP, che, se<::oll(lo fa .. gr·a,ndio8::I· conce zione latina., ponP- la 8alus pitblica a, base gra.niti.ca. della g•ran dezza. e <le]!],1, forza <li Roma..
IL. - L'ASSH;'l'ENZA. SA:"sITARIA PRESSO L .lil I•'OKZE ARMATE DEJ ,L1 i\!'~'l'ICA ROJHA.
Aubiamo ritenuto di qualche intere;sse premettere queste som111.1xie notfaie sui me<l.ici e snJl'esel'cizio dell'a,rte sa,nita,ria, nel. 11 'I J.d1c, perch1\ CtSse ci spianano la via allo stndio cl.ella IDPdicina 111il ita1·e del tempo.
Secondo Ja. tra,dizione virgi!liana; lapis rwppres·enterebhe il .-:ipo ,stipite dei medici militari 1·0-malli. J~J noto l'e,pjsotlio del , ·:i nfo XI dell'Eneide: l 'e:l'oe troiano, colpito da ,rna freccia, è coi-:l.1·et.to a, ritirarsi dalla k1ttaglia; .i:;ostenuto dal figlio Giulio e ,J;i. Mne.steo, si J'ifugia, in luogo a,ppartaw, e dopo hmtili tentativi di <'Rt.ra.zione d~l dà,rdo, implora che colla spaida gli sia allargata
l:1. f<'l'it.a. rn nng-c il ve<'.chio J~.pif.l, ehB. a detta di Virgilio, a-veva. prefo1·ito ane glorie militari ]'esei·cizio dell'a·rte sa:lutare (sO'ire 1101 m1lulff~ hcr bar"lnn us1trnq11.p, rne,lendi maluit) ; egli solleva· le pi,c•ghe della sua veste per essere più libero nei. movimPnti t·(mta di asportare la, freccia, scuotf'T1dola con ila ma-no esperta (man11,
,nr:d-ica).
« ........... . . _ . 8br<accfato intanto E <;On la. veste it )a, cintura avvolta, Qual dei meùid è l'uso, il vecchio lapi Gli era d'intm·.uo e con diver,se provi~ rn ma:U, di forri, di liquori e d'erbe Invan 1:,i affaticava,, i.uvan ogni opra, Ogn'arte, ogni 1·imcdio e i 'Preghi e i voti Al suo rnaestL'O Apollo c1•an tentati >J.
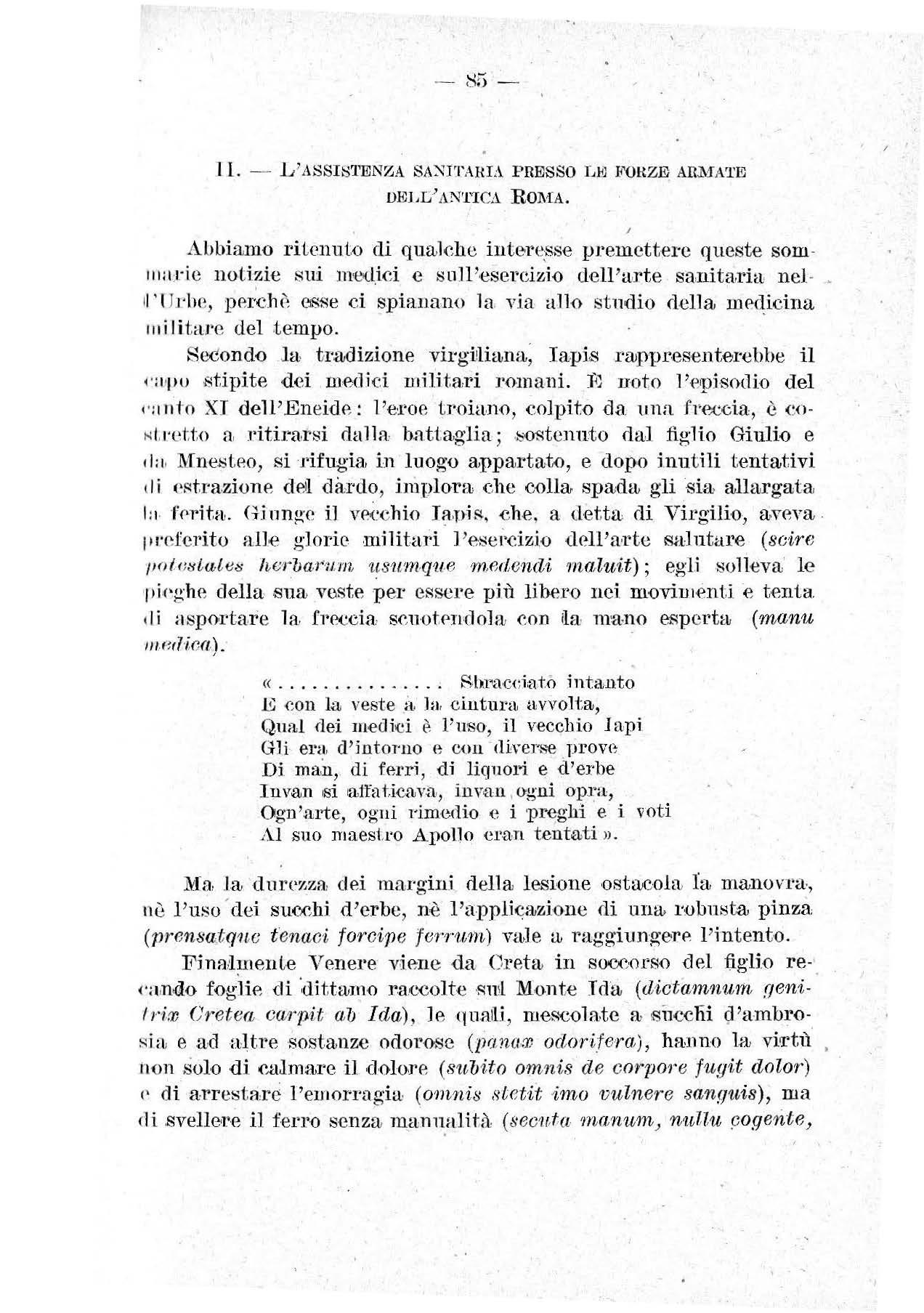
Ma, la dnre;,,za, dei margini della les~one ostacola la manovra, nè l'uso · dei suochi d'erbe, nè l'appliça,zione di una. mbnsta pi.nza (prensat;q1ic tenac-i forcipe fcrru,t>i) vale a, raggiungerP. l'intento.
Fjn::3ilment.e Venere v:i.enc da OrP.ta in soccorso del i;iglio re<"a,ndo foglie di ·dittamo raccolte ·Srnl. Monte Ida (dictamnuin geni I rim Cretea C(trpit o,b I da), ]e quHJl.i, me5.-colate a s1Jccni cl 'ambro:--: i a e ad altre sostanze odo1·osc (pano x odorifera), hanno h.1i viirtlì . i1on solo di calmare il dolo,1·P. (siibito omnis de cor porc fugit dolor) ,, di arrestarci l'emorragia, (oninis st etit imo vulnere sanguis), ma di svellere il ferro senza man nali tà ( se01da maniim) nitllu pogeirte,










